

Nicola della Volpe






Tu t ti i diritti ri serva ti Vi e ta t a la rip roduzion e a n c he parzia le se nza a ut o ri zzaz io ne
© BY UFFI CIO STO RI CO SME - RO MA 1992
STJLG RAF ICA S.R L - V rA DE L LA M O RT E LLA , 36- T F. r 06 -4 388200- 001 57 ROMA
Quale ruolo ebbe l'Esercito nelle attività di propaganda fra la la e la 2a guerra mondiale?
Vi furono inter essi reciproci fra la Fo rza Armata e il Fascismo , e fu perseguita una politica comune p er la ric erca del consenso?
Trovarono, i militari, spazi autonomi per utilizzare L'arma della persuasione, nella monolitica organi zzazi one piramidale del R egime ?
A questi, e ad altri interrogativi, s i propone di rispondere la presente ope ra, seguito del precedente volume Esercito e Pr opagand a nella Gra nd e Gu e rra .

G li interrogativi, anche nella parte strettam en te storiografica, non sono di facile risposta, per la complessità d el periodo in esame e per i dibattiti, ancora oggi molto accesi, sugli eventi e su lle gu erre del « ventennio », ovvero quella condotte in Etiopia e Spagna .
Guerre che, al di Là delle motiva zioni politi che, dim ostraron o ancora una volta «s ul campo» L'assunto delle ne cess ità della propagand a, per la feroce battaglia id eologica che esse scatenarono fra gli Stati, bellige ranti e non.
Fu proprio in tali co nflitti ch e la pro pagan da si trasjòrm ò in gue rra psico lo gica, condotta senza esclusione di colpi, arti co lata e sviluppata a dismisura in ogni sua attività; e fece uso, a piene mani, anche di strumenti relativamente nuovi che scienza e tecnica avevano reso disp oni bili, quali la radio e il cin ema.
La scansio ne del volume, di cui è auto r e il tene nte co lonnell o Nicola della Volpe, segue ritmi espositivi già collaudati in altre opere dell'Ufficio St orico, e coni uga finalità informati ve con esige nze Divisa in tre par ti, La pubblica zione prop one, infatti, al Lettore e allo studioso, i lin eamenti storici della propaganda, g li strumenti e Le immagini di cui essa si servi, la guida bibliografica e documentale : un prezioso strumento che rende possibile agli storici l 'approfondimento di tu tti g li asp etti t rattati, perché mette a loro dispo sizi one la chiave d 'a ccesso ad una cospicu a docu mentazio ne d'archivio.
IL CA PO D ELL'UF FI C IO STOR I CO
Intr oduzio n e...... .................................................................................. ............................ 7
Tra s toria e propaganda. Sintes i storica........... ... .......... ... .. ............ .. .. .. ............ ............ 9
Capitolo!: 1919-1925 ................................................................................................... 11
Capitolo II: 1925 -1935................. ................................... ....................................... ........ 32
Capitolo III: 1935-1939................................................... .. .. .. .. .......... .... .. ............ .... ........ 47
Gli str umenti della propa ga nda .... ................. ............. .... ............. ..... .............. .... .......... 83 Nota dell'autore.............................................................................................................. 85 Cartoline .................................. .... ..... .............................. ............. .... ................... ............. 87 Fotografie e Cinematografie .... .. ... ........ .. .. ............. .... .... .......... .... .... ... ... ..... . .. ..... .. .. ...... 129 Radio : 181 Manifesti, scritte murali, vo lantini................................................................................ 199 Giornali e riviste. Opuscoli... .... ................. ............. .... ........................................... ........ 249

G ui da al le fonti 301 Avvertenze....................................................................................................................... 303 Storia e Propa ga n da ....................................................................................................... 304 Cartoline e Po sta Militar e ....... .... ................ ..... .............. ............... ... .... .............. ..... ....... 318 Fotografie e Cinematografie ..... ..... ......... .... ............. ...... .......... ...... ... ....... ............ ......... 320 Radio .... ............................................................................................................................ 323
Manifesti, scritte murali , vo lantini................................................................................ 324 Stampa. Giornali, riviste , op uscoli........... 326

A l te rmin e d e ll a g rand e g uerra g li organi c e ntrali e direttivi d e lla propa ga nd a, cos titu i ti in se no a ll ' Eser c ito , furon o progr ess ivam e nt e s mantellati. Il p ri mo colpo lo ricev e ttero a s eguit o d e lla s m o bili t az ion e e d e i continui , fr e ne t ic i riord in a m e nti ; il se co nd o , definitivo , dall'a v ve nto d e l fa scismo. Andarono così pe rdute pr eziose es peri e n ze accumulat e, co n e normi f a tiche, in quattro a nni eli g ue rra.
L'Eser cito contin u ò, comu nqu e, in tono min o r e ad occ upar si eli ass is t e nz a e propa ganda , attr ave rso i va ri Uffi ci d e llo Stato M ag giore e o rgani p e riferici , che ve nivan o cos tituiti a lla bi sogna.
Dal1 919 al19 39 è poss ibil e distingu e r e tr e fa's i - fasi c he segnano a nch e le t a p pe d e ll' ev o lu z io ne dell a po li tic a f a sc is ta - n e ll e atti vit à propagandistiche s volte, e s ubite, da ll'E ser c ito: - una prima fa se, d a l191 9 a l1925, in cui tal i attività furono ancor a promo sse in proprio a ttr av e r s o vari E n t i e Uffici s ub e ntr a ti all ' Uffic io Sta mpa e Propa ganda d e l C omand o S u pre mo , f ino al momento in cui s co mparir o no con l' a vv e nto d e lla dittatura ; - una seco nda fa se, da l1 925 a1 1935, in cui l' E se rcito principalme nt e s ubì , co m e tutta l a Na z ione , l a p rop a ga n d a di r egim e, limitando la s u a opera
all ' a ss is tenza material e e mor a le cle11e tr upp e, e· con co rre nd o ta lvolta all ' a zi o n e d i b o mbard a m e n t o psico l og ico de ll e mas se all e armi ; - un a t e r za e ul tima fas e, clal193 5 a l 1939 in c ui l 'Ese rcito ritr ov ò s p az i d ' a zi o ne - ma se mpre so tto le dir et ti ve de gli organ i d i regim e - co m e n e lla guerr a italo- et iopica e n e lla c ampag n a di Sp ag na. A llo s t esso t e mpo esso comunque par te cipò , a ttravers o il Sott ose gretari o a lla Gu e rr a inse rit o nell a Co mmi ss io n e Supre ma Di fesa, alla o rganizzaz ione d e ll a prop aga nda. Due f urono le direttri c i in cu i l ' I s tituz ion e s i m osse in q u es to ultim o arco di te mpo: una vols e l'a tt e n z i o n e a ll e p rop ri e truppe, l ' a ltra a i t erritori tea tri di o pera z i o ni. All ' int e rno del P a e se l 'az ione pr o pagandi st ica de ll 'E se rcito fu nu lla , o quasi . No n in ga nn i , p e raltro , t a le a rti c ol az ion e t e mp o r a le sc he m a ti ca : è fatta solta nt o p e r comodità di lettura. Il problema prop aga nda , ne l ventennio preso in es am e, ri s ulta m o lto compl ess o e i mod e lli de sc rittivi e di lettura , che potrebb e ro e ss e r e applicati , sono num e r OSISS IIDl. Ques t o v olume s i prop o n e di off rir e s emp li ce mente un contribu to allo s tudio d e l fen o m e no pr o pagand a - non h a, e non p o tre bb e a ve r e , n ess una pre tes a

esa ustiv a - visto secondo una part icolare ottica in un m ome n to s ign ificativame n te difficil e, ancora ogg i co ntr overso, della sto ri a de ll'Ese rcito e d 'ltali a . Utili zz ando a pie ne m an i, come g i à è stato fatto n e l p rec ede nt e
«Esercito e Propaganda nella Gr and e Guerra », i mezzi spiegati dalla propaganda, se nza l'ausilio d e i quali non sa rebb e mai poss i b il e cogli e r e l'essenza d e ll ' «arma d e ll a persuaswn e».



All'indomani
• della vittoria e della p ace, l ' Esercito v isse e subì un a se rie di g r av i problemi , c h e ne sco ssero l 'id e n t it à c il prestigio ; problemi di natura poli.tica, interna cd interna z ionale, sociali c d economici , «scari c ati » dalla classe politica, in m o lti cas i con g r a nde abilit à, s ull ' I s tituz ion e e sui ve rti c i militari. l qu a li ultimi , divis i da invidi e e gelosie , spinti da intere ss i personali , non seppero o non vollero n é difenders i né contrattaccare . Un fenom e no comune a tutti i dopogu e rr a, vinti o p e rs i che fo sse ro i c onflitti antec e d e nti o succes s ivi.
La smobilitazionc cd il reinserimcnto dei reduci nella vita civile , le battagli e nazion a lis tiche per l'atteggiamento rinunci a tario d e l Go ve rno alla confere n za di Pari g i - o vc, dim e nti c h e del Patto di Londra d e l 2 6 aprile 191 5 (con il quale erano state promesse all'Itali a le province au s triache fino al confin e d e lle Alpi , la Dalmazia sette ntrionale con le iso le e Valona , più compe n si territoriali in Asia Minor e e nelle Colonie), l ' In ghilt e rra, gli Stati Uniti e s opratt ut to la Francia perorav a no la creazion e di uno Stato, la Jugo s la vi a, che coprisse il vuoto las ci a t o dall ' Imp e ro Austro-Ungar ico e r es ta sse loro zona d'influenza - l a riconversion e indu striale delle fabbri che di guerra , i fermenti s oc i a lis ti ed i moti di piazz a , le pr e pot e n ze e i d e litti d e ll e squadre di a z ion e fa sc is t e, gli int e rve nti dei militari in serviz i di ordine pubblico, le denigra z ioni str um enta li mosse da molti partiti , le discussioni tcor e tic he sulla
leva volontaria o obbligatoria, l'ostracis mo delle pote n ze alleate e avve r sa ri e , il probl e m a di Fiume e la propa g and a anti-itali a n a d e gli s la v i , coin vo lse ro sempre più direttam e nt e l'Eser cito e pesarono n e gativam e nt e s u di ess o. Nonostante c h e all'interno d e lle Forze A rmate ricc o e vivace continuasse il dib a ttito s ull e qu es ti o ni militari prese nti e futur e, l 'I s tituzion e fu se mpr e più sp ess o accusata di in e rzia, m e ntre in effetti fu costretta a vivere alla giornata , sempre più alla merc é degli uomini politic i , troppo imp eg nati altrimenti p e r acce tt a r e, a ffrontar e c di s cutere problemi di politica militare , ed elaborare progetti c piani per il dom a ni. Fu così che i militari , abbandonati , v il ip es i e d ingiuriati , s i s entirono defr a udati e traditi. Ness uno s i sa r e b be dovut o m e ravigliar e, in tale situa zio n e, se più t a rdi molti di ess i avrebbero d a to la propria incondizionata adesion e a l fasci s m o .
Il clim a di mal esse r e non imp e dì , comunque, agli or ga ni d e lla propa ga nd a di continuare, sia pure in tono minor e, la propria opera. Al ce ntro ed in perife ria, per molti m es i dopo la fin e della g u e rra , i provv e dim e nti a s sis t e n z i ali e propa g andi s tici ebb e ro costant e a ttuazion e .
Cont inuarono a provvedervi principalmente l'Ufficio Stampa e Propaganda del Com a ndo Supremo , le S ez ioni e le Sottosez ioni P (propa ga nda) dell e Armat e, d e i Corpi d ' Armata e delle Unità paritetiche , sussidiati d a a ltri Uffici del Comando Supremo (Opera z ioni e Informazioni); e, per

quanto concerne il fronte interno , dai C omitati e dalle Opere Federate so rt e nel corso d e lla guerra e ancora operanti a l termine del conflitto.
Nel contempo , mentre vecchi o rgani ven ivano sciolti , come il Sotto se gretariato per la propaganda all'es t e ro c la stampa del Minist ero dell'l n tern o (gennaio 1919) , a ltri - creati per sco pi diversi- avviavano la loro a ttivi tà n el se ttore , come la Sezione Militare della D e legazione Italiana per la pace di Parigi.

Nello stesso mese di gennaio gli Uffici ITO ( Informazi oni Trupp e Operanti) delle Armate passarono dall e dipendenze dell'Ufficio Op eraz ioni a quell e del Servi zio In formaz ioni , poich é, co n la fin e delle ost ili tà , le notizi e racco lt e as s unsero sempre più carattere politico , perdendo le pcculiarietà militari . Il Serviz io Inform azio ni precisò quali notizi e dov eva n o essere raccolte , per poi essere riunite in un appo sito notiziario diviso in qu a ttro parti: militari , politico- militari, economicocommerciali, stralci sta mpa.
R estavano inv e ce immutate le informazioni da compendiare ne lla relazione quindicinal e sullo spir i to delle popo lazioni e d e lle truppe (Sezioni e Sottosezioni P ), in cui particolare attenzione doveva essere posta alla segn alazion e di eve ntuali malcontenti , b iso gn i, correnti di id ee, ecc.
La ricerca dell e noti z ie politich e fu ca usa di contrasti tra il Governatorato della Vene z ia Giulia , che avocav a al suo se rvi z io tale competenza, e il Comando della 311 Armata , il quale faceva notare
al Co mando Supremo come , p e r la si tu azio ne venutasi a determinare n e l territorio dell ' Armata, non potev a esimersi dal raccogliere tale tip o di informa zio ni , ess endo esse alla base di ogni azione di co mando della gran d e unità: com e, ad ese mpio , l 'emanazione dei bandi , la cui redazion e era stretta fun z ione d e lla pe rfetta conoscenza d e lla situazione politica.
Non sembra peraltro che capi politici e militari si siano r ea lment e e ra z ionalm e nt e resi conto quanto importante, in momenti cosÌ. difficili e delicati , sarebb e stato accentrare ancora ma gg iormente tutta l'attività di propaganda e di contropropaga nda , inv ece di litigare e di distrugger e quanto d i buono e ra s t a to fatto: s i finì così pe r frazionar e indirizzi e demandare competenze ad Uffici già presi e totalment e assorbiti da altri compiti, altr e ttanto prioritari.
L ' azione di propa ga nda continuò comunqu e a muovers i in tre dir e zioni: i soldati, il Paese , l ' estero. I soldati furono as s istiti e, fin dove possibile , aiutati ad inserirsi nuovam e nt e nella vita civile ; alcune Armate , fra cui la P e la 3", dedicarono ai militari congedati un opuscolo, che sot tolin eava quanto era stato fatto per lo ro e quali di ri tti ess i avevano ac qui s iti ; spiegando, sotto forma di dialogo diretto c con un linguaggio molto semplice, com e muoversi per ottenere il dovuto: la polizza d e i combatt en ti , il premio di congedamento, il pacco vestiario, i s ussidi alle famig li e, i sussid i di disoccupa z ione , le pensioni, le
agevolazioni per gli emigranti.
L'opuscolo della l a Armata segnalava, inoltre, particolari provvidenze per i propri dipend enti. E, come mezzo di propaganda, non disdegnava di invitare i sold ati a ricordarsi , nell 'ese rcitare il diritto al voto , di «tutti quegli uomini che sanno non soltanto parlare bene; i più de gni per il loro passato e per la loro istruzione ed educazione, i più onesti; quelli che non amano il popolo a parole ma coi fatti; quelli che durante la guerra hanno diviso con loro le ansie, i dolori , Le pene ed i peri co li » .
Chiudeva, infine, avvertendoli dei pericoli di un a rivoluzione; d e lle lusinghe prov enienti da certi ambienti politici , delle m e ndacie deg li «imboscati di ieri, falsi ma/Levadori di oggi».
La propaganda verso il Paese, fatta ancora con il concorso di Assoc i azioni e Comitati, poneva invece l 'acce nto sul debito di riconoscenza che i cittadini avevano contratto verso i com batte nti , e auspicava che cssò si traducesse soprattutto nell 'a iutare i r e duci a trovare un posto di lavoro , adeguato ri conoscim ento a mesi ed a nni di du ri sacrifici e privazioni . Stigmatizzava, inoltre , l'atteggiamento di quei partiti c di quei cittadini che, passata la bufera , incominciavan o a nutrir e indifferen za, qu a ndo non d isprez zo c osti lità , verso l'Es e rcito.

Più complessa l 'azione di propaganda -e di contropropaganda - sv olta all'estero. L'Esercito, con la soppressione del Sottosegrctariato della propaganda , ven ne a t ro varsi di nuovo isol a to e costre tto a muov ers i su terreni
infidi , con compiti num eros i e di sparati; per svolgere i quali dispon eva soltanto d eg li Addetti Mi litar i, di qualche informatore dell' Ufficto I c della Sezione Militare della D e legazio ne a Parigi. Scarso , infatti, fu il cont ri buto offerto dall'Ufficio Propaganda del Ministero degli Es teri. L'Esercito doveva, in s intesi: continuare a fornire documenti e iconog r afie per dimo stra re e soste n e r e il peso avut o dall'ltalia nella g uer ra , pro gressivamente se mpr e più misco no sciuto dalle altre Potenze vinci triei; «te n e re » su l fronte dell e rivcndicazioni territoria li contro l' attegg iam ento ostile degli «a lleati »soprattutto Francia e Inghilterra -; controbattere la feroce propaganda contro l ' Itali a che gli sloveni della n asce nte Ju gos lavia andavano tenacemente perseguendo; porre attenzione alle manife stazioni di antiitalianità , la cui tenden za si dimostrava crescente n egl i. Stati balcanici, n ell 'Europa centrale c sette ntrional e e in Russia ; dife ndere l 'opera to e il prestigio dei milita ri italiani dei Corpi di occupazione e eli spedizione, nazion a li ed internazionali. Ll tutto in un diffic il e esercizio di equ ilibrio tra il Governo - la cui posizione co ntraddit toria d enu nciava la debolezza, se non l' asse nza, di un'organica politica es tera e da cui , p e r ta nto , n essuna di r ettiva pre cisa veniva -, i na zi ona list i e i fascisti delle squadre d'azione - se mpre pronti acl int e rpretar e a modo loro ogni presa di posizione elci r a pprese nt a nti militari -,c la sta mp a, che terminata l 'es igen za guerra e cessato, per opportunismo,
ogni «corteggiamen to », andava assumendo via via posizioni sempre più critiche , fino alla denigrazione cd al vilipendio dei militari e delle loro ist ituzioni.

Intanto tutto que ll o che avveniva a ll 'estero, riportato distorto da alcuni gior nali di parte , era font e di nuovi problemi per quanti si occupavano - e pr eo ccup ava no - della propaganda.
Alle d i fficoltà o rgani zzat ive e politiche che im ped ivan o a ll ' Esercito di sviluppare un'articolata azione di propaganda, si aggiungevano crisi e critiche all'i nt erno d e ll o stesso organismo militar e . La smobilitaz ion c di fatto avv e nne , p e r voler e del Ministero d e lla Gu e rra, senza che s i tene sse conto di un piano organico approntato dal Comando Supremo, ch e avrebbe sicuramente in contrato l'approvazion e dell ' opinione pubblica , per la celerità con cui le dispo s izioni avre bb ero consentito a molt e classi di leva di ritornare in famiglia. Preoccupazioni politiche del Mini stero della Guerra (manifestazioni di piazza, s ommosse contro il carovita e la p e nuri a di viveri, diffuse aspettativ e di grav i disordini di isp irazion e bol scev ica , allarmante attivismo di socialisti c catt olici, timori di rivolte in Alto Adig e e nella Venezi a Giulia) prev alser o s ulla logica e provocarono in co mpr ens ibili rall e ntam e nti d e i co n gedamenti. Numerosissime c irco lari, eman a te da più parti pro pri o perché venne a m a ncar e un piano organico, cambiarono in conti nu azione le modalità de g li invii in co ng edo delle classi a ll e armi ,
confondendo c turbando l'animo se mplic e del so l dato.
All'atto della smobilitazion e, ad eccezion e dei provvedime nti di assistenza già indicati e di vagh i accenni a i compiti devoluti all 'O pera Nazionale Co mbatt en ti , l' a utorità militar e non promosse una adeg uat a legis l azio ne ch e assicurasse il r e inserim c nto sociale d e i congedati , nono s tant e l'esist e nza di un Ministero per l ' Assistenza ai militari c le pensioni di gu e rra.
Non so lo , m a il generale Cavigli a , c he sost ituì il generale Zup e lli al Dicastero d e lla Gu er ra ne l gen n aio 1919, in occas ione del rimpas to del Governo Orlando, si affr e ttò inoltre ad assumere pos izioni critiche nei confronti della partecipazione d e i militari all a vita politica , disconoscendo di fatto le rivendicazioni territoriali e frustrando le aspe ttative di tutt i col o ro ch e si erano battuti in nome dell'id ea le delle terr e irredent e, tanto esa ltato dall a propaganda durante l a guerra.
V'è da ricordare, inoltre: ch e l'ufficialità era in ferm e nto p er l'elevato numero degli alti gradi esis t enti nell ' Es e rcito , fatto det e rminato dall'accelerazione dell e carriere provocata dalla g uerr a; che in Colonia pers isteva una s ituazione disa st rosa in quanto, pur esse ndovi dis lo cato un con tin gente di circa 80.000 u omini, il territorio libico e ra in mano ai rivolto s i a r abi; che i num e rosi impegni internazionali assu n ti (interv e nto in Carinzia , spedizion e in Anatolia, occ upa zione d e 11 ' Albania) avevano portato ad un a disper s ione di uomini
all' es tero senza precedenti dall'inizio del co nflitto (grad ualm ente vi fu d esti nato, infatti , il 20% dei mobilit ati).
Gli unici provved im enti tangibili adottati n el1919, furono , in pratica , il mi glioramento del tr a ttam e nto eco n omico a ufficia li e sottufficiali, l' aumento della cinq uin a da L. 0,50 a L. 2,50 , l'arricchim en to del r ancio con una n uova razwn e .
L'Ufficio Stampa e Propaganda del Coma ndo Supre mo , nel frattempo, nono stan te i num erosi imp egn i cui dov eva far fronte , s ubì un drastico taglio dei fo nd i, tanto da dover diramare, il 29 lu glio 1919, una circolare che sopprimeva tutte le spese dei Corpi «ge nericamente co mpres e nel titolo per la propaganda (stampe, pubblicazioni, ricordi, feste , erogaz ioni, ecc.)» I Comandanti di Grandi Unità e gli Uffici I.T.O. delle Armate furono così privati de l maggior in troito finanziario che , fino ad a llora , avev a conse nti to di svolgere la loro attiv it à. Le spese propagand istiche non furono più ritenute necessarie di fronte ad altre maggiori es ige nze.
L'Ufficio Stampa e Propaganda , d e ll a Sezio n e Militar e della D e legaz ione It aliana per la P ace di Pari gi, fu l 'uni co privil eg iato in ta le situazione di penuria. Num e rosissim e le richi este da esso avanza t e, e soddisfa tt e, agli Uffici d e l Comando Supre mo che operav ano nel settore (o lt re a Stampa e Propaganda , anch e Inform azioni e Operaz ioni): opusco li , fa scico li , fotografi e, cartolin e, ca r te , gio rn a li , dat i statistici furono for niti con abbondanza a ll a Sezione , che dov e va pubblicizza re gl i in ge nti sforzi

soste nuti dall ' Italia in guerra, far conoscere le azio ni promozionali a favore della pace e del riassetto d ell 'Europa , co ntrobat tere la propaganda - dir e tta ed indiretta - di avversari e alleati.
Un compito decisamente difficil e in un ambiente ostile. La Sezione, tanto p e r far esempi: fu int eressa ta per l 'is tituz ione di uno speciale servizio di propaganda a Vienna, dove, nono stante gli sfo rzi compiuti per l'or ga nizzazion e c l ' invio dei rifornimenti a limentari a favore delle popolazioni dell ' Austria , gli aiuti italiani venivano disconosciuti (la propaga nd a s lava, soprattutto , diffu se la notizia che i viveri pro venivano dire ttament e dall'A m erica, e ch e le r efe zio ni approntate sarebbero state b en presto ripagate con l 'istituzion e di gravose tassa z ioni); dov e tte fornir e dati e notizie per cont robatte r e a ncora la propaganda jugos lava contro gli italiani, g iu nta a di ffonde re fal se notizie su pres unte fucilaz ioni di s oldati itali a ni , co nd a nnati s olo perch é co lpevoli di ave r riconosciuto pubb li camente il carattere etnico -ge ografico slavo di alcuni t e rritori occup a ti ; do vett e occuparsi d e ll a recension e sta mp a c della segna lazion e deg li artic o li e degli scritti, ch e in qual s iasi modo co i.nvolgesscro l'Italia.
Un lavo r io t a nto arduo , q u est ' ultimo , d a pr ovocare l ' ist ituzione di un apposito Uffic io Stampa p resso la Presiden za de l Consiglio dei Ministri in Par igi (p r ovvedimento resosi a ncor più n ecessario i n quanto s i e r ano diffu se lamen tel e per pres unt e dispa rit à di
trattame nto dei giornalisti accreditati).
Mentre avveniva tutto ciò, il 9 agosto 1919, in occas ione di un riordin a mento del Comando Supre mo e del s u o trasferimento di sede da Padova a Roma , venn e so ppr esso l'Ufficio Stamp a e Pr opaganda .
Il compito di sondare lo spirito dell e truppe e di produrre propaganda diventava esclusiva pertinenza dell'Ufficio Inform azioni. Altri provvedimenti, imm e diat a ment e s ucce ss ivi , sma ntell arono progr essiva m e nt e le attività propagandistiche anche in periferia, co n lo sciog lim e nto di alc un e Armate e d e i relativi Uffi ci I.T.O.

L 'Ese rcit o s i trovò così a d affrontare, co n una frammentaria e disarticolata o r ga ni zzaz ion e, il problema d ei territori d i confine annessi c di Fiume.
A provved ere al ser vizio in t a li località era n o la Sezione P della 3a Armata, qu e lla d e l Gov e rnator at o d e lla Dalm az ia , e l'Uffi cio P o liti co Militare , cos tituito n el febbra io 1919 dal C omando del Corpo d'O cc up az ion e Interalleato di Fium e .
l noti z iari del Comando della 3a Ar m ata e i bollettini bise ttiman a li d e llo s poglio stampa ci co ns entono di acce rt are e val utar e qu e l ch e avveniva nei territori di confine e di occupazione. I so ldati itali a ni us ufrui va no d e ll e solite opere ass is te nziali, e d e r a no in ge ner e ben accetti dalle popola z ioni. li loro moral e e ra quindi e levato, e le proteste s poradiche e contenute; l' e uforia dell a vittori a aveva esa lt a to gli a nimi.
Compless a e temibile e r a inv ece la
propaganda s la va, condotta sop rattutt o attraverso op us coli e giornali , co n tecnica spesso ro zza e violenta , ma a tratti so ttilmente raffin ata. A notizi e di atti eli violenza c di terr o re compiuti s u ma sc hi e femmin e dell e zo n e occupate, di rub e rie di viveri e di danari (.Tadr an, 23 -28 mar zo 1919) , si alte rn ava no uscit e di g ior nali co n spazi bianchi; per far intendere che l'op e ra d e l censore itali a no e r a stata p esa nte a l fine di nasconder e chi ssà quali misfatti. Emissari e ag itat ori jugoslavi (sopratt ut to di estrazione int e ll ett ual e: avvocati, maestri , preti , impiega ti) , diffondevano noti z ie di s anguinarie rivo l te in città italiane , di disa s tros e co ndi z ioni eco nomich e dell'Italia, di eccidi e d efferatezze p er petrati dall e trupp e.
N onostan t e la fe bbrile attività di giornalisti e eli agitatori, la pr o pagand a s la va non r iu sciva t utt avia ad essere incisiva; le notizi e raccol te da gli informatori dell 'A rmata annotavano come le m ass e, in un primo momento diffid e nti c fredd e ve r so gli it a li a ni , in brev e tempo fo ssero state rabbonit e dall e distribuzioni g ratuite di ge neri alim e ntari , tant o c h e serb i e croati della zona di Spalato non voll e ro sottosc rivere sch ede di ades io n e al plebisc ito p e r la Jugoslavia promosso da un comitato locale, dichi ara nd o a perta ment e ch e avr ebb er o pre fe ri to l'ann es sion e all 'It a lia.
P esava n o peraltro sulla situazione: l'equivoco attegg iamento dei franc es i, i quali favorivano l'azion e di pr opag a nda jugos lava in ogni modo ; la po s izion e
assu nta da g li Stat i Uniti, che si pr estava a privilegiare la strume nt al e diffusion e di sole nni «pronuncie» del presidente Wi lso n a favore della causa jugoslava; la capillare opera dei propagandisti s l avi, che s ull 'onda di t ali voci erano arrivati a di str ibuir e, perfino a contadini e pastori de ll e zon e pi ù isol ate ed imp e rvie , coccarde con i colo ri sta tunit e nsi. L imit ata, per contro, era l 'attivit à di propaganda svo lt a dalla 3a Arma ta ; anche se il Co man do della Gra nd e Un ità , a proposito della s ituazione di confi n e e s ulli to r aneo adriatico, conc lud eva, co n mo lto r ealismo, i n una relazione de l gennaio del1919: «carne prima cosa devesi ottenere di far cessare ogni azion e politica, sia essa favorevole o contra ria alle aspirazioni italiane, degli enti militari alleati, politicamente irresponsabili cosi verso di noi come verso il loro paese ... Le eccessive pretese che nell'interno del paese vengono sosten ute da chi non co nos ce nemmeno superficialm ente Le èo ndizi oni delle coste orientali dell'Adriatico nuociono assai alla nostra causa e fanno apparire fondate le accuse che si muovono contro di noi. È facile nei comizi ri chiede re intere province abitate da parecchie migliaia di indi vidui di altra nazionalità, ma non è a l trettanto agevo le sosten ere di fronte agli avversari la giustizia delle nostre aspirazioni, quando costo ro dalle parole di nostr i stessi conna z ionali traggono argomento per dim ostrare che l' I talia, dimenticando il suo pass a to, vuo le sostituirsi all'Austria nell'oppressione politica dell e genti slave» .
Più che ass um ere l'iniziativa, la 3a Arm a ta quindi subiva e s i preoccupava so lo di con troba ttere le false not izie, o di interve nire a tamponare le falle dove era necessano .
Un tentativo invece di articolare e razionalizza r e l'azione di propaganda fu co mpiuto dalla Sezio n e P del Gove rn atora to d e lla Dalmaz ia che, co n una circolare de l febbraio 1919, punt uah zzava i criteri inform at ori d e ll ' attiv ità da svolgere.
Il compito di g u adagnare l a Dalm azia all' Italia veniva affidato al soldato, definito re toricam e nte «ag en te di it a lianit à»:
«Il soldato che facilmente e spo ntan ean1.ente, per ragioni evidenti, s i avvicina alla pop olazione, che entra nelle case ospitali, che beve allegramente alla tavola del serbo, del croato, dello slavo, che fraternizza con l a cordialità nostra anche con chi non sa farsi capire completamente; il soldato che più si avv icina per la sua ani ma popo lar e a questo popolo, deve diventare , o per meglio dire continuare ad essere, mig liora to, un n ostro el emento prim o di p ro p aganda .
È lui che deve parlare, insospettato, co n entusiasmo del/ 'Italia , dire con nosta lgico ricordo le sue bellezze e, fiero, cantarne le gesta eroiche del suo popolo.
E perch é Lui, siamo sinceri, possa parla re con vero sen tito entusiasmo, perché non abbia a nascere nel suo animo sano la minima ombra di malcontento verso La Patri a, è necessa rio orga ni zzare subito il servizio up " secondo le disposizioni che il Comando

Suprem o ha emanato con la circolar e 11797 OP. di Pro t. in da ta 30 gi ug no 1 918 a fi rma de l So ttoc apo di Stato Maggi o re dell' E se rcito. È n ecess ari o ci rcon dare il so ld a to di tante pi ccole cure ch e gli addimostrin o la g ratitudine della Nazi o ne - non !asciarlo so lo con la preocc up az ion e d ella f amiglia nella miseria - assisterlo moralm ente- di s trarlo con s vag hi e div erti menti - e soprattutto r en d erg l i facilm ente visi b ile il n o stro doveroso interess amen to pe l su o a v v enir e; p er res ti tu i rlo, miglio re, alla fami g lia, alla vita civile »
Il s old a to , quind i , qu a le o gge tto e s ogg e tto , com e r e cetto r e e all o stesso t e mpo pr odu ttore di pro pa ganda La circol a r e s pec ifi ca va anche come ottenere gli scopi indicati n e ll a premess a , quali mezzi ut ili zz ar e e qu a li a ttiv i t à intrapre nder e n e i confro n ti sia dei militari (opuscoli , giorn ali , sc uol e per a n a lfa beti , s ussidi , doni , s p e ttacoli , le ttur e, a ttivit à pe r la « r e s iste nz a m o r al e», oss ia morale e cont e gn o d e ll e trupp e, contatti con la popol az ione civil e, e limi n a zio ne d e lle cause di malcont e nti, co ntro ll o d i agitatori e di sfattis ti , ce ns ura) s ia della p o polaz io ne civ ile, (assist e nza scola s tica , is titu zion e di biblioteche popo lari , co ll aborazion e co n i giornali lo ca li , a ss is te n za sa n itar ia, diffusione di material e propa ga ndi st ico , s pacci di distribu zion i v iveri g rat uit e c r e fetto r i, circoli di cu l tura , ini z ia ti ve di be n efice nza, attività ricreative , e cc.) .
Come semp re, partic ola r e a t te nz ione dovev a essere posta n e ll a sce lta degli ufficiali da adibire al se rvizio e di quanti
potev a no fornire op e ra di cons ul en za.
An c h e il G ove rna to rato d e lla Dalm az ia annotava , e s ubi va, l' irriducibile az ione a nti-italiana svo l ta d a i pr o paga ndi s ti jugos la vi , sos t e nu ti d a franc es i, ingl es i e statunit en s i. Il governator e Millo , l' e roe d c i Dard a n e lli, e bb e a d e nunci are tra l 'altro a n gh e rie serb e a Ra g usa ver s o conna z ionali , ig norat e dall e autorit à franc es i , e un a not ev ole a t tività croa ta a favor e de l bol s cev ismo.
La S ezion e P della Da lm a z ia sv olse, inoltre, l ' opera di sos tegno , n e l territorio di compet e nza, d e ll'azione di contropropag anda e di riv e ndicazion e del Governo italiano in corso a Pari gi: p rom osse in fatti la raccolta di una nutrit a se r ie di le tt e r e dirette al se n a tore O rl ando, in cui città , a ss oc iaz io ni e com i t a ti dalmati manifestav a no la lo ro italianità con «v ibranti » m ot ivazioni e d es pre ss ioni.

In definiti va, anch e in D a lma z ia, no n o s t a nte l 'o s til e a t t ivi tà avversaria , lo spi rit o de ll e truppe e ra buo no , il morale e lev a to, i contatti con la popolazion e sereni e cos truttivi.
Complessa la s itu a z ione a Fi um e , do ve il ge n e r a le Fran ce s co Sa verio G ra zio li , Comandante del Corp o di Occupa z ion e Tnterall e a to , d o vette chiarir e e r iordinare ne l febbraio 1919 i co mpiti dell 'Uffic io Politico Militar e, nelle c ui man s ion i ri e ntrav a no le questioni di ca ratt e r e politico , il se rvi zio informazioni , il se rvi z io di pol iz ia politi ca, il con t ro ll o d e ll e p e r s on e in tra n s i to (passa porti) , la stampa, il se r vizio censura.
L'U ff icio com pre n dev a , fr a l'altr o , una S ez ione Stampa e Tradu z ione (rapporti con la stampa, stampa e prop a g a nda , ce nsur a e recen s ione s tampa , p r oduzio n e docum e nti), una Sezion e Fiume (affid ata al ca pitano Host- Ve ntu ri co n il co mpi to di inda gare s ullo sp irito pubb li co d i Fium e e di co ndurr e ind ag ini ri se rvate d i carattere poli tico) , un a Se z ione Sussak ( p e r le informazioni s ullo sp irito pubblico ne l territ o rio cro ato occupato c ne i comuni limit rofi , co ll eg a ment i co n le a ut orità civili , se rvi z io p osti co ntroll o) e un a Sezion e Pro pag anda (se rvi zio propa ganda e vigilanza, assi s tenza , doni e pro pag and a pe r la popolazio ne civi le).

Compito principale della propaga nda a Fium e f u qu e llo , cons u eto , di co ntrobatter e l ' in izi at iva avv e rsari a c l'atte gg ia mento ostico degli a ll eati.
L a massa d e i fiumani, infatti, era fi loitaliana e qu asi osann av a per la prese nza d e i nostri. milita r i. Alm e no f inch é l'occ up az ion e non d ege n e rò . P er F ium e è n ecessa rio , però , far e un p asso indiet r o , per ce rcare di ca pire i prodr o mi e le ca use dei fatti di se tt embre , il clima c he si e r a instaurato. l ' efficacia d e ll ' az ion e di propaganda e co ntr op ropa ga nda sp ieg ata da più parti n e lla ci ttà.
Ancor prim a d e lla f ine d e ll a gu e rr a, il 30 ott o bre 1918 , a Fiume si e ra cos tituito un Co nsiglio Naziona le, presied uto d a Anton io Gro ss ich, ch e aveva proclamato l 'a nn essione all'Ita li a. L ' avv e nimen to contr i bu iva ad esasperare il pro blema dell a sparti zi one delle terre di co nfin e . Con il patto d i
Londra de l 1915 era s tat ç> d e ciso , infatti , sopra ttutto p e r vo lontà della Ru ss ia, ch e Fiume fosse asseg n ata alla C roa z ia. Poi l'usc it a eli s ce na delJa Ru ss ia al termine del conflitto , la fort e prese nza i taliana n e ll a città , l'atteggiame n to de l presidente s tatun it e n se Wil s on (ch e, ol tr e a soste n ere il principio dell' a utodet e rmin az ione dei pop o li c dell e min o r an z e , proponeva di dichi arare Fi ume citt à lib era), le pretese dell a nas cent e Ju go s lav ia d i ann ette r si Tries te , l ' I stria e l ' in tera D a lm az ia , il conteg no ost il e verso l 'Itali a di Francia e In gh ilterra , r esero le tratt ative diplomat ich e a lla confe r e nza di P a rigi oltre modo dramm atic h e.
La questione eli Fi um e es ace r bò molti animi in h alia; specia lm ente qu elli di colo ro ch e, sp in ti a cred ere n e ll a r ede nz io n e di terre intrise di italianità , furono persuasi sin ne ll ' intimo d a ll a batt ag lia pr opaga n d is tica fatta in ta le dire z ione nel corso de ll a g ue rra , e oltremodo esa ltati a fi ne g u e rra , qu a ndo F ium e fu as s urta , con d el iri o , a s imbolo di ogn i rivendicaz ione .
C'era, in effe tti , un fond o di r ealismo politico , storico e soc iale n e ll e richieste per F ium e: p iù d e ll a metà dei fium a ni e ra d i lin g u a itali a n a c costituiva la parte più co l ta e attiva d e ll a pop o lazio n e . Ne l nov e mbre d e l l918 un Corpo di Occ upazion e inter a ll ea to , a l comando de l te ne n te ge neral e Gra zio li (succeduto al brigadiere gene ral e Enrico A s in ar i eli Sa n Marzano a l fine di ev i tare che il co m ando cadesse, per mot ivi gerarc hici e di anzi a nità , n e lla mani del gener al e d i div is io ne T rani è ,
franc ese), fu di s loca to a Fium e per il m antenime nto d e ll ' ord in e pubblico. Il Gra ziali, convinto asse rtor e dell'it a lianità d e ll e t e rre r edente, fece ogni tentat ivo , fino a lla s u a fr e ttolosa de sti tu zione (l se tt e mbre 1919) , per guada g nare F i um e a lla cau sa italiana. Fu un co mandan t e sc omod o e si espo se persona lm e nte , appogg iand o aper t amente la costit uzione de lla L egione Volo ntari Fiumani di Ho st Venturi , com prom e tt e ndosi co n gli alleati , s ti g mati zzando l ' in erzia d e i politi ci. Si batté co n t ro l ' ostilità d ei milit ar i franc es i, il c ui smacca to atteg gia mento filo -j ugosla vo fu la ma ggior causa d eg li incid ent i che scopp ia rono a Fiume dall ' ap ri le all ' agosto dell91 9, fino all 'avve ntura dannun zia n a.
Non è qui il caso di analiz zare a fondo le cause politich e c militari di ta li avvenim e nti , se n o n p er la pa r te in str etta r e lazion e co n la pro paga nd a fatta intorn o a d essi , e a ll ' influen za c he essa e bb e ne i co n front i d e i mili tari dell ' Ese r ci t o , pers u a d e ndon c molti a partecipa r e alla spe dizion e del 12 se ttembre. U til e a co mpr e n d e r e il fe nom e no è la R ela z ione sui fatti di Fiume , re d a tta il 26 giu g n o 1920 dal ge n era le Pe cori G ir a ldi, i ncaricato dell ' in chi e sta.
L 'Ese rcito , e d in pa rticol ar modo i r epa rt i dislocati ne lla città , e r a ve nuto a tro va rs i al centro di una favorevole e tenac e ope ra di propaganda , s volta con ogni m ezz o e sosten uta d a ogni parte.

Il so ldat o ch e ve ni v a d a ll a t rin cea av eva co nosciuto c viss uto , p e r quan to
rozzo c ana lfabeta- ma non per qu esto non int e lligente -, i mom ent i d i esaltaz ione d ella vit toria , i se n timenti di itali a nit à dell e nu ove po po laz ioni d e ll a zona di armistizio , il fascin o e l'effica cia della prop a ganda sv o l ta dall 'ele m e nt o f e mmin ile - arr e nd evole ve r s o quanti ne spo sava no il patr io ttismo e l'ardente d esider io di di ve ntare ita lian e; un ' arren d evolezza giustificata a n ch e dal fine di sott rar si a ll ' i nc ub o d e lla domin az io n e croata, l'in cita m e n to continuo d egli stess i s up erior i , ch e favoriva n o i vin co li di intim a fratella nza con i fi um ani e n e esa lt avano co n ogni mez zo lo spirito , n e l timor e c come antidoto a possib ili «infez ioni bolscev iche ».
Toccato n ell'i nt imo, il soldato itali a n o era a ll o s t esso tem po sdegna to per la fe ro cia de lla propaga nd a slava e r ise n ti t o per l 'arroga nza , la prote r via e la viole nza dei cosiddetti ch e p ur e avev a tr attato co n le a l tà; di conseg u e nza egli s i intristì , per l'inerzia e per l 'a bbandono dei politici , per le affr e ttat e sost i t u z ioni, e per gl i allon ta namenti d e i reparti da lla zona d i Fium e, che sap e vano di un a prec ipitosa e mortificante ritirata.
Ques ti se ntim e nti co n traddittor i crearo no n egli u o mini un o sta to di agita z io n e e di ins tabilità e d una i ncon sc ia pred ispos iz ion e ad azioni ch e ave sse ro mirat o , a nch e co n la vio le n za , a risolvere il probl ema .
Il rie ntro di Orlando in It a li a da P arig i il 24 apr ile per pr otes ta - Orlando fu for se uno dei poch i politi c i a s ostenere la causa fiuman a - e il s uo s uccessivo
ritorno a ll a conferenza in condizioni di su ddit an za ne i confronti d eg li alleati ; i continui in c id e nti protr a tti s i da ma gg io a d a gos t o, fr a le trupp e fr a nces i da un a parte e la popolazion e fiumana e gli italiani dall ' a ltra; la commissione d'inchi es t a dei ge n era li int e ralleati p e r i fatti di lu glio , e la rip e r c uss ion e ch e l ' esito m o r t ifica nt e d e ll ' in c hi es ta s tessa e bb e sulle t rup pe; la d ec isio n e a P a ri gi di scioglie r e la legione vo lontari fi um a ni e di sost i tuir e il continge nte it aliano , agg ra vat a d a l contegno rinunciatario e accondi sce nd e n t e de l G ove rno ; le diretti ve di D iaz di prep a r a r e gli an i m i dei comand a nti e delle truppe alla doloro sa e ve ntualità di abbandonar e Fiume; le proposte di s o s tituz ion e e gli avvicend a m e nti , non compl e tati , de i reparti p a rti c olarment e leg a t i all a citt à; lo stess o a ll o nt a nament o de l Graziali , furono tutt e concause ch e portarono 5000 milit a ri circa ad ad e rire a ll ' avv e ntura dannun z ia n a .

L 'entus ia smo in iz ial e d i tutti si s m o rzò q ui ndi b e n p r es to. Già a lla fin e di settembre, u n capitano d e l serviz io informa zio ni , in fi ltratos i a Fi um e, incominciò a inviare br e vi r e lazioni sul ca mbi am e nto degli um ori in ci t tà. Mo l ti militari fece ro quasi s ubito ritorno ai Corpi ; altri , appartene n ti a classi congedate, die d e ro il via ad un esodo vo lont ario. A d ese mpi o , il 29 se tt e mbr e, ve niv a seg na lato che 25 s olda!i d el1 28° reggimento fa nt e ria a vev ano abbandonat o Fiume per r ie n trare nell e proprie lin ce ; alc uni bersa g li eri del4 ° r eg gim e nt o f urono min acc iat i dagli ar diti p e r il loro manife s to malc on tento
s ull a situ az ione a Fiume e per il tacit o desid e ri o di ri e ntrar e a l Co rpo. Fur o n o indica t e, co m e ca u sa d ei defe zio n a mc nti, la care n za di ves ti ario, i fatico s i se rvi z i di guardi a c di ronda , la cont in u a t e nsione, il ma n cato pagam e n to degl i ass eg ni , le ingiustizie subit e d a a lc uni ufficiali (a loro volta s co nte n t i de l pro vve dim e nto di D'Annun z io che di sp ose la ridu z ion e a semplici volo n tari di mol t i suba lterni) ; e infine , il brusco d ecadere d i ogni disciplin a, d e plorato d ag li s te ssi s old a ti . Di fron te a ll a s itua z io n e p o litica delin ea t as i in Italia (d ove l 'az ione di D'Annun z io e ra vista co me un ' ulteri ore minaccia pe r la stabilità interna e una font e d i g uai in politic a es t e ra) , molti fiuma n i inc o minciaron o a mostrar e prope n sio n e p e r il «p r ogra mma minim o» prosp e tta to p er ri s ol ve r e la q uestion e di Fiume: St at o libero con porto e f e rrovia sotto prote z ion e dell'Itali a .
Cost i t ui va no. inoltr e, ult e riori moti vi di seri e p reoc cupazioni le di fficoltà log ist ich e per il sovraffo ll a mento dell a città, la chius ura d e l porto e della fe rr ovia e, ma n man o in un crescente cont i nu o, la mancan za di vi veri , l ' im p o s iz io n e de ll e t asse, le difficoltà economi c he, il disordin e a mmini stra tivo , fino a ll e viol e nze- che l 'i nform atore incomin ciò a segnalare a partire d a ottob r e - all e pr e potenze , a i borse gg i, a i fu r ti , p e rp e tr a ti dagli s te ss i volo nt a ri e rimas ti impuniti.
l ni ziav a no , inoltre , a scontra rsi diverse id e a lità e opzion i politiche dell'affar e fra g li s t es si capi:
D ' Annunzio- pur irrigiditosi di fronte al p ro gra m ma minimo - t emeva la propaganda degli estre misti e d e i repubblicani , e d un' e ve ntuale ri vo l ta contro la mo narchia. Eg li en trò in contrasto con il maggiore Reina , su pos izioni più moderate e lea list e, a tal punto c he qu esti fu su cces sivam e nt e accusato e processato per tradimento e p e r la distra z ion e di presunti fond i av uti sottobanco da l Governo. Fatto c he f e ce infuriare i gra nati er i di Rein a . L ' Ufficio Colpi di Mano , creato dal Poeta con l ' int e nt o di procacciare con met od i sbrigati vi quanto occorresse alla bisog n a, div e ntò una so rta di as s ociaz ion e a delinqu e re (già in uno dei primi «co lpi » fu ucciso un carabiniere che tentava di dife nd e re il carico al qu a le e r a di scorta) , sì da attirarsi le critich e di molti ufficiali. 11 comanda nt e Rizzo , ch e aveva tramato p e r ottenere l ' adesione quasi totali tar ia degli amb ient i d e ll a Marina , con l'aiuto d e lla qu a le aveva sperato e vag h eggiato g u e rre , rivincite e vitt orie , il 26 di ce mbr e lasciava Fiume. La «Vedetta d ' Italia », il gio rn a le dei volontari che tanta parte aveva avuto n e lla vicenda come strum e nto p ubblici stico e propagandistico , il20 dicembre fu costretta a sos p en d ere la pubblicazione e a chiudere i battenti perché , co n un radicale cambiamento di rotta, aveva incominciato a critica re le rigid e po siz ioni di D'Ann un z io; il giornalist a P e draz zi , già capo u ff icio stamp a , il 24 abbandonav a a sua volta la città. Nello stesso gio rn o se n e allo nt anava a nch e il m aggiore Giurati , altro protagonista

d e gli avvenimenti.
A controbatte r e la fe roc e propaganda de gli e lementi serb i, sloveni e croati e a sos ten e re l 'italianità della città furon o ancora una volta le donne ; tra le altre, la signorina Porro , de ll ' Ufficio Propaganda di Fiume , svo lse un' es altante opera contro la propos ta politica del «modus vivendi ». Sintomatiche d e l t empo , a proposito della partecipazione dell e donne , le deduzioni riportate n e lla relazione d ' inchiesta: «Le donne, p er motivi pass ionali, a qualunqu e ceto appartengono, simpatizzano ancora con gli elementi militari, e non vorrebb ero che questi andass ero via: esse, non abituate a Lavorare n é a produrre e quindi non s empre consci e delle impell enti e crude realtà d ella vita, guardano le cos e e le g iudi cano attrav erso il prisma del sentim ento » .
Nel1920 la situazione a Fiume finì con l ' incan cre nir e . L' irriducibilità del Comandante e la dege n e razione dell'occupazione , l' eq uiv oco atteggiame nto de l Nitti che trattava sottoba n co con i fiumani ma pubblicame nt e sconfe ssava la r e ggenza d e l Quarnaro , il trattato di R apallo del 12 no ve mb re tr a Italia e Jugoslavia (con cui si riconosceva Fiume s tato lib e r o e indip en dente) , l' or di ne di evac uazi one della città dato dal Governo p e r bocca del generale Caviglia , il «Na tal e di Sa n gu e» , il s u cce ssivo Governo di Zanella, il s uo rovesciamento , l' e pura zion e auto nomi sta, l' int e rvento dell'Esercito , furono s oltanto conseg uen ze di una storia , ini ziata male e finita peggio , protrattasi per cinque
an ni doloro si , fino a l Patto di Roma del 27 gennaio 1924 tra Italia e Jugoslavi a, ch e chiu se l' anno sa e sp in osa qu estio n e co n l ' a ssegnazi one di Fiume e d e i s uoi territori (tra nn e il po rto di Su ss ak) ali ' Tt alia.
Con qu es t a sanz io n e, agli occhi di molta gente il fasci s mo acqui siva un o d e i suoi primi m er iti ; s ul pi a no de ll ' immagine l 'Ese rcito s ubiva un a sco nfitta. Questo p e rché i cap i milit ari non avev an o saputo- e n eanc he potuto - ges tire l'affa r e fium a no , n e ll ' alt e rn a n za di d e cisioni s ubite dal pote re politico e n o n contrastate, n e l ruo lo di opp r essori c he finir o no con l' ass umer e d i front e all'opinion e pubblica, a ca usa d e ll ' interve n t o ordinato a Cavigli a dal Go ve rno e d e l lun go p e ri odo di mal vista occ upazi o ne. Viene da chied e rs i che cosa man cò, a parte le ind e cisioni , alla pr opagand a. Probabilme nte una se ria , se ntita e a d e guata mo ti vazione ch e se mpr e, in tutte le gu e rre, f un ge da forza aggrega nt e c trainant e in tal e cam p o; e la cosidd etta «a d e r e n za », se mpr e ri ce rcata dai pubbli c isti . Sbolliti, inf att i, gli e ntusi as mi inizi a li , complice il t e mpo -g r a nd e spegnit o r e d i entu siasmi e logo rator c di e n e r g ie -, scemato l 'ardo r e d e ll' «armi a moc i e partiamo», p arola d 'o rdin e amp li a ta d a ll ' o n da di un a esalta z ion e colle ttiva s up e rfici ale, poco r estò ne ll ' i ntimo dei so ldat i e d eg li it a liani. In fo ndo , Fiume era un sim b o lo cos truito e s trum enta li zza t o co n la vac uità di ideo logie c di parol e che nu ll a ave vano d i concr eto ne ll 'a nimo di un bracciante ca labr ese o d i un o p e r a io
lomba rd o, vo lto e teso verso più seri e r e a li probl e m i di so pravviv e nza.
Il ge n era le P ecor i Giraldi , n e ll e co nclu sio ni d e lla s ua r elazione, ben r iass uns e- nell 'ott ica d e l te mpoquanta parte e bb e la prop aga nd a s ull e tru ppe n e ll a s tori a di Fiu me, e le responsabilità di cias cuno:
«Mi pr eme qui tuttavia di insistere su di un aspetto di qu esto nuovo fenomeno co llettiv o: que llo della influenza ese rcitata s ulla m assa militare dalla propaganda di guerra, la quale può cons ide rarsi la causa iniziale, sebbene indiretta, degli av ve nimenti. Occorre, dunque, ri co rdare che dop o l e infauste giorn ate de lla fine di ottobre del/917allorch é, se condo un ' Augusta parola, per la sa l vezza della Patria era con di z i one essenziale che cittadini e soldati fosse ro un Esercito solo -fu fatto appello, e non invano, alle fo r ze mora li de l soldato con una prop aganda diuturna, intesa a tenerne alto lo spirito combattivo e la sen sibilità patriotti ca: prop ag anda svo ltasi ad opera di ufficiali, in ma ssima pa rte di complem ento ed an che di personagg i politi ci, partic o la rmente adatti p er cu ltura ed eloquio; apost o li dell'idea e artefici della parola, più inclini a co ncezioni appassionate, dove vib rava la nota patriottica e politica , che ad un pensiero sob rio e severo del dovere s tre ttam ente militare e della osseq uenza ge rarchi ca .
Questa propaganda- ingiusto sa rebbe non ricon os cerlo - e bbe b enefici effetti su llo spirito del soldato e d el giovan e ufficiale, e fu un effic ace strumento di ed u cazione patriott ica e guerresca; ma,

come è proprio di ogni cosa umana, eb b e anche qualch e co ns egu en za m eno de si derabile: quale quella di sottrarre in parte la truppa all'a z ione morale dire tta dai propri ca pi, di sta bilire in fatto una nu ova forma di disciplina, più paterna che rigida , e di avve zz are alla discussione ed alla critica politi ca Alla nawrale agilità 1nentale d e lla n ostra gente si aprirono cos ì nuovi campi: e germogliarono negli animi nuove tendenze, che non potevano non fruttificar e, se poste in favorevoli condiz io ni. Non è quindi, da far troppa meraviglia se, dopo avern e pas ci uta l 'anima co n l 'a lta idea di una Patria forte e si c ura n e i su o i confini contro lo stranie ro, i giovani ufficiali siano stati acc essibili alle seduzioni di una nuova propaganda ispirata agli stessi ideali. N ei soldati, poi, i moventi idea li agiro no - come è naturale- in più mod erata misura. Alcuni - i Granati eri ad es empio - ignorarono fino all 'ultimo lo sco po e più ancora il caratter e sedizioso della spedi z ion e; altri obbedirono semplic emente ai loro uffi c iali; altri, vennero trascinati dall 'e sempio, dalla genera le esaltazione e da un indefinito d es ideri o di novità: tutti c redette ro di compiere, sen z a gran pericolo, o pera meritoria ed utile agli interessi della Patria, favorita segretam ente (co m e ne era stata fatta correre l a voce) dai ca pi di grado eleva to e vista volentieri dall o stesso G ove rn o . Ou es to p er quanto riguarda le defe zi oni dei primi gio rni.
Particolarm en te a Fium e e sulla lin ea d'armisti zio, ufficiali e truppa avevano
viss uto in uno stato d'animo passionale: al qu al e faceva contrapposto quello, che n on esito a definire se mplicistico, imperan te al Comando dell'B a Armata; o ve il fervore patriottico fiumano era considerato con sc e tticismo e la partecipa zione della truppa a un simile sentimento r eputata una (( montatur a" effime ra e senza importanza.
Lo stato di esalta z ion e delle truppe, favorite dalla dispersione in numerosi dis taccamenti, ovunque fraternizzanti con le p o pola z ioni r edente, e la v ita di svaghi e di divertimenti in cui si tr ova rono immersi g li ufficiali, avevano p oi prodotto un certo rallentamento nei v incoli disciplinari , che dai numero si rapporti in atti traspare per più segni; quali l e abbondanti licen ze, la sc arsa vigilan z a diretta, l e ripetute assenze co n permessi di dubbia legalità , l'arbitrario soggiorno di ufficiali fun gi da gli a cc antonamenti d e lla truppa, l 'abbando no di certe pres crizioni del servizio in gu erra , il catt i vo funzionamento dei telefoni, il deterioramento dei materiali ecc . C o n i cambiamen ti di personale e con le economie imposte dalla ridu z ione d elle unità e dalla smobilitazione, vennero, per di più, a man care, o furono ridotti poveri di mez z i o di personale idoneo, tutti qu eg li organi di comando e di informa z ion e parti co larmente incaricati di seguire e sostenere lo spi rito delle truppe: anzi, talun o di essi, trascinato dal generale entusi asm o, continuò, in segreto, e per sc opi non più autoriz za ti, a valersi dell'ascendente acquistato in pr ec ed enz a.

Per i gradi elevati, come per i più mo desti, f ra g li uffici ali come ne lla truppa, il cambiamento di ro tta politica fu po i troppo brusco per poter essere attu ato senz a scosse: e f u, a m io g iudiz io, un err ore i l credere di p oter mutar automati camente, pel solo vincolo della discip l ina, una men tali tà e una p s icolog ia co ll ettiva, venuta formandosi pe r gradi; ammettendo com e una cosa naturale che la m assa, incoragg iata p er nove mesi ad innegg ia re a Fiu me ita lia na, potesse, d' un tratto senza resisten ze, voltare le spalle alla ci ttà, nel supposto momento del pe ricolo, e indursi a cons ide rare u na colp a ciò che fino a pochi g iorni innanzi era reputato più che un merito un dove re . .. ».

P e ccato c he la lu ng imir a nza di a lcu ne d e duz ioni sia s t ata a tta gliata solo al se nno di poi .
U n ri svo lto p ositivo p er i milit a r i «a descat i» a ll a causa fium ana c om u n que vi fu. Nelle s tesse co nclu s io ni, P ecor i G iraldi mi se in ev Ìde nza co me non b isog n asse at tu a r e lo s t esso m etr o re press ivo ve r so qu a nti av e va no ader it o a ll ' impr esa .
Eg li p r op ose di ope rar e un a dist in z io ne, n e i ne cessa ri p rovve di m e n t i d is ciplinar i da ad o ttar e , pur ri conosce ndo ch e e r a solo un a p r es u nz io n e class ificar e co n prec is io ne le r e sp o nsabilit à d i cia sc un o . Ten e ndo inoltre co nto ch e un velo pi e toso e r a già sces o s u q ua nti , n el corso de lla g u e rr a , s i e r a no m acc hia t i di grav i co lp e- un d e creto di Nitti av e va , p e r ese mpi o, am ni st ia t o i di serto ri - e isp ir a nd os i, di co n seg ue n za e p er co e renza, a cr iter i d i
la r ga indu lge n za. S ugger iva, così , d i d is ce rn ere nel giudi zio qu a nt i a vevan o aderi to in izia lm e n te in sette mbr e e qu a nt i era no in vece p a r t i t i fi n o al d icemb re; di v alu ta re sepa ratam ente la se m p li ce dise r z io ne e l'abba n dono di pos t o da ll a di serz ione aggrava ta da in subo rd ina zion e, rivolt a, agg r essio ne , furt o , ecc .; di d ist in g uere le co lp evo lezze degli ufficiali in fe r ior i e di q uelle degli uff ici al i s up e ri o r i, p e r esse r e più be n evo li n e i primi casi e p iù se veri nei secondi.
U n a m ag nanimi tà r a r ame nt e e s pressa ne lla s t o ria dell 'Ese rcit o.
Neg li s t ess i ann i di Fiu me , l' Ese r ci to faceva fro n te a mo l tep li ci i mpegn i in tern az io n a li. Tr uppe num er o se eran o di s loc ate in Alb a ni a, in Ege o , in S i ria e i n P a lesti n a; co r pi d i spedizione e d i occup az io ne f u ro n o in v iati in Murm a ni a, in Carinzia , i n Alta Sles ia, in A na to li a ; a liqu ote d i tru ppe fur ono impi ega t e n e ll a orga ni zzaz io n e dell 'esercito c e cos lovac co; altr e a n cora furono a ll e rt a t e pe r una proge tt ata s pe dizio n e in Tr a n scau cas ia, i n seg ui to non più effettu a ta . In tot a le in tali na zioni e r e gioni f u n ecessaria la p r ese n za d i 120 .000 u o mini ci r ca . Indub b iam e nt e, anch e ta li ev e n ti richi ese r o op er a di as s is te nz a , di propa ga n da e co ntr o prop aga nd a; fa tt a sul p os t o, co n m ez zi scarn i e m e t od i a rtigi a n a li.
L e d oc um e n taz io ni d 'a r chi vio so n o ca rent i su quan to fu fatt o in o ccasio ne di
qu est i avvenimenti; i docum e nti rin ve nuti conse nt ono appe n a di farsi un ' idea di qu e llo che fu tent a to o attuato.
In Albania aveva ope rato , dalla fin e del 1917, il Sottoseg retariat o di Stato per la Propa ganda all'Estero , tramit e l'Ufficio Albania e Pa esi B alcanici, sotto la direzione del colonnello Fo rtunato Ca s taldi , già Capo dell ' Ufficio P o liti co Militare press o il Co m an do del Corpo di O cc upa z ion e L'Uffici o s opravvisse, co n nome diverso , an che alla soppress ion e del Sottosegre tariato, e d es e rcitò l' ope ra di prop ag and a fin o all ' ottobre d c 11920 . N ei quas i tr e a nni di attività , con il concorso d e l Comando Truppe Albania, esso pubblicò il giornal e i taio-alban ese Ku vendi, ass eg nò borse di st udi o , tenne contatti co n i not abi li loca li. Un 'a ttività , comunque, sp oradica , s upe rficiale, di scars a efficacia. A gu erra finita , lo stesso Castoldi mantenn e, a Parigi , l ' Ufficio per la Tratta zio n e degli A ffari Albanesi Con qu a li m e todi e ri su ltati , lo possiamo ril evare da un fatto a dir po co sconcertante: trovandosi, in fa tti , in diffi c oltà eco nomi c he la D e le ga z ion e albanes e a P a rigi , il Castaldi pose i suoi buoni u ffici presso la D e legazion e italiana per la concessione di un prestito di t r ecentoci nquantamila lir e . In pratica, egli finì co n il sovvenz ionar e qu eg li a lb a nesi che faceva no propaganda contro gli int e r ess i italiani. Co n la costituzione d el Governo provvi s orio a lb a ne se (ottob r e 1918), fu istituito l'Alto Commissariato Italiano in Durazzo , ch e avrebbe dov u to tutelar e gli interess i italiani e sv iluppare l' opera
di propaganda. All a car ic a fu chiamato ancora il Cas toldi , ch e e ntr ò in co ntr asto con il C omando Militare Italian o di Valona. I f or ti ss imi attrit i e le r ec iproch e d en igr az ioni non fec e ro altro che d a nn egg iar e il n ost ro prest igio in qu e lle regioni , in un m omento già fort e mente crit ic o per l'atteggiamento ostile, sos tenuto d a ll'a zio ne di b a nde ar m ate di varia es tra zi on e, c h e da più part i s 'e ra levato co n tro l'Italia. Le autorità militari e p o litich e commise ro in A lba nia pare cchi e rrori ch e spin sero contro l' Italia l 'a nimo degli albanesi , già irr c titi dall a propaganda a vv ersa ria, mirant e a sminuire e s valutare l'op era d eg li i ta liani Ch e fur o no così acc usati di av e r a ccettato il co n ce tto di sp a rtizione d e ll ' Albani a, nonost a nte il Proclam a di Argirocastro , in cui l 'I tali a s'era imp egnata a garantire l'indipenden za di qu e l P aese .
Ne ll ' ag osto d el1920 le trupp e itali a ne furono cos ì costre tte a s gomber are d a ll ' Albania , ad e cce z ion e dell a base di Sase n o. Un c apitolo di s t oria che sarà ri a perto 19 a nni dopo.
Ne l Medit e rraneo Orie ntale, intanto, gr e ci c turchi si fro nt e ggiava n o , appoggiati gli uni da gli in g lesi , gli altri d a itali a ni e francesi. La propa ga nd a dei gr e ci e degli in gles i contro gli i ta liani era particolarm e nt e a ttiv a Attraverso emissari, gli ingl es i non p er dev a no o ccasioni p e r d e nigr a r e turchi e itali a ni.
Nel g iugn o 1919 uff iciali ingl es i p e rcor se ro l' A nat o li a sv ol ge nd o propa ga nda filo -e llenica e a nti-itali ana. N e l m es e di luglio il ca po del Governo greco , Veni ze los , accusò g li italiani di

fornire armi a bande turche.
D all'ottobre al dic e mbre 1919 un cappellano in g lese, Hcmbling, con la sc us a di constatare le condizioni di vita di profughi greci, cinematografò sce ne di inc en di e r ov ine , spacciandole poi in Europa e ne gli Stati Uniti come atrocità turch e, implicitamente spalleggiate dagli ita li ani.
Contro il Corpo di Spedizio n e si accanì a nch e la stampa nazionale. L'«Avanti» d e l23 agosto 1919 aveva pubblicato in fatt i una co rri spo nd enza a nonima , in c ui militari del reparto di Konia s i lam entavano de l trattamento economico, d eg li alloggiam e nti , delle con di zio ni sanitarie. L'a rti colo provocò l'int erve nto persona l e de l genera le Diaz e un ' i spezione del colo nn ello Vital e, a dd etto mil itare a Costantinopoli, la c u i relazione mise in evidenza come le m aggio ri diffico l tà in co ntr ate dall e tr upp e, e limi tate alle cond iz ioni d eg li alloggiamenti , deriva sse ro n o n dal disint e resse dell'aùtorità militare , ma dalla sca rsa co lla borazione degli «alleati » in glesi. Nell ' affare int e r ven n e anche N i tti, il quale ge n erica m e nt e raccomandò di c u rar e in ogni modo il benesse re materia l e c le condizioni mor a li dei n ostri soldati in Asia Minore. L 'es ige nza di una maggior e opera di ass is te nza e propaganda era comunque se nti ta dal Coma nd o del Corpo di Spedizione , ch e fin da giugno aveva ric hi esto al Co mando S up remo, tra i p r ovved im enti di propagand a, l ' istitu z ione di un g i o rnal e setti manal e bilingu e (it alo-t urc o) quantificando anche le spese (7 00 li re a l m ese), e
l ' impi anto di sa le di proie zio ni a Sokia, Milas , Mengla , certamente gradit e a i militari e ai civi li. Tali strumenti dovevano servi r e a propa ga ndare le bell ezze n aturali d ' Italia e la nostr a guerr a, e la ric hi esta in dicava come non sarebbe stato difficil e trovare il materiale n ecessario , per avvia r e l 'attività , tra quello r e cup crato con la s mobilit azione. Ma il Comando Supre mo nicchiò, rimandando il problema all ' Uffic io ITO - che doveva essere a n cora istituito presso il Comando d e l Corpo di Sp e dizion e - e pregando l 'Ufficio Sta mp a e Pro paganda di in viare in Anatolia giornali e opuscoli da c u i poter trarre mat e ria le di propa ga nd a.
Una s uccess iva proposta , del19 2 0 , di aprire un a «picco la sc uola » a Ko n ia e in altri ce ntri , pe r ass i s tere , educare e guadagnare a lla causa italiana gli indi geni, dopo essere stata pa ll eggiata con pa reri fa vo revoli (!) fra i Minis teri dell a Guerra, degli Esteri e fra l 'Associ azione Nazionale dei Mis s ionari , si concl u se con un nulla di fatto.
Non mi gli ore era la s itu aL ione in Alta Slesia dove , per i forti rancori fra tede sc hi e po l acc hi , g li scontri erano all'ord ine d e l g iorn o con ri pe rcu ssio ni s ugli italiani c h e, in mezzo, s ubi vano. Qui fu segnalata l 'az io n e sovve rsiva svolta da agent i comu ni sti , g ià dal ma ggio 1920 , se nza però che fosse r o pr esi provvedimenti a d eguati. Nel1921 f r a l e trupp e it aliane e fr ancesi di R atibo r si acuirono d i ssidi latenti , che fecero sc oppi are incidenti a Gloiwitz fra so ld ati del32 ° reggimento di fant e ria e

militari franc es i.
Non a bbi amo tr acci a di provved im en ti co ncr e ti pr es i per l'as sist e nza , il be nesse r e, il mo r ale e la propaganda tra le trupp e in A lta Sl es ia , ad eccez ion e della dis tribu zi one di un li bretto pe r i so ld ati offerto dalla Nun ziatura Apos to lic a di Vi e nn a; e, fatto cur ioso (il d i avo lo e l ' acqua sa nt a?), la rich iesta di una maitress e di Ve rona per a prire un a casa di to ll era nz a. No n ci è dato di sa pere se il permesso fu co nce sso.
Sap pia m o ancora di un a le tt era a nonim a dir e tta al Ministero della Guerra che l a m entava la «bella vi ta degli u ffic i ali co n l e s ign orine s les ian e», c «il fr e ddo , l a fame e le malattie pati te da ll a t rupp a». Di certo il co lonn e ll o co ma ndant e delle tr upp e in Alt a Slesia, Filippo Salvioni , non do ve tt e avere vi ta facile fi no al 25 giu gno 1922, data in cui i re par ti rimpatriarono. ***

Gli an ni d a l 1922 a l1925 segnarono la progressiva cessazi one di og ni at ti vità propaga ndi stica in se no all ' Es e r c ito. È natur ale ch e, con l 'a vvento del fas cism o, uno stru mento di potere così imp o rtant e per la for m azione d e lle m as se e per l a di fesa int e rn a e d este rna della n az ion e non poteva esse r e demandato dal Governo (ovvero da Musso lin i) a d altri , se non negli aspe tti , merament e mar gi na li , di ser vi zio . M a i n eg li as p etti direziona li , crea ti vi e deci s ionali.
La mistica dell' i mmag in e, su cui il fascismo andava cos tru e nd os i , non co ns en tiva d er ogh e .
Nel g iu gno 1923 , a segu it o dell 'o rdinamento Diaz, le attribuzioni riguardanti l'assiste nza moral e e la propaga nd a, che dal1919 - com'è stato detto - e r ano p assate all'Ufficio Info rmazi oni, div e ntarono di p e rtin e nza de11 ' Ufficio Addestramento. Con qu a le beneficio , è poss i b il e imm ag in are. All 'Ufficio In formaz ion i restava il co mpito d e llo spoglio de lla stam pa , perché n e facesse st ralci e ria ss unti (per la part e di interesse) al Ministro d e ll a Guerra , ali ' I spettore generale dell 'Es ercito e agli uffici d e llo St ato Maggiore Ce ntr ale; ed il collega m ento co n il Ministe ro d eg li Affa ri Esteri, pe r la situazion e politi co- mi lit are c quindi per eve ntu a li conco r s i n e ll ' azione di prop aga nd a e di co ntropropa gan da a ll 'este ro.
A livello per iferico , Divisioni e Cor pi di A rmata Territ oria li avevano altri uffici prepos ti alla bisogna nell e proprie s trutture: l a Sezione Op e r azion i di t a li Coma nd i esp letav a a n che co m piti di assist e nza e propaganda , o ltr e che occup a r s i de ll ' istru zion e pre c postmilit a r e . In queste ultim e man s ioni s i profilava all ' orizzonte il co nnubio tra Esercito e fascismo ne11a form az ion e della Naz ione Armata.
Ne l 1925, a seg uito d e l cambio di d e nominazio n e d e llo St at o M agg ior e Ce nt rale in Sta to Maggiore R eg io Esercito (2 1uglio ), ne ll e att ribu zioni d egli Uffici , di nu ovo riordinati , i co m pi ti di assistenza e propag a nda sc omp a rver o; re sta rono , prima a ll 'U fficio S itu azio ni e poi di nuovo a l Servizio Info rma z ioni (dive nu to SIM) ,
vaghi acce nni a lla recensione della sta mpa; all'Uffic io Storico fu de sti n ata una ge nerica «pro pagand a cu ltur ale» , non meglio id e ntificata.

Tn sintesi, in un mom ento in cui si stab ilizza va definitivamente l' a vve nt o della dittatura (a dicembr e Mussolini non fu più Pres idente del Co nsiglio d c i Ministri , ma Capo del Gov e rno , con la facolt à di assumere in proprio più dica ste ri), non e ra più consentito all 'Ese rcito di produ rr e propaganda; a ll o s t ess o modo in cui , già qualche anno prima, gli e ra stata tolta la facoltà di avere ing erenze sulla s tampa e di dialogare con ess a. Mussolini infatti , consc io dell'importan za che i mezzi di informazione aveva no in ca mpo pubblicistico, già n e 1 1923 aveva costituito un Ufficio Stampa che av eva posto alle sue dirette dip ende nze; e c he in segu ito diventerà prima Sottosegretariato (1934) e poi Mini stero della Stampa e Prop agan da. Per essere, nel1937 , de finitiv a mente il «fami gerato» MINCULPOP (Ministero della Cultura P o polare).
Prima di chiud e re questa fase della storia della propaganda fra le due guerre , sembr a doveroso ricordareanch e perché p iù volte indire ttam e nt e richiamato - l'eve nto cruciale di tal e periodo, l'avv en to del fasci s mo, anch e se non è qu esta la sede per una di sa mina storico-politica del fenom e no. Occorre comunque accennarne, p er le implicazioni che eb b e sulla propaganda , al punto da cambiarne i connotati.
L'aspe tto fond a mental e che specificamente ci riguarda del fascismo
è il consenso che esso ottenne. A nni or sono il professore Renz o De Felice sollevò un vespaio nell 'affro ntare il tema, in quanto le sue tesi- rimettendo in discussione una Itali a che si era riscoperta e consolidata come r esiste nt e e a ntifascista - contrastavano la lett ura storiografica ricorrent e, fortemente critica e d ec isa ment e n ega ti va d e l fascismo. Eppure su ll e capacità politiche c tattiche d ei Ca pi, an zi de l Capo d e l «movi m ento», e rano stati tutti d'accordo , espo n e nti della s inistra comp r es i.
Mussolini, in prima p erso na , riuscì ad attivare e a coagulare intorno a sé le masse, quell e masse che dalla storia c dal potere decisionale e r a no stat e sempre escluse: offrendo loro un ' illusione vest ita di realtà.
Masse composte dall a media c piccola borghesia, ma a nch e dal proletariato e dal so ttoprol e tariato (mancano, n e ll a storiografia sul fascismo , ricerche di ampio respiro e studi statistici sulle componenti socia li dei nazionalisti, dei fasci di combattimento, d e i volontari fiumani, degli sq uadri sti, dei partec ipanti alla marcia s u Roma , dci vo lo ntari d e ll a Milizia; c pertanto n on è ancora poss ibile s tabili re fino a che punto l' indi ce della «bilancia ma sse» sia ferm o alla piccola borgh es ia e/o graviti decisamente verso il prol eta ri ato) , schiacciate tra intellighenzia, bor ghesia e ari stoc razia d a un lato e rivolu z ion arismo di sinistra dall ' altro. Non bis ogna , infatti , dim e nticare che il contadino, il manova le, il piccolo artigiano, era es cluso da ogni forma
part e cip a tiva non solo dall ' alto , ma ta gliato fuori an ch e d a l ba sso, d a i s u o i stessi simili: in alcun e z on e d ' Italia fort e me nt e p o liti c izza te, a d ese mpio , non esi s teva nes s una possibilità aut o nom a di la voro e d i sop ra vv ive n za se non s i era iscritti a le gh e e co o p e r a ti ve . Se n za parlare dell'isolamento in cui e ra t e nut o il Sud. M as se c he a ve vano vi ss uto gli ind es crivibili orr o ri d e ll a g u e rra , ch e av e vano sup e rato il terror e dell a morte e le indi cibili s offe ren ze de lla trincea solo in virtù di un atavico f a talis mo c n e ll a sp e ran za di o tt e ne r e, qual o ra sopravvissut e, qualch e segno di gr a titudin e e di ric on os ce nza; c ch e inv e ce e rano sta te abbandonat e e an cora umili a t e .
Qual e mer a vi glia se aderiron o a un ' idea c cre dett e ro a uomini ch e vendev a no il «pr o dott o» ch e e sse, n e l lor o stess o intimo , cercavano ed al qu a le , incon sc iam e nte, fin a llor a av e vano an e lato?
A l punto ch e ne l gir o ·di tre anni poche d e cine di uomini riu s cirono a se rrare intorno a sé, co n m e todi ro zzi e violenti - altra m e ravi g lia di alcuni st o rici - ce ntinai a di migliai a, milioni di uomini. Guardando a Roma , esclusiv a mente come fonte del b e ne , di cui e rano all a rice rca: d a pre nd e r e, a tutti i costi, con la viol e nza se n ecess a no.
Il ges to eclatant e, la marc ia su Roma d e ll ' ott o bre 1922, non fu altro ch e l'a cquisizion e del «prodotto», si a pure se con se ntita - quale es plicazion e mitigant e - dalle incapacit à, dall e
in s ipi e nze e dall e conniv e nze. Conni ve nze a d d e b itat e a nch e ai militari. Altro dibattuto e s pin os o probl e ma. L' E se r c it o e bb e par t e ·d e termina n t e ne ll a m a rci a s u R o m a? E co sa a vrebb e fatto se Vitt o rio E manu e le III av esse firma to lo s t a to di asse di o? Interr o gati vi ch e hanno appas s ionato m o lti s tudi os i d e ll ' e ve nto: a l punto t ale ch e alcuni di ess i, utilizzando e d an a liz z and o gli s t ess i docum e n t i, so no arrivati a conclu s ioni opposte! A dimo s trazi o ne ch e qu a nd o le le ttur e critich e dell e fonti div e nt a no st rum e ntali , s i fini s ce con l' inv a lid arle. Eppur e la s tori a dovr e bb e legge r e so lo i fa tti, e dall 'a nali s i di es si trarr e obie ttiv e co nsid e raz io ni. Ne l n os tr o ca so , rit e ni a mo ch e e sse si poss a no così ria ssum e r e : molti milit ari , c api e gr eg ari , ad e rirono al fas cism o e alle sue m a nifes ta z io ni. U n ' a des io n e il p iù d e ll e volte nata per l' atte gg iam e nto fo rtem e nt e d e ni grat o rio - è s t a to già d e tto - che partiti politici c stampa ass un se ro n e i con fronti d e ll ' E se rcit o . Altri , te nn e ro a preci s are la lor o p os izi o ne: pe r il giur a mento di fe d e ltà pre stato all a monarchia , n o n a v rebb e ro consentito azioni viol e nte contro di e ssa , o s ovvc rtim e nti dell 'a utorità leg alm e nte costituita.
Molti ss imi an cora - la ma ggi o r p a rtenon ebbero att eg giamenti deci s i, anche se occas ionalme nt e es presse ro il loro consens o di ma ss ima al fa s cismo. Una po ssibil e lett ura scaturisce proprio d a lle consid e razi o ni es pos te : consens o , m a n o n p a rtecipazi o ne , a lmeno d e lla maggi o ran za . E se è ve ro che le

rivo lu zi oni s i possono vincere con l'entus iasmo o con il co n senso di un esercito, è altrettanto vero che difficilment e esse si vincono contro un esercito, specialmente in momenti in cui esso è pa rticolarmente aggu e rrito per gli efficaci addestrament i e per le esper ie n ze maturat e s ui campi di batta g li a; co sì come e ra l 'Ese rcito italian o a l termine d e lla grande gu e rra.

Né , infine , ci aiuta a scoprire cosa avrebbe fa tto l'Esercito, qualora avesse avuto l' ordin e di aprire il fuoco, la documentaz ione ufficiale: nes suna re la zio ne è più asettica dell e mem orie storiche del Corpo d ' Armata di Roma , interess ato all ' avvenimento, ch e per curiosità riportiamo a lla lette ra:
«Ne l mese di ottobre, si svolge progr essivamente un vasto e compless o movimento fascista che porta alla cad uta del Governo Facta ed alla successiva instaurazione del Governo Mussolini.
Nella giornata dei 27 ottobre fu indetta dal Partito Na z ion"al e Fascista la mobilitazione di propri squadristi allo sc opo di assumere il Governo dello
Stato. Succ es sivam ente anche il Partito Nazionalista ordinò la mobilitazione delle camicie azzurre.
N e lla nolfe sul28 s'iniziarono i movimenti di trasferimento alle vicinanze di Roma e gli squadristi si concentrarono nei g iorni 28 e 29 nelle località adia centi a Roma.
Il29 si formò il nuovo Ministero ed il 30 i fascisti ed i na zion alisti- circa 60.000 - entrarono a Roma.
Durante il periodo del movimento fas cista si ve rificaro no vari incidenti; note voli, p er quanto riguarda l'Es ercito, qu elli dell'a s porta z ione di armi nelle Case rme di Siena-Spoleto-PerugiaOrvi eto- restituite poi successivamente.
N ei primi g iorni di Novembre hanno luo go in Roma num erose manifestaz ioni patri ottich e organi zz ate dai fascisti quali una importan te sfilata di cam icie nere ed azzurre davanti al Quirinale alla p res enza di S.M. ii Re e L'omaggio solenne reso alla tomba del Milit e Ignoto da parte di tutti i m embri d el nuov o Gov erno».
Nel d ece nnio • 1925-1935la
propa ga nda divenn e linfa escl us iva e vital e del r egime.
Lo s tudio e l'analis i di tale periodo so no import a nti , e co mpl ess i allo stesso t e mpo , poich é toccano d a vicin o i rapporti- non sempre f ac ili - tra Eserci to e fa sc ismo.

Sul passaggio di mano de lla pro p aganda , s ulla via in c ui si inca mminò , s ul suo sv ilu ppo, furono d e terminanti la cos tituzione d e ll ' Uffi cio Stampa de l Ca po d e l Go ve rno ne l19 23, la legge per l ' Organizzaz ione d e lla Nazione p e r la Gu e rra (n. 969 dell'8 giugn o 1925), i continui riordinamenti dell'Esercit o c dei s uoi organi ce ntrali. Dell ' Uffici o Stampa si è già fatto ce nno ; Mus so lini b e n con osceva il ruolo c l ' im porta n za ch e la stampa aveva n e lla manipolazione d e ll 'i nform az ion e, e quindi s ull e ma sse; nato gio rn a li s ta, c ontinuò ad esse rl o fino a lla caduta. N on avrebb e mai potuto fare a meno di uno s trum e nto che poss e deva una presa così imm e di ata e un palese pot e re di cre dibi li tà s ull e ma sse, inimmagi nabil e e non paragonabile n e anch e lo ntan a men te a qu e ll o di ogg i. Le notizi e s ui giornali e rano va ng e lospe cialment e quando i giornali , a colpi di «dir e ttive », div en tarono se mpre più simili l'un l' altro ne lla veste e n e i c onte nuti - : pochi i le tto ri disin ca ntati e gli spiriti critici ch e riuscivano a cog li e re le ver it à omesse , di sto rt e o ce late d e n tro e dietro le noti zie (ancora non mo lti a nni f a e ra lu og o com un e se ntir dir e «è sc ritto s ul giornal e», qua si con
religiosità).
P e r evita re in ter fe r enze, n ell926 fu soppresso l 'a nalo go uffi cio de l Mini s tero deg li Esteri, che entrò a fa r parte dell' Ufficio Stampa come sezio ne es t e ra. Fu così e liminata ogni possibilità di div e rg e n za fra i d u e Ga binett i (Presidenza e d Esteri). G li ambi e nti giorna li s tici degli Este ri mal accettarono il pr ovvedim e nto , per la perdit a di autonomia e pe r la scarsa conside razi one ch e aveva no d e i giorn a listi «disoccupati e fu or i ruolo » in se rvi z io press o l ' Ufficio Stampa.
E t a le fu l' imp ortanza di comuni care, di collo qui a r e dir e ttame nt e con le ma sse per il capo de l Governo , c he ben pres to eg li si appropriò a n c h e d e l nuo vo mezzo tecnico, che gli avrebbe co nsentito di s tabilir e un co nt atto ancora più imme d iato dei giornali, d i pen et rare personalme nte n e ll e case de gli italiani , i n presa dir e tta: la r a di o.
Con l' av ve nto d e llUffic io St a mpa i milit ar i finir o no per p e rdere l' ut ili zz azione di quello s trum e nto pubblicisti co ch e aveva loro conse ntit o di ori e ntar e le opinioni durante la gu e rr a; già a partire d a l l9 19 la lor o ing ere nza s ulla sta mpa fu di irri leva nt e effic ac ia. Tolte le intervis te d e ll e grosse p ersonalità , a lcuni int e r ve nti essen z ia lm e nte t ec nici più ch e di opi ni o ne , acco r at e difese sempr e s uscettibili di critic he p e rch é troppo s pe sso perso nali o personalizza te , l' in formaz io ne e il pensie ro mili tare non e bb e ro più a dispo sizion e la ca rta s tampata p e r soste nere il proprio opera to, n é tantomeno a d essi furon o
lasciati spazi. Le grandi firm e del gi orn a lismo di g uerr a , co m e Ojetti , C ivinini , Simoni, che p ure av e va no prestato la loro opera a fav ore del C om ando S upre mo , con una certa disinvoltura mutaro no rotta , resta n do gli art efici d e l g iornalis mo du ra nt e il fasc ism o; i giova ni cro ni st i, r e legati a co llab orare con fog li e giorna let ti di secondaria importan za , riusci rono a sfo nd are s olt anto qu a ndo furono presi s otto l'ala prot e ttrice c mec e natica d e lle g randi firme.
Ai militari fu consentito di ave r e a lcuni fogl i c pubb li cazioni co n co nte nuti t ecn ici, che peraltro aveva n o tiratur a, diffu s ione e circola zio ne limitat a. Gli argo men ti affrontati non e bb ero più ri sco ntri diretti s ull a r eal t à, ec cezione fatt a -e non sempre -p er i dibattiti s u pr ob le mi di natu ra sq ui s i ta me nt e dottrinale. In p ra tic a , nell'op e razion e di ac ce ntram e nto pr ess o l ' Uffi cio Stam pa di tutta la pub blici s tic a , a nch e quella di politi ca milit are ric ad de s otto l' eg ida d e ll' Ufficio, c agli Stati Ma ggio ri fu permesso so lo il co ntr o ll o d e ll e ri viste s p ec ialistiche; nonostant e che la Co mmi ss ion e Difesa, n e l 1924 , p a rland o di tut ela d e l p a trim o nio morale , avesse incaricat o gli Sta ti Mag gior i e il Ministr o dell'Int e rno di co ncordare un a idon ea legi s laz ion e s ulla s tamp a, al fin e di tut e lare nel Paes e il più pr ofo ndo se ns o di di sciplina e ogni a zion e idonea a sostenere i due fronti, quello di g uerra e qu e llo int e rno.
Non a caso a lc uni p e riodici , palestra di dib a ttito e di form az ione a nche politico e culturale d e ll ' uffi cialità,
furon o soppresse . «A le re Flammam » , e dita dalla Scuo la di Guerra , iniziò le pubblicazioni nel 1923 e chiuse i b a tt e nti tre an ni dop o , nel1926. La « Rivista Militar e», c he da l 1856 al1918 aveva dato notevo le apporto al progresso degli s tudi militari e una p r ez iosa testimo nian za di id e e , dopo aver ripreso le pubblicazioni ne l 1927 le interrupp e n el1933 , p er l' impo ss ibilit à dei co lla bo ratori di es prim ere un pensiero a utonomo. La deci s ione di so pprim e r e la rivi s ta fu firmata da l sottosegreta ri o alla G ue rra , ge nera le Baist r occhi; in s ua s ostitu z ion e fu pubbli ca ta , c curat a direttamente dal Di castero militare , la « Rivista di Fanteria» . L' «Es ercito I taliano», per iodico trise ttim a nal c , sub entra to ne l 1880 a «Esercito» e divenuto nell923 «Ese rcito e iV!ari na», eb b e vita fino a1 1926 Chiusero anche «Rassegna dell'Esercito Italian o» (192 5) dirett a da Eugenio B a rb a rich , la « Cooperazione delle A rmi» (1 926) delle Scuole Centrali Milit ar i , il « Bollettino dell ' Uffici o Stori co » (1934) , d e ll o st esso Uffi c io Storico.
Ac cre bb ero , p e r contro , le ri vist e te cnic he n e l biennio 1934-1935 («Rivista dei Carabinieri Reali» , «Rivista giuridica delle Forze Armate», «B ollettino dell ' Istituto Storico e di Cultura dell ' Arma d el Geni o » , «Riv is ta d ei Servi z i di Commissariato e Amministra zio ne » ).
Un ruolo politico -militar e, dop o l' es p e rim e nto di «L ' Italia in g rigioverde» (1929 -1 934) , f u tenu to da «Es erci to e Nazi on e» , fond a ta n e l 1926

ed edita dal Ministero della Guerra ; essa, ncll9 35, mutò la denomi n az ione d e lla t e stata in << Nazione Militare », quasi a s ottolin ea r e il pa ssaggi o del compito d e lla difesa , non più preroga ti va d ell ' Es erc ito , ma d e ll ' intera n az ion e or ga ni zz ata. La rivista finì presto per esse r e uno strumento di propa ganda d e l Regime , e cess ò le pubblicazioni con esso; anche s e durant e il percorso non mancò di ag it are colpi di coda (nel dicembre·1937 e ntr ò in aperta polemica con «R egime Fa scista», ch e la accusava di dedicare poco spazio alla g u e rra di Spagna e a quella cinogiappones e) . Anch e il bis e ttimanal e «L e Forze Armate», nato co n intenti propagandistici nel 1926 , chiu se con la cad ut a del fascis mo. U m oristica la precisazione contenuta in una circolare d e l 1933, firmat a da Baistrocchi, ch e m e ntr e da un lat o esortava gli ufficiali alla collaborazione con il gior n ale, d a ll ' altro pr ecisava c he e ssa dovev a consistere «nella obi ettiva esposiz ione del proprio pensiero vi nc o lata, è o vvio, dalla voluta dis ciplina formale e sostan z iale » . Un pas ticcio di p a rol e, p e rch é fos se b en chiaro che n ess uno poteva es primere id ee contrarie al «pensi e ro ufficiale »
In d efinitiva l ' Esercito, oltre a p erdere la s tampa come s trum ento di inform azione, di comunicazion e, di c ircola z ion e di id ee , fu co s tretto anche a subi rl a come m e zzo di p ene tra z ion e de ll'id e a fa sc is t a, nel pro cesso più ampio eli «fas cist izza z ion e» totale che dov e tt e patire e eli cui il più accanito promotore fu sempre il B a istrocchi ,
co adiuvato da ca pi militari via via più accondiscendenti. Le circolari da lui emana t e, re lati ve alla pubbli cistic a, sono altamente c hi ar ific at rici e ist ruttiv e in merito. Voll e che gli uffi c iali progredi sse ro «fascist ic a mentc» se gu e ndo l'evoluzione del p e n sier o milit a re - quale , l ' abbiamo già a ccennato - s ull e ri viste milit a ri ; che leggessero «lvfilizia Fas cista» , «brillant e peri odico » che «s impa ticamente e c on passione » s i era adoperato a rinsaldare i vi n co li camerat eschi tra Esercito e Mili z ia; che fo sse diffus o tra i milit ari «Il Contro A ereo », con l'a us picio di co llabora zioni s econdo i noti crit eri. Bai st rocchi sollecitò, ancora , la lettura dell e opere più di sparate , dall e «M emori e» d el Mar esciallo Joffre , se mpr e p e r «l 'a u sp icata mentalit à (fascista) tipicamente gu e rri e ra», a lle «Manifestazioni agricole del Decennale » (?);dal «Davanti a San Martino d e l Ca rso con la Briga ta P isa», «st im o lante » per l 'e mulazione ch e avrebb e s us citato nei giovani u ffic iali, a «La Nuova Itali a d'oltremare», campione di «co nto moral e» d e ll ' azio n e svolta d a l R egime nelle co loni e durant e il prim o dec e nni o di vita. Pubblicazioni b en div e rs e dalla citata «Rivista Militare » e dai pur modesti c ing en ui « Tricolore » e « Teso retto», che n eg li anni ve n ti venivano acquistati per la truppa , con fun z ioni e ducativ e, inizi a lmente co n i fo ndi del Minis tero e d in segu ito co n gli utili de gli s pacci coopera tivi. Gli ultimi , raris s imi t e ntativi di esp rim ere un pensiero a uton omo , in co ntr as to con le direttive ufficiali , avvenne ro ne l 1934.

È pur vero che, a par tire da11935, molta parte d e ll 'ufficialità fu imp eg nata in ben a l tre atti v ità , quali la guerra italae tiopica e la campagna di Spagna: «im pegni» c he la sciaro no scars i spa z i a ll e accad e miche discussioni teorich e, d ottrinari e e letterarie, e agli esercizi di p e nn a. Al più, consentirono ad alcuni di produrre agiografiche opere, di dubbio valore «a mmae st rativo », derivanti dalle espe rienz e delle campagne.
L'opera di penetrazione mess a in a tto dal Baistrocchi non s i limitò , ovvia m e nte , ai sugge rimenti di edificanti letture. Lo stillicidio di dir e ttive e di circolari, e manate in un br ev issimo a rco di tempo, restano a test im onianza del suo frenetico impegno promo zi on ale a favore dell ' idea fa sc ista: basta esa minarn e un campiona rio, valutarn e g li oggetti e comp e ndiarne i testi. « Massim e di S.E. il Capo d el Governo » : i l pe nsier o del D uce è se mpr e chiaro, pr eciso, inci s ivo , e .non è poss ibile fraintenderlo; «Cameratismo militare» : fraternizzare fasci st icamente è alla base di un sano cameratismo; «Circ oli militari»: es plicare «az ion e fasc ista» anche nei circoli p e r farne ce ntri di propaganda militar e c guerriera; «Co nferenze sullo Stato Fas c ista»: la parola di uomini d e l Regim e è determ in ante per una magg iore consapevolezza e partecipazione; «Ca nti cora li»: l'inno «Giovinezza» è bas e di ogni canto in marcia (attenz ion e, p erò, quando s i canta la « Leggenda del Piave >> bisogna sostit uir e , nella seconda strofa, «t radimento » con << fosco evento» e «O nta con s umata a Caporetto» con
«p oich é il nemico irrupp e a Caporctto ); «S tile militare-fascista»: chi parla c scr ive trova il s uo va n ge lo nella p a rola d e l Duce, in cis iva c vibrante; «Discorso del Duce a Cuneo»: un programma di vita da tener e se mpr e presente, illumina nte per i Qu ad ri; «Addestram ento sportivo nell'Esercito»: la gioven tù di Mus so lini non dev e ge nerar e camp i oni, ma plasmare guerrieri in mod o omogeneo, in massa; «Simboli » : il ritratto d el Duce , la parola del Duce, il saluto alla voce, so no seg ni impr esc indibili e insost ituibili dell'a nim o fascist a Un bombardam e nto continuo, che ben si addice al progetto di Stato fascista e airorganizzazione della Nazion e per la gue rra, di cu i l'Es ercito doveva rappresentare l'apice. Forse fu proprio questo obiettivo a tradir e Baistrocchi, fino a fa rne il vertice is tituzionale c allo stesso tempo il capro es piatori o della s u a fa sc ist izzazion e. Ricordiamo, tuttavia, per imparz i.alità, c he molte delle b e nefich e innova zion i dello strumento militare furono dovute a lui.
Nei ra ppor ti fra Esercito c Fascismo e bbe p eso determinante la legge s ull'or ganizzazione della Naz ion e per l a guerra , che faceva tesoro delle esper ienze tratte da ll a gran de guerra e fi ss ava le norme per mett e re lo Stato in cond izion e di affrontare e s uperare l 'inevitabile mom en to di cr is i, all'atto della mobil i tazion e genera le. Una legge importante per la prepara z ione del Paese al conflitto, e per il potenzi a mento d e ll e Forze Armate, che però finì co n l 'esse re svuotata di ogni

efficacia e svilita di fronte all ' imprevisto sviluppo de gli ev e nti c a ll e necessità cont in genti, di natura soprattutto finanzi a ria.
La mobilitazione n az ion a le, cui la legge guardava , e ra nel suo comples s o cost ituita dalla mobilitazione militar e e da quella civile. La mobil i tazione civile era qu e lla ch e ri e ntrava n e lle espress e finalità legis lative , e fu attuata co n l'is titu z ione di una serie di organi (posti a lle dipend e nz e dei Dica ste ri ri s pettivame nte co mp ete nti , e sottoposti, per la coordinazione, alla Commissione Suprema di Difesa), av e nti l' incarico di: importare le mat e rie prime , occuparsi dell e fabbrica z ioni di guer ra , assicurar e l'a limentazione, fare opera di propaga nda e di assis t enza civile.
Co mitati regionali e sottocomitati avrebbero assunto la direzione di tutte le attività civili mobilitate , nei limiti d e lla propria giurisdi z ione te rritori ale.
Ne l 1927 la Commi ss ion e Suprema di Difesa s i occupò p e r la prima vo lta d e ll 'Organo di propa ga nd a e a ss istenza civi le , tracciando qu e ll e che sare bb ero state, in caso di mobilitazione , le lin e e di azione. D ispose che i co mpiti dovev ano essere s uddivisi tra il Minis tero degli Esteri (Propaganda all 'est ero) e il Min istero d eg li Lnterni (Propaganda all ' interno ed assisten z a civile); qu es t'ultimo si sare bb e avva lso , o l tre ch e dei suo i uffici , del! ' ausilio dell'Associa zion e Nazionale Mutilati.
I du e Dicasteri dov e vano op e rar e in stretto contatto , al fin e di ottenere unità di indiri zzo e di lavoro.
La lettura del verbale presentato nell ' anno s ucce ss ivo - nel19 27 nulla di concreto fu fatto - ci fa comprendere, fra l 'a ltro , come fos se ro vaghe le id ee in materia di idea z: ion c e organiz z azione della propaganda. L e seriose considerazioni ge nerali , di introduz ion e all'argomento, già di per se stesse partivano da alcuni presuppos ti su perflui, scontati e, se n za vo le rlo esse r e, umoristici. La propaganda e l ' assistenza nella grande g uerra - diceva la relazion e - erano s tate co ndott e mal e, affid ate ad una p letora di enti e com itati , e aveva no prodotto un ' infinità di inconvenienti , ch e neanche la tardiva is titu z ione del Co mmissariato Generale per l'assist e nza civ il e e la propaganda interna (febbraio 19l8) era riuscito ad e liminare. Sen z a un preordinato indirizzo, si era verificata una disp e r s ion e di mezzi c di e nergie, e so prattutto una disparità di interv e nti e di trattam e nti , che avevano finito con il provocare danni.

Fin qui si potre bb e essere d ' acco rdo. È, però, soltanto retorica l'affe rmazione che «molti dei s istemi ch e si ra vvisarono indispensabili durante la g uerra , non appaiono più utili; giacch é qu el ch e riguarda t obiettivo sostanziale della propaganda, tendente a ri chiamare i cittadini a s trin ge rsi in un sol partito per la salvezza della Patria, è ora insito e persis tente nell a stessa anima nazional e, sce vra ormai da tutte le passioni di parte, per sempre sepolte».
In sintesi , dopo tutte le bell e parole su lla n e cess ità di avere un or ga no di propaganda ed una direzione
centralizza ta per att uarla , si affe rm ava che non e r a nece ssa rio produrne, in quanto i ci ttadini non n e aveva n o bis ogno , esse nd o n e ll'intimo già profond a m e nt e m ot ivati e persuasi: la forza e lo sp irito nuovo ch e palpitav a n o dovunqu e, e rano garanzi e s ufficienti perché, al moment o opportuno, la macchin a s i mett esse in m o to da so la per automatismi conge niti.
Né c 'e ra bisogn o- alm eno per il momento - di prev e d e re l 'o rgani zzazio n e d e i va ri Co mitati e Sottocomitati, po stulati d alla legge per l'assisten za ai civili. Prefetti c a uto rità loca li avr e bbero av uto il ma gg ior on e re prima e dopo l'ev e ntuale co nflitto , poiché i Co mitati c Sottocomitati non av r e bb ero potuto ch e viv e r e per il co ntenu to peri odo g uerr egg iato . Si p o t ev a , quindi, att e nd e r e .
Della propaganda e d e ll ' assist e n za av r e bb e ro dovuto occ up a r s i , naturalmente, u o mini «ge niali ssimi» - n ess un accennò a lla pr e parazione pr o fes s i ona le eli tali t ec n i.c i- e l'A ss o c i azio n e Naziona l e Mutilati, che ann over ava n e ll e su e fi le «c o loro c h e h anno già impr esso nella car n e i seg ni d e ll a g lori a » c pertanto «e lementi formidabili di propag a nda morale d e ll e ma sse» Vi av rebb e ro , in ol tr e, co ncor so Provin ce e Comun i (pa gam e nto eli s u ss idi, ri c hiest e di n o tizie , ricerch e di lavo ro), e gli alt ri En ti ch e aveva n o g ià in s i ti , n e i p ro pri co mpiti , quelli di ass iste n za, co me l ' Opera Na z ional e Invalidi eli Guerra, il Comitato Na z io n a le Orfani d i G u erra , la Cro ce Ro ssa,

l ' Op era Naziona le M ater nit à e Infanzia , l ' Op era Naziona le Dopol avo ro , le o r ga niz zaz ioni s indac a li c giov a nili , ecc.
La r e laz ione , dopo av er ricono sc iuto ne lla pre messa la necessit à eli un a organ izzaz ion e, conclud eva, anco r a una volta, affe rmand o che di ess a non c'e ra a lcun bisog no , che la P atria e ra già s uffi cie n temente o r ganizzata, sia p er il periodo di pace s ia per qu e llo di guer ra , s ia per l' ass isten za ai civili , s ia ai militari ; rico no sceva al tempo stesso, co ntraddi ce ndo s i ulteriorm ente , c he pe rsist eva in mat e ria qu e l ca ratt ere di fr a mm e ntarietà - che sare bb e stato meglio defin ir e di improvvisazion e- che a veva prodotto d a nni in passato: e ra pertanto indisp ensa bil e otte n e r e, in caso di guerra, un coordi nam e nto dell e va ri e fo rme di ass isten za per avere risult ati a rmoni c i n el campo dell 'ass isten za c de lla prop ag and a militar e e civil e. Ma, la rela z ione non dicev a come. Niente di più sconclusionato potev a essere scr itto. Ness una prop os ta se ri a ve ni va av an zata, né si m et teva a ll o s tudi o a lcun progetto. Le conclusioni riportav a no la bozza ge n e rica di uno sch e ma de ll ' Organo di propaganda all'interno ed assis tenz a civile in caso di guerra , che s i prefi g urava arti colato in una Direzione dell'Org ano - co n S eg r e te ria , Ufficio di Coordinamento , Servi zio di Propaganda all'int e rno , Servizio dell ' a ss is tenza civile , S erv iz io l s p e ttivo e d i Controllo - e c he tracciava i lineame nti dei tr e se rvizi (p rop aganda, ass isten za e isp ett ivo ), come di se guito riport ato:
-Servizio della propaganda all 'interno.
Costit uito da: Direzione del Servizio; Se g reteria de lla Direzione Propaganda; Ufficio Conferenze di Propaganda; Ufficio Informazioni (s tato di animo della popolazion e); Ufficio Stampa (diffusione notizi e e comunicati). -S e rvi zio dell'assistenza civ ile.

C ostituito da: Direzione del Servizio; S eg r e teria d e lla Dire zi one Assiste n za; Ufficio per l'Assis t enza all e famiglie dei combatte nti ; Ufficio p e r l' Assist e nz a d eg li em igrati rimpatriati; Ufficio p er la sistema z ion e dei minorati di gu e rra; Ufficio per la s istemazione dell e p e n sioni di gue rr a. - Servizio I spetti vo e di Controllo.
Cost ituito da: Direzione del s e rvizio isp e ttivo di controllo, ave nt e a di sp osi zi one un congruo numer o di isp e ttori -e ntità comm is ur ata alla ripartizione compartime nt ale r eg ion a le del Re g no -co n se de presso la Dir ez ion e dell'or ga no , e comandati press o i dipendenti organici periferici per isp ez ion e e co ntr ollo d e ll ' andam en to della propaganda e del funzionam e nto r ea le delle opere as s isten ziali , in r e lazione alle dis posiz ioni imp a rtit e dagli Uffici centrali.
La Commi ss ion e Suprema di D ifesa , n e ll 'esamin are la rela z ion e, acc e ttò la schematizza zion e proposta dal Comitato per la Mobilitazione Civ il e, s uggere ndo p erò d i tener prese nte la proposta avanzata da Turati s ul cont ributo ch e potevano dare i Fasci fe mminili n ell'opera di assis t e nz a .
Per la propaganda all'estero ven iv ano
ribadit e le linee diret tive del servizio, affidato al Mini ste ro degli Aff a ri E steri , attrav erso il Corpo diplomatico co nsolare e i Fasc i d e ll 'este r o. La r e alizz azione di ogni programma c di ogni attività era lasciata alla completa discrezion e degli E steri.
Nella stessa seduta, il Co mit ato s i occupò anche d e l servizio di propa ga nd a da svi luppare n e l progetto di difesa passiva controac rea del te rritorio n az ion a le. Il servizio dov e va proporsi di: prepa r a r e moralmente la Naz ione a d affrontare «con a nimo virile» il periodo d e ll 'offesa ae r ea; convincere la collettività s ull a nec essità di pre disporr e le difese com un i cd individuali ; diffondere tra la popolazione le no zioni più e le mentari sulle possibili t à offensive d eg li aerei; divulgar e i m ez zi d e lla difesa pass iva .
Il Minist e ro d e ll'lnterno do vev a cost ituire la Di rezion e d el servizio, propaga nd a nd o e coordinando tutta l 'a ttività all ' inter no del Paese; organ i esec utivi erano i Mini steri , gli Enti pubblici, il Partito Nazionale Fascista, le sc uol e, la stampa , le associaz ioni varie, le dir ez ioni deg li stabilim e nti indus triali , le case cin e matografiche , le parrocchie. l mez z i di propaga nd a per la forma z ion e d e lla «c oscienza controaerea» e ran o i corsi d ' istruz ion e e gli esper im e nti pratici (obbligatori per sanitari , vigili del fuoco , agenti d e ll ' ordine , e nti di pubblica assistenza) , le confere nze pubbliche illust r at ive, le proi ez ioni cinematografich e, gli opus coli specia li , gli articoli di gi o rnali e riviste , i manife sti ecc.
l nt c rmini stc riale per la Protez ione Antiaerea , creato ad hoc e posto alle dir e tte dip e ndenze del Mini s tero d e ll'Interno, grazie all'azion e svolta, fra mille difficoltà, dal ge neral e Alfredo Giannuzzi Savell i, riuscì ad avv iar e una capi llare opera di propaganda. Nel1932 esso divent ò Comitato e fu posto alle dipendenz e del Ministero d e lla Guerra. L e continue diffico ltà finanziarie, nelle quali trov ò a dibatt ersi, indu sse ro il Savelli a proporre l' istituzione di una lega nazi o n ale della protezione ant iaerea. La prop os ta restò inascoltata fino al1934 , anno in cui, sempre il Savelli , riuscì a far riconosce re giuri dicam ente l'Unio ne Nazionale Protezione Antiaerea (U .N.PA.) , sorta ne l frattempo a Milano com e associazione pri vata.
L'U.N.P.A. fu un ' occasion e mancata; pur prodigandosi n e lla preparazione de lla Na z ione all ' offesa aer e a, fu cos tretta alla sopràvvivenza per la scars a lun gimir anza di politici e militari , mentre all ' estero analoghe organizz azio ni furono sostenute con dovizia di uomini, mezzi e danari.

* **
La sup e rficialit à co n cui i massimi orga ni dello Stato , a li ' uopo pre po sti, affro ntar ono il problema propaganda è indice di quanta insensibile grettezza vi fosse in materia, e di co m e , per co nsegu e n za, esso f u sottovalutato.
È vero, peraltro , c he n eg li stess i anni il car is ma de l capo del G ov e rno
prevaricava, surrogava e plagiava tutto e tutti. Né esisteva una real e opposizione ge neralizzata al r e gime , ad e ccezione di gr uppi di s paruti fron di sti , o di pochi illuminati; né ebbero peso le «fastidios e», m a in influ enti lotte condotte dai partiti politici al bando in quegli anni. Le contestazioni esisteva no sì , ma erano solo un fenomeno irrilevante e riconducibile a formule casistic he, legate non tant o alla realtà quanto alla legg e dei grandi numeri. Come un a rondin e non fa p rima vera , poche migliaia di spiri ti critici e ri b e lli non ebbero alcun c onto e peso s ull 'a d esione in cond izion ata al Regime di decin e di milioni di individui.
Apparentemente, in tal e situazione, ca d e va la necessità di un a ser ia organizza z ione d e lla propaganda da s piegare s ulle mas s e.
Anche la lettur a delle relazioni sulla s ituazion e po liti ca , l 'o rdin e, lo spi r ito pubblico e la pubblica s icurezza , compi late dagli organi di polizia e da quelli in formativi , co nfermava tal e rea lt à; le veline infatti giud icavano se mpre la situazione «buona) soddisfacente) generalmente buona » . A pa rte alcune mani re stazioni di piaz za contro il carovit a dei primi ssi mi anni del fasc ism o e l'attività sovversiva svolta da alcu ni partiti, le lamentele e le po le mi che furono sì annotate, ma co me e lementi acc id enta li di di st urbo , incidenti di p e rc orso accettati n el gioco delle parti , più che come fonti di serie preoccupa zi oni.
Non bisogna dimenticare che il fascismo , ol tre i provved im enti sociali
con cr et i - qu a li le mutu e- e la r e ali zzaz io n e di gra ndi oper e pubbli ch e - come qu e lle di bonifica -che in co n t rarono i fa vori dell e ma sse, m ise in a tt o t utt a un a po liti ca d i irr eggimentazione e di a ccul t ur az ion e ch e si pro t ras se n e l t e mpo e i cui fruttia ll a vis ta di tu t ti - furon o colti fino a lla se co nd a g ue rr a m o ndiale.
Una politic a int e lli gent e, alm e no n e i propo siti, ch e partiva dalla form a zione d e l citt a dino , con s id e rat o un a tah ula rasa tutta da incid e r e .
Già nel192 3, infatti , con la san zione da parte d e lla Commissi o ne Dife sa d e l principi o c he g li s tud i sc o la st ici dov e sse ro e ss e re coordin a ti e d ade g uati all e neces s ità della Difes a, si ini z iav a il ca mmin o «m e n ta le» d e ll 'alli e vo citt a dino ve rso la N a z ion e Arm ata d i stampo fa scist a .
Il sintetic o con ce tto di bas e, se condo il qu a le c iasc uno do veva co nc o rr e r e co n tutt e le pr o prie e n e r gie, non sol o fi s ich e ma anche intellettuali , alla dife sa d e l Pa es e , ne pre suppon e va un secondo: ch e il cittadino , come sold a to , d oveva procur a rsi in a nti cipo tut te le cog nizio ni nece ssari e per as solve re , in futuro , il propri o ma nd a to nel mig lior modo po ss ibil e . Su t a le c onnubi o in siste va quindi la n e c es sit à di introdurre nell a scuola di o gni ordine e grado , e nell e Uni ve rsit à , d e t e rminat e m a terie attinenti la militarità: bali s ti ca , radiot e legrafi a, chimi ca el i guerr a, topogr a fia , a e rodinamica ecc.

P e r ev it a re di sp e r sio ni di f o r ze, inoltre, fu pre di s post o il coordin a m e nt o de gli es p er im e nti sci e ntifici n e ll e
indus tri e e n e lle Univer sità.
Ne l 1925, i n a der e nza con i p os tulat i eli princi p io , fur o no is tituit e, p resso gli I st ituti di In ge gn e ria e le Univ e rsit à, sc uol e speci fic h e di p erfe zi o nam e n t o , co rsi di s tori a militare e di c ultura militare t e cnico -sci e ntifi ca. N e ll a progr a mma zion e d e lla pre para zion e c ultu r al e d e l Paese, fu d a ta pri o rit à all e U niv e r si tà, pe r ev it a r e ch e i giova ni p i ù avanti n eg li s tudi e p iù a pe r ti a r ece pi re id e olo gi e «fuorvianti » sf ug giss e ro ali ' indirizz o c he si int e nde va d a r e lo ro.
Fu , però, proprio a li ve ll o univ e rsit a rio che a ll e int e n z ioni non fecer o seg ui to i risultati. E ccettuati qu e lli di s toria milit a r e, il r e ndi conto de i co rsi f u scarno pe r pa rt e cip azi o ne e r e ndim e nto , per cui la C ommiss ione Difesa prog e ttò eli in se rir e ob bli gat o ri a m e nte le m a t erie di attin e nz a militar e n e i n o rm a li co rsi univ e rsit a ri. Il fallim e nto p a rzi a le del pr o gramma fu d o vuto a l fatto che i corsi n o n e ran o obbli ga t o ri e valutati vi , costituiv a no un a ggravi o di la vo ro e di ora ri o p e r gli studenti, non fornivano va nt aggi p e r il co n seg uim e nto di la uree e diplomi , e n e con ced ev an o m o l to pochi p e r l'adempim e nto d e gli obblighi milit a ri. U n a sconfitta inasp e tt a ta se si p e n sa ch e gli uni versit a ri eran o gi à or ganizz a ti n e l1 926 ; e che n e l19 29 erano confluiti n e i G ruppi Univers itari F as ci s ti (G U F).
La Commi ss io ne Difes a rit e nn e quindi n e ce ss ari a la riform a d e i corsi di cultura milit a re ; r ifo rm a ch e r es tò , p e r diff ico lt à fin a nz ia ri e, allo sta to di pro ge tto fin o a gli anni 1932- 1933. S olo
in questi anni fu possibile far s orge r e, press o il Politecnico di Torino, la Sc uola di balistica e di costruzioni di armi e a r ti glieri e.

Se l'Unive r s i tà sfuggì in un primo m o mento all ' indirizz o vo luto dal R eg ime, d iversament e avvenne, p er la pre parazione sco las ti ca artatam e nt e fin a li zzat a, nell e sc uol e medi e e primari e, la ddov e era be n chiaro c h e d ov esse co ntinu are la «preparazion e m o r a le » i niz iata in famig li a e dove l 'az ion e d e l R eg ime fu s oste nuta d a ll 'a tt eggia m e nto, in ge n ere accond iscen d ente, d e l co rp o doc e nte. B ase d e lla «preparazio n e moral e» era l' ese mpi o dell'educatore , coad iu vato d a ll 'i ndi spe nsabil e cont r ibuto dei libri di te sto , da scegli ere con es trema cura per m ante n e re, nell e ma sse gio va nili , «calda e viva la fia mm a d el s e ntim e nt o na z iona le» .
Gli inseg nanti dov e vano ess ere in ce ntivati con l'i s titu zio n e di opportuni pre mi di bcne m e rènza , perch é avvertiss e ro an c he tang ibil mente l'importanza d e l co mpito. Fatto più importante, l 'ed ucazione m ora le d oveva estrinsecarsi in e duca z ione <ifo rmal e dis ciplinare, info ndendo i concetti di di scip lina , di obbedien z a e di responsabilità, e sviluppando l 'attitudin e al co mando col senso dei dov e ri ch e d a ess o derivano » .
Nel1934 tre leggi (n. 2150, 2151 e 215 2), definite L e gg i s ulla Nazion e Militare , co difi cavano organ ica m e nt e l 'iter che il cittadino doveva co mpi e re per co n corre r e a lla difes a m oral e e m ater ial e d e ll a Naz ion e. Fu intro do tta ,
in fa tti , accanto all 'in seg nam e nt o d e lla cultura mili t ar e, l ' istru zio ne pre e postmilitar e, un'id ea che fr a gli ad d etti ai lavori e fra i sostenitori d e ll a Nazione Armata a veva s uscitato dib a ttiti fin dal 1919, c d i cui il fasc is mo t e ntò di r ea li zzarne l ' attuazione, utilizzando il P art ito , la Mil iz ia e l 'Ese r cito
Il ciclo e duc at ivo avveniva in tr e fasi pro g res s iv e ch e cadenzavano le tre tappe fondam e ntali di formazione d c ll '« uomo fa sc ista » : balilla (8 -14 a nni) , avang u a rdi sta (14 -18 a nni ), gi ov a ne fa s cis ta (18 -21 a nni) , per arrivare al se r viz io militar e e all ' is tru z ione postmilitar e (fi no al32° an no) , intesa a manten e re in a lterat e le capacità di guerrier i e specia li zzat i in. quanti le Forze Arma t e avevano formato.
T p r ogrammi dell ' is truzi o n e pre e pos t -militare era no dettagliati e l'idea in sé e ra ottima per un o Stato che faceva d e lla for za la s ua stess a ra gione d 'essere; ma a l ferv ore dei pro g rammi fec e ro ri scontro le n t ez ze burocratiche , scarsi ent usia s mi , difficolt à finan z iarie , n o nostante la creazione di un Isp ettorato apposito, cui fu prepos to l 'e nergi co ge n e r a le G ra z ioli.
L'Esercito e bbe il co mpito di fi a nch egg iar e e s oste nere g li obie ttivi e ducativi del r e gi m e e d i p a rtecip a re, a t a l fine , a ll ' o p e ra di propaganda ne l P aese : r e cupe rando , co n qu es to t ramit e, la s ua partecipazione a t al e attiv ità , sia pure in a sse nz a d i appositi organ i e d i com pi ti s pecifici. Fa tto ch e vo leva so ttolin ea re il divieto forma le di non p r omuov e re al c un a impresa per proprio con to . Va colta, però, una d ifferen z a
ce llul e e agitatori comunisti, anc he in se no all' E sercito , non ebbe frutti. Più vo lt e, n eg li a nni dal 1926 al 1930, gli o r gan i informativi ebbero a seg nal are la diffusione di manifes tini e di opuscoli co nt ro il fasc is m o, tr a i militari e all'interno d e ll e case rm e; ma parime nt e, quasi con soddi sfazio ne , g li stess i or gani an n ota vano come t ali m e zzi non avesser o n ess un a pr es a neg li an imi: s ov e nte e tano gli st ess i militari a de nunci a r e a i pr o pri Comandi il ritrovamento di biglietti e gior n aletti s ovv e rstvL

L 'i nutilit à dei te nt at ivi di pen e tr azio n c de ll'id e o l og i a c omun ista nel tessuto militare dov e tte risultare ev idente a n c he a i prom otori, che finir ono con il d es istere dall e loro iniziativ e, almeno fino allo sc oppio della g u erra civi le s pa g nol a .
L 'edu cazione dell a Naz ion e all' id e a fas cista , la prop ag anda di R e gime , l ' arrivo a lle armi di gi ov a ni c he n e ll e sc uol e aveva no resp irat o ari a e cultur a «g u e rri e ra », avevano sortito i loro effe tti con il passa r degli anni.
Più se rie pre o ccup azio ni d estava n o, anch e s e limitati e spo r adici , i cas i di diserzione, ch e avve niv a no specialm e nt e tra gli alpini e n e i r ep arti di frontier a; cinq u e casi , se gn a lati nell'a gos to 193 0 , fecero sca tt ar e seve re punizioni nei co nfronti de i dir ett i com a ndanti «respon sa bili», e pr o voc a rono un a dura c d allargata reprimenda del ge n e rale Pietro Gaz ze r a, Sottoseg r eta rio a lla G u e rra , ag li ufficiali , sollecitati a rifl e ttere d e ll ' altezza della l o ro missio n e e d e ll e responsab ilit à d eriva nti dal
comando.
Attività propagan di st ich e ostili all'Esercito venivano, inoltre, sv ol te dalla Jugo slavi a e dalle popola z ioni a ll ogene di confi n e, che , ch i amate a lle armi, mai tacquero il l or o o dio contro l 'It a li a e l 'as pir azio ne a «rivendicaz ioni irr e dentistiche » (ter min e ch e, p e r i ro nia della sorte, er a serv ito a stimol a re le c oscien ze d e gli italiani dur a nt e la g r a nd e g u e rra ).
Le scgnalazioni di m a nifes ta z ioni , anche minime , di anti-italianità , in Ju gos lav ia e n e i t err ito r i acqui s iti , non cess arono mai. La s compars a eli cippi d i confin e, le espressio ni ingiu rio se con tr o militari e civili , g li incid e nti tra stude n ti italiani e jugosla vi , le continue campag n e osti li della sta mp a a llo ge n a e s la va, le accuse di asse r vim e nto a ll o Sta to italiano ve rs o quanti ne av ev an o acc e ttato l 'a u to rit à , la diffus i o ne di opuscol i e g iornal e tti di propa ga n da , l'opera sobillatrice eli d oce nti e associazioni slavofi li , le agg r essio n i a militari , il rifiuto di utili zza r e l a lin g u a italian a, le false acc us e di br ut a lit à c di vi o lenze a danno d e gli s lavi, la politica s ubdol a e avversa sv olta da un a p arte del clero l oca le, rappr es entarono uno s tillicidio co ntinuo con t ro l ' Italia, nonost a nt e ch e il Gov e rno av esse avviato , già n ell' immedia to dopoguerr a, un a impon e nt e opera di ricostruzione nell e t e rre di confine , e non os t a nt e avesse con cesso mo ltiss im e agevolazioni a ll e po po l azi oni allogene.
L'attività di pr opaganda a d a nno dell ' Italia fu svolta anche in altri stat i ester i, o ltre ch e in Jug os lavia.
A p a rt e le bordate ch e la sta mp a, già all e a ta, t irava contro lo St ato italian o e gli es ponenti d e l R e gime , s pe cialmente in Fr a ncia pullul a rono i co sì detti «Uffi ci di Cons ul e nz a » p e r e migrati , ch e svol gev ano d e le te ria atti v it à app oggiandosi a lle stess e s t r utture mini s te riali italiane; per cui il Gabin e tto d e ll a Gu e rra do ve tte dar e o rdin e, n e l 1927, di int e rromp e r e ogni r a pporto co n que g li uffici e di e vadere so lo le richie s te proveni e nti dagli Uffici Con so la ri e dall a Segreteri a Consolare d e i Fas ci Itali a ni a ll 'E s t e r o . ***

Torn a ndo al te ma del c oin vo lgim ento , c ' è d a ag giun ge r e che l 'E se r c ito fu totalm e nte assorbito dall e manifes tazioni p ropagandi s ti che d e l fa sc ismo all ' in ter n o d e l Paese . La prese nza d e llo strum e nto militar e all e cerimonie, alle inaugurazioni, alle mo s tr e, ai concors i: alle vi sit e di de legazioni es te r e, e ra in fa tti la d egn a corni ce alla sce nog rafia ch e il fascim o sol e va allestir e p e r interpre tare, rappr e sentare e d e sprim e r e tutta la grand e zza , la f o r z a e la p o t e nz a d e l R egim e . Gli s t ess i addestr a m e nti militari e le grandi manovr e finirono , con il passare deg li anni , p e r diventar e più d e ll e scen e ggiate dim os trative ch e non momenti di ve rifica d e ll ' efficien za dello strumento militare , e dell ' efficacia dell e s ue dottrin e Rappr ese ntazion e e d . . 1mm ag mano corn s pos e ro e c omc1se r o così in quella sce lta ideolo gic a , intorno alla quale ruota va tutta la macchina
p ropaga ndi st ica d e l f asc is m o : il culto del «Du ce» o vve r o d e ll 'imp era tore , d e l C esa r e che av e va rimess o o rdine n e ll o Stat o e godev a d e l trionfo tra le su e leg io ni , osann a to dal pop o lo al passag gio. Si rit ro va v a così a nch e il p er ché della n e cessità in e luttabil e d e ll a «romanit à» nella fi g urazion e d e l fasc ismo.
U n idillio , dunque , p er altr o rive la tos i in qu a lche occa s ione più f o rmale ch e sos tanziale.
L 'Esercito , infa tti , pur tr ov ando si imme rso fino a l collo a fare da sup po r ter all a grand ezza d e l Capo , ce rcò di salvaguardare la propria dignità, ch e n o n e bb e tim o r e di di fe nd e r e a ll 'occas ion e . U n a di esse fu la Mo stra d ella Rivolu z ione Fasci sta , v oluta d a Mu ssolini nel1932 in occ as ione del d ece nnale d e ll a marcia s u Roma. Di visa in sa le t e ma t ich e, la m ost r a died e sp az io an ch e ai fatti di F ium e e a l «Natal e di san gue»; il conte sto in cui tali eventi furono rappr ese ntati , offe nsi vo p e r l ' E se r cito , pr ovocaron o il ri se ntim e nto d e i ve rtici milit a ri. I Capi U fficio Sto rico del t e mpo (colonnelli de Biase, 1932 e Bron z uoli , 1933), in più ripr e se visi ta rono le sa le della mos tra , indi ca ndo al dottor D e voto , segre tari o gen e rale all'e s posizion e , i documenti da to gli e re. Cosa che fu fatta di nott e e un po ' a ll a volta , pe rché il pubblico non s i r e nd esse conto d e ll ' incid e nt e . Furono soprattutto «a s portati furtivamente » articoli e manifes ti conte n e nti appr e zzam e nti «non lod evo li » su Ca viglia e s ui so ldati, accu sati di crud e ltà ingius tificata e
appell a ti con tito li poco rig uard os i (sgh c rri, mani goldi).
Un eve nto si ntomati co, an ch e qu esto, d e i difficili rapporti esi s tenti tra Esercito e Miliz ia , reso a n cor più evidente dall e parole del Bronzuoli «... ho es amina to co n la cura maggiore) co mpatibilmente con il tempo) con la folla, e con la sorveglian z a dei militi ch e non consento no di prendere appunti e con i quali era o pp ortun o evitare co ntest azio ni ... » -. Si te nga prese nte che chi rit e n eva «O pportun o evita r e conte sta zioni » era un co lonnell o Capo Ufficio d e l Corpo di Sta to Mag gior e, in un momento in cu i tal e Corpo e ra una cas ta cd i rapporti ge rarchici tra militari r eg olati da rigidi forma li smi e vincoli disciplinari severiss imi.
P e r concludere, nel d e cennio in e sa me la propaga nda mo ss e tutte le sue pedine p e r a ggre gare le masse intorno al co n se n so e ancor più intorno al Capo, al mito così ben costruito attraverso gli

s trum e nti pubblic is ti ci e la lor o manipola z ione , i cui effetti sara nn o duraturi fin o a l 1940.
L e ma ss e , dal canto lor o, fur o no a perte e pronte a recepire ogni attività promozi o nal e, pr e parate in qu es to da a lcuni avveduti provv e dimenti e conomi ci , politici e soc iali. E furono così pers uas e, da non esse r e sca lfit e minimament e dalla propa ganda avvers a interna ed es t e rna.
N é furono indotte a1la rifles s ion e dall ' is titu zion e del Tribun a le Speciale per la Di fesa dello St a to ; uno s trument o repr e ssivo, in verità , non così disumano e feroc e com e è sta to acc r e ditato , se paragoniamo - pur nel ri s petto di quanti n e soffriro no - le se nt e nze da esso pronunciate con i terrificanti proce ssi s ommari che altri , co n te mporan ea m e nt e, e seg ui vano in mez z a Europa, senza avver tir e neanch e la n ecess ità di leg ittimarli nell a forma.
progressivo accentramento, nel corso di questi anni, della macchina propagandistica nell e mani di un unico Dicastero, potrebbe fa r pen sa re ad uniformità di indirizzi e di realizzazioni, almeno a partire dal1935 e fino a ll a 2a g uerr a mondiale. Ne ll a realtà non fu così; la g uerr a italo-ctiopica , la campagna di Spagna , lo scoppio del 2° conflitt o mondiale, eb bero come effetto, indubbiamente, l'allargamento d ei limiti delle funzioni e dell e sfere d ' interv ento dei vari organi della propaganda, ma non soltanto questo. G uerr e c campagne, in fatti, duplicarono i recettori dell a azi on e propagandistica: se prima dei conflitti la propagand a e ra di na tu r a ideologica e diretta soprattutto al fron te int erno, ora ava n zava la necessità di trasferire , in termini co n cret i s ul fronte di guerra, la propaganda fascis ta c , quindi , diventava ineluttab ile conceqerc deleghe ad altri: in particolar modo, alle autorità militari operanti su tali fronti. Ria ssumiamo, schema ti camente, come e ra articolato i n qu est i anni l'apparato propagandistico d el Regim e, quali era no gli organi e quali f un zioni essi aveva no: - la Commissione Supr ema di Difesa, presied ut a dal Capo del Governo, pred isp on eva ed ema na va i criteri organizzativi su tutta la materia in v ista della m obilit azione;

- il Ministero per la Sta mpa e la Propaganda, poi Cultura Popolare (1937), id eava, e att u ava l a prop ag and a attraverso i ma ss -m e dia, produceva e contro ll ava i mezzi c gl i
strumenti di prop aga nda c di contropropaganda all ' int e rno del Paese; -il Ministero degli Affari esteri, sv ilu ppava l'azione di informazione, di pr opa gand a e di con tro propaganda all'estero; - il Ministero della Guerra, curava all'interno del proprio apparato l 'ope ra di assistenza , propaganda e contropropaganda s ull e truppe. Con l 'apert ur a dei fr onti di guerra, attraverso propri organ i, incominciò a prod urr e pro pa gan da cd avocò a sé una sempre mag gio re autonomia , u ni ta a pote ri d 'intervento sui massm edia c s u g li strumenti della propaganda n on so lo all'estero e su i fronti, ma a n che a ll ' interno del Paese; - il Partito Nazionale Fascista , che aveva un proprio Ufficio Prop aga nda , con le sue orga ni zza zioni sv ol geva propaganda id eologica «Sp icciola » all'interno, per la preparazio n e e la formazione dei cittadini. I suoi in terventi arrivavano sino a sovvenzionare g i o rn a li e gior nali s ti , perc h é i commenti politi c i avessero sempre forti connotazioni filo- fasc is t e. Co n cor r eva anch e a lla propaganda all'estero. Ricordiamo, infine , c h e la Milizia Volontaria Sicur ezz a Nazionale, il br accio arm a to d el partito , aveva un proprio Ufficio Stampa e Propaganda; - il Minister o dell'Interno, a ttrav erso la sua rete informativa e l 'opera di controllo c di cen s ura- svolta anche dal Minist er o d e ll a Gu er r a - forniva u t ili e l ementi per gl i indirizzi d e ll a
propag a nda ; -il Ministero della Colonie, poi Africa
I taliana (1937), concorreva all'azione di propaganda e di contropropaganda nelle colonie , o l' attuava talvolta in forma aut on o m a; - il Comitato Centrale Intermini steriale per la Prote zione Anti-Aerea c l' Unione Nazionale Protezione Antiaerea int e r ve nivano ne l Paes e p er l'o p era d i in fo rm az ione e di propaganda nec essa ria al cittad in o p e r la protezion e pass iva dall'offesa a erea. In b reve, la Commissione Sup r e ma di Difesa doveva p r epa r are l 'attività propagandistica p er la mobilita z ion e, Cul tu ra Popolare era l 'organo direttivo c di con tr o llo de ll a propaganda , t u tti gli altr i i bracci operativi nei set tori di competenza.
È fac il e immaginare cosa s u cced esse in pratica. Nonostante, comu nqu e le fughe dall'accentramento , grosso modo Minculpop riuscì a dirigere l ' or ch estra pubb licist ica e tencrne gli s trum en ti sot to contro ll o.
Ne l febbra io 1936, Galeazz o C ian o, Min ist ro per la Stampa e Propaganda , presentò a lla X III Sessio ne della Commissione Sup rema di Difesa la r e lazione pe r l'orga ni zzaz ione e il funzioname nt o de i nu cle i di pr op a ga nd a all'inter n o e all'estero (NU.P. l. E.) .

Ne lla prima pa rt e della r e lazione, ve niva ria ss un to quanto era s ta to fatto prece dentemente dal Ministero d e ll ' Int e r no, che fino al1935 era stato preposto a ll' att ivi tà p ropagand ist ica e assiste n zia le, unitam e nt e al Partito Nazionale Fascista e ai so dalizi
patr iottic i sorti dopo la grande guerra. I n sintesi, a partire dal1931- nulla di concreto era stato rea lizzato n egli an ni a nt ecedenti - gli Interni aveva no cost i tuito un ufficio p er la trattazione deg li affari d e lla propaganda , c hiamandon e a far p arte un vice prefetto , un funzionario, un arc hi vista, una dattilografa. L'ord in a m e n to del serv izio ris u ltava, dalla do cum e ntazion e ag li a tti , art ico lat o s ul nucl eo ministeriale e 93 Organi p eriferi ci provincia li , co n sede presso le Prefe ttur e del R eg no ; ess i aveva n o il co mpito di organizzare, attivare e seg uire le attiv it à p r opagan di stich e a live llo lo ca le, s otto la direzion e e la vigilanza dell'a u tor i tà prefett iz ia . C iasc un o rg an o provinc ia le era dir e tto da uno o du e fun zionar i, in genere ufficiali invalidi e fun zio nari civili a riposo, d es ignati, s in da l t emp o di pace , da Guerra e Interno. Sostenevano questi enti distaccati un compl ess o di oratori e di propagandisti, sce lti dai prefetti - d'intesa co n il P art it o e i s od ali zi - tra noti profession isti, rit e nuti idonei al particolare incarico e distribuiti n ei va ri centr i di propaganda della provincia. Inol tre, n e lle sc uol e, f u se lezionato un fo l to numero di ins eg nan t i, presce lti d ai c ap i d 'is tituto c co n l' app r ovazione pre fetti zia, per svo lge r e a tti vità seco ndo un « piano prestabi lito », non m eg lio sp ecificato.
T a le organizzazio n e fu ritenuta va lid a da l nuo vo Minist e ro de ll a Cultura , so prattutto per la su a a r tico lazio n e p ro vi n c ia le , che faceva capo ai p r efetti e quindi ai rappresentanti d e l G o verno in
perife ria. E ra , in d e finiti va , n e lle sa ld e mani del p o tere ce ntr a le . P e r c ui C ia no prov vide a d avvi a re e sse nzialment e un la vo ro di rev ision e, t eso ad agg iorn a re , int eg rar e e pote n ziar e la ma cc hina della pr opagand a, in vis ta d e ll e fin a lità da ragg tung e r e .
Fu c osì prov ve duto a lla compila z io n e di un Bollettino di mobilitazi o n e p e r gli org a ni provinciali , in m o do ch e ess i fo sse ro se mpre pronti a d agir e, e ch e avv e nissero le d e bite s o s titu z ioni d c i fun z ionari non p iù utili zzabili (per decesso, p e r infe rmità , per ri chiam o alle armi , ecc. ) . Fu ist ituito l ' organo pro vinciale pr ess o la ne onata 94a provincia di Asti (15 aprile 1935). Si pro ced e tt e all a r ev is ion e d e lle list e d e i propagandisti, ch e accr e bbero not ev olme nte di num e ro ; p e r ev it are sp ese di tra sferim e nto , e ssi furono pr cscelti c a sse g n a ti n e i luo g hi di re s id e nza d e i ce ntri di propa ganda. Nel 1936 risult a rono istituiti 1.055 centri di pr op ag an d a con 3281 propa ga ndis ti , tutti selezionati con cura (occupa z ione, attitudini , b e n e m e r e nze, e cc .) e schedati.
Fu tenuto conto dell a nec ess ità di ope rare propaga nda s p eciale «S picciola» pre ss o le piccole comunità rurali, ch e non av e v ano altrimenti mod o di ascoltare confere nzieri , né potevano e ss e r e ind o ttrinat e o agg iorn a te sull e dire ttive d e l R eg ime attrav e r s o radio, stampa , cin e ma. Gli uffici pr o vinci a li furono forniti di pubblicazioni ; mod e ste nell a quantità e nella qualità (per st e ssa a mmi ssion e dell a r e lazio ne ) e illustranti , in pr e valenza, il conflitto italo-etiopico.
Quando il NU .P.I. E fu ist ituito , n e l 19 35 , e p os to all e dip e nden ze dell a Dire zion e Gen e rale d e lla P ro pa ga nda d e l Dicastero , e r a gi à pratica ment e in fun z ion e . Fu articolat o su du e S ez io ni , Int e rno ed E s t er o.
La Se z io ne Interno aveva , per co mpiti prin cip a li: la d ef ini z ion e di un pr og ramma, la compilazione di uno sch e dari o de gli s critt o ri , ora tori , confe r e n zie ri , pubblicis ti; la pre dispo s iz ion e di norme e r e gol a menti p e r il fun z ionam e nto d e ll ' or gano i n tempo di g uerra ; l ' acc e rtam e nto e Ja s eg nalazi o ne d e ll e d e fi cien ze .

P e r qu a nto ri g uard a va il programma da attuar e in c as o di mobilita z ion e, e sso con siste t te soprattutto in pre disp os izioni diramate ai pr e fetti con circolari ri se rv at e p e r uso int er no. Le dir e ttive concernev ano s oprattutto l'or ganizz azione- qu e lla a cce nn a ta- , e la c ollaborazion e dell a s tampa loc a le, d e ll a radio, dell a cine mato g rafiafur o no p a rticolarmente cald eg gia te le proiezioni. di propaganda de li 'Istituto Lu ce, d e lle sc uole.
In occa sione del conflitto italoe tiopico , fu chies to di a ttiv a r e l ' o r ganizza zion e int e rna p e r mett c rla alla prov a ; con il dichiarato intento di illu s trare n e lla «g iust a» luc e gli avv e nimenti, a soste g no della spinta patriotti ca ch e s'e ra lev ata n e lla N az ione , ma con il ce lato d es iderio di contrast a r e la la rga a z ione di propaganda ch e il Partito s t a va m e ttendo in atto per proprio cont o
L 'es p e rim e nto , durato d a l 28 ottobre all9 novembr e 1935 , a detta della
relaz ion e, confe rmò una pres unta pi e na e fficienza d e ll'organizza zi on e.
L a Se z ion e Estero prese invece in co nse gna il nucl e o di pr opaganda costit uit o presso il Mini s tero de gli Affari E s teri , la cui attività e ra risult a ta pari a zero, a parte un'inchi es ta co ndott a nei vari Pa e si s ull 'im piego del cinema e della radio come strumenti propagandistici c alcune insi g nificanti inizi ative.
In previsione del conflitto italo -e ti op ico, p e rò , fu accelerata la cost ituzione dei nuclei di propa ga nda all'estero, sopratt utt o n e lle città dov e numerose erano le co ll ett ivit à it a liane. Gli uffici consolari furono incaricati di porre in atto provvedime nti consoni alle diverse s ituazioni e a ll e es igenze dci si ngoli Paesi. I nucl e i furono costituiti, di pr e fer e nza, con ufficiali in co n gedo e d ebbero il compito principale di e levare a l massimo il sentimento patrio dei connazionali, di influenzare l'opinione pubblica locale e di trarr e e leme nti informativi da essa. Alla fine, r isu lt aro no operan ti all 'est e ro 146 nuclei con 631 propagandisti , distribuiti tra E uropa , Asia , Africa , Americhe. Nell'Ame ri ca d e l Nord non fu possibile is tituire nucl e i, per la mancanza di se di dei Fasci e di Sezioni ufficiali in congedo, e per la compl e ssa que s tione della doppi a nazionalità de gl i ìt a loamericani; furono p e rò costitu iti comitati patriottici e l' Unione Italia na d'America svo lse utili ss ima opera di propaganda. A differenza d e i nuclei operanti all ' interno del Paese, quelli a ll' estero furon o efficienti p e r l'intero
period o d e l cont1itto italo-c tiopico c svolsero notevole az ione di propaganda , nei confronti d e i connazionali em igrat i e dell e popolazioni es tere . A tal e scopo furono distribuiti pubblicazioni e opuscoli (per un totale di 300.000), articoli (cir ca 3.000) fotografie (circa 30.000), grafic i, diapositive , cinematografi e

Il maggior e Amedeo To s ti, che ebbe il compito di curare la costitu z ione e l' indottrinamento dei nuclei, sì sottopose a dei veri tour de for ce , ten e ndo in pochi mesi numero se conferenze- b en 36, specifica la rel az ione - in Svizzera, Francia , B e lgi o, In gh il ter ra , R od i, Grecia , Turchia , Romania, Bulgaria , Ju gosl av ia , E gi tto , Tunisia, Algeria e Marocco.
Il m ateria le propagandistico inviato fu messo a disposizione, oltre che dei nuclei , anche d c i giornal i locali ; difficile s ì rivelò , peraltro , l'op e ra dì propa gand a sull ' elemento es tero, in genere ostile all ' Italia. In qu alche m odo, comunque , fu fatto fr on te a ll' es ig enza di orientare a favor e dell e tesi italiane l 'o pinion e in te rn azional e, utilizzando conferenzieri loc a li e forn e ndo ad alcuni gio rn ali accondiscendenti corrispondenze addom es ticate. In taluni cas i furono efficaci gli interventi polemici , come a Montrcal, ove la vivac e r eaz ione d e i propagandisti italiani cos trin se un confere nzi e re de ll a radio local e a rettificare, dopo appena un giorno , malevoli gi udi z i sull ' azione militare italiana in Etiopia.
Alcuni opuscoli , come «L 'ultimo baluardo della schiavitù » di Barave lli e
«
Quel che Ginevra non vuoi vedere», furono tradotti in sette lingue e in centinaia di migliaia di esemp lari, con risultati giudicati imp or tanti per l' opera di pen et razione , di orientamento e di persuasione dell'opinione pubblica internazionale.
Non mancarono part ico lari form e di propaganda, come quella fatta sui piroscafi , o attraverso Enti industri a li e co mm e r cial i.
Di quanto fece l 'Esercito in pa rt icolare , in tale occasion e, torn e r e mo a parl arne a par te ; annotiamo, per ora, l'atte ggia mento «rinunciatario» di Pariani (sottocapo d e l Corpo di Stato Maggiore), il quale dopo av er sintetizzato la relazione sulla propaganda p e r la g u e rra in Etiopia al Gabinetto d e lla Gu erra, segnalava la richie s ta de l Partito di avocare a sé la propaganda all'interno e si p ronun ciava favorevolmente .
In sede d i di scussione , il capo del Governo stigmatizzò aspramente alcune critiche che si erano levate circa presunte carenze della propaganda, a lt ernando di scutib ili affermaz ioni (l'unico mez zo per convertire il mondo è la vittoria in guerra e non la propa ga nda) con più realistiche analisi (nessuna meraviglia se la propaganda non fu completamente efficace; si doveva ben essere consapevoli che l'Italia era in conflitto non so lo con l ' Etiopia, ma co n il mondo intero: con le sinistre, per motivi ideolog ici; con le destre, invidiose dei successi. E co n tu tti gli stati ce n trali d e li ' Europa, aggi un ge remmo noi, p e r le apprensioni che la crescita dell'Ital ia
come potenza suscitava). Interessante anche la di sc u ss ion e per la difesa contro le tr asmission i radiofoniche straniere, per le sfacciate affe rmazioni («oggi il popolo italiano crede ai comunicati, perché ormai sa ch e noi diciamo la verità») e p e r i dra s tici siste mi di rappresagli a via etere sugge riti.
Nella r elazione prese n tata nel 1937 alla X IV Sess ione , il nuovo mini stro per la propaganda, Din o Alfieri, in sintesi, riassunse e aggi orn ò q uanto già era stato detto in quell a precedente.
La propaganda p e r l ' interno ora disp oneva, per la mob il itazione, di 3 .200 conferenzi e ri distribuiti in 1.100 cent r i di propaga n da, e di 162 fun z ionari di conce tto per gli organi provinciali. L 'unica oss e rvaz ione degna di not a fu fatta a propo s ito d e ll'ina zione di tali o r gani L ' int e resse ad agire , infatti , te nd ev a a diminuir e , cd il lavoro organizzativo a rallentare , in quanto la propaganda interna incominciava a cr istallizzare come pratica di ordinaria amministrazione in vista di una utili zza zion e - la mobilitazione ge nerale - lo nta na ed eve ntu ale . Alfieri prop o n eva , pertanto , di autorizzar e anch e la Sezio ne Interno a sv olge re a tti vità prop agandist ica , sepp ur e limi tata, al fine di t e n e r e a ll e nato e pronto l ' int e ro app a rato. La Commission e riconobbe l 'ut ilità di ta le proposta; ma difficoltà finanzia ri e c la n ecessità di acc ordi co n il Partito Nazionale Fascista fecero soprassedere alla decis ione di attivare la Sezio ne . Era chiaro , ancora un a vol ta , che il Partito non gra diva di essere di st urbato

nell 'influ e nza ch e gi à ese rcita va s ull e mas s e.
L a propaga nd a all ' este ro fu invece mante nut a in vita anche al t e rmin e d e l conf lit to con l ' E ti.opia; alla fi n e della ca mpagna, i n Afr ica Ori e ntal e soltanto, risultarono operanti 152 nucl e i con 700 propa gandi sti. Co n tin u ò la prod uzi one c l ' u tilizza zion e d e i consu e ti mat e ria li pubb li cis tici (a qu e ll i già prodotti s i agg iun se ro, nel co rso d ell 'anno , a ltri 1.050 art icoli , 28.020 fotografie, 275 g rafici e 2.200 libri e o pus coli) e il maggior e Tosti pros e g uì il suo p e re g rin a re v isit a ndo altri P ae si , tra cu i l a Sp a gna.
Il NU.P.I.E. ritenn e n ecessario mant e n e re in vita i ce ntri di pr opaga nd a a ll 'e s tero , s ia per far acce ttar e la co n qu ist a it a lian a «susc e ttibile di ult e riori sv iluppi », s ia p e r contra s tar e la propaganda comunis ta , fe rocis sima p e r gli avven im e nti in Spagna. U na s peciale sezione d e lla D irezione Gen e ral e d e lla Propaganda a veva , in propos ito , raccolto e d is tr ibu it o un 'abbondante documentazion e sulle atrocità commesse d a i «rossi ».
In linea co n gli or ie nt ame n ti politici , a nch e il Corpo di St a to Maggiore riten ne pa rti co larm e nte util e, da l punto di vist a informativo e contro-informati vo , lo svi lu ppo della propagand a anticomunista.

È s oprattutto tale svilupp o ch e preoccupò, ne ll a XV Session e , il Ministero d e lla C ul t ura Popolare; preoccupazione tanto ev idente da modificare anch e il t e sto della r e lazion e co n l'agg iunta d e lla fras e «e loro
a da tta ment o (ri fe rit o ai nucl e i a ll ' es t e r o) ad ulteriori nec essità » . La prop ag anda comunis ta - ribadiamo- era divent a ta in va de nte e, pre nd e ndo s punto dall a gu e rra civil e sp a gnola , dila gav a dappertutto. Anc h e in Ital ia, dove per oltre un d ece nnio e ra stata m ess a a tacer e .
La r e lazione pre se ntata i n C o mmi ss ione riportav a po c hi acce nnirip e tit iv i - d i quanto e r a st a to fa tto n ell ' anno prece dente a ll ' int e rno e all' es t e ro . M e tte va però in e vid e nz a gli inconv e nienti che incomin c iav a no a ver ificarsi all ' e s tero, perch é alcuni centri tendevano a sfuggir e all ' ac centram e nt o e ad as s um ere la fi s ionomi a di veri e propr i uffici di propagan d a au to n om i; per cui , dopo a vern e ridim e nsi o na to la co mpo s izione num e ric a, l'organo centrale si e ra preoccupato di «dar e ad es si una fig u ra corrispond ente, in ce rto modo, a qu ella delle cellule, di cui ta nto abilmente si avvale il G o verno sovie tic o p er la s ua n efa s ta propag an d a ». An c ora un riconos cimento a ll a temibi le efficacia de ll ' azio n e avv e rsaria, ta n to da cos tituire la parte più impo rt ant e d e lla relaz ione e da e lencare - dopo a ver gius tificato alcu ne deficien ze- quanto l ' U ffic io C e ntral e a veva prodotto pe r la propaganda «antibo lsce vica» : 300.000 manifesti murali an ti -co muni sti , 150.000 fotografie di atroci tà bolsce viche, 97.000 opuscoli di propaganda antibol scevica.
Il resoconto chiu deva con l' elenco d e l m ate ri a le in viato a s copo di propa ganda nella Spagna n az ionalis ta: 1.900 volumi p er la costituzio n e di un a biblioteca circolante, con s ed e a Salamanca; 500
fotografie del «Duce con la sp ada dell'Islam» per le truppe marocchin e franch is te; 500 fotografie del «Duce che trebbi a» da diffonder e tra i contadini sp agn oli; 200.000 striscioni murali con frasi del Duce, opportuname nte sce lte, per i leg ionari e per la popola z ione s pagnola ; 500 bandierine italiane per automobili.
In a lc uni promemoria, preparati - a titolo di pre se ntazion e e di commento alla relazione - per il Gabin e tto della Guerra e per il Corpo di Stato Maggiore, comparvero per la prima volta considerazioni integrative sulla «parte militare » e sull' «aspetto mili ta re della propaganda>>. Etiopia c Spagna avevano, infatti, evidenziato alcuni problemi in m er ito. L a prop aga nda , che già in te mpo di pace aveva notevoli risvolti di int e resse militare in una Nazi-one Arm ata per definizione, era destinata a diventar e durant e le guerre un potente mezzo di lotta, offensivo c difensivo, per agirè sulle for ze armate e s ulle popolazioni, proprie , amiche, neutrali e n emic he.

Non e ra saggio quindi non prevedere una minuta organizzazione, che consentisse di passare dall ' ordinamento di pace a q uello d i guerra senza traumi. Era oltremodo ne cessario c he i militari conoscessero a fondo quanto veniva ratto in pace c contemporaneamente, di comune accordo co n l'autorità politica, indicassero,approntassero ed esegui sse ro - al mom e nto opportunol'insieme di attiv ità che avr e bbero dovuto sviluppare in g uerra.
Apparve pertanto conveniente c he , fin dal tempo di pace, l ' Ufficio Centrale di Propaganda del Ministero della Cultura Popolare avesse uno speciale ordinamento interministeri ale (Cultura Popolare- Forze Armate - EsteriInt e rno - P arti to) c comprendesse un organo di st udio, di consulenza e di collegamento con le Forze Armate, con compiti che furono così indicati: -ten ere al corre nte i ministeri militari dell'ordinamento di pac e della propaganda e del suo fun z ionam ento (orientamento, direttive, sviluppo) all'interno, perché ess i possano estendere alle for ze armate l 'azione es ercitata sulla popolazione; -ass o l vere analoga funzione nei riguardi della propaganda all'estero, perché i ministeri militari possano concorrervi negli ambi enti militari stranieri (relazioni co n gli s tati maggiori, missioni militari, sca mbi ufficiali, pubblica z ioni militari, etc.); - es erci tare funzioni di consulenza per la parte militare; - definire la ripartizione dei compiti di gu erra fra l'autorità civile (propa g anda sulle popolazioni proprie, amiche e neutrali) e l 'autorità militare . (propaganda sulle propri e trupp e, sulle truppe e sulla popola zione avversaria); -concretare, di concerto, le relazioni di servizio d egli organi civili e di qu elli militari per il migliore coordinamento della loro azione; -definire i mezzi della propaganda militare, raccogliere il materiale relativo, riprodur/o, immagaz z inarlo, mantener/o
a numero e gwrno; -adottare ogni altro provvedimento idoneo ad ass ic urare a!l 'atto della mobilitazione, e anche prima se ordinato, la pronta entrata in azione, a pieno rendimento, della propaganda di gu erra.
È inutile dire che di tale proposte nulla fu fa tto ; troppo ovvie le considerazioni s ul fatto che Cultura Popolare e Partito mai e poi mai avrebbero consentito ingerenze nella loro sfera d' azi on e. Pa vo lini , in caricato del Dic aste r o, rispose chiaro e tondo: collaborazione sì , ma ni en t e di più.
Ancora n e lla XVI Sess ion e d e l 1939 veniva retoricam e nte riconosciuta l ' opportunità di un coordinamento di tutti gli Enti che esercitavano la propaganda , se nz a che si addivenisse però ad alcun provvedimento concreto .
Anzi , il Partito tenne bene a ribadire il principio (XVII Sessione, febbraio 1940, a r gomento 14°) che, poiché la sua f un zi on e f ondam enta le era quella di formare la coscienza politica dei cittadini con a nn ess i e c onn ess i (morale eroica , va lori patriottici , spirito di dis ciplina , di sa crificio , di rinuncia, su prema dedizione alla P atria, ero ismo), non ravvedeva la nece ss ità di istituire un apposito o r gano di propaganda in caso di mobilitazi one, le cui funzioni invece potevano b e ni ss imo esse re ass ol te dalle sue s te sse or ga ni zzazioni.
Questo a di sta n za di a nni , ormai, d ella istit uzio n e d e ll 'Organo centrale di propa ga nda , di dibattiti e di funzionamento del NU. P.I.E.!
In qu esta u ltima seduta , che
preced e tte l 'e ntrata in guerra dell ' Italia , più che le r e lazioni prese ntate in sede di Com mi ssione, so no di int e r esse alcune annotazioni dell e stesse relazioni.
Tra esse, sopratt utt o, la continua, agguerrita campagna anticomunista che fu condotta , oltre che con i consueti strumenti, anche con la realizzazion e di due collane pubblicat e da gli editori Le Monnier e Bocca (q u e st ' ultima diretta alle «classi colte»). Il Minis tero della Cultura Popolare rinvigorì, inoltre , la sua azione in It alia e all'estero offrendo, d'intesa con il Cen tro di Studi Anticomunisti, un servizio quotidiano di informazioni ai mass-media.

È da annotare, ancora, una prima segnalazion e dell a propaganda contro gli ebrei, attuata con un opuscolo antisemita «Antifascismo in Italia », diffuso a ll 'estero i n migliaia di copie e in diverse lingue e- seco nd o la r e lazion efavorevolm e nt e accolto .
Per la prima volta, infin e, nella citata XVII sess ione , il Sottosegretario di Stato per la Guerra presentò una propria rel az ion e s ull a pr opaganda militar e in guerra, alquanto concisa , ma chiarificatrice d e l pensiero militare in materia.
Compi ti della propaganda dovevano essere: -in pace , l 'es altazion e dei valori, il rafforzamento dello spirito p a triottico e combattivo de lle trupp e, l ' attuazione di forme assistenziali materiali e morali per i mili tar i e le loro famiglie; - in guerra, l ' efficienza morale delle proprie trupp e e la vigilanza su l loro
s pirito e s ull e popolaz ioni a cont a tto con e sse, la lotta aU a prop a gand a n e mica , la disg rega zione d e ll e for ze e d e ll e popolazioni av ve rsari e fino all a rivolt a . al m o m e nt o, prev e dev a un Ente dir e ttivo (Minis tero dell a Gu e rra) e d Enti es ecuti vi (Comandi perife rici).
In g u erra , avr e bbe dovuto e sser e così arti co lata:
- Enti di r e ttiv i pre sso il Comando Supremo
• Uf fici o Sta m pa e Pr opag anda , pe r l'assis te nza moral e e mat e r ial e e la propa g anda , in collabor az ion e c on g li organi simi lari d e lle altre F o rz e Armat e e con il Ministero dell a C ultura Pop o la re.
• Servizio Informazioni Militare , per il se rv iz io di indagin e s ullo s pirito delle trupp e operanti e d e lle popol az ioni a cont a tto di esse . - Enti esecutivi pre sso le Unità
• Sezioni e Sotto sezi o ni P , per l' ass iste nz a e ta· propaga nda press o 1c Grandi Unità.
• Ufficial i P , co n gli s t e ssi compiti presso le minori unità.
Ta le organizzaz ione fu di fatto re sa op e rante allo scoppio de l conflitto, in ass e nza di og ni autorizz az ion e preventiva. Non fu inv e ce attuata al mom e ntoperché re s pinta - la proposta di costituire press o il Ministero dell a C ultura P op o lare una Sezione Propagand a Forze Arm ate, che avrebb e dovuto av e re le funzioni di nucl e o di mobilit azione di un a nalo go organism o a llo sco ppio de lla guerra.

** *
M e nt re a l ve rti ce si sv ilu p pa va il dibattit o s ull ' or gani zza zion e dell a pr o pa ga nda in caso di mobili t az io n e, Cultur a Popola re , P ar tito e Gu e rr a continu a rono a d eser citare la lor o influ e nz a nel Pa es e s ui citta dini i n borghes e ed in divisa .
G li a vve nim e nti d ec is ivi di questi anni (g uerr a italo- c tiopi ca e campa g na di Spagn a) con se ntir o no di m e tter e in pratica la te oria , di mi s urar e il livello di cons enso che il fascismo a vev a otte nut o, di pr ov ar e l 'effi cacia d eg li strume n ti utili zz at i. G uard ando più da vicino , pe r la pa rte ch e ci int e res s a , e saminiamo cos a avvenne n e ll'Eser cito e quali sc ambi e bb e r o le au t orit à militari c on g li or ga ni pubblicis tici d e l Regime.
A ll ' int e rno de ll ' I st ituzion e e in se n so lato nell e For ze Armate, continu a rono ad ess e r e m ess i in att o i con s ueti pr o vvedimenti per il b e ne sse re d e l soldato: s pacci coop e rativi , posti r is tor o, case d e l s old a to , pr e mi in d a naro per i m e ritevoli ed i biso g nos i, suss id i a lle fami glie, int e r ve nti st raordinari di n a tura economica , offerte messe a di s posizione d a ditt e c da fo ndazioni. Pi ccole so mm e appo s itame nt e st a n zia te (L. 1.000 men s il i ) furono di s tribuit e ai C o mandi di D ivis ion e, p e r cons e ntire ai militari in di gent i di pagare il bi gli e tto f e rro viario p e r r e cars i in li ce nza.
Non mancaro no provvedimenti tes i all'istru z ione e a ll a fo rmazion e culturale d e l s old a to , com e le s cuole re ggim e ntali p e r ana lfabeti , le bibliotech e, gli abbonam e nti a giornali, libri , rivi ste . Fu impost o , in proposito , l'abb onam e nto al
«Giornale d el Soldato» da pa g ar e con i prov e nti d eg li spacci , non solo p e r i Co rpi di s locati in I ta li a, ma a nch e per le tr upp e operanti in Afric a e Sp a gna ,« per la sana e patriottica propaganda » ch e co n te n eva Co ntinuam ente fu ca ld eggi ata la dif fus ion e tra i militari di «Gioventù fa scis ta » , gi ornale dei fasci giovanili di co mb att imen to, perché anch e tr a i soldati il periodico a lim e ntasse «la fiamma de lla fe d e, dell 'o rdinamento e della dedizione alla no bil e causa».

Di alcune nuove form e di ass iste n za p romo sse dal R eg im e, p e r riflesso, ne ben ef ici aro n o a n c h e i mili ta ri ; ad ese mpio , dell e Colonie estive e mont a n e e della B efa n a fa s cista, quest ' ul ti ma di s ci p lin ata da p a rticolari no rme all ' int e rno del Ministe ro dell a Guerr a per agevo lar e i d ip endent i più bi s ognosi. Essa filiò la «B efa n a del So ld ato », di cui se gn a liamo un «incidente » curios o: n e l 1940, il Du ce non gr a dì molto il fatto ch e nei p acch i d o no inviati ai so ld a ti fosse stat a inclusa un a sua fotografia. T e mev a , ev id e nt e mente, qualch e ico n oclasta !
Alcuni problemi ve nn e ro d a i ri chi amati; n c11935 Baistrocc hi dov e tte inter ve ni re più vo lt e perché fosse ro adottati i provv e dim e nti nece ssari ad ev itare le lor o lamente le sul vi tt o, s ull' a llo gg iame nt o , s ui s u ss idi che le fa mi g lie non se mpre ricev e va no r eg ol arme nt e . Una cos t a nte a tt enz ion e fu pos ta a l mi gli ora me nt o d e l r a n cio , attraverso continue is pe z ioni fatt e anche da u ff ici a li di grado e lev at o ; n e l 1939, fu introdotta la dist ribuz ion e gio rn a lier a di
un quarto di vino e la quot a per il mig lior amento ra n cio fu portata , p e r or din e di Mussolini , da L. 0 ,22 a L. 0,30.
I richiami furo n o anc h e oggetto di mo r mo rio per le e se nz ioni co n cesse - le ese n zioni, in o gn i ep oca, sono se mp r e stat e fattori di sg r ega nt i e oggetto d i forti c riti ch e -; tanto ch e s ull a qu estio n e int e rvenne pe r sonalmente il Capo del Governo , ribad e nd o duram e nt e che non dov e vano , in n ess un ca so, ver ificarsi f avor itis mi e che la legge d oveva asso lu tamente esse r e ri s pett a ta ; molti casi «p a rti co lari », sottoposti a ll e sue deci sioni , furono r eg olarm e nte respinti con esi to negativo; e ccez ionalm e nt e furono pre se in c on s id eraz io n e s olo le richiest e di cap i famiglia in particolari dis agiate con9i z ioni economich e, al limite d e lla sopravv ivenza. Raram e nt e fur o no con cessi rinvii, a l pos to dell e ese nzi oni, a st u de nt i al termine deg li s tudi e a d opera i specia lizzati indis pensabili p e r l ' industri a b e llica , n ei casi in cui ess i non r ie n tr a vano ne i dis pos ti di legge. Ulteriori richi es t e di es on e ri e di sp e n se per i ferrovi e ri (avanza te in sede di di sc u ssio n e a ll a XIV S ess ione d e lla Commiss ione Suprema di Di fes a n e l 1937 dal Minist er o d e ll e Comunicazioni) , fur o n o respint e per la determinant e opposi zio n e d e ll ' Amministr a zi o ne della Gu e rra.
In occas io n e della mo bilitazion e pe r l 'Africa Ori e nt a le , s i pr os p e ttò un fenome no più p e ricolo so d e ll e prot es te per i ri chiami e gli es on e ri: quello d eg li a ut o les ioni s mi , dell e dise rzioni e d e lle reniten ze . Anche se tali reati furon o
irrilevanti nelle proporzioni - un documento del settembre 1935 fa ascendere a ci rea 300 i militari condannati - furono pres i immediati provvedimenti per combatterli.
Un decreto ministeriale provvide a far sì che i colpevo li fossero comunque d es tinati a reparti combattenti e imbarcati per l' Africa, e dispose che la p e na fosse differita al t ermine della campagna. In tal modo , non aveva più senso correre il ri sc hio di un processo e di una co nd a nna , perché comunqu e l 'a utole s ioni s ta , il disertore c il r en itente, p artivano per il fronte.
A seguito del d ec reto , l'autolesionism o in pratica sco mp arve e i cas i di di se rzione diminuirono con il tempo; n e furono segna lati, dal gennaio al lu glio 1939, 7 3 di cui 15 vcrificatisi a ll 'este ro.
Baistrocchi , nell'occas ione , fu molto duro con i giudici militari, per la benevolenza usata in alcuni procedimenti e p er la difformità d ei g iudi z i e m ess i da tri bun a li diversi per gli stess i re ati .
Proteste ed el usioni, legate a i richiami e a lle mobilitazioni, non assunsero dunque le dimensioni di fenomeni pre occupanti, anche p e r la vigilanza esercitata e per le pronte di s po sizi o ni m esse in atto dall ' autorità militare.
Peri co losi livelli di guardia non furono mai raggiunti. Al contrario i documenti esa min a ti (relazioni d ei Comandi p er iferici all'autorità centrale, qu e lle d ei Comandi op e ranti s ui fronti di g u er ra in Africa e Spagna, le informativ e d el Servizio Informazioni Militare , rapporti periodici d e lla censura ep istolare) ,
sembrano avvalorare la tesi che, nono s tante i disa gi derivanti dalle gue rr e e le difficoltà di natura ec onomica in cui il P aese incomincia va a dibattersi , il consenso gen er ale verso il fascismo restava molto forte c gene r a liz zato, e la fede n e l Capo aveva sempre una indisc ussa presa sugli animi.

Ciò g r azie alla propaganda ed alle a ttivi tà ad essa connes se, su cui si potranno sempre aprire dibattiti cd affro nt ar n e in chiave crit ic a l a sc ienti ficità , la mod.ernità, i mod e ll i, ma di cui è innegabil e l'efficacia che ebbe s ulle masse.
D 'altrond e, che il m essaggio pubblicistico del fascismo anticipasse una d e lle t eo ri e più attuali e accred itate oggi, fra gli esperti di comunicazione, è cosa poco nota. Più di c inqu a nta a nni or so no infatti l' Enciclopedia Militare scr iv eva - cer tam e nte in aderenza alle dottrin e in auge - a proposito della propaganda di guerra, che tutti i s uoi mezzi e le s ue azioni, che «qua nto meno si dichiaran o tanto più so no efficaci», devono tendere a pers uadere , per <ifar si che alla pers uasi o ne segua una determ ina ta condotta». In altre parole , co me oggi, la propaganda doveva essere tesa, più che a convincere profondamente, a ottenere co mportam enti. C he poi tale co ncez ion e avesse d e i limiti temporali , poco inter ess ava il pcrs uasore: il prod ot to da consumare- id eo lo g ico o materiale - cambia in continuazione, per mutam e nti o adattament i evolu ti vi s ucce ss ivi imposti dall e nec ess ità di m ercato; veri, presunti o finti che sian o. In sostanza, fino al1 939, tali adattamenti
e volutivi de i te mi propagandistici vi furono e si susseg uirono nel processo s tori co, in un a m esco lan za di obiettivi ideologici e mat e riali: la ve nd etta p er Adua e la ric e rca dello spazio vit a le (il posto al so le), la lott a alle «plutocra z ie d e i cinqu e pa s ti a l giorno » (ricche , g rass e e borghesi) , la ne cessità di acqui sizione di materi e prime e di sbocchi commerciali , la lotta al bolsce vismo , la difesa della razza , il tradimento di Versai ll es, a nzi di Ve rs ag li a, italiani zzata s econdo il cos tume in u s o, furono sciorinati in se qu e nza per m ot ivar e e /o giustificare le gu e rre.
Capi e gre gari militari risposero in pieno ai temi d e lla propaganda, adegua ndo il lo ro comportamento all e attese dei promotori. Non poteva esse r e altrimenti, p e rch é le at tività s pi ega te a loro favore e il pre sti gio che , all'epoca , d e riv a va dall ' indossare la divisa , fur o no profi c ui di ri s ultati.
I documenti d ' a rchivio denotano l' o rg og li o e l' a nimo sità che prov e niva alle t ruppe d a llo status di combattenti in Et io pia e Sp ag n a; entusiasmo e partec ip azione di amici, pare nti e borghesi e rano alt r etta nt o generalizzati. L e voci critiche e i mom e nti neg a tivi non mancarono; ma certa m ente - all a pari di quant o a vve nuto in altre occas ioni - non furono ridondanti , come pentimenti tardivi o s tori e strum e ntali hanno voluto far crede r e .

Ri assum iamo , s uddivid e ndo - a ncora sc h em aticam e nt e e se mpre p e r co m o dit à di le ttura - gli avve nim e nti , mett e nd ol i in rela z ione alle a ttività
propagandistiche sv olte, in Itali a, in Et iopia, in Spag na e in Alb a nia.
I ta lia. La partecipazione a i conflitti portò in seno alle f a mi gli e dei combattenti b e nefici econom ici inas pettati: ind e nni tà, su ssid i e pensioni s upplirono a lla mancan z a di aff e tti , e alla lontananza. Tanto che la censura e pist ola r e non mancò di ril evar e come molti congiunti e sortasse ro i soldati a resta r e a ll ' estero, p e rch é p otesse ro usufruir e d e i b e nefici eco n om ici e d e ll e rim esse di d e naro. Allo s te ss o t e mpo , s pe c ie ai militari in viat i in Afr ica, c a lde pre g hi ere ve niva no ri vo lte dai familiari affinc h é essi cercasse ro un lavoro in Colonia, ch e garantisse loro , a f ine g u e rra , una dignito sa siste mazio n e . Molto viv e era no infatti , in Italia , le preocc upa zi oni per la mancanza di la vo ro e per il continuo ria l zo del costo della vita, speci a lm e nt e nell e r eg ioni meridionali. A tal punto , che la notizia della chiusura d eg li arruolamenti p e r l'A fri ca e la Spagna (19 37) prod us se <1orti d elusioni negli animi dei disoccupati ».
Un a r e la z ion e della c e nsura , redatta dal SIM (marzo 1937 ), mise allo stess o tempo in ev idenza che , in tutta la corrispondenza esaminata (35.51 O p e zzi) nella so la s e ttimana dal 19 a 125 febbraio, non e r a stata rilev a ta «la minima fras e di impreca z ione» , ma constatato, inv ece «un se nso di rassegnazione e una ce rta fiducia in un avv enire mig lior e».
L e su ccess iv e relazioni d e lla censu ra , fino al1939 , furono più o m e no
analoghe nell e osservazioni.

Dalle le tter e pe rv e nute in Italia dall 'Africa e dalla Sp ag na, le voci di protesta si levarono maggiormente n eg li intervalli d e i co mbattimen ti; fi nch é combattevano, le truppe viv e vano sta ti di auto es alta z ione- puntualmente registrati n e ll e c orri spo nd enze - ch e le autorità militari dov et tero p e rfino frenare. I di sag i e le s offerenze patit e e rano s p ess o a nnotati con toni esasperati, ma soltanto perché , in tal modo , risultavano più ev id enti e rimarch e voli il coraggio e la bravura personale di quanti scrivevano. Cresceva così il mito de l comb a tt e nt e e roico , che senza scarpe, acqua e v iv e ri e mag a ri con l a sola baio n etta, dop o lungh e mar ce affronta va orde di s anguinari, barbari guerrieri, vincendo li.
D a ll'Afric a, imp az ie nze p e r i rim pat ri , p e r le li ce nz e c per i co ngeda m e n t i furono segna lati a fin e guerra , fino a divent a r e ve ra e propri a insoffe ren za di interi r e parti , che d1i c devano il ritorno in Patria dopo aver esa urito il loro ruo lo di conqu istatori d e ll ' Imp ero. In ge ne re , in tutt e le Colonie , lo s tato d ' a nimo della massa d e i militari anzi a ni era in agi tazion e per i mancati congedamenti .
Dall a Spagna , si segnalavano preocc upazioni deriv a nti dall a care nza di noti z ie, dall e «barbarie» d e i rossi , dalle false noti z ie su co mport ame nti immorali d e ll e donn e rima ste a casa - la propa ga nda comunista fac e va leva sul profondo senso dell ' «onore» del maschi o italian o-. Il moral e d e i legionari restava comunque e levat o.
Fon te di appr e nsion e per i Comandi
furon o soprattutto le indiscrezi oni c le notizie di carattere militare che i so ld a ti trasmettevano alle fam igli e dai fronti. Molt e delle le tter e ce nsurat e lo furono proprio p e r t a li mo tiv i; n e ll e corri sp onden ze, infin e , non furono mai rilev ate espr essioni a ntifa sc iste o antimilitari ste, eccezion e fatta p er quell e dei militari allogeni , che con fr eq u e nza faceva n o u so di fras i ostili all ' It a lia , di for ti cri t iche p e r disagi ingi gant iti - e il più delle volte acc e rtati co m e in esiste nti d a ll ' autorità militare-, fino a firme accompag nate da un sa luto che sa r e bbe diventato presto, in tu tto il mond o, tri ste e fam oso : «H ei l Hitl e r » Vol e ndo fare un bilancio s tatistico sugli interventi op e r a ti dall a ce nsur a, forzatame nte appro ss imativo, ma sufficie ntem e nte re a listico , perché non so n o disponibili oggi t utt e le r e lazioni compilate al tempo dagli orga ni prepo s ti, si può affe rmare che le co rri s ponden ze tolt e di cor so furon o poch e migli a ia (a fr o nt e di d e cine di milioni spedite), m e ntre cir ca un dicci per ce nto d e lla po s t a ve niva censurata prev alen t emente p e r i segu e nti motivi: -s eg nalazioni di op e razioni militari in . . pre para zwne o m corso; - lam e ntele e ccessiv e per i disagi e per il ran cio ; -noti z ie fal se e allarmistich e; -ann otaz ioni con segni convenzionali (in ge ner e missi ve amorose); -ra ccon ti di s tragi inesistenti; -citaz ione di nominativi di morti c fer iti ; - segnalazioni di pres unte o false epidemie tra le truppe ;
- missive con fotografie di impiccagioni di indi gen i (dall'Africa) o gr uppi di volontari in compagn ia di fa lan gisti (dalla Sp ag n a) ; - let te r e con scritte o fotog ra f ie os ce ne. Nel disporre la censura tota le di tutte le corris pondenze , più volte i s ervizi inform a tivi ra ccomandarono che gli uffi c i addetti eseguissero i controlli s enza lasciare , poss ibilm en t e , tracce di manomissioni; perché i soldati es prim esser o - non se nt e ndo s i co ntrollati - quanto più lib e r a m e nt e il loro pensiero .
.Il lavoro di censura e ra infatti molto imp o rt ante non solo a fini inform at ivi e e ventua lm e nt e repres s ivi. ma - come a nnotano le stes se istruzioni e manat e in merito - d ete rmin a nt e per la propaganda e la cont r opropaganda. E solo l 'il1u soria g aranzi a dell' int occab ilità della pos ta ( i so ldati in effe tti conoscevano l 'esist enza della censura) poteva fornir e ele me nti utili per tali attività.
Il tenore dell e lettere cambiò nc11939, quando si spen s er o gli ultimi e ntu s ia s mi per la vittoria dei le gi o nari in Spagna. I mutamenti int e rni ed interna zi on a li , l ' occupazione dell 'Albani a, l ' amma ss amento di trupp e alla frontiera jugoslava, l'att e ggiam e nto ostile dell a Francia - o m e glio d ei fr a nc es i verso gli italiani , anche se non mancarono fe n omeni contraddittori co m e «l'affrat e ll a mento » d e lle truppe di frontiera, che fu causa di preoccupazioni pe r il Duce-, le te nsioni per il r i ncaro de i pre zzi e per gli in aspr im en ti fisca li , il razio n amento dei viver i, incominciarono
a minare la «fe d e» di civi li e militari e a far esp lod ere le lamentele. Ne ll a relazi o ne presentata a llo Stato Maggiore G e nerale nel ma ggio 1940 , in un conciso stralcio privo di og ni a nnota z ion e po siti va, furono messe in evidenza soltanto l e preo cc up az ioni d e ri va nti dalla previsione di una guerra di lun ga durata, dal ca r o vit a, dalle di s occupa z ioni , d a ll a d i fficile situazione economica. Il Du ce restava però nell ' animo d eg li italiani a ncora a l di sopra di ogni critica; incrollab il e la fiduci a n e lla s ua persona e la capacità a lu i attribuita di poter guidare, o me g li o dominare , gli e ve nti.
Ric o rdiam o, infine, ch e l e leg gi s ulla difesa dell a r az za avevano portato non pochi problemi, relativi a i cittadini italiani , m e ticci e d ebrei; il clima d i caccia a ll e streg h e che ess i dov ettero subire fec e n ascere timori e a nsie , specialmente nelle Co lonie , in molti che avevano guardato all ' It alia com e all a lor o vera Madre Patria.

L'eccessivo ze lo di funzionari e di burocr a ti costrinse il capo d e l Governo ad int e rv e nir e in più occasioni : un valoro s o tenente colonnell o d e ll ' Esercito , m eticcio, fu perse guitato finch é Mussolini n on an no tò di proprio pugno , sulla pratic a con cui si int e nd e va a nni e ntarlo m o ralmente e d economicamente , «basta, è ora di finirla » .
Etiopia. ln una lett e ra segreta diretta al Ministro d e ll e C oloni e, ai Sottose gr e tari militari (Gu e rra , Marin a, A e ron autica) e al C a po di Stato
Maggiore Generale, il lO agosto 1934
Mussolini invitava i destinatari a stroncare con ogni mezzo tutte le voci s ulle intenzioni aggressive del l 'Itali a verso l ' Etiopia , e disponeva che il R egio Corpo Truppe Coloniali e l a linea difensiva dell e co loni e fosse rinforzata, per preve nire ev entuali offensive d e l Negus. Chiar i.va, pr ecis ando il suo pensiero , che la critica s itua z ion e intern az ional e (mi li tar ismo tedesco , fall im e nto della confere nza del dis ar mo, co nflitti in Estremo Oriente) non consentiva, al momento, di sottra rr e importanti for ze militari dall o scacchiere europeo , depauperando il potenziale bellico italiano. I n sintesi, lo svi luppo degli avve nimenti imponevano di rimandare - ma solo di rimandar e -la << questione abissina».
La ca uta politica estera condotta fino al 1935 da Mussolini, accettabile e ragionevole al di là degli eccessi verbali c degli infuocati interventi sulla n ecess ità dell a guerra irrinun ciabile e fatale, valsero all 'It alia un atteggiame nto di celata connivenza, durante la gu err a itala -e tiopica, da parte dell e democrazie occidentali. Nonostante, infatti , la rottura del «Front e di Stres a» e nonostante l 'acces a propaganda condotta da Fra ncia , Inghilte rra, Ru ssia e da molti altri Stati, co ntr o la politica aggressiva e g uerrafondai a di Mussolini , sos tan zia lm ente i provvedime nti adottati , come le san zio ni della Socie tà delle Naz ioni , f urono blandi ed ininfluenti sullo sviluppo de g li avvenimenti. La flott a inglese, inoltre , si
tenn e «distr attamente» lontana, durante la campagn a, dal canale di Suez, per volontà dello stesso Governo britannico. Tale attegg iamento de lle pote nze europee ebbe il suo p eso sull'alimentazi one del conflitto, considerato, dal punto di vista logistico, un vero capo la voro e un mod e llo per i tempi. Gli avvenimenti milit ar i sono noti e furono un indubbio successo, riconosciuto tardivament e anch e dalla stampa interna z ional e che, con un mutamento di rotta so rp rendente, passò da ini zia li po s izio ni di o sti lità e di incredulità nelle capacità bellich e delle Armi italiane , all ' ammirazione più comp iaci uta della condotta della guerr a, a conquista avvenuta. Basta sfogliare quotidiani e periodici dell 'e poca , e le segnalazioni e le recensioni s tamp a trasm esse a Roma dal SIM. dai Comandi e da g li Addetti Militari, per rendersene conto. Sopr at tutt o i giornali in g lesi, austriaci , sov i etici, avevano svo lto un ' impon e nte campagna d e nigratoria dell e capacità militari itali ane; essi preconizzavano , nell a primav e ra dell935, una lun ga, sanguinosa g uerra , seguita da un'interminabile gue rri glia, che av r ebbe procurato seri imbarazzi agli inva sori. Terr e no e capacità bellich e degli etiop i avrebbe ro , seco ndo i comme ntatori , inflitto una seconda Adua ag li itali ani . Nei prim i m es i della campagna i toni degli articoli r estarono immutati ; accr eb bero, a nzi, la campagna ideologica avversaria e la disin fo rma zione sulle operazioni militari, favorite dai ritardi con cui l'A ge n z ia Stcfani diffu se inizialmente i

com uni cati rispetto a ll e corrispondenti agen z ie st ranier e, consentendo così che que s te precedesse ro i s u oi di spacci con notizie te nd e nziose o al te rat e. Ta li ritardi furon o segnalati co n a llarmismo dagli Addetti mili tar i itaJiani all 'es tero, che non pote ndo disporr e di fonti nazi o nali di prima m a no , e r ano cost r e tti a confutare notizie se nza docum e nti , per ri m ed ia re, con un a t ar di va opera di s mentite c di contropropaganda , alle corris ponden ze dei giornali es t eri.
La rapidità e il s u ccesso ott e nu to in Eti opia s pia zz ò, di fr o nt e all'opinion e pubblica int ern a z ion a le, gra n parte dci cr iti ci militari europ e i. Al termine d e l conflit to , il SIM inviò un a situazion e a l Mini s tero d e lla G u err a , dov e veniva mes so in ev id enza come non sol o nei Paesi amici e s impati zzan ti della causa i ta liana, ma anche in quelli ost ili , mol t i pubblicisti e giorn a li st i avessero fi ni to con i l pubbli ca r e s critti favorevoli al n ost r o E se r cito. La vo ce più a ut ore vo le s i levò pr o prio in In g hilt e rra , e fu qu e lla d e l ge nerale F ull e r, noto e d ac cre ditato sc rittore militare , ch e ri co no bbe l ' abilità del Mar es ciallo B a d og li o n ella co nd otta della gu e rra e lodò il comportamento delle trupp e.

Du ra n te il conf litt o in Et iopia, o ltr e all ' a z ion e di propaganda s vol ta a liv e llo ce ntr a le c dai nuclei di propaganda, fu ron o m ess i in at to a ltri e d ult e riori provvedimenti , s ul front e di g u erra.
Il l o settem bre 1935, a segu ito di acc ordi tra C ia n o e Mussolini (e dopo che fu va g liata , diba tt uta e scartata l ' ipotesi d i is t ituir e un Se rvizio storicosta mp a e propaganda d e lla Milizia,
p r opos t o dal Comando General e d e lla Mili zia s tes sa), fu costi tu it o ad Asmara l ' Ufficio Stamp a p er l'Africa Or ienta le ; a reggerl o fu chi amato il conso le Caser t ano. L'Uffici o era int egrato da un Servizio fot o -cinem atografico, in c ui prestavano la lor o opera tecn ici m ilitari e d e li' lst itu to Luce.
Co mpiti dell'Ufficio furo no: la t r asmissio n e, al Dicas t e ro d e lla propagand a, de ll e n otiz ie s ulla s itu az ione e sulle opera z ioni , p er la s uccessiva diffu sion e all ' int e rno e a ll' es ter o; l a raccolta e l'in vio di fotografie e filmati; l ' org ani zza z ion e dell e corrisponde n ze giornalistiche via radio; l'in vio e la ri cezione dei giornalist i ; la ce nsu r a su lla s tampa tramit e e leme nti d es ign ati dal C om a ndo Superiore Africa Orient ale. L' Ufficio e ra a rt ico lato in sp e cifici s e rvizi : a llo ggio e men sa p er i g iorn alisti, tel eg rafico c pos tal e, c e nsura , radiotelegrafico (not iziario q u otidiano) , ra dio (di ffu s ion e bollettino), fotocin e m atogra fi co, in formazioni (per i corrispondenti di guerra).
l se rvizi di stretto int e res se de i corrispondenti poggiava no s u coll e gamenti con gli ufficiali addetti s tampa dei C om a ndi mi li tari, che forn ivano- dopo un prim o co ntroll o e seg uito da gli Uffici Informazi o ni dei Comandi stess i - n ot izie, articoli, illus tra z ioni.. Questo pass aggio o bbli gato a ttr avers ò i cana li mi lit a ri non p iacque molto a Case rt a no , il qual e provocò un int e rvento di Mussolinì press o il Maresciallo D e Bono, affin ché il su o U ffi cio fosse agevo lato al mas s imo e
non fo sse so ttop osto a ce nsura da a l tri . D e Bono replicò con fermezza, asserendo ch e a Caserta no veniva sempre offerta l a massima, solleci t a collab ora zio ne e che non con sen tiv a «in venzion i» danno se per la sua ser ietà. Ribadiva , comunque, che era nece ssa rio sa lv ag uard a re le esigenze militari e tutel ar e il se greto in via prioritaria . Restrizioni sempre ne cess ari e in g uer ra , di cui è po ss ibil e fare co nfronti anche per avvenimenti a noi vic in i: il « ba vag lio » imposto alla stampa nella guerra del Golfo ha certamente avuto rifl ess i div e r s i, su ll a formazione dell 'o pinion e, d e ll e lib e r e corri s pond e nze permesse n e l Vietn am.
Con il progredire d e ll e operaz ioni , il Comando Superiore Africa Orientale accent uò maggiormente il controllo su ll a stampa.
Il 7 dic e mbre 1935 , nell'istituire ad Adi g rat la base avan zat a dell 'Ufficio Stampa , ribadiva una circolare norm e e restrizioni im poste a giorna li st i e corrispondenz e.
I g iornali sti pot ev an o recarsi n e ll e retrovie o a l fronte solo se autorizzati e accompagnati d a ufficiali addetti s tam pa; dovevano , inoltre , essere indottrinati sugli argomenti ch e potevano trattare o m e no. L e corrispondenze dirette ai giornali dov ev ano co nten e re solo le informazioni del notiziario compilato per il Mini s tero Stampa e Propaganda. Il notiziario , prima d e lla divulgazione al Capo Ufficio Stampa , doveva subire l'approvazione del Se rvizio Informa z ioni. Gli articoli r edatti ad Adigrat
dovevano esse r e prev e nti vame nt e censurati dall'Ufficio l sul posto, e definiti vamente ad Asmara , citt à ove subivano la c e nsura anche quelli inviati per posta. Il commento su ll e notizie fornite era preparato dall'ufficiale di collegam e nto stampa (tenente colon n ello R ave nni ) , che prendeva a sua volta direttive in merito.
Ad Asmara ed Adigrat furono installate per i gior nalisti stazioni radio fis se e mobili ; furono cos tituiti du e drappelli muletti e messi a l oro disposizione, unitamente a mezzi di trasporto meccanici.
Tutte le citate dispo s izioni furono emanate , uffici a lment e , p e r di scip linar e il serv izio e per renderlo indipend ente dai Comand i delle Grandi Unità di lin ea; in realtà l ' accentramento- come già detto - favoriva il controllo. L o dimostra una successiva circolare , em a nata di seguito all a prim a, il 15 di cemb r e , con c ui in sos tan za si rim e ttev a nelle mani di Badoglio ogn i decision e relativa alla s tampa ed a lla censura. La prese n za di Badoglio , avvicendato a De Bono caduto in di sg ra zia per carenza d 'iniziativa , influì molto sul controllo d e lla stampa; nel febbraio 1936, infatti , il Mini s tero per la Stampa c la P ropaganda si affrettò ad as s icurar e, su richiesta del Gabinetto d e lla Gu err a , che a veva rev ocato alcun e di sposizioni r elative alle corrispondenze giornal istiche pro ve ni e nti dall'Africa Orie ntal e, e prece dentemente impartite ai Prefetti. Un es plicito atto di rinuncia conseguente alle pressioni dei militari , che in più occasioni, sia con c ircol ari

in t erne che co n lettere dirett e al Dicast ero d e lla Stamp a , aveva n o s oll ec ita to r es trizion e e limitazioni a lle notizie che venivano diffus e s ull a ca mpagna
All'int e rn o della stessa compagin e militare , d'a lt ronde , più vo lt e era stato sa ncito il principio che tutti dov ev an o «ten e re la b oc ca chiu sa»; sop rattutto l' uffi cialità , la p arte più informata e co lt a d eli 'organi zza z ion e, e quindi l a più i rret ita c coinvolta nella pubblica zion e di ar ti coli. L e no tiz ie do veva no essere fo rnit e so lo att r ave r s o i canali a utorizzat i, e gli a r ticoli p otev an o essere p ubblicati solo se pr eve nti vamente ce n su rat i. P e r m ot iv i di s icurezza, n on dovevano essere comu ni cati dati rel at iv i a lle tr up pe , a movim e n ti dei rep a rti , all e operazioni, alla produzione agricola e indu s tria le n e ll e Colo ni e; né intendim e nt i op e rativi , d is l ocaz i o ni dell e for z e, co m pos izion e di colonne, noti z ie s ul n e mico . Né d oveva n o essere diffu s i , co n e nfa s i, comunica t i eli vitt or ie milit a ri , tanto m e no quelli r ela tiv i a co mbattim enti in corso e di es ito i ncerto, a l fine el i non cad e re n el ridicolo.

Ai g io r nali fur o no fa tt e anche « rac co m a ndaz i oni» circ a gli a rg omenti da privil egi are , so pr a ttutto p e r co ntrob a tter e la propag a nd a dell a s tampa es tera: evi d e nziare c h e l'Es e rcito etiopico non era una banda ar ma ta alla meg l io, ma un 'o rgani zzaz ione effici e nt e c he s i avva le va anche di arm i e m ezz i mo d e rni , e di co n s igli e ri milit a ri este ri , forn i ti da Stati s an z ioni s ti c n on (ricord i amo ch e in Etiopi a ass ist e vano il Negus uff icia li
fran ces i, tedesch i, be lgi , ru ss i, svedes i, in g lesi , sv izz eri , gr ec i , turchi , statunit e n si, tutt i individuati nominat ivame nte dai se rv iz i d'informazione it ali a ni ); far r isa lt are che le sos t e de lle opera zi oni n on era n o dovut e a ins uccessi o in cap aci tà , m a a difficol tà log istic h e c d a r ag ioni strategich e e p o liti che; controbat t ere che le forz e italian e in cam po non eran o ecce ssive , ma adeguate a ll e nec e ssità , consi d e r ando che n e ssun co nquist ato r e e uro p eo si e ra mai tro va to di fronte un eserc it o più numer oso e d effici e nt e di qu e llo e tiopico ; acce nt uare ch e le notizi e della stampa estera e rano esager a te e contraddittori e, p erc h é rispondevano e vid e n temente a dir e ttiv e d e ll a co ali z ion e anti-italiana. E così via . Contemporaneam e nte alle restrizioni e all e rac com a nd az ioni , pe raltro , fur ono diffu se c irc o l ari che invita vano a fornir e la massima assist en za c la pi ù ampia co ll a borazio ne a giorn a li, rivist e e case e ditrici postulanti i nformaz ioni , do c um e nti e imma g ini dell a campag n a Num e ro sissime le richie ste, corrisposte , in It ali a; e a ll 'estero, tram i te gli Addetti militari. Numer osi a nch e gli articoli e i sa ggi pubblica ti da militari; un a co ll abor azione soll e ci tata s pesso dai Comandi , previa ovvia cen s ura. A proposito di pubbli cisti ca milit a re , durant e la g u e rra italo -e ti op ica non si rip e té il fenom e no rileva nt e d e i giornali di trin cea, es pl os o durant e la gra nd e g u e rra. Fatte sa lv e rar e eccezioni , ai soldati , p iù ch e g iornali confezio n at i «in casa», perve nn e ro quelli editi su l t e rritorio nazi o nale o in Coloni a,
unitam e nte a pubblicazioni e s tampe di vario genere, offerte da E nti o da pri vati. Uno dei giornali più «ca lde ggia ti » tra le truppe in Et iopi a fu an c ora Gioventù Fascista. Spi go lando fr a i do cumenti , si cog li e la varietà - ma sarebbe meglio dir e il << raccogliticcio »d e lle let t ur e offert e ai so ldati: dal m a nual et to s u u si e costu mi locali al Vangelo , dal discorso del Duce all e canzone tte , d a gli inn i al ro m anzo (d 'a mor e o storico) , dall a ras seg na e nigmi st ica all e rivi s t e d ' automobili s mo. Ai soldati, inso mm a, perveniva tutto - o qua s i- quanto veniva pubblicat o in Italia. Era stato stabilito , infatti, ch e a lor o giungesse la « r es a » eli giornali c ri v iste, grazie ad una delibera adottata dalla F e dera z ione Naz iona le Fascista Editori Giornali; un elenco comp leto di tal e r esa ci consente oggi di conosce r e con esattezza le testate dei giornali e d e ll e rivi s te che leggevano i soldati in Africa Orientale; in pratica, i quotidiani e le rivi s te più d iffu se in Patria.
Qual c uno t e ntò eli ricavare an ch e profitti da qu es ta fe bbril e att ività tesa ad informare e d acculturare il soldato ( «un libro p er ogni mos chetto » era lo slogan promotore); la Società Ita liana Arti Grafiche offrì , a l Ministero d e lla Guerra, «cassette-biblioteche someggiate» a l di L. 55 cadauna (più il costo a parte dei li bri e delle rivi s te da porre a corredo dell e casse tt e); ma la proposta fu r es pinta: informa zio n e e cultura non dovevano gravar e sul bilancio.
Accanto all'offerta di giorn a li e libri , ven n e sp iegata tutta un ' attività t esa
all'assiste n za e al ben esse re delle truppe. O gge tto di cont inu a attenzione furono l' alimenta zion e e le co ndizioni sa nitarie dei soldati. Con il miglioramento rancio furono introdotti numerosi viv e ri di conforto (agrumi , liquori , fr utta fre sca r e perita s ul posto , latte conden s ato e marmellat a); molti ss ime dispo s izioni tutelarono l'igien e e la profilassi d e ll e malattie (sugger im enti per l' igi e ne p erson a le, vaccinazioni per le mal att iesop ra tt utto malaria e co lera - ;perfino norm e per l 'istitu zion e delle case di tolleranza e per la t ut e la dalla prostituzione).
l Comuni furono so ll ecitati al pagam e nto degli assegni dovuti ai famili ar i d e i combattenti - fu ron o er ogati in sussidi L. 101.814.542 -; furon o repr esse le s p ec ulaz ioni che alcuni civili e militari facevano in prima lin ea s ui tab acchi e su particolari ge n eri.
Furono istituiti spacci cooperativi per i r e parti , con a nti c ipazioni d e i fondi per l 'i mpi a nto e per gli acquisti ( ri spe tti vam e nte L. 10.000 e L. 5.000) , d a prel e vare press o la cassa de ll e Grandi Un ità.
Ai so ldati giunsero premi e doni offerti da ass ociazioni e privati (num erose le offerte in danaro provenie nti dall'e s tero) ; in ta l uni cas i, i premi in danaro fur ono elargiti a particolari condiz ioni: la Fratellan z a Militar e di Arezzo offrì L. 1.000 al primo militare d e lla provincia ch e fo sse stato decorato di med ag lia d'argento a l va lor militare. Non mancarono pacchi d o no e le tter e di incitam en to, inviate da scuo le di ogni

o rdin e e grado del Regno; testim onian ze d e lla pa r tec ip a zione att iva d e l fr o nt e interno a lla g u e rra , a nch e se limit ata e non co ral e come e ra av v e nu to n e l confli tto 1915-1918.
In debito co n to fu te nuta l ' assistenza sp iri t u a le , mediante l'asseg n azione di ca p pe ll an i militari , non s olo c a tto li ci , m a a nch e di alt r e re li gio ni (rabbi ni e pa stori per israeliti e d evange li ci); n é manca ro n o i m oment i di svag o (pro iezio ni di documentari e di filmati a soggetto, rappr ese nt azioni teatrali , p artite di ca lci o, ecc .).
E g uale attenzio n e venne rivolta a ll e truppe co loni a li , ch e , in parti cola r m o do , soll e citava n o e g radivan o prom oz ioni , ricomp e n se e concessioni di por t i d'a rma f uo r i serv izio . Nient e, i nfatti , pot e va g ratificare di più g li indi ge ni c h e la p a lese attestazione d e ll a l o ro condizione di guerrieri , di va lor osi g uerrieri , d ecor a ti e armati.
Sul pi a no propagandistico ideolog ico, l' a u to ri tà militar e d ovet te contrastare numero s e - e talvolta nuov einizia ti ve.
Più che l' E ti op i a, fu r ono i P aes i occid e n ta li a pr o mu overe p e r icolos e a ttiv ità di propa ga n da. Gli et iopi , infatti, s i limi t aro no a d un a ge n e ric a azi one s volta, all'interno d e l territo r io , a ttr av erso appelli r e ligi osi, di frate ll anza , d i in v iti a lla d iserzi one pe r l e trupp e colonia li , di lotta co mune a ll 'i nva so r e; a ll ' es te rno , tramit e i Conso l ati, in v oca ro no se n za troppa convinzio n e la so lid a rie tà d e ll e Pote nz e e d aiu ti economici e militari. L a s te ss a propaganda s pe c ifi ca contro g li
aggresso ri italiani fu bl anda; in un P aese, nel q ua le l e ma sse versavano in di sas tr ose co n diz i on i di indigenza e dove vigeva no leggi tribali , era diffic il e contras tar e la ca m pagna id eo l og i ca avversaria, ince ntr a ta s ull a «c ivili zzazio n e » e s ulla lib er a zio n e dalla schiavitù e , fatto più import a n te , attuata con provv e dim e nti concreti- a lm e no per i bisogni primari, co m e l 'alimentazione e l 'ass is ten za sa nit a riaman mano ch e venivano occup a ti v ill aggi e città. Le rival it à tra i Capi, e tra le diver se tribù , non fa cilit ava n o inoltre il co mpito.
Più i ns i diosa fu pe r l ' Italia, l a pr op a ga nd a d eg li Stati occidenta li c h e , naturalmente, p otev ano spi ega re tecniche, str \)m e nti e mezzi non dis ponibili presso g li et io pi .
Attraverso stampa, radio e c inem a, la di s informa z ion e e la propaganda d e gli occidentali- n o n ult im e qu e ll e d ei Paes i rit e nuti «simpatizza nti », come la G er m a nia - d e tt ero un gran da fa r e, soprattutto agli Addetti mi lit a ri , che t em p esta r o no di richie s te il Centro per esse r e a iu tati n e ll a lor o opera di in fo rm azione e con tropro paganda.
C omitati e a ss oci a zi o ni es tere n o n m a n ca r ono di r accog li e re ai uti per l' Etiopia anch e n e i lont a ni e d isolazi o ni sti Stati U niti , d ove p e r l a prima volta fu rono segnalate att ività di comitati n eg ri a fa vo r e dei loro fra te lli di raz za . Vi furono a n ch e t e nt at ivi di or ga n izzare forma z i on i armat e volo nt a ri e. c ui non rest a rono estra n e i i fuoriusciti it a liani , sop r attut t o comuni sti .

Ma la propaganda più del ete ria re s tò quella imperniata s ull e « at ro cità», vere e/o presu nte che fossero, commesse dagli italiani sulle pop o lazioni dell'Etio pia. In s idiosa perch é fu la più persistente e distruggeva, nella sostanza, il mito de l combattent e ita li a no , buono , mite c civi li zzatore. Sembra, pertanto, opportuno s offermarsi s u tali asp e tti della propaganda avversaria, e delle misur e di co ntr opropaganda ch e le autorità mi li tari - e politiche - italiane misero in a tto p e r contrastarla, a lmeno fino al punto in cui è disponibile la rimanente documentazione d'archivio.
I militari furono accusati sulla stampa, att ra verso la r ad io e co n altri disparati mezzi di avere perpetrato, ne i confronti degli indigeni , delitti e atrocità così riassumi bili: - uso dei gas; - omicidi sfrenati; - vio l e n ze sull e persone; - violenze sull e cose, f urti, atti di vandalismo , ecc .
Gior gi o Ro ch a t h a m esso a fuoc o il problema d ell'uso dei g as nella guerra itala-etiopica in uno st udio pubblicato su «R ivista di Storia Contemporanea» ( n. 1/1988). A parte alcune o sse rva zio ni strettam e nte personali s ugli agg ress i vi chimici (te cni camente un'arma come le altre, moralmente, affe rma l 'autore, non diversa da una scheggia di granata e da una baionetta nella pancia,quantunque con tali ana lo gie e si militudini s i potrebb e ro giustificare le più nefande efferatez ze tra-i co mbatt en ti) , c i se nti a mo di co ndivid ere

co n lui a lcuni aspe tti della questione: l' uso d c i gas e ra stato ipotizzato dai politici e dai militari, fin da Il ' inizio della campagna e n on fu - o almeno non fu so lt anto - un atto di ritorsione per le atrocità subit e (spie gaz ioni presumibilm e nte dettate da motivi propagandistici a posteriori, poiché es ist ono num e rosi d ocumenti di archivio in cu i è testimoniato come fatto di norm a le amministraz ione l ' ipotesi eli impi ego degli agg r ess ivi , non s olo per la g uerr a di Etiopia). Al momento , non vi furono freni morali inibitori a ll'impi eg o delle arm i chimiche , tanto che ne circolò notizia e non f uron o fatt i eccessi vi sfor zi per im pedirne la divulgazione. É s uffi ciente ricordar e i dibattiti s ull a stam pa del tempo; ed una ser ie di cartoline di propaganda itali a na , ove l'illustratore De Seta r affi gurò in una vign etta, addirittura umori st ica , un sol dat o itali a no nell 'a tto di spr uzz are mosch ici da - o gas, è la stessa cosaaddosso a in digeni impauriti. Una rimo zio ne p sico lo gica dell 'acca dut o avvenne so lo tardivamente i n capi e g r egari, a di sta n za di lustri , ca usat a probabilmente dall'aumento di indignazione d e lle ma sse n e i confronti delle armi chimiche c batteriologich e, impl aca bili c invisibili portatrici di mort e, alla pari del fall-out d i un'e sp losion e nucl ea re (e forse è sta to l ' in co n sci o p arago ne dell 'ar ma chimica co n l ' arma atomica a ing enerare la rimo zio n e).
Né so no qu a ntific ab i li, oggi, gli effettivi danni prodotti dall ' uso dei g asin Eti o pia fu impie ga ta soprattutto
iprite, un vesc icante a d e lev at a den s ità , ch e si d e p os it a su l t erre no , s u u o mini e anima li ; n o n so n o dis ponib ili , in fatt i, fonti documentali e dati s tatist ici in propos i to né i n ar ch i vi italiani, né di altra n a zionalità (fatte sa lve rari ssime fotograf ie ch e far e bb e ro pens ar e a perdite molt o limitate ). G li «in ge nt i» effe tti danno s i prodotti dagli a gg r ess i vi sono tes timoniati s ol o d a lla propaganda e da r accon ti orali . Fo nti docum e nt a li di sc u tib ili , anc he i n r e la z ion e a cons id e r az ioni te cni che: molti la nci f ur o no effe ttu at i per m ot ivi tattici (a s b a rramento e pr o te z ione di co lo nn e italian e, o a d interdizione di ar ea; in pratic a, il gas veniva irrorato per cos tituire una fasc ia intr a nsitabil e a favor e di Grand i Un i tà c he n on di spo n eva no di f o rze s uffici e nti per gara n ti r si la sic ur e zza di movim e nto o di manovra ); altr i fu ron o in effic aci per la c onforma zion e d e l terr e no (a m p i spazi a p e rti) e p e r le cond iz ioni atmo sferich e (alte t e mp e r at ur e e press ioni , ra r e fa z ion e d e ll ' ar ia ) ch e n e fa vo ri va n o la d ispers io n e .

C on s id e ra zi oni , comunqu e, ch e n o n conse nton o d i valutare sta tis tic amen t e l' imp ie go di un ' arma che , p e r i s uoi effe tti più psico log ici ch e r eal i, dov e tte av e r e s oprattutto il ris u ltato di terror i zzare le popol az ioni.
A co nclu sioni pi ù r e ali s tich e co nduc e lo s tudio de i docum e nti s ui d e litt i e s ull e vio le n ze co mme ss i d a i milit a ri i ta li a ni su gli i ndige ni , l ' altro gro sso motivo conduttore d e lla p r opaga nd a avver s ari a.
La prima certezz a , d edo tt a d alla co n s ul tazio n e dell e fonti , è che ne ssu n a
dir ettiva ven ne im p a rti ta dal potere p o litico-militare, c e nt rale e perifer ico , di infi er ire s ull e p op ol azioni indi ge n e. Nu m e ro se e r ip e t ut e furon o inv ece le di sp os iz io ni e m a nat e , intese al risp e tt o di u o mini e cose e all ' a s ten s ion e d a o gni atto d i coercizione e di viol e n za , ancor pri m a d e ll e os tilità.
Una circol a r e del s ette mbre 1935, d e ll 'Uffi cio Politico de l Comando Superiore Afric a Orientale, così riassume gli or dini e manati: av eri e donne debbono esse re rispettate n el modo più ass oluto , n on si infierisca co ntro i so ldati ab iss ini. .. , è da e vitare l 'o ccupa z ion e di chiese, m oschee, ci miteri. , ri cambiar e con denaro le offerte di ospitalità , n el caso di reclami, mostrare interessamento ... limitare e comp ensare i danni ca us ati dai movimenti d elle truppe .. .... , nel dispo rre gli ac campamenti, tenere conto della n eces sità dei villaggi.
Su ccess ivame nt e, man m a n o ch e si proce dette ne ll 'occ up a z ion e, furono e manat e a lt re n o rm e, ge n era li e minu te, p e r sa lvag u a rd are gli ind ige n i e le lor o p r opr ie t à, co m e il divieto di a s portare leg n a d ai villa gg i o dai bosch i s ac ri, qu e llo di cacciare , ecc .
I delit t i comm e ss i fu ro n o atti di violenza indi viduali ed es clusivam e n te p e rsonali , d e tta ti d a natur a cr im in a le o so ll eci ta ti da stati e motivi commisti di od io e di ve nd e tta. E qui n o n è diff icile co m p r en dere come ne ll a legge s tatistica d e i g randi num e ri - dur a n te l a ca m pagna furono impi e gati comp less iva mente 14 .960 u fficiali a 402.580 s o ttuffi c iali e uom i ni di truppa -
vi possano rientrare cas istich e di cri minalità. Una realt à amara , ma in ev itabile in gue rra, in ogni gu e rra.
Le azioni de littuo se e le infrazioni disciplinari , lievi e g r av i, furono sempre pro nt amente rep re sse; le condanne inflitte da i tribunali militari fi occarono. Gli uffi ciali in capa ci di tene r e la disciplina furono rimpatriati a decin e; quelli c he s i macchiarono di dep lorevole co ndott a mor ale (convivenza c on indigen e ) o di viol enze (maltrattam e nti) furon o proces sati e durament e colpiti. I cas i di furti e danni p e rpetrati dalle truppe furono a ltrett a nto puniti e i danneggiati ri sa rciti (la certezza d e l risarcim e nto produss e, in alcune re gio ni , un eccess o di la ment e le da parte d e i locali , tanto che furono s ollecitati severi controlli su ll e denuncie presentate).
Gli omicidi noti non furon o mai to llerati , neanche qu an do furono co mm ess i in stato di ecc itazione e di esas p erazi on e d a m!litari ch e aveva no visto i loro compagni at rocem e nte muti la ti. Bado g lio int e rvenn e, in proposito , ogni volta ch e se n e prese ntò l' occasione, affe rmando che e ra «asso lutam ente necessario porre fine a tali atti di malvagità».
Tutta la document azio ne e sa minat a non offre, purtroppo , una s tati stica definitiva e completa in campo penal e e disciplinare, d at i che consentire bb ero di m e tter e un punto conclusivo s ull ' int e ra vicenda, a ll ' in fuor i di ogni tes i sog gettiva e strume n ta le. N e i docum e nti militari s ulla disc iplin a delle truppe so no arc hiviat e mi glia ia di denunce , di cui la s tragrand e ma gg ior anza riguarda no

infra z io ni di li eve entità (divieto di cacci a e aspo rtazion e di leg na); rispec c hiano , c omunque , in proporzione - per quanto a ttien e a i tipi di reati commessi- due r e la zioni statist ich e dell ' attività giudi z iaria del Trib un ale Militare d e l I Co rpo d ' Arm ata, relative a incriminazioni pres e ntate d a l I e d a l III Corpo d ' Armata nei mesi di aprile c mag gio 1936.
I d a ti sono così ria ss umibili: - complessiv a ment e 168 procedimenti, con 200 imputati ; -p ro cess i archiviati 49, con 43 imputati; -processi d efiniti con d e cret i p e n a li 23, con 32 imputati; - proces si giacenti 139, con 161 imputat i.
Com e abbi am o d etto le d e nunci e, in preva lenz a, riguardavano co ntr avve n z io ni al divieto di c ac cia , con relativo reato di alienazion e di muniz ioni da guerra ; seg uiv a no qu e lli r e lativi alla di sciplin a , a l servizio, al patrimonio, alla incolumità delle perso ne.
Le r e lazioni an not ava no , tra i r eat i di riliev o dei du e me s i indicati , l omi c idio volontario ne i confronti di un indi geno commesso da un milit e e 7 cas i di diser zi one; ma anch e 2 condanne p e r omicidio e 3 p e r rapina a carico di indig e ni es tr a ne i all e Forze Armate.
Face ndo ricorso a proiezioni dell e relazioni giudiziari e e dei r ea ti segnalati , si ha un qu adro abbasta n za ve ro s imile e ragion evole d e i delitti commessi dagli italiani in Africa dur a nt e la guerra d ' Etiopia.
Ci interessa , peraltro , mett e re in ev id e nza la g u e rra p sico lo gica
scatenata intorno a tali eventi; c la c ontropropaganda spiega ta dagli italiani , ch e ribaltando le accus e, propagandarono gli eccid i sub iti , la mutilazione dei Caduti, l'uso da parte e tiopica di pallottole esplosive in combattimento, con prot este documentate e fatte pervenire alla Società delle Nazioni a Ginevra.

S ec ondo una testimonianza inglese , raccolta in India dall'Addetto militare italiano , Io stesso Negus fu imp ensier ito dagli «eccess i» commessi in co mbattim en to dalle sue truppe , tanto da esserne ser iamente preoccupato , per le dannose ripercussioni che la diffusione di tali notizie potevano derivare , in campo internazionale, al suo Paese.
l promotori italiani d e lla propaganda non mancarono di testimoniare le «barbari e» commesse da gli abissini su ll e loro stesse popolazioni , come l ' u s o dei ceppi sugli schia vi c le torture inflitte a g ruppi tribali minoritari e indifcsi, a s uffragio d e lle tesi ideologiche della campagna che stavano cond ucendo .
Al di là d e lla lotta propa ga ndi st ic a s uscitat a dalle «a utorità », ci semb ra di cogl ie r e la sp ietata, immutevole saggezza del vecchio andante «la guerra è guerra». Una sa lomonica via di m ez zo tra c hi ha voluto , in passato , forzatamente rappr ese ntar e il combattente italiano come mite e civ ilizzatore, e chi, oggi, in p edisse quo omaggio a certe tendenze storiografiche interessate e dis sacratrici , vuole raffigurarlo ad ogni costo feroce e sa ng uinario.
L' unica co n cl u sione ce r ta, ripetiti va ma inoppugnabil e, che si può trarre dal conflitto it al o- etiop ico, è la vittoria delle armi , che co ll ocò definitivamente l ' Italia tra le gra ndi potenze europee e consacrò il mi to del capo del Governo. La campagna d ' Eti op ia fu la vera punta apicale dell e fortune italiane e del consenso a l fascismo. La partecipazione alla guerra civile spag nola e l'occupazione dell'Albania servirono soltanto a perpetuare l'illusione che la grandezza d'Italia e ra divenuta inarrestabile.
Spagna. «Nella notte sul2 settembre 1936 due automobili giung e vano velocemente al molo di Gaeta. Ne scendevano sette persone dall'aria misteriosa, ch e erano attese da un t enente di vascello, il quale le faceva salire immediatamente verso un esplorato re. Non appena saliti sulla tolda della nave, l 'esploratore la sciava l 'ancoraggio e si perdeva nel buio della notte »
Non è l'ini z io di un romanzo d ' appendice, n é di s pionaggio , né di avventura. É la citazione da una serie di appunti inediti consegnati all'Ufficio Storico nel1937, r e datti dal colonnello Nulli, dell ' Ufficio S (Spagna) del Minist e ro degli Affari Esteri, p er una storia della partecipazione italiana alla gu e rra di Spagna. U na guerra «civile » per defini zion e; m a, come e bb e a dire lo stesso ge ne ral e Franco (in un colloquio avuto il14 ot tobre 1936, a Salamanca, con il tenente colonnello Emilio Faldella), «ormai la guerra non è più civile fra gli spagnoli qui vengono a
cozzare delle Potenz e» . Franco si riferi va alla notizia p e rvenutagli da Cartagena dello sbarco di 50 carr i a rma ti inviati dalla Russia , co mpl eti di e quip agg io. I n r ea lt à , n ei t r e a nni d i co mb a ttimento i du e as petti convisse ro: p e r gli spa gnoli (ma non solo per lo r o) fu un a do loros a ed atroce guer ra ci vile; per le Poten ze e urop e e ch e s i tuffaro no nel conflitto , la Spag na div en n e te rr e n o d i scont ro id eo logico e banco d i p rova di dottrin e, uomini , mat e riali e tec nol og ie Esperienze d a s fruttare per l'a ltra «grand e g uerra », orm a i a ll ' orizzonte. In Spag na s i trovar o no so prattutto la Francia e la Ru ss ia co n i re pub b licani, l'Italia c la G e rmani a co n i n az ion a lis ti ; molti a lt ri Stati e bber o co munque parte n e ll a vice nda , in posizioni m eno scoper t e
La Fra n cia int e rv en n e per dichiarati mo ti vi id e olo gic i - il soc ialista Leon B lum m e ra alla g uid a di un go verno front is ta a l m o m e nt o - e per ovv i motiv i di buon se n so pol ifico. Una vit tori a del nazion a lismo in Spag na a vr e bbe s t r e tto la Fr a n cia in una mor s a m anovrata da p e ricolosi confinanti ( Italia , Ge rm an ia , Spagna) ; come di fatto avv e nne.
La Ru ss ia co nta va molto s ulla vittor ia del comunismo sp a gno lo; era riusc ita infatti , attrav e rso l'Int ernaziona le , a porre un balu a rdo bol scevico all'estremo o cc idente dell 'E uropa cd aveva t utti gli interess i perch é esso s i co nsolidass e p e r diven tare, a s ua volta, un ce ntro di diffusion e e di p ro se litis mo dello s ta lin ismo. U n a necessità s trat eg ica, quindi, no n so lo di na t ura ideol og ica.
La Germa ni a na z ista n on po t eva che lottar e co ntr o l ' affe rm ar s i d i una poli tica e di una id eo logia deleteria a tal p unt o per i( nazional -socialismo , da indurre Io stess o Hi tler ad e rige r si a paladino contro il co muni s mo .
Più di t u tto , comunque , e r a di capitale importanza pe r la Ger mani a un 'affe rm azio ne militare o ltr e confine e d una s ua vittoria indirett a nei confronti di Mosca , che le av rebb e cons e ntito di c onso lidar e la s ua premin e n za ne ll ' Europa orientale, s opra ttutto in Pol on ia (che incominciava a dar e seg ni di in soffere n z a ), n ella Cecoslovacchia (terrorizzat a dal riarmo ted es co, ma n e ll 'eve n tualità di ce dim ent i pronta a rin ga llu zzirs i ), in R o mani a (ancora inc erta a qu a le carro agga ncia rsi ).

La dimostrazione de ll 'effi cie nza bellica dello s tr um e nto milit are nazista a vreb b e testimo niat o la sua rinata pote nza; una sco nfitta , l'av rebb e trasformata in un colosso dai pie di d 'a rg illa. A Hitler non era co ncesso un altr o scacco internazional e, dopo la battuta d ' arresto subita n el1934, con il fa lli to te ntativ o di an n ess io n e dc ii ' Au s tri a, pr opr io pe r l' inte rv e nto de l Du ce.
Di a ltra n a tura furono le caus e ch e indussero l ' It a lia ad int e rv e nir e . l pretes ti id eo log ici ch e rip etevano la solita prop aga nda d e lla n ecess ità d ì co m batte r e il bo lscev is mo , il terroris m o ros so, l'anarchia e il di sordi n e, le barb a ri e, non co n vin cono d e l tutt o . l moti vi d e ll 'int e rvent o vann o cercati anch e a ltrov e . L' It al ia int era viveva or m a i il mit o dell ' Im pero ; u na
constatazio n e oggi sg radevole , ma all ' epoca reale e palpabil e . E Mu ss olini dove va p a rt ecipar e a ll a gu e rra: il capo di un o Stato così p otente non poteva es imersi dall 'erigers i ad arbitro d e gli avvenimenti, a chiunque appartene sse ro. Rinunciar e al ruolo di g iudice, che con il proprio p e so det e rmin a i destini dei popoli , non s i addic e va al pres tigio di un Du ce. Quest e affermazioni sono ris c ontrabili nei docum e nti. É da consid e rare inoltre che, in caso di sconfit ta , la pote nza milit are dell ' Italia non sarebbe stata offuscata. Ancora troppo vivid a era la luce rifle ss a dell e im prese in Etiopia a ll ' interno della Nazione; a ll 'esterno, fort e era il timore che lo s trum e nt o militar e italiano , al momento , suscitava.

L'avve ntur a it a liana inizi ò il 7 agosto 1936 , quando partirono per l a Spagn a 11 uomini di truppa e 5 carri armati . A fin e agosto Mussolini , d'accordo con Hitl e r, decid e va l ' invio di una mi ss ione militar e (M.M.I.S.), capegg i a ta dal generale R oatta (nom e in codice Colli) e dal tenent e colonnello Fald e ll a (nom e in codice Ferraris). La missione aveva il compito di appoggiare i n az ionali s ti di Franco sopratt utto con tecnici e materiali ; e, inizialmente, ta le fu il concorso.
Nei p1imi mesi d e l conflitto , gli invii furono scarsi e alla s picciolata: 26 militi il 3 settem b re (21 ri e ntrarono qu as i s u bito); 34 ge ni e ri , 108 artigli e ri e 25 carristi il 21 settembre; 21 carristi e 23 fanti il 24 ottobre . Un totale di 24 ufficiali, 54 sottufficiali , 175 uomini di truppa (i docum e nti non se mpre
riportano le stes se cifre; i tot a li ge n e rali si di s costano comunque da q ue11i p a rzia li di poche unit à ).
I parte nti ves ti va n o abiti civili , erano disarmati , e rano muniti di p assa porto falso e d e rano tutti volontari. L e caratteristiche di segretezza e di as s oluta volontarietà d e ll 'esig e nz a furono più volt e e ripetut a m ente ribaditi. In codice, l'op erazione fu definita Mis si on e S e l a ricerca dei volontari volontari per esigenza S: nes s un dubbio, quindi, su ll ' impi e go. S o ltanto a dice mbre fu di s p osto ch e uffici a li , sottufficiali e soldati volontari p er es ig enza S , fo sse r o d e nominati «volontari per qualsiasi d es tina zio n e»
Il ca mbio di d e nomina z ione fu d e ttato dalla necess it à di ma s ch e rar e, almeno forma lmente agli occhi de g li aJtri Stati, le spe di z ioni , poiché e ra in tanto scoppiata la pole mica sugli inter venti s tranieri in Sp agn a . Dall a documenta zion e non s i rilevano dubbi di sorta, n ei volontari , sulla l oro d e stina zion e, n é che essi s uppon essero di esse r e mandati altrove o in Afri ca, come è s tato ipotizz ato.
Una <<V oce» arb itraria c pos tuma s e guita a l fatto che ai volontari veniva d a to l' equipaggiamento kaki e non g rigi o -verde; anch e l ' uniforme, con alcuni capi inu s uali , come il ca ppotto sportivo ed il b e rre tto bas co , do veva s e rvire a confond e re l e id ee nell e int e nzioni dei vertici (a part e la considerazion e che i magazzini erano comunque s forniti di uniformi gr igi <?ve rdi). Più volte i Coma ndi periferici in Itali a furono segnati da rimproveri ,
p erc h é u ffici a li e sott uff icia li pr o nun c iavano a c hiar e lettere la f atid ica parola «Spagna » da van ti all a truppa , a scapito de l segreto c he avrebb e do v uto tu tel are l ' oper azione.
In altra o ccas ion e ( aprile 1937) fu segnal ato al Ministero d e lla G uerr a che alcuni C omandi Mi lit ari , di propria iniziativa , in v it avan o g li ufficiali di complemento a far s i richiam a r e in se r v izi o per «qual si asi d es tin azi on e»; incontr a ndo s carsi conse nsi , perché tutti sapeva n o ch e sarebbero finiti in Sp a gna , in un momento in c ui i massi cc i aiuti ri cev uti dai «rossi » faceva n o prevedere un conflitto duro e molto lun g o. Fu anche segn a l a ta u na certa inizi al e appren s ione della popolazione, per le partenze dell e trupp e p e r la Spagn a e p e r i sa c rifici in u omini c in d e naro c he s i rip e rcuotevano sull a Nazio n e.

Varr eb be la pen a di st udiar e a fondo l a diatriba so ll evata , sull a «vo lont ar ie tà » d e i legi o nari , da s torici e mass- media, e le mo tivazioni s u ccèss i ve c h e hann o indotto e x-le gionari a recusar e la s pont ane ità di un ges to fa tt o , in pi e n a coscien za, n e l pas sa to. U na spo ntan eità ancora og gi rivendi cat a dal p e riodico edito dall ' A ss ocia z ione Nazionale Combattenti Itali a ni in S pa g n a ( Il volontario di Spagna, n. 111 990)
Il primo in v io ma ss iccio di vo lont a ri avvenn e il 28 dicembre 1936; un t e legramma di Mu ss o lini a C o lli così reci t av a : «Sono partite 3.000 cc. nn. con un morale magnifico et poiché fina lm ente si pensa ad attaccare 1\1alaga - come io av e vo pr oposto da moltissi mo tempo - penso che le n ostre v enti
co mpagnie di stil e ardito po tre bb ero esse re imipegate in tale dire z ione. Riservomi ma ndare pres tissimo dire tti v e politiche da comunicar e a Franco .. . » . Il mo ra le atte s ta l'entusia s mo partecipativo e l a consapevo lezza dei vo lon ta ri ; l e direttive poli ti che a Fra nc o co nfermano l a t es i ch e il Du ce si pose ad arbitro e gi udi ce d c i de s tini altrui; una pre sun z ion e c he com unqu e Musso lini avrebbe pa ga to con coce nti de lu s io ni.
A partire da di ce mbre incomincia rono , quindi , gli afflu ssi ma ss icci. A diri ge r e tutta l ' operazione furono il Ca p o del Governo ed il Ministr o d egli Affar i Es t eri, Ciano, p resso il c u i Dicaste ro fu is tituit o il già citato «Uffici o Spa g na (S) » Lo Stato Maggior e G e neral e e lo S tato Magg iore R. Esercito , coinvolti a d e cisioni pres e, fe cero , in pratica , da passacarte e da s upporto. N e l f e bbrai o 1937 la M.M.I.S. f u tra s formata in C orpo Truppe Vo lontarie (C.T.V.) , se mpr e al co mand o d e l genera le R oatta; ai primi di apri le 1937 , dopo la ba t tagli a di Gu a dalaj a r a, il C.T.V fu riordin ato e contratto, e dai r e parti furono epurati g li el e menti inaffid ab ili mor a lm e nt e e fi s icam e nt e (una prima selezione portò a l rientro di 2 .50 0 a m aggio i rimpa tr iati f urono circa 5.000).
Ba s ti co (nom e in codice Doria ) sub entrò a Roatt a (cui fu affidato il comando d e ll e bri g at e mi ste, poi Divisione Frecce) e tenne il C .T.V fino a li ' ottobre , mese in cui fu sos titui to dal ge ner a le B e rti. L'ul tim o a co mand are il C. T.V. fu il ge ner a le G a mb ara, ch e ass un se il comando n e l nov e mbr e 1938,
dopo c h e fu disposto il ritiro dalla Spagna di 10.000_volontari. Un evento, qu es t 'u ltimo , scaturito dai r ap porti non idilliaci fra Italia e Spagna, nonostante il gran clamore cost ruito intorno alla pa rtec ipazio n e e al co ntributo d eg li i ta liani .
C ompless ivam ente , in Spagna fu rono inviati - in quasi t r e a nni - oltre 40.000 uomini , ch e s ubiron o n otevo li perdite (7.286 morti e feriti per l 'Ese rcito );il solo Ministero della Guerra sos t e nne un a sp esa totale di L. 5.778.658.000 e inviò 160.000 t on n ella t e di m ateria li (armi , mezzi , muni zio ni , viveri).
Uno sfor zo non indiffere nt e p er un a sem pli ce partecipazione , dai costi enormi se s i raffronta no alcuni dati con qu e lli della guerra in Eti op ia: sp e se totali sosten ut e in Etiopia (al 1o luglio 1937) L. 9.849.051.909, contro i circa 6 mili ardi già ci ta ti per la Spagna; munizioni inviate in Spagna 301.656.823 (cartucce, proiettili, bombe) contro le 282.097.000 dell ' Etiopia ; perdite compl ess iv e (dell'Esercito c della Milizia) in S pa gna 11.740, contro le 7.313 sub it e in Etiopia.
U n bilancio ingiustificabile, p erc hé l' impegno in Spagna non produsse alcun vanta gg io. Servì solo ad indebolire il potenziale bellico i ta lian o, ad agg r avare la s itu azio n e finanziaria , ad inasprire gli animi di qu eg li italiani che si trovarono a co m batte re s u opposti fronti (i «perdenti » in Spagna , nelle fila d ei «v incitor i» dopo il 1945, trovarono modo di rifarsi s ugli e x le giona ri ) ; e , in f ine , ad in g ro ssa r e le fil e d eg li oppositori al r eg im e. L'id e ologia

marxista, sconfitta su l campo di battaglia , trovò in quell ' occasione il t e rreno di coltura ideale per crescere e diffondersi: la stori a dovrebbe insegnare che un'id e a sconfitta con la viol e nza quasi semp re si tr asforma in un mito , pronto a risorgere alla prima favorevole occasiOne.
L' unico a tr arre proficui vantaggi fu ovviame nt e Franco , in ap pare n za sempre titubante e ind ec iso s ull a co nd otta della guerra e delle operazioni, ma in realtà molto abi le a co ndurr e una s ua po liti ca, t e nd ente ad evitare l ' int ervento diretto della Francia sop rattutt o , e a sfru ttar e al massimo lo spi ri to «partecipativo » al trui, senza consent ir e a ll o s te ss o t e mpo a n essuno di sostituirsi a lui o di prevaricarlo ne lla sua az io n e di co m ando. Un ' abilità spinta fino a misconoscere , con una sot tile opera di man ipola zio ne, a nch e propagandistica , il contributo alla lotta che gli proveniva dagli a lle at i. P er qu esto i rapporti fra gli italiani c gli spagno li non furono m ai idilliaci. L e relazioni del S.l .M. , d e l C.T. V. c quelle degli Esteri , so no indi cative : «Si è deliberatamente evitato, da parte spagnola e d anche in alto loco, di riconoscere l'importante contributo offerto dai nostri rep arti volo ntari; dopo l'azione di Guadalajara non si è per co ntro evitato di gravare sui nostri la r esponsabilità delle incontrate» (relazione del7 aprile del co n so le di Siviglia trasmessa dagli Esteri alla Guerra); «l n una festa celebrata a Salamanca in o nor e d e li 'Esercito Italiano, l ' oratore ufficiale - fra le più
entusiasti che e conv inte acclama z ioniebbe ad affermare che f Es ercito e lo Stato Ma ggio re spagnolo sono i primi del mond o» ( r a pport o dell ' Ufficio I d e l C .T. V. in dato 18 maggio 1937); « ... o ra, ripeto, du o l e ai na zio nali che non so l o la s tampa nos tra, ma an che qu ella estera, e que lla stessa dei ross i, abbia gi udi cato Santander ciò ch e essa è realmente: vittoria esse n z ialm ente italiana » (comun icazion e d el comanda nt e d e l C .T. V a C iano e P a riani in data 10 se tt e mbr e 1937).
Di frasi analogh e se ne riv e ngon o ad ogni passo nei documenti. Non a ndavano ne anche troppo b e ne i rappo rti tra la truppa e la popolazi o ne, fes tosa e d es pans iv a verso gli italiani al momento della lib e raz ion e di città e di p aes i già in mano ai «ro ss i», ma pronta a ri e ntrare in un o st il e riserb o quando occu pa zio ne e permanenza s i prolungavano.

L' orgoglio latino di italiani e spagnoli manteneva i rapp ò rti tra gli s tessi militari di truppa s u identici binari , co me tr aspare da segnala zione di «incidenti» fra soldati italian i e spa g noli .
I rapporti fra i ve rtici milit a ri furono co rdiali so ltanto a li ve llo fo rmal e o personale. I Comandanti de l C. T.V costantemen te espr essero , con rela z io ni a Roma , la loro pr ofo nda s fiducia n e ll e qu a li tà st r a tegich e e tattich e di Franco e dci s uoi ge nerali ; f e cero continuame nte inutili press ioni p e rché i volonta ri non fosse ro cost r e tti all ' ina z ion e o utilizzat i maldestramente, e ch e foss e ro impieg ati in blocco o autonomament e n gen e r a le B e rti , dop o la batta glia dell ' E bro ,
ne ll ' april e del19 38, arrivò a invo care l' interv e nto di R o ma perch é gli spagnoli si asten esse ro dall 'aiutarlo ne i co mba ttime nti. C'e ra , inoltre , continua tens ion e tra i Coma nd i, p e rché gli ital iani te ntavan o di imporre le lo ro c oncez ion i oper a ti ve ag li s pagnoli ; i quali, non persero occasione per rinfacci are agli all ea ti ch e e rano in Sp agn a so ltanto per s al vagua rdar e il fas cism o, e che quindi dov e va no lasc iar e ag li spa g noli i loro affari , se nza interfer e nze.
Dive r ge nti le s t esse opinioni di Mussolini e di Fr a nco, ch e ovviamente pensava s olo a tut e lar e i p rop ri int e r ess i. Ne l febbraio d e l1 938 Mu ss olini indirizzò una lette ra a Fra nco nella quale , in s int esi , g li chied e va se intend eva spinge r e l ' offe ns iva in cors o a fondo; minacciando , in caso contrario, il ritiro d c i legionari. Franco lasciò la le tt e ra p e r un m ese se nza rispo s ta ; C iano d ove tte sollecitare Berti p erc h é e s ternasse a Franco l'irr itazione d e l Duce ( non si lasc ia una le ttera d el Duce - e quale Lettera - p er alcun e se ttiman e senza risposta ... ). Cosa che Berti fec e; ma la risposta d i Franco fu , co me a lt r e preced e nti , e lu s iva e , a ll a fine, pos t ulante la consuetud inari a richiesta di armi , materiali e me zzi. I co ntinui di ssid i furono all ' ultim o la vera ra gione del r itiro di 10 .000 volontari nell'ott ob re di qu e ll 'anno ; le decis ioni adottat e a Londr a ne ll a co nferen za del m agg io 1938, nella quale un Comitato de g li Stati int e r e ssati ribadiv a il principio del non interv en to, nulla vi e bbero a c he far e , tanto ch e
Mussolini già in preceden ti sed ut e d e l Comitato s i er a potuto p e rmett ere direttive d e l ti po «a ccetta re la tesi del ritiro dei volontari (di qualsiasi na z ionalità) in linea di prin cipi o, ma renderla inapplicabile » .
Le de cisioni de l Comitato , ri badiamo , n o n e bb e ro mai alcuna influen za s ul corso d egli a vv enimenti
L e polemich e s ulla s tamp a, a proposito d e lla partecipazione all a guerra dell ' un a e dell ' altra nazion e, servirono so lo a scontri propagandistici.
II gove rn o r ep ubbli cano spagnolo aveva prod o tt o, già n e i primi mesi d e l conflitto , un d oc um e ntato « libro bianco» , a G in e vra, s ull'int e rv e nt o italiano a favore d e lla Spagna nazionalista, senza ottene r e alc un ri s ult ato pratico. Tanto e ra accanita la lotta p ubbli cis tica , ch e l' Agenzia Reuter te ntò di organizzare un se r vizio d i co rri s pond e nti , che avrebbero dovuto seg uire meticolosam e nt e la parten za d ei vo lo nt ar i dai porti d el Tirreno, p er comprovare il co invo lgimen to d ir e tto d e ll'It a li a alla guerra.
Ovviamente , l'It a li a fece az io n e di contra st o e tentò a sua volta di dimo s trare che erano g li altri St ati ad esse r e maggiormente imp eg na t i in campo avverso.
L a s toria dell a «partecipa zione non p a rt ecipata », in cui r es tarono co in vo lti gli stati e ur o p e i, div en tò alla fine un b a lle t to dai risvol t i. ridicoli. ·
Ne l feb bra io J 937, con la cost ituzi o ne d e l C.T.V., fu istitu ito presso il Comando l'Ufficio Stampa e P ropaganda . Fu p e r ò l'Uffi ci o I del C.T.V. a pred isporre, il4

apr il e, l a prima circolare in mat er ia di propaganda e d i assiste n za morale a i volontari.
L a circol a r e fu art icol at a in qu at tro punti. Fu inn anz i t utto s ottolineata l a n ecess i tà di svo lge r e, in un m omento di sosta operati va p e r il riordino delle unit à, «un ' intensa e v ibrante a z ione di propaganda nazionale e di contropropaganda» , nonch é «.. . una acc urata, appassionata, amorev ole assisten z a mo rale delle nostre trup pe » . S e n za attimi d i t r e gua «... p er penetrare profondamente nei cerv elli e nei c uori dei gregari, alfin e di otten ere que lla sa ld ezza co llettiva indispensabile per superare le or e più dure , e vin cere» Un ch i aro riferimento a lla critica s itua z ion e ve nut as i a determinare dopo G u ada l ajara e, indir e tt a m e nt e, all'epurazion e in corso presso i repa rti. Furono po i delin ea t e le attività ass is tenziali e p r opagan di s t iche da metter e in atto: diffusione d e l gio rn al e El Legionario pr esso i repa rti e g li osp e dali; t ras mis s ioni radiofoniche speci fic he dalle sta zio ni radio di Salamanca , Valledol i d, Purgos e Madrid, con l ' ista ll azi one apposi ta , e a d es clus iv o beneficio d e ll e trupp e , di r adio e d a lto parlanti press o ogni b a tt ag li o n e , g ruppo , r ep arto s p ec iale , ospedale , c cc.; a ll es tim e n to di trasmitte n ti r a di o e di a lt oparlanti i n autof ur go ni p e r l a propaganda e la cont r o pr o pa ga nda in line a dur ante i cicli o pe rativi ; avvio di inizi a tiv e p e r il te mpo lib e ro , c om e spettaco li c in e m a to g ra f ici , g i oc hi a premio , attrezzatur e sportive. Inoltr e, approntamento di mat e ri a le di
co ntropr o pagand a s ul ne mi co, c om e o puscoli , manifestini , testi p e r radi o t ras mi ss i o ni .
N on m a n cò l a r eto ri ca so tto li n e a t ur a d i una n ecess aria e ducazion e morale d e lla trupp a con l 'a rma d e ll a parol a d e i ca pi (v i b rante, entusiasti ca, trasc inatrice), co n l ' es e mpio di o g ni coma ndant e (ne lla f a tica, n ella lotta, n el s acrific io ) , con la c ura e l' int e r essa m e n t o vig il e (p o r tato fino allo sc rupolo).
L' ultimo punto d e lla rela zione affid a va a ll ' Uffici o S tamp a c Prop aga nda il compito di a ttuare i pro vve dimenti indicati , ad e rendo a lle richi es te dci Co mandi dipend e nti «con fe r vore fascista ».
L' istitu zione d e ll ' Uffici o S tamp a p o rtò, come era gi à accadut o in Eti o pia , a continue int e rfere nze n e ll e disposiz io ni a ll a s tamp a Si t e n ga prese nt e ch e in Spagna a g ivano , pe r conto di vari Minist e ri , l' Uffi cio Stamp a de l C.T. V., qu e llo d e ll ' Amb asci a ta in Sa laman ca e l' Ufficio Stampa lialiano a Sa n S e bast ian.
N onosta nte le num e ro se di spos iz io ni e d il clima di collaborazion e «forzato », i r a pporti fr a Minculpop , E s te ri , Gu e rr a e C. T.Y. non furono idillia c i. Bas tico c B e rti ebb e ro spesso a lam e ntarsi ch e no tizie ri se rvate , come gl i e le nchi n o minati vi di Caduti in co mb a ttim e nt o, ve ni vano anticipat e dai giornali it a liani ancor prima che le autorità militari po tess e r o co muni ca r e, ai f a miliari int e r ess a ti , il luttu os o ev e nt o; qualcuno , come il commend a tore Dan z i, capo de ll'Uffi cio Stamp a a Salam a nca , st rafec e pe r mett e rs i in m os tra , e p e r il
s uo com po rtam e n to s cat enò le ire de ll o s te sso C ia no.
L'Ufficio S t ampa del C.T.V. r i uscì, co munqu e, g rad ua lm e nt e a p il o tare i rapporti tra stamp a c Com a ndi milit a ri , e man an d o di s pos iz io ni ch e, da un la to in vit ava no all a m ass im a co mp re n s ione e co llabor az ione , d a ll ' altro es igevan o che le corrispo nden ze te ne ssero s emp re p rese nti le n ecessità mili tar i, alm eno d e lle trupp e italia n e e d e ll e op e r azio ni che ess e conduc e va no. A ta l fin e f u p r e di sposta la co mpil azione, a cu ra dc i C omandi d i Di visi o ne, d i un bollett in o da mett ere a dis p os iz ion e d c i corri sp on d e nti , e f u prec isato di limit ar n e l' u s ci ta so lo q u ando fo ssero a ccaduti a vvenim e nti di rili e vo (n o n e ra n e cess a ri o che fosse giorn a li e ro ) . I co r r is p o nde nti e r a no t e n uti a svolgere la lo ro atti vità d ' in tesa con i C omandi militari.

Quan to ai co n te n uti , a n co r a un a vo lta ve ni va riba dito ch e ne ll 'ela borazio n e d e lle corri s pond e nz e giorn a listiche doveva esse r e ev it a t a o g ni va nit à o esa ltazi o ne di ges t a individu a li , n e l presupp os to che lo scopo d e lla stampa e ra qu e ll o di s e rvir e il P aese e non «l'esibi z io ni sm o d i qualc he mal ato moralm e nte».
A scrive re per i g iornali italiani le co rris p o nd e nze d a lla Sp ag n a f ur o n o a ncora i maggiori g iornali s ti del momento (alcuni di essi a ve vano g ià o p e ra-to in Etiopi a) . Qui ri cordiam o Luigi B a rzini e M a rio App e lius p e r il Popolo d 'Italia, S a ndra Sandri e Giovanni Arti e ri p e r La Stampa , A chill e B e n e d e tti p e r il Co rri ere de lla S era Il
Messaggero s i servì d e l giova n e Indr o Montan e lli , ch e p e rò finì con l 'esse r e radiato dall ' albo d e i g iornalisti p e r la sua sca r sa propensione alla retor ica e p e r l a realistica de s crizione della resa di Santande r.
Maggiore fortuna era toccata in pre cedenza a Luigi B arz in i, che pure si era lamentato con Giulio B a rr e lla- e d e l fatto fu informato il Duce - di come il suo articolo su Guadalajara fosse comparso alterato e imbottito di material e fantastico, prodotto da altr i, e non consono alla realtà dell'ev e nt o.
In alcuni casi furono i comandanti militari a stigmatizzare il comportamento per null a profess ional e e d eo ntologico della stampa . Basti co si lamentò con Ciano pe r un articolo , a firma di A lex is Z acoff, dell ' Illu strazione Italiana (n. 23 del 6 giu gno 19 37) , che definì «una ra cco lta inqualificabile di falsità e di idiozie», oltre che offensivo per la Brigata Frecce Nere.
Gambara chies e a P aria ni di intervenire perch é la stampa smettesse di rappresentarlo e adularlo come «Greta Garbo >> .
Episodi diversi , che dovr e bb ero fornire spunti di rifl essione per un o studio sistematico e oggettivo s ul giornalismo di gu e rra ed i suoi corrispondenti.
La stampa estera fu seguita co n attenzione; l ' Ufficio I del C.T. V. compilò Riassunti stampa g iornalieri e settimanali, ove venivano riportati gli stralci d e lle principali notizi e delle m agg iori te s tate estere, a nnotate da comm e nti. Un mat e rial e di s tudio

e s tr e m ame nt e interess ant e pe r comprend e re come fu condotta l a lotta p e r la formazion e d e lle opinioni, interne ed interna z ionali.
La batta g lia pubblicistica non fu comba ttut a so lt anto attraverso i giornali ; conobbe eguale intensità di f e rvori anche in opuscoli c volumi.
Alcune opere di autori s tranieri furono segnalat e per la loro pericolosità e perch é ritenut e efficaci st rum ent i di propaganda antifascista , come il volume di U p ton Sinclair No pasaran.
Di altre n e fu ausp icata la diffusion e, dopo essere state passate a l vaglio del Servizio Informa z ione Militare e d e li ' Ufficio Stori co del Corpo di Stato Mag giore. Citiamo, fra le a ltr e, Un anno fra i rossi di Spagna) di Tony Bekker (pseudonimo di un ufficial e dell 'Esercito infiltratosi fra i r e pubblicani) ; Arriba Spa gna , di Alfon s o Pellicciari; L egi o nari di Rom a in Terra Ib eri ca, di Varo Varanini; La verité sur Guadalajara , di Bernard D e schamps; Le Frecce Nere nella guerrd di Spagna, del generale Sandro Piazzoni.
Il Ministero della Guerra i ncaricò il Ca po d e ll 'Ufficio Storico, colo nnello Biondi-Morra di compi lar e un opu scolo ce lebrativo , l volontari dell'Es ercito nella guerra di Spagna, diffuso in 61.000 ese mpl ari. Il C .T. V pubb li cò in proprio IL C TV da Malaga a Tortosa.
P e rfino la Sezione Topografica d e li' Istituto G e ografico Militare vo ll e offrire un opusco lo propagandistico del proptio cont1i buto tecnico al seguito del C.T. V
La battaglia pubblicistica attraverso la
stampa e le pubblicazioni fu com unqu e feroc e . Orrori d ella gu err a e assassinii furono in giga ntiti fino all'esasperazione, dall'una e d a ll'altra parte .
La s tampa però - non ostante le preoccupa zio ni d e i capi - non e bb e un peso detenninante sul morale dci legi o nari. Né in se nso p os itivo né forse anche perch é essi non ebbero uno strumento giornal istico proprio parag onabile ai giornali di trin cea ( El Legio nario era un prodotto poco gradito).
Sui volo ntari eb be ro pe..c;;o n ega tiv o a ltri fattori, pun t igliosa ment e annotati dai Comandanti: il lun go p eriodo in linea , i rimpatri di fort i aliquote di commilitoni con te mpi di pe1manenza in Spagna infe riori a que lli di quanti restavano , l'attegg iam e nto d eg li spagnoli (timorosi e risp e ttosi d e i te d eschi ma alt e ri ver so gli italiani), la disparità di trattamento all 'int e rno d e lle stesse unità volontarie.
La crisi morale si diffu se soprattutto fra le Divisioni Frecce nell 'o ttobr e 1938 e, segnalata a Roatt a, ebbe r isposte non convincenti: parlare e fornire spiegazioni, co ncedere permessi, suss idi, li ce nze , vitto ed eq uipaggia m ento mig liore p er elevarne il m ora le .
Secondo Berti, a nov e mbre la crisi sarebbe rie ntrata: ill3 scriveva infatti a Ciano « Caro Conte- sintetizzo le impressioni in una frase molto semplice: al primo che mi verrà a parlare di morale depresso (e cos ì ho detto ad ufficiali e truppa) use rò non il rigore del rego lam ento di disciplina, ma il bastone. Ogni offesa personale va lavata a ca zz otti. Non è Lecito offendere ques ti ragazzi. Non pecco di ottimismo (anche se di questo mi si a cc usa).
B isogna distinguere tra mugugnamento e morale d ep ress o. L'italiano - e prima tra tutti il so ldato nostro - mugugna . Cosi, per abitudine, per <<diversivo», p er vecchio diritto consentito dalle leggi (ved i Repubblica G enovese). Salvo « rara avis », dal Ministe ro della Gu erra all ' ultimo piantone, tutti si lamentano: contro il soldo, il vitto, il vestito, la licen z a ch e non viene, le donne ch e mancan o e quelle che abbondano, con tro ciò che ha e que llo che non ha e via di seguito. Cos ì sino a tanto che non viene impegnato il/oro nome di italiano e ronore della Pa tria. Non appena ques to avviene... l 'indi viduo per cui è già stato destinato il rimpa trio rifiuta di andarsene, Le miserie che lo affliggono scompaiono, la moglie che Lo chiam a passa in seconda linea; tutto dimentica, all'infuori di essere so ldato e italiano »

A parte la tir ata patriottarda e la rea le crisi es ist e nte (B erti stesso av ev a tel egrafato a Cia no in se ttembre chie dendo l 'aut o rizzazion e a fa r rie n tra re 1.100 legi o nari in partico lari co ndizion i di d epress ion e «fis ica e morale ») , la relaz ion e sottolineava un a verità da sempre esistita ne l soldato italiano: la te nden za (e il diritto) al mugugno , che alcuni auto ri hanno int e rpretato più volte come protesta sos tanzial e e profo nda verso l ' Is tituzion e .
L e attività assi s tenziali per limitare le lam entele , co munqu e , a umentaron o; a parte quelle già citate (s pettacoli ci ne mato grafici , distribuzion e di radio e di attre zzature sportive), quelle inutili (come l'in vito all ' acquis to di una seri e di cartoline che la Mili z ia av eva e dito p er commemorare il «volo ntari smo popolare
espresso gloriosamente per la conquista d e ll'Impero) , e quell e fumose (come le tombolate e le «is tituzio n ali » madrin e di guena), furono distribuiti generosamente viveri di co nfo rt o (per le festività di Natal e giuns e ro 60.000 panettoni e 60.000 tononi) , previsti sgravi s ui pagamenti d i tasse e contlibuti , m esse in atto con assiduità le provvidenze igi e niche c sanitarie ( un a costante attenz ione , a n cora più che in Etiopia, fu pres tata per la preve nzion e delle malattie ven e ree ), sollecitati int e res sam e nti per le provvidenze e per le pensioni ai familiari d e i Caduti.
Nel tentativo di favorire i rappo rti co n la popolazione civile- che nell e relazioni fu ro no segnalati sempre oscillanti fra a lti e bassi - affinché l ' ospitalità degli spagno li contribuisse a tenere alto il morale dei le gionari , f u spieg ata anc h e un ' inte nsa , disparatiss im a attività prop agandi s tica e assistenziale nelle città (« lib erate» o «occupa te», seco ndo i punti di vista): diffusion e di veri gadget promozionali (come dist intivi i tal o-spagnoli, b uste di foto grafie a nticomunist e, bandi e rine) , istituzione dì bibliote ch e circolanti , allestimento di ambulatmi medici.
La propaganda, ovviamente, non poteva non t e ner conto d i qu e l «fronte interno» , anche se le intelicrenze italian e non erano gradite a Franco. Soprattutto per contrastare la capillare attività svolta dai «r ossi » , es tesa fino alla te n era infanzia; un 'info nnat iva diceva , infatti, ri co noscendone l 'efficacia , c he l'o rganizzazione bolscevica si muovev a già n ei giardini d ' infanzia, in questi termini: «Bambini spagnoli! Mentre gli assassini

fasci s ti vi gettano bomb e ed uccidono i vostri fratellini, il Ministero d 'lytruzione Pubblica del Fronte Popular vi regala giocattoli e racconti e si preoccupa della vostra istru zione affinché domani s iate uomini utili alla nuova società»
In conclu sione, le pro paga nde avverse impiegarono a piene mani in Spagna tutti gli strumenti e gli argomenti a loro di sp osizi one , anch e attrave rso i prigionie ri di guerra- un ' attività con osci uta nella 1a G.M. ma non più utilizzata- , sia verso i co m battenti sia verso la popolazione civile . Anch e se appare pr e maturo fare un bilancio definitivo della propaganda dei tre anni di guena, ad una prima analisi si h a comunque l' impressione che essa non abbia avuto un a grossa influenza né s ui combatte n ti , n é sulle popolazioni , nonostante c h e in Spagn a fosse stata s piegata l' azione propagandistica più brut a le, più ma ss iccia e più aggressiva mai co n osciuta fino ad a llora. Sembra quasi che l ' impegno propagandis tico , effuso a pien e mani dai promotori, s ia rimasto Wl fatto pri vato tr a i promot ori stess i e c he non sia riu scito in alcun modo n é ad influ e n za re, n é a mutare n é ad orientare l ' opinione interna e d internazionale.
Albania. Il7 ap r ile 1939, m e ntre la ca mp agna di Spagna si avv iava all ' ep ilo go, un Corpo di sp e dizion e italiano occupava l'Albania, mette nd o fine al vacillante r e gno di re Zog e all'alternarsi di «a ppe titi » e progetti di spa rtizion e fra Itali a e Jugoslavia. L'occupaz ion e, diventata annession e il16 aprile , fu possibile grazie agli atteggiamenti conniventi degli altri Stati e urop e i: la
Ge rmania, ch e av eva da poco occup a t a la Boemia e la Mora via e s i acc in ge va ad inva dere la Poloni a , aveva d ato il suo assenso a qu als iasi ti po di int ervento italiano; la Francia aveva «la sciat o correre »; l' [nghilt e rra , tramite il suo premier Chamberlain , se n e e ra lavate le m an i; l'Ungheria , in sintoni a con la Germani a , aveva s trafatto di c hiarand osi dispo nibile a ten e r b uon a la Jugoslavia; la Jugoslavi a, non più filo fascista dopo la caduta di Stojadin ovic, si era accon tentata di ge n e rich e ass ic ur azioni s ul fatto ch e l'Albania resta sse fo rmalm e nte un o stato ind ip end e nte; ·]a Ru ss ia era pi uttosto occupat a a tagliare tort e con la Germania , in pr evisio n e di fu turi assetti te nit o riali; la G r ec ia se ne ste tt e buo n a , n e lla preoccupaz io ne di esse re coinvo lt a in risse internazi o n a li.
T ale acco ndiscend e nza d eg li Stati co nfinanti e l'acco g li e nza fa vo revole d egli a lb anes i , indusse addirittur a il Gab in e tto d e lla Gu erra a ridurre gli scaglio ni d e l Co rpo di occupaz ione ed a sm obilitare a lcune Gr a ndi Unit à già approntate p er l' es igen za Va detto , in m e rit o e f ra p are nte si, c he n egli anni tren ta convissero se mpre a spe tti forte m e nt e con traddi ttori n e l co mport ame n to di Ca pi e Govemi. Ne l campo pro pagandistico e quindi di f01 mazi o n e d e lle opinioni, gli Stati furono se mpre e n e ttament e schierati s u posizio ni opp oste: naz ionalisti c fascisti d a una p arte, soci a listi e d e mocratici da ll ' altr a . Questo e ra quanto appariva a ll a luce d e l so le; ma , n e l segr eto del le p os izioni e rano m o lt o più fluid e e gli uni s i a ll e ava n o co n gli altri, veniva n o s anciti
continui co mprom essi , stip ul a ti patti e d a ll eanze . Ogni va lore e ogni id ealit à e ra ricusata in nom e di «s upre mi interessi», come ogni pattegg ia mento e ra suscettibile di ulteriore revis io ne (il 7 f ebbraio 1939, nonostant e l ' acerrima prop aga nda a n t icomunista itali a na , ricambiata co n a ltrettanta veem e nza dall 'U nione Sovie ti ca, ve niva s iglato in so rdina un accordo co mm e rc iale, t r a R o ma e M osca; a ncora , ne i primi mes i d e l 1940, tra Italia e Ing hilterra e ran o in v igore accordi per lo sca mbio di informazioni di interesse militare) .
La m aggioranza della popolazion e albanese acce ttò di b uon gra do la repen tina an n essio ne a ll ' Italia, ma ntene ndosi al più in un a posizione di a ttesa , per i vantaggi c h e poteva riceve re dal nuo vo r egim e. No n man ca rono , è ver o. venti con t rari, sop r a tt u tto fra gli intellettua li , alin1 e ntat i dall a propag a nda pro m ossa negli Sta ti ostili a ll ' Italia , e in centr ata s ul fan atismo r e li gioso e s ull ' atta cca mento a l vecchi o re gin1 e; mo lti a lbanes i, inoltre, nu trivano se ntim e nti irreden t ist ici pe r una gra nd e A lbani a, da realizzare con i fratell i so ggiogati da Jugoslavi a e Gr ec ia.

La mi seria d e l paese gio cava però a fav ore d e ll ' a nn ess io ne; le prin1e a ss is t e nze messe io a tto (dis t ri buzione di viver i e d i m e dicinali , servizi d i ambulato ri) , unite a provvedime nti politici e ammin ist rativi ( integrazio n e d e i mili tari alb a n esi con q u elli italian i, inqu a d ram en t o d e i giova ni n e ll e orga ni zzazio ni fasciste, lotta alla malaria) , reser o f ac il e l' ac quiescenza delle masse.
Né fu n ecess aria un a grossa opera
propagandistica s ull e trupp e italiane , nonostante il grosso numero di richiamati «per esigenze di carattere eccezional e» : una posizione , questa , che vedeva i richiamati giUiidicamente es clusi da alcuni benefici concessi a i mobilitati (ad esemp io , i professionisti privati richiam at i, co ntinua vano a pagare l e tasse d i ese rcizio) e contemporaneam e nt e gravati da alcuni oneri propri d e ll e trupp e mobilitate (per le lice n ze , ess i e rano esclusi dalla concessio ne dell e licenze ordinmie, per cui , po tend o usufruire solo di licenze straordinmi e per motivi privati ; venivano a perdere emolum e nti). ***

La conquista d ell 'Alb ania è l'atto che chiude la storia d e ll 'Itali a fra le du e guene. Anche dal punto di vista d e lla propaganda: si chiude un ciclo e, a br eve imminen za , se n e aprirà un altro.
Uguali r es te ranno gli strum e nti , m a diversi sa r a nn o i motivi ispira tori della propaganda.
Nel ventennio gl i obiettivi d a raggiungere furono la ricerca, la conquista e l'affermazione di un primato: ed è fuor di dubbio che essi furono raggiunti. La propaganda , seppure m al congegnata e diretta , vi e bb e larga parte, e l'Esercito vi trovò una propria collocazione. Ma, volutarn ente, evitiamo di tirare conclusioni definitive, in attesa che altri contributi facciano maggior luce su tal e te ma. P e r conto nostro , s iamo fermamente con vinti che la storia d e lla pr opaganda - lo '
abbiamo già affermato altrove e lo ribadiamo - sia tutta , se non da r isc1ivere. almeno da approfondire. Ci riferiamo ancora una volta al «consenso», che non può essere altrimenti le tto - in questa sede -che come il prodotto finito ottenuto dali' az ion e propagandi stica.
C i piace chiudere , in proposito. con un a notizia atti nta dalla s tamp a mentre lic e nziamo queste pagine; noti zi a ch e rimette in discussione i sacce nti giudizi di alcuni s torici sulla propaganda raffazzonata , folklori s tica e pa es ana che il fascismo avrebbe spiegato.
Nell'annunciare la p ubbli cazione d e i diari di Joseph Goebbel s , Ministro d e lla Pr opaganda del R e ich, uno ch e in fatto di propaganda - a detta degli specialisti -se n e intend eva, sono s tate anticipate alcun e annota z ioni , fatte dal personaggio , durante la visita compiuta in Italia con Hitler nel 1938. Esse così recitano: «4 maggio: Con il Fuhrer e il re sul balcone. Il popolo smania dall'entu siasmo ... ; 5 maggio: ... Mussolini ha fatto qualcosa di questa nazione ... ; 6 maggio: A Napoli accogli enza fantastica L'esulta n za del popolo è indes crivibile ... ; 7 mag gio: ... la parata è meravigliosa. Una dimostra z ione di vo lontà. e forza ; 9 maggio: C en tusia smo popolare durante il v iag gi o di ritorno è indescrivibile ... ; 10 maggio: .. . Di lato il popolo acclama. Mussolini ce l 'ha tutto in mano ... » (Riv ista Panorama, n. 1306 del 28 april e 1981 ).


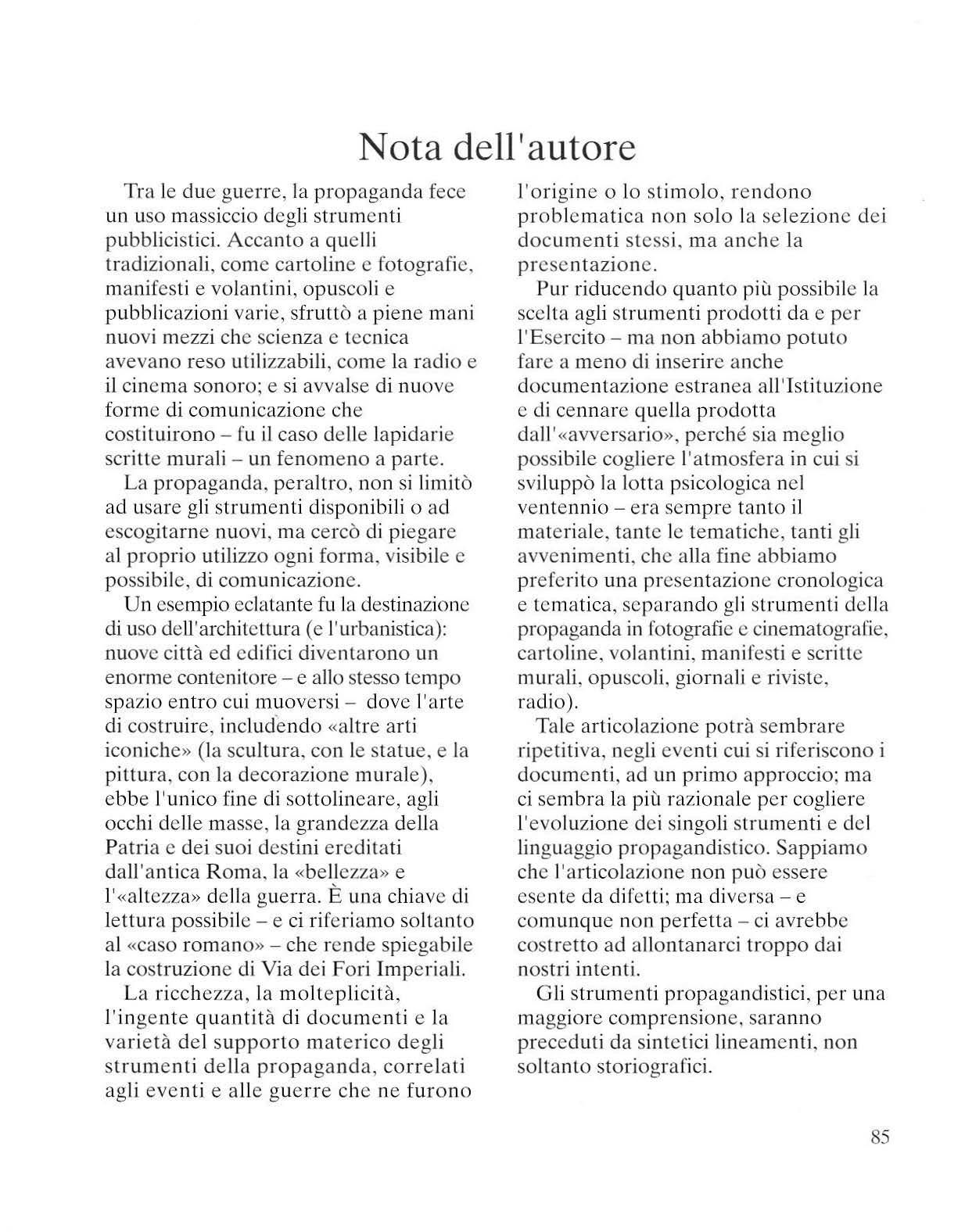
Tr a le due guerre, la p ropaga nda fece un uso mas siccio degli strumenti pubblicistici. Acca nto a qu e lli tradizional i , come cartolin e c fo to g r afi e, m anifes ti e vol a n tini, opu sco l i e pubbli caz ion i va ri e, sfr u tt ò a piene m a ni nuo vi m e zzi che sc ienza e tec nica aveva n o reso u tilizzab ili , come l a r adio e il ci ne ma sonoro ; e si a vvalse di nu ov e for m e di comunicazione ch e cost i tuirono - fu il caso d e ll e l ap id ar ie scri tte mur a li - un fenom e n o a part e . L a propaganda, peraltro, non si limitò ad usare gli strumen ti dispo nibili o ad esco gi tarne nuo vi, m a cercò di p iegar e al pr op ri o utilizzo ogni forma , visib i le c possib il e, di comu ni cazion e .
Un ese mpio e clatant e fu la des tin azion e di uso de ll ' archit e ttura (e l 'u rba nistica): nuo ve c ittà ed ed ifici di ve nt a rono un enorme conte nitore - e allo stesso tempo s p az io e ntro cui m uo ve rsi - dove l' art e di costr uire , includendo «a ltre arti ico n iche » (la sc ultura. con le s tatu e, e la pittura, con la deco ra zione murale) , e bb e l'unico fin e di s o ttoli ne a r e, agli occhi d e lle ma sse, la grand caa dell a P atri a c d e i s u o i d es tin i e r ed it a t i d a ll 'a nt ica R oma , l a «b e ll ezza» e l' «a l tezz a» d e ll a g uerra. È una chia ve di lettur a poss ib ile - e ci r ife ri a mo soltanto a l «cas o rom a no» -che r e nd e sp iega b il e l a costru zion e di Via d e i Fori I mp e ri al i.
L a ricchez za, l a molt e plicità , l ' in ge nte qu antità di do cume nti e l a varietà del s up por to mat e rico d eg li st r u m e n t i della pro p aganda , corre l ati a gli eve n ti e a ll e g u erre c h e ne fur o n o
l ' orig in e o l o st imolo, r e n dono pr ob l e ma t ic a non solo l a se lezion e dei documen ti stess i, ma a n c he l a pre se ntazion e .
Pur rid u cendo q ua nto più possibil e l a scelta agli st rum e nti prod o tti da e per l 'Esercito - m a no n abbiamo potuto far e a meno di in se rir e a nch e do c umenta z ion e estran ea a ll 'Isti t uz ione c di ce nnar e q u e lla prod o tta dall ' «avve r sario», p e r ch é s i a m egl io poss ibil e coglie re l ' atm osfer a in cui s i sviluppò la lotta ps icolo gica nel vente nnio- era se mpr e tanto il m ate riale , tan te le temati c he, tanti g li avve ni menti , c he a lla fin e abb i a m o pr e fer ito un a pr ese ntazion e crono logica e tc m atica , sepa rando g li s tr um enti dc lJa propagand a in fotografie c c inemato grafie, carto line , vo l an tini , m a nifes ti e sc ri tte mur a li , opusco li , giornali e ri viste , rad io) .
Ta l e articol az ion e potrà se m b r ar e rip et iti va, negli eve n ti cui s i riferiscono i d ocu menti , ad un pri.mo a pproccio ; ma ci se mbra l a più razional e pe r co gli e r e l 'evo lu z ione d c i s ingoli s trumenti e d e l linguagg i o pr opagandi stico. Sappi amo che l 'a rticola z ione non può ess ere e se nt e da dife tti ; ma di versa - e comunq u e non perfetta - ci avre bb e cos tretto ad a ll ontana r c i tr o p po d a i no str i int e nt i.
Gli s trum ent i pr opagandis tici , p er una . m agg w r e compre nsw ne, sar anno pr ece d u ti da s int et ici l in ea m e nti , non soltanto sto r iog r af ici.
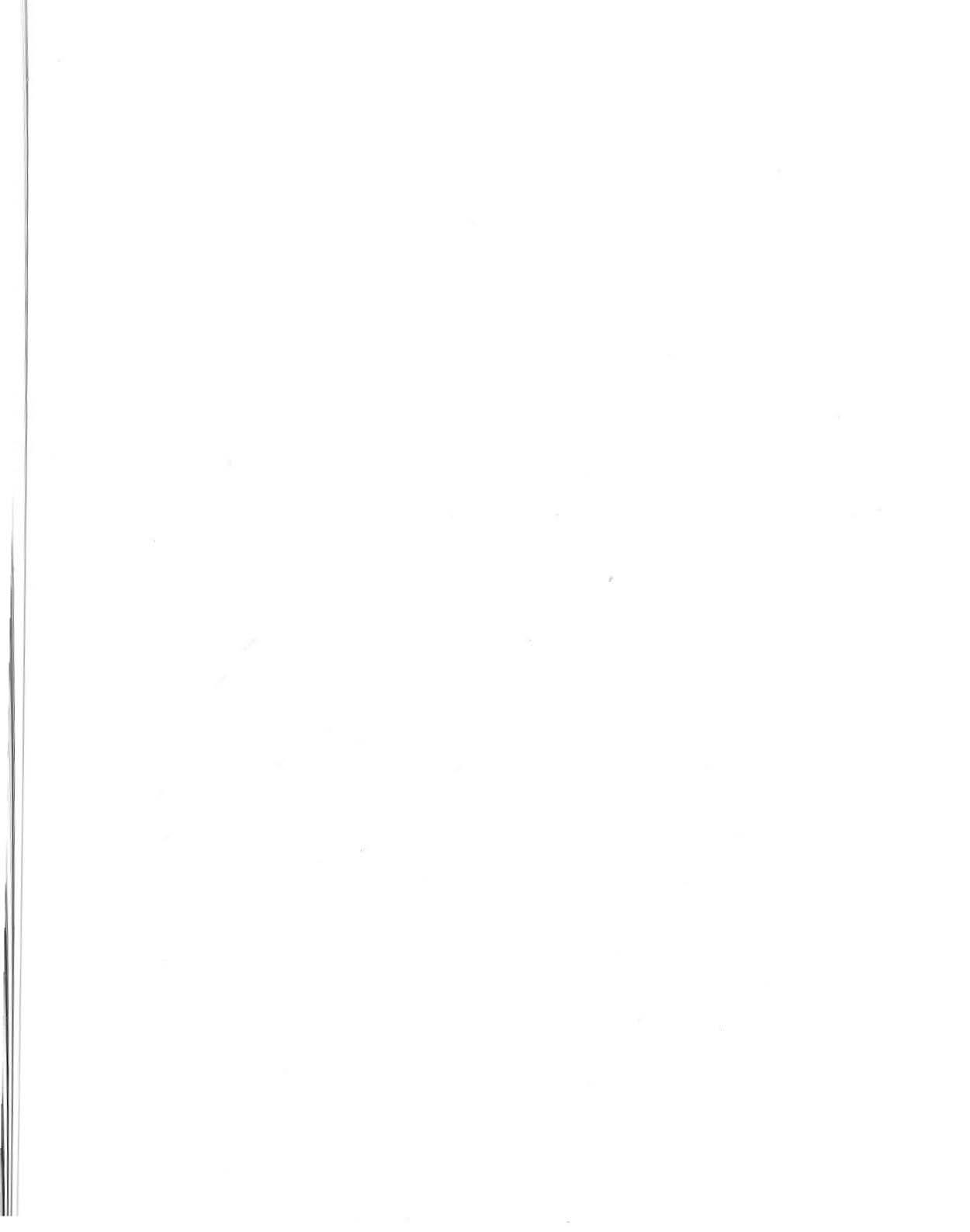

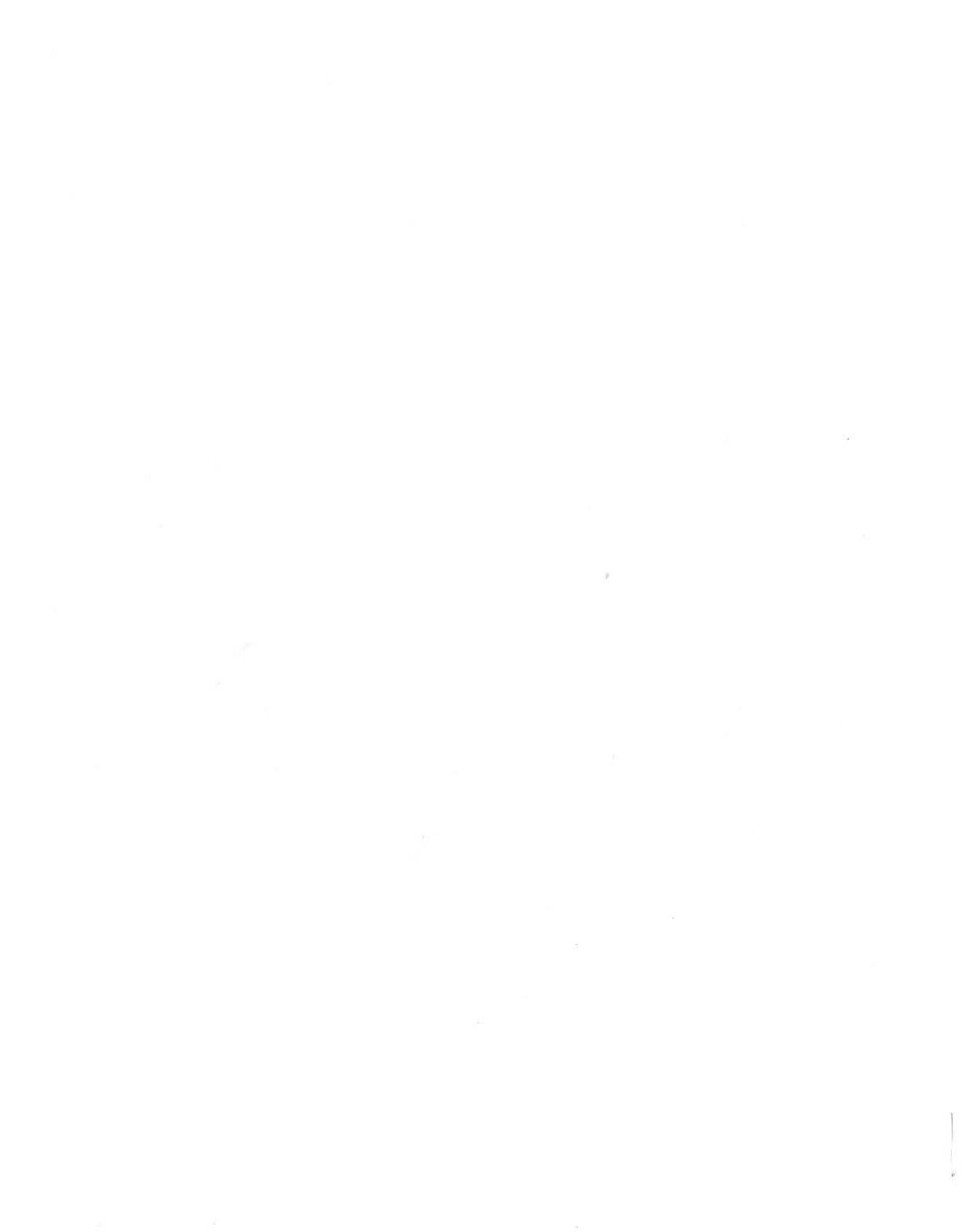
Le car to lin e militari conobbero nuove for tune all'indomani della gra nde g uerra. Larga eco propagand is tica trova r ono , n e ll e vig n e tte , i fatt i d ' arme, che contribuirono da un lato ad arr icchire le tradizioni milit a ri dei r egg imenti c, dall ' altro , a f a r riviver e a ncora il fenomeno cartolina.
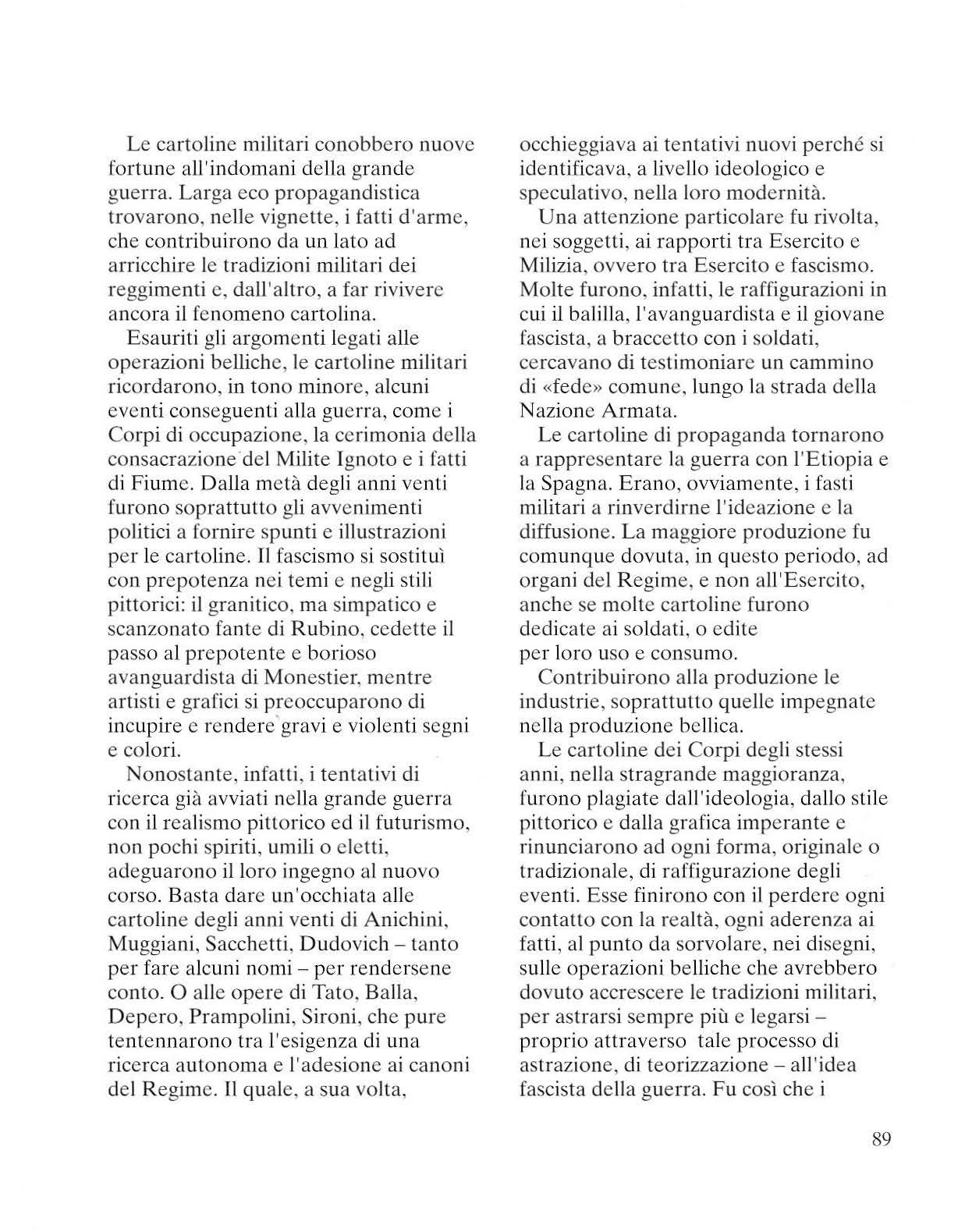
Esauriti gli argom e nti le ga ti alle op e razioni b ell ich e, le cartoline milit a r i ricordarono , in ton o minore , a lcuni e ve nti con seguenti alla gu e rra, com e i Co rpi di occ upa z io ne, la cer imoni a d e lla co nsacra z ione del Milite I g no to e i fatti di Fium e . Dalla m e tà degli anni venti furono sopra ttutt o gli avv e nimenti politici a fornire sp unti e illustrazi o ni p e r le cartoline. Il fasc ism o si sostituì con prepo t e nza n e i te mi e n e gli stili pitto ri ci: il gra niti co , ma s impatico e sca n zonato fante di Rubin o, cedette il passo al prepotent e e bori oso ava n g u ard ista di M o n es tier, me ntr e a rtisti e graf ici si preoccup a rono d i incupire e r e nder e'g ravi e vio lenti s eg ni e co lori.
No no sta nt e, infatti , i tent a ti vi di r icerca già a vviati n ella grande guerra co n il r ea li s mo pitt or ico e d il futuri s mo , non pochi spiriti , umili o e let ti , adeg uar ono il lor o ingegn o a l nuov o corso. Bas ta dar e un 'occhia ta alle ca rtolin e d eg li anni ve nti di Anichini , Muggiani , Sacche tti , Dudovich - tanto per fare alcu ni nomi - per ren ders e n e co n to . O a ll e op ere di T ato , Balia , D e p e ro , Prampolini , Sironi , c he pure te nt e nnarono tra l' e sigenza di una rice rca autonoma e l'adesi o n e ai canoni de l R egime . Il qu a le, a s ua vo lta ,
occhi egg iav a ai tentativi nuovi perch é si id e ntifi cava, a liv e llo ideol og ico e s p ec ul a ti vo, nell a loro m ode rnit à.
Una atte n zio n e particol a r e f u r ivo lt a, ne i sog gett i, ai rapporti tr a Esercito e Milizia , ovvero tr a E serci to e fasci s mo. Molte fur o no , in fa tti, le r affigurazi o ni in c ui il balilla, l ' av a nguardi sta e il giovane fascista , a braccetto con i so ldati , cerca va no di t es timoniar e un cammino di «fed e » comun e, lungo la strada de lla Nazion e Armata.
Le cartoline di pro pa ganda torn a rono a rappr ese ntar e la g uerr a con l 'Etiopia e la Spagna. Erano , ovviam e nte , i fa s ti. militari a rinverdirne l ' id eaz ion e c la diffu sio ne . La m aggi ore prod uzi o n e fu comunqu e dovut a, in qu es to periodo, ad organi d e l Regim e, e non a ll'Es e r c ito, a n c he se mo lt e ca rtolin e fu r ono dedicat e a i soldati , o ed it e per lo ro us o e cons umo .
Contribuirono a ll a pr oduzione le ind ustrie, so pra ttu tto qu e ll e imp egn ate nella produ zion e bellica.
Le cart o line d ei Corp i deg li stess i a nni, n e ll a stra g r a nd e ma gg ioranz a, furono p lag iate d a li ' ideolo gia , dallo sti le pittorico e dalla g r afica im pera nt e e rinunci a r ono ad ogn i form a, or igina le o tradizionale, di r affig ura z io ne degli e venti. Esse finir o no con il perd e r e ogni co ntatt o co n la r ea lt à, o g ni ade r e n za ai fa tti, al punto d a s orvolare, nei di seg ni , s ulle op e razioni be llich e ch e avr e bbero dovuto accr escere le tradi zioni milit ar i, per astr ars i sempre più e leg arsiproprio at traver so tale processo di as trazio n e, di teorizzazion e - all'id ea fa sc ista de lla g ue rra. Fu così ch e i
so ld ati persero le connotazioni umane e div e ntarono divini guerrieri; i rassicuranti fucili , le salvifiche vangh e tte e le fedeli baionette dai mille usi, vennero riunite in fasci e se lv e di arm i angosciose; gli sg uardi , sempre minacciosi, persero la dignitosa fi e rezza e conobbero solo la feroc e esalta z ion e . L'allegoria della stessa Italia fu spogliata d e ll'antica , rasserenant e femminilità, e di ogni lineamento di dolcezza, di tener ezza , di pietà: p e rfino i l suo seno, prima morbido e protettore, materno e se nsuale, di ve nne una rigida e d is pida coppa , simile ad una fredda , marmor ea corazza in capace di sugge r ire ogni sentime nt o. Tra gli autori di tali ca rt oline, che meglio adeguarono a i ca noni del R egi me i loro tratti e i loro colori e ch e più fertili furono n e lla prod uzi one, ric ordiamo D 'Ercoli , Tafuri, Molino e Pi sani.
P iù di tutti, fu ecceziona le interprete g rafico della propa ga nda fascista G in o Boccasile. Un «cartellonista» che , non a caso, veniva dalla pubblicità e aveva mosso i suoi primi passi n e llo s tudio di Mauzan. Eclettico e versatile in ogni forma di comunicazione pubblicitaria , Boccas ile poss e deva doti naturali di cartellonista pubblici sta, che istintivamente traduc eva in seg ni percepibiJi co n imm e diatezza e chiarezza dal recettore d e l messaggio.
B occasile div e nt ò famo so so prattutto per le sue sensua li s ign orine, dise g nat e per il settimanale Grandi Pinne. La ge n e ro sità e la procaci tà d e lle forme femminili, us cite dai suoi pe nn e lli , non furono di ostacolo a lla nascita di corpi
virili, pod e rosi e imponenti , che produsse per la propaganda , s u incarico delle organizzazioni del Partito, c del Minist e ro della Guerra (e, più t ar di , per la Repubblica Sociale Italiana).
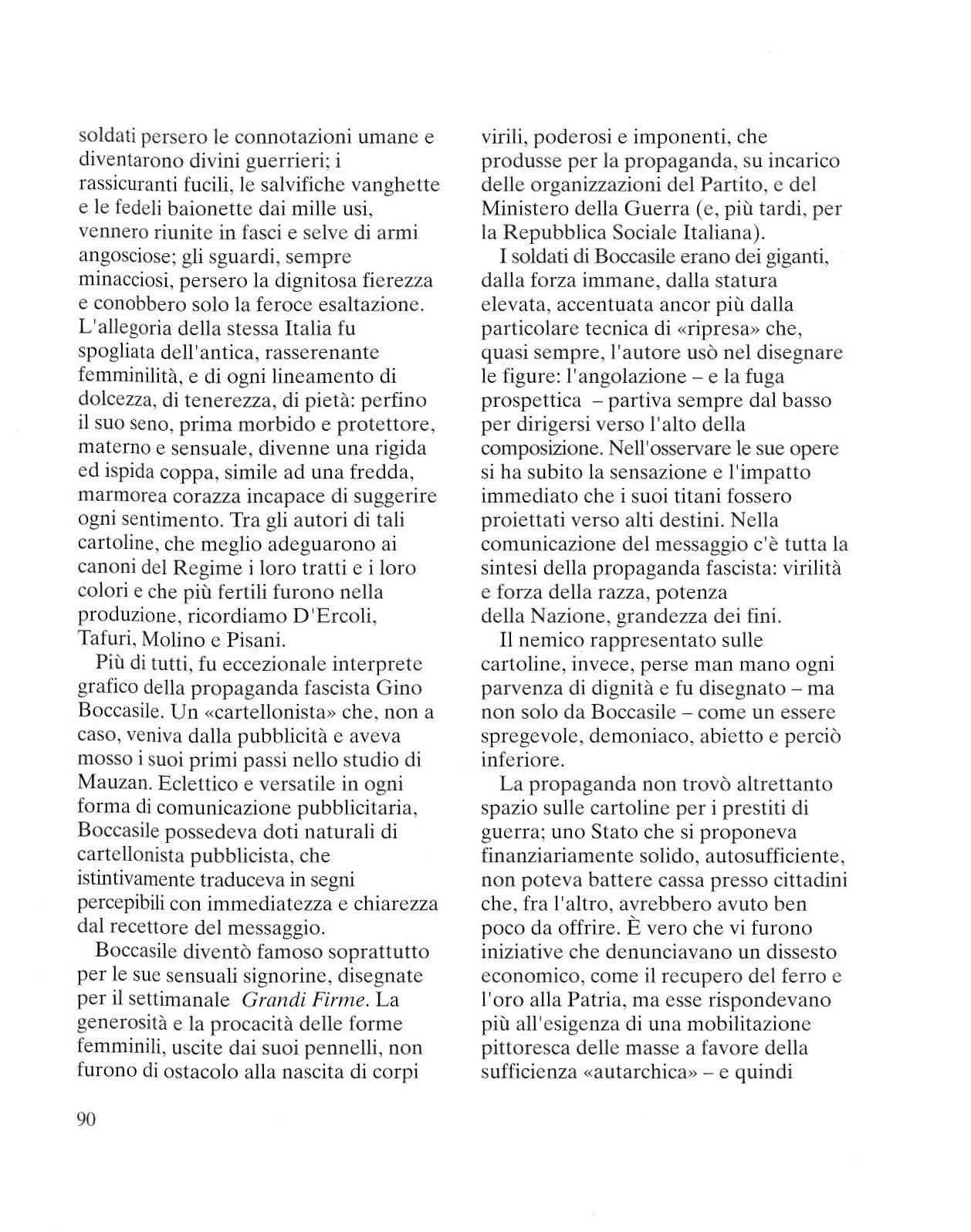
I soldati di Boccasile erano dei gig anti, dalJa forza imman e, dalla statura e levata, accentuata ancor più dalla particolare te cnica di «ripresa » che, qu as i se mpre , l'autore u sò n e l di segna r e le f igure: l 'a n go la zione - e la fuga prospettica -par tiva semp r e dal bass o per dirigersi verso l 'al to della composizione. Nell'osserva r e le sue opere si ha subito la sensazione e l'impatto immediato ch e i suoi titani fossero proiettati verso alti d es tini. Nella comunica zion e d e l m essagg io c'è tutta la s int esi della propaganda fascista: viri lit à e fo r za della razza, poten za della Nazione , grandezza dei fini.
I1 nemico rappr es entato sulle cartoline, invece, perse man mano ogni parven za di di gnità e fu disegnato- ma non so lo d a Boccas il e - c om e un essere s p regevole, demoniaco , abietto e p erciò infe riore.
La prop aga nda non trovò a ltr ettanto spazio s ull e cartoline per i pres titi di g u e rra ; un o Stato che si proponeva finanziariamente s olido, autosufficie nt e, non poteva battere cassa presso cittadini ch e, fra l' altro, avrebbero avuto ben poco da offrire . È vero che vi fu rono iniz iative c he denunciavano un dissesto eco nomico , come il r ecuper o del ferro e l'oro alla Patria , ma esse rispondevano più all 'esig e nza di una mobilitazion e pittoresca dell e mass e a favo re della s uffici e nza «autarchi ca» - e quindi
indirettame nte e rano anch e mom e nti di ve rifica d e lla ad es ione e d e l co ns e nsoche ad un a poss ibil e o eff icace az ione di risanamento.
Neanch e le cartoline in fra nchi gia, emesse per l' Eti opia e per la Spagna, furo n o ve icolo di propaganda.
Inizialm e nt e, p er l 'Africa Orientale , ve nn e approntata dal Pol igrafico d e llo Stato u na ti ra t ur a di l Omilioni di ca rtolin e in fra n chig ia p er le trupp e, se nza alcun dise gno; nell'o tto bre d e l 1935, però , l'Istituto Geo gr afico Mil itare propose un a cartolina il cui vers o fu pe r la m età occupato da un a ca r tina a co lori d e ll 'Africa Orientale. 11 bozzetto fu approva to da Baistrocchi, perc h é era sta to «mo lto b ene concepito per scopo di propaganda e vo lga riz zazione cartografica e coloniale»
L ' allestimento de lla nu ova s tam pa iniziò a dice mbr e, s ubito seg uita dalla distribuzione; il primo tipo di car tolina restò in adozione per le Forze Armate dis locate in Libia e ·in Egeo per l' es ige nza Etiopia. L' Ist ituto Geografico, produsse, per l ' inte r a du r ata d e l conflitto, 46 milioni di ca rtolin e.
È veram e nte in sp iegabil e come in tale occas ion e il R eg im e non abb ia sfruttato, con imm ag ini di propaganda e ffica c i, anc h e la ca rtolin a in franchigia , pu r ave nd one s tampat e a d ec in e d i milioni di esemplari, e pur pros eguen don e la d ist ribu z io ne all e truppe di a lt r i mili o ni , a g uerra co nclusa .
In Spa g na, inizialme n te, furo n o utilizzate per la corrispondenza in franc hi gia carto line com uni ; so lt anto n e ll 'april e 1936 l a D ir ezione de i Servizi
Postali dell' In tende nza avviò una prima distribuz ione di spe cifiche carto lin e, di un mod e llo molt o se mpli ce; s ucces s ivamente ne furo n o sta mpati modelli div ersi (anc he cartoline doppie per ag evo lare la cor rispondenza) , ma con scarsa rilev a nza prop agandi stica: piccoli diseg ni di f regi , qu alc he slogan o frase aulica .
Innu me r evo li furono, invece, le ca r toline d i pro paga nda pura pr odotte per l' Etiop ia e per la Sp agna. Edit e inn anzitutto da g li Organi del P artitoma anche dall 'edito ria privatasfruttar o no t utti i te mi lega ti dall a gue rr a: l a lotta alla schiavitù, la lotta al bo lscev ism o, la mi ssi one civ ili zzatrice dell ' Itali a, la grandezza de ll a Patria, gli atti di eroismo, ecc.
Figure fort i e co lori vi olenti fec e r o da s upporto pittorico a lle tematich e; so ltant o in qualch e caso si ricorse a co mpo siz i o ni p i ù leggiadre, o a n cora all' iro nia e all ' umorismo. Ricordiamo , fra le altre , la serie di D' Erc oli «Fiori dell'Africa Ori entale», dov e un sott il e e rotismo s i nascon d e di etro la presunzione etn olog ica di raffigurare la be ll ezza fe mmi ni le dei popo li africani ; o le ca rt oli n e umori st ich e di B e r tigl i a e del già citato D e Se ta. Il primo fa s orridere - amaramente? - perché i su oi vincit ori, gli oppr ess i lib e rati e il nemico vin to , so no tutti q ua nti raffigurati ne ll e improb abi li ve st i di paffuti b a mbini , molto s im i li a rub icondi pu ttin i.
Il secon do , di etro un ' ironia appar e n te, ce la m olte crud e e doloro se verit à c he non sfuggono al letto r e attento, e che dovrebbero far molto rifl e ttere sull a
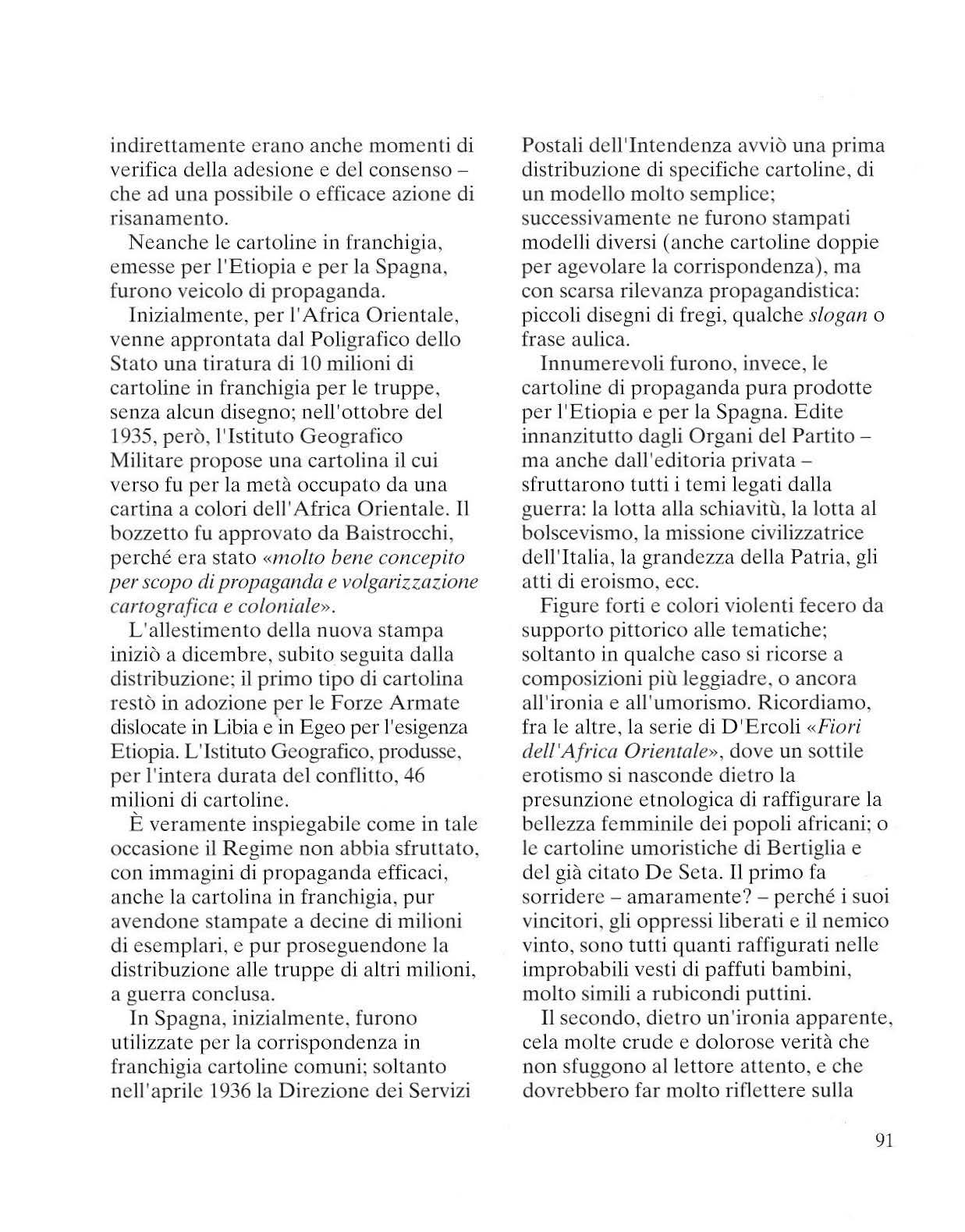
mission e liberatrice e c ivi lizzatrice italiana in Etiopia: c 'è il le gionari o ch e vuole spedire in Italia , come ricordo ad un amico, una fanciulla etiope; qu e llo che vuol e comprare «a m ezzo » una d e ll e s chiave nud e in liquida zione al m e rcato ; quello che contribuisce alla civili zzazione facendo nascere «bebè » bianchi da donne afric a ne (e tutti contenti in famiglia , marito compreso); quello che posa sui vinti, come un cacciatore sulle belve; quello che utilizza il gas come l'arma più opportuna.
E così via. Una serie che il lettore potrà rivi s itar e p e r s uo co n t o perché po ss a fare valutazioni in prima persona: su come un certo modo di far e propaganda , appar e nt e mente superficiale, a llegro , accattivante a l momento , po ss a avere nei tempi lun g hi riflessi ne ga tivi e controproducenti; o s u co m e un autor e scaltro , utili zza ndo opportunamente satira ed ironia , pos sa divul gar e id ee ch e a l trimenti m a i pass e rebbero attrav e r so le maglie della ce nsura.

Nell'immediato dopoguerra le cartoline propagandarono i fasti de ll a vittoria. Ogni reggim e nto , o Corpo ch e aveva part ecipato a l conflitto , legò il suo nom e a d una data , ad una lo ca lità , ad un fa tto d ' arme. I vinco li furono così stretti , che ancora oggi le fes t e di Corpo si celebrano , per la gran parte, a ricordo de lla 1a guerra mondial e. Furono co munque edite anche cartoline per tes timoniar e gli impegni fuori d e l territori o n aziona le, a ricordo d i ce le brazioni particolari e avve nimenti p o litici.
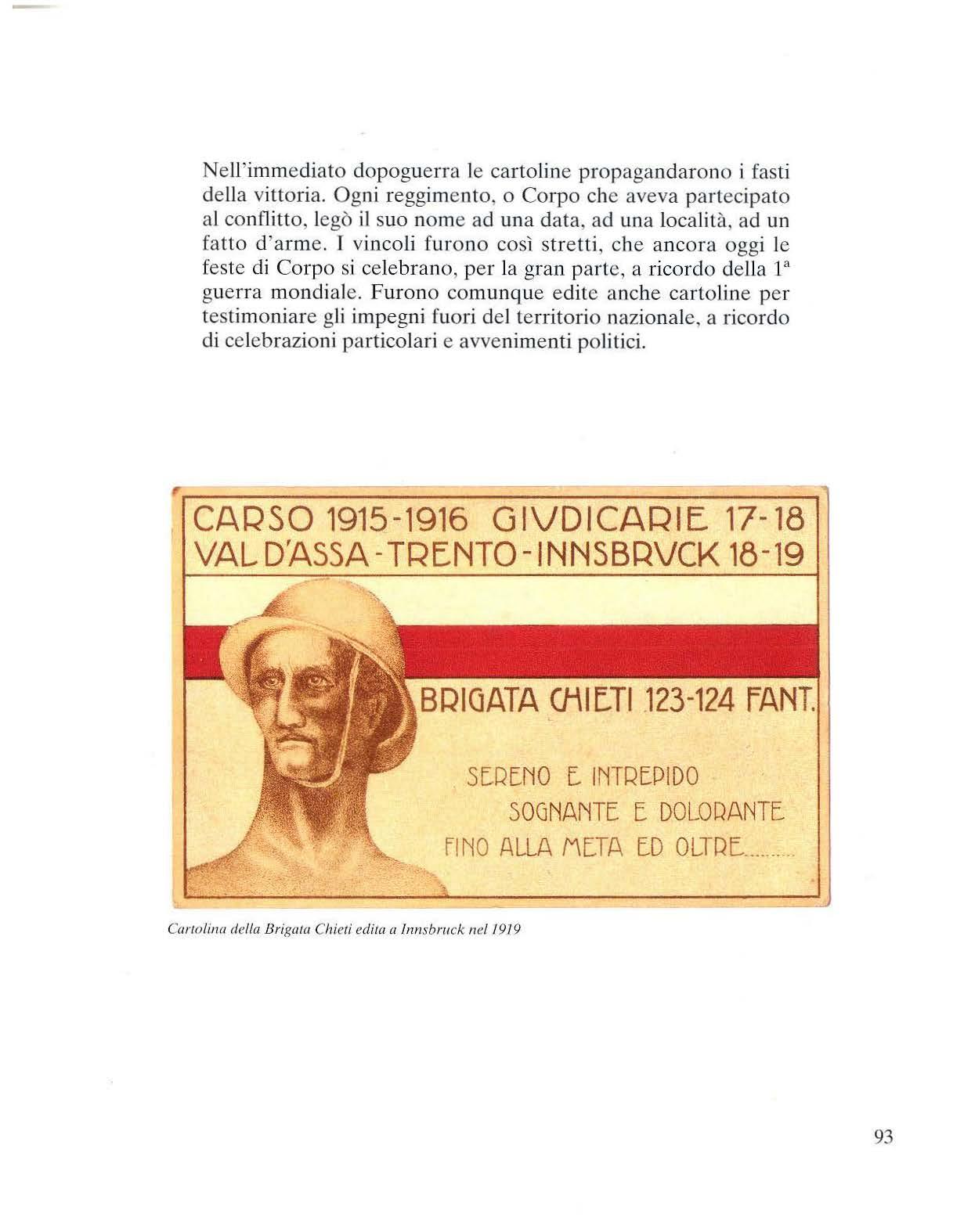
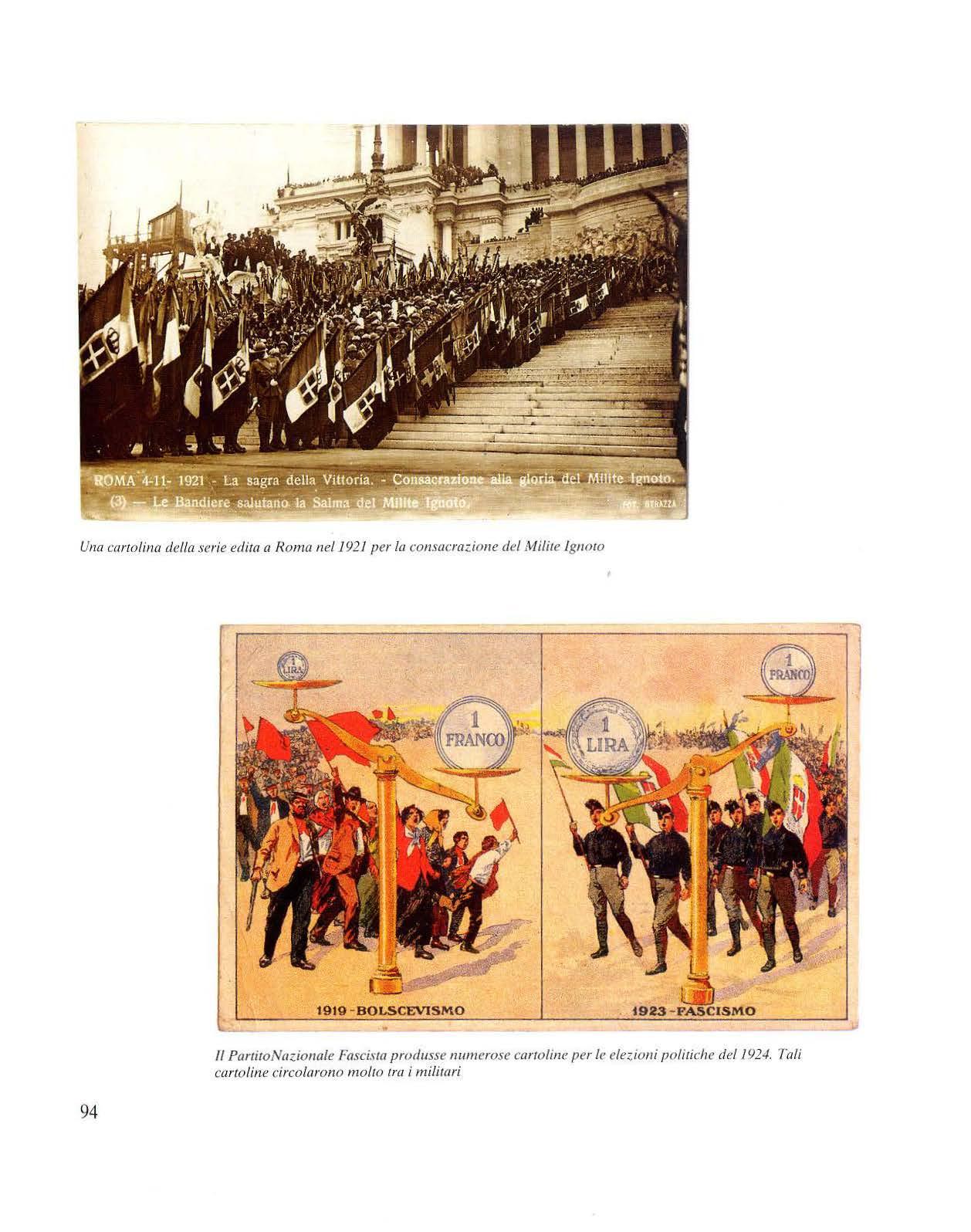
Con l' avvento d e l fascismo , le Grandi Unità com e i Reggim e nti si adeguarono ai temi e a g li stili. In pace e in g ue rra, in ltalia, ne ll e C olonie e n e ll ' Imper o . Se , p e rò , fu abbondant e m e nte raffi g urata n e ll e vign e tt e la campagna d ' Etiopia, la gu e rra di Spagna fu completam e nte ignorata nelle cartoline r e ggimentali. Anch e per esse valeva l'ordin e che l ' E se rcito «n o n aveva pre so parte» ( ufficialm e nte) alla g ue rra ci vil e .
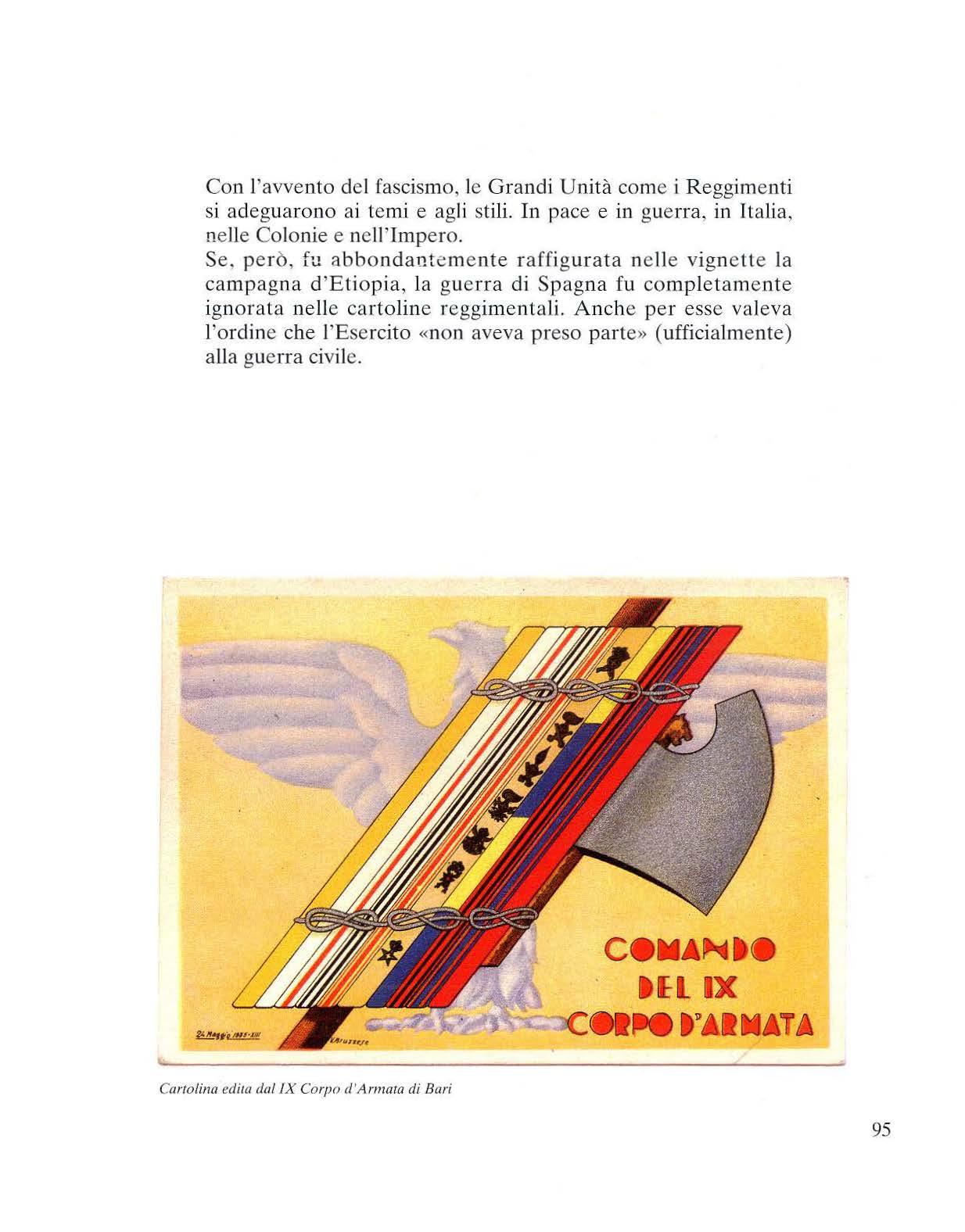
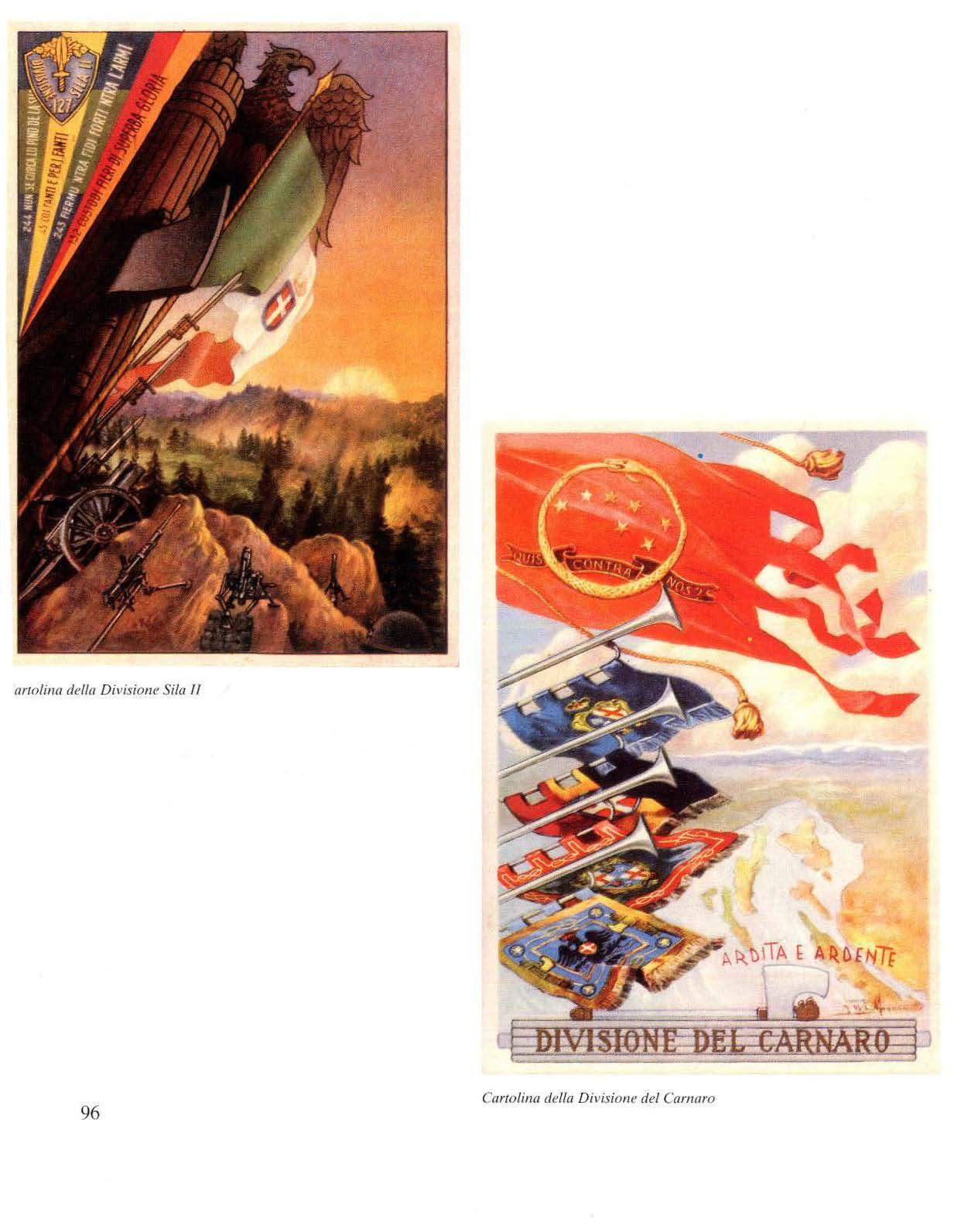 rmolinn della Di visione Sila Il
rmolinn della Di visione Sila Il
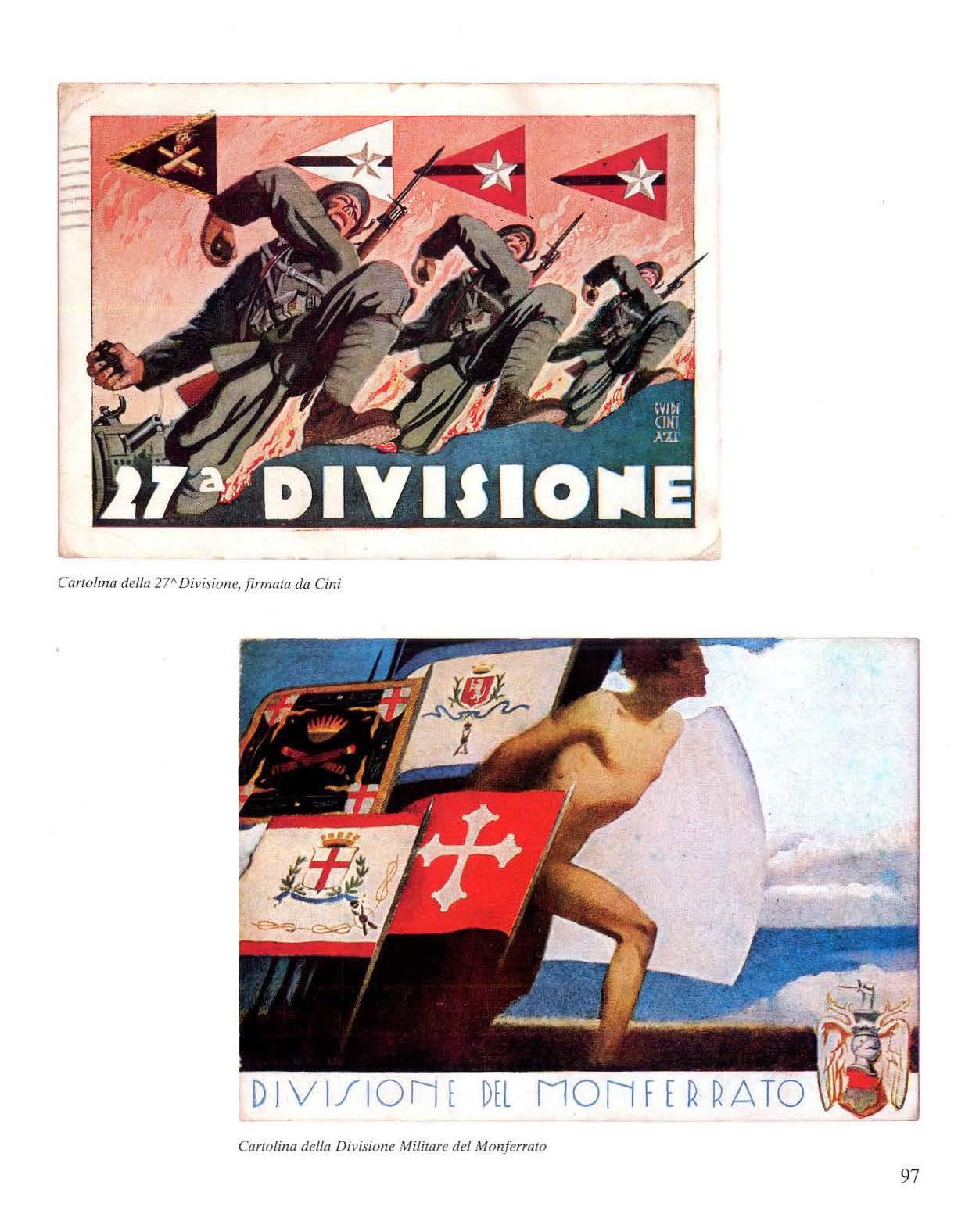
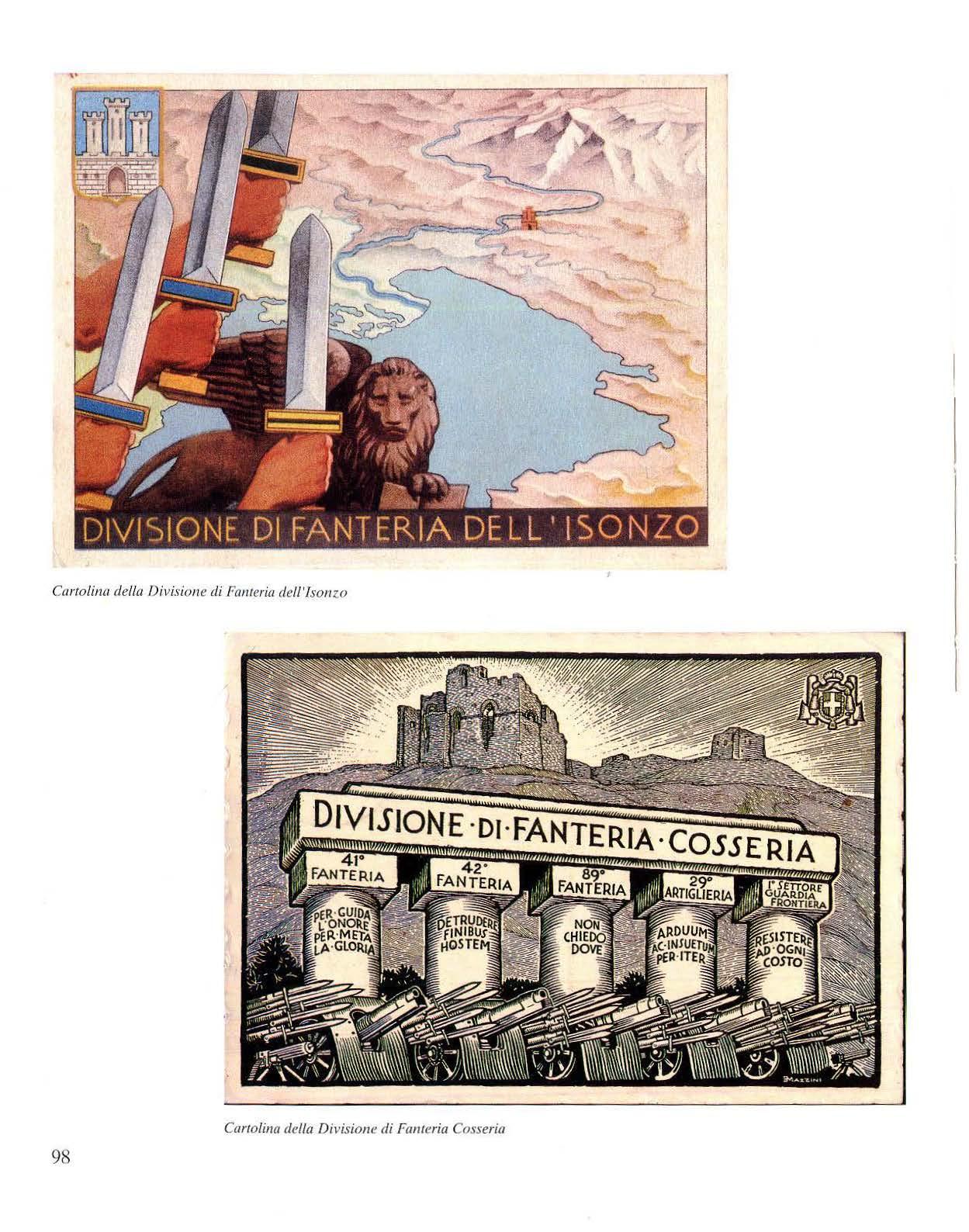
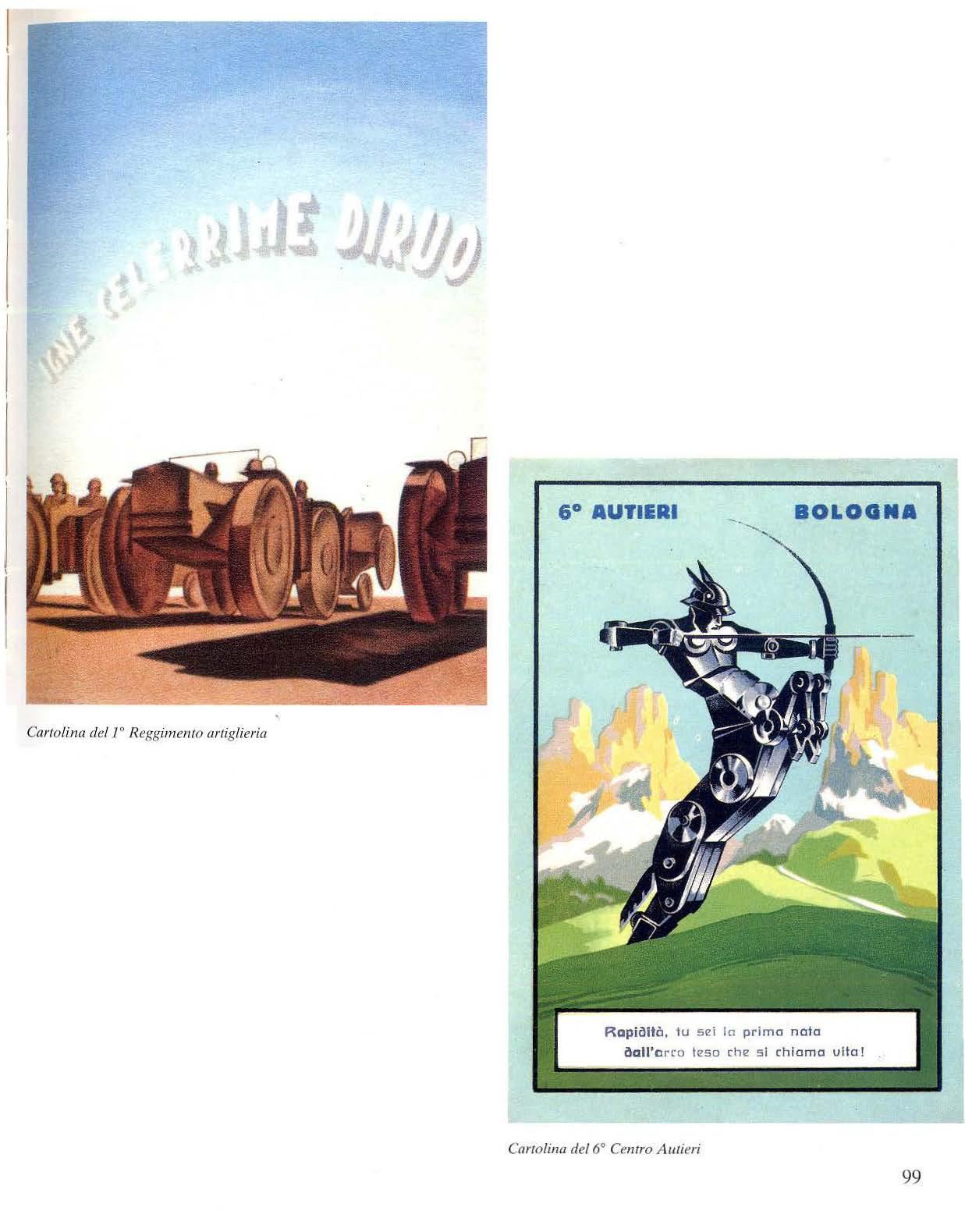
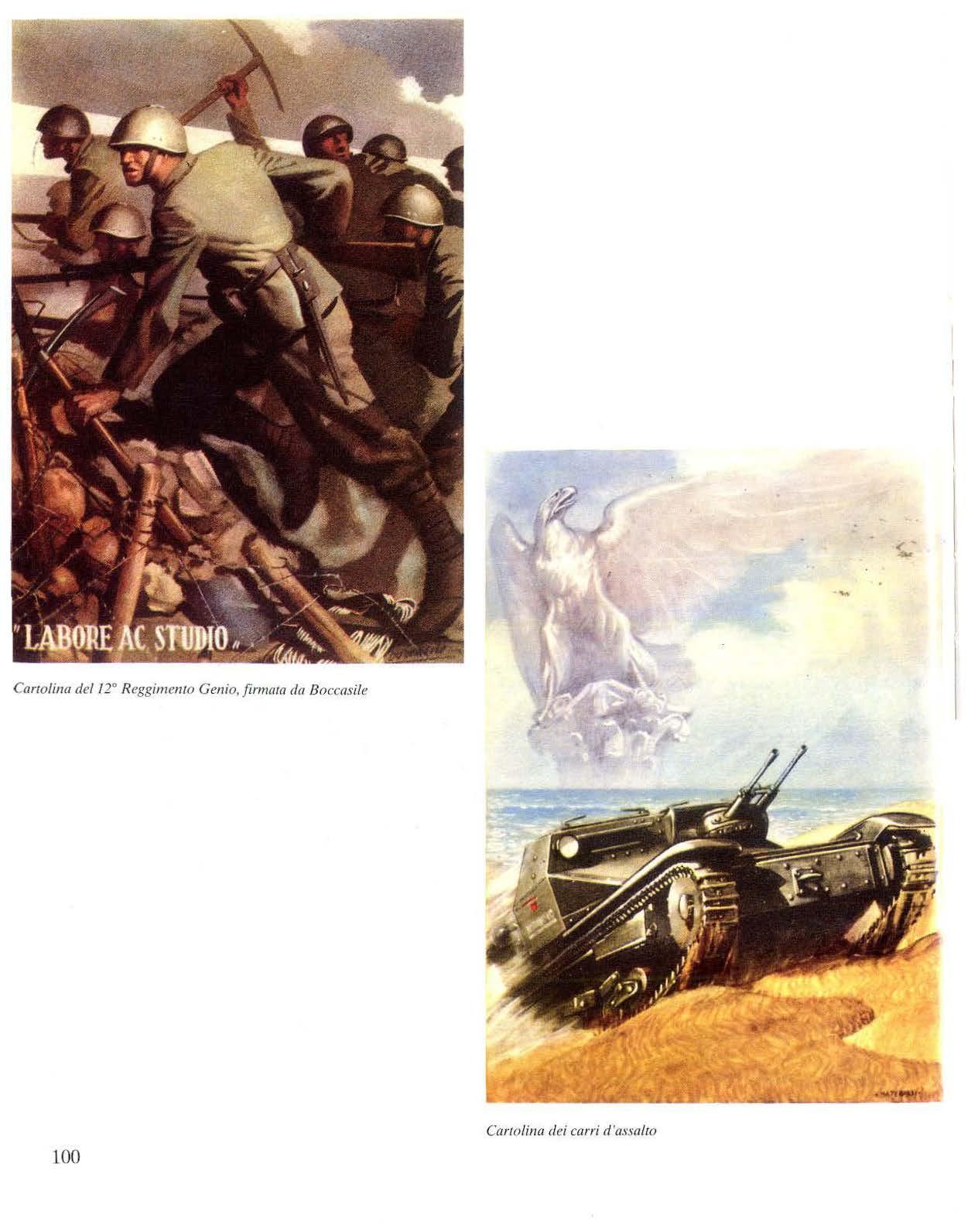 Ca rt o lina de/12 ° Reggimento Genio, fi rm Ma da Bo ccasile
Ca rt o lina de/12 ° Reggimento Genio, fi rm Ma da Bo ccasile
L e cartolin e definite co lo niali furono e dit e dai reparti indigeni. Co mandi e unità na z ional i em isero , comu nqu e, a n c he ess i cartoline con sogge tti rife riti agli eventi colon ia li
Carto lin a d ella DiFis io n e Ubia
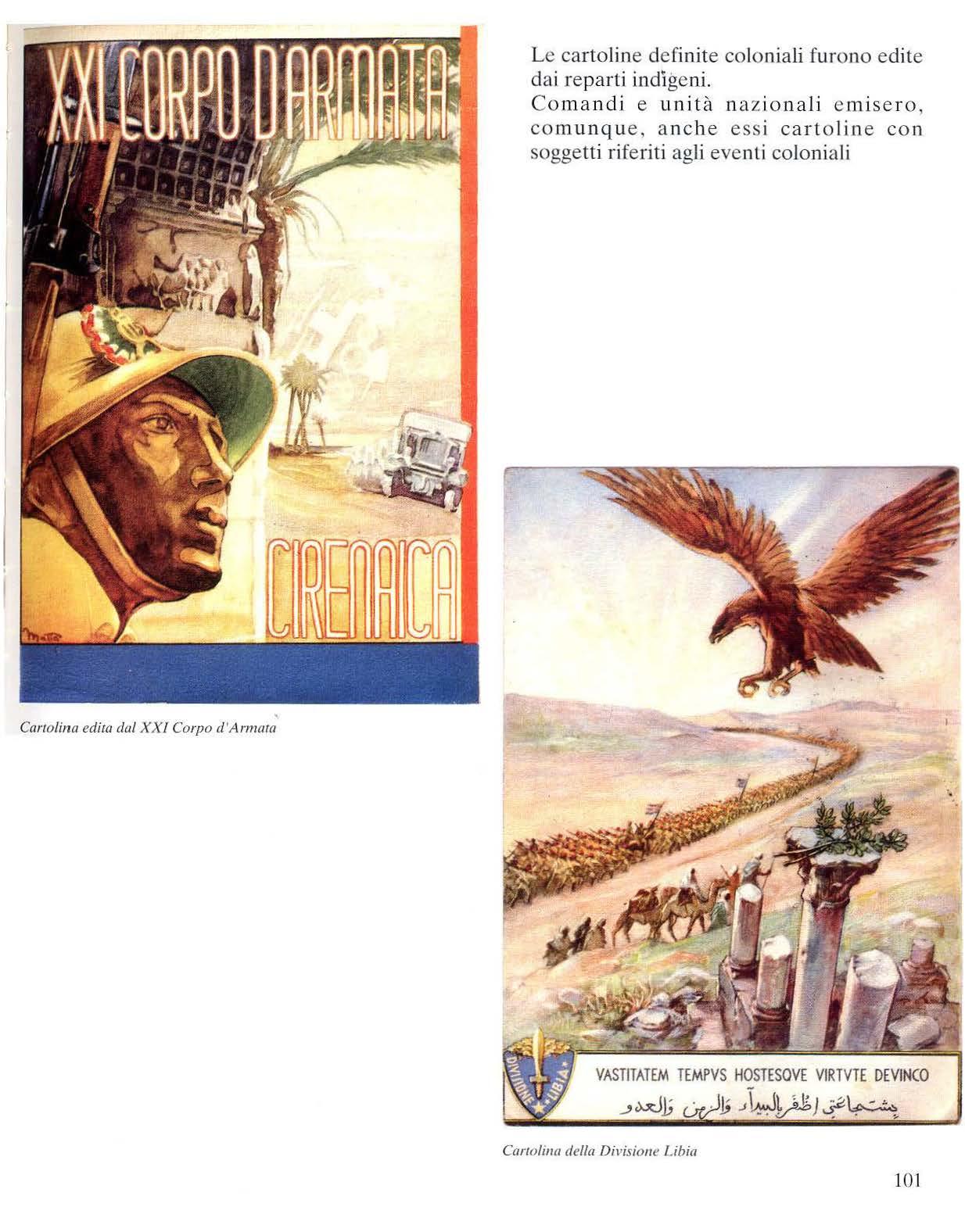
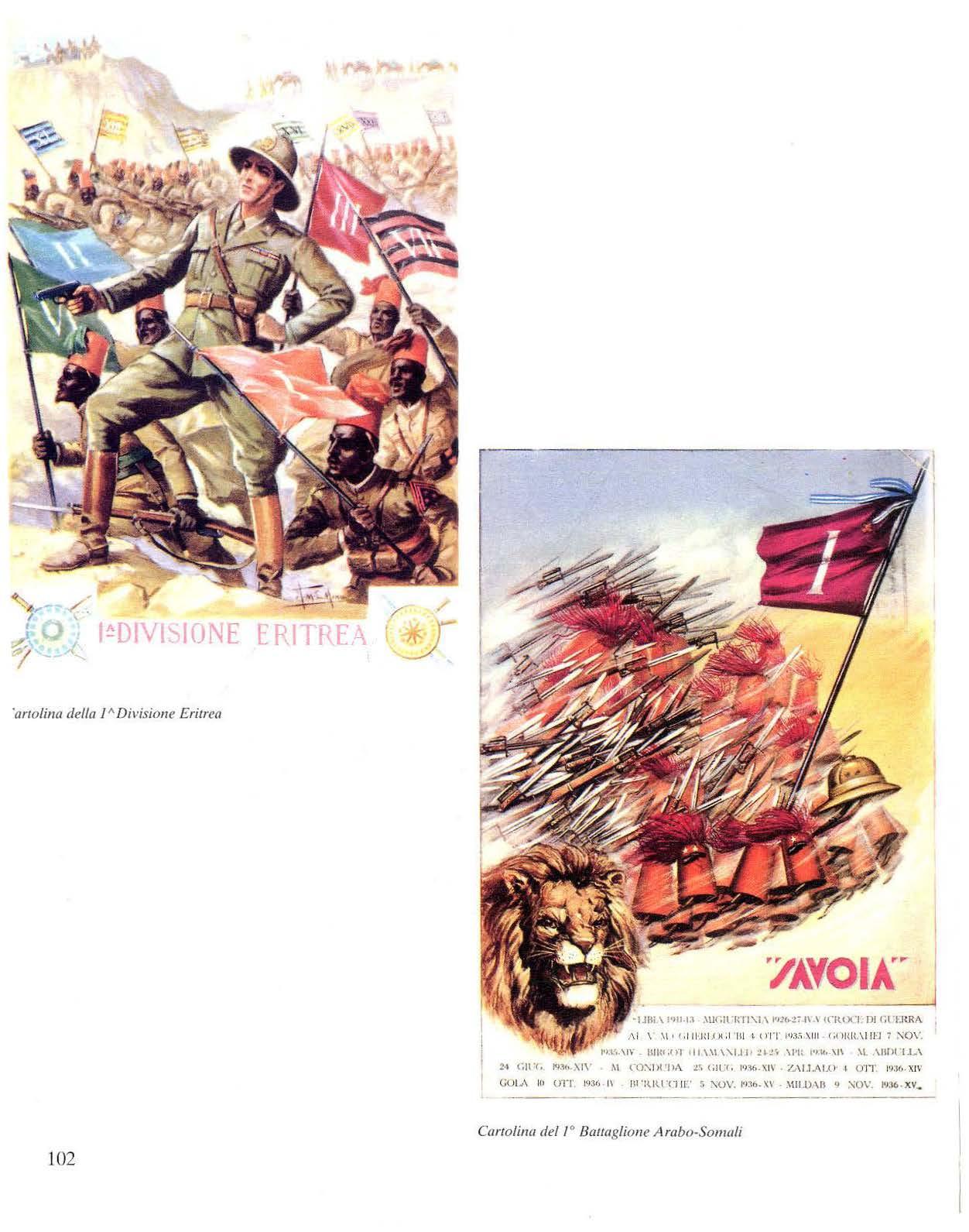
Durant e la g uerra di Et iopi a furono eme sse molti ss im e cartolin e, dall 'Eser cito o p er l 'Ese rei t o
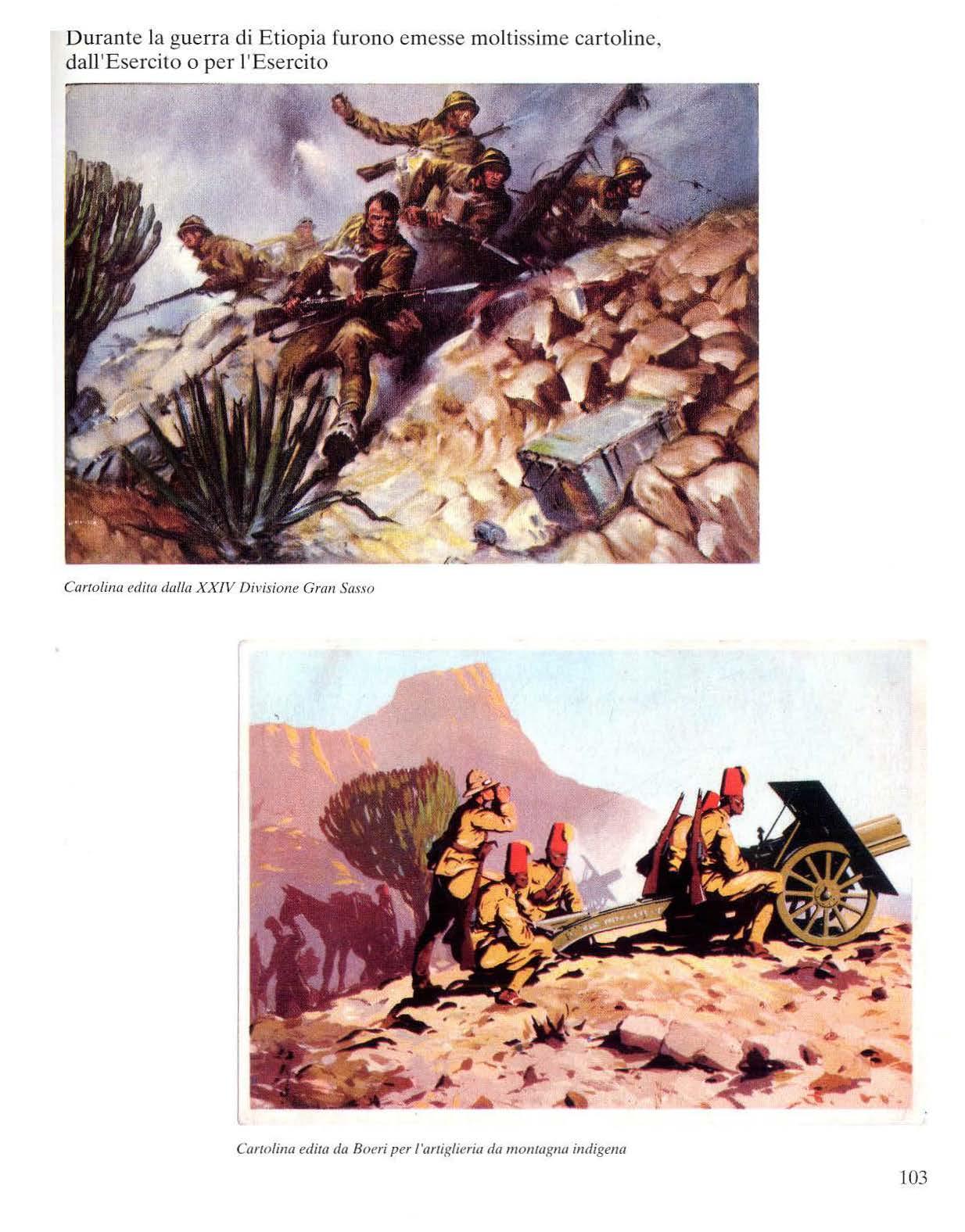 Car/Olina ed it a dalla XXIV Divisione Gran Sasso
Car/Olina ed it a dalla XXIV Divisione Gran Sasso
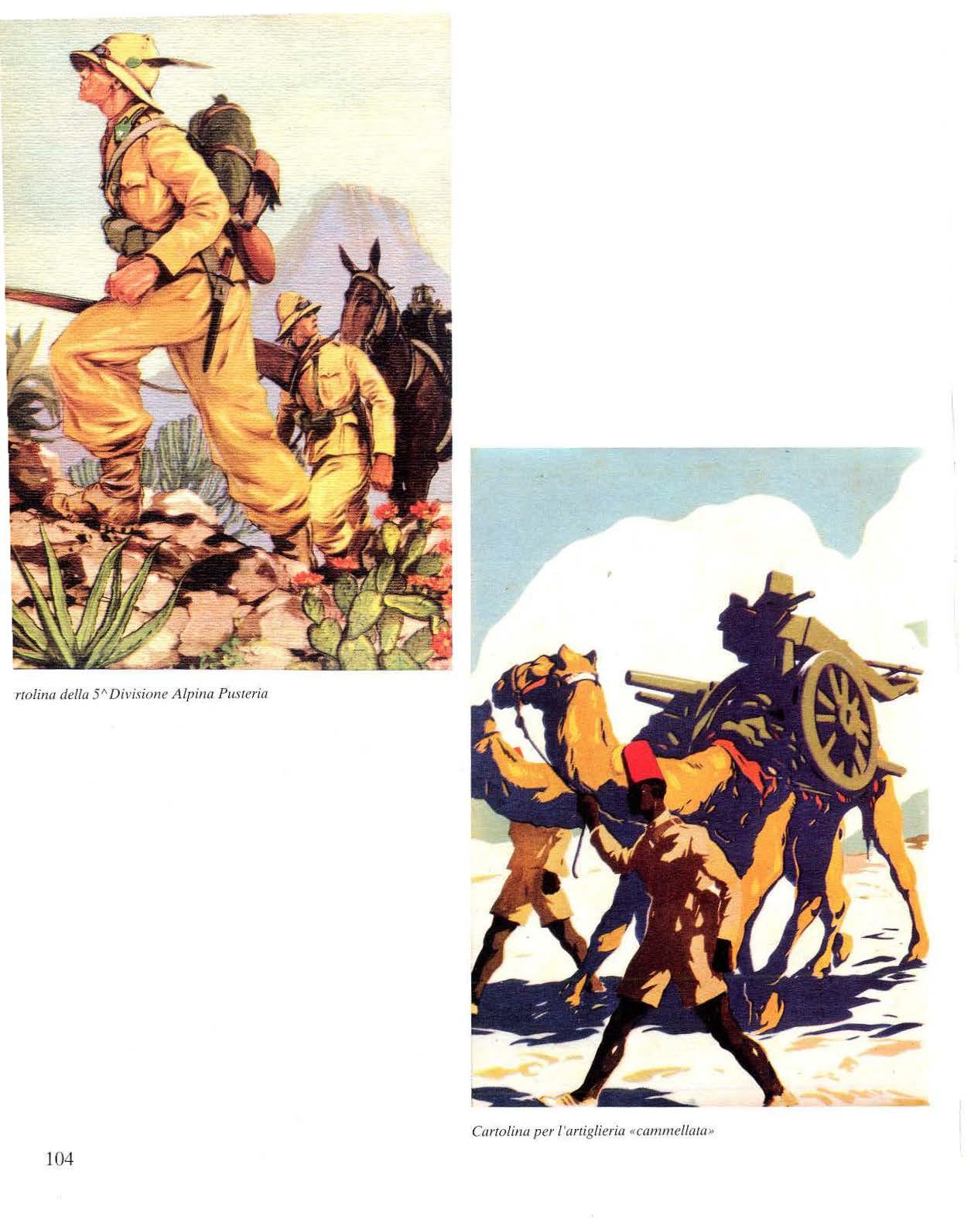 rrolina della 5 " Division e Alpina Pusteria
rrolina della 5 " Division e Alpina Pusteria
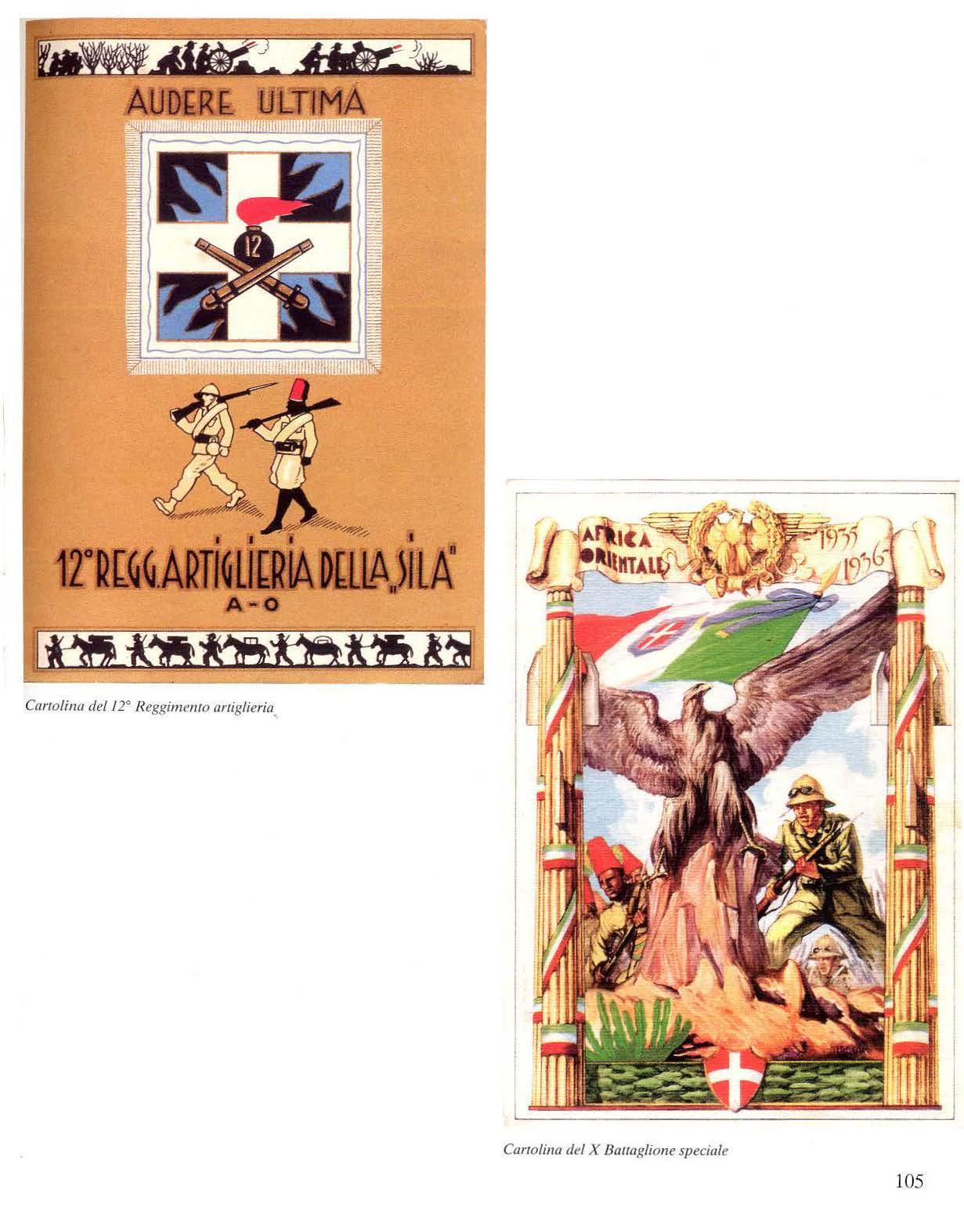 CartoNna del 12o 1 . ?eggcm ento artiglieria.
CartoNna del 12o 1 . ?eggcm ento artiglieria.
Il posto al sole e la guerra d ' Etiopia di e d e ro il via ad un a straripante produzione di cartoline di propaganda pura , da ogni part e . I temi furono quelli «ispiratori» ed a gius tifi cazione della guerra; i soggetti se ri e scanzonati , i di segni forti e puerili , o «gentili» . Satir a e umorismo fecero capolino; non mancarono i soggetti sacri
•
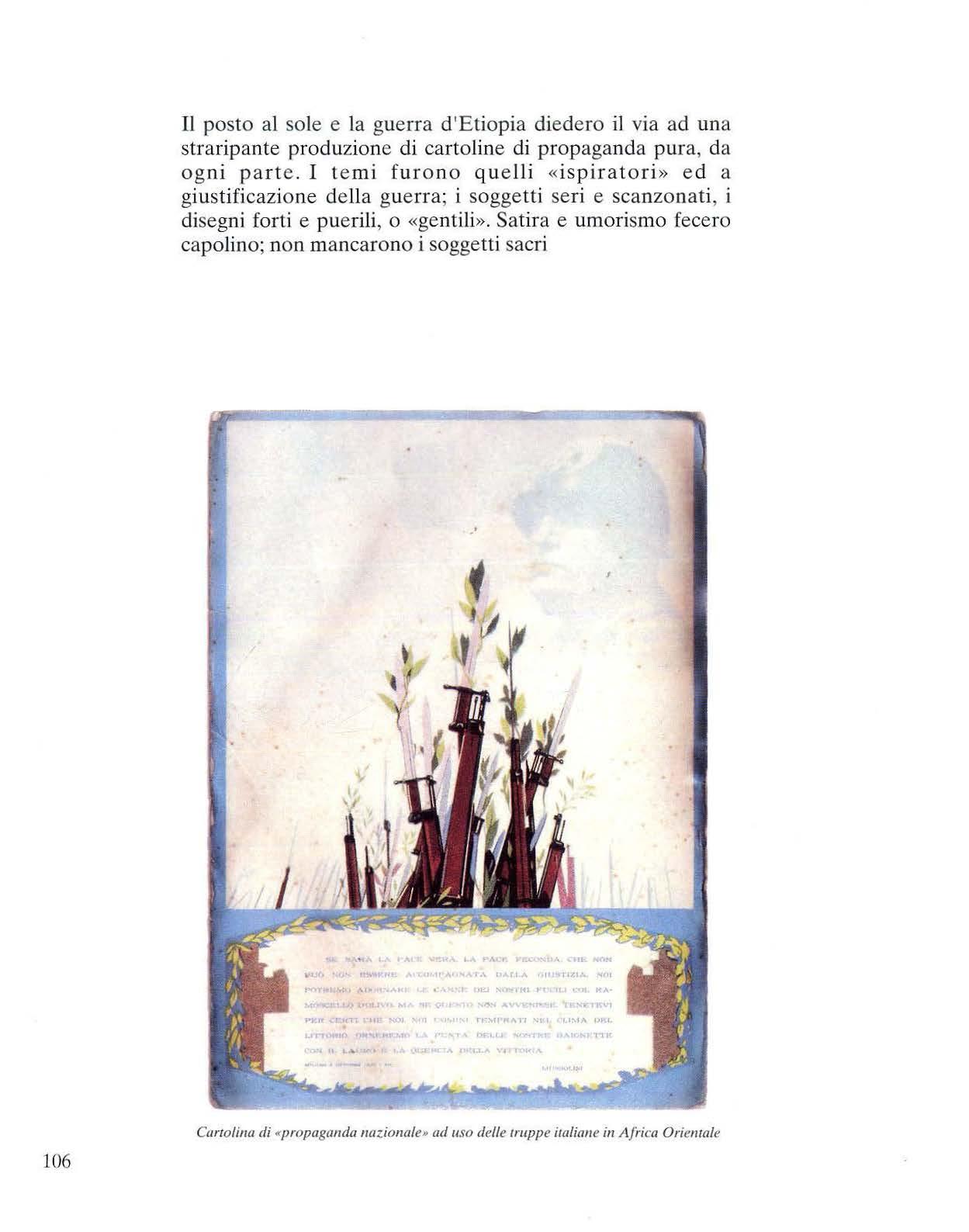
Il fuoco della .. . e quello sacro? (ca rtolin e dal fondo Ravecto )
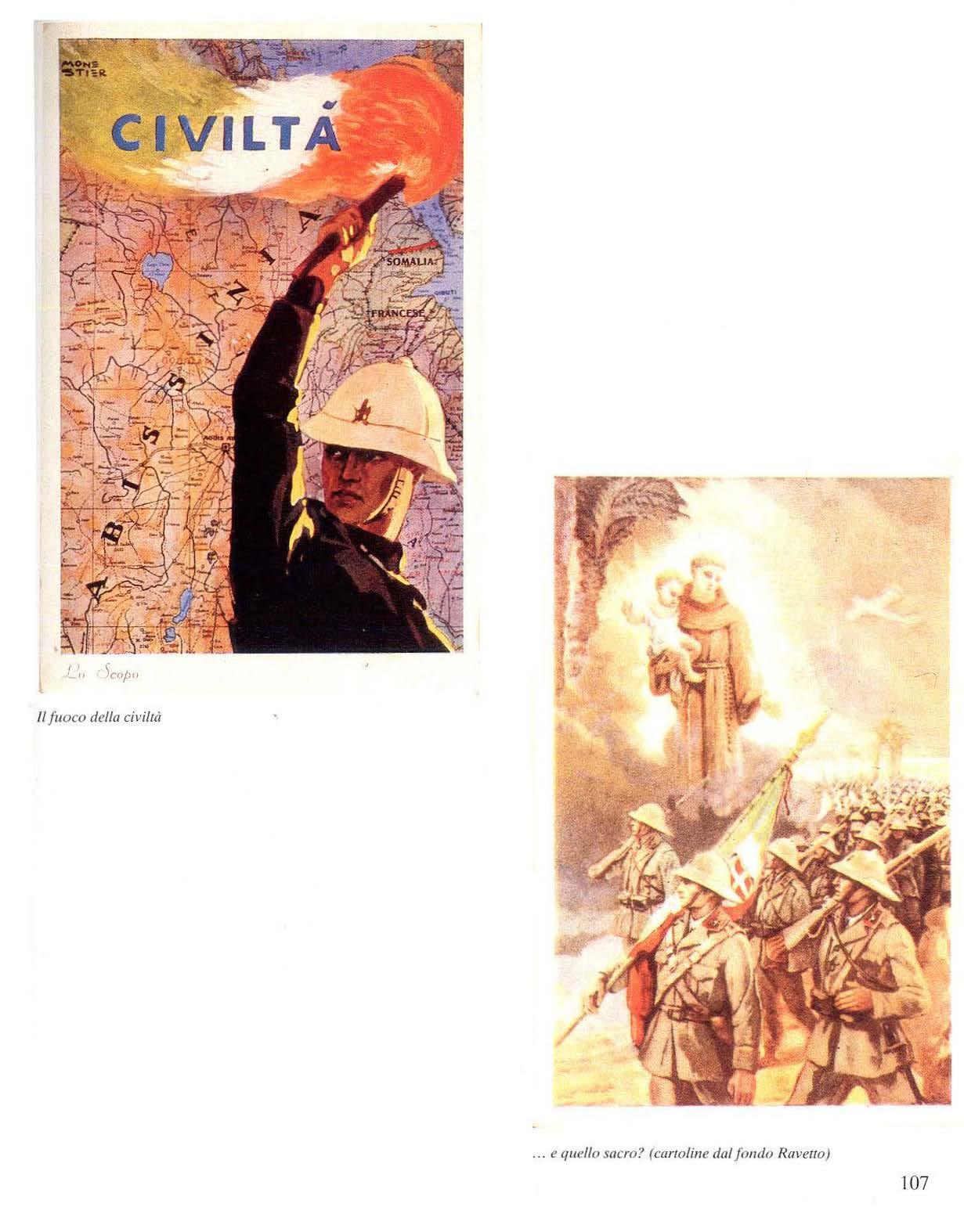
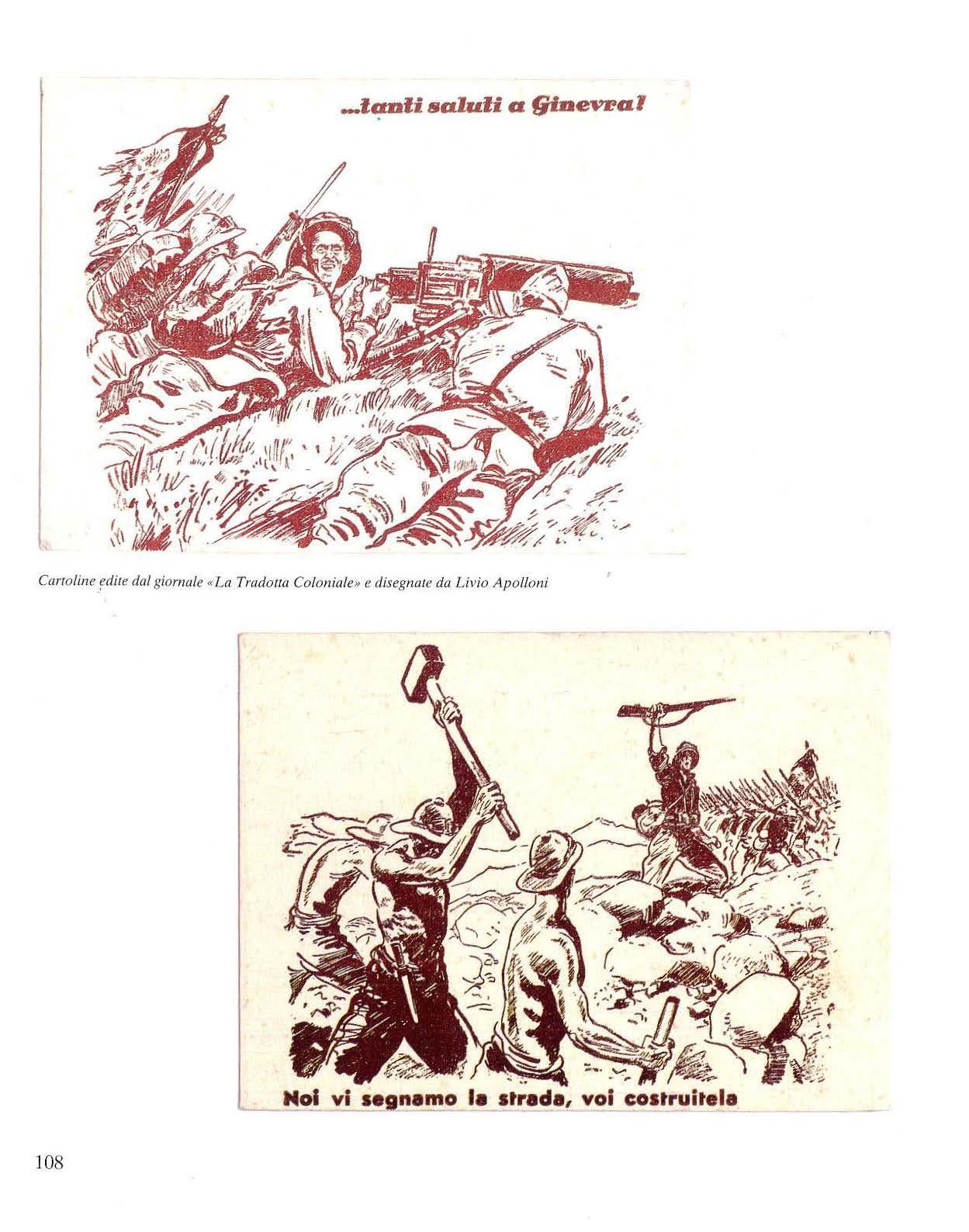
Anche la stampa diede il suo contributo alla realizzazione delle cartoline. Non con Io stesso peso, né con la stessa efficacia di venti anni prima. Le edizioni de «La Tradotta», firmate da Rubino, non furono più eguagliate, anche se a disegnare i soggetti per l'Etiopia furono autori di una certa fama
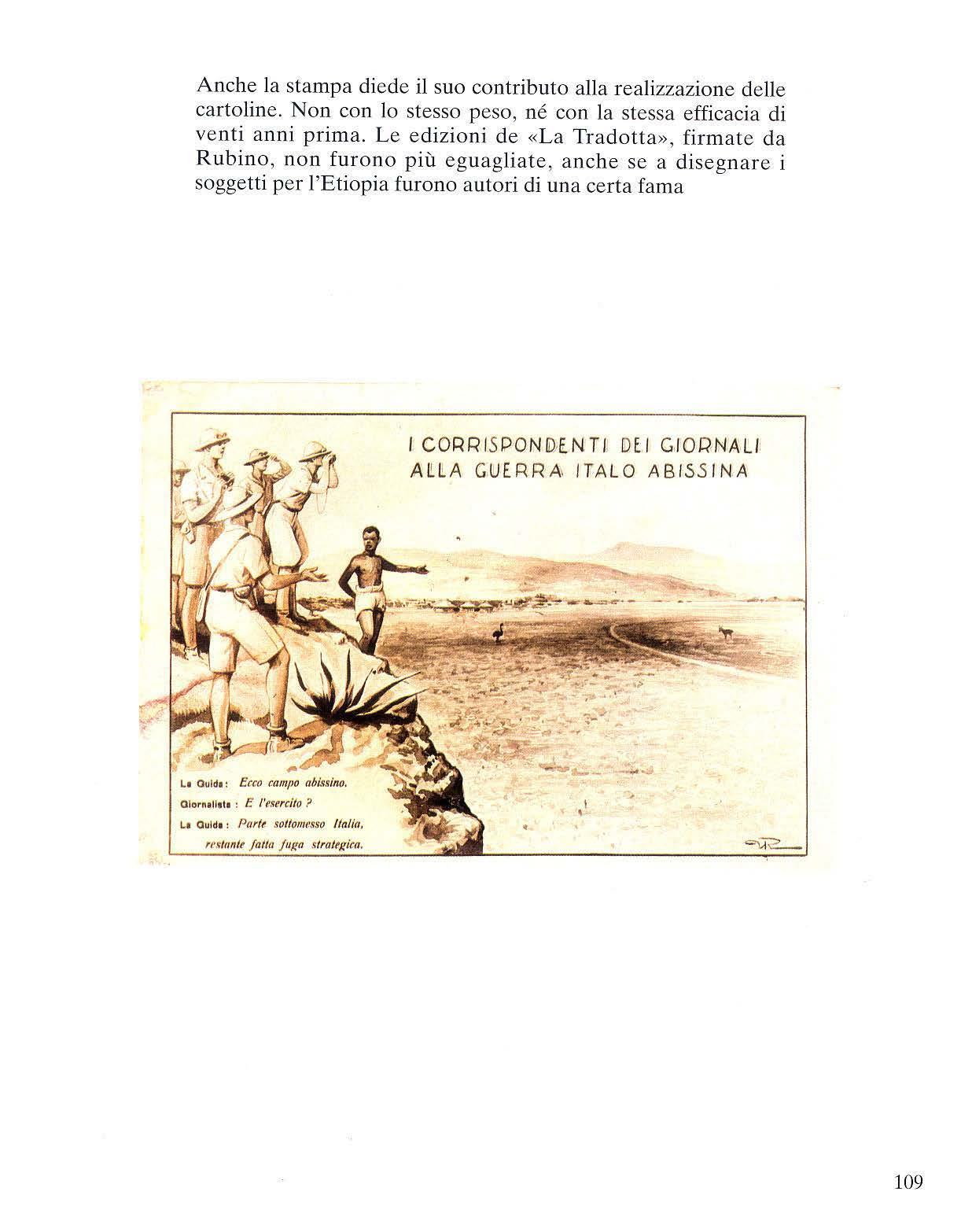
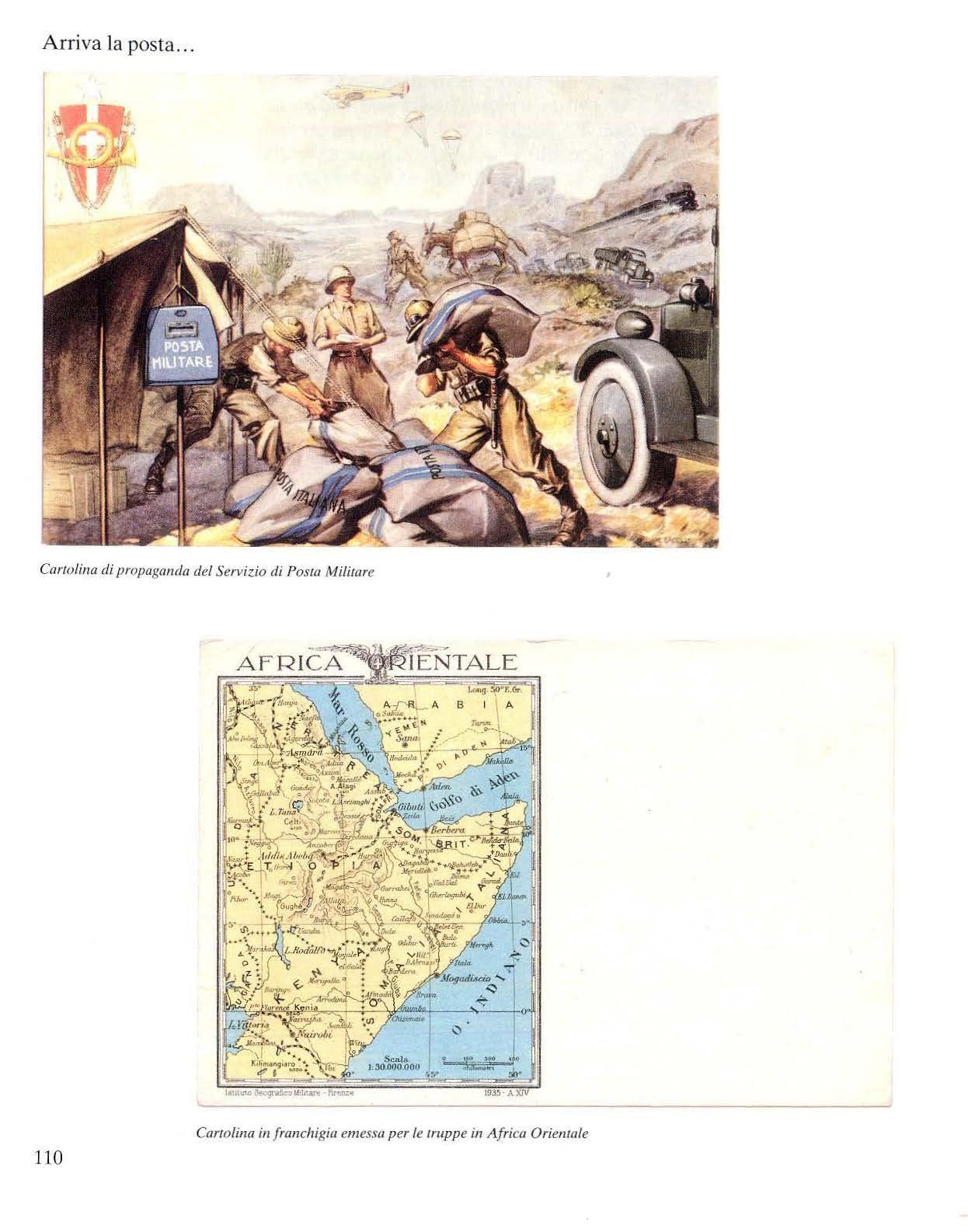

Tra le carto li ne di prop aga nd a per l 'E ti o p ia pr o liferaro no i paesagg i e le be ll ezze ind ige n e

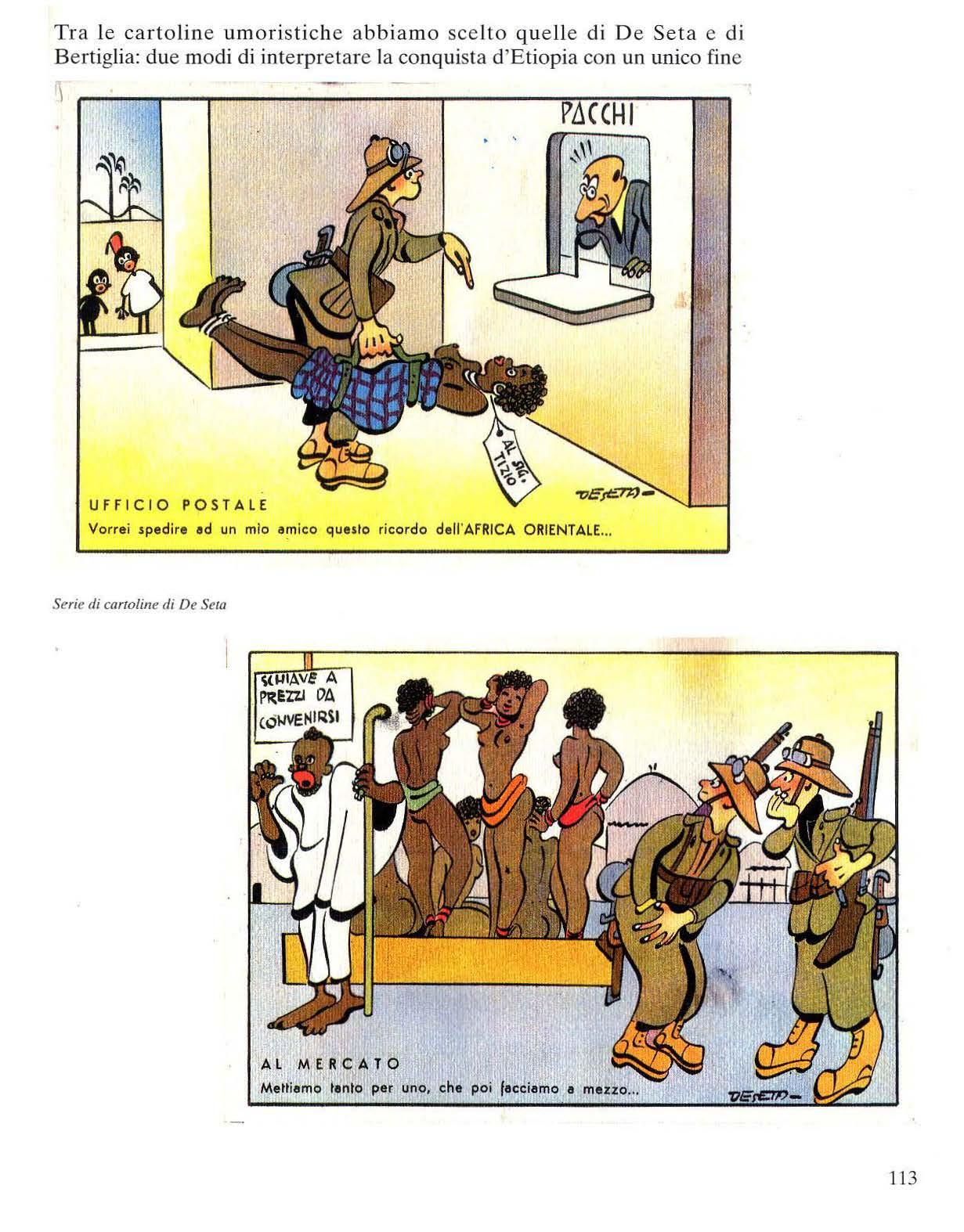
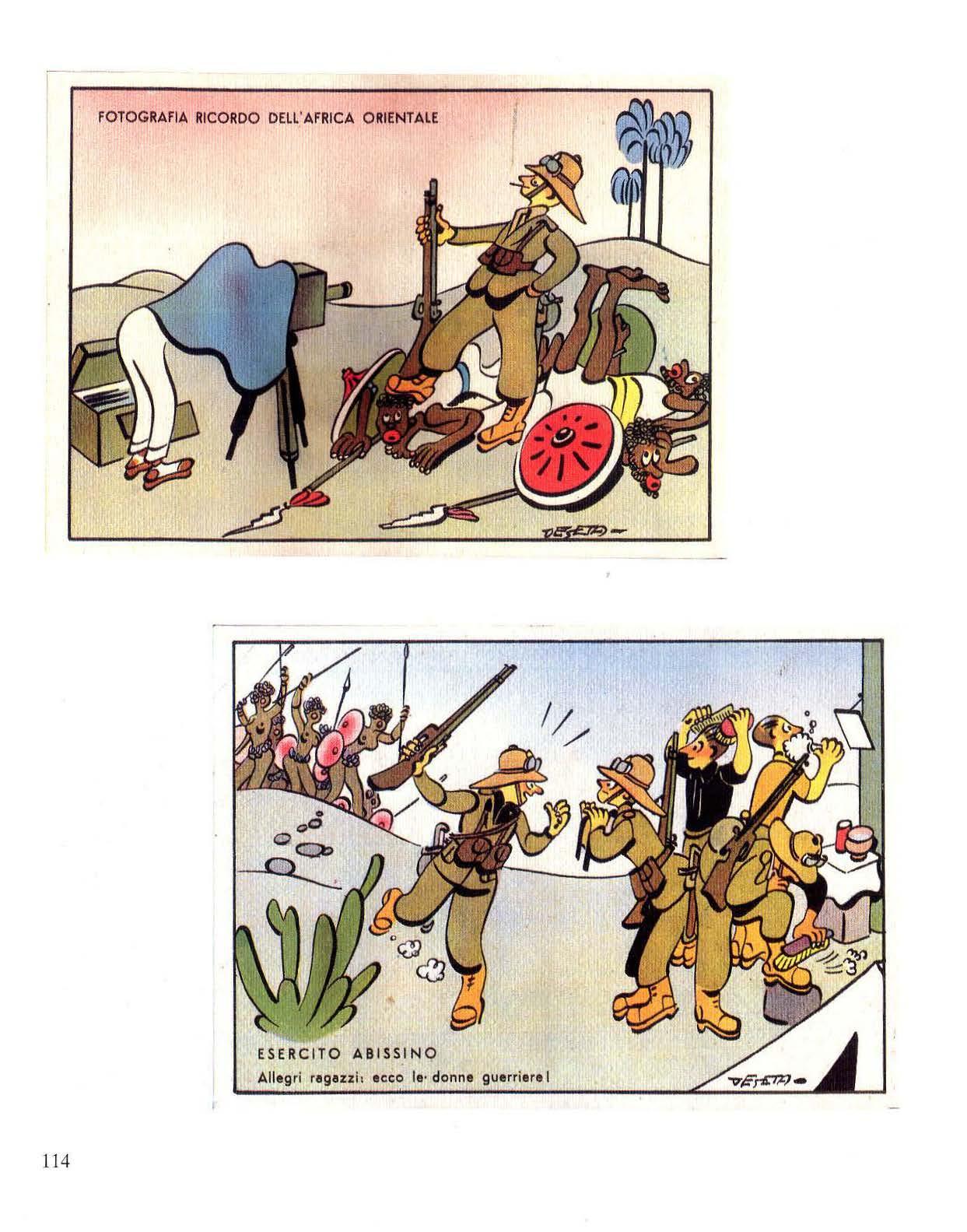 FOTOGRAFIA RICORDO DELL ' AFRICA ORIENTALE -
FOTOGRAFIA RICORDO DELL ' AFRICA ORIENTALE -
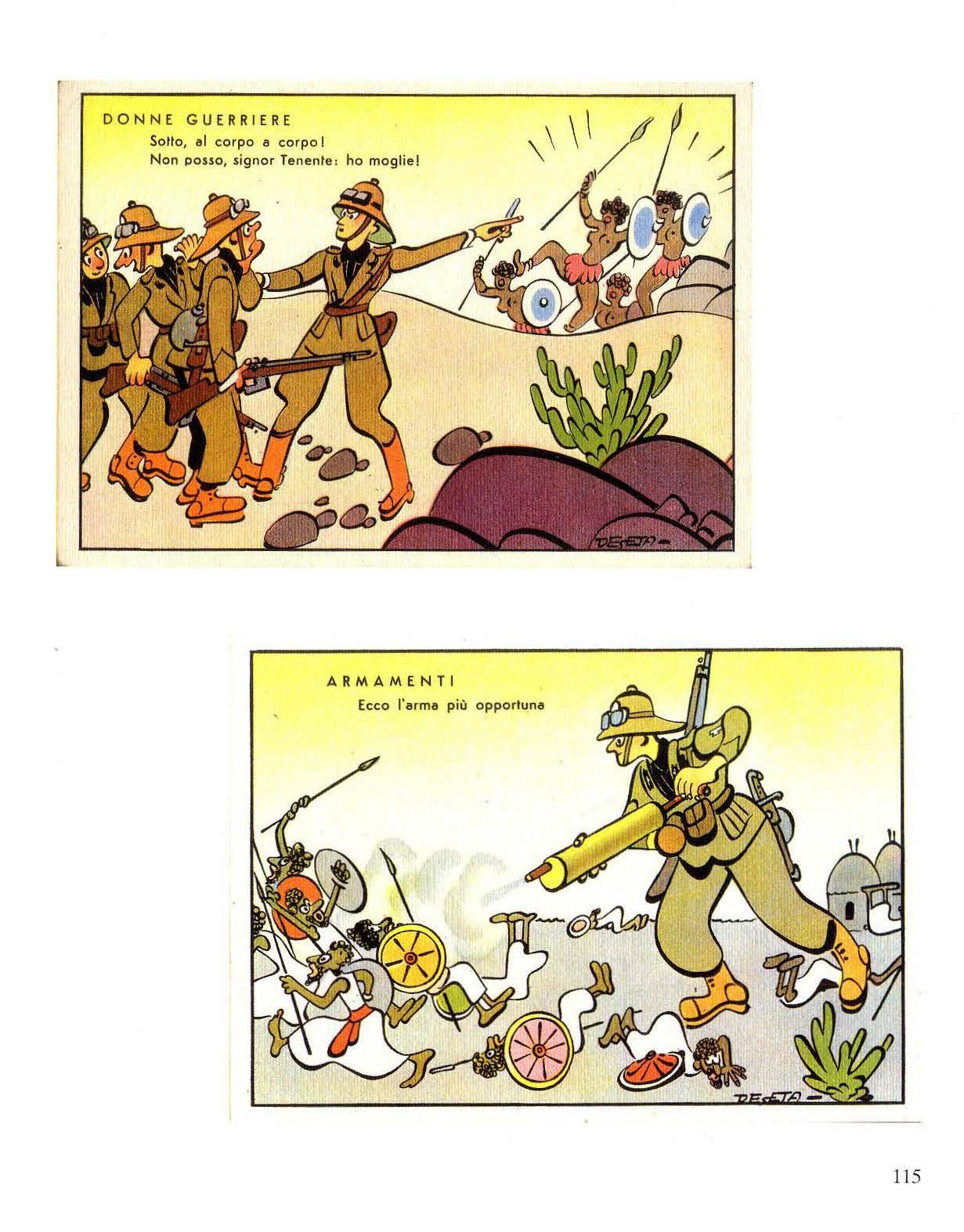
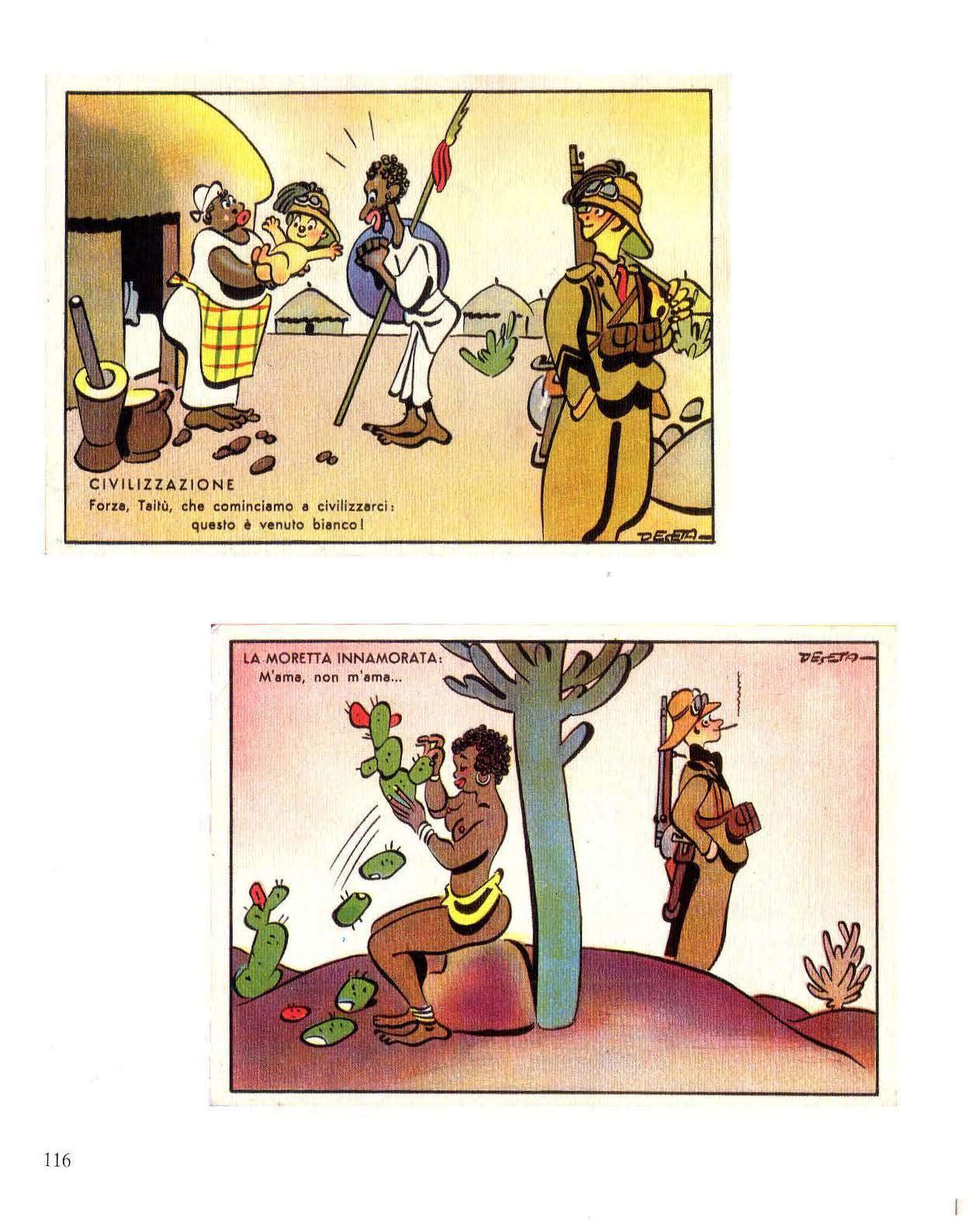
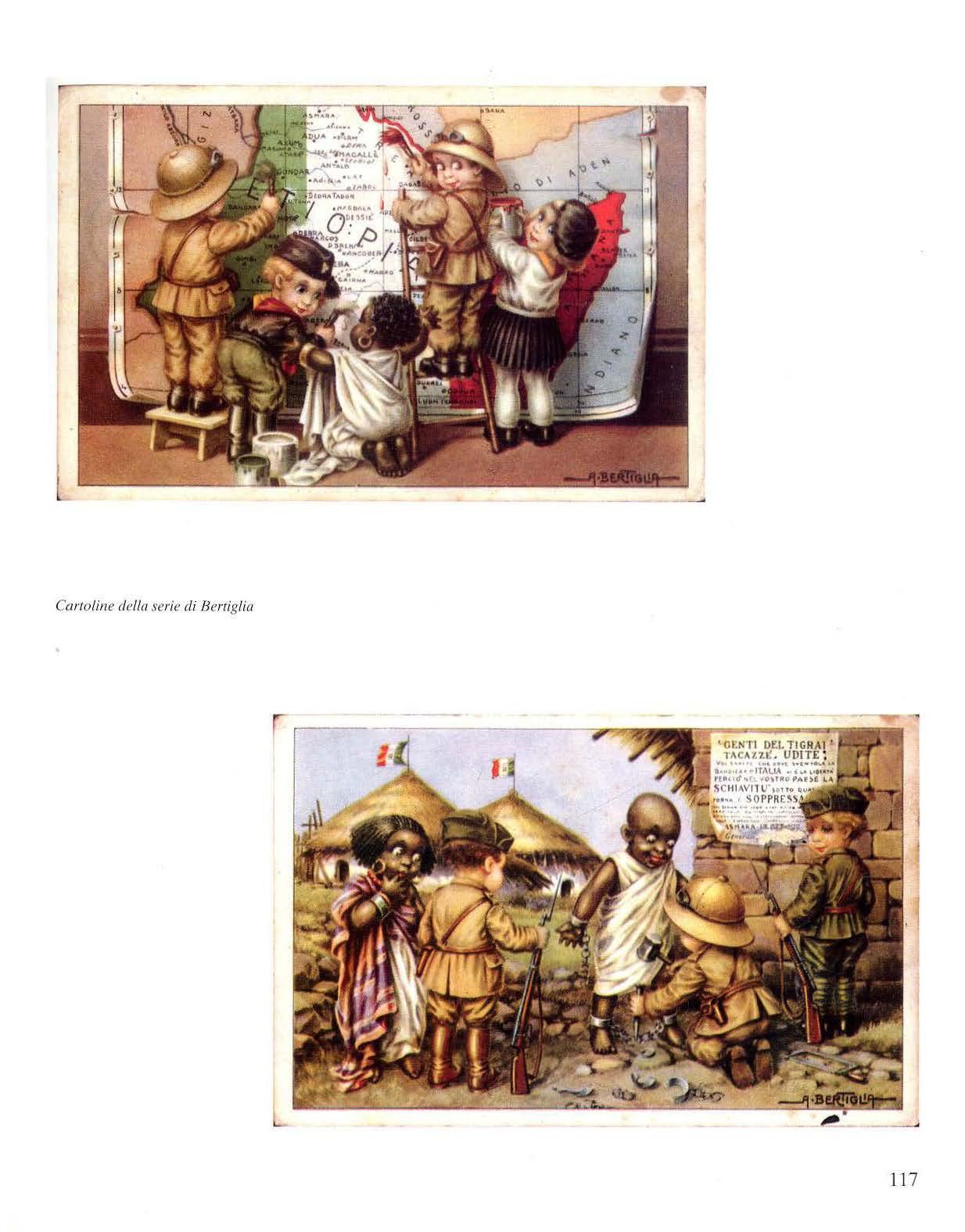
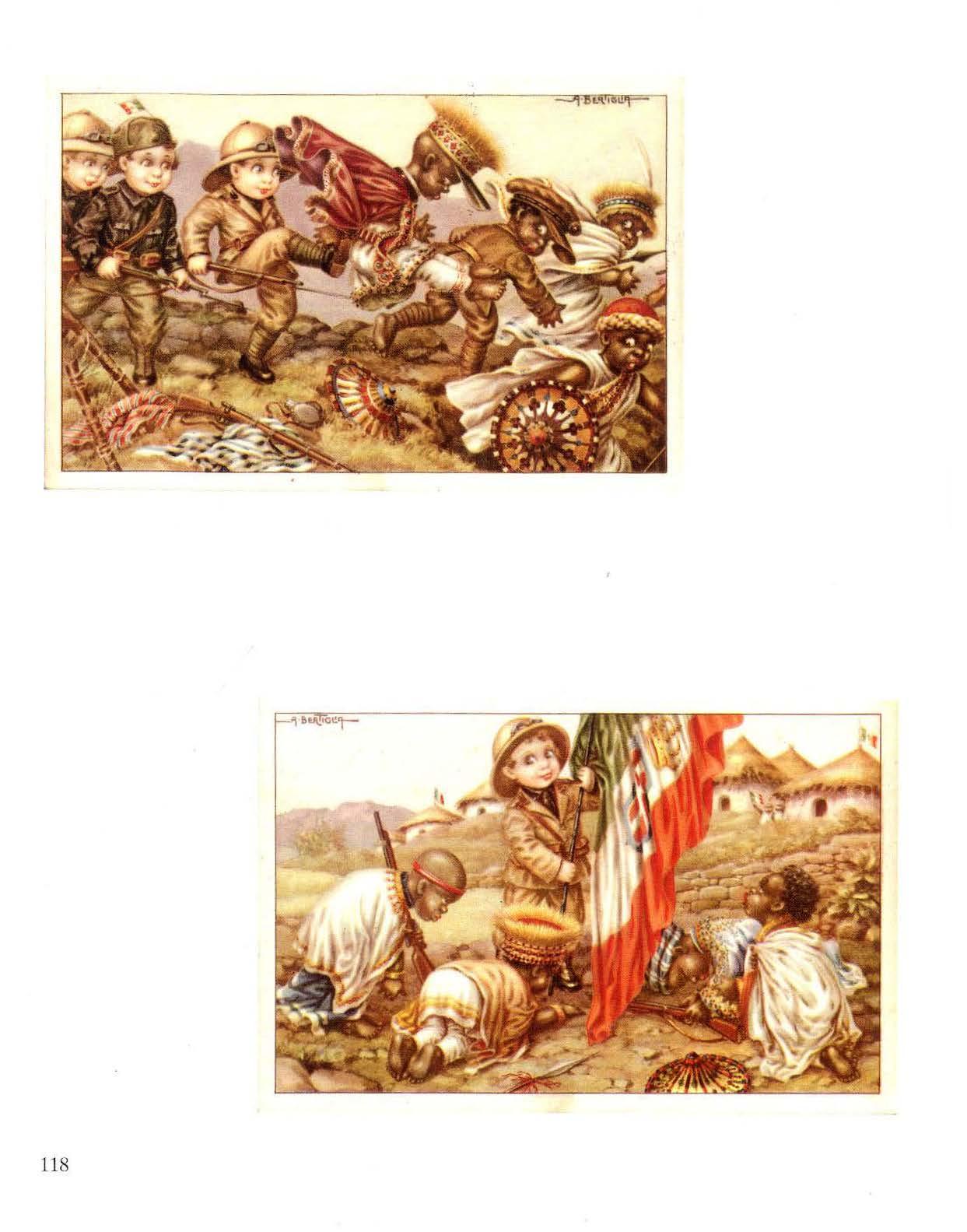
Nonostante g li sforzi degli I s tituti Bancari, la propaganda per i prestiti e bbe sca rso s uccesso.
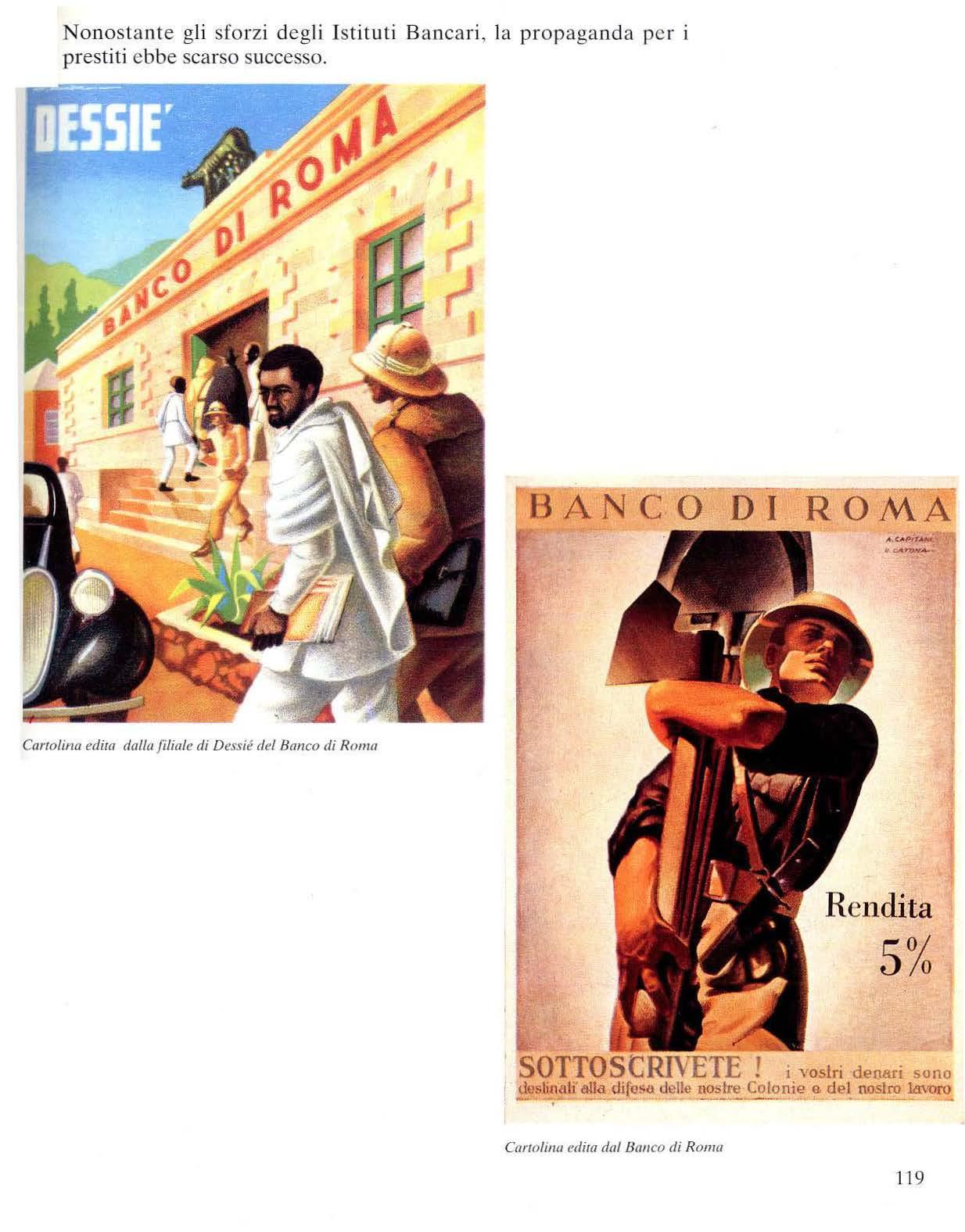
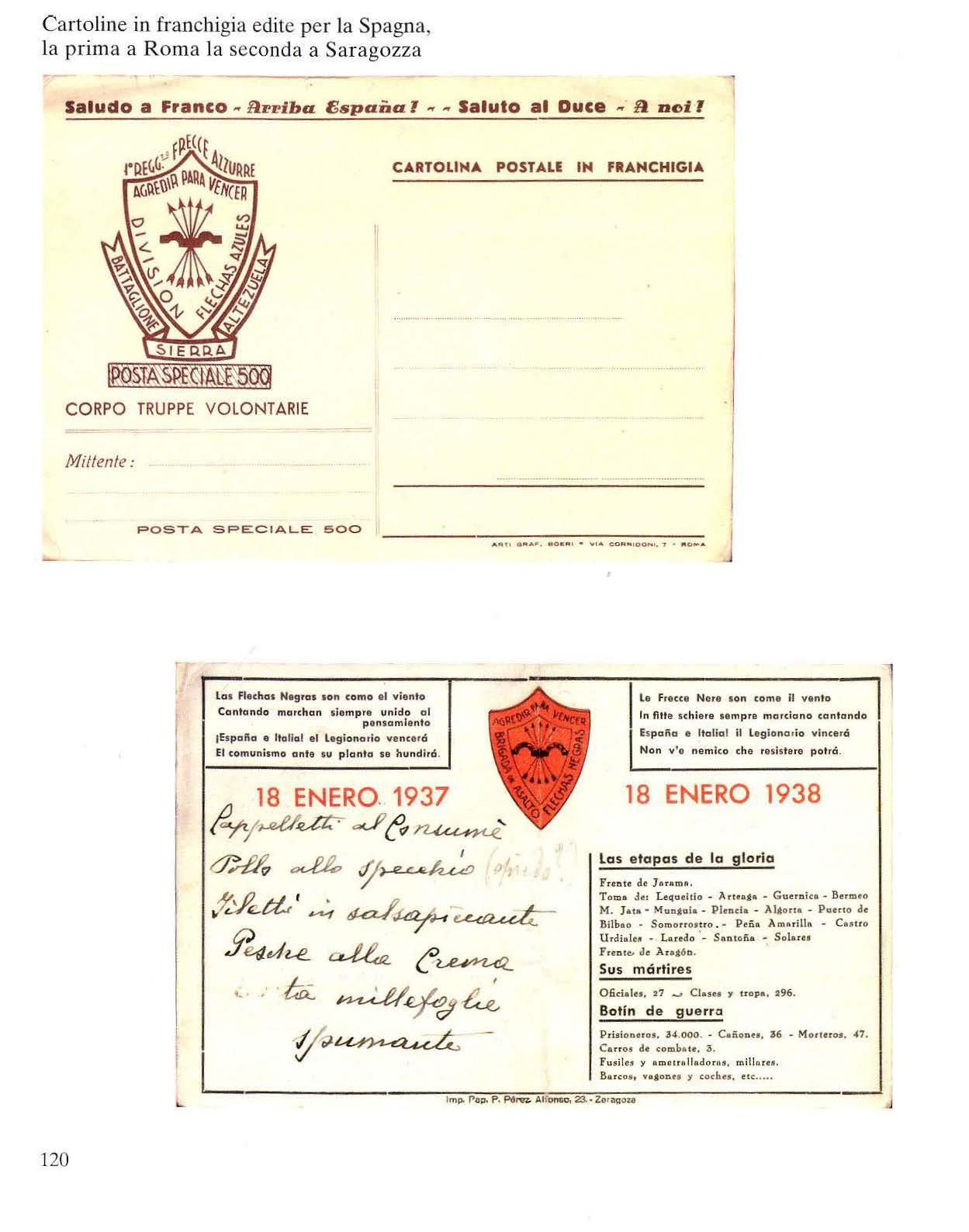
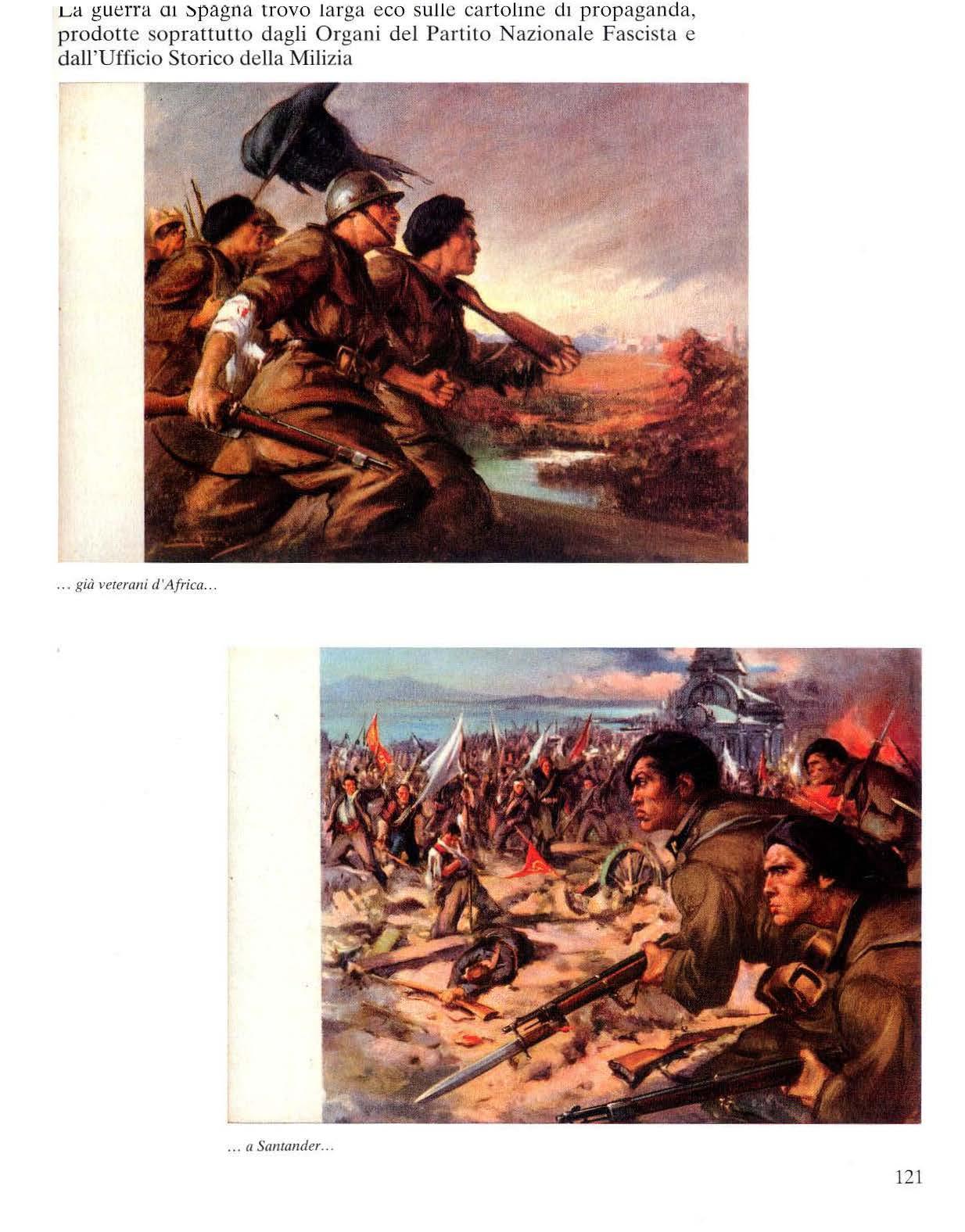
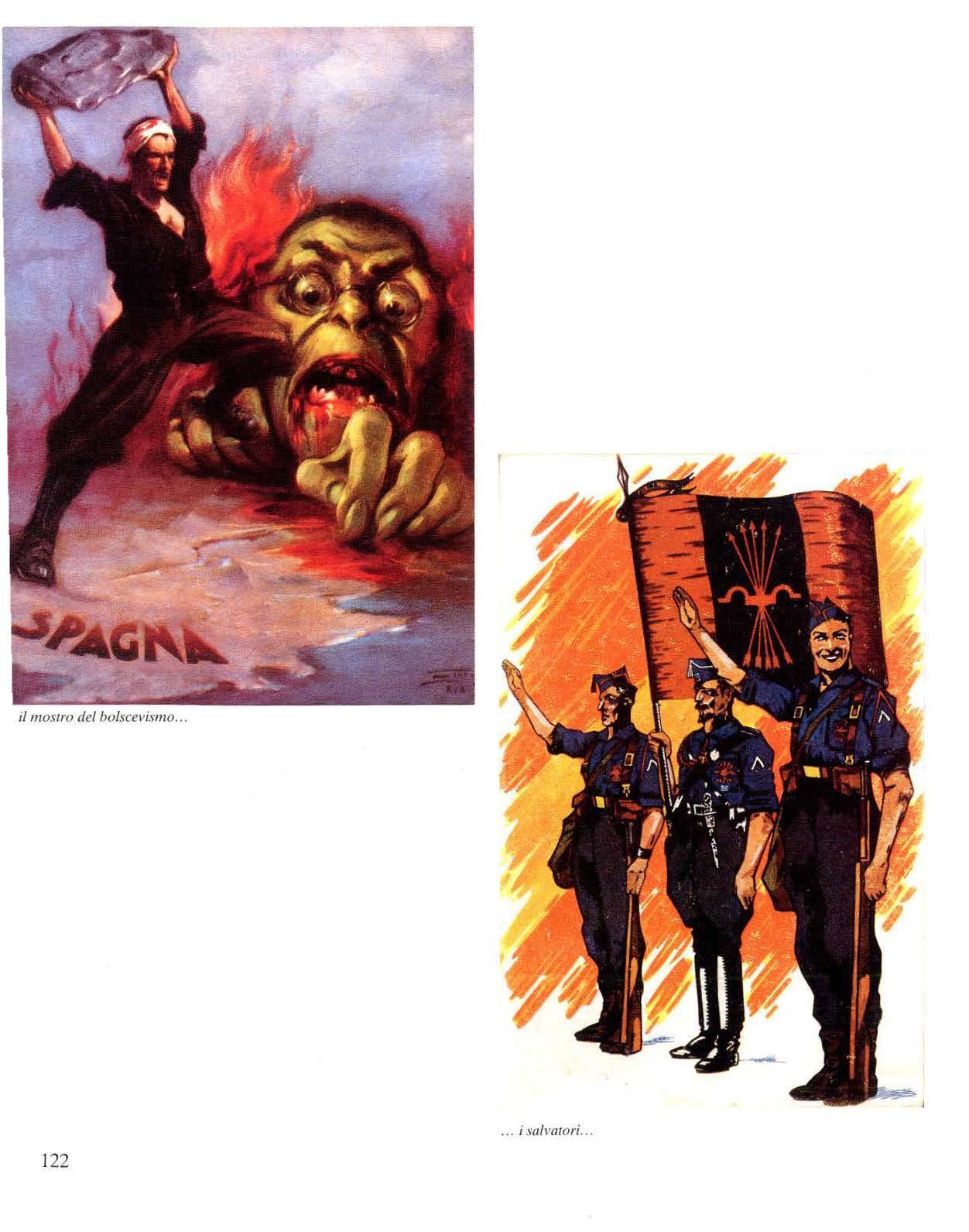
il processo di «fasc istizzazion e» d e ll ' Esercito, in izia to nel1925, raggiunse la pw1ta apicale a l tetmine d e lla g uerra d'Etiop ia e in concomitanza della p artecipazion e alla g uerra civile spagnola , anch e ne lle cartoline.
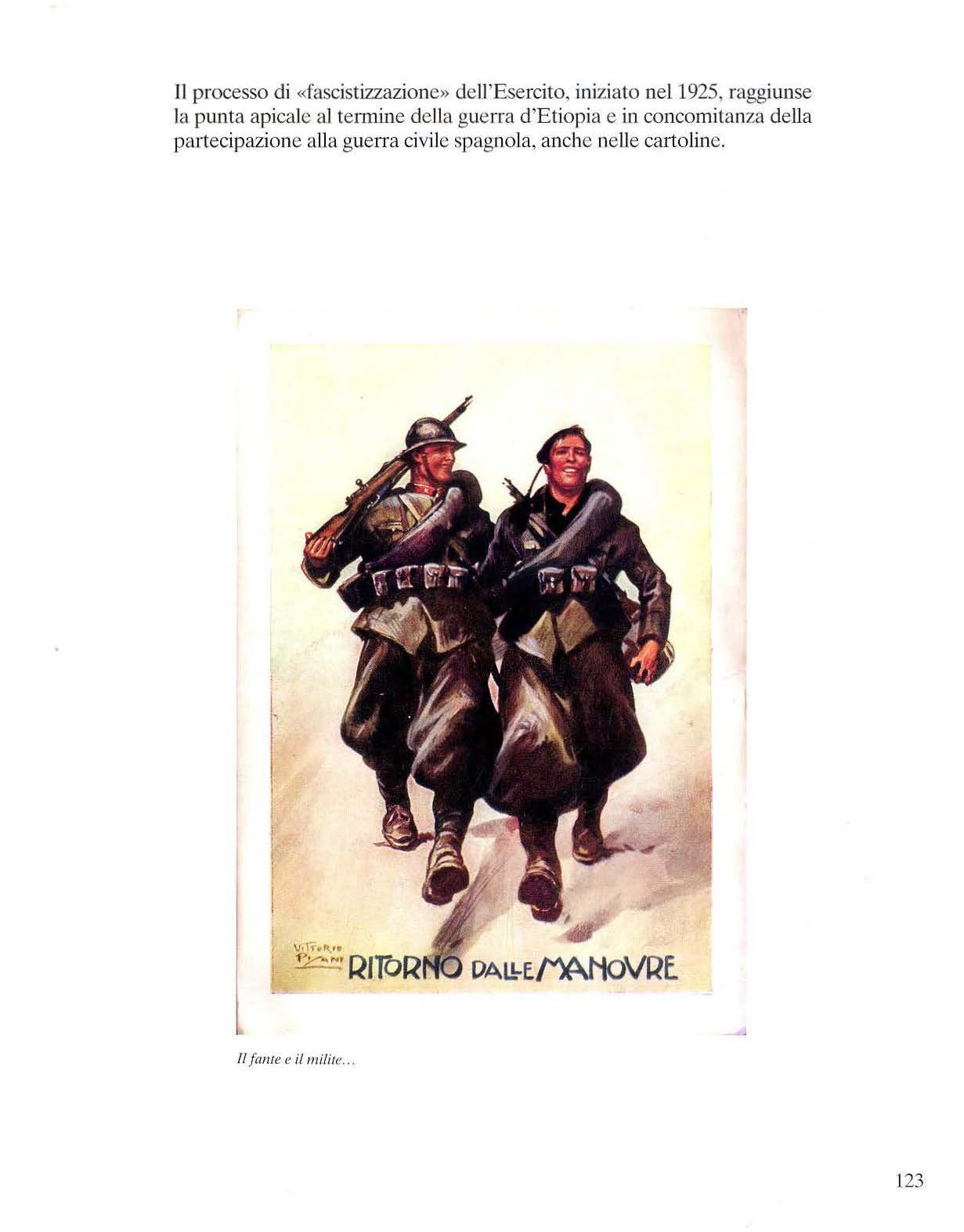
•
Tifante e il milite
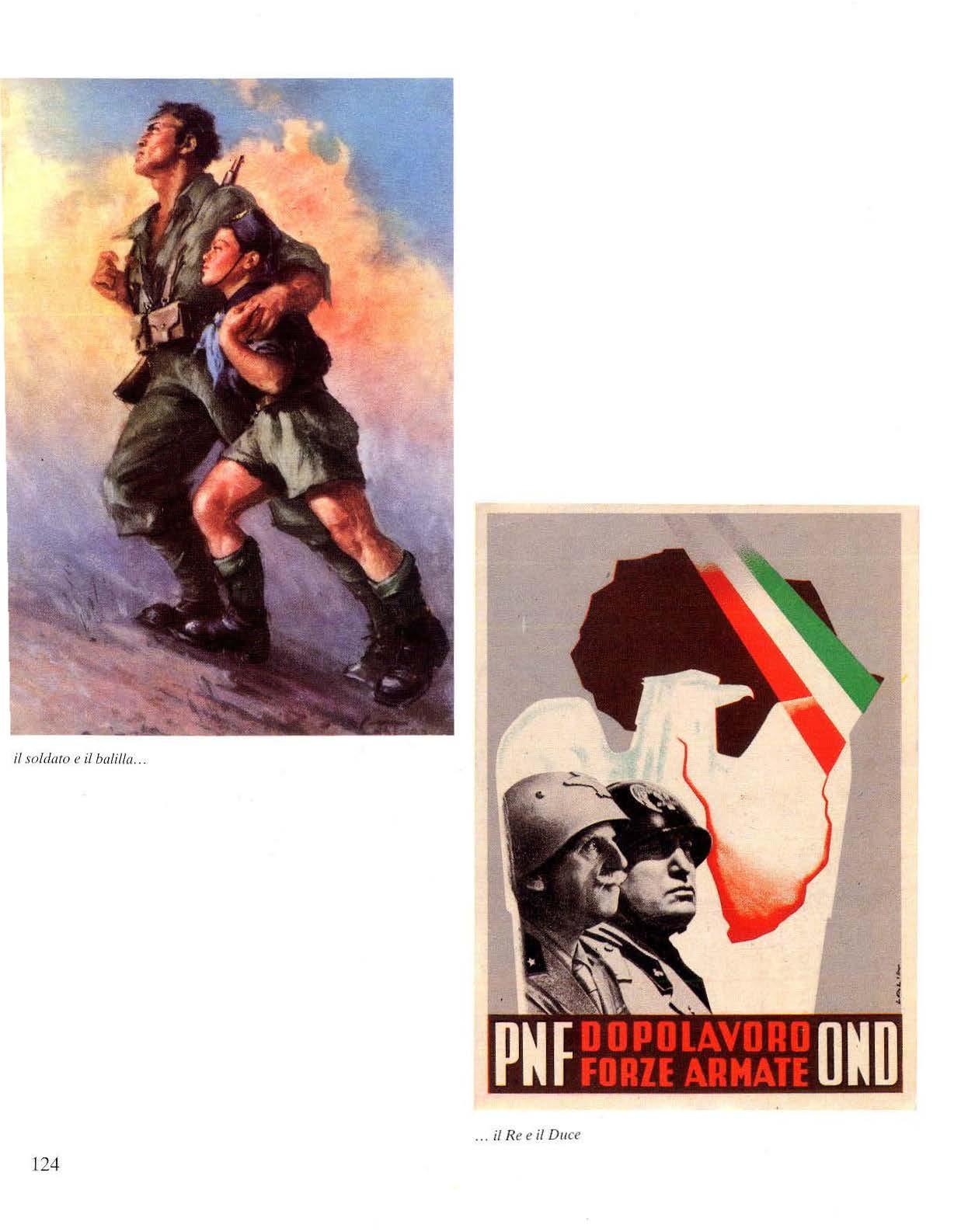
Attraverso le cartoline è possibil e ogg i accedere alla sto ri a di particolari Corpi e R e p arti, di cu i so lo gli addetti ai lavori conoscono l'es istenza . L a lettu ra visiva so llecit a così, con l ' immagine , la cu rio sit à del ricercatore. Le carto line propos te di seg uit o ricordano la teo ria del cordone difensivo dei co nfini d' Itali a, che avr eb bero dovuto essere inviolabili : ma cie lo , terra e mare s ubiranno l'offesa n e mi ca in tutta la sua violenza

 rtolina della G uardia alla Frontiera
rtolina della G uardia alla Frontiera
Cartoline di pr o p ag anda pe r l 'occ up az i o n e d eli ' Alb a nia
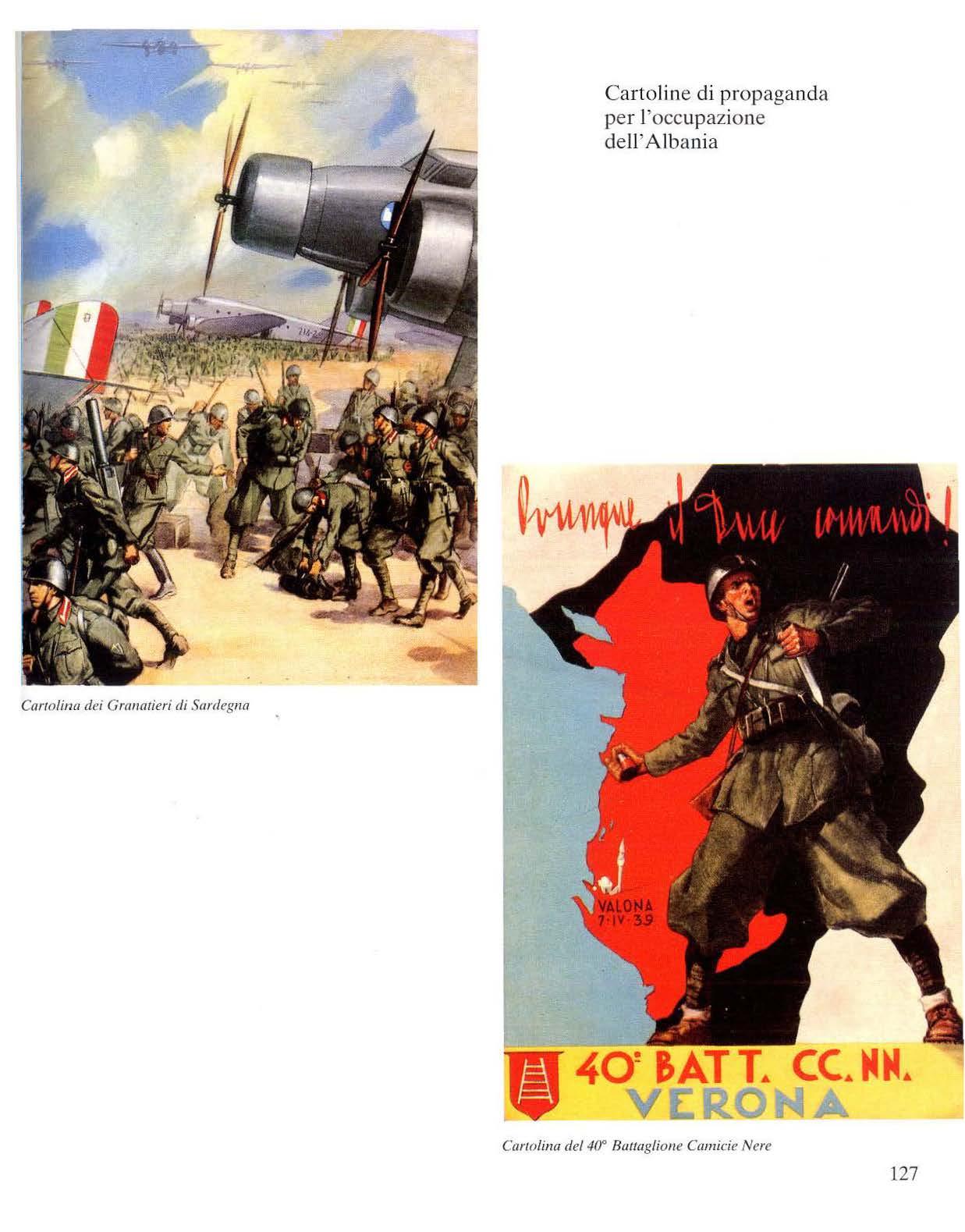 Carrolina dei Granmieri di Sardegn a
Carrolina dei Granmieri di Sardegn a
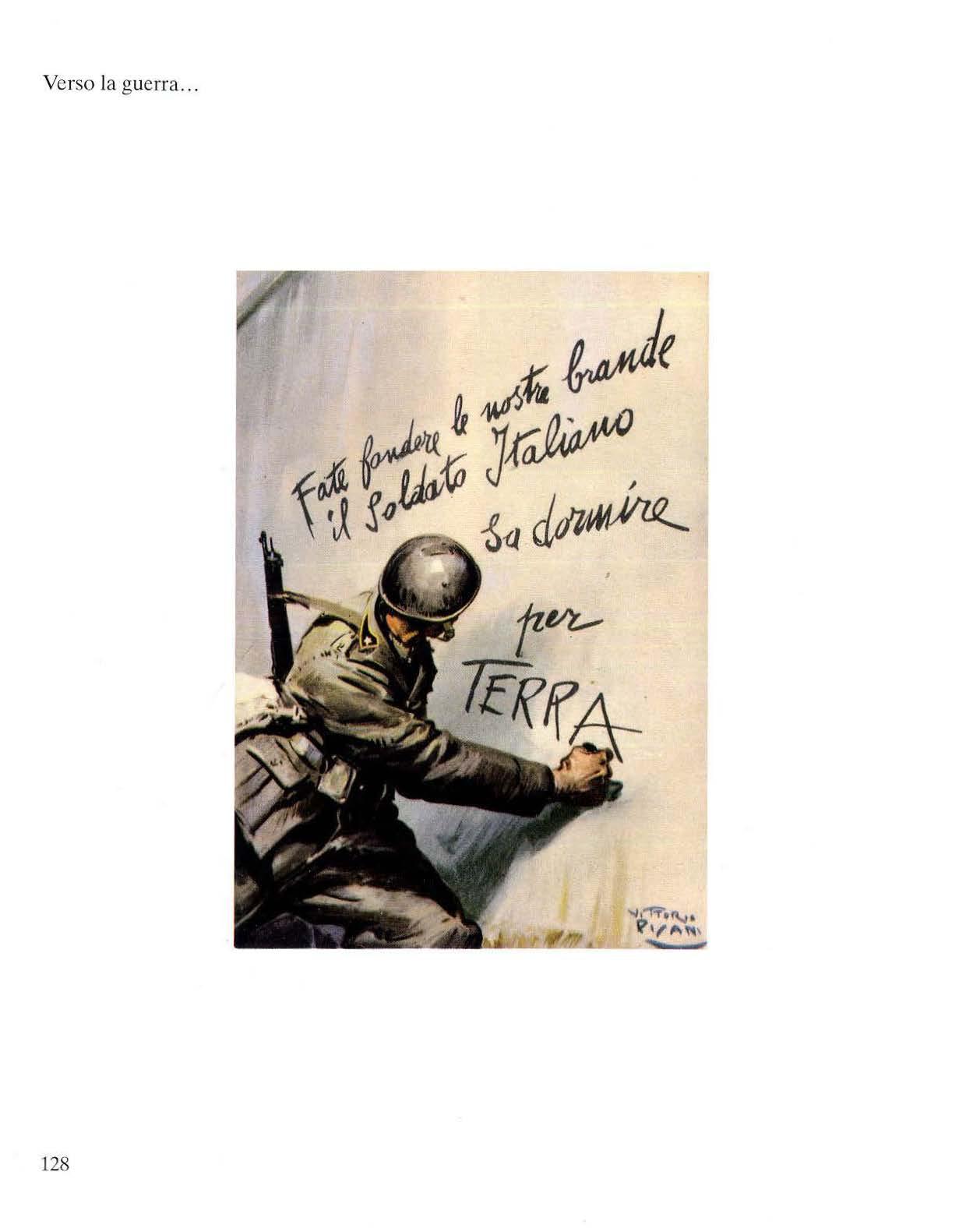
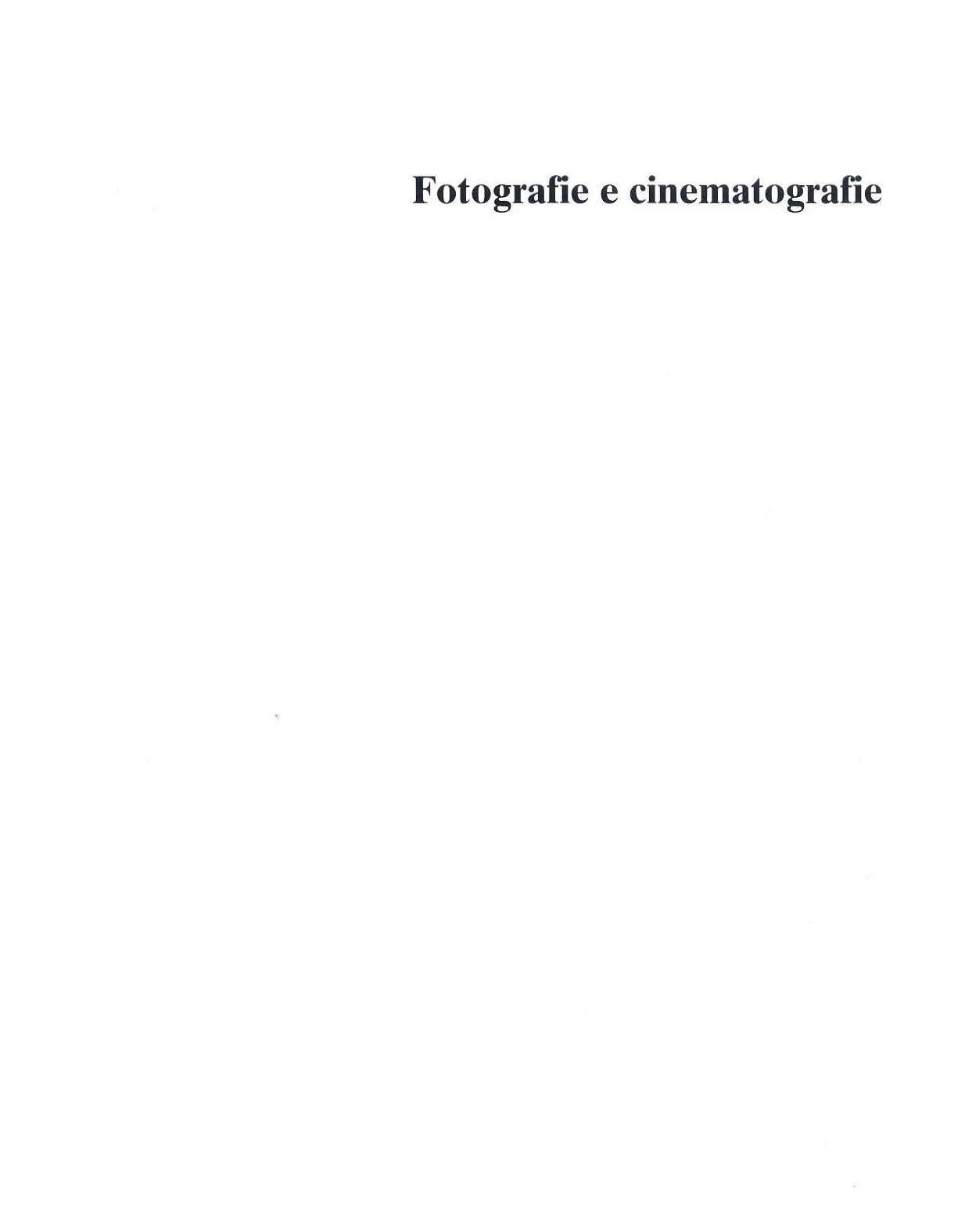
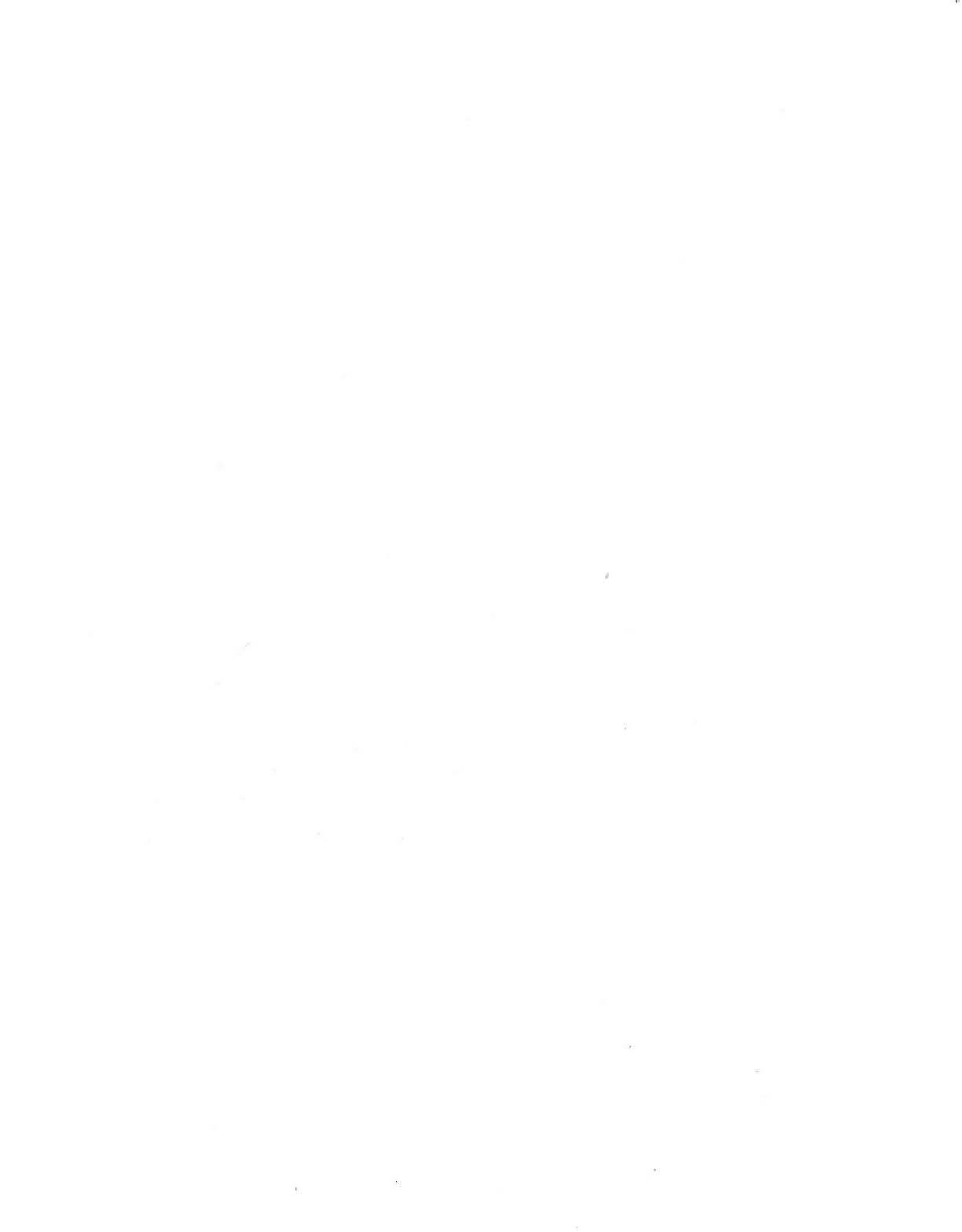
A part ir e da11 919 , il serv izio fotocinematografico so rto in se n o ali ' Arm a del Genio e presso il Comando Supremo subì un a progressiva contrazione. fino a d essere as so rbito , n e l 1923, dali ' Arma Aero n aut ica , ap p ena costituita. Il patrimonio di immagini si disp e rse fra Es erc ito, Aeronautica, Comit ato N azion a le per la Storia d e l Ri so rgime nto , Sottosegrctari ato per l a Propaga nda all 'Este ro c Istituto Geografico Militare; a qu est'ul timo fu affid ata , temporaneamente, la vend it a d e lle fotografie della 1a guerra mondi a le.
Nel 1926, con il riordinam e nto dell' Eserc ito , le co mpeten ze del servizio furon o restituite a l Gruppo Aerostieri del Genio e, a partire dall ' anno success ivo, furon o disimpe gna te da un a Comp ag nia Fot ografi, che poco alla vo lta riprese tutte le vecchie att tibuzioni. inclu sa la vendita delle fotografie. Nel1924 era , intanto , sorta l'Union e Cin ematog rafica EdÌtcativa (l'Istituto L UCE), l a cui n ascita segnò l ' inizio di stretti ra pporti tr a cinema c propaganda, e la cui attiv ità avr eb be spesso interferito con qu e lla strett a mente milit a re e con la fotograf ia c la cin e matogr afia di guerra , sovrastandola. Cultura, istru z ione e «Opere del regime » restarono comunque gli obi e ttivi prioritari dell'I stit uto LUCE , i cui filmati (g li arcin ot i Cin egio rnali , proi e ttati ancora nel dopogu err a) dal 1926 incominciarono a circol are, obbligatoriament e, nelle sal e cin e m a tografich e . Una co e rcizione -non nuov a, perché già durant e l a l a guerra mondi a le due d ec r e ti del Ministero
del l ' Int erno (5 apri l e c 24 giug n o 1918) avevano fatto obb ligo. agli esercenti di cin ematog rafi , di proiettare dicit ur e e film at i ai fini d e ll a propa ganda di guerra e della mobilitazione civile.
Fino agli anni trenta gli operatori militari produssero, soprattutto , film ati e do c umenta z io ni tecnich e e addestrativc. Conti nuaron o , inoltr e. ad effettua r e ca mp ag ne fotografiche c tcl efot ografiche a lle fronti ere, che dov e v a no fornir e agli organi operativi e in forma tivi i n ecessa ri do c um e nti per l ' appronta m e n to dc i piani di difes a e di offesa, c per l'aggiornamento delle situa zioni dell e opere fortificate di confine , allestite dagli Stati vincitori. Notevo le fu a n c h e la produzione fotografica relativa agli add es tram e n ti c alle g randi manovre , che cost ituivan o m o m e nti di not evo le ril evanza n e i rap po rti tra Esercito e Nazio n e, p er la gran ma ssa di reparti e di so ldati che venivano impiegati , e per lo s picgamento di forza che testimoniava l a potenza dell ' ap parato militare. Tali ese rcitazi oni , quindi , ben si pres tavano a d es sere utili zzate ai fini della propa ga nda tramit e le imma g ini.
Ne ll 'ap ril e d e l1934, Bai s trocchi d ec ise di dare maggior e impulso a l se rvizio , soprattutto alla cinemato grafia milit are add es trativa , educativa e propagandisti ca; per eu i dispos e che fossero cos tituiti , con c le menti d e ll a compa g nia fotogr afi, un Servizio Militar e e una Cinemateca Militare, all e dip e n denze d ' impiego dell 'U fficio Add est ram e nto del Corpo di Stato M aggiore . Es si e bbero il com pito di

addestrare il personale , condurre studi t ec nici s ull e apparecchiature fot ogr afiche più idonee all'uso in g uerra , preparare cop10m cinematografici - o esprimere il proprio parere s u qu e lli altrui di ca ratt ere militare- ed effettu a re le ripre se, cur a re l a con se rvazione c l a manutenzione d ei filmati (compresi i documentari, di intere sse militare , del L UCE). l tec ni ci militari ebbero in dotazione numero si mezzi, tra cui autocomple ss i da ripres a e da proie zion e e laboratori campali; e poterono di s porre de lle migliori macchine e apparecchiature reperibili su l mercato.
L'approssimarsi del conflitto italoe tiopico e «la nec essità di una armonica e inten.sa propagandafotocinematografica»
i n Itali a e all'Ester o, spinsero il Ca po de l Governo a d emanare in prim a persona direttive p e r il coordinament o dei molteplici se rviz i cinefoto in atti vi t à. Eg li dispose , il 7 settembre 193 5, la costituzione di un R epart o FotoCinematografico p er l'Africa Oriental e presso l ' Istituto L UCE, con perso n ale d e i Di casteri militari, delle Colonie, della MiJizia. Organo direttivo sa rebb e sta to un Comitato Tecnico lnterministeriale, con sed e presso l'Istituto ; or ga no esecuti vo in Africa , un Servizio Fotocinematografico A. O., con sede acl Asmara e diretto da Luciano DeFeo.
Il Comitato, nell e sue riunioni , oltre a s tabilir e il contributo - pe rsonal e, me zz i c danaro - che ciascun Minister o avrebbe dato (l'apporto maggiore vénne da Gu e rra e Milizia) , stilò un pro-
memoria per le ripres e cinematografiche, in cui furono fis sate le modalità perch é le immagini diventassero non so lo documenti per la cro nac a, per la storia e per la propagand a, ma anc h e materi a le da utilizzar e per l'addestramento militare coloniale.

Le pe llicole furono de st inate all'archivio dell' I s tituto LUCE , ma una copia, gratuita, doveva esse re ced uta al Mini s te ro d e lla Guerra per la Cinemateca dello Stato Maggiore.
Poi ché ad Asmara operava la Se zione Cinematografica «E» (Eritrea) dell'E s ercito , il Comando Sup er ior e dell'Africa Orientale di sp ose che il Servizio in A. O. promanasse da tale sezion e, int egrato dagli operatori ci vili del LUCE e da qu elli messi a dispo s izion e dall e amministrazioni milit a ri. Prec isò, inoltr e, che tutto il personale, munito di apposito bracciale e di tessera di riconoscim e nto , av r ebbe dovuto att enersi a lle limita zioni e all a vigil a nza impost e dalle a utorit à militari; e, per l' impi e go n e ll a zona di operazioni, alle dir e ttiv e che lo s tes so Comando avrebbe emanato.
Fotografi cd operatori furono impie ga ti per nuclei , so meg g i ati o carreggiati, in relazione all e esigenze e se condo le indicazioni fornit e da D e Feo.
L'Esercito impi e gò, contemporaneamente, p e r suo conto (e non sol tant o con co mpiti tecnicooperativi, ma anch e propagandistici) otto s q uadr c (4 fotografiche c 4 telefotografiche, con numera zione bivalente 7a-l43 -1 63 -20a), mobilitat e dalla Co mp ag nia di Roma e alle dir ette
dipend e nze d e i Corp i d 'Arma ta.
Ult e riori dir ettive sul servizio - ch e provocarono risentimenti del presidente del LUCE, per le interferen ze insite in esse - ve nn ero dall'Alto Commissario D e B ono .
Dopo aver stabilito che con il servizio fotocinematografico avrebb e ro dovuto coUab orare gli ufficiali add e tti al servi z io stampa , e che poteva no essere raccolt e ed utili zz ate anch e le immagini prodotte dai militari in pos sess o di macchine personali , De Bono dispo se che il Servizio di Asmara m ettesse rapidamente a disposizione d eli' Uffici o Stampa soltanto il materiale utilizzabil e ai fini d e lla prop aga nda , e d inviasse inv ece a l Comando Superiore la docum e ntazion e st orico-militare e add estrativ a.
I primi giorni di campagna non furono felici p e r gli op e ratori: essi furono lasci at i se nza m ezz i di trasp o rto dai Comandi delle U nità e, in qualche caso, senza c ibo ; furono deris i e sos pettati; ferm ati, minacciat i e, in ca s i limiti , tratt at i da specul ato ri e maltrattati. Tanto c he , già ill2 ottobre 1935, il Comando Superiore A.O. fu cos tr etto ad e mett e r e un a dura circolare sul depr e cabi l e trattamento ri se r vato a operatori militari c civili; al term ine deJle di r ettive contenute n e ll a circolar e, i Capi di Stato M agg ior e d e ll e Divisioni furono minacciati di severi provv e dimenti, qualora l'andazzo deplorevo le non fosse mut ato.
D opo il conflitto , vi fu un t e ntativo d e l Gov e rn 'o Gener a le d e ll ' Eti op ia di sciogliere il Rep arto fotocin e matografico c
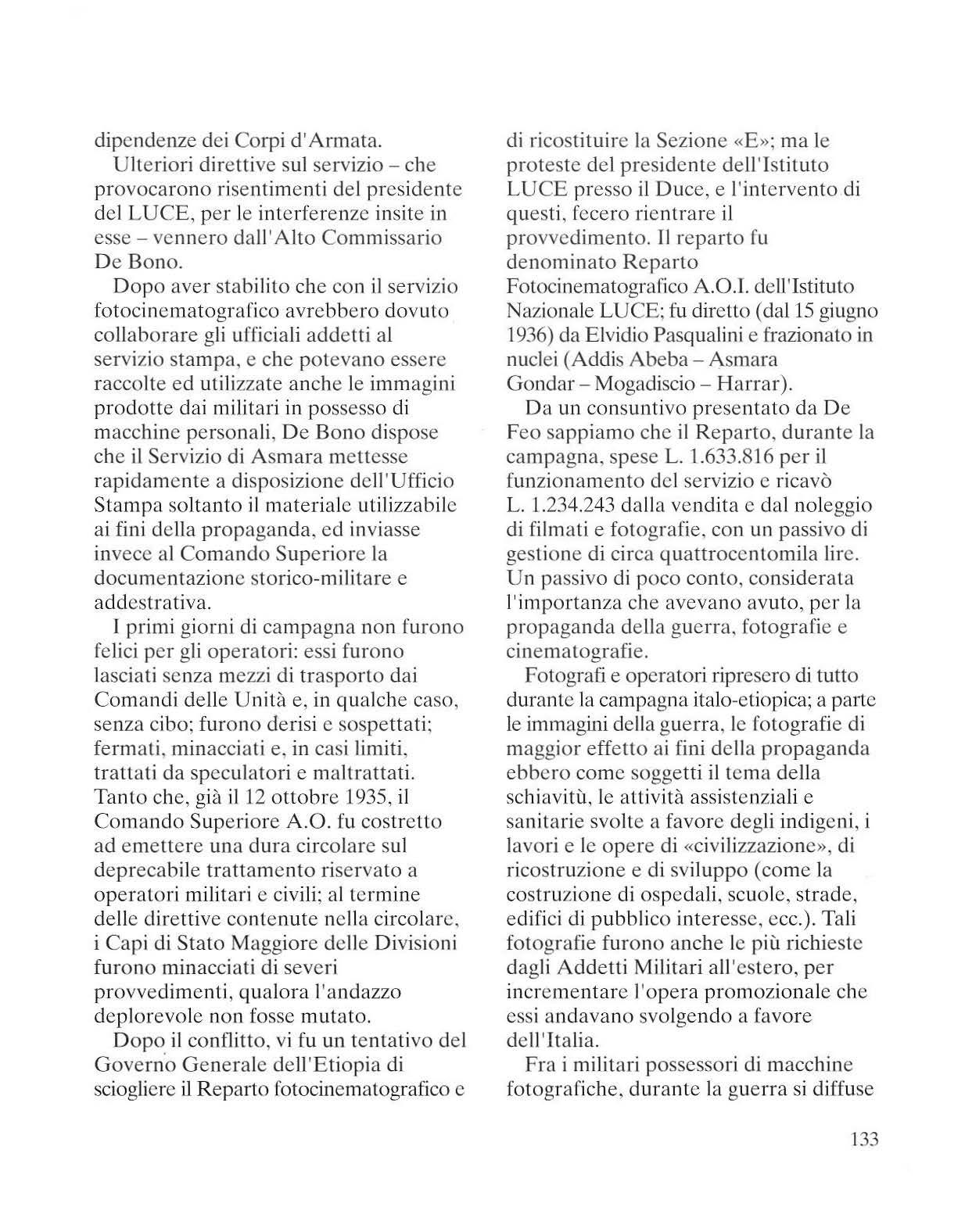
di ri costi tuir e la Sezion e «E»; ma l e protes te d el pres ident e d e JI ' Istituto LU CE presso il Duce, e l ' intervento di que st i, fecero rientrare il provv e dimento. 11 r e p arto fu d enominato R e parto Fotocinematografico A.O.I. dell ' Istitu to Nazionale LU CE; fu diretto (dal15 giug no 1936) da Elvidi o Pasquali n i e frazionato in nucl e i (A ddi s Abeba - A smara Gondar - Mogad iscio - H arrar ).
D a un consuntivo pres e ntato da D e Feo sap piamo c h e il R eparto, durant e la campagna , sp ese L. 1.633. 81 6 per il f un zio nament o del servizio c ricavò L. 1.234.243 dalla vendita c dal nole gg io di filmati e foto g rafie , con un passivo di gestione di circa quattrocc ntomila lir e . U n passivo di poco conto , co nsiderat a l'im porta nza che avevano av uto, per la prop aga nda d e lla g uerra , fo tografi e e cine m atografi e.
Fotografi e operatori ripresero di tutto dura nte la campag na itala-etiopica; a parte le immagini dell a g uerra , le fotografi e di ma gg ior effetto a i fini d e ll a propaganda ebbero come sogge tti il t e m a della schiavit ù , le attività assist enzia li e sanitarie svolt e a favore d eg li indi geni. , i lav or i e le oper e di «civilizzazione», di ricostruzione e di sviluppo (come la costru zione di o s p e dali, scuo le, strad e, edifici di pubblico interess e, ecc.). Tali foto g rafie furon o anche 1c più richie ste da g li Ad d ett i Militari aJI 'cs t e ro, per incr e mentare l ' opera promozionale che es s i andava no sv olgendo a favo re d e ll'Italia.
Fra i militari possessori di macchin e foto grafiche, durante la gue rra si diffuse
l 'usanza di inviare in Patri a, con la c orrispondenza, fot og rafi e di atrocità com m esse dag li etiopi e di nudi fe mminili: un flusso di immagini interrotto solo dall'interv e nto d e lla censura , che provvid e a toglierle di co rso.
l nudi femminili furono , pera ltr o, « ufficializzati » in alcune ser ie di cartoline fotografiche, a nche dell'Istituto LUCE , che circo la van o abbondant e mente e liberam e nte in Itali a con dicitur e ora et nografiche , ora di costume ( « ra ga zz a a s mara », «portatrice d ' acqua », ecc.). Ancora una vo lta , si contrabbàbdava l 'e roti smo con pretes ti culturali , co m e er a già s ucces s o nell e prece denti imprese coloniali , a partire d a ll ' ottocento.
l film a ti prodotti , ug ualm e nte diffusi in Italia e all 'es tero , ripreser o tutta la cam pa gna di Eti opi a; purtroppo buon a parte di ess i so no andati di s trutti. Diamo qui la notizi a che n e l 1982 i l C e ntro Ci n efoto dello Stat o Ma gg ior e Esercito r e cup e rò un centinaio di vecc hi e « pizz e», su s upporto infiammabile , di cui ben 12 rela tive alla co nqui sta cieli' Etiopia. Un materiale di est remo interesse stor ico-docum e ntal e, pe rché in esso è ria ss unta tutta la campagna; attualm e nte tali pelli co le so no in c ustodia press o l ' I st ituto LUC E, p e rché so ltanto ad ess o le norm e in vigo r e consento no di conse r v are p e llicole in fiammabi li.
Tra i film -do c um e ntari sa lvati , è s tat o r ec up erato il notissimo <<Il Cammino d eg li eroi », ch e assi e me ad a ltri ( « Le manovre dell 'anno XII», « La gi o rnata
dell 'Ala », «Ca micia nera », « Glo ria ») ve ni va proi et tato a beneficio d e lle trupp e in It a lia e in Afri ca, per t es tim onia r e la part e che esse aveva n o av uto nella nascita dell ' Impero.
Occor r e ricordar e che , co ntemporaneam e nte, I ' industri a c inem a togr a fica privata metteva in ca nti ere, in quegli a nni , con rife rim e nti all a campagna d ' Africa e a lla guerra di Spagna , num e ro si f ilmati a soggetto; tra e ssi ri co rdiamo, famosis s imi, Il g rand e ap p ello di Camerini , Squa drone bian co e L 'asse dio del! 'Alcazar di Geni n a, Sentin elle di bron z o di Marcellini , Luciano S erra pilota e Abuma Messia s d i Al ess andrini.
Spe sso furono utilizzati interi reparti militari per le s cen e di qu es ti film, n ei quali co nvi sse ro , co n un a ce rt a dignit à, a rte, «ca ssetta » e propag a nda.
L 'i mportanza d e l mezz o ci n e m atografico a i fi ni d e lla propaganda non era, ovviamente, sottovalutato d a ll e altre N az ioni e urop ee, ch e se da un lato e rano costret t e a sorb ir e i filmati itali a ni diffusi dalle rapprese ntan ze diplomatiche a ll 'est e ro, p er loro conto co nfez ionavan o c inem a di contropropaganda. U n ' atti vit à sv olta s opr attutto clalJa Russia , i cui tecnici, utili zzando le stesse pellicole it a liane , riuscivano a produrre filmati «d e cisamente antiitaliani »; ricorrendo acl es penclienti molto se mpli c i come, ad esempio, quello di ag g iung e re sc e ne eli rov in os i bombardamenti s u citt à e villaggi , p e r dimostra r e la «fe roc ia » dei co nqui sta tori sull'inerm e popolazion e e tiop e .
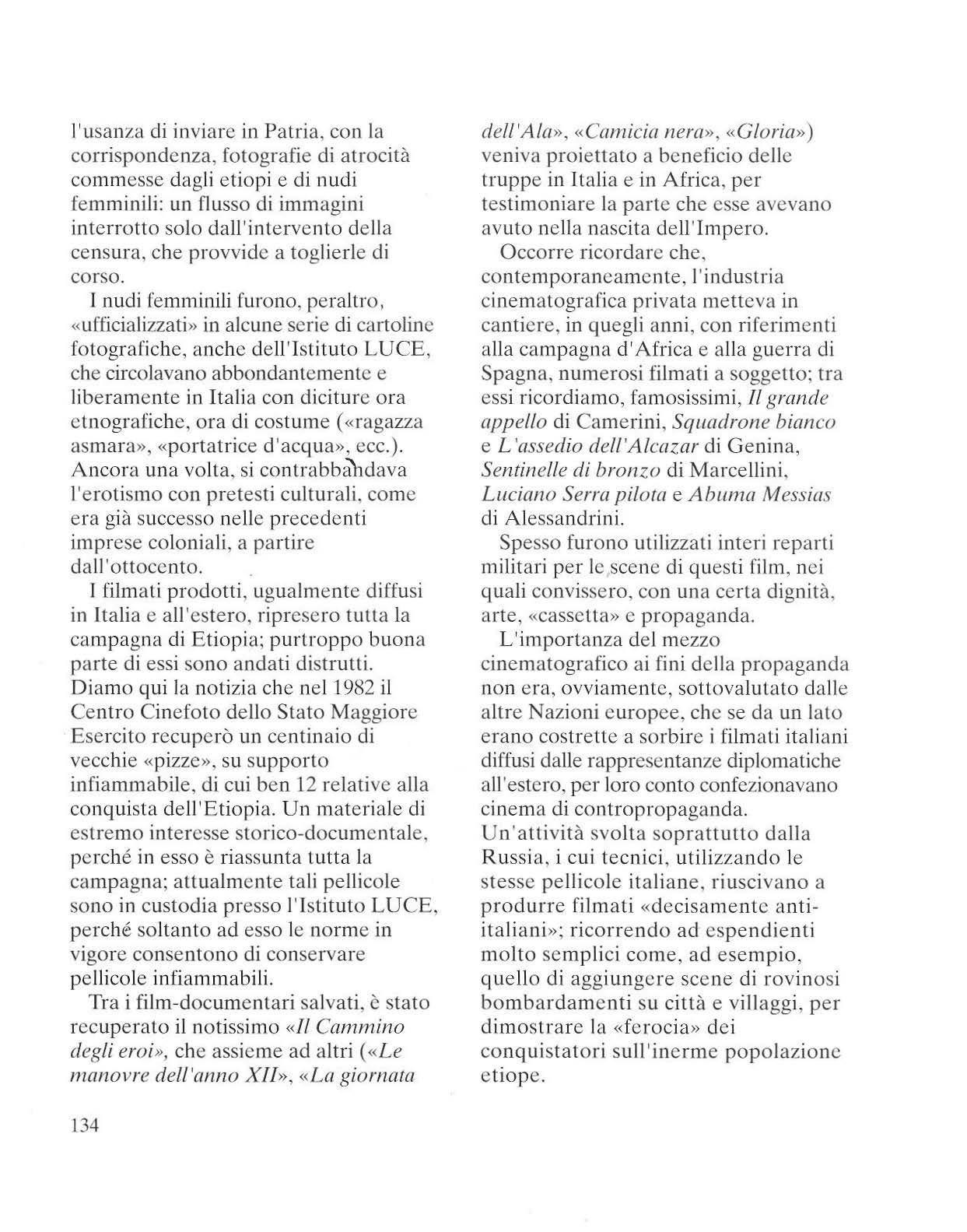
Benché non fosse stata organizzata in anticipo come in Africa, analoga battaglia per immagini si ebbe anche in Spagna. Inizialm e nt e furono gli stessi volontari della MMIS a scattare fotografie della guerra; ad essi subentrarono successiv am ente operatori dell'Ufficio Stampa in Salamanca . Dov e le fotografie fatt e sui vari fronti ve ni vano inviate, per lo sviluppo e la stampa. Ciò comportava una not evole perdita di tempo , so prattutto per l'utilizzazione propagandistica delle ripres e, che perdevano in attualità. Il capo dell'Ufficio Stampa in Spagna , pertanto, richiese a Roma un laboratorio mobile per lo sviluppo c la stampa d e lle fotografie , in modo che il m ezzo potesse intervenire rapid ame nte su! fronti di maggiore interesse. L'autofurgon e attrezzato venne prelevato , nel mese di febbraio 1937. dall e dotazioni di mobilitazioni dell '8° reggim e nto genio , in cui era inquadrata la compagnia fotografi , unico entè in possesso di compless i mobili pe r la ripr esa, per lo sviluppo e per la s tampa.
Con la costituzione del CTV, fu predi spos to un Servizio Fotografico dell'Ufficio Stampa.
Nel fratte mpo , operavano in Spagna tecnici dell'Istituto LUCE , che produceva no foto grafie e filmati. Nel settembre del1938 , il Ministero degli Affari Esteri comunicò, al Ministero della Guerra, che l ' Ufficio Stampa di Salam a nca era in possesso di una notevole quantità di materiale cinematografico (se i sacchi!) ripreso sui vari fronti della Spagna, e che era
dispo s to a cederlo alla cincmateca del Corpo di Stato Maggiore.
Più tardi, nel dicembre d e l1938 , fu invi ata in terra iberica una Sezione Cin ematog rafi ca, al comando del sottotene nte Be niamino Starace, che n e l febbraio 1939 inviò in Ital ia 1.800 m e tri di pellicole, girate durant e le operazioni in Catalogna.
I vertici della Guerra di Roma portarono una gran fretta alla sezione , per ave re material e da montare in un filmato propagandistico; anche perch é, in qu ei tempi , veniva proiettato nei cinema italiani un film che , esaltando le gesta dell'aviaz ione legion aria nei combattimenti di Teru el, s uscitava ovvie gelosie nei vertici dell ' E serc it o.
M e ntre l ' Ufficio Addestramento si affrettava a montare il filmato, l'Isti tuto LU CE proiettava a Rom a «No Pasaran » (al M o derno in prima visione il lO marzo 1939) , dai contenuti fort emen te propagandistici c anticomunisti , in quanto incentrato sulle violenze, gli inc e ndi e le di s truzioni commesse dai « rossi».
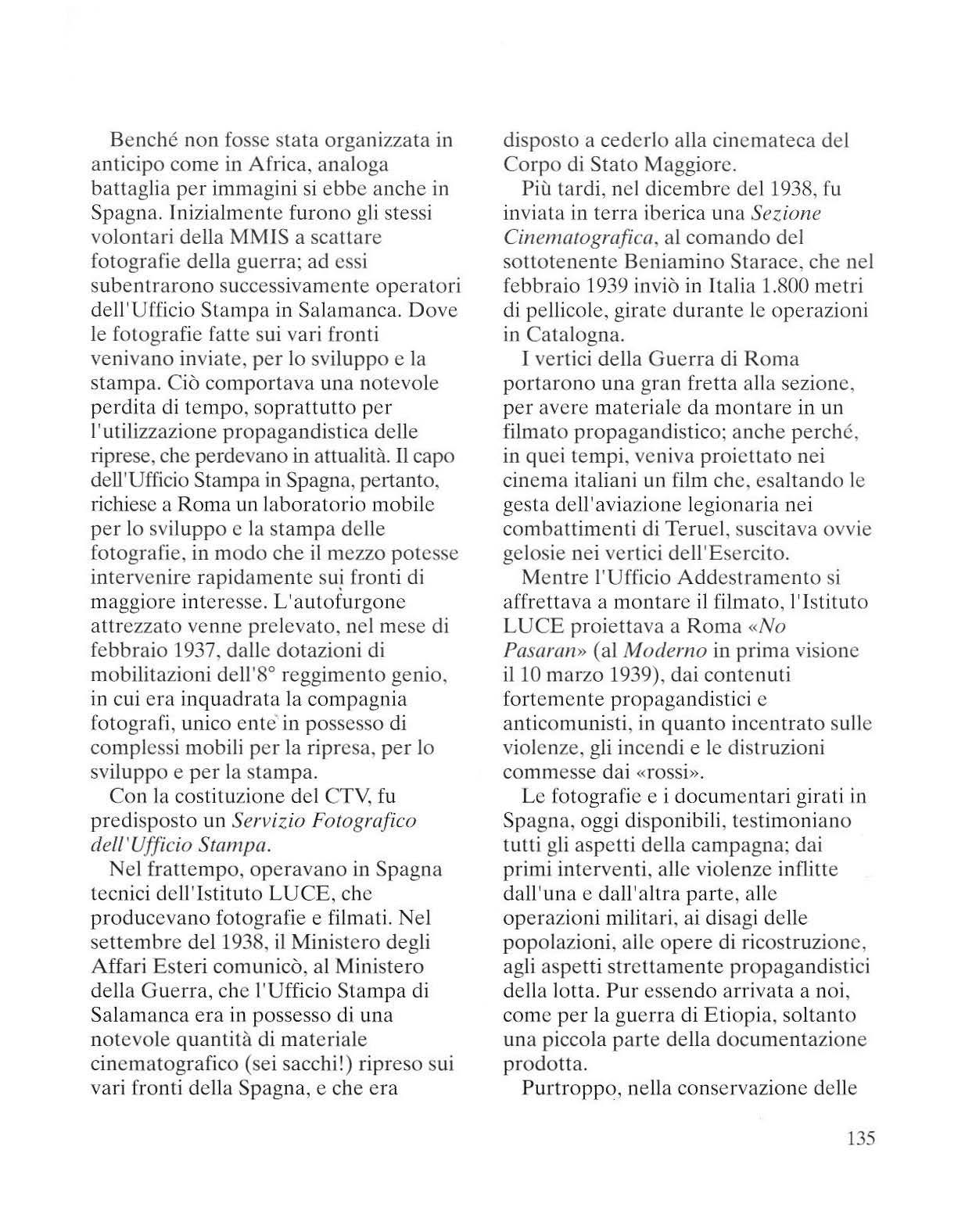
L e fotografie e i docum e ntari girati in Spagn a, oggi dispo nibili , testimoniano tutti gli aspetti della campagna; dai primi interventi , alle violenze inflitt e dall'una e dall'altra parte , alle oper az ioni militari , ai disa g i delle popolazio ni , alle opere di r icostruzione , agli aspetti strettamente propagandistici della lotta. Pur esse ndo arrivata a noi , com e per la guerra di Etiopia , so lt anto una piccola part e della documentazion e prodotta.
Purtroppo, nella conserv az ione d elle
immagini in po ssesso de ll 'Ese rcito , ha avuto una conseguen za ca t as trofica un incendio, subito negli a nni sess anta dalla Cineteca dello Stato Maggiore
de ll 'Ese rcito , che ha dis trutto la m agg ior parte d e ll'ar c hivio fotografico e quasi tutto qu e llo cinematografico.
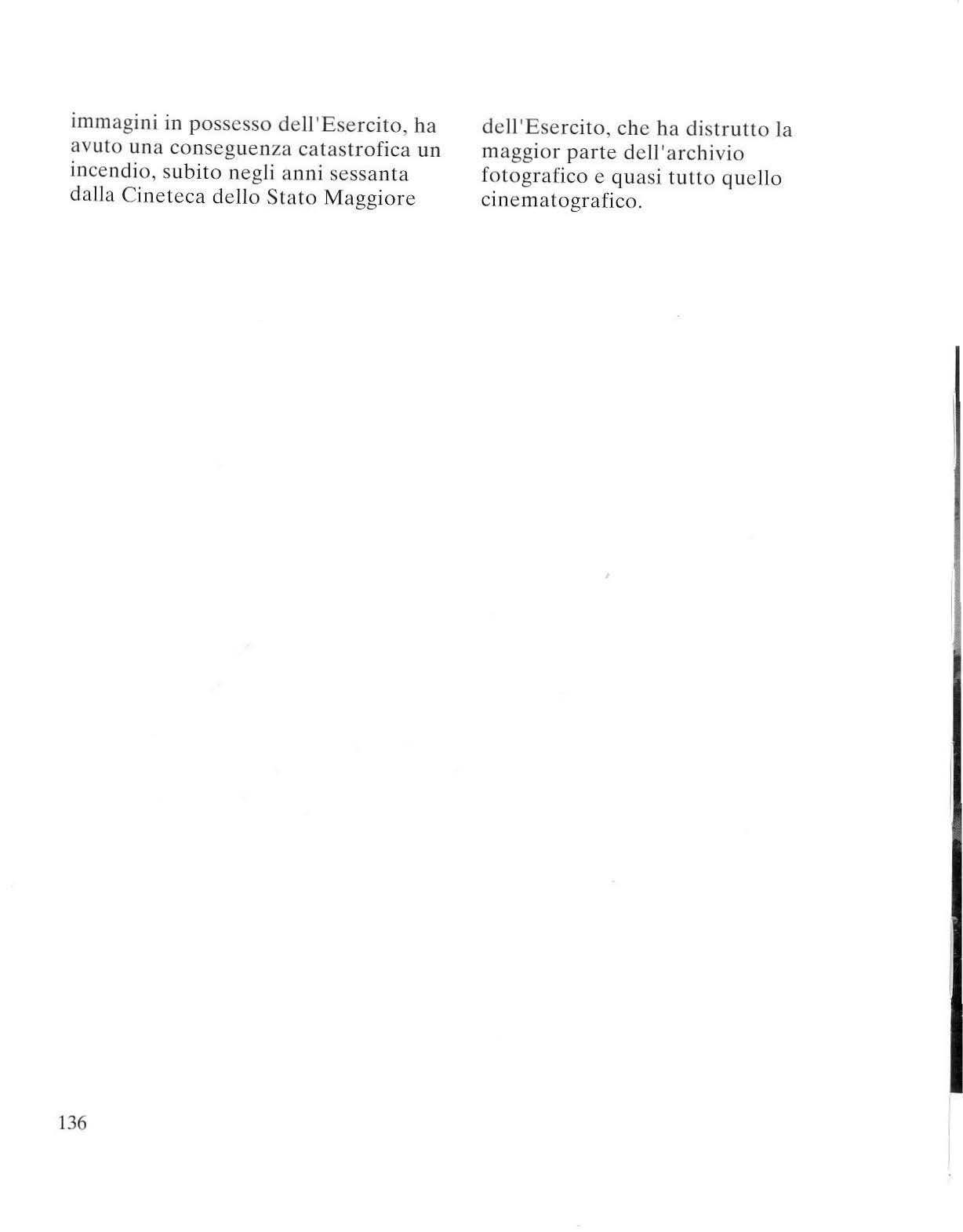
Gli avvcmmenti , la prepara z ione, la propaganda, il consenso

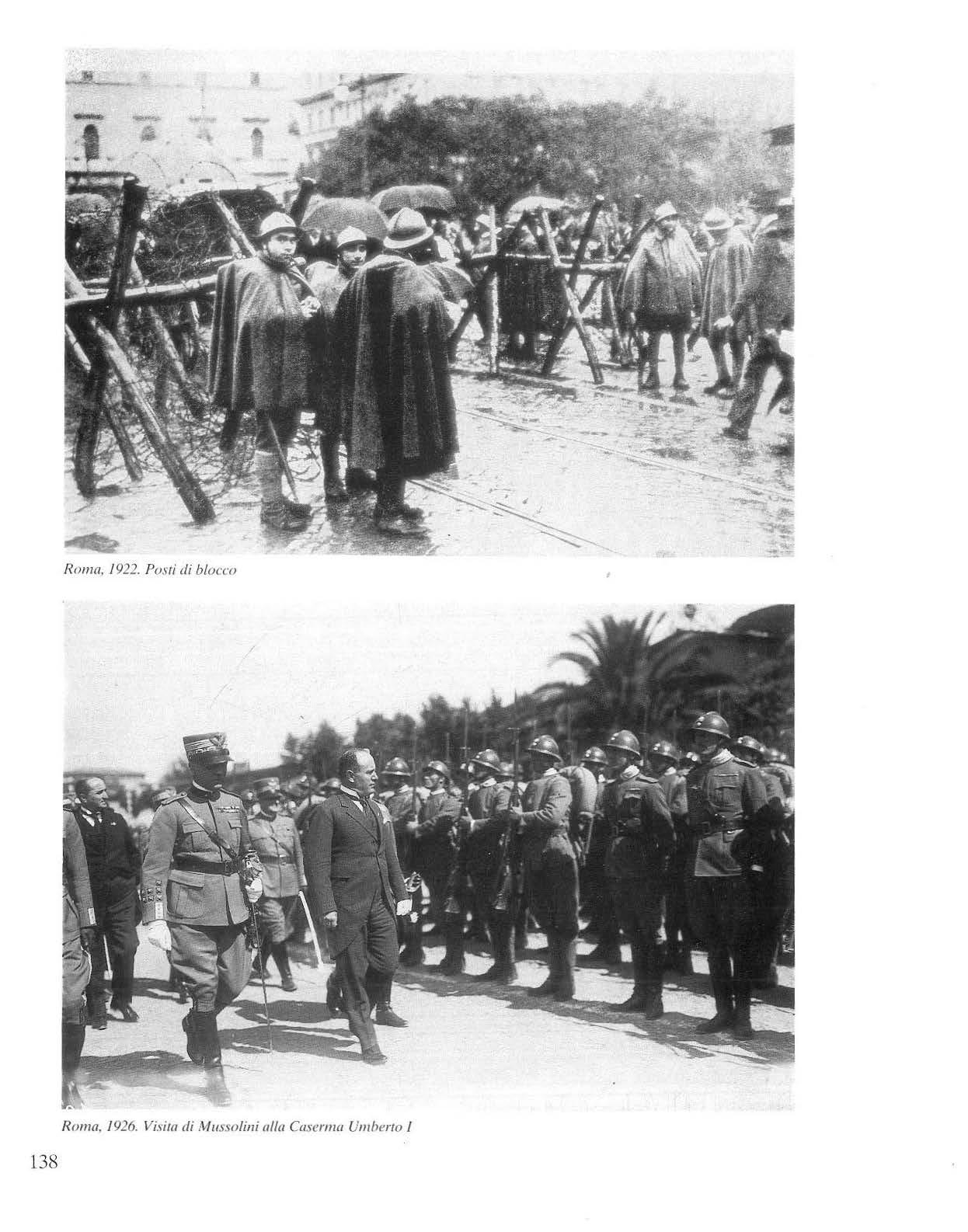 Roma, 1922. Posti di blo cco
Roma, 1922. Posti di blo cco
La preparazione alla Naz ione Armaw generazioni a confro!lto


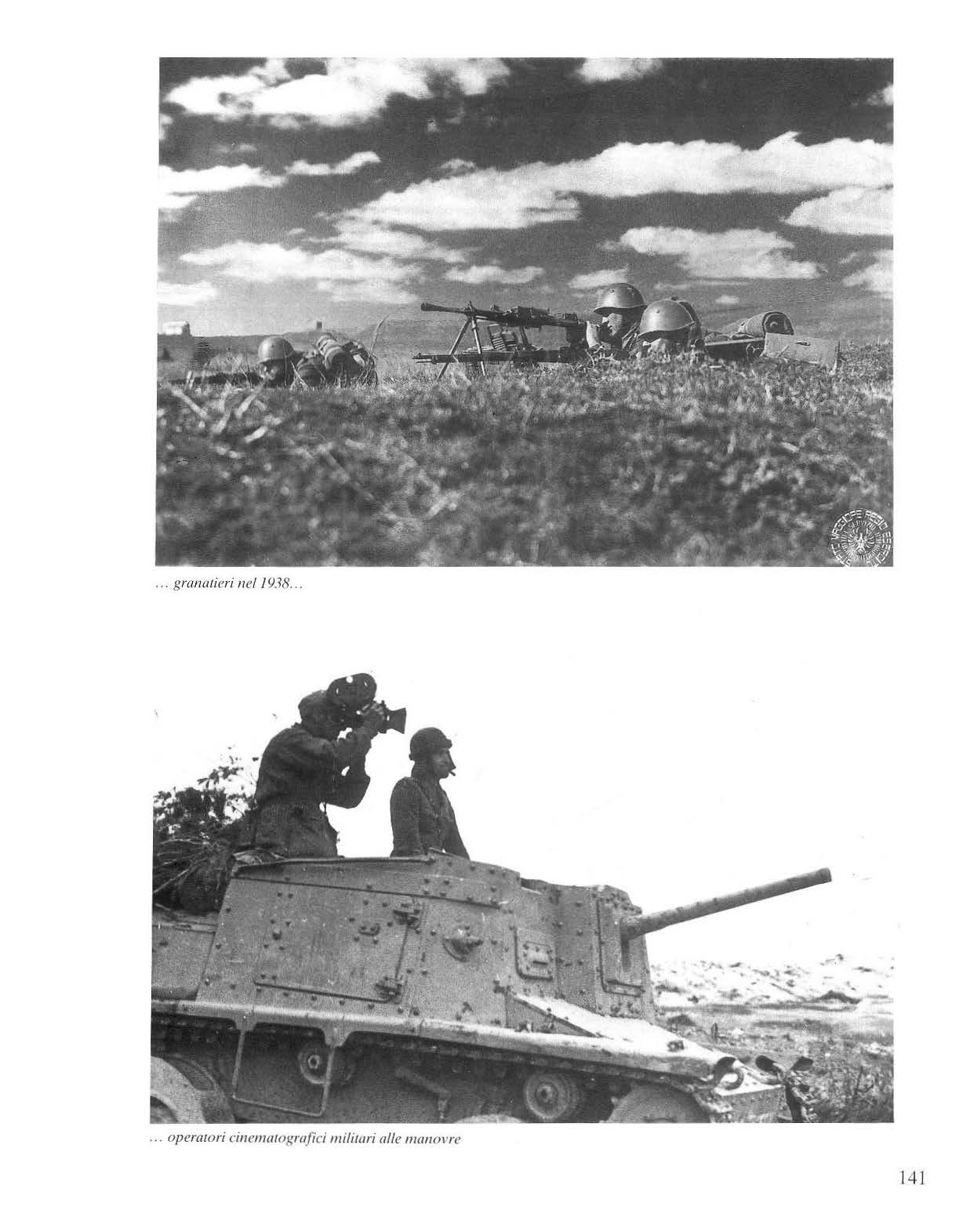 g ranati eri n ef 1938
g ranati eri n ef 1938
La
/

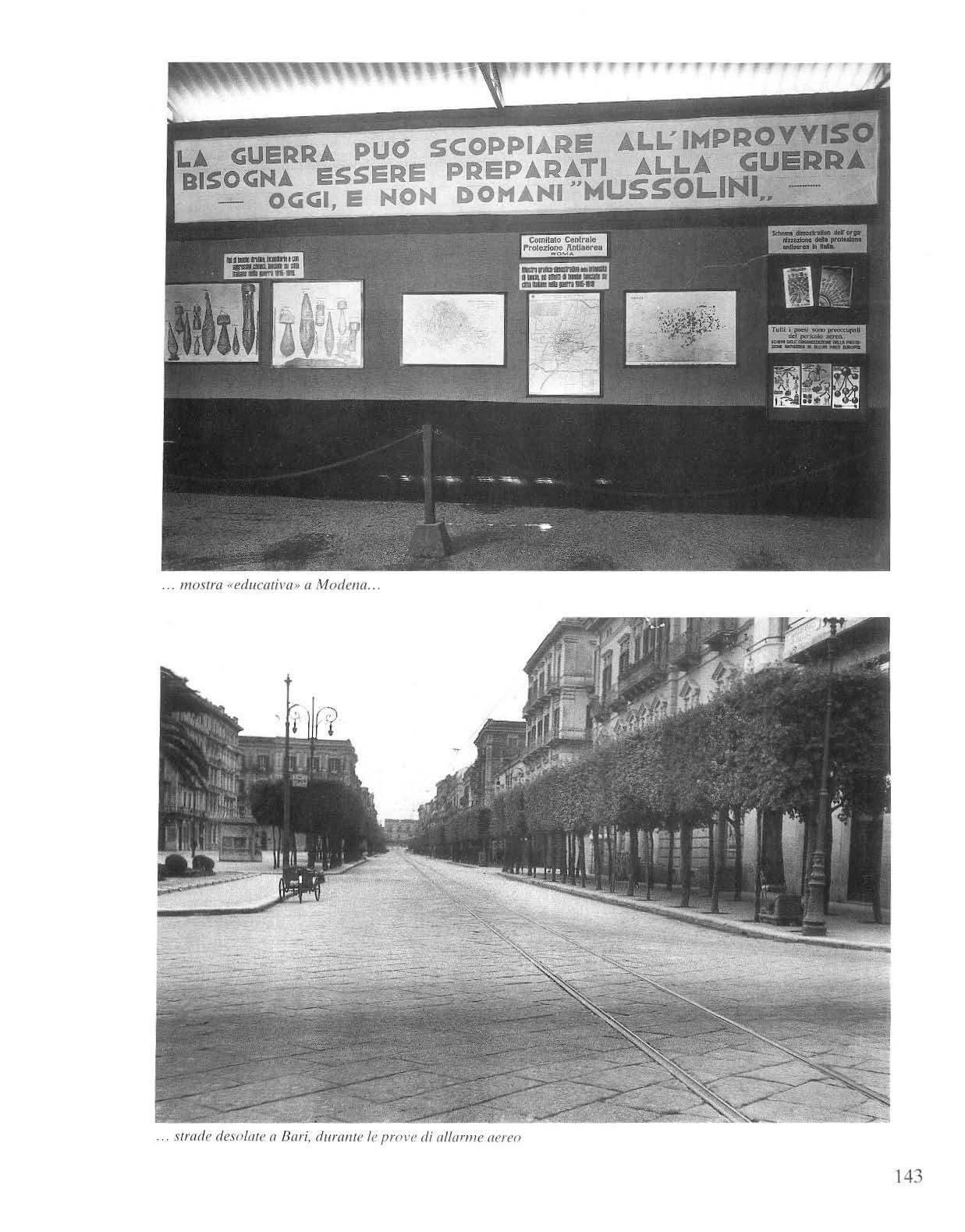

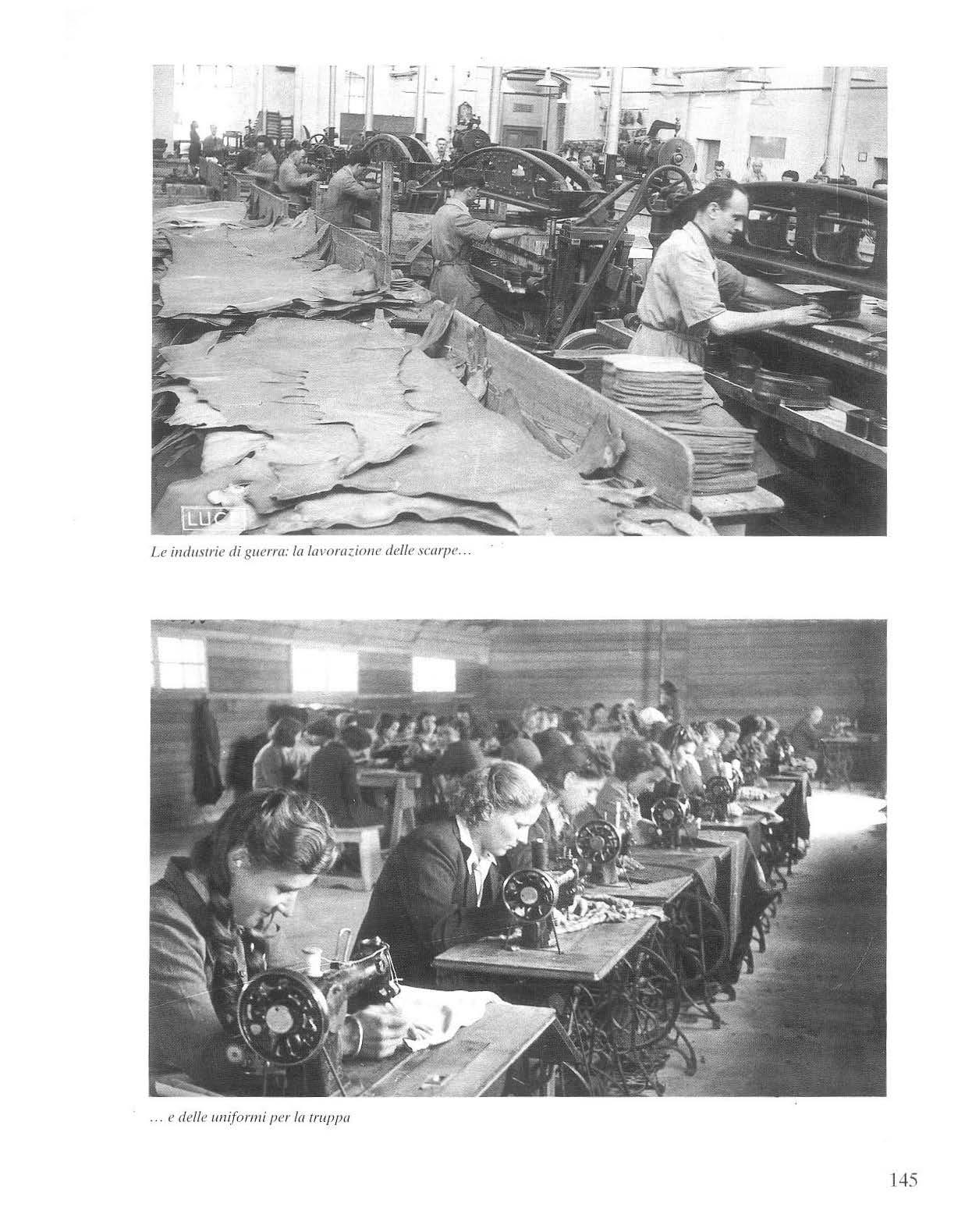
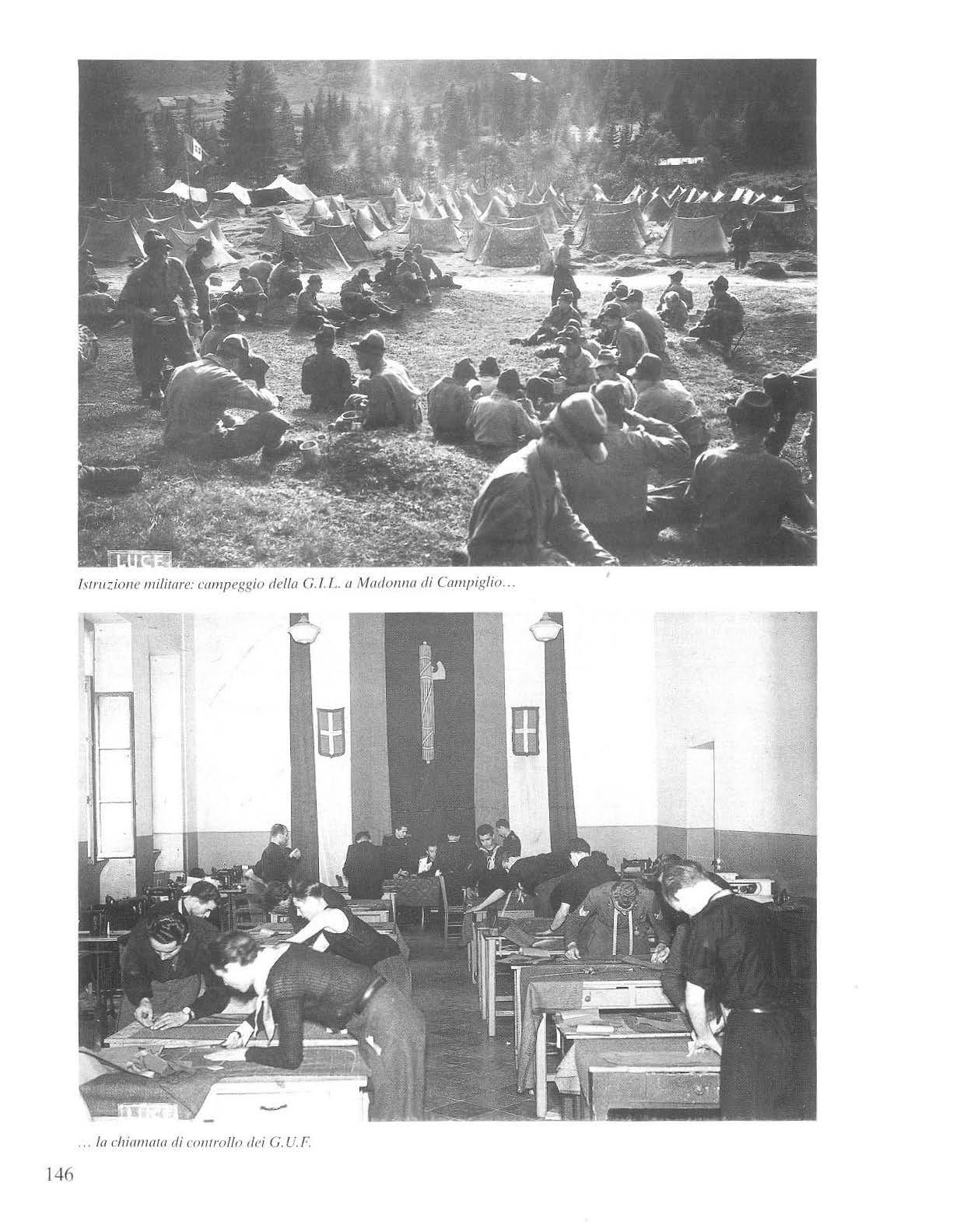 lstm::.icm e 111ilitare: c·ampeggio della C.I.T a Madonna di Campiglio
lstm::.icm e 111ilitare: c·ampeggio della C.I.T a Madonna di Campiglio
 L e consegne: dalla Befana del Soldnto
L e consegne: dalla Befana del Soldnto
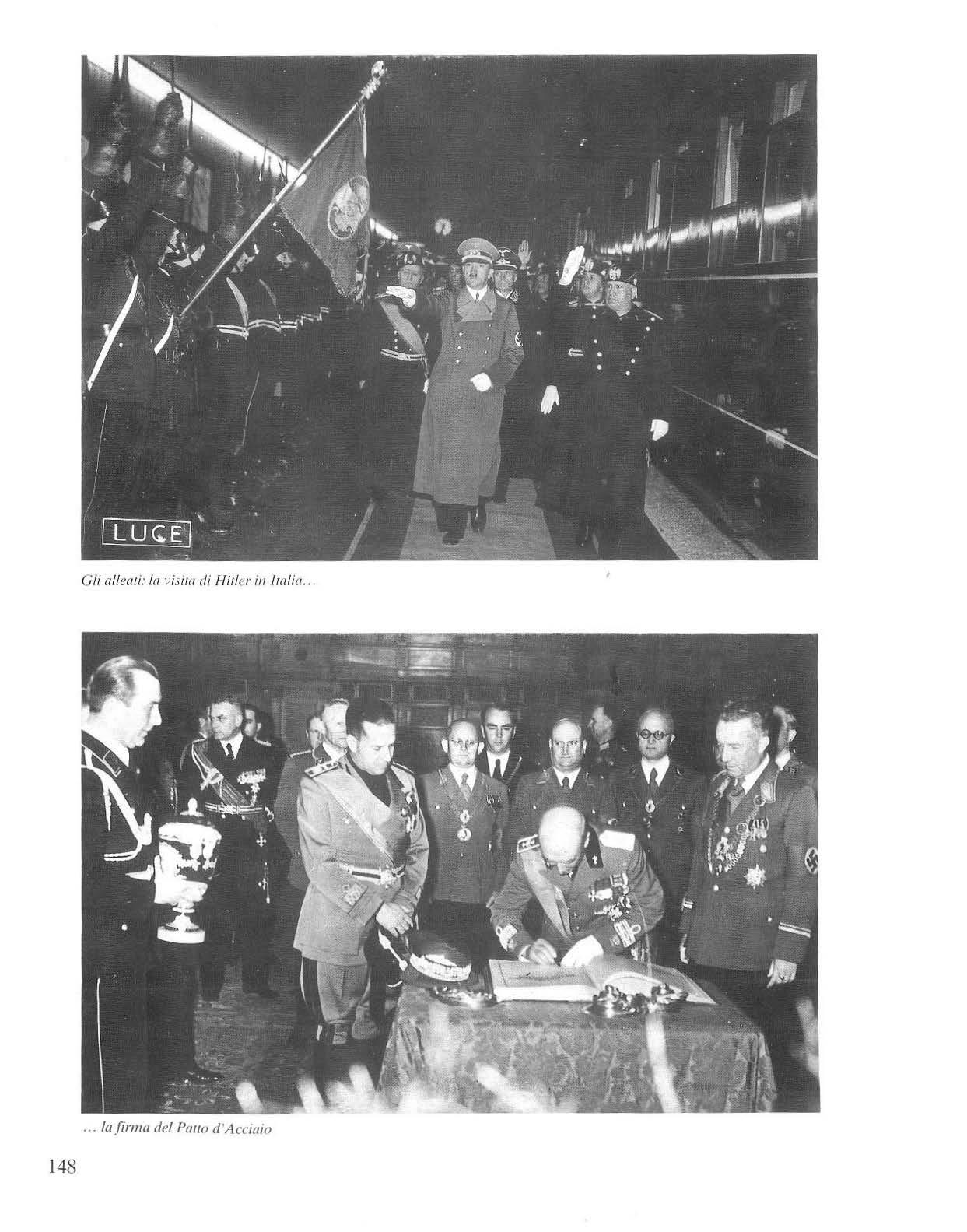 G li a lleali: la visi!a di 1-filler ili 1!alia
G li a lleali: la visi!a di 1-filler ili 1!alia

L e gius fijicaz i oni: fowgra.fia di un o sc hiavo in cepp i in v ia ta alla Cro ce Nossa ad Asmara •
fowgrafin di una fusfign::..ione per /esfùnoninre le barbarie abissine
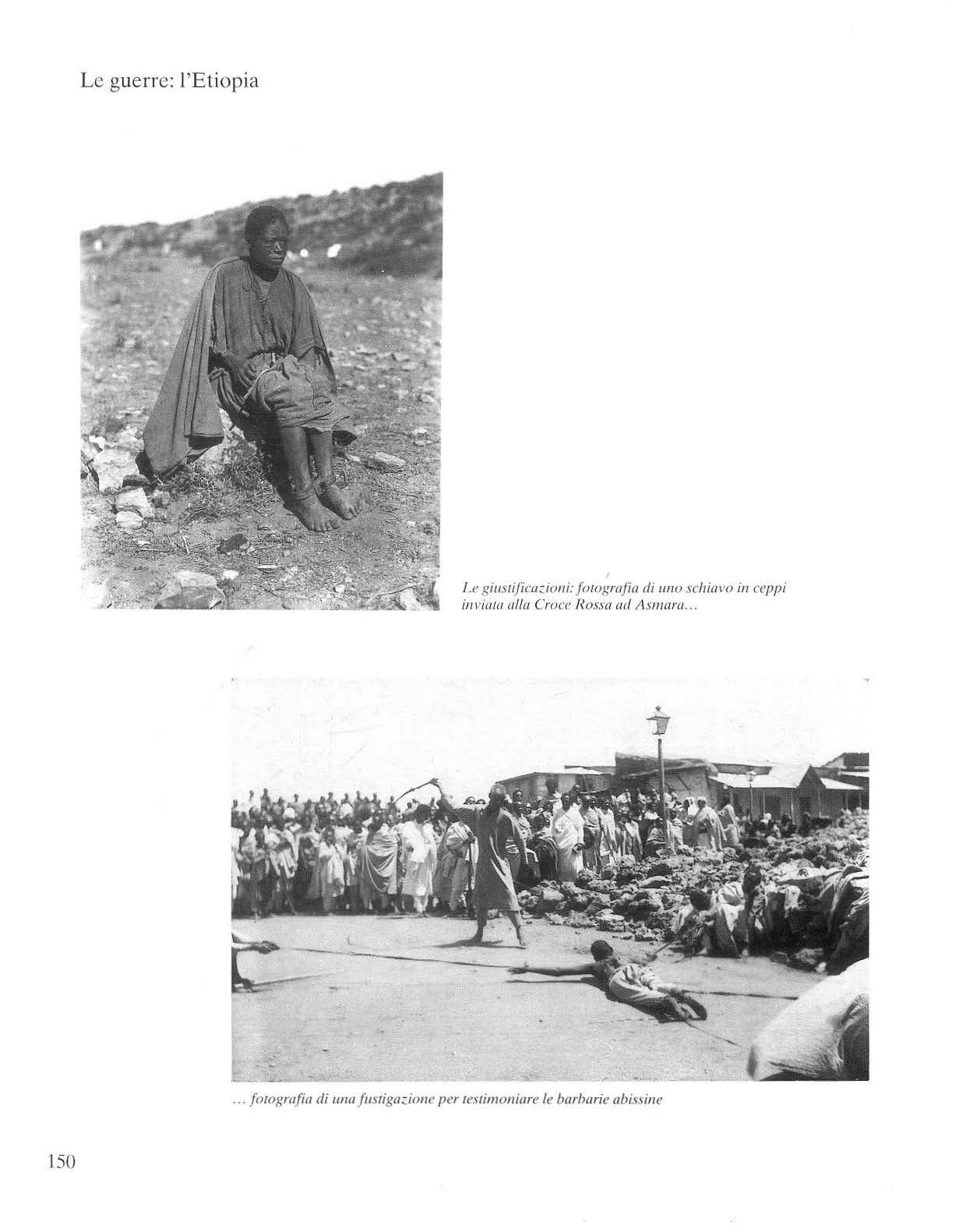
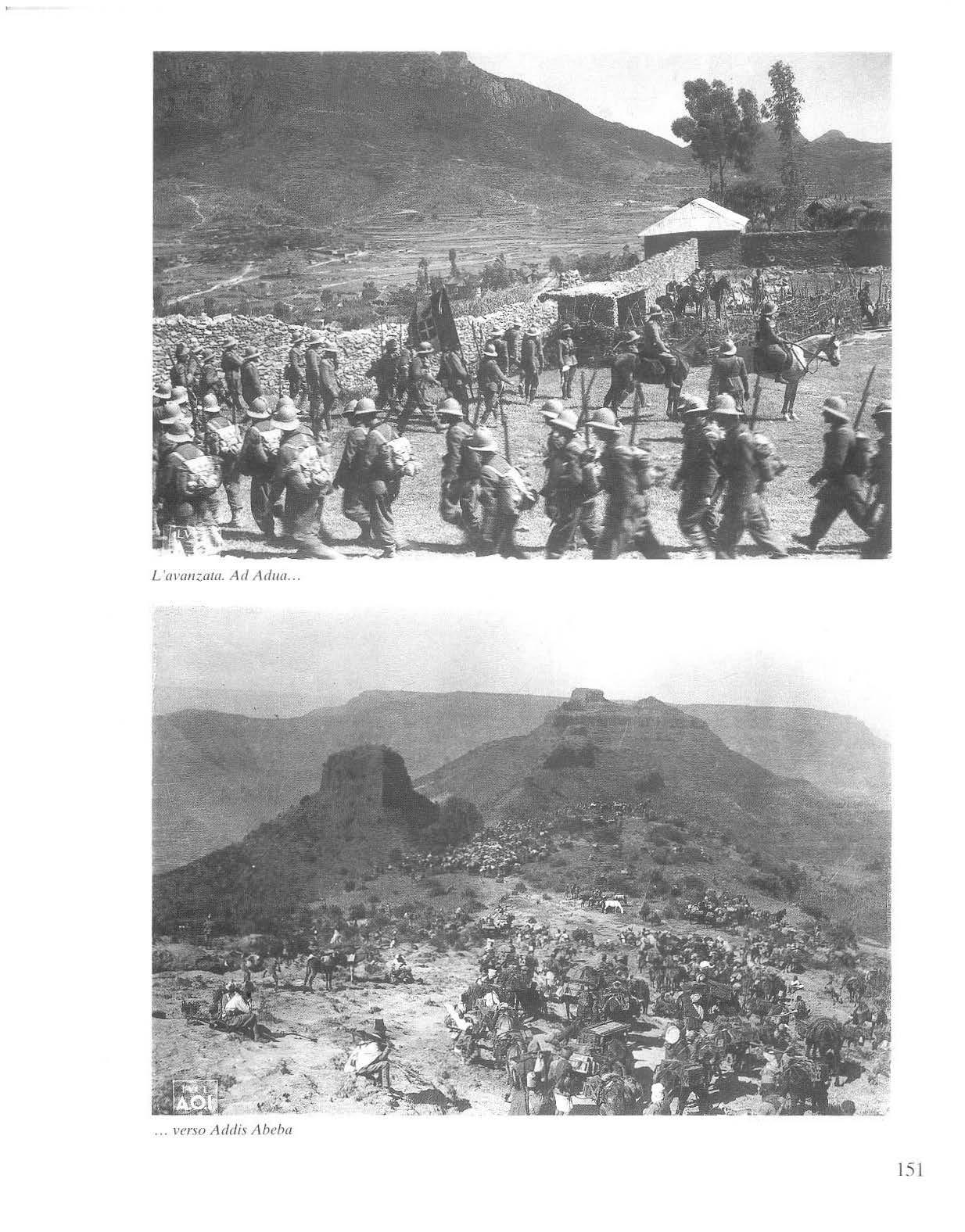
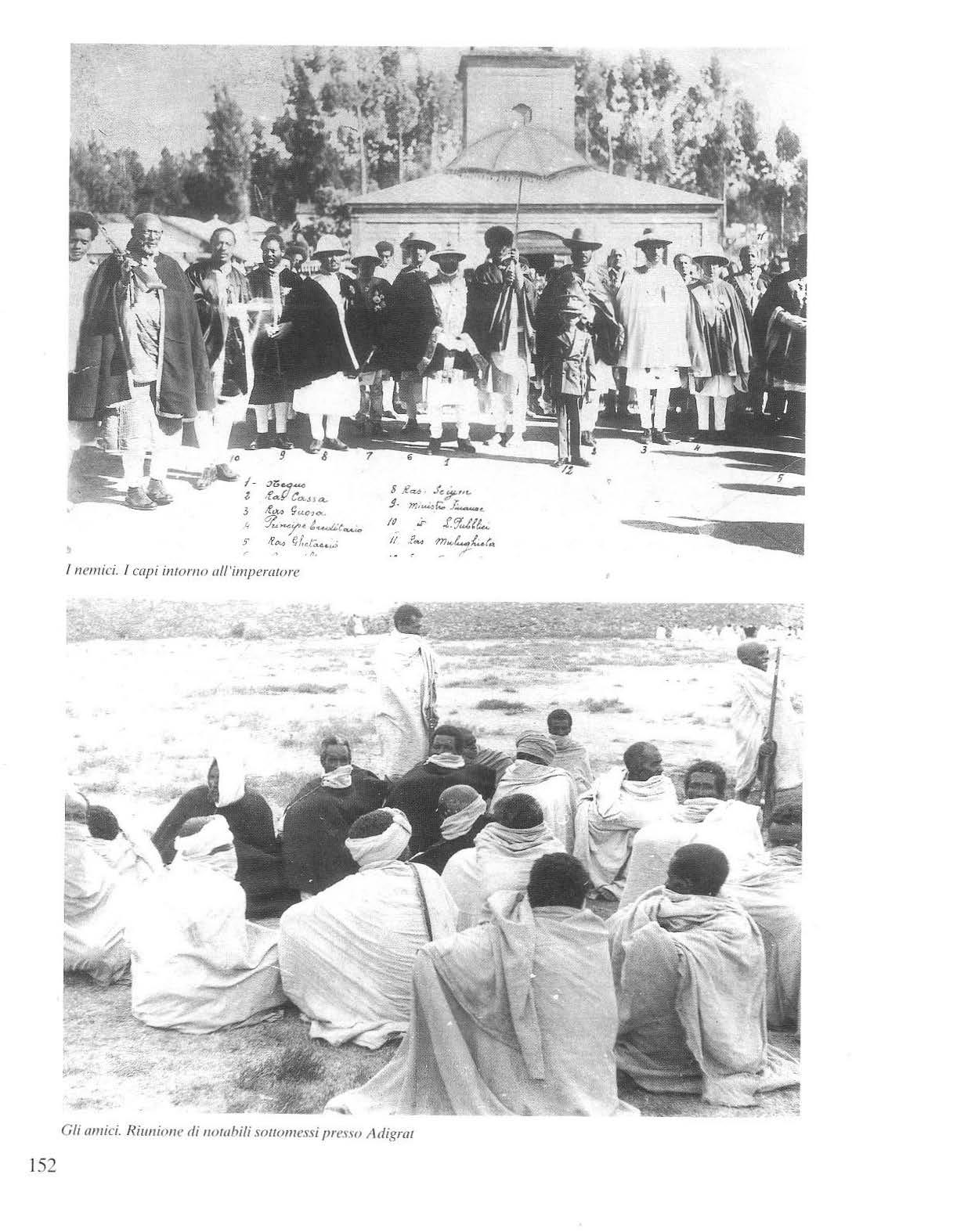
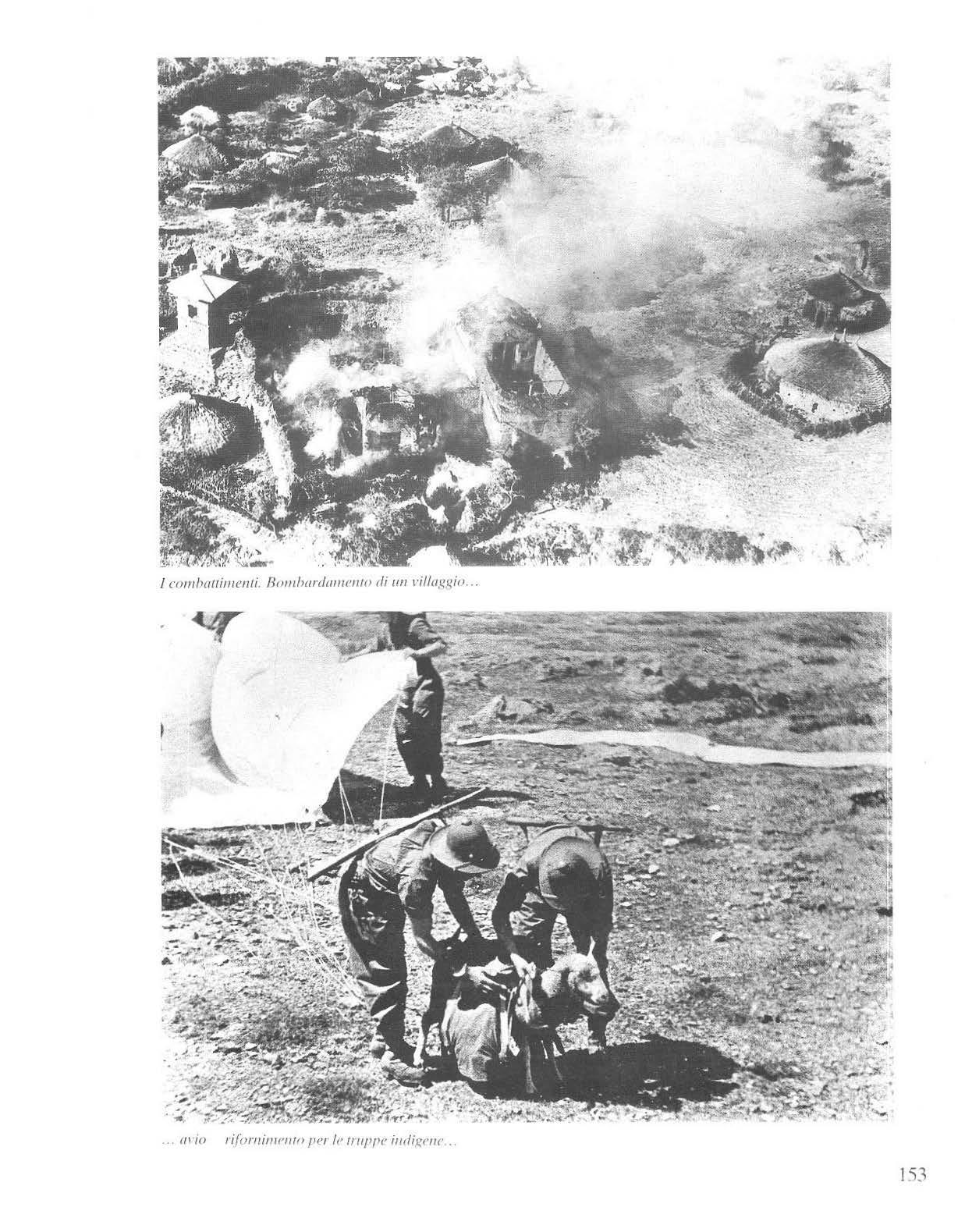

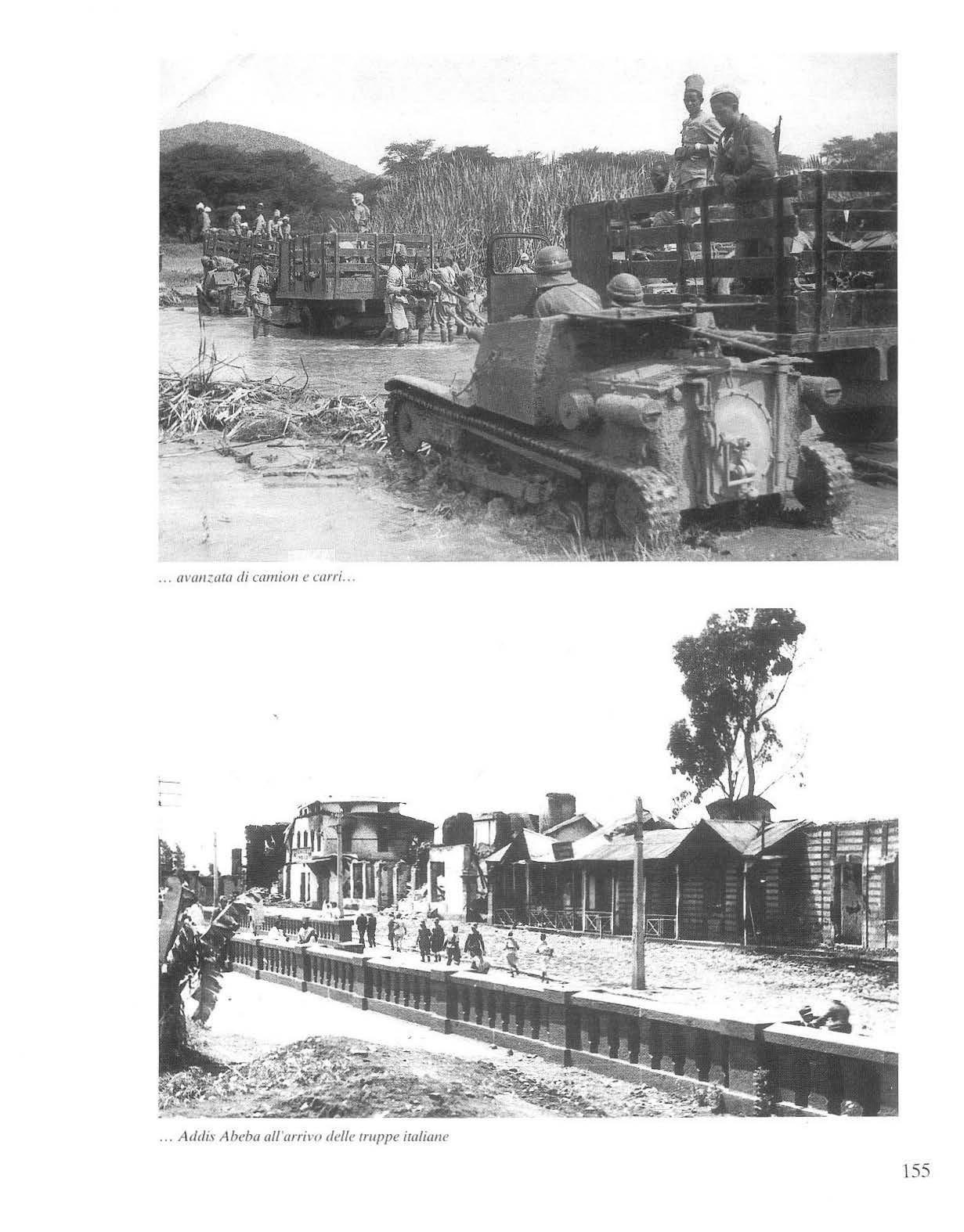 Gl't.lll:ara di camion c carri
...
Gl't.lll:ara di camion c carri
...
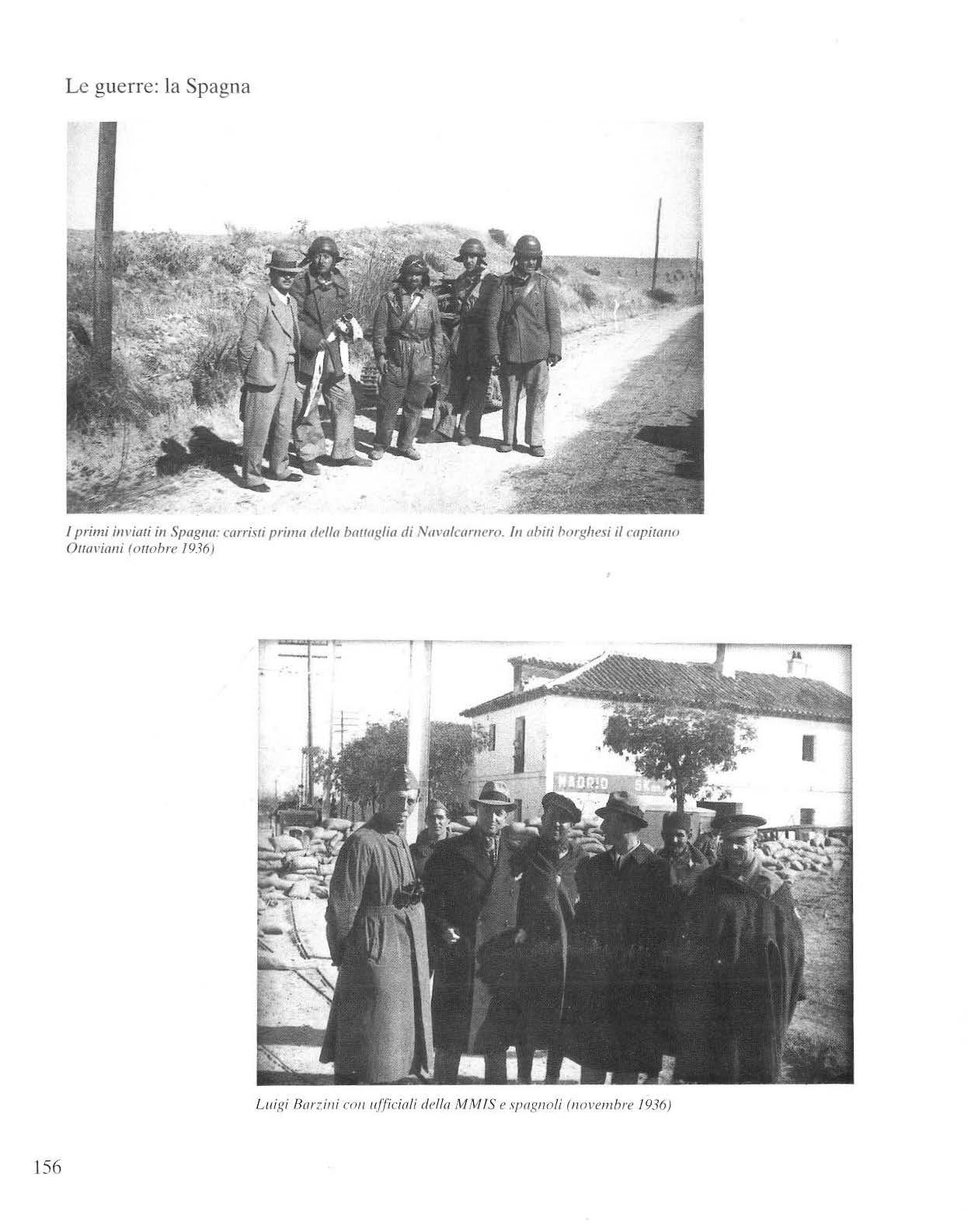
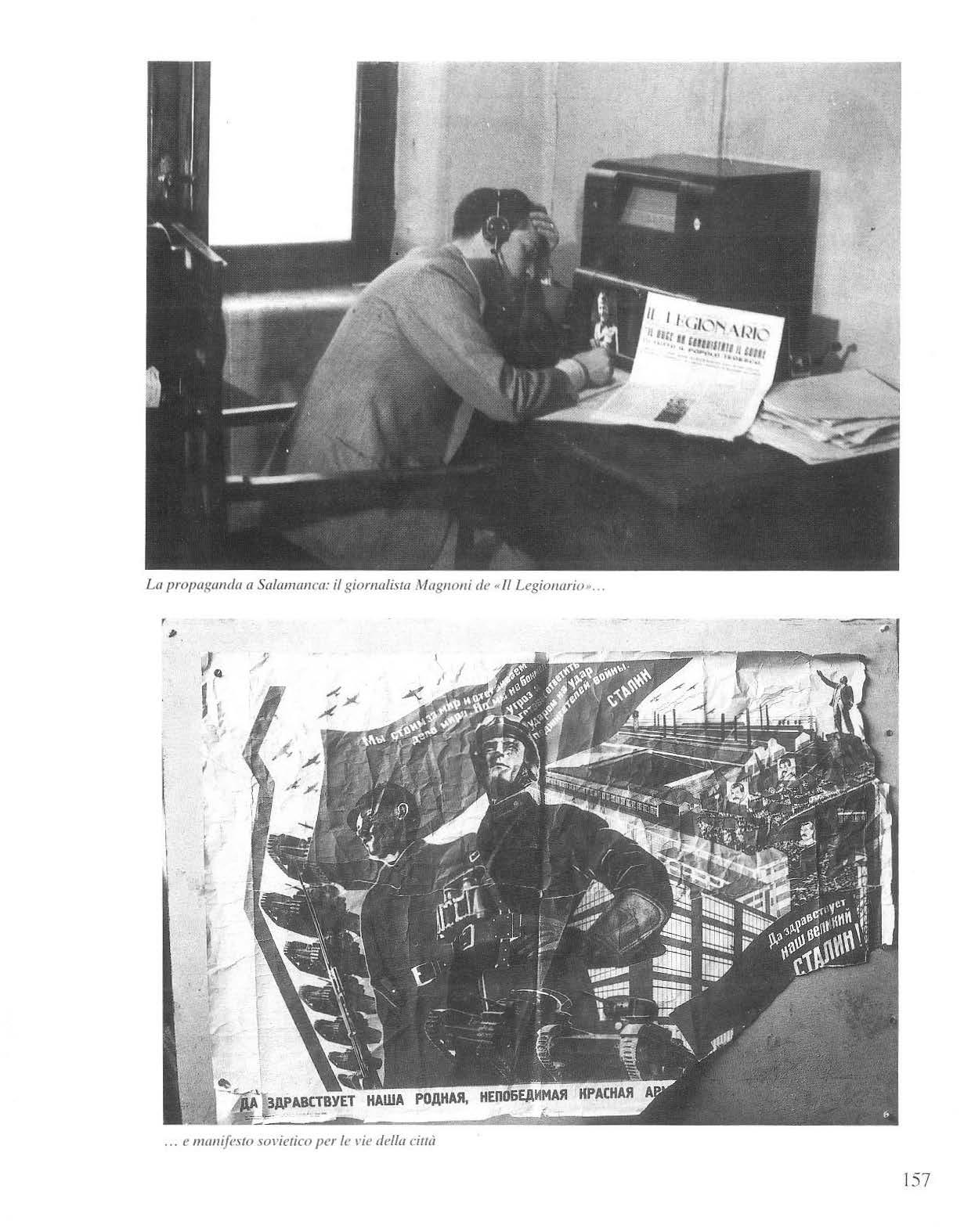
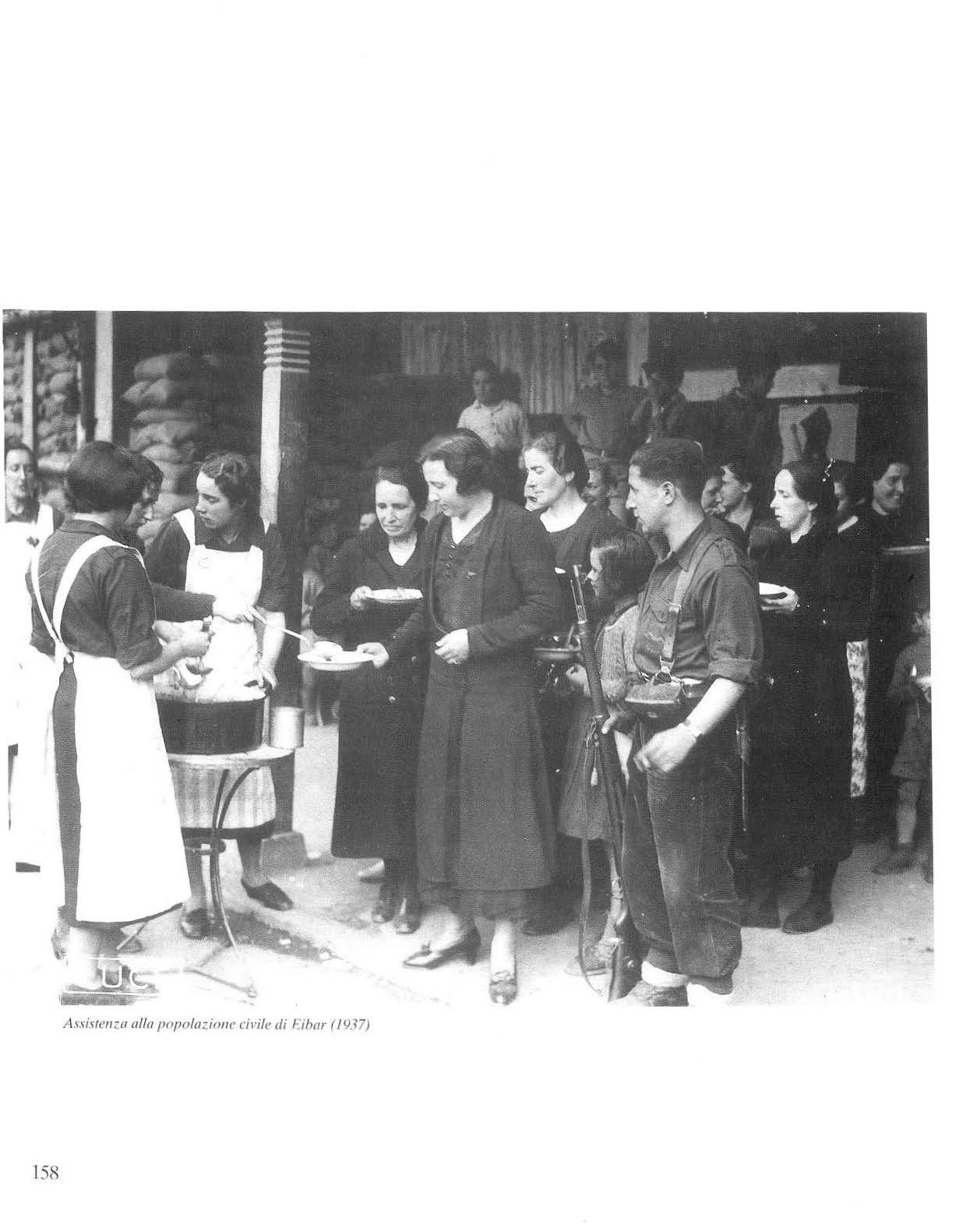
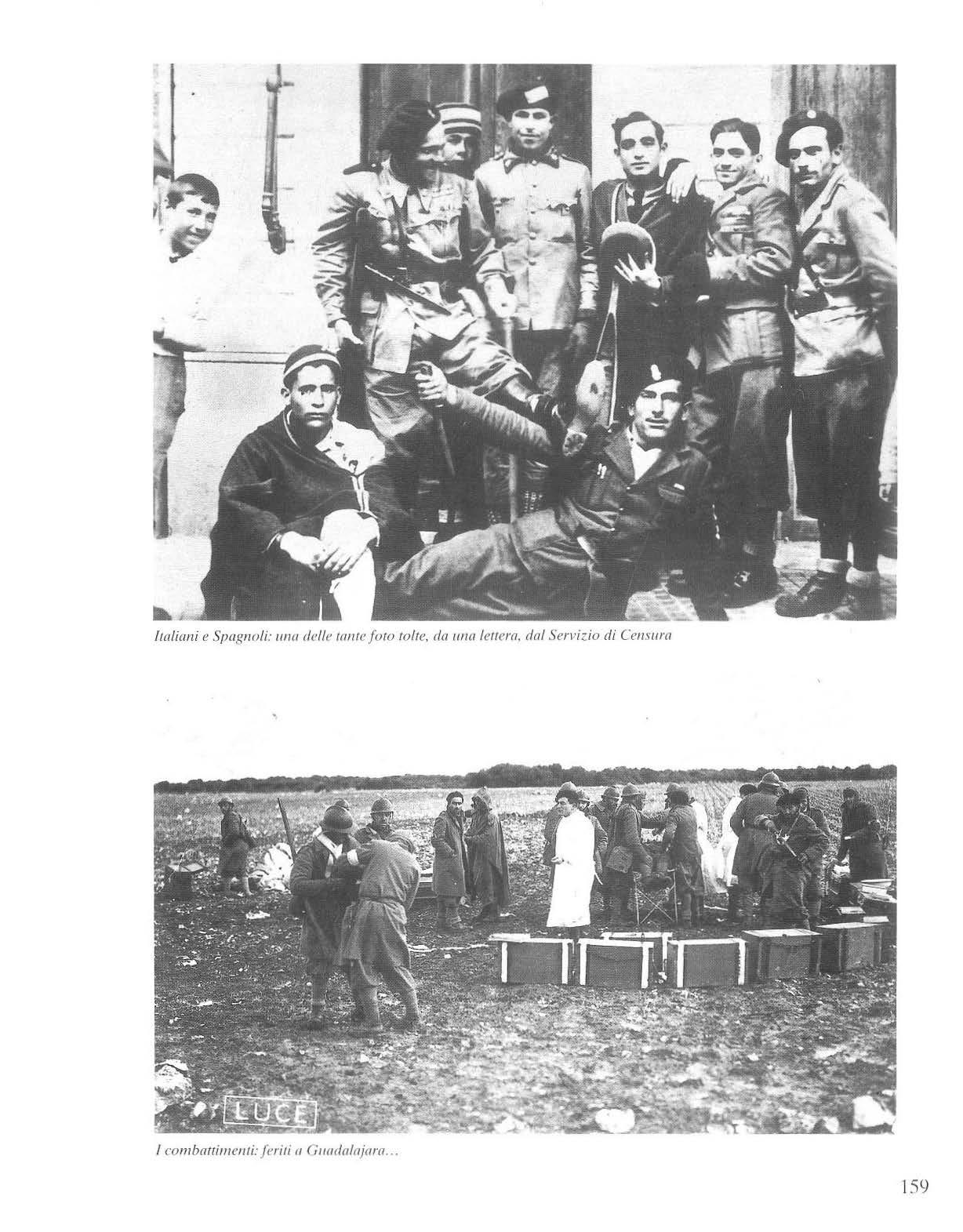 lwliani e Spagnoli: ww delle tante foto tolte, da 1111a letr em. dal Servizio di Cens11ra
lwliani e Spagnoli: ww delle tante foto tolte, da 1111a letr em. dal Servizio di Cens11ra
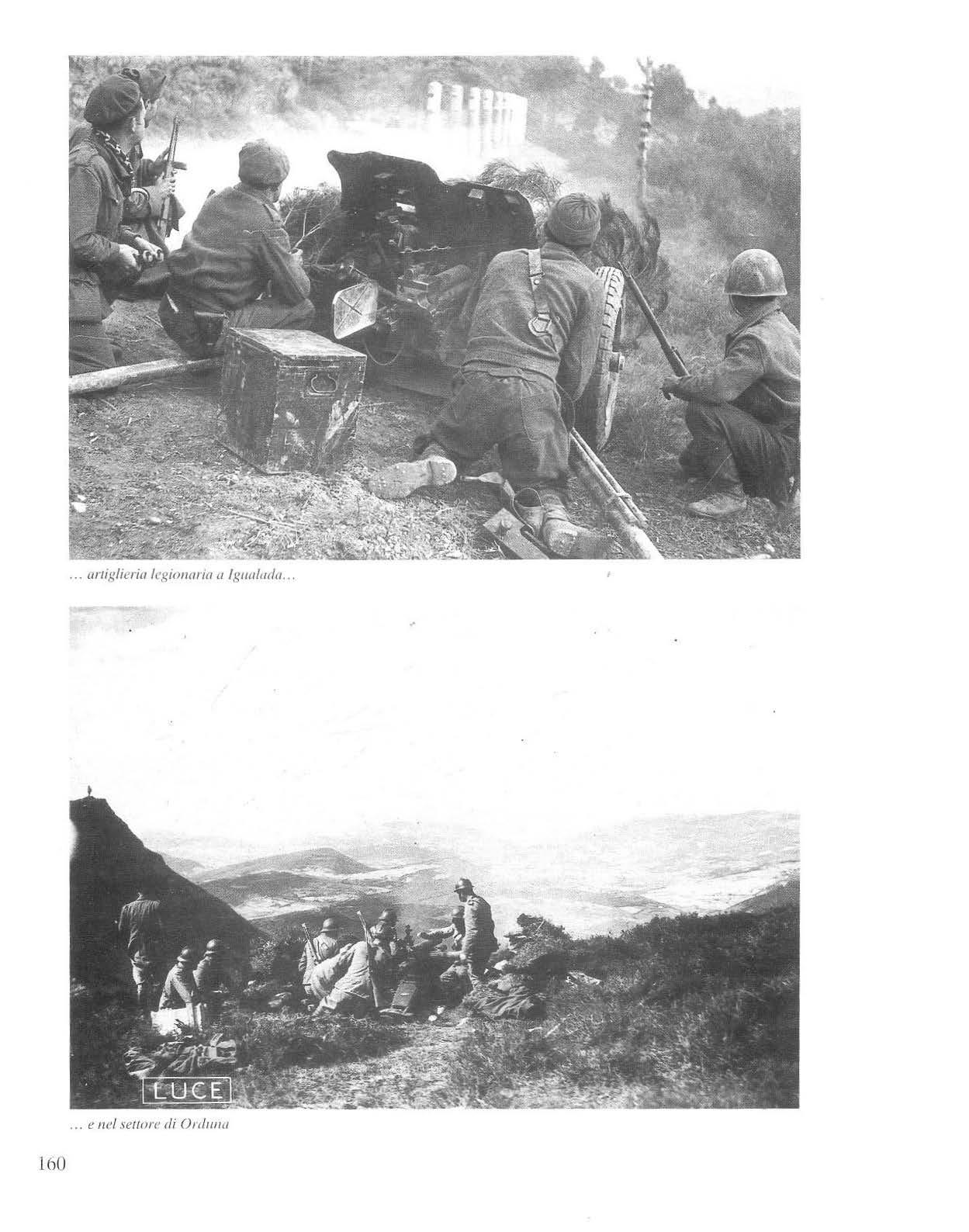
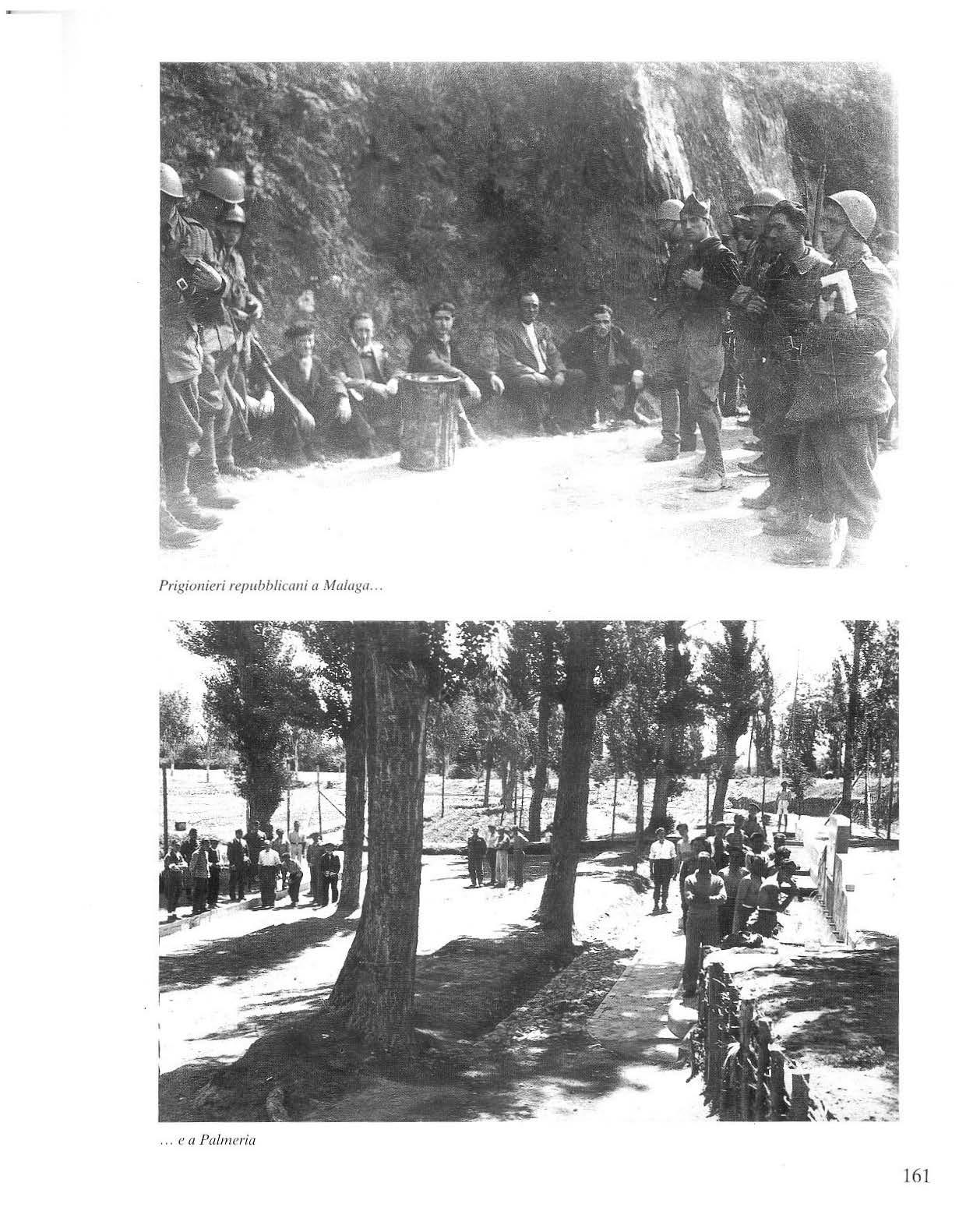
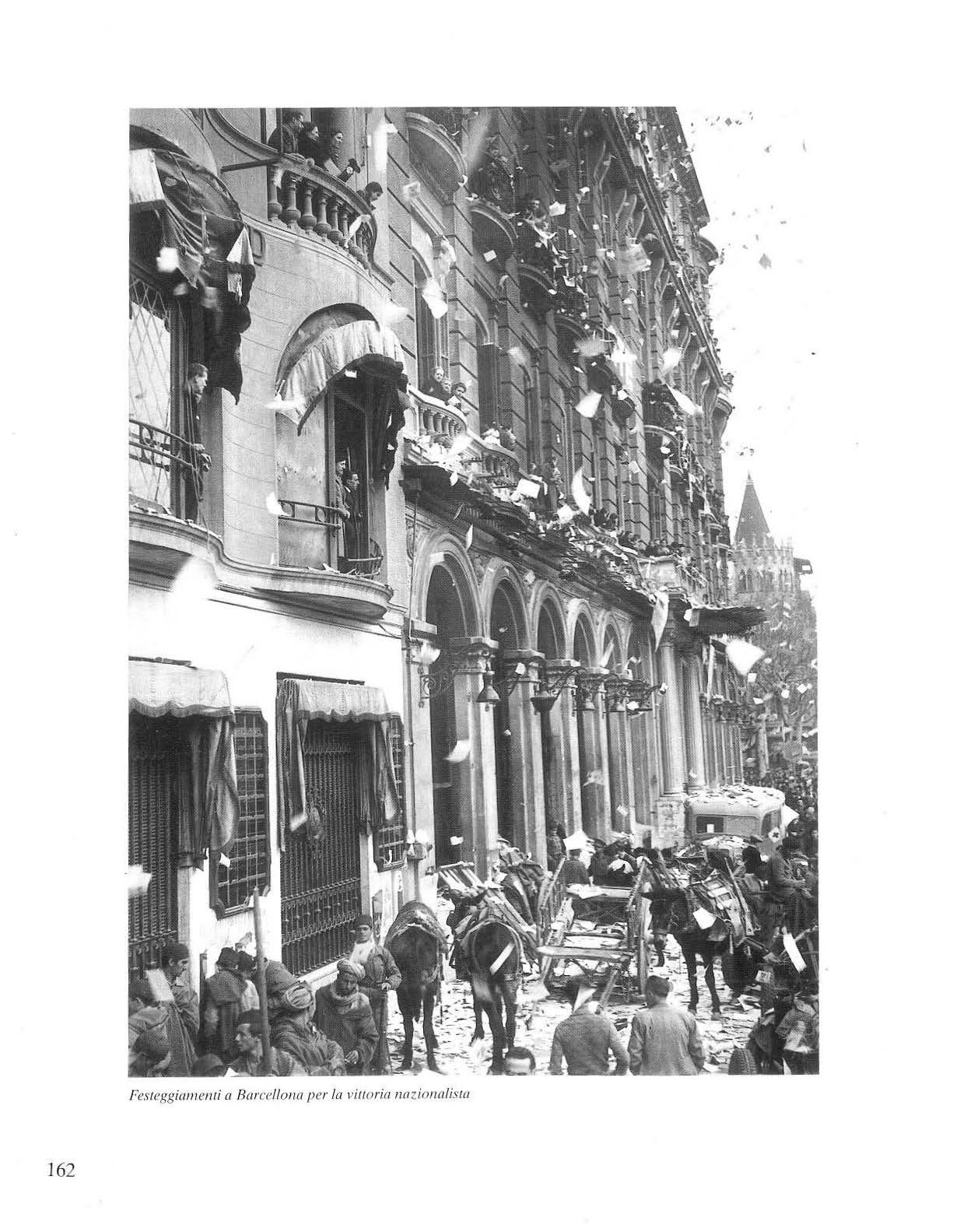
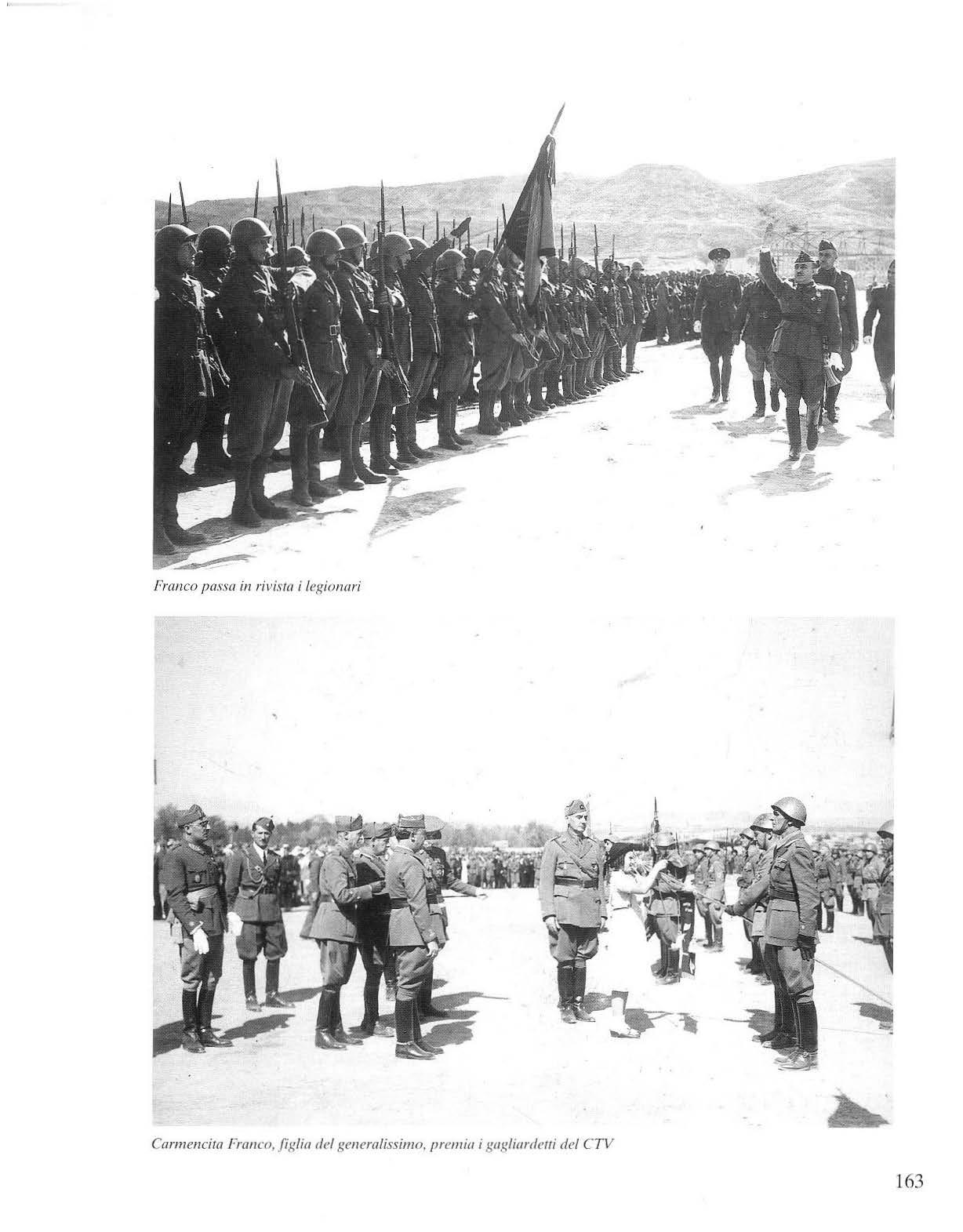 Franco passa in rivistn i le;: ionari
Franco passa in rivistn i le;: ionari
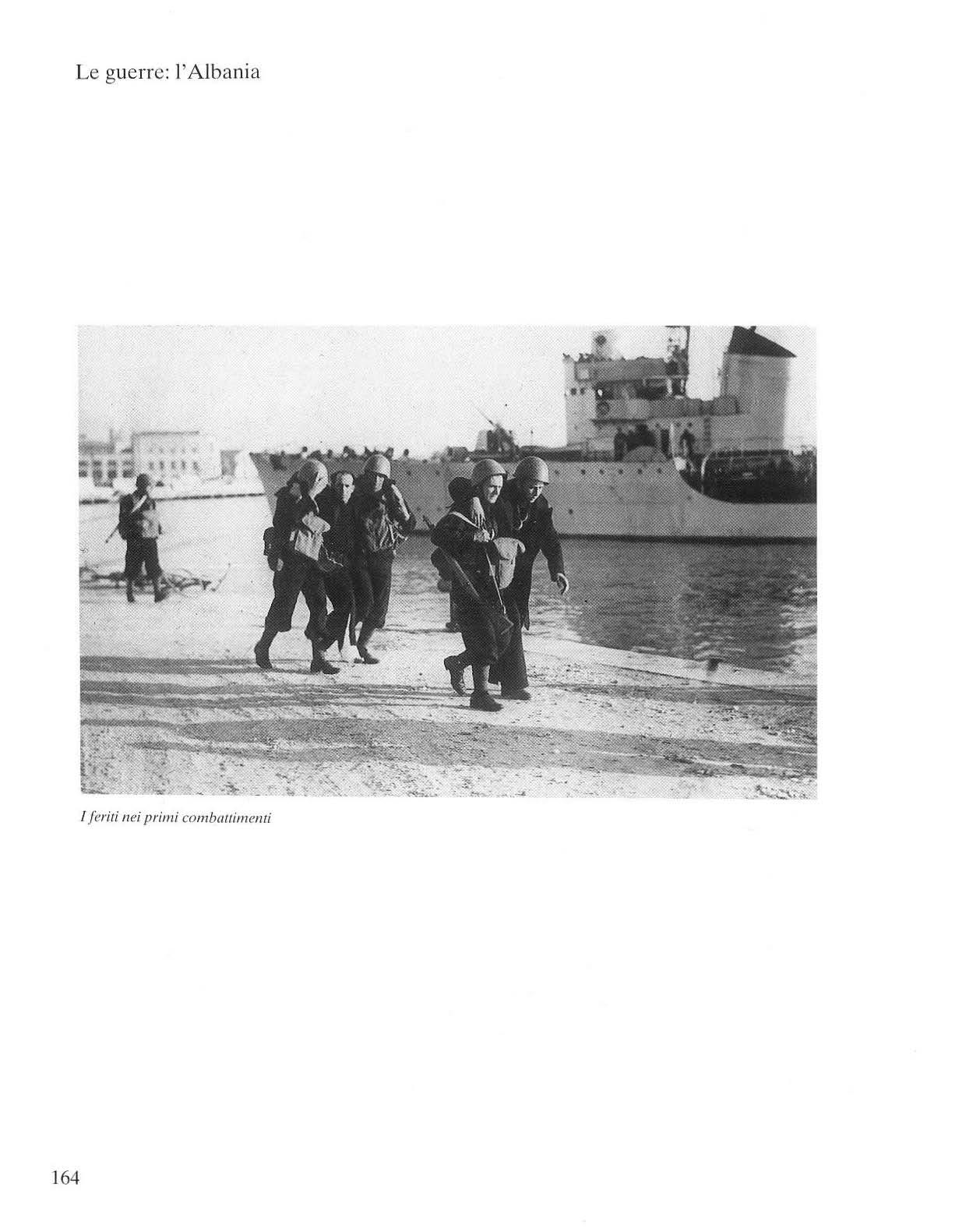
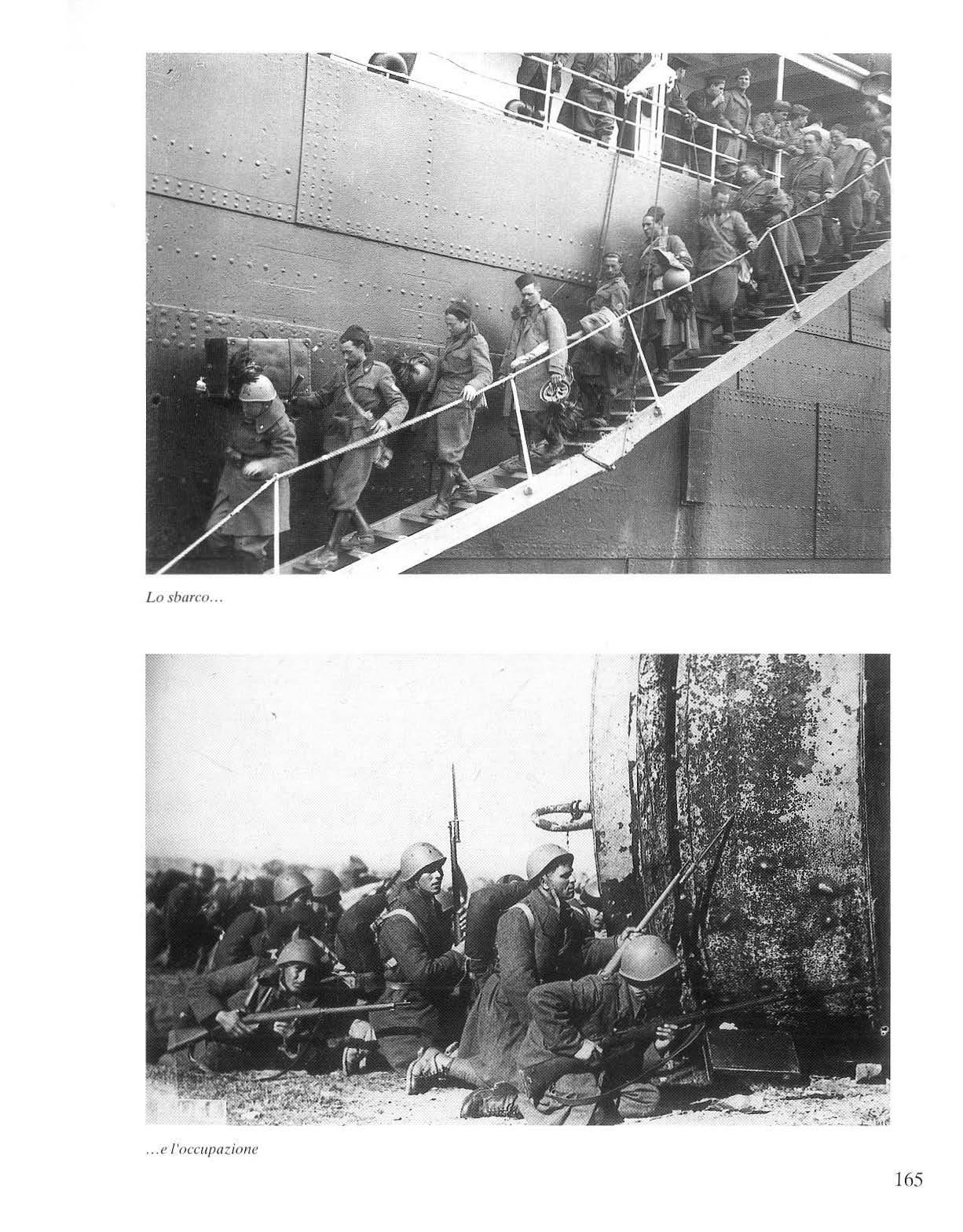
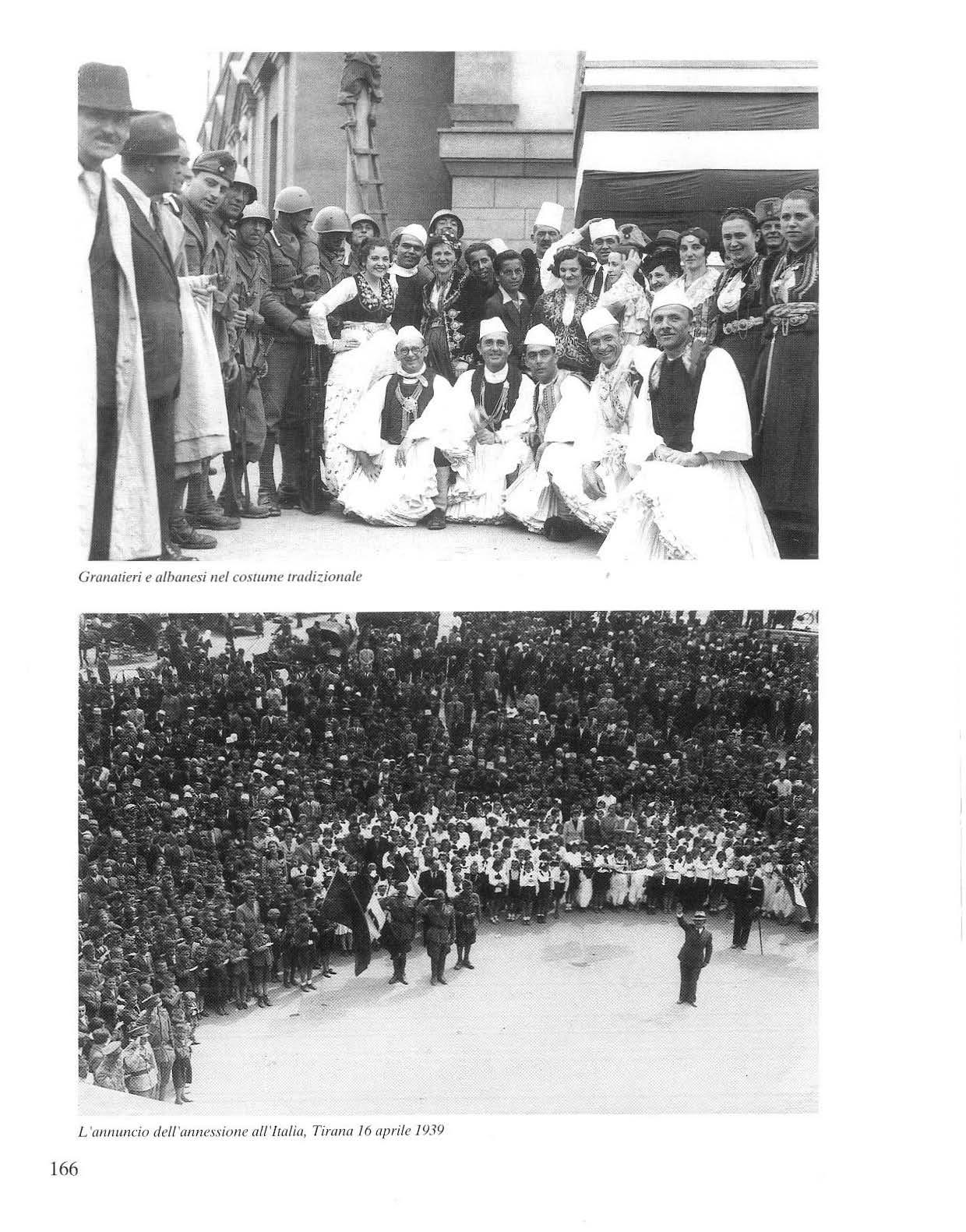 Granatieri e albanesi nel cos tu me tradi::.ionale
Granatieri e albanesi nel cos tu me tradi::.ionale
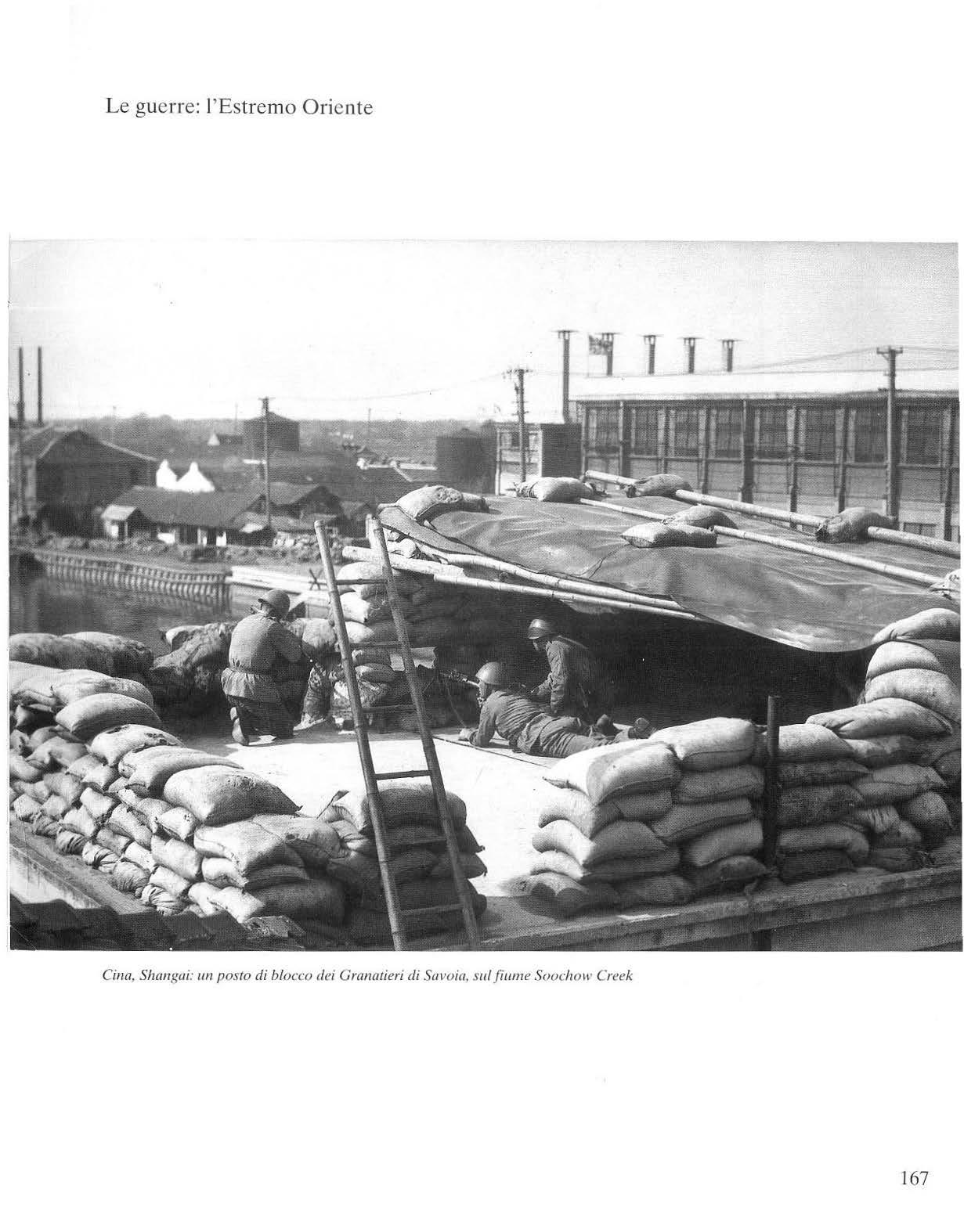 Le gu erre: l' Estremo Ori e nte
Le gu erre: l' Estremo Ori e nte
n a/la Spagna: Le}{ionari d el CTV in t'rasj enmt::'" "
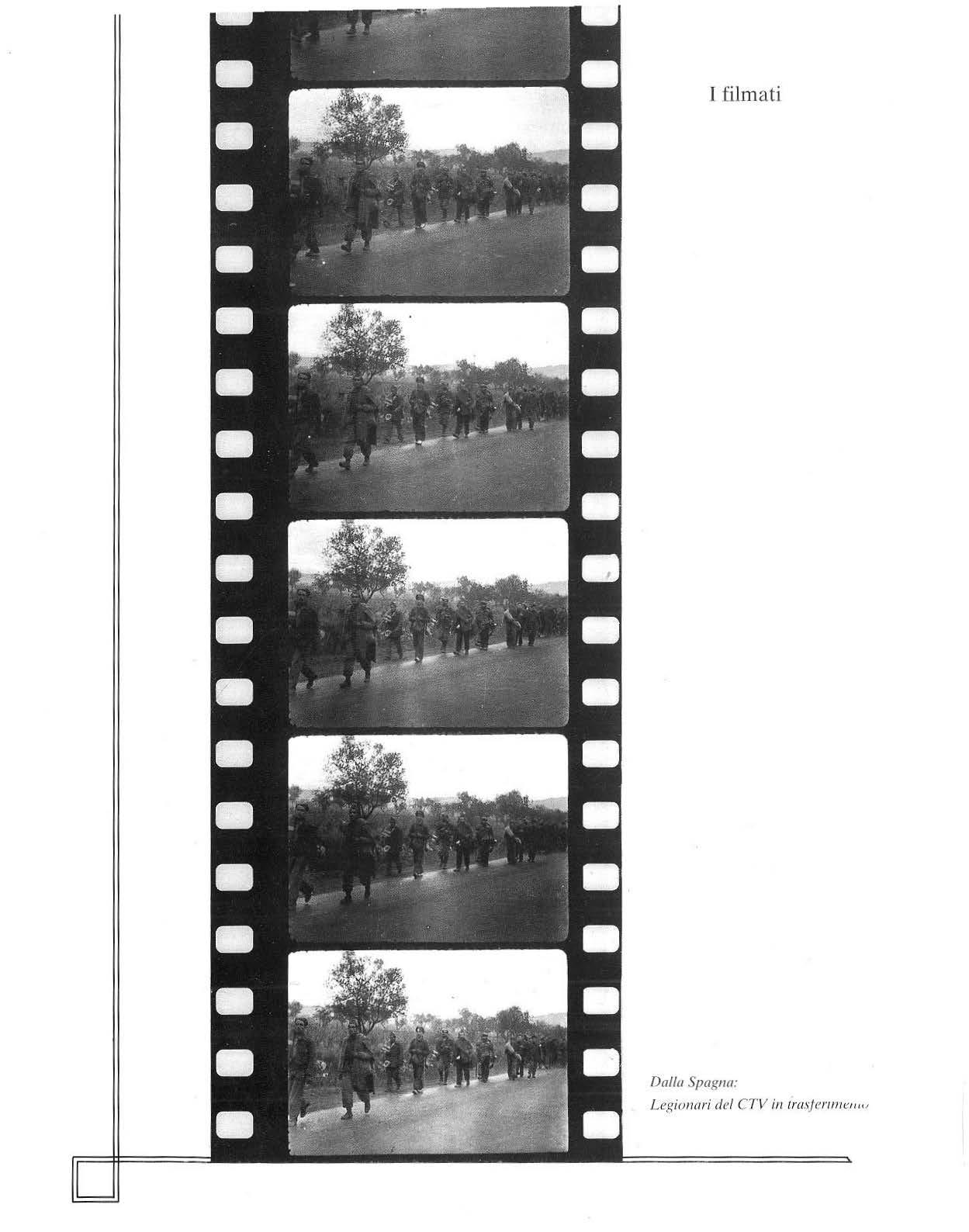
Incontri p er le c ittà lib erate
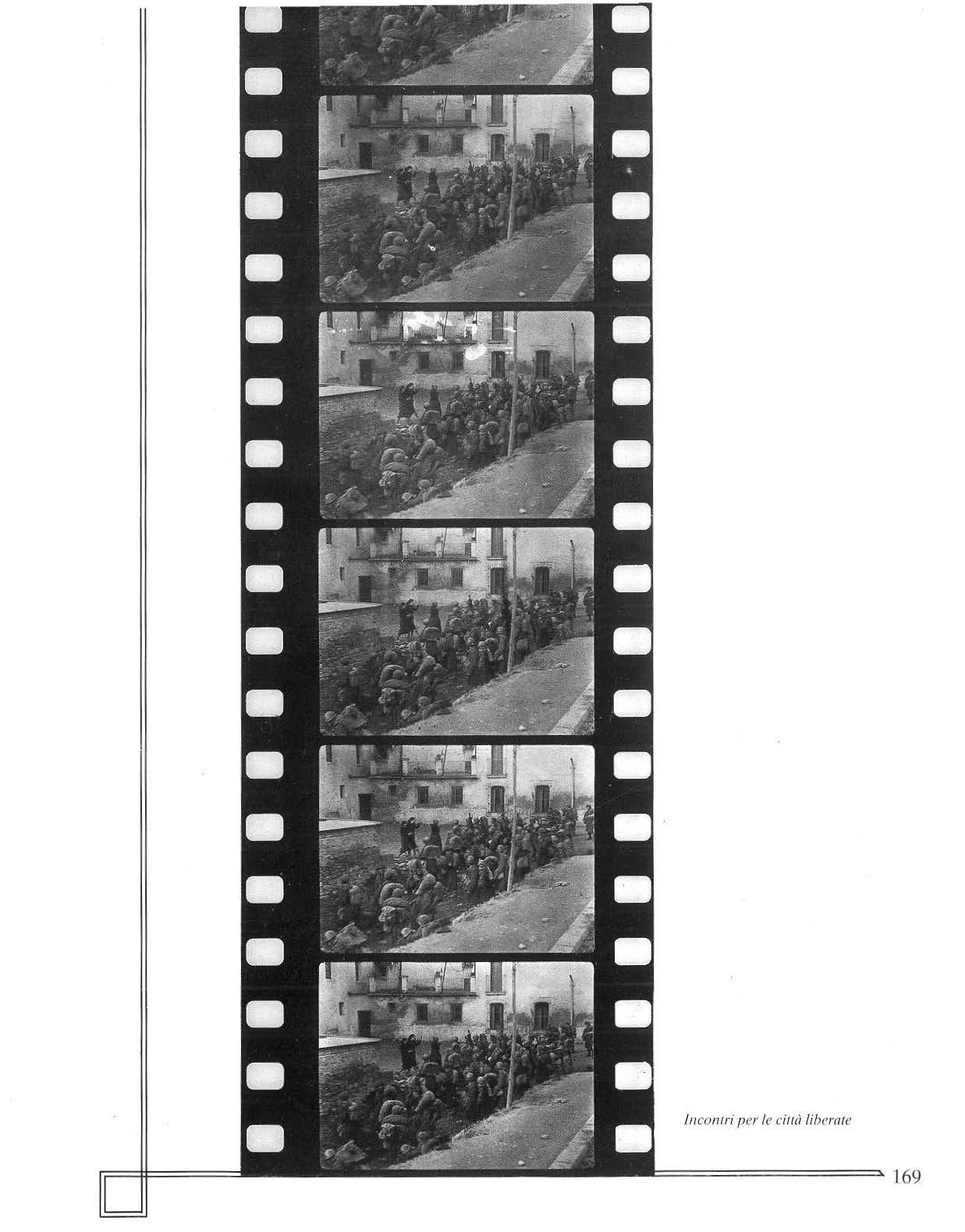
Esulta11za della p opo lazione spagnola
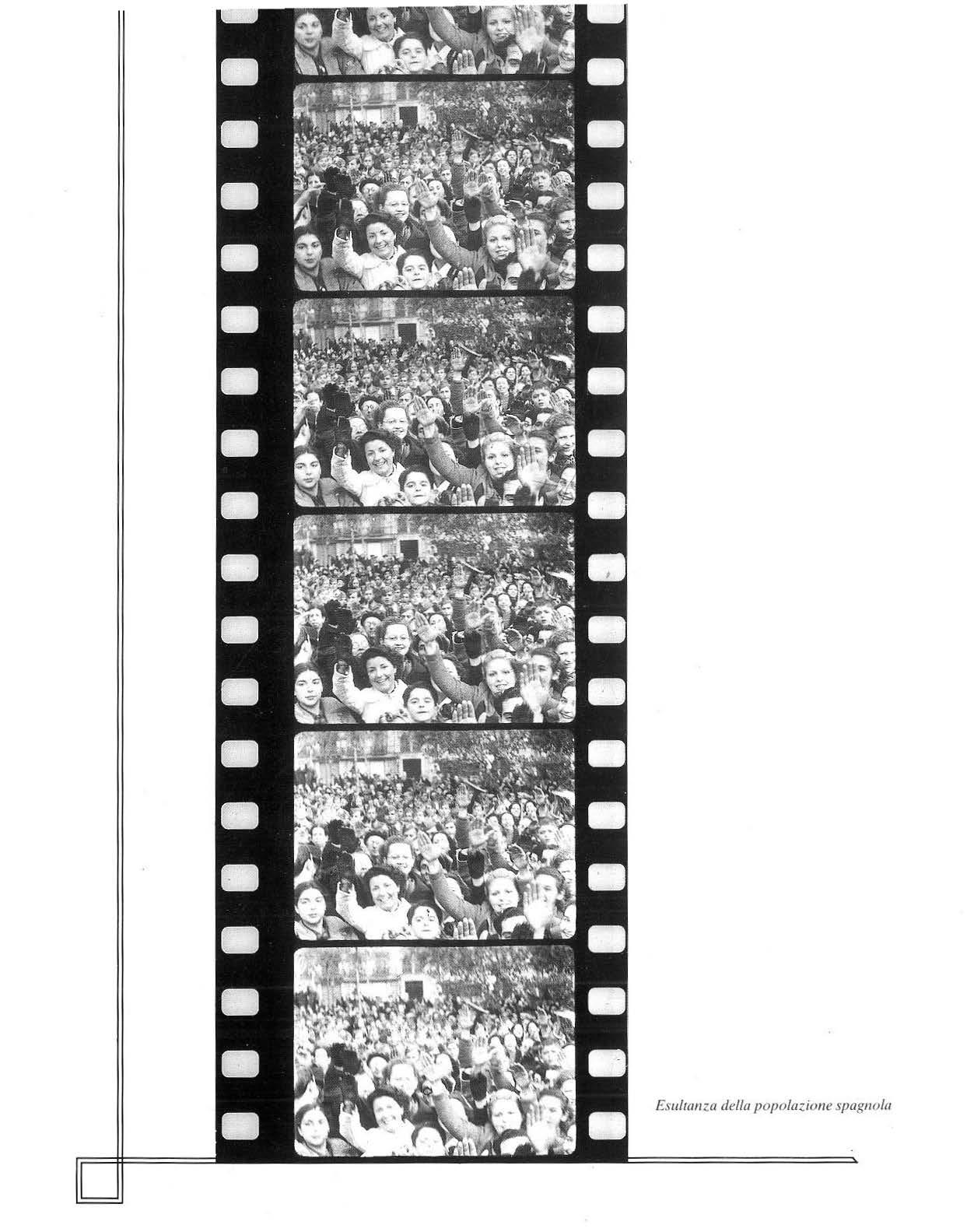
Le rovin e della guerra
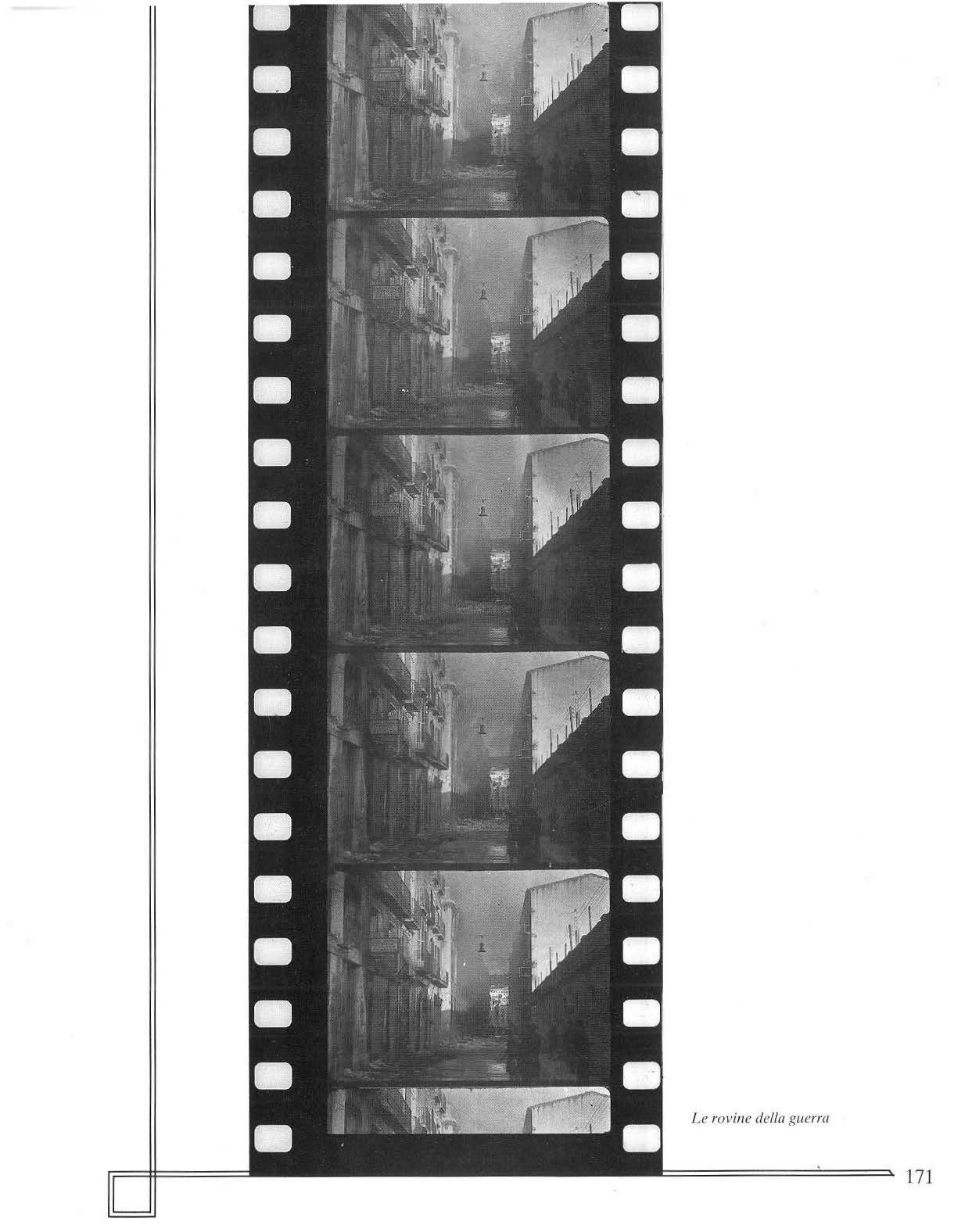
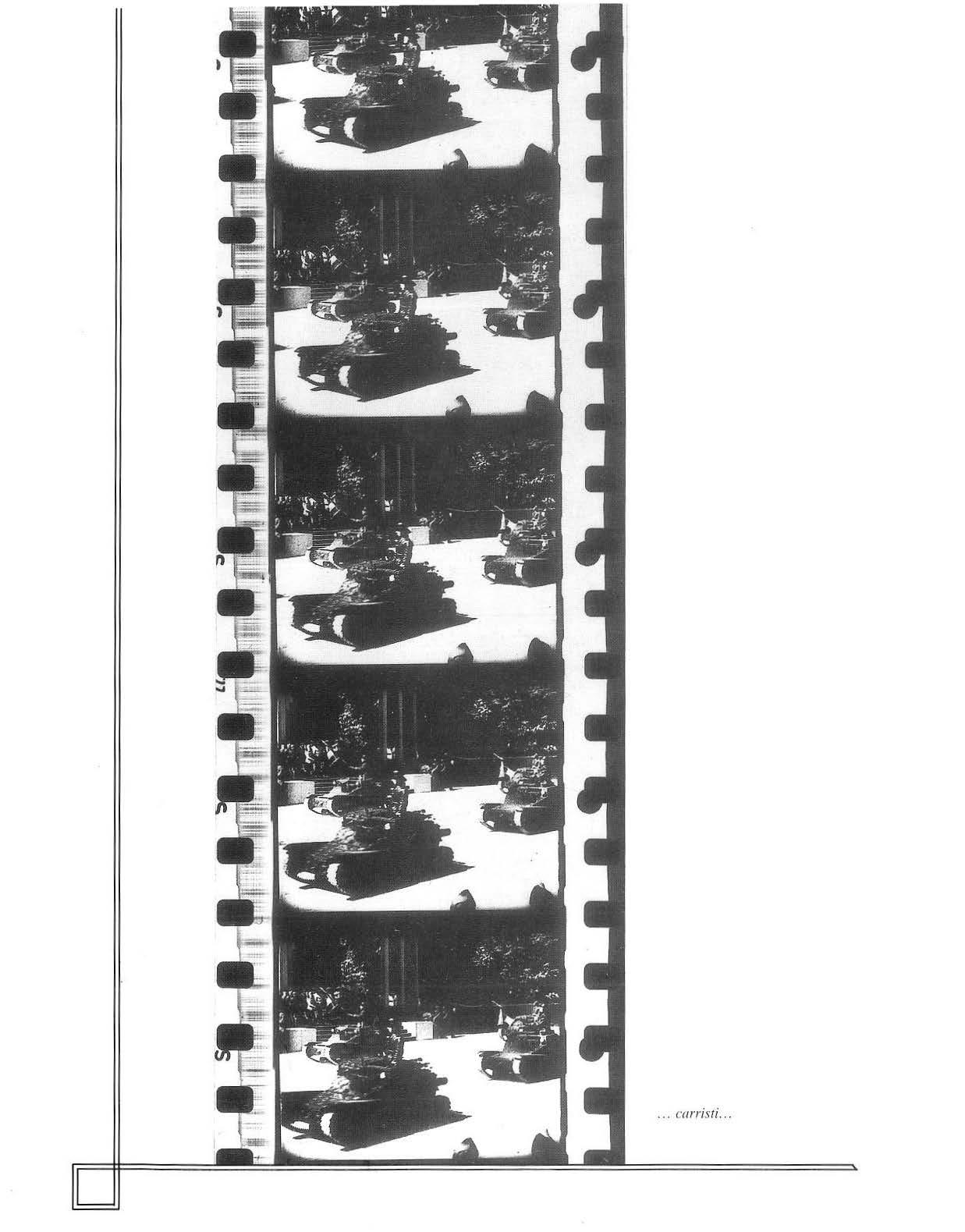
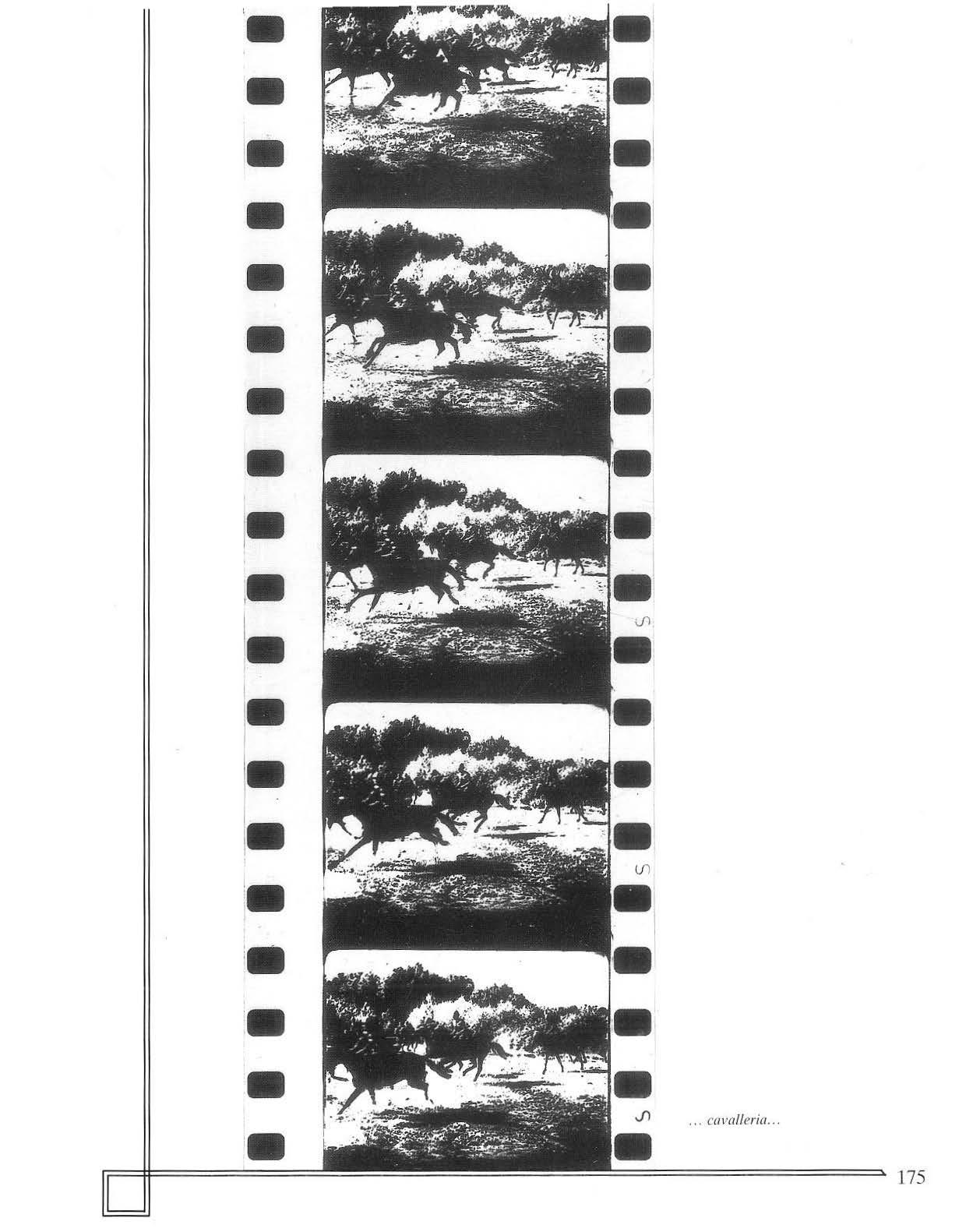
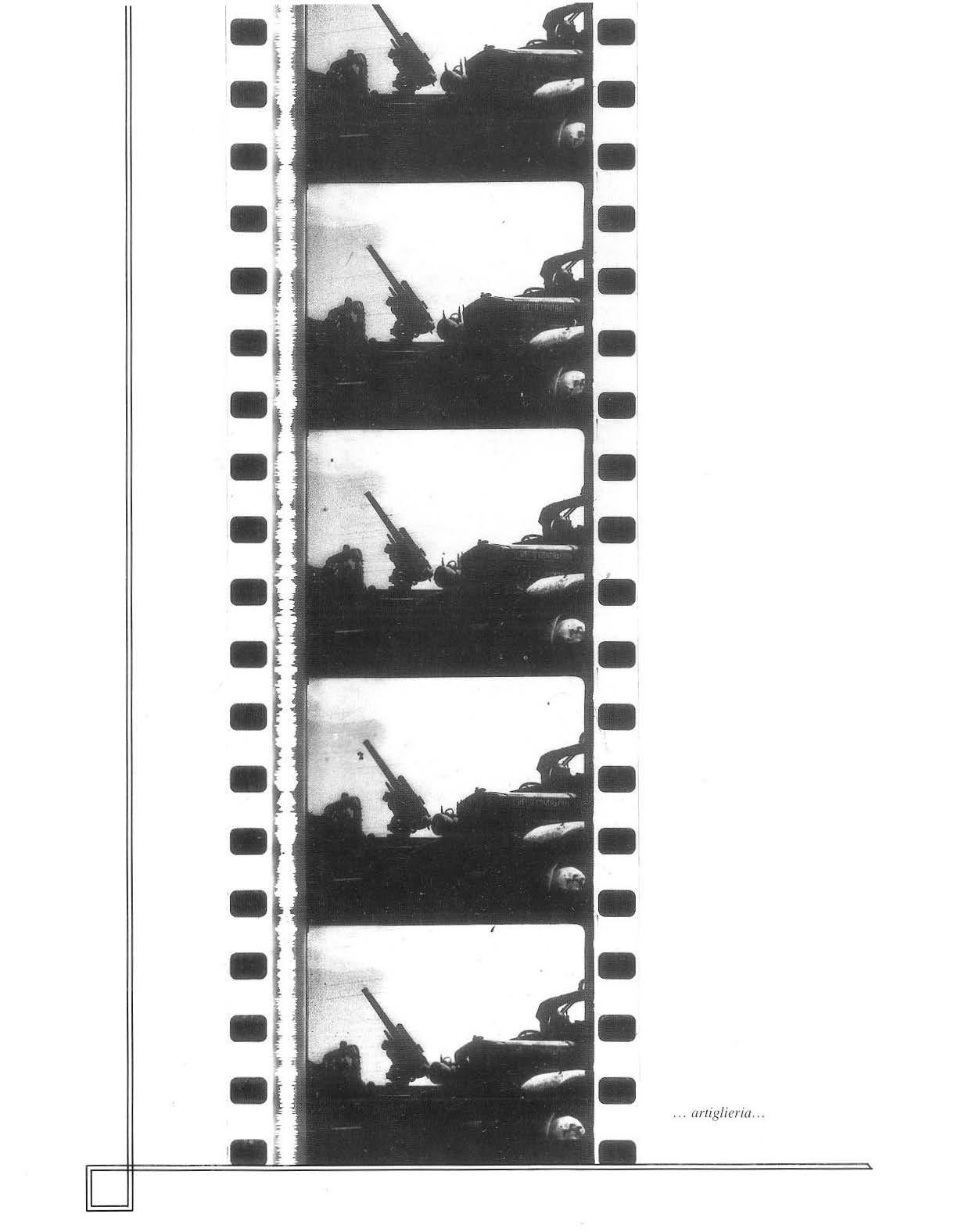
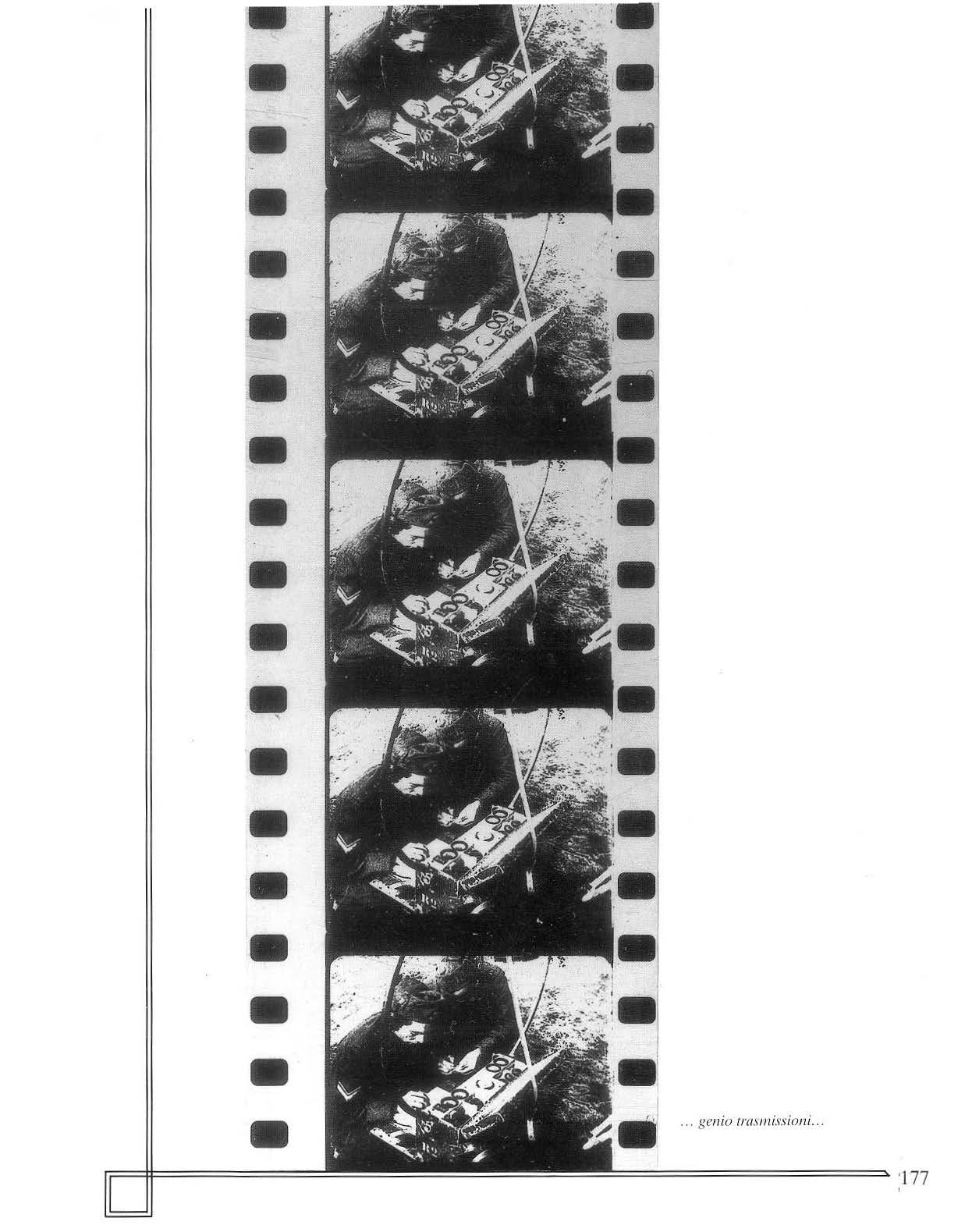
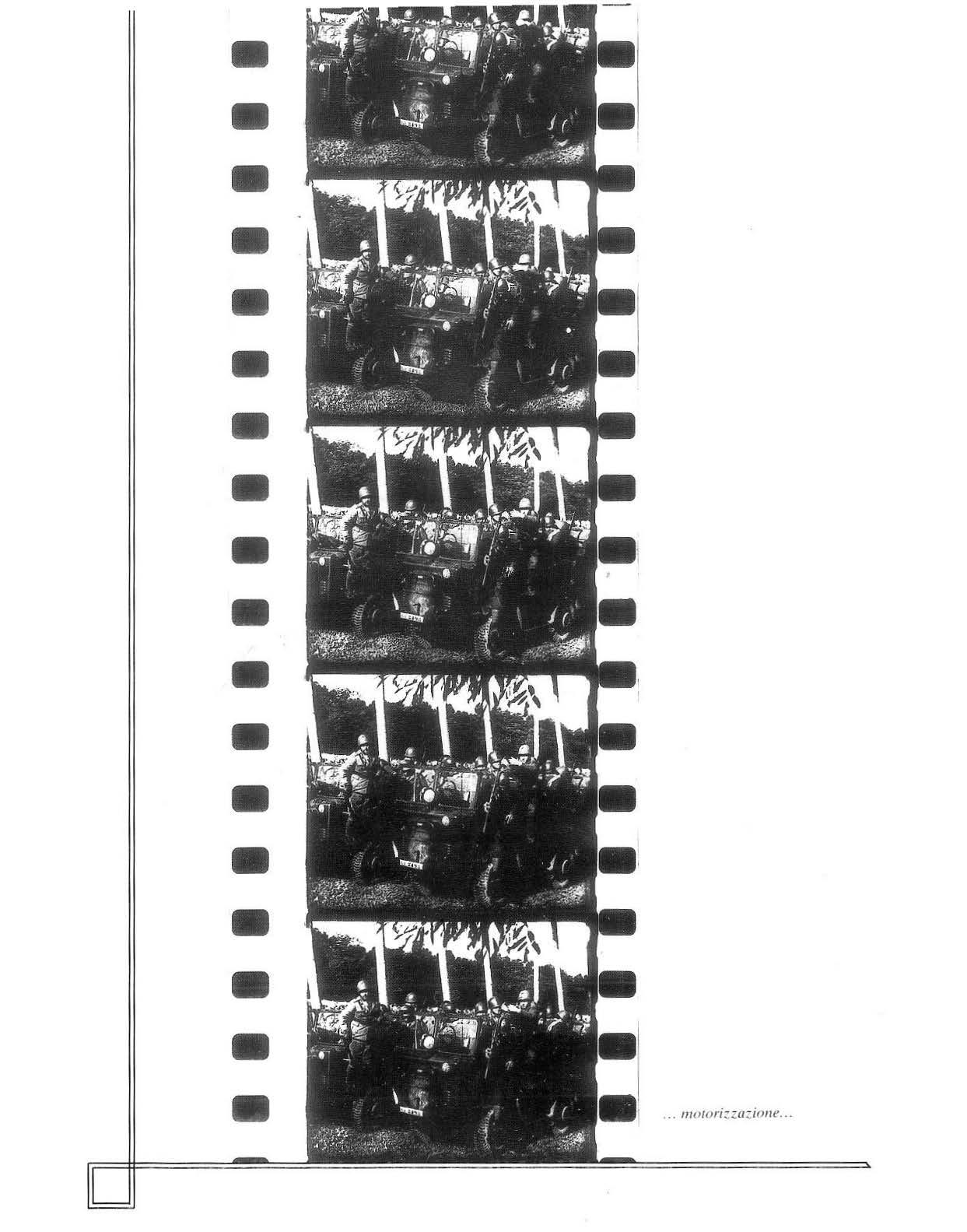
i nuovi acquisti: la G uardia R eale Alban es e
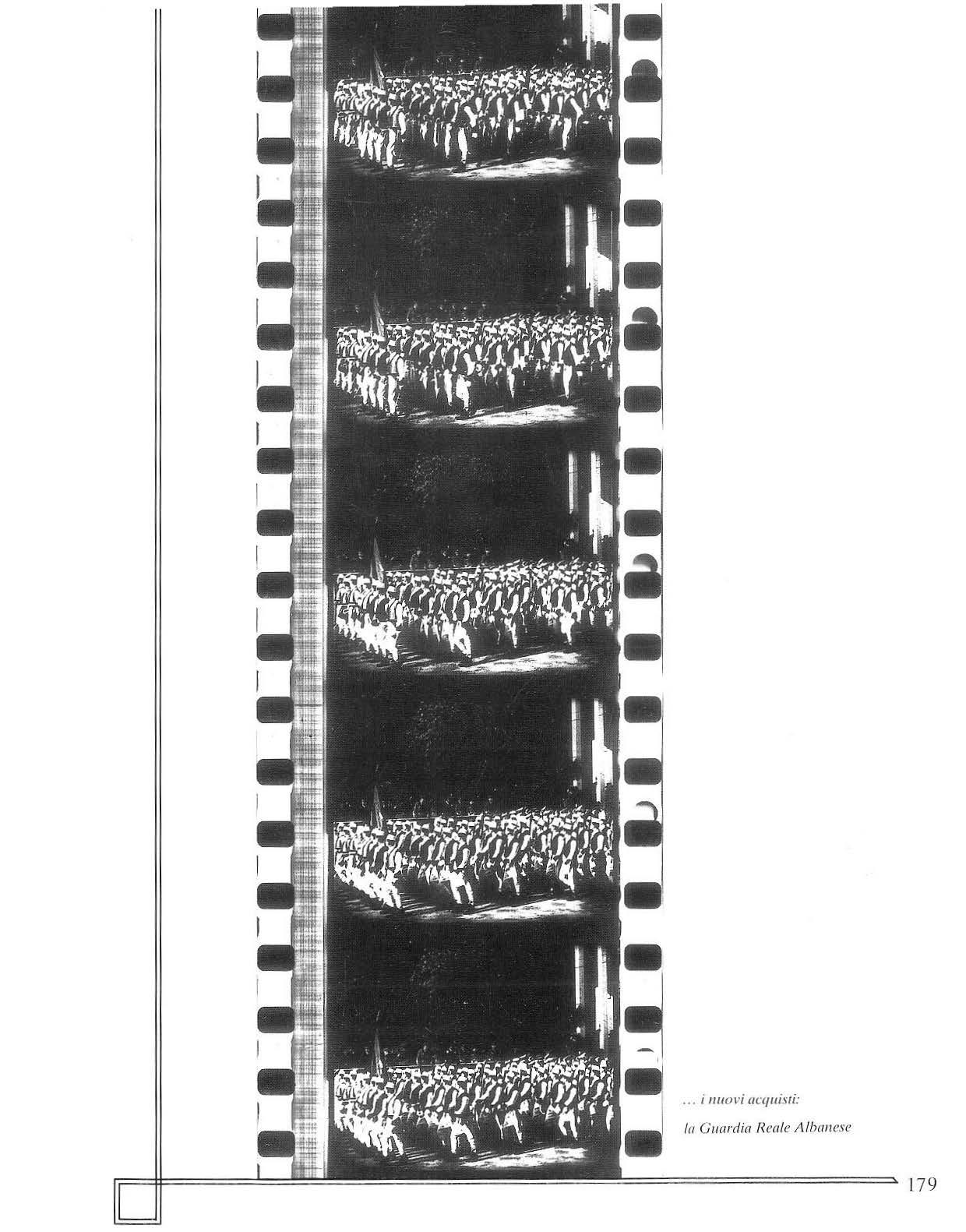



6 ottobre 1924 la gracchia nte voce della radio in co min ciò ad ent rare nelle case degli italiani; i programmi erano diffusi da una stazione insta llata a Roma , di proprietà eli un consorzio, l'Un ione Radi ofonica ftaliana (U .R .I.). Benché il fascismo non avesse sub i to rece pito l ' importanza di un tale s trumento per la propaganda, ne intuì com unque la va lidit à n e l campo dell'info rma zio n e, t a nto da porre subito in vigore nonne e divi et i che diventarono nel t empo se mpre più p esa nti , man man o e di pari passo co n l ' interesse che il n u ovo mezzo di co muni cazione andava susc itando n ei promotori d e l consenso e della co n dotta id eo logic a d ella propaganda, a nch e qu e ll a militare di guerra.
1110 ottobre 1926, Mu sso lini fece la s ua prima rilevant e arr in ga radiofonica a ll e masse in occasione della «battag li a d e l gra no » .
L ' anno s uccessivo, la co nce ss ione gove rn ativa per le trasm iss ioni radiofoniche fu tra s fer ita a ll 'Ente Italiano Audizioni Radiqfoniche (E .l.A.R.).
Nei s uoi primi anni eli vita, la radio tra s mise soprattutt o canzonett e , scialbi pro g rammi e ducativi e c ulturali , n o t iziari g iormili er i r e datti s ull e ve lin e d ' agenzia d e lla Stefani (cioè in fon nazioni g ià «purgate» e man ipolate) . Dal ·t929, le trasmissioni di info rma z ion e div e nnero più regol ar i co n il giornale radio, che passò , n e l 1936, sotto la d i retta s upervisione d i Sta mpa e Propaganda. Il R eg im e, co nsape vo l e d e finiti v am e nt e d e lla potenzialità di
controllare informazioni e cultura attraverso le radiodiffusioni , non poteva più lasciarsi sfuggire tale mezzo. Anzi , si adoperò molt o perch é g li apparecchi radio avessero sempre più larga diffus i one, pro m uov endo ne l a costr uzione a ba ss i cos ti (fino a pochi a nni fa, ancora m o l ti conservavano il ricordo della spartana Radio Balilla) e regalando apparecc hi a organizzazioni del P arti to, a comunità , a ll e Forz e Armate; a qu eg li en ti , c io è, dove un solo appara to potev a raggiungere , e coagulare intorn o a sé, centinaia di orecchie.

Lo sfo r zo non fu indiffe r ente, se si val uta che dalle po che miglia i a di abbo nati del 1925, se ne raggiunse la cons id erevole cifra di 1.200 .000 circa nel 1939.
Qualora si consideri i l numero compless ivo di ascoltatori che tante utenze pote v ano raggi ung e re. non è difficile comprendere come la radio a ndasse assume n do un ·importanza propagandisfica u guale, se non maggiore, a quella della stam pa; che co ntinuò ad esse r e , com unque , il canale interlocutorio privil eg i a to del Regim e Più degli altri strume nti della propaga nda , essa fece so rgere , tutt avia, non pochi problemi. Ta n to da diventare ben presto a rgomento di discussione ne ll e sed ut e della Comm issione Su pr e ma di Difesa .
Le onde radio , si sa, v iaggiano lib e re n e ll ' etere; un loro con trollo è assai di fficil e . Lo era ancor più n eg li anni trenta. E questo, p er il fasc ismo. rappresentò un ri svo lto estremamente
pericoloso nella diffusione dei programmi. Qu alu nqu e avversario poteva m e ttere in onda trasmissioni n on gradite; tr as missioni ch e molti avrebbero potuto ricever e, ascoltar e , m e ditare.
La Direz ione Superiore Studi cd Esp e rien ze dell ' I s pettor a to d el Genio fu in caricata, negli anni tr e nta , di stu diar e i l problema dell e radiodiffusioni degli Stati potenzialme nte avversari , di esaminare la pos s ibilità di interce ttarl e e di disturbarle , di consid e rar e le implicazio ni che le trasmissioni na z ionali potevano avere sulla s icurez za militare , in quanto le sta zioni emittenti potevano esse r e utilizzate da velivoli avversari come radiofari ,trasformandosi in involontarie guide per gli obi e ttivi di int ere sse militar e .
Le conclusioni c ui giun s e n el1935 il gene ral e Luigi Sacco , inc aricato dello studio, non furono incoraggianti: se era possibile sa lvagu arda re la sicurezza militare con un esped iente tecnico (scambio d ' onda fra le emittenti per d epista r e i velivoli nemi ci), non e ra altrettanto possibile, neanche con una spesa ri levante, impedire le trasmissioni di propaganda e co ntr opropaganda proveni ent i da em ittenti estere Per cui fu s tabilito che l'unica arma poss ibile , contro la propaganda avversaria , era l ' intcnsificazion e dei pro g rammi di propaganda nazionale c la trasmission e di ulteriori programmi p e r l 'es t e ro , sull a stessa lu n ghezza d ' o n da de ll e emittenti concorrenti , per disturbare la ricezion e sia nei Pa es i avversari, sia nel t e rritorio na z ional e.

Ne11937la «battaglia dell'etere» (che a detta del Duce e ra pri o ritari a s u qu e lla dei cann o ni), in c ui la r a dio era divenuta un ' arma di offesa e di difesa , era ormai in fase ava nzat a . Numerose era no , infatti, le trasmissioni quotidiane di propaganda itali ana ch e raggiungevano ben 19 P aes i. l quali , p e rò , non stava no a loro volta con le mani in mano.
Il Capo del Governo fu così irretito dalle tr as missioni prop aga ndistiche diffuse dalla Francia, dalla e dalla Ru ss ia -l a quale ave va tante e mittenti da arrivare a trasmettere su 14 lun ghezze d'onda diver s e in un so lo g io rno - da is ti tuire un Ufficio Radio Rappresaglia, che aveva lo scopo di portare l ' contro le radio antagoniste, po ss ibilme nte n e l rapporto di 10 a l (nelle intenzioni del Ca po d el Governo , per o g ni noti z ia falsa diffus a d a ll 'avve r s ario , s i do veva controbatt ere co n 10 notizie artefatt e trasmesse dall'Italia). Fu sta bilito anc h e che la diffusion e di tra s missioni di rappresaglia (falsi comunicati di riv o lte , scioperi, ca tastr ofi, epidemie ecc . , riguardanti g li Stati avv e rsari) dovess e essere ripetuta p e r tre sere di segui to in 17 lin g ue diverse.
Il sistema dov ette funzionar e, se è vero che esso provocò , com e è affermato in un a relazio ne d e lla Commissione Difesa del 1939 , la reazione e l e proteste di vari ambasciato ri - tra cui qu e llo ru sso- a Roma.
La stessa rela z ione riportav a il p e nsi e ro del Du ce. ch e non na s condeva la p e ric olos ità delle tra s missioni di propaganda dell 'a vver sa rio. Con una
acrobatica inv ers ione di rotta però eg li , che aveva voluto la rappresaglia radio , dopo inutili divagazioni su li ' impossibilità di ritirare gli apparecchi radio in circolazione (per impedire che gli italiani ascoltassero le trasmissioni straniere), affermò che: « Peraltro non bisogna drammatizzare il fenomeno; molta gen te ascolta per curiosità e non perché voglia fare una dimostrazione di fede politica. Si vuoi sentire la radio italiana e poi la radio di Mosca ... ». E p i.ù avanti: « ... In questa guerra delle onde noi abbiamo già vinto Gli inglesi hanno già detto di smetterla ... » Quanto fossero semplicistiche e superfici ali ta li affermazioni, sarà dimostrato in seguito dall e trasmissioni di «Radio Londra » del colonne llo Stevens.
Il problema della guerra psicologica attrav erso l'etere, comunque, insistette fino a llo scoppio de ll e ostilità, tanto da essere ancora causa di rela zio ni in sede di riunioni della Co mmissione Suprema Difesa fino al febbraio 1940 (e oltre) , a n no in cui- riconosciuto a ncora un a volta inefficace il servizio di disturbof u approvato un progetto eli a ll es tim ento eli una ap posit a rete radio per ostacolare la propaganda estera contro l'Italia , con una spesa preventivata in 60 milioni di lire . Nessuna organizzazione veniva predisposta, invece, per il con trollo e l a disciplina delle trasmiss ioni radiofoniche in caso di guerra, poiché s i ritenne s uffic ente che, all 'atto dell 'e m ergenza, Cul tura Popolare e Dicasteri militari avrebbero saputo e potuto mettere immediatam e nte in atto le misure più idonee allo scopo.
Fu, comunque, ribadito che il servizio el i di st urbo delle stazioni di propaganda nemica fosse affidato all'E.I.A.R., e fu ravvisata l'opportunità di distaccare, presso il Minculpop, uffi ciali superiori con funzioni di collegamento e di controllo sulla effett iva aderenza alle necessità militari delle forme di propaganda radio.

A tal proposito, va ricordato che fino alla se conda g uerra mondiale furono sporadiche e saltua ri e le trasmiss ion i di propaganda strettamente militari o dedicate ai militari. In genere, and arono in onda confe re nze di grosse personalità, come qu ella di Badoglio s ull 'o rganizzazione pre e post-militare della Nazione. notizie di esercitazioni , celebrazioni di ricorrenz e s toriche e di particolari manifestazioni.
Alcuni servizi s u esercitazioni militari e su lla guerra d'Etiopia furono curati da Fo rges Davan zati nella rubrica «Cronache del Regime>>, una trasmissione di indubbia efficacia che molta parte ebbe nella propaganda radiofonica. Pres tarono la loro voce a ll a radio , prima e dopo, alcuni mostri sacr i del g iorna lismo, come Aldo Valori , Rino Alcssi, Mario Appelius, Umberto Guglielmotti , Ezio Maria Gray.
Particolare atte nzion e fu dedicat a dai giornali radio a lla guerra i ta io-etiopica, con la trasmi ss i one dei comunicati; l 'E nte R a di o Rurale chiese e diffus e, in alcune occasioni - come quella dell a partenza dell e truppe per l 'Et iopiaserviz i speciali.
Bollettini radio furono diffusi in Italia e in Afr ica durante la campagna;
riportati anc he a s tampa , erano uno zibaldo n e di noti zie (operazioni militari , propaganda , sport, politica, avv eni menti int e rni ed int ernazionli, arte varia , ecc.).

In Africa operarono stazioni radio ad Asmara, Assab e Ad igrat, che oltre a svo lger e traffico di interesse militare, m et tevano in onda notiziari per le truppe. Queste stazionÌ, note al nemico, ebbero anche la «s ventura» di captare p esa nti e volgari app r ezzamenti s ugli italiani diffusi da Radio Etiope Libera di Addis Abeba.
A fine guerra, il 2 ottobre 1936, furono mc:::;se in onda, con l'approvazion e del Duce e sotto il diretto controllo di Bastico , una serie di 22 r ad ioco n versazioni s ulla g uerra it alo-ctiopica; tenute da alt i ufficiali delle For ze Armate, avevano la durata di 12 minuti e dovevano soprattutto esa ltare le battaglie vinte , sottolineare lo sforzo operativo c logistico comp iut o dai Comandi, magnificare gli atti di eroismo.
Una guerra d ell'e tere più feroce fu svolta in Spag na , dove comp lessi radio e altoparlanti furono impiega ti d i rettamente in linea, a s tretto contatto con le unit à repubblican e, per diffonder e trasmi ss ioni di propaganda; e dove fu necessario organizzare «Radio Verdad», con fun z ioni di propaganda naz ionali sta nella Spagna rossa c di radiodisturbo delle emitte nti repubblicane.
Co n il mezzo radio veniva svolto anche il serv izio sta mpa , pe r le corrispondenze di g uerr a, tra Spagna e Italia ; vi provved eva l a stazione di Monte Mario, che, ingolfata di lavoro (svolgeva oltre al serviz io per la Spagna ,
anche qu e llo p er l ' Africa Orientale) e ra spesso causa di lamente le ; ad avanzar le, f r a gli altri , Luig i Barzini.
Per cui fu deciso di dirottare (almeno in teori a) tutto il servizio stampa al Ce ntro Radio di Bellosgu ardo , di cui ne fu previsto il potenziamento.
Lam e nt e le di a ltro tipo vennero da Bastico, c h e il18 agosto del1937 avanzò l e sue proteste direttamente a Ciano; l'E.I.A.R. , infatti , aveva mand ato in onda notizie in esatte c controproducenti sugli avv e nimenti spagnoli:
«EIAR ha dato ieri ore 23 per presa da parte dei legionari REINOSA e TORRE ARRIBA soggiungendo che stessi hanno incontrato scarsa resistenza . Non co mprendo che si possa pubblicarnenl e dare notizie cosi infondate. REJNOSA è sta ta presa da .spagnoli. TORRE ARRIBA è soltanto uno dei numerosi episodi che hanno costituito n el/oro insieme la battag lia dell 'ESCUDO. Nemico questa volta ha offerto resisten z a tenace e spesso ammirevo le. Per le m.ie truppe che si sono valorosamente battute in nome del RE del D UCE dell ' ITALIA sen to il preciso dovere di rivolgere a V E. la più fi era protes ta. Con questi metodi si irritano e con ragione Governo, Comandanti e Truppa nazionale e si svaluta il valore dei no s tri »
Incid enti di tal genere furono fr equenti, anc he in E tiopi a e nel corso d e ll a seconda guerra mondiale. Può sembrare incre dibil e come , in un siste ma sot topo s to a rigidi sc he mi di controllo , dalla confezione a lla diffusione della notizia , possano essere sfuggiti s pesso com uni cati deleteri pe r la propaganda di guerra .
Sono, tuttavia. proprio tali incidenti a dimostrare com e il sistema di controllo non fosse così p erie tto.
In Spagna si verificarono a nche due eventi innovativi, grazie alla radio: per la prima volta furono fatti parlare, a scopo prop agan distico , prigionieri di g uerra , s ia in trasmissioni a livello locale , che in que ll e a live ll o nazionale ed internaz ionale. P art icolarme nt e g radit a ed e fficace fu , in vece, l'altra innovazion e portata dalla radio. Ne l dicembre del 1937 fu istituito , per i l eg ionari , un se rvi zio di comunicazioni a i familiari. I volo ntari scrivevano su cartoline messaggi di 10 parole diretti a parenti o amici, li inviavano all'Ufficio Stamp a c
Prop aganda del CTV che , attraverso Radio Napoli- tale era la denominazion e della stazione in Spagna d e l CTV - Ii inoltrava a Roma ; dove l'E.I.A.R. pro vvedeva a diffonderli tre volte al giorno (dalle 9,00 a ll e 9,30; dalle 12,30 alle 13 ,3 0; dalle 22,30 alle 23 ,00).
Tal e trasmissione ; fu, in effett i, il primo tentativo di dedicare uno spazio radi o a lle trupp e in guerra; bisognerà poi attendere il ·1941 perch é s iano me sse in onda trasmi ss ioni p iù consistenti, in presa diretta e co n voci e impressioni

dei soldat i come: «Radio del combattente» e « L ' ora del so ldato » Sul fronte int e rno l 'Ente Radio Rur a le curò, in collaborazione con i Ministeri delle Forze Armate, alcuni programmi di c ultura militare dirett e agli a lunni dell e sc uole e le m e ntari «per l'assistenza morale a favor e del popolo ». All'Esercito furono dedi cate le radiocronache «Ese rcitazioni di artiglieria» (11 dicembr e J 936), «Una esercitaz ione di ca rri armati » (15 gennaio 1937), «Una esercitazione di radiorelegrafisti » (15 febbraio 1937) , «Con i bersaglieri di Lamarmora» (8 e 9 marzo 1937), «Savo ia! D esc rizione di un assalto di fanteria » (26 e 27 maggio 1937).
Ancora Radi o Rurale ini ziò, il 31 ottobre 1937, un a radiotrasmissione dom e nica le per i soldati. Il discorso inaugurale fu trasmesso da Pariani c ascoltato, secondo st im e d' e poca , da circa 200 .000 soldati.
Ricordiamo , in ultimo, che nel 193 3 erano iniziati g li esperimenti di trasmissione t e levisiva; un mezzo di lot ta c h e non poté essere sp iegato , perché il soprag g i.ungere d e lla guerra ne imp e dì , momentaneamente , lo sviluppo e l 'uti lizzazion e.
Su proposta del Capo del Go ve rno il 18 se ttembre di quest'anno il Consiglio dci Ministri ha approvato un complesso di legg i militari , brevi nel testo , ma d ' una portata cons ider e vole nella stori a d e lla Na zione. A differ e nza dell e altre leggi in s imil e mat e ria , ch e per ragioni di progress o tecnico o di evol uz ione sociale, hanno insito il carattere della transitorietà, se pure la loro tra s forma z ione o sostituz ione avve nga in un lun go ciclo d ' anni , le leggi militari de l 18 settembre intitolate d ella istruzi on e premilitare, d e lla istruzione postmilitare e d e lla cultura militare , h anno una speciale poss ibilità di sopravvivenza n e l futuro. Esse non sanzionano so lt anto la costituzione di organismi nuovi , s uscettibili, col tra sc orrere del tempo di variazioni nella st ruttura c nel funzionamento, ma e nunciano una ser ie di princip i che valgono p e r l'ogg i, e abbracciano ins ieme il lontano avvenire . In esse possono ada ttar si le tr asfo rma zio ni sociali dal ritmo più accelerato e le tra sforma z ioni tec nich e più ardite; possono trovarsi , non soltanto una poss ibilità di inquadram e nto , m a anch e una sp inta alloro progresso .
L'esam e so mm ar io d e l testo mette in evidenza questi caratteri partico l ari delle leg gi.
La legg e premilitare eso rdisce con l a defini zione lapidaria della inscindibilità di funzioni del cittadino e del so ldato
n e llo Stato Fasc ista E ciò vale non so lt anto per il contenuto morale, chiaro e indiscutib ile , di questa aff ermazione, ma anche nel sens o tecnico. Il cittadino d e lla legge mili tare italiana è, e riman e se mpre so ldato , anc h e quando non vesta l a divi sa o quando abbia depo s to la

divisa. Neg li Stati a servizio militare obbligatorio il cittadino si trasforma in soldato all ' atto dell ' arruolamento c lo ridiventa se venga richiamato alle armi. Il cittadino, al di fuori d e l servizio militare , n o n è un soldato: è un cittadino eve ntualm ente «disponibile » per le Forze Armate. Con la legg e premilitarc l a caratteri s tica essenzial e che costituisce la fig ura del s o ld ato, qu ella di aver ricevuto una educazione morale c disciplinar e e un adde stramento tecnico , s i d elinea fino dall'infanzia assai prima dell'epoca d e l s e rvizio militare comun e alla maggioranza degli es e rciti e continua per l'intera es istenza del cittad ino.
Il cittadino è perciò - o un soldato ch e si addestra a ll e armi- o un soldato alle armi- o p r onto per le armi. La Legge dice: " L ' addest ram e n to militare è part e integrale d e ll ' ed uca zion e nazionale; ha ini zio appena il fanciullo è in grado di apprendere, continua fin o a quando il cittadino è in cond izioni di impugnare l e a rmi per la d i fesa della Patria ».
I giovani , dall ' So anno in poi e fino al momento in c ui sono c hi amati alle armi e cioè fino al 21 o anno , vengono preparati sp iritualmen te , fisicamente, militarmente dalle organizzazioni poli tiche , civi li , e duc at ive del R egim e (Opera Naziona le Balill a, Fasci Giovanili di Co mbattim en to e Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazional e).

Ques to provvedimento r apprese n ta una d e ll e so luzioni più o ri gi nali e più geniali della L egge .
Sono enti c ivili e politici che preparano i futuri combatte nti in una serie successiva e ininterrotta di p eriodi
di insegnamento distribuiti in 13 anni consecutivi.
Molti di quegli enti so no già costituiti e in pi e no rigoglio di fun zionamento. La loro organizzazio n e si st a s viluppando con rapidità in estensione, in profondità c a pieno r e ndimento. In poc i anni e !S s i inquadr e ranno tutta la g io ve ntù d ' Itali a L ' educa z ion e spirituale e fi sica che impartiscono questi enti è quella , ch e nel clima del Fascimo, sta trasformando nell ' anima e nel corpo le g iovani generazioni italiane, cre ando il tipo dell ' italiano nuovo nel morale e nel fisico , ch e già si è affe r mato nel mond o sportivo internazional e La psicologia di quegli enti civ ili sorti dalla Vittoria c dal Fascismo si identifica gi à con quella delle For ze Armate, p e r l ' ideale sens o de l do ver e ch e li anima , c anche per analogo se nso di compre ns ione e di esecuzion e di una disciplina intelligente, vol e n terosa e piena di d e dizio ne che è l'elemento essenziale , a nimatore della tattica n e ll e battagl ie odi e rne in terra , in mare e n e ll ' aria - ov e- il disseminamcnto delle p e rsone e la difficolt à di impiego d ei mezzi, richi ede da tutti che , per il raggiungimento dello scopo coll e ttivo , i si n goli s iano cresciuti alla scuola , non solo d e l s acrificio , ma anche d e lla co llabor azione più in te nsiva c della iniziativa personale più volent erosa .
Nei programmi stessi d e gli e nti civ ili che debbono formare il cittad ino solda to prima del servizio militare , sono inseriti programmi a carattere progr ess ivo di tecnica militare ; programmi proporzionati all'e tà , agli
studi d e l cittadino so ldato in forma zione. Quanto più s i avvic i na l' epoca dell'incorporaz ion e d e l giovane nelle Forze Armat e, l' addestramento a carattere milit are e s peciali zz ato acquist a se mpr e ma gg iore svi l u ppo in modo che il cittadino si present i alla sogl i a de ll a caserm a non com e recluta ma com e so ld ato completo atto ad esse r e g ià inquadr ato come combattente agguerrito n elle Forze Armat e .

Una ana loga or ga nizzazion e di co ll aborazione civil e e milit are provv ede a mant e n e re al corrente, ed in fo rm a , il cittadino -so ldato in co ngedo. P e r ciò il citt a dino , prima d e l s uo a rru olamento è un so ld ato in corso di addestr a men t o e dopo il servizio militar e è un soldato, non so ltanto disponibile, ma s u b ito impiegabile.
L 'a dd es tram ento militar e s i sv o lge qui n di in tre fasi :
«prima fase- istru z ione prem ilitare », nell'amb it o degli e nti d e l R egime, col compito di p ro vvedere alla prepar az ione spi r itua le, fis ica e te cnicomilitar e de l ci ttad in o, nel pe riodo che precede la sua in corporazion e ne lle Forze Armate;
«s econda fase- is tru zione militare », n e ll ' ambito delle Fo rz e Arm a te, col compito d i perfezio n are e complet ar e il premilita r e per form a rne u n g u e rriero nelle unità ch e l o in quadra ;
«terza fase- istru zio ne postmilitare », nell'ambito degli e nt i del R eg im e, col compito d i mant ene re il milit a r e in co ngedo ad un liv e ll o add es trativo agg iorn a to e d ad eg uato al su o impiego 1n g u erra .
Qu esto s istema ini z ia un r ivo lgimento comp le to e rappresenterà , a c iclo compiuto e attua to della nuo va L egge , la solu z ion e di un pro blema militare che attualme nt e è tra i più di sc uss i. L ' attr ezzamento bellico odi e rno , dai me zzi di lotta propriamente detti, a tutti qu ell i a usiliari , è com plicato , è complesso di s p ec i a lità di ogni gradazione e r i chiede qu indi un pe r s onale corris pondentem e nt e speci a lizzato . La nece ss i tà di conosce nz a e l a compre n s ione t ec nica che n e deriva , comport ere bbe un a perman e n za il più poss ibil e l ung a a ll e armi p e r il person a le di ogni spe cialit à, circostan za che entro certi li miti trov a la s ua diffi coltà di attua z ione con l a necess it à di possed e r e una g r ande forza numerica di ci ttadini militarmente istru i ti , poiché i l quantit a tivo elevato degli u o mini alle armi e leva anch e i bilanci a c ifr e non soppo r tab ili dell e finanze s tat a li. Si pon e quin di il dilemma: o ridurre la ferma pe r aum e nt are il num e ro dei soldati e diminuire le s pese raggiun ge ndo un grado d ' addestr a m e n to minore, oppur e a pari tà di spesa , ado ttar e un a fe rm a più l un ga otte nendo un miglior e add es tramento m a con un num e r o m i nor e di soldati. Vi è un m ezzo termin e: disporr e di molti uffic ia li e di molti so ttufficiali perma nenti, in mod o c h e j so l idi quadri fi ss i a carattere profess ionale ven ga n o compl e tati col minore num ero possib il e d i e lementi tr ansitor i a breve ferma meno bene istruiti. Ma anch e questo s is te ma non r agg iu ng e compl eta me n te lo scopo , sp eci a lmente in este n s ion e , e p uò esser e
applicato , in alc uni stati, limit atamente alle trupp e per la prima difesa delle frontiere e per il pres idio dei siste mi fort ifi cati , o presso i paesi ch e hann o eserciti a fo rza stabilita dai trattati di pace e quindi, a persona le teor icamente permanente.
Lo scopo raggiungibi le in parte presso altri ese rciti col sistema di un num eroso e cos toso perso na le permanente o semipermanente, vien e ottenuto nello Stato fasci sta con la prestazion e persona le del cittadinoso ldato ne i tredici anni che precedon o il serv izio militare. Qu esta prestazione personal e è quindi un e leme nto di valore morale e tecnic o altiss imo. Quanto può ess ere altrove otten uto con un contributo finanziario oneroso viene in part e ottenuto in It a lia con la dedizione volenter o sa della gioventù nelle stesse palestre ove forgia il suo an imo cd il s uo fisico. E a ltro e lemen to di valore morale è questa fusione spiritual e e t ec nica dell e forze politich e civili e militari ch e si completano e si armonizz a no in un a coll a borazione integrale e id ea le compl e t ament e nuov a n egli organi s mi sociali odi e rni.
Ques to co ncorso degli ent i politici e civili alla formazione d e l c ittadinosoldato, d e lla sua psicologia morale e della sua capacità bellica, rappresenta una trasformazione di me todo nel campo tecnico la cui importanza appa r i r à se mpr e maggiorm e nte quanto più il sistema delle leggi militari esaminate acquisterà intens ità ed estensione nella loro applica z ione.

Il perfezionamento , la mo l tep licit à e
la complicazione dei mezzi di guerra, neces sitando un perfett o addestramento di ogni si ngoli soldat o. impegnano per la quas i totalità il tempo disponibile dell e att u ali ferme p e r giungere a l grado di istruzion e individuale in c ui il buon rendimento dei singoli ga rantisca il buon fun z ionamento d e ll' ass ieme.
Rifc r endoci alle forz e terrestri , tipich e per la massa e la quantità di elementi, col s istema finora in vi gore, ten uto conto d e l t e mpo neces sa rio per l'istruzion e del s in golo co mbattente , il tempo disponibile p e r l'istruzione dei reparti, rim a neva assai ridotto, mentr e il carattere del com battim e nto odierno , impon e una collaborazione intensiva ottenibil e so lt anto con un lungo tirocinio pratico dai comandanti dall e piccole ce llul e alle grandi unità. Col sistema della nuova legge il cittadinosoldato s i presenterà alle sog lie della caserma provvisto di un a istruzione individu a le g ià ultimata o quasi, cosicché il tempo che eg li passerà alle a rmi p ot r à esse re devolu to essenzialmente alle esercitazio ni d'ass ieme.
Eleme nti d'importan za cap itale de gli organis mi de lle F orze Armate odierne so no i g r ad uati e gli specia li st i. A formarli vie ne provveduto con modalit à diverse a seconda dell e Forze Armat e e dell'età d i incorporazion e in esse. Gli speciali s ti di ogni gen e r e (motoristi , mitra gli e ri , radiot e leg r afis ti , gon iometristi, cavalieri e mo lti altri ), sa rann o già formati n e ll e orga nizzazioni civili e po litiche in coll aboraz ion e in alcuni cas i co n scuole spec ia li e così
saranno istruiti gli e lem en ti trasformabili in breve tempo in gra du at i. Tutto ciò c he richiede orientamento, nom e nclatura , conosce nza di macchinari e di armi ed insiem e allenamento e svi luppo di vigore fisico, sarà svolto, insegnato, c provato nel periodo premilitare .
Il programma prcmilitare ha fisionomia essenzia lment e fisico-ginnico fino a 18 anni. Il programma div enta poi cssenz .ia lm cnte militare al18o anno all'epoca d e lla lev a fasc ista, s ignificato a nche questo morale e id ea le altissimo.
Con modalità pratiche analoghe a quelle della premilitare , la legg e provvede alla istr uzione postmilitarc pe r mezzo degli e nti del Regime e in base ai programmi formulati dalle Forze Armate. La legge postmilitare ha lo sc opo di mantener e il cittadino-soldato nell'atmosfera morale d e ll e Forze Armate e di tenerlo fisicamente e tec ni came n te addestrato , m etten dol o anche continuamente al corrente dell e novità di procedimenti e di mezzi di g uerr a . Que sta part e della legg e - ad organ izza zione attuata- porta con sé la risolu z ione di una delle ques ti oni più ri levanti e più difficili nel campo degli or din ament i militari; qu e lla di ottenere un grado di e ffici e nza bellica n e lle truppe n ei primi momenti della g uerr a e nelle unità format e ex novo durante la g uerra , quando nei quadri permanenti d i pace, c h e rappresentano un percento minimo di guer r a, vengono imm esse le mass e dei richiamati.

L 'istruzio ne pos tmilitar e tend e a ottene r e qu e l grado di efficie n za e
que sto sarà tanto più alto quanto più essa sarà intensiv a ed este nsiv a . Il cittadino -soldato, dal punto di vista tecnico, non sarà quindi un di sponibile condizionato, ma un combattente «se mpre pronto».
All e leggi de11 ' ist ruzione pre militare e postmilitare si ricollega quella della cultura militare nelle scuole medie e superiori e nelle Università. Il cittadino che r agg iun ga un determinato grado di c ultura e occupi un gradino nella gerarchia soc ial e r app r ese nta un elemento dirigente.
Corrispondent eme nt e a qu esta sua personalità civile e soc iale, egli deve poss e dere una personalità militare , poiché nello Stato fascista le f unzioni civili e milit a ri, n e l diritto e n e l dov ere, nell'azion e e nel sacrifi cio sono indisso lubili. Qu es ta personalità militare del cittadino deve essere perciò integrata da una cu ltu ra militare che lo renda degno e id oneo a comandare. Inoltre la conoscenza diffusa nel paese e specie ne11 e classi dirig en ti, d e lla tecnica e de lla cultura militar e è un elemento che influisce sulla efficienza b e llica delle Forze Armate, poiché, oggi più che mai, il mi g liore impiego e r e ndim ento dei mez zi in ogni campo d'azione , è in ragion e diretta dell 'o rient a mento collettivo e della comprens ion e individual e.
La necessaria armoniz za zion e di sì vaste attività militari che s i inseriscono n ella vita d e l cittadino e della Nazione, è assicurata o ltre che da un programma unico , a carattere di continuità c di pro gress ivi tà, dalla costituzione ,
all e dire tte dip e ndenze d e l Ca po d e l Gov e rno , di un «o rgano di coordinamento» fra le Forze Armate e gli enti civili, politici , e ducati vi de l Re gime, in modo ch e poss a esse re otten ut o lo svolgimento t ot a lita r io de i p ro grammi , l'impiego int ens ivo dei m ezz i, l'adattamento a ll e situazio ni locali , con que l ri go ro so impulso ch e è proprio de l clima fascista, in cui alla p a r ola scritt a deve corrispond ere un'appli cazione effettiva, completa e mas sima .
L e legg i militari del1 8 sette mbr e r is p ecchiano in modo tipico le caratteristiche delle le ggi de l Re gim e: or ga nicità estes a e comple ta, stab ili tà ed adattab ilità, co ll abo r azione po liti ca , civi le e milita r e .
Esse rappr ese ntano un nuovo in ce ntivo all a trasforma zione dell e future gen eraz ion i in cittadini-soldati fort iss imi p e r affront a r e la lot ta d e lla vita - fortissimi per a ss ic urare la potenza della Patria.

L'adunata fascista e L'avanzata delle truppe. Nes s una p a rola amplificatrice è necessaria per fissare il va lor e dell'adunata fascista di ie ri, nella qu a le il Duce ha seg nat o i caratteri dell'ora so lenn e per la storia dell a P atria .

Prim o valore esse nziale. Il fatto, c he si sa rebb e vo luto considerare esclusivamente fa sc ista, è divenuto intern az ion ale non so ltanto per la co mmovent e partecipazi o ne d e i mili o ni d'italiani ch e vivono fuori dei co nfini della Patria , ma per la d ire tta comunio n e ragg iunta da Mus sol ini co l se ntim e nto dei popoli , chiamati alloro senso di gius tizia, al lor o senso di responsabi lità.
Non s i dic a, dai so liti ar idi discettatori, che le relazion i d ei popoli appartengono a lla dip lom az ia, alla finanza, a i clans di pochi dirigenti , che agiscono n e l chiuso . Vi sono ore de lla s toria e v i sono s oprattuto er oi, ch e giun gono , di tempo in t empo, a seg nar e il di s tacco dei
grandi cicli di civiltà, che s up erano nett a ment e que s t e clau s ure più o m e no accorte o dissennate , spesso egoistic he e interess at e, e riv e lano a i popoli la loro in sopp rimibile funzione di pr o t agonis ti.
Quanto il Duce ieri h a dett o, ha avuto il pot e re di riunir e e m o ltiplicare la volontà d eg l' ital ia ni int or no a lla profonda umanit à di qu e sto conflitt o , a nch e e sopratt utto n ei su oi rifle ss i europei . Ma que s ta um ani tà è sta ta a nch e scoperta agli altri pop o li , sp ec ie a qu e lli che si vorrebbe r o co nt rapporre, per la più re pu gna nte ingiusti z ia e per la più per ic olosa fo llia , al popolo italia no.
E prima di tuW i popoli, il fra nc ese e l'in glese , che proprio ve nt' ann i fa il popolo italiano affiancò in armi, quando le sort i d ell' Intesa p e ri co lavano, quando no ve m es i di guerra avevano già ammonito quant o duro c grave fos se il co nflitto.
Mussolini , uom o dell'interv e nto , sor to dal popolo a fare, vent'anni fa, della
guerra volon t aria e non coatta una decisione consapevole di popolo, è il Duce che ieri ha fatto intendere come quella forza. quella volontà in vent'anni si sono ce ntupli cate, e conser vano intatto lo stesso se nso di passione e di gi ustizia.
Ebb e ne, questo. possiamo dirlo, è stato sentito n egl i strati profondi popolari. quelli ch e meg lio int e ndono le regioni intime della storia .
Il conflitto eccitato, promosso, calcolato proprio in quell e zone oscure e limitate ch e pretendono di essere dirige nti. e che dovrebbe contrapporre g li alleati di ieri al popolo italiano, il quale con le so le sue forze domanda di conquistare ciò che altti ottenne in altri territori a spese della vittoria comu n e; questo conflitto è stato denunziato concisamente. Esso è stato definito nei suo i tennini essenziali, che sarebbero, n e ll a realtà, la più nefanda ingiusti zia, la più ripugnante cd ipocrita violenza.

Tutt av ia per es cluderlo , per scongiurare dall'Europa qu es to s'uicidio - il tentativo cioè di colpire alle spalle un popolo impegnatosi a risolver e in Africa una lotta se misecolare con genti barbare ed oppresse - il Duce, dopo avere invocate le s upreme ragioni della civiltà di cui l 'Europa ha vissuto e vive, dopo avere rivendicato l 'opera millcnaria della gente italiana. che h a gene rato nei secoli, con feco nd a sofferenza, tanta luce, tanta for za, tanta fede di vi ta, ha precisato esat tam e nte e fe1missimamcnte il pericolo di questo assurdo conflitto. Lo ha precisato. indicando i propositi success ivi , ma irrevocabili, ma degni di essere valutati da chicchessia , di quella che sarebbe la
resistenza italiana alle pretese sanzioni: da quell e economiche a quelle militari , ag li atti di guerra.
È b e ne rip e te re che le ipotesi estreme si possono eliminare con un solo metodo virile: affrontandole , traendol e fuori dal linguaggio tracotante o insidioso dell e minacce, e accetta nd ole col proposito unico. di un popolo degno di questo nome: di saperle sopportare per vincerle.
Ecco il punto in cui il fatto nazional e dell'adunata fascista, co n la parola di Colui che può parlare per tutti. uomini, donne , fanciulli, raccolt i visibilment e in una moltitudine organica: che può parlare per le generazioni passate e avv e nire, dei morti e dei nascituri , divi ene necessa riamente intern az ion a le .
È internazionale p e rché qu es to R egime che ha potuto, con la s ua Rivo luzione, ordinare la Nazione n e l Partito. nei Sindacati, nell ' Opera Balilla , nei Giovani Fascisti, nella Milizia, nel Dopolavoro, nelle Forze Armate. realizzando la più vasta so cietà eli popolo che si sia mai av uta, è un regin1e che si prese nta anche ai detrattOti, anche agli odiatori, come una delle magg ior i conqu iste eli questo temp o. L'accanimento soc iald e mocratico contro di esso è infatti d e terminato proprio dal paragone al quale sono costrett i coloro che credevano di avere il monopolio del popolo . La democrazia masso nica è soffocata nell a divisione dei partiti e nella corruzione d ei Governi; il socialismo bolscevico non può promettere che la tirannia dell' ol iga rchi a di classe . L'It a li a proletaria e fa sc ista è. in vece, an im osa e concorde, tutta in piedi, a doma nd are g iust iz ia , a pretenderla, a conquistarse la
con la propria virtù , co n la pr opria forza, col proprio sacrifizio. lcri è stato ben chiaro oltre i confini , che tentar e di colpire il Regim e significa trovare int ero e intatto il popolo italiano.
È int e rnazional e, pe rché ieri s i sono tistabilite ve rità fondamentali. intelligibili da tutti, ridotte in se mplici e appassionat e antitesi , che hann o richiamato le gra ndi solidarietà di ieri , le quali, per una improwisa mostm osa inversione, dovrebb ero diven ta re una lotta d i domani, suicida per l'Europ a.

È int e rnazional e . perché la inn egab il e essenza politica e morale dell e dichiaraz ioni del Duce, che h a raggi unto la comprensione di tutti e anch e la respon sa bilità deg li avversari, s i contrappone a tutto il falso e me nzognero meccani s mo socictario , manovrato prepotentemen te dalla infatuazione del signor Eden , per condurlo ad ava llare l'eserci z io esclus ivo della pote nza britannica. Tu tte le discussioni sanz ioni ste, interpretative, ch e pure sono state necessa ri e, che ancora forse sa r a nno neces sa ri e, tanta è stata la sopraffazione esercitata a Ginevra , sono tuttavia da ieri come accanto nate da una mano potente, che ha tolto l'in gombro parolaio e insidioso per scoprire quella ch e è e resta la sostanza intin1a di ogni grande politica: l'umanità volitiva e intelligente .
Amm ess o anche quello che non è: che la stessa Socie tà dell e Nazioni d e bba contenere i pretesti per metters i contro l'Italia , ecco che la s tess a Società delle Nazioni s i trova in s tato di accu sa . Da pretesa g arante di pace essa si denun z iereb be automaticamente come la
p eggiore e più iniqu a propa ga trice di guerra.
E a nc he questo è stato inteso.
Att e ndiamo ora. Con intatta la fede , col prop os it o fermo di ot tenere un rin savimc nto, con la decision e altrettanto ferm a di contrastare tutte le avversità calcolale e di smascherare con chiarezza, con tranquillità tutte le ipocri s ie di una sopr affaz ione che non osa esse re se stessa, ma pre tende di avere un mandato societario, nel quale la prepote nza sarebbe accompagnata d al più trist e se rvilismo di co loro che se ne facessero complici.
Attendiamo .
Intanto le nostre truppe sono g ià a] loro posto. La mobilit az ione etiopica le ha trova te pronte e decise a non subire alcuna inizi a tiv a aggressiva.
T utta l'Italia in piedi saluta i suoi soldati. E chiama, fi e ra e consapevo le, tutt e le sc hi ere lontane, oggi impr ovv isamente vicine ai n os tri Cuori. Dogali, Amba Alagi , Coatit, Senafè, Cassala, Macall è, Adua , Adua sfortunata ma g lo riosa ch e a llineò i morti dei s uoi battaglioni , ri so rgono dalla storia per il diritto c p e r la meritata conqui s ta italiana. Ritornano i nomi ca ri: De Cristoforis, Toselli , Arim o ndi. da Bormida, Galliano, e tutti gli eroi che cade ndo ebbero la ce rt ezza di que s ti giorni , e tutti g li esp loratori nostri di terra africana, ch e cadendo ebbero la visio n e di questo presente, p e r loro ancora lontano avvenir e . Tutta l'Itali a è in p iedi per agire da so l a senza nulla chieder e . Chiede soltanto rispetto, giu s ti z ia , poiché ess a saprà raggi un gere la vittoria. E Dio la concederà.
Soldati d'Italia , Per iniziativa di S.E. Staracepresidente dell'Ente Radio Rurale - c col concorso dell'E.I.A.R.- presieduto da S.E. Vallauri- si inizia oggi una serie di radiotrasmissioni domenicali, che io inauguro inviando il mio cordiale saluto ai duecentomila soldati, che mi ascoltano nelle caserme, e alle loro famiglie, che pure mi sentono nei rispettivi paesi.

L'Ente Radio Rurale ha il nobilissimo compito di diffondere ne] popolo la cultura che vale a sempre più elevarlo,
perché sempre migliore ne sia il rendimento.
Ed ora di questa opera altamente patriottica potrete t rar profitto anche voi, perché giungerà costantementenelle vostre sale convegno -la rievocazione delle grandi tradizioni della nostra ltaJia; la narrazione delle imprese compiute dalla nostra gente; la vibrazione di tutto ciò che interessa la nostra vita in questo periodo in cui il popolo italiano - animato dallo spirito innovatore del Fascismo - compie la sua ascesa: ascesa sicura, perché il nostro popolo sa sposare decisione a tenacia, slancio a disciplina , sacrificio a gloria.
Le radiotrasmissioni dimostreranno come non vi sia zona del sapere umano ove non brillino, come fari di orientamento, nomi italiani. Non vi è punto nel mondo ove il nome di «Roma» non suoni sinonimo di «fondatrice di imperi e di civiltà ». Non vi è una grande città ove l'arte italiana non abbia fatto sorgere opere immortali.
Non si possono rievocare grandi avvenimenti storici senza ricordare i nomi dei nostri condottieri: Scipione l'Africano, che varca il Mediterraneo per battere il nemico sulla sua terra; Giulio Cesare, che porta le armi e la civiltà romana nelle Gallie, fra i Britanni, fra i Teutoni , nei Balcani, in Egitto; Eugenio di Savoia; Napoleone; i quali, ove compaiono, portano la luce della vittoria.
E n o n è forse un m erav ig lioso frutto del genio italico qu esta radio che mi consente oggi d i parlarvi?
Galvani , Volta, Pacinotti , Galileo F e rr a ri s. ec co i n omi che seg nan o le gra ndi conquis te d e ll 'ele ttri ci tà .
Scoperta, la s ua trasformazione in moto e il s uo trasporto a gra ndi distanze, so no dovute ad italiani , come ita lian o è il gra n m o nd o d e Ji a sc ie n za che tutto r iassu m e in questo campo: Guglielmo M arconi che - con l a su a innov azion e- ha f a tto co mpi e r e un nuovo pass o a ll ' uomo ve rso la divinità , dando m odo al genio uman o di essere co nt e mporan ea mente pres e nte o vunqu e vi s ia una mente o un cuore che voglia ascoltare.
Le radiotrasmis s ioni vi ri e vocheranno g li eroismi d e ll e n os tre gu e rre di indip e nd e nza , g li ordinamenti d e lla rivoluzione fascista , ed infine i trionfi della nostra g ue rr a imp e ri a l e .
Ma non biso g na s olamente vivere del passato.
L'l ta li a o ra è i n marcia: i ricordi e l e tr a di z ioni debbono servire so lo a d are maggior fede per procedere.
Ricordate che tutto c iò che qui se ntir e te ha un solo scopo: quello di raffor z ar e s empre più la vo s tra fede n ei d es tini d ' Italia , de s tini che la sa ga ce mente del RE fissa e che il no st r o
g rande DUCE g uid a.
Attra ve rso la radio vi giungerà l'eco del lavoro in s tancabilmente tenace di t utt a la N azione c he - nell'emblem a d e l Fascio Li ttorio - riunisce tutte le sue e n erg ie per trion fa re di o gn i ostacolo. eli o gni diffic olt à .

O gg i tutti l avora no per la Patria: si fucinano armi e s trum e nti eli la vor o, si fo rgia no gli sp iriti , si a llen a no i corp i; c tutto ciò per es s er pronti a tutto d a re per essa .
E vo i , g io van i solda t i che avete la fortuna di portare le a rmi in un mom e nt o in c ui l ' Itali a - dopo aver vinto la s ua ultim a guerra eli indipend e nz a -ha ini z iat o con prodigioso s l a nci o, la s ua marcia imp e rial e; voi , dico , dovet e essere orgog li osi d el ret agg i o di g lori a, m a a nc o r più d ei d est ini c he vi a tt endono, perché sarà co n voi che ess i matur eran no .
Soldati , in piedi!
Con la visione di qu e sto altissimo compito , ch e vi è a ffid a to , co n la sacra promess a eli tutto fa r e per rendervi ca pa ci e d egni di co mpierlo , vo lg ete la vostra m e nt e alla s acra M aes t à del RE e al DUCE , n e i qu a li s i s in t e tizz a no le g lo rie e l 'avve nir e d' Ital i a.
Sa luto a l RE!
Saluto al D UCE!
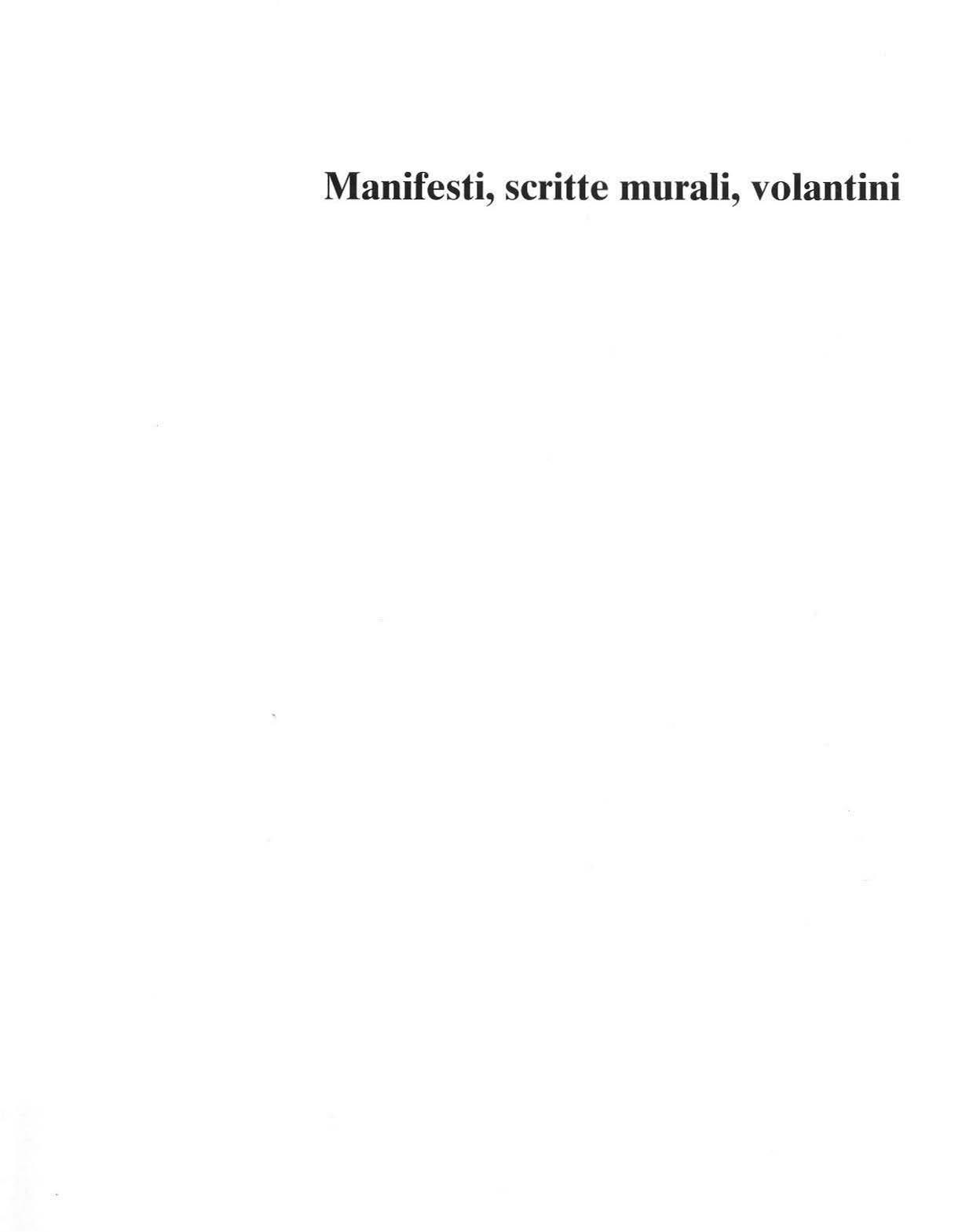

Il venten ni o fu un 'e poca rel ativamente povera di m a nifesti illustrati, per quanto attien e alla prop aga nda in gene re e a quella di guerra in particolare. Tra gli affissi murali preval sero qu e lli scr itti , e i bandi; qu est i ultimi, in determinate occasioni e soprattutto in Afric a Orie ntale, e bb ero n e tti co nnota ti pro pagand istici.
Annotiamo p er inciso ch e in campo pubblicitario il manifesto pittorico ebbe diffu sio ne ma ggio re e fu anche ogg etto d e i tentat ivi di rice rca ch e gli artisti italia ni in seg uivano (pens ia mo ai m anifesti di Prampo lini , Munari, De Pero, Sironi e di molti altri).
La scarsa utili zzaz ione d e l manifesto di propaga nda d a parte del R eg ime , a d un a prima anali s i, è poco s pi eg abile; né convincono affr ettate d e du z ioni che s i rifanno ai costi ch e il manifes to di seg nato a vr eb b e avuto: esso era uno strum e nto pubblicistico di facile reali zzaz ione e di indubbi a e fficacia, ancora oggi lar ga nìente usa to , non os t a nt e s ia superato , qu a nto a t ec ni ca, da b en più inci s ivi mezzi di comunicazione di massa.
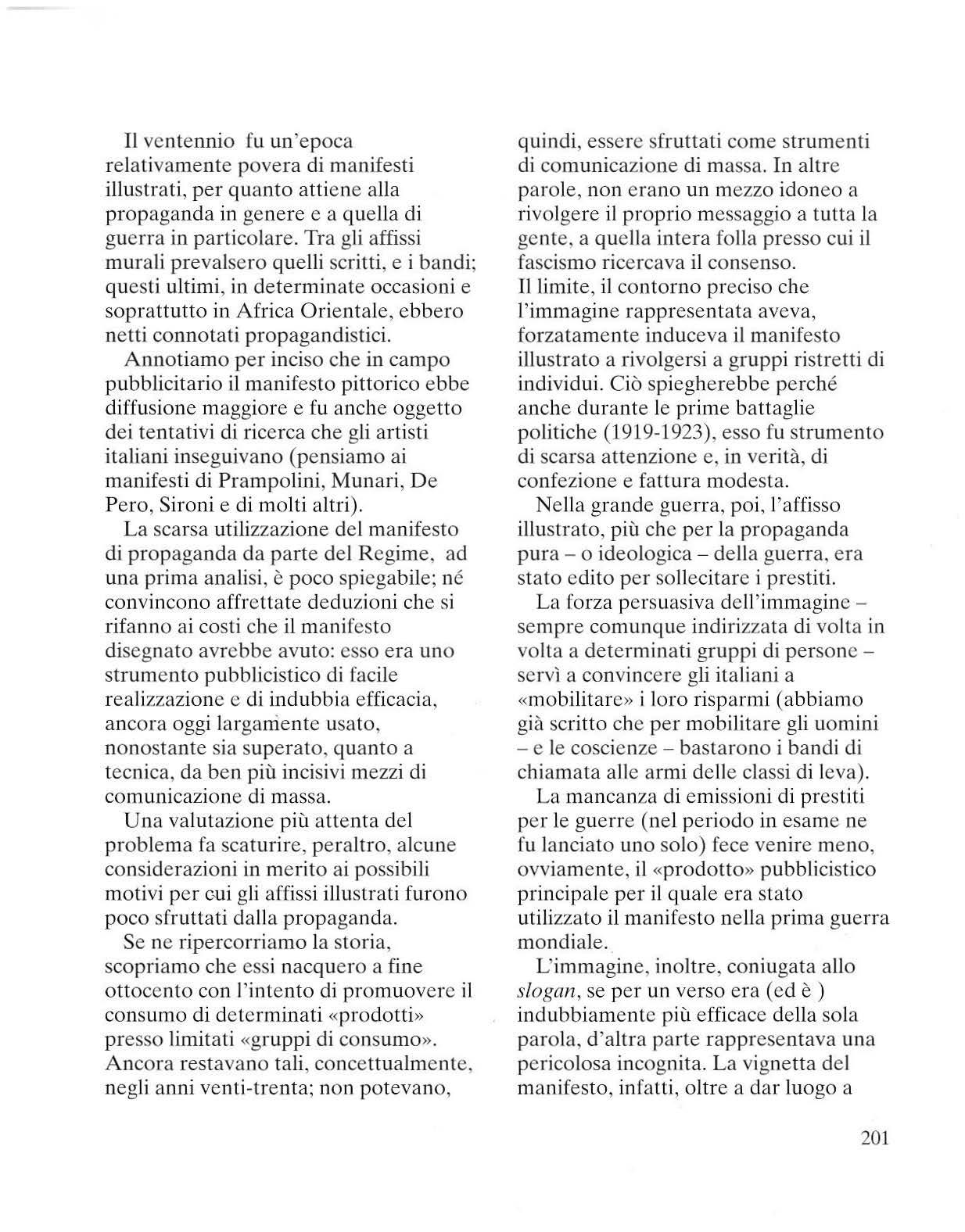
Una valutazione più att e nta del probl e ma fa scat urir e, p era ltro , alcun e considerazioni in m e rit o ai possibili mo tiv i per c-ui g li affissi illu s trati furono poco sfruttati dalla propa ga nda.
Se n e ripercorriamo la sto ria , scopriamo ch e ess i nacqu e r o a fine ottoce nto con l ' intento di promuov e r e il cons umo di d ete rminati «pro dotti » presso limitati «g r uppi di co nsumo ». An co ra r estava n o tali , co nce ttualm e nt e, ne gli anni venti- t renta; n o n potevano ,
quindi , essere s fruttati co m e strumenti di com uni cazione di ma ssa . In altre parole, non e r a no un m ezzo idon eo a rivolgere il proprio m essagg io a t utt a la ge n te , a qu e ll a intera foll a presso cui il fasc ismo ri cercava il consenso. Il limite , il contorno preciso che l'immagine rappresentata aveva, for za tament e induceva il manifes to illu st rato a ri vo lge r si a gr uppi ristre tti di individui. Ciò s piegherebbe perché anch e durant e le prim e battaglie politiche (1919-1923) , esso fu strumento di sca r sa atten zione e , in verità, di confez ione e fattu ra mod es ta.
N e lla grande guerra , poi , l'affisso illus trato, più che per la pro p aganda pura - o ideol og ica - dell a guerra , e ra sta to e dito p er so llecitare i prestiti.
La forza p ers uasiva d e ll ' immagin ese mpre comunque indiri zza ta di volta in vo lt a a dete rmin at i gruppi di perso neserv ì a convin cere gli itali a ni a «m obi litare » i loro risparmi (abbiamo già sc ritto ch e per mobilit are gli uomini - e le coscie nze- basta r o no i bandi di chiamata all e a rmi d e ll e classi di leva ).
La mancan za di emissioni di pr estiti p e r le guerr e (ne l period o in esam e n e fu lanciato un o so lo) fece ve nir e m e n o, ovv iamente, il « prodotto» pubblicistico prin c ipale per il quale era s tato utili zz ato il manifesto n e ll a prima g u e rra m o ndiale.
L' immagine , i noltre, co niu gata a ll o slo gan, se p er un verso era (ed è ) indubbiamente più effic ace d e lla so la paro la, d ' altra p a rt e r apprese nta va un a p er icolosa in cog nita. L a vig netta d e l m anifes to, in fa tti, oltre a dar luogo a
interpr etaz ioni ed a considerazioni controproducenti -s i riflett a un attimo sugli effetti che può produrre sul destinatario il di segno di un orfano in lacrime, o di un milit a r e mutilato che incitano al prestito di /e/o alla g uerra -s i presta a nche a int e rpretazioni ironich e, umoristiche, sarcastiche, qu anto non proprio di ss acratori e .
La ferti le fanta sia e d arguzia italica è stata sempre ma estra in questo campo; tanto per fare un esemp io , lar ga mente noto- m a di episodi sim ili si h a notizi a anche pe r la prim a g uerra mondi a le - ci spostiamo per un m o mento n e l tempo. Molti ricordano il manifesto ed ito dalla Repubblica Social e Italiana , c he, ripetendo un tema più volte s frutt a to , mostrav a il so ld ato dal volto sev ero e il dito puntato, mentr e incitava con lo slogan - anche esso a busato - «E tu che fai!» cui fece eco la lapidaria r e plica , apposta da mano «ig nota » s u molt i d e i manife st i: «Il partigia no » . Mat e riale da manual e, che gli ideatori di manifesti di propa ga nda sempre dovrebb e ro te ner presente .
Queste poss ibili a rgome nt azio ni dovett e ro avere il loro peso s ulla scarsa diffusion e del manif es to illu s tr a to di propaganda ; n e con se guì che le emissioni furono limitate a poche occasioni. A parte la sca rsa produzione per gli avve nim e nti , per i fa s ti e per le ricorrenze d e l R eg ime , la pr opag anda militar e ricorse saltuaria m ente all ' imm ag ine nei m a nifesti p er g li arruolamenti e per la vittoria in Etiopia. Le firm e furono di Pi s ani , Tod es ch in i, Gros , R etrosi, Bo rghi, Ro veron i ,
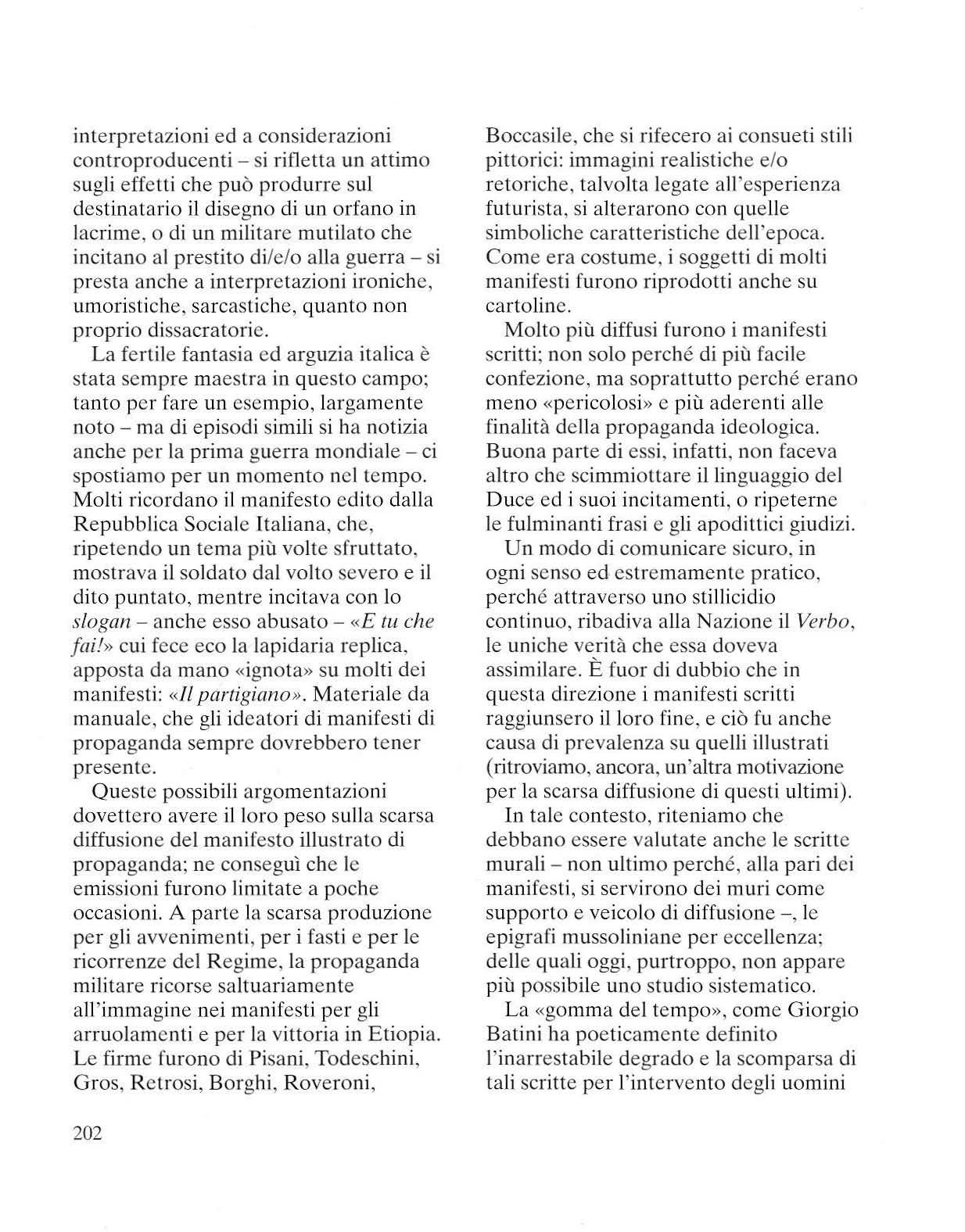
Boccas il e, che s i rifecero ai cons ueti s tili pittori ci: imma gi ni realistich e e/o retori ch e, talvolt a leg ate all 'es perien za futuri s ta , s i alterarono con qu e lle simboliche caratt e ristiche de ll 'e poca. Com e e ra costume, i soggetti di molti manifes ti furono riprodotti anche su cartolin e
Molt o più diffu s i furono i manifesti s critti; non solo p e rché di più facile confezio n e, ma sop rattutto p e r c hé eran o meno « pericolosi» c più ad e r e nti alle finalit à della prop aga nda id eo l ogica. Buona parte di ess i, infatti , n o n faceva altro ch e scimmiottare il lin g uaggi o del Duce e d i suoi in c i tam enti , o ripeterne le fulminanti fra s i e gli apodittici giudi zi.
Un m odo di comunicare s ic uro , in ogni se ns o ed est r e mament e pratico, perch é att raver so uno stillicidio continuo , ribadiv a alla Na zio n e il Verb o, le unich e ver it à ch e essa d oveva as s imil are . È f uor di dubb io c he in questa direzione i manifesti scr itti raggiun se ro il loro fine , e ciò fu anche causa di pr ev alen za s u qu e lli illustrati (ritroviamo , ancora , un ' altra m ot ivazione per l a sca rsa diffu s ione di qu es ti ultimi).
In t a le contesto , riteniamo che debban o esse r e va lut a te anch e le scritte mur a li - non ultim o perc hé, a lla pari dci manifes ti, si servirono dei muri come supporto e veicolo di diffu sione, le e pi grafi mussoliniane p e r ecce llenza ; dell e qu a li oggi , purtroppo , non appar e più poss ibi le uno s tudio sistematico .
La «gom ma del t e mpo», come Gior gio Batini h a poe tic a m e nte definito l' inarr es tabile d eg rado e l a sc omparsa di tali scritte per l ' in te rvento d eg li uomini
e d egli agenti atmosferici, consente infatti di cogliere ogg i solo i frammenti di quello che fu un mod o diffusissimo di far propaga nd a. E che r esta, n e lla storia del pubb li cismo. come u n fenomeno esclus iva m ente italiano, le cui origini vanno ricercate ne lla pr ima g uerra mondi a le ( «0 il Piave o tutti accoppiati » ). Tanto per non a ndar e t r oppo lontano nel tempo. Un fenomeno ritenuto così degno di att e nz ione, da esse re codifi cato: tipi di scritte, gra nd ezza de i caratteri , vernici da u sare, e di fi c i o case da utilizzare come s upport o, trovaro n o la loro norm a tiva perch é l ' epigr afe murale fosse sfruttat a al meglio possibile e secondo gli indirizzi d ettati dalla propaganda di Regime.
La concisione delle fras i , la fac il e lettura, la st ud iata posizion e, l a resi ste nza al tempo . l'aderenza del me ssagg i o alle di ve r se situaz io ni locali , erano ga ranzi a di continuità di fr ui z io n e, e certa m e nte d ove tt e ro avere la loro influenza s ull e ma sse Specialmente se si consid era ch e le scritte contribuivano a p er pe tuare inflessibilmente ne l t emp o, g r az ie alla lo r o durata e a ll 'im possib ilit à di sfuggire a ll a lett ura , quella percussione mart e llante c conti nua de ll e cos cienze già att uata attraverso i m a nifesti e su rr ogata dai disco r s i de l Ca po , da g li articoli dei giorna li , dalle trasm issio ni d ella radio .
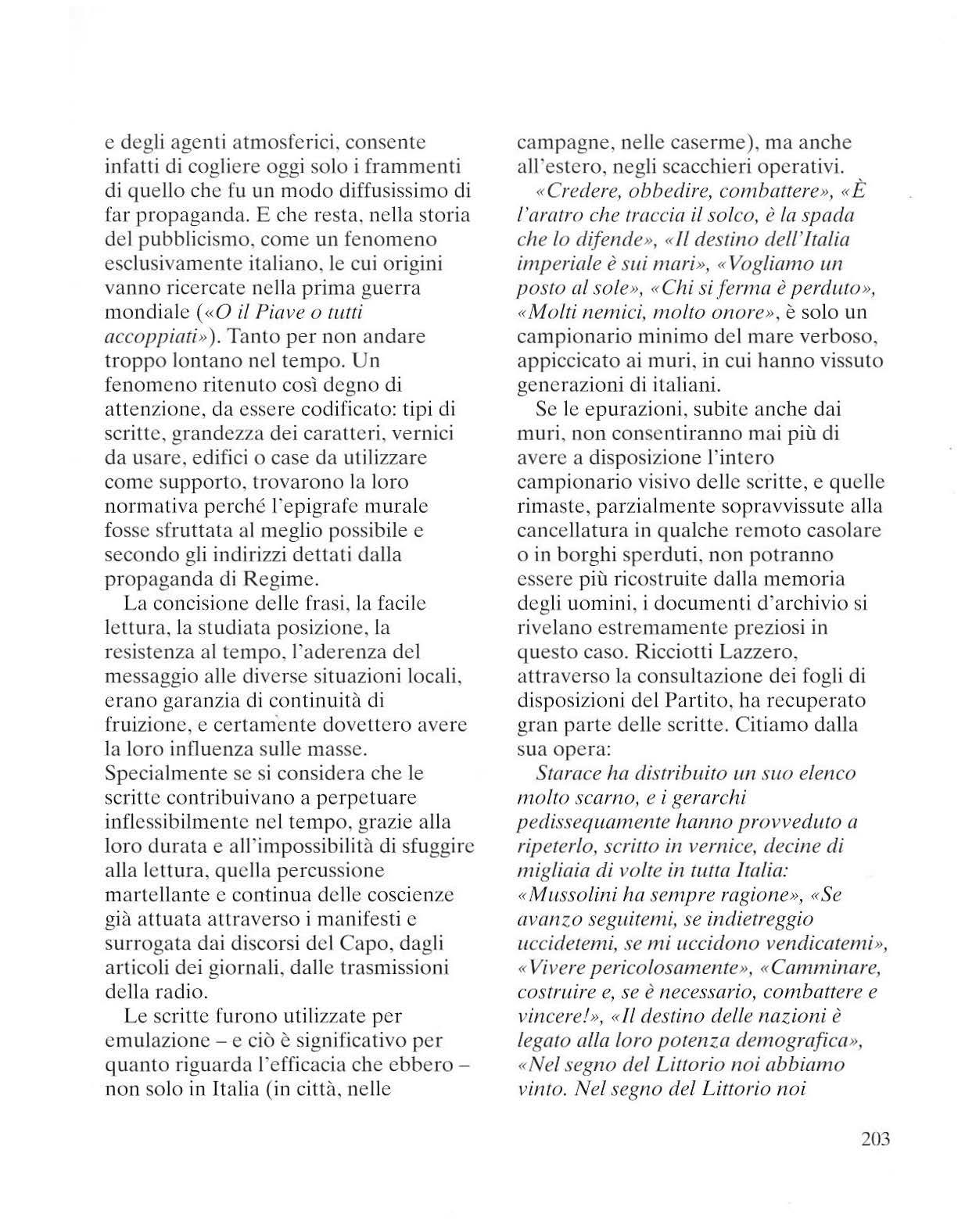
L e sc ritte fur ono utili zza t e per e mul az ion e- e ciò è s ig ni ficat ivo per qu a nt o riguarda l'e ff i cacia che ebberonon so lo in Italia ( in città , nelle
campagne , nelle caserme) , ma anch e all 'es tero, negli sc acchieri ope r ativi.
<< Credere, obbedi re, combattere», «È l 'aratro che traccia il so l co, è la spada ch e lo difende », « Il destino dell'Italia imperiale è sui mari », « Vo glia mo un posto al sole », << Chi si ferma è p erduto », « Molti nemici, molto onore », è solo un campio n ario minimo del mare verboso , appiccicato a i muri , in c ui hanno viss ut o generazioni di it a liani.
Se le epurazio ni , subit e a nche dai muri, non consentiranno mai più di ave r e a disposi z ione l ' in tero campionario vis ivo dell e sc ritte, e quelle rima ste, parzi a lm en te sopravvissute a ll a cancellatura in qualche remoto caso lare o i n bo r g hi sperd uti , n o n potranno essere più ri costr uite dall a memoria d eg li uomini , i doc um enti d'a rchi vio s i ri ve l ano estremame n te prezios i in qu esto caso. Ricciotti L azzero, attrave r so la co n su lta zione d ei fogli di di s p os izioni d e l Partito , ha recuper ato gran part e delle sc ritte. Citi a mo d alla sua opera:
Starace ha distribuito un suo elenco molto scarno, e i gerarchi pedissequam e nte hanno provveduto a ripeterlo, scritto in vernice, decine di migliaia di volte in tutta I talia : «M u sso lini ha sempre ra gio ne », «Se avan z o seguitemi, se indi e treggio uccidetemi, se mi uccidono vendicatemi », « Viv e re pericolosamente », « Camminare, costruire e, se è necessario, c ombattere e vincere!») « Il destino d e lle nazioni è legato alla Loro potenza demografica >>, « Nel segno del Littorio noi abbiamo vinto. Nel segno del Litto ri o noi
vinceremo domani», «Noi tireremo diritto>>, <<Nessuno pensi di piegarci senza avere prima duramente combattuto», <<Roma doma», «Nessuno ha potuto fermarci. Nessuno ci fermerà», « Per noi fascisti le frontiere, tutte le frontiere, sono sacre . .Non si discutono: si difendono», e alcune altre.
Quando Muti assume la segreteria del PN.F si scatena e invia ai segretari federali (<<Fogli di disposizioni» n. 40 del 28 dicembre 1939) questo suo pacchetto di frasi del Duce affinché «s iano riprodotte sulle pareti interne o esterne delle sedi del P.N.F o delle organiz zazi oni dipendenti>>.
Per le case del fascio (esterno). << Credere, obbedire, combattere», <<Solo Iddio può piegare la volontà fascista: gli uomini e le cose mai», « Il Fascismo crede ancora e sempre nella santità e nell'eroismo», «Non si può esaltare il di ieri se non si è pronti a quello di domani», « Questa è l'epoca nella quale bisogna sentire l'orgoglio di vivere e di combattere», <<Il P.N.F è un esercito: in esso si entra soltanto per servire e per obbedire», <<La pa ce per essere sicura deve essere armata», «Il simbolo del Littorio vuoi dire audacia, tenacia, espansione e potenza», « Se vuoi la pace prepara la guerra», «Mo lti nemici, molto onore».
Per le case d e l Fascio (in te rno).
«È innanzi ai nostri martiri che noi dobbiamo rispondere dell'opera nostra», «Le verghe del Fascio sono potentemente strette come non mai», <<Il Partito è l 'a rtefice della Rivoluzione, la spina dorsale del Regime, il motore delle
attività nazionali», «L'Impero chiede disciplina, coordinazione di sforzi, dovere e sacrzficio», <<IL gerarca deve avere in sé, moltiplicate, quelle virtù che egli esige dai gregari», «l migliori fascisti obbediscono in silenzio e Lavorano con disciplina», <<Né onori né cariche né guadagni, ma il dovere e il combattimento», «Noi siamo contro la vita comoda», «Il Regime fascista quando impegna una battaglia la conduce fino in fondo», «Il credo del fascismo è l'eroismo, quello del borghese l'egoismo», «La camicia nera è una tenuta da combattimento», «Vincerà chi vorrà vincere», « La Milizia fascista è la milizia volontaria del popolo», «La generazione modellata dal Fascismo: poche parole e molti fatti>>.
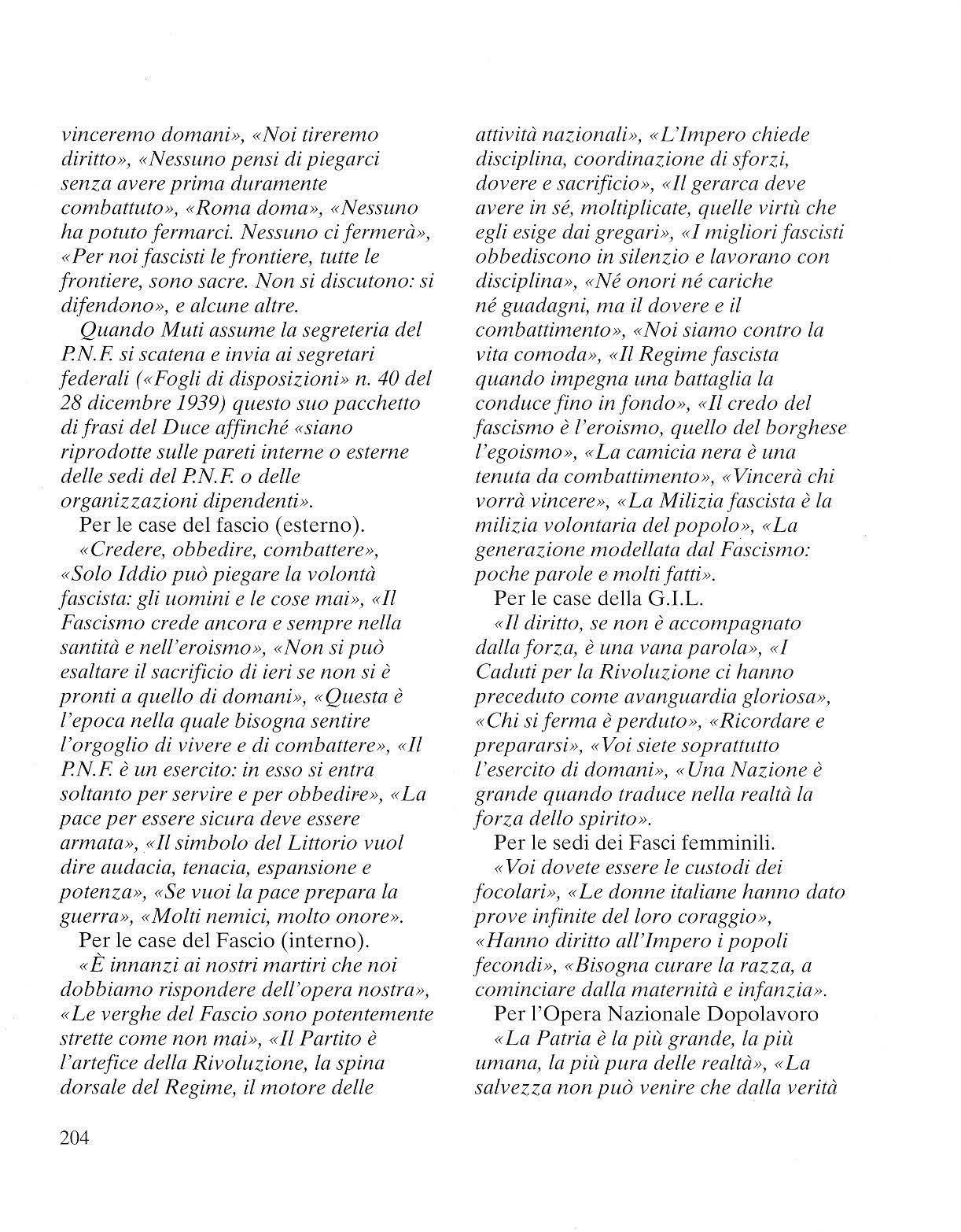
Per le case d e lla G.l.L. «Il diritto, se non è accompagnato dalla forza, è una vana parola», <<l Caduti per la Rivoluzione ci hanno preceduto come avanguardia gloriosa», «Chi si ferma è perduto», <<Ricordare e prepararsi», « Voi siete soprattutto l'esercito di domani», «Una Nazione è grande quando traduce nella realtà la forza dello spirito».
Per le sedi dei Fasci femminili.
«Voi dovete essere le custodi dei focolari», «Le donne italiane hanno dato prove infinite del loro coraggio>>, «Hann o diritto all ' Impero i popoli fecondi», «B isogna curare la razza, a cominciare dalla maternità e infanzia»
Per l'Opera Nazionale Dopolavoro «La Patria è la più grande, la più umana, la più pura delle realtà », <<La salvezza non può venire che dalla verità
di Roma, e da Roma verrà », « La Patria si serve soprattutto in silenzio, in umiltà e in disciplina », «Abituare gli italiani al moto, all'aria aperta>>
Per le case rurali « Condi z ione insostituibile del primato è il numero », «Bisogna essere forti prima di tutto nel numero», «l popoli che abbandonano la terra sono condannati alla decadenza », «Bisogna dare la massima fecondità ad ogni zolla di terra», «Le nazioni solide, le nazioni ferme, sono quelle che stanno poggiate sulla terra>>, « Verso la terra debbono volgersi le speranze e le energie dei popoli », « Gli eserciti si perfezionano combattendo,· cosi avviene dell 'esercito rurale italiano », <<La vera fonte, la vera origine di tutta fattività umana è la terra », << È l'aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende ».
Pe r le fabbriche e sedi sindacali «Il popolo è il corpo dello Sta to, e lo Stato è lo spirito del popolo », «Nell ' Italia fascista il capitale eagli ordini dello Stato», «Anche con l'opera,. minuta ed oscura, si fa grande la Patria», «Il lavoro è la cosa più solenne, più nobile, più religiosa della vita>>, «Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato »
Per le Città Marinare «Tutta l'Italia è sul rnare », «Se per gli altri il Mediterraneo è una strada, per noi italiani è la vita» . * * *
I volantini furono uno strumento pubblicistico quasi esclusivo della
propaganda di guerra. Fatta eccezione p e r le tirature edite in occasione della battaglia politica condotta a cavallo d e gli anni venti , essi furono stampati in massima parte durante l' occupazione di Fiume, la guerra italo -etiopica e la campagna di Spagna.
Come strumento di propaganda, il volantino era ed è un prodotto di facile allestimento. Dal punto di vista tecnico , non richiedeva complicati macchinari: anche la più improvvisata tipografia era in grado di stamparne e , al limite , poteva sempre essere riprodotto con strumenti poveri come il poligrafo o il ciclostile.
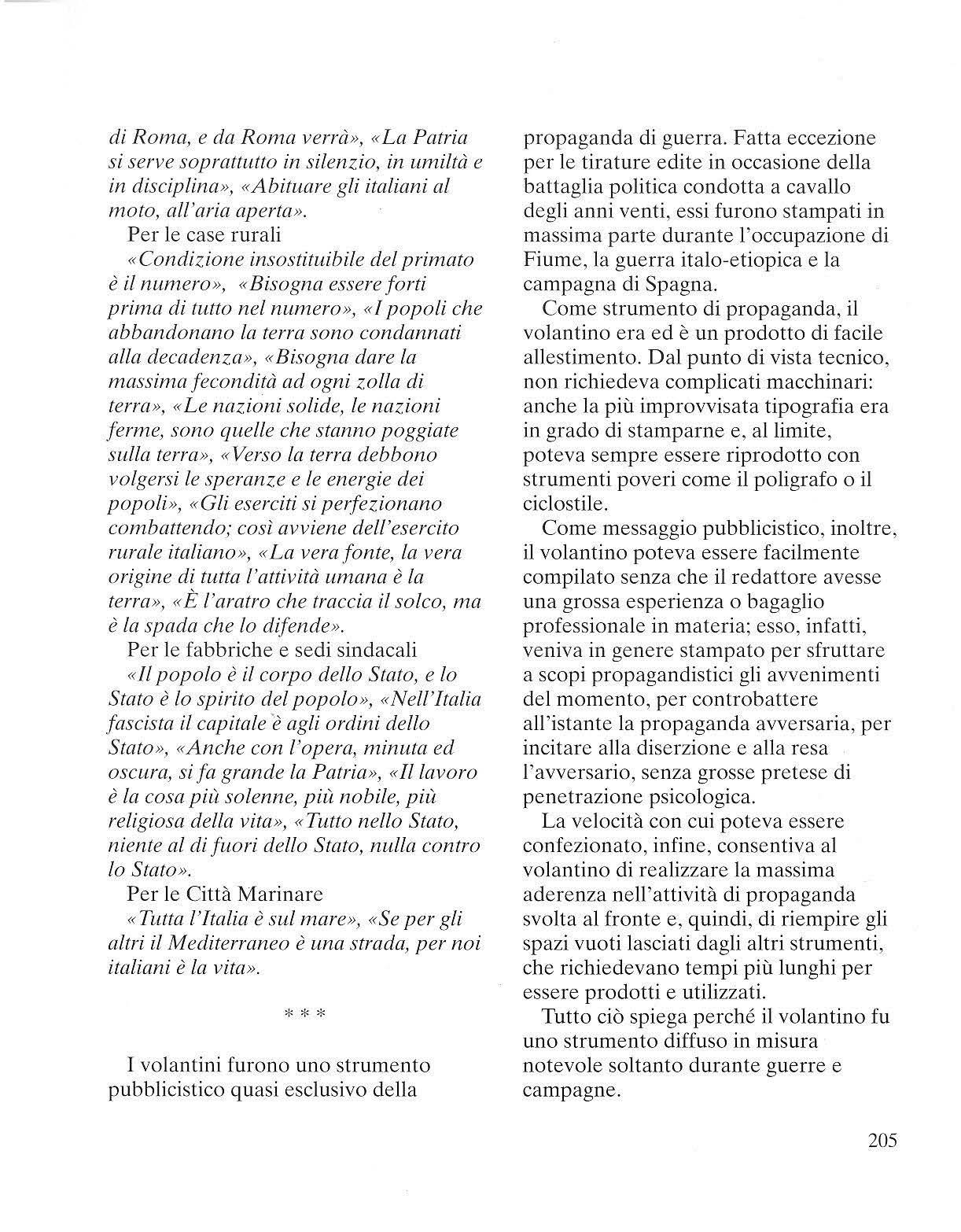
Come messaggio pubblicistico, inoltre , il volantino poteva essere facilmente compilato senza che il redattore avesse una grossa esperienza o bagaglio professionale in materia; esso , infatti , veniva in genere stampato per sfruttare a scopi propagandistici gli avvenim e nti del momento, per controbattere all'istante la propaganda avversaria, per incitare alla diserzione e alla resa l'avversario, senza grosse pre tese di penetrazione psicologica.
La velocità con cui poteva essere confezionato, infine , consentiva al vo lantino di realizzare la massima aderenza nell'attività di propaganda svolta al fronte e , quindi , di riempire gli spazi vuoti lasciati dagli altri strumenti, che richiedevano tempi più lunghi per essere prodotti e utilizzati.
Tutto ciò spiega perché il volantino fu uno strumento diffuso in misura notevole soltanto durante guerre e campagne.
I volantini confezionati dai Comandi it a lian i in Etiopia ricalcarono i temi ideologici che av ev ano gius tificato lo scoppio del co n flitto: lotta alla schiavitù, liberazion e degli oppr ess i , iniziazione alla civil tà. Rar a ment e furono minacciosi (il s oldato italiano è sacro e chiunque lo tocchi s arà passato per Le armi), molto più spes so rass e renanti (promess e di non toccare villaggi, do nn e, chi ese e organizzazioni sociali) e accattivanti (l e popo l azi oni non osti li sa rebbero state ricompensate a fine g ue rra) .
I vola nti ni diffusi d ag li. etiopi e dall e Nazioni sos tenitrici d e l Ne g us , ripet e rono , a loro vo l ta, la propaganda co nt ro l'azione aggress iva e prepotente dell ' Itali.a, bollata dalle Nazioni Unite con le sanzioni.
D i diver sa na tu ra furono i volantini d iffusi in Spagna; in essi la ferocia del confl itto, ideologico c militare , fu se mpr e prese nt e nei contendenti di ambo le p arti . L'odio fu visceral e e d es trin secato in esp r essio ni fort i
L u s ingh e e promesse fu r ono ri se r vate s olo ai volantini che incitavano alla diserz io n e. La crud ezza de llo scont ro non conse ntì compromessi di alcun ge n ere. È da annotar e, comunque , ch e non fu permesso , se non raramente, ai Comandi italiani di stampare vo l a ntini: il Generaliss imo mal to ll erava ch e l ' a ll ea t o prod ucesse in proprio
.
A ss iem e ai volantini, ai bandi ed ai manifesti , riapparv ero du ra nt e le gu e rre stampe va ri e di propaganda, che non è poss ib ile ig n orare per la diffusione che esse ebbero, anche se è difficil e dar loro una connotazione sp e cifica.
Ci rife ri a mo a canti, preg hier e, ed elaborati di vario genere c he gi un gev ano a i so ldati a l fr o nte , e me ssi spesso da privati , m a a ppr ova ti e diffusi dall' a utorità militar e .
Ult im o fenomeno rilev an te , c he p e r comodit à di tr at tazi o ne qui ri cordiamo , f ur ono le le tt e r e inviate ai combatt e nti dall e s col a resche ch e aveva n o se mpr e pres e nte l'immagin e dei s oldati e d e lla guerra, p e rfin o s ull e copertine dei quaderni. Sulla sc ia di quanto e ra già s uccesso nella g rand e g u e rra. le lette re se r vivano a ri nsa ld are i leg ami tra For ze Armate e Na z ion e e a t e ner e alto il morale del soldato , per la ben e fica influ e nza p s icologica c he pot e van o indurre n e ll'animo d e l combatt e nte il confortevole ricordo, il caloroso s aluto c l ' incitamento genuino eli giov ani vite , alle q uali egli si sentiva legato istintivament e da se ntim e nti di affetto e a nalo g ic am e nt e da vincoli di sangue.
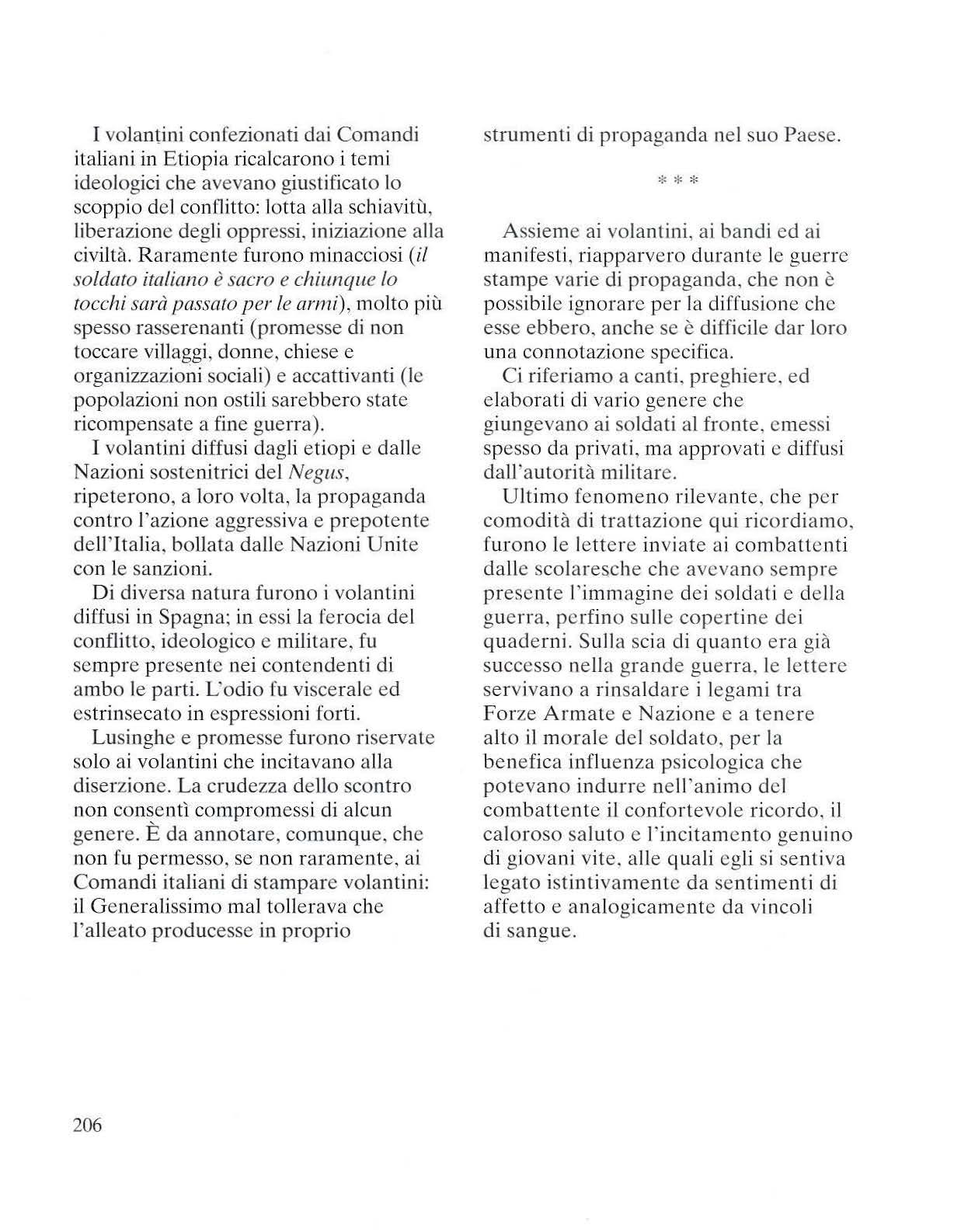
Parole del Generalissimo ARMANDO
Capo dell'Esercito Italiano: '' l resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo, risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza l ,
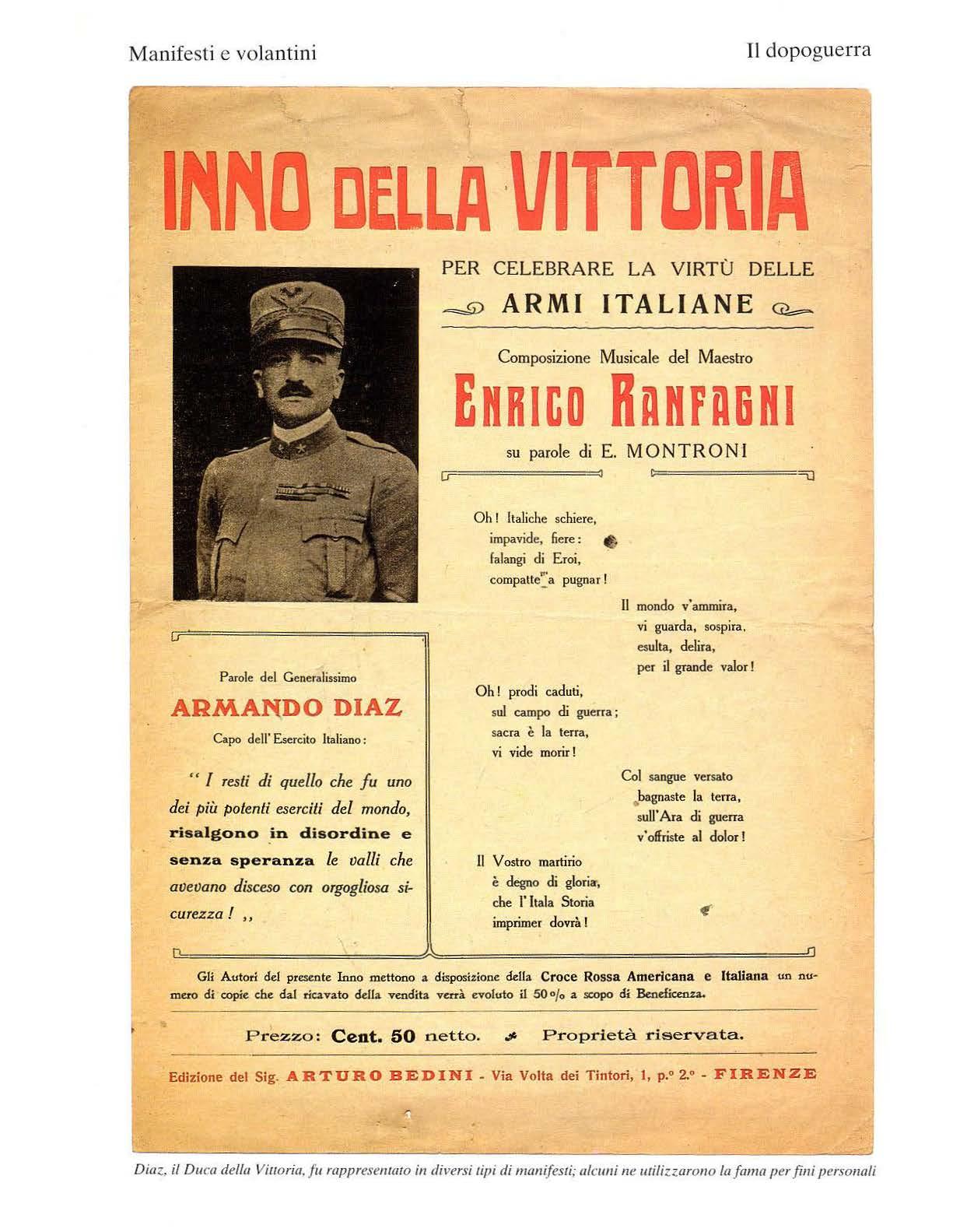
Composizione Musicale del Maestro su parole di E. MONTRONI
Oh ! ltaliche schiere, impavide, fiere : • falangi di Eroi, compatte: a pugnar!
Il mondo v'ammira, vi guarda, sospira, esulta, delira, per il grande valor l
Oh! prodi caduti, sul campo di guerra ; sacra è la terra, vi vide morir !
Col sangue versato bagnaste la terra, sull'Ara di guerra v'offriste al dolor !
Ci?.=-
Il Vostro martirio è degno di gloria-, che l' Itala Storia imprimer dovrà l
Gli Autori del presente Inno mettono a disposizione della Croce Rossa Americana e Italian a uo numero di copie che dal ricavato della vendita varà evoluto il SO ofo a scopo di Beneficenza.
Prezzo: Cent. 50 nett o. .:1- Proprietà riservata. Edizion e del Sig AR T URO BEDIN I- Via Volta dei Tintori, 1, p o 2 0 - F IRENZ E
Dia z, il Du ca della Viuoria, jit rappresentato in diversi tipi di manifesti; alcuni ne utilizzarono la fama per fini personali
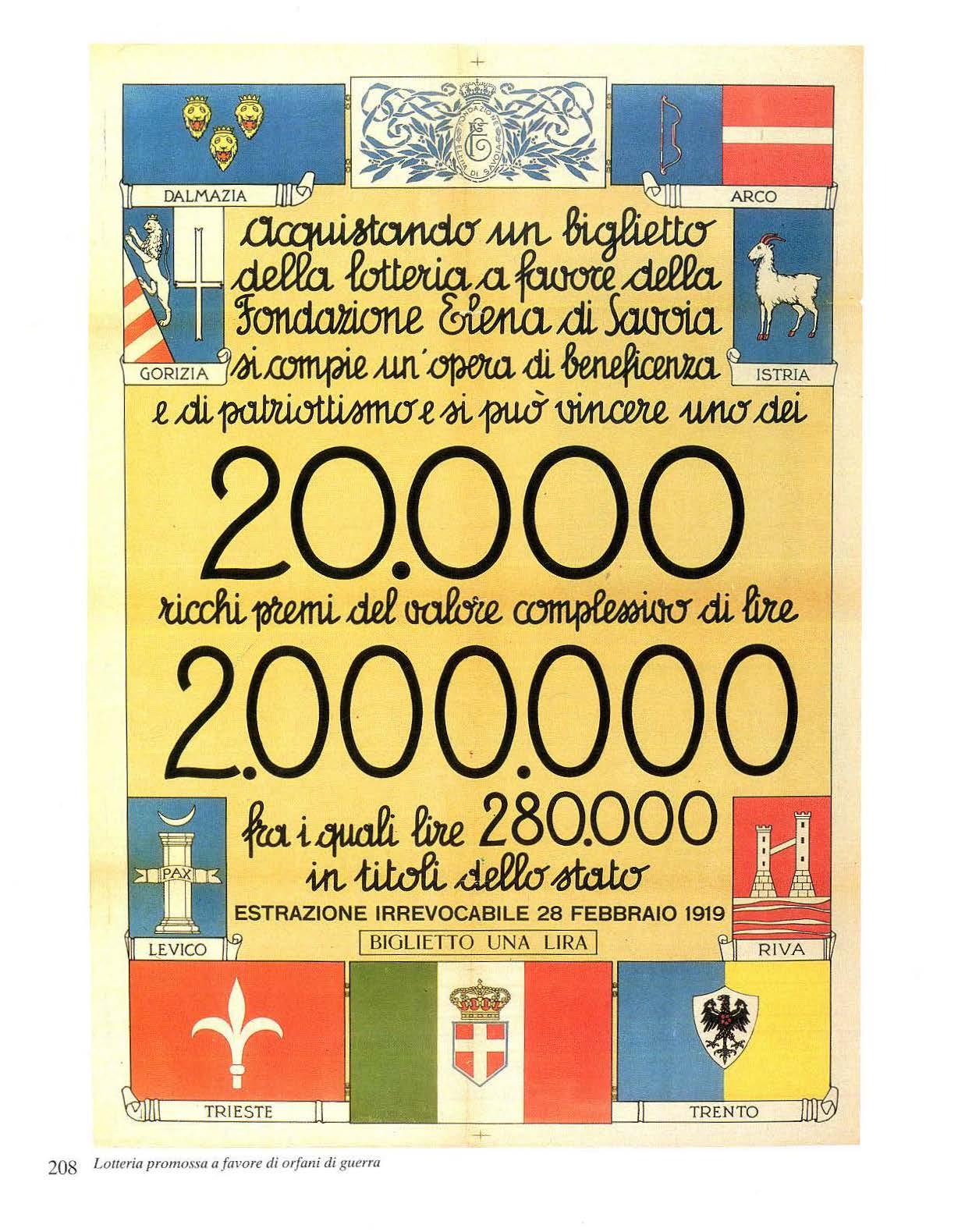
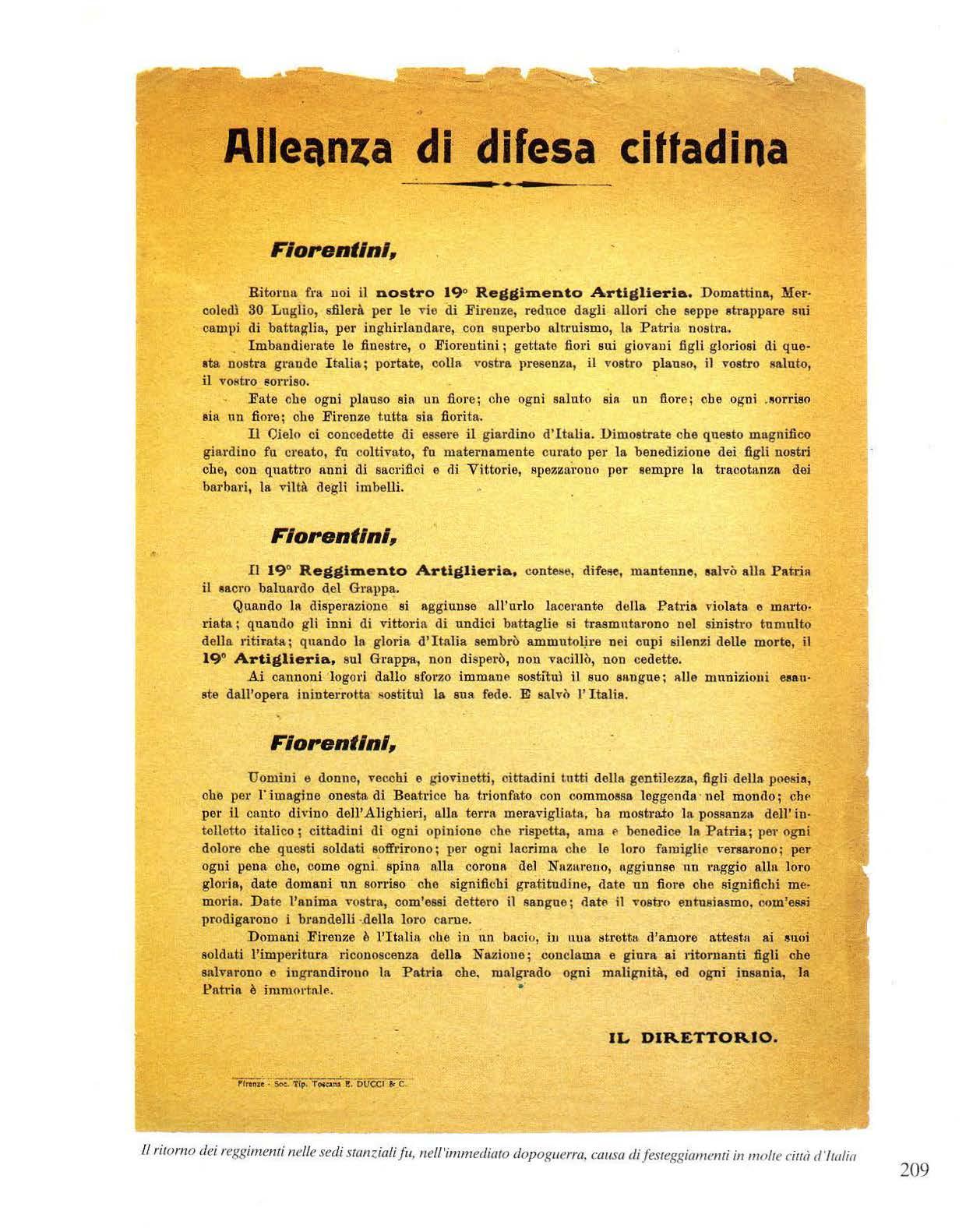
Ritoma fra noi il no s t r o 19° Re gghnent o Arti g lier i a. Domattina, Mer· coledi 30 Luglio, sfilerà per le "'"io di Firenze, reduce dagli allot·i che seppe strappare su i campi di battaglia, per inghirlaudare, con superbo alt.ruiswo, la Patria nnst.ra.
I m bandierate le finestre, o Fiorentini; gettate fiori s ui giovani fig l i glori osi di que· eta nostr a gmndo I talia; portate, coli n vostra presenza, il vostro plauso, il vostro R&l ut.o, il voatro eo r riso.
Fate che ogn i plauso s ia un fiore; ohe ogni salnto siA nn ftorr; che ogni l!orr ieo 11i a un fi ore; che F irenze t.ntta sia fiorita.
Il Oi el o ci concedette di essere il giardino d'Italia. Dimostrate che questo mugnifi.co gia rdino fu creato, fn roltivato, fu maternamente curato per la benedizione dei figli nostri che, con quattro an n i tli sacri fici e il i Vittori e , spezzar ono per se mpre In tracotanza dei barbari, la viltà degli imbelli.
Il 19° Reggimen to Artiglier ia , conte8e, di f ese, mantenn e , salvò alla Patria il sacro baluardo del Grappa.
Quand o 111 dis peraz i one si agg iu nse all'u rl o lacemnte élo ll a Patria ' ' iolata o m11rto· riata; quando gli inni di vittorio di undici battaglie si trasmntarono nel sinistro tumulto della r iti r ata; quando l a gloria d'Italia sembrò am m utoljre n ei cupi silenzi delle mor t e, i l 19° Arti g lieria, sul Grappa, non d i sperò, non vacillò, non cedette.
A i cannoni l ogori dall o sforzo immane sostitul i l suo s•mgue ; alle mnnizio u i u a n· ste dall'o pera ininterrotta I!Oetitul l a sua fede. E salvò l' I talia.
Uomini e donne, vecchi e giovinetti, cittadini tutti della gentilezza, figli della · pt>es ia , che per l'i magi ne onesta di Beatrice ha trionfato con commo11sa l eggenda · n el m on d o; oh P per il canto divino dell 'Alighi eri, a !ltt temt meravigliata, ba mostrato h\ dell' iu· telletto italico; cittadini di ogni opinione che rispetta, ama P benedice la Patria.; po1· ogni dolore che questi soldati soffrir ono; per ogni lacr ima che le loro famiglie ,·eraarono; por ogni pena che, co m o ogni s piu n, nllu, coro nA, del Nmmreu o , ttgginne e nn 1·aggi o 111ltt lo ro g l oria , d a to domani un sorriso che significhi gratitudine, <lato un fiore obo significlli me· moria. D ate l'an ima vostrn, com 'essi dettero il sangue; dRt!' il vost.ro eutus iaamo. o<>m'e811i prodiga r ono i brandeJli .della loro carne.
Do m an i F i r en ze è l' Italia obo ìn im baciu, i u nua 11tretttt d'amore attesb1 ai e u oi soldati l ' impel'itu.ra riconoscenza dell a N azione; conc lama e giur a ai ritornanti figli che salvaron o e ingrand irono l a Patri a che. malgrado OJtn i malign i tà, ed ogni insan i a, 111 Patria è immorhtiP-.
il ritorno dei reggimenti nelle sedi swnzia li ji1, nell'immediato dopoguerra. causa di festeggiamenti in molle cituì d '/tu/i o
A t utti g li u f ficiali mobi lita ti d el/e categorie In conge do.
Signori Ufficiali,
A voi tutti, Ufficiali delle categorie in congedo, che la smobilitazione restituisce ai consuetj ordini della vita civile, mi è caro esprimete la mia grat itudine per la collaborazione oltremodo pre zi osa che durante la guerra ave te dato ai fini della vittoria e porgere il saluto dei cam erati dell'Esercito permaneme coi quali avete diviso in largo tributo di sa n gut: e di gloria le asp r e vicende di quattro anni di guerra.
Chiamati in difficili contingenze ad un a n uova forma di vita e di opere: assunto , per la maggior par te do po un periodo di preparazione brevissimo, H non lieve e non facile compito di essere guida ed esempio agli uomini lanciati nel turbine della lotta immane, voi, quasi due volte decuplicando l 'efficienza numerica dei quadri, av e te portato ali ' Esercito il concorso fecondo del vostro patriottismo, del vostro intelletto, della vostra energia.
Prontame n te fusi co n gli Ufficiali del servizio attivo perma ne nte, supplendo col fervore d ell'entusiasm o e co!la tena('ia del volere alla brevissima preparazione, deste sempre prove indiscusse di mirabile valore ed abnegazione e foste d'esemp io e d'inc itamento ai vos tri soldati. ·
II collo camento in congedo non vi allontanerà per ò dall'Esercito, che le vicende di questi ultimi anni hanno ancora più intimamente fuso colla nazione: in ognuno di voi r esterà vivo il ricordo e l'orgoglio di quanto in esso, scuola virile di coraggio di fer mezza e d i sacrificio, si è compiuto.
So n certo che voi co n tinue r ete ad essere nella vi ta civi le gli educ a tor i de l popo lo n ell'amore della Patria e delle sue istituzioni. compito nobilissimo cbe spetta sopratutto a chi come vo i può dire: lo ero là dove si è combattuto e s i è vinto
Dal Comando Supremo, Roma 22 agosto 1919.
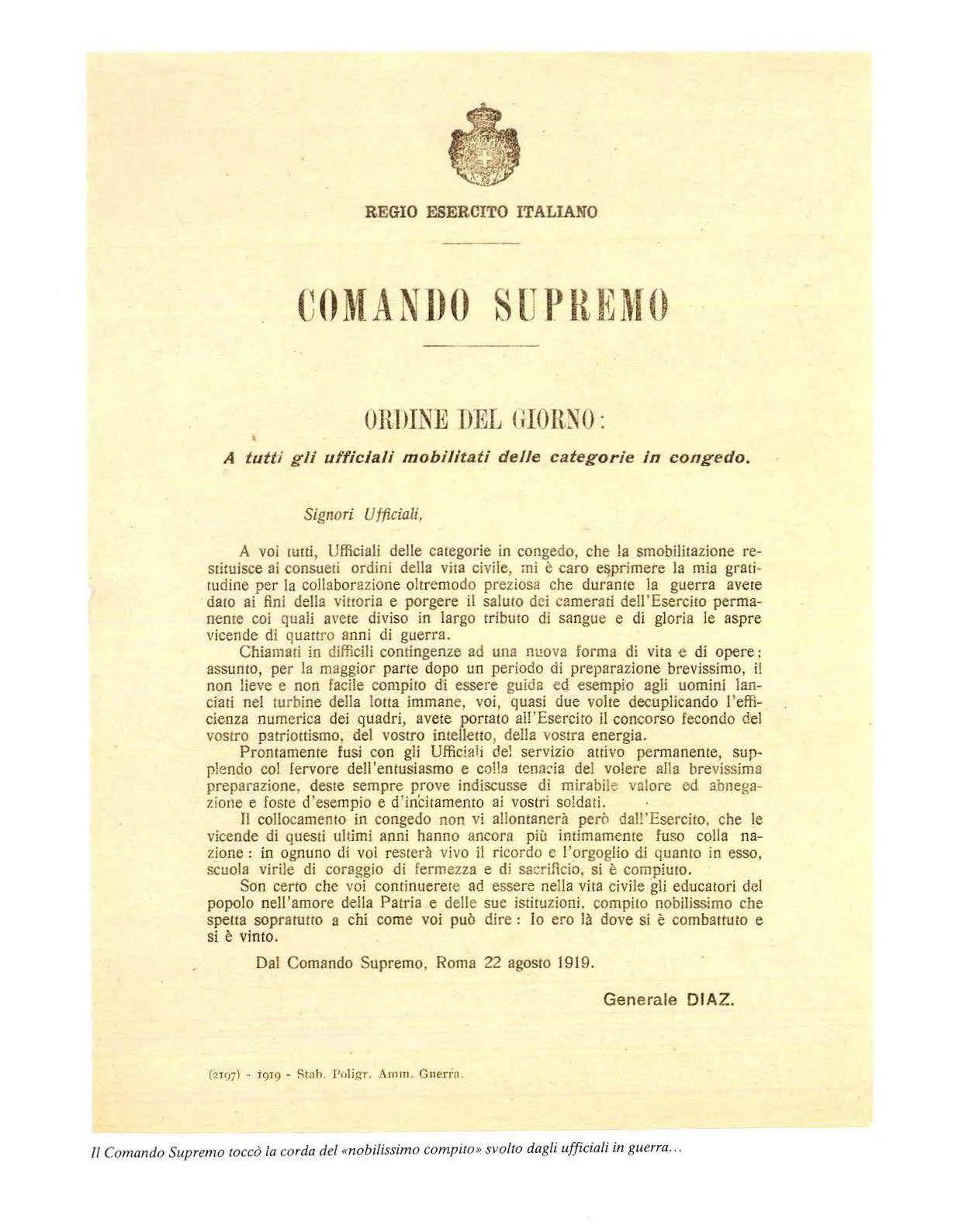
Generale DIA Z.
Il Comando Supremo toccò la co rda del «nobilissimo compito» svolto dagli ufficiali in guerra
I nostri vittoriosi soldati tornano a casa. Dalle spedizioni d'oltremare, dalle terre redente e da quelle ancor rotte di trincee e di ricoveri , dai depositi delle retro vie e da quelli territoriali tornano , diversam ente e pur tutti beneneriti della patria, tutti animati dallo stesso pemìiero: riprendere la vita di famiglia e l'ant1m lavoro. La dolce speranza che li èonfortò per mesi e per anni sotto le armi nelle ore di tedio e in quelle dì pericolo, che nei momenti più tristi parve sogno ormai inavverabile, sembra loro sul punto di tradursi in realtà. Invece davanti a molti, davanti a troppi, sorge lo SJettro crudele della disoccupazione: .il sognato la..voro è l'inutile pellegrinaggio da un Jaborat<rio all'aUro, dall'uno all'altro ufficio di collocamento.
Cittadini di Firenze non dovete permetterlo! Non basta a parole rovesciare la coltJa sul governo ladro. sul comune inetto, e sulla grande industria rapace , e dire che la disoccupazione è problema statale e non tocca interessarsene al privato cittadi no che aspetta tranquillo i ribassi futuri.
Non interessar-sane è anzi stolto e cier,o egoismo, che attenuano solo in le elargizioni di denaro·per beneficenza. La miglior bemficenza è il dar lavoro. E se non volete darlo per beneficenza, datelo nel vostro interesse. Meatre aspettate gli sperati ribassi , che nulla fa prevedere vicini, i piccoli guasti diventano i bisogni diventano necessità impellenti e intanto cresce il disa€'10 e il giusto malcontento de i dis6ccupati. Temete che essi porgano orecchio a cattivi consigli ed a perfidi 1 E qual peggiore incitamento che vedersi negato il lavoro di cui è palese la necessita 1 ] cornicione che cade, la grondaia ohe gocciola, la finestra che non chiude, i vetri rotti. le fac.ciate scrostate parlano più eloquentemente all'operaio in cerca di lavoro che non la direttissima e le altre opere pubbliche di là da venire.
Date lavoro ognuno secondo i propri mezzi ed i propri bisogni at t uali: nessuno creda che l'azione sua: per quanto piccola, sia senza effetto. date lavoro per amore di patria, per dovere sociale, per giusta. visione dAll 'i nteresse generale e del vostro particolare.
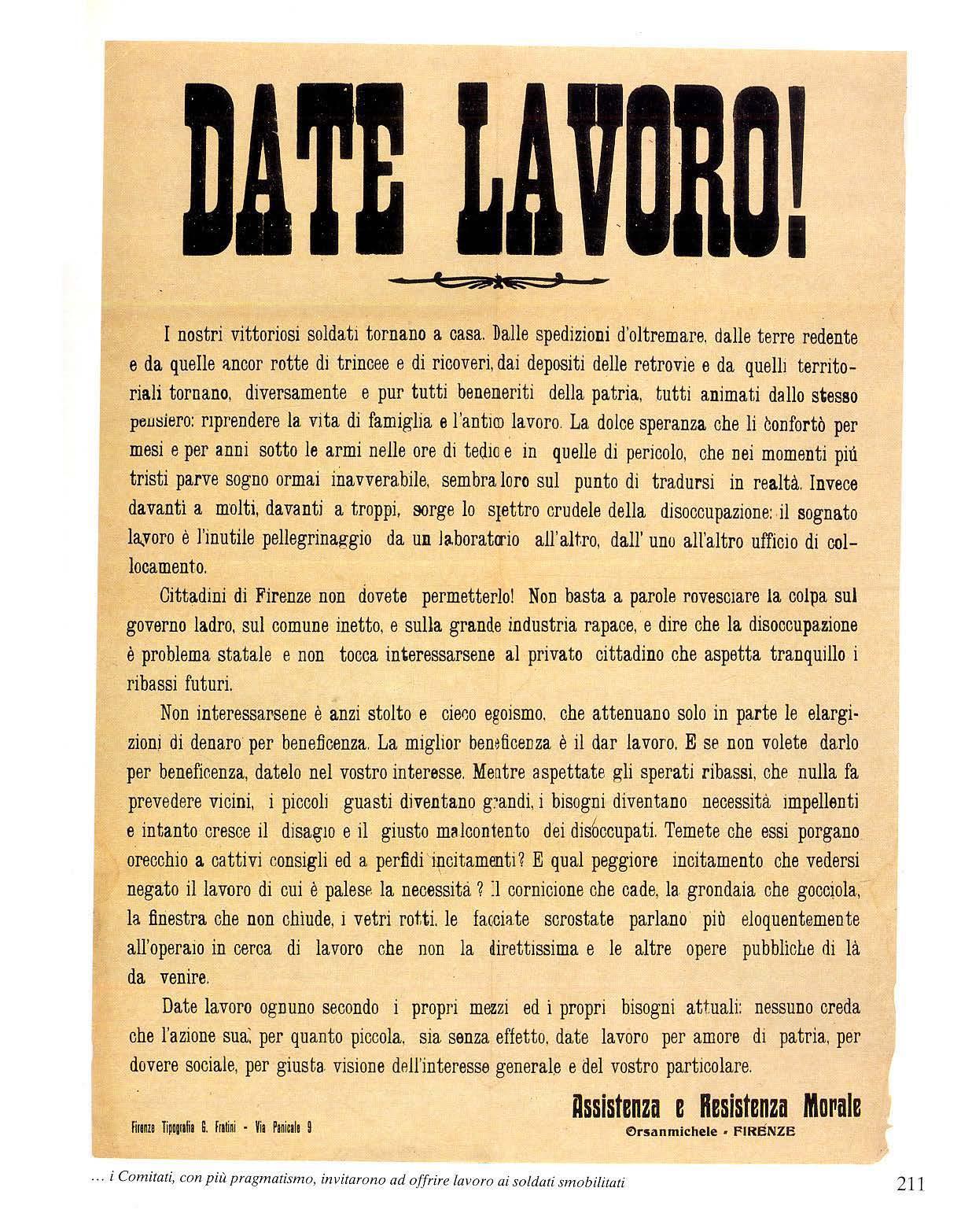
i Comitati, con più pragmatismo, invitarono ad offrire lavoro ai soldati smobilitati
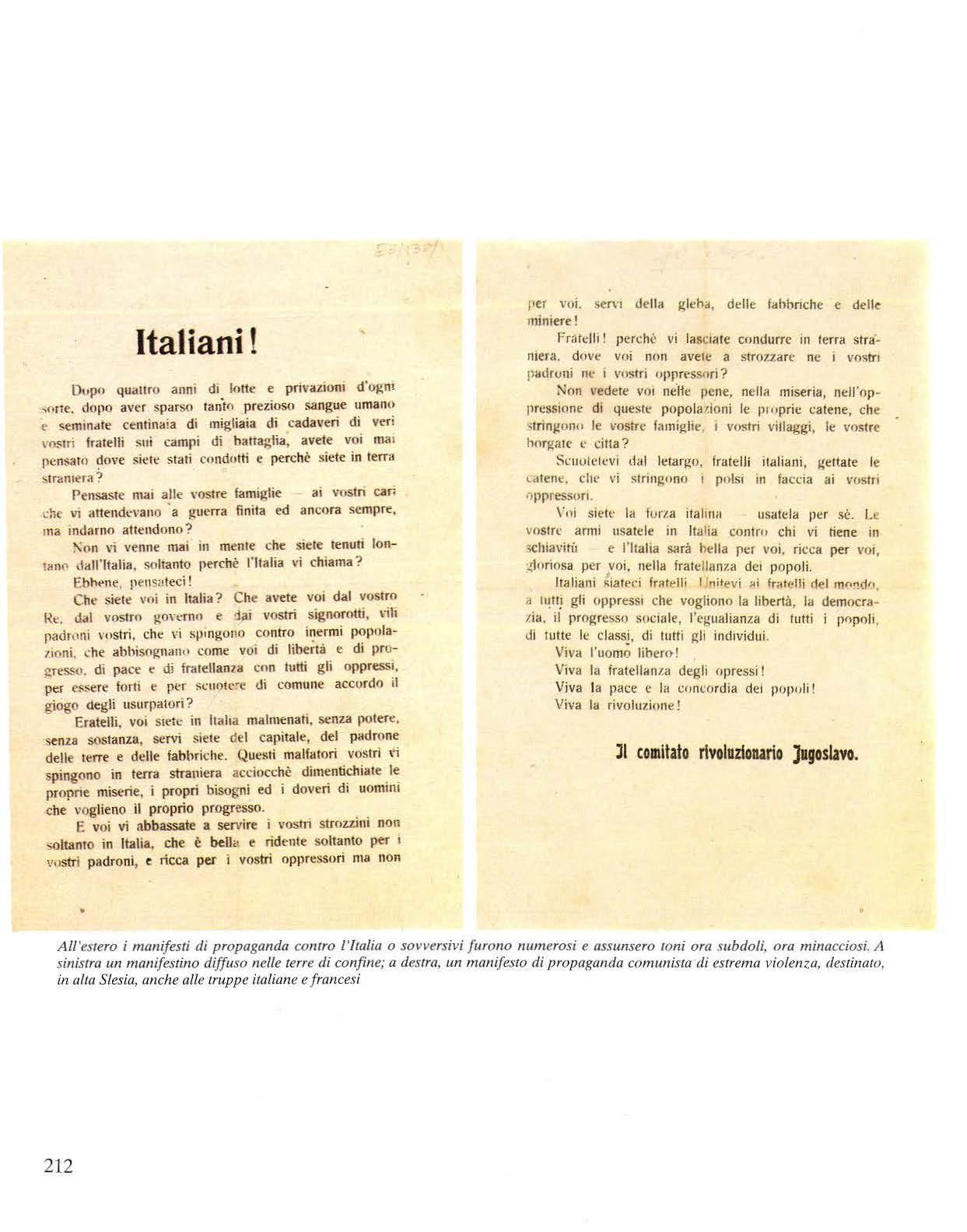
D"po qua11ro anm di lntte e pnvaZJOOI d'ogm ,orte. dopo avt:r sparso tan'to p rezioso sangue uma no t · semm.tte centinaia di migliaia di cad averi di veri ,.ol'tr i fratelli !mi campi di battaglia, avete voi ma1 pensato dove siete stati rondotli e per ch è siete in terra
Pensaste ma1 alle ,·ostre fam1glie a1 vostn cari .: he vt attendevano ' a guerra finita ed ancor a sempre, ma indarno attendono?
!\<m ,; venne mai 111 mente che siete tenuti lon!an n dall'Italia, soltanto perchè l'Italia vi chiama?
Ehht>ne , p e ns ateci!
Cht· siete vni in Italia? Che avete voi dal vo tro He. dctl vostro e 1ai vostri signorotti , \ili padwni \'nslri, cht:: vi sp•ngono contro popolalioni. .:he abhisognan<' come vo1 di liberia e di pror!fesl' ll di pace c di fratellama con tutti gli oppresst, pt:r ef.::;ere forti e sc.:uott''e di comu ne accordo il giog(l degli usurpatori?
Eratelli. voi stek in ltètlia malmenati, senza potere ò\e nza sostanza, servi siete del capìtale, del padrone delle terre e de ll e fabbriche_ Ques tì ma lfatori vostri ri spingono in terra stnUliera acciocchè propne miserie , i p ro p ri bisogni ed i doveri dt uommt che voglieno il p roprio progresso
E voi vi a b bassate a servire i vostri stroaini non -,oltanto in Italia, ch e è b ell<t e ridente soltanto per 1 V•lStri padro ni , e ricca p er i vostri op p ressori ma non
per voi serv1 della gleha , delle f<thhnche c delle rnmiere!
Fratdh! perchè vi lasciate condurre in terra stramera. dnve voi non avele a strozzare ne i vostri padroni ne i vostri <1ppress on?
Non vedete vo1 ne"lie pene. nellii miseria, nell'oppressione di queste popola r. ioni le p111prie catene, che le vostre famiglie i vostn villaggi, le vostre horgarc c cit1a?
Snwtclcvi da l fratelli italiani, le l cttene. che vi stringono i polsi m faccia ai vo stn 'l ppresson
Voi siett la fo rza itahna per se. Le voslrt armi usatele in Ita lia contro chi vi tiene in e l' Italia sarà hella per voi. ricca per vo1, per yoi. nella frate ll anza det popoli.
Italiani "iate r i frHtf.' lli T nite vi :.i rlel m0"d" <t ll!lt} gli o ppress1 c he vogliono la hbertà , l<t democra 1. ia 11 progresso socJ<tle. di tutti i popoli , di tutte le classi , di lutti gh individui.
Viva libero!
Viva la fratellan1.a degh <1pressi!
Viva l a pace e ht concordia del rwp•1li!
Viva la rivolu7ione!
All'estero i manifesti di propaganda contro L'Italia o sovversivi furono numerosi e assunsero to ni ora subdoli, o ra minacciosi. A sinistra un manifestino diffuso nelle terre di confin e; a d estra, un manifesto di propaganda comunista di es trema vio len za, destinaLO , in alta Slesia, anche alle truppe italiane e francesi
Spadly maski z oblic::1.a bnr.lnnzji pol!<kicj i nieroiec:kiej o raz i ch wiernych s lngn sòw. po<Jszczuwa ni e mas robohùczych doko11ywane przez bur. :m.zjQ p rzy najczynniejszej pomocy SOf'jalistol,. i przyw6dcòw zwi11zkowych. slanowi w lnSc:iw ego osznstn·a hascl g6rnoSI4-'!kiej i buriuazji. J c.st f}·lko jednym 7. ogniw og6ùtes:o lanenchn w walro z Rosj<l Sow ieckq i klaSII ro ·
Ale bnriuazja przez Sllm plebiscyt nie mog:la nneczywishrié swych zaminrow. Obeenie wil)c szuka jeszcze inuych srodkow dia osiqgni Qci n swego ce ln Wkroczyla na drogQ zbrodni Ozego nie zdolala catkowicie nzyska é p r()pagandQ, te,::o post:mo" ila dokona<i prowokaeji w$r6d klasy robotniczej. D:t zY do iJrt.rlamanin' - jednolitego Irontu polskich i niemicckieh robotnikow: albowiem buriuazja \vie doskona le. jakq niczmicmq potQgll kryju w sohie jcdnolitosc proletarjatu, ktclra musi doprowadzi é do upadku bnriuazji. ·
Pol scy i niemiccey robotniey i towarzysze! Czyz nic ";dziecie co si4! ' B ur7.wl.zja z obydwn obozòw po.w.cznwa Wa.<;, niby psy, jedo ych przeciwko d rugim .
"Wmawia "' \Vas. ie bracia przypadkiern innym, ni z Wy, jezykiem mowiqcy, Waszemi wrogami. j cj rozkaz mordnj11 robotni k ow boj owki b ur-.l uazji. Polsey i niemieecy robotnicy i robotnice !
'C'fJII lnlkt. Bnriuazja i socjaJpatrjoci znown sgnielli braci nn.s:zyc.h.
W :Xicmcrech "·alcz.1 robotniey na S.mìcl'é i t"l·eìe, walf'UI o b)·t, o proletatiatu.
Hiirsin,;, kat, morde.rea robobùkow, ktorego i \V y GornoslttUlc}· dobrze J)OZU.llliScie, ssaleje prse:Seip Noslde,ro.
Coi myS!icie robi é'l s1aé na11boozu! \ :Xie! pom6e braciom Wa.sz;m w Kiem<'%eeh, do ws(l6lnej z niemi s1an11é walli.
Lecz jestCS.cie rozbici na wrogio obozy, pomit:d%Y kt6remi stoi polskn i niemiccka buriuazjo., by w ten s posòb latwiej Wns pokonaé. Stoicic nad prupa8(-ì11 i niP uniknieeie o ile w ostatniej c:hwili nie J>rwj rz)·c io. Polqozenie s it: Wasze ponad glowami i wbrew soejaJpatrjot-ycznym przywoocom jest nakazem c:h"; li.
rozbici, nic moiecic siQ rusu é, na rllmiouach Waszycb ciqzy stJ·uszny cic:iar stanu oblQZe-· nia. Tylko wsp6l n c natatcie na dzieriycielr "·ladzy zerwiccie Wasze okowy.
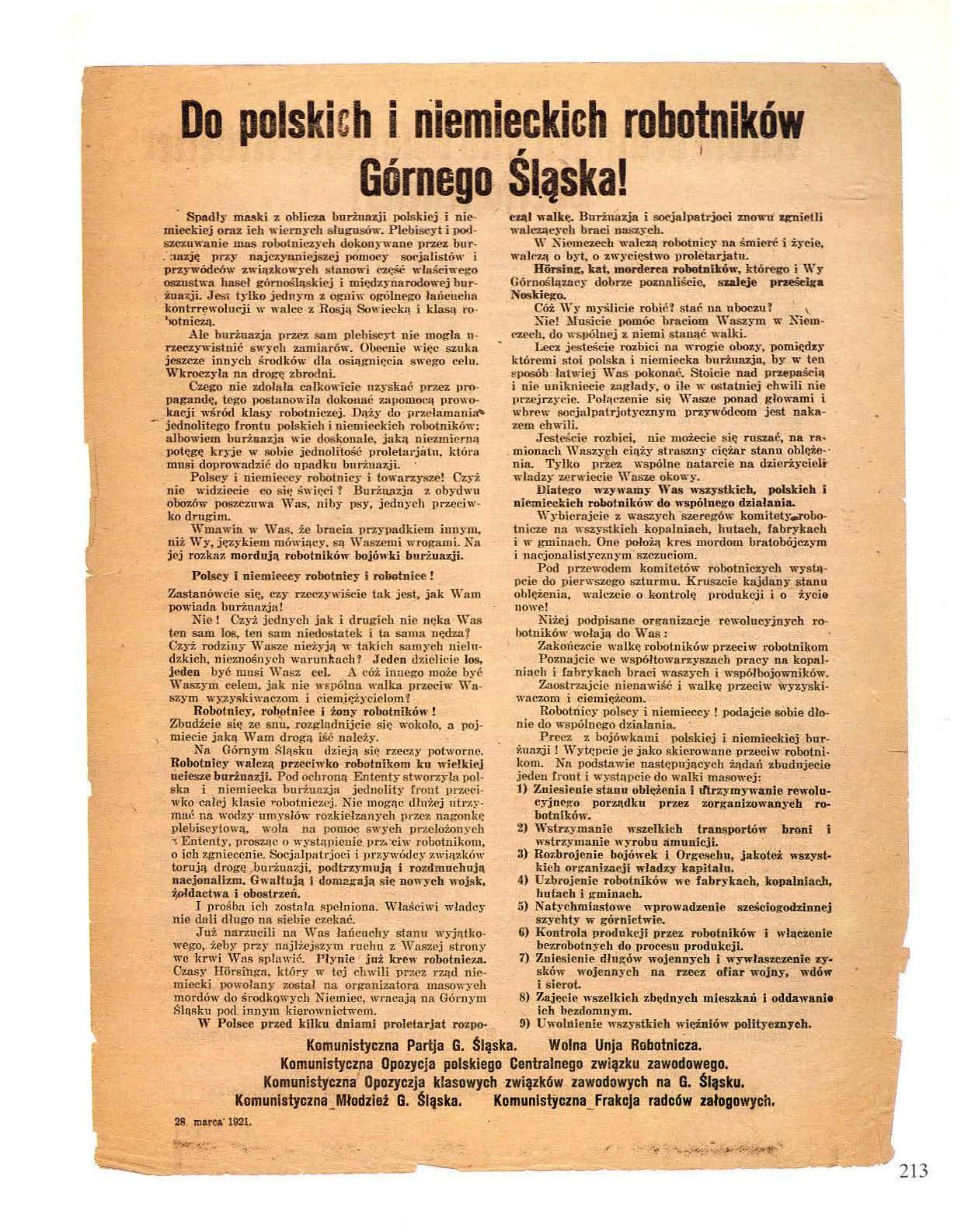
Dlates:o wzywamy Was wazystldch, polskieh i nie.'lliecldch robotn ikow do wspt)lnego dzial ania.
\Yybicrajcie z waszych szeregòw komitety_-robotnicz.e na kopa lniacb, h utach fabrykach i '" gminacb. One po}oùt kres mordom bratob6jazym i uacjonalistycz:nym szc.zuciom.
Pod przewodem komitct6w· robotnicz.ych wyst&pcie do J)icrwswgo szturmu. Krus-.teie kajdany stano Zasta.noweie czy rwczywiscie tak je.,t, jak Wam obiClic nia, walczcie o k{)nt.rolQ PJ'OI.htkcji i o iyoi& powiada buritlazjn! nowel ·
N ie! Czyz jcdnych jak i drugich nie nQka Was NiZej podpisane or ganizacje r ewolu olinych roten sam los, ten sam niedostatek i ta sama nt:dza1 hotnik6w wolaj& do Was: Czyz rodziny Waszc nic-&yjl\ w takich samych nieln- Zako1iczcie walkCl robot.nik6w przeciw robotnikom d z kicb, nic•zno5uycb warunl';-achl Jedcn dziclicie los, Poznajeie we wsp6ltowa1·zys7.ach pracy na kopal;l t.-den byé musi Wasz ceL A c(r.& Ìllil.ego moie niach i Iabrykach braci wnszycb i wspòlbojownik6w. Waszym celem, jak nie wnlka prwc:iw "'a· Zaostl'?.ajcie nienawiéé i walkQ przeciw wyzyski· SZ)'ID wyzysldwuczom i cicrn_!Qz ycic lom f wac7.om i c iomiQzco m. Robotnicy, rob;0tnice i iony r obotnikow ! Robottl"i c}· polscy i uicmieccy ! podajcie sobie dloZbndicie siQ ze snu, rozglqdnijcic siQ wokolo, a poj- nic do wsp6lncgo dzialania. · miecie jak11 Wam drogq iSé nale:iy. Prcez z boj6wkami i niemiec kiej hurNa Oornym S l=lsku dziej11 si() rzec-t.y potworno. Y.uazji l Wyt.Qpcie je jako s kierowan o Pt'ZOOiW l.'ObotniRobotnlcy walcz11 p rzeciwko robotnikom kn wielkiej kom. Nu podstawie nastQpnjl\cyeh Z.1 dau zbndnjecie ueiesze bnrinazj i. Pod ochron11 Ententy stwor.tyla poi- jeden front i wystnpcie do walki masowej: ska i niemiccka huriuazja jednolity front J)rz('<'i - l ) Zn iesie nie stanu o b i«:Zon ia i dtrzymywa n le rewoluwko calej klasi e •·ohotn.icznj. Nie mOglie dln7.ej utrr.y- eyjn cg o p r zez zorga n izowan ych romué na wodz)' t11nysl6w rozk ietzanych JWZCZ nagonkt: botnikow. p lebiscytowl!, wola na pomoc swych p1-zeloionych 2 ) W1;trzymanie '1\"SZelldch trans port.6w b roni Ententy, pros7..!1C o wysl<\pienie, J)r7A ' ci w robotnikom, wstrzy manie wyrobn am u nicji. o ich zgnieccnie. Socjalpaldoéi i pr?,yw6dcy zwi& zkow 3) R ozbro;ienie boj6wek i Orglll!ch u, j a k otoi wszysttornj& drogQ bUI·.tuazji, podb-z)-ulujq i rozdm uc buj:t kich orga n izacji wladxy k a pita l u. nacj onallzm. Gwaltuj:t i s i e now ycb wojsk, 4) Uzbrojenie robotnik6w w c fabr y kach, Jrop.alniach, ipldactwa i obostrzen. hntach i gminach.
I prosb a ich zostala '\'l&Sciwi wlaù cy 5) Natycb miastowe wprow adzen le szClic logodzinnej nie dali dlugo na siebie czekaé. szychty w g6rnictwie.
Jui narzncili na Was lali.euchy s1anu wyj11 t ko- 6 ) K ontrol:! produkcji przez l.'Obol ni k o w i w l11 czen ic wego, zeby przy najl7..ejszym rucbu z Wnszej strony bezrobotnych do p roces n produ kcj i wc 'krwi Was splawié. P l yuie jui krew robotnicza. 7) Znies ie n ie woj e nnych i wywlaCJzczenle zy· Ozasy Hilrsinga. ktory w tej cbwili przez nie- skow wojennych na necz ofi ar w ojny, w d 6w miecki powolany zostal na organizatora masowych i sierot. mo rdow do srodkowycb Niemie c, wmcaj11 na Gclrnym 8) Za jecie wsw lkic h z b t:d n ych m i eszka.D i oddawanie pod innym kierownictwem. ich bezdonm ym W Polsce przed kiiku dn iami prol etarj at rozpo- 9) wszystkich wieiniow polltyomyeh Ko munistyczna Partja G. Wolna Unja Robotnlcza.
Komu nlstyczna Opozycj a pol ski ego Centralneg o za wodowego Komun isljczna Opozyczja kla sowych zawodowych na G. $11)sku.
Komu nlstyczna _ Mlodzl ei G. Sll)ska. Komunlstyczna_Frakcj a radc6w zalogowych. 28 marea·
La rivendicazione di Fiume f u oggetto di mo l tissimi manifesti , volantini e locandine. Non soltanto , p e r ò, di propaganda fa vorev ole a ll 'a nness ion e
Comitato per l'Adriatico Italiano. l IT/ILIA - IIKEAIJIJ'.PIII?TIIICQ//E JI/80Stlll/111
Con le rinunzie (l) l' Ita lia: perdereb be il confine delle Alpi Giulie lasciando aperte le porte alla invasione nemica, e Pota, Trieste e Gorizia sotto il liro diretto dei medr calibri iugolaslavi. l'
. vedrebbe le isole e le altre terre Italiane della Dalmazia continuare ad nelle mani del nemico, formidabili basi di attacco, principalisslma delle qu &li donde parti già la flotta austriaca per bombardare Ançona. l lascerebbe indifese, come ebbe a confessare alla Camera lo stesso min lstrò Scla loja, le coste romagnole , march igiane , abbruzzesi e pugliesi. Queste iniq ue rinunzie, presentate come necessarie per salvare Fiume, erano invece accompagnate dal mostruoso progetto di smembramento (3) della itallanisslma città che, lasciata accerchiare dalla Jugoslavia, sarebbe stata sottoposta al ridicolo di tre sovranità: quella italiana sulle case; quella della Lega delle Nazioni sulle banchilje e sul porto; quella iugoslava sulle ferrovieJ sui sobb, e sul porto Baros. Con queste rinuncie le quali significherebbero l'annullamento della vittoria, li Italia perderebbe Il frutto maggi ore della guerra e cioè la sicurezza sulle Alpi e in A'driatico e si troverebbe irreparabilmente bloccata (4), polchè coloro che già dlsPflngono di basi di attacco ad occidente e a mezzogiorn o, trove rebbero disponibili al loro fini lutto l'Adriatico e lo stesso conHne giulio.
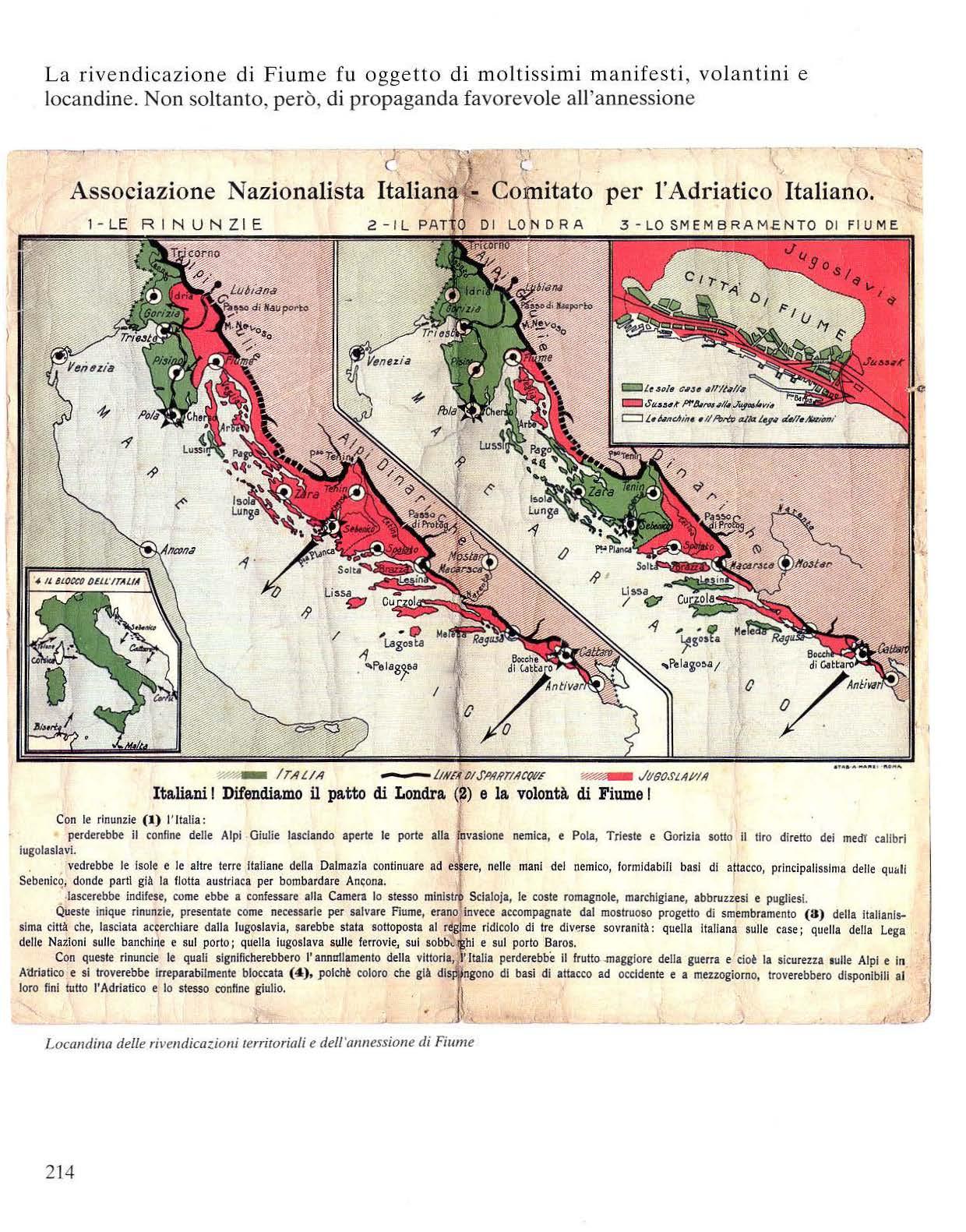
Locandina delle ri vendicazioni te rritoriali e dell 'annessione di Fiume
A Voi, che, dopo aver compiuto il più sacro dei doveri, ritornate nei grembo della famiglia, Za ra s ente il bisogno di rivolgere una paro la calda e sincera di saluto e d i ringraziamento. In ginocchio, o soldati o mar inai benedetti d'Italia, noi vi accogliemmo dopo tante soffe1·enze, tan te e pers ecuzw m; e tutte noi dimenticammo nella gioia e nell'es ultanza di abbracciarvi, di vedervi alfine in mezzo a noi; tutto obbliammo dinanzi :::.1 grandioso evento di veder sventolare nel no stro purissimo cielo la Bandiera tr:colcre.
La terra di Dalmazia, che fu di Roma e di Venezia, dovrà essere c ongiunta alla Madre Patria ! l
l natii paeselli, a specchio dei tre man, le città popolose e ferventi di lavoro, viilaggi festanti nel tripudio del buon raccolto Vi attend.:mo per glorifica!'vi ed esaltarvi.
Dite sempre ·e dovunque che qui è Italia, d ite <{ Ue sta verità nei vostr o linguaggio, che conosce il grido della Vittoria e non della menzog na.
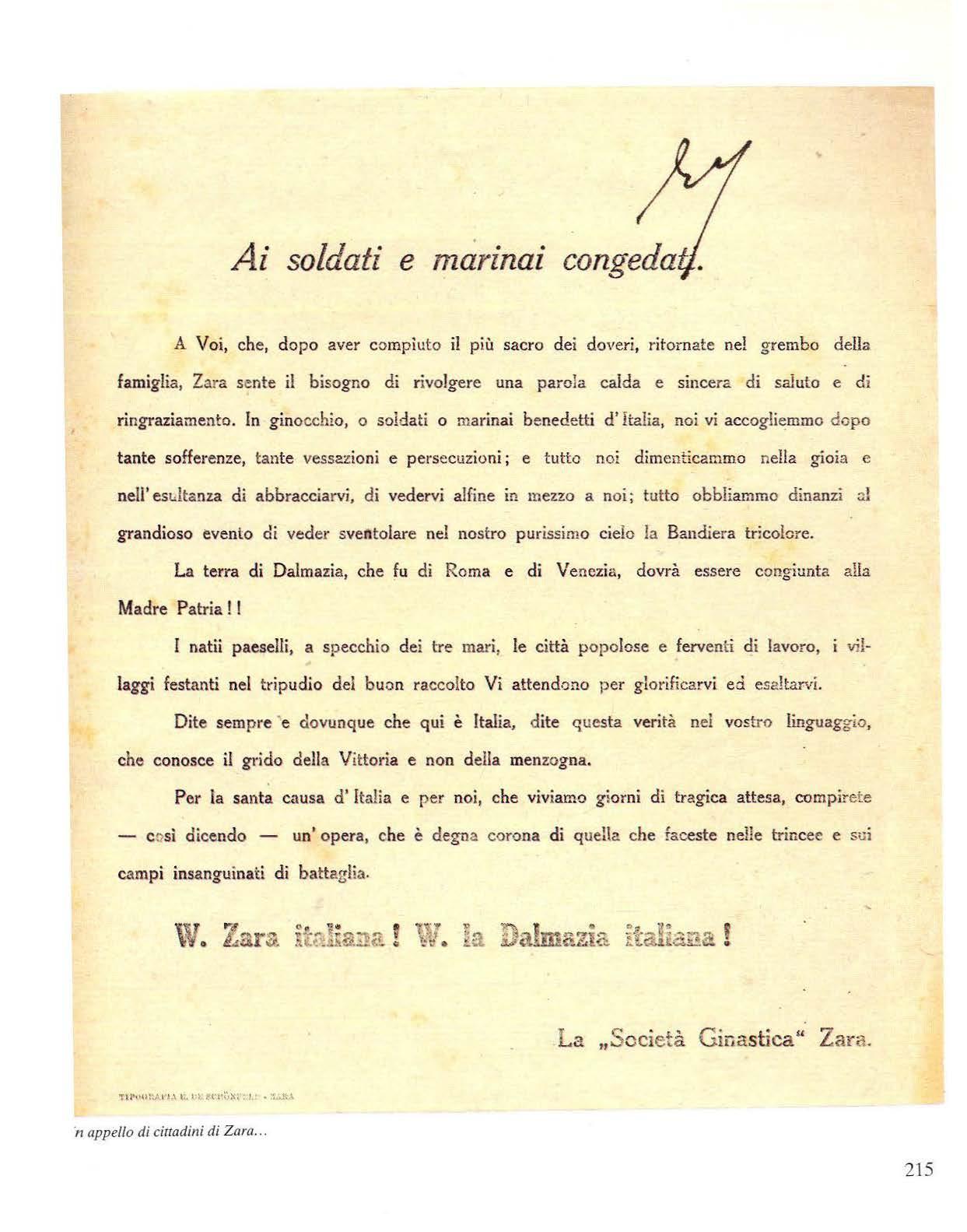
Per la santa causa d' Italia e per noi, che viviamo giorni dì tragica attesa, compirete c osì dicendo - un'opera, c he è degna coro na di queUa che faceste nelle trincee e s;;i campi ìnsanguioati di battaglia.
La ,Società Gin a sti ca" Zara. ·n appello di cittadini di Z ara
Presidente Consiglio Nazionale Fiume Grossich mente assere nd o unanime volontà popola zione fiumana per annessione all' Italia
Oltre a gruppo slavo, esiste a Fiume forte g ruppo socialista e gruppo autonomo formato da veri v€cchi fiumani che amano l a lin gua e popolo i taliano ma · sono contrari ad una annessio ne.
Questi du e gruppi so ppressi dal re gime terrorista regnante il paese, perciò impo ss ibilitati di elevare ape rtamen te la voce dichiarano unica soluz i one per · il bene di tutti i cittadini e benesstre della città, l ' internazio nalisazione sotto protettorato, inglese o americano.
Questa soluzione sta pure nell'interesse d'Italia che invece di una città morta, possederebbe in Fiu me il nodo del traffico per il retr0terra.
Migli ori elementi del par tito nazionale i ta li ani sono già usci ti dal partito che sfrutta le casse cittadine e dello stato ungarico per scopi di co rruzi one . propaganda ed anche per proprio uso personale.
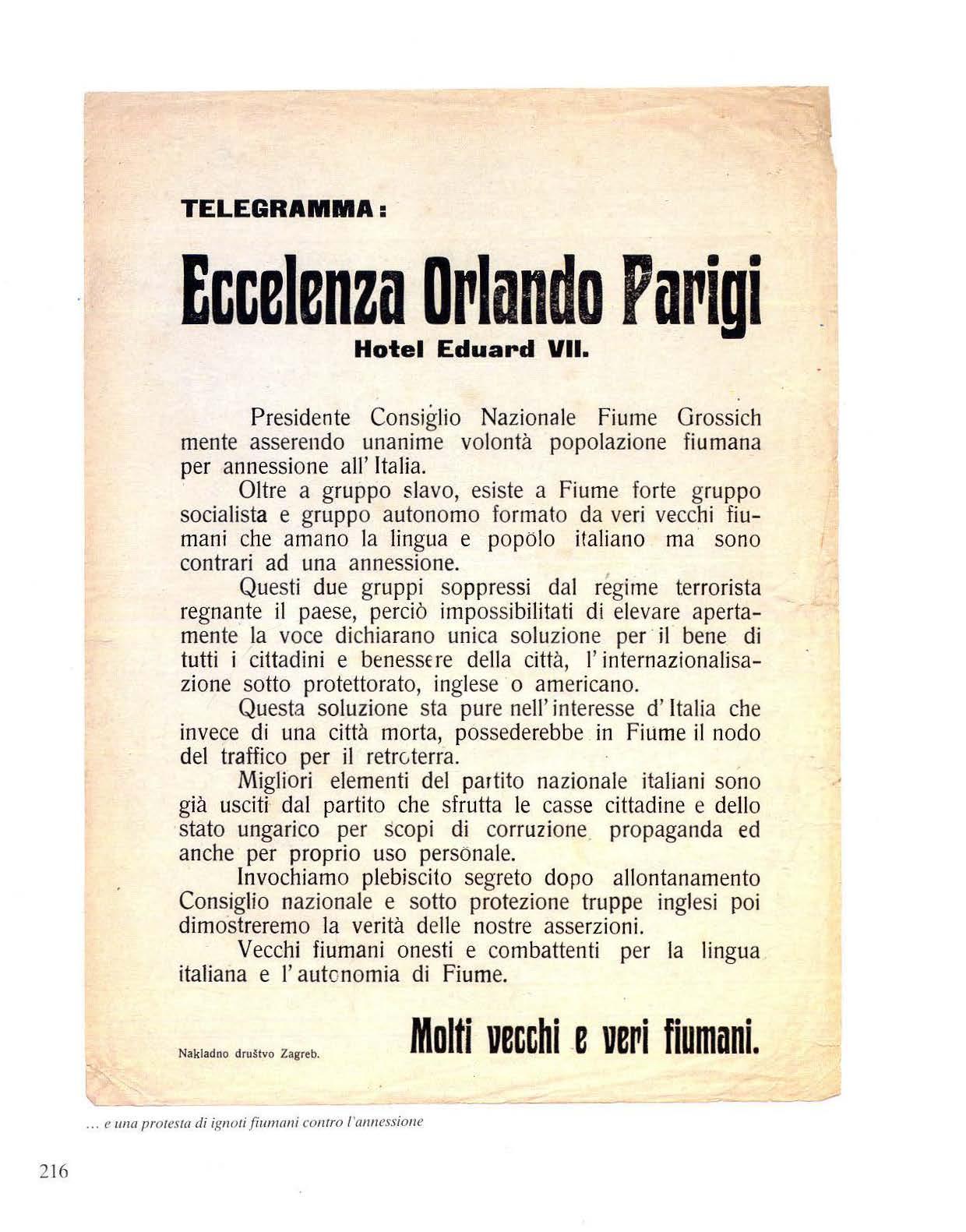
Invochiam o plebiscito segreto dopo allontanamento Consiglio nazionale e sotto protezione truppe inglesi poi dim o'strerem o la verità delle nostre asserzioni.
Vec ch i fiumani onesti e com batten ti per la lingua itali ana e l 'aut onomia di Fiume.
Nak la d no d ruMvo Zagreb
. . e ww pro tesw di ignoti .fium ani c ontro l'annession e
.
Com.m. Fr. Saverio Ora zioli
Qualunque possano essere i motivi che in questi ultimi giorni hanno d e terminato uno stato d'animo anormale nella cittadinanza, è di so mmo interesse che l'ordine non venga più oltre turbato nella città.
In questi giorni, più ancora c h e nel l'attenzione del mondo è volta verso questa nobil e città. E Fiume deve dimostrare, oltre a lla coscienza del proprio diritto, anche l a coscienza della propria forza morale ed il pieno possesso d ella indispensabile disciplina degli animi.
Investito dei poteri militari, ho l a responsabilità del mantenimento d e ll'ordine Mentre intendo che i 5entim enti della cittadinanza siano da c hiunque rispettati , debbo d' altra parte esigere che la tranquillità cittadina non sia ulteriormente turbata
Più che su ll e forze armate, di cui dispongo, faccio assegnamento sui sentimenti della pop o lazione fiumana, certa del proprio diritto, sicura dell'immancabile conseguimento dei proprii Ideali.
Ma poichè l'esperienza dei passati giorni dimostra che sono incidenti di piazza queli che determinano poi -più gravi avveni-
J.o So'no vietati nelle vie e nelle piazze della citta g li assembramenti ed ogni pubblica manifes t azione;
2.o E' vietato di recare in qualsiasi modo impedime nto alla circolazione;
3.o E' vietato- di po'rtare armi di qualsiasi specie, mezzi o congegni esplosivi di qualsiasi n at u ra ; .
4.o E ' vietato di comm ett e r e atti ostili contro le a utorita o le truppe del Corpo d ' Occupazi one lnteralleato;
5 o E ' i m posta la più asso luta e pr o nta obbedi e n za agli o rdini delle autorità -militar i comp et e nti e d egli agenti d e ll a f orz a pubblica delle l o r o f u n z ioni ;
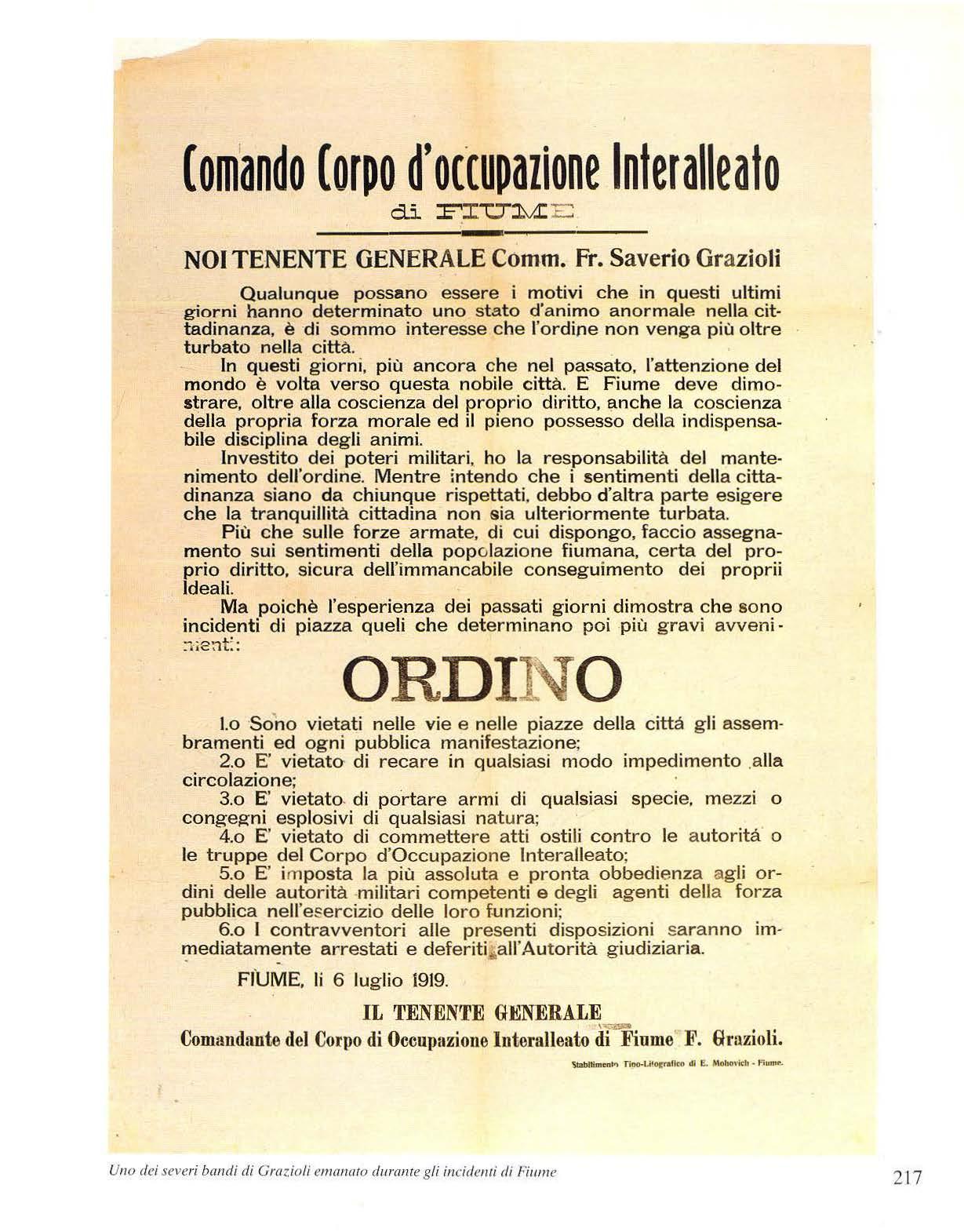
6.o l contravventori alle pr ese nti disposizioni s a r an no Immediatamente arrestati e defer iti Jà ali'Au t orità giudi zi aria. - -
FÌUME, li 6 luglio 1919
Comandante de] Corpo di Occupazione Interalleato di Fiume' F. Grazioli.
Uno dei seve ri bandi di Gra z io/i e manalo durante glì incide n ti di Fium e
Fa n. t: e d' I t: a. l l a, il tuo nome modesto è il titolo più grande della tua gloria. d'It:alia, tu sei grande quanto è grande n popolo d'Italia, quanto è grande la storia dell'Italia : d' It:alla, tu sei la forza che vinse nella guerra, sarai la forza che vincerà netta pace.
1 Fiume d' Italia, 4 novembre 1919 FANTE!
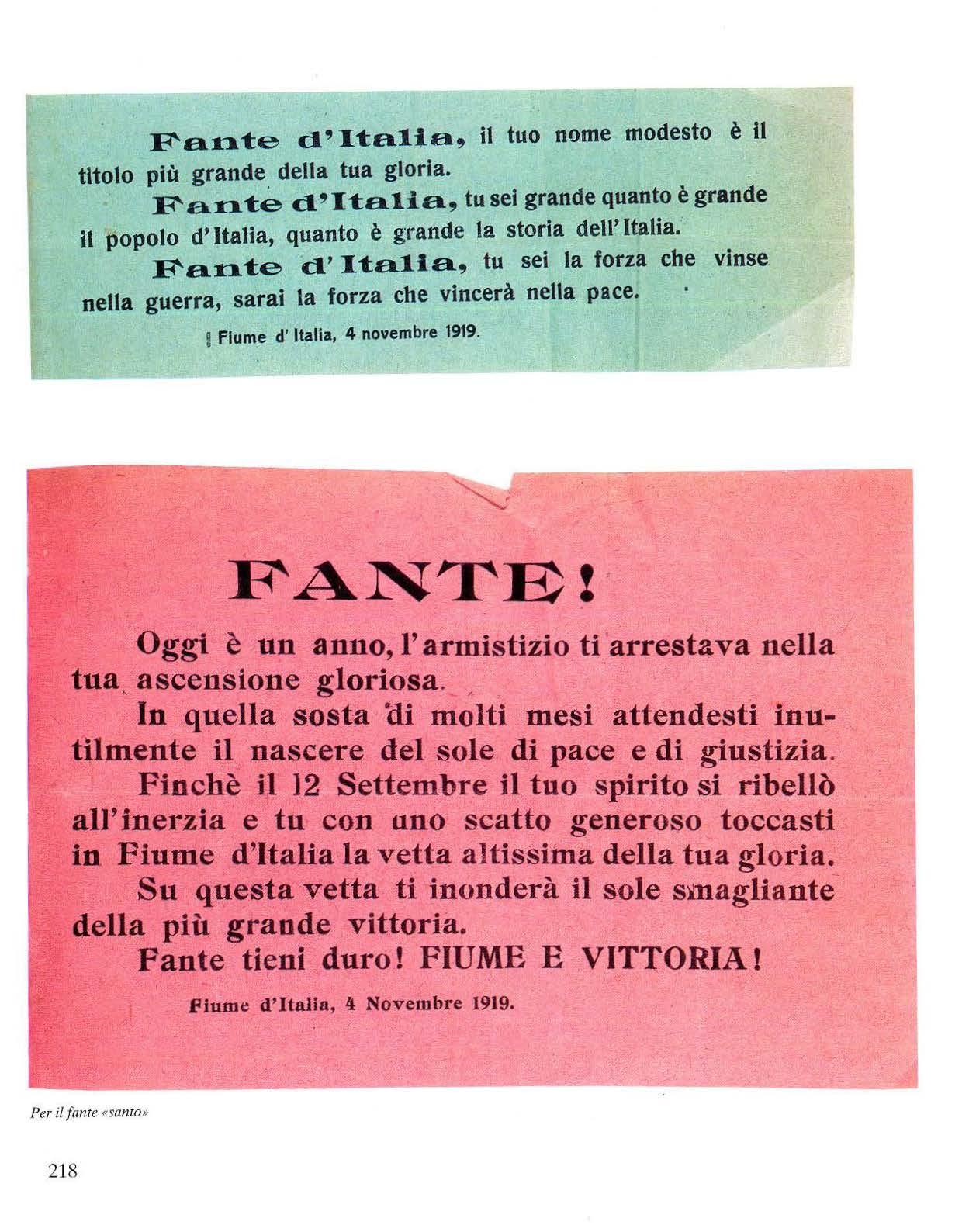
Oggi è un anno, l'armistizio ti arrestava nella tua .. ascensione glo riosa . , I n quella sosta lli molti mesi attendesti inut ilmente il nascere del sole di pace e di giustizia . Finchè il 12 Settembre il tuo spirito si ribellò a ll'inerzia e tu con uno scatto generoso toccasti i n Fiume d'Italia la vetta a l tissima della tua gl o ria. Su questa vetta ti inonderà il sole smagliante d ella più grande vittoria. F a nte tieni duro! FIUME E VITTORIA!
.fiume d'Italia , Novembre 1919.
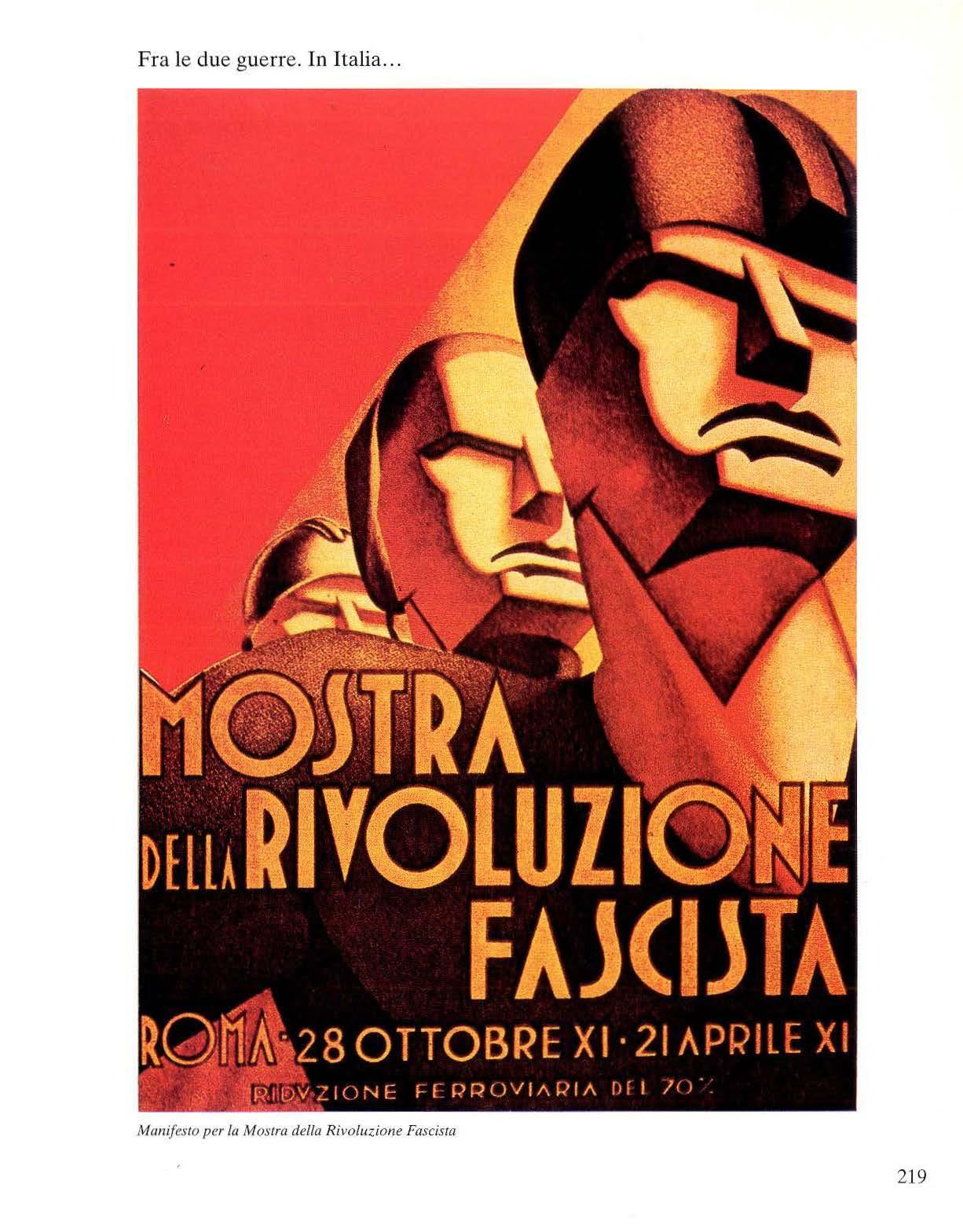
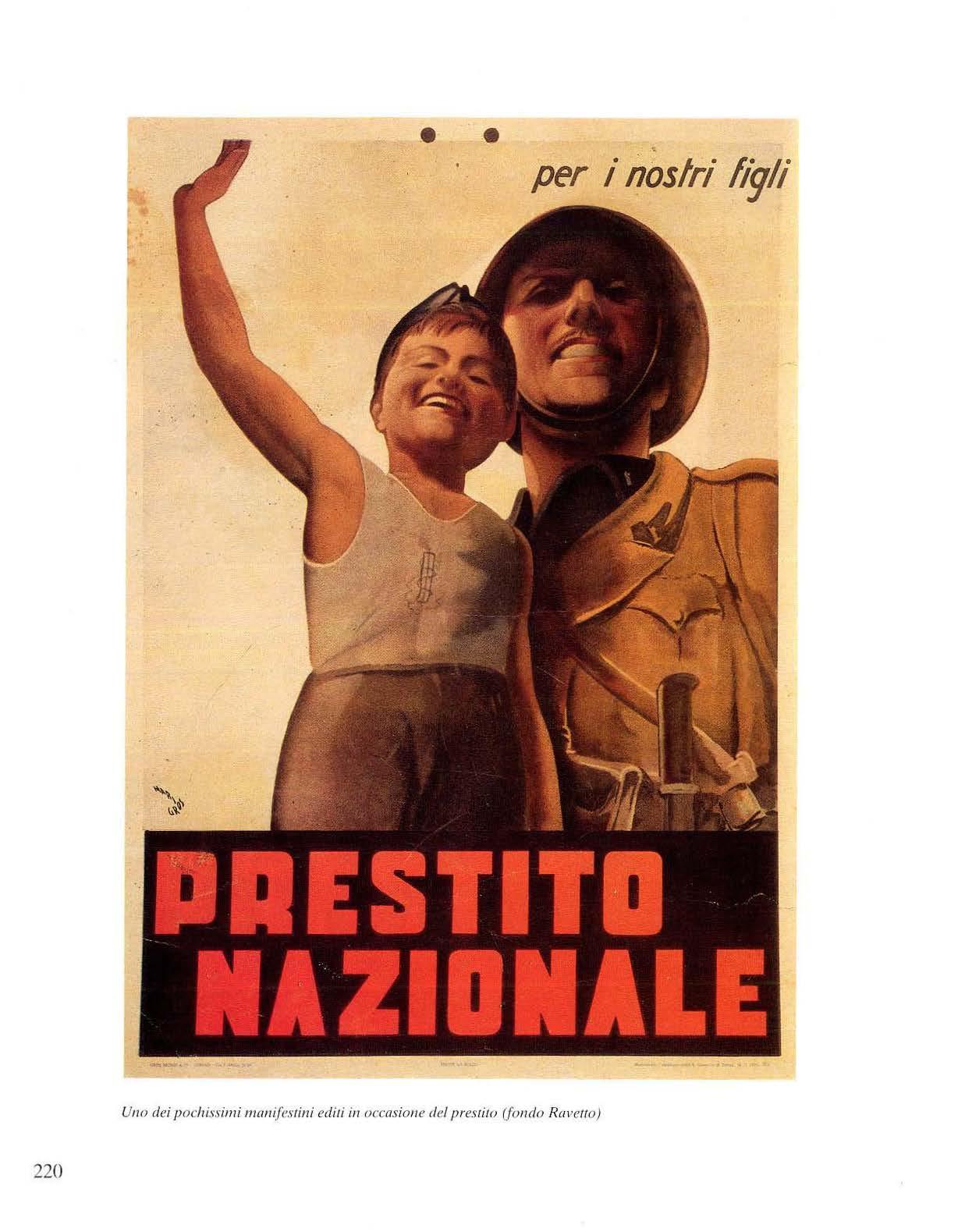

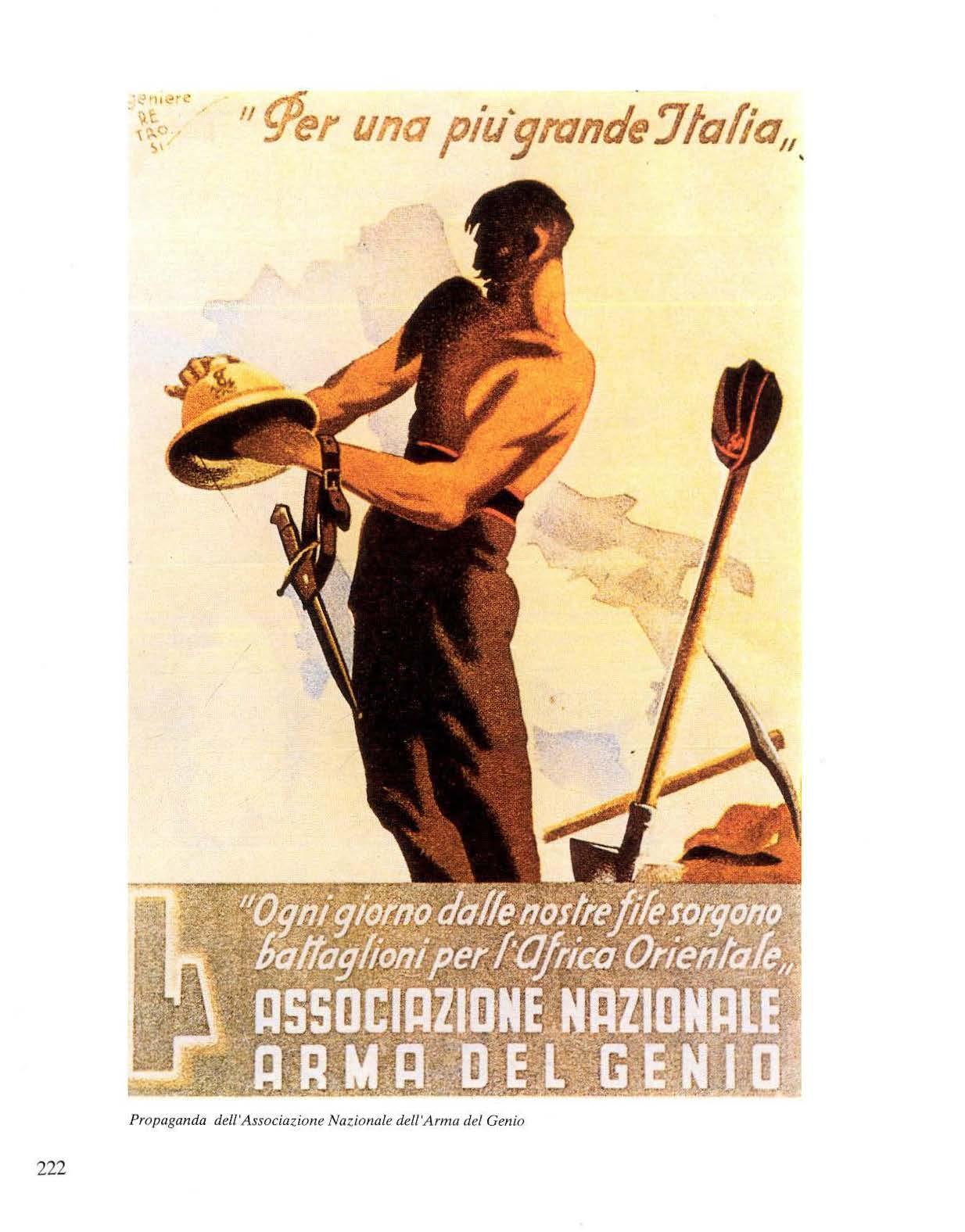
Ge n t i del T igrè, UDI T E :
Voi :;apctc cl 1e dcn·e SH·ntola la J3audi c ra d'Italia jyj è In lihertl\. P c• rdò u e l 1·ostro Paese la .,;chia,·it:ù , sotto qua l uuqn e t'orma. ò sop-
Gli r hP so no attnahncntc iu 'l'igrè sono libPrÌ e d è l'i ct ata la c omp e ra e l:t l ' é'tHiita degli s ch i al'i . C hi c·outravver r à. a lle ch •l presente bando sarà. p uu i t o , :< i<:eo m o t r asgr essm ·e a g li ord ini de l O oven1o J>ato acl A tlun il H ot.to l> re l!J;\5-Xlll (S te k emt 1H215) li "'' Il
fA.RIA1 1 IJ 'J.f..t. 1 h++hAO+ 1 h7C: 1 hll.f l 1 (]D"'IJ"': 1 1;l't»o.P'PIIIJ:: lllllf.U 1 Oh7C:U : t»oll'l' 1 O"''li=Ft»of" 1 'Jt.t+ 1 0.111 1 fiJC:t+ 1 t7C: 1 +H•ii"'PA a h+"'t. 1 tl7t: 1 ID-111' • 111 : IJC:1 • '1ol\ 1 1\ t. : )CD- a fi)C:f • oua'f'lò • OD"'"T • +hAb 11-'PA = 1\ILIJ 1 fh'P!- • ?A • f"7.?0Jf" • '1ol\ • fou1"1P'T : .h"' • +1\1\i. • 171'1]'). 1 tt»oli 1 0-tl r.-l: : ..PRI+ • t.4>RIA = hf:'P 1 or.,., l 1'4>f"+ , 1 , , ,.. •
Bando di propaganda per l'abolizione della schiavitLì

1\IJ·
""'t l· • f-1·"1&.'." • fA,;:J"'l • tlt1111 • hA.IIJA.f • IJ')J.'..t. 1 O:J"'f • • = :J' • t'tr'fii • 111\IJO"'· • jf. ,...,.'J·JJ • f ·tnRoloAIJ • 0!71:1JII" • qu,· • • All'f. 11111 • 1.11"11 • 11·1\- 1 1;";:. • " hllm1111J • • ftllC • Allf.'fll" 1 hltJJ'ì ·f'fu : ,;:JC: • 1\11l1J • ot>c:nu • >.'H':"'· :I--41olo • J.'.ll·1 " Mlh • Arte • + ' } • f.:t.ll • 1A11l • flm· • v-h- • m":t • ootr)· 1 1 >.11-m "-l' 1 t.<f>lliJA • >. '}4' 01\ '1'1\1 = • 'fi."' ll" 't.f. 'f : 1 f"'.f-'1· : (19' 'fll" : 11 1\- l h.f+l.ll'fiiJ 'l•>.IJ11 : )',').f.·-T<f>tlt\- l J.'.ll•'t = fi'tlf.ll • llm- • tJot\- : 1 +Cil 1 J.'.11Ct;' • llt.+ • lt»m-1\:I"A " 111: : "111C9"' • fil'!" =A.ro"l • • "111C : J.'.<l-0\'f!IJ " llf111 1 t»- • 1 +l"f't,· • IIC9"' 1 9"' t. 111v- " ),;:JJ.'.. • • 1\t.'llll" : >. lll =
l BAND O
!n nome di S.M. il RE d'Italia assumo il governo del paese. Da oggi voi, geme d el T ig rai e dell 'Agmnè, s iete alla dip enden z a e sotto la p ro tez io n e della B andi era Italian a.
In cau te prom esse: l'a bo li z io n e dei lribu ti no n p o te va far piacere ai capi d e lle trib ù
l cicca rimangono in carica e rispondono dell'ordine e della disciplina del risp etti vo paes e F;ssi si pres ente rann o a ltauto rità mil itare più pro ssima insiem e al cle ro d e lla ch iesa parrocch iale pe r fare atto di souomissione.
Colo r o che non si p resentera n no entro 10 giorni sara nn o considera ti e tra u mi co me n e mici.
l mesleniè e tuui co lo ro ch e so no ri ves titi d i grado o d i comando si p resentino per ricevere o rdini.
C hitm q u e.fu dann eggiato s i p resenti a i miei gen erali e a v rà giusri zia. N es s un trib uto: la riscossio n e di qu elli ch e f ossero in co rs o è a nnullata. l dazi dei mercati, i pedaggi e le dogane sono abolire. Com mercianti commercia te; co lti va tori colti va te
Dato in Ad ua i/1 4 o tto bre 1935 -X lll E. F. 3 tekemtl928 a.m.
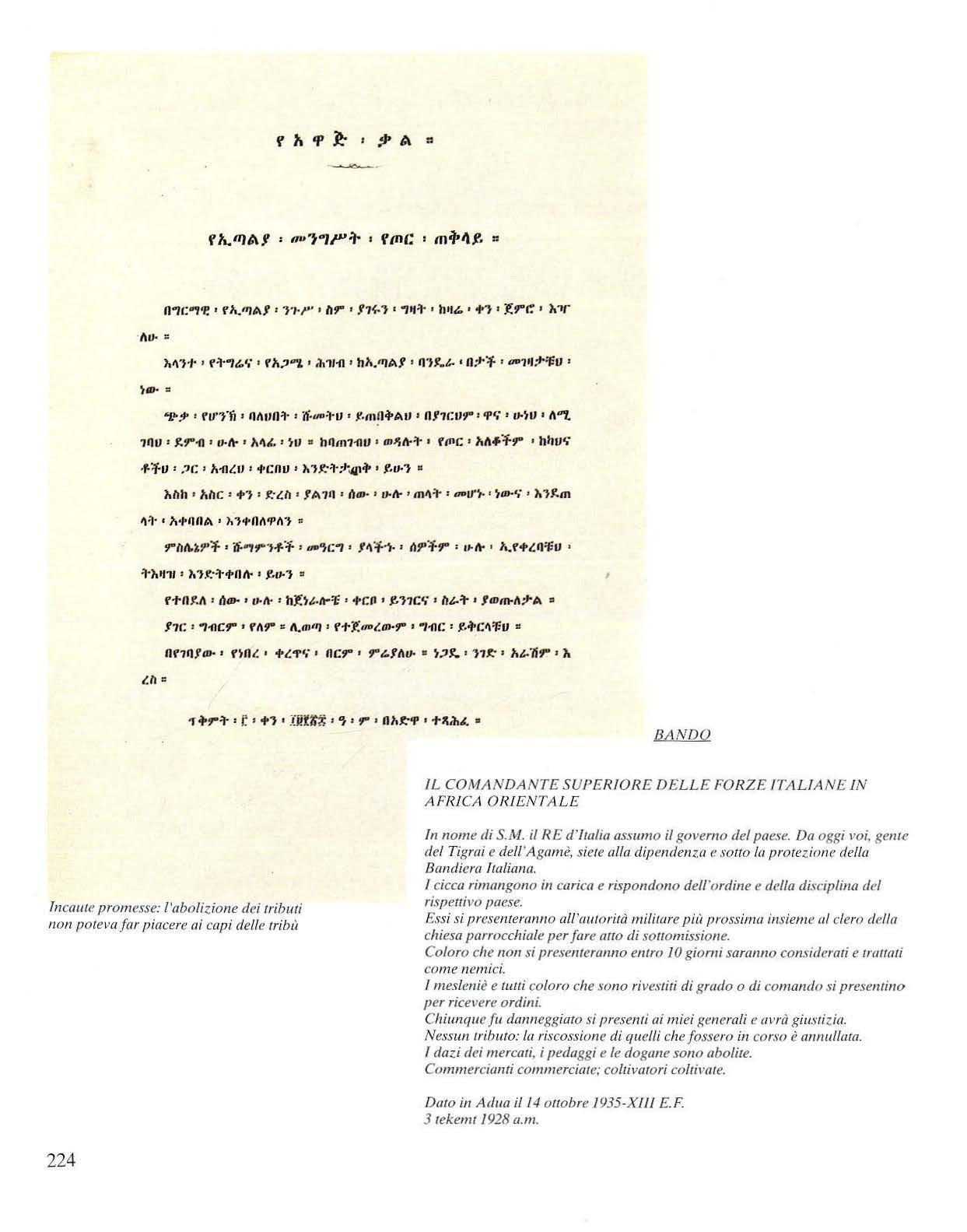
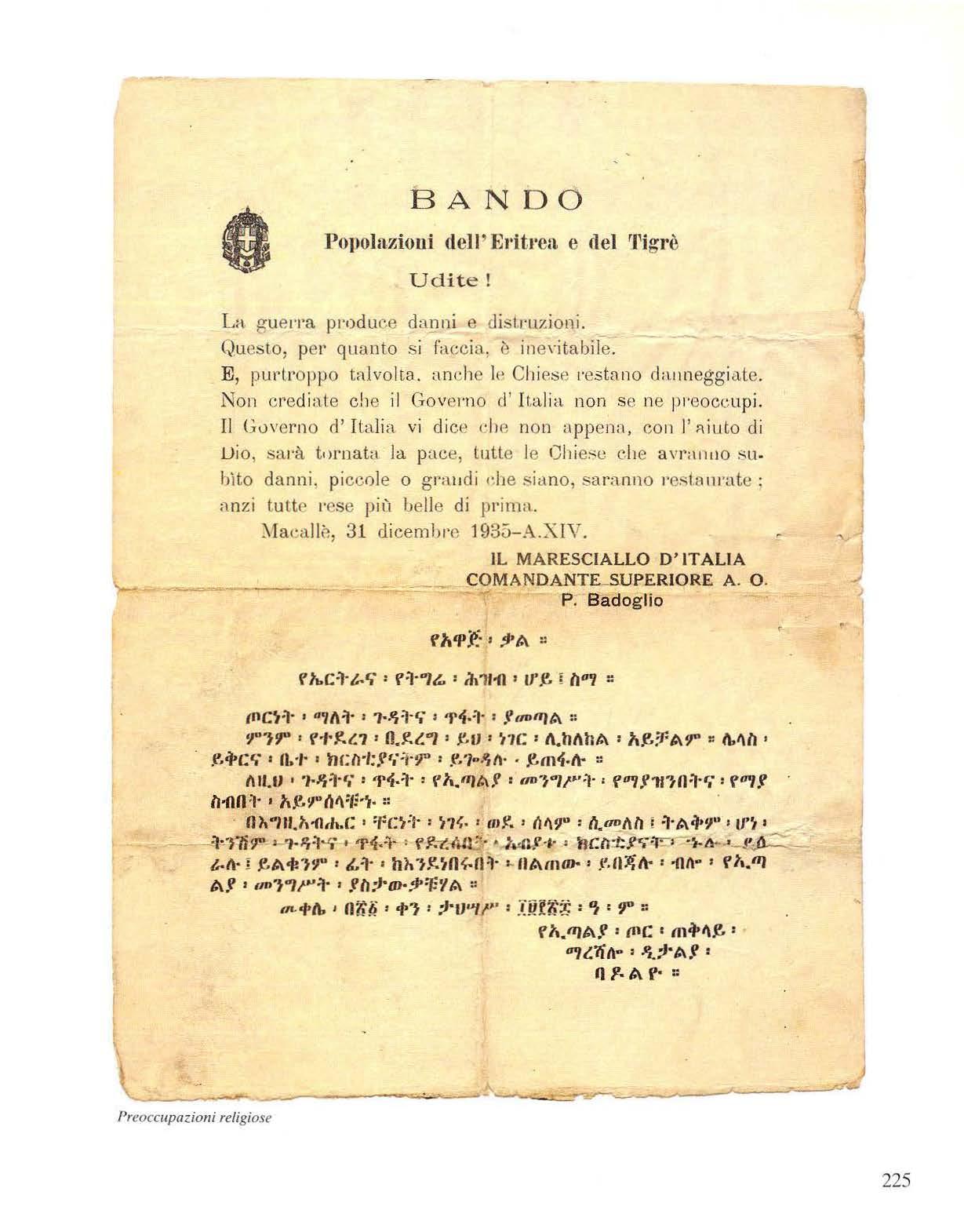
Popo l azioni dell ' El'itrea e del rl'ig r è Udite!
L a g u e rr ·a pro du ce dann i e d i ' lruzioni Qu es t o, p e r q u anto s i facc ia: è ine ,·itabil e . E, p ul' lt·o pp o talvolta. an ehe l<"' Chi es e t·e.stano dn.nn eg gi ate . Non c r e dia-te ch e il Gov e l'n o cl ' I t al ia non s e n e pr·e oceup i. Il G0v crn o d ' It a li a vi di c<) c·he non app enlì, c or1 l' :iiu to di Ui o, sa r à tl) r n atu la p ace, tutte le C hi e::;e e h e a v r<ll ll l O su . hito da nn i. p icc ole o g r'n ll d i d1e si<:\ n o, sa r a nno reslfl lll 'atc ; a n z i t u t t e' r ese p iù belle di pt·im<\. 31 d icemhr·e 1930- A.X IV.
IL MARESCIA LLO D ' ITALIA COMANDANTE- SUPERIORE A. O. P Eradoglio
OLcf'A. ' n?Ui ' .,.'l = :J·o·_,r = = ' = = f 1\.flJA..f : ti' C c mtl>I\J!,. : '"llìf 1\ : ·'t:J•/.\ y : flf Af• ::
tnCrl· 1 °'1tt1· : : 'J'IJ.!)· : .VriDfl)A :: ?" '}9" : f1•f.t.7: O.f-.l"?: J!. IJ 1 )'IC: r i\. hi\hA : )if,!F/.\9" :: 4l,l\h 1 1!-.Pcc; l n.·J· l : f.'loJI,f\• • f.m4-i\· :: "li.IJ l : : f 1\,fl)A ..f : CID'}"?P'1· ' f"l ..f11'HH·f,' l fD'/..f /! i) Q;'J• 1 :: , : • mf. • fll\9" : fl.aof\{1! s - .:t·11i?"- '1·-'t:'f..r; • l • t&41S J· l ttcli:f.rr.:r-: t-1\·! r Li· : 1- fiAmm.: : 111\ ' f t,.flJ AY ' tm'l"?f"'-=1· , Yfi:J·m·:J':l!'/A :: ---
1'h'tJO. • ht:lll' hl:llb t·• 'lfl.' ,..,...n,., •1 "' h? o.a ,..,,, "·''""'' .,.,.p-, il.::-ret • htl'lt- • r11' '"'A' .,,..,,, .,.,.. V" 11 ttA ·,., 41lç 1 '"'111.'tofof'" • ,.,.".'" .,t-Ut• J\-41: 1Jt: -'"V oC"r.'• .,ç,.. &-).A.• r.n :,., 11 .&-'1!'!-o t.M',.• h'!' A-<·1'!-o 7..:>1·• ,., ).ti'• ,..,n·• )-t• :.tA • 1?o r 1 ·mrt.• hA>. • ,. .t-mU·• ,tu:·J·I 1iih• rm-:t··l'' ,,t'f,,,-1·• •fll't·ll+• 111.+• -nu11• 1hli.1·• hl"' • ·nt.++' ·mr:?•.:; -,·ur.·· H·t':'• hft.f 'l'llr:'• hl} l )l"'fp rtl.·l•')' 1hPr.ll • hftf'l 1 .,•6tl1 t lttt•r n flll).-.tt.• ,t,fljt• ).'o)t f\1 flf·A('·• )·f·l"'• h·flt 't'f,t .,, t·J\h.M'"I 1tHt-::.: hfl')l /.·"Il.' IW·9'"'1• h n• tfttiO•'/H•J 'Ji ,l,• 'lli)'IM• ' h9"',fl/.·' r..hl\1"'• l.'fl/.1 l•.t.if.• hh-• h,, .,.,..l. •n• Ali '•'" .,.TJ"''ljA'i'' 'Jh>-A• n,.ç. n.A"n-r• ht.+;t-"h-• 'f'Af')• IU='+'J ' .h.ur t f.A=t-•ll-,.' h/UJ\.' ,. ,.,1:, >.r,·ooo 1t-d tt-,., nl h:'f-')• 1'">.11:' h.lli:m-ntt-r1 • A,,.,.., .,._., h'' ,..n-t:• nr.?""mo -nl·r·r• th.JI,., ,,..,. JMIhV"• -'.;J·'f!* t11\H'"'' ,..,.,._1·<J-floC\hr9'r• '? }' n.:t·h , }, tt nt.:a··tt-1"'1• tt.·l·tlc:n:r-t'i:'t tt·?'"'>• h.1i-n<·1• H. ll,.t.'.·1• ''·"·?"' • h1) 1 ?''• >.•"}• 'Ht·M:'ti Nto?"• >. t.n•1• 1'161. ')1 h.OA'l• fl.thl.•"'lcD') 1 h,P·'I"'• "'f')• )r.') l')'.h• •I· ,<Jitn'J"' 1 n·t• t.M11t!+• 1r'li.,, n11·• h nc:>.l\. ,....... ""tJtt'l·• h.'li>-1 A..r·r•
Gen ti dell'Adi AM, det Merlebai Tabor, 1 dell' Adirbaté, detlo Scité, dello 'l'zem beld ' e dello Tzrma i1!
Gli eserciti del fra i potenti, il Re d" Italia. banno scoulillo c(uC'IIi del alle due estremità del suo impero. Nel paese dci Galla B01·ana il Generale Gra ziani ha dislrulla rarmala di Hns Lo sue valoros issi me lrUJlpe inseguono il genero del Nog us che lrol'n scampo soltan to t co lla fu ga. <ÙJba ndonnucto l0000 morti, mi- l gliaia di ferili, armi e Le nos tre l 1
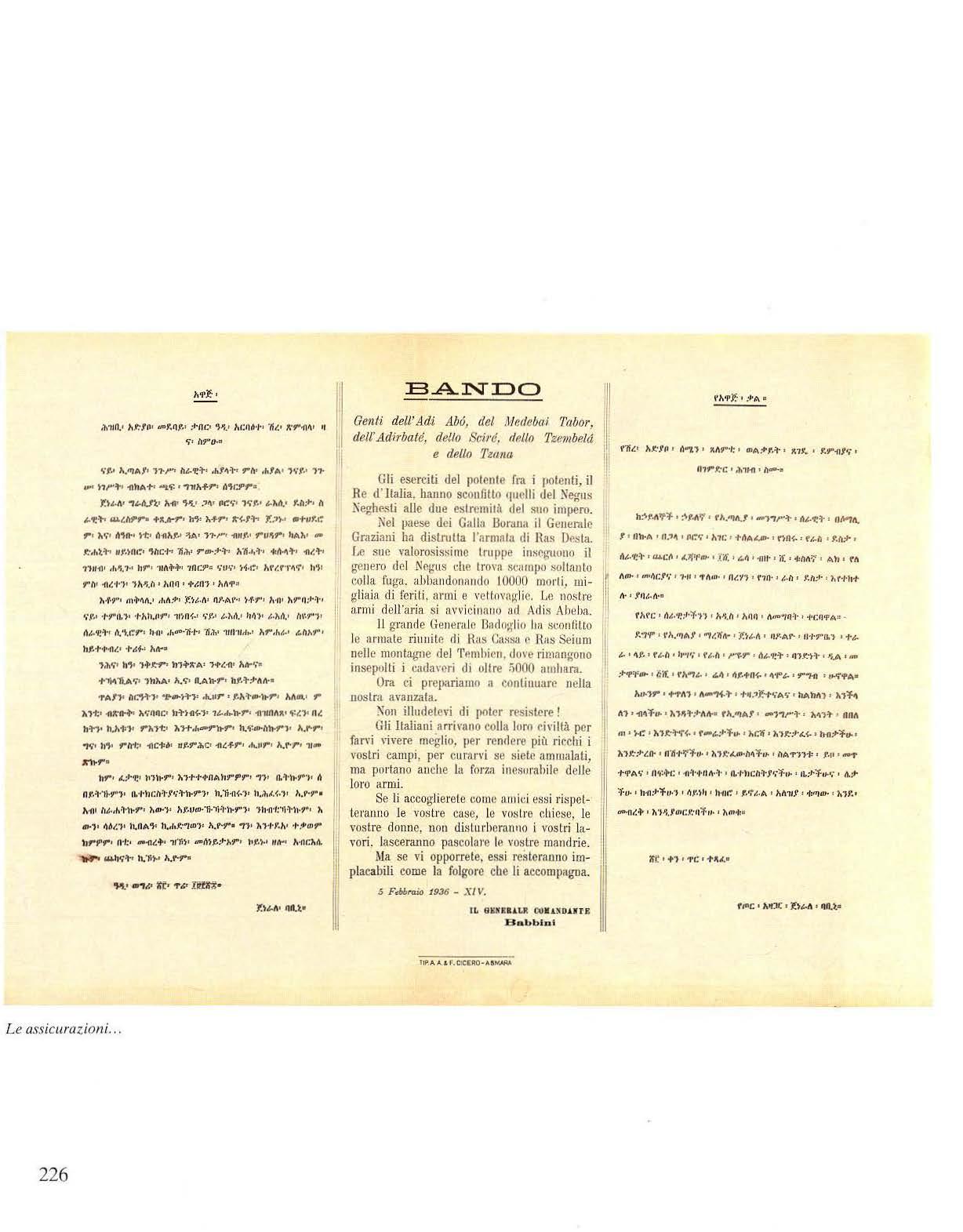
armi dell'ari a s i nvv ici uant) N el Adi s Abeba. 1 l i grand e Genera lo hu scon tit to le anna te ri uu itn rl i Cass< t r R11s Seiu m 'l nelle mon tagne de l 'rPmhic•n, dul'e ri mangono insepolti i di oltre -'iOOO mnhara .
Ora ci prepariamo <t continuare nella nostra a\ anzata . illudetevi di pol<'r rPsistere !
Gli HaJiani arrivano colla loro riviltà per farvi vivere megl io per renM1-e piìt rirchi i vostri campi, per curarvi se siete am uwla l.i, 1 I ma portano an c be la forza ineso rabile delle ,. l loro arm i l ·. Se li accoglierete com e nnli ci ess i ris jle ttenmuo le vostre case, le vos tro dticse , le ,1 l vost re rlonn e, non dis tu ril cmM o i vostri la·1 .1 vori. lasceranno pasco lare lAvos tre mandrie.
• :'1../t.V '"·"'Ili• flt:.t'!f·, """"", ' rlh·A. 1 • .'1.1r., t t"t-. h • f.(l;}•, 1\ar • rn•fl f:!'/ • ·r·tt • 1'/lllt• • III.Y l t f•IO· ' t flr f.rtj· : )1N·h+ A· 1.t'rlt-1\•ll
5 F<bhraiiJ 1936 - Xl V.
IL 9XS811L-It OOKUD.I.liU
Ma se vi opporrete, ess i res terann o im11 placabili co me la folgore che li accompab'lla Ili
Babbt:o i
At,.'lJ"'' -M'A'J, • hAhl\1 r )k'J!f-4\ "'' 11.1\':fu- • >.1-"-l·:""""• rl\.lt'fA1• _.,..,,..-1. • ).4\'l+ , nn" m • 1 ).'l.t'W<"· 1 f,.&:l·l·u-, >.r.lf • l\").f.·;i't(..ç., h.n:l"';fu- • t fi'IH·Ji'!frJ.' 1 itA'1"1'l•J: t J'.JI • _.,. ·t-ttA.-.· • /l'r:•l•c • fl·l••f•UI\·:t· • lloNlC:Il:t·fr,::Y·•J.' tt.;l'!f•u-'f· • A?' • <t') ' 1'C 1 1'Jtl.•
L ' Imp e•·o d'Etio pia h.1 cess:\lo d1 esi s le• c
I terri tor·i e le geuli che appa•·tencvano all' Jmpe •·o d'Etiopia sono passati la sovmnità piena ed inte1·a del Rt'gno d' Ital ia
Il t itolo di lm perittore d'Etiopia è assunto per Sò c p e •· i discemleuti dal Re ll 1 Ital ia.
L ' Etiopin è gover·nata dn un Gov e1 na tor c Ge:1 e r a lc co l litolo di Vh le•·è. Da ess o d ipendono anc h e l' Erili' ea e la Som a lia.
8. M. il Re d' Itn ll a. ed I mperatore d' Etiopin mi hn n o mina to Governttto J'e Genc J·ale co l titolo di Vicerè
ADDfS ABEBA 9 19:!6-XIV J O 1928
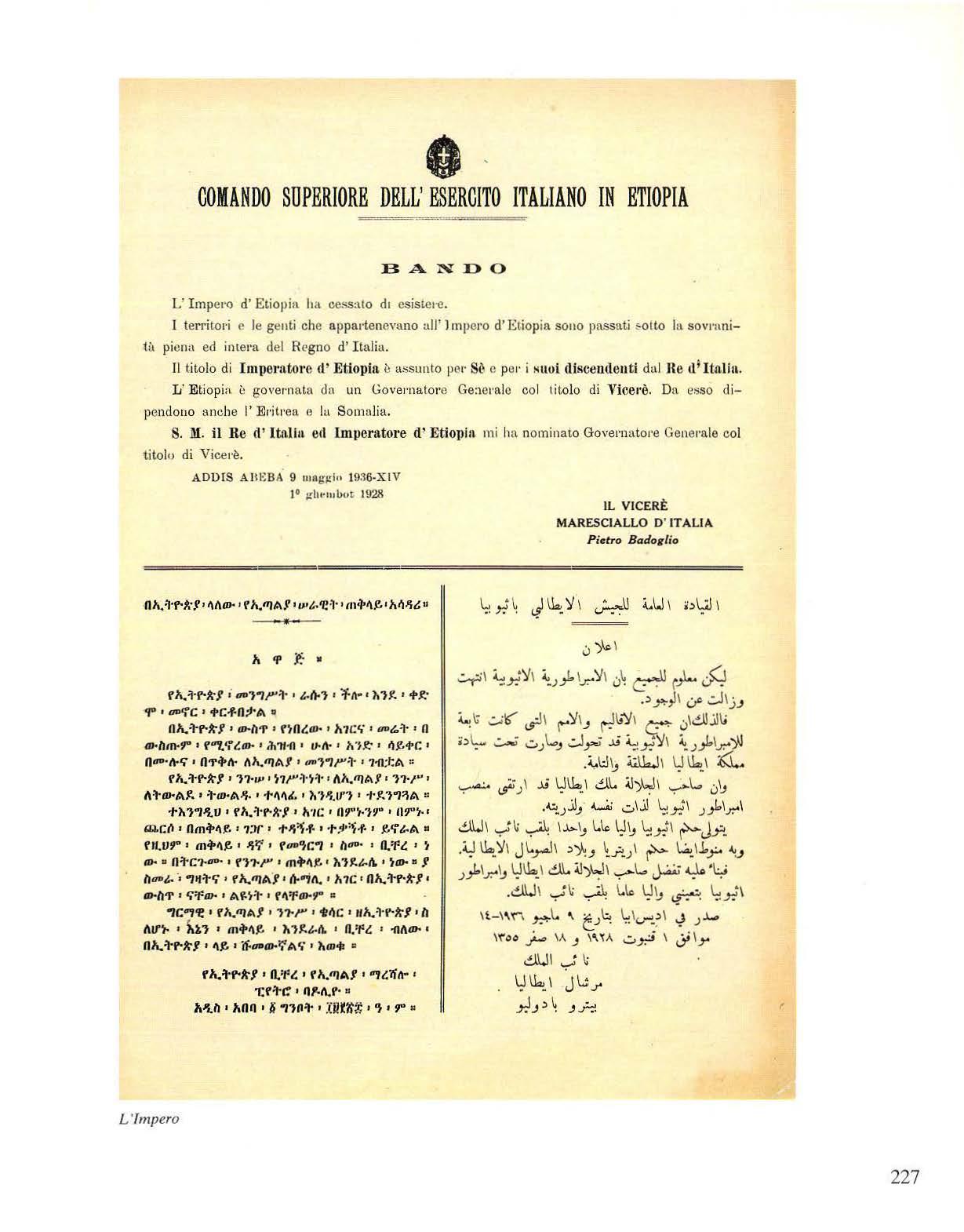
j DD ')"J.f"1• 't.fl.') r 'fil• r ),').f.'.' +t:· .,.. DDt;'C l +C-tt O;t-A o l tD-/11'. I') Olm-. h1 C'i. o m- llm•r' • f"'l..'flm- • m1l·O 1 Vo i\• 1 h'}J!" 1 I) ,S'.+C r n.,. ,...,. , 1\h.IFIA! ' OD't"'P''I· ' 111:J:A " f 1\..1·1'-ti! • 't 'l· lP r 'l·H • /\1\..lf! A f r 1 1 1 " r M m-A'- •1·m A-"· • .,.1111 ". • • _,.>.'}"1-'lll • rt.. 1·r-Ao! • 1\'I C • • Q;I.C /1 • 1 1:1r , 1 ,. , t.'ft-A " \'ll tl r' l l .IS '." r il""' r O. 'fl l ) = OT C'I-DO· r f1 '1-P' r r 11\ '}.f.'.t-1\. 1 • ! /I ODt- "' lfT'ì 1 f l\..lf! A f 1 (1. .;1\. 1 h'IC 1 01\.. T r ·tìf r •111' 1 'ì'I'ID- 1 A f.}T 1 fii 'I'ID-r' " "JC.., 'f! 1 f h.lf! Af 1 1'1-P' 1 .,li'I C 1 11 1\..'l· l'- ti! • il 1\lf). l M't • h't'-t-1\. O'l'l 111\ ID- l 0 1\..TI'-tìf 1 ilf. 1 r h m41 "
f h.-1 1'-tìf 1 O.'l'l 1 fh.lf!Af 1 .., l il' ll· r -r.r +G' • llf.l\.f· " Allll• Mll • li "11M· • 1 • 9" "
IL V I CERÈ MARESCIA LL O D ' ITALIA Pietro Badoglio 0 )1..> \ ..:..fi l y.-,l l r:r ..::..1\j.J r--'YI_, (7' 01.!.1!.lll.i ib l:-- .:-i -:: .) , ..::..! .;.; ,.J'il ) ).\.r.)\l ,i.,.8 1_, ;(LA ..,.......:.. .;.; d jj)Y I _,; L. 01, .:.,1] .>_,bl_r,l &.11 1»- 1_, LI..> \)1_, JL_,....ll )_,1.\.r.A'-' d\... .&.11 ..,J \i L\c \}1, \t.-"r' ' -? .> .J\ oroo )- \A .J \ O..l A \ Ji ly &.Il ..,1 \; Jl:.r l r.J J.f"'!.
Il },, ·1· l'· '' Y Il j ,.. &- ID' 1\ Il ,.. t1o 11 Il 'f '} "'' h :J' m 4! j •
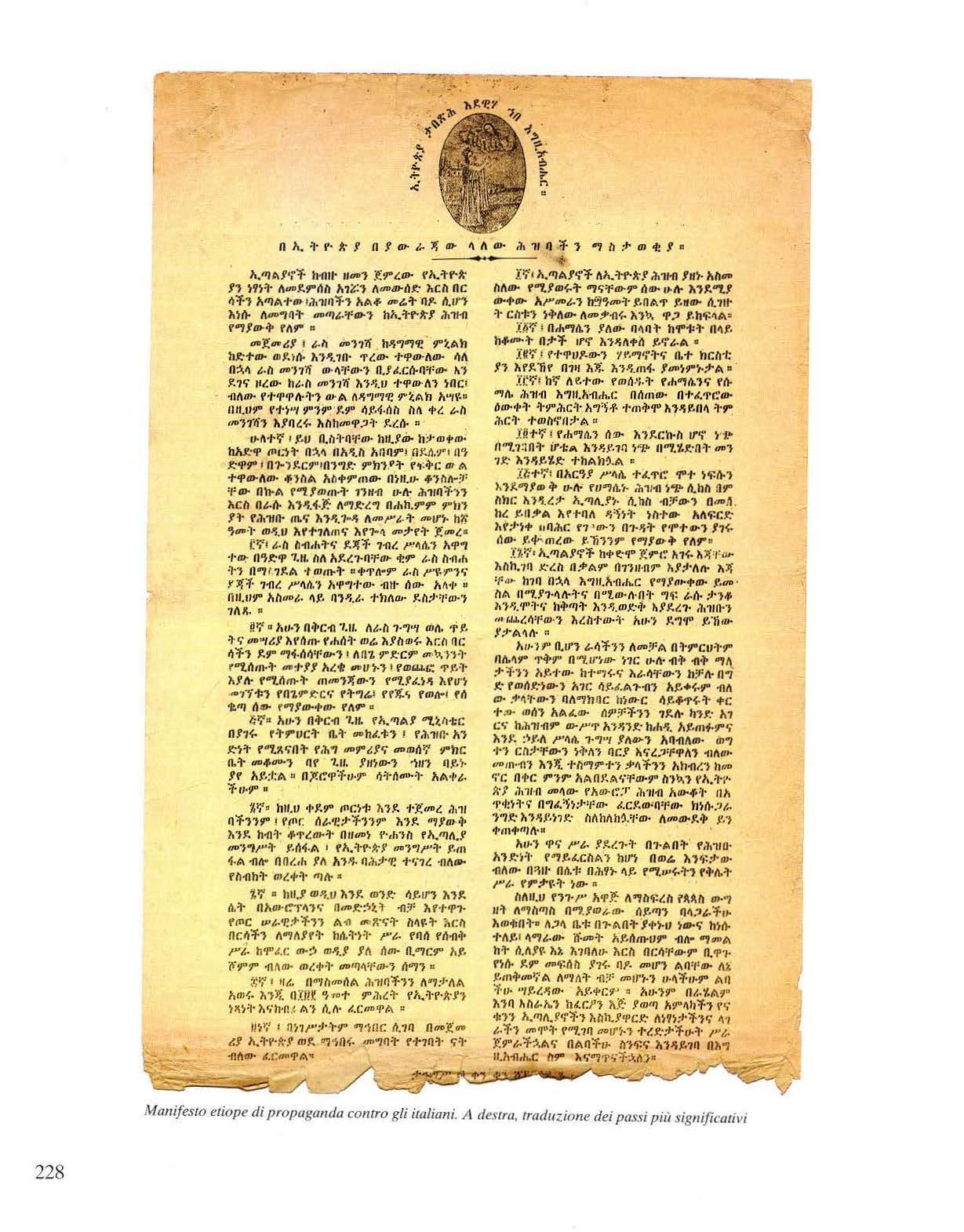
t. "l/.\N'f h-nll· lloD'J l 'l"t./Do fh.+f-,_. n )9 ):t- flliDY.,.frn 1\tiD/Dofrt: "cn ne Il T't h"'A'f'm-•ilo1JII1·'t h&\41 ""&.T IIJI. fr, 11'1 1\ou "lfl'l· 11D"l&-rm-1 nl._-'!·f-*"1 .1.1111 f"''fiD-i)> f/1,. H 11D'"f..ao&Y I t-11 t1o')7l'f M"lO,'l? . ti m!. ) fl. Tt.m- i''PID-/1/Do l'Ili ll :S.I\ /,.fl 11D '}'flf ID I\ ' I'ID·'} )\') 5!.7'1 JI/./Do ht.. lJ tm')•J'fi l\'Pl.U ·l''l'n>-/1') HIC t ofl(IOJ• 1'1''11 '1'1\-'l•') h"t f. n llll.lll'" fof')"l 9"'}9" '1.9" t'l .f.1.flfl hfl tjo l. t·fl tll>')'(,f') Mhoo'l'..?·)· f.t. fl• :o tJofl1•1f' l .1'·11 R h'l·ll'l'm- hll.J.'IiJ. IJ :rmtm: b.hf.•if' (ll t; H· 11 '>.1\ llt."'.fl MI O'!"! rl Kn,,•o ti '} 1:'1',. 1 01-').I?.C?• tiJ')-I.f.'.· !l"tl1 "t r;:o)>c m A 1''1'/Doii/Do fo')(IA 1.11+?"111/Do mH.tJo oJ.1flii·!J' '1' /Do liti- A f "'l.f.'IDtn·-'1· 1')1111 tJo/1- tl.1JII':f· )') l\ClJ },')Jl,<f.:f. llthll.!l"!l" 9")1'} J.'i• fil11111• tM' /IOP!".t T 11Dif)· h n mP,.tJ l\f.,.7tl m 'ì l\f?- 1\ m>;J-f·r '1..""1. • r lf'i t, (l 111l .W.fiM >.•P"/ '1, 11, {1/1 hY.t.'l-fl'l'n>- 4!9" {,.(l ll·l'llh :1·1 Il "'' t 11.&1 ·t U>flloT n .,.'1'1\•9" /.oli l"i'·!I"'}'J r ;t{':(· 7111. 1"1\ll>t 1•'f'-l·l·m· -oli· IIm- h ll•l• " 1111.119" hflou(,. IJ')Y,,/,. 1•ttl\llr Y,(l;l''l'm•') • !11 • h V•'t o+r.-n '1,1/. flt.·l'l 1·"1"1 m(l, :t r,· uo"t&.l' l\l'nm· fthfl'l· m.:. l\ r: ll Il t: t'l::,:'} S'.9" "''<I·M'I'm-1 • 1\ (J l ?"f. C?" ctr> \;1,')1 1· r "'l.frm·t no1·1Y ht.<f! '"'Il 'J' f,·l· 'l\J.' /1· f"'l.llm·t V"'l.16' )JI, "' '171:') fii 7.11"J:-C t,' ft'?&.l fiDI'l•l fil t. "l f"'l .f.'OJ-4•m· 1'11'1" • htJ·') ll<l•Cofl 7, 1/, f h."'AY 1117{. f 'I•9"UC-'l · O.'l· ""h&':J:'t ! f,lo110· .h'l .K:Ft f '"l.K'ìll'l' l't'h"l liD9"t.J.'t; oomiJlt' '!"ti C 0 '1' ""ofl""'') 111' 'I.U. ' )lll Il M · 11' »f.:I:A " t'l'l ll-'1· hA•l'&1·11·9" • illt'• h ii.U •1'1.9" 'l\'l .l?. ,},11 ll'f1't9" • l'fili: frMI!:J•':f·')')?" },')f, "'1,\'0J if• hofl'l · 4-•'l't.m·-'1· """") r·.h'tfl l'h."ltl.,l' ou'l'?l"'l · f M A t rt•• 'l f ·'-·.1' no')"l!"'l· Y m 4·A 11 0 /. , /o 1 11 Otlt:J' ' P. ·1 •, 71. •01\IPI'lloflh:t· mt.4·'1· "'li- • 1.'1' • htU' msw }.') f. m11: t'l K-If1 ), ') 1. tt.'l· 11 1\lll-CT I\'l 'ò 11?1' ), f·I''P7 · l'(llC t'di D'>J',' <,''I' Mf. -l- 1oc:(l IIC: t'l'f ') tl"'ltiYf'l · h l'l.-l H· l"t.· Vllfr 1" /. · h'l" t.r. m-') mP,.,V 111. frn>· ll."'l C'l" 1•!'(t' 'J"?" 11 1\11>- OJ/.•1"1· tn)''ll\'fll> '} n"''') ' tlt.:. 11" '/ (lno iiA lo11f1 'f•n AV?;I·AA }',m/,. 11'tYt. 9" t1,C:'I- ffa.'l·I'·A·J''t A'} 11 1\ • t. Co»'/'t.\ " l "'''HIC li. 711 llno :e:"" &Y t..'l·l'·'-·.1' mS'. m•"lll'l- f·I' 70 'l · 'ì·l'
!'ì'• h "'Af'f'f flh.'fi>-,...1' il11111 1\fiiiD M,.. v"'l.! "'''ìr,..,.. llt»o l\11."tf (Do+t»o h/"{10&- '} f. OA1' f,rrf»o fr. 711' T Cll1:1 )c)>l\aJo l\1\;>, 'P;J 1/i'ì' • llth "''h.1 .filai- h'I"-J:t llfl.f, hfo""'t II :J''f lf'l' f.'f&-A ! ll'ì' ' r·f''PuJI.t»o1 11,.,. tll:n·r: n l\r1.1il' 11'111 l\'}P,,tn'l· faro)<r'f.:J't.\ = :!r'ì'' h'i" A l'. i't»o f,h"''M'ì "'1(1. 1111111 l\"111.1l1lth.t: llfrtntD- IJi',(,'J'C!'aJo l) t»otjo'f' h"l'H· ·r·mil>'l" t.'JJIJI.III\ ,'IJc:·l · l' mh'l'II;I'A" · · J !!i''i' ! fd1"'10.1 IJfDo l\'}f.Ch-fl tf'f iNA ) r.f!o tl "'l.'t.t:IJ'I• 011'} 'JjC• • l7; 1''ì'oIl t. Y P'il h. N.'l't': ,..,. ), ') )?."''fa>+ V·h- fi)"''M· ,'h1t11 )"!" lthh fi l'" ntlt: l\H l:J' .thn -n r m-1 n-n h l l\f.,.llll JI'SH )fl·,.,._ l\ll'f.t:f.· l\f;J·)+ ulltl.C f7 ' or'J 1''1"1'•1 rlo>- f. <#A mlm- ,r 1i119" f"''!m-+ fil,. • :0,1 • h."'AY'f'f Mh. /11 t:lfl tl.-l't.\11" llnll ll?" 'hf:J'/111'l' l)" 11111 0:\1\ l\"ltUi·O,h.C r•71m·+• ,e"" · ilA 11'"1 .1'1·1\11-'l·s· ;l"')ofl >o'l"i.'l"'l·r, h•l>"''l' h'!P,,mjC·.f• 11.1',1.1• tMIII• ' I u•IJJ.I.Il'l'aV) l\lili'm+ hll•'} Y.'?'l" f.'!illlY;J•Aflll· :: >.11•H" R.ll'l &-t'lT111\11DfJ'A 11 '1-l'"CU·l·?" 11(1.'\!1° 'l'<l>!l'' 11 "'1.11'}11" )'IC V·ll· 11+ 11+ "''li loJ!.'f·m· l\&-t'l'I' CD·1 h il'l\·11"1 t: fmllf. )m-') Mt: ll .f.&'.t.\1-11') 1111 m• :1'11 '/·m-') 111\"'')l!IC
I)J'..f.'J'?-l- +t: ·1· 1)· IDfr '} h&\,(, ID- M ' 31''fT> 1 S'.II- 11'}1: C: \' tJ ,l,1111,. tJ,M, >. f!. m4·9" '1 l\'H'. :) f ./1 1"11/l. 1-"1"1 .V/10:>-1 hfloflflm· m '? 1·1 cn:Nfm-1 )<}•f11 ne? M'l.'J'r'l'll't 111111 tto rn· ofl'J .:1'1\'f' n hhofl l. '} h rm r,•c; Il .PC V"')'l" }',AIJY.&\ 1o''I'/Do9" (l')l;>,') 1'1.,.)·;•· *'' 7 tlo11 0 001\ID- ,M/11 l lh &'.Cf.m' ll ' l'm- )l)IJ•,'J t.. MhfiM 'I't»o 1\<JD/Dof.•l> J' .'} '/•ti i +"/1\-U ' hl)•'} 'f'fj !"t· 111•1.\11'1- ftlo1JO· >.').f.•H f"''f..C.Cll/:\ 1 II m&. >.H: ;hv· 111\11" fl:jll· llh.1: flt'h'll- 1\f. f+(l. -t fu &- \',..;l'f•.!)• fliiii.U f11·1" .h'PJ': ll"'ill(ì:lfl i'AM m '? ut t1 "7 fl"lfl 11 "'/.YIDtrm- t'lt "l1 llfi.'J&- Tll· l\ t» ojlfl•h 1\;JI\ 0.1: 0 1-A il'l' J.'4•l-tl )/Do t; 1'1\K.l 1\"'/;! /l)o j'j..,:, t.t. illll-1) 9" "'"""' h-l' h fi.V V· M. MII I\ V· >.e h IIC:t'l' J'm-?" Il. '1''1· l'M· ,,.. m> (ì:t'lh llf· m>tfl All ' l'm- M. J.'.m o}>tn> 1i' A 11"7 11 '1· ofl?F ll·il':f·ll·9" Ali :f·rl· " IJ!,t.Ji tll • hf.<j>C'/
.
.
Avvertenze al nostro popolo delle dive rse regioni dell'Etiopia

Tra le popolazioni etiopiche non vi è chi non sappia che gli italian i da lunga data si applicano con tutte le loro forze per abbauere l'indipenden z a etiopica e suscitare delle ostilità tra di noi al fine di distruggere il nostro popolo e renderne deserto il paese, onde potersene impossessare Riuscendo a far combattere il degiac Gabrè Sellassiè contro il ras Sebhat con la morte di questo ultimo in combattimento, essi si vendicarono dei rancori che avevano per lui sin dal tempo della battaglia di Adua. Più tardi istigando il ras Sejum a combattere contro il degiac Gabrè Sellassiè fecero perire molte persone. Questo avvenimento venne festeggiato ad Asmara con esposizione di bandiere . ..
. Non appena incominciata la guerra, st imando il nos tro popolo ed il nostro esercito privo di ragione e simile alle bestie, gli italiani gettarono dei manifestini che riportavano le profezie di un eremita secondo cui nell'anno di S Giovanni (1935-36) il Governo italiano avrà delle espansioni mentre quello etiopico si annienterà
Dopo di questO, comportandosi non già da uomini ma da vili, combaaendo solamente con gli aeroplani ed i gas, a vendo visto ciò nonostante che il morale delle nostre truppe era forte, allo scopo di disunirci, per falsa propafitmda hanno gettato dove dicevano che alle popolazioni di oltre Mofer Uaha, pur avendo sufficiente cullura non viene permesso di aspirare ai gradi
. . Quando noi siamo entrati a fa r parte della Società delle Nazioni, essi hanno firmato dichiarando che l'Etiopia aveva diritto di esservi ammessa
Vengono ridotte all' impotenza la religione e le chiese copte, perché s'impoveriscano e scompaiano lentamente ...
. . La gente dell'Hamasien è considerata come impura e ad essa viene proibito di frequentare lo stesso albergo e di camminare nella medesima strada con il bianco
Gli italiani hanno per principio di istigare il popolo a mezz o di denaro e di buone parole prima di occupare un paese, mentre dopo aver raggiunto il loro scopo, al fine di distruggerla, ostacolano ed opprimono la popolazione spingendo/a al suicidio ed a commettere delle gravi mancanze
Dimentichi del passato, ecco che anche oggi essi imbrogliano la gente Anche ora gli iialiani, dopo essersi persuasi che noi, sia colle parole sia con alt ri mezzi che danno vantaggio al nostro paese, avevamo cominciato a progredire; nel pensare che se noi s viluppassimo le nostre scuole ed il nostro progresso non avremmo mancato di domandare loro la restitu z ione delle terre che ci furono tolte con la jòrza; senza curare il rispello dei loro trattati e l'onta di violar/i: hanno valicato la frontiera ed uccisi i nostri uomini. E poiché su ogni paese e popolo non man ca qualche Lraditore, hanno sobillato della gente specie di Haile Sellassiè GufiSlÌ e sono giunti, senza provocazion i da parle nostra co l programma di toglierei le nostre proprietà e farci loro schiavi Dato che noi fin'oggi non abbiamo mancato verso di loro, ma abbiamo semplicemente vissuto in armonia rispettando i nostri trattati, ecco che il popolo europeo ricunoscendoli per aggressori e condannandoli per tali ha applicato loro le sanzioni e gli italiani vacillano e stanno per cadere. Non arri vando a far crollare l'unità del popolo con la forza, essi ora si sono prefissi di combattere svergognatamente, come b en lo potete vedere, i convogli, le donne ed i bambini. Perciò, se il diavolo non ve lo impedirà, cercate di stare attenti a non cadere nelle loro tenta z ioni che mirano a far vi trasgredire gli ordin i del Re e gli aworevoli consigli deli'Abuna Voi tutti certamente siete a conoscenza che gli italiani nel d ire ai Galla di separarsi da noi, perché vennero da noi colonizzati, e nel dire agli Amhara che presso di noi non possono aspirare ad alcuna carica, compiono una falsa propaganda avente per scopo di seminare tra di no i l'odio e la disunione, di sollevare delle agitazioni, provo care spargimenti di sangue ed infine di rendere deserto il paes e ed inaridire i cuori per acquistarne benefici. Tn attesa che il nostro Dio, che in cornpassione dei pianti di Rachele si degnò di liberare Tsraele dalle oppressioni di Faraone , svergogni gli italiani ,che ci hanno vilipeso, poiché a vete incominciato la bauaglia convinti che è giusw morire per la Patria e per la libertà, nel nome di Dio vi esortiamo a raccomandarvi a Lui affinché nel vostro animo non penetri la pigrizia.
30 Tahasas 1928 (9 gennaio 1936)
"ACCEPT our friendship or die." This compel it to use its pòsitton in the League is the threat dropped on the Abyssin- . of Nations fot the immediate operation ·of ian people by the bombing planes of the Covenant, which they have Mussolini. proclaimed w,ould outlaw war .
The A:byssinian people, fighting with all Demand that the of Nations the odds against them, are faced by every applies sanctions now against Italy. latest and devilish .instrument of war. Stop ali fuel and war materials being While appealing to the peace:loving people sent to Italy. · of the world · for a.id, : they have already Stop all loàns and other forms of asdemonstrated their unconquerable de- sistance being sent to Italy. termination to defend the last remnants of Refuse to load and unload ali Italian independence which imperialism has left ships, or to transport Italian Blackshirts to them from Britain to ltaly.
Whò can remain unmoved at this Close tlie · Suez Canal NOW to all wanton slaughter of an innocent peoFle? ltalian shippiJm. Is this of no account to the peoples pf other countries ? On the contrary, the vital in- Working Men and Women terests of the people ali over the world are of the Labou r Movement ! at stake. ·: · "
Fascism is preparing a new world war. You belong to a ,m.ighty Labour MoveIf we do nòt check the Ita:lian Fascist ag- • ment. You wield tremendous power. You can force the Nàtional Government to act gression in Abyssinia, we are opening . G . h ld at eneva ìn the way that you desire. You t e to '\1\IOr wa;. . can that the British L;1bour MoveWE piace the responsibility· of the _ ment accepts proposal of the Compresent situation at the door of the munist Intei:-national ' for an immediate National Government, and all those who conference of the two working-dass lnterhave the afplication of sanctions nationals to work out _ a common pro-(the stoppage of fue, war materials, loans, gramme and campaign that can restore and closing of the Suez Canal to ltaly), and preserve the peace of the world. which could have prevented war from SANCTIONS mean peace. The abbreaking out. , sence -of sanctions has already led to The Nation?l Government will shordy · war in Abyssinia. Unless we act now, try to secure a so--called "honourable" · this war can engulf the whole world. peace setdement, after the soil o,f Abyssinia There is not a moment to lose. Peacds has been drenchèd with the blood of an lndivisible. The hour has struck to fight innocent people; who bave been butchered as never before to defend peace. to make a Roman holiday for a modero Drganise meetings to demand the enNero. forcement of sanctions, for the defence of Abyssinia. Hurl your protests àt the Peopl·e of Britai n ! Italian Embassy and Consulates against the Death . already stalks in the -villages and.. bloodY. war polìcy of Fascism. plains of Abyssinia. Together we can Follow the lead of the "Daily W orker" prevent the continuation of this bloody every day. massacre. We can force the League of Unite all the working-class fo rces of the Nations tò act . W e can exert our will world in the struggle against Faséism and upon the National Government, and W ar!
MANIFESTO ISSUED BY THE NATIONAL CONFERENCE OF THE COMMUNIST PARTY, OCTOBER 5-6, 19?5·
Printed by the Marston Printing Co. (T .U.), Nelson Piace, Cayton Street, London , E.C.I.
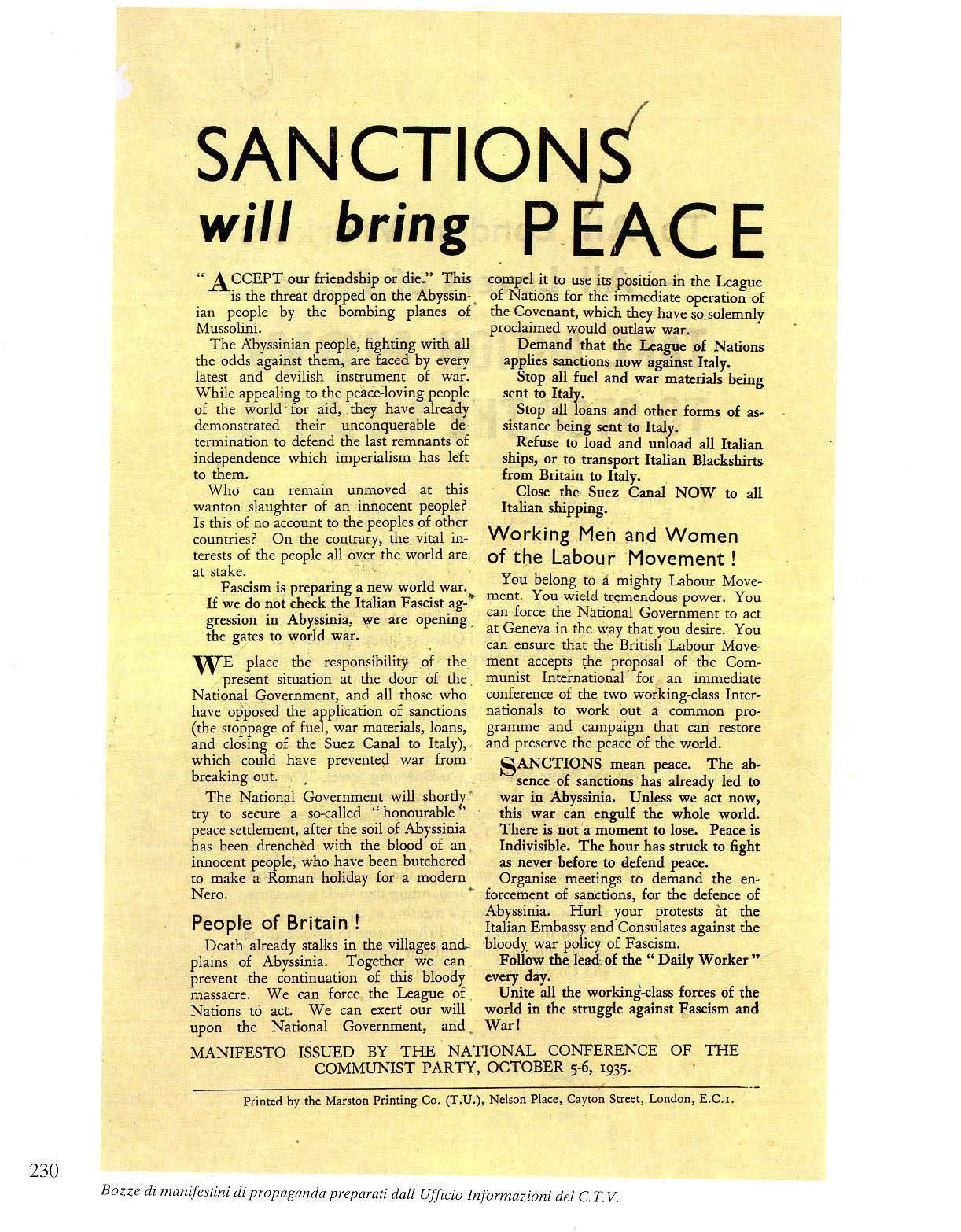
LI I L I C I A !T O S ! ro espereis que os ataquemos . Pasaros a nosotros antes - Zn caso contrario os aniquilaremo s. Para hacerlo contamos con centenares de aviones ,tanqu es y cru1ones que os ha rén
i M I L I C I A n o s l J. No os habéis dado cuenta todavia , . , de que teneis p'erdida l a guerre. ? Dejad las armas ya s1no el palizon va a ser muy fuerte y os dejara sin aliento.
I.1 I L I C I A N o s 1 Sabeis que es lo que les ha pasado a las Brig adas que nos han atacado en Navalcarnero ?
En una semana han perdido 71 aviones, 20 tanques y cerc a de 34 mi l hombres,sin tomarnos la mas pequena trincera ni el mas insignificante parapeto.
Los que se pasen a nuestras filas seran acogidos como hermanos, los que quieran r e sistir la pasaran negra! No t en d r emos mas reme d io,muy a pesar nuestro,que obrar sin miramientos .
i 1.1 I L I C I A N O S ! Nos da p ena veros trabajar c o n tanto ahinco en ha cer trinchera s y fortificaciones cuando tendreis que d ejarlas en nuestras rnanos .
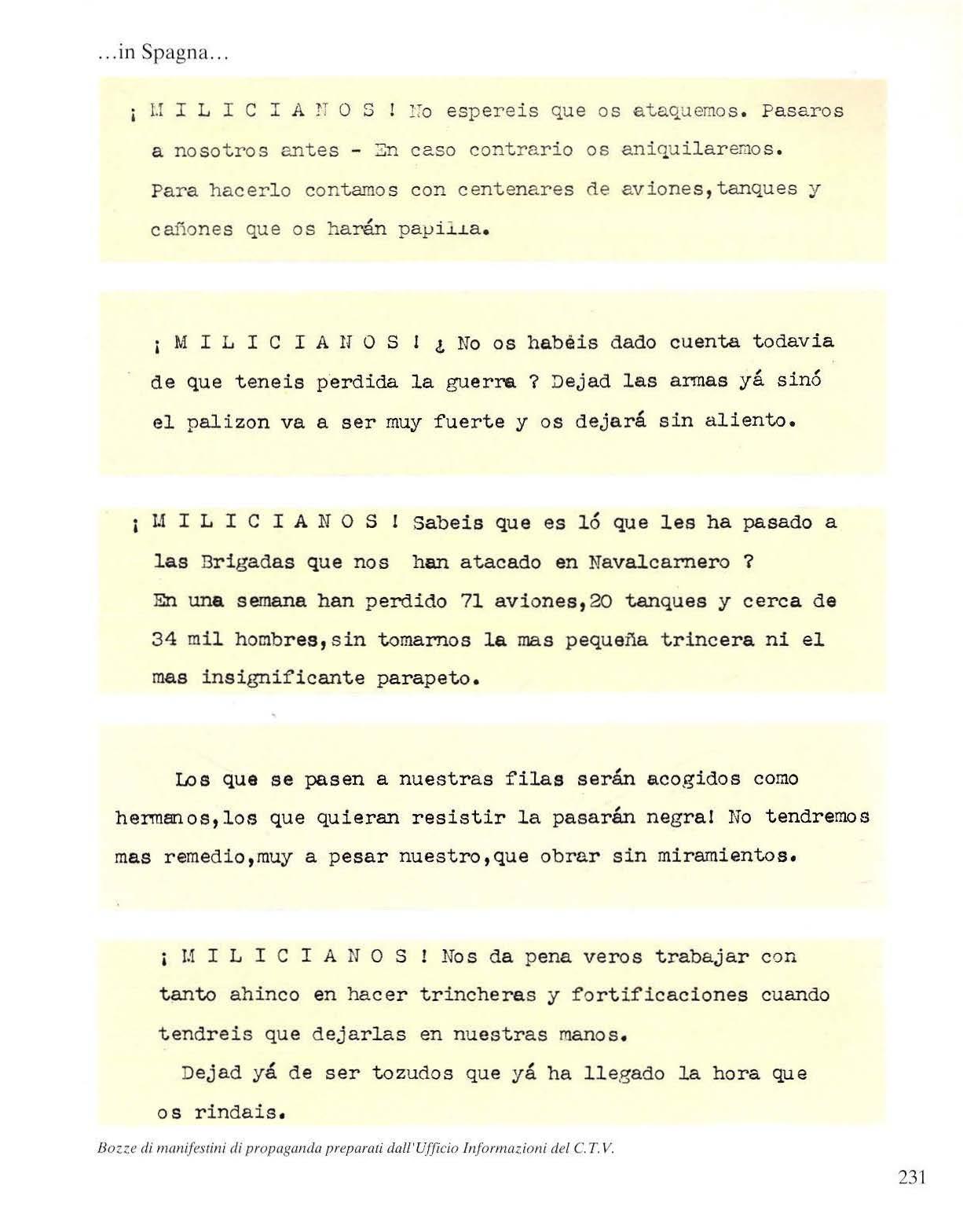
De jad ya de ser tozudos que ya ha llegado la bora que os rindais .
Bo zze di manifes tini di propaganda preparali dali'UJJicio Inform azioni del C. T. V.
'' c/.flu.lit- pattl II!JitCet;,)
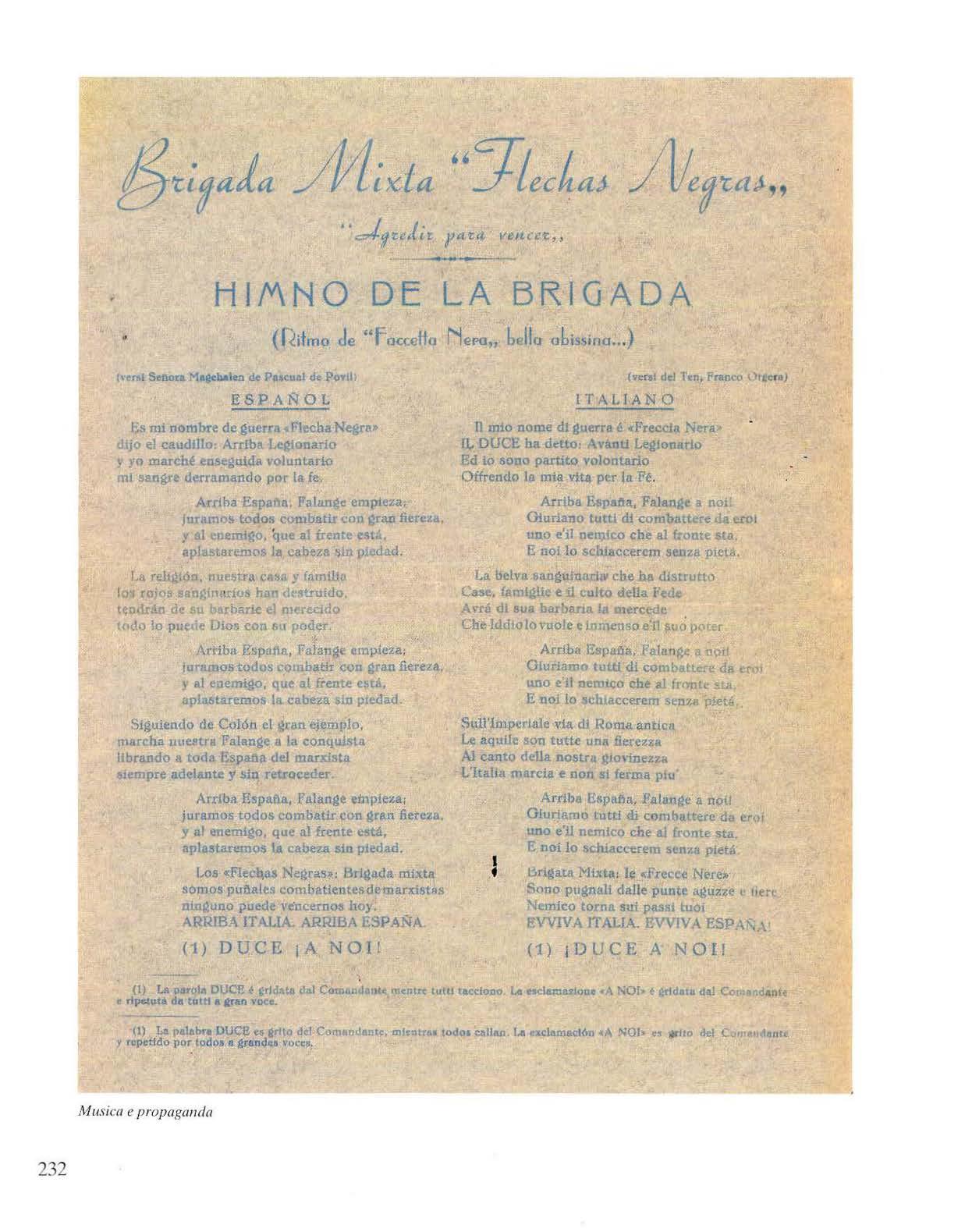
(l (i tm o de "fo<:cefto Nero, bella ubi l>Jna...)
(• er l SrliDru Mal)ebe le.n de clc PoTll
es mi nombre de JO cl caudillo ArrJb11. Legionario yo marché cnseguida mi sangre <krramanclo por la fe.
Ar.r.tha Espnfia. Falllllge empleza. jurnmos todos combatir con gra,n ficrcza, y l cnenugo, lJUC at frente est , api staren1o \;{lbeza hl p darl. r hl! () , c s fnmill ra·os an lrt • Los h n lc:struldo teodrAn de rbarle e m recido tfldo lo pue e lJios con su Arriba f?spnf\a, emple7a, .fur mos todos COtlbatlr con gran Jiereza. ) al cuernigo, que at frente e apla6taremos la cabeza sin pfe<lad.
S1guiendo de Colon el <ljemplo, rnarcho Duestru 'Fàlange a l,t conqu4t.a librando a toda Espafin del mauista adelante y sin retroceder
Arriba Espafla, einph:,za; juramos todos combatir con grll.n fiereza. y nl enen:tigo, que al frente cstA, aplastarcmos \a cabeza sin piedad.
Los «Flec!1as Negras»: lirigada. somos puaa les comhatientes dll marxists•s ninguno pueùe ve·ncernos ho}. ARRIBA l TALIA. ARRIBA ESP ANA ( 1 ) D UCE 1A N O l '
(ttral del 'l'en, Fnnco Ott< r •) ITALIANO
n mio OOJllC dl guerra é Nera Il•. OUOE ha"lletto Avaot:l Lcglonurlo Ed lo sono partito volontarlo Offrendo la mia vtta per la Fé.
Arriba hspnfta.. "Falange a no1 Oiurlnno tutti di combattere dJ eroi u n o e'ìl che al fronte stn ll noi lo schlaccerem senza J).tet La llclvn sanguina hv che hll distrutto Case. famigl,le culto dena Fede Avr6 di su h01brn la merced · Cb e l dd lo lo-.: uole e e J1 IlO r
Arrtba Espana, 110 Giuriamo tutti d! combatt a uno e il nemico ché al fr<m s E lo .-.chlaccerern cnz p et
Sull'Jmperlale via di Roma anticn Lç aquile son tutte una fierezza Al canto della nostra glo \inez:1a L'[t aha marcia e non: si ferma plu Arriba E11pa1'u1, J1alange a n9\l G iuriamo tutU di comhvttere da cr un o e'il nemico che al fronte sta E noi !o schiaccerem sen1.a pietli Muta: l e "Fr ecce Sono pugnali dalle punte aguz"J! c uer Nemico torna sui passi tti61 EVVIVA lTAUA. ,EVVIVA ESPAN,.\
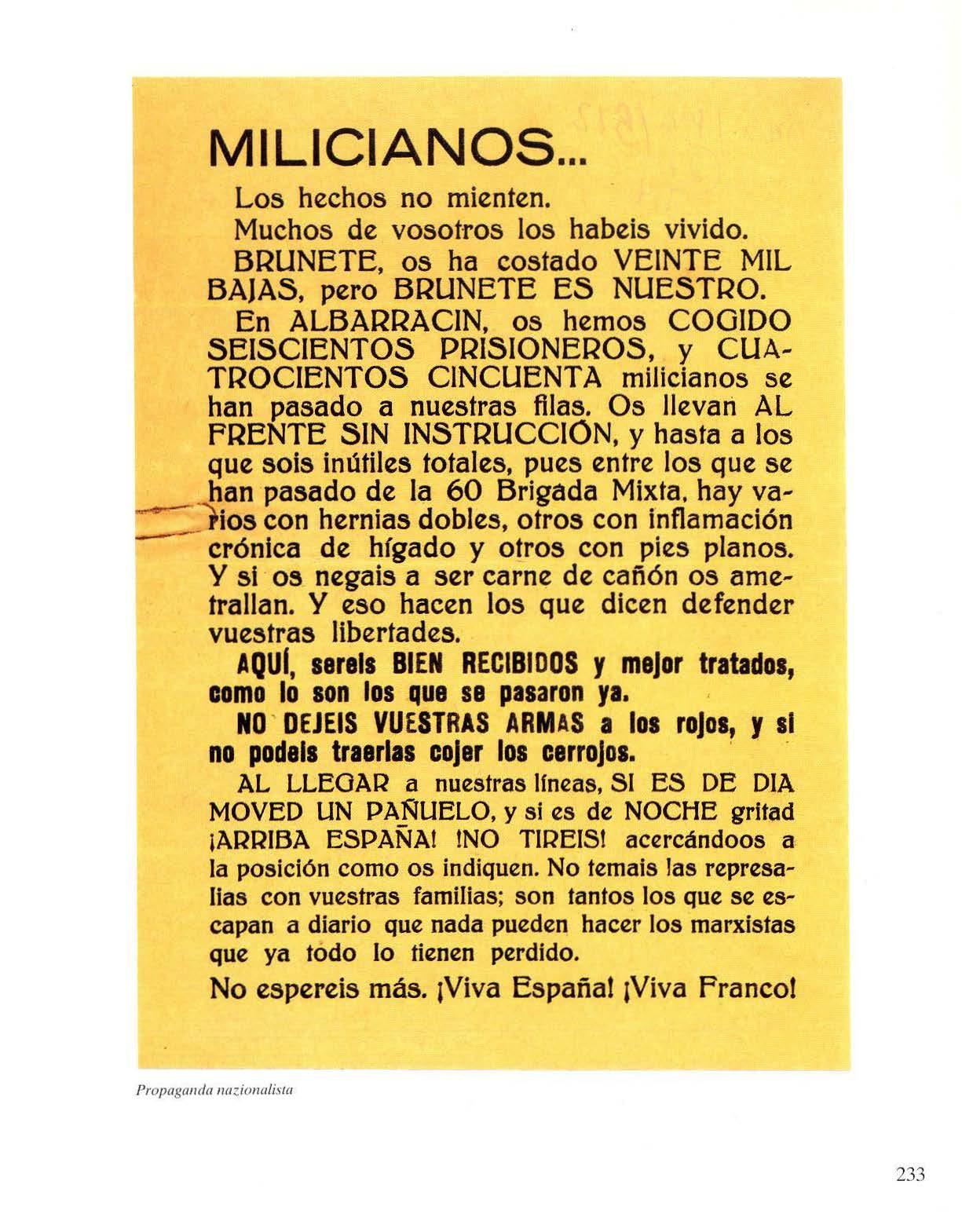
.. .
Los hechos no mienten. Muchos de vosotros los habeis v i vido. BRUNETE, os ha costado VEINTE MIL BAJAS, pero BRUNETE ES NUESTRO. En ALBARRACIN, os hemos COGIDO SEISCIENTOS PRISIONEROS, y CUATROCIENTOS CINCUENT A milicianos se han pasado a nuestras fllas . Os llevari AL FRENTE SIN INSTRUCCION, y basta a los que sols inutiles totales, pues entre los que se han pasado de la 60 Brigada Mixta, hay vacon hernias dobles, otros con inflamaci6n cr6nica de hfgado y otros con pies planos. Y si os negais a ser carne de cafi6n os ametrallan . Y eso hace n los que dice n de fender vuestras libertades.
AQUI, serals BIEN RECIBIDOS y major tratadas, como lo san las qua se pasaron ya. NO . OEJEIS VUESTRAS ARMAS a las rojos, y si no podals traarlas cojer los carrojos. · ·
AL LLEOAR a nuestras Hneas , SI ES DE DIA MOVED UN PAI'lUELO, y si es de NOCHE gritad iARRIBA ESPANA t tNO TIREIS t acercandoos a la posici6n como os indiquen . No temais Jas represalias con vuestras familias ; son tantos los que se escapan a diario que nada pueden hacer los marxistas que ya t6do lo tienen perdido.
No espereis mas. 1Viva Espafia! 1Viva Franco!
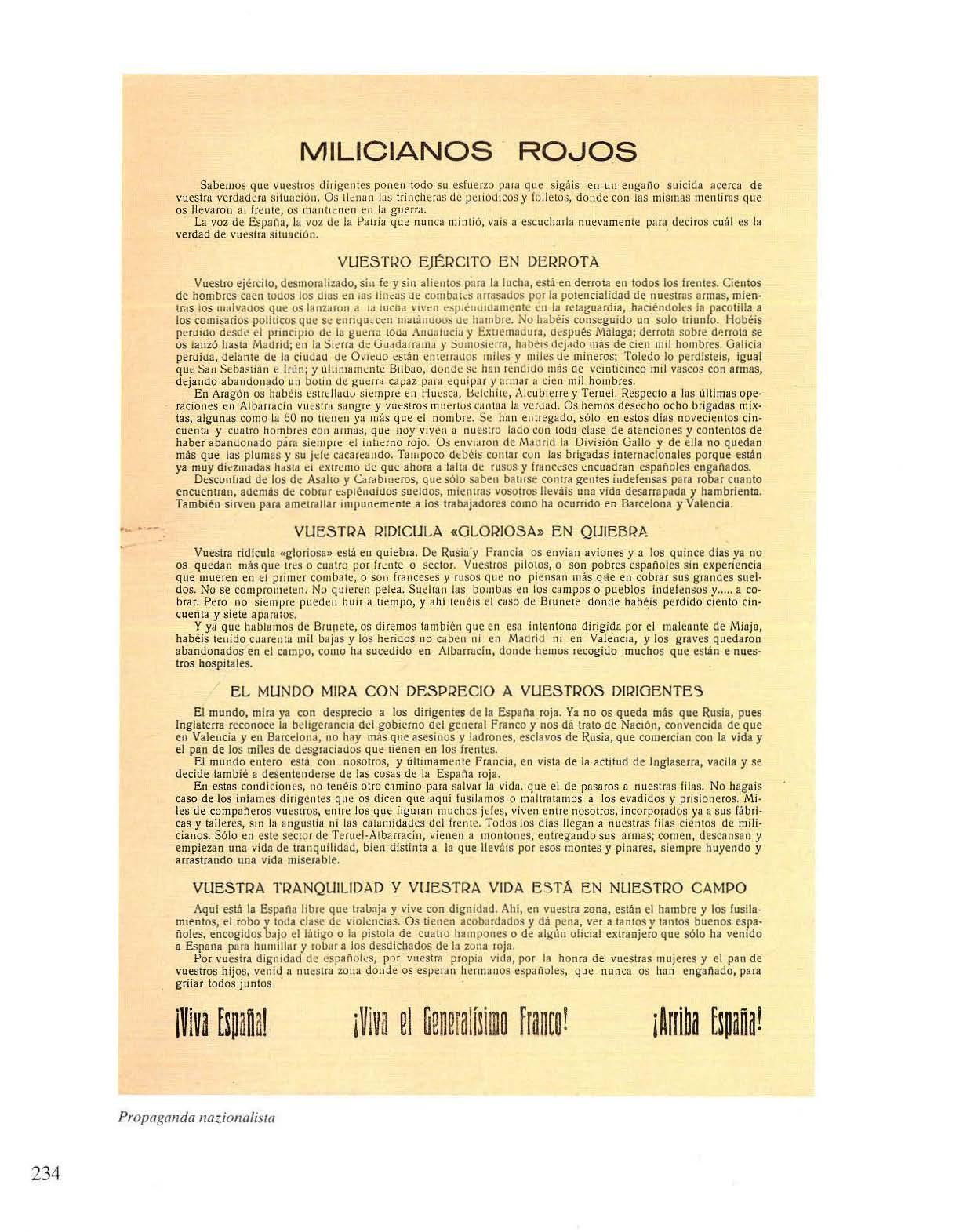
Sabemos q uc vucstros dirigentes ponen lodo su esf uerzo para q ue sigil is en un en ga iio s ui cida ace rea de v uestra si lu aci6n. Os l len an las t rincht:ras pcliùdicos y fo l le to s, do nde con las mismas mentìra s qu e os llevarou al os la guerra.
La voz Espaiìa, la voz de la Pa t ria que n uuca minti6, vais a escuc ha rla nueva men te parn deciros c ulti es la verdad de vuestra situaciòn.
Vuest ro ejército, desmoralizado, sin re y sin alientos pitra la lucha, est:i en derrata en todos los frentes. Cientos de hombres caen todos los <.has c n ;a; lincas ue combat,s :trraS<tdos por la potencialidad de nueslras arrnas, mientras los 111:tlvauos quc os lanz:uon a ta JUCua Vl\' cn C>p oénUI\lamentt c11 IM retaguardia, hac1éndol,;s la pacotilla a los comi:;arios pollticos que s..: enn<Ju,co.:n mat:inuous u.: hambre. No habéis conseguido un solo triunlo. Hobéis per<Ii<lo desde el principiO dc la guena IOlla y Exuemadura, Millaga; denota sobre se os ranzo MJdnd; en la S1,·rra dc y ra, habé1s dc:jJdo rn:\s de cien m li hombres. Galicia perui<Ia, dela nte de la ciuuau Ov1ctto cs r:\n ent eii<HlOS miles y males dc m i nc ros; Toledo lo perdlsteis, igual qut: San Sebastian e lrùn; y ultimamente B1 l bao, uun<le se han renditi o m:ls de veinlicinco mi l vascos con armas, dcja ndo aband onado un bot ìn oe guerra capaz parli eq ui par y a1ma r ade n m i l hombres
En Aragon os h11beis cs trc ll auo sicmprc en Udchì te, A lc ub 1erre y Tcr uel. Rcspccto a Jns ulllmas operaciones c n A l b;mucln vut stra sangrc y vu.:stros muenos can tna la ver<.la<.l. Os hemos desccho ocho brigadas mi x· las, algunas com o la 60 no ll euen ya nlits qu e el nomb1e. Se han enhcgado, so lo en estos d i as novec i tntos cincuen ta y cuatro hombres con armas, q uc noy viv.w a nuestro lado con toda clase de aten ciones y contentos de haber pam si emp 1c cl inllcrno rojo. O s de Maorid la D 1visi6n Gall o y d e ella no q ueda n mas que las y su jdc cacar<!audo. Ta mpoco dtbeis contar con la s briga d as internaciona l es porque estan ya muy diczm"das h•SW c l ex rrc mo <l .: que ah ora a !alta <lt: rusos y lranccses cncuadran espanoles enganados Desconllad de los d.: Asaho y Cawb1ncros, que sOlo sa ben batuse contra gerues indefensas para robar cuanto encuentran, ademas dc cobrar c:.plénuiuos suèldos, vosotros llevais una vida desarrapada y hambrienta. Tambiéo sirven para ametrallar impunem ente a los trabajadores como ha ocurrido en Barcelona y Valenti a
Vuestra ridicula «gloriosa» esta en quiebra. De Rusia y Franc ia os env ian aviones y a los quince dias ya no os quedan mas que t res o c uatro po r f rente o sector. Vuestros pilotos, o son pobres espaiìolcs sin expe riencia que mueren en el pri1 11 cr com baie, o son francests y rusos QUè no piensan m:is q !le en cobrar s us g randes suel· dos. No se comp ro mcten. No qu1eren pelca Suehan las bomba s en lo s ca mpos o p uebl os indefensos y a co· brar. Pero no sicmtJre pu eden huir a tiempo, y ahi tenéìs el CllSO d e Bru nete donde perdido elen i o c i n· cuenta y sie l e aparatos.
Y ya que hab la mos de Br ur ete, os d iremos ta mbién quc e n esa inte ntona di rigida por el malennte d e Miaja, habéis tt::nido cuart::nta mil baja s y los hcridos no ca ben n i c n Madrid ni en Val.:ncia, y los gravcs quedaron abandonad os en el campo, como ha suct::dido en Atba rracln, donde hemos recogido much os que esta n e nues · tros hospilales
E l mundo, mira ya con desprecio a los dirigentes de la Espat1a roja. Ya no os queda màs que Rusia, pues lnglaterra reconocc la beligeranc1a dt!l gobierno del generai Franco y nos da Irato de Naciòn, convencida de que en Vatencia y en Barcclona, no hay mas q ue asesinos y ladrones, esclavos de Rusia, que comercìan con la vida y el pa n de los miles de desgraciados que tienen en los frentes.
El mundo entero esta con nosotros, y till i mam cn te Francia, en vista de la actilud d e Inglaserra, vac ila y se decide tambié a desentenderse de las cos as de la Espal1a roja. ·
En estas condicio nes, no tené is otro camino para salvar la vida. que el de pasaros a nuestra s l i las. No hagais caso de los i nlamcs diri gc ntes q uè os dicen que fu si l amos o maltrntarnos a l os evadidos y pri sioneros Mi· les de compai'l eros vu cstros, cn tre l os quc fig u ra n uru c ho s j des, viv en cn tre nosotros, incorpon1dos ya a sus l abri· cas y tall eres, sin l a an gus tia ni la s ca l ami daùe s dd frent c. Todos tos dia s llegan a nuestras filas c i entos de mi licianos. Solo en este sec to r de T erue i ·Ai barracin, vienen a mo n loncs, ent regando s us armas; corneo, descansan y empiezan una vida de tra nquilida d, b ie n distinta a la <JU e llevais por esos mon tes y pinares, siempre huyendo y arrastra ndo una vida miserable.
A qui eslil la Espana libre que trabaja y vive con dignidad. Ahi, en vueslra zona, esliln el hambre y los lusilamientos, el robo y toda cinse de violcnc1a; O s lienen ucobJrdados y dà pena, a tantos y tantos buenos espa· ftoles, encogidos bdjo ellatigo o la pistola de cuatro hampones o de algun oficia! extranjero que s61o ha ve nido a Esp a11a para humillar y robur a los desdicbados de la zona roja. Por vu est ra dignidad dc espailo ks, por vuestra pro pia vida, por la hon ra de vue stras muj eres y el pa n de vuestros vcnid a nu esl ra zo na don de os espcran espa li ole s, que n u nca os han engan ado , para griiar todos juntos · Propaganda nazionalista
Il vostro governo vi ha ingannati. Vi ha detto che andavate in Abissinia per lavorare. per sfamare le vostre famiglie. O vi ha detto che andavate a Spagna per fare un servizio di polizia. Il vostro gove rno vi ha promesso mari e mon ti. Ha approfittato della vostra fame , della vostm miseria, della vostra buona fede.
Ascoltate: in Spagna noi lottiamo contro un piccolo gruppo di gener ali che hanno tradito la loro parola di onore, che si sono ribellati al governo legittimo e riconosciuto da tutto il mondo che si sono sollevati contro la loro patria, il loro popolo, il loro paese. Noi lottiamo per la nostra li berta: per la nostra indipendenza, per il nostro pane, per la pace di tutti, per la felicita del nostro popolo. Noi facciamo una guerra che ci e' stata imposta de q u esti generali che hanno approfittato delle loro posizioni ufficial i p er tradire la patria.
Noi non vogliamo la guerra , Noi vogliamo la pac e. Noi lottiamo per la nostra pace che i traditori della patria non hanno voluto. E con i genera li traditori si sono uni ti i grandi propieta ri di te rra che affamano i poveri contadini, gli u surai che li soffocano con gli i nteressi. qualche grande capitalista che vorrebbe che l'operaio spagnuolo fosse uno schiavo.
Noi lorriamo per il benessere delle masse popolari di Spagna. Siamo di tutti i partiti e di tutte le tendenze. Siamo repubblicani, socialisti, comunisti, anarchici, neutrali; siamo operai, contadini e intellettuali; pero'tutti uniti per l'amore alla nostra patria ed al nostro popolo.
Perche'siete venuti in Epagna? Cosa volete ia no i? Cosa fareste voi domani un a nazione straniera volesse invadere l'Italia, il vos tro bel paese? Cosa fa reste voi se a lcuni ge ne rali vostr i vendessero la vostra terra a dei predoni stranieri? Voi insorgeres te come un sol 110mo per d ife ndere il vostro p aese come lo hanno fatto i vostri padri contro il tiranno austriaco n el secolo passato. E d e'questo che noi facciamo
Voi non dovere permettere che il vostro governo vi inganni e vi lanci al macello. Voi non dovete impugnare le armi contro dei cittadini che difendeno la loro patria. Voi non dovete essere degli assassini di un popolo che lotta per il diritto alla liberta, alla vita, alla felicita.
Gettate le armi e ritornate vostre case. O venite con noi. In n oi troverete dei fratell i, degli UO!nini come voi, una terra fett ile c he lavorerete con no i affin che' dia pane p er tutt i
Tutt i i vostri am ici, tut ti gli ita liani che so no ve nuti con noi o che noi abbiamo fatto prigionieri, sono stati ricevuti a braccie aperte, come figli de ll a stessa famiglia ed oggi lavorano nell<t nos tre citta'o lottano nelle nostre file.
Noi siamo forti. Noi siamo disposti a fare pagare caro a coloro che vogliono attentare alla nostra li bert a ed alla nostra pa tria. Intorno alle mura delia nostra Madrid sono caduti i mori. i fascisti spagnuoli , tutti coloro che hanno vo lu to conq uistare la nostra gloriosa capita le. Voi siete partiti dall'Italia per andare a crearvi una vita felice e non p er morire.
Venite con noi!
Viva la fratellanza fra tutt i gli uomini che vogliono viv ere in pace e nella feliciu\!
Viva la Republica democratica spagnnola, creata dal popolo e riconosciuta da tutti i paesi!
Viva la lotta per il pane, per la felicita, per la libem1 dei popoli!
IL COMANDANTF-, Enrique Lister
Marzo, 1937.
Volam ini d i co mropropaganda repubblicana dire tta ai legionari
IL COM JSSAIUO DI GUF-RRA, Carlos Contreras.
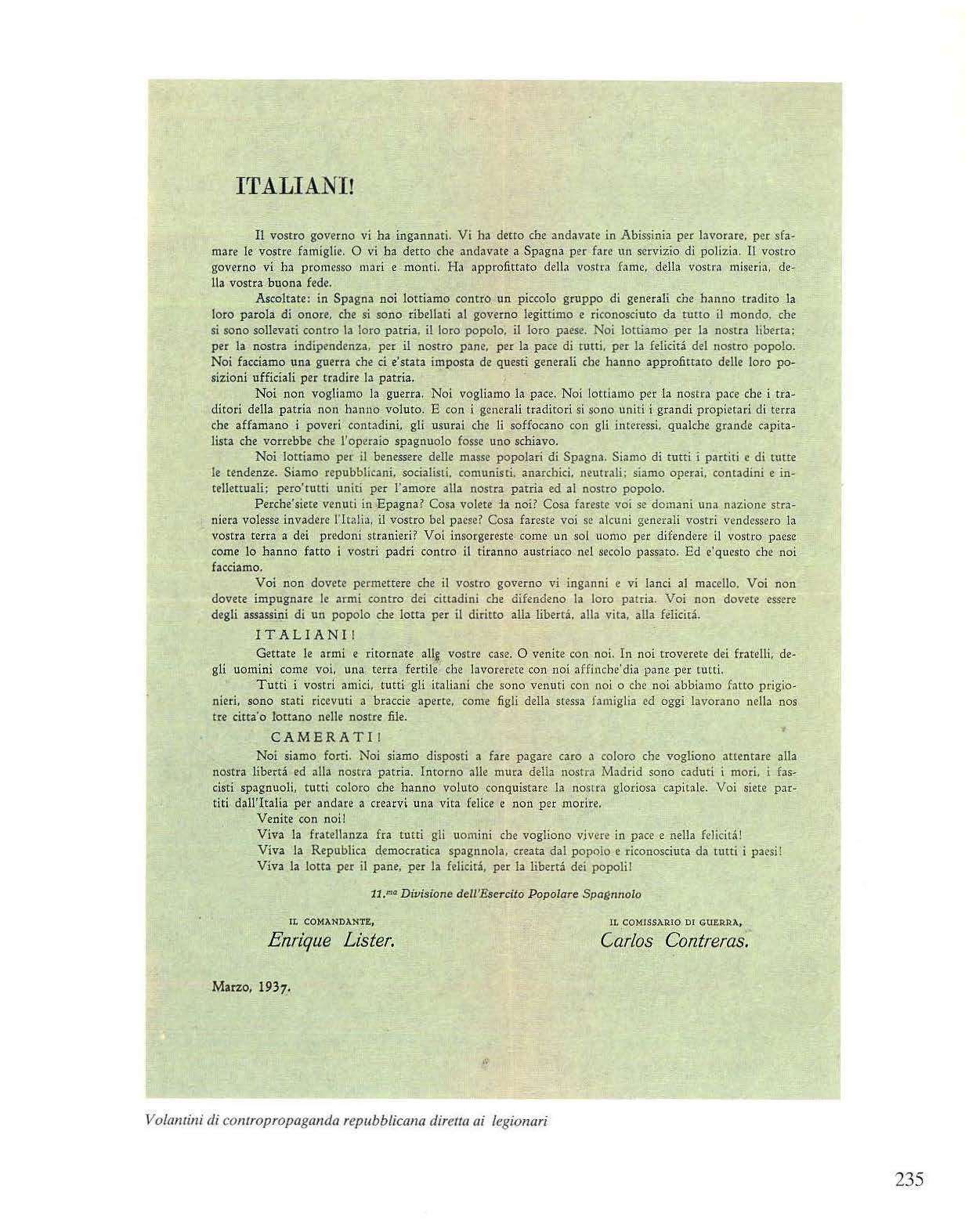
Perché lotti? Perché s offr i? Perché vuoi morire?
La ' tua patria é l'Italia. tua famiglia é in Italia. C os a ti ha fatto il popolo spagnuolo per combattere cont ro di lui? .
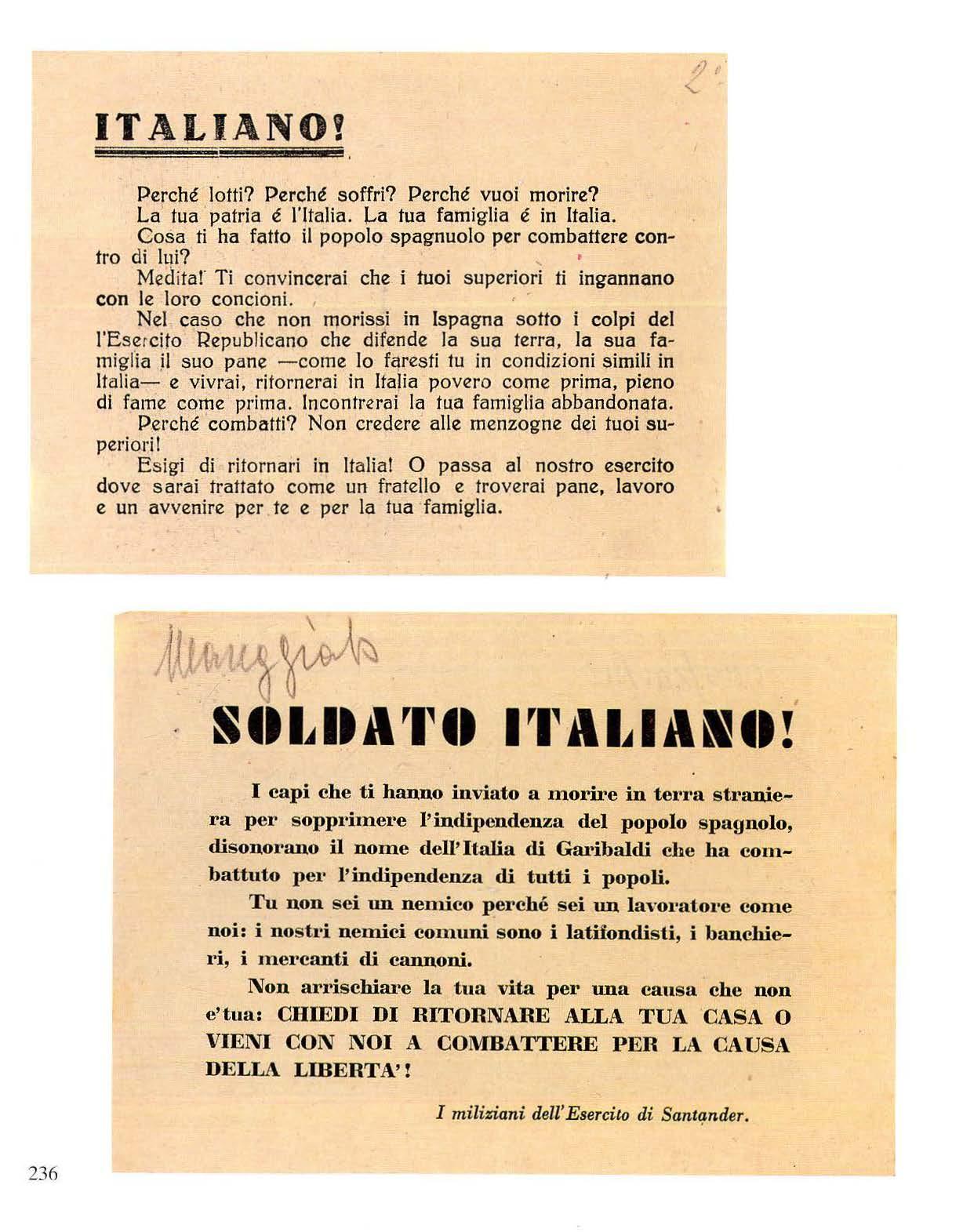
Med itar Ti convi nce r ai che i tuoi s up eri o r i ti ingannano con le loro con cio ni. , N el caso che non mo ri s si in Ispa g na s otto i colpi del l'Ese rci to Rep u blica no che di fende l a sua terra , la sua famigfi a jl suo p a n e - com e lo fq resti tu in c o ndi z ioni simili in It alia- e vivra i, ri to rn er a i in Ita Jia povero co me prima, pieno di fam e come prim a . Inc o ntr erai la tua fa miglia abbandonata. Pe1·ché combat ti? N on credere alle m enz o g ne dei tuoi sup er ior i!
E sig i di ri to rn a ri in It a li a! O pa ss a a l no s tro esercito dov e sa r a i t ra tt at o c o me un frate llo e tr o vera i pane, lavoro e un av venire p er te e per la t ua fami gli a .
I capi che ti hanno inviato a morire in te1•ra stl•aniera per s opprime1•e l'indipendenza del popolo spagnolo, disonorano il nome dell' Italia di Garibaldi che ha cmnbattuto per l'indipendenza di tutti i popoli.
Tu non s ei un nemico p e rché sei un lal'oratore come noi : i no s tri nemici comuni sono i latilondis ti , i banchieri, i mer canti di cannoni.
Non a r rischiare la tua vita per una causa che non e'tua: CHIEDI DI RITORNARE ALLA TUA 'CASA O VIENI CON NOI A COMBATTERE PER LA CAUSA DELLA LffiERTA'!
I mil iziani dell' E sercito di San tq.nder
Voi credete di comandare neUa zona di Franco. Non è vero, voi siete solo della carne da cannone; sono l tedeschi comandano. La loro influenza è ben più grande e son contenti di vedere gli italiani che si dissanguano In Spagna; poi, essi potranno comandare anche in Italia.
Non lottate più contro la Il· bertà del nostro paese. Tornate In Italia a conquistare la vostra libertà/
.
Mussollnl non puo dar da mangiare al 'popolo lia· Bano, e VI manda In lpal}· na a morire In guerra. Scrlveie alle vosire fa• miglle cbe reclamino Il pa· ne; e voi qui, refiuiaievl di C:ombaUere. Noi spagnuoll non vi abbiamo faiio nulla percbè -'YenlaCe a Invadere la nos•
·- tra ·:pairl••/
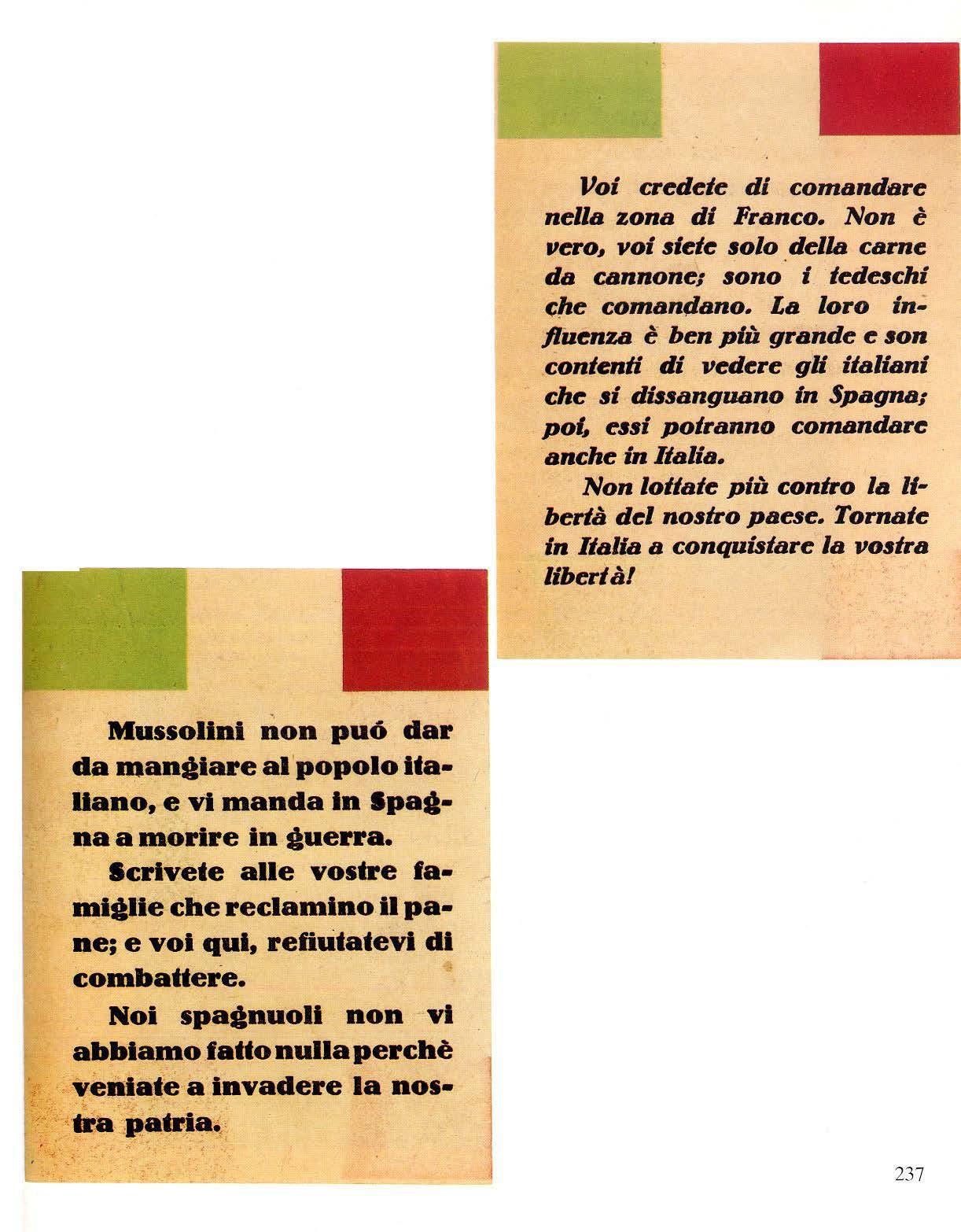
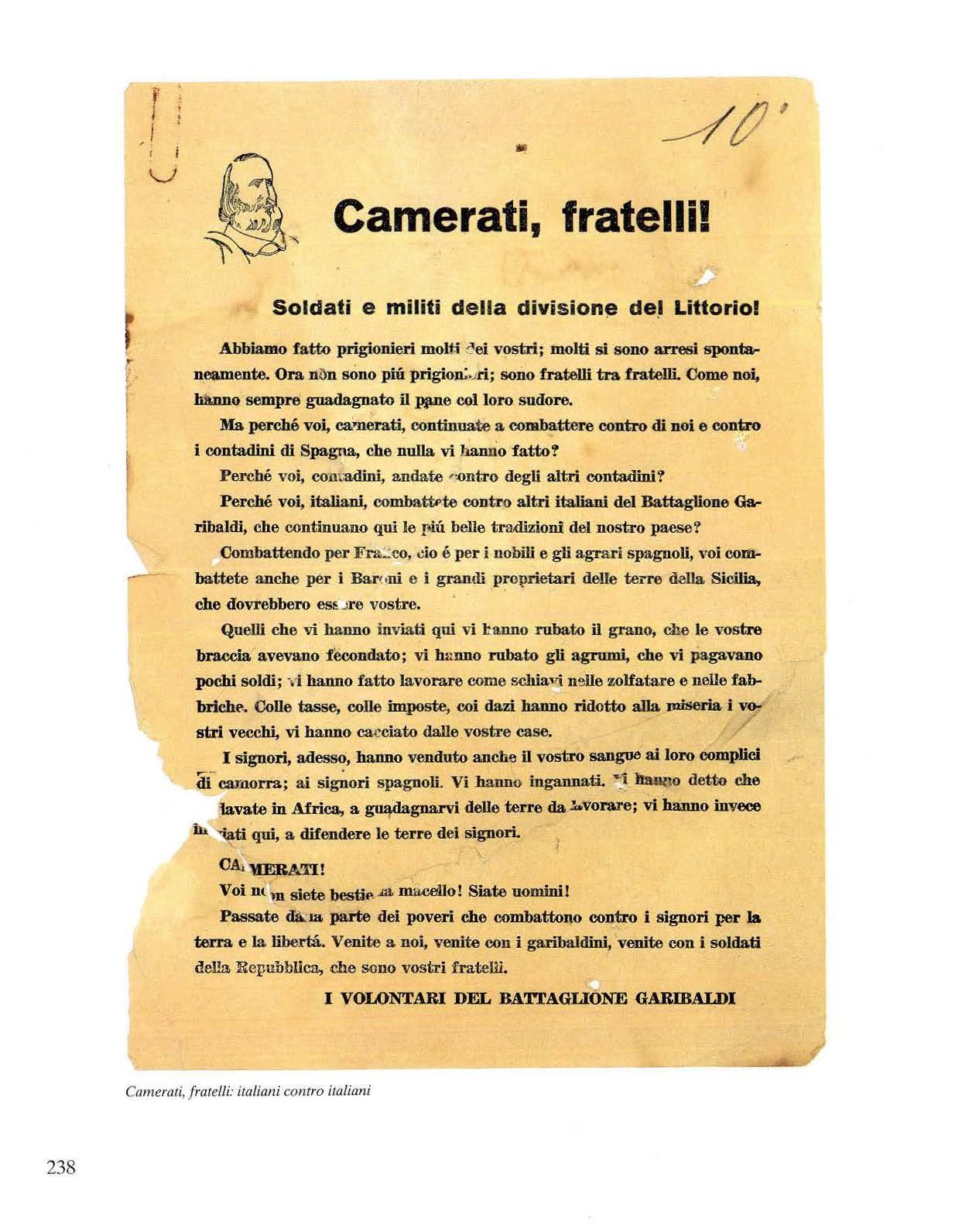
Abbiamo fatto prigionieri molti vostri; molti si sono arresi spontaneamente. Ora n òn sOno piu prigion:.;ri; sono fratelli tra fratelli. Come noi, Jùumo sempre guadagnato il .PilJle col loro sudore.
Ma perché voi, ca?Ilerati, continuate a. combattere contro di noi e contro i contadini di Spagna, che nulla vi b.a.mÌo fatto!
Perché voi, contadini, andate ,·.ontro degli altri contadini?
Perché voi, itali.a.ni, comba.ttPte contro altri itaJi.a.ni del Battaglione Garibaldi, che continuano qui le piu belle tradiziom d el nostro paese ?
Combattendo per Fra.:co, é per i nobili e gli agrari spagnoli, voi coltlb.a.ttete anche per i Bar<•ni e i grandi protJrieta.ri delle terre Sicilia., che dovrebbero .Jre vostre.
Quelli che vi hanno inviati qui vi hanno rubato il grano, che le vostre braccia avevano fecondato; vi h anno rubato gli agrumi, che vi pagavano pochi soldi; vi hanno fatto l avorare come schia-.i nelle zolfatare e nelle fabColle fassa, colle imposte, coi dazi hanno ridotto aJla JDiseria i vostri vecchi, vi hanno da.lle vostre case.
I signori, adesso, hanno venduto anche il vostro sangue ai loro complici éif camorra; a i spagnoli. Vi hanno ingannati. detto che 'lavate in Africa, a delle terre da l..vorare; vi hanno invece ih qui, a difendere le terre dei signori.
Voi ne. m siete bestiA JW:t.Cello! Siate uomini 1
Passate dà m parte dei poveri che combattono contro i signori per la terra e la liberta Venite a noi, venite con i garibaldini, venite con i soldati della Repubblica, che sono vosi"I'i fratelli
Camerati, frat elli: italiani contro italiani
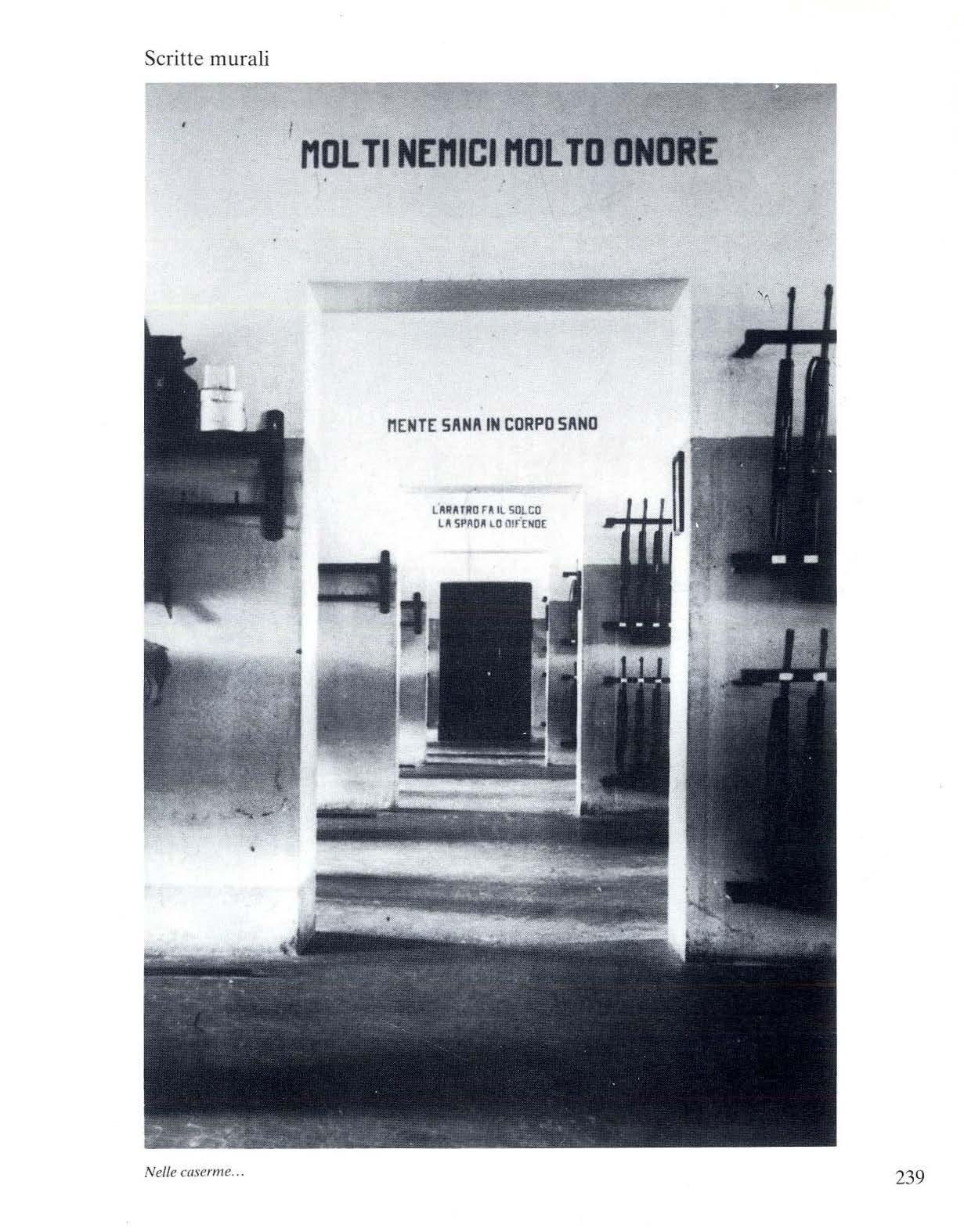
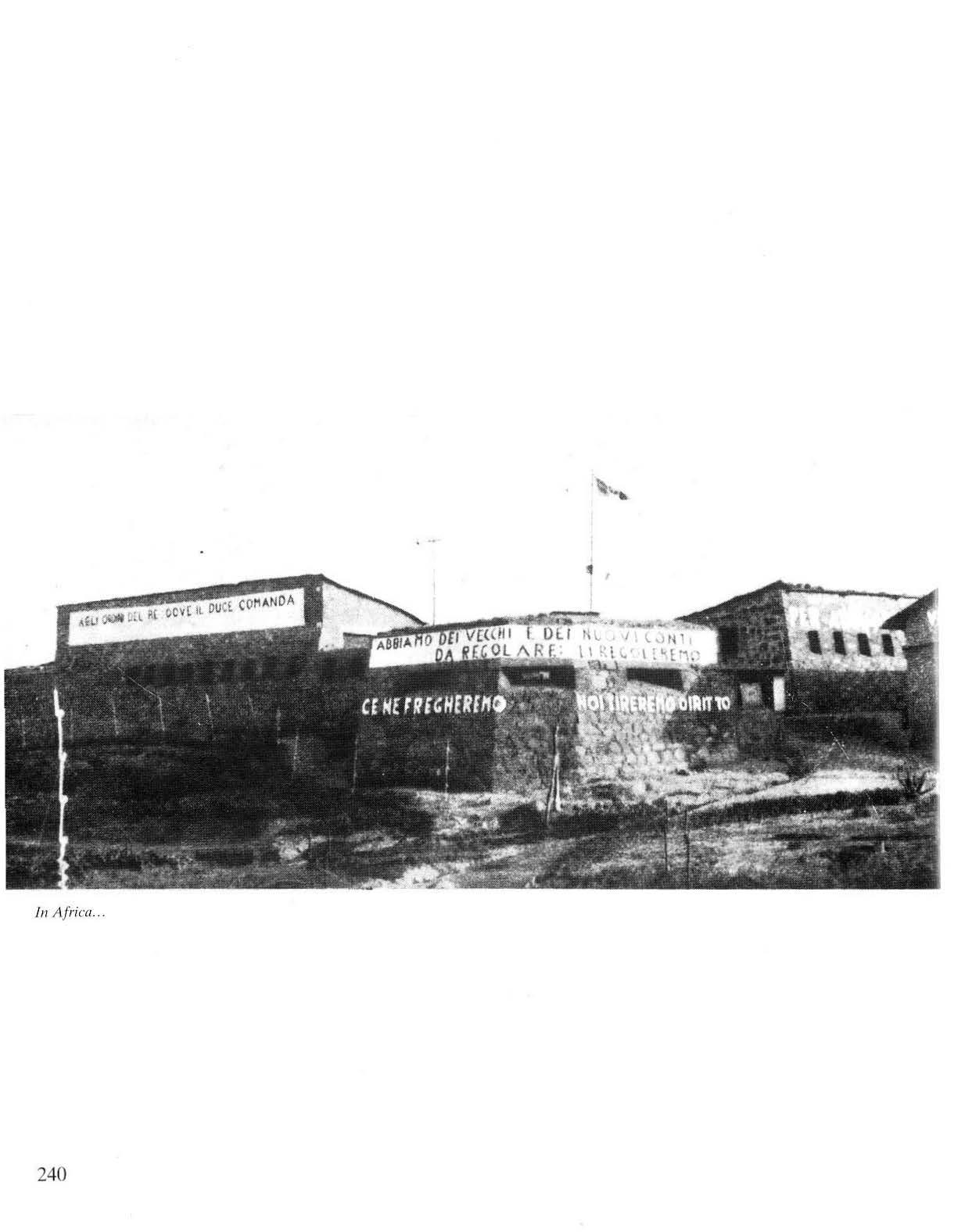
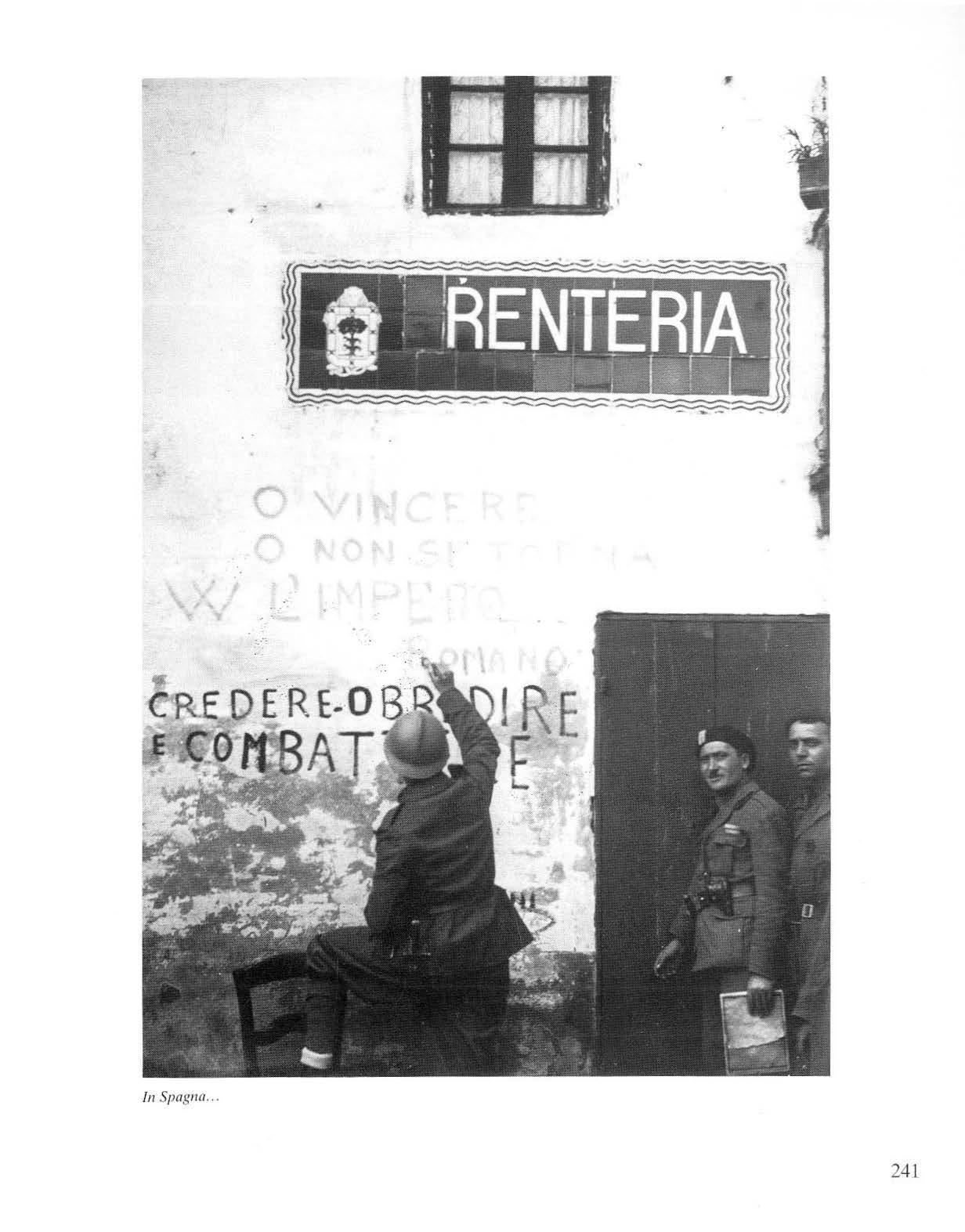
Que l c h e r es w (da Gio rg io Ba tini, T.' halia s ui muri )
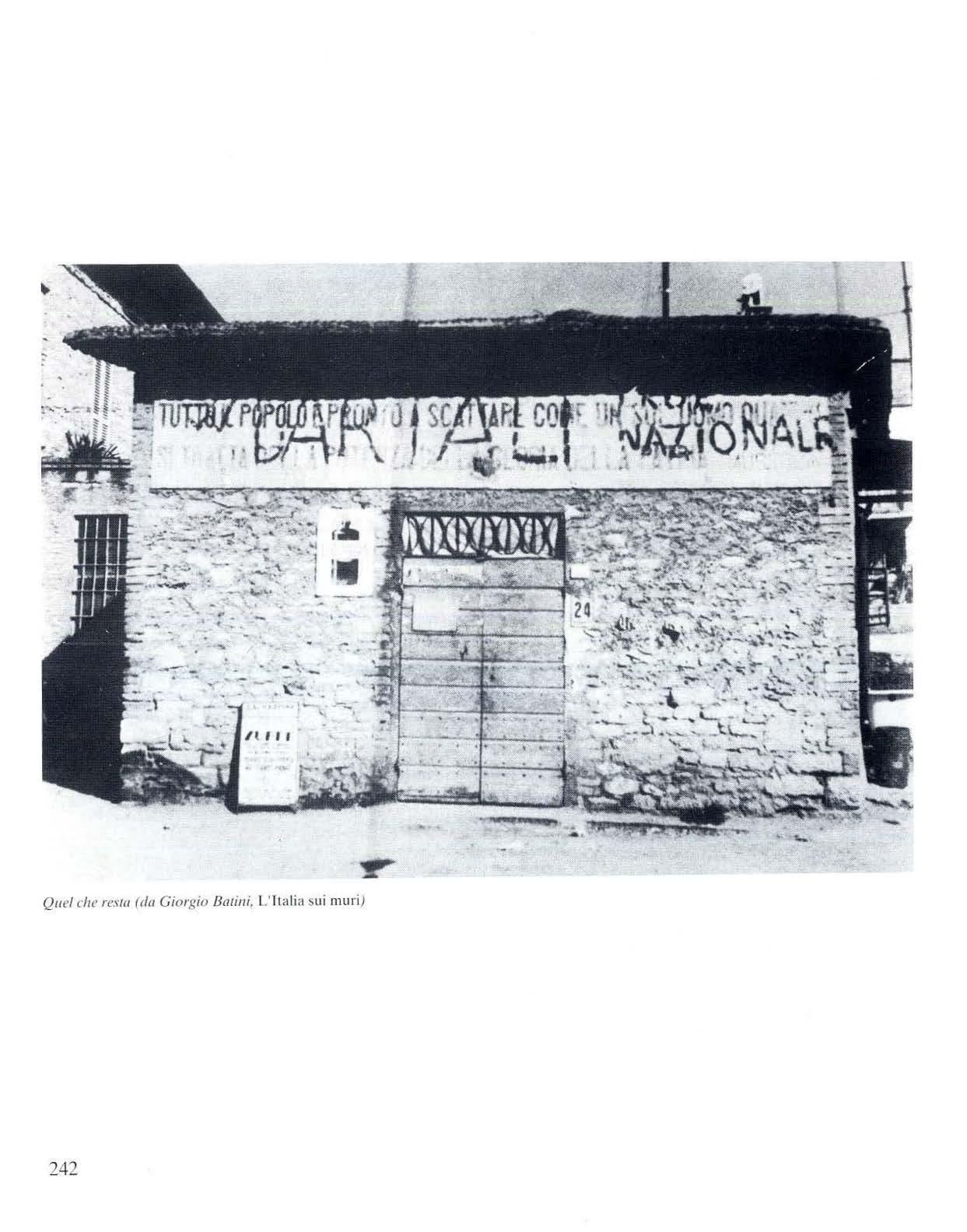
Stamp e vari e . Di particolare interesse perché a tt esta n o la p arteci pazione popolare e d il conse n so. A volte con intenzione di lucro
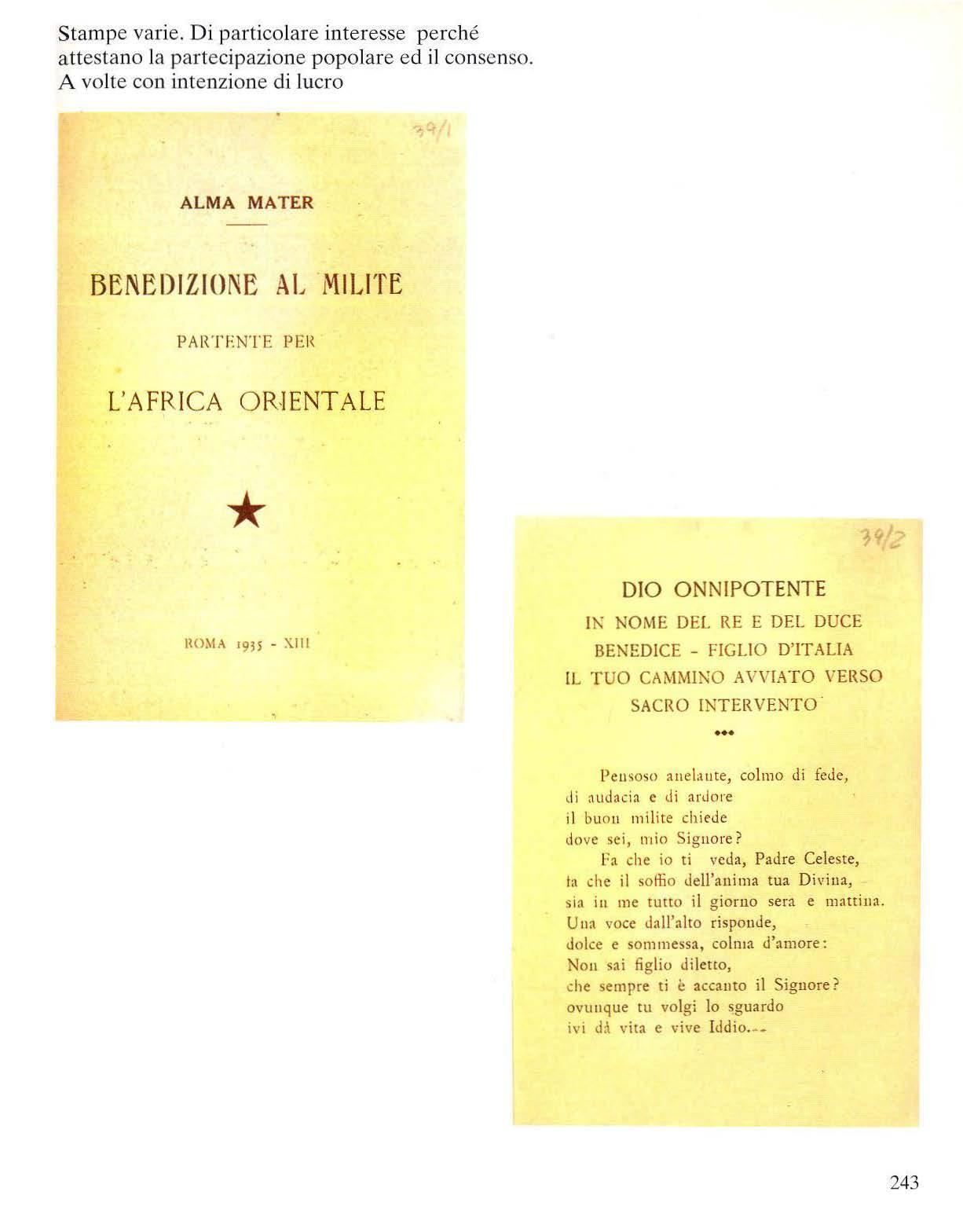
Ii'\ NOME .QEL RE' E DEL DUCI: I1E;\t:DJCE - FIGLIO D'ITALT.\ IL TUO C MMl:\ù AVVfA TO \"ERSO SACRO •••.. ..,
Peusoso <J.,uebme , colmo di fede, di e di ardore d buon milite ch iede dove i, p !io Signo re?
Fa che io ti veda , Padre Celeste, la ..:hc il soffio dell'anima tua Divina, '>la in me tutto il gioruo sera e mattina. Un a voce dall'alto rispoude, dolce e sommessa, colma d'amo re : :.Jon sai figlio diletto, ..:he sempre ti è accanto il Signore? ovunque tu volgi lo sguardo n·1 d\ yita e vive Iddio. -
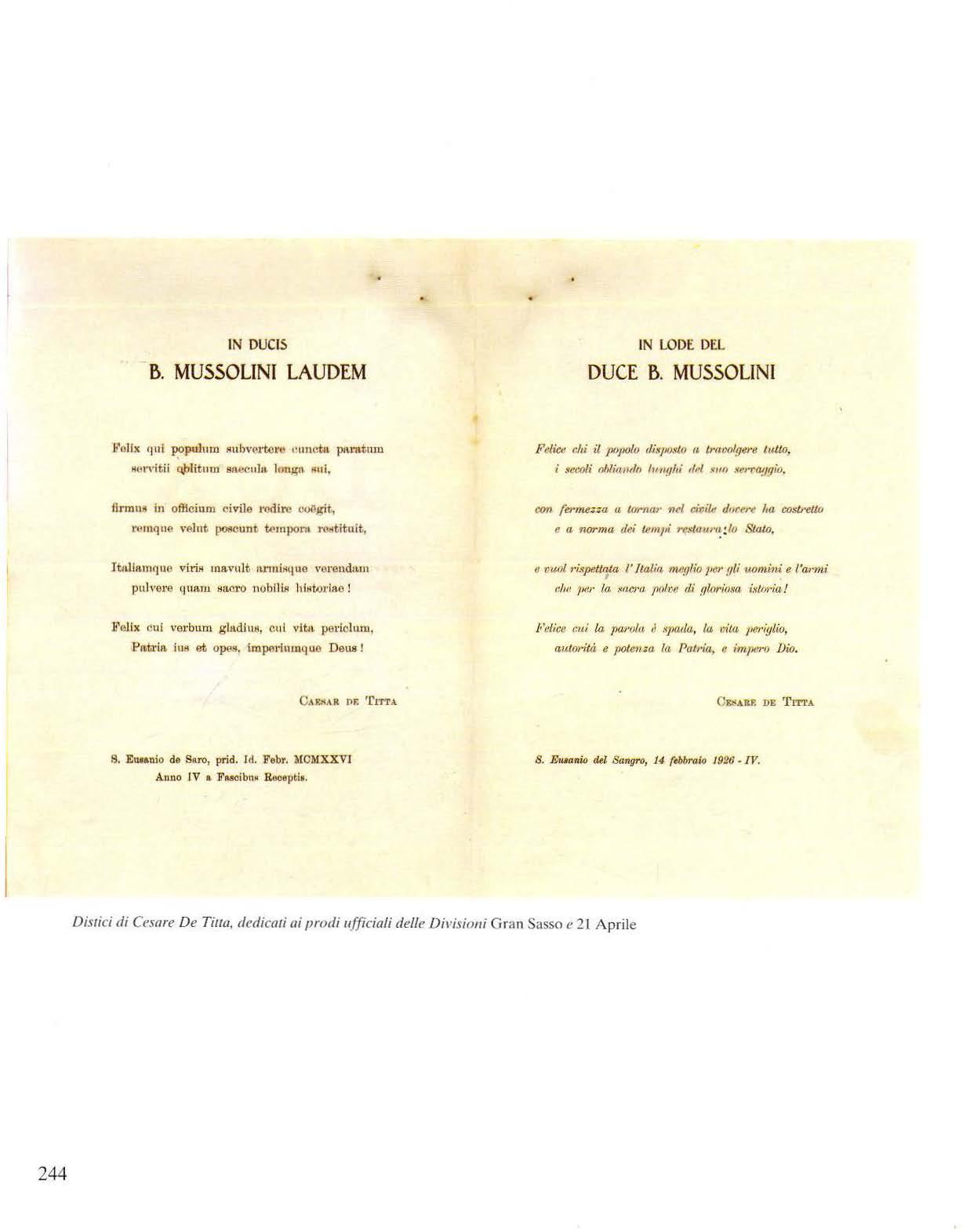
lfoJix 1111i Hubvcrror!' ··nn<lta. pamtiUu H(tn•itii qblitnrn S>W<'nlll l'liti, in officium rivilo r<!diro co(lgit, l'i)Jnqne veJnt poscunt wmpom 11\>itituit, viriH •na.vnlt vorcnd,lm pnh•ere qua,ru no biliH
Jl'elix ve1·bum gladiLLij, cu i vita. pe1'iola:m, PMria illfl et impowimnq ul.l Deus !
111: 'fiTTA
S. Euaanio de Soro, prid. In. Febr. MOllfXXVI A.nno 1V a Fascibo• Reoeptii.
Felice citi il popolo di.vpo.•to 14 tutto, i vecoli lunghi tM stili .W'I'rll(lqio, con {èrm<t::::a a lllrnm· nrl cirJil.- dorrre /,a costntlb " a ncrma dei tempi rr.vta /(1 Stato, e vunl •·if<pei.VJ.,ta l' Jtalirt. 11U!fJ{io JlCr !Jli uomini è {'a•·mi d11• JW' {q, :<ncriJ. pOif·l' di .f!loriosa isloria !
Felice cui la pa,•ola ,J spada, la m·u, Jleriglio , e polen;a la Patr1'a, e impwo Dio.
DE 'f('[TA
8. Etuanio dd Sangro, 14 {tbbraio 1926 -IV.
Distici di Cesare De Tiua , dedicati ai prodi ufficiali delle Divisioni Gran Sasso e 2 1 Aprile
Una delle numerosissime lettere inviate ai com ba/lenti in F.tiopia da alunni e studemi di ogni ordine e grado; spesso alle leuere erano uniri paccheui dono per i soldati
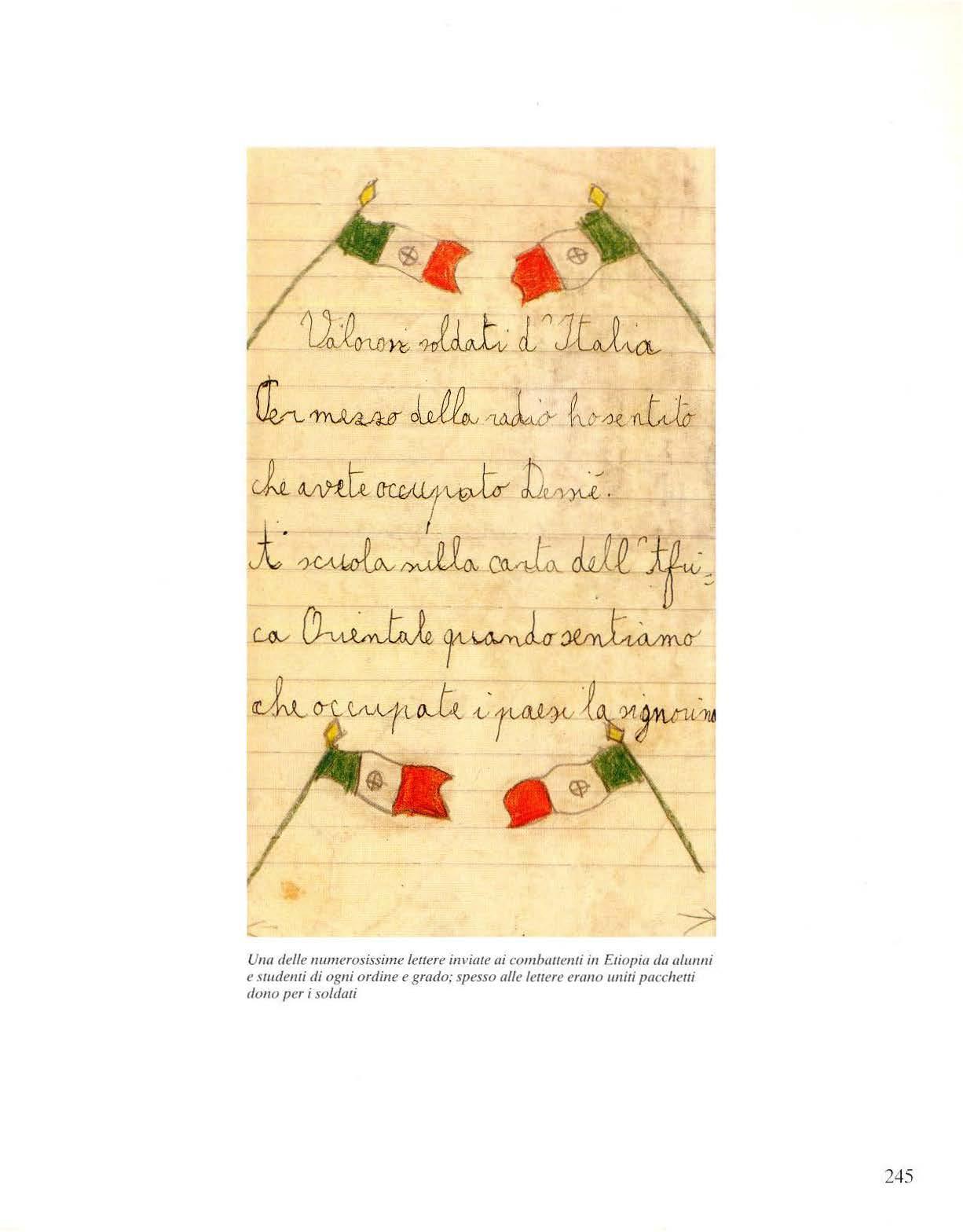
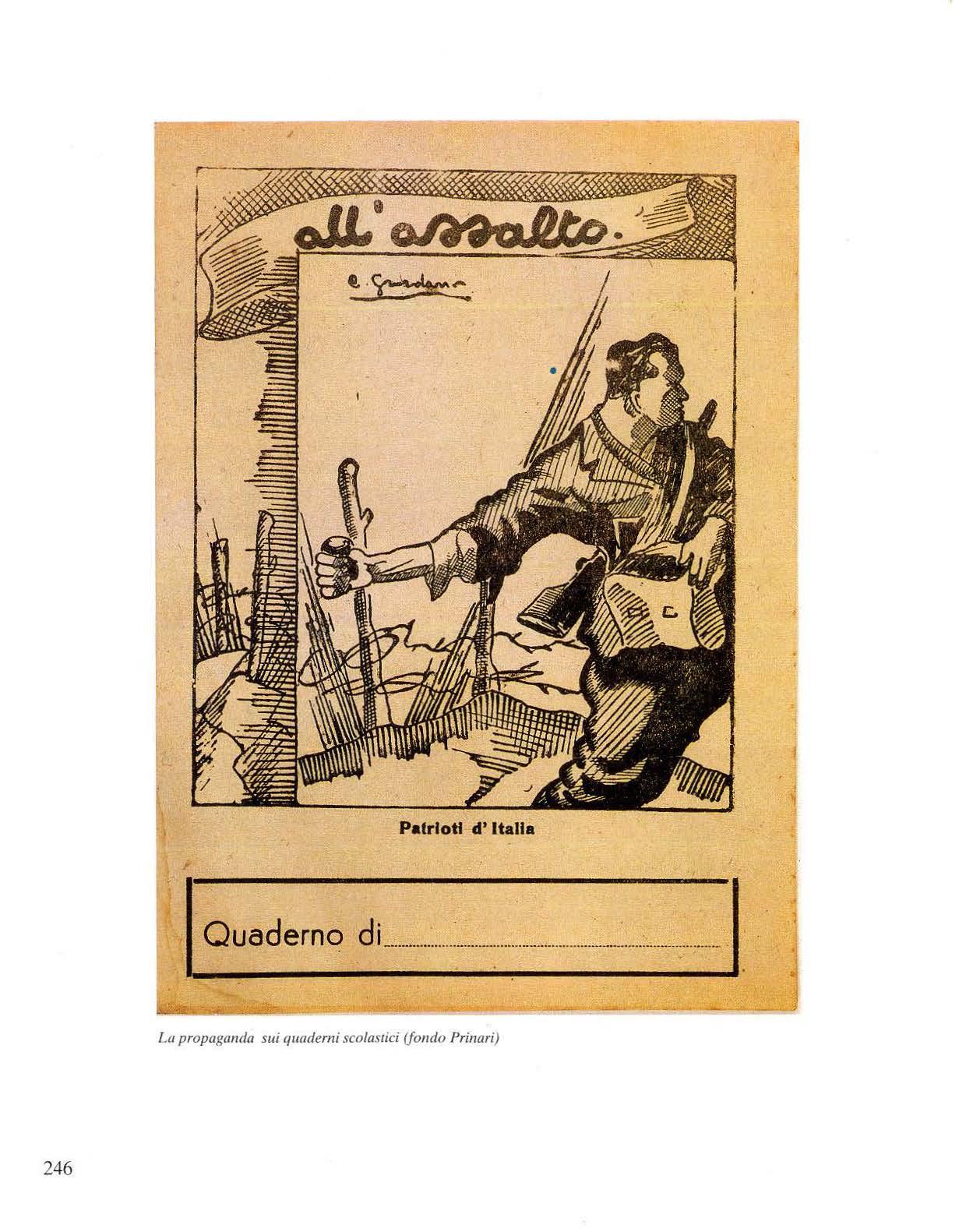
Elmetto e cuffiella: maxi-francobol/o della campagna anfituhercolare (Archi Fio Cemrale dello Stmo. R oma)
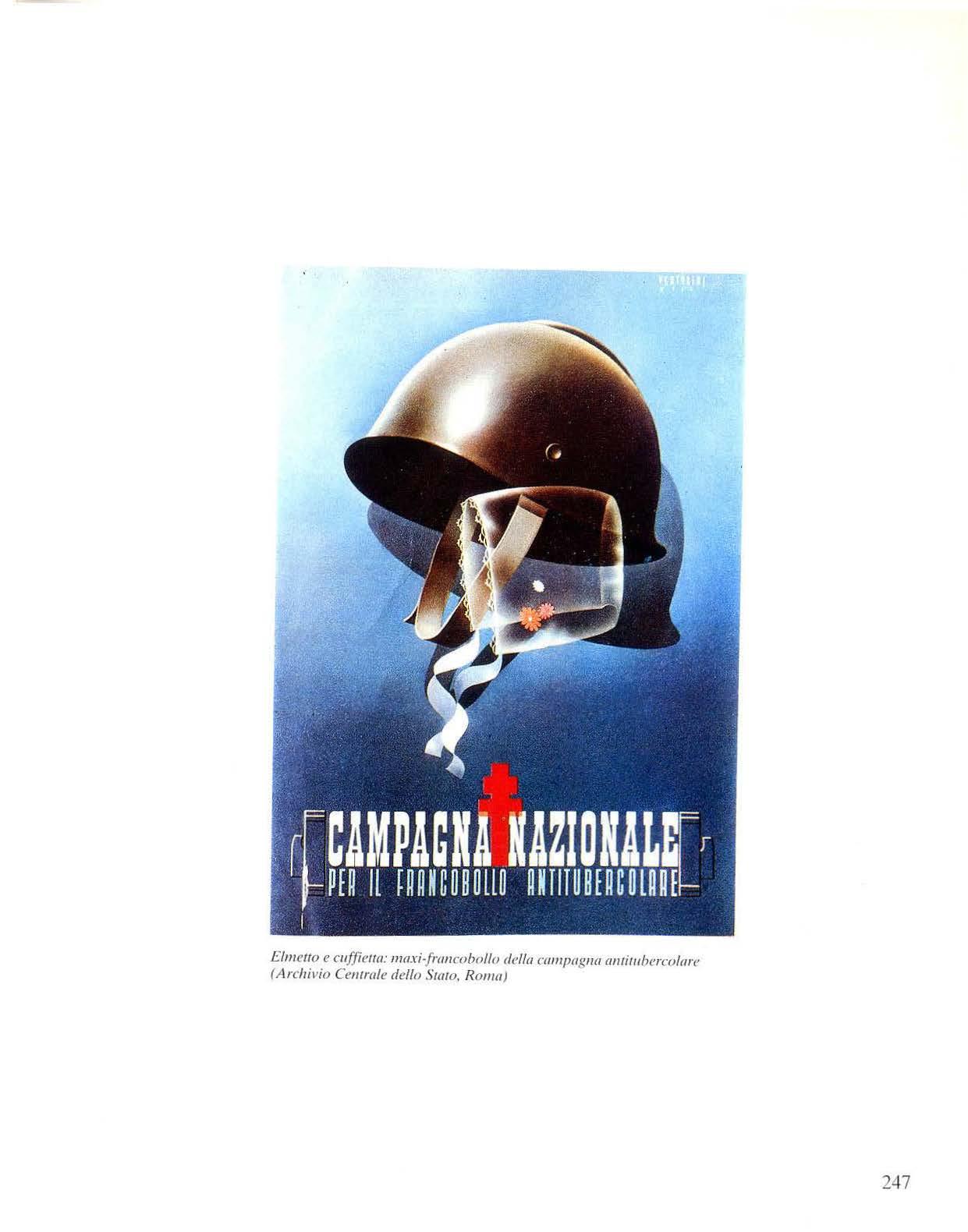


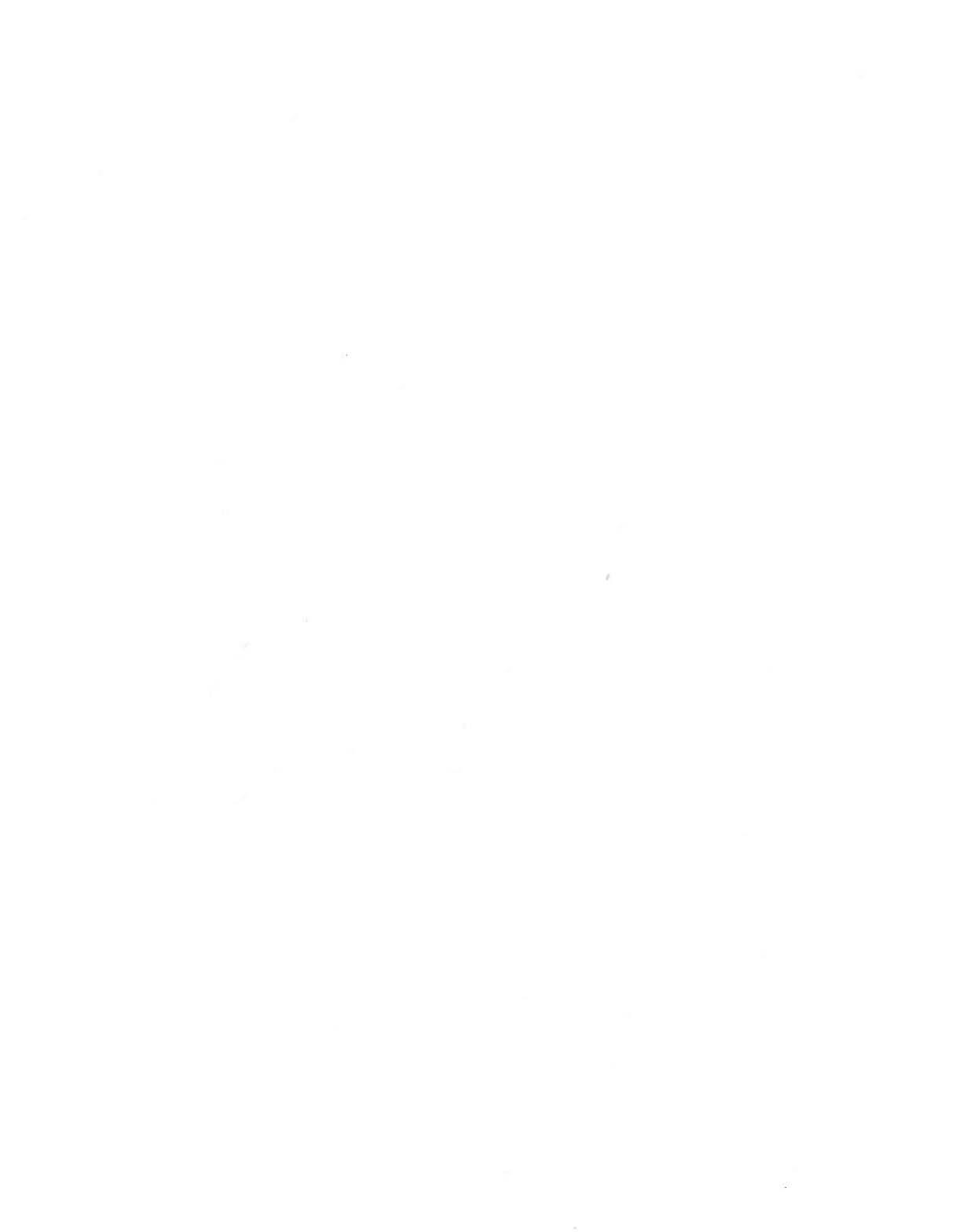
N egli anni successivi alla grande guerra, la stampa militare , che produceva anche propaganda, finì con lo scomparire. I giornali di trin cea morirono di cause naturali, tutti entro il 1919. Sopravvissero alcuni fogli non st rettamente legati alla guerra e altri editi da As sociazioni d'Arma e specialità. Furono ancora i fatti d'arme e le guerre a far rivivere alcuni giornali di propaganda assimilabili a quelli di trincea . Fiume, Etiopia e Spagna, fecero da propulsore, nel più ampio contesto del giornalismo di guerra, a specifici giornali per le truppe, editi da Comand i e Corpi, o addirittura per iniziativa di gruppi di militari. La p rod uzione maggiore fu comunque dovuta alla costante presenza, anche in questo settore degli strumenti della propaganda, degli organi e degli apparati dello Stato, e, su l fronte, di quelli militari. Furono soprattutto essi ad assicurarne, infatti, l'uscita costante. Prima di segnalare le testate rinvenute nel corso delle ricerche , va d etto che non esistono contributi sistematici, né repertori d'archivio o bibliografi e, che siano di aiuto nello studio di questo particolare aspetto del giornalismo; pertanto , il contributo offerto resta un primo approccio, di cui sono auspicabili ulteriori approfondimenti.

Fra i fog li non strettamente legati alla guerra continuarono ad essere editi Il giornale del Soldato, Esercito e i\1arina, e, più tardi, Le Forze Armate . Il «fron t e interno» continuò , per poco e fino ai primissimi anni venti , la pubblicazion e di fogli per la
mobilitazione civile, come Resistenza a F ir e nze; oppure promosse edizioni a sostegno dei soldati smobilitati, come I Combattenti, edito a Genova, Italia Reduce, ed i to a Roma, Il bollettino del soldato, edito a Milano. Questi giornali f urono spesso fortemente polemici nei confronti dell'atteggiamento «d istratto» assunto dallo Stato verso i problemi dei soldati e delle terre irr e d ente.
Alcune Associazioni d ' Arma vollero essere presenti con propri fogli per tramandare tradizioni, per rivisitare peculiari storie, per rinsaldare i vincoli di appartenenza degli associati. Veri zibaldoni, essi riuscirono a far convivere nelle loro colonne articoli di storia militare e di memorialistica, polemiche ed atti di riverenza (vedasi, ad esempio, Il mitragliere).
A Fiume, du rante l'occupazione dannun zia na , scrissero la cronistoria p ropagandist ica dell'occupazione La Vedetta d 'Italia e La Testa di Ferro.
Alla guerra italo-etiopica si riferirono La tradotta coloniale e Aprilea, più alcune testatine minori, realizzate a guisa dei giornali di trincea, talvolta grazie alla pass ione di singoli militari , come Er guerriero, quasi un diario «personale» di una camicia nera, Luigi Lodoli.
Anche El Legionario, edito in Spagna duran te la guerra civile, fu parimenti affiancato da pubblicazioni minori; che comunque , in ogni caso, dovevano essere inviate p e r l'autorizzazione alla Direzione Generale per la Stampa del Minculpop.
Quest'ultimo però - e l'episodio è
importante per co mprend ere i rapporti fra Cu ltura P opo lare e Guerr a, s p ec i a lm ente p er quanto riguarda il frazionamento di co mp ete n ze s ull a propaganda- tratta ndosi di gior n a li mili ta ri , non si es imeva dal richi e dere il parere a l Ministe ro della Gu erra . Nell'esp rim ere uno di qu esti pareri, ri c hi est o per l a s tampa di un num e ro unico del 2o r egg imento volontari del Littorio, Sorice, Capo di Gabin e tto alla Guerra, così s i pronu ncia va il 1 2 se ttembre 193 8 (dopo aver se ntit o l 'Ufficio Stori co i n merito ):
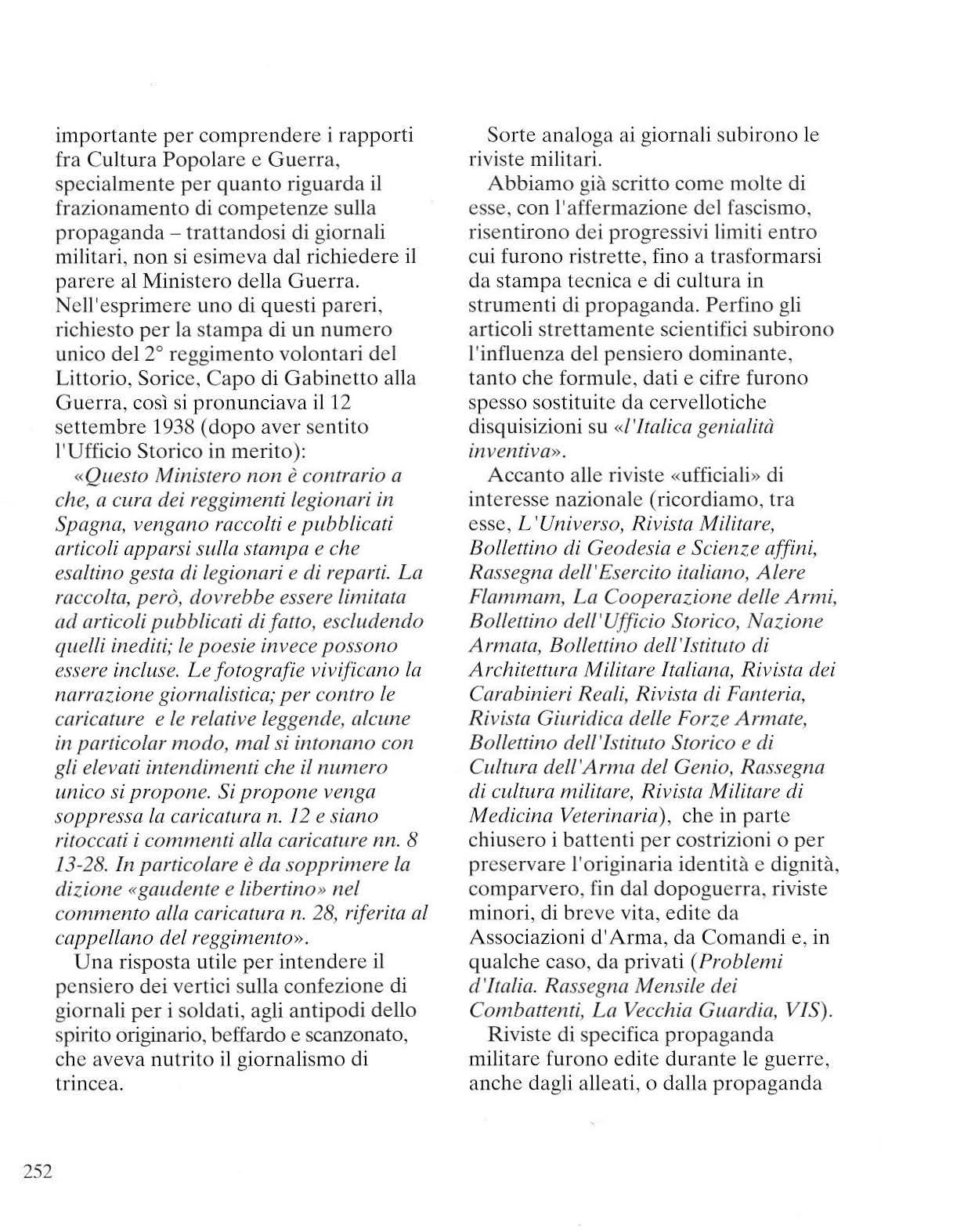
« Questo Mini ste r o non è contrario a ch e, a cura dei regg imenti legionari in Spagna, vengan o raccolti e pubbli ca ti articoli apparsi su lla stampa e ch e esa ltino gesta di Leg ionari e di r ep arti. La ra cc olta, però, dovrebbe essere limitata ad articoli pubblica ti di fatto, esclu dendo quelli inediti; le poesie invec e posso no esse re inclus e. Le fotog rafi e vivijzcano la narrazione g io rnalistica; p er co ntro le ca ricature e le relative Leggend e, alcune in pa rt icolar m odo, mal si intonano con g li elevati intendimenti che il nwne ro unico si prop one. Si propon e venga sop pressa la caricatu ra n. 72 e siano ritoccati i comm enti alla caricature nn. 8 13-28. I n par t ico lare è da sopprimere La dizione «gaudente e libertino » ne l co mmento alla ca ricatura n. 28, al cappellano d el reggimento ». Una risposta uti le per in tendere il pe n s i e ro de i vert i ci s ulla confez ione di gi o rn a li per i so ldati, agli an t ip odi dello s pirito originario, beffardo e scanzo nato , c h e a veva nu tr i to il g iornali smo di t ri nc ea .
So rte anal oga ai giornali s ubirono le riviste militari.
A bbiamo già scritto come molte di esse, con l ' affe rmazione del fa sc is mo , risentirono d e i prog r essivi lim iti e ntro c ui furono ri s tr et te, fino a tra sformarsi da s tampa t ecn ica e di cultur a in str um e nti di propaganda. P erfino g li art icoli stretta m e n te sci e nt ifi ci s ubiron o l ' influ e n za d el pensiero domin a n te , ta nto che formul e, dati e cifre furo no s pesso sostituite da cervellotiche di s quisizioni s u «l ' ftali ca genialità inventiva » .
Acca nto a ll e riviste « uffi ciali » di int e r esse na zio n ale (ricordiamo, tra ess e, L 'Universo, Ri vista Mil itar e, Bollettino di Geodesia e S cienze affini, Rassegna dell 'Ese rcito italiano , AZere Flammam, La Coope ra zione delle Armi, Bollettino dell ' Ufficio Stori co, Nazione Armata, Bolle ttino dell 'Istituto di Arch itettur a Militare Italian a, Rivista dei Carabinieri R ea li, Rivista di Fanteria, R ivista Giur idica delle For ze Armate, B o llettino dell 'I stituto Stori co e di Cultura dell 'Arma del Genio , Rassegna eli cultura militare, Rivista Militar e di M edicina Veterin aria), che in parte c hiu sero i b atte nti per costri z io ni o per pr ese rva re l ' ori g in ar i a id en tit à e digni t à, com parvero , fin dal dopo g u erra, riviste minori, di br eve vita, edite d a Ass ociazioni d'Arma, da Coman di e , in qualche caso, d a privati (Pr ob lemi d' I tal ia. R ass eg na Mensile dei Combattenti, La Ve cchia Guardia, VIS). Ri v iste di s p ec ifica p r opa ga nda militare f u rono e dit e durant e le guerre, anc h e d agli allea ti , o dall a propaga nda
avversaria per co ntra stare l'a zio ne italiana.
Non mancarono num er i unici e inserti speciali di propaganda, diffusi dalle riviste a tiratura nazion ale .
Rapidi cenn i meritano a parte gli opuscoli di propaganda. Anche di tali pubblicazioni non esistono s tudi, fatto sa lvo un limitato contributo s ulla guerra civile spagnola, in un a bibliografia di Nanda Torcellan. Eppur e, ovunque so no presenti libri del pas sato (biblioteche pubblich e e private, libr er ie antiquarie , bancarell e, mercatini, ecc .) non è difficile scoprire tali op e rette. Esiste , quindi, una disponibi l ità di mater i ale ancora tutta da es plorare. S i ha la se nsazion e che una pazi e nt e indagin e porterebbe a s tudi rimarch evo li in materia. Questo a prescind ere dal fatto che, per questa epoca, è davvero diffici le distinguere. l'opuscolo d i propaganda dal libro della stessa natur a, specialmente quando esso ha pretese storiografiche. Se infatti , p e r conve nzione, si definisc e opuscolo un libro di poche pagine (meno di 100), a parte questo limite quan tita tivo non vi sono differe nze sostanziali di contenuti in opere di più' ampio spessore, in massima parte «ce leb rat iv e» e quindi poropagandi st iche (si p e ns i al mastodonti co «Legionari di R om a in Terra Ib erica») Sarebbe, in ve rità , difficile addivenire ad un criterio metodologico che indicasse chia rament e il limite tra libro e opuscolo di
propaganda , a meno ch e non si voglia, ripetiamo atte nersi all'arido sistema, derivato dalla biblioteconomia, della quantit à di pagine per dist in guere l ' uno dall'altro.
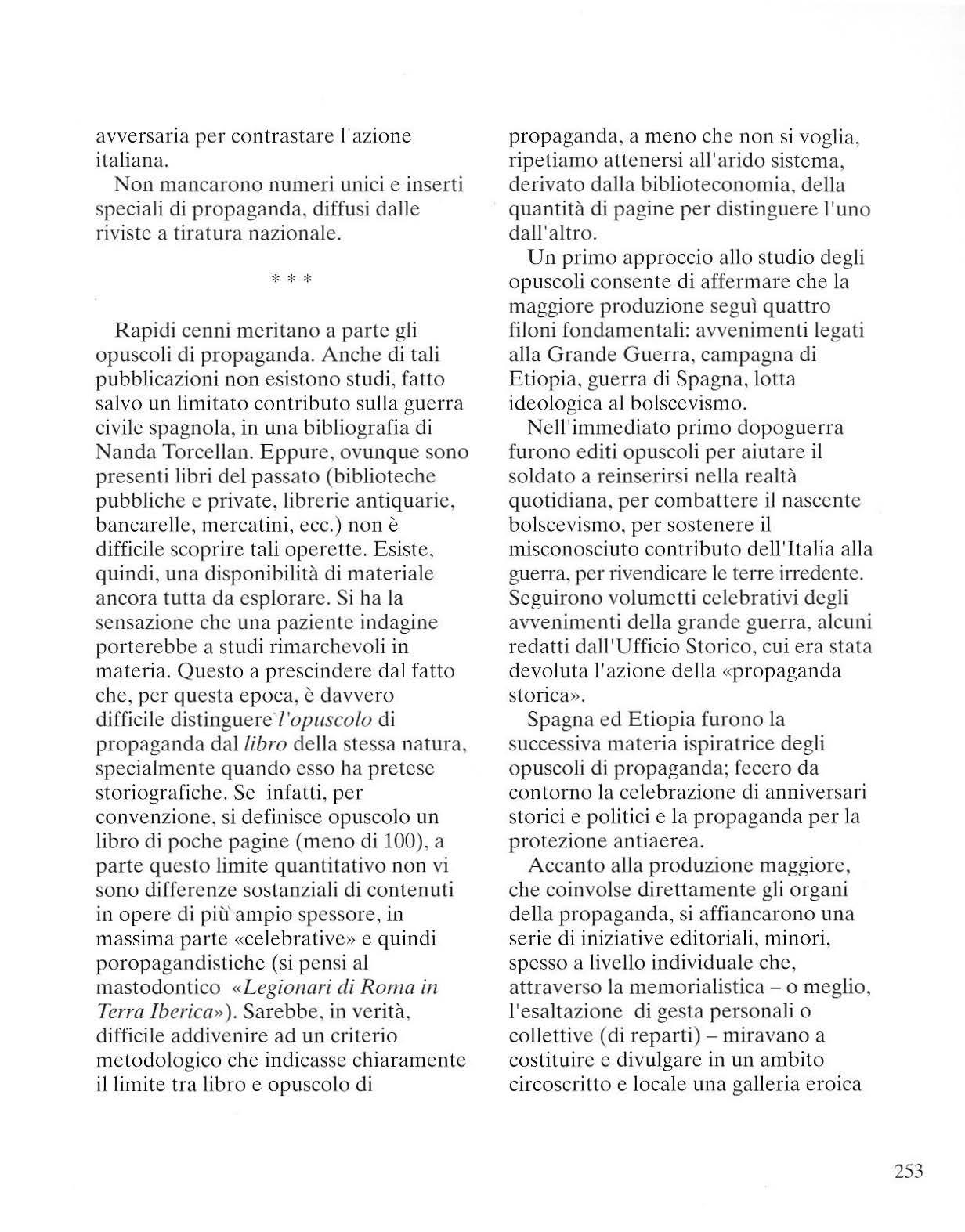
Un primo approccio a ll o studio degli op usc oli conse nte di affermare che la maggior e produzione seguì quattro filoni fondamentali: avvenimenti legati alla Grande Guerra, campagna di Etiopia , g u erra di Spagna , lotta ideologica al bolscevismo.
Nell'immediato primo dopoguerra furono ed iti opuscoli per a iutare il soldato a reinserirsi nella realtà quotidian a, per combattere il nascent e bolscevismo, per sostenere il miscono sc iuto contributo dell ' Italia alla g uerra, pe r livendicare le terre irredente. Seguirono vol umetti celebrativi degli avvenimenti della grande guerra, alcuni redatti dall'Ufficio Storico, cui era stata devoluta l'azione della «p ropaganda storica».
Spagn a ed Et iop ia furono la successiva materia ispiratrice degli opuscoli di propaganda; fecero da co ntorn o la celebrazione di anniversari storici e polit ici e la propaganda per la p r otezione antiaerea.
Accanto a lla prod uzione maggior e, che coinvolse dir etta m e nt e gli organi della propa ga nda, si affiancarono una serie di iniziative ed itori ali, minori, spesso a li vello individuale c h e, attrav erso la memorialist ica - o meglio , l ' esaltazione d i gesta p erso nali o collettiv e (di reparti) - miravano a costituire e divulgare in un ambito circoscritto e locale un a ga lleria ero i ca
della Nazione, concorrendo co sì a pote nz iar e l 'opera della propa ga nda. Non man ca rono op usco li c he att es tavano la parte cipa zio n e del front e int er n o a ll e g uerr e e al fa sc is mo.
N e i temi ispirato ri, gli op u scoli e diti tra le due gu e rre n o n pr ese ntarono gro sse diffe r e nze co n qu e lli s tamp a ti prece dent e mente. No te vole fu, invece , il divar io lin g u ist ico che separò gli uni da gli al tri: le form e lette r a r ie e semantich e , che n e lla prima guerra mondiale furono se mp lici e comprensibili a tu tti, nella consap e volezza ch e l'opuscolo era diretto ad un a massa p e r lo più inco lt a , di ve nt ar ono auliche e ricerca t e n elle op ere tt e pro pagandi stiche success ive, quasi che, all 'improvv iso , w1a Nazio ne segnata dalla piaga dell' a nalfab e tismo foss e dive n tata erudita
e colta. Pro babilme nte , il salto dal pian o e co mpr e nsib il e a ll'intri ga to e in com pre nsibil e fu dov uto all e forti tin te id e o logi ch e ch e se g nar ono gli op uscoli di propagan da: la prevale nza d e lle sp ie gazion i teor e tiche cos trin se, quin di , a dissert az ioni compl icat e che r ichi ese r o di conseg u e nza form e es positive e litar ie, o pseudo ta li , e la rgo uso di r etor ica. Sotto tali aspetti propa ga ndistici di m ess aggio per le masse g li opuscoli furo no , pres umibilrnen t e, fallim e ntari (ta le aff e rmazion e v a co munqu e approfondita in uno studio ad hoc)
C on una punta d i cattive ria, vorre mm o a gg iunger e e concludere che for se il fa sc ismo de term inò la n as cita de l m alv ezz o dell 'inco mpr e ns ibil e, tanto caro alla p rop aga nda id e o lo gica e politica d e i no stri t e mpi.

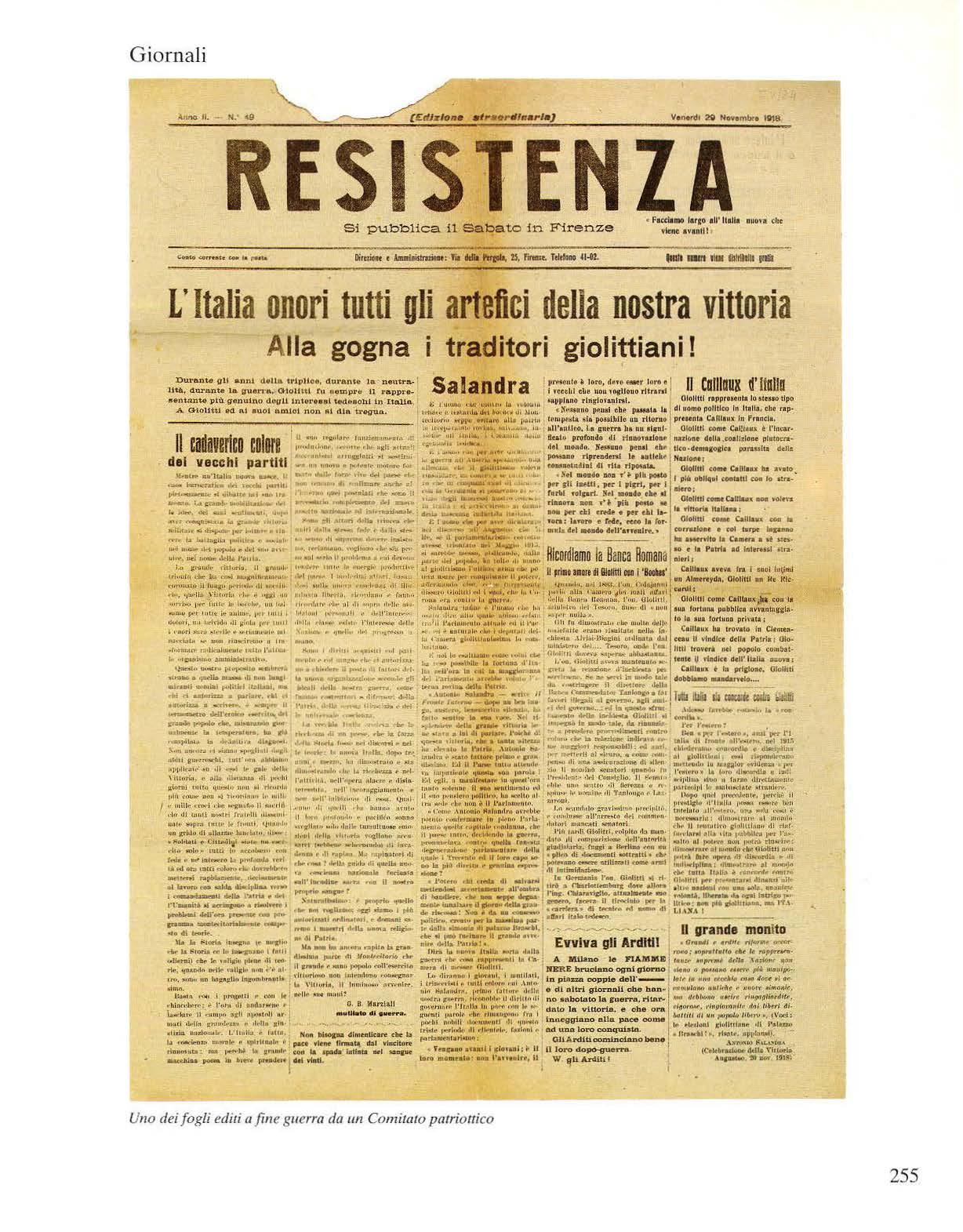

Questo giornaletto si propone principalmente di partorii di le, Fante d'Italia. In queste colonne troverai illustrale in modo semplice e piano le principali questioni che riguardano i tuoi interessi cosi di combattente come di cittadino
I problemi nazionali; le modalità della· smobilltazione e i diritti che lo Stato ti accorda in premio dei sacrifici da te sostenuti per la Patria ; i vari problemi del tuo dopoguerra ; i mezzi messi in -opera per sottrar/i alla minoccfa della disoccupazione; l' emigrazione : -lutto c(ò su cui può esserti utile avere notizie precise e sicure tu troverai in queste pagine. Esse sono scritte unicamente per te, nella sola cura del bene di colui ha ta nto fatto e dato per l'Italia, e si raccomandano perciò alfa tua benevola e diligente attenzione.
L' It alia, ch' è en trata in ·guerra li beram en te per il tri onfo dei principi di diritto e di giustizia de l mondo, e che l'ha chiusa riportando sull'Austria - Ungheria la più grande vittoria militare che un Esercito ed un popolo abbiano mai ottenuto sopra un'altro esercito e , un a ltro po polo intende po rre i s uoi confini ai termin i sacr i che la nafura le ha posti. ·
Fra tutte le accidentalità geografiche (mari, fìumi, monti, laghi) che ordinariamente si prendono a limite di un paese, nessuno trova riscontro più perfetto e completo dei monti nelle condizioni naturali di vita.
Il mare, i laghi, i fiu mi so tto un ce rto as petto ·uni scono; le mo nt<igne dividono. Chi, par tendo da un punto qualsiasi della pianura del Po, procede verso l'interno del continente europeo, e s'interna man mano nella profonda zona montana che recinge l'Italia, trova a poco a poco le condizioni di vita farsi più djffi cili , poscia, in ternandosi fra gli alt i picchi nevosi, ve de spa ri re uom ini e piante fino a giunge re s ull' a lte cime dove nessuna traccia di vita è pervenuta -dalla pianura, e nulla rompe iJ · solenne silenzio di morte dei maestosi ghiacciai.
Procedendo ancora avanti, dove le montagne tornano ad ab bassarsi, la vita ricompare; ma non è più la stessa vi ta; gli uomin i ap partengo no ad un 'a ltra razza, la loro lingua è diversa; essi non sono partiti dalla valle del Po; non sono le ultime propaggini di un popolo che da sud si è esteso verso il setten-
trio ne ma so no le estreme punte di un popolo diverso elle da nord cerca di raggiungere il dolce clima e le fertili terre del mezzogiorno. ·
E le montagne, le nostre grandi Alpi benedette stanno in mezzo ai due popoli come muragli e incrollabil i, che nes suna forza umana può spostare, che ness un rag iona mento può ca nceHare.
L'Italia vuole raggiungere ovunque le sue Alpi, vuole arrestarsi a quei confini naturali che il genio di Roma superò di balzo portando la civiltà e la forza latina nei barbari che l'attorniavano.
_ Nel 1866 l' Jta li a, da poco costitu ita , nazione povera, incom pleta e prcssochè disorgan izzata e senza esercito, completamente fidandosi della Prussia sua alleata, aveva iniziata la sua 3• guerra d' indipendenza sperando di poter allora raggiungere le sue Alpi. Ma tradita dalla Pruss ia che, ottenu ti aUa battaglia di Sadowa i s uoi scop i di guer ra, s i era af frettata a conch iudere pace con l' Austria, l'Italia dovette cedere ed accettare un confine ingiusto e convenzio-nale, e dovè rimandare al futuro il compimento della propria indipendenza.
li momento di tale compim ento giunse il 3 novem bre 19 18 qu ando , sconf itto ed ann ien tato l' ese rcito nemi co, l'Eserci to Italiano res tò padrone co mple to de l campo e libero di avanzare.
Se noi avessimo voluto, se il diritto della forza avesse mai imperato fra noi, avremmo potuto, come
Si co noscono solo due num eri di questo bolfetrino, pubblicato a V en ez ia nei1CJJ 9 e reclaman.t e i diritti /e rrit o riali acquisiti co n il sacrificio d ei s o ldati
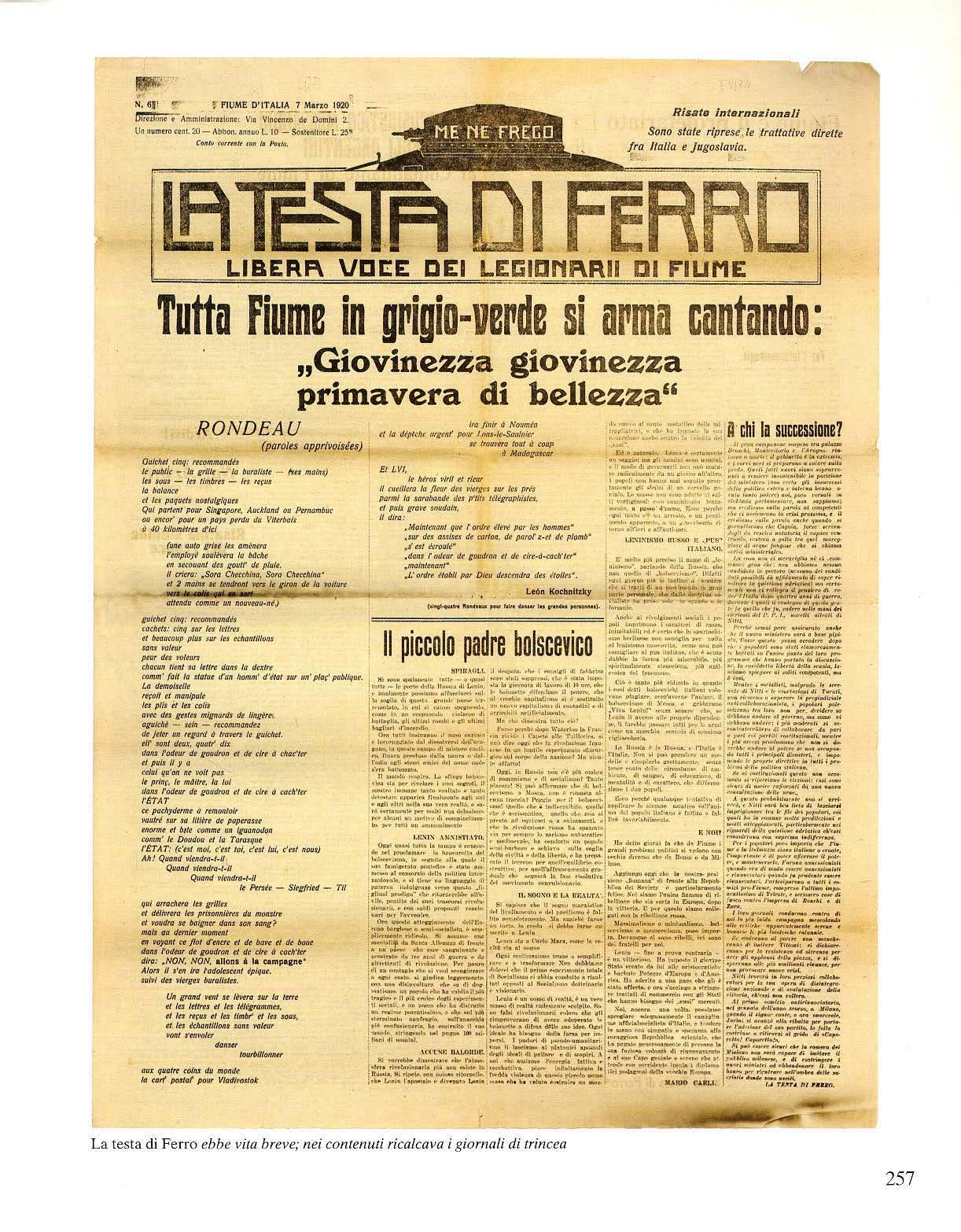
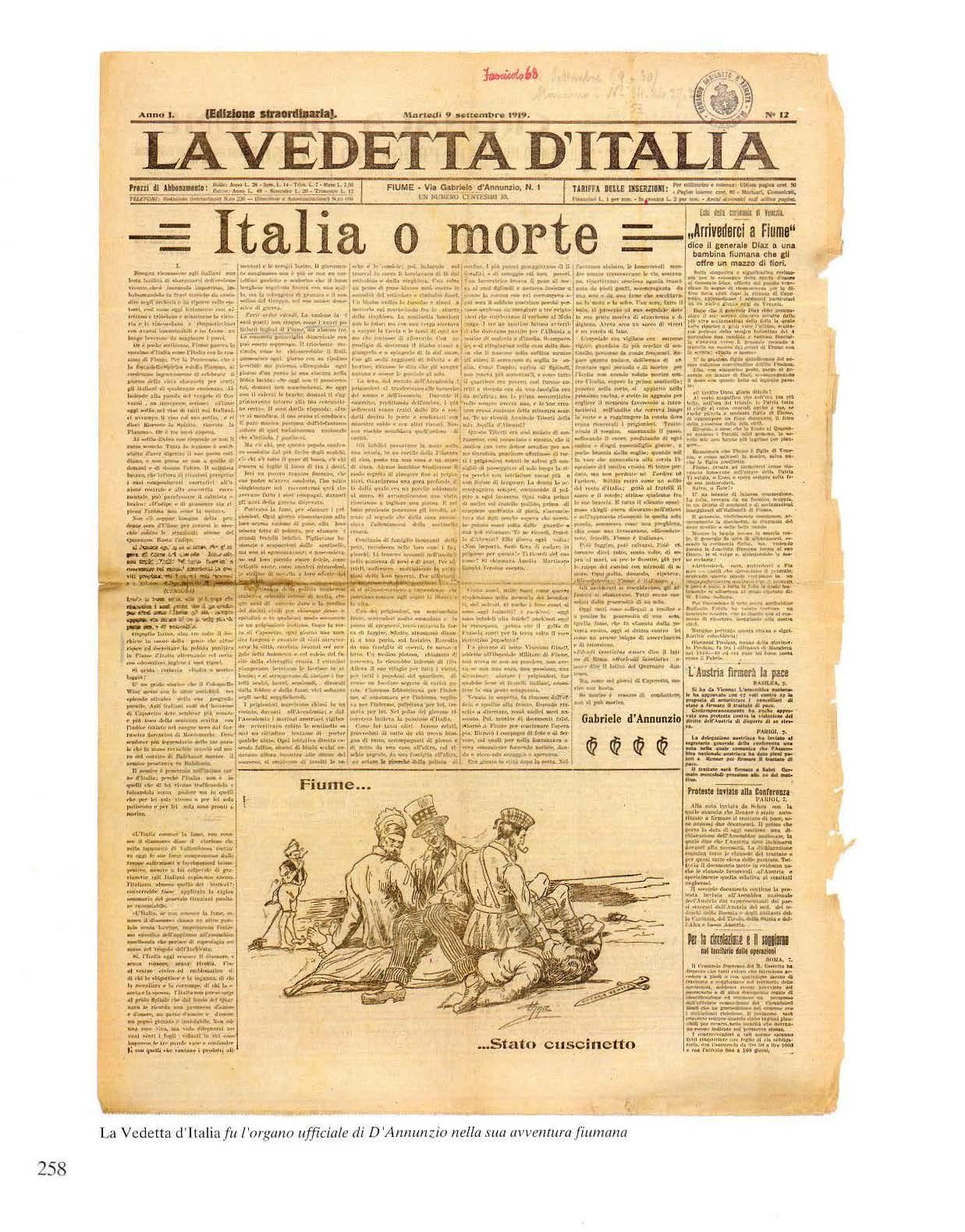
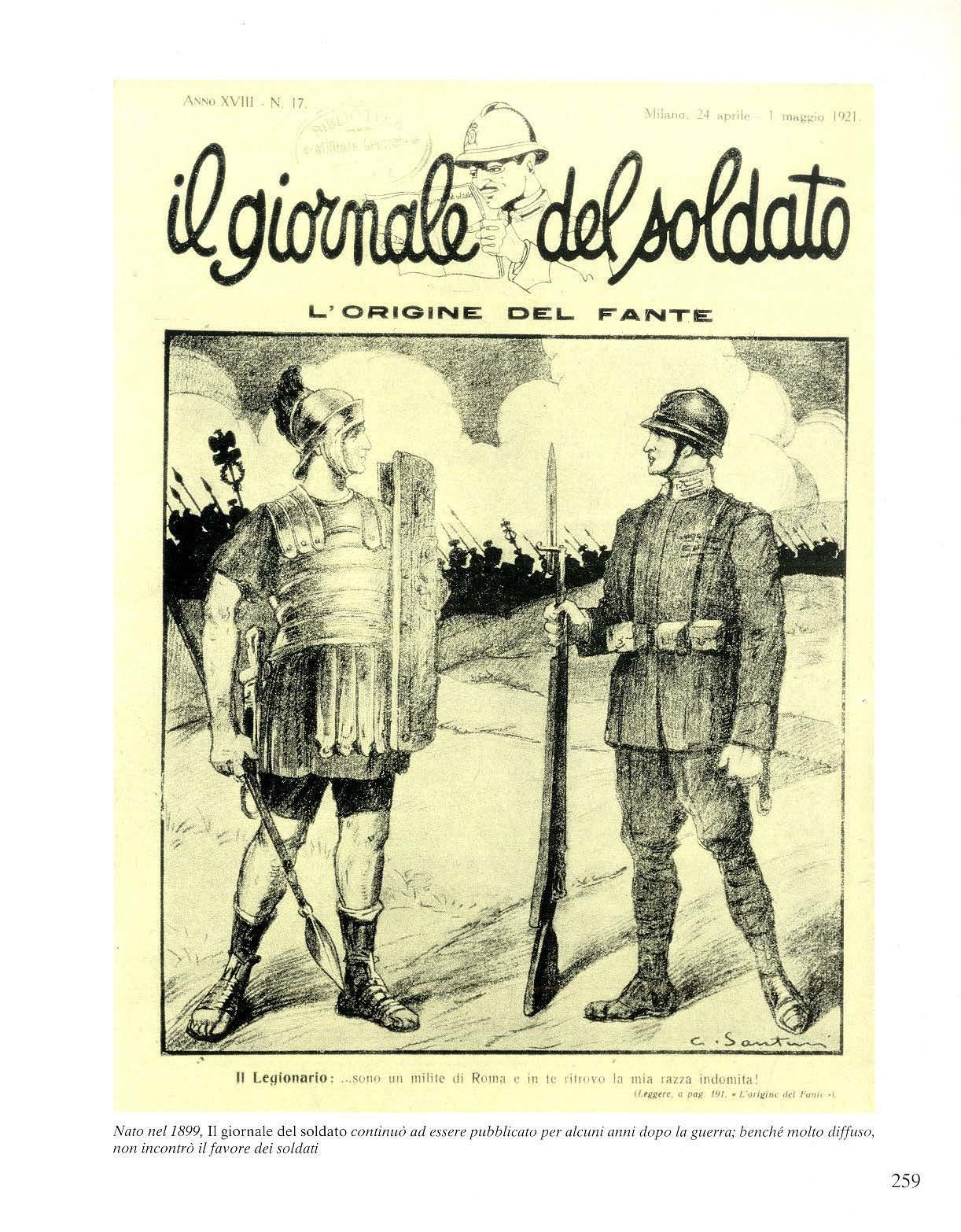
giornale fit Ira i pochi ad avere fini informativi, phì che propagandistici
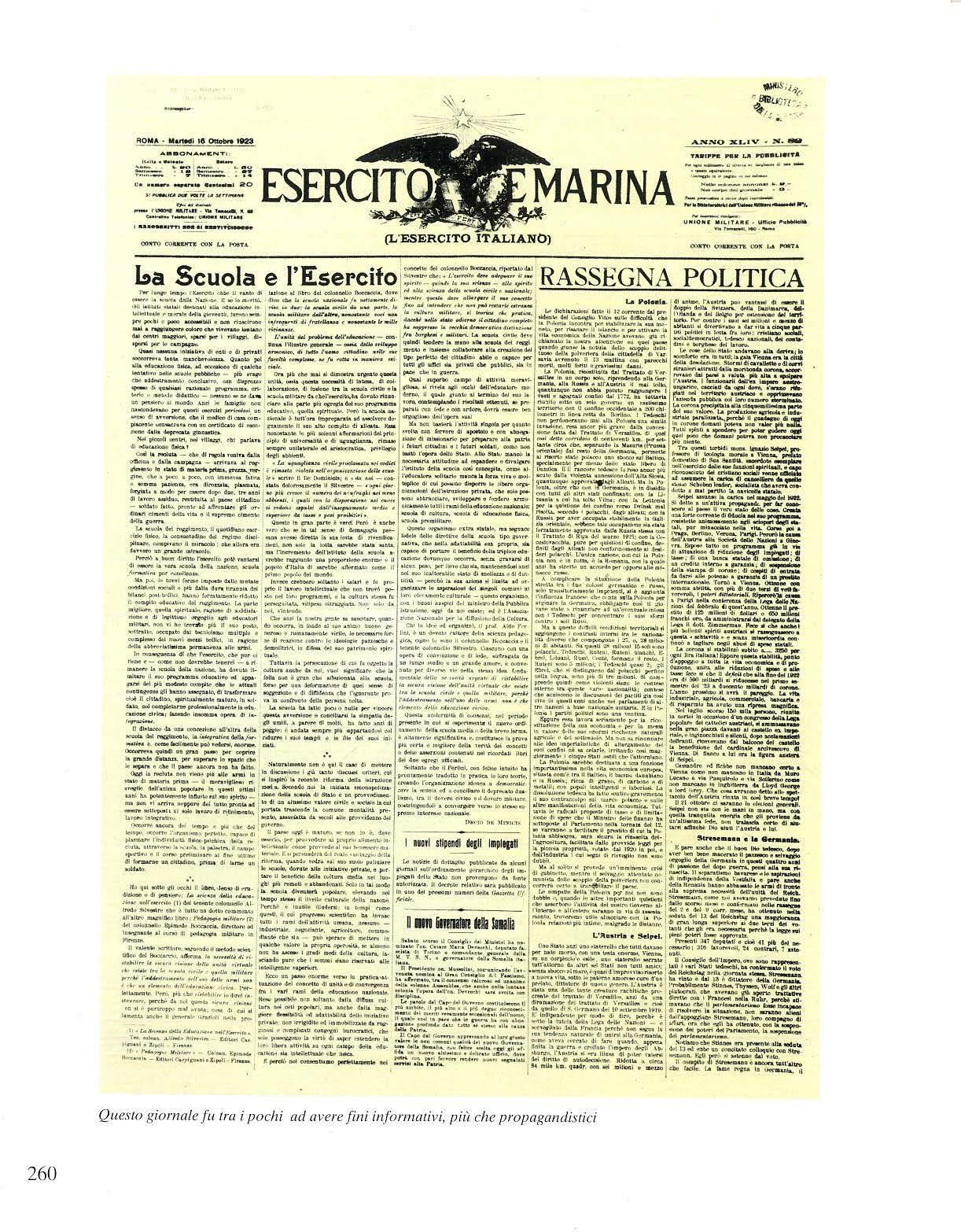
$ 1 mol'1 i (' d ebbu cssc.r pron t:i tt m or"Ìl'C', n1 n !ìOP r: ltul.lO c.·ome Si l clt:hha t!-Cr vi r sonc· pér ,·h :er e é l) tH: p cl' 1:1 .;;_Pf:md czzs d {'ll fl Tt OSf•t:{\. 11 H CJ.'\ttfl ltt intim :l d ell u. Nn 1.ion:\lc ll,,l.i\ t';t lg li nri chl ' non so- ; è nssoojnzh)ne- tJ.i b;.\tt<' n t i. H m :1 1u.;ht' cd esscuz ittl mto n1 C' d '.\..nn n { fl)g-l io doRtin tHQ , :l \"Ìt4 pi'il JH i $tJoi:a tò.l h't :\ pur de1le fa hn.gi cltc pa1lceip:u·•.mù l1 n g'l 'tl.n · d C' g'I ICI't!l, ma n \'Ìta se1Upr-c p iit lHh) a linfn {')d oucrgit_-. u uov9 trnrr1'• dai \"Ì rJ,!:U 1tì a4c in tt,btmo o prc n\OI •O pc.u· tihrt<•· v;lrC'I r. ri:ugio,·omit"' quç1 Jc1-ro,\ l U 1·icordi Yi vJ·i\ · Hi'o ..;oltatu«, J;lt\r òi N.'nza. Il' c·h•· ru t'OllO ai 11\m,;Uf, ne i c,'On t h uwtori Ht l t <'tn&to • l[n qut- i lllC'1.7...i dt ht

t'O'' pvclle ordluoti riHstgms del nostro Labnro glorìoSQ, sen.tan() semp re phi 1 anm. quatt-tjo m)! fa!tl'
tlcMrsl 'in rum'! la nu('f.arrlmtv-u cr r:òJI f;an n r-
essare pront i ad ogni op- ra pc.llo, qnde. .scaltafe-genc· .lf<t 1a quelle P.nlm rosamtmlt con if, stando • 4ttMil-O ((rtn:r!lt ttl di chi d fo rte,. prep()ratq! er?· tfl/.Q 'S. o)fty'J?"
{l 'rU.J.I[,f uulrn·
1 ftli()ri r1(:l. pc.ri:Oao ltt ' rìÌ.ira/A • prt<cédtn/.& 'f i tt<>riO l'c1 net;.o · f!'of 'Vi 0!/{t i SOlO
!lsr · riCo1d att• 'Juc11rt c• h t. P Sl1sta u vi,:lfn(lo di 1Cdr. ma p r- r lenP;riJ l1C.'tia la fimwu w rLi l'olf}l·G cmt./ ft)turr,(! a d trurJUNi :J_t)t/o • lhl. :a'bl:, ro può mm co! 'f'f'f' tlrrJ: mt::l• t e: f J,X:.r ptez>ara.,-.si a, 'Jtt(l/rhe NU<l- .Ebbe-· ne -çh c voi àduna:t.-j noli' .lli\ ,,i ràccog l ici r e t è pet m:nt_t0 Ìi'r.rc uu u untl. m jO ,; el' qo egtò scu l itnento _ rioi l'atuù1mo J qJteilfJ nost ra (trma P pèr f l•t · la é lo su fii p i'& d e i" p i cco); [tali n ni g jÀ 1u 1.'1 uosi r a cl( c t'OM e ,,.; MtUM.ia nlla t $'Ì Pimbu(.<JYtlpitlfnto•nt(J: '"01111' !lt' c.fl.ntbia tm J)t'!z <) (: p rprltèr lo t;,lllflb la ,· lf'' <mtlo ;. r·a.m.bù.rre lfft(l ca tr- "'f (} (/U(Ihf[Q >-i pUÒ <t...!!ip CI f ure;; ((W'flrlo t)Norrf! JIC'r ('(Wtldurla e q,utult• pttt rùu tmiarla quc;:lo /w $(11i<Jrt• b•·l/icol Br.ièlt•it(et'll.rillt' '11o t m/J t?apou 7>11•/ f)ll(/(r <li .._ :l [ ti iu mcz::o nt/a /HfC' <t.4.,it(1fflfJ, f7a le: l.wllf' rvse- ,,, ll,i(r«ft114t.rù;, per,·hf- ,-..; (; lfal /.(t !Jitt. rtfl t: pert-hft _.;. la lu•Jl.(l arma. f"rrt:?UO ,.,,,_ f/t) f<t *"'ua:ti'JhC ,lf :.-:er,•niNi r lrmtfrtt illètà allu spirito. ·
Kon ri\C'I.l.Ì:uno l n utilc 'qneoto o&g-i", ln h'à:t.ì i ;Wu() ctest i natì .:_.d Ali t ro,glieiL Quel giOI' UO, 1)'111:1 fJiÌ.l :)VréHN da se uéssu n n ltd.e nt(ll' fl"\ ' l;eul o dn •·edt:u"'" ._.. s otntti i pP· 1e1 u uo sempre t'ti in qtm 1nnt).n""' llltiiUNHO l'l"'élic-mto 31l'npp<'llo che li chiumtt. con la , tli tam c ntç- n. llttn tò, $0. !li ii\u. nn 1 fn ih10 : 1 qu:1ndo centinaia di tl i ex c<1ol b u.tlcu ti
])a r]ftl <'I'Olfo ''$•·iti per un 1m"'. rtrrdlo ·d,· "CliOltlcÌ fili · 'tomitt i ç h e Ut> SOlO il h lftUIHO ,ric.ordo òc.U:A.f-. Ìt(UJilO !Jnlfltr.fo l<; :,èzioJli f' le C()fl'tlH<l ua.:n:l i rl gurrm, fluo .-t q}l:'lndo )Xl.(liJit'f· mitragliatr-ici Cll/11 ra i.\rtnA e smiL af/4. al ia fi bgm di oi- :i'Jnt"c doli' I W/i(t , uo n qu :u1d() i Du qui $Oitt.l r.m1 1/fl loaLide:st.rtiÌ L prim:l eli vcst ire noM ltni.Q ,. mnftH.lico d i p r c{WJYa,. ln g l ori •1S!* rli \'.i8.."ì dC'l F:mtt>-. 6oo zionc. i riio·(tllf1U (U uti iJ flil(qnific(l nd tt11 orn l n nO:..t l"l) b'' t•llt.. lo !ut · " " ' •lo>·ero>l" rogion d N>"'<)!'('. gomlr eerfe/t/1 ilei/<> .• p irilo • dtl Q n csto r\lglio Sì :mg'\ll'a
tlullrhoo• hl l •lo <lo"""" 'l'"'" 1.,,. \toll" tr •J l" '.foj1 41,1ln, Ilo..,.,•. (Fil jj,..,, ;>'"Il to+j'l"'t'•"'''" d.o t.roo IIIJ11111:U;o (•,... Ì•iiH•I•t •i ,,. •.,., 1 , ••'"""'' tfo h+ · o l ot nhl'"'\1 \;ol1>t•r l"'t flt\llllt,.l .ll.ohoo!•li+to ol ! •,....l t•lwt. •Il •llt,.t•l. o>l t'"•I •Uh•; roo1 1HI, 1111'1, olfoof+l, •l'i•t' t ••,f,ll' liot loolòl!l;tt 1-Ìd.o !.,Jtu, io; ,..,.,. ''"" +h 11"1 •Il

è il nostro motto .••
Camerati, anche nelle ore più dure, più tormentate della grande guerra dalle schiere dei Soldati d'Italia sgorgavano improvvisi, schietti, irrefrenabili, giocondischerzo e riso.
Scritti, lazzi, caricature, can• e zoni di guerra allegramente eroiche zampillavano fresche, ilari, ;mordaci da sotto l'elmo del fante _ CO'!le acqua argentea da pura = fonte alpina.
L e Camicie N ere, i Soldati della n XXI APRILE R vogliono, devono continuare in tutta la sua integrità la tradizione ereditata dagli eroici anziani della grande guerra; tradizione di valore tenace, ma ridente, lucente al sole come lama di puro acciaio.

A P R I L E A apre le sL4e pagine per voi, camerati, per la vostra letizia, per l'affettuoso gaio cameratismo della nostra grande famigli a, per fissare nelle sue colonne le vostre impressioni, i vostri pensieri, i vostri ideali, e, perchè non dirlo ? , le vostre allegre birichinate !
APRILEA hapermotto quello dei nostri arditi, quello dei nostri squadristi: '•Me ne frego!"
E' un °menefreghismo 8 sano, che se ne infischia dei pericoli immagi nari e reali, e passa oltre, filando dritto la strada romana che il Re, il Duce, l'av· venire del nostro Popolo ci han· no segnato
Accogliete APRILEA sotto le vostre tende, conservatela nei vostri zaini, e collaboratevi.
Gtnerale GIACOMO APPIOTI'IL'ardimento ha per base la oo · lontà e la consapeoolezza
Ancora prima di un atto "late· riale è un atto spirituale.
La carne ha sempre la sua mag · giare o minore fragiHtà , la sua maggiore o minore vibrazione che a condo della sua intensità può assumere anche il nome di timore o di codardia.
Si può pertanto nascere più o meno coraggiosi, ma arditi lo si di· oenta per uolontà- per fierezzaper spirito di emulazione.
Ho an;ora ben netto il ricordo di un tenente di Milizia Territoriale, oggi mio buon amico, che durante i primi della nostra grande guerra, per vincere la matta paura che inizialmente lo angustiaua, aue· va adottato un interessante sistema di alfenamento: quello cioè di usci· re in pieno giorno dai ti di Monte Fortin sull' Isonzo e ili passeggiare in uista del nemico organizzato sull'altro lato del fiume sino a che il sentirsi specifico bersaglio di qua lche ignoto tiratore e lo spesseggiare dei proiettili gli permet· te vano di reggere all' angosciosa t or tura fisica della sua paura
Con questo singolare allenamen· t o egli seppe poi durante /'invasione degli Altipiani (maggio - giugno 1916) documentare eroicamente col proprio sangue il suo ari.limento.
Non mancano d'altronde documenti storici del genere. Noto e famoso quello di Re Enrico IV di Francia che durante la battaglia per uincere la sua paura soleoa spingersi a cauallo nel folto della mischia.
Oggi il combattimento ha ancora più che nel passato le sue asprezze, ma è sempre lo spirito ciò che pre· uale sulla materia.
E' sempre l'ardimento del singolo o dei pochi eletti che uarca la striscia azzurra del ualore e del sacrifi· cio e strappa al nemico e al ilestino l'alara uittoria.
Siano pertanto le nostre Divisio· ni CC. NN. ed in prima la • XXI Aprile • scuole d'ardimento, scuole d'assalto come quella tale scuola di Sdricca di Manzano ila cui uscirono le nostre prime magnifiche Fiamme Nere che incliiodarono il nemico al Piave ed al Montello e che seppero sempre così bene applicare il motto "meglio uiuere un giorno da leone che cent'anni da pecora •.
Le CC. NN. che lìanno risposto all'appello del Duce non saranno seconde a nessuno.
che da tempo hanno forgia· to il loro spirito come la lama del più puro acciaio hanno decisamente una sola mtta : la viu oria.
Una nostra canzone di battaglia afferma che le Camicie Nere • amano le donne e beuono il buon uino • ma se è logico ed umano che cosl sia anche in questa fase d'attesa che operosa tras<:orre, specie nelle ore nostalgiche ed al ricordo di chi a· morosa ci attende, egli è certo che r---IL
Noi se11tiamo elle se domalli J1aovame11te alla gra11de ora sao11asse, il Re saggio, il Bèl vittorioso si metterebbe alia t es t s. del reggime11ti e delle leglolli.
Con queste parole del Ouce, che hanno
manamente la sacra maeatl d el Re VJt. torio Emanuele III all'alba del Suo 36' anno di regno Uaqu n a sabauda, usa da sempre al supremi ardimenti, è 11 bolo t errlbile e a ugusto della nnstra · Impiegabile volont! dl marciare com· e vincere.
neU' ora del combattimento e dello ardimento, una sola donna e madonna sarà in noi e con noi, quella che sin dalla nascita è sangue del nostro sangue - infinitamente bella e cara .:... e che risponde al nome delfalma terra che ci ha creati e mr triti e che si chiama /T ALIA!
Conaol • O•n•r•l• A. MISCHI
Il Gl1Vf'J'"<J./OI't di Romo, S • .E.
lò penso per l'Italia come hanno pensato per l'lnghil; terra i grandi Inglesi che hanno fatto il suo Impero, come hanno pensato per la Francia i suoi grandi colonizzatori, M.
Porw• .u,u .._, •rilrol "'"'' tutte le viunck della ••pan · MIO'' 1 coloniale italiafUl, oli.. qua/l vo · limltrOIOtnlnte parteciparono, iJon IO• /un tnlf ln ErltrD.a, ma anche ln Somalia •d In L/h/o.
(luut• 1plendlde truppe • òboro lo IO· ro <wlJlno <141 r•f>Orli lrrefOiori illll11/ll a •otto il nome di on•, • tun q,,.fto di baacl buzuk p.l •u· bilo dopo l'occupa:ione dt Uta•laua E•p•rfmentatane le buone q&udltd mi· litarl, acccrlal4!1e la fe<kltd, addestroti i migliori elementi per la formul ?nu dei neoutar/ quadri di gradtU»tl, nel 1889 ebbero rcgo/crc ordinamento 1u quattro Battllglioni, una Botterh1 1onre1· l''a/4 cd uno SqU<Jdron4 CawJJe ,.to. I &ttoelr•· •l furono poi oum.n/4/lflno od otto pe-r l4 umptJgiUJ 1895-96, • poscitl nuot.'dmcnfe e ricoJiiJulll plll lardi In numero a &econda del· /e milit4r{ che pru.,ntorono do/ 191/ in poi.
1';tt ll l voWutorl delle ttlrpl, h·llnl e rcrllglorw, concor1oro c concor· rono n/In formarlon" di '"' pcrchd la Damltcr4 d'l14lla, che i $/mbolo di gfu. 11i:Ja o di for:.a, assicurd a que•t• re· elonl t. condizioni indùfJDlMihill ptl-f' IG loro pacifica; cosa cM mal sotto il dominio abUtli iO, che ero rcf/nut •fomite di dJ.eordla, Jl lolla, di IOflrG/ftl:ione reciproea Pochi, foru nessun altro Corpo •t>e· clnl1, pu6 vantare in meno di cinqJJnn· ta anfll dalla IJua e$lstennr.a, 1m "B'Jfto Còll ruumrroso dJ combattimenti brll· Janfflm•nt.o so1lennuti nelJ. tre Coloni• nottro: circo oenlosessant4. Cmamo
CCJ"*lluti in Eritroo: Zulo I• .ettnnbre 1886; Sar-tt8 ogono 1888; Occupczion• di CMren 2 clupO 'S89,· Occupo;lon• di A.rmaro S og0114 1889; Arordoll• 'l'l fl"f"" 1890; Po:=l di Holot 21 febbraio 1891; Mal Dord 1891;
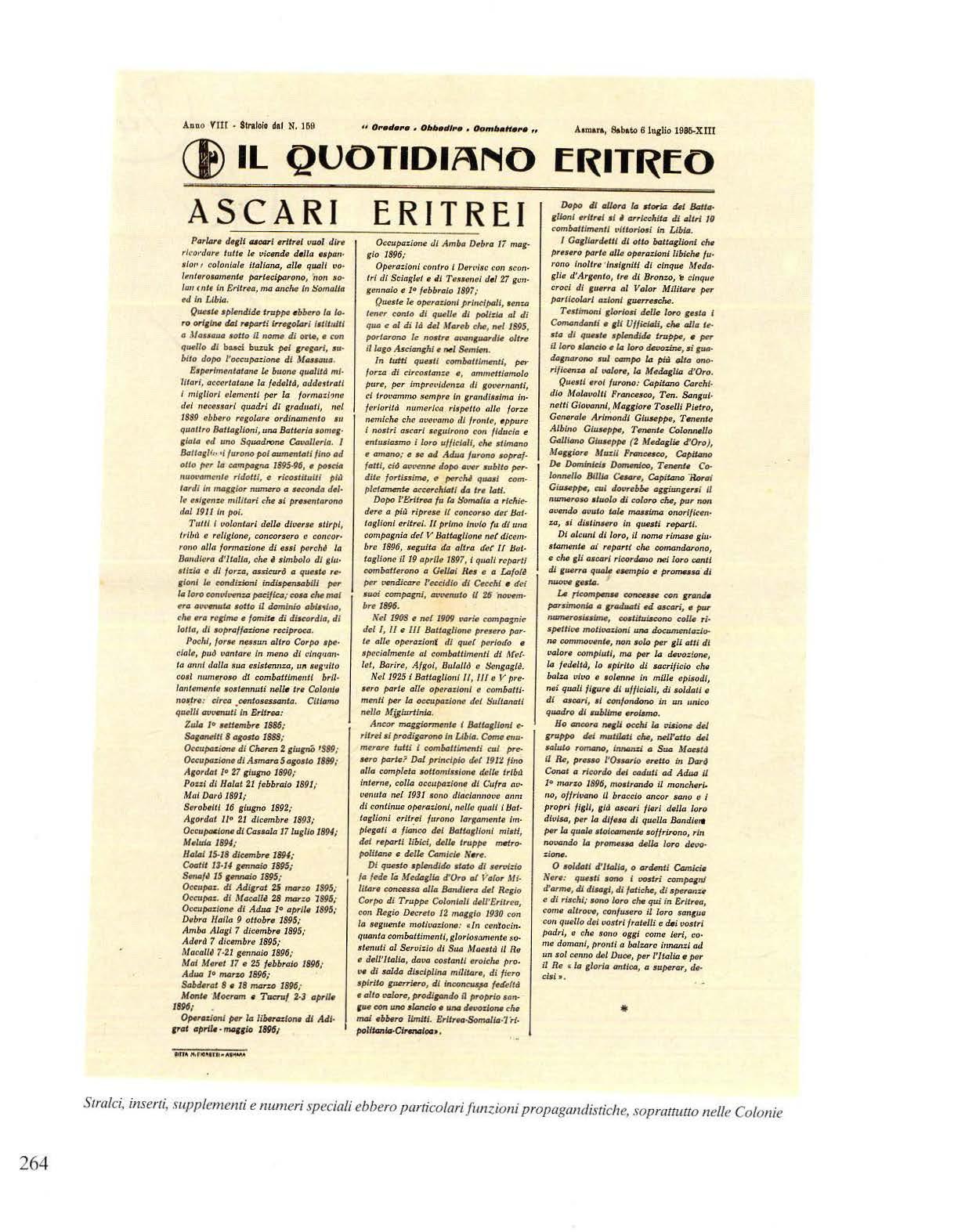
Soroh•ltl 16 giugno 1892; Agordo! Il• 21 dicembre 1893; Occu,..iorM di CoSiola/7 luglio 1891; Meluto 1894; Halol 15·18 dicembre 1891; Cootlt 13-14 gnrrraio 1895; s.,.,.,. 15 '""""" 1895;
Occupo= di Adigrot 2$ mor:o 1895; Occupo=. di Maoollè 28 mor:o 1896; Oocupozlone di Aduo 1• aprl/4 1895; D•hra l/ello 9 otloòr• 1895; Ambo Alogl 7 dicembre 1895; Adtrd 7 diCimbre 1895; Moco/11 7·21 gennaio 1896; Mal Morot 17 • 25 febbraio /895; AdU<l 1• morzo 1896;
Sabd.rol 8 • 18 marz.o 1896; Aloni• Alocrom • Tucruf 2·3 apr/14 1896;
Opora:Jonl p.r lo l lberll%/on• d/ Adi· rat aprilo· """'lo 18961
Occuptuione di Amb« Debra 17 mag· rio 1896;
Opera:iom' cont,.o l D4n t•llc con scon· trf Jl ScJ'aglel e t/1 Teuenel d.J 27 g<.'1t· gennolo s 1• febbraio 1897 ; ()ue&te operat/0111 prlnclpoll1 tcn:.o Un4!r conio di q&UU• dJ poli:Jo al di q.., e ol di /d del Mord clw:, n•l 1595, portarono le nufl'• Oeldi'JU4Ttlle oltre Il Ulgo As<ion&hi • ,.1 &mion.
In tutti questi comòntllm.nll, Pft" for:a di drco.fltm:tt •· ammettiamolo pure, per imprev/tlcn:o tU d trovammo sempre in grnru(/ulmo /criorità num erica rllpetto alle forze nemiche che nv,.wamo r/J fronte •ppure { no6tri ascari "'f"lrono con flducia e entusiasmo i loro uJ/Itlcli, cM. t limono e amano: e u ad AcWa furono •opraffalli, ci6 4Pt-"<'nne Jof>O 4'\.!el' #ubito perdite forlis$im., e- com· plt!lamente «CDrchkltJ dca Ire loti Dopo l'Eritroo fu fa o rlclliea pi1l ripre!l.e Il concor&o dr.t &1· laglfoni eritre;, T/primo Invio fu di una compagnia del V BattaBIIOn« oo( brc 1896, 6eiJUfl4 da a/lrn tkf II 8al· loglionc i/19 aprii• 1897, l qtu>ll rcporl/ combatterono a Utlflll H.e1 c c lA(old per di C.Ccht e de-i 1u<;/ ovwonuto JJ 26 bre 1696.
Nel e nef 1909 vede compagn;e del 11 lJ • Il/ &ttagllon G pre.1ero par· te alle 0/)(!ra.:iont dJ quel periodo e •Pccialmenta o/ combottlmtntl dJ t.fP.l· lct1 &r-ire, 4fgol, Dufa/M o ::X:ngog/4. N.t 1925 l Botlogl/onl Il, l Il o V pre· .ero fXJrte alle Of'el'a:/onl et combatti· mcmli pdr la occup4:lonc del ntllo
Ànet>r moggio,.,...nl• l Bot14gl/on/ •i prodigarono In Llblc. Com11 evu· merGre lutti i cui preuro porte ? Dal principio tkl 19/l fino olio completo S<>llomflllon• <WIItl frlhù interne, colW occupazione di Cufra tu venuta nel 1931 sono dlaclannovc anm di continue opcra:Joni, no/lo quali l JJot· tag11oni eritrei furono Jorgamf!.nts irn· piegati a flinoo del Batt,oglionl misti, del reparti libicl1 frupp. m.tropoU14n• • tklt. Comici• Norc DI qU4l$.UJ tpl4ndlt4> dJ l•f•d• la Medi:JIIo d 'Oro ol Va/or Mi· lltare 'on00$84 cU.a &mdlera del Regio Corpo di Truppe Coloniali deUJErllrea, COli ll<gfo D•crefo 12 m4gglo 1930 <an lo segtWnte moUwnlono: «<n cenlocina qtuJnfa comboltlmentl, ftlorlos.:.me.nte 1tenu ti o/ Servi:io di Sun Mue.1td il Ile • de/1'/lollo, d4vo coslonll oro/che pro. di salda di$cipllna milit4r•, di fi ero •Pirlw g1.errC.ro di lncon""'l" /O<kfld • otto oclore, J>rodJc4ttdo n proprio 60ft· 1u• con uno slmtdo • UIIGI thvotlorw che l7llli •hbero Umttl. Brltr &mollo·1rl· poliiGnltJ.CI,..,...Ioa•,
Dopo di ollora lo <loria tkl &ztt• rUon/ orllro/ •l 4 arricchita d/altri ID comhattfmentl ultlon'Q.si in Llbl4 l GorltorO.II/ di olio bot14f/lonl eh• prenro parto oJI.cr operD.t.Umlllbidt4 fu · rono Inoltre 'ln.tlgniJI di cinque Meda· glie d'Ar14nto, tr• di Bron:.o, 1! cinque croci di 1uerra al Vafor ltlllit.Gre pc.r parficolorl az.lonl guerresche. Te1tlmonl florio•i d./le lor<> geJia t Comandaoli • Jll UfliclolJ, cJw: olio l<· IlO di quut• 1p/endùk truppe O per il h>ro 1lanck> • te Wro ÙtHnins, si fU#· thlgnarono 1ul cmnpq 14 fJlù. gJ.t.o ono riflunz.o DI VGiore, /Q. ltfedacli.a d' Oro Quelli eroi furono: CapHmao Corchl· rlio Malauo/11 PrOilusoo, T6n. Sangui· netti Glow:mnl,, Mcggloro Toselli Pietro, Generalo Artmondt Gluuppe, T•nentc Albino Gluupp., T-..te Colonn•llo Gol/Cono Gtu pp. (2 Mod4glie d'Oro), Monioro Mu:J I Coplltmo De DominW. Tenmte C'olonnello Blllto eu,,., Copit4ru> 'Rorai Glusepp., cui dovrehb. •8fÙUlf•rtl Il tluolo di coloro clut, pur non avendo avuto t.al• mcnima onorificen· u, 11 Ji•tlnuro in quuti Dt tllc,ml di loro, J'J n.omo rimtUe giu· tUunffiihJ of r•portf cM oomanclarono, e cluJ cii OIC4rl rlcortlo.oo nei loro wntl di fLWTr# qu.oZ. eRmpio e dJ ntW[Jif guf4 r.. (ieomp.mu conouu CQn gand• parsinumla o voJaa.ti ed IUC4ri, • pur nu:mero.llnin-., ct>Ue ri· sp.ettiu. m ollPtnlon i una Joc.u.menlo:fo· M c.omnU>wnl4, non •oW p.r cll otli di U4lor. compiuti, mo p.er 14 cUvoz!one, 1.4 fed•ltd, lo 1plrlto eli sacrificio ch" balut vivo 4 tolfnuw in mille epiaodl, nei quo/1 fleuro di ufficio/i, di •o!doU • di OIC4ri, 11 confondA>no in un unico qu.odro dl 'uhllm• uoUmo. Bo cncoro MJll occhi la Nions del gruppo tlel 11Wti141i clw:, Mll'otW <hl 60/ulo rom4n0, lnruutzi <1 Suo Maut4 il Re, preuo l'Ouario .,et/Q in Dtu"d Conot o ricord4 <hl coduti od Aduo il 1• 1896, il moncherl. tJ01 ojfrlvatl() Il broccio ancor BanO o J propri figli, (Id 41104ri /illri d•llo loro dlvl&o, per la dlfell<l di quollo &ndie,. pilr lo qua/o 1toiomncnt. 10/frirono, rln ncoondo ÙJ prOrMIH dcllD loro devo.:io,... O 1olddtl d'lt4.llo, o ardenti Comici• Nere: qu<tlti •ono l uostri compagni cPMme, àJ d1Ufl1 d/ fatiche, di B(leron.:, c di rischi,- 10no loro che qui in Eritrea, come oltroue, con/U$6-ro il loro sanruu ccJt' quelfo del UOJtrlfralelli e cbli. I)OSfrl padrJ', e c.ho 1ono oggi come ieri, co· me dom.anl, pronti a balzare lnruzn.:,· ad un .sol cenno d.ol Duoe, per l'Italia • por il Re • la eloria tmtioa a superDr, d9• cisi •· •
Stra/ci, inserti, supp lementi e numeri sp eciali ebb ero partico lari fu n zio ni propaga11distich e, so prattuuo n elle Co lonie
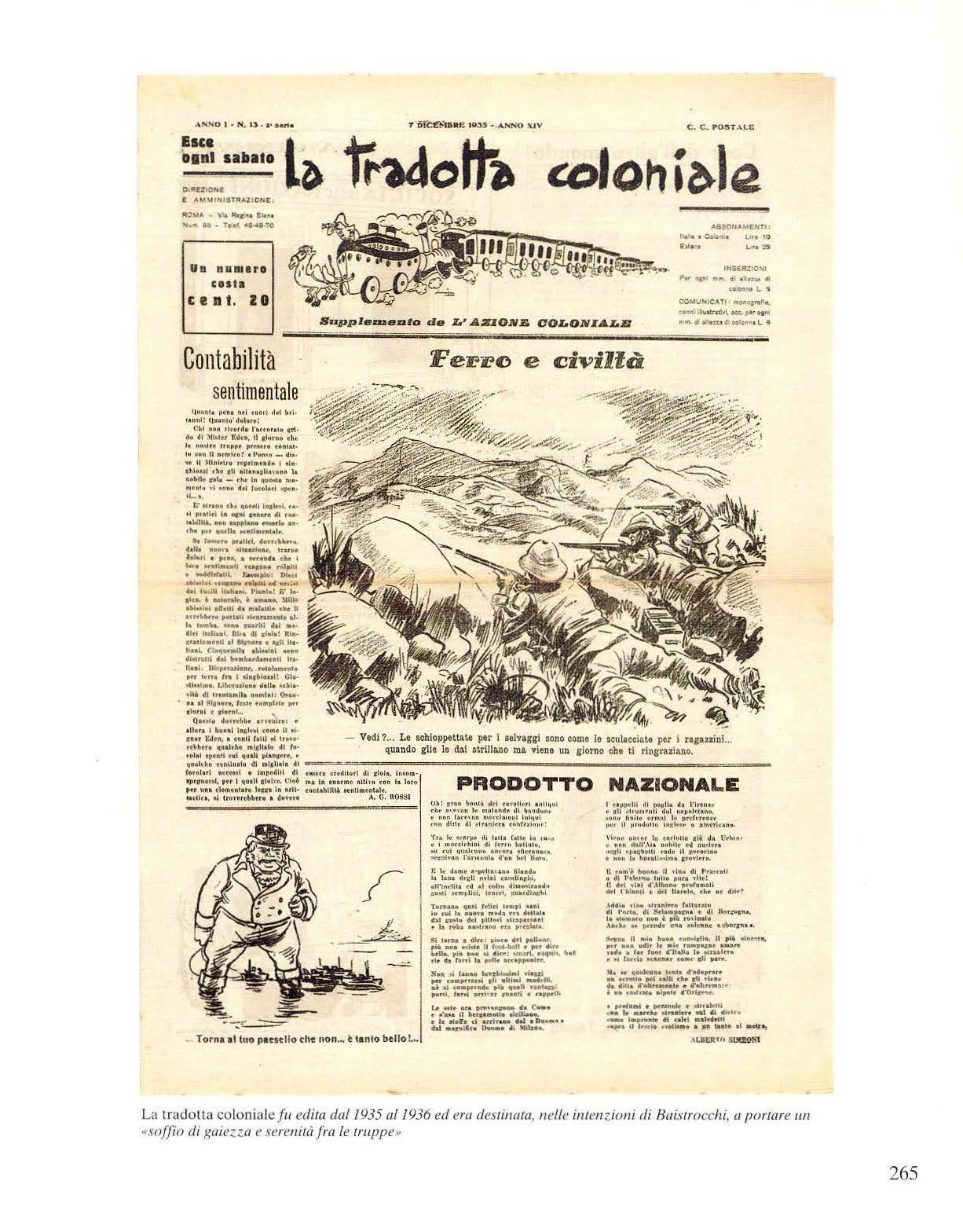
Un giornaleuo «personale », diffuso in ETiopia ma co nfe:.io naTo in ITalia (da D iario di un fant e in Abissinia RivisTa MiliTare R oma 19M)
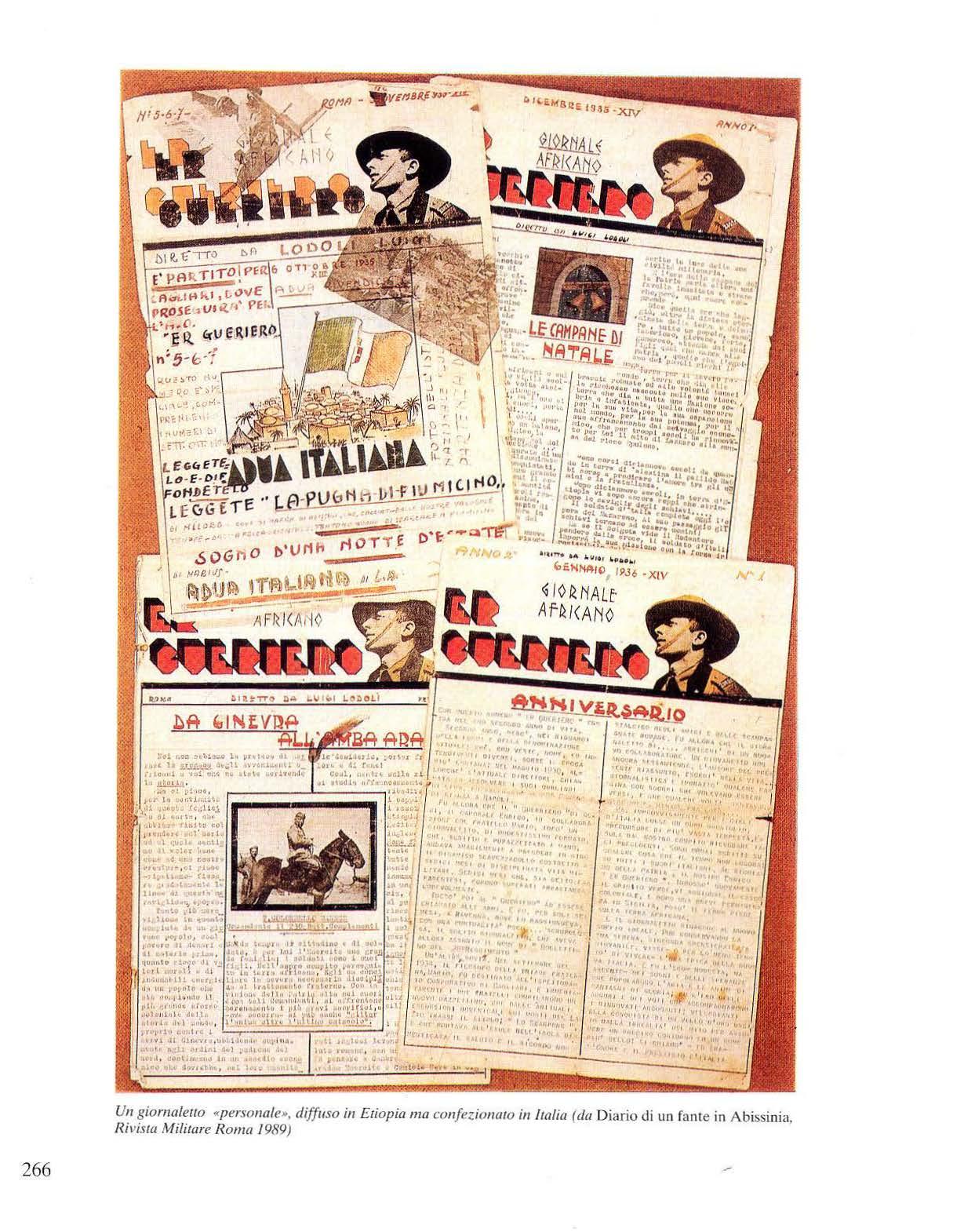

• t
I L L E 3 I O N A a I O
P eriodico dei vo lon tc:X•i i t a li ani c ombe.ttenti in Spe'-'ne.
Saregozza , Ge nneio t219 - - Anno. XVII E • F. ·.

SI ••• • l
I l com<>ndo le;;lm1"r.L1. , h a inviato alle t rupp e i ta:J.:. m e che si bç.tto o sul f r o n te di il suo a l to ' lcgio per i l con super...no l;;;. o.;t.:...a:te ::-o s!_ stenza dell e Eorzc ss.ri e -
L 'e log i o dei nostri S'.l periori - che dai posti del o.1premo cor_unè:u l edi oreo31io t u tti i nostri ri c h e sa.1uo tras:fornc.re g li Ol'dini de l CoJ:tO.ndo , i n e costo <li s:r ,rz i sovr un::;.r>i e r:i dol oro se.n d i C't' e s t!': o f fer>siva è d al l a resi st Cl' :.--a se-:1za coni':ruEt i che l ' ese rci -
q:w li hann o partecipat o a d altre c he hanno dec imat o le nostre file mentando il nftmero de i n olatri morti e d i col or o c he :hanno lasc ia to brandelli delle loro carne i n qu e s1. a · t erra st raniera .-
!l'el suo stori c o dis c o r so di Geneva dell 1 0t t obr e . sc or so ,i l Duce ha de t t o:
I mi ei l egi onari di Spa -
j Le a c q ue d e l Se gre sono arros s at e dal sangue -d ei ' · no s tri c adut i.Le ' colline
lde l l a s ± copri' r anno di al t re mi g liaia , di c adaveri ! - Le éissa ed il :s angue i t a l li ano le l
' terr e d e lla il c ui p op olo n o n pe r dona a c hi te rit a di carpirgli i ' 4uoi ben i ed impot g l± una dominaz ion e a lla q iuù.e non i n tende sott om e t tersi , Andalusia , Casti g l in , Bisc agl ia,Aragona,Catalogna: sono d egli imm ens i ç imi teri p er i figii d ' It a lia.-
gna che l a l oro 'divi l s a è di ç r ede re fi a= 1 t are , ubbi èii re ci e came n t e, c ombatt e re - fino al la morte . l l . .
•
Ogni b at t SJSli a costa .Co s t a l Il noto @. ornalista ini n mate riale , che v al e mi- glese f a tto lia.r di ,e sopratutto in uom!, al Telegraph " le t o df'l -ov"'l''10 rosro 0 2 ni se guenti d i chi arazi oni : !_'Ione elle trU)I!e l e io - I · Abbi amo l ' esp erienza delle naz1 onal i s anno mol t o :'.ar:e e :u:zio.1ali - · b h l' t · l perdi t e di Guad alajar a,de l ene c e e n u s 1 a sm o ne Il nar.d co : • c·,-'!tt::..l;o Nord , di Ara ,q; o n a e de l Lev an le lo r o file d:imlnui s cene · :, è:::.tt::. U'l Ul'\e te . A muc<hi i -no s tri fr a - - gior n o p er gi orrio e che ro r.1ai vi stv di te l li hann o c op e rto c o i lo ro 1 in "'a rie pa'rt i la s t ànn i d c a cc ia , d e mi tra- c adaveri le st r cd e d el l ' Al - chezza de l l a g uerra sboc:::lLtiD.en t o c d e bomb a.r d!]: c arria , 1 mont i di Sant an der, c a i n mani f e st 'azi on i ache d i Bi l bao ,11 Viver s e le pe r t e di gran malco n t ent o u.c.a co:::ti ::lUità i :;usi t2.- strade c he conduco n o a1. ma- 1-come è a vvenut o ad Avi la , . i;a L ' :u-ti J j erib. dei 1 re. Il saneue de i nos tri e altre marlds ti è pure più nu- f r ate lli ha int r i s o a f lo tti città l oro tutte l e pian ure delle Spa- Do p o d ichi arazi o":omnti cr e SO".O <!l!!le'ltc.•.;e gna Da due anni ormai s emi - 'Ili e quest i fa tti c h e fac e or -giù r.·icj.di al i. L e n1 am o c adaveri i n ogni part e c i amo noi i tali ani in trnpp e de i 1·ossi non di ques t a te r r a c osi poco 1 Spagna? Se uni amo a queso!'!li liano in null a alle os pital e p er no i. Brand e lll ste manifesta z ioni di sttlf male di del nos tro popolo chezza per l a di r.:a.l aga . sono di s pe1•s i i n o p;ni t ri n - terri b ile che ci I l. freddo eccezioral e c ea serba la retrag uardia , di oue s ti E offer enz e, s acrifici ,sangue p erc hè d ob b i am o c ontide ll ' offe nei v a , ha certa- morti : e c co i l costo di o gni n uare a st are q ui? Chi eme n te re so an cor p iù du- offen siva diamo il no s tro ri mp a trio r o il compit o dei no - L ' o ffe nsi v a odie rna no n co- i mmedi a t o,e l a sci am o g li s tri l eP,ioneri, molti dei ste rà me no d e l l e p r e c ed e nti a rego l ar e le LEGGERE I N SECO:IDA PAGI!l.-. LE ULTn.IE NOTIZ;I:.E DAL da 90 li •
fiOSt;ri vil
L a pro pag an da ro ssa n o n man cò di fa ls i 11111/l e ri de 11 Leg io nari o. Q u ello ripro douo j it / rovato a Cer l' itt (Spag na )
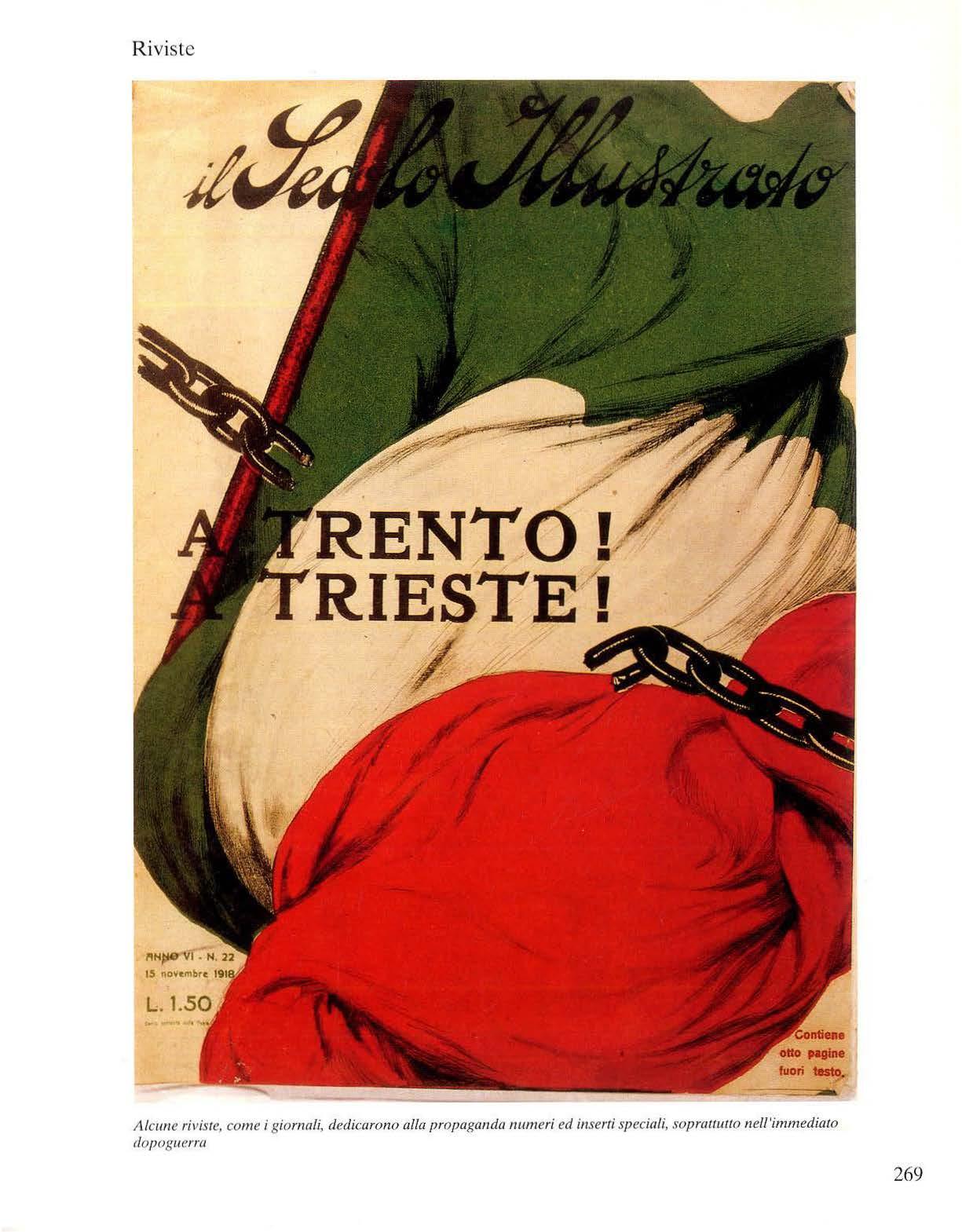
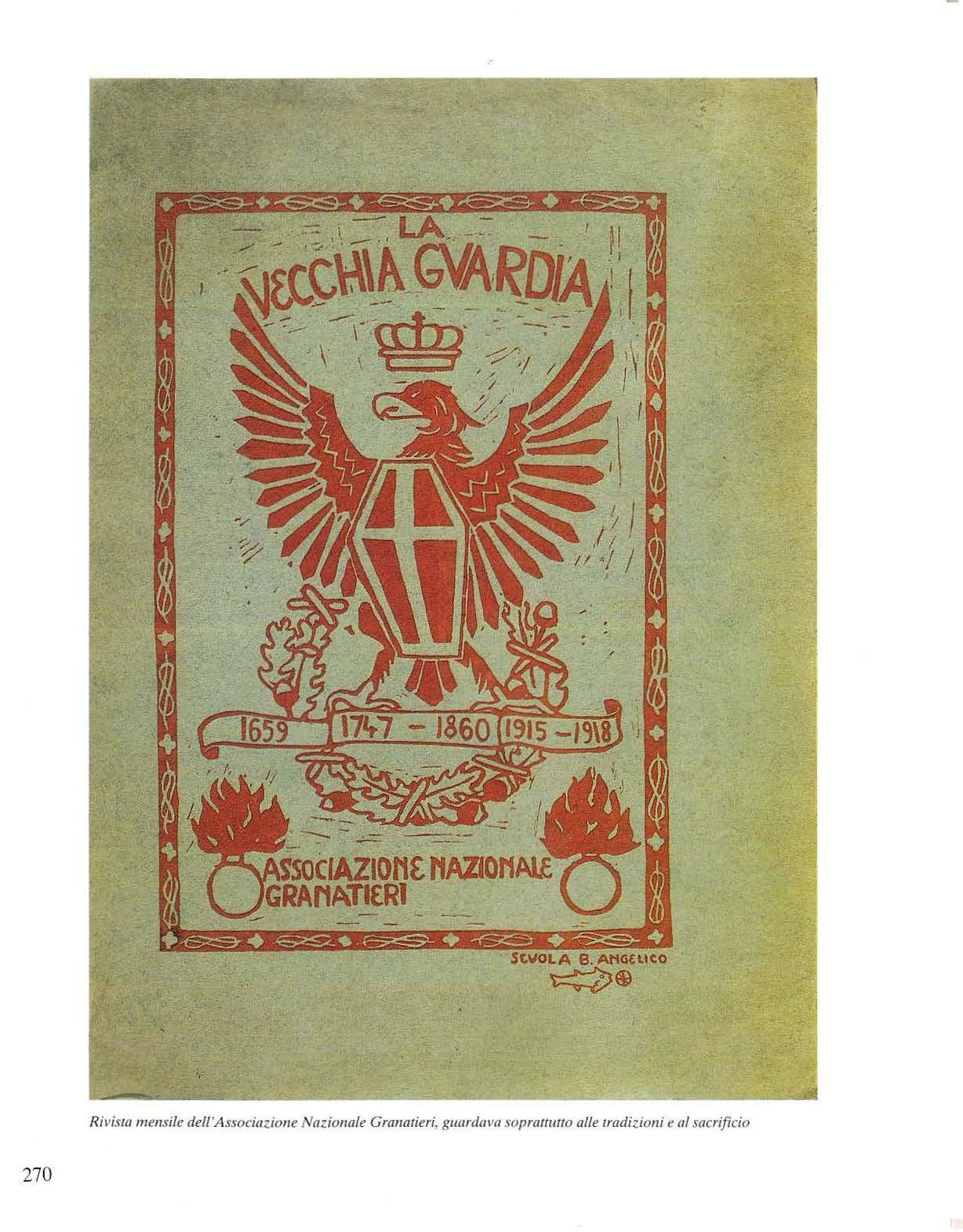
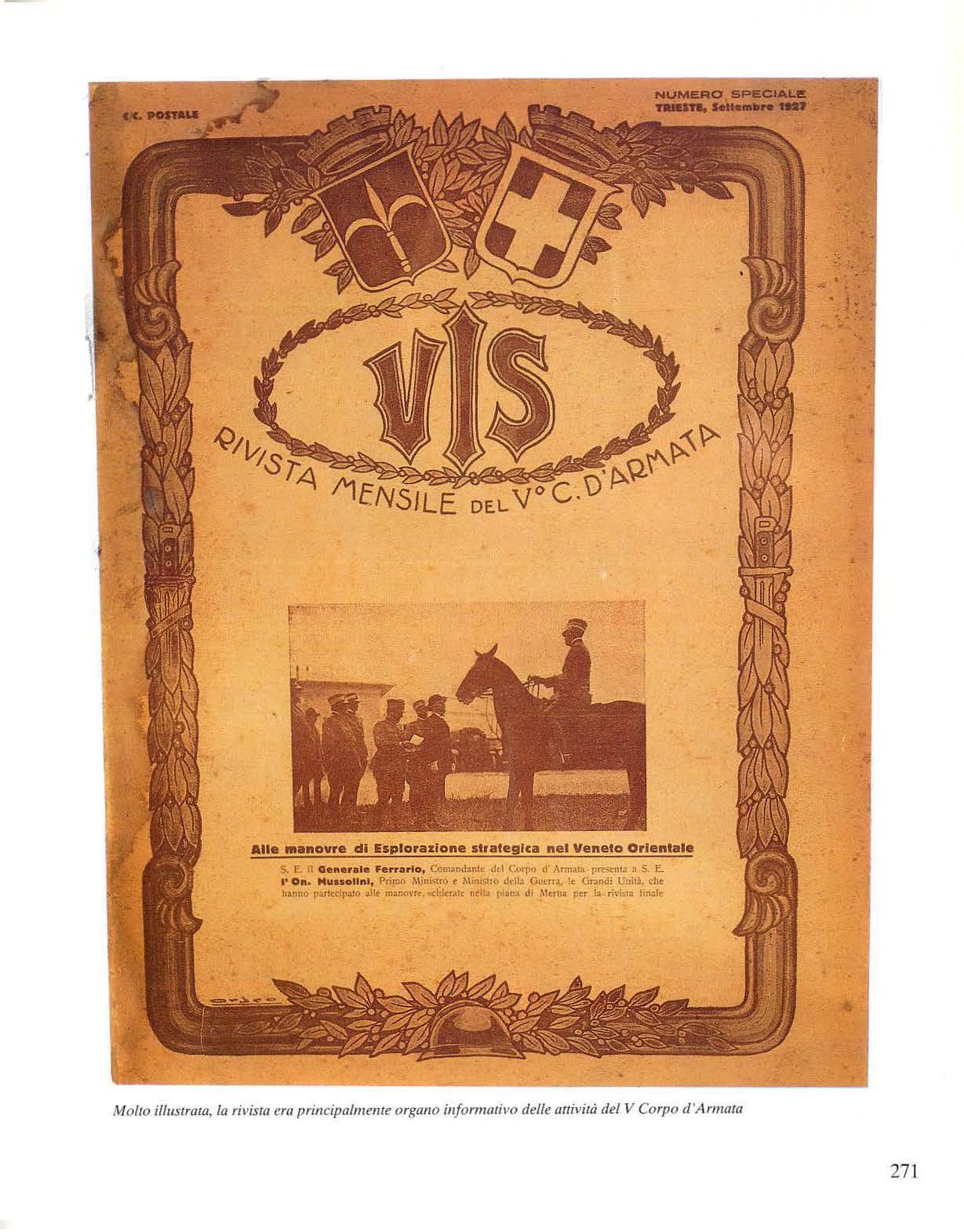 atte Manovre di Esplorazione strategica nel Veneto Orientale S. f. Il Generale Ferrarlo, Comand>nk dd C••rro d' .\rmata prtstnfa " S. E. a• On Muasollnl, PriiDO Mini-.tro t della Guerra. le Grandi Cnit.3. cht hanno p.U1:rtÌ('t.J.lo manovre ntH:t p!an:L d1 .\1tnta la rivi.H3 fin:tl'e
atte Manovre di Esplorazione strategica nel Veneto Orientale S. f. Il Generale Ferrarlo, Comand>nk dd C••rro d' .\rmata prtstnfa " S. E. a• On Muasollnl, PriiDO Mini-.tro t della Guerra. le Grandi Cnit.3. cht hanno p.U1:rtÌ('t.J.lo manovre ntH:t p!an:L d1 .\1tnta la rivi.H3 fin:tl'e
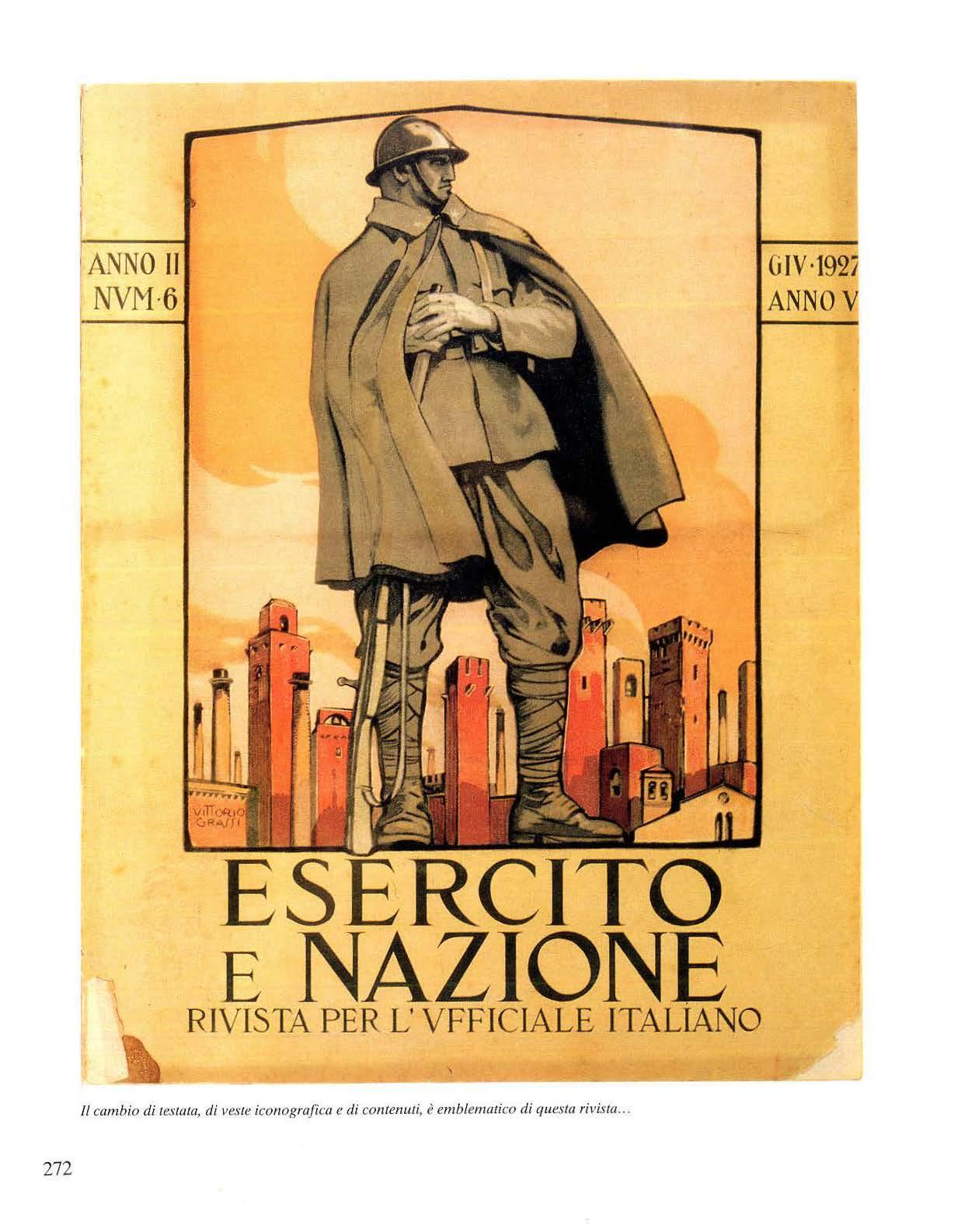
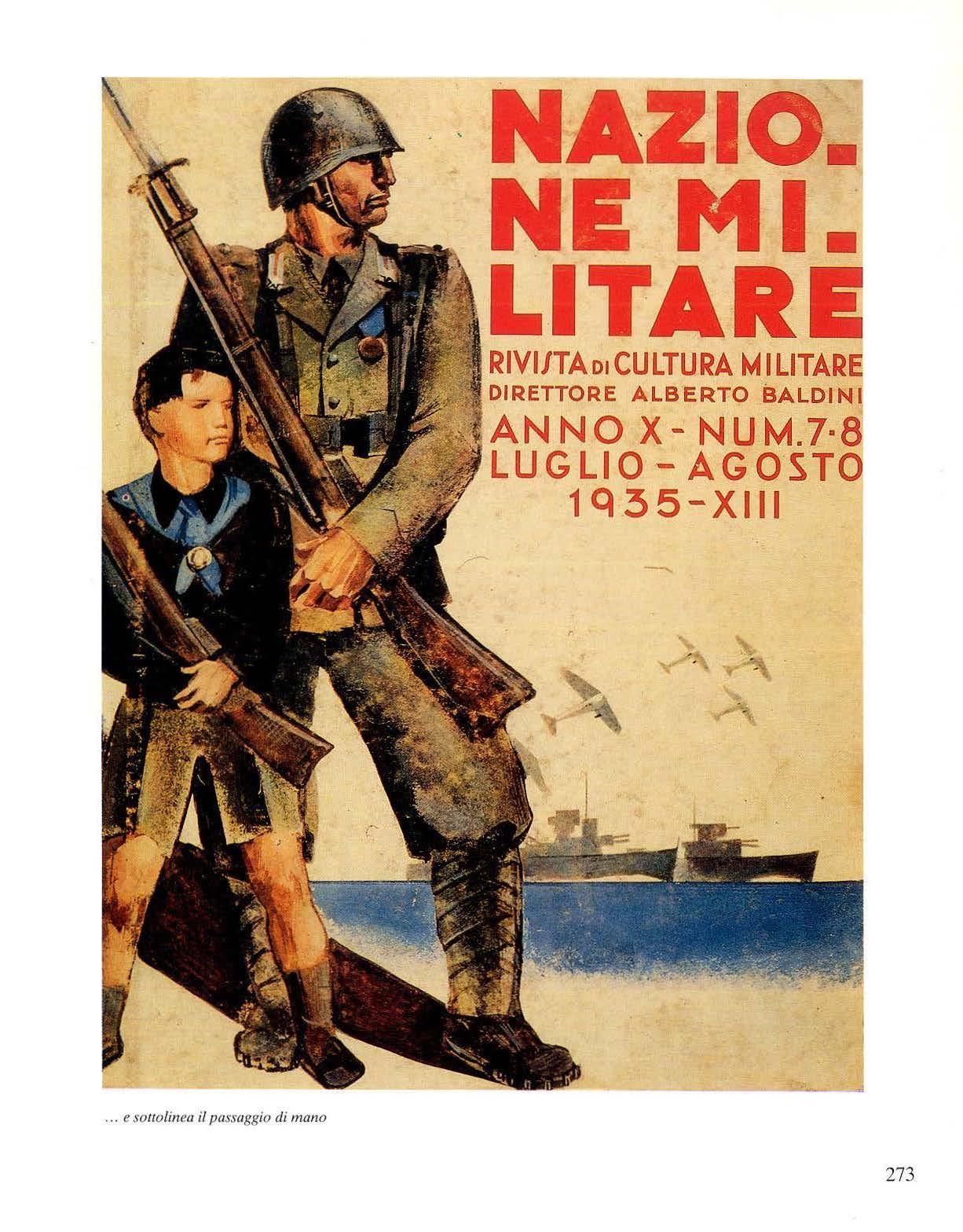
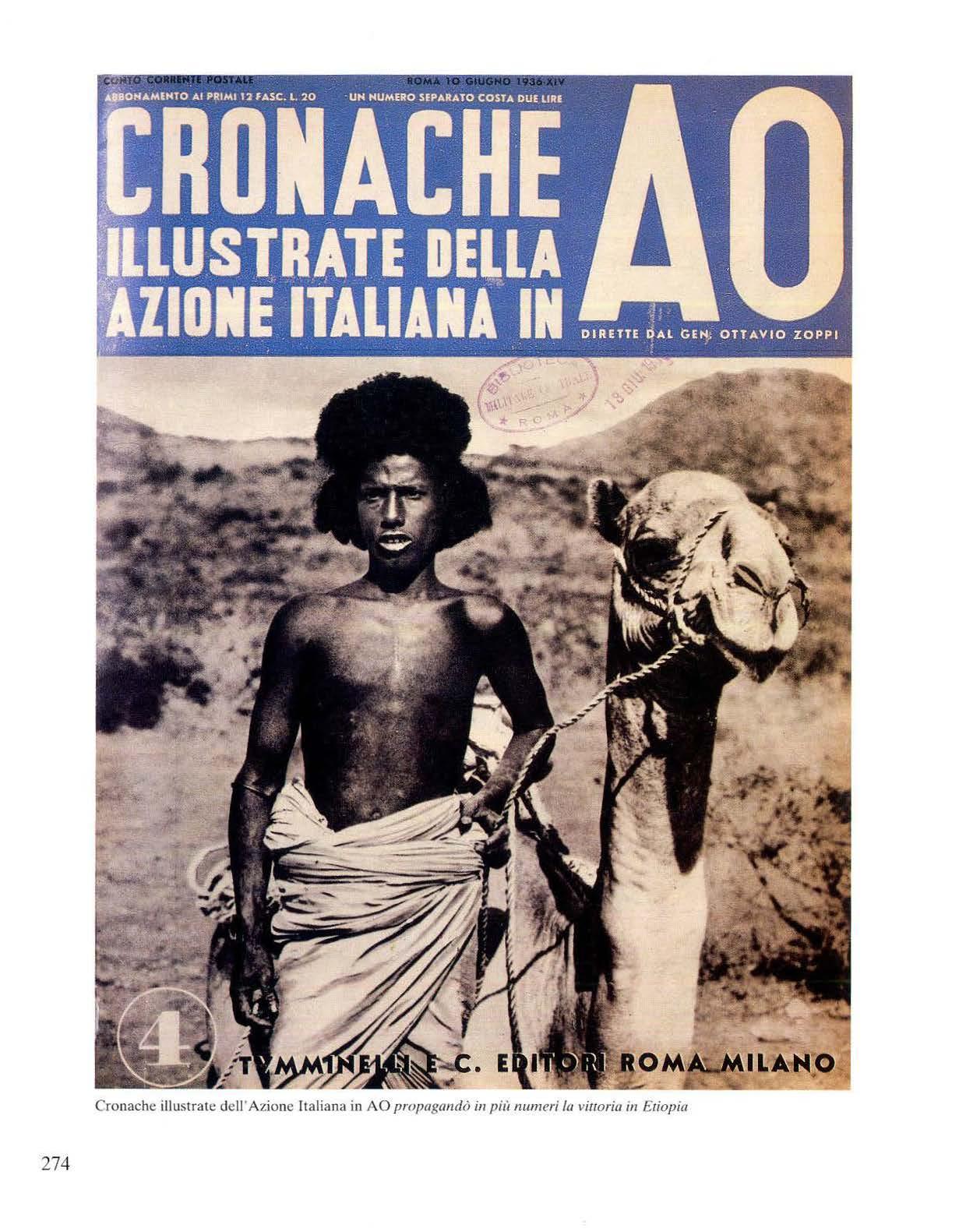
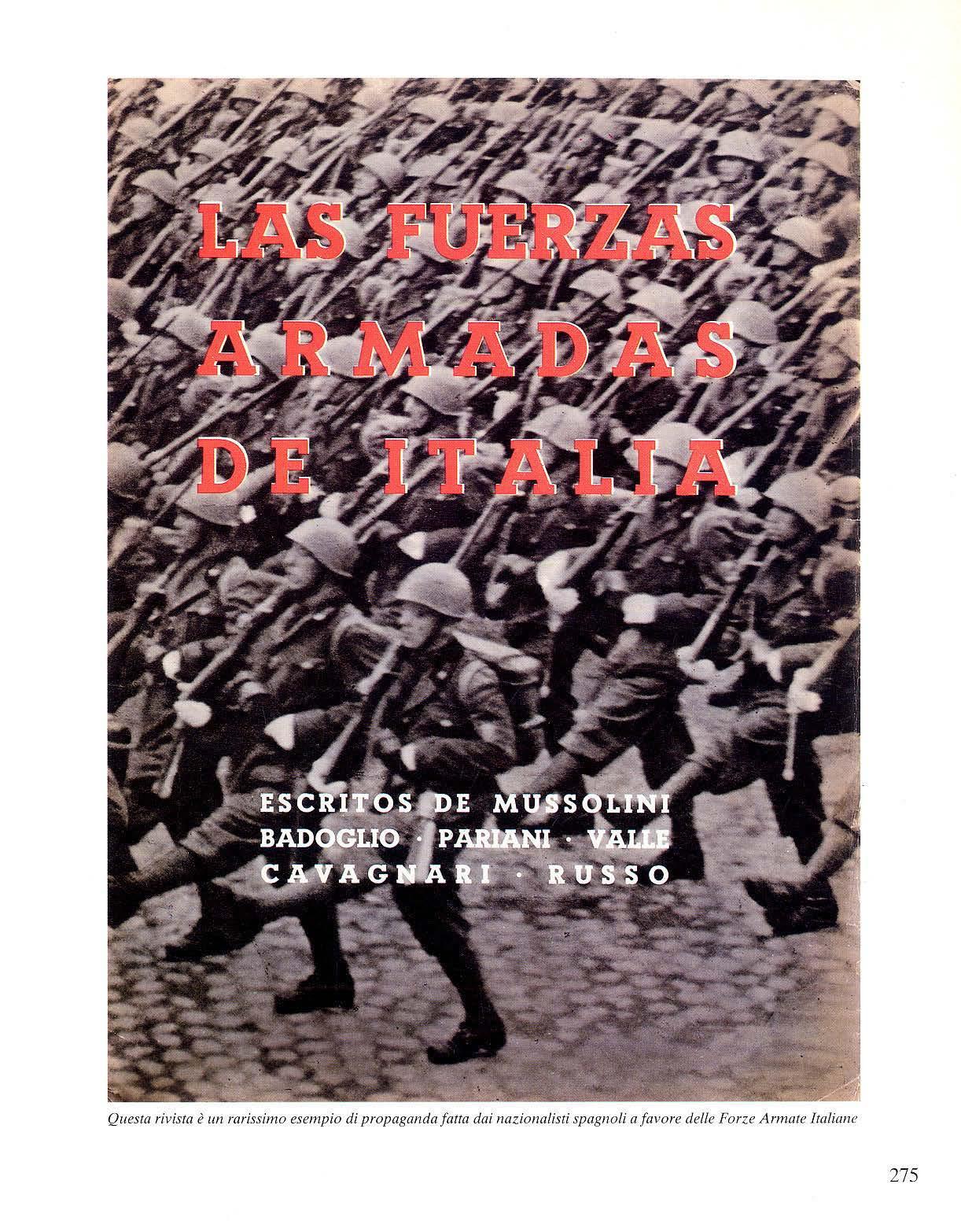
Cr o nache de lla gu e rra iniz iò le pubblica zioni ne// 939, us uf ruendo dell 'ampia collabora z io ne deg li o rgani di propaganda del R eg ime e di quelli miliwri
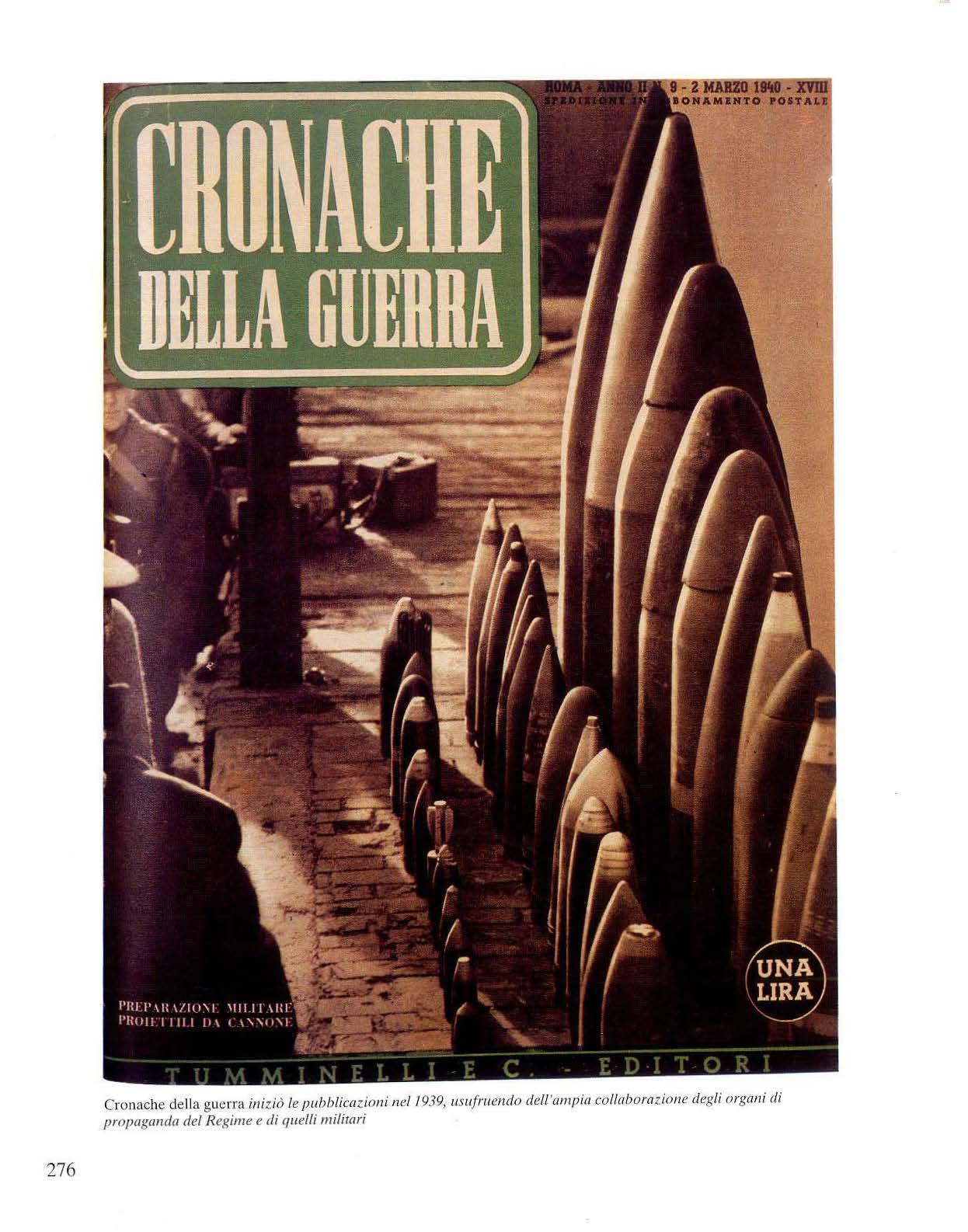
STA T O ffiA66 10R E o--
Quello c.he a'Jete fatto. Qu ell o c. he è st ato fatt o per IJ Oi. Que ll o c. he do bbiam o anc.or fare. MED/\GLI/\
gl i ero i 11o l o ntà e de l sac rifi cio so ll e\l ano su i raggiunti e conquis tali t er m i n i sacri ·la bandiera del l a Patria, nel lungo mar ti rio att esa da T ren to, che In essa si avvolge, stri n· gendola con filiale Impe to di passione al cuore. Nel fondo. qietro 1'1\rmata che pugnò fiera· mente, si profilano Il Pasubio, fulcro della sua resistenza e i l castello di Trenlo, la mèta , ,
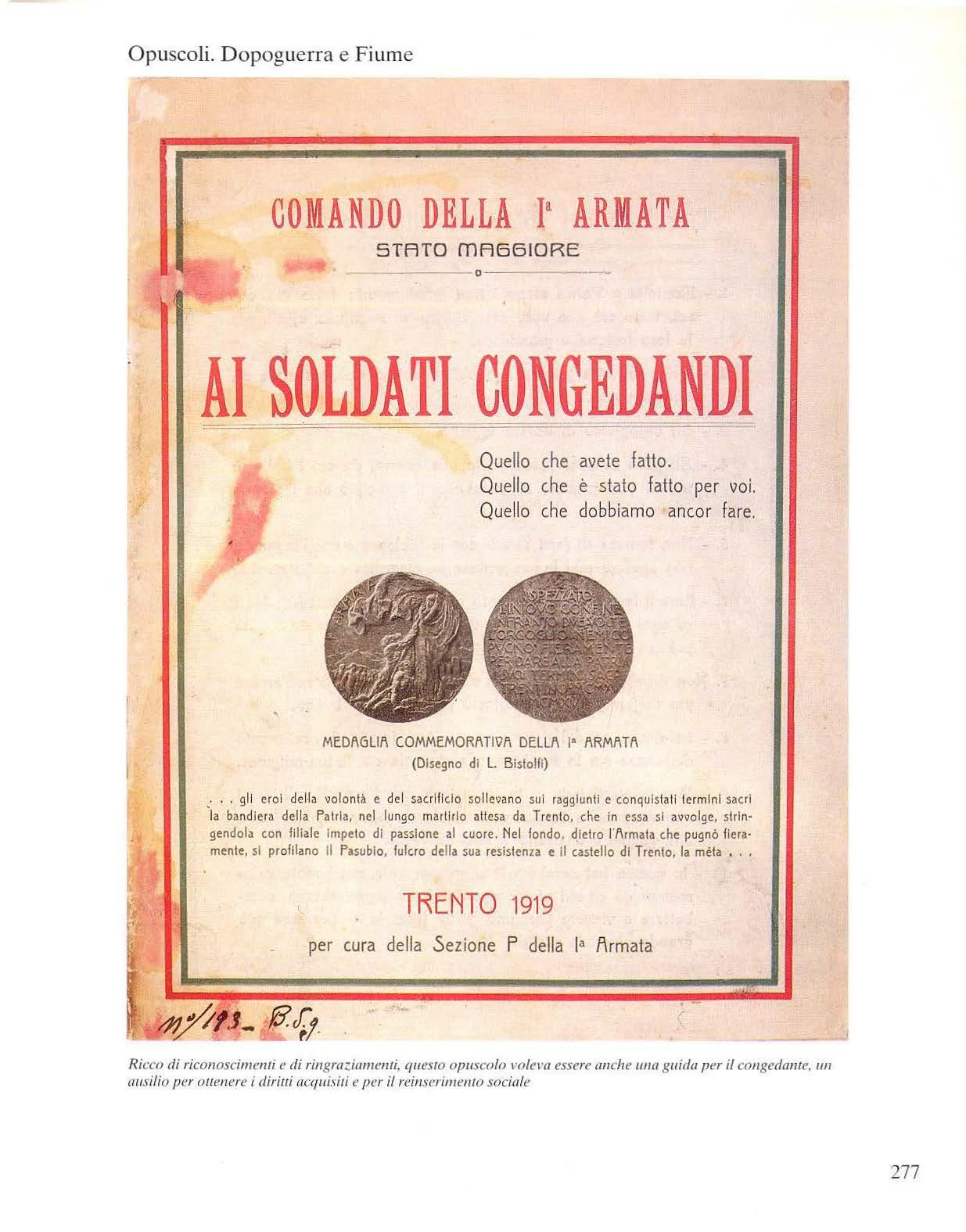
TRENTO 191 9
per c.ura della Sezione F della la f\ rmata . ........ (
Ricco di ricon oscim enti e di ring m::Jam enti, questo op usco lo vo le 1·a essere an ch e un a g uida p e r il con gedante, 1111 aus ilio per o u en ere i dir irti acquisili e per il reins erim ento sociale
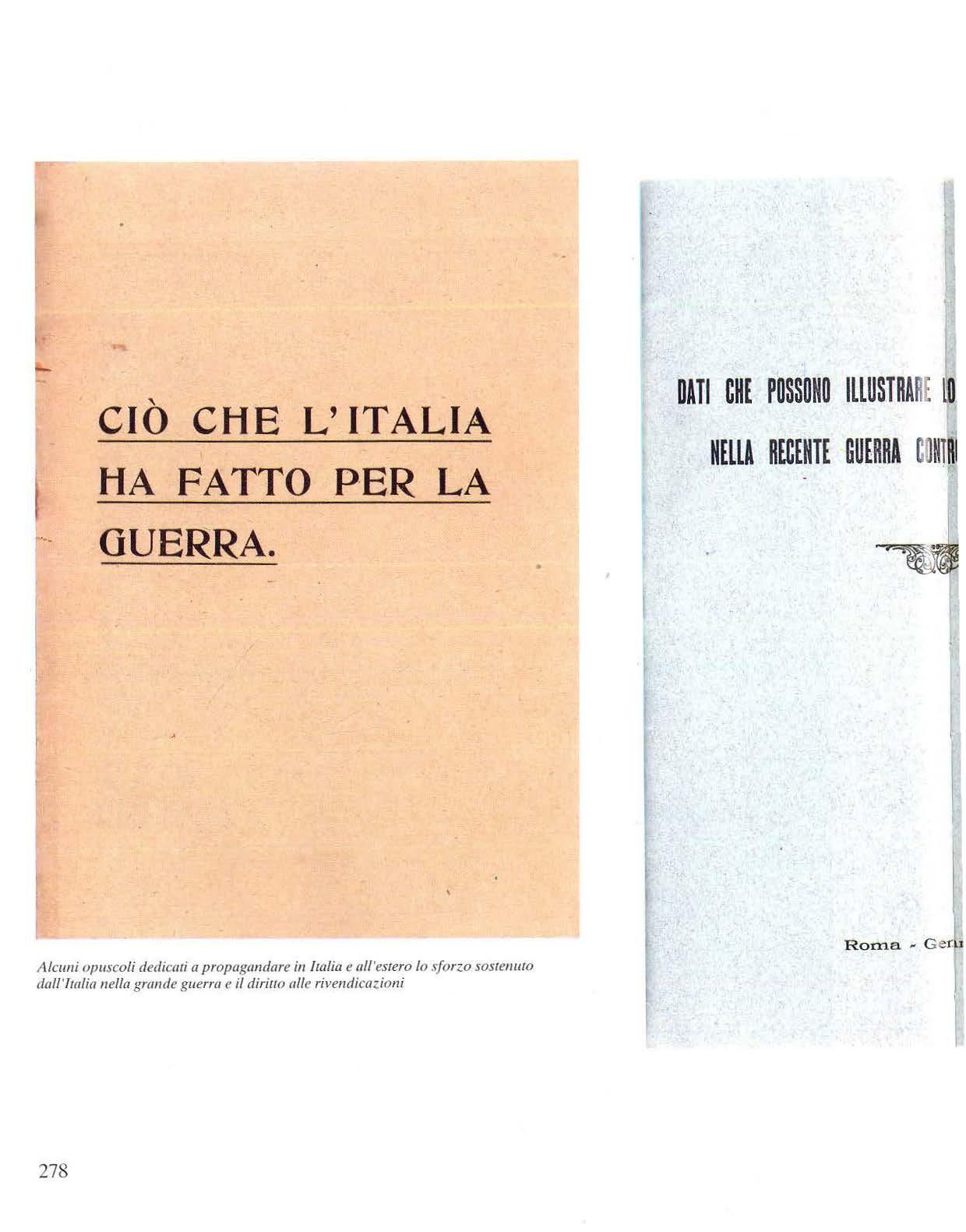
 l SfORZO fATTO DAlL' ITAliA · ·
l SfORZO fATTO DAlL' ITAliA · ·
Firmato da un anonimo iwlo-russo, l 'opuscolo conclude ch e «la ri volu zio ne oggi sarebbe la carestia, la fame, la rovina, la morte»
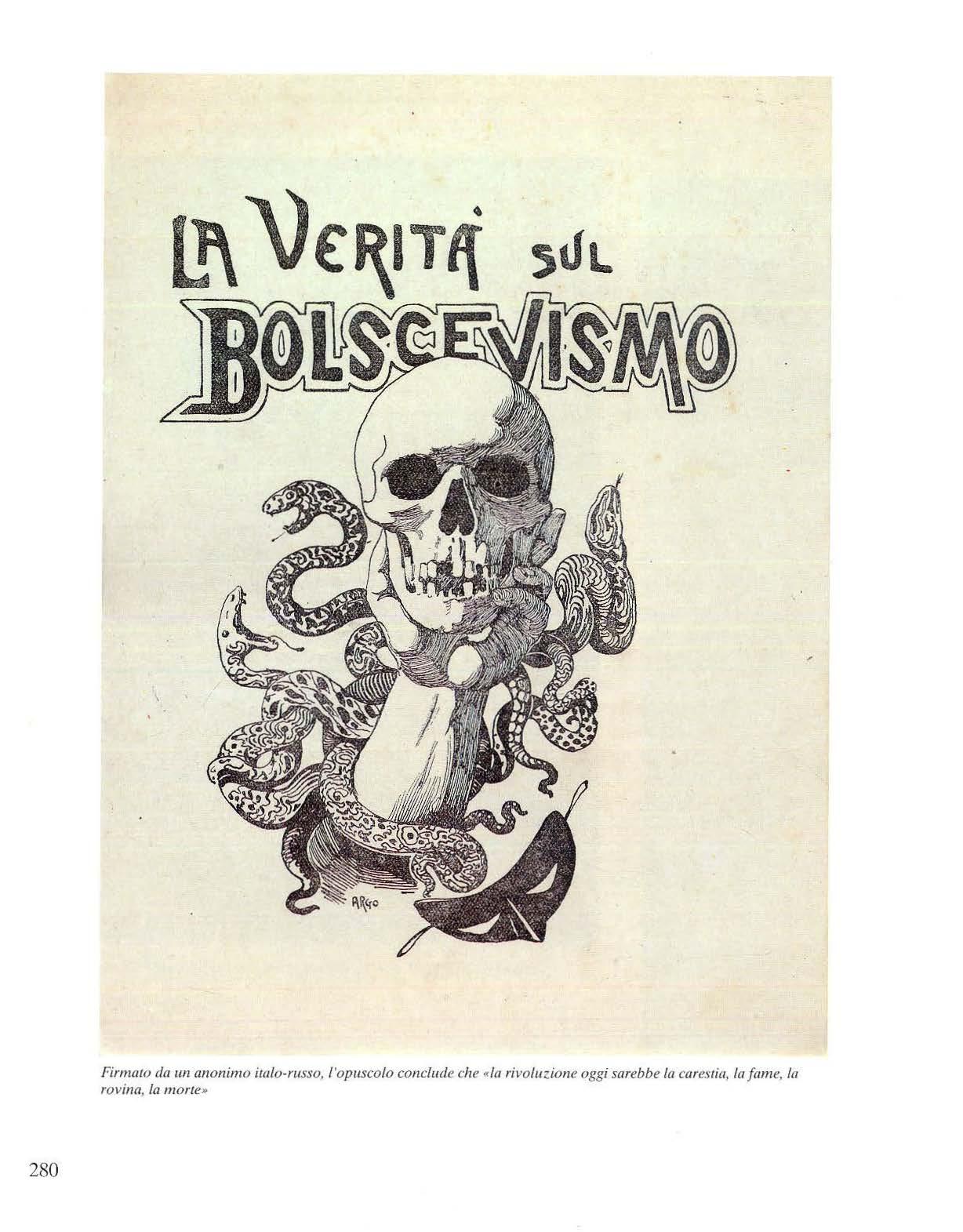
Sorro fo rm a di circolare, quesTO opuscoleuo edito dalla Se z ione Propaganda del Govemo de/fa Dalma zia forn isce consigli agli ufficiali sul comporramento da tener e pe r acquistare stima in un territorio difficile

Redauo dal cappellano m ili w re della Brigara Sesia, l'opuscolo magnifica l 'azione del 201 "e del202"reggimemo di fa m eria per Fiume
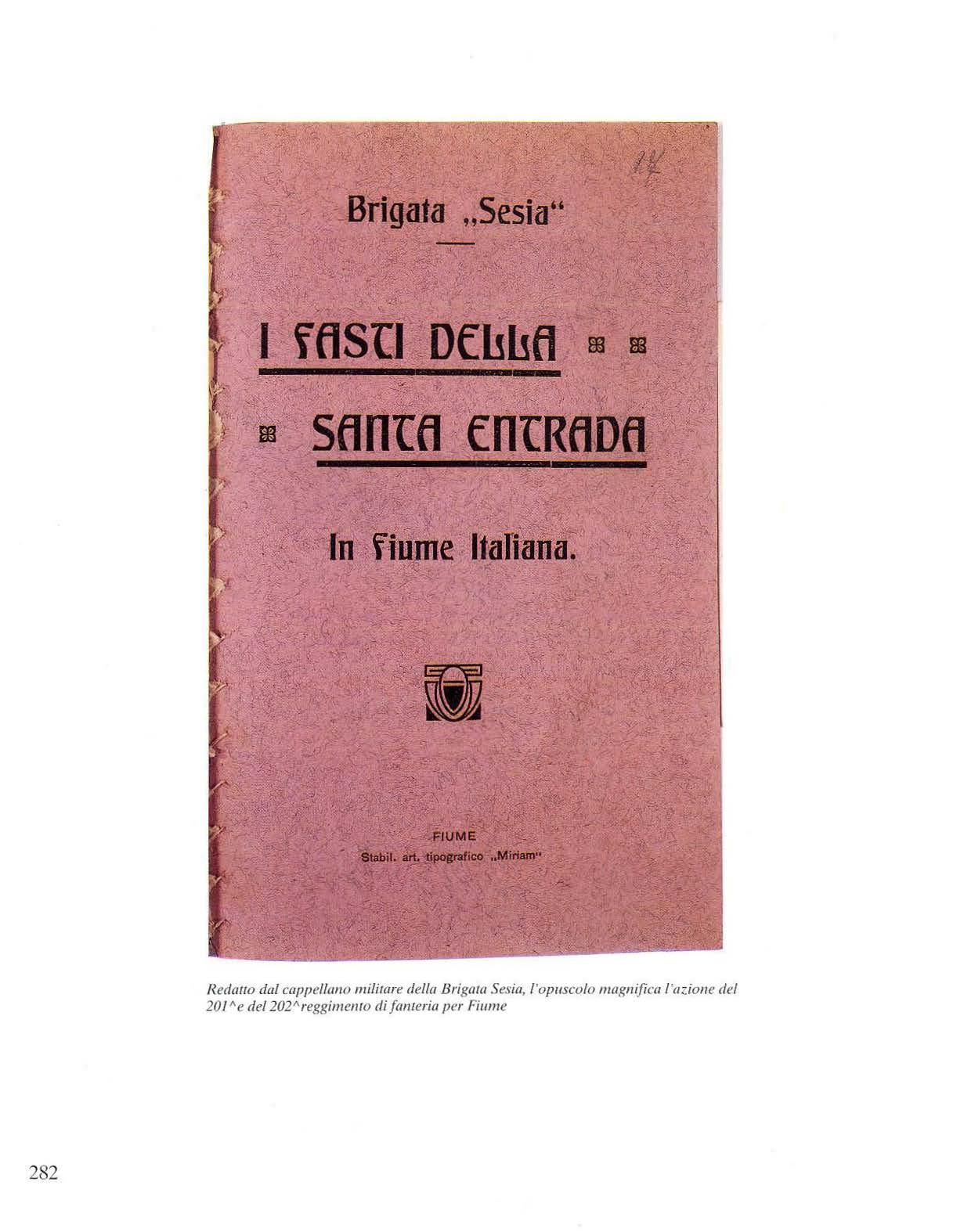
!n quesw pagina e n e lla seguell/e due opuscoli di propaganda <<storico -culturale » rea li :.:.a ti dall ' Ufficio Storico del Corpo di Stato Maggiore per ricordare i fasti della l A guerra mondiale
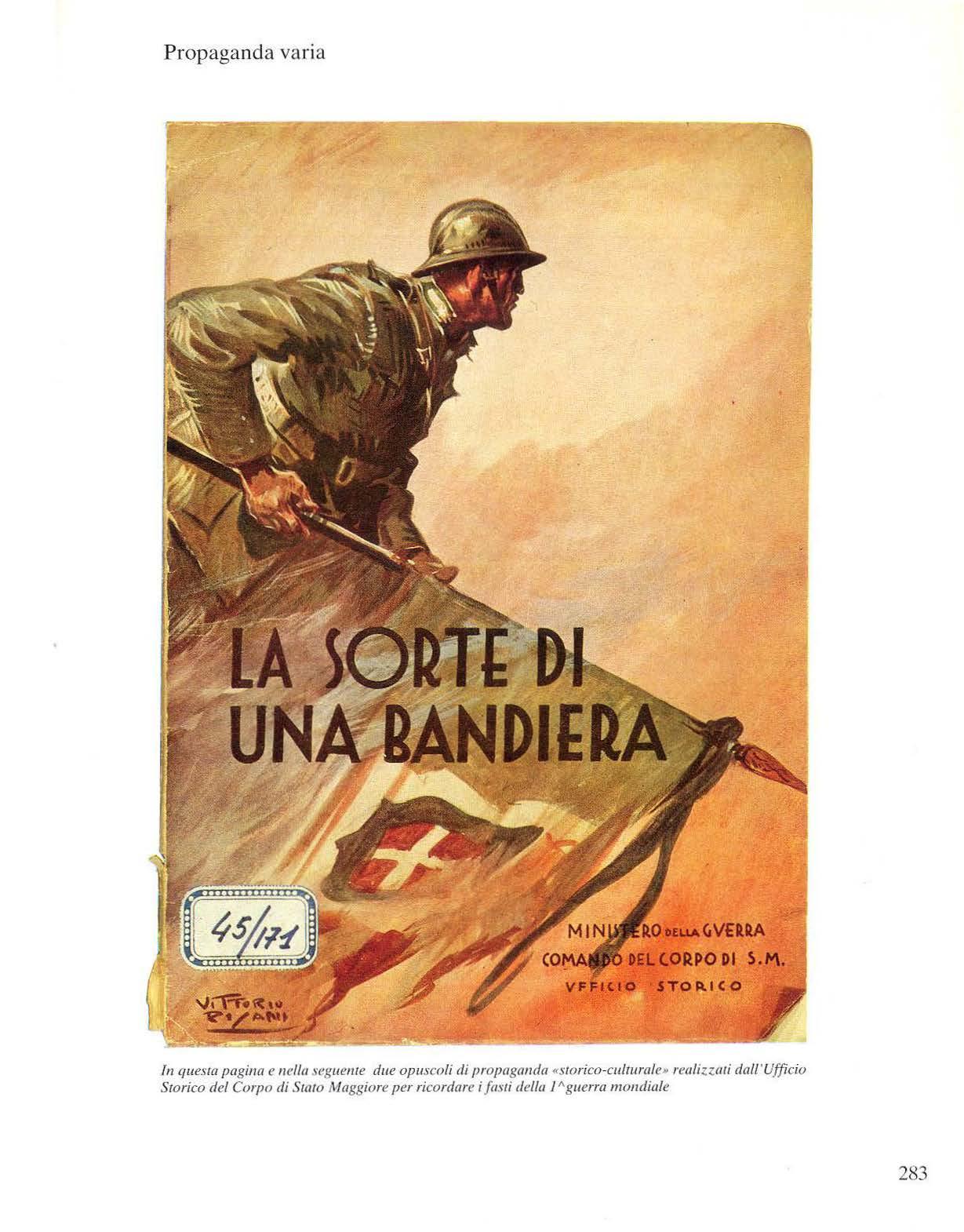
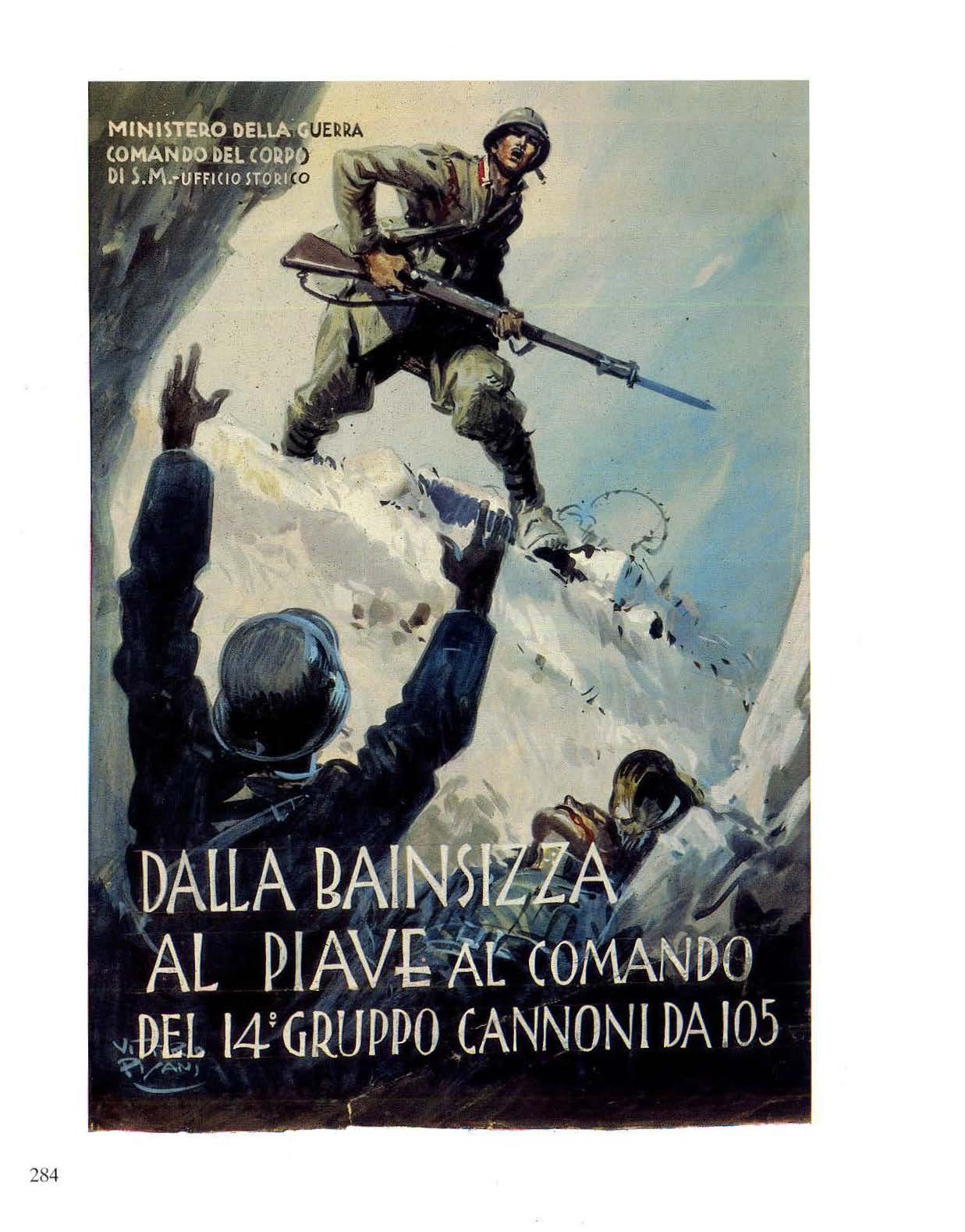
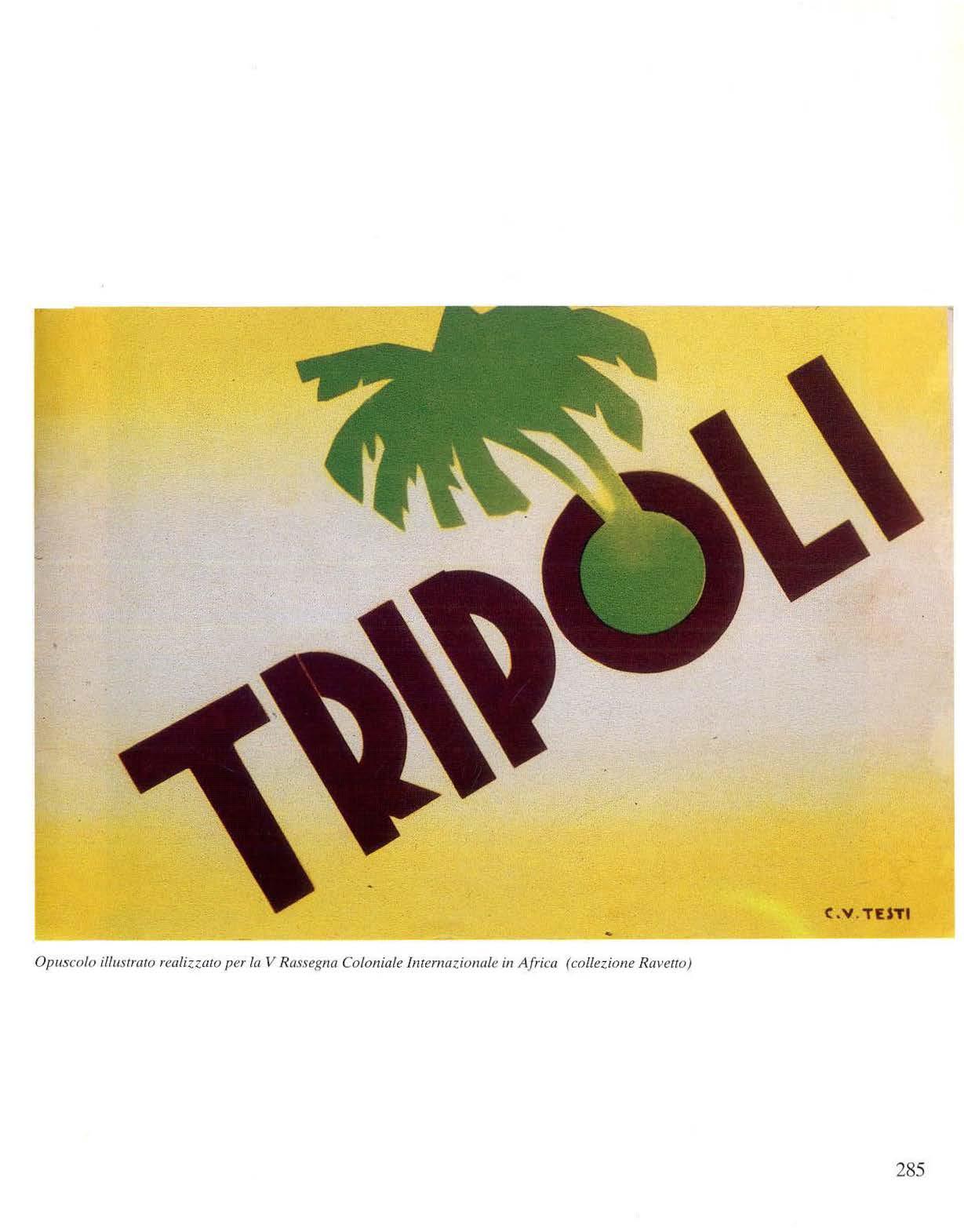

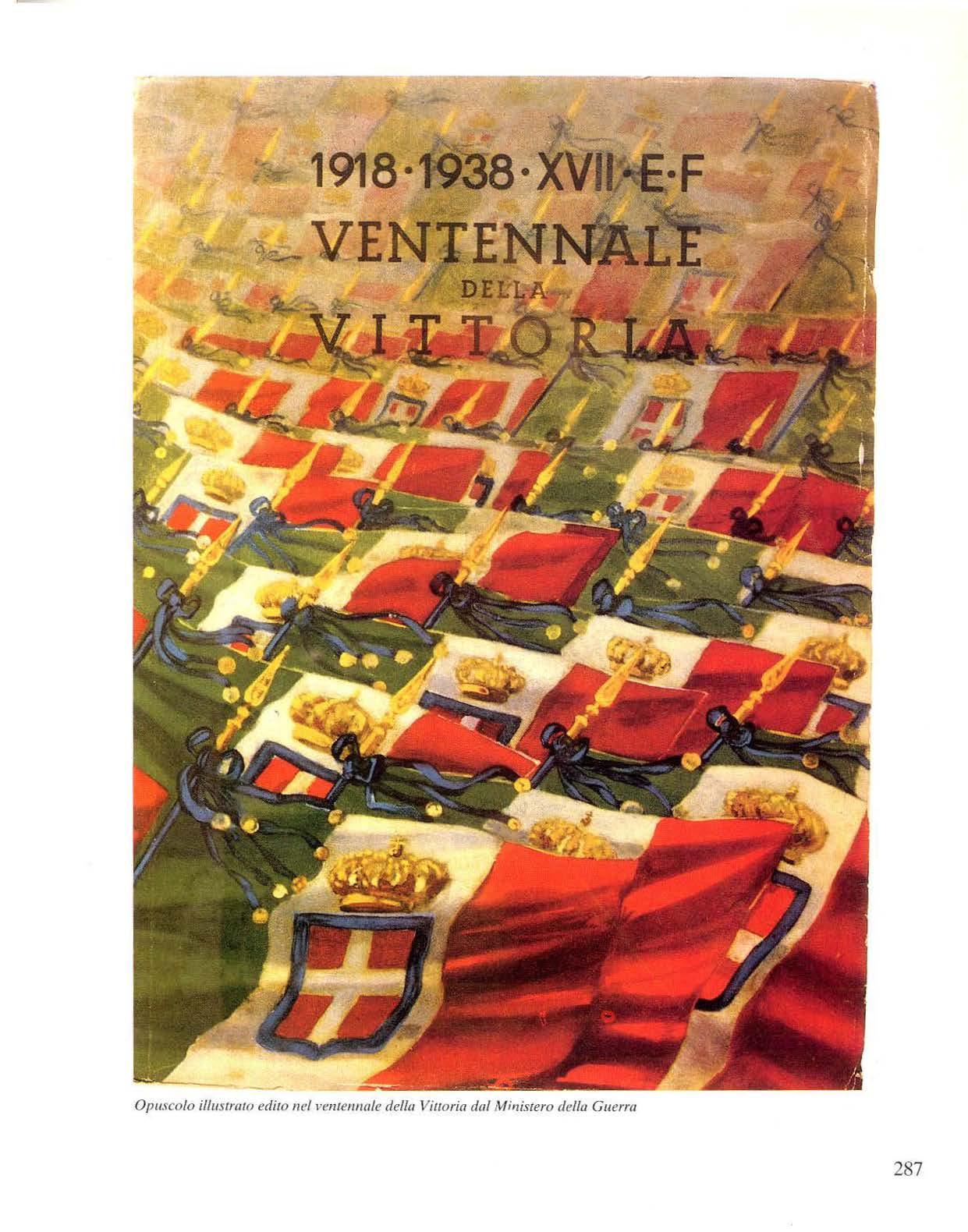
Opuscolo per la giornata ce le brati va dell'Esercito, con l 'organi z za zione della cerimonia ( Archivio Cenrra/e dello Stato, R o ma )
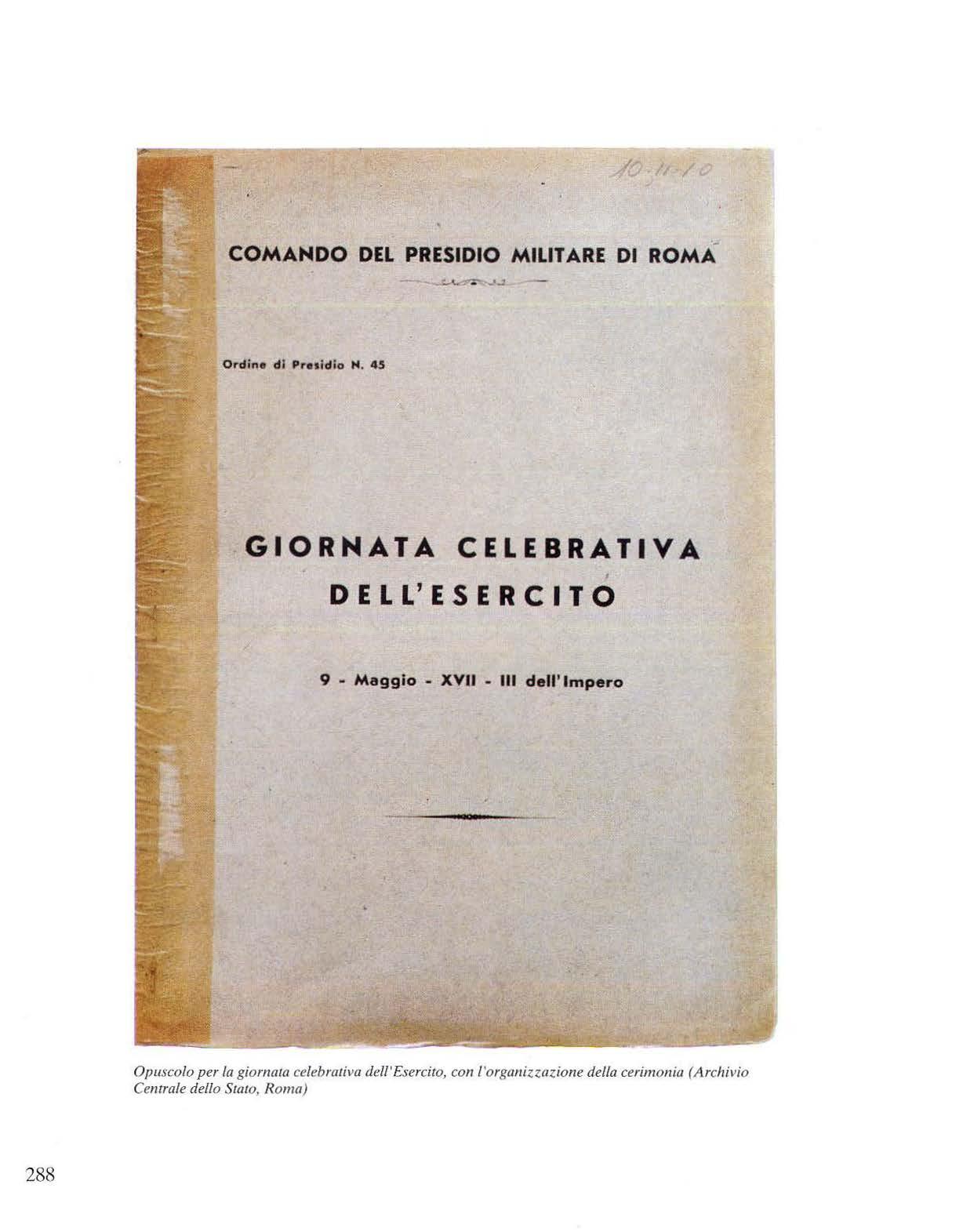

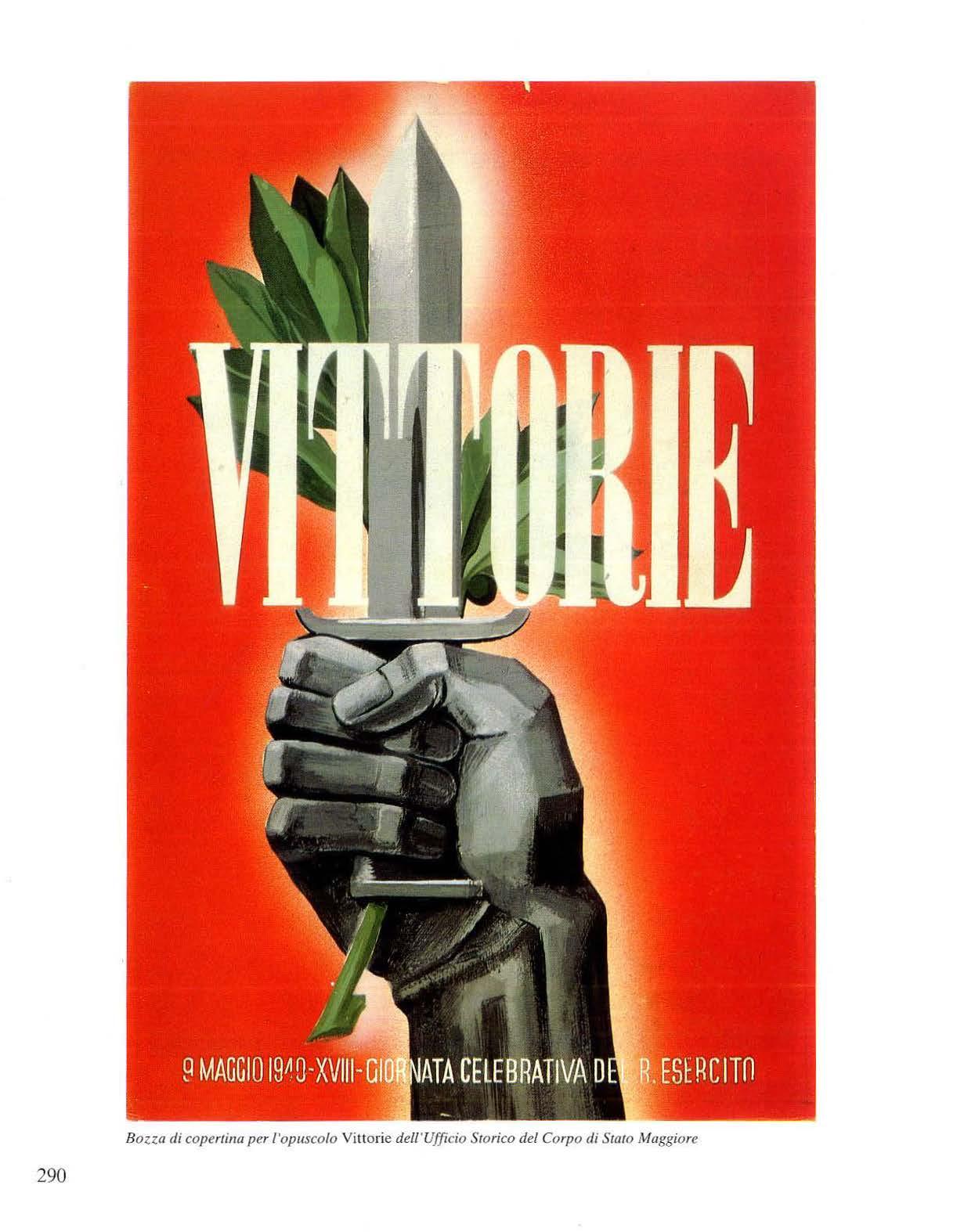

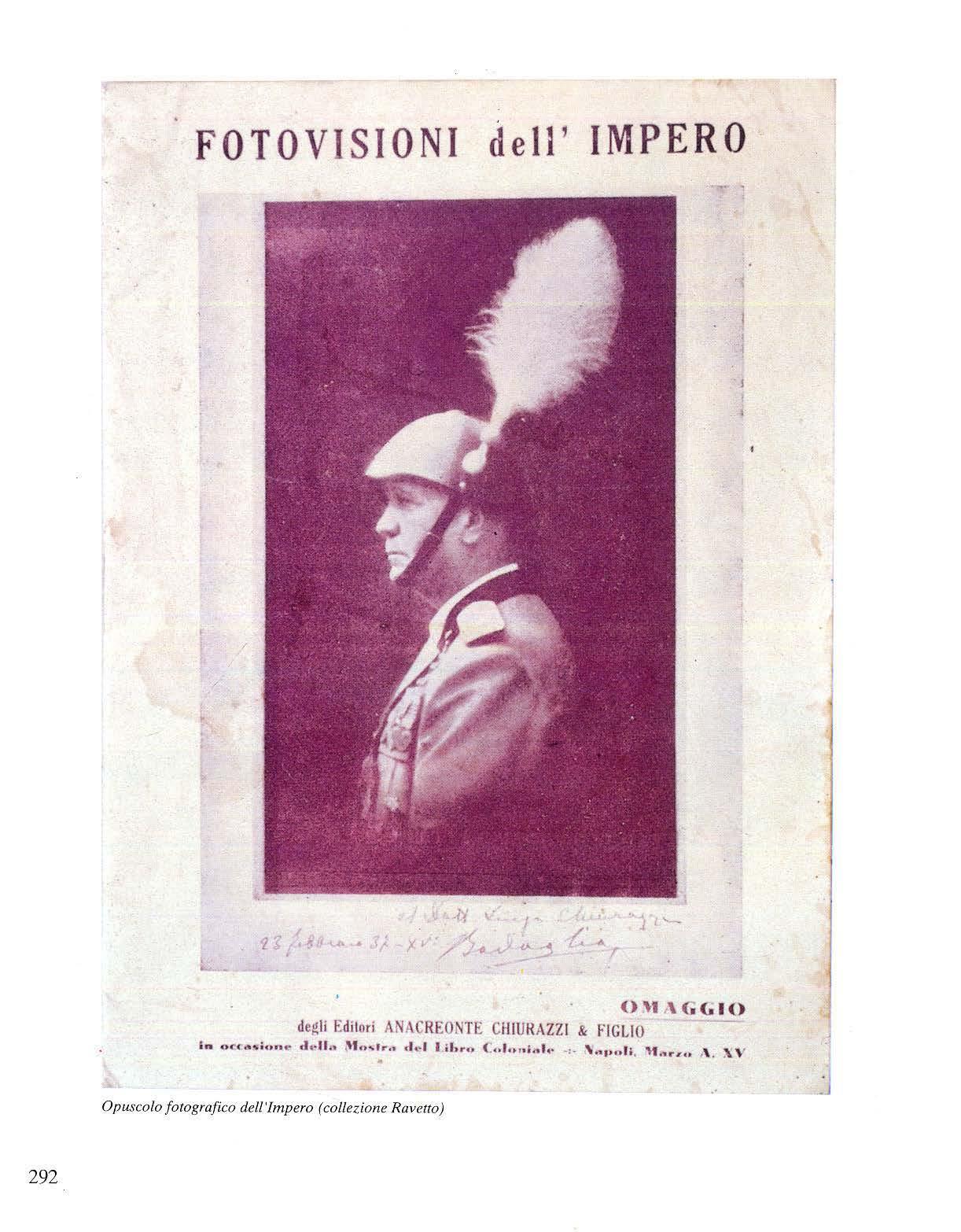
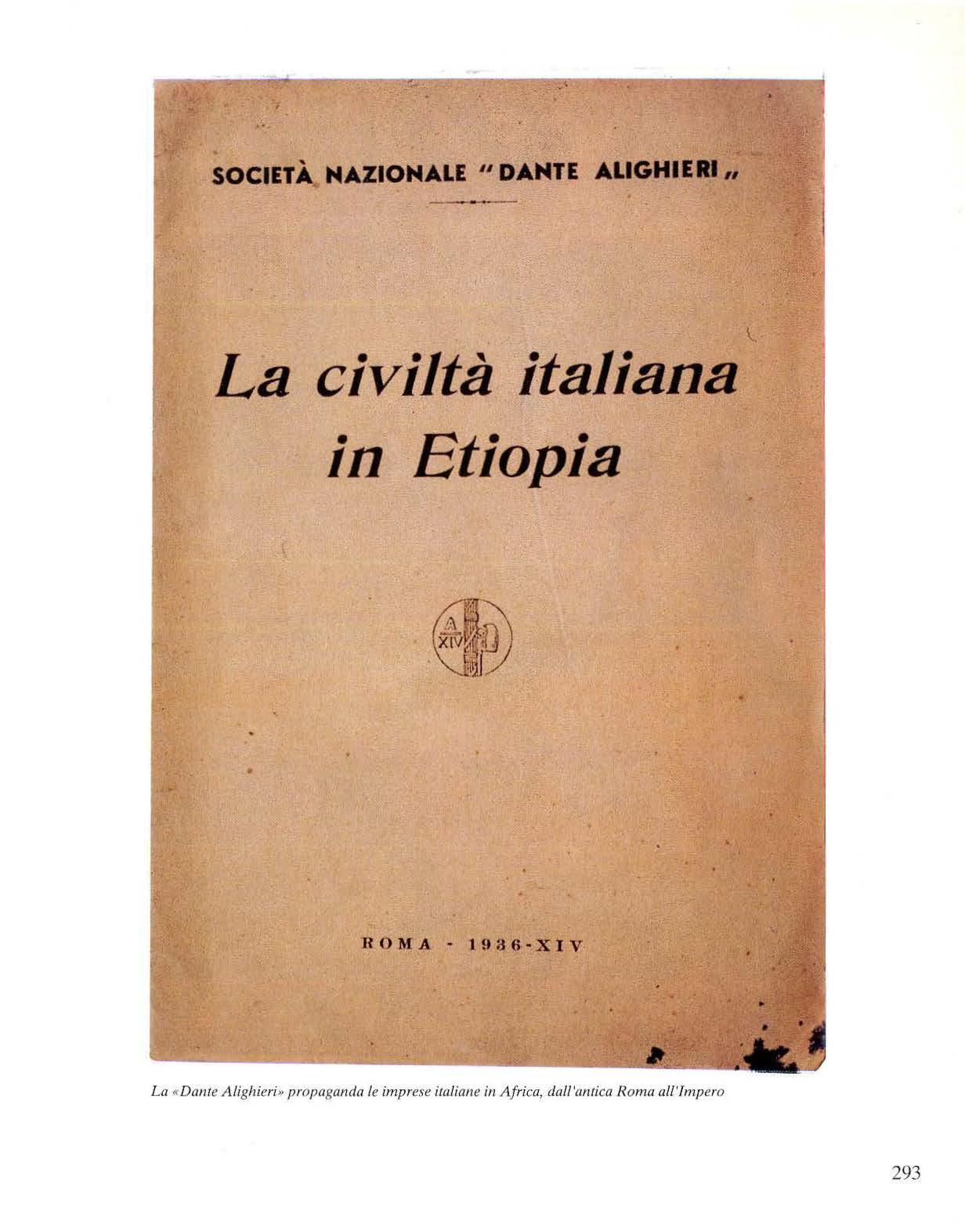
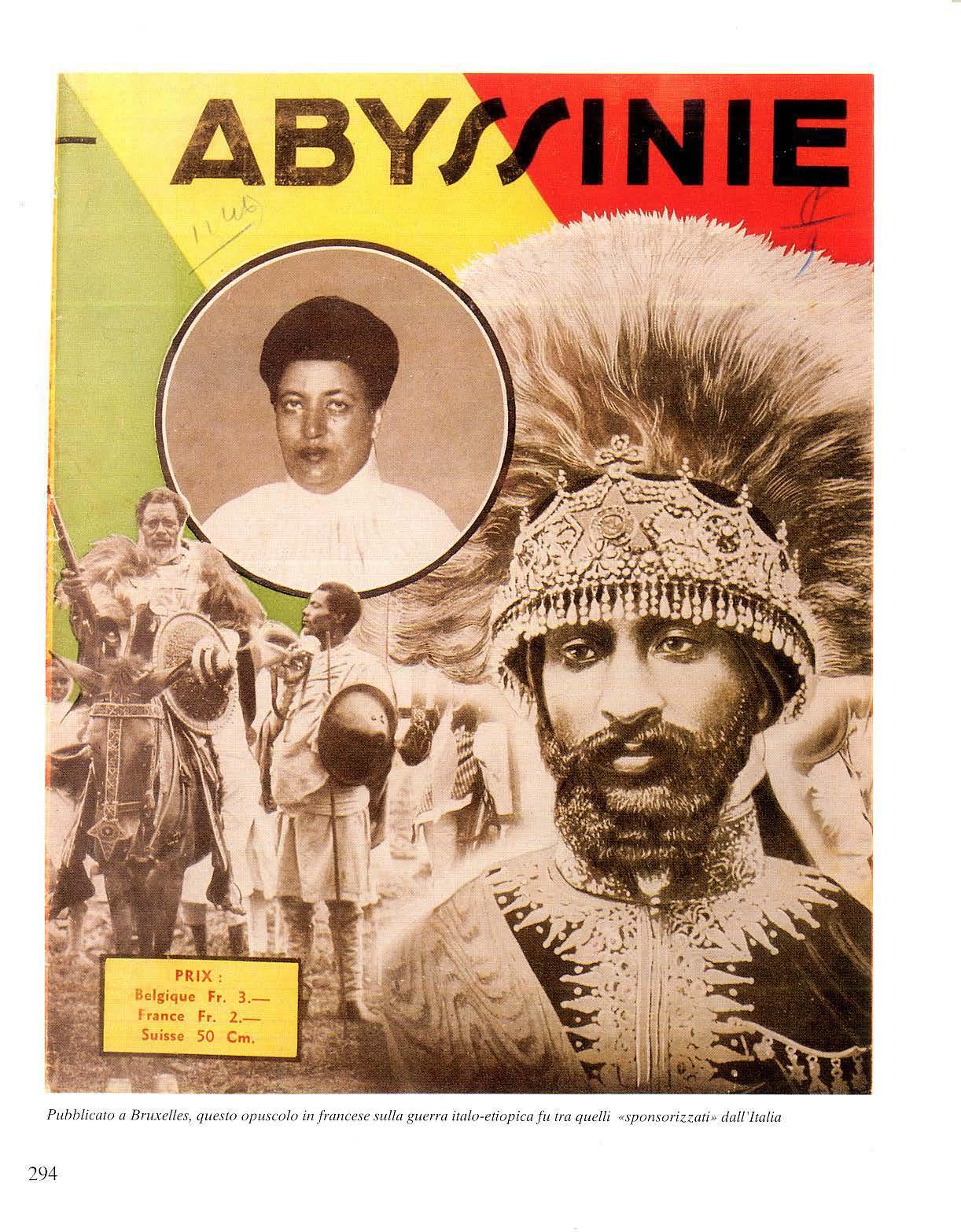
Anonimo, l'opusco lo spiega la n ecess ità dell'in tervento italian o
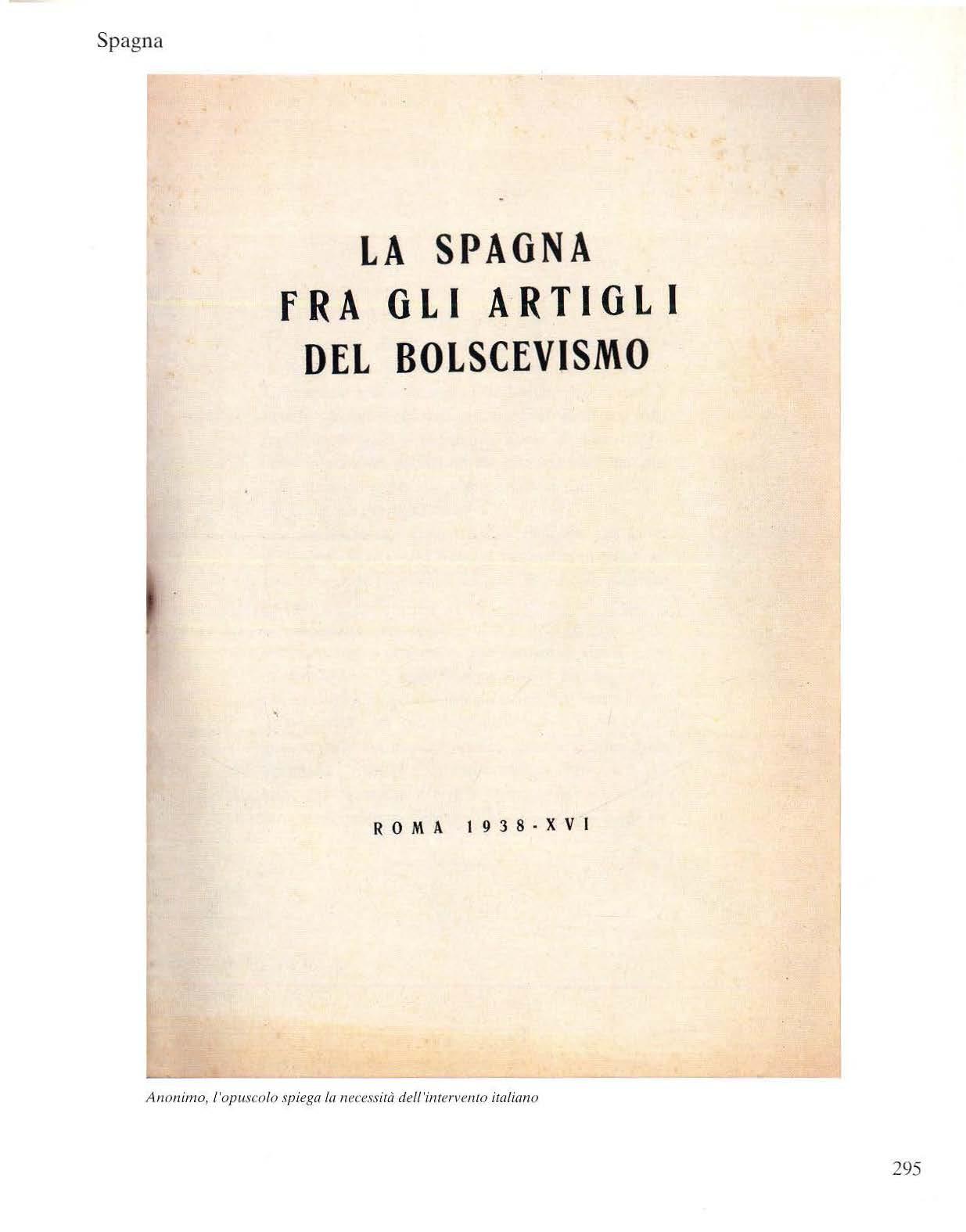
Palri6f i ca foao patriota aebe canfat' a &spafia (z.A EDIClON AUMENTADA) /
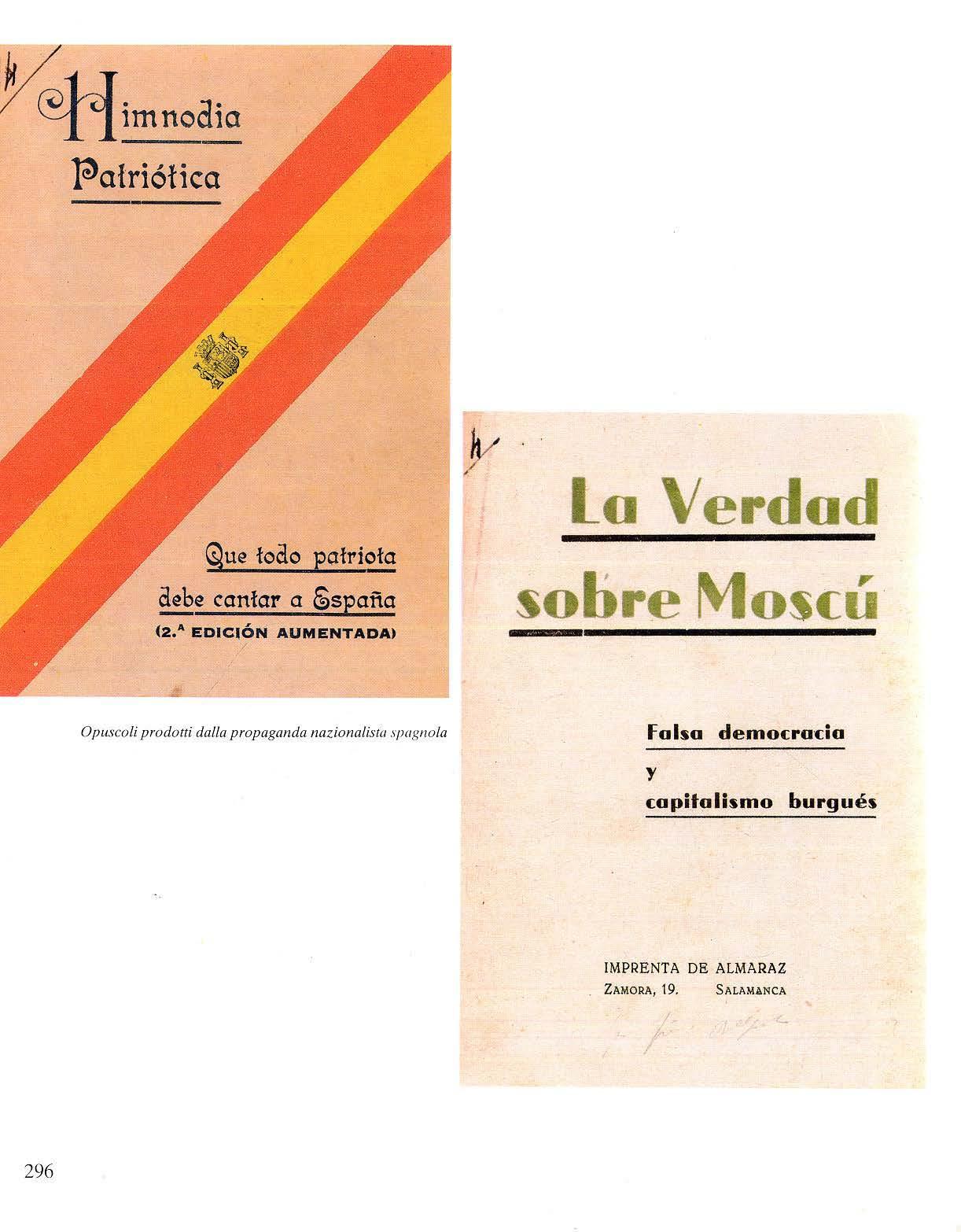
Opusco li pro d o tti dalla propaga n da na z i onalis ta spagnola
Folso democ:rodo )' c:opitolismo burgué s
IMPRENT A DE A LMARAZ ZAMORA, 19. SALAMANCA
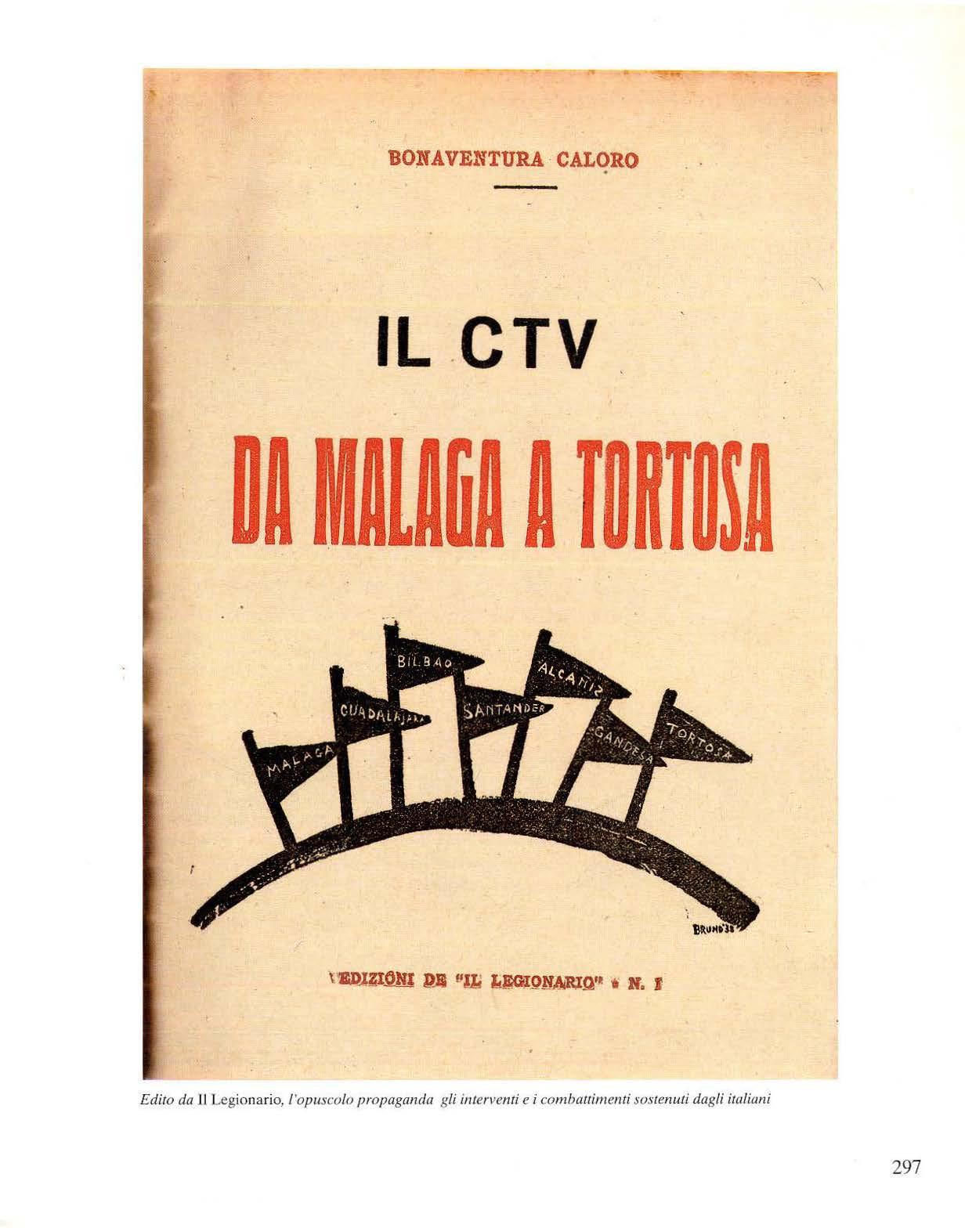
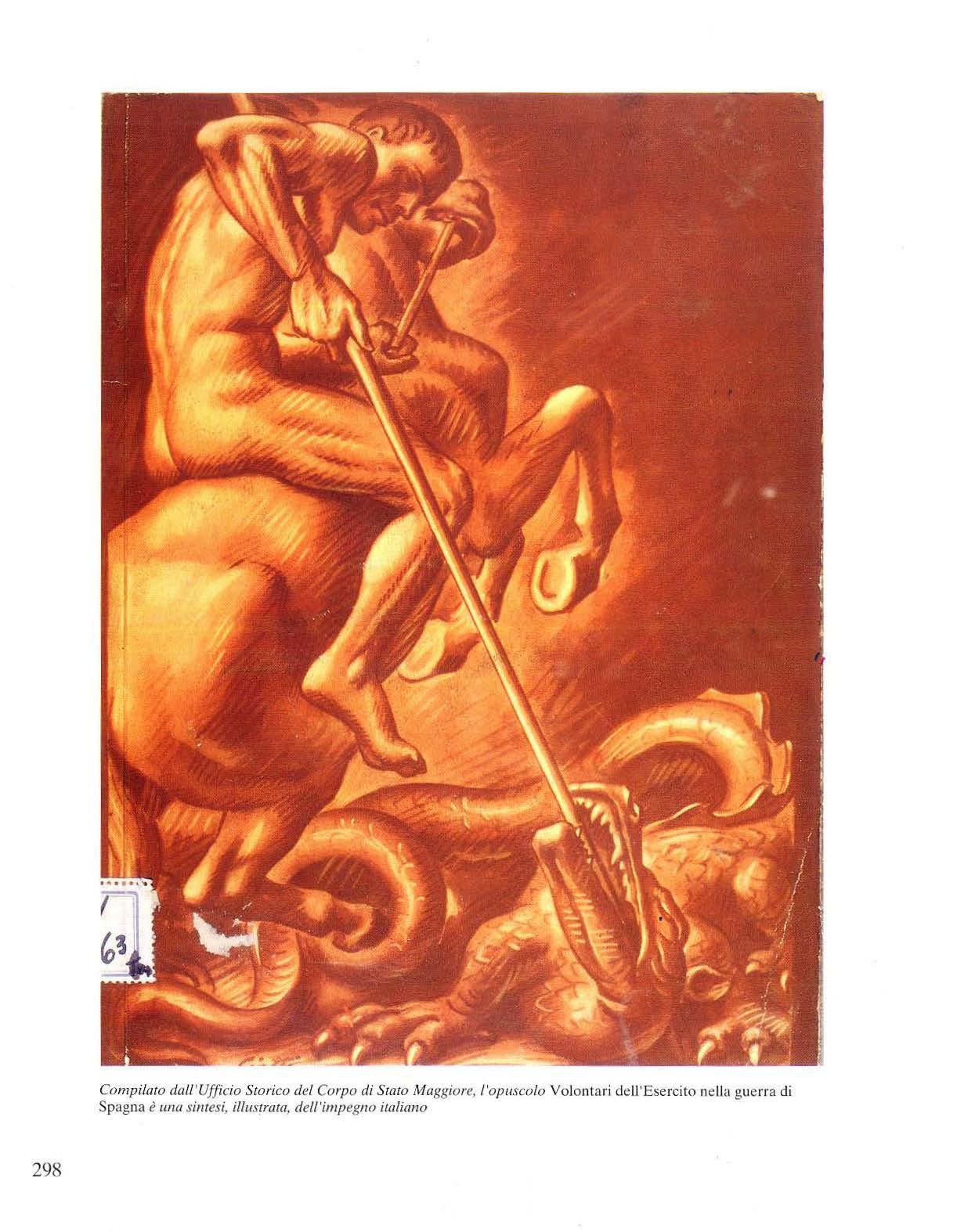
Tra scienza e propaganda, anche l'Istituto Geografico Militare vo lle testimoniare in qu esto o pus co lo il suo operato
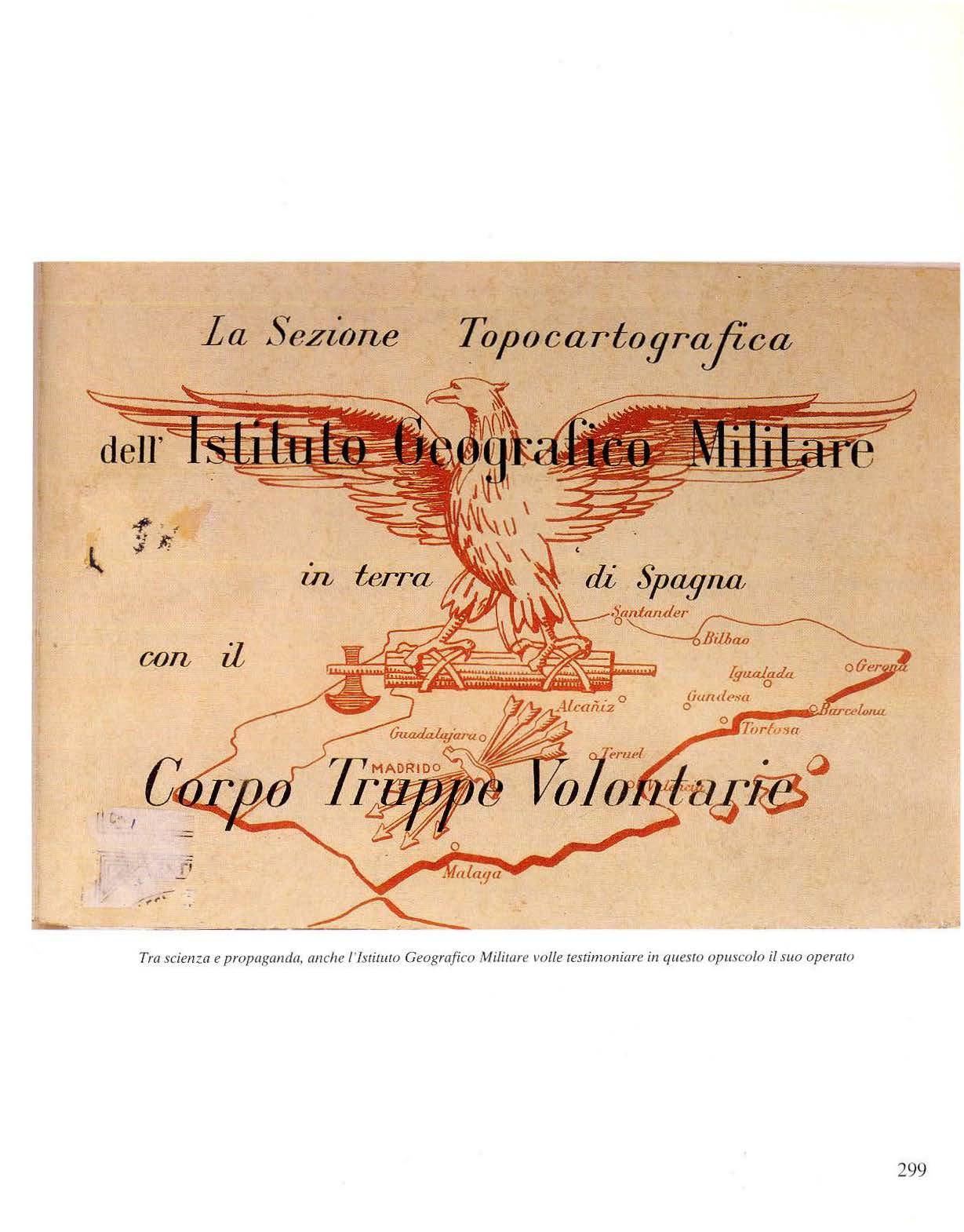


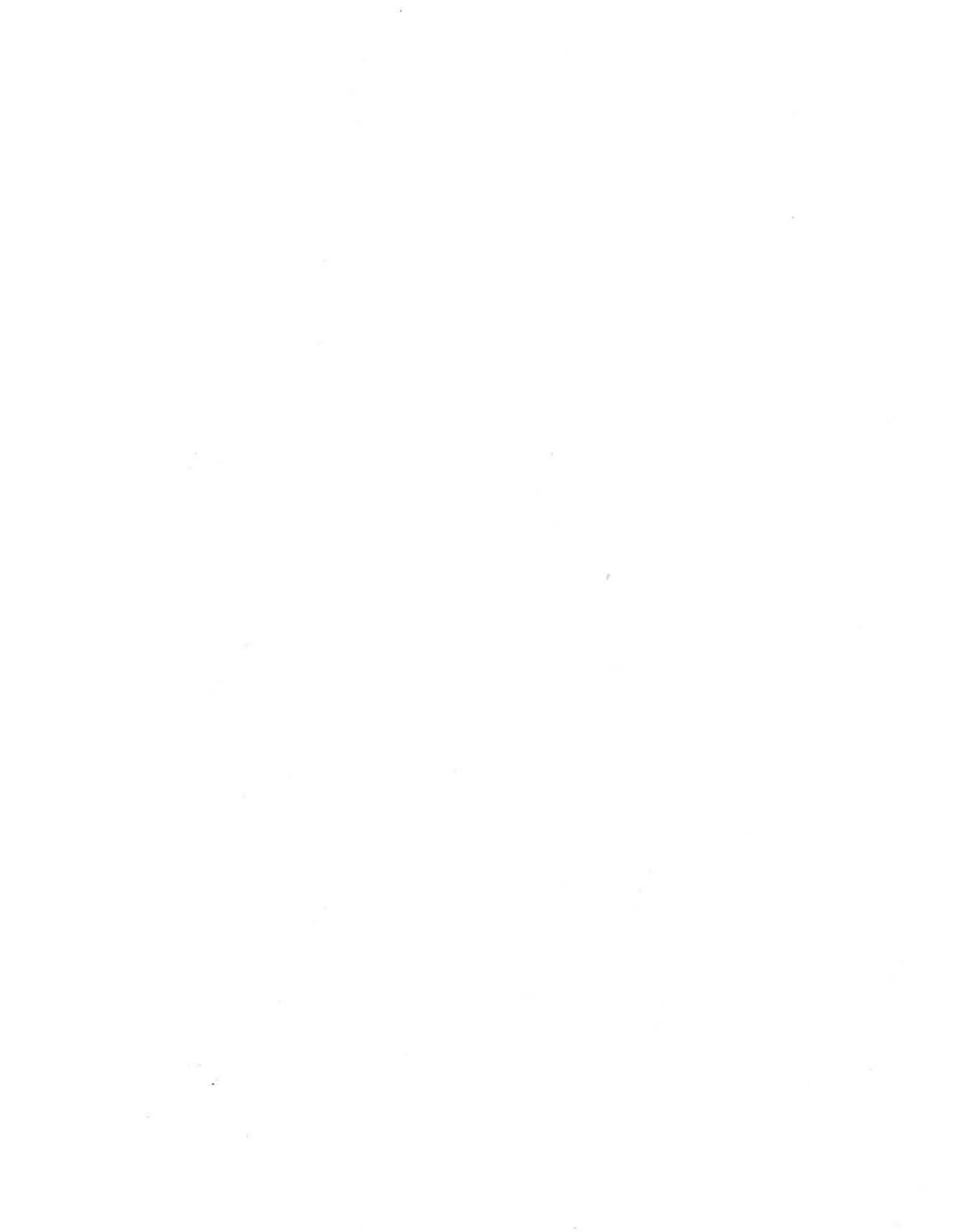 Avvertenze
Avvertenze
Molti studiosi della propaganda di guerra, e dei problemi storiografici e interdisciplinari ad essa connessi, hanno espresso il loro gradimento per la guida alle fo nti inserita nel volume precedente, Esercito e propaganda nella Grande Guerra Continuiamo, perciò, ad offrire loro questo strumento, ancor più con vi nti che possa servire, in misura maggior e delle note bibliografiche e docum e ntali , ad approfondire gli argomenti trattati nel volume.
La speranza, inoltre, è che la guida solleciti la curiosità intellettuale di storici e ricercatori, fino a spingerli a ricerche autonom e e a contributi che amplino la conoscenza della materia. O almeno, che essa possa servire a far conoscere una documentazione che abbiamo trovato per la maggior parte «intonsa» nell ' archivio dell ' Ufficio
Storico : segno che era sconosciuta a molti.
Per una più fac ile consultazione , la guida è ordinata per materia (storia e propaganda; cartoline; fotografie e cinematografie; radio; manifesti, volantini, scritte murali; stampa, giornali, riviste e opuscoli) e segue l'articolazione del testo.

Le fonti a stampa sono quelle essenziali; ci scusiamo , qui, per involontarie omissioni: troppi sono, infatti, i debiti contratti.
Le fonti documentali provengono quasi esclusivamente dall'Archivio dell ' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Nei pochissimi casi in cui si è fatto ricorso ad altri archivi, questi sono citati.
Le segnature sono dat e secondo il sistema in uso presso 1' Ufficio Storico; di ogni fondo v ie n e fatta una sintetica descrizione. Le fonti sono ripetute quando interessano più materie.
Raccolta Giornali Militari
Sono state consultate le annate dal1919 al1940. Raccolgono , a stampa, tutte le norme e le circolari relative all'Esercito e a] personale. Sono una fonte poliedrica, in cui è possibile trovare tutto , dall'ordinam ento, alle uniformi, alla propaganda , all'assistenza. Dai giornali militari sono state ricavate , tra le altre, le note sull'istituzione della Commissione Suprema Difesa e degli organi della propaganda. Diamo qui solo l'elenco delle principali materie consultate per ciascuna annata, nell'impossibilità di elencare tutte le circolari: - avanzamento; -corrispondenza d'uffic io e servizio postale e telegrafico; - disciplina militare; -leggi e decreti; . -ordiname nto dell'Esercito; - pubblicazioni militari; -reclutamento ; - sottufficiali; - stato degli ufficiali; - stipendi, assegni ed ind e nnità.
Raccolta delle circolari, registro M 7 Colleziona le disposizioni emanate dal Ministero della Guerra, dal Comando Supremo, dallo Stato Maggiore R. Esercito e dai Comandi di Grande Unità e Territoriali , dalla l a alla 2a guerra
mondiale. Le circolari trattano le materie più disparate. Sono stati consultati: - raccoglitore 151, cartella 1: provvedimenti di carattere generale per l'O.M.S. (Spagna, 1936-1937); -raccoglitore 154, cartella 13: sussidi per le famiglie dei militari in O.M.S. (Spagna, 1937); - raccoglitore 162, cartella 4: pensioni e sussidi O.M.S. (1938); -raccoglitore 170, cartella 3: diserzioni, denunce O.M.S. (1939); -raccoglitori 224-225: Reparti dello SMRE e Ufficio Segreteria e Personale; ' -raccoglitore 313, cartella 3: disposizioni sull'istruzione pre-militare; -raccoglitore 339: protezione antiaerea; -raccoglitore 408: Organi Centrali e SIM· ' - raccoglitore 550: disposizioni del Ministero della Guerra-Gabinetto.
Carteggio Sussidiario Guerra, registro L 14 Miscellanea di documenti di ogni genere, prodotti dagli Organi Centrali e dalle Grandi Unità; la docum en tazione copre l'arco di tempo ch e va dal19 18 al 1945. Sono stati consultati: - raccoglitore 18, cartella 8: norme per l'Ufficio Notizie alle fa migli e dei militari (1935-1938); -raccoglitore 29, cartella 1: protezione antiaerea, circolari delle confederazioni e delle federazioni
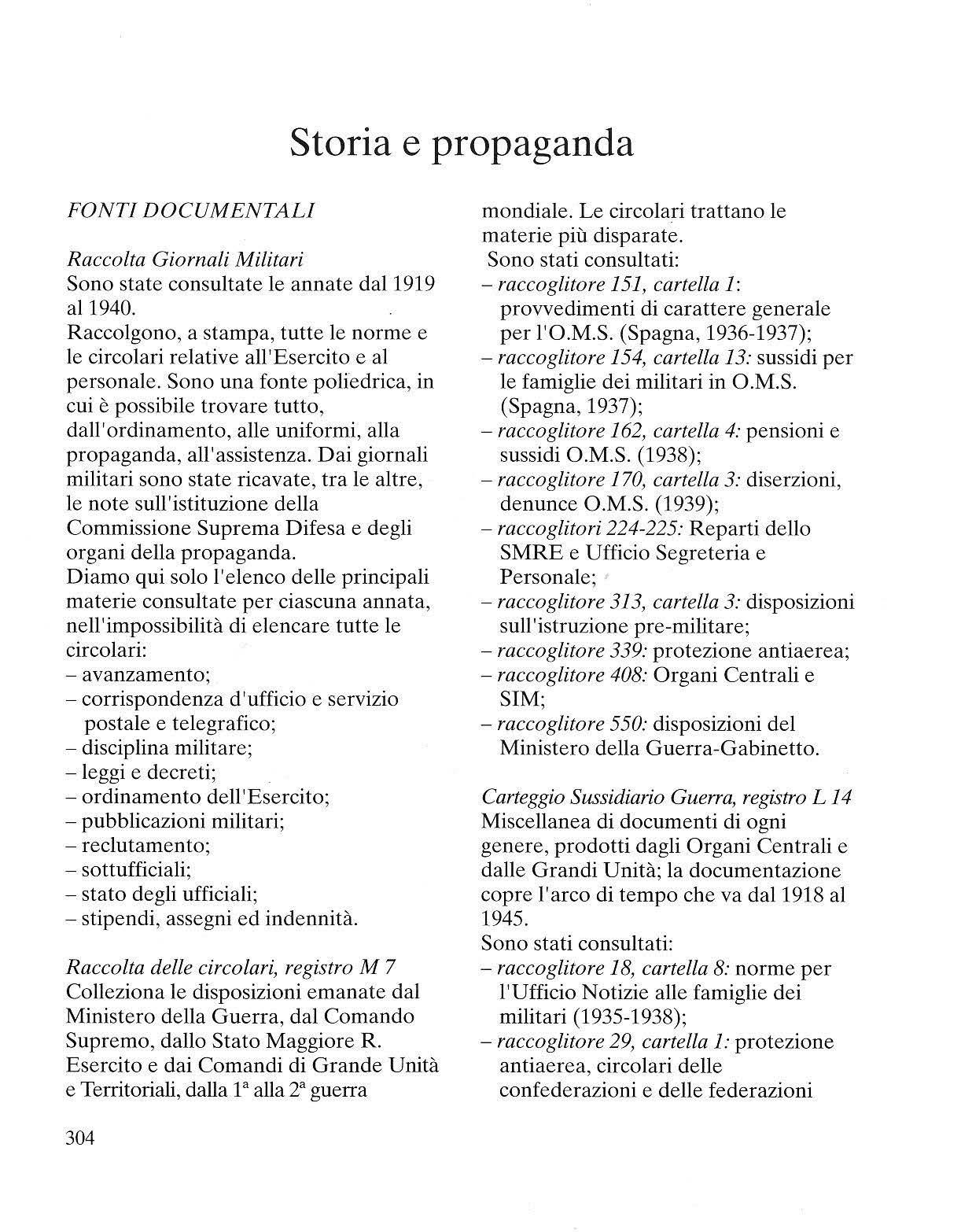
fasciste (1938); -raccoglitore 40 cartella 2: direttive dj polizia militare (1938); -raccoglitore 101, cartella 8: documentazione varia della Somalia (193 5-1936); - raccoglitore l 07, cartella l: provvedimenti riguardanti il m e ticciat o in A.O .I. ( 19 38-1940) .
Carteggio Libia, regis tro L 8 Vi sono tutti i documenti d e ll a g uerra italo -turca 1911-1912 (diari storici, carteggio s uss idiario e vario), con a ppendici deg li an n i venti c successivi. So no stati consu lt at i: - ra cc ogli rore l 75, cartella 9: lettere di Ca pi arabi (1929); -raccog litore 189, cartella 3/J: propaganda per gli arruolamenti n el R.C.T.C. (1926). .
Carteggio de ll o Stato Ma ggiore Regio Esercito, registro L l O Raccolta dei documehti prodotti degli Uffici dello Stato Maggiore dal 1923 al 1946, di particolare in teresse per l 'assistenza e la propagan da . - raccoglitore 3, ca rtella 1: attribu z ioni dell ' Ufficio Informazioni (1923); -raccoglitore 3, cartella 4: U fficio Affari Vari (1934-1937); - raccoglitore 3, ca rtella 5: Uffic io Affari Generali ( 193 4 -1940) ; - raccoglitor e 8, cartella 16: co r s i premilitari di special izzazione (19391940); -raccog litor e 21, cartella 6: doc um e nti dell'Ufficio Storico per la Mo st ra della Ri vo lu zione Fascista (1932 -
1933): -raccoglitore 41, cartella 3: informazioni politiche interne (1925-1926): -raccoglitore 41, carre/la 4: propaganda antifascista (1926 -19 27); - raccoglitore 41, cartella 5: situazione politico-militare (1927 -1929); - raccoglitore 41, cartella 6: antifascismo fra gli uffici al i (1927 -1931 ); -raccogli/ore 42, cartella 3: propaganda a nti fasc ista (1930-1931): - raccoglitor e 68, cartella 17: predispo s izioni per la propaganda (1940).
Carteggio dello Swto Maggiore Generale e del Comando Supremo, registro l 4 Mi s cell anea di documenti rccuperati n e l dopoguerra presso vari uffici dello Stato Maggiore: i documenti sono disparati e vanno dal 1924 a11948: molti riguardano la stampa c la propaganda. Sono stati consu l tati: -raccoglitore 64, cartella 3: propaganda anti -i taliana in Jugo slavia (1926 - 1928): - raccogiitore 66. cartella l 0: servizio informa zion i (1931 - 1934): - raccoglitore 67, cartella 2: istr uzion e pre e pos t-militare - raccoglit ore 68, carrello 6: situazione politica ed app rontam ento m i litare (1937); -raccoglitore 69, cartella 5: revoca delle dispen se c ritardi d e l servizio militare (1939).
Carteggio Ordinamenro e Mobi/iwzione, registro F 4 Oltre a raccogliere documenli ordinativi e di mobili taz ion e . qu esto fo nd o

conse rva di tutto, dal 1860 circa fino alla 2"guerra mondiale; è una vera miniera. Sono stati consultati: - raccoglitore 304, cartella 14: domande eli sussidio; - raccoglitore 209: questioni inerenti alla s mobilit azio n e (1918-1919); - raccoglitore 2 l 0: ordine pubbl ico nel l o dopogu e rra; - raccoglitore 306, cartella l 4: doma nd e eli sussidio; - raccoglitore 306, cartella 15: documenti pe r la Mostra della Rivolu zione Fascista: - raccoglitore 309: organici de ll 'Esercito.
Carteggio della Commissione lnteralleata di Parigi, registr o E 8 Co ntiene i documenti prod o tti dagli organi militari inviati a Parigi ed è est remament e interessante per lo stud i o dell'assetto politico-militare dell ' Europa nel dopogu erra. Una parte del fondo è dedicata alla sta mpa e alla propaganda. Di esso sono s tati consultati: - raccoglitore 289, cartella 2: notizie internazionali (1920); - raccoglitore 290, cartella l: pro pagand a s ovversiv a co ntro l'ltalia (t919); - raccoglitore 29 1, cartella 3: propaganda sovvers i va (1919); - raccoglitore 291, cartella 4: in fo rm azioni var ie; - raccoglitore 292: stampa e propaganda.

Car teggio dei Corpi di Sp ed i zione e di Occupazione, r egistro E 3 ll fondo r accog li e t utti i documenti dei Co rpi all 'este ro dall897 al1922; eli particolare interesse sono qu e lli eli Fiume, d e ll a D a lmazia , d e ll a Francia,
dell ' Alt a S lesia, dell 'Anato li a . Sono stati consu lt at i: -raccoglitor e 12, cartella 4: raccolta circolari c disposiz i oni per le po lizze ai combattenti (Fiume 1919); - raccoglitore l 3, cartella 2: c i reo lari e dispo s iz ioni relative a sussid i. , premi . indennità e pens ioni (Fiume 19191920);
-raccoglitore 9, cartella 1: spirito delle truppe e bo ll ett ini Ufficio I.TO. (Dalmazia 1919); - raccoglit ore l 9, cartella l: v is i te di personalità (Dalmazia 1919); - raccoglitore l 9, cartella 3: propaga n da italiana in Dalmazia (1919); - raccoglitore 20, cartella 7: propaganda << italofil a» d a parte d e ll a Fra ncia (Dalm azia 1918-1919): - raccoglitore l , cartella 1: morale e propagand a in Francia (T.A. I.F. , 1918): - raccoglitore 73: lettere ano nime sullo sta to delle truppe (Alta Sles ia , 1920); - raccoglitore 17, cartella l: manifesto comunista, in tedesco (A lta Slesia, 1920);
-raccoglitore 2 4, cartella 1: medaglie ricordo (Alta Slesia) ; - raccoglitor e 32, cartella 2: propaganda e informazio ni (A lta Slcsia); - raccoglitore 3, cartella 5c: propaganda e ll enica co ntro l ' Italia (Anatolia 1919); - raccoglito re l O , cartella 5c: riordinamento Ufficio In fo rmazioni di Smirne (A n ato lia 1919): -raccoglitore 12, cartella 4: co ndi zion i e situazioni degli it alia ni a Co nia (Anatolia 1919); -raccog litore l 3, cartella 2a: propaganda
inglese contro l'Italia nel Dodecann e so (Anatolia 1919) ; - raccoglitore 74, cartella 2b: propaganda e spionaggio di ufficiali greci contro l'Italia (Anatolia 1919); - raccoglitore 17, cartella 3c: censura e interpreti (Antolia 1921) ; - raccoglitore 19, cartelle l e 2: propaganda greca e inglese (Anatolia 1919-1920); - raccoglitore 25, cartella 2a: organico del Corpo di Sp e dizione (Anatolia); - raccoglitore 25, cartella 5a, c: censura (Anatolia) .
Carteggio del Gabinetto Guerra, registro Hl
Ricco di documenti politico -militari, soprattutto per il periodo 1940-1945. La documentazione parte, comunque, dal 1924; nelle carte, da questa epoca, vi sono alcuni docum e nti di int e resse per la propaganda e la stampa. Sono stati consultati: - raccoglitore l, cart ella 14: questione ebraica, espatri clandestini (1938); -raccoglitore 2, cartella 6: autarchia (1938-1940); - raccoglitore 2, cartelle 7 e 13: manifestazioni per il ventennale della Vittoria (1938); - raccoglitore l O, cartella 2: organizzazione della Nazione per la guerra; -raccoglitore 12, cartella 17: esami per le scuole regg imentali.
Carteggio del Capo del Governo, registro H 9 Il fondo raccoglie le corrispondenze

(appunti , circolari, lettere , promemoria , relazioni) tra il Ministero della Gu e rra , i vertici militari e Mussolini, dagli anni trenta al1943. Sono documenti di estremo interesse, che a volte testimoniano la diversità degli atteggiamenti e delle opinioni, in pubblico e in privato , dei Capi. Sono s t ati consultati: - raccoglitore 2: relazione al Duce sul morale delle truppe (1938); - raccoglitore 4: appunto per la Giornata del Soldato (1939); appunto per la Giornata Celebrativa dell'Esercito (1939); appunto sulla propaganda tedesca in Ungheria (1939); cerimonia per il rimpatrio dei legionari dalla Spagna (1939); penetrazione tedesca in Jugoslavia (1939); richiamo alle armi dei confinati politici (1939); appunto sulla propaganda (1939); relazione su incidenti per i richiami alle armi (1939); conferenza sulla preparazione alla guerra totalitaria; - raccoglitore 5: promemoria sul vitto del soldato (1939); disposizioni del Duce sul miglioramento rancio (1939); promemoria per il vestiario e l ' equipaggiamento (1939); promemoria per volontari per la F inlandia (1939); -raccoglitore 6: promemoria per la Befana del Soldato (4-1 -1940); - raccoglitore 7: soppressione di riviste, parate e cerimonie (30 -1 -1940); scambio informazioni militari con la Gran Bretagna (17-2-1940).
Carteggio Sussidiario A . O.l. della guerra italo -etiopica, registro D l
Carte prodotte dagli Organi di Comando Centrali e autorità varie, in Italia e in Etiopia, relative a tutte le attività connesse con la guerra dell9351936.
Sono stati consultati: - 8, cartella 5: nuovi stabilimenti <<antisanzionisti» per ovviare alla deficienza di materie pnme; -raccoglitore 14, cartella 4: atteggiamento ostile delle missioni protestanti svedesi in Eritrea, Somalia, Abissinia; . - raccoglitore 14, cartella 24: documentazione dell'eccidio al cantiere Gondrand; - raccoglitore 16, cartelle 22-37 -38: imboscati, renitenti, riformati; -raccoglitore 19, cartelle da l a 5: esoneri e dispense; - raccoglitore 20, cartelle 2 -3: raccomandazioni, direttive ed istruzioni per gli ufficiali e la truppa ; - raccoglitore 20, cartella 5: propaganda sovversiva fra le truppe partenti per l'A.O.; -raccoglitore 43, cartella 12: ufficiali per gli uffici censura; - raccoglitore 46, cartella 1: ufficiali rimpatriati; - raccoglitore 54, cartella 23: sottufficiali e truppa rimpatriati; - raccoglitore 55, cartella 3: igiene e profilassi, case di tolleranza; - raccoglitore 56, cartella 16: norme igieniche per le truppe in A.O.; - raccoglitore 94, cartella 7: propaganda disfattista tra le truppe; - raccoglitore 97, cartella l : soccorsi
giornalieri alle famiglie; - raccoglitore 99, cartella 4: spacci cooperativi per i reparti in A. O.; - raccoglitore 99, cartella 7: reclami per il pagamento dei sussidi; - raccoglitore 99, cartella 8: agevolazioni per i militari e le famiglie ; -raccoglitore 101, cartella 4: trattamento economico per le famiglie di mobilitati e Caduti in A .O.; - raccoglitore 101, cartella 5: offerta di denaro per i militari; - raccoglitore l 08, cartella 3: lettere anonime; -raccoglitore l 08, cartella 6: militari sovversivi, autolesionisti; - raccoglitore l 08, cartella 8: contegno dei militari; -raccoglitore l 08, cartella 9: circolare sulla preparazione militare; - raccoglitore l 09, cartella 6: circolare s ulla cura del soldato; -raccoglitore l 09, cartella l 0: espatri clandestini di giovani soggetti al richiamo; -raccoglitore l 09, cartella 14: corsi di rappresentazioni artistiche; - raccoglitore 11 O, cartella 5: esposti e reclami· ' - raccoglitore 121, cartella 2: Servizio Informazioni, propaganda; - raccoglitore 128, cartelle 1-2-3: Servizio Informazioni, denunce alla Società delle Nazioni delle vicende etiopiche ; - raccoglitore 149, cartella 127: censura; - raccoglitore 160, cartella 256: spacci cooperativi per le truppe; -raccoglitore 161, cartella 277: autolesionismi; - raccoglitore 163, cartella 283:

propaganda per le truppe;
- raccoglitore 167, carte lla l 27: censura; - raccoglitore 171, ca rte lla 270: norme igie niche per le trupp e A.O ; - raccoglitore 171, cartella 277: au t oles ioni smi; - rac coglitore 173, carte lla 296: assistenza religiosa; - raccoglitore 174, ca rte lla 330: Ufficio Notizie; - raccoglitore 180, carte lla 296: assistenza religio sa ai militari israeliti.
Carteggio Sussidiario d e i Corpi d'Annata in A. O.!., regis tro D 5 Oltre alle carte o p erative (diari storici) , i Corpi d 'A rmata produsse ro carteggi accessori di varia natura durante la g u erra italo -etiopica. Sono tali documenti quelli più importanti, per compre ndere gli stessi avven imenti politico- militari c le attività propagand istich e. Sono stati consultati: - ra ccog litore 14, ca rre /la 5 g: disciplina; - raccoglitore 16, cartella 5: stralcio del notiziario giornali e ro del Comando Superior e A.O. -Uffic io I (19351936); - raccoglitore 20, cart e lla 8: sottomi ss ioni , denunc e di danni (19351939); - raccoglitore 21, cartella 10: spionaggio c controspionaggio; - raccoglitore 22, carte lla l: relazioni s ull'organ izzazion e pol itico-mi litar e nei territori occupati. (1936); - raccoglitore 22, cartella 9: censura della corrispo n denza (1935-1936); - raccoglitore 24, cartella 5: uccisione di
indigeni; - raccoglitore 24, ca rtella 6: stampa e propaganda (1935 - 1936); - raccoglitore 25, carte lla 1: relazione sull ' attività svolta all'Ufficio Informazioni, con foto (1935 -1936 ); - raccoglitore 27, carte lla 4: morale dell e truppe; - raccoglitore 27, ca rte lla 6: propaganda s ovversiva (1935 -1936 ); - raccoglitore 28, cartella 1: stampa c propaganda; - raccoglitore 32, cart e lla 4:assistenza sanitaria, igien e c profilassi; - raccoglitore 47: di sciplin a ufficiali e truppa: Milizia ( 1935-1 936): - raccoglitore 48, ca rt e lla 4: incidenti (1935 - 1936); - raccoglitore 48, ca rte lla 5: feste e saluti; - raccoglitore 50, car t e lla 3: assistenza morale e materi a le alle truppe, pratiche varie; - raccoglitore 52, cartella 3: saluti e augu ri. circolari varie; - raccoglitore 57, ca rtella 4: spacci cooperativi per soldat i: - raccoglitore 62, carte lla 2: disciplina: - raccoglitore 64, car te lla 6: infezioni e profilassi , disposiz ioni; - raccoglitore 65, cartella 6: ordini del giOrno; - raccoglitore 67, cartella 3d: cura e vigi lanza sui reparti indigeni ; - raccoglitore 71, c artella 9: eccidio al cantiere Gondrand ; - raccoglitore 83, carte lla 0: guerriglia, informazioni , dis er tori , popolazi one indigena; - raccoglitore 98, ca rt e lla 5: corrisponde n za ce n s urata e protocollo
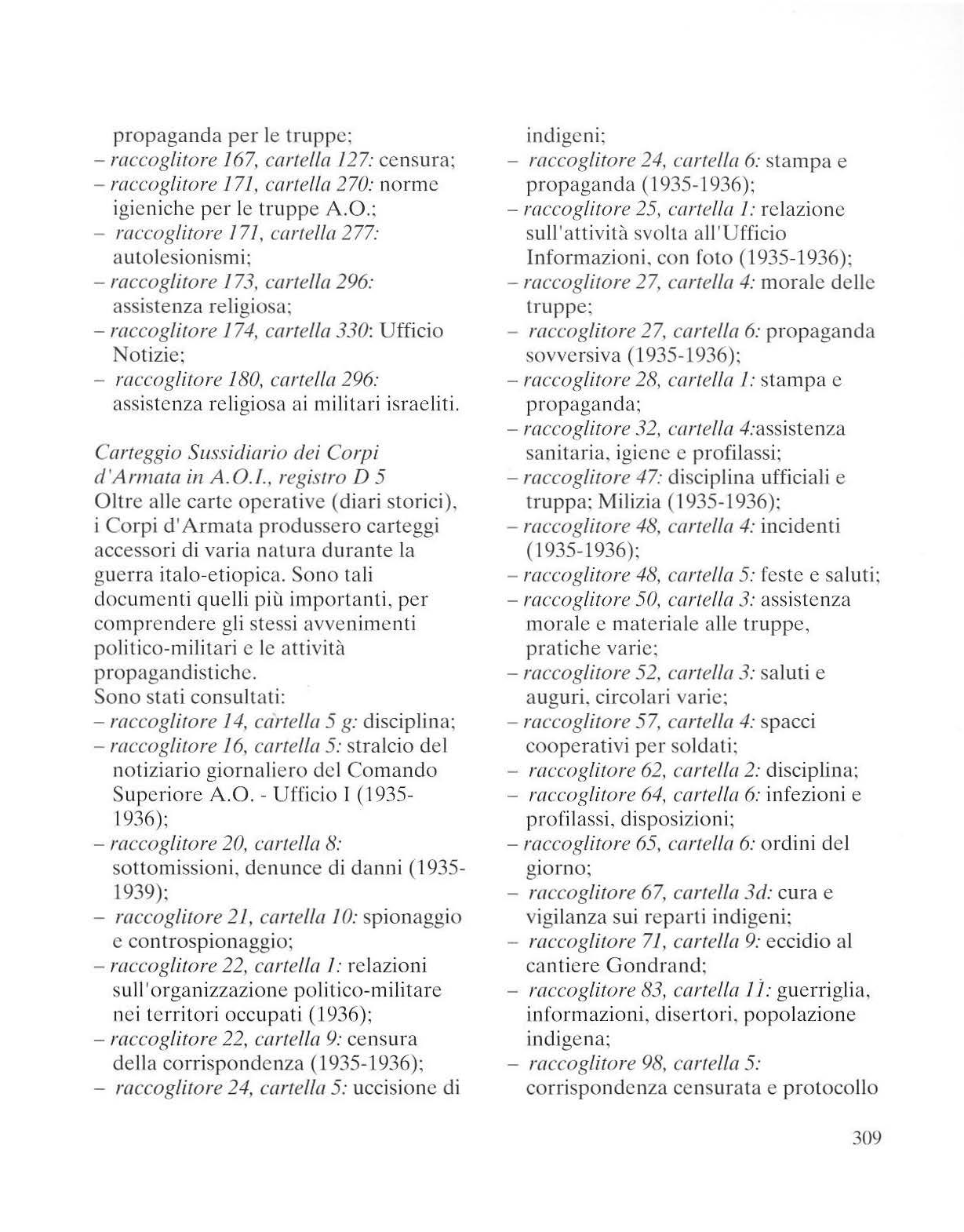
(1936);
- ra ccog litore 101 , cartella 3: co nt egno truppe; case ; propagand a sovve rsiva; - raccoglitore l 04, cartella 4b: Il C.A., s tato fisico c moral e, d ece duti; - rac c oglitore l 04, cartella Ba: Il C.A., spacci cooperativi; - ra ccog litore 123, cartella I 3 : di sciplina d e ll e truppe; - ra ccog litore 143: matrimoni , premi, s ussidi, oro alla Patria; - ra ccog litore 155, cartella 5: corrisponde nza d eli' Ufficio Stampa; - ra ccog litore 158: notiziario di in fo rmazioni dell ' Ufficio I ; - ra ccog litore 163, c art e lla 2 : raccolta noti z iario giornaliero (1"936-1936); -raccoglitore 171, cart e lla l 1: note s ull 'i mpiego degli aggr ess ivi chimici e d e lla iprite; - ra ccog litore 172, carte lla 4: direttive s anitarie per i campi di prigio ni eri; r e lazione sulle condi z ioni sa nitarie dell e truppe (1936): - raccoglitore 175, cartella 6 : richiesta di assistenza morale , spacci cooperat ivi; - raccoglitore 177, carte lla 1: rifornimento e provviste spacci; miglioramento rancio ; - ra ccoglitore 183 , cartella 8: assistenza moral e alle truppe ; - ra cc oglitore 184, cartella 2 : g iustizi a militare , denunce; - ra ccoglitore 188, cartella 7: militari dispersi, incidenti; -rac c oglitore 190, cartella 6: censimento della popolazione et iopica; - raccoglitore 199, cartella l: circolari r e lative alla disciplina ; punizioni; p e rsonale;
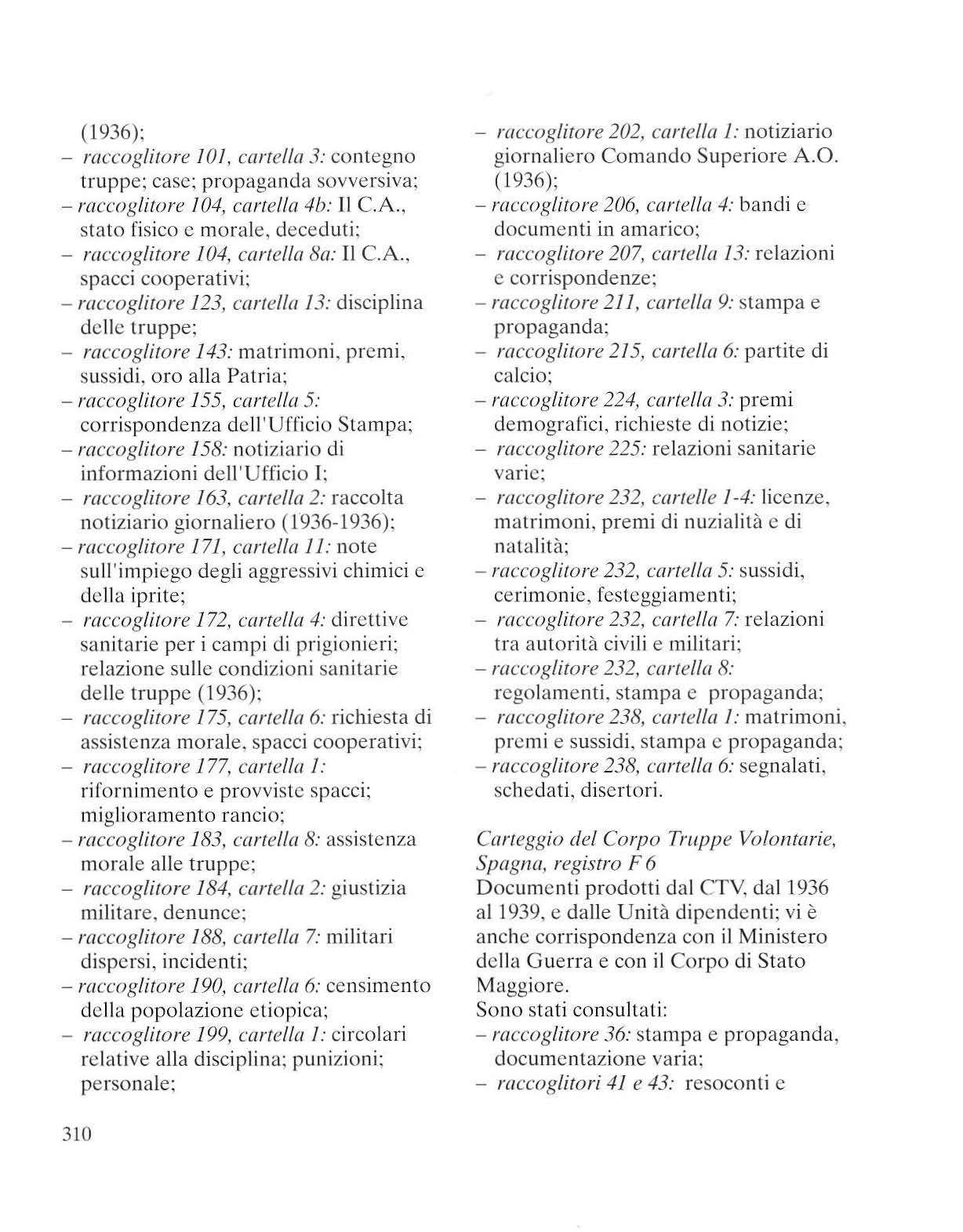
- ra cc oglitore 202, ca rtella 1: notiziario g iornaliero Comando Superiore A.O. (1936); - ra cc oglitore 206, cart e lla 4: bandi e documenti in amarico ; - ra ccog litore 207, carrella 13 : re lazioni c corrispo ndenz e; - ra ccog litore 211 , carte lla 9: s t a mpa e propaganda; - ra cc oglitore 215, c arte lla 6: partite di calcio; - ra ccog litore 224, carte lla 3 : premi demografici, richie ste di notizie; - ra cc oglitore 225: relazioni sa nitarie vane; - raccoglitore 232, carte lle 1-4: licenze, m a trimoni , premi di nu zialità e di natalità; - ra cc oglitore 232, carre /la 5: sussidi, cerimon ie, festeggiam e nti; - raccoglitore 232, cartella 7: relazioni tra au torità civili e milit a ri ; - ra ccog litore 232, car t e lla 8 : regolamenti, stampa e propaganda; - ra ccog litore 238, carre/la l: matrimoni , pr e mi e sussidi , sta mp a c propaganda ; - ra cc oglitore 238, carre lla 6: segnalati , s chedati, disertori.
Carteggio del Corpo Trupp e Volontarie, Spagna, regisrro F 6 Do cum e nti prodotti d a l CTV, da l 1936 al 1939 , e dalle Unità dip e ndenti; vi è anche corrispondenza con il Ministero della Guerra e con il Corpo di Stato Mag giore. Sono s tati consultati: - ra ccoglirore 36: stampa e propaganda, documentazione varia; - ra ccog litori 41 e 43: r es oconti c
bollettini radio (1937-1938); -raccoglitore l 04: circolari dei Servizi (intendenza, sanità, posta ccc., anni 1937 -1938-1939); - raccoglitori 112 e 117: notiziari cicli' Ufficio I ( dal1937 al1939); - raccoglitore 173: stampa e propaganda, disciplina, conferenze (1937); - raccoglitore 197: Divisione Mista Frecce, informazioni e propaganda (1938); - raccoglitore 241: propaganda varia; -raccoglitore 263: notiziari dell'Ufficio I (193R); . - raccoglitore 296: notiziari d eli 'Ufficio I (1938); -raccoglitori 303 e 304: raccolta dei notiziari dell ' Ufficio I (1937); -raccoglitore 312: politica e propaganda; -raccoglitore 314: raccolta dei notiziari dell ' Ufficio l (1939); - raccoglitore 319: raccolta dei notiziari de Il ' Ufficio I (1938); -raccoglitore 329: stampa e propaganda; -raccoglitore 334: informazioni s ulla sit uazione politico-sociale in Spagna; - raccoglitore 336: situazione politicomilitare in Spagna, relazioni varie.
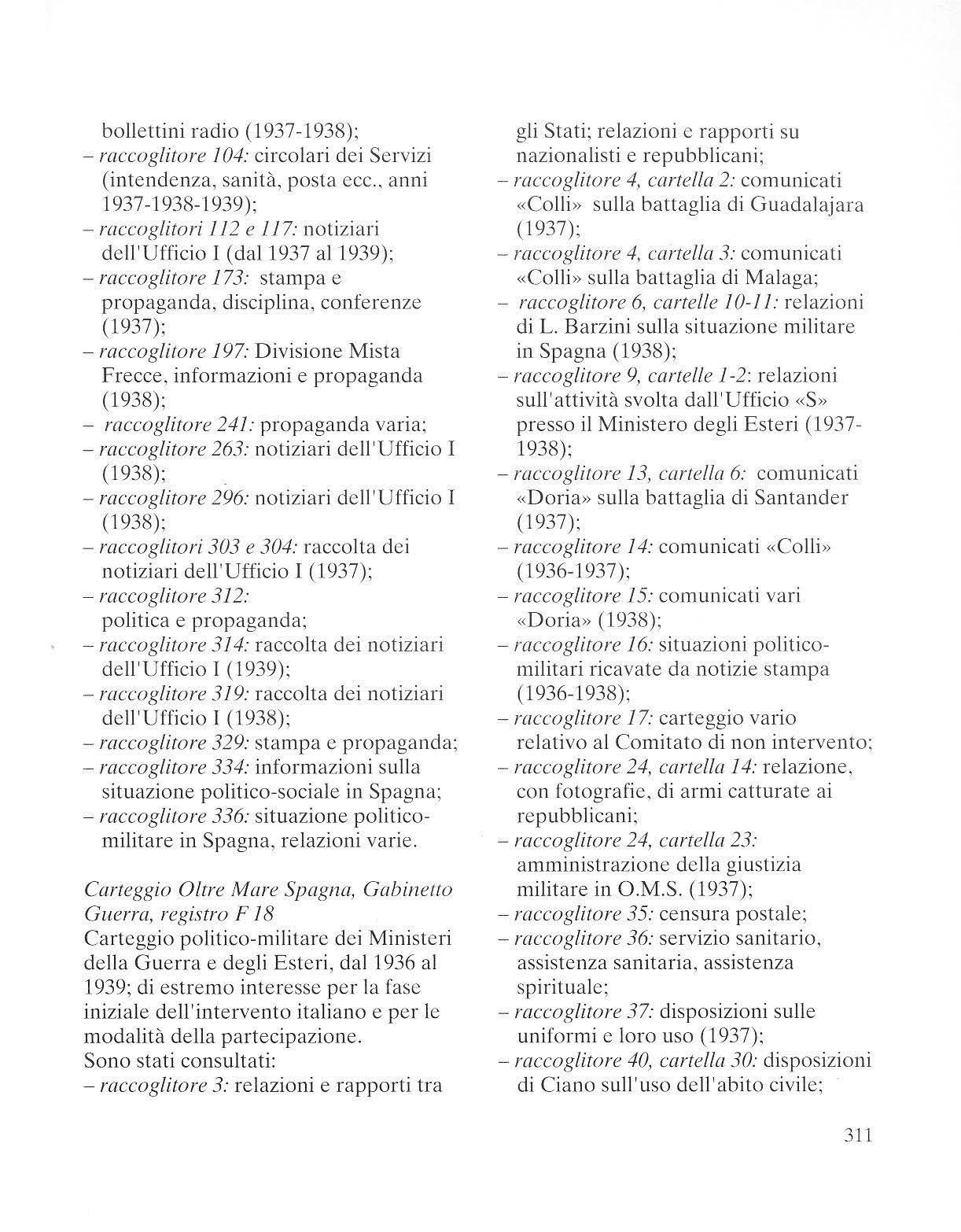
Carteggio Oltre Mare Spagna, Gabinetto Guerra, registro F 18 Carteggio politico-militare dei M-inist eri della Guerra e degli Esteri, dal 1936 a l 1939; di estremo interesse per la fase iniziale dell'intervento italiano e per le modalità della partecipazione. Sono stati consultati: -raccoglitore 3: relazioni e rapporti tra
gli Stati; relazioni e rapporti su nazionalisti e repubblicani; -raccoglitore 4, cartella 2: comunicati «Colli» sulla battaglia di Guadalajara (1937); - raccoglitore 4. cartella 3: comunicati «Colli» sulla battaglia di Malaga; - raccoglitore 6, cartelle l 0-11: relazioni di L. Barzini sulla situazione militare in Spagna (1938); - raccoglitore 9, cartelle 1-2: relazioni sull'attività svolta dall'Ufficio «S» presso il Ministero degli Esteri (19371938); -raccoglitore 13, cartella 6: comunicati «Doria» sulla battaglia di Santander (1937); - raccoglitore l 4: comunicati «Colli» ( 1936-1937); - raccogLitore 15: comunicati vari «Doria» (1938); - raccoglitore 16: situazioni politicomilitari ricavate da notizie stampa (1936 -1938) ; -raccoglitore 17: carteggio vario relativo al Comitato di non intervento ; - raccoglitore 24, cartella 14: relazione, con fotografie , di armi catturate ai repubblicani; -raccoglitore 24, cartella 23: amministrazione della giustizia militare in O.M.S. (1937); - raccoglitore 35: censura postale; -raccoglitore 36: servizio sanitario, assistenza sanitaria, assistenza spirituale; - raccoglitore 37: disposizioni sulle uniformi e loro uso (1937); -r accogli tore 40, cartella 30: disposizioni di Ciano su li' uso dell'abito civile;
- ra ccoglitore 45 , cartella l 9: generi di c onforto per la O.M.S. ; - rac c oglitore 46, carte lla 2: mezzi chim ici dei repubblicani; - ra cc oglitore 47, cartella 9: propaganda c ultural e in Spagna.
Ca rt egg io della Commiss i o n e Suprema r egistro F 9 C a rt e prodotte dalla Commissione a partire dal 1923; vi sono anche alcune r e la z ioni del Consiglio d e li 'Ese rcito e di Comitati e Corporazioni varie. Il fondo è frammentario, in quanto non vi s ono tutte le relazioni, e mancano i ve rbali di alcune sedute , come alcu ne re laz ioni delle decisioni adottate. N e l s uo complesso, però, è il fondo più importante per studiare la preparazione della Nazione (e dell ' Eserc ito) alla guerra (e alla propaganda). Sono stati consultati: - ra ccoglitore 5: studio d e l Consiglio d e ll ' Esercito per l a pr e parazione pre e pos t - m ili tare ( 1934); - ra cc oglitore 6. cartella 3: ordinamento dell'Esercito; contributo dell'Esercito a ll a guerra di Spagna ( 1939); - raccoglitore 12, cartella 7: si ntes i sui lavori della Commissione dal1925 a l1934: - ra cc oglitore 15, cartella 73: cos tituzione degli o rgani per la mobilitaz i one civil e . propaganda per l 'es tero ( 1929); - raccoglitore 18, cartella 7: regolamento sugli esoneri; - raccoglitore 38, cartella l 5: re lazjone sui nuclei di propaganda a ll'interno e a li' e stero: - ra ccog litore 42, c artella 15: relazione
d e l Ministro della Stampa c Propaganda sug li organi di propaganda (1937); - raccoglitore 45, cartella 2: relazioni sugl i organi di propaganda (1937); - raccoglitore 46, carte lla l 9: relazione d e l Ministro della Cultura Popolare s ug li organi di propa ga nda all'interno c all ' estero; - ra cc oglitore 49, cart e lla 5: relazioni varie sugli organi di propaganda (1938); - raccoglitore 57, cartella 15: nuclei di propaganda all'interno e a ll 'es tero; propaganda militare in guerra (1940): - ra c coglitore 60, cart e lla 2: relazioni sulla propaganda militare in guerra (1940); - raccoglitore 77 bis, carte lla 3: critica (anonima) sulla preparazione militare (1939).
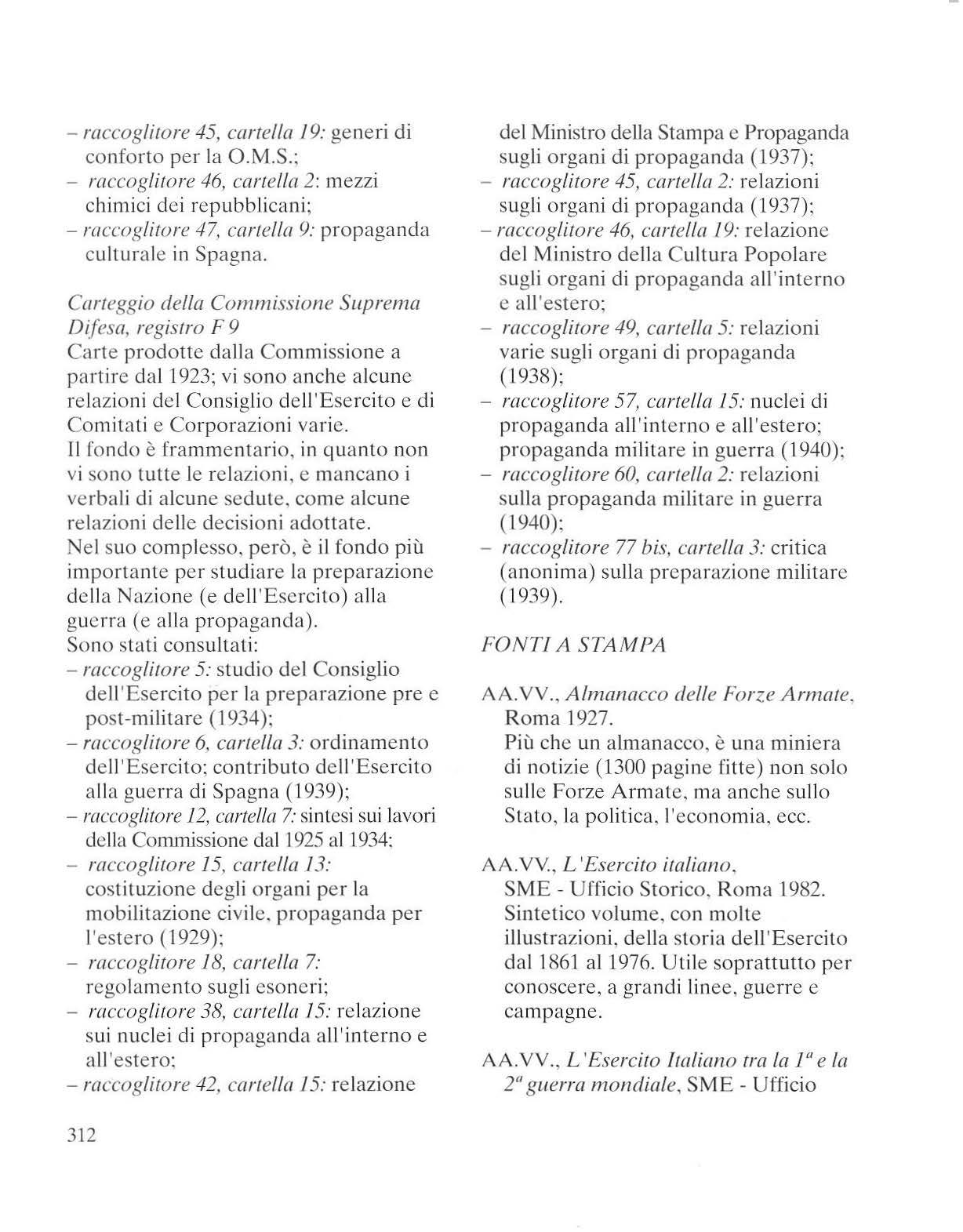
AA.VV. , Almanacco d e lle For z e Armate . Roma 1927. Più che un almanacco , è una miniera di notizie (1300 pagine fitte) non solo su ll e Forze Armate, ma anc he sullo Sta to , la politica, l'economia, ecc .
AA.VV , L 'Esercito italiano , SME- Ufficio Sto ri co , R oma 1982. Sintetico volume , con molte illustrazioni, della storia dell ' Esercito dal 1861 al1976. Utile soprattutto per conoscere, a grandi linee, guerre e campagne.
AA.VV. , L 'Esercito Italiano tra la re fa 2 aguerra mondiale , SM E- Ufficio
Storico, Roma 1 954 . Sintesi dei lin ea menti evolutivi, sopratt utto ordinativi. dell'Esercito fra le due guerre.
AA.VV., La campagna 1935-36 in Africa Orientale. La preparazione militare, Vol. I. SME - Uff icio Storico, Roma 1939. L'opera sottolinea lo sforzo logistico comp iuto prima della campagna. Il volume sulle operazioni non fu ed ito per lo s coppi o della 2 11 guerra mondiale.
AA.VV., Cultura e Società negli anni del fascismo, Milano 1987. Atti del Convegno promosso dal Comu n e di Milano « Ideologia, professioni e tecniche negli anni del fascismo», sul tema della cultura delle classi medie negli anni Trenta.
ANTON ICE LLI Franco (a cura di ) Trent'anni di storia italiana (!915-1945), Torino 1975. Raccolta del ciclo di lezioni tenute, a l Teatro Alfieri di Torino nel1960, da storic i, politici c protagonisti dell ' antifascismo.
AQUA RO NE Alberto, Fascismo e antifascismo nella storiog rafia italiana, Roma 1986. Lett ura del fascismo in chiave storicogi uridica , soprattutto per la «ro ttura » che esso segna con lo Stato liberale ereditato d a l Ri sorgimento nazionale.
ATTANASIO Sandro, Gli italiani e la
guerra di Spagna. Milano 1974. L'autore intend e testimoniare le imprese degli italiani , che si ritrovarono in terra straniera su opposte barricate.
B TAGTN I Anton e ll o-FRATTOL ILLO Fernando (a cura di), Verbali delle riunioni tenute dal Capo di SA1 Generale, Vol. l , SME- Ufficio Storico, Roma 19R3. Raccolta di documenti, illuminanti su lla direzion e po liti co-stra tegica e sulla reale situazione del Paese e dell e Forze Armate.
BOTII Ferruccio - ILARI Virgilio, li pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra (1919-1949), SME - Ufficio Storico, Roma 1985. È soprattutto un amp io tentativo di analisi della vasta l ettera tura militare ita liana , con annota7.ioni sui principali p r oblem i dottrin ali. politico-militari, cultural i.
BUCCIANTE Giusepp e, I generali della dittatura, Mi lano 1987. Lavoro interessante per la parte che ebbero i vertici militari nella dittatura fascista, da leggere comunq ue rlopo aver consultato altre biografi e asett iche dei protagonisti citati .

CANNIST RARO Philip V., La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, Bari 1975.
L ' autore d escr iv e il «co nsenso» ottenuto dal fascismo , ana lizzando gli st ru menti di comunicazione utilizzati
(stampa, radio, cinema).
CAVALLO Pietro, Immaginario e rappresentazione, Roma 1990. Attraverso l'analisi d e i copioni tea tra li , viene testimoniata l'o pera di propaganda e la part ec ipazion e degli italiani all'immaginario collettivo dell 'epo ca.
CECCHIN I Ezio, Le istituzioni militari. Sintesi storica, SME - Uffi cio Storico, Ro ma 1986. Compend i o generale dell'evoluzione organica, tecnica e dottrinale d e lle isti tuzio ni militari.
CESERANI Gian Paolo, Storia della pubblicità in Italia, Bari 1988. Nel fare la storia della pubblicità, un esperto di tecniche delle comunicazioni giudica , da un ' ango lazione esclusivamente pubblicistica, Mu sso lini , il «prodotto Itali a » e il consenso.
COMANDO D EL CORPO DI SM - UFFICIO STORICO, Annuario Ufficiale delle Forze Armate de l Regno d'Italia, Ann o 1938-XVI. IR egio Esercito, Roma 1938. Storia dell e Ar mi e d e i Corpi dell'Esercito; docum e nto bas e per chi studia l 'evolu zio ne ordinativa e la storia dei Corpi.
(COMMISSA RI ATO PER LE RIPA RA ZION I DEI DANNI DI GUERRA, Le ricostru z ioni nelle terre liberate, Rom a 1924.
Consuntivo dell'impeg no soste nuto dal Commissariato per le riparazioni e la ricostruzione nei territori maggiormente danneggiati dalla 1a guerra mondiale.
DE GRAND Alexander J .. Bottai e la culwra fascista, Bari 1978. Un ca tt edratico am e ricano giudica la cultura fascista. sostenendo la tesi che accanto a quella uffi ciale, soltanto retorica, vi furono t e nsioni più consistenti e profonde di intellettuali raccolti intorno al B ottai.
DELLA VOLPE Nicola, Difesa del Territorio e Protezione Antiaerea (1915-1943). Storia, documenti, immagini, SME -U fficio Storico , R oma 1986. Il saggio ricostruisce le vicende della difes a dello Stato lungo i confini terrestri e marittimi c pone particolare atte n zione alla difesa e alla protezione anti-aerea, che coinvolse direttam ente i cittadini attraverso l ' U.N.P.A.
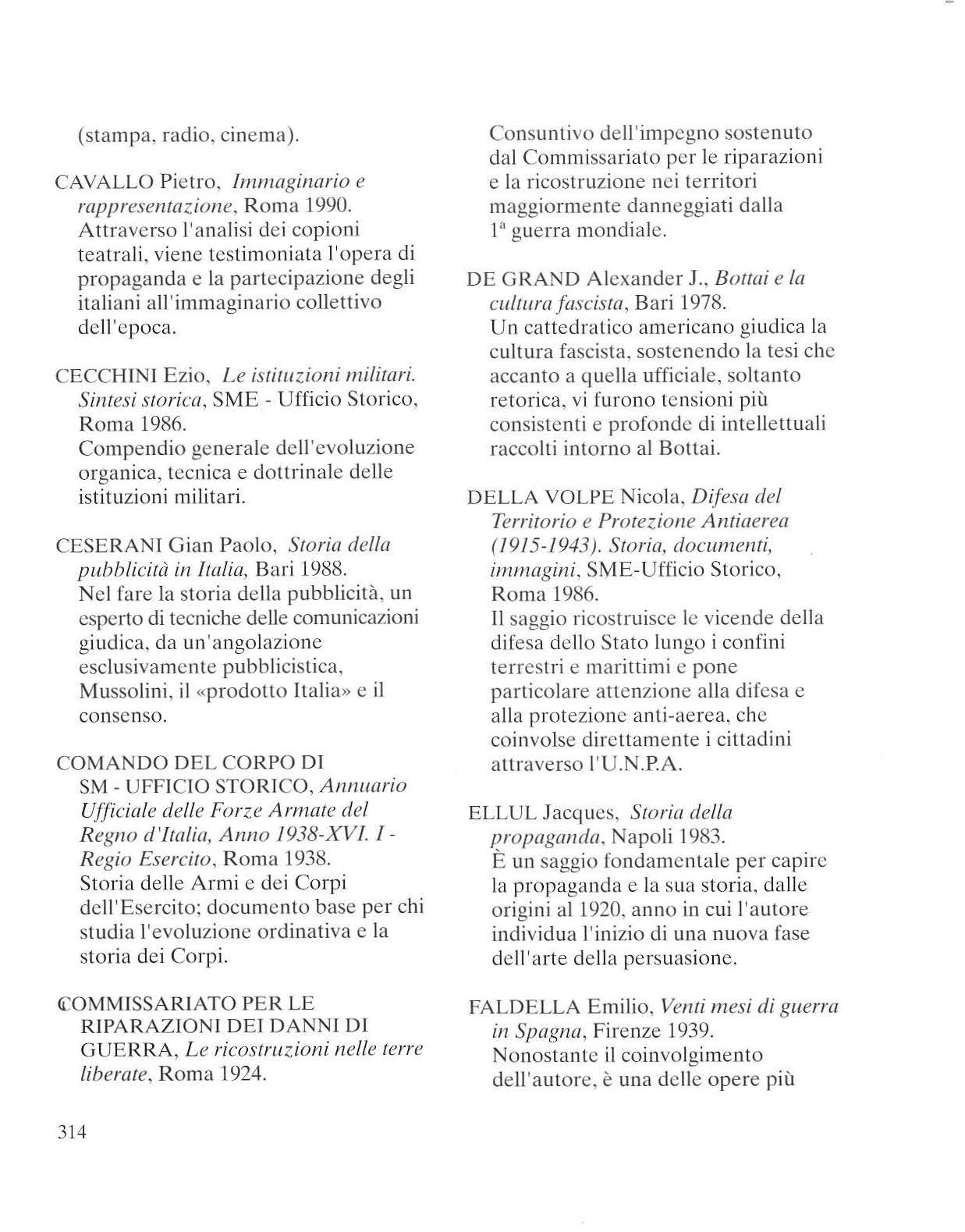
ELLUL Jacqucs , Storia della propaganda, Napoli 1983. È un saggio fondamentale per capire la propaganda e la sua storia, dalle origini all920. anno in cui l'autore individua l 'inizio di una nuova fase dell'arte della persuasione.
FALDELLA Emilio, Venti mesi di guerra in Spagna, Firenze 1939 . Nonos tant e il coinvolgimento d e ll 'a utor e, è una delle opere più
valide della part ec ipazione italiana, dal 1936 al19 38, a lla g uerra s pagnol a.
GAL LlNARI Vince nzo, L 'Es·ercito italiano nel primo dopoguerra.l9181920, SME-Ufficio Storico, Roma 1980. È un vol um e fo n dame nt ale per co mp r endere un pe r iodo sconosciuto della s toria militar e, epp ur e d e terminante per il coinvo lg imento e per le s celte che condizio narono , n e i decenni successivi , la vit a d e ll 'Esercito.
GUS PINI Ugo , L 'o recc hi o del Regime , Milano 1973. U no d egl i add ett i rip c rcorre la storia del se r vizio di int erce ttazione te le fonico, alternando s toria, costum e e cu rio s ità attraver so l a cita z ione di brani di conversa zioni
LAZZERO Ricci otti, Il Partito Nazionale Fascista, Milano 1985. Da co n su l tare per la stor i a articola t a e doc um e nt ata d e l P a r tito, delle sue o rga ni zz azioni , d e ll e s ue manifestaz ioni ; cont ie ne a mpi richiami alle attivit à propagandistiche.
LON GO Luigi Emili o, Francesco Saverio Gra zio /i , SME-Ufficio Sto ri co, Roma 1989 . Bi ografia di un generale c he molta pa rt e ebbe n e i fatti di Fiume, nel dibattito sull'Esercito , ne lla pr e paraz ione d e ll a Na zione Armata.
MALYANO Laura, Fascismo e Politica de ll 'Immagin e, T or in o 1988 . Breve s in tesi , co n illu straziQni , d c i
rapporti tra arte c fascismo; int eressanti le a nn o t az ioni s ugli aspe tti p r opa gand is tici ch e ricoprirono, sotto il r eg im e, pittura , sc ultura e archit e ttur a.
MINISTE RO D ELLA GUE RRA , R ela zione sull 'attività svolta per esigenz a A. 0. , R oma 1936. Testimonia lo sforzo sos t e nuto nella g u e rra d ' Etiopi a. L ' opera fu confezionata p er fini pubb li cist ici, ma s u documen t i d 'a rchivio.
MINISTERO DELLA GUER R A -S.l. M., No nn e per il funzionamento degli Uffici C ensura P osta Militare, R oma 1935. Organizzazione e modalità esecutiv e del servizio di ce ns ura s ulla posta militare.
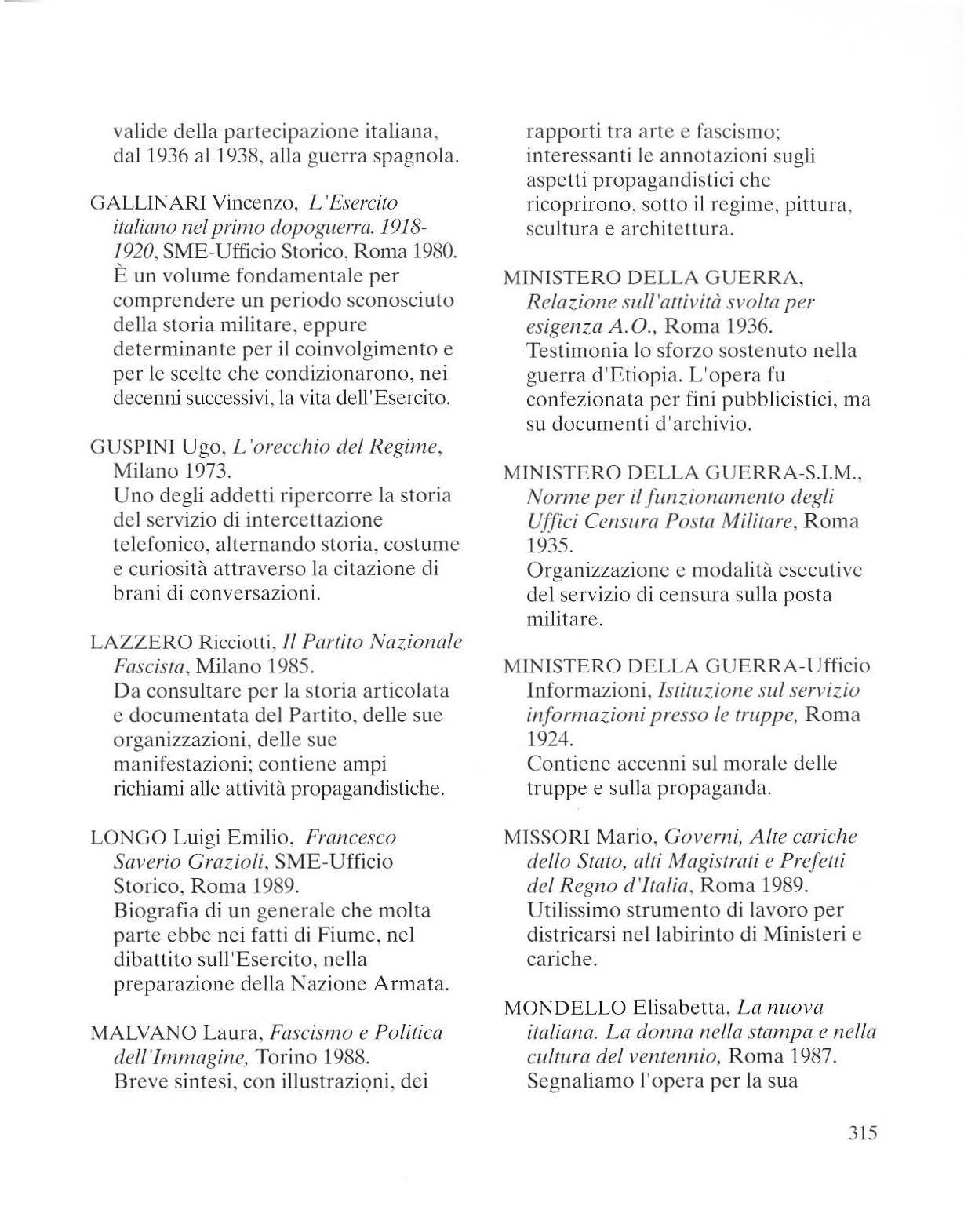
MIN ISTERO DELL A GUE RR A -Ufficio
I nfo rma zioni. IsriLu z ione su l servizio inform azioni presso Le truppe, Rom a 1924. Co nti ene accenni s ul mora le d e ll e truppe e sulla pr opaga nda.
MISSORI Mario , Governi, Alte car ich e de llo Stato , alti Ma g istrati e Prefetti del R egno d 'I talia, R om a 1989. Utiliss im o s trum e nto di la voro per districarsi ne l labir into di Ministeri e cariche.
MONDELLO Elisab e tta , La nuova italiana. La donna n ella s tampa e nella cultura del ventennio, Roma 1987. Seg naliamo l 'o p e r a per la s ua
peculiarità e per la tesi della Mond e ll o s ull a donna italiana , diver sa dal mod el lo che il fascismo avrebb e voluto accre ditar e.
M O NTANA RI Mario , L 'Esercito italia no alla vigilia de lla 2 aguerra mondi al e, SME -Ufficio Sto ri co, R oma 1982 Monografia che ilJu s tra ampiamente e rigorosamente l e co ndizion i dell'E se rcito e l a s u a efficienza alla vigilia del conflitt o .
M ONTANAR I Mari o, Le trupp e italiane in Albania (Anni 1914-20 e 7939), SME -Ufficio St orico, Rom a 1978. Storia deg li eventi c h e portarono l ' E serc ito in Albania; presenza v oluta dai Governi più p e r considerazioni di ordin e politico c h e per esig e n ze di carattere militare , come sottolinea l ' autor e .
MONTA NE LLI Indr o, L 'Italia in camicia nera , Milano 1976. Una lett u r a in chiave g iorn a li s ticama non troppo - di un principe del giornali s mo , che non è solo tale; con lucid e osse r vaz i oni su lla na scita del fasci sm o.
OSTEN C Michel , La scu ola itali ana durant e il fascismo, B ari 1 981. Attra verso l ' anali s i della ri forma Gentil e, il volum e esa mina la fisionomia dell'app a rato educativo del fa scis mo ed i s uoi rifl ess i s ulla scuol a e s ulla pre parazi one cu l t ur a l e della Nazio n e .
REPACI Antonino , La marcia su Roma , Mil ano 1972.
Op era docum enta ta sull'avvenimento che portò il fasci s mo al potere.
ROVERI A lessandr o, Le caus e del fasci sm o, Bolog n a 1985.
L' autore a nali zza le caus e sto rich e ch e portarono al fascismo e a l nazismo, sostenendo la tesi c h e furon o esse, e n o n il carism a dei Capi , a condurre ai du e r eg imi reaz i onari di ma ssa
STEFAN I Filippo , Sto ria della dottrina e degli o rdinamenti dell'Esercito italiano, Vol. I l, tomo 1, SME-Uffici o Stori co, Rom a 1985. Op era in più volumi (il tom o segnalato va d a Vittorio Ve neto a ll a seconda gue rr a mond ial e) in c ui l ' autor e, al di là d e i limiti imposti dal titol o, mette in luce le condi z ioni dell' Eser cito , g li avve nim e nti , le ma ggiori figur e dei ve r tici m ili tari, con an notazioni cr iti c h e d e l periodo 10 esame.
STEFA NT Filipp o -RO VIGHI A lb e rto , Il Corpo Truppe V o lontarie n ella guerra civil e spagnola, 193 6-1939, SMEUffi cio Storico Roma 1992. È l a p rima opera redatta su lla docum e ntazion e, in e dita , d ell 'a rchivio d e ll ' Ufficio Storico dello SME , di notevol e valore sc ie ntifico ; non tratta so l o le operazi oni militari ed è ricca di considerazioni e di documenti, sui vari aspetti della
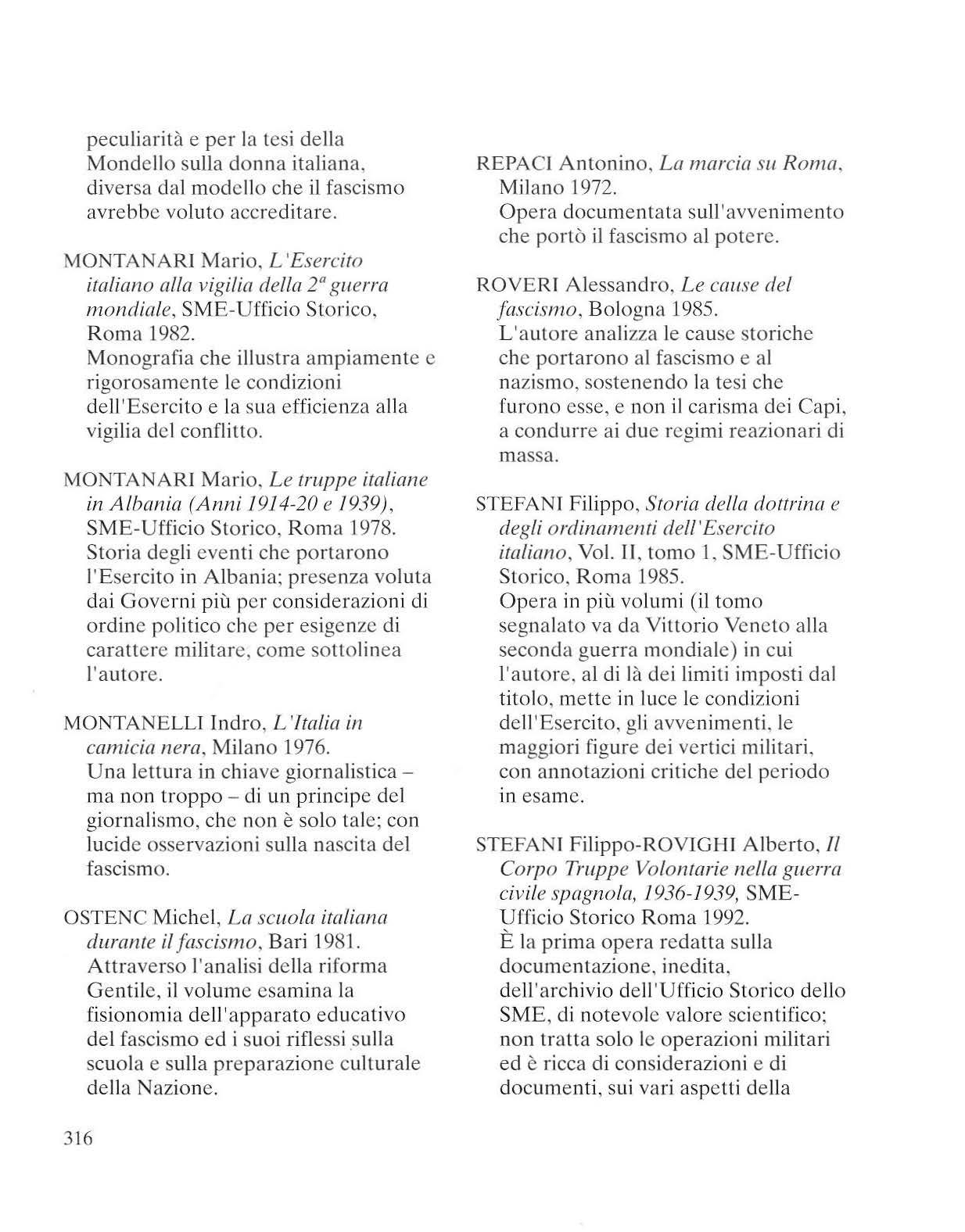
partecipazione italiana.
TORCELLAN Nanda, Gli italiani in Spagna. Bibliografia della guerra c ivile spagnola, Milano 1988. U n a delle poche guide b ibliografiche disponibili , con introdu z ione critica e presentazione di Enzo Collotti . * * *
Si segnalano, di seg uit o. alcune opere celebrative, di esclusivo fine propagandistico, riferite a guerre ed avve nimenti , talvolta redatte sotto forma di catalogo o almanacchi. Sono utili per cogli e re l'atmosfera del momento e per toccar e un deleterio modello storiografico in uso nel venten nio:
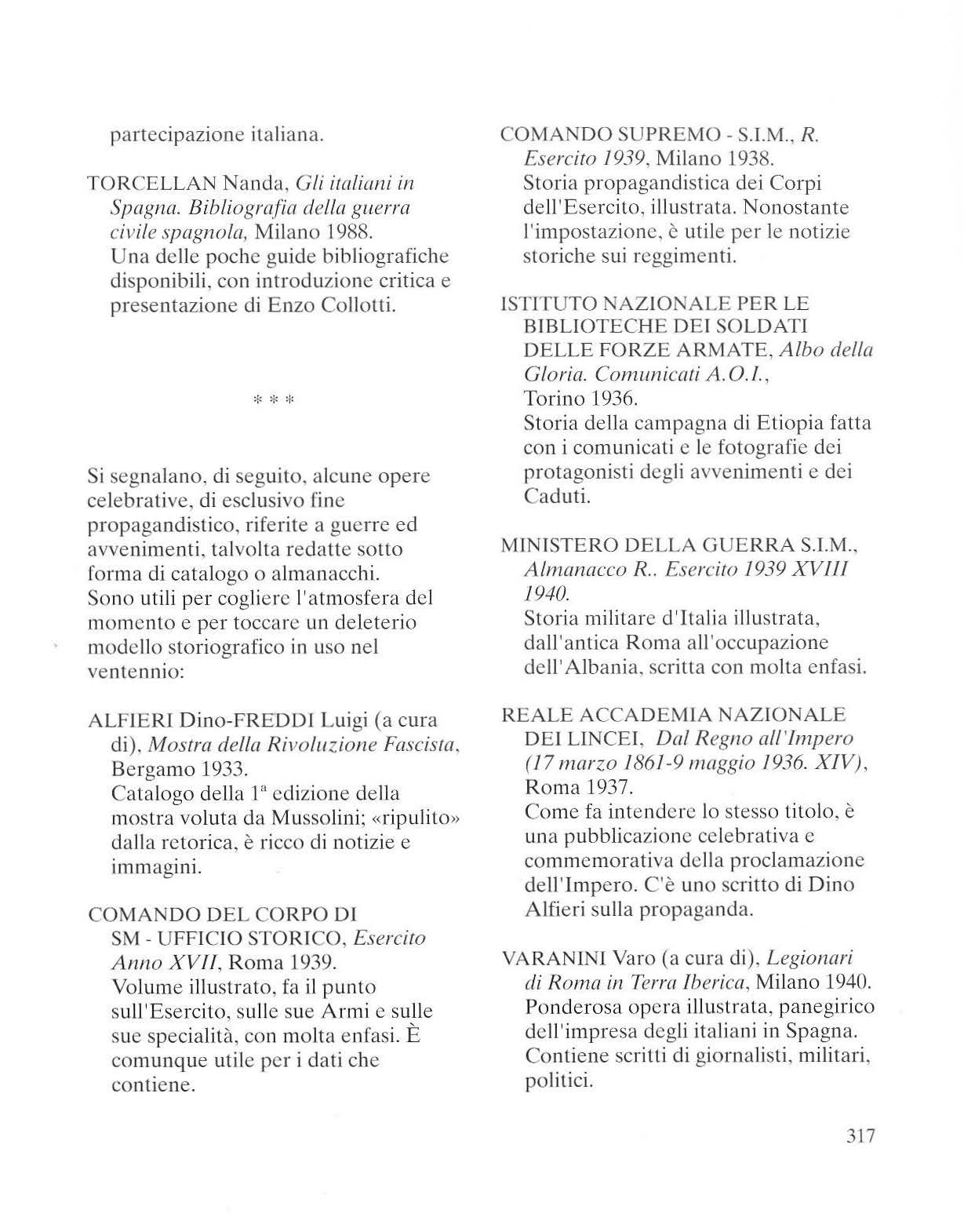
ALFIERI Dino-FR EDD I Luigi (a cura di), Mostra della Rivoluzione Fascisra. Bergamo 1933. Ca talogo della Ja edizione della mostra voluta da Mu sso lini; «ripulito>> dalla retorica, è ricco di notizie e 1mmagm1.
COMAN DO DE L CO RPO DI SM- UFFICIO STORICO, Esercito Anno XV/l, Roma 1939. Volume illustrato, fa il punto s ull'Esercito , sulle sue Armi c sulle sue s pecialità , con molta e nfasi. È comunq ue util e per i dati che co nti e ne.
COMAN DO SUPREMO- S. l. M., R. Esercito 1939 , Milano 1938. Storia propagandistica dei Corpi dell'Esercito, illu strata. Nonostante l'impostazione , è util e per le notizie sto riche sui reggim e nti.
ISTITUTO NAZIONALE PER LE BIBLIOTECHE DEI SOL DATI DELLE FORZE ARMATE, Albo della Gloria. Comunicati A. O.!., Torino 1936. Storia della campagna di Etiopia fatta con i comunicati c le fotografie dei protagonisti degli avvenimenti e dei Caduti .
MINISTERO DELLA GUERRA S.l.M., Almanacco R Esercito 1939 XVIli 1940. Storia militar e d'Italia illustrata, dall'antica Rom a all'occupaz ione dell'Albania, scritta con molta enfasi.
REALE ACCADEMIA NAZ IO NALE DEl LINCEI , Dal R eg no all 'Impero (17 marzo 1861-9 maggio 1936. XIV), Roma 1937. Come fa int e nder e lo stesso titolo , è una pubblicazione ce lebrativa e commemorativa della proclamazione dell'Impero. C 'è uno scritto di Din o Alfieri sulla propaganda.
VARANINI Varo (a cura di), Legionari di Roma in Terra Iberica, Milano 1940. Ponderosa opera illustrata, panegirico dell'impresa degli italiani in Spagna. Contiene scritti di giorna listi , militari , politici.

Ca rto line (co lle zioni)
L 'U fficio Storico possiede co ll ezio ni di ca rt ol in e p er un totale di circa 60 .000 p ezz i, raccolte in album. Sono stati co ns ult ati gli album relativi a : - Co mandi c Corpi d e ll 'Ese rcito: - franc higia ; - propaganda; - Mili z i a Volontaria ; - rèpa rt i co loniali.
Ra cco lta delle circolari, registro M 7 fondo ci tato - ra ccogìitore 153, carte lla l: orga ni zzazio ne servi zio postale in O.M .S. (1937); - raccoglitore 168, cartella l: servizio postale O.M.S. (1939); - ra ccoglitore 308: se r vizio posta militar e, anni var i .
Carteggi o dei Corpi di Spedizione di O cc upazione, registro E 3 fondo citato - raccoglitore 6, cartella 3 : se rvizio postale (Anatolia 1919); - ra cc oglitore 18, cartella l: serv izio po s tal e (A natolia ).
Ca rteggio Sussidiario A. 0.1. della guerra itala-etiopica, registro D l fondo citato
- raccoglitore 72, cartella 6: uffici postali per la l \ 2a Di visione i ndj ge n a e Corpi cl ' A rm ata autonomi;
- raccoglitore 72, cartella 8:se rvizio posta l e A.O. ; - raccoglitore 72, cartella 9: ca rt o lin a in fr a n c hi g i a: - raccoglitore 72, cartella Il: uffici co n ce ntr ame nto eli Posta Militare; - raccoglitore 73, ca r tella 1: co rri s pondenza da c p e r le colonie; - ra cc oglitore 74, cartella 3 : lettere rinven ute , corri s pond enza g iorna listica ; - ra ccog litore 74, cartella 6: servizio posta le A.O. ; - ra ccoglitore 74, cartella 9: car te valori ; provent i in Libia ; - raccoglitore 91, cart ella 4: servizio ae r e o postale per l ' A.O. ; - raccoglitore 91, cartella 5 : corr is ponden za p er l'Eg itto e pe r I'A .O.; - raccoglitore 157, carte lla 208 : corr ispo nd e nz a per l ' A.O.; - raccoglitore 169, carte lla 208: co rri s pondenza per I'A .O.; - ra ccoglitore180, cartella 208: corrispo nden za per l 'A .O.; - r accog litore 189, ca rtell a 208 : co rrispond e nza p er l ' A.O.; - ra ccog litore 192, cartella 143: se r vizio postale in A.O. _
Ca rteggio Sussidiario dei Co rpi d 'Armata in A. O. l. reg is tro D 5 fondo citato - ra ccog litore 15, cartella 5 : se rvizio postale ( 1935); - raccoglitore 39, carte lla 5: se r vizio
postale;
- raccoglitore 41, ca rtella 2: serv izio postale;
- raccog litore l 02, car te lla 15: serviz io postale, collegamenti;
- raccoglitore l 04, carte lla 6a: II C.A., servizio postale;
- raccoglitore 116, cartella 9: serv izio postale (1935);
- raccoglitore 11 7, carte lla l: serv izio po s tal e (1935 ); - ra ccoglitore 118, carte lla 2: servizio postale;
- raccoglitore l 19, carte lla 4: se r vi zio postale;
- ra ccog litore 122, c art ella 7g: servizio aereo postale; - raccoglito re 123, cm·rella 9: se rviz io aere o postale; - raccoglitore 170, carte lla 1: serv izio postale; - raccoglitore 232, carte lla 9: servizio postale .
Carteggio del Corp o Truppe Volontarie , Spagna, reg istro F 6 fo ndo citato
- ra cc oglitore l 04: se rvi z io postale (1937- -1938-1939); - ra ccoglitor e l 77: serviz io postale, varie ( 1 937) .
Carteggio Ol tre Mar e Spagna, Gabinetto Guerra , registro F 8 fondo citato
- raccoglitore 34: dispo s iz ioni var ie sul se rvizio postale; - raccoglitore 35: se r v izio postale, franchigia , censura.
BRE DA R e n a t o, Le cartoline dei prestiti di guerra , S M E - Ufficio Sto ric o, R oma l 992. Opera di notevol e int e resse, non solo per le ca rt oline e per il cata l ogo specifi co, ma anche p e r la stori a dei prestiti di guerr a.

DE LLA VOLPE Ni cola, Carto lin e militari, SME -Ufficio Storico, Rom a 1983. Storia dell e carto li ne militari, con an n otazio ni critiche; alcuni capitoli so n o dedicati a ll e carto line di propaganda.
DONADE I Mari o, L ' I talia delle c artoline 1919-1 945, C uneo 1978. L ' autore tent a di leggere la storia d 'Italia attraver so le cartoline.
FRASC HETII Luci a no. Storia v i va. La sto ria attraverso i manifesti, i giornali, le cartoline, (vedi Stam pa ).
MI GNEMI Adolfo, Immagine coo rdinata per un impero Etiopia 1935-1936, (vedi Fotografie).
ZAM BELLI Emi li o Nuovo c a talogo Zambelli della cartoline di B occasile 1979, R oma 1 979 . Opera d .i un co ll ez ionista , priva di annotazion i; è util e s olo perché raccoglie buon a part e delle cartoline di seg n ate da Gino Boccasile.
Fondi fotografici. La fototeca dell ' Ufficio Storico raccoglie circa 600.000 fotografie (negativi e positivi) a partire dal1840 c1rca.
Sono stati consultati i seguenti fondi, da cui sono state tratte quasi tutte le immag ini presentate (quelle provenienti da fondi e raccolte private sono segnalate in didascalia): - Africa Orientale , codice 592; - Guerra itala -etiopica, codice VE; - Campagna di Spagna , codice 506; - Addestramento , codice 693; - Grandi Manovre, Propaganda , Fascismo, codice 786; - Personalità militari , schedario alfabetico.
Raccolta delle circolari, registro i\1 7 fondo citato - raccoglitore 499, cartella 8 : fotografi e cineopera tori.
Carteggio dello Stato Nlaggiore Regio Esercito, registro L l O fondo citato - raccoglitore 131 , ca rtella 12: campagna fotografica delle frontiere.
Carteggio del Capo del Governo, registro H 9 fondo citato - raccoglitore 5: autocinema sonori alle Divisioni di Fanteria (1939).
Carteggio Sussidiario A.O.I. della guerra itala-etiopica, registro D l fondo citato - raccoglitore 15, cartella 1: fotografie dei segnali della Croce Rossa; -ra ccoglitore 20, cartella 4: propaganda cinematografica, riprese filmate ; - raccoglitore 20, cartella 9: sezione cinematografica per l 'Eritrea; - raccoglitore 20, cartella 14: notizie su filmati; -raccoglitore 29, cartella 12: squadre fotografi e telefotografi per l ' Eritrea ; -ra ccoglitore 89, cartella 5: macchina fotografica per Centro Informazioni di Mogadiscio; ' -raccoglitore 169, cartella 223: sezione cinematografica; - raccoglitore i21. cartella 1: fotografie vane.
Carteggio Sussidiario dei Corpi d 'Armata in A. 0./., registro D 5 fondo citato - raccoglitore 5, cartella 2: fotografie e documenti eli ricognizione (1935); - raccoglitore l 2, cartella 8: organici dei fotografi militari (1935); - raccoglitore 21, cartella l: foto della relazione sull'attività svolta dall ' Ufficio Informazioni (1935- 193 6); - raccoglitore 62, cartella 2: pubblicazioni (servizio stampa e cinematografico); -raccoglitore l 02 , cartella l 0: autocolonna eli propaganda, Servizio cinematocrrafico· b '
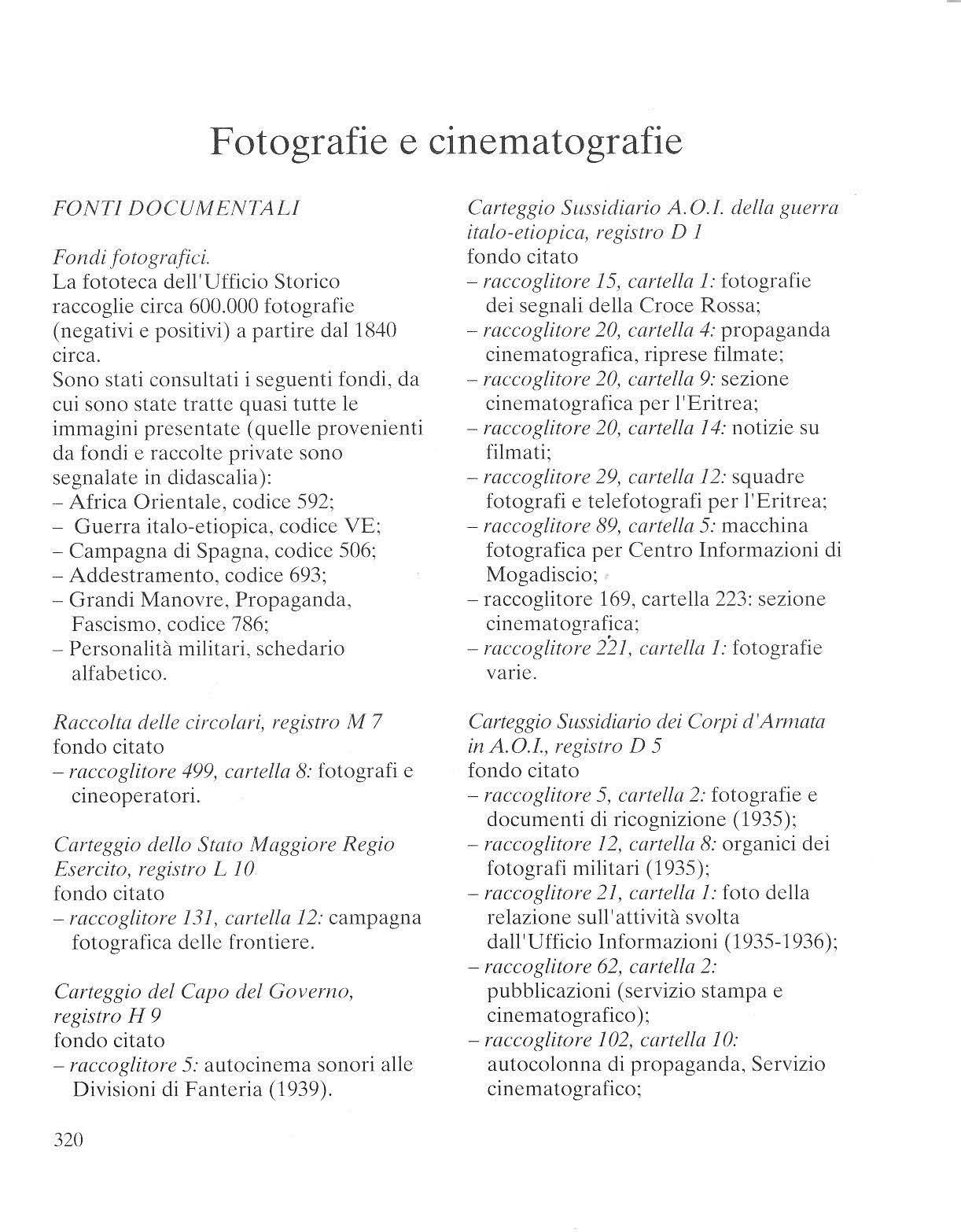
- raccoglitore 133, cartella 13: fotografie, circo lari; - raccoglitore 216, cartella 4: sq uadr e fotografiche.
Ca rteggi o del Corpo Trup pe Volontari e, Spagna, registro F 6 fondo citato
- racco g lirori l 0-118- 742-159-250-305: racco lta di fotograf ie va ri e, a nch e in album , della ca mpa g na.
Ca rteggi o Ol tre Mare Spagna, Gabinetto Guerra, registro F 18: fo ndo c it a to - raccoglitore 5 , c artella 25: fotografia pianta d i Madrid (1936); - racco g litore 24, c ar te lla 74: fotografi e di armi «ros se» preda b e llic a; - racco gli tore 40, cartella 7: cos titu z ione d i un a Sezion e cinematografica p er il C T V
Carteggio della Commissione Suprema Difesa, r egistro F 9 . fo ndo c i ta to - raccoglitore 38, cartella 76: di sc iplin a della c in e m atografia in guerra (1936); - racco g litore 40, carte lla 3 : r e l azi oni su lla c in e ma tografia in g ue rra (1936).
Arc hi vio Centrale d e ll o Stato Fondo Ministero dell'Aeronautica, Ga bin etto: - 1938, busta 48, fase 6- VII-6: fi lma ti della guerra di Spagna.
BRUNETTA G.P. -GILI J .A., L 'o ra d'A frica d e l cinema italiano , Trent o 1990. Catalogo r agio n ato dei filmati a soggetto e dei documentari d e li 'Is titut o Luce , di tutte le gue rr e d ' A frica.
CANN ISTRARO Philip V., La fabbrica d e l consenso. Fascismo e mass media, op.ci t.

C OMADO COR PO SM- Uffic io Storico, Esercito Anno XVli, op.cit.
C OMANDO SUP R EMO R. ESE R C ITO, L ' Esercito per la rinascita delle Terre lib e rate, B o logna 1919. O pera fo t ogra fi ca che te stimonia l ' imp eg no dell ' Esercito p er l a rico s truzione nelle terre sco n volte dalla g uerra mondiale.
DE SANTI P ier Mar co, Cin e ma e Storia. II Guerra Mondial e, Vol. I, Rom a 1990. Int eressa p er la segnalazione di alcun i film at i a sogge t to, propagandistici , prod o tti da11936 a l1940.
DELLA VOLPE N icola, Fotografie Mili ta ri , SM E -Uffi c io Stori c o , R oma 1980. Conti e ne , in a pp end ic e, u na s in tesi storica dell e fotografie militari d a lla 1aalla za gu e rra mondial e.
FONTI A STAMPA
F E RR O Mare, Cinema e storia. Linee per una ricerca, Milano 1980. Un s intenti co saggio che propon e
aspetti metodolo g ici s ul cin e ma come «agente d e lla stor ia» . GOGLIA Luigi , Storia dell'Impe ro fascista 1935-1941, Bari 1985.
Go g lia è uno d e i pochi s tori ci che ut ilizza la fotografia com e fonte do c u me ntal e prim a ria per scr ivere la storia. E ci riesc e .
GORI G i a n fr a n co (a c ura di ), Passato rid otto, Firenze 1982 . Antol og ia di scr i tti s ul dib atti to , aperto neg li ultimi a nni , d c i r ap porti esistent i tra storia e cinem a .
ISTITUTO NAZ I ONALE P ER LE BIB LIOTECHE D E I SOLDATI D EL L E FORZE A R MATE, Alb o della Gloria , Comunicati A. O .l. , op. ci t.
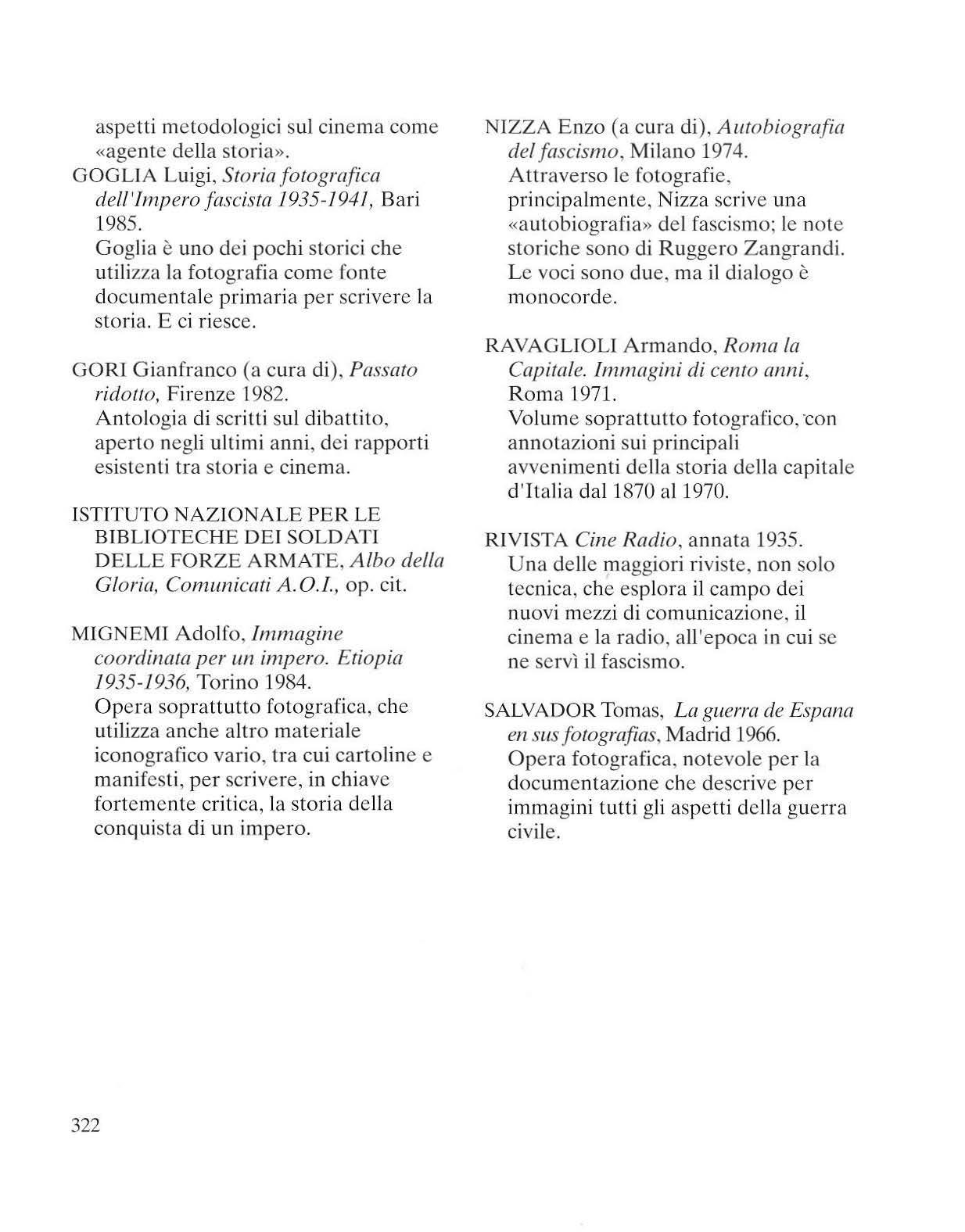
MI GN E MI Adolfo , Immagin e coordinata p er un impero Etiopia 1935-1936, Torin o 1984. Op era soprattu tto fotografica, che utilizza anche a lt ro m a t eriale ic on ografico vario , t r a cui ca r tol in e e manifes ti, per scr iv e re, in chi ave fort e m e nte critica, l a storia d e lla conqui s t a di un impero.
NIZZA E nzo (a cura di) , Autob iografia del fascismo, Milano 1974. Attraverso le fotografi e, prin cip alm e nt e, Nizza scriv e una «autobiog ra f ia» del fasci smo; le not e sto ri c h e s ono d i Rugg e r o Zang randi . Le voci so n o due, ma il dialogo è mo noc orde.
R AVAGL IO L I Armand o , R oma la Capitale. imma gini di cento anni, Rom a 1971. Volum e soprattutto foto g r a fico , ·con annotaz ioni s u i princi pali avvenime nti de ll a stori a de lla capit ale d ' It a li a dal1 870 al1970.
RIVI STA Cine Radi o, annat a 1935 . Una de ll e magg iori ri vist e, non solo tecn ica, che esplora il camp o d e i nuovi m ezz i di co munica z ione , il ci nema e la radio , a ll ' epoca in cui se n e se r vì il fa scis mo.
SALVADOR Tom as, La guerra de Espana en sus fotografias , Madrid 1966. O p e ra fotograf i ca , n otevol e per l a do c um e nta zione c he d escr ive per imm agi ni tutti g li aspetti d e ll a g u erra civil e .
Carteggio Sussidiario A. 0.1. della guerra etiopica, registro D I fondo citato
- ra ccoglitore 20, cartella 13: conversazioni radiofoniche suil a guerra del generale Bastico.
Ca rteggio Sussidiario dei Co rpi d'Armata in A.O.l., registro D 5 fondo citato

- raccoglitore 13, cartella 6: r adiointe r cettazio ni e bolle ttini del Comando S up e riore A. O. (1935-1936); - raccoglitore 26, cartella 1: bollettini radio (1936); - raccoglitore 36, cartella 5b: racco lta dei bollettini di Radio Littor io; - raccoglitore 58, cartella 1: bollettini notizie di Radio Littorio; - ra ccoglitore 85, cartella 8: bollettini radio: - ra ccoglitore 153, cartella 2: bollettini radio; - raccoglitore I 54, ca rtella 3: bollettini radio, stralcio noti ziar i g iornalieri; - raccoglitore 162, cartella 4: radio nazionale (1935); - raccoglitore 163, cartella 2: raccolta bollettini radio ( 1935-1936); - raccoglitore 202, cartella 1: bollettini radio del IV C.A.; - raccoglitore 219, cartella 4: gi ornale radio.
Ca rteggio del Corpo Truppe Volontarie, Spagna, registro F 6 fon d o citato - raccoglitori 41 e 43: r es oconti e bollettini
radio (1937-1938).
Carteggio della Commiss ione Suprema Difesa, registro F 9 fo nd o citato - raccoglitore 38, cartella 16: disciplina de ll a radiofonia n azionale in guerra (1936); - raccoglitore 40, cartella 3: re lazioni e discussioni su ll a r ad iofonia in guerra (1936); - raccoglitore 57, cartella 3: organizzazione e funzionamento d e lla radiod iffusione in guena (1940) ; - raccoglitore 58, cartella l: discussione sulla radiodiffusione in guena (1940).
Archivio Centrale d e llo Stato Fondo Ministero dell ' Aeronautica, Gabinetto : - 1937, busta 80, fase. l l -J-8: vendita di ri produzi o ni grammofonich e di discorsi del Duce.
CANNISTRARO Philip V , La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, op. cit.
FO RGES DAVANZATl R o be rto , Cronache del regime, 3 voli., Milano 1936-1937. Pubblicazione dell e radio-conversazioni di uno d ei più efficaci speaker del R eg ime.
RIVISTA Cine Ra dio, op. ci t.

Ca rteggio Sussidiario Gu erra , registro L 14
fo n do citato
- ra ccoglito r e l l I , carte lla 2: bandi A.O.L (1939).
Carteggio d ei Co rpi di Sp edi z ione e di Occupazione, registro E 3 fo ndo cit ato
- raccoglitor e 9, cartella l: bandi, ordinanze, manifestini (Fiume 1919).
Carteggi o Su ss idiario dei Corpi d ' Armata in A. O. l. , registro D 5 fo ndo citato
- raccoglitore 160, ca rtella 1: bando di Badoglio alla popolazion e e tiopica; - raccoglitore 206, cartella 4: bandi c manifes tini in a maric o c i ta liano ; - raccoglitore 207, ca rtella 1: b a ndo d e l IV C.A. a ll e popolazioni indigene (1936).
Ca rteggio d el Corpo Trupp e Vo lontarie, S pag na, registro F 6 fo ndo citato - raccoglitore 10: manifestini di propagand a naziona ]ista e repubblicana ; - raccoglitore 24 7: manifes tini di propaganda r e pubblican a, anche per g li italiani ; - raccoglitore 312: ma ni festini di propaganda r e pubblican a.
Fondi vari
Sono fondi di varia natur a, non meglio identificabili , cust oditi in arch ivio e in fototeca.
Sono stati co n s ultati: - R elaz ion e della Commissio n e d'Inchiesta per i fatti di Fiume: raccoglitor e 8, cont iene manifestini c volantini ; - Fondo Scotti , Croce R ossa Italiana, raccoglitori FV da 22 a 27, con t engono manifesti e volantini d e l primo dopoguerra.
AA.VV., Collezionismo itali ano, Milano 1979. Zibaldon e per collezioni s ti , utile per alc un e noti z ie s ui manifes ti e sug li autori di ico nografie.
BATINI Giorgio, L'Italia sui muri, Firenze 1978.
Opera uni ca nel s uo genere, ripercorr e dall ' antichità a i nostri giorn i il «malvezzo » it a liano di scrivere sui muri e sulle op e re d'art e.
BOCCA Giorgio (presentazione di) , l ntanifesti italiani fra belle époque e fascismo, Milano 1971.
Opera illus trata sui m a ni festi, soprattutto pubblicitari , con uno scarno apparato critico. Da vedere
più ch e da legge r e.
F R ASCHETI I Lu ci a n o , Storia viva. La storia attraverso i manifesti, i giornali, le cartoline, (ved i sta mpa ) .
MIGN E MI Ado lfo, Immagine coo rdinata per un imp ero. Etiopia 1935- 1936, (op.cit.).
VEROLI Se b ast iano , Il R eg ime sui muri, Polle nza 1 987. Ca talo go d e ll a mostra di man ifesti fasci s ti d a l 1921 al1944 realizzata a Mac erata .
V ILL ANI Dino (prese ntazion e di) , Skema , rivista m e nsil e, n. 111973.
N u mero de ll a ri vista dedicato a i ma nifes ti p ubblicita ri e d i propaganda , a nc he d i guer ra. Un a ve loce ca rr e ll ata.
VILLAN I Din o, Storia del manifesto pubblicitario, Mila no 1964 . L'a u to r e fa l a stor i a d e l manifesto e d e dic a spaz i o anc h e a quelli di prop aga nd a poli tica e per la guerra.
ZE MA N Zby ne k, l manifesti e la guerra (1939-1945) , Novara 1978. Carre ll ata int e rn az ionale di manifes ti di prop aga nda di g ue rra, che tocca solo ma rgi na lm e nt e l'Ita lia e il periodo di interesse . Utile pe r po rre a confronto id eo log ia c grafica de l manifesto.

Carteggio Sussidiario Guerra, registro L 14 fondo
- raccoglitore 99, cartella 5: stampa nazionale ed estera (1935); - raccoglitore l 00, cartella 4: racco lta di comunicati della guerra italo-etiopica (1935-1936).
Carteggio Libia, registro L 8 fondo citato -raccoglitore 230, cartella 1: stralci notizie da giornali arabi (1920); - raccoglitore 230, cartella 2: stralci stampa (1921-1923); - raccoglitore 230, cartella 7: stralci stampa (1925); - raccoglitore 230, cartella 14: notiziario della stampa estera (1928); - raccoglitore 230, cartella 15: dattiloscritto per un opuscolo celebrativo «Le operazioni nella Sirtica» (1928).

Carteggio dello Stato Maggiore Regio Esercito, registro L l O fondo ·citato - raccogfitore 128, cartella .1: notiziari militari speciali (1924-1927) ; - raccoglitore 143, cartella l: articoli sulla stampa (1937-1940).
Carteggio dello Stato Maggiore Generale e del Comando Supremo, registro l 4 fondo citato
- raccoglitore l, cartella l 0: stralci della stampa e notizie sulla situazione politica internazionale (1936-1940); - raccoglitore 3, cartella 1: r ecension i stampe e di pubblicazioni della guerra in A.O. (1937-1938); -raccoglitore 6, cartella 6: censura sulla stampa (1939-1940).
Carteggio della Commissione In teralleata di Parigi, registro E8 fondo citato - raccoglitore 289, cartella 1: stralci di giornali riguardanti il problema italiano (1918); - raccoglitore 290, cartella 2: notiziario stampa (1919); - raccoglitore 290, cartella 3: stralci della stampa estera (1919); -raccoglitore 291, cartella 1: stralci di giornali vari (1919); - raccoglitore 291, cartella 2: notiziario stampa (1919); -raccoglitore 292: stampa e propaganda.
Carteggio dei Corpi di Spedizione e di Occupazione, registro E 3 fondo citato - raccoglitore 8, cartella 2: opuscolo «La rivendicazione d ell'Italia sulle Alpi e nell'Adriat ico» (1919); - raccoglitore 19, cartella 1: articoli di giorna li (Dalmazia 1919); - raccoglitore 2, cartella 4d: propaganda a m ezzo di giornali turchi (Anatolia 1919); - raccoglitore 3, cartella 6b: accuse
all'Italia della stampa (Anatolia 1919); - raccoglitore 5, cartella 3d: estratti della stampa di Smirne (Anatolia 1919); - raccoglitore Il, cartella 7a: lettera sul giornale «Avanti» (Anatolia 1919); - raccoglitore 18, cartella 6: articoli e rassegna stampa (Anatolia 19191921); - raccoglitore 36, cartella 6a: protesta della popolazione di Aintab sui giornali (Anatolia 1921).
Carteggio del Gabinetto Guerra, registro Hl fondo citato
- raccoglitore 67, cartella 8: notizie politiche e militari riportate dalla stampa estera (1939).
Carteggio del Capo del Governo, registro H 9 fondo citato

-raccoglitore 2: appunto per un opuscolo del col. Bronzuoli sulla protezione antiaerea e la difesa civile ; - raccoglitore 4: appunto per un opuscolo del gen. Figari (1939); appunto per il Calendario Anno XVII (1939); appunto su corrispondenza di giornalisti (1939); relazione su corrispondenze di giornal isti italiani in Polonia (1939).
Carteggio Sussidiario A. O .l. della guerra itala-etiopica, registro D l fondo citato
-raccoglitore 13, cartella 12: notiziari e comunicati per la stampa; - raccoglitore 20, cartella 16: stampa propagandistica nazionale ed estera;
- raccoglitore 92, cartella 1: pubb lica z ioni riguardanti le coloni e; -raccoglitore 93, cartella 4: pubblicazioni varie; - raccoglitore 93, cartella 5: parere di Baistrocchi su «Cronache illustrate dell'azione italiana in A.O. >>; -raccoglitore 93, cartella 6 : richiesta notizie e materiale per pubblicazioni; -raccoglitore 93, cartella 8: pubblicazione «Relazione dell'attività svolta dal Ministero deila Guerra per l'impresa A.O.» ; - raccoglitore l 08, cartella 9: articolo pubblicato dal «Telegrafo»; -raccoglitore 121, cartella 1: varie, pubblicazioni; - raccoglitore 122, cartella 1: Servizio Informazioni - pubblicazioni, riviste , stampa; -raccoglitore 122, cartella 2: Servizio Informazioni -stampa, pubblicazioni; - raccoglitore 123, cartella 1: Servizio In formazioni - giudizi della stampa estera; -raccoglitore 124, cartella 2: Servizio Informazioni - rit1essi sulla stampa belga del cont1itto italo-etiopico; - raccoglitore 125, cartella 1: Servizio Informazioni - giudizi della stampa estera divisi per Stati; - raccoglitore 126, cartella l: va lorizzazione della vittoria a mezzo stampa; - raccoglitore l 33, cartella 5: Servizio Informazioni - giornalisti in Etiopia; -raccoglitore 191, cartella l: la stampa e l'A .O.J.; - raccogLitore 238: notizie per la stampa fornite dal Ministero della Stampa e
P ropagan d a : -raccoglitore 240: co mm e n t i d e ll a s t am p a s u perso n a li tà e s u p ub b li cazion i ; - raccoglitore 241: co mm e nt i d e lla stamp a a i vo lumi di D c Bon o e di Bad og li o.
Carteggio Suss idia rio d e i Corpi d'Armata in A.O I. , reg is tro D 5 fondo c itato
- raccoglito re l O , carte lla 7: var ie pubb li caz i o ni ( 1935 ) ; - ra cc o g lito re 24, carte lla 6: sta m pa e prop aga nd a ( 1 935 -193 6) ; -ra ccog lito r e 28, carte lla 1: s tampa e prop aga nd a; - raccogli to r e 48, carte lla 6: g io rn a l i; - raccog li to re 60, ca rte lla 4: ab b o nam e n t i a g io r n a li: - raccogli tore 62, ca r te lla 2 : p u bbl icazi on i (se r v iz io s t a mpa c in e m atog r afi co); -ra ccog lit o r e 92, ca rte lla 1: gu ida pratica p e r l ' uffi ci a le d es tinato in A.O ; -racco g li to re l 08, ca rte lla l 0: m o n ogr a f ie d e ll a pis ta a u tomo b ilistica Adu a-E n t icciò ; - racco g lito re 133, c arte ll a 14: ist ruz ioni e p ubb lic az io ni va r ie; - ra cc o g lito re 155, c arte lla 5: corris p o nd e n za d e ll 'Uffic io Sta m pa ; -ra ccog lito re 2ll, ca rte lla 9: s tampa e propa ga nd a; - ra ccog li to r e 232, ca rte ll a 8 : r ego la m e nti , s t a mp a e p ropa g anda ; -raccog li to re 238, carte lla 1: stampa e pr op a ga n da.
Carteggio de l Corpo Trupp e V o lonta rie,

S p agna, r egis tro F 6 fo nd o citato
-raccoglito re 36: s t a mpa c p r o p aga nd a . do c um entaz io n e v ari a; -raccoglito re 173 : sta mp a e p rop aga nda ; - raccoglitore 24 1: a r t i co li , o pus coli, propa ga nd a va ri a; - ra ccog li to re 268: Bolle ttino d ' in form az io n e a nti-marxista (n. 4 , 193 9) ; - racco g lito re 271: g io rn a le «Il L eg ion a rio », d a l n. l a l n 3 04 ( 1937193 8); - ra cc o g lito re 329: s t a mpa c p r opagand a.
Cartegg i o Oltr e M a re S pagn a, Gabin etto Gu e rra, reg istr o F 78 f ond o c it ato - raccog li to re 2, ca rte lla 32 : se rv izio g io rn a l ist ico p er le az ion i in O .M S.: - ra ccoglito re 2, carte lla 33: se rv izio g iornalist i co; - raccog lit o re 7, ca rte lla 12 : ri ass u nti s tamp a ( 1939); -ra ccog li to re l 6: s i t u a zione po l iticomi li t ar e, n o ti z ie s tampa ( 1936 - 1938); - racco g lito re 48: p u bbl icazio ni e op u sco li eli pr o p a gan d a.
AA. VY. , La s tam p a m ili tar e in I talia. Atti de ll o Conveg n o E u ro p e o d e lla R ivis ta Mili ta re, R oma 1977 . U t ile p e r le s in t e ti c h e n otiz i e dei p e r iodi c i m ilit a ri e diti durante i l fa sc is m o .
BALDI Ubaldo, L a guerra civile di Spagna. Saggio per una bibliografia italiana, Urbino 1974. La maggiore utilità del saggio è nella segnalazione degli articoli dei periodici, contemporanei e postumi.
BARZINI Ludina, Barzini Barzini Barzini. Una dinastia di giornalisti. Un secolo di fatti , Milano 1986. L'opera non è solo la storia di un impero giomalistico, ma attraverso interviste e nanazioni di avvenimenti interni ed intemazionali 1ipercorre la storia d'Italia e i rapporti tra stampa e fascismo.
BON ARDI Pierre , Senlizio Stampa A. 0., Firenze 1936. Raccolta di conispondenze di guerra al seguito del II Corpo d'Armata di un giornalista estero dell ' «Excelsior».
BOTII Ferruccio- Virgilio, Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra, op. cit..
CANNISTRARO Philip V., La fabbrica del consenso. Fascismo e mass-media, op. cit.
CARABBA Claudio, Il fascismo a fumetti, Rimini 1973. Rassegna della stampa per ragazzi, dove si dimostra come anche i fumetti non furono risparmiati dalle direttive propagandistiche del Regime.
CESARI Maurizio, La censura nel periodo fascista, Napoli 1978.
Cesari riscrive, attraverso i documenti d ' archivio, ma in modo frammentario , l'ingeren za della censura fascista sulla stampa , in un saggio contenuto.

DEL BUONO Oreste, Eia, Eia, Eia, A/alà! La stampa italiana sotto ilfascismo, con prefazione di Nicola Tranfaglia , Milano 1971. Antologia della stampa italiana , con spunti e osservazioni interessanti sul giornalismo e le corrispondenze, sugli interventi del regime. Opera fortemente critica.
FRASCHETIT Luciano, Storia viva. La storia attraverso i rnanifesti, i giornali, le cartoline, lO volumi, Roma 1990. Ponderosa raccolta in facsimil e di giornali, manifesti e cartoline del '900. Manca di apparato storico e critico.
LICATA Claudio, Storia e linguaggio dei corrispondenti di guerra, Milano 1972. L'autore, giomalista professionista, esamina il linguaggio dei corrispondenti di guerra, secondo un'ottica che, in ve1ità, appare alquanto parziale.
MURIALDI Paolo, La stampa del regime fascista, Bari 1986. Storia del giomalismo dal1925 al1943, ricca di dati e notizie; è tra i lavori più attendibili.
RIVISTA Cronache della guerra, n. 1111 del1939, Roma 1939. Rivista di propaganda della guerra, illustrata, interessante per comprendere l'atmosfera del momento.