Militarisn1o

(a proposito del " M il i tar i s m o , di Guglielmo Ferraro).
MILANO FH.ATELLI TREVES, EDITORI -MILANO
Via Palermo, 2, e ffalleria Vittorio Emanuele, 64 e 66.
Rpma: Via del Corso, 383. Napoli: Via Roma (già Toletlo), 34. Bolo,qna: Libreria Fratelli Treves di L. Beltrami, Angolo Via Farini.
Trieste: presso G Schubart.
Parigi: presso Boyveau et Chevillet, 22, rue Ile la Banque. Lipsia, Berlino e Vienna : presso F. A. Brockhaus.

A V V E R T E N Z A.
Le pagine _che seguono contengono alcuni articoli apparsi, col medesimo titolo, nel giornale La Perseveranza del settembre scorso. Diverse persone, il cui giudizio io tengo in altissimo conto, mi mostrarono desiderio di vederli riuniti in un opuscolo, reputando, a quanto io credo, che la gravità della materia e la bontà della causa li faccian degni di meno effimera vita.

Per gli stessi motivi io aderii al desiderio cortese, pur resistendo ad ogni tentazione di rifacimenti o di più ampii sviluppi del piccolo lavoro. Ho voluto anzi deliberatamente serbargli quel carattere giornalistico che solo può spiegarne la tenuità e renderne meno intollerabili le mende; recando insieme una più viva e spontanea impronta dei sentimenti che mi indussero a scrivere.
Olgiate Molgora, ottobre 1898.
S. .

ESERCITO E MILITARISMO
I.
Un egregio ufficiale del nostro esercito, il capitano Fabio Ranzi, pubblicò nella Rivista d'Italia del luglio passato un importante studio intorno a quella teoria della guerra che Guglielmo Ferrera espose primamente nelle conferenze tenute a Milano e raccolte poi in un volume ben noto che intitolò Militarismo. Lo studio del Ranzi é un'efficace ed elevatissima confutazione della dottrina del giovane scrittore piemontese. Egli vi combatte l'avversario con le stesse armi sue, mantenendo cioè la disputa sovra un terreno rigorosamente scientifico e contrapponendo a quella del Ferrera una propria teoria della guerra dedotta, pare a noi, con istretta logica, mediante la quale egli arriva a determinare lucidamente la legittimità e la moralità della funzione mi· G. S. Esercito e Mi!itu1·ismo.

Jitare nella società moderna. Di questo problema, fra i più vitali che possano agitarsi nella coscienza della nazione, vogliamo Intrattenere a nostra volta i lettori; ma avanti di affrontarlo ci preme dire di alcuni lamenti che n Ranzi muove , con grande nobiltà e moderazione di linguaggio, a nome dell'esercito italiano: lamenti l quali, perchè non cç)l)ressar·lo 1 ci andat·ono diritti al cuore e vinsero ogni nostra esitanza ad eutl'are in cosl grave argomento.
Si duole il Hanzt che in una città come la nostl'a e da un pubbllco che le crouache de'giornali dissero elettlssimo la pa•·ola del Ferrera, suonante cosl ftet·a rampogna agli ordinamenti militari in genere e all'esercito italiano in ispecie, abbia riscosso applausi calorosi ed unanimi. " Di codesti applausi , dice il Hanzi "l'esercito ha ricevuto l'offesa in pieno pètto ,. Anche si lagna che, all' apparire del Militarisma, la stampa militare quasi sola siasi mossa a combatterlo, menti-e il più dei giornali monarchici, o si chiuse in un silenzio noncurante, oppure fu prodigo di lodi al Ferrera senza mostrar tampoco di accorgersi del veleno che si nasconde nella sua dottrina. Deplora infine l'egregio scrittore della Rivista che in Italia, e specie in Milano, a render giustizia all'esercito e a proclamarlo la parte sana per eccellen::a della nazione, si sia scelto il giorno in cui esso venne chiamato al tristissimo ufficio di una in certo modo con questi inni al sangt a versato l'indegna accusa che fa della milizia nazi1

....:..3 naie, in mano alle classi dominanti, uno stromento di oppressione delle misere plebi.

Del primo. di quei tre peccati noi siamo in tutto mondi, poiché alle conferenze del Ferrero non ci fu dato d' assistere. Perciò appunto non ci troviamo in grado d' affermare con certezza quale sorta di pubblico vi accorresse, e tanto meno di porre in " dubbio che quello che vi accorreva -fosse elettissimo. Abbiamo bensl ragione di supporre che nell a sua grande maggioranza si componesse dei radicali più avanzati, di repubblicani, di socialisti, e di quell a frazione della studentesca milanese che segue tali parti politiche; di gente, insomma, degna di ogni r ispetto, ma già. sufficientemente persuasa, anche prima di recarsi al teatro dell'Alhambra, che le istituzioni militari son cosa poco meno che abbominevole. Dell'atmosfera intellettuale che regnava in quelle ad unanze noi non sappiamo se non quanto ne disse il prof. Ottone Brentari ih. una bella e calda letter a aperta ch'egli rivolse nel Corriere della Sera al Ferrero, dopo una sua applauditissima conferenza: le ttera nella quale la tesi del conferenziere era mol to efficacemente combattuta, ma all'ingegno e all' elo quenza di lui si rendeva pieno e sincero omaggi o.
"Sarebbe, scriveva il Brentari "difficile assai .il . cogliere intera l'impressione che il vostro discorso fece domenica scorsa sul numeroso pubblico dell'Alhambra. Le frasi che mordevano persone , il tentativo di abbassare quanto da altri è considerato alto,
: ed altri

par-ddOSSaJi fra uo b1
e .-tlarico1 fra Alesi
ma quando
,.elte dei vostri eccelsi i
c;•)n vi seguiva piu e:
grazioso morso a
le maai ed applaudi
d'ounbiente, fatta allo si
suoi uditori, non può e
da essa il Ranzi se o
!.Ira era da vvero l' ani
il valoroso scrittore ri
noi siamo purtropf
nel fatto1 colpevoli;
addurremo più innan;
dolorosamente ci sen
sua. Potremmo
ricevuta in pieno
proprio noi che scriviamo,
di maggio in uua delle
della nostra città, un e lo facemmo
al Ra.nzi più sem-
contorti dell'ora 1
stava· a.ttraverlaJ suo esercito, nel
-5quale si doveva riconoscere la parte per eccellenza sana dell'organismo nazionale. Ciò ripetiamo con sel'ena coscienza oggi , pur sapendo che i nemici delle istituzioni fingeranno di vedere, o anche vedranno, in una affermazione simile, l'inno di grazie di una paura che ora soltanto principia a calmarsi, o forse il programma di una parte politica abbastanza cieca per non sognare altri metodi di governo che la violenza e l'arbitrio. Ma in verità codesti miser·evoli giudizii . non arrivano fino a noi. Troppo alto e puro è il sentimento che ci lega all' esercito, troppo si confonde nel nostro cuore col sentimento stesso della patria, perchè i sarcasmi dottrinari ci impediscano di manifestarlo e di gloriarcene.
Se non che nemmeno possiamo accettare la cen· sura, pur cos\ misurata e impersonale, dell'egregio scrittore della Rivista d'Italia. Il contrasto che gli ultimi eventi sciagurati palesarono fra le condizioni generali della vita italiana e le nostre istituzioni militari, contrasto che torna a tutto onore di queste ultime, è un fenomeno psicologico non solo assai notevole, ma , per certi rispetti, fin an co sorprendente; nè si poteva pretendere che lo spirito pubblico non avesse a commuoversene. Il paese, chi vorrebbe è malato nel più intimo delle sue fibre. Ha veduto precipitare uno dopo l' altro, nelle crisi economiche, nei disastri mUital'i, nelle vergogne bancarie, i suoi giovanili sogni di prosperità, dì gran-

-Gdezza e di rinnovamento civile. S'è sentito ricoprire tutto da un'ondata fangosa di corruttela morale e poli tica, che non lasciò immune alcuna parte del suo organismo. Il parlamento e il governo, la burocrazia e il giornalismo, il mondo della politica e quello degli affal'l, tutti ne andarono chi più c hi me110 inzaccherati. Perfino la magistratura, arca santa dei popoli liberi, ed anco fra noi degnissim a in tanta sua parte di profondo ossequio, non fu sem pre e dovunque superiore al sospetto. E fra ttanto, moltiplicandosi da un lato le tirannie minu te ma corrompitrici del parlamentarismo, e dall' alt ro imperversando sempre più la stampa sovversiva e le propagande settarie, la coscienza politica dell a nazione non tardò ad annebbiarsi del tutto ed a smarrire il senso della misura e della realtà. Si venne cos\ a poco a poco spegnendo nella vita pubblica italiana ogni ardore di bene, ogni fede nell'a vveni re, e vi si fiaccò ogni sentimento di respons abilità individuali e collettive. In brevi anni il paese aveva percorsa intera la china degli scetticismi e delle transazioni colpevoli; e, giunto al basso, s'era acca sciato in una indifferenza fatta di stanchezza e di sfiducia, che è il peggior dissolvente delle socie tà umane.
Qual meraviglia se il turbine lungamente prese ntito a bbia, scoppiando, trovato a terra tutte, sal vo una, le difese sociali, e per sola virtù di quell'un a non sia riuscito a porre in -grave pericolo la co m-

pagine dello stato? E qual meraviglia se la nazione, la quale ha pure una istinti va coscienza dello infer· mità che la travagliano, tremasse per uu momento al pensiero che le stesse infermità, diffuse nell'esercito, avrebbero potuto rendere irremediabile la rovina? Non è egli umano che essa non sapesse frenare un senso di immenso sollievo ed un vivo impulso di gratitudine, scorgendo la vanità de' suoi timori'f * ....
Non v'ha in questo sentimento, ce lo creda il capitano Ranzi , nulla che sia ingeneroso o che offenda la pietà dovuta a vittime, misere e incoscienti, di colpe altrui; chè anzi, esso non ha radice se non nel convincimento che una repressione compiuta colle armi è il più doloroso sacrificio cui possa essere chiamato un esercito moderno, e sopratutto un esercito italiano. Nelle epoche e negli stati che il Ferrera descrive con tanto compiacimento, in cui le forze militari si riducevano ad accozzaglie di feroci tolti alla feccia sociale, ere· sciuti alla violenza ed al sangue, n domar una rivolta popolare non era per esse compito più ingrato nè più ripugnante del combattere una guerra esterna. In tempi meno barbari, nei quali tuttavia le milizie si mantennero istituzioni chiuse ad ogni influsso della società civile, educate al sentimento

-8-' della propria uperiorità e ad una tal quale antipatia altezzosa verso le altre classi sociali, questa lor condizione d' a nimo non poteva temperare •l'asp r ezza dell e lotte intestine. Ma soltanto i solita r'ii inebriati di una loro tesi, o i nemici dichiarati della ocietà p•·csente, possono trastullarsi a scoprire analogie, o a t rovar somiglianze, fra quei due vecchi tipi mi litar'eschi e il soldato d'oggi. Il concetto moderno della sovranità nazionale, la costituziflne democ!'atica de lle società civili, il servizio obbli gatol'io, Ju ferma breve e infinite altre cause, tencl no a po r re gli eserciti in sempre più direttn, comuni ne di sentimento e di pensiero colle popolazioni onde e cono. Se v'ha in tal condizione delle milizie odierne qualche pericolo, esso sta in ciò che lo spi rito critico e la coscienza individuale, prevalenti a dismisura nelle società demor,eatiche, possano affievolire il sentimento della disciplina c lo spil'ito di abnegazione che sono come le intangibili colonne dell'edificio militare. Ma ogni peric lo di indole op posta pare a noi sogno di menti inferme.
Ora non v'Ila fo1·se esercito che più del nostro sia legato da saldi e stretti vincoli alla nazione. Sorto con questa into·rno al vecchio e forte nucleo del Piemonte, er'ede della tradizione patriottica che pre iedette al risorg imento nazionale, esso è d L lunga pezza abitua to , cosl come la grandissim L maggi 1'a11za degli ita liani, a confondere in un ffi(-

desimo sentimento l'affetto alla patria e la devozione alla gloriosa dinastia che la ridusse ad unità. Nessuno oserà negare che il nostro esercito sia stato e sia un efficace strumento di unificazione po1itica, cui è quasi in tutto dovuto quanto. si ottenne fin qui nel vincere i pregiudizii regionali e ,nel fondere moralmente fra loro le varie parti del regno. Ed è non !lleno innegabile che tra le sue file un largo senso di umanità e un altruismo generoso abbiano aleggiato sempre. Ogni volta che vi furono in qualche angolo d' Italia pericoli da sfidare, fatiche da sopportare ed aiuti pietosi da porgere, esso prodigò sé medesimo alla nazione con una spontaneità ed una semplicità che già da lunghi anni gliene conquistarono il cuore.
Ma perché un esercito siffatto affronti serenamente il dolorosissimo ufficio di una repressione, occorre che egli abbia una coscienza molto chiara e molto determinata del dovere che gli incombe. È d'uopo che i capi e gli ufficiali trovino nel patriottismo e nella virtù di sacrificio la forza di assurgere a quell'intuito delle necessità superiori, a quell'alta pietà sociale, che non rifuggono dai mali mi.nori per scongiurarne di infinitamente più grandi. Occorre altresl che a codesta concezione del dovere si accosti, se pure in modo più rudimentale, la massa meno colta dei gregarii e vi trovi un valido sussidio nello sforzo di obbedienza che le è richiesto.

10·-
Sotto questo aspetto la condotta del nostl"o esercito durante l'infausta crisi del maggio apparve degna di ogui encomio. L'azione sua, pur ispirandosi ad un preciso concetto di responsabilità sociale, fu tutta compenetrata da una larga corrente di bontà e di pietà umana. I suoi membri, dai capi supremi all' ultimo soldato, gareggiarono di sollecitudine, di longanimità, di abnegazione, persinÒ di pietosi artiftcii, per mitigare, fin dove era possibile, la tragica necessità delle cose. Ma la fede che l' esercito mostrò di nutrire nella nobiltà del proprio mandato, la sua devozione alla patria e alla monarchia si palesarono cosl salde e pure, da recare nella precoce vecchiaia del paese come un alito di freschezza e di gioventù. E chi può rimproverare al paese, immerso da tanti anni nel pantano degli sterili scetticismi e delle cupidigie utilitarie, di essersi commosso e quasi risvegliato a questo soffio di giovinezza e di avervi trovato un conforto al suo grande dolore?
Or ecco perché da un cotal punto di vista il fenomeno spirituale che ci offre l'esercito sembra, secondo dicemmo a principio, quasi sorprendenh Se consideriamo che nell'immane congegno di c1 i esso consta, cosl come in ogni organismo vivent :,
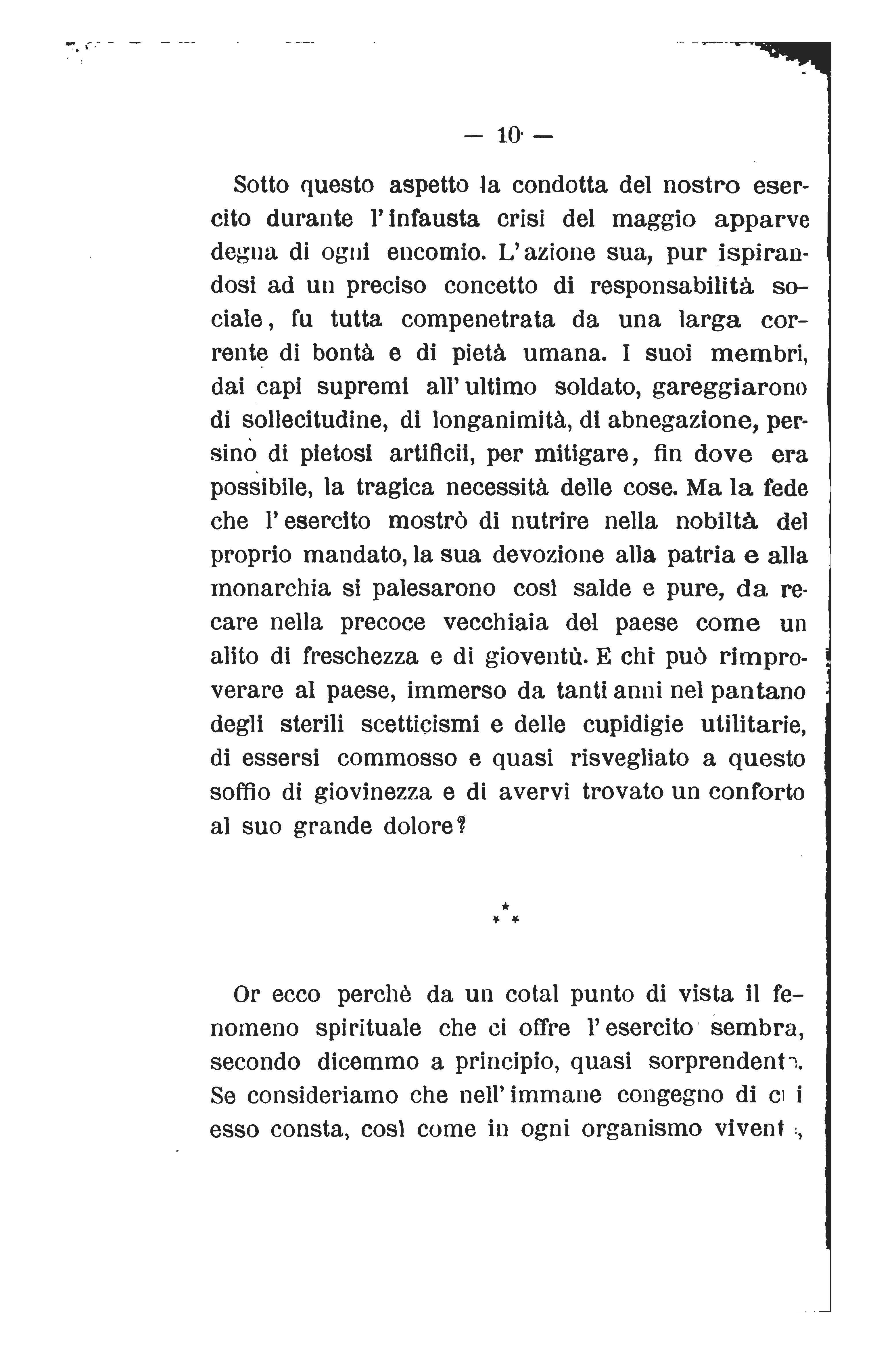
-11-
le cellule elementari si mutano e si trasformano senza tregua, ond' esso va di continuo assorbendo dal paese nuovi elementi, già in parte inquinati dalle propagande sovversive o avvelenati dagli odii di classe, noi siamo indotti a chiederci come ' mai in codesto organismo il sangue trascorra ancora cosl puro, e la vita si mantenga cosi rigo·gliosa.
Pasquale Villari hl un nobilissimo discorso pronunciato in occasione del centenario del Savonarola (discorso che un caso felice collocò nella Rivista d'Italia accanto allo studio del Ranzi) si pone lo stesso quesito e lo formola argutamente cosl: "Ma " dunque questo cappotto è un talismano che tras.. " forma istantaneamente gli uomini 7 ,, E lo risolve allegando la condizione di superiorità morale in cui l'esercito si trova rispetto al resto del paese, le correnti di affetto e di rispetto reciproco che vi affratellano le diverse classi e dirozzano e placano le più diffidenti e le più rudi. Certo gli ordini militari, quali l'evoluzione storica li ha condotti ad esser oggi in Italia, posseggono una loro propria e preziosa virtù di assimilazione e quasi di purificazione, che i loro nemici si affannano indarno a negare. Vi si compie un processo di adattamento spirituale che. nelle misere condizioni di coltura e di coscienza di una gran parte delle nostre popolazioni, rappresenta un incalcolabile valore educativo e moralizzatore. Av viene per tal modo che una istitu-

-12zione destinata al presidio materiale dello stato n e di ven ga una delle forze morali più vi ve, poiché c ti serv a intatto in sè n tesoro di quelle idealità che nel s eno della nazione si vanno scolorando e spegnendo.
Ma non bisogna dimenticare che si fatto squilibrio, temporaneamente benefico, fra nazione ed e ct·cito, è fenomeno d'indole tr·ansitoria, do vuto a precede nti storici affatto eccezionali. L'esercito non può ilormalmente sussistere che applicando e ra t'fl uaud le en ergie morali che gli vengono dalla nazione, né può alimentarsi se non delle stesse virt ù che fioriscon o nella società civile. Onde se questa de ·r1ùe il'rem issibilmente, le istituzioni militari potmn no bensl difendersi per alcun tempo con la vir·tù pro pt'ia dal comune contagio, ma finiranno pur col s ccom bervi. "Una nazione scettica, osserva il Ranzi 11 ed un esercito generoso sono, a lun go anda1·e, "termini inconciliabili, e aggiunge fin ameote che l'ese ecito italiano vive oggi spendendo co n larghezza un capitale di tradizioni e di virtù accumulate i n lun go volger d'anni e di vicende; ma che se jJ paese non penserà a reintegrare via via quel capitale prezioso, presto o tardi gli accadrà di tmvarlo inter·amente esaurito. Si può infatti ripetere, rispetto a"'li eserciti, quel che fu già detto dei go vernl, e loè che i popoli finiscono sempre con l' averli quali se li son meritati. Questa opera di rei ntegrazione vuol esse1·e continua e sagace e deve cou istere

-13nel non lasciar perire in seno alle nuove gener-azioni gli ideali patriottici che sono l'anima dell'esercito, nel circondarlo di benevola sollecitudine, sopratutto nel difenderlo gelosamente da ogni accusa e da ogni sospetto.
Perciò è con grande tristezza che noi assistiamo da tempo alla guerra che in Italia si muove, in varie forme, contro gli ordinamenti militari. Meno ci turba quella che viene dai nemici dichiarati del presente assetto sociale, la quale, logica e aperta com' è, offre per la stessa evidenza dei suoi ultimi fini minori pericoli. Ben altrimenti paurosa ci sembra invece quella che è combattuta nei campi più elevati del pensiero e si ammanta di imparzialità storica e prende a vessillo concetti ideali che seducono lo spirito delle moltitudiui e in ispecie avvinghiano irresistibilmente il cuore dei giovani. Screditare e demolire almeno moralmente i vecchi congegni guerreschi degli stati civili, affine di promuovere nel mondo il trionfo della giustizia e della pace; dimostrar coi metodi e col linguaggio della indagine scientifica che quei congegni e il mostruoso fenomeno cui sono destinati rappresentano, sulle vie della umanità, gli ultimi ostacoli al raggiungimento de' suoi più alti destini; spargere nelle coscienze la convinzione che il disonorare gli ordinamenti militari equivalga o basti ad abolire la guerra, assicurando il finale riscatto dei miseri e degli oppressi : ecco il fulgido miraggio che si fa splen-

dere ngli occhi di questi miseri ed ecco l' opera pregna di pericoli cui attende una scuola sociologica della quale è capo riconosciuto in Italia Guglielmo Ferrera.
Quando, in principio d'anno, ci accadde di leggere per la prima volta il Militarismo noi ne riportammo questa duplice impressione: che il pensatore era forte, e lo scrittore ricco di fascini; ma che la sua dottrina, in ragione appunto dell'arte con cui è ammanita, doveva ritenersi sostanzialmente perniciosa. Da qui il vivo desiderio nostro di veder sorge!'e una confutazione del libro che, per ampiezza di svolgimenti, per ricchezza di indagini e per rigore di metodo fosse degna dell'avversario che im· prendeva a combattere. Ci parve perfino che in un argomento di cosi vitale importanza per l'avvenire della nazione non sarebbe stato superfluo il contrapporre libro a libro. Un simile desiderio non potè essere appagato in tutto dalle recensioni apparse in diversi giornali italiani, molte delle quali prege· volissime, qualcuna di penna insigne, ma o troppo sommarie o mancanti di carattere prettamente scientifico. Nè certo poteva cadere in mente a noi che scriviamo di sobbarcarci ad una simile 1 npresa, per la quale, oltre l'ingegno e il sapere, tro po ci sarebbe mancato di giovanili energie.

- 15-
Tuttavia (ed è questa la giustificazione che ab biamo annunciato) convinti che a combattere le dottrine avverse agli ordini militari debbono concorrere, secondo le loro forze, tutti gli amici delle istituzioni, noi ci accingevamo a parlare con qualche ampiezza del libro del Ferrer·o, quando scoppiarono i moti di maggio. Ohimè, che lugubre e eloquente commento a quelle dottrine e quanto lontano, ne siamo certi, dalle aspettazioni e dagli intenti del giovane autore! Ma dopo quei tristi fatti, in una città ove lo stato d'assedio lasciava i giornali monar·chici a parlar soli, senza possibilità alcuna di sentirsi contraddetti; e mentre i loro più fieri avversari (e quanti fra essi gli ammiratori del Ferrero !) andavano sgominati e dispersi, una discussione del problema militare ci era parsa cosa mancante di ogni garbo; e ne smettemmo il pensiero.
Leggendo ora lo splendido studio del Ranzi, noi vi abbiamo riconosciuto di primo tratto l'inizio di quella confutazione alta e scientificamente fondata delle teorie del Ferrero che da tanto tempo invochiamo. Sentimmo insieme che, dopo la sua, ogni ' altra parola potrà sembrare superflua e che ormai il meglio che si abbia a desiderare è di veder presto attesa da lui la promessa di compiere il suo lavoro. Ma anche provammo assai dolorosamente il n orso della censura rivolta dal Ranzi ai giornali n )narchici, e vogliamo a ogni costo scuotercela di d >sso, -tornando al primitivo disegno.

-16-
Perciò , senza pretendere di camminar sulle alte vette della speculazione scienti fica e tenendoci all e modeste forme consentite all' indole di un giornale quotidiano, noi daremo ai nostri lettori una idea delle linee generali del Militarismo e indicherem o lOI'O i precipui punti in cui dissentiamo da esso. La nostra, più che una confutazione metodica, sarà un a affer mazione, pur troppo non breve, di principii opposti. Quando la casa è assalita (e qui la casa è uno de' supremi interessi della patria) tutti devon o acco rrere a difenderla, senza badar troppo alla q ua lità delle armi che impugnano; basta a iTe l' rare cou cuore saldo le prime che vi cadon fra m ano. Que lla che ci decidiamo a brandit'e non é ricca di fregi scientifici. È un vecchio fucile delle guerre di indipendenza, ripescato fra le ra gnatele della rettori ca patriottica, e farà di certo poco male ai ue m.ici. Ma che importa, se il rumore de' suoi colpi dester·à qual cuno di coloro che hanno o bbligo di vigil are, c pUl' sonnecchiano, nel campo a mico'
E usciamo ormai di metafora. La generazioue alla qual e apparteniamo, che ha pa rtecipato alle lotte del risorgimento nazionale, non si dissimula di essere assai poveramente armata per quelle del pen sier·o moderno. " I nostri buoni vecchi 11 dice il Ferr·er·o in non sappiamo più qual punto del suo libi·o, " non ponno intendersi con noi n- A concezioni ftl o soliche e sociali sfolgoranti di n ovità e di audacia , chiuse come in corazze lucenti nelle formule dì me-

todi rigidamente scientifici, quella generazione non ha da opporre che le sue vecchie patriottiche;· tanto vecchie da parere ormai, ·fino alla nausea, volgari. ed ingenue. .E tuttavia es.sa vede. 9gni ·giorno, con infinito dolore,· il suo ideale pa,- · triottico assalito dai punti più estremi dell'orizzonte , ·intellettuale. Coloro che aspettano l'avvenire da una . . prevalenza sempre pfù e costrittiva della · collettività, e i solitarii che sognano inveee la sublimazione dall'individuo nel rallentarsi o nel dissolversi del vincolo socfhle, in questa uhic.a cosa · si nel coprire dl il sentimento della. patria, nel considerarlo un miraggio rettòrico già sfatato anche in Italia dalla realtà, onde le sue ultime parvenza dilegueranno fra breve, fors'anche colla generazione stessa ehe se ne valse per l'op'era della ricostltuzione nazionale. Ma non è que· sta la prima lotta nella quale il sentimento abbia vinto il pensiero. I vecchi. patriotti si confortano colla certezza che nei loro sentimentalismi si· na:scondé una verità seniplice e suprema, la quale ha le sue radici nel profondo dell'anima umana, sicché· le _più smaplianti audacie dell'intelletto riusciranno a smuoverla. Non è vero, .non è vero, che il nostro culto·sia condannato a morire con noi ! Esso rigerrnoglia con vigore nuovo entro innumerevoli cuori giovani e generosi che si stanno ·temprando per le battaglie dell'avvenire. A loro pensiamo ed
S.

in loro speriamo, afferma ndo che la patria è aucora rra le. concezioui um ane la più perfettibile e la più feconda di bene; che e sa può contenere le più ardite e le più geperose a pil'azion l della co scienza; che la sua difesa equivale ancora oggi, e equivarrà forse per secoli , alla difesa della civiltà .
I l.
Parliamo dunque del M ililarismo. Guglielmo Ferrera é, già lo dicemmo, un seducentissimo sct·ittore. Per quanto in lui la profondità del pensiero e l'a c utezza della indagine scien tifica si impongano, le doli predominanti "del suo ingegno sono, a giudizio tt n· stro, di indole arlistica. Di rado i accadde di incontrare un t emperamento letterario in cui, meglio che nel suo, l a semplicità e la chìarezzg si fondano armoniosamen te in . :una persuasiva ele ganza. V'ha· nei suoi libri una densità saporosa d i idee, una giovanile novità e fres hezza di andamenti che esercitano sottili mali e sui più acciglìati avver sari suoi. Cet·te descrizio ni, in cui ama indu ...iarsi, sono deliziosi paesaggi.; i n certe sue analisi storl ho è un'efficacia di rapprese utazione, una vivacità c l colore, un'abilità dia}ettica veramente singol ari. L

immagine· che sotto la -sua penna fiorisce ad ogbi tratto, felice sempre e spesso squisita, mostra bene che una certa acredine tribunizia ed una cotale soprofetica appena na:scondono in lui uila delicata indole di poeta.
Il contenuto scientifico dell'opera ferisce crudelmente mdl.te fra le nostre convinziùni più care; ma ciò non ci impedirà di riconoscere che esso anche rivela una forza d'ingegnp, una vastità. çli studi ed una individualità spirituale cui saranno assai probabilmente· dischiuse le vie maestre dell'avvenire;· se pure i odierni dello scrittore dovrai:mo subire· quel processo di attenuazione che agli spiriti maturati nella solitudine degli studi impone il contatto· vivo con la realtà.
Due pecche, secondò pare a no( si ravvisano di primo tratto nel Militarìsmo: un vizio d'origine che ne compenetra l'intero ordinamento, ed un equivoco grave cpe vi si mantiene attraverso tutti i meandri della dimostrazione scientifica. Di quest'ultimo diremo a suo tempo: il vizio d'origine consiste in ciò, che il libro del pensatore rappresenta un trionro, stavamo per dire un'apoteosi, del metodo aprioristù;o. Curiosi ricorsi che si verificano nelle manift::stazioni del pensiero, pei quali i novatori più imbèvuti di spirito moderno, coloro che volontieri n.pporrebbero la data d'oggi al principio della civiltà tmana, ricadono nei metodi rimproverati ai metalsici dei vecchi tempi l

-20-
Il nostro autore s'è posta una tesi semplice e recisa e ne ha cercate le immancabili applicazioni uella storia dell'umanità" Ma egli si trovò ilella condizione comune a tutti coloro che presumono di far entrare a forza, nella cornice troppo angusta e sim metr1ca di un loro preconcetto, tutta unà sequeia di elementi disparati e cozzanti fra I01·o ;. ha dovuto cioè storpiarne non pochi perchè bene o male ci entrassero, e metterne da. parte infiniti altr'i che a nessun patto ci volevano entrare.
Ed ecco, ridotta alla sua più espressione, la tesi del Ferrero. Tutto o quasi tutto il male che ha funestato il mondo proviene dalla guerra. ·Essa non ha creato nulla mai che meritasse di vivere ; non ha lasciato dietro di sè che dolori e rovine; non è stata la madre di nessuna virtù, sl bene la figlia dei pegr;iori uinan.i. Mtt lo spirito di cupidigia e di violenza onde ella· nasce porta in sè il .. . germe della s1,1.a punizione. Una legge di giustizia iusita nelle cose fa sl che questo medesimo spirito generi la progressiva decadenza e la finale distruzione delle società che furono per esso vittoriose e.soverchiatrìcl. Oggi la guerra non ha più, fra i popoli ci vili 1 missioni da compiere ; è virtualmente mOl'ta; le istituzioni militari, già stromenti di ingiustizia e di corruttela, SOl lO ormai sulle ·vie della civiltà uu inutile ingombro.
Per illustrare la prima parte di codesta tesi il nostro autore galoppa a briglia sciolta traverso la

21storia delle stirpi umane, in cerca di delitti guerreschi. E cosl, con mirabili pagine, le- quali pu e seguono da vicino le .orme di Slatin Pascià, ci mostea (quasi un esempio Ù10derno di quella prima e an tichissima forma bellica che fu l'orda barb arica) l'invasione trionfante del Màhdismo nel Suda n metter capo alla rovina dei conquistatori, dopo u n pe riodo di spaventevole tirannia, che isterill la ten·a, sperdè la ricchezza, distrusse la popolazione. Cosl egli ci presenta, sebbene in maggiore scorcio, la decadenza dell'impero romano e l'invasione barbari ca che Io soffocò, siccome i castighi storici ed inevitabi li dell'_opera di oppressione compiuta per secoli d ai Quiriti. Si sofferma poi a tutto suo agio, e con qu ell a. predilezione che gli scrittori non riescono se mpre a dissimulare pei loro migliori argomenti, si so fferma, diciamo, a descrivere . il sozzo palude d! corr u ttela, di bassezza e di (eroda in cui sta agonizzando il colosso della potenza ottomana.
La rovina della monarchia francese, caus a ta da . quella stessa aristocrazia militare che ne era il fondamento; la catàstrofe in cui precipita la s a nguinosa e infeconda tiramiia del primo Napoleon e (l'11eil Ferrer·o çonfronta pel carattere, per le ten detlzé, e per l'opera compiuta, ad Attila re degli Un ni, n 11 senza una segreta tenerezza pel 'Flagello d i Dio); infine la triste servitù militare e burocratica a. cui quei due precedenti storici hanno ridotta la F r an ia _d'oggi, chiudono il ciclo degli avvenimenti ai quali

-22-
l'aut01·e chiede l a riprova di una legge di giustizi a ch'egli l'iass ume nel detto evangelico: Qui glad io j'erit ylrtdio perit.

u questi esempi ritorneremo poi; ma, se a nche fosser·o tutti ed in tutto concludenti , ognun vede che, rispetto alla lunga, varia e dolor·osa odissea che è l a stor·ia delle stir>pi umane, essi appaiono scarsi e scelti con ade troppo palese. Basti che, fta i p poli designati dall'autore a fa1· arr·ossire quelle nazioJJi c ivili d'oggi le quali ancora esitano a libel'arsi dall e istituzioni militari, figurano si i Romani, ma hanno una par·te preponderante i Turchi e i Dervisci!
* ...
Se non che pare a noi che il concetto di q uella legge di giustizia a cui 11 Fet·rer·o affida le veudet della storia possa essere difficilrneute accolto, almeno nella forma assoluta e inesorabile in cui egli la concepisce; una giustizia che si esercita indipendentemente dalla volontà degli uomini, ed anzi a l'itroso di e sa, e embr·a teuer· insieme d el fa to greco e di una cer·ta fosca ed indeterminata fatalilà punitrice, cara alle v ecchie scuole romantiche. N da un punto di veduta schiettamente positivista , che è senza dubbio qu ello del nostro auto r·e, s i intende bone su quali basi e sa d 1 ba appoggiare. Il mon1·o nel quale viviam ci ffl'e , pur troppo, non solo }l consorzio degli uomini, ma in tutte le gradazi li
-,--23della vita, giu giu fino alle piu umili, alle più irresponsabili e alle piu immutabili, lo spettacolo costante dell'ingiustizia e· della violenza vittoriose; la selezione ottenuta e la vita perpetuata col trionfo. dei forti sui deboli, dei feroci sui miti, dei divoratori sui divorati. La natura che sell!brll, sorridere intorno a noi è, in fondo, un concerto pauroso in cui i lamenti disperati e le grida di terrore dei vinti si confondono cogli accenti d'Ira e cogli inni di trlorifo dei vincitori.
Chi dunque contempla coll'occhio della scienza il misterioso poema di dolore che si svolge intorno a noi, senza che la nostra. mente rfesca ad afferrarne il segreto; chi considera la scala degli esseri come .una catena che fra i suoi estremi anelli non consente lacuné; può ben essere trascinato a non vedere nella guerra se non un canto di quel triste poema, se non il fenomeno medesimo che in quella catena perpetua e propaga la vita, colla distruzione dei· fiacchi e la vittoria dei forti.
Ma senza giungere a cosl estreme illazioni del pessimismo filosofico non è possibile il non ammettere che nelle società primi ti ve la guerra sia stata una funzione della lotta per l'esistenza, ed abbia stituito una necessità cui nessun popolo della terra ha saputo sottrarsi. Siffatta necessità si è poi _osti. natamente mantenuta a tra verso tutte le fasi della evoluzione storica, sebbene con forme mutevoli, a determinare le quali i COStUIPi, l'indole

della civiltà, il modo di concepire la mot·a!e e la vita che erano propriÌ di ciascun tempo. Tauto essa fu imperiosa e irresistibile che, dopo un si lungo giro di secoli, ancora la stirpe umana non potè scuoterne il giogo. Oggi appena le nazioni di più raffinata civiltà comincia'no a s ognare il giot·no in cui la vedranno dileguarsi: ma gli eventi che solto i nostri occhi riempirono fino ad oggi il mondo sembrano irt·idere a_ codesta speran za, valeria respingere sempre più lontano nella regione dei sogui Nè v'ha, crediamo, senno umano capace di prevedere il momento in cui essq. potrà effettuarsi per le civiltà inferiori e per le società barbariche, che insieme costituiscono ancora la g rande maggioranza dei viventi;
Negar dunque al fenomeno della guer ra e alle cause che lo determinano quel carattere di unie di necessità, nel quale t·isiede in certo modo la sua giustificazione; attribuii'tle tutta intet·a la colpa a ìiequi;lia di minoranze meritevoli di esset·e poste a)la gogna della storia; giud icare le civiltà g uerriere come se fosse stato in poter loro di essere pacifiche, equivale per noi' a rifare, o piutlosto a disfar·e la storia, per sostituire alle sue realtà i criter·i, le passioni e le aspirazioni del tempo nostro. Sembra strano che, mentre il Ferrera. inclina ad ammettere un a forza misteriosa e ineluttabile che trae alla dissoluzione le civiltà basate sulla nequizia conctuistatrice. trovi poi affatto semplice di negare tale carattere

i.
di necessiià storica alla genesi e allo sviluppo del fènomeno guerresco, e lo inv.ece come l'e l'fetto di un impulso in tuttò riflesso e cosciente. • 1 l'umanità è in balia di forze cieche che provvidet t zialmente o brutalmente la travolgono verso il su n destino, o essa può; entro certi limiti, creare a s ò . stessa i propri.i fati, antivedendo e preparando il fu · turo. Ma come accogliere la prima ipotesi per d i mostr·ar·e.le .tristi. conseguenze della guerra, e p i acconciarsi alla seconda per analizzare le cause da cui essa nasce
La legge punitiva che il nostro autore vuol fai' scaturire dal fondo stesso della · storia non è, s em bra a noi, che la <!_i .caducità che governa le cose umane.' Tutto al mondo invecchia e muore, o le vie della civiltà son:o anch'esse, come certe stra de del Lazio antico, seminate di sepolcri. Questa le g c di distruzione collima non di rado col sentimen to di giustizia dègli uomini, poiché molto di quel ciP perisce merita a giudizio loro di perire; ma ciò n o11 toglie che le catastrofi storiche, le quali segnano la fine delle grandi civiltà, non siano la risultante di innumerevoli e svariatissime cagioni, e che l'atit'Jbuirle esclusivamente al peccato della loro origit H' sia darne una spiegazione unilaterale e insufficie nto. Ed ecco come, spostato il punto di veduta, gli a ,_ venimentl che lo scrittot·e ci pone innauzi a co ttforto della sua tesi assumono ai nostr·i occhi 111 1 significato in grau parte opposto ad essa.
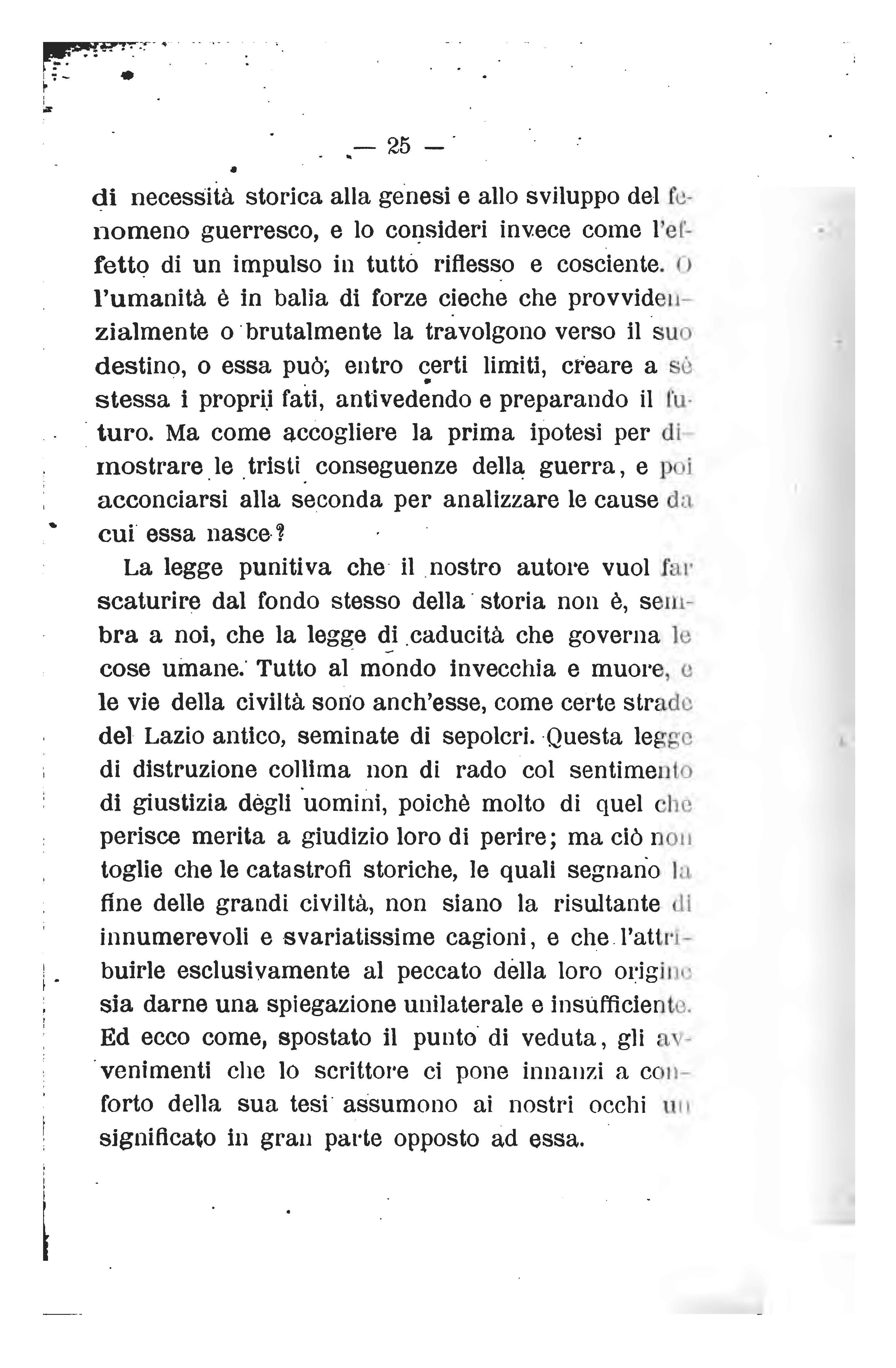
Cosl , come ;;h . d icemmo, egli vuoi mostrarci nel C'l'O li de ll a do miuazione r!Jmana il castigo ultimo de ll o s piri to di vi oleur.a e di cupidigia da cui essa. sorse. Noi pe r sis ti a mo invece a scorgere nelle vicende dell' Ur/J u no dei migliori argomenti çhe H mo nd o a nti co fo m isca contro l'affermazioue di lui, c ere cioè lo spi t·ito guerriero ne' suoi estremi crfetl i it•r emedi ubil me nte infecondo e Per uoi la potenza di Rom a , creata e mantenuta mediante la. couquista, non l'u solo il più magnifico fra gli spettacoli che ai.Jbia o fferto la storia umana, ma fu pure una g igautesca e fortunata opera di civiltà. Quella che s'andò forma ndo all'ornbra delle sue armi, e per e se si diffuse nel mondo, fu indubbiamentè la più alta che allora c n sentissero le· condizioni sociali e il sapere accumul a to·dagli uomini. Se codesta somma di sapere a vesse potuto esser maggiore, ed una civiltà pili perfetta o moraJmente più elevata avesse potuto usci me, u ulla prova cho. il forte e flessibile cougegno della lg uoria romana uon si sarebbe rnustmt altissim o ad ·iutegrarla e a propagarla.
11 llOSli'O aulOl'O, inebriato dall'orgoglio dei tempi uuovi, di e ui vede biancheggiare l'alba, trova in C•}desto sentimento il coraggio di tutte le negazioni •i iuvita a c; r ridere dell'inutilità fastosa del ma ttmneuli che l t..n n a ha dissernina.ti $Ulla e

-27indugia. a contrappOI:re la meravigliosa rète · ferroviaria che abbraccia i nostri continenti alle sterili magnificenze del Colosseo. Per poco, in un passo del SUO libt:.O, egli non· rimprovera al sibarlta del te. pidarium qi ignorare le dolcezze dei nostri caloriferi e la morbidezza dei nostri cuscini l Ma eglj non riesce a convincerci che lo spirito pratico e un sentimento largo dell'utilità· pubblica non fossero caratterf spiccati· della conquista romana. Alla rete stradale, di cui Roma dotò il mondo .antico, il Ferrero dedica un fugacissimo cenrio; e . tuttavia essa non è, relativamente, meno ammira- . bile· di quella cui si volgono i suoi funi. Forse lo è anche più, se si considera per rapporto alla potenza tecnica dei Romani e ai mezzi di cui dispo- . nevano. essa rappresenta un ta1 cumulo di · difficoltà superate che al loro confronto l'Impresa dell'erigere il Colosseo (nella quale il Ferrero ostenta di vedere la maggiore materiale della grandezza romana) appare un giuoco da bimbi. Quella stradale, se da un lato serviva : gli ·Interessi militari dei conquistatori, costituì va dall'altro un incalcolabile beneficio e un progresso inaudito pei paesi conquistati e ancora in gran parte immersi nelle tenebre barbariche. Onde si può affermare aver essa corrisposto al massimo sforzo di incivilimento che fosse conceduto ai Romani dalla séien:(:a del tempo loro; cosl come le ferrovie e nmplego è.elle energie elettriche corrispondono al mas-

Inerevoli indirizzi di pensiero cui non sappiamo ancora sottrarci.
Certo che siffatta ostinata infiltrazione di rom anità. nell'anima moderna è quant? più spiace al l a scuola filosofica cui il Ferrero appartiene; sicch é, ad esempio, nel concetto romano, cos\ rigido ed il' · riducibile, della proprietà, vede la genesi d el · l'ingiustizia sociale che ancora contamina la terr a. Né di cio potremmo disputare qui. Noi ci chiederem piuttosto se un pensiero civile che ha signor·eggla t per tanti secoli la coscienza umana; che ha procl a mato il principio giuridico : nemi ne m ledere, .suu m cuique tribuere; che oggi ancora informa in gra n parte la legislazione delle nazioni più progredite, n o n sia per questo solo a.ltamente benemerito della civllt ù. Ci chiederemo se una società che lasci? di sè t al i traccie possa considerarsi come una effiorescen za passeggera e maligna, nutrita di delitti e di me; o non sia invece una delle più vigorose, de ll più solide e delle più feconde creazioni politiche cl 1 la storia degli uomini abuia registrato mai. Che se questa -società portò seco la colpa congenita de ll a origine militare, e se ne fu punita dall'alluvione bat ·· barica, noi' possiamo ben dire felice la colpa , è tal'd 0 il castigo. In verità , a noi poverelli, che per poco n o n vediamo ruinare i nostri istituti politici ad ogni g nerazione, a noi che abbiamo sognato di trovar , cent'anni or sono, la base definitiva dell'edificio s o ciale, e già lo sentiamo sgretolarsi da ogni parte, si

-30-
addice bene di guardare con ùno sdegtioso so rri so ai dodici secoli della vita di R oma!
Ad ogni modo i nemici ordinamenti militat·i dovrebbero dimostrare che l' epoca e le condizioni in cui sorse la civiltà romana avt'ebbero ci:>nsentito il fiorire ·di un' altr·a civiltà d i tipo diverso da quella, e tale da dar più glòriosi e più durevoli frutti; dovrebbero per·suade r c i che il mondo sarebbe stato più felice ·e l'u manità si tl'ovel'eiJIJe oggi più sulla via del progresso se nei dodici· secoli della prava tiran nide il Lazio fosse stato sede di una popol azi o ne i nge nua e mite, schiva delle armi, dedita alle placide ar ti della pastorizia. III.
Nel prender· hr esame le ·pro ve storiche del M i l i tarismo ci siamo diffusi intorn o a l tip i co pun t o della · signoria romana, ed ora cl è forza sorvolare agli altri. Del Napoleone il F errero ci offre un ri· tratto alla Ta.ine, che è un pi cco l o capo l avot·o di finezza psicologica.· Un volum e r·icchissim o di do cumenti, apparso or fa qualch e anno sotto il tilolo di Napoléon intime, ci indur rebbe a c redere che molte linee di quel s i ano alquanto f01·zate e rispondano piuttosto ad una ormai il'distruttibile, che alla realtà. M a ciò ()Ui poco Importa invece che, anche qui, l a tesi abbia cost t•ettt

n Ferraro a considerare .sotto un unico aspetto l'uomo e l' opera .sua.
Che mi!?sione storica compiuta , se pure involontariamente, dal grande Còrso fosse necessario l'uragano di guerra che egU scqtenò sul mondo, nessuno vorr·à sostenere. Ma ridurre l' opera sua ·ad un brigantaggio esercitato da lui e da pochi seguaci .della sua fortuna, con nessun altro scopo se non di obbedire alla passione del dominio , del sangue e .della ricchezza, cl sembra un assunto storico sufficientemente temerario. Nap0leone ha senza alcun dubbio impedito che la rivoluzione francese perisse soffocata nel sangue e nell' anarchia. Le sue armi imposero, fors'anche. suo malfò·ado, alle vecchie so· r. ci età europee, disperatamente riluttanti, i prlncipii che i mperano nel mondo moderno: imposizione tauto efficace e profonda da sopravvivere alla caduta di . chi la operò, e'da resistere agli sforzi, durati lunghi an-ni, della reazione vittoriosa. Epperò si può ritenere che, senza la meteora napoleonica, la fase sto· r·ica onde uscl .là società· presente sarebbe stata r·itardata forse di parecchie generazioni.
Il regime imperlale diede poi allo stato fmncese una solidità in cui ancora oggi risiede la sua salvezza di fronte allo forze dissolventi che lo minacciano. Le stesse guerre· più tngiustifieate a cui Napoleone trasse la Francia, non solo acc•·ebbero il I ·estiglo di lèi nel mondo e furono già per questo t 1 importante della sua pr·osperità; ma an-

32che, ecoudo una l egge storica immancabile, ·co n l'accum ulamento delle energie e con la sovreccitazioué ct eile menti, p repa1·arono un pe1·iodo di febbrile atti vità intellettuale economica, che fece la g1·andezza della Francia nel secolo presente. Dopo c i ò, f1·an ca egli la s pesa di agg iunge1·e che in m olti stat i , e particolarme nte nel nostro, l'influenza del domilllo napoleonico fu benefica e p1•ogressiva; e ch e il nome del terribile conquistatore è pur legato nei secoli ad un monumento di alta sapienza giuridic!l Le stes se qualità im petuose e impel' iose del suo ge· nio, che sen:irono alla sua !lliss.ione di sal v are la Fr·ancia dall'anarchia e dall'invasione straniera, l o trascina 1·ono, raggiu nta la meta; ad oitrepassarla e lo pe1·d ettero; al modo medesimo peC' c ui 1' impeto a srondare una porta chiusa ti fa pr·ecipitar·e, se non riesci a frenaeti, quando essa si spalam:hi d 'un teatto. M a nepput· l'epopea napoleoufca, Ile r·appresenta pure in g 1·ado inaudito l 'ab uso e l'eccesso della funzio ne militare, risponde a quel carattere essenzialmen te negativo c he il Feri'ei'O atteibuis ce. a quest'ultimo..
Il nos tro autore p1·eude poi a studiat·e co ll a te sa abilità d ialettica, ed anco colla so lita subicttività di g-i udizio, le condizio ni della società f1·aucese inedema. Egli vi riceeca la dupJice impro11ta della w n·

-33narchia militare e della tirannide napoleonica da cui essa è uscita, e ci descrive il solido e pesante congegno della sua burocrazia, tutta intenta a per petuare il culto dello stato, e ad imporre il pregiudizio militare; e conclude indicando i sintomi di un a decad enza nuova della Francia, che è, s' intend e bene, l' ultima conseguenza del peccato guerresco che contamina tutta la sua storia. E noi, perch é dissimularlo 1 ci sentiamo sedotti dalle finezze di 11uesta dipintura, cosparsa di ironie squisite; e per poco non ci lasciamo scivolare su11a china del su o pessi mismo. Ma ad arrestarci d ' un tratto e a salvarcl dalle debolezze analiti"che, ecco giungerci un a riflessione di ordine sintetico. E pensiamo: l'aristo1 crazia militare che dominò per secoli la Francia ha dato una ancor più forte tempra all'indole naturalmente bellicosa del suo popolo; la monarchia as soluta ha gittato nella forma di una potente unità le mem bra sparse della nazione; la repubblica trov ò nell'assetto militare dello stato e ne11a educazion e gue1•re ca del popolo la forza di resistere eroicameu te all'invasione europea; infine il massicci o meccanismo dell'amministrazione imperiale ha an cora cresciuto la compattezza e la solidità della com pagine sociale. J"rutto ultimo di tal serie di regimi , ' malgrado errori, colpe e sventure infinite, fu di plasmare una nazione la quale reputa sè stessa la i prima nel mondo ed è, per qualche rispetto, la prima; che al mondo si è imposta lungamente co n G. S. Eaet·cito e Militarismo. 3
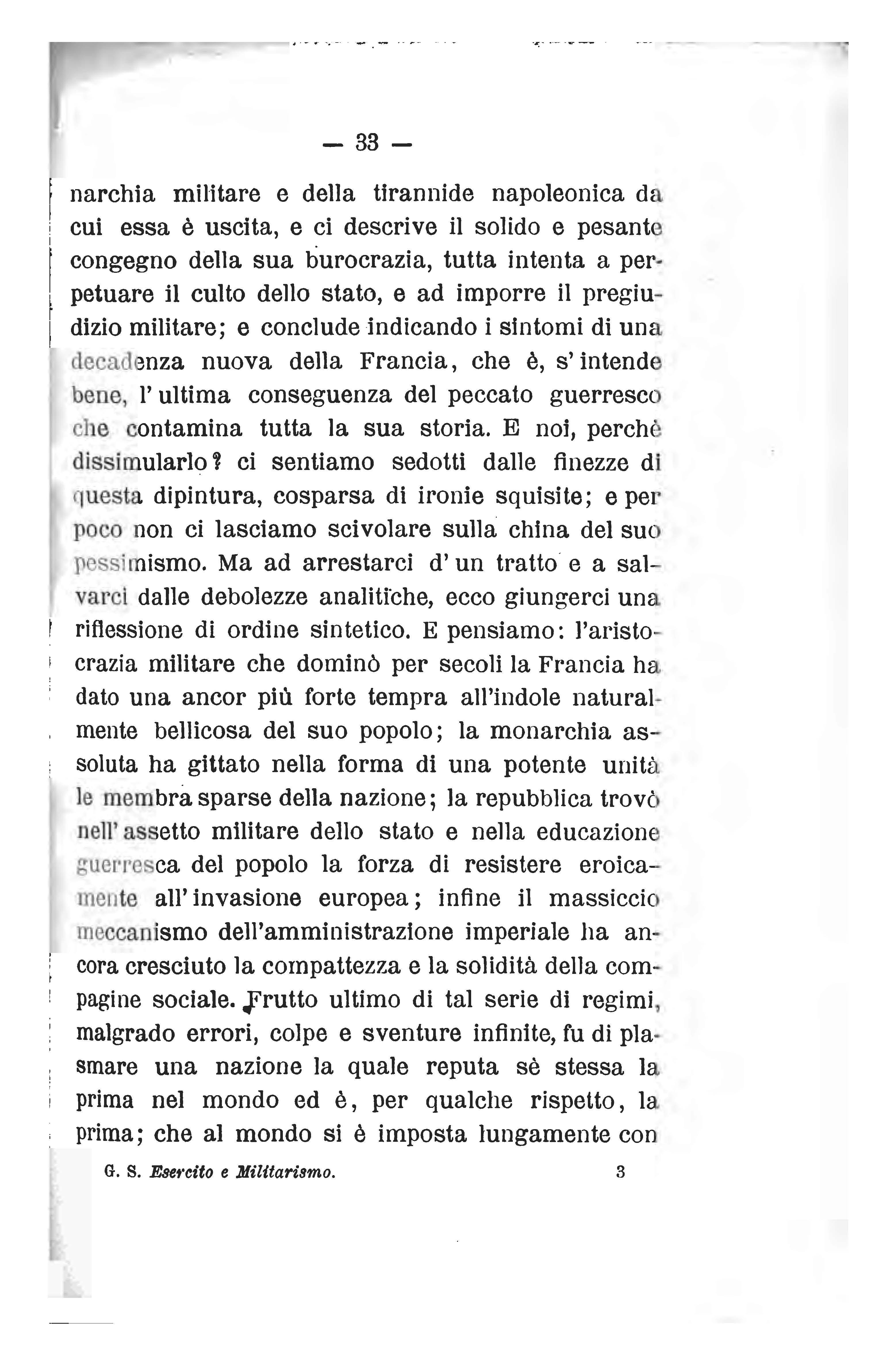
-34-
la sua potenza, e se n' è fatta invidiare per la sua prosperità, per la sua ricchezza, per gli splendori del pensiero, per l'influenza spirituale esercitata sugli altri popoli; che infine possiede tanto vigore di vita da aver resistito ai più terribili rivolgimenti, ed essersi rialzata dalle più spaventose catastrofi. Noi in verità dureremmo fatica a convincerci che nel bilancio morale delle istituzioni militari una nazione simile rappresenti un ente passivo!
E come tristi e tragicamente succinte le deduzioni di una sl fatta sintesi applicata, per ciò che concerne le armi, al corrispondente periodo di storia italiana! Il sorgere dei nostri Comuni dalle lotte popolari c0ntro la feudalità fu senza dubbio una mirabile e feconda evoluzione storica. Essa preparò quel varli ed illustri centri di vita italiana donde, coi fulgori del pensiero e con le meraviglie dell'arte, la civiltà nostra doveva una seconda volta diffondersi nel mondo. Anche, qua e là, diedero i Comuni italiani vivi sprazzi di virtù guerriera, sicché il valore della stirpe potè affermarsi lottando vittoriosamente contro i due più potenti imperatori dell'età di mezzo. Ma troppo presto quelle democrazie si consumarono nelle discordie che a loro cosl fieramente ·rimproverò il divino poeta, e poi,• per gran parte dtsavezze alle armi e inclinate, giu· sta una tendenza costante dello democratico italiano, a precipitare nella demagogia, si spen sero nelle tirannidi principesche; e queste, dopo

fugaci splendori del Rinascimento, fruttarono l'inter'vento straniero e la servitù.

Cosi per secoli di abiezione e di miseria venne r·itardata l'unità nazionale e solo fu faticosamente raggiunta ai nostri giorni, con armi, pur troppo, in gran parte non nostre, e in parte fornite dalla sola regione italiana ove il culto e la tradizione delle virtù militari eran rimasti vivi. Chi vorrebbe disconoscere che quei secoli di imbelle servitù siano la remota cagione per la quale, dopo lo sforzo di virtù richiesto dalla conquista della indipendenza, noi ci l'itroviamo tutto1·a poveri, ignoranti, corrotti, e tali che gli altri popoli hanno di noi men che mediocre stìma Certo che la grandezza stessa di tale sforzo e la brevità del tempo trascorso dacché fu compiuto (un attimo nella ·vita di un popolo!) e gli innegabili progressi che la nazione ha raggiunto in molti rami della sua attività, devono salvarci dagli scoramenti eccessivi dinnanzi alle miserie dell'ora presente, ispirandoci il proposito e la speranza di vincerle. Ma tuttavia quale italiano, meditando •]uesto confron to fra le due sorelle latine , avrà cuore di rallegrarsi con la sua patria perché sia stata, fra tutte, la nazione più lungamente disusata allo armH
"'*"'
In quanto alla decadenza ottomana, della quale H Ferl'et·o ci pre senta un'analisi diffusa ed effica-
-36cissima, essa è, già lo dicemmo, da un punto di veduta assolutamente teorico, l'argomento princjpe dei nemici degli ordini militari; poiché la stori a non registra, crediamo, altro esempio di un popolo mi· litarmente costituito, e levatosi a g rande potenza per le armi, il quale sia poi precipitato in un più buio fondo di barbarie e di corruttela. Sebbene dal punto di vista opposto si potrebbe a nche obbiettare che all'unica virtù dell' imp.ero turco, che é la sua attitudine guerriera, si deve in parte che ei sia tut· t'ora vivo ; onde le eroiche resisten ze opposte alla Russia e le non ardue vittorie ripor tate sulla Grecia potrebbero paragonarsi a quelle inspit·azioni d'ossi· geno che prolungano la vita ai moribondi. Ad ogni modo quell'argomento impressionante non ha per noi valore pratico di sorta. Noi non sappiamo ammettere che nel gravissimo problem a della funzione serbata alle istituzioni militari presso i popoli liberi e civili, abbia qualcosa a ved ere la sanguinosa e appena larvata barbarie del Bosforo. È chiaro che a determinarla concorrono, assai piu che la costituzione militare dello stato, troppi elementi affatto estranei alla vita delle società l'inerzia, il fatalismo e il fanatismo che s on pr·oprii della. razza, un concetto affatto speciale della religione, della sovranità e della famiglia; u na singolare ed assoluta deficienza di attitudini civilizzatrici; infine una demoralizzazione cosi profonda, cosl autica e ormai cosi incancrenita, che i paesi moralmente

più miseri del resto d'Europa sono, al confronto, oas i di virtù. Partire dall'analisi di una società siffalta por concludere io un senso qualsiasi . intorno arrli eserciti delle gran di nazioni civili sembra a noi cosa p co dissimile da quel che sarebbe il fondare una teorica del matrimonio nelle società moderne sovra la psicologia di Barbebleue.
Nè, per lo stesso ordine di ragioni, vediamo come possa scuotere il conv incimento degli amici degli ordiui militari la stupenda descrizione che il Ferrera ci regala della in vasione madhista. Se qualche cosa può, a parer nostro, provare un tale racconto, esso questo solo prova : che una forte organizzazione militare dell'Egitto avrebbe risparmiato ad una sterminata regione orribili sventure; e che la forte organizzazione m ilitare inglese sta rendendo alla c iviltà il servigio che gli egiziaui non han saputo renderle.

•*•
bbiamo cosl esamin ato, sebbene sommariamente e nella misura concessa ad uno studio giornalistico, i fondamenti sto rici che il Ferrera ha dati alla sua affermazione della iniquità sostanziale della guerra. Vedemmo (per tornare alla nostra, prima immagine) quali eleme uti egli abbia potuto far enh'are nella cornice dell a sua tesi. Ma quanti ne rimasero fuori l Quanti avvenimenti guerreschi, di
cui il Militarismo tace, furono indiscutibilmente supreme fortune di popoli o conquiste preziose di civiltà, trionfi di giustizia o ofm d i leale che atti' versarono ed elevarono le 11azioui! Gli esempi si affollano al pensiero cosl numemsi e noti che iJ numerarli può quasi sembmr puerile.
Perfino quella Svizzera, le cui virtù casalinghe e borghesi gli avversari degli eserciti permanenti contrappongono ogni giorno al vizii fastosi degli imperi militari, non ha ess a conquistato l'indipendenza colle armn E, a tacer pm·e del mer·cato che delle sue armi fece per secoli , non pone essa ogni cura nell' ispirarne l'amore a i uoi figli con riti militareschi che possono far so rridere 1o scetticismo latino, ma che al popolo svi zzet•o ono p r·ofondamente Nè il risveglio guerrier·o pel quale l'unità germanica si è levata sulle ceneri di quel formicolalo aulico che fu la vecchia Confederazione, può apparire altrimenti che come un felicissimo evento alla immensa maggioranza delle stirpi tedesche. Da questo evento noi vedemm o nascere sotto i nostri occhi una meravigliosa fi oritura di progresso scientifico e di energie econ omiche che in pochi anni posero la Germania alla testa della civiltà: spettacolo che, come dianzi dicemmo, sussegue quasi sempre alle grandi agitazioni guerresche dei popoli e contiene già in sè u n'esplicita condanna delle teor·ie antimilitari. La nostr·a stessa unità, sebbene abbia in parte deluse le speranze de' suoi fondatori

non vorrà il Ferraro contrastarci che sia, rispetto alla desolata servitù in cui gemeva il nostro paese, un'insigne conquista civile, tale che parrà ai posteri meravigliosa per la rapidità con cui fu compiuta, per l'altezza d' ingegno, la virtù e la concordia che si richiesero a compierla. Ora è egli possibile immaginare che l'effettuazione di questo sogno di tanti secoli potesse altrimenti avvenire che mediante la E ci sarebbe da non finir più. Se non che forse
. il nostro autore è abbastanza magnanimo per concedere le armi ai popoli soggetti che hanno da conquistare l'indipendenza. Ma di questa concessione, che pur già ferirebbe a morte la sua dottrina, noi non ci appagheremmo. Non è punto vero che l'unica giustificazione storica della guerra risieda nell' intento di costituire la patria e di rivendicarne l'indipendenza. Abbondano esempi di guerre combattute da nazioni già formate e già potenti, per cagioni di politica generale ed anche per scopi di conquista e perfino ai danni del sentimento patriottico di altri popoli, delle quali i risultati ultimi furono indiscutibili benefici per la causa della civiltà. La conquista dell'India, malgrado l'inesorabilità dei metodi con cui venne attuata, non solo fu sorgente inesausta di ricchezza e di potenza per la madre patria, ma deve oggi considerarsi, per rispetto allo .tesso paese conquistato, come una insigne opera li incivilimento. La vittoria con cui in principio di

-40
questo secolo l'Inghilterra fiaccò definitivamente il colosso napoleouico fu iniz io e base della miracolosa fortuna per la quale essa divenne uno dei piu attivi stromentl del progresso umano. Quella stess a Unione americana per cui, malgrado alcune ris et·ve di indole sociale, il Ferrero non sa r ascondere la sua tenerezza, ebbe d'uopo, afRrJe di costituirsi quale oggi è, non solo di una guerra accan ita contro la madre patria, ma anche della graduale e spietata distruzione delle stirpi .indigene e di una terriblle lotta civile per l'abolizione della schiavitù.

E ai nostri giorni, veden do il giovane popolo giapponese sorgere in armi contro la CWna, dopo essersi assimilato con cosl geniale prontezza la civiltà occidentale, chi potè aver dubbi nel riconoscere da qual parte stessero la necessità storica e la causa del progresso e da quale la decrepita compagine destinata a perire 1 Codesta China medesima, la quale ha posto a norme della sua lunghissima vita il disdegno delle armi e l' isolamento che ne è necessaria conseguenza, ed o ra si srascia in putredine, come affogata nel lago della sua vlltà, è essa un esempio di saggezza storic a che debba far arrossire le nazioni guerresche intente ora a dividere le sue spoglie t
Riassumendo il fin qui detto, noi c rediamo che la dimostrazione che il Ferrero for11isce della nequizia e della sterilità storica del la g uerra sia del tulto manchevole, poiché gli ese mpii su cui egli vuoi fon·
-41darla non appaiono in alcun modo decisivi, ment re egli ne trascura prudentemente troppi altri, rispe tto ai quali l'applicazione della sua tesi riesce di u na assurdità manifesta. Che se,· per sfuggire ques ta assurdità, egli si acconciasse a riconoscere che vi furono pure guerre giuste, inevitabili e benefic he per l'umanità, venendo cosl ad ammettere due ti pi distinti di guerra, l'uno dei quali buono e l'altro ne· fando, la sua dottrina non ne sarebbe meno sosta nzialmente scossa. E invero egli dovrebbe consenti r e la guerra non solo alle innumeri stirpi umane che sono e saranno ancora per secoli in signoria altr ui , o si sentono spinte da· impulsi etnici irresistibili ad contrarli allo stato di cose presente ; ma anche a quelle altre che si trovano in una de lle svariatissime condizioni favorevoli al tipo buon o: cioè a dire, alla grandissima maggioranza dei viventi, rispetto ai quali le nazioni di raffina.ta civiltà sono una quantità numericamente trascurabile. Or a che è mai una legge storica, che, cominciando a funzionare dopo innumerevoli secoU di storia uman a, non si adatta che ad una piccola minoranza dell a umanità1 ..
•
Ma noi vogliamo penetrare più addentro nel pensiero dell'autore e ricercare il più intimo e pernicioso succo delle sue teorie. Egli non s'acconte nta di calunniare la guerra nei suoi effetti storici, aspiru.

-42altres\ a disonorar·Ja rispetto ai suoi effetti etici ed alle sue influenze psicologiche.
n Ferrera si ribella energicamente al pregiudizio che vede nel mestle1·e delle armi la scuola di ce1·te determinate vh·tù; nega elle dallo spirito guereesco emani alcuu impulso buono ; sostiene che la gueiTa non fa germogliare nel cuore degli uomini se non le passioni più torbide e i più bassi appetiti; che essa è, ripetiamolo un'alt1·a volta con le sue parole, la madre d ei peggio1'i vizii umani.

Ora no! già a(l'el'mammo che la genesi del fenomeno guerre co è la lotta per la vita· ammettiamo alli·esl che a determinarlo, a traverso i secoli più bui della storia, lo spirito di prepotenza e di sopraffazione, la ete delle ricchezze e dei godimenti abbiano avuto gran parte. E poiché le istituzioni militari si plasmano come ogni altra, sulla società da cui escono, ci pare ovvio che in quelle barbariche, o più prossime alla barbarie, nelle quali il concetto della giustizia è pressoché ignoto e la violenza è legge dominante, il mestiere delle armi, che ha la violenza per ultimo fine, ne sia anche l'estrinsecazione più intensa e più rude.
Ma superati gli stadii pt·imordjali della umanità, e mano mano che agli scopi istintivi della guerra se ne andarono mescolanùo o sostituendo di meno rozzi, e via via di più nobili, l'es enza del dovere guerriero si affi uò gradatarnenle, fino a raggiungere una idealità a cui tutt i i popoli della terra hanno reso omaggio.
-43-
A questo punto noi vorremmo poter riassumere le eloquenti pagine con cui il capitano Ranzi descrive siffatta trasformazione e ne deduce una sua ingegnosa teorica, secondo la quale la guerra fu l' ambiente stesso in cui la civiltà si è formata e il tramite per cui si sviluppò e si propagò nel mondo. . Ma non vogliamo correre il rischio d'una sintesi i m perfetta e preferiamo incuorare i lettori a leggere quelle pagine nella· Rivista d'Italia, proseguendo qui la nostra modesta via.
Non v'ha popolo presso cui la poesia e l'arte non si siano ispirate all'idealità guerresca, associandola ai sentimenti più alti e più gentili che germoglino nel cuore degli uomini: la dolcezza del focolare domestico, l'affetto al paese natio, l'amore della donna, l'onore della stirpe. Le società guerriere non solo, ma anche e sopratutto le società più intellettualmente affinate, gareggiarono nel tenere alto il prestigio del guerresco, nell'onorare coloro che sacrano la vita alla difesa della patria. Una simile universalltà di consenso dovrebbe pur aver qualche peso nel salvare le virtù militari dai dispregi delle novissime scuole sociologiche. Ma noi sappiamo che il consenso universale, prediletto cavallo di bat taglia dei metafisici, poco commove il cuore indurito dei positivisti, onde all'intima natura del feno-rneno guerresco dobbiam chiedere le ragioni della .ua dignità.

Vincere il prepotente islinto della conservazione, affrontando la morte per uu ftne superiore ed esteriore alla propria individualità, è il massimo sacrificio che possa richiedersi all' uomo. Per indurlo a compierlo occorrono sp inte poderose: o attrattive di beni che egli ardentemeute vagheggi, o forli sentimenti che dominino l'a nimo suo e vi attutiscano le resistenze dell'istinto. Il Ferrera si compiace a descrivere i tempi (e qua si non ci descrive che quelli ) nei quali i beni che esaltavano il va lore guerriero erano le ricchezze dei nemici e il bottino dei sac cheggi; e i sentimenti che signoreggiavano l'animo delle milizie erano la passione atavica del sangue, e la voluttà delle stragi. Ma da quanto tempo tali impulsi han cessato di influire sulla guerra, e chi non sorriderebbe a ll'idea di attt'ibuire ad essi gli atti di eroismo compiuti in uno dei grandi eserciti moderni 1
D'altronde, anche per rispetto alla guerra barbarica, quella affermazio no del Ferrera è troppo lata . Pur quando gli scopi della guerra erano più fet·ocemente utilitarii, i benefici diretti cbe essa arrecava ai vincitori cadevano s opt·a esigue minoranze, e il grosso dei combattenti non vi aveva se non una minima parte e sproporzionata al sacrificio del , vita. Nelle guerre moderne poi , l'attrattiva del ber

-45materiali scompare quasi del tutto di fronte alle ingenti masse di uomini che son chiamati a combattere. La grandissima maggioranza dei s oldati d'oggi ha la certezza che nessun atto di val ore le fl'utterebbe vantaggi personali di sorta e sa di un11 poter aspirare che a ricompense d'ordine on ot·inco. Ma Il pregio di queste ultime non misurandos i se non dalla intensità che lo spirito militare raggi unge in un dato esercito, il desiderio di consegu il'le è piuttosto una derivazione che una sorgente di quelln spirito.
È quindi nel campo psicologico che si devon o ricercare le cause più intime e pi\1 costanti del valore. Senza una fiamma che penetri le anim e o le tempri contro le insidie della paura istintiva, c Ildurre le masse umane alla morte fu sempre, e sar·à ogni giorno più, ardua cosa. In tutti i tempi, a nclle nei più imbevuti di violenza, taluna di queste fi a me passò a traverso gli eserciti che furono lungam e11te vittoriosi: perverse talvolta, come gli odii di r azza e i fanatismi religiosi; ma anche spesso gen eroso e nobili. Dio ci guardi da classificazioni , ch e riescono troppo spesso scolastiche. Ma è difficil e dubitare che la concezione dell'eroismo diffusa nella società greca non abbia contribuito a scald ar e 11 petto dei suoi soldati; che i legionari! roma ni non abbiano trovato qualche sussidio morale nel pt estigio di cui sentivano circondato il loro nome e uell'orgoglio della loro stirpe: cosl come i crociati

nella fede religiosa e nèlla poesia di cui si ammantava ai loro occhi la lontana e misteriosa avventura.:
Certo è pure che un forte impulso guerriero fornl alle aristocrazie militari il culto cieco della persona del sovrano, nella quale si concentrava e si confondeva per esse il concetto e il sentimento della patria. In codesto senso il Dulce pro patria mori del poeta, e la frase mourir pour le service du roi che correva, siccome formala precisa e intesa da tutti, nelle sale di Versailles, si corrispondono integralmente. Che dire della malia irresistibile che taluni conquistatori esercitarono sui loro soldati f Chi ignora quali prodigi di abnegazione ispirasse a quelli del primo impero il sentimento enfaticamente classico della gloria che Napoleone sapeva cosl bene suscitare nelle loro anime' E chi non udl narrare degli ardori di sacrificio che destava nei seguaci di Garibaldi una parola od un sorriso dell'eroe'

....
Cosl, mentre il Ferrera non vede nell'azione del combattere se non lo sfogo di crudeltà sanguinose e di istinti spietati, noi crediamo che siano innumerevoli i campi di battaglia della terra ove la morte fu almeno in parte nobilitata dal. concetto di un dovere più o meno chiaramente intuito. A noi piace figL rarci, a traverso la storia, queste umili eignorat1
-47vittime dell'ideale. Quanti oscuri capi di decurie o di centm·ie romane, morenti in qualche estremo lembo de1l'Asia o della Sci zia, non consolò forse la visione della Ùrbs dominatrice! Quanti giovinetti dalle parrucche incipriate e dalle sottovesti fiorate non caddero in oscuri combattimenti delle interminabili guerre sul Reno, g ridando colla spada alta: Vive le Roi, o Es lebe der Kaiser, e suggellando con questo grido, nella rinuncia dolorosa della loro giovinezza, la fede in un principio superiore cui avevano obbligo di immolarsi l Quanti grognards degli eserciti napolconici non sostenn e, nelle più disperate difese, la vista o il ricordo dell'uomo fatale "dagli occhi d'aquila, ! E quanti patriotti nelle insurrezioni della Polouia e delJ' ng heria, e nelle guerre della indipendenza italiana, non chiusero per sempre gli occhi sorridendo all ' ideale della patria risorta!
Vogliamo por termine a questa rassegna di anonime vittime del dovere guerresco col nome di una fra le più recenti: il nome caro agli italiani, di Vittorio Da bormida. In stesse colonne narrammo come, scrivendo a d uno de' suoi dalla nave che lo portava in Africa, dopo aver dipinto l'entusiasmo e l'umor guerriero dei soldati che viaggiavano con lui, il prode generale soggiungesse: Potremo non esser fortunati, m a non .faremo disonore al nostro paese · e s , dov essimo lasciar tutti le ossa in Africa, il nostro sa cr ijtcio non sarà inutile.... Un mese dopo con quei soldati che il Ferraro paragona a branchi

di pecore fuggenti, il Dabormida tenn e testa da11e ore mattutine fin presso l' imbrunit·e a forze incredibilmente- maggiori delle sue; poi di resse sino a che fu umanamente possibile la ritirata dei suoi : infine, rimasto fra gli ultimi, si abbandonò quasi desioso alla morte, cui già tanti generosi s'erano immolati nel tristissimo giorno.
Nella nobiltà di questo sacrificio risiede il riscatto morale dei mali che trascina con sè la guerra. Intenderla, è tutta la poesia del mestiere delle armi· formarne una profonda e serena conv inzione degli animi, è il processo educativo che le istituzioni militari son chiamate a E qui pure sta il segreto delle influenze benefiche che d a esse si propagano alla società civile. Nulla più elev a e rischiara la coscienza ancora confusa e rozza delle classi in· colte che la concezione di un alto dove1·e; nulla è più atto a farvi germogliare certe spec iali virtù che riescono preziose anche nel consorzio sociale: il rispetto di sè, lo spirito di abnegazione, il sentimento della mutua assistenza, la comprensione di quei cardini della vita civile che sono la disciplina, l'ordine e il metodo.
Come gli umill aromi di cui la industriosa mas saia compone un liquore riconfortante , quelle modeste virtù compenetrate nell'idea fond amentale del

dovere formano il buono spirito militare di cui vivono gli eserciti. Illuso chi pensa che a dar loro saldezza bastino le costrizioni della disciplina! Vo· ler guidare di fronte al pericolo una massa d' uomini non signoreggiata da altri sentimenti che dal timore del castigo, è figurarsi di far camminare un cadavere trascinandolo avvinto ad una catena.
L'intimo convincimento della elevatezza del proprio mandato, la fede devota alle istituzioni nazionali, il desiderio di ottenere e la coscienza di meritare l'affetto e la simpatia della nazione, sono le sole forze morali in cui un esercito moderno possa trovare l'impulso e la forza di resistenza che gli sono necessarii nei momenti supremi. E poiché da una parte la guerra permane e il giorno in cui dovrà sparire dal mondo è più che mai nascosto nelle nebbie dell'avvenire, e dall'altra i raffl.namenti della civiltà, anzichè attutire l'istinto della conservazione, sembrano renderlo sempre più acuto e imperioso, la necessità di coltivare quelle forze morali, e di mantenerle gelosamente, non dovrebbe aver d'uopo di essere dimostrata.
...
Nessuno ha saputo descrivere con più gentile efficacia di Edmondo De Amicis l'atmosfera morale te si forma all'ombra delle armi, nò ha sentito eglio di lui la poesia semplice -e bonaria, ma inG. S. Esercito e Militarismo. 4

-50tensa, che emana da un esercito devoto alla patria. Per ciò appunto il Ferrero esalta la conversione del suo illustre concittadino all'ideale socialistico; e quasi attribuisce ad essa il valore di un avveni mento storico. Ma questa argomentazione non ci commuove gran fatto. Noi intendiamo bensl che il considerare una data serie di feno meni spirituali d a punti di vista opposti possa produrre impressioni soggettive assai diverse, non già mutat·e l'e se nz di quelli; e rispettiamo troppo l'i nsigne autore dei Bozzetti Militari per credere che i documenti da lui forniti alla psicologia della guerra non siano il frutto di uno studio coscienzioso e sincero della verità. Ma se anche dovesse mancarci la sua preziosa testimonianza, noi ci consoleremmo invocando quella di una intera generazione, non per anco scomparsa dal mondo, che ricorda le lotte della indipendenza e quelle, ben più tristi ed aspre, della repressione del brigantaggio.

Essa non ha dimenticato di certo quale fioritura di sentimenti buoni sorga nella vita del campo, dai disagi e dai pericoli affrontati in com une; quali correnti di simpatia e di fiducia r eciproche si sviluppino tra superiori ed inferiori; e che ingegnosità di assistenze fraterne, e che tesori di paziente e gio· conda filosofia sgorghino, nei giorni difficili, dai più semplici cuori.
Ah ! se il Ferrero avesse potuto assistere a simili spettacoli, come sorriderebbe egli stesso di q'
sciabolatori sa nguinarii e corrotti che egli agitò , a guisa di fantoc ci paurosi, dinanzi agli occhi dei suoi uditori dell'Aihambra; senza dir loro che fossero, ma la ciando che alla loro ingenuità paressero, qualche co a di poco dissimile dal soldato italiano!

IV.
Abbiamo cos i adombrato l'equivoco fondamentale che informa l'opera del Ferrera ed a cui alludemmo fin da principio del presente studio; equivoco tanto propizio alla g uerra che l'opera muove contro le istituzioni militari, da parer difficile che non vi sia mantenuto ad arte. Consiste esso nel non far distinzione di sorta fra spirito militare e militarismo: il quale ultimo dovrebbe, secondo il comune uso della parola, essere non altro che la perversione del primo, e cioè quell'eccesso di accensione dello spirito di casta e del sentimento del proprio valore sociale che indusse, in alcuni tempi ed in alcuni stati, la milizia a soverchiare col disprezzo e talora a sopraffare colla violenza le altre classi di cittadini.
Ora, che cosa sia lo spirito militare, inteso nel senso alto e benefico della parola, abbiamo tentato di .porre ii o qui : che cosa precisamente intenda per ilitarismo, il Ferrera non dice in nessun punto
del ·libro. Certo egli comprende indistinta mente sotto quel nome le più svariate e le più opposte esplicazioni del fenomeno guerresco. Ma è fa cile s cor g ere l'effetto di un simile artificio. Tra la m oderna concezione degli ordini militari, secondo la quale, per-durando fin qui la guerra, e non essendo punto dimostrato che abbia a cessare, essi rapp resentano una necessità della difesa esterna ed i utema dello stato, disciplinata dalle leggi e coordinata come ogni altra funzione sociale all'interesse pubblico, tra questa concezione, diciamo, e le violenze, gli arbitril le corruttele militaresche che il Ferrero descrive, intercede un abisso : ma ecco che l'abi sso sparisce nella confusione voluta dei due termini in una formala unica. La quale confusione ne gen era un'altra ancor più funesta, in cui risiede come il substratum politico del libro: e consiste nel ritenere che la verificazione storica di quelle infamie mili taresche, di tempi andati e di luoghi barbari, sia u n argomento decisivo per l'abolizione degli eserciti nei paesi civili.
In tal guisa mostrarono di interpretare le esposizioni storiche del Ferrero i suoi focosi ammiratori dell'Alhambra, affannati a cercare in og ni pa 1·ola sua un'allusione, un frizzo, una ironia rivolta all'e· sercito italiano. Financo coll'aver detto che i nastri ujJlciali qualcosa fanno, pur soggiungen do che compiono un lavoro del tutto inutile, l'oratore suscitò, narra ancora il Brcntari, una ilarità rumorosa: poiché il pubblico s'era figurato a quella prima frase ,

-53ch'efl'li volesse s arcasticamente alludere all'ozio militaresco.
Ma noi non s appiamo tacere dell'acredine e, vorremmo dlre, della durezza con cui il nostro autore combatte il prestigio della professione delle armi. La cart'iera militai'e è fra le più disagiate e faticose ed anco potrebb e tene1·si per la più scarsamente retribuita, se si co nsidera che essa impone alla libertà individuale le m aggiori costrizioni ed esige un continuo e illimitato s acrificio di sè, una rinuncia frequente agli agi e alle dolcezze della vita. Per questo, e pel nobilissimo fine cui è diretta, sembra che coloro che 1' abbracciano a bbiano ragionevolmente a contare, non solo sull'estimazione, ma anche sopra qualche speciale simpatia de' loro concittadini. Siffatto compenso morale è di gran lunga il maggiore che possa concedersi al mestiere delle armi e, per ventura, il paese nostro no n ne è punto avaro a' suoi soldati. In questo stesso triste anno, per citar un esempio, e in città di quella Homagna che è invasa da una propaganda sociallsta tutta speciale , le truppe giuntevi pei cambi di guarnigione ebbero dalla folla festosissime accoglienze. Ma il Ferrera si inalbera fieramente a l pensiero che queste gioje morali possano pettal'e alla milizia in grado maggiore che a qualsia i altra professione più umile. Egli rivela intero ·animo suo nar rando con palese soddisfazione (e di 1uesta notizia lasciamo a lui tutto il carico) che nel' esercito inglese si insegna ai soldati a farsi am-

mazzare come si insegna ai postini a ricapitar bene le lettere; raffl·onto che vale un intero trattato di filosofia politico-sociale !

Né è a dire qual selezione accurata egli faccia di tutti gli aspetti della funzion e militare , ponendo in luce i meno simpatici, 1 più alti a suscitare l'odio verso la milizia, e lasciando i migliori nell 'ombra . Un simile metodo critico applicato a q ualslasi altro fattore della vita sociale, poniamo al parlamentarismo o anche alla democrazia borgh ese, darebbe indubbiamente assai singolari 'risultati.
E qui non ci par superfluo accennare ad una curiosa piega dello spirito del pensatore piemontese. Si direbbe che ciò che più lo offende nelle istituzioni militari, sia la loro origine nobiliare, l'essenza aristocratica che, fin presso ai tempi nostri, set·barono in quasi tutti gli stati, e con servano tuttora in alcuni. Alla aristocrazia egli di rige, a traverso la milizia, i più acuti strali del s uo sarcasmo, e ciò fa con un'insistenza ed un'amar·ezza che non ci sem· brano scevre di qualche oste ntazione. Tutta la sua concezione storica è impreg 11ata di questo duplice odio per le armi e pel blason e, ch'egli a socia nella formola: aristocra.;ia militare. Se non fosse indiscreto il ricercare altrove che nel pt·ocesso intellet· tuale di un autore le ragioni delle sue tendenze, noi
oseremmo attribuire quella di cui parliamo ad uno stato d'animo che è speciale ad una parte (ormai sem· pre più esigua) della borghesia piemontese.
Varie cause di indole storica, che sarebbe ozioso noverare qui, mantennero a lungo vive in Piemonte distinzioni e rivalità di classi, sparite o assai attenuate altrove; e insieme vi fecero crescere rigoglioso quel che potrebbe chiamarsi il pregiudizio democratico, spesso non meno cieco e tenace del suo opposto. È fuor di dubbio che tra una aristocrazia la quale dal 1821 al 1859 vide alla testa del movimento liberale i rappresentanti di moltissime fra le sue più Hlustri famiglie (i San Marzano, i Lisio, i Santarosa, i Collegno, i Balbo, gli Azeglio, gli Sclopis, gli Alfieri, i Lamarmora, i Cavour, per tacere di altre) e una borghesia che ha reso alla causa nazionale emi· nenti servigi, le antinomie non furono né poche né lievi. Uomini anche insignì, usciti da codesta borghesia, mostrarono di non aver perdonato mai al conte di Cavour la sua origine patrizia, né mai deposero del tutto le armi di fronte alla sua politica liberale e vittoriosa. O noi ci inganniamo, o al fondo di questo Militarismo che olezza delle più moderne audacie socialistiche, è come un resto atavico di vecchi rancori borghesi.

..*..
Noi non abbiamo alcuna in tenzione di farci pala clini dei regimi aristocratici, né di nasconde rne le debolezze e le colpe: ma crediamo che un elemento a cui il Ferrera ha dato tanta par·te nella sua guerra contro le istituzioni militari, non po sa essere trascurato del tutto nella loro difesa. Ci pare altt'esl util e di notare come, anche su questo punto, i g iudizi suoi manchino alquanto di quella elasticità e di quella larghezza che vengono da u n proposi to di imparzialità assoluta.
Per valutare una forma stol'i ca ch e nella società francese ha dm·ato lunghi secoli, egli nou tl'ova di meglio che qualche aneddoto coetigia nesco dei peg giori tempi; come chi cercasse la storia della borghesia italiana nelle novelle del Boccaccio, o nei novellierl del cinquecento; o quella della virtù muliebre delle antiche nostre democrazie nel verso terribilmente verista con cui padre Dante rimprovera alle sue concittadine la scollatura soverclti a. Il Ferrera sembra non voler consentire a lcut a influenza buona al rispetto della tradizione, all' amor del nome, al culto delle glorie famigliari, ch e ono la caratteristica dei regimi aristocratici; e tuttavia non si può negare che in codesto ordine d i sent imenti l stato abbia non di rado attinto grandi forze conservatrici e tl'ovato un validissimo sussid io in momenti

supremi, ne i _quali ogni altra energia sociale gli faceva difetto .
Il Fe1·rero si dilunga a descrivere Il mal costume e le dissipa tezze dei nobili fattisi cortigiani di vizioso corti; ma dimentica innumerevoli famiglie vissute per lun ga serie di generazioni nelle loro terre in una semplicità austera, non lontana dalla povertà, e tutta imbevuta dei concetti dell'onor famigliare, del dovere guerresco, e dell'illimitata devozione al sovr·ano; onore e dovere che, se pur intuiti in un modo particolare ed esclusivo, rappresentarono, in taluui tempi, un'alta e quasi unica idealità sociale. 11 Ferret·o dimentica altresl che 1' aristocrazia del suo paese nativo, per essersi mantenuta guerriera fino a l nostri giorni, è ancora, fra tutte quelle d'Italia, la m eno fastosa, la più semplice di costumi, la più propensa a dedicarsi al servizio dello stato. A questa a ristocrazia subalpina egli, che si vanta di non aver pregiudizi nazionali, non ha obbligo di esser be nevolo; ma noi non potremo scordare che , aggue rrita per secoli nelle armi sotto la vaIOI·osa scorta dei suoi Principi, essa contribui poteutemeute a preparare in Piemonte quel lievito di euergie e quella saldezza di cat·atteri che furono tra le maggiori fortune d'Italia.

E qui, a costo di perderei in minuzie, vogliamo mostrare con un esempio qual grado di intensità raggiunga nell'animo del nostro autore l'avversione per l'aristocrazia dei tempi andati. Egli non esita a sostenere che il rispetto della donna, la cortesia dei modi, e perfino la cura della nettezza personale, sian virtù insegnate dalle società borghesi alle aristocrazie, che le ignoravano compiutamente; e che in queste ultime soltanto debbasi cercar l'origine di quel disdegno del vincolo conjugale, e di quella mania di farne oggetto di scherni che signoreggiarono le lettere e il teatro nel secolo scorso, e in molta parte del secolo presente. Affermazioni simili sono, ad umile avviso nostro, piccole eresie storiche, che tornerebbe istruttivo e fors' anco divertente il confutare con alcuna ampiezza, se lo fren dell'arte, pur troppo già allentato di soverchio per noi, non ce lo vietasse.
Osserveremo solo che, a voler risalire alle sorgenti di quell'insieme di usi raffinati e di sottili regole di contegno che non sono scritti in nessun codice, e pure costituiscono per tacito consenso ciò che il linguaggio comune chiama la buona educazione o le buone maniere, ci sarebbe da sbrogliare una matassa assai arruffata, della quale l'un dei capi si riattacca senza dubbio alle raffinatezze del

-59-
Rinascimento che i francesi appresero in Italia e tm.piantarono sulle rive della Senna; ma che q uegli usi e quelle regole, quali sono oggi , rappre . elltano un prodotto misto di cortesia francese e di correttezza britannica.

l n Francia, un'urbanità istintiva e una tendet lza , insita nella razza, a trattare cavallerescamen te il sesso più gentile, la facilità e l'arguzia del con versare, l'amore all'eleganza e ai convegni sociali, t·earono un'atmosfera di cortesie che, nel secolo s cot'5 f'l, quando la democrazia borghese del Ferraro s kt va ancora in mente Dei, era già famosa e invidi a ta i 11 Europa sotto il nome di politessefrançaise; e d : ill :1 aristocrazia francese si propagò, per imitazio ne o per voga, a quella delle altre nazioni.
L'Inghilterra vi aggiunse di suo e, a dir cosl , vi sovrappose una più rigida sollecitudine dei rig uut'ili sociali, scaturita dalla gravità e dalla compos tezza che sono nell' indole britannica; una serie m ittHia di norme di contegno, le quali s'ispirano insit 'tlle al senso pratico ed al rispetto di sé che contr a1lti istinguono i figli d'Albione. Ma, anche qui, la ge uc:-;i del fenomeno è in tutto nobiliare: tale patri m ll tlin di usi passò, in Inghilterra, dall'alta alla borghesia, questa sempre sollecita e ge h'"a colà di plasmarsi in tutto su quella; onde Gu i/• 't o,ffermava che una tra le fortune del popolo inglc-..r :onsiste nell' aver una aristocrazia democrati ·a c ma borghesia aristocratica. Dalle rive del Ta tttigt
-60poi la correttezza britannica si t rasfuse nelle aristocrazie del continente, e da esse nelle rispettive borghesie. La miglior prova di tale asserto risiede in ciò, che quella finezza esteriore del costumo e del modi, della quale parliamo, si r·iscontra a un dipresso in egual grado nelle a f'istocrazie di tutti i i paesi civili, mentre in taluni di essi ancora non è penetrata, o lo è assai scarsamente, fra le classi borghesi.
La nettezza personale poi ha, in tutti i paesi del mondo moderno, una storia pur troppo t•ecente. I primi disegni architettonici di gab inetti da bagno di cui noi abbiamo conoscenza, api al'tengono a palazzi signorili di Parigi, e sono tr acciati nello stile capricciosamente squisito che prese nome da Luigi XV di Francia. Ma anche in questa materia l'iniziativa principale fu britannica ed aristocratica, e collegata agli esercizii dello "sport,, i q uali furono in fiore presso quella nazione assai pri ma che presso ogui altra. Da essa il culto della pers ona si trasmise allo aristocrazie del continente per u n tramite singolare, e cioè mediante la febbre di an rrloman ia che colse queste ultime dopo la vittoria di Water·loo, diffondendo tra loro l'abitudine di fre quenti pellegrinaggi a Londra. Così ci conceda il no h' egregio avve t·sario questa affermazione che deve parergli mostruosa: la guerra ha servito, u na volta almeno, a propagare nel mondo l'amor del sapoue l

Se vol essimo dimostrar falsa l'altra asserzione sua che il disprezzo del vincolo matrimoniale e l'esaltazione dei celibato abbiano origine esclusivamente aristoceatica, dovremmo varcare i confini di ogni discretezza. Ci limiteremo a notare come l'antica letteratura che i francesi hanno chiamato drolatique, la quale creò in Francia il tipo comico del marito ingannato, circondando dl un'aureola di giocondità vittorjosa gli autori dell'inganno, letteratura il cui spirito s i ritrova vivissimo nel romanzo e nel teatro del XV III secolo, sia stata tolta quasi di pianta agli antichi novellieri italiani, e massime ai toscani, e sia torn ata in Italia camuffata alla francese, nella stessa g uisa che vi tornano, duplicate di prezzo, da paesi st ranieri le umili stoffe tessute sui telai paesani. Osserveremo altresl che quei vecchi novellieri toscani prendevano a modello dei loro racconti, non già le a ristocrazie militari che non conoscevano punto, m a la democrazia borghese in mezzo a cui vivevano: nella quale, per colpa dei tempi e senza che le is tituzioni militari o non militari ci avessero a vedere, la licenza del costume e l'oscenità del novellara e rano non minori di quell(3 che il Ferrera rimprov era alle società guerresche.
Non voglia il lettore scorgere in cosl fatta digres-

-62
sione velleità retrograde, lo ntanissime, checché altri creda, dal nostro pensiero. Se ci permettessimo il lusso dei rosei sogni, vor·remmo sognare una società nella quale, per una parte, coloro che portano un nome chiaro nella storia, o illustrato da lunghi servigi resi alla patria, no n avessero maggi'or sollecitudine che di mostrarse ne veramente degni con le opere e le virtù; e per l'altra, un'onesta e tutta intima compiacenza di pot·tarlo 11011 fosse contrastata loro, o derisa, da quelli che, non di rado, più ardentemente la invidiano; u na società tuttavia io cui avesse a prevalere un'aristocrazia sola: quella della virtù e della pietà umana, dell'ingegno e del sapere, ed anche (c!le non guasta pu nto) della cortesia e della buona educazione.
Ma, in tempi ne' quali il maggior timore dei molti è di non parere abbastanza feroci odlatori di ogni cosa del passato, piace a noi di dare qualche risposta ai disdegni del giovane autore; e non ci tratterremo dal dar loro anche quest' ultima. Nella triste sequela di fiacchezze di sventure e di schiavitù che fu, considerata nel suo insieme, la storia guerresca d'Italia, fino agli albori del XIX secolo, tre stati soli formano un'eccez ione luminosa; essi soli seppero, per lunghissima s erie di secoli, mantenere la loro indipendenza con le armi; uno dei quali non l'ha, per fortuna d'Italia, per·duta mai; e sono Roma antica, la Repubblica di Venezia, e il Pie monte: tre stati variamente, ma essenzialmente ari

-63stoc1·atici. Tanto è facile che alle negazioni troppo recise accada di spezzarsi talvolta contro i duri scogli della realtà. •"' "'
E tomiamo alla questione fondamentale. Nel libro del pensatore piemontese tutti i tipi della fisiologia militare sOiano sotto i nostri occhi: dal capo feroce dell'orda preistol'lca al guerriero unno che beve nelle coppe d'oro rapite ai templi; dal generale turco devoto al bakshish aH'ufftciale inglese che siede a mense reggimentali ricch e dì preziosi vasellami d'argento.... Manca solo in questa rassegna l'ufficiale italiano cb e, sal vo •·are eccezioni, suol mangiare, anziché nell'ar·gento, entl'o majoliche fin troppo modeste, e vive una vita semplice, studiosa, tutta chiusa nella monotona cercWa de' suoi doveri professionali. Mancano, sopratutto, d ue tipi italiani che in un intero volume dedicato a lle armi, e fra cosl grande richezza di descrizio ni, potevano trovar luogo, non foss'altro per amo re di contrasti. Quello dei volontari accorsi d'ogui parte sotto le bandiere di Vittorio Emanuele e n elle schiere di Garibaldi, per le gueree patrie; e quello dei militari d'ogni grado che consumarono i mi gliori anni della giovinezza nella nscura e teiste guerra contro il brigantaggio. Se in certe notti buie nelle quali quei volontari .rarca vano il Ticino, nascosti nel fondo di una barca

silenziosa, ascoltando col cuore in sussulto risuonar · lontano i passi delle pattuglie austriache, qualcuno avesse detto loro che obbedivano ad impulsi di sopraffazione e di cupidigia, come avrebbero e si riso sommessamente! E gli um ili eroi dei tempi più duri del brigantaggio, che nel buio della notte, e fra le nevi dei monti, a piccoli drappelli composti talvolta di due o tre uomini (tanto le fot'Ze t·iuscivano scarse al bisogno sempre rinasce nte) perlustravano senz· posa terreni che apparivano deserti, e casolai·i che sembravano abbandonati, e dove pur ad ogni tratto poteva sorgere per loro, nelle sue più terribili forme, la morte 1 ; quegli umili eroi che si offrivano ogni giorno al sacrificio, senza altra gloria o premio che la coscienza di un oscuro dovere adempiuto, come avrebbero inarcate le cigli a udendo che si affaticavano per l'oppressione e per l'ingiustizia!
l Frequentissimo il caso che quei piccoli drapllelli, varcando la soglia di una masseria in appa renza disabitata, fossero accolti da una scarica micidiale. Frequentissimo pure il caso di feriti barbaramente tormentati e mutilati dai briganti. Un am.ico nostro, giovine ufficiale di cavalleria, f11 tagliato u pezzi nel senso letterale della espressione. Parecchi soldati vennero sepolti vivi con la testa sola sporgente dalla terra, oncle furon ritrovati poi fatti orribilmente mostruosi dal sol e cocente e dal morso ùegli insetti. Questi tristi particolari, dim enticati ormai, ogliamo ricordare per mostrar che sorta eli pericoli abbiano quotidianamente sfidato per lunghi ann i i nostri soldati.

E chi avesse detto alla gloriosa nave salpata dallo scoglio di Quarto che essa non drizzava la sua pro ra verso l'ideale l
•••
imili ricot•di fara nno battere qualche vecchio cuore di soldato, e torneranno graditi a coloro che, amando di an tico a ffetto l'esercito, ignorano quel sacro orrore di ogni sentimento che a non pochi giov ani pare oggi fo rtezza, e forse è precoce vecchiaia dello spirito. Temiamo tuttavia che le nostre evocazioni chiamino un ironico sorriso sulle labbra dell'autore del J.lfilitarismo, se dobbiamo giudic arne dal modo con cui egli mostra di concepire e di apprezzzare il risorgimento italiano. Non sarebbe in vero facile l'imma ginare a priori qual grado di jmpassibilità analitica, e (sia detto senza ombra .di intenzioni scol'tesi ) q uale aridità spirituale egli rechl nello studio di a vvenimenti che pure furono il sogno ardente di nobilissimi intelletti e vennero prepa1·ati con tanti sacrifici, e invocati con tante lagrime.
L'opera con la qu ale il conte di Cavour, fra lo sbigottimento astioso dei nostri più fieri nemici , faceva sorget·e dal nulla il problema italiano, e l'imponeva a ll'Europa riluttante, e ne proseguiva la sozione, appoggiato alla fede di un Re magnanimo, a mezzo a difficoltà che aucora oggi appaiono

spaventose, sembra al Ferre ra tale che le giovani generazioni debbano, assai più che a quella, interessarsi alle riforme finanziarie del g1·ande ministro. Lo sforzo poderoso cou cui Napoleone nr trascinava all'impresa d'Itali a la Francia, risoluta· mente e innegabilmente contral'ia ad essa, è p e l nostro autore un piaggiare che l'infelice sovr·ano faceva le classi colte, allo scopo di acquistar favore al suo governo col prestigio delle armi l La guerra del 1859, il cui primo annunzio fece delirare di gioia una generazione di italiani è, ci assicma il Ferrera, per la generazione sua, null ' aUro che uu episodio e un aneddoto; e dicendo ciò dimentica, l'ingrato! che a quella guerra unicamente egli deve di aver potuto far stampat·e in Milano e far leggere in tutta Italia il s uo sdegnoso Milita-risma l Egli ammette bensl che la rivoluzione i ta· liana procedesse in parte da una corrente ideale di pensiero e di sentimento, ma anche (giusta una legge che a parer suo si m anHesta in ogni rivolgimento politico) da correnti di interessi e di cupidigie. Secondo egli crede, i fondatori della nazione non si proposero già di costituirla militarmente, perchè ricordassero che l'ab bandono delle armi era stato per l'Italia fonte di vergogna e di schiavitù; nè già perchè sapessero che, mentre i popoli di razza germanica trovano il germe della disciplina ociale nell'intimo della loro s tessa indole, i latini uot l'acquistano se nou quando si piegano ai freni del·

l'educazione militare; non già, diciamo, per simili concetti ideali, ma per formare un nucleo di interessati al nuovo regime, mediante la creazione di una vas ta burocrazia militar·e e civile, modellata sull'esempio francese. Questa ebbe per còmpito di trapiantare al di qua delle Alpi un cesarismo, anch'esso di tipo francese, intorno al quale s i raggr upp ò u n vasto sistema di affari e di meudicità; mentre le così dette classi dirigenti si assumevano Ja missi one di spargere nella società italiana i pregiudi zi favorevoli al sorgere del mllitarismo. Ed ecco i poveri uomini illustri del risorgimento, i primi ri gidi e probi reggi tori del nuovo stato, i Ricasoli e i Farini, i Minghetti e i Peruzzi, i Lanza, i Sella, i Rattazzi, trasformati in grassi di una allegra impresa di cesarismo, condita di affari du'bbi, e di réc lames patriottiche e guerresche ! •••
Di questa traduzione libera della· epopea del risorgime nto, che si è svolto sotto i nostri occhi, possiamo stupirei, ed anche sorridere; ma il sorriso muore sulle labbra quando l'autore, dopo essersi di ffuso ad esporre le per le quali il tentativo di una coltura artificiale del militarismo italiano andò fallito, impreude a parlare del nostro esercito.
Alla battaglia di Adua e ai soldati che vi com-

-68-
batterono egli dedica p-arole che il piu feroce nemico nostro non oserebbe forse adoperare; egli mostra di rallegrarsi che una catastrofe, della quale ha pur una cosl umiliante visione, s uscitasse scarso sdegno, e scarsissimo desiderio di riscossa fra gli italiani. Di questa remissiva attitudine loro egli non accagiona la loro fiacchezza, e nemmeno le gigantesche difficoltà finanziarie e le impossibilità strategiche e logistiche che troppo evidentemente si opponevano ad ogni disegno di guerra a fondo; ma ne dà merito ad una superiorità morale, ad un progresso di pensiero civile che l'It alia, a suo credere, ha raggiunto rispetto alle altre nazioni; massime rispetto alla Francia, inferoci ta, dopo Sedan, in una furibonda e inutile difesa, e ancora dopo tl·ent'anni ostinata a sognare la ri vincita l Poiché, dice egli, al popolo italiano mancano la violen;;a e la crudeltà necessarie a fondare' u n vigoroso miUtarismo! Facendo questo singolare ragionamento, il Ferrera dimentica da un lato che i nostri emigranti, secondo egli stesso deplora, s i lasciano troppo facilmente bastonare e linciare in America; e dall'altro, che questo popolo italiano, mancante di crudeltà militare, tiene di gran lunga il primo posto nella triste gara dei reati di sangue; e, oggi ancora, mentre scriviamo, è, a torto o a ragione, ludibrio del mondo civile per un delitto che strappò in questi giorni al Ferrera medesimo un nobile grido di sdegno. Ma codesto più alto pe nsiero civile di

-.;69- : cui il nostro scrittore ci fa vanto, che :sforzi ha egli prodotto e che iniziative ha preso, per metter fine a tanta jattura o almeno per mostrarsene intensamente addolorato e vergognoso'
Se non ch e il Ferrera non s'accontenta di accusare il nostro soldato d'oggi; offende pure, in modo crudele, quello del domani! Egli si arroga, non sappiamo come, una rappresentanza, quanto triste! della giove ntù italiana agiata e colta che gli è contemporanea ; ed assicura, per la conoscenza che ei ne possiede, che, nel caso di una guerra, essa abbandonerà sole nei ranghi, a compiere colle loro magre energie il terribile dovere, le classi popolari aggiogate dalla leva nell'esercito! Onde egli crede che da cosl misere forze non si debba aspettare che la disfatta costante ed immancabile delle armi italiaQ,e.
oi faccia mo violenza a noi stessi per scrivere queste cose, sia pure allo scopo di confutarle, in uu giornale italiano. Come il Ferrera non s' è sentito tremar n cuore scrlvendole in un libro, dopo che un altro libro suo aveva trovato, oltre le alpi, diffusione e favore 1 Noi speriamo per lui, anzi ci teniamo certi, che, se ,lontano dall'Italia egli le sentisse risuonare sovra labbra straniere, sarebbe preso, for·s'a11cbe s uo malgrado, da un impeto grande di sdegno. Ad ogni modo è fuor di dubbio che, in quei paesi di san gue germanico che il Ferrera ammira tanto, nessu n più crudele nemico dello stato si ac-

-70concierebbe a scrivere in cotal gu isa dell'esercito nazionale; che, anzi, l'ipotesi di una guerra patriottica vi provocò, non di rado, dichiarazioni affatto diverse dalle parti politiche più avanzate.
In quanto ai caduti di Adua, noi rammenteremo di aver dimostrato con le cifr e ufficiali in queste medesime.colonne 1 che, durante il duplice combat· timento cui fu dato l' infausto nome, e su quella prima 'linea di battaglia ove soltanto si sarebbe po tuta disputare la vittoria, circa sette mila italiani, divisi in due gruppi incapaci di reciproco soccorso, sostennero per più ore a sinis tra, per un giorno quasi intero a destra, l'urto su ccessivo delle forze abissine, che i più discreti calcoli facevano ascendere a ottantamila uomini. Se questa dimostl'azione, la quale ebbe, fra altri conforti, la benevola adesione dell'illustre generale Cosenz, aggrava terribilmente le responsabilità del comando supremo, che importa Qui si tratta di ben altro; si tratta dell'onore della stirpe: poiché noi non consentiremo mai che un popolo, del quale fosse irrimediabilmente dimostrata la v iltà e che esso me desimo si piegasse ad ammette1·la, potesse poi per virtù d'intelletto aver qualche valore e qualche dignità nel mondo. Confronti il Ferrero i suoi paviòi emigranti che si lasciano bastonare dagli stranieri,
1 Vodi In Mcmo1·iam, nel 1mmero 1.0 marzo 1897 del "'iornale la Ptrseverq.nza.

con quelle oscure e forti vittime del dovere ; astragga per u n momento dalla giustizia o dalla utilità intrinseche della guerra abissina, e poi negi1i che per la nostra razza infrollita nella servitù, le istituzioni militari siano ancora una sorgente di forza e di elevatezza morale.

Il Ferrera rivendica alla sua generazion e il diritto di attendere tranquilla a preparare i prop ri destini , senz a disturbi guerreschi; e la rivendica in nome di " quei cinque mila giovani che non volev.ano " mo rire e che hanno lasciato, nessuno s aprà mai "per quale [ragione, le loro ossa nella conca di "Ad ua,.
Noi abbiamo pianto qùant' altri mai la siuistt'a ecatombe; ma rispetto ad essa crediamo ave r e sul uo::>tro avversario una superiorità, che certamente sarà l'unica di cui potremo mai vantarci a riguar·do suo. Di quei poveri giovani che il Ferrera paragona a tar me di montoni impauriti davanti a ll'incendi o praterie, noi difendiamo la memoria; egli fu tratto dalla sua tesi a disonorarla.
v .
Ci rimane a dire delle applicazioni che il sociologo piemontese fa della sua teoria del militarismo ai popoli di stirpe germanica ed an glo-sassone. Ad essi egli ha levato un inno con quel geniale libro dell'Europa giovine, che recò la fama dell'autore oltre l'alpi. In loro è, a giudizio suo, la sperauza dell'avvenire, il tesoro di rorze e il succo di vita onde verrà la grande trasrormazione che l'umanità aspetta per acquetarsi nella giustizia e nella pace.
Noi riconosciamo ampiamente codesto fiorire delle nazioni di origine germanica, e vi scorgiamo in parte il frutto di certe peculiari virtù della loro razza, le quali si sviluppano con altrettanta fortuna nella democrazia americana e ne i l'eglmi monarchici del vecchio mondo, cosl com e certe fiacchezze latine perdurano pur troppo anche trapiantate, con le turbe dei nostri emigranti, al d i là dell'oceano. Ma crediamo altresl che il trionfo del sangue germanico sia dovuto in gran parte a quella inesorabile legge di decadenza, di cui parlammo più ad-

-73dietro la quale vuole che, nella storia come nella vita, la vecchiaia ceda il posto alla giovinezza. Le giovani e robuste nazioni di quel sangue vanno oggi surrogando nella potenza e nel pre· dominio sul mo ndo le antiche e stanche del sangue latino , cosi come le latine furono un tempo eredi delle vecchie c lviltà orientali. Non siamo tuttavia convinti che la loro felice evoluzione storica sia legata, come il Ferrera sembra credere, al fatto dell'aver esse pot uto sottrarsi all'incubo del miUtarism o.

In quanto all 'Inghilterra, si intende come la condJzione eccezion ale in cui essa è posta dalla giacituea geografica, dallo sterminato impero coloniale, dalla non meno sterminata ricchezza, le abbia consigliato e cons entito un tipo di milizie affatto diverso da quell o che si riscontra presso le altre nazioni civili. Sembra che assai difficilmente essa avrebbe potuto adottarlo se, pur col suo attuale grado di civiltà e di ricchezza, fosse stata potenza continentale. Notevole è dunque l'affermazione del Fereero che a quel tipo di milizie dovranno, in un tempo più o meno remoto, acconciarsi tutti gli altei stati ci vili.
Nell'esercito inglese l'assoldamento volontario si fa oggi con modi poco dissimili da quelli usati nel medio evo por raccogliere le compagnie di ventm·a. gl'adi vi rima ngono ancora in gran parte priviIglo delle classi ricche, e solo da non molti anni
cessarono di essere comperati a denaro. L' atmosfera in cui vive codesta milizia britannica ò raffinata ed aristocratica. Gli ufficiali conducono una vita elegante, fastosa e costosa, e il Ferrera cita una loro mensa reggimentale che possiede per mezzo milione di argenterie. L'aggr avio che l'esercito inglese reca al bilancio dello stato è, proporzionalmente , assai maggiore di quello che sopportano pei loro eserciti le altre nazioni. Dato tutto ciò, non senza una certa sorpresa noi vediamo un rappresentante di idee sociali avanzatissime, quale il Ferrero è, considerare le istituzioni mili tari di codesto tipo siccome un progresso rispetto a quelle che si fond a no sul principio, finora ritenuto democratico per eccellenza, del servizio obbligatot'io. Ad ogni modo, nelle odierne condizioni degli stati continentali, e in particolare del nostro, ogni r affronto dei loro ordinamenti militari con quelli dell'Inghilterra cl sembra non poter avere che un valore affatto accademico.
Della Germania il Ferre ro asserisce che non è Stato militarista, e per qua nto, a tenore dell'opinione comune, siffatta sentenza possa sembrar arrischiata, noi non siamò lontani dall' accoglierla. Un paese ove sovrano e ministri vestono perpetuamente l'uniforme militare, e questa ha, sempre e dappertutto, le haut du pavé; ove l'ufficiale, impettito e superbo, vede senza soverchio affanno la sua sciabola impigliarsi fra le gambe del prossimo, e mostra in ogni sua attitudine quel bonario, ma sicuro convincimento

-75della propria sup eriorità sugli altri mortali, che ha rnito ìmpaee"'gi abili tipi ai Fliegende Bliltter; un paese simile, dic iamo, parrebbe di primo tratto la cittadella europea del militarismo, dalla quale dor-ebbe fuggir·e inorridito il Ferrera, che si impenna davanti a quello, cosi attenuato e modesto, dell'esercito italiano.
Ma chi penetra al di là delle apparenze e pon mente ai caeatte l'i essenziali dell'indole tedesca, che ono la serietà, la propensione allo studio e al lavoro, l'attitudine al commercio e alle industrie, l'amore della famiglia e della casa, dovrà ammettere ·he codesta nazio ne non è militarista nel senso ind eterminato, epp ur indubbiamente cattivo, che il sib iltino vocabolo assume nel libro intitolato da esso. La Germa11ia è ben lungl dal subire, cosl prepotentemente come la Francia, il fascino della gloria guerresca; essa. non si lascia, come la sua rivale, abbagliare dal m iraggio del dominio sugli altri popoli, in modo da sacrificare a codesto sogno più concreti beni.
Noi conosciamo da vicino persona la quale ebbe a trovarsi a Sedan, ospite degli ufficiali di un regg lmeuto prussian o, due soli giorni dopo la celebre battaglia, e fu pr-ofondamente colpita dalla gioia pacata e mode ta che lasciavano trasparire i vincitori, To1lantisi nella piccola città. Essi si dimostravano ma sorpresi e quasi sgomenti, della granl zza della loro vittoria, e insieme si compiacevano

-76che la guerra (com'essi allora credevano) mente chiusa consentisse loro di rivedere tra la cara patria tedesca. Si può, senza offesa, Tn•.oc. ...mere che, se i francesi si fossero trovati in stanze corrispondenti, l'animo loro sarebbe stato preda ad una ebbrezza trionfale; ed essi avrebberq invocate nuove vittorie e sognato la prossima egemonia della Francia sul mondo.
Ma, se non andiamo errati, questa nozione dello stato d'animo del popolo tedesco rispetto alla guerra, scuote il fondamento stesso della teoria dello scl'it· tore piemontese.

Infatti quel popolo, che non è ·affatto militarista, possiede in grado tutte le qualità militari: più agguerrito del mondo. Che altro prova ciò, se. manifesta in un esercito che è, e sarà a lungo, il il valore, la calma, la pertinacia , lo spirito di abnegazione, il sentimento del dovere; e. sl fatte virtù non che la sozzura di vizii, di impulsi perversi, e di cupidigie, postaci innanzi dal Ferrero siccome essenza immutabile della guerra, non è punto condizione necessaria della grandezza militare di uno stato, e che, per contro, un popolo in alto grado virtuoso e civile può mostrarsi attissimo a creare un congegno militare perfetto 1
E degna di grande meditazione che un paese che sta, come la Germania, a capo del movimen•:l scientifico moderno e novera nel suo seno cosl a tdaci pensatorl, circondi di tanta simpatia e di tan !1.
-77
Becitudine i suoi ordiui militari; ignori il disdegno he si ostenta, in paesi intellettualmente più miseri , er le forme esteriori e pei simboli tradizionali diI tti a coltivare nell'esercito l'emulazione e lo spiito guerriero.
Si intende che, anche in Germania, i numerosi c mpagrii di fede del nostro autore e quella parte el la borghesia industriale che, per legge economica, i trova in inevitabile antagonismo con le istituzioni militari, formino correnti di opinione contrarie ad esse. Ma l'anima della grandissima maggioranza dei tedeschi è con l'esercito, cui sa di dovere l'attuale grandezza e da cui aspetta di vederla tutelata e, a ll 'occorrenza, difesa.
Pare a noi che il Ferrero, il quale ha pur studiato c n tanto acume la vita delle nazioni germaniche e ang lo-sassoni e nutr·e per esse una cosi calda a mmii'azi ne, non tenga co nto bastante dell'indiri zzo a cui, praticamente, la loro azione si informa. In quegli stati, n mare delle idee e delle dispute teoriche è mare libero ed aperto, e i più audaci possono spiegarvi le vele; ma la nave governativa uol mantenersi prudentemente nelle acque più note. Quegli stati, come tali, sono rimasti, in fondo e senza quasi confessarlo a Io1·o stessi, ostinati adoratori della fo rza, salvo ad impiegarla con grande misura e con u n delicato senso della oppo rtunità. nche quel vecchiume che è, pel Ferrero, il senti nazionale, acquista presso di loro una in-

-80sta non avrebbe usato; cet'to con uon lievi stl'appi al diritto pubblico, e tali che la sua a:ggressioue non apparve in al cun modo giustificata. V'ha d i più; il governo flemmatico e positivo della Casa Bianca si lasciò, o mostrò di lasciarsi forzar la mano da una cort'e nte itTesistiblle d'opinione, no u altrimeuti che que llo nervoso e debole che sedeva alle Tuileries all'iui f.io della guerl'a frau ·o-pmssiana.
Ma il peggio si è che lo spirito di cupidigia, di violenza e di sopralfa zlone ehe muove giustamente a sdegno il Ferrero e nel quale egli vede la caratteristica delle ari stocrazie militari, raramente si manifestò con sintomi più upeeti e più acuti che in codesta belligerante democeazia. L' iudole utilitaria e mercantile dell'i mpresa fu per alcun tempo dissi. mulata da qualche parveuza di pr tezione del deble contro il forte, ùall'affeemato peoposito ·di la ciar i cubani aebitri dei loro destini. Ma queste maschere caddero presto a terra, e l'avidità di guadagno e i brogli finanziarli che si connettevano alla con()uista della grande Antilia si rivelar·ono ai più ciechi.
Se dobbiam credere al Tim es, ancor prima che principiassero le stilità , un persona"'!!io politico americano aveva dichi a t'ato, in una intervista, che gli Stati Uniti agognavano al pos es o di Cuba, non già per fisim'e umanitarie o patriottiche, ma perchè le industrie dell'isola rappresentavano un grande interesse finanziario dell'Unione, che vi aveva impegnato capitali ingenti. Come poi le aspirazioni

conq uistatricl si siano allargate a Portorico, e via vja alle Mariane e alle Filippine, è noto. Con quest' ultima occupazione , compresa nel raggio d'influen za dell'Asia, la dottrina di Monroe riceveva l'estremo colpo.
Che il prestigio de lle armi cominci a sorridere alla grande repubblica, che il vino della vitto1·1a abt ia dato ai buoni yankees un po' della sua ebbrezza, a ppare assai probabile. Che una simile tendenza p ssa afforza rsi tino a far sorgere quel partito imperi lista che taluni già sognano, sarebbe premat uro atlermare. Certo non ci stupirebbe che gli a mericani dell'Unione, cosi come stanno mettendo i nsieme, a furia di mlli oni di dollari, un loro patrimonio artistico , volessero a furia di miliardi, concedersi la gioia di improvvisare, con la fretta degli arricchiti, una grande potenza militare. oi non siamo fra coloro i quali ln siffatte vell e ità d'oltre oceano ravvisano un futuro pericolo per le nazioni europee ; ma nel solo discutere di c iò, rispetto ad uno s tato dal quale s'attendeva la luce di una nuova gi ustizia internazionale, che dura lezione pei sognatori del vecchio inondo I

•••
Non sappiamo tuttavia come tale esperienza americana possa lasciare intatti t convincimenti che il nostro autore manifesta intorno all'avvenire delle istituzioni militari presso i popoli occidentali. Egli riconosce che, per secoli ancora, le nazioni ci vili d'Europa avranno bisogno di s oldati, non già allo scopo di prevenir contese che ormai non poss ono più sorgere fra loro, ma solo per mantenere aperto il campo di espansione nei due continenti vicini; funzione questa che, sia detto di sfuggita, non si vede come differisca gran fatto da quella che i Romani compirono lungamente e elle valse loro di esser presi dal Ferrera ad esempio di oppressione militare. E invero che altro essi fecero se non allargare a grado a grado eone armi la loro srera di efficienza in Asia, in Africa e n elle regioni , allora non meno barbariche, dell' Europa 1
Il Ferrera anche accenna con parole copel'te ad ingrate sorprese che potranno venire all' Europa dai vicini continenti; pericolo tutt'altro che fantastico. Ognun sa che lievito di adii fermenti fra le stirpi africane ed asiatiche, e m assime fra le razze musulmane, contro l'invasore europeo: e come siffatti odii, nutriti dal fanatismo r eli gioso, si rivelin ( oggi in un continuo germogliar e di se tte, le quali

-83allacciano in uu pensiero comune di riscossa le popolazioni fra loro più lontane. È pm· evidente che fra quelle stirpi spuntano, qua e là, civiltà rudimentali le quali, come quella abissina favorita dai nostri errori, cominciano a salire con I'elativa rapidità la curva del loro sviluppo. Chi mai può esclud ere che, giunto il momento psicologico, quegli odii smisurati e quelle civiltà ascendenti non diven tino una grave minaccia per l'opera c olonizzatrice delle grandi nazioni civili; e fors'an· che, in tempi più remoti, non mettano capo ad uno di quegli irresistibili spostamenti etnici che rifarebhe eo a ritroso la storia delle espansioni europee l Questa duplice necessità dell'adito aperto ai continenti e della difesa contro i pericoli che possono sorgere dalle ci viltà inferiori, sembra sufficientemente seria pe r dimostrare assurda ogni ipotesi di abolizione degli ordini militari. Il Ferraro la ricouos ce, sebbene a denti stretti; ma, come già si ùis e, egli crede che i popoli civili debbano in futuro provvedervi col sostituire al sistema democratico del servizio ob bligatorio quello, assai più aristocratico e incomparabilmente più costoso, del reclutam ento volontari.o all'uso inglese; il che, dal punto d i vista delle fi nanze continentali, assomiglia un pi) CO al voler persuadere chi stenta a comprarsi il ane di sostituirlo con le focaccie.
Ad ogni modo , queste premesse dello scrittore, on si vede bene come possano conciliarsi col suo

-84evidente disegno di screditare le istituzioni militari e di reciderne le rad ici nel cuore della nazione. P er nostro conto a quei due argomenti ne aggiungiamo senza scrupoli un terzo; ed è la scarsa fiducia che poniamo nelle. sue profezie ottimiste, secondo le quali fra le nazioni europee la pace dovrebbe ritenersi assicurata per sempre. Certo che, rispetto alla possibilità di un co nft it to cruento fra le potenze europee, noi ci trovia mo da parecchi anni in un periodo di sosta, dovu to, più che altro, a ll a coscienza dell'immane catastr ofe che una guerra sarebbe, e per la natura dei m ezzi d'offesa che vi si dovrebbero impiegare, e pel cumulo di interessi economici che ne andrebbero m inacciati ; onde la grandezza del pericolo h a servito e serve finora a scongiurarlo.
Ma, d'altra parte, lo spettacolo di una nazione forte e prospera, come gli Stati Uniti, lontana da ogni pericoloso contatto, eminentemente pratica e progressiva e, a dir cosi, tutta imbevuta di modernità, si lascia pur s edurre dai fascini della conquista, è meritevole di seria cotJsiderazione. E non lo è meno il vigore che conserva in Francia, dopo quasi trent'anni, il s entimento della rivincita, e il carattere di unanimi tà e di spontaneità che v'ebbero i delirii per l'alleanza russa. Nè, a tale proposito, deve dimenticarsi c he uoa caratteristica del popol• francese è la suscettibilità di lasciarsi trascinare, il qualsiasi momento, e quando altri ed egli stesse

-85meno se l'aspettano, da certi irresistibili impeti di passione, ad esprimere i quali ha creato un vocabolo inh·aducibile: l'emballement. Chi pensi allento e fatale andare della lotta che ferve fra l' Inghilterra e la Hussia per l'egemonia asiatica, lotta alla quale la seconda di quelle nazioni prepara pacatamente ma sorabilmente immani fot·ze, non potrà escludere la eventualità che da una favilla impreveduta sorga an · che nel mon do europeo qualche terribile incendio.

;Mentre scriviamo si va compiendo in Europa un avve nimento che non ha esempii nella storia. Il s vrano assoluto di uno sterminato impero militare si fa egli stesso propugnatore di disarmo e banditore di pace. Se la proposta dello Czar, secondo noi cr ediamo, non s'ispira ad altri intenti fuor che a quello, palese, della pietà umana, essa è tal cosa davanti alla quale tutti gli uomini di cuore hanno obl.lli go di Inchi narsi con gratitudine e rispetto. Quando dovess e approdare a qualche pratico risultato, chi vorrà non rallegrarsene sinceramente'
Non possia mo tuttavia in alcun modo aspettarne effetti tali da infirmare la tesi che sosteniamo e da sminuire la necessità della difesa che abbiamo assunta. Che anzi, le ancor larvate riserve dell'Inghilterra e le proteste che, malgrado ogni sforzo di prudenza, vanno scoppiando qua e là in Francia e, 1iù di tutto , 1' inesorabile logica delle cose, lasciano 1ssai scarse speranze che all'onesta impresa possa ;orridere la fortuna.
86-
Ma, sarebbe puerile il disconoscerlo, la possibilità sola che essa sia stata tentata, nella forma e nelle circostanze in cui fu te ntata ogg i, già corrisponde ad un progresso della coscienza umana. Se anche dovesse andare in tutto fallita, il g iOt'nO in cui co desto autocrata pietoso pronunciò la sua pa l'Ola di pace t•imarrà per ie stil'pi umane una data memo· rabile; e la figura di lui, come quella d i certi eletti del paradiso dantesco, ri splenderà di una luce mite e benigna a traverso la storia.
VI.
Dobbiamo ora toccare di un ' a ltra importanti slma funzione degli ord ini mmtari, che è quella di provvedere alla sicurezza interna dello stato. Argomento spinoso e sul quale ritorniamo a malincuore, ma che è pure u no degli aspetti essenziali della questione che ci occupa. Nessuno si attenterà di porre in dubbio che lo stato abbia, non solo il dirit.to, ma anche il sacrosanto dovere di difendersi con le forze di cui dispone contt'O quelle che, nate nel suo seno, mirano all a sua distruzione. L' integrità propria è il supremo degli obblighi che esso assume in faccia alla nazione, mancando al quale mancherebbe alla ragion e stessa della sua esistenza.
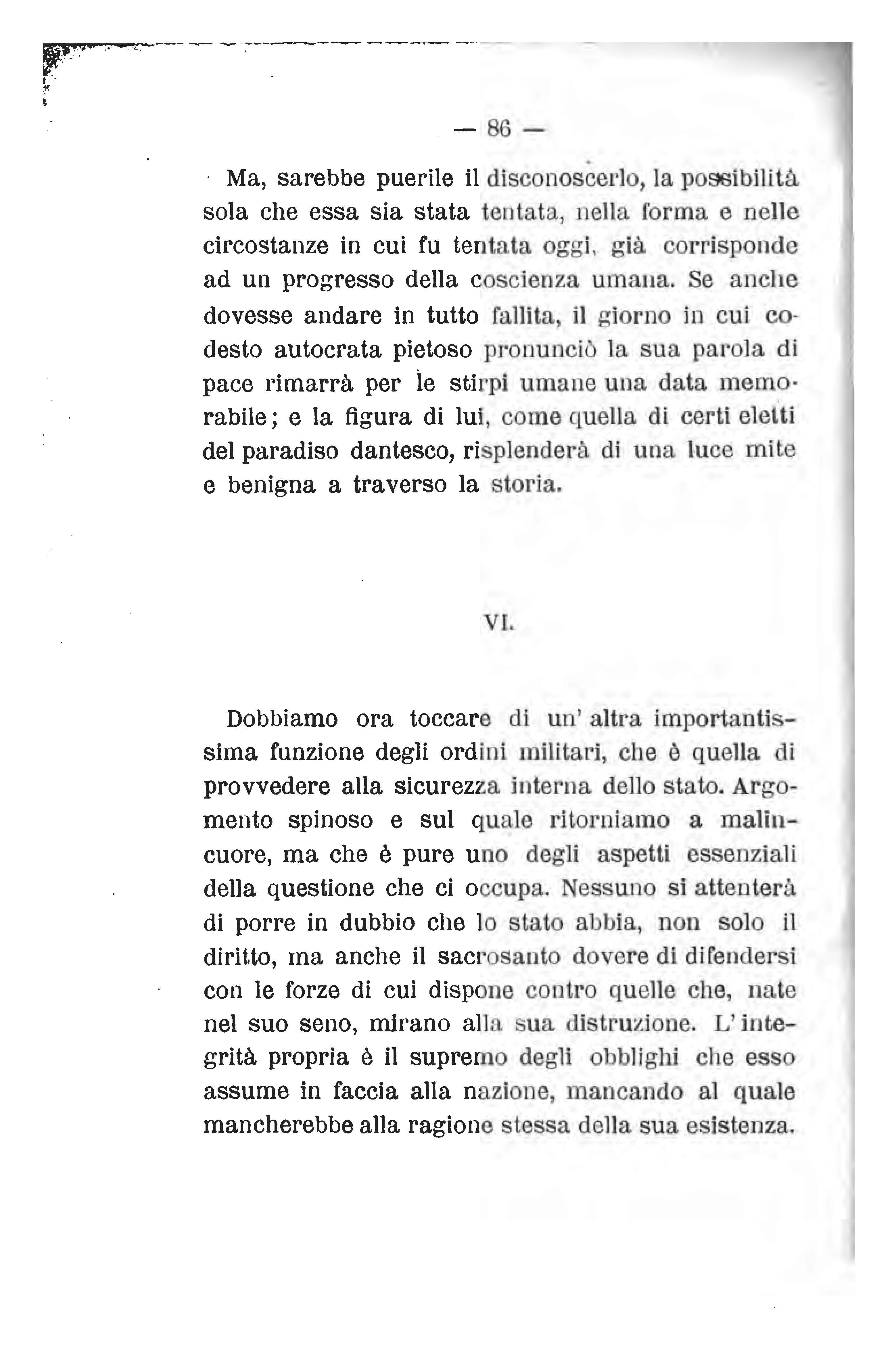
-87-
Ora, salvo casi non mai abbastanza deplorati, e per fortuna oltremodo rari, gU ordini militari compiono il loro ufficio di conservazione, a dir cosi, negativamente·, pel solo fatto di esistere, ma sono guarentigia indispensabile di sicurezza e di pace, dalla quale la genesi storica dello stato italiano e le sue attuali condizioni, rendono a11che più palese la necessità. È antteo nell'animo nostro il convincimento che la rovtna delle istituzioui militari segnerebbe in Italia la fbte dell' uuità e della libertà, e darebbe il paese in braccio alla più cie a e alla più disastrosa delle tiraunidi. Ma, dopo le giot·nate di maggio, non vediamo come di questa verità si possa dubitare.
Lo sforzo dei partiti esti·emi si volge ora Jorricamente a sminuire la gravità di quei tristi fatti, ad escluderne ogni concetto di premeditazione e di preparazione. E a noi ripugna disputare intorno n. ciò; vogliamo anche ammettere che l' abilità c la rapidità con cui la rivolta fu soffocata nel suo nascere abbiano impedito ognl esatto calcolo delle proporzioni che avrebbe potuto assumere e delle conseguenze che avrebbe potuto produrre. Fu un baleno nelle tenebre di una notte procellosa, che ap pena ci consenti di ritrat're il p iede dall'orlo di un dirupo, senza darci tempo di mìsurarne coll'occhio la profondità. Ma chi può dubitare che sulla stes a via altri abissi, di pl'ofondità mortale, non ci aspettassero'

-88-
Si intende dunque facilmente che i partiti sovvel'sivi si accordino nell'accusar la difesa sociale ' di essere stata in quei giorni sproporzionata aUa tenuità del pericolo; ma è singolare, e nou poco istruttivo, che persone appartenenti ai partiti d' ordine già mostrino di consentire In codesta accusa. quale, in bocca loro, ci sembra doppiamente ingiusta; perché il giudizio che di tentativi simiU può farsi, dopo che essi andarono falliti, non può in alcun modo esser fatto a priori da coloro sui quali pesa, in faccia alla nazione, l'immane responsabilità della sua salvezza; e perch é spesseggiano nella storia esempi di rivolgimenti di stato sorti da ragioni immediate assai più tenui che non fosse la crisi del maggio, i quali tutta via si consumarono per non esser sopraggiunto n r iparo abbastanza rapido e risoluto.
Ma se si tien conto della conte mporaneità dei moti scoppiati nelle diverse provincie italiane, del nerbo di truppe che fu necessario a so.trocarli rapidamente e dello sforzo di mobilitazione che una tale necessità richiese, vien fatto di domandare ai più tepidi amici deg·U ordini militari che cosa mai sarebbe a vvenuto in Italia se, negli anni precedenti a questo infausto che corre, l'esercito fo sse stato, in tutto o in parte, sacrificato alle ubbie dottrinarie che da tempo lo insidiano.
Certo sarebbe stolto e colpev ole il sostenere che l'opera di salvezza della nazione possa limitarsi ad

-89assicurarne le difese mateeiali; e nou debba invece ricercare le più riposte sorgenti della sua vita, e studiar·e coraggiosamenje le piaghe che la contl'istano, e tendere con ogni sforzo alla sua reden zione morale ed economica. La quale non può trovarsi, per un lato, se oou in un cresciuto impulso di attività e di lavoeo, e, per l'altro, in un piu sano conce tto dei diritti e dei doveri pubblici, in una piena l'estaurazione dei principii di a utorità e ili rusciplina sociale.
Ma non meno stolto e non meno colpevole arebbe l'affermare che quest'opera, lun ga ed ardua, cui devono concorrere il buon volere, la pei'tinacia e la sincerità di tutti, possa compiersi altrimenti che a traverso un lungo periodo di sicurezza, di r·accoglimento e di fiducia. Ora, non solo nella società italiana, ma anche nelle piu progredite società europee, una simile cot:dizione non può verificat'Si se non all'ombra di solidi e rispetLati ordini militari. All'infuori di tale guat'entigia, la possibilità di grandi catastrofi sociali è oggi assai più strettamente legata all'accumulamento ed alla facilità di esp losione delle forze sovversive, che al grado di benessere che una determinata società abbia ra"'giunto. Nè è punto vero che questo e quella stiano, sempre e dovunque, in una ragione inversa. La iermania, n nostro autore ce lo insegna, è nazione progressiva , virtuosa e forte; la Fl'ancia, à fra le più prosperé del mondo e le classi popo-

-90lari vivono colà assai meno disagiate che altrove. Eppure entrambe quelle nazion i sono, nel loro pro· fondo, travagliate dal lavori o delle sette avverso allo stato; le quali constano s i di minoranze numeri· camente esigue, ma posseggono l'audacia e lo spirito di violenza con cui impo rsi alle maggioranze. Ora, se si potesse immaginare che in quei due stati le istituzioni militari scompa1·isscro d' un tra tto, nessun dubbio che· essi andre bbero subitamente in fiamme e diverrebbero per l 'Europa due spaventosi focolari d'incendio. Che accadrebbe mai , nella medesima ipotesi, di questa povera Italia, ove non solo l'accumulamento delle forze settarie é grande, ma il loro lavorio trova terre no cosl propizio uella miseria, nella ignoranza delle popolazioni. e, triste a dirsi, nella spensierata inerzia delle classi dirigenti 1
La Francia sperimentò da molti anni che cosa siano i soffi di tempesta che si rovesciano outro uno stato e minacciano di travolgerlo, non appena la sua potenza militare appa ia fiaccata o scossa. Il Ferrera ha amare parole per la implacabile repressione versagliese e benev ole per gli insorti della Comune parigina. Ma le òrde che questa scatenò, sognanti di per qua11t0 stava in poter loro., la civiltà moderna, con la città nella quale esse stesse riconoscev;1no il cervello del mondo, in che differivano mal, per le conseguenze ultime del l'opera lo.ro, da quelle altre orde devastatrici che il

nostro autore ci con cosl vivi e tragici colori 1 Le rept·essioni compiute con la forza son s nza dullbio lagt•imevoli sciagure; e fornirono in ogni tempo il tema delle piu fiere invettive dei poeti · e dei retot'i. Ma, da Publio Clodio a Vietar IIugo, i rctori e i poeti han dimenticato sempre di dirci che torrenti di sangue e elle orror di rovine certe repressioui inevitabili abbiano risparmiato alla civiltà umana . La notte in cui le invasioni barllariche piomba rono il mondo romano ha durato lunghi secoli. periamo che una barbal'ie uova che sentiamo fl'emere ancora confusamente in-torno a noi non dia, presto o tardi, gli stessi lag r·imevoli frutti. <t ., .
Ed ot·a, non fo s'altro per mi eri ordia del Letto r e che ci avesse seguiti tln qui, noi dobbiamo riassumere le nostre ciarle vagabonde e analizz re poi le ultime conclusioni del libro che abbiam pres in e ame.
A noi dunque la prova storica e la prova psico-log ica che il Ferrera fornjsce nella sua tesi non paionQ convincenti. Noi persistiamo a ravvisare uella gucrm una necessità storica, fìno ad oggi indeclinabile, che non di rado ha servito l'ideale, fia contribuito a cr eare e a propagare la civiltà; e non di rado diede l' ind1peodeoza ai popoli fond ò la

!)-,2loro prosperità e la lor grandezza; che è stata bene spesso ma clre di nobilissimi sacrifici e di preziose virtù. Noi pensiamo che il militarismo, quale il Ferrero lo intende, e Io spir·ito militare, quale é inteso da noi e coltivato ue' migliori eserciti europei e nel uostro, iano due termini affatto distinti e poco meno che opposti, la cui confusioue mantenuta ad arte fomenta i pt·egiudizl volgari e gio va ai partiti so vversivi per uutri[•e l'odio alla milizia. Noi siamo infine convinti che tale buono spirito guerresco, non solo abbia virtù di plasmat•e e di indirizzare ai suoi fini le forze sulle quali deve svolgere la sua diretta azione, ma eserciti anche, in ispecie nel nostro paese, una influenza altamente benefica sovra la società civile.

Ciò pel passato e pel presente: in quanto all' avvenire, noi nou sappiamo condividere la rosea certezza nutrita dal Ferrero che la guerra sia un fenomeno sparito por sempre di mezzo ai popoli civili ; né ci piega a crederlo la ser·ie di avvenimenti che si svolgono sotlo i nostl·i occhi nel mondo. Ad ogni modo le speranze di pace, se. anche volessero dirsi cresciute, no n sou già cosl solìde che gli stati possano, senza follla, spogllar·si delle loro difese; e queste sono, d'altro nde, indispensabili alla loro interna sicurezza.
Nè a noi riesce di conciliare l' affermazione del Ferrero che l'Eur·opa avrà per secoli ancora bisogno di soldati, sia a scopi coloniali; sia a difesa di pericoli
-93che possano minacciarla dai due co ntinenti barbal'ici, con l'opera di discredito e di d ispregio che egli va compiendo a danno delle istituzioni militati.
Ci sembra invero che nel corso del libro la tesi d l nostro autore cammini talvolta come a fatica, traverso i fiori dello stile, e talvolta quasi si perda fr-a iudeterminatezze e contraddizion i non poche. Ma essa si disegna e, a dir cosl, si irri gidisce nell e ultime conclusioni sue, acquistando la consi tenza di un vero program ma, che merita di essere set·iamente p nderato.

Nell' ultima sua conferenza, il Ferraro delinea in un ampio quadro una nuova forma di oppressione che ai giorni nostri è rappresentata dalla grande industa·ia esportatrice e dal commercio mondiale che le nazioni più prospere esercitano a danno delle altre. In simili im prese economiche trionfa, a parer suo, uno spirito dl conquista e di rapina che tradisce la loro parentela colla guerra, onde possono paragonarsi ad una guerra addolc ita. Egli scorge in esse un "macchinoso congegno, che è bensl in parte diretto a fin i economici, ma che in parte serve "a certe classi e a certi popoli per im padronirsi delle ricchezze di altre classi e di altri popoli, proprio come servivano una volta gli eserciti.,
Narrate poi la genesi e le fasi di questo fenomeno tutto moderno e il formarsi di una plutocrazia che surr.oga le vecchie aristocrazie militari, et·editandone le s[renate cupidigie e la sete di go dimenti, il Fer-
!>4rero pone a raffro nto l'antica con la nuova tirannide e conclude testualmente cosl:
"Noi vogliamo app unto prestamente liquidare quanto resta di q uesta antica e rozzissima forma di male; noi vogliamo annientare totalmente l' atavismo della guerra per avere le mani libere a combattere la nuova forma dell' ingiustizia e del male, che è non meno inesorabilmente condannata a sparire per la forza stessa dell' interno lavorlo della vita.,

E più innanzi, ricordando come le antiche oligal·chie mllitari, spinte dall' avidità di vi vere a dlsmisura, si distruggess ero a vicenda, non lasciando che rovine e deserti sull a terra; e predicendo che "il complicato sistema di a rtifici economico-politici, con cui le classi dirigenti dei paesi civili si affannano acrescere artificialmente il valore del proprio lavoro, è pur destinato a precipHare in una gran crisi, soggiunge:
"La crisi non sarà, come quella della guerra nel mondo antico, una distruzione di ci viltà, ma solo una pausa momentanea nel progresso, perché la punizione è, nella giustizia dei fatti, sempre proporzionale alla colpa; m a anche questa volta l'avidità di vivere a dismisura delle minomnze che oggi dirigono il lavoro del mondo civile, finirà in una par::iale distru::ione di vita e ttella sterilità del dc erto. Scontato anche questo peccato, la società potrà ri comporsi in forme che aranno tanto migliori delle
pt·esen
tt quanto le presenti sono migliori delle pasate.,
Vegga il lettore come, in queste previsioni, il pro· ce so logico si svolga rigoroso, e il programma social e si disegni con inesorabile chiarezza. Il ùito e la rovìn a degli i tituti militari lascier•à alle n ove generazioni le mani libere per abbattet'e la pi ù moderna tirannide industriale e commerciale; q uesta cadt'à in una gran crisi, che produrrà una p nrzirtle di vita e la sterilità del deserto, Ula dalla quale la società rigenerata uscirà in nuove e migliori rot'me.
Un punto S'Oio di cosl mir1acciose profezie rimane o curo e come a vvolto nelle nebbie d' incenso che n ascondevano un tempo alle tul'bc pl'ostrate, il Dio endicatore. Non s'intende bene quale sia la Nome i che ci deve coglieee, quale la gran crisl che scuoterà il mondo, per salvarlo l • ."
Noi non chiedi amo di magli che di attribuiee a codesto pro(J'ramma del nostro autore un carattere strettamente teorico e intenti esclusivarne11te cientifici. Confessiamo tuttavia di non saper trovare un ragionamento, da cui scaturisca per esso un valot' diverso da· quello di una dichiarazione di Jcrra alla società moderna.
Noh abbiamo poi alcu11 dubbio che in cotal seu o
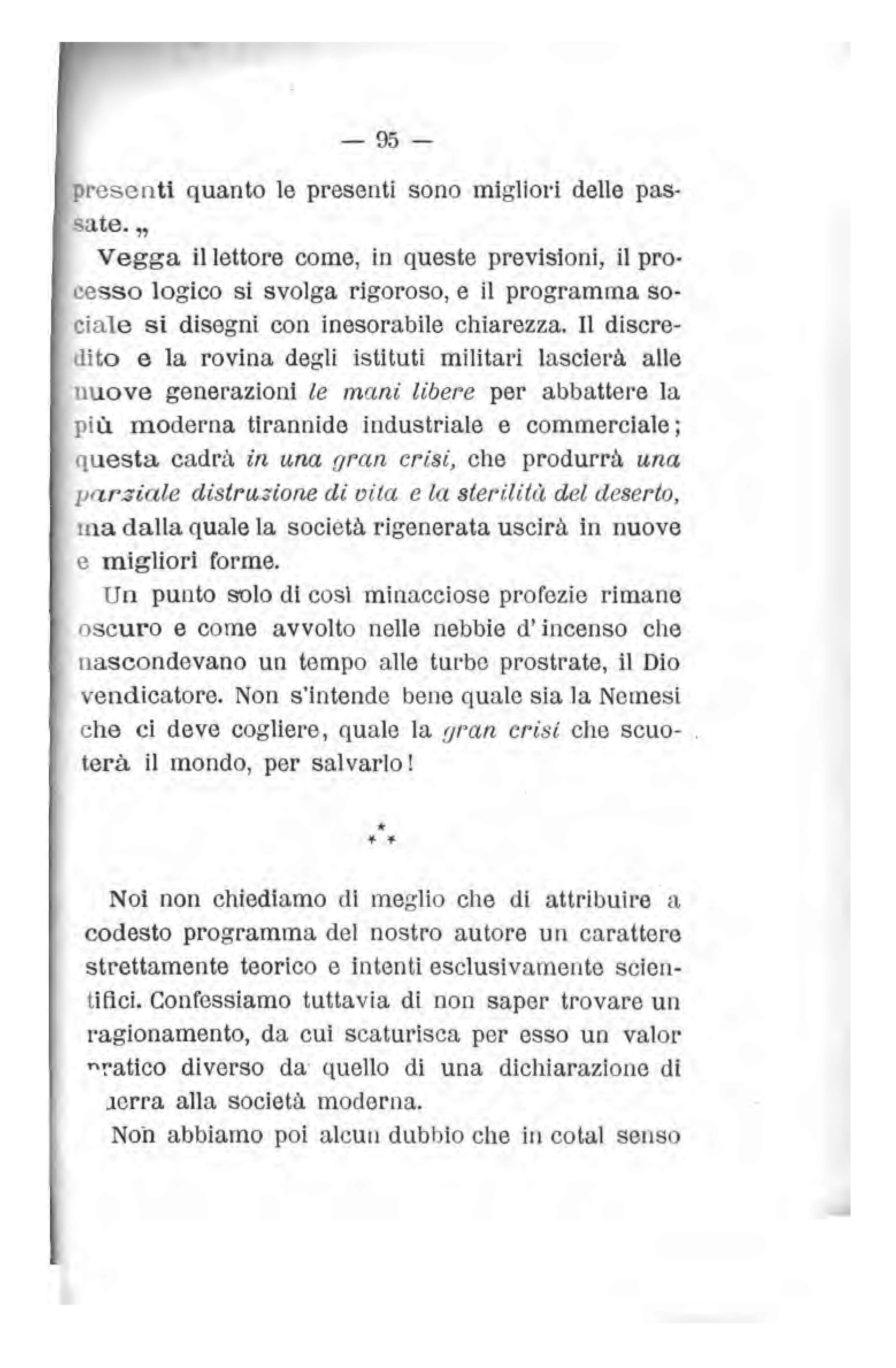
-96non sia stato inteso dalle assemblee, composte in gran parte di elemen ti popolari, funanzi a cui egli ebbe a svolgerlo. Negli applausi che lo a ·c·nlsero il Ferrera vide , rallegrandosene, il segno di una larga comunione di spirito che lo legava ai suoi uditori. Ma come potè egli mai illudersi che la lor grande maggioranza fosse in grado di cogliere le sfumature di pensiero che separano i prooostici de siosi di un sociologo dai p!'opositi concreti di un tri· bunof Nè solo gll ardori popolari a vrebbero dovuto parlo In sospetto. Non s 'accorse egli, l'egregio conferenziere, che i suoi plu caldi lod ato ri erano appunto gli uomini pri ncipali di quei partiti che non nascondevano allora, e meno nascosero poi, il disegno di rovesciare l'ordine di cose esistente; di rovesciar!o, diciamo, no n già mediante una lenta e pla· cida evoluzione, sl bene con l'aperta violenza 1
Un non dissimile e quivoco, e non meno funesto, si verifica da tempo nell'opera delle propagande per la pace. Cuori generosi ed eletti in gegni vi si dedicano, sedotti da una speranza nobilissima, cui nessuno può desiderare di veder frustl'ata. Ma anche vi si adoprano, con non minore zelo, i più irosi e i più grossolani rappresentanti dell'idea rivoluzionaria, pei quali .tutto il succo di quell'opera si riduce all'opportunità di spargere a torrenli il dispt·ezzo sovra le istituzioni militari.
L'effetto di tali equivoci è sempre il medesime . Le audaci teoriche sociali, che i loro banditori .

-97 -
sicurano di voler m antenere nella serena regio ne del pensie1·o, scendono invece e si propagano fra le masse incapaci di tropp o sottili distinzioni, ln germi di odio e in p ropositi di veJJdelta. Nelle iu-. fauste giornate di m aggio, narra il capitano Ranzi, le più at1·oci ingiurie rivolte all'esercito nel gergo dei trivii, presentavano (salv o l ' ignobile degenerazione della forma) '' una d olo!'osa analogia an quelle stesse affermaz ioni di indole scienl(flca che avevano riscosso il plauso d al publJlico eletto n elle geniali conferenze,.
Lungi dal nostro pensiero, come da quello del Ranzi , che una simil e relazio ne potesse esser· preveduta e tanto meno desiderata dal gioviue conferenziere. Ma chi parla al pop olo un linguaggio che sia pericoloso frainte ndere, deve usar di una gelosa prudenza, o non può sottrarsi in tutto alla respou· sabilità dell'essere stato frai nteso, allegando il carattere scientifico delle propri e parole. Colui che mesce un villa troppo ardente a persona cui sa incapace di sopportarlo, può egli scagi onarsi delle foiUe derivate dall'ebbrezza, protestand o che il vlno era ge neroso e puro' .. .. .
Noi dicemmo più volte ·che il presente studio, più ad una metodica confutazione del .Nlilitari m a, nirava ad offt'irci l'opportun it à di afTel'ffi!H'e i G. S. Es er r.ito c M i/ ilal·is mo.

stri opposti principii. Ora, alle franche e recise conclusioni del libro, opporremo, con pari franchezza, le nostre. Ed anzi tutto ci sia concessa una considerazione d'ordine generale, che varrà a fermare il nostro punto di veduta.
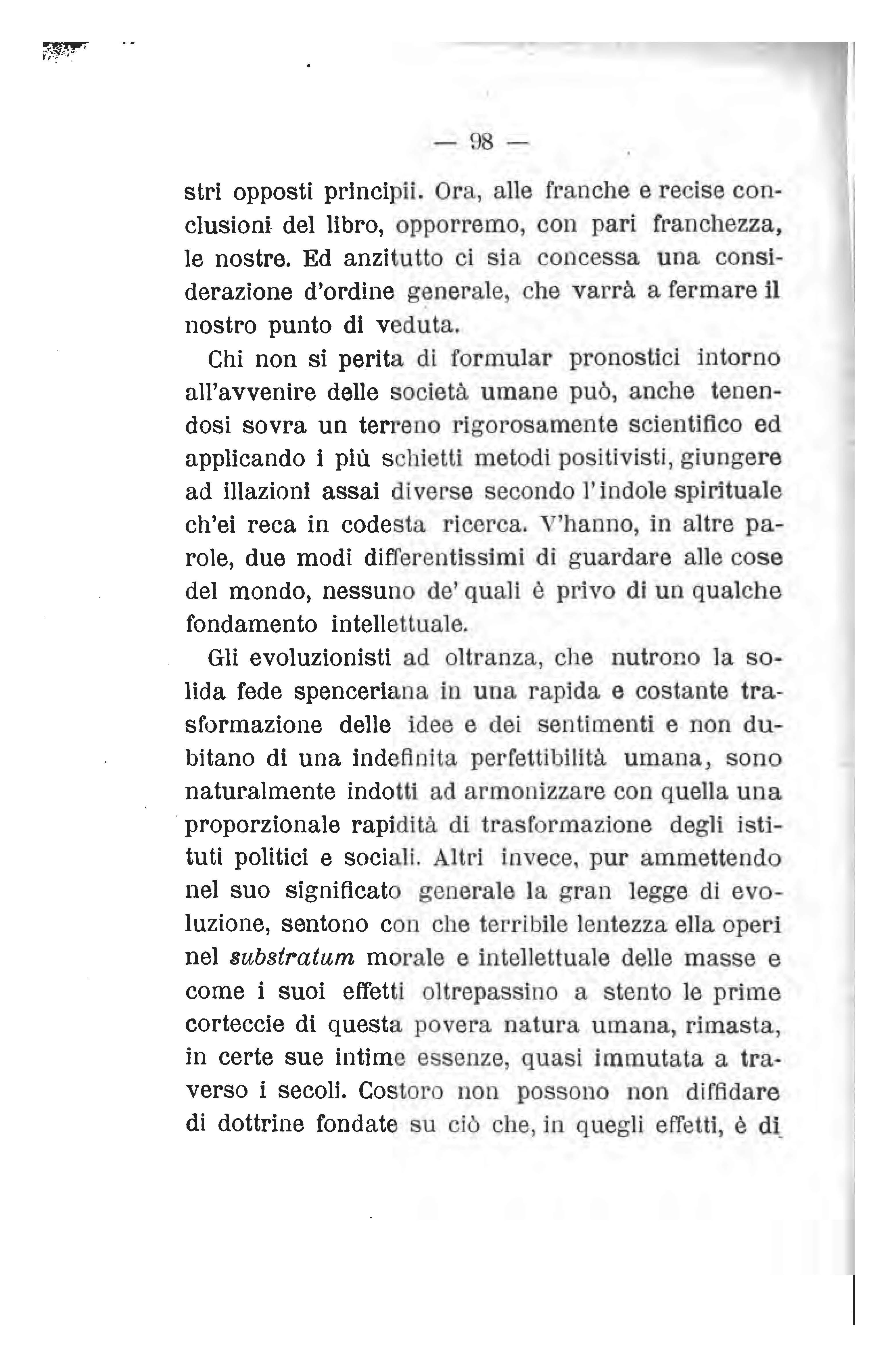
Chi non si perita di formular pronostici intorno all'avvenire delle società umane può, anche tenendosi sovra un terreno rigorosamente scientifico ed applicando i più s chietti metodi positivisti, giungere ad illazioni assai diver·se secondo l'indole spirituale ch'el reca in codesta r icerca. V'hanno, in altre parole, due modi di fferentissimi di guardare alle cose del mondo, nessu no de' quali é privo di un qualche fondamento intell ettuale.
Gli evoluzionisti ad oltranza, che nutrono la solida fede spenceriana in una rapida e costante trasformazione delle idee e dei sentimenti e non dubitano di una indefinita perCettibilità umana, sono naturalmente indo tti ad armonizzare con quella una proporzionale rapi dità di tr·asformazione degli istituti politici e soci ali. Altr·i invece, pur ammettendo nel suo significato generale la gran legge di evoluzione, sentono con elle terribile lentezza ella operi nel substratum m orale e intellettuale delle masse e come i suoi effet ti oltrepassino a stento le prime corteccia di questa povera natura umana, rimasta, in certe sue intim e essenze, quasi immutata a traverso i secoli. Costoro non possono non diffidare di dottrine fondate su ciò che, in quegli effetti, è di.
più apparente e di più ,superficiale; non possono non consider·ar·e c0 me dannose utopie le affrettale e temerarie soluzioni dei problemi sociali che da cos1 fatte dottl·ine s i vogliono trarre.
Fra questi dubbiosi siam noi. Il Ferrera nutre invece quella robusta fede. Ma egli a mmette pure che, nel segreto dell'anima umana, la innata ferocia sonnecchia ancor oggi latente, come la dinamite dorme, con le sue orrende potenzi alità , nei magazzini ov'é riposta. E però egli non dovrebbe stupirsi che noi ci dogliamo di vederlo spargere, con l'ornata parola, nell'atmosfer·a sociale le faville che possono produrre miserandi scoppii. * ""
Noi fidiamo dunque nel progre sso umano, pur credendo che la li nea ideale che esso segue ia lun g l dallo svolgersi con moto diretto e sempre ascendeute. Noi no n vogliamo rip udiat·e, almeno teoricamente, la sp eranza che un giorno Vbnga nel quale la guerra fr a i popoli civili sarà una cosa morta e H seme della giustizia a vr·à germogliato cosi rigoglioso ne lle società uma ne da distruggere nel loro seno ogni germe di r aucori e di violenze.
Ma finché quel giorno non spunU, e la salvezza e la dignità delle nazioni continu ino ad esser ri-

-100poste i n un pacato eppur sicuro sentimento delle loro fo rze; finché esse abbiano a difendersi da ire cieche, che ribollono nell'intimo loro per mioaccia l'le di r·ovina; noi guarderemo alle istituzioni mi· Jitari come a presid io della patria e della civiltà. quanto il nostro egregio avversario e assai più di molti declamatori settarii, il rinnovamen to mor·ale e la redenzione economica del paese. la da vanti alla minaccia di quella gran crisi che i profe ti annunciano vicina, senza che alcuno di essi, e nemmeno il nostro autore, osi dir chia r o in che cosa. abbia a consistere, pare a noi che H consegnare la società disarmata ai suoi nemici affine di r•ifor marla a lutto agio, che il lasciarla tranquillamente uccidere per imp r·endere la sua guarigione, sian propositi degni del leggendario signore de la P ali ce; o piuttosto (poiché l'argomento non consente face zie) sembra a noi che sareiJbero colpa e follia supreme.
Noi p rotestiamo poi con tutte le foeze dell'an imo contro il tl'iste artificio di chi invoca, ai danni delle istit uzioni militari, la vi ltà della nostra stirpe e l'insan abile impotenza delle nostre armi; né sappiamo inte nde re come si possa , a cuor leggero, disonot·are cosi q uella propaganda della pace che dovrebbe ispirarsi ai più aHi orrrogU umani.
1 oi proclamiamo infine a voce alta e con un con· vjnci mento sicur'o e profondo, la fede e l'affetto che legano la nazione al suo esercito. Non siamo en-

101-
trati in ques ta lizza se non cop la speranza di at tenuare in qualche parte, e secondo er a conced uto alle nostre misere forze, l'impressione dolorosa pr·odotta nelle s ue file dalle accuse del Mil itarismo; e sopratutto dalle ingiurie volgari che ogni giorno spar·gono a piene mani sovra di esso i nemici della patria. Non vogliamo a nessun patto che il silenzio serbato dina nzi a tali ingiurie dalla in erzia e dall a timidezza dei più, fuorvii n giudizio dell 'esercito intorno ai sentimenti della grandissima maggioran za degli italiani.
.. .
Ai giovani specialmente ci indirizziam o per ques ta opera onesta e gentile del confortare , con la coscienza dell' affetto e della estimazion e del paese, coloro clte si consacrano alla sua dife sa. Noi preghiamo la balda gioventù che, in tanto novo fiorire di associazio ni monarchiche, si adopera a promuovere il culto dell'idea nazionale e l'affetto alla gl oriosa dinasti a liberatrice, noi la preghiamo di accettare anche la nova battaglia in pro degli ordiui militari , che sono con quelle difesa suprema della unità e de lla libertà.
Combatta essa a viso aperto e respi ng a sdegnosamente il pregiudizio che ostenta di vedere nel disprezzo delle istituzioni monarchiche un segno di G. S. E8Prcito e Militm'islno .

-102superiorità intellettuale o morale; quasi non fosse invece una miseria latina questo eterno prevalere delle questioni di forma sovra quelle di sostanza; e questo eterno illudersi, che il mutare la prima valga, per sè stesso, a trasformare beneficamente la seconda. E quasi che le istituzioni che han saputo riunire, dopo secoli di schiavitù, le membra sparse della nazione non siano in grado di guidarla a qualsiasi alta meta di progresso e di civiltà, se gli ita- . liani se ne faccian degni per intelletto e per animo. Anco combattano i giovani quelPaltro più bieco pre-· giudizio, o piuttosto quell'incredibile pervertimento dello spirito, pel quale v'ha ehi considera siccome una eccitazione degna di quasi berievola pietà il fa., uatismo anarchico disposto ad immolare a centinaia le vittime innocenti; e insieme guarda dall' altò di non so che alterezza morale il soldato che compie il dover suo difendendo la società minacciata.
Ai giovani abbiam rivolto il nostr·o pensiero principiando questo studio, ad essi lo rivolgiamo al rno· mento di deporre la penna. Siano essi la forza, la tutela, la salvezza dell'avvenire. Noi auguriamo e speriamo che altre prove siano risparmiate all'Italia, che le nuove generazioni sian lasciate, cosi come il Ferrera chiede, ad attendere alle opere della pace e della civiltà. Ma se il giorno della prova dovesse sorgere, noi non invidieremo al sociologo piemontese quei suoi giovani risoluti a negar il braccio alla patria. Noi ci affideremo alla gioventù ben

ltrimenti num erosa che offrirà, ne siamo certi, il uo sangue con lo stesso ardore col quale lo offrirn no i suoi pa dri.

"*"
fa un altro ,servigio, di orJine intellettuale, noi ttendiamo dalle novisslme· generazioni. Il mondo el pensiero é oggi in preda al furore delle formale, a gli orgogli dell a speculazione soggettiva, alle intranigenze di uu'a nalisi fatta schiava di concetti già determinati: procedimenti tr·oppo rigidi e angolosi perché possan o a dattarsi alle infinite sinuosità del vero, perché la nozion e della storia e quella della vita reale u n abbiano ad uscirne sformate.
Sul cammino doloroso dell'umanità si levano oggi da ogni parte i vapori dottrinari, si addensano le geliùe nebbie dell a. negazione, nascondendo ai suoi occhi le antiche fonti del sentimento, ove soleva trovare refrigerio e conforto. Oude ella le cerca invano dintorno a sé, q uasi paurosa di aver smarrita la via e guarda, non s enza terrore, ai fantasmi che vau sorge ndo senza p sa dalle nebbie maligue e si agitano minacciosi sull' ol'izzonte buio di tempeste.
Venga duuque, noi lo invochiamo, dalle anime gioVl:lrJili un soffio buono di sincerità, di semplicità e d e spazzi le nebbie e metta in fuga i f< .tasmi; e fa ccia sl che tornino a risplendere le
verità umili e fondamentali, che l'orgoglio dottrinario presume di aver oscurate per sempre.

Tra le quali, non ultime queste: che non si elevano, nè si afforzano i cuori col persuadere loro la propria viltà; che non è coi rancori che si affretta il regno della giustizia; che non è sognando catastrofi che si redime .la miseria umana.
FINE.INDIOl'J.
I.
Le co nferenze di G. Ferrero e il capitano F. Rnnzi. n n ostro peccato. L'esercito durante l a crisi del .!\[aggio.- La guerra alle istituzioni militari e al sen timento patriottico pag . l
II.
H. Ferraro. La sua tesi. L1 giustizia tlella s tori fl. - R oma .
III.
Napol eone. Francia e Italia. Turchia e udan. Con quiste civili della guerra. -Impulsi gue•·•·escbi.Le vittime dell'ideale. - Spirito militare. - Fanto pau rosi
IV.
L 'eq ui voco nel Militarismo. - L'aristocraz ia militare.Ol'igine della cortesia. Tipi italiani d imen ticati. Il r isorgimento italiano. G. Ferrere e l'e ercito.
30 Adna. . 51
Y. , azi on i di sangue germanico. La Germania non è stato militarista. La guerra ispano-am ericana. La gue rra nell'avvenire. Lo Czar pietoso . 72

VI.
L'esercito e la sicurezza interna dello Stato. Le r epressioni. Riassumiamo le nostre idee. Le concl u sioni del Ferrero e le nostre. -Ai giovani -Le verità nm ìli e fondamentali 6

·,
PREZZO DEL PRESENTE VOLUME: Una Lira. Ultime Pubblicn:ziÒni.
Annuario Scientifico' ecl I11dustriale (Anno XXXIV), diretto dal dottor ARNOLDO UsiGLI. Un vol. tn-16 di 590 pag. con 71 incis. 6 B&ooelli (Alfredo).. Iride umana, pqesie. Vol. formato bijou. 3B&rrili (A. G.). Con Garibaldi alle Porte eli Roma (}lentana). Un volume formato bijou 4 Sm·risi di Gioventù. Un volume formato bijou . . . 3 Bulwer (Edoardo). La' razza futura, romanzo. [B. A.] . . 1Cordella. Nel regno delle Chimef'e, novelle fantastiche con fregi di E. G. Chit»'ino. 3 Vita intima, bozzetti. [B. A.] . . lDe Amicis (Edmondo) La Vita Militare. 44.& impressione dell'edizione definitiva del Hl80. 4 La Carrozza di tutti [escirà il 10 novembre). . 4 -• ·
D'Annunzio (Gabl'iole). La Città Morta, tragedia . 4 Sogna d'un Tramonto d'Autunno, poema tragico. 2 Edizione speciale in-g, in carta di lusso. L. 5.
Il Piaeere, rolll1lnzo. 10.a edizione. . · . . · . . . . . 5 Dell& Quero!& (Gian). Il"'Risveglia, romanzo. . . . . 3 50 De Boberto (Federico). Una pagina della storia dell'Amore. 2Giacomo I;eoparài •. 3Ferrèro (Guglielmo). Il Militarisma, dieci confei·enze. 3.& ed. 4
L'E-ttropa Giovane, studi e viaggi nei Paesi del Nord. 6.a ed. 4 H&uptm&nn {G.). I Tessitori, dramma l Ibsen (Enrico). Il costrutto1·e Somess, dramma .. . . lHedda Gabler, dramma l
La fattoria Rosmer, dramma. . . . . . . . . . . l
Merlino (Saverio). Pro e contt·o il Socialismo, esposizione critica dei principii e dei sistemi socialisti. 3.& edizione. . . 3 50 ...-
L'utopia collettivista o la crisi del sociali8mo scientifico . lMosso (Angelo). F·isiologia dell' Uomo sulle Alpi. 2.a edizione · aumentata di tre capitoli inediti e di 19 n uove edizioni. Un vo-· lume di 490 pagine in-8, con 59 incisioni e 48 tracciati. 8 La Riforma dell'Educazione, pensiet•i ed appunti 9 Orvieto (Angiolo ). ·Poesie (La sposa mist,ica. Il velo di Maya). Formato bijou . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Plaooi (Cario). Mondo mondano, novelle e bozzetti [B. A.). l -' Pr&teai (Mario). Le perfidi e del Caso, romanzo. . . . . 3 50 . Bontinl (Augusto). B1tbbole e Panzane, novelle per i ragazzi, illustt·ate da 20 disegni di Alessandro Rontini. ln-8 di 300 pagine in carta !li lusso con coperta in cromolitografia. . . . 4
S&lg&ri (Emilio). La Città dell'Oro, romanzo fantastico, illustrato da A. Bonamore o G. De Bini. ln-8 di 368 pag. e 41 incis. 5Trebl& (I.). Volontm·io anno.- Sottotente di complemento, impressioni e ricordi. . . . . . .
.
. a Zola (Emilio). Le sue lettere ed Articol-i e il stw p1·ocesso per l'affare Dreyfus. Dull vol. di complessive 740 pagine con 21 l'Ìtratti di Zola, di Dreyfus, d•Jgli avvocati. dei generali e dei testimoni principali ; nonchè i fac-simili dei borderò e delle scritture· di Dreyfus o di Esterhazy. [B. A.J . . . .

. 2 -
Dirigere commissioni c vaglia ai Fratelli Treves, editori, in Milan!'.
