

UlmRIVInA miLITARE
Direttore re s p o n sab il e : Giovanni Cerbo
© 1995
Proprietà let1eraria artistica e scie ntifica riseNata

F oto lito S tu d io Lod o li S ud Stampa S til gr a fica s r.L - Roma
Pubblica z ione c urata da: Adri an o Sch.eggi e Fran co A s tuto
LE TRASMISSIONI DELL'ESERCITO NEL TEMPO


Hann o co lla borato:
I G enerali : Ernesto BASILE
Salvatore l3IAZZO
Luigi CAM PAGNA
Vinc e nz o CAVALIERE
l:' ranc esco CREMONA
Re n ato D ' ASCIA
Corne lio D'AVE N IO
Roberto DI CAPUA
Luigi G IOVE1 ALI
Carlo
Bruno SIME00TE
Pi erino SO PRANZETII
Armando SPO RTELLI
I C olonnelli: Lu igi D'AMATO
Antonio LEO CI
Adriano SC H EGGI
I T enenti C olonnelli: Franco ASTU TO
Ga eta no LA VACCA RA
Cbe si sono avvalsi cmcbe del mate riale cortesemente messo a disposizione dal professorFran co SORESINJ

Le "VICEND E VI SSUTE " sono un gentile contrib uto de i:
Generali: Gius eppe CALAMA N I
Guid o MARTINELLI
Manlio O RLANDINI



)opera
Lche bo il piacere di presentare, p1 ·endendo il v ia dal fontemo mo ndo !!)'eco e sno da ndosi lu ngo sec oli d i storia .fìno ai nostri giorni, euiden zia con d ovizia di particolari L'i mportanza del ((comunic are a dis tanza".

Questa esige nza, sempr e senti /a con.fòrza an ch e nel m on do militam, ha /rovato, nel tempo, risposte adeguate nell'euoluzione scientifica e tecnologica . Ta le sviluppo, unitamente alle dottrin ali sull'impiego delle .forze de ri vate a nch e da ll 'in cessan te evolversi d elle situ a z ioni di 1?/èrùnento, ha comportato la c ontinu a ric erca d i strutture organizz a tiv e e procedur e sempre piiJ .flessibili e funzi ona li.
In pa1-tico lare, la stessa cos f1'1uzion e dei Reparti delle Trasmissioni, nali dalle Uni tà del ·'Genio Collegamenti" agli inizi degli anni 50, è conseguita dalla cowzp lessità di gestione delle nuove apparecchiature introdotte e da ll 'applic a zione d e i nuovi p roc edi m enti che h anno imposto l 'impiego di sernpre phì specializzato ed espert o.
È i n q u es ta continua euo lu z icme on;linati ua dun q ue, cd/ etto an che d el progresso tecnologico scan dito da ril11''ti semp1-e più in ca lza nti, che si inserisco11 o due quesitifondctnwntali: quali sono le sfide del futuro? Carne potranno e ssere fronteggiate?
Nessuno può dire con certezza dove e come l'Esercito sarà chiamato ad operare. Com u11que, in qua lsiasi scenario in cui saremo cbiaJnati ad inteTve nire, ce rto non si p ot7'Ù far e a me no di mo d erni ed ejjkaci mezzi di tras1nissione.
Questo p erché solo efjì cienti sist emi di comunicazio ,ne riescon o a gm'anti n ? il felic e esito di q ualsiasi gen ere di attività, a pTes cin d ere da l grado di pericolo che essa pu ò nascondere.
Tu tti qu esti asp etti pec uliari son o stttt'i magistm lmen te messi in luce neL piacevo le vo lum e cu rato dal Gen. CAMPAGNA , nel q uale, p eraltro, si evidenzia la n ecessità di integrare tutti i sottosistemi dell 'architettura C31 in u n a r e t e di risorse inte rconnesse .fra i01·o, ancor più in nwdo retico la r e e 11'Wno in maniera gera r chica, a l fi n e di p enn ette -
re a tutte le compo nenti dello strumento operativ o di agire in modo decentrato ed in au tonomia inform ativa.
!l volume presenta inoltre un ricco insieme di spunti quali l 'ordinamento delle Unità , l 'addestramento del personale, la logistica dei nuovi materiali. Idee cbe do vranno essere u lten:ormen te approfo ndite p er divenire presupposti da porre alla base degli studi riguardanti una migliore organizzazione delle risorse uman e e materiali della Forza Armata, n ella fondamentale e strategica area delle Comunicazioni, dell 'Intelligence e del Comando e Controllo.

Se/tori in cui le Trasmissioni svolgono e ancor più svolgeranno nel futum un ruolo di prim issimo piano .
TL C.A..P O DI SM DEL L' ESER CITO
G ene ra le Bonifaz io I NC ISA di CAMERAN A


LJ esigenza dall ' uo mo di "comuni care a è antica q u anto la sua presenza sulla Terra , specie a pctrti1'e dalla nascita delle conu milà. In campo rnilitare, tale esige nza è stata a vve rtit a con sempre m,aggio re intensità nel tempo, cou particolare rfferimenlo ai mo111enti critici, alle guerra, allo rquando la disponibilità di mezzi e di appropriate modalità per '·telecomunicare·· era necessaria per esercitare il Comando e Controllo· · delle unità operative.
La storia delle telecomunicazioni si intreccia intima·mente con quella dell'umanità, fino a diveni rn e elem ento jo1temente condizion ante in questo secolo, il XX dell 'e ra cristian a.
Restringendo il carnp o, ma volendo tu/./. avia tm "fegge7'1da e storia " per rintra cc ia re i prodrom i della nostra Anna delle T7'asmissioni di cu i mi onoro di essere IJ::.petlore Generale, è in sorto il desiderio di dare vi ta a un libro che, ripercorrendo le tappe dell ' evoluzione delle Trasmissioni nell 'ambito deiiEsercilo Ttaliano. ne evidenziasse la multifonni e preziose attività esplicate nell 'interesse del Paese, in pace e in guerra.
Tl libro vuole essere innanzitutto, un tri bu to d 'on ore a coloro che ci hanno jJ1'ecedut o e ch e si sono prodigati, duran te i vari conflitti, spasso .fino all'estremo sac1·[j ìcio.

Vu ole altresìj(Jrn ire ai giovani che hanno avuto o avranno l'onore di indossare le fimnm e azzu rre hordate cremisi, un motivo di orgoglio ed uno stimolo a ben operam, traendo ispirazione da un passato contradd istinto da un 'attività intensa e meritoria , quale emerge dalla lettura del Lib1'0 stesso.
Vuole r(flettere l'impegno dei protagonisti di ogf?i, che iu un contesto di sviluppo tecnologico senza sosta, p rovvedono ad adeguare l 'Arma delle Trasmissioni alle crescenti e sempre pit.ì co mplesse esigenze dell 'lisercito, in ambito sia nazionale sia interna zionale
In sintesi illt:bro si qjfre come punto di rifèri1n ento per tutti i Tra..r:;rn ettitori, g iovani e meno giovani, in seruizio e in co11gedo, fo r nendo a cia..'>CW'lO la possibilità di riuisitare il passato, aggiornarsi sulle problematiche e gli i mpegni di oggi, dare uno sguardo alle prospettive per ilfttluro.
Non è stato facile definirne il taglio, fissarne il contenuto, sceglierne il tito lo: armonizzare u n Lavoro a più mani. Alcune precisazioni si impongo·no, pertanto, anche per agevo larne la lettum.
È stata lascia ta amp ia libertà agli Autori dei vari capitoli sulla impostaz ione da da r e al proj)1' ÌO elaborato, n ella conv inz ione che l'adoz ione di t"igi -
di criteri com uni a vrebbe appiatt ito il testo, 1·ende ndolo di u nifòrme e di lettu ra monotona.
Si è reso purtroppo necessario, per ·ragioni di spazio e per salvagumdare l 'equilibrio tra i vari argomenti, apportare in alcuni casi dei tagli, talvolta anche consistenti, agli elaborati jò1•niti. Me ne scuso con gli interessati ma voglio, ne l contempo, rass icurare il lettore: là unitamente ai numerosi riferimen ti inseriti, gli permetteranno di risalire agevolmente alle fonti , per eventuali approfondimenti o per maggiori dettagli

Sul contesto storico ci si è limital.i a qualche b-eve cenno di inquad?·ame nto. Maggiore spa:zio è stato ris ervato invece a quegli elemen ti ch e concorron o a configura r e, per il periodo considerato, le esigenze da soddisjcwe: scenmio operativo, tipo e caratteristiche del conjlitto, dottrin e di impiego in vigore, tecnologia
Q uest 'ultima è stata ten uta in opportuna considerazion e, nella consapevolezza che essa costituisce l 'ossaturut portant e nella evoluzione dei mezzi. Considerato però l'og_rtetto del libro, si è cercato di contenerne La trattazione, dando maggiore spazio alle componenti ordinativa e d 'impiego ed ai materiali utilizzati.
Una considerazio ne p articolare merita il tit o lo dellihro Ess o compo rterebbe, a rig ore, una trattazione a partire dal 1861: è da questa data infatti che, con la proclamazione del Regno d 'Italia, ha senso parlare di Esercito !Latiano. Si è invece ritenuto opportun o ampliare il quad ro includen do le pdme due gu erre di indipendenza, qu e Lle del 1848 e del 1859, in quanto determinanti ai fini della costitu z ione del Regno d 'Italia, e per stabilire un elemento di continuità tra l 'Esercito italiano e l 'Esercito Sardo -Piemontese che può esserne conside rat o l 'antesignano.
Occorre qu i prec isare che neL perio do a ntecedente 1' 11 Giugno 1859 le co municazion i militari furono garantite da personale civile, al quale va il merito di averle realizzate e gestite. Sotto tale data un decreto prescrisse che il personale indossasse l 'untforrne e gli attribuì i fregi ed i distintivi deLLa specialità telegraji:sti
Per completezza di trattazione, il tutto è stato preceduto, nei due capitoli iniziali, da un rapido sguardo a/Le "comunicazioni " deg li eserciti dell'antichità, del periodo Greco e Romano e del Nfedioevofino al Ris orgimento.
Non sarà sfuggito al lettore il tennine, appena usato, di "comun icazioni "
Ne noterà, attraverso la lettura del testo, ta evo luzion e in "collegamen ti" prima e, a partire dal 1953, in "tn,tsmissioni". E ' un'evoluzione termin o/agi
ca che sottolin ea inizialmente la fun zione comunicatiua, per allinearsi poi sutta evoluzio ne ordinativa che vede apparire in su ccessione il '·Ge nio collegamenti" e, infine, L' "Arma delle Trasmiss ioni ".
Va da sé, ma è bene ribadir/o, che le "Trasmissioni dell'Eserc ito·· includono anche quelLe dei Carabi nieri, i cui Reparti Mobili, in particolare, hanno sempre operat o fianco a fi anco con i Reparti delle altre Armi, da lla gloriosa carica di Pastrengo di ie1'i, alle 1nissioni uman ita?'ie di oggi Esig enze di interoperabilità inducono ad equipaggiare tali reparti essenzialmente con gli stess i materiali in dotazione aLl'Esercito di campag na.
Una precisazione .fìnale su ll ' 'Istituto Storico e di cu.Ltura dell'Arma del Gen io " Per r(flettere la situazio ne attu a te, che vede t 'A rrn a delle Trasmissioni in essere sin dal lontano 1953, l'istitut o è stato rilitolato, nel Libro, "'stituto Storico e di Cultura deLl'Anna del Genio e delle Trasmissioni': pur non essendo intervenuto ancora a lcun provvedimentofo·rma le in tal senso .

Cbiudo con un sentito 1 ' ingraziam en to agli Autori dei vari C'apitoli e delle Appendici e msto lo ro riconoscent e per la proficua collaho?'azione fornita e per l'ottimo lavoro svolto.
L'ISPErfORE D ELLE TRASMISSIONI Ge n .C.A. Luigi CAMPAGNA
Ro ma , 30 settem bre 199 4
PARTE PRIMA




Stampa d 'epoca - Suonatom di conchiglia

Comunicare sig nifica condi v id e re conosc e nza , informazi one ed espe ri e nza: è , p e rtanto , una d e lle es igenze fond ame ntali dell'uomo.
Nella pre istor ia, come quals ias i a ltro compon e nte del mondo animale, l' uomo utilizzava i più semp lici mezzi di comunicazione , "i segn ali acustici e v isivi" , per trasmettere ai suoi simili gli elementi ess enz iali di conoscenza n ecessa ri per la sopravvivenza.
Succ ess ivamente l'uomo, evo lvendo, divenne qu alcos a di irrip et ibile in natura , riuscen do per com un icare ad el a b o rare codici comp less i quali il lin guagg io e la sc rittura
Con riferime nto a ll' evol uzi one de l linguaggi o e della scrit t ura, fortem en te con dizionata dai limi ti dei sensi uman i , si p uò afferma re che la sto ri a dello s v iluppo dei mezzi d i comunicazio n e al tro non è che la continua ga ra per su perare i limiti della v oce e dell'ud ito e quelli dell a port ata ottica di una seg nalazione ges tua le. Rip onandoc i ai primord i nelle attività eli gue rra dell ' uom o, n o n è dunque difficil e imm ag inarlo adop e ra re il suono prod otto dalla percussion e de l tronco cavo di un a lbe ro per invia re, a distanze s up er io ri a quell e cope rte dalla voce, un suo segna le oppure utilizzare i prim itivi st rumenti a fiato, qua li con chiglie o corna di animali, per la generazione di s u oni d i intensità e potenza maggio re d e lla sua voce.
Si n dagli a lbori della storia, l' u omo comprese dunque il ruolo d e ll e comunicazion i quale e leme nto fondamenta le di conosce nza e di ass ociazione e d e lla trasmissio ne a distanz a q u ale fattore m o ltiplica tore delle s ue ca pacità e pote nz ialità, tanto da attribt1ire ad una "Entità Superiore" le più grandi capacità di comunicazio ne.
Nel mito troviamo così Mercurio, che i Greci c hiamav ano H erm es, figlio d i Giove e di Maia, co nsiderato Di o d e ll 'eloque n za, perso n ificazione del v en to ed anc he "mess aggero degli Dei". Fu sc e lto infatti d al pad re Gio ve, indulgente con lui nonostante le s ue nori po c h e malefatte , come suo am basciatore ed incaricato di molti compiti piuttosto ardui c h e eg li seppe bri ll a ntem ente as so lve re con la ra pid ità del vento e l'astuzia d e ll a vo lpe. Ad un cen no di Giove si muoveva rapido n ello spaz io con l'a usili o d e ll e a li ch e o rnavano i s u oi aurei "ta lari". Appa riva all'improvviso a D ei ed uomi ni porta n do mess aggi ed ordini. Aveva una memoria ferrea , il fa sc in o della co n vin z ione, il dono dell ' e loq uenza ed il m ie l e amaro d e ll'astuzia . . Iess uno meglio di lu i poteva imperso nare il ruolo di un perfetto "po rtatore di m essaggi"! L'Eserci to Brita nnico lo ha ado ttato infa tti come simbolo pe r i s uoi trasmett ito ri , che ne o rn a no il bavero d e ll ' uniforme.
Nelle Sacre Sc ritture appare la figura dell 'An ge lo. Il nome deriva d a l greco "a nghelos" che significa mes sa ggero. È un essere sovrumano c he opera come intermediario tra Dio e gli u omini.
Mostrina dei Tt-asmeuitori dell 'Ese rcito ingles e rapprese ntant e Mercurio.
Nella Bibbi a l'Angelo è u n "Messaggero di Di o" ed u n esecutore de i s u o i ordini. Si mostra a singo li uomini opp ure a m o ltit udin i, per lo più con sembianze umane per non ess ere subito ri co nosci uto come essere superiore. Ne ll'Esodo è
descritta una sua apparlZlone, in forma d i fia mm a di fuoco, p er mettere Mosè in co nta t to con Dio (3,2) ed a nco r a un suo inte rv e nt o per,prot egge re il pop o lo d ' Israele che s i a pprestava acl attra versare il mar 1\osso (14, 19}
l passi più celebri e n mi dei Vangeli che descrivono l'Annuncia z ione , la ascita e la Re s urrezione di Gesù, pongono ripetutan1ente in evidenza il ruolo di messaggero deg li Angeli . E ' un Angel o ad annunciare ai pastori la n ascita de l Sn lv a to re , attOrniato subi to do p o da un a mo lt it ud ine d e ll ' e serc ito ce le st e ( Lu ca 2.9 c 2,13).
Sono due Angeli, in semhianze umane e vesti sfolgora nti , ad annu n ciare alle donne che si recano al Sepolcro la Resurrezione del Salvatore (Luca 24,5) .
Ma il più illustre d ei messaggeri ce lest i è certamente l'Angelo Ga bri e le, c ui la tra diz io ne cmo li c a attrib u isce il ran go di "Arcangel o" cioè eli "capo" o "primo" angelo. Una s ua appa r izione è infatti d escri na già n e l Libro di Dani ele (9 , 20). Poi , nel Vangelo di Luca, egli annuncia a Zacca ria la nascita di Giovanni il Battista ( l ,19) ed alla Vergi n e Maria il mistero dell ' Inca rn azione (1,26).
Riscontrand o nel ru olo dell' Arcan gelo Gabriele profonda analogia con qu e llo di u n capo di co municat o ri , s i p e nsò di r ic hi e de rlo qua le ce leste patrono.
11 12 gennaio del 1951 l'Arcangelo Gabr ie le venne infatti dichia rat o , dal Pontefice Pio X l L. "Patrono delle Telecomunicazioni e dei loro addetti cd a1tefici ", e quindi anche della special ità "Collegamenti " dell 'Arma del Genio, successivamente d iven u la Arma dell e Tras m iss ioni.
Le cotnunicazioni nel m o ndo g r e co
Dalla sto ri a c da ll e legg e nde, c h e la le tterat ura d e ll 'a nt ica civilt à g reca ci h a trama n da to, possono essere tratt i molti ese mpi d e llo sforzo c h e l' u omo h a compiu to per s up erare i limiti imposti da i suoi sensi, ovvero per comunicare
Teseo , figlio di Egeo e di Etra, partendo per affrontare il Minotauro, aveva promesso che avrebbe sostituito le vele nere, che issava sul suo vascello, con vele bian c h e n el caso fosse torna to v in citore. Eg li, p e rò, di me nt icò opp ure n o n polé rnante nere la promessa fatt <l, così il vecchio padre, vede ndo rito rn a re la nave del figlio con le ve le nere e credendo che Teseo fosse perito nell'impresa, si uccise gettandosi nei flutti del mare che prese il suo nome . Tragico esempio eli quali tristi conseg uenz e possa avere una co muni cazione e rrat a !
Esempi di co m.u nica zio nc a di stan za son o ci tali da l m aggi ore poe t a greco, Ome ro (900 :1. C.) , c he riferisce de ll' impi eg o de l fu oco pe r le segnalazioni duran te la guerra di Troi<t.
Eschilo (5 2S-456 a.C. ), nella sua tragedia "Agamennone", narra del condottiero greco c he fece giun g ere a Clitemnestra la no t iz.i a della fi n e d ella g uerra conlro T ro ia e d el s u o pross im o ri e mro con l'a cce ns io n e d i fuochi seco n d o moda lit à co nvenute in prec e denza.
Il tragcdi og rafo greco dà una descrizione dettagliata del collegamento e dcll ' uhi ca zione d e lle stazioni ripetitrici posizionate sul monte Ida, sull ' iso la di Lesmo, su l monte Athos c così via da Troia fino acl Argo.
In te m pi mo de rni è stélta fatta una verifica de ll a rea le pos sib ilità di rea li zzare il co ll ega mento desc ritto nell a tragedia , ind ividua nd o "tratte" alternative a ll orq uand o la variazione dell a [Oponomastica non perm etteva l'univoca indiv idua zione dei luoghi.
Il positi vo esi to della ve rifica, pur se non consent e d i affermare che coll egamenti di qu es to ripo fossero rea li zza ti effe ttiva m ent e a ll'e poca dell a gue rra dì T ro ia (XIT Sec. a.C.) , testimo n ia com un qu e le potenzialità ragg iu nte d a ll e co mu ni cazion i
Nella pagina a fia nco: Penorso c b e Agam enno ne .fece seguire a i segnali dì ji,tOco per comunicare alla moglie Clitemnestra l 'cwuenuta presa di Troia (Xli sec. a .C.), secondo E-;cbilo ( 525456a . C.).

Vl.l<> H\ \.T'r,lrMr'- L'VSO W /'{OTIZU. .4.
I>At.L! P'f fS<•ui.Q ;2)- &ilA t.4i<S)
A\4"' A (U'<>'.N+}Tl1A (ltf1 Il •19- Il<>!<> F...-r<> <W .U.IVALI
t>l IV<><.O <0"\HA U<Eli\ J.t.
MJUV'ofltf IIWOA H l W'-WA .:S«ANOTT<-. 1
FV (!<( i'WII>Ò IL P<\11'\0 • rW$'11\.U:!Ai'V\)1\ ViT'TAtloil./t\QHft tR.n<OQ) P-« t-ttL'fSO I,Ap-1 r""'OCA L:A<<«5< (U\4 l>(t M NT<- ('\) ( IY Il
$At.VIO L'( l).t44M16f/ill.fV{PI(T'f.(
"'LI'\OHT( Wo(tfl<> td 1-<IAILfW1)19. ,. E lA V/WA •. ll f ("'.A ·
L< Al GV4Rl>14>11 (>(l '(.Ì···A(,..lff/• F<>U4 l4F""""' V W<'Mk9Rf
• Mi! ..so 101 tt 00 LA tM'X f """'' t'll'iltA W>WKI'o
<?•·93/ ' IL QllR<tA!"' L4R'•>< ("' ( jrl't(TfQ
(IOA·IOIÌ· < IW<'>M.!. lo /'Rf<J•trA AV.vtf l f IL .lt.A<14<>W
E' LA V()(1'TA PIY I>LLJ. (ltrÀ (11) ( LA "'" (
J\'\. nrr<> Ar,.J,.,, t.V<{ <riN'+-AAV4 c-.4. No<O IP.A 1'/UQ- 4i /'\
(1) ,.,,.
l'l.{tA 0441 1767

Q) l'l. tv>< I'<W$ · (V ""'····n.o)· ovor" }f.#.· M .•w.-:.,ltON. ov(lo'P' vo, ('i) W•: (Jt1'A (n f1..;)
1-V'<twi O • Olt'!'A
W ,.., (8} l.f( LlA f\\4A.l::A
(f/ f'.«.•tt.NI<TO. u.<<tTA o>(HllFI<AZOOfiC
all 'epoca di Eschilo.
Si dicevano "pyroes" i fuochi che si vedeva no di notte per il loro s plendo re e d i giorno p e r il loro fum o; "phares" le to rri su lle quali si facevano i fuochi più gra ndi; "phryctes" i segnali minori fatti con semplic i to rce .
L' impiego di seg nalaz ioni per mezzo de l fuo co ci vien e tramanda to anche da Erodoto (485-425 a.C.), il quale narra che i Greci seppero da Artemisie della cattura di una loro trireme da parte dei barb ari presso l 'isola d i Sciato , graz ie a tale ti po di se gna la zioni.

Ne l secon do libro dell e !storie di Tu cidlte (460 -396 a.C.) si legge che g li Aten iesi, durante la guen·a del Peloponneso, riuscendo a sapere dell'imminente assalto de i Peloponnesiaci al Pireo d 'Atene, grazie alle fiacco le innalzate sul promonto rio di Sa lamina dai soldati del presidio, ebbero modo d i prepararsi alla difesa.
Un antico autore eli ann otazio ni ai test i classici precis ava, n e l co rnmentar e il racco nto d ello sto rico greco , c he quei fu oc hi venivano realizzati u ti lizzando fasci d i legna facilmente combustibile che, acces i di notte , erano forieri di fa u sti eventi se tenuti fermi ed annun ciava n o invece disgrazie se venivano agitati.
Le staffette a piedi o i porta tori di o rd ini sul campo di battaglia so no istiluz io ni di tutti i temp i, an che moderni , ma le prim e notizie sull'impie go di tali "sis temi di comu nicazioni " s i hanno già con gli Assiri e gli Egizian i. Il più noto episo dio d i trasmissione di notiz ie mediante staffetta c he la stor ia ci tramanda , è certame n te quello c he si verificò nella battaglia di Marato na (490 a.C.), dove i Grec i difes ero la loro lib ertà co ntro le p re ponderanti forze persiane La battaglia avve nne nel co rso dell a seco nda sp ediz io ne persi ana con tro la G recia e vide
A sinistra: Conw di Alessandro - Tratto da "Le Meraviglie della 'l 'ecn ica" ed FIGW EJ<.
A destra: Sistemct di segnalazione ottica di Enea il tattico (336 a.C.) da una stamp a d'e poca di ]AN DARGENT
Sistema di segnalazione di Po lihio (150 a C.) da u na stampa d'epoca dij/ IN DARG'ENT.

affron tarsi, secondo la H<l di zione, 10.000 G reci (per la m ag g io r parre ate ni esi) e più di 100.00 0 asiatic i, c h e furo n o mess i in rorta da l va lo r e dei G rec i e d el loro co ndott ie ro Mib:: ia d c Pe r comuni car e la n o ti zia a<.l Ate ne un .sold ato a ten iese, F ilippide, sup e rò, in buona p a rt e di corsa, i 42 Km circa che d iv id e vano il campo d i b a rt ag li a dalla c ittà Dopo aver dato l'a nnuncio d e lla v it to ri a, Filippide morì per lo sforzo compi ut o. Ed <:: in rico rd o di questo episodio che la corsa sulla distanza di Km. 42, 192 , pari a quella superata dall 'e roe greco, vien e chiamata " marat o n a" .
Senofonte (430-3 54 a C. cir ca) rife risce dei Mosc nici ( n ome greco che sta p e r abitanti el i to rri ), popolo el i pre d a tori che viveva s u ll e spond e d e l mar Nero , e del le loro to rr i di le gname , di s tanti lra loro cir ca u na d e cina di c hil ome tri , c h e essi usavano per seg n alare il passaggio di ca rovane da ass alire. Che l'im pie go di tale tecnica di avvistamento rappresentasse un serio prpblcma viene confermato d al fatto che Se n ofo nte s tesso crede tte opponuno farsi prece d ere, per n o n co rr e re peric o li , da un mess ag ge ro incaricato eli tr a ttare l ' attra ve rsa m e nto del te rri torio.
Ne ll ' agosto de l 405 a.C., presso h1 foc e de l fium e Egos potami, la fl ot ta aten iese ag li o rdin i di Co none venne p ressoc hé d istrurt:a da quella spanana, coma ndata d a Lisandro; a tale evento, dec isivo per la conclus io n e della guerra del Pelopon neso, è legato forse il primo esempi o di trasmiss io ne "eliografica" di una informazio n e d i s ig n ificato con ve nu ro Una n ave ve loce, invi a ta in esp lo r a zione p e r ver ifica re il comportamento d eg li Aten iesi, inna lzò s ull ' albero un o sc udo per rifl e tte r e la luce de l s o le . Vede ndo sc inti ll a re lo s c ud o a d is ta n za .sul ma re , Lisa n dro eb b e la confer-
ma che attendeva per far salpare la s u a t1otta da Lampsaco, dove era a l ri paro. G li Ateniesi, che avevano tirato in secca le navi e si erano spa rp agliati per procurarsi i mezzi di sussistenza , attacca ti di sorpresa , non ri uscirono a riorgani narsi e furono annie ntati quasi senza combattere.
F rutto di legge nda appa re , in vec e , uno dei primi ese n1pi di "attività info rmativa " de ll 'an tichità, che ci viene tramandata a proposito di Dion isio (432 -36 7 a.C.) t ir anno della citt à di Siracusa , c del luogo ave rin c hiudeva i suo i avve rsar i: l' Orecchio eli Dionisio, a ppunto.

E' questa una g rotta artificiale, lun ga 65 m e alta 23, situata a Ovest della città di Si rac usa. La grotta, pe r la sua particolare configuraz io ne a S, rico rd a il co ndotto ud itivo dell 'orecchi o umano In origin e e ra una latomìa (cav a eli pietra) e fu ad ibita a prig ione dal tiranno.
E' stata prob ab ilme nte la caratte ris tica capacità d e ll a grotta di tra s mette re a distanza la voce, graz ie a fenomeni di rifl essione, a far nascere la leggenda che essa fosse stata fatta cos truire da Dionisio per poter asco ltare le voci bisbigliate dai prigionieri ivì racch ius i ed a farla d iventa re esempi o di att ività di raccolta de lle infor mazioni sull'avve rsario nei tempi mitologici.
Merita in fin e un cen n o un'altr a legge n da ch e vede come pr otago nista Al essa ndro il Grand e (35 6-323 a.C. ) e c h e conferma, se a n cora ce n e fosse bisogno, la grande aspiraz ion e dell ' uomo a vincere le distanze co n le comunicaz ion i.
Alessan dro riccveue, da un abitante dì Sidone , la proposta di migliorare i m ezzi di corrispondenza co n osciuti ai suoi tempi. Il sido ni ano, ipotizzando la r eali zzazione di un sis t ema di comun icazio ni rapido, che cop ri sse tulli i territori sotto posti alla dominaz ion e d e l mace do n e , pr o mett e va la trasmi ss ione di noti z ie in t empi così br e vi che n on fu c reduto . Al essa ndro ri fiutò la p rop osta, ma un suo success ivo ripensamento , c onnesso a ll 'ave r co mpreso gli inc re dibili vantaggi che la c reaz ione di una siffatta rete di comu n ica zione gl i avrebb e ga ran t ito , lo indusse a far ricercare , ah imè invan o , il geniale inventore che si e r a or mai dil eguato.
Si narra, comun q u e , che la flotta di Alessa ndro il Grande, reduce d a ll a co nquista de lle Indie, fo sse guidata n e l go lfo Pers ico (32 5 a.C.) con segnala z io ni per m ez zo del fuoco La leggenda tram anda, inol t re, che il g rande cond ottiero avesse trova to il modo d i invia re messaggi a ll a sua annata , fino alla dista n za d i 20 Km , per mezzo del corno acusti co di cu i si ha raffigurazione in un'antica stampa conserva ta presso la Bi blioteca Varicana .
Enea il Tatti co, che visse ai temp i di Alessan dro il Gran de , cita in una s ua op e ra un interessa nte metodo p e r tra s mettere segnali a distanza. T a le s is tema merita d i essere d esc ritto, rappresentando un notevol e prog resso rispetto a l metodo de i semplici segnali luminos i di c ui finora si è parl ato: app lica infatti, inco n sapevolmente, il p ri ncipio de lla comuni cazione sincrona.
Il s istema, che si rit iene in ventato dai Cartaginesi e co nosci uto da Polibio, utili zza va un vaso cili ndrico di terracotta o di rame in ogn una delle stazio ni corri spondenti; i vasi aveva no le stesse d im e nsioni, conteneva no la s tessa quantità di acqua ed avev a no un fo ro d'us c ita de llo stesso diame tro , opportuname n te occl u so . Un pez zo di sughero, gall egg iante sull'acqu a , so rreggeva un ' asta ver ticale divisa in parti , s u ciascuna d e ll e q u a li erano indi ca te , con d ei s imb o li , le n ot izie che più comu nemente accadeva di dover trasmenere in guerra In ogni stazio ne c ' era una f ia cco la acc esa e uno sch e rmo in prossimi tà del vaso col mo d 'acq ua. Quando da una stazione s i voleva trasmett e re una delle noti z ie riportate s ull'asta vertical e, un addetto agit ava la fiaccol a e d a tt e ndeva che il s u o co rrispo ndente agita ss e sua vol ta la s u a Avvia to il s in c ro ni s mo del sist ema, la fiac -
cola veniva n ascos ta dietro a ll o s chermo e, c onte mpo rane amente, ve n iva d ato il v ia a ll a fuorius c ita dell 'acqu a dal vaso; la s Le ssa man o vra ve ni va ese guita n e ll a st a :d one ri cev e nte La fu oriu sc ita dell ' a cqu a provoc a va il progr ess ivo abbas samen t o de l gallegg ia nte e q uin d i dell 'asta. Q uando il segn o ind ica ti vo d e ll ' informazione d a trasmette re tr ag u ardav a l'o rl o su peri ore del vaso, il foro v e niva occlus o e la fi acco la scop erta ; uguale ope ra zio ne v eniva condot ta p ress o la staz io n e ricevente . Po iché dai vas i era fuoriu s cita acqu a per un ugu a le p e riodo eli t e mpo, sull'orl o d e l vaso d e ll a s taz ione ri ce ve nte era poss ibile ril e va re il segnale co rr is p o n d en te a ll'informa:do ne che sì vo leva c omun ica re. Torri "ri p etitr ic i", provviste so lo eli fi acc o la e sc h e r mo, e rano talvol ta frapposte alle stazioni te rmin a li, attrezzate in modo com ple to, per mi g lio rare la "p or tata " dell a seg na lazion e; il li e ve ritard o introdotto dall a sincroni zz a z ione dell e to rri "rip etitr ic i" non preg iu di cava sens ibilmente l'e s ito d e lla tra s miss io ne .
Il s is tema descri tto fu p erfezi ona to da Ele o xe ne c De m oclite, ingegn eri eli Filippo III il Mace d o ne (mo rto ne l 317 a.C ), che idearono la trasmissione, per mezzo di fuo c hi , di le ttere d e ll 'alfabeto an z iché eli frasi pres tab ilir e. Per conseguire tale o biettivo ci asc una dell e s taz ioni fa cev a uso di und ic i fuochi, eli c ui otto grandi serviva no a des ig na re un g rupp o d i tre lette r e dell'alfabeto , p rev en t ivame nte predisposto, e g li altri tre, pi ccoli, posti ad una certa d is tanza dai p r imi, indicavano il posto c he la lette ra occup ava in ciascu n grup p o E' stato questo il primo tele grafo "alfa betico" el i cui si ha noti z ia
Il siste ma sopra desc ritto fu p e rfezionato da Polibio (2 05 -120 a. C.), s tori co militare, che di vise l'a lfabeto in so li cin q ue gru ppi: p e r t ras mettere , ad ese mpio , la terza lette ra d el p rim o gruppo, il seg nalatore di u n a stazione faceva apparire una to rcia alla su a d es tra per definir e il gnt ppo eli app arte n e nza d e ll a lett er a , e tre torce a lla s ua s ini s tra per indi ca re la p osi z io n e della lette ra nel grupp o . All ' intern o d e ll a stazione v i e ra una sp ec ie di tavola pitagor ica ov e , all ' incont ro tra la pri m a colonna e la terza linea o ri zzonta le , co rr ispon deva la lett e ra de ll'al fabe to che s i voleva tras m ettere.

Ta le m e tod o e ra parti co la rme nte le nto. Pe r que s to mo ti vo p are che ven isse pre fe ri to un s is te ma mi s to, co n la tras miss ione di fras i già predis p o ste, in un a p r ima fase , e le tte re in un a sec on da. La to rre polibiana e ra dotata, a n che , eli un s is te m a d i collimazione , otten u to med iante u n lu ngo tubo d i rame c he, di re tro verso la s taz io n e corris p o nd ente, m o s trava su bito la direzion e d i quest ' u ltima.
Co rre infin e l 'o bbligo d i acc ennare, p e r il perio do esa mina to, a ll a cri ttografi a co me mezzo p e r s alvaguardare il seg reto di comu ni cazi o ni destinate a passare p e r m an i n on am ich e, ovvero p er g ara nti re la so rpresa , fatto re capita le d i vittoria in ogni co mpe tizione
Le p i ù a n t iche n o ti z ie sicure s on o que ll e s u ll a "scitala lacedemonica" che Li sandro , il gi à cita to condo tti e ro spart a n o, semb ra utili zz asse Co n s is tev a in un b asto ne su cui s i a vvolgeva a d e lica un na s tro di cuoi o ; s ul nastro s i s criveva, p e r co lonne para ll e le all 'ass e d e l bas tone , lett era per lett e ra, il testo segreto. Tolto il n ast ro dal bastone, il testo r is u ltava trasposto in m odo regola re ma sufficiente per evita re la le ttura se nza u n secon d o bas to n e u g u al e a l pr imo.
Risale al 400 a .C. il prim o tratta to sull a cifra, inclus o in u na più vas ta opera di En ea il Tatti co s u ll a dife sa d e ll e fortezze. Rife ri sce di me ssaggi seg re ti e eli a ltri mod i di nas conde rli mater ial me nte ; e vi è des critto un disc o cara tteri:t.zato d a ll a p resenza a i s u oi bordi d i 24 fori, aventi una corr is p o n denza co n le lettere dell'alfab e to, no ta sol o a l mittente e al riceven te. Un filo ve n iva avvolto a p artir e d a u n for o ce ntrale c fa tto passare , in successione , per i fori co rrispond.e nci a ll e le tte re d e l te sto Lo svo lgersi del fil o, graz ie alla co rrela zione tra le ttere e fo ri del disc o ,
permetteva di indi v iduare le lettere del messaggio trasmesso. Il testo doveva po i essere letto a rovescio.
el citato documento è pure riportato il resto di un dispaccio cifrato nel quale le voca li sono sostituite da gruppi di pun tini.

Di poco pos Le ri or i a q u este so n o le più sicure noti z ie s u ll a cifra indi a n a e s u qu e ll a e braica , ad alfa beto cifrante rego lare, spo st<ll O o rovesc iato. Le le ttere venivano spostate o rib a lt a te rispetto a ll a pa rola da trascrivere sec ondo un c odicc prestab ilito. Pare che l'uso di tali sistemi si rendesse necessario per celare nomi propri, innominabili o sacrileghi. Iella Bibbia (Geremia 25,26) si ha un esemp io di impiego di rale alfabeto cirranre regolare spostato con la sostituzione d e ll a paro la Ba/Be/L co n Sfia / SHe/K, o tte nuta traspone ndo la second a le ttera d e ll 'a lfabeto eb rai co (B) con la penu llima (SH), e la le tt e ra L co n la K.
L e comu ni cazioni n el mondo romano
l sist emi a segnali co mplessi di Po li b io di vennero d ' imp iego corrente anc he p e r i Romani . Si h a nno not iz ie s ull ' u so d i fuochi d i no Lte e d i vessilli di g ior no , q u a li co m unic az io ni d i guerra pr esso i Romani , g ià a l tempo d el l'asse dio d i Numanz ia 035 a.C.) Anche Cesare (100 - 44 a C.) e i s uoi av versari usarono segnali di f uo co durame la campagna di Ga ll ia (58-52 a.C.), ma la notizia che maggio rm eme colpisce si riferisce all"cpoca imperiale , quando l'organizzazio ne militare ro m ana riuscì a rea li zzare, mediante torri di segna lazione, la più impon e nt e re t e di comun icazio ne di tutta l'ant ic h ità. Rom a r iu sc iva a comun icare, grazi e a ques te torri, co n a ltre 1200 città e presidi d e ll a p e n iso la italia n a , co n a ltrettanti ce ntri strategici d e lla Gallia, con 300 c it tà ne ll<t peniso la iberica e co n 500 in Asia attra verso una rete il cui sv iluppo comp lessivo raggi un geva ben 60.000 Km; alcuni ruderi delle tor ri costruite allora per questa esigenza sono ancor oggi visibili a Ni mes , a Uzes, a Bellega rd e e ad Arlcs in Fntncia. Secondo il biografo Sveron io Tr an quill o (70-120 d .C. ), T iberio (4 2 a.C. -37 d.C.) riceveva a Ca pri da Roma, co n s e gn a li ril a nc iati eli faro in fa ro, noti zie prove n ie nti d alle più lo ntane reg io ni del suo im pero
La cos tituzione eli tali torri c i è traman d ata anche da ll a raffigurazi one p rese me sulla colonna Traiana.
La rorre era circondata da una palizzata per la difesa degli operatori ed era dotata di una balcon ata dalla qua le s i poteva no in viare i segnali in div e rse direz ioni a se conda delle es ige n ze
Not izie rife ri t e d <l Veg ez io, scrittore latino d i cose mi litar i vissuto Lra il IV e il V sec. d.C. , fanno rite n e re c he in ta le periodo i fuochi d e ll e torri s iano s tat i sos tituiti con a li mob ili somig li ant i a q uell e che i fratelli Chappe realizzarono, in tem pi molto più recenti , con il loro telegrafo aereo.
Trasmettere ordini c n oti zie il più rapidame nte p ossibile e, q uan do necessa rio , il più lo ntano p ossibi le, con i mezzi più se mplici, anch e qua ndo osta co li o nemici si frappongono fra "rras m it te nti " e "ri ceve n t i", è sempr e s wta un 'esigenza p r imar ia p er l'o rga nizzazion e mi li tare.
Un ese mpi o di trasmissione a mezzo di s ta ffe tte, risale a l p eriodo di Roma posto tra storia e mito e s i riferisce alla battaglia del lago Regill o (496 a.C.).
Tarquinio il Superbo, caccia to dalla cirtà, si alleò con i Latin i e mosse co ntro Roma, che aveva eletto dittatore Aul o Pos t1.1mio. Lo scontro avvenne presso il lag o Reg ill o (o dierno Pamano Secco , n e i dinto rn i d i Frascati). Vinse r o i Roma ni e la legge nda racconta c h e i mitic i D ios c uri (Casto re e Po ll u cc) portaro n o imme dia ta -
Torre di vedetta e segnalaz ione romana - simbolo delle Trasmissioni dell'Esercito L 'immagine è tratta dai bce sso rihevi d e lla Col onna Traiana O 13 d :·c: .) Rom a.
Terracotta rajfip,umn te una t on·e di segnalazione, trovata in una tomba presso Vulci (Montalto di Castro ) Il rep e rto è conse r va to presso il Museo di Villa Giulia (111 -II sec. a.C.) Ro ma.

mente a Rom a la noti zia de lla vitto r.ia , abbev e ra ndo p oi i loro cav a lli a lla fonte di Clitu rnna.
la vita di gua rnigi o n e del soldato romano appar iva regolata da schem i ri g idame nte de fini ti , s ulla ba se de i qu ali eg li sapeva co n esa tt ezz a com e e qua nd o agire. Pe r ta le scop o erano im piegati segna li a cus ti c i, o ttenu ti co n strum e nti in d ota7 io ne a ciasc una u nità: la tuba , la bucina ed il corn o
La tub a, antica prog en itrice d e ll a nostra tromba, era lo strumento eli guerra per am o nomasia , in quanto forni va il seg n ale d e ll ' a tt acco c della ritirata, richiam a va i so lda ti al turn o eli guardi a, d ava l'a vviso dell a parte n za dall'accampamento, m a era anche adoperata nel corso delle cer imonie sole nni e religiose, connesse sempre all 'es erc izio militare
O ltre alla tu ba erano usa ti la bu cina, strume nto ricu1vo des ti nato probabilment e a lle segnal az ioni notturne , ed il corn o , peral tro già u sato in epo c he pre cede nti da Assiri, Egizi , e Greci
In parti co lare il co rno, capace eli e metter e un suono c upo e possen te, svol gev a an che la fun zio ne di ge n e rare confus ione e s pave nto nel clamore de lla b a trag lia, configurandosi, qui ndi , come primordiale e fantasioso st rumento , ant esignan o del mode rn o "di stu rbatore " cd "ingann ato re "
Altri elementi import a nti per il so ldato roma no erano le in segne milir ari. Ta li "siste mi di s eg n a lazion e ott ica" svo lge vano la duplice fun z ione di s imbolo, sotto il qu ale vivere e combatte re uniti al .Re pa rto di appa rten enza , da una pa rte , e di rapporto quasi sacrale con le a utorità daU ' altra. Ciasc una leg io ne aveva , a p artire da lla ri fo rma di Mar io, insegn e particolari. Esse erano costituite da un 'asta in legno s ulla cui cima s i trovava l'aquila le gionaria ad a li sp iegate. Lungo il leg no veniva no aggiunte le d ec orazioni merita t e ( phalerae e coronae), targhe ed altri e lementi aug urali.
In età tardo imp eria le è inve ce tes timoni ato l'uso , co me ins egna di cort e o di legione, del drago . Sim bolo guerri e ro di ori g ine sarm at ica, il dra go e ra un invo lu-
ero serpentiforme di p elli d ' anima le e stoffa, ap erto alle due estremità e portato su di u n 'asta . Ag itato con en ergia, permetteva un rapido pass aggio d 'aria, provocando rumo ri violenti e sibilan ti.
Nota zione a pan e meri ta l'uso per le com unicazioni di un altro sis tema , per la verità impiegato largamente fino ad epoche recenti Nell'Es ercito Romano era già sfruttata, infatti, la meravigli osa c apa cità dei piccioni viaggiatori di rito rnare ai lu og hi di origin e ; d i ciò dà n oti;da Plinio c he rac conta come Decimo Bruto, assediato in Modena (44 a .C .), pot eva com unic are a ll 'es terno con Aulo Irz io se rvendosi d ei pr e ziosi volatili.
Si h anno scarse notizie della crittografia roman a. Si sa solo per ce1to che Giulio Cesa re ed Augusto, nella loro corrispondenza con i familia ri, u savano un alfa beto rego lare, s p ostato di pochi pos ti (la lettera D al posto della A, la lettera E al posto de ll a B, la lettera F a l posto della C, ecc.); questa cifra, co mpendiata ne lla tavola di Biagio di Vigenere, nel suo tra ttato del1586 , è appunto detta di Giu lio Cesare.

DAL MEDIOEVO AL RISORGIMENTO


Campana custodila nel comprenswio di Redipuglia.
L'ampiezza del periodo storico preso in considerazione richiede una rapida panoramica cronologica che p e rm etta eli caratterizzare, in qualche modo, le fasi di questi 14 secoli di storia con le più significative realizzazioni dell'ingegno umano nel settore delle comunicazioni.
Nel V secolo , ovv e ro dalla caduta dell'Impero Romano d 'Occidente (476) fino alla scoperta dell'America (1492), non si hanno sostanziali innova zi oni n e lla storia dell'evoluzione dei sistemi di trasmissione.
In tale p eriodo, infatti, continuarono ad essere impiegati i s is temi acustici, animati ed ottici che erano stati le risors e di comunicazione d ell'e poca di Roma Imperiale.
Solo nel campo delle seg nalazioni acustiche si ha la novità dell' impieg o di campane e successivamente, nel 1400, dell'uso della polv e re da sparo.
Nel Rinascimento, durante il periodo delle dominazioni straniere e via via tìno al Risorgimento, insi eme ai tradizionali mezzi di comunicazione ottica, quali fuochi , fumate e bandiere, si impose uno strumento che segnò una real e rivoluzione: il cannocchiale.
Il perfezionamento di tale strumento portò alla realizzazion e di tu tta una se r ie di telegrafi ottici che rappresentarono, nel XVIII secolo e nella pr ima metà del XIX, il mezzo trasmissivo più largamen t e usato.
In piena diffusione della telegrafia ottica furono, infine , condotte, nei primi decenni del 1800, in Europa ed in America, le sperimenta z ioni che porteranno alla te legrafia elettrica , vera svolta nella battaglia dell'uomo contro i limiti di tempo e di spazio.
Le campane
E' proprio l'uso delle campane a rappresentare l'unica vera novità nelle comunicazioni del Medio evo. La Chiesa dei primi secoli le adottò per segnalare le principali fun z ioni religio se
Successivamente le campane furono installate sulle torri civ iche dei Comuni e vennero utilizzate per diffond e re m essaggi vari alla popolazione. Le vecchie torri di vedetta e segnalazione di epoca romana, divenute parte integrante dei cas telli delle Signorie, assursero a s imboli orgogliosi di Comuni fiorenti.
La campana è present e anche sul Carroccio.
E' questo un carro da combattimento la cui comparsa, secondo il cronista Arnolfo, è datata 1039, quando l'Arcivescovo Ariberto di Intiniano raccolse ed armò i cittadini di Milano per difendersi dalle minacce esterne, dando loro, come segnale di battaglia, un carro sormontato da una croce, fornito di aste e che portava un grande vessillo. Assurto a simbolo della libertà comunale, era trainato da buoi ed irmalzava una campana, denominata "mattinella", che trasmetteva vari segnali di battaglia.

Il carro, posto al centro degli schiera menti, era d ifeso da mil izie scelte. Sono le trom b e e le camp a n e a d iven ire in qu es ti secoli i mezz i di com unicaz ione destina ti a ch iamare a racco lta g l i u o min i p e r le b attaglie Co me no n ri co rd are, a ta l riguardo, il n o to episodio avven u to dura nt e la campagna d'Ita li a (1 495) , allorquando Carlo v'JII di Franc ia, gi umo alle porte di Firenze, ch iese con intento minaccioso un ingente tributo alla cittadinanza . Quivi , Pier Capponi, uomo politico fiorentino, di fronte all'arroganza del re invasore, pronunciò, inducendolo a più miti consigli, la famosa frase: "Se voi darete fiato alle vostre tromb e , noi suone remo le nostre campane".
I fuoch i, le fum a te, gli s pa ri
Me rita el i essere cita to u n episodio eli segn a la zi oni con fuoch i c fumate avvenuto durctnte la battaglia di Montaperti tra Fiore n tini e Senesi nell 'ap rile de l 1260. Si narra , infatti, che un soldato avesse il compito di segnalare la co mposizione e lo schieramento dell'esercito avversario, mediante segnali precedentemente co;Kordati : l' accens ione di due falò , rapid a meme nascosti e poi mos trati, indicava la presenz a, al di là d i u n cert o confine, di un grup p o d i armati avversari, infe rio re alle 200 unità.
Attorno a lla me t à d el 1400 , il perfez io namento d e ll e tec nic he d ' im pi ego d ella p o lve re da spa ro e de i si stem i di fus io n e d e l fe rro pe r m isero già l'imp iego d e ll e armi da fuoco come micid iali strumenti di gu e rra, ma si ha not iz ia d e l lo ro u so anch e n e l ca mpo delle comu nica zi o ni. Un o scri tt ore del tem p o narra , in fa tti , di un episod io avve nuto durante la già cita ta discesa di Carlo VIII in Ita lia, quando un repatto d i francesi, bloccato in Novara ed lvi assediato, riuscì a comunicare con for ze amiche in Vercelli, mediante colpi di bombarda concordati in precedenza Di pochi decenn i più tardi è un e pisodio che vide imp eg nato come "trasmettitore " Benvenuto Ce llini (1500-1571) Egli, ne lla s ua a u tobiografia, sc rive d i come fosse s tato in car icato, d a p apa Cleme nte VI I, as se dia to in Cas te l Sa nt 'An g e lo al
Ca rtolina reggimentale raffigu.mnte un trombettiere a cava llo del 7840 di A. Cen;i.
Trasmissioni a mezzo di 'fu mate" nella città di Piomoino
Ne lla p agina a fianco: Uso d el cannoc cbiale - dumnte una e sper·ienza del telegmfo di CHAPPE f a t ta il 12 luglio 1 793 da Men ilmont an t a Sain t Mm·tin du Te11re.


tempo del sacco di Roma (1527), di effettuare com unicazi oni ottiche (con fuoch i) ed acustiche (con artiglierie) al Duca di Urbino, per comunicare la capacità di resistenza delle forze papali ."...... che tanto quanto il detto castello durava a fare ogni sera tre fuochi in cima di detto castello, accompagnati con tre colpi di artiglieria rinterzati, che in sino che durava questo segno, dimostrava che il castello non saria arreso ".
Agli albori del Rinascim ento, il grande Leonardo da Vinci (1452 - 1519) non poteva mancare di cimentarsi nella trasmiss ion e delle informazioni, immaginando , come descritto in un manoscritto (Cod B, f 23 c) del 1489, un sistema eli trasmissione della voce che utilizzava condotti sotterranei e "relè" umani. Testualmente afferma : "Puossifare in ciento miglia ciento case, ne le quali stia cento guardie che ffarranno per sotterranei condotti, sentire una novella in qucl110 d'ora".
I piccioni viaggiatori
Nei secoli in esame si ebbe un notevole incremento nell'impiego dei piccioni v iagg iatori come mezzo di comunicazione rapida a distanza. E non poteva essere diversamente, in considerazione della capacità che questi vola tili possiedono di volare a velocità tra i 40 ed i 60 Km/h per grandi distanze (2000 - 3000 Km) e di oltre 100 Km/h per brevi distanze (fino a circa 300 Km).

Nel Med ioevo sovrani mussulmani di Siria e di Egitto utilizzarono in maniera regolare i piccioni viaggiatori. M. Thiene , nel suo libro "La posta dei Sultani d'Egitto", afferma ch e Mour-ed-Din aveva a sua disposizione dei colombi di razza speciale capaci di coprire, in un solo volo, lunghiss ime distanze quale quella tra Damasco ed il Cairo.
Un altro esemp io di tale tipo di comunicazione "aerea" , lo ritroviamo durante l'assedio della città di Leida del 1574. Quivi, il principe d'Orange utilizzò questi volatili per corrispondere con gli assediati. Per la meritoria opera svolta, allorquando gli spagnoli assedia nti furono sconfitti, questi animali furono oggetto di particolare riconoscenza da parte di tutta la città.
Il cannocchiale
L'avvento del cannocchiale rappresenterà nel 1600 un punto di svolta significativo nello sviluppo delle trasmissioni ottiche, grazie alla sua capacità di aumentare la portata ottica del segnale e di migliorarne l'intellegibilità. Il primo cannocchiale sarebbe stato costruito in Olanda, al principio del sec. XVII, da occhialai fìamminghi. E' del 1608 un documento con il quale gli Stati Generali dei Paesi Bassi accolsero la domanda di brevetto eli Hans Lippersheim, ausp icando , nel contempo, la realizzazione di uno strumento "accomodato per la visione con tutti e due gli occhi" ovvero del binocolo.
Resta, comunque, il fatto che la nuova invenzione, oltre ad aprire nuovi orizzonti nel campo dell ' osservazione astronomica con Galileo e Keplero, è una pietra miliare nella d elle comunicazioni.
Un primo esempio eli impiego del cannocchiale nelle comunicazioni ci viene descritto in un'opera scientifica del gesuita Francesco Terzi de La na nel 1670. In essa troviamo la descrizione di un telegrafo a pendolo che utilizza il cannocch iale come sistema di rilevazione ottica dei segnali di sincronizzazione di pendoli corrispondenti, a distanze fino ad allora mai raggiunte. Il sistema di trasmiss ione del
Telegrafo C'bappa Primo telegrafo aereo installato a Condè il 30 novembre l 794. Biblioteca Scientifica Tllustrata -A. Clerc -

gesuita sfnmava il principio fisico g razie al q u ale pendoli uguali , presenti su due torri di corrispondenza distanti tra loro u na decina di chilometri, compivano un uguale numero di oscillazioni in periodi eli tempo uguali. Il numero delle oscillazioni veniva defin ito da seg n a lazion i luminose effettuate con fiaccole osservate a loro volta con un cannocc hiale.
Il telegrafo ottico
Una inte ressante ve rsione <li te legra fo ottico success ivo al telegrafo a pendol o è rappresentato dal .sis tema id eato dai fisici Sc hott (1608 -1666) e Becher (16351682). Essi utilizzarono un a se rie di corpi opac h i di g iorno e di fari di no tte , che venivano fatti scendere e sa lire ad aJtezze va riabili su delle .aste. La posizione, che i ci tati corp i opachi (o fari) a ssum e vano, d eterminava, seco ndo un codice pr estab ili to, la individua zio ne eli lettere o gruppi di lette re da trasmettere. I primi proto tipi di tal e telegrafo utilizzavano 3 soli s imbo li c he veniva no combinati su tre alberi; successivamente il sistema utilizzò un cod ice più artico la to con l'im p iego di 5 simboli.
Le diffico ltà connec;se alle co ndi zioni di scarsa visibilità, sugge rirono al fis ico Amo ntons (1663 -1705) l' impi ego del cannocc hiale che , peraltro , era già stato proposto nel telegrafo di pad re Terz i de Lana. Amo ntons ebbe modo di sostenere che l'impiego comb in ato del cannocchiale e di segnali correlati nel modo sopra desc ritto avrebbero permesso di trasmette re una data notizia tra Roma e Parigi in sole tre o quamo o re.
Sull 'argomento merita di essere c itata l'ope ra di un anonimo appassionato cultore di tele grafì a che, in Ge rm an ia, negl i a nni che vanno dal 1784 al 1788, reali zzò u n g ran nu mero di s istem i eli co municaz ion e, utilizzando tutti i mezzi allo ra d isponibili, quali fuoco, fumo , col pi eli a rm a da fuoco, fi accole , vasi d'acqua , campane, trombe , strumenti musi ca li c band ie re
Ma il merito più g ra nd e attribuibil e a questo s tudioso è quello di aver perfezionaro il vocabolario de ll a co rr bpond e nt:a te leg rafica mediante l'impiego de ll 'aritmetica binaria. Con il s u o mcrod o no n ven iva no più trasmesse le let tere che componevano le p arole d e l testo, ma i nume ri co rrisponde nti a ciascuna paro la el i un patticolare voc abo lario
Dando pratica a tt uazion e a ll e a ttività de ll o s tudioso tedesco, Claude C happe (1763 - 1806), un ecc les iastico francese, ass ieme ai suoi frat ell i I gnace ed Abraham , ideò e costruì un te legrafo o ttico , le cu i seg nala zion i p otevano essere avv istate con l' aiuto eli cannocch iali a n c he a notevoli distanze. Il mezz o f u prese ntato a ll 'assemblea le g islativa fra n cese il 22 ma rzo 1792 e , d o p o rapida sperimentazione , venne adottato nel lu glio dell'an no segue nte La prima linea telegrafica Chappe fu impianrat a tra P ar igi e Li lla e comprend eva 16 stazioni , distanti circa 14 Km l' una dall'a ltra ; essa fu in augurc:tta il 1° settembre 1794 con la trasmissione della notizia della liberàzione della c ittà di Co ndè da parte delle truppe repubblica ne Il testo del mes saggio inviato a l ministro delta guerra re citava: "Condè est restituèe a la Republique : !et reddition et eu lieu ce maNna si:x heures "
La s tazione e ra costitui ta d a un osserva torio su l qua le era innalzata un 'a ntenn a fissa, sporgente dall'osserva to r io p e r alc uni metri e c he port ava alle es tremità 3 "r ami" , mobili su un unic o piano, o rtogona le a ll a d irezione del collegamento. All 'inte rn o della s tazio n e vi e ra un id e nti co comp lesso più piccolo attrezzato co n una serie di carr u cole c co rd e senza fine, c h e p erme ttevano ai rami es terni di ass umere le st esse co nfi g uraz ion i d e fi nit e a ll ' inte rno. L'operatore, muovendo a mano il di s p ositivo inte rno , compo neva le varie combinaz ioni che venivano r ipor-
tar.c all'esterno . Le tre as te es terne mobi li potevano assumere fi no a 196 confi guraz ion i di verse; eli queste i fratelli Chappe ne individuarono la metà (98), tra le più diverse tra loro e defin irono un "voca bo lar io " cos tituito da 98 p ag ine , ognuna d elle qtw li a sua volta conteneva 98 paro le. 11 vocabo lario, realizzato da Leo n e Dela u nay , vecc hio dip lomatico che aveva acquis ito ne l sett o re della c r ittografia grande esperienza, e ra cos tit ui to da c irca 10.000 pa r o le ogn un a de ll e qua li e ra defin it a da due successive configurazioni ass u nte dai 3 rami mobili de l tele g ra fo.
La brillante in augu raz ion e cleJla p ri ma li nea te legrafica Ch appe inco raggiò lo sviluppo eli wle sis tema di com u n icaz ione. E' del 1797 ia second.a linea tra Parigi e Strasb urgo su 46 stazio ni; la te r za, rea lizzata nel 1799 tra Parigi e Brest, si articolava s u 55 swzion i. A.nc he n el pe ri odo d e l Direttor io e so tto l'Imp e ro, co n 1noclifich e ch e n e perfezionavano l'impiego, furono realizzate var ie linee Un dato, in conclus io ne, pu ò re nder con to de ll a d iffus ion e d el telegrafo ottico Cb.appe in Franc ia; nel 1844 erano ope ranti 543 s taz ioni , per uno svilu ppo d e ll a re te el i co munic az ione el i ci rca 5000 Krn. L'amp iezza el i ta le rete fu di os taco lo in Francia alla diffusione eli una n u ova invenzione che inca lzava intorno ai p rimi decenni clcl l'800 : il "teleg rafo e le ttri co" .
Lo svil uppo de lla telegrafia ott ica negli a ltri Paes i e uropei può e ss ere acce nnato r ico rdando la real izzazio ne di un sistema a semafori in Danimarca nel 1802; la costit uz io n e d i u n a ret e di co ll e gam en to i n P russ ia tra Berl in o e d a lt re città, intorno a l 1832; la cos tit uzio ne d i un sis tema d i co ll egame nto ottico, durante il regno eli Nico la I (182 5-1855) , tra Pie tr oburgo e Varsavia , articolato s u 220 stazioni.
In Ita lia fu im piantata nel 1806 t ra la Savo ia e d il P ie n1o nt e u n a lin ea di comun ica zione utilizzante il telegrafo a e reo ideato dall ' in gegne re Go nella , d ire tt ore d e i te legrafi de l Reg no Sardo -Piemon tese. Nel 1848 la lin ea f u ampliata verso la Lom ba rd ia da u na parte e la Ligur ia d al l'a lt ra, affinché "segu isse sin presso gli accampamenti l'armata italiana" . Il s istema Gonella s i rive lò il mig li o r e fra tu tti que lli de r iva ti da ll 'o ri g inale te legrafo Ch a p pe .
Anche nel Regno de ll e D ue Sic ili c il tel eg rafo ott ico fu util izzato ampiamente Piet ro Colletta 0775 -1831) r iferisce éhe Gioacc hino l'vlu ra t (1767 -1 8 15 ) fu avvert ito, 1 ' 11 g iugno 1809, dal "telegrafo de ll e Calabrie" , d ella partenza d alle is ole Eolie eli u na forre s quad ra nava le in g lese, la cu i com pos iz ione fu p rec isa ta da i se ma fo ri ott ici.
I nfine, me r ita un cen n o la costruzione in Algeria di un a rete ottica da pa rte d el Ge ni o Militare frances e, tra il 1844 e d il 1854, che rappresenta l'ultima gran d e reali zzazione di telegra fi a o tt ica p r im a de ll' avve nt o d ell a te leg ra fia ele ttr ica
Di questo tipo di tel egrafo fu realizzat a anche una versione campa le c h e, smo ntata, aveva un ingombro non superiore ai 3 metri e d era rrasponabile con un solo mu lo. I nstallabile rapidame nt e e fac il mente, fu impiegata du rante la gu erra d i Crimea ( 1855 - 56).
Gli a lbo ri della te leg rafia elettrica
Era n o o rmai maturi i tem pi per l' inve n z ione d el seco lo n el camp o d e ll e comuni cazioni: la telegrafia eler trica .
Fu Sa m uel Morse (1 791 - 18 72) , un pi ttore ritrattista ame r icano con il p all ino d ell ' inve n zione, che , di ritorno da un viaggio in Europa , ove a ltre e s peri e n ze ve nivano condotte in q uesto campo , co n cepì la prima idea di telegrafo elett rico , re alizzando lo nel 1835. Ne l marzo de l 1843 il gove rno ame ri ca no lo a iu tò con sovvenzioni ed eg li , l' an n o seguen te, po té finalm e nt e trasmettere il p rimo mes s aggio telegrafico da \Vashington a Baltimo ra .
Val la p e n a prec isare che, tanto nel mo do co n cui fu concep ito or ig inariamente
Telegrafo Gonella da un modellino conservato presso l 'Istituto di Cultura dell 'Anna del (Jenio e delle Trasmissioni di Roma.

c he in quello in cu i fu brevettato (1838), il sistema Morse n o n poteva funz iona re a gran de distanza e sarebbe stato forse dime ntic ato se Morse non fosse venuto a co n oscenza dell ' invenzione del relè di Davy e n on avesse , con l'uso di questo accessor io, potuto superare le difficolt à di trasmissione dovute a ll a res istenza e le tt rica tro ppo a lta d e lle lince, a b atterie di basso vo ltagg io e d a ricev itori p oco sensib ili .
La crittografia
La c rittografia nel Me dioe vo è adope rata per celare nomi propri , dapprima con se mp lic i sostitu 7. io ni di u n a lettera o di sempli c i voca li , poi con l ' introduz io n e , intorno a ll 'a n no 1000, d i s eg ni div e rs i q ua li le tte re appa r tenenti acl di a ltre lin gue o s imb oli di fa ntasia.
E' con il Rin asci mento che nasce rà la nece ss ità, da pa rte dell e dip lo mazie di Repubblic he e Sig n orie, d i utilizzare forme di critt ografia più sofist icate. Fu allora che v enne introdotto uno degli element i che p oi dovrà svo lgere un ruolo preponcle ra nte in tutt a la s toria d elle com unicazioni c ifrate: il n omenclatore, ovvero la li s ta d i nom i pr opri e di parol e com uni c h e venivano masc herate sos tituendo le co n semp lici lettere o con p arol e diffe re nti; q u este e rano spess o scelte in modo da ada ttarsi ad un li nguaggio conve n ziona le.
Interessant e appare, per questo aspetto, una raccolta di lettere dell 'Arcivescovo di 1\apoli Piet ro di Grazia, scritte intorno al 1365, nell e quali le vocali significative sono sost ituite da semp li c i seg ni, mentre le voca li trascritte rea lme nte , fun:lionano da "null e", ovve ro da sim boli pri v i el i signifi cato . Tn tal mod o, des igna n do a = • ; e = L; i = l; o = TI ; u = t, la paro la "omni a" s i s a reb be potuta scri ve r e "u iT m on{i •"
Nella seconda metà del XIV se colo, per ren dere meno sempli ce la dec rittazione dei sistemi monoa lfabetici , veniva n o impiegati dei s egni che, per co n ve nzio n e, no n avevano a lcun s ignificato, ment re alle lettere più frequentemente usa te ( e p er ciò più fac ilmente de term inabili da parte dei decrinatori) ve nivano a ttr ib ui ti pi ù s iJ1"'tbo l i, app a rt enenti a ll'a lfabeto cifra nt e , e d a venti tutti lo stesso s ig nificato c h ia ro La correlaz io n e tra la lett e ra de ll 'a lfabeto e d i var i seg ni el i ugua le significato ven iv a stabilita a prior i da coloro che corrisp o ndevano.
Le cifre diplomatiche italiane dei secoli XIV c XV erano sostanzialme nte di questo tipo : nulle ed omofone ( stesso s u ono e significato in chiaro) erano usate con la cifratura continu a (ovvero senza s eparare le parole ), ed e rano, spesso, co mplicate d a ll 'impi eg o eli talun c co nve n zioni p er il tes to in chiaro, co me l'a bol izione d e ll e lette re doppie, d e ll e le ttere rare, d e ll a punteggiatu ra e d e ll e sig le ab breviate.
Leo n Battista Albe rti (1404 - 1472) propose, per ci frare , un disco co mpost o da una coppia d i ce rchi cifranti concentrici: uno esterno, fisso, di 24 case ll e (20 lette re dell 'alfabeto maiuscole, escluse le lettere rare ], K, Y, W, Q ed H , co n i numeri l, 2, 3 c 4) per il testo in c hiaro, ed uno int e rno, mobil e, cos tituito con 24 le tte r e, m inu sc o le (escluso W e con U = V ) in disordine. L'operazio ne eli c ifratura s i avvi a va fi ss ando un a lette ra ma iu scola co m e in dice e spos tando il disco mobil e , in modo tale da defini re una p a rt ico la re fasatura che e r a indicata dalla pr ima lettera del cifra to. Sulla base di questa fasatura veniva cifrata la prima parol a con la lista che si e ra ott enu ta. Volendo , poi, cambiare la lista cifra nte , s i inser iva nel testo in ch ia ro uno d e i q uatt ro numeri indi cati s ul disco fisso , di mod o c h e, in co rri s p ondenza, se n e avesse una le tt era s ul ce rc hi o c ifran te .

La s uccessio n e d elle lettere ch iavi, che indicavan o la success ione delle liste d a u sare, p e r c ifrare o d eci fra re, e ra el e tta "motto " , "frase" o "verse tto " ed è att1.1 a lm ente, ne l ge rgo cr it tografico , c hi ama ta "ve r me"; essa costituiva la parte p iù segreta d e l s istema e doveva essere co nv e nuta volta per volta tra i co rris pondenti e d indicata in modo segreto nel carteggio. Quella di Leon Battista Albe rti fu una cifra polialfabetica ad alfabeti intervertiti, cambia ti saltuari amente ed in modo segreto. Rappresentò, ad onor del vero, la cifra più sicura, non solo rispetto a quelle in uso al suo tempo , ma anche di quelle c h e la s eguirann o, quale la cifra di Bellasio , che usava pochi alfabet i e c o n un cambio d i lista non segreto, e la c ifra eli G.B. Pott a, considerato il p adre della c rittografia mo derna.
Q u es t' u ltimo, ne l suo libro "De f1.11tivis litt erarum not is, vu lgo de z ife ris " d e l 1563, espo ne , in mani e ra chiara e concisa , tut te le conosce n ze c ri tt ogra fiche d e l tempo, d esc ri ve una sua tavola, basata su ll 'uso di 11 alfabet i (c iascu n o d i 22 lettere) e dà il p rimo esempio di "verme letterale", poi generalm e nt e adottato.
Biagio di Vigè nère , ne l suo trattato s ull a cifra (1586), ha po i proposto l'uso d i una tavola quadrata costituita da so li alfabeti regolari, per la prima volta pubb li cata dall'abate Tritemio (1 518) ed attrib uita dallo ste sso Vigè n ère agl i eb rei.
Adottando per il suo uso il verme lette rale proposto dal P orta, Vigènère finiva per realizzare una cifra più d e b ole e sco moda da u sare ri speno alle precedenti . No n ostan te ciò, q u es ta c ifra e bb e g rande fo rtuna e fu utili zzata da molti Eserciti an c h e d o po che, ne l 1863 , era s ta to pubb lica to il sistema per d e cifra rl a
La c rip to log ia r aggi u nse il mass imo s plend o re ne l XVI seco lo e p o i d ecadd e gradualme nte , ragg iu n gendo forse il livello pi ù basso con Na po leo ne (1769-1821).
Ri su lta , infatti, che nella campagna d i Russia l'armata frances e utilizzasse sistemi di cifratu ra di assai facile decrittaz ione.
Disco cifrante di Leon Battista
Alberti. Esempio di cifratura con la lettera indice B ed una prima fasatw·a ottenuta con la Lellera q in corrispondenza della B come in (A), la frase: "LA (4) VIRTU (1) VA (3) SEMPNH (2) PERSEGUITA " diviene: "pi a tmnyv k zs t bka c ik n bvaitwcsqz".

CAPITOLO III

LE CAMPAGNE PER L' INDIPENDENZA E L'UNITÀ D ' ITALIA
FI N O ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE

La P Guerra d'Indip endenza (1848 - 1849)
Nel periodo risorgim en ta le, le comunicazioni militari sub irono una radica le evoluzione per effetto s ia d e ll e c rescenti es igenze operat ive, sia delle innova1.i.oni tecnologiche svi luppa te n e l p e riodo. In part ico lare, all' inizio dell'epoca, i mezzi di comunica zione erano costituiti da g li stessi materiali già trattati nel precedente capitolo 2 e non rispondevano ad alcuno dei requis iti di affidabilità, soprawi ve nza, interoperab ilità, flessibilità e necessari ad una condotta appropriata dell e opera zioni.

L'Armata Sarda si presentò alla P Guerra d 'Indipendenza , con le unità organiche dell'Esercito Piemontese ( due C.A. su 3 Divisioni), e numerosi gruppi di volontari, var iamente organizzati cd in quad rat i, pe r un totale di circa 66.000 uomini.
Cn siffatto corpo di battaglia non poteva non essere gravato da seri problemi di coordi namento, senza un valido sistema di comando e controllo.
Le forze a ustriache ( du e C.A. o rg an ici), numericame nte inferiori alJ'iniz io, erano ben inquadrate e s i appoggiavano alle fortezze del quadrilatero (Vero na, Peschie ra , Mantova e Legnago). Esse aveva no assunto un atteggiamento difen s iv o in attesa eli realizzare un favorevo le rapporto di forze per passare all 'offensiva.
Il teatro delle operazioni, costit uito da ll a pianura padana da Novara a Ve rona, presentava qua li ostacoli al movimento essenzialmenre gli affluent i di s in istra d el Po (da l Ticino al Minc io). La co ndo tt a d e ll e operaz ioni postt1lava, ai fini del coordinamento deg li interv en ti , la di sponibi lità eli s istem i eli comunicazione rapidi ed affidabili
Mentre l 'Ese rcito Piemontese, cresciu t o qualitativame nte , poteva mett e re in campo solo i tradizionali e lenti s is temi di co municazione quali staffette a piedi e a cava llo e mezzi di segnalazion e a breve distanza, presso l'Esercito Austria co venivano già impieg ati, a li ve ll o divi s io n a le, i primi prototipi di telegrafo eler.trico. Erano i segn i della miglio re organizzaz ione delle forze austriache che, in contrapposizione co n la disomogeneità , le in comp rensioni e le carenze di comando in campo italiano, portò all'es it o finale negativo delle campagne del 1848 e 1849.
Evoluz ione tra la P e la 2a Guerra d ' Indipendenza
Anc he per gli ins egnamenti scatu riti dalla l u Guerra d ' Indipendenza, si ebbe un gradua le ingresso del telegrafo e l e ttrico nei collegamenti cl ell ' J:::se r c it o Piemontese, analogamente a quanto avve nut o nei paesi più evoluti del Nuovo Continente , dell'Asia (G iapp one in pa1ti co lare) e dell ' Europa (oltre all 'Austria, la Pruss ia , la Ru ss ia e la Francia). U na panoramica abbas tanza completa sui m ezz i di comunicazione militari dell 'epoca, qua li i te leg rafi (ott ici, elettrici ed a seg n ali) e d i sistem i eli segna laz ione, venne trac c iata nel manoscritto del Cap it ano Borson
(1856), Ufficiale di Stato Maggiore Austriaco . Nel manosc ritto vennero descritte le sperimentazio ni condone presso l' Esercito Austriaco, s ul s is lema tel egrafico e le ttrico divis ionale conclu se nel 1853, e la d efin izione degli o rga nici e dell e dotaz ioni eli un a specia le unità d ' imp i.ego del Ge ni o Militare. Qu es ta unità aveva un a forza di 16 uom ini, era clorata eli mate ri ale telegrafico (condulto ri , sostegni, ca rriolabarella) trasportabile con un carro ecl era in grado di realizzare e gestire u n a li nea campale di circa 7400 m
Tra i siste mi eli segnalazione e tel eg rafici, il Borson desc risse, in particolare, il tel egra fo campale a seg nali ideato dal Maggiore itali a n o del Genio Rocc i, che sare bbe po i stato impi eg ato nei succ ess iv i co nflitti.

Tabe/lintl delle 36 combinazioni del codice usato per il teleg rafo Rocci.
TI telegrafo Rocci consisteva essenz ialmente in un palo recante sulla sommna due ali-s egnali "in metallo leggero" di forma diversa, una triangolare e raltra a "T". Le du e ali ruoravano con comandi manuali (ma novella, corda e carrucola) attorno ad un perno infisso nella parte alta del palo. li sistema e ra completato da un supporto a traliccio in legno alto circa 4 m Anche questo sistema veniva t raspo rtato mediante u n carro.

Tra le moltepli ci posizioni c he poteva assumere la coppia delle du e ali -segnali ne furono scelte 56, cu i p otevano corrispo nd e re le lettere dell 'a lfabeto e/ o parol e e frasi co nvenzionali
Il Cap. Borson fece anche menz ione d e ll e prospettive d'impiego di un s is te ma teleg rafico elettrico ''legge ro " , in fase d i st udi o presso il Ministero d ei Lavori Pubb lici- Direzione Genera le dei Te leg rafi del lo Sta to , derivato dal telegrafo Mo rse e modificato dallo svizzero Hipp , co n la se parazione del relè dalla macchina , p er un migliore isolamento me cca ni co e p e r una migliore affidabi lità della stazione. Il sistema delineato appare , risp e tto ag li altri in uso in quei tempi , paJticolarmente innovativo per quanto rigu a rd a il materiale e, so prattutto, per il metodo di s tend imento delle linee. Si p revedeva, infatti, di u tilizza re un conduttore molto sott il e, eventualmente ricoperto di materiale gommoso (guttaperc a), avvolto su piccoli tamburi (sp ezzoni d i fi lo lunghi circa 500 m.) da fissare alla sella del cavallo. TI cavaliere, mediante apposita manovella, poteva svolge re il filo durante la corsa senza curarsi, in caso di urgenza, di ancorarlo o sollevarlo . Per le n o rmali condizioni di stendimento, il cavaliere riceveva in dotazione u n ceno num ero eli aste leggere con ganc io da in figge re nel terreno a sosteg no del filo. La concezione d i questo sistema, eli cui il 13orson si mostrò conv imo sostenitore, v iene attribuita al fisico G Bonelli , Dir ettore Ge n e ra le d e ll a pr e d etta Direzione G ene ra le dei Telegrafi dello Stato.
Le valutazioni di sintesi di .13orson possono così riassumersi:
-i vari mezzi di segnalaz io ne (c hiamati "a rtifizi di guerra ") non potevano esse re considerati campa li per la loro inaffidabilità, limitata portata e scarsa sopravvivet1Za;
-i s istemi di fu oco semafor ici, tipici dell 'impiego nava le, potevano essere util izzati solo in condizioni panico lari (assenza di n e bbia o di fumo);
- le comunicazioni ottiche, utili zza nti so rgenti di alimentazione elettriche, potevano risolvere solo i probl e mi d e ll e co munica zioni notturne navali, ed in particolare per evitare co llisioni;
- il telegrafo Rocci rispon d eva a ll e esigenze delle comunicazioni campali a nche se presentava alcune limitazioni, quali la necessità di ricognizioni preventive, la dipendenza dalle co ndizi oni atmosferic he, l' impossibilità d 'impiego nomuno e la lentezza di trasmissione;
- il telegrafo elettrico, se realizzato secondo le linee indicate d al Bonelli, rappresentava una ri sposta a d eguata, ancorché costosa, alle esigenze di collegamento campale.
All 'estero, nel frattempo, d ive ni vano operativ i var i tipi di telegrafi orrici tra cu i gli eliografi. L'eliografo era costituito da due specc hi dei quali il primo catturava la lu ce del sole e la inviava al secondo, c he la rifletteva , a sua volta, nella direzione del corrispondente. Un setto mobil e, manovrmo a mano, interce tt ava il raggio di luce e p e rmetteva la segna laz ione, che pote va esse re eli tipo convenuto o Morse. Il corrispondente poteva avvalersi di un ca nn occhia le per la ricez io ne dei segnali allorché la distanza di collegamento d iveniva ragguard e vole (fino 150 Km ) . I l Lauserre utiliz%ò m ate riale d i questo tipo , con successo, ne l co rso della guerra eli Algeri a (1855).
La Guerra di Crimea (1855 -56)
L'Esercito Sa rdo -P iemontese parte c ipò alla Guerra di Crimea a fian co della Fran c ia e d e ll 'Ingh ilterra, co n un con ting e nte di quindicimila uomini eq uip aggi ati con g li stess i m ezzi d.i com unicazio ne utilizzati ne ll a P Guerra d'In dipen den za. F.sso, però, potè trarre im portanti ammaestramenti s ull 'impiego dei telegrafi utilizza t i dagl i alleati , in qua n t o questi co lsero l ' occasione p e r confro nt a re sul campo le prestaz io ni dei telegrafi a segna li con que lle dei telegrafi elet tri ci.
I francesi, c he impiega rono l inee t elegrafiche a segnali ottici ed e lettriche costruite e gestite da personale dell'organizzazione c ivile dei telegrafi, realizza ro n o in meno di un mese una linea, con te legrafo a segnali derivato da quello di Chappe, tra Varna ed il porto eli Botscick, e succ essiv ame nte una seconda li nea per l'all acci amento al sistema teleg rafico inte rnaz ionale, tra Varna e Bucarest.

Gli inglesi, anc h ' ess i dotati di mate ri ale telegrafico misto, reali zzaro n o numerosi collegamenti, anche co n il concorso di persona le civile, tra i quali assunse paiticolare rilievo que llo e lettrico sottomarino tra Varna e Balak lawa.
L' Esercito Russo d isponeva di un parco te legrafico simile a quello francese .
Nel corso d e lla guerra il ,materiale te legrafico a segnali fu impiegato con ottimi ris ul tati, ma manifestò la sua netta inferiorit à rispetto a que llo elettrico che anda va impon endosi con rapidità .
La za Guerra d'Indipendenza (16 ap rile -lO novembre 1859)
L'A rm ata Sarda all ' in izi o delle ostilità era forte di 5 Divisioni di fanteria , el i una Div isione eli cava ll eria e di un corpo (su cinque reggimenti) eli Cacciatori delle Alpi comandato da l Generale Garibaldi. L' "Armèe d'ltalie" d i Napoleone III , che intervenne, a guerra iniziata , in favo r e d e ll 'Arma ta Sarda, comprendeva 15 Divisio n i di fanteria e tre Divisioni e tre Bri gate di cavalleria.
L'Ese rcito Austriaco contrapposto ai due Eserciti alleati cont ava invece, a ll 'inizio delle ostilità, 11 Div isi on i di fanter ia ed una di cavall eria . Esso, però, doveva esse re affiancato in tempi brevi dalle forze d i altri 6 Corpi d ' Armata.
Il teatro delle operazioni era più ampio di quello re lativo alla l a guerra d' indipendenza, in quanto s i es t ese ai t er ritori dalla riva destra del Po (Vog hera , P iacenza). Anch e gli Appen nini Ligure e Tosco- Emiliano furono secli di movimenti eli trupp e, sebbene n on di scontri.
L'organizzazione de lle forze ed il t ea tro opera ti vo su d es critto esasperavano, più ch e in pass ato, l'esigenza di un coordinamento de ll e u nit à, in particolare della coalizione franco piemontese e quindi postulavano la disponibi lità dì un adeguato s is tema eli comunicazioni.
L ' Armata Sarda all ' inizio della campag n a d isponeva, o lt re a i soliti mezzi di comunicazione camp ali , de l mate riale te legrafico a segnali del t ip o Rocci, ma poteva far ricorso anche alla telegrafia ele ttri ca , impiegando personale civile per la progettazione, la re a li zzazione e la ges tione delle linee telegrafic h e e dell e s ta zioni.
Il "Regolame nto del 23 aprile 1854 per il se rvizio del Genio Mi litare in campagna" , infa tt i, affidava:
- la responsab ilità della concezione, rea lizz az io n e e ges tion e dei collegamenti te leg rafici d ell'Arma t a all'Ispettore Capo dei Telegrafi d i Stato (sarà ancora des ignato il Bonelli), coadiuvato da due Vice Ispettori;
- il controllo delle attività di detto personale civile ai Comandami del Genio militare delle Grandi Unità impiegate in operazioni;
- al Genio Militare il concorso allo stendimento, manutenzione e sorveglianza de lle line e.
Co n decreto 11 g iugno 1859, si stabilì che il perso n ale civ ile addetto ai telegrafi elettr ic i indossasse l'u n iforme con fregi e d is t in tivi della spec ia lit à teleg rafist i, co m inciando a dar vita ai "comunicatori" nell 'Esercito
L'Esercito a ll eato Fra n cese portò al seguito il so lo materiale tele g rafico elett r ico campale. ·
L'Esercito contrappos to Au s tr iaco d isponeva di un parco di materi ale camp ale teleg rafico molto vario e valid o, tra c ui il s is te ma telegrafico elettrico d escritto d a l Borso n.
All'inizio delle opera z io ni fur o n o rea lizza te tre linee con m ateriale Ro cci c he s i diramavano da San Salvato r e sede de l Q u a 1tie r Generale , verso i comandi d e ll e truppe avanzate, ubica te in Casa le, Alessandr ia e Novi. Tali linee furon o realizzate da un nucl e o d i U ffi c ia li , Sottu fficiali e soldati d i truppa d el Genio zappa t o ri agli o rdini del Ca pitano de l Ge n io Luigi G iannett i.
Q ue sti g enie r i, anche se non ancora inquadrati ufficia lme n te in un a u n ità organ ica di telegrafisti, sono considerati i progenitori degli attuali "trasmettitori".
Gli alleati francesi non solo provvidero alla realizzazione de i collegamenti telegrafici prop ri, raccordandosi o urilizzando la rete telegrafica civile o militare esistente (ad esempio quella austriaca abbandonata in Lomellina ), ma supponarono validame nte a n che l'organizzazione telegrafica sarda, quando questa si trovò in diffico ltà ( e capitò spesso) o add irittura in crisi.

A campagna in iz ia ta, a cu ra de l Ministero de i Lavori P u b b li ci, ven n e d ist ribu ito a 4 Di v is ioni materi ale te legrafico elettrico. Ta le m ateriale, t ras p o rt ato da apposito carro comprende va, tra l'a ltro, g li apparati Morse com p leti da camp o, gli e le m e nt i di pil a Daniel, i pali te leg rafici, c irca 300 Kg el i fil o elettrico rivestito e nudo, s taffe p e r comporre i pali doppi, iso lator i, il tavo lo p e r a pparato Morse, nonché s rru mcnti ed accessori per te le gra fis ti e zappa tori .
La campagna fu interrott a-dopo i s u ccess i di Varese e San Fe r mo (Ga r iba ldi), Magen ta , Solferino e San Ma rti no a causa de l ritiro d e lle forze francesi da p a rte di Napoleo n e III, che te m eva l' im m inente e n tra ta in guerra dei Prussiani a l fi a n co degli Aus triaci.
Al termine del co nfl itto, con la restituzione d e l materiale telegrafic o d ivisiona le al Minis tero de i Lavori Pubb li c i, fu vanificato il p ro me ttente avvio verso l'a uto n omia d ell'Ese rc ito in m at e r ia di comunicazioni. Auto n o mia ri velatas i ind ispe n sabile per gli e ffetti n egativi della rivalità fra civil i e militari, guerra durante.
Le comunicazioni tra la 2a e la 3a Guerra d 'Indipendenza
Fu q ues to un dece n n io in cui l'Armata Sardo-Piemontese, in vista d i un decisivo co nflitto contro l'Austria, si trasformò per diveni re u n e s erci to po d eroso. Il p o tenz iamento, p e rò, rigu a rd ò tutti i vari sett o ri dell ' armame n to , e cc ett o que ll o d e ll e comunicazio ni. Cosicché, n onostan te il decreto d e l 1859 , nel co rso de ll a campagna del 1860 co n do tta d all 'Armata Italiana, dalle Marche all a Camp ani a, i collegamenti telegrafici furo n o ancora ass ic urati da personale civi le del Mini ste ro d e i Lavori Pubblici. E'd a ri co n osce re c h e il se rvi zio te legrafico fu efficiente e continuo: i due Corpi d'Armata c he ini zia rono la marc ia, l'uno (i l lV, co rn andato d al Geo Cialdini) dalla Roma g n a e l'a ltro ( il V, coma n dato dal Generale Morro z zo
della Rocca) clall'Umbria, furono costantemente co llegati malg rado l' ostacolo costituito dalla catena degli Appennini.
Il materiale impie gato ed in par ticola re quello necessario per la costruzione delle li n ee "eve ntuali " (volanti) era realizzato secondo le idee suggerite dal Bonelli e richiamate dal Borson. Il filo, ad esempio, era costituito da conduttore ricoperto di guttaperca e poteva essere posato semplicemente sul t erreno od appeso a murì o pali con semplici chiodi oppure, come scrive il Matteucci, lo si poteva "nascondere nei solchi di un campo e sotterrare nei passaggi (attraversamenti) delle strade". In alternativa al filo ricoper to poteva essere utilizzato quello nudo, più adatto a linee semipermanenti, che veniva sospeso con iso latori a puleggia di porcellana o d i terracotta, motanti intorno ad un perno, nella cui gola scorreva lo stesso filo.

Con materiale per linee "eventuali" fu realizzato un collegamento di otto chilometri, in otto ore, attraverso boschi e lungo sentieri difficili, tra il Quartier Generale installato nei pressi di Gaeta (assediata) e Monte Tortona, sulla cui sommità aveva preso posizione una batteria di artigli eria.
Considerazioni e proposte in fatto di materiali telegrafici elettrici, basate anche sull'esperienza maturata nel corso di questa campagna, furon o formulate dal Matteucci.
Egli espresse, tra l'altro, un giudizio positivo sulla maneggevolezza e facilità d 'uso delle cassette portatili Morse (che sarebbero poi state utilizzate con modifi-
A sinistra : Ricostruzione storica - operatori telegrajìsti con cassettina telegrafica
A destJ·a in a lto: Cassettina telegmjìca "Morse " mod. 1860.
A des tra in b asso: Aljàbeto Morse.
ch e non sostan ziali fino alla fine della guerra 191 5-18) , ma criticò la fra gi lità e la sc arsa maneggev ol e:aa d e ll e pile Daniel, infe ri o ri a ll e Marie-Da\ry (adottate in seguito),già in dota z io ne ai tì·ancesi nella 2a Gu e rr a d' Indip e nden za.

Quan to alla mobilità del mate riale teleg rafico ele ttrico , il Matte1.1 cci osse rvò che le linee telegrafiche "vo lan ti " erano adatte ad aderire alle trupp e degli scaglio ni ava nza ti, in quamo il relat ivo mate riale poteva essere someggiato, ev ita n do così l'intralcio dei ca rri aggi che trasportavano i "rifornimcmi ". Viceversa il materiale per la costruzione delle linee "pesa nti ", che sarebbe stato "portato avanti a fatica fra detti carriaggi, av rebbe potu to segui re co n il grosso delle truppe " .
Le proposte eli Matte u cc i s paziavano p o i dal tip o d i filo da us a re , a ll a qualità deg li isolatori, a ll e d ime ns io ni ed al tipo eli legno da u sa re per i pali.
Nel 1863, per ini ziativa del Maggior Gen e ra le Cesare Ricotti -Magnani, Dire ttore Ge nerale delle Armi Spec ial i, vennero effettuate es p e ri e nze telegra fiche d a p a rte di una compag ni a di zappatori del Genio Militare. Sull a base di dette esperienze, vennero redatte le prime norme d 'impie go p er lo ste ndimento ed il ripiegamento delle linee. Si costitu irono, inoltre, i "d rapp e lli " e s i definì il "car icame nt o" de i materiali su app os iti carri.
Il l o n ovembre 1864, ve nne istituito in Alessandria il primo Ente dedicato a lle Telecomunicazio ni , "la Scuola telegrafica p e r le Truppe del Geni o", per Ufficiali s ubalterni, Sottufficiali e sold ati: i corsi dur avano sei mes i per gli Ufficiali e quatt ro mesi per gli altri fr e qu e ntatori. Da questa scuo la usciro no i primi t e leg rafisti d e l Ge nio che avre bb e ro preso parte alla 3a Guerra d ' Indipendenza.
La 3a Guerra d ' Indipendenza (g iug no 1866 - agos to 1867)
L' Ese rc ito Italiano a ll'inizio delle ostilità pot é sch ie rare quattro Corpi d 'Arma ta, il Corpo d e i vo lontari di Ga riba ldi e d una risetv a di liv e llo Corpo d 'Arma ta (cavalle ria e artiglieria ip po t rainata) per un tot ale d i o ltre 25 0.000 uomini.
L'E sercito Au striaco (Annata Imperiale d e l Sud ) potev a contare s u truppe combatte nti per un total e di 75.000 uomini e su tru ppe di pari e ntità dislo cate in fo rtezze e presidi de ll a Lomba rdia e de l Vene ro.
Il teatro d elle ope razioni si estendeva dalla parte orientale della Lombardia fmo al Veneto ed a l Friu li, dal P o alle P realpi Lombard e ed alle Dolomi ti .
Si trattava d i un 'area mol to ampia e difficile da gestire sotto il profilo delle "co municazio ni". Si imponevan o misu re con crete e s i cominciò , poc o dop o l'iniz io della guerra, con la pubblicazio ne delle "Norme su l Servizio Tele grafico Mil itare in Campagna n ei s u o i rappo rti con l'Ammini s t raz ione dei Telegrafi eli Stato", che sa ncirono l 'attribu zione al Ge nio Militare dell e responsa bilità della costtu z io n e e dell'ese rcizio delle linee teleg rafiche in guerra co n pe rso nale dipend en te e materi a le di dotazione. Furo n o e limi nati così qu e i co ntras ti che tanto aveva n o n oc iuto allo svilup po delle comunicazio n i militari e sopratlutto allo svil u ppo d i una spec ifica com petenza d ei militari. Alle op erazioni parteciparo no tre compagnie zappatori 15!! e 17'1) del l o reggin1ento Genio ed a ltrettante (9il, e 16") d el 2° reggimento Ge ni o, otien tate alla realizza zi o ne de i collegamen ti te legra fici. Il personale d i tali compagnie, p er la p rima volta impegna to in guerra in u na attiv ità rit enuta troppo impegnativ a sul pia no te cnico, n on solo non sfig urò per professionalità rispe tto al person ale c ivile, ma si distinse per abnegaz ione e spirito di sacrificio. In q u e lla oc casione, s i man ifes tò chiaramente l' es igenza di disporre eli un ad eg u ato
num ero d i unità militari nello specifico se ttore. Propri o da un te leg rafo da campo insta llato e ges tito da eletto p e rso n a le ve nn e trasm esso d a Bezzecca il famoso te legramma de l 9 agosto 1866, il c u i testo, co me scrive il De Rossi, comprendeva la sola parola "O BB ED ISCO " e la fi r ma de l gene rale Garibaldi.
Duranle la guerra vennero costruiti comu nque ben settecentotta nta chilometri eli linee ed impiegate centosessanta macchine telegrafiche.
Come è noto questo conflitto fu sfavorevole alle armi italiane che subirono a Custoza (giugno 1866) una sconfitta imputabile anche alla mancanza di coordinament o e di un coman do unificato (era stato ripartito tra Lamarmora e Cialdini). Gli unici s u ccess i ve nnero da Garib aldi che co n la battaglia di Bezzecca (luglio 1866) s i e ra aperto la st rada verso il Tr e ntine, ma venne fermato da ll e decisioni d e l Comando c ui rispose con il ce le bre c ita to te legramm a.
L'orga ni zza zione d elle co municazioni militari smo al 19 14
Si è già visto che la gestion e della telegrafia elettrica in tempo di gue rra passò, pur con qualche eccezione , n elle mani dei militari con l'inizio della 3A guerra d'indip e n denza.
I r eggime nti d e l Genio, in c ui era no inquadrate le comp agn ie za ppatori orientate ai collegame nti, alla fin e d ell e ostili tà, co n R.D. 25 ottobre 1866 e s uccessivi, vennero tuttavi a o rganicamente r idim ensionati. L'assetto dell'Arma del Genio subì ancora evoluzioni di scarso rilievo fino al 1873, anno in c ui venne promulgata una "Legge sull 'o rdinamento dell'Eserci t o e serv izi dipendenti dall 'a mministrazione della Guena ". Con questa legge si stabilì lo scioglimen to del "Corp o degli zappatori" e la costituzione dei due reggimenti del Genio, ciascuno comprendente una sezione telegrafi ca su un Ufficia le subalterno, circa sessa nta tra graduati e truppa, d ue carri stazione, un ca rro materiale telegrafi co volante ed una carretta di battaglione
Il l 0 gennaio 1883 avv en n e la sepa raz ion e tra zappatori te legra fisti e telegrafisti (s ul piano p uramente formale la deno minazione "zappato ri tclegrafisti" cambiò in quella di "teleg rafisti" solo più tardi co n R.D. 22 dic embre 1898).
Successivamente con R.D. 7 settem bre 1883, si s tab ilì l'orga nico di due Brigate zappator i te legrafisti , d i cui una s u se i compagnie inquadra ta nel 3° reggimento del Ge nio e l'alt ra di tre compagnie assegnata alla Mil izia Mobile (costituita regolarmente da elementi congedati dopo il primo biennio di ferma e dopo le successive rafferme annua li)
Sempre ne l 1883 la "Sc uol a Te leg rafica per le truppe del Ge ni o" venne trasferit a da Alessan dria a Firenze. Ne l 1884 ven ne pubblic ata una nuova "Istruzion e sul Servi z io Te leg rafico"
Con R.D. n° 4912 del 18 agosto 1887, l ' ordiname nt o dell ' Arma del Genio ve nne nuovamente modific ato Per qua nto ha tratto con le uni tà te legrafisti, si ebbe la suddiv isione delle sei compag nie del 3° reggim ento in due "Brigate" e l'aggi un ta di una compagnia specialisti, me n tre la "Brigata" della Milizia Mobile fu ridotta ad una sola compagnia (tu ltavia nell 'anno successivo l'organico venne ripristinato al livello del 1883).
Ne l 1893 venne pubblicata un 'istruz ione sugli "apparati telefo nici da ca mpo" (che sarà poi riveduta e comp letata ne ll 'edizione 1897) . Con questa istmzione il telefo n o da cam po entra ufficia lm ente n el parco m ateria li de l 3° re ggimento telegrafi sti e qu indi nell' e quipag g iamento dell ' Esercito Italiano .
Disegno tratlo da "Sulle origini della elettrica nell'Esercito Italiano " di Giovanni Giornellì.
Ricami alla goletta della tunica:
N. l Per lr;pettore Capo
N.2 Pm· Sottoispetture Capo a Verificatat·e
N. 3 Pe1· '-!ff1ciali d'ogni classe
N.4 Occhiello alla goletla della tunicct per la picco la divisa in etti il numero delle righe varia secondo i gradi
Ricami alle mostre delle maniche:
N.5 Ispettore Capo con tre righe, Sotroispettore Capo con due righe
N.6 con due righe, '-
Dall'alto:
-Distintivo per R.lv/.
- Distintivo per R. T
- rregio per· berretto 3° reggimento genio t elegrafisti - delle poste
- D is ti ntivo p e r carich e speciaU pe1· telegrafisti.
Con R.D. 15 ottobre 1895 il ''3° reggimento Genio", ri s trutturato, prese il nome di "3° Reggimemo Genio telegrafisti".
Il Reggim ento ebbe la seguente composi zione: Stato Maggiore;
4 "b r igate" zappa to ri-te legrafisti (dod ici comp agn ie) ;
l "brigata" s pecialisti dista ccata a Rom a;
2 compagnie treno;
1 deposito.
Nel 1896 fu pubblicato un "Regolamento sul servizio telegrafico in tempo di guerra", modific ato poi nel 1899 , e fu ado ttato un distintivo per telegrafista trasme ttitore.
Nascita della telegrafi a ottica
Alla fine della 3a Guerra d 'Indipendenza l'Esercito Italiano venn e in possesso di un comp lesso di mezzi di trasmi ssio ni ottich e aust ri aci che avevano ass icurato i co ll egamenti a breve e grande dis ta nza tra le fortifi ca zioni del "q u adrilate ro". Di tali mezzi alcuni e rano tipicame nt e legat i all'infrastruttura, altri , invece, poteva n o trovare impieg o anche in postazi one mobile. Qu esti ultimi poteva no quindi essere facilm enre adattati all ' impiego tauico.
Tra i primi, di minor interesse in quanto poteva essere considerato un ' evoluzione dei teleg rafi a segnali, ri entrava il telegrafo a sportelli per b r evi distanze Esso era costituito da una coppia eli spo rtelli qu adrat i, incernierati acl un muro. Detti sporte lli e rano di colore scuro da un lato e eli colo r e id en ti co a que llo de l muro da ll 'altro. A spo1tello alzato era visib ile, su l muro, il la to .scuro dello sportello, a sportello abbassa to esso era indistinguibile, a distanza. Era così possibile ottenere le seguenti combinazioni:
- uno sportello alzato = punto,
- due sporte lli a lza ti = una lin ea,
- sporte lli abba ssa ti = pausa
Il sistema te legra fico u tili zzava l'a lfabe to Mors e. Un rc leg rafista s iste mato a l di là del muro azionava gli sportelli con manovelle c funi.
Sempre del tipo infrastrutrurale era il telegrafo "della torre della gabbia di Mantova" che potremmo anche definire del tipo a "lame orientabili"
Era costituito da due serie di lastre metallich e applica te cias c un a ad una lastra vertica le . Ogni serie di lastre era azionata da una manovella che, tramite un s istema mecca ni co, le dispo neva in posiz ione orizz ontale o ver tic ale. A dis tanza, le las tre in posizion e orizzontale n o n .sa rebbero state vis te ( e quindi segna le nullo); mentre in posizione ve rtica le sarebbero s L:'lte viste come un ' un ica superficie (e qui ndi "punro" nel caso di una sola serie verticale, "linea" nel caso di due serie vertica li). In pratica questo sistema funz ionava come il precedente ma , dispon endo di superfici di segn alazione ma gg io ri, poteva rag giunge re magg iori distanze. Ulteriori vantagg i di questo sisten1a r ispetto a qu e ll o a spo rtelli e rano:
- possibilità di orientamento delle superfic i e quindi possibi lit à di co ll egamento con più corrispondenti, in qua nto le aste potevano motare into rno a l proprio asse e quindi essere orientate in direzioni diverse;
- adattamento all e condizioni di visibilità e eli luce, grazie alla diversa colorazione delle facc e delle lastre: colore scu ro su quella ante riore e colore ch iaro su quella posteriore . Ciò consentiva la sce lta delle 1ni gliori condizion i eli trasmiss ione: superfici chiare (forte illuminazione so lare) o scure (debo le illuminazione .solare).

I mezzi di m aggio r interess e e ran o, pe rò, q u elli di seg nalaz ion e o tti c i, in q u anto innova tivi so tto div e rsi as pett i e , come già detto, tra s p o ttab ili.
In particolare i telegrafi ottici, dotati d i p ropria sorgente luminosa (più s inteticamente definibili "diottric i"), erano adatti ai collegamenti nottu rni , in vers ione differente a se conda de lla portata ottenibile. Essi erano costitu iti essenzialmente da lam p ade m un ite di uno sche rmo manovrabi le a mano.
La version e p er i co ll e game nti alle brev i e medi e d is ta nze (fino a qu alche chilo m.e tro) utilizza va, ad u n estremo d e l co ll egame n to, du e lam pade vicine, p iù o meno pote n ti e da ll 'a ltro est re m o , un can no cc h iale
Co n ta li disp ositiv i era possibile trasmett ere il punto (d e ll 'alfabeto Morse) scop ren do la luce d i una so la lampada e la li nea scoprendole ent ramb e.
P e r gran di dista n ze e cio è tra Ma ntova e Veron a (35 Km ) e tra Mantova e Pa s trengo ( 37 Km) gli Au s triaci impi ega ro n o, nov ità assoluta in Euro pa , un' unica (per rag io ni d i costo!) g ra nde lam pada. La sorgen te e ra costit uita da u n arco voltaico a limentato da pile e d a un rifle ttore parabo lico ( di d ia m e tro di poco s u perio re al metro) in metallo argentato. I segnali venivano t rasmessi , ancora con codice MORSE , per mezzo di un man ip olatore o tasto ch e agiva s ulla d ista n za degli ele ttrod i e che quindi faceva variare la lum inosità de lla la m pada . I te mpi d i tras missio ne con i diottric i so p ra de sc ritti e ra no de ll 'ordin e di q u a lche ca ratte re al m inuto .
Il Cap ita no de l Genio Gae tano Fa in i e b be l'i ncarico di ana li zza re i s uddett i mezzi a ll o scopo di stab ilire q ua li e d in quale misura p otesse ro rispond ere alle esigenze d i co llegamento de ll ' Esercito Italiano.
E' a quell' epoca che si fa risalire la n ascita press o l'Eserc ito Italiano de lla telegrafia o ttic a, ed in particola re l' origin e degli a ppa ra ti d iottr ici e degli eliog rafi che saran no ut iliz zati durante le guer re d ' Africa (1895- 96), Ita la -Turca (19 11 -12) e la prima gue rra mo ndiale (1 915 -18) .

A sin istra:
Telegrafo ottico a lampada di petrolio per medie distan ze
A d estrd:
Telegrc!ft>ott i co aust riaco t td arc o voltai cc> per grandi distanze.
ln basso:
Apparato diottrico di media portata - Faini Conservat o presso l1stituto di Cultura dell'Anna del Gen io e delle Trasmissi on i di Roma
Colombaia militare autocarrata.
Nasci ta de lle co lomba ie tnilit ari
Nel 1876, probabilmente ispirato dalle informazioni circo late dopo la guerra franco -prussiana (1870-71) sui s uccessi ottenuti con i colombi viaggiatori, iJ Tenente Giusepp e Malagoli, in servizio presso U 12° reggim ento Art iglieria di Ancona, ca ldeggiò l'is t ituzione eli una co lombaia fissa m ilitare, a titolo spe rimentale .

In q u e ll a guerra ed in particola re nell'assedio di Parigi, i francesi avevano impiega to i colombi viaggiatori "]es ois e aux de paix enro lès pour la grande guerre", per collegarsi con le unità militari al fronte e con le provinc e A qu esto proposito vale la pena ricordare che, data l'enorme mole del traffico civile da smaltire, furono utilizzati processi di microfotografia per compattare i messaggi: si poté così soddisfare l'esi genza eli comunicazione di migliaia e migliaia di utenti con un numero di lanci r elati vamente ridotto .
Le spese re lativ e all'allestimento della colombaia , che in effetti so rse p resso la sede del predetto reggim ento, furono sostenute person almen te dal Colonnello Emilio Pon z io Vaglia, comandan t e del Ma lago l i, che aveva accettato con entusiasmo la p roposta del suo subalterno. L'isti tu zi one d e lla colombaia fu presto ufficializzata e ne vennero istituite ben dodici tra il 1878 ed il 1890.
I primi passi de lla te lefonia
Ne l 1835 l'italiano Antonio !Vleucci ebbe l'idea del ptincipio eli funzionamento del telefono, ma so lo nel 1871 ne venne accolta a New York la relativa domanda d i brevetto.
Nel 1864 il valdostano Innoce nza Manzetti realizzò il primo apparec chio telefonico .
Ne l 1876, a brevetto del Me u ccì scaduto (o per relativo incartamento smarr ito), lo statunitense Graham BeH depositò a Washington la domanda dì brevetto di un sistema adatto a trasme tt ere la parol a a d istanza pe r v ia elettrica.
Tra il 1876 ed il 1878 si ebbe lo sviluppo del microfono a carbone (mo lto simile a quello in u so at tu almente) acl opera eli Berliner, Rig hi , Ed. ison, Hughes Majorana e Vanni svilupparono invece un microfo n o a vena liquida (elettrolito contenuto in u n tubo la c u i resistenz a elettrica, misurata alle estrem ità del tu bo, veniva modulata dalle ond e sonore), che sarebbe poi stato impiegato nei primi esperimenti di radiotelegrafia.
Ne l 1878 venne installata la prima centrale telefonica n1anuale a New Haven (Connecticut, USA) .
Nel 1892 lo statun itense St rowger rea lizzò la prima centrale di commu t azione automatica (elett romecca n ica)
In campo militare furono sper imen t ati in Francia (a pa r tire dal 1879) e in Inghilterra (a partire dal 1882) i p rimi mode ll i d i telefoni militari, tutti a batter ia loca le. In particolare vennero esaminati i tipi:
- Berthon-Ader, sviluppato dall 'Amministraz ione Fra n cese de i Telefoni;
- Co lson , adottato dall'Esercito Fr:mcese ne i collegamenti degli osservatori di artiglielia;
- Mist-Genest, prima adottato dall 'A.nuninistrazione Tedesca delle Poste e poi dall'Amministrazione Mili tar e.
I primordi e la nasc ita delle trasmiss ioni radio
Negli "Annali de ll e Opere pubbliche di Napoli 1858-5 9" figura una memoria "so pra i parafulmini " de l Capitano del Genio dell"Ese rc ito del Reg n o delle D u e Sic ilie Francesco Sponzilli circa l a possibilità di una corrispond enza telegrafica "senza fil o a lc uno ".
Ne l 1859 l' ingegn e r e Cle rt-Biron presentò al Comando s up er iore del Genio dell'Ann ata piemontese una proposta relativa ad un telegrafo e leu:rieo p ortatile senza tìli (propagaz ione attrave rso il s uolo o geotelegrafia). La proposta , che avrebbe potuto accelerare lo s vilupp o d e lla radio, non venne presa in attenta considerazione

Ne l 1865 Maxwe ll e nunciò la fondame nta le teoria clell'elettrornagn c ti s rno
Ne l 1888 Hertz eseg uì le es perienze di trasmissione d e ll e o nd e e le ttromagnetiche nello spaz io c co nfe rmò che la propagazione di dette o nd e e ra in tutto id e ntica a quell a dell e onde luminose. Ciò consentì alla teoria eli Max\v e ll di passare da "geniale concezione mat e matica .... nell ' ordine dei fatti stabi liti " .
Il ted esco Munk (1835), l'inglese Varley (1866), l'inglese Hughe s (1879), l'italiano Calzecchi-O n esti ( 1884), il fra ncese Branly e l'inglese Lodge svilupparono il "Co h e re r" (o coesore o radioconduuo re), cioè un dispositivo ad uno o più "contatti imperfetti" fra pezzi o lirnatura di metalli in grado di rivelare onde elettromagnetiche.
:\'el 1879 il cohe rer, collega to in parallelo ad un ricevito re telefonico , permise allo Hughes di rivelare, a distanza di qualche centinaio di metri , il campo e le ttromagnetico originato da una sci milla
:\'el 1895 il ru sso Popoff mise a punto un s is tema ricevente in grado d i reg is trare le scariche a tm osfe r iche. L'attrez zatura era basata su un 'antenna ve ra e propria (s i trattava el i un 'as ta me ta lli ca eli un parafu lmin e o u n semplice filo verticale) collegata ad un ci rc uito co ntenente un coherer. L'apparecchiatura, p e r quanto el e tto , era srara co n cep ita p e r scopi di ricerca e no n di comunicazioni.
Ne l settembre 1895 !VIarcon i, a Pontecchio, reali zzò il famoso co ll egamen to rad iote legrafico ad un c hilometro e mezzo di distanza ( tratta no n in v is ibilit à ott ica).
La novità dell 'apparecchiat ura usa ta da Ma rcon i, come è universalmente ricono sc iut o, cons isteva esse nzialmente ne ll a fi n a lit à specifica tamente per co mun icazioni, n e ll e ca ratt e ri stiche d e lle a ntenne e nelle conness ioni a massa.
11 12 dicembre 1901 Marconi stabilì un collegamento radiotelegrafico (Morse) tra Polclhu (Corn ovag li a, Gra n Bretag na) e l'iso la di S.Giovanni di Terra nova neg li USA.
Per eseguire l' impr esa eg li utilizzò:
- un trasmettitore di g rande pOlenza alime nta to con alternatore m o n ofase di 25 Kil owatt;
- un'antenna tras mitte nt e a ventaglio;
- un 'antenna ricevente a filo sorretto da un cervo volante;
- un ri velatore spec iale denominato •·coherer R.M arin a ", in quan to svi luppato con il conco rso della Marina Italiana.
rel 1897 l' Esercito pubblicò le prime sperimentazioni di Ma rconi.
Nel 1903 a Firenze, sotto la direzione del Tenente Colonn e llo Maranto ni o (de l Gen io te legrafisti) , furono sperimentati appa rati a sdntilla con esito purtroppo negativo.
Nel 1904 per iniziativa del Capo di Stato Maggiore , Generale Sale tta, ve nne dato incari co a ll a Brigata Specialista (Magg . Moris) di reali zzare staz ion i di nu ova concezione avva lendosi de l concorso della ditta Ma rco ni. Le staz ion i sv iluppate furono fina lm ente impi egate con so ddisfaz ione unanime nell e vicinanze di Roma e ne ll e grand i m a novr e in Ca rn pa nia ne l 1905.
Nel 1907 ve1u1e istituita presso la Brigata Specialisti la p ri ma sez ione radiotel eg rafi-
ca, che ricevette in dotaz ione le prime stazioni rad io prodotte ( mod. 107 d a 1,5 Kw).
Con R.D. 23 sette m b re 1909 si costituì la Brigata Specialisti Autonoma, staccarasi dal 3° reggimento telegrafisti, comprendente due compagn ie spec ia li s ti, una sez io n e rad iot el egrafica, una compag ni a treno.

Ne l 1910 la Brigata specialisti cambiò nome e divenne battaglione specialisti Nel 1911 il 3° reggimento Ge ni o Te legrafis t i ragg iu nse u na fo rza d i sedici compag n ie tel egrafis ti .
La pritna Camp ag n a d 'E ritrea (1 885- 1889)
Il corp o di spediz io n e italiano, comandato dal Teneme Colonnello Tancredi Saletta, era costituito da circa 800 uomini. Le operaz ioni ita li a n e, tend e nti ve rso la conquista dell' impetvio a lt opiano e ti o p ico, fu rono tempo ra n eamente b loccate dal tri ste ep isod io di Dogali, ove un battaglione italiano , inviato a r inforzare i l pres id io di Saati, venne massacrato dagli Ab issini.
Con l'arrivo de l Gene ral e Asi n a r i d i San Ivla rza n o , dopo i dolorosi fatti sopra citat i, la forza della grande spedizione san a 18.000 uomini , inqua d ra ti in due Brigate e quattro batterie d'art ig li er ia.
Pe r q u anto a ttie n e alle comun icaz ioni, allo sba r co di Massaua partecipò un drappello eli zappatori telegrafisti (un Sottuffic ia le e nove te legra fi sti) d e l 3o reggiment o de l Genio dota to di stazioni t e legrafiche el ett riche e d i materia le per lo s te n d imento d i linee te lefon iche.
La s ec o nda Catn pagna d ' Erit rea (1895-1 896)
Fu avvia ta dal Crispi con il proposito di un'ampia espansione coloniale ve rso il Suclan ed il Tigre
Il Coman do Militare d ell a colonia c[L<;p oneva, all 'inizio delle ostilità, di q u attro Brigare di fante1ia per un totale eli circa sedicimila uornini (comprese le truppe incUgene).
Le forze avversarie si aggiravano su ce n tom ila uomi n i agli ord in i d i var i capi ab issini
Il tea tro de ll e o p e r azio ni fu q u ello della prima campagna, esteso a nche a ll 'a lt opiano etiopico per una profon d ità eli ce nt o-duece nt o c hil omet ri. Vi ebbe luogo una serie eli eve n ti sfa vorevo li , quali la sco nfi tta d i Am ba Alagi, la resa del forte eli Maca ll è e sop rattutto la d isfatta eli Aclua, dovuta in gran par te alla mancanza di collegamenti tra le colonne condo tte dal Ge n. Bara tti eri. In seguito a ciò con i rinforzi inv iati al Ge n erale Ba ld issera, succeduto a l Barattieri, giunse, nella primave ra de l 1896, un'a liq u ora del 3° reggimento Genio Te]egrafis ti (7 Ufficiali e 192 uomini di truppa) equipaggiata con rna teriale teleg ra fi co e lett r ico ed ottico Tale ma ter iale, già desc ri tto in p recedenza, sarà sostanzialmente lo stesso utilizzato anche ne ll a p ri ma guerra mondiale.
La Gu erra di Li b ia (1911 - 1912)
Il Corpo di Spedizione Italiano, a] coma ndo de l Gene ra le Ca rl o Caneva, comprendeva, all'i n iz io de ll e ostil it à (se ttembre 19 11), d u e Divisioni, servizi e t mppe sup pl e tive. Alla fi n e d el co n t1irto la forza raggiunse circa 100.000 uom ini.
Le forze turche ammontavano inizia lmente a circa 7 000 effett iv i, distribuiti tra
Tripolitania e Cirenaica .
Il teatro libico delle operazioni aveva un'estensione enorme (circa sei volte l'Italia) e , quindi, le esigenze di comunicazioni risultarono molteplici c complesse
Infatti, in concom itanza con lo sbarco, si dovev ano:
- te nere i collegame nti tra le test e d i sbarco e le navi a lla fonda;
- assic urare i co ll egamenti d egli oss ervatori con le navi per la dir ezio ne del fuoco;
- ass icurare i collega menti tra le località occupate , i Comandi e gli e lementi logistici;
- assicu r are i collegamenti d elle un ità in operazioni di penetrazione con i rispettivi Comandi.
Occo rreva , inoltre, collegarsi con i vertici militari in Roma.
Per soddisfare le predette es igenze furono in iz ial men te assegnate al Co rpo di Sped iz ione :
- una compagnia telegrafisti di Corpo d'Armata;
- mezza compagnia per la 2 ll Divisione operante in Cirenaica;
- una compa gn ia radiotelegrafisti con quattro sta z io ni radio (div enute poi se tte alla fin e d e ll e os tilità) cost ituita es pressamente per il Corpo di Spediz ion e .
All a fine del confli tto risultavano inv iate in zona di ope razioni le compag nie l 2 , 7il. e 9a del 39 regg imento Tele grafisti, la co mpagni a rad iotcleg rafì s ti e tre p loto ni auto nomi , di cu i u n o dislocato a Rodi.
Lo stesso giorno de ll o sbarco (18 ottobre) venne realizzato il collegamento radio tra il forte di Tripoli e la nave "Benedetto Brin" in rada e , successivamente, que llo tra Tripoli e il pa llone fren ato di osse rvazione d e l tiro naval e
Subito dopo lo s barco si provvide a riattivare più di duecento c hilome tri di linee tel egrafoniche tu rche alle quali furono connesse:
- se ttanta chilometri d i linee permanenti;
- trenta chilometri d ì linee vo lanti;
- otto chilometri d i linee inten-ate.
Gli apparati utilizza ti erano ventidue de l tipo tel egrafonico e settantaquattro eli que llo telefonico.
In Cirenaica lo sv iluppo dell e lin ce te legrafoni che fu più limi tato ri s p et to a quello della Trip olita nia: centoq uaranta c hilomet ri di li nee, due apparecc h ia ture telegrafiche, quarantasei sta zi oni telefoniche ed una centra le telefonica (installata a Bengas i).
Sia in Tr ip o litania, sia io Cirenaica ve nn e ro anche rea lizzati numerosi co llegame nti ottici per il co ll ega mento d elle ci ttà co n le località circostanti.

A qualche giorno dallo sbarco a T ripoli fu reali zzato il collegamento ra dio tra questa città e Lamp ed usa e poi con Vittoria (Sicilia). La sta zione rad io ubica ta in quest' u ltima locali tà ritrasm etteva il traffico d iretto verso le altre stazioni nazionali.
La quantità del traffico radio , sempre in aumento , richiese una regolamentazionc del servizio che fu e lab orata dal coma ndo della compagnia radi otclegrafisti ed app rovata dal Com a ndo del Corp o di Occ upazione (agosto 1912)
Le stazioni radi o in servizio erano eli due mode lli c he troveremo tra i mezzi rad io in dotazione (co n qualche modifica}·anche durante la guerra 1915-1.8 ed in particola re:
- la stazione radio da 1.5 Kw, carreggiata mod. 1907, del tipo a scintilla rada ;
- la s t azione radio da 1. 5 Kw, camme llabile mod. 1911, del tip o a sc intilla musicale.
La seconda de ll e due stazioni, ch e s i ri ve lò più affidab ile della prim a, co nsentì il co llegamento in co ndizione di propagazio ne favorevo le tra Tripoli e le c ittà eli
"Sta zione telefonica" camme llata. Pa r c o zappcttori de l Gen i oAfrica sett en trionale.
Derna (100 Km) , Mi s ura ta (2 00 Km) e Vittoria (5 00 Km).
Ma rconi s i rec ò in Libia a ll a fi n e cl e l 19 11 p e r verifica re la funziona iità d e i mezz i radio e per offri re la s ua co ll a b o razio n e a l p e rsonal e radiotelegrafi s ta. Ne l cors o della s u a p erma n e n za, in co ll aborazione con il Cap. Sacco, sp e r ime n tò u n'anten n a d irez io na le ri ceve n te <.:OSlituita da se mpl ice filo telegra fico lu ngo du ecento metr i circa, s teso nella d ire?. ione de l co ll egame n to. 1 risul ta ti de lle prove fu ro n o incoraggianti c le antenne del tipo in argomento trovaro n o applica?.ione per quasi un decennio.
Tn Libia furono anche sperimentate per la p rin1a volta, da metà dicembre 19 11 in poi, dopo la visita di Marconi, stazioni campali per fante ria (cioè, con po1tata più ridotta e per i collegamenti a i minori livelli) molto leggere, ma il loro rendimen to non fu ritenuto soddisfacente e vantaggioso rispetto a i me zzi a filo già in u so . Ciò avvenne s ia pe rché la limitata potenza di em issio ne le re se mol to soggette a d istu rbi , s ia p erc h é e rano legate ag li accu mul ato r i, p esanti e sog ge tt i a freq ue nti guasti ed a l gru ppo elett rogeno Pe r com un icazioni a bre v i di s tan ze s i r ite nnero per tanto più id o n ee le stazioni per ca va ll e ri a so meggiate C da 0.5 Kw) co n gruppo e lettrogeno indip e n dente . Dopo a ve rl e sperimentate c on buon es iro, s i propose di cosrruire co n qu est i mate ri a li un a s taz io ne t e legrafica mobile , da impi egare in caso eli avanzata.
Jn si nte si la g u erra di Libia fu un 'eccezio na le occasione per va lutare la ri sp o n-

d e n za dcglì organ ici e d el le d otaz io ni de ll e unità telegrafi st i c radiote le grafist i alle es igenze de ll e fo r ze in campo. Ammaestramenti preziosi furono tratti in particolare sulle prestazion i dei mezzi tecnici , soprattu tto radio e sui relativi crite ri d ' impi ego. Tali ammaestramenti sarebbero stati d i grande uti lità per preparare l'assetto delle Trasm ission i alla Grande Guerra.
I primi interventi p e r le pubbliche calamità
In occas ione del terr e m oto de l d ice mbre 1908 la 10 a co mpagnia del 3° Reggimento Ge nio telegrafisti venne in via ta in Ca labr ia e in Sicili a co n il comp ito el i ripr ist inare le linee te legrafiche dannegg iate. Il reparto operò con g ra nde efficacia ed abnegazione, nonostante le condizio ni d i lavoro proibitive , e ricevette da più parti riconoscimenti ed attestati di benemerenza al valore civile.

La Prima Guerra Mondia le
L'Ese rc ito Italiano schierò a ll ' in i7.io delle ostilità trentacin que Divis ioni , di cui quatt o rdici ( P , Arm a ta e Corpo de ll a Ca rnia) su l confin e tra Ste lv io e Carnia ,
Sop ra: Stazione R T. da 7,5 KW - A:fi·iccl orientu le.
i'\ella pagina a fianco, in alto: S .M. il Re d'Italia Vittorio t:manuele Ill in visita al frontel" Guerra Mondiale.
In basso a sinis tra: Gua1·dafili a/lavo ro.
Al cen tro: J\!Iilitari Guardafili al laooro durante La 1" Guerra i\llondictle.
A destra: Militare telefonista al fronte7" Guerra Mondiale .

esteso per 100 chilometri, e quattordici (2ll e 3ll Armata) sul confìne cleii"Tsonzo, esteso per 90 chilome tri , e se lte in riserva strategica.
Nel corso della guerra il numero delle Divisioni salì a cinquantuno a cui se ne agg iunsero sci straniere (tre inglesi, due frances i ed una cecoslovacca).
Le esigenze eli comunicazione da soddisfare già eli per sé molteplici e gravose, in relazione alla configuraz ion e del dispositivo sch ierato ed alla vast ità elci fronte, erano in cont inua evo luzione con l'aumento delle Grandi che s i formavano e con il moltipli cars i di arm i, speciali tà e servizi.

la vulne rabilità delle linee te legrafo niche in zona eli operazioni e le diffico ltà eli st e nclim e n to in r a rri colari sit uazioni (penetrazione in zone co ntroll ate dal nemico o in prese n za di terreno diffici le) imponevano la disponib ilit à di n"\ezzi alternati v i qua li i te legrafi Olli ci, i m ezz i radio, la geote legrafia e, ov e le c ircosta n 7.c lo permettessero, i colomb i v.iaggiatori.
Le lin ee te leg rafoniche, destinate a co llegare Gra ndi U nit à o a co nnettere la rete milit a re con qucll.a civile, dovevano rispondere ad elevati standard di qua lità, otte nibili so lo co n l' impi ego d i materiale per linee permanenti, con conseg uente aggravio di lavoro per le unità telegrafisti.
Occorreva, in o ltre, potenziare col personale telegrafisti gli uffici telegrafìci civili per smaltire il traffico enormemente aumentato rispetto ai livelli in tempo dì pace. l telegrafisti cd i radiotelegrafisti dovettero, infìne, col progredire delle operazioni , arr ivare le p1ime misu re di guerra eleuronica, quale l'intercettazione telefonica e quella radio.
A tutto questo le compagnie di telegrafisti e radiotelegrafisti, ancorchè potenziate nel corso del conflitto, non erano in grado eli far fronte. Fu , tuttavia possibile realizzare , anraverso un 'acc urata gestione delle risorse disponibili ed i provvedimenti di cui si farà menzione, le reti di comunicazione e eli intercettaz ione che, consentendo un a efficace az ione el i coma ndo , contribuirono validamente a ll a vittoria finale, come ri co nosci uto dalla motivazione della medaglia d'oro confer ita a ll 'Arma del Genio.
Le a ttivi tà spccifi<.:he svolte dalle varie compagnie telegrafisti in Italia o in a ltri teatri eli operazione so no riportate nella monografia del Capitano Vezio Ange ll ott i.
Evolu zione delle unità telegrafis ti durante il conflitto
Co n la mobilitaz ione, le compagnie telegrafisti furon o portate da sedici a venticinque. Esse vennero asseg nate al Comando Supremo , ai comandi di Corpo d'Annata e ad En ti territo ri a li eli rilievo (fortezze e zone el i frontiera), menrrc alle Di vis ioni di cavalleria fu au ribuita una sezione telegrafica
Gli organi direttivi del Servizio, sempre all'inizio del conflitto, erano:
- l'Ispettore Capo del Servizio Telegrafico militare presso il Comando Supremo;
- gli Isp etto ra ti del Servizio Telegrafico di Armata.
Duranre le ostil it à fu assegnata al Corpo d'Armata una seconda compagn ia telegrafisti orientata alle comu nicazioni dell 'attiglieria del Corpo d'Armata in sostituzione di spec ial i se7. ioni telefoniche in forza alle unità d 'a rtiglieria.
Alla fine eli settemb re 1916 si raggiunse la forza di c inquantadue compag nie tele g rafi sti e quattro sezion i te legrafic he per cavaller ia.
Tale or din amento rimas e inalterato fino all'ottobre 1917, quando il nume ro delt e compagnie teleg rafis ti fu portato a settanta, mentre non variò il numero delle sez ioni te leg rafiche p e r cava ll e ria.
Ne l geru1aio 1918 s i addiven ne acl u n ordinamento definitivo che prevedeva:
- la tra s formaz ione d e ll e 57 sezioni divisionali , g ià compagnie :tapparori, in
Colo mbo v iaggieti. Oré c on tas c h e tta po1·1a o rdini
compagnie telegrafisti c on parco ri d o tto;
-l 'assegnazione di una seconda compagnia ai Comandi d 'Armata;
- l' alleggerimento degli organi c i e dei mezzi delle due compagnie di Corpo d' Arrn ata, ri ve latis i trop po pesanti
Ne ll 'ott obre d e ll o stesso an n o g li e ffe ttivi dell e compag nie c sez io n i te leg rafis ti e ra no o rm a i scssa nt a mil a e p o te vano ass icurare i co ll ega me nti telegrafon ici fi no a l li vello g rupp o d i a r tig lie ria e b att ag li one eli fan te ria. TI bat taglio n e di fa nte r ia re a li zzava i collegamenli al suo int erno ''con i no r mali mezzi di corrispondenza "
Ev
All 'inizio de ll e operazioni erano state formate , con personale e mat e riali provenienti da l 32 reggim e nto, 9 sezioni rt.tdiotcleg rafiche ciascuna su due stazioni radio mobili. Ess e furono così ass e gn ate:
- una a l Com a n do Sup r emo;
- u na ai q u a tt ro Co mandi d i Anna ta;
- una a i q uatt ro Co mandi di Div is io n e di Ca va ller ia.
Com p letavano le dotazioni dodic i stazioni radiotelegrafiche fisse di slo cate ne l te rrito rio di frontiera e dipendenti dalrufficio radiot elcg rafico di T revis o.
In totale si dispo n eva d i tre n ta staz io n i, di cui diciotto mobili e dodici fisse.
Fu pres to ri conosci uta l'i n ad eg u a tezza di org a n ic i e d o ta z ion i rispetto a ll e es ige nze Vers o la fin e de l 191 6 le sez io n i r.t. div e n n ero se d ic i. Qu esto num e ro non va r iò p e r tutto il 1917, ma aum e nta rono le stazion i rad io, ta n to d a p o te rl e as s e gn ar e anc he ai Comandi mino ri.
Dal 19 18 le sezio ni r.t. d 'Armata assu n sero la respo n sabilità del Servizio Radiotelegrafico di Aeronautica fino ad allora autonomo. Ciò, allo scopo di coord inar e a l m egli o l'impiego dei me zz i r<tdio ne ll ' area d i gi urisd izione de ll 'Armata. Alla fi n e del la g u e rra p er g es tire le nuo ve attivi tà p rev is te p er i r acl iote legrafisti (se rvi zi ae ro lo g ico, m e te oro log ico, r a diogo n iom et r ico e d'i n t e rce tt az io n e) , fu dis p osta la cr eazione d e lle sezi o ni r.t. d i Corp o d 'Armata. Si s arebbe ro così avute:

-u n a sezione r.t. ed un a sezio n e ra di ogoniom et rica presso i Coman d i di Armata;
- una sezione r.t., con form azione d ivers a a seconda de lle e s igenz e, per Co rp o d 'Armata , D iv is io n e di Ca va ll e ri a e Gra n d e Uni tà auto n oma
Ques to se r viz io f u por taro in campo tattico all ' inizio delle os tili tà e fu d is impeg na t o con p erso na le pr eval e n teme nt e t elegra fi sta. L'a tt iv it à fu in iz ia lment e s v o lta p e r m ezzo eli una colo mb a ia a ll es ti ta ne l F r iu l i Ne lla p r ima ve ra del 1917 r is ult a va n o im pi ega te n e ll e a ree di co mp e te n za d e ll a za e 3a Arm at a ben cinq u e c o lo mb a ie . :\ell'otrob re 1917 il numero delle colombaie salì a tren taquattro , di cui trenta alle Ar mate e quattro a dis p os izione d el Com an do Supremo.
Nell'a nno success ivo l'organizzazione del servizio ragg iunse il mass imo svil uppo con sessan tac in qu e colombaie e nove mila col omb i Pa Jt ico la rme nte e fficace s i mostrò l'u tili zzazione d e i colo mb i durante le battag li e del Piave c el i Vi tto rio Ve n eto.
oluzion e de lle u n ità radiot e le g r a fisti du ra nt e il c o nflitto
Il se rvizio colo tnbi v ia gg ia tori
L'intercettazione telefoni ca
l fatti all ' origine eli q u esta attività r iguardano :
- nel settembre 1915, zona Carnia e sul Monte Rosso (53A Divisione d e l IV C.A.), la ricezio n e casuale , da nostre stazioni te lefoniche, eli fonogra mmi austriaci;
- nell'au t unno del 1916, sul Carso, per l'ammissione di prigionieri austriaci, circa l'interce tt azione eli nostre trasmissioni te lefonic h e da parte nemica;
- nel novembre 1916, su l coston e Viona del Carso, la cattura di una cassetta telefonica eli tipo non conosciuto, che più tardi si scoprì esse re un apparecchio inte rcettatore austriaco.
E' sopratt u tto quest 'ultimo evento che diede lu ogo alle direttive per l'app licazione di misure di inte rc ettazione dei segnali emess i dal nemico e di contromisure protettive delle nostre trasm issioni telefoniche e telegrafiche.
Con l'opera di valenti Ufficia li (Co lonne llo Guasco e Ten en te Pellizzi che condussero, indipendenteme nte , una preziosa attività sp erimentale e te cnica in materia) f u possibile d otars i de i mezzi tecnici necessar i a ricevere i segna li telefonici nemici. I primi di detti mezzi, realizzati secondo le più avanzate tecn iche e tecnolog ie di allora , en t rarono in servizio nel settembre -1916 pre sso il primo Centro di Intercettazione Telefonica della 2ll Arma ta.
Trasmissioni e d intercettazio ni iniz iarono così il loro inseguimento, come n el caso de lla classica gara corazza-cannone , che ved e acl una contromisura contrapporre una contro-co ntromisura se mpre più ardua e costosa. L'Eserc it o austriaco adottò alcuni provvedimenti certame n te e ffìcaci, ma non tali da precludere drasticamente ogn i fo r ma d i intercettazione. Tra di essi si evidenziò l'el imi nazione di circuiti mis ti (cioè quell i con un ico filo , co n ritorno a terra), che r idusse d i molto la portata dei sist emi eli intercettazione.
Con l'imp iego di amplificatori a tubi ele ttronici appron ta t i dai nostr i tecnici e con l'audacia dei nostr i in tercettatori (che dovettero porre i sensori in pos izioni
In al to a s inistra:
Colomba ia militc11·e mobile (1"imorchio)
In a lto a destra : Colombo viaggiatore con mac china fotografica per riptese aereeanno 1930.

Al ce nt ro:
Accessori per colombi viaggiatm'i, cesta con pamcadu.te.
Qu i sopra:
Tessera dell'Ass ociazione Colomhieri italiana rilasciata a Gabriele d'Annunzio
sempre più prossime alle linee nemiche) fu ancora possibile ricevere le conversazioni telefoniche del nemico.
I successi ottenuti con questa attività furono premia ti da un compiacimento scritto del Generale Badoglio, capo di Stato Maggiore del Comando Zona di · Gorizia, diretto al Comando Genio della stessa zona (9 maggio 1917).
Gli albori della guerra elettronica
Il mezzo radio è un mezzo "indiscreto" per sua natura. Di ciò erano consapevoli Marconi e gli altri "addetti ai lavori" dell'epoca che in vest irono notevoli risorse nella "segretezza" intesa come sintonia (cioè nella emissione e ricezione a banda il più possibile stretta e chiusa) e concentrazione della radiazione n e lla so la direzione voluta. Questi , p e rò, fu rono solo i primi approcci; infatti all'inizio della Grande Guerra gli austriaci ed i francesi avevano sviluppato una certa capacità in a lcu ni settori della guerra elettronica. Gli austriaci, in particolare , già dai tempi della Gu erra di Libia, avevano istituito 1.m servizio eli intercettazione che aveva come obiettivo i nostri collegamenti radio di maggiore portata, riuscendo a s e guire le nostre operazioni per tutta la durata eli quel conflitto. Gli stessi austriaci sul fronte occidentale erano in grado, all ' inizio della Grande Guerra, di fornire all 'allearo germanico informazioni pregiate ottenute attraverso l'intercetta zion e radio. Gli Eserciti Inglese e Francese disponevano di un serv izio di interc ettazio ne al livello di quello Austriaco.
I francesi avevano associato n e llo stesso sito (ne allestirono cinque) un centro d'intercetta zione ed un radiogoniometro. Tsiti erano poi collegati tra loro. Allorché il centro d'intercettazione rivelava una nuova emissione questa veniva seguita fino a che non veniva localizzata.
Quan to a lla capacità italiana in fatto di guerra elettronica, si è fatto già cenno alle attività eli intercettazione operate dai radiotelegrafisti ed ai mezzi impi e gati. Per la radiogoniometria non si dispone di notizie sul relativo impiego nelle operazioni terrestri. Le uniche indicazioni disponibili riguardano esclusivamente l'istituzione (che con ogni probabilità non ebbe seguito per la fine della guerra) della sezione racliogoniometrica presso il Comando Supremo, nel 1918. In ogni caso si ritiene che non esistessero problemi sul piano tecnico per la r ealizzazione eli racliogoniometri manuali (come quelli in dotazion e agli altri Ese rciti). E' degno di nota quanto il Solari circa l'attività svolta in proprio da Marconi. Questi utilizzò nella sua v illa al Gianicolo in Roma, verso la fine del conflitto, un 'a ntenna a telaio girevole, collegata a cl un "sensibile apparecchio ricevitore a valvola" , per l'intercettazione d e lle comunicazioni dei belligera nti. Marconi poté cosi ven ire a conoscenza dell 'abdicazione del Kaiser, prima dell' annuncio ufficiale.
La cifra
Fu nella Grande Guerra che l'ermeticità dei cifrari, fino ad allora piuttosto bassa, divenne più accettabile grazie alla utilizzazione del cifrario Rosso a repertori intervertiti di 1000-4000 gruppi cifranti, cambiati ogni due o tre mes i a seconda che fossero cifrati o sopracifrati. Vi apparvero anche dispositivi meccanici di cifratura, che rappresentavano una evoluzione del "elisco eli Wheatstone", datato 1887 . .Altro avvenimento eli rilievo in materia di cifra , che si verificò durante la

Grande Guerra, fu l'utilizzazione della cifra "ìn linea". A questa ca tegoria apparteneva il dispositivo Vernam. Questo, che era una vera e propria cifrante telegrafica in linea (con alfabeto tipo Baudot a 5 elementi); secondo iJ Sacco fu utilizzato nella guerra 1915-18 anche su reti radio. Detto dispositivo era in grado di ottenere la cifratura di un testo chiaro impresso su una zona (nastro di carta) perfo rata mediante la chiave di pcrforat ura impressa su una seconda zona perforata.
La geotelegrafia
Un nuovo mezzo dì corrispondenza impiegato durante la guerra 1915-18 fu la geotelegrafia, ossia la telegrafia (senza fili) attraverso il suolo. Tale mezzo (d i cui fu precursore il Clert-Biron) v e nne preferito come collegamento con le zone più avanzate, perchè meno vulnerabile rispetto alla telegrafia elettrica convenzionale La vulnerabilità riguardava sia le linee esposte ai tiri dell'artiglieria sia il personale costretto a stendere le linee sotto il fuoco nemico.
Il collegamento g e otelegrafico veniva realizzato mediant e stazioni di produzione francese e sonde infisse n e l suolo collegare a dette stazioni. Le portat e raggiungibil i variavano con la natura del terreno (sabbioso, roccioso o acquitrinoso) e d erano into rno ai 2-3 chilometri.
Oltre allo svantaggio di aver portata limitata, le trasmiss ion i geotelegrafiche era no s uscettibili al disturbo di correnti vaganti o telefoniche presenti nel terreno, oltre che facilment e intercettabili e mutuamente int e rfe r e nti . Comunq u e anche questo mezzo, caratterizzato da un numero di difetti maggiore dei pregi, trovò la sua nicchia di impiego e costituì alternativa valida al telegrafo, in particolari condizion i.
Considerazioni finali
Il sis t ema di comunicazioni dell'Esercito nella Grande Guerra raggiun se una grande complessità. Conseguentemente non poteva più essere gestito da Quadri e personale di spec ialità intercamb iabili con le altre branche del Genio. Il personale addetto alle comunicazioni doveva distinguersi, per specifica preparazione professionale, da quello delle altre specialità del Genio e possedere spiccata pront ezza a predisporre, anche senza attendere ordini precisi, opzioni di collegamento adatte, affidabili e tempest ivament e utilizzabili, senza alcun vincolo per le decisioni del Comandante. Ciò in virtù del valore operativo assoluto che ha la trasmission e tempestiva, in tutte le situazioni, della volontà dello stesso Comandante alle unità e agli organismi d ipendenti. Va ricordato ad esempio, che concors e ro non poco, all'in fausto esito della battaglia di Caporetto, le interruzioni delle linee te lefoniche che pilotavano il tiro delle artiglierie del C.A. e l' interdizione dei sistemi di comando e controllo n ell'ambito della 2ll Annata.
Irresponsabile fu anche il mancato uso delle informazioni acquis ite attraverso l'intercettazione e la carenza di mezzi sostitutivi alle linee te lefonich e fisiche.
Qui sopra: Due esempi di macchine ccttrici, rispettivamente: Enigma Gennania e O.M.J. Nistri Italia (Collezione Cremona).
Sono: Stazione .RT in valigia per servizi segreti tipo T.XO - oca - italiana (Collezione Cremona).

DAL PRIMO DOPOGUERRA AL SECONDO CONFLITTO MONDIALE


Il pritno dopogu erra: segna li di tendenza
Gli albori del primo d opog uerra reca no, p e r le Trasmiss io ni , alcuni seg n ali premonitori di una loro più s pic cata ident ità c he s i a ndrà poi progress ivamente affe rm and o. Già ve rso la co nclu s io n e d e l primo conflitto mond ia le si era venuta fa ce nd o chiara la consapevolezza che il mezzo rad io av re bb e a ssu nto un imp o rramc ru o lo nella condotta de ll e o p erazio ni mi li tari.
L'i ntroduzione di m ezzi di offesa semp re più po ten ti av rebbe avut o immedia ti rifle ss i di g rande rilievo sull'organizzazione delle Trasmissioni.
Il frazionamento delle forze , la loro mobilità, gli aumenrati rapporti di distanza , la necess ità della cooperazione tra le varie armi , l'aumenrata velocità dei verrori di offesa, avrebbero potuto determinare il collasso dell'azione di comando c controllo se, in parallelo, la scienza e la tecnica non avessero permesso di sviluppare nuov i e più efficienti mezzi eli collcgamcnro, specie radio , in grado di fa r fronte agli accr esci uti e più comp lessi co mpiti delle Trasmissioni.
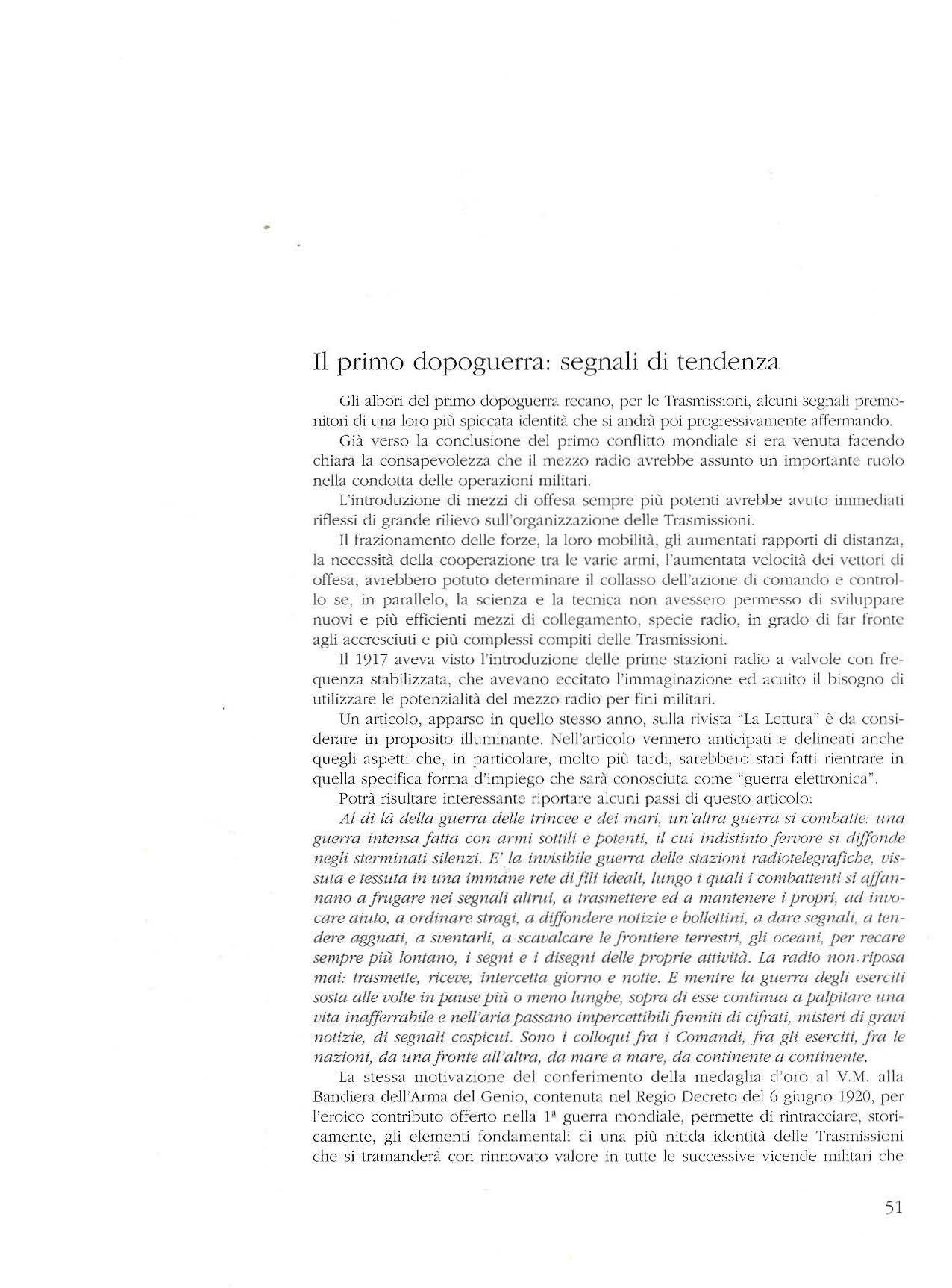
Il 1917 av eva v is to l' introduzione delle p rime staz io ni radio a valvo le con freque nza stab iliz zata, ch e avevano ecc itato l' imma g inazione ed ac u ito il bisogno el i u tilizza re le potenzialità d e l mezzo radio per fini militari.
U n articolo , apparso in qu e ll o s tesso a nn o, s u lla r iv is ta "La Le tt u ra " è d a co n s iderare in prop osito illu minant e Ne ll 'a rtico lo ve nnero anticipali e d elineat i a nc h e qu egli aspe tti che, in pa rti co la re, molto p ili tardi , sa reb bero s ta ti fa tt i ri ent ra re in qu e ll a s p ecifica form a d'impi ego che sarà co no sc iu ta co m e "gue rra e lett ro n ica" .
Potrà risultar e inte r essante ri po rta re alc uni pass i d i q u esto artico lo:
Al di là della guerra delle t1'incee e dei mal' i, un 'altra guerra si combatte: una guerra intensa fatta con anni sottili e potenti, il cui indistin to jeruore si d([(onde negli stenninatì silenzi. E' la invis ibile gue rra delle stazioni radiotelegmficbe, v issuta e tessuta in una inmzane rete di fili ideali, lungo i quali i comba ttent i si ajfa/1nano a fruga1'e nei segnali alt1-ui, a trasm.ettere ed a mantenere i propri, ad in mcare aiuto, a oniinare stragi, a d([fondere notizie e bollettini, a dare segnali, a tendere agguati, a svent.arli, a scava/cetre le ji·onliere terrestri, gli oceani, per recare semp-re pitt lontano, i segni e i disegni delle proprie attività. La r-adio 1lOI/. riposa mai: trasmette, riceve, intercetta giorno e notte. E mentre la guerra degli eserciti sosta alle volte in pause più o meno lunghe, sopra di esse continua a palpitare llllCI vita inajjèrrabile e nell'aria passano impercettibili ji-emiti di cifrati, misteri di gravi notizie, di segnali cospicui. Sono i colloqui fra i Comandi, fra gli eserc iti, fra le nazioni, da una fronte all 'altra, da ma re a mare, da continente a continente La stessa motiv azione de l co nfe rim e nto della medaglia d 'oro a l V.M. alla Bandiera d e ll 'Arma de l Ge ni o, co nte nuta ne l Regio Decre to de l 6 g iu g n o 19 20, p e r l'e roico contributo offerto n e ll a P guer ra mo nd ia le , permette di rintra cciare, s toricame n te , gli elementi fond a me n ta li d i un a più nitida identità d e lle Trasmissioni che si traman d e rà co n rinn ovato valore in t ut te le s u ccess ive vicend e miliLari c he
A s in istra : Stazione da Kw .1,5 a scir11illa someggiata.
In basso a s i nb Lra: operatore in adele stmmento con Stazione RF 1-2.
l n basso a des tra : Stazione RF .l lra:;portata a

Qtl i SOtlO: Autostazioue R - 5 - rista laterale.
In basso: Opera tori del Ge ni o Radiotele{l. ra:.fìsti- co llep,am e nti w n stazione radio tipo NF 2.
l e hanno vim e co invo lte.
Vale la penn qui ricordare le ele,·are parole di questa motivazion e. clcsrinate a costituire il motivo di orgogl io più p er ogni riann odando, sotto l 'urap,cm o del ferro e d elji wco . i tenui ji1i o 11 de passa l'intelligenza re,!!,olotrice clelia l?attap, lia, !anc ia1l dosi alf'assctfto in Rpicu ,!.!,O rcJ con i fan ti s i prodigò co n ed eroismo per la grancle:z:z-a c/pffa Patrio
I ri fle ss i sulle trastnissioni dell 'evoluzione orci inativa de ll 'Esercito da l 191 9 al 1939

TI period o cons ide rato, ch e abhnt cc ia 4 lustri. si ca nnte riz:t.a p f' r un a m ;tr cara evoluzione de l l e Trasmissioni p ia no o rdi n ativo.
La conclusione della P guerra mondiale ru seguita dall'introduzion e del nll<''·o ordi namento del 1919, che prese il nome dell'allora Minisr r o Creneral e A.lhricci. Questo ordinam e nto doveva servire a snelli re l'orga ni sm o militare nel suo insi eme. Le U nità de ll e Tr:t!im i ss ioni furono r i dotte a co mpl es siv i 15 ba rt ag ll oni Genio racliote l egnlfisli i nq uadrati i n 12 r egg iment i m isti de l Gen io , u no p e r ogn i Co rpo d 'Armara, cd i n un r eggimento G e nio radiotelegrafi sri.
:\'el 1920, ad un a nn o dalla sua introduzione, l'ordinamento A lhri cc i fu sostituito daH'ordinamemo Bonomi, allora Presidente del Consiglio dei _\lfinislri , che ridus-
se a 10 i.l numero dei Corpi d 'A rmata, pe r moti v i el i o rdine economi co. Conseg u e nt emen te le Unità d e ll e Trasm iss ioni furono ridotte a 10 b a tt aglion i ed un regg imento Ge nio Hadiote leg rafist i.
C\e J nuovo quadro ordinativ o che n e seguì, continuarono a cl esse re mantenu ti:
- l'I stit uto Ce mra le Militare di Racl iote legrafia ed El<:!ttrotecnica , costituito n e l 1916 per trasformazione del preesistente Istiruro M ili t are Superiore eli Kadiotelegraria fondato nel 1911;

- l'Officina Mil itare di Radiotelegrafia ed Elettrotecnica cost ituita durame la l" guer ra m ond iale.
Ulte riori elementi di inform az io n e s u questi importanti E nti possono essere att inti n e ll'Ap p endice n .S.
Tra il 1922 c il 1926 l'O ffi c in a s i vide affidare il comp ito el i stu diare nu ovi ti pi el i s ta7.i o n i n 1dio ca m pali ba:;at e su ll e nuo ve tecnol ogie affe rmates i con l' introduz ione dei t ubi e le ttronici.
a l p er iod o in d icato Jo sv ilupp o e la r ea li zzaz ione da part e dell'Officina di mezzi di riconosciuta validità sul piano tecnico ed o p e rati vo, tra i qua li si possono ricordare:
- le stazioni radio V1, V1 bis e Vl re r;
- le s tazio ni radio ad onde co rte Rl , R2, R3 , R4 , R5 ;
- la RF- 2 acl ond e co rte;
- i p o st i r iceven ti RA-1 e RA -2 p e r l'asco lto eli trasmiss io ni da aeromobili in vo lo;
- i eli intercettazion e rad io 1:{ 1-1 e RI -2;
- il racl iogon iorn ctro portat il e GM33 -RGP ed il racliogoniometro au to trasportato
G!\1133-HGA
:\etrEsercit o di campagna , il Servizio radiotelegrafico fu affidato in pa1te a radiotclegrafisti del G enio ed in parre a specialisti delle Varie Anni.
Ai primi ve nne affidata la gest io ne dei collegamenti dei Co mandi di liv e ll o s up erio re ::1 quello di reggin1 e nto c dei colle gamenti radi o per a lcuni Se1vizi s p ec ia li q u ali l'ant iae reo, l'a e r eo log ico e l' id rome tr ico, nonché i co ll ega m enti del servizio el i r:1cliogo niomerria c el i q u e ll o di int e rcettaz io n e te le fonica.
Ag li <1lt ri, invece , f u affidata la ges tione dei coll egam e nti rad io d ei Comandi el i li vello infe r iore, s in o a livello regg im e nto escl u so.
L'ordiname nto introdotto nel 1923 d a l Maresciallo d ' Ita lia D iaz , nella sua ves te di Ministro de ll a Guerra, trasformò i reggimenti misti del Genio in ragg ruppamenti Genio eli Corpo d'Armata, costituiti da u n ità delle specialità zappator i, minato ri e telcgrafisri.
Nel 1926. con l'introduzione de ll 'o rdinamento tern a ri o per le Division i, i raggrupp<ll1ìcnt i Gen io di Corpo d ' Armata ri cl ivent.aro no reggime nti misti del Genio, aJt icola ti s u tre battagliÒn i, d e i quali uno telegrafi st i Il num e ro co mplessivo el c i regg im e nti m is t i ven n e portato da lO a 11 , pe r poter co sì sodd isfa re, o lt re a lle esige n ze d e i 10 C. A. di s locat i sulla pen iso la, anc h e que lle dei nuovi Co mandi Militari d e ll a Sic ili a e della Sardeg n a che furono assimilati, rispetti vamenrc, a d un Comand o eli C.A. e a cl un Comando di Di v isione. Per cìascu no di qu est i due Comandi fu inizialmente prevista una compagnia te legrafisti autonoma Successivamente queste due compagnie vennero inquadrate in d u e diversi battaglioni.
Nel 1923 era stata attuata intanto la u asfo rmazione d ei battaglioni misti del Genio dislocati in Afr ica Ori entale in battag li oni speciali Genio A.O. che verranno poi i nt eg ra li , all'a tt o d ella mobilitazio ne del giugno 1940, ne l reggimento s p ec iale Genio A.O, d i sta nza in Addis Abeb a. Detti battaglioni e rano co s tituiti d a soli effettivi n a ziona li.
L'esigenza di copr ire, in o ltre , il vasto terr itorio della coloni a ita li ana in Afri ca, richiese una accresciuta disponibilità di mezzi rad io e la conseguente cost ituzione di un secondo reggimento Radiotelegrafisti.
Nel 1927 il num e ro co mp lessiv o dei Co r pi d ' Armata terr itoriali fu portato a 12 , e cos ì il num e ro d e i r eggi m en ti m is ti Ge nio.
N el 1932 venn e ro sciolti i du e regg imenti racl iote leg rafisti e g li dfc rtivi rcc uperati vennero de st in a ti a i battaglioni tclcgra fisti di C.A., per ognuno dei quali fu rono previste due compagnie releg rafisti ed una compagnia radiote legrafisri.
Nel 1934 le Trasmissioni risulteranno così ordinate:
- per il territo ri o nazio n ale:
• batta glioni lelegrafis ti in quad rati in 12 r egg imen ti Ge nio di C.A. metropolitani;
• Istituto Militare Sup eriore de ll e Tra s mis sioni;
• Officina Radiote legra fi ca ed Elettrotecn ica.
- per le colonie:
• una compagnia telegrafisti ed una Sezione [C[egrafisti per la Tripolitania;
• un a comp agn ia mista zappatori-telegrafisti ed una Sezione racli o telegrafisti per la Cir e naica;
• una compagnia comp osta da teleg rafisti e racl io te leg rafisti per l'E rit rea;
• un a compagnia mista de l Genio pe r la Soma lia.
11 1938 vede il ritorno alle Divisioni binarie che caratterizzò il riordinamento dell ' Ese rcito voluto dall 'aUo ra Sottosegretario di Stato alla Guerra, Gen. Pariani. Il riordinamento porrò a 20 il num ero dei Corpi d ' Armata che comp less ivament e 63 Div is ioni.
Le Un it à d e ll e Tras miss ioni fur o no art icol a re in:
- 17 battagli o ni misti collegamenti per i C.A. no rm ali, ognuno su 2 compagnie telegrafisti ed una compagnia radiotelegrafìsti ;
- 2 compagnie collegamenti, u na telegrafisti c una marconisti. inquadrate nel baaaglionc misto del Genio del C.A. corazzato;
2 compagni e co llegamenti , un a te leg rafì sti e un a marco ni s ti , inquad ra te nel ba ttagli o n e misto del Ge ni o de l C.A. celere;
2 compagni e co ll eg amenti , una releg rafisti e una marcon is ti , in quadra te n el battag li one misto del Genio de l C.A a lpi n o;
- 63 compag nie miste telegrafisti e radiorelegrafisti per Divisio n i eli fanteria. Il precipitare intanto degli eventi politico-m ilitari porta, nel 1939 , all'attuazione delle previste mi sure d i emergenza per l'Esercito.
Le Trasmissioni, a segùito d e l re lativo piano el i mob ilitaz ione, ragg iunsero una co n s istenza così riass umib ile :
- 3 raggrup pame nti misti co ll ega menti s u un num e ro vario eli bau.aglio ni teleg ra fi sti e marconisti, per i tre Comandi eli Gruppo eli Armate;
-2 bauaglioni speciali marconisti per lo SME, dei quali uno su 2 compagnie inte rcettazione ed una compagnia ra diog oniomctr ia;

- 9 batta glioni mist i co ll egamenti s u 2 co mp agni e te legrafis ri c una co mpagnia spe cia le ma rco nisti , per i 9 Coma ndi d 'Armat a, co n co lombai e m ob ili ;
-21 battaglioni misti co ll egam e nti s u 3 compagni e te legrafisti e u na co mpa g nia ma rconisLi , per i 20 Co rpi d 'Armata no rma li e per il Corpo d'Arm ata auto trasportato;
- 8 compagnie di cui 4 tel eg rafisti e 4 marconisti , per il C.A. alpino, il C.A corazzato , .il C.A. ce lere ed il C.A. libico;
- 75 compa g ni e mis te tel egrafis ri e marconis te , p e r le 7 5 Div isi oni moh ilit a te. De i mezz i prin cipali in dota zio n e alle Trasmiss io ni va nno ricord at i:
Sopra: Stazione fotoLelegrcifiw Fil/N! '!'HIULZI da 80 mm. alimelltata con eieLtrogeneraLore a mano tipo S. Giorgio.
A sinistra: Operato1'i con stazio11e_(otq(onica da 115 mm. - 13° Reggimento G'enioCagliari.
- le s tazion i R2 c R3, cos lituenti l'ossa tura dei collegame nti radi o de ll e minor i uni tà;
- le s ta7. io ni H4, 1\5, H6 e R200 per i co ll egamenti radio tra i Comandi de lle G U.;
- le staz ioni r.f. RFI e RF2 cam p a li;
- le "cassette te legrafic he" ca mpa li per le reti tel e grafic he tra le d e i C.A.;
- gli apparati stampant i per i co llega menti tra le G U. com pl esse;
- i tc lcscrittori campa li per i co llegamenti nell'ambito dei Comandi d'Armata e del Comando Supremo;
- le stazioni fotote legrafiche e fotofoniche, vere antesignane dei pomi radio.
Le Trasmissioni si preparavano così, con un totale di 200 compagnie per circa 40.000 uomini , a forni re il prop rio valoroso contributo nella 2A guerra mondiale , che iniziato nel giugno 1940 sulle Alpi Occidentali e proseguito sulle impervie montagne Greco-Albanesi, nelle assol<!tC piaghe africane e nelle steppe ghiacciate eli Russia. doveva co ncludersi sullo stesso ten-itorio italiano nel 1945.
La can1p ag n a de ll 'Africa Orie n tale (5 ottobre 19355 n1aggio 1936)
L'antefatto clc..:l l a campag n a d e l l ' A.O. fu r a ppr esen t a to dall ' uni ficaz io n e d e ll 'E r it r ea co n la avven uta ne l genna io 1935 , u nifi caz io ne isp inlla da fi na

Comunicazione a graude distanza. tavola diA. Be/trame dalla Domenica del Corriere del 25. 05. 1936

lità pre valentemenre milit a ri , p e r p repa ra re la g ue rra co n l'Etiopia ( 5 ouobrc 19355 maggio del 1936) .
Le operazioni, che imp eg n a ro no le fo rze italiane, inte res sarono un vasto Lea tro con abi tati situati a grandis s ime dis ta m:c tra loro , e furono caratterizzate da prob le mi logistici cresce nti con la progress iva occ upazione te rritoriale e di diffic il e so luzione, mettendo a dura prova le cap ac ità co nsegui Le dal Comando Su p eriore deli'A.O. d i tenere all a m a n o le G.U. clip e nd e nt:i In ta le complessa s itu azione l'efficienza dei co l-
legam e nti divenne fattore d eterminante del conseguimento del successo.
Il Coma ndo Supe riore dell 'A.O. aveva l'esigenza del con trollo de lle operazioni e d el conta tto con la madrepatria. Da qui la straordin ar ia importanza assunta da i mezzi el i co ll egamento che vennero organizzati in modo da permettere la disponibilità di una rete telegrafonica perma nente di base da cu i proseguire poi, con reti campali, lu ngo le d irettrici di Adua, Adigrat, Macallè, Entisciò, il tutto integrato da linee trasversali che assicuravano la continuità propria dei collegamenti ad anello.

La rete a filo, fitta ed estesa, fu affiancata da una rete radio che dovette misurarsi con le condizioni di oggettiva difficoltà ambientale date le caratteris tiche geoorografiche de l teatro di operazioni.
Il mezzo radio si rivelò , peraltro, ince1to e poco s icuro ne ll e prime fasi della campa gna, a causa delle paitìcolari condizioni eli propagazione e lettromagnetica, anche se successivi miglioramenti lo elevarono a ll 'a ltezza d e lla situazione, facendo meritare alle unità radiocelegratìs te l'elog io da parte del Coma ndo Superiore cle ll 'A.O.
Durante la campagna vennero impiegati, tra l'altro, oltre 140 posti di ascolto e radiogoniometria del XV banaglione del Comando Superiore del Genio, che assicurarono un accurato servizio di interceuazione di tutto il traffico etiopico ed inglese, in pa1ticolare durante le battaglie del Tambien. Venne anche attuato un servizio di ascolto d ella rete del Corpo d'Arma ta eritreo c he permise al Comand o Su periore dcll'AO di seguire lo svo lgimento delle azioni co me da un normale oss erva torio.
Nella ca mpagna d 'Africa vennero imp iegat i:
- i battaglioni collegamenti dei f , 11 , Ili e IV Corpo d'Armata ;
- il XV battaglione radi o ed il XVT battaglione telegrafisti del Comando
Superiore del Geni o A.O.;
- 13 compagnie telegrafisti divisionali;
- 3 sezioni radiotelegrafisti per i gruppi di bande del bassopiano orientale, del bassopiano occidentale e dell'altopiano;
- 7 sez io ni telefonisti e fotote legrafisti per piazzeforti;
- 6 ploton i misti collegamenti per Div isio ni Cam icie Nere.
Tra i mezz i radio im piegati, meritevo li di essere ricord at i, sono :
- le s ta z ioni R2, R3, R4-A, R4 -D, R4 , RS, RFC3T, R6;
- la staz ione R60 -C su automezzo pe r i collegamenti intercontinentali;
' - la stazio ne 300 SITI , semifissa, per il collegamento Asmara-Roma;
- la stazione RT-RF SAFAR per installazione fissa;
- la stazione RT-RF SWB8 Marconi per il servizio duplex celere automatico, r.t. e r.f. Asmara - Roma;
- i posti ascolto RA2 ;
- i radiogoniome tri Allocchio -Bacc hini;
-le staz ioni radio RF3-A , RF2, RFl, R12 e R13;
- la stazione FOC camm e ll ab il c
La Seconda Guerra Mondiale
Il secondo conflitto mondiale presenrava, rispetto ai conflitti precedenti ed in particolare rispetto alla guerra del 1915-18, differenze notevoli per ambiente operativo e per forze impi egate. Non s i trattava più eli una guerra di posizione combattuta su territorio nazi onale con fo rze prevalentemente appiedate , ma eli una guerra eli mov im e nto, con l' im p iego el i masse coraz zate e di aviaz ione, combattuta quasi inte rame nte lontano dalla mad re patria, su diste se ste nTl in ate quali il dese rto
Nella pagina a fianco: Radiotelegrafisti del Gem:o, illustrano le prestazioni di un apparato RF 3 C al Capo del Governo (Fo to Istituto Luce)

africano e la steppa rus sa, ed in co ndi z ion i cl imatiche part ico lar i.
In un co nflitto del genere sa rebbe stato ne cessar io d is porre el i mez zi radio qualitativamente ido ne i e quantitativarnente commisurati all 'enrità delle forze in campo. Purtroppo, le care nze era n o tante e non so lo qua lirati ve ma ancb e qu an tita tive.
Ne va innanzitutto sottoli n eata la li mit ata d ispo n ibi li tà. Un esemp io, p e r tutti: so ltanro un ca r ro su trenta rnontava un apparato radio. Ciò comportava n otevoli difficoltà in mater ia di co nt rollo e coo rd inamento. Van n o p o i rH evmi p roblemi eli affidabilità, conseguenti all'impiego d i componenti elettron ici no n ce rt o compatibili con le rigide tempe rature russe o con il caldo e la sabbia del deserto
Va aggiunta la scarsa maneggevo lezza dei rn ezz i, eccess iv an1 e ntc pesanti d i per se stess i e u lteriormente g rava ti da fo n ti d i alimentaz ione in go mb ranti. La loro mobi lità fa ceva affid amento, nella migliore d elle ipotesi, sui rnotocarrozzi ni ; ma s p esso poteva contare so ltanto s ul trasporto con mezz i an ima li ( mu li o cammelli) , d i cu i era r ichiesto un impiego plurimo pe r ciascun comp lesso radio , per le neceseli ripa rti re il car ico
Occorre tenere presente infin e ch e so lt anto a co ntlitto ini ziato l' in dustri a nazion a le co min c iò a part ecipare co n sforz i autonomi ai programm i de ll a d ifesa . Sino ad allora si e ra limitata a pro d urre quanto prog ettato da En ti governativi.
A fronte di tante ca re nz e, è motivo di orgog li o so ttoli nea re che l' impegno , la per izia tecnica , lo spirito di sacrificio d el personale addetto ai co llega m e nti co nsentirono di utilizza re a l megl io i mezzi radio es istenti tanto da ovviare effi cacemente s ia alle esige nze operat ive nei va ri Teatr i d i Operazione s ia alle es ig enze eli co ll ega ment i tra questi e la 1vladrepatria .
Merita altresì rico rdare che, a partire dal 1. 942, co n il programma "Notizie da casa", la radio fornì la possibilità a i so lda ti a l fro nte d i tenersi in co nta tto con i propri fa miliari. Si faceva così ricorso, sin da allora, al rneao radio per soste n ere il morale delle trup pe, così co m e s i fa oggi pe r analog he es igenze legate all'impiego dei nos tri soldati in miss ioni all'estero .
Telr:ffonisti del Conzando avanzato del 53° Reg,gimento Fanteria -
2 !! Guerra Mondiale

Stazione radio campale, scen e d at.fì unte
Fronte occidentale (10-24 grugno 1940)
IJ formale ingresso d e ll'Italia nel secondo conflitto mondiale avvenne con la cosiddetta "Ba ttaglia de ll e Alpi Occidentali".
Pres e parte a q u esta battaglia il Gruppo Armate Ovest, forte ·di 6 C.A. , su un complesso di 22 Divisioni , che videro impegnate 60 compagnie collegamenti. Le operazion i interessarono un terreno la cui aspra natura so ttopo se gli uomini ed i mezzi a prove dure ed impegnative, in particolare per lo ste ndimento e l'esercizio delle lunghe reti telegrafoniche
I collegamenti radio fmono resi partico larmen te diffico ltosi a causa delle caratte ristich e orografiche del rerreno interessato.
No n fu raro, in qu es ta breve campagna, il diretto intervento nei co mbattimenti di interi reparti delle Trasrni.ssioni;
Fronte dell'Africa Orientale Italiana (11 giugno 1940 - 27 noven1bre 1941)

L'Afr ica Orienta le Italiana (A. O .L) qua le risul tò per effetto de ll'annessione dell 'Etio pia a ll a Somalia ed all'Eritrea, a conclusione della campagna del 19351936 , venne a trovarsi strategicamente isolata.
L'A.O.I. fu b loccata infatti sulle frontiere mar ittirn e , fin dall 'i nizio delle ostilità, d alla superiorità navale inglese e accerchiata sulle frontiere terrestri dalle colonie de l nemico. Essa fu, perciò, costretta a fare assegnamento soltanto sulle proprie fo rze, assolutamente in adeguate a sostenere un a guerra eli lunga durata.
All'inizio del conflitto le nostre forze assommavano a circa 280.000 uomini, de i qua li 80 .000 nazionali e 200.000 coloniali, inquadrati nelle Divisioni "Africa" e
"Grana tieri dì Sardegna" e nell e 23 Brigate Co loniali
Le Trasmissioni consistevano in:
- 10 compagnie teleg rafisti e 10 comp ag n ie marconìsti, inquadrate nei battaglio ni misti d e l Ge nio nazi onali ;
- 29 plotoni te leg rafisti e 29 plotoni marconistì, in q uadrati nell e co mpagnie mis t e del Ge nio de ll e 29 Brigate co lo niali.
In un territori o ste rmina to e con infrastrutture tel eg rafonic he mo ltO sca rse, il p eso d e i collegamenti ve nne sostenuto prevalentemente da i mezzi radio, costituenti l'ossatura fondame ntale della nostra rete di comunicazione.
Il s uccedersi degli eve nti imp overì le forze d isponibili dei mezzi di lotta e di vita , re nd endo ancora più arduo il com pito dei Tra smetti tori, spess o cos tretti a cimenta rsi come fanti, in asp ri comb attime nti.
Fra i molti che fece ro olocaust o d e ll a propria vita, va ricordato il Capita no Anto nio Cavalieri , co mandan te della compagnia coll egament i dell 'Barar che, pe r il s uo co mportament o, ve nne insign ito di medaglia d 'oro alla memoria.
Front e dell 'Africa Settentrionale (11 gi ugno 194013 maggio 1943)

Su questo fronte, prima dell 'inizio delle operazioni, fu ro no compiute impo•tanti ope razioni di m ob il ita zione ch e p o rt arono le forze prese nti in Libia ( 4 Div isioni m e tropolitane e trup pe libiche) alla cons istenza di du e Arma te:
- la 5" su 3 C.A. e 8 Div isioni;
- la IO!! su 2 C.A. e 6 Div isio ni di cu i 2 Divisioni libi che.
Ta li fo rze v ennero poste all e dip e ndenze d e l Comando Su peri ore Africa Setten trio nale (A.S.). A queste G .U. furo n o assegn ate, per qu an to riguarda le Trasmissioni, 62 compagnie collegame nti co n circa 7000 uom ini, distribu iti tra:
- l raggruppamento p er il Comand o Su periore A.S. ;
- 8 battaglioni mis ti collegamenti d 'Armata, ciascuno s u 4 compagnie;
- 8 battaglioni co ll egamenti di C.A., c iascuno su 2 comp agnie;
- 14 compagnie miste collegament i delle Divisioni.
La particolare confo rmaz io n e del te rritorio, il clima e le esigenze operative el i u na guerra di mov imen to costrinse ro a re n dere il p i ù possibil e mobili c leggere le unità de ll e trasm issioni.
Le operazioni si s viluppa rono in tre fasi successive, fatte di avanzate e rip iegame nti. La terz a fas e dì ripiegam ento impos e alle for ze ita lo-te desc h e, so praffatte dalla netta superi o rità de l n e mico, di ritirarsi in Tunisia.
A qu esta fa se fu inte ressata la l a Armata itali ana con 3 C. A e 7 D ivis io ni , comprendenti 25 compagn ie co llegame n ti .
Gli ita lian i soffrivano d i notevoli carenze di materiali, non solo rispetto agli ingl esi, ma anche rispe tto all ' alleato tedesc o.
Tra i mezzi eli tras missione in d otazione , fu molto sen tita la carenza di a utostaz io ni ca paci di trasme ttere e ric evere in movimento e ciò rese oggettivame nt e c ri tico qualsiasi movim e nto di truppe.
La man ca nza, inoltre, d i cavo e la sca rsità di co rdo n c ino tel efonico costrinse a far la rgo uso della rete permanente telegrafo nica , mo lto vulnerabile a i bombardamenti di varia natu ra.
Le unità delle trasmissioni riu scirono co munque ad assic urare buona p a rte dei co ll e gamen ti tel efonici, ricorrendo sp ess o a mezzi di fortuna e a mezzi rec upera ti ,
sfruttando ogni possibilità che la tecnica e l' esperienza suggerivano
Il contributo eli sacrificio e eli sangu e , profuso dagli uom ini delle Trasmissioni sui vasti territori della Marmarica , della Cirenaica, della Tripolitania e della Tunisia, è testimoniato dalle ricompense al valore che furono loro riconosciu te nei 35 mesi di lotta
Fronte Greco-Albanese (28 ottobre 1940 - 22 aprile 1941)

Alla vigili a delle operazioni, le forze dislocate in Albania erano ordinate su un Corpo d 'Armata eli cinque Divisioni, con un batta glion e collegamenti di C.A. e 5 compagnie miste telegrafi sti e marconisti divisionali. Queste forze furono portate a due Corpi d'Armata, su complessive otto Divisioni , posti alle dipendenze d e l Comando Superiore Truppe Albania. Il Comando Superiore poteva disporre anche di un a Compagnia s peciale per l 'inte rcettazi one e la radiogoniometria. All'aumentato numero d e lle GG.UU non corrispose un proporzionale incremento delle u nità delle trasmi ss io ni, a causa della indisponibilità el i me zzi determinata dalle operazioni concomitanti sui fronti dell'A.O.I. e dell 'A.S ..
La Campagn a di Grecia si sviluppò in tre fasi:
- offensiva in Epiro, dal 28 ottobre a l 14 novembre 1940;
-con troffensiva greca, dal 14 novembre al 28 dicembre 1940 ;
- battaglia di arresto, dal 28 dicembre 1940 al 23 aprile 1941.
Nelle prìme due fasi i collegamenti radio ebbero la preminenza a causa de lla inadeguatezza dei collegamen ti a filo tra i Coma n d i eli G.U. e le uni tà sui confini e lungo le pr inci pa li direttrici offens ive Lu ngo le dire ttrici di fianch e ggiamento, l'utilizzazione de lla rete telegrafonica fu praticamente nulla, soprattut t o per la Divisione alpina 'Julia''. Dura n te la 3a fase , invece, i collegamenti a filo acquistarono consistenza grazie alla interve nuta di s ponibilità, anche s e limitata , del cavo bicoppia de l tipo Siemens e alla precettazione delle linee telefoniche dell'ole odotto Devoli-Val0na
I collegamenti radio riacquistarono tu tta la loro importanza ed affidabilità
Fronte Greco -Albanese, 2fl Gu erra Mondiale, operatori con stazione RF-4du rante l"occ u paz ione succe ss iva de lla Grec ia
Si fece la rgo ricorso anche all 'impiego di colombi viaggiatori per sopperire alla carenza delle reti telefoniche cd alle difficoltà di rifornimento delle parti di ricambio v ia mare
D u ra nte t u tt a la ca m p agna fu ten u to in fu n z ion e un a ppos ito nucl eo di co ntro ll o c ascolt o ra d io a i fi n i d e ll a d isc ip li na d e lle pro pr ie com uni caz io ni ra d io e per te n e re agg io rn ato il Comand o Su pe ri o re, sull a base d e ll e intercet tazion i e ffe ttuate , su ll e a z ioni messe in atto dal nemico.
Fronte Jug o s lavo (11-1 8 ap rile 19 41 )
Alle ope ra zion i su l fronte jugo s lavo pa rtec ip ò la za Ar ma ta, s u 4 C.A . co n co mplessive d icc i Di visioni.
Le unità trasmissioni erano tutte dotate el i mezzi radio adegua ti ad assicurare i collegamenti in operazioni imp rontate a dinamismo e rapidità di interventi. l va 1 i collega m e nti att u a ti fu ro no, p e rt a nto, efficac i c ri spondenti.
AJc uni C.A furono co s tretti a spos ta ment i cele ri p e r ce n t in a ia d i c h il ome tri ed in c ircos tanze che cos t rin s e ro a n ch e i tras mettito r i a co mb atte r e fian co a fia nco con i fa nti .
Sotto: Schema delle comunicazioni te/egraflcbe, tele.fon i cbe, oli icbe della zona di Gorizia Da un f,lra.fico dell 'epoca.

Stazione Radio RF - 3 nwntata su carro tipo "L".
Fronte Russo (agosto 1941 - gennaio 1943)
All'iniz io delle os tilit à, il Corpo d ì Speclizione Ttaliano in Russia (C.S.I.R.) comprendeva tre Divisioni, inquadrate in un Cor po d ' Armata.
I collegamenti furono ass icu rati clall'8° battag lion e misto collegamenti eli C.A. su due compagnie telegrafisti e d una compagnia rnarconis ti e dalle 3 compagnie miste collegamenti della 9 a, 52a c 103a Divisione.
Le truppe italiane, sch ie rate ne l settore meridionale del tea tro di operaz ioni, dopo l'iniz ial e slancio c h e le aveva portate nel baci no de l Donez, a mi gliaia di chilometri dalla Ma dreparria, si attestaro no in posizione d i attesa per il sopragg iun gere dell'inverno, per loro parti co larm e nte rigido.
Con il superamento della logorante s tasi inverna le e la ripresa , nell 'estate 1942, delle operazioni offensiv e, il C.S.I.R. v e nne incorporato nell'Armata Ttaliana in Russia (A.R.M.l.R.) che poté di s p o rre di 3 C. A. e 10 Divisioni
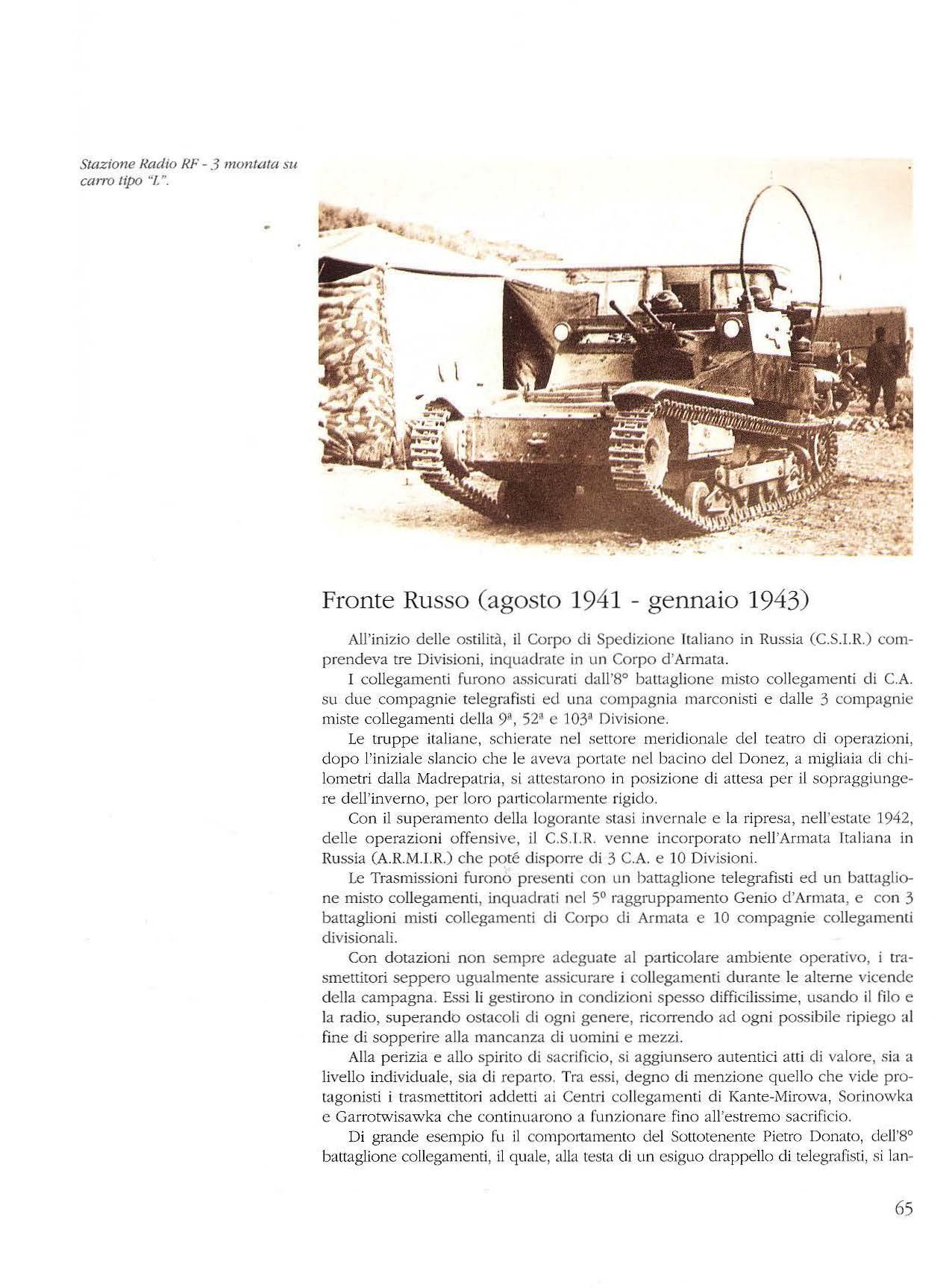
Le Trasmissioni furono prese nti con u n battaglione telegrafisti ed un ban:aglione misto collegamenti, inquadrati nel 5° raggruppamento Genio d'Armata, e co n 3 battaglioni misti collegamenti d i Corp o di Armata e 10 compagnie collegamenti divisionali.
Con dotazioni n on sempre adegua te al patticolare ambiente operativo, i trasmettitori sepp ero ugualmente assicurare i co ll egamenti durame le alteme vice n de d ella campagna. Essi li gestirono in co n d izio n i s pesso difficilissime , usando il filo e la radio, superando ostacoli d i og n i ge n ere, ricorrendo acl ogni possibile ripiego a l fine d i sopperire alla man ca nza d i uomini e mezzi.
Alla perizia e allo spirito eli sacrificio, s i agg iunsero autentici atti di va lor e, s ia a livello individuale, sia di reparto. Tra ess i, degno di menzione quel lo che vide protagonis ti i trasmett itori addetti ai Centri co ll e gamenti di Kante -Mirowa, Sorinowka e Gar rotwisawka che continuarono a fun ziona re fino all ' estremo sacrific io.
Di gra nde esempio fu il compo1tamen to del Sottotenente Pietro Donato, cl e ll '8° battaglione co llega me nti , il qua le, alla tes ta di un es iguo drappello di telegrafisti, s i lan
c iò con ge neros ità c co raggi o co ntro torzc nemich e so ve rchianti. sa clifica nclo così la propria giovane esistenza e meritando il co nfe rimen lo della medaglia d'oro al V.M.
Fron te Itali ano (1 0 lu g li o - 8 se tte m bre 194 3)

Gli avve n im enti bellici dell 'esta te del 1913 interessaro n o il territo ri o met ro p o lita no i ta li a no che d ive ntò, così, tea tro d i ope ra zioni.
Lo sbarco a nglo -a m er ican o-c anades e in Sici li a avvenuto il 10 lu g li o, fu contrastalO dall a Annata che , con le Divisioni "Aosta" ed "Assiena·· del 12! C.A. schiera te ad occ idente e le Divis ion i c "Livorno'' del H)! C.A. sch ie rate ad o r ie n t e , c le sei Di vis ion i e le due Brigate cost ie re, fu im p egna ta p er 40 g io r n i in una batta g lia senza spe ra n za
Le Tr.ts mission i, anche s u questo fronte, offrirono il meglio di se stesse . Esse furo n o prese nti con :
- l Ragg ruppam e n to per il Comand o F. A. di Sici lia;
- l b at taglione misto collega menti d 'Ar mata con una colomba ia m obile;
- 2 battaglioni misti collegamenti di Co rpo d 'Arm ata;
- 4 com p agnie m is te collegamen ti div is ionali;
- 13 Co lo mb a ie fisse .
Rep a ·rto dal Ceniu 7'eleg rafisti con apparato tipo RF - 3 montato su motocarrozzetta Bene/li.
Nella p agi na a tì anco: Guerra di Libe razione - Soldato Italiano a Americano intenti a stendere una linea. telefonica.

La Guerra di Lib e r azione
L'armistiz io dell'8 settembre 1943 gettò le basi per quella che verrà chiamata guena di lib e razione. La dichiaraz io n e di guerra alla Germania ed il riconoscim ento dello sta tus di cobelligeranza da pa tte degli Alleat i nell'ottobre 1943 avviarono anche la ricostru zione dell 'Esercito Italiano.
Le truppe di liberazione fu rono rapprese nta te, in un primo te mpo , da un raggruppamen to motoriz zato di 10.000 uomini, che o però in Ab ru zzo, dal febbraio all'aprile del 1944.
I co ll ega menti operativi furono assicurat i, a questo raggruppa mento, da una "compagn ia teleraelio" fac e nt e parte del LI batta glione misto del Genio. Success ivamente, con la costitu z ion e del Corpo Italian o di Lib e razione (C.I.L.) che sostituì il suddetto raggruppam en to motorizzato, le Trasmiss ioni disposero di 4 compagni e collegamenti el i cui una per il coma nd o del C.I .L., una p e r la Divisione "Nembo" e due per la I e II Brigata eli cui era costituito lo stesso C.I.L.
Nel luglio del 1944 fu iniziato l'approntamento di 6 gru p pi di combattimento che avrebbe ro preso parte alle operazioni in Italia a fia n co degli Alleati.
Di tali gruppi ne furono messi in cam po quattro, per un totale di 60.000 uomini ci rca, dotati di armamento e mezzi moderni, di fabbri caz ione a lleata. I 4 gruppi assun sero le denominaz ioni di gruppo di combattimento "C remona", "Folgore", "Friuli" e "Leg nano".
Di ogni gruppo faceva parte una co mpag nia te leradio di circa 300 uomini, con un plotone per il comando d el gruppo stesso, due plo ton i per i reggimenti di Fante ria e un plotone per il reggimento d i Artiglieria. Per l'impo rtanza assunta dai collegamenti furono costituite una "Scuola Ita lia na dei Collegamenti" a Nocera I nfe ri ore ed una "Scuola Genio", con comp o nen te collegamen ti , a Bracciano Queste due Scuole provvidero all'ad d estramento de l personale specia lizzato d elle Trasmissioni da destinare ai 4 gruppi di combattimento appronta ti.
Un a volta ultimato il breve p e riod o di addestramento, i gruppi di combattimento furon o sc hierati, fra il gennaio e il marzo 1945, con l e Unità alleate. I gruppi "Cremona", "Fri uli " e "Folgore" con l'8ll Armata Britannica, su ll e es treme propaggini dell'App e nnino Abruzzese, e il gruppo "Legnano" con la 5a Armata americana.
Pa rall e lame nte ai gruppi di comba ttimento regolari, le Trasmission i offrirono un contribu to prezioso alle forze di liberazione partigiane, o rganizza ndo un servizio radio clan destino che richiese eleva to spirito di sac rificio e spiccate doti di pe rizia tecn ica
Con le unità tele radio assegnate a i gruppi di combattime nto e co n le Scuole di Nocera Inferiore e di Bracciano, le Trasmissioni Italiane si avv iarono decisamente sulla s trada di un profondo rinnovamento, illuminato da una tradizio ne che si era arricchita di molteplici prove d'ingegno, di capacità e d i d e dizione.



Staziou e R- 79.
Le Trasmissioni al tennine della Seconda Guetra Mondiale
Tra le tante ed urgent i n ecess it à affronta te aJ term in e della 2A guerra mondial e, il Paese s i accinse anche alla diffic il e o p e ra d i ricostruzione materia le e moral e delle Forze Armate, prostra re da eve nti tragici spesso s ubiti senza co lp a o deme rito. La costituzione , prim a d e l "raggruppamento motorizzato " e poi dei '' gruppi d i comb a trimento ", che affiancarono gli All ea ti a ll ' inizi o del 1944 , certamen te servì a realizzare un "ponte ideale'' tra il Regio Ese rcito, sciolto p er effetto dei disast.ros i avvenimenti culmi nati n el settembre 1943, c le unità del d opoguerra.
I ma teriali delle Trasm iss io ni ne l n u ovo Esercito
Al termine d el co nflitt o i mat er iali delle Trasmiss io ni provenienti dal d isciolto Reg io Ese rcito furon o a b bandonati c sos tit1.1iti co n mezzi radio a m o dul azione d 'a mpiezza di prov enienza anglosasso n e (R-19; R-48; R-38) e americana (SC R- 506, SCR-299), e con conduttori, t ip o DR-3 o DR-4, e centra lini tipo, UC -1 O e F&F ancb 'ess i di provenienza angl osasso n e.
In un secondo tempo e bb e ini z io la dis Lribu zionc delle p r ime stazioni radio a modulazion e eli frequenza (SCR-300), prodOtte neg li Sta ti Un iti e riprodotte s u ccessiva me nte anc he in l La li a. L' inrrocl tllio ne d ella modulazione eli freque n za segnò una svolta ne i collegam e nti d e ll e min o ri unità per ef fe tto della migliore qualitù

della fonia e per la semplicità di impiego rispetto ai precedenti sistemi a modulazione d 'a mpiezza (R-38 e SC R 536).
Ne ll o stesso pe ri odo fu dis tri b ui ta a n c he la s tazione ra dio SCR-5 22 pe r l'a e ro coo p e razione
Ma l' a utentic o sa lto eli q ualit à, a tu tti i livelli ordina tiv i, s i e bbe con l'a rri vo dagli USA de i mate riali PANI. Ta le famigli a di ma teriali comprendeva le stazioni ra di o Hf del tipo SCR- 193 c SCR-299, per i collegamenti a livello G.U. e verso i reggime n ti , e le sta z ioni radio A:\'/ GRC -9 per i collegamenti btg.-rgt , no nché le stazioni radio a modu laz io n e d i freque n za, d ella serie SCR-508/10 e SCR-608/10, rispettiva mente r c r i co llegamenti ne ll 'ambito d e ll e Un ità Corazzate e d i Art ig lieria .

Pe r fronteg g iar e le crescenti es igc n;r. e di comuni caz io ni vennero altresì asse -
Sopra: Centralino telefonic o campale t ìpo UC-10 (G .B.).
A s ini st r a: Operatori in. addestram ento su centrale telefonica tipo F&F al campo d 'arma.
Sotto : Sta z ione SCR -3 00
gnali, in quel pe riodo , mezzi concetrualmente nuovi, quali i primi po nti rad io a 4 canali AN/TRC-1 ed A.'\J!fRC-8, con relativi multiplcx a freque nze vettrici CF-l e multiplex a telegrafia armonica CF-2 , c le te lescriventi.
Anche nel campo de ll e linee fisiche pervennero mater iali di nuovo tipo quali i condutto r i \\ID-Im ed il cavo bicoppia Spirai Fou r- S4. Q ues t' ultimo, equ ipaggiab il e co n ter m inali CF1 e r ipetitori CF3, ven iva im p iegato per co stru ire le linee in ca vo a 4 ca n a li te lefo ni c i o 3 canali telefonici più 4 canali telegrafic i ( con l'agg iunta de i termi n a li CF -2)
Nel settore d e ll a te le gra fi a compa rve ro le prime macchi n e asincron e e d in pa rtico la re le te le s cr ive n ti EE-97 a co rren te semp li ce, dotate d i p e rfo ra tore aut omatico eli b anda , e d el pos to di el i b a nd a TC - 16 Il m a teri ale te legrafico compren d ev a anche alcu ni ese mp la ri , d is tr ibuiti a i so li s up p orti Tras mi ss io ni d i A. e C.A , d i t e rmin a li TC- 18 e ripet itori TC-19 c he ve ni va n o impie gati per l' interfac ci amen to delle tele scriv en ti T G-7 co n le li nee te leg rafic h e d ell e PTT op e ra nt i a corre nte doppia F ur o no, in o lt re, assegnate, ag li s tess i liv e lli ordinati vi, apparecc h ia ture per il fu n z iona m e nto s im ult aneo in fon ia c tel eg rafia s u uno st esso ca n a le tele fo nico (S + Dx).
Nel campo de lla commutazione telefonica entraro n o in se rv iz io ce ntr ali manuali a va r ia capacità, da 40 a 200 linee , come ly TC-4, le T C-2 e le TC-10.
Grazie alla disponibil ità del parco materiali così ricostituito fu possibile o rganizzare ai vari livelli operativi , a metà degli anni '50, i primi sistemi di trasmissione complessi , capaci cioè c.li garanlirc servizi in fonia e telesc1i vente sulle reti telegrafoniche fisiche e in ponte radio , e telegrafici e telefonic i sulle reti radio.

E' bene rammenta re che in questo periodo le unità delle T rasm issio n i div isionali o di Bii gata auto noma (Brigata AlpLna) erano res p onsab ili d e i collegamenti anche nell 'a m b ito d ei reggimenti de ll 'Arma base e d i Alt iglieria . A ta l fine ciascu n a el i elette unità inquad rava a nc he i p loto ni Trasmissioni destinati a i va ri regg imenti.
Ne l periodo s i e b be, comp lessivame n te, un sa lto s ig n ificativo non solo oc ll e te cno log ie d e i mate r ia li , ma a nc h e ne ll a co n cez ione e reali zzazion e d e i s iste mi di te l e comun icaz ion i m ili ta ri , co n un a maggior e di s p o nibilit à d i app a rati a n ch e per le unità d e lle allre a r m i c a i m in o r i li ve ll i, cons entendo a qu este el i int eg rars i nei s iste mi rea li zzat i d a ll e uni tà de l Ge n io co ll egamenti.
L' addestratnen to
ie J 1946 le a u ivi tà svolte p resso la Scuola Auto n o m a Ita liana Co llegame n ti di Nocera Inferiore c presso la Scuola di Bracciano si trasferiro no nella Scuola Genio Collegamenti di Roma Cecchignola , ch e assunse il com pit o di r iqu alificare , nel periodo 1946 - 1950, tutti i Tra s mettitori , anche quelli assegnati alle Varie Almi , conferendo agl i stessi un ' improma unitar ia ed una prepa raz io n e specifica sulla base dei nuovi inca richi che si stavano affermando: centralin ist i, stenditor i guardafìli, telescriventisti, marconisti , fotografi , radiomontatori, motoristi pe r gruppi e lettrogeni, apparecc h iator i te legrafonici e di linea.
L' impe g n o adcl es t rm ivo ormai esteso a n che ai Carabinieri , a lla G uard ia di Fina n za ed ag li a ltri Corp i Armat i de ll o Sta to, fu ta le c.la fa r ri s u lta re la Sc u o la delle Tr asmissio n i in a d eg u at a a ll e semp re crescen ti es igenze. Nel 1948, d i c onseg u e n za, la Scuola delle T ra s mi ss io ni concorse, co n p a rt e de i prop ri Qu adri , all a cos t itu zion e d el C.A. R. d e i Colleg a m e nt i el i S. Gio rg io a Cremano ( Napoli) , ch e , s u c cessivamente si trasfo rm ò ne ll a Sc u o la Speciali zza ti Tr as miss io ni, cu i h.1 dema n data la fo rm az io ne el i marcon isti, te lescriv e n tisti , ce nt ra lini s ti ed a p p arecchi a to ri tcl eg rafo nici ,
Stazione SCR-193.alleggerendo così l' Istituto de lla Cecchignola .
Cresceva n o intanto le esige nze di cooperazione tra le diverse Forze Arma te e, con esse, le necessità di standardizzazione. Ciò pottò alla costituzione nel 1952 in Chiavari, della "Scuola Interforze delle Te lecomun icazioni", col compito di uniforma re le proced ure e l'imp iego de i materiali nelle tre Forze Armate : primo esempio di approccio, unitario ed interforze, ne ll a so lu zion e dei problemi dell'organizzazione militare
L'o p e ra di ri costruzione e di potenziamento si sviluppò anc h e a livello cu lturale, mediante l' invi o di Uffic iali e Sottufficiali negli Stati Uniti per la frequenza di corsi tecnici.
Il baga g li o eli co nosce nze co là acquis it o poté essere rapidam en te diffuso in tu tto l 'Es e rcito, con la stesu ra di una copiosa normativa riguardant e la concezion e, l'organizzaz ione e l'attuaz ione dei sis temi di telecomunicazioni campa li , n o nché con la stesu ra eli ma nuali tecnici, che assic urarono all 'Arma un a rea le ed a utonoma capacità tec nico-o p e rat iva.
Risa l e a t a le epoca l a prima emissione delle Norm e Generali per l e Trasmissioni (No.Ge.T.) e dell'Ordine dì Base per le Trasmissioni (O .Ba.T.), nonché l'int rod u zione d e ll a documentazione operativ a contingente, co m e il Sottoparag r afo Tr asm issioni a ll ' Ordine di Operazione e l'Allegato Trasmiss ion i all'Ordine di operazione.
Sul piano logisrico fu attuata l'Organizzazione in uso presso l'Ese rc it o USA, basata s u 4 livelli logi stici. Le parti dì ricambio , previste per i va ri tipi d i mezzi a ciascun l ivello, fu rono e lencate nei documenti CM 7 e CM 8, cos t antemente agg iornat i a cura dell'Ispettora to Trasm issio ni sulla base dei consumi medi delle parri di ricambio autodetermina te da ciascun repmto
La svolta degli an ni '5 0
Ne ll a s to ria d e ll e Trasmissioni, g li anni cinquanta appaion o partico larme nte s ig nifi cat ivi p er d 1.1 e impo r tant i fatti innovativi: uno di ordine te cno logico, segnato dall ' impi ego el i tran s is to r ne lle apparecc hiature e lettroniche , l' a ltro di tip o tatt icostrateg ico, connesso co n lo sv iluppo delle dottrine relati ve a ll e ope razioni in ambient e "a tom ico" .
Il tran s isto r, a differenza del tubo elettronico, consumava poc o, n o n risca ldava, non si esa uriva , e ra di dimensioni estre mamente rid otte.
Le o p e razion i in amb ie nte nucl eare delineate nella normativa delta se ri e 600 comportav a n o a loro volta problemi di vulnerabilità dei Posti Comando, con pesanti ripercussioni sull'a rchitettu ra dei sistemi di telecomuni caz ioni.
Si sviluppò, di consegue nza , una copiosa normativa che ten d eva a ridurre l'impiego del cavo e ad accentuare le misure di sicurezza de lle comunicazio n i, ad esaspe rare le esigenze d i continuità e di qu antità eli traffico co n la cost ituzione di Posti Comando ripartiti in più aliquote e sc h ie rati in spazi più ampi e con il ricorso all' impi ego d i mezz i per la telefonia e la telegrafia a grande di sta n za.

Seguendo le donrine militari dell'epoca, i sistemi di telecomun icazioni, ancora prevalente m e nte basati su ll ' impiego dei cavi multicopp ia, prevedevano più posti prova e riparti z io n e c ircuiti, per dirotta re i fasci d i comunicazion e da u n posto comando a ll 'a ltro, lin ee te le foniche pupinizzate ed amplificate, circuiti te leg rafici su lin ee v irtu a li cd un ridotto impi ego delle stazioni radio che, p er la loro riconosci u ta vuln e ra bil it à a ll a g u erra elettro n ica, avrebbero dovuto essere uti li zza te solo n e ll e fasi dinamic h e d e ll e o p e razioni
Una so lu zio ne a i prob le mi d e lle telecomunicazioni tatti c h e fu intra vis ta nel ere-
Ponte radio AN/ !T?C-8 con terminaLe telefon ico a frequenze uettric i CF- l ( U.S.A.).

sceme impiego del pont e radio multi canale, prom osso a mezzo fondamentale dei sis temi dell e trasmissioni s ul ca mpo di battaglia
A basso liv e llo anche le s tazioni radio a mod ulazione di freq uenz a ric evettero g rande impuls o - per l'effi c ie nza, la ru st icità e la sem plicìtà d'u so - anche n e ll a co nsiderazione delle reali condizioni di impiego degli apparati, affidati normalmente a perso nale con un minimo di addestramento, da ta la grande quantità ed ete rogeneità dei me zzi prese nti nell e u n ità e dell ' in1p oss ibilità di dedic are lunghi period i di addes ti·amento a l g ran num ero el i operatori e di riparatori necessari.
La norm at iv a d ' impi ego delle Trasmiss io ni fu in quegli anni co mpletam ente rivista in modo da allinearla al corpo dottrinale della serie 600. Venne, così, a lla luce la p ubblicaz ion e 9000: "Norme sull'organizzazione e l'in1piego dei coll egamenti delle Gra ndi Unità' Ope rative" ch e disegnav a ancora una s truttura radia le d e ll e reti, ricalca nte le dip endenze gerarch iche.

Stazion e radio portatile AN/PRC8/1 O (U.S.A .).
Nel settore de i materiali, la lin ea dei multiplex telefonici CFl , CF2 e CF3, nota anche come Sistema 100 miglia , dopo un onorevole periodo di impi ego - vanno rico rdati in particolare gli stendimenti multipli lungo la "Pontebbana " p e r collegare il pos to comando designato d'Armata a quelli dci tre Corpi d 'Arm ata dipendentifuro no sostitui ti da i più moderni multiplex eli provenienza USA, AN/ TRC -23 e d AN/TRC-25, anch 'ess i a 4 canali più il ca nale di servi:òo.
Nello stesso periodo in iz iò la sosti tuzione dell e precedenti stazioni radio a modu la zione di freque nza con le nuove e più compalte CPRC-26, per i collegamenti pl - cp, e AN/ PRC-8/ 10, per i collega men ti cp - btg e con la AN / GRC-3/ 8 , per i coll egamenti de lle unità di Fante ria , Artiglie ria e corazzati. l primi esemplari erano di prov en ienza a mericana mentre, per i rim anenti fabb isogni , fu avviata una riproduzion e in Italia
Per quanto concerne la sicurezza d e lle trasmissioni, a livello G U. co mple ssa

vennero im p iega te c ifran ti on - li n c a zo na perforata tip o ETCRM, d i proveni e n za USA, ment re ai li ve lli inferiori co mp a rvero le cifranti off-line tipo Adonis, il codice a repertorio Manfredi e s uccessivame nte , negli anni 60, furono distr ibuite le prim e cifranti on-line naz io nali CT-62 a "7.0ne ge melle".
Per quanto attiene ai ponti radio, furono acquisiti i ponti radio analogici a media capacità (12 canali) Al'\J / MRC-69 (te rminale), AN / MRC-54 ( ripetitori) ed AN/ MRC-73 ( term inale tel egrafico). Essi f urono imp iegati ne i sistemi di trasm issioni di C.A. e ne lla rete di trasmissioni del sis tema di difesa aerea co n miss ili HAWX.
Ne ll 'a mb i.to dello stesso programma d i acquisizi o ne fu rono approvv igi onate in USA .s taz ioni rad io HF a band a la te ra le unica ins tall a te su jee p aviol ancia bil i tipo i\N / MRC -9 5. Tale stazione costituì la prima vera s tazione radio te lescrive nte e fu

Sistema di trasmissioni a g riglia di Arm ata. ?S
LEOENDA
D Cenui tcumissioni di grisll a d' Armau
O Ccn cti uasmissioni ® Centto crasm iu i o ni d'Armata
Il cana li in ponte udio o via c.avo (b ig. 1. di J ri &l ia di Armata )
EnenJioai del siuema. a &rl&fi& (bt g. t. gri &lia di
Colhaam c: nli late n li (biJ 1 di &tigli a di Armau )
Collc g amcnci usi eurall dal bt a. t. di Corpo d'Armata
Co llca a menti aJla gr i gli a ush: ucaci dal btg. 1 di Armala
Cu lleg:t.menti dd shtema di tnsmissiooj del TO
assegn ata alla Brigata para ca dutisti . Sempre per le es igenze dell a stessa Brigata fu ro no acqt1isite in USA le staz ioni radio HF AN/PRC-47 e d AN/TRC-77.
Nella secon d a metà d egli a nni '60 furono introdott e in servizio, in sostituzione delle te lescriventi TG -7, le te lescrive nt i T2-0C, che rappresentavano le pr ime tel escr iventi italian e co n caratte ri s tiche cam pali. Ess e, a differenza d e ll e precedent i TG- 7 , poteva no ope rare sia in corrente semp lice sia in co rrente dop pia.

Sul fini r e degli ann i '50, l'esigenza di incrementare le capacità di comunicaz ione e di ridurre la vulnerabilità dei sistemi indusse a ricercare configura7.ion i di reti alternative ai s istem i usua li di tipo gerarchico. Una prima fotma di architenura a griglia - o s istema d 'a rea - ap patve come una delle soluzioni in grado di rispondere alle future esige nz e.
La griglia nacqu e ufficialmente ne l 19 59, a nn o in cui le dirett ive a nnu a li sull ' addestrame nto d e ll e tra s missio n i descrivevano così il sistema da rea li;. zare:
- un complesso di Centri trasmissioni artic olati su ampie zone;
- circuiti pturìcanali con te rmina li nioh ili e d i rapido impianto (ponti radio) co lleganti i predetti centri;
- c ircuiti e reti, .filo e ?'adio, inseriti nella griglia p er la relat iva integ ra zione e completamento
La gri g li a doveva confe rir e a ll e tras mis s ioni le caratte ri s ti c h e el i mob ili tà, fless ibili tà , e sop ravvivenza , in v irtù delle qua li , meglio di og ni a ltro s iste ma, dov e va so ddis fare n e l te mpo e ne ll o spaz io le p e cu liar i esigenze de ll 'amb ie nt e atO mico.
La g ri glia concep i ta pe r agevo l a r e l a m a n ovra de l l e for ze i n a mpi spaz i abbraccia con ejjìcacia omnicHreziona le, aijìni del moviment o delle truppe operanti, tutta l 'a rea operativa delle Grandi Unità cui è destinata
La dislocazione d ei mezzi d el le trasmiss io n i, quindi, non co incideva semp re con i PC, ma si d is ten d eva su delle anonime aree elememari in c ui veniva suddiv isa l'area della battaglia.
Gli sviluppi o p era ti vi della fine degli anni ·50 richiesero , conseguentemente, l'adozione d i una nu ova gene razione di mezzi imposta anche dall 'evoluzione dell'elettronica e da una congrua variazione degli ordinamenti
In realtà, le prime g rigli e rea lizza te in sede di esercitazioni non ebbe ro g ra nd e successo, a n c h e a ca u sa della care n za di mezzi di trasmiss ion e multicanale e, so prattutto, di sistemi di com mutazione. Le ce nt ra li in se1viz io (TC-2, TC-4, TC-10) ris a li va n o, in fatti , a ll a 2ll gue rra mo ndi a le .
La separazione da l Genio
In armo ni a con qua n to avve nuto in altri Eserciti dell ' All ea n za At lant ica, il 10 giugno 1953 le u nità "Genio Co ll eg amenti " s i stacc a rono da ll 'Arma d e l Genio p e r cos titui re l' Arma d e ll e Trasmissio n i che, p ur n on ave ndo a tutt'oggi sa nz io n e g iur id ica, g ià ag iva in modo co mp letamente au to nomo .
Alle Trasmissioni vennero q u indi affi da ti "in toro" l' organizzazione, l' impianto, l'esercizio dci sis tem i d i Lrasmission i inte rforze, territo riali e d o p e rat ivi , no n ché le attiv ità di Gue r ra Elettronica relati ve a ll e comunicazioni ed alla formazione cd all'addestramento di quadri e specializzati delle Trasmissioni e di g uerra e lett ro ni ca p er i reparti propri e de ll e alrre Armi.
D i pati p asso con l'inc remen to numerico e qualitativo delle trasmissioni nell 'Ese rcito, crebbe l'esigenza del suppo1to tecnico-logistico, che faceva capo ad un Centro Tecnico, ad uno Stabilimento delle 'l i'asmissioni e a vari Depositi Materiali spccifìci.

I Q u adri de ll a nuova Arma, specie g li Uffici ali , ge n ier i che avevano da se mpre in d iffere n temente trattato gli esp los ivi e l' eliogra fo , i cavi ed il fil o spi nato, comandato in pace ed in guerra zappatori , te le gra fis ti e d a rti e ri , v issero inte nsamente il trava g li o di questa gen itu ra ed il dubbi o dell 'opzione . Anc h e i più giovan i, d i forma z io ne pos t bellica, p ur p riv i dell ' affratellante esp e ri e n za d e ll a g u e rra, lascia ro n o le "pipe ne re" pe r la "fiamma blu borda ta cremisi" con ùn ce rto ri mp ianto, sc pp ure attenu a to d a ll 'a ffasc in a nt e pros pettiva della nuova esperien za
Ne lla p ag ina a fianco : Ce ntro No dale d'area di Pogg i o Nibbio - Visione notturna - esterno

Gli anni '60
La dottrina militare del periodo, ispirata al concetto dell ' impiego massiccio deiJ"ordigno atomico, sostituiva alla bivalenza la caratteristica della duttilità. La dourina espressa dalla s er ie 700 esasperava, tra l'altro, la minaccia elett ronica e così la nuova pubblicazione 9000 "O rgan izzazione ed Impiego delle Trasmissioni " si ispirava ai tre concett i operativi del tempo: strumento eli gue rra polivalente, dottrina d i impiego duttile e pianificaz ione ope rat iva e lastica.
l sistemi di trasmissione a rea li o a grig li a, eli cui si è già faLco cenno, prevedeva no ass i e brete ll e estes i s u tu tta l'area d e lla bat tag li a, co n nod i c h e , sv in co lat i dai Post i Comando , cost ituiva no i punti eli accesso di questi u ltimi a ll a re te
Tal e co nngurazione gara nti va la cont inuità del co llegamento e l a de ll e v ie offe rte a lle comu nica zi oni, o ltre ch e la fl essib ilit à e l'ade renza a i dispos it ivi , a ttraverso le possib ili tà ass icurate a i coma ndi di mettersi in rete indip endentemente dal la dislocazione assunta.
Alla pubb li caz ione 9000 segui rono la 9100 "Nor me sull 'organizzazione e funzionamenLO dei Centri Trasmissioni" e la 9200 "Ordi ni e Prescrizioni per le Trasmissioni".

La r e te T LC infrast rutturale
Già nella fase di riorganizzazione dell 'Ese rcito del dopoguerra, e quindi contemporaneamente alla costituzione dei nuovi com a ndi operativi e terriLOriali, era emersa l'esigenza di dar vi ta ad una rete di telecomunicazioni per in tcrconncrtere detti comand i tra loro e con le Autor ità Centrali. La Re te TI C Infra s tn.mur a le di F.A. nacqu e negli ann i 50.
I primi col legamen ti furono t'ea lizzati mediante l'utilizz az ion e di circuiti no legg iati dalla rete co mmerciale PTT e da ll e Società co n cess io n a ri e de ll 'e po ca. Ne ll e zone di scarsa dispon ibili tà di circ uit i civili e eli inte resse militar e prior it ario , come ad esempio la Regione Nord -Est, fu pro vve duto a ll a rea li zzaz io n e di lin ee mi li tari p e rman e nri cos ti t uit e da condu ttori fis ic i s u pa lificazioni d i p rodella F. A..
Successivamente, anche per fronteggiare possibili interruz ioni su i c ircuiti nolegg iati , detti co ll egament i furono duplicat i ed estesi ai livelli inferiori m ed iante la rete radio nazion a le e le reti radio regionali, tutte in gamma HF. La rete nazionale e ra costituita da apparàli di produzione europea da 200 W di potenza c da apparati USA BC-610 e BC-312; le reti regionali utilizzarono principalmente appar&ti di provenienza anglosassone R-19 e R-52 e , successivamente, apparati USA SCR-287.
I collegamenti regionali prevedevano l'interconnessione dei Comandi di Presidio Mi litare ed i Depositi Carburanti e Mu nizioni. I comandi operativi inquadrati nelle G.U. venivano in vece collegati sempre via radio, utilizzando i mezzi in dotazione ai rispettivi supporti trasmissioni. La gestione dei co ll egamenti suddetti era affidata, a livello centra le, al X btg. trasmissioni, co n il concorso, in periferia, delle compagnie tetTitoriali inquadra te nei battag lioni trasmissioni di C.A. assegnati a ciascuna Regione Militare. Dett i battaglioni disponevano a n c h e di capacità di in terce tta z ione e radi ogon.ometria (p l. I-RG) con il compi to d el contro ll o de ll e emissioni ra di o n e ll 'a rea d i co mpete nza.
Con l'a rriv o dei materiali PA.l\.1 (Piano Aiuti Marshall) fu cost itu ita la prim a ret e in ponte rad io in fra s truttura le utili zz ando ma ter ia le del tipo AN/ TR C-1 t1.mzionant e
Antenna per stazione :troposcatter sotto la neve.

inizia lmente soltanto nelle ore diurne.
Fino al 1955 i servizi forniti dalla rete sopradescritta e rano essenzialm ente la fonia e la telegrafia Morse nei collegamenti radio, nonché pochi collegamenti in telescrivente. Questi ultimi riguardavano in pa1ticolare collegamenti protetti, con cifra on -line, tra i maggiori comandi assegnati alla NATO.
Successivamente la rete TLC fu oggetto di un continuo potenziamento ed ammodernamento tecno logico, con una copertura es tesa man mano a tutto il territorio nazionale, con un gradua le affrancamento dalle r eti commerciali e la di s missione delle linee fisiche permanenti militari. Dal punto eli v ista ordinativo la rete veniva affidata al X btg.t..
Da segnalare inoltre l'integrazione in rete, con funzione di scavalcarnento e eli potenz iamento dell 'asse tirrenico sud, del primo collegamento troposcatter a 12 can ali tra M.re Vergine e M.te Cammarata.
All'inizio degli anni '70 divennero intense le iniziative per conseguire l' interoperabilità e l' integrazione delle reti TLC delle tre FF.AA. , nonché per impostare i criteri realizzativi di una rete TLC interforze , intesa come rete di trasporro al serv izio delle sottoreti eli F.A. , secondo le direttive dell ' apposito Comitato Interforze (COM ITELE).
Il primo risultato di questa co ll aborazione fu la costituzione d ei primi tre centri nodali del quac\r ilatero int erforze attorno a Roma (Poggio N ibbio, Vigna eli Valle e m.te Terminillo) e l'impostaz ion e de l quarto centro nodale a m.tc Guadagnalo.
In a lto: "RA DO/v!", antenna per ponti radio di g1·ande capacità .
Al centro e in basso: Antenne per ponti radio.

In a lt o a sinistra : Allievo L
Per quanto aniene a ll a re te infrastrutturale, nella prima metà degli a nni '70 furono anche avv iari numerosi lavori per l' adeguamento o la costruzi o ne cx-novo d c i principali siri della rete TLC eli F.A., nonché i progranuni per il mi glioramento di taluni impianti. come ad esempio la trasfo rmaz ione della sala teles<.1·iventi del centro trasmissioni de l Pa lazzo Esercito (SME), operante con il criterio de l rra nsilo messaggi a "zo na stra pp ata", in un centro telegrafico a conunurazione a ut o ma ti ca di m essagg io (S is rc ma CETAl'v1) ub ica to presso il s it o di Bell osguard o. l vecchi pont i rad io A0! / TH.C- 1 dell e re ti iniziali venn e ro sos t itu it i co n mat e ria le a 12, 24, 60 c 120 cana li d i produz io n e nazional e t ipo SMC - 212, IVIS -8 e CTR-145, con mu ltipl ex te lefon ici FDM CE/ P6M, MX5/155 , !VIX6/ 151 e se rie MX-500 e m ul tiplex tel egrafici tip o MT 305.

Interventi p e r pubb liche calamità
Sin da ll 'in izio d eg li a n n i 50, le fo r ze Arma te e, d i conseg u enza, te unirà tras m iss ioni d e ll'E serci to , venne ro impegnate in a tt ivi tà eli s uppono in num e rose c ircostanze di event i calamitos i d i var ia na tu ra occors i su l te r ritor io nazion ale.
Il primo imp01tante intcrvc mo del clopoguetTa si manifestò in occasione dell'alluvione del Pol esine (1951). Seguirono gli interventi do vu ti allo straripamento del fiume Secchia nel Modenc c 0960), a ll'alluvione del bacino del Vajont (1963), allo s traripamento dei fiumi Li ven7.a. Meduna, Piave e Tagliamento nella zona di Latisana, l'alluvione di Firenze e di vas te a ree della Pianura Padana c della Carnia (1966) .
Si intetve nn e anche per scosse tell ur iche: il terremoto nelle zo n e di Arian o Irpino (1962 ) , c.l e l Be lice ( 1968), eli Ancona (1972 ) , d el F r iuli (1976) e delltl Ca m pania - Bas ilica ta ( 1980)
I n ciascu no d eg li eve n ti cita ti le unit à delle Trasmiss io ni venn e ro impiega te , olt re che in a ttiv ità di soccorso dire tto all e popol az io ni c o lpite , sgomb e ro p ro fugh i, t raspo rto ma te rial i e ri fo rnim e nt i, a ll e st im e nto a tte ndame nt i, campi, anc h e c .soprattutto n e ll a rea li zzaz io n e c.lei co ll ega m e nti nece s sari all e Aut o rit à c ivili e m ilita ri p e r il coo rdin a rn e n to el c i s occors i, nonché nella creazio n e eli Ce n t ri d i Comuni caz io ni , co ll egat i a ll a re te infras t rutturaJe militare e d a ll a r e te conu11e rc ia le PTI, p e r g ar a ntire la ripresa d e l traffi co de ll e comunicazioni pri va te p e r le popo lazio ni colp it e
Le unità int(;! tv e n u te venne ro sce lte , di no rma, tra q uc lJ e d i sl<lnza in pross imi tà de ll e zone co lpir e c, s ucc ess ivame nte, r info rzat e co n p e rsonale c mezz i di altre unità in relazion e a ll e n ecess ità eli collegame n ti ed alla vas t ità dell 'a rea co lpi ta.
La ril evan te impo rt a n za d e l co nt ri buto offerto da i trasmellitori nell 'o p e ra d i soccorso delle popolaz io ni colpite da eve n t i calamitosi richi e d e un a più ampia trattazione dell'argomenro. per la quale si rimanda all'apposita appendice.
La gu e rr a e le ttr o nica
Ne l d opoguerra le attività di G u erra Elettronic a fu ro n o r ip rese a p a 1tirc dall'inizio degli anni 50, co n la cos t ituz ione dei pl oto ni 1-RG (interce ttazione e rad iogoni o me tri a), inquadrat i ne i ba ttag li o ni co ll e gamenti di C. A./Region i Milita ri e, s u ccess ivam e nt e , d e lt a co mp ag nia s p ec iale tras missioni 1-RG, inqu a dra ta nel battag l.i one collegamenti s p ec ia le de l Min is te ro Difesa - Esercito
De tte unità, opera n t i so tto il contro ll o dello SME - SIOS s vo lgevano esse nz ia lmente op e raz io n i d i inte rce ttaz ione e radiogo ni ometria di emiss io ni rad io sospette,
di
cont rollo della disciplina d elle frequenze e de l rispetto delle n o r me d i sicurezza su ll e reti rad io del la Fo rza Arma la.
l mezz i a dis p os izio n e e ra n o di prov eni enz a a ll ea ta , co me il ri cev ito re HF R107 , i rad io go n io m e tri DFM/ DFG- 2 , AN/TRD-4 e H F AN/PRD - 1 , i p r im i du e tras portabi li in s h c lte r, l' u ltim o p o rt a rilc.
f\e l p e ri odo vari Ufficia li d e ll e Tra smissio n i fu rono inviat i n eg li Sta ti Un iti a Fon-Mo n molllh nel ew Jersey per freque ntare cors i specific i.
A metà anni '5 0 la elcrtron ica ini ziò ad assume re imporranza se m pre pi ù r il e v a nte n e ll o scenar io op e ra t ivo, per c u i in tutti i Pa esi d e lla N ATO fu avv iato u n pro ces s o d i ra pido ammo d e rn am e n to e el i p o te n zia m e n to d el se tto re.
Dagli Sta ti Unit i arrivarono num e ro s i nuovi m ezzi co rn e i ricevit o ri l iF R-390/ UKR
 Alluvione
Firenze , 1 966. Soldati delle Trasmissioni spa lano nelle vie del centro.
Alluvione
Firenze , 1 966. Soldati delle Trasmissioni spa lano nelle vie del centro.
e VHF R-220/ UR R, i racl iogo n iornet ri VHF Ai\'/ Till) -10, le centra li eli cont ro ll o e d intercettaz ione /\ì\ / 1TQ-3 e OA-596 -TDQ -3, i r ic ev itori di sorveglianza 1-1/V/UHF AN/ TLR-1, i ricevi tor i pe r ra cliospoJette V/ UHF A!':/TLR-9/10, i rice v itori pe r in te rcettazion e racl<Jr AN/ API\-9/ 13 ed i racliocl is tu rbato ri HF AN/GLQ/2A da 0,5 Kv·,;.
La dispon ib ilità di cletri materiali consentì eli dive rs ificare il persona le ed i mezzi dedica ti a ll e atti v it à SKì TNT eia quell i dedicati a ll e attiv it à g u. e lt., eli es tendere il co nrroJlo delle em ission i ( comun icazioni) anche alle gamme V/UHF ed a ll e e m ission i (no n comu ni caz ioni) eli radar e radiospo lette, nonc hé el i svolge re numerose ese rcita zion i a n nua li a par titi con tra pp osti pe r a ddes trare il perso nal e delle T rasm ission i a conrrasta re l'a ttiv ità d i g u elt
Nel fratte mp o , s u l piano ordinativo, furono sc io lti i p lotoni I-RG eli R. ìvL c la compag nia spec iale I-RG e fu tra sfo rm a to l'XI battag lione collega m en ti s p erimentale n e l 9° barraglio nc collegamenti, s u u na compagnia I- RG e d ue compagnie g uerra ele ttronic a.
La compagnia 1-RG die d e vita a var i n ucl ei SIGINT, d islocati in vari siti del te rr itorio naz io nale per svolgere attiv ità informa tiva alle d ipendenze del lo SMF. - SJOS .

All'inizio degl i ann i '60 le u nità el i guerra e lettronica era n o, dunque , ra ggruppate nel 9° btg. r. con se d e ne l comp r e n sorio della Scuola Trasmission i a ll a Cecc hi gnola, mentre un distac camento del batrag li one (il l 0° pl. de lta 7 a cp.) era di slocat o a d Arzene (P n ) , co n co m p iti eli ìntercettazio n e e r acl iogon io met ria su poss ib il i ob iett ivi dislocati lungo il co nfin e
Presso il la bo rator io di a r tiglie r ia d el poli go no eli Ne tt uno es is t eva altresì un n uc leo d i Lfficiali tec n ici che sper imentavano i materiali di gu.e lt de l setto re "no n comuni e<17. io n i" (dis Lur bo e in gan n o ra d a r, radiospolerte, etc. ).
Per q ua nto a tti ene ai ma teria li , il 9° btg aveva r icevuto a pp ara ti PAM e d i prototipi sperimenta li g ià a pp ar te n en ti al X e XI btg . t, assie mari ed in st alla ti a cura de ll a Sc7. io nc D ifesa Elettronica d el Cen tro Te cnico dell e Trasmission i di Roma .
Nel 196 1 il 9° btg. prop ose all 'Ispe tto ra to d elle Tr asmiss ioni u n adeg u amen to degli o rga nic i a fronte d elle semp re crescen ti e sigenze na zi o nali e Nato. Le p ro p oste fu ro no recep ite n el organico che p o i di ede lu ogo alla costi n 1zio n e del Ce ntro Difesa El e ttro nica (C DE).
Tra le atti v ità opera tive sv ilu pp a te dal 9° btg t. v a ricord a ta l 'es ige nza "Alt o Ad ige " , colà svo lra n e ll 'esta te 196 1 all o r q uando un p lotone I-RG venn e inv iato p e r ci rca quattro m es i a d e ffe ttu a re inte rce ttazio ni H F e VT-I F d a postazi o ni d iv erse in Val Pus te ria , realizzand o u na base r adio gonio metrica in q uota , p oi trasfe rita in zo na pianeggia nte, tecn icamente pi ù favo revo le A partire d a l 1968, anche in base a ll e crescenti es ige n ze nazion ali e NATO, fu p o rtaro ava nt i un v asto prog ra mma di a mmo dernam e n to e pote n z iam ento s ia d e ll e comp o n e nti' SIGI NT (cos tit u zione d e ll 'So btg e d e i s uo i distaccamenti , d ipe ndenti p e r l'impie go dal SIOS d e l lo SME), s ia c on il rinn ovam e nto d e i mezz i, g ià d iv enu ti obso le ti , de l 9° btg . gu. e lt..
Tra il 1969 e il 1975 ven n ero gra du alme nte rea li zz a ti i programmi SIG IN T (fis so e mobile) ed i prog ranuni di g uerra e le ttro nica con l' introd uzione d i apparati al tamente s p ecializzat i e l' av vio di sn1d i pe r la reali zzaz ione el i s istem i evo luti. e ll o s te sso p e ri o do il CDE , dive nuto Ce ntro Info r ma zione e Dife sa Ele ttron ica (CI DE) , fu interes sato a s volge r e u n ' inte n s a attivi tà a dcle s trativa e d i s tud io nazion a le e int e rn a zi onal e in a mbit o NATO , FlNABEL e b i-t rilateral e co n i Paes i più evo lu ti n el p a r tico lare s etto re.
Il pl otone T-R G da Arzene passò in Latisan a, d iven ne co mp ag n ia c venne posta a ll e di p e nde n ze de l coman d o desig n a to dalla 3a Al'mata . Il re pa1t o crebbe nel te mpo, da n do lu ogo al 33° batta g li one gu e lt. di p endenze opera ti ve el i FrAS E e log istico di sc ip li na ri del 5° C.A Fu d is locato a Co n eg li a no , co n una co mpa gni a .ESM in Bassano De tta compagni a contin uò acl op e ra r e sec ondo le dir e ttive del TT Re pa rt o de llo SME , costi tuendo s uccess iva mente tre d is tacc amenti p e r la re a liz zazio n e d i una b a se go ni o metric a.




I cambiatnenti degli anni '70
Ne l periodo compreso tra il 1970 cd il 1980 la Forza Annata venne interessata a radicali cambiamenti d i ca rattere stru ttura le, ordinativo e d addestrativo conseguenti all'esigenza di contrarre lo strume nto, ne ll'inten to di potenziare il setto re dei materiali e dei mezzi a parità di r isorse disponibili. Fu attuata una vera e propria ri struttu razio n e (eliminaz ione dei reggimenti e scioglimen to di d iverse Grandi Unità a livello divis iona le), e in trodotto l'addestramento "per imitazione". T battaglioni, eredi de lle tradizioni dei reggimenti, vennero inquadrati nelle Brigate, Grandi Unità pluriar ma caratterizzate anche da autonomia logistica. Le poche Divisioni rimaste, destinate ad operare in zona di combattimento, n ormalmente compresero due o tre Brigate c suppo1ti, costituendo un anello in termedio tra i Comandi di C.A. e di Brigata.

L'opera d i ristrutturazione, condotta in tempi relativamente brevi, s i concluse con lo sc ioglimento dei battaglioni trasmissioni, a suo tempo inquadrati nelle Divisio ni soppresse, o con la t rasformazione degli stessi in compagnie, nei casi le Divisioni divennero Brigate.
In campo dottrinale si sentì la necessità di rivedere co mpletamente i criteri d i impiego delle nuove Grand i Un it à, divenute in preva lenza corazza te o meccanizzate; attività che si concre tiz zò ne ll a p roduz io n e di un a nuova norm ativa dottrinale: la serie "800".
Anche le Trasmissioni, superata la fase di riorganizzaz ione e di rinnovamento dei mate riali, affrontaron o i probl em i o rd inat ivi, o rga nizzativi ed addestrativi, pensa nd o al fu turo e p ersegue n do, altresì, l'affrancamento totale, per lo sv iluppo d ei materiali, dai progett i e dai prodotti non naz io nali. In patticolare, per accrescere la cu ltura e la competitività de ll 'i ndu st ri a naziona le, furono intensi ficate le attività in ambito internazionale con la partecipazione attiva di rappresentanti d ello SME, dell'Ispettorato Trasmissioni e dell'Industria, a i maggiori programmi impostati in am bito NAT O, Eurogrupp o, U.E.O. e FINABEL.
Il primo decennio ( 1975 - 1985)
La prima fase della r iorganizzazione ordinativa delle unità T rasmissioni dell'Esercito di campagna prese spunto dal g ià citato processo d i ristmttura zione delle Grandi Unità e, in parti co lare, dal potenziamento d elle esigenze d i comando e co ntrollo a livello Regione Milit a re, Corpo d'Armata, Divisione e Brigata , conseguente all'estendersi dell e competenze e delle responsab ilità opera t ive delle Gra ndi Unità rimaste . I b a ttag li oni trasmissioni eli C.A. e di Rlvl venn ero po tenziati nel personale e n ei mezzi, p e r garantire la più ampia copertura dei sistemi di trasmissione, armonizzata co n i comp iti e le respo nsa bilità di settore d e lle nuove
GG.UU .. A tale fine, le reti di telecomunicazione subirono una graduale trasformazione, con st rutture sempre meno "gerarchiche" e sempre più "a maglia ", giacché i PC delle GG.UU., cara tterizzati da un'accresciuta mob ilità, non potevano più subire i condizionamenti prop ri dei sistemi d elle t rasmissioni tradizionali. A live ll o Brigata vennero costiruiti dapprima 2 pl.t. e , poi, la co mp agn ia trasm issioni inquadrata ne l Reparto Comando e Trasmissi o n i d e ll a G. U.. Success ivamente fu avvertita l' e s ige n za eli d isporre di un Uffi ci al e addetto alle Tra s m issioni ne ll o S.M de ll a Briga ta Detta o rganizzaz ione f u es te sa anche alle Brigate Alpi ne, in p recedenza dotate d i u na compagnia t ras mi ss io n i autonoma
Si provvid e, in fme, pe r effe tto de ll a prog ress iva estensione e p o tenziamento d e ll a Rete TLC infrastru ttura le, al graduale passaggio della responsabilità ges ti o na le de lla re te
Le tra foto mostrano il Centro di pmduzione televisivo delia Scuola delle Trasmissioni dell 'Esercito Visione parziale.

Telescriuente
infrastrutrurale, prima accentrata nel X battaglione trasmissioni, ai reparti Trasmissioni eli Regione Militare per gli impianti presenti nelle rispettive aree giurisdizionali.

I provvedimenti ordinativi adottati e la ristrurrurazione dei sistemi eli trasmissione campali e della rete TLC inrrastrutturale co mportarono , nel comempo, l'aggiornamento eli tutta la normativa di base, cd in panicolare delle circolari 9000, 9100 e 9200 de ll a serie do tt rinale , la cui precedente edizione risaliva al 1967.
Anche l'att ività addestrativa venne intensificata e corre la ta con l'introduzione in servizi o d e i n uovi materiali.
Furono , in part ico la re, note volmente miglio r a ti , n e ll a t ip ol ogia e n e ll a q u a nti tà , g li aus ili d idattic i p e r l' acl d estra rr tento dc i m il itari di lev a Esempi signifi cati vi, f u rono la creaz ion e dd Cen tro d i Prod u z io n e TV press o la Scuola Tra s missi o ni d el la Ce cchignola, l' au la eli te le d att il ogr<1fi<1 p resso la Sc uola di S Giorgio a Cre m a n o e l' au la addcstra tiva p e r la Swz io n e rad io d i g ra nde potenza RH6 / 1000 presso la Scuola TLC inte rfo r zc d i Chiavari. Con l' int ro du z io ne d e i nuovi me zzi ve ni va no svo lti co rs i, presso le ditte for ni t ri c i, per Urfìcia li e So ttuffi c iali d es ti nati a lla f u nzion e el i Istrutto ri p resso gli enti addestrat iv i e presso i re p a r ti d es tina tari d eg li s tessi mate riali
Contestualmente all'introduz ione in serviz io dei nuov i mezz i, venivano elaborate e diramate specifiche "Note Informat ive" co ntencnri i dari fondamentali relativi alle cararretistiche temiche ed operative di ogn i singolo materiale, ai piani di distribuzione , alle modalità d 'impiego e ai programmi addestrativi. Nello stesso periodo (1976) veniva diramata anche la seconda ser ie di va rianti al "Prontuario dei Mezzi delle Trasmissioni". VoLI del ··Manuale per l'Ufficiale delle Trasmissioni ", che ne aggiornava il conrenuto con l'illustrazione dei nuovi materiali in setvizio.
campale TCi-91200 installata su t•eicolo ciuROialo M 577.L'introd uzion e in se tvizio dei m ateria li di produzio ne nazionale comportò inol
tre la revisio ne della metodologia d i composizi one della sigla di identificazione degli stess i, attribuita al momento della loro omologazione. Ven ne , così, elaborato il nuovo "Sistema di Nome ncl atura de i materiali dell e Trasmission i", adottato in sostituzione del v ecc hio, a suo tempo impiegato p er g li apparati di produzione sta tunitense.
Pass o importante nel campo d egli a pprovvigioname nti fu l'adozion e eli cr iteri d i prog ram mazione pluriennale Lo Stato Ma ggiore dell 'Esercito approvò , infatti, un p iano elaborato dall' Ispettorato Trasmissioni per l'ammo dernam ento di lungo respi ro (programm azione decennal e) co mprendente le linee guida della "politica dei materiali" nello spec ifico settore, i te mpi, le modalità di svi luppo e di acquisiz io ne dei nuovi m e:.:::z i. La visione degli obiettivi da p e rse guire costituì p er l'industria e lemento fondame ntale di stimolo a lla progettazione nazionale d e i mezzi di trasmiss ione. In tale co ntesto venn e avv iato l'ammodername nto dei multiplex te legrafic i, dei ponti radio a media capac ità in gamma UH F PR6/ 190, delle sta zioni radio HP a banda laterale unica RH4/178 ed RH5/478, del compattato re di messaggi e delle telescriventi el ettroniche TG9/ 200

I sistemi di trasmissio ne dell ' ep oca e rano dunqu e in buona parte caratterizzati d a una li nea mod e rna di stazioni radio VHF ed HP e, specia lmente n e ll 'amb ito d e ll e mino ri unità , si e ra verificato un vero e proprio sa lto di qualità rispetto alle prestaz ioni delle ormai obsolete stazioni radio di provenienza USA (seri e AN/ GRC3/8, AN/ PRC-8/1 0, SCR-193, ecc.)
Per quanto attiene alle comunicazio ni multicanal e di media capacità, le dotazioni e rano costituite dai vecchi ponti radio USA AN/ MRC-69 e da p ochi ponti radio nazio n ali PR-6.
A ma no a mano che i nuovi mezzi venivano introdotti nelle dotazioni , a ncorchè molto restava da fare come nel campo d ella commutazione rimasta manu a le e lenta, l'architettura d ei sis t emi d i trasmissione evol veva verso una struttura a maglia, mediante l'accentramento dei ponti radio in aree indipendenti dai PC, d enominate "ce ntri nodali", veri e propli perni di manovra delle linee di co municazione .
L'evoluzione d ella st mttura verso le reti a maglia d e rivava dall'esig enza di confe rire a i sistemi eli trasmission e un live ll o di flessibilità cong ruente con l'acce ntua ta mobilità delle unità ope rative utilizz atrici del sistema e per conferire agli stessi un maggior grado d i sopravvive nza complessiva mediante un'ap propriata rido ndanza de ll e linee d i comunicazione.
I n definitiva, il perio do in questione rappresentava una fase di tra n sizione verso sistemi di tra s missioni più aderenti alle esig enze operative moderne e soprattutto segnava una svo lta vers o m e todo logie vo lte a ll'ammodername nto de lle Trasm iss ioni, secondo linee programm atiche organiche e non più episodi ch e.
L 'attività di ricerca e sviluppo
L' attività di ricerca e sviluppo fu intensa e strettamente connessa con la progranunaz ion e finan z iaria. Vennero avviate n u meros e es perien ze a liv e llo Forza Annata e Interforze, e furono messi in cant iere moltepli ci studi, tra i quali la "valutazione delle possibilità di trasmis sio n e dati sui mezzi radio e pon ti radio già dis p o nibili", la "definizione di modelli matematici per la correzione degli errori", la "valutaz ione comparativa di tecnich e d i trasmissione numerica previa la re alizzazio n e di prototipi di multip lex PCM e multiplex Delta finalizzati all 'impiego militare", e la "s helteriz zazione dei me zzi cos tituenti i centri trasmissioni camp ali".
Pa rt icolare menzione mer itano lo stu dio per la re a li zzazio ne del "Siste ma cam-
Gra:fìco delta r ete TLC Naz ionale lnter:fm"ze.
pale integrato delle trasmissioni n ella zona di operazion i per il periodo post-75", poi denomin ato "CATRlN ", ac ro nimo di "Sis tema Campale delle Trasmiss ioni Integrate" e lo stud io AM-77 , p er lo sviluppo d i u n a serie d i apparati cifranti destinat i a co prire tutte le esigenze delle FF.AA
I sistemi "post-75 "
G ià dalla fine d eg li anni '60 furono date direttive per definire le prestazioni e i parametri tec ni ci de l futmo "S istema di tra smissioni tattiche per il post-75 ", con sp icca te caratteristiche di inte ro p e rab ili tà int ernazio nale.
In ambi to Nato , gli espe rti d e l se ttore misero a punto abbastanza agevo lm ente il conc e tt o op e rati vo el i base d e l sis te ma, ma inco nt raro no , invece, insormontabili diffico ltà nel raggiu ngimento di accord i sug li aspe tti tecn ici e parametri.c i da porre a fattor comune ne l success ivo sv iluppo d e i sis temi dei rispe tti v i Paesi membri.
Ta li difficoltà derivavano esse n zia lm e nte dall'impossib ilità d i derogare da ta lun c scelte tecniche, già consolidate neg li studi di fattibilità svolti da Stati Unit i, G ran Bretagna, Francia e Ge rm a nia, ch e apparivano non sodd isfacenti in pros petti va, come la scelta della tecni ca di trasmissione numerica PCM (Pulse Code Modu lation), d1e risultava onerosa in termin i d i occupazion e di speuro a racliofrequenza , n on utilizzabile a livello monocanale e vulnerabile sotto l'as petto sicurezza.
Contestualmente anche l'Esercito Italiano aveva avviato lo svil uppo prototipico di multiplex PCM e d i multiplex in tecni ca num erica Delta , al Hoe di acquisire elementi eli valutazio n e sulla qualità dei segnali Delta c di raffro n to PCM/DELTA, e aveva promosso lo s tu dio di fatti b ili tà d el sistema d i Trasmissioni per il post-7 5, con l'obiettivo di definire la filosofia gene ral e del s is tema , le tecniche ottimali utilizzabili, l'a rchitettura ed il dimension amento d elle reti, le prestazioni per l'utenza, i parametri tec ni c i fondamentali e le caratte risticbe el i massima d eg li apparati componenti.
Le difficoltà incontrate in ambi[() NATO portarono, all'in izio degli anni '70, a ll a cos tituzione , in ambito EUROGR UPPO, d e l Gruppo di Lavoro EUROCOM comprendente i soli Paesi NATO ade re nti alla Co munità Economica Europea.
L'andamento d e i lavori d e li 'EUROCOM risultò immedia tam ente più agevole c cos ttu tti vo grazie ai co n tributi d e lla Delegazio n e in gles e, olandese ed ita li ana ed alla decisione unanime dì sceg li e re la tec nica numerica Delta. In poco più di un anno fu possibile definire i requisiti operativi del Sistema ed i parametri tecn ic i fondamentali per garantire l'interope rab ilità a livello inte rnazionale.
I risultati conclusivi d e ll o stud io di fattibilità nazionale, aggiornati con le risultanze dei lavor i EUROCOM , co n sentirono alla Fo r za Armata, a metà degli an ni '70, di elaborare i req u is iti m ili tari da porre a base dello sviluppo del futuro sistema di trasmissioni e di avviare lo sviluppo protoripico di apparecch iature di line a per la trasmiss ione di seg nali Delta su cavo CX- 1065 e d i concentratori con capacità di com mutazione CD-101. Nonchè di avviare l'a pprovvigionamento eli ponti radio in grado eli essere equipaggiati co n multiplex numerici, in gamma UHF.
La rete TIC infrastnttturale
Nella seconda metà de g li anni '70 la Rete TI.C infrastrutturale dell 'Esercito e ra g ià abbastanza svilupp ata su tutto il te rritorio nazionale, ma presentava importam i criticità, propri e di una c rescita affrettata, dovute principalme nte a ll a disomog eneità dei live lli di qualità di alcune tratt e in ponte radio troppo estese, allo scarso livello di affidabili tà per l'insufficiente co e fficiente di connettivi tà de ll a rete medesima e per la precarietà di alcuni siti. Ciò nonostante , la situaz ione raggi u nta in

quegli anni co nsentiva la pressoché torale d ismissione d i circuiti noleggiati dalla PTf e quin di la massim a auto nomia o p e rativa per la F. A..
La ret e a d isposizion e e ra costituita da fasci princ ipali e dorsa li reali zzati in ponte radio , p rin c ipalmente PR -8 a 12 e 60 ca nali FDM, e da code verso i bacini di urenza, comandi operativi fino a livello Brigata e comandi territoriali fino a livello Co mandi Zona.
In ambi to Reg ion a le venne ro sv ilu ppa te reti se conda rie , per il co llegamento di em i e comand i di più basso livello, cost icuite da ponti rad io monocana li e a pi ccola/ media capacità T servizi a disposizione erano soltanto la fonia e la telegrafia ( telesCiivente); quest'ultima disponeva anche di una rete sicura con cifra in lin ea (o n-line). Negli anni seguenti le attività svolte riguardarono essenz ialmente la bonifica elcl hl rete esistente, c he port ava a l li ve llam.e nlO della quali tà dei segna li eli tuna la r ete, c d il pot e n z iame nto eli a lcun i assi fino a 120 canali.
Venne po i avviata la realizzazione di numerosi co llegamenti trasversa li , denominati '·bretelle interassi'', per migliorare la connettività e, quindi , la sopravvivenza co mplessiva. Particolare attenzio ne fu posta al sistema relativo agli Al ti Comand i (a rea SME), co n l ' introdu z ione del nuovo ccnlro nod.ale d'area di rnont e Gua dagnol o, nel quadril atero attorn o a Roma . In qu es to periodo ent raro n o in serviz io, anche se in tempi successiv i, i Centri Elettronici Trattazione Automatizz ata dei .Messaggi (CETAi'vf) l, 2, 3 e 4, la prima rete in tclescrivente a conunu tazion e di messaggio co mpletamente au tomati zzata e la nu ova rete radio nazionale, basata s u ll e stazioni radio H.H 6, in tegrata nell a rete telefonica per il traffico in fonia e ne ll a rete CETAM per il traffico messaggi in te lescrivente.
In merito a l completamento della rete infrastrutturale analogica, si verificò, a fi ne anni '80, un ripensam enro . Infatti mentre doveva ancora essere avviata la realizzazione dell 'ass e pedemo nrano c di alc une brete ll e, se mpre con tecni ca anal ogica, s.i ritenn e op portuno progra nunare !::1 "n umeri zzazione" del s iste ma prevede ndo prima la rea li zzazione in tecnica digitale d ei tratti mancanti e, poi, il completo transito in tecnica numerica dell'intera rete interforzc. ll problema venne affrontato dagli Stati Maggiori con ip otes i di soluzi one diverse: l'Aerona utica e la Direzione Ge neral e degli Impianti e dei Mezili per l' Assistenz a al Volo, per la D ife sa Aerea e per le Telecornun icazioni (TE LECOMDlfE) propend evan o per l'ad oz ione di app arati PCM , perché maggiormeme diffu si nelle reti civil i c quindi meno costosi, l'Esercito per la modulazione Delta, al fine di poter integrare la rete infrastrutturale co n i me zzi tattici già acquisiti La scelta finale portò ad una ripartizione dei fasci a 2048 kb it/s tra i diversi ur ilizzatori se condo la tecnica sce lta, assicuran do ad ogni F.A. la poss ibilit à di utiliz zare g li apparati co n le caraueristiche vol ute.
Interventi per pubbliche calamità
L ' e levato numero di eve nti calamitos i occorsi ne l periodo precedente (19 501975) ed i conseg uenti interve nti da parte de lle Forze Armate , portarono all'inizio del 1975 alla c reazione di organismi civili, a livello cen trale e periferici (Ministero della Protezi one Civile, con ramificazioni nelle Prefetture e nei Comuni), e militari (sa le operative a livello SMD e SM di Fo rza Armata) r es ponsabili ciel coordinamentq de ll e forz e d i soccorso.
Qua n to alJ'Ese rcito, vennero avviati prog rammi eli appro vvigion amento di mezzi co n caraneristiche di impiego "bivalenti " ossia utilizzabili , oltre che per scopi tipicam ente militari, anche per collegame nti in circostanze di pubbliche calamità
Con quest i prog ra mmi ve nnero acquisite le central i eli co nunu tazione autom at ica ASB -900 in s he lt er, inrc roperabili con la rete PTT, alcuni po nti radio UHF

PR6/I90 ed anc h e un certo nume ro di staz io ni rad io VH F RV3 ed RV4.
La nuova o rganizzazione, per a ltro non ancora su fficienrernenre co nsolidata , venne so tto posta a dura prova già ne l 1976 in occas ione del terremoto n c.I Ja zona del fri uli orienta le, co l massiccio inte rvento de lle un ità de ll e Tra s mission i della Reg ion e Militare No rd -Est e el i rinfo rzi provenienti da altre Regioni.
Venne realizzato un vasto · s is tema d i trasm issio ni c h e co ll egava la Sa la Op e rativa (unità civili e militari) di Ud ine co n le auto rità cen trali, con que lle loca li dei Comun i interessati da l sisma e co n le forze d i int e rvento e d i depos iti logistici. l numerosi centri trasmiss io n i a ll estiti, o ltre a l traffico operativo, co n se ntiron o, soprattutto nella fase iniziale degli interventi, anche lo svolgimento de l traffico pr ivato a favore delle popo laz ioni colp it e .
Ancora più vasw ed impegnativo fu l'intervento de ll e Trasmiss io n i in occasione de l te rre moto Campan ia/ Basili ca ta d e l 1980.

Graz ie all'es perienza acqu isita n el s is ma del Fr iuli, fu attivata co n imm ed iatezza la Sala Operativa dello SME e vennero costit ui te Sale Operative militari a Napo li e a Salerno, Potenza ed Avellino.
Il s istema di trasmissioni , re aliz zato si n d a lle prime g io rnate dell ' interve nt o, prevedeva i collegamenti della Sala Operativa Militare e dell a Sala Op era tiva Civile (re tta da personale dell a Prot ez ione Civ ile) presso la P refe tt ura eli Na p oli co n le Autorità civili e militari centrali, con le Sale Operative provincia li, i centri di soccorso co mun ali, i num eros i depositi , parchi roulotte , aeroporti , e tc . TI s istema raggiunse la s ua ma ssi ma es pans ione nei p r imi s e tt e giorni da ll 'eve nto ca lam itoso, impegnando progressivamente gran parte di t u tte le u nità Trasmis sioni dell 'Ese rcit o. Per la prima vo lta ven ne disposto un im p iego massiccio eli terrnin a li fac -s imil e, rilev atosi prezios o strumento pe r la p res entaz ione in te m pi ri stre ttiss imi d i s ituazioni, e da ti informativi per la form ulazione d elle decisioni conseg uenti.
Il secondo p eriodo (dal 1985 ai giorni n ostri)
Questo periodo è caratterizza to da eventi estremamente innovativi. In campo ordi n ativo si è veri ficata l'e limin azione del livello d iv isio na le e, success iv amente, si è avuta una contrazione progressiva d el gett ito di leva con riduzion i annuali d i di eci mila - quindicimila uo mini , che ha imposto lo scioglimento progressivo di a lt re Briga te e di alcuni supporti .
In tale contesto, a n c he le Trasmissioni han n o pagato un pesante contributo con la riduzion e di ci rca ut1 terzo delle prop rie unità: sono stati scio lti i battag li o ni ex d iv isiona li , in u n primo momen to accorpati a live ll o C.A., e le com pa gn ie trasmissioni delle Brigate soppr esse, nonché la Scuola Sp ec iali zzati delle Trasmissioni con sede in San G iorg io a Cremano.
In un quadro generale di congiuntura economica negativa , mo lti programmi sono stati rinviati, proprio mentre l' Autori tà Po li tica affidava n uov i e innovativ i impegni opera tiv i a ll a Forza Arma ta. Dopo la felice spedizione in Liban o , l'Ese rcito Italiano è stato, infa tti, impiegato in Nam ibia, in Kurd ista n, in Alban ia, in Somalia e d in Mozambico Le Trasmissioni hanno dovuto affrontare problemi nuovi, imp iegando i mezzi già intro do tti , rivelati si perfettamen t e r is pondenti e a ltr i nuov i d i tipo satellitare, rapidamente acquisiti per le nuove esigenze Sono state, inoltre, la rgament e impiega re unità d e ll' Ese rcito in funzione d i ordine pubbl ico n elle cosi ddet te Regioni a r is ch io (Sa rdegna, Sicilia, Ca labria e Campan ia) .
Dal punto di vis ta tecnico, il periodo ha segnato la progressiva osmosi tra sistem i eli telecomun icazione e s is te mi in for rnati c i. Infa tti l'ele tt ron ica d ig ita le è diven ut a
compo nente essenzia le eli tutte le appa recc hiature e le ttroniche ed il calco la tore è stato sem pre più impiegato come parte dei sistemi di telecom unicazione.

La lìlosofia delle reti è in continua evol uzione. Alla tradizionale commutazione di ci rcu ito s i sono affia n cat e , con ruo lo cres cente, quelle di mes saggio c di pacchetto . Anche p e r le esige n ze d e l Comando e Controll o il ruolo dell ' info r matica diviene v ieppiù co ns istente : le capacità decisionali non posso no essere più p e naliaate da sistemi di tra ttazione dell e info rmazioni trad izionali e postul ano orga nizza7.ioni razionali , idonee a frontegg iare s ituazioni in rapida evol u zione.
La miniaturizzazione consentita dai circuiti integrali, coniugata con la tecnica numerica, ha moltip licato a dismis ura le possibilità operative offe1te dall'elettro nica in rutti i suoi campi eli applicazione. Così, mentre nel settore dell e trasm iss ioni la possibi lità eli inviar e a dis ta nza e di riprodur re t est i scriui, s uoni ed immag ini facilita le com unica zioni, è proprio ne ll a faco ltà uman a ove s i intravedono i limiti di co mprendere ed imm agazz inare questa grand e mo le di dar i.
L'informatica viene però in aiuto e si inserisce laddove i mezzi rrasmissivi te rminano la loro fun7.ione: dal connu bio delle due tecniche, entrambe in rapidissima evo luzione, nasce la "Telematic a", o "Te leinformatica " neologism o per indi ca re un'union e sempre più stretta tra le citate tecnic h e.
Il progresso in vog li a gli Stati Ma gg io ri a chiedere sempre di più alle trasm issioni. Tecn icam en le v ie n e richies ta un a quali t à della co municaz ione e leva ta nel tempo e nello spazio, indipendentemen te dalle d istan7.e e dai percorsi dei circuiti , nonché la resistenza alle attività di guerra e le ttronica, sop rattutto all'intercettazione, no n ostan te le aumentate pote n zia li tà di quest 'ultima e la protezion e criprografi ca quas i a "tappero", cioè non più riserva ta alle co rn uni caz ioni più se nsib ili. La poss ibilità di prot ez io ne dal rum ore, d a ll 'inte rferenza e dal disturbo , la ca pacità di pe rfe tta r igen erazione del segnal e negli orga ni rip etito ri , la fattibilità dl una cifra sempli ce ed effi cace, la commutazione au tomatica n onc hé i valoti d i econo mia , affidab ilità, ingombro, peso, consumi c mantenib ilità p ropri del binomio tecnica digitale-circuiti inlegrati consentono, o rmai , di dare risposte adeguate, su l piano tecnologico , all e esigenze degli Stati Maggiori.
Tn questo peri odo vengo no fin a lmente avviati tre ril evanti programmi parzialmente a ffidati alle Trasmissioni : il CATRIN, il SIACCO N e d il SIE.
Il sistema Catrin
Il concetto operativo del Catrin deriva dalle esigenze di poter e se rcitare le funzion i di comand o e co ntrollo in un co ntes to operativo moderno. A tal fi ne risulta indispensabile ott e n e re la rapida acqu is izione ed elaborazio ne eli tutte le informa:doni necessarie a l processo decis iona le, la immedi ata dirama zione d eg li ord ini e de ll e info rmazi oni conseguenti , n onché il co ntroll o funz io n a le della loro esecuzione, secondo un p rocedime n to operativo con risp oste se mpre più pross ime al "tempo reale " .
Per soddisfare dette esigenze, i comandi chiedono la disponibilità di un sistema glo bale ed armonico di Comand o, Controllo, Comun icazio n e e Informaz ione (C3 I) , var iamente a rtico lab il e in r e laz ione a ll a consistenza e alla tip o logia del d ispos itivo di forz e da se rvire.
Il sistema CATRIN (d ivenuto acronimo di Sistema CAmpale d i TRasmiss ioni e IN forma zio n i) costituisce quindi una patte fondam e ntal e e p ro pedeutica del più am pio f u turo sistema C3 I de lle Forze Armate, inglobando i seguenti sottos is te mi :
- so ttosistema SORAO per la sorveglianza e l'acquisizione eli obi e ttivi te rres tr i;
- sottosistema SO ATCC per l 'avvistame nto t atti co a bassa quota, il co m a ndo ed
il controllo d e i velivoli dell 'Aviazione dell 'Esercito e d eJJa Contraerea;
- sottosistema SOTIUN per la rapida circolazione del flusso delle informazioni e degli ordini su una piattaforma di trasmissioni integrate a l servizio di tmte le esigenze d i comun icazion i prese nti nell 'area servita dal sistema C3L Lo sviluppo di un sistema così con cepito è sta to affidato al consorzio CATR fN, composto d a indu strie nazionali de ll a Difesa.
Per i Sottosistemi SORAO e SOATCC è p revisto Io sviluppo delle seg u enti pri ncipali apparecchiature:
- SORAO:
• Telegoniometro las e r
• Comp lesso fono te le m ct ri co
• Visore all' infr arosso p ass ivo int eg rato con telemetro lase r
• Radar contro fuo co
• Rad ar su piattaforma ae rea

• Comp lesso mini rpv

• Complesso clronc a media e lunga portata
• Centro correlazione dati
-SOATCC:
• Cent ri di scope rta, rad ar di sorveg li a n za e eli acquisizione
• Cent ri eli riporto
• Cellula operativa
• Centri di controllo
• Ricevitori di allarme aereo
Il sottosistem a Sotrin
L'a pproccio a ll o svi luppo del sottosiste ma SOTRJN ha rappresentato una s volta nei crite ri di ammodernamento dci mezzi delle trasmi ssion i, in precedenza basati sulla semplice sostitu?.ione dei singoli apparati con altri più moderni e di equivalente funzione.
L'orie ntam ento verso un sist ema di comu ni cazioni integrato nelle tecniche e n e i se rv izi, basato su ll 'uso este n sivo de ll 'au tomazione, ha infatti indo tto l'Ese rc ito ad app rofo ndire lo sv iluppo del futuro s istema e dei re lativi mezzi e componen ti in modo unitario ed
In alto: Radio Centrale - Stazione Base (RAP) , vista in terno.
In basso: Rad·io Cent-rale - Utente Mobil e (M())

Al momenro della s tes ura d e i req ui s iti militari , il sottosis terna SOTRIN, nonostant e il co nfo rto dei risultati e d e l precedente studi o di fatt ibilità e dei lavori EUROCOM, a ppari v a come una so lu z io n e troppo avanzata e ad a lto ri s chio tecnico, in quanto basato su soluz io ni te cniche e tecnol ogich e appe n a inrrave dibili e non anco ra s ufficientemente conso lidat e, per cui il sistema stesso s i poneva come un 'aute nti ca s fi da tecno logica per le aziende nazionali interessate.
Nei req uis iti milita ti il SOTR I è staw concepito come un modulo per Corpo d 'Armata e per soddisfare tutte le es igenze di comunicazioni delle Grandi Unità, qual e pi attaforma per il più vasto sis tema integrato di com a nd o, controllo e com unicazione e info rmazione (C3J).
La modu larità , la f-l essibilità di impiego e la de i mezzi compon e nti , co n se ntono tuttavia qu a ls ia s i ada ttamento per impi eg h i limitati a livelli ordinat iv i infe rio ri.
Partico la re men zion e m er ita l'arch it et tura del sottosis tema a rtico la ta su tre re ti , p er e vitare v in coli alla mobil ità deg li stess i u tilìzzato ri : la re te n odale, la rete di accesso, e la rete radiomobile , con g rad i d i mobilità diversi, liberamente m utabili nella co nfi guraz ione, ma accomuna te nel modo di funzion amento, ne i tipi di servizio e nelle prestazioni offe rte.
La r e te n oda le è costituita d a un nume ro di centri, varia bil e in fu nzione dell 'ampie zza d e ll 'a rca da servire! ognuno compre ndente una centra le eli co nunutazi o n e e i ponti rad io p e r la interconn ess ion e el c i centri medesimi , in un a s truttura di tipo a g ri g li a capace di garantire un e levato g rado di soprav viv enza e un più fl essib il e instrad a me nto de lle comuni cazioni. La fu nzio ne della r e te no cia te è essenzialm ente eli transi lo pe r le esigenze di comunicazione deg li utenti del sis te m a.
La rete di accesso comprende le ce ntrali di commutazio n e assoc iate ai posti comando delle unità , che operano nell 'a rea di copertura d ella rete nocla le ed i ponti radio per il collegamenro contemp oraneo a due cenui nodali. La funzione di questa rete è d i collega mento alla rete n oda le dei gmppi di utenti associa ti a i posti comando.
La re te raclio mob ile compre n de s taz ioni base, o RAP (Radio Access Po int), c iasc u na co llega ta ad un centro n oda le , ed un numero variabil e di te rminali radio o MU ( Mobile Unit}
La funz io n e de ll a ret e rad iomob il e è di consentire il co ll ega mento alla re te nodal e di ute nti singoli isol ati o co n es igenze di mobilit à e levata . Si tra tta, in pratica, di una so rta di rete radio cellul a re, co n cara tte ristiche e presta zio n i m ilitari

Tutti i co ll ega menti , sia multi cana li che monocanali , so no protetti da un a cifra di rete.
Le reti s uddette e tutte le utenze del sistema sono pian ificate, controllate e ges tite da u n siste ma di superv is io n e, a 1tico lato s u tre li ve ll i.
11 primo li ve llo, CPS (Concez ione e Pianificazione Siste n1 a), è resp onsabil e d e ll a pianificazione, progettazione e co ntrollo global e d e l s is te ma, nonché della gestion e d e ll e chiavi cripto e d EPM; il secondo livell o, GS (ges tione s istema), è responsab il e della gestione tecnica d e l sistema; il terzo live llo, ES (ese rcizio sistema), è respo nsabile d ella gestione e d e l co ntrollo d e i compless i di app artenenza (centrali di commuta zion e e RAP).
Tulli gli organi di supervisione operano coordinati tra loro e co llegati in sistema mediante rete dati a commutazione di pacchetto.
Per qua nto attiene alle prestazioni del sis tema , va sotto li neato ch e ciascun ute nte, mobile e/ o relativament e s tatico , viene identificato da un num ero a sette c ifre, asseg nato s econdo i criteri de ll a sta ndardizza zion e NATO e d EUROCOM, che rim ane in va ri ato quali che s ia n o gli s postame nti dell ' u te nt e n ell 'a rea serv ita dal sist ema
L' utente, a secon d a della sua funzione ed importanza op erativa, può gode re di prestazioni automatiche parri co lari, come a d esempio vari livelli di priorità o l' appropriazione di canali di comunicazione risultat i occupati.
Per casi partico lari è anche previsto l'utilizzo di cifranti di utente "end to end".
Le comunicazioni possono avvenire in fonia, teleg rafia, dat i e fac-simile mediante selezione di retta ed automatica de ll 'u tente chiamato. Per la telegrafi a (telescriven te) è anche prevista la poss ibi lità di comunica zione indir e tta di tipo "sto re an d f01warcl "

La ricerca dell'ute nte chiamato avv iene a diffusion e sull'in tera rete.
I mezzi che compongono il s is tema SOTRIN, a seconda della loro funz ione, sono raggruppati nelle fami g li e eli apparati di utente, di rete, di cifra e eli complessi particolari.
Il Pre-Sotrin
Nel corso dello sviluppo del Sistema CATRIN, la disponibilità d e i primi prototipi acquisiti, in parti colare il concent ratore CT6-101 ed i ponti radio UHF, ha consentito di avviare una prima sperimentazione di rete campale numerica a commutazione automatica nonché l'a ddestramento del personale sui nu ovi mezzi e s u lle nuove procedure d'imp iego degli s tessi.
Gli ulteriori approvvigionamenri hanno permesso, in seguito, la realizzazione di una rete PRE-SOTRil\, inizialmente limitata alle aree del 4° e 5° Corpo d'Armata e, successivamente, estesa a tutto il teiTito rio nazionale, con qualche significativa appendice anche per i collegamenti delle unità dell'Ese rcito impegnate "fu ori area".
La distribuzione dei mater ia li d i nuova generazion e ai Reparti ha fatto fare ag li stessi un rilevante salto di qua lit à, assicuran d o fiducia, cultura e credibilità alle Trasmissioni. L' introduzione, in particolare, del CT6 -101 ha coperto una lacuna n el settore della commutaz i o n e ri sa l e nt e a de ce nni: in pratica le unirà d e ll e Trasmissioni dell'Esercito sono p assate repentiname nte da sistemi di commutazione manua li , tipo CT-4, alle centrali automat iche digitali a programma registrato.
La rete PRE-SOTRlN si è ri ve lata di importanza fondamentale non solo in Italia , per le esigenze di controllo d e l territorio da parte dell'Esercito, (op eraz ione Forza Paris, Vespri Siciliani, Ria ce , etc ), ma anc he all'estero (Albania, Somalia, Mozambico). Le isol e PRE-SOTRIN co là rea li zza te , hanno risposto puntualme nte alle esigenze di comunicazio n e locali c, median t e l'integrazione con satellite o stazione radio HF di grande potenza, a n ch e a lle necessità d i comando e controllo dalla Madrepatr ia, nonché a fronteggiare i problemi di comunicazioni personali dei militari dei contingenti.
Il Siaccon
Il sistema di comando, co ntrollo , comunicazioni ed informazioni (C3J) campale sarebbe rimasto incompleto se nz a la componente "Com ando e Controllo" (C2), denominata "S TA CCON ", acron imo d i Sis t ema Aut omatizzato di C omando e CONtrollo
Inizialmente suss isteva l'es ige n za di avviare, attraverso un contratto parallelo a quello del CATRIN, la realizza zione di un sistema in grado di migliorare l' org a ni zzazione interna dei Posti Coma nd o a i vari livelli (dal C.A. al gr.tat. ), in modo da trattare in tempo reale e co n metodi a utomatizzati, le informa zion i acquisite mediante il CATRIN, al fine di con se ntir e la rapida assunzione delle decisioni e la veloce diramazion e degli ordi ni

Nella pagina a fianco: J<ete Pre-Sotrin '94
In basso: Grafico del autom a tizzat'O Coma ndo e Co ntr·ofto SIA c-· CON.
CAS.I = CentroAnalisi eSelezione delle Inform azioni C.F. =Ce ntrodi Fusione = Ce nt ro

Diversi sono ::;ta ti i tentativi per avv iare la del SIACCON Poi , anche a causa delle sem pre più limitate risors e dis p on ibi li, lo SME ha dec iso d i realizzare in proprio, utilizza n do i mate ri ali già introdott i, le re alizzazioni e le espe rienze ma turate a utonomamente da d iversi Enti , un s is tema prototip ico di C2 , afficl a rtdone la cond otta tecnica al Ce ntro di Trevi so e la va lutazione opera tiva al Coma ndo del 5° C.A
L'esp erienza d oveva co nsentire eli ragg iungere div e rs i obiettivi, tra i qua li l'acquis izione di un a ce rta ca pacità da pa rte del personale ope ra tivo dei coma ndi eli G.U. d i operare con ::;istemi a utomatizzati e l'i ndi v iduazione dei prin cipali prob lemi tecnico -op erati vi per meglio d efinire i req uisiti milit ar i de l sis tema da r ea li zza re.
In Treviso, petta nt o , è stata re alizza ta una prima str uttura di t ipo dida ttico per d e line are i probl emi di comunicazione, pe r iden t ificare le funzio n i ess enziali e pe r v e rifi ca re la funziona lità e la risp onde n za. del disegno di s is te ma individu ato.
In un secondo momento si è dato avvio alla rea li zzazione p ratica d i un PC mobile, utiliz zabile a live ll o C.A. o B. e utile ad aftì·ontare c r isolvere i problemi di int e rope rabilità tra PC d i Unità dei diversi Paesi dell a NATO dest ina ti ad opera re co n le F.A. Italiane
Ciò ha perm esso l ' inseriment o d e ll'Italia nel g rup po d e i paesi ( US A, UK , G e rmania e Francia) c h e sta risolvendo a naloghi probl e mi in vista d e lla cos tituzione d e ll e G .U . compos ite, in grado di affrontare le n uove s fide e gli imp egn i multinaz iona li emerge nti in sede O. N.U. c NATO.
La st ruttura del STACCO N prev ede la costituzione eli un Ce n t ro Ana l isi e Selezio ne delle I nforma zioni (CASI) co n diverse cellu le (5 a livello C.A. ) in g ra do di tra ttare le acquisite, scle zio narle e m emo rizzarie in un "Ce nt ro di Fus ione", v era e propria banca dati d e ll e informazioni "p ulite", in modo da co nsen tir e a llo SM ( Sala Dec isional e ) di pote r operare su d at i ce rti ed agg io rn a ti per va iU[a re le possibili azio ni del ne m ico, for mulare le linee di azione propr ie e trasfo rmare la decis io n e de l comandante in or dini , controllandone l'esecuzione Le so lu zio ni adottate e le rea lizza zioni effe ttuate sono state verificate in numerose attività addestrative, porta ndo all a conc lu s ione che sarà possibile cons eg uire l'obi e ttivo d i disporre, al te rmine dell a fase prototipica d e l CATRI N, el i un a s truttura di co mando e controllo in grado di ve rificare la valid ità ope rativa d e l s is te ma , n e ll a s ua globalità C3I.

Il sistem a informativo dell'Esercito
Tra i tanti pro bl e mi da affrontare p e r rendere più e fficace eli comando della Forza Armata, vi è qu e llo di raz iona lizzare lo st ru mento informativo de ll 'Esercito ch e, a ttraverso gli anni, s i è sv ilupp ato co n l' ac quisto di un a quantit à cons istente ma var ia d i ha rdware.
Si è pensato eli risolve re il problema attraverso la realizzazio ne d i una rete di trasmissione dati che avrebbe d ovuto inte rconnettere i va ri s is temi già acqu is iti e ri so lve re i problemi di interoperabi li t à (gateway) tra e laboratori caratte rizzat i da sign ifica tive d iversità (ba nche dati, s is te mi operativi e tc.)
Il programma è sta to affidato a ll a S.I. P. , che d oveva , tr a l'altro, fornire a no leggio un a rete trasmiss io ni dati a commutaz io n e di pacchetto, effettuare una se rie d i lavori sui siri ove era prev ista l'ins tall az ione d el centro d i gestione , de i nod i e de i co ncentratori ed affrontare, mediante stu di da portare poi a so luzio ne, i problemi de ll a co nnession e in re te dei vari elabora tori e di interopera bilità tra gli elabora tori caratte rizzati da s iste mi o perat ivi div ers i.
La re te realizzata è articolata in un a com ponente prima ria , costituita da l ce ntro
Ne ll a pag ina a fianco: Grafi co della 1·ete Trasmissioni Dati per i l SIE.
- NODI
• CONCENTRATORI
- CENTRO GESTIONE RETE


Nella pagina a fianco, in alto: Stazione radio VHF ECC/V! (EPM.).
rn basso:
Terminale Mohile Satellitare TCSLite 9200.
eli gestione, dai nodi e dai relativi circuiti dati di interconnessione ad alta velocità, ed in una componente secondaria , di primo livello, formata dai concentratori X25 e da altri circuiti dati per collegare i concentratori tra loro e con i nodi. Es ist e anche una rete secondaria eli secondo livello, formata dai circuiti a bassa velocità, per allacciare i sistemi di elaborazione ai nodi ed ai concentratori.
Particolare attenzione è rivolta alle modalità per la sostituzione della rete noleggiata con una più moderna -ed è un problema ancora in trattazione - in grado di confluire ed integrarsi nei progetti della Rete Numerica Interforze, nel PRESOTRIN e nella Rete Infrastrutturale dell'Esercito.
La sicurezza delle comunicazioni

L'esigenza di proteggere le trasmissioni proprie dall ' attività SIGINT e eli guerra elettronica è sempre stata presente nella storia delle comunicazioni: è dall'inizio della guerra fredda, tuttavia, che l'es igenza è divenuta necessità primaria da affrontar e mediante procedure sempre più attente e tecniche sofisticate ed allo stato dell'arte.
ln particolare , all'inizio degli anni '70 erano in servizio solo sistemi essenzialmente rivolti alla sicurezza delle comunicazioni, (COMSEC), orientati a proteggere il traffico telegrafico mediante cifra, con s istemi in linea (ON-LINE) e fuori linea (OFF-LINE) 1 materiali impiegati, di provenienza USA (acl eccezione delle ONLINE CT-65), non riuscivano a coprire che io minima parte le esigenze nel settore ed in particolare non salvaguardavano la fonia. Per tali ragioni è sta to avviato, a fine anni settanta, uno studio interforze ad ampio spettro per la realizzazione di cifranti foniche analogiche e numeriche, a banda stretta ed a banda larga, orientato anche alla produzione eli una logica cifrante nazionale. I risultati dello studio non hanno ri spos to del tutto alle aspettative per motivi di carattere tecnico ed operativo, per cui ogni Forza Armata ha proseguito autonomamente nelle realizzazioni dei sistemi eli protezione, ricorrendo a memorandum di intesa con gli altri paesi per l'acquisto di logiche approvate NATO.
L'Esercito ha avviato lo sviluppo della cifrante trivalente ON/OFF-LINE con tre tipi eli logica, delle quali una nazionale e due approvate NATO, ha acquisito alcune cifranti dati e foniche ed ha affidato al consorzio CATRIN la realizzazione di tutto il rimanente parco eli cifranti (di fascio, monocanale, di u tente , etc.).
Per quanto attiene componente sicurezza delle trasmissioni (TRA1'\!SEC), è stata portata a termine la realizzazione di un compattatore per messaggi digitali (al fine eli ridurre le possibilità di intercettazione) ed avviato l'acquisto di una famiglia di nuove stazioni radio in grado di s fruttare le tecniche dello spettro espanso per sfuggire al disturbo (apparati EPM).
Si è affermata, inoltre, una rigida normativa (normativa TEMPEST) per la separazione dei segnali non classificati da quelli contenen ti informazioni da proteggere, destinata a tutte le apparecchiature impiegate per la trattazione eli argomenti classificati.



Il quadro gene ra le "verso il 2000 ed o ltre" non p u ò prescindere da alc u ne considerazioni di fondo.
Innanzitu tto, un Esercito nuovo, con i mo lteplici compiti che gli vengono attribuiti, n on deve più contare su s trum e nti di coma ndo amanuensi, incapaci eli offrire con tempestività piattafo rm e informativ e puntuali ai fini della formulazion e delle dec isioni. Si impone, quindi, di co ntinuare e comp letare l' acquisizione di sistemi automatizzati di comando e contro llo sia per le sedi territoriali s ia per que lle di campagna.
Quanto ai sistemi di trasmissioni sono da valutare taluni elementi correlati all 'impiego della com p onente di forze sul territorio nazionale e all'estero.
Per l'impiego in territorio nazionale, pensiamo che non siano ipotizzabili varianti sostanziali, in quanto l'attuale organizzazione, sia infrastnmurale sia campale, manterrà la sua validità, così come l'arc hitettura dei sistemi areali digitali indipendenti e svincolati dallo schieramento dei posti comando, con la diffusa p oss ibili tà, concessa ai Posti Comando stessi, di accedere liberamente ai nodi delle reti
Unica variante pot rà essere quella di un a maggiore disponibilità di accessi alla r ete NAT O, attualmente riscontrab ili solo ne lla orma i superata ex -zona di combatt imento (p ianu ra Veneto-Friul ana).
Per le forze impegnate f·uori dal territorio nazionale, interverranno criteri di impiego ed esi genze nuove, sia che esse oper ino iso la ta mente che inserite in complessi internaziona li

Nel primo caso, dovrann o essere dotate di mezzi per il collegamento a l loro interno e di mezzi sia per l'in ser imento nelle reti (qualora esistano) dei paesi in cu i sarann o chiamate acl opera re s ia per il collegamento con la Madrepatria. Tali apparati dovranno consentire co llegamenti a lungo braccio, rapidi, efficaci e s icu ri , per i vari tipi di servizio (fon ia, te legrafia, dati, facsimile e video).
Grande spazio, quindi , a i mezzi satellitari, da conseguire mediante l'accelerazione dei programm i già avviati. Il tutto senza esclude re l'utilizzazione della radio HF, anche se opportunamente migliorata n elle prestazioni (trasmissioni dati , correttori di errori, trasmissioni adattive ).
Qualora , poi, le Forze Armare Italiane vengano chiamate ad operare inserite in complessi internazionali, esse dovranno esse re dotate anche di mezzi che assicurino l'armonico interscam bi o dei flussi di comand o e controllo con le Forze dei paesi alleati , NATO e non.
Da tali considerazioni discende immediata la defin izione dei parametri caratterizzanti i sistemi trasmi ssivi del futuro:
- sistemi automatizzati per l'attività C2 dei posti comando ( tip o SIACCO N) a tutti i li vell i pe r un a esaltazione de ll a capaci tà operativa in tempo real e delle forze;
- sistemi di trasmi ss ion e digitali interconnessi tra di loro ed estesi s u tutta la
p iattafo r ma nazio nal e, in m o d o da co n sentire il rapido in serimen to d e ll e forze, indi pendente mente d a ll a loro dislocazione;
- mezzi di tipo sate ll ita re , affiancati da evol u ti siste mi HF, per le forze destinare ad operare [uori dal te r rilori o nazionale, onde co nse ntire coll ega menti a lungo bra cc io, ra pidi, effica ci e s ic uri per i va ri tip i di servizio (foni a, teleg rafia , d ati , fa csim il e e v ideo) ;
- reti radio el i co mba ttimen to, per i live lli ordin ativi più bassi, dot ate di p ro tezione dalle contromis ure elettroniche e id o ne e a ll a trasmissione dati.
È fuo r di du bbio che qualsiasi siste ma di comando e controllo deve essere inreropcrabile con q uell i dei Pa esi co n i qua li si è ch ia n1 ati ad operare
Fatte qu es te pre cisaz io ni, pr emessa indisp ensabile per delimitare i confi ni e ntro cui "mu ov e rs i", acce n neremo a ll a po litica d a p erse g uire per p o rtare l'Arma d e ll e Trasmissioni ve rso il nuovo seco lo, con un a struttura , in termini di p e rsona le c mezz i a l p asso co n i tempi , capace di v incer e la sfi da co n il nu ovo e di fo rn jre, in conclus ione , un serv izio idoneo a sod disfare le es ige n ze precedentemente indica te.
ln tale quadro ana li zzeremo gli asp e tti peculiari c h e riguardano i seg ue nti settor i, tipici d e ll 'attività quotid iana d e ll e T ras missioni:
- ordi nam ento ;
- materia li , m ez:d e sv iluppo tecno logico;
- regolame nt azione d'im piego;
- adcl estram cmo;
- logistica .
Ordinamento
Per garantire il so cldisfacimento delle esige n z e C3I, le Trasmissio ni devono assu mere gli s tessi schemi o r ganici della f.A.. Dev ono, cioè, a tticolars i in una o rga nizza zione:
-centrale;
- per iferica ( te rrito ri ale/operati va);
-sco lastica.
Ta le articolaz io ne scan1risce dai compiti assegn ati , c he possono essere sintetizzati in :

- ges tione d e i siste mi TLC infrastrutturali ;
- ges tione d e i s iste mi di tr asm i ss ione ed in format ici camp a li ti po il SO ttosi stema el i TRasmission i INte gra te (SOTRIN) de l CATRIN e il Sistema Auto m ati z zato di Co mand o e CO Ntrollo (SIAC CON);
- gestione dei sistemi rad io int egrati, sia nel settore infras trutturale sia in quello campale (Combat Net Radio).
Te ne ndo conto che l' Es ercito, e non so lo questo, sta de cisamente p untando ve rso una sempr e più ma rc ata co n ce ntraz ione d elle funzio ni C2 (Co mando e Con tro llo) , l'o rdi name nto nel campo delle Trasmiss io n i dovrebb e preve dere, a li vel lo ce ntral e , un so lo org an o di vertice di coman do delle TIC in cui fa r co nverge re le responsa bilità a n che dei setto r i d ell 'elettronica e dell' informatica.
f\el momento in cu i la Forza Armata è sottoposta a d un severo processo d i revisione delle s trutture, sàre bbe quindi o pportuno preve dere l'accorpamento di funzio ni in setto ri a ffini, quali qu e ll e delle comuni caz io ni e d e ll 'informatica, in n'\odo da aver e un unico organo conce ttl.Ja le e dire ttiv o ido neo e d eputa to soprattutto a gestire, con vis io ne unita ria, U complesso mon do d e ll'informazi one .
Tale organo, r isultan te dal compendio d e ll e fu nzioni, n e l setto re sp e ci fi co d elle Trasmiss ioni e dell' Informatica, arnralmen te esplicate da d ifferenti Ent i, dovrebbe aver e in s é le ene rgie sufficie n ti per dirige re e coo rdinare tu tto il settore C3 in am bito Es ercit o e costituire "braccio o p e ra t ivo " per la defi n iz io n e d ella po liti ca d e ll o stess o set tore in ambito in t erforze.
E' ra g io n evol e a u s p icare che tale o rgano d i F.A . poss a i d ent ificarsi con l' Ispettorato de ll e T ras mi ss ioni, la cui ri st rutt ura zio ne r is ult e re b b e co er e nt e con i nuovi c riteri p re visti d a l Nuovo Modello di D ifes a , tra cu i l' o ttimiz zaz io ne d e ll e riso rse A sos teg n o el i tal e tes i c'è anc h e d a rileva re l' aspetw , no n me n o im po rt a nte , della resp o n sabil ità in te rmin e d i s ic urezza tecnica e dell a pro tez io ne el i tutte le for me di co mt mi caz io n e, g ià a ttri buita all ' Is p e tt o ra t o d e ll e Tra sm iss io n i, c ui dovr e bbero ass ociars i q u ell e s u i s is te m i in fo rm a tivi in g ene re.
Ciò non esclud e il ma rì.te n ime nto in se no a llo Stato Maggiore dell ' Esercito , d e ll'attuale Uffi cio Tra s mi ss io ni e d Info rma tica ch e pur s empre s ar à d es ig na to a ll a

" Verso il 2000". Dipinto di A . Fiore.
defi nizi one della politica di F.A . nel setto re.
A livell o periferico, l a st ruttura att ual ment e es ist e nte, alm e no in ambit o Re gione Milit a re, è r itenut a valida an c h e per il futuro, in qu an to i Com and i Tras miss io ni d i RM rapprese ntano i necessa ri organi dirett ivi a li vel lo periferico in tutti i settori cons iderati ; a essi d ovrebbero far capo anche le responsabilità dell' informatica e le funzi o ni attualmente es plicate, p er lo sp ecifico settore trasmission i, da i Com and i dei Servi zi Traspo rti e Ma teriali e dai Comandi Genio di R.tvl.
Sarebbe s icurament e un sa lto di qu a lità se si riu scisse in tal e unifi cazione, semp re ricercata, mai conseguita!
Quali organi esecutivi alle dirette dipende nze , essi dispo ng ono g ià di unità tras missioni a liv e llo rgt ./btg., in grado , co n modesti adeg uamenti, di ges t ire le reti TLC infrastrutturali e di cos titu ire orga no di 2° an e llo pe r le attività logisrich e nel se ttore dell e tras missioni. Ta li unità potreb bero includ e re le Sezio n i Lavori TL C d e l Genio e gli e lementi dei Ce ntri Elaboraz ion i Dati.

Sempre a livello periferico, s i ritiene, invece, non più valida l'attuale struttura de i Comandi T rasmissioni di C.A. e d e ll e unità da ess i dip endenti , in previsione d e ll a r is tr utturazione orma i annunciata deg li esist enti tre Corpi d'Armata . La r e vis ione di t a li org an i postula però la defin izione , certa ed ine quivoca bile , delle responsabilità della F.A. , soprattutto in concomita nza di possibili eme rgenze (difesa de l territorio, im piego fuori area, ordine pubbli co, co ncorso in pubb lich e calamità).
Quali le possibili solu z ion i da perseguire, nel caso in cui i C.A. vengano sopp ressi o trasforma ti in Comand i Op erativi a livello Divis ione?
Per quanto attiene ai Comandi Trasmissioni, s i ritiene che essi possano essere riconfig urati e trasfo rmati in Uffi ci da inse ri re nell o Sta to Maggio re d el comando c he verrà costi tuito.
Le u nità trasmiss ioni di C.A. dovranno ri m an ere a su pport o delle eventu a li Divisioni d erivate dai citati C.A..
Tenen do altresì conto dei comp iti cui la F.A. potrà ess ere chiamata, una possibile so luzi one porrebb e preve dere, in termini genera li:
- un ' unit à o perat iva p e r il supporto dello SM d e ll 'Esercito, d ota ta eli cap ac ità tecni co f unzionale , per l' ese rci zio d e l comand o e de l contro ll o s ia in pa ce s ia in emergenza e da u tiliz zare , con alcu ne ped in e, per l'in1piego (anche isolato) fu o r i a rea;
- un'unità o perativa da ut ilizzare pri o ritariamen te qua le supp orto trasmis s iv o d i G.U. c hi a mata acl op e rare , in serita in co mpl es s i internazion al i e d alle dirette dipende n ze di tale G.U. ( Comand o Div is ione "Cele re/ ARRC" );
- unità opera tive da utilizzare per il s upporto d elle a ltre Di v ision i o Comandi Intermedi che siano.
Anche l ' attua le org an iz zaz ione sco las tico- addes trat iva , b asa ta su Sc u o la Teleco mu ni caz io ni Interfo r ze e Scu ola de ll e Trasmi ss ion i, andre bbe rivista per co nseguire un a netta distin zio ne tra:
- corsi a carattere formativo;
- corsi a cara ttere q ualifica ti vo e/o di aggiornam e nto.
I primi d o vrebbero esse re svolti es clusivame nte presso l a Scuola d e ll e Trasm issioni, Scuola Madr e d e ll'Arma, p e r tu tti i Qu adri U. , SU. e per la T rupp a, all o scopo di un iforma rne la p reparazione.
l secondi dovre bbero essere svolti presso la Scuola Te lecomun icazio ni delle
F.A. , a caratte re Interfo rz e ed alle dirette dipenden ze de llo Stato Magg iore Di fesa, p e r la form a;do ne e la d iffu s io ne di una c ultura ve ra m ente interforze e di ordin e su perio re p e r le TLC.
Materiali e mezzi
L'accentu ata dinamicità delle operazioni e le necess ità di sopravvivenza dei sistemi C3I imp ongono l'impiego eU mezzi di trasmissione:
- leggeri, di ridotte dimens ioni e basso consu mo el i e nerg ia;
- di portata adeg uata a l prevedibile d iradamento delle forze, eli fac il e e rapido imp ianto;
- idonei per caratteristiche intrinseche, quali le gamme di frequenza ed il software operativo, a garantire l' interoperabilità;
- dotati eli dispositivi idone i a cont rasta re l'offesa elettro nica.
Ob iettivo genera le, qu indi, è perseguire la digit alizzaz ione estesa , c he offre la poss ibilità di fornire in modo diffu so, oltre ai se tvizi telefon ic i e tel egrafici, anche que ll o dei dati , d el facsimjle e del video, in una v is ione integrata che co nsenta di cons iderare in un qua dro u n ita rio quelli che oggi sono distinti in sistemi infrasrrutturali e sistemi campali.
In patticolare, si posso no espli c itare gli obiettivi per i materiali e mezzi ne l modo seguenr.e:
- procedere n e ll 'ammo dernam e nto del p arco dell a re te ra dio di co mb a tt imento con me zzi a ca pacità EC CM, p untando a ltr esì a ll a rea lizzaz io ne di ap parati multifunzionali a tecnica di trasm iss ione d el tipo MIDS (Mulrifuncr io nal Information Distribution Sysrems);
- procedere nell 'es pansione de l SOTRJN;
- comple ta re l'a mmodernamento de lla rete TLC infras truttmale a tecnica dig itale, prevede nd one la pi e na compa tibilità cd inte rope rabilità con le re ti campa li ;
- realizza re un'unitaria re te radio mob ile campale inser ita nella rete TLC nazionale;
- realizzare un siste ma di supervisione general e a livello nazional e, articolato in sottosistemi di s up ervis ione regionale e/ o setto riale , anch 'esso integ ra to co n i s istemi di s upc rvis ion e campa le ;

- acqui sire sistem i satellit ari affian ca ti da sistemi HF e volut i p e r cons e ntire l' impiego d e ll e forze "fuori a r ea" e d il loro inscrirnento imme diato n e ll e reti nazionali, infrastrutturali e / o campali.
Prosp ettive di svilup po tecno lo gico
La necessità eli ot timizzare l' impi ego delle scars e ri so rse d isponi b ili richiede , inol tre, di:
- perseguire con tenacia gli obiettivi di s tandardizzazione sia in ambiro NATO che EUROCOM;
- utilizzare sempre più tecn ologie tip ic he dei sistemi di tele comunicazioni e telemati c i di uso "civile" anche per app li cazioni m ilit ari
La defi niz ion e di stan dard EURO CO M per s is te mi avanzati di co municazio ne EES ( Enhanc ed Euroco m System) rappresen ta una tra le p iù significative atti vi tà di regolamentaz ione tecnico -operati va ne l se tt o re della standa rdizzazion e (attualmente in fase di conclusione) e un impo rtante mezzo p e r "traghettare" dall 'a ttuale normativa EUROCOM verso sistemi del post-2000.
Alla luce an che delle incoraggianti prospettive offerte dalla tecnolo g ia , appare n ecessaria un a sem pre p iù s p icca t a integ razion e co n ll mondo n on m il itare. L' impiego di protocolli, d i standard e di interfaccia d i tipo c iv il e o ltre a ridurre i
costi di sviluppo dei sistemi militari el i comu nicazioni , garantisce la trasmissio ne d i 'oce, dati, gralìci, fil es tra computers, programmi televisivi acl alta definizione a velocità sempre più elevata ed una pill agevole integrazione con le reti c ivili a larga banda.
Per q ua nto ri guarda in parti colare l 'a rc hitettura eli un s istema di comunicazioni m ili rar i pos t -2000 , appa re interessant e riferimento ag li studi condotti in a mbito NATO ch e configurano un sistema cos tituito essenzialme nte da sottosiste m i integrati che. nell'attuale terminolog ia militare e civi le , vengono identificati come Local Area Subsysr.em ( LAS), Sysrem Management and Contro! Subsysrem (SMCS), Wide Arca Net\No r k (\Y/AN) e Mobil System (MS).
L'e le m ento qua lifkanre de l sistema è cos tituito da l LAS che comp rende una o p iù .LAN (Loca.l Area Ne tw ork ) p e r l'access o di termin a li multiservizi o d'ute nte, installat i sia in p os izione fis s a c he mob il e
Le LAN prevedono l'uso estens ivo dci collegamenti in fibra ottica o in pont e radio ad onde millimetriche, in configurazione diversa (ad anello, bus , a stella ecc.), in cui si esaltano le caratteristiche di ampia larghezza eli banda e d i immunit<ì dalle contromisure e lettro nich e EPM (E lectronic Prot ec tive Measure) e dall 'impu lso ele ttroma g netico (EM P).
Per l' interconn ess io ne fra LA N div e rse o fra LAN e \"(!AN e/o con le reti civ ili BISDN è p re vista la fibra ott ica e l'impiego d i po n ti radio.
Tn prospettiva , la proposta più avanzata per l' integrazione fra reti d iverse a larga banda è rappresentata dalla tecni ca ATM (Asynchronous Transfer Mode) che, con lo svil uppo della microclettronica , co nsentirà la massima capacità e flessibilità di mu lt iplazio n e e eli co mmuta z ione eli dive rsi ti pi eli informaz ioni a diffe renti "b it ra le'', co ns e n tendo d i s up erare l'a ttu a le dist inzione tr a co mmutaz ion e eli c irc uito e di pacche tto e rend e ndo accessibili a tutte le tipol ogie di utenza la totalità de lle risorse t rasmissive.
Fra i mezzi di trasmissione da impiegare nelle ret i militari di comunicazione, oltre ai già citati cavi in fibra otrica e ponti radio ad onde mill imetriche, è da prevedere l'utilizzazione dei tradizion a li pont i rad io UHF/S UF, ma con mag giore protezio ne e le ttro n ic a (EP M).
L ' imp iego d e l troposca tt e r e dei siste mi s ar. eUi tari, funz ionanti n e lle bande SH F e EHF, in orbita bassa, geos tazionari a, sarà s ignifica tivamente increm entato.
:\el settore delle comunicazioni radio in banda HF, il progresso tecnologico migliorerà ulteriormente le prestazioni e l'affidabilità dei co llegamenti, co n l'uso di più effic ie nti tecni c he eli mo dul azione, di equ alizz azione del ca nale , di corre zione degl i e rro ri , c di pro cesso ri adattativi , pe r la trasmis s ione della fonia dig ita le e di d a ti ad a lt a velo c ità.
E' previsto che i s istemi radio HF, unicamente alle com unica zi oni Metcor Burst , il cu i svi lupp o è unanimemente auspicato, continueranno ad assolvere la funzione di ri se rva degli altri mezzi di trasmissione a lunga distanza.
Il sottosistema mobile (MS) costituirà il suppotto per gli utenti tel efonici tradizion.: di e ·'ce ll u lari ", pe r la re t e radi o di co mbattim ento (CN R = Co mbat Ne t Radio) e r e r la tras missi on e dati in zona avanzata
Il co llegam ento fra i divers i u tenti radio e l'ac cesso a i LAS/ WAS sarà ass ic urato mediante i RAP s ( );{adio Access Points) co ll ega ti a comm utatori ATM
Tn futuro, è prevcd ibile la realizzaz ione di termin ali radiomobili MULT ISERVIZLO, in cui risultino integrate le funzioni CNR, SCRA (Singl e Channel Radio Acccss), PNl\ (Packet Net Radio) e mult igam ma VHF e UHF, con uso estens ivo di tec no log ie EPM , come lo SNAP (Ste c rable Null Ant enna Processar) e le tec niche eli rnod ul azio ne "sp read s p ec trum"

Centro Trasmissioni -posto comando

• r L'obiettivo da consegui re è l' ottimizzazione dell 'impiego dello spettro elettromagnetic o, inteso co me ri so rsa pregiata e limi tata. Gli s forzi saranno d iretti, da un lato ad incrementare le capacità di traffico , dall'al tro a migliorare "l'efficie n za sp e ttrale", contenendo la "larghezz a di banda necessa ria" graz ie all 'adozione di evolute tecnic he di codifica per i segnali fo nici. Le più recenti proposte prevedo n o di adottare tre standa rd di cod ifica: uno standard "primario" a 4,8 Kbit/sec., d iffus o su tutta la rete; uno sta nda rd a bassa ve locità (e qualità inferiore) da im pi egarsi so ltanto per i collega menti HF (800 bit/ sec .); uno standa rd ad "alta qualità" per le reti locali (PCM 64 Kbitlsec. CCITI') e per l 'inte rfaccia co n le reti s trategiche e civili ISDN.
Infine, nel sistema di comunicazioni militari post-2000 è indisp e nsabile che ciasc un sottosistema risponda a specifici requ isiti di gestio n e e controllo delle reti.
Per il sonosistema mobile detti requisiti riguardano l'imp ieg o delle frequenze, le fu nzi oni di contro llo (per esemp io, la sincronizzazio ne), la dist ribuzione delle chia vi crypto ed EPM.
Pe r la d efiniz io ne d ei protoco lli di gestion e e co ntrollo eli rete, g li standard ISO/C CI1T costituiranno p recisi elementi d i riferim ento
G li sviluppi tecno logici nel campo d e lla intelligenza artificia le e dei sistemi espe rti forniranno un determinante co ntributo alla so luzione dei problemi di controllo, in dividuazione, diagnosi automatica e riparazione delle avarie.
Inol tre , l'archite ttura del futuro sis tema di comun ica zion i dovrà presentare sp iccate c aratteristic he di modul arità in modo ch e le nuove LAN, WAN e MS possano entrare in servizio integrandosi con i mezzi in co rso di avan za to sv iluppo,
senza n ecess ità di m od ificare pro fo ndamen te qu esti ultimi
T già cit a t i s ta ndard ISO cos titu ir ann o la base p e r lo sviluppo d e ll e ulteriori es ige nze n el cam p o dell e co muni ca zio n i ta tti c he p os L-200 0, non anco ra s ufficientemente definite c che 1iguarclano, in particolare :
- la sicurezza multilivello nelle trasmissioni (TRANSEC) e nelle comunicazioni ( COMSKC);
- la rapida r iconfigura z io n e de ll a re te in condiz io ni di v u lnerabili tà diverse ;
- l' affidabi lit à d e lle com uni ca zio ni in t ras mi ssion i a cl el e va LO l3 ER ( Bit Erro r Rate);
-l' interfaccia dei sottosisremi di comunicazione nell'architettura eli gestione di rete.
Il sistema d i co muni cnio ni tatti c h e posr-2000 è ce rta me nte an co ra lontan o cla u na co m p lew e uni v o ca defin iz io ne
Sono state indicate linee di tendenza coerent i con il prevedibil e svil u ppo Lecnologico, ma alcuni elementi di ciascun sottosistema non ris u ltano anco ra sufficie ntem e nte ide ntifica ti e ric hi e dono ul te ri o ri s t ud i e d a pprofon di m e nti. La so luzi one dell e di ve rse pro hl ema tic h e s arà ess enzia lm e nt e dete rmi n a ta da lla cap aci tà d i trasfe rire ed adorta re l'innova zi o n e tecno logica appl icata in campo ci v il e ai sistemi militari di comunicazione.
Reg olan1e ntazione d'itnpi e go
La regolamentazione d 'i mpiego dell ' Arma delle Trasmissioni è in gran pane impront a ta alla circolare 900/A d e ll a serie do ttrin a le, che, pur tuttora valid a ne ll e lin ee fonda m e nta li , nece s sita di una profo nda revi s io n e c onsegu e nte a i mutam c nri d e ll o scen a rio o p e rativo e d ag li a ttu a li cr ite ri d'impiego d e ll e for ze .
La situazione a tt uale della regolamen t a zi one delle T r asmis s ion i , pertanto , necessita eli aggiornamento, determinato anche da div e rsi motivi , tra i quali: i co n tinui ri o rdiname n t i cui è stata so t toposta la F.A. e, qu indi , le u nità Trasmiss io ni ;
- la r a pid a evoluzion e tec no logica de i mez zi dell e trasmissioni, co n conseg uenti var iazion i normative ed ordinative non sempre co n testuali;
- gli esiti d e lle s p erim e ntazion i per quanto concerne i materiali TLC e l'organizzazione d i Co man do e Co ntroll o ;
- la difli cil e ri c e rca di utili rife rimenti o rdinativi e d o ttr in ali in altri Paes i NAT O
Sa rà ' Op port uno quindi, ne ll ' imm ediato futuro; cost iLuire un "·poo l" nell 'am biLo dell'Ispettorato che, avval en dosi del contributo degli Alti Comandi Pe riferici :
- valut i atLentamente la nuova documentazione di base (nazionale e NATO);
- ricon ce pisca le m o claliLà d ' impi ego de lle unità a seg uito dell ' in t ro duzion e de l CATRI N;
- stabil isca le mo d a lità d'i mpi eg o "fuo ri a re a ", a segu ito d e lle espe rien ze tratte dalle operazion i "Pellicano", "Ibis" ed "Albatros ".
Acl destr an1e nto
ll tipo di organizzazione addestrativa e le conseguemi m odalità co n cui essa opera sono condizio n ati da fa n o ri gen e ra li (il contesto p o litico naz io nale, l'ambie nte soci a le, le disponi b ili tà finanziarie e l'economia d e l Paes e ) e da fatto r i tecn ici ( quali' il s iste ma di recl ula menro, la durata dell a fe rma , la rego la menta z ione

d'impi ego, la struttura o rd in ativa e la disponibil ità d i poligoni e di a ree addestra tive e naturalmente i mezzi ed i sistemi operativi specifici).
L'attuale organizlazio n e addestrativa si ispira a due criteti fondamentali:
- co mp atibi li tà con i pre d e tti fattori;
- g radua lit à n e l conse gu imento degli o biettivi s econdo norme e p roced ure unifica te che co n se nta n o, attr ave rso una cond o tta e minent e mente pratica, d i otte n ere il massimo re ndim ento de lle ri so rs e disponib ili.
La tecnica addestrativa da porre in at to deve prevede r e il largo ricorso ai moderni ausili didattici e, per quanto possibile, alla simulazione, al fine di facilitare l'appren di mento da par te d el persona le, otte nere risultati o m ogenei e concentt·are l ' imp ieg o dei Qua dri istrutto r i p reva le ntemente sulle att ività pra ti che
Per quanto ri gua rda gli Uffi c ia li , il problema interessa s ia la form a:do n e degli Ufficiali d e l R!'TU (Ruolo Norma le Un ico), sia la qua lificaz ione eli que ll i del RS U (Ruolo Spe ciale Unico). L'o rientamento emerg e nte in questi u lt imi tempi è quello di salvaguardare il comenuto tecnico dei corsi di formazione degli Ufficiali delle Trasmissio n i. L'addestramento dei Quadr i si prefigge fondamentalmente lo scopo di p re parare i comanda nti d i ogn i li ve ll o a ll ' im postazione e d alla risoluz io ne di p ro blemi op e rativ i d e ll e Trasmi ss ioni, a pattire d a i m inimi livelli, c ur a ndo ne le capaci tà di coordiname nto e di coope raz ione e aff ina ndo ne , con l'e se rcizio, l'a z ione di com a n do.
Per la fo r mazione degli Ufficiali del RNU delle Trasmissioni, l'iter formativo prevede, oltre ai due anni di Accademia, un corso triennale di smdi con un solo indi r izzo u nive rsitario "Scienza dell'Informazio n e" Il ciclo for mati vo è poi co mpletato co n una fase d'Ar m a , della durata eli 3-4 m esi, d urante la q ua le i g io van i Uffic ia li svol gono att ività e mine n te me nt e pratiche , in tese a d approfon dire la co noscenza dei mezz i tecni ci e d a fa r apprende re la tecnica d i comando del le minori unità dell'Arma (in partico la re , a livello Comandante di plotone).
Per quanto riguarda gli Ufficiali del RSU, oltre al corso previsto, il problema è principalmente di qualificazione, risolvibilc co n corsi specifici.

Per gli Ufficiali di co mplemen to el i lA no mina, base eli alimentaz io ne per la catego ria del RS U, la fo rmazione ricade so tto la re sponsab ilità dell 'Ispettorato . I co rsi AUC (Allievi Uffi ciali di Compl e m ento) ve ngo n o s vo lti p resso la SC UT e d ura n o 5 mesi. Circ a i programmi, q ue sti sono in fase di continua revisione pe r evitare scollamenti dallo sviluppo dell'Arma in campo tecnologico, normativa e ordinativo. Gli obiettivi per il prossimo futuro, qu indi, possono ess e re individuat i nella necessità/o pp o rtunità eli:
- co n solida re l'attuale iter Accademia/Sc uola di App li caz ione, che co n s ente di avvicinar e ttm i i Te n e nti del RN U, a l te rmin e d e i 5 a nni, alla lau rea;
- a d o ttare un criter io eli addestra n1ento defin itivo ed u n ita rio pe r gli Uffici ali eli complemento, il cui n umero è comunque destinato a co ntra rsi sempre più;
- indire corsi dì aggiornamento periodici e seminari, con la partecipazione dì Uffici ali anche eli d ivers o grado, per man tene re i Quadri a co ntatto con l'e voluzion e d e ll e tec nich e, dell e tecnolo gie e dell e proced ure
Pe r quanto r igua rd a i Sottuffi c ia li , l 'i te r eli s p ecializza zione in atto pr e ss o la Scuola TLC Interforze di Ch iavari, incaricat a della formazio n e d e i Sottufficia li riparatori e degli operatori, si b asa su corsi dì durata che varia da 10 a 16 mesi. Tale addes tramento consente di forma re SU molto p iù preparati tecnicamente rispetto a l passa to e co n una base più co nsolidata.
Pe r t al e categoria è p revedibile n e l prossimo futuro:
- l' adegu a m e n to d e i corsi per fronteg g iare le es igenze con n ess e con l'introclu -
zion e di s istemi integrati a tecnica dig itale e con il maggi or co inv o lgimento nel sett o re dell' in form atica;
- la forma z io ne di op e ratori e riparato ri delle prime due categor ie d i interv e nti logistici (p untand o su ditte spe cializzare per interventi di o rd ine su periore);
- la pa ttecipazione anche di Sottufficiali ai seminari d i cui si è detto in p receden za per gli Ufficiali .
Per i militari di le va in fe rma prolunga ta , il nuov o "s tat us giuri dico" co n sente a i militari di truppa d i tramutare la fer ma eli leva obbligatoria in ferma d i leva pro lu ngata per alcune specializzazioni che h anno un risco ntro nel mondo del lavoro.
L' iter add es trativo, p er ta li specializzati , prevede tre momen ti:
- un add es tra mento eli base;
- un addest ramento di spe cializzazio ne presso g li e nti add estrat iv i d'Arma in funzi one della re lativa specializzazione;
- un corso d i perfezionamento presso le Scuola d'Anna.
Tale addes tramento conse nte di produ rre Sottufficia li (S ergenti ), dopo 14 m es i da ll 'incorpora7.io ne , p er un vo lume teorico per le FF.AA. m olto e leva to a front e d e l qua le fa riscont ro un volum e e ffettivo molto più conte nuto ed u n livello qu alitat ivo da potenzia re per le unità dell'Arma.
Per i m ilitari d i tru pp a, la maggior pa1te degli appartenenti alla categoria d eg li ope ratori, spec ia li zzati presso la Scu ola cl' Arma e pre sso i rep arti, pres enta un a s uffic iente prepa razion e, nonos tan te la pes ante in c id e nza dei serv iz i s ul re golare svo lgimento dei corsi.

Passando alla categoria dei riparatori , la situazione è d ecisamente peggiore. Ques ti ultimi , infa tti , nonosta nte il bu on livello culturale di base che generalmente posseg gon o e d il riscontrato interesse espresso, n on se mpre sono in grado eli conseg uire risulta ti ap prezzabili. Fanno ec cez ione i giova ni co n precede nti di m es ti ere , presenti in quan tità pera ltro ridottissima.
I n futuro si dovrà pertanto:
- migli o rare la selezione dei volontari in ferma pro lungata (VFP), mi litari di leva in fer ma prolunga ta (MLFP), vi s to che il n umero dell e doman de è correlato anc h e a lle crisi ne l mo ndo d e l lav oro civile;
- puntare maggiormente su ll 'addestramento dei VFP, MLFP, limitandosi, p er i militari di leva, ad un add estramento al minim o livello, a ca ratte re informativo, presso le unit à;
- prepa rar e i VFP, MLF P a nche in re laz ione all'i nce ntivo di s b occ hi s u cc essiv i nel mondo d el lav oro civile .
Tutto ciò n ella considerazione che, almeno nell 'Arma d elle Trasmissioni, si potrà fare semp re meno affida mento (data la durata della fe r ma ) su i soldati di leva in re lazi o n e a ll a co mpl ess ità dei n u ov i mez zi che sara nno introdotti in servi zio; m ezzi per la c ui gestione non sa rà suffic ie nte u n corso eli poch e settima ne
Logistic a
L'incettezza su lla fision om ia che un odierno conflitto p uò assumere e l'e ventua lità d i pe rdite ingen ti ed improvvise, p er effe tto delle n otevo li p o tenzialità dell 'offesa, conferiscono oggi alla logistica u n ru olo ancor più importante che nel passato. La condotta delle op erazioni milita ri p resuppon e la d isponibilità di un pote nziale log is tico conuni surato ag li scopi da conseguire e d accuratam e nte predis pos to Il probl ema operativo , pur se inscindi bi le nei s uoi aspetti strateg ico, tattico e logistico, deve essere
imposta to , ana lizza to e risolto entro i limi ti delle p ossib ilità logistiche.
A tale scop o la normativa logistica è già in adegu ame n to risp et to alle nuove es ige nze ope rative
Infatt i, g ià a partire d all'a n no 1994, per i ma te ria li delle trasmiss ioni, il p arco è sta to suddiviso in d ue aree: un'area TRAEMAT, a cui fanno capo i mater ia li delle trasmis sioni a più a mp ia di ffus io ne ed u n 'a rea ISP ET, relat iva agli appara ti in d otazione prevalente m en te ai re p a rti dell'Arm a de lle Trasmiss io ni.
A tale m o di fica si è , inoltre, aggiunto il passaggi o da 4 a 3 anelli n e lla cate n a funzional e log istica, accorpando , in pratica, al l o anello le attiv ità previste da ll a vecchia n ormativa per il l o ed il 2° livello/grado logistico.

Ta li inn ovaz io ni h a n n o co mporta to pe r l' Arm a l 'ass unzion e in propri o d i nu o ve responsabilità che si poss ono sint et icamente estrinsecare:
- nella rea li zzazi one ex-novo di una prop ria "cate n a de i riforniment i";
- nell'effettuaz ione delle ri p a razioni di 2° a n ello (ex 3° grado) a li vello rg t./p o lo.
Per quan to a ttiene allo svo lgimen to de lle attivi tà log is tiche si sotto linea c h e, att u almente, p e r il rifornim e nto, i materiali sono stati suddivisi in du e ca tegori e :
- categoria "A": comprende i materia li per i q uali si applica il criterio dell'autodeterminazione dei li velli di magazzin o ed il cui rifornime n to ha , perta n to, carattere di automatism o A tale categ o ri a apparte ng o n o perciò i m oduli, le sche d e e le parti di rica mbio impi ega te per la m anutenzion e e riparazione de i materiali;
- categoria "B": include i rimanenti m a te riali per i q ua li non si a p plica il crite ri o d ell 'au todete rminazi o n e dei livelli Dett i materiali vengono assegna ti in b ase ad apposite disposizioni delle Autorità Ce ntrali. Ad essa appartengono: gli a pparati campali e TL C delle T ra smission i, le att rezzat ure p e r i labora to ri , la carta e zo n a per le te lescrivem i, g li a ppara ti , i so ttocompl essi e moduli d i scorta, e t c
Di conse guenza, l'att ività di rifo rn imento viene effettuata, p e r la catego ri a "A", tene n do conto de ll 'auton omia logistica dei li velli di magazzino.
Pe r qua n to h a tra tto co n i materiali d e ll a categ o ria "B", l' a ttiv ità d i rifo rnimento pu ò avve nire so lo su specifico o rdine dell ' Is p e ttorato d e lle Trasmiss io ni.
P artendo d al pre suppos t o che tale nu ova organi zzaz io n e logis tica è da consid erare operante, anche se ancora da sperimenta re comp iutame nte, pe r g li a nni a ven ire s i p otrà p reved ere:
- una sem pre più spinta orga niz za z io n e "pe r mat e ri a ";
- una più acce ntu ata te n denza a re a li zz are sistemi d 'Arma in co llaborazion e internaz io na le , con conseg uenti va n taggi di o rdi n e econo m ico- logistico e d ope rativo. l p rimi so n o da p o r re in relazione a l ma ntenime n to ed ai ri fornimento d i rica mbisti ca affi d ati a s p ec ific h e age nz ie interall e ate, i seco n d i a ll a s tandardi zza zione d e i mat eriali, o qu an tomeno a ll ' in te rcambi abil ità e all ' interoperabilit à d e lle s ing o le c omponenti, ch e agevola la con d ott a d i operazioni combina te con gli Esercit i Alleati;
- la semplificazion e ed il miglioramento delle operaz io n i di mantenimento con l'a dozione de l s upporto log is tico integra to, ogg i già pre so in consi deraz ione pe r tutti i m ateriali sin da lla fase di ri ce rca e svilup po , preveden d o archite tture modula ri, sistemi a uto matizzati per la ricerca g u asti e possi bilmente apparecchiature di auto diagn o stica g ià inco rpora te n e i sistemi d 'Arma;
- una p iù s p iccata qua li ficazione per l'attiv ità di ma ntenimento al 2° ane ll o ed un maggior ricorso all a sostituzi o n e dell e pa rti dann eggi ate ai minimi live ll i, dove sarà se mp re m e n o avve rtita l'es ig enza d i p e rso nale spe cia li zzato e sarà favorito il ripristino in te mpi brevi de ll'effici e n za de i mate ri a li , a ncorchè se
ciò co mpor terà un aument o della ricamb istica ; - una magg iore ade renza d e l s upporto logistico territorial e , dimensionato p er bacini eli uten za ed adeguat o a ll' es igenza dei nuovi mezzi e materiali. In conclusione la sfida del 2000 è iniziata!
L'Arma delle Trasmissioni si sta "a ttrezzando" in tutti i setto ri di competenza affinché acl u no strumento mil ita re snello ed efficace, come da ogn i parte ausp icato, corrispondano sistemi di comando e co ntrollo in grado di fronteggiare tutte le ipotizzabili situa zio ni del futuro.
La risposta a questo diuturno lavoro verrà soprattu tto dall' imp egno serio e costruttivo de lle nuove leve dell 'Arma del le Trasmissioni.



PARTE SECONDA


CONCORSO PER PUBBLICHE CALAMITÀ


Terremoto di J'v!essina, 1908.
In caso di pubbliche calam ità l'esito dei soccorsi è fortemente condizionato dalla tempestività con cui le informazioni viaggiano dai luogh i ove si manifesr.ano le esigenze ai centri che coordinano l'invio di uomini e mezzi.
Se la diffusione di queste notizie è frammentaria o lenta, le relative operazioni eli soccorso risulteranno inadeguate, determinando interventi carenti o eccessivi o in ritardo. Da ciò deriva l'importanza del compito che le Trasmissioni devono assolvere sin dai primi momenti dell'emergenza, sia per permettere alle "grida" di allarme ed alle richieste di soccorso di giungere sino a chi è in grado di prestare i necessari aiuti, sia per consentire il tempestivo e razionale funzionamento della complessa macc hina dei soccorsi. Tl primo aspetto, quello della tempestività dell'allarme, è di competenza delle autorità civili o militari presenti nell'area ove si verifica l'e vento (i Comandi territoriali dell'Arma dei Carabinieri dispongono di una rete di telecomunicazioni in grado eli far convergere nel punto voluto tutte le informazioni sull 'evento verificatosi e sulla sua entità). A queste Autorità possono affiancarsi altri organi, quali i locali Comandi dei Vigili Urbani o i Civili volontar i, come i Radioamatori. Tali organi, se ubicati nella zona colpita, sono in grado di ·effettuare una rapida valutazione della gravità dell'evento e della verifica dei danni relativi. Successivamente, potrà essere interessata la Protezione Civile che attiverà la propria organizzazione che dispone, tra l'altro, di terminali sate llitari "Argo", gestiti in gran parte da personale delle Trasmissioni, che consentono il collegamento video tra la zona d ' interesse e le Autorità centrali nazionali.
Qualora le competenti Autorità civili giudichino l'accaduto di tale gravità da richiedere il concorso delle FarLe Armate, esse provvedono a farne richiesta alle Autorità Militari: solo allora, fatti salvi gli interventi eli iniziativa delle Unità già in sito nelle zone colpite, le Forze Armate, e tra queste anche i reparti delle Trasmissioni, potranno intervenire
Le modalità d'interv e nto dei r e parti delle Trasmissioni, le loro dotazioni eli .-

mez7.i c d il loro addest rame nto consentono d i ademp iere a questi compiti, d 'a ltra parte sa nci ti per legge
l n particolare, il concorso dell e Tras mi ssio ni è finalizzato s ia al ri pr ist ino , anche con co llegamenti a lternati vi , d e i coll ega me nti infraSlr ullurali civili, sia a ll a costituzione di un sistema camp a le militare di T ras m issioni che co nse nta la az io n e di comando, contro ll o e coordin am e nto de i reparti in socco rso. TI sistema ca mpa le nor malmente sì allaccia e si integra co n la preesistente rete infrastrutturale militare , ove a n cora disponibile.
Uno dei primi esempi di inteJ ve nto per pubbli c h e ca lami tà è star.o il terremoto d e l 1908 quand o la 10u compagnia d e l 3° reggim e nto Genio tclegrafis ti ve nn e inviata in Calabria e in Sic ilia con il comp it o di ripri stin a re le linee tel eg rafic he civili dann egg iate. Il repa rto operò co n gra nde efficienza ed ab negazi o n e, malgra d o le condizion i di lavoro proibitive , e ricevette da più parti menti cd attestati di benemerenza al valo re civile.

Alluv ion e d e l Polesine (195 1)
Evento/Concorso fornito
Il 14 novembr e 195 1 il Po, a ca u sa delle abbon danti piogge cadu te inc essantement e per dive rsi gio rni , ruppe gli argin i in molti punt i della provin cia di Rovigo e l'o nd ata d i pien a s i trasfo rmò in una gigantes ca alluvione che a ll agò l' inte ro Polesine. Ad acc rescere le dimensioni dell 'evento co nco rsero a nche le acq ue dell 'Adige , che usciro n o dagli argini in va rie zone d ella stessa regi o ne. La ca lami tà s i presentò di un a g rav it à eccezionale, dat i i num erosi paesi, borg hi , fraz io ni c cascina li inonda t i d a ll e ac que irrom penti, che in mo lt e loca lità t ra volse r o e somm e rse ro case, azi e n de ag ri c ole, uomini , bestiame , magazz ini e dep ositi di derrate. Dato lo s tato di preallarme ed a seguito degli acco rd i intercors i con le Autorità civili e con i Comandi dci V.F., il V CMT ( P a dova ) ed i l V I CMT (Bo logna) attivarono co n immedi atezza le unit à d ip e ndenti. Le trupp e a ffluiro no con la mass im a cel e rità nel Polesin e p e r lo svo lg ime nto ordina to d e ll 'o p e ra di soccorso. G li interventi , svo lti da truppe dmate di mez z i s p ec ia li , vennero co ndotti con un 'o rga nizzazione che, nonostant e la s u a compl ess ità e le proibitive co n dizioni dell'ambi ente e d el cl ima (fa ngo, stra d e interrotte, ponti crollati, pioggia , freddo, n ebbi a), s i ri velarono efficienti in tutti i lo ro aspetti tec nico -o perati vi , grazie anc he allo s pirito di solidarie tà e eli altruismo co n cu i tutti ( Alt i Comandi e Uffi c ia li , Sottufficia li e militari di tru ppa delle unit à imp e gnate) affronta rono i compiti loro assegnati per sa lva re il maggior numero possibil e d i vite uma ne, nonché capi di bestiame, viveri , masse rizie, a u toveico li , attrez zi agricoli.
Po les ine.
ZonaNella pagina a fianco: Terremoto di lvlessina, 1908, jòto d 'epoca Tetegrafisti detta JQ?!
Compagnia del 3° Re,qf.:imen t o Genio •
Reparti delle Trasmissiorli interessati
Supporti Trasmission i delle Divisioni "Mantova", "Folgore " , "Ariete" e d e lle Brigate "Ju li a " , "Trieste" e "Fri uli ".
Uomini e mezzi impiegati
978 uomini; 73 stazioni radio eli vario tipo , 28 term inali ponti radio, 90 te lefon i e 72 km. di ca vo te lefonico
Straripatnento del fitune Secch ia (1960)
Evento/Concorso fornito
Una grave alluvione in prov inc ia d i Ivlodena , il 20 april e , provocò lo s trarip amento del fi ume Secc h ia.
Zona
Po les ine (Rov igo ed Adria), Monza.
Reparti delle Trasmissioni interessati
3° btg. l. di C.A. - 42° btg. t
Uomini e 1nezzi impiegati
174 uomini, per un cotale di 59 757 ore d i lavoro/ u omo; 38 stazioni rad io, 18 terminali ponti rad io, 40 te lefon i e 66 km. di cavo telefonico.
Valanga a Rochetnoles ( 1961 )
ft'ento!Concorso fornito
li .::; febbra io, in località Rochemoles, cadde una valanga. La B.alp. Taurinense inviò urgentemente sul posro n 93 uomin.i tra Uffic iali , Sottufficiali e truppa appartenenti a l btg alp. "Susa " , al Gr. a.mo n ''Pinerolo", alla Cp t. e alla Cp g.p della stessa unità. Insieme a ll e fo rze d i po li zia i militari provvidero al disseppcllin1en to ed all o sgombero s u Bardonecchia eli 4 deced uti, allo sgombero su ll a s tessa Bardonecchia dei fe rit i, elci bambini e dci vecch i, al collega mento tra Bardonecchia e Rochemo lcs e a ll 'apettura della strada tra Bardonecchia e la locali!lt si.nistrata. G li interventi durarono tìno al giorno 9
Zona Bardonecchia.
Repa11i delle Trasmi.'>·sioni interessati
Cp . t della B.alp. "Taurinense".

Uomini e mezzi impiegati
11 milita r i s p ec ializzati e 7 staz ioni radio di vario tipo.
In cen di o di boschi a Roc c a Rainola ( 1962) fornito
ll gior n o 6 agosto grandi incendi di boschi si svilupparono ne ll a zona di Rocca Rain ola. In tervenne ro a sp egnerli in co llaborazione con i VV.FF personale d ella Sc uo la Specia lizzati delle Tra smiss ioni di S.Giorgio a Crem ano . T mi litari operarono inintcrrouamen te sino al giorno 14.
Zona
Rocca Rainola (NA) e Monte Somma
R epartt: delle Trasmissioni interessati

Scuola Specializzat i delle Tra smissio ni.
Uomini e mezzi impiegati
8 Urficiali, 11 Sorrufficiali e 312 militari di Truppa; 16 autocarri e 220 attrezzature da zappatore.
Te rr emo to dell ' Irpi nia ( 1962)
Evento/Concorso fornito
Il giorno 24 agosto l'Irpinia fu co lpita da scosse di terremoto. Le unità Trasmiss ion i realizzarono i collegamemi radio con le Prefetture di Avellino e la poli per le esigenze di soccorso alle popolazioni di Ariano Irpino.
Zona
Napo li, Case rta, Ariano Irpin o.
Reparti delle Trasmissi oni interessati
45° btg. t..
Uomini e mezzi impiegati
452 u om ini , per un total e di 160 952 ore di lavoro/ uomo ; 59 sta zioni radio di vario t ip o, 4 ce ntralini te le fon ic i , 120 telefo ni e 160 km. eli cavo t e lefonico
D isas t ro del Vajont ( 1963)

Evento/Concorso fornito
Alle 22.45 del giorno 9 ottobre una enorme massa di terra s i staccò da l monte Toc e p recipitò ne l bac ino de l Vajont , in provincia di Bell uno, provocando la fuoriuscita di una n1ass a eli acqua di oltre 5 milion i eli metri cubi. l'ondata si abba tté con v iolenza sul so ttostante paese eli Longarone sommergendolo e distruggendolo completamente La massa d 'acqua colpì anche gl i ab itati eli Erto e Casso, disJocati lungo Ja sponda s e ttentrionale del bacino, danneggiandoli in modo grav issimo . In tota le le v itt ime el i tutta la zona de vasta ta furono circa 3000. Le unità Trasmissioni provvidero ai collegamenti tra le zone colp ite dall'inondaz ione e la Pre fe ttura eli Belluno a m e zzo eli ponti i·adio e lin ee telefoniche
Zona
Belluno e Valle del P iave .
Reparti delle Trasmissioni interes:;ati
Cp t. della B.alp. "Cadore " , 4° btg, r. del 4° C.A., 5° btg t. del 5o C.A. , 42° btg. t..
U01nini e 1nezzi impiegati
20 Ufficiali, HO Sortufficia li , 728 mi li tar i el i truppa pe r un to ta le di 631.040 o re di lavoro/uomo; 54 stazion i r adio eli vario tipo, 22 termina li ponti radio, 8 centralin i telefo n ici, 194 te lefoni e 326 kn1 el i cav o te lefonico
Terremoto dell'lrpinia, J 96.!1962 Ariano Irpino, centm radio in collega-mento con la Pnfettura di Avellino. .!962 - Longarone, collegamenti telefonici d 'emergenzaNevicate in Campa ni a ( 1 965)

Evento/Concorso fornito
:\elle prime ore del mattino del 10 febbraio un 'eccezionale ondata di maltempo provocò abbondami nevicate in Campania . Tre colonne di soccorso vennero organizzate dal Coma nd o della R.f. "Avellino", d islocato a Salerno p e r p o rt are soccorso ad alcuni paesi iso lati dalla ne ve . Me t a delle tre co lonn e: il Cile nto , Lagonegro e dintorni di Ebo li La cp t. della B. assicurò i co ll egamenti radio fra le co lo nn e ed il comando Brigata e fra le pattuglie e le stesse colonne
Zona
Cilento, Lagonegro ed Ebo li.
Reparti delle Trasmissioni interessati

Cp t. della B.f. "Avellino".
Uom ini e m ezzi impiegati
2 Ufficiali, 3 Sottu ffici a li, 15 mi li tar i di truppa ; 15 staz io ni radio eli vario tipo
Nubifragio a Parma-Piacenza (1965)
Evento/Concorso fornito
Un violento nu bifragio si abbatté il 4 luglio sui comuni di Cadeo, Cottem;tggiore , Fio ren zola , Besenzone, Bussero. Zibello. TI Comand o del Pres idio di Piacenza inte rvenne in socco rso de lle popol azioni e per ripristin are i co ll egamenti interro tti.
Zona
Parm a e Piacenza.
Reparti delle Tras missioni interessati
43° b tg. t.
Uomini e m ezzi impiegati
4 Ufficiali, 6 Sottufficiali, 118 milit ari d i truppa ; 16 s tazioni radio d i va rio tip o.
Alluvio n e di Firenze (1966)
Even to/Concorso fornito
Nel l'au tunn o 1966 per oltre un a se ttimana le Reg io ni Settentriona li e Centra li d e ll a Pe ni sola fur o no col pite da un ma ltempo di eccez io nale gravità Il 4 novembre fiumi, ca na li e torrenti, ingrossati dalle copi ose p reci pitazioni , cu i s i aggiuns e nelle zone alpin e il contem p o ran eo scioglimento delle nevi al di sotro di 1200 m. , iniziaro no a rompere in molti punti gli argini provo cando inondazioni cd alluvioni in Lombardi a, nel Tremino, in Alto Adige, n el Ve n eto, nel Friu li, in Ca rnia , ne l Po les ine , in Toscana. La calamità ass unse dim ensioni disas tro se n e ll a pianu ra ve neto friul ana c, so prattutto , a Fire nze ed a Grosseto. I Comandi Militari delle region i co lpite , sospese ro le ma nifes ta zioni in prog ramma p er la Festa d e ll e forze Armate e mo bilitaro no le unità dipende nti chieden do, tram ite lo SM, l'ap porto eli unità di Comandi Militari di altre regioni.
Si mise così in moto una poderosa macchina che vide impe gnati, nell'op era intesa a poùare a iuto alle pop o la;::: ion i nonché a contenere e ridurre i dan ni della ca lamità, interi batt<tglioni, reggim e nti e Brigate, co n i mezzi , le attrezza ture ed i mater iali d isponi bi li.
Zona
F ire n ze, Pi a nura Veneta -Friu lana, Bolzano, Trento, Belluno.
R eparti delle Trasmissi oni interessati
3° btg. t. dì C.A., btg. t. "Cremona", brg t. ·'Legnano", 43° brg. t., cp. t. "Friuli", 5° btg. t. dì C.A , 32° btg. t. , 42° btg. t. , btg t. "Mantova", 4° blg L di C.A. e 44° btg t.
Uomini e mezzi impiegati
16 54 uonlin i pe r un total e di 1.045.328 ore di lavoro/ u omo; 118 s tazion i radi o di vario tipo, 54 pont i radio , 47 telefo ni e 180 km di cavo te le fo nico .
In
ce ndio di boschi a Rov egno-Cann o bbio ( 1967)
Evento/Conco rso fornit o
11 22 ma rzo sc oppiò un violento in ce ndio boschi vo nell e loca lità di Rovegno e Cannobbi o.
Zona ì\ovara.
R eparti delle Trasmi..r;;sioni interessati

Cp. t. "Ce ntauro "
Uomini e mezzi impiegati
21 m ili ta r i specializzati e 9 staz io ni radio eli vario tip o.
Te rr e moto del Be lice ( 1968)
Even to/Co ncorso for nito
Il 14 ge nn a io, alle ore 17, la Sic ili a occidental e ve nn e funes tata da un grave terremoto ne lla popolosa Vall e d e l Beli ce Il s isma, che s i ri peté poi nei g iorni 15 c 25 gennaio, ca usò la distruzion e di inter i Paesi, con crolli totali o parziali eli vecc hi edifici e vittime tra la popolazione civi le c tra i soccorritori. l danni furono particolarm en t e grav i nei centri abitat i di Calatafi mi , Camporeale, Salem i, Gi bell in a , Poggioreale, S. Ninfa, S. Margherita Belice, Partanna, Montevago , Castel De T rano , Campobello di Mazara, Me n fi , Sciacca, Chiusa Sclafani. 11 Comando dell 'XI CMT de ll a Regione Militare della Sici li a, su richies ta della Pre fettura di Palermo, attivò e fe ce int e 1ve nirc contingenti di trupp e da Palermo e da Trapa ni , in socco rso delle pop o la:do ni. Le unità Tras missioni re a li zza rono Centri Trasm iss ioni , Centri radio , lin ee in ponte radio e linee telefonic h e in tutta la zona inte ressa ta.
A s inistra: Terremoto del Belice, l 968. Gibe llina, stendim e 1Ùo di linee telejonicbe.
A destra: Militari delle Trasmissioni impiegati per il soccorso alla popolaz ione.
Zo na
Palermo e Trapa ni.
Reparti delle Trasmissioni interessati
btg. t. "Granatieri eli Sardeg na " , btg. t. '' Cremona", btg. t. "Centauro " , 46A cp . t., cp. t. "P inerol o" , 3° btg t di C.A
Uo1nini e mezzi impiegati
643 uomini , p e r un totale di 722.960 ore di la voro/ uomo; 81 stazioni radio, 28 terminali ponti radio, 9 centralini telefonici, 76 te lefoni e 224 km d i cavo te lefonico.
Alluvione di Genova ( 1970)

Evento/Con corso fornito
Il 7 ottobre Genova fu imeressata da un'alluvion e Le unità Trasmissioni intervennero per as s icurare i co llegamenti necess ari all'azion e eli coordinamento dei socco rsi.
Zona
Genova, Voltri, Mola ssana.
Reparti delle Tras missio ni interessati
b tg t. "Cremona", Scuola TLC interforze di Chiavari.
Uomini e mezzi impiegati
96 uomini, per un to tale di 98.023 ore di lavoro/uo mo; 14 stazioni radio, 2 terminali ponti radi o, 4 centralini te lefonici, 18 te lefoni.
Vala
n
ga n e l Ivlone se ( 1 97 1)
Evento/Concorso fornito
Sulle Alpi Marittime, il 22 febbra io, si abbatté una grossa va la nga in zona Monese, travolg en do va ri e persone. In soccorso ve nn ero inviati i militari che s i adoperarono ne ll a r icerca de lle vittime e dei superstiti . Le unità T rasmissioni intervenn ero per ass ic ura re i co ll ega menti interrotti.
Zona
Monese
Reparti delle Trasmissioni interessa ti

Scuola TLC interforze di Ch iava ri.
Uomini e m ezzi impiegati
60 uomini e 18 staz ioni radio di vario ti p o.
Terre m o to d e lle Ma r che ( 1972)
Evento/Concorso fornito
Il 4 febbra io la città eli Ancona e il circostante territorio furon o ripetutame ntc sottoposti a scosse telluriche di notevo le en tit à , che causarono in genti danni ag li edifici e gravi di sag i a ll a p o polazione . Le unit à Trasmissioni impiantaron o c gestirono 2 centri trasmis s io ni, 8 ce ntri radio.
Zona Ancona .
Reparti delle Trasmissioni interessati
Cp. t. "Friuli ", 43° btg. l..
Uomini e mezzi impiegati
120 uomini; 26 staz ioni radio d i vario tipo, 4 centralin i telefonici, 124 km di cavo tele fonico .
Incendio di boschi a Sestri Levante ( 1973)
Evento/Con corso fornito
Un esteso in ce ndi o bosch ivo scoppiò il 24 marzo in zona di Sestri Le va nte
Zona
Sestri Levante
Reparti delle Trasmissioni interessati

Scuola TLC interforze di Ch iavari.
Uomini e me.zzi impiegati
4 U., 10 SU., 100 tr , l AR, 4 autocarri, 16 stazioni radio di vario tipo.
Incend io di boschi nell'Isola d'Elba (1974)
Evento/Concorso fornito
Il 15 agosto estes i incendi distrussero un'estesa area boschiva dell ' Isola d 'El ba La B. paracadutisti intervenne s u l posto .
Zona
Iso la d 'E lba.
Reparti delle Trasmissioni in teressati
Cp t. de ll a B. paracadutisti.
Uomini e mezzi impiegati
92 apparati radio di vario tipo.
Terretnoto del Friuli (1976)
Evento/Concorso fornito
Il 6 maggio , alle 21.05, la terra tremò in Carnia ed in tutto il Friuli. L'ep icentro del ter remoto, eli intensi tà pari al 9° grado della scala Mercalli, fu localizzato a Monte S. Simeone La televisione , a ll e 22.00 circa, diramò le prime informazioni su un sisma di notevoli proporzion i che aveva sconvolto l'intera regio ne. Le not izie però erano ancora vaghe e, in assenza di dat i certi, s i tese a non drammati zzare. Solo più tardi, al mattino dopo, l'I talia conobbe cosa era avvenu to. Le popolazion i carnic h e e friulane, pe rò, lo seppero subito e con loro lo seppero anche i milìtari dislocati nell 'a rea veneto -friulana I fan ti delle Divisioni "Mantova'' e "Folgore ", g li alpini della Brigata "Ju lia", g li attiglie ri , i gen ieri ed i trasmettitori de l yo Corpo d'Anna ta non es ita rono ad accorrere, già nella notte, in aiuto a ll e popo la zioni colpite, nonostante i lutti e d i feri ti presenti anc h e t ra le loro fila. Un caso per t utti: a Gemona, la caserma Goi - Pantanali, sede dei gruppi di artiglieria da montagna "Conegliano" ed "Udine" e di altri reparti della "Julia" , venne in g ran parte distru tta e sotto le sue macer ie persero la vita tren tun o alpini
I soccorsi giu nse ro numerosi da tutta Italia e d anche dall'estero. L'azione massiccia, però, v e nne svolta dall ' Esercito c h e , sia in occasione d e l primo evento sismico, sia nel s e condo ripetutosi a settembre , imp ie gò nell'area, mediament e, 3.600 uomin i per nove m e si, con punt e di oltr e 13.000 Le dimensioni del disastro furono tali che il Governo nominò un Commissario straor dinario. Le modalità di richi e sta e di invio dei soccorsi vennero regolate sulla base de ll e esperienze vissute giornalmente , avvalendosi d e ll e strutture di comando e controllo della Forza Armata: centri operativi , organi di . coll e ga -
In alto: Te rremoto del Friuli, 1976. Centro Tr-asmissioni presso Gemona

In basso:
Ten ·e moto del Friu.li, 19 76. Soldati, vWii del fuoco e popolazion e civile scauano fra le macerie dopo il gra ue terremoto .
Terremoto dell 'Irptnta , 1980. Autocolonna di un reparto delle Trasmissioni ìn partenza per le zone terremotate I reparti delle Trasmissioni sono tra i primi u muovere in caso di calamità per ristabilire il flusso delle informazioni.

mento, mezzi di tra·smissione. Per le esige n ze di soccorso alle p o p o lazi on i de l Fri uli Orientale colpite d al t erremoto le uni t à de lle Trasm issioni assicu rarono l'i mpianto e la gestione di 10 centri trasmissio ni , 36 c en tri radio, 20 linee di co rri s pondenza in ponte ra dio, lo s tendimento di linee telefoniche per un totale di 2 .000 Km/ circu ito.
Zona
Osoppo, Gemona, Tarce nto, Civid a le, Ve nzone.
Reparti delle Trasmissioni interessati
42° btg. t., 32° btg. t., 11 o btg . t. , btg. t. "Mantova", btg. t. "Ariete", btg. t. "Folgo re", cp. t. "Julia", cp. t. "Cadore", cp. t. "O robica", cp. t. "Tridentina" , 4° btg. t. di C.A., 5° btg. t. di C.A. , 13° btg. t., 44° b tg. t. "Penne".
Uomini e mezzi impiegati
1.324 uomini per un tota le di 635.520 ore di lavoro/ u o mo, 90 stazioni radio, 92 ponti rad io, 69 tel efoni e 336 Km d i cavo telefo n ico.
Terremoto della Campania-Basilicata ( 1980)
Evento/Concorso fornito
Quattro Provincie della Campania e della Basilicata furono in larga misura spazzate via in pochi secondi da un terremot o verifica tosi il 23 n ovembre, alle ore 19.37. Il sisma venne valutato int o rno all '8° grado della scala Mercalli: i superstiti furono tagliati fuori dal resto del Paese, i co lleg a menti impossibili, le necessità tante.
Manca ndo ogni cosa, vi fu bisogno di aiuti imm e dia ti , massicci e ben coordinati. Con inne gabile tempestività la macchina degli aiuti -c ome venn e da più ·parti chi amata - s i mis e in moto , si organ izzarono i soccors i: in breve tempo tutto 6.1 pronto per assicurare alle zone colpite u na prima, necessaria presenza.
Il pron to inte r ven to d e ll' Es erc ito e delle prime unità di aiuto accorse sui luoghi intere ss ati da l s isma fu reso poss ib ile gra zie al funzioname nt o dei centri delle Trasmission1 sparsi lungo tutta la dorsale appe nn inica e nell ' epic e ntro del sism a dov e , tra le mura anc ora v ibranti p e r le terribili scoss e che con tin uavano a susseguirs i, i tr asmett itori del 4 5° Regg im ento Trasm ission i e de ll a disciolta Scuola Specializza ti di S Giorgio a Cr emano d imostra ro n o san gue fre ddo e s pirito di a b n egazione non comuni, o ltre che un ott im a prepara zione tecn ico -militare rim an endo vici ni alle appa r ecch iature per oltre tre nta ore, se n za mai concedersi u n a pausa. P e rmis e ro cos ì all e v arie unità in a ff1u sso nella zona del disastro di comunicare con la sala opera tiva del Comando Region e Militare Meridi onale (RivlME) , dove i trasmettitori potenziarono i coll e ga me nti in sta ll ando quattro nuov e lin ee di corrispond e nza in ponte radio campa le. Per l'allestime nto d e lla sa la operat iva del Comando RMME e del Comando Zona In tervento eli Ave llin o ven n e ro in sta llat i in poche ore sess anto tto punti tel e fonici, s te s i divers i chilometri di lin e e t e le fonich e inte rn e, impiantata una re t e radio
Dopo q u esta prima se rie dì attività, svolta in c ondiz io ni dramma ticamente p recarie, nell 'ambiw d ella "Prim a Fas e " eli attuazione de i soccorsi , si passò ad una seconda serie el i interventi impi a ntand o u n Centro Noclale di Area (Monte Sant'A ng elo di Cava, a q uota 1200 me tri), sosti t uendo i po nti radio di piccola capacità con qu a ttro nuove tra tt e in ponte rad io CTR/145 , installando di e ci appar e cchia ture in fa csimile. Si provvide, inoltre, a ll a costitu zion e eli nuclei autotrasporta ti per rip a razi oni d i pronto in terve nto ed alla insta ll az io n e di collegamenti in ponte radio di grande capacità e di pon ti rad io di piccola capacità . Fu realizzata , infine, una rete radio mobile con otto ill uminatori. I tre nucl e i d i pronto intetvento ope rarono in tutte le zone maggiormente danne gg ia te dal sisma.
Purtroppo la gravità d e ll' ev ento si d e li neò rapidamente: alle 20.30, su richie sta d e i Carabinieri di Torre del Greco, venn ero inviati per l'op e ra di rimozione dellemacerie in q u ella città l Ufficiale, l Sottufficiale e 30 militari d i trup pa . Con q u esto provv e dimento, at t uato di propria iniz ia ti va dal Comandante d e lla Scuola Specializzati Trasmissioni, cominciò per l 'Ist itu to lo stato eli emergenza.
Venne a ltresì imme di atamente costituita una Sala Operativa , o n de assi curare u n coordinamento delle vari e richie ste eli soccorso.
Successivamente, e durante l'arco eli circa 7 mesi , la Scuola concorse d irettamente al socco rso delle p opolazioni colpite dal sisma opera n do con i propri uomini nel monta ggio di te ndopoli , n ella rimozion e eli macerie ed in manovalanze varie.

La Scuola, in oltr e, fornì il conco rso di 6 Ufficiali , 7 So tt uffici ali, 4 militari di Tr uppa in rinforzo ai c entr i trasmissioni cost ituit i dal 45° btg.t. nelle zone di Avellino, Salerno , Potenza e Napoli e d i l Ufficiale e 12 Sottufficiali coman d ati per affian care i Sindaci de i Comu ni più co lpiti dal sisma
Zona
Avellino , Sale rno , Potenza , Napo li e province.
Reparti delle Trasmissi oni interessati
Oltre all e unità d elle Trasmis sioni d e lla Regione Militare Meridionale, pres e ro
pa1te alle attività co n tinge n ti· dei seguenti reparti:
3° btg. t. "Spluga", 4° btg. l. "Gardena ", ) 0 brg. t. "Rolle ", 11 ° btg. t. "T.conetisa ", 13° btg. t. "Mau ria ", 32° btg. t. "VaJi es", 33° btg. gu . elt. 41° btg. t. "Frejus ", 42° btg. t. "Pordoi ", 43° btg. t. "Abetone", 107° btg . t. 'Prcdil", 184° btg. t. "Cansiglio", 232° btg r. "Fadalto"
Uomini e mezzi impiegati
P er l'opera di ricos tru z ion e la Sc u o la venne ancora impegna ta , nei m es i di magg io e giugn o 1981, per co ll a bora re a ll a ços truzio ne d el Villaggio Ese r cito di Napoli, con un impi ego m edio g iornali e ro di 4 Uffic iali, 20 Sottufficiali e 200 tras mettitori.
C'è da segnalare infin e che lo Stabilim e nto Militare Nlareriali d e ll e Trasmiss ioni in Roma costituì per circa un m ese un attrezza to cl is raccarnento per le ripara z io n i dei mez zi tecnici d e ll e Tra s missi o ni presso il labo ratorio riparazioni d ella Scuola .
Alluv ione di Val di Fiemme-S tava (1985)
Evento/ Concorso fornit o
Il 19 luglio una grave sciagura colpì il Trentino: decine di persone vennero travolte dalle acque di un torrente fuo r iuscite per il cedime n to di uno sbarramento eli terra. Il fatto si verificò in località Stava, nei p ressi del comune d i Cavalese. La massa d 'ac qu a trab occata dallo sbar ranìento in terra del torrente Stava, si incana lò in una valletta precipitando pe r circa cinque c hil ometri. l morti furon o 300.
Zona
Val di Fiemme.
Reparti delle Trasmiss ioni interessati

4° btg. t. di C.A
Uomini e mezzi impiegati
123 uomini , 92 stazioni radio , 12 termi n a li ponti rad io, 58 telefoni e 38 Km di cavo te lefonico .



Compito fondam e nta le d e ll e Fo rze Armate è la difesa del territo ri o, la cu i co ncez io ne , o rga ni zzazione e co nd o tt a è affidata princ ipa lme nte all'Es erc ito.

La minacci a diretta a l te rrito r io in c lud e a n ch e quella d ir etta alle lib e re istituz ion i ln tale quadro e in segu ito a ll a d ifficile si tu azione d e te rmin atas i nelle reg ion i meridionali de l Paese a causa d ell a c rimin a lità orga nizzata , il Governo ha riten uto opportuno impiegare l'Ese rc ito r e r co ntrastare il fenomeno.
I mi lita ri , avva lend osi della qualifica lo ro confe rita el i "age nti di pu bblica sicurezza ", opera n o in stretto coo r d in ame nto con le Forze de ll' Ordine. Nelle pagine che seguono sono presentate le operazio ni sinora condotte o in atto.
Operazion e "Forza P ar is "
Nel 199 2, per arginare il fenomeno della crimina lità orga n izzata che imperversava in alcune zone dell a Sardegna, fu deciso l' in v io di un co nt inge n te dell'Esercito nell 'isola, per esp rim e re co n c retamente la solid arietà dello Sta to ne i confronti delle popo lazion i locali e per fornire un co n corso indirett o alle Forze di Po lizia attraverso un accenrrato co ntro ll o d e l te rr ito r io ed un ' imp licita l imit az ione d ello s p azio di manov ra de ll a ma lav it a o rga nizzata. L'area interessata r iguardava la prov inc ia eli Nuoro, compre nd ente va s te zone imp e rvie.
La p rese n za milit are in Sardeg na, d a l lu g li o a l sette m bre 92, venne garant ita mediante l'impiego co nte n1p o ra n eo di du e Briga Le, con una forza compless iva di circa 4.000 uomini. Le pr ime du e GG .UU. d es ignate furono la ·Brigata mecc aniuata "Gor izia " e la Brig ata a l p in a "Taur in e ns e", co n il concorso dell a Bri ga ta "Sassari" L'inte r a att iv ità ve nn e gestita dal Comando de lla Reg io ne Milit are d e ll a Sardegna che si avvalse eli un Cen tro d i Coordinamento "ad h oc ", distaccato a Nu o ro ed a ll e dirette dipendenze de l Vice Coma nd a nte della Regione
Su richi esta delle autor ità civ ili , vennero e ffen uati i nterv en ti nel sett ore d ella sanità (visite, cu re medich e , donazion i di sangue, ecc.) e del genio (lavori st rada li , seg nalizzazione e manutenzione di se ntieri , ecc.), nonché in quello delle Trasmissio ni ( rea lizzazion e d i collegamenti in ponte radio acl uso dei civili) La presenza militare contribuì allre s ì all 'a t tività di rrevenzione e di allarme degli incendi, nonch é a d inte rventi sul terreno coordina ti con gli elicotteri dell'Aviazione
Il Comando Trasmiss ioni del la Reg io n e Mi litare della Sardegna ebbe il comp ito d i realizzare e gest ire il s istema d e ll e tras missioni tdoneo al soclcl isfacime n to d e ll e es ig e nze di coma ndo e controllo del ce ntro cl.i coo rdin amento in Nuoro c dell e un ità in aft1u sso per le att ività aclclcst ra ti ve rrev iste dall 'esercitazione "Fo r za Paris "
La vastità c l'o rografia d e l te rri torio inte r ess ato all 'ese rc itaz io ne , unitame nte a ll a sca rsa fless ibilit à d 'azione d e l s u pporto t ras m iss ion i d e lla RlVISA , resero n ecessa rio il ricorso a p ersonal e e ma teri a li eli a ltr i re p a rti p e r l'a ssolvimento d el comp ito affidare
I suppor t i trasmissioni inte rven u ti (RMSA, 5° C. A ., 4° C.A., RMCE , RMNE, RMNO, RMME) impiegarono, in termi n i di personale e mezzi, g lobalmente:
- 15 Ufficiali ;
- 48 So ttufficia li;
- 88 milita ri d i truppa;
- 4 ce n trali digitali CD- 101 ;

- 16 ter mina li ponti radio;
- 19 staz io ni radio HF e VHF;
- 13 stazioni di energ ia da 10+10 KVA
Opera zio n e "Vespri Si cil iani"
In segui to alle determinazioni as sunte nel corso d el Cons ig lio dei Minis tri d el 25 lug 1992, il Go ve rno d ecise d i inviare in Sicilia 5000 u omi ni , in rinfo rzo all e unità del Coman do de lla Regione Militare Sicilia, per co n correre alle attività d ell e Forze di Polizia nella prevenzione dei delitti della crimin alità organizzata e p er la sicurezza ed il controllo del territo rio.
A tutto il person ale militare impegn a to fu attrib uita la q u a lifica di "agente d i pu bbl ica sicure zza". I compiti pa rt ico lari pre ved evano il controllo d i zone este se , "posti d i blocco", pattugliamenti, rastrellamenti e difesa passiva di infrastruttu re.
L'attività sv o lta, nel periodo lu glio 92 - d ice m b re 93, pu ò essere sintetizzata in :
- 14.804 posti d i b locco e co ntrolli strada lVauto ;
- 4.258 pattu gliame nti e verifich e opere d'arte ;
- 249.784 au tomezzi contro ll ati;
- 314.638 persone identificate ;
- 6 .397 e difici cont ro llati;
In alto: Sicilia, 1992. Operazione "Vespri Siciliani". Vigilanza armata.
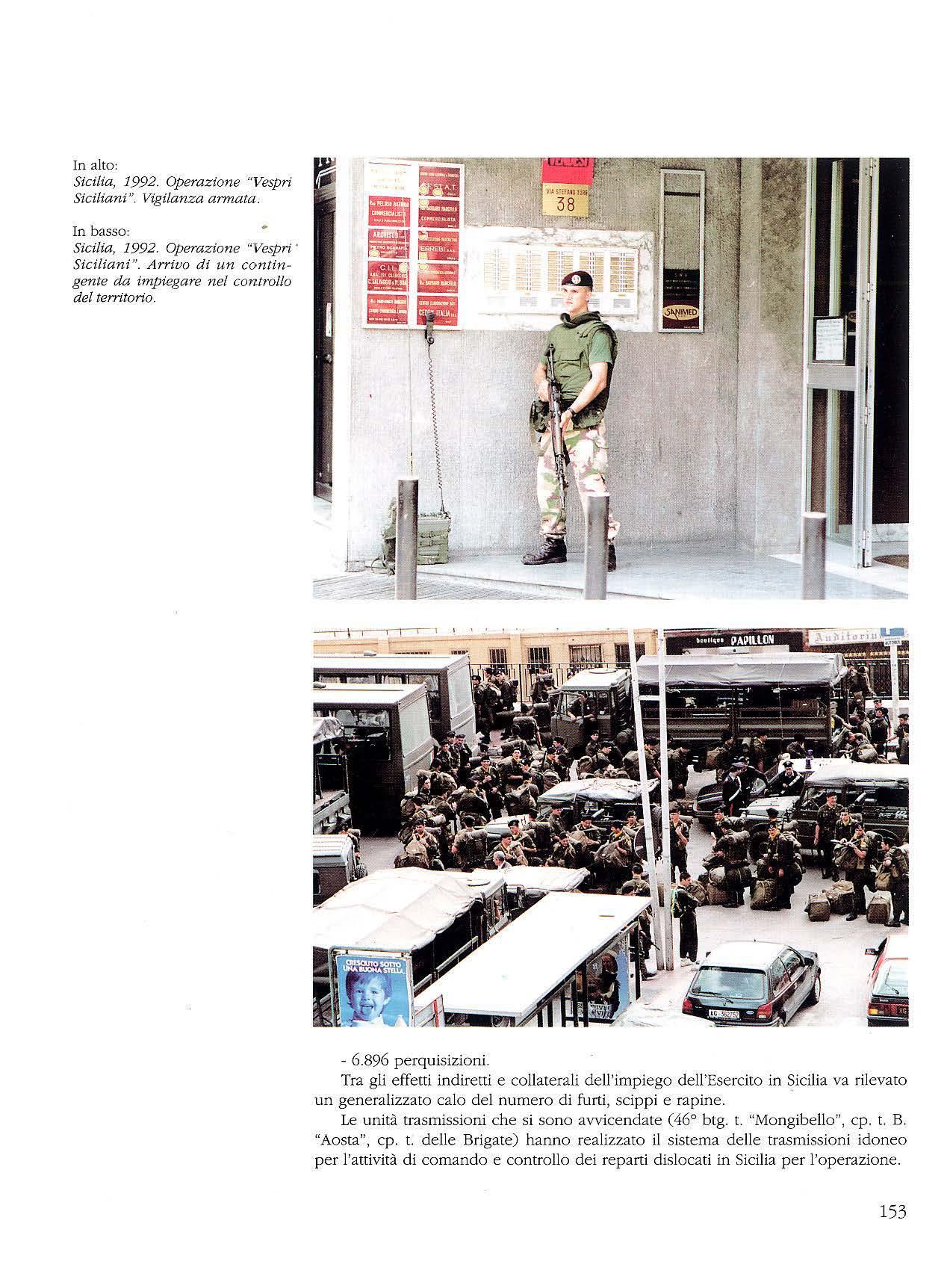
In basso: Sicilia, 1992. Operazione "Vespri · Siciliani". Arrivo di un contingente da impiegare nel controllo del territorio.
- 6.896 perquisizioni.
Tra gli effetti indiretti e collaterali dell'impiego dell'Esercito in Sicilia va rilevato un generalizzato calo del numero di furti, scippi e rapine.
Le unità trasmissioni che si sono avvicendate ( 46° btg. t. "Mongibello", cp. t B. "Aosta", cp. t. delle Brigate) hanno realizzato il sistema delle trasmissioni idoneo per l'attività di comando e controllo dei reparti dislocati in Sicilia per l'operazione.
Operazione "Test uggine "
Il Ministero della Difesa, su richiesta del Ministero dell 'Intern o in data 16 agosto 1993 , dispose il concorso de ll 'Ese rcito a favore dell e Forze d ell'Ordine nelle provincie di Udin e, Gor izia e Ttieste allo sco p o el i intensifica re l'azione eli co ntro ll o nei confronti dei te nta ti vi di ingresso irregolare in Italia di uomini , mezzi e materiali attraverso il confine o ri en tale ( frontiera italo -s love n a). Tn ta le quadro, ve nne dato mandato al Coma ndo della Rl\1f\é di svo lgere , a pmtire da l 16 agosto 1993, att ività di pattugliam ento e osservaz io n e in corrispon d e nz a d ei principali valichi/itin e rar i eli front ie ra compres i tra le loca lità di Monte Fo rno a nord e Lazzarcto a s ud. Le forze nece ssarie, g io rn a lme nte pari a circa 300 uomin i, furono tratte d a ll a B. a lpin a "J u lia" e d a lle Brigate meccan izza ta "Gor iz ia" c corazzata "Ari e te".
Ne l quadro del le s udde tte att ività , le unità tra s miss ioni de ll e r is p e tt iv e Brigate hann o assic urato i co ll ega me nti tra i Comandi della Grande Unità e le patt1.1 g li c dis locate st.d territorio inte r essa to impi ega ndo s tazioni radio d i vari o tip o
Op e r azioni "Ri ace" e "P a rtenope "
A seguito dell 'e manazione del Decreto Legge n. 550 del 30 d icembre 1993 e delle determinazioni assunte nel corso delle riu nioni del Comitato Nazionale per l'Ordine c la Sicurezza Pubblica del 25 gennaio e del 2 febbraio 1994, il Governo ha deciso d i impiegare 1350 uomini in Calab1ia ( Operazio ne "Riace'' ) e 500 ne ll a c ittà di Napoli (O p eraz io n e "Partenope n), per concorrere a ll e allività svol te dal le Forze d i Polizia per la preve nzione eli delitti del la cr imin a lità o rganinara e per la sicu rezza ed il co ntro ll o d e l te rritorio. Anche in questa c ircostan za a l p e rso n ale milita re impi ega to è s ta ta a ttribuita la qualifica di "agente di pubb li ca sic ur ezza''.
Le un it à d e ll e Tra s m iss ioni im p eg nat e (45° rgt. t., cp. t. "Ga ri ba ld i", cp t. "P inerolo "), h a n no provv e duto a d. impiantare il s istema d e ll e trasm iss io ni p e r la condotta d e ll e op e raz io ni d i co ntro llo del territorio n ell 'area d ' int e resse. Ta le s is tenl.a utili zza la esistent e r e te infrastruttu rale militare opportunamente a dattata alle specifich e es ige n ze c um t re te rad io VHF per soddisfare le es ige n ze d i co ll egamento d e i nucl e i ope ra tivi distaccati s ul territorio.

CONCORSO PER IMPIEGO "FUORI AREA" IN MISSIONI ONU


La situazione intcrna%iona le, dopo la fine d e l "bipolarismo", sì è così profondamente modLficara da ri ch iedere anche una revis ione dei comp iti delle Forze Armate. La comu nità intern aziorude è sostanzialmente una com unità di Stati. La base della sicurezza internazional e de l futuro consiste nel la stab ilità degli Stati che non abbia no ancora completato iJ lo ro processo di "Nation Building" Nel n uovo quadro mondiale l'obbliga zione p olitica alla sicurezza diventa oggetto di impegno internazionale di ogni Stato ed in tal se nso vie ne tiferita ad un contesto mu ltilaterale, abbandonando gli approcci uniJaterali d el passato. Ciascu no Stato , a seco nda delle sue capacità e risorse e del s uo ruolo e voca?. io ne, deve prepararsi acl interve nire a livello regional e o internazionale, attr ibuendo adeguata priorità e mezzi a tali missioni nell'ambito della s ua p ianificaz io ne dell e forze.

La volontà d e i Paesi di partecipa re alla prev e n z ione ed alla gestione d e ll e cris i che mettono in peri co lo i loro interessi o la pa ce nel mondo, conferisce all'azione militare un nu ovo asp e llo
Il ruolo delle Fo rze Arma te è ormai final izzato sia a limitare od a controll are l'espansione e le diverse manifestazioni di un a cris i, sia ad imervenire prontamente in un conflitto armato. Oggi il contributo de ll e Fo rze Armate sì inserisce pertanto in un insieme di azion i politiche, d iplomat ic h e, eco nomiche e della stampa, che am pliano il loro tradizi o n ale camp o d'azione. La loro partecipazione è qu asi se mpre in ambito inLerforze c multinazio n ale.
La gestione de lle c ri s i si basa su operazioni di due tipi: quelle che le Forze Armate compiono congiuntamente acl altri organismi, che hanno come oggetto la prevenzione dei conflitti e le azion i u manitarie, e quelle interamente d evo lute a lle Fo rze Armate, cioè le o pera zioni di ristabilimento e mantenimento clelia pa ce. Le az io n i di prev e n zione hanno lo scopo di raffo rzare la pace , medi ante misure attuate prima d e ll o scoppio di un a cris i. Si basano, in particolare, sull'an ti cipazione, la localizzazione, la s tabilizzazione ed il contro ll o L'anticipazione associa la lo ca lizzazione delle vulnerabilità al monitoraggio d i evo luzioni geopoliti che in una visione prospetti ca. La loca lizzazione si basa su un a buona gestione delle informaz ioni per raggiunger e la qua le le Forze Armat e devono fare uno sforzo costa nt e I.a s tabilizzazione privileg ia le az ioni indirette , co me la coope razion e militare, il rinforzo e la sorv eg li a n za. La cooperazione milita re, nella sua forma più ampia, si traduce in una assistenz a militare tecnica ai Pa es i firmatari di accordi di difesa e di coo perazione. Le m isu re d i co ntrollo cons entono di scop rire molto rapid amente i segni dell 'inizio di uno sq uilibrio suscettibi le di sfoc iare in una crisi e , quindi, di predis porre misure chiaramente percettibili da parte del potenziale nem ico.
Le azioni umani ta rie hanno lo sco po eli soccorrere le vittime delle calamità di q uals iasi natura. Ricopro no essenzialmente quattro aspetti: lo sgombe ro dei profughi, l'assis tenza alle popolazioni, l'intervento in caso di ca lamità naturali o indusni ali e gli interventi di tipo militare-uman ita 1io ( azioni di sminame nto, protezione e sicurezza del p ersonale, come in Kurdls ta n e d in Somal ia). Le azioni umanitar ie so no generalme nte
condotte da organ izzazioni non governative; ma per rafforzarne l' e ff icacia è possibile far ricors o alle Forze Armate, ch e forrtisc ono .i mezzi compleme ntari di una potente log.is tica e s trutture/mezzi di comando efficac i. Esse possono ga ra ntire la sicurezza dell e o pe raz io ni , nonché pro cedere ad azioni specifiche quali lo sm inamento e la bonifica. Le Forz e Armate , ed in pa rti co lare l'Esercito, hanno cara tteristiche tali d a potcrsi adatta re alla durezza d ell e situ azioni ed all'entità di ca lamità di q ualsiasi natura; esse dispongono inoltre di mezzi sanicari, delle trasmissioni e di mobilità terrestre ed ae rea che co nsentono di accedere e di opera re in zone particolatmente difficili
Le operazioni di mante nim e nto della pace si inquadra no gene ralmente n e ll' ambit o de l Cap itolo VI della Carta ONU, come gli intetventi in Cambogia ed in Jug os lavia, e, più raramente, n e ll ' ambito del Capitolo Vll co m e gli inte1venti nel Golfo Pers ico ed in Somalia. Esse so no finalizzate a limita re qua lsiasi escalation, vietare o c ircosc rivere qualsiasi sco n t ro diretto, far diminuire le tensioni e consentire la ripresa del dialogo. Si basano s u l rispetto della sovranità d eg li Stati, sull 'accordo e la negoziazione fra le p arti e su ll 'impiego minimo de lla forza Non mirano ad imporre un a soluzi one, ma sol tan to a c reare le condizioni necessarie per la sua elaborazione e realizzazione. Le modalità di a zio ne più frequenti sono l'assistenza al processo p o litico in fa vore della pace, l'applicazione ed il co ntro llo del cessate il fu oco e l ' interposizione. Ta li o p eraz io ni, che compre n dono un e levato nume ro di compiti (informazion e, rimp a trio dei co nnazionali all' es te ro, e lezioni sotto il controllo int e rnazionale, inqu ad rame nto della polizia lo ca le, sorveg lianza del risp e tt o dei diritti d e ll'uomo, ecc.), im p licano una stretta cooperaz ione e coordinaz ion e tra c ivili e militari. L'uso d e ll e a rmi è limitato ai soli casi di legittima difesa
Le ope razion i di ristabilim e nto de ll a pace, che si inqu adrano nell ' ambito del Capitolo VII della Carta ON U, co n sistono nell ' imporr e, con la fo rza , u na soluzione ai protagonisti di una crisi e conse nto no , pertanto, l'uso delle armi, d a impiegare semp re con moderazione. Es se corrispondono a conflitti d i intens ità variabile: il "Golfo" è un esempio di conflitto d i med ia intensità. Possono avere vari scopi, quali la protezione di un Paese vittima o minacciato di agg ress ione, la difesa di interess i n az ionali o comuni a più Paesi, il manteniment o od il ripristino della sovranità nazionale del Paes e in quest io n e.
In caso di intervento, è possibile ipotizzare due strateg ie: un intervento in forza, sceg li endo un volume di me zz i d is s uasivo e che consenta di affrontare qualsiasi eve nn.1alità eli escalation, o ppure un intervento a più basso live llo, più rap ido e con mezzi precisamente dimens io n at i, mantenendo comunque un a capacità d i rinforzo e d i reve rsibilità. Tale modalità di intervento rapido è la so luzione ottimale per risol vere il problema con il minor imp iego possi bil e di forze. La prima opz io n e implica notev oli riso rse milita ri e finanziarie e ri c hie d e tempi maggiori. Sembra p e rtanto di gran lunga prc fe ribile optare per l' azione flessibile, piuttosto che p e r l'azio n e in forza; ta le modalità d 'azio ne esige una ch iara finalità politica ed un'azion e re versibile ne i confron ti di avve rsari poco risoluti. Le az ioni flessibili hanno quindi una evidente sp ec ificità, dalla quale deriv ano co nseguenze che influisco no s ull'organizzazion e dell e fo rze e sulle modalità di interve nto.
Tnna n:d tutto , la struttura d elle forze deve essere modulare per consentire di adattarsi in maniera flessibile alle condizioni specifiche di ogni intervento, all'evoluzione della situazione ed alla costituzione di una fo rza mu ltinazionale. Pertanto, quando si pensa di "p roiettare una for za", una volta decisa la missione in accordo con il potere politico, bisogna in primo luogo pre vedere il comando dell 'op e razione, i mezzi di trasmissione locali, eli teatro e verso la madrepatria, i mezzi eli informaz ione, la logistica, i mez zi idone i a l tipo di intervento ed, eve ntualmente, i vari appogg i. A mano a mano che l'ope raz ione assume magg iore entità , nuovi moduli completano i precedenti in

Mis s ione Libano !TALAlR Antenna HF log-Pe1·iodica per esigenza " UN/FIL " Libano Naqoura

ognuna delle suddette funz ioni Inversamente il disimp egno si traduce in ritiri successivi dei moduli. In secondo luo go, la buona gestione delle crisi implica una grande rapidità di reazione e quindi di intervento. Ciò ha due ripercussioni sull 'organizzazione delle forze: da una pa1te è opportuno disporre di unjtà in permanente stato di alletta , pronte ad essere proiettate con tempi di preavviso brevi (da 6 a 72 ore), dotate eli m ezzi necessari p er assicurare un'ampia gamma eli missioni, sia nell'ambito di operazio n i di ponata limjrata, sia per operazioni "più dure" , che richiedano l'impiego di forze corazzate ; dall 'altra pmte, l'impiego di forze preposizionate consente eli rispondere i.n ternpi brevi e di fornire il sostegno logistico o anche la sola conoscenza del Paese. Un preavviso breve, ta lvo lta imposto a ll e forze, g iusti fica il preposizionarnento delle unità fuori dalla maclrepatria in vittù di accordi di difesa o di cooperaz ione In ta le contesto, appare evidente Uruolo dell 'Asma dell e Trasmjssioni che in ogni circostanza è chiamata ad ass icurare la realizzazione dei collegamenti che, in aree lontane dal territorio nazionale , diventano ancor più necessari ed it11pegnativi.
lVlissione Libano (ITALAIR)
Una de lle prime opehtzioni fu or i area svolta dalle Forze Arma te italiane dal termine del secondo conflitto mondiale fu quella del Libano.
Nel 1979 I'ONU chiese infatti all'Italia di partecipare a UNIFIL ( Unlt e d Nations Interim Force in Lebanon), la Forza di Pace delle Naz ioni Unite ancora oggi in Libano per "mantenere la pace" in questo paese martoriato per anni da un intermi -
nabile confl itto interno ; in pa rt icolare f u ch ie sta una co mponente elic otteristica e in tal senso fu costitu ito lo Squadrone Eli cotteri ITALAIR anch 'esso ancora o gg i pres ente in Li ba no. Nas ceva c osì l'es ige nza di co llega re con la Ma drepatria il Co nti nge nte militar e itali a n o inv iato o ltre confine. Fu invia to in quella occasione un nucl e o di Sottufficiali marconisti co n una s tazione ra d io RH-6/100 0, di gra n de pote nza, op e ran te nella gamma HF.
La stazione radio, oltre a permettere il collegame nto con lo Stato Maggiore d ell ' Esercito a ttra verso il prop rio centro tras mission i, ha offerto e d o ffre an co ra ogg i la possibil ità d i mettere in co municazione il p e rsonale d e llo squa d rone con i prop ri familiari in Italia.
Missione Liba no (ITALCO N)
Ne l 1982 l'Arma dell e Trasmissioni fu impegnat a nella realizz azione dei collega menti tra il Co mando d e l Contingente ITALCON sito a Beirut , i Re parti dip e nd e nti in Liban o e gli Organ i Centrali d e ll a Difesa in Ita lia. Per qu e ll 'occas io ne fu cos ti tuita la prima Unità orga ni ca de lle trasmiss ioni opera nte fu ori da l territo ri o n azio na le : u n plotone trasmiss io n i a cui fu attrib uito il compito di soddisfa re le esige n ze di collegamento d el cont ingente ita lia no. A ta l fi n e vennero impiantati un cen tro trasmiss io ni per il p os to comand o d e l conting e nte, una rete in ponte radi o, u na rete radi o e d una rete te leg rafonica.
Fu ro n o impiega te in quella o ccasione a lc u ne s taz ioni radio RH -6/1000, e RH5/478 a modulazione di a m piezza per i collegamenti a media e g rande d istanz a e stazioni radio a modulazione d i frequ e n za del tipo RV-4/213 p er i collegame nt i loca li F u ino ltre introdotto p e r la prima vo lta un sistema di collegame nto via sat e llit e. I termin ali UHF SRT-619/C utilizzava n o u no dei sa te lliti geostaz io nari FLTSATCOM ( Fleet Satell ite Commun ications) e fu nzi o navano in semplice fra il Coman d o Contingente e lo Sta to Maggiore d e ll'Esercito.
Dopo l 'es ige n z a "Lib a n o" gli imp eg ni oltre co nfine per l e unità de lle
Centro tra s missioni ins tallato presso l'Ambasciata italiana a Beirut . Vis i one parziale.

L'Ambasc i ata i t a lia n a a B eirut
Trasmissio n i s i sono moltiplicati e la richiesta di collegamenti , con soluzioni sempre più all'avangua rd ia nel <.:ampo delle comunicazioni, si è farra più pressante.
Miss ione N a m ib ia ( H ELITALY)
Ne l 1989 l' ON U, su ll a scorra degli ott im i r is u ltati consegui t i d a lle forze d i pace italia ne , chies e l a p a rtec ipazione eli u no s q uad ro ne elicotteri AB-205 ital iano n ell'U NTAG ( Un ited Na t io ns Transir io n Ass is tan ce Gro u p) in Namib ia Come .s upp o r to tr asm iss io ni lo Stato Magg ior e de ll ' Ese r cito -su pr oposta dell'Ispetto ra to -d es t inò un ' a li q u o ta de ll 'l l 0 reggime nto "Leoness a' ' . Con caratte re di imm e cli ateaa ve n iva e ffe ttmt to , n ell o s te sso p rimo po me r igg io d e ll 'arrivo alla b ase eli Ru nclu , ove e ra dis loca to il coma nd o dello squ a dron e, u n colleg amen to radio co n il centr o trasmiss io n i de ll o Stato Maggior e d ell' Es e rcito e co n la sede del l'll o rgt. (a ll ora battag li o ne), media n te stazione rad io RH -5/478 e s tazio n i sa tellita ri (s istema IMMAR SAT) Tra i compiti dell 'aliqu o ta trasmissioni vi er a que ll o di collegare le altre du e bas i operative d i Onda ngwa e Windhoek co n il co ma n do d el con t ingente , n o n ch é gli elicotteri dura nte le mission i o pe rati ve e/ o logistichc. Qu es ti collegamenti fu rono realizzati mediante le stazion i radio RH -4/178.
I m ezzi delle trasmissioni dell'Esercito Italiano rimasero gli unici operativi fino a lla fi ne d e l me se di aprile e vennero impiegati anche per le necessità di collegamen to d e lle altre Nazioni. Durante gli scontri fra opposte fa zioni i trasmeniwri del contingente Italiano fo rn irono al quartier gene rale clell ' UNTAG di Windhoek tutte le no tiz ie utili alla conoscenza della drammat ica situazione in a tto n el Paese. Attr avers o le s tazio ni rad io italiane parlarono "mo nit o rs" p olacchi, fin landes i ed "oss ervatori " pe ru v ia ni. Ne i giorni el i cris i a n ch e i tr asme ttitori dell a Roya l Signa ! Fo rce impie ga ro n o i "nostri apparat i" Ne ll 'occasion e ven n e anche s p erime n tato, co n ottimi r is u ltat i, un app a ra to per la tras mi ss ione in telescrivente con corr et tore d i e rr ori. Esso rispose a ll e as p etta ti ve e ve nn e usato in tu tte le success ive mi ss io.n i all' estero che vide r o la p rese n za d i tras m e ttitori italia nj.

Missione Turchia-Iraq (AIRONE l e 2)
A seguito d e lla risoluzione 668 del 5 aprile 1991 , del Consiglio di Sicure zza deii ' ONU, veniva decisa l'op e razione militare "Provide Comfort" con la partecipazione anche di Forze militari italiane.
Il 2 maggio 1991 veniva inviato in zona operazioni un contingente dell 'Esercito, denominato "Airone". L"'Airone" compr e nde va paracadutis ti d e lla "Folgore" , alpini della "Taurinense" , il raggruppamento "Antares", 1.111a cellula dell'A e ronautic a Militare e un ' aliquot a dell'n ° rgt (allora battaglione) trasmissioni "Leonessa " , quest'ultimo con il compito di r e aliz zare c g e stir e il sist e ma d e ll e trasmissioni necessario per assicurare i collegamenti con la Madrepatria e garantire il comando
In alto: Missione Turchia-Iraq AIRONE, 1991 A ntenne del centro radio
In basso : Missione Turchia-Iraq AIRONE, 1991. Interno del centro radio.

e controllo delle forze interessate.
L' aliquota del "Leonessa'' comprendeva, tra Ufficial i e Sottufficiali , 17 unità. L'afflusso presso la zona d 'ope razione era suddiviso in tre nuclei distinti, ognuno associato al proprio posto comando.
De tti nuclei, imbarcati nei giorni 3 e 4 del mese di maggio su aerei militari c n avi civili, dopo lo sbarco mariuimo di Mersin, e g li sbarchi aere i a Incirlik e Dijabakir raggiungevano le zo n e di sch ierame nto per via o rdinaria.
Nel giorno 7 maggio l' in tera aliquota de l battag lione era schierata in zona di op erazi one e nella matt ina del giorno 9 maggio tutti i collegamenri pianifi cati dall'o rdine di operazione erano rea li zzati ed ope rativ amen te attivati.
Il sistema delle trasmiss ioni realizzato per l'es ige nza "Airone" era cos titui to da una rete a struttura " reticolare" art ico lata s u tre ce ntri trasmissioni, ognuno as sociato ad un posto comando.
Per coprir e le notevo li distanz e es istent i tra i cent ri tra smissioni e tra questi ultimi e la Madrepatri a, furono impi ega te tmitam ente stazion i radi o di media potenza e stazioni sate ll itari.
Ogni Centro trasmissioni comprendeva quindi una sezione radio, una sez ion e satellita re , una sezione facsimile, una sezio ne messaggi ed un nucleo alimentazione e ripa razione.
Le stazioni satellitari grazie anche al ridottissimo tempo di impianto (circa 10 minuti) risultarono utilissime specialme nte nelle fasi di sbarco del contingente e di impianto dei centri trasmissioni.
Nel complesso le trasmissioni radio fornirono eccellenti risultati, rivelandosi ancora una volta un sistema insostituibile per la semplicità e l'economicità di impiego.
Per fornire un 'in dica z ion e della mole di lavoro svo lto durante l'operazione "Airone" , conclusas i il 18 lugli o 1991, n ei Centri Tras m issioni furono gest iti complessivamente circa 8000 messaggi e 9000 comun icazioni telefon iche.
Missione Albania (PELLICANO)
In seguito a l crescente arrivo di profug hi albanesi in ltalia, n egl i anni 19901991 , il Governo italiano, d 'accordo con le Autorità albanesi, decideva l' ope raz ione militare denominata "P e lli cano".

Il 18 settembre 199 1 veniva inviato n e lle zone di Durazzo e Valona (Alb ania), un contingente dell 'Ese rcito, forte di 59 U., 855 SU., 2800 Tr. con il compito di ricevere , staccare e smistare ai centri di distribuzione albanesi gli aiuti uman it ari in viveri e vestiario provenienti da ogni parte del mondo.
In aggiunta ai bartaglionj logistic i "Ca rso " e "Acqui", venne assegnato un nucleo dell ' l1° rgt. (allora battaglione) trasmissioni per assicurare i collegamemi co n la Madr epatria ed il comando e controllo delle forze interessate in territo1io albanese.
L'aliquota del "Leonessa" per l' Operazione "Pellicano" comprendeva 48 mi li tari tra u ffic iali, Sotrufficiali e militari di truppa.
L'afflusso presso la zona di operaz ioni avvenne in tre al iquote distinte La prima aliquota con personal e e mezzi per due centri trasmissioni, imb arcat i la mattina del giorno 14 settembre 1992 su ae rei mi litari, raggiungev a in tarda serata le zone di schieramento. Tal e aliquota aveva il co mpito di r eal iz za re la rete in ponte radio per collegare, tramit e due posti relè, il centro trasmissioni di Valona con il centro trasmissioni eli Duraz zo e quest'ultimo , tramite un altro posto relè, con la Madre patria.
Le altre due aliquote imbarcate s u navi civili nei giorni 18 e 19 se ttembre, sbarcavano a Durazzo e Valona, e raggiungeva no per via ordinaria le zone eli schieramento.
Il giorno 20 set tembre l'intera aliq uora del battaglione "Leonessa" era in zona d'operazione c, nella mattinata del g io rn o 22, tutti i collegamenti p ia nificati d all 'ordine di operazione erano realizzati ed opera tivamente attivati.
Il sistema dell e trasmissioni realizzato per l'esigenza "Pell icano" comp rende va una rete a st ruttura reticolare , realizzata con ponti radio digitali e sistemi eli commutazione automatica di tipo Sotrin, a rti co lata s u du e centri trasmissioni similari (ognuno associa to al propri o posto coma ndo).
Stante la distanza relativ amente breve tra i du e centri tras mi ss ioni e la Ma dre patria fu possibile interall acciare la rete realizzata in Alban ia con la rete TLC nazi onale r,ramite un ponte radio in scatre r troposferico tra Durazzo ed il cenn·o n oda le avanzato di Mo nte Caccia, presso Bari.
I mezzi radio provvidero egregiame nte ad assicurare i collegamenti d i primo tempo (ovvero prima dell'attivazione della rete ponti radio ) fra i due ce ntri trasmissioni e la Madrepatria. Essi assunsero inoltre un ruolo prioritario ed indispensabile per i collegamenti tra i due posti coma n do ( Dura zzo e Valona) e le autocolonne in movimento lungo tutti gli itinerari del te rri to rio albanese.
Il giorno 3 clic. ' 93 l'operaz ione "Pelli ca no" aveva termine. Durante la stessa le unità de ll e Tras missioni avevano gestito co mplessivamente 39.000 messaggi e sm istat o 210.000 co nversazioni te lefoniche.

Nel la p agina a fianco, in a lto : Operazione Pellicano, Albania, 1991/ 1993. Centro trasm ission i di Valona - 1(/ s istemazione
In bass o : Operazione Pe llican o, Albania, 1991/ 7993. Antenne p er p onte radio a df[fi-tsione Tropoife rica
Qui so p ra : Operazione l hi<;, Som alia, 1992. Particolare di una anten na HF omnidi1·e:z:ionale

Miss ione Somalia (IBIS l e 2)
In seg uito d e lla Ris o lu z io n e O N U n.775/1992 ve nn e cos t1tu tta in Somalia, fi n dal mese d i agosto 1992, la missione UNOSOM , la cui a tti vità , in segui to ,veniva sospesa a causa degli sco ntri fra le opposte faz ioni eli guerrigli eri local i e d i continui assa lti ai m agazzi n i per imp adronirsi delle m e rci giu n te n ell'amb ito degli aiuti u manitar i d'emergenza.
Con la ri so luzione n. 79 4/ 1992 il 3 dicemb r e 1992 l'ONU autorizzò g li s ta ti memb ri acl im pi e ga re og ni p ossibi le mezzo p e r ris tab ilire a l p iù presto le condizioni eli sicurezza , chiedendo ne l con tempo ai gove rn i p a rte cip a n ti all 'operazione eli "pcace keepi ng " eli forn ire forze milita ri per d isarmar e le varie fa z ion i cont ra ppos te e ristab ilire l'o r di n e pubblico Gli Stati Uni ti , in pa r tico lar e, avevano già espresso la prop ria disponi bi lit à ne ll 'ass ume re un ruo lo g ui da nelle operazion i in t ese a ris t abilire, an ch e con l' impiego de ll a forza , le condiz ion i eli si curezza nece s sa ri e per lo svolgimen t o d el la m iss ione u ma n it a ria. In ta le contesto , il Governo italiano d ecise eli im p iega re u n co nti ngente mi li ta r e interforze, per conco rrere un itame nt e alle u n ità eli altri Pa es i, all'operaz ione "Restore Hope" pia n ificata dag li USA e diretta d a un comand o mu ltinaz io na le Si in ser iva in questa cor n ice l'op era zion e "Ib is" .
Pa rt ecipa ro n o a ll 'ope raz io n e le tre fF.AA. con :

Nel la p agi n a a fi a nco, in al to a sinis tra:
Operazione Ibis, Somalia, 1992
Visione parziale del Centro Radio con stazioni HF (RH-5).
A dest ra :
Op erazione Ibis, Somalia, 1992
Operato re delle Tr a s 1n.iss ioni al terminale satellitcn e.
In basso:
Op emzione Ibis, Somalia, 1992
Prove tecniche su materiali delle trasmissio ·n.i pri11w di recarsi in pattuglia.
Qui sotto :
Operazione Ihis, Somalia, l.992

Autocolonna dotata di mezzi delle trasmissioni (';ta HF) si a ccinge a lasciare il campo hase.
• u n Gruppo na va le (24° Gruppo) sotto il comando di .MARISTAT;
• forze aeree (G -222 e HH -3F) sotto il coma ndo dello SM de ll' A.M . ;
• forze terrestri (B. "Folgore") alle d irette d ipe n de n ze de ll o SME .
In u n'operaz io n e così comp lessa e acl alto rischio, f u fondamentale il ru o lo delle Trasmissioni , pe r po ter ese r citare il com a ndo, il contro ll o e g est ire le informaz ion i.
Ve n ne disp iegato in fatti 1.m vas to s istema di comunicazioni impiegando i p iù moderni mezzi de ll e tel ecomu n icaz ion i dis p o n ibi li L' impianto e l' eserc iz io venne affida t o a ll 'esperienza del personale dell'll o reggimento t. ch e realizzò, in te rra soma la , un a rete in po nte rad io con m ateriale num er ico SOTRlN Da e per la Maclrepatria i co ll egamenti fu ro n o realizza ti con s taz ion i s a te llita r i IMMARSAT, I NTELSAT e co n stazioni radio Ilf di grande potenza . La compag n ia trasmiss io ni della Brigata "Folgo re", in o ltre, realizzò t utt i i co ll egamenti ope ra t ivi necessari nelle zone eli intervenro e eli contro llo della Br igata stess a .
Ne ll a pr ima metà el i g e nnaio il sistema delle trasmissioni fu dispiegato nella s u a in terezza e lo ca lità come Mogad iscio - Joar - Ja la las ji - Balad ven n ero co ll ega te
fra di loro e con l'Italia. Il traffico telefonico, fax , dati e telegrafico con l'Italia fu continuo. Tutto il personale impiegato ebbe la possibilità di telefonare ai propri familiari in Italia, grazie a i sistem i messi in atto dal personale d e lle Tra smissioni. Nel maggio 1993 il Comando italiano veniva posto alle dipendenze di UNOSOMII ; ebbe inizio così l'operazione "Ibis 2" , che passava sotto la conseguente responsabilità d ella Brigata Folgore
Il sis tema d elle trasmissioni f u il vero cen tro pulsante del contingente. Il traffico sviluppatosi fu elevatissimo, i me ss aggi ricevuti e tr as messi centinaia di migliaia, a fronte di un lavoro improbo e costante, pienamente rispondente alle esigenze.
Missione Mozambico (ALBATROS)
Il 4 ottobre 1992, dopo anni di guerra fratricida tra le opposte fazioni in lotta, venne firmato a Roma !"'Accordo Generale di Pace" tra il Gov ern o del Mozambico ed il movim e nto di guerriglia Renamo. L'accordo entrava in vigore il 15 ottobre, dopo la ratifica da parte del Parlamento Mozambicano. Tale accordo prevedeva che il controllo dell 'esecuzione corretta dell e clausole fosse affidata alle Nazioni Un ite. In ta le contesto, la risoluzione 797/1 992 del Consiglio di Sic urezza dell 'O NU

autorizzava l' op e razione denom in a ta "ON UMOZ" la q ua le, a ttrave rso una comp lessa azione politico - militare e un s occorso umani tario, doveva tendere a rea lì:aare le co ndizioni ne cessari e a l lo svo lgime nto di lib c(e e lez io ni.
In ta le contesto il Gove rno Italiano d ec ideva di fornire all'O NU un contingente dell'Eserci t o p er concorrere, unicamente ad altri Paes i , alla r ea l iaazione deli'"ONUMOZ" L'arca assegnata al contingente ita li ano, denominato "Albatros", e ra compresa nelle province di Sofala e Manica (corridoio di Beira). Il contingente veniva incentratO sulla Brigata alpina "Taurinensc", rinfor zata dali' "AVES " . Il coma n do del contin gente "Aibatros" costitu iva il coma ndo 0 1·u della Regione "ce ntro".

Il Capo di SM d e ll 'Eserc ito, pur mantenendo il co mando pieno d el contingen te, delegava il comand o a l ca p o del Dipartim e nto Militare "ON UMOZ".
L'o p erazione "Alb atros" e bbe inizio 1'8 feb braio 1993 co n la p artenza del primo conti ngente. Un p lotone de ll e trasmission i dcll'll 0 reggimento trasmissioni e la comp agn ia trasmissioni della 13.alp. "Tauri nense" ricevettero il compito di realizzare un sistema di trasmissioni a supporto dell'opera:done.
I n sintesi bisognava realizzare i collegamenti tra la zona di operazioni e l' Italia e collegare i va ri comandi - posti mob ili - pattuglie tra loro e il comando superiore . Le prob lematiche relative alle distanze con l'Italia, al cli ma , alle difficoltà deriva nti dalla mo bilità dci co mandi e degli u tenti spars i in un territorio piuttosto esteso, venivano r iso lt e dall 'o rmai conso lidata r e ri zia cl.e l p e rsonale delle Trasmiss ioni acquisita in tant e esercitazion i in Patria e nelle precede nti missioni internaz iona li.
I trasmettitori, in pochissimo tempo , reali zzaro no un sistema di trasmissioni altamente affidabile, comprendente stazioni satellitari 1/V!J.v!ARSAT, INTELSAT e stazioni radio HF (RH-6/ 1000) sulle qua li viaggiava tutto il traffico telefonico, dati e telegrafico verso i comandi dislocati in Italia (Roma , Bolzano e Torino). Grande imponanza veniva posta anche nel soddisfare la primaria necess ità del personale, spec ie quello di leva, di comun icare con le famig li e in Italia Ciò venne fatto fin dai primi giorni.
La compagnia trasm iss ioni della B.alr. provvid e a realizza re i coll egame nti in zo na eli operazioni , perme tte ndo così a tutti i repar ti e nuclei di staccati eli essere cos tantemente in co ll ega mento con il comand o ''A lb atros"
Professionalità, perizia, senso pra tico, scrupolosa app licazione delle norme eli sicure zza, capacità di gestione , controllo e riparaz ione , amore per il proprio lavoro e per l'Arma di appartenenza , queste sono le basi sulle quali i trasmettitori hanno condotto la loro azione durante i numerosi inrervcmi fuori area delle Forze Armate Italia ne.



All ' inizio del XX secolo, con la cresce nte diffusione dei mezzi di trasmissione che sfruttavano le scoperte di Guglielmo Marconi sulla propagazione elettromagnetica, l'Esercito si avviò ad acquisire nuovi materiali per immetterli nelle un ità preposte alle attività di collegamento.
In tal modo, già al termine della 111 Guerra Mondiale, prese avvio una consistente revisione ordinativa di tali unità che interessò non solo la loro struttura interna ma anche i relativi compiti, che ovviamente dovevano essere adeguati alle mutate situazioni derivate dalla utilizzazione delle nuove tecnologie.
I vantaggi così ottenuti, per effetto del consistente miglioramento qualitativo dei sistemi eli comunicazione, innescarono il proliferare di richieste e di nuove esigenze. A ciò seguì la neces sità di impostare programmi finalizzati all'ampliamento della disponibilità di reparti idonei ad operare nel pa1ticolare settore.
Nacque pertanto anche il bisogno di una adeguata collocazione di tali unità .
La soluzione fu trovata facendo ev olvere la specialit<:ì "telegrafisti" della seconda metà del secolo pre cedente in "telegrafisti e racliotelegrafisti" e quindi in specialità "Collegamenti" che bene esplicitava le funzioni e le peculiarità d'impiego eli quelle unità pur se mpre nel contesto della preesistente Arma del Genio. .

La sensibile evo lu zione eli quegli anni postulò anche l'a deguamento di quei centri scolastici, tipo la Scuola di Telegrafia per le Truppe del Genio ,costituita nel 1864 in Alessandria e trasferita nel 1883 a Firenze, nei quali si era iniziata la formazione del personale da abilitare all'impiego dei mezzi di collegamento.
Obiettivo più concreto fu raggiunto nel corso della 2.a Guerra Mondiale. Infa tti nell ' ottobre 1944, dopo lo sbarco alleato a Salerno, fu costituita una Scuola Autonoma Collegamenti RT, dislocata a Nocera Inferiore (Salerno) . La scuola rimase in vita fino al ter mine del cont1itto.
Successivamente, con il progredire delle operazioni alleate verso nord e stante l'esigenza eli disporre eli nuove unità preposte alla formazione del personale tecnico, fu costituito anche un "Reggimento Addestramento Genio" che trovò collocazione a Bracciano (Roma), nella infrastruttura che già ospitava le due Scuole Artieri e Collegamenti.
Negli anni in cui si sviluppò il se co ndo cont1itto mondiale e in quelli immediatamente successivi, l'Esercito fu ulteriormente impegnato ad ampliare e ad adeguare la componente preposta alla realizzazione dei collegamenti militari. E ciò dipese non solo dal bisogno eli soddisfare le molteplici e crescenti esigenze dei comandi e dei reparti di combattimento, ma anche dalla necessità sempre più pressante di disporre di persona le idoneo a ricevere e a gestire la gran massa di materiali tecnici che in quel periodo gli Alleati stavano fornendo all'Italia
In tale contesto la Forza Armata pervenne alla decisione di costituire anche strutture da destinare alla formazione e all'addestramento del personale interessato all ' utilizzo delle nuove procedure e all'impiego dei materiali che venivano immessi nelle unità eli collegamento.
Quelle strutture iniziali assunsero nel tempo configurazione pm omogenea dando così vita alle Scuole d'Arma delle Trasmissioni che, con la formazione del personale, iniziarono a diffondere nel mondo militare la cultura tecnica necessaria per elevare l'efficienza e l'operatività dei reparti.

Quando si citano le Scuole d 'Arma si fa normalmente riferimento alla Scuola delle Trasmissioni (Roma) e alla Scuola Specializzati delle Trasmissioni (San Giorgio a Cremano). In talune occasioni ci si riferisce però anche alla Scuola Telecomunicazioni Forze Armate (Chiavari) ed al Centro Informazioni e Difesa Elettronica (Anzio) che fin dalla loro costituzione hanno svolto un'analoga e specifica attività addestrativa per una parte del personale della Forza Armata.
Un ruolo primario fra i predetti Istituti va però riconosciuto alla Scuola delle Trasmissioni. E ciò non solo perché - essendosi formata per prima - ha svolto la funzione di "culla" per i primi Trasmettitori e di "casa madre" per tutto il personale dell'Arma, ma anche perché da essa sono state enucleate le aliquote di personale intorno alle quali si coagularono le forze che consentirono di dare vita alla Scuola Specializzati Trasmissioni prima e alla Scuola Telecomunicazioni Forze Armate poi.
Vicende diverse ebbe invece il C.I.D.E. perché nacque dalla evoluzione di una unità delle Trasmissioni dello Stato Maggiore dell'Esercito e perché è stato l 'unico Istituto che, nel tempo, si è svincolato dalla diretta dipendenza (tecnica e d'impiego) dell'Ispettorato delle Trasmissioni.
Scuola delle Trasmissioni
Nell'ampio processo evolutivo delle unità dell'Esercito avvenuto in quegli anni, il l o gennaio 1946 fu costituita la Scuola Genio Collegamenti che nacque dalla evoluzione e dall'ampliamento della prima aliquota di personale e di materiali del Reggimento Addestramento Genio di Bra.cciano, a Roma per la specifica esigenza.
Posto alle dipendenze del Comando Scuole Centrali Militari, l'Istituto trovò sede nell'ambito della Città Militare della Cecchignola (Roma) e più precisamente
nelle due caserme denomina te "Genova cavalleria" e "Truppe di passaggio", adiacenti e collegate fra loro.
Nel corso del 1946 la Scuola Gen io Collegamenti cominciò a funzionare a pieno regime (mese di maggio), contribuì al servizio d'ordine pubblico in occasione delle consultazioni referendarie per la scelta fra ordinamento m ona rchico o repubblicano (2 giugno), festeggiò la prima fe sta dell'Arma alla presenza del Ministro Cingolani (24 giugno) e vide anche cambiare la denominazione delle due caserme "ex Genova cavalleria" e "ex Tmppe di passaggio" in quella unica d i caserma "Generale Perotti", a ricordo del martire della Resistenza fucilato a Torino il 5 aprile 1944.
L'Il novembre 1946 la Scuola Genio Collegamenti cessò di dipendere dal Comando Scuole Centrali Militari e passò alle dipendenze dell'Ispettorato del Genio (per gli aspetti disciplinari e di benessere) e del Comando Militare Territoriale (per i servizi e le gestioni territoriali) .
Dal l o settembre 1948 nella Scuola furono avviati corsi per la formazione e l'addestramento·del P corso Allievi Ufficiali di Complemento della specialità "collegamenti".

Successivamente, nel corso dei festeggiamenti del 1952 in onore della Patrona del Genio (S. Barbara), i Trasmettitori si distinsero dai Genieri perché indossarono per la prima volta le nuove mostrine azzune bordate a-emisi ancora oggi in vigore. Di consegtJenza, a decorrere dal 1° giugno 1953, la Scuola assunse la nuova denominazione di Scuola delle Trasmissioni che di fatto sanciva la scissione fra le Trasmissioni ed il Genio.
Il 24 marzo 1956 venne festeggiato per la prima volta S. Gabrie le Arcangelo come Patrono delle Trasmissioni. In quella occasione la Scuola ricevette la Bandiera d 'Istituto dal Capo dello Stato, nel corso di una cerimonia solenne alla quale presenziò anche il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Due anni dopo, sempre durante la celebrazione della festa di San Gabriele, la Scuola ricevette le nuove drappelle, ancora dalle mani d el Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Nel frattempo l'Istituto assunse compiti sempre più impegnativi e venne dotato di nuove strutture interne.
In tale contesto nel 1963 fu costituita la Direzione dei corsi AFUS - preposta alla formazione dei Capitani prossimi all'avanzamento- che nel 1964 fu trasformata in Reparto Corsi per gestire l' intera attività addestrativa della Scuola.
Anche l'apparato addestrativo venne adeguato alle nuove esigenze con l'incremento degli istruttori, dei mezzi didattici e delle aule. Queste ultime n e l 1970 assommavano a ben 104 unità e venivano utilizzate per lezioni teoriche, per attività pratiche e come laboratori.
Nel 1975 fu realizzato 'il Centro Didattico Televisivo per la produzione di filmati addestrativi ad uso interno e per altri enti della Forza Armata.
Il sal to di qualità avvenne però con l'introduzione delle nuove tecniche di comunicazione d igitali e con l'entrata in funzione di strutture addestrative in prevision e dell'introduzione in servizio del sottosistema SOTRIN (al termine della fase di sperimentazione del PRE-SOTRIN).
Da quel momento, infatti, la Scuola, per uniformarsi alle nuove esigenze dei reparti delle Trasmissioni, ha adeguato la preesistente organizzazione acldestrativa qualificando i suoi istruttori ai nuovi insegnamenti e dotandosi di attrezzature didattiche per la preparazione tecnica dei Quadri destinati a gestire le nuove reti TLC.
Una di quelle attrezzature è l'aula SOTRIN che fu concepita e realizzata proprio per fare fronte alle esigenze di quel periodo.
A decorrere dal 25 settembre 1990 il comando della Scuola è stato affidato acl un Generale di Brigata. Da questi sono venuti a dipendere lo Stato Maggioreretto da l Capo di Stato Maggiore della Scuola - e i tre battaglioni (AUC ,
Specializzati e Supporto Tattico-Logistico).
Dal 3 maggio 1991 la Scuola Trasmissioni ha assorbito - alle dirette dipendenze - il 2° battaglione specializzati (S. Giorgio a Cremano), n ato dallo scioglimento della Scuola Specializzati Trasmissioni e preposto all'addestramento dei tel escri ve ntist i di leva.
11 provvedimento è risultato però transitorio perché il 2° battaglione specializzati è stato sciolto il 9 luglio 1993. Contestualmente l' addestramento dei telescriventisti è stato accentrato n e lla s e de di Roma.
Nel 1993, per meriti complessivi dell'Arma delle Trasmiss ioni, acquisiti soprattutto durant e le numerose operazioni "fuori area" , la Bandiera d e lla Scuola veniva decorata con "Medaglia d'Argento al merito dell'Esercito". La medaglia veniva appuntata sulla bandiera dell'Istituto durante la celebrazione della Festa dell 'Arma , il 19 giugno 1993, dal Capo di S.M. dell 'Esercito.

Il 27 gennaio 1994 nell'ambito della Scuola è stata inaugurata una m1ovissima palazzina dedicata a Guglielmo Marconi e destinata ad ospitare il battaglione AUC. L'inaugurazione è avvenuta nel corso deHa visita d e l Capo eli Stato Maggiore dell'Esercito, che, nell 'occasione, ha scoperto un busto dell'illustre scienziato ed ha presenziato ad una dimostrazione tecnico-operativa di materiali costituenti il sistema CATRIN. Tali materiali (alcuni ancora allo stato eli JXe -prototipo) sono stati riuniti nell'Istituto per condurre prove di funzionamento in condizioni il più possibile simili" a quell e del normale impiego.
In campo addestrativo, l'atti vità della Scuola ha interessato nel tempo tutte le categorie del personale delle Trasmissioni. In linea con questo orientamento anche oggi presso l' Istituto vengono svolti corsi per Ufficiali, per Sottufficiali, per Allievi Ufficiali di complemento delle Trasmiss ioni e del Corpo Tecnico dell'Esercito, per volontari in ferma di leva prolungata e per militari di leva, per un totale di circa 4200 allievi/anno ai quali si impartiscono nozioni tecniche eli live llo anche elevato.
Oltre alla didattica, nella Scuola delle Trasmissioni vengono condotte molteplici attività di studio e fasi di sperimentazione sui materiali d a introdurre in servizio. Inoltre viene assicurata la produzione di audiovisi vi e di vicleofilmati addestrativi per tutte le unità dell'Esercito . .
Il motto della Scuola delle Trasmissioni è "SPATIA DEVINCO DISIUNCTA CO NIUNG O" e fu conc esso (unitamente allo stemma araldico) dal Pre sidente della Repubblica con proprio decreto del 12 marzo 1973.
Scuola Specializzati delle Trasmissioni
Nel territorio eli S. Giorgio a Cremano, al limite delle città di Napoli e di Portici, nel novembre 1941 iniziò la costruzione di un immobile per soddisfare le esigenze eli accasermamento eli due reggimenti eli artiglieria ippotrainata.
All'armistizio clell'8 settembre 1943 , la caserma fu occupata dalle Forze Alleate ed adibita a deposito di materiali bellici anche per la sua breve distanza dalla zona portuale eli Napoli.
Dal 1946 nell'immobil e subentrò l'ARAR (Azienda Rilievi e Ali e nazion e Residuati) che ne mantenne il possesso fino al 1948 , anno in cui fu restituita all'Amministra zione Militare e destinata a sede della 10/\ compagnia collegamenti (l'attuale 45° reggimento trasmissioni).
L'atto della costituzione della Scuola Specializzati Trasmissioni risale al 10 luglio 1948 allorché - su ordine dello Sta to Maggiore Esercito - nella caserma si costituì il Centro Addestramento Avanzato Reclute (C. A. A. R.) del Genio collegamenti incaricato di organizzare e condurre l'addestramento avanzato di specializ-
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZ IONE GENERALE PER GLI UFFICIALI DE LL' ESERCITO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTA la legge 26/uglio /974, 11. 330; SU PROPOSTA del Ministro Segretario di Stato della Difesa, co11 Suo decreto n in data
AL VALORE DELL'ESERCITO
CON LA S EGUENTE MOTIVAZIONE:
'Fin dal momento della sua costituzione, 1953, innestandosl su una lunga e gloriosa lradlzlone nel seuore dei collegamenti militari, l'Arma delle Trasmissioni si è costantemenle prodigata, con generosità ed ammirevole spirito di servizio, In difficili e complessi interventi, volti alla realizzazione o al ripristino di sistemi di comunicazioni, a supporto di siluazionl operative importanti e diversillcate, sia in territorio nazionale sia lontano dalla madrepalria.
Il suo contributo è sempre stato prezioso e fondamentale per consentire l'altività di comando e controllo, con particolare riferimento alle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità ( Vajont, Sicilia, Friuli, Toscana, Campania - Basilicata), alle operazioni per missioni di pace ( Libano, Namìbia, Kurdistan, Albania, Somalia e Monzambico) ed alle operazioni di controllo dellerritorio ("Forza Paris' - ·vespri Siciliani").
Le elevate qualità professionali e lo spirito di sacrificio del personale dell'Arma, le caratterlsiiche di modernità tecnologica del mezzi In dotazione e la prontezza operativa delle sue unità, hanno contribuito sostanzialmente all'efficacia degli interventi operativi ed al prestigio dell'Esercito Italiano".
Roma, 1 giugno 1953 -8 marzo 1993.
Il Direttore Generale, visto il decreto legislativo 11. 2911993, rilascia il presente documento per attestare/' avvenuto conferimento

Roma,.. 01 giugno 1993
zazione dei militari di leva e dei volontari sp e ci a lizzati a lunga ferma.
In tal modo la nuova struttura assorbì parte d e i compiti adcl esrra tivi già s volt i dalla Scuola Trasmissioni della Cecchignola (Roma).
Il C.A.A.R. Genio collegamenti, retto da un Colonnello e <Hticolato su tre batta-
glioni allievi, il 21 maggio 1950 ricevette la Bandiera di Guerra nel corso di una cerimonia solenne alla quale partecipò anche il Sottosegretario di Stato per la Difesa.
In quella occasione l 'Ispettore del Genio consegnò ai trombettieri le nuove d rappelle.
Il l o gennaio 1952 il C.A.A.R. assunse la denominazione di "l o reggimento Collegamenti"
Il l o giugno 1953 il l o reggimento Genio Collegamenti cambiò denominazione divenendo l o reggimento Trasmissioni. Successivamente, dal l o luglio 1953, si trasformò nella Scuola Spe ciali zz ati ' Trasm issioni (alle dipendenze dell 'Isp ettorato delle Trasmissioni) con il compito principale di:
- arruol are e condurre l'addestramento preliminare ed avanzato dei Volontari Allievi Sottufficiali d elle Trasmissioni;
- svolgere l'addes tramento di speciali zzazione dei Volontari Allievi Sottufficiali aventi l'incar ico di apparecchiatore telegrafonico , centralinista, marconista e te lescriventista;
- sviluppare l'addestramento del personale di leva delle Trasmissioni (marconisti, telesc riventisti , apparecchiatori telegrafonici e centralinisti), delle varie Armi (apparecchiatori telegrafonici , c e ntralinisti e specializzati per le trasmission i radi o) e di alcuni operatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.
Negli anni '80 e fino al 1991, la Scuola Specializzati de lle Trasmissioni ha assolto ulteriori ed imp ortanti compiti esplicitati in alcuni corsi di particolare valenza. Fra questi i corsi d i :

- Istruzione .Gene rale Professionale (!.G.P.) per Marescialli Ordinari marconisti, telescr iventisti e comandanti di minori unità delle Trasmissioni;
- sp e cializzazione e perfezionamento per Volontari in Ferma di leva Prolungata (V.F.P.) telescriventisti e centralinisti ;
- formazione iniziale per telescriventisti della Guardia di Finanza.
Inoltre, nel tempo , l'addestramento era passato dalla classica lavagna con g essetti alla la vagna luminosa, alla T V a circu ito chiuso e ai moderni complessi per la te ledattilografia controllati da micro -computers.
Stema araldico della Scuola Telecomu nicazioni delle Forze Armate.
Il motto della Scuola Specializzati Trasmissioni era "ARDUA VIRTUTEM NOSTRAM EXCITANT" e fu concesso (unitamente allo s temma araldico) dal Presidente della Repubblica con proprio d ecreto del 4 aprile 1973
La Scuola ha cessato la s ua intensa attività il 3 maggio 1991, in attuazione degli ordini che lo Stato Maggiore dell'Esercito ha imparriro per razionalizzare tutta l'organizzazione scolastica della Forza Armata.
Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate
L'esigenza di costituire una Scuola interforze per i Sottufficiali addetti alle telecomunicazioni emerse già nel corso della 2° Guerra Mondiale perché si sentì il bisogno di superare gli inconvenienti che si erano riscontrati in sede di cooperazione fra unità delle tre Forze Armate. Tali inconvenienti conseguivano principalmente dalle diverse mentalità e preparazioni possedute dal personale che operava nei settori anche similari (e fra questi anche quello dell e telecomunicazioni).

L'obiettivo di creare un Istituto formativo unico appariva però di difficile reali zzazione p erché mancava un corpo legislativo che consentisse di unificare le differenti e non omogenee norme di reclutamento, di s tato e di avanzam ento che allora vigevano in ciascuna Forza Armata.
La necessità di disporre di operatori TIC in possesso di una comune formazione nel settore delle conoscenze tecniche e de lle procedure te legrafich e comportò l'emanazione di ordini con i quali fu sancito che, a decorrere dal 17 agosto 1950 , si procedesse alla graduale costituzione di una "Scuola Unica Operatori Radiotelegrafisti delle Forze Armate".
Allo scopo si scelse la caserma "Leo ne" di Chiavari ove dal 1940 al 1943 era stato ospitato il 15° reggimento Genio.
Il provvedimento ebbe rapida attuazione anche perché, con l'adesione
Visione aerea della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari.dell'lralia alla :\ATO , bisog n ava dis p orre in breve tempo d i operato ri capac i di impiegare le nu ove procedure ed i moderni materiali tecn ici in v ia di acq ui sizione.
Fu così che la nuova Scu ola si fonnò in ves te embrionale n el maggio 1951 ed assunse una fis ionomia più co n creta nei primi mesi de l 1952, quando iniziarono i co rsi eli fo r mazione s ia per gli inse gnanti e gli istrutt or i sia per il personale da addest rare a ll e nu ove procedure NATO.
L ' arto u ffi c ia le di cos tituzione dell a Sc uola risale però a l 16 maggio "1952 allorché l' Istituto assunse l'a ttua le d e n o minazione eli Scuola Tel ecomun icazio ni F. A co n il compilo eli impartire a l p e rso nale delle telecomunicazioni d e ll e tre Fo rze Armat e un a fo rm az io n e professionale comune, esse n z ialm e nt e n e l campo d e ll e pro ce dure eli com un icazione NATO .
La Scuo la , posta a ll o ra a lle dip e ndenze d e l Comitato Comunicazioni, ebbe iniz ialm e nte il co mpi to d i:
- aggiornare e perfez ionare la prep a razione profession a le d e i Sott uffi c ia li add ett i a ll e teleco mu nicaz ioni;
- aggiornare gli Ufficia li inferiori speciali zzati nelle tel ecomuni caz ion i sulle nu ove p roced ure RT e filo;
- completare, con i co rs i di lunga durata , la preparazione dei Sottufficia li d es tinati al passaggio di carriera.
Essa ricevene la Bandiera d 'Istituto il 10 maggio 1961 nel corso di una cerim onia alla quale e rano presenti anche il Sottoseg rerario eli Stato On. Bovetti e il Presid ente del Comitato per le Te lecomunica zio ni militari ( Gen . S.A. Erco le Savi).
Successivamente, con il p assare degli anni, la Scuola Telecomunicazioni F.A. ricevette il com pito d i formare no n so lo gli ope rato r i, ma anch e i ri parator i dei mezzi de ll e te lecom uni cazioni.
L' Ist ituto d ipende da l Capo eli Stato Maggiore della Difesa. Questi però, da l 1o maggio 1963, h a d e legato l' Ispe ttorato delle Trasmissioni dell ' Esercito a svo lgere il controllo disc iplinare e tecnico-funzio nale sull' Istituto In tal modo il Coma nd a nte della Scuo la ( inizi a lmente a liv e ll o Colonne llo, a tu rno t ra le tre F.A. e ogg i Capitano di Va sce ll o de ll a Marina) è s tato posto alle dirette dip e n denze del Vice Ispetto re d e lle Tras missio ni .
Attualm e nte presso la Scuola Telecomunicazioni F.A. vengo no svo lt i mo ltep lici corsi per il pers o n a le milita re d e ll e tre Fo rze Armate, della Gua rdia di Fina n za e d e i c iv ili d ell a Difesa, lutt i indirizzati alla formazione deglì operatori d e i m ezz i di comunicaz ione e d e i tec n ici addett i alla man uten zione e d alla r iparaz ione degli apparati.
La preparazione tec ni ca fornita ag li a llievi è ge ne ralmente mo lto e levata ed anche ambita a i fini di un loro eve ntuale inserimento nel mondo d el lavoro.
No n tutti i corsi svo lti hanno però carattere int er forz e p erché le t re Forze Armate destinano a ll 'Istitu to a n che cors i di proprio escl u sivo interesse.
Tn partico lare:
- l'Eserc ito vi fa svo lg ere corsi informativi su procedure, tecno log ie e materiali TLC per Sottotenenti della Sc u o la di Applic a zi one, co rsi el i Is t ruzione

Gene rale Professiona le (IGP) per Marescialli Ordinari delle Trasmiss ioni e co rsi eli specializzaz ione o di qualificaz ion e per i Serge nti p rove ni e nt i dalla Sc uo la AS o dai VFP;
- la Mar ina vi fa effettu are corsi eU formazione per telecomuni cato ri (ex radiotele grafi st i e seg n a la tori) di leva e VFP ;
- l'Aeronautica è inte ressata a i cors i di specializzazione per Sergenti marc o nis ti TLC.
Il m o tto d e lla Sc u o la Te lec om un icazioni F.A. è "TRINAE MILITIAE UNA VOX" e fu concess o (u nica me nt e a ll o stem ma araldico) dal Presidente d e ll a Re pubb lica con proprio de creto d e l 10 magg io 1961.
Ce n tro Informaz i o ni e Difesa El e ttronica (C IDE)
Le o r ig ini de l CIDE si possono fare risalire al l o dicembre 1963, data n e ll a quale fu costituito in Anzio il Cen t ro D ifesa E lettro ni ca (CDE).
La costi t uz ione de l CDE cons eg uì dalla es igenza, avvertita dallo Sraro J\ilaggiore de ll 'Esercito fino dagli anni ' 50, eU conferire un asse tt o un ita rio e coord ina t o a varie attiv ità ( di rice rca, di stud io, d i sper imentaz io n e, ad d est ra t iva e d i r iparazion i d i te rzo g ra d o d i ta lun i m at e riali) che fino ad allora e rano state sparse t ra va ri organismi appartenenti principalme n te a lle Trasn1 iss io ni.
Il CDE ve nn e in izia lmente a dipe n de re d al III Re p arto de ll o SME Poi, e decorrere da l l o febbraio 1965, fu posto alle clirene dipendenze dell'Ispettorato Trasm ission i.

Il più remot o precursore del CDE, do p o g li an n i de l secondo conflitto mon d iale, fu la com p ag ni a I-RG d el battaglione co ll egamenti speciale ma rcon ist i de llo SME, diven u to X barraglione trasm iss io ni a decorrere da l P d icemb re 1957
Il 1o a pril e 1959 quell a co m pagn ia I-RG con fluì poi nell 'XI battaglione trasm iss ion i, cost ituito n el ge n naio 1957 nella caserma Perott i (Roma -Cecch ig no la) c he era sede della Scuo la T rasm iss ion i.
L'XI battaglio n e trasm ission i d ette poi vita al IX battaglione trasmission i, che il 1° ottobre 1961 f u Lrasferito nella sede el i An zio d ove costit uì b ase per la fo n daz ione del CDE, el i cui d ive ntò il "braccio ope r a ti vo" .
Il IX ba tt ag lio n e tr asmiss ioni ass u nse successivamente - il 1° se ttembre 1970la denominazione di battaglione d i guerra e le tt ron ica E c iò avve nne con l'enucleaz ione de ll a sua com p o nente a s piccata vocazio n e SI GINT (Signa! Intelligencc), che p o rtò alla d istin zione fu n zionale ed ordinativa dei du e setto r i "guerra e lettro ni ca " e "ricerca elettronica".
La p redett a compone nt e SIG INT (r icerca e lettronica) - dopo Ja s e paraz io n e da l IX battag li o n e - consentì di costituire un Nu cl eo STGTNT autonomo che, pur conti-
Stemma araldico del C'entro lr!formazioni e D[jèsa r.'lettmnica. Visione aerea del Centro Informaz ioni e l Jijèsa Clettronica.nuando a dipendere dal CDE sotto l'aspetto disciplinare e logistico , operava sotto il co ntrollo operativo dello SME - II Repart o.
Il l c se ttembre 1972, il nucleo SIGI NT si trasformò in reparto SIGI NT che, il 1o se tte mbre 1976 , dette vita all '8° battaglione trasmis sion i ricerca elettronica.
Dopo poco , il 20 s ettembre 1976, il IX batt ag lione e 1'8° battaglione cambiarono denominazione di venendo risp ettivam e nte il 9° battaglione guerra e lettronica "Rombo" e 1'8° battaglione ricerca elettro n ica 'Tonate"
L'anno seguent e il 20 marzo 1977, in una solenne cerimonia , furono consegnate la Bandiera d i Istituto al CDE e le Bandiere di Guerra ai battaglioni "Rombo" e "Tonal e"
Il l o marzo 1980 il CDE ass unse l ' a ttua l e denominazione di Centro Informazioni e Difesa Ele ttronica (CJDE) che risultava più adeguata ai suoi due diversi campi d i impiego op e rativo: quello della guerra elettronica e quello della ricerca elettron ica.
Co ntes tualmente il CIDE passò alle dirette dipendenze del II Reparto dello SME. Negli oltre se i lustri di attività - come CD E prima e CID E poi - l'Istituto è divenuto , nel s ettore:
- coagulo delle attività di ricerca tecnica e scientifica nel campo della guerra elettronica;
- luogo d i formazione del personale de ll 'Esercito (d'Arma e di Stato Maggiore) poi impi egato nella specifica attività , n ell 'a mbito de i comandi e dei reparti d ella Forza Armata;
- centro di sperimentazione della dottrina e delle tecniche di guerra e le ttronica. La notori età del CID E s i è estesa poi anche in ambito intern az ionale, in quanto il centro è stato int eressa to:
- all'organizzazio ne e svolgimento annuale di corsi avanzati di gu.elt., frequentati da Ufficia li degli Ese rciti NATO ;
- a llo svolgimento de l terzo e sesto "Lanci Symposium" (aprile 1977 e settembre 1984) che permis ero inco ntr i qualificati fra spec ialisti , per l'aggiornamento e per lo scambio d.i vedute sulle problematiche di impiego e di uso d ei materiali dello specifico settore ;

- alla partecipazione, con propri e s perti , a varie riunioni (_ •ATO e FINAB EL) in materia eli mezzi di guerra elettronica terrestri; ·
- alla assistenza fornita per la costituzione, nella propria a rea di insediamento , d e l Gruppo Inter forze Mobile eli Supporto di Guerra Elettronica (ME\X!SG) della NATO. Tale costituzione, avvenuta nell 'ottobre 1993, ha consentito di inser ire l'attività di guerra ele ttron ica, a fini add e strativi, n el contesto delle esercitazioni NATO svolte in amb ienti opera tivi altamente differenziati.
Il motto d e l CIDE è "HOST ES PER A.ETHERA. ERUO " e fu concesso, unitamente allo sre mma araldico, dal Presid e nte della Repubbli ca con proprio D ecreto del 21 dicembre 1987.


Veduta dello Swbilimento d i Pavia come risulta da una ca rtolina databile 1890 - 1900
Le origini
A partire dall a secon d a m e tà ciel XIX seco lo , lo s viluppo te cnico-scientifico d e i sistem i di comuni c azi o n e richiese all'organ izzazione militare di adegua re le sue s trutture alle nu ove esigenz e, impos te da un imp iego sempre più diffuso d e i mezz i d i tras missione
Al l'A rma d el Gen io, da sempre caratterizzat a da spicca t o tecnicismo e nei cui qua dri o p eravano Ufficiali di insigne valore, tra i qua li molti erano anc h e esponenti di primo piano nel mondo sc ientifico, toccò il compito d i adegua re le specializzazioni di coloro che o p eravano nel settore delle comunicazioni e di gestire le strutture ido n ee a fa r fronce alle nu ove es igenze di lav orazione e riparazione che l'impiego de i nuov i mezzi richi edeva.
La prima figura di militare italiano che s i presenta alla ribalta delle comunicazioni è il Maggiore de l Genio Alessandro Rocci, ideatore del te legrafo a segnali, impiegato ne ll a campagna del 1859.
Al 1874 risale la prima attività di lavorazione di apparati telegrafici di va ri e specie e tip ologie in d otaz ione a ll e specialità telegratìsti-telefonis ti dell'Arma d el Ge nio presso l' Officina re gg ime n ta le de l l 0 reggime n to Ge ni o di Pavia. Il l 0 ap ril e 1879 l'Officina si trasformò in vero e p roprio stabil imen to d ell'Arm a del Genio, assumendo la denomina zione eli "O ffic in a eli Costruzioni del Genio " e diventando au ton oma con dipendenza dal Minis te ro d e ll a Gu e rra (D irez io ne Generale del Genio)
In stret ta con ness ion e con il progresso scie ntifi co, se gnato in partico lare d a ll o svilu ppo della "radi o tel eg rafia", emergono sempre più le esigenze di s tudio, spe ri -

;
N. 723
13 1911, che iBiituiJoe ;,. &ma "" l•ttt..to militare suptr·ior• di rodio-klegra{fa.
relati •o alla loro inYOJtziope, sempre cbo quostu da.lla Comm jgsiono pormunonto p o1· In iografìa 11ol lloguo - tlolln qua lo fa1 à parto di dìrillo
:;" iJ comandaot(• doJ batta g lionu apocialis ti dol c:onio;
;t,0 H dirottora del gabinetto :
5° un p r o{er;sorc ordiua rjo dt fisica presso vcnli!A o Istituto supo riOI' O del !!ogno :
6° il ca po ::;.o;dono dai ser v izi l'ad io tolografici della (P•tbbtlcaltt ncll•t- G<t%;dlti Udtciuk• tlcl 20 lugliO /Oll, 11 /tJ9) n. marina
H diruuore doJ gabinetto - aia r ieono sciut.n dogna di osaore J)l'6Su in oonaidoraziono per un ovontua le miglior-amento ai serviti J'tt:diotvJegtufh:i doJIR difoan nàziooalo
7° il d i rottoro de l t·aparto l'adiotcJogratko doJ Ari. :1. H. esorcito :
8(,) un _ unlcinlo dcJ1o s tOl:il:iO rotHu'to.
VITTORIO EMANO)l:LE lll per erula 41 Dio- per' YOioalll della lladoao
R& D'ITAUA
Le iuuronti a tale istituziono (stipendi od indcqn.i tll dol porl)onalo flsso od avveu ti1. io, ac11Ui sto di apparecchi o di libri. o simiU) vcrl'anno divi tlo i n parti oguali tra i bi lanci doHa guorro. o d oUa. marina. Noi bilaucto dot .Ministero de ll a marina -verrà UHciU-gnata a taio scopo annuaJmontG la ;.onunn eli L. 25,000 a oomineiar<t daJJ'esercir.io finanzinrjo t910 - 9 11, pre lovan dola dallo ,;tanz. inmonto dol capito lo t.i :i dolio stato di pr&visio.no dolla spesa.
Soltanto ai mombr i osu anci aJJ o doHa marina o doUn guornl cotnpote un 'i ndonnità rli J>roa.onzu J)&r ogni :ieduta, da stahlJirs i dal regolamonto. \rt. (J. Il S.mato a la Cu1nora dei doputaU hanl)O appro•·•to; Noi abbiamo st.Juiona!O o pt-omuighì:tmo quonto •eguet
U rog:o luu.H)Hto intol uo s up..;,riord r a diot vJograJìco sarà a;>pro •ato con dcl!roto ltoalo su JWop ostn d oi mìniatri d oHa gu erra o della JUarinu f: iu Roma l'Ist-ituto militare di r<tdiolelegre03.
Art l. Eguale l:lOtnUln dJ t. 25,000 aa1 à auuua.hnento prelevata - cominniando Oall'osorciz io tinomz.iado 19l0-9U - dallo 11tanziaruouto del capitolo i> l - do l io SWIO di tn'eYision& d olJa sposa por il Ministor o doU::t guorra.
Art. 2.
3"' dar modo di eompioro lo ricerche teoriche o spo· rirnoutall inorouti a i di\'OJ'SÌ sistoml, J>er la trasmissione deUu onergia oloUrica sonza fìJo, per la applica-zioni di quMU uoll'intoroase dìfesu nazionale;
4" forniro infine agfi inventori. anche esb·aJUti allo \mm i u iatra.Zioni militari, Jn possibilità di compie r e le
Con decreto dol ministro dot tesoro sarà ))I'OVVBduto allo conseguenti modificazioni noi s uindieati stati di t>rovi•ioue della •J)(lsa.
·l.
f/organico doll'l$tihllO t'imano fllobilito a Cconcio l::t. annessa tnbolla.
5.
A.rt..
Ordiniamo cho .In J>I' OHt.! ntu , rnun i ht (tello Sta to, ei a inaorto n e lla rn ct.:ol tn ufficialo do lio logr;i o dci dl3croti d(I LRogno d'l t ulin, OHì.nc.Jando n chiunquo spetti ùi ossorvarla o di Corio osscrvoro confo dello Stato , Sool>i [ll'incipali dello stesso Istituto sono: t coordinare i i»Or\"jti raùiotofegrafici o rnd fonici della marina o della guerra oell'intez·esSe suv •·omo dolio difesa nazionale; formoro Ja necessaria cultura generale o speciaJo ngli ufiiciali di Q di mare· por abHilarli agli impianti e alla dirotione <li sta1.ioni rndiotclegraficho ;
IJa geationo am •uin is t rati \'n o wc uica ù oll 'Jstituto so. r h affidata ad unil comm issione suporioro COl:ii co mposta :
1° il tliro t toro gene r alo d'artiglieria e armamenti dol Ministero della marina. preaideuto ; zu il dirouore supedoro doU'Jstituto;
mentazione ed acqu isizione dei nuovi materiali di trasm ission i des ti n ati a pot e n ziare le capac it à operati ve de ll' Esercito , La sto ria della radioteleg ra fia m ilit ar e itali ana era infatti iniziata nel 190 5, con la partecipazione alle grandi manov re di una s tazione radio te legra fic a , e ne l 190ì con la cos tituzione, con R Decre to dell'l l o tto b re, d i u na sezione radiotel egra fica inqu adrata nella Brigata spe ci a li s ti del 3° reggimento Genio telegrafisti che, costituito con R. Decreto del 15 ottobre 1895 , è storicamente cons idera to la p r ima u n ità organica d e ll e T rasm ission i.
Sempr e n el 1907 avv en ne t m ve ro e proprio sal to di qualità n elle applicazioni radiotelegrafiche militari, con la partecipazione al le grand i manovre di be n 6 staz io n i rad io t e legrafiche, di cui 5 a traino anima le e una a u tomobile.

Tutte le sta zio n i erano a corrente alternata, a circuito sintonico con aerei orizzontali e dirigibili, alti 15 1n. da terra, sistema Marconi, aventi la portata di 100 Km in terreno pianeggiante. Ogni s taz ione a tra ino ani ma le er a trasportata su 4 ca rri. La s tazione "a ut omobile" (cioè, in ter m ini moderni, motorizzata e semovente) riuniva in un so lo autoveico lo tu tt i i mat eriali , compresa una "scala a ntenna a s til o" p e r sopraelevare l'aereo, per esige n ze di magg io ri portate.
La re lazion e su ll e g ra n d i manovre s i co n cluse con questo giudizio:
La radioteleg?·a:.fia ha dato risultati Restano però ancora insolute le due questioni del "sintonismo" e del "segreto della che sono di capitale importanza per un largo impiego della radioteleg1·ajt:a nelle operazioni di guerra. E' quindi di somma importanza che gli studi e le esperienze siano pmseguiti.
Già n el 1911 , con lu n gimiran t e in tu izi one d e l fu tur o de lle comunicazioni radio, ve n ne cost it u it o, co n legge n .723 de l 13 l uglio in Roma, l'Is tit uto Militare Superiore di Radio -telegrafia, Ente dipendente da i Min is teri della Gue rra e de ll a Mari n a , per coordinare gli s tud i e le sper imenta zion i, i servizi e l'addestramento n el campo de ll a radio telegra fia e ra dio tele fonia.
In alto a sinistra:
Decreto d'istituzione dell'Officina Militare R. T..
A d est ra:
Pi anta dell 'epoca del q uartie re Piazza d'Armi.
Qui sopra:
Fo to d'epo ca. Istit uto Mili ta re Superiore delle Trasmissio ni.
Co n il R. Dec re to d e l 2 settembre 1912 ve nne approva to il regolam ento inte rno dell'Istitut o. Nel 1916 , con decreto luogotenenziale n .776 dell ' ll giug no , passando alle dipendenze esclusive del Ministero della Guerra , assunse la denominazione di Istituto Centrale Mili t are di Radioteleg rafia e Ele ttrotecnica . L' En te s i trasferì dalla preca ria sede press o la case rma Cavo ur in Roma a quell a di vial e Ma zzini.
Nel 1917 poi, verso la fine della I Gu erra Mo n dial e , il Regi o Stato Maggiore sentì la necessità di un ' officina per la cosuuzione e la riparazione dei materiali m il itari per le trasmissi oni radio ed a filo .
L'officina , d isloca ta in Rom a nel co mp renso rio di viale Angeli co, fu istituita il

15 novem br e 1917 con l a d e nominazione di "Officina eli Costruzioni Radi otelegrafiche ed Elettrotecniche cie l Ge nio militare".
Fu posta alle dipendenze del 3° reggime nto Genio telegrafisti c , a nte s ignana d ell ' attua le Stabilimento Militare Materiali delle Trasmissioni, fu eme di prima ria importanza nel campo degli studi e realizzazioni di materiali di Lrasmissione.
In dat a 1o giugno 1918, in consideraz ione della complessità c importa nza dei compiti svo lti, l'Officina assunse la fisio nom ia di ente autonomo amministrativo.
Ne l primo dopoguerra l'Officina militare fu incari cata d i riordinare, riparare cd ammode rn a re il materiale e s istente, a d onde smorzate (a sc intilla), proveniente dalla wna di guerra e succ ess iv a me nt e, tra il 1922 ed ii 1926, eb be il compito di

studia re nuovi tipi di stazioni milita ri campali ad onde persistenti.
Con R. Decreto n .45 1 del 20 a prile 1920, nel quadro del riordinament o dell ' Arma del Genio , l ' Off i cina assunse l a de n om inaz ione d i "O ff icin a Radiotelegrafica ed Elettro tec n ica".
Nel 1927, l' Officina venne posta , con l 'Istituto, alle dipendenze del "Serv izi o degli Specialisti d el Genio", costituito il 16 dicembre 1926 (Regio Decreto legge n.2122 , convertito in legge 22 n ovembre 1928, n .2781) , al quale era stata attribuita l'a ttività tecnica dell 'Arma d e l Genio e la d ire zione unitaria degli organi di stu dio , di ricerca e di lavora zione neg li specifici setto ri di specializzazione. Le attribuzioni dell'Officina furono così d e finite:

- allestire, con mezzi pro pri c co n qu e lli dell'industria privata, apparati e complessi radio-elettrici o cco rre nti a ll 'Ese r cito;
- eseguire studi, ricerc h e e d es p e ri e n ze inerenti al programma e le ttrico e raclioelettrico;
- esprimere pareri su argome nti e materiali d i radiotecnica ed elettrotecnica. Furono anche istit uiti , con R.D. 23 lu g li o 1927 n.1 4 33, quattro Ce ntri Studi de l Genio di cui un o , p er le spec ia lità telegrafisti e radiotelegrafisti, con sede in Ro m a presso la "Officina Radiotelegrafica ed Elettrotec nica". Con R.D. n.69 7 del 5 ap r ile 1934, i quattro Centri suddetti vennero riuniti in un unico Centro Studi d el Genio con sede in Pavia, presso l'Offic ina di Costruzi oni d el Genio Militare
Il 4 giugno 1934, con legge n .952, il Se rvizio assunse la denominazione di Servizio Studi ed Espe rienze del Gen io, con lo scopo di fa r fro nte al n otevole sviluppo della tecnica dei materiali e delle attrezza ture. L' Officina , d enominata Officina Mil ita re delle T rasmission i ( O.M.T.) per effetto de l R. Decreto 31 ottobre 193 5, n.2233, svolse, con l'Istituto Militare Superiore de lle Trasmissioni, un ru o lo d e ter minante nel settore dell a ri cerca app lic ata alle telecomunicazioni, costituendo un punto di riferim ento anche p e r l' industria nazionale.
Sono gli anni a cavallo tra le du e g ue rre mondiali quelli in cui la tecnica d e ll e trasmissioni subì radicali trasformazion i.
Nella telegrafia a fi lo si p assò g ra du a lm e nte dalla "macchinetta Mors e" alle apparecchiature amomatich e stampanti (IIughes , Weas tone) e agli apparecchi multipli (Baudot, Rowland), ch e possono co nsiderarsi gli antesignani delle modern e telescriventi.
Nella telefonia i progress i prin cip a li s i eb bero con l'introduzione della commutazione automatica.
Negli anni ' 30 fu adottato un complesso per te lefonia sel ettiva , che consentiva il collegamento su un ' uni ca linea t ra due qua lsiasi degli apparati d 'utente.
Ma le vere protagoniste della r ivo luzi o ne , che aprì la v ia delle moderne trasmissioni , fu ro n o soprattutt o la radiotelegrafia e la radiofo nia.
So n o gli anni di più in[e n so fervore, che vid ero impegnati, a fia n co eli scie nzi ati di fama mondi ale, t ra cui lo stesso Guglielmo Marco n i, val enti tec nici milita r i, come l'aU ora Tenente Lu igi Sacco.
A questo svilu ppo contr ibui rono l'Is tituto e l'Officina che, proprio sotto la dir ezione del Col. Sacco, rea li zzò tutta un a se ri e eli a pparati radiotelefonici e te leg rafici a valvo la, estremamente inLeressant i p e r prestaz io ni tecniche e semplicità di impi ego e di ricono sciuta validità s ul pi ano te cni co e d operativo.
Viene sperimentata la prim a s raz io ne rad io portatile nella gamm a YHF anche se non sarà seguita da una produzi o n e in se rie
Nel 1933 Guglielmo Marco ni convocò in sede riservata esperti militari italiani per dimos trare come mezzi m ob ili, inves titi da un fascio di onde radio, produ cessero perturbazioni nella ric ez io n e d e i segnali di un ponte radio sistemato fra Rom a
e Caste lgando lfo , agli esperime n ti prese nziava anche il Col. Sacco Co nvinto as sertor e d el rad io telemetro, il Col. Sacco in ca ricò il Prof. Tib e ri o, g iovan e e preparatissimo Uffic ia le eli comp lem ento dell 'Is titu to Superiore Mili ta re de lle Trasmiss ioni , di d eterminare "l'equa z io ne d e l radio te le metro" e di co ndurre, successiva mente , re alizzazioni e s p e rimentazi o ni eli grande interesse, m a d i cui non fu m a i a bb astanza riconosciuta l'enorme validità operativa.
All 'inizio della guerra mondiale l'O.M.T. si presentava come una moderna officina di produzione con un'efficiente o rgani zzazione, adeguata a soddisfare le molte esige n ze d i collegamento di un Ese rcito m o d e rn o.
A seguito delle distm z ioni operate dall e truppe te d esche in ritira ta , l' O.M T. sos p ese le at tività di lavorazion e
G li Enti tecnici oggi
Tutte le att ività di ricerca, sviluppo, s p erimentazione ed approvvigionamento dei materiali delle Trasmissioni, come si è visto, si so n o sviluppate con il concorso armonico e determina n te d i enti tecnici dive rsi, pur n ella molteplicità dei comp iti a loro assegna ti .
Ne l seco ndo dopoguerra i sopracc ita ti organi tecnici si sono ra pidamente evoluti ve rso q u e lli che attua lmente so n o g li en ti t e cn ici più rapp rese ntativi ovvero lo "Stabilin1ento Militare Mate ria li dell e T ras missioni" , il "Ce n tro Tecnico Militare delle Trasmiss ioni" e d il "Repart o Tecnico Ele ttronic o " del Ce n tro Infor maz io n i e Difesa Elettronica d i Anzio
Tali enti, apportando qua lificanti contribu ti alla soluzione di problemi op e ra ti vi e forne n do elementi d ecisiv i al conseguimento degli obiettivi di potenz iamento e ammodernamento dei mezzi di trasmissione e di guerra elettronica impi egati dalla F. A., hanno rappre sentato e rappresenta n o per l'orga n izzazione m il ita re significa tivi p u nt i di rife rimento per le es igenze de ll 'Esercito Itali an o .
Lo Stab ilim e nto Militare ed il Ce ntro Tecnico dip endono d a lla Direzione G e n e rale Armi, Munizioni e Armamen ti Terrest ri (A.M.A.T. ) d ove le attività di ricerca, sv il uppo, a pprovvigioname n to e s upporto logi s tic o per i m a teriali campali de ll e trasm issioni s i svilu p p ano ne ll 'a m b it o del IV Reparto, co n 1'8!! e la 91! Div isione.
Per quanto riguarda gli impianti e i mezzi d elle trasmiss ioni in installazioni fisse è competen te la Direzione Generale degli Impian ti e dei me:ai per l'Assiste nza al volo, per la D ifesa Aerea e p er le Telecomu n icazio ni (TELECOMDIFE).
Nel campo de lla guerra e lettronica, u n ruo lo te cn ico importa nte è ricoperto d a l Repa r to Tec ni c o Elettroni co o rga ni ca mente costituito ne ll 'am bito del Centro Inform azio ni e Difes a Elettroni ca, dip e ndente dal II Rep att o d e ll o Stato Maggiore dell ' Ese rcito.
Lo S ta bilim ento Militare M ateriali delle Tra sm ission i
Dopo la liberazione veniva avviata la ricostmzione e ripre n deva l'attiv ità da parte della "21" Offici na Ri parazioni Genio d i tip o A", denom inat a, ne l 1946, 21° Stabilimento Ge n io Militare, organo esecutivo del servizio Genio per la branca collegamenti con temporanee fu nzioni anch e d i centro per la elabora z ione della tecnica dei co llegamenti (f.n.220100 da ta to 3 agosto 1946 d el M inis tero della GuerraGab inetto).

Raj]'igura zione d e ll'Jstltuto Sup erio re delle Trasmissioni ne lla nuova sede del Lido di Ostia.
Rimanevano sos tanzi a lmente immutat i i suo i comp iti di studio, riparazion e, revisione ed approvvigionamento degli appara ti di telecomunicazioni per le es igenze dell'Esercito di campagna.
La stessa cosa n o n avvenne inv ece per l' Istituto Militare Supe rior e dell e Trasmissioni le cui attività e rano state sospese n el 1943, quando era da poco iniziato il trasferiment o della sede in un grande edi ficio appositamente costruito a l Lido di Ostia, in prossimi tà della pineta di Castel Fusano.
PUitroppo, anche il ruolo degli Ufficiali del Servizio Studi ed Esperienze del Genio, che aveva assunto nel 1942, con la legge n .104 , la denominazione di Servizio Tecnico del Genio, non era stato risparmiato dalle avverse vicende dell 'u ltimo conflitto mondiale.
Questa importante e delicata organizzazione, costituita da un Corpo scelto di Ufficiali che avevano raggiunto un eleva[O livello di qualificazione tecnico-professio nale, venne d is ciolta con il Decreto Legge 20 gennaio 1948 n.45 che fi ssava l'ordinamento provv isorio dell'Esercito.
Nel 1949 lo Stabilimento, che nel frattempo aveva assunto la denominazione di "21 o Stabilimento Collegamenti del Genio Militare", cedeva le attivit à di studio, per lo sviluppo delle quali veniva cost ituito, con tutt o il personale e le attrezzatur e dell ' Ufficio Studi, il "Centro Studi Co ll ega menti" , precursore dell'attu ale Centro Tecn ico Mil itare Trasmissi oni.
Nel 1967 lo Stabilimento passò a ll e d ip e ndenze della Direzione G e nerale Armi , Munizioni ed Armamenti Ter res tri.

Nel 1978 , per e ffetto de l D .M. del 23 dicembre 1977 , a seguito della ristru ttura zione degli Stabi lim enti e d ArsenaliMilitari a cara tte re ind ustr iale, l'ente assu n se la d en ominazione at tua le d i "Stabil iment o Militare Materiali de ll e Trasmission i"

La struttu ra organizzativa-fu nzio nale dello Sta bilimento è defin ita ne l D.M. 30 apri le 1984.
Il Centro Tec nico Militare delle Trasmissioni (C. TM. T )
La gen es i d e l C.T.M.T. risale al 28 aprile 1949, quando tal e Ente fu is tituito dallo SME com e "Ce ntro Studi Collegamenti" , allo scopo di p o ter di s porre di un organismo tec ni co-s p e rime n ta le in grado di sviluppare le attività di s tudio, di ri cerca e di sp e rime nta zione relative all'ammodernamento dei m e zzi eli tras miss io n e nonch é l 'a ttivit à di costruzione di prototipi sperimentali e di ind a g in e scientifica.
L' Ispetto rat o d e ll'Arma d e l Genio fu incaricato di presiedere a ll a fase in iz ia le eli costituzione d ell 'E nte
Il Centr o Stu di Co ll ega menti passò poi alle dipend e n ze d e ll 'U ffi cio Telec o m unicazion i d ello SME ed infin e a quell e d ell'Ufficio d ell'Is p ettore p e r i Co llegam e nti , costituito il l 0 o ttobre 1952 e denominat o, a pa rti re da l l 0 giug n o 1953, Uffic io dell' Ispetto re de lle T rasmissi oni.
Il Centro fu p reposto a compiti d i co nsulenza , ricerca, s tud io e s p erime n tazione , svol t i anche in stre tta co ll abo ra zio ne con l' Is ti tu t o Supe ri ore delle Poste e Te lecom unicaz ioni di Ro m a e l'Is ti tuto "Ga lileo Ferraris " d i To rino
Da ta li collaborazioni sca turiro no contributi scientific i, in p articolare ne l ca mp o d ella radio pro p agazione, la cu i incidenza conferì orientamenti ed im p u lsi s ignificativi anche all 'in du s tria na zi o n a le che , proprio in quel p e riodo, ten tava fa ticosa m e nte di risorge re da ll e rov ine d e lla guerra.
L'attività d e l Ce ntro abbrac c iava anche altri camp i di inter esse ch e d e riva no d a lla branca te lecomuni ca zi o ni, come gli s tudi e le esperie n ze n el ca mp o ra dar, delle radiosp o le tte , d e ll a te levisione e della visione notturna a ragg i infraross i, p a ssati successiva m e nt e di compete nza d el Servizio Tecnico di Attiglieria.
Negli anni '50 ve nn e ro effettuate l.e prime sp erimenta zioni con a pparati facsimile campali e d eseg uite le prime realizzazio n i nazionali nel camp o d e i p o nti radio infras truttura li.
Con !" is titu zione, nel co rso d e gli ann i, di nuovi reparti e s ez ioni , l' Ente ass unse configurazio ni se m p re più ri s pondenti ad a ffr o ntare le compl esse p rob lc ma ti ch e le g at e a ll 'e vo lu z io n e dell'e lettr onica e dei mezz i di comuni cazione .
Il Cen tro Stu di Collega ment i d iv enne Centro Studi Tras miss io n i ne l 1953, pe r effe tto de lla ci rco lare dello SME da ta ta 18 m aggio, che a ttri b ui va la denomi n azio n e dì Arm a d e ll e Trasmissio ni a ll a s p ec iali tà Collega ment i dell 'Arma del Genio e m o difi cava d i co nseguenza la d e sign az ione di tutti i rela tivi organi centra li e pe rìfe rici , enti e reparti.
N el 1954 venne adottata la d e n o minazio ne di Ce n tro Tec ni co delle Trasmiss io ni , ma n te n uta fi n o all' entrata in v igore del D.M 23 d icemb re 1977.
Ne l 196 1, a segui to d e ll a is tituzione del Servizio Tec n ico de ll e Trasm iss io ni (legge n . l 479 d e l 6 dice mbre 1960), l'Ente passò a dipendere d a ll a Direz ione del Servizio trova ndo la s u a più valida colloca zione e definizione sotto il p ro fil o tecnico, normativa e d is t itu zio n a le.
Ne l 1967 , in co n seg u e nza de l D.P.R. n. 1478 del 18 novembre 1965 , co n ce rnente l' organiz za zio n e d egli Uffici Cen t rali del Ministero della Dife sa , il ce ntro, so tto la data d e l l o fe bbraio, fu posto a lle dipendenze d ella Direz ione Ge n e rale
delle Armi , Munizioni ed Armamenti Terrestri.
Infine, per effetto del già citato D.M . 23 dicembre 1977 l'Ente , assunse la denominazione attuale di Centro Tecnico Militare delle Trasmissioni
Occorre precisare ch e n e l 1969, la Sezione "Difesa Elettronica" d e l centro , costituita nel 1957 per lo studio dei problemi connessi a lla guerra e lettroni ca, aveva cessato temporaneamente l'attività tras ferendo le proprie risorse ed i comp iti all'Ufficio Studi del Centro Difesa Ele ttronica d i Anzio.
Il Reparto,Tecnico Elettronico del CIDE
L'Ufficio Studi del C.D.E. assunse successivamente la denominazione di Uffi c io Ricerche e Studi e, in data 4 ottobre 1976 , quella attuale d i Repar to Tec nico Elettronico
Sono rimasti invariati i compiti di studio e prog e tta z ione di esemplari prototipici per la guerra elettronica nei settori "COM'' (COM un icaz ioni) e "NON COM" (NON COMunicazioni), di installazioni fisse RIC EL (RICerca ELettronica) e di Sistemi ELJNT (ELectronic INTelligence) , di spe rim en tazion e eli complessi prototipici di gu.elt. (guerra elettronica) e SIGINT (SIGna! INTelligence) per installazio ne fissa e mobile e di riparazione di terzo grado delle apparecchiature e comp lessi SIGINT e di guerra elettronica.
Particolarmente inten sa è risultata l'attività dr sperimentazione in tutti i se ttori eli interesse, finalizzata al potenziamento ed ammod e rnamento dei rep arti e delle unità di guerra elettronica e SIGINT.
Nel settore della radiogoniometria sono stati spe r imentati ed acquis iti i posti mobili TELEGO . ·-IV, costituiti essenzialmente dal r icevi tor e racliogoniometrico SIG 638 e dal ricevitore da interc ettazione EUK-72 4, funzionanti in gamma HF e in parte della VHF.
Nelle installa zioni fisse, i ricevitori PST-396 sono sta ti sostituiti dai più modern i TELEGON-VI.
I posti di intercettazione HF, sia fissi che mobili, dopo aver utilizzato i ricevitori EUK-724 e d EK-56 sono stati successivamente dotati dei nuovi ricevitori di costruzione nazionale HF-L-RI.

Nelle bande VHF/UHF sono s tati realizzati pos ti di intercettazione mobile comprendenti essenzialmente il radiogoniometro \Xì] 8986 ed i ricevi tori \Xì] 8615 P e 8617.
Successivamente è stato introdotto in servi z io un sistema computerizzato di intercettazione, p e r l'acq uisi zione automatizzata dei segnali di int eresse.
Non meno significativa è stata l'acquisizione, nel settore delle Contro Misure Elettroniche (ECM), del disturbatore mobile multifr e qu enz a Vllf DRVB-1A (Bro mure) mentr e , in gamma HF, è stato sv iluppato e realizzato dall ' industria nazionale il disturbatore radio HF "DH7/1000", che presenta caratteristiche tecniche ed operative di notevole interesse.
Parallelamente alle acquisizioni indicate, sono stati spe rimentati e approvvigionati sistemi eli analisi di segnali e clemoclulato ri/decodificatori eli vario tipo per il potenziamento delle attività SIGINT.
Sono state definite, inoltre, le caratteristiche tecnico-operative di un complesso mobile di intercettazione e disturbo contro ponti radio cui è seguita la realizz azione del prototipo.
Il Reparto Tecnico Elettronico, p e r la competenza tecnica nel campo dei materiali , che si integr'a armonicamente con le attività op e rative e ad d estrative del CIDE, è Ente tecnico di sicuro riferimento nel campo della guerra e lettronica.
Il Servizio Tecnico delle Trasmissioni nel ventennio 1960/1980
Con l'evoluzione delle e sigenze operative e sotto la sp inta del progresso tecnico -s cientifico , si manifestava inderog ab ile la necess ità eli costituire, insieme ad altri organismi, il Servizio Tecn ico delle Trasmissioni , colmando la lacuna determinatasi con lo scioglimento del Servizio Tecnico del Genio , avvenuto il 20/01/1948.
Nel 1950 il progetto eli nuovo o rdinamento dell'Esercito , cos ì come indicato nel foglio n. 3299/0rd.I di SME Ordinamento datato 25/10/1950, prevedeva, all 'art. 14 , la cost ituzio ne dell'Arma dei Collegamenti, per scissione dell'Arma del Genio e, all 'a rt. 17 , ipotizza va l'istituzione anche di un Servizio Tecnico dei Collegamenti, in considerazione della necessità di seguire lo sviluppo della tecnica in tale materia.
L'organico degli Ufficiali in s.p.e. del Servizio Tecnico dei Collegamenti era stabilito in 52 Ufficiali , fra cui un Tenen te Generale, Capo del Servizio, un Maggior Ge n erale e sei Colonnelli.
La legge n.1479 del 05/12/1960 , che istituiva i nuovi Servizi Tecnici dell'Esercito, riduceva la consistenza organica degli Ufficiali del Se tvizi o Tecnico delle Trasmissioni a 31 Ufficiali, di cui un Maggiore Generale, Capo del Servizio, e tre Colonnelli.
Tale numero, fin dall ' inizio già esiguo rispetto alle esigenze, si confermava assolutamente insufficiente se rapportato all ' enorme progresso tecnico e scientifico nel ca mpo dell'elettronica e delle telecomunicazioni degli anni successivi.
La stessa legge istitutiva fissava i compiti del Servizio Tecnico delle Trasmissioni e cioè:
- presiedere agli studi scientifici e tecnici dei mezzi eli trasmi ssione occorrenti all'Esercito , nonchè alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
- provvedere all'elaborazione delle co ndizioni tecniche di progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione , la manuten zione, l' uso e la riparazione dei materiali;
- sovrintendere al controllo della produzione e fissare le direttive tecniche per il collaudo dei ma te riali da approvvigionare .
Le tapp e salienti, successive al 1960, possono essere così sintetizzate:
- costituzione in data l o novembre 1961 della Direzione del Servizio Tecnico delle Trasmissioni, retta dal Capo del Setvizio Tecnico delle Trasmissioni e posta alle dipendenze dell'Ispettorato dell'Arma delle Trasmiss ioni;
-costituzione con fg.n. 147/154 d e l 31.1. 1967 eli SME-Uff.Ord., d ell 'Ufficio del Capo del Servizio Tecnic o delle Trasmissioni in sostituzione della Direzione del Servizio Tecnico delle Trasmissioni;

- definizione, con D.M. in data 19.7.1967, della collocazione ordinativa dei Capi dei Servizi Tecnici, in forza della quale questi ultimi venivano posti alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore d ell'Esercito con funzioni di collaborazione alle scelte di consu lenza ed alle soluzioni di ordine tecnico riguardant i i m ateriali dell'Esercito di competenza del Setvizio, di consulenza per l'i mpiego degli Ufficiali del rispettivo servizio e eli responsabilità per la loro milita re e tecnico-p rofessionale;
- costituzione, nel 1975, del Comitato Permanente dei Capi dei Setvizi Tecnici con com piti eli coordinamento generale in vis ta della unificazione dei sei Setvizi Tecnici esistenti ;
- confluenza del Servizio Tecnico Trasmissioni, con gli altr i Servizi Tecnici nel costituendo Corpo Tecnico (legge 20 settembre 1980 n.574).

Per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, sperimentazione, costruzione, approvvigionamento e riparazione dei materiali di telecom unic azioni e di guerra elettronica, il Servizio è stato organicamente rappresentato in numerosi Enti dell'Amministrazione della Difesa, tra i quali:
- l'Ufficio del Capo del Servizio;
-le Divisioni tecniche delle Direzioni Genera li (Al'vV\T e TELECOMDIFE);
- lo Stabilim ento Militare Materiali delle Trasmissioni;
- il Centro Tecnico Militare delle Trasmissioni;
- il Re parto Tecnico Elettronico del CIDE;
- altri Enti specializzati Sebbene caratterizzato da un organico estremamente ridotto, il Servizio Tecnico delle Trasmissioni è riuscito , superando non poche difficoltà, a fronteggiare le esigenze di maggior importanza e urgenza, pur ne ll a vastità, comp lessità e diversità delle attività di interesse .
Agli inizi degli anni 70, le prospettive offerte dall'incessante progresso tecnicoe le ttronico e le esigenze operative formulate in sede NATO, hanno determinato l'avvio eli uno studio per la realizzazione di un siste ma di trasmissioni avanzato, in grado di rispondere con immediatezza ad esigenze eli collegamento a piccola, media e grande distanza di Comandi ed Enti comunque e dovunque presenti nell'area della battaglia, nonostante situazioni di dinamismo anche esasp e rato ed i · foni condizionamenti imposti dal nemico, dall'ambiente fisico e dall'ambiente elettromagnetico (Studio El 56 : sis tema di trasmissioni post 75) configura to il CATRIN (Sistema Campale di Trasmissioni Integrate) , sistema comp le tamente integrato ed automatizzato, capace d i ass icurare trasmissioni rapide, sicure, acl elevata soprav-vivenza, in grado di trattare grandi masse di informazioni in telefonia, tel eg rafia , dati e facsimile necessarie all'azione di comando e controllo
La sua fattibilità è garantita dalla crescente capacità dell 'in dustria nazionale, in grado di concorrere , ormai alla pari , con quella straniera più evo luta.
E' in tale prosp e ttiva che il Servizio Tecnico procede alla definizione delle caratteristiche di nuovi materiali e delle modifiche da appottare ai mezzi recentemente introdotti in servizio (digitalizzazione dei ponti radio) per renderlì idonei ad operare anche nel sistema avanza to.
Detta attività è sviluppata rispettando i vincoli di ordine tecnico derivant i dall'esigenza dì compatibilità dei parametri tecnici stabiliti in sede d i acco rd i internazionali NATO ed Europei, con particolare riguardo alle esigenze di in teroperabili tà fra i sistemi de i paesi membri.
In tale contesto, significativa e rilevante risulta l'attivi tà del personale tecnico del Servizio nell 'ambito dei gruppi di lavoro NATO, EURO COM e FINABEL. Contemporaneamente il Setvizio Tecnico continua ad impegnarsi attivamente nei programmi eli ammodernamento eli importanti materiali e mezzi tecnici, con prospettive di avanguardia ed in piena sintonia con la rapida evoluzione tecnica e tecnologica
Nelle attività descritte , l'impegno de l Servizio Tecnico delle Trasmissioni è principalmente rivolto alla definizione di modifiche di materiali esistenti, all'elaborazione de i requisiti tecnici dei nuovi apparati, alla sperimentazione t ecnica dei proto tipi, al controllo e collaudo della produzione nonché alla manutenzione eli 4° livello dei materiali approvvigionati
Ma è anche nel campo delle installazion i de i materiali TLC a bordo di auto -
mezzi ruotati e cingolati che il Servizio Tecnico delle Trasmissioni ha profuso un significativo impegno con le attività di studio di fattibilità, di proge tto, di realizzazione prototipica, di sperimentazione tecnica e di concorso nel pratico impiego ai fini d ell'omologa zione o dell'idoneità all'adozione in servizio.
Non m e no significativo è il contributo all'attività addestrativa, con l'organizzazione ed effettuazione eli corsi di aggiornamento sulla tecnica di impiego dei sis temi TLC, di specializzazione sui materiali di ammodernamento delle Trasmissioni e di perfezionamento tecnico-amministrativo per Ufficiali delle Trasmissioni.
Inoltre, il Servizio Tecnico dell e Trasmissioni si è distinto per l'alto livello delle attività eli consulenza e collaborazione tecnica fornita, in patticolare , all 'Arma dei Carabinieri (rete infrastruttura le in PR ed operativa), e acl altre Amministrazioni dello Stato (.Ministero degli Interni, delle Finanze, ecc.) nel campo delle telecomunicazioni.

Quanto preced entemente esposto testimonia come il periodo di vita autonoma del Servizio , seppur breve , sia indicativo eli un costante impegno, di efficien za, e di capacità realizzativa.
Il 20 settembre 1980 il Servizio Tecnico d e lle Trasmissioni cessa di esistere. Con legge 574 è costituito il ruolo del Corpo Tecnico de ll 'Esercito che sostituisce, riunendoli , i ruoli d ei Servizi Tecnici d'Artiglieria, della Motorizzazione , ChimicoFisico, del Genio, delle Trasmissioni e Geografico.
Il Corpo Tecnico dell'Esercito
La costituzione del Corpo Tecnico dell 'Esercito rappresenta una ulteriore pietra miliare sulla via di una razionale e armonica organizzazione delle attività tecniche.
Avvenuta dopo anni di studio, di incertezze procedurali e di ripensamenti, la costituzione eli un Corpo Tecni co unitario intende rispondere alle necessità dell 'Esercito in modo più uniforme, più integrato, più razionale di quanto non potessero fare, con la loro sostanziale compartimentazione, i già esistenti Servizi Tecnici.
Alla citata legge 574/80, istitutiva del ruolo del Corpo Tecnico, è seguito il D M. 26/6/1981 che sancisce le attribuzioni del Generale Ispettore, Capo del Corpo.
Per l'esercizio delle sue attribuzioni e per lo svolgimento delle attività di competenza, esplicitate nella circolare SME/4000, "No rme per l'attività di ricerca e sviluppo dei nuovi materiali per il riconoscirnento della loro idoneità all'impiego presso l'Esercito", il Capo del Corpo Tecnico ha alle sue dipendenze il Comando del Corpo Tecnico.
Il Comando è organicamente collocato nell'area tecnico -operativa di F.A. e d è ordinato su 6 Uffici competenti per materia.
Il 4° Ufficio - Te lematica ed Optoelettronica - svolge compiti di ricerca e sviluppo di nuovi mezzi e materiali di elettronica per le telecomunicazioni e relativa guerra elettronica e dei sistemi telematici e di comando e controllo.
Può quindi considerarsi l'erede delle tradizioni e delle attività del disciolto Servizio Tecnico delle Trasmissioni.
L'Ufficio continua pertanto acl essere impegnato, in collaborazione con le Direzioni Generali tecniche competenti, allo sviluppo dei programmi di ammodernamento della F.A. nel settore delle Trasm issioni.
Ma l'attività tecnica più impegnativa e qualificante è attualmente rappresentata dallo sviluppo del SOTRIN, che rappresenta la compon ente "comunicazioni" del più ampio sistema CAmpale di TRasmissione e INformazione (CATRIN).
In aggiunta, sono in avanzata fase di definizione i requisiti militari per l' acquisizione del SIACCON (Sistema Automati:aato di Con1ando e Controllo) che, integ randosi con il CATRIN, consentirà la realizzazione di quel sistema ormai noto come C3I (Comando -Controllo-Comunicazioni-Informazioni) .
Consapevo le d elle responsabilità che derivano dalla suddetta situazione, il perso n al e tecn ico d el settore Trasmiss ioni è impeg n ato attivamente a forn ire il suo co ntri b u to d i es p e r ie n ze e d i capacità per il raggiung imc nt o degli obie tti vi finali.

Conclusioni
La breve stori a degli Enti T ec nic i de ll e Trasm issi o n i può apparire es clus ivamente cronaca d el proc esso evo lu ti vo tec ni co-scientifico d e i mezzi el i te lecomunica zione e, per quanto inte ressa n te, arida d i co n te nut o s pirituale.
In realtà il perso nale tecnico de ll e Tras mi ss io ni è partecipe di attività d a l co nt enuto umano e soc iale c he de ri va da ll 'essenza stessa del campo di interesse.
La sc ienza dell e co m u nicaz ioni, nelle sue d iverse for me di svilup po, consente eli traspo rta re info rmaz ioni a dist.am:e sempre maggiori e a velocità sempre p iù alte. Nonostante il suo progresso vertigino::;o, essa non ha murato la sua impostazione iniz iale per la quale l'o rigine della com unicazione ed il destinatario del messaggio era e 1imane l'uomo.
E' principalmente nella modern a società, strutturalmente e operativamcme complessa e caratterizzata dalla crescente interdipendenza dei s uoi membri , che la scie nza delle telecomunicazion i aiuta l' uomo a comprendere e risolve re con successo la molti tu d in e d ei p rob lemi che ogni giorno è c hi a m ato a fronteggiare.
In q uesto qu a d ro , a n che la st ruttura mi li ta re d e ll e comunicazi o n i, p u r ne ll a sua es asperata tipizzaz io n e, assu me conno tazioni sempre più s fum ate e s oc iali .
In tal e contes to a ss um e s ignificatO emb le matic o la particolare con ge ni a li tà d e ll e telecomu nic azioni a ll a b iva le n za, c ioè a ll a possibilità eli impi ego in con co rso a l bene d ella coll e ttivit à na z io na le, n ei cas i eli pubbli ca ca lamità, in una d efi n izi one sempre più lata del con ce tto d i ::; ic ure zza
Le esige nz e che n e scat uri sco n o h a nno trovato n e gli Enti Tecnici dell e Trasmissioni organismi es tre m a mente sensib ili e rea tti v i, consapevoli d e ll 'in t rin seco s ignifi cato morale e s oci al e che è a lla base d e ll e proprie attività e ch e t ra sce nd e l'ovv io valore o p er ativo d i u n sistema di com unicaz io n i e fficien te



Riproduzione del gruppo murmo1'eo di Mocchi raffigurante l'Arcangelo Gabriele celeste Patrono.
Il Santo Patrono
Il 12 gennaio 1951 , il Sommo Pontefice, Pap a Pio Xll, con Breve Pont ifi cia, de s ignava l'Arcangelo Gabriele quale Patrono delle Trasmissioni.
Breve Pontificia
Poiché "ogni cosa ottima ed ogni dono viene dall'alto , discenden.do dal padre della luce' : si può am mirare la Sapienza divina quando gli uomini seruendosi delle invenzioni, frutto della tecnica moderna, possono per rnezzo dell 'elettricità sia trascrivere con la massi-ma velocità le parole agli assenti, sia parlare tra di loTO da luoghi molto distanti, sia inviare messaggi attraverso le onde dell'etere, sia ir?fine assistere come presenti alla rappresentazione di cose e di avvenimenti lontani. ( .)Per questo ci è sembrato molto opportuno che questa mirabile tecnica e gli addetti ai suoi seruizi godessero di un pa11icolare celeste beneficio e di uno speciale patrocinio. Siccome parecchie illustri persone di molte Nazioni che lavorano in questo campo banno rivolto le loro suppliche r4fincbé Noi dichiarassimo Celeste Patrono lm-o e di tutti gli addetti alle telecom.unicazioni San Gabriele Arcangelo, il quale recò il desiderato annunzio della redenzione al gene re umano, avvolto nelle tenebre e quasi della propria salvezza, Noi, molto volentieri considerata la grande importanza della cosa, (. .) in forza della presente lettera ed in modo pmpetuo, confenniamo, stabiliamo e dichiariamo San Gabriele Arcangelo Celeste Patrono delle Teleconnmicazioni e dei loro con tutti e singoli onori e privilegi liturgici che, secondo il rito, spettano ai Principali Patroni di Associazioni e nonostante qualunque parere contrario.( .)
Dato a Roma, pt·esso s. Pietro, sotto l 'Anello del Pescatore, il 12 gennaio .7951, anno dodicesùno del nostro pontificato. Pio Xli.

San Gabriele
L'Arcangelo Gab ri e le, come ripo r tato ne ll e Sacre Scritture , ha il comp ito di '' rn ess aggero annunciatore" d ei voleri e decreti divin i. L'Arcangelo appare al giovane profeta Daniele due volte. La prima per rassic u ra re il Profeta sul Messia e sugli avvenimenti che precederanno ed accompa gneranno la venu ta de l Redentore. Egli trasporta Danie le s ull 'a lto della port.a d'Ufai, ne ll a c itt à di Susa: il Pro fe ta "al za gli occhi e vede" i fatti "a breve scadenza " e que lli che si sarebbero dovu ti verificare "a scadenza di seco li". Una secon da volta, per dirgli: "Daniele, io sono venuto ora per istrui11i e perché tu abbia intelligenza". Tn tutto ciò appare visibile l 'opera di Gabriele nel trovare la v ia per illuminare l' intellet to umano, chiuso in piccolo orizzon te , pe r la percezione dei fatti che avverranno nel te mpo, ma che superano lo
PIVS PP. XII

0:./k.pnpeturu n.. rez: / TI l"
.a teT1lC anirruf ..A/os'"h-cr,. a!ft's- est.. "solltctlm:/<f Wllllturn Ecclc:sinrllro." (ptò,. XT.U}.hcwd _ parvarn COIJliO.rrl're.. qurun rnLI!It. sc:-u.. rwHcN '"lioru.•,;cne!eS!i.s- (Jàlronz../ull"/at!..,larrtqucn;t:.f.Jt'rferllssirni hornttlron t/1laP. yl<'r?/_//kll·ls-se. crrdt•re:. n offrir t/eL tzt.nderrt.-.7'"77;>C.H I 'terunua.Js-, nfJt/ISSl rruf.u7el/IW7./l?
c/ù:"inurn.. e;</'_elunL aù{'lilturr,: s'"Q'fH'. :il'!f.Jt'ru rn f'/l'nL.f.'ltJ' n d.. bontun.ftugnn. Oao laudczbi[L. con.stlto·, 71ulr.. III.Jt/tSSIInoe.A('tt•rct.fus /Jat'/t.r 177lh'i'es- sinf]Uinrrrrz. ccwtes/e7tt.. YulrOIILI/77. Slbi ctrl'?plrtt/t•rtll7i:.$(< yutJ l'l/Irti, re rntlt'lrtri._/)ropiFr, rmvaf rallollcs· "!"'';nn nli'rtbalo. q 11 tt/TZ 7rtt?f11rtl!.. hodu per jeélu,rt Ot.III'.$'1/TUt.s- T7Uit'lulr4 'nrldlr17rl runr Orr!t.J ·"/77C!ch/t IU/O(t'bus- st;juné!ur l' ,'/.:, :/t<>den 1. Onlti ll.!r (rtll/les- not/urrr utac <:tr/t ictoneurn..jarronarn :zaa,·r/f:rllrti. l>kul; l>anrla.. YJ"rhara l/irgr< l'L .5fpos'foltrn.s-· !J,•rt·rnbns anrto r; rt/lr•sir{..té non;rnli' •tnm· qatri'J'l.IUIJCSITn'!•.7u·trrtd CL 4>st.s- sub nnuld rla/as-, Jto/ls n t t ;,;,hLI.r J?.!/roba!/t:f117rlls-'.- nau/l.s-; rnachtnarus- t;L lrtr.J!'IIdrt:-; a<khélzs- ce<clr<11 s!7éz!rona. t'Ortji'rtl7alr.z. t7/'luc. renat7liatujurrt7L; t!a. .Òanéltts- c)al•ricl drr/Jartf!''/u 1 - n 11• liffbns p<'r e!ec'?r/carn. J/11n f'j. lon,;p7}'qud C<)//o!Zuenh"bus- z/eL scnbnrl7bus- Vf"L f-brtrP_t'ru·n/lbu..- t?f>ltor 'Ji.t...:-:. Srt!e. 1//sus- e a.· E'/nu!n ./._"'1/leru .,- ilt•nz. 1rz. joo11o (Jirrvi s, e/li"'. Xlllrtt/T( ftS }ctrl.l/C7rll: '' TZOTTIIrt B. c/lrurt/1./r C<'TLtrrtytw _, 017!771/lll l CJIII., l '/t/e t/trt.._prtt/(1/1, /.le.j?l"I //CI/?.!C. \OCfCifTfa/èY", Z?SC(r'// l. :J_t1l'C//Irr7TI70dr> clflrt/ O.fH'r't'l?r.<., r77L'rrt(.'l'<lllln/ _ f..7rc bang<'lt..r rtt,, f'tf 'l"rYI "'rnorliJ!lLIItZ.. gener-i e(<qpltd; liTI. h1l'1"77CZ7tae (}(t>tlr·ny;;/iortl.r nunùur n:'dr!t.t.!t'ral. U7t'k \'/nn {/bfronuuz. a',•rlarat//rnus- ...A/equi!.. !une:- dubi/al/ùnu.s ' : ,Jattélù. Jlt6all:r Llak:;'lcz hatC.._pt!... j>ulorutn. at.!lul.. non •·oful72 ntllltflllf'trrt. of/ectl:,secl.. rurc u >..I:Jobllil eL habeL rurn cztere,proUe/tt'rc.ac. /urari. :7uarn 1/lf{ }'(.llrte: ;z_uctnclvqutc/eT!L quù:7g_uid. Vf'rL,fluidguicf. not/z.. tn.dagandtfa/1/nytlur, rei t/e!uh.. c//t/lNI7"- rnrnfnr· 1/c.SITyu:.trn.. du/tllf/cqui':.._polen/u:u:. agnoscenclurn rsL ". Quocf. St. ('OT/iuùnae.t!Tar .Ar/t:·S"' not/i'>J'trncu'/('C-I/lflrurnen!a,.JN'OUL_pacirqpcra., /7tt-,tllurrz. rrzz;r7lurntzuc 7/a!rnt.(uL ...AtJs/ra. J/rrba.derl!uf TtSt n;pet77u s-)ar/ fra/t'rnarrL. hornirll.t7rL. Co7nrnunil"alt!rrz.joJ/f'17dCUTL robotnfla'atn.gu.e.., att COr/11'77.. e(<oJ!PndaiiZ ;/ilarrt., t ll.'/es- l'l. ad ingt' ltuas 9t..Htrrt /u lt$_çinu: n utili.'> u<.L fuendar1L. r nllilz.un. tlt/r11n olqttf! acL eflù:iena'lflll 1/(tln tts- qzto ' cr)r:;_ungardur , (psn t'rtserv.ù e. t/a/eantyuP ( '111 rt. ltl!·a.l/ener'Cibllt... :/'rct/ì·e. l l r r n tro' tlt/1/p !l r' / W , .5/rc!ut;JHSC'?f"d !zl-u/arL... 'J/;,ecn -to.szqRoh1am:J NL %·cadta rtt'c.. notL ()rdtll<l, r/tf .9t'/tt"ldo rt..pro 1':1/r.. "7i'-ctnS"t77is<ionibu.'r': 1711/<e- r oga!t- es,·c.......; 1 nus-- caele.J'frrrt....Sanéli {Jaòn.ell:r -'"lrrhangdt: lult·larn t•flarrz. ad r;_asdt:rn.. OrclllllS rtll!tki i>f.rtrgne. e;<terrclere. dtyllo;_·c: rrnu·, ..,.}os- !u.yu rrnociLprece.s- ac/n7t'l/çndas-..f'er/ibenkr ansutn7u.r Quo/rqptrr, c. .Sacrae t/(ituurn. Corr,gregalronrrcoruu/f<f, _pepensLr-,cerla• .saenhi:z. a c. rrralura qelibernlionc:.. ..AIFJ.s'Tra.. clegue.. 9J.po.(/olùae po/eslahr'..ple f!t1ucltne..,hantr17. .P"r:f"'<'hrurnguc.. 1n I tjuht j e / err' - ,!4rrh ange/#f:(.l- nut/I.S.frnn 7iv'! sm qu<'f77: z:ora:_d:,. o_rnni':'rn.. r;< 71a ltcé Et<erdlz.z.. /Til'l}/u 117._., n upud..J.J('Unz!/111rv':"Trn. wnnibas ac(jeélts- hnnortbu./ ac.pnt/t'ktJIIJ-IdurtJicr!r,guae._prueC!,('Lds- cot'luurn tJatronts' n te. r..o;npt•fun/;, /i!. etrlll/jlçtt:... (on/7 a r/is 177ll71fTlf! ob..{/-anfibus·._Efoec. cr/td1rti.Js;S/aluùnus;c/ecernerzfd /3 '11t·ra.ljì?:nta.f,r.tu l/t.luJ atqu.t!;- eff/ral.·d;i.tgtfll'r t•;<s?r:u-e Cl c ._pcrrnanere.,5uor9ue...p!cno:;1 czt9.ue rn/l'g r o.fejjèél-u.f,,'orllrt.. t•L op_ !tttere ; lllu!iue. f-7(/.guo.s' s'n !..spel:'lare..pott·ran/.:.,nunç. el: ,rz._posferurn..:Ptcrrt:SSin7e..su.ffì·aecrrl.. ;sicq_uP.. r/t'!./"dt--. <t;' t clurn esje. a c.. c!ej'tlu 'errd u rn..; trrt7LIIrtqu e. ej( n une. el;. /nanf±/ù'I'L,.si qurd'l..ua1n. .frrus- St.pt!r hls-, a. !JLI:Ot/ts; aué7orilrtle. '7"a. //bi'/.,Saen/cr J'it/e. wnot'C7rtf?r con!lÉft'r/t af/enrari. 'lJn/urn.. 9(o777ae.qpud.f.'fJ'l"frurn.,.fub anu/d Yt".rredorlf,c/ie Yf /771!Tt.StS..t.J.iirt!t'l t1 lJìm !ijicalu.s' .AIO.r!ri. duoi/f't/icesund'.
De. SJHYU.dlJlno n?JV'"T
spazio cd il tempo. L'A rcangelo Gabriele riappare nel pe ri odo d i preparazione al Cristianesimo a Zaccaria per annunciargli la nascita eli suo figlio Gi ovanni Battista. Ma il più grand e collegame nto tra il c ielo e la terra viene istituito dall 'Arca ngelo Gab riele quando ap pare a lla Vergin e Maria per annun c ia rLe che da Lei nascerà il "Mess ia"
Le leggend e g iudaiche assegn ano a lui altro compito. Gabriele sa reb be stato fra g li Angeli che seppe llirono Mosè e in lui fu identific ato il dis tmttor e dell'a rmata di Sennac herib. E' uno dei quattro Arcangeli preposti alle quatt ro patt i del globo; con Michele , Raffaele cd Urie le appare spesso nelle preghiere del giudaismo.
Eg li raffigura anco ra , nella sua miss ione divina di "confidente " e di " messaggero eli Di o" , la più a lta immagin e del T ra sme ttitore c ui è affidato il comp ito eli far g iungere a destin az io rt e il messa gg io co ntenente il p e n s ie ro del capo, pe n s iero
Allo originale con cui il Sommo Pontefice Pio XII elesse a Patrono delle Trasmissioni San Gabriele Arcangelo.
Recent e reali zzaz ione di ·un bronzo l 'A rcangelo Gabriele Tale immagine attualm ente è la piil. diffusa p resso g li Enti e le Unità dell 'Anna delle Tmsmissioni ( 1·ealt:zza ta d allu Stabilim en to Militare delle Trasmiss ioni).
spesso decisivo della sorte di un popolo. L'alla dignità del "messaggero divino " fa sì che non sia soltanto il portarore di un annuncio ma lo spiiito ìntelligeme e partecipe della determinazione div in a, cui l'Ete rno affida di rivelare la sua volontà. Q uesto c i fa intravedere , su scala umana, l'elev atezza del compito dell e Tra s missio n i, le quali p artecipano all'att iv ità concettu al e dei comandi più elevati, trasferendo e rivelando g li o rd ini supe ri ori ai rep arti che debbono tradurli in a tto. Gabriele non è nuovo per gli Eserciti, anche se in termini di leggend a Le canzoni che cantano le gesta del c iclo caro lingio ci rappresentano Gab ri e le che detta a Carlo Magno gli o rdini dell'Al tissimo per le crocia te contro gli infede li. Esse dicono altresì che durame la batt ag lia, l'Arcange lo rimase a fianco dei prodi, s osten en cloli con la sua p aro la e d ass ic urando loro un costante co ll egamento co n Dio. La Chanso n de Ro land c i trmn a nda c h e Rolanclo, stre mat o dalle ferite e s ul punto d i spi ra re, tende a Gabrie le il suo gua nto, pe rché s ia rimesso a Dio.
L'A.rma d elle Trasmiss ioni n o n poteva essere affidata acl uno spirito p iù eccelso e d i Trasmettitori d 'It a li a potranno sentirsi guidati ed illum inat i in ogni atto d e l loro servizio e dell a loro vita da ll 'o nnipresenza di San Gabriele, s e riu sci ranno a compr enderne l'alta s piritu a lità.
L' iconografia più comune c i propo ne l' immag ine creata da Francesco Mocchi con l'opera "Madonna Annu n ziata" che si trova n el Duomo d i Orvieto.

L'opera fu composta tra 1605 e 1608. Il gruppo marmoreo è composto da due distinte figure: la Vergin e, con l'espressione di stupore per la presenza dell'Arcangelo; S .Gabr iele, nel momen to in cui sta per mettere il piede a te rra, con le vesti scomposte, per il vo lto batmto d a l vento, il bracc io s ini s tro rivolto verso l'alto, a simbol egg ia re che la sua ve nu ta è u n co mandamento div ino. La fig ura armonica, curata nei particolari, ci tes timoni a l'abilità compositiva d el Mocchi che ha sap u to tra l'al tro cog li ere con ra ra p eriz ia, il momento più saliente dell 'avvenimento . Questo grupp o m a rmoreo barocco rappresenta una delle op ere più import a nti dell ' attista.
Il sitnbolo d e ll e T rasmission i
La tor re di segnalazione romana, uno dei più antichi e diffusi mezzi di tra sm issione p erve nuto a noi in d ocum en taz io n e origina le , è stata sce lta a simbolo de ll e Trasmissioni dell 'Esercito p e r la d ire tta d isce ndenza della nostra civiltà da que ll a latina e per la luce d ella fiacco la c h e accom una le te lecomunicazioni antiche e mode rne La t orre richiama , inoltre, ai trasme ttit ori l' Arm a d ' origine : il Gen io .L'immagine è tratta dai ri li evi d e ll a Colonna Traiana inaugurata il 12 maggio 11 3 d .C. nel Fo ro di T raiano in Roma per commemorare le due campagne vittoriose dell 'I mperatore cont r o i Daci. La Colonna si eleva tra le ro vi n e del Foro Tra ia n o, l'ul tim o e il p iù grand ioso dei Fori Impe riali, opera di Apollodoro di Damasco, architetto imperiale.La Colonna Traiana, giunta a noi quasi in tatta, costituisce oggi il monumento più ca r atter is ti co de i Fori Imperiali.Essa è alta ci rca m. 40 senza la statua (la co lo nna è a lta, co n base e capitello, m. 29. 78, pari a 100 piedi); è posta sopra un pi edis tallo ornato d i trofei e d ha in cima la statua di S.Pietro, bronzo di Tommaso De ll a Porta, eseguito in collaborazione con Leon Sormani. La statua è stata co llo cata n e l 1587: anticamen te eme rgeva la stat ua di Traiano.
Attorno a l fu sto, costituito da 18 b locc hi di ma r mo sovrapposti (alti m 1.50, p er u n d ia m etro di m 3 .50) si nota un freg io a spirale (lungo 200 m e alto circa l m ) ornato d a circa 2500 figtlre (le principali alte 60-70 cm), c he rap p r esentano g li e pi -
sodi p iù sa li enti delle sped izio ni di Traiano contro i Daci (101-103 e 107-108).
Le scultu re sono discretamente visibili dal marciapiede fra le due chiese: guardando circa a metà altezza, si discerne bene una figura di vittoria, del tipo notissimo clerto "Bresci a", sepa rante i due cicli d i ra ppresentazion i (a l mus eo della Civiltà Roma na esistono i ca lch i in gesso di tutti i rilievi) .
l rilievi del ba same nto rappresenta n o un affastell am e nto di armi barb ar iche; .su l davan ti , c 'é la ponicina d ' ingresso alla ce ll a sepolcrale dove, in un'urna d'o ro, furono riposte le ceneri di Traiano.
L'emble ma scelto a simboleggiare le Tr asmissioni militari è espresso dalla prima delle 125 sculture a s pira le dell a colonna e s ta ad illus trare gli elementi term inali de l vastissimo s istema delle trasm iss ioni che , con i c irca 60.000 Km di lung h ezza comp les siva, cop riva tutto l 'Imp ero Romano.

I DECORATI AL VALORE


Medaglie ai va/or militm·e
Le glorie dell 'Arma delle Trasmissioni
Il 12 Settembre 1860 venivano approvate, con R.D. "Le Norme provvisorie pel servizio presso l'Armata". Praticamente in detta data veniva sanzionata la nascita dell'Arma de ll e Trasmissioni dell'Esercito
Aveva inizio così un cammino che si sarebbe rivelato irt o di ostacoli, ma costella to di valore e di grande perizia tecnica, ove l'inventiva, fino ai più piccoli livelli diveniva, a volte, determinante n ella risoluzione del problema operativo.
T Trasmettitori, da allora , parteciparono ed operaro no in tutte le vicende belliche che videro l' Ese rcito italiano prmagonista. Il va lore dei Trasmettitori è testimoniato anche dai num eros i caduti e dalle num e ros e onorificenze ricevut e dai singoli e dalle unità.
Questa appendi ce e le nca i nominativi di co loro che per manten e re fede a l giuramento prestato all'Esercito e alla Patria , fecero anche olocausto de!la propri a vita.

Vuole esse re un atto di omaggio, che i Trasmetti tori di oggi, rendo n o, con o rgoglio, ai m igliori di ogni tempo, con la certezza che possano essere d i sprone a tutti nell'ademp imento del dovere.
Nelle tabelle che seguo no , sono ripor tati so lo i nominativi d elle g lo ri e delle Trasmissioni, la cui appa rtenenza all'Arma ri su lt a accertata dalla chiara indi cazio n e del reparto o da un esp licito riferimento, n e l tes to della motivazione, ad a ttività tipiche delle ''Trasmiss ioni". al nomin at ivo, per ragioni eli sintesi, sono ripottati solo la data ed il luogo dell'ev ento g lorioso, rinviando , per le motiv alio ni , al testo : "Glorie delle Trasm issioni" edit o ne ll 'an no 1962 dalla Scuola delle Trasmissioni.
Le Medaglie d ' Oro a l Va lor Militare "Alla Men1oria"
za Guerra Nfondiale (1915-1 918)
Maggiore spc
Mario Fio r e Piave, 17 giugno 1918
Itala-Etiopica
(1935-1936)
Sorto rene nre c p l.
79" btg. zap.
Capitano spe.
Sollot<.:n cnte cp l.
So tto te n cntc cpl.
Sottoteneme cp l.
Francesco Busignani
Zona el i 21 luglio 1936 15a cp. t r. (D iv. i. "Sabauùa")
2 ' Gu erra Mondiale ( 1940-1943)
Antonio Cavalieri cp. tr. deii'Tlarar Africa Orienwle Italiana, 2 luglio 1941
Pietro Donato 121 c p. relegra fìsri (XXXV C. A.)

Fiume Don-Frome ru sso. 19 cl icernh re 1942
Fedele Gua ldoni c p. mista r. e r. r. di C. A Tscherrkowo (Russia), 19 d icem bre 4 2 - 4 gennaio 1943
Guerra di Lib erazio ne (1943-1945)
Luigi Morandi F iren ze, 7 g iugn o 1944 partigiano combattente
Le Medaglie d'Argento a l V. M. "Alla Memo ria"
l a Guerra Mondiale ( 1915-191 8)
Tenente
Ugo Cecc W
Ponte eli Caporeuo, 21\ o trobre 1917
Souote nc ntc cp l.
Capora l maggiore
Caporale
Soldato
Luigi Mutto
Casa Pin Vill a B erti (P iave), 20 gi ugno 19 18
Luigi Ca riolaro
Bosco Cappuccio, 29 giugno 1916
Esp e rio BrioscW
Zenson, 24-28 febbra io 1918
Riccardo Biglia
Bosco Cappu cc io, 18 gennaio 1916
Soldato
Antonio Giuliani
Cima Ec har, 15 giug n o 19 18
7° rgt . g tele grafis ri
Soldato
Guido Marzuttini
Cuitron-Valle Ardea, 17 lu g li o 1918
7° rgt. g . tdcgrafisri

Soldato So ldato
Carlo Porinelli
Monte San Michele , 18 novem bre 1915
Giovanni Vietti
Graz igna , 16 maggio 191ì
Guerra Itala-Etiopica (1935-1936)
Tenente spe
Sergente Maggiore
Caporal maggiore
3° rgt. g tel egra fisti
3" rgt. g. teleg rasfis li
Carlo Manzo Gruppo Bande de ll ' Al topiano (sez R.T.) De mb e guinà, 15 dicembre 1935
Giovanbattista Biondi Gmppo Bande dell'Altopiano (se::z. R. T. ) Dembeguinà, 15 d icembre 1935
Giovanni Dal Pra' 33 cp. sp m ista g. ( Div CC. 1\"N ''21 Apri le") Acidi Bek Ma lech, 2 marzo 1936
Operazioni di Polizia Coloniale in A. O (1937-1938)
Sergente
Caporal magg iore R.T.
Genie re
Gen iere
Geniere
Eugenio Maciotta Rolandini
Langhei, lì se tt embre 1936
Vito Annese
Aia lfiscium (Goggiam Meridiona le), 7 agosto 1939
Mario Gio rdano
Dengheziè, 29 novembre 1937
Adamo Bellini
Amba-Addi-Musu, 22 sette mbre 1937
Amleto Travagli
Amba-Addi-.Musu, 22 settembre 1937
Guerra di Spagna (1937 -1939)
5P cp. t. (So malia)
LXX brg . co lon ia le
P cp Sp g ., Dess ié
XX:X.Vll btg misto g.
xx.-xvn btg mis ti g.
Sergente
Sergente
Antonio Cipolla
Sarr ion, 15 luglio 1938
Antonio Malagorgio
To rreci ll a de Alcaniz, 30 marzo 1938
b tg. L del C. T. V
l)[g. misto g.(D iv "L ittorio")
Caporale
Soldato
Ad o lfo Falegnami
Torrccilla de Alcaniz, 30 marzo 1938
Ome ro Martinelli
Soncillo, 14 agosto 1937
btg. misto g. (Div. "Littorio")
btg. r. r. del C. T. V.
2' Gue rra Mon d iale ( 19 4 0 -1 943)
Co lo n n e llo s pe
J'vlaggiore s p e
Capita no cpl.
Tenente spe
Tenente spc
Tenen te spe
Tene n te cp l.
Tene n te c pl.
Tenente cp l.

Vittorio Raffaelli
Afr ica Se tt e ntri ona le , 26 g iu g no 19 42
Giuseppe Fiorentino
Enna (Sic ili a), 13 luglio 1943
Mario Bosi
Spalato-Signo ( Dalmazia), 8 -30 settemb re 1943
Edo ard o Celoria
Fronte russo, 17-27 gennaio 1943
Giov anni Magn e r
XXC. A
C. G . FF. AA. Sic il ia
cp. telegrafisti (VI C. A.)
cp. mista t. e r. t. (D iv. "Julia")
132a cp.mista g. (Div. "Arie te ")
Sidi Rezeghn (Africa Settentrionale), 30 novembre 1941
Mario Tacconi
Altipiani Aruss i (Africa O ri e n ta le ), 8 april e 1941
Sante Nardini
Spala to-S ig no ( Da lma z ia), 8-30s enembre 1913
Pie tro E. Pe llegrino
Spa la to-S ig no (Da lmaz ia) , 8-30 s e tte mbre 1913
Mario Righini
cp. r t. della Somalia
50a cp. telegrafisti
125a cp. ma rconis ti Comando Div. "Savona"
Bir Ghirab -Ha lfaya (Afr ica Sett.), 17 nov em b re -13 dic e mb re 1941
Sottotenente cpl.
Sottotenente cpl.
Sottorenente cpl.
Sottote n e nte cp l.
Umb erto Milanese XII Brigata coloniale Garb el Gasc (Cassala), 30 luglio 1940
Antonio Occhiochiuso 233 cp. mista t. e r. t. (Div. "Fcrrar-.1.")
Val Drino (fro nte Greco), 16 aprile 1941
Carlo Onofri 973 cp. telegrafìsti (VT C. A.)
Uglaine (Croazia), 11 ma rzo 1942
Mario Paraggio 53 2 cp . m ista t. e r. t. (Div. "Arezzo")
Pojani (Alba ni a), 20 febb raio 1943
Carlo Berruti 18a c p mis ta t. e r. t. (D iv. "Mess ina")
Obzovlca ( Ba lc ania) , 13 lug lio 1941
Caporalmaggiore Camillo Biglioli 1043 cp marconisti (VIII C A. )
Bregu Scialesit ( Fronte grec o), 2 febbraio 1941
Geniere Nello Biliotti 13F cp collegamenti (Div. "Centauro")
Tunisia (Africa Settentrionale), 21-28 marzo 1943
Geniere Giuseppe Francia sa cp. mista l. e r. l. (D iv "Cosseria")
Mentone (Alpi Occidentali), 22 giugno 1940
Geniere Alfonso Mangini officina co ll egamenti (X C. A.)
Zona Operazioni (Africa Sette ntriona le), 18 novem bre 1941
Geniere Adolfo Montangero l x rg L g settore operativo "I3ard o n ecc hi a" Co ll e di Valle Srrena, 21 gi ug no 1940
Geniere Giuseppe Petix sacp. mista t. e r. r-. (Div. "Cosseria")
I Colletti (Alpi Occidentali), 22 g iu g no 1940
Geniere Silvio Pollo so raggmppamento genio (Annir)
Kantemirowka ( Russia), 19 dicembre 1942
Geniere Giuseppe Rabughino 33a cp. mjsta t c r. t (Div. "Acqui")

Maison -Meanne (Alpi O ccide ntali) , 21 giugno 1940
Le Medaglie di Bronzo Al V. M. "Alla Memoria "
la Gue rra Mondiale
(1915-1918)
Soldato
Soldato
Pietro Angelini Larghetti 3° rgt g. te legrafist i (23a cp. t.)
Sagrado-Castt:lnuo vo, 18 o ttobre-7 novembre 1915
Mario Di Carlo 3° rgt. g tdegrafisti o sa cp. t.) Alture di Polaz7.0, 29 ottobre 1915
Guerra !taio-Etiopica (1935 -1 936)
Sergente
Sergente
Caporale
Solda to
Duilio Noverino
Dembeguin , 15 dicembre 193S
Gruppo Bande dell'Altopiano (Sez. R T.)
Guido Sandri 19a cp. tr. (D iv. "Gavinana ")
Selaclacà (Africa Orientale), 29 febbr'c1io 1936
Romeo Fortin 24a cp. tr. ( Di v. "Gran Sasso")
Selaclacà (Africa Orienta le), 2 marzo 1936
Duilio Cozzoli cp. tr. (D iv "Gavinana")
Selaclacà (Africa Orienra le), 29 fehbraio 1936
Soldato
Comunardo Tozzini c p. tr. (D iv "Gavinana")

Sdadacà (Africa Orientale), 29 febbraio 1936
2' Guerra fiifondiale (1940-1943)
Car itano
Teneme
Adriano Fidora En fi davil le (Tunis ia), 12 maggio 1943 119a cp marcon is ti (lA A. )
Paolo Diamantini 37a cp. mista t e r. t. (Div."Modena") Kurve le sh (G rec ia), 12 di cembre 1940- 27genna io 1941
Teneme Carlo Benveduti 47a cp. mista t. e r. t. (Div "Bari")
Klis ura-Premet i-Po nte Pe rati (Fron te greco) , 16-22 aprile 1941
So ttotenente
Sottotenente
S<.:rge n te m aggio re
Se rge n te
Sergente
Efisio Alba LXV btg collegamenti (XXIC. A.)
Africa Settentrionale, 24 novembre 1941
Gaetano Celestino XXI b tg collegamenti di C A. Sidi el Bana ni, 20 settembre 1940
Antonio Vecciù Stazione radio d i Gobbà Sella Ricciò (Africa Orientale), 8 a prile 1941
Antonio Bruni Marmarica, 29 novem bre 1941
Cesare Ramorino
cp. marcon is ti cp mista t. e r. t. (Div. "Savona") Africa Settentrionale, 17 nov emb re - 16 dicembre 1941
Capora l maggiore Aniello .Amadei cp. marconisti(Vl!I C. A.)
F ronte greco -albanese, dicembre 1940 -marzo 1941
Capo ra l maggio re
Capo ral maggiore
Capo ra l maggiore
Carora l maggiore
Caroral maggiore
Caporal magg io re
Alberto Bianchi 114a cp. mista t. e r t. (D iv. "Cuneense") Zo na d i Va lniki (Fronte russo), 27 1943
Eusebio Candussi Marmarica, 29 novembre 194 1 cp. marconisti
Ugo Graglia 193c p. teleradio(Div. "Venezia ")
M. Rresc he niku t (Fronte g reco), 30 marzo 1941
Giovanni Malatesta 134a cp m a rconist i El Mechili ( Africa Sette n trionale) , 15 gi ugn o 1941
Vasco Secchioni 1523 cp mista t. e r. t CDiv. "Macerata")
M. Lesnica (Bakania), 2 ottobre 1941
Guido Verdi Catania (Sici lia), 8 lu g lio 1943
Comando difesa porto "E" Catania
Capo ra le
Ge n iere se
Ge n iere a lp.
Ge n iere
Ge n iere alp
Ge ni ere a lp
Gen ie re
Gen ie re
Gen ie re
Gen ie re
Giusepp e Tonsi
Ma nnarica, 29 nove m br e 1941
cp ma rc o n is ti
Gia con10 Viviani m is ta t. e r t ( D iv "Cu ne o")
Mes si me ri t ( Fronte greco) , 8 fe b braio 19 4 1
Natale Basso 114' cp. mis ta t. e r t (Div ' Cun<::ens e")
Va ln ik i ( Fron te 26 gen na .i o 19 43
Mario Clerici 36a c p . mis ta t e r. t. ( Div. "fo r lì ")
Va ll e sh k um bi ni (F ronte g reco), 4 ap r il e 19 41
Federico Cognassi 114a cp mis ta L e r. L ( Di v. "Cunee nse")
Va ln ik i ( Frome russo) , 27 gen na io 194 3
Pietro Ferrero 114a cp. t. e r. L (Div "Cunee nse")
Va lni k i ( Frome r us so ), 27 gen na io 194 3
Giuseppe Grassi 2" cp m ista t. e r. t. (D iv "Sforze sca ")
Se tt o r e Mong in evro (Claviere), 24 gi ug no 1940

Quinto Pallicchi
Resa nov ici (llalca nia), 16 se ttembr e 19 41 III b tg . te le grafis ti A )
Rolando Parigi 19'1 cp mista t. e r. t. (Div. "Ve ne zia·') M lvanit-Vogel ( fronte Greco) , 14 -17 n ovembr e J9 40
Domenico Pistola cp marconisti O M (raggntppamento !Vlaletti) Ga b re Sa le h (Africa Orie n tale) , 11 s e t te mb n: 1940
Le Croci di Guerra al V. M. "A lla J\1emori a"
2
1 Gu erra
JV!ondiale ( 19 4 0 - 1943)
Se rge nte magg io re Antonio Greco :Xv b tg m isw g en io c p m a rc o nis l:i Scele id ina (Africa Se tte n trionale) , 28 g enna io 1942
Ca pora l maggiore Andrea Barilari 27! cp co llegame nti ( Div ' 'B re;:s c ia" )
Deir e l An g ar ( Africa Se tte n tr iona le) , 4 s e;: tte mb re 1942
Ca po ra l magg io re
Capo ra le
Ca pora le
Giuse ppe Zordan
Fro n te;: russ o , 5-25 ge nn a io 19 43
Gi useppe Battilocchi
113" cp mis ta t. e r. L ( Di v "J uli a ")
36a cp. m is ta t. e r L ( Div "Fo rlì ")
Co ll e d el le Mu ni e , 22 g iu gno 1940
Michele Corniola
47a c;p. mi sta t. e r. L ( D iv "Ba ri ")
Bagn i di kuk es (Fro me g reco) , 13 novem bre 1940
Caporale
Caporale
Capora le
Geniere se
Geniere se.
Geniere se.
Geniere
Geniere
Geniere
Geniere alp.
Geniere alp.
Geniere
Geniere
Geniere
Geniere
Geniere
Pietro Gerace 102a cp . marconis ti (C.S.I.R.)
Nikolajewka ( Fronte rus so), 20 febbra io 1942
Gaetano Gianmatteo 111a cp. misca L e r. t (D iv. "Taurinense")
Ovci Dò (Montenegro) , 6 ottobre 1943
Costanzo Manentl XI lxg. marconisti di A Africa Settentrionale, 13 dicembre 1941
Luigi Bresso 2a cp. mista t. e r. t. (Div. "Sforzesca")
Casciti (Fronte greco), 13-23 febbraio 1941
Gaetano Capozzi
Nik o laj ewka (F ronte russo) 20 febbraio 194 2 102/\ cp. marconisti (C.S.I.R.)
Francesco Russo cp. marconisti (C.S.LR.)
Nikolajewka ( Fronte russo) , 29-30 settembre 1941
Glauco Argenti cp marconisti (III C. A.)
Grecia (posto di guardia nx 35), 25 novemb re 1942
Feliciano Assandri cp. mista t. e r. t. (Div. "Torino")
Ka menka (Fronte russo), 27-28 settembre 1942
Luigi Calciati 7a cp mis ta t. e r. t. (Div. "Lup i d i Toscana")
Monte Groppa (Fronte greco) , 30 gennaio 194 1
Giuseppe Giordana 122a cp. telegrafisti (C. A. Alpino)
Erseke ( Fro n te greco) , 21 aprile 1941
Silvio Giorgetti ll P cp. mista t. e r t (D iv. "Taurinense")
Ovci Dò (Montenegro) , 6 ottobre 1943
Rino Guberni 127a c p marconisti Marmarica (Africa Settentrionale) , 29 novembre 194 1
Pietro Manera 97a cp marconisti (Ill C. A.)
Grecia ( posto di guardia nx 35) , 25 novembre 1942
Noè Manzotti ssa cp mista t e r. L (Div. ''Le gnano")
Dragoti (Fronte greco) , 26 marzo 1941
Alessandro Molino Colle delle Munie, 22 giugno 1940 36a cp. mista t. e r. t. (Div. "Forlì")
Mario Motta 52a cp. mista t e r. t. (Div "Torino")
Kamenka (Fronte ru sso, 27-28 sene mbre 1942
Ge niere Vincenzo Pietrantuono 17a cp. collegamemi (Div. "Pavia")
Q. 182 a Sud d i El Aden (Africa Senentrionale), 7 dicembre 1941



Handiera Na.z:iouale delia Presidenza Vozlonale. Dime11 shm i reali cm.
Costituzione
L'i\NCF.T (L'Associazione Nazionale G·enieri e T rasmell i tori d'llali<t) lutti co l oro che h<tnno prestato o prcsl<tno se rvizio presso Scuole, Uffic i o Stai.J i lit nCt tti \lilir:tri del c delle Trasmissioni. Possono iscriversi all'Associazione :mc he i parenti (genitori, figli , mogli, fratelli e sorelle) dei Genieri e elci. Trasmcuitori, nonché evemu;tli simpatizz:tnli.
L'associaz i one lw le seguenli firw lit:'t:
- r ico rda re ç:cl onora re i Caduti dci Ccnio e d elle Trasmissioni e gli uomini. che hanno dato l ustro all'Arma;
- custodire la d ei suo i decor:Hi ; ti Valore :'vli litarc:
- rn:lntcncrc c sv iluppare i vincoli di fratellan za e sol i darietò fra i propri sia in servizio sia i n congedo.
L ANGET < .t poi iti ca.
Origine ed evoluzione
1919 Nasce la " Associazione di m utu<t so lidaricri'i r·ra i rcdttci del C.enio" I combaucnt.i della (;randc CttCtT<l. afTrarc l lmi dalle vicissitudini di un così lungo conf-litto. vo ll e ro rivedersi ricordare gli episodi ed il Lernpo rrascorso in trincea è :-;osten ersi ne i giorni assa i amari del dopoguerra.
1922 si rraskmna in ·' i\ssoc ia z ione :'\azionale dell'Arnw clcJ Ccnio - la S.Barbara'' (ANAG)
19Yi le Associazioni d Anrw prendono i l nome di rcggimcnri, per so ttoline:t re la conrinuitù ciel p rcsta ro dal cittadino alla Patria, sia d<t sia da congedato. Quella d el Genio assume la eli " Reggimento Genio ,\la r io J'iorc··.

]<)5 ?> li 25 Novembre v i ene configurata giuridicamente la Naz ional e dei Genieri e dei Trasmettitori d 'll<Jli<l', la cui pe rs onalità giuridica verd poi riconosciuta con DPI·L- del 18 Ciugno 1954 , n. 700.
Orclìnarnento
L'Associazione, q twl e oggi cd opera, si riCà allo Statuto del 198,1, nel quale sono sm hiliri i rini sociali, l';unmissibilit{t e le categorie di soci, gli organi sociali e le regole di vita. Esso è integrato nel relativo n::gol.antcnro, della stessa epoca.
L'Associazion e comprende organi centrali e periferici. So n o organi centrali la Presidenza :'\azionale ed il collegio dei Probiviri. La Presidenza Nazionale provvede a tutto quanto si riferisce alla associazione nel suo complesso; mamiene i collegamemi con le autorità centrali e coordina l'attività delle sezioni per il tramite dei Delegati Regionali; promuove manifestazioni nazionali e locali; pubblica un notiziario petiodico a carattere nazionale (denom in atO ANGET); tiene lo schedario dei soci; dich iara disciolti di propria iniziativa i Consig li di che siano in co rsi in gravi infrazioni o inadempienze ai fini morali.
La Presidenza Nazion ale è così cos ti tuita:
- Presidente Na7.ionale, che rap pres enta l' Associ a z ione a tutti gli effetti: mo ra li , lega li ed amministrat ivi;
- du e Vice Presidenti Naz iona li , ch e coadiuvano il Presidente iaziona le o c he, in caso di indispon ibilità , lo sost ituisco no e lo rapprese ntano;
- un Segretario Generale, che ha la direzione e la resp o n sabilità de ll a Segreteria Genera le, cura la custodia degli atti , traduce in atto le delibere, etc.
- un Vice Segretario c he provvede alla tenuta della contab il ità dei beni della Associazione e compila il bilancio annuale della Presidenza Nazionale n Collegi o Nazionale dei Probiviri è un organo consultivo ed è nominato dal Consiglio Nazionale ; esso è composto da un Presidente, due membri effettivi ed un supplente, scelti tra le personalità residenti in Roma, che siano soci ma non r icoprano cariche in seno all 'Associazione. Esso è chiamato ad esprimere pareri in caso di comroversie tra i soci o tra questi e gli organi sociali. I noltre la politica del Sodalizio e le linee generali della gestione amministrativa e delle procedure di attività generale sono determinate da l Consiglio Nazionale , che è organo consultivo e de li berativo dell ' Associazione per le questio ni c he interessano la vira associativa nell 'a mbito nazionale.
Esso è p resieduto dal Preside nte Nazionale che lo convoca almeno una vo lta l'a nn o. Le de c isioni de l Co nsiglio Nazionale, verbalizzate, sono tras c ritt e in apposito registro firmaw dal Pres ide nte Naz iona le e dal Segreta rio Generale.
Ogni tre ann i s i riunis ce l 'Assemblea dei Delegati Regionali c h e h a il comp ito di e legge r e i membr i deg li organi centrali (Pre s id e nt e e Vic e P res identi Naziona li e m embr i del Collegio Nazionale dei Probiviri).
Sono Organi Periferici: le Delegazioni Regionali , le Sezioni, i Gruppi e le Specialità.
I D e l egati Region a li , agendo in conformità a lle dirett ive della Presidenza Nazionale, coordinano l'attività delle sezioni, ne promuovono lo sviluppo, ne favoriscono i reciproci legami ed esercitano su di esse funzioni ispettive e di controllo, con particolare r iguardo al tesserc1menro ed alla partecipazione a manifestazioni ufficiali di rilievo. Le delegazioni sono 17.
Le sez ioni ANGET s i possono costituire nelle località dove esistono almeno 25 soci. Esse sono rette da un Consiglio Direttivo c he prende le decisioni per la vita e lo sviluppo della Sezione e per la defin iz ione delle attività di rappresentanza e partecipazione a manifestazioni, nonché per le atti vi t à promoz iona li.
A questi consigli sono affiancati i Collegi dei Sindaci ch e h anno il compito di controllare la corretta tenuta dei registri e de i conti.

Il numero de ll e è variabile intorno ad u n a media di 180.
Vi sono poi le Sezioni Autonome di Tri este , Melbourne e New York. ·
I Gruppi di Sp ecialità so n o nazionali (attualmente in numero di quatt ro :
Cartolin e regg im en tali edite in occasione di ra dun i nazionali.
G uastatori, Ponrie r i, Ferrovie r i e Radioperarori) e settoriali, (attualmente in numero di 2: Radiomolini , 3° Corso AUC). Quest'ultima denominazione indica q uei Gm ppi che investono un territo rio ridotto, oppure raggruppano soci appartenenti a d una spec ia li tà o ad u n a attività limitata.
Attività svolta
Opera meriroria è s ta ta svo lt a nel temp o dall 'Associa zione soprattutto neg li anni '50 e ' 60 a soste g n o d e i Soci c h e a l te rmine del servizio milita re obbli g atori o dovevano inserirsi n e l mond o d e l lavoro T ale op e ra si è concretizzata:
- nel sostenere il ril ascio di br e ve tti di s pecia li zzazio ne al personale qualificatos i attraverso i vari co rsi svo lti presso Enti Addestrativi o Reparti;
- nel promuove re il ri co n osc imen to legale di tali brevetti da parte del Minis te ro del Lavoro;
- nell 'agevol a re l' a vvi ame nto a l lavoro dei G enie ri e Trasmettitori co n geda ti che av ev an o acq ui s it o tito lo di qua lificaz io ne professionale duran te il se rviz io militare.
L'Asso ciazione è ogg i pa rt icolarmente attiva nel prom u overe una sempre maggiore e qual ificata partecipazione alle attività d i Prote z ione Civile, con parricola re atte n z io ne p e r q u anto più strenamente attiene alle conoscenze tecniche dei Gen ieri e dei Trasmettitori:

- comunicazioni d i emergenza
- rimo z io n e macerie
- sa lvatagg io intrappo lati da sisma
- aniv ità antincendi o,
- costruzione te nd e e baracc h e,
- potabili zzazion e,
- mon itoraggio aree b osch ive.
( radiop erato ri), (gru, escavator i), (m ic rofo ni, microte lecamcrc)
ASSOCIAZIONE NAZIDNALE GENIERt E TRASMETTITORI D'ITALIA
Per tenere unito lo spùito eli cotpo e legare tra loro le vecchie e le nuove ge neraz ion i l'Associazione prende pa1te attiva alle cerùnonie e manifestazioni dei reparti del Genio e de lle Trasmissioni nelle va rie loca lità di Italia in cui è presente con le prop rie Sezioni. Partico lare importanza assumono le celebrazion i seguenti:
24 Giugno: Festa dell'An na de l Genio e delle Trasmissioni; Pr ima Domenica dopo 1'8 sette mbr e : Anniversario del sacrif i c i o de l S.T e n Ettore Rosso ( M O.V.M. ) dei 4 genieri (M. d'A V. M.) e di due cavalleggeri- cerimonia in Monterosi (Viterbo);
29 Settembre: Celebrazione eli S .Gabriele - Patro n o delle
4 Dicembre: Trasmission i; Cele brazione eli S Barbara - Patrona d e l Genio, Artiglieria , Marina e Vigili de l Fuoco .
Piace chiudere citando due particolari iniziative in atto:
- la r icostruzione, in parole e musica, dell'Inno del Genio , realizzato nel 1941 da un compositore rimasto ignoto;
- la ricostruzione eli una chiesetta edificata dai prigionieri di gue rra a ll eati della 2" Guerra Mondiale in Premariacco (Udine).
Vessilli - simbo li - elementi distintivi - ricompense

Vessilli
La Presidenza Nazionale custodisce il Medagliere dell'Associazione che si fregia d i tutte le decorazio n i a l Va lor Mil.itare ed al Valor Civile concesse all 'Arma de l Genio e de lle Trasmissioni ed ai rispett ivi Repmt i, nonché , quelle individuali delle quali
Cartolina edita in occasione del/XI Raduno ANGHT de/1982FUSA Editrice - Roma.
lU RMlUNO 1'\l"llONALE ANGET CASTELMAGGIOf=IE BOLOGNA 1t • '12 SElTEMBRE 1882)tendardo dell'Associazione Ge'Zieri e Trasmettitor'i d'Italia.
:n basso: )temma ctraldico dell'Associa?:ione Genieri e Trctsmettitori i1ta/ia.
sono stati insigniti i militari di tutti i gradi, sia del Genio sia delle Trasmissioni. Attualmente sono appuntate su l medagliere le seguenti decorazioni:
-Cavaliere dell 'Ordine Milimre di Savoia - 1935/ 1936 - alla Bandiera ;
- Medaglia d'O ro al V.M. - 1915/ 1918- alla Bandiera;
- Me d aglia d ' O ro al Valore dell'Esercito alla Bandiera;
-Medaglia d'Oro di Benemerenza - 28/12/1908 - al la Band ier a;
- Me d ag lia d'A rge nt o - 1911/1912 -,alla Band ie ra;
- Medaglia d 'Arge n lO a l Va lo re clell 'Eserciro - 1953/1993 - alla Band iera;
- Medagli a d 'Arge n to a l V.M . - 1942 - a l XXXI btg . Gua s tatori;
- Me d aglia d'Argento a l V. M - 1942- a l XXVII btg. Arrie ri ;
- Meda glia d 'Arge nto a l V.M. - 1941/1912 - a l l X b tg de l I Rgt. Po n tie ri;
- Me d aglia d 'Arg e nto al V. M. - 1942/1943 - a l IV bt g mis to Gen io d e ll a Di v "Cu neese";
- Me d aglia d 'Arge n to a l V.M . - 1911/1942 - al l btg. del 2° rg r. P onrie ri ;
- Medag lia d ' Ar ge n to a l V.M. - 1942 / 1943 - bt g. misto G e n io d e lla Pi v ''Tride nt ina ";
-lvl edaglia d 'Arge nto a l VM. - 1942/1943 - a l 3° btg . m isto Genio de ll a Div. "Julia";
- Med aglia d'Argento al V.M. - 1943/ 1915 - al LI btg. misto Genio della Div. "Legnano";
- Medaglia d 'Argento al Y.C. - 1951 - 2° rgt. Pontieri;
-Me daglia d 'Argento al V.C. - 1963 - 2° rgt Pontieri;
- 16 Medaglie el i Bronzo al Y.M;
- 3 Croci d i Guerra al V.M. concesse alla Bandiera dell'A rma o Repatti. Il me dag li ere si fregia ino ltre delle seguenti decoraz io n i concesse individualmen te a milita ri d e ll 'Arma:
- ì\. 76 Med agli e d'Oro al Y.M;
- N 2079 Me d aglie d 'A rge n to a l V.M;
- N. 4659 Me dag li e di Bronzo al Y.M;
- N. 3555 Croci d i Gu e rra a l V. M
Note: con d e term in az io n e ass un t a ne l corso d e ll a Se ssi o n e O r d in a ri a d e l Co n s iglio Naz io n a le , tenut as i a Fogg ia il 16 Ap ril e 1994 , le sudde tte decoraz io n i indiv idu ali ve rra n no trasfe ri te a i Meclag li e ri d e ll e Del egaz io ni Reg io n a li in r elaz ione al luogo di n as ci ta d e i d eco r ati.
Le Delegazioni Regio n ali verr anno p e rta nto a dotarsi di Me d a glie t·e Regionale, simile a que llo Naz io n ale
Sim boli
L'Associazione dispone di un ·'Crest", rappresentativo del sodalizio. Esso è composto da un suppotto di legno a forma eli scudo, sul quale sono fissati , in materia le bronzeo , il distintivo deii'ANGET, l'elmo della Minerva (Oca della Sapienza), la denominazione dell'Associazione ed il motto : ingenium jun ioribus rrade re"

Elementi Distinti vi
I so ci so n o dor ati, p e r l'app licazione a ll 'occhie ll o della giacca , di un di s ti nt iv o. É previsto inoltre c he , in occas ioni d i ma nife s ta z ion i so ciali, i s oc i in doss in o:
- il b asco n e ro co n tì·eg io;
- la crav atta socia le, a st risce ob liq u e di co lore azz urro ed ama ra nt o con sc u-
detto de ll 'ANGET in oro;
- il sovra-co He tt o di pann o nero, bord at o di azzurro e eli ama ra nto con d u e scudetti d e ll'ANGET in o ro.
Ricompense A1VGET
a) Targa Al'\GET
É u n riconoscimento che la Presidenza Na ziona le conferisce a:
- Ente o personalità militare o civi le che abbia opera to a favore dell'Associazione o le abbia proc ura to onore o prestigio;

- re parti del Genio e de ll e Trasmiss io ni che s i s ia n o di s tint i ne l campo add estrativo, o p e rativo o soc ia le o ch e abbi ano s vo lt o pa rtico lar e a ttivi tà in favore d e l! 'Assoc iaz io ne;
- o rga ni de ll 'Associazione che si s iano d is tin ti n ell 'op e ra di prose litis m o.
b) Ricompense ANGET
Sono medaglie d'oro, d ' argenro e di bronz o e vengo n o concesse dalla Presidenza Naz io nale , al meri to, a quei soci che, nello s piri to delle finalità associarive , s i s ia no res i au to ri di azioni o iniziative d e gne di p artico la re apprezzamento. Una me daglia di bronzo vien e inoltre co n cessa a quei soc i che sia n o s ta ti isc ritti p er lungo tem po , dimo s trand o inint e rr o t to a tta ccamento a l Sodalizio.
Noti z ia rio
Il pr im o notiziario dell 'Associazione ve nne pubbli cato il 24 maggio 1931 con il t it olo "La Sa nta Barbara ". Esso cessò la pubblicazione il 31 dicembre 1934. Sappiamo dell'esistenza di u n Bollettino d'Informaz ione nel periodo in cui l 'Associaz io ne ass uns e la denominazione di "Reggim e nto Genio Mar io F iore " ( 1934-19 43).
Il 4 dicemb re 1959 v id e la luce il pe riodico "Jl Ge ni e re". Da l l o aprile la tes ta ta assun se il nome di "ANGET" rima s to ta le fino ai nostri giorni. Attua lme nte la riv is ta "ANGET'' viene stam pata in 9 num e ri annui d i circa 13.000 co pie ciascu n o, rip orta le attività dei re parti del Geni o e delle Trasmissioni , sia in It alia sia all'estero, ed ha varie rubriche riguardanti la v it a associativa.


Proiezione o11ogonale J"Cfffigurante l'edijìcio ove è ubicato l'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio.
Museo s to rico dell'Arn1a del Genio

P iù eli un secolo fa un illustre ufficiale del Genio conc ep iva l' id ea el i tog li ere Castel S Angelo dall 'umi le funzion e d i case r ma, di a ll ogg i e, peggi o an co ra, d i carcere , c ui da tempo era adibito , e di riconferirg li que ll a sontuos irà che aveva raggiunta so tto i Pap i artis ti e fastosi de l 1500. Il vecchio e g lo ri oso mon u mento, riporta to così a nuova v ita , av rebbe do vu to essere d es tin a ro a mu seo de lle armi, alloggiandovi un prezioso m a teri ale che g iaceva incassato n e ll 'Arse n a le eli Tor ino.
Q u ell'Uffic ia le era l'allora Co lonn e ll o Luigi D u rane! d e la P e n ne, che ass u rse poi ai più al ti gradi dell'Esercito e fu Is pe tto re de ll 'Ar ma. Eg li sce lse corn e s u o co llaborato re, per tradurre in atto qu es to s uo nob ile propos ito , co lui c h e do vev a diventare il restauratore impareggiab il e e lo sto r ico ins igne d e l monu mento s Lesso , cioè Mariano Borgatti, che in q u el tempo e ra Capitano de l Gen io.
Ma, per c aus e var ie, non s i pot é allora fa re che qua lc h e s tudio e qua lc he assaggio, né si fece pi ù nulla poi per a ltr i qua tto rdi c i ann i ci rca; f u s o lo ne l 190 l che l' id e ato re del progetto ed. il suo coll a boratore , avendo persis tit o con costan za e con fede ne i loro propositi , poterono , con l'aiuto d e i Ministeri d ella G uerra e della Pubblica Istruzione, ottenere fi na lmen te il com pl e to sgo mb e ro d e l monumento da ogni eterog ene a o cc up az ion e e mett e re mano a i non pochi né fac ili
la vor i di resta uro e d i adat tamento, dopo aver superato g rav i d iffico ltà , forti opp os izion i e ta nte diffidenze ed apati e.
Ne l tì·attempo p e rò il muni cip io eli Torino av ev a ri attato il Ma sch io della cittad e ll a c s is te mato in essa qu el mate ri a le c he si vo leva raccog li e re in Caste l S. Angelo. Svan ita così la possibilità di a truazionc del progettato museo d e ll e armi, fu stabi li to di crea re a l suo posto un "museo dell'ingegneria militare italiana ", che avrebbe trovaro sede veramente degna in un monumemo dove nel corso di più secoli avevano lavorato insignì ingegneri militari, come Nicolò Di Pietro, Lamberti di Arezzo, Anton io da Todi, il Rossellin o, Baccio Ponte lli, il Taccola, Anto ni o da Sanga ll o i l giovane, il P e ru zzi , Michelange lo , il Castrioto, Ca millo Orsini , il Laparclh, Ga brio Serbclloni , l'Al ess i, il Pac iotto, il Macul ano, il 13uratti, il De Rossi ed a ltri a n co ra.
Co min c iò nel 1902 ad aftlu ire in Cas tel S Angelo da ogni parre d'Italia materiale vari o del Ge nio , nonch é mode lli, p las ti ci, disegni , stamp e c rappresentazioni grafiche eli fortifìcazioni e el i o p e re milirari, che si anelavano man mano o rdinando n ei vari locali a misura che erano pronti. Dopo c inque anni di indefesso e geniale lavoro sono la direzione del Colonnello 13orgatti tutto era pronto cd il 13 febbraio del 1906, alla presenza di S.M., il Re, il museo dell 'ingegneria militare italiana ven iva so le n neme nte in augurato. In questa occas ione S.M. al museo un Suo busto .
So rgeva cos ì in Rom a il primo museo militare.
Ne l res ta1..1 rato monumento, ecce tto i so tt e rranei , i loca li priv i di luce e q u elli d e l "co rtile delle pa ll e" adi bit i a museo de ll a storia d e l cas te ll o , tutti gli altri ambie nti rurono occupa ti dal museo de ll 'ingegne ria militare it a li a n a, suddiviso ne i seg ue nti se i g ru pp i :
1° Grup p o : Cimeli , ri tratti e busti; s to ria della fortificazione italia na ; fortificazione di città; attacco e difesa, mine.
2° Gruppo: Lavo ri del Genio per la marina.
3° Gruppo: Attigli er ia; il Genio in Ctimea nella guerra di ind ipendenza; fortificazione campale; macchine; fmti da campo; co lombaie militari.
4° Grup po: Biblioteca; man osc ritti; d ise gni di costruzi oni e eli forti ficazione.

5° Gr uppo : Fot og rafie; tel eg rafia e le ttrica.
6° G ru p po: Storia de ll a tel eg rafia ottica; m ateria le d a ponte e dei lagunari; materi ale ferr ov ia ri o; aeronautica. Grande fu l' interess e des ta to da l museo , c h e ill u strava le att ività e le benemerenze dell'Arma del Geni o e meneva in evidenza il grande apporre, spesso ignorato, dato dagli italiani ag li stu di di architettura militare. S.M. il Re lo o norò di Sue vis ite il 14 gennaio 1907 e poi il 13 ap ri le ed il 3 l uglio del 1909; il pubblico vi affluì numeroso e ben pres to dive nne ragione di orgog li o per l'Arma del Geni o, influ e nd o favo r e volmente su l s u o sp irito di Corpo. Circa t re a nni dopo anche i Be rsag li e ri avev ano il loro mu seo e stlccessivamente, come è noto, lo ebb e ro anch e i Gra natieri, i Carabini er i e d i Fi nanzieri s ull' esempio di quanto a ve va fatto l'Anna d e l Genio. Preparand osi, poi, p e r l'an n o 1911 gra ndi mostre d'a r te p er sol e nn izza re in Roma il cin quantes im o ann iversa ri o d ella s ua proclamazione a capitale d ' Italia e volendo si destinare il Maschio di Castel S. An gelo a sede di mostre retrospettive, fu presa la determinazio ne di trasferi re il museo in alcuni fabbrica ti detti Casermette eli Urbano VTTT, situati entro la cin ta pentagonale bastionata di Castel $.Angelo. Questo trasferime nto fu molto pro vvidenziale, perché ne l fra ttempo il m use o aveva avuto uno svil uppo così grande da no n poter più e ssere contenuto n e lle sale di prima d es tinazione .
In tale occas io ne esso assuns e la nuova denominazi one d i "Museo Storico del Geni o militare" e la s ua esist enza fu ufficialme nte ric onosciuta da l R.D. 5 fe bbraio
Il Re del Belgio e il Re d'Italia visitano il Museo del Genio GO mm·zo 1922).
1911 (Circolare N. 53, dispensa 6 del G .M. U del 1911). Con decreto ministeriale 24 agosto 1913 venne successivamente approvato lo Statuto del museo storico del Genio Militare ed il suo regolamento interno.

La sistemazione dei nuovi locali, avvenuta sotto la sapiente, vigile opera dell'allora Colonnello Mariano Borgatti, direttore del museo, fu all'incirca analoga a quella di Castel S.Angelo, ma con una più appropriata disposizione delle suppellettili, con notevoli aumenti nel modellario della storia della fortificazione italiana, nelle ricos truzioni e nell e memorie storiche e con l'aggiunta eli un archivio contenente documenti storici dell'Arma e documenti del vecch io comitato eli artiglieria e genio.
Il museo, in questa sua nuova sistemazione, fu solennemente inaugurato il 13 febbraio 1911 da S.M. il Re.
In questa sede più ampia e più adatta, che S.M. il Re visitò ancora il giomo 28 eli quello stesso mese, il museo ebbe l'onore di vedere nelle sue sale anche S.M. la Regina Madre e i P1incipi di Casa Reale e poté continuare acl arricchirsi sempre di più. Ma un incremento veramente notevole ebbe luogo dopo la grande guerra del 1915-18.
Con l'autorizzazione del Ministero della Guerra e grazie all'attivo interessamento della direzione del museo, nonché di reparti e di Enti dell'Arma, affluirono in vari tempi a Roma molti materiali tecnici ed armi di preda bellica; modelli, plastici, fotografie, disegni e grafici relativi alle varie att ività dei reparti e delle specialità dell'Arma durante la grande guerra.
Fra i principali materiali tecnici e bellici austro-ungarici erano proiettori, periscopi, lanciafiamme, bombol e e maschere per gas asfissianti, apparecchi fumogeni, torpedini, bombe a mano, mazze ferrate, mitragliatrici, bombe d'aeroplano, scudetti, ecc.; un motocompressore; la centrale telefonica del maresciallo Von Conrad (presa a Gries presso Bolzano); v arie stazioni telefoniche e telegrafiche, ecc.
La direzione del museo dal canto suo provvide a far riprodurre carte topografiche parziali con organizzazioni difen sive e collegamenti, diagrammi dello sviluppo dei se1vizi del Genio, nonché modelli e plastici su dati sicuri e precisi.
Fra le opere direttamente eseguite dal museo so no principalmente da segnalare una grande carta murale del teatro della guerra del 1915-18 con le sistemazioni difensive alla scala di 1 a 25.000 e la rappresentazione al vero dell'organizzazione tecnica di una trincea.
Contemporaneamente fu riordinato l'archivio storico dell'Arma, furono iniziate raccolte di dati biografici e di altre notizie occorrenti per la istituzione di schedari d'onore per i caduti ed i decorati, e fu provveduto alla raccolta di ricordi e cimeli dei valorosi che avevanq. lasciato la vita sul campo, onde il museo potesse diventare anche il custode delle glorie dell'Arma.
La raccolta e la sistemazione di tuno q u esto materiale non fu cosa facile , né semplice ; occorsero circa due anni di tempo e l'aggiunta di nuovi fabbricati.
Il 13 febbrai o del 1920 S.M. il Re, accom p agn ato dal Generale Diaz e dal Ouca Del Mare Tahon di Revel , inaugurava il grandioso ampliamento.
Il museo fu da allora in poi onorato da molte visite d i P rincipi e Sovrani. S.M. vi ritornò ancora pochi giorni dopo la inaugurazione e s u ccessivamente v i si recarono a nche le Altezze Reali Jolanda, Ma fal da e U mb e rto O i Savo ia. l.l 15 dicembre d i q ue ll o s tesso a n no 1920 il Sov ra n o acc o mpagnato da S. M. il Re di Dan imarca, o nora va a n cora il museo el i u na s ua vis ita e vi ritornav a ancora : il 30 marzo de l 1922, acco mpagnandov i S.M il Re de l Belgio, il 20 nov embre 1925 p e r l'ina u g u razion e del Mo m.1m c n to a i Ca duti d e ll 'Arm a , ed infin e il 24 novembre 1926 p e r l'a rriv o in Cas tel S An ge lo d e ll e b a ndi e re dei disciolti r e ggim e nti
Il mus eo d opo il suo ing ra ndimento andò acquistando sempre magg io re impo rta nza anc h e come museo el i g ue rra, di cui e ra il primo es e mpio in Ita lia; ne furo no aum e nta te le raccolte e fu rego la ri zza to il funzionamento d eg li arc hi vi c degli sch eda ri.
Istituto di Ar c hit e ttura Militare Italian a
Cna imperLante pane dell ' attività del museo fu anche dedica ta in quel tempo al riconoscimento cd alla classifica di numerosiss ime tavole di disegno di opere di fortificazione di fabbricati militari pazientemente raccolti in lunghi anni di attente ricerche. Spcciahnente per il volenteroso ed a p passionato concorso del Generale Leone Andrea Maggiorotti furono indiv iduati, con certosina pazienza, non meno di cinquemila disegni che si riferivano, per la magg ior parte, a l per iodo compreso fra la metà de l sec. XVlll ed il seco lo seguente , m o lti dei qu ali rel ativi a lavori eseguiri da ese rcit i st ran ier i di occupazione.
P e r la sola ci tt à di Alessa n d ri a furono contate du ece n tottantac in q ue carte di c ui un ce nt ina io a lmeno de ll 'epoca napoleonica; a ltri gruppi eli ce ntin a ia el i tavo le furono ricon osc iute co me appa rte n e nti all e città di Piacenza, Peschi e ra, Mantova, Ve ron a, An co n a , Portofe rr a io Quas i tutte queste tavole fl.1rono ri co n osci ute d oc umenti int e ressa nt iss imi , n o n so lo per la tecnica delle fortificazi o ni, eli cu i rapp res e nta no lo svilu p p o d i c ir ca u n sec olo, ma anche n e i rifless i s to r ic i, perc hé, in alcun e eli esse, si riscont ra ro n o pi a ni di assedio o di op e raz io ni el i a t tacco o di difesa di c ittà con particola ri ta lvo lt a s fu gg iti allo storio grafo. l n ques t i document i s i trovano fi rme a utografe d e i più noti ingegneri nost r i ed es teri , come i generali I3arab in o, Pimo, Bordino, Sauli , Ch io d o, O li vcro, Menabrea e , fra i francesi, Chasseloup de l Ge ni o fra n c e s e c he rim odernò le fortezze eli Alessa n dria, Verona , Mantova, Rocca d'Anfo, e altre .
Alcuni disegni di To1tona, P izzighettone, Valenza Exilles, Savona, Serravalle Sctivia si riferiscono anche ad avvenimenti aventi relazione con le guerre combattute tra la metà del 1600 e quella del 1700
Questa pregevolissima raccolta di disegn i costitu iva una ricca e preziosa fonte per lo studio dell'architettura militare, onde il Generale Borga tti , direttore del museo, ed il Gen e rale Maggiorotti ebbero l'idea d i affìda rla ad u n e nte che potesse averne cura e s e rvirsene per far rifiorire in Ita li a lo studio di questo ram o d e lla scie nza mi li tare nel q uale il nostro Paese ebbe sempre il prima to, spesso purtroppo d isconosciuto e la c ui r ivendicazione fu efficace me n te ten ta ta in passato solo dal Promis e da l Rocchi.
Na cqu e così ne l 1927, co n il cons enso e l'aiuto del Ministe ro d e ll e G u e rra c nel seno s tesso d e l mu seo, !"'Is tituto di Architettura Militare Italia n a" ( l. A. M.I .) co n il compi to di ra ccog lie re e va lo ri zz are qua nt o si riferisc e all 'archite ttura mi litare ne i

Veduta d 'iusieme dell'edificio dell'Is tituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio nel 1939. primtt della realizzaz i 011e del L1111p,oteuere della Vittoria.

riguardi sto ri c i cd ar r.i st ic i, tanto bibliograficamc nt c che iconograficam e nt e, allo scopo eli costittlire un d eg no monumento cu ltmale d i questo ramo d i s c icn ;.a c di a ttività dei nostri padr i
L'Istituto fu messo sotto l'egida di un patronato d'onore eli cui facevano p<tt"le il Ministro della Gu e rra e que ll o della Pubbli ca Istruzione del tempo (Gazze ra e Fedele), il Vi ce -Pres idente della Camera On. Acerbo. il Principe Gelasi o Caeta ni ed il Generale Borgatti. La s ua direzione fu affidata al Ge nerale Maggioroni , coadiuvato da un consiglio di direzione fra i cui componenti erano anche note au[Orità nel campo scientifi co, co me il pro f. Giovannoni. Il n uovo Ente ri scosse s u bito lmgo conse nso da part e degli st udiosi; molti cu ltori eli S[Oria e di archeologia furono larg hi di consigli o inviarono loro pubblicazioni e Studi p reg evo li ; fra qu es ti ultimi occo rre rico rdar e : il prof. Giuseppe Gero la, il co nte dott. Riccardo Fi iHngicr i el i Ca nd ida Gonzaga , il pro C Berti n i Ca losso, il prof. Holik 13arabas (U ng he r ia), il Co l. Teno Gyalokay (U ngh e ria) , il prof. G.Q Giglioli , il Te n. Co l. Josè Sans (Spa gna) , l'aw Lou is Philipp oteaux (Francia), Louis Leco nt e ( Belgio).
L'Istituto s i impegna attiva mente a riordinare e classificare tutto il maLeriale già esisteme presso il museo, acl arricchire gli schedar i es istenti ed istituirne dci nuovi. acl acquistare nuovi libri e s tampe , a provvede re alla stampa d ei p e ri od ici ''atti" , che dessero anche co m o della sua vita ed infin e a dare il suo appoggio al lH pubblicazione eli ope re eli a rc hitettura militare, come il magnifico volume d e l Genera le Borgatti : "Cas tel S.Angelo eli 'Roma", edito dal Poligrafico dello Stato , il volumetto: "Po rti , castelli c torr i de l Sa lenti n o " d i P Primaldo Coco, il "B reve dizionario degli a rchitetti militari italiani " del Gen. Maggiorotti e d a ltr e anco ra.
Nel 1929 l'Istituto fo rnì prova della sua attività co n una rius citissima mos tra di architettura militare, ne i loca li di Castel S.Angelo, in a ugurata da S.M. il Re il J2 giugno e rimasta ape1ta fin o a l 15 luglio. Principale es posito re fu l'Istituto stesso con ci rca cinquecento disegni ; espose ro libri , disegni e fotografie anche di versi enti e p r ivati fra cui la R. Sovrainrc ncl e nza a i monumenti dell 'Umb ri a, i Mun icipi eli La Spezia. Savona, Fano e Santo Arcangelo di Romagna ; le Bibliotec he del Re, del Ouca eli Ge nova , lVIarcia na di Ven ezia, Na7.iona le di Firenze, Comuna le di lV!ace rata , O li veriana; il mar
chese Albani, il marchese Guglielmi, il marchese Lucifero ed altri.
Una seconda mostra dedicata a ll 'arte nei castelli, fu inaugurata il 26 aprile d el 1930, restò aperta fino al 10 giugno. Il 16 maggio essa ebbe l'onore di essere visitata dal Sovrano. L'Istituto vi concorse con molto suo materiale, specialmente fotografie e stampe, ma grande fu anche la partecipazione di en ti e di privati fra cui: le Reali. Sovraintendenze di Torino, Trento, delle Marche, di Napoli e di Trieste ; i comuni di Marostica, Brescia, Vigevano, Soncino, Bergamo, Spoleto e Gatteo; l'abbazia di Grottaferrata e fra i privati, il dott. Pietro Capparoni, l'ar chitetto Ugo Tarchi, il conte Roero di Monticello, il col. Villasanta, il conte Pallotta ed altri.
Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio
L'Istituto eli architettura militare ed il museo del Genio continuarono, integrandosi, a dare sempre maggiore sviluppo alle loro attività e nel 1933 si trovarono in grado di potere fra l'altro, contribuire, con l'autorizzazione del Ministero della Guerra, all'allestimento di due importanti sezioni della Mostra Augustea del 1937 (IX, il campo e la fortificazione; X, la battaglia e la vittoria), il cui Direttore Generale, prof. Giglioli era nel frattempo entrato a far parte del consiglio di direzione dell 'Istituto.
Ma in quello stesso anno 1933 uno speciale av-venimento veniv a a turbare la vita dei due enti ed a provocare radicali cambiamenti e cioè la sis temazione a parco pubblico della zona adiacente a ·Castel S.Angelo con la conseguente demolizione delle casermette di Urbano VIII, nelle quali il museo era sistemato ed il trasferimento di quest'ultimo nell'ex caserma Piave al Viale Angelico, in attesa che fosse costruito un nuovo adatto edificio.
L'allontanamento da Castel S.Angelo riuscì in qualche modo doloroso per il legame ch e esso rappresentava con la memoria del Gen Borgatti, deceduto il 5 aprile di quell'anno stesso dopo aver lavorato in Castel S.Angelo per cinque lustri con passione e con fede, ma fu di conforto il pensiero che la cos truzione di una nuova ed adatta sede avrebbe permesso un più facile e pieno raggiungimento di

Il Re di Danimana e il Re d 'Italia, accompagnati dal Gen. Bor-gatti, visitano il Museo Storico (l5 dicembm 1920).
ogn i finalità cultura le e mora le e d avrebbe potuto aprire il campo a nuove attività
Si pensò , all ora, di fondere insieme il Museo e l'Ist it uto di arch it e tt ura militare, nella g ius t a conv inzione che le finalità dei due preesi.stenti orga n ismi, me ss i so tto u na d irezione u n ica , avrebbero potuto essere p ersegu ite co n maggiore impulso e più efficace rendimento. Fu proposto d i denom inare il nu ovo ente "Ist ituto Stor ico e di Cultura de ll 'Arma del Genio" (I.S.C.A.G.).
Ma intanto il museo, fra la metà de l mese d i genna io e que ll a del febbraio 1934 si trasferi va nella caserma Piave. Era da poco u ltimata la sua s istemazione in que sta sede provv is oria , quando la proposta trasformazione riceveva il consenso delle più alte autorità ed il 28 giu gno del 1934 S.M. il Re firmava a S. Rosso re il de c reto ch e approvava la costituzione d e ll '"Is tituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio" in sostituz ione del "museo Storico del Ge n io". Questo decr eto swbiliva inoltre che al nuovo istituto, o ltre alle mansioni già spettanti al museo in base a l R.D. 5 gennaio 1911 , eli cui s i è fa tto cenno avant i, fossero affi d a ti anche i seguenti compiti:
a) provvede re a ll a racco lta, custodia e messa in va lore di rutta la do cu ment<1zione relativa alla Storia dell'Arma del Genio e dell'arch itettura militare;
b) funzionare da centro eli cultu ra storica e tecnica sia per gli Ufficia li dell a detta Arma , che per tu tt i g li .studiosi in genere di discipline affin i a ll a tecn ica militare;
c) funzionare da organo eli propaganda di cara tt e re tecnico militare pe r le scolaresche e per le organizzazioni cultura li giovanili create da l reg ime
Ques ta semplice enumerazione di compiti basta a dimostrare quante maggiori fosse ro , r ispetto al Museo del Genio, le responsab ili tà de l nuovo isti t uto e qu anto maggiore sviluppo dovesse avere la sua att ività .
Successivamente, con decreto ministeriale del 4 luglio dello stesso anno , fu approvato lo statuto de ll 'Is titllto ed il IO lug lio il suo regolam e nto in te rno.

Benché i loc a li della sede provvisoria fossero i nadatt i e sco modi, l'Istituto cominciò sub ito a (unzionare (restando però chiuso al pubblico); iniziò la pubblicazione di un suo "bollettin o"; attese all'accrescimen to de ll a b iblio tec a e delle raccolte grafiche, a lla costruzione e man u tenzione di p lastic i ; prese parte alla "Esposizione - fiera d i Bo logna" del 5- 20 maggio 1934, alla "1\Jlostra italiana d i. strumenti ott ici" a Fire n ze (20 magg io - lO g iugno 1934) ed alla "Mos tra de ll 'aeronautica italiana " a Milano (giugno ottobre 1934) e continuò nella co ll aborazione alla Mostra Aug1.1stea de ll a Roman ità Ino ltr e, in quell'anno e nell 'anrio successivo, svolse d ei corsi pla.st ic isti a sottufficiali e solda t i d i var ie Armi e Corpi.
Ne l frattempo fu decis a la costruzione della n u ov a .sede da ubicarsi nella stessa area demaniale de ll a casérma Piave. I l prog etto fu comp il ato dal competen te UtTic io de l Ministero de lla G u erra, a cura del Ten Colonne ll o del Gen io Gennaro de Matteis I lavori furono iniziati il 20 marzo 1937.
Ai p r im i el i gennaio de l 1939 lo stato de i lavo ri p e rmett eva I'in izio de ll' occupazione dei nuo vi locali, che procedette po i regol a rmente in re lazione al s u ccess ivo sv iluppo d ei lavori; a metà del mese di ottobre dello stesso anno tutto il materiale e ra g ià n e l nuovo edificio e ne fu inizia to il ·clefini ti vo s istematico ordinamento.
In Europa, intanto, e r a iniziato il secondo con tl itto mond iale e l'Italia stava approntando il suo ingresso ne l conflitto. Le spes e eremo enormi ed al fine di non lasciare l' Is t ituto privo di fo n di , con R.D. 1242 de l 27 luglio 1940 venne modificato lo statura clell'l.S.C.A.G. La modifica riguardava prat icamente un solo p u nto: le risors e finanziarie de ll'Ente. Infatt i, men t re ne llo st'ltuto del '34 e ra prevista per l'Is t ituto so lo un'assegnazione annuale da parte del Minis tero de ll a Guerra, ne ll o statuto del '4 0 a tale assegnazione si aggiungevano contrib u ti di reggimenti e degli e nti dell'Arma del Gen io no nché i contr ibu t i d eg li Uffic ia li d e l Genio in serv izio cd in congedo.
la caduta del fascismo in Ttalia. la fine del 2° conflirro mondiale ed il passaggio della Nazione dalla monarchia alla repubblica portarono ad un notevole incremento dci materiali del Genio cd in particolare delle T rasmissioni in possesso dell'Istituto ed a nuova \':triantt' dello statuto organico dell'Eme sancita dal Presideme Einaudi, su proposta del Mini:>tro della Difesa Pacciardi , in data 18 giugno 1949. Di conseguenza il 22 novembre 1950 ve n ne modificato il regolamento int e rno Lo statuto èd il rcgo lam<.:nto ir:llerno appena c it at i so no ancora in v igore.
La sede d e ii "I.S.C.A.C. è si tu ata tì·a Lungoteve re della Vittoria, su cui si allinea la s ua facc iata pr in c.:ip al e. b v ia Cor ricl o ni e d il piazza le Maresciallo Gia rd ino, su l p ro lun g am ento de l qu:ak en t srato p rece d ente m ente ri cos tr u ito il monumento a i Ca du t i cl d i'Arma , g ià in p i::t7./.a Pi < l press o Castel S.Angelo.

Il progel'to in fo rmmo r e de ll 'o p e ra fu q u e ll o eli tener e p e r ce n tro il Sac ra ri o dedicato all a m e m or ia deg li Eroi ed in to rno a d e s so raggru pp ar e le testimonianze de ll e p ri n c ipa li <ttli vità d e ll'Arma , s ia ncJ ia preparazione d e ll a g u e rra, che s ui camp i el i h arraglia. L'c difi<.:io è cos tituito da u n corpo centra le a due piani, a l c ui cen tro è sit uato il Sacrario so rmontato d a un 'alta to rre , e da quattro co rpi a so lo piano terren o disposti simmetricame nte a tto rno a l corpo centrale. Questo ha n e l centro un cortile dedicato a S. Barba ra, co n ingres so sul lungotcvcrc, e chiuso nel lato opposto da un 'esed ra nel c ui mezzo è il port ale di accesso all'antisacrario e quindi al Sacrario. Dal cortile eli S. Rarhara. a mezzo di ampi porticati, si accede in due corrili simmetricamente disposti e detti uno "delle armi'' e l'altro "delle gue rre". TI cortile di S. Barbara è adorno di paraste sulle quali sono incise le date delle campagne alle quali hanno partecipato l'Arma del Genio e delle Trasmissioni.
Le sale principali. lunghe dieci metri e della superficie eli oltre duecento metri quacl rari ciascuna. sono dodici a l piano terra e cinque al pr im o p iano. Le sa le del piano terre no sono dedic.:ate alla dimostrazione delle varie dell'Arma de l Genio e de ll e Trn::;m ission i, de l loro svi luppo in te m po eli pa ce e de ll a loro applicaz ione in tempo d i g u e rr a; que ll e del primo pia n o conte n gono invece nmo quanto s i rife risce progr<:>sso de ll'arch itett ura militare attraverso i secoli; qui una s r ec ia le sez io n e è desti n ata a rico rdare la vas ta o p e ra co m p iu ta da i n ostri archi tetti m ili tar i all'es te ro
Al pr im o p ia no s i trovano a n c h e g li Uffi c i d e ll a di rezione, nonc h é la biblioteca e l '<w la p e r co rs i cl'istru;;.ione, co m u nicaz ion i, ecc.
Tn pa rz ia le sopre leva;;.ione della parte centra le del p ri mo piano so n o s istem a ti g li a rch ivi. Lr:: forme arch itetton ic h e este r ne semplici e severe, con predominio asso luto della li nea re tta. il rivest im e n to di travertino d e ll a facc iata principale e quella di travertino e mattoncini nelle rimanenti parti, le due saldi torri fra cui si apre l'ingre.%o principale e quella che si eleva sul Sacrario conferiscono all'edificio uno spiccato car<mcrc militare. Gli ambienti interni, ampi e luminosi, sono privi di qualsiasi decorazione , dovendo l'a uenzione del visitatore essere r ichiamata solo da quanto vi è esposto; l'atrio eli ingresso, l'antisacrario, il Sacrario ed i1 salone del primo piano sono in\·ccc rivestiti eli pietra. Sulle pa reti dell'antisacrario sono ricordate le decorazioni al valor militare guadagna(e da singoli o da repart i dell'Arma dalla sua costi tu zione oggi. TI Sacrario, a tre navate, ha le pareti ricopert e da marmi: termin a con un'abside al cui centro è un ' ara di marmo nero , offerta dai Genieri in congedo del regg imento del Genio "Ma rio Fiore" e progettata da ll ' ing. Pao lo Napoli, Ufficia le di co mp le m e nto dell ' Arma Ne lle pareti dell 'abs ide sono ricava te no ve fi n est re a ire e s lanciate chi use d a be lli ss ime ve trate a rti st iche del n oto p ittore Dui li o Ca mb c ll ott i L'ambient e è mol to d ecoroso e seve ram e nte m ist ico, co m e s i conv iene ad un luog o co ns a c ra to a ll a m e m o ri a el i co loro che d et tero la vita pe r la Pat r ia.


In alto: Sottujficiale racliotelegrajìsta lungo l'Uebi Scebeli, nel dicembre 1935, riesce a mantenere il contatto per tutto il combattimento, protrattosi p e1· 26 ore, malgrado la sua antenna sia stata abbattuta pm· quattro volte. Da una tavola di Vittorio Pisani Zinchi tratta da "La Tribuna lllustrata ".
A des tra: Cartolina reggimentale d'epoca edita dal ] 0 Reggimento Òenio Telegrafisti.
L'immagine come comunicazione
L'immagine è una vera e propria forma di comunicazione, dive nuta pubblicismo con l'evo lve rs i ed il diffondersi della stampa. Particolare menzione meritano le celebri tavole della "Tribuna Illustrata", entrate nella storia de l costume ancor più che in quella della comunicazione di massa. All'espressione classica della stampa su carta si sono associati ne l tempo altri mezzi di comunicazione vi siva, qu ali il cinema, la televisione, gli audiovisivi come forma autonoma di e spressione. Rispe tto agli altri modi eli comunicare, in particolare parola e scrittura, l'immagine presenta caratteristiche di immediatezza e di sintesi che la rendono adatta a messaggi di rapida comprensione.

L'immagine nella pubblicistica militare
La pubblicistica militare ha fatto spesso ricorso alla comunicazione visiva come mezzo espressivo destinato ad un vasto pubblico. Le carto line reggimentali sono l'esempio classico dell'uso dell'immagin e come strume nto immedia to ed espressivo , in grado eli condensare in forma sinte ti ca concetti e s entimenti non esprimibili con altrettanta immediatezza e semplicità attraverso al tre forme eli comunicazion e Questa caratteristica fu d e terminante p e r consacrarne il successo presso un
pubblico eli livello culturale modesto , con alte percentuali di ana lfabeti tra la truppa . Il comme rcio s p ecu lativo, poi, si appropriò d el genere facendolo scadere a veicolo di messaggi commerciali c he facevano ricorso a d iciture e s taglia ture spurie o, peggio, a banali vi g nette di .soggetro tattico - eroticheggiante . L ' inev it abil e sbocco de l progressi vo deterioramento della qualità eli questo genere esp r ess ivo è stato l'allontanamento dalla produzione ne l settore di artisti afferma ti e eli c hi ara bma, c he pur, in passaro, si erano cimentati con pregevoli lavori
E' sta ta da un la to l'esigenza di tr aman d are e far conoscere una forma di esp r essio ne che ra gg iun se va lor i a 1tistici notevoli, cons a cra n do personalità di ril ievo e, con Quinto Cenni, di e levata produ zio n e , dall 'a ltro l'esigenza di r iva lo riz za re u n gene re c he ha i mol ti pregi evid enziati in precedenza, la ragione per cui la Forza Armata h a, negli anni p iù recen ti, vo lu to ris coprire il gene re , con pubbl icazioni su ll 'iconografia di soggetto militare quali il vo lume dal titolo "Ca r toline
Mi li ta ri " (1983). Si legge, nella presenta zi one , che il volume tratta un " argomento che non rientra apparentemente nei filoni istituzionalmente trattati dall'l[[ficio Storico, al quale si è soliti associare una produzione d i carattere più scientijìcomilitare che non iconop,rafico ... ". In rea ltà , come viene success ivamente precisato, si è inteso estendere il conce t to docume nta le cl ass ico is tit uzio n a le acl al tri aspetti cultura li, quali la presenza e l' imp atto dell'Esercito ne ll a realtà socia le, il modo di .se ntire e di esprimersi d ella gente nella quotidianità e sugli aspetti spiccioli, ma non per q ues to meno imp orta nti , de ll a condizione militare ; in definitiva, si è vo luto dare un'ulteriore immagine dell 'Esercito nel Pa ese e della sua reale in teg razione con esso .
Iconografia delle Trasmissioni

Qu es ti autorevoli precedenti han no brto matu ra r e l'idea di focalizza re l' attenzio ne sulla produz ione iconografica che avesse per sogge t to l 'Arma delle Trasmiss ioni, ripe rc o rr e ndo, attraverso le immag in i, i modi co n cui è s t ata sentita,
Cartolina reggimentale d 'epoca edita dal 12° Regg imento Genio Collegamenti
Cartolina fotografica edita da SME - DAP (Cent r o di Produzione Audiovisivi della Scuola Trasmissi011i del/ 'Eser cito).

vissuta ed in terpretata , nel tempo, a l s u o interno e n el Paese. Per evitare d i fare la replica "specializzata " di ca rtol in e milit a ri , il campo di indagine è stato est eso anche ad a ltri setto r i dell 'iconografia, qua li l'insieme de i pi cco li oggeni ricord o o d ' u so co m u n e, caratlerizzati d a s imb o li o soggetti g rafici d 'Arma, la cu i fu n zione di messa ggio è s im ile a que ll a de ll e immagini a stampa cl assic he.
Si è così s co p e rt a un a mo lt e plic ità el i s ogge tti e di tematich e che h a posro non poche difficol tà n e lla carabgaz io n e . A p a rt e le g ro ss e fir me , qu a li quella di Pao lo Caccia Dom inioni , p a rt e cos pi cu a d e ll a iconog ra fia mi litare di interess e d e ll 'A nna delle Trasmissioni è op e ra d i a rti s ti , ar t ig ia ni e spess o anc h e n on professioni s ti Un non trascurabil e apporto a l ge n e re d e ll e cartoline mi litari propriamente d e tte è stato fornito dall'Associa z io n e d 'Arma, ch e so litam e nte ha ricordato i ra duni co n l'edizio n e di partic o la ri carto lin e ri co rdo e, s p e sso, anche con l 'emi ss ion e di un o s peciale annullo posta le .
Apporto del mezzo fotog rafico
P er lu n go tem p o , a l fotografo militare è stato attribui to il molo quasi esclusivo di "a d d e tto a lla documentaz io ne d 'a rc hivio ". Le sue immagini, sono state spesso fredde ed insignificanti nell'efficacia e nell 'incisività quale v eicolo di mes sagg i pubblicistici.
Solo successivamente so n o compa rs i soggett i o r iginali e non ripet itivi ; si è a rricchito e divers ifica to il messagg io, che è stato reso vivo e d attua le dal senso di atti n enza all a real tà che emana dalla fotografia ; s i è migl io rato il va lo re artist ico d elle imm agin i fotografiche, a lm e no ne i te r m in i in c u i q uesti fatto ri p osso n o venire infl u enza ti d a ll a padronanza delle tecno logie e d e ll e tecniche e d all'espe r ie nza pro fessionale.
In questa rice rca la Scu o la d e ll e T ras miss io ni di Ro ma è stata il centro d i p rodu zione di cartolin e di v ari o tipo, calendari e bigli e tti reggimenta li. Un a es p e ri e n za che si è trava sata in altri reparti de ll 'Arm a e che, presumibilmente, costituirà un nuovo ed int e ress an te fil o n e p e r t utt a l a Forza Armata . Alla Scuola d e ll e
Iddio è con voi
Tr asmission i v engono i nfatti addest rati tutti gli s p ec ia li sti de ll ' immagin e de ll' Ese rcito, ch e in questo nu ovo cl ima d i c ul tura professiona le ri cevon o ora un addes tram e nto c h e va o ltre que ll o trad iz io n a le del freddo e sem plice inseg namento d e ll e nozioni teoriche e delle ar ide tecniche esecutive.
Apporto della televisione
Un a svo lta importa n te è stata la c reaz ione pre sso la Scuola delle Trasmissioni di Roma di un Centro Televisivo di Produz io ne che ha proie ttato il p ers on a le in un a nuova di m ens io ne pub b licistica, face ndo gli acqui s ire notevoli capa cità profess io n a li . De termin ante a tal fin e è stata la collaborazione co n gli O rga ni Istituzionali di Forza Ar ma ta, q uali l 'U fficio Do cume ntaz io ne e d Attività Pro mo zi o nali d ello Sta to Magg io re de ll ' Es erci to e l'Ufficio Rivista Militare , non c h é il conti nu o co n fro nto con i più qualificati p rofessioni sti civ ili dell'immagine.
Questo nu ovo impegno della Scu o la Trasmissioni, scaturito da esigenze addestrative e d i ri cerca di nuov i ed e fficaci aus ili didattici, ha finito co n il produrre benefi che ricadute su un settore app are ntemente secondario, comun que non precipuo d 'is tituto, tuttavia import a nte perché mette a di spos iz ione d ella Forza Armata e delle Tra s mi ssio n i uno strume nto d i lingu agg io co mpre nsib il e e quind i fac ilm e n te com pres o nel Paese.
Cons id e razioni finali
Esaminando il p atrimonio iconografico che rigu ard a l'Arma delle Trasmiss ioni, pur protesa ve rso l'applicazi on e d i tecniche e tecnologie avanzate, notiamo prevalente lo sfo rz o di rice rca delle antiche tradizio n i cul turali . Si è s p esso posto in evidenza il fatto c he le o rigini de lla "nuova " Arma affondano in una conso li d ata tradiz io n e cultura le militare.

Ne è segno evidente la to rre romana eU seg n alazione , il sogge tt o più ricorr ente nell 'iconog rafia d'Arm a, della q u ale è ass urta a s imbo lo , q u ale ese mp io s ignificati vo
A s inistra: Carto l ina fotografic a d'epo c a edita per l 'Arma d elle 71·asmission i da Fotocelere- Torino 1942.
In basso e nella pagina a fianco: Esempi di scudetti da braccio realizza ti per i Corsi A UC delle Trasmissioni.
Nella pagina a fia n co a de srra: Ca , toll:na reggimentale edita dal Battag lione Collega menti della Divisione Granatieri d i Sardegna - Alterocca, Tern i - Auto re Loreto.
dell'approccio con cui i Romani affrontavano la problematica delle Trasmissioni militari. Apparentemente semplici e primitivi, essi realizzarono r e ti complesse ed estese senza le quali, con la sola forza delle legioni, non sarebbe stato possibile conquistare e tenere così ampi territori. In epoca imperiale, Roma era collegata, tramite torri di segnalazione, con ben 1200 città e presidi della penisola italiana , con altretta nti centri st rategici della Gallia, con 300 città della penisola iberica, con 500 dell'Asia. Lo sviluppo complessivo della rete raggiungeva b en 60.000 chilometri.
Questo richiamo qua si costante ad una cultura militare caratteriz zata dall ' enfatizzare l'aspetto del supporto tecnico fu il motivo predominante a cui si richiamò l'iconografia della "nascente" nuova Arma tra le du e gu erre mondiali

La Domenica del Corriere, emblematica interprete del gusto e della m e ntalità iconografica di numerosi decenni, dedica alle Trasmission i le sue celebri tavole quando l'Arma si trova al centro di episodi fortemente caratteri z zati in senso epico: la Crocerossina che muore esalando via radio "Viva l' Italia"; il Trasm ettitore che sotto il fuoco nemico rimane per ore attaccato alla radio, nonostante l'antenna più volte clistwtta e le ferite riportate.
Alle Trasmissioni viene altresì dedicata l'attenzione delle celebri tavole eli Achille Beltrame per enfatizzare il fatto che i combattimenti d 'Africa , insieme al loro Comandante, potevano, grazie alla radio, udire in diretta a settemila chilometri di distanza la voce del Capo d e l Governo che annu nci ava la loro vittoria alla Nazione.
In futuro, fare cultura d'Arma ed esprimere operatività profess ional e per le Trasmissioni potrà significare anche tendere ad offrire, con sempre maggiore efficacia, una realistica cultura dell'immagine esaltandone i valori.
Abbiamo già fatto cenno ai positivi ri sultati che si stanno ottenendo nel campo dell'immagine fotografica e te levisiva, dove, lavorando spesso a co nta tto el i gomito e misurandosi quasi quotidianamente con qua lifi cati operatori civili e con la loro cultura professionale, si è trovato un linguagg io espressivo e cultura le comune, che ditTerisce s p esso so lo per i sogg e tti trattati, non per le tecniche e l'approccio con cui essi vengono trattati. Per questo, forse inconsciamente e senza rend e rsene
perfettamente conto, la fotografia e la televisione, in particolare, hanno guadagnato e guadagnano sempre più spazio nell'iconografia militare.
Un analogo approccio dovrebbe essere tentato nel settore d e ll'iconografia che potremmo definire "postale" per le trasmissioni militari, quali canoline e biglietti di circostanza Sarebbero auspicabili edizioni di "immagini postali" militari di soggetto e di gusto moderni, da porre in commercio almeno nei nos tri spacci. La creazione di un punto vendita aperto al pubblico, quale quello di recente realizzato da Rivista Militare per le sue pubblicazioni, appare come un'interessante iniziati va pilota.
Ci si sentirà comunqu e appagati se le immagini selezionate e le parole di commento stimolassero gli inte rlocutori a diven tare , ognuno a suo modo e ciascuno con le propri e potenzialità ed i propri limiti, protagonisti di cu ltura militare per quanto attiene all'a1te figurativa e all'iconografia che da essa trae s punto o ad essa si ispira.

L'iconografia militare - scrive il Capo d ell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito nel presentare Cartoline Militari - "è una componente che, sotto l'aspetto del veicolo soCiale, ha avuto ed ha il potere di avvicinare la Forza Armata alla sua base di estrazione " Un Esercito, come il nostro, che ricerca il co nsenso della gente e del Paese non può estranearsi dalla cultura nelle sue varie espressioni, ma deve farsi anzi promotore eli una cultura specifica in grado di ama lgamarsi, moclificandola, con quella esterna. Oggi più che mai, con una cultura d e ll'immagine televisiva che è certamente la più determinante per i compo1tamenti nelle moderne società, l'auspicio per l'Arma dell e Trasmissioni è ch e possa farsi carico anche di questa istan za.
Nella pagina a fianco: D a una tavola di A. Be/trame della Domenica del Corriere del 18/uglio 1937. Crocerossina assiste un militm·e delle Trasmissioni morente.
L/\fieMENiet\oEt@RRIERE




I collegamenti della l a Armata in Africa Settentrionale (10 - 13 maggio 1943)

- a cura del Gen. C.A. Giuseppe Ca la mani -
Dopo lo sfondamento del fron t e d e lla sa Arma ta tedesca e l'occupazione di Tunisi (7 maggio), la 1a Armata (Gen. Messe), che teneva il fronte sud da Medjez e l Bab a l mare (E u fidaville), era completamente accerchiata da nord.
Nella mattinata del 10 maggio il coma nd o della P Armata , che fino al 12 aprile era dislocato nella zona di Sai nte Marie du Zilt, si spostava in una piccola valle presso El Batt ria, una decina di km più a sud
Nella nuova sede il centro co ll eg a menti (di cui era pmte integrante il centro cifra) convisse con il comando della F Armata , mentre, in prece d e nza, dopo il duro bombardamento subito a Zerkine , ove le nostre s ta zion i radio erano s tate radiogoniometra te , ess o ven iva installato a l - 2 km dal comando dell 'Annata
T collegamenti a filo - li mitati a quelli interessanti il comando - furono stesi rapidamente; dei collegamenti radio rimasero in attiv it à so lt anto quelli con lo Stato Maggiore dell'Esercito ( t rami te Roma -M.Mario), quello con il comando Gruppo Armate (termi na to il gio rno 11, con la resa del Gen Von Armin) e que lli co n i comandi del XX e XXI C.A., del resto d istan ti ormai pochi km.
I col legamen ti radio erano realizz ati co n stazioni A310 e A350 da ins ta ll are, essendo in cofani, ad ogni spostamento; soltanto pochissime staz ion i A310 erano installare pe r manentem e nte su au t omezzo (SPA do vunque). Un 'autostazione R6 , giunta dirett am ente dall'Italia in T un isia per il collegamento con Roma , venne da me inviata a lla base della sua compagnia, perché troppo ingombrante per i nostri continui spostamenti.
Desidero qu i so ttoline are come nei nu merosi movimenti e scavalcamenti (da Homs ad El Battri a, da dic embre '42 a maggio '43) del centro rad io , i m arconisti della stazione eli Roma-M.Mario co n encomiabile spirito di solidarietà rimasero in con tin uo ascolto su tutte le fre quenze disponibili (vi era la necessità el i cambiarle a seconda della zona e , soprattutto, a s e conda dell ' ora del giorno e della nott e), sempre pronti ad atti vare il collegamento appe na iniz iavano le nostre c hi amate
Avendo amp ia d is po n ibi li tà di provetti capi marconis ti in co n seguenza della drastica riduzione eli collegamenti radio , pensai di impieg arli per trasmettere notiz ie ai fam iliari de i comba ttent i in Africa Settentrionale. Chiesi, quindi , a Roma una frequenza eli sicuro aftìdamento per trasmettere alle famiglie, co n un testo standard : "sto bene; nonpreocc-upatevi più': i so li nom in ativi ed ind irizzi dei d estina tari.
Mi venne negato ; allora, indignato, diedi ordine a tutte le nos tre trasmittenri di potenza di interfe1ire sulla frequenza delle navi ospedale (internazionalmente protetta), trasmettendo in continuaz ione il mio "nominativo radio ": CL!\1. Ed entro b revissi -
mo tempo, oltre al rimbrotto radiotelegrafico, mi assegnarono un'ottima frequenza su radio Coltano e potemmo così trasmettere fin dai primi giorni di maggio migliaia eli telegrammi che ci venivano po1ta ti a mezzo motociclisti da tutte le unità schierate.
E, dopo la gu e rra, ho saputo che tutti furono regolarmen te recapitati.
Nulla di rilevante mrvenne , nel centro collegamenti, nei giorni 10 eclll maggio.
Nella mattinata de l 12 maggio giungeva al Gen Messe un messaggio del Comando Superiore "Poiché gli scopi della resistenza possono considerarsi raggiunti, lascio VE. libera accettare onoreuole resa - A voi ed agli eroici superstiti della JY A1·mata rinnovo il mio ammirato vivissimo elogio ".
Ebbi eli conseguenza l 'ordine di contattare il comando del X C.A. inglese (Gen. Freyberg) su una frequenza di lavoro fornitami dall'Ufficio I del nostro comando.

La radio inglese venne agganciata alle ore 13.00 ed in s eguito, dopo s uccessivi controlli ed accordi, il collegamento fu definitivamente stabilito ed ininterrottamente mantenuto sia con Armata che con il X Corpo d 'Armata.
Il Comandante della 1ll Armata chiese eli poter trattare la resa con l'onore delle armi. Acl un diniego da parte inglese per analogo comportamento dei tedeschi che non avevano concesso l'onore delle armi agli inglesi dopo la battaglia eli
Dunkerque e eli fronte a una ulteriore minaccia di bombardamenti aerei e di ripresa delle ostilità contro le nostre linee, ormai quasi senza artiglierie e muni zioni per fanteria , il Comandante accolse alle ore 1.30 del giorno 13 maggio l'invito ad una
Fronte libico: una stazione radio campale in una postazione dffen s iva nel deserto. Tratta da "Esm·cito Italiano storia di uotnini e armi" ed Edilalia, 1988.
tregua d'armi ed all'invio di parlamentari per trattare la resa sen za condizioni.
Secondo un itine rari o indicato dagli inglesi partirono con una bandiera bianca il Capo di S.M. (Ge n. Mancinell i) il Ca.U. Operazio ni (M agg. Bosca rdi) ed un Colonnello tedesco. Non mi soffermerò sulle vicen d e dei nostri parl amentari, trattenuti a lungo e d offesi d a l coma n dante e dagli Ufficiali del XIX C A fran cese le cui linee avevano dovuto att raversare e d elle perentorie richieste degli inglesi, ch e, accusandoci eli non voler tenere fede agli acco rdi di resa, sollecitavano l' in v io dei parlamentari, p ena un attacco gene ra le contro le nostre difese.
Comunque alle 8:30 la resa venne co ncordata ed alle ore 12.30 due Ufficiali inglesi giunsero al nostro comando per darvi esecuzione
Il comando e rutti i nume ro si uomini che vi erano affluiti da ogni direzione si sc hierarono sui pendii d e ll 'Dadi e d a l ce ntro, dopo brevi parole del Comandante , venne effettuata l'ammain a bandiera . Fu l'ultimo tricolore in terra africana e la commozione era fortis sima: molti piangevano
Avevo distrutto tutte le s ta zioni rad io tranne una A 310 che portai sul più vicino colle mantenendo il collegamento con Roma fino alle ore 16.00
Ebbi la fortuna d i p oter inviare u n t e legramma a mio padre, assicurandolo sulle mie condizioni e di riceverne una co nfortante risposta per la prevedibilmente lunga prigionia.
Poi, salutati uno ad uno i brav i marconisti eli Roma e distrutta la stazione, mi diressi, con tutto il personale del Centro Collegamento, verso il campo di concentramento.
L'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.P. I. S.)
-a cura del Gen. C.A Guido Jl1artinelli-
Premessa
Ufficiale post - 2il Gu e rra Mondiale non ho, pet: buona sorte della Patria e d e ll e nostre generazioni , ricordi di gue r ra con associati sac rifici, eroismi, caduti , brani d'epopea e di gloria. Nondimeno, ho vissuto un 'esistenza in uniforme ben feconda di esperienze profess iona li e d umane che hanno arricchito ed affinato mente , carattere e spirito, facendomi matura re Ufficiale, meritevole anche di assumere a suo tempo l' in carico d i Ispettore Gen era le de ll 'Arma dell e Trasmissioni.
Con p articolare inte n sità, anche per la sua eccezionalità, ho vissuto l'esperi enza di Ufficiale su b alterno della compagn ia s p eciale Genio del corp o d i sicurezza per I'A.F. I.S Dopo quasi un quaranten ni o conservo intatte, nell a memoria , le vicende di qu el periodo e sono g ra[O dell'occasione afferrami, per fare conoscere ai nostri successori che, t ra l'altro, l'Arma ha partecipato al delicato incarico d i preparare all'autogovern o e a ll ' indi pendenza una nostra ex colon ia per incarico dell'ONU; segno indubbio della riconquistata fiducia dell'Italia a livell o int e rnazi onale a pochi anni appena dalla mortifìcaz ione della pesante sconfitta.

La mia esperienza nel Corno d 'Africa
Destinato alla compagnia s p ecia le Genio del corpo di sicurezza per l'A.F.T.S. , mi
i1nbarcai a Napoli il 13 agosto 1955 sulla nave DIANA d el Uoyd triestin o. Giungemmo davami alle coste di Mogadiscio la sera del 2 settembre TI crepuscolo equatoriale, brevissimo, si consumò prima dell'an-ivo sul luogo di sosta, al largo della linea di costa, per l' impossibil ità di attracco a causa dell(:l pres enza della barriera corallifera, e le renebr<:: <:ala rono impecl e ncloc i di gettare lo sgua rdo sulla vi c in a te rra fe rma .
L'e nrità dei punLini IUJni nosi ch e brilla vano di front e él noi e la loro este ns ione s u sc itaron o in me, c h e e ro nu ovo el i quei luogh i, l' impressio ne di essere in prese nza el i un denso e vasto ce ntro abitato; impressione ridim ens ionata dal modesto panorama che si presentò al mio sguardo il martin o successivo: un gruppo eli edifici bianchi, per la maggior pane tcrrazzati all 'a raba , intorno a cui si stendeva n o i ()U a rtieri indig eni di Shingani ed Ama ruin , entrambi cost ituiti p er larga p a rte da abitu ri di ram ag li e c fa ngo o sterco bov ino, addossa ti gli uni ag li a ltri q u as i per soste nersi c fars i cuore a vicenda.
L'imposs ibili tà per la na ve di attracca re, fece vivere a no i p asseggeri l'espe rienza dello sbarco in "giappo nesina " e "barco ne ", !"una , una gabbia di corda fissata ad una base eli tavole e appesa ad una delle gru dell a nave; l'a ltro, uno zatterone cl e n o n1inato appunto "ba rcone " che rull a va sulle onde dell'Oce ano Indiano ag itate d a l monsone di sucl -es r.
A gruppetti d i 8-10 p e rso ne s i sa li va s ulla piattaforma del la giapp o n es ina, la gru t irava in alto lo s tra n o veico lo con il s u o caric o umano e lo sp ostava ve rso il mare sul cielo dello zanerone .
Lentamente, i passeggeri venivano ca lati sul ponte del natante ma, nonostante l'ab ilit à e l'accoJtcz:t,a del g mis ta, l'impa tt o tra la '·giapponesina " e la za tt era e ra, il pill de ll e vol re, piutt osto b ru s co.
Il ba rcon e , comp le tato il carico, s i dirig eva alla vo lta de l po1to sotto la sp inta di numeros i remato ri e la dire z ion e di un p ilota p arti co larmente esp erto ' ' s fr uttare la cres ta dell'onda ne l momento de l supcramen to della ba rrie ra di corallo.
Arrivato indenne sul molo fui prelevato da una jeep ve nuta a rilevarmi che mi condusse di filato al coma ndo compagn ia .
Mi prescn Lai a l co mandante, Cap Be lviso , un u omo in perenne, fre n e ti ca a ttiv it à, il quale , dopo i co nvenevoli d ' uso, mi inv itò ad acco mpagnarlo p er una ri cogn iz io ne alle fogn e el i Villa ;'Itali a", se d e del Pres idente italiano in Soma li a, che accusava no dell e pe rd ite.
Co n molto rispetto e co n la fermezza conse ntitami dalla condizi one di giovane subalterno alle prime armi al cospetto, per la piim a vo lta, di un maturo , navigato ed ene rg ico capita n o, osse rvai che ero un Ufficiale del Genio T rasmissioni, co n il che vo levo intendere che di lavor i e dili e co nnessi non avevo né cultura n é pratica

Co n bonomi a ma co n ton o ch e no n lascia va adito a replich e i l Cap itano
Be lv iso mi rispose c h e a ll a co mp agni a spec ia le Gen io g li Ufficiali dov evano esse re pronti acl assolvere ogn i incombenza co nnessa con i com pit i " is tit uzio nali " del reparro, che spaziavano dalla realiaazione dei complessi collegamenti radio, anco ra considerati un poco come ri su ltato di magia , a ll a demolizio n e di st runure in murat ura o m e wllo e allo spegnim e nto eli incendi. A tale ultimo rig u a rd o la co mpagnia in corpora va un plotone "po mpie ri " .
Ne i g iorni s uccess iv i presi contatto co n il plotone Tras m iss ioni di cui ero, v irtu almente, il comandante, incar ico che non ass uns i mai per la mo lt eplic ità degli impeg ni . Ciononosta nte , dedicai semp re particolare attenzione al personale delle Trasmissioni di cui mi sentivo responsabile ed al s istema delle telecomun icaz ioni che esso gest iva Questo s is tcrna, abbas tanza sempli ce, co mprendeva co ll egamenti radio e co ll egam e nti a filo. I prin'l i e ra no arti co lat i in un a maglia a due p er le comuni ca zio ni in l lf io nosferico tra il co m an do d el co rp o eli sicurezza e la Madreparria e in u na
maglia multipla p e r le com u nicaz ioni tra Mogadiscio e le sedi dei reparti del co rpo di s icu r ezza schi erati s u l territo r io. Per le c on t ingenti il plo tone d ispone va di un 'aliquota di radio mob ili di varia poten za - da ll e R-299 alle R-300.
J collegamenti a filo, rea li zza ti in cavo S-1 o in co rdonci no , con linee sem ìpermane nt i , servivano a so ddisfare le d i co municazioni tele fonic h e tra i reparti stanzia ti nella stessa località e all'i nterno delle caserme T sostegni de lle linee eran o costituiti da edifici, alberi, tralicci della rete elettrica e palificate messe in op era dalla squadra "cos truttOii d i linee" del repano.
Il personale o pera to re era misto, italiano e somalo ln particola re , gli equi paggi delle radio di maggiore era no costituiti da "marco ni sti " indigeni inqu adrati da so ttuffìciali e graduati ita lia ni me ntre le radio eli min o re potenza erano affidate a specia lizzati so ma li . Analoga compos izione prese ntavano gli eq uipaggi delle ce ntrali telefonic h e.
Alle attività di m a nutenz io ne specialistica c eli ripa raz ione attendeva un laboratorio gestito da p e rso n a le italiano in tegra to d a pochi specializzati in digeni.

L' impegno ope rativo co ns isteva nella gestione dci co llegamenti ordinari, il cui se rvizio era ad appu ntamento per le maglie radio e continua tivo per le cent rali telefo niche, e nello svolg im ento di ese rcitaz io ni settimanali con i mezzi radio mobili, a cui erano strettameme associate le attività di manutenzione e di riparazione che la vetustà dei mezzi e Ja prcc ipuità del clima, caratte ri zzato da contin u e variazioni di umidità te mperatura e sa lsedine, r e ndeva no freq uent i, onerose e, talvolta, affatto manua li , co me mi ca pitò di s p e rim e ntare q ualche giorno dopo il mio anivo
Ero intento acl o rga n izzare il m io hJOgo di lavoro, una linda, bassa, luminosa stanza a p ianot erra, che, dopo l'e nunci ato d e l Ca p. Belviso, mi stavo in gcg nanclo di co rredar e con tutti i ma nuali d i leu eratura tecnica c he mi capitavano sott o mano , dai testi sulle costru zioni di ogni tipo a quelli per le loro de molizioni , ai libri s u l mov imento terra, alle pubblicazio ni sull'illumina;.-.ione e sullo spegnimcmo deg li in cend i, quando il comandante di compagnia s i precipitò ne l mio u ffi cetto gridand o al mi o indiri zzo , quasi fossi stato ricon osc iu to colpevole dell'accaduto, che uno elci pa li d i sostegn o de ll e no s tre line e tel efoniche s i era abba ttuto su ll a s tr ada c he a dduc eva al centro città interrompendo il tr a ffi co st radale: quel lo te lefo ni co, in ve rità r isu ltava ind e nn e da intoppi el i so rta.
Per m ia for1una, il mio precedente incarico e ra s tato q u ello di comandante di co mpagnia alliev i cost ruttori di linee Per qu esta favo revole co in c id enza, olt re alla profonda cogn izione sui percors i degli elettroni e su lle e quazioni di Maxwc ll app rese alla Scuola di avevo acquis ito una buona cultura teorica e p ratica su materiale, attrcz7.i c tecn ica per la costruzione eli linee semiperma nenti e pe rmanenti, essendo stato impegnato, tra ]'altro, a redigere un manuale per i mie i allievi costrutt ori e a realizzare un po ligo no per il loro addestramento prat ico. Convocai d ' urgenza il ca posqu a dra costruttori eli linee ed i s uoi uomini e ci precipitammo a verific are l'accaduto. In effe tti , il pa lo, un grosso tronco d 'abete, giaceva ob liquo s u ll a s ie p e s trada le c on la cim a acl un m e tro da l pia n o d i campag na, sos tenuta a meuo aria dai massicci roto li eli cavo S-4 c he avrebbe dovuto regg e re, ancora ti come e rano a du e tra li cci de ll' energia elettri ca. Ac<.:e rt.ato c he i num erosi sostegn i messi in opera dall a co mp agnia era no identici e coev i eli quello caduto , avv iai imm ediata mente una capillare ricognizione lungo tutte le linee, dalla quale emerse che la maggior parte dei pali era nelle stesse condizioni di precarietà di quello abbanutosi ; solo che la loro cadu ta era impedita dai robusti fasc i d i cavo ancorati frequentemente ad appigli ben sald i. Ammaestrat i dall 'accaduto , procede mm o alla sos tituzione dei pali m arci co n sostegni s upeJtrattati in corrispo ndenza della parte inte rra ra .
I mezzi di cont in ge nza furono u tilizzati esse n zia lmen te p er la forma zione tec nicoope rativa d e i so ttu fficiali indigen i destinati a sos tituire il perso n a le italiano e per l'a ffi-
nam ento della preparazione deg li spec ializzati di truppa. Il loro impiego operativo si limitò a sod disfare l'esigenza di seguire la maratona Afgo i-Mogacl iscio, progranunata in occasione dell'incontro eli calcio de lle nazionali keniota e so mala , allo scopo di comunicare, in tempo reale, la s itu az io ne in testa alla corsa a lla folla radunata n e llo stadio all 'interno del quale era posto il traguardo. Il collegamento risultò piuttosto laborioso per la presenza, lungo il percorso, di zone sfavorevoli alla propagazione eletrromagnetica, ma un'accOlta combinazione di mezzi di diversa potenza assicurò il regolare flusso informativo che giunse puntualmente a suscitare l'entusiasmo dei tifosi assiepati sulle gradinate, i quali g ratificarono con un nutrito app lauso non solo l'atleta di testa ma, a ltresì, l'auto-radio che lo seguiva da presso.

Imp egno ben diverso mi d erivò dallo sforzo di migliorare cu lturalmente i militari somali e far lo ro acquisire un titolo eli s tudio elementare nella co nvinzione ch e la capacità di indipendenza di un uomo e di un popolo sono legate al loro affrancamento da ll a schia vitù dell'ignora n za e eli farli maturare in senso civico anche per temperare la loro mentalità tribale. Non minore impegno mi venne dal governo del personale , segnarame me dei nuclei periferici promiscui, per le frequenti diatribe che insorgevano fra militari italiani e somali. Jn questi casi il rimedio più efficace era l'intervento tempestivo in loco e l'analisi dialettica delle controversie, ingenerate, di massima, da fut ili mo tivi ma amplificate abnormemente dalla strena convivenza. In assenza di reali mancanze disciplinari , co ncludevo il mio intervento con un sofisticato giudi zio finale che dava ragione al persona le italiano senza dare tOltO a quello indigeno, sempre su sce ttibilissimo e m o lto orgoglioso In presenza di palesi violazioni del regolamento d i disciplina non filosofa vo ma , messi bene in evidenza torr i e ragioni , adottavo prowedime nti esemplari, sempre molto paventati dagli indi geni per la possibilità che assumessero la forma della sanzione di uno o più giorni di "mezza paga".
L'assenza di una rete viaria ordinaria, sostituita da piste, la lunghezza dei tragitti e la tipologia e la modesta affidabilità dei mezzi di trasporto a disposizione rendevano disagevoli i viaggi verso la lontana periferia Tunavia, la giovane età, il senso del se rvizio , e l'innata curiosità o spirito d'avv entura che dir si voglia, me li fa cevano se mpre ben acce tti , segnata mente, dopo l'esperienza v issuta nel corso del prim o di ess i, meta Calcaio, n e l Mudugh.
Part ito a bordo di un Lanc ia 3-RO ca rico di indigeni militari e c ivili ai quali, in man canza di un regolare servizio di trasporti, si dava la poss ib ili tà di fruire degli automezzi militari, lungo il tratto di pista di sabbia giallo polenta che ta gliava in due la boscaglia tra gli abitati eli Beler Hen e Dusa Mareb e che s i perdeva, infinita, nel lontanissimo orizzonte appena ond ulato al di là del quale c'era la meta, la temperatura del motore dell 'autocarro salì repentiname n te. L' autista, un accorto e solerte somalo della Cabila Averghedir, arrestò il pesante automezzo e si precipitò ad aprire il cofa no motore.
Lo raggiunsi per veritìcare le ca use del preoccupante inconveniente e p er evitare che stappasse il radiatore senza le accortezze necessarie; con il s uo lungo indice puntato al centro de l radiatore mi indicava un foro da cui fuoriusciva acq ua mista a vapore. Acl un esame più dettagliato risultò che pareti e lamierini del radiatore erano corrosi per o ltre un centim etro q uadrato e, cosa ancora più grave , apparivano friabili, il che escludeva ogni lavoro di tappatura a mezzo eli un "tappo di legno". Frattanto gli indigeni, informati dell 'accaduto dall'autista , schiamazzavano e gesticolavano mulinan do le scarne braccia per esprimere il loro disappunto e la loro preoccupazione. "Cosa fare , signor Tenente?" mi chiedeva l'au tista con espressione perplessa e sconfortata. Subito mi venne in mente eli utilizzare il fusto eli acqua potabile che avevamo a l segu ito per rimboccare eli tanto in tanto quella d el radiatore ma, resomi conto che man cavano quasi 100 km al villaggi o più prossimo e che, sulle catte al segu ito, non era riportata l'indicazione di 250
pozzi lungo il percorso interm ed io, conclusi, entro me s tesso, che occorreva trovare un'altra soluzione. Peraltro, ero preoccupato dall'evenienza di una sosta all'add iaccio per la presenza, nell'area, degli Slùftà, banditi sanguinari e spietati che avrebbero potuto attaccarci durante la notte incombe nte. Facendo lavorare memoria, ragione e fantas ia, mi ri co rdai della presenza, tra i materiali di scorta, di un barattolo di pastos o grasso lubrificante . Lo fec i recupera re e lo m escola i con la sottile sa bb ia della pis ta e con t:Ouina di dura (so rgo), avuta dagli indigeni, fmo a ricavarne un impasto abbastanza cons istente. Ne 1iempli uno dei miei calzettoni di rise1va e applicai l'impasto in conispondenza del buco. Lo feci aderire strettamen te al radiatore con ripetute fasciature di bende Iicavate da una mia cami cia, quindi so llecitai a riportare a livello l'acqua di raffredd amemo.

Nonostante le s ue petplessità , c he aveva espresso co n ripetuti sc1.10time nti della testa durante tutto il corso del mio inusua le intetvento, l'autista ubbidì senza te nte nname nti.
Alla prov a dei fatti, l'estemporaneo rimedio tenn e e gregiamente e per i residui, lu nghissim i cento c hilometri non perdemmo u na so la goccia d 'acqua co n grande meraviglia di tutt i, me com preso.
AtTivammo a Calca io alle prime ombre della sera. L'autista e gli altri indigen i si affannarono a raccontare l 'accad uto ai militari m arcon is ti autori d e ll a diatr iba che e ro andat o a dirime re, es prim endo e logi sperti cati n ei miei riguardi.
Le mie qu o taz ioni presso dip e nden ti che, p e r a ltro , incontra vo per la prima volta, saliron o vertiginosamente, il che mi consentì di risolvere la controversia con estrema facilità.
Il programma di rimanere inimerrottamente in Somalia per tre anni fu alt erato dal risultato delle prime elezi o ni per la nomina del Parlamento somalo, favorevole a lla "Lega d e i Giovan i Somali", part ito an ti -italiano che sollecitò il disimpegno del Corpo di Sicurezza e mi c ostrinse a rientrare in Patria dopo appena un a nno.
Las ciai la terra s omala con enorme rammari co Quel clima che anda va dall'um ido appiccicaticcio della stagione d el monso n e di N.O. al cald o opprim ente del grande Tangabili, quel vivere al ra llen tatore delle popolazioni locali che, in tale mo do, si godono forse più a lungo di no i europ e i la gioia fugace della vita, quell'a tmosfera di verginità che non e rava mo riu sciti a profa nare con la n os tra inquietudine indiscre ta e , sopra ttutto , que l lasciare incompiuto il compit o di preparare i So mali all'auto go ve rno e p01tarli a ll 'indipendenza, os ta vano al mio allontan amento co me invilupp o della mente, dello spirito, e del cuore; avvertiv o vivissi mo la voglia di restare per complet are l'opera avviata e forse per continuare ad asso rbire, dall 'i nu sirara miscela d i suoni, odo r i, sapori, immagini, stimo li e ricruami, il narcotico che inietta n e lla vene il "mal d'Africa" .
I collegamenti per l'Amministrazione Fidu ciaria Italiana della Somalia (A .F.I.S.)
-a cura del Gen. C.A. Jl!fanlio Oriandini-
Premessa
Nel corso della 23 guerra mondiale, la Somalia italiana venne occupata, nel 1941, dalle forze armate britanniche e la situazione rim ase immurata per quasi un decennio. Infarti , solo nel febbraio d e l 1947 l' Italia rinun ciava ufficialme nt e ai s uoi possedimenti in Africa con la firma del Trattato di Parigi ( 10 febbraio 1947).
No n essendo, però, s ta to rag giunto un accordo fra le grandi pote nze vincitr ici
del co nflitto, la d e finizione del futur o asse tto delle ex co lon ie italiane v enne d ema ndata all 'Assemblea Generale dell ' ONU che, il 21 novembre 1949, deliberava di affidare all 'Italia , per dieci anni , l' amministra zione fi duciaria della Somalia co n il comp ito princip a le di c rea re le prem esse per l' indipendenza di qu e l territorio da ragg iunger e al term.ine del mand ato. Compito mo lto impegnat.ivo in q u anto relativo acl ogni aspe tto di una .modern a soc ie tà, dalla sic urezza acl u n p roces so acce lerato politico, sociale, e ducativo, ecc.
L' iter per la d efinizi o ne degli accordi in base ai qual i l'Italia do veva ag ire come amministratrice ficluciària veniva completato il 2 7 gennaio 1950 anch e se la ratifica per acc ettazione da parte dell 'Italia avve nne il 4 novemb re 1951. Ciò rese possibil e il passaggio dei pote ri in Somalia già dai primi de l me se di a p r ile 1950.
Appronta m ento
Corpo di sicurezza.
L'o rg anizzazi o n e del co rpo di s icurezza italia no ini ziò nel 1948 quando s i era d e lineata la possibilità che una o pi ù d e lle ex colonie ve nisse affidata all ' Italia in amminis tra z io ne fidu cia r ia
Le forze previs te in iziaron o a cost itu irs i in var ie Re g io n i Mil itari e si conc e ntra rono in un secondo te mpo nel te rritotio d e l CMT eli l\'apoli. I re lat ivi mov imenti furono effettuati in gran p arte en tro il l 0 di cemb re 1949 ed ultimati il 15 febbra io 1950.
Il Corpo di Sicu rezza comprend eva:
Comando del Co rpo di Sicurezza

Co man do Trupp e Ese rcito
Comando Marina
Comando Ae rona ut ica
n° 4 btg. m otob lindati f.
n° 3 btg. motob li nd ati CC
n° l btr.a. 100/ 17
n° l cp g. artieri
n° 1 cp. g. co ll egame nti
re p a1ti e servizi va ri
nucleo uffi ciali primo inqua d ramento repart i soma li, per un total e el i circa 6.000 uomini (pe r ragioni di bilancio due btg.CC. rim ase ro in Italia).
Il trasferimen to in Somalia iniziò il 2 febbraio 1950 (i nizio del carico della prim a nave) ed ebbe termine il 2 april e dello stesso ann o (a rrivo a Mogadisc io dell' ultimo carico):
Compagnia Ge ni o Co llega m enti
L'a rticolazione della compagnia prevedeva:
- n° 1 pl. comando
- n° l pl. tel efon isti e telegrafì sti
- n ° 1 pl. co ll egam e nto co n aerei
- n° 2 pl. marconisti co n mezz i di gra nde portat a
- n° 1 p !. m arconi s ri per m in ori reparti.
Come richiesto d a ll e ca ratt eristich e de ll a zona di imp iego, il reparto prese nta v a una accentuata preva lenza dell a componente radi o per cu i a questa componente si riferiranno le osservazioni che seguono.
Co me e nte di cos tituzione era stato designato il btg.g. coll. "Gr ana ti e ri di Sardegna" co n sede a Roma-P ietralata, me n tr e la sede s tanziale era stata definita pr esso la Sc uo la Genio Collegam ent i d e ll.a Cecchigno la.
I primi ass e gnati giunsero nella te rza decade di agosto 1949 e, nell'arco di tre se ttiman e, l'a t1luss o del personale poté considerarsi concluso .
L'approntamento del reparto incontrò numeros e diffic oltà , sop r attutto nella pr im a fase della cos titu zione cara tt erizzata dalle e s ig e n ze d i trasp orto per il perso. nale in aft1usso e per il prelevamemo de i materiali in clor azione .

Infatti, la disponibilità di m e zzi di trasporto e ra limitata ad uno SPA 38, in te mporanea conseg na , mentre il persona le aft1uiva scaglionato alla stazione Termi n i e gli organi dei servizi erano frazion ati in diverse sedi; i m ez zi di trasporto civili erano in es is tenti , mentre l'un ico iti nerario disponibile era rappresentato dalla v ia Laurentina i n cattive co n diz ioni d'uso tanto da ut ilizzare, fra l' altro, un ponte Bailey per il sup e r amen to di un fosso in zona Tre Fontane.
I materiali erano eli provenienza alleata e, per la componente rad io, si trattava di SCR 299-399-499, R 19 e di compl e ssi per il collegamento con ae re i p er assiste nza al vo lo (SCR 522). Inoltre, era prev is t a una stazione trasmittente da l KW il collegamento con l'Ital ia.
Gli automez zi, invec e , oltre che di prov e ni e nza all e ata (J eep, Doclge 3/4, aurocarri lab orator io rad io e filo , auto -offici na) comprendevano anche nuovissimi autocarri OM Taunus e Lancia 3Ro.
Un accenno particolare merita il proble ma d e i mat e riali di scorta per i mezzi di collegamento, in quanto l'organizzazione log istica non prevedeva, per la compagnia collegamenti , organi superiori a quelli di r e parto.
P ertan to , fu necessario cost itu ire scorte di materiali eli ogni ti po non potendo, inoltre, fare affidamento sulle risorse locali Trattandosi, poi, di materiali di provenienza alleata, la fonte principale di alim enta zione e ra rappr es e ntata da i magazzini di Camnago Lentate, presso i qua li venivano scaricate le casse di parti di ricambio accatastate, in attesa della apertura colli, in cumuli corrispondenti ai va goni ferroviari con i quali erano state trasportar e .
La ricerca veniva condo tta consu ltand o gli e len chi re lat ivi alle varie spedizioni che precisavano il materiale con tenuto nelle singole cas se . Le sorpre s e p erò non mancavano p e rché, ad e sempio, so tt o la voce generica "pa1ti eli ricambio per SCR 499 " una cassa poteva contenere solta nto picchetti per antenne.
Comunque, fu possibile costituire scorre ch e si dimostrarono, poi , in buona misura, rispond enti alle n e cessi tà.
Infine, per quanto riguarda il personale non si presentarono probl e mi in quanto la disponibilità di un ottimo gruppo di sottuf ficiali richie se so ltanto il perfez ioname nto eli alcuni e l' amalgi';lma fra tutti.
D i rilievo la preparazione di alcuni graduati, specie riparatori e marconisti.
I primi di dicembre 1949 la compagnia si trasfe rì a S M Capua Vetere in attesa d'imbarco.
Trasjèrimento in Somalia
Un primo contingente di persona le si imbarcò a Napoli s ulla "Auriga" il 2 febbraio e sbarcò a IVlogacliscio il 20 febbraio 1950 per p redisporre la s istemaz ione della compagnia che seg uì , sulla "Giovanna C." , a un mese di distanza, facendo sca lo a Bencler Cassim per sbarcare il btg. CC. destinato a presidiare quella locali tà.
La compagnia fu provvisor iam e nte sistema ta in un campo transito organizzato al 4° Km della strada che da Mogadiscio porta all'a e roporto. La p e rmanenza nel campo si protrasse per il tempo n e ce ssario alla sost itu z ion e dei va r i pres idi dei reparti inglesi con que lli italiani.
Pertanto, venne subito all estito un centro di collegamenti campa li che com -
pr endeva:
- s tazion i radio grande pote n za per il collegamento con Roma ( SM E) e con le co lo nne dirette a Galla ca io, Baidoa , Bender Cassim, Chisi maio;
- s taz ioni R.19 per i coll egamenti co n le altre colonn e;
- stazio ni radio per il co ll egamento di e mergenza s u freq u e nza di socco rso.
Venne, inoltre, atti vato u n serv izio di ricezione dei bollettini A!\SA presso la seg reteria dell'Amministra zi one Fiduciaria per le sue esigenze.
In sintes i, il movime n to verso l'i n terno era articolato principa lmente su autocolonne che dai du e itinerari a dispos izio ne Mogadisci o - Bender Cassim , lun go il confine co n l' Eti opia, e Mog adi scio - Chisimaio, lungo la costa , si arti colava in autocol o nne minori ch e rag gi un gev ano le varie lo calità.
I mov imenti vennero effettu a ti tra il 17 e il 31 marzo
Il primo aprile ebbe lu ogo il passagg io dei poteri fra le au tor ità britanniche ed it al iane.
In questo periodo ebbero modo d i mettersi in ev ide n za le notevoli capacità tecniche de i m arconisti che riusciro n o ad effettuare collegamenti s u d istanze che ragg iu n gevano anche i 1.000 Km (Garoe, Gardò) ed oltre (Bender Cassim).
In questo perio do si ebbe anche il battesimo delle pi ogge monsoniche c h e non cadevan o da ol t re d ieci anni , fatto che i nativi ritennero di buo n auspicio.
Schieramento
La co mpagnia occupò la sede sta nziate definitiva in un a case rma ad Ama r Ge Geb, alle port e di Mogadiscio, s ull a s trada d i collegame nto co n l'ae roporto.
La sistema zio ne del p ersonale e de i materiali era in baracche, mentre il comando occupa va du e piccole costruzioni in mura tura di du e locali ciascuna. Sistemazione che poreva essere considerata del tutto soddisface nte perché i manufatti erano immersi in una boscaglia , vi era la d ispon ibilità d i uno spiazzo in cemen to p er le attività addestrative u tiliz zato an che come ca mpo da tennis, la zona era sovrastata da un cordone d i dune su l qua le e ra stato ricavato il Circolo Sottufficiali Oltre le dune vi era la case rma della batteria di a rtig lie ria e poi il mare .
L'impiego operativo della co mpagnia , logicamen t e e ra co nseg uenza dell a di slocaz io ne assu nta da i reparti

Infatti, la Somalia venne suddiv isa in sei zon e territo ria li ciasc un a articolata su Comandi Zona ( Chisimai o, Ba id oa, Belet Uen, Gallaca io, Bender Ca ssim, Mogadiscio) e Pres idi dipendenti (u n d ic i in totale).
Di co n segu enz a , la rete radio articolata in mag lia regionale (GP) per il collegamento di Mogadisc io con i Comandi Zona e m aglie presidia ri e (R.19) con centri d i collegamento a Mogadiscio, Baidoa e Ga lla caio
A Mogadisc io il centro coll ega me nti fu inizialment e impi antato presso la compagnia , ma la distanza dal Com ando Truppe Somalia, situato a ll 'es tremo opposto dell a ci ttà, e d evidenti es ige n ze di funzionalit à prosp ettarono be n presto la necess it à di trasfe rire presso il Comando T mppe gli u ffici del ce ntro co llegamenti e la parte rad io ric eve nte. L ' aliquota trasmettitori rimase presso la compagn ia.
Si prospettava così il problema del collegamento fisico fra le due aliqu ote de l centro co ll egame nti per il quale erano disponibili cavi S-4 e pali in legno, ma non cavo metallico per il sostegno dei cavi. Fu tuttavia possibile reperire una quan tità sufficiente d i filo d i ferro zi n cato ch e ve nne ritorto (lO capi) co n u n marchingegno ru d im e ntale ma efficace rapprese ntato da un disco di ferro a n corato al terren o e fatto ruota re con una manove ll a. Lungo il perimetro del disco ve ni vano attestati i 10 fili di fe rro, ciascuno d ei quali, a ll 'a ltro capo, era an co ra to ad un gancio libero
Cartolina reggimentale rajJìgurante un militare del Genio Collegamenti impiegato nell'Africa Orientale. Tratta da "Esercito Italiano - storia di uomi?1i e armi " ed. Editalia, 1988.

di ruotare su un sostegno re tto in tensione da un militare.
La minacci a delle termiti, po i, rappresentava u n pericolo incombente sulla palificata poiché l'urgenza e l'indisponibilità di materiale idoneo non avevano consentito di osservare gli accorgimenti del caso n ella posa in opera dei pali.
Non vi furono conseguenze negative immediate.
Il centro riceve n te fu allestito utili zzando i ricevitori dell e sta zioni di grande potenza mentre il centro trasmitte nte si basò su un trasmettitore da l KW per il collegamento con lo SivlE, BC 610 per la maglia regionale, per collegamenti con presidi particolari e per il collegamento di emergen za , R.19 per i collegamenti con presidi minori.
Proprio nell'allestim e nto del centro trasmittente venne messa in risalto la capacità dei radiomontatori (2 SU e 4 graduati). Vennero infatti brillantemente riso lti, con i materiali di scorta, i problemi incontrati nella manipolazione a d istanz a dei segnali telegrafici e nella centralizzazione su unico pannello della accensione dei
tra s m e ttito ri e della lettura d ell a strumentazion e di contro ll o.
An ch e ne l se ttore d e lle ant e nn e fu rono condotte a term ine, con esito positivo , sp e rim c ntazione di cos t ruzion e eli a nt e nne effi cient i in carem::a di s paz io (Yagi , utili zzando e le menti di antenna de ll a .R.19).
In fine, ebbe subito inizio l' at ti vità di assistenza a l volo nei pres id i dotati di strisc ia di atterragg io ( comandi zona ed alcun i pres idi minori) memre proseguì senza interruzione l'ascolto sulla frequenza di soccorso e la ricezione dei bollettini A.'\ SA. Esercizio e della rete di
La re te eli collegamento radio non subì significative trasfo rmazion i durante il primo anno di esercizio.
Le novità più s ignifìcativ e tigua rd ava no il traffico svolto e l'impiego dei mi litari somali.
Il co mandante chiese ed ottenne c he il traftìco pri vato fra Moga discio e Bendc r Cassim ven isse istradato su ll a r ete militare. Il t r a ffi co d' is tit uto, militare e dell'Amministrazion e Fi duciaria, in1pegna va già quasi tutta la pote nzial ità della compagnia, per cui questo nuovo onere fece nascere subito problemi di non facile soluzione conne ss i con le caratte ristiche e con il volume del traffico da smaltire in situazi o ni amb ie ntali non favorev oli, specie a Bender Cassim (sistemazio ne in capanna).
Infatti, la comp agnia era stata formata prevalentemente con pe rso nale tratto da unità dell 'Ese rcito di campagna, non addestrato in particolare alla ricezione co n trascrizione diretta su macchina da scrivere, pera ltro quas i inesistenti. E qui s i mise a ncora in evidenza la ca p acità dei marconisti che facendo ricorso al famoso "Morse a fri cano" riuscirono a smaltire vo lumi di traffico eccezionali. In ques to campo divenne gius tame nte famosa la coppia Ma r Magg. Agostini (Mogadiscio) e ca p.magg. Sorrentino (Be nder Cassim).

r m ilit a ri somali ricevevano l'addestramento basico presso il btg. reclute di Ua rsciek (60 km . NE di Mogadiscio, sulla costa) e venivano avvia ti ai re p arti per l'impiego dopo ave r frequentato i co rsi relativi ai vari in car ichi
Pu ques to un pe riodo patti co larme ntc interessante, ricco di es p e ri enze perché m etteva a diretto contatto culture , m e ntalità, graduatorie di vaioli molto ditJerenti L'attività di coma ndo offrì le più signifi cativ e sotvrese e richiese sensibi li tà e comprensione p e rch é al s uperiore veniva demandato il g iudi zio petfmo su proble mi d i v ira familiare.
In rapida s u ccessione di tempo vennero affidati a i soma li nuovi inca richi (p es : co nd uttori di a utomezzo) mentre ve nivano svolti cors i d i spec ializzazione
Di pa rticol are inte resse e sodd isfaz io n e il co rso per marco ni sti che p01tò in breve t em p o, circa quattro mesi, alla costitu zione di eq uipaggi somali per R 19 che sostituirono gli e quip aggi nazionali ne i presidi di Uarsciek, Itala, Afgo i, Danane.
Ebbe così inizio la progress iva sost ituzione di persona le nazionale con somali con co nseg uenti rimpatri di p e rsonale e co ntrazion e eli comandi e reparti na z ionali
In po co più di due anni fu poss ibile contrarre le comp ag nie genio a rtieri e co llegam c nli in un 'unica compagnia n1ista.
çonclusioni
Come si è visto, l'impegno con cui furono svolt i i compiti affidat i a cias cu n o, l'ambie nt e se re no , di reciproca compre nsione e fidu cia che si era ins taura to fra nazionali e somali cons e ntì il rispetto dell'impegno per il raggiu n g im ento dei traguardi indi ca ti all 'Amministrazione llaliana in Somalia.
Purtoppo oggi la Somalia è in una s ituazione politi co-socia le talmente grave, da far in so rgere legittimo il dubbi o s ulla utilità d el lav oro s volto co n ta nta gene rosità, imp eg no e spi rito di sacrifi c io s ia durante l'A.F.I.S. s ia in te mpi più re centi.


Annuario Ujjìciale d elle Fo rze An nette de l Reg no d'Italia. Roma 1938
.Apercu des Dijferents Pm ced ès de 'J eleg rctph ie /Vlilitaire d e l Cap . F. Borson , manos c ritto del 1856, c us Lod ito p re s so I' Ist itu ro d i CulLura d e ll 'Arma de l Ge ni o, Rom a.

Bi bliograjìa JI!Iarco n ia na, Ce n tro per la Sto ri a d e ll a Tec ni ca in Ita li a d el Co n s ig li o Na ?.i o na le d e lle Ric e r c h e. Eci .G iunt i, 1974.
Cenni Storici sulla Telegrafia efellrica di]. Bozza. Ed. Du ra Napoli, 1861.
Con la Radio contro la Grecia, del Ten . Co isillenri. Ed . a c ura del ::\otiz iario delle Trasmissioni, 1956.
De Furtivis Literarum Notis Vulgo de Ziferis di G. B. Porta. Napoli 1563 &ercito e Contunicazione, a cura dello SME, 1993.
Hse rcito e Scienza, a cura del lo SJ\ILE, 1991.
Evoluz ione d elle Trasm issioni i li Campo Tattico, de l Mag . T um ba re ll o . Ed. a cura de l No liziario dell e T ras mi ss ion i, Nov-D ic 1956
I Telegm:fìsti nella Guerra 1915- 18, d i V. Angclo ni Ed a cura dell 'Is tituto Storico e di Cu ltu ra de ll 'Arma d e l G e n io, Rorna 1963.
Il Geni o e le Trasmissioni p e r il Paese Ed <:1 c u ra dell 'Is pettor a to Ge n eral e d e l Gen io e dell ' Ispe tto rato delle '.l 'r<1smiss io ni.
Il Genio Militare n ella campagna in A.O., d e l Gc n. C. A. Ca ffo Ed. a cura d.e ll ' Is t. Storico e di Cu ltura Arm a del G(;nio, 1963 .
Il Servizio !r(fòrm azioni Milita re Italiano da lla sua cos lil uzion e a lla fi ne della Seconda Guerra l'V!ondiale, a cu ra di SMD / S IFAR. Ed. 1957 .
Il Telegrafo da campo presso il Co1po dei Volontari italiani nella cctmpagna del 1866 di E. De Rossi. Ed. Voghera , Roma 1902 .
Istruzioni tecnicbe del GelliO - Telegrafia Eletrrica. Telefonia e Telegrafia Ottica, a cura del Ministero della Guerra. Ed. Voghera, Roma 1916
Italia iVfille Anni, eli R. Romeo . Ed. Le Monnier 1981.
L :A r ma d e l Genio - Cenn i Storici, a cura delle Sc u ole d i Appli caz io n e d'Ar m a, To rin o 1966.
L'Arma d el Genio nella Grande Guerra 19.75-18, a cura del Ge n . L. Lastrico , d e l Min istero d e ll a Gu e rra c clcll 'l spe tto ra to d e ll ' Arm a d el G e nio. Ed. Tip. Reg iona le, Roma 1940
L'Arma del Genio, a c ura d ell a Riv is ta Milita re , 1991.
L 'Eserc i to ita l iano da l J o 1ì'icolo re al l ° Cen te n ario , a c ur a d el['{jffi cio Sto r ic.:o d e ll o SME. RotTW .1 96 1
L '&ercito p e r il Paese, a c.: ura de ll o SME.
La Gu e rra Elettro nica - da lla Ba ttag lia di Ts ushima ai Gio rni Nost ri, d i M De Arc.: an ge lis Ed Mu rs ia, M il ano 198 1.
La Logist ica deii'E·w rcito Italiano ( 1831-1981) vol. 11 d i F. Roni. Ed. Lmerza Ba r i 199 1 . (Per con to dell'Uffido Storico dello Stato !'vi aggi ore clell'Esercito.)

La radio in grigio t..•erde, eli Galasso e Gaticci. Ed. C&C Kadioelettriche. Faenza.
f.a Rivista Jllilitare.
La Sacra Bibbia. AA.VV. Ed. CE I- CECl, Roma 1989.
Manuale di Crittogrr4i'a , del Gen . L Sacco. Roma 1947.
;vf anuale d i '.J'el ep,rc(/ÌCI h'lelfrica d i C. Ma tt e uc c i. Ed . Unione Ti pografica, Torino
186 1.
Manua l e pe r 1'1...!/.fi c ia le d el Ge ni o i n Gu erra. E d . a cu ra d e ll 'l spctlO r:tto Gc n c..: ra l c d e l G eni o , Ro ma 19 1H.
Mondo se n za jìli. el i G Mo nte Ciml lc. Ed C&C Ra di o el ett ro n iche, Fae nza 199 1
New Age En cyc loped ia d i P Lex ico n 1978
Oltrema re, a c ura de ll o SMf.
Op ercrz ioHe A irolle, a <.:ura d ello SM.E.
Special ità Telegrcifìsti - Istruzione Pr ouuisoria su lla Telegrajìa Ottict1, a cura delle Ist r uzioni P ratiche dd Genio. Ed. Voghera , Roma 1890.
Storia dell'Anna del Genio (dalle origini al 1914). di M. Rorgani. Ed. a cum della Rivista di Artiglieria e Genio , Roma 1931.
Storia della Radio. di L. Solari. Ed. F.lli Tre,·es, Milano 1939.
J'elegn-!{ia senzajìlo eli A. Righi c R. Oessau. E d Za n ichelli, Bologna 1903.
Voci tra i monti - Rttdiu e Te lecomun icaz io ni in Valle d Aosta. Ed. Mu.su lll eci
Edito r e, Aosta J 990.
Bibliografia per autore
V. Anp,elotti. "I Te leg rafi s ti n ella Gue rra 191 5 -1 8". Ed. a cura d ell ' ls tit uto Sto ri co c di Cu lt ura d ell'Arm a del Gen io, Roma 1963
M Bmgatti. "S to ria de ll' Arma del Genio ( d alle orig ini a l 1914)" Ed. a cura della Riv ista di Artiglieria e Genio, Roma 1931.
Cètp. F "A p e rcu cles Differents P rocedès d e Telegr a phi c l'vli li ta ire " , man osc r it to del 1856, cu s todi to p r esso l 'Istitu to d i Cult u ra dell 'A rm a de l Ge nio , Roma.
P. Botti "La Logist ica de ll'Esercito Italiano ( 183 1- 1981)'\ vo l TT. Ed . La te rz a , Bari 199 1. (Per con to d ell'Ufficio Sto ri co de ll o Stato Maggiore d ell'Ese rcito. )

I B ozza."Cen n i Sto rici s u lla Telegrafia Ele ttrica". Du ra NapolL 1861.
(]en. C.A "TI Ge n io Mili tare n e ll a campagna in A.O '' Ed. a c ura de ll 'Ts t. Storico e di Cu ltura Arma d el Genio, 1963 .
'I'en. Coisi!tenti. "Co n la Radio co ntr o la Grecia ". Ed. a eu ra d e l No t. de ll e T ra s missi on i, 1956.
M De Arcangelis "La Guerra Elett ro nic a - dall a batt aglia di Ts us J1 im a a i g io rn i n os tr i". Ed 1Vlursia , Milano 1981.
E De Rossi. "TI Te le grafo d a campo presso il Co rpo dei Vo lonta r i Ita li a ni ne lla ca mpagna del 1H66' ·. Ed . Vogh era, l:Zoma 1902 .
(]a/asso e Gaticci "La radio in g r ig io ve rde". Ed C&C l{adioelettr ic h e , Fae n za.
Gen. L. Lastrico d el Min iste ro d e ll a Gue rr a e clell 'Is pettoralo d ell'A r ma d el Genio. "L'i\ rma de l Ge nio n ella G rande GuetTa '15 -'18" Ed. Tip. Re giona le , Homa 1940
P. Lexicon "Ne vv Age Encydope clia " . Ed . 197B.
C. Matteucd. "Manuale di Te legr afia Elcn ri ca" . Ed. Un ione T ipog rafica , Torino 1861.
C . Afontl!fìnale. " /Vlon do senza fi Li ". Ed . C&C Hadioe lettro nic he , Faenza 1991
G B. Porta "De Furtiv is l ite ra ru m Notis Vulgo d e Zifc ri s ' Napo li 1563.
R. Rorneo. "Ital ia M ille Ann i" . Ed. Le Monnier 1981.
A. Righi e B. Dessau. "Telegra ria scn7.a fi lo". Ed Zanichelli, Bo logna 1903
(Jen. L. Sacco. "Ivlanuale d i Crittog rafia". Rorna 1947.
L. Solari. "S to ri a del la Hadio". Ed F.ll i T reves, Mil a n o 1939. kfal!, "Evo luzione d elle Trasmissioni in Campo Tatti co ". Ed. a cu ra d el No(. de ll e Tras mi ss io ni , Nov -Dic 1956.
Bibliog rafia per titol o
"Annuado Ufficiale delle Forze Armate del Regno d 'Italia". Homa 1938.
"Bibliografia M.arconiana" , Centro per la Storia del la T ec nica in Italia de l Cons ig li o Naz iona le delle Rice rche. Ed.G iunti ,1974.
"Esercito e Comunicazione" , a cura dello SME, 1993.
" Esercito e Scienza" , a cura dello SME, 1991.
" Il Genio e le Trasmissioni p er U Paese". Ed. a cura clcli'Tspettora to Generale del Ge ni o e de ll 'Is perronno delle Trasmissioni.
"Il Se rvizio Informazioni Militar e Italiano dalla sua costituzione alla f"lne della Seco nda Guerra Mondiale" , a c ura di SMD/SIF/\R . Ed. 1957 .
"Istntzioni tecniche del G e nio - Telegrafia Elettrica, Telefonia e Telegrafia Ottica" , a c ura del1Vlinisrero della Guer ra. Ed . Vogh era, Roma 1916 .
" L' Arma del Genio- Cenni storici ". a cura delle Scuole di Applicazione d'Arma , Torino 1966.
" L'Arma d e l Genio", a cura della Rivista Mi litare, 1991.
"L'Eset·cito Italiano dal 1 ° Tricolot·e al P Centenario " , a c ura d e ll 'U ffi c io Sto ri co de ll o SlVIE . Ro ma 1961.
"L'Eset·cito pet· il Paese" , a cu ra dello SME
"La Rivista Militare"
" La Sacra Bibbia" , AA.VV. Ed. CEI-t;ECI , Roma 1989.
" Manuale per l 'Ufficiale del Genio in Guerra". Ed. a cura deii'Tspettorato Generale del Gen io, Roma 1918
" Mondo senza fili", el i G. Montefinale. Ed. C&C Radioe lenronicb e, Fae n za 1991.
"Oltremare", a cura d ello SMF.
"Operazione Airone" , a cura d e ll o SME
" Spe cialità Telegrafisti - Istru z ione Provvisoria sulla T e l egrafia Ottica" , a cura delle Istruzioni Pratiche d el Genio. Ed. Voghera , Roma 1H90.
" Voci tra i monti - Radio e T e l ec omunicazioni in Valle d ' Aosta". Ed. Musumcci Editore, Aosta 1990

SIGLE ED ACRONIMI


A
- A - A.C.
- A.F. I.S.
- AflJS
- A M.
- AJ'v1AT
- A.l\AG
- ; \ :\'GET
- AO - AOl - .ARAR
- ARRC - AS
- i.\ .S - ATM - AUC - AVES B - B.f. - BER
- B -ISD N
- BITE
- Btg.t. c - C3J
- C.A. - CAAH.
- C;\R
- CATRI N
- CDE
- CETAM
- CIDE - C.I.L.
- CMT - CNR
;\rmata
Aut o rità Ce nt ra le Amm inis trazione Fiduc ia ria It aliana de lla So malia Addestra m en to a ll e Funz io ni di Ufficiale Supe ri o re Aereona utic a ?vli lita re Armi, Muni;,.ion i c i\rmam en ti Te r res tri .Assoc iazione Nazionale Ar ma d e l Genio Assoc ia zione Na zio nal e GE ni e ri c Trasme ttitori Africa Or ien ta le Afr ica Ori e nta le Ita li ana Az ien d a Rilievi e Alienazione Rcsicl uati
Ace H.a p id Rcaction Corps
Alli evo Sot tu ffi c ia le Afri ca Settentrionale
Asynchrono us T ra nsfe r Mode

A lli evo U fficial e el i Comp lemento
AVia z ion e de ll 'ESer cit o
Brigam eli fan teria
Bit E rror Ra te
Broadband Inregrated Serviccs Dig it a i Ne two rk
Built- ln Tes t Eq uipm e nr
Ba ttag li one t ra s mi ss io n i
Comando, Con tro llo, Comun ica zioni e Informa z ioni Corpo d 'Armata
Cent ro Add est ramento Avan za to Reclute
Ce ntr o Add estramento Reclut e
Sistema CAm p a le el i TRasm iss ion i INform az ioni
Cen t ro Difesa Elett ro nica
Ce nt ro Ele ttronico Tr artaz io ne Au to matica d ei Messagg i
Centro Info rma z io n i e D ifesa Elettronica
Cor p o I ta li a n o d i Lib e ra zione
Coma n do Mi litare Territor ia le
Combat Ne t Rad io
COMunicatio ns SECurety
Compagnia genio pionieli Compag nia trasmissioni
Corpo di Spedizione Italiano in Russia
Centro Trasmiss io n i
Centro Tecnico Materiali d elle Trasmiss io ni
D ir ez io ne Gene rale Armi , Munizioni e Arma m e nlo Terres tr e
E Lect ro n ic lNTe l ligence
Eler ro ni c Counter Meas ures
Enbanced EUROCOM System
Eserc ito ltaliano
Electro.>v1agne ti c Pulse
.Electronic Protective Meas ures
Elctronic Support Measures
Gruppo di lavoro EUROpeo sulle CO Mnicazioni
Fo rz a Armata l Forze Armate
Frequency Division Mu ltiplexing
Comitato Francia, Italia, Netherlancls, Belgio, lnghilterra , Lusscrnburgo
FLccT SATe llite COMmmu nication s
G iga H e rt z
Gr u ppo t<tttico
G ra nd e Unità/Gra ndi U nità
Guer ra e le ttronica
High Frequency
Tnstitute of Electrical and Electronic Engineers

Int ercettazio ne e RadioGoniometria
lnregrated Services Digita i Netwo rk
ISPEttorato Tr asm iss ioni
Loca l Arca Ne twork
Loca l Area Subsys te m
Line Te rminai U nit
- MHz
- .MIDS
- 1\·ILFP
- MS - .MU
MegaHe rt z
Multifu nctio nal Info rmative D is tribut ion System

M il it are d i Leva a Ferma Prolungata
Mob ile Sysrem
Mob.ilc U n it
- N1\ TO - NOG ET
!'\orth Atlantic T rea ty Org aniza tion N Orme GEne rali pe r le Trasmiss ioni
- OBAT - O lVfT - ON U - O Op.
PAM - PC - PCM
- PNR - PTT
- RA..P
- RTCEL
RM - RlvlCE
- Riv1 ME
- RMNE
- Rl\1NO
- RMSA
- RMSI
- RMTE
- RNU
- RPV - RSC s - SATCOM
SCR
- SCRA - SCUT - SHF
Ordine BAse per le Trasmissioni
O ffici na Militar e d elle Trasmiss io n i
Organizznion e del le Naz io ni Unit e Ord ine di Operaz ione
Piano Aiu ti lVlarsha U
Posto Com.an cl o
Pu lse Code Mo d:ula ti o n
Packet Ne t Rad io
Post e c Telecorn ini cazion i
Radio Access Poi n t
RICerca ELettronica
Regione Mili tare
Reg ione .Militare CEntrale
Re g io n e Militare MEridiona le Re gione Militare No rd - Est
Reg ione Mi litare Nord -O vest
Regione Ivli litare SArdeg na
Reg io ne Mi lit ar e Sic ili a Re gion e lVli lit are Tosco-Emiliana
Ruolo N ormale Unico
Remoted Pilotecl Vert icu le Ruolo Spec ia le Unico
Satellite Commu nicat io ns
Signa ! Corps Radio
S in gle Chan nell Ra d io Access
SCUola d e lle Trasmiss ion i
Super H ig h Frequency
STACCO:\
SIE - SlG l NT
SIOS - SM - SiVlCS - SMD - SME - SMMT - SNAP - SO.c'\'fCC
SORAO - SOTRIN
s u
TELECOMDIFE
TIC
TRAEMAT
TKANSEC
TROT.
Si stema Auwmmizzato di Comando e CONtrollo
Sistema I nformativo dell 'Esercito
SIGna! INTelligence
crvizio l nrormati vo Operativo sulla Sicurezza
Stato Maggiore
Systcm ,'vlanagement and Contro! Subsystem

Stato Magg io r e D i fesa
Stato Maggior e Esercito
Sta bi li mento IVli l iwrc Mate r ia li d elle Trasmi ssi oni
Stee r ahlc N ull Anten n a Processor
SO ll os iste ma d i Avvis t amento Ta t tico, Co m a ndo c Co ntro ll o
Sorr os isrc ma di SO Rveg lia nza e Aqu isiz i o ne Obi ettivi
SOtr.os iste ma el i TRasmissio ni I Ntegra te
SoLL Uffic ia l e
T i mc Division Mu l riplex i ng
Direzione generale impi anti e mezzi per assist<::nza <tl volo, per la DIFEsa aerea e per le TELECO:VI unicazioni
TeLeComunicazioni
TRAsporti E MATeriali
TRA 'smission SECuriry
Tapclcss Howrless On Line
1I nionc Europea Occidenta l e
Cl tra H ig h F req uency
L: n i cc J Trans i tion Ass ist ance Gro up
VllF
V.M.
Va l o r e Ci v i l e
Vo l o nta ri o a Fe rm a Prolungata
Very High Frequ en cy
Va l ore Militare
Vigile/ i de l Fuoco
Wide Area System
Widc Arca .:"Jctwork



I primi p ass i de lla telefonia
l p r imord i e la nascita d e ll e rras mis sion i radio
La pr im a camp a gna d 'E r itr e a (188 5-1889)

La seco nd a campagna d 'E ritrea (1895-1896)
La g uerra cl i Libia (1911 - 19 12)
r pr imi in terv ç nr i p er le pubb lic h e calamità
La p r im a G u e rra J'v1o ncli a le
Evol uzione d e ll e unit à rcleg ra fi s ti dura n te il co n fl itt o
Evoluzione d elle unità racliotclegrafi sti durante il conflino
11 se rv iz io colomb i v iagg iatori
L' int<::Tc c tr.az io n e tele fo ni ca
G li a l bori d e lla g ue rra e lc rrro nica
La cifra
La gco telegrafia
Cons ide r a?. ioni fi nali
CAPITOLO IV
DAL PRIMO DOPOGUERRA AL SECO.l\DO CO ·purro MO IDIALE 49
Il p r imo d o po g u erra : d i te nd e n z a
T1iflessi sulle Tms miss ion.i del l'evo luz ione o rdina tiva dcli' Ese rc.ito dal 191S> a l 1939
La ca mp agna dell 'Afric a Orientale ( 5 oltobre 1935- 5 maggio 1936)
La seconda Gue rra Mondiale
Fro nt e occid e nta le (10 -24 gi u g n o 1940)
Fro n te d e ll'AJì ·ica or ie nt a le ila Jiana ( 11 gi u gno 1910 -27 novembre 1941)
Fronle dell ' Africa se tt ent ri ona le (l 1 g iu gno 1940-13 magg io 1943)
Fronte greco- alba ne se ( 28 ottobre 1940-2 2 aprile 1941)
h ·on te jugos lav o (11 - 18 aprile 1941)
Fron te ru sso (agos lo 194 1-ge n n a io 1943)
Fro nte italiano (10 Ju glio-8 settembre 1945)
La gue rra di liberazione
CAPITOLO VI
LE "TRASMISSIOI\I " DEL POST- '75
T cambiamenti degli anni '70
ll primo decennio 0975-1985)
L 'attività di rice1'Ca e St)iluppo
I sistemi "post- 75"
La rete TLC infrastruttura/e
Interventi per pubbliche ca la 1nità
Il secondo periodo (dal 1985 a i giorn i nostri)
Il sistema CATR!N
!l snttnsistema S011(JN
!l PRlJ-S01RIN
!lSIACCON
Il Sistema Informativo dell'.l:.'sercito

La sicurezza dcJle comu nicazioni
CAPITOLO VII
VERSO IL 2000 ED OLTRE
Ordinamento
Ma teriali e mezzi
Prospetti ve di sviluppo tecnologico
Re golamen tazione di impi ego
1'\evicate


L'Amm inislrazione Fid uc iaria Italia n a della Somali a (A.F.l.S.), 247 a cura d el Gen. Guido Mart inelli Premessa

I co ll e gam enti pe r l'Amministraz io ne Fidu cia ri a Ita li a n a de ll a Somalia (A.F. l.S.) ,
a c ura del Gen. C A. Manlio Or/andini


