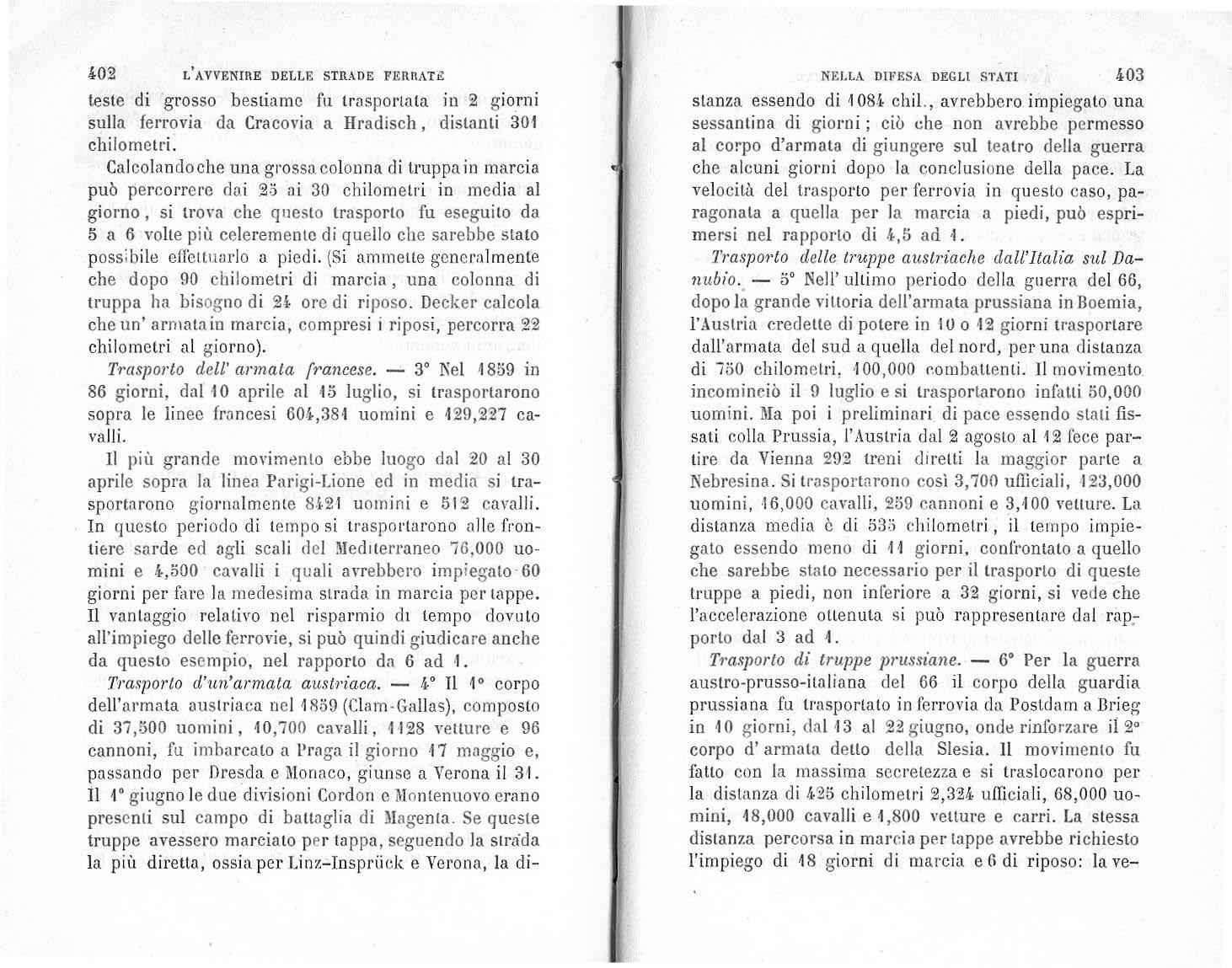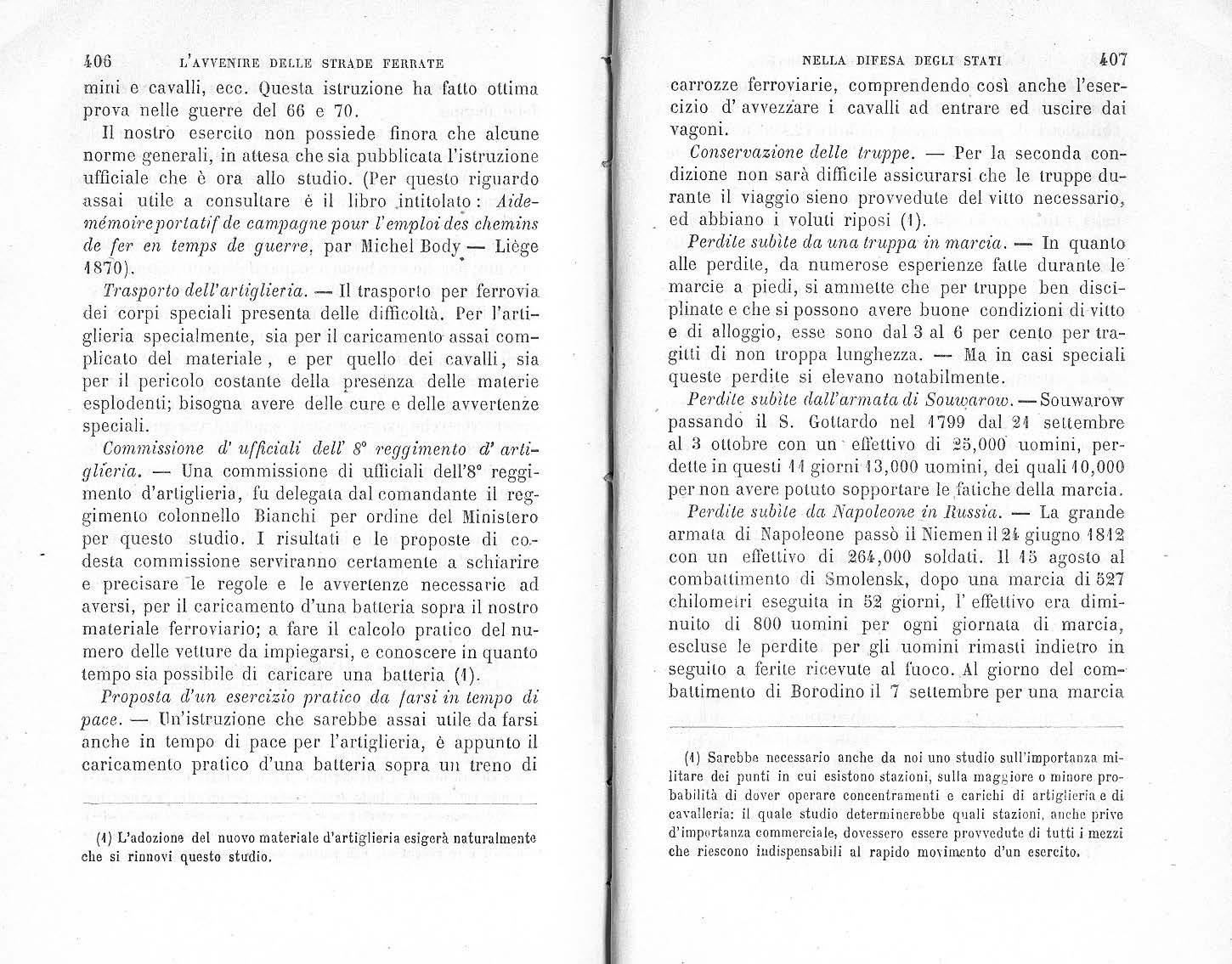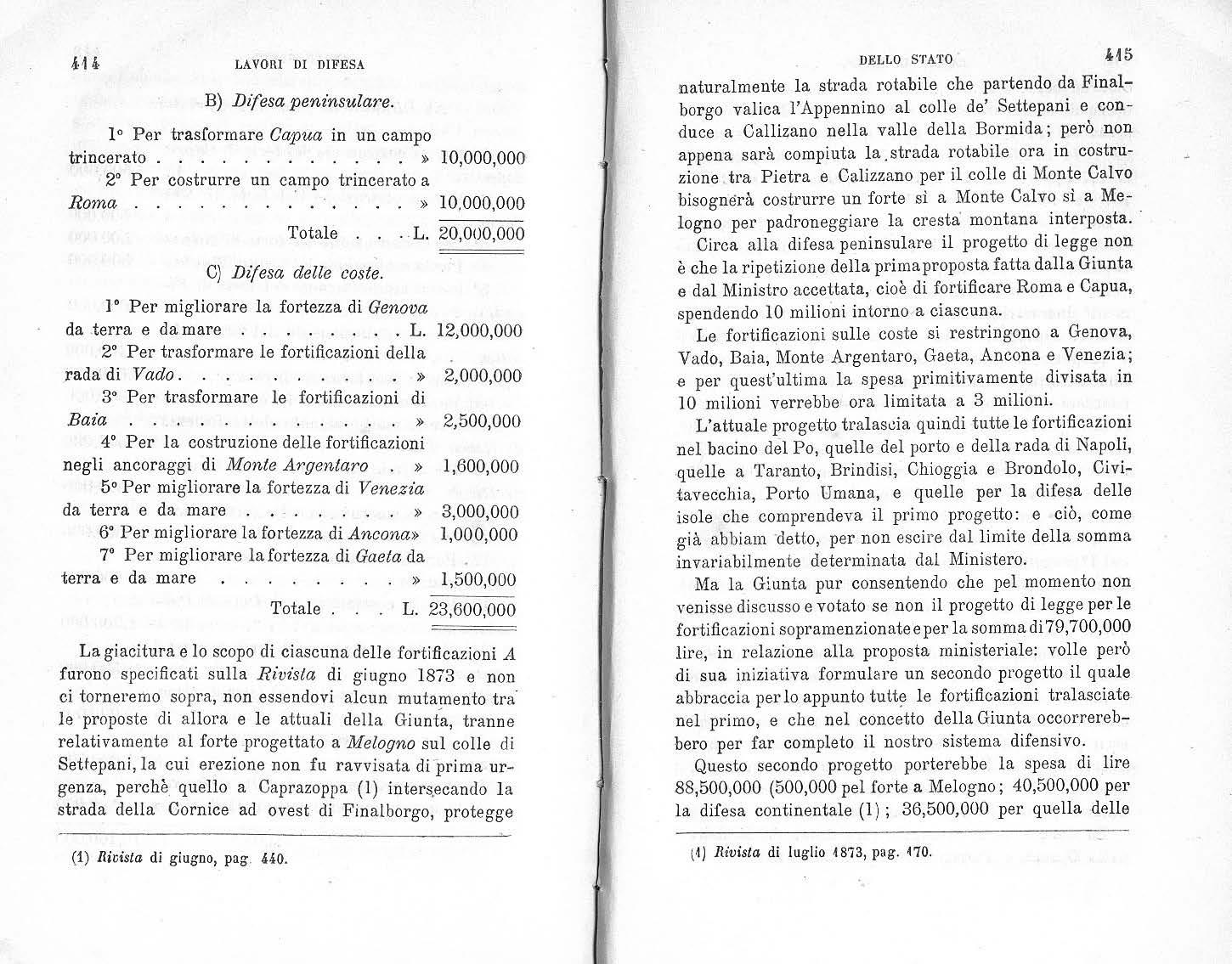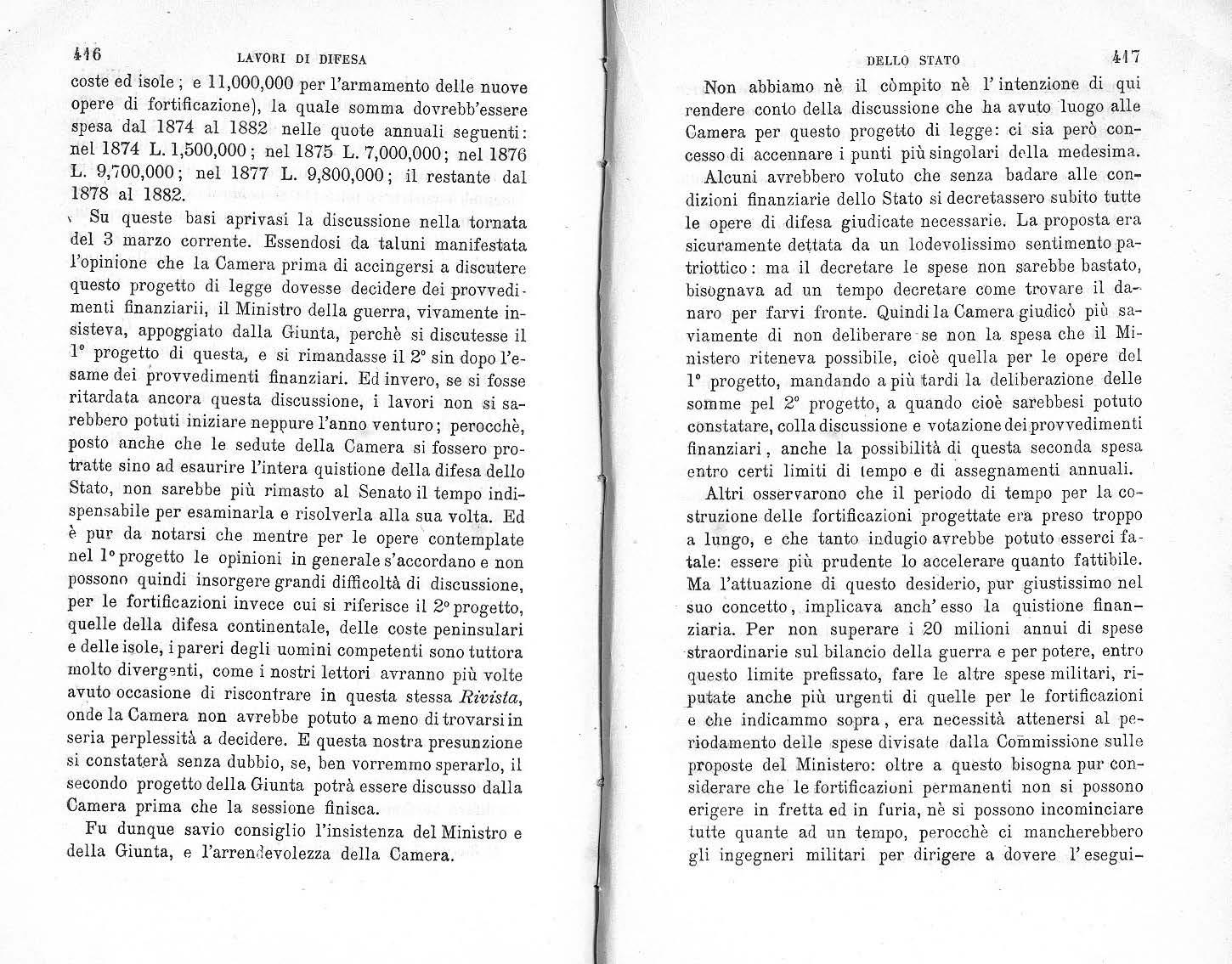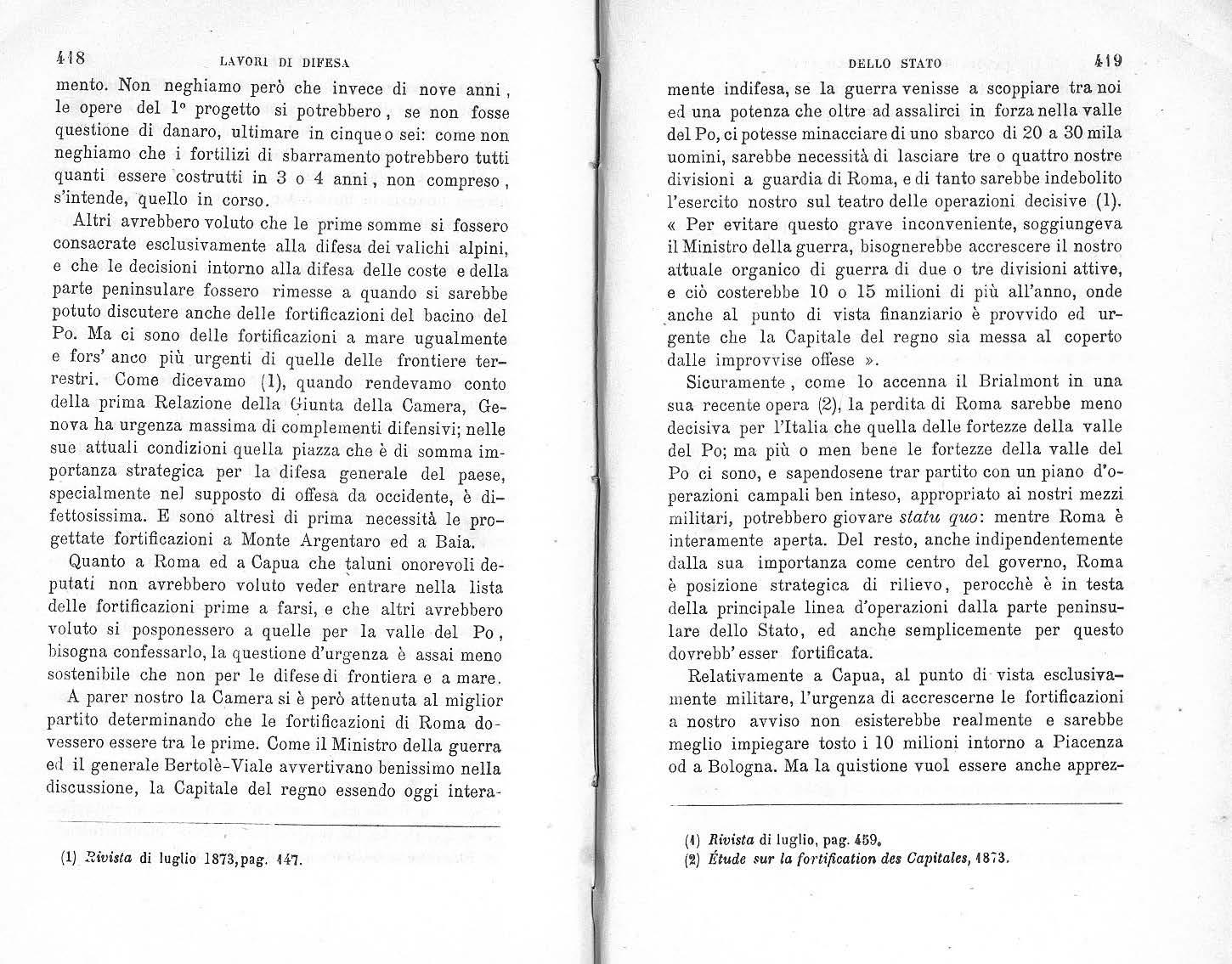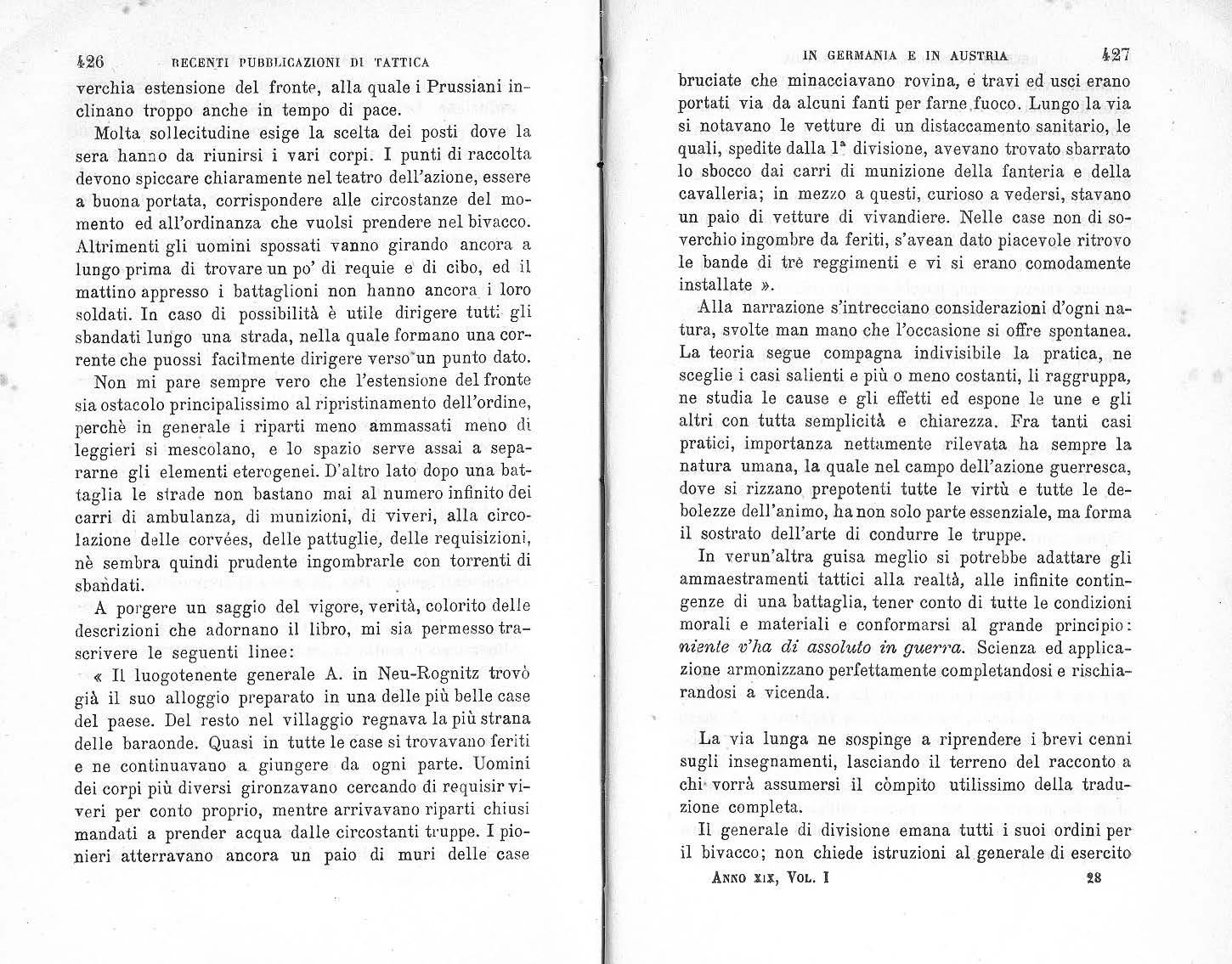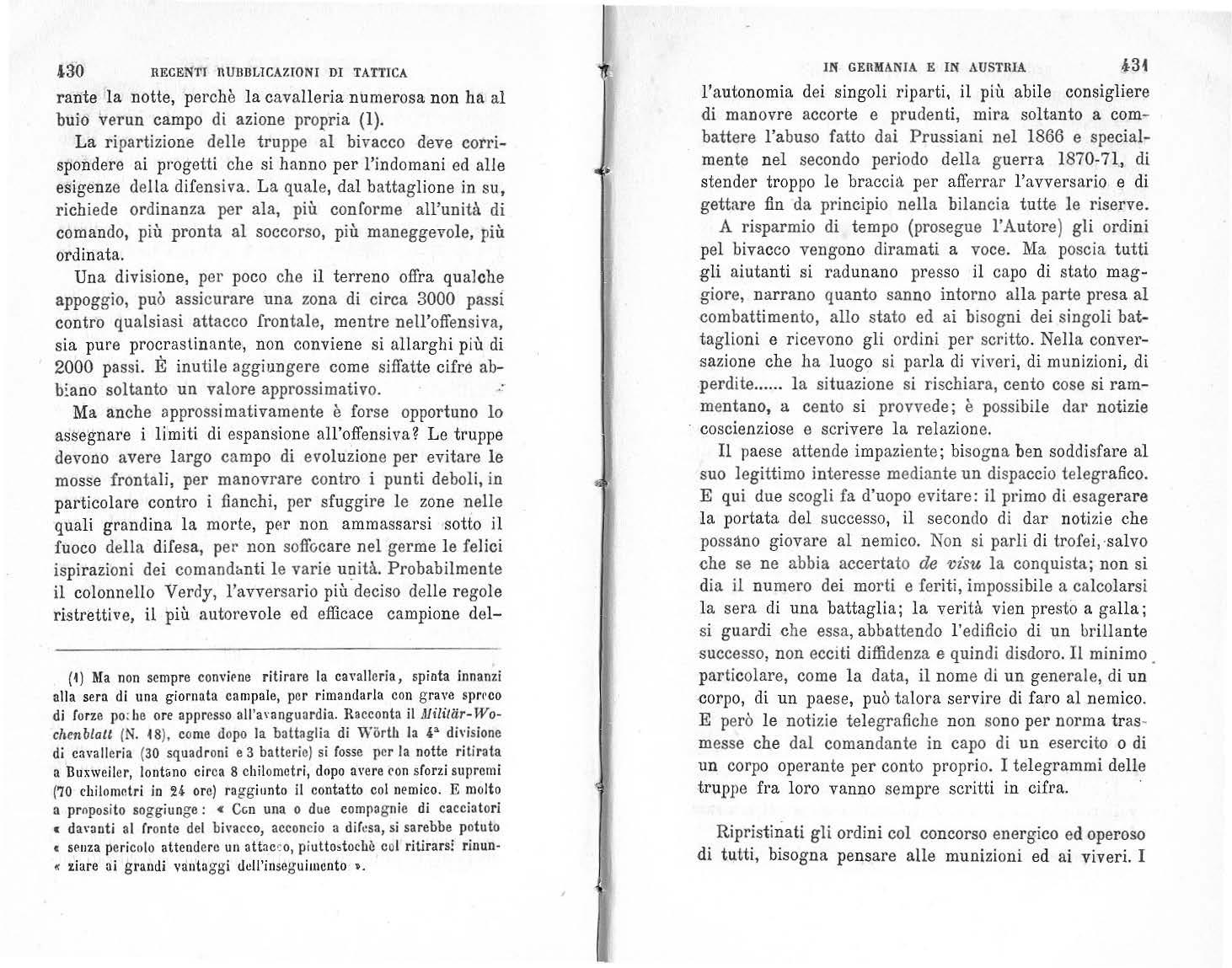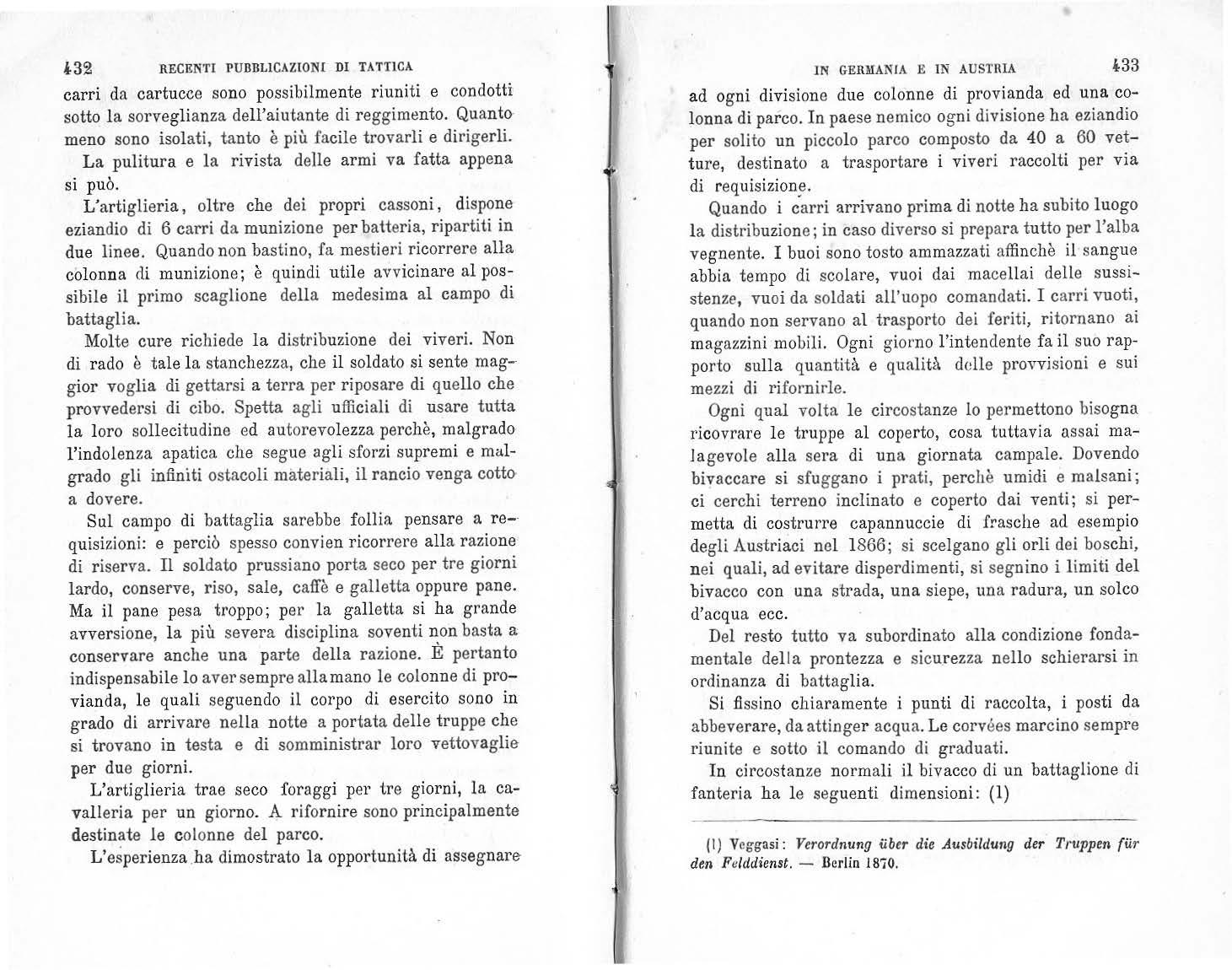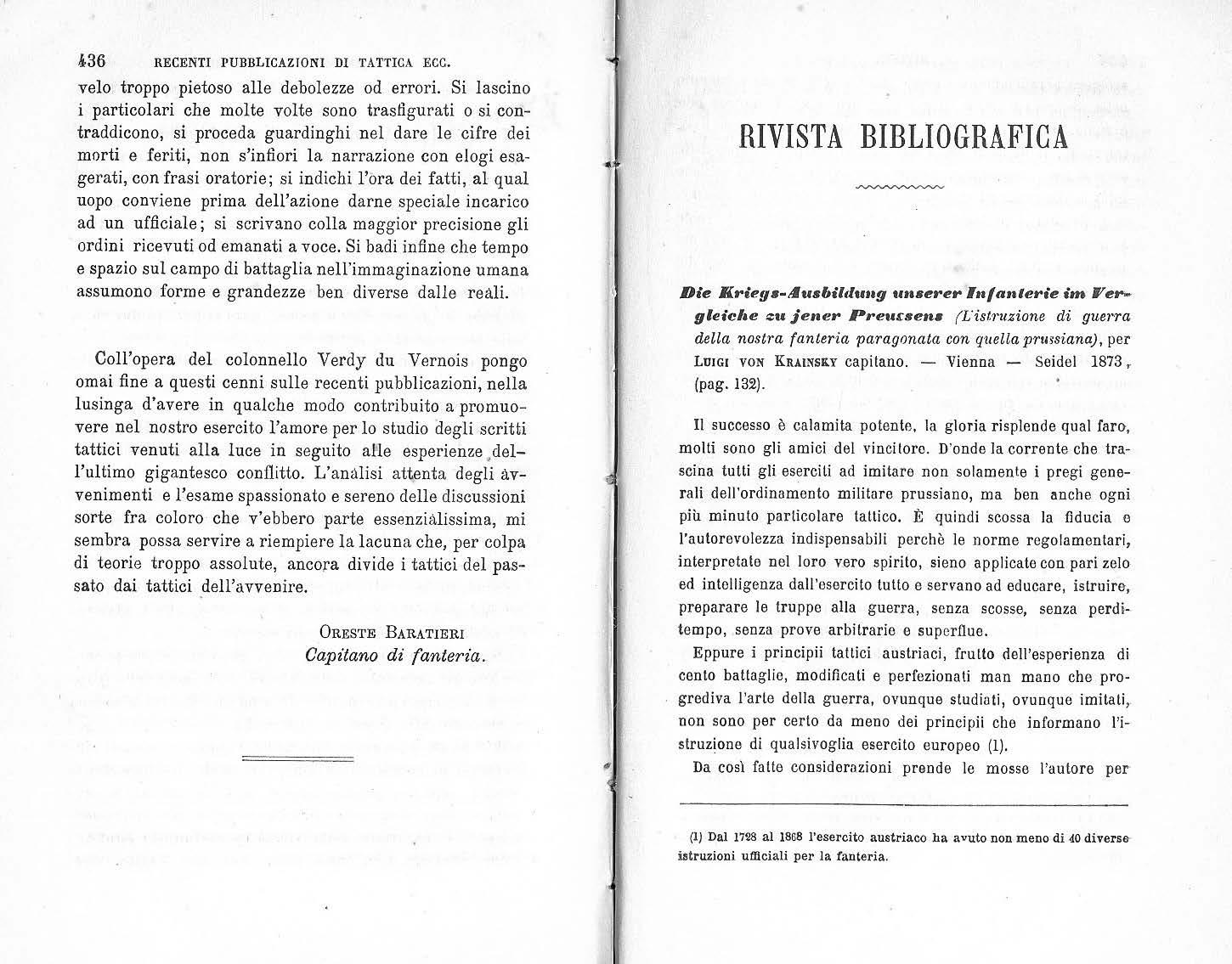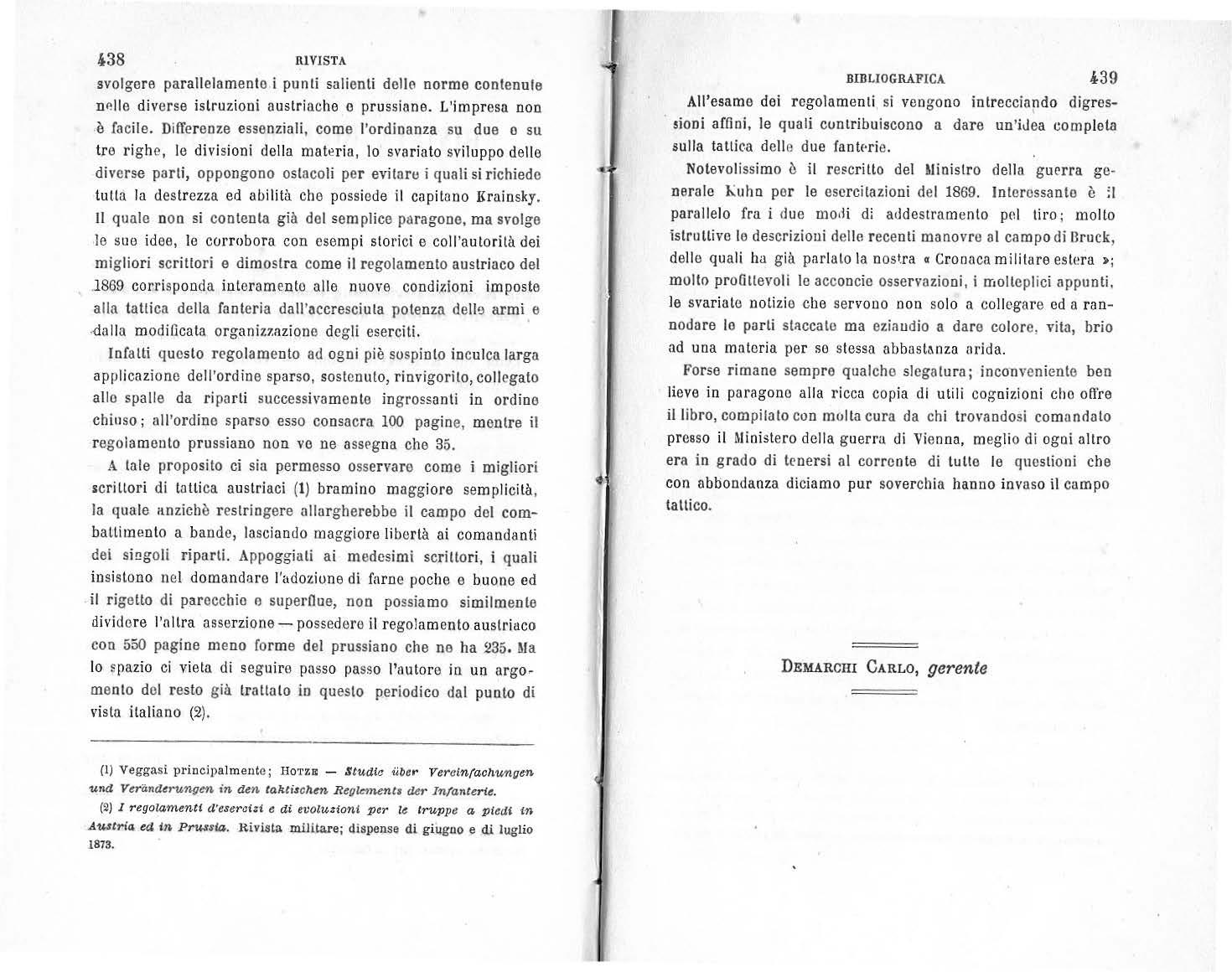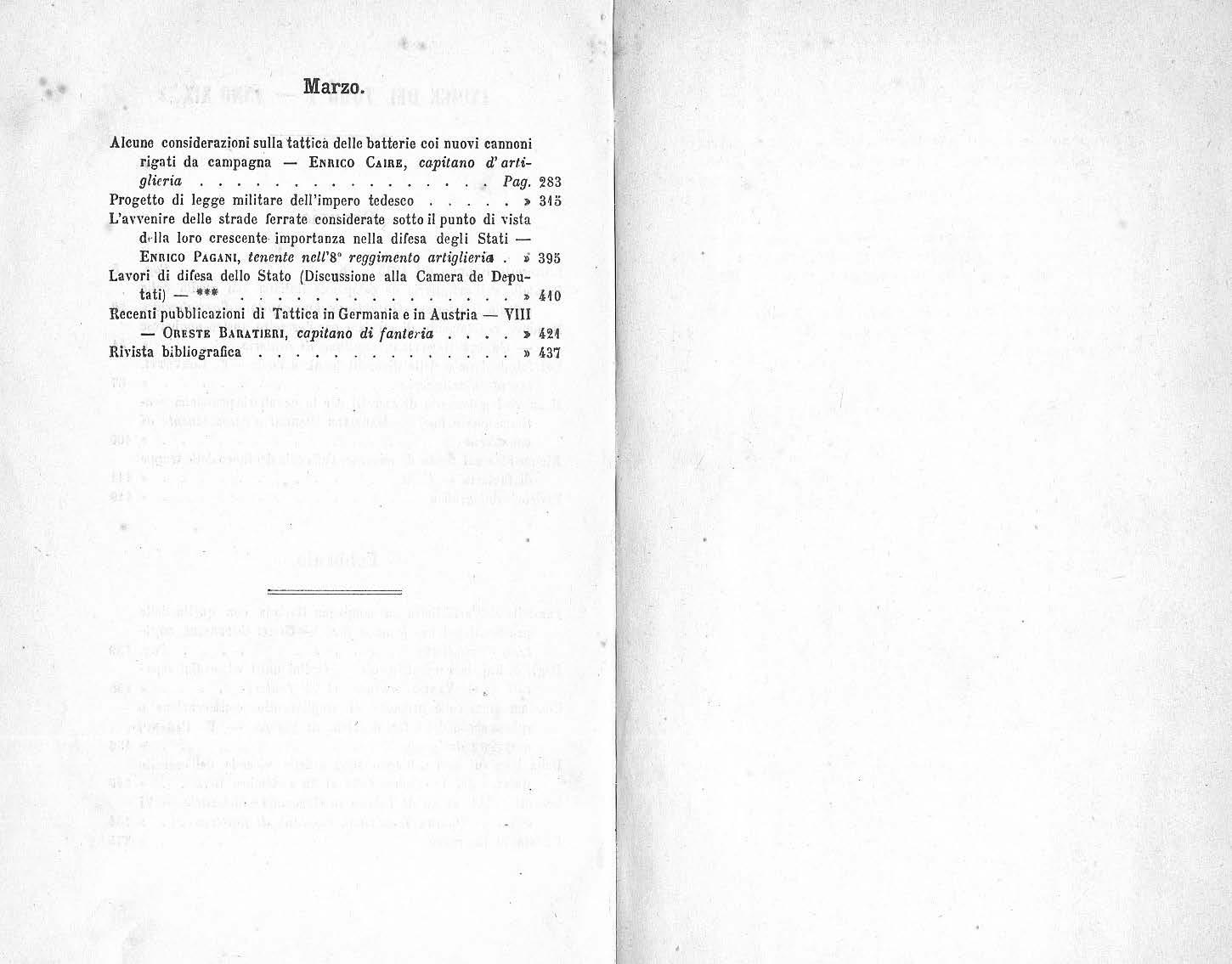RIVISTA MILITARE
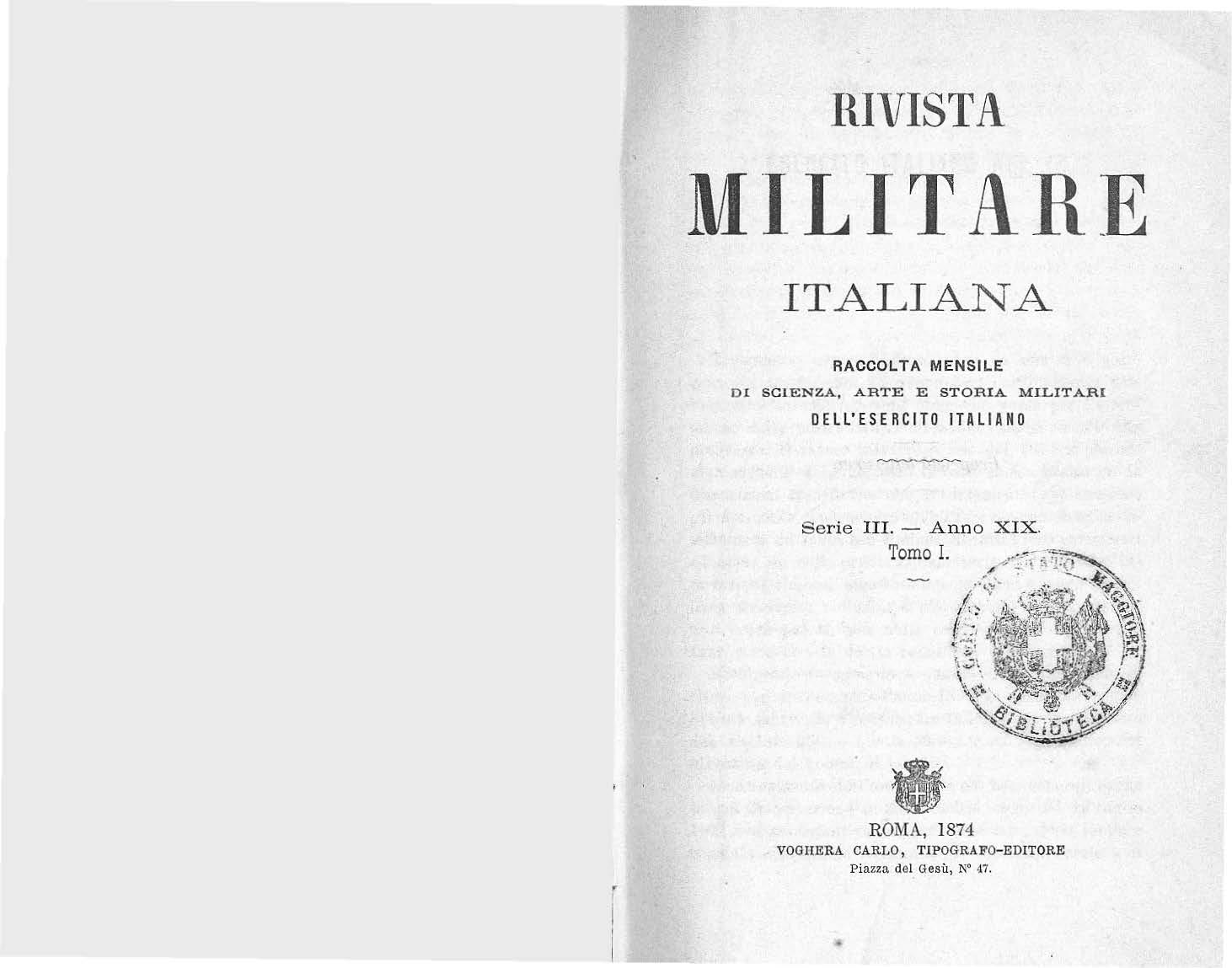
ITALIANA
RACCOLTA MENSILE
01 SCIENZA, ARTE E STORIA MILITARI
DELL'ESERCITO ITALIANO
Serie III. - Anno XIX.
Tomo I.
ROMA, 1874
VOGHERA CARLO, TJPOGRAFO-EDITORE
Piazza del Gesù, N° 47.
r l
L'ESERCITO ITALIANO NEL 1873
È compiuto ormai il terzo anno da che si è posto mano a trasformare su nuove basi l'ordinamento dell'esercito italiano; ed ogni anno che .passa , per l'incremento delle nostre istituzioni militari segna un notevole progresso . Il lavoro intrapreso fino dal 1871 si presentava difficile e lungo; esso doveva essere preparato da disposizio ni transitorie, ch'El gradatamen te appianasser o gli ost~lcoli e ci portassero infine ad avere un sistema determinato da leggi ben studiate in tutti i loro particolari ed applicate colla prudenza necessaria, trattandosi di innovazioni che pel momento non poteano a meno ,di turbare inveterate abi tudi ni e che richiede vano un tempo non breve per entrar e nelle convinzioni di tutti e per funziçmare con la debita regolarità e sicurezza.
R ivo lgendo lo sguardo a quanto si è fatto nell'esercito e per esso dur an te l'anno 1873, la nostra attenzione è tratta a.nzitutto a considerare le leggi discusse e votate dal Parlamento, e quelle che ancora sono sottoposte all'esame del potere legisl ativo.
L'ordinamento delÌ'esercito, le cui basi generali erano in via · d i attuazione in forza della legge del 19 l uglio 1871, venne definitivamente determinato, dopo lunga e sapiente dis cussione . avvenuta nei mesi di febbraio e di
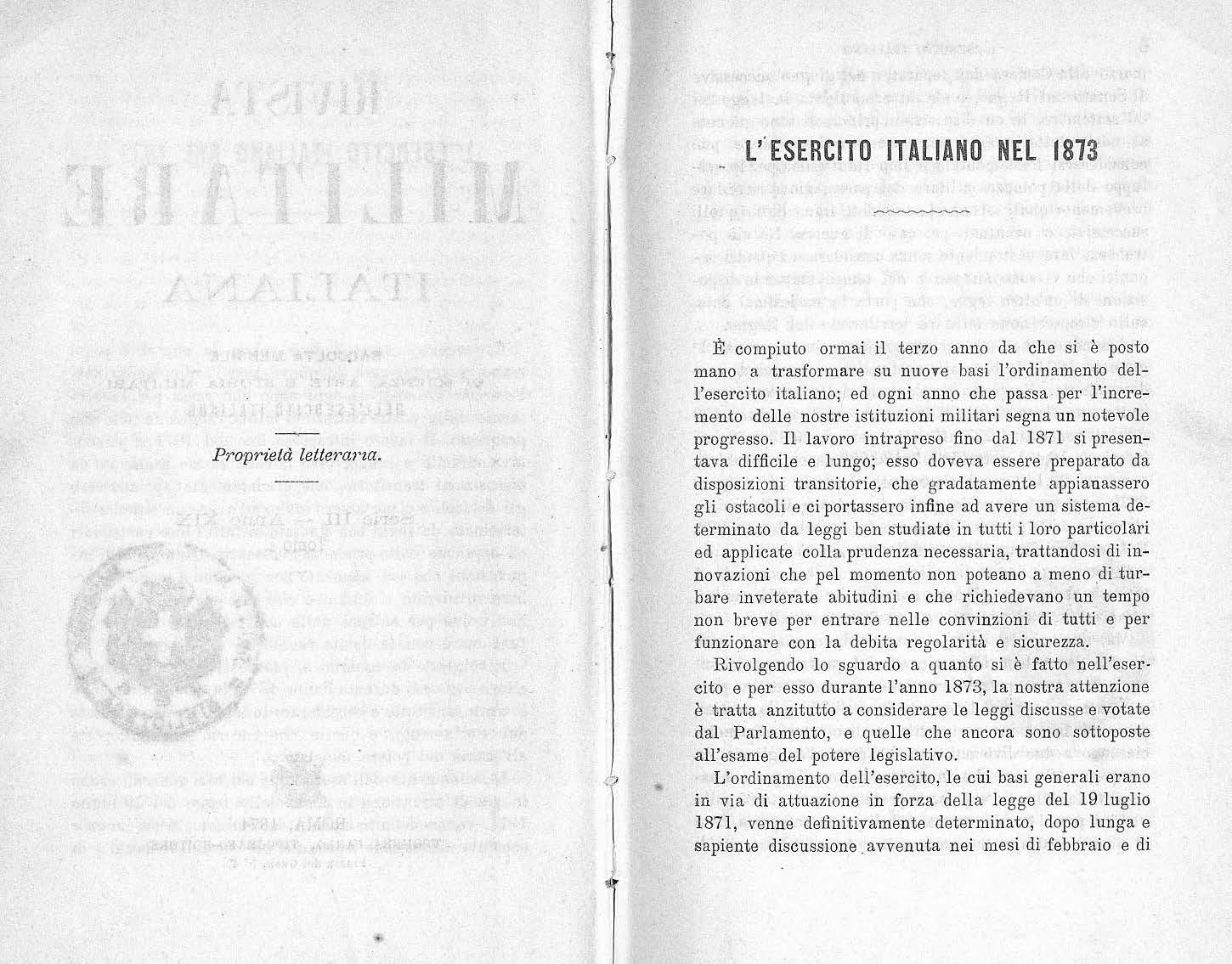
'I I ) •
L'ESERCITO ITALIANO
marzo alla Camera dei deputati e nel giugno successivo al Senato del Re gno, onde fu promu l gata la legge del 30 settembre, le cui disposizio ni principali sono già note ai nostri lettori. Tuttavia, siccome éodesta legge può consider'arsi fondamentale e impo rtantiss ima per lo svilu ppo della potenza militare del paese, gio va ricordare brevemente quali saranno i suoi effetti im mediati e quelli · · 1iuccessivi, o eventuali pel caso dì gue rra. Nè ciò pot r ebbesi fare esatt amente senza considerare i quadri organici che vi sono annessi e nel temp o stesso le disposizioni di un'altra legge, . che porta la medesima data, sulla circoscrizione milita re territorial e del Regno.
Amendue quelle leggi sono entrate in vigore a! 1° gennaio 1874. In base alla costituzione organica ~s-se, 1~7· ~f deterE11inata f l'esercito perma nente nello stato 1di ·pace t,... re,,',. c ontfi una forza di 214,630 '' uomini così ripartiti~ 130 3o l(~ 12 ·s ufficiali generali; 1,223 ufficiali sup,eriori ; 10,834 ufficia'1i inferiori; 16,431 sottufficiali; 186,003 caporali e soldati, com presi 2Q, 149 carabinieri Teali, Soo-O-à&-aggi:1'n,gersi 2870 im piegati di vario grado dipendenti dall'ammini~pe della guerra. Il numero dei cavalli illi 26,228. E tale, con ins ignificante differenza, ·s:arà l a :forza da mantenersi nell'anno in cui siamo entrati, portando il bilancio preventivo gli assegnamenti per 216,251 uomini, compresi 12,193 ufficiali, e per 26,222 cavalli. Ma, quali risultati darà i l nuovo ordinamento nel caso di una generale mobilizzazione ? · - I quadri ongani.ci sul piede di guerra potrebbero contenere nell'esercito permanente e di ·prima linea una forza di 350 mil.a ,uomini, presente in ·campo ·e ripartita in dieci corpi d'armata, ciascuno a due divisioni, con 800Jpez.zi d'artiglieri.a .da campagna. Se non che in ragione dei crediti per ora assegnati nel bilancio si possono cprelevare soltanto 65 mila uomini per il contingente annuo di .prima categoria. Otto i:ii questi contingenti · concorro.no a . formare .l'esercito di

NEL d873
prima linea il quale per conseguenza, dedueendo ,le 'perdite, avrà un .effett ivo massimo di 300 mi1a uomini r ealmente presenti e combattenti. Questa forza è alimentata da otto classi di seconda categoria con 100 m ila uoroipi rappresentanti gli .assenJ> i e ·gli indispo nibi li e 100 mila quali truppe di complement o. Un secondo esercito, c,omposto della milizia mobile, r inforza, occorrendo, quello di prima linea e.on 250 mila .uomini. In complesso, second-0 il nuovo ordi,namento, le forze disponibili pel caso di guerra conteranno 750 mila uomini.
È facile .comprendere come non t utte le disposizioni contenute nelle =leggi del 30 sette mbre .potessero ad ,un tratto essere completame nte applicate. Però le .princip ali, e quelle che .si ,direbbero fondamentali, ent~rono in pieno vigore col 1° gennai.o 1874. Per quanto rig1:ard.a l'ordinamento: si è costituito il comitato cli stato maggiore generale; vennero sciolti il comitato d'arti glieria e quello del genio, dovendo .all'epoca sopra accennata entrare in vigore il comitato u nico per le due ar rni con sede a Roma; si è disposto per la separazione dell'art iglie ria da c ampagna da quella da fodezza. éli ques ta formando 4 reggimenti; col 31 dicembre 1873 i .pQn-bie ri cessarono di far parte dell'ar-tig lieria, dovendo esse-re compresi nei due re ggimen ti del genio; si è formato un terzo battaglione d'istruzione a Sinigaglia; infine fucostituito il .cqrpo degli ufficiali ,contabili, e ai medici, ai commissari ed ai veterinari ,militari :venne dato il grado effettivo e rispettivamente corrispondente nella sc:ala gerarchica. Per la ,circosc1·izione 1militare del ,terdtorio :vennero pure date disposizioni esecutiv.e : si nominarnno i generaili ,che debbono assumere i 7 comandi ,generàli e si istituirono nuovi distretti militari, non mancando di questi più che due a completare il ,lor,o numero.
Stabilito , l'organico del tempo idi ·pa.ce, non .tardò . il Minis te ro della gue rra a preoccuparsi .deUa mobilizzazione.,
6
l r J •
7
specialmente per assicurare il numero di quadrupeqi all'uopo necessario; una legge fino dal 1872 era stata sotto po:sta alle deliberazioni del Parlamento per la r equisizione di cavalli e veicoli per ser.vizio delresercito in guerra; essa ve nne nel giugno 1873 approvata dalla Camera e dal Senato e promulgata sotto la data del 1° ottobre.
Altre leggi, intese o a migliorare le condizioni del personale militare o a porre in armonia col nuovo ordinamento le singole parti dell'amministrazione della guerra, vennero approvate dal potere l egislativo e promulgate nelle seguenti epoche ,durante il 1873:
La legge del 20 marzo, che autorizza il Ministro della guerra a d aprire negli anni 1873 e 1874 un concorsq speciale per coprire le vacanze avvenute e che potranno verificarsi nei sottotenenti delle armi d'artiglieria ·e genio; vi possono aspirare i ·giovani laureati in matematica o quell i che abbiano fatto in una scuola superi'ore pareggiata un corso o superato gli esami che saranno giudicati equivalenti ; ·
La legge, di pari dat a, colla quale venne abrogata la legge 28 maggio 1871 relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del terzo ·anno di corso dell'accademia militare ;
La legge del 2 luglio, che autorizza il governò del Re ad operare la lev a sui giovani nati neil'anno 1853, essendo fissato il contingente di ·la categoria a 65,000 uomini;
La legge dell'8 ottobre, che modifica gli articoli 2 e 22 della legge sull'avanzamento dell'esercito; quanto al primo di detti articoli n el senso che nessuno può·essere nominato caporale se non dopo avere servito se i mesi come soldato; quanto all'altro articolo stabilendosi che i sottotenenti d'artiglieria e genio siano pro mossi t~ enti nell'arma ris pettiva, se provenienti dalla scuola di ap-
plicazione dopo superati g li esami finali di essa, se altrimenti dopo raggiunta l'anzianità dei sottotenenti di fanteria;
La legge del 9 ottobre, che abroga l a legge 28 giugno 1866 sul riord inamento de l ' corpo sanitario e modifi.ca la legge sulle pensioni r el ativamente agli ufficiali medici.
Ìnfine il Parlamento votava il bilancio preventivo del Ministero della guerra per l 'anno 1874. Le spese o rdinarie salgono a lire italiane 166,732,047.28 e le straordinar ie a lire 17,305,000.00; in totale lire 184,037,047.28, alle quali aggiunge)1do le somme trasportate dal bilancio . del 1'873 complessivamente di lire 20,175,000 .00 si ha per l'anno 1874 la comp eten za di lire 204,212,047.28. Giova osservare che nelle spese ordinarie sono comprese alcune spese meramente figurative, qu ali sono lire 3,022,847 .28 per affitto di locali. demaniali e l ire 1,179,000 .00 per i volontari di un anno, di modo che le dette spese ordinarie pel 1874 si riducono effettivamente a sole lire 162,530,200.00. E se pur vogli asi a queste aggiungere l'aum ento di spesa che sarà per produrre nell'anno stesso la legge sugli sti pe ndi e assegnamenti dell'esercito, tutta..-ia sottoposta alle de li berazio ni del Senato, cioè · una spesa maggiore d i lire 1,250,000, la)p esa ordinaria effettiva salirà a lire 163,780,200, cioè per 1 milione e 300 mila lire al cli sotto di 165 milioni, l imite cbe si vuole tene re come normale per il bilancio della guerra.
Ci rimane ora a parlare brevemente dei progetti di legge che debbono ancora essere discuss i o da uno o da amendue i rami del Parlamento. Essi sono tre e tutti importantissimi; dell'uno abbiamo f~tto cenno ed è relativo agl~ stìpendi; un altro riguarda la difesa territoriale ; ultimo è il proge tto di legge sul reclu t amento, n nov ame.nte pres ent ato a lla Camera de i deputati dal Ministro de lla guer ra co n qualche note vo le modificaz ione.

8 L'ES ERCITO ITALIANO
t l NEL 1873 9
L'ESERCITO ITALIA NO
Lo stato economico degli ufficiali, per l'aumento di tutti i generi necessari alla vita, rendevasi negli ultimi tempi assai difficile, e, fin dall'an no precedente, r.ichiamava sopra di esso l'attenzione del Governo e del Parlamento. Per quanto ,le strettezze del pubblico erario non permettessero di provvede re nella de siderata misura al benessere degli ufficiali, e dovendosi o tosto o tardi anc he migliorare le condizioni non molto più favorevoli degli impi egati ·civili, pure si decise di non lasciare più lungamente insoluto un -pro blema che aveva un interesse così vi;vo e diretto per uomini che hanno consacrato la maggior parte della loro vita .al serv izi o del Re e della patria. Un •progetto di l egge sugli stipendi ed asseg namenti fissi degli ufficiali, della truppa e degli impiegati dipendenti dall'ammin is tr az ione militare fu presentato dal - Ministro ci.ella guerra alla Camera fin dal gennaio 1872, s ubì in seguito •modifìcazion i·é nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento ed infine venne approvato dalla Camera nella seduta del 4 dicembre, con un articolo che fissa l'epoca in cui dovrebbe andare in vigore al 1° luglio 1874; manca tutt.avia l?approvazione ·del Sen ato del Regno, c he non tarderà guarì , essendo tal progetto fra i primi da discuters i appena terminate l e vacanze parlamentar i.
Anche il progetto dì legge pe i lavori di difesa dello Stato andò soggetto a v: arie vicende . Esso forma la terza parte del primitivo prqgetto, col quale il Ministro della guerra chiedeva, fino dal dicembre.1871, un credito straordinario di 152 militmi da ripartirsi nei bilanci di due quinquenni. Sulle spese già acc.or da te in .co;nto di quel credito abbiamo avuto occasione di discorrere rparticolarmente l'anno scorso . .C'importa ora ricordare che -i fondi disponibili nel primo quinquennio, secondo il progetto ministeriale, rimanevano esauriti non solo, ma veniva.no anche prelevate 600 mi l a lire su·i fondi del secondo quinquennio ed impegnate l ire 13,200,000 per le
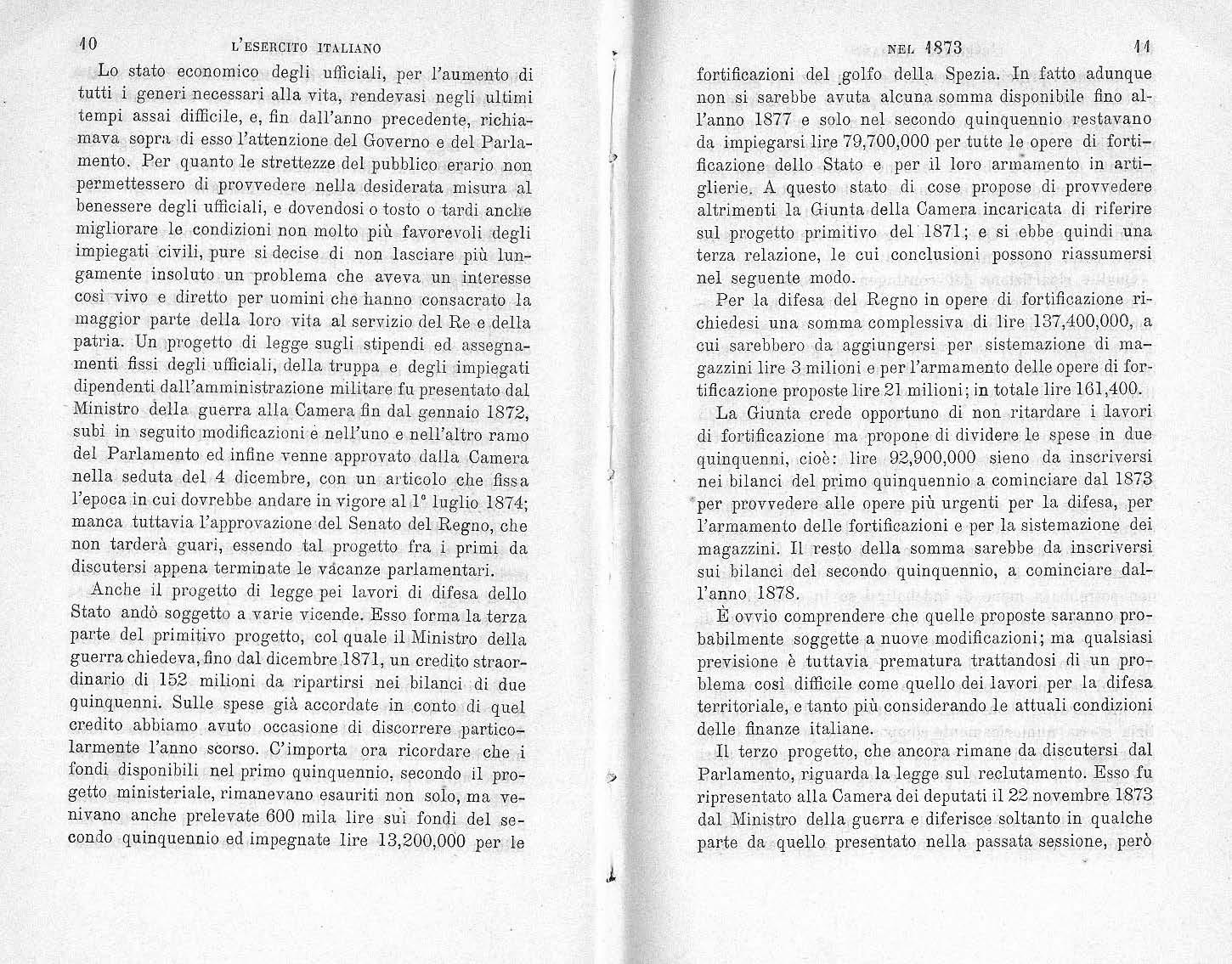
fortificaz ioni del _go lfo dell!J, $pezia. In fatto adunque non si sarebbe avuta alcuna somma disponibile fino all'anno 1877 e solo nel secondo quinquennio restavano da impiegarsi l ir13 79,700,000 pe r tutte le opere di fortificazione dello Stato e. per il loro arm-amento in artiglierie. A q\lesto stato di cose propose di provvedere altrimenti la Giunta dell a Camena incaricata di riferire sul ,progetto primitivo de l · 1871.; e si ebbe quin di una terza relazione, le cui conclusioni possono riassumersi nel seguente modo.
Per la difesa del Regno in opere di fortificazione richiedesi una somma compless iva di lire 137, 400,000, a cui sarebbero àa aggiungers i per sistemazione di magazzini lire 3 milioni e per l'armamento delle opere di fortificazione proposte lire 21 milioni; in totale lire 161,400.
La Giunta crede oppo~·tuno di non ,r itardare i lavo,ri di fo r tificazione ma •propone di dividere le spese in due quinquenni, cioè : lire 9.2,900 ,000 s ieno da inscriversi ne i bi lanci del p.rimo quinquennio a comincjare dal 1873 ·per provvedere alle oper:e più urgenti per la difesa, per l' armamento delle fortificazioni e per la sistemazione dei magazzini. Il resto della ·somma sarebbe da inscriversi sui bil anc i del secondo qu inquennio, a cominciare dall'anno . 1878.
È ovvio comprendere che quelle proposte saranno probàbilmente soggette a nuove modificaz ioni; ma qualsiasi previsione è tuttavia prematura trattandosi <li un problema così difficile come quello dei lavori per l a difesa territor iale , e ta,nto più considerando le attuali condizioni delle finanze italiane .
Il terzo progetto, che ancora rimane da discutersi dal Parlamento, riguarda la legge sul re,clutamento . Esso fu ripresentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 1873 dal Mini stro della guerra e diferisce ·soltanto in qualche parte da quello presentato nella passata se,ssjone, però
10
I '.>
NEI, 1873
serbandone i principii generali. Le modificazioni più importanti cons ìstono nel modo di ripartil'e il contingente di leva, che sarebbe ancor:i diviso in tre categorie; se non che la terza categori a anzichè essere composta soltanto di coloro che vi debbono essere assegnati per considerazioni di famiglia comprenderebbe inoltre tutti gli inscritti che sieno esuberanti ai contingenti di prima e seconda categoria. Questi contingenti dovrebbero essere fissati colla legge annua d i leva .
Quell a ripartizione del contingente è consigliata da considerazioni economiche e dal proposito di non eccedere la spes a di 165 milioni pel bilan cio ordinario e di avere l'esercito permanente sul piede di g uerra forte di 300 mila uomini. In rapporto di quei due termini il contingente di prima categoria non potrebbe oltrepassare i 65 mila uomini, e ne rimarrebbero disponibili altri 35 m ila . Ora a costituire le truppe di complemento con otto classi di seconda categoria, impartendo loro una istruzione sufficiente, il bilancio non permetterebbe di avere un contingente di seconda categoria eccedente i 25 mila· uominì; e questa misura sarebbe anche cooveniente per non pregiudicare la qualità compless'iva delle forze combattenti. Infatti la solidità dell'esercito di prima linea non potrebbe a meno dì ind eboli rsi se in esso gli elementi impe rfettamente istruiti, come sono gli uomini di seconda categoria, entrassero in una proporzione maggiore di un quarto sul totale della forza. Più ancora si consideri che col sistema proposto anche la solidità della m ilizia mobile sarebbe abbastanza assicurata, risu l tando la milizia stessa numericamente composta per poco più di un quarto di uomini di secon da categoria e per gli altri tre quarti di uomini di prima categoria con tre e più anni di servizìo.
Gli iscritti esuberanti sulle due prime categorie e passati a lla terza categoria entrerebbero a far parte della
milizia comunale, istituzione destinata a trasformare in sè l'attuale guardia nazionale.
Ma è da notarsi ancora che il numero di cotesti giovani asseg nati alla terza categoria può scemare ed anche sparire affa.tto, <li mano in mano che i mezzi del bilancio permetteranno di aumentare il contingento di prima categoria, e ciò fino al punto da comprendervi tutti gli inscritti.
È probabile che questo progetto di legge venga discusso entro un breve termine di tempo dall a Camera d ei deputati .
Durante l'anno 18.o/3, l'esercito permanente fu diminuito cli vecchi eleme~ti, d~'l.t i dalla prima categoria, e venne temporaneamente ingrossato per motivi di istruzione da classi di seconda categoria. Col giorno 25 ottobre cominciò l'inv io in congedo illimitato dei militari di l" categoria de lla classe 18t19, eccettuata la cavall eria; ma essendo in quel tempo alcune provincie infestate dal chol èra, l'invio si eseguì per motivi igienici gradatamente ed ebbe termine nel successivo novembre.
Quanto agli uomini di 2°' categoria, quelli della classe 1851 furono chiamati alle sedi dei distretti militari per essere esercitati ed istruiti nelle armi dal 1° aprile al 10 magg io; quelli della classe 1852, appa r tenent i ai distretti della parte central e e settentrionale del Regno , furono chiamati all'istruzione presso i distretti il 3 giugno ed al 5 luglio successivo vennero inviati nei r eggimenti che facevano parte delle tre di visioni d'is truz ione, rimanendo sotto alle armi fino all' 8 ago s to. Infine il Ministero della guerra ha dato disposizioni per la chiam ata degli uomini di 1a categoria della classe 1853 che avrà luogo in due volte, l'u na al 3 e l'alti·a al 19 f ebbraio del nuovo anno.
Da quanto abbiamo precedentemente esposto si rile va che l'anno 1873 dal punto di vista legislativo fu per

2 L'ESERCITO
O
ITALIAN
/ .> J.
18'73
NEL
L'ESERCI'l:0 ITALIANO
l'amminis trazione militare uno degli anni' più laboriosii nè lo fn meno per molti altri riguardi e in particola1,e modo per l'incl'ernento dato alle nuove istituzioni e per le cure poste; ne'lla istruzione e nell'educa0ion e dei quadr.i e dell e truppe.
, L'importantiss ima istituzione dei distretti Si è di mano irr mano consolidata; due n'uovi ne furono formati, onde non ne mancono più che due per raggiungere il nu'mero di 62 staoilito dai qU'adri ovgartici.
lLe com pagn'ie alpine; che nella rassegna del1o scorso anno si è detto a quale scopo e come venissero istituit!e, si - portarono alle risp ettive loro ..sedi, accolte d'òvunque dalle a-ùtorità com:nnal-i e dalle p0pol~zioni1 con patriottico entusiasmo . Esse, duriante Uestatè fecero una eseursione fra i monti, spingendosi fino ai confini, per ese rcitare gli, uomini nella tattica particolare e nelle fatiche deHa guerra di monta~na. R loro numero è tuttavi<t di qu.indrci, però nel marzo prossimo 1 v.enturo1 se' ne for'meranno altre quattro e: più· tardi- nel corso del 187'.4 . altre cinque, portancl'o il loro numero a 24;: come è stabili to dall'orgrunico; intintamente coNe:gaite adi esse v.ertanno pure · formate 24 co'in pag nie alpine di m'iL lìzia mo·bile.
Fra l'e ist ituzioni, ch'ebbero n•uov.a, v ita neWa:nrto 1873, debbonsi annovevar.e gli ufficiali di complemento•, gli zap,pator,i dì cavalleria, e le compagnie d'artiglieria da costa.

G-li1 ufficiali di complemento servono ad aumentasrei i quad.r.i,· dell'esercito attivo; o• a, ripa,rarne gli eventuali biso gni pel ca-so di gueitra. Si t'raggono essi, secon'd0 la legge, d-agli uffic iali che- lasciarono, fesercito •pe-r volontaria, dimissione, dai sottufficiali congedati con 1 12 anni di servizio e dai volontaPi di un anno. Parecchi di questi giovani avendo terminato' l'anno di servi,zio vennero invitati dal Ministero deUa guerra a concorrere
NEL ,j-8ti'3 rn ad essere ammessi qu ali ufficiali di complement o nei quadri• dei corpi · attivi , purchè subissero un esame e ' si obbligassero a1 servire nel corso dèll'anno per -tre mesi nel corpo a cui venissero ascritti . Tutti, salvo poche eccezioni, accettarono e soddisfecero poi alle :rrescritte condizioni. Codesti uffici::i.li sono da considerarsi in sopra numero ai qu adri permanen t i e sono- più particolarmen te destinati a portare a quattro il numero · degli ufficiali subalterni in ogni èompagnia, squadrone o batteria. Servono tempora,neainente in guerra, finita la: quaie lasci ano d,i nuovo· il servizio e ritornano nella primitiva pnsizione .
Gli ottimi risu1tati ottenuti nell' anno 1872 · dagli zap patori di fanteria, recent~mente· istitui ti , cònsigl'ia11ono di- adotta-re una istit'uzicme, analoga anche• ·per là cavalleria, considerando quali servizi · si potranno otten.ere - daUò avere aU' estrema Mangu:ardià. uomini montati, ed istruiti' per la: rapida distruzione dei fili telegrafici e delle · linee' ferroviarie. In seguito a; ciò il màrtuale regola0ment-are già< adotfato )?er gli zappatori d'ì. fanteria verine rit'0ccato e ne fu fatta una sec0nda edfzione eol titolo di htr·uzioni prati'che speciali' per gli zappatori di fante'l'ia e cavalle1·ia. Questò libro meTita, particolare menziònè, p0ic-hè fu lodatissimo dai periodici • militari esteri e ne furono fatte due . edizioni del'la v:erisione francese i
Quanto alla1 ter za: nuo va istituzione di• cui sopra: a bbiam@, fatto ~enno, essa ebbe origine dal fatto che nell'annu 18W si ebb~ro disponibili u:n certo m1me:ro di eànnon.il di gran potenza, destin-ati alla difesa-delle coste ; onde occorreva1 0J1ganizzare un personale speciale che alila c'onosc·enza l perfetta: del maneggio di un materiale così
C'omplicato, aggiungesse le cognizioni- pratiche per ben conservarlo, mediante ripieghi e riparazioni· che possono o'C-co.rrer,e, nel suo impiego. In conseguenza. venne far-
H
r • , •f
mata una compagnia d'operai d'artiglieria, da costa; altre compagnie di quest.a specie si formeranno a misura che aumenterà il numero delle artiglierie di gran potenza da collocarsi nelle nostre piazze marittime.
E così gradatamente l'ordinamento dell'esercito si svolge, ad ogni anno che passa in parte assodandosi, in parte allargando le sue basi, di modo che poco ci rimane per raggiungere i limiti determinati dalle Jeggi organiche. Ma non basta dar forma e vita alle istitu· zioni in conformità di un disegno ben concepito; è necessario sopratutto animare lo spirito degli uomini cui spetta di applicarle, e far progredire la loro istruzione ed educazione militare fìno a quel grado che è richiesto oggidì dall'arte e dalla scienza. Moltissime furono a quel riguard~ le cure rivolte nel 1873 dall' ammi.nistrazione della guerra e pos~iamo dire con la massima soddisfazione che il livello dell' istruzione nei quadri dell'esercito nostro ormai può reggere il confronto con gli ~·eserciti più apprezzati in ~uropa. Non parleremo di quanto fu fatto negli istituti niili~ tar i, se non per ricordare èhe siamo giunti in complesso a triplicare il numero degli aillievi; e questo fatto è da attribuirsi sia allo spirito della nostra gioventù, che accenna ad un favorevole ritorno verso la carriera militare, sia alle misure insistenti, continue del Ministero della guerra per eccitare quello spirito e per migliorç1,re le condizioni degli uffìciali. Una questione importante è ormai deci sa. . I collegi secondari rimarranno a preparare allievi per l'accademia militare e pe r la scuola di fanteria e cavalleria; il loro nµmero è fissato a tre negli organici annessi alla legge del 30 settembre.
Un altro segno significantissimo di quel. ritorno della g io ventù alla carriera delle armi lo abbiamo nel . numero . sempre crescenie di concorrenti per essere ammessi nei battaglioni d'istruzione. I dne battaglioni pree-
sistenti diedero nel 1873 i loro primi frutti e fornirono alcune centinaia di ottimi sottuffici'ali ai corpi attivi. Un ter:w battaglione si è dovuto formare, a Sinigaglia; e cosi uno de' più difficili problemi, e che in ogni esercito oggidì presenta ostacoli gravi, quello cioè del reclutamento dei sottufficiali, presso di noi è avviato a so4disfacente soluzione.
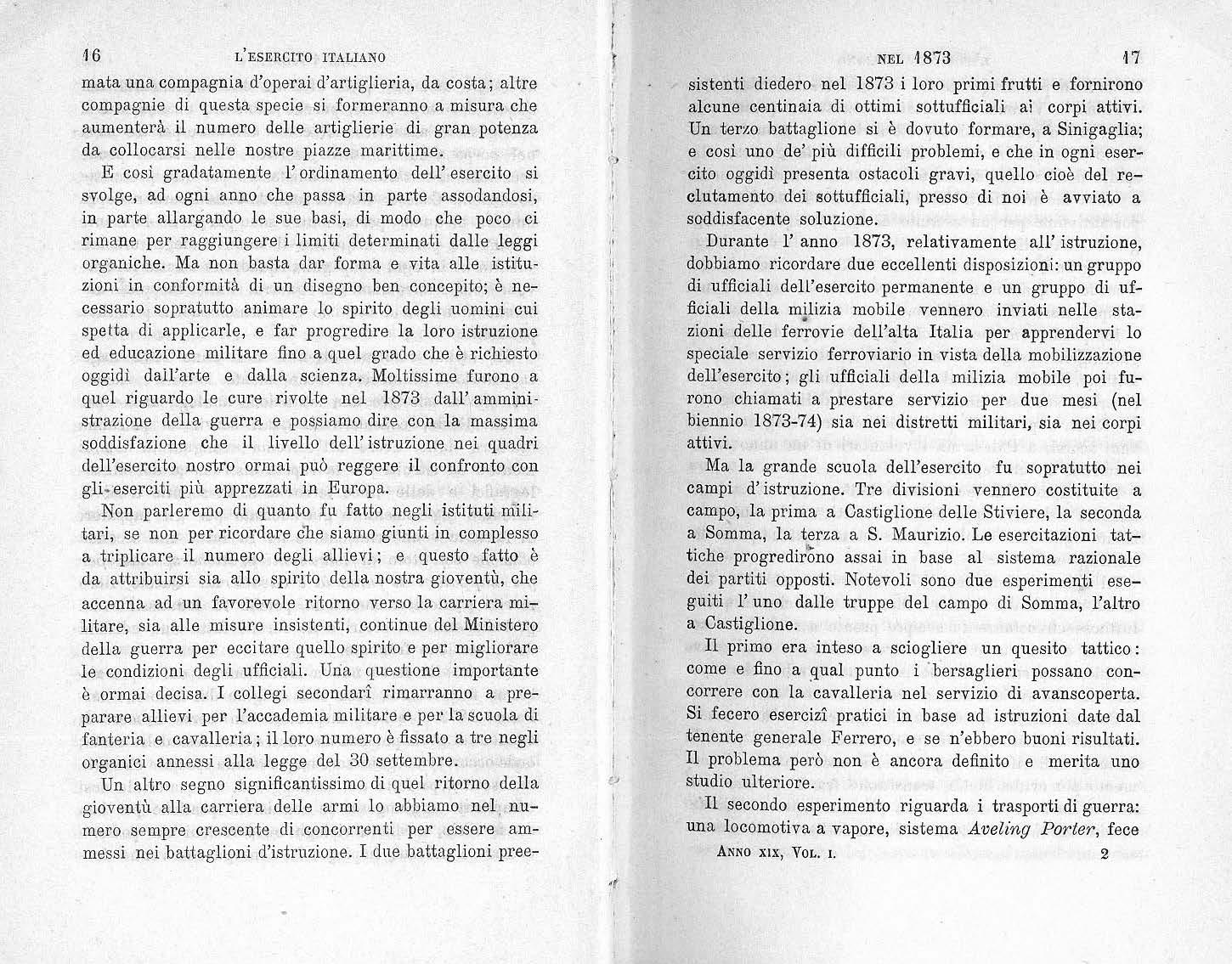
Durante l' anno 1873, relativamente all' istruzione, dobbiamo ricordare due eccellenti disposizioni: un gruppo di ufficiali dell'esercito permanente e un gruppo di ufficiali della milizia mobile vennero inviati nelle sta• zioni delle ferrovie dell'alta Italia per apprendervi lo speciale servizio ferroviario in vista della mobilizzazione dell'esercito; gli ufficiali della milizia mobile poi furono chiamati a prestar e servizio per due mesi (nel biennio 1873-74) sia nei distretti militari, sia nei corpi attivi.
Ma la grande scuola dell'esercito fu sopratutto nei campi d' istruzione. Tre divisioni ve nnero costituite a campo, la pr ima a Castiglione delle Stiviere, la seconda a Somma, la terza a S. Maurizio . Le esercitazioni tattiche progredi~Òno assai in base al sistema razionale dei partiti opposti. Notevoli sono due esperimenti eseguiti l'uno dalle truppe del campo di Somma, l'altro a Castiglione.
Il primo era inteso a sciogliere un quesito tattico : come e :fino a !lual punto i ' bersaglieri possano concorrere con la cavalleria nel servizio di avanscoperta. Si fecero esercizi pratici in base ad istruzioni date dal tenente generale Ferrero, e se n'ebbero buoni risultati. Il problema però non è ancora definito e merita uno studio ulteriore.
·n secondo esperimento riguarda i trasporti di guerra: una locomoti va a vapore, sistema Aveling Porter, fece
1J6 L'ESERCITO ITALL\NO
I. I l ' V I 1, \1 h [i 11 :~ 1, •I I · ., I· I NEL 1873 117
VOL. I. 2
ANNO XIX,
L'ESERCITO lTALIANO
il servizio p el trasporto dei v iveri e dei malati fra Castiglione e Verona. I risultati ottenuti in questa e in altre prove precedenti e posteriori hanno ormai dimostrato che pel servizio. dei trasporti in gue rra, alle spalle dell'esercito combattente, potremo usare utilmente e senza inconve nienti delle locomo bil i. È un fatto importantissimo per un esercito di un paese ove scarseggi ano i cav alli.
Le grandi manovre nell'anno 1873 non ebbero luogo, essendo scoppiato in alcÙ:10 provincie il colè ra e nel campo stesso di Castiglione. •
Ind ipe nden teme nte dai campi, l e tr upp e di ciascuna guarnigione ese guirono ne l periodo estivo esercitazioni tattiche. Ricorderemo il campo di Quadr elle, a cui si recarono successivamente le b rigate della guarnigione di Roma e presso il quale, colle norm e seguite neg l i a nni scors i, a Palestrina i volontari di un anno si costituirono in un reg gimento.
Dovremmo infine tener parola dell'opera prestata dagli ufficiali e dalle truppe nelle calamità, a cui sve n turatamente ogni anno sembra .Predestinata qual che p arte del nost1•0 paese.
Alle inondazio ni del 1872 successe ro n el 1873 tremendi terremoti e il colèra. Dire che l'esercito in qu es te luttuo se circostanze fu sempre pronto e sollecito e col braccio e col cuore a soccorrere , talvolta co n grave ris chio, le pericolanti popolazioni, non sarebbe che ripetere ciò che av vieHe continuamente sotto a' nostri occhi .
Conchiuderemo qu esto r apido sguardo con una osservazione. Goll'anno 1873, presso a ch iudersi il periodo delle gra ndi riforme orga ni che, è anche passato il momento più criti co della transiz ione fra il vecchio e il nuovo. Le basi di un ese rci to più numeroso e ordinato in conformità delle esigenze odierne dell'arte de lla gu erra
NEL 1873
sono gittate; le leggi che ne r egolan o categoricamente i . particolari vennero promulgate. Rimane tuttavia a dare solidità all'edificio co n }a pratica, con una operosità straordinaria e col concorso di tutti. gli elementi. Da un lavoro legislativo siamo pass ati ad un lavo ro esecutivo, il quale porterà presto i su oi frutti poichè buona volontà ed istru zione sono le doti che distinguono i quadri dell'esercito nostro .

18
K. "'
DELL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA ITALIANA
DELLE PRINCIPALI POTENZE (1)
Nei primi tempi rn cui {urono introdotte le bocche da fuoco negli eserciti, esse erano di g rosso c.alibro a disposizione esclusiva del generale in capo; e questi sul campo d i battaglia assegnava l oro un posto che difficilmente mutava no. Tali artiglieriè a causa del loro en orrn e peso e difficoltà am u oversi, rirnanevano generalmente preda dell'avversario ad ogni battaglia perduta.
Più tardi s'introdussero artiglierie di calibro piccolissimo che si assegnarono ai regg imenti di fanteria; e da ciò pre sero nome d' artiglie1·ia reggimentale, rimanendo i pezzi cli g rosso calibro in r iserva od in certe posizioni determinate e non facili ad es sere assalite.
A questo punto àa l'artiglieria da campagna al tempo di Federico II; ma dopo quell'epoca essa fece considerevoli progressi in Francia, progressi e5he poi furono più o meno prontamente imitali dngli altri eserciti europei. Soppressa l'artiglieria re ggimenta l e e diminuito il calibro a quella di riserva o posizione si rese anche questa facile al t raino e tanto mobile da poter seguire le truppe in ogni luogo; ed in conseguenza poi del r ipar to dell'esercito in division-i e corpi d ' armala, si distribuì quell'artiglieria tra tali riparti .
(i i Lettura fatta dinanzi agli ufficiali d'artiglieria della divisiono di Perugia, noi febbraio ,(873 .

PARALELLO DELL1ARTIGLIERIA ECC 21
Le bocche da fuoco erano distinte in cannoni ed obici; i primi lanciavano palla sferica, i secondi granata, ambedue scatola a metrnglia . I cannoni si d istinguevano dal peso del proiettile di ghisa che l anciavano espresso. in libbre; gli obici tanto dal peso della corrispettiva palla di pie[ra come dal diametro del proiettile stesso.
Il peso dei ·proiettili p ieni var;i ava fra le 6, 14 libbre; e quello delle granate fra le 6, 24 .
Terminate le guerre napoleoniche, tutti gli eserci ti · si trovavano nella necessi tà o di rinnovare il pro prio materiale , oppure di rimediare agli inconvenienti palesatisi in ess o nel corso di quelle lunghe guerre . Mo lti erano nel primo caso avendo perduto la maggior parte del loro materiale da campagna; gl i altri dovellero apportarvi niolti perfezionamenti onde adottarlo alle . esigenze d'una nuova tattica. Ma siccome a quasi tutti ei·a assegnato un campo definito e circoscritto a motivo delle misere condizioni finanziarie, conseguenza di quel travaglioso passato, così questi cambiamenti e migliorie non avvennero che gradatamente e dopo lunghi e accura ti studi.
L'Inghilterra che, puossi dire, somministrò i modelli. pel nuovo materia le da campagna, ultimò i suoi studi nel 1822 adottando le seguenti bocche da fuoco {;I):
Cannoni da ,f 2 libbre;
Id. 9 »
Id. 6 »
Obici da cent. ,12 ;
Id. 1o.
(~) La rnaggior parte dei dati sono tolt i dal JACOBJ: Besch?'eibung des gcgenwartigcn Zustand es der e·uropaischen Feld-artillcrie.
PARALELLO
CON QUELLA
DELT} ARTIGLlERIA DA CAlIPAGNA ITALIANA
L'affusto era d i legno, a coscie parnllele e s ala pure di legno. L'insieme del ma te6ale e r a solido, adattato allo scopo e ciò che più importava molto mobi le (pe r quei tem pi); perciò a ragione fu r i tenuto come esemplare, imitato da quas i tutti gli ese r citi con piccolissime varianti, in viùiato da molti.
La batteria era fo rmat a di 6 pezzi , tra cui u n obice {Jeggiero o pesante:). Ogn i pezzo era tr ainato da sei od otto cavalli secondo il cal ibro ; il peso era come seg ue :
Canno ne da 12, chiL 914, coll'affusto ed ava ntreno, chi!. 2200 .
Cannon e da 9, chil. 685, coll'affusto ed avantreno, c hil. 4900.
Cannone da 6, chi l. 305, coll'affusto ed avan tr eno, ch i!. 11350.
L'obic e pesante da 15 cent., chi!. 585, co ll'affus to ed avan treno, chi!. 2000.
L'obice legg iero da • 1'2 cent ., chi!. 330, co ll' affus to ed avantre no, chil. U.50.
La Franc ia ved en do necessario sempl ificare il suo s is tem a abo lì i cannoni da 6 e da ,i. libbre, ritenen do r egolamentari solo le seguenti quattro specie (1) :
Cannone da 12 li bbre de l peso di ch il. 880, coll'affusto ed ava ntreno, chil. 21. 1)0.
Cannone da 8 l ibb r e del peso cli chil. 58 11, coll' a ffu sto ed avanlt·eno, chil. ·185G.
Obi ce da cent. 4 6 del peso di chi !. 88 5 , coll'affusto e d avan treno , chil. 2•175.
Obice da cent. 15 del pes o di chil. 58 f, co ll' affu s to e d avantreno, chi I. 850.
Il re lativo carreggio fu adottato ne l 1828 , e d i n sostanza altr o. non era che il materiale i nglese modificato e fu denominalo Fallée dal nom e del gene ra le che lo fe ce ac ce lla re . Ri mase più pesante di quello in glese preso a modello. Gli affus ti furono ri dotti a du e sol i: sul r;• 1 s'incav alcavano il can none da 8 e l'obic e da ce nt. i15 ; sul N° il cannone da 12 e l'ob ice da cent. 16. La Pr ussia in vece cominciò ne l · 18 •16 coll'abolire le bocche da fuo co ed il carreggio di prove nienza forestier a (inglese , francese e russa }: quindi si s tudi.ò di alleggerire il suo materiale ai~corciando le bocche da fuoco e rimpicc iolendo le dimen sioni degli affusti; appose ai veicoli la sala di ferro, corresse il sis tema di pun teri a tuttora a lquanto p r imi livo e m igliorò gli armamen t i dei pezzi. Questo mate r iale n el 4819 prese il nome di modello mm (c/16) (1).
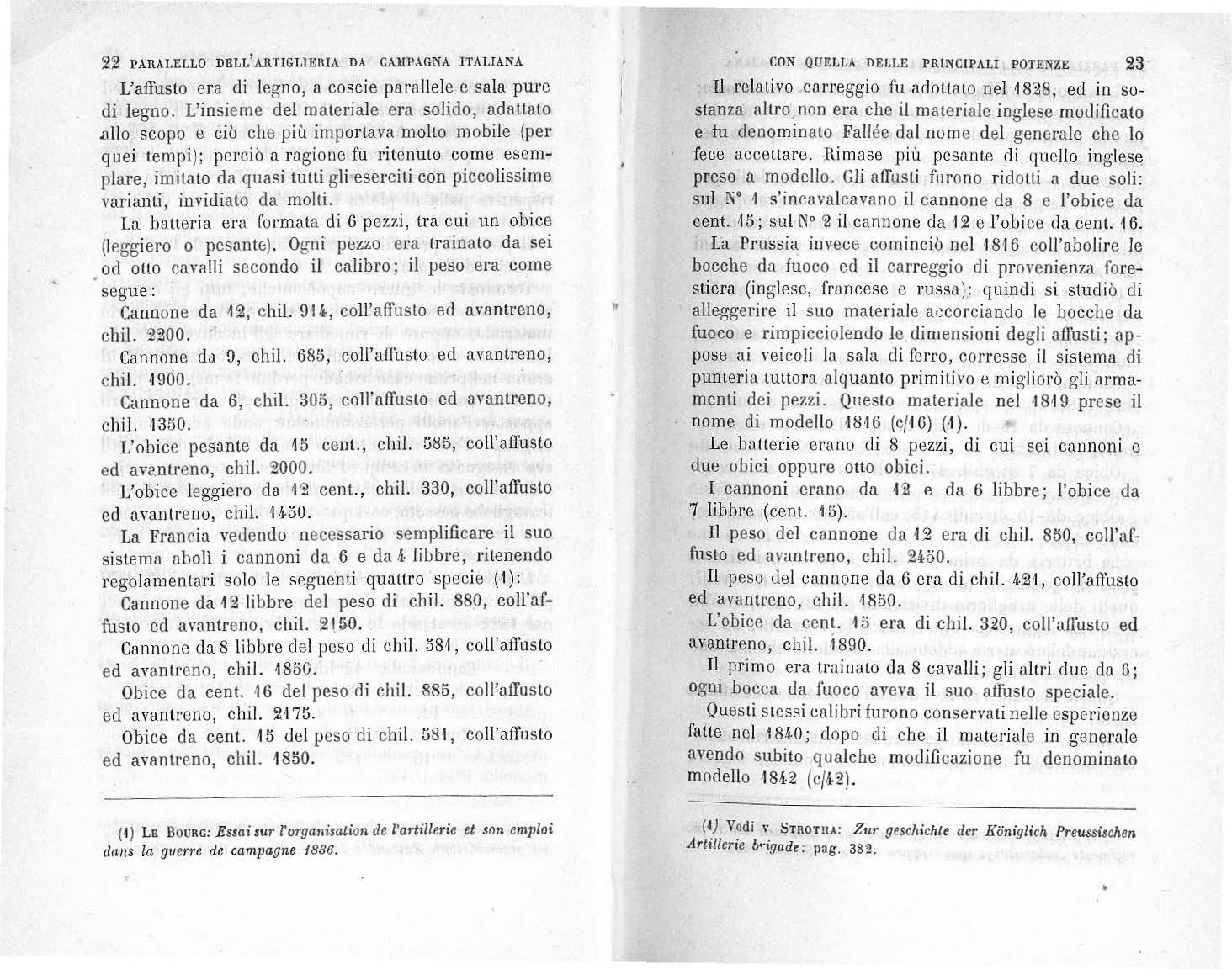
Le ballerie era no di 8 pezzi, cli cui sei ca nn on i e due obici oppure otto obici.
I cannoni erano da ~2 e da 6 lib b r e; l'obic e da 7 libbre (ce n t. 15) .
Il peso del cannone da ·12 er a di chil. 850 , coll'affusto ed avantreno, cliii. 2i-i'.i0.
Il peso de l cannon e da (3 e r a di chi !. 4211, co ll'affusto ed av an tre no, ch i!. 4850.
L'ob ice da cent. 15 era di chi!. 320, coll'affusto e d avantreno, chil. 189 0.
Il primo era tr a inato da 8 cavalli; gli a l tri due da O; ogn i bocca da fuoco aveva il suo affus to speciale. Ques ti s tessi ealib ri fur ono c onse rvati nelle espe rienze fa u e nel 1840; dopo di che il ma te ri ale in gen era le avendo subito qualche modifi cazione fu denominalo modello 1842 (c/42) .
(~) LE DOURG: Ess ai $u1· l' organisation de l'artiller-ic et son cmploi dans la g11 e1·re de cam11agne 18B6.
(~) Vedi v STRO TnA: Zur geschichte der Koniglich Preussische n Artill crie l,.-igade: pag. 382.
22 PARALE LLO
" CON
I.E PRI NC
P
ZE 23
QUELLA DE I.
IPALI
OTEN
DELL'ARTIGLIERIA DA. CAM PAGNA ITALIANA
Il cannone fu alleggerito, come pure il suo affusto; l'obice invece fu aumentato di peso. Agli a van treni furono poste ruote di d ia m etro inferiore a quelle del retrotreno.
Austria. - L'artiglieria austriaca, persuasa dall ' esperienza de lla guerra, che il suo materiale da campagna (di vecchia origine) (4) era sufficientemente solido, mobile ed efficace, lo conservò con piccole modificazioni fino al 1850.
I calibri erano: cannone da 3 (che venne abolito ne l 184'.2).
Cannone da· 6 di chil. 386, coll'affusto ed avantreno, chi!. · 1150.
Cannoni da 1:2 di chil. 750; coll'affusto ed ava ntreno, chil. 1785.
Cannoni da 1'8 di chi!. '1440, coll'affusto ed avantreno, chi!. 2'.2.2'.2.
Obice da 7 di chil. 270, coll'affusto ed avantreno, chil. 104'.2.
Obice da rn di chi!. 4HS, coll'affusto ed avantreno, chil. 1'.263 .
La batteria d a principio fu di 6 pezzi, poi di 8. I pezzi da posizione (da 18) erano tralli da 8 cavallì; quelli dell e artiglierie divisi onali (da 11'.2) da 6 cavalli; e i pezzi leggeri (da 6) e li obici da .4 cavalli; ad eccezione dell e batte rie addette alla cavalleria che avevano tre pariglie per pezzo.
Questo materiale rimase fino all'adozione dei cannoni rigati .
Rimia. - La Russia pure conservò il materiale adottato nel 1805, non apportandovi ch e qualche leggera
CON QUELLA. DELLE PRINCI PALI POTENZE 25 modificazione nell'anno 11838 . I ca libri erano da 12 e · da ti, p esan te l'uno chi!. 8 11O e 350 l' altro . Le batterie erano parte di dodici e parte di sei pezzi. ·
Piemonte. - Il P iemonte aveva seguite le orme francesi, riten endo i calibri da 116 e da 8 li bbre, di cent. 5 per l'obice.
Più tard i , in seguito ag li studi del valente capitano di artiglieria {ora gene r ale) Cava lli, l'artiglieria piemomese trasformò interamente il suo earreggio da campagna , d en om inand o lo modello · 18U , che è quello tuttora u sa to . 00n semplic i modificazio.ni a i c.:ofani.
Tutti gli altri eserciti acceuarono con piccoli rnulamen ti il materiale regolamentare inglese, ad eccezi one degli Stati tedeschi del sud, i quali durante le guerre napolepni che avendo adoperato materiale francese, dopo la guerra. lo conservarono con poche co rr ezioni, poscia a poco a poco lo smisero, dimoclochè n el 1840 poco più ne a ve vano e nel • I 843 nulla più.
Riassumendo, ve diamo come in gene r ale foss ero due i calibri dei cannoni da campagna in uso, l'uno pesante da 12 e l 'altro l eggero da 6 libbre, con due obici corrispond e nti l'uno pesante e l ' altro legge ro, e presso ·qualche esercito pure solo quello da cent. 4 5. I calibri piccoli da 4 e da 3 erano scompaesi.
Le bauerie relativamen le a ques ti calibri si distinguevano in pesanti e leggere, a ca.vallo o batte1· ia di cava.llel'ia. l~ rano composte o di una sola specie di bocche da fuoco o di due; q u est'ultim o modo predominava. Si avevano pure batterie cli soli obici. Le batterie erano per lo più cli otto pezzi .

(·Iì F. RRITER: Elementar- J,Vaffeiilehl'e zum ,gcbra,.1,ch der I( K. regim ent s vorb ere ittmgs uml tmppen divisions Schule, 869.
Sostanziali migliorie erano state arrecate mercè una costruzione più rnzion a le, in parte scemando le dimensioni e semplifi cando il det tag l io. L'alleggerimento erasì principalmente otte nuto coll'accorciare la bocca da fu oco e sce ma ndo la grossezza del melullo, in con-
2.i PARALELLO
/)
DELT,'ARTIGLIERlA DA CAMPAGNA lTALIANA seguenza d'una diminuzione nella carica di fazione; di più col limitare il munizionamento da tr asportars i .
l\la le guerre cagionate dai moti politici dell'anno 4 84.8 in Europa (Ilalia , Gf:rmania ed Ungbe ria) e successivamente la guerra di Crimea, dopo lungo tratto di tempo, offrirono nuova occasione di ra ccogli ere ·sui campi di battaglia copiose esperienze per ogni ramo della scienza rn ili tare. ll miglior impiego dell'ordine sottile adattato al terreno e l'uso del fucile rigato dette motiv o a nuove e gravi considerazioni nell'impiego dell'artiglieria e sulla sua essenza medesima.
Nel suo im piego tattico, quegli jnconvenienti che sono l'in evitabile conseguenza d'un lungo stadio di pace, si resero palesi e l'artiglieria r iconoscendo 'prontamente il proprio stato rispetto ai oangiaLi modi di com~attere della fanteria, si diede a tutt'uomo a porvi riçnedio, attuando quelle riforme che ebbe ro per ri sulta lo la sua totale trasfornrnzione , di cui mai per lo i"nnanzi erasi veduta l'uguale.
I più gri:lndi sforzi furono diretti alla ricerca d'una nuova bocca da fuoco liscia ehe avesse qualità bali-, stiche tali da r iacquistarle quel posto da cU'i era slata scacciata dal fucile rigalo.
Mediante forti modificazioni, alleggerimenti, ecc .,aveasi ottenuto bensì una perfetta armonia fra le parti ed il tutto, ma tuttavia si poteva ch ie dere se qu~sta armonia fo sse ancor<1 in rapporto ai bisogni tutti ed alle condizioni richieste, cioè se questa armonia esistesse pure fra gli altri fattori di mobilità e potenza .
L'adozione dello Shrapnels fece balenare la possibilità d'un grande aumento di potenza. Nel 1836 il generale Okoun efpredice va un import ante avvenire all'artiglieria per questo nuovo trovato; ma il fucile r igato Thouwenin . e quindi il l\finié lo contraddissero cpndannando l'arliglieria ad una azione , affatto secondaria.
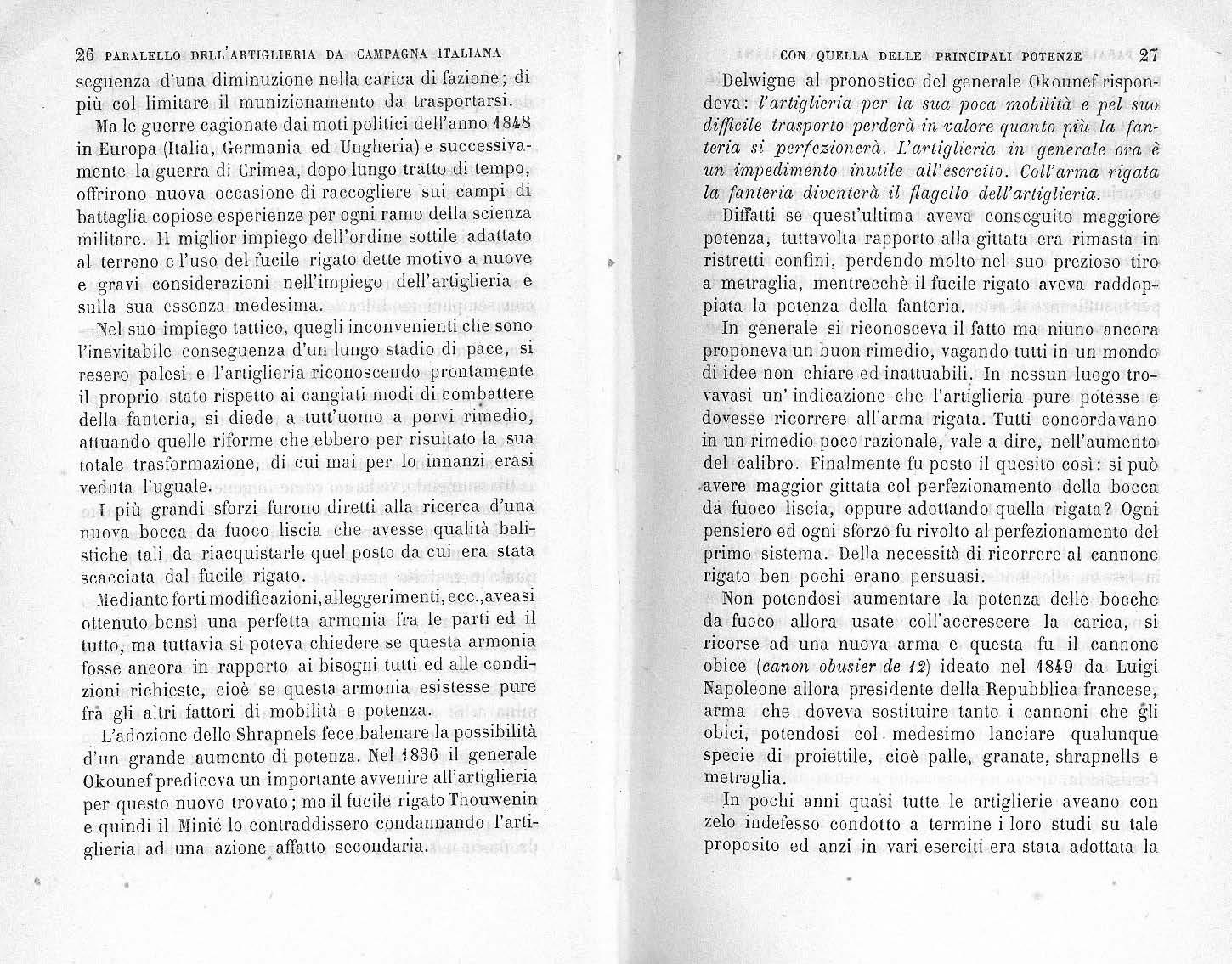
Delwigne al pronostico del generale Okounef rispondeva: l' art?"gheria per la sita poca mobilità e pel suo diffi cile trasporto pel'derà ùi valore quanto più la fanteria si perfezionerà. L'a1·tigli"eria in generale ora è un impedimento 1·nutile al.i' eserci to. Coll' anna 1·igata la fa.nte1·ia diventerà il flagello dell'artiglieria.
Diffalti se quest'ultima aveva conseguito maggiore potenza, tuttavolta rapporto alla gitta ta era rimasta in ristretti confini, perdendo molto nel suo prezioso tiro a metraglia, menlrecchè il fucile rigato aveva raddoppiata la potenza della fanteria.
In generale si riconosceva il fatto ma niuno ancora p rop oneva un buon rimedio, vagando tutti in un mondo di idee non chiare ed i nattuabili_. In nessun luogo trovavasi un'indicazione che l'artiglieria pure potesse e dovesse ricorr ere all'arma rigata. Tulli concorda vano i n un rimedio poco razionale, vale a dire, nell'aumento rlel calibro. Final mente fu posto il quesito così: si può .avere magg ior g ittata col perfez ionamento della bocca dà fu oco liscia, oppure adottando quella rigata? Ogni pensiero ed ogni sforzo fu rivolto al perfezionamento del primo sistema . Della nec essità di ricorrere al cannone rigalo ben pochi erano persuasi .
No n potendosi aumentare la potenza delle bocche da fuoco allora usate coll'accrescere la carica, si ricorse ad una nuova arma e questa fu il cannone obice (c anon obusier cle 1:2 ) ideato nel 18.i-9 da Luigi Napoleone allora presidente della Repubblica francese, arma che doveYa sostituire tanto i cannoni che gli obici, potendosi col . medesimo lanciare qual unque specie di pro ie t.Lile, cioè palle, granate, shrapoells e me traglia.
In pochi anni quasi tulte le ar ti glieri e aveano con zelo indefes so condotto a termine i loro studi su tale proposito ed anzi m vari eserci ti era stata adottata la
26 PARALELLO
CON QUELLA DELLE PRINCIPALI. POTENZE .27
DELL'ARTIGLIERIA DA CA.MPAGNA lTAUANA
nuova bocca da fuoco ('I}, quando i s.orprendenti risultati di una nuova arma (rigata) per la sua grande gittata e maggior giustezza di tiro, atlrassero la universale attenzione.
Arti:glieria rigata. - La costruzione d'armi rigate, a caricamento posteriore, era già stata da gran tempo e spesse fiate tentata. Fin dal 45° e rn° secolo si videro armi di tale fatta, riconosciute sotto il . nome di a1·mi a camera, a cuneo, ecc. Ma sino ai dì nostri non era stato trovato un modo di fabbricazione facile e sicuro per insutncenza di arte. Le difficoltà tecniche incontrate erano perciò state ritenute insuperabili, e quella idea era stata abbandonala non essendovi chi fosse bene compreso degli importanti vantaggi eh' ella prometteva quando fosse convenienterpente attuata.
Gli studi per avere bocche da fuoco rigate datano dall'adozione del fucile rigato. Nel 1826 in Annover e _ nel 83:2 in Torino furono provati cannoni di ferro muniti di righe; ma queste prime ricerche detlero meschini risultati. Le riprese a condurre s11 miglior via un distinto nostro ufficiale d'artiglieria, il capitano (ora generale) Cavalli. Questi nell'anno 484-0 trovandosi in Isvezia alla fonderia di Àke r per sorvegliare alla fabbricazione di artiglieria per conto del Governo sardo, conoscendo le prove fatte a 'l'orino, propose al barone Wahrendorff, possessore di una fonderia di ferro in Aker, il qual e aveva già sperimentato un cannone liscio a retrocarica, la fabbricazione d'un cannone solcato dà due righe con cui intraprendere un seguito di esperienze.
Da ciò ebbe principio una vera trasformazione del1' artiglieria.
Tan(o in Isvezia quanto in I1alia al ritorno del cap itano Ca valli, si COQ.Linuarono indefessamente esperienze che però tutte si riferivano alle artiglierie da muro, n~n sentendosi ancora quanto maggior bisogno d'arma rigata avesse l'artiglieria da campo.
Per comprendere la ragione di tale trascuratezza per quanto si riferiva alle artiglierie campali in quel tempo, basta leggere gli scritti militari di Germania e d'Inghilterra. del 4855.
Nell' ,:l.rchiv von 1855 Band 38, sull'adozione d'artiglierìe rigate l eggesi: il .c annone ri°[;ato a retrocarica ri'cliiecle una certa lunghe zza, non ha t'Ìro curvo; con esso non si possono lanci'are che palle, non g1·anate n~ shrapnells a motivo delle d1/ficoltà insormontabili che s'incontrano per l'a.ccensione; non ha nemmeno tfro cli rùnbalzo nè quello a metraglia; in una pa1·ola il cannone 1·igato non è applic abile alla guerra campale.
Schuberg ( Hcinclbuch cler artillei-i~ - Wissenschaft) nel 185G di ce va: v'è poco d'aspettarsi dal cannone rigato per la guer1·a cli campagna, non potendosi col medesimo esegiiire nè il tfro a shrapnells nè qiiello a met1'agli'a . ;
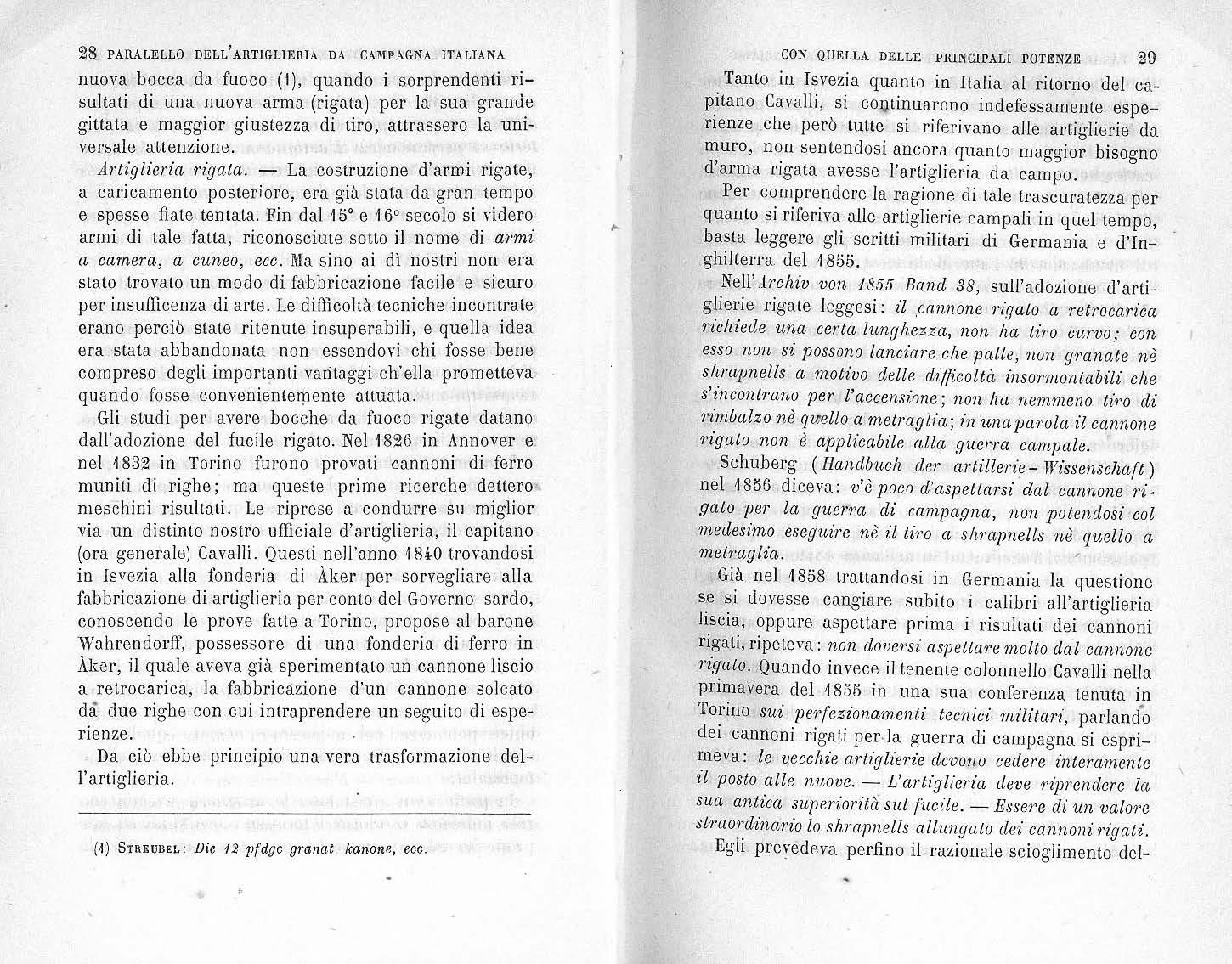
,Già nel 11858 tratlandosi in Germania la questione se s i dovesse cangiare subito i calibri all'artio-lieria liscia, oppure aspettare prima i risultati dei c:nnoni ri?ati, ripeteva: non dove1·si aspetta1·e molto clal cannone rigato. Quando invece il tenente colonn ello Cavalli nella primavera del ,J 855 in una sua confere nza ten uta in 1'o~ino sui pe1·fez2·onamenti tecnici militari, parland°o de, cannoni rigati per-la guerra di campagna si esprimeva: le vecchie artigli'e?-t'e devono cedere interamente il posto alle n-uove. - L'artiglieria deve riprendere l a sua antica superiorit a sul fucile. - Essere di un valore strao1:clinario lo shrapnells allungato dei' cannoni rigati'.
Eg h preyedeva perfino il razionale scioglimento del-
'.28.
PARALELLO
( ~) STREUBEL: Dic 12 pfdgc granat kanone, ecc.
CON QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE 29
TIELL'ARTIGLIER I A -DA CAMPAGNA ITALIAN A
l'attuale questione dei due calibri dicendo : essere un cciUbro solo cosa des1'de1·abile ma non sufficiente .
Nel · 1857 in Francia e nel 1858 da no i si intrapresero accui·ati studi per un cunnone da campagna rigato a ~ari ca mento dalla bocca; ma si dovellero sospendere allo . scoppiare de ìl e ostilità coll'Au~tria, dim od ochè l'artiO'lieria sarda doveLLe entrare in campo senza cano . . noni ri ga ti, mentre la francese poté portare sm camp i di Lombardia 36 batterie da 4 e quatt ro <la 42 rigate .
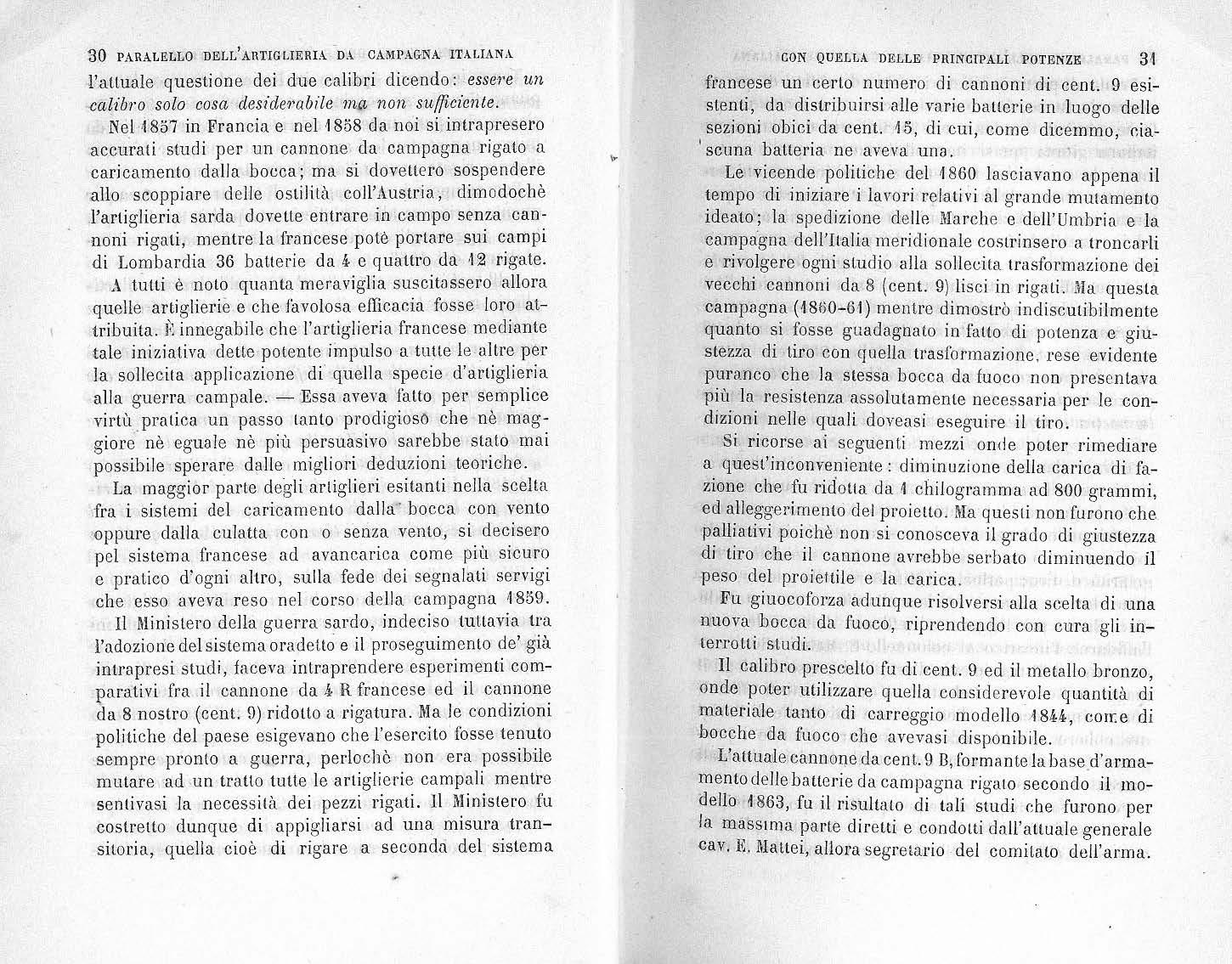
.A tÙtti è noto quanta mera viglia suscit:Jssero allora c1uelle artiO'lieriè e che favolosa efficacia fosse loro ato ]' t ribuita. f: innegabile che l'artiglieria francese mec iante ·tale iniziativa elette polente impulso a tutte le altre per la solle cita applicazione cli' quel la spec ie d'artiglieria all a guer ra campale. - Essa aveva fallo per semplice vi rtù pralica un passo tanto prodigioso che nè maggiore· nè eguale nè più persuasivo sarebbe stato mai possibi le spera~e dalle migliori deduzioni teoriche.
La maggio r parte degli artig li eri esitanti nella scelta fra i sistemi de l caricamento dalla · bocca co n vento ·oppure dalla culatta con o senza vento , si decisero pel sistehla frnncese ad avanca ri ca come più sicuro e prat ico d'ogni altro, sulla fede dei segna lati servigi che esso aveva reso nel corso della campagna '1859.
I l .Ministero della guerra sardo, indeci so tut.tavia tra l'adozione del s istema oracletto e il proseguimento de' già intrapres i stud i, faceva in traprendere esperimenti comparativi fra il cannone da 4 R france s e ed il ca~n on~ da 8 nostro (cent. 9) ridotto a rigatura . Ma le condmom politiche del pae se esigevano che l'esercito fosse te~~to sempre pro nto a guerra, perlochè non era poss1b1le mutare ad un tratto tutte le artiglierie campali mentre sen tivasi la necessilà de i pezzi rigati. li Min is teeo fu costretto dunque d i app igliars i ad una misura transitor ia, quella cioè di rigare a seconda del sistema
CON QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE 31
francese un certo num ero di cannon i di cent. 9 esistenti, da distribuirsi alle varie batlcrie in luogo delle sezioni obici da cent. 15 , di cui, come dicemmo, eia' scuna batteria ne aveva ·una ,
Le vic ende politiche del 1860 lasciavano appena il tempo di iniziare i lavori relativi al grande mutamento ideato; la spediz ione delle Marche e dell'Umbria e la campagna dell'halia meridionale costrinsero a troncarli e rivolgere ogni studio alla solle<.:ita trasformaz ione dei vecchi cannoni da 8 {cent. 9) lisci in rigat i. àla questa campagna (,1860-6 · 1) mentre dimostrò indiscutibilmente quanto si fosse guadagnato in fauo d i potenza e gius tezza di Liro co n quella trasformazione. rese evidente pura.neo che la stessa bocca da fuoco nor1 presentava più la resis tenza assolutamente necessaria per le condizioni 11elle quali doveasi esegui re il tiro .
Si ricors e ai seguent i mezzi onde poter rimediare a quest'inconveniente : diminuzione della carica di fazione che fu riciotla da 1 chi logramma ad 800 grammi, ed alleggerimento del proietto. ~fa questi non furono che. palliativi poichè non si conosce va il grado di giustezza di tiro che il cannone avrebbe serba to diminuendo il peso del proiettile e la carica.
FLl giuocoforza adunque risolversi alla scelta di una nuova bocca da fuoco, riprendendo con cura g li interrotti studi.
Il calibro prescelto fu di cent . 9 ed il metallo bronzo, onde poter ut ilizzare quella comid c revole quantità di materiale tanto di carreggio modello ·1844 , corr.e di bocche da fuoco cne avevas i dispon ib ile.
L'attuale cannone da cent. 9 D, formante la base d'armamento delle batterie da eampagna rigato second~ il modello 1863, fu il r isultalo cli tnU studi che furono per la massima parte diretti e condotti dall'attua le generale cav . lt .l\1auei, a11ora segr etari o -del com itato dell'arma .
30
PARAl,ELLO
PARALELLO DELL'ARTIGLJERIA DA CAMPAGNA ITALlANA
Prima di porre in rilievo i p regi ed i difetti di questa bocca da fuoco, farò osservare come per mo l to tempo fosse generale credenza che l'artiglieria da campagna italiana gi1mta qunsi insensibilmente a quello stato, mercè le successive trasformazioni ed innovazioni sopradette, fosse tale da ·competere per leggerezza e potenz a con quella dei sistemi più recenti e già adottati, od in via d'adozione presso le potenze straniere, e potesse soddisfare pienamente ai bisogni della guerra. · Ciò era ufficialmente confermato dalla conclusione del resoconto delle espe ·rienze sidl' adozione di nuove bocche da (uoco rigate eseguite nel 18 62, in cui riguardo al cannone da 8 (cent. 9) BR modello 1863, era detto: rhe è tale da compiutamente soddisfare a tiitte le esigenze sia della pratica che della teon·a, e , che rende la nostra a1·tiglieria da campagna, se non superiore, al certo eguale ci qiielle delle altre potenze europee.
Tale credenza non permetteva certo ulleriori innovazioni senza la sanzione &lunghi e feiici esperim enti.
Ma la guerra del 1866 contro l'impero austriaco mostrò ad evidenza che la nostra artiglieria campale lasciava molto da desiderare quanto a mobilità e regolarità di tiro; perlochè il Ministero della guerra , credeLte dovere promuovere la scelta d'un altro materiale d'artiglieri.11. più leggero ed ;efficace dell'atluale, coll'affidarne l'incarico al colonnello E. ~fattei allora comandante il 3° reggimento d'artiglieria, associandogli il maggiore Rossi cav. Celestino. A questi distinti ufficinli offrl ottima occasione l'esposizione universale di Parigi ove ebbero agio di vedere e studiare a fondo i prog ressi (atti nella teorica dell'artiglieria dai principali eserciti d' Europa
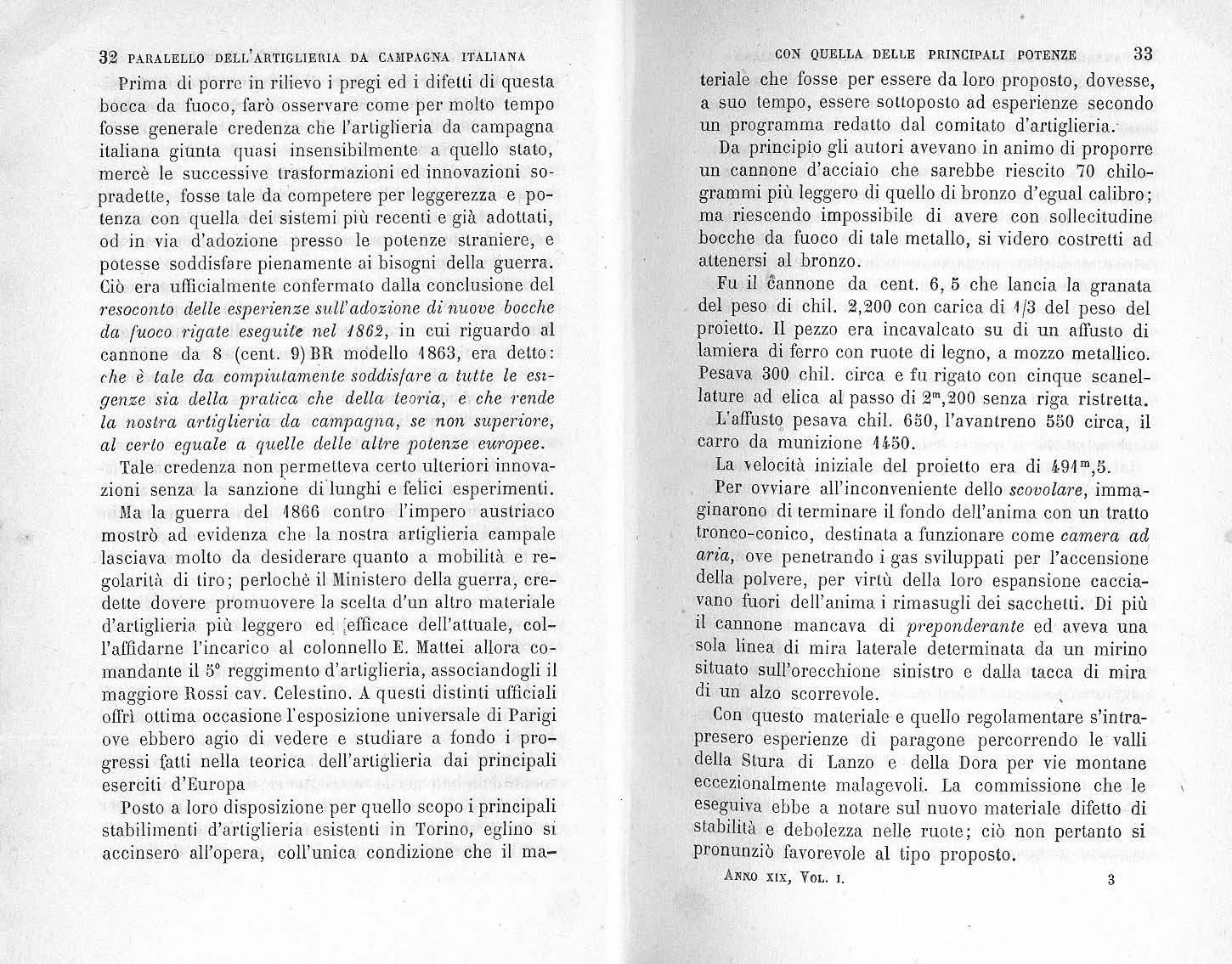
rosto a loro disposizione per quello scopo i principali stabilimenti d'artigl ieri a esisten li in Torino, eglino si accinsero all'opera, coll'unica cond izione che il ma-
teriale che fosse per essere da loro proposto, dovesse, a suo tempo, essere sollopo sto ad esperienze secondo un programma redatto dal comitato d'artiglieria:
Da principi,o g li autori avevano in animo di proporre un cannone d'acciaio che sarebbe riescito 70 chilogrammi più leggero di quello di bronzo d'egual calibro; ma riescendo impossibile di avere con sollecitudine bocche da fuoco di tale metallo, si videro costretti ad attenersi al bronzo .
Fu il èannone da cenl. 6, 5 che lancia la granata del peso di chi I. 2,200 con carica di ·1/3 del peso del proietto. Il pezzo era incava lc ato su di un affusto di lamiera di ferro con ruote di legno, a mozzo metallico. Pesava 300 chil. circa e fu rigato con cinque scanellature ad elica al passo di 2''\200 senza riga ristretta. L'affusto pesava chil. 650, l'avantreno 550 circa, il carro da munizione H50.
La 'Velocità ini ziale del proietto era di 49'1 m;5.
Per ovvinre all'inconveniente dello scovolare, immaginarono di terminare il fondo dell'anima con un tratto tronco-conico, destinata a funzionare come camera ad aria, ove penetrando i gas sviluppati per l'accensione della polvere, per virtù della loro espansione cacciavano fuori dell'anima i rimasugli dei sacchetti. Di più il cannone mancava di 7n·eponderante ed aveva una sola linea di mira laterale determinata da un mirino situato sull'orecchione sinistro e dalla tacca di mira di un alzo scorrevole. , Con questo material e e quello regolamentare s'intrapresero esperie nze di paragone percorrendo le valli della Stura di Lanzo e della Dora per vie montane eccezionalmente malagevoli . La commissione che le eseguiva ebbe a notare sul nuovo materiale difetto di stabilità e d ebolezza nelle ruote; ciò non pertanto si pronunziò favorevole al tipo proposto.
32
33
CON QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE
3
ANlw xix, YoL. 1.
DELL'AR'l'IGLIERIA DA CAMPAGNA I'l'ALIAN,\
Al campo di Po iana pure il materiale Maltei-Rossi diede ottime prove d i leggerezza e resistenza, soddisfacendo pienamente chi vi presiedeva.
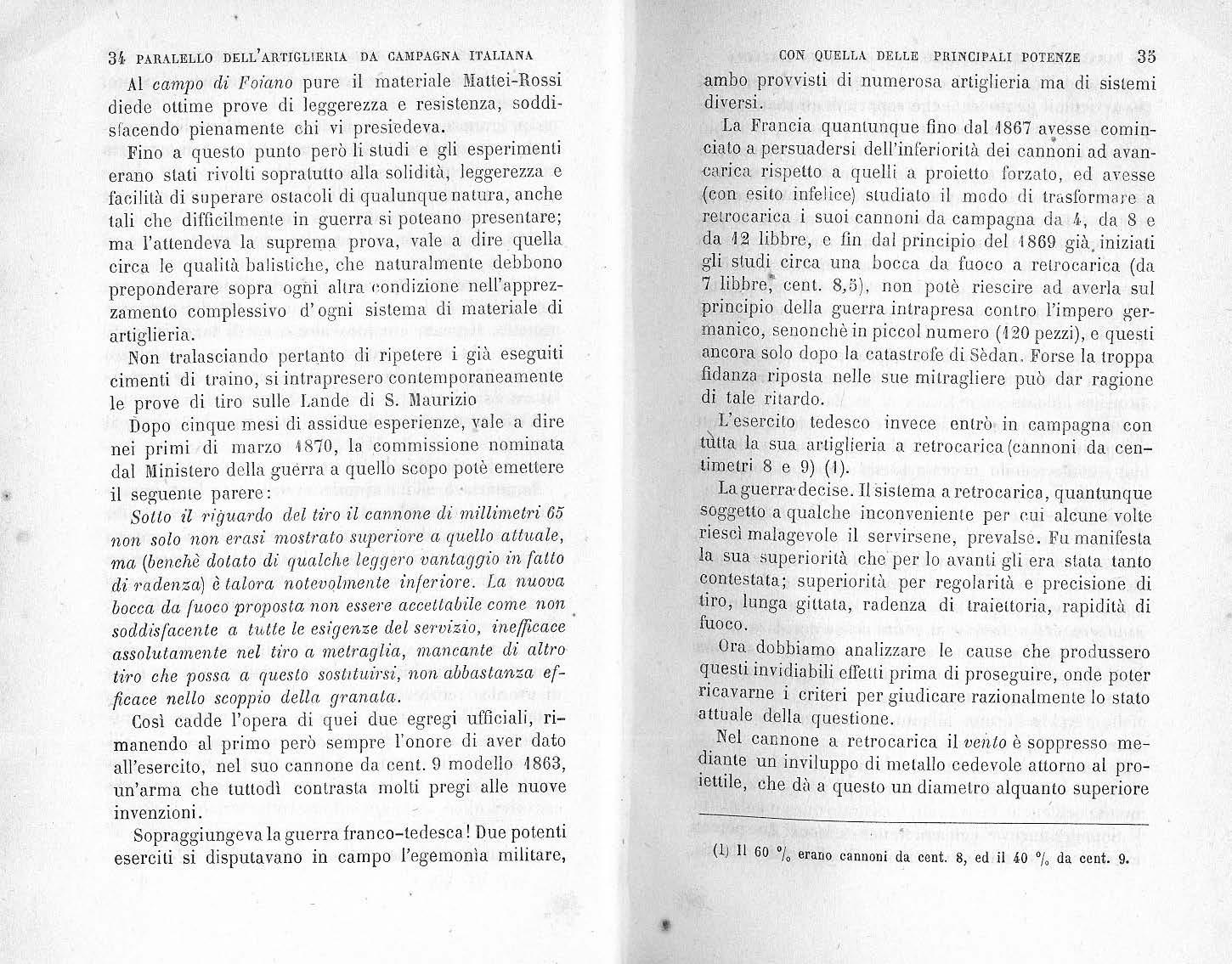
Fino a questo punto però li studi e g li esperimenti erano s tati rivolt i sopratutto alla so li dità, leggerezza e faci lità di s11perare ostacoli cli qualunque natura, anc he ta li che difficilmente in guerra si poteano presentare; ma l'attendeva la suprema prova, vale a dire quella circa le qualità ba lis tiche, che naturalmente debbono preponde.rare sopra ogni altra r:ondizione nell' a pprezzamento complessivo d'o gni sistema di materiale di artiglieria .
Non tralasciando pertanto di ripetere i già eseguiti cimenti di tra i no, si intrapresero conternporaneamenle le prove di Li ro sulle Lande di S. Maur i.zio
Dopo cinque mes i di ass idue esperie nze , vale a dire nei primi di marzo "870, la . commi ss ione nominata da l Ministero della guèrra a quello scopo polè emettere il seguente parere:
Sotto i·z 1·iguardo del tiro il cannone di mt'llimet?·i 65 non solo non erasi mostrat o superio1·e a quello attuale , mci (beneh è dotato di qualche legg ero vantaggio in fatto .di 1·adenza) è talora not evqlniente inferiore. La nuova bocca da fuoc o proposta non essere accettabile come non . soddisfacente a tutte le esigenze del se1·vizio, inefficace assolutamente nel tiro a metragha, mancante di altro tiro che possa a questo sostituirsi, non abbastanza efficace nello scopp ·io della granata.
Così cadde l'opera di que i du e egregi ufficiali , rim anendo al primo però sempre l'onore d i aver dato all'ese rcito, nel suo can none da cent. 9 modello 4863, un'arma che tuttod ì contrasta mo l ti preg i alle nuove invenzioni.
Sopr aggiungeva la guerra franco-ted esca ! Due potenti eserc iti si di sputavano in campo l'egemonìa m ili tare,
ambo provvisti di numerosa artig lieria ma di sistemi diversi.
ta Francia quantunque fino dal 11867 avesse cominciato a persuadersi dell'inferiorità dei carn;o ni ad avan{:arica rispe tto a quelli a proietto forzato , ed avesse {con esito infel ic e) studiato i l modo di tr&sforml!l'e a retro c arica i suoi cannoni da campagna da /4., da 8 e da 42 libbre, e fin dal principio del ·1869 g ià . iniziati gli .studi ci rca una bocca da fuoeo a. ret r ocarica (da 7 ltb,bre , eent. 8,5), non potè riescire ad a ve rla sul pr incipio della guerra intrapr·esa contro l'impero germanico, seuonchè in picco I numero (·1'.ilO pezzi), e questi ancora so_lo dopo la catastrofe di Sèdan . Forse la troppa fidanza riposta nelle sue milragliere può dar rao·ione di tale ritardo. 0
L'esercito tedesco invece enlrò in carnpagna con tÙtta la sua arliglieria a retrocarjca (cannoni da centi metJ·i 8 e !J) (I).
La guerra·decise. Il sistema a retrocarica, quantunque soggetto a qualche in conveniente per cui alcune volte riesci malagevo le il servirsene , prevalse . . Fu manifesta la sua superiorità che' per lo avanti gli era stata tanto c.o ntestata ; superiorità per regolarità e precisione di tuo, lunga giuata, r adenza di traiettoria, rapidità di fuoco .
Ora dobbiamo ana li zzare le cause che produssero q_ues ti invidiabili effeui prima di proseguire , onde poter ricavarne i cri teri per giudicare razionalmente lo stato attua le della questione .
Nel cannone a r etrocarica il veiito è soppresso me?1a? te un invi l uppo di metallo cedevole attorno al proiettile, che dà a questo un diameteo alquan,to supet'iore
.
34 PARA.LELLO
35
CON QUELLA DE LLE PRINCIPALI POTENZE
(l) li 60 % erano cannoni cla cent. 8, ed il 40 °/. da cent. 9,
DELL' AR1'IGLIEIUA DA CAMPAGNA lTALlANA
a quello dell'anima del cannone. :eer conseguenza di ciò avviene il forzamento che sopprime gli sbattiment i; l'ano-olo di tiro e la vel,ocità iniziale esse ndo perciò più uniformi ne risu lta meglio assicurata la coinc idenza degli assi di rotazione e di figura del proietto uscente dall'anima. Ne deriva maggiore g iustezza di tiro. La soppressione del vento fa sì che tutta quanta la potenza ~splosiva della carica si utilizza nel til'o. Da ciò rna o-gior veloc ità con cariche relativamente piccole e pe,~ conseguenza radenia di truietloria e lun?a gittala:
Il forzamento mediante Io inviluppo di p10mbo o d1 qu alche altra materia malleabile, concorre pul'e alla buona conservazione <}elle righe e succedendo lo scopp io di qualche grana la nell'interno dell'anima ne attutisce i danni.
Col caricamento posteriore si evitano gli inceppamenti dei proietti n ell'anima ed il tiro si eseguisce più ra~ pi.do, non essendo necessario scovolcwe, e potendosi tirare di dietro a qua lche riparo, bassi il g rande vantugg io cli assicurare alquanto i serventi dal fuoco dei tiraloTi nemici .
Qu es ti effett i,' comprovati pure dall'esperienza della guerra , non potevano rim a nere rinosservati dall'Ita lia. Una commissione d'uffi ciali d'artiglieria nominata dal Mini stero della gue rr a , a d esaminare e decil\e re su tre tipi di ca nnoni a retrocarica, pr:~celse q~ello a. sistema di chiusura Jfrupp, a cuneo c,hndro pr1smal1co, studialo dal comitato .. Questa bocca da fuoco fra non mol to verrà sos tituila all'attuale cannone da cent. 9 nelle b a tte rie divisionali .
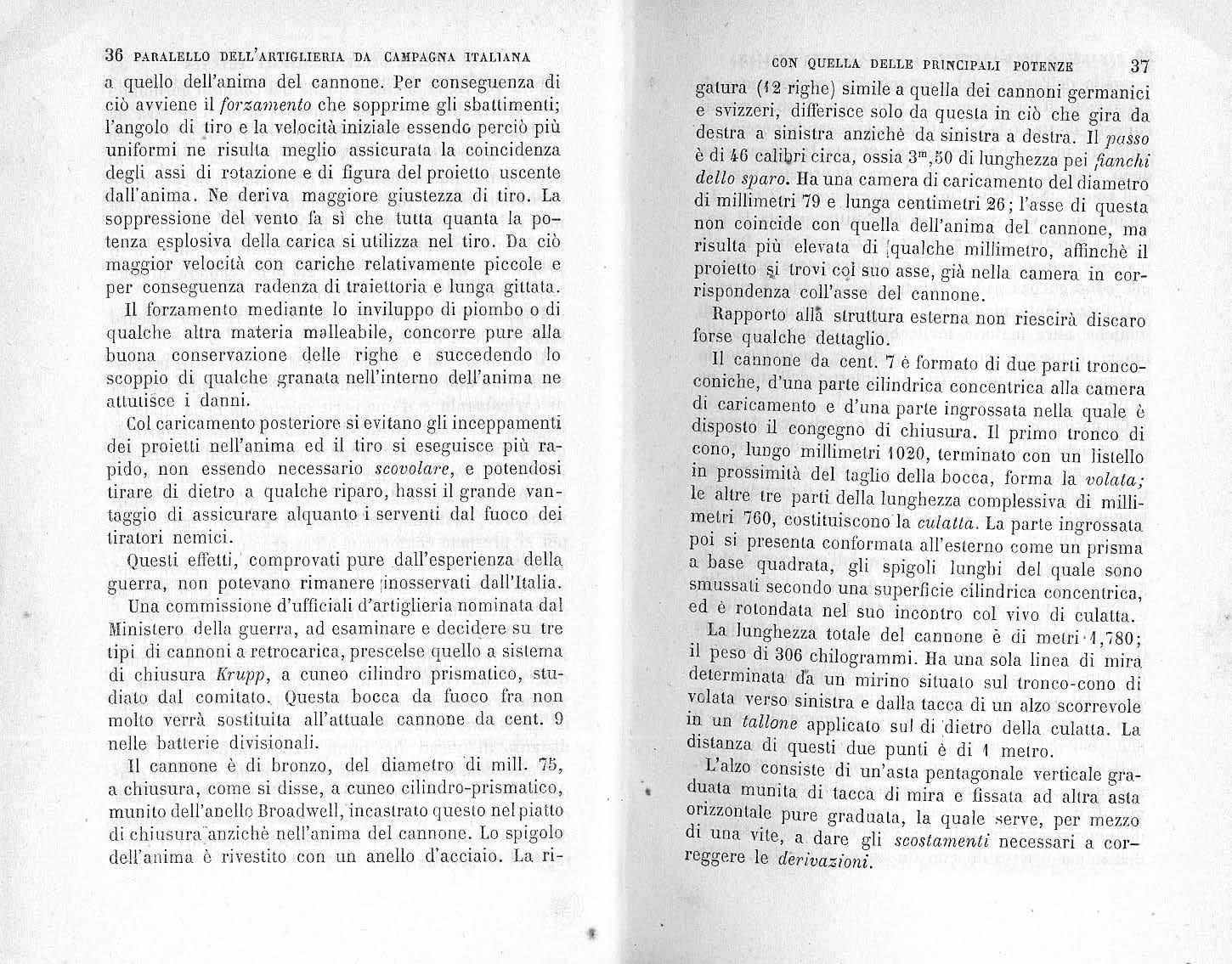
li cannone è cl i bronzo, del diamelC'O di mili. 75, a chiusura , come si disse, a cuneo cilindro-prismatico, munito del l'anclloB roadwell, incastrato questo nel pia u o di chiusura"anzichè nell'anima del cannone. Lo spigolo dell' anima 6 rivestito con un anello d'acciaio. La ri-
CON QUELLA DELLE PltTNCIPALI POTENZE: 37 galura (Vii righe) simile a quella dei cannoni germanici e svizzeri, differisce solo da questa in ciò che gira da 'destra a sinistra anzichè da sinistra a destra. Il p asso è di 46 cali:bri circa, ossia 3rn ,5 0 di lunghezza pei /ia,nchi dello sparo. Ha una camera di caricamento del diametro di millimetri 79 e .lunga centimetri 26; l'asse di ques ta non coincide con quella dell ' anima del cannone, ma risulta più elevai.a di (qualche millimelro, affinchè il proietto ~i trovi cql suo asse, già nella camera in corrispondenza coll'asse del cannone.
Rapporto ali~ struttura esterna non riescirà cliscaro forse qualche dettaglio.
Il cannone da cent. 7 è formato di due parti. troncoconiche, d'una parte cilindrica concentrica a ll a camera di caricamento e d'una pa rte ingrossata nella quale è disposto il congegno dì chiusura. Il primo tronco di cono, lungo millirnetri 1020, terminato con un listello in prossimità del taglio della b occa, forma la volata; le altre t1·e parti della lunghezza complessiva di millimetri 760, costituiscono la culatta. La parte ingrossata poi si presenta conformala all'esterno eome un prisma a base quadrata, gli spigoli lunghi del quale sono smussati secondo una superficie cilindrica concentrica, e d è rotondata nel suo incontro col vivo di culatta. La lunghe zza totale del cannone è di melri ·1 780; il peso di 306 chilogl'ammi . Ha una sola lin ea di' mira determinata da un mirino situato sul tronco-cono di volata verso sinistra e dall a tacca di un n.lzo scorrevole in un tallone applicalo sul di 'dietro della culatta. La distanza di questi ' due punti è di 1 metro.
L'alzo consiste di un'asta pentagonale verticale graduata munita di ·tacca di mira e fissata ad altra asta o:izzontale pu re graduata, la quale :-;erve, per mezzo dt una vite, a . dare gli scosta.menti necessari a correggere le derivazioni .
36 PARALELLO
DELL'ARTIGL1EIHA DA CAUP AGNA l'l'ALlANA
Il focone è p ratic a lo normalmente aUa parete della camera .
I proietti che possono essere lanciati dal cannone da cent. 7 DR sono di tre spe c ie, vale a dire:
La granata ord inaria;
La granala a pali elle (shrapnell) ;
La sc atola a metn1glia .
La gr anata oblunga da cent. 'i è çl i ghisa ordi naria della lungh ez za di 180 millimelri, avvolta da un' incamiciatura sottile di piombo, fissala mediante prevent iva zin catu ra . Il suo cavo interno è fogg iato in gu isa da otte nere la rottura del proietlo in scheggie numerose e di peso presso a poco eg uale. La granata vuota pesa chi!. 3,380; munita di spoletta e carica ch i!. 3,72 0; lu ca1·ica 'interna Lè di 200 gra mmi. La carica di fa;;i'one chil. 0,5150.
La granata a pallclle ancora in ria di esperimento ( 1) è piu corta della granata ordinaria ed ha le pareti assai sottili . Contiene circa 400 pa ll ctte (di circa ·16 gramrni l'una) d i lega di piombo ed antimon io, tra ttenute dal zolfo colato fuso negli interstizi . Lo scoppio è prodouo da grammi 1O di polvel'e contenuta in un tubo di lamiera di ottone disp osto secondo l'asse de l p roietto. Il peso di questa granala o shrapnell carica e mun it a di spolella ascende a 4 chilogrammi .
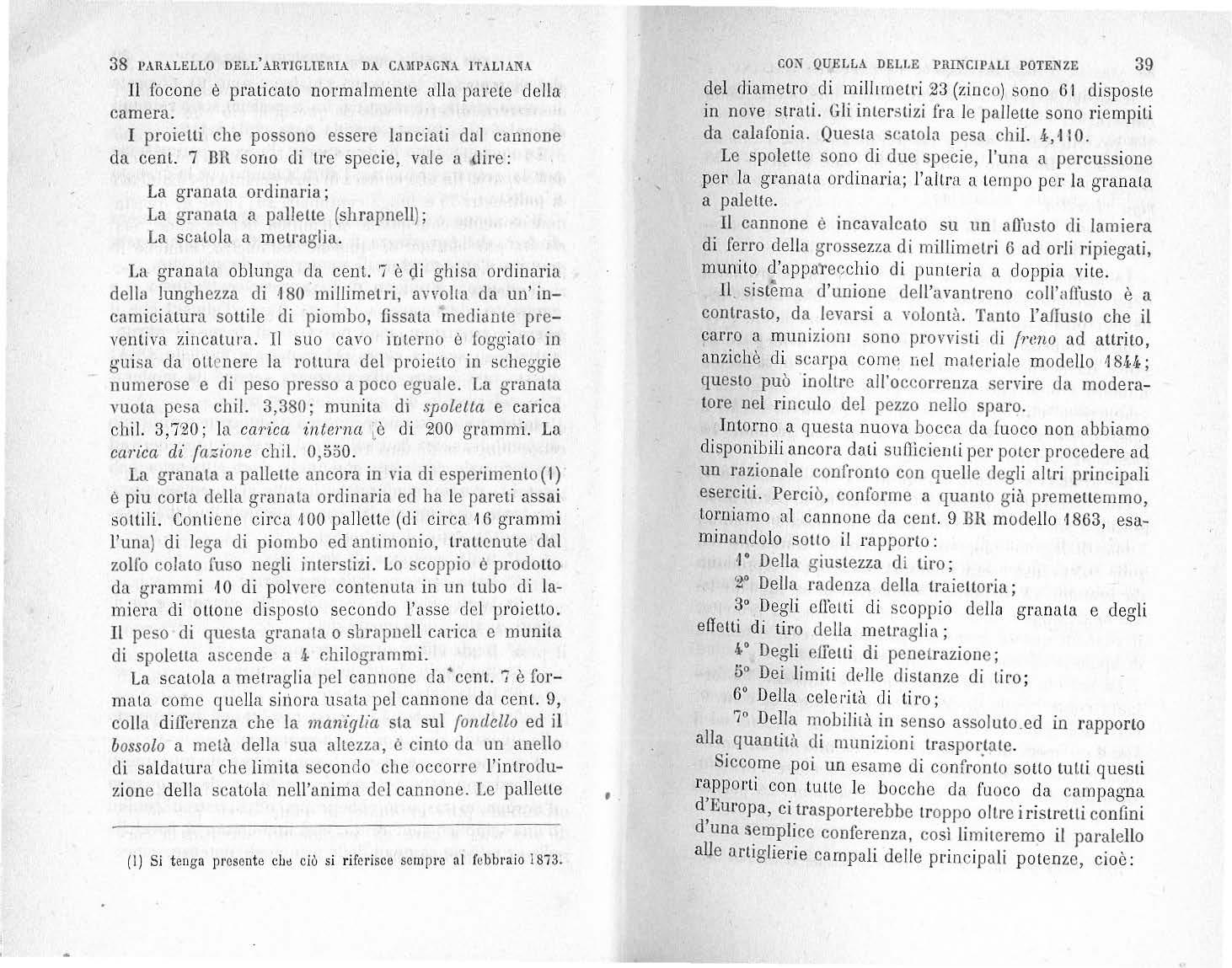
La scatola a rne 1raglia pel cannone da· cen l. 7 è form a ta come que lla siriora usata pel cannone da cent. 9, colla di fferenza che la maniglia sta sul fondello ed il bossolo a metà della sua altezza, è cinto da un anello di sa lda tur a che li mita sec ondo che occorre l'introduzione dell a sca tola nell'anima de l cannone. Le pall e ue
CO~ QUELLA DELJ,E PRINCIPALI POTENZE 39 del diametro di m illi metri ~3 (zinco) so no 61 dis posLe in nove s tr ali. Gli inter,,tizi fra le pallette son o riempiti da calafonia. Ques1a seatol:i. pesa chil. .f.,110.
Le spolelte sono di due specie, l'una a percuss ione per la g rana ta ordi naria; l'altra a te mpo per la granata a palette.
Il cannone è incavalcato su un affusto di lamie ra di ferro della g ross ezza di millimetri 6 ad orli ripiega ti , muni to d'ap pa'recchio di p un teria a doppia vite .
ll . s istèma d'unione dell' avantreno co ll'a ffusto è a contrasto, da levarsi a volontà . Tanto l'afiusto che il carro a mu niziorn sono provvis1.i di freno ad allrito, anzichè di scarpa come nel maleeiale mod e llo 4844; questo può in oltre all'o cco rrenza sel'v ire da mode ratore nel ri nculo del pezzo nello sparo .
I n torno a questa nuova bocca da fooc o non abb iamo di sponibil i ancora da li sufììcie nti per poter pro cedere ad un razional e confronto con quelle degli altri principali eser~ili . P erciò, conforme a quanto g ià premettemmo, torrn amo al cannone da cent. 9 BR modello 1863 esa. . ' mmando lo sotto il r apporto :
,1• Della giu stezza di tiro;
~· Della radenza della traiettoria ·
3° Degli effetti di scopp io delln 'gra nala e degli effetti di tir o della metrag lia;
4- 0 Degli effetti di pene trazione;
0° Dei limiti dt>lle distanze cl i Liro ·
6° Della cele rit à di ti ro ; '
7° De~l a mobililà in senso ac:;soluto .ed in rapporto alla_ qua ntllà di munizioni traspor.tate.
, .
(I) Si ten ga prcsonte eh.i ciò si ri ferisce sem pre al fobb rai o 1873.
Sicco me poi un esame di co nfronto sotto tulli quest i r~~p~rti co~ tu tte le bocche ei a fuoco da campagna d Eu i opa, c1 trasporterebb e lr oppo oltre i ristretti co nfini d'una s~~pli ce conferenza, così limiteremo i l paralello all e arl1gl1er1e campali de[le pl' i nc ipali potenze, cioè :
38
l'ARALELLO
PARALELLO DELL'ARTIGLIERIA ~cc.
Cannone austriaco da 4 (millimetri 811,2) BR (4) modello 18G3, ad avancarica; con sei righe a passo costante, senza restringi·mento nelle righe.
Cannone francese .da 4 (mi ll imetri 86,5) BR mod . 11858 ad avancarica, a sei righe con p1·olimgamento della ri_qa rist1·etta .
Cannone belga da 4 (millimetri 78,5) AR, a retrocarica. Sistema di chiusura Wabrendorff.
Cannone inglese da ,12 (millimetri 76 ,2)'FR mod. 1863 a retrocarica , con sislemà di chiusura a vite (Armstrong), ha 38 r ighe.
Cannone prussiano da 4 (millimetri 78,5 dett-0 pure da cent. 8) A e BR mocl . 18o-9 a retrocarica, con chiusura a cuneo cilindro-prismatico, ha· 12 righe.·
Cannone r usso da 4 (millimetri 86,6) A e BR mod. 1869 a retr ocarica, con chiusura e righ e simile al cannone prussiano .
Cannone svizzero da 8 (millimetri84) BR mod. 11871 a retrocarica, co n s islema d i chiusura a cun e o sem·plice ed anello nroadwell, ha pure Hl righe.
Le artiglierie degli altri Sta ti minori differiscono o nulla o ben poco da quelle che stiamo per esam inare, essendo s tate tutte su queste più o meno modellate .
( Continua)
Go zzi Go11FnEoo
Capitano d' artigl-ieria.
I regolamenti di disciplina e servizio, formatisi man mano dalle esperienze e dal bisogno di secoli allo scopo d' i nspirare nei soldati i sentimenti di dovere, d' onore e di obbedienza che valgano a tenerli saldi . contro le infinite c::a u se disso lventi della g uerra, allo scopo di costituirli s pada e scudo della nazione contro i nemici e stern i ed interni, sono specchi molto fede li non solo del carattere , delle abitudini, dei pregi e difeui di un esercito, ma ben anche dell'ambiente in cui esso vive .
L'antico regolamento austriaco , paterno sì e rigidamente morale, ma grave , diflìdente, geloso, pieno d i formalità, di minuti ri g ori, di repressioni poco conformi alla dign ità del sold a to e del cittad ino, iso lava l'esercito dal paese e corrispondeva a capello ai sent imenti autocratici della casta allora dominante ed alla necessità di vivere· in conLinua lotta colle oppresse ed agi tate na ziona lità . Ad ogni modo l'eserciLo austriaco vi ha guada gnato quelln 1empra di acciaio, que lla compattezza di granito ch e ta nte vo lte lo h a condotto alla vittoria e tante volte l' ha fatto risorgere al i' indo mani
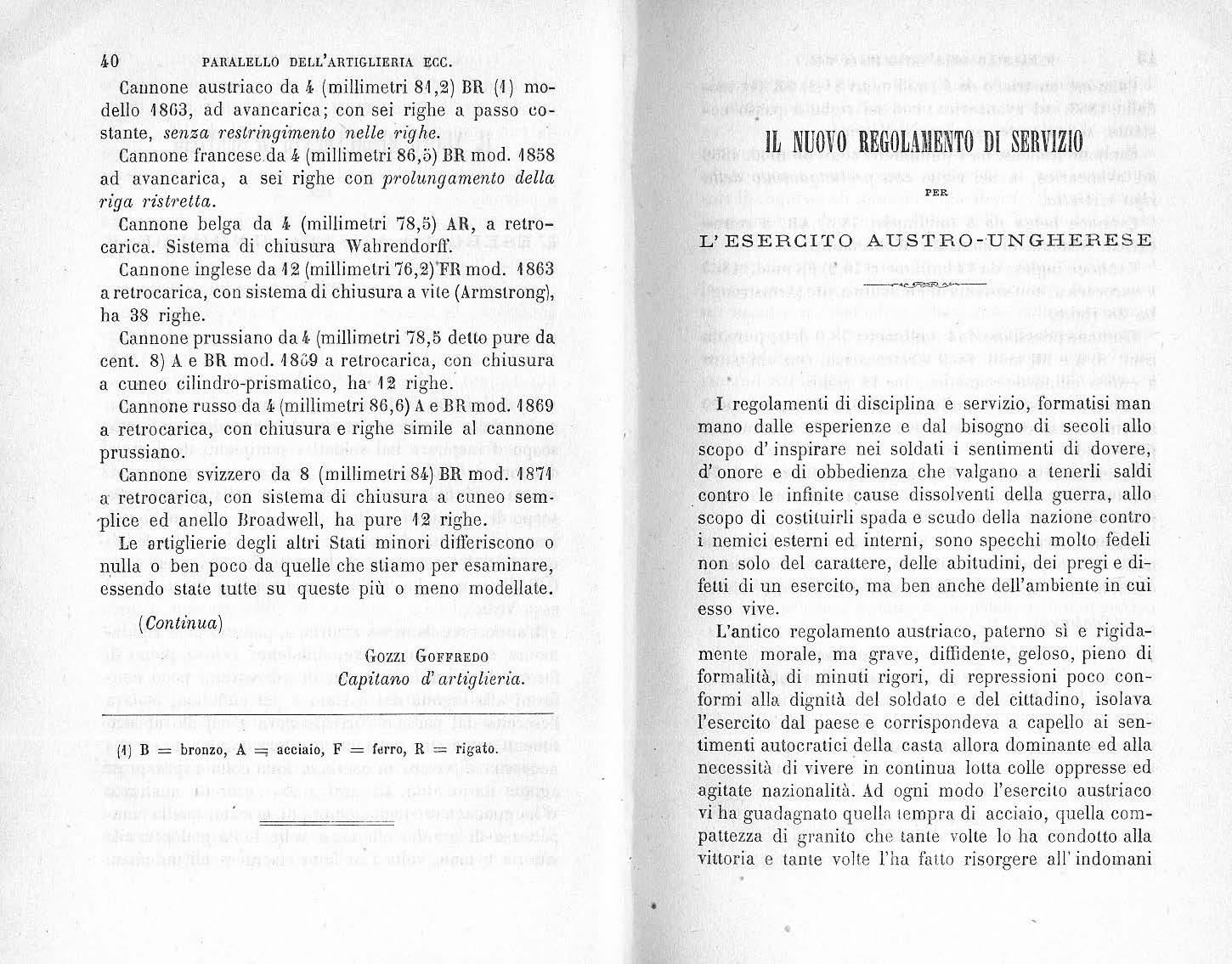
40
•
l'ER
---.. .. -
(~ ) B = bronzo, A :::::; acc iaio, F = ferro, R = rigato .
IL NUOVO REGOL.UIE NT ODI SERVIZIO
L'ESERCITO AUSTRO - UNGHERESE
e
della sconfitta, que lla discip li na e quell'ordine mirabile che imponendo ad amici e nemici l'ha tenuto riunito in mezzo al ternpeslare de lle rivoluzioni. ·
Ma la monarchia austro -ungherese si è politicamente e militarmente trasformata: largo si sterna rappresentativo, larga libertà di associazione , d i stampa, d i riunione; autonomia a lle singole razze; indipendenza ammin istrativa dell' Ungher ia; obbligo uni ve rsale alla leva; ferma di tre anni. A forza qu indi si davea mutare. Già non pochi cambiamenti s 'eran ven uti i ntroducendo nel rigorismo antico; non poche pedanterie e penose restrizioni s'erano buttate fra i ferra vecchi; nuovi principii, nuove forme avevan preso il dis sopra; il vecchio regolamento che contava già 70 anni d i vita tirava innanzi zopp i cando; l'esercito aspettava impaziente; era tempo di coronare Ja grande opera della ricostituzione mil iLareincominciata sette ann i or sono sopra basi add itate non solo dal progresso delle istituzioni e delle i dee , ma ben anche da l progresso tattico, avvalora to dall'esperienza delle ultime guerre.
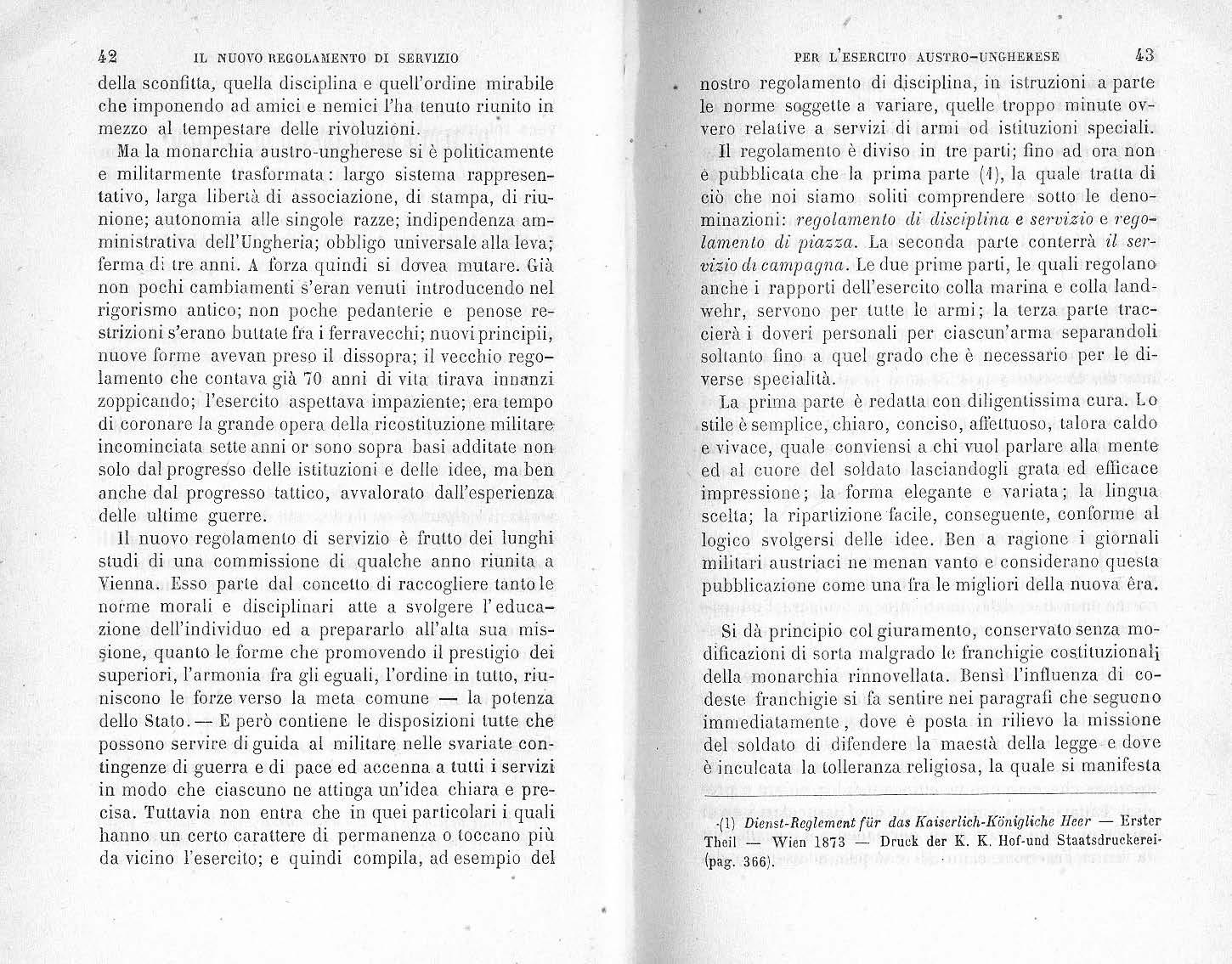
Il nuovo regolamento di s e rvizio è frutto dei lunghi studi di un a commissione di qualche anno riunita a Vie nna . Esso parle dal concetto d i raccogliere tanto le noi·me morali e d iscipl inari alle a svo lge r e l'educazione dell'individuo ed a prepararlo alt' alla sua rrris~ione, quanto le forme che promovendo il prestigio dei superiori, l'armonia fra gl i eguali, l'ordine in tutto, riuniscono le forze verso la meta comune - la po tenz·a de llo Stato . - E però conliene le disposizioni tutte che possono servire di guida al militare nelle svariate contingenze di guerra e di pace ed accenna a tutti i servizi in modo che ciascuno ne attinga un'idea ch iara e precisa. Tuttavia non entra che in quei particolar i i quali hanno un certo carattere di permanenza o toccano p i ù da vicino l'esercito; e quindi compila, ad esemp i o del
PER L'ESERCITO AUS'J' RO-UNGHERESE 43 no stro reg olamento d i cLisciplina, i n is truzioni a parte le norme soggeue a variare, quelle troppo m i nule ovvero relative a servizi di armi od isliluzioni speeia li.
Il regolamento è diviso in tre parti; fino ad ora non é pubblicala che la prima parte (·1), la quale traua di ciò che noi siamo sol iti comprenùere sotto l e denomin azioni : regolamento di disciplina e se1·vizio e regol amento cli piazza. La seconda parte conterrà. il servizio di campagna. Le du e prime parti, le quali rego lano anche i rapporti dell'esercito colla marina e colla landwehr, servono per tutte lo armi ; la terza parte tracc ierà i doveri persona li per ciascun ' arma. separandoli solranto fino a quel grado che è necessario per le divers e specialità.
La pi'ima p a rte è redatta con diligcnlissima cura. Lo stil e è semp lice, chiaro, conciso, affettuoso, talora caldo e v ivace, quale con vi en si a chi vuo l parlare alla mente ed al cuore del soldato lasciandog li grata ed efficace impressio ne ; la forma elegante e variata ; la li ngua scelta; la riparliz ione fac il e , conseguente , conforme al l ogico svolgersi delle idee . Ben a ragione i g iorna l i rnilita r i austriaci ne monan vanto e consid erano questa pubblicazione come una fra le migl iori della nuova èr'a.
Si dà principio col giuramento, conser va to senza modificazioni di sorta malgrado le franchigie cos.tituz ionali della monarchia rinn ovellata . Bensì l'infl uenza dì codeste franchigie sì fo senti. re nei paragrafi che seguono immediatamente, dove è posta in ri li evo la miss ione del soldato di difendere la maestà della legge . e dove è ineulcata la lo lleranza religiosa, l a quale s i manifesta
·(ll Dienst-Rcglemcnt fi.ir das [(aiscrlich-I(onigliche
42 IL
NUQVO T\EGOLAMENTO DI SERVIZIO
Heer - Erster Thcil Wien 1 873 Druck der K. K. Hof-und Staatsdruc kerei · (pag. 366).
NUOVO REGOLAMENTO DI SERVIZIO in varie altre disposizioni. Così i singoli accallolici non di servizio vengono dispensati dal rendere gli onori al sacramento ; i distaccamenti per ·cerimonie religiose -sono, ~er quanto possibile, composti di seguaci di una medesima fede; per lo meno una volta al mese i militari a gruppi sono condotti nelle chiese della rispettiva religione per comp iere le devozioni loro. Codesta pratica sì di recente sanzionata, insieme con parecchie alt re, -come la triplice preghiera delle guardie, gli accompagnamenti, spalliere ed altre cerimonie nelle funzioni religiose e nelle solenniLà di r ito cattolico e greco, le minute prescrizioni sulla messa, sulla benedizione delle bandiere, sul giuramento, mostrano che malgrado la. lotta fra lo Stato e la Chiesa , si procede a rilento nel proclamare la pura e semplice libertà di credenze.
I doveri morali, il contegno, lo spirito di unione e . <li fratellanza corrispondono quasi esattamente ai precetti paterni, ai consigli amorosi, alle norme saggis-sime tracciate nei primi articoli del nostro regolamento di disciplina.
. Interessan~e, perchè nuovo, perchè frutto delle espenenze proprie nel 1859 e 1866 ed altrui nel ·1870, è il paragra{o relativo àl contegno di fronte al nemico:

« La forza sta nell'azione 01;dinata e concorde di tutti;
« i conati divisi quantunque eroici non assicurano suecesso di .sorta .
« Chi nel momento decisivo parla vigliaccamente, ~- ge tta armi o munizioni, rifiuta obbedire, tenta sOl« trarsi al combattimen to oppure snccheggia,sarà fatto
« imm ediatamente fucilare -perchè serva di esemp io ai <1: compagni , o verrà ucciso per mano stessa del su« periore.
« I soldati i quali senza difendersi fino al l' estremo « si danno prigionieri meritano severissimo castigo.
« Un riparto rovesciato deve al prim o segnale rac-
P'ER L' Esrmcrro AUSTRO -UNGH ERESE &.-5
« cog'f icrsi in modo da poter di nuovo essere condolto « nel combattimento. In istanti così critici spicca il vero
« valore di una truppa brava e disciplinata.
« Chi vicino al nemico ollrepassa fuggendo il posto « di rannodamento, va punito con tutto il rigore; se
« poi al primo cenno non vi torna può essere ucciso « dagli ufficiali che tro vans i dietro la lin ea di battaglia << o dai gendarmi di campo » .
Pe r tal modo i dettami della nuova tattica, la quale CO$Lringe a frazionarsi per poi sempre riunirsi dietro ripari, si collegano a precetti morali ed a pene terribili pei vili. È lecito bensl dubitare se la morte minacciata con tanta prodigalità, e qui, e nel regolamento di esercizio ed altrove, valga ad infondere bravura in chi non l'ha. L'esecuzione sommaria sul campo di battag lia è ben ditlicile e rara; forse val meglio darne facoltà all'uffici ale di quello che educare conLinuat amenle il soldato nella tr iste e paurosa idea del dovere eseguito colla sciabola del gendarme alle reni. - Proseguo toccando i precetti salienti, i quali per avventura potranno trovare luogo acconcio nel nostro futuro regolamento pel servizio di guerra .
Nel punto di rannoda.mento il cornando spetta al più' elevato in grado o più anziano. I dispersi si devono presentare al comandante del primo riparto nel qunle si imbattono. Le ambulanze vanno trattate coi riguardi stabi liti dàlla convenzione di Ginevra; i prigionieri nemici rispettati come commilitoni. Gli uffi ciali prigionieri di guerra , quando rich iesti, danno parola d'onore di non tentare la fuga; ma è assolutamente vietata la promessa di non servire contro il ' nemico durante la campagna. Ogni militare, il quale siasi arreso senza esser ferito, di ritorno al corpo è ch iamato a giustificare la sua condotta davanti un consiglio di onore.
Al militare austriaco non è lecito partecipare a ve-
44 IL
REGOLAMENTO DI SERVIZIO
runa riunione politica; e sta bene. l'Ila Jl taluno potrà sembrar singolare il giuramento richi esto da ciascun ufficia le cli non legars i gia mmai a società segrete, poichè un simile fatto non s olo è contrario al giu ramento generale, ma eziandio riv es te ca rattere di reato per qualsivoglia cittadino .
Fedele alle antiehe tradizioni, il regolamento non ammette che un militare i.n servizio attivo possa essere e letto a rap presen tan te del paese. I.e condizioni politiche e morali d'It ali a Mn ci obbligano a coclestll esc lusione; la quale se da un lato, fino ad un certo punto, giova a ten ere I' esercite in un'at mosfe ra tutta sua , dall'altro priva ilGoverno dell'appoggio vigoroso e leale dei suoi ufficiali, il Parl ame nto d ella loro intelli gente e d auLorevole coope razione e gli ufficiali stessi dell' opportun ità di meglio procurarsi l' att itudine ai pubblici affari, cui in contingenze difficili sono talvolta chiamati .
Un'innovazione , consigliata da frequen ti equivocì ed abusi di potere, stabilisc r. la distinzio ne fra più elevati in grado ( Flo!i e1 ·en ) e super iori ( Vo rgesetze) , fra me no elevati in grado (Niede ren) ed inferiori ( Untergese tze).
Superiori sono coloro cui per r ipartiz ione organica, pee nor me di se rv izio o per momentan ea disposizione spetta· il driLto del coman do sopra tutti i militae i des 1.inali a dipenderne.
Ai più elevati in graclo si deve deferenza e rispetto; obbedienza solo quando es si assum a no in casi be n definiti la responsabilità degli ordini che dann o . La differenza è-\ ingegno s a; il regol amerùo la spiega in modo chiaro e fino ad un ceito punto pre ciso . ~li sia lecito tuttavia dub itare se essa all' atto pratico valga a togliere i lamentali inconvenienti, i quali non si manifestano già nella vita ordinaria de ll e g uarnig ioni, ma in guerra, quando le faco ltà moral i ·ed inLelle tlual i di
tutti sono assorbite da ll a serietà, dalla res ponsabilità, dall'interesse d i ciascuno di cooperare al bene comune. Forse allora è in opportuno l'inspirar dubbi sull'at.1torit à di chi trovas i più elevato ed imbarazzare la mente del militare od infirmare in lui il sent imento di assoluta obb edienza con distinzio ni, le quali ad og ni piè sospinto a forza devono urtare in eccezioni. Ne ll' es ercito ilaliano non si hanno a la men tare frequenti casi di indebite inge renz e, e però, riguardo a noi, mi sembra ~preterib ile la sem pl ice definizi one nostra del la subordinazione a quella austriaca che suona : « La subor<< dina zione cons is te n el do ve re di incondizionata ob« bedienza in servizio di c iascun inferiore ve rso il « suo supe riore e nei cas i indi cati ~ l punto iH eziandìo << del meno el evato al più elevato in g rad o ».
l\fo lto pro filleYOli so no le norme relati ve alle modificazioni che possono subire g li ordini in particolare di fronte al nemico, si~ per eventi inattesi, sia p er nuove disposizioni di altl'i superiori. È un mézo codesto pe r correggere l'obb ed ienza cieca e pass iva, il soverchio timore di assumere responsabilità, l' inerzia di concetti e di azioni e la pigra incuria che scuote l e spalle celandosi di e tro il manto deg li ordini ricevuti .
Sono difetti di tutti gli eserciti, perchè pur troppo hanno le radici nel cuore umano. Convi ene strapparli mediante 1 l'educazione e mediante disposizioni che, come codeste, spronino ad obbedienza pronta ed assoluta sì, ma serena, illuminata e coscienziosa . Trattandosi tuttavolladi cas i di guerra, mi s embra che queste d isposizioni . potrebb e ro essere eomprese in un artico lo del regolamento di campagna.

Il d iritto , la forma, il moclo dei reclami sono presso a poco r egolati conforme alle nostre dispos izi oni .
Sono tuttavia permesse le domande ed i reclami col · lettivi, purchè presentati in de bita forma. .La proibì-
46 IL
NUOVO
PER L' ES ERCITO AUSTilO-UNGllERESE 47
zione nostra serve non poco a sostenere la disciplina col soffocare oel germe tutto ciò che possa aver l'aria di pressione. E codesta severità è tanto più utile ora coll'obbligo universale al servizi o, coi volon tari di un anno, colla brevissima ferma, e confessiamolo pure, coll'indole nostra paziente si e sommes5a, ma svelta, vivace e ciarliera. Del r esto noi abbiamo un potente correttivo nella facoltà accordata a ciascun militare di presentarsi al proprio capitano senza autor izzazione di sorta.
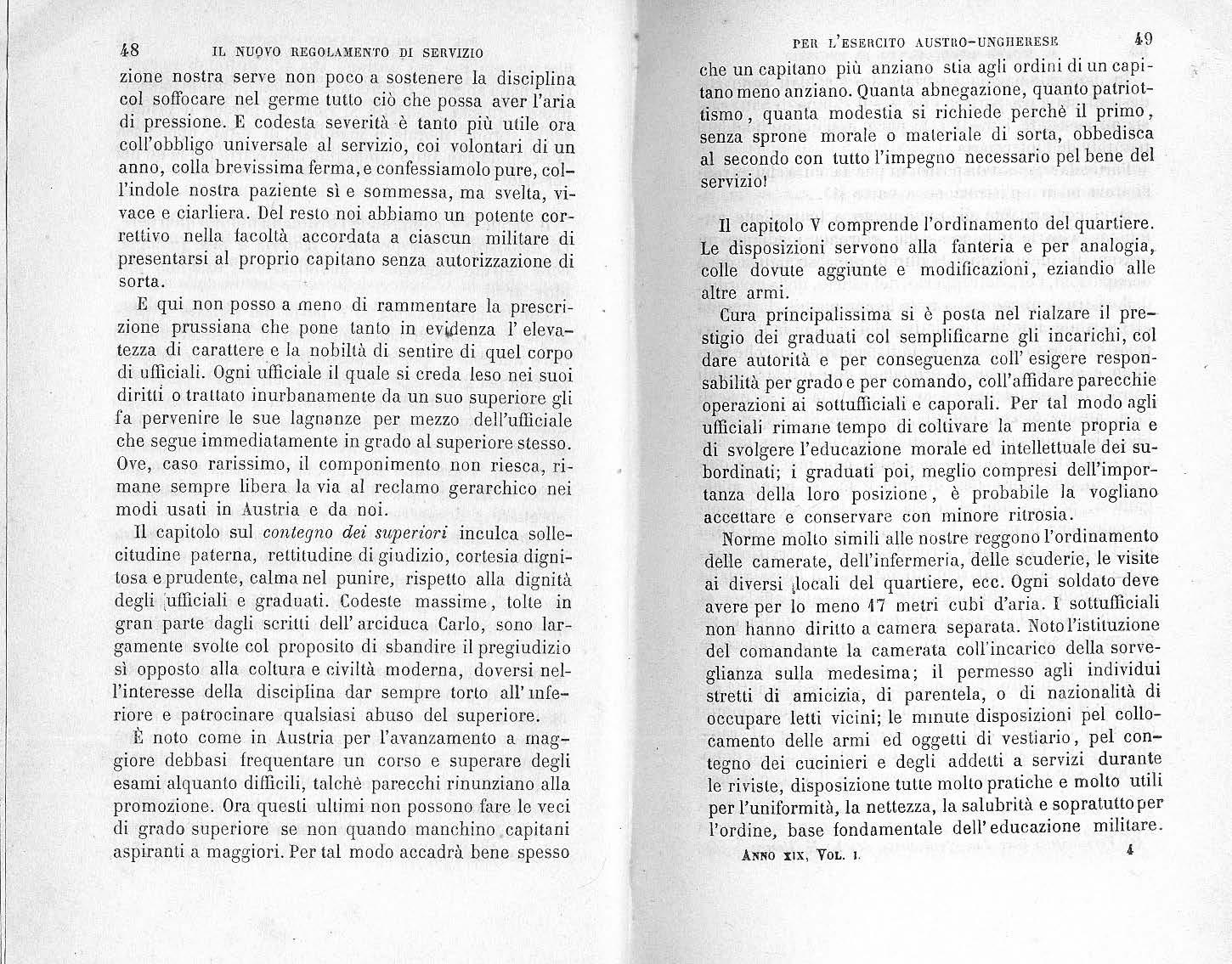
E qui non posso a meno di r ammentare la prescrizione prussiana che pone tanto in evij3enza l' elevatezza di carattere e la nobil tà di sentire di quel corpo di ufficial i. Ogni tifficiaìe il quale si creda leso nei suoi diritri o trattato in urbanamente da un suo superiore gl i fa perven ire le sue lagnanze per mezzo dell'ufficiale che segue immediatamente in grado al superiore stesso . Ove, caso rarissimo, il componimento non riesca, rimane sempre libera la via al reclamo gerarchico nei modi usati in Austria e da noi.
ll capitolo sul contegno dei superiori inculca sollecitudine paterna, rettitudine cli giudizio, cortesia dignitosa e prudente, calma nel punire, rispetto alla dignità degli tUfficiali e graduati . Codeste massime, tolte in gran parte dagli scritti dell'arciduca Carlo, sono largamente svolle col proposilo di sbandire il preg iudizio sì opposto alla coltura e civiltà moderna, doversi nell'interesse della disciplina dar sempre torlo all' mferiore e patrocinare qualsiasi abuso del superiore.
È noto come in Austria per l'avanzamento a maggiore debbasi frequentare un corso e superare degli esami alquanto diffi cili, talchè parecchi rinunziano a lla promoz.ione. Ora quesl i ull'imi non possono fare le veci di grado super io re se non quando manchino capitani aspiranti a maggiori . Per tal modo accadrà bene spesso
che un capitano più anziano stia agli ord i ni d i un c~pitano meno anziano. Quanta abnegazione, quanto patriottismo, quanta modestia si richiede perché il prir:io, senza sprone morale o maleriale di sorta, obbedisca al secondo con tutto l'impegno necessario pel bene del servizio!
Il capitolo V comprende l'ord inam ento del quartiere. Le disposizioni servono alla fanteria e per analogia,. colle dovute aggiunte e modificazioni, ez iandio alle altre ar mi.
Cura principalis sima si è posta nel rialzare il prestigio dei graduati col semplificarne gli incarichi, co'l dare autorità e per conseguenza coll' esigere responsabililà per grado e per comando, coll'affidare parecchi~ operazioni ai sottufficiali e caporali . Per tal modo :1gh ufficiali rimane tempo di coltivare la mente propria e di svolo-ere l'educazione morale ed intellettuale dei subordin:i,i; i graduati poi, meglio compresi dell'importanza della loro posizione , è probabile la vogliano accettare e conservare con minore ritrosia.
Norme mollo simili alle nostre reggono l'ordinamento delle camerate, dell'infermeria, delle scuderie, le visite ai diversi tlo cali del quartiere, ecc. Ogni soldato d~v~ avere per lo meno ,t7 metri cubi d'aria . I ~?t\uffi?1ah non hanno diritto a camera separata. Noto l 1slltuz1one d el comandante la camerata coll' inca rico della sorveglianza sulla medesima; il permess~ agli. ind~v!du~ stretti di amicizia, di parentela, o d1 naz1onahta d1 occupare letti vicini; le mmul~ d!sposi~io?i pel collocamento delle armi ed oggetu d1 vestiario, pel contea-no dei cucinieri e decrli addetti a servizi durante le 0 rivisle, disposizione tut7e molto pratiche e molto utili per l'un iformità, la nettezza, la salubrità e_soprat~t~o per l'ordine base fondamentale dell'educazione m1htare. , ANNO xix, VoL. 1.
il 48 IL NUOVO REGOLA)IENTO :PI SERVIZIO
PE!\ 1,'ESEflClTO AUSTllO-UNGJJEllES.11 4-9
NUO\'O REGOl,HIENTO DI SERVIZIO
In ogni compagnia austriaca 3 o i saldali sono add_eslrati si~ a trasportare i feriti sul campo di battatrlia s ia ad ~ss1s tere i med ici. In pace, essi sono gli adde tti naluralt dell'infermeria.
. Parti cola!'eggia te disposizioni per la cura dei c.:ivall i s1 trov_ano in un'istruzione a parte {•1). Ogni co.ma nda_nte di reggimento o battaglione auton?mo .nparte 1~ temp o della giornata mediante un ordme, .ti ~u~le mdica la durala approssima tiva delle occup~zLOm.' l ~ra delrapporto, del rancio, della guai:dia, delle 1s.tr~z 10?1 comun i a tulle le compagn ie, lasciando a~ po~s1btle intatta l'iniziativa d ei comandanti i va1·i riparll. C?de~ta in(ziativa è indispensabile perchè sorga?~ e _si ahmentmo le principali doti mili tari, quali sp1~1to rntraprendcnte ed ardito, fiducia in sè e negl i ~llr1, autorev?lezz_a.,. ene.rgia? coraggio di responsabil!tà, ~alma, .ab~to d1 tirarsi facilmente d'impaccio, perchè l azione d1 ciascheduno si svoltra con ma trofore effi• • t> t> t:> cac1a ~n una sfera ben distinta e mano mano allargan tesi, perchò non si perda di vis ta cosl di legge ri lo scopo per il mezzo, la sos tan za per la forma l'o r o per l'orpe llo. Pertanto il regolam enlo di servizi~ memore degli spl_endidi risultati ottenuli in Prussia 1 dalla larga auto~om1a gradatamente ascendente affidata ai comandanti delle varie unilà tattiche, si studia di ripet~re ~pe~so la ra ccomandazione di non invader e le attnbuztont degli inferiori. ·
Da canto nostro _il r egolamento di disciplina W dice~b~e 18_72)'. la circolare mini stedale sull'autonom ia dei smgoh riparli, le disposizion i relative al rapporto, ecc.' la corr~nte delle idee man ifestatasi dopo

Il 1866, sono arra sicura che ~ziandio il futuro nostro
rego lam ento di servizio sarà informalo agli stessi principii e che questi ve rran no applicati coll'imelligenza, operosità e sollecitudine necessarie perchè riescano a bene . Ma torniamo alle operazioni quotidiane. L'istruzione dura nell'estate ordinariamente otto ore, nell'inverno sei. La sveglia in estate si suona alle 5, in inverno alle 6; la ritirata ordin ariamente alle 9. I g raduati dal sergente in su possono rientrare due ore dopo. Il segnale di riti r ata ripetuto due volle o dato in ora straordinaria indica che cias cuno deve accor rer e al quartiere.
Il servizio di quartiere è r egolato, sorvegliato, dir etto dal personale d'ispezione giornaliera. A tal uopo ogn i compagnia comanda un caporale di g iornata (Korporal vom, Tage), ogni battaglione un furiere d'ispezione (Inspektions Feldwebel) , ogni battaglione isolato o s ul pi ede di guerra un ufficiale subalterno di ispezione (Oataillons- l nspektions 0/fizier}, due o più battag lioni insieme accaserm ati, un capitano o tenente di ispezione ( Reg-iments- Jnspektions O!fizi·er ).
Il caporale di giornata accumula le attribuzioni e i doveri del nostro sergente e caporale di settimana; egl i ha molto da fare, ma il servir.io dura poco , non richiede che op erosità e buona voglia, l' amor proprio rimane lusingato, il primo gradino della scala gerarchica guadagn a prestigio. Lo coadiuva un soldato di prima classe comandato ad hoc.
I caporali di giornata riferiscono quanto riguarda gli incarichi loro al furiere d'ispezione, il quale da canto suo comp ila un rapporto mallinalc pel battagl ione in cui sono indicati i mancanti alla ritirata, le visite al quarliere e gli avvenimenti speciàli.
G·li u!Iiciali di ispezione cli ba ttag lio ne e di 1·eggimento devono es~ere se mpr e r e peribili e sorvegliano alla quiete, all' ord ine ed all'esatta osservanza delle di -
50 li.
PER L1 ESEI\ClTO AUSTHO-UNGl:iERESi 51
(·1} Vorschriften uber das Pferdewe, en des K. K . Eleercs.
spos1Z1oni tulle che non loccano l'immediata sfe1·a di servizio dei comandanti di compagnia. Del r esto non r apporti, non, visiLe, non presenza ad ore determinate, non sorveglian za di singole operazioni o di sin,,.oli ri. m o parlt. U 1cio loro principale è di trovarsi sempre pronti per qu als ias i caso che richieda la presenza di un uffi ciale.
Nelle grandi caserme, dove sono aquartierati due o più ba tta g li oni, sia dello stesso corpo, s ia di corpi o di armi diverse, è eztandio comanda to g iornalm e nte un ufficiale suballerno ( Kasern-Tnspektio11s -Offi::s ie r), il quale abita in caserma ed ha relativamente alla guard ia, ai drappelli sorlenti , agli individui co nsegnati, alle prigioni, alle richi este dell 'autorità, le stesse incomb enze che il nostro ufficiale di picchetto.
Per tal modo sono soppressi gli ufficiali di g iorn ata per compagnia ed è rtd otto noLevolmenle il suvizio . Non siamo ancora alla semplicità prussiana, la quale con un ufficiale di giornata per r egg imento ed un gradualo per compagnia fa andare ogni cosa; ma è pur d'uopo considerare che l'esercito prussiano ha abitudini, indole , disciplina, saldezza, coesione diverse dell'esm·ciLo nostro ed austt'iaco e che di tuuo ciò fa mestieri tener conto ne l compilare un regolamento. f'i:'ente per salto deve essece la divisa di ogni riformatore, poiché è perico loso gettare di bollo le grucce, spogl iarsi senz'altro di secolari abitudini. Pre,,.resso conti nuo, studio accurato dei pregi e difetti O n ostri ed altrui, profiuo giud izioso delle esperienze della storia, festina lente, ecco il programma degli eserciti. austriaco e?
italiano, i quali gareggiano sulla sLessa via per gmngere alla stessa meta di ricostituzione sull e basi delle mutate istituzioni, dei nuovi bisogni, dell'is truzione progr edita nelle masse ed in tutta la scala gerarchica mili tare.
PEll L'ESERCITO AUSTRO-UNGHEI\ESE 53
Il rapporto è te nuto dai com an danti di compagnia, ballaglione e reggimento. Al rapporto di compagnia inte rvengono uno o due ufficiali subalLerni, i due furieri ( uno incari cato della contabili tà e l'altro della discip lina J ed il caporale di gio rnata. Al rapp or to di battaglion e e di reggimento as sistono I rispellivi aiutanti e gli uffici a li che hanno a porge re domande, reclami per sè o pei subordinnti, chiedere schiarimenti od alt,ro. Per ciascun rapporto vengono annotati in un registro i fatti e le cifre salienti della giornata. A volte i generali o colonnelli comandanti di co rpo tengono eziandio gran rapporto al quale intervengono tutli gli uffi ciali.
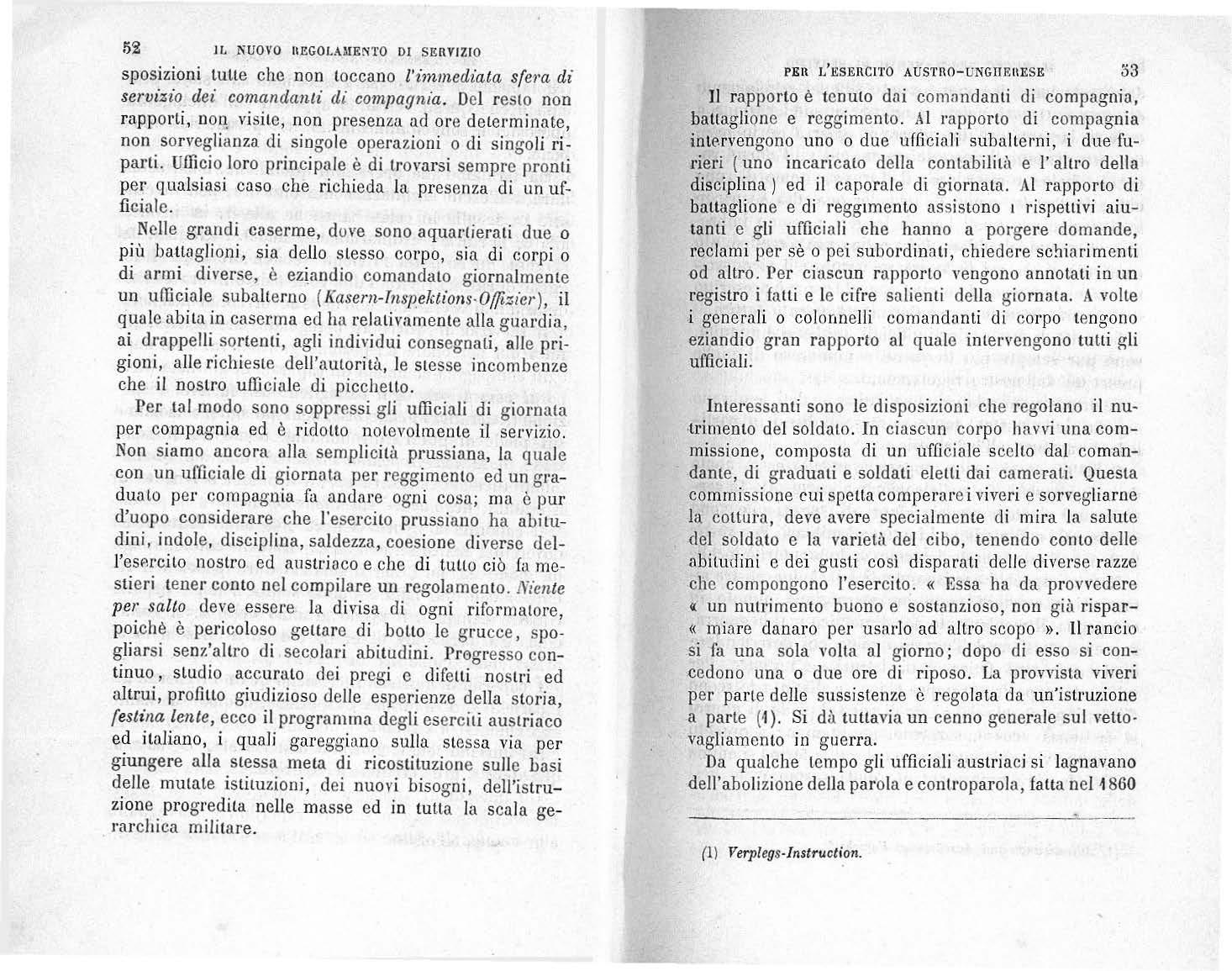
Interessa nti sono le disposizioni che regolano il nu-trirnento del solda1.o. In ciascun corpo lrn.V\'.i una commissione, compos La di un ufficiale scello dal co mandante, di graduati e soldati eletti dai camerati. Questa commissione cui spe tta comperare i viveri e sorvegliarne la cottura, deve ave re specialmente di mira la salute .del soldato e la varietà del cibo, tenendo conto delle abitudini e dei gusti cosi disp ara ti delle diverse razze che compongo no l'esercito. « Essa ha da provvedere q un nutrimento buono e sostanzioso, non già rispar<< rnia r e danaro per usarlo ad altro scopo ». 11 rancio si fa una sola volta al giorno; dopo di esso si concedono una o due ore di riposo. La provvista viveri p er parte delle suss istenze è r ego lata da un'i s Lruzione a parte (1). Si dà tullavia un cenno genera le sul vettovagliamento in gue rra.
Da qualche tempo gli uffic iali austriaci si lagnavano d ell'abo li zione della parola e controparol a, fatta n el 1860
(1) Verpl egs-Instru ct ion.
5i JL l'\UOYO
IIEGOI.AMENTO DI SERVIZIO
IL NUOVO REGOLAM ENTO DI SERVIZIO d al regolamento di servizio e n el 1~69 dal re go lam e nto di campo. Ora si è da ta amp l issima soddisfazi one a codesti lamenti coll' inlrodurre in guerra ed in pace tr e so rta di segni di riconosc im ento, cioè: il Fel clru f, vocab olo facile a rico rdar e ; il Losung, nome di una città; la Parol e, nome di u na persona. Ciò cos tringe a di s tinzi o ni, l e qu a li ben di legger i possono im broo·liarel amentede l sol da to. Più pra ti co, più semplice, p iù ~onfo rm e ai bi s ogni di guer ra mi s e mbru i l riconoscimento med iante parola .e cont ropa1·ola com e è prescritto dalla nostra Istntzio n e per l' am,maest1·amen to tattico.
Le v isite di d(lve rc degli uffi c iali , se bb ene diminuite, sono pur sempre più fr eq uenti e numerose di q aelle prescri tte dal nostro regola m e nto.
L e dis posizi oni rel ative a i s oldati ammalati sembrano cÒpiate da lle nostre, tanto si rass omigliano in p ar ticolare r appor to all'infe r mer i a .
Della di visa s i tocca appena, venendo essa , come da noi r errolata d a un'i s tru z ion e a parte (1 ). In sert> vizio tutti devono vestirla; fuori d i serv izio ne sono disp ensati i soli medici ed impi egati militari. ~ er vest~r la div isa all' estero bas ta il pe rm esso delle autontà l ocali.
Noto gli specchi corrispondenti ed alcune nostre sit uazi oni e serv ibili tanl o in g uarni g i one quanto in campagna. li r egolamento non dimentica mai la g u erra , supre ma missione d ell'ese rcito , m eta cui deve tendere ogni cura , ogni falica, og ni is truzi one milita re . Per tal modo appa risc e sempre chiaro e dislinto lo scopo final e ; il passaggio dal pi ede di pace al pi e de di guerra s1 fa s enza scosse, s or prese, perditempo; i precetti ass umono viva ci Là , inte re sse e calore ; la f orma si anima e div enta vera rappresentante della sostanza.
PER L 1 ESERCl'fO AUS1'RO - UNGHEllESE 55
Il capitolo VII si occupa d ei servizi s~eciali: 1:1servizio d'ord inanza , il quale sotlrae canti uomu;n alla istruzion e , è forse più esteso in Austria che altrove .
Il reg olamento si contenta di racco ma n da re la massi~a parsimonia. Per le ordinanze a cavallo nel porlare di-: spacci una croce sulla busta indica y~ss~, du~ croci trotto tre croci trotto e galoppo. Il serv1z 10 d1 corrispondenza: uti li ssimo in certi paesi della monarçhia , vasti e poco abilati, forma ogg etto di minute di sp osizioni.
Fedele al propos ito di servire d i guida ~l ?1ilitare in tutti i casi ne i quali q ues ti può trovarsi, 11 reg~la mento trulla de g li arresti di milit ari e di borgh esi, delle scorte ad arrestati, a prigionieri di guerra, a convogli o trasporli ecc ., fermandos.J d.i pref~r e~ ~a s u i singol i doveri dei soldat i e gradua t i, 1 q u~.1.1 p rn cb.e mai h anno bisoano di norme chiare, sempllc1 ed esplicite che mella~o al coperto la loro responsabilità e tolgano l oro l'apprensione continua di c~dere i1: e rrore: T,a s i curezza di sè., l a conoscenza pre cisa dei propn doveri sono condizioni fondamentali d e ll'energ ica azione ed os ta coli efficacissimi contro prepotenze od abusi. Le disposizioni ge neral i i' elative ag li onor i non sono gran fallo divers e dall e no s tre. l1 meno e le vato sal:1la sempre il più elevato in grado nel modo pr~scntt~ da l re O'olamento di istruzione; anche fra gradi. egualt è d'obbl igo il sa luto. Nelle m i nute formalità per le divers e gradazioni ·~ pei diversi casi si os se rv ~ un luss~ di gua rdi e e di posti d'onore che in Pru~s1a e da noi sembrerebbe soverchio ( 11).
(4 ) Adjustirungs -m1d Ausrii stungs- Vorschrift.
(~) Un ordine dell'imperatore Gugliel mo (3 settembre 4873) r estringe non --poco il numero delle guardie ai magazzini di polvere ed alle opere di fortificazione, come pure il numer~ dei posti. d'.ono'.'e ,. delle sentinelle di alcune g uardie e delle patt uglie pel sarvlZIO dt piazza.
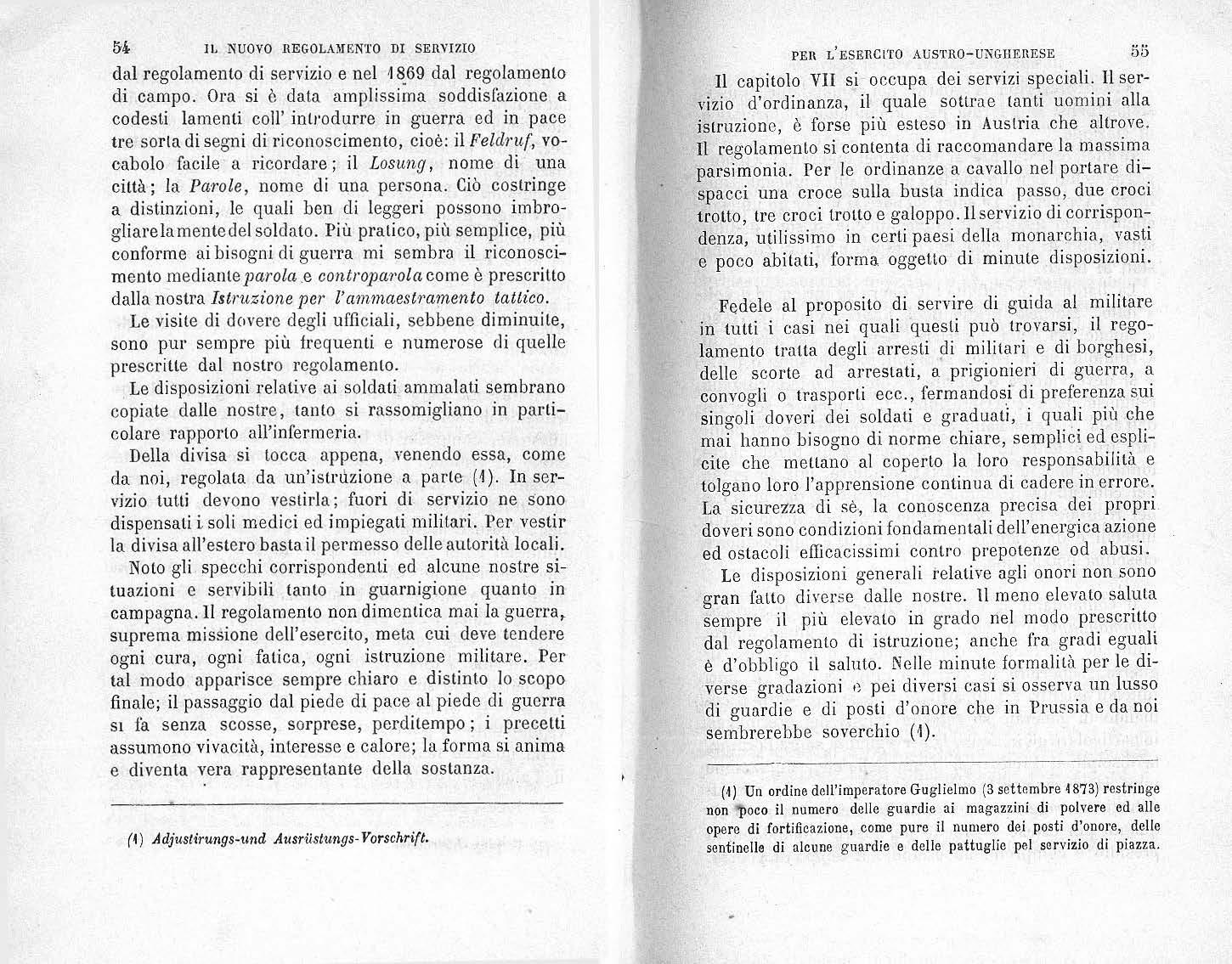
5'{.
NUOVO REGOLAMENTO DI SERYJZIO
Non è pres critta l a g u ardia pel co ma ndante di divis ion e, bensì la guard ia pel comandante di fo rt ezza e di staz ione .
Gran d i onorificenze si usa no nei funeraìi . L' a cco mpagnamento per un medico o per un im piegato m ilitar e è senz' a rmi. La salva d'c,nore s i fa per gli uffic iali effettivi , pei medici ed impiegati che si sono d istinti sul campo di battaglia, pei g raduati e soldati che sono slati al fuoco .
La bandi era é definità: <1. Sacra p rop rietà del so l"' dato, gforioso pegno della fiduc ia che il so vrano « ripone nei suoi guerrieri, segno d i raccolta e di « ri uni one neg li istanti s.ttp r em i, vess illo soli.o il quale « si d eve vincere o morire ». Curiosa è la cerimon ia religiosa della co ns acra zi one . Il drapp o é1 separa to dall'asta. Il cappellano comincia a fissarvelo col p iantare tre bullette in onore di Dio; tre n e p ianta il colo nnello, una in nome dell ' Im pe ra tore, una in nome del comandan te generale dell ' ese rcito ed una in nom e del r eggimen to. Le altre bullette so no conficcate dagli ufficiali e da grad u ati -e soldati scelti a rappresentare ciascuna compagnia.
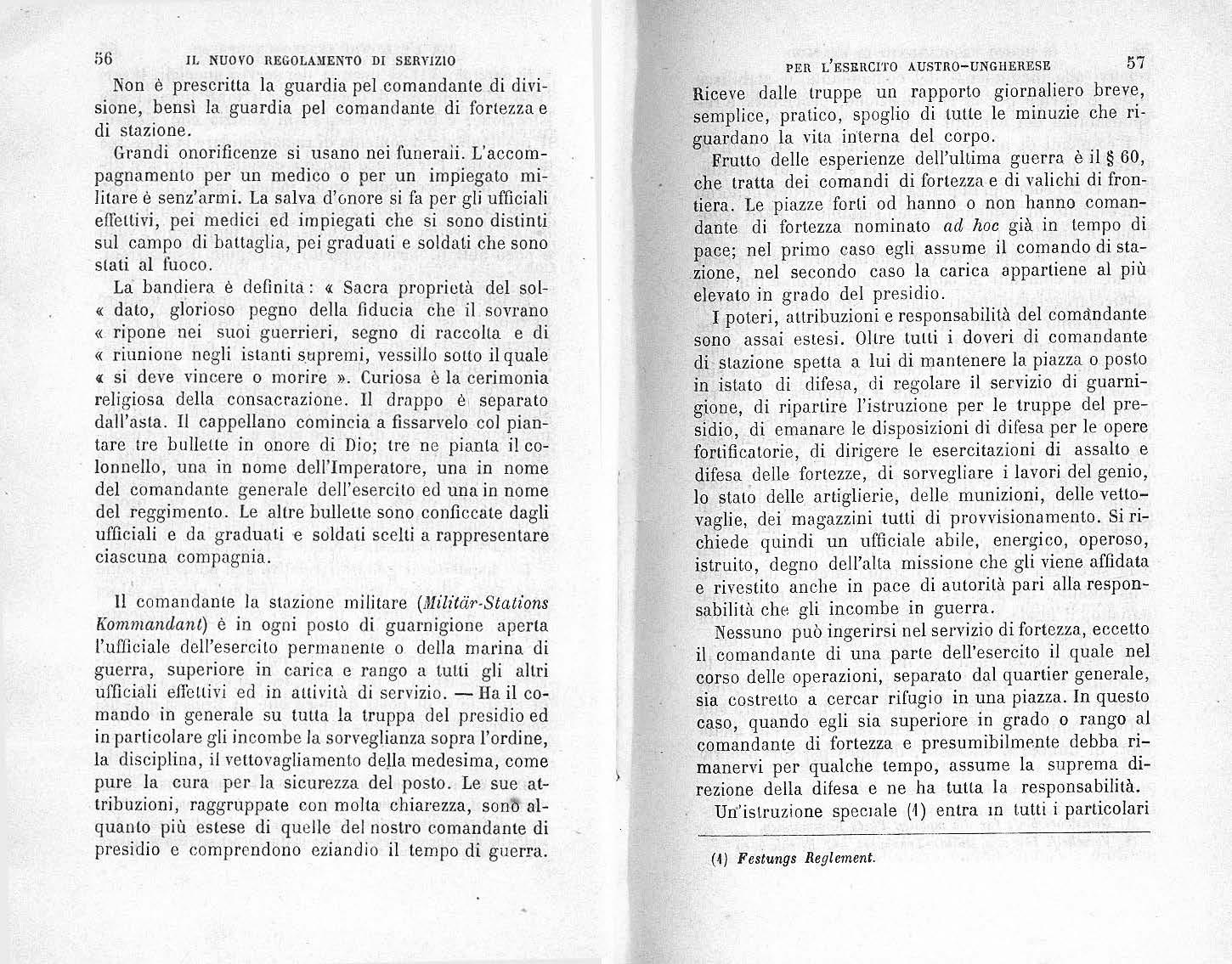
11 comandante la stazione militare (111ilitar -S tations
Komrnandan t) è in ogni posto d i guarnigione aperta l'uffìeiale dell'esercito permanente o della marina di guerra, superiore in cari c a e rango a tutti gli altri ufficiàli effotl ivi ed in allività di servìz io . - Ha il comando in gene rale su tutta la tru ppa del pre s idio ed in partico lare gli incombe la so r veglianza sopra l'o r d ine, la disc ipli na , il ve ttovagliamento deUa medesima, come pure l a cura p e r la s i cu r ezza del posto. Le sue a ttribuzioni, raggruppate con mo l ta ch iarezza, sanò alquanto più estese di quelle del nostro comandan te di p r esid io e comprendono ez iandi o il tempo di guerra .
PER L'ESR!lCITO AUS TRO- UNGHERESE 57
Rice ve dalle truppe un rapporto giornaliero breve, semplice, prati co, spoglio di tu tte le mirmzie che riguardano la vita inlerna del corpo.
Frutto delle esperienze dell'ultima guerra è il § 60, che tratta dei comandi di fort ezza e di valichi di frontiera. Le piazze forti od hanno o non hanno comandante d i fortezza nominato ad hoc già in tempo di pace; nel prim o caso eg li a ssu 1;0e il com~ndo di st~: .zione, nel secondo caso la carica apparuene al prn elevato in gra do del presidio .
I po ter i, attrib uzi on i e responsab ili tà del comàndan te sono assa i estesi . Oltre tutti i doveri di com andante cl.i - stazion e sp etta a l u i di mantenere 1~ ~iazz~ o pos~o in istato d i difesa, di regolare il serv1Z10 d1 guarmgione, di ripar ti re l'i struzio ne per le truppe del presidio, di emanare le di spos izioni di difesa per le opere fortificatori e di dirige re le esercitazioni di assalto e difesa dell e 1 for tezze, di sorvegliare i la vori del genio, lo stato d elle artiglierie, d e ll e munizioni, delle ve~to_vaglie, dei magazzini tutti di provvisionarnento. S1 nchiede quindi un ufficiale abile, ener~ico, operoso, istr uito, degno dell'alta missione che gli vi ene affidata e riv estit o anche in pace di autorità pari alla res ponsabilità che gli inc.ombe in gue rr a.
Nessuno può in.(J'erirsi nel servizio di fort ezza, e ccetto il com andan t e di °una parte dell'esercito i l quale nel corso de lle ope r azioni, separato dal quartier generale, sia costretto a cerca r rifugio in una piazza. In questo ca?o, quando egli sia s u periore in grado o rango ~l comandante d i fortezza e presumibilmente debba rimanervi p~r qualche tempo, assume la supre~~ direzione d e lla d ifesa e ne ha tutta la responsab1htà.
Url"'istru zio ne specia le (•I) entra 10 tutti i particolari (•) Festungs Reglement.
fj6
JL
NUOYO I\EGOLAMENTO Dl SE RVIZIO
r ela tivi alle incumbenze del comanda nte e stabilisce tutte le n orme per la composizione, procedura e responsabilità de i consigli di difesa.
I comandi di p iazza so no ausi liari dei comandi di fortezza e di stazione nei minuti servizi di gua rdi a . I dove ri dei com and i di p iazza p resso i quartieri ge n erali dell'esercito in cam pagna sono stabilili da altro re golam ento speciale ('1 ).
Nece ssari a sapersi da ciascun militare sono i pochi cenni sui com andi d i tapp a, il cui servizio è pur esso particolar eggiatamente regol a to da istruzione a parte (2 ).
l i capito lo XV tratta del mantenimento dell' ordi ne e della sicurezza pu bb lica. Il militare vi tr ova esp licitam ente tracciati i limiti de ll a sua azione e della sua auto1·ità . La titubanza sì faci le e sì naturale nelle rivolte ed insurrezioni, com pagna sì fede le dell'i gnoranza dei prop ri d iritti e dove ri, sì esiziale negl i is tanti suprem i in cui lottan o sentimenti i più disparati, n:on ha più scuse di so rta. Di sposizioni simili, atte a-imprim ere calma, sicu1·ezzn, energia nelle delicate attr ibuzioni militari che tocca no da vicino la legge , l'onore delle armi, le guarentigie costituzionkli, l'ordine pubbli co e l a sic ur ezza interna dello Stato, saranno date, non v'ha dubbio, da l reg olamento pel servizio territoriale itali ano , il qua le venendo alla luce riempirà un a vera lacuna e sarà salutato con gioia dall'esercito tutto.
Il regolamen to aus tri aco in culca ai comandanti la prudenza della prev is ione; acce nna ai sintomi forieri delle sommosse; ordi na in og ni caso di giud ica re con calmo la situazione, di impiegare tanta forza che metta fuori di dubbio il successo , di agire per sol a propria
inizia tiv a, di guardarsi dalle mezze misure e pre sa un a risoluzione di co ndurl a a fine con en ergia.
L'anti ca apprensione contro i moti di piazza vie~e in rilievo in quasi tutti i capitoli. D'onde la gran_copi~ . di prescrizioni per la sicul'ezza delle caserme, c!e1 corp~ di guardia, delle pattuglie, delle r onde , de1 s?l?at~ isolati ed indrappellati; le particolareggiate dispos1Z1om per il picchetto e per la consegna in quartiere ~e!la truppa; le molteplici formalità pel servizio di pres1d10~ per le is pezioni delle g uardie; le minute regole d1 contean o pei tl iversi capi ; la sorveglianza assol u ta e respo~sàbilil lt imposta ai singoli. superiori, i nfine il frequente ribattere sullo stes so argomento. .
Le guardie si d istinguono in guardie d' ono r-e. e d1 sicurezza, in posti d'onore e di sicurezza. In og m presidio v'è la guar<lia di stazion e (guardia principale)
• cui fanno capo tutti i rapporti. . .
La guardia normal men te è da ta dalla fan ter ia e da ~ · cacciatori. Una volt a la fanteria aveva lunga ferma e poco bisogno di istruzione lattica. Ora il caso inverso ed il temp·o è per essa p re zioso del pan che per le altre armi. D' onde il des iderio u~iversa_l~1e nte espresso di ripartire proporzionalmente 11 s.ervmo fra tutte le armi, specialm ente nell'esercito nostro dove è• piu lunaa la ferma per la cava lleria . Acc en no di volo , o ' a codesto desiderio, del quale in parte si è già tenuto, conto e ch e fors e avrà completa soddisfazione n el nostro futuro reaolamento p el servizio territoriale. Del resto o . . .. quando il servizio di guardia sia ridono ai mrnrnn termin i e posto in armonia, per quanto lo perme tta no le diverse esigenze, col se rvizio di sicurezza in campagna, qualche nottata di se n tinella non può essere di nocumento all'istruzione d ei soldati di qualsivoglia arma.
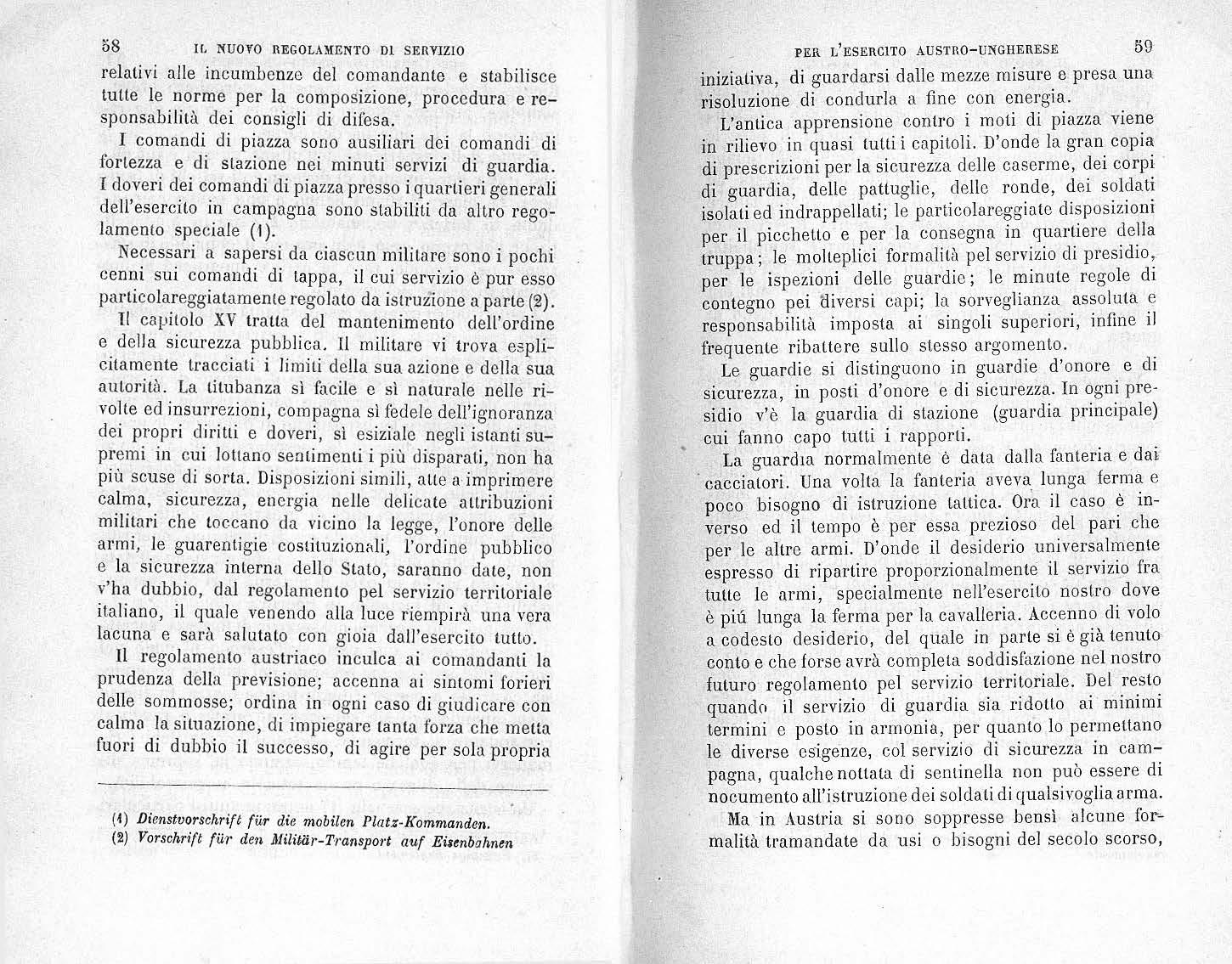
(~) .Dienstvors chrift fur die mobilcn Platz-Kommanden.
(2) Vorschrift fii:r d en .Militar-Transport auf E·i1enb ahnen
Ma in Austria si sono soppress e bensì alcune for-~ malità tramandate da u s i o bi sogni del sec olo scorso ,
58 IL
AUSTR 0-1,J NGH ERES E 5 9·
PER L'ESERCITO
tì0
IL N UOVO RE GOLA MENTO DI SERVIZIO ma non mi pare che si abb ia taglialo e semplificato .abbas tan za {1). Rimango no sempre troppi fronzoli, trop~ e cerimonie , troppe minute pratiche di pace le .quah confondono la mente, richiedono assai tempo per l'istruzi one, ab ituano il solda to ali' in cer tezza ed al la pe r plessità e gli danno un'idea trop po fall ace del ve ro servizio di s icurezza in g uerr a. li serv izio di pi az za and r ebbe fatto collo s pirito, forme, s e mplicità , esattezza, sco po chi a ro e de finito de l s ervizio a{J'li avamo pos ti. La ferma tr oppo .breve non permette ornai più il lusso di due abiti diversi, quello di pace e que llo di guerra .
Ve ni amo alle puniz ioni di sc ipl ina ri' : al c une fra esse lurono res e alquanto più inten se on de o!frir mezzo di repressione più pro nta ed efficace a i comanda nti i s in{J'oli b re pa rti auLonom1. E per vero co lla costituz ione a ttuale deg li ese rciti sono cadu te le fa sce che, comprimendo l'az io n e individu ale, to glievan o molle occasioni di mancanze ed errori. La nuova tattica es ige soldati s velti, acco rti, destri, n è è possibile a verli tali te nend oli sempre nel lett o di Pro custe de l vecch io pedantismo . Del resto 'la progredita collura e l'educ·az ione più intellige nte s ervon o a dare a ciascu no cosc ie nza più chiara e più defi.n ita delle proprie aUribuzion i e dove ri. E però il bi s ocrno di infrenare la magg io re spigliatezza degli inferio~i e di accresce re pres ti g io ai superio r i, si accord a a mer~vig li a colla g ius ~izia risultante da colpab ilità maggiore e co lla brentà della fe i:ma, per consig liare pen e severe, immedia te ed al poss,ibile brev i. .
Tuttavo]ta i tempi nuovi e l'accresciuto rispetto per l'umana dignità hanno co nsi gliato di sopprimere tantoil r ingraziamento già imposto a chi aveva subito una punizione, quanto 'il ba s tone , ornai con s iderato come , degradante .da quasi tutti gli es erciti europei.
Le punizi oni disciplinari so no:
Pe1' gli ufficiali: .
I O Il rim prov ero :
a) se mgJ ic e, al rapporto o per iscritto;
b) di rigor e, con comunicazione ai superiori eagli eguali ;
2°L'arrestosem pli ce{Stations-A 1nst)(1) n fino a

3°L'arresto di rigo re (Zim mer- Arres t) ; }30 .giorn i ..
Pe1· gli aspiran t·i u fficial i e pei fiwù~1·i:
1° Il r i mprovero se mp lice e di rigore;
(4) Nè questa è soltanto opinione mia, ma eziaadi.:> dell'ufficiosa Oesterreichisch-ungarisch e Militar Zcitschrift « dic Vedette ,, la quale ha or ora pubblicato una serie di articoli apologetici sul nuovo ,regolamento
a) sospen sio ne del permesso serale; l f
2° Le punizi oni d'ordine (Ordnungs-Strafen):
b) obbligo di r ie ntr are prima dell a 30 1 ~ 0 a_ · · Q'IOrm. r1t1rata;
3° Le puniz ioni d'arresto (Ar rest-Stra(en) :
a) consegna i n camera (Zimm er-Arrest) ,J fino a
o)sala di disciplina (Einfache - Arrc st); 30 giorni ..
,i 0 La retro ces sion e (Degraclirun g ):
Per la t1·uppa da se·ryen te .in giù:
1° Il rimprovero al rapporto;
2° Le puniz ioni d'o rd in e :
(~) Per non diffondermi di soverchio non tradu co i vocaboli tedesch i' all a lettera, ma secondo l' ana logia che presentano colle punizion i: usate da noi.
PER 1,'.ESE fl CITO A USTilO-U NG HERES E 61 '
. .
r1t1rata;
HEGOLAllENTO DI SERVIZI.O
a) obbligo di rientrare prima della )
b) pei soli sottufficiali e caporali - fin.o a. sospensione del permesso serale; 30 giorn 1 ·
e) soldo dato a rate giornaliere;
d) presentaz ione in una tenuta prescritta;
e) servizi straordinari di fatica fino a 30 giorni;
/1 pei soldati - ferri o legatura con allri vincoli;
3° Le punizioni d'arresto:
a) consegna (Kasern, Quart-ier ode1·
Lage1·-J rrest); fino a
b) prigione inasprita {Verschèirfter- 30 giorni. An·est):
e) eella (R inzel-Arrest);
d) di prig ione di rigore (Strenger-An·est) (soltanto pei soldati) fino a ,115 giorni;
4° Retrocessione.
Alla r e troce ss ione precede ordinariamente un rimprovero solenne allo scopo di prevenirt il graduato e di esortarlo ad emendarsi . È abol ita la sospens ione dei sottufficiali .
I gra duati puniti co ll a consegna e colla sala di disciplina ri cevono paga di soldati di seconda classe.
I puniti colla prigione sono chiusi in una sala ove dormono su tavolato; tre volte in settimana ricevono soltanto pa ne ccl acq u a e quotidianamente (con interruzione ogn i ter zo giorno) sono legati per sei ore. Eguali inasprimenti accompagnano le punizioni della cella e dell a prigione di rigore, la quale ultima é sco ntata isola tamente al buio. In guerra cessa il pane ed acqua; nelle marcie di pace non si digiuna che nelle giornate di r iposo.
In G·ermania le pene disciplinari sono : Per gli ufficiali: il rimprov ero semp lice; il rimpro-
PER L' ESERCITO AUSTRO-ùNGHEI\ESE {ì 3
vero in presenza d egli ufiìciali; il rimprovero all'ordin e · del giorno; l'arresto in camera fino a due setLimane.
Pei so ttufficiali: il rimprovero semplice e di rigore; il serviz io fuori turno ; la consegna fino a quattro settimane; la prigione isolala e pane ed acqua fino a tre settimane .
Per i soldati : il servizio fuori turno; il soldo dato a rate giornaliere; l'abbreviazione del tempo di lib era uscita; la consegna sino a ,quattro settimane; la prigione isolata come sopra; l a cella oscura a pane ed acqua fino a due settimane; la retrocessione da scello; il passagg io ad u na sezione eh lavoratori (1).
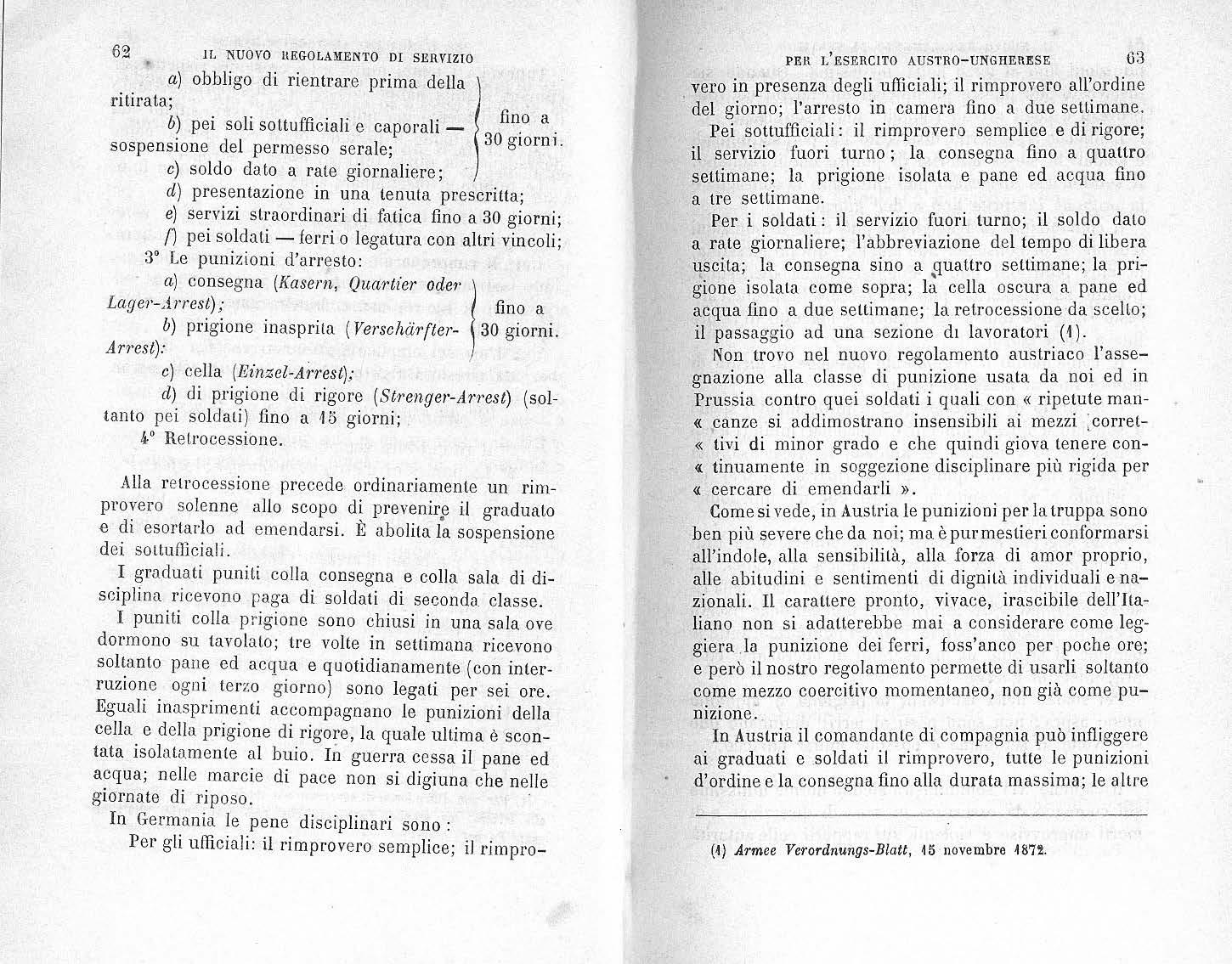
Non trovo ne l nuovo rego lamento austriaco l'as segnazione alla classe di punizione usata da noi ed in Prussia contro quei soldati i quali con « ripetute man« canze si ad dimostrano insensibi li ai mezzi ;correl« tivi di minor grado e che quindi giova tenere con« tinuamente in soggezione disc iplinare più rigida per « cercare di emendarli ».
Come si vede, in Austria le punizioni per la truppa s ono ben più severe che da noi; ma è pur mestieri conformarsi all'indole, alla sensibilità, alla forza di amor propri.o, alle abitudini e sentimenti di dignità individuali e nazionali. Il carati.ere pronto, vivace, irascibile dell'Italiano non s i adatterebbe mai a con siderare come leggiera .la punizione dei ferri, foss'anco per poche ore; e però il nostro regolamento permette di usarli soltanto come mezzo coercitivo momentaneo, non già come punizione : .
In Auslria il comandanle di compagnia può infliggere ai g radu ati e .soldati il rimprovero, tutte l e punizioni d'ordine e la co nsegna fino alla durata massima; le altre
62 JL NUOVO
l
j
(~) Armee Vei·ordnu-ngs-Blatt, ~5 novembre ~87%.
6,i. IL NUOV O REG OLAMENTO Dl SERYlZIO punizioni fino al terzo de lla medesim a. Quando sia d is taccalo può pun ire g li u fficiali dipende nti col rimprovero e cogli arresti se mpli c i fino a sei g iorni.
L'uffi ciale subal tern o d is t accato ha p ei s ottu fficia li e s o ld ati la stessa aut orità di pun ire che il capitano .
Il sottufficiale di s taccato può infliggere la consegna e la prigione inas prita fino a du e giorn i .

Il comandante di b a ltag lione può dare le punizioni d'ordine e di consegna fino alla lo ro durata m a ssi ma, le ,altri punizi oni fino a due terzi della medesima. Quando sia di s t ac cato può infligge r e all'urfìcia le l'a rresto sempli ce fino a ve nti giorni e l'arresto di r igore fino a di e ci giorni .
Il com and an te il r egg imento possied e il diritt o di punire fino al massimo g rado.
« Il diri lto di punizion e (c ome in Germania) spetta
"' soltan to a queg li uffi ciali e funz ionari militari a c u i
« in sie me al co mando é affidata la r es ponsabili tà
« del serviz io e di sciplin a di un rip arto, uffi c io ed
« istituto e si es tend e a coloro c h e n e dipendono
« dir e uamente ».
S ono soggetti alle punizio ni disciplinari, oltre t utti i com pone nti l' esercito alt ivo (co m p resi i m edic i, gli ufficioli c onta b ili , g li aud itori, ecc .}, i m ilitari d ell a rise r va chiamati so tt o le arm i, g l i ufficial i della ri serva anche i n congedo quando ves Lono l'uniform e, tu tt e le person e al seg uito di un esercilo di op e ra zion e ed i p rigionieri di gue rra .
Pei so ldati della landweh r la p rigion e è alq uanto meno as pra; n on son o posti ai fe rri, :dig iunano due sole volte in se t timana e posson o fuma r tabacco .
PER L'E SERCITO AUSTRO-U NGHERESE 65 giuridiche, su i tes tamen ti d e i mililari, sull' esecuz ione delle sen t enze, sui consigli e sulle co mmi ss io ni d'onore cui sono sottop os ti i militari tutti fatti prigioni eri d i guerr a senza ess er e feriti , e final mente su i pareri t attici (Tak
tische Pare1·e).
Do po ogni campagna, ed ov e facc ia d'u opo eziandio durante le operaz ioni, il Ministro de lla guerra no m in a cinque gen erali od uffi cia li superiori s celti fra i più autore vo li e più capaci. Tre d i questi cos titui sco no una comm issione che ha l'incari co di formù la re il s uo parere t atti co sop ra qui s ti oni sottopos t e ai tri bunali di guer r a e rel a ti ve a mancanze d i fronte al nemi co, per giudic a r de lle quali occorra un a lto grado cli esperie nza e di sc ienza mili t are.
L' ultimo capitolo con ti en e g li articoli d i guerra (K1·i egs -A.rtik el ) i qual i consistono in un s un~o ~e°: p li c ~, chiaro, giudizioso e completo d elle essenzrn h di spos 1zioni del co dic e penale necessarie a sape r si da ciascu n militare .
La definizione de i r eati e l' app li cazi one delle pene offre m olta an a loO'ia col nost ro codi ce p enale del 1186 9. o d. Si è tuLL av i a mo lto più prodi ghi della p ena 1 morte . A mo' d'e sempio per l' amm uti na m e nto in massa vi è an corn. la d ecimazione; a lla decima zione è pure soggetta quella tr up pa ch e non fa il suo d?v ~re_ n el ~ombatli mento e che si arre nde senza neces s1t.\p r1grom era ; ben qua t tro volte si dà facolta al super io re di amm azzare sul posto l' inferiore .
Il cap itolo XlV somm inistra a lcune norme utilissi me s ul contegno da osservare in caso di diserz ione e di m orti im provvi se e viol ent i , sui rappo rt i colle a utorità
Fra 1 mo l ti cas i d i r ea ti in servizio noto la p erd ita per tras curat ezza di carte segrete o di piani;_ i rapporti inesatti o per fr etta o per mancanza di auenzione; l'ommi ss i on e di not ifi cu r e imm ed iatamente l e mosse de l nemico.
Le pene comm inate pel furto, per la l'ap ina, per la
6
A NNO XIX, VOL, I.
REGOLAM ENTO DI SEnV IZIO ECC infedeltà , per il fa lso, per la prevaricazione, per il saccheggio non commesso durante il combattimento, sono più mi ti delle nos tre .
DEL FUUIICOTONE E DELLE DINAlllTl
Da questo rapido schizzo mi pare r is ulli come la pri ma parte del regolamento austriaco · corrisponda perfettamente allo scopo cli costituire la ln"bbia del soldato e la sua guida fedele i n tulte le circostanze di pace, le quali ad altro non devono servire che aprepararlo alla guerra .
Ho osato di muovere qualche appunto; ma le norme di vita militare sono tanto soggette al carattere, alle tradizioni, ai costumi cli 11n popo lo, che il giudizio di uno straniero può ri feri rsi soltanto a ll 'utilità loro per l'esercito proprio; nè diverso poteva esser~ il proposito m io nel parlare di un l ibro il quale merita la più alta considerazione, sia per l'autorità c he riveste, sia pE-.i suo i pregi intrinseci, sia per la meta a cui tende .
L'esercito austriaco continuerà ad attingervi quella disciplina sev era, quei propositi fermi, quell'abnegazione coswntc , que l contegno d ign itoso ed ardi to, quella fiera sicurezza di sè che gl i procurarono la stima, il ri s petto e la- simpatia degli eserciti tulli,· ma specialmentr~ di quelli che ebbero a provarne la salda bravura sul campo di bauaglia . f
ORESTE BAnATIERl
Capitano cli f'anteria .
(C ont. e flue - V. dispensa del dic e mbre 1878)
SOMMARIO.
Dinnmltl (continuazione) : Modo di ag ire de lle d i namiti - Modo di usa!' le din a miti - (Esemp i d i mina subacquea - di mine in massa metalliche - d i d e moliz ione di ponti - di c ar ic t1e libe,·e) - La d i nam i te impiega ta ne l caricamento de i proietti cavi - Cenni sulla fabb r icazione dell e dinamiti - (Fabbricazione de ll a d ina m i te a Parigi ne l 1871 Applicazioni elle se ne fecero) - Prove delle di namiti - Recenti perfezionamenti introdotti nelle d inamiti - Cenaosul dinamit ilìcio de lla Ditta Caadi au i e Biffi (Mi lano)- Conservazioni e traspo1·todelle di namiti - Note
Modo di agiré delle dinamiti.
Numerose es pe r·ienze eseguite presso vari eserc i ti esteri, e d anche pres so noi. dal corpo zappatori a l poligon o de l genio in Casale sullo scorcio del 11871 ( 1), diedero lu ogo ad interes sant i osservazioni circa il modo di agire de ll a dinamite . Tali osservazioni possono riassumersi nel modo segue nte :
a) !\elle Le rre e nelle roccie tenere e mollo compress ibi li la dinamilc non lancia mo l to l'ontano le p ietre staccale; - essa piuttosto franLuma e sgretola in tutt i
(1) Un cenno de lle esperienze esegu ite al po ligono di Casale, mi fu gent ilmente favor ito dal capitano del genio s:g. G. B. ANDRn LONJ, il quale era stato appLrnto incaricato di ta li esperienze.
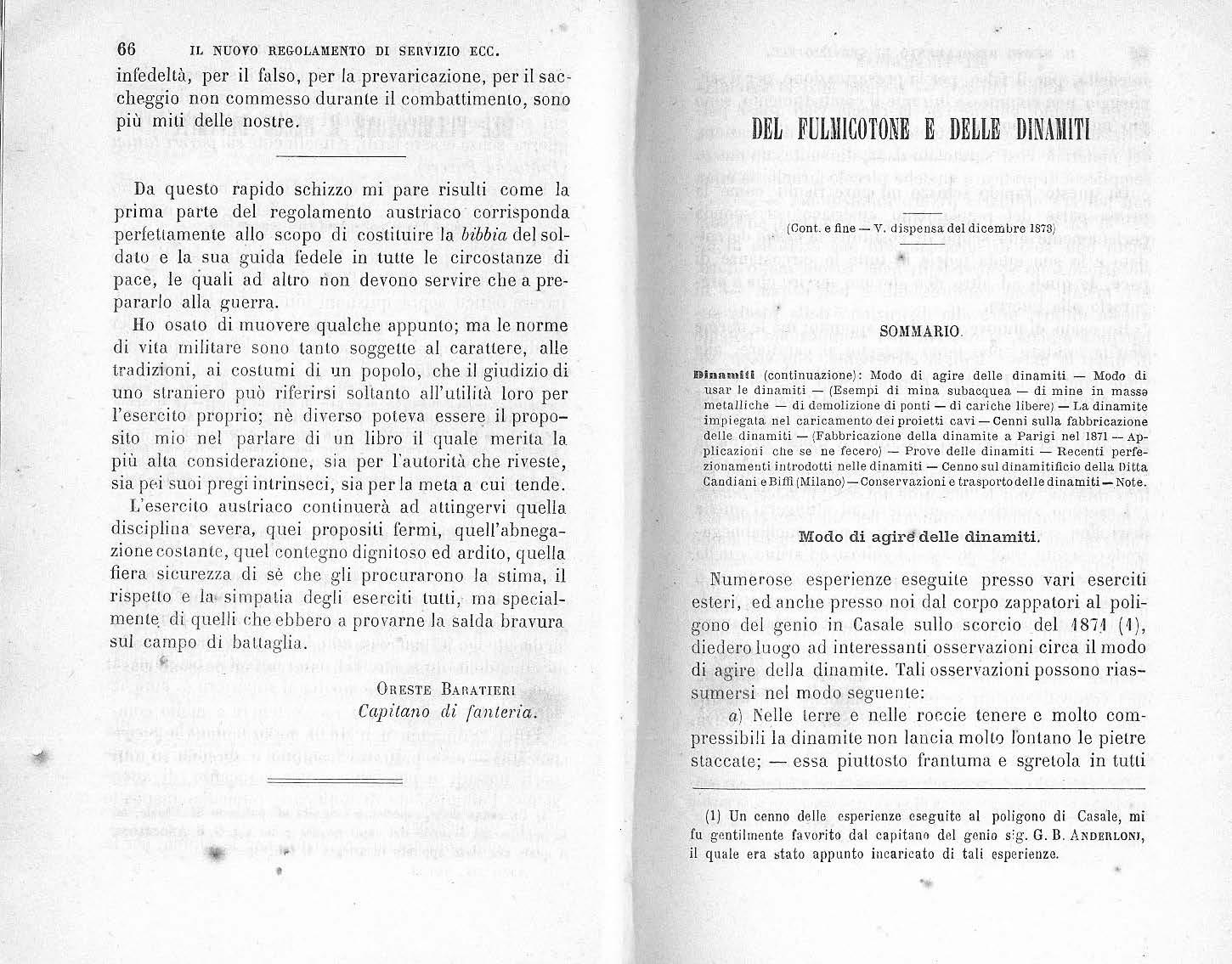
66 Il,
NUOVO
•
i sensi il solido minato; - sovente anzi lo sgrelolamento è tanto pot.enle che la roccia vien quasi polverizzata. - Affine di ottenere effetti di dislocazione de l materiale cosi sgrelolat.o dalla dina mite, un mezzo semplice è di pra ticare qualche piccolo fornello da mina con polvere ordinaria ovvero fulmicotone. -
ù) La dinamite spiega tutta la sua forza, ed i suoi effetti non ~olo di sgretolam~nto ma eziandio di dislocazione sono sorprendenti nelle roccie mollo dure, nei metalli poco compressibili e nell'acqua. - In questa ultima, oltre alla distruzione della roccia subacquea minata, si osserva una commozione potente d i tutla la massa liquida circoslante, che viene sovente lanciata ad altezze ragguardevoli ('t). -
e) Men tre nelle mine di polvere ordinaria, questa agisce qua:3i solo nel senso della linea di minor 1'csistenza, ed al disotto del fondo del foro di mina non si verifica mai alcuna lesione o sfasciamento del solido minato, con la dinamite invece lo sfacelamento e lo sgre to lamento comunicasi per un terzo circa dell"altezrn totale del foro di m ina, a l disotto del fondo del foro stesso (2) . -
d) I fori di mina caricati a dinamite, non ricltiedono alcuno int as amento - operazione questa che nelle mine ordinarie è difficile non so lo ma pericolosa, massime nella calcatura e n ella estrazione dello spillo;sembra tuttavi1:1. che un po' di inlasamenlo fallo nei fori verticali con un secchio o solamente con un bicchier d'acqua,!) nei fori inclinati con s'abbia o terra,
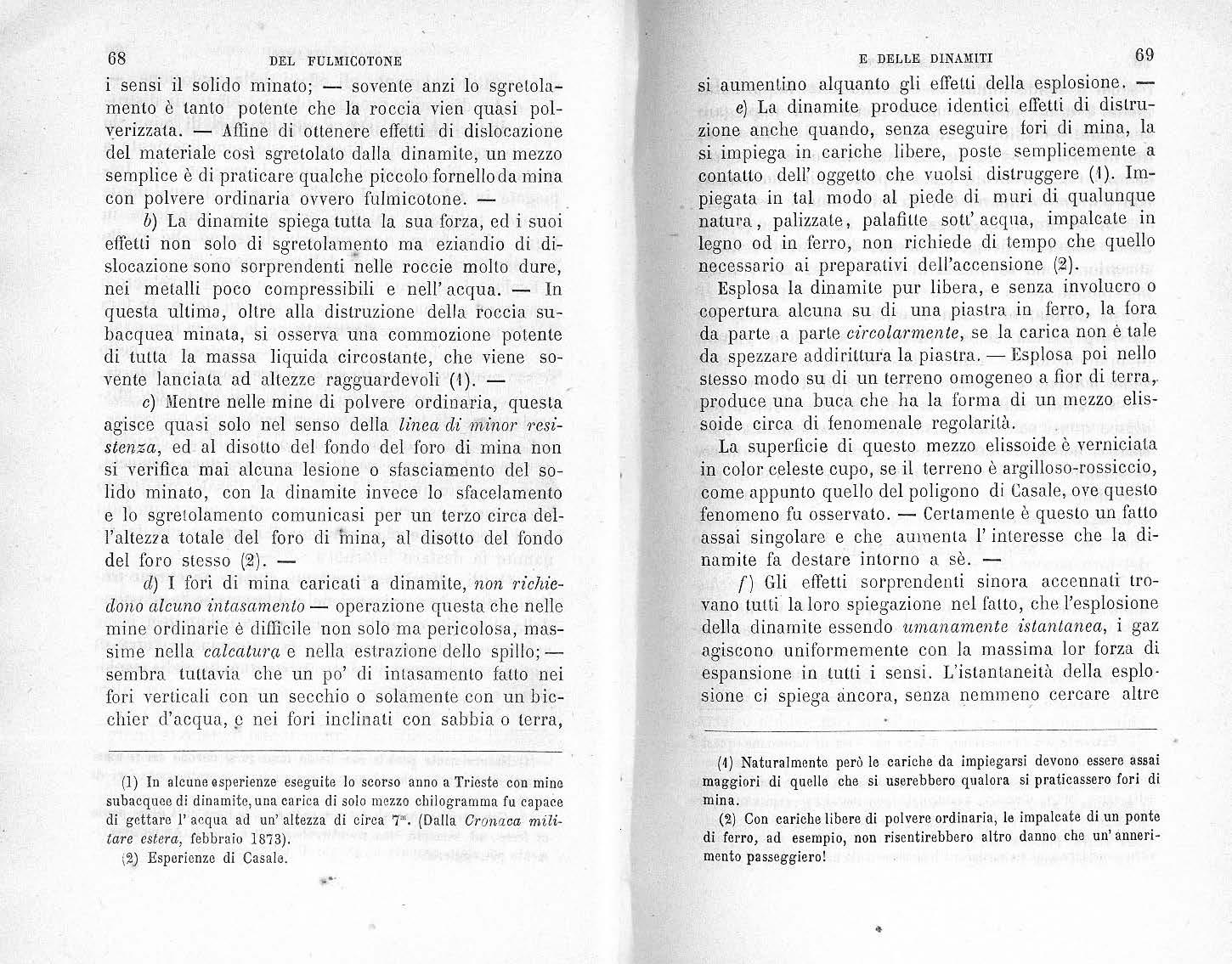
(1) In alcune esperienze eseguite lo scorso anno a T1·ieste con mino subacquee di dinamite, una carica cli solo mezzo cbiìogramma f u capace di gettare l'acqua ad un'altezza di circa 7". (Dalla C1·on a. ca milit are estera, febbraio 1873).
(2) Esperienze di Casale.
E DELLE DINAMITI 69
s1 aumentino alquanto gli effetti della esp losion e. e} La dinamite produce identici e1Ietli di dislruzione anche quando, senza eseguire fori cli mina, l a si impiega in cariche libere, poste semplicemente a contallo del!' oggelto che vuolsi distruggere (11) . Impiegata in tal modo al piede di muri di qua l unque natura, palizzate, palafille sott' acqua, impalcate in legn o od in ferro, non richiede di tempo che quello necessario ai preparativi d ell'accensione (2).
Esplosa la dinamite pur libera, e senza involucro o copertura alcuna su cli una piastra in feno, la fora da parte a parte circolarmente, se la carica non è ta le da spezzare add irittura la p i aslra. - Esp lo sa poi nello stesso modo su di un terreno omogeneo a fior di terra,. produce una buca che ha la forma di un mezz o elissoide circa di fenomena le regolarità.
La superfic ie di questo mezzo elissoide è verniciata in color cele s te cupo, se il terreno è argillo so-rossiccio, come appunto quello del po l igono d i Cas ale, ove q u esto fenomeno fo osservato. - Cerlamenle è questo un fallo assai singolare e che aumenta l' interesse che l a dinamite fa destare intorno a sè. -
() Gli effe tti sorprendenti sinora accennati lrovano tutti la loro sp iegazione nel fotto, che l'esp losione della dinamite essendo wnanamcnte istantanea, i gaz agiscono uniformemente con la massima lor forza di espansione in tulli i sensi. L'istantaneità della esplosione ci spiega Eincora, se nz a ~emrnen,o cercare altre
(·1) Natural mente però le cariche da i mpiegarsi devono essere assai maggiori di quello che si userebbero qualora si praticassero fori di mina.
(2.) Con caricbe libere di polvere ordinaria, le impalcate di un ponte di ferro, ad esempio, non ris entirebbe ro altro danno che un' annerimento passeggiero!
68 DEL FULMICOTONE
ragioni bal istiche pure di considerevole impor tanza, come non si pos sa nemmeno pensare ad i mpiegare la dinamite nel tiro delle a.rrni. - È noto infatti come, nel tiro delle armi, affine dì raggiung ere e!feui di proiezione ragguardevoli, i gaz devono agire successivamente e contirmatamente contr-o il proietto, e non istantaneamente come appunto farebbe la dinamite (11)Questa dunque è capace soltanto di effetti cli sch iantamento - ma in questa bisogna è per noi l'ideale della cosa. -
g) Quando la dinamile esp lode non ve des i che un lampo, e non sentes i fracasso, ma solo un rumor cupo e sordo; - alcune vo lte ànzi ed in certe circo·stanze non odesi rumore alcuno. I prodotti della combus tion e, per ragioni analoghe a quelle indicate pel fulm icotone, non possono rappresentarsi con una formula costan te; - essi del resto nei lavori di mina sono affatto innocui pei la vo ratori; - incom odi, raramente.Modo d i usar le dinamiti.
È provato che la dinamite in paragone della polvere ordinaria economizza alme no cl, un terzo le spese di brillamento e circa del 70 e dell'80 per cento il tempo necessario dì fabbricaz ione. Eg li è per ques ta economia
E DELLE DINAMITI 71 di spesa e di tempo congiunta aì suoi pÌ·egi_che ~l suo smercio cresce rao idamante nella ìndust.r1a privata. Germania , Austria,' Svezia, America , Francia , Inghilterra ed ora anche Italia, possiedono dinamitìfici, o governativi o pri vati . . . . . . .
Il modo pratico di usar la dinamite sia nel bisogni dell' ino·errnere militare che in grandi lavori di costrub b l zione ci vi le, è da perlutto, meno naturalmente _ e?giere varianti di dettag lio, c~me quello e~egu1to Hl Austria dall'esercito austriaco, Il quale per pnmo adottò o·ià definitivamente la dinamite, a bcJse silicea e confenente il 72 p er 0 / 0 di nitroglicerina al m i nimo.-.
• · Le truppe del genio austriaco son_o dunque mu~1t~ di cartuccie c ilindr-iche a bossolo d1 pergamena d1 3 centi me tri di diametro sopra 112 centimetri dì lun ghezza , e di scatole /1.thnincmti di Jaua, pure cifindriche, contenent i 7 libbre (31t ,9~) di dinamite . Ultimam en te furono sperimentate ancora scatole fulminnnti cilind1~iche ma con sezione elittica anzichè c ircolare come le pnme. -Fu provato che hanno su quesL'ullime il var~ taggio di resi ste re meglio ai trasporti, e produrre po, mago-iori effett i. di esplosione . - prescritto che le carfuc c ie s ieno impiegate per i lavori da mina; -:- le ~catole per distruggere oggt-itti colla semp li ce apphcaz1one della ca rica libera.
Le ca1·tucc'iè in numero conveniente da formare la· carica totale 1;ecessaria {'I), sono poste a contatto l'una dell' altra sul fondo del foro di mina, collocando per

(i) Parlando dèl fu lmicotone, dotato pur esso di esplosione quasi istantanea, acc ennammo quali sono i mezzi tentati per renderla successiva, ed ottenere un progressivo spandimento rii gaz nell' interno delle armi. Per la dinamite nessuno di quei mezzi può evirlentcrnente essere attuabile , nè sembra che altri ve ne possono essere.
Nella Nota A posta in calce aUa presente 'Memoria sono esposte altre considerazioni riguardant i l'esp losione della dinamite.
(1) Ne l determinare quale sia la carica necess àri a per una data mina, sarà ulila ricordare che la dinamite ha una forza esplosiva 8 0 10 volte mag"iore di que ll a della polvere ordinaria. Del resto la quantità di din:m ite varierà a secon da degl i scopi e effetti c?e voglionsi ottenere: - alcuni esempi che esporremo p1u innanzi, chiariranno meglio la c: osa.
70 DEL FULMICOTONE
•
ullim a una p i~cola cartuccia spe ciale, detta ·cartuccia d'accensione ( Zùndpatr one ) . Tale cartuccia è piena co me le altre di dinamite , ma porta nel su o fond o una cassula di rame a fulminato d ' arge uto ( mezzo gramma circa) e nell' interno di detta cassula è a ssicurata mediante strozzatura l 'estremità di u n a m icci a ordinaria d a minatore (Zuniìschnitr) , oppu re vi si fa pervenire il filo e lettric o. Quando a mo t ivo della temperatura t r oppo bassa , l a dinamite della cartuccia: di accensione è congelala, a llora si a d opra un'altra cartuccia d' accensione , che differisce dalla prima solo per a v ere il bossolo ripieno c on una miscel a di 75 parti per cento di cotone fulminante macinato e 25 di nitroglicerina ('I), in luogo di dinamite ordinaria.
L'accensione della c assula fa esp lo dere la cartuccia, e questa la carica totale di qua lu nque grosse·zza es sa sia. Le mine s ub acquee si praticano e si accendono n ell o stesso modo che quelle ordin arie, s a lvo che qualora i m p iegh isi la miccia, questa deve esse re impermeabile. - E se la carica d eve soggiorna r e l ungamente sott' acqua, è mestieri collocarla in sacchi d i caoutchoitc (2).
Le scatole ful minanti sono adoperate da l genio austriaco essenzìalmente in due modi. Un primo modo consiste nel p os are l e scatole a contatto l'u na de ll' a l tra sull'o s tacolo che, vuo ls i fulm inare , e si cornùnica poi il fuoco ad una sola d i esse rnedianle la cartuc ci a d'accensione; - questa viene a l solito collocata sopra
l a scato l a che si vuole fare esplodere, opp ure - ciò che è meglio -n ell' interno di essa . - Un secondo modo consiste nel disporre le scatole non a conta tto, ma ad una certa distanza l'una da ll'altra, e perchè esploda no s im ul ta neamente mediante l'accensione di una sola di esse, vengono collegate fra loro mediante so ttìl i cannuccie ripiene di dinamite (11). - Il primo modo serve pe r apri r e una breccia qua lu nque ed abba tt ere ostaco li od opere d i co rt a e media lunghezza, come ad e sempio un fabbricat o, l'i mpalcata cli un ponte, ecc . - Il secondo modo invece convi ene quando v uolsi abbattere contemporaneamente in tutto i l suo svilup po linea r e un'opera od un ostacol o di ragguarde vole l u nghe zza , come ad esempio un lung o muro di cinta, lunghe palizzate e simili {2} .
Ollre l'impieg o r egolamentare della dinamite, in cartu écie -e scatol e fu lmi nanti , l e t ruppe del genio austri ac o sono esercitate anco ra ad usare la dinami te in altri svariat.issi.rni modi, a seconda della natura deg li osta coli d a a bbattere e dei bisogni che si presenta no in campagna, ovvero nei lavor i di costr uzi one. I principali fr a ques ti svariati modi di impi ego , nppariranno dagli esemp i che stiamo per es porre, affine appunt o di completare la co sa .
Esempio di m ina subacquea .
Come esemp i o di un impiego speciale de ll a dinam ite nelle mine subacquee, c iLerem o la descriz iof!e di una
(~ ) Secondo la proposta de l colonnello TnuNGLUN, g ià ~ltrovc acco1m ata.
(2 ) No n sappi amo sinora sa l'Austria abbia dec iso di adottare Ia dinami te pi ross il ica im()ermeabile, che dicemm o esse ro sta ta proposta dal colon nel lo TnuNGLU N per qu,~lle cariche nppunto clrn devon o lungamente sogg iornare sott'acqua .
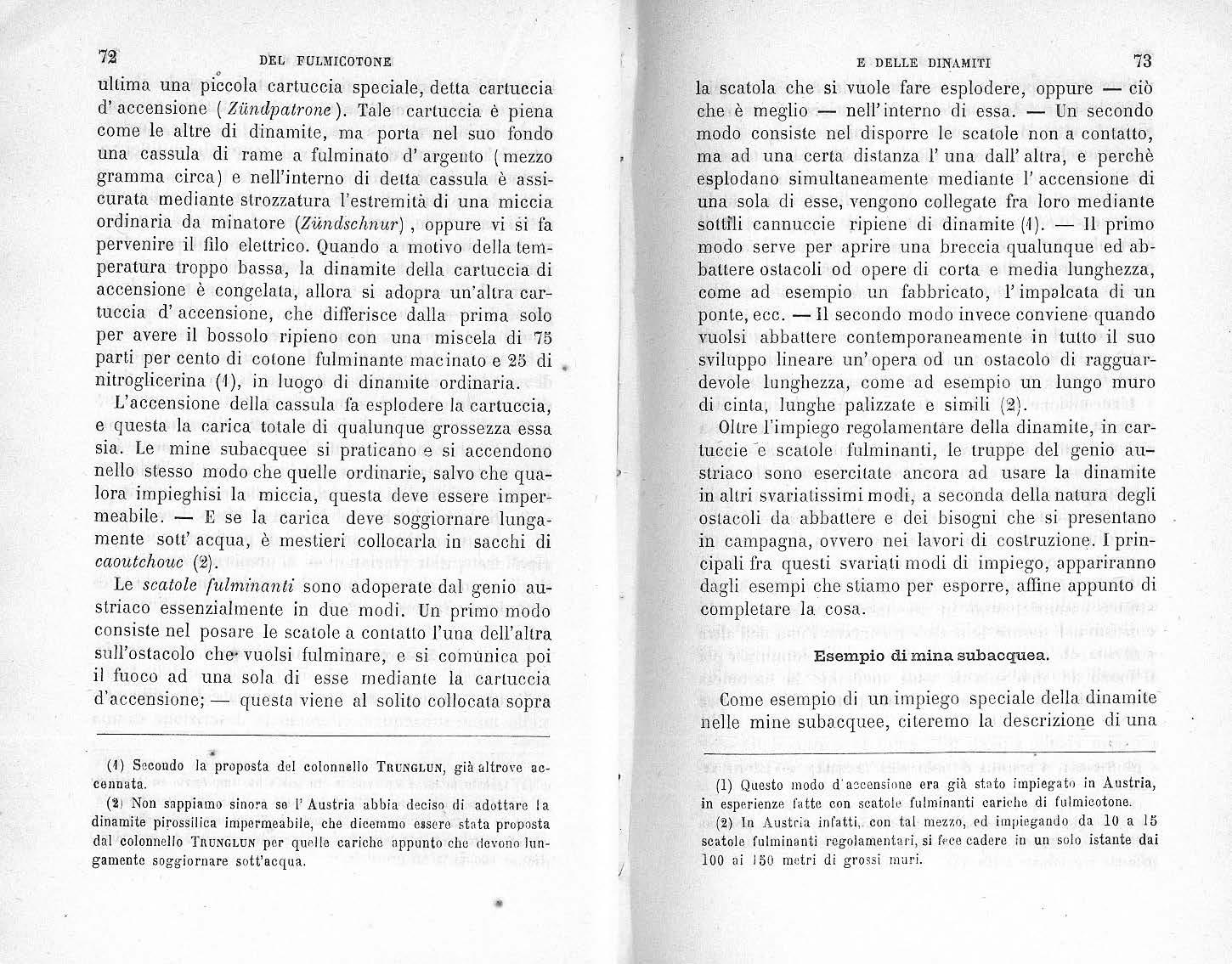
(l) Questo modo d·ac.censt one era già sta to impiegat/l in Aust ria, in espe rie nze fotte con scat ol,, fulm in an t i carklH1 di fulmicotone.
(2 ) In Austria infatti ,. con ta l mezzo, i>d impi~ga udo da 10 a 15 scatole fulminanti regolament a ri, si fi,ce cade re in un so lo istante dai 1 00 ai 150 rn el ri di gross i ma ri.
7~ DEL
FULMICOTONE
• )I E DELLE DINAMITI 73
E DELLE DINAMITI 75
interessante operazione eseguila il giorno 8 febbraio 1873 da un battaglione del gen io austriaco di stanza a Vienna, sotto la direz i one del capitano Larnir ( 1) .
Tra tta vasi di provare se meg lio e pièt rapidamente che con i soli L i mezzi dei cavafanghi e simi li si potesse demolire mediante grosse cari c he di dinamite il grande sperone di Schwarzlaclcen che taglia obliquamente il le tto che dovrà avere il Danllbio secondo il nuovo progecto di sistemazione. Lo sperone consiste in una gro s sa e robusta scogliera legata da una soli da palificazione .
« L'esperienza si fece con due mine con cariche di
« 40 e cli 50 libbre (chi loge. 2.2,40 e 28) di dinamite ,
« ed i l processo con cui queste cariche si in trodus -
« sero alla voluta profondità è ingegnosissimo . Sic-
« come la corona de lla scogliera tr ovasi in generale a
« 2 o 3 piedi (O'n,63 e om,95) souo il pelo de ll'acqua,
<( e so lo ne sporgono alcuni p il oni, si pensò di forare
« l ong itudina l mente dlle di questi e fare una piccola
« mina in ciascuno , con cariche di libbre 1 ccl ,1 1 ; 2
« di dinamite alla p rofondit à necessaria, in guisa da
« creare u no spazio per poi ricevere la carica del le
« due mine propriamente det te. Per introdurre a posto
« queste ull i me cariche le si divise r o in tante seatole
« di latta impermeabili di forma ·cilindrica, d el d ia -
« metro di 6 /. di pollic e (O•n,033) e della lunghezza cli
« 6 p oll ici (Om,HS8 ) contenenti oncie ,Jil 3/~ di din a mite
« c iascuna. Di tali scatole se ne posero H ,O in una
« delle mine e 1150 nell' al tra . Il punto medio della
« carica ri sultò a piedi 9 ¼ sotto l a corona del l a sco-
« gliera e a '12 so tto il pelo dell' acqua ; - la lin ea
(·1) Tale descrizione, desunta dal fVehi-- Z eitu,nq del 12 febbraio 1873, N° 19, è r iportata nell a nostra Oronaca .Milita.re estera N• 5 1873 . I )
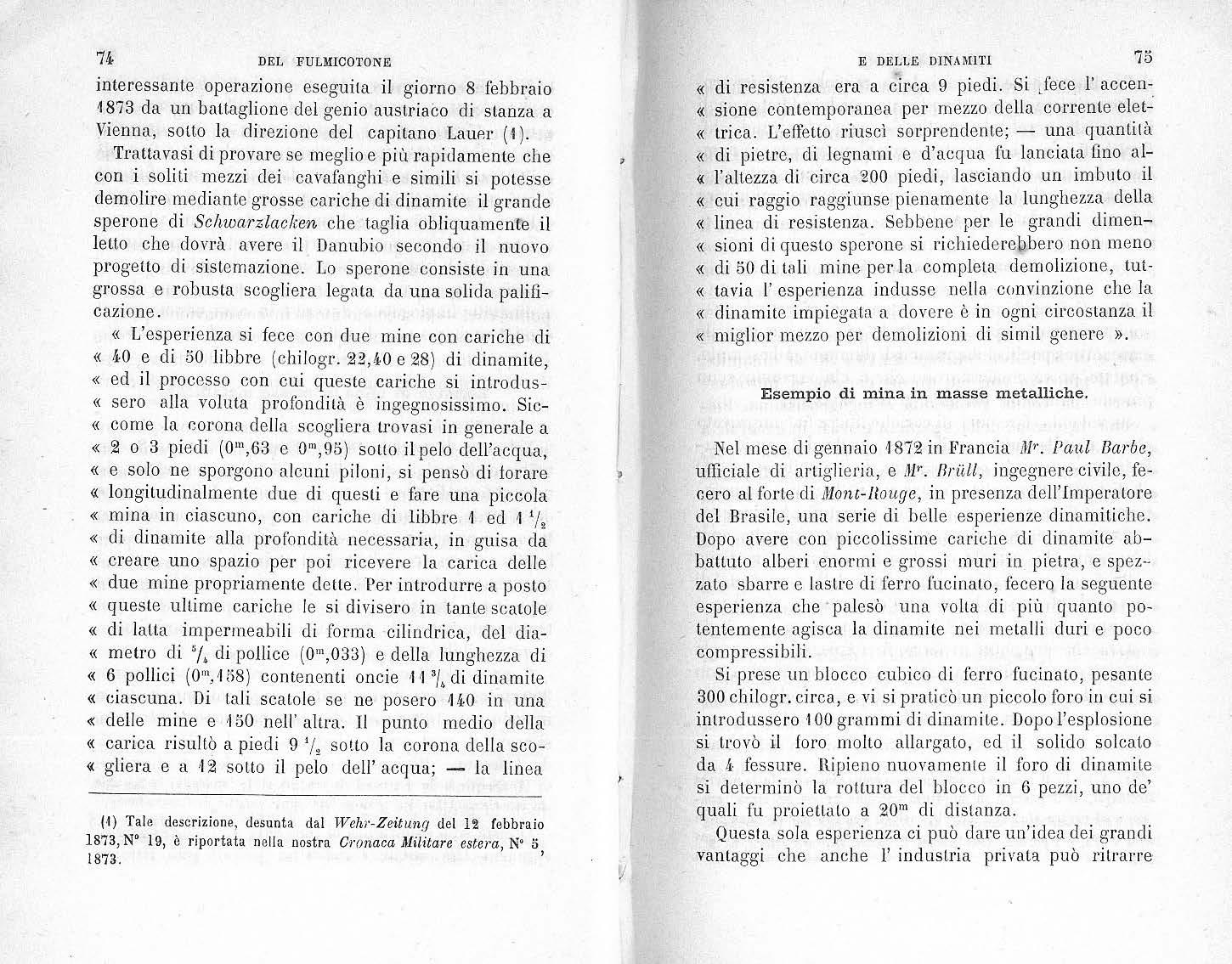
« di resi stenza era a circa 9 piedi. Si Jece l' accen« sione contemporanea per mezzo della c orrente elet__.
« tri ca. L'effetto riusci s orprendente; - una quantità
« di pietre, di legnami e d'acqua fLl lancia la fino al« l'altezza di ci rca '2 00 piedi, l asciando un imbuto il « eui raggio ra ggiunse pienamente la lunghezza della « linea di resistenza . Sebbene per le grandi <l imen« sioni di ques to sperone si rich ied e rebbe ro non meno « di 50 di tali m ine per la compl eta demoli zione, tut« tavia l'esp erienza indusse nella convinzione che la « dinamite impiegata a dovere è in ogni circos tanza il « miglior mezzo per demolizioni di s irnil ge n ere » .
Esemp i o di mina in masse metalliche.
Nel mese di gennaio 11872 in Feancia Jl11• • Paul Barbe, uffic iale di artigl ier ia , e m 1 •• flr illl , ingegnere civil e , fecero al forte di 1'1oni -I1 ouge, in presenza de ll 'Imperatore del Brasi le, una s eri e di belle espe ri enze clinamitiche. Dopo av ere con piccolissime c a rich e cli dinamite abbattuto alberi enormi. e gross i muri in pietra, e spez .. zato sbarre e lastre d i ferro fucinato, fecero la segllente esperienza ehe · palesò una volta di più quanto potentemente agisca l a d i nami te nei metalli duri e poco compressi bi h .
Si prese un b lo cco cubico di ferro fuc inato, pesante 300 chilogr . circa, e vi si praticò un piccolo foro i u cui si introdusse ro · t 00 grammi d i dinamite. Dopo l'esplosione si Lrovò il foro molto allargato, ed il solido solcalo da ,i. fessure. Ripieno nuovamente il foro di dinamiLe si determinò la rottura del bloceo i n 6 p ezz i, uno de' quali fu pro iettalo a 20m di distan za .
Ques ta sola esperienza ci può dare un'idea dei grandi vantaggi che anche l' in dustr ia pri vata può ritrarre
74
DEL FULMICOTONE
/•
dalla dinamile negli scavi delle mini ere. Ed invero. mo lte m in iere state abbandonate per lo acldielro da gli industria li, perchè la rendita - causa le g ra n di dif. .ficoltà d i scavo inconlrate -non compensava più nemmeno la ma no d'opera , vennero oggi ripr ese , pote ndosi con tu tta facil ilà e col massimo guadagno conlinuare i lavori usando la dinamile .
Esempi di cariche libere .
Demolizione cli ponti. - I ponti i n muratura po::;sono essere demoliti minando le pil e con un fornello caricato con pochi chilogrammi di dinamite. Ad esempio, r ipetute prove confermarono che G chi log ra mmi sono più che suffici en li per pile grosse 3m circa. ,.
Ma vo le nd o fare uso di cariche libere fu comprovalo che 2 scato le fulminanti c om e qu elle del gen io a us tri ac o - cio è ·14 chi logr amm i di dinamile - posate al di sop i·a della volta, bastarono a demolire co mplet amen te l' arcata di un po nte in muratura, qualunque .
La stessa carica cli 11t chilogrammi, costituita analogamente da scatol e o cartuccie ordinarie ripartite s ulle foccie . ve rti ca li ed ori zz ontali de lla i mpalcata di un ponte d i ferro, bas tò per con lorcere, spezzare e fra nlumare le sba rre de lla impalcala slessa. - È da not.t\re che per ponli in ferro, fu. imp iega la sovente la dinamite anche diversa me nte, - fo r mando cioe con essa delle salciccie in tela com un e , ed a vvo lge ndo con ques le a spira le sba rr e della impalcata (11) .
( 11) A titolo di confronto accen neremo come, impiegando la polvere ordinaria, se il ponte è in muratura con pile grosse 3"' circa , conviene adoperare almeno 2 for::iclli, cari ca ti con 200 chi logrammi circa di polvere. Ed anche con la pol vere ordinaria si può tentare 1' impiego di ca riche libere; - ma allora occorrono ni entemeno che 2 o 3
E DELLE DINAMITI 71
Abbattimen to d' alberi, pal izzat e, ecc. Alberi i pi ù robu sti furono istanta neamente abbattuti conto rnando il loro piede con una salciccia contenente al più i o chilogrammi di dinamite. Naturalmente invece di saloicde po lrassi impiegare egualmenle una o du e s cato le fulminanti, ovvero cartuccie ordinarie, colloca le intorno al piede de ll' albe r o . - In modo ana logo furono demo lite murag lie, palizzate, e p or le in Jegno od in ferro di qualunque grossezza (i).
Le artio·lierie furono d is trutte in due modi: - od D • applicando alla loro bocca sacchetti di tela co nlenen~1 chilogram ma di dinamite - oppure co llo cando 11 sacchetto sopra uno degli orecchioni. - (2)
IDistr ,uzio1ie di /erro m:e. - 11 26 giugno 11873 s i eseguirono a l poligono di Breitensee in Aus lri a, interes-
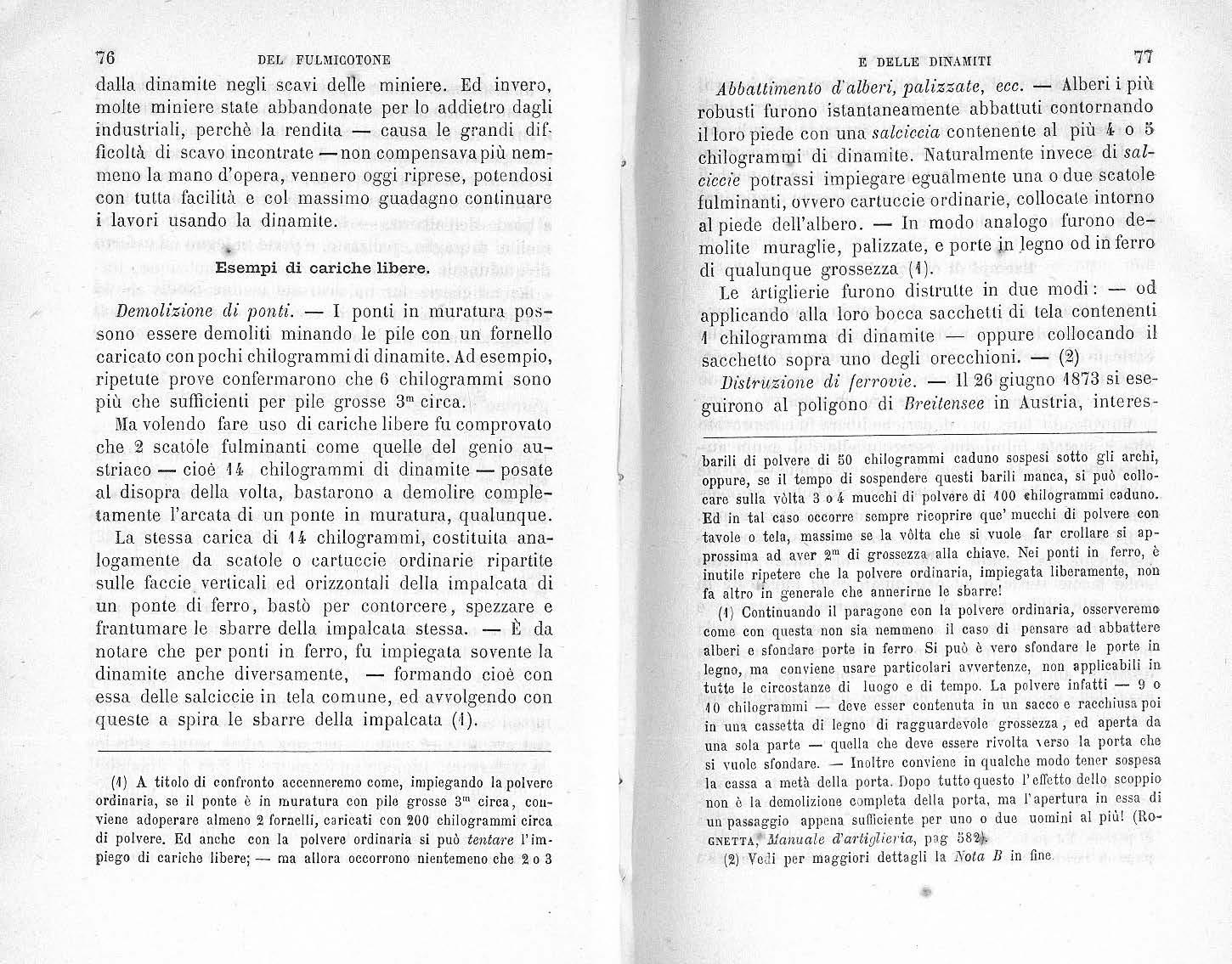
barili di polvere di 50 chilogrammi caduno sospesi so tto g li arch i, oppure, se il tempo di sospendere questi barili manca, si può collocare sulla vòlta 3 o 4 mucchi di polvère di 00 thi logrammi caduno. Ed in tal caso occorre sempre ricopr ire que' mucch i di poh·crc co n ta vo le o tela, ~ass inie se la vòlta che si vuo le far cro llare si approssim a ad aver 2,m di grossezza alla chiave. Ne i ponti in ferro, è inutile ripetere che la polvere ordinaria, impiegata li beramente , 110n fa altro in gene r ale che ann er irne le sbarre !
(,1} Con tinua ndo il parag one con la poive re ordinaria, osserveremo corne con questa non sia nemmeno il caso di pensare ad abbattere al beri e sfondare por·te in ferro Si può è vero sfondare le porte in legno, ma conviene usare p art icola ri avver ten1. c, non appl icabili in tutte le circosta nz e di l uogo e di tempo. La pol vere infatti - 9 o ,1 O chilogrammi - deve esse r contenuta i n un sacco e racc hiu sa poi in una cassetta di legno di ragguardevole grossezza , ed aperta da un a so la parte - · que ll a che deve! essere rivolta ,erso la porta che si vnolc sfondare. - In ol tre co nvi ene in qu alche modo tener sospesa la cassa a metà della por ta. Dopo tutto qu es to l'effetto dello scoppio non è la demolizione completa della porta, ma l'apertura in essa di un passaggio appen::t sul1ìciente pe r uno o due uomini al più! (R.oGNETTA, Manuale d' artiglieria, pag 1i8'2).
(2) Ve di per maggiori dettagli la Nota JJ in fin e
'76
DEL FULMICOTONE
E DELLE DINAMI'fI 79
santi esperienze all'oggett o di constatare qual fosse il miglior modo d'i mpiego pratico quando occorra usar cariche lib ere cli dinamite pe r distruggere le ferrovie.
- Le scatole fulminanti impiegate nano cilindric he ad involucro di lalta, ma in luogo di contenere 7 li bbre di dinamite, eorn e quelle ordinarie usate dal genio austriaco sino ad ora , contenevano solo 2 libbre di dinamite ('I le, 112). - Se ne avevano di due sorta - alcune a sezione cirno la re altre a se- ' zione elillica .
Si cominciò a d ispor re u na scatola a s ezione circolare contro ciascuna r otaia, nel p unto d i congiunzion e di due verghe contigue . Comunicato il fuo co s eparatamente, si r isco ntrò che in amb edue le prove ii cuscino di cong iunz ione e le traverse furono co mpletame nte div e lti; le ve rghe, solle va te ed in c ur vate ve rso l' interno . - Il dislocamento totale fu giudica lo suffic ie nt e a r ender ce rto lo sviamento del treno .
Si sperimentarono allora, n ella stessa condizione, due scatole a sezion e el ittica- collocandone una con l'as se maggio r edell' elisse ve11Lica le, e l'altra co n questo stesso asse orizzontale. - In arnl) edtre le di sposizion i - nell'ul tima so pratutto - l'effe tto prodotto fu s uperiore a quell o otten uto eon le' ·scatole circo lari .
Si rinno vò l' espel'ienza disponendo una sca tol a elittica in modo che l' as se magg iore clell' elisse focesse un ango lo di M>° con Ja ve rga , ed il ri su !laLo fu più sorp rend e nte a nco ra . le es tr emi tà delle due verghe vici ne e le pa rti di collegarnento, fu r ono quasi polveri zzate; gro ssi pezzi furo no pro ietla ti a uO passi di distanza, ed alt ri più pi ccol i a 20 0 pas si circa. ·
Disponendo in segu ito una ·cartucc ia verso il mezzo di ima ve rga , co n le gene r a trici no r ma li o .pAralle le alla verga stessa , si otlen.1,1 ero effett i re lativame nte rriin ori ...., . ' ed un' u ltima prova fo lla con una cart uccia co llo ca ta
sopra una travers a, a 3 piedi da una delle verghe, non fece che spezza re la traversa, e la ,ve rga rimase intatta.
La disposizion e precedente è dunque s e nza dubbio la più conveniente in si mili dis truzioni ('I).
La d i namite impiegatane! caricamento de'proietticavi.
Da quanto fu detto sinora circa l'impiego della dinami te, po ss iamo concludere che innumerevo li sono · le sue applicazioni sia nell'ingegneria civ ile c he rn ilitare, ed in campagna (2). Per n oi c h e la con s ìd e riomo essenzialmente s otto questo pun to di visrn , interes sa accenn are ancora come la din am ite sperimentata tanto in Austria, che in Francia, nel caricamento de' proietti ca vi , s i dimostrò a,nche in questa b isogn a atta ad essere impiegata con molti vaQtaggi .
Tutta la qu estione s i riduce ad esser certi che non possa avvenire lo scoppio prematuro del proietto, nello interno dell'anim a delìe a rti glierie ed a trovare una spoletta conveniente . -Il colonnello Trunglun scriveva che molte esperienze a vevano provato che med iante foga.te p os s ono con suffi ciente s icurezza lan cia 1;si proi etti pesanli da 600 a 11000 libbre {396 a 560 chilogra mmi) fino alla dist,rnza di 400 o 50 0 passi (300 o 3'i1S me tri cù:ca); ed in vitava. i lellOl'Ì a considerare l' effetto di Savart i ne' (3) carica te con 4 o 500 libbre di din amite

(4) A co mplemento dfgli ese.mpi ora recati circa l'impiego di cariche libere, v~gga si ancora la Nota B in fine. •
(2) Ve dans i, oltre g li esempi te'slè citati, le app licazioni che si fecero de lla din amite durante l'assedio di Parigi nel 4874 ; sono riportate poco più a vanti.
(3) Chiamansi appunto qavartfac certe immense granate , che s i lanciano da un convenie.ntc fvro sca \'alo ne l t er reno e che t.ien l uogo del!' anima delle artig lierie. - Da molto tempo l'A ust ria pe rsiste a fare esperienze con q uest e sa vartinc. -
78 DEL FUT,)f[COTONE
" l > I
"
corrispondenti a cariche decuple di polvere ordinaria, e lanciate contro un fronte d'attacco nell'ultimo stad io di un a ss ed io . - Sarebbe cosi in potere dell o attaccan te - egli esclama - produrre nell' inte rno delle opere l'effetto d ella esplosione di un magazzino a polvere abba sta nza considerevole!
No i c i limiteremo soltanto· ad a cc ertare che apposite e num erose esperienze dimostrarono la possibilità d i poter caricare i proi etti cavi con dinam ite , impiegandola in unione alla p olvere ord inaria, ed anche da sola quando la materia incorporante sia convenientemen te scel ta e convenientemente preparata . In Francia le esperienze fu ro no cominciate fin da l 11874 durante l'assed io di Parigi. Abbandonate momenta neamen te dopo la campagna, fu rono ben tos to riprese e nello scot'So mese di marzo ,J 873 si sonq sparati a Calais, se n za che avvenisse n essuno scoppio dentro l'anima, 30 colpi con un pezzo da 7 fu ori di servizio, e con velocità iniziale di circa .i.OOin, e g rana te cariche di . dinamite fabbrica ta d al signor Jbos (11). Il Min istero della guerra ordinò l a con tin uazion e di qu este intere ssanti esperienze, ed or a l a comm iss ione di Cala'is s i propone anzi tutto determinar·e il limite d i velocità iniziale che si può darè senza pericolo a proielli carich i di dinam i te Jbos (2).
Cenni sull a fabbricazione delle dìnamiti.
La fabbricazione delle d inamiti comprende due sole operazion i preparatorie :
a) Fabbri cazion e della n itrog licerina ;
b) Pre par a zione della materia inc orpo r ante .
Le operazioni definitive son o anch'esse du e s olt an to:
e) Incorporamento dellù nitroglicerina con la materi a assorbente;
cl ) Compressione de lla dinamite e suo impaccamento.
Solo la fabbricazione della nitroglicerina pre·senta un certo pericolo, e richiede pe rci ò operai in telligen ti , sebbene il processo dell'op e razione sia serpplicissirno. Basta infatti che nel vaso c onten e nte il miscuglio degl i acidi azotico e solforico nelle volute proporzioni, perve ng a a po co per volta la g li cerina, ed in mo do uniforme : - ag itare il miscuglio a mano o meglio meccanicamente, e veg liare a che la temperatura di esso, malgrado il grande calore s vil u ppa to dalla nitroglicer ina in formazione, non . ecceda mai i 20° cent. circa.
E ciò si ot tiene mantenendo continuamen te intorn o al vaso con te ne n te g li acidi, o ghiaccio o miscugli frig ori fici. Al termine della reazione, si estrae la nitrog licerina per dec a ntazione, e non rimane che lava rl a accuratamente, ed in più r iprese, in appositi lavatoi, ·per fare sparire da essa t racc ie dì acidità .
La prepa r a zi one della materia incorporante , con sis te nel polverizzarla finamente, m ed ian te un mezzo meccanico a datt o, per esempio, macine o pestelli.
(
i ) Non ci f u possibile ancora venire a cogn izio ne de i caratteri part icola ri di 11ucsta din amit e. -Solo sappi am o che la materia incorporante impieg ata è la randanit e, sorta di sil ice gelatinosa.
(2ì Dalla Revu e d'a rti ll et·i e del mese d i maggio ] 873, r iportata dal!a nostra Cro naca Militare Estern, g iugno 4873.
Le due op erazioni defin i tive , eccettuata la compress ione c he d eve essèr fatta-con appositi torc hi, sono, d el resto, tut to a ffatt o manuali e n on ric hiedono che l'unica avvertenza di n on sorpassare la quantità di nitroglicerina che p roduc e la satu ra zi one nell'assorbente impiegato: senza di ciò si correrebbe ri sc h i o di aver dinamiti soggelle ad un trasudamento pericoloso di nitroglicel'ina. - Conviene poi munirsi le mani di guanti di pelle, finchè l a dinamite non sia impacchettata; e-
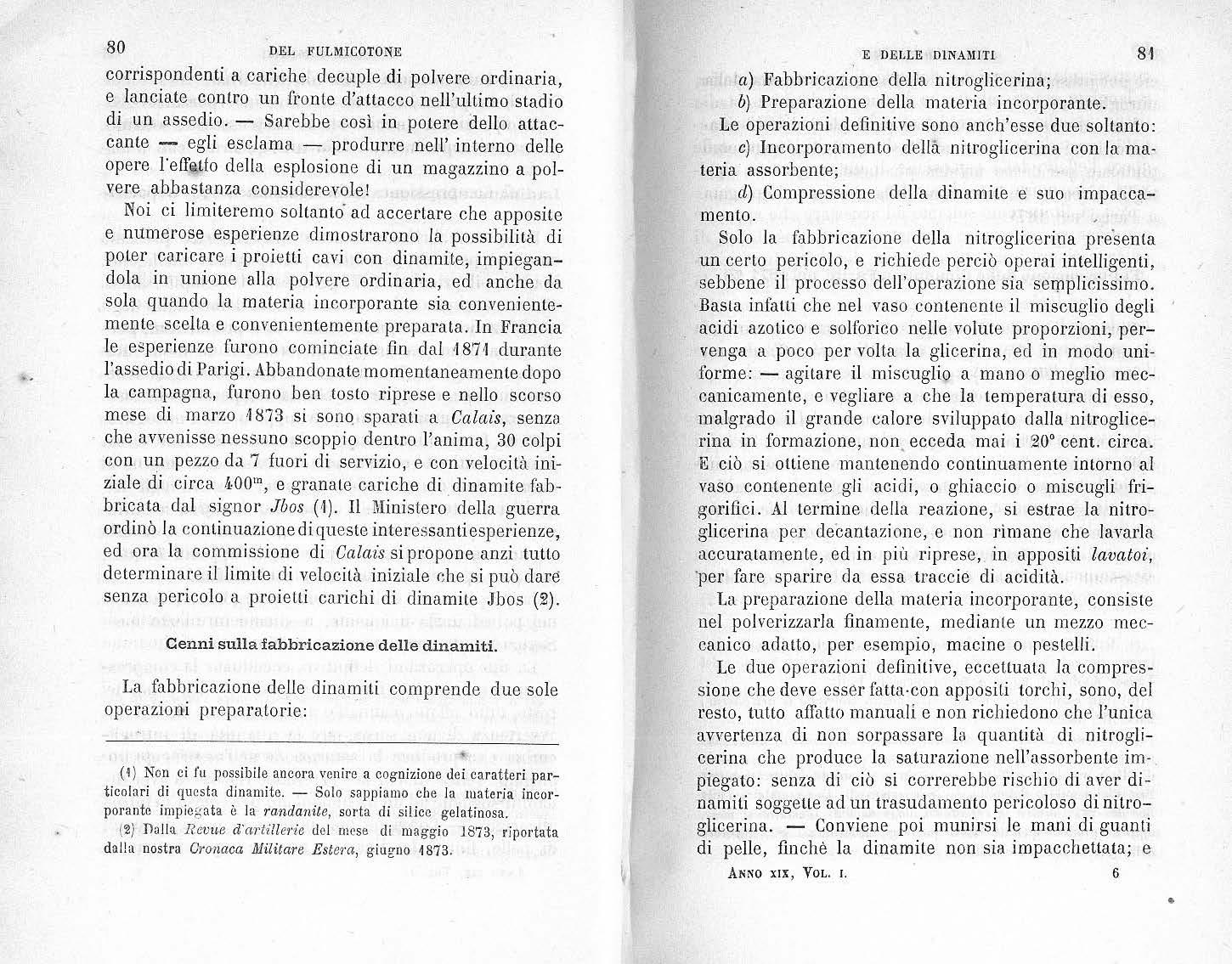
80 DEL FULMICOTONE
E DE.LLE D1NAMIT1 81
ANNO xix , VoL . 1. 6 •
ciò per preservare le mani dall'azione corrosiva della nitroglicerina.
Non entreremo in maggiori particoltt.ri di fabbricazione, .basti avere accennato la cosa ('1}. Aggiungeremo piuttosto, per darne un'idea più precisa, qualche dettaglio circa la fabbricazione della dinamite impiegata a Pai-igi nel 1871.
Fabbricazione della dinamite a Parigi nel 1871 (2).
Durante l'assedio di Parigi i Francesi crearono due manifatLure di dinamite - una alle Buttes-Chaiimont, l'altra alla Villette (3).
Gli acidi e l a gl icerin a furono requisiti - e per materia assorbente si adoprò in mancanza del l(ieselguhr, la cenere del carbone di Baghecfd, im piegato sino allora nella 'fabbricazione del gaz-luce . Questa cenere, miscugli o bianco, e morb idiss im o di sel ce e di argilla, non raggiungeva il potere assorbente del Kieselguhr il q uale è 1:apace di incorporare c ir ca il triplo del suo peso, di nitroglicerina: - essa tuttavia purgata accuratamente e macinata si mostrò preferibile a molte altre ·
(<1) Dettagli estesi riguardanti la fabbricazione della dinamite, potranno rinvenirsi nei tratt11ti di chimica industriale çlel Knapp e del Vagna,· pubblicati da poeo tempo anche in Italia.
(2) Tali cenni furono desunti da l nostro Giornale à' artiglieria, Parte 110., 872 .
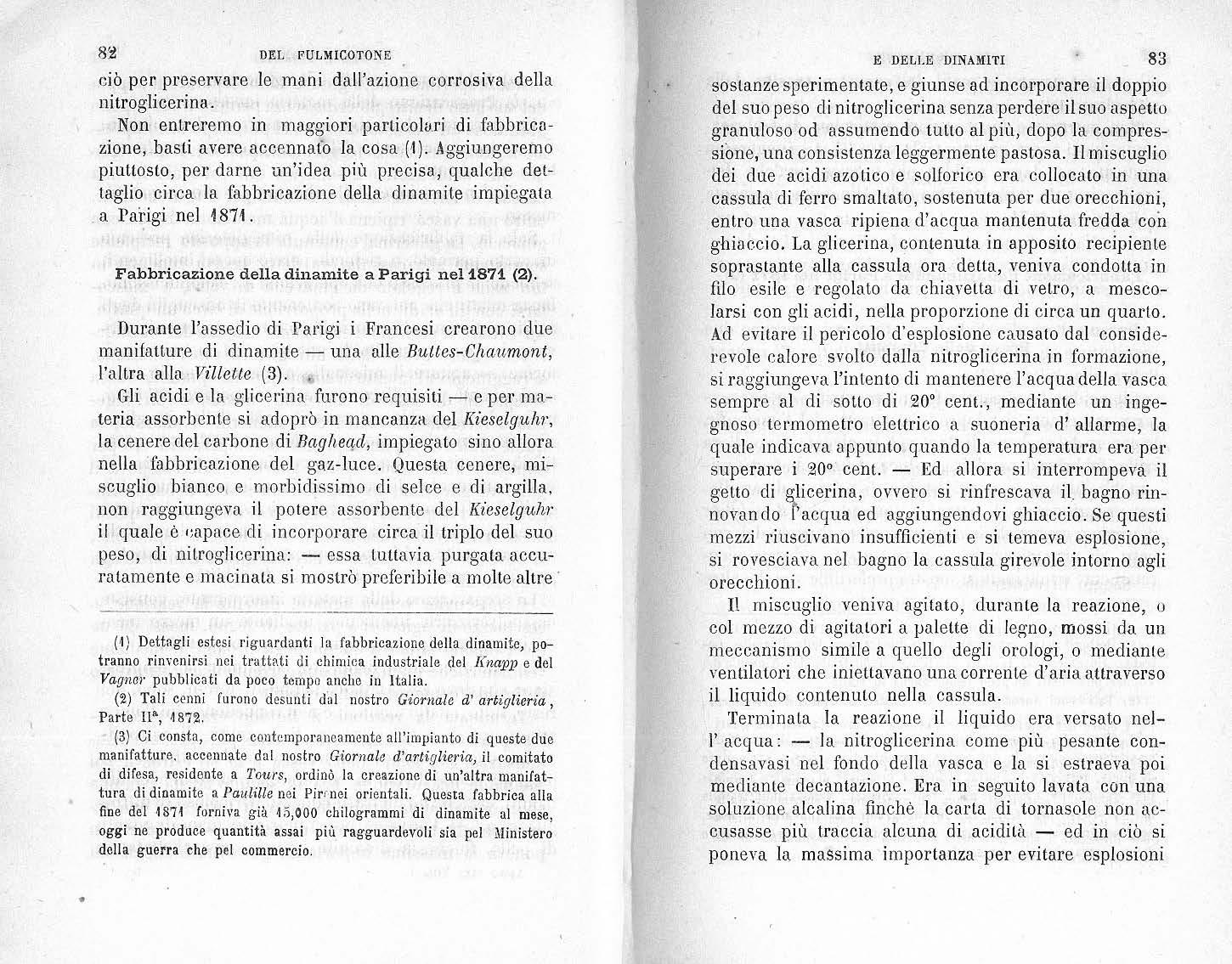
(3) Ci consta, come contemporaneamente all'impianto di queste due manifatture. accennate dal nostro Giornale d'artigliei·ia, il comitato di difesa, residente a Tours , ordinò la creazione di un'altra manifattura di dinamite a Paulille nei Pir rnei orientali. Questa fabbrica alla fine del ·187~ forniva già 15,000 chilogrammi di dinamite al mese, oggi ne produce quantità assai più ragguardevoli sia pel Min istero della guerra che pel commercio .
sostanze sperimentate, e giunse ad incorporare il doppio del suo peso di nitroglicerina senza perdere il suo aspetto granuloso od assumendo tutto al più, dopo l a compressione, una consistenza leggermente pastosa. Il miscuglio dei due acidi azotico e solforico era collocato in una cassala di fer ro smaltato, sostenu ta per due orecchioni, entro una vasca ripiena d'acqua mantenuta fredda con ghiaccio. La glicerina, contenuta in apposito recipiente soprastante alla cassula ora detta, veniva condotta in filo esile e regolato da ch iavetta di vetro, a mescolarsi con gli acidi, nella proporzione di circa un quarto. Ad evitare il pericolo d'esplosione causato dal con sid erevole calore svolto dalla nitroglicerina in formazione, si raggiungeva l'intento di mantenere l'acqua della vasca sempre al di sotlo di 20° cent.-, .mediante un ingegnoso termometro elettri co a suone ria d' allarme, la quale indicava appunto quando la temperatura era per superare i 20° cent. - Ed allora si interrompeva il getto di o-licerina, ovvero sì rinfrescava il. bagno rinnovando °r acqua ed aggiungendovi ghiaccio . Se questi mezzi riuscivano insufficienti e si temeva esplosione, si rovesciava nel bagno la cassula girevole intorno agli orecchioni.
Il miscuglio veniva agitato, duranle la reazione, o c ol mezzo di agitatori a µalette di legn o, mossi da un meccanismo simile a quello degli orologi, o mediante ventilato ri che inietlavano una corrente d'aria attraverso il liquido contenuto nella cassula.
Terminata la reazione il liquido e ra versato nel.I' acqua: - la nitroglicerina come più pesante condensavasi nel fondo della vasca e la si estraeva po i mediante decantazione. Era in seguito lavata con una soluzione alcalina finchè la carta di tornasole non accusasse più traccia alcuna di acidità - ed in ciò si poneva la massima importanza per evitare esplosioni
• 8i DEL FULMICOTONE
E DELLE DINAMITI 83
spontanee della nitroglicerina durante il successivo as. sorbimento della nitroglice rina stessa. - Questo assorbimento facevasi poi disponendo la cenere di carbone sopra un foglio di piombo laminato e terminato tutto allo ingi rn con orli alquanto rilevati.
La quantità voluta di nitroglicerina veniva versata sopra lo strato di cenere, ed incorporata fino a perfetta omogeneillt mediante una spatola di vetro. La dina,. mite così preparata veniva per ul timo compressa e racchiusa in cartuccie di pergamena e scatole di zinco.
Prova deÙe d inamiti.
Indicato il processo di fabbricazione, è mestieri in~ dicare eziandio quali sono i metodi di pro va che valgo no a constatar e il valore relativo di una dinamite.
11 capitano del genio francese Ji'ritsch indica alcuni me todi che servono a valutare assai esatLamente una dinamite a bas e silicea, quando -non "si voglia o non si possa ricorrere all'anali si chimica (1).

Tali metodi di prova sono ,i seguenti:
Saggio di neutralità;
Valutazione del titolo di nitroglicerina;
Valutazione della purezza e del potere assorbente della silice;
Valutazione della forza esplosiva .
(~) L'opera del capitano signor FRITSCll fu inserita non ha guarì nel « .Mèmorial de l'officier du génie »· ed ba per titolo « Les Dynamites , étude théorique et pratique de quPlques poudres bri.santes dérivées de l'azote ». In mancanza di tale opera, potemmo ad ogni modo indicare i metodi di prova in questione, desumendo li dalla « Revue d'a1·tillerie, septcmbre 1875 > ove il capitano d' artig!ieda signor BoMnAno li riportava nella sua Nota « Des .àynamites et de leiw s applicatfons dans l' artillerie > .
Saggio di neutralità . - Si fa passare a più riprese fra la dinamite una striscia di carta tur c hina di tornasole, umettata con acqua distillata. La minima traccia di coloramento nella carta, indica che la nitroglicerina non fu lavata abbastanza, o vvero ch'essa comincia a decomporsi.
Valutazione del titolo in rnit·rogHcerina. - Si pesano con esattezza una- ventina di grammi di dinamite, e poi si abbruciano sop ra una lamina m etallica ben forbita . .li residuo - che deve essere silice puraè pesato, e la differenza delle due pesale darà il peso di nitroglicer-ina, che per una dinamite normale non deve esere inf'eriore a 72 per cento. Potrebbe evidentemente eseguirsi la stessa valutazione, facendo disciogliere la nitroglicerina in un suo dissolvente - l'alcool, l'etere, la benzina, ece . - e pesare in seguito il Ms id uo , previo ess iccamento.
Valutazione della purezza e del potere assorbente della silice . - Si rompe in due l'invoglio di carta di qualche cartucc ia. Il colore della rottura deve essere uniforme, ed il fianco su cui la ca rtu ccia riposava non deve avere apparenza più grassa : - giammai poi devesi scorgere la più piccola traccia di gocciolelle di nitroglicerina. - Bruciatu una cartuccia, la silice residua deve avere l'aspetto cli una polvere quasi bianca, farinosa ed a geani finissimi.
Valutazione della fo1·za esplosivci. - Ne dà già una · idea il titolo in nitroglic e rina. Interessa tuttavia averne prova diretta perchè sostanze combustibili e meno esplos ive possono trovarsi mescolate alla nitrogl icerina. La prova diretta indic ata dal capitano Fritsch, è quella prescritta in Austria, e consistente nell'esame de lle dimensioni e della forma di un foro prodotto da una data cartu ccia esplosa liberamen te per m ezzo di ap~ posita cartuccia di accensione, su di una lastra me~
84 DEL ~'ULMICOTONE
--- ------------------
E DEf, LE DINA~IlTI 85
tallica. Questa lastra metallica è di ferro fucinato, di circ a om ,46 di lato e 001 , 0066 di spessore, sorretta da due piedi in legno . Nel mezzo di essa lastra si dispone una cartuccia di om,019 di diametro e om,02.0 soltanto di altezza. La cartuccia d'accensione è di peso e composizione determinali. Il buco che l'esplosione pro. duce nella lastra deve avere da om, >IO a om, '13 di diametro, ed i labbri devono esser tag liati- netti., o fortemente ncurv1.
Applicazioni della dinamite a Parigi nel 1871.
Certamente la facollà assorbente della cenere di c arbone impiega ta, essendo come dicemmo minore di ,quella del J(ieselgulw, la dinamite francese era men o potente - a parità di peso - della dinamite Nobel :ad ogni modo però rese ingen tissimi servig i ai Francesi che durante l'assedio di Parigi la impiegarono per moltissimi e svariati scopi, e principalmente pe' seguent i:
Per abbattere alberi 01Jde improvvisare grosse barricate.
Per aprire istantaneamente e contempornne am enLe·,12 breccie nel muro di cinta dèl p arco Ruzenval, in occasione della sortita del ,J 9 gennaio.
P er rompere per un trauo di quasi 2 chilometr i il ghiaccio della Senna e liberare così alcune cannoniere che erano state imprigion a te dal ghiaccio stesso.
Per mettere le artiglierie fuori di servizio.
Per atterra re istan taneamente porle di edifizi, gli edifizi stessi, i ponti sì in muratura che in 'ferro, ecc.
Finalmente pe r la pesca dei pesci nella Senna, quando fecero difet.to gli alimenti . Per tale pesca. bastava collocare sott'acqua fiiccole cartuccie di dinamite, che si facevano esplode r e dalla sponda pei· mezzo dello elet-
tncrsmo, al ·momento opportuno. Dopo l'esplosione i - pesci tramortiti vedevansi galleggiare in un raggio considerevole di fiume. SiffaLto genere di pesca è in oggi proibito perché vuolsi che se per caso i pesci inghiottono i gaz della esplosione riescono avvelenati e velenosi .
Anche dopo l' assedio, la dinamite rese a i Francesi importantissimi servigi . I p-onti fatti saltare ne ll' interesse della difesa, ostruivano co n le loro macerie, composte di grossi massi' di muratura e di ferro, il corso della Senna. e della . ~Iarna . Alcun e mine di dinamite frantumarono quei massi in modo da rendere facilissime le successive operazioni manua li per lo sgo mbro cli detti fiumi. Al ponte di Clichy, ad esemp io, due archi di ghisa, cli quasi 7om di corda , ostruivano il corso del fiume: - bastarono poch i sacchi di te la di vela, ripieni cli dinamite, ed esplosi ne ll' acq ua sotLo quelle pesanti masse , per ridurle in frantumi.
Al giorno cl' oggi si annoverano in Francia diverse fabbriche di dinamite, sì private che g ov erno ti ve. Un decr eto presidenziale del 311 maggio 1873 stabilisce per le varie qualità di d inamite che sono messe in comm ercio <lai dinamitifici governativi, i prezzi seguenti :
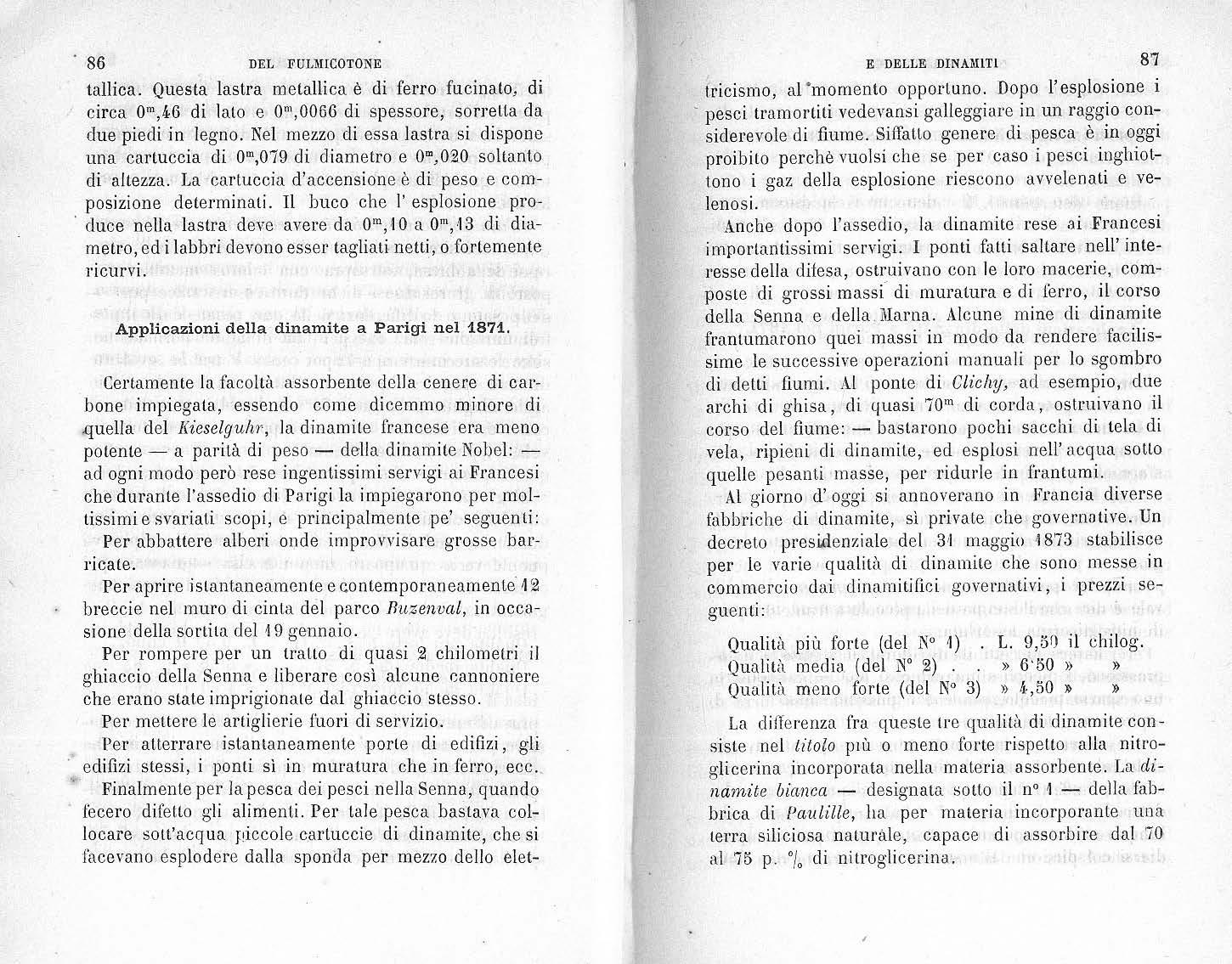
Qualità più forte (del N° 1)
Qualità media {del N° 2) .
Qualità meno forte (del N° 3)
L . 9,50 il chilog .
» 6 ·50 » »
» 4,50 » »
La differenza fra queste tre qualità di dinamite consiste nel titolo più o meno forte rispetto alla nitroglicerina incorporata nella materia assorbente . La dinamite bianca - designata sotto il n° 1 - della fabbrica di {'aulille, ha per materia incorporante una terra siliciosa naturàle, capace di assorbire dal 70 al 75 p. °lo di nitroglice r in a .
\. 86
DEL FULMICOTONE
E DELLE DINAMlTl 87
Recenti perfezionamenti introdotti nelle dinamiti..
Dopo lutto quanto s i è dello circa le dinam i ti, ed in procinto d'indicare sommariamenle qual sia la dinamite che si fabbrica nel noslro paese, sarebbe prezzo dell ' opera ind agare i mezzi adalli a p erfezionare un preparato di g i à tanto potente. Se non che, gli studi e gli esperimen li fatti in proposito essendo poco conosciuti e la maggior parte non pet anche di pubblica ragione, ci li miteremo ad esporre soltanto quelle conclusioni ch e ci crediamo aut orizzati a lrarre dall'esame di quanto potemmo sinorn raccogliere.
La materia incol'porante della nitroglicerina, per adempiere convenienternente al suo scopo, deve soddisfare alle principali condizioni seguenti:
a) Fra due dinamiti, a parità di peso e di altre circ0stanze , la più potente è senza dubbio que ll a Ja cui materia incorporante h a potere ass'1rbente maggiore; - prima di tutto dunque questa materia incor'porante deve possedere un potere ass01·bente grandiss i mo, va le a dir e che i l suo peso s ia piccolo a fronte del peso di nitroglic erina assorbita; ·
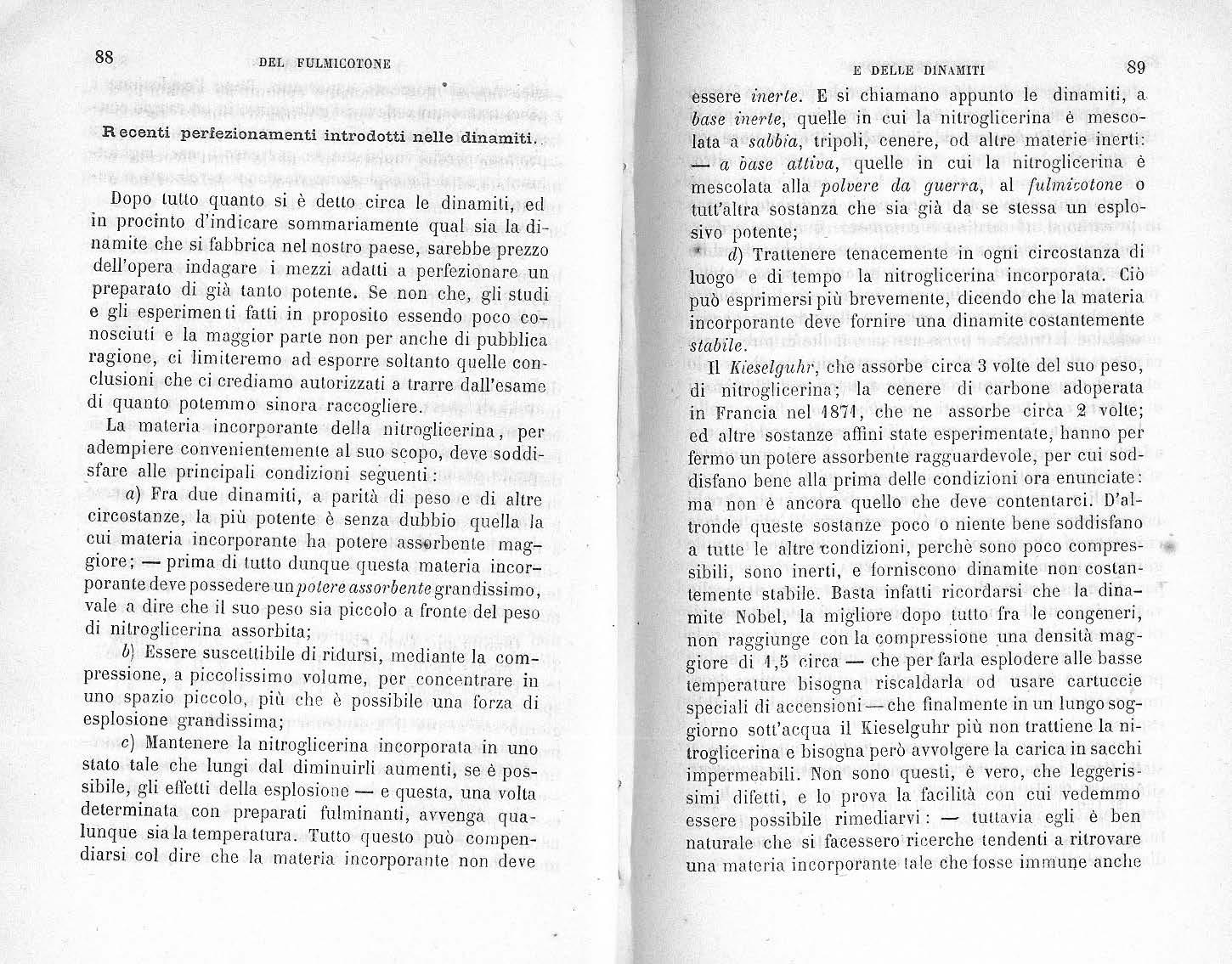
b) Es sere susceuibile di ri,dursi, medi ante la compressione, a piccolissimo vo lu me, per conce ntrare in uno spazio piccolo, più che è possibile una forza di esplosione grandissima;
e) Mantenere la nitrogli cerina incorporata in uno stato tale che lungi dal diminuirli a umenti, se è possib i le, gli effetti della esplos ione -e questa, una volta determinala con preparati fulminanti, avvenga qualunque sia la temperatura. Tutto questo può compendiarsi c ol dire che la materia incorporante non deve
E DELL E DINAMITI 89 essere inerte. E si chiamano appunto le dinamiti, a. base in er te, quelle in cui la nitrogliceri na è mesc olata a sabbia, tripoli, cenei·e, od altre materie inerti:
- a òase attiva, quelle in cui la n itroglicerina è mescolata alla polve re da guerra, al fulmir;otone o tutt'altra sos tanza che sia gi à d<!. se stessa un esplosivo potente; _ .
• d) Trallenere tenacemente in ogni circostanza d1. luogo e di tempo la nitroglicerina incorporata . C!ò può e sprimersi più brevemente, dicendo che la matena incorporunte deve fornire una dinamite costantemente -stabile.
Il /(iese.lguhr, che as s orbe circa 3 volte del suo peso, d i nitro g lic erinu; la cenere di carbone adoperata in Fra ncia nel 187 · 1, che ne ass orbe circa volle; ed ultre sostanze affini state esperimentate, hanno per fermo un potere assorbente raggua rdev~le, per cui soddisfano b ene alla prima delle condiziorn ora enunciate: ma non è ancora que llo che deve contentarc i . . D'altronde ques te sostanze pocò o niente bene soddisfano a tutte le altre ·condizioni, perchè sono poco compressibili, sono inerti, e forniscono din am ite non co~tanlernen te stabile. Basta infatti ri corda rsi che la dmamile Nobel, la migliore dopo tutto fra le congeneri, non l'aggiunge con la compress ione .una densità maggiore di 11,5 drca - c he per farla esplodere alle bas~e temperature bisogna riscaldarla od 1:1s.a re cartucc1e speciali di accensioni-che finalmente m un ~ungoso~g iorno sott'acqua il Kieselguhr più non lr~tt1e_ne l a 111 ~ t roO'licerina e biso.rrna però avvolgere la canea IIl saccln o o . . imperm eabili. Non sono quest!,. vero, cl~e l egge nssimi difetti, e lo prova la fa cilita con cm vedemmo essere possibile rimed ia1·vi : - tulla via eg li. è b en naturale che s i facessero ·ri ce rche tendent1 a ritrovare una rnalcria in corp orante tale che fos se i mmun e anche
88 DEL FUUI1CO'l'ONE
daqueileggerissimi difetti. Tali ricerche però non furono in s ul principio troppo felici. Jn Prussia ad esempio si propose il litofraltore ed il cl-ualino. Il litofraltore non è altro che la dinamite Nobel a cui si aggiunge ll'Ìtro, solfo e carbone (18 circa per °lo fra tutti e tre), cioè g li elemimti della polvere ordinaria con grande eccesso di carbone. 11 dualino è corrrposto di nitroglicerina, segatura di legno e salnitro. Si riconobbe però subito che tali composti erano poco potenti e poco stabili : - l'unico vantaggio che presentavano e ra di esplodere a qualunque bassa temp eratura . Nell'ultima campagna, sebbene i Prussi ani avessero seco il litofrattore, pure non vollero impi egarlo che in rarissimi casi,. e solo per distruggere grosse bocche a fuoco trovate nei forti di Parigi. (1) Le dinamiti pirossiliche, sono forse quelle la cui materia incorporante -il pirossile-soddisfa eccellenternente a tutte le condizioni dianzi accennate. Es~e ~erò costano eccessivamentè, ed il loro impiego qumdt n on può ragionevolmente estendersi ch(a pochi casi ecc~zionali, com e ad esempio quelli g ià altrove accennati. Potranno per. avventura trovare un util~ impiego anche nelle torpedini (2).
In questo stato di cos e, e mentre in allesa di meglio l' impiego delle dinamiti a base inerte sì. estendeva rapidamente nei vari paesi, gli studi atti a rintracciare la .materia incorpora.nte migliore si continuarono ,e sembra con esico felice. In quesli ultimi anni infatti si esperimentarono certe sostanze organiche (3) che si addì- -
(1) In Francia la dinamite gri uia di Paulille, e quella nera di ,ll. Martel, hanno costituzione e proprietà analo ghe al litofratto1·e, e sono da rigettarsi assolutamente.
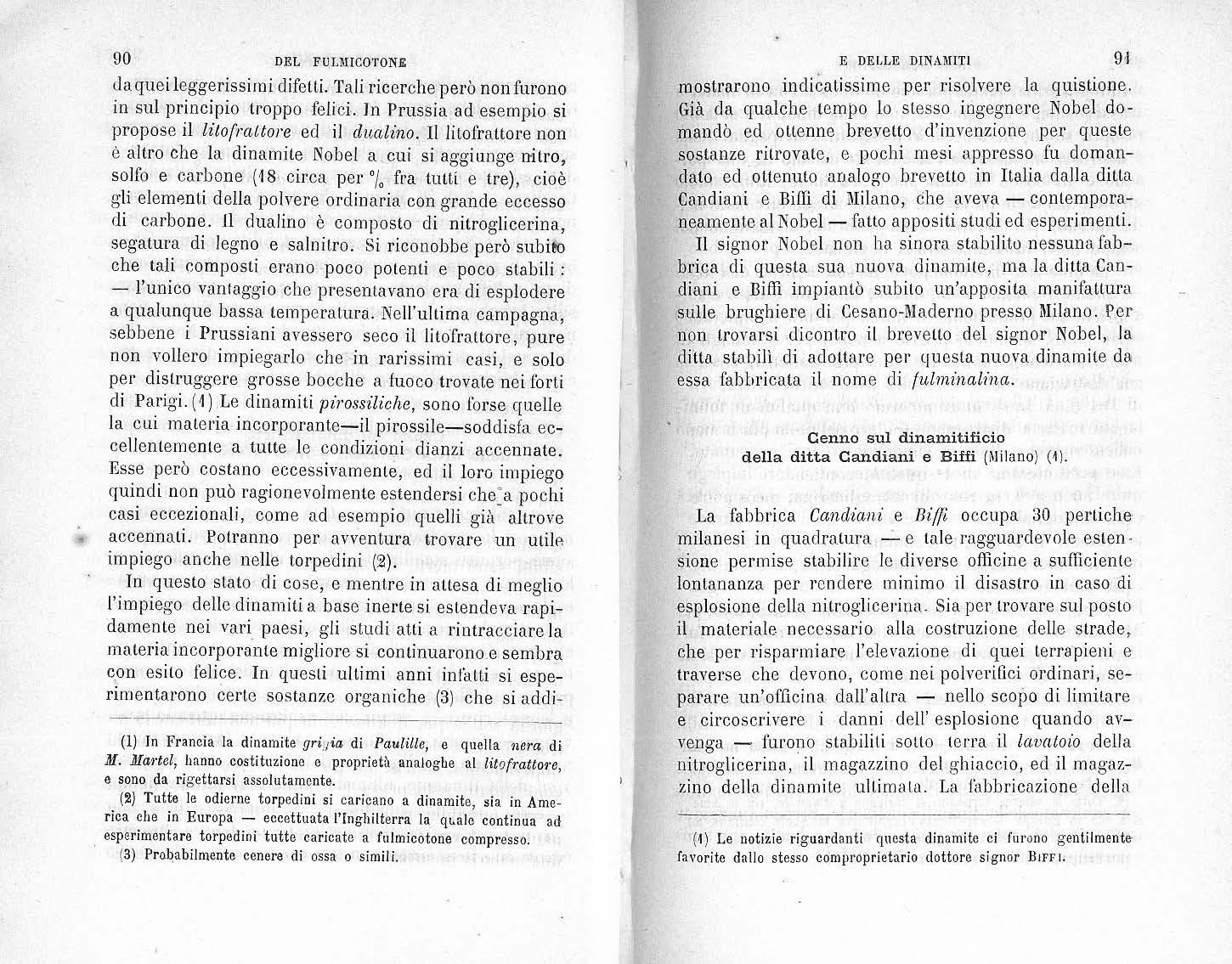
(2) Tutte le odierne torpedini si ca ricano a dinamite, sia in America che in Europa - eccettuata l'Inghilterra la qt.ale continua ad esperimentare torpedini tutte caricate a fulmicotone compresso.
(3) Pro.qabilmente cenere di ossa o si mii i.
mostrarono indiéatissim e per risolvere la quistione. Già da qualche tempo lo stesso ingegne r e Nobel domandò ed ottenne brevetto d'invenzione per queste sostanze ritrovate, e pochi mesi appresso fu domandato ed ·ottenuto analogo brevetto in llalia dalla ditta Cnndiani e Biffi di Milano, che av eva - contemporaneamente al Nobel - fatto appositi studi ed esperimenti. Il signor Nobel non ha sinora stabilito nessuna fabbrica di questa sua nuova dinamite, ma la ditta Candiani e Biffi impiantò subito u n'apposita ma nifattura sulle brughiere di Cesano-Maderno presso Milano. Per non trovarsi dicontro il brev ello del signor Nobel, la ditta stab ilì di adottare per questa nuova dinamite da essa fabbricata il nome di fulminaHna .
Cenno sul dinamitificio della ditta Candiani e Biffi (Milano) (~).
La fabbrica Cand-iani e Biffi occupa 30 pertiche· milanesi in quadratura __:_ e tale ragguardevole eslen , sione permise stabilire Je diverse officine a sufficiente lonlananza per rendere minimo il disas(ro in caso di esplosione della nitroglicerina. Sia p er .trovare sul posto il materiale necessario alla costruzione delle strade, che per risparmiare l'elevazione di quei terra-pieni e traverse che devono, come nei polverifici ordinari, separare un 'offic ina dall'altra - nello scopo di limitare e circoscrivere i danni del!' esplosione quando avvenga - furono stab iliti sollo terra il lavntoio della nitroglicerina, il magazzino del gh iacc io, ed il magazzino della dinamiLe ultimata. La fabbricazione dell a
90 DEL FULl\IlCOTON!l:
E DELLE DINAMITI 94
(1) Le notizie riguardanti questa dinamite ci fur ono gentilmente· favorite dallo stesso comproprietario dottore signor Birri.
DEL FUL)f[COTONE
n it rog li ceri na, l'incorporarnento di essa con la materia assorbente, e l'impacco ulti mo dèlla clinamiLe, si fanno s~pr~ su?lo, i n laboratori [costrutti con paglia. NeJla ~1str1bu~1.0ne dei locali si è te nulo calco lo di una porz10ne eh bosco esisLent~ nella br ughiera; utili zzand olo come una seconda d ifesa . Diverse strade circol ano nel1' interno , pel servizio del la fabbrica , e mettono poi capo nell a prossima strada comunale .
La ditta trae d irettamente da lla sua fabbrica di ( A.cidi prodotti cMmici )> in Milano, gli acidi nitrico è solforico. la produzione si limita per ora a chil. 3600 per r1:1ese_, seguendo presso a poco, per i _ dettagli di fabbncaz1one , quanto fu detto più i nc!ielro, circa la .fabbricazione de lla d ina mite francese nel 187•1.
La ditta pone in commercio due qualità di fullbinalinv ,. che si disti nguono fra loro pe l til olo più o meno forte n s peuo alla n itrog licerina.
La fulminalina di ,1a qualità, contiene :
80 per 0 / 0 in peso di nitroglicerina, e cos ta lire 8 ·pe r chilogrammo, •
Quella di 2a qualità cont{ene:
60 per 0 /o in peso di nit ro glic erina e cos ta lire 6 per chilogrammo , '
Ra~menta.ndo .i _rrezzi che altrove indi cammo, per le odierne dmam1t1 francesi, si ca pisce come Ja folm inalina m ilanese possa fare una vantaggiosissima
.,concorrenza alla merc e estera .
Si spacc ia · in cartuccie a bossolo di pero-amena del d . a· l:> , iametr o 1 ·I 5 mill . e delta lunghezza di 40, e mo mili. Sembra che riunisca tutti i pregi che . poco fa indican~mo :-lo ve r possedere una dinamite perfezionala .
Ed rnfalll - sos tiene il signo r Biffi - la fulminalina a con_fr onto deJla dinarrrile ord inaria, pres e nta magg ior e nergia no n solo , ma può esplodere a qualunque temperatu ra, _ ed è costantemente stabile,
. Un leggerissimo difetto, osservato da qualche minatore, è questo, che allorquando la fulminalina viene impiegata in galle ri e da m in a chiuse, lascia un odore alquanto incomodo. Ma la ditta, uppunto per le galler ie cJ1iu$e, p r epara nella sua fabb r ica un a d inamite a base inerte che non presenta affatto i l legger 0, difetto accennato, e che viene falla non con sostanze organiche ma con sostanze mineral i assai assorbenti, che lro vansì - sebbene con difficollà _:, nel paese. La nostra inclusi.ria priva ta, prima che la manifattura Biffi e Candiani fosse ap(ita, t raeva la dinamile dalla Francia e dal!' Austria: - non era stata per allro adope-rata in grand i lavori di costruzione tranne c he allo scavo della galleria del ì\'leschio (ferrovia Genova -Spezin) sotto · la direzione dell'ingeg nere s igno r Faust i no Anderloni. In oggi, lo srnercio della fu'Jrninalina sr è ,rapidamenteestesb, g iacché viene adope ra ta da quasi tutt i i nos tr i ·costrutlori (1) . -
L'eserci to nostro non ha fi no ad ora adottato regolamenlarmente la dinamite : s embr a però che, ad esemp io del gen io austriaco , anche il nostro ge nio m ilitare sarà fra non molto mun i to di cartuccie e seatole di dinamite.
Conservazione e trasporto delle dinamiti.
La conservazione dell a dinamite nei magazzini può dirsi scevra affatto di pericoli, e non r ichiede tutte quelle cure e precauzioni prescritte n ei magazzini di
(l) Si farà facilmente sentire ben presto il bisogno di un dinamitifìc io anche nel mazzogiorno d'Italia - presso Napoli, ad esempio, ed in Sicili a. - Le pomici de' nostri vu lcani, potranno forn iresi può dire sul posto - una matc1 ria inco rporante eccellente - almenoper dinamiti ordinarie a base inerte.

'92
> E DELLE DlNAllI!Tl 93.
•
polvere ordinaria . Basta infatti che il magazzino sia ben e areato, e ripar ato con parafulmine .
Anche il trasporto per via ordinaria, per acqua o per ferrovia, può dirsi s.cevro di pericoli , e n on rich iede cure troppo diverse da quelle che si hanno per una merce qualu nque. Dal 1° gennaio 4868 al '15 maggio -1870, solo in Germani a, circa 500,000 chi!. di dinamite percorsero la distanza complessiva di 450,000 chilometri . Centinaia di quintali forono trasportati per mare in climi caldissimi, e le ferrovie svedes i trasportano continuamente la dinarpite, in stato di congela' zione : - mai si è verificato sinora il più piccolo disastro.
Nei lunghissimi trasporti l'unica precauzione consigliata è quella dì imballare le cartuccie di dinamite entro cassette di legno chiuse, riempiendo tutlo al più con segatura di legno gli interstizi lasciati vuoti tra cartuccia e cartuccia.
Nel nostro paese però, fino al giorno ·d'oggi, furono prescri( te, pel trasporto delle dinamiti, le stesse precauzioni e norme che sono in vigore per la polvere ordinaria. Ci consta tuttavia che la direzione delle ferrovie clell' Alta Italia, ad esempio di ciò che pratic asi all'este ro, stabilì, non h a guarì, convenienti norme che, fac ilitando appunto il trasporto delle dinamiti sull e sue linee, più non incepperanno l'industria con precauzioni inutili o per lo meno eccessi ve .
c. CO tWETT I Tenente d'artiglie ·1'ìa.
Nota A.
Il capitano ,signor BOMDARD, trattando nella llevu e d' a1·tillerie (agosto e settembre 1873) delle dinamiti e delle loro applicazioni nell' artiglieria, riporta in apposita nota l'estratto di certe esperienzf\ esegui te dai signori .Rouco e Sar1·au , comunicate ali' Accademia delle scienze il '.28 aprile 4873 e pubbli cate poi nel resoconto settimanale delle sedute (Tomo LXXVI, N. 17). Sono interessanti s enza dubbio le sen·uenti considerazioni, tolte appunto dall'estratto ora 8etto , e riguardanti gli effetti clella esplosione delle dinamiti:
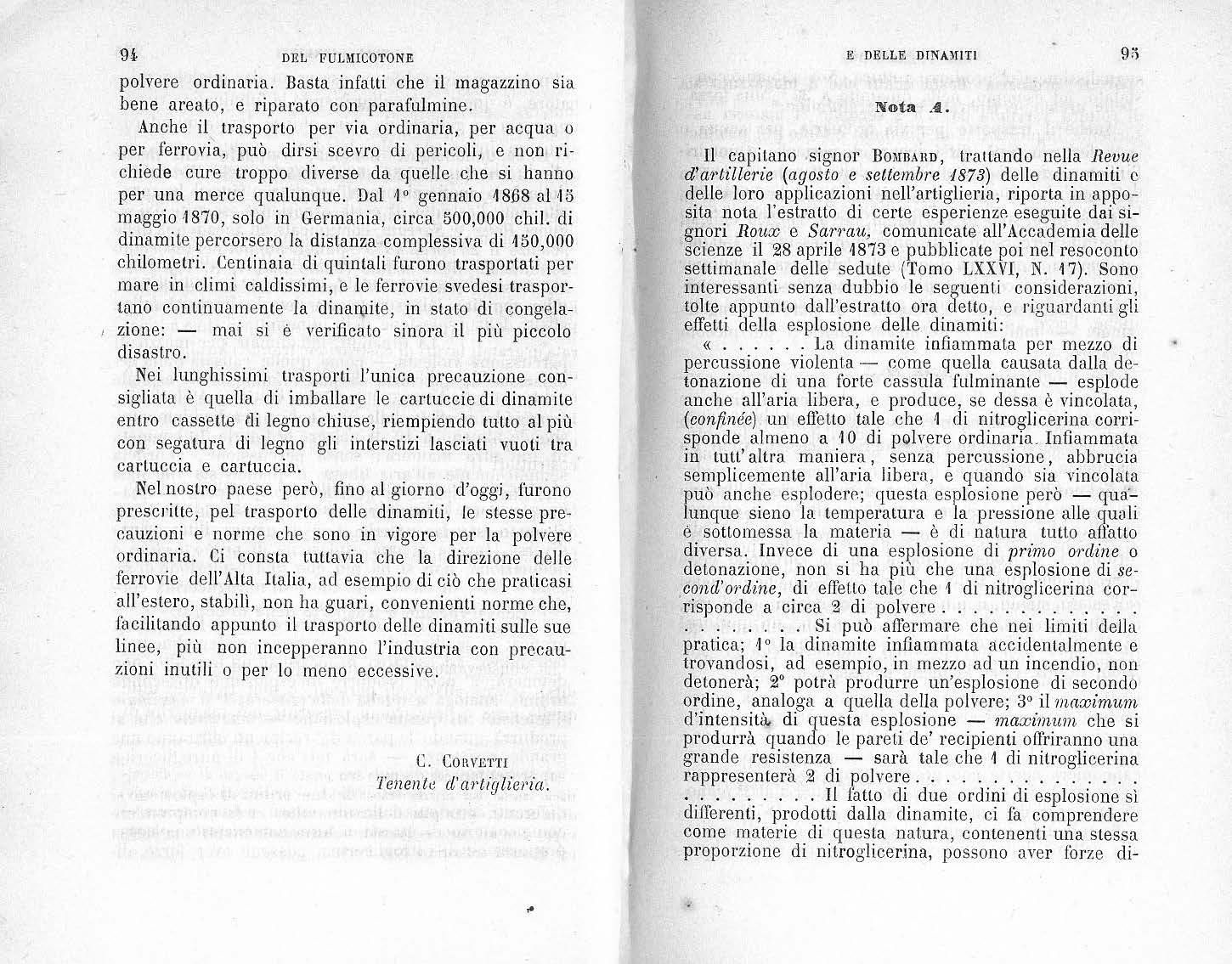
« . . .... La dinamite infiammata per mezzo di percussione violenta - come quella causala dalla d eton a zion e cli una forte cassula fu lmi nante - esplode anche all'aria libera, e produce, se <lessa è vincolata, (confinée) un effe tto tale che 1 di nitroglicerina corrisponde almeno a 1 O di pol vere ordinaria, Infiammata in tutt'altra rnaniern , senza percussione, abbrucia semplicemente all'aria libera, e quando sia vincolata può anche esploderr.; questa esplo sione però - qua·lunque sieno la temp e1:atura e I~ pressione alle q,uali è sottomessa la ma teria - è di natura tutto affatto diversa . Invece cli una esp losione di primo orcline o detonazione, non si ha più che una esplosione di se.cond' 01,dine, di effeLlo tale che ,1 di nitroglicerina corrisponde a circa 2 di polvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sì può affermare che nei lirn.iti della pratica; 11° la dinamite infiammata ac cidentalmente e trovandosi, ad esempio, in mezzo ad un incendio, non detonerà ; 2° potrù produrre un'es plos ione .di second o ordine, analoga a quella della polvere; 3° il 1naximum d'i1ntensit& di questa esplosione - macvinium che si produrrà quando le pareti de' recipienti offriranno una grande res istenza. - sarà tale che 1 di nitrogl i ce rina rappresenterà 2 di polvere . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . II fatto di due ordini di esp losione sì differenti, p~·odo_tti dalla dinamite, ci fa c?mprendere come rnaterre di questa natura, contenenti una stessa proporzione di nitroglicerina, possono aver forze di-
9i, DEL FULMICOTONE
,. E DELLE DINAmTI
. . . . .
sugualissime per pro durr e rottura. No i abb iamo constatato, ad esempio, nella dinamite a 3 0 °/0 una. forza di rotLura va riabile da 11 a 2 second o la materia assorben le im p iega la. Una d in amite tanto più po te nt< i quanlo è più facile ad infiammarsi per urto . . Quando l'infiammazione è facile, l' effe lto della percussione pr?dou a dal fu lmin a to si tr asm eue immedia tamente rn tutta la massa: tale é il caso di dinamiti preparate con sabbie quarzose. Qq~ndo al contr~ri? la so~ tanza è diffici le ad in fiamma r s i pe r urto, 1 az10n e s1 tr asmette incompletamente, una parte sola de lla ~nassa. del?na, il r estante aaisce per esplos10ne semplice . 81 ~tl1e ne questo efl'eltg con dinami ti preparn Le con rnatene plas tiche, l' ocra ad escm pio. . . . . . . . . . ».
Nota B.
Il capitano signor Bo11DARD, 1:1ell.a s~a pubbli c_azione citata nell a No ta preced enLt, m d1ca Il pr ocedunento tenuto n ella difesa di vill aggi per aprire co n la dinamite una comunicazione tra clue case vic ine . Attaccando ad una cord ice lla, a qualche centimetro l'una dall'altra, 60 car tuc cie ( 4 chi logr ammi ùi di nami te) s i ottiene una filza che sospesa pel' le due estrem ità a chiodi distanti om,50 fra loro ed 11m,80 da l suolo, por la la sua cu rv awra interiore a 0111 ,80 c ir ca dal pavime nto. L'effetto dell'esplosione essendo esseozialmenLe locale e non estendendosi più ùi 25 a 30 centim . <lall'uoa e l' altra parte del !~ t:ar tucc ie, s i otti en e un'a pertur~ di 1 m 30 a ,1m,50 d1 allezza, sopra 11 mP.tro circa d1 larrrh;zza, e tutlo ciò senza distrugge re il pavimen to . Ou~sto ri su ltato - osser va il s ignor .Bombartl - è tanlo più importan te in quan to cl1 e s i cerca quas i sempre di comunicare fra i piani superiori., e la dis truzione dei pavimenti cos tituirebbe un os tacolo seriss imo p er la circo laz ione. Ci ta poi l' esem pio d'una cannon iera aperta co n procedimento analogo, per un pezzo da 4 da mo.ntagn.a p~sto in hatt ~ria al 2° piu no di una casa del v1/ lagg10 d Is sy (rr: agg1 0 1187 11).
E
DELLE DINAMITI
11° Basta i ch ilogrammo di d ina mi te e ntro l'an im a, ed 1 chilogeammo sull a vo la ta, per porre un pezzo da campagna fuori di servizio .
2° J1 b ronzo può esse re defo rm ato entro un largo li mite , senza produrre scoppi pericolo s i, ma la ghisa e sopratutto l' acciaio danno scoppi pericolosissimi per poco che si forz i la car ica e ch e s ia s orpassato il li mite di elast icità.
3° È sempre vantaggioso, quando la carica è posta en lro l'anima, di otturare la bocca con un tappo di legn o o di argilla, ovvero con qual che zolla.
Fa pel' ultimo sapere il capitano .13ombard che per ordine del Minislro della guerra, si fecero nel 1872, alla direzione di Bennes, appo s ite esperienze per fraziona r e in pezzi di peso medi o e fa cile trasporto, le nocche a :ruoco in ghisa riformate. La commission e in c1:1ricata delle esp erienze concluse che per econ omia e s icu1:ezza con vien e rompere i pezzi di un so l colp o, e che la carica di rott ura pu ò essere calcolala p er mezzo della formola : ·
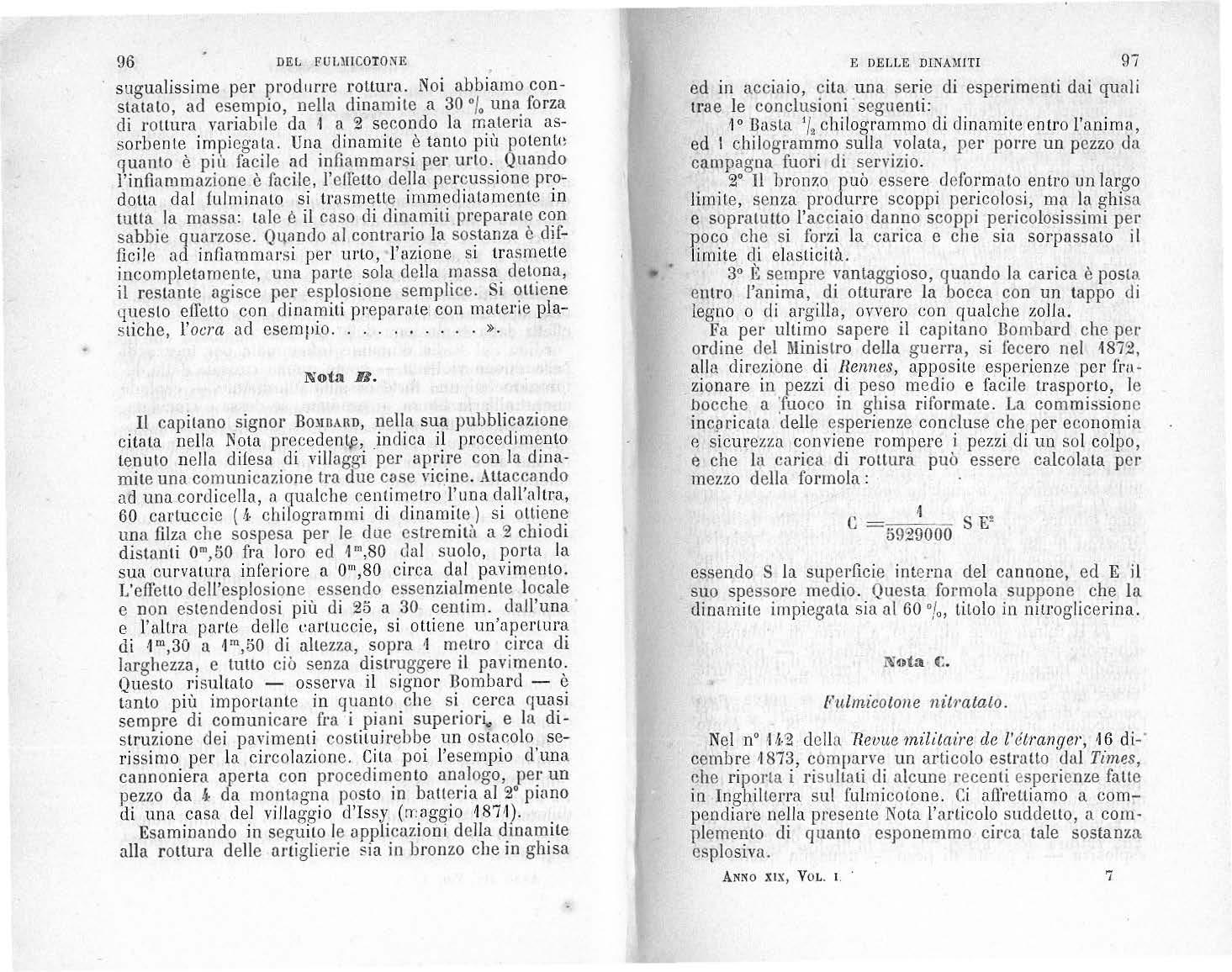
essendo S la superficie interna del cannone, ed E il suo spess ore medio. Questa formola suppon e che la dinamite impiegata s ia a.l 60 °/0 tito lo in ni tr ogl ice rin a .
Nota C.
Fulmicotone nit1·atato.
ANNO XIX, V OL. I 7
96 DEL FUU!JCOTONE
Esam inando in segu ito le applicaz ioni de ll a dinamite all a rottur a delle artiglierie sia in b ronzo che in ghisa 97
ed in acc1a10, cita una serie di esperimen ti dai quali trae le conclusioni seguenti :
Nel n° H2 dell o. B evue mi'lit ai're de l'étr ang er, 46 di- · ccmbre 4873, comparve un articolo estrallo da l Times, che rip orta i ris ulta.ti di alcune r ecenti esperi e nze fatte in Inghilterra sul ful micoto ne . Ci affrettia mo a compendiare nella presente Nota l'artico lo suddello, a complemento di quanto esponemmo circa tale sostanza. esplo siva.
Già sappiamo che il fulmicotone. non contiene nella sua molecola oss igeno ba stante per bruc iare tnlto il carbonio, ma l'intento sàrebbe ottenuto aggiungendo al fulmicotone una materia oss idante qualunque, ad esempio un nitmto od un cZ.01·ato. Il chimico Abel , dopo numerose esperienze , ha trovato che la materia add izionale più conveniente eù economica ad un tempo, è il nitro (ni lrato cli potassio), ne ll a proporzione cli 28 per cento circa . Questo sale, ridotto in polvere finissima, viene mescolato in tim amen te col cotone-polvere ordinario non per anche compresso ed imb evuto di una so lu zione satura dello stesso sale . Il misc ugl io viene in segn ito granito o compresso come il cotonepolvere ordinario.
Il ful1nicotone nitratato, così ottenuto , presenta i due lievi svantaggi di esigere per la sua conservazione d i star-e immerso in una so luzione all ungata di salnitro invece che nell'acqua pura come que llo ordinario, e di non essiccare poi così rapidamente come quest'ultimo:.in co.mpenso però, presen ta su quello OTdina rio compresso numerosi ed importanti vantaggi che possono riassumersi nel modo seguente.
a) t più duro, si rompe meno facilmente e produce minore quant ità di polverino sia nella manipolazione che nei tra sporli. - Questa durezza relativa dipende probabilm en te da ciò, che nella essiccazione il sale aggiunto al fulm icotone cristallizza e forma una specie di cemento che co ll ega intimamente le particelle tutte della massa .
b) Il fu lmi coto ne nitratato , a parità di vo lume , è superior~ per effe Lti a quello ordinario: - possiede ezia ndio maggiore stabilità, sotto l'azio ne di una forte tempera tura.
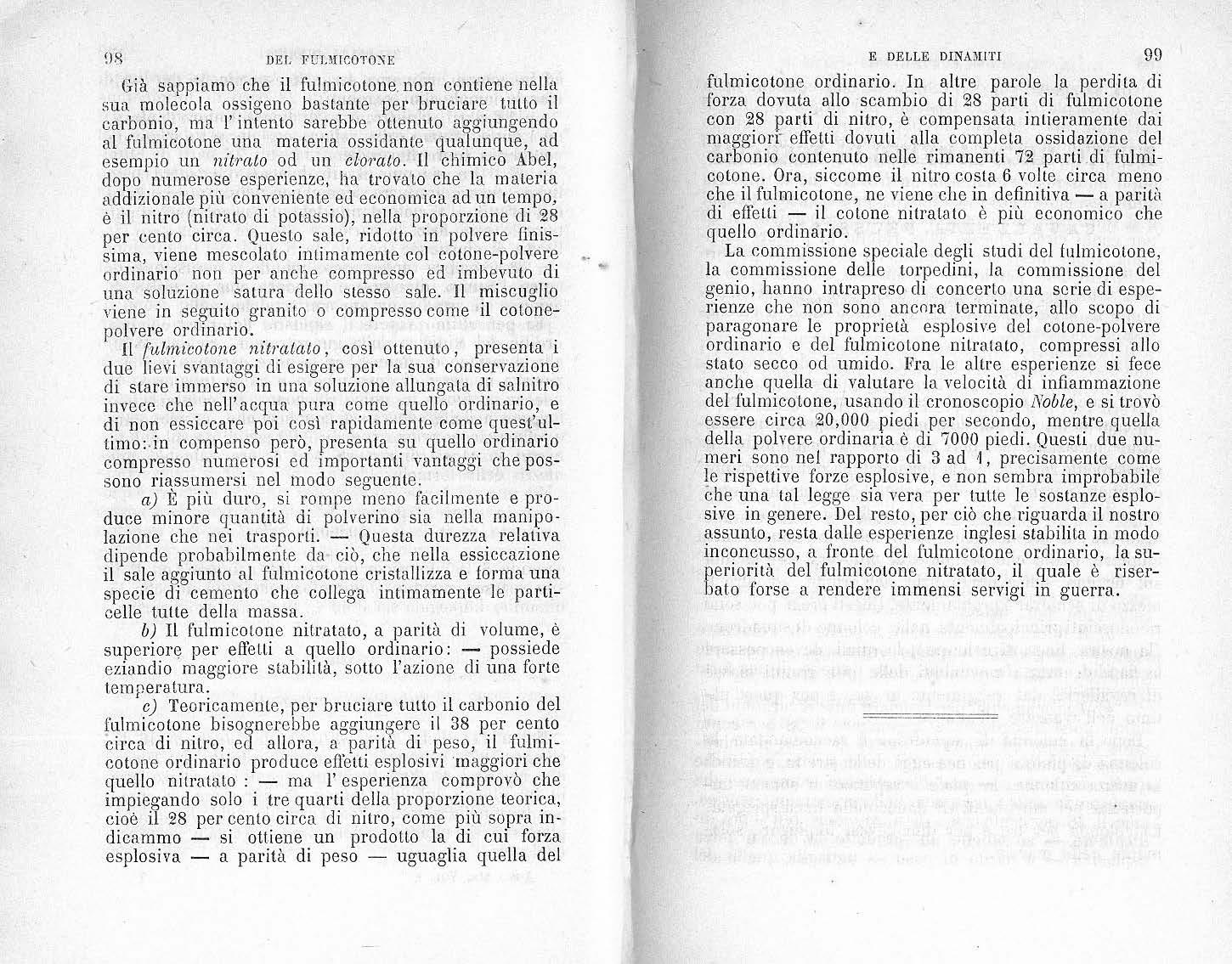
e) Teoricamente, per bruciare tutto il carbonio del fulmicotone bisognerebbe aggiungere il 38 per cento circa di nitro , ed allora, a parità di peso, il fulmicotone ordinario produce effetti esplosivi ·maggiori che quello nitratato : - ma l'esperienza comprovò che impiegando so lo i tre quarti della proporzione teo r ica, cioè il 28 per cento circa di nitro, come più sopra indicammo - si ottiene un prodotto la di cui forza esplos iva - a parità di peso - uguaglia quella del
fulmicotone ordinario . In altre paro le I.a perdita di forza dovuta allo ·scambio di 28 parti di fulmicotone con 28 parti cli nitro, è compensata intierarnente dai maggiorr effetti dovuti alla com pl eta ossidazione del carbonio contenuto nelle rimanenti 72 parti di fulmicoton e . Ora, s iccome il nitro costa 6 volte circa meno c~e il fu )mico.tone, ne vi~ne che in definitiva - a pariU1 d1 effetti - il cotone rntratato è p iù economico che quello ordinario.
La con~m~ssione speciale degli studi del fu lmicotone, la comm1ss10ne d elle torpedini, la commissione del g~mio, hanno intrapreso. di concerto una serie d i esperienze che non sono ancora terminate, allo scopo di par~gor~nre le p~opr~età esp l~sive de l cotone-polvere orclrnano e del fulmicotone mtra!ato, compressi allo stato secco od .umido. Fra le altre esperienze si fece anche quella d1 valutare la velocità cli infiammazione del fu lmicoLone, usando il cronoscopio Noble, e si trovò esse re circa 20,0.00 piedi per secondo, mentre quella della polvere ordmaria è di 7000 piedi . Questi due numeri sono nel rapporto di 3 ad ,1, precisamente come ~e r ispettive forze esplos ive, e non sembra improbabile c~e ~na tal legge sia ve r a per tutte le sostanze esplosi ve m genere. Del resto , per ciò che riguarda il nostro ~ssunlo, resta dalle esperienze inglesi stabilita in modo mconcuss o, a fronLe del fulmicotone ordinario , la superiorità del fulmico t~ ne nitr~tato,. il. 9uale è riserbato forse a rendere 1mmens1 serv1g1 m guerra.
08 DEI,
FUUHCOTO~E
E DELLE DINAM ITI 99
NUOVO REGOLAMENTO DI ESERCIZI
CAVALLERIA PRUSSIANA
La scuola di reggimento comincia con alc~ni principii generali, i quali determinano l'im portanza delle varie formazioni che può assumere il reggimento; iI rego l amento ricorda che la forma tattica più i mportante è la linea, perchè da quella seguono g li attacchi contra i l n e mico, e che l a colonna è l a: forma migliore per muovere sul Lerre no . Nelle varie colonne è considerata migliore quella che permetté di muoversi con facilità sul terreno, senza p regiudizio dell'ordine, ed offre ìl mezzo di schierarsi prontamente. Questi pregi poi sono riconosciuti principalmente nelle colonne cli squadrone ( la nostra linea di colonne), le quali devono essere 1a base di tutti i movimeq ti delle più_ grandi masse di cavalleria, dal reggimento in su, e per quest' ultimo nell'avanzare all'attacco.
Dopo la colonna di squadrone è raccomandata la colonna di ·plotoni pei passaggi delle ~tret te, e quindi la m ezza colonna, la quale è reputala cli somma importanza pei movimen(i di fianco della linea spiegata. La colonna per tre e per due devesi impiegar~ sol amente nelle marcie.
1L ,Nu ovo REGOLAMENTO 01 ESERCIZI ECC 101
In ques ta s1:iec ie d'introduzione è pure ricordato, che ne ll a scuola d i reggim ento si troveranno molte altre cfo rmaz·ioni, le quali non offrono gli stessi vantaggi, s ia per manovrare sia per muovere all'attacco; desse tuttavia hanno un valore non disprezzabile sulla piazza d'arme, come quelle che possono servire d'utile esercizio al so ldalo ne lle righe, ed al capo che dev e guidarlo .
Non è nostra inte nzione di seguiee articolo per articolo il testo prussiano, nè di ana lizzare movimento per mov,ime nlo; cercher emo invece . di r iassumere bT'evemente questa istruzione, accennando alle principali difierenze che esistono fra le nostre evoluzioni e quelle del regolamento prus siano .
E cominciando dalle varie formazioni , troviamo che mentre noi . abbiamo nove formazioni, t re in linea e se i in colonna (11) i Pruss iani non ne hanno che sette, una sola in linea, e ~ei in colo nna ·e cioè :
Ordine di battagli'a.
,J O La linea spiegata.
01·dine di colonne .
; 0 Il reggimento i n colonne di squadr one (Regiment ùi Eskad1·ons - Kolonnen , o la nostra linea di co lon ne ).
2° Il reggimento i n colonna d i plotoni (Regiment in de1· Zi(q-Kolomie) .
(1) Il nostro ord ine di battaglia comprende: ·JO la li nea spiegata 2' quella di col onne, 3° quella a scaglioai. L'ordine di colonne comprende le formazioni : -1° in co lonna di via, 2• in co lonna di plotoni, a~ in colonna do.pp ia, 4° in massa, 5• i n colonna serrata , 6° in colonna di squadroni con distanze.
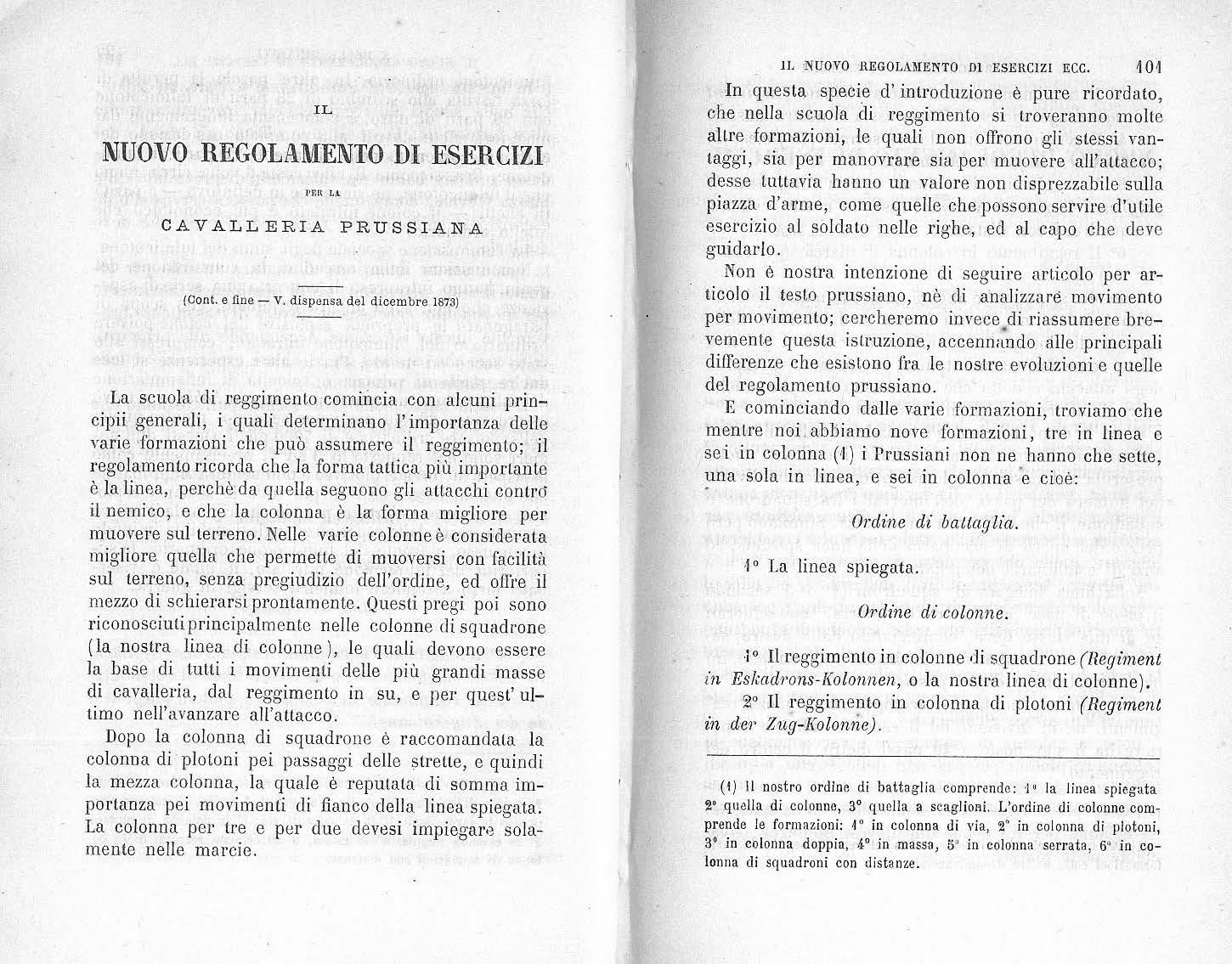
IL
P8R L1
(C ont. e fine - v . dispensa de l dicembre 1873)
l\EGOLAMENTO DI ESERCIZI
. 3° Il reggimento in colonne avvicinate (.Regiment in zusarnmengezogener-Kolonne, ossia la nostra massa).
4° Il r eggimento in colonna s errata (Regiment in geschlossenen -Begiments -Kolonne).
.. 5° Il regg!mento in colonna aperta ( Regùnent in ,qeoffneten Regiments-T<olonne, ossia la nostra colonna cli squadroni con distanza ).
6° 11 reggimento in colonna di marcia (per due e per tre) (11)
Volendo, s·i potrebbe ancora notare la mezza colonna (Kolb-Kolonne), ma. qu esta è una modificazione della co~onna di plotoni, la formaz ione a scaglioni poi non es1s~e come '.ormazione tattica , e soltanto parlando degli a~tac?h1 è detto ch e si possono eseguire anche a scaghom, come vedremo più sotto.
Circa la disposizione degli squadroni nelle differenti forrna7: ioni, diref!lo so ltan to· che è identica a quella prescritta nel nostro regolamento, con qualche divario nel numero dei passi, nell' intervallo fra squadrone e squadrone , il che è di poca i mportanza . Stimiamo però pre~zo_ dell'op_e ra di occuparci de lla linea sp iegata, ed anz , d, esam ina rla dettagliatamen te.
Nella line a spiegata gli squadroni (4 o o secondo il piede di pace od il piede di guerra) sono schierali su di ~na stessa linea, cominciando dalla destra, second o il loro numero amministrativo . L'in tervallo fr a ogn i squadrone è di sei passi.
Il reggimento poi non si scompone nè in mezzi reo·g!menli, ~lÒ in di visioni, ed il seco nd o uffi~iale sup:r10re ha il suo posto a 20 passi dietro il centro del r eggimento.
PER LA CAYAL LEHIA PllUSSIANA '108
L' allineamento si eseguisce sullo squadr one centrale, il quale resta per rego la, sal vo ordine speciale in contrario, lo squadrone di direzione . Nel nostro regolamento, quando il reggimento trovasi formato su quattro squadroni, resta squadrone di direzione il s econdo, por analogia a quanto praticusi nella scuola di s q uadrone; in quello prussiano h a sempre la dir ezi one il 3° sq uadrone.
Confrontando ques to ordinam e nto col nostro, salta no all'occhio capitali differenze, e tra queste, pri n · cip ale, quella che gli sqµadroni -hanno un posto :fisso . Secondo le nostre prescrizion i,...gli squa<ll'o ni prendono il numero, secondo il posto che occupan·o, il che natur a lme nte permette una maggior facilità di movimenti, non essendo soggetti per tal modo ad alcuna restrizione, regolandosi . secondo il te rreno, e sui movimenti del nenuco contro il quale si m.anovra . Cosl noi possiamo rompere in colonna cla qualunque squadrone, sia d' ala, sia del centro, e parimenti spiegar ci su qualun qu e squadrone, a destra o sinistra, oppure d'ambo le parti contemporaneamente sen za riguardo; ad altro che alla conven ie nza del mome nto, e a non frammischiare gli squadroni dei due di versi mezzi reggi menti. Secondo il rego lamento prussiano nulla è fattibile di tutto questo: è gi.uocoforza rompere sempre da uno squadro ne d'ala, e formarsi in linea da lla parte obbligatoria, per tro varsi nell'ordi ne normale di battag lia. Vedremo i n segu ito che si cercò di ovviare a qu es to inconveniente, ma solamente per talune formazioni.
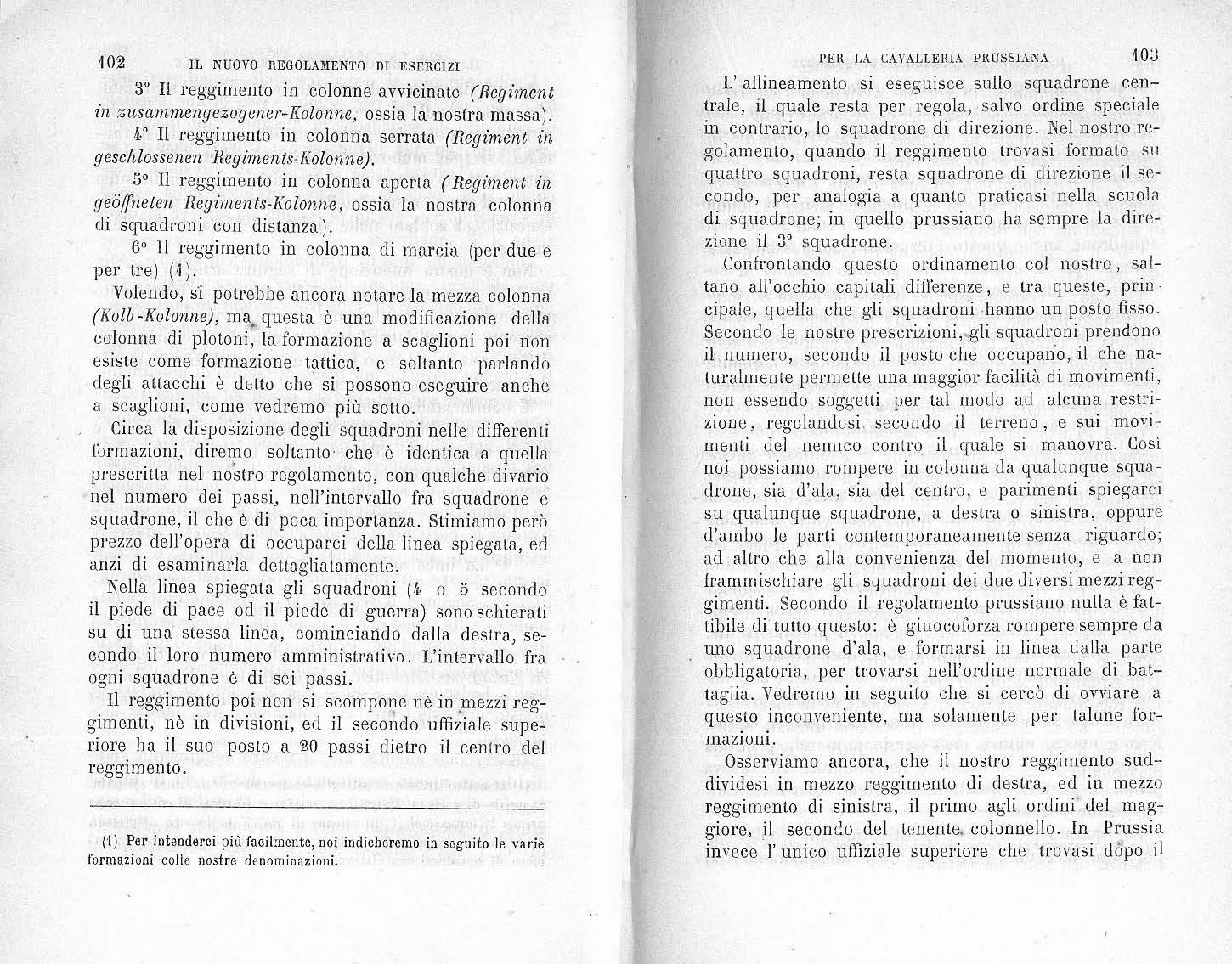
('I ) Per intenderci più facil:ne nte, noi indicheremo in sco-uito le var ie formazioni colìe nostre denominazioni. b
Oss erviamo ancora, che il nostro reggimento suddivide:;i in mezzo reggimen lo di destra, ed in mezzo reggim ento di sinistra, il primo agli ordini del maggiore, il secon do del tenente. colonne llo. In Pruss ia invece l' unieo uffizia le superiore che trovasi dopo i I
102 I L N UOVO
c?lonn~l!o (maggiore o tenen!e colonnello} ha posto dietro il centro del reggimento. Di qui emerge che noi ~os~iamo dividere il reggimento in due parti , ave nti ciascuna il proprio comandante; eziandio rielle n:anov r e il reggimento può manoyrare su due linee , ciascuna delle q.uali h a il proprio capo , nel tempo stesso che i capitani conser va no il comando dei loro squadroni. An che questo i Pr ussiani no i possono fare, a meno che · il capitano più anziano assuma il comando del distaccam en to o della nuova linea e sia ' surrogato nel comando dello squadrone dal ,1° tenente.
I~ questa una piccola differenza, alla quale annetti amo pochissi mo valore nel tem po di pace: quando però trattisi di distaccam enti ed in eampao-oa non è più questione di poco mornenlo, e credia 0 mo certam ente superiore la nostra organizzazione.
Ed ora diciamo una parola di alcune re o·ole o·ene1. J 1· o o ra t, e q ua I sono da applicarsi n ella. plmalitè'.1 dei cas i, nella formazione de i diversi movimenti. I Pruss iani per guadagnar spazio sul fianco fanno uso dell ' obli(] uarnento, e delle con version i a 45°, e di que1!e ad a ngolo retto. Nel loro r egolamento è anche stabilito che in tulte le formazioni, ad eccezione deo'li spieo-a~ menti in avnnti, lo squadrone base si fe~mi, ct;po avere avanzato d ' uno spazio uguale al proprio fronte. Neg li spiegamenti in a vanti però, ì qunli costituis c ono il mo vime nto più importante della cavalleria, e che importa cli compi ere nel minor temp o possibile, lo squa~rone che è p~rno del mov imento comandato, se da piè formo, non s1 muove, ma essendo in m a rcia c ontinua all'incontro nella d irezione e nell'andatura che aveva prima ,_ e gli allri squadroni s i portano sulla linea raddoppiando l'and at ura.
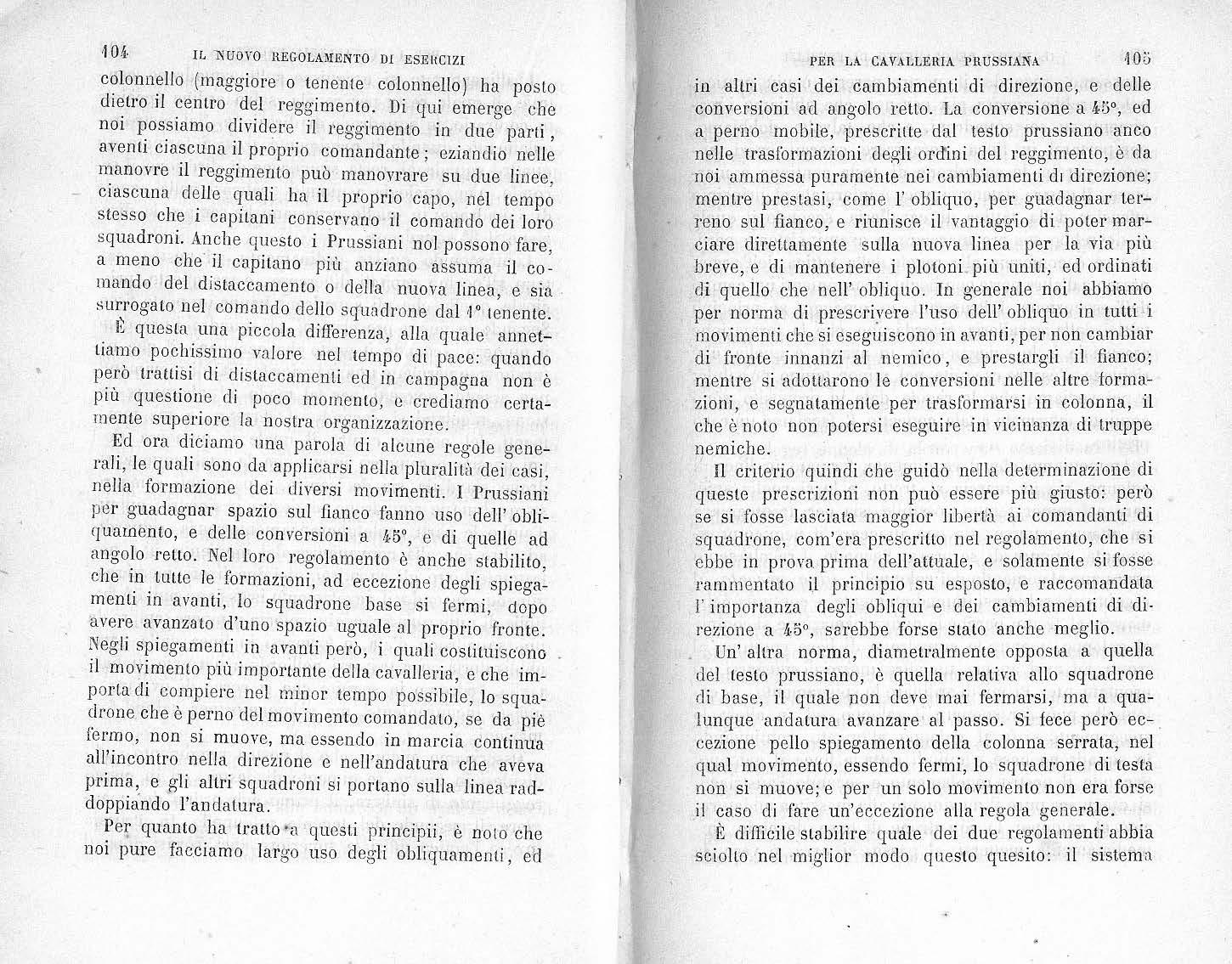
Pe~ quanto ha tratto ·a questi principii, è noto ·che noi pure facc iamo largo uso degli obliqua.men ti , eH
PER LA CAVALLERIA PRUSSJAN'A ,100 in al tri casi dei cambi amenti di direzione, e delle conversioni ad angolo retto. La conversione a 41:S°, ed a perno mob ile , prescritte dal tes to prussiano anco ne lle trasformazioni degli ord'ini del reggimento, è da noi ammessa puramente nei cambiamenti di direzione; mentre prestasi, com e l' obliquo, per guadagnar terreno sul fianco, e riunisce il vantagg io di p oter marciare direttamente sulla nuova linea p er la via più breve , e di. man te nere i plotoni più uniti, ed ordinati di quello che nell' obl iquo. In generale noi abbiamo per norma di prescriyere l'uso dell' obliquo in tutti i m ovimenti che si eseguiscono in avanti, pe r non cambiar di fronte innanzi al nem ico, e pre s targli il fianco; mentre s i adottarono le convers ioni ne lle altre formazioni, e segnatamente pe r tras fo rmai's i in colonna, il ch e è noto non potersi eseguire in vicinanza di truppe nemiche.
Il criterio quindi che guidò ne lla de terrninaz io ne di queste prescrizioni non può essere più g iusto: però se si fosse lasciata maggior lib ~rtà a i comandanti di squadrone, com'era prescl'itlo nel r egolamento, che si ebbe in prova prima dell ' attuale, e solamente si fosse rammentato il principio s u es posto, e raccomandata l'im portanza degli ob liqui e dei camb iamenti di direzione a 4-5°, sarebbe forse stato anche meglio.
Un'altra norma, diametralmente opposta a quella del testo pruss iano, è quella relativa allo squadrone d i base, il quale rion deve mai fermarsi, ma a qnal unque ·andatura avanzare a l passo . Si fece però ec- . cezione pello spiegamento della colonna se·rrata, nel qual mov imen to, essendo fermi, lo squadrone di testa non si muove ; e per un s olo movimento non era forse il caso cli fare un'eccezione alla re gola gene rale.
È d iffiòile stabilire quale dei due regolamenti abbia sc iolto nel migl ior modo questo quesito: il sistema
,.
104,
1
IL "NUOVO REGOLAMENTO DI ESEHCtzr
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESERCJZl
prussiano, secondo il noslro pare re, è più prnlico, e lo sarebbe ancora più per noi, che abbiamo i re g' gimen li su sei squadroni, e che talvolta dobbiamo, per porlarci in linea, percorrere enormi spazi, a ppunto pel'Chè lo squadrone di tesla continua a marciare. Il nostro sistem a invece è in fo rma to al principio offensivo della tattico. d i cavalleria, secondo il quale si dovrebbe sempre marciare in a.vanti: sisLema però, che se è conforme ulJe re gole della tutlica dell'arma, presentu d'altra parle non pochi inconvenien ti nel campo dell'esecuzione. 1 Prussiani, in omaggio ni principii Lallici della cavalleria, ricordaroì:10 che la formazione essem~iale è lo spiegamen Lo in avanti, e quella che r ichiede d'essere eseguita nel minor tempo po:,sibile; e noi vediamo che le regole date in proposito sono appunto informate a tale concetlo. E facciamo un caso pratico.
Amrnetliamo che il reggimen to, forma to in linea di colonne, sia in marcia al trotto, e lo si vog li a spiegare ne l minor tempo possibile, sia per fronteggiare un a ttacco nemico, sia per- auaccaee il nemico prontamente, oppure di sorpresa. Secondo il regolamento prussiano al comando del colon nello, linea spiegata, il r eggimento schicl'asi immediatamente, e continua nella marcia al trotto, perchè la nuova formazione si compie al galoppo, menLrn Io sq uadrone di base continua nl trouo. Ed aVYi ancor·a un ahro mezzo di spiegarsi piÌl prontam en te. Prima d i ordinare lo sp iegam ento, il colonn ello può far suonare il ga loppo, ed in allora lo spiegamento si fa al galoppo allungato, conti nuand o lo squadrone base e quindi Lulla la linea al galoppo. Secondo il nostro re gola me!}lO e seco ndo l'austriaco , si eseguisca pure il movimento alla massima andatura, cioè al galoppo; lo squad rone di base dovendo immediatamente mettersi al passo, si avrà, è vero, la
PER LA CAVALLEIUA Pf\USSJANA 07 lin ea f::irmata prontam ente, ma al passo; ond' è che in u n caso, specialmente, di so rpr esa, Finfcriorità delno stro regolam ento è palese.
Circa i s ingoli movimenti abbiam o a dire poca cosa, poichè da ciò che abbiamo accenna to relativamente alle prescrizioni generali, fPcilmenLe si rileva come vengono eseg uiti . Noteremo soltanto che anc h e 1rngli esercizii é ammesso il cambiamento di fronte ad angolo retto, come quello a 4.5•, e diremo anc01·a di alcun e disposizioni coll e quali si cercò di ovviare in parte al grave inc onveni ente cli doversi spiega re n ell'ordin e normal e, non essendo ammesso l'ordine inverso che pei casi pi ù urgenti. Così la co lonn a serrata può spiegarsi da qua lun que pa1·te. Nel caso che ci fosse il 1°· squadrone in testa, e s i volesse spiegare· la colonna a destra, il comandante del r f\gg irncnto dà il com ando Une a spiegata a dest1·a sul 5° (o ~ . 0 ) squadrone . Tutt.i gli squadroni eseguiscono una conrcrsionc ad angolo retto a dcstl'a, meno il quin to (od il 4° ), il quale, quando ha sgombra la propria fronte, avanza sulla linea già occupala dal ,1• squad rone, l'oltr epassa cli Lanti passi, quan ti rappresenta no la fronte di un plotone e mezzo, e quindi si arresta. Gl i altri squadroni si spiega no a s in istra in linea , quando arrivano i11 faccia al posto che devono occupare nella nuova linea . La colonna serrala può ancora spiegarsi sopra uno sr1 u aclt'o ne centrale, gli squadrnni che sono anrnti allo squadrone del ce ntro des igna to, es sendo la destra in testa, si spiegano a destra, quelli che sono dietro si spiegano a sinistra, e lo squadrone di base si porta innanzi sulla nuov a linea, app en a ha lo spazio libero in nanzi a sè. Nella linea di colonne finalmente, è prescrillo di spiegarsi prontamente a sinistra, fossevi pur anco la sinistrn io testa, in segui to a movimenti eseguili anteced entem ente, co me, per esempio, per aver formalo
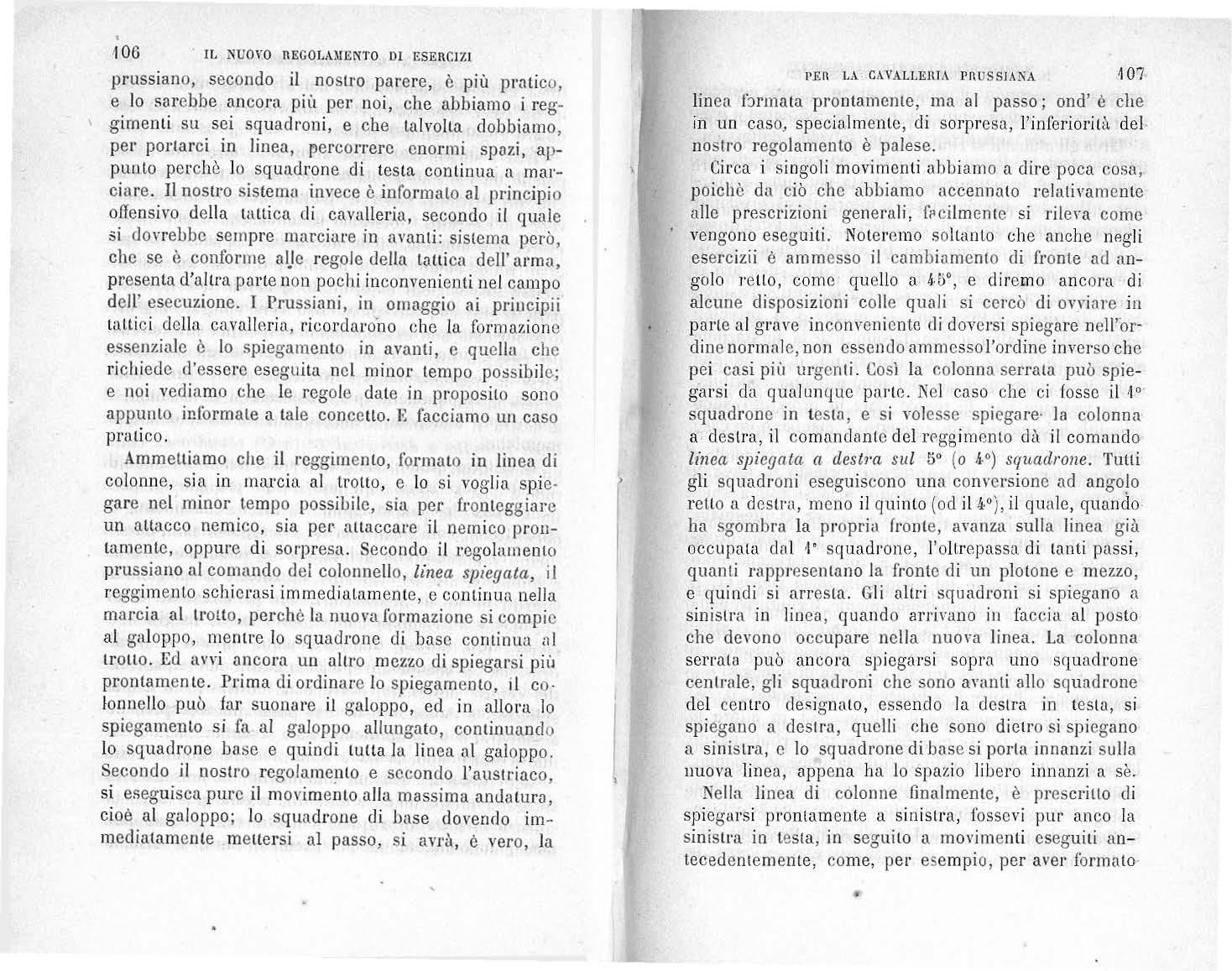
10(3
IL NUOVO REGO LAMEN'l'O DI ESEI\CIZl
1~ linea di colonne dalla colonna di squadroni con drst~ nza , ~Jer mezz_o c! i ?onversione a sin istra per ploton i.
Circa gh alt~cch1 s1 rima nda ~Ile prescrizioni g ià date ne lla scuola dt squadrone; epperò dovendosi caJ'ica r e della fanteria, _s i d ovrà in ti:ap rendere il galoppo almeno alla clisurnz~ d1 600 pa_ssi. E pur e ricordato, che quando ,debb as1 c_aricare su cl1. un terreno sconosciuto, devonsi spedire rnnanzi degl i uffizial i a riconoscerlo. Fi nalmente, quando_ il reggimen to trovisi innanzi a l nemico se?za avere il sostegno d'altra cavalleria, non devesi spiegare all'attacco l'intero reggimento, ma devesi trattenere _una parte dello stesso come seconda lin ea .
Ne~lt attacchi_ trov iamo per la prima vo lta menzionato · . 11 nome d1 scaglioni; va le a dire che gli squadrorn pos~ono muovere alla carica l'uno dopo l' altro, ad una d1s~anza di 50 passr. Lo scaglione ,può essere formato sì dr uno che di due squadroni, e pe l' tal modo.si v~ngono ad eseguire de lle caric he successive a breve eh stanza e su terreno libero .
Pari?1enti pe~ ~omba~timenti di cavalleria appiedata, e . pegl~ ~tt~cch1 m ordme sparso, sono richiamale le d1spos1z10m date nell'istruzione di squadrone .
Dopo _1a scuola di reggimento si passa a parla r e della br,_gata, _ la quale può .essere composta ùi due 0 tì·e regg11nenL1. Per regola, e quando non s ia diversam~n~e ordinato, alla destra vengono collocati i corazz,_el'I , e _segL10n_o .·.i dra?ooi, gli ussari, ed ultimi gli ulam. Negli eserc 1z11 ed mnanzi al nemico è fatta facoltà a l coma~danle di disporre le sue truppe su una,' due o tre schie re (Tref/en): quando però la hrio-ata sia compos~a di più di due regg imenti, verranno ~empre co~loca~t ;u due o tre li nee, e sollanto per eccezione sp~egat1 1 uno accanto a l!' altro . Pei movimenti delle br1~~te va)gono le ~orme clell'istruztone di reggimento.
L 1struz1one prussiana termina infine con alcune norme
l'ER LA CAVALJ;EUIA PIIUSSIANA •109' gene-rali sulla condotta dei corpi di cavalleria su due 9 tre schiere, e eone prescrizioni sulle parate a cavallo. , Le norme date sulla formazione dei corpi di cava lleria in varie schiere, sui movimenti della pri~na linea, e sullo scopo della formazione della seconda, sull'artiglieria addetta ai corpi cli cavalleria, sul posto dei comandanti delle diverse schier:e, ecc., meriterebbero tulte di essere notale minutamente, e si verrebbe per tal modo ad una traduzione del testo; il che eccede i limiti di questo lavoro.
Diremo solo che nessun regolamento forse (11) conLiene r egole così minule, e prineipii tattici così. ehiar arnenle formulat i, sicchè questa sola pa rt e viene a costituire un lavoro pregevole di lattica superiore clf'lla cavalleria. •
fer conchiudere, diremo che a noi sembra difiìcile il formulare un apprezzamento sul regolamento prussiano in confronto de l nostro (che è in sornma l'ausiriaco ). Il nostro regolamento ha maggior libertà cli movimento,concesso dalla facoltà fatta di as sumere qualunque forma senza alcuna re s ll'izione: a nos tro parere però, la parte essenziale delle manovre di cavaller-ia, quella che rifl e tte gli spiegamenti in avant i, e specialmente le rnirnniose e bene appropriale norme sugli attacchi, è forse svolta in miglior modo nel regolamento · prussiano. L'inferiorità di questo è appunto costituita da: che non si ammisero le formazioni per inversione, e· per a ver; voluto conservare il vecchio sis tema, che i capi- · plotone debbano condurre i loro plotoni con comandi a voce, a vece di guidarli con cenn i della sciabo la,. e coll'esempio. È d'uopo ricordare però che il regola(4) Il regolamento austriaco ha pure norme preziose sulla condotta, dei grossi corpi di cavalleria.
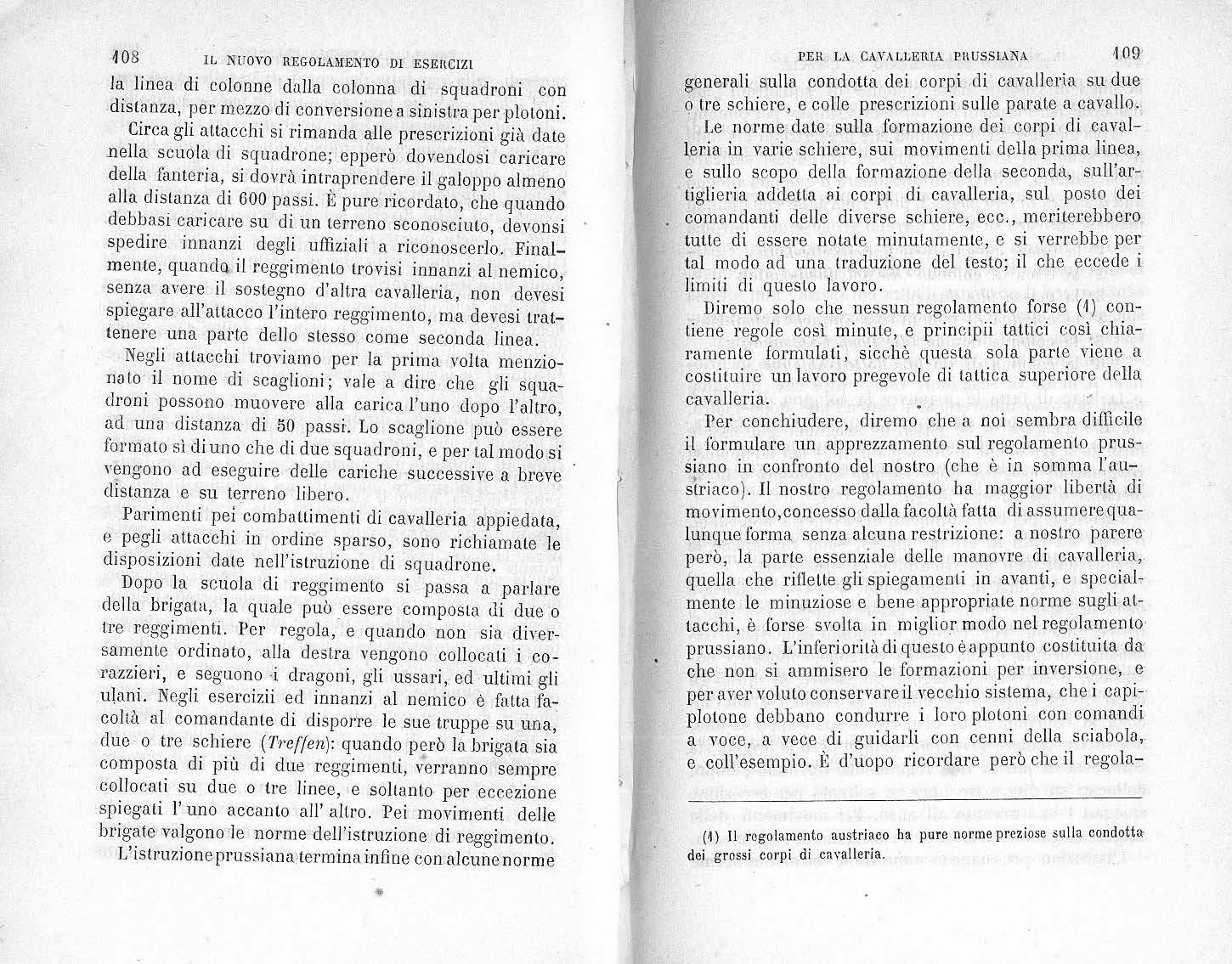
l\EGOLAMENTO DI ESERCI ZI ECC
mento prussiano è solamente in prova, e ehe quindi potrebbe subire nuove modifirazioni.
Il nostro r egolamento infine, essendo una copia di quello austriaco, con alcune modificazioni cd aggiunte, . ti-ene e d 'un sistema e dell'altro.
Il testo austriaco non ammette p el reggimento che sei formazioni, e cioè:
,J • la linea spiegata (die En twickelte- Linie );
·2° la linea dì colonna (die [(olonnen -Li"nie );
3° la massa (die il:fasse);
4° la coionna di plotoni (clie Einfache Ko lonne);
5° la colonna doppia (die Doppel-Kolonne);
6° la colonna di via (clie Rotten-T<olonne),
e fa base di lulte le man.ovre la colonna di plotoni, s ia per squadroni, sia per reggimento. Come chiaramente sì scorge , g li Austriaci intendono a fazioni leggere, rapide, spicciolale, e l'esperienza di vari anni ha già dimostrato l'eccellenza di questo s istema.

No i copiammo dal regolamento aust ria co le formazioni in linea di colonne, in massa, in colonna doppia, e conservammo ancora quelle a scug lioni, ed in colonna di squadroni, sia con distanza sia serr ata del nostro vecehio regolamento . Abbiamo gia veduto che i Prussiani non hanno nè la colonna doppia, né la formazione a scaglioni, ond "è che noi veniamo ad avere tutte le formazio ni ammesse nei vari sistemi: abbiamo a dunque ricchezza stra ordinar ia di movimenti, e per. si no sovrabbondanza .
MARZ[ALE -BIAl'ìCHL D'ADDA
Tenente di cavalleri·a.
ALCUNE IDEE SUL
MODO DI MISURARE L'EFFICACIA DEL FUOCO
DELLE TR UPPE DI FANTElll A
Le trnppe di fanter ia possono, col fuoco del fucile di cui son o armate , infliggere al nemico perdite più 0 meno grav i secondo le qualità dell'arm~, e secondo la loro abilità, sia individuale, sia collettiva nel ser·virsene: Tali perdite dipendono inoltre da l modo e dal tempo durante i l quale le truppe nemiche si sono trovate esposte al fuoco . • Le perdite di un partilo costrtu1scono quindi l' eftì. c acia del fuoco dell'altro partito (1).
Questa efficacia reale, praticu, così variabile per a ltro in conseguenza di vari0 cause, non_ potrebbe esse_re misura la che ·colla più esatta c ogniztone delle perdite suhìte da ll e truppe che furono esposte al fuoco, e delle circostanze tutte nelle quali tali perdite si avverarono.
Le statistiche che si compilano dopo le guerre, tanto più per quelle più lontane d_alla_ nostra. epoca ; non sono, nè possono essere sufficienti; esse ci danno
( l) È da notarsi bene che qui si fratta solo delle perdite sofferte per elfetto del fuoco di fucileria,
110 JL NUOYO
tulto al più i titoli delle perdile subìte per effetto d el fuoco nemico, in seguito alle numerose e diverse fasi d ei combatLimenti o delle battaglie sostenute.
Pe r ùefinire molte ed im portanti questioni mil itari in discussione al g iorno d'oggi, si usa cli ricorrere a quest'efficacia del fuoco delle tr u ppe di fanteria; ma i cr iter ii e le misure relative a quest'efficacia nè sempre nè completamente sono stabil i te sui faui , come in realtà dovrebber o i medesi mi essere cons i deral i; quindi è che le seguent i osservazioni circa tale effi ca c ia riuscirarmo forse assni interessanti se n on in se s tesse almeno per mosirare sotto il suo vero punto di vist; ta le efficacia .
L'armamento delle truppe d i fanteria è costl lm to da un dato ti po o m od ello di fu cile, il quale ha speciali qualità di tiro , di sparo e di servizio, e dall e sue munizioni . Non perb tuue le armi e nemmeno le muniz ioni sono tull e prec isamente eguali al rriodello; anzi esse non n e sono che una derivazione più o meno prossima; m o ti vo per cui le qualità speciali al tipo adotta to non si riprodurranno perfottamen(e in ciascuna delle a r mi che formano l'armamento, ma difle.1;- iranno alquanto per la difficoltà di fabbricare arm i tutte perfettamente eguali al modello, e quindi eguali fra loro; la causa della differenza più o meno grande, dall'una arma all'altra, dipend e dai metod i e sopratutto da i mezzi di riproduzione, e dai limiti cli tolleranz a accettati per le varie parti del m e ccanismo .
I risul tat i di tiro che si ottengono da una truppa a rm ata con un dato fu cile di.fieriscono quindi da que ll i ottenuti col modello , e sono necessariamente alquanto inferiori a questi u ltimi .
Le norme da seguirsi dalla trnppa per l'esecuzione conveniente del fuoco s o n o state d e fin i te appunto sul
r, MODO DJ iUlSURARE L'EFFICACIA DEL FUOCO 113
riflesso che l'arma in distribuzione e così p ure le munizioni non sono più perfetlarnen le eguali all'arma ed alle mun iz ioni che serv irono di tipo; tali norme sono dete rmin ate in modo da poler e ss ere seguiLo fac il mente; s i impiegan o metod i e mezz i di puntamento, alzi, ecc . , scelti in qu ella previsione, lu nghezza d ' alzi per distanze determinate; ecc.
L'efficacia ass ol u ta d'un arrnamento e delle sue munuz ioni , è dunque q nella che s i può ottenere nelle condizioni tutte dianzi in dicate; ne c onsegue perciò che n el paragonarne fra loro due armamenti in quanto alle loro c ondi zion i di tiro, è nec es s ario il r iferirsi non all'arma tipo, ed alle s ue m u ni z ioni, J'!la bensì all'arma ordin a ria e d all e munizioni di s ervizio, quali si ottengono coi mezzi di fab b ricazion e di cui si dispone. Dell' alluale nost ro armam ento e mun izionamento i risultati di tiro, che ne m i su rano l' efficacia ass oluta, cioè quella indipenden t e da l t ira tore, sono i s eguenti ; i quali si possono prendere come co r ri s ponde nti a quelli che danno i vari attuali a r mamenti de lle tmppe e ur opee , almeno s ufiicientemente p e r lo .:3 copo di questo lavoro(~).
Pe rce n to Pe rcen to Percento ne l bersaglio Distan ze nella nella fronte ______.., del bei·sag li o J.roi ez ione di 'un uomo 1G uomini 9 X 1, 50 2X4,5.0
400 'i5 mo ,100 ,100
200 58 96 !lO 96'
300 ,') o_ -84 8,1 88
400 22 6 I 51 69
500 ,10 39 24, 46
600 "I 36 Hl 35
700 ,. i.) 21.i 9 2t
800 2 46 6 rn
(1) Vedasi l'opuscolo in titolato - Delle nuove armi 11ortati li adottate od in corso di studio presso l'ese1·cit o italiano - Torino 1867, - ed il nostro R egolamento pel tiro al bersagli o.

ALCUNE IDEE
su
AKNO XIX , YOL, I. 8
Il raggruppamento dei _colpi sul bersaglio attorno al centro della ro sa d e i ti ri è cosi misurato:
Distanza del bersaglio mo 200 300 .(00 50 0 600 700 800 Ragg io del circolo che contiene '/ i dei colpi
sultato finale , o se vuols i l' efficac ia fina l e sarebbe del 30 per ce n to .
Non è possibile riunire in allra maniera i tir i per differenti bersagl i ed a distanze varie, quando vogliasi rappresenta r e con una sola cifra l' efficacia del fuoco .
Desumendo da questi risultati ottenuti esperimentalmente quelli che si a vre b bero per bersagli minori, p e r esempio pe r bersagli che corri spondess ero all'uomo in g inocchio , all'uom o dietro un pé!rapetto, ed all'uomo sì in pie? i ehein ginocchio, pe r metà nascosto, si trov a :
Uomo I/ .'! ,. Proie zione Uomo • I 'l, Distanza d ' un i n dietro p role zJ.one pro1ez1one uomo gioocchio un d' un d'u n uomo 1iarapet to uomo in ginoccb ìo
Ma s iccome le armi sono adoperale dai soldati che non sonò tutti tiratori perfetti, le norme e condizioni volute ·p er l'esecuzione del tir o sono più o meno bene osservate da ciascun o , secondo la s u a attitud ine, seé ondo la sua istru zio ne .
Ora l'istruzione delle tr L1ppe nell'esecuzio n e del ti1'0 è variabile per se stessa, e dipende pure dalla com. posizione delle medesime . . .
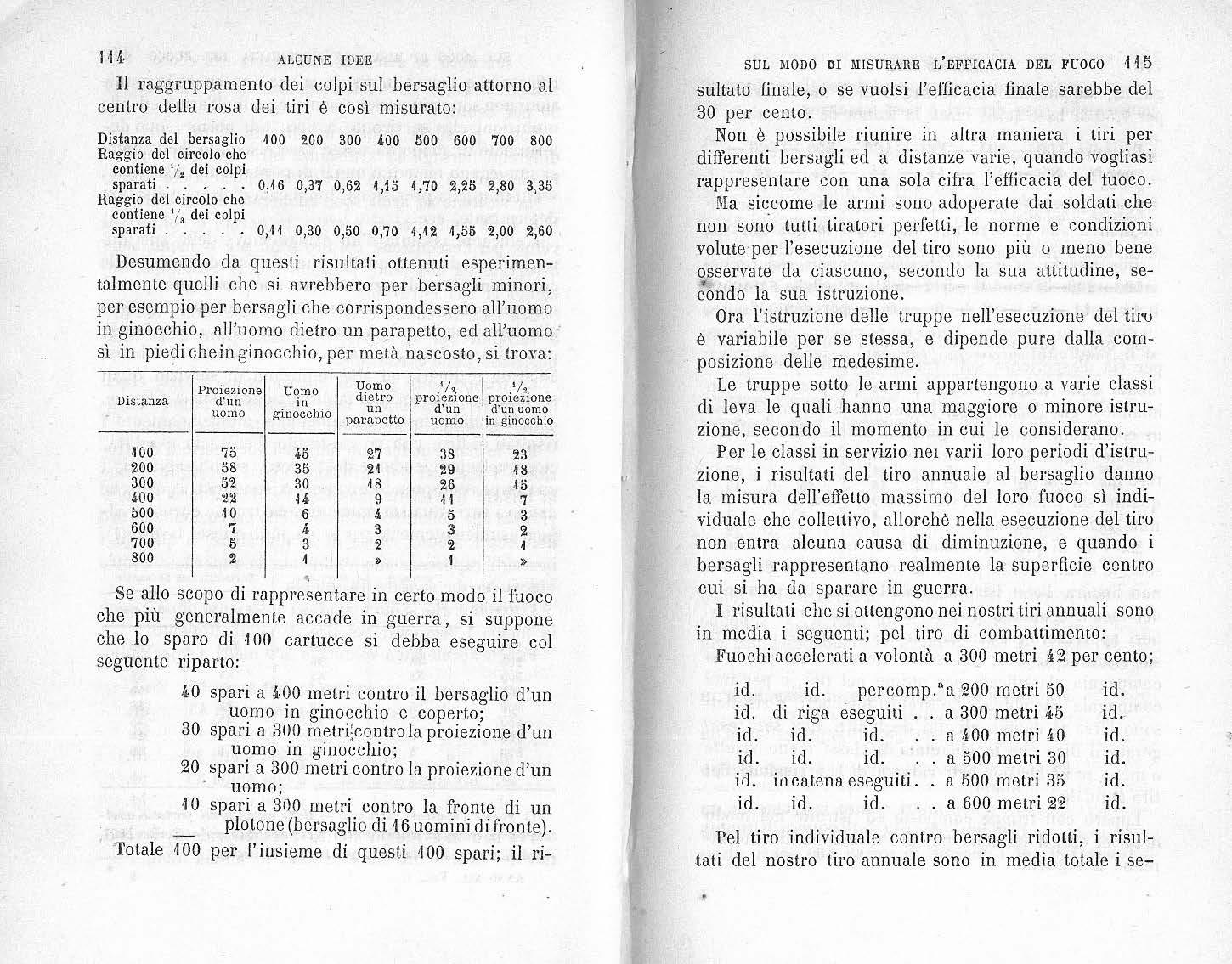
Le truppe sotto le armi appartengono a varie class i di leva le qnali hanno una maggiore o minore istruzione , seco n do il momento in cui le cons iderano.
Se allo scopo d i rappresentare in certo modo il fuoco che più generalmente accade in gueC'ra, si suppone che lo sparo di 100 cartucce s i debba eseguire col s eguente ri p arto:
40 spar i a 400 metri contro il bersaglio d 'un uom o in ginocchio e coperto;
30 spar i a 300 rnet ri.~contro la proiezione d ' un uomo in ginocchio;
20 spari a 300 metri contro la proiezione d ' un uomo ;
1O spari a 300 metri contro la fronte di un plotone (bersagl io di ,J6 uomini di fronte).
Totale '100 per l'insieme d i questi 100 spari; il r1-
Per le classi in s ervizio ne i va.rii loro periodi d'is truzione, i ris ultati del tiro annuale a l bersagl io danno la misura de ll' effetto massimo del loro fuoco sì indivi duale che co llettivo, allorchè ne lla esecuzione de l t iro non entra alcuna caus a di dim inuzione, e quando i b e rsagl i ra ppresentano real mente la superficie centro cui s i ha da sparare in guerra.
I risultati ch e s i ottengono n e i nostri tiri annuali sono in media i seguenti ; pel t iro di combattiment o :
Fuochi accele rati a volontà a 300 metri 42 per cen to;
id . id . percomp . aa 200 mett' i 50 id . id . d i riga eseguiti a 300 metri 45 i d . id . id. id. a 4,00 metri ,i O id. id . id . id. a 500 me t ri 30 id . id. i11 catena esegui ti . a 500 metri 35 id. id . id . id. a 600 metri 22 id.
Pel t iro individual e contro bersagli riclolti, i risultati del nostrn li1·0 annuale s ono in media totale i se -
,J,l,i.
Al,CUNE IDEE
2,25 2,80 3,35 sparati
o,rn
1,·12 4, 5& 2,00 2,60 sparati
. O,H 0,30 0,50 0 ,70
. . . . .
0,37 0,62 4,15 4, 70 Raggio de l circolo che contiene ' / 3 de i colpi
. . . .
~00 75 45 27 38 23 200 58 35 2~ 29 ~8 300 52 30 48 26 ~5 400 22 14 9 4,, 7 òOO ,10 6 4 5 3 600 7 4 3 3 2 700 o 3 2 2 800 2 4 » ·1 » <I
SUL MODO 01 MIS URARE L EFl~ICACIA DEL FUOCO 1115
guenti, supponendo un bersaglio di 2 metri d'altezzre per 1,50 di base (cio è circa la fronte di 2 uom ini).
Distanze 1 00 --- 200 - 300 - 400 - 500 - 600per °lo 85 - 64 - ,H - 44 - 34 - 26 -
Per un bersaglio metà del precedente , che corrisponde nll' incirca a lla proi ezione d'un uomo in g inocch io o d i un uomo metà nascosto, per l e medesime distanze cli 100 - 200-300-400-500-600, gli effet.ti sarann o: · di . 114 - 1.1 - 8 - 8 - 6 - 5 - per cento.
Se ora s ì raffrontano tali ris ulta ti con que lli trovnti per via d' espe ri enza sull'arma ch e costitui$ce l 'arrna.mento della trup p a ( e · notisi che qui per arrna non intende si già l'arma tip o, l' a rma modello ; ma l'ar ma in condizioni ord ina rie , quale si ottiene dalla fabbricazione in gran de, con tlllte le i mp er fez io ni che sono r es e inevitabili da i limiti di tolleranza accettati), si v ede· quanto sia inferiore ali' ellicaci a assoluta quella otLenuta n e i Liri annuali.
l\fa v'ha di più. Col r i chi am o even tua le d elle cla ssi sotlo le a r mi, e colla possibile incorporazione di c lassi non a ncora bene istruite, l' at titudine all' esecuzione dei fuochi è an cora d'ass ai d iminuita, e non snprebbesi apprezzare e s atlarnente la m i sura d ì ta l e infl uenza sui risultati di Liro; ma se si Ticord a che, per una compagnia clas sificata per oui ma nel t ir!) , . e per una co mpagn ia che abb ia so lo t ira t ori medioc ri , j ris ultali sono eirca i l do pp io gli uni degli altri, non sarù esagerato il dire che l a chiamata di classi meno istrutte o meno p rati che n el . tiro ridurr à di 1/! i r isultati dd tiro annuale.

Ep però con truppe composte ed istruite nel mododetto or ora, il risultalo pel Liro di c o mbattime nto sarebbe il seguente:
"Distan ze - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 -
pe.r 0 /o - 25 - 22 - 2 0 - 17 - 12 -
Analoga influenza dovrebbe rnanifostarsi nel tiro in·dividunle; ma è pe r ò da ten e rsi conto che questo è di esecuzione più agevo le ed accurata.
Se quindi si v olesse e spr imere l'efficacia totale di •fuoco in genere che otterrebbero le nos tre trupp e d ata Ja loro i struzion e presente, prendendo per '100 colpi il -r i parto ipotetico indica to a pagi na 1·1,i. si otterr eb bero i risu lt ati che seguono;
.Per 40 spar i a 300 metri contro la proi ezione d'un uomo in ginoc chio e coperto ( ridot t o a ¼l . 1,6
,> 30 spa ri a 300 metri contro la proiez ion e cl ' u n uomo in g inocchio . 2,4
·» 20 spari a 300 metri co ntro la proiezione d'un uomo 3
» 1 O s pari c ontro la fronte di 16 uo-
5 mini .
t ota le 1l 00 spari eseguiti; totale· colpiti 12 per 0 / 0 ; r i sullato questo che rappres e nterebbe l'efficacia massima, poichè si suppose che le tru pp e a ve sse ro l'istruzione comp leta.
Se si. volesse però tener co nto della minore istruz ione di talune class i , come è naturale dov e rsi fare per aver un conce tto esatto della effi cacia del tiro, i risultati sa re bb ero inferiori a s sai , ed arriverebbe ro a mala pena a 9 colpi utili su 1100 sparati nel modo indicato da l riparto sopra riferito. Se d'altra parte si con-s idera il .risultato di tiro ottenuto con un · identico ri,parto di 1100 spari esegu iti, suppon endo che siano state
H6 ALCUNE IDEE
) ' \..t I ...
SUL MODO DI lllSUnAl\E L'EFFICACIA DEL FUOCO 1 1'7
esa.ttamente osservate tutte le norme stab ilite, se n e deduce che per il fatto de l modo col quale la trupp a eseguisce il s uo tiro n e lle circostan ze ordinarie, si ottengono risultati che raggiungono appena il terz o di quello che comporterebbe il nostro armamento, astraz ione fatta del modo di esecuzione per parte d e lla truppa.
Questi ri s ultati di 30 per cento per efficacia massima dell'armamento che abbiamo più sopra indicati, ed i 9 per cento ora ottenuti dal tiro delle trupp e misurano· a un dipresso l'efficacia del tiro che s i può raggiungere nelle circostanze abituali d el tiro annuale al bersaglio.
Questi risultati so no quelli che otteniamo annualmente tirando a distanze definite, in ore convenienti , in condizioni di atmosfe ra .non tr oppo sfavorevoli, e con truppe tr anq uille , non spossate nè stanche, disciplinate ed attente ai suggerimenti dei capi .
l\fa nell'esecuzione del fuoco in guerra, molte e molte diverse cause d'influenza e di circostanza veng ono a cambiare completamente il risultat o del tiro , ora per un moti v o ed in una data misura, ora per altro motivo ed in m isura anche diversa .
Le cause che influiscono sul modo con cui il soldato eseguirà in "realtà le prescrizioni pel tiro sono moltiplici, vari ab ilissime, e dipendono in parte da circostanze di fatto, e pel riman ente da ll e condizioni morali che possono influire sull'uomo , considerato s i a ind i vidua l mente, sia collettivamente.
Le 1,;ircostanze di fat.to si possono specificare, e l a loro influenza sull'efficacia del Liro può sino ad un certo punLo essere valutata.
Tali circostanze sono essenzialmente le seguenti:
a) Soppres s ione totale talvo l La , o diminuzione considerevole de ll'influenza, della dire zione , dei suggerimenti deg l i uffic iali , nell'esecuzione dei fuoch i, tanto più ne i tiri individuali ed in catena .

SUL MODO DI MI SURAI\E L'EFFICACIA DEL FUOCO 419
b) Stanchezza o spossatezza delle truppe.
e) Esec uzione dei fuochi in qualunque ora del g iorno, e qualunque s ia la stag ione, o lo stato delt' atmo sfer a.
d) I bersagli sono costitui ti dal nemico s econdo le formazioni c he esso sceglie, e dipendono dalle maggiori o minori facilitazioni che i l terreno g li o ffre per coprirsi, cli modo che la parte real mente esposta al fuoco è talv olta assai diminuita; ed ino l tre moltissime volle tali bersagli sono variabili e mobili, e più o meno .sensibili all'occhio.
e) Gli errori individ ua li nel va lutare le distanze, e nello scegliere gli alzi da adoperare .
f) L'assumere talvolLa posizioni indi vidual i meno facili e convenienti per l'esecu zione del Liro .
g) ll cominciare e continuare il tirn a distanze meno c on venienti.
h) Gli u,omini per effetto del clima , o d'altro fatto climater ico anche s olo momen ta neo, possono essere più o meno capaci di servirsi delle loro a rmi.
i ) Lo stato d e lle munizioni e degli inn esc hi.
L'importanza elfo si dà, nell'esecuzione d el t iro al bersag li o , ai suggerimenti de g li ufficia li e de i sottufficiali onde conseguire r isultati convenienti, influisce naturalmenLe p er otten e re risulta ti migliori di qu e llo che si avrebbero altrimenti .
Si potrebbe anche valutare la diminuzione di efficacia che avviene pee la mi.not'e influenza degli ufficiali, confrontando i risultati che si ottengono con truppe meno ist ruite con quelli che si ottengo no con altre più istruite.
Una tale minor i nfluen za porta con s è notevoli diminuzioni nei risultati del fuoco quando s i produco n o errori nel valutare ind i vi dua lmen te le d istanze; quando gli uomini s i lasc iano trascinare a sparnrè con tropp a
118 ALCUNE !DEE
precipitazione contro bersagl i troppo poco vi sibili, tropp o piccoli, od a distanze che ren dono sicuramente nullo il risultalo del tiro (1) .
Per ogni tipo d'armamento sono calco!ati gli spazii pericolosi per le varie distanze; quando g li er rori di di stanz a sono compresi in tali spazii , si può dire che i ris ulta ti del tiro n on cambiano .
In tal e circo stanza p osson o avere quindi una o-randissima importanza le qua lità balis tic he del modello scel to per tipo dell'armamento.
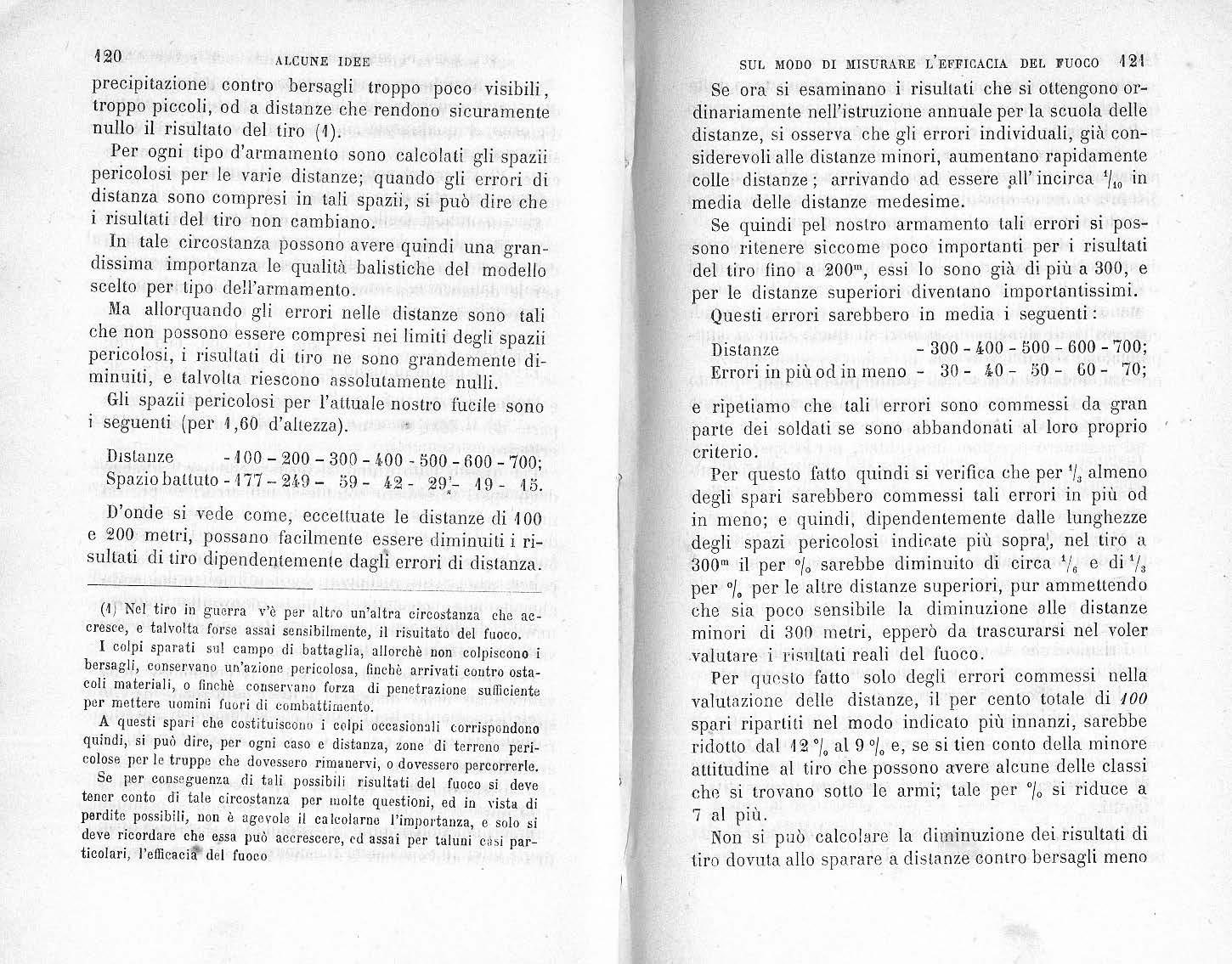
Ma allorquand o gli errori ne ll e distanze sono tali c he non posson o essere co rnpresi nei limiti degli spazii pericolosi, i ris ultati d i tiro ne sono grandeme nte diminuiti, e talvolta riescono asso lutamente nullì .
Gli spazii pericolosi per l' att uale nostro fucile sono seguenti (per 4 ,60 d'altezza ).
D1stauze - ,f 00 - 200 - 300 - 400 - 500 - fiOO - 700; Spazio battuto -177 - 249 - l>9 - 42 - 29:- 49 - ,15.
D'onde si vede come, eccettuate le dis tanze di 100 e 200 me tri, possano fa c il mente essere diminu iti i risultati di tiro dipendentement e dagli errori di distanza. - - - - - ------·· - ---· -···-
(1 J Ne l tir o in g-n crra v'è per alt ro un'altra circostanza che accresce, e talv olta fprse assai sensibi lmen te, il ri suitato del fuoco.
I colpi spa rati su! cam po di battagl ia, all orchè non colpiscono i bers ag li, conse rv ano uri'azionr, p ericolosa, fiochè arrivati contro ostacoli materia l i, o rìncbè conse rl'an o forza di penet razi one suffi ciente per mettere uom ini fuori di com battime nt o.
A questi spari che costit uiscono i c(llpi occasion3 Ji corris pondono quind i, si può dire, per ogni caso e di sta n-za, zone di terreno pericolose per le truppe che dovesse ro ri~a ne rvi, o do,·essero percorrerle.
Se per con seguenza di tali possibi li risu ltati del fuoco si dev e tenor conto cfi tale circosta nza per rnolte quest ioni, ed in \'i st a di perdite possi bil i, non è agel'ole il ca lcolaroc l'impo1·tanza, e solo si deve ricordare che essa può accrescere, {'d assai per taluni c.isi particolari, l'efficacia del fuo(io
SUL MODO DI MISURARE L'EFF ICACIA DEL ll UO CO 121
Se ora si esaminano i risulta ti ch e si ottengon o ordinari ame n te ne ll'istruzion e annuale per la scuola delle distanze, s i osserva ·che gli errori individuali , già considerevoli a ll e distanze m inori, aumentano rapidamente colle distanze; arr iva n do ad esse re jtll' incirca 1 / 10 in media delle distanze medesime.
Se quindi pel no s tro arm amento tali errori si possono ritenere siccome poco impo rtanti p er i ri sultati del tiro fino a :200111 , essi Io sono già di più a 300, e per le distanze s uper iori diven tano impor tantiss im i .
Questi erro ri sarebbero in media i seguenti:
Distanze - 300 - 400 - 500 - 600 - 700; Erro ri in più od in meno - 30 - ,~O - !50 - 60 - 70; e ripetiamo ehe tali e rrori so no commessi da gran parte dei soldati se sono abbandonati al loro pr oprio ' criterio.
Per questo fa tto qu indi s i ve rifi ca che per Yi a lmen o degli spari sarebbero co mmess i ta li e rrori in più od in meno ; e qu indi, dipendentemente dalle lunghezze deo-li spazi pericolosi. indir.ate pi ù sopra), nel tiro a 300"' il per 0 / 0 sareb be diminuito di circa 1 / 0 e di 1 / 3 per °/. per le ahre distanze superiori, pur amm~ttendo che sia poco sensibi le la diminuz ione alle di stan ze minori di 300 metri, epperò da trascura rsi nel vo ler .valuta r e i risnlt~H i reali de l fuoco .
Per qucslo fatt o solo degli e rr ori commessi nella valutazione delle distanze , il per cento totale cli 100 sp\J,ri r ipar ti ti n el modo indicato più innanz i, sa1:e bb e ridott o dal 112 °/. al 9 °/0 e, se s i tien conto della rmno r e att itudine al tiro che possono avere alcune delle classi chi~ si tr ovan o sotto le armi; tale pe r °/o si riduce a 7 al p iù. . . . . .
Non si p uò calcolare la d i minuz10n e de1 r1sultat1 d1 t iro dovuta a llo spa rare a di sta nze contro bersagli meno
ALCUNE IDEE
convenienti, tanto più avuto riguardo al consumo delle munizioni causato da che la truppa non tenne conto dei suggerimenti ricevuti dai rispettivi gtaduati.
Tale spveco di tiri senza colpire può essere grandissimo e trasc?rabile, appunto secondo che la truppa è più o meno disciplinata, esperta ed istrutta, più o meno agguerrira, solida oppur demorµlizzf!,ta .
l vari'bersagli presentati dal nemico in guerra offrono maggiori o minori facilitazioni pel puntamento; essi sono inoltre pe!' lo più mobili , variab ili , più o meno distinti all'occhio, più o meno coperti, e quindi in realtà di dimensioni minori di quelle che si suppongono nei tiri annuali.
La tendE:nza dei soldati (tanto più seguìta, quanto è minore l'influenza dei superiori) a coprirsi dal fuoco e dalla vista del nemico, li induce il più delle volte ad assumere posizioni individuali, per lo sparo, assai meno sciolte e comode; ne riceve quindi detrimento l'esecuzione del tiro e sono conseguentemente inferiori gli effetti otLenuti .
Non è possibile preci sare l'influenza dei risultati di tiro derivante dall'essere i bersagli animati, ma un; cevta misura si può ricavare dai risultati delle scuole del t iro al bersaglio contro bersagli mobili, come sono prescritti da lle attuali istruzioni sul tiro.
I risultati che si ottengono contro bersagli che sono mobili sono appena circa ¼di quelli che si avrebbero se invece i bersagli fossero fissi.
Pe.i . fuochi contro catene di cacciatori, i bersagJ:i nem1c1 sono cer ta men te da considerarsi come mobili epperò non sarebbe esag·erato per t~li fuochi cl i riclurr~ di ¼ i risultati di tiro che si sarebbero altrimenti ottenuti.

La precip itazione nella esecuzione dello s paro, alfa quale i soldati si lasciano così facilmente indurre se
SUL MODO DI MISUHARE L1 ll.FFlCACIA DEL FUOCO ,j ~3' non sono trattenutj dagli ufficiali e graduati, è caus a necessariamente cli una meno buona esecuzione del tiro, e quindi di risulf.ati inferiori.
Di tutte queste varie influenze, le quali non possono. essere valutate numericarnerùe, è assai difficile, per non dire impossibile, lo stabilire l'enti tà per i risultati di tiro finali; però iutte influiscono in evitabilmente • su di una meno buona esecuzione del tiro, e dipendono essenz ial mente dalla m inore attitudine ed istruzione della truppa al tiro .
Ora nelle nostre istru zioni annuali del tiro ul bersaglio la differenza per cui una compagnia è giudicata ottima o med iocre è cli' 1 / 3 ad 1 / dei risultili di tiro ouenuti, epperciò il limitare le conseguenze sul tiro di tutte l e influen ze or ora citate a quella diminuzione di 1 / 3 ad 1 / non sarà esagerato, che anzi il risultato finale, che così si potrà raggiungere, sarà certamente da considerarsi come un massimo. _
Ma tutte indistintamente, si può d ire, queste influenze sono assai poco sens ibili alle minori distanze, e crescono poi rapidam ente col crescere delle dis tanze, pe r cui è da arnme llersi che fino a 200 esse in massima sono trascurab ili quando si voglia esprimere con un numero il risu l tato finale; e che sono g ià sensibili a 300 rn ètri. tanto più per fuochi in catena o contro ca~ tene, e diventano considerevoli alle distanze maggiori.
Se quindi, allo scopo di potere indi care una misura finale dell'efficacia del tiro, ammettesi, per conseguenza di quanto fu ora detto, che tali influenze sono trascurabili fino a 200 metri, che a 300 metri pei tiri in catena o contro catene riducono cli 1 / ., i risu ltati ab ituali e di 1 / 3 quelli per le distanze oltre i 300 metri, il per 0 / 0 di 1100 spari, sopponendoli sempre riparlifi nel modo indicato più sopra, diventa al massimo di
,j'.zz ALCUNE IDEE
· 4 a fj 0 / 0 •
F i na lmente le truppe possono essere più o meno ·spossa te e rese le mporariamen te meno ab ili a servi rsi de ll a loro arma, per conseguenza della stagione, del ,c li ma, dello stato dell'a t mosfera .
Non v'è misura possibile per l' i nfluenza che ta li circos lanze possono avere sul ti r o; esse possono talvolta però d i ventare considerevo li ss i me .
L'influenza de llo stato delle munizioni e degl ' inne·schi poteva acquistare una considerevole importanza colle armi a pietra focaia o silice, od a capsula, colle ·car lucc i e delle arm i ad an ticari ca, ecc., essa ogg ìdì tende sempre più a diminuire colle nuove armi e colle nuove cartucce; e se con esse è inut ile il ten erne conto, è indispensab ile i l ricordarle quando si fanno studi su ll e guerre passate , ove s'impiegarono quelle arm i ad ~nticarica e le relative munizioni .
.Per tutte le circoslanze d i fatto che influiscono sui risulta l i del tiro che furono fìn qui enunciali_devesi ammelle re che:
a) Non è possibile di confondere in un risu l tato finale i vari risu l ta li parzial i ottenuti per ogni distanza per ogni bersaglio, !confondendo ins ieme l' istruzione e l ' attitudine delle truppe, ed alt re circostanze, senza prima stabilire un riparto; che possa surv i re per tutti i paragon i, d i tali circostanze del tiro ;
b) Amm esso che serva di modo comun e di paragone il riparto indicalo {a pagina 1 H ,} cli 100 spari, l'efficacia di tirn delle nostre truppe, secondo la loro istruzione annuale, si può di r e misurata dal ,12 per °J. ;

e) Tale efficac i a d i minuisce per la chiamata sotto le armi cli c lass i meno istrtrite, e si può calcola r e in 9 °/0 ;
d) J>er le circostanze ùi fatto c he accompagnano l 'esecuz ione dei fuochi in guerra, tale efficacia è ancora diminuita e si può calcolare al 4 o 5 per °/o, essendo di 7 °/o pel solo fatto .deg li errori nella valu-
tazione delle distanze e qu i ndi degli alzi da adoperare;.
e) L'eflì.cacia di tiro assoluto, particolare al nos tro armamento, sarebbe misurato con tale riparto dal 30 °/o;
l) In queste misure l'efficacia è sempre riferila agli spari fatti, cioè a ll e cartuccie realmente consumate per l'esecuzione dei fuoch i.
Questi r is ultati furono culcolat i tenendo solo conto delle influenze che cleri vano da circostanze rnatèr iali di fatto, ma in guerra ad esse s i agg iungono le cause morali le qual i hanno conseg uenze material i cl' ogni specie sull'esecuzione de i fuochi, sì individualmente, che collettivamente.
Non è p oss ibi le specificare tali cause moral i, e meno ancora l e loro conseguenze.
Esse per<':> hanno sempre per i nevitabile ed immediato effetto di d iminuire i risultati del tiro, di aumentare la tendenza d e i so ldati ad una · meno buona osservanza delle prescrizioni regolamentari , di distoglierli dal dare la dovuta auenzione ai suggeriment i dei loroc api, ed accrescono l'entità di molte delle circostanze di fatto che furono più sopra indicate, aumentando per conseguenza g li effetti che ne derivano s ul tiro.
l~ssc inoltre ag iscono differen temente su i due parti ti in . presenza, ·s ì individua l mente che collettivamente . ·
Ad esse si possono agg iungere quelle cause che.provenienti dalla situazione del momento dei partiti, possono costringere una truppa a servire di bersaglio, senza che questa col suo fuoco possa produrre effetti moral i corrispondenti sull'esecuzione del fuoco nemico.
L'efficacia del fuoco delle truppe di fanteria h a certamente ner misura l e perdite cag ionate al nemico, ma com~ già si diss e sarebbe indispensabile, oltre alle perd ite, conoscere non meno ~sattamente ~l n~me~o degli spari effettivamente esegu1t1, e le vane npart1zioni degli spari, e degl i uomini colpiti per le distanze ,
ALCUNE IDEE
2 5·
SUL MODO DI msunARE L'EPFICACIA DEI: FUOCO /4
'
.e circostanze differenti onde ovviare a che siano insieme confuse in un risultato final e e totale.
Se tali dati fo s sero riassunti, come pur dianzi si è detto, l'efficacia del fuoco prati oamente ollenuta od ottenibile in guerra sarebbe misurata e para(J'ornJ.n. ' ' o dola a quelle efficacie parziali da ottenersi in UO'uale . . o c irco~tanza, ma m tempo di pace, se ne potrebbe dedurre l'influenza totale da attribuirsi alle cause morali che agiscono in guerra sulle truppe.
Ciò evidentemente non è possibile, non potendosi conoscere in re a ltà l'efficacia del fuoco in guerra in modo sicuro e scevro di grandi errori di fatto o di apprezzamento.
Sulle cause morali, sulle perdite, sulle quantità di munizioni sparate, o perdute, od altrimenti consumate, hanno grnpclissima parte ancora il diverso risultato del fatto d'arme per i due partiti, di vari fatti d'ai·mi, della campagna o dell'insi e me di diverse campagne, e ciò tanto più allorchè si danno non i totali parziali, ma i totali generali.
Inoltr e mentre le perdite d'ogni specie, le catise di demoralizzazione, la disorganizzazione, la minor obbedienza ai capi, ·ecc. aumentano enormemente pel partito cui toccò la peggio, esse tendono a scomparire od almeno a diminuire grandemente pel vincitore; nè di ciò tengono conto i totali suindicati se paraO'onati fra loro in modo astratto. ·

Per lo meno nel voler precisare i totali delle perdite e delle munizioni consumate per una abbastanza approssimata misura dell'efficacia del fuoco, dovrebbesi solo considerare quei fatti d'armi in cui la lotta fu sostenuta dai due partiti in condizioni abbastanza ugu a li da truppe solide, disciplinate, istruite, resistenti; per nessuna delle quali si manifestarono, . per causa dell'esito sfavorevole, circostanze di demoralizzazione
SU L MODO DI HI SURAl\E L' EFFIC ACIA D:EiL t>UO CO 1i7 o di impotenza tali da non più rendere paragonabili i risultati prodotti od ottenuti.
Attenendosi ad alcuni d i tali fatti d'armi per le uliirne campagne di Boemia e di Francia, e s tati ri p ortati pure dalla Rivista militare, il risu ltato fin a le che pot rebbe essere come un a misura dell'efficacia d a fuo co prodotta, sarebbe stato fino all' 11 1ft °fo , il che si potrebbe forse, per ora almeno, ritenere come il massimo in quelle· circostanze ora dette, le so le su cui è pos sibile basarsi per paragoni . ... S e il riparto fissato in questo arti eol o per 100 spari fosse paragonab ile con quello che ebbe luogo in quei combattimenti, e credesi che lo sia in limiti s ù ffi c ienti, si dovi·ebbe dedurre evidentemente' chenon vi è dunque, finchè il combattimento è so s tenuto in circostanze non troppo disuguali tr;i i due partiti, quella cç>sì grande differenza dall'effic a c ia del t iro in {tempo di pace a quella che ve rificas i in t e mpo di gue rra, come vorrebb e si d esumere instituenclo parag oni numerici fra la cifra totale delle pel'dite, e la c ifra totale delle munizioni consumate; tan t o più se tali cifre sono riferite a p iù fatti d'armi ed anche a campagne intere, ma di ness un altro accordo fra loro .
Si possono dunque prendere i risultati del tiro di pace, come vennero qui riassunti, per basi da poter servire ne ll e quislioni ove taluni particolari si fanno dipendere dall' e fficacia del fuoco cui le truppe saranno esposte in guerr a, e pei criteri div e rsi che possono emettersi su tale efficacia; ·avve rt endo però che, allorquando le truppe d'un partito sono in cond izioni di combattimento troppo sfavorevoli per qualunque motivo, l'efficacia del fuoco n e mico tende ad aumentare a loro danno oltre le proporzioni fin qui state indicate.
D'altrond e , nel misurare l'efficacia del fuoco, riferendo le perdite cagionate alle munizioni indicate poi
ALC UNE IDEE
0
come consumate, é ·indispensabile il ricordare che tali munizioni, date per consumate , non sempre rappresentano il numero dei colpi sparati.
Le munizioni date siccome consumate dopo i fatti d'armi, e p i ù ancora a guerra fi nita, .si compongono:
muniz ioni sparate; a) Delle
b) Id. perdute dai corpi o parchi;
e) Id. rese inservibili . ·
Il quantitativo delle munizioni sparate non si stabilisce direttamente, · ma bensl si ottiene dalla diffe~ renza fra le munizioni che i corpi ebbero a ricevere, e queUe ·che loro rimasero da ultimo.
Figurano quindi sparate le munizioni rimaste ai morti, ai feriti, ai. prigionieri, ai di spe r si, agli assenti, per i quali poi i corpi non· si riforniscono di mun izioni.
Non si possono dunque riferire l e pèrdite all e munizioni poi risultanti con su mate, ma dovrebbero esse riferirsi soltanto alle munizioni che effettivamente produs se r o tali perdite, per ogni fase, per ogni circostanza e per ogni fatto. .
Il totale però delle mun iz ioni consumate ha pur sempre una grande importanza, e deve anche essere s tabilito per ogni fatto d'armi, per gruppo di fatti d'armi, per una camp ag na, o per una o p iù guerre, poichè esso sei·ve di criterio e di dato d'esperienza pei· stab il ire le dotazioni in munizioni pel soldato, pei r iparti tattici, per i parchi , per un esercito; per l e riserve da aversi sempre dispon ibili per entrare in campagna, e per rinnovarle prontamente anche durante la guerra . c. ll.
RIVISTA BIBLIOGRAFICA

L.a twsta •a difesa inle••ua nella !//alle ,lei !P•o, per AGO· snNo R1ccr, colonnell o di stato maggiore. Un volume in 8° di 170 p<1g. con schizzo li Lografato. Tor ino 1873, tipogra fì a Candeletli.
Si può dire che sia un vero avven imento ne l mondo miti fare ogni qual volta il colonnello Urcc1 manda qua lche co sa alla pubblicità . L'autorità di cui gode meritamenle qoesto nom e è tale, che al lorquando vediamo in una questione qualunque seguirsi da lui un'opioioue differente da quella gpn eral mente amméssa, sontiamo i l bisogno di rimettere ogni cosa in. discussione e d i rifare i nostri studi da capo, giacchè sappiamo che in tutto <Juaoto eg li di ce apporta non solo una mente luc ida e co mpre nsiva ed un sentire elevato, ma el.iand io un profondo e maturo esame del la questione stessa sotto tutti i suoi r ispetti. Tale è il caso per la gravissima questione dell a difesa d'lta!ia . I due precedenti opu sco li del colonnello Ri cci SU questo argomen to, de ' qua li la Bi-vista di ede conto a' SUOj lettori (1), produssero una vera rivo luziono negli spiriti di tuitr co loro che si occuparono d ella materia; poichè se ess i valsero a confermare alcune idoe comunemente ammesse, a porre fuori di discussione talu:10 altre, su cui regnava ancora il dub bio, valsero allresì a scuoterne di quelle che avevano dal la loro l'autorità di sommi uomini e i l consenso quasi indisc usso di un'immensa ma ggioranza. Le opinion i em esse dal Ricci fecero il loro cammino; esse furono commentate, dis cusse, ed
128 ALCUNE IDEE
SUL MODO DI MISUH AilE ECC.
ANNO XIX, VOL
I. 9 •
(I) V dispense del febbraio e marzo 1872
.
DÌBLIOG-RAFICÀ.
oramai si può dire che l'accordo è fatto su .ciò che riguarda il modo con cui dev'essere sistemata la difesa della nostra front ie ra. Rimaneva ancora la diverge nz a per ciò che riguarda la difesa interna della Va llo del Po, od è p·er tog liere anche que sta ch'eg li scende una terza volta in ca mpo_.
La Rivista , fedele al suo còmpito, ha serbato rn tutta que~ta discussione un contegno neutra le, ma non indifferente, schmden do le sue pagine a varii scrilli che trattavano dell'~rgomento quali in un s enso, quali in un altro, ed·ha tenuto dietro con attenzione a tutte le pubblicazioni roiative all'argomento s tesso , dandone conto ai lettori, ma astenendosi in pari temp~ dali'e nt rare nel merito della questione. Lo stesse> contegno Cl è imposto ora che dobbiamo fare un cenno t~ella .recen.te .pubbli cazione de l co lonnel lo Ricci, della quale r 1port1amo 11 titolo.
Qu esto opuscolo prende le mosse da uno scritto del colonneilo Ara ldi pubblicato Jiel fascico lo di ma ggio di questa Riv ista. in cui sotto il titolo: Bol ogna o Piacenza? si combatteva~o le conclusioni fo rmu late da l colonnello Ricci in favore del!' erezione di una gràn piazza di rifugio n e lla posizione Piacenza-Stradella-Bobb io. Il Ricci prende occasione da questi appunti per dare piìl ampie dich iarazioa i del suo concetto, e lo fa con tal luc idezza e vivacità di espressione, con tanta copia di argomentazioni da rendere la l e ttura di questo lib:o non so lo proficua, ,ma dilettevole, e da r endere prnna e facile l'intelligenza di parecc hie idee , che nei due precedenti suoi opuscoli , per la forse soverchia condensazione de lle , materie, erano rimaste osc ure ed al lo sta to embrionale. - Cercheremo di darne un rapido sunto, sperando che- esso, anz ichè dispensare il lellore dal pre ndere conoscenza di qc:esto libro, lo inviti anzi a leggerlo ed a med itarlo.
li libro è diviso in tre parti. La prima comprende tre qu estioni prin cipali.
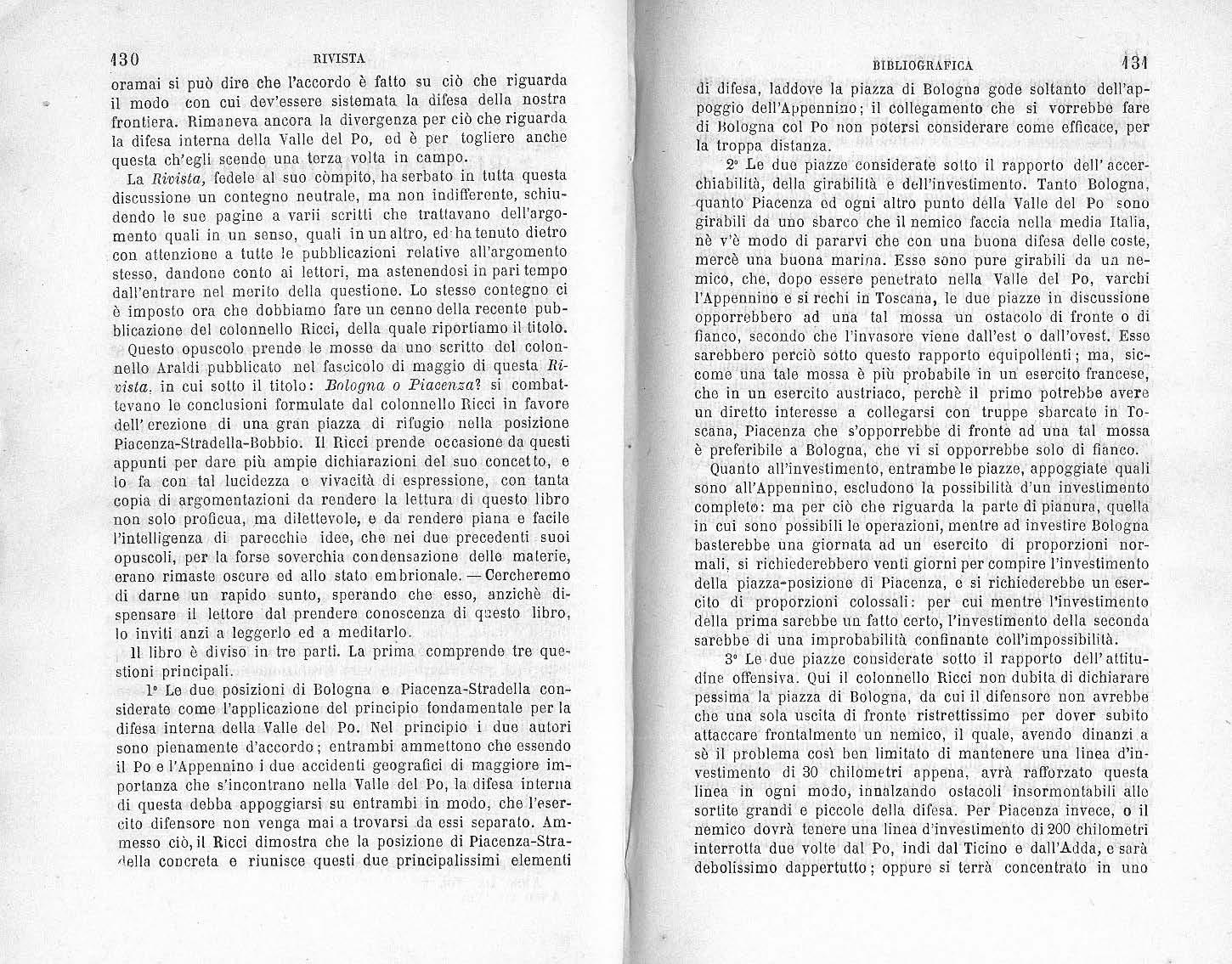
1° Le due posizioni di Bologaa e Piacenza-Stradell a considerate come l'appl icazione del pr incipio fondamentale per la difesa interna della Valle del Po. Nel princip io i due autori sono pienamente d'accordo; entrambi ammettono che essendo il Po e l'Appennino i due accidenti geografici di maggiore importanza che s'iacontrano nella Valle del Po, la difesa in terna di ques ta debba app oggia rs i su entrambi in modo , che l'f.sercito difensorè non venga mai a trovarsi da essi separalo. Am· messo ciò il Ricci dimostra che la posizione di Piacen za- Str a1\ella coo;reta e riunisce ques ti due pri nc ipalissimi elementi
<li difesa, laddove la piazza di Bo logna gode solla:nlo dell'appoggio dell'Appenni.!'.lo; il collegamento che si. vorrebbe fare di Bologna col Po non potersi considerare come eflìcàce, per la troppa distanza.
· 2° Lè due piazze1 considerate sotto il rapp orto dell' accerch iab ili là, della girabilità e dùll'invcr,timonto . Ta.nto Bologna , . quan to Piacenza od ogni altro punto della Val le del Po sono girabili da uno sbarco che il nemico faccia nella med ia Itali a, nè v'è modo di pararvi che con una buona difesa delle coste, mercè una buona marina . Esso suno pure girabi li da un nemico , che, dopo essere penetrato nella Valle del Po, varchi l'Appenni no e si rechi in Toscana, le due piazze in discussione oppor r ebbero ad ua a tal mossa un ostacolo di fronte o di fianco, secondo che l'invasore viene dall'est o dall'ovest. Esso sarebbero perciò sotto questo rapporto equ ipo llen ti; ma, siccome una tale mossa è più probabile in un ese r cito francese, che in un eserc ito· austriaco, · perchè il primo potrebbe avere un diretto interesse a collegarsi con truppe sbarcate in Tosca na, Piacenza che s'opporrebbe di frontè ad una tal mossa è preferibile a Bologna, che vi si opporrebbe solo di fianco. Quanto all'investimento, entrambe le piazze, appoggiate quali sono al!' Appenn ino, escl udono fa possibi lità d' un investimento completo: ma per ciò che riguarda la parte di pia nura, quella iu cui so no possib il i le operazioni, mentre ad invest ire Bo logna basterebbe ùna giornata ad un esercito di proporzioni norma li. s i richiederebbero venti giorni per compire l'investimento della piazza- posizio ne di Piilcenza , é si richiederebbe un eser~ c ito di proporzioJ1i colossali: per cui ment r e l'investimento della prima sarebbe trn fatto certo, l'investimento della seconda sarebbe di una improbabili tà confinante coll'impossibi li tà.
3° Le , due piazzo considerale sotto il rap porto dell' attitudin e oft'e nsira. Qui il colonnello Ricci non dubila di dichiarare pessima la piazza di Bologna , dà c ui il difensore non avrebbe che una sola uscita di fronte ristrettissimo per dove r subito attaccare frontalmente un nemico, il quale, avendo dinanzi .a sè il problema cosl ben limitato di mantenere una l inea d'investimento di 30 ch il ometri appena, avrà rafforzato ques ta linea · in ogn i mofo; inna lzando ostacoli insormontabili allo sor ti te grandi e piccole della difesa. Per Piacenza invece, o il nemico dovrà tenere una li nea d'investimento cli 200 éhilomelri interrotta due volle dal Po, i nd i da l Ticino e dall'Adda, e sarà debolissimo dappertutto; oppure si terrà concentralo in uno
'130
RIVISTA
DIBLIOGRAFICA. . 433
o due dei cinque settori creati attorno a Piacenza dai detti corsi d'acqua, e rimarranno liberi gli altri, lasciando ampia latitudine ad og ni combinazione di m an ovre controffensive.
La parte seconda pr ende ad esa me g li appunti speciali fatti da I colonnello Araldi alle 10 proposizion i, co n cui il colonnello Ricci formulava la conc lusione d el suo secondo opuscolo: La piazza di Piacenza - Stradella riella difesa della frontièra nord-est; e qu i ci è im possibile seg uire il co lonnello Ricci nelle sue argomentazioni, chò altr imen ti usciremmo dai confini d i un cenno bibl iografico. Bas ti accennare che fo questa seconda parte le du e piazze sono consider a te: 1° sotto il rapporto della potenzialità ferroviaria: 2° soUo il rapporto del concentramen to dell'esercito italiano sul la frontiera nord-est: 3° sotto il rapporto del le funzioni che la piazza ·di Man to vaJ3orgoforte av r ebbe con esse: 4° sollo il rapp orto delle loro qualità tattiche: 5° sollo quello degli approvvigionamenti : 6• int1nb sollo quello della durabilità del le comunicazioni.
Nella terza parto la qu!}stione è sollevata in una sfera più a lta e comprensiva. Il' colonne llo Ricci espo ne qua le sia il sno modo di vedere nel concepire la d ifosa dell'Ita lia in generale. Beuchè qui \)g li non esprima idee, che già non fossero · contenute negli opuscoli precedenti, pure il lettore non potrà a m on o di ammirare in qu es te poche pagine, che costitu iscono la 3"' parlo, una chiarezza tutta nuova, un accento di profonda convinzione, un cuore di soldato e di italiano.
I vi egli insiste sul fatto, che la cosliluzione delle società m,oderne e l'adozione presso gli Stati principa li de l sistema mi litan~ prussia no devono avere una de cisiva influenza sull'andamen to delle future guer r e, le qua li si risolveranno in po clrn grandi battagli e; da ciò egli prende occasione per studiare le cons eguenze che potrà avere in Italia e sul problema de ll a nostra difesa questa innovazione ne l sistema militare, e g iu nge ad affermare cbe il volere imaginare una difesa metodica, passo passo, per linee successivo, è un voler chiudere gli occhi ai fenomeni del mondo militare moderno, è un sognare l'i mpossibi le . E qui ritornando alla questione speciale, che è l'argomento del libro , egli conchiude che in caso d'invasione nemica nella Valle pel Po: una piazza di rifugio , dovunque situata nella Valle stessa, riuscirà nove vo lte su dieci in utile, perchè la guerra sarà stata d ecisa senza remissione in una grande battaglia . - Ma dato il caso che fosse ancor possibile sperare eh.e, dopo una battaglia infelice, si potesse
continuare la guerra con probabil ità di su ccesso, l'utilità di una buona piazza di rifug io si renderebbe a ll ora evide nt e: e rivolgendosi al Parlamento, il quale dovrà fra .non mollo occuparsi della questione, egli sottopone alla sua considerazione queste quattro proposizioni:
1° In fatto di fortificazioni non esservi questione di min imo o di mass imo, ma esservi un ta nto , e questo necessario : faro di me n o sarebbe un er r ore militare, faro di più sarebbe un errore mi litare ed economico ad un tempo .
2° Il tanto necessario per la difesa interna della Va llo del Po consistere in u na grande posizione di r ifug io in cui l'esercito italiano sfortunato mJIJe prime battaglie, quando non decisive, possa r icoverars i, riordinarsi, rinforzarsi e ten tare al più presto le seconde.
3° Una grande posizione di rifugic, dovere avere in qualità difensive il puro indi spensabile, e sarà sempre sufficient o, in virtù offens iva , il massimo possibil e e non sarà mai di troppo .
4° Il Po e l'Appennino congiunti essendo, a dotta di tutti. l'espressione idea lè di una posiz ione dì tal nat ura, la qu es tiono ridursi a questo: constatare o·ve si ·veri fì,chi il fatto della congiunz1:one del Po coll'Appennino, ed iv'i, co'sussidii dell'arte, C1·eare la posiz'ione che ci è n-ecossaria.
Riuscirà questo lavoro del Ricci a rivolgere dalla sua qu ella maggioranza che fi n ora stava contro la sua opi~ione? Noi ci asteniamo a questo ri g uardo dal formular vot i o predizioni; ma ben possiamo formulare un volo, che quasi è una predizione, che cioè questo opuscolo venga attentamente letto o moditato, affincbè se le sue conclu5ioni non fossero desti na te a trionfare, ciò avvenga dietro matura deliberazione, non perchè non siasi studiata la questione s0lto tu tti i suoi lati.
Die militiiritwl,e Lei.tltmgsfiil,igl.è.U der em•o11iiischen Staateu (La potenza militare dagli Stati europei), per FrncKs, capitano - Lipsia, Luckart 1873 (pag. 228) .
La ques tio ne doli' organizzazione e forza dei vari eserci ti interessa vivamente non solo col ui il qua le mediante opportuni confronti v.uo le cercarvi utili ammaestramcn Li, ma ben anche ogni militare co lto, ogni uomo politico, ogni. st ud ioso del le condizioni dull'odierua società . Fa mest ieri bens) notare come in cruesto tempo gli eserciti vadano rapi damente trasforman-

1132 RIVISTA
RIVISTA
dosi coll'al largare la lo r o base, coll'accorciare la loro ferma, col porfeziunare le armi loro . Ed in ciò g li insegnamenti delle ultime guerre tr-ovano vigorosa spinta neg li stnèi militari, i quali .da l gabinetto so litario di pochi si sono spa rsi nelle scuole, nelle caserme, ne i campi di \:lsercitazione , n~lle g r andi manovre; ed banno assunto quel ]' abi to pratico che così spesso loro mancava .
Di singoli eserciti abbiamo alcune belle e recenti monografie (organ izzazio ne mi litare russa, prussiana, turca, serba, greca, rnmena) pubb li cate specialmente per curA de l l\!inistero della gue r ra austro-ungherese. Notissime sono le ope r e sulla potenza mili taro tedesca di Wi tzleben, di Udinghausen, di Buschbecks, le quali si ristampano quasi a nnualmente colle necessarie aggiunte e mod ificazioni. Allo stesso "Moltke s i af.lribui sco un aureo libretto desli11ato ad ins egnare al popo lo lo s tup e ndo ordinamento che ha fallo di sè così splendida pro va. Sull' esercito austriaco notizie in copia offrono a lcun i r ecentissimi scrjtti, fra i quali mer itano partrco lare menzione: Die T(riegsrnacht Oeste·rreichs, in corso di pubb licazione a Vienna presso Seidel, o D'ie Organisation de1· os te1 ·1:eichisc h-ungarischen Armee. (Teschen 1873).
Fanno difetto s tudi compara tivi dei vari eserciti eur opei , pe r le diffi coltà opposte, vuo i da ll ' int r icato labirin to di costituzioni cos) di.verse .e sotti>pos te a quas i g ior na liere var iazioni, vuoi da ll e notizie generalmente m0nche sulle mo ltep li ci . oscillaz ioni .
L'esposizione comparativa delle forze miWari d'Eiirop a (1) è già diventata vecchia e da molti mesi invano si attende una nuova edizione. Solo in certe cose, e non senza qua lche appre nsione, si può ornai va lersi del libro di Kummer (2), in cui con mo lto acume e profonde cognizioni si esa mi nano i principii che reggono lo organ izzaz ioni degli eserci ti in Austria, Russia, Italia, Fr.,mcia e Gel'man ia.
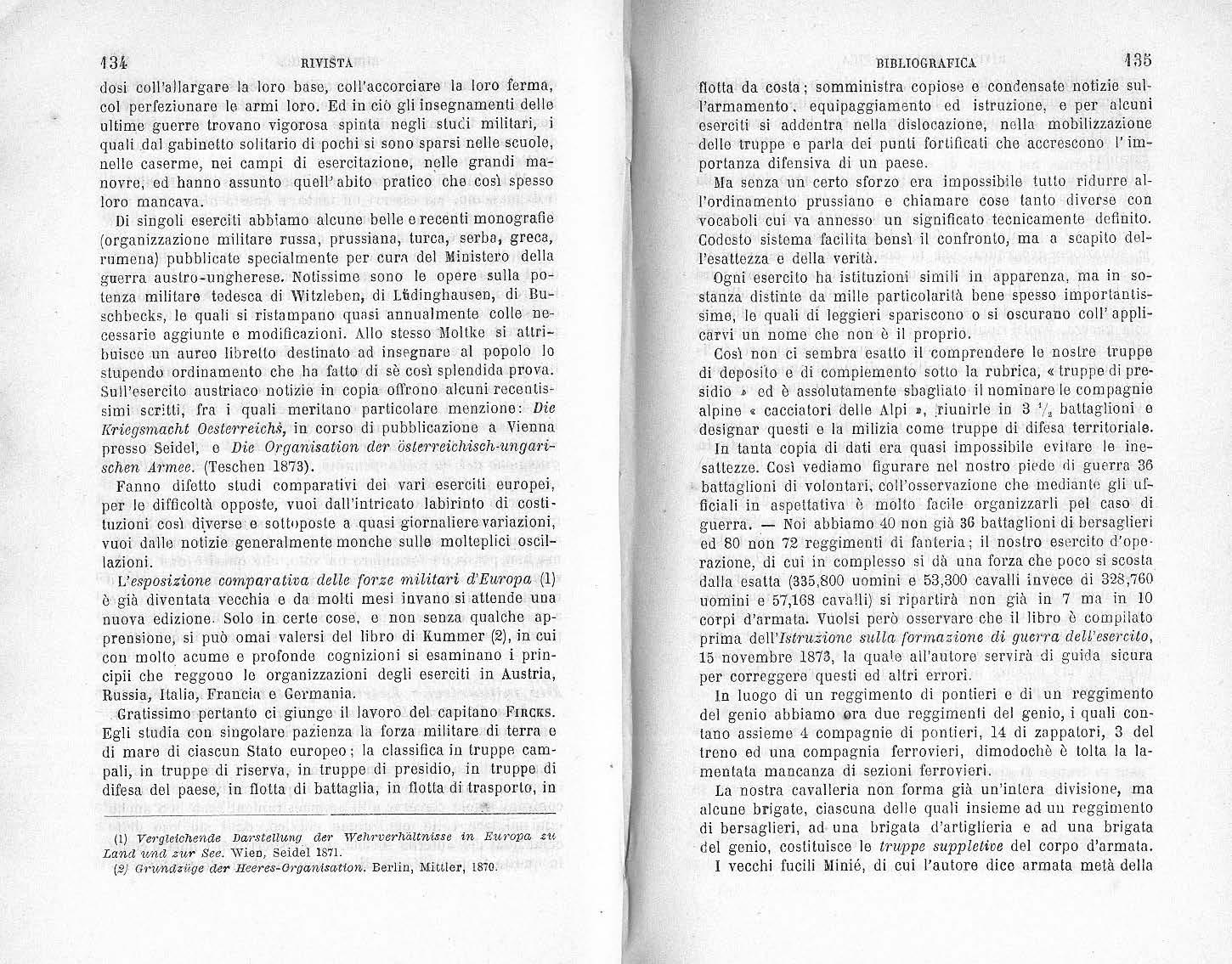
. Gra tissimo pertanto ci g iungo il lavoro de l capitano FmcKs. Egli stud ia con singolare paiienza la forza mi litare di te rr a e di mare di ciascun Stato europeo ; la classifica in truppe campali, in truppe di risen1a, iu truppe di pres id io, in truppe di difesa. de l paese, in flotta di batta glia, in flotta di· trasporto, in
(1) Verglelchenae Da.rst el/.ung ae1· Wehrverhiiltnisse in Ei wopa, .z-u Lana una zur See. Wieo, Seidel 1871.
{2) Grimazu ye der -lleeres- O,·ganisatton. Berliu, Miuler, L8iO
BIBLIOGRAFICA
flotta da costa; somministra, copiose e condensate notizie sull'armamento. equipaggiamento ed istruzio ne, e per alcuni eserciti si add!mtra ne lla dislo cazione, nella mobilizzazione de lle truppe e parla dei punti fort ificati che ac cr escono I' importanza difensiva di un paese.
Ma senza 11n certo sforzo era impossibile tutt o r idurre all'ordinamento pru ssiano e chiamare coso lauto diverso con voca boli cu i va annesso un significato tecnicamente defin ito. Codesto siste ma facilita bensì il confronto, ma a scapito dell'esattezza e de lla verità.
Ogni esercito ha istituzioni simili in appare nza , ma in sostanza distin te da mille particolarità bene spesso important issime, le quali di leggiori spari scono o si oscurano co li' applicarvi un nome che non è il proprio.
Così non ci se mbra esa tto il ·comprendere le nostre truppe di deposrto e di complemento sotto la rubrica, « truppe di pres idio .. ed è assolutamente sbagliato il nominare le compagnie alpine cacciatori tie ll e Alpi », ,riun irle in 3 ' / . batta glioni e designar questi e la milizia come trup pe di difesa territoria le.
In tan ta copia di dllti era quasi impossibile evi tare le inesattezze. Così vediamo fi g urare nel nostro pi pdo cti guerra 36 battag li oni di vo lontari, coll ' osservazione che med ianti! gli ufficiali in aspe ttativa ò molto facile organizzarli pel caso di guerra. - Noi abb iamo 40 non g ià 36 battagl ioni di bersaglieri ed 80 non 72 r eggimen ti di fanteria; il nosl.l'O eserc ii.o d'operazione, di cui in comp lesso si dà una forza che poco si scos ta dal la esalta (335 ,800 uomin i e 53,300 cavalli invece di 328,760 uomin i e 57,168 ca va!li ) si ripartirà non già in 7 ma in IO corpi d'armata. Vuolsi però osservare che il libro è compi lato prim a dell'Istruzione szilla: for m a zione di gue r1·a dell'esercito, 15 nov embre 1873, la qua l.e all'autore servirà di g ui da sicura per cor r eggere qu esti ed alt r i errori.
l n lu ogo di un reggimento di pon tieri e di un reggimento del gen io abbiamo ora duo reggimenli del g·enio, i quali contan o assieme ,1 compagnie di pontie ri, 14 di zappatori, 3 del trono ed una co m pagn ia ferrovieri, dimodoch è è tolta la lamentata mancanza di sezion i ferroviari.
La nostra cavalleria non forma giil. un'intera divisione, ma alcu ne brigate, ciascuna delle quali insi eme ad uu r eggimento di bersaglieri, ad una brigala d'artiglieria e ad u11a brigata del go nio, costituisce le truppe suppletive del corpo d'armata.
I vecch i fuc ili Minié, di cui l'autore dice armata me tà delta
RIVISTA IlIDLIOGRAFICA
nostra mil izi a, sono affatto spariti, ed al gio rn o d'oggi abb iamo un numero sufficiente di fucili Carcano per tutte le truppe di seconda linea. È assolutamen te erroneo che la nostra cavalleria a bbi a il primo rango arma to di lancia, il secondo di ca r abina.
Il cap itano Fircks, dopo alcune esprossioni agro-d olci sulla fant eria e cava ll e ria italian a, dopo qualche elogio ai be rs aglier i ed al perso nale d'arligl ieria, conchiude quanto riflette il nostro ese r cito, co lle parole: « La (orza di resistenza dell ' Ita lia per !a situazione geografica, per la configurazione natura le de l paese, pnr il bene ordinato sistema di for tificazioni, come pure per le onimo qual ità dei soldati che tanto si prestan o all'ostinata difesa di singo le posizion i ed alle mille astuzie della piccola g uerr a, vuolsi r ipu tar e notevolissima o sotto ogni r iguardo sufficien te a di fendere da se sola co n successo la propria indipendenza contro la potenza mi li tare d i qualsivoglia S ta to conlìnanle , - condizio ne che essa non ha raggiunto rn non d opo l'occupazione di Roma. l>
Il lavoro è vasto, interessante, utilissimo, fallo con mollo criterio, ma va co rr etto da parecch ie mende. Co sl va rifatto in gran pa rte il cap itolo V - Es1n-cit o francese - compilalo su lla scorta di un rapporto presen tato dal gen er ale Cissey a Th iers. : L' Jng h illerra nei suoi 25 primi regg im en ti non ha 34 ma 35 ba tt ag lioni; la Svi zzera ha 177 n on 175 battagl io ni ; « l'asse1~ire che l'Austria ha 4 pezzi per mil le uomini è dare una ceffata alla ver ità~ dice forso un po'trop po energicamen te l'Oes te rrei'chisch -imgari sch e JWitd1· Zeitsch?'ift. Ad ogni modo speriamo che l'a uto re, tenendo conto delle osse rvazioni che non mancheranno di fargli i periodici stranieri, come pure delle r ece ntissime innovazioni, vog lia completare o mig liorare il s uo · libro affinchè esso possa cor ri spondere allo scopo di presentare e la vera potenza milita r e dei singoli eserciti e dell e singole flo lte europee . »
PARALELLO
DELL' ARTIGLIERIA .DA CAMPAGNA IT AL IANA
CON QUELl,A
DELLE PRINCIPALI POTE NZE
Giustezza di tù·o - Uno de' principali elementi da cui di.pende l' effelto utile del tiro è la gi·ustezza . In qùest o ~ta il car attere distintivo dell'artigli eria moderna (rigala) . Dessa rende efficace l a massima parte de' colpi sparati .
Ia rappresentazione più convenie nte di questo elemento è quella fornita dalla deviazione probabile, da quella cioè che offre il 50 °/0 di probabilit ~ favorevole, in a ltri term in i, la probabilità di colpire un daLo oggetto u n a vol ta su due .
Quanto m inore è l'ap ertura de l /'a scio di traiettorie che si ottengono realmente da una bocca da fuoco, tan to maggi ore riesce la p recisione d i tiro; rapportando quindi la t raietto r ia media ( quella cioè su cui son o regolate le attuali tavole di tiro) di questo fa.sc io al centro d'un bersagli o, s i avrù la dimen sione che esso deve avere in larghezza o in altezza o profondità secon do il la to da cui lo si considera, per essere colpito . Èso uo questrtrerapporti che devesiesaminare una bocca da fuoco nelle sue deviazioni probab ili ond e poter convenientemente apprezza.re la g iustezza cli Liro.
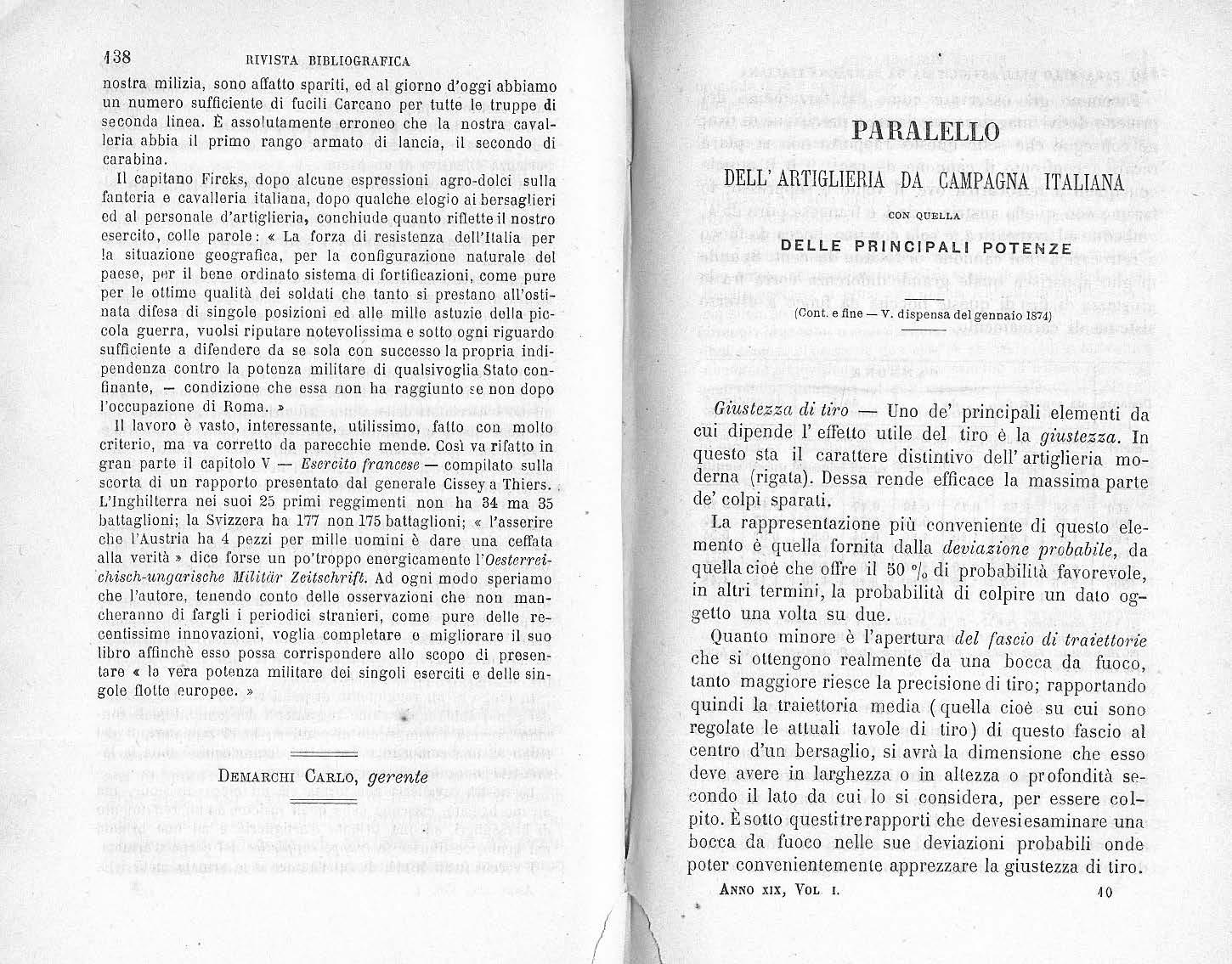
138
! \
DE JVIARCHI C ARLO, gerente
(Con t. e fine - v . dispensa del gennai o 1874)
ANNO XIX , VO L I. ~o
DELL'AR'rIGLIERL\. DA CAMPAGNA ITALIANA
Facemmo già osservare come dal forzamento del proieLto derivi maggiore regolarità e precisione di tiro; ne consegue che sotto questo rapporto non si potrà recare a confronto il cannone da cent. 9 B R atluale con quelli a retrocarica ove il vento è soppresso; lo faremo con quello austriaco da i e francese pure da i, am bedue ad avancarica, e solo con una bocca da fuoc o a retrocarica (col cannone prussiano da cent. 8) onde meglio apparisca quale grande differenza corra fra la g iustezza di tiro d i quesLe bocche da fuoco a diverso sistema di caricamento .

CANNONE
Distanze da c;eutim. 9 da 4 da 4 da centim. S ital i ano austriaco (IJ francese (2ì prussia no (3) in Devia zioni medie Devin ioni med ie De viaz oni m odie Oeviaz,ooi medi metri
e rertica li 111izzoot3l1 , ertica li or inontali ,orticali ori11oolali mticdi oriuoolal - - - - - - - -
CON QUELLA DELL E PRINCCPALl POTENZE 1141 pagna nei momenti decisivi generalmente si tirerà con bersagli di grande estensione ma di poca profondill1. La superiorità poi del cannone prussiano su tutti i cannoni ad avancarica è tale da non poter fare un serio confronto; e perciò, invece delle deviazioni medie di tutte le altre artiglierie estere, preferii raccogliere nel seguente quadro i dati di probabilità di colpire °f. di ciascheduna bocca da fuoco tirando su un bersaglio di ·1 m ,80 d'altezza, rappresentante un dato fronte di fanteria. Distanzain
9 me ri Haliano
(1) Vedi llandbuch fii.r d ie 1(. IC. Artillerle, l 'l'heil. Wien 1870.
(2) Aide·-n•cfmoire por t a,tif de campagne. Paris 18 64.
(3) lfand-und Taschenbuch fii,• Of{lziere der Preussischen Felà..-Arti/.1erie Berlin ISGS
Da q11es10 spe cchio risulta chiaramente che il nostro cannone da centimetri 9 alle piccole distanze ha mollo minor giustezza di tiro di quelli francese ed austriaco, ma a 1200m li raggiunge, quindi alle distanze maggiori li sorpass a. Rimane, è bensì vero, alquanto inferiore : nelle deviazioni orizzontali, ma per li effetti utili sono evidentemente l e deviazioni in altezza che influis~ono di più nella precisione del tiro, avvegnaché in cam-
(1) Vedi A. Nrn A1 S1< . l!artillerie de campagne Belge. Bruxelles 1870.
(ll)· Aide-m émoire à, l'usage des o(!iciers d'artillerie su;sses. Aarau !SiO e per l e alt re indicazioni, vedi: Zeilsch, ift f iir die Scht;:,ei;rerische Arti/~ · lerie. J ahrgang 187 J. ·
J ii rTNER voN JONSTORFF. Die Feld-Artillerien Oest e rreichs, Franlweichs Jtaci ens, de,· Schwei..-, Englands, Preussen~ una Busslands. '\:Vie n 1871
Ciò che si disse per le deviazioni risulta comprovato pure da questo specchio delle probabilità di colpire °fo.
I: cannoni austriaco e francese esordiscono con risultati migliori del nostro cannone da cent. 9, ma col!' aumentarsi dell e distanze perdono a grado a gracfo la. loro superiorità. A sooin il cannone italiano supera il franc ese di solo uno per cento, ma a rnoom ha un sopravven to di 8 colpi; a 11500~1 raggiunge l'aus tt'i aco ed a 2000,n Io supera di un colpo. Resta· però sempre inferiore di oltre la metà del numero di tiri utili, risp~lto
140
P,\RALELLO
----- ~'---
400 0.81ì 0,98 0,% 0,40 0,47 0,35 0,13 0,25 600 1,~n 4,~3 . 0,68 0,80 0 ,56 0,55 0 ,27 0,32 800 4,66 •l,98 4, 40 4, ':lO 0,94 0 ,80 O 52 0,54 400J •1,98 2,61 ·1,60 2, 40 4 ,45 4,20 0,75 0,69 4200 !l.-15 3,23 2,10 4.80 2 ,00 ,40 4, 05 0,539 ~500 2 ,b 1:i 4,30 2,90 2,60 3,40 4,90 1,42 .~ 8
500 800 ~000 4500 2000 ¼ 84 6~ 46 23 43 d a 1 francese --°lo 93 60 38 48 H CANNONE da 4 da 4
) i
ese --- - -°lo °lo °lo 96 98 98 68 83 82 49 73 75 23 49 37 42 36 29 dacent.8 pruss iano °lo 98 76 60 31 20 da cen t. 8,4svizz.(lli olo 99 89 82 55 37
t . dacent.
da 12 austriaco belga (!
ngl
DELL'ARTIGLlEnIÀ ·DA CA~PAGN~ l'rALIANA al cannone belgi! e allo svizzero, e di poco meno della metà al prussiano.
Questi raprorti dimostrano pienamente quanto la giustezza cli tiro col cannone rigato a retrocaricrn sia superiore a quella de ' cannoni rigati caricantisi per la bo•!ca.
Radenza o tensi"one dei'la trniett01·ia . - Altro e lemento principale da cui ·dipende l'effetto utile del tiro è la. radenza o tensione d.ella traiettoria, la quale è determinata clall' angolo di caduta, o forse meglio dalla zona pe1·icolosa relativa ad un bersaglio di grandezza data, sia fronte di fanteria, o cavalleria, ecc.
La radenza aella traiettoria descritta da un proietto verso il suo punto di caduta diminuisce l' influenza degli errori, che inevitabilmente si co mmettono nella valutazione delle distanze in campagna. A parità di condizioniessa è in ragione diretta della velocità del proietto, vale a dir.e che aumentando la velocità si accresce proporzionatamente la radenza e per conseguenza la probabilità di colpir,e, ma essendo questa limitata dal peso della bocca da fuoco, che alla sua volta è limitato da,i mez.zi cli trasporto, ne cons eg ue che, do.vendo la velocità avere un limite, naturalmente anche la radenza v'è sottomessa.
Da ciò il maggiore problema di ba listica di cui tutt e le potenze d'Europa . cercano atlualm ente la soluzione : cioè irnpi;imere a.i proietto una velocità iniziale considerevole, mantenendo al pezzo ed all' affusto una grande leggerezza , ed una grande .mobilità ; dare in seguito al proi.etto il mezzo di conservate più che sia possibile quella velocità.
Lasciando ai tecnici la soluzione di questo problema, · sia coll'adozione d ' un proietto c).i forma meglio appropriata al suo movimento nell'aria, sia coll'aumentarne· la densità assoluta,. passiamo ad esaminare i vantaggi

CON QUEf, LA DELLE PIUNC[PALI POTENZE 114-3
<lì radenza della traiettoria in paragone a quelli della giustezza di tiro.
Fino ad ora non è ben definita la questione se più ,convenga sacr ificare, entro certi limiti, Ja radenza alla giustezza, o viceversa.
V~rie sono le op inioni e le ragioni in proposito. . Dalle idee svolte d al tenente colonnello Giovanetti, -sembra che i vantaggi di radenza si palesino solo nel caso cli tiro erroneo, ossia ne' tiri di prova . Ne risultache a misura che il tir.o si corregge, una gran parte ,del vantaggio tende a scomparire.
In pratica, alle grandi distanze, colle attuali bocche da fuoco, l'importanza della radenza è minima Tispetto .agli errori che si possono commellere nella va lutazion~ delle Jontananzè, g iacchè uno sbaglio di 50, 1 oom commesso toglie il vantaggio che si potrebbe avere <la uno spazio battuto da 24 inve ce di 5m. Naturalmente ciò d evesi intendere valevole in considerazion e clelle velo.cità iniziali e 1'e,~tanti possedute dagli attuali proiettili. Che se col tempo si riescisse ad avere alla -distanza di 1500 01 uno spazio battuto noo inferi ore a 50 o 601n, non s i avrebbe ragione ad esitare .di preferire la radenza alla giustezza .
Rispetto al primo asserto abbiamo l'appoggio del fatto che i Prussinni stessi dopo la campagna del ,1866, .abb andona rono il loro cannone obice da 12 centimetri liscio a granata eccentrica, quantunque la sua radenza . fosse molto superiore a quella de' cannoni rirrati e d . o .non _ 1sp_rezzabile la sua giustezza di tiro, la quale però era rnfer10re a quella di queste ultime bocche da fuoco .
L~sciando pertanto impregiudicata la questione fra la gmstezza e la radenza, riuniamo ne' due specchi se,guenti i dati principali sugli spazi pericolosi o hmghezze utili d elle traiettori e delle bocche da fuoco sovracitate, nonche gli angoli di cl).duta dei rispettivi
1,i,2 PARAI,.ELLO
DELL'ARTIGLIERIA D,\ CAMPAGNA ITALIANA proietti, onde poter giudicare anche sotto questo aspetto il nostro cannone da campagna in confronto 3gli esteri tanto ad avancarica che a retrocarica.
Spazi battuti a .,.\lm d',i zza alla d istanza di BOCCHE DA
Anche per questo rapporto si manifesta sempre più. la grande :;;upel'iorità de' cannoni a carica,mento posteriore: alcuni de' quali non esordiscono è vero con risultati migliori del nostro cannone da cent. 9 ma oltrepassata appena la portata utile della rnetraglia, tutti acquistano una tensione di traiettoria ognor più crescente e maggiore di quella del nostro cannone a misura che aumentano le distanze.
A 15porn i cannoni belga, prussiano (rigato}, svizzero, inglese e russo hanno in media una lunghezza utile di traiettoria di . metri 23, mentre quella de' cannoni a caricamento dalla bocca, si limita circa a due terzi di questa ( circa 115-16m), il quale rapporto si riduce . per quasi la metà alla distama di '2000m.
Quadro contenente gli angoli di caduta Alla distanza di BOCCHE DA FUOCO ~ , -
Cannone da cent. 9 italiano .
da 4 francese . .
4
. . .
Il cannone da cent. 9 alle piccole distanze, vale . a dire a 500m o fino a rnoom ha spazi pericolosi più estesi dei cannoni francese od austriaco e poco infer iori a qu eJli de' cannoni a caricamento forzato . A 1500m è raggiunto dall'austriaco, quasi dal francese e sorpassato di 6-7m da quelli a r etrocarica; a 2000m la cede tanto al francese che all'austriaco ed in r agione mnggiore a tu tti gli alLri rimane sempre inferiore a tutti in proporzion e crescente co ll'aumentare delle distanze.
Quella che rip.orta la palma su tutte le bocche da fuoco, liscie e rigate, è il cannone·obice ·prussiano da cent. 112 liscio; ma lo svantaggio d ella sua minore giustezza d i tiro lo condannò all'oblio.
Prima di indagare però la ragione per cui i l cannone da cent. 9 italiano alle piccole distanze abbia una lunghezza utile di traiettoria pari ed anche mag- · giore di quella de' retrocarica, geuiamo un' occhiata alle velo c ità ini ziali e velocità restan ti delle diverse bo cc h e da fuoco.
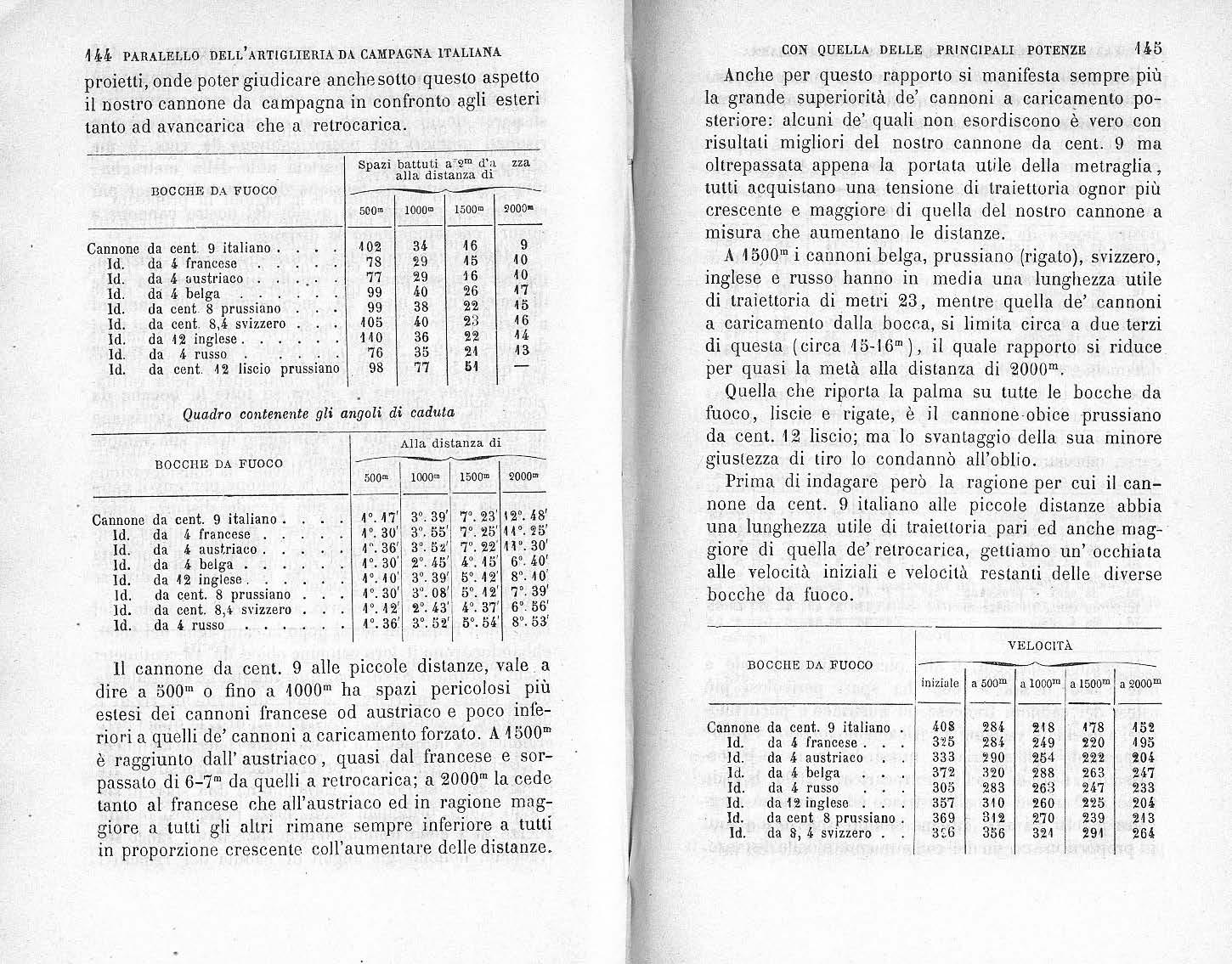
.i-4 PARA.LELLO
FUOCO _ , -:om 11000" 1500111 2000,.-
ld.
Id. dà
99
da
99
da
Id.
76
Id.
98
Cannone da cent. 9 italiano . 402 34. ~6 9
da 4 francese '78 29 45 rn Id. da 4 austriaco 77 29 16 40
4 belga
40 26 47 Id
cent 8 prussiano
38 22 45 Id.
cent. 8,4 svizzero rn5 40 28 46
da 42 inglese . 110 36 22 44 Id. da 4 russo
35 24 43
da cent. ·12 liscio prussiano
77 5~
- - - - - - I 500" 1000" 1500m 2000"'
ld.
ld.
Id.
ld. da
Id. da
Jd. da cent.
svizzer·o Id. da 4 russo 4°. 47' 3°. 39' 7 ° 23' ·12°. 48' 4° . 30' 3°. 55' 7°. 25' H •. 25' 1". 36' 3 ° . 5t 7°. 22' 4 P. 30' 1•. 30· 2 °. .rn' 4 °. rn' 6 °. 40' 4°. rn· 3•. 39' 5°. 42' 8°. rn' 4°. 30' 3°. 08' 5 ° . 4 2' 7 • , 39' 4° 42' [ 2• 43· 4°. 37' 6 ° 06' 4°. 36' 3°. 52'1 5° 54· s • 53'
da 4 austriaco . .
da
belga
42 inglese
cent. 8 prussiano
8, i
CO~ QUELLA DELLE PRINCIPALI POTENZE U.5
VELOCITÀ BOCCHE DA FUOCO _____.,.. iniiiale a 50()m a 1000'" Ia 1500tn I a :2ooom _ ,_. ,_ Cannone da cent. 9 italiano 408 284 2m 478 452 Id. da 4 francese . 3'2o 284 249 220 495 Id. da 4 austriaco 333 '.290 254 222 204 ]d. da 4 belga 372 320 288 263 247 ld. da 4 russo 305 283 268 247 233 ld. da 1:t inglese 357 310 260 225 20.i Id. cl:i cent 8 pru~siano . 369 8,12 270 I 239 213 ]d. da s, 4 sv izzero . . 3~6 306 324 29~ 264
D.ELL 1 ARTIGLIEil1A DA CAMPAGNA lTALIANA
Il cannone da cent. 9 esordisce con una velocità iniziale no n solo superiore a quella ·de'cannoni ad avancarica, ma anche a quelli a retrocarica; se non che quella velocità ben presto diminuisce, ed a 500m è appena eguale a quella del cannone francese ed austriaco, inferiore di mollo a quella del cannone prussiano, belga, svizzero, russo ed ingl ese; a 1 ooom l'inferiorità della nostra bocca da fuoco è grande in paragone degli altri ad avancarica ed é grandissima in confronto di quella a caricamento posteriore; a 2000'" poi è tale da non poterne p iù fare un paragone.
Da ciò vedesi chiaramente come la traiettoria del nostro cannone molto tesa fino a 500 1n, s'incurvi gradatamente, e quindi alle grandi distanze precipiti velocemente in basso, ben diversamente dì quanto avviene nella via tracciata dai proietli delle ,altre po tenze. La ragione di questo fenomeno, d'altronde facile a spiegarsi, consiste nel!' a vere il pro ietto del cannone da centimetri 9, una r:nassa, corrispondente ali' unità dì superficie, esposta alla resistenza dell'aria, sensibilmente più piecola che negli altri proietti, come fac il ~ mente s i può sc.orgere dal seguente quadro.
Quadro indicante il peso in grammi ver cent. quadrato di sezione della granata ordinaria delle seguenti bocche da fuoco
BOCCHE DA F UOCO
Cannone da cent 9 italiano
Id. da 4 austriaco
Id. da 4 francese . .
Id. da 4 belga . . . .
Jd . <fa cent 8 pru ssiano.
Id. da 4 russo . . . .
Id. da cent. 8,4 svizzero
ld. da ,12 inglese . . .
.Dunque la granata ilaliana da cent. 9 deve- perdere più preslo il vantaggio della sua maggiore velocità ini'-
CON QUELLA DELLE PltI NC[PALI POTENZE •1 ,i7 ziale e perciò la sua traiettoria più tesa sul principio si incurverà più rapidamenle délle altre.
Che se vogliasi tenere contò anche della maggiore radenza alle piccol e dislanze, corrispondente a quella maggiore veloci là iniziale che il cannone da cent. 9 possiedea paragone degli altri, dovrassi pure osservare come dentro quel breve limite si abbia efficace il tiro a metraglia; per lo che anche il vanlaggio di radenza suddetta non basta a stabilirP- un equilibrio di potenza tra quella specie d' artigl ieria e quella a retrocarica. Effetti di scoppio della granata ed effetti di tfro della metraglia,. - Esaminiamo ora. il cannone da cent. 9 sotto il rapporto degli effetti di scoppio della granata ed effetti di tiro della melraglia.
Questa bocca d.11 fuoco spara la granata ordinaria da cent. 9 del peso di chi l ogramm i 4,500 e la scatola da metraglia cli chil. 6,450.
Ne' tiri concro truppa l'effetto della granata dipende in parte dal numero de' pezzi (scheggie) prodoLti dall'accensione della carica interna .
La granata da cent. 9 dà ir~ media n° 30 scheggie micidiali fino a rnom circa dal punto di scoppio.
La granata da4 francese ne dà in media n°24 (scheggie)
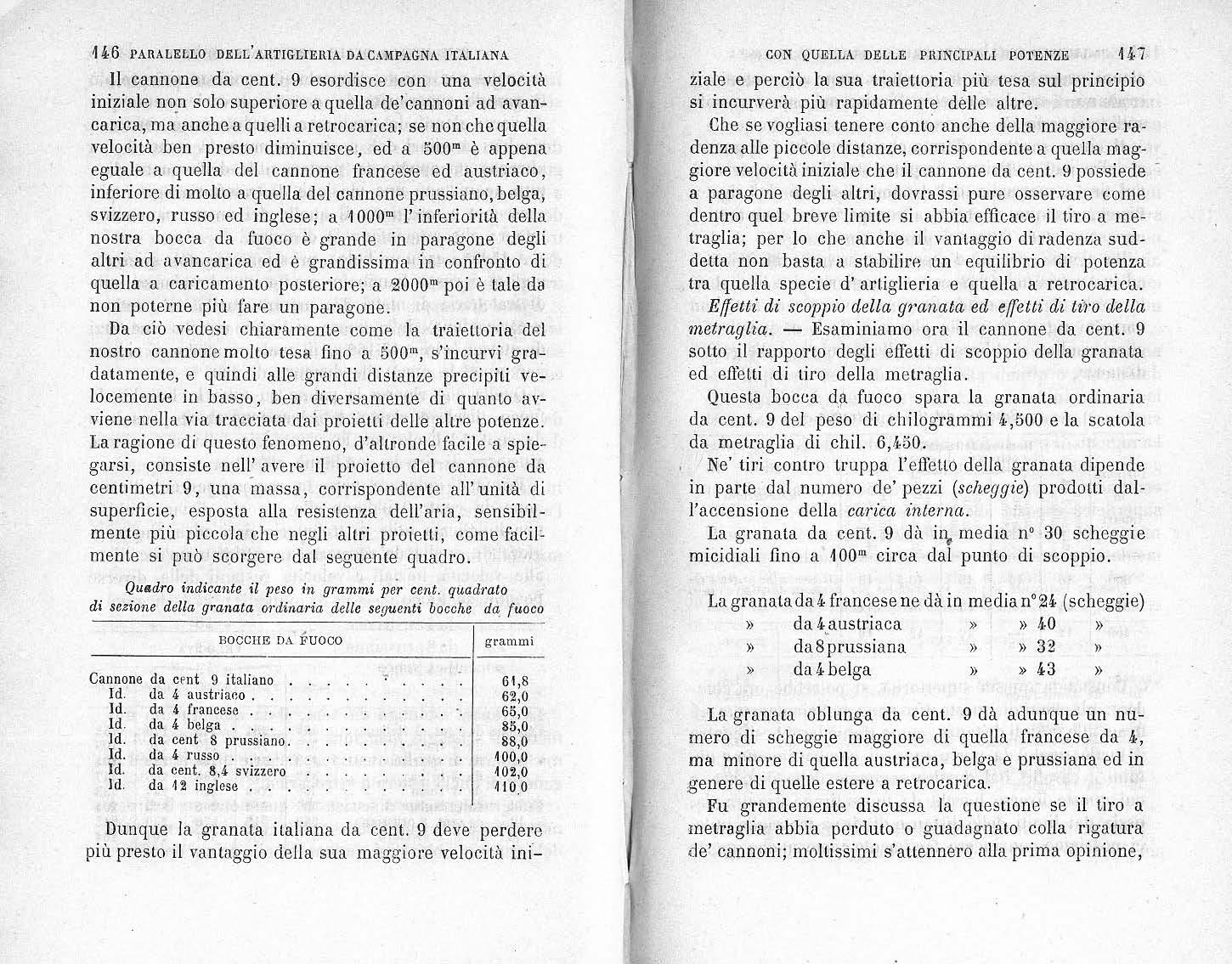
» da '~~austriaca » » .i:O »
» da8 pruss ia na » » 32 »
» da 4 belga » » .i:3 »
La granata ob lunga d a cent. 9 dà adunque un numero di scheggie maggiore di quella francese da 4, ma minore di quella austriaca, belga e prussiana ed in genere di quelle estere a retrncarica.
Fu grandemente discussa la questione se il tiro a metraglia abbia perduto o guadagnato colla rigatura de' cannoni; mollissimi s'attennero alla prima opinione,
H6 PARALELLO
grammi 61,8 62,0 65,0 85,0
88,0 400,0 402,0 410 0
,
DELL' AllT1GLIER1A DA CAMPAGNA ITALIANA
alcuni propugnarono la seconda, come ad esempio il capitano d' artigli éria belga Nicaise nel suo opuscolo sull'Artigli"eria da campagna. -
Il citato scrittore afferma che nessun fatto di guerra ci offre dati sufficienti da poter stab'ilire la superiorità del tiro a metraglia del cannone liscio o del rigatoBisogna dunque ricorrere alle esperienze comparative che sono s tate fotte ne' diversi paesi.
Da alcuni specchi d' esperi e nze eseguite io Svizzera ed in Austria nel 1868 con cannoni rigati e lisci si ri- . leva, che il tiro a mitraglia riescì più eflìcace fatto con cannoni rigati cli quel lo che con lisci, e qu esti migliori risultati si ebbero tanto alle piccole che alle grandi distanze.
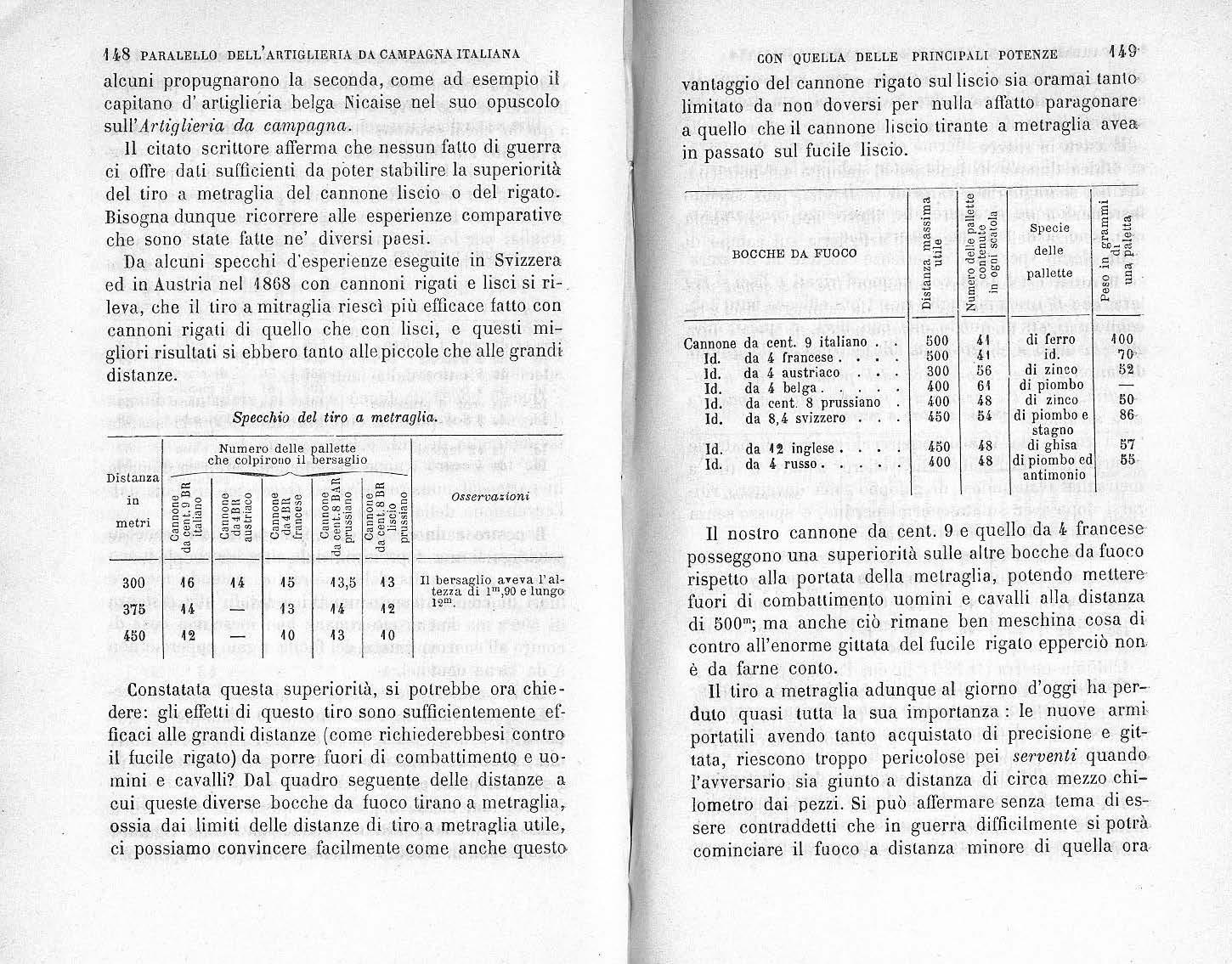
CON QUELLA DELLE PRINClPALl POTENZE U,9 ·
vantaggio del cannone rigato sul liscio sia oramai tanto· limitato da non doversi per nulla affatto paragonare · a quello che il cannone liscio tirante a metraglia aveain passato sul fucile liscio.
BOCCHE DA FUOCO
Cannone da cent. 9 italiano .
)d. da 4 francese . .
Jd. da 4 austriaco
Id. da 4 belga
Jd. da cent. 8 prussiano
Id. da 8, 4 svizzero
Id. da 42 inglese .
Id. da 4 russo • .
500 4l di ferro ~00 500 ,it id. 70•
300 56 di zio co 52
400 6t di piombo
,WO 48 di zinco 50
450 54 di piombo e 86, stagno
450 48 di ghisa 5'7
400 48 di piombo cd 55 antimonio
Il nostro cannone da cent . 9 e quello da .i- frances eposseggono una superiorità sulle altre bocche da fuoco r ispetto alla portata della metraglia, potendo metterefuori di combattim ~nto uomini e cavalli alla distanza di 500m; ma anche ciò rimane ben meschina cosa di contro all'enorme g ittata del fucile rigato epperciò non; è da farne conto.
Constatata questa superiorità, si potrebbe ora chiedere: gli effetti di questo tiro sono sufficientemente efficaci alle grandi distanze (come richiederebbesi contro il fucile rigato) da porre fuori di combattimentq e uomini e cavalli? Dal quadro seguente delle distanze a cui queste diverse bocche da fuoco tirano a metragl ia~ ossia dai limiti delle distanze di tiro a metraglia utile, ci possiamo convincere facilmente come anche questo,
Il tiro a rnetraglia adunque al giorno d'oggi ha perduto quasi tutta la sua importanza : le nuove armi, por tatili avendo tanto acquistato di precisione e gittata, riescono troppo pericolose pei serventi quando, l'avversario sia giunto a distanza di circa mezzo .chilometro dai pezzi. Si può affermare senza tema di es-· sere con traddetti che in guerra difficilmente si potrà. cominciare il fuoco a distanza minore di quella ora-
·14,8 PARAl,ELLO
300 rn 3'15 44 450 42 Specchio del tiro a metraglia. _ Numero delle pallette che colpirono il l>ersaglio H HS 43,5 13 H 40 43 Osserv a,.;-ioni ~3 Ii bet•sa8Ji0 aTeVa ]' a}• t.ezrn i I"',90 e lungo42 12m. 40
g • ., ·~ e ·.; .,o Specie I:: VJ O. .,,> _ ., ., - ~ ~ · ~., ., ::l o ~ ;,::: -· =(/) delle ' tio- ., .,;i Q>~.- ~,:,. "O cC .~ I'$" N O O CO paJleUe o :... oO o o .!:! Q) .!:; u> ;:l <n s <I) i5 ::, p.. z -- - -
•
•
detta. Perciò il tiro a metraglia efficace non sarà possibile che raramente, nelle imboscate a cagion d'esemrio, nelle so r preso, oppure pe r respingere la cavalleria, nella dife ns iva in genere .
L'idea dunque di lanciarsi al galo ppo sul nemico e quind i sbaragliarlo a furia di metraglia, può soltanto sorridere a. menti esaluite ed illuse, non a. chi abbia. conoscenza dell'impiego del!' artiglieria sul campo di battaglia.
Maresch n el suo libro intitolato: Die gezogenen imd glatten feldg eschutze (i cannoni da campagna lisci erigati) a. pag. 2·15 dice: la metraglia pPr l'artiglz'eria tutto al più un mezz o difensivo, tanto cl' arma 1·igata che liscia. La potenza offensiva del wimilivo tiro ci rnetraglia, dopo l' adozione del fucile 1·igato, è passata allo shrapnell.
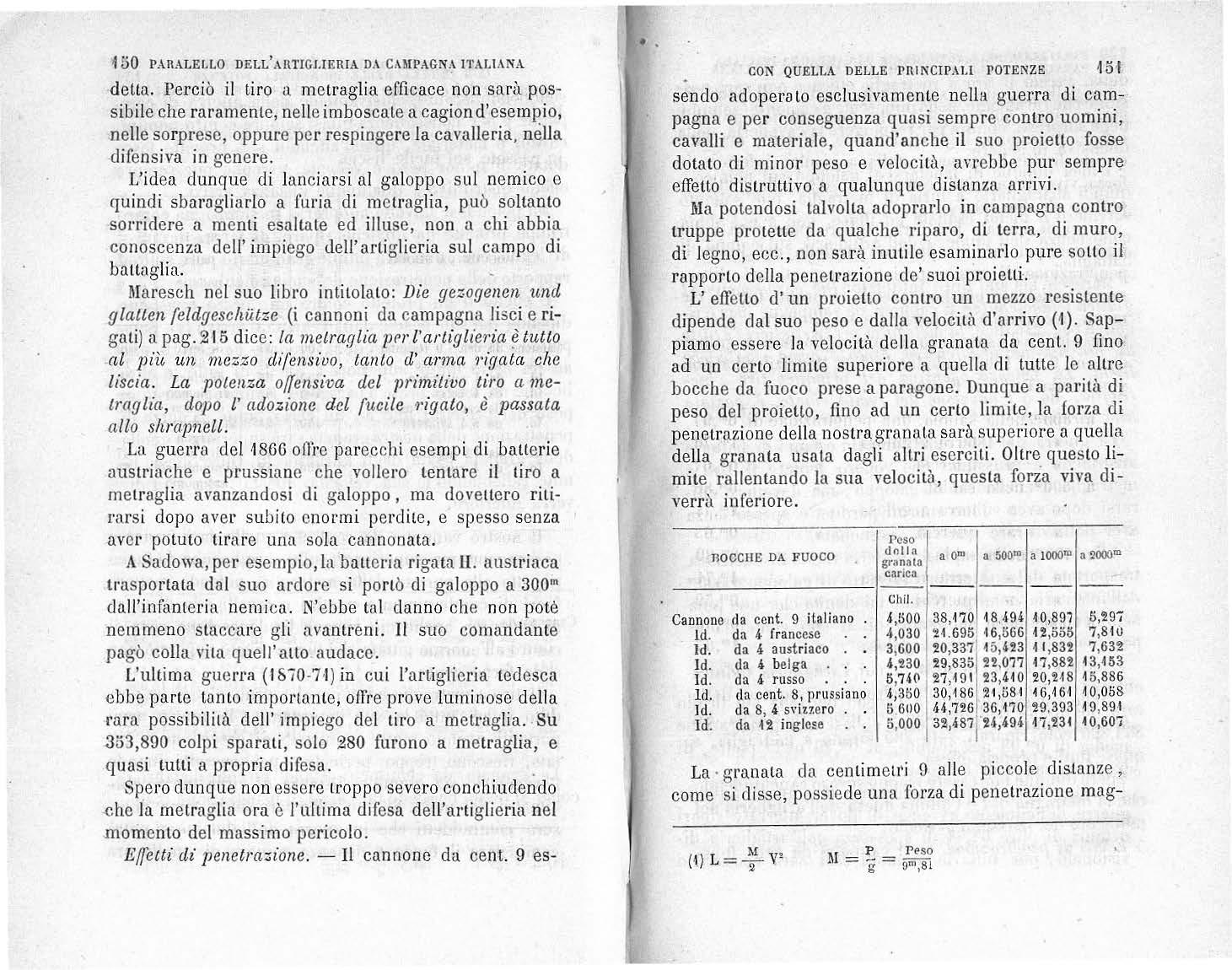
La guerra del 1866 offre parecchi esempi di ballerie austriache e prussian e che volle ro tentare il tiro a me traglia avanzandosi di galoppo, ma dovettero ritirars i dopo aver subilo enor mi perdite, e spesso s enza nver potuto tirare una so la cannonata.
A Sadowa, per esempi o, la batte ria rigata ll. austriaca tras porlata dal suo ardore si portò di galoppo a 300m dall'infantcria nem ica . N'ebbe tal danno che non potè nemmeno staccare gli avantren i. Il suo comandan te pagò colla vita quel!' allo audace.
L'ultima guerl'a ( 1670 -7'1) in cui l'artiglieria tedesca ebbe parte tan lo importante, offre prove luminose della rara possibililà dell' impiego del tir o a metraglia . . Su .353,890 colpi sparati , s olo 280 furono a me traglia, e quasi Lutti a prop ria difesa . .
Spero dunque non essere troppo severo con chi udendo .che la metraglia ora. è l'ultima difesa dell'artiglieria nel momento del massimo pericolo.
Effetti· di· penetrazione. - Il cannone da cent. 9 es-
CON QUELLA DELLE PIUl'\CIPAU POTENZB 15f sendo adoperato esc lusivam en te nella guerra di c~~pagna e per conseguenza quasi sempre con tro uom1m, cavalli e materiale, quand'anche il suo proietto fosse dotato di minor peso e velocità, avrebbe pur sempre effetto distruttivo a qualunque distan za arrivi.
Ma potendosi talvolta adoprarlo in campagna contro trup pe protette da qualche ripa ro, di terra, di mur~, di legno, ecc ., non sarà inutile esaminarlo pure sotto 11 rapf)orlo della penetrazione de' suoi proieui. .
L' effe tto d'un pro ietto contro un mezzo resistente dipende dal suo peso e dalla velocità d'arrivo (1). Sappiamo esse re la velocità della granata da cenl. 9 finoad un certo limite superiore a quella cli tutte le altre bocche da fuoco prese a paragone. Dunque a parità di peso del proietto, fino ad un certo limit~, la forza di penetrazione della nostra granata sarà_ s_upe [']ore a quell_a della grana ta. usata dagli altri eserc1t1. Oltre_qu~sto l~mite rallentando la sua velocità, questa forza viva diverrà inferiore.
Cannone da ccnt. 9 italiano ld . da 4 francese
da 4 austriaco . •
da 4 belga . . .
d. da 4 russo
da cent. 8, prussian o Id. da 8, 4 svizzero Id. da 42 ingles e
La . rrrana la da centim ett'i 9 alle piccole dis.tanze, come ~i disse, possiede una forza di penetrazione mag-
150 PARALEI.LO
DELL 1 ARTIG!.lERlA DA CAMPAGN.~ ITALIANA
.
JlOC CHE DA F UO CO r eso I do li o a oru a soom a1ooom .1 2ooom granata car ica --------- - 1-- -- - - -- --
Id.
Id.
4,500 38,470 18 ,,i94 40,891 5,297 4,030 ~H. 695 46,566 0 ,555 7 ,81 U 3,600 20,337 45, 03 4 1,83! 7 ,632 4,230 29,835 22 ,017 47,882 43,rn3 5,740 27,Hlt 23,440 20,248 45,886 4,350 30,486 24,584 46,461 40,058 5 ,600 44 ,726 36, 470 29,393 Hl ,89 ·1 6, 000 32,487(24,494 47,234 40,607
Id.
I
Chil.
(4) L = ~r V' P P eso M = - =9ms1 g •
'15'.2
l'ARALELLO
OELL1ARTIG-LrEl\IA DA CAMPAGNA ITALIANA
.giore delle granate austriaca e francese, e di poco inferiore fino a 5oom a quella che posseggono i proiettili belga, prussiano, inglese, russo e svizzero; ma oltre ,questo limite la granata italiana risulta inferiore in forza viva ai proietti li esteri, non solo della metà ma perfino di due terzi.
Avrei desiderato poter raccogliere pure tulti i dati µecessari per fare un pratico paralello del limite di penetrazione di tutti i proietti suesposti nei diversi mezzi i·esistenli; rna non avendo in pronto tutti li elementi necessari a tal paragone m i lim iterò a presenta.rne alcuni- d'esperienze eseguite colla nostra granata da cent. 9 nel 11863 sulle lande di S. Maurizio ed al poligono della Trebbia. E sono:
a 300m nella sabbia, una penetrazione di om,97
» » terra argillosa » 1 m, 76
» » quercia » om,67
a 500,n nella sabbia » om ,86
» » terra argillosa » 1 m, 7 &,
» » quercia » om,63
a 700m nella sabbia » o•n,80
» » terra argillosa » ,1 01 ,7 11
» » quercia )) om,59
a 1ooom nella sabbia » om,10
» » terra argillosa » 1m,67
» » quercia » om,52
Nelle esperienze fatte a Laveno nel 11864 sul tiro in ,breccia contro il forte Cerro ebbesi una penetrazione media di 0"',08 nel gra nito, di Om,26 nella pietra, di om,55 in muro di mattoni .
Da tutlociò si può conchiudere che quantunque ,in guerra difficilmente avvenga di dover atterrare ripari o muri di oltre 0"',55 di spessezza coll'artiglieria divisionale, pur tuttavi a in molti casi sarà necessario
CON QUELLA. DELLE PRINCIPALI POTENZE _ 153 ricorrere alle artiglierie da posizione, che è pur difficile aver pronte alla mano, non possedendo l'attuale cannone i requisiti necessari . Una prova di ciò si ebbe nell'altacc,o di Roma nel 1870 in cui la suddetta granata da centimetri 9 fu di pochissimo effetto contro le mura, sicchè bisognò ricorrere al cannone da centimetri 12 BR.

Limite dellu distanza di tiro. - Tre sono le specie di tiro che si eseguiscono coll'artiglieria nostra da campagna: di lancio a.granata, a metraglia ed in arcata.
Essendosi di già parlato de' limiti di tiro utile a metragHa poco prima, ci rimane ora ad esaminare quello di lancio a granata .
Il cannone da cent. 9 italiano lancialagran.afino a 3200m
>> » 4 francese » » 3400m
)) » 4 austriaco >> » 340Qtn
» » 4be lga )) )) 4000,n
» » 4russo » » 34QQm
» da cent. 8 prnssiano )) » ssooni
)) )) 8,4 svizzero )) )) . 400Qm
)) » rn inglese )) )) ·sooom
Il cannone italiano ha il tiro di lancio più limitato di tulle le altre artiglierie campali europee, eccell.ualo soltanto il cannone da '12 inglese . La sua inferiorità poi è molto sensibile rispetto al tiro de' cannoni a retrocarica. 11 belga e lo svizzero primeggiano.
Riguardo al tiro in arcata non si può porre a paragone il cannone nostro che con quelli d'Austria, Francia, Svizzera e Russia, poiché le altre arliglierie estere non usano questa specie <li tiro. Il maggior tir o in arcata è dato dal cannone da 4 russo che giunge fino a 1700m; l'austriaco a '1500m; l'italiano a H,00'"; lo svizzero a 1200m; il francese a 1 ooom .
,
PARALE!.10 DELL'ARTIGLIERIA DA CA!IPAGNA I TALIANA
De l t iro a sb rapnell no n facciamo parol a non essendo slal o accora definitivamente acce ttato tr a noi (1).
Celerità di tiro . - La celerità di tiro pel cannone d a ca mpag n a è un coefficiente imp ortantissim o , avve. gnachè , a cond izioni pari, a vrà vantaggio senza dubbio quello che tir e rà più rapidamente bene.
È innegabile che l'esercizio continuo de' serven ti e la sem plicità de lla manovra , possono risparmiare lernp o; tuttav i a non si potrà mai dai pezzi ad avancarica ottenere la velocità di tiro di quelli a retro ca ri ca . P er consegue nza l'Ilalia, l'Austria e fino ad ora la F ran c ia per q uesio l ato a vranno un' inferiorità incontes tabil e rispetto alla Prussi a, a l Uelgio, alla Svizzera, al!' Inghilterra e alla Russia. Esperienze eseguite n e lla cel erità. di tiro , pun tando bene, diedero un imp iego di tem po di:
,12minuti per tir ure2o col pi colcann.da cent. 9 ita liano;
12 » )) )) )) }) 4francese;
12' /i » » » )) )) 4austriaco;
H )) » » » » 4 belg a;
H )) » » » » 8 prussian o; H 1/,» )) » » }) 8,4 svizzero ;
11 » » » » » 4russo.
Risulta dunque che per tirare un co l po d i cannone s i pe rdono:
28"¼ d i tempo co lla bocca da fuoco italiana e france~e; 26" . » » >> belga, prussiana e
28" 30" » » )) » » ))
russa; svizzera; austriaca.
Anche sotto qu esto rappo rto dunq ue la supe r i orità rimane ai cannoni a retroca ri ca. Fra quelli ad avan-
(~) Ciò s i riferisco sempro al febbraio 873.
CON QUELLA DELLE l'RlNClPALl POTENZE 155 carica il cann one italiano s ta alla pari c ol fr an c es e e sup er a -1' austriaco.
!tlobilità. - Fino a qualche anno add ietro l' arligliel'ia italiana poteva vanta rsi di possedere il material e da campagna più leggero di tu tta Europa; ma i ra pidi prog ressi fa tti d ag li alt ri in questi ultimi anni, tanto in riguardo a l egge rezza di carreggio che a boc che da fuoc o, l e t ol sero il prim ato .
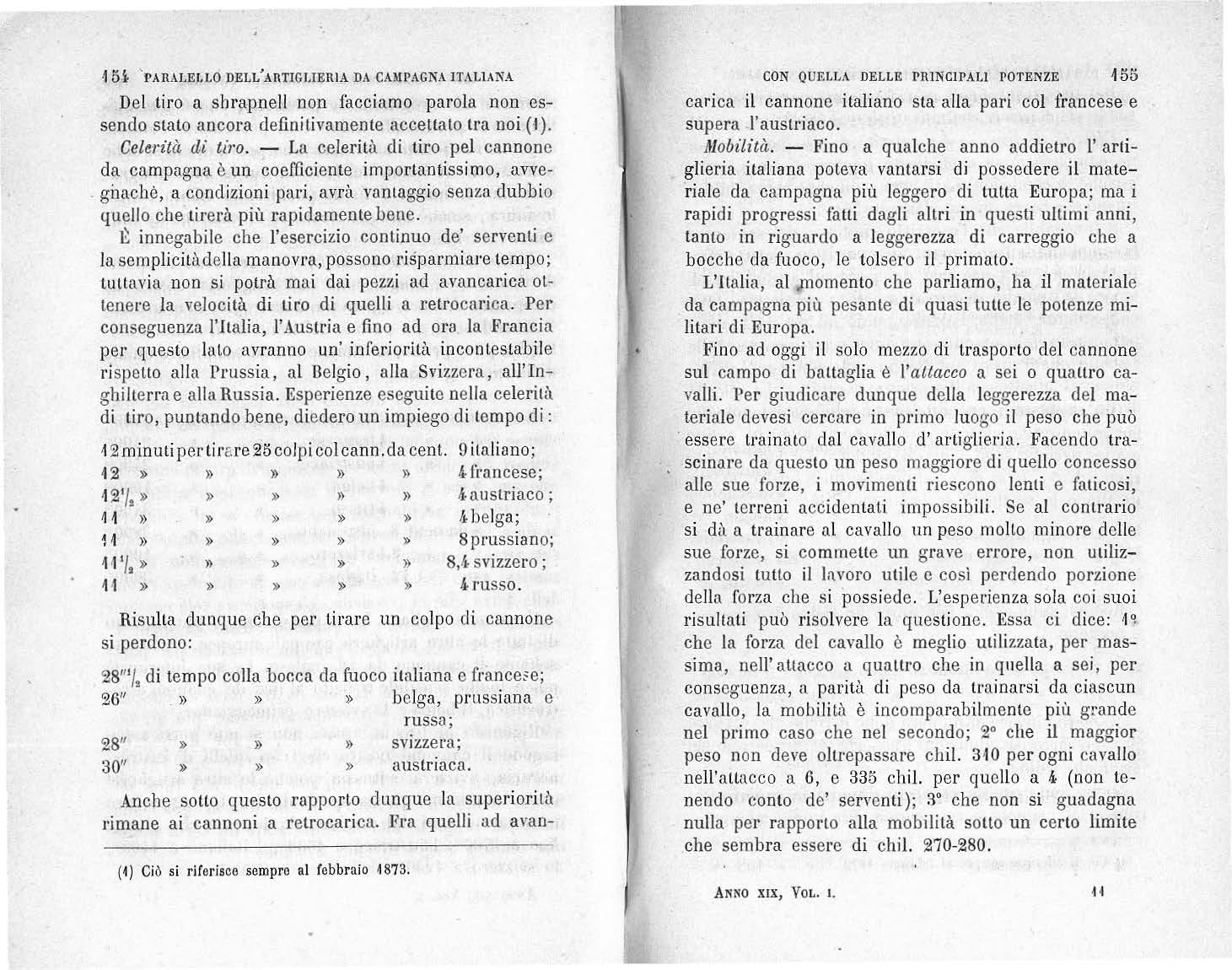
L'Ita lia, al .momento che pa rli amo, ha il ma teriale da campagna più pesante di quasi tu lle le potenze militari di Europa.
Fino ad oggi il s ol o m ezzo di traspor t o d el can none sul campo di batt ag lia è l'attacco a sei o quallro ca, ,alli. Per giudica re dunque d ella legge r ezza del materiale devesi cercare in p rimo luogo il peso che può · ess er e tra i nato da l cavall o d'artiglieria. Facendo t rascinare da que s t o un peso maggiore di quello concesso alle sue forze, i movimenti riescono lent i e faticos i , e ne' terreni accidentati imposs ibili. Se al contrario si d à a trainare a l cavallo u n peso molto min ore delle sue forze, si co m me tt e un g rave errore, non u tili zzand osi tutto il lavoro uti le e così p erdendo porzione dell a forz a che s i possied e . L'esp erienza sola coi suoi risult a ti può ri solve re l a question e . Essa ci d ice : 11ci che la forza del cavallo è meglio Ulilizzata, per massima, nell'attacco a quattro che in qne lla a sei , per conseguenza, a parità di peso da tr a inarsi da cias cun cavallo, la mobilità è incompa rabil me nte più gran de nel pri mo caso che nel second o; 2° che il maggior peso non deve oltrepassare chi!. 3'10 per ogni cavallo nell'atta cc o a 6, e 3315 chil. per qu ello a 4 (non tenend o conto dc' serventi); 3° che non si guadag na nulla per rapp orto alla mobili tà sollo un cert o limite che sembra essere di chi l. ~70-280.
1 O-~
'
ANNO XIX, VOL, I.
PARALE;LLO DELL'Al\'.DlGLIERIA DA CAMJ,>AGNA ITALIANA
Qur~ro d~mostrativo del peso di ciascun pez-zo e carro a munizioni di tutte le princip ali artiglierie d' Eu1·opa.
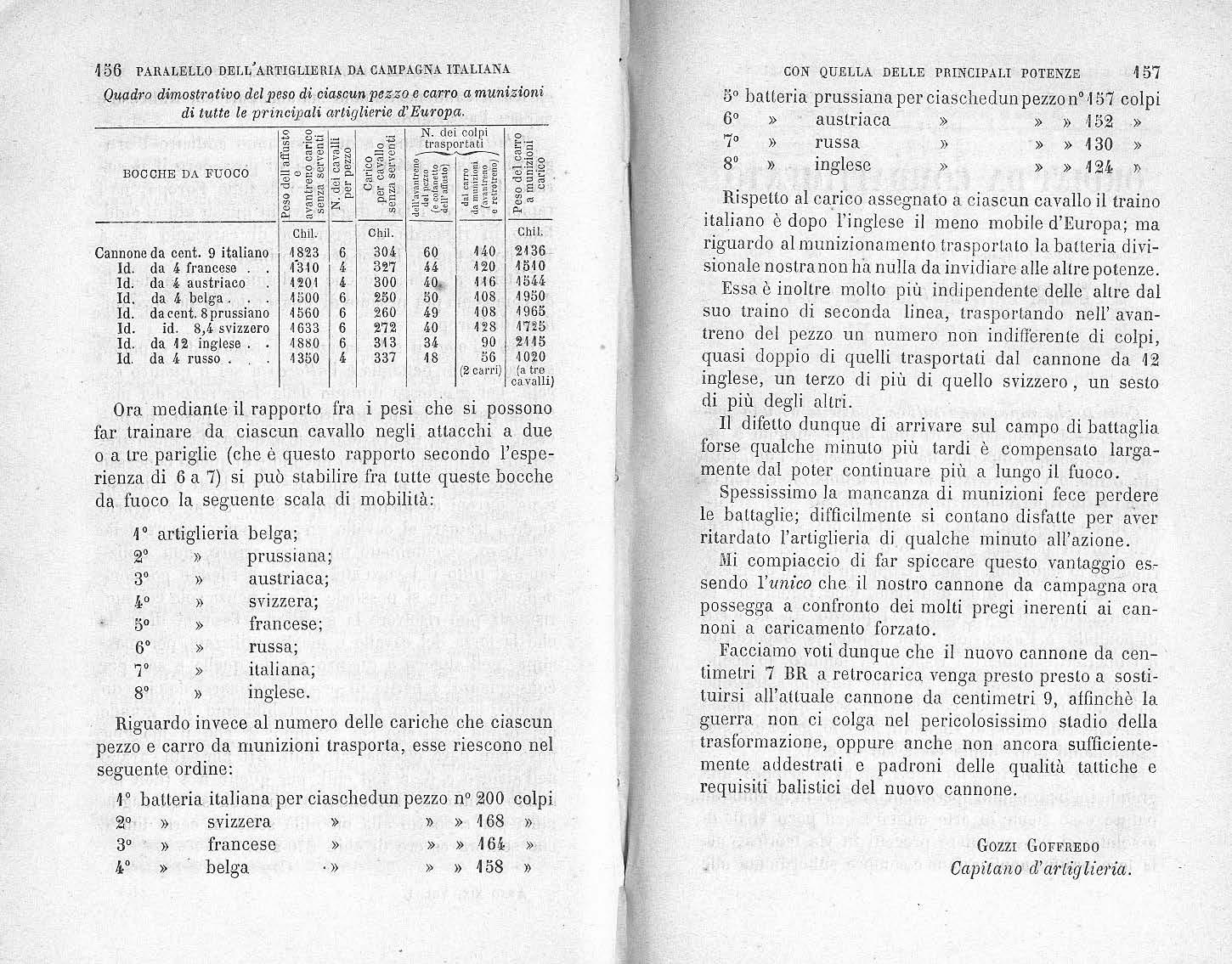
N. dei col pi t r asp or tati
BOCCHE DA FUOCO
Cannone da ccnt. 9 italiano
Id. da 4 francese
Id. da 4 austriaco
Id. da 4 belga .
Id. da ccnt. 8 prussiano
Id. id. 8,4 svizzero
Id. da 2 inglese
Id da 4 russo
Chi!. rn2a 4°310 -120 ·1 HSOO 1560 rn33 ~880 ·13150
4 32.7 44 .120 mm
4 300 40 ,U 6 Hi44
6 250 50 •108 950
6 260 49 •108 A965
6 272 40 ~28 4725
6 34 s 34 90 2,1 rn
4 337 ,18 56 020 (2 carri) (a tre cavalli
Ora mediante il rapporto fra i pesi clÌe si possono far trainare da ciascun cavallo neg li atlacchi a due o a tre pariglie (che è questo rapporto secondo l' esperieuza di 6 a 7) si può stabilire fra tutte queste bocche da fuoco la seguente scala di mobilità:
1° artiglieria belga; 2° » pruss iana;, 3° » austriaca; )) » svi zzera; francese;
6° » russa;
'i 0 » ilaliana;
8° » in glese .
Riguardo invece al numero delle cariche che ciascun pezzo e carro da munizioni trasporta, esse riescono nel seguente ordine:
1° batteria. it!).liana per ciaschedun pezzo n° 200 cQlpi
2° » svizzera » » » 168 »
3° » francese » » » 16i- »
4° » belga · » >> » 458 »
CON QUELLA DELLE I'RINCIPALt POTENZE 157
5° batteria prussiana per cias che dun pezzo n° ,157 colpi
6° » aus(riaca » » » ,f 152 »
7° » russa » » » 130 » so )) inglese » » » 4 24 »
Rispetto al ca_rico asseg nato a c iascun cavallo il traino itali ano è dopo l'inglese il meno mobile d'Europa; ma riguardo al munizionamento traspor lato la baueria divisionale nostra non ha nulla da in vidiare alle altre potenze. Essa è inollre mo lto più indipendente delle allre dal suo traino di seconda linea, tr<'.l sportando nell' avantreno del pezzo un numero noh indifferente di colpi, quasi doppio di quelli trasportati dal cannone da 12 inglese, un terzo di più di quello svizzero , un sesto di più degli altri.
Il difetto dunque di arrivare sul campo di battaglia forse qualche rninuto più tardi è compensalo largamente dal poter continuare più a lungo il fuoco.
Spess issimo la mancanza di mu nizioni fece perdere le bauaglie; difficilmente s i contano disfalle per aver ri tardato l'arti glieria dì qua lche minuto all'azione . fli i compiaccio cli far spiccar e questo vantaggio es." sendo l'unico che . il nostro cannone da càmpa.gna ora possegga a confronto dei molti pregi inerenti ai cannoni a caricamento forzato.
l?acciamo voti dunque ch e il nuovo canno11e da cent im etri 7 BR a retr ocari ca venga presto presto a sostituirsi all'attuale cannone da centimetri 9, affin chè la guerra non ci colga nel pericolosissimo stadio della trasformazione, oppure anche non ancora sufficientemente addestrati e padroni delle qualità tattiche e requ isiti balistici del nuovo cannone.
156
---go.SO
'igf llll l!l! ~I ~!~14
t:
-:- -:: ~;);~
Gozzr GOFFREDO Capitano d' artig lie1·ia.
ORDINI DA C01\IIBATTI1\IIENTO
ORDINI UN ITI ED ORDINI SEPARATI
Crite1·ii che influi"scono sull'occupazion e di una posizione. - L'occupazione di una data posizione è un fatto che sempre dipende da variì cr ìterii i quali tutti più o meno vi esercitano la loro influenza, entrando come fattori nei calcoli preventivi di chi deve stabil ire i l modo con cui tale occupazione devesi effettuare. Tali criterii possono essere, o d'ordine morale, cioè riflettere lo s.tato morale delle tru ppe propri e e di quelle del , nemico, o d'ordine materiale, cioè riguardare la conformazione del terreno, il rapporto fra la forza disponibile e l' estension e del fronLe, la superiorità o l'i nfe riorità numerica rispetto al nemico, lo scopo che s i vuol r aggiu ngere . No i qui fa remo astrazione dai fallori morali, per cons iderare solo quelli ma teriali, che ridurremo ai seg uenti; terreno, forza e scopo. Esami niamo brevemente ciascuno di essi .
Te1·1·eno . - Il terreno ebb~ ed av rà sempre un a grand e influenza sulle op eraz ioni militari di qualunque natura esse sieno; io arte militare ben poco vi ha di assoluto; si possono dare precetti in via teorica, ma la loro pratica appl icazione è sempre subordinata alJe
DEGLI ORDINI DA COMBATTIMENTO ECC, 59 forme del terren o su:! qua le le operazioni s i svolgeranno; le modificazioni introdotte nel sistema odierno di combattere non hanno fallo che aumentarne l'importanza , rendendo ognora più cl ifficile l' azione direttiva di chi è prepo s to al comando delle truppe che su di esso agiscqno. In altri tempi i campi di battao-lia si sceglievano su quelle località nelle quali il terr;no pe1· lo p iù piano o leggermen te acc identato, scoperto ~l più possibile, permetteva i movimenti di og ni ~rrna m ogni senso; co là gli eserciti quas i si da vano convegno, e la villoria si decideva coll'urto delle o-rosse o masse. Coll'aumentare dell'efficacia delle armi da fuoco ciascuno ,<lei due avversarii cercò na turalmente di porsi per quan to possibile al riparo dai co lpi d ell'altro; le truppe s1 trasportarono su quei terreni che offrivano questi ripar i; le grosse masse si sciolsero; si andò sempre aumentando l a mobilità di queste truppe; e cosi si Yenne alla guerra odierna, nella qua le i terreni piani e tr oppo spacciali non si cercano che per evitarli e si . ' r~puta fortunato quello fra i combattenti, il quale arnvo a s ta bilirsi su di una posizione che abbia il fronte il più poss ibilmente coperto da os tacoli naturali ed artificiali, che nascondano alla vista, ma specialm che coprano dai proietti de l n emico .
Ciò naturalmente doveva influire sul modo con cui Jc truppe devono disporsi su qu esto fronte. Quand o il terreno in avanti è ovunque praticabile e gl i attacchi. per. par te del nemico poss ono quindi sviluppa rsi in · ogni senso, è naturale che le truppe della d ifesa vi si deb~ano disporre in modo pressochè uniforme, colla ris erYa o le riserve in posizione cen trale, pronte ad accorrere sul punto minacciato; l' offensore es so pure avrà ~ul _fronle una lin ea uniforme di tr uppe, e le proprie riserve od al cent r o o più ravvicinale ad una delle proprie ali, secondo il' punto sul quale egli vu ol
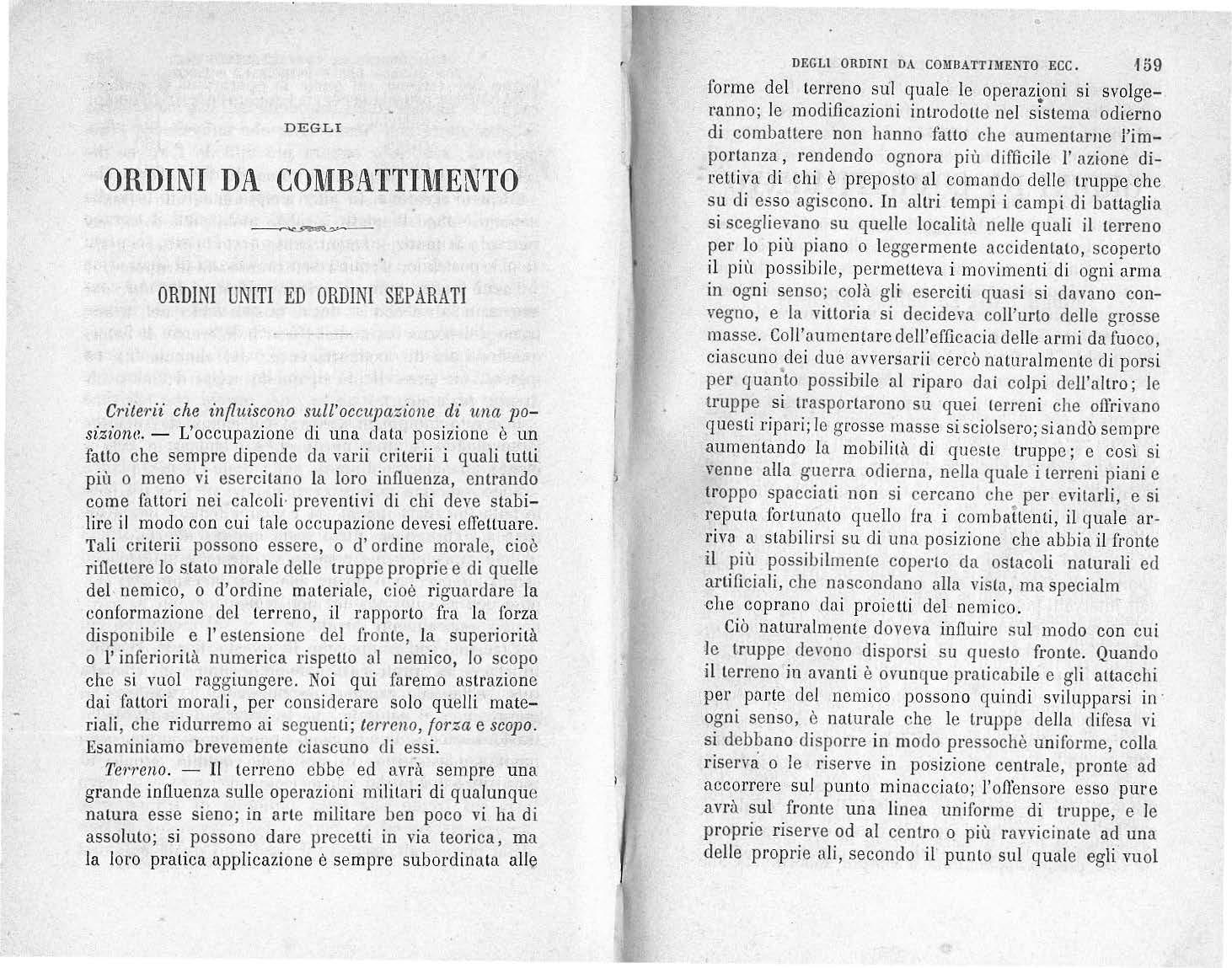
DEGLI
•
DA COMDA'r.Tli\IEN'l'O far impeto; iq {questo caso si avrebbero due ordini uniti. 1\fa, come si disse, oggidì è ben raro il caso nel quale l'a.zione si svolga sn di un terreno siffatto; per contro , sul fronte della posizione si avrà quasi sempre qualche ostacolo, qualche accidentalità, che renderà se non impossibile, per lo rnep.o assai diffi cile l'avanzare del nemico in quel tratto, oppure che impaccerù le nostre mosse in quella direzione ; si com. prende quindi co me spiegando le forze in modo uniforme su tutto questo fron te , in alcuni punti si avrebbero truppe inoperose, perchè coperte dalla natura del terreno, mentre in altri, sui quali probabilmente si concentrerebbe lo sforzo del nemico, o dai quali si dovrebbero svilupp are le mosse offensive, non• si avrebbero truppe sufficienti, sia per resistere a questo sforzo, si a per procedere ad un atto risoluti vo .
In tal caso , cioè quando una parte del fronte è impraticabile o per lo meno assai difficile, non solo non sarà svantaggioso, ma anzi sarà conveniente il lasciare alcuni tratti o totalinente sguern'ili od almeno assai de- · bo lmenLe occupati, concentrando invece le forze su quegli altri sui quali esse possono trovare più u tile impiego . Si verrà cosl ad avere un ordine sepa.1·ato, con intervalli più o .meno larghi a secondo delle forme del Lerreno, ordine che se ben impiegato può riescire efficacissimo, ma che può anche prodi.1rre uno slegamento ed un difetto d'assieme nell'azione. Vedremo più ·innanzi come ciò possa avvenire, e come vi si possa in gran parte rimediare. . ·

Fo1·za . - Passiamo ora all'elemento forza. In tutti i libri che trattano cti· tattica, noi troviam o indicati i rapporti che devono esistere fra l' estensione- del fronte di una posizione e la quantità di forze da destinarsi alla sua occupazione, s ia che ciò si faccia con scopo difensivo, sia che si faccia con scopo offen-
sivo. Questi rapporti naturalmente non poterono venir stabiliti che in via teo rica , e sòno sempre subordinati agli altr i due elementi di teti'eno e di scopo; in generale essi variano fra un massimo di 8 uo mini ed un minimo di 4 uomini per ogni metro lineai'e di fronte da · occuparsi; e ciò sta bene quando questo .fronte sia tutto praticabile; ma nei casi nei quali una par'~e di esso è già naturalmente.coperta di ostacoli, ,o ritratta in modo che assai difficilmente vi si potranno sviluppare operazioni d' importanza, allora questi dati cambiano di valoTe, e ciò che prima era un minimum appena suffici ente, pnò diventare una media già vantaggiosa, offrendo il mezzo di aumentare il rapporto fronte-forza su quei punti sui quali più probabilmente si risolverà il combartimento. Nel calcolare dunque la forza nece:ssariu all'occupazione di una posizione, per dedurne poi l' ord in e di combattimento da assumersi, non si dovrà solo tener conto dell'estensione totale del frònte, ma invece converrà studiare la sua natura, le sue a.e- , cidentalit.\, l'influenza · che esse possono esercitare nel comba ttimento, gli appoggi d 'ala, la possibilità e convenienza degli aggil'arnenti . Solo dopo un'esatta conoscenza di questi dati, sarà possibile determinare la densità dell'~ccupazione e quindi l'ordine da addottarsi, per avere arlmeno sui punti più impoi'tanti quel quimtita tiv o di truppe che busti, se non ad _ assiclii'are defi:. nit ivamente l'esito dell'operazione, almeno a procaééia'i'e \}Ila ce.i'ta probabilità di riuscita. supponiamo di avere un fronte di 3000m da ' occuparsi con una sola divisione di 110,000 liòtnini ·ai fanterià, oltre alle al rre armi; se l' occupa'.ìione si dovesse fare con ordine unito, il rapporto ve rr ebbe ad essere di 3 1 /~ uomini per ogwi. rnetr·o lineare; il che sarebbe appena ammissibi le pel cas o di una di fesa temporanea intesa a guadagnare tempo; ma s·e dalla ricognizione
160 DEG-Ll
ORDINI
ORDINl UNlTI ED ORDINI SEPARATI 161
ORDI NI UNlTI ED Ol\DI
163
del fronte, risultasse che un terzo di esso o pe.r esser coperto da ostacoli naturali, o per essere troppo ritratto si potrebbe anche non occupare senza gravi inconvenieJ1ti assumendo così un ordine separato, allora noi vediamo tosto questo rapporto fronte -forza salire a 5 uomini per ogni metro lineare, i l che è g ià sufficiente per poter effettuare una vali da difesa atLiva.
Quando s i assumesse un ordine troppo denso, si volesse , cioè, ammassare su di un dato fronte una quantità di forza superiore a quella che razionalmente vi potrebbe trovare utile imp iego, e per concretare, se si volesse andare al di là di 1O uomini per metro, allora oltre allo svantaggio di d is t rarre questa forza da un altro punto del teatro della gµerra o dal campo di battaglia ove potreb be essere ne cessaria , vi sarebbe pure lo svantagg io dell'ingombro che ne risulterebbe all' indietro del fronte, ingombro che siuchè la truppa avanza .non potrà essere di gran danno, ma nel caso di una ritirata, può essere causa di funeste conseguenze .

Concluderemo adunque c ollo stabilire che i l rapporto migliore fra la fo rza ed il front e, varia fra 4 ed 8 uomini per ogni metro a seconda che ·da un ordine separ ato si passa ad uno che maggiormente. si vada avvicinand o a ll'uni to.
Scopo. - Ri mane ora a vedere come lo scopo che si v uol raggiungere possa influire s1:1ll' ord ine da combattimento da addottarsi.
ccupazione difensiva . - Quando Jo scopo sia difensivo , allora si possono dare due casi ; o la difesa vuo l essere fatta con tutta energia per giungere a ributtare il nemico assa ltan te , oppure non vuol essere che temporanea, cio è intèsa a guadagnar temp o. Nel primo caso, per con segu ire un risu!Lato conviene che il fronte ch e si difende s ia guernito .c on quel massime, di forze cqe vi può essere utilmente impiegato, i n modo che su qualunque punto il nemico faccia i mpeto, egli venga sempre a trovars i di fron te una forza se non superiore, a l meno capace d i neutralizzarne gli effetti ; a meno quindi di conformazioni speciali del terre no che consigli no d iversamente, l'o rdine da addottarsi in questo caso vorrebbe es~ere quello unito, e con un rapporto piuttosto forte fra il fronte e la forza . Al contràrip quando la difesa non debba essere che temporanea, oppure quando i l fronte da tenersi sia eccess ivo per la truppa che si ha disponipile, allora si po tt·à usare l' ordine separato , cercando di utilizzare il meglio po ss ibil e le accidentalità. del. suolo, e supplendo a l difetto di forza , coll' impiego razionale ed opportuno ·di quella che si ha.
162 DEGLI ORDINI DA COMBATTIME:NTO
Occupazione offensiva . - Quando una posizione si occupa con iscopo offensivo, cioè so l o come punto dr coordinamen to· fra le varie colonne , per quindi passare ad un altro punto occupato dal nemico , non è necessario, a parer mio, che tutto il fronte venga guarni to di truppe, ma basta che lo sieno fortemen te quei tratti dai quali s i vuole sviluppare l' assalto, in modo che esso si possa preparare e quindi condurre ad efNI SEPARATI 1
fetto con forze prevalenti; in tal caso ad unque un ordine continuo non avrebbe che il vatitaggio di obbligare il nemico a rivolgere la sua attenzione a tutta la nostra linea, vantaggio che sarà però minimo per poco che questo nemico sia avveduto e conosca il terreno, poichè non s i lascierà cosi facilmente trarre in inganno sul vero punto di atlacco ; meg lio sarà quindi cercare di preponder are :mi punti più importanti, anzi.ché disperdf}re l e forze su tra tti di terreno dai quali poi esse non / potrebber o esercitare un'azione diretta. L'ordine séparato adunque, quando ben impiegato, potrà essere conveniente per l' occupazione di una posizione con iscopo otfensi~o.
ORDINI DA COMBATTIMENTO
A questo punto cr~do però conveniente l'osservare, che se in teoria può sempre esistere questa d istinzion e fra gli scopi cui si tende, nella pratica applicazione invece difficilmente si potrà mantenere , perchè le forme del combatti mento odierno sono tali, che in esso !' azione' offensiva e quella difensiva, qualunque sia questo scopo, non solo possono, ma debbono sempre compenetrarsi, adattandosi alle forrne del terreno ed alle ·siiuazioni parziali che si manifestano nel combattimento stesso; perciò l'ordine da adottarsi sarà sempre indicato più dal terreno e dalla forza disponibile, che dallo scopo che si vuol rnggiungere. ·

Abbiamo dunque visto come per quanto riflette la disposizione di una data quantità di truppe nel senso del loro fronte, s i possono date due specie di ordini di combattimento; cioè l'ordin e unito e quello separato: vediarno i vantaggi ed i difetti inerenti a cìascuno di essi, come si possono utilizzare i primi, se e come correggere i secondi.
Ordine 'Unito. - Ordine 1.mito abbiamo detto esser quello, nel quale i varii corpi costituenti la prima schiera si trovano ad immediato contaittofra di loro, sì che sulla fronte de·lla posizione occupata ne risulti una linea continua e di forza conveniente. Con ciò non intendiamo certo che i corpi vi si debbano schierare come sulla piazza d'armi, c io è che fra i soldati debba esistere il contatto dei gomiti, e fra i varii ripal'Li le distanze regolamentari; col modo di combattere d'ogg idì ciò non è più possibile, perché basla u q solco nel terren o, un filare d'alberi, per far alterare queste forme ; per ordine continuo intendiamo que llo nel quale ogni punto del fronte occupato è più o meno fortemente guernito, e tutto il terreno in avanti è direttamente battuto dai fuochi di questa trupp a: -
Suo impi"ego nell'offensiva. - Nell'offensiva quest'or-
OltDlNI UNITI ED ORDl:Nl SEPARATI '165 d ine, come già si disse, presenta jl vantaggio di obbligare il nemico a tenere la propr ia attenzione rivolta a tullo il fronte, non permettendogli di riconoscere sin dal principio quale sarà il punto sul quale si proriuncierà il vero attacco; per tenersi parato ad ogni evenienza, egli si vedrà forse costretto a portare presto nella prima schiera una parte delle proprie riserve, e questa minaccia , questa pressione generale su tutti i punti probabilmente gli impediranno d i occuparsi come converrel)bedei movimenti aggiranti, che qualche nostro corpo tentasse sulle sue ali, s ia mai'ci anclo diretLamente alle sue. comunicazioni, sia al solo scopo di faGilitare il difficile attacco fr ontale.
A questi vantaggi materiali conviene pure aggiungerne uno morale non trascurabile, che è quello della maggior fiducia, della maggior energia che nasoe sempre in una truppa la quale si vede da ogni parte appoggiata e sostenuta da altre forze de l proprio partito; è evidente che quando l'assalitore deve preoccuparsi di un contrassalto che gli può piombare improvvisamente sul fianco, non opererà mai con tanta risolutezza come quando tale preoccupazione è distrutta dal fauo, che i fianchi sono assicurati da altre forze appostate all'indietro in buona posizione, e che seguono l' attacco a breve distanza.
Il volersi però troppo sistematicamente attenere a quest'ordine, può generare serii in convP,nienti; la pcatica odierna del combattimento consiste nel dilatarsi sempre più per spuntare ed abbracciare il nemico; se quindi non si pone ben m ente a mantenere questo dilatamento entro giusti limiti, ne può facilmente na-. scere un indebolimento generale del fronte, approfitta ndo del quale un nemico avveduto ed ardito focil~ mente giungerà a sfondare l a nostra linea in uno o più punti, prima che le riserve possano accorrere a
164
D.EGLI
ORD1Nl DA COMBATTIMENTO
porre un argine a . questo suo irrompere. co?troffe~sivo. Diremo dunque che nell'offensiva l ordine unito è vantaggioso sinchè non porta ad un eccessivo frazi~namento delle forze, e ad ·un conseguente indebolimento su tutto il fronte. · .
Suo impiego nella difensiva. - Quanto alla difensiva. già accennammo come l' avere la prima schiera formata in otdine unito presenti il vantaggio , quando l e truppe sono ben d isposte, di contrapporre al nemic~ la massima potenza di fuoco, e di portare già innanzi quelle fo rze, le quali a seconda delle esigenze ?el comba Ltimen to dovranno poi venir impiegate ne, controattacchi fatti o direttamente o meglio sul fianco dell'assalitore. Ma appunto per essere queste forze spinte innanzi, per quanto esse si tenga no al coperto dietro qualche accidentalità, l a loro presenza e probab~lmente anche il loro numero saran no ben presto nott al nemico, il quale potrà così prendere le misure necessarie a paralizzarne l' azione, e così verrà a mancare pienamente l'effetto della sorpresa . A ciò conviensi pure aggiungere il logorame nto proçloùo dall.e perdile che tali truppe non potranno a . meno di subire se por~ate sin dal principio nel raggio d'azione del fuoco nemico, il che andrà tutto a scapito dell'impeto e della celerità , con cui queste parziali azioni controffensive devono esser condotte perchè possano sortire buo n esito.
Se nell'offensiva si manifesta nel combattimento odierno una tendenza ad allargare eccessivamente la p rop1;ia fronte per esercitare ~on c!? 1:1na pressione sulle ali o sui fianchi del nemico, c10 s1 verifica pure come ·Conseguen za naturale nella difensiva, appun.to per me tte rsi al coperto da questi aggìran:1enti. Quando adunque si è stabilita la forza necessana per tenere una posizion e in ordine unito, per poco che. q.uesto fronte si vada ampliando per l' ,anz idetto m~llvo, ne
ORDI NI UNITI ED OllDINI SEPARATI 167
nasce fac ilm ente un indeb olimento in tutta la prima schiera, sino al punto da produrre in essa delle lacune; e no tisi che tali lacune ·non saranno, come in un 01:dine separato, in quei punti nei quali esse sono indicate dalla natu ra del terreno , nèl qual caso non possono essere mollo dannose, ma formandosi invece nel processo del eomb1J.ttimento, posso no verificarsi su punti il cui possesso è di capitale importanza pel conseguimento dello scopo finale. Perciò l'o rdine unito netta clifensiva può esser vantaggioso, sinchè non va a scapito della forza colla quale .vogliono essere occupati i punt'i più importanti del terreno, e dell'energia colla quale vogliono esse1·e condotte le parziali azioni . controffensive. ·
Or·dùie separato. -Impiego nell'offensiva. - Veniamo ora all'ordine separato. Già vedemmo che esso si ha, quando l e forze non sono distribuite in modo relativamente uniforme su tutto il fronte, ma invece si trovano più o meno raggruppate su varii punti favorevoli, costi-· tuendo nuclei separati da intervalli, la cui ampiezza dipende dalla forma delle accidentalità che su questa fronte s'incontrano. Abbiamo pur visto come operando offensivamente , quest'ordine possa riuscir vantaggioso per un primo schieramento, permettendo di tener ammassate le forze su quei punti dai quali esse dovranno poi spiegare la massima efficacia di fuoco pei· preparare convenientemente l'attacco, e quindi la mass im a azione d'urto per condurlo ad effetto .
Ci resta a vedere come esso possa venir utilmente impiegato anche nel process o d·i un'azione offensiva.
La potenza d elle armi da fuoco oggidì è tale, che a meno di erronee disposi zioni del nemico, di circostanze di terreno eccezionalmente favorevoli, o di una straordinaria solidità ne.li e trup pe clell' assalitore, un attacco portato sul fronte della d ife sa ha ben poca

,\ 66 DEGLI
ORDINI DA COMBATTI~IENTO probabilità di riuscila , se esso non viene. contemporaneamente appoggiato da un alL r o attacco, che si svilup pi su uno o su ambedue i suoi fian:chi, allo scopo di distogli ere la sua attenzione e parte delle sue truppe - dal fronte, e paralizzare i movimenti controffensivi delle sue riserve, movimenti tanto pericolosi per l'assalitore7 se lo vengono a cogliere nel niomento di iniziare l'attac co. La storia dell'u ltima. guerra coi suoi molteplici esempi, P- là per provare non solo la convenienza rnà la necessità di questi due attacchi contemporanei.
Ora , se l' attaccante si presentasse avanti la posizione della difesa in un ordine i·istretto, per portare una parte delle proprie truppe sull e ali od a l r·ovescio di questa posizione, si vedrebbe obbligato ad eseguire un movimen to di fianco , il quale se fatto in vista del nemico perderebbe totalmente l'effetto della sorpresa, e se eseguito invece più in largo, potrebbe cagionare una perdita immensa di tempo. È quindi indispensabile che l'attacco, s in da quando inizia il suo movimento offensivo, assum a un ord ine assai più largo, il quale, perchè non porli. ad un indebolimento di tulto il fronle, dovrà necessariamente essere un ordine separato. Si avranno a ll ora due o p iù nuelei indipenden ti che prendendo le mosse da punti discosti fra di loro, muoveranno per linee convergenti, per ven ire a concorrere su quel punto della linea nemica sul quale vuolsi portare il massimo sforzo; e questo dicasi sia per le maggiori unilà strateg iche, come per le più picco le un i tà tattiche .
Ma perchè quest'ordine possa dar buoni risultati, conviene che i vari nuclei, quantunque separati da distanze talora non piccole, sappiano però operare sempre colla massima armonia, in modo da to g liere al nemico .ogni pòssibilità di batterli separatamente,
ORDINI UNITl ED ORDINI SEPARATI •169 facendo gravitare la massa del!e proprie forze successivamente contro ciascuno di essi nuclei . ·A tal fine, oltre alla buona scelta delle linee di marcia, ad una forma di ordini che indichi a ciascun riparto lo scopo da conseg uirsi, è necessario. che ai coroandantf parziali venga lasciata la massima. liber-tà d'azione intorno a i modo onde giungere a questo scopo , modificando ani;he le dis'posizioni del comando supremo a seconda delle e$igenze del ·moménto .

Quando ciò sia, cesserà in gran parte il pericolo, che la difesa approfittando della distanza che separa i nuclei dall'àttacco, possa far gravitare le proprie forze contro ta luno di essi, senza che gli allri accorrano a portare quel mutuo appoggio, che fu sempre la causa precipua di tutti i grandi s uccessi . -
Possiamo dunque dire, che l'ordine separato permette all'of{ensi'va di concent1'are il grosso delle forze sui punti pi'.ù ùnpo1·tanti, e di assumere un ordine assai largo diretto ad. v..rtare il nem,ico conternporaneamente ·sul fronte e sui fianchi, senza che ne risulti un serio pericolo cli vede1·e i suoi-rzj1arti o separn,tarnente battut·i, od ùnpecliti cli e({eltiiar e la loro cong itmzion e sulla cMave della posizione nem,ica.
V-ediamo ora come tale ordine possa venir impiegato nella difensiva.
lmpi·ego nella difensiva·. - Un corpo che sta sulla difensiva, lascia già presupporre una inferiorità numerica rispetto al nemico , perchè altrimenti non rinuncierebbe ai va ntaggi che una offensiva ben condotta può sempre arrecare, anche di fronte alla potenza che l' aumentata efficacia delle armi da fuoco ha dato alla difesa . Se dunque l'assalitore si trova in superiorità di forze, egli potrà. distendersi su di un fronte, il ql)ale sarebbe eccessivo per la difesa, qualora questa si atteaesse ad un brdine unito ; essa deve qu indi
• 168 DEG-U
DEGLI ORDINI DA COMB A'l'TTMEN TO t r ovar modo cli disporre a far agil'e l e proprie forze in gui sa, che men tre sul fronte si pos~a t enei: t_esta con vantaO'gio agli assalti dell'offensore, 1 fianchi s1eno o . d abba s tanza protetti contro i movimenti aggiranti e avvi luppanti . A ciò soddisfa appunto l'ordine separato.
P nnti d'appoggio. - P er poco ch e un terreno sia accid en tato, è difficile che su di esso non s'i~contrin o alcuni p un ti j quali, o p er esse r più e l evati , o per a vere declivi i rapid i o difficili, o per l' _esi_s tenz a di edifici , di muri, d i siep i od a ltro, coslitmscon~ solidi punti d'appoggio, p erchè da essi, p ur tene ndosi abb as tanza al coperto, è possibile l o sviluppare un a gran massa cli fuoco e fa r subire alle forze d e ll'a tta ccante perdite così gravi, che esse, o si ano costrette a r e trocedere, opp u re, se oppo rtunamen te contrass altate, non si tr ov ino più in grado di sostenere vantagO' iosamen te l'urto e proseguire l a loro marcia. Ma ~erclté r. iò p ossa avvenire, co~vicne_ che tali p~nt~ d'appoggio si ano siffattamente d1sposll , che da essi si pos sa non sol o battere il terreno che sta inn anz i, ma altresì incro c iare i fuo chi sui t ratti che li separano, a meno che questi non siano già co perti da ostacoli di nat ura tal e da imp edire ass ol utnm ente l'avanzare d el n emico : L'assa litore allora preferirà s emp l'e d irigere i suoi sforzi con tro qual cuno di questi punti d'appoggio, per quanto difficile possa essere i l rendersen e padrone, anziché cacciar si in una gola, nella quale poll'eb he ve ni re annientato prima di giungere a c~nt atto colle truppe della d i fesa; ed a q ue sto proposi t o piacemi citare ciò che l o Scherff dice, a pag. ,1115, d e ' suo i Studi pe1· la nuova tatt i·ca della (ante1·ia , parland o della difensiva :
« Anche là dove le condizioni topografiche e le di« sposizioni ·tattiche della difesa non impediscano ~l

<< n emico di sp inge r si tra i s ingoli pun ti d'a ppogg10
ORDINI UNITI ED ORDINI SEPARATI 171
« (i posti della posizione), q u esti, s e be ne scelti, eser-
« citeranno pu r non di meno s u di lui una irresis~i-
« bile attrazi one, s ia direttamente col loro fuoco, sia
« indirettamente coi contrattacchi di fianco cui offrono
« base , cosicch ò egli non avrà sicuri i fian chi e il
« t ergo sino a che non sias i impadron ito di qu e i « punti.
« P.er adempiere al suo cò mpito colle sue forze re« l ativamenLe d ebo li, dev e dunque (la d i fensiv a) ag" grupparsi sui punti d'appoggio deci"sivi. »
Ris erve pa1·ziali. - Dietro le tr uppe costituenti la prima schi e ra , cioè l'occupazione di ques ti punti d'appogg io, deve esis ter e una.lin ea cl i riserve parziali abbastanza for ti , aventi il doppio scopo di rinforzare le · truppe della prima linea, qualora il terreno l o consenta , e l'a ndamen to del comballimento l o esiga, e di c ontrattaccare a tempo opp ort uno i nuclei dell'assalitore, s.ia che essi si dirigano con tro i punti salienti, sia che tentino di penetrare fra l'uno e l'altro per prenderne i difenso ri sui fianch i ed a l rovescio. Gdifficilissimo il voler determinal'C il dove ed ìl quancto si dovranno po ri.are questi con tratta cc hi, essendo ciò tu tt a ques t ione d'oppo rtunità e di criterio di chi comanòa le parzi al i riserve, ed a noi bastar à stabilire che da essi non si potrà sperare buon es ito, se le trupp e de ll' as.,. sali tore non sono state prima fortemente scosse dal fuoco della di fesa.
Ris erva generale. - Dietro queste ùue schiere dovrà esistere u ua rise rva generale la quale, se frova una p.osizione assa i for te, potrà occuparla solidamente per res is tervi po i a tutta oltranza dopo che sieno state roves ciate le prim e due lin ee, oppure dov r à tene rsi in p osizione tale che le perm e tta d i accorre r e sui punti minacciati ancora in tempo pe r cogliere l'assalitore in q-uello s ta to di disordine che segue semp re la presa <li
70
ANNO
x ix, VoL. 1. ~2
DA COMBATTl~IENTO una posizione validamente contrastata. Il determinare a quale di queste due linee di condoua debba at.teners~ la riserva genernle, è questione che d ipende assolutamente dalle forme e dalla praticabilità del terreno.
Forza da darsi ad ogni schiera . - R imane ora a vedersi la quantità di forze da destinarsi a ciascuna di queste schiere , ed il modo di disporle.
I punti d'appoggio, o posti della posizione, vanno occupati in gu isa che da essi si po ss a svil upp ar e la massima efficac ia - cli fuoco. A men o dunque che dietro il fronte esista una buona posizione da difendersi dalla riserva, tuLta l'arti g lieri;i dovrà venir fraziona ta nella prima schiera, coper ta per quanto pos s ibile da ri.pari . natural i e artificiali, e stabilita su quei punti dai quali _ essa possa fruire del massimo campo cli tiro. La fanteria dovr à guarnire tutto il fronte di questi pu n ti d'appoggio in modo da dare il maggior numero di fuochi; dunque avere al meno 1 uomo ogni metro, e ,t 1/ 2 contando i rinforzi o sostegn i. Le riserve parziali, già notammo che per essere efficaci de vono essere abbastanza forti, e non sarà quindi eccessivo l' assegnare ad esse 1 uomo per ogni metro di fronte occupata, cioè i 2/ 3 di que llo che v'ha in prima li nea, tanto più se si considera che- da esse probabilmente si dovranno trarr e quei piccoli d ista ccamenti cui s arà dato l' incarico di osservare i tratti non · occupati. Abbiamo dunqu e un totale di 2 1/i uomini per ogni rne.tro di fronte occupata . Dando alla riserva generale una forza eguale a quella delle due prime schiere, veniamo ad un totale di 5 uomini per metro, rapporto già sufficiente per poter operare una vali.da difesa atti'va.
Lo Scherff stabi l isce quest i rapporti come segue: 1 u omo ogni passo in prima linea; una seconda linea a nie tà for za della prima; una riserv a generale di forza ugua le alla somma delle due prime linee; cioè
un totale di 3 uomini per ogni passo, {4- uomini per ogni metro); ma se si considera chè egli non ha tenuto calcolo de ll a forza occorrente p er osservare, per quanto deb olmente, i tratti non occupati, credo non a ndar errato ne llo stabilire come più conveniente il rapporto di 5 uomini per ogni metro.
Cavalleria. - La cavalleria dovrà venir impiegata all'esp lorazione di tutto il terr eno in avanti e su i fianchi; quando costretta a ritirarsi, potrb farlo o sulle ali della posizione od anche fra i vari punti. d'appoggio, ove potrà forse trovare buone posizioni dalle quali, sapendo cogli ere il momento opportuno, potrà ancor rendersi ut ile piombando improvvisamente sul fianco delle colonne attaccan ti .
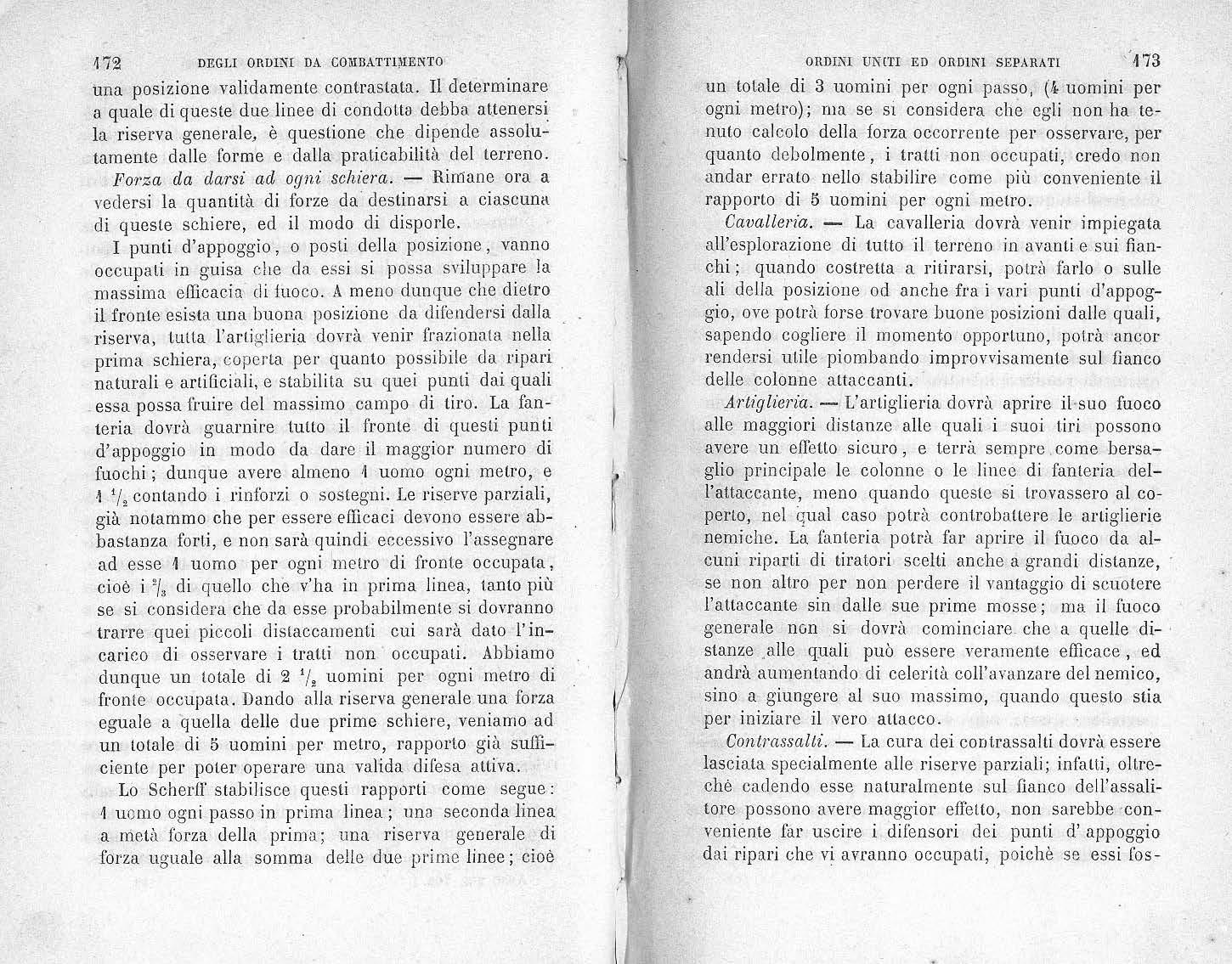
Artiglieria . - L'artigli eria dovrà aprire il ·suo fuoco alle maggiori distanze alle quali i suoi tiri possono avere un efietto sicuro, e terrà sempre . come bersaglio principale le colonne o le linee di fanteria dell'attaccante, meno quando queste si trovas sero al coperto, nel qual caso potrà controbattere le art ig lierie nemiche . La fanteria potrà far ap rire il fuoco da alcuni riparti di tiratori scelti anche a grandi distanze, · se non altro per non perdere il vantaggio di scuotere l'attaccante sin dalle sue prime mo s se; ma il fuoco generale non si dovrà cominciare . che a quelle di- · stanze .alle q:uali può essere veramente efficace , ed andrà aumentando di celerità coll'avanzare del nemico, sino a giungere al suo mas simo, quando questo stia per iniziare il vero attacco .
Contrassalti . - La cura dei contrassal ti dovr à. essere lasciata specialmente alle riserve parziali; infatti, oltrechè cadendo esse naturalmente sul fianco de ll'assalitore possono avere m agg ior effetto, non sarebbe ·conven iente far uscire i difensori dei punti d' appoggio d ai ripari che vi avranno occupati, . p o ichè se ess i fos-
172 DEGLI ORDINI
t r
ORDINI UNCTI ED ORDINI SEPARATI -'173
ORDINI 'DA COMBATTHIEN<ro sero respinli, facile ri escirebbe all'attaceante di penetrare con essj ne lla posizione; si potranno bensì fare àelle piccole sortite parziali quando favorite da l terreno, ma tutti i difensori di questi punti non lascieranno la posizione , se non quando le sorti generali del combattimento volgessero tanto favorevoli da consigliare un movimento offensivo su tutta la fronte.
Quando una parte della nostra posizione fosse talmente forte da lasciare al nemico poca puobabilità di r iuscila, oppure quando la chiave della posizione è facilmente riconoscibile , probab ilm ente il nemico c011ce11trerà tu tti i suoi sforzi su questo punto capi tale, in modo da avere . su di esso Lale soverchianza di numero, da rendervi inf'rt*uoso ogni atto della difesa; in tal cas0 non solo è utile ma necessario, ·che una volta nettamente chiarito questo disegno, anche gran parte delle altre forze della difesa s i rivolgano contro l' altacco principale, manovrando direttamente sul suo fianco , oppure gir.ando più in largo per venirlo a cogliere quasi alle spalle ; ma perché ciò possa avvenire, sul fronte .della posizione non de vono e:;istere ostacoli di nalura tale da irnpeclire questi . movimenti di traslazione. Se dunque esso è ta gliato in direzione più o meno normale da corsi d'acqua, da alture, o da h urroni insuperabili, converrà evitare cli stabilirvisi a cavallo, a meno che la difesa non possieda forze tali da poter 11esistere vantaggiosamente . al gro ~so del nemico in ognuna di queste parti nelle quali essa rimarrebbe · scissa; ma, come abbiamo già visto, ciò avverrà diflìcilmenle, e così mancando l'appoggio diretlo dei corpi laterali, per poco che il nemico faccia impeto contro uno di questi fronti parziaJi, i.suoi difenso ri si vedranno costretti a cedere, e probabilmente tutta la posizione si dovrà sgombrare perchè minacc iata nelle comunicazioni.
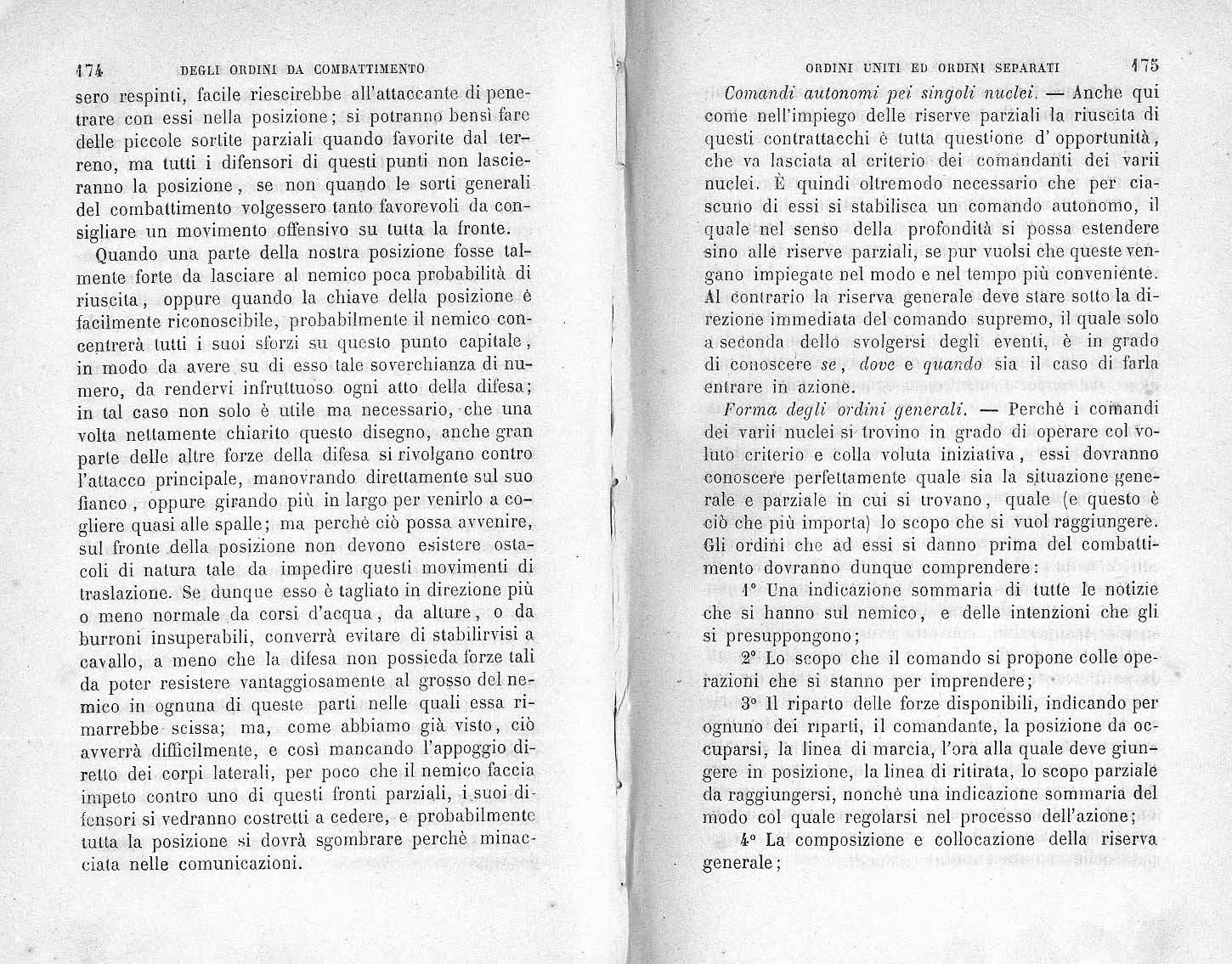
Comcmcli autonomi p-ef singoli nuclei. _,_ Anche qui come nell'impiego delle riserve parziali la riuscita di questi contra ttacchi è tutta questione d' opportunità, che v;:i las'ciata al cr iterio dei comandanti dei varii nucle·i. È quindi oltremodo· necessario che per ciascuno di ess i si stabilisca un comando autonomo, il · quale nel senso della profondità si poss a estendere sino alle risen;e parziali, se pur vuolsi che queste vengano impiegate nel modo e nel tempo più conveniente. Al èontrario la ris erva generale deve stare solfo la direz ione immediata ci el comando supremo, i l quale solo a seéonda dello sv olgersi degli eventi, è in gl'aclo di conoscùe se, dov e e qi1,anclo sia il caso di farla entrare ili azione.
Forma clegli ordù1i generali' . - Perché i comandi dei varii nuclei si trovino in grado di operare col voluto criterio e colla volu ta iniziativa, essi dovranno c onosceie perfettamente quale sia la sjtuazione generàle e parziale in cui si Lrovano , qnale (e questo è -ciò che più importa) Io scopo che s i vuol raggiungere. Gli ordini che àd essi si danno prima del combattimento dovranno dunque comprendere,
,1° Una indieaiione sommaria di tutte le notizie che si hanno sul nemico, e delle intenzioni c he gli si presuppongono;
I2° Lo scopo che il comando si propone colle òpe- i'azioni che si stanno per imprendere; ·
3· 0 Il riparto delle forze disponibili, indicando per ognuno dei riparti, il comandante, la posizione da oc-cuparsi, fa linea di marcia, l'ora alla quale de ve giungere in posizione, la linea di ritirata, lo scopo parziale da raggiungersi, nonèhé una incli.cazione sori1maria del mo"do col quale regolarsi nel processo dell'azione;
,i. 0 La composizione e colloc az ione della riserva generale;
174, DEGLI
ORDINI UN !Tl ED 01\DINl SEPARATI 75
DEGLl ORDINI DA CO~IBATTIMENTO
5° I lavori da eseguirsi e le truppe da destinarvisi;
6° Il punto di riunione delle forze in caso d' insuccesso;
·7° Le disposizioni amministrative;
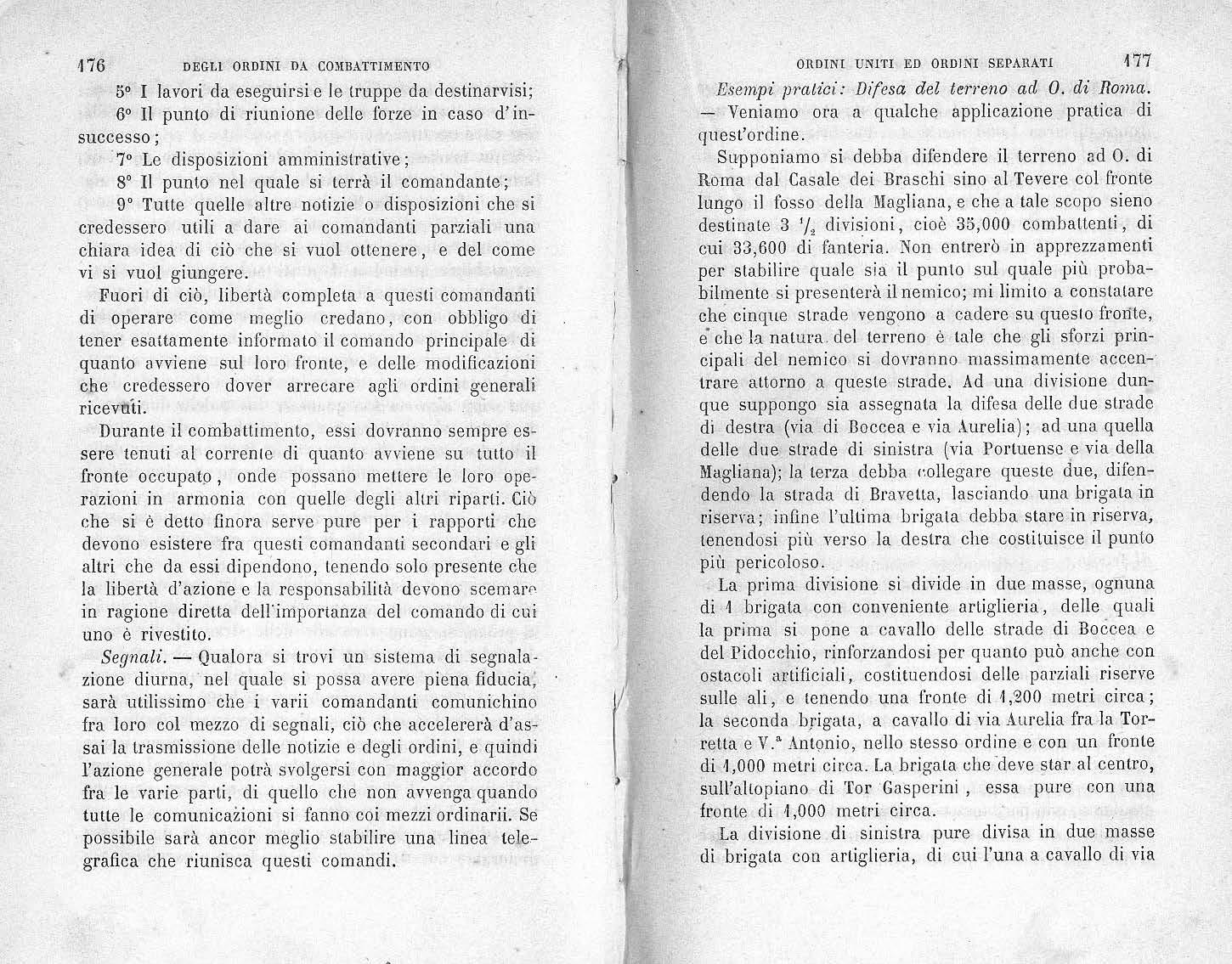
8° Il punto nel quale si terrà il com anda nte-;
9° Tutte quelle altre notizie o disposizioni che si credessero utili a dare ai comandanti parzial i una chiara idea di ciò che si vuol ottenere, e del come vi si vuol giunge re.
Fuori di cib, liber tà completa a questi co man danti di operare come meg lio creda n o , co n obbl igo di tener esattamente informato il comando principale di quanto avv iene sul loro fronte, e delle modificazioni che credessero d·o ver ane care agli ordini generali riceva.ti.
Durante il combatti mento, essi dovranno semp re essere tenu ti al correnl e di qucmto a vv iene su tutto il fronte occupato, onde possano mellere l e loro operazioni in armonia con quelle degl i altri riparti. Ciò che si è detto finora ser ve pure per i rapporti che devono esistere fra questi comandanti secondari e gli altri che da essi d ipendono, le nendo solo presente che la libertà d'azione e la r esponsabilità d eYono scem ar /:\ in ragione diretta dell" i rnportanza del coman do di cui uno è rivestito.
Segnali . - Qualora si trov i un sistema di segnalazione d iurna , · nel quale si po ssa avere piena fiducia ; sarà utili ss imo che i varii comandanti comunichin o fra. loro col mez zo di segnali, ciò che accelererà d'assai la trasmissione delle notizie e degli ordi ni, e quindi l'azione generale potrà svo lgersi con maggior accordo fra le varie parti, di quello che non avvenga quando tulle le comunicazioni si fanno coi mezzi ordinarii. Se possibile sarà ancor meglio stabi li re una linea- telegrafica che riunisca questi comandi.
ORDINI UN I'fl ED ORD I NI SEPAllAT1 177
Esempi pratz'ci: Difesa del terreno acl O. di Roma. - Veniamo ora a qualche applicazione prat ica di quest'ord i ne . Su,pponiamo si debba difendere i l terreno ad O. di Roma dal Casale dei Braschi sino al Tevere col fronte lungo il fosso della Magliana, e che a tale scopo sieno destinate 3 1 / 2 divisioni, cioè 35,000 combattenti , di cui 33,600 di fan teria . Non entrerò in apprezzamenti per slabiliee quale sia: il punto sul quale più probabil mente si presenterà il nemico; mi l imito a cons tatare ché cinque strade vengono a cadere su ques10 fronte, e· che la nat ura . del terreno è tale che gli sforzi principali del nem i co si dovranno massimamente accentrare attorno a queste strade. Ad una cl ivisione dunque suppongo sia assegnala la di fe sa delle due stra de di destra (via di Bocce a e via Aurelia); ad una quella delle d u e strade di sinistra (via Portuense e v ia della Magliana); la terza debba ,:allegare queste due, difendendo la strada di Bravetta , las ciando una brigata in ri serva; infin e l'ultima brigata debba stare in riserva, tenendosi p iù verso la destra che costituisce il punto pili pericoloso.
La prima d iYisione si divide i n due masse, og nuna di 1 brigata con conven iente art iglieria, delle quali la prima si pone a cavallo de lle strade cli Boécea e del Pidocchio, rinforzandosi per quanto può anche con os ta co l i artificiali, costituendosi delle parziali riserve sull e ali, e tenendo 1,1.na fronte di 11,:200 metri circa; la seconda brigata, a cavallo d i via Aurelia fra la Torretta e V... An t9nio , nello stesso ordine e con un fronte di 1,000 metri circa. La. brigata i;he ·deve star a l centro , sull'altopiano di Tor ·Gasperini , essa pure con una fronte di 1,000 metri· c i rca. .
La divisione di s i nistra pure divisa in due masse e.li brigata con artiglieria, di cui l'una a cavallo di via
176
r ,,
ORDIN[ DA COMBATTIMENTO
Po rtuense con un fronte di 1,200 metti cir6a ; l'altra a:ll' estrema s inis tra, SHl Monte delle Picche, con una fronte di circa 11,000 metri. Le due brigate d i riserva l 'una ad O. di Villa Pamfiii, l'altra a N. del .Casale di Pio Y. La maggior parte dell'artiglieria portata sul fronte e coperta da spalleggiamenti , giacchè per la natura general mente ·scoperta dei terreni che stannb avanti, essa troverà memo a sviluppare sit10 da lungi un'azione assai efficace contro le forze dell'attaccante.
Su di un ·fronte totale di circa ,J 0,000 metri abbiamo dunque 5,4-00 metri occupati da una prima schiera e da riserve parziali aventi una forza di 24,000 ùomini di fanter ia, e quindi con un rapporto di i ¼ uomini per metro, non conlando le altre armi; te nendo calcolo della forza necessaria ad osservare i tra~ti non occupati , si avrà sempre un ·rapporto di 4. uomini per metro. ·Aggiungendo a quest i i 9,600 uominj che sono in riserva, si viene ad un rapporto di 6 1 / 3 uomini per metro, rapporlo già m olto vantaggioso; se invece ci fossimo voluti attenere ad un ordine unito non a ·i1remnio avuto .che un rapporto di uomini 3, 5 per ogni metro di fronte . ·
Supponiamo ora un attacco che si sviluppi a cavalJo di via Aurelia, sostenuto da un alta<;co secontlario per via di Boccea. Spellerà allora alle truppe de lla prima schiera a hatlere col proprio fuoco quelle dell'assali I.ore in modo che esse non giungano a contatto coi difensori, se non dopo aver subito perdite considerevoli: quando muovano all'assalto, sarà allora il momento di far agire le riserve parzi al i per i fianchi d ei valloni che fiancheggiano via Aurelia, in modo che esse possano giungere all'i mprovv iso sulle masse assaltanti, e in pa ri tempo una parte dei difensori del· l'altopiano di Tor Gasperini, se non trallenuti da altre forze nemiche, attraversando il fosso di Brava, oppure
ORDIN[ UNITI ED onnJNI SEPARA'lll . 79
rimontando il fosso di Magliana, potrà gettarsi su· l fianco od alle spalle dell'attaccante, neutralizzando così tutto l'effetto della sua offensiva.
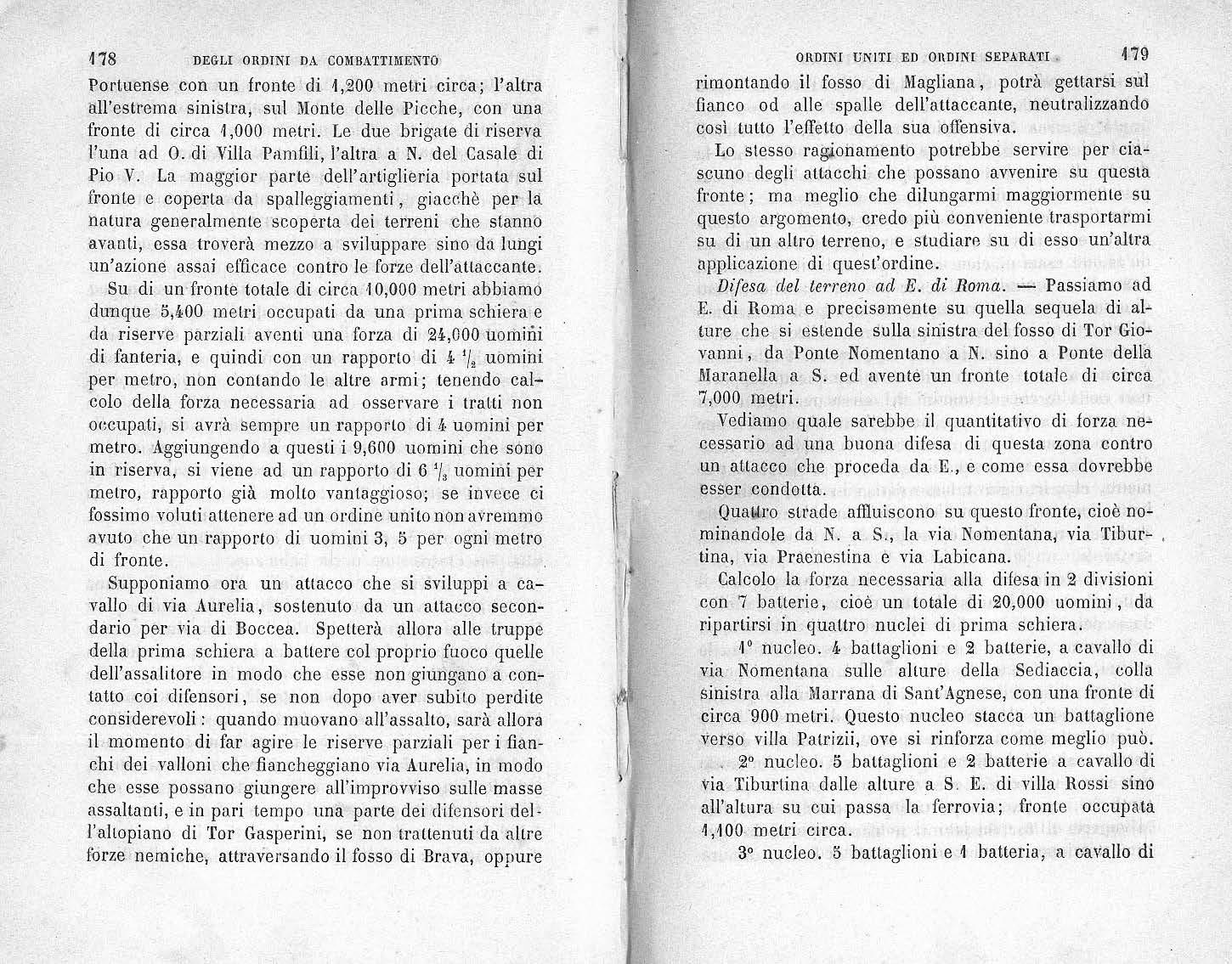
Lo stesso ragionamento potrebbé servire per ciascuno degli attacchi che possano avvenire su questa fronte; ma meglio che dilungarmi maggiormente su questo argomento, credo più e onvenienLe trasportarmi su di un altro terreno, e studiare su d i esso un'altra appl icazione di quest'ordine.
Difesa del terreno ad E. di Roma. - Passiamo ad E. di Roma e preéisamente su quella sequela di al-' ture che si es tende sulla sinistra del fosso di Tor Giovanni, da Ponte Nomentano a N. sino a Ponte de lla Maranella a S . ed avente un fronte totale di circa 7,000 metri .
Vediamo quale sarebb e il quantitativo di forza necessario ad una buona difesa di questa zona contro un attacco che proceda da E., e come essa dovrebbe esser condotta.
QuaLt.ro strade affluiscono su questo fronte, cioè nominandole da N. a S., la via Nomentana, via Tibur- . tina, via Pràenestina e via Labicana.
Calcolo la ,forza necessaria alla difesa in 2 divisioni con 7 batter~e , cioè un totale di 20,000 uomini , da r ip artirs i in quattro nuclei di pri ma schiera,
4° nuc le o. 4 baltaglioni e 2 batterie, a cavallo di via Nòmentana sulle alture della Sediac:cia, colla sinistra alla Mar rana di Sant' Agnese, con una fronte di circa ·900 metri . Questo nucleo stacca un battaglione vetso villa Patrìzii, ove si rinforza come meglio può.
2° nucl eo. 5 battaglioni e 2 batterie a cavallo di via Tiburtina dalle alture a S. E. di villa Rossi sino all'altura su cui passa la ferrovia; front e occupata 4 , 1100- metri circa.
3° nucleo. 5 battaglio ni e 1 batteria, a cavallo di
178 DEGLI
I J )
DEGLI ORDI NI DA COMBAT1'IMEN'l'O
.
via PraenesLina sulle alture d i villa Ta roni. Fron(e occupata 1,000 meLri c irca .
4° nucleo . 4 battaglioni e 2 batterie, a cavallo di via Labicana sullè alture a S. E. di v.ia lHarelli, e la destra all'acquedotto dell'Acqua Claudia. Fronle occupata 800 metri circa.
Su di un fronte che dicemmo essere di circa 7,000 metri ne abbiamo dunque 3,800 oceupati con una forza di 14.,600 uomini, cioè un rapporto d i circa 4 uomini per metro, quindi sufficiente per dare anche i posti di osservazione nei lra.tti non occupali. Ci rimangon o 6 battag lioni in riserva, i qua l i fanno salire il rapporto fronte-forza a o,1 ·uomini per ogni melro. Se invece cì fossimo atteriu ti ad un ord i ne unito, questo 'rnpporto non sarebbe che di uomini 2,1 circa per ogni metro di fronte. In questo caso , auesa l'estensione del fronte e la mancanza di un punto central e dal quale irradi ino strade ve rso i singo l i nuclei, io crederei conven i ente che l a riserva fosse divisa in due parti d i 3 battag l ion i cadauna, u nu delle quali starebbe ne l,la villa . Torlo~ia pronta a dar appoggio sia· al fianco sinistro, sia ai due nuclei di sinistra ; l'altra all'Acqua Viva à. S. E . di Porla San Lorenzo, pr onta ad appogg iare il fianco destro ed i nuclei d i destra. Il com a ndo s tabilito su qualche e levazione dietro la basilica di•San Lorenzo . Vediamo ora come procederebbe ·questa d ife s a . Io escludo che l'attacco principale del nemico si possa verificare sull a s inistra, c ioè per via No mentaoa, perchè jl passaggio dell' Aniene a così breve dis tanza dalle posizioni della difesa sarà sempre un'operazione difficiliss ima, sinchè i difensori dell'allura d ella Sediaccia ·non sieno costretti al sile nzio , ciò che non avverrà tanto facilmente, se essi avranno saputo rnetlersi ben al coper to . Da quel lal o si potrà dunque avere una dimostrazione, rna mai un rero attacco .
ORDINI UN1TI ED ORDINI SEPARATI •I 81
Più facile invece credo un attacco combina to per le due vie Tiburtina e PraeJ:).esti na, perchè abbaslanza ravvicinate fra loro, perchè di fronte alla nostra posizione trovansene a ltre sulle quali il nemico può spic~gare le forze che devono preparare l'attacco, ed infine per ch è superata la prima schi.éra, non .s' fn c ontrano più seri e difficoltà sino all a cmta . Esammiamo qual e sarebbe la condotta de lla difesa di fronte a questo attacco.
· Quando il fuoco dei difensori appostati a cavallo all e due strade non basti da sè ~olo a contenere l'a.ttaccanLe e questi proceda all'assalto, le riserve parziali sta bilite all'indietro e sui fianchi delle varie po -· sizioni, cal andosi rapidamente o pei declivii delle alture o per le insenature laterali, piomberanno su l fianco dell'assalitore, n el mentre d alle posizioni occupate , potrà es ser tent a to anche qualche contrassalto diretto, attesa la natura genera lm en te facile del terreno che si ha sul fronte . Contemporaneamente a ciò una parte dei difen s ori delle due :posizioni es treme · , sia manovrando direttamente per le vù ll i di Tor Giovann i e cli Marranella, sia più in l argo pel fo sso del Quarticeiuolo o pel casale di Pietralata, potrà gettarsi quasi alle spalle dell'attaccanle. Anche la cavalleria, ,se .ben comandata, troverà in queste circostanze frequen L1 occasi oni, nelle quali sviluppare efficacemente la propria azione di sorpresa . .
Supponiamo invece che il nemico tenti di lgettaTS1 frammezzo a due dei nostr i punti d'appo ggio , e prec i samente fra ·via Nomentana e via T iburtina, punto che sembrami per esso il più favorevole, perchè trova di fronte una posizione ele vata dalla q4ale preparare col fuoco il proprio attacco, e lateralmente ad essa varie insenature nelle quali ammassare al coperto le truppe che lo devono eseguire. Tn tal caso le nostre
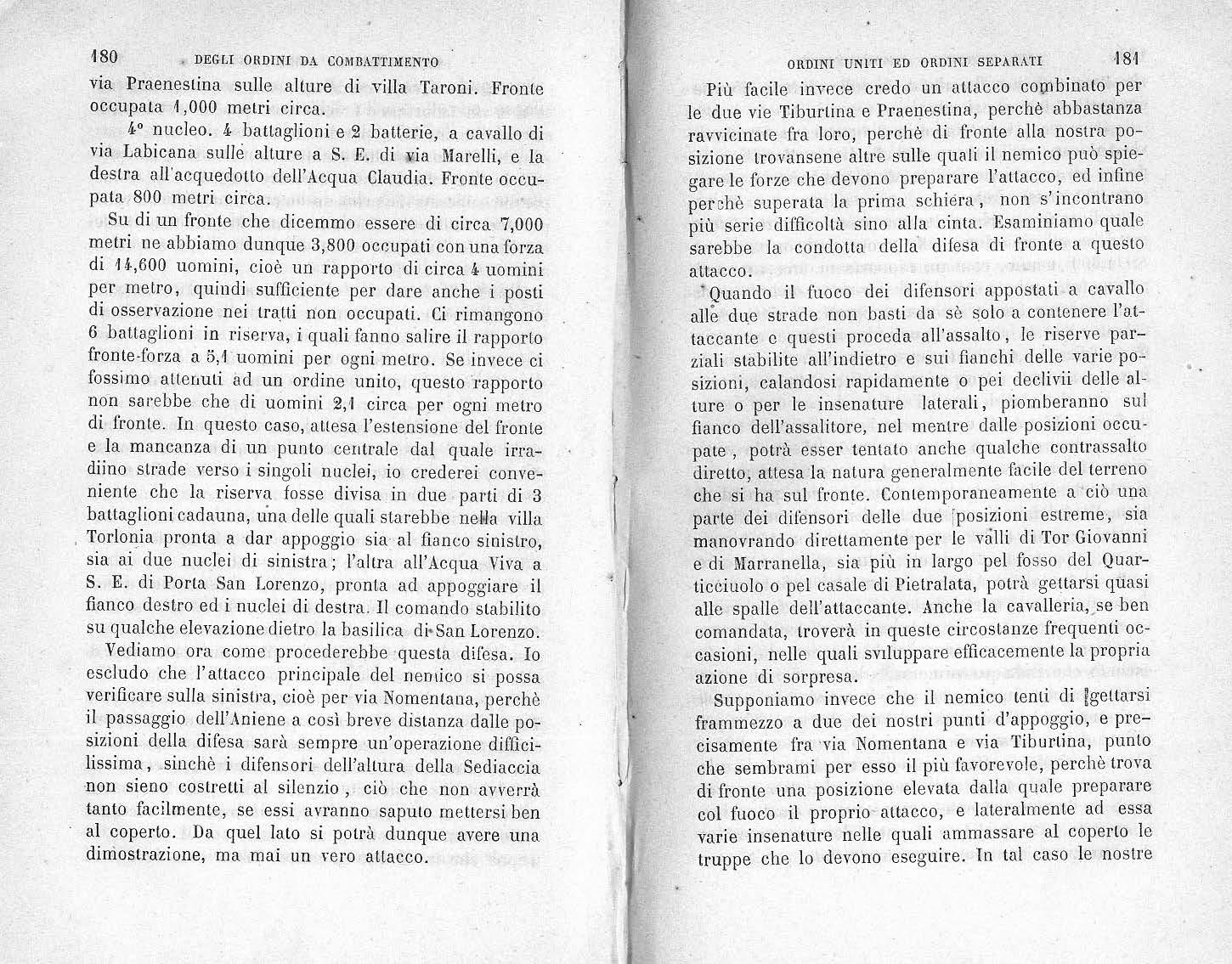
180
batterie stapilite a cavallo delle due anzidette vie, controb;llterebbero le artiglierie avversarie sinchè le altre truppe sono al coperto, e non appena queste si preSèBtrno pet· attraversare il ·fondo delJ.a valle si concentrerebbero su di esse i fuochi di queste batterie nonchè i fuochi diretti delle truppe già stabilite a Vill~ Patrizi o più avanti, e di quelle altre che eventualrilente si c redesse di eh iatnarvi dalla riserva. Qualora ad onta di ciò, il nemico continui ad avanzare, una parte delle tru~pe che sono a cavallo delle strade, dovrebbe géttars1. sul suo fianco, nel mentre quelle stabilite a Vi lla
Taroni, potrebbero, manovrando in )aro-o giuno·ere ' o ' o fors e ~Ile _s ue spalle. Lo stesso modo d'agire potrebbe venii' rmp1egato per ·qualunque altro attacco, dirntt o fra due degli altri punti d'appoggio.
Dtfesa della linea dell' Ani'e ne. - Veniari1o per ultimo ad un altro caso. Supponiamo invec e che la direzione presa dal nei·nico consigli di tenersi più a nord, ciòè a . cavallo delle tre strade Salara, Nomentana e Tiburtina, difendendo i,l corso dell'Aniene; avremo allora 3 nucl~ i separa~i fra di loro da intervalli di '1500 e più metri; suppomamo che menti·e i due estremi si lengono sulle alture che sorgono sulla sinistra del fiume dietro i pbnt [ Salaro e Mammolo , quello centra le, o per ape. profi _tta~·t~ d~ .vantaggi di terreno, o per coprire un passaggio m r1t1rata, o infine per mantenersi uno sb occo offensivo, prenda posizione sulla desLra del fiume sul monte Sacro . Supponiamo che il nemico avanzando per via Nòn:entana e per via delle Vig ne, porti il grosso delle p1:oprie_ forze contro il nucleo centrale;· per poco che egli abbia conLezia delle nostre di~posizioni non mancherà d'inviare alcuni distuccamenti di forza coriveniente a:nche sulle altre due strade, i quali stabilendosi sulle alture che sorgono sulla dest r a e raffor~ zan dovisì, renderanno, se non imp'Ossibile, per lo meno
ORDINJ: UNITl ED 01\Dl NI SEPARATI 4g3 assai difficile uno sbocco offensivo, che noi volessimo tentare su quei punti. Ne avverrà quindi, che quando il nemico dopo una conveniente preparazione procede .all'assalto della nos tra posizione centrale, noi ci vedremo nell'impossibilità di eseguiFe a tempo opportuno un movimento controffensivo procrdente dalle nostre ali mentre l'ostacolo dell'Aniene ci impedir ebbe dì tentar-lo su ogni altro punto. I corpi laterali in questo periodo dell'azione non potranno dunque prestare che un appoggio indiretto, la cui efficacia non può essere che limitata, <li fronte alle molteplici accidentalità dietro le quali il nemico può tro var riparo.
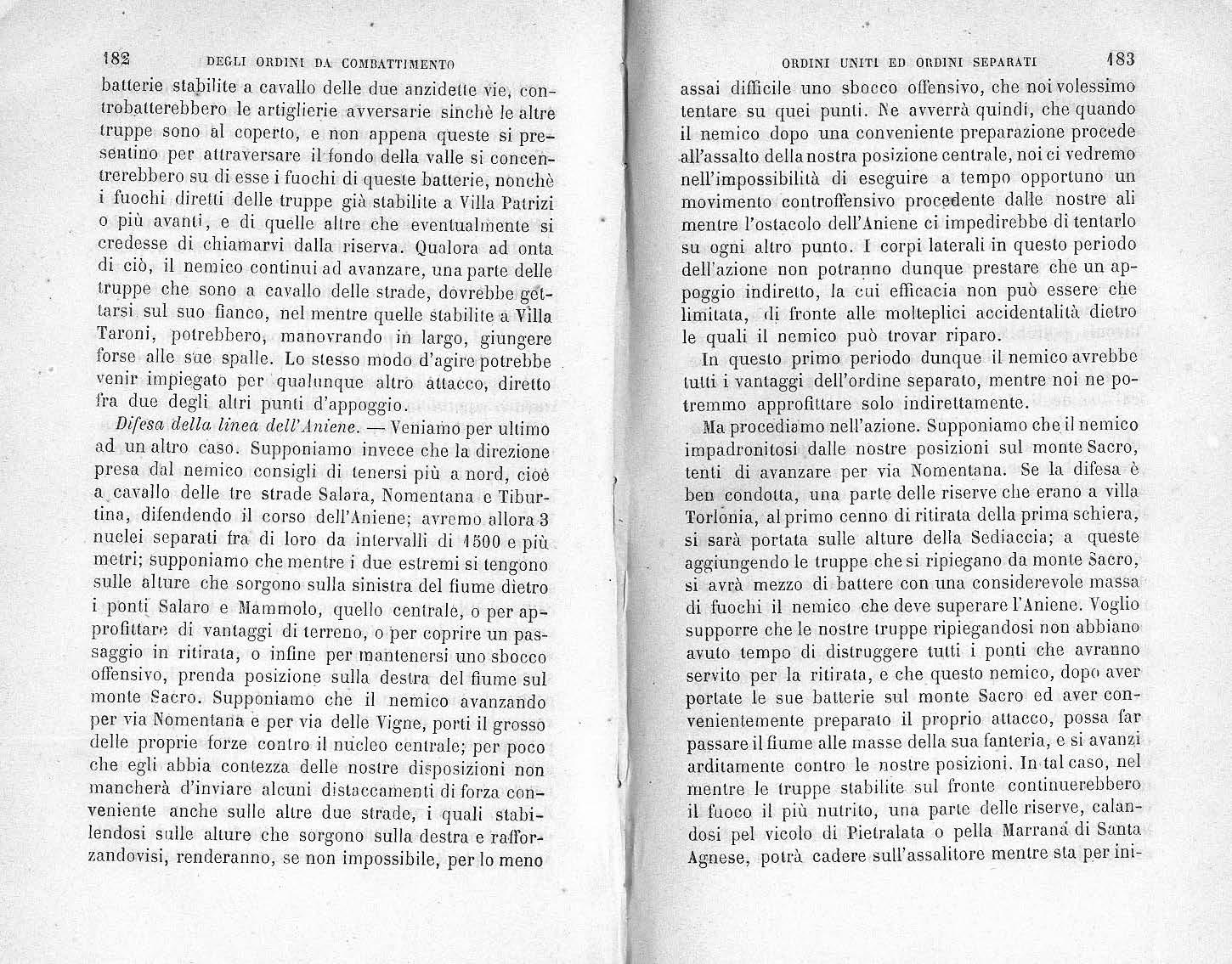
In ques.lo priimo pedodo dunque il n emico avrebbe tutti i vantaggi dell'o rd ine. separato, mentre noi ne potre mmo approfittare solo indirettamente.
1\fa procédia·mo nel.l'azione. Supponiamo che.il nemico impadronitosi dalle nostre posizioni sul monte Sacro, ten~i di avanzare per via Nomenta na. Se la difesa è ben condotta, una par-te delle riserve che erano a villa Torlònia, al primo cenno di ritirata della prima schiera, si sarà portata sulle alture della Sediaccia; a q_ueste aggiungendo le truppe che s i ripiegano da monte Sacro, sì avrà mezzo di balLere con una considerevole mass a · di fuochi il nemico che deve superare l' Aniene. Voglio supporre che le nostre truppe ripiegandosi non abbian0 a'\éttlo tempo di distruggere tutti i ponti che avranno se.rvito per la ritirata, e che questo nemico, dopCl aver· p0:rtate le sue batterie sul monte Sacro ed aver convenientemente preparato il proprio attacco, p oss a far passare il fiume alle masse della sua fanteria, e si avan zi arditamente contro le nostre posizioni. Jn ,tal caso , n el mentre le truppe stabilite. sul fronte co ntinuer:ebb e ro il fuoco il più nutrito, una fi)arLe de lle riserve, ca landosi pel vicolo di P.ietralata o pella Marrana di San ta Ag;nese, potrà cadere sull'assalitore mentre sta P.er ini-
.. 182 DEGLI ORDlN[
DA CO MDAT'l'InIENTO
f,
DA CO!llDATTlMENTO
ziare l'assalt0; ma ciò nbn è tutto. Quando vedendo coronarsi d' artiglierie il monte Sacro, verrà posta in chiaro l'intenzione del nemico di proseguire nel suo movimento offensivo, i due nuclei d'ala, lasciando cli fronte ai ponti so lo quel tanto di forze c h e basti a trattenere . l'avversario sull'altra sponda del fiume, per le bassure esistenti d ietro il Casale di rietralata, e pel terreno coperto attorno a Villa Chig i, potranno portare una parte de lle forze presso ponte Nomentano , per farle poi concorrere al movimento controHensivo, da attuarsi nel momento in cui si pronunci a l'assa lto contro la Se·diaccia e Villa Solisciogni.
Ora l a s ituazion e si è dunque invertita; la difesa cioè si trova in misura di fare l'impiego i l più vantaggioso dell'ordine da lei ass unt o, mentre l ' offesa, avendo i suoi nuclei separat i dall'ostacolo dell'Auiene, s i trova nell 'impossibilità di ag ire concordemente e qu indi decis ivam ente colle sue parti .
Vediamo ora il caso opposto; supponiamo cioè che le nostre truppe stabil ite a monte Sacro, non so lo· riescano a tra1tenere l'assalitore, ma coi loro movimenti.controffensivi lo obblighino a cercarsi una posizione più r itirata; in tal caso anche le ali del nem ico, s ia per non l asciarsi separare dal centro, sia per arrestare il movimento controffensivo del nostro nucleo cent r ale, si sentira n no spinte a spostare tutta o parte della forza che prima fronteggiava i ponti Mammolo e Salaro . Sarà questo il punto nel quale i nostri nuclei d'ala, avanzando risolutamente, potranno superare l'Aniene, e s i a sp ingendo s i diret~arnente contro le. a li nemiche, s ia girando in largo per ven i re a cadere sul suo centro, potranno compl etare un successo, che senza il loro concorso probabilmente non sarebbe s tat o che parziale o rnomenlaneo. Resterebbe così dimostrato che l'esistenza di un ostacolo abbastanza serio fra i vari nuclei
ORDINl UNITI ED ORDINI SEPARA.TI 185 di un ordine separato, può riuscir da n noso opponendosi a ch e t ali nuclei s i prestino un reciproco appoggio, come abbiamo diflatti potuto rilevare ne lle prime due ipotesi di quest'uhimo caso pratico; mentre invece sa· rebbe stato possibile sv iluppa r e un'azione concorde e GJU indi probabilmentefeconcla di buon i risultati, quando per lo · spostamento avvenuto in una parte della nostra linea, essa venne a trovarsi tutta eia un lato di questo ostacolo, nel qual caso tutto lo svant~ggio s.-1,rebbe stato per l'assalitore, il qua le s i sarebbe trovato nella impossibilità di assecondare col mezzo d ei corpi laterali , il movimento offensivo de l suo nucleo centrale .
Conclusione . - Concludendo possiamo dunque dire~ che l'ordine .separato si p res ta as::;ai bene per la difensiva, quando le forme del Lerreno sul fronte che si d ifende sono ta li da offrire so lidi punti d'appoggio non eccessivamente discosti fra loro; i tratti non occupali possono esser battuti da questi punti; e la zona avanli questa fronte è tale da· obb ligare l'avversario a fare i suoi preparativi d'attacco relat ivamente allo scoperto , e da permettere facilmente le mosse controffensive dei corpi della difesa. che s i trovano lateralmente a quella contro il quale é d iretto l'attacco principale.
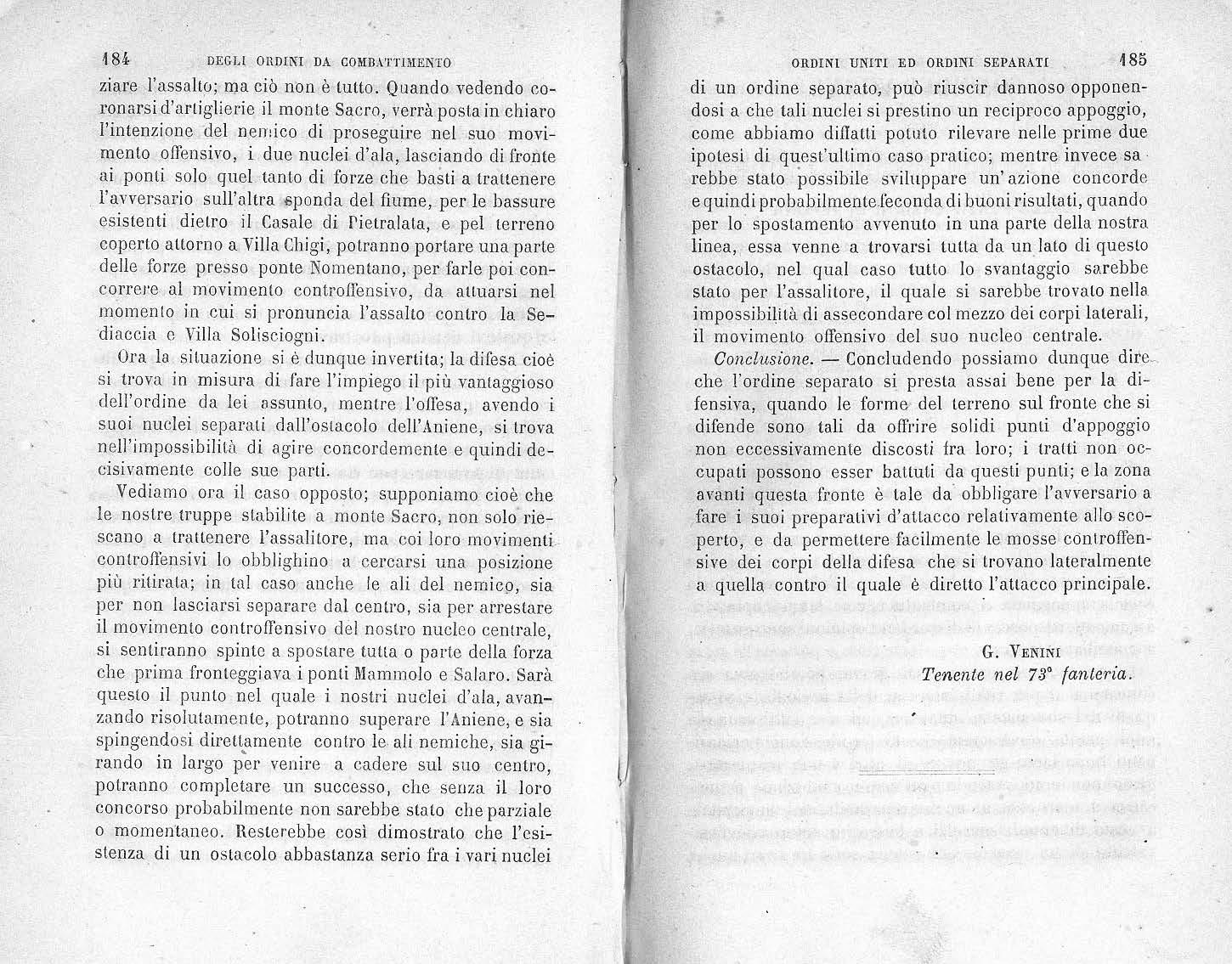
·184 DEGLC ORDINI
-. ---~- ~-
G. VENINI Tenente nel 73° fanteria.
CONSIDERAZIONI
PROPOSTE Df AMPL!!MENTO. CONSERVAZIONE O·SPIANAMENTO
DELLE FORTIFICAZIONI DI VERONA I.
Jl ne taut pl us désormais quo dc grnnde, placcs pouv.:i,nt. scnir Je l'i, ots de m.l )l<te uvre, et dés forh.•s ou ùe pe tites piace, 'l)u re 1ne nt milita ir,'s, déstiné,.s a dé (el)dni des no eui,ls de ,;o u tr.s, des 1i9ne!I impor ta11tes de c,hem in $ de Jer, de s pon ts, des digues (H des cob de roontarrncs .
DRULMONT, Lei (or(ificoli,m (Ì (qs aé& $6:CS,
Fra le controversie cui ha dato luogo la discussione del piano generale di difesa dello . Sialo, quella relativa al mantenimento od alla soppressione delle fortificazioni di Ver0na h ~ certamente occupato un posto import;rnlissimo, e nell~ diverse pubblica;-:ioni che sin oggi hanoo veduto la ltwe l 'una e l'all1•a soluzione è stata appoggiata o comLattu ta con larga copia di argomenti, nè perciò le discordanti opinioni sono g iun te a conciliarsi tru loro. · ·
La questione invece è assai grave, perchè essa si ('.Oncatena ai più vitali interessi della naz ione, cioè a quelli del suo sistema di d ifesa, ed a quelli economici, per la gra ve spesa che le fortificazioni permanenti importano; gl i uni e g li altri vanno maturatamente ponderati, potendo ogni erronea soluz ione esser causa di mali che, se anche reparabili, nol sono che a _ costo dj grandi sacrifizi a lungo, e dolorosamente senti ti.
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMEN~O ECC 187
L'importanza che ebbe Verona nelle guerre occorsPnei passati tempi, e segnatamente da due secoli a questa: parte; i grandi servizi r esi dalle sue fortificazioni a coloro che n e furono pos sessori, e le gloriose tradizioni che si rattaccano ad esse, che furono in parte opera di' uno dei più illustri ingegneri militari ital iani, il San !Uicheli, mentre impongono a tutti l'obbligo di andar molto cauti nel decretarne la distruzione, fanno a molti concludere che convenga tali fortificazioni conservare, o solo migliorandole, o considerevolmente ampliandole.
D'altra parte quando si ponga mente alle mu t ate condizioni politiche e territoriali d'Italia; ai cambiamenti introdoLLisi nel sistema di guerreggiare, per lo sterminato accrescimento degli eserci ti, consentito dal moderno ordinamento militare, e per i perfezionamenti introdottisi nei mezzi di offesa; all'enorme disp endio che portano con sè l'er ezione e l'armamento di grandi opere fortificatorie: vedendo proposte da taluni tre grandiose piazze di guerra, sussid iate da altre minori, su d'una zona profon°da non più cli 180 chilometri , qùanti ne corrono dal confine a Bologna, sorge spontaneo il quesito, se sono tutte necessarie, e se non sarebbe miglior consiglio sopprimerne qualcuna che non sia indispensabile ai vitali interessi della difesa, cosicché , senza compromettere questi, si sollevino le tutt' alt r o che fiorenti finanze dello Stato dalla spesa di parecchi di quei milioni di cui, a nche in più sc ars o numero, si ha gran sten to a provvederle.
Sorto queslo dub bio , ed osservato che, se havvi disparità di op inioni circa il formare di Piacenza o Bologn a il perno principale della nostra 'difesa, si è invece, nelle sfere militari, generalmente d'accordo circa l'opportunità di avere quali grandi cam pi trincerati l\ianto va e Bologna, circonclaLi dai punti fortificati di Pe -

SULL~
ANNO XIX, VOL. I. H
I
PROPOSTE nr AMPLIAMENTO ECC. schiera, Pipol.o -Moscalli, Legnago, Badia, Boara, Cremona e Santa ~fo ria Maddalena, facilmente se ne conchiude esser di soverchio Verona; anche pel certo danne, che a noi derivE>.rebbe dalle sue fortificazioni, qualora cadessero in potere del nemico , se ne vuole la distruzione.
L'una e l'altra con clusione sono esse giuste? Debbono ritenersi applicabili nelle loro estreme conseguenze? Ecco quanto ci proponiamo di discutere qui appresso. ·
II.
Autorevoli scritto ri sono fautori della conservazione, e quindi dell'nmpliamento delle fortificazioni di Verona, stantechè queste ne l loro s ta to attuale rispondono più ai bisogni di chi tenda alla nostra offesa, anzichè a que-tli inerenti alla nostra difesa: ed a ltri non meno autorevoli propendono per la soppressione delle fortificazioni medesime.
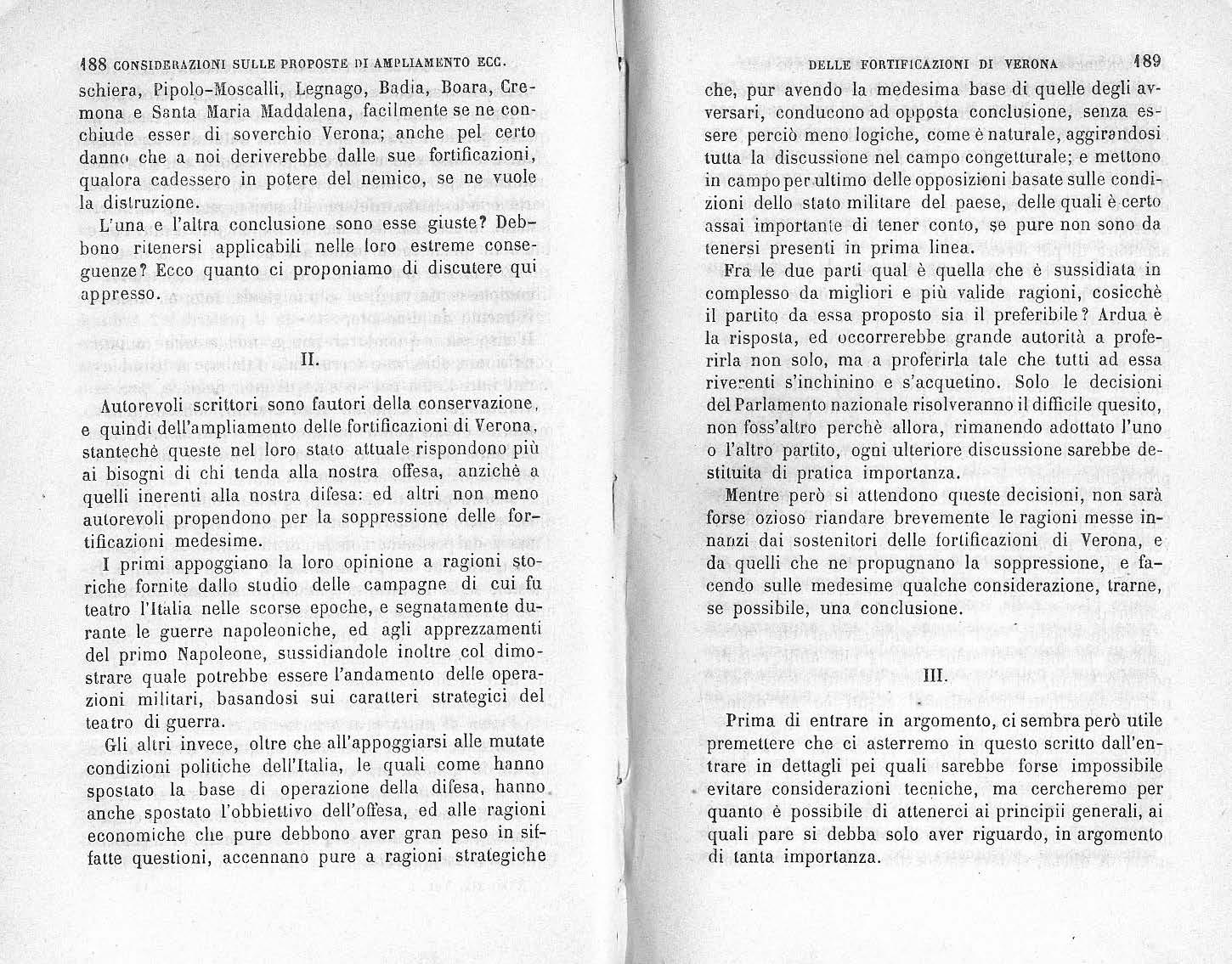
I primi appoggiano la loro opinione a ragioni storiche fornite dall o stu dio delle campagne di cui fu teatro l'ltitlia nelle sco rse epoche, e segnatamente durante le guerrt3 napoleoniche, ed agli apprezzamenti del primo Napoleone, sussidiandole inoltre .col dimostrare quale potrebbe essere l'andamento delle operazioni rni li tari, basandosi sui caralleri strategic i del teat ro di guerra.
Gli a.Itr i invece, oltre che all'appoggiarsi alle mutate condizioni politiche del!' Italia, le quali co.me hanno spostato la base di operazione della difesa, hanno . anche sposta~o l'obbiettivo dell'offesa, ed alle ragioni economiche che pure debbono aver gran peso in siffatte questioni, accennano pure a ragioni stra(egiche
I V
DELLE FORTIFICAZIONI DI VERONA 489
che, pur avendo la medesima base di quelle degli avversari, conducono ad opposta conclusione, senza essere perciò meno logiche, come è naturale, aggirandosi tutta la discussione nel campo congetturale; e mettono in camp o per .ultimo delle opposizioni basate sulle condizioni dello stato militare del paese, delle quali è certo assai importante di tener conLo, se pure non sono da te nersi present.i in prima linea.
Fra le due parti qual è quella che è sussidiata in complesso da migliori e più valide ragioni, cosicchè il partito da essa proposto sia il preferib.ile 1 Ardua è la risposta, ed occorrerebbe grande autorità a proferirla non solo, ma a proferirla tal e che tutti ad essa rive:-enti s'inchinino e s'acquetino. Solo le decisioni del Parlamento nazionale risolveranno il difficile quesito, non foss'altro perchè allora, rimanendo adottato l'uno o l'altro partito, ogni ulteriore discussione sarebbe destituita di pratica importanza.
Mentre però si altendono queste decisioni, non sarà forse ozioso riandare breverne~te le ragioni messe innanzi dai sostenitori delle fortificazioni di Verona, e da quelli che ne propugnano la soppressione, e facendo sulle medesime qualche considerazione, trarne, se possibile, una conclusione.
III.
Prima di entrare in argomento,. ci sembra però utile premettere che ci asterremo in questo scritto dall'entrare in dettagli pei quali sarebbe forse impossibile • evitare considerazioni tecniche, ma cercheremo per quanto è possibile di attenerci ai principii generali, ai quali pare si debba solo aver riguardo, in argomento di tanta importanza.
"88 CO NS1D ]H\AZ10Nl
SUl.,LE
CONSJDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO ECC.
Ci sembra inoltre di do ver agg iungere, per prevenire l'appunto che già ad al tri scritt ori fu mosso, d i basare c io è i loro ragionam enti su lla ipotesi di insuccesso, ed anche di rovesci delle nostre armi, c he no i siamo qua nt o altri con vinti che il m iglior mezZ0 per dife ndersi è di attaccare; e che è più conveniente e savio consiglio il portare ·la g u erra n el territorio al trui , che aspe ttare di piè ft,rmo nel nostro.
Ma svar ia te e!f imprevedibili circostanze po ss ono obbligare a tener la difensiva a llo ap rirsi delle ostilità , sa lvo a trasformarla in offensiva, quando le sorti della g uerra ci arr i dano. In questo caso però qu a le necessità, specialmente , d i grandi piazze da guerra alte a me t tere a l s icuro nume ro se truppe con tutt o qu a nto lo r o abbisogna? Qua lche punto fortificato, per guarcntire la linea d i operaz ione , qualche città chiusa con opere di poca importanza, per contenere g l i apprnvvigionamenti, e proteggerl e eia q ua lche ardita scorreria nemica, formerebbero tutto il bisognevole in fatto di fo rtifica zioni . E sarebbe g ran for tu na, poichè verrebbero risparmiate le ingenti spese che l'erezione e l'armam ento di qu es te richied e , che il solo sentim en to del patr iouismo rende la nazione disposta a sopportare.
Ma non è sopra cosl r osee supposizioni che deve fo nd a rsi la dife sa di uno Stato . I più abili calcoli possono fallire, ed i più valorosi eserc iti esse re battuti e sgominati (r e cent"issimi eventi ce ne danno solenne esemp io) , ed è allora che so no necessa r i qu~i forti baluardi sollo la cu i protezione le trupp e possano riordinarsi e prendere nuovo vigore; d' onde consegue che essi debbono essere p r edisposti per rispondere, in si ffùt te circostanze, co nvenie nteme nte al loro ufficio. Egli è perciò che, nello stud io di un sistem a di difesa, st deve essenzialm ente tener cu nto dei
DELI,E FORTIFICAZIONI DI VEI\ON:A 9i t,risti ~ven ti che potrebbero to ccarci, per potere, alI occasi one, del nosfro m eglio riparare .
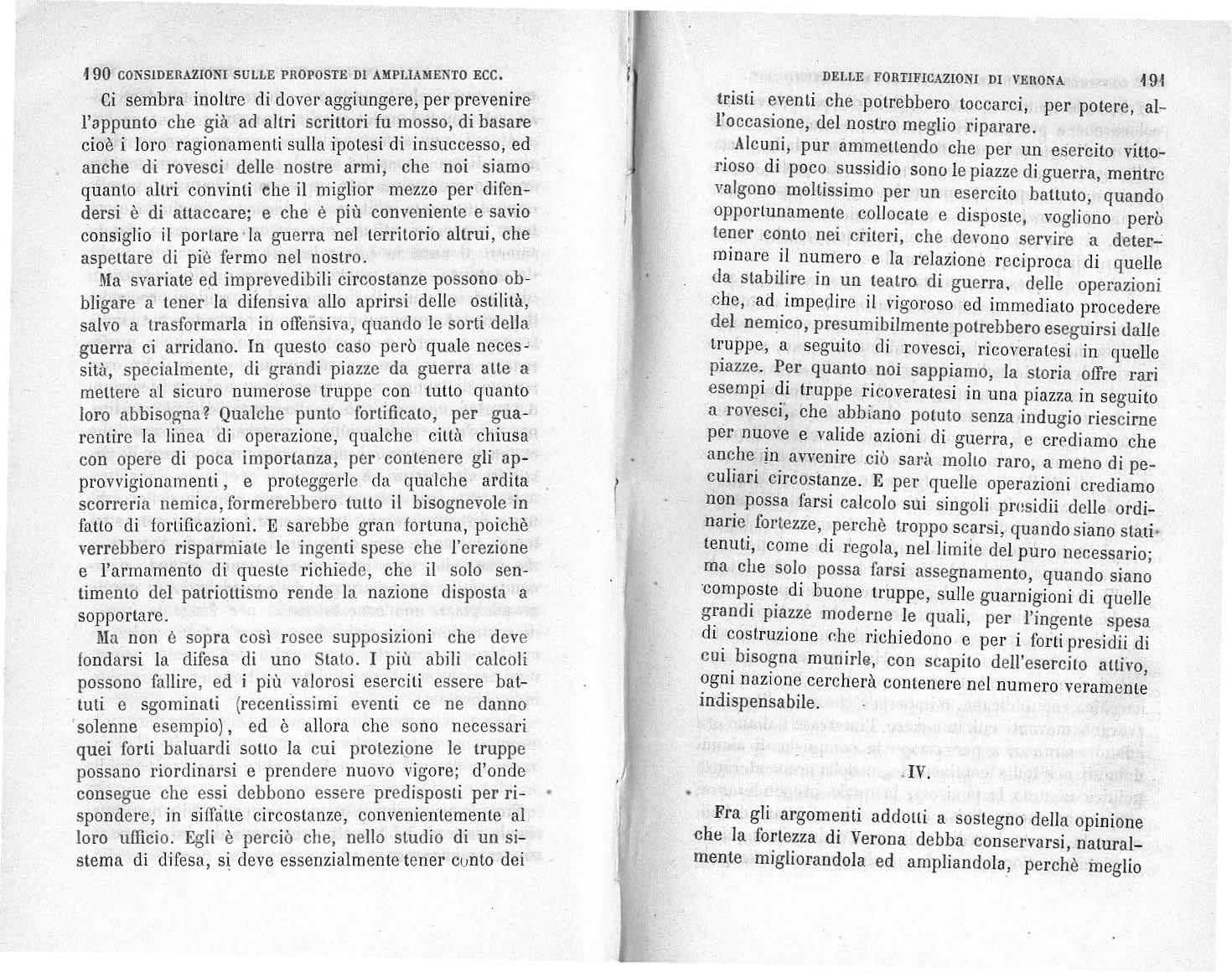
Alc uni, pur ammettendo che per un e sercito vittorioso di p oco s ussi d io sono le piazze d i guerra, mentre valgono mo ltissimo per un esercito battuto; quand o -0pportunamente collocate e disp oste, vog liono però tener conto nei criteri, che devono servir e a de ter...: minare .i ~ n~mero e la r elaz ione reciproc a di que lle da s tabilire rn un teat ro. di guerra, delle operazioni <: he , ad impeçlire il vigoroso ed imm e diato procedere del nemico, p resumibil mente potrebbe r o eseguirsi dalle t1:uppe , a seguito d i ro ves ci, ricoveratesi in quelle piazze . Per quanto noi sappiamo, la stori a offre rari esemp i ~-i truppe r_i co veratesi in una piazz a in seg uito a r ovesci, che abbiano potuto senza i ndugio ries ci rn e per n uo ve e valide azioni cli guerra, e crediamo che an~he_ jn_ avvenire ciò sarà molto r aro, a meno di peculi a ri circostanze . E per quelle operazioni crediamo no~ pos sa farsi calcolo sui s in goli p rnsid ii de lle ord inarie for te zze, perchè troppo s carsi , quando siano s tati · tenuti, come di rego la , n el li miie del puro necessario; ma che sol? possa fars i assegnamen to, quando siano ·comp~s t~ d1 buone trupp e, s ull e guarni g ioni di quelle g:and 1 pia.zze mode r ?e le quali, per l'ingente spesa dt. co~tru z1on e r.h e richiedono e per i forti presi dii di cu i bisogna munirlij, con scapito dell'eserci to allivo ogni naz ione cercherà contenere nel nu mero ve ram en t~ indispensabile.
. IV.
Fra gli argomenti addotti a sostegno della opinione c he la fortezza di Verona de bba co ns ervarsi, natura lmente migliorandola ed ampliandola, pe r chè meglio
90
corrispondesse al suo nuovo ufficio di baluardo contro coloro che a propria difesa la misero nelle sue attuali condizioni, primeggiano quelli dedotti dalla storia delle passate guerre, e segnatamente di quelle napoleonich e, nelle quali Verona ebbe capitale importanza. In sussidio, anzi a dare maggior valore a tali argomenti, si cita poi quanto lasciava dellato quel sommo maestro di guerra, che fu Napoleone I.
Qui pare necessario premettere che, a nostro avviso, che riteniamo suffragato dal consenso di molti, quanto è occorso nelle ·guerre avvenute anteriormente alla seconda metà del secolo in cui viviamo, se deve servire di norma nelle guerre future, lo deve solo in quanto riguarda i con celti generali da segu ire in queste, poichè tali concetti trovano il loro fondain en to sui principii generali dell'arte della guerra, che dall'epoca grreca e romana sin oggi rimasero immutati a traverso dei secoli. Ma il parziale svolgimento dei falli passati, se può dettare dei criteri pel pratico svolgi mento dei futuri , . non può servire di norma pei medesimi, poiché al compimento di questi· concorrono dei mezzi per numero; potenza e celerità di gran lunga differenti da quelli che concorsero al compimento dei primi, cosicc hè le combinazioni tattiche , nonché la logistica e la p0liorcetica, ne sono state grandemente modificate. Non sembra poi fuori luogo ricordare che le guerre cui si ricorre; combattute sempre · tra la Francia (monarchica, repubblicana, o imperiale che sia) e 'i'Impero, avevano moventi cui, in genere, l'interess e italiano era affatto estraneo, e per i sco po la conquista di alcuni dominii nell'Italia continentale, e de lla preponderanza. poli tica in tutta la penisola, la quale preponderanza , .. per essere questa divisa in tanti piccoli Stati, deboli, e per lo più tra loro discordi, era d'ordinario acquisira al vincitore. Conseguiva da ciò che nessuna delle parti ,
contendenti si preoccupava di ciò che per noi è di capitale interesse, cioè di coprire la parLe peninsulare; che anzi soventi le provincie adiacenti al teatro della guerra erano impunemente scorazzate a volta a volta dall'uno e dall'altro belligerante, a seconda che gli eventi guerreschi gliene fornivano il destro. V.
I fatti storici che principalmente si adducono sono: la discesa in Italia del principe Eugenio nel no ,1 e la campagna d'Italia d~i Francesi nel 1 '796.

Secondo noi, il primo di tali fatti non prova nulla a favore dell'importan za di Verona, come perno di difesa di u n tratto di frontiera, che del resto crediamo non sia da nessuno revocata in dubbio: Se quella discesa ebbe fe lic e esi t o, pare non si debba ciò auri.tmire all'essere stata quella cillà, senza ostacolo, occupata, ma bensì a che il principe Eugenio, ricevendo t ullo l'aiuto possibile dalle popolazioni, non ebbe a superare.:neanche il più piccolo ostacolo pe11 parte del nemico, sia µerchè questi non ebbe sentore delle sue . mosse, come afferma l'Arneth; sia che per racrioni politiche fosse stato ingiunto al maresciallo C~tinat di non attaccare per il primo, come direbbe il Fuquière, e come sembra più p ro bab ile.
In quanto poi all'importanza. attribuita da Napoleone alla piazza di Verona, nelle sue memorabili campagne del 1796-97 , noi siamo p0rlati a credere che alla medesima non si riattaccasse per nulla l'idea di coprire . la media e bassa Itali-a, per le quali, in allora, quel sommo capitano non aveva alcuno interesse diretto che lo obbligassei a proteggerla, ma essa era conse. guenza dello scopo precipuo della guerra, di impedire,
, rn.2
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO ECC.
DELLE F0fi'f1F1CAZ I0 NI DI VERONA. 19R
S(JLLE PRO POSTE DI AMPqAMENTO ECC, cioè al nemico di occupare le province lombarde e vènete, donde, traversando il Piemonte, manifestamente devoto all'Austria, avrebbe portato probabilmente le sue armi in Francia.
D'altronde in quell'epoca i s.oli ponti stabili che esi,stev·ano sull'Adige erano i quaHro interni alla città di Vel'ona, e quello di Legnago, e non è chi non vegga quanto fosse importante, anche per questo solo rispetlo, cli possedere la prima; mentre ora, oltre i ponti di Verona che sono sei, e quello di Legnago, ve ne hanno sull'Adige altri quattro, cioè a Pesc ant ina e Parona a monte, ed a valle quelli di Albaredo e Boara, ai quali non è improbabile se ne agg iunga un altro a Zevio, locchè, manifestamente, non è senza influenza sull'andamento sia clell' offesa che della difesa. Ma, si dirà, i ponti esterni alle piazze forti si fan no saltare: e noi ri sponderemo che questo è un provvedimento che si va molto a rilento a mettere in allo, e per la gravità del danno che si produce, e perchè se i ponti possono riuscire utili all'aggressore, lo sono certamente al difensore; e quando questi se ne riserbi la distrnzione all'ultimo momento, non sempre è e.erto che riesca ad ~fe ttu arla.
Non è da negare però che il grande capitano ha lasciato scritto, nella sua Descri~ione dell'J'talia, che l e li.nee che un esercito italiano deve prendere, Rer opporsi ad una invasione germanica, sono qu elle dell'Isonzo, del Tagliamento, della Livenza, della Piave , del Brenta e ·dell' Adige, le quali sono altreUante linee di difesa le quali copro'no la vallata del Po , e quindi chiudono la penisola e coprono l'alta, la media e la bassa Italia. Ma allorquando ciò dettava, egli certam ente informava il suo concello ai risulta~i d ella prqpria esperienza, ed alle condizioni logistiche e tattiche dei suoi t.empi, e forse non prevedeva un'epoca, no~
DELLE FORTlFICAZJONI or Y.F.llONA 195
mollo lontana, in cui gli eserciti numerosi come la Grande Armé,l.ta avrebbero cessato di essere l'eccezion e in guerra, per divenire la regola, e che perciò gli attacchi contro l'Italia anzi che pronunziarsi solo per alcune di quelle valli, avrebbero di necessità dovuto provenire da parecchie di quelle, e forse da tutte s imultaneamente, cangiando così sostanzialmente le condizioni della difesa.
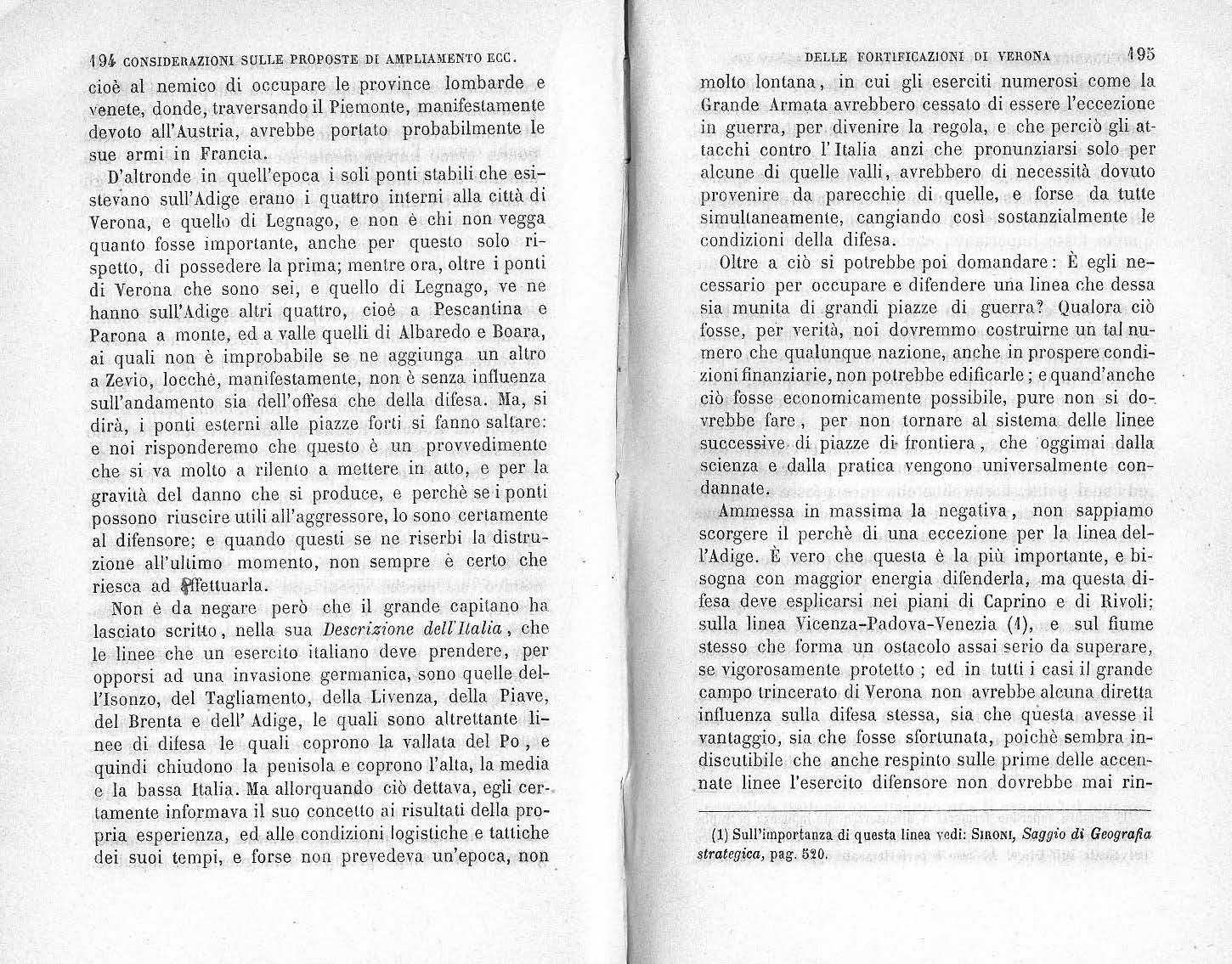
Oltre a ciò si potrebbe poi domandare: È egli necessario per occupare e difendere uria linea che <lessa s ia rnunit.a di grandi piazze di guerra~ Qualora ciò fosse, per verità, noi dovremmo costruirne un tal numero che qualunque nazione, anche in prospere condi. zioni finanziarie, non potrebbe edificarle; e quand'anche ciò fosse economicamente possibile, pure non si do-. vrebbe fare , per non tornare al sistema delle linee successive . di piazze di- frontiera , che ·oggimai dalla scienza e dalla pratica vengono universalmerlle condannate.
Ammessa in massima la negativa, non sappiamo scorgere il pe r chè di una eccezione p~r la linea dell'Adige. È vero che questa è la più importante, e bisogna con maggior energia d,ifenderla, ma questa difesa deve esplicarsi nei piani di Caprino e di Rivoli; sulla linea Vicenza-Padova-Venezia (4), e sul fiume stesso che forma u,n ostacolo assai serio da superare, · se vigorosamente p rotetto ; ed in tulli i casi il grande campo trincernto di Verona non avrebbe alcuna diretta influenza sulla difesa s tessa, sia che qùesla avesse il vantaggio, sia che fosse sfortunata, poichè sembra indiscutibile che anche respinto sulle prime delle accennate linee l'eserci to difensore non dovrebbe mai rin-
19i CONSIDEUAZIONI
(1) Sull'importanza di questa linea vedi: SmoN1, $q.ggio di Geografìa strategica, pag. 5~0.
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPI,JAMENTO ECC . chiudersi nel campo trincerato s udd e tto , o limitarsi ad agire entro il s uo ra ggio d'azione, ma dovrebbe bensì, sorMlto dalle trupp e inc ar icate · della difesa del terr eno interposto tr a l a linea ìtlantova-Legnago, il Mincio, i l basso Ad ige e d il Po , manovrando sull e spo nde del!' Adige, opporsi con ogn i sforzo ai tenta ti vi di passaggio di questo fiume, che i l nemico non mancherà di fare.
VI.
Sarebbe estraneo allo scopo di questo scritto !'"entrare ora a discutere ciò che dovrebbe farsi quando la di fesa r iescisse vittoriosa, e d'altronde ciò ci porterebbe in quel campo congetturale nel qua le, a nos tro avviso, debbono quanto m~no è possibile portarsi discussioni come quella che ci occupa. Non tra1ascieremo però dì notare che in tal caso, p er trarre utile partito dei vantaggi che presentano la postura di Verona e d i suoi p on ti, basterebbe che qu es ta fos s e a l coper to da un col po di mano, ciò che p uò consegui rs i s'enza chq occorrano estese fortificazioni.
Consid er ia mo invece il caso pure possibile, che la difesa fosse soccombente, che, pur troppo, è quello che occorre ·più d iligen te men te es ami na re. In questo caso l'eserci to si ritirerà nel camp o tri ncera to di Ver o na? Ma a ll ora con trup pe indeb olit e e scosse dai patiti rovesci, con un nemico a fronte probab il men te di noi p iù numerOS?, ed imbaldanz ito dalle riportate vittori e, non è molto probabile, se non certo, che esso sarà. tagliato fuori dalla sua b~se d'operazione, il Po, e che avremo u na ripetizione della catastrofe di l'lletz? (1 )
(1) Sembra superfluo fermarsi a di scutere qual e influenza potrebbe avere Verona come posizione di fianco, sulle operazioni di un nemico preval ente sull'Adige. Al caso è perfettamente applicabile quanto, a
DELL E FORTIFICAZIONI DI VERONA .4 91'
Sembra quindi che, n e l caso di cui si discorre, do- · vesse esser miglior parlito ripiegare verso l\Ian tova, sulla zona di terreno sop ra ccenn ato , per quivi, protetti dalle trupp e po ste a difesa della zona stessÙ, e del campo trin ce ra to di. Ma ntova, rifa.r si in ques to per quanto è possibile dei danni patiti, e fors ' anche essere di utile sussidio ne ll a difesa della linea del P o . Quando questo partito, che c i sem bra, senza dubbio,il più logi co ed il più utile, fosse adottato, non è chi non vegga quanto sarebbero s ta te inutili le costose fortificazioni di Verona, e che anzi esse sarebbero per noi dannose, poichè o imm ob ilizze reb bero per la loro difesa passiva un buon nerbo di truppe che . potrebbero t r ovare più efficace impiego a ltrove, o fornirebbero al nemico quella eccellente base di operazione c ontro di noi, che que lla p iazza cosli.tuiva in nanzi che le province venete fossero ridonate all'Italia.
VII.
Una r agione c apitale per l'ampliamento di Verona starebbe nell'a sserzione che qu esta debba esse re Fob · biettivo. primo dell'invaso re .
Nelle passate gue rre , nelle qua li scopo finale delle campagne fa tte in Italia si era se mpre il possesso del duc a to di Mi lan o, e scop o pe r lo meno tran s itorio era lo assi cur arsi dei varii Stati compresi tra l e Alpi ed il Po, è ce rto che Verona doveva essere il primo obbiettivo dei contendenti , potendo da tal fortezza il suo poss ess ore irradiarsi ne lle circostanti terre, essendo
proposito di Mantova , è detto dal colon ne llo R1 cc1, nel su o scritto: La piazza di Piacenza-Strade/la nella di/esa della fron tiera nordest dell'Italia (pag. 36 e 38).
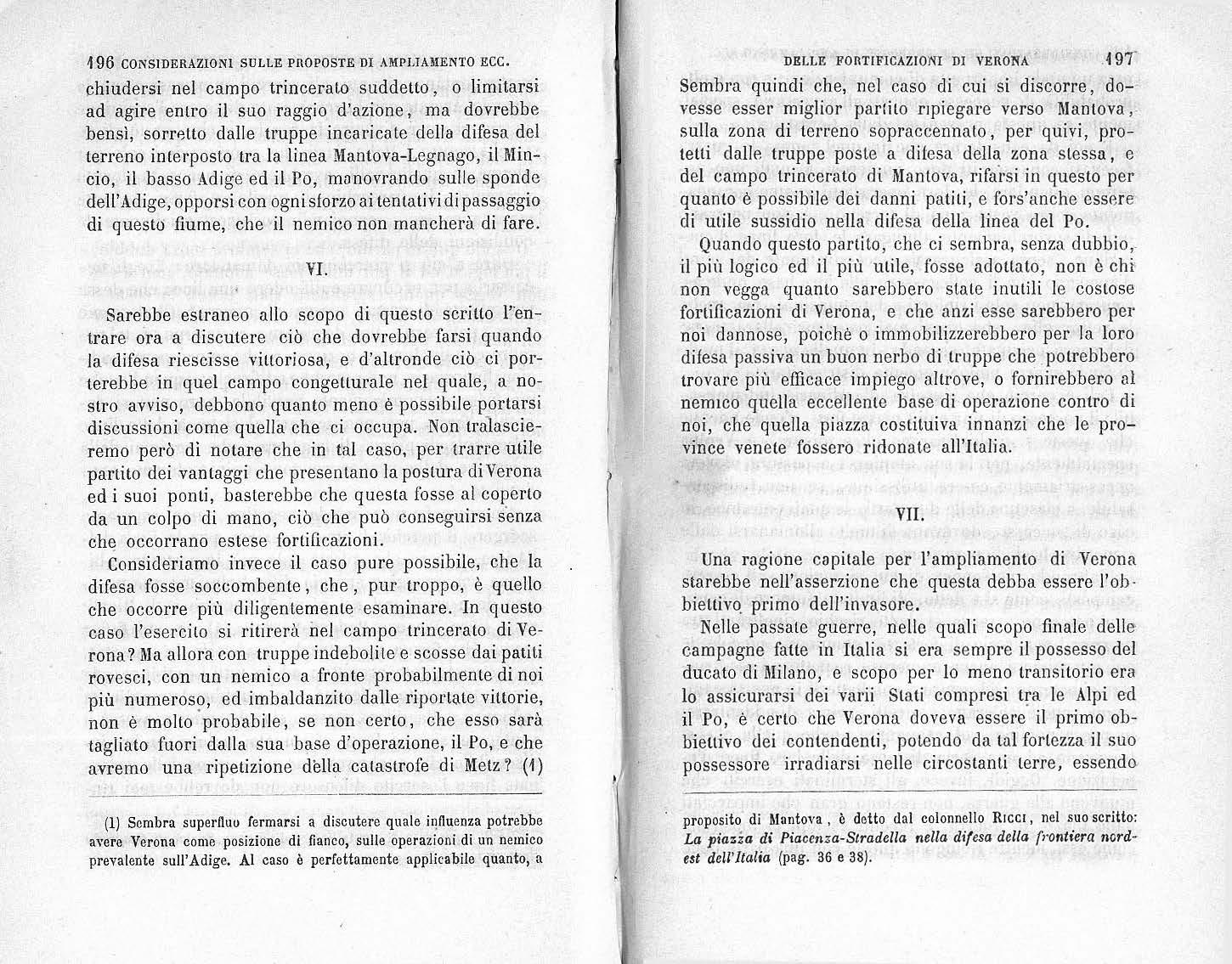
196
l3ssa un nodo importante di comunicazioni; e con molta probabilità di successo opporsi all'avverf;ario, specialmente se questo provenisse dalla Germania.
È poi da considerare che in quel tempo la guerra facevasi con eserciti poco numerosi, i quali non potevano estendère l e loro operazioni contempor;1neamente sopra vasta zona di terreno , e non potevano quindi soverchiamente allungare le loro linee d' operazione, senza assicurarsi successivamente dei punti d'appoggio che li co llegassero alla loro base, onde assicurarsi non solo i rinforzi e le munizioni, ma anche le vettovaglie, che quasi mai potevansi allora trarre dal paese occupato, essendo, in quella epoca, il modo di far la guerra eminentemente distruggitore.
Egli è perciò che riusciva d'ordinario indispensabile il possesso ,di una o più piazze forti, d'onde nacque che queste si moltiplicarono oltre misura '., e Verona specialmente, per la sua ampiezza e postura, doveva necessariamente essere utilissima, se non indispen- ·· subile, a ciascuna delle due parti, le quali entrambe, in caso di successo, dovevano di molto allontanarsi dalle rispetti ve basi d'operazione.
D'altronde, nell'epoca di cui si ragiona, gli eserciti composti, come si è detto, di limitato numero di genti, non potevano , senza evidente rischio , ino!Lràrsi tra mezzo ad una serie di fortezze, comunque piccole, le cui guarnigioni ancor numerose rispetto ad essi, riunire si potevano ed uscire a combatterl i in aperta campagna, ond·e ch'erano costretti, prima di addentrarsi in paese nemico , ad espugnare anche quelle che si t rovavano ad una certa distanza dalle loro linee d'operazione. Oggidì, in vece , gli sterminati eserciti che muovono alla guerra, non restano gran che impacciali dalle piazze di guerra, e recenti esempi ci mpstrano come essi, mentre ricingono queste con una parte delle
loro forze corrispondenti al caso, proseguano senz'altro nelle loro operazioni.
Per l'Impero poi è certo che Verona doveva aver e una singolare importanw, come quella che, a seconda dei casi, sbarrava o proteggevà la via più comoda e più breve per la qualé esso mandava le sue truppe in Italia, e che fu in passato quasi la sola praticabile finchè gli eserciti fur ono contenuti in ristrelli limiti di numero ; che quando questi cominciarono ad accrescersi, dovettero di necessità per diverse vie procedere, come nelle discese cli Wmmser ed Alvinzi nel ,1796-97.
Attualmente questa suddivisione de lle forze, per chi debba traversare le Alpi, è divenuta più che necessaria, inevitabile; poichè, come giustamente osserva il colonnello Ricci nei suoi App1mti siilla difesa d' Italia in generale, e della ma frontiera 1io1·d-ovest iri particolare, per un esercì to quale oggi occorre per ag~ gredire l'Italia, che non s~ può valutare a meno d1 250 a 300 mila uomini, nell'allraversare le Alpi, « al« l'inconveniente di colonne enormemente profonde , « ammassate in lunghe ed alpestri s trette, ove gli « spiegamenti sono impossibili, il vettovagliamento « raro €\ difficile, l e code a più marce dalle teste, di« venta preferibile quella di più colonne , isolate s e « vuolsi, ma che almeno offrono il vantaggio di atti« rare l' attenzione del nemico in più punti , ed in« durlo, forse, a commettere errori)>.
Ago-i unta a queste inoppugnabili considerazioni l'altra, o ' che la nostra frontiera orientale è affatto aperta , e da ritenere indubbiamente che l'invasore pro ce derà in più colonne per l'ora della frontiera e per le d~verse valli che sboccano nel Ven eto, ed allora è mamfesto che l'obbiettivo primo di quella discendente pe r . la valle dell'Adige, potrebbe essere Verona, mentre quello di tulle le altre non può essere che l'occupazione della linea Vicenza-Pado va- Venezia.
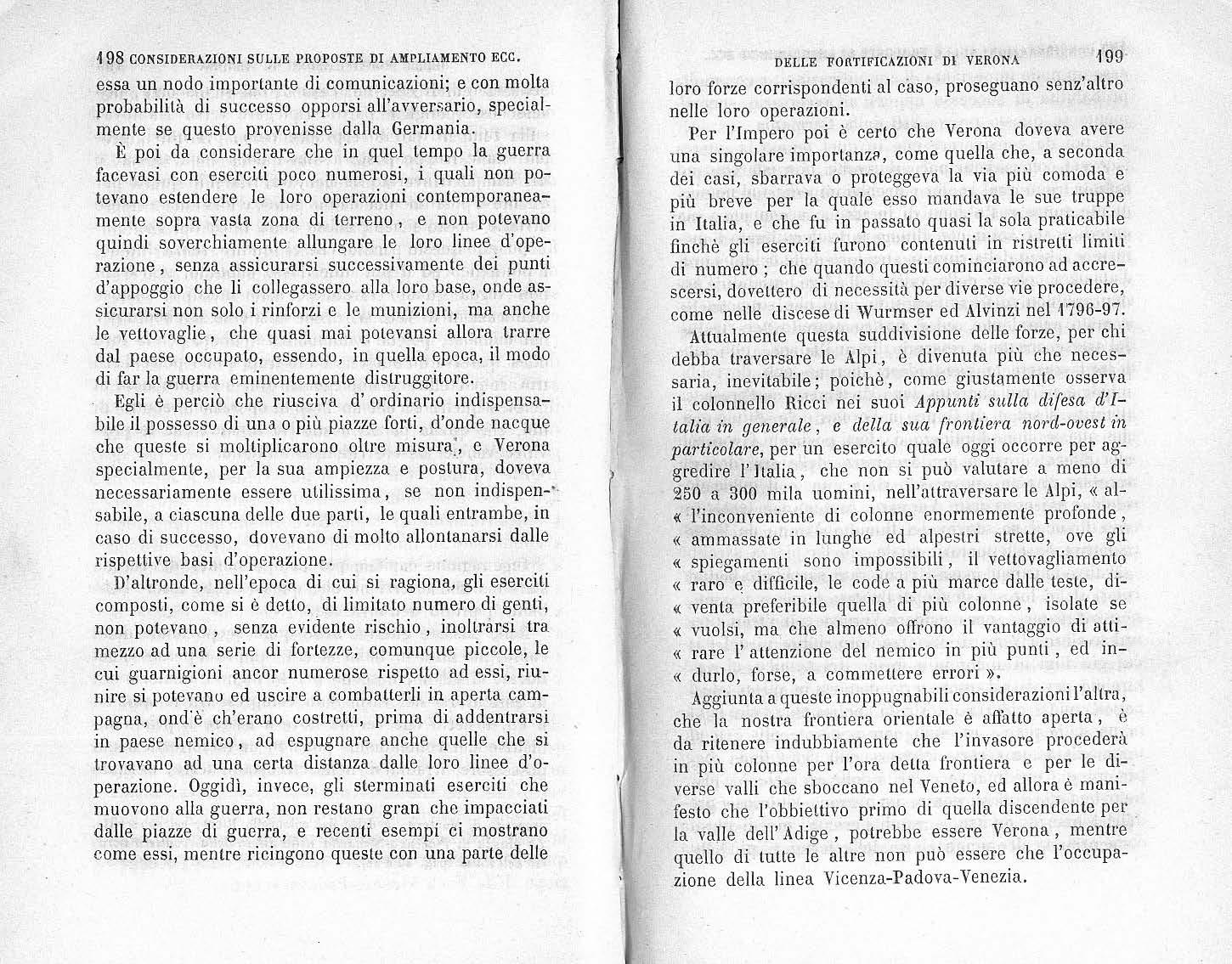
4 98 CONSIDEMZIONI SULLE PROPOSTE
AMPLIAMENTO ECC,
DI
(
DELLE FOI\TIFICAZIONI D} VERONA 19 9
Per le considerazioni già svolte non istaremo ad .esaminare in qual modo potrebbe impedirsi al nemico .di raggiungere l'obbiettivo in ultimo accennato ; ma supposto che abbia c9,n buona fortuna superato il momento critico della riunione tra loro delle colonne procedenti a levante della valle dell'Adige, quando l'ora detto obbiettivo fosse raggiunto, ciò che suppone uu nemico prevalente, ed il nostro esercito per ripetutirovesci costretto a riparare dietro l'Adige, non sappiamo verarpente persuaderci perchè egli. dovrebbe impegnarsi nella stretta zona di teneno compresa tra il tratto d'Adige da Ronco a Verona e le ultime pendici dei monti, dominata da forti posizioni favorevoli alla difesa, dove la preponderanza delle sue forze gli sarebbe di poco giovevole , ed occupato il qùale dovrebbe poi espugnare Verona , in vece eh~ tent!lre a viva forza il passaggio del fiume sul tratto da Ronco a Legnago, effettuato il quale, quella piazza sarebbe girata, e le truppe in essa ricoverate sarebbero tagliate fuori dalla loro base d'operazione.
Si dirà forse : per occupare Verona con i suoi ponti ed ovviare ali' operazione, sempre diflìcile, del passaggio d'un gran fiume a fronte del nemico, che po. trebbe per di _più molestarlo con truppe distaccate da quella piazza. Ma a ciò v'è da contrapporre che la caduta della piazza essendo conseguenza, piiì o meno immediata ma certa, del passaggio del iìnme , oggi in cui più che mai .!a celerità delle opera·zioni e principale fattore di successo, un nemico vittorioso preferirà questo con i suoi grandi pericoli, ma di pronta .esecuzione, all'oppugnazion<" della foflezza, più lenta
e non esente da gravi inconvenienti. Soggiungeremo inoltre che l'esercito attivo, riparato dietro l'Adige, dovendo naturalmente appoggiare le sue operazioni a ~Iantova, d'onde solo possono giunge_rgli rinforzi e provvisioni, il presidio del campo trincerato di Verona sarà per lui di poco sussidio e pel nemico poco temibile, poichè essendo di necessità ad ·esso devoluta la difesa dei I'l1onLi Less.ini, sulle ultime pendici dei quali è in parte posta la fortezza, avrà quella guarnigione di già un grave peso a sostenere.
Però tra .le colonne invadenti essendovene una ch é procede per la valle dell'Adige, potrebbe Verona essere il primo obbiettivo di -questa? Ciò può ammettersi: ma comunque sia, è chiaro che perciò nulla resta mututo ·nel procedimento a tenersi dalle altre colonne, le quali, evidentemente , dopo riunitesi non do,vrebbero tendere ad altro che al p ossesso del Po , per quindi ferirci nella nostra parte più vitale .
Non è però così evidente che la r.olonna, cui si accennava, debba necessariamente venirsi ad urtare contro Verona, dappoichè, ammesso che abbia potuto espugnare le dilese della stretta zona tra l'Adige ed il lago di Garda, sulla linea di Monte Moscalli, essa sarà padrona delle due rive di quel fiume a monte di Verona, e potrà, occorrendo, prestar mano alle operazioni della rimanente parte dell 'esercito, ed aiutarlo ad isolare questa piazza , senza perciò doversi necessariamente urtar contr' essa.
IX.
Da quanto precede ci sembra risultar chiaro che l'influenza di Verona essendo per lo meno assai limitata sulle grandi operazioni di guerra fra l ' Italia ed
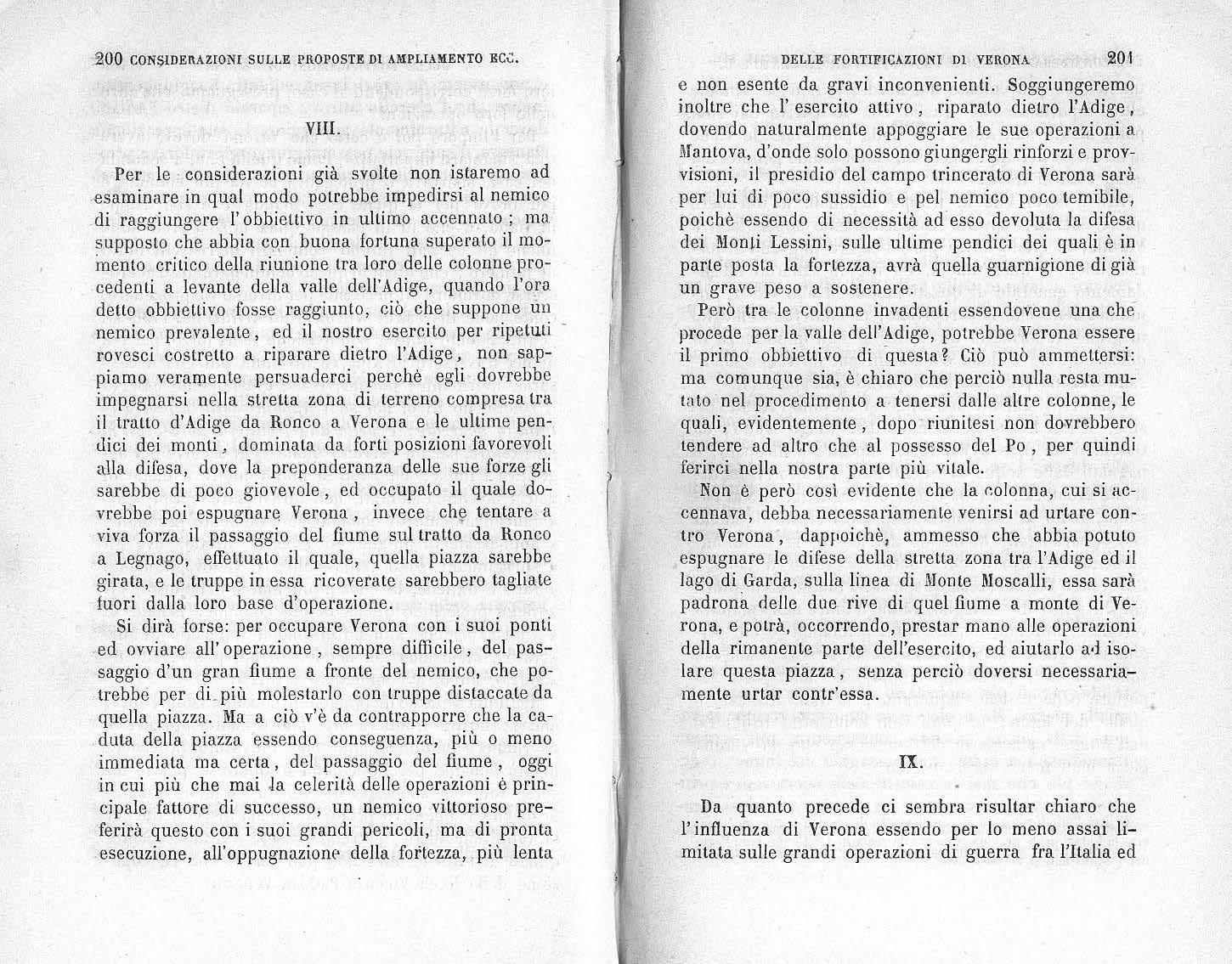
,200 C0N$IDEI\AZI0NI
SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO RC,:. VIII.
DELLE FORTIFICAZIONI Dl VERONA. 20 •1
SULLE PROPOSTE DI AMPLI.AMENTO ECC, un n~mico proveniente dal nord-est, non le rimane altra i mportanza che quella che le deriva dai suoi ponti ~tabil i sull'Adige, e dalla parte che le viene nella difesa dei 1'Ionti Lessini, sulle ultime pendici dei quali essa si trova.
Egli è certo che le truppe destinate a difendere questi monti, devono essenzialmente appoggiarsi a ~erona, la quale dovrà perciò essere in g rado di co rnspondere · a qu est'uffici o. Un rapido sguardo all'andamento generale di questi monti ed alle vie di co~nunicazion.e che li percorrono, ci metteranno meglio rn grado . d1 fo rm arc i un concetto dell'importanza di questa difesa, e delle condizi oni cui dovrebbe soddisfare Ver?na per es serne il perno principale (1) .
Sulla r1va sinistra dell'Adige s i elevano i Monti Lessini, _il cui fianco oc c identale per lungo tratto, da Ossemgo fin press o Volargne, alpestre e dirupato, è bagnato dalle acque di que l fiume . La l oro cres ta dal Rfo n.te Uontor.io, tra Ossenigo e Borghetto, fino al Pas ub10, n od o m cui convergono altre creste di monti che ap parten gono al bacino dell' Astico, se;ue un andamento concavo il cui centro è presso· 0 a poco a .R.overedo .. Da t.al cresta si spiccano lunghi contrafforti che, a guisa d1 ventaglio, va nn o a finire nella pianura ve r onese, apren d o quattro valli principali le cui orig ini rimontano fin presso la cres ta stessa, e sono: la va li.e Pante na ;· quella del Fibbio, che nella parte su. peri ore è detta dello Squaranto ; la valle d' 1llasi , e quella dell' Agno; le qua li valli sono tulle tri b utarie dell'Adige, nella parte del suo co rso che da Verona piega man mano verso ori en te.
I?ra queste valli poi la valle d1llasi forma nel mezzo della zona montuosa, di cui si discorre, u n profondo taglio, che dal passo d ella Trappola , sul confine , scende fin presso a Tregnago sempre con fianchi ripidi, in cui si riscontrano scarsi e difficil i sen tieri per poter transitare nelle al tr e valli.
La cresta di questi monti, lungo la qua le sco rr e in generale la linea di confine, e le cui faldè mollo alpestri sul versante setten trionale , si stendono molto meno acclivi nella parte me ridi onale, non è traversata da veruna strada carreggiabile, ma bensl da vari sentieri che partono tra Borghetto, Ala e Roveredo.
Tali sen tieri, che tralascieremo, per brevità, di partitamen te enumerare, traversano l'accennata cresta per sei paesi, detti de lla Lian a, della Sega, della Podesteria , della Trappola, della Lora e di Campogro sso .
Superata la cr esta, e sul no stro ve r sante, i sentieri stessi mantengonsi dapprima per buon tratto mulattieri o pedonali, co me erano sul versante opposto, e poscia quelli che la sormontano per i p ri mi tre paesi, in parecchi rami si suddividono , i quali proseguendo alcuni sempre atti solo alle bestie da som a , cd altri essendo anche , a tratti a tratti, ora mulattieri , ora carreggiabili, ed alcune volle anche carro zza bil i, vanno poi da una parte a congiungersi nelle strade rotabili che da Cavalo e da Pnm me ttono a Parona, e quind i, per la postale tir olese, a Verona; e dnll'allrn lato (verso levante) immett ono n ella strada rotab ile di val Pantena che fa capo alla provinciale vicentina , innanzi porla Vescovo a Verona stessa.
(l) Per l'intelligenza ed a complemento di quanto segue, può servire la Carta delle province venete alla scala di 1 : 43 ,200 pubblicata dallo Stato maggiore aus triaco.
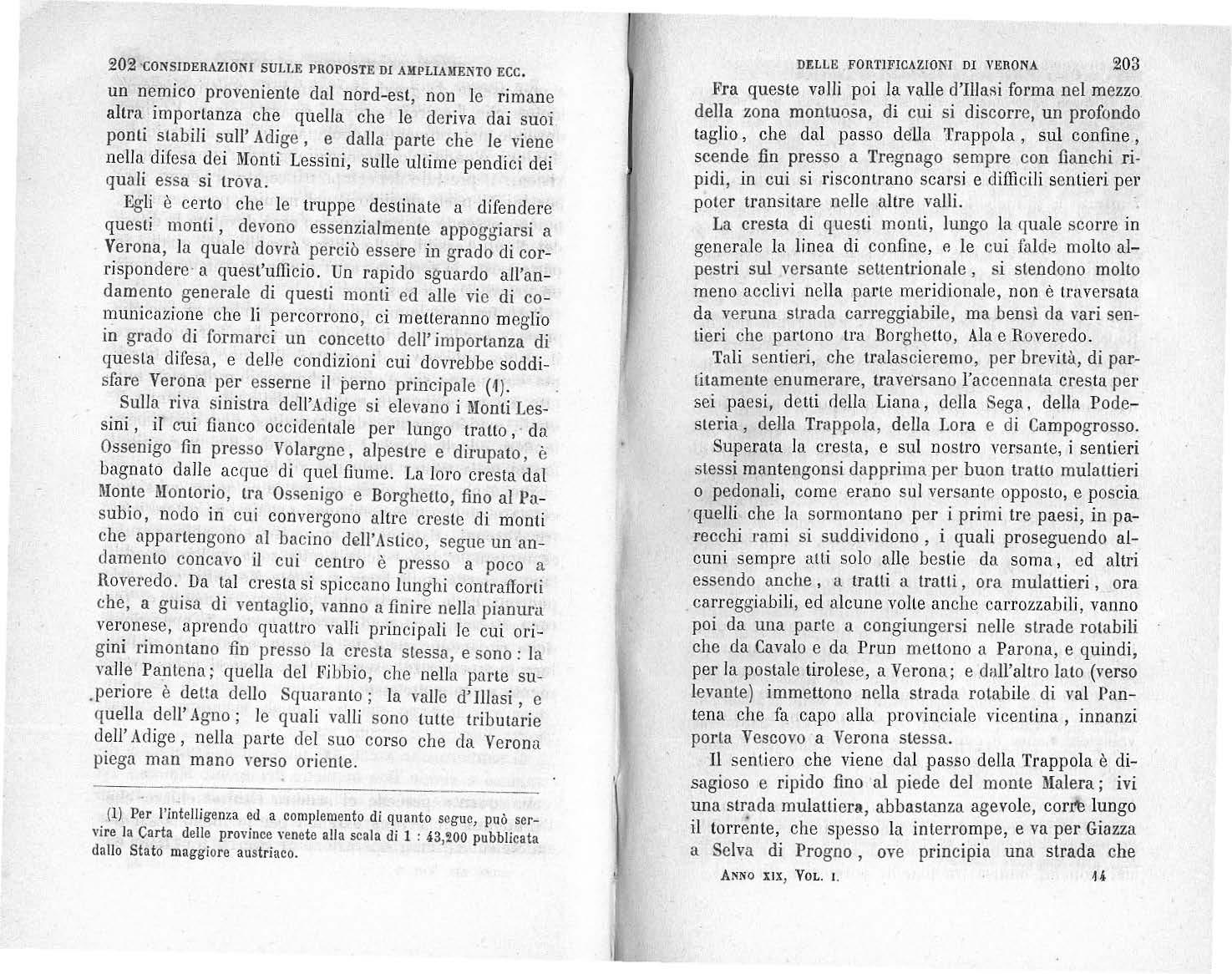
.
Il sentiero che viene dal passo della Trappola è disagioso e ripido fino a l piede del monte àlalera; ivi una strada mulauiera, abbastanza agevole, co rre l ung o il torr ènte , che spesso la interrompe, e va per Giazza a Selva di Progno , ove principia una strada che
ANNO xix, YoL. 1. H
202 ·CONSJDERAZIONI
DELLE FORTIFICAZIONI DI VE RONA 203
scende sempre l ungo l'Illasi fino ad incon trare tra San Martino e Cal d iero la postale vicentina. Il senti ero che dal passo della Lora discende ·in val d' Agno è .anche esso praticabile per bestie · da som a sino a Recoaro, dove incomincia la st r ada rotab ile che scende ad inco ntrare a l\fon tebello la postale t estè ricordata ..
Sull' i stess a cre s t a ove è il passo della Lo r a , e circa quattro chilometri più a nord, è il passo di Ca mpogrosso; in questo g iunge un senti ero praticab ile con bestie da soma, che da Roveredo risale la valle del teno , e di qua dal co nfin e disce nde da una parte a Recoaro e dall'altra per Staro a Valle dei S ign ori sulla strada nazionale Vicenza- Schio- Roveredo .
Di 'tutti gli accen na t i sentieri, che provengono di là dal confine , q u elli che, metlono capo ai passi de lla Sega, della Lora e di Campogrosso, sono per~orsi d~ bestie da soma, gli altri solamen te da pedoni, e tuttl sono piuttosto ma lagevo li . Però que llo da Ala al passo della Seo-a è assai probabile che, in epoca non molto lontana , 0 venga trasformato in una strada rotabi le che è presumibile verrà di poi proseguita di qu.a d.el c?nfine ove la via è già mediocreme n te carre ggiabile s rno ' c. a Bellori sulla comuna le d i va l Pantena.
In quanto alle com un icazioni trasve r sali fra le vie di eui si discorre , si note r à che fra Campogrosso ed il passo della Lora, è molto più facile comuni care al d i qua che al di là del confine ; men tre da quel lato chi volesse recars i dal pr im o passo ali' altro e vieeversa , dovrebbe d i scendere per un lungo t ratto la valle del Le no, e poi risalire pe r sorm ontare la cima di p osta e g i unge r e indi in Campo Bruno alla Lora .
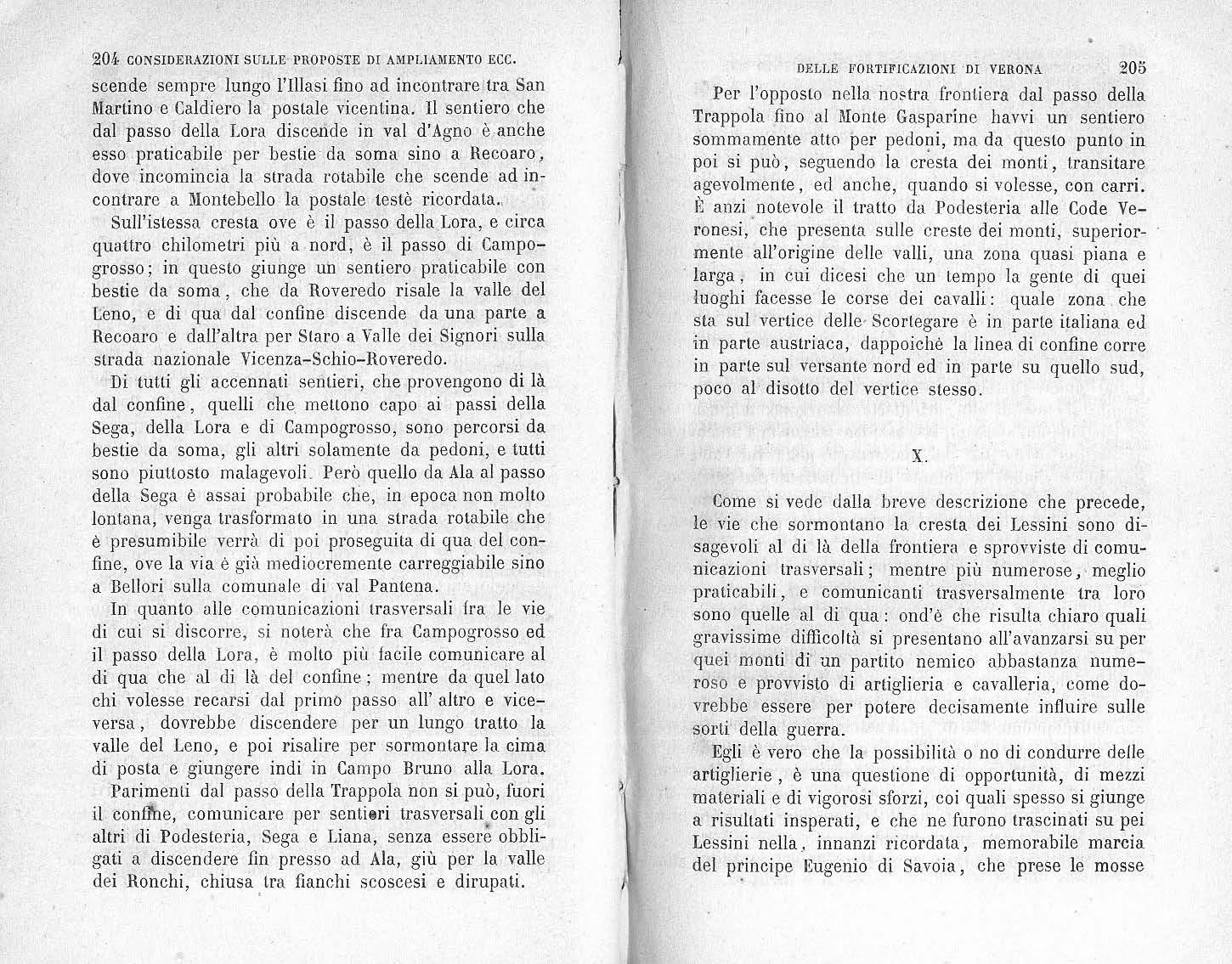
Parimenti dal passo dell a Trappola non si .può, fuori il confì'ne , c omunieare per senti@ri trasversali . con gli altri d i Podesteria, Sega e Liana, senza essere obblig ati a discendere fin presso ad Ala , g iù per la valle de i Ronchi, chiusa tra fia n chi sc osc es i e dirupati.
DELLE l!'ORTil'lCAZlONI DI VERONA 2 0/5
Per l'o ppos Lo n ella nostra fr onti era dal passo della Trap pola fino a l ~fon te G,asparine havvi un sentiero s o mmamente att0 per pedoQi , ma da questo p unto in poi si può, seguendo la cresta d e i m onti, tra n si tar e agevo lm ente, ed anche, quando si vo lesse, con car r i. l~ anzi n otev ole i l tratto da Podesteria a lle Code Verones i , · che presenta sulle creste de i mo nti , supe riormente all'origine d e lle valli , una zona quas i p i a n a e larga, i n cui d ic esi che un tempo l a gen te di que i l uoghi facesse le corse dei cavalli: qua le zona . che sta sul vertic e delle, Scortegare è in parte itali ana eJ in parte austriaca, dapp oichè la li nea di confine corre in parte sul versante nord ed in parte su quello sud, poco al disotto de l vertice stesso. X.
Come si vede da lla breve desc ri zione che precede, le vie ch e sormontano l a c resta dei Lessini sono disagevoli al di là della frontiera e sp r ovviste di comunicazioni trasversali ; mentre più numerose, · megl io pratica bili, e comunicanlì tr as versal men te tra loro so no quelle al cli qua: ond'è che risulta chi ar o quali gravissime d iffi colt~i. si presentano a ll'avanzarsi su per que i mon ti di' un partito nemico abbas tanza numero so e p r ovvisto di artiglieria e cavalleria, come dovrebbe essere per potere d eci samente influire sull e sorti della guerra .
Egli è ve ro che la p ossi b ili tii o no di condurre delle a rti g lieri e , è una questione di opportunità, di mezzi materiali e di vigorosi sforzi, co i quali spesso si gi unge a risultati insperati, e che ne fu rono trascinati su pei Lessini nella, innanzi rieordata, memorabile marcia del p~incipe Eugeni o di Savoia, che prese le mosse
204 CONSIDERAZIONI S ULLE
ECC
PROPOSTE or AMPLIA!tIENTO
, J
SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO EC1;.
da Ala, and ò a Breoni o a s tabilire il suo quartiere generale, e quindi per val Policella e val P~ntena d iscese innanzi Verona, con un esercito munito di artiglieria e cavalle ria. Ma un tentativo di questa sp ecie è da ritenersi che sarebbe inattuabi le quando i Lessini non fossero abbandonati, come si verificò allora.
Anzi dalla somma ria descr izione precedentemente fo.tta della strutt ura di quel terl'eno montuo so , e dal diligente esame di un piauo top ografico d el medesimo, facilmente si deduce che sulle zone lungo la cr esta dei monti può farsi una attiva ed efficace difesa dei passi . Quivi , volendo, potrebbero trasportars i delle ar ti g lierie d i campagna, per la strada di Chiesa Nuo\'a. I due mon ti Castelberto e Cima degli Sparvieri, entrambi acce ss ibili alle artiglierie, sporgono a guisa di bastion i da lla cres ta , la quale tra mez zo fa l'uffi c io di cortina, e da essi può battersi g iù n ella Valle dei Ronchi, e vietare al nemico di rimontarla per guadagnare i passi. E quand'anche qualche partito nemico g iungesse a ri u nirsi nel ristretto spazio che presen tan o le sco rtegare basse, e supe rasse per forza o per sorpresa la cresta, delle truppe mobili disposte opportun amente nelle forti posizioni rclrostanti, e sorrette da qua lch e ope ra di camp agn a, g li impedirebbero certamente di procedere oltre .
Esclusa così la possibilità che corpi· di trupp e di qualche imp ortanza, supera ti i pass i del confine, possano valicare i Mo nti iess ìni (sempre che qu es ti si an o convenien tem ente d ifesi ), qu ali offese potrebbe Verona temere da tal parte ? A noi pare nessuna, ammenochè non si tratti di un tentativo di sorpresa ch e ìl nemico si arrischiasse d i fare con poche fo rz e, ten ta ndo di eludere la vigilanza, ci ò che certamente non potrebbe essere coronato d i successo .
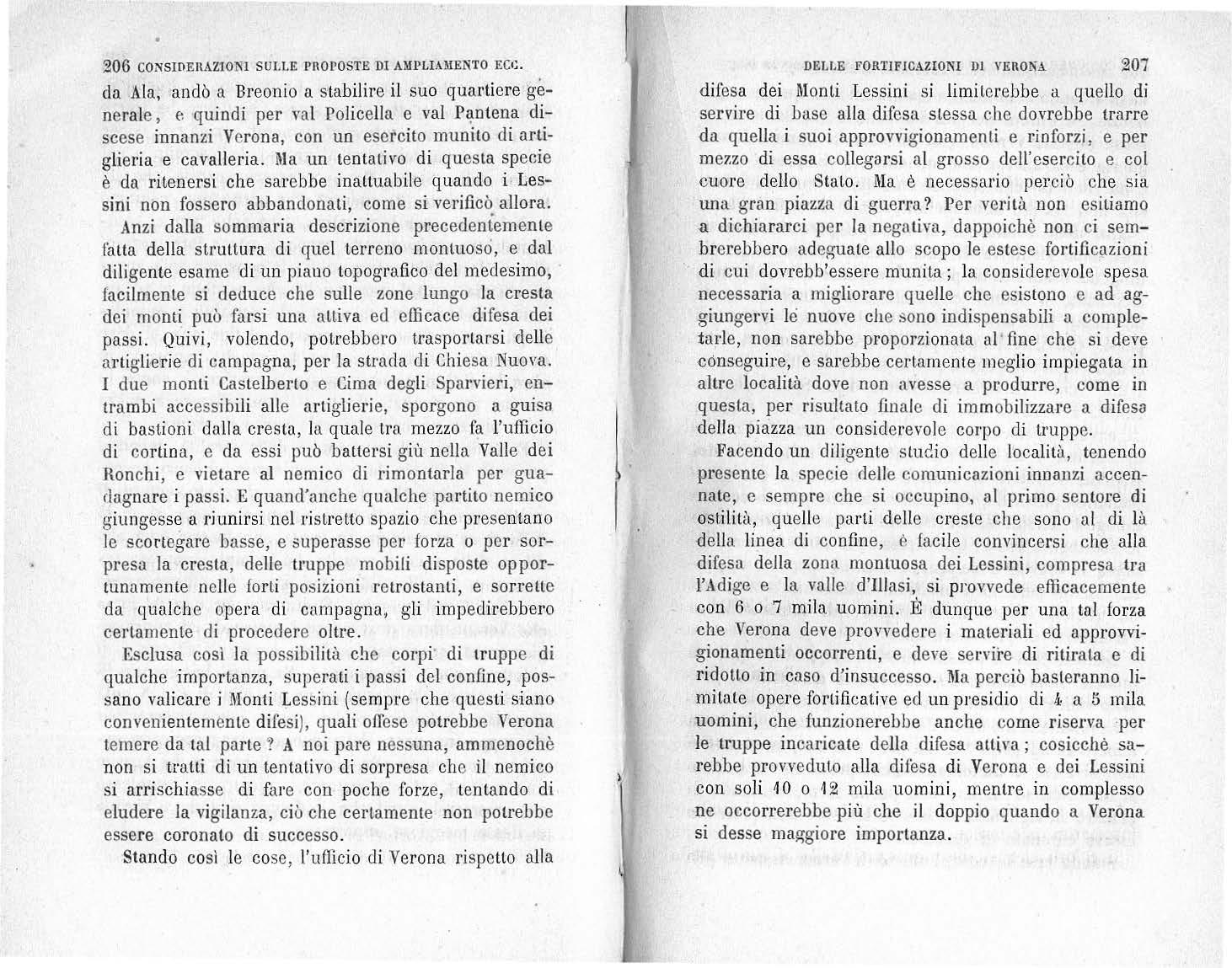
Stando così le cose , l'ufficio di Ve rona rispetto alla
difesa dei Monti Lessini s i limi tc1·ebbe a que llo di servire di base alla difesa stessa che dovrebbe tra rr e da quelJa i suoi approvvigionamenti e rinforzi, e per mezzo di essa collega rsi al grosso dell'esercito e col cuore dello Stato . !\fa è necessario perciò che s ia una gran piazza di guerra? Per verità non esitiamo a dichia rarci per la negativa, dappoichè non c i sembrerebbero adegua le a llo scopo le es tese fortificazioni di cui dovr ebb'essere munita ; la. co.nsiderevole spesa necessaria a migliorare que lle che es istono e ad ag.giungervi le nuove che sono in dispensabili a completarle, non sarebbe proporzionata al fine che si deve ,conseguire , e sar ebbe certamen te meglio impiegata in altre località dove non avesse a produrre, come i n questa, per risultato finale di imm ob ilizzare a difesa della piazza un c onsi derevole corpo di trupp e .
Facen do un di lige n te studio delle località, tenendo presente la specie delle comunicazioni innanzi accenna te, e sempre che si occupino, al primo sentore di ostilità , quell e parti delle creste ch e sono al di là <lella linea dì confine, è> faci le convincer si che alla difesa della zona mon tuosa dei Lessi ni, compresa tr a l'Adi ge e la valle d'Illasi, si provvede efficacemente con 6 o 7 mila. uomini. È dunq ue per u na tal forza -che Verona deve provvedere i material i e d appr ovvigionamenti occorrenti, e deve servire di ritfrala e di ri dotlo in c aso d' insuccesso . Ma perciò basteranno limitate opere fortificative ed un pre s iùio di 4 u 5 mila uomini, che funzionerebbe anche co me r iserva ·per le tru ppe i ncaricate della difesa atti ,,a; cosicchè sarebb e provveduto alla difesa di Verona e dei Lessini con soli 10 o ,12 mila uom inì, mentre in complesso ne occorrerebbe più che il dop pio quando a Ve~ona si desse maggiore importanza.
206
CONSIOEllAZIONl
DELLE FORTIFICAZIONI Dl VEROKA 207
Egli è indubitaLo che gli straordinari avvenimenti politici succedu tisi nella seconda metà di questo secolo, effetto dei quali è stata la riunione dell'Italia in un solo 3tato, sollo un governo nazionale, e quindi la sostituzione di una politica unie;a alle differenti e disparate che seguivano i governi preesistenti, ha di molto anche cangiato l'imp ortanza militare di parecchi, punti del ·territorio che, fortificati con scopi e mire diverse da quelli cui ora devesi soddisfare, o sono divenuti di molto mino re interesse, o non. ne hann o più alcuno.
L'antico dello : le sorti d'Ital ia si decidono nella va lle de! Po , ha perduto mollo del suo valore ora che la capitale ess endo stata trasportata nell'interno della penis ola, abbiamo dietro l'Appennino, il centro di gravità dei nostri interessi politici ed amministrativi, non chè circa due terzi del nostro territorio e della nostra popolazione.
Ora sono trascorsi i tempi in cui la potenza, cui arrideva l a sorte delle armi nelle pianure dell'Italia continentale, aveva, come abbiamo più innanzi accenJ?ato, assicurato il suo predom ini o in tutta la penisola. Oggidì una guerra infelice in quelle pianure, l'occupazione di tanta cospicua parte della nostra patria, sarebbe certo grave sciagura, ma potremmo ancora trovare nel resto d'Italia tanta forza e tanta: energia di propositi, da ritogliere all'invasore la sua conqmsta.
Non è però che la linea del Po non sia di vitale importanza per noi, e tanto è ciò vero e sentito che tutli coloro che si sono occupati della difesa dello
DELLE FORTIFICAZIONI DI VE RO NA 209
Stato, pur dissentendo ·sulla questione se debba da.rsi maggiore importanza a Bologna od a Piacenza, sono però d'accordo nel principio di doversi validamente fortificare, oltre che una di quelle due città, anche ~fantova, e costrurre o conservare delle teste cli ponte in diversi punti di quel fiume.
Si è sulle piazze a , difesa di punti importanti, ma non di vitale interesse che si fanno grandi le divergenze, ed una di queste p iazz e è Verona che trova molti dichiarati oppositori .
XIL
Le principali ragioni per le quali mo lLi distinti militari parteggiano per la demolizione delle fortificaz ioni di Verona, sono le seguenti, che trovans i con molta chiarezza sviluppate nella Memo r·ia III del generale
A. Brignone, Sulla di:[esa cleg li Stati in generale, e dell'Italia in particolare (1), e in gean parte -riepilogate nel noto pregevole scritto Bolog!ia e l'Appennino nella difesa d'Ito,lia, di A. G·., dal quale quasi testualmente le riproduciamo :

1° Verona A troppo addossata alla frontiera, per lo che se lasciata unicamente in balia a se stessa , mentre da una parte non influirebbe gran che a ritardare le mosse offensive del nemico, d'altra parte se da esso occupata costi tu irebbe per lui un'ottima base per le sue ulteriori operazioni .
2° Yerona fortificata sarà sempre deb::>le verso il (1) V,
208 CONSIDERAZIONI SUL!,E l>ROPOSTE DI AMPLIAMENTO ECC.
XI.
l I
Rivista Militare Italiana, anno •187~, pagina 335 e segnenti.
nord e fortissima verso il '.sud, essendo dominata dai monti, ed avvifuppa ta dalle valli clell' Ad'ige e del Brenta.
:t• I più elevati vertici dei Monti Lessini, sulle ultime pendièi dei quali è in parte pasta la piazza, essend o in potere del!' Austria , questa da essi può discendere è fulminarla c on le sue artiglierie .
4° Verona dovrà essere sgombrata ogniqual'lolta una m assa nemica superiore · in forze si rovesèiasse sul saliente formato a Ronco dall'Adige per tentarne il passaggio; altrimenti può esserci fatale se un generale , ponendo in non cale il fatlo indiscutibile che <lessa è fuori delle nostre linee di difesa, tanto se siamo attaccati dall'est com:e dal nord-ovest, e allettato dal nome e dalla importanza intrinseca di Verona, si lasc.iasse indurr:e a rifugiarsi in tale fortezza; · mentre battuto sul ~lin cio e sull'Adige altro non potrebbe e dovrebbe fare che ripiegare sulla linea Mantova-Legnago.
5° Verona scoperta ma sostenuta com'è ad una marcia da lUantova, acquista , per la prontezza con la quale potrà essere soccorsa, la forza per soddisfare alla limitata importanza che ha per noi. Nello stesso tempo Verona scoperta di fronte all'azione offensiva dell'esercito situato a Mantova sarà di difficile e malsicuro possesso. XIII.
DELf,E FOHTIFl C!iZIONI DI VEH.ON'A 211
Senza dubbio una piazza s ituata su di una valle impo rtante che si addentra nella frontiera , ed al punto ove sboccano varie altre vallate, ha per sè la buona condizione di dare, a chi .n'è in possesso, la facoltà di attaccare con si curezza l' ao-o-ressore do• i:,,, vunque s1 presenti, e rendere difficile ai suoi corpi un congiungimento sempre pericoloso. quando facciasi in presenza di un esercito raccolto e fortemente stabilito alla d ifesa degli sbocchi : ma tuuo ciò è vero a cond izi one che la piazza trovisi a t a l e distanza dalle alture fra cui si aprono le valli, da non ammettersi · che possa l'assalitore trarne profitto per opere ·d'assedio costrutte in punti dominanti. Questa impo rtante condizione non si verifica per Verona, appoggiandosi essa a nord sopra co lli che la dominano completamente, a portata efficace delle moderne artiO'lierie.
È vero che, siccome altrove fn detto, sul!~ vette d ei Lessini è ben difficile, se non impo ssibil e, che possano dall'altra parte della frontiera trasportarsi artiglierie, anche di cp.mpagna, ma queste potrebbero, senza gravi difficoltà, essere portate sulle è:!lture che dominano la p iazza , quando il nemico superate le difese del Pipolo-Moscalli e la linea dell'Alpone, le facesse rimontare pei sentieri abbastanza agevoli che mettono capo alle postali ti rol ese e vicen t ina.
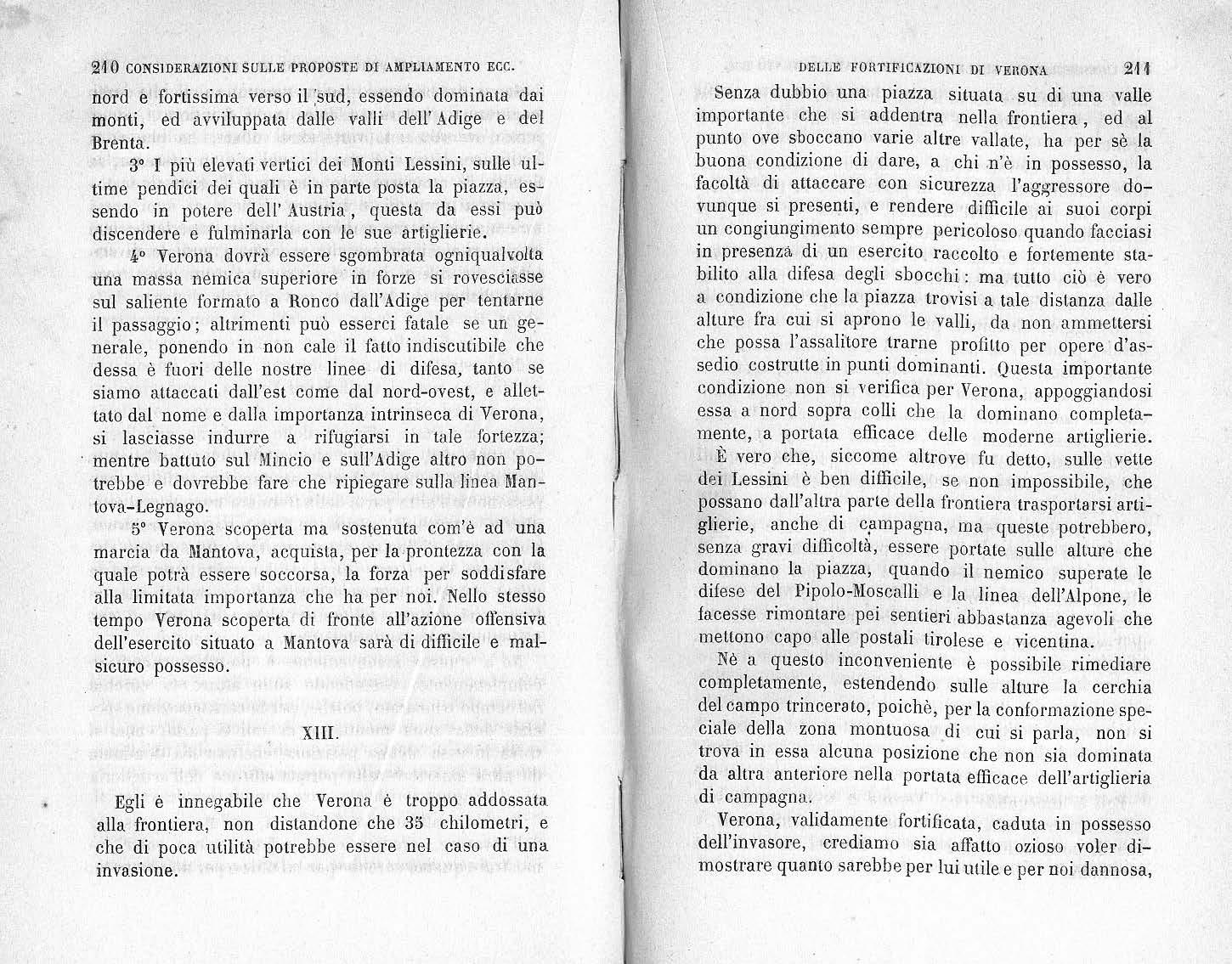
Egli è innegabile che Verona è troppo addossata alla frontiera, non distandone che 35 chilometri, e che di poca utilità potrebbe essere nel caso di una invasione.
Nè a questo inconveniente è possibile rimediare completamente, es tendend o. sulle alture la cerchia d~l campo trincerato, poichè, pe r la c onformazione speciale della zona montuosa di cui si parla, non si trova in essa alcuna posizione che non sia dominata da altra anteriore nella portata efficace dell'artiglieria di campagna. ·
Verona, validamente fortificata, caduta in possesso dell'invasore, crediamo sia affatto ozioso voler dimostrare quanto sarebbe per lui utile. e per noi dannosa,
210 CONSIDERA:ZIONI
ECC.
SULLE PROPOSTE ìH A&lPUAMENTO
CONSIDERAZIONl SULLE PROPOSTE 1)1 AMPLIAMENTO ECC. non essendovi chi non sappia quale valore essa aveva per l'Austria, altorchè era in possesso del Veneto , e qÙale influenza ebbe anche nelle più recenti guerre combattute in Italia.
Queste brevi riflessioni, coordinate con . q uanto aJ)biamo già avuto campo di esporre precedentemente, supponiamo che esprimano abbastanza chiaro la nostra opinione .circa i primi tre appunti, cioè : che riteniamo assai fondali i primi due, e non così il terzo, a riguardo del quale non abbiamo che a riportarci alla sommaria des crizione faua dei Monti Lessini. XlV .
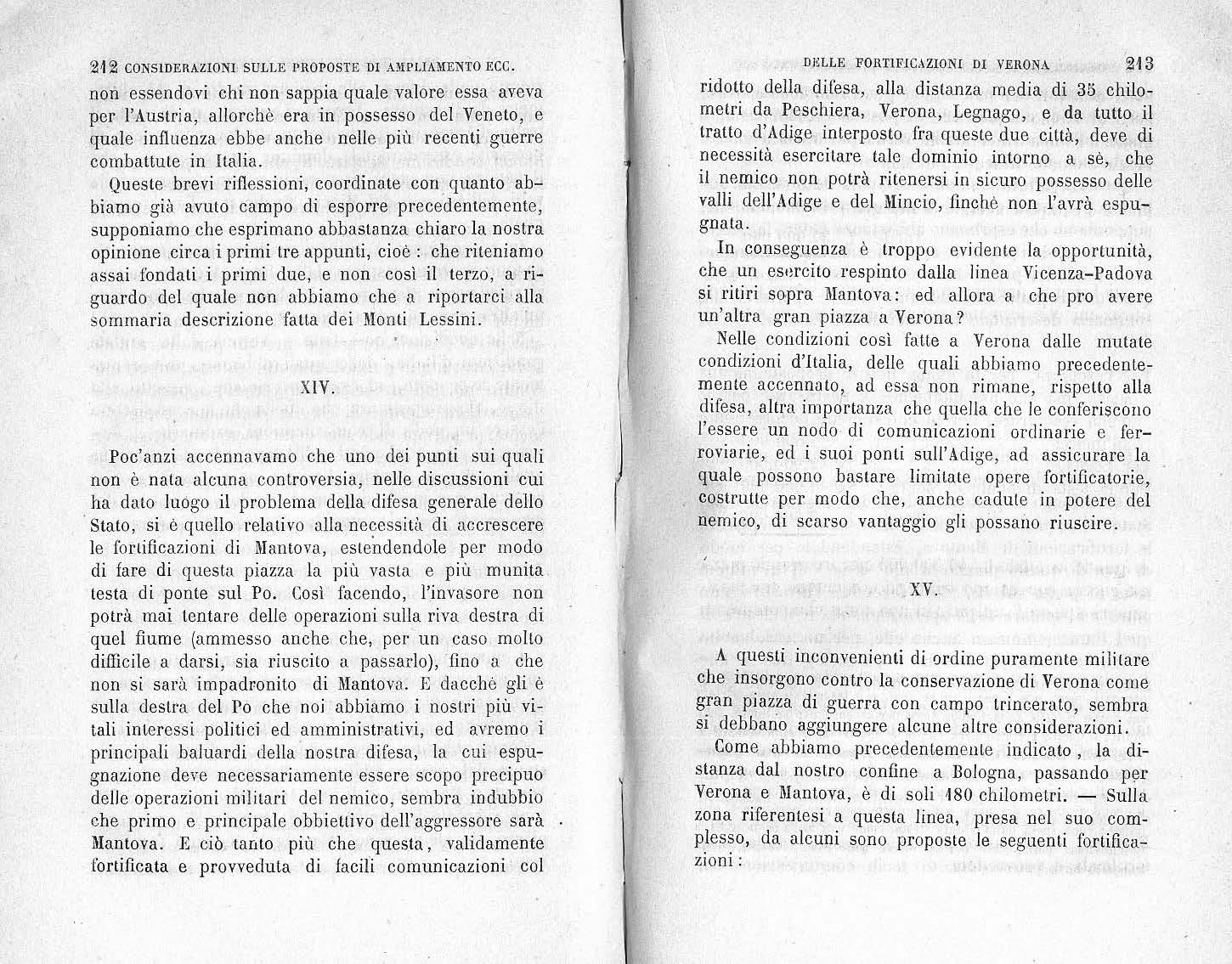
1ll>LLE
F01lT1F1CAZI0NI DI VEHONA. 213
ridotto della difesa, alla distanza media di 35 chilometri da Pes,c hiera, Verona, Legnago, e da tutto . il tratto d'Ad ige interposto fra queste due città, deve di necessità esercitare tale dominio intorno a sé, che il nemico non potrà ritenersi in sicuro possesso delle valli dell'Adige e del Mincio, finchè non l'avrà espugnata.
In conseguenza è troppo evidente la opportunità, che un esercito respinto dalla linea Vicenza-Padova si ritiri sopra Mantova: ed allora a che pro avere un'altra gran piazza à Verona?
Poc'anzi accennavamo che uno dei punti sui qua li non è nata alcuna controversia, nelle discussioni cui ha dato luogo il problema della difesa generale dello ·Stato, si è quello relativo alla necessità di accrescere le fortificazioni di Mantova, estendendole per modo di fare di questa piazza la più vasta e più munita lesta di ponte sul Po. Così facendo, l'.invasore non potrà mai tentare delle operazioni sulla riva destra di quel fiume (ammesso anche che, per un caso molto difficile a darsi, sia riuscito a passarlo) , fino a che non si sarà impadronito di Ma n tov a . E dacché gli è sulla destra del Po che noi abbiamo i nostri più vitali interessi politici ed amminis tr ativi, ed avremo i principali baluardi della ·nostra. di fe sa, la cui espugnazione deve necessariamente essere scopo precipuo delle operazioni militari del nemico, sembra indubbio che primo e · principale obbiettivo dell'aggl'essore sarà Mantova . E ciò tanto più che ques ta, validamente fortifica ta e provveduta di facili comun icazioni col
Nelle cond izi oni così fatte a Verona dalle mutate condi1,ioni d'Italia, delle quali abbiamo precedentemente accennato 1 ad essa non rim/lne, rispetto alla difesa, altra importanza che quella che le conferiscono l'essere un nodo di comunicazioni ordinarie e ferroviarie, ed i suoi ponti sul!' Adige, ad assicurare la quale · possono bastare limitate op ere fortificatorie, costrulle per modo che, anche cadu te in potere del nemico, di scarso vantaggio g li possaùo riuscire.
. A ~ruesti inconvenienti di ordin e puramente mili1are che rnsorgono contro la conservazione di Verona come g~an piaz~a di guerra con campo trincerato, sembra s1 debbano aggiungere alcune altre conside razioni. Come abbiamo precedentemente indicato , la distanza dal nostro confine a Bologna, passando p\;r Verona e Mantova, è di soli 180 chilometri. - Sulla zona riferentesi a questa linea, presa nel suo complesso, da alcuni sono proposte le seguenti fortificaztom :
242
xv .
Fo·rti di Rivoli per L. Forti al Pjpolo e Moscalli. » 500,000 1,500,000 5,000,000
Piazza e campo trincerato di Verona»
Piazza e campo trincerato di MantovaBorgoforte. » rn,000,000
Piazza e campo trincerato di Bologna» 18,000,000
Totale L. 37,000,000
a cui bisogna aggiungere, per le allre seguenti fortificazioni che formano sistema con esse, le seguenti
somme:
Per Peschiera, per la quale non è proposta alcuna spesa, ma che assolutamente è necessario per lo meno restaurare, per lo che si crede occorreranno all'incirca L . 500,000
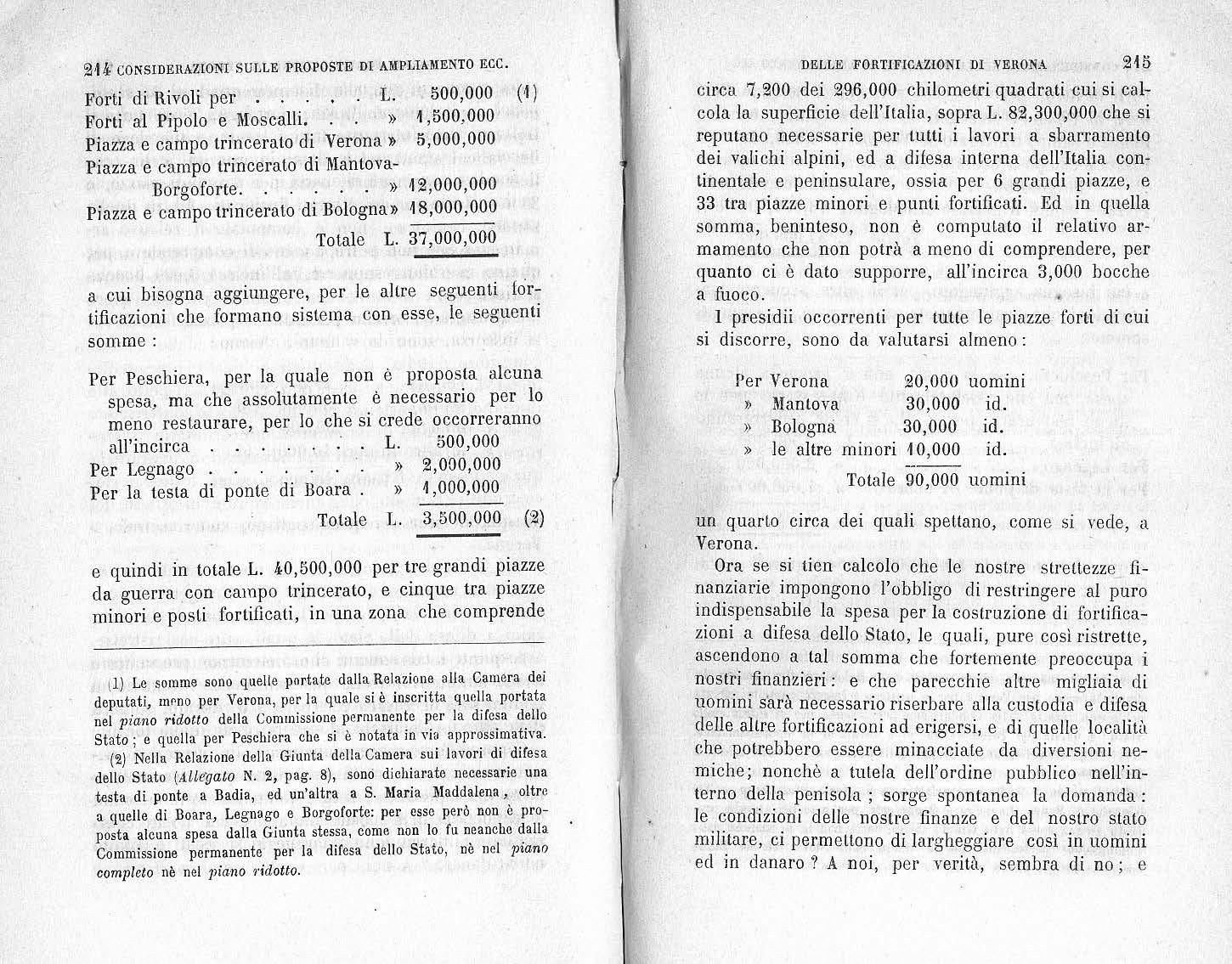
Per Legnago . » 2,000,000
Per la testa di ponte di Boara » 1,000,000
Totale L. 3,500,000 (2)
e quindi in totale L. 40,1500,000 per tre grandi piazze da guerra .con carnpo trincerato, e cinque tra piazze minori e posti fortificati, in una zona che comprende
(1) Le som me sono ·quelle portate dalla Relazione alla Camera dei deputati, mrno per Verona, per la quale si è inscritta quella portata nel piano ridotto della Co mmissione permanente per la difesa dello Stato; e quella per Peschiera che si è notata in Yia approssimativa.
(2) Nella Relazione della Giunta della Camera sui lavori di difesa dello Stato (A.lle"gato N. 2, pag. 8), sono dichiarate necessarie una testa di ponte a Badia, ed un'altra a S. Mari a 1\Iaddalena,. oltre a quelle di Boara, Legnago e Borgoforte: per esse però non è proposta alcuna spesa dalla Giunta stessa, come non lo fu neanche dalla Commissione permanente per la difesa dello Stato, nè nel piano completo nè nel JJiano ?'idotto
DELLE F01lTinCAZI0Nf DI VEHONA 2 5
circa 7,200 dei 296,000 chilometri quadrati cui si calcola la superficie dell'Italia, sopra L. 82,300,000 che si reputano necessarie per LUtti i lavori a sbarramento dei valichi alpini, ed a difesa interna dell'Italia continentale e peninsulare, ossia per 6 grandi piazze, e 33 tra piazze minori e punti. fortificati. Ed in quella somma, beninteso, non è computato il relativo armamento che non potrà a meno di comprendere, per quanto ci è dato supporre, all'incirca 3,000 bocche a fuoco.
I presidii occorrenti per tu.ile le piazze for~i di cui s1 discorre, sono da valutarsi almeno :
Per Verona 20,000 uomini
>, Mantova 30,000 id.
» Bolognà 30,000 id.
» le altre minori 10,000 id.
Totale 90,000 uomini
un quarto circa dei quali spettano, come si vede, a Verona.
Ora se si ticn calcolo che le nostre strettezze fi~an_ziarie i~pongono l'ob bligo di restringere al puro md1spensab1le la spesa per la costruzione di fortificazioni a difesa dello Sta to , le quali, pure così ristrette, ascendono a tal somma che fortemente preoccupa i nostri finanzieri: e che parecchie altre min·liaia di . . o uomm1 sarà necessario riserbare alla custodia e difesa delle altre fortificazioni ad erigersi, e di quelle località che potrebbero essere minacciate da diversioni nemiche; nonchè a tutela dell'ordine pubblico nell'interno della penisola ; sorge spontanea la domanda : le cond izioni delle nostre finanze e del nos tro stato mi litare, ci permettono di largheggiare cosi in uomini ed ju danaro ? A noi, per verità, sembra di no; e
:z,,U:
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE- D1 AMPLIAMENTO ECC.
(,1)
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO ECC cosi ·essendo crediamo che, a risparmiare e quelli e questo, senza perico lo p er la nostra patria, occorra prescindere da quelle · fortificazioni, le quali, ammèttendo pure che potessero in date evenienze tornare utili, non sono però ne cessarie , anzi diremo indispensabili a ll a difesa; hel qual caso, a nostro avviso, trovansi le fort ificazioni di Verona , come sono da molti propugnate (·1}. Ad esse ci pare che calzi a capello quanto, a pl'Oposito di Alessandria; è detto nella Relaaione della Giunta della Camera dei deputati sui lavori a difesa dello Stato, che cioè la Giunta
(1) Notiamo incidentalmente che sarebbe il pi ù grave errore erigere o consllrvarc delle fortifìr.2z ioni imperfette, od al cui completo armamento non si possa in ,•ia normale provvedere. Il BR!ALMONT, nella sua opera: La fortification à fossés secs (cap. 4'} , dimostra che la parsimonia con la quale ven ne sem pre costituita la dotazione delle piazze forti, cosicchè non avevano nean che il quar to dei cannoni necessari ad una buona difesa, e neppure le munizioni, i ricov eri e le casematte in proporzione di quest'armamento ridotto, unitamente all' i nsufficienza e spesso anche alla cattiva composizione delle guarnigion i, furono causa della poca resist enza delle piazze dall'epoca di Luigi XIV io poi: alle quali cause va anche attribuita la res iste11za corta ed inefficace della magg ior parte delle piazze fort i francesi nella guprra del •1870-7L
Lo stesso autore dimostra , accennando dapprima alla bell a difesa di Sebastopoli," sostenuta da truppe di linea, ed alla infelice difesa delle piazze francesi, affidate nel 1870 ai mobili, ai tirat ori franchi ed alle ·guardie nazionali; e poscia citando parecchi rapporti di uffizi ali superiori francesi: essere erronea l'opinione, io altri tempi sostenuta da illustri mi li tari, che cioè la difesa delle piazze fort i può essere affidata à truppe di recente formazione, a volontari, o a guardie nazionali.
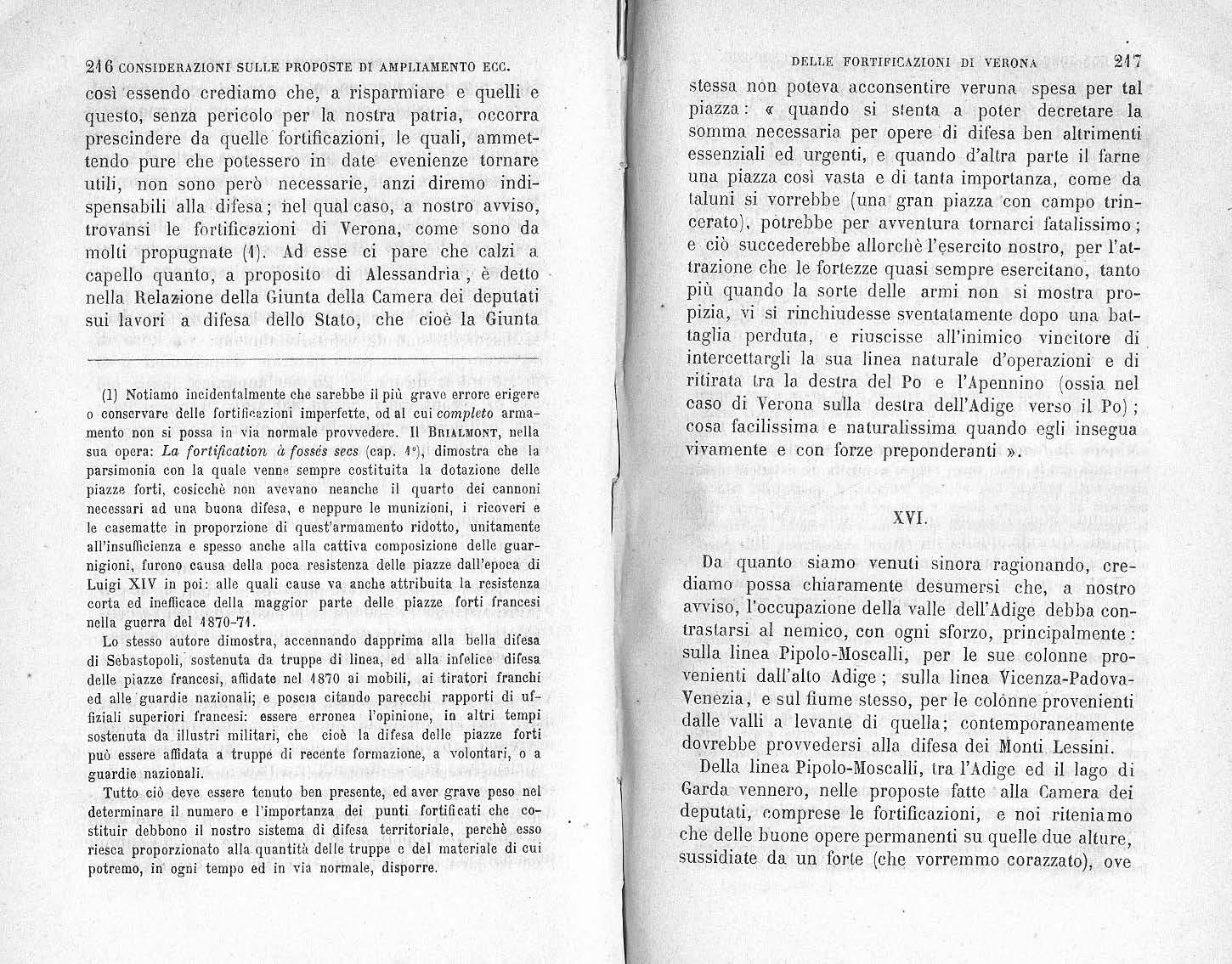
Tutto ciò deve essere tenuto ben presente, ed aver grave peso _ nel determinare il numero e l'importanza dei punti fortificati che costituir debbono il nostro sistema di difesa territoriale, percbè esso riesca proporzionato alla quantità delle truppe e del materiale di cui potremo, in ogni tempo ed in via normale, disporre.
Is~essa non poteva acconsentire veruna spesa per tal piazza : « quando si stenta a poter decretare la somma necessaria per opere ·di difesa ben altrimenti essenziali ed urgenti, e quando d'altra parle il farne una piazza così vasta e di tanta importanza, come da taluni si vorrebbe (una gran p iazza ·con campo trincerato }, pòtrehbe per a vvenlura tornarci fatalissimo ; e ci_ò succederebbe allorc!Jè l'~sercito nostro, per l'att1:~z1one che le fortezze quasi sempre esercitano· , tant o pm quando la sorte delle armi non si mostra propizi~, v i si rinchiudesse sve.ntatamente dopo una battaglia perduta, e riuscisse a ll'inimico vincitore di i~tercettargli l a sua linea naturale d'operazioni e di · ritirata. tra la destra del Po e l' Apennino (ossia nel caso di Verona stJilla destra dell'Adige verso il Po) ; cosa facilissima e naturalissima quando ecr li inse.o'ua • l:) l:) vivamente e con forze p reponderanti ».
XVI.
Da quanto siamo venuti sinora ragionando, crediamo possa chiaramente desumersi che, a nostro avviso·, l'occupazione della valle dell'Adige debba contrastarsi al nemico, con ogni sforzo, principalmente: sulla linea Pipolo-rrloscalli, per le sue colonne provenienti dall'alto Adige; sulla linea Vicenza- PadovaVenezia, e sul fiume stesso, p~r le colonne provenienti dalle valli a le va nte di quella; contemporaneamente dovrebbe provvedersi alla difesa dei Monti . Lessini .
Della linea Pipolo-Moscalii, tra l'Adige ed il lago di Garda vennero, nelle proposte fatte · alla Camera dei deput ati, comprese le fortificazioni, e noi riteniamo che delle buone opere permanenti su quelle due alture sussidiate da un fol'Le (eh~ vorremmo corazzato); ov~
216
DEJ,J,E FORTIFICAZIONI DI VEJl0NA 217
·
ora esiste il forte della Chiusa, e da opere, fors'anco passaggier e, sulle colline che si estendono dal l\foscalli a Rocca di Garda, sul lago di tal nome, saranno un ostacolo assai serio da superare, quando siano energicamente difese .
La· difesa della linea Vicenza-Padova - Venezia appartiene al còmpito dell'esercito di prima· lin ea : il ragionare di essa ci por~erebbe di necessità nel campo strategico, e quindi in quel campo congetturale che ci siamo, fin da principio, precluso. ·
Alla difesa dei !\fonti Lessini non v'ha dubbio che . occorrerebbe provvedere, perchè non si rinnovi il fatto della d iscesa del principe Eugenio, consegue.nza del quale sal'ebbe la caduta delle fortificazioni del Pipolo-àloscalli, e qùindi la necessità cli ripiegare sulla
Jine a del ·po tulle le truppe postate tra l'Adige ed il Mincio. Del modo di sviluppare questa difesa prossimamente alla frontiera, fino a tanto che questa non sarà trave rsata da ve runa strada rotabile , già dicemmo abbastanza quando abb iamo parlato di quei monti. Quando quella difesa sia soccombente, i vari contrafforti dei monti stes si presentano più indietro, do ve , per le migliori condizioni di viabilità che vi si riscontrano, sono accessibili anche alle artiglierie, posizioni opportunissime alla resistenza, e che convenientemente fortificate, al · momento del bisogn0 , . possono presentare una barriera assai difficile da superare. E quèste vantaggiose condizioni della dif~sa non sarebbero per nulla mutale dallo effetluarsi dell'acceEJnatn costruzione di nna s tr ada rotal;>ile da Ala al passo della Sega e ad Erbezzo, quando in conseguenza di essa un forte permanente venisse costrutto in località opportuna tra Campedello ed il Pedocchio. Questa difesa però, come si è anche accennato, · dovendo basarsi sopra Verona, alla quale convergono
DELLE FORTIFICAZIONI DI VERONA 249 anche importanti comunicazioni ordinarie e ferroviar ie è necessa~io che. questa piazza non sia affatto aperta: ma che sia murnta di fortificazioni atte a garantirla da un ardito colpo di mano non solo,! ma anche a proteggere per qualche temp o le truppe che vi si ricoverassero, e le provviste e munizioni che dovranno racchiudervisi, ed assicurare le comunicazioni che vi fanno capo, o per dar tempo alle truppe altrove impegnate di venirle, occorrendo in aiuto; ov:ver0 sino a che le sorti della guerra non ci obbligassero a concentrare tutte le nostre forze sul Po, ufficio pel quale sarebbe sufficiente la cinta magistrale sussidiata da poche opere esterne ('I ) . XV II.
Secondo il nostro concetto, la cinta magistrale di Veron~, . sussidiata da quei forti ·staccati che per la loro vicrnanza alla medesima possono piuttosto chiamarsi opere esterne, come sarebbero i forti Gazometro,
(~) Questo concetto è l'applicazione di quello espresso dal Vn.LENOJSY nel suo Essai historique sttr la f ortication, che il BRIAUIONT nella sua opera già citata, .riporta (pag, 6), ed è espresso nei seguenti termini: « S'il s"agit de maìtriser une route, une vo ie ferrée, " un passage important; d'occuper un point stratégique dont la pos" session soit nécessaire pour couvrir la ligne d'op ération, et laisser « aux armécs actives toute li herté de manocuvre; une piace de mé" diocre étendue, formée par un e simple enceinte, ou pourvue d'un « petit nomhre de dehors, sera très -suffisante - Elle sera plus eonve" nable qu'une grande piace,. parce qu'elle immobilisera un moindre « nombre de troupcs'. Il faudra sculemcnt la mun ir d'assez d'artillcric < pour bravcr les cfforts de l'ennemi jusqu'a ce qu'il se suit décidé « à fair venir un pare de siège , et souvent avant son arrivée, la « gar'nison aura pu ctre dégagée par l'armé e dc secours, dont Ics < mouvements seront plus r<1pides qu'ils ne l'étaient autrefois >.
,\_NNO Xl.X, VOL. I. HS
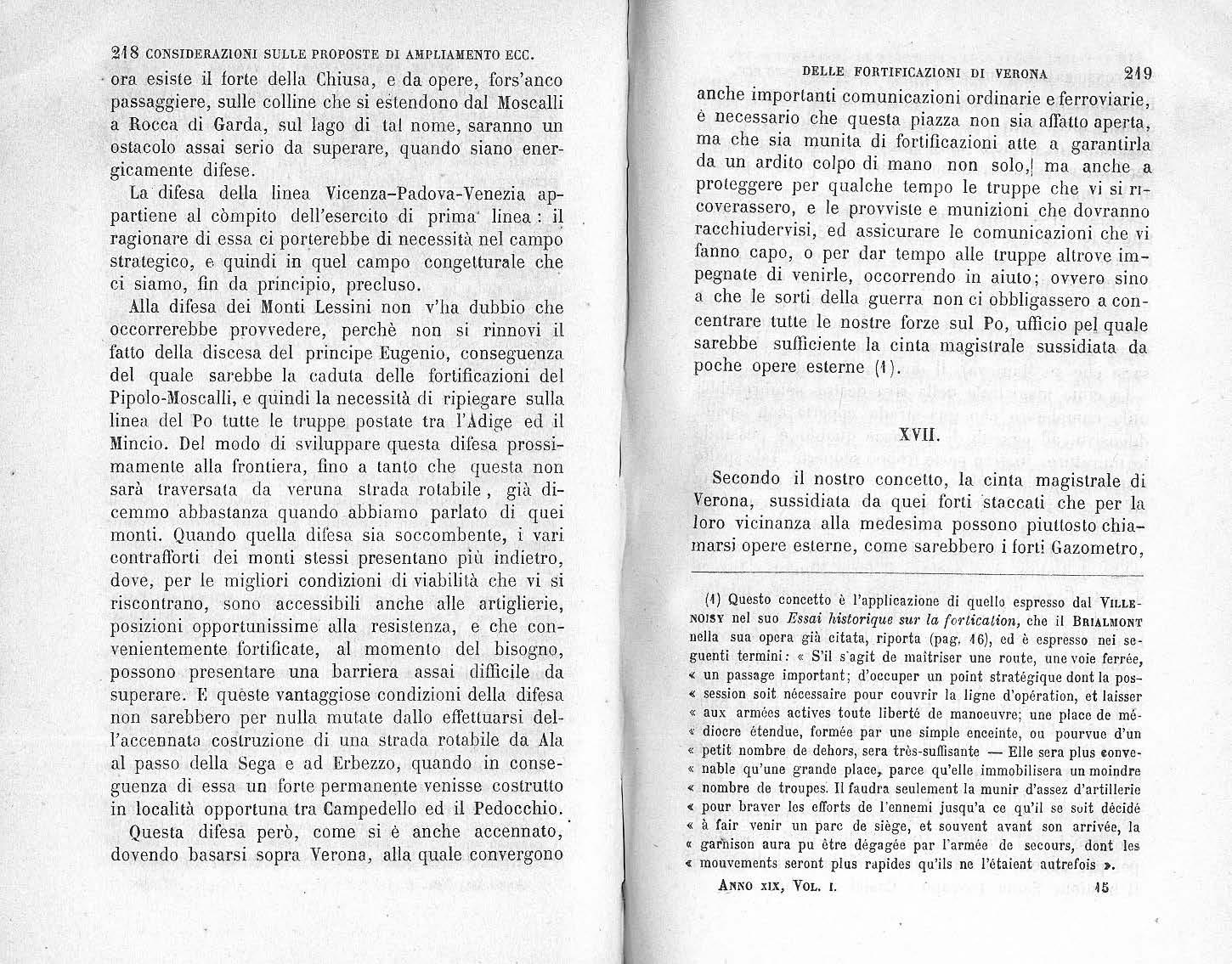
218 CONSIDERAZIONI
SULLE PROPOSTE Dl AMPLIAMENTO ECC.
CONSIDERAZlOlH SULLE PROPOSTE DI AMPLTAMENTO ECC .
Biondella, S. Leonardo , S. Mattia, Santa Sofia, dalle quattro torri, tutti opportunamente migliorati, e con l'aggiunta di qualche altra nuova opera, ?astereb.bero per {'ufficio cui noi crediamo debba adempiere la piazza <li Verona.
Per attuare .siffatta proposta oc.correrebbe spianare tutti i forti ora esistenti sulla destra dell'Adige, che furono costrutti ad oggetto di resistere agli attacchi provenienti dal sud, e che quindi ci _ sarebbero di grave · ostaco lo, quando per necess ità di guerra, perdut~ od abbandonata la pia zza, entrasse di poi nell'atluaz,one di un nostro ritorno offensivo (che non potrebbe basarsi che su Mantova), il dover la riprendere.
La cinta magistrale deHa riva destra sembrerebbe utile completare con una strada coperta con spal lo difensivo, ad oggeu.o d i defilarne quanto è possibile le murature, in gran parte troppo scoµerte. Tale spa lto e strada coperta avrebbero le loro estremità appoggia te ali' Adige, e potrebbe,ro essere ben rafforzati con qualche ba tteria da armarsi cop pezzi di carnpngna.
Anche i forli sulla riva sinistra dell'Adige occorrerebbe demolire, non escluso il forte l\Iontorio. Invece il forte Gazometro occorrerebbe conservare miglio. randolo, per togliere il gr ande ri entran te che form a la cinta. della riva. sinistra dell'Adige dietro la ferrov ia.
Similmente occorrerebbe conservare il forte Biondello, ampliandolo per modo da. portare i suoi fuochi verso la par le superiore della va l Pantena, di cui ora batte solamente lo sbocco nella pianura; ed inoltre costruirne di pianta un altro più in alto, sul ripiano soprasla9le la casa Tessa roli, per battere la valle stessa e le prospicenti pendici di M:onte Vendl'è, per impedire al nemico che si fosse avanza to s ino a S. Martino di rimontare la val Panlena. Questi due forti avrebbero poÌ per oggetto di rnfforzare la cinta assai debole tra il bastione Santa Toscana e Castel S. Felice.
DELLE F'ORTIFICAZlONl DI VERONA 221
Innanzi la porta Vescovo, alla quale mette la postale vicentina, occorrerebbe costr:uire un'opera di grande resistenza, la quale, o['tre al coprire la porta medesima, che ora può dirsi indifesa, potrebbe (quando opportunamente postata), spazzare ,con fuochi radenti lo . sbocco della val Pantena, per impedirn e l'accesso al nemico, e coprire la stazione de!l a ferrovia per as2 sicurarne ad ogni evenienza il possesso.
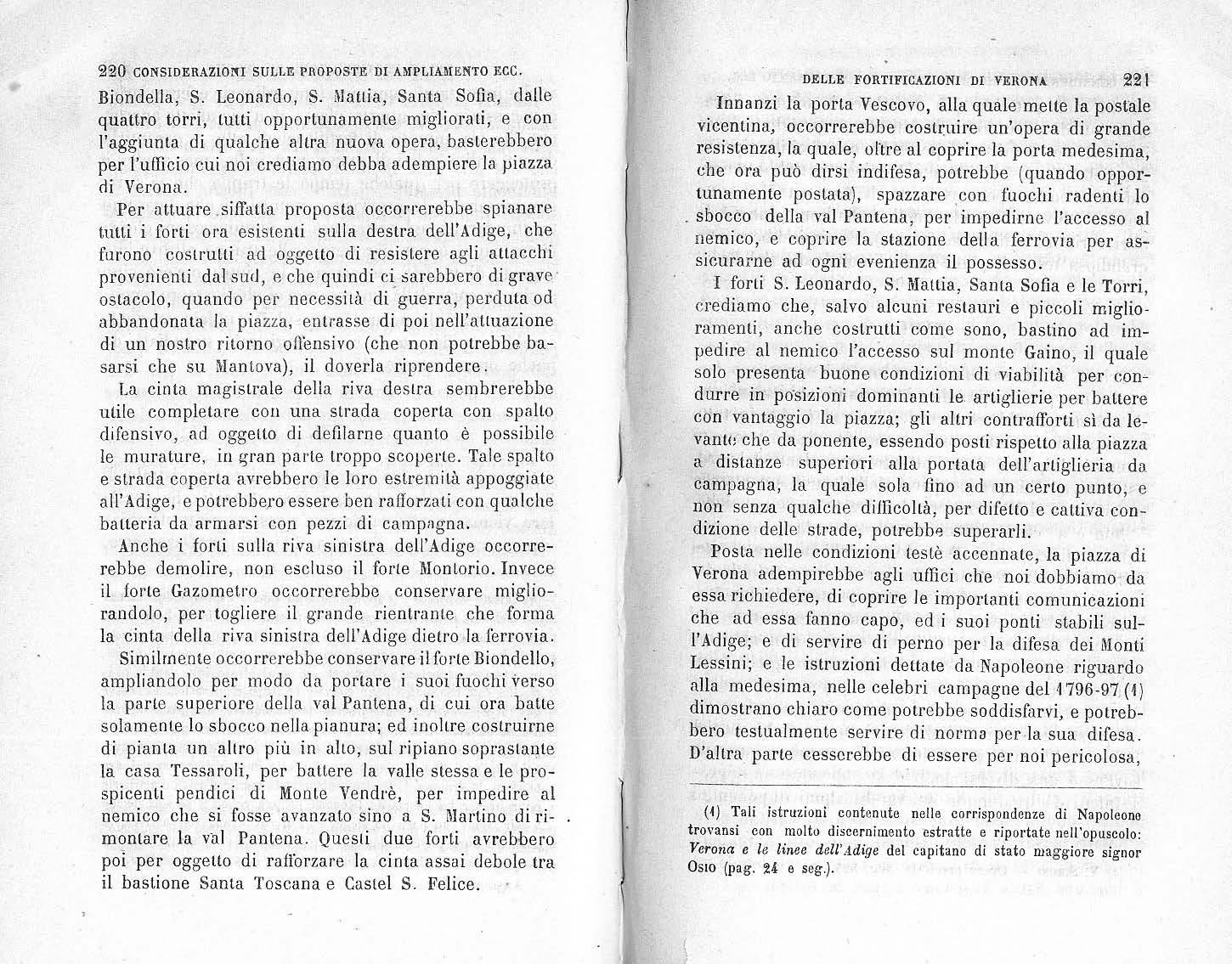
I forti S. Leonardo, S. Mattia, Santa Sofia e le Torri, c rediamo che, salvo alcuni restauri e piccoli miglioramenti, anche costrutti come sono, bastino ad impedire al nemico l'accesso sul monte Gaino, il quale solo presenta buone condizioni di viabilità per con~ durre in po·sizioni dominanti le. artiglierie per battere con vantaggio la piazza; gli aHri contrafforti sì da levanti: eh.e da ponen te, essendo posti rispetto alla piazza a distanze superiori alla portata dell'artiglieria da campagna, la quale sola fìno ad un certo punto, e non senza qualche difficoltà, per difeuo e cattiva condizione delle strade, potrebbP, superarli.
Posta nelle condizioni tesLè accennate, la piazza di Verona adempirebbe agli uffici che noi dobbiamo da essa richiedere, di copri're le importanti comunicazioni che ad essa fanno capo, ed i suoi ponti stabili sul1' Adige; e di servire di perno per la difesa dei Monti Lessini; e le istruzioni dettate da Napoleone riguardo alla medesima, nelle celebri campagne <l el 1796-97 (1) dimostrano chiaro come potrebbe soddisfarvi, e potrebbero testualmente servire di noema per -la sua difesa. D'altra. parte cesscl'ebbe di essere per noi pericolosa, (4) Tali istruzioni contenute nelle corrispondenze di Napo leone trovansi con mo lto discernimento estratte e riportate nell 'opuscolo: Verona e le linee dell' ,!dige del capitano di stato maggiore signor Osio (pag. :U e seg.).
220
j
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO ECC. poichè non potrebbe più esercitare la temuta attrazione su di un esercito .in ritirata; e quando cadesse in poter del nemico, si potreboe con facilità .riprendergliela. ·, Essa, Peschiera e Legnago potrebbero consi derars i come opere avanzale di Mantova. (4 ); e tutte quattro (diremo valendoci della bella immagine già da a.Itri scritrori militari adoperata), costituirebbero una grandiosa testa di ponte gettata nella valle del Po.
XVIII.
Prima di passar oltre, sembra qui opportuno fermarci per poco sopra due importanti obbiezioni che da. taluno potrebb ero farcisi. L'una si è che in tutlo quanto siamo venuti sinora esponen do, ci siamo sempre attenuti all'ipotesi di un attacco proveniente, dal nordest, senza mai preoccuparci dell'altra di un attacco proveniente dalla frontiera dell'ovest. .
Non è a caso che di questa seconda. ipotesi non venne mai accennato . Essendo noi dell'opinione di quei militari i quali affermano che un attacco consimile do -· vrebbe avere per primo e principale obbiettivo Piacenza, onde impossessarsi di entrambe le rive del Po, non ostante il più diligente esame, non abbiamo saputo sc oprire verun diretto legame tra. quella fron ,tiera e Verona, e quindi non sappiamo persuaderci che un invasore, prov~niente da queJla, possa formare di questa uno dei suoi obbietti vi, ammenochè speciali circostanz e non lo consiglino ed incoraggino a tentare sovr'essa. una diversione.
Infatti da qualunque dei varchi alpini di ponente a
DELLE FOR:"l'-IF ICAZIO NI DI VERONA 223
Verona intercede una. distanza non mi·nore di 4-00 chilometri, che ci sembra assai arduo possa venir superata impunemente, anche da un importante corpo di truppe operante isolatam ente, dovendo procedere, per ben più che la metà di quella dist~nza, ~er _una zona di terreno larga in media 60 chilometri circa, compresa tra il piede delle Alpi ed il Po, lungo il ,quale sono s tabili te le nostre maggiori dife~e . _P er ammettere la buona riuscita di una così ris ch iosa impresa, bisogna supporre non solo annientata qualunque resistenza nelle pianure piemontesi, ma an.che il nostro esercito c osì stremalo di forze che sia. costretto, rinunziando ad ogni difesa attiva, a limitarsi alla più stretta difensiva , . e quindi che non possa, sboccando da. q~alcuna delle varie teste di ponte su! Po, punire il nemico della sua temerità, gettandosi in buon punto sulle sue comunicazioni ed attaccandolo nella sua pericolosa marcia. .
E d ' altronde ammessa, anche per poco, la riuscita dell'azzardosa. impresa cui si accenna. ; di qual vantaggio sarebbe al nemico l'averla compiuta? Qua?do avrà occupato Verona., di che si sa1ià avvantaggiato per impossessarsi della riva destra. del Po, ove sar anno le nostre maggiori difese la cui caduta solo deciderebbe irrevocabilmente le sorti della guerra?
·- Nè conseguirà certo l'annullamento di qu~lla parte delle nostre forze incaricata della difesa di Verona., perché è da. presumere che esse eviterebbero l'accerchiamento, ritirandosi in tempo sopra Mantova, ·cosicchè il nemico oltre questa piazza da espugnare, avrebbe sempre il gravissimo ostacolo del nostro
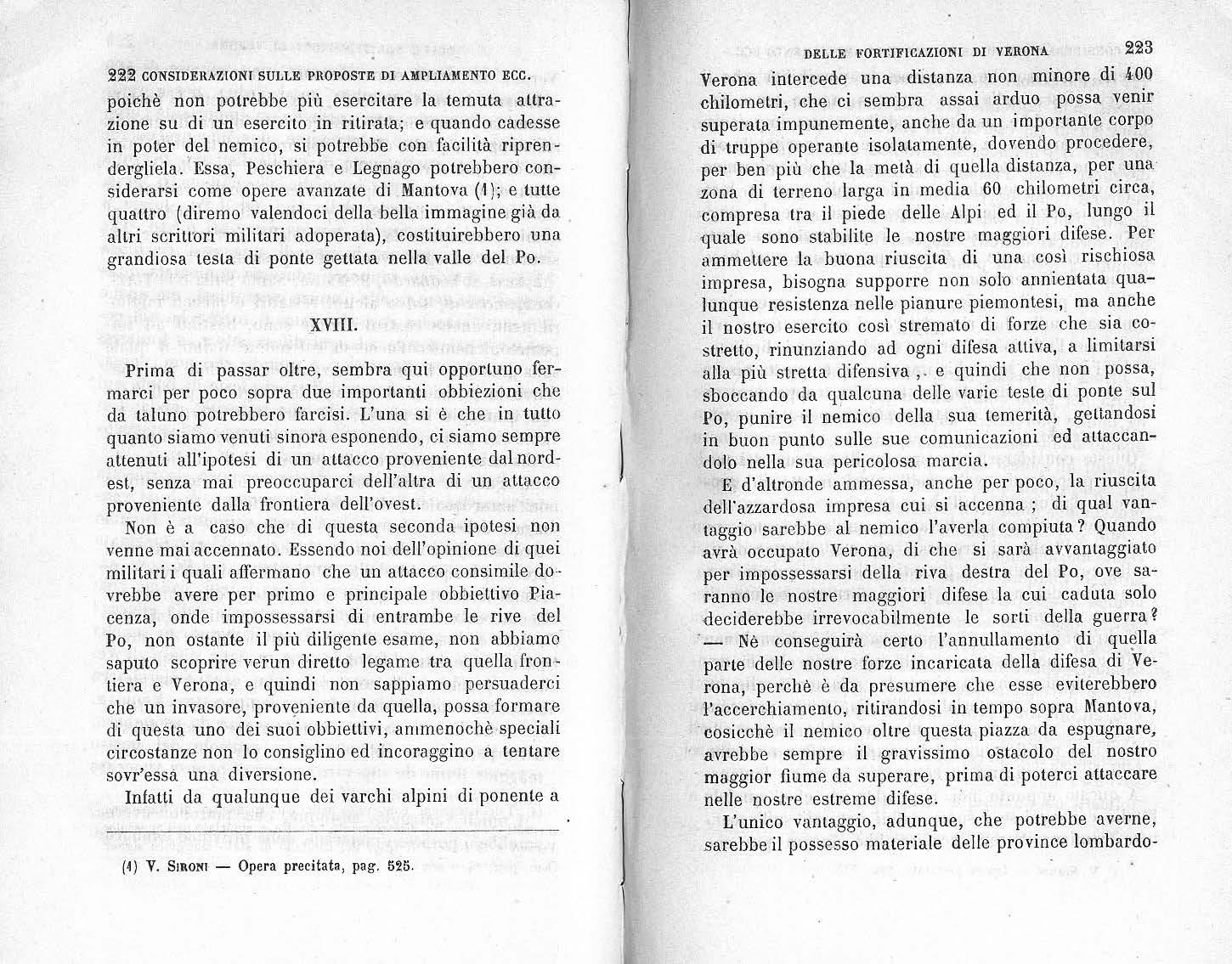
· maggior fiume da supera.re, prima di poterci attaccare , nelie nostre estreme difese. ·
L'unico vantaggio, adunque, che potrebbe averne, .sarebbe il possesso materiale delle province lombardo-
222
(~) V Smoru - Opera precitata, pag. 525. l
CÒNSIDEI\AZIONI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO ECC .
venete, possesso che, ammessa Ja possibilità che il nemic0 riesca nella su.a impresa, anche ~enza VP-rona, gli sarebbe .assicurato dalia nostra impotenza a contrastarglielo, e dalla conseguen.te inevitabile occupazione di molte altre cospi c ue cillà che adornano le pl'ovince stesse, alcune delle quali, per la loro ~ in?r _distanza dalle basi d'operazione, e per le magg10r1 nsorse che presentano, si presterebbero assai più opporlunameote di Verona per servire qual base seconda ria d'operazione.
Ch~ se poi il nemico procedesse con operazioni c.omb.mate sulle due rive del Po, ci sembra tanto evidente che l'ufficio di Vernna sarebbe assai limitalo, e che l'attaccar soverchia importanza a questa piazza c1 esporrebbe a farci tagliar fuori le truppe poste a sua difesa, che non ci pare mestieri s penciere parole a dimostrarlo.
Queste considerazioni, come qu elle esposte nei paragrafi precedenti, svolte neìl'ipotesi di attacc hi provenieqti dall'una o dall'altra frontiera isolatamente, pare che sussi~tano inalterat e, quand'anche, per sua s ventura, l'Italia si trovas se esposta all'attacco simultaneo dei suoi due potenti vicini, e quindi non pare che debba questa ipotesi formare oggetto di speciale disamin a .

~'altra obbiezione cui accennavamo si è che nei con · molti altri, n el discutere dell'argomento che ci occupa , abbiamo avuto riguardo solamente alle attuali _condjzioni territoriali dell'Italia, senza preoccuparc1 delle nuove esigenze che potrebbe creare alla difesa una rellificazione del nostro confine nord-est poss ibile a verificarsi in epoca più o meno lontana:
, A _questo app_unto_ noi . risponderemo che, quando l Italia conseguisse 1 suoi confini na tur ali sull'accennata frontiera . Verona scapiterebbe ancora più che
ogg i della sua importanza militare, poichè nell'alta valle dell'A dige ha vvi qu alche loca lità che l'av rebbe di gran lunga maggiore , me tte ndo ad essa capo tutte le s trad e che , da lla ·val Sabbi a a ll a val Sugana, traver s an o le nost re Alpi.
XIX.
La cos tr uzione di fortifi cazion i perman e nti a difes a dello Sta to esse ndo fo nte di gravi s s ime spe se, ed og ni · rn r iaz ione al p ia no genera le g ià pr op os to pe r tali fortifi cazio n i aheca nclo con sid e re voli aumenti o dimin uz ioni ne ll e sp ese su dde ll e, c r ed ia mo· che qual s iasi proposta dì modifi ca zio ni si a in comp leta, se non è accompagn a ta da un esa me dell e con seg uenze economic he ch e n~ d eri vano . Eg li è per ciò che cr ediamo ne cess ari o ve n ir e qui appre sso esami nando quale sare bbe il risulta to ec on òm ico delle cli ve rse p rop os te relati ve all e fo rtifi cazi oni dì -Verona.
Ques te proposte possono riassu me rsi i n tr e, cio è : Spia n am ento tota le d elle esis te n ti fo rti ficaz io ni, proposta che, propugnala da va ri egregi militari, venne adottal a dalla Com mtssione dell a Cam e r a de i deputa ti incari cata di ri ferir e sul proge tt o di legge r ela ti vo alla difesa gen e ral e dello Sta to.
Conse r vazione ed amp lia me nto delle es is ten ti fo rtifi cazioni, pl'Op os ta dall a già Commi ssion e permanente per la difes a ge nerale dello Stato, e propugn ata da altri n on me no egregi !-c r ittori militari.
Con servazion e di Verona tra le piazze fortifi cate, s ce ma n done cl i molt o l'imp orta nza, propos ta ch e è sta ta
22,i.
DELI.E F
2 25
On'l'l FICA ZIONl DI VER ONA
ZION'l SUL!.E PROPO STE DI AMPLIAMENTO ECC. fatta prima di n o i da autore-Vo l i ingegneri militari (~ ).

Esaminiamo per ordine le conseguenze economiche di siffatte proposLe . xx .
Quando la proposta della comple la demolizioue dell e fo rtifi éoz io.ni di Verona fosse amm essa, noi crediamo ch e essa dovreb be essere a ttuata so llec ita men te, pet· quan lo Io con se ntono le modalità di legge : dir e ltamente da l Governo per mezzo dei suoi l egali rapprese n tan t i ed in tutto il suo rigore ed eslens io ne .
So llecitamente , perché è sicuro che qu a lora si eseg ui ssé con tro ppa lemezza , potrebbero n el fra tt empo sorgere eventualità n ell e qua li un'incompleta demolizione ci s arebbe molto dannosa, pe r !'imbarazzo che non manchere bbero di d a re a noi de lle op ere sol o i n pnrte dis trulle, e pel probab ile van tagg io che potreb b e r icavarne il n em ico venendone in po ssesso. In co nsegue nza, no i cred ia mo che, decre ta ta l a demoliz ione i n discorso, essa dovrebbe effe ttual'si quasi co nt em-
(1) Il genera le Bn1GNONK, nelle Memorie iunanzi citate, in yista de llo scopo limitatissi mo cui è destinata la piazza di Verona, propone di abbatterne le tro ppe difese su i fr onti oves t e sud, per ridu rl a non ad altro c he ad una piazza forte ordinaria , atta a costituire un'ottima doppia tes ta di ponte s ull'Adige (Rivista .Jliti tar c ItaUcin a, anno ~,'i7 1, dispen sa 111\ pag. 347) .
li colonnello del ge nio ~lAnTJNI ri t iene che Verona co me fortezza debba discendere di un gradino o du e, riducend one i fortilizi ad un numero assai minoro per modo da ooo richiedere guarn igi one maggiore di 8 o rn mila uomiui, ritene ndola così sistema ta io correlazione dello scopo ch e ogg i può a vc 1·~ di co op erare cioè all a difesa diretta delle Alpi e della !iolla dell'Adi ge ( MARTINJ, Studi sulla difesa d'ltalià, pag. 53. e seguenti) .
DELLE F ORTIFICAZIONI DI VERONA ~27
poraneamente per tutti i forti ed alt.re singole parti dell'esistente fo rtezza, e siamo persuasi che, anche così facendo, viste l e mo lteplici formalità cui bisogna soddisfare, la decre tata misura non sarebbe condotta a compimento in meno di un anno , tempo che può riuscire luogo o breve, a seconda cli eventi che certamente a niuno è dato pre vedere.
Abbiamo aggiunto direttamente dal Governo, perchè potrebbe sorgere facilmente l'idea di fare . della demolizione delle opere un onere dell'acquisto dei terreni su cui sono impiantate. A dimostrare quanto ciò sarebbe impro v vido, anzi dep lorevole , basteràa cc enn are che tuttora esistono, ed in condizioni da potersi in breve tempo restaurare ed armare, tutt e le batterie int ermedie ai fort i di prima linea, che vennero coslrutte dag li Austriaci nel 1866, le quali appunto avrebbero d ovuto essere spianate dai proprietari ai quali furono restituiti i terreni su cui trovansi impianlate, ed ai quali sembra sia tornato più convenien te lasci are incolte le aree occupa le da quélle balterie, piuttoslo che sobba rcarsi alla spesa del lo spianamento e della rimessa a coltivazione delle medesime.
Crediamo poi che de,bba essere applicata in t.utto il suo rigore f\d estensione, nulla escludendo in quanto a fortificazioni, salvo forse i tralti di muro di cinta d al bastione Santa Toscana a Castel San Felice, e da questo alla Rondella Boccare, i quali non hanno nessun valore fuori di quello archeologico che loro si attr ibuisce . Ma contro questa s evera condanna che importa la demolizione di tulta la rimanente parte della cinta magistrale non appellerà il ~Iunicipio di Veron~ in nome del dazio consumo, e quindi degl' interessi finanziari del ·comune e dello Stato, p er ottenere quanto non venne, in a l tre epoche, ricusato ad àltre cospic ue
226 CO NS lDEI\A
l i
ci ttà, come l\1ilano, Bresc ia, Modena, ecc., i cui rampari fu consentilo che rimanessero per servire come cinta daziaria? -Noi vorremmo sperare che ta le domanda fosse diniegata, e che la città di Verona, nel caso di cui si tratta, fosse costretta a fare come altre importanti città, fra le quali contansi Napo li e Torino, che si sono cinte di un semplice muro per lo scopo suddetto; ma siamo tratti a dubitare che in questo caso, alle considerazioni econom i che possano venir sagrificale le militari, e che l a cinta magistrale sia risparmiata. ·
Di tal fatto non vogliamo certo esagerare l'importanza, ma è . incontestabile che la conservazione della cinta manterrebbe a Verona, in visto. della sua specia l e pos izione topografica, una importanza militare. troppo l ieve per esserci utile, ed abbastanza sentita per esserci dannosa, essendo il valor difensivo di quella nella parte a sinistra d 'Adige, quasi nullo, mentre nell'alt ra parte a destra è ancora abbastanza importante per poterci questa essere di danno, se caduta in possesso del nemico .
Dalla condanna di demolizione noi p.erò intenderemmo escludere gli stabil i menti militari che attualmente contiene Verona, la cui d istruzione é caldamente consigliala da un egregio scrittore in un articolo comparso lo scorso anno nel n° ~35 del Diritto. Già essa non contiene che un arsenale d'artigliel'ia ed un panificio mili tare; che non ostante siano allogati in vast! edifici sono di secondaria imporlanza, perchè sprovvisti di tutti quei mezzi meccanici che era mente dei. loro costruttori d ' impiantarvi : poche caserme ed un ospedale militare . Quelle non possono contenere in tempi ordinari che 6 in 7 mila uomini e poco più che 1000 cavalli , e queslo è uno dei migliori locali che si abbiano per l'uso cui serve, e tutti, non sarebbe ,
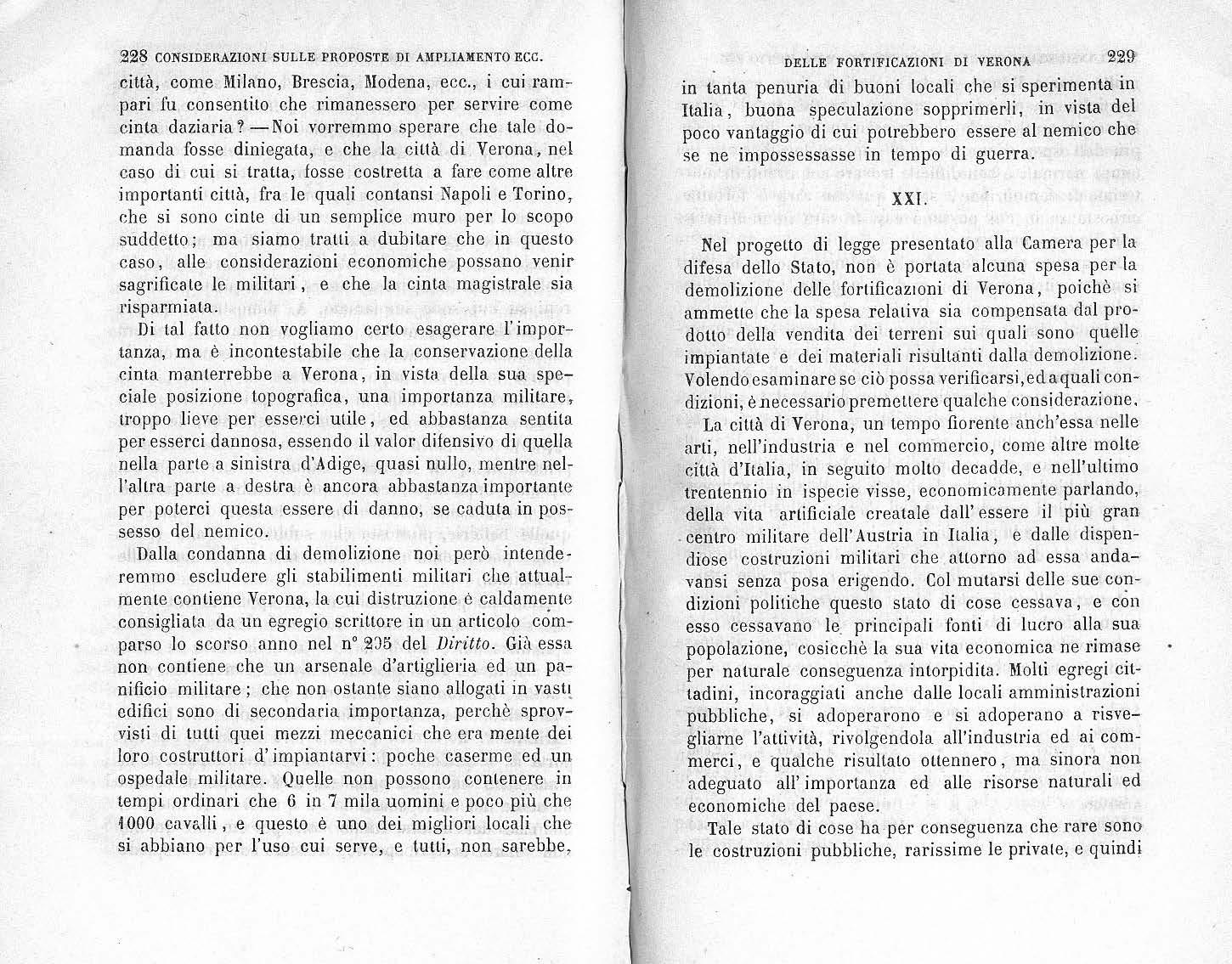
DELLE FORTIFICAZIONI DI VERONA
in t~nt~ penuria di buoni locali che . si sperimenta in Italia, buona speculazione sopprimerli, in vista del poco vantaggio di cui potrebbero essere al nemico che se ne · impossessasse in tempo di guerra.
XXT.
Nel progetto di legge presentato alla Camera per la difesa de ll o Sta to, non è portata alcuna spesa per la demolizione delle for t ificazioni di Verona, poich è si· ammette che la spesa .relativa sia compensala dal prodotto del la vendit a dei terreni sui quali sono quelle impiantate e dei materiali risultanti dal~a demoliz!one. Volendo esam i nare se ciò possa verificars1,edaquali condizioni, è necessario premet tere qualche considerazione.
La città di Verona, un tempo fiorente anch'essa nelle arti, nel l'induslria e nel com·mercio, come altrè molte citlà d'Italia, in seguito molto decadde, e nell'ultimo trentennio in ispecie visse, economicamente parlando, della vita artificiale creatale dall'essere il più gran . centro militare dell'Aus tria in Italia, e dalle dispendiose costruzioni militari che attorno ad essa andavansi senza posa erigendo. Col mutarsi delle sue co~dizioni politiche questo stato di cose cessa va, e con esso cessavano le. principali fonti di lucro alla sua popolazione, cosicchè la sua vita economica ne rima~e per naturale conseguenza intorpidita .. Molti. e?regi. c1t~ tad ini, incoraggia t i anche dalle loca h ammm1straz1om pubbli che, si adoperarono e si adoperano a risvegliarne l'attività, rivolgendola all'indnsLria ed ai commerci , e qualche risultalo ottennero, ma sinora non adeguato all'importanza ed alle risorse naturali ed economiche del paese.
Tale stato di cose ha per conseguenza che rare sono· le costruzi oni pubbliche, rarissime le private, e quindi
228 CONSIDERAZIONI
ECC
SULLE PROPOSTE DI AUPLJAHENTO
.
NI SULLE PROPOSTE DI AMPLIAMENTO
molto scarso l' impiego dei material i di costruzione , specialmente murali, di cui sono ricchissime le lo ca · Jità circostanti, ond'é che le relative cave hanno vita più dall'esportazione che dall ' impiego locale, e che in tempi normali è ben difficile trov are acquiren ti di m~teriali di demo li zion e, salvo qua lche rara e fortuita circostanza in cui possano essi tr ovare immediato e non lontano impiego.
Da quanto precede è fac il e ded urre che noi fond atamente rit eniamo che sarà ben ~ifficile la vendita della ril evan te quantità d i pietre da taglio , pietrame e ma ttoni che si ricaveranno dall e demo li zioni, an che a prezzi minimi. Amm ettendo però per un momento che i ·materiali provenienti dalla demolizione possano esitarsi a prezzi normali, ecco un ca lcolo del r isultato econom ico della demolizio ne s tessa, che crediamo non si s costi di molto dal vero .
Lo spianamento completo delle fortificazioni di Verona richiederebbe la demolizione di circa 873,000 metri cubi di muratu ra; 2,800 metri cubi di ar mature d i leg nam e, e ~a rimo zione e spianamento di 11,3il6,000 me tri cubi di terra; lavori che, nel loro complesso , non potranno costar meno di circa 4,270,000 lire.
I materiali util izzabili che , a noslro crede re, potr anno ri sullare dalla demo lizion e di cui si parla, ed· il loro valore, crediamo che, senza incorrere in rilevanti errori, possano slabi lirsi come segue:
DEL LE FORTIFIC AZlONI DI VERONA 231
Ri su lta quindi, secondo tale calcolo, ch e lo_ Stato dovrebbe, i n corrispettivo dei l avori di demoliz10ne. e spianamento, cedere tutti i. materiali _risult~n t i , più pagare oltre lirn 900 mila. Ciò però ?01 .credHl~O n_on corrisponda a quello che nell ' applicazione s_i ver1fi: cherò., dappo ichè egli è vero che I I prezzo _det t~rren ~ è quello risultante dalla media della veo~1La_ d1 bem dell'asse ecclesinstico, vcntlu Lisi nella provincia, e eh~ quelli de i mn teriali sono i prezzi m~cli o r~ co rr ent1 sulla piazza, ma~ da no tare che ùe1 pr1m1 havvene ancora non pochi invenduti in possesso dello Stato, e che quindi la loro alienazione po tr à es sere n?n tanto agevole, anche in vista de ll e spe_se occ~rr~nLL a renderli fruttiferi , e che jo quanto a1 materw.h, affiuendo essi in così grande quantità sul merca to , non sarà faci le ottenere · per essi elci prezzi , ch e ora é anche diffi cil e ricavare da piccole partite, tanto più che la pie tra da taglio e ferramenti: le fer~amenla essendo di dimensioni e fa tt ura speciali, quah occo r rono per opere fo rtilizie, non potrebbero da i pri va ti adoperarsi , senza mollo lavoro di riduzione e conseguente spr eco di materiale. Epperò si può con fondamen to presumere, <lovere lo Stato , nel caso concre to , ~borsare effe tti vamen te una somma assai moggiore di quella sopra no ta ta.
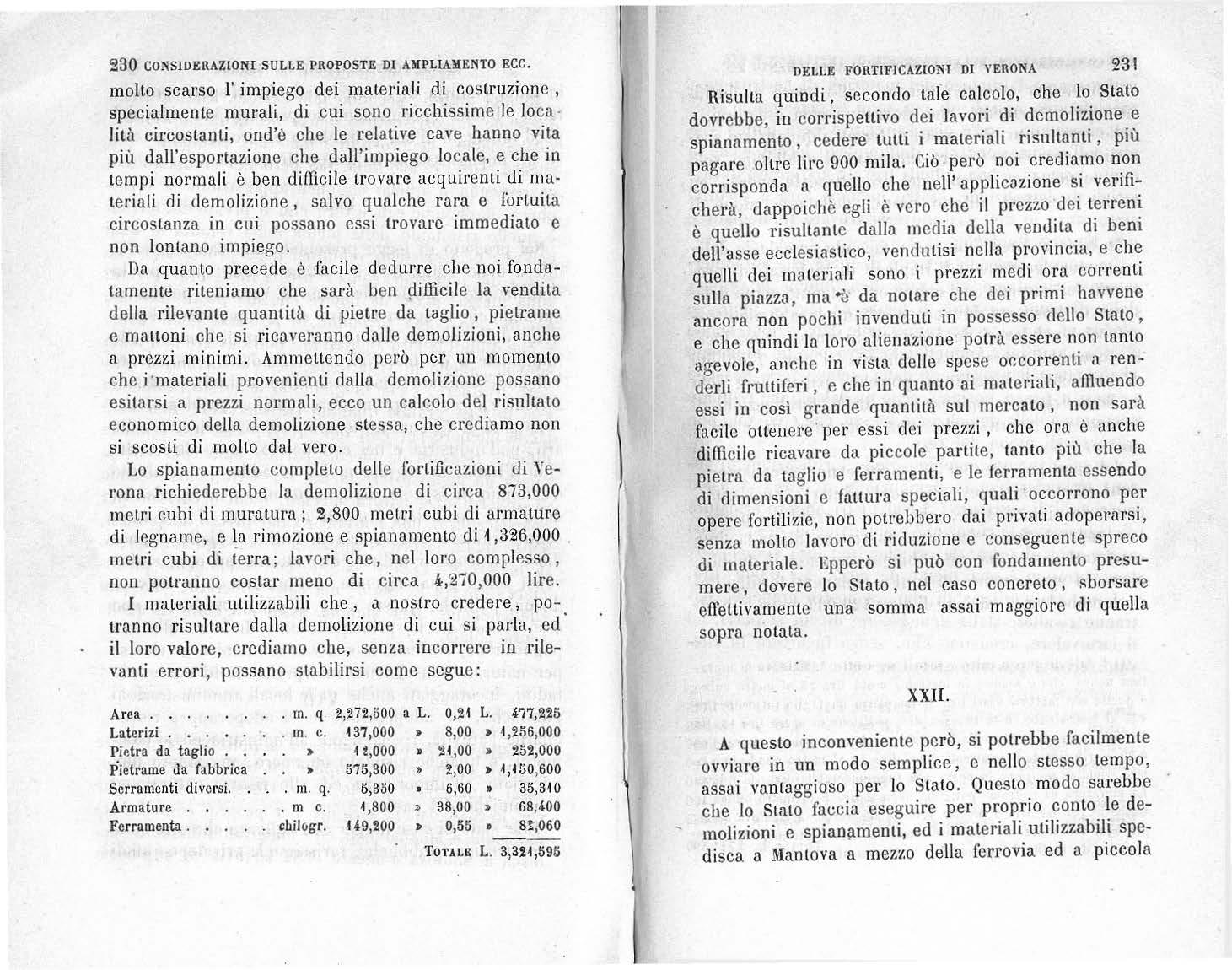
XXII.
A ques to inconveniente però, si po trebbe facilmente ovviare in un modo semplice, e nello stess o te mpo, assai van taggioso per lo Stato. Ques to. modo sarebbe che lo Stato faccia eseguire per propno conto le demolizioni e spian~menli, ed i materiali utilizzabili spedisca a Mantova a mezzo della ferrovia ed a piccola
230 CONSID ER AZLO
ECC
Area . . rn. q. 2,2i2 ,fi00 a L. 0,2 1 L. 477,22 6 Laterizi . . m. c. 4 37,000 > 8,00 > 4,256,000 PiP.tra da taglio > 4 t,000 li 2 4,00 li 252,000 Pietrame da fabbrica > 575,300 ) 2 ,0 0 > ~,150, 600 Serramenti div ersi. m. q. 5,3 /i O • 6,60 • 35,34 O Armature .m c. 4,800 » 38 ,00 • 68 ,400 Fe rramenta . chilc,gr. 449,200 > 0,55 li 81,060 ---TOTALB L. 3,324,596
vel~cità, per esservi impiego.ti n e lle opere di fortificazione p~rman ente c h e dovranno colà e seguirs i, e n~ll:' qu ali tuUi g!i ogge tti di forma e dimensioni speciali tr overebbero sicuro impi ego t ali quali son o, solo c he se n e ten ga cal colo nel progettare le opere, ed anche solamen te all'atto pratico della e secuzione di ·e ss e .
In base a ques ta proposta, facendo un calcolo d ella ec?nomia d e rivant e dall'impieg o di materiali d.i pro-pne tà d el governo anz i che nuovi, e t enuto con to d e lle spese di tras por to da Verona a Mantova, abbiamo tr ova to che n ei la vori da eseguirsi in quest'ultima l ocalità potrebbe ave rsi una economia di oltre 7 milioni di lire, la quale s i potrebbe pagare n on solo la d erno l1z1 on e e sp ian a mento delle fortificazioni di Ve rona, ma avere anche una economia di ci rca 3 milioni (4).
Nel caso po i che per le sopraccennate considerazioni affat to estranee a g li scopi militari , anzi quas i contrarie ai m edes imi, che pure do vrebbero prevalere sopra tutto, si lasc iasse sussi stere intalla la c inta mag is tral e , siccome ne abbiamo esp ress o il dubbio a llo ra lo spianamento di tulli i ri mane nti fortilizi im~ po rterebb e la demolizione di ol t re 420,000 melri c ubi di .
(4) I dati di questo calcolo sono i seg uenti : A Mantova Ja muratura nuova (c he è sempre in mattoni) cos ta lire ,3 al ,metro cubo, o qu ella con mattoni usati lire 9. La pio tra da taglio in me di a lire 435 al met~o cubo. e la sua semplice posizione in ope ra lire 46. La ·fer ram ent~ rn. opera in media lire ,50 al chilogrammo se nuova, lire 0,30 so r1(ucmata. I se rramenti nuovi lire 2 al metro quadrato e la loro sem plice posizione in opera non raggiungerebbe certo le 6 lire . La muratura di pietrame potrebbe p·agarsi lire 8 al metro cubo. 11 trasportn per ferrovia a piccola velocità da Verona a Mantova costa per _ogni tonncll~ta lire 3,40 por i mattoni ed il pietrame, lire 6 per lo pietre da toglio, i serramenti e la fe rram enta.
DELLE FORTlFIC AZlONI or VERONA 233 muratura, 1600 metri cub i di armatura, e Io spianamen to d i circa 776,000 metri cu bi di te rra, per i q ual i occorre rebb e una spe s a. di cir ca lire 2,Hl4,000. La quantità d e i materiali utilizzabili ed il loro val ore , in tal caso, si ridurrebbero all'i n circa ai seguenti:

Area compreso i fossi e spalti della cinta . . . . m. q. 2,~34,800 a L. O,'H L. 448,308
Laterizi . . . . . . m. c. 78,000 > 8,CO > 6!+,000
Piet ra da taglio . . ,, 9,000 > 24 ,00 > 89,000
Pietrame da fabbrica » 279,000 > 2,00 » 559,6 00
Serramenti m q ! ,300 » 6,60 > 28,380
Armatura . . m. c. 4,'70 > 38, 00 > 551860
Ferramenta. chilogr. 447,900 > 0,55 > 64,8'5
TOTALI L. 1,9C9,993
Dai qua li calcoli risulta c he an c h e in questo caso lo Staio dovrebbe aggiungere al valore d e i materiali (semprechè potranno esit.ar si ai prezzi sopra notati) cil'ca lire 120,000.
Supposto però c h e fosse accettato il prin cipio di impiega re nelle· nuove· costruzioni di Manto va il materiale utilizzabile sopra indi cato, ri sulterebbe p er questi, facendo un calcolo analogo a quello del cas o preceden te, una economia di ollre 3 mili on i e mezzo di lire, con la quale s i compenserebbero le spese di d em olizione e spianamento, pu r rimanendo un· ava nz o di oltre 700 , 000 lire.
Da quan t o precede risulta che la demolizione delle fortificazioni di Verona, sio che ven ga esegttita i n tutta la sua es tens ione, sia che venga li mi tata esclud endon e la c inta magistral e, sarà causa di u.na s pe sa più o meno g ran de per l't-:rario, quando s e ne vo g liano esitare i m a teriali utilizzabili ris ultanti sulla piazza stess a, ed imer,e sarà font e d i una sempre ra gg uard evole economia quando i mate riali stessi fossero impi egati nelle nuoYe fortificazioni d i Mantova.
23;2 COl'iSIDEI\
ECC.
\ZLONI SULI.E PROPOSTE"DI AMPLIAMENTO
La conservazione ed ampliamento della piazza di Verona che raccolse i voti della g ià Commissio n e permanente per la difesa dello Stato, verme da questa computata per ,f O milioni di lfre nel piano completo, e per 5 milioni nel piano ridotto.
Nel primo si intendeva ridurre tulle le opere di riva destra dell'Adige in modo da resistere alle moderne artiglierie, ed eseguire tutte l e sistemazioni ed opére nuove necessarie a rafforzare i fronti a nord e ad est sulla r i va sinistra di quel fiume.
Nel secondo invece si sopprimeva l a riduzione delle .opere a destra dell'Adige , comechè poste sul fronte meno probabile degli attacchi, e si manteneva invece la sistemazione delle fortificazioni esistenti, e la cos~ruzione d elle nuove opere dall'altro lato di quel fiume , rJLenendos1 quel lato come più esposto , in caso di guerra dalla frontiera orientale . .
La stessa Commissione nella sua Relazione, discorrendo_ d~i pro~edimenti con i quali raggiungere Ja comp1laz1o~e di un piano ~idouo, notava _che « pe!'
« la maggior parte delle piazze, sia nuove, sia spe -
« cialmente fra le esistenti, talune op ere sono asso-
« lutamente indispensabili ad assicurarle contro una
« p~ematura_ espugnazione, per cui la loro soppr-es-
« s10ne eqmvarrebbe poco meno che al loro abban-
.i: dono, e colla trista conseguenza di lasciar facile
« preda al nemico i nostri cannoni, depositi cli ma-
« teriale, ecc., e di gettare lo sconforto nelle pop9-
«. lazi?ni_e nelJ'esercito » (Pag. 33). Ora a queste sagge

rdless1om sembra alquanto contraddittoria la proposta fotta nel piano ridotto, <li lasciare come si trovano i
DE1LE FORTIFJCAZlONI Dl VERONA .
235
forti sulla riva destra dell'Adige, poichè questi per la loro costruzione, che presenta scoperte ai tiri nemici · gtancli masse di murature, dietro un ristretto terrapieno, sono suscettibili di ben limitata resistenza contro gli odierni mezzi di attacco, e quindi di ·ben limitata utilità nello · stato in cui si trovano, come si vede dalla Relazione stessa (pag. 39).
Ora, ammesso che il nostro esercito si sia riparato dietro la linea dell'Adige in Verona e Mantova, ciò che suppone abbia patito dei rovesci , per cui un nemico intraprendente e vittori oso è molto probabile che riescirù di passare quel fiume, a noi pare che sulla des tra di essa rimanga il fronte probabile di attacco delle piazze , come quello contro il quale potranno più facil~ ente essere condotte le artiglierie d'assedio, ed i l avori di trincea essere p iù agevolmente eseguiti, che non sul terreno montuoso della riva sinistra, ove scarseggiano anche le opportune comunicazioni; epperò ci sembra che il lasciare le opere di quel fronte nello stato in cui trovansi , se non equivale a!fobbandono della piazza, la mette i.n tali condizioni di debolezza che di poca utilità essa potrebbe tornare. XXIV.
A noi sembra che, ammessa come necessaria a Verona una gran piazza da guerra con campo trincerato sulla destra dell'Adige allo s copo di appoggiare efficaceniente la difesa della valle dell' Adi'ge, ed arrestare un'invasi'one clal Tfrolo, come viene enunciato da lla predetta Commissione negli specchi A e B, annessi alla sua Relazion e, si debba, nel caso del piano completo, surrocrare ao-li attuali forti di prima linea a destra d' Ao o . dige, ed a quelli di Ca Bellina e San Michele sulla
ANNO xix, VoL. 1.
234 CONSlDRRAZfONI SULLE PROPOSTE DI AM PLIAHEN'CO ECC.
XXIII.
~7
C0NSID1l:RAZ10N1 SULLE PROPOSTE DI A~[PLIA!IENTO ECC.
riva sinistra, sei forti di più ampio tracciato opportuna men te situati, a maggior distanza dalla piazza degli. attuali, uno sulla riva sinistra e cinque sulla destra, siccome veniva già pr0posLo dal generale Brignone nel suo scritto Sulla di:fesa degli Stati in generale. e dell' Itah'a in particola,re (V. Rivista J.lilitare dell'anno 1871, dispensa IIJa); e nell'altro caso quei forti·assolutamente trasformare secondo i preceui dell'odierna arte fortifìcatoria.
Effetluandosi la trasformazione completa della piazza, la spesa sarebbE> all'incirca :
Per i 6 forti nuovi di prima linea . L. 4,'000,000
Riduzione del forte Montorio . » 5"00,000
' Còstruzione di 5 nuovi forti sulle alture » 2,000,000
Strade di comunicaz ione . » 300,000
Rista uri e sistemazione del corpo di piazza 200,000
Tota'le . L. 7,000,090
Non si mette a calcolo spesa alcuna p-er la demolizione e spianamento dei forti esistenti, poichè la differenza che passa tra il loro importo ed il valore dei materiali di spoglio non essendo che di poco superiore a L. 140 mila, rimane largamente compensata dalle eco-. nomie che potranno conseguirsi adoperando tali ma- · teriali nelle nuove costruzioni.
Nel secondo caso poi la spesa sarebbe.presso a poco la seguente:
Ttasforinazione dei forti di prima linea sopra entrambe le rive dell'Adige in L. 3,300,000
Costruzione di 6 nuovi forti » ·2,50-0,0 00
Stradff di comunicazione . »' 250,000
Riistauri.e sistemazione ·del corpo di piazza 1'50,600 - - - -
Totale . L. 6,200,000
LLE FOilT.IFICAZlONI Dl VERONA 23'7
Da questi ,calcoli, che riteniamo aver fatto senza larghezza, si vede occorrere pella trasforQ1azione com•pleta della piazza la ragguardevole $pesa di 7 r,nilioni . :di lire, .e per la' semp}ice riduzione a poter soddisfare alle moderne esigenze, l'altra non -lieve spesa di oltre 6 milioni; {lell' uno e nell' al,tro caso, escluso l'armamento che sempre dovrà coniprendere a l.Ì'incirca un migliaio di bocche a fuoco.

Al cospetto di queste cifre non possiamo a meno di porre una domanda, alla quale lasciererno che altri risponda, ed è che ammesso che la piazza di Verona debba rimanere nel novero delle grandi piazze . da guerra se non sarebbe più conveniente, sotto ogni rapporto, trasformarla completamente, anzi che eseguirvi per una economja, relativamente limitata, delle riduzi,oni che di poco varranno ari accrescere la sua potenza sulla destra dell'Adige, ove stanno i suoi fronti che, fondatamente, non possono dirsi i mei;10 minacciati.
XXVI.
La terza proposta in dìscussi,o~e è quella della conservazione di Verona tra le piazze fortificate, scemandone molto l'importanza.
L'attuazione cli tale proposta crediamo possa importare le seguenti spese:
Miglioramen~o del fo~te Gazometro . L. 50,000
Idem Biondella » t0,000
Costruz. d'un nuovo forte a CaTessarolli» 200,000
Nuovo forte davanti Porta Vescovo . » 'i00,000
Ristauri al corpo di piazza e suo cornplet. 900,000
R\stauri alle opere sul monte Gaino • » 60,000
Totale . .C 2,0oo:ooo
236
.DE
f}
CONSIDERAZIONI SULLE PROPOSTE D;r AMPLIA MENTO ECC ,
Per la demolizione dei forti sulla destra dell' Adige, che costerebbe circa 1,750,000 lire, e dalla quale si ricaverebbero dei materiali utiliz2a·bili per un valore di . oltre 1,600,000 lire, non si pone nulla a calcolo, ritenendosi che la differenza fra queste due somme sar~bbe ampia1;nente compensata dall'impiego degli accennati materiali, parte a Verona slessa e parte a :Mantova.
XXVII.
Riassumendo i dati che precedono , si conchiude che con le tre soluzioni proposte si hanno i seguenti risultati :
Con la prima si avrà apparentemente, o per meglio dire, durante la sua attuazione, una spesa superiore alle 900 mila, od alle HlO mila lire, od anche un vantaggio di qualche milione, secondo il modo della sua attuazione, ma si lascierà intei·amente scoperta una località che pur avendo scapitato dalla sua antica importanza, non l' ha però del tutto perduta , a causa della sua situazione topografica, e che quindi in caso di guerra bisognerebbe coprire con opere occasionali, spendendo in queste probabilmente assai più di quanto · si sarà risparmiato. .
Con la seconda si avrà, erogan do 7 milioni o 6 e mezzo, secondo che si voglia una trasformazione completa od imperfetta, una gran piazza di guerra con gran campo trincerato, che richiederà un armamento di oltre 600 bocche a fuo co in batteri a, ed un presidio di oltre 20 mila uomini per la sua difesa.
Con l'ultima, mercè una spesa di 2,000 , 000, -conservando Verona come semplice piazza di guerra, abbisognevole di un armamento di circa 2/SO bocche a fuoco in batteda, e di 4 a 5 mila uomini di presidio,
DELLE FORTIFICAZIONI "DI VERONA 239 si conseguirebbe lo scopo di a:.sicurarsi dei vantaggi che essa pres~nta, s ino a che potranno esserci giovevoli , senza che poi essa c i potesse ·essere di molto imbarazzo e pericolo, quando le circostanze di guerra ci costringessero ad abbandonarla.
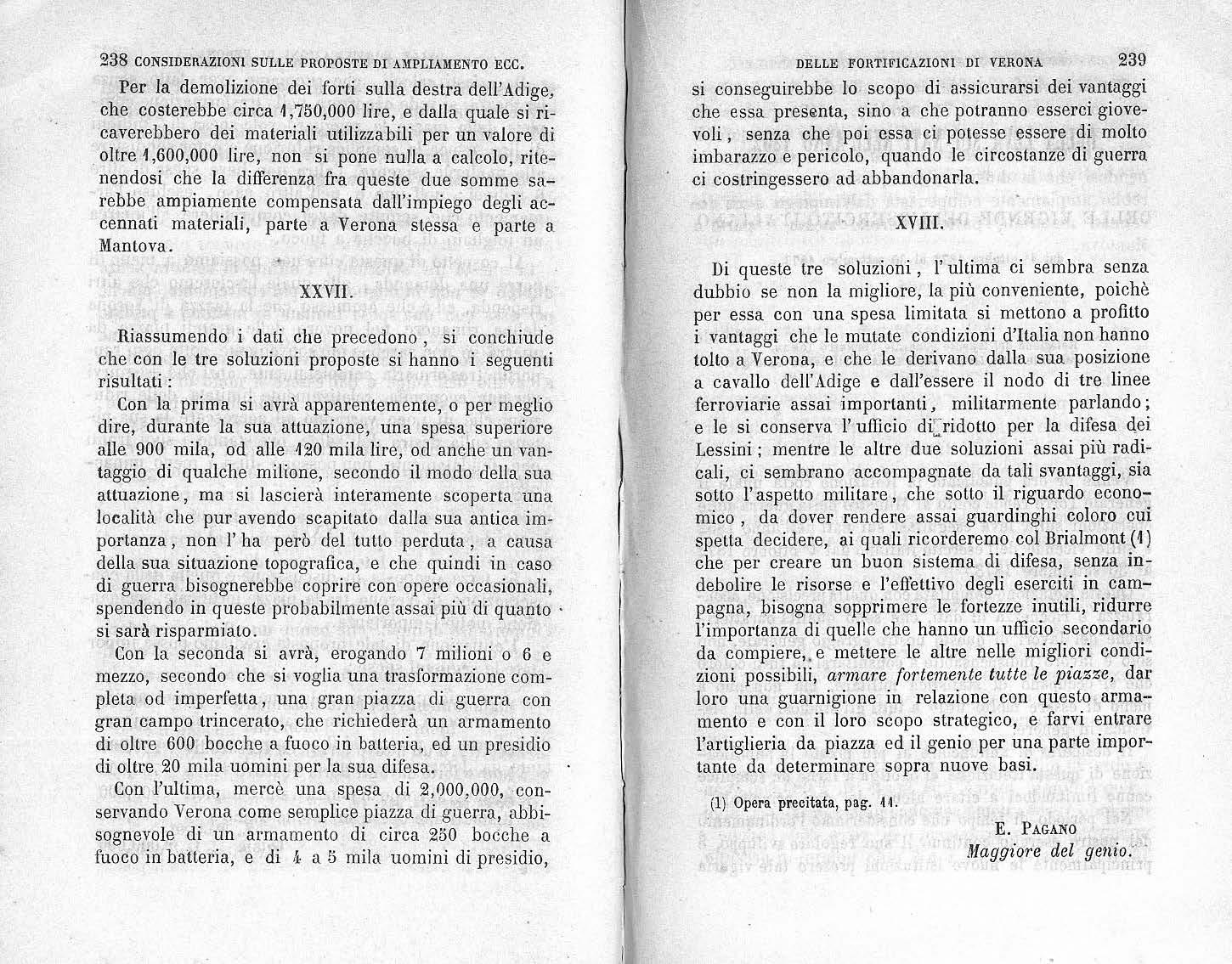
XVIII.
Di queste tre soluzioni, l'ultima ci sembra senza dubbio se non la migliore, la più conveniente, poichè per essa con una spesa limitata si mettono a profitto i vantaggi che le mutate condizioni d'Italia non hanno tolto a Verona, e che le derivano dalla, sua posizione a cavallo dell'Adige e dall'essere il nodo di tre linee ferroviarie assai ,importanti, militarmente parlando; · e le si conserva l' uliicio d( ridotto per la difesa d,.ei Lessini ; mentre le altre due soluzioni assai più radicali, ,ci sell!-brano accomp~gnate da tali svantaggi, sia sotto l'aspetto militare, che sollo il riguardo econom ico , da clover rendere assai guardinghi coloro cui spelta decidere, ?i quali ricorderemo col Brialmont (1 ) che per creare un buon sistema cli difesa, senza indebolire le risorse e l' effettivo degli eserciti in campagna , bisogna sopprimere le fortezze inutili, rid_urre l'importanza di quelle che hanno un ufficio secondariq da compiere, . e mettere le altre nelle migliori condizioni po ssibili, armare fortemente tutte le piazze, dai: loro una gua rnigio ne in relazione con questo armamen to e con . il ioro scopo strategico, e farvi entrare l'artiglieria da piazza ed il genio per una parte importante da determinare sopra nuove basi.
'.238
(lì Opera precitata, pag. H.
· ·,
E. PAGANO Maggiore del genio :·
dal • ottobre 487i a) 30 sottcmbre 4873
DELLA: LEYA SUI NATl NELL'ANNO Hl5~ :!WC . 941 di vita da affermarsi pienamente per la loro pratica u t ilità nella pubblica opinione. .
Nel proemio deHa Relazione abbiam~ un prospetto della forza dell'esercito italiano al 30 settembre 18173 che era di 751007 con un aumento di 71130 uomini sulla forza éfell'anno precedente.
Questa for:za era , cosi ripartita:
Eserez'.to permanente.
Sotto In congedo· Totale le armi illirpi tato
Ufficiali in attività di servizio 10661
, classi di l"' categoria 138127
( clas~i ~i 2"'categoria 30
Truppa) uomm1 , con ferma
I permanenteosenza .
\ limiti di ferma 10661
'.l'otale ~otto le armi 186152
Venne or ora pubblièata la Relazione colla quale il gen~rale Torre rènae conto al Ministro della guerra delle operazioni sulla leva eseguitasi sui nati nell'anno 1852 e sulle vicende dell'èsercito italiano dal 1° ottobre 1872 al 30 settembre 1873.
Questa Relàzìone compilata con quella precisione, accuratezza e ricchezza di dati, che sono qualità caratteristithe dei lavori di questo nostro egregio gen~rale, non sòlo è lavoro' indispensabiÌe a consultarsi 'da tutti col6ro che sì occupano di statistica militarè, ma non può a menò dì essere molto utile a tutti gli studiosi della statist ica in genere.
Il desiderio di annunciare al più presto la pubblicazione di questa Relazione ci obbliga a farne un semplice cenno limitandoci ·a citare alcuni .dei dati princip.ali-.
Nel periodo di tempo che consideriamo l'ordinamento del nostr o esercito continuò il suo regolare sviluppo, e principalmente le nuove istituzioni presero tale vigoria
» » » »
Ufficiali in aspettativa o disponibilit.à 236 classi di l" categoria . . 193975
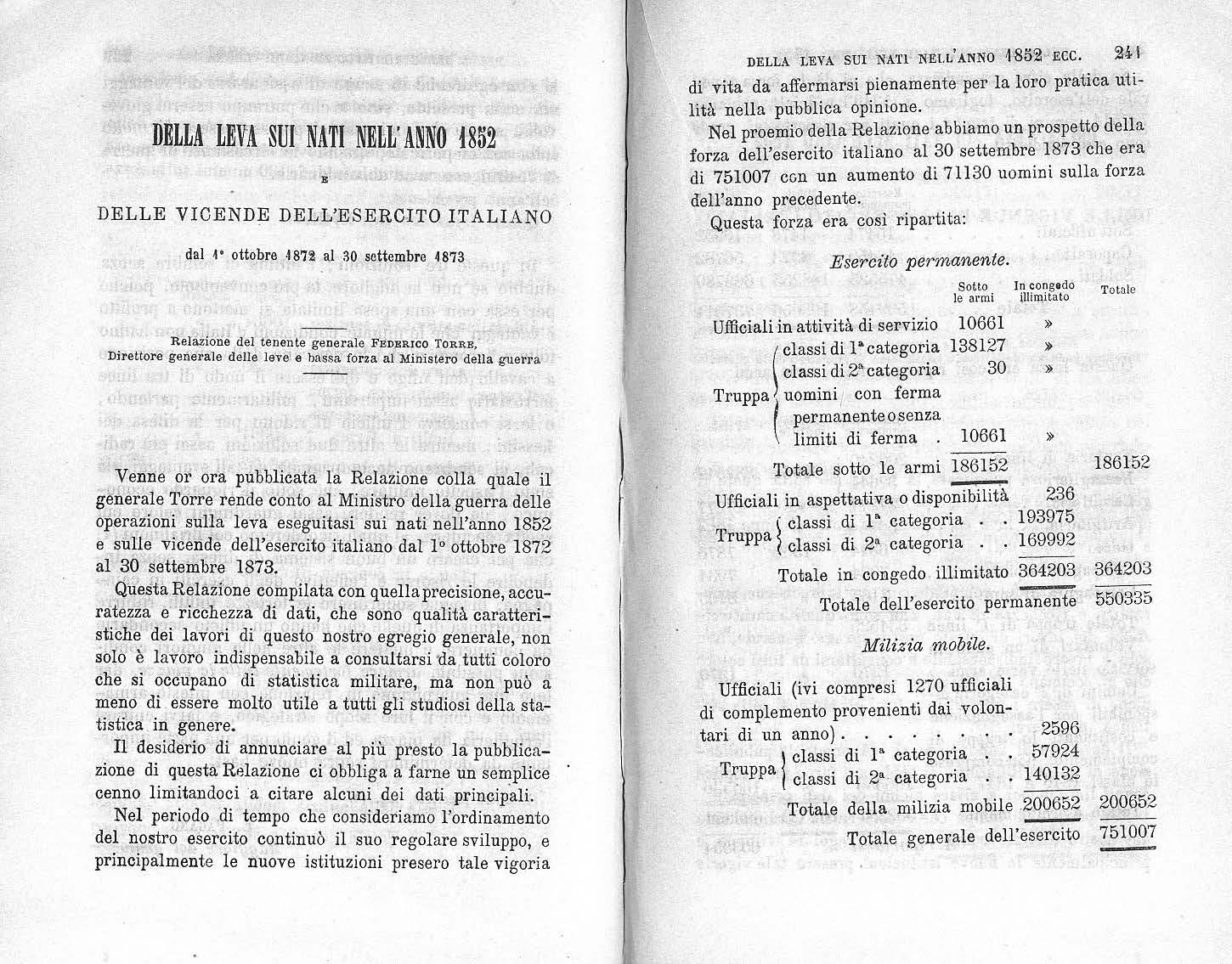
- Truppa? classi di 2~ categor1a . . 169992
Totale in congedo illimitato 364203
186152 364203
Tot~le d'ell'esercito permanen té 550335 Milizia mobile.
Ufficiali (ivi compresi 1270 ufficiali di complemento provenienti dai volontari di un anno) . 2596
) classi di l" categoria .• 57924
T~uppa I classi di za categ:oria 140132
- Totale della milizia mobile .200652
Totale generale dell'esercito 200Q52 751007
DELLA LEVA SUI- NATI NEtL' ANNO ·f 802 B
DE LLE VICENDE DELL'ESERCJTO ITALI ANO
R.elàzione del tenente generale FÉDERICO TORRE; Direttore generale delle le ve' e ba.ssa forza·al Min'istero della guerrà
DELL A LEVA SUl NATI NELL'ANNO 1852
Se dalla cifra ora indicata, che ci dà la forza generale dell'esercito, togliamo i 13493 ufficiali, abbiamo 737514 uomini di truppa i q.uali per rispetto ai gradi sono cosi suddivisi:
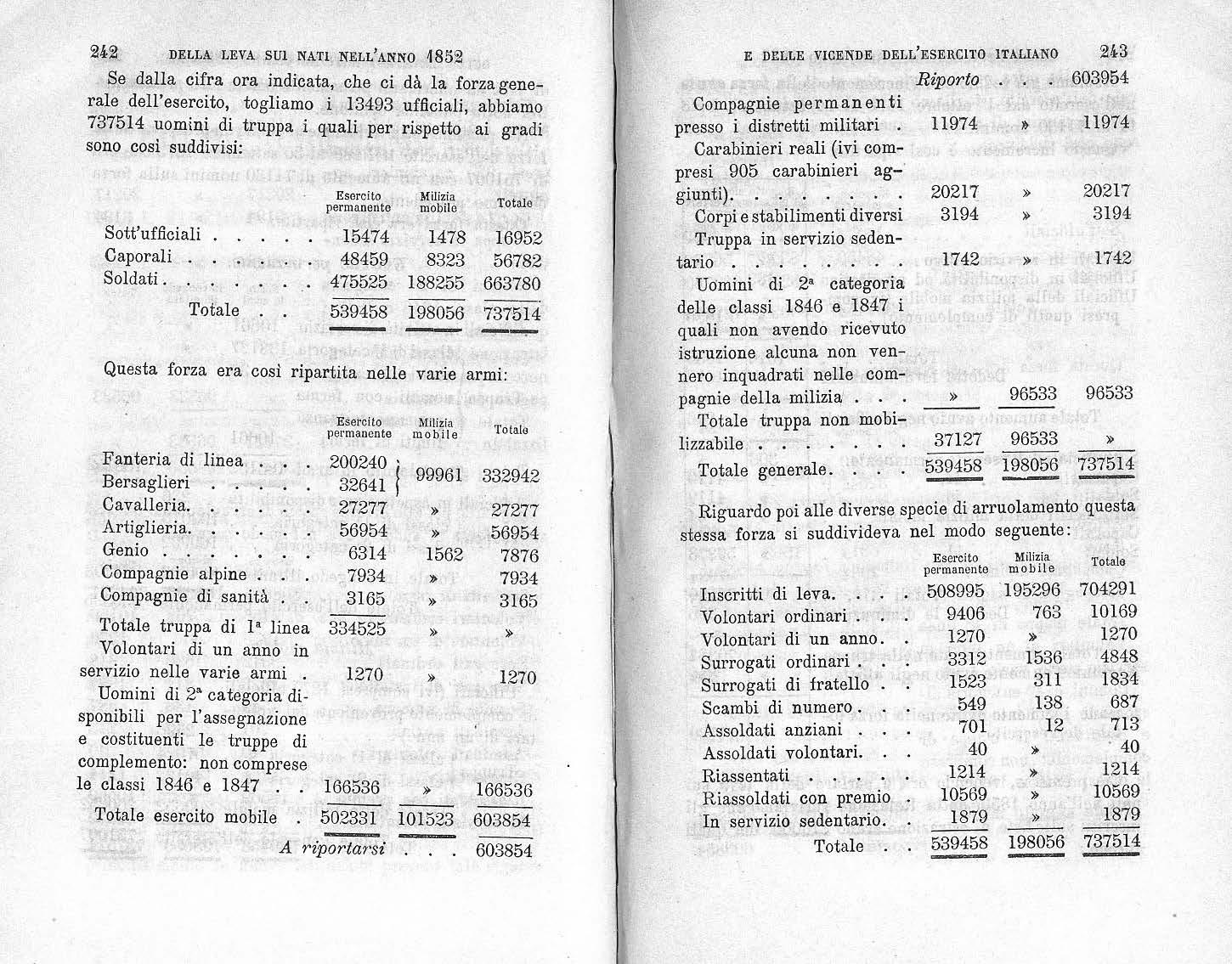
Questa forza era così ripartita nelle varie armi:
1846 e . 1847 i
Riguardo poi alle diverse specie di arruolamento questa stessa forza si suddivideva nel modo seguente:
242
Esercito Milizia permanente mobile Totale Sott'ufficiali Caporali Soldati. 15474 48459 475525 1478 16952 8323 56782 188255 663780 Totale 539458 198056 737514 --
Fanteria di
Bersaglieri Cavalleria. Artiglieria. Genio Compagnie alpine Compagnie di sanità Esercito Miliz ia permanente mobile 200240 ì 99961 32641 I 27277 » 56954 » 6314 1562 7934 » 3165 » 1'otale t r uppa di I a linea 334525 Volontari di un anno in )) servizio nelle varie armi 1270
costituenti le truppe di complemento: non comprese le classi 1846 e 1847 166536 » » Totalo 332942 27277 56954 7876 7934 3165 » 1270 166536 Totale esercito mobile 502331 1.01523 603854 A riportarsi 603854 E DELLE VICENDE DELL'ESERClTO ITALIANO 2-i,3
permanenti presso
Carabinieri
. Corpi e stabilimenti
Truppa in servizio sedentario . . Uòmini di
delle classi
quali
nero inquadrati
pagnie della milizi3i . . 'l'otale truppa non mobilizzabile Totale generale. Riporto 603954 11974 20217: 3194 1742 » )) » » 11974 20217 3194 1742 » 96533 96533 37127 96533 » 539458 198056 737514
linea
Uomini di 2" categoria disponibili per l'assegnazione e
Compagnie
i distretti militari
reali (ivi compresi 905 carabinieri aggiunti).
diversi
2a categoria
non avendo ricevuto istruzione alcuna non ven-
nelle com-
Inscritti di leva. Volontari ordinari . Volontari di un anno. Surrogati ordinari . Surrogati di fratello Scambi di numero . Assoldati anziani Assoldati volontari. Riassentati Riassoldati con premio In servizio sedentario. Totale Esercito Milizia pe1-manente mobile 508995 ·195296 9406 763 1270 3312 1523 549 701 40 1214 10569 1879 » 1536 311 138 12 Totale 704291 10169 1270 4848 1834 687 713 · 40 1214 10569 · 1879 539458 198056 737514
DELI.,A LEVA SUI NA:TI NEbl/ANNO 1852
Abbiamo già veduto, ch& l'incremento della forza avuta nell'esercito dal 1° ottobre Ì872 al 30 settembre 1873 fu di 71130 uomini.
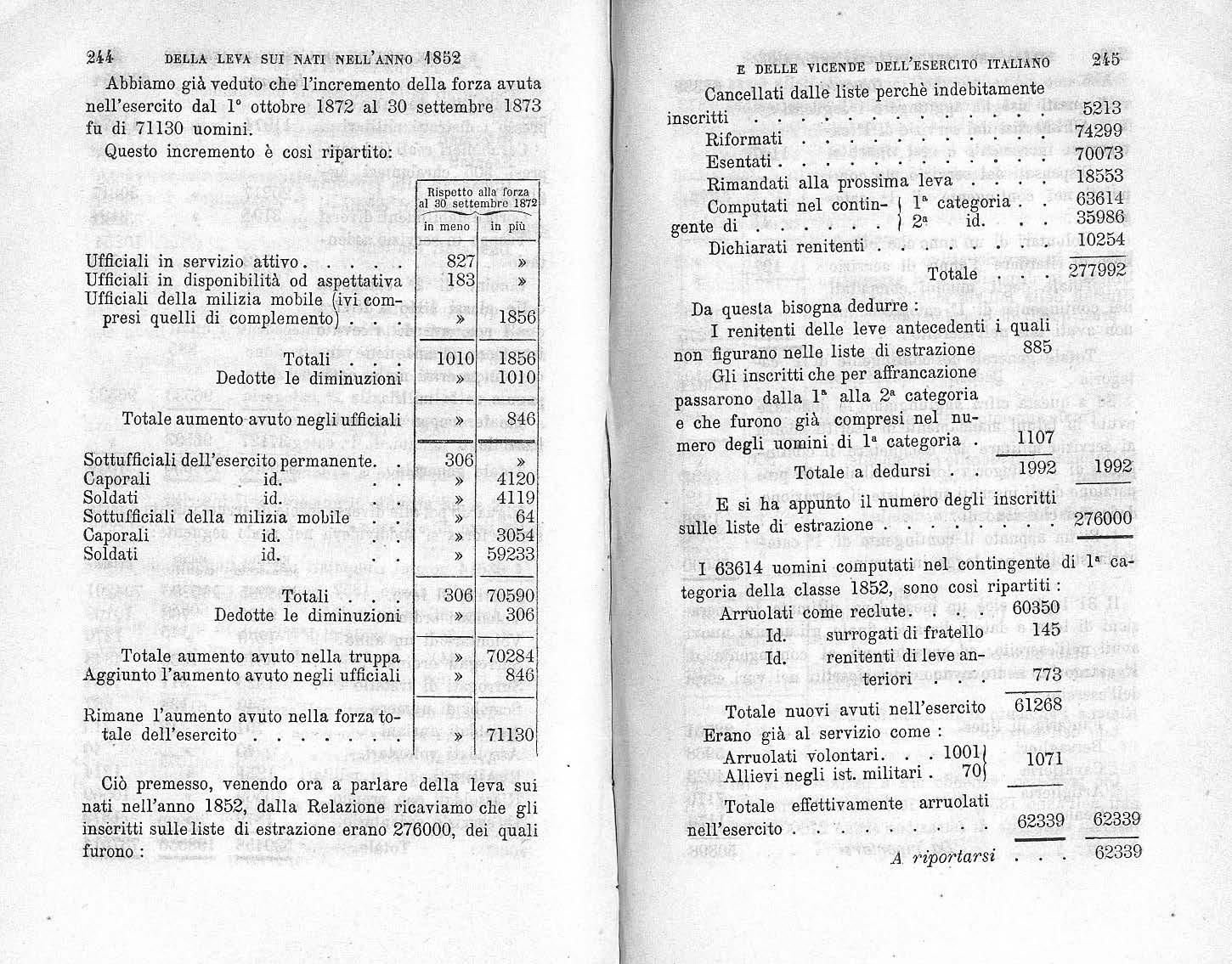
Questo incremento è così riP,arti'to; .
alla' Jorza . al ao settenibre 1872
Ufficiali in servizio attivo . . . . .
Uffic~al~ in disp<mibilità od aspettativa
Uffic1a~1 dell~ ~ilizia mobile {,ivi-compresi quelli di complemento r . ... .
Totali . . .
Dedotte le diin inuzioni,
Totale aumento-avuto negli ufficiali
Sottufficiali-dell'esercito permanente.
Caporali .
· .
_Total ~ aumento a::vuto nella truppa
Aggiunto 1 a.umento avuto negli ufficiali
Rimane l'aumento avuto nella for zatotale dell'esercito . . .. . . .
Ciò premesso, venendo ora a parlare della leva sui ~at~ ~e ll'anno. 1852, dalla Relazione ricaviamo che gli rnscr1t~1 sulle liste di estrazione erano 276000, dei quali furono : /
E DELLE VlCEN DE DELL'ESERCITÒ ITALIANO
Cancellati dan'è- liste perchè indebitamente inscritti
Riformati . Esentati. .
alla prossima leva
Co~putati nel contin- J l: cat~g'oria . gente d1 . . . . . . 2 - 1d. •
Dichiarati renitenti . .
Totale
Da questa bisogna dedurre : I renitenti delle leve antecedenti i quali non figurano nelle liste di estrazione 885
Gli inscritti che per affrancazione passarono dai l a l" p.lla za categoria e che furono già compresi nel numero degli uomini di 1a categoria . 1107
Totale a dedursi . 1992
E si ha appufito il numero degli inscritti sulle liste di· estrazione .. .
I 63614 u0mini -computati nel contingente di l" catego~ia della classe °1852, sono così ripartiti : Arruolati come ree-Iute. · 60350
I&. surrogati di fratello 145
Id.· renitenti di leve anteriori 773
Totale nuovi avuti nell'esercito 61268
Erano già al servizio come : Arru0lati volontari. . . 1001/ 1071
AllieYi negli ist. militari . 70\
Totale effettivamente arruolati nell'esercito 62339 62339
A. ripottarsi 62339
2,i.4
Soldati id. Sottufficiali della milizìa mobile Caporali id. Soldati id. Totali
.
Dedotte le diminuzionir
id.
.
.
Ri~petto
· in meno in pfù 827 » ' 183 » I » 1856 1010 1856 » 1010 » 846 m 306 )) » 4120 » 4119 » 64 . » 3054 » 59233 3061705901 » 306 » 70284 » 846 » ·'71130
Rimandati
5213 74299· 70073 18553 6361 4! 35986 10254 277992 199Z 276000
Riporto . . .
A questi bisogna aggiungere i seguenti : Affrancatisi dal servizio di I" ca- ·
tegoria . . . . . . . 1107
Dispensati dal servizio ma computati nel contingente di I a categoria . . . . • . . 41
62339
E DELLE VÌCENDE DELL'ESERCITO ITALIANO Riporto
Compagnie alpine. . .
Compagnie di sanità. .
Compagnie permanenti presso i distretti. Scuole . militari e riparto d'istruzione .
Squadroni palafrenieri .
Carabinieri reali . .
Volontari di un anno che ottennero di ritardare l'anno di servizio 127 Totale d·egli uomini computati nel contingente di l" categÒria, ma non avuti tali nell'esercito. • . . 1275 1275
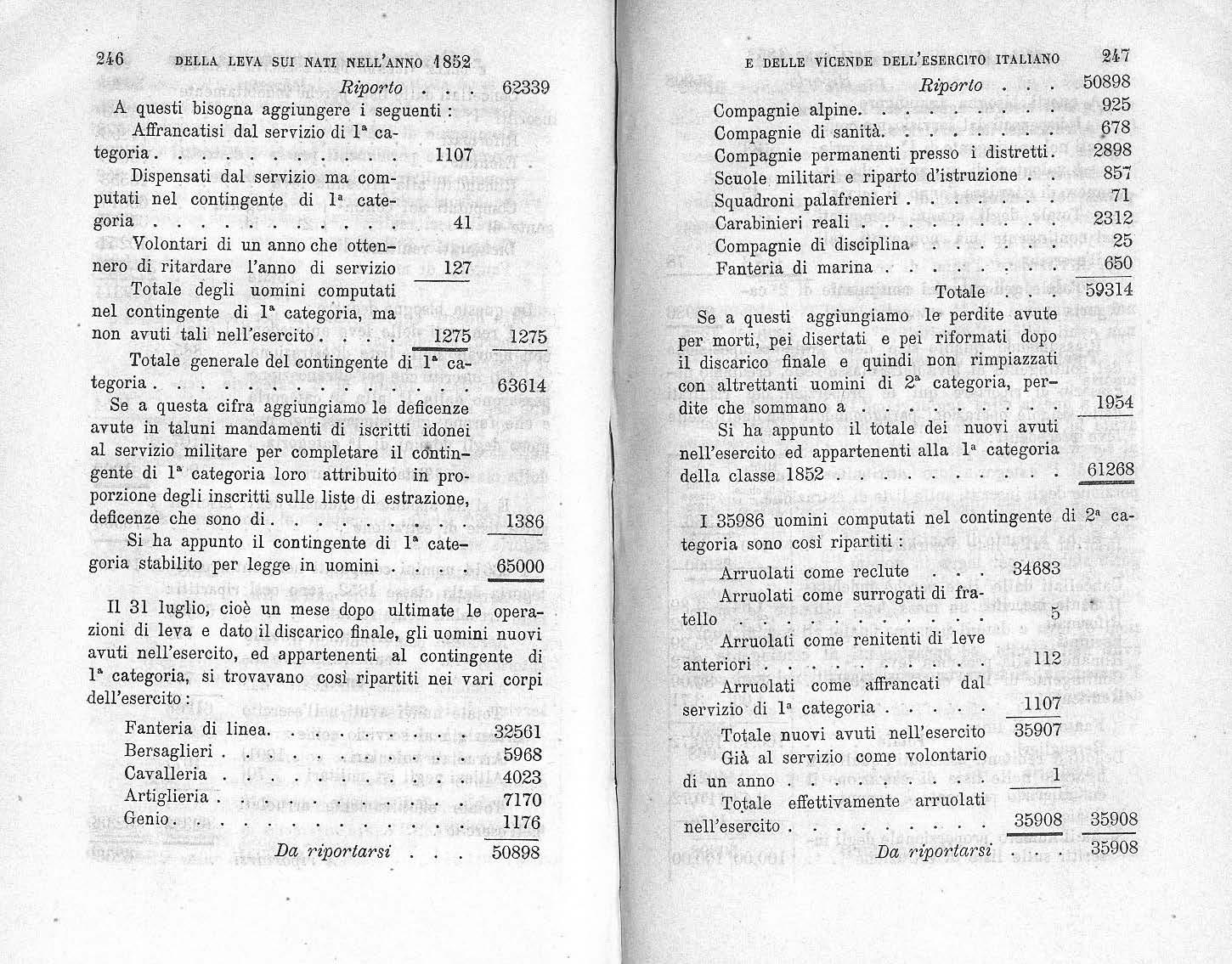
Totale ·generale del contingente ~i 1• categoria . . . . . . . 63614
Se a questa cifra: aggiungiamo le deficenze avute in taluni mandamenti di iscritti idonei al servizio militare per completare il còntingente di I" categoria loro attribuito in proporzione degli inscritti sulle liste di estrazione, deficenze che sono di . ·
.
Compagnie di disciplina , Fanteria di marina . · .
Totale
Se a questi aggiungiamo le perdite avute per morti, pei disertati e pei riformati dop9 il discarico finale e quindi non rimpiazzati con altrettanti uomini di 2" categoria, per- , dite che sommano a . . • . .
Si ha appunto il totale dei nuovi avuti nell'esercito ed appartenenti alla ia categoria
della classe 1852 .
1386
Si ha appunto il contingente di l" cate.,. goria stabilito per legge in uomini . . 65000
Il 31 luglio, cioè ~n mese dopo ultimate le operazioni di leva e dato il discarico finale, gli uomini nuovi avuti nell'esercito, ed appartenenti al contingente di l" categoria, si trovavano così ripartiti nei vari corpi dell'esercito: ·
Fanteria di linea.
Bersaglieri .
Cavalleria .
Arruolati come reclute
Arruolati come surrogati di fra-
I 35986 uomini computati nel contingente di 2a categoria sono così ripartiti : tello
Arruolati come renitenti di leve -anteriori .
Arruolati come affrancati dal servizio · di in categoria .
Totale· nuovi avuti nell'esercito
Già al servizio come volontario di un anno . To~ale effettivamente arruolati
246 DELLA
LEVA SUI NATI NELL'ANNO 1852
Artiglieria : Genio. . Da riportarsi 32561 5968 4023 7170 1176 50898
50898 925 ~78 2898 857 71 2312 25 650 59314 1954 61268
nell'esercito . Da r,iportarsi 34683 5 112 ·1107 35907 I 35908 35908 --35908
Riassumendo quanto si è· detto sulla composizione del contingente di leva della classe -1852, cr·ediamo necessario · di riportare qui le proporzioni dei risultati -delle singole operazioni paràgons1ndoli con quelli delle leve precedenti :
.Dal suindicato specchio noi vediamo che v i è in tutte le op·erazioni di leva un notevole migli?ramento e pri~·cipalmente constatiamo .con vera soddisfazione che 11 numero -dei renitenti va sempre diminuendo.
Altro dato i mportantissimo è lo stato di coltura nel quale pure eonstatiamo un miglioramen:0 sebpene tenuissimo. I numeri dati •rappresentano iìl rapporto per cento.
Inscritti sulle liste d'estrazione .
Cancellati dalle liste . perchè indebi tamente inscritti .
Riformati
Esenta,ti . . .
Rimandati alla prossima leva
.Contingente di 1" e di 2a categoria
Renitenti.
Totale
Dedotti i renitenti assentati i quali non figurano nelle liste di .estrazione il cui rapporto per cento è appµnto
.Si ha il ·numero proporzionale degli inscritti sulle liste di estrazione
Classe 1846
Classe 1847
Classe 1848
Classe 1849
Classe 1850
Classe 11851
Classe 1852
A confermare sempre più quanto utile ritraggono i soldati nella loro istruzione letteraria durante la permanenza nelle file dell'esercito, ci conviène esaminare. lo stato di coltura degli uomini quando si ebbero sotto le armi con quello che avevano quando vennero mandati in con,gedo illimitato.
Questo 'dato statistico risulta dal seguente prospetto per quanto riguarda le classi 1846-47-48.
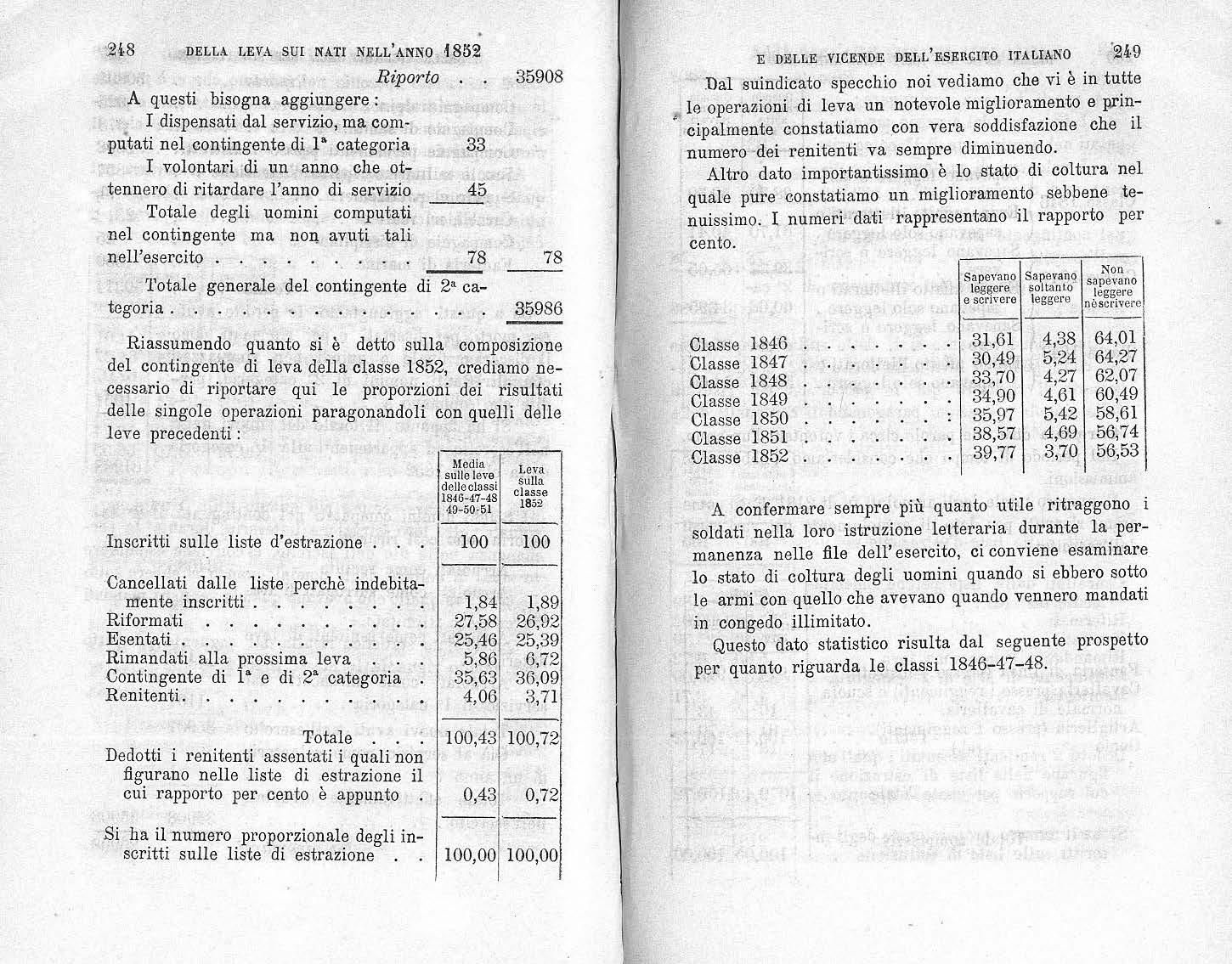
'.2,i,8 DELLA LEVA .sur ,NATI N~LL' ANNO ,f 852 Riporto A qu~sti bisogna aggiungere: I dispensati dal servizio, ma com-, ,putat i n~l contingente di 1,. categoria . 33 I volontari ·di un anno che ot·tennero di ritardare l'anno di servizio Totale degli uomini computati, .nel contingente ma no:q avuti tali nell'esercito . 45 78 Totale generale çlel contingente di 2a ca35908 78 tegoria . 35986
I Media sulle leve delleclassi 1846-47- 48 49-50-51 100 1,84 27,58 25,46 5,86 35,63 4,06 --100,43 OA3 - -100,00I Leva sulla classe 1852 100 1,89 26,92 25,39 6,72 3fi,09 3,71 100,72 0,72 · --100,00
E DELLE VlCE))ìI>E DELf,'F,SERCITO ITALIANO "'.2,i.9
I
, S Non
31,61. 4,38 64,01 1 30,49 5 ;24 64,27 33,70 4,27 62,07 34,90 4,61 60,49 35,97 5,42 58,61 38,57 4,69 56,74 39,77 3,70 ,56,53
Sapevano apevan ci_ sapevano leggere soltau t.o leggere e scrivere legge r e nè scrive1·e
leggere ·e
Ci resta a dire due parole circa i volontari d'un anno. Nel periodo di tempo che consideriamo si ebbero due ammissioni.
Il numero totale degli arruolati fu di 2181. Ecco come erano ripartiti per dato di arruolamento nei vari corpi dell'esercito: • 1
E DELLE VICEND E DELL'ESERCITO ITALIANO 2i>'I
Nel resoconto fatto dalla Relazione sulla l eva delle classi 1850 -51 abbiamo dato il prospetto dei volontari di un anno arruolatisi nel m~rzo 1872, ed ora possiamo dare lo s.recchio dei risultati ottenuti in detta ammissione come pure in quella dell' ottobre 1872.

Fanteria dì linea (presso i distretti) .
Cavalleria (presso i reggimenti) e scuola normale di cavalleria. . . .
Artiglieria (presso i reggimenti).
F inal mente dei 1117 volontari d'un anno che ultimarono il loro· anno di servizio nell'ottobre 1872 e nel marzo 1873, ve ne furono 483 che si pr esentarono e fecero lodevolmente gli esami di idoneità ad ufficiali e fu r ono quindi nominati ufficiali di complemento, cioè:
250 DELLA LEVA
SUI NATI NELL'ANNO rn52
Quando Quando vennero furono sotto rinv iati "
sapevano
Sapevano leggere e
Classe
vere·
Erano affatto
o sapevano
le a1·mi in congedo 38,30 59,59 61,70 4:0,41 39,32 . 65,05 60,68 34,95 41,84 85,40 58,16 14,60
( Sapevano
seriClasse 1846 ' vere· · · · · · I Erano affatto illetterati o \ sapevano solo leggere . ( Sapevano leggere e seriClasse 1847 ) vere· · · · · · · ì Erano affatto illetterati o \
solo leggere . )
seri-
1848
· · · · · ·
illetterati
solo leggere .
Totale Totale complessivo Arruo lati ------n ell' nel marzo otto bre 1872 1873 974 979 19 43 6'1 70 18 17 1072 1109 --2181 '
Genio (id.)
o .S ! Oiqucllichecompirouo .8 !:: ::? l' ann o di se r vizio - o ·§ g "g ottennero 2 o ,_. ·= o ~·- il certi fica to i::_-0° i s~ d - ~ t"-:... o=6 o_, P ~,_, ~ - <;.- o {.Jo zc.;:; ,_e ..... e ce I o 8 .::2 :a~ ·~ ;s·~ g:J a e? oa;
AM~fJSSIONE e ARMA IN CUC PR ESE R O SERVIZIO I :: ::s .:::; -.::S<n - - - - - --- --!--- - - - -"' - ___!:,.=_ M arzo 1.872 Fanteria dilinea (dis tretti militari) Cavalleria Artiglieria Genio . 'l'otale Ottobre 1.872 Fanteria di linea. Cavalleria Artiglieria Ge nio . Totale 782 75 70~J 10 169 528 4 » » 2 2 31 5 26 2 7 17 5 » 5 » 1 4 822 80 742 12 179 55 1 ----- ----974' 77 897 32 256 609 m l 1 18 » 1 11 61 I 6 55 3 rn 36 18: 1 17 1 5 11 I -' --- -- - - -10721 85 987 36 284 667
DATA D'
AN NO XIX , V OL. I.
Per quanto riguarda la seconda parte della Relazione daremo solo il riassunto.
La situazione della forza dell'esercito il 30 settembre 1872 era di uomini . . .
La qua l for za dal 1° ottobre 1872 al 30 settembre 1873 ebbe gli aumenti e le diminuzioni seguenti: .. Aumenti·.
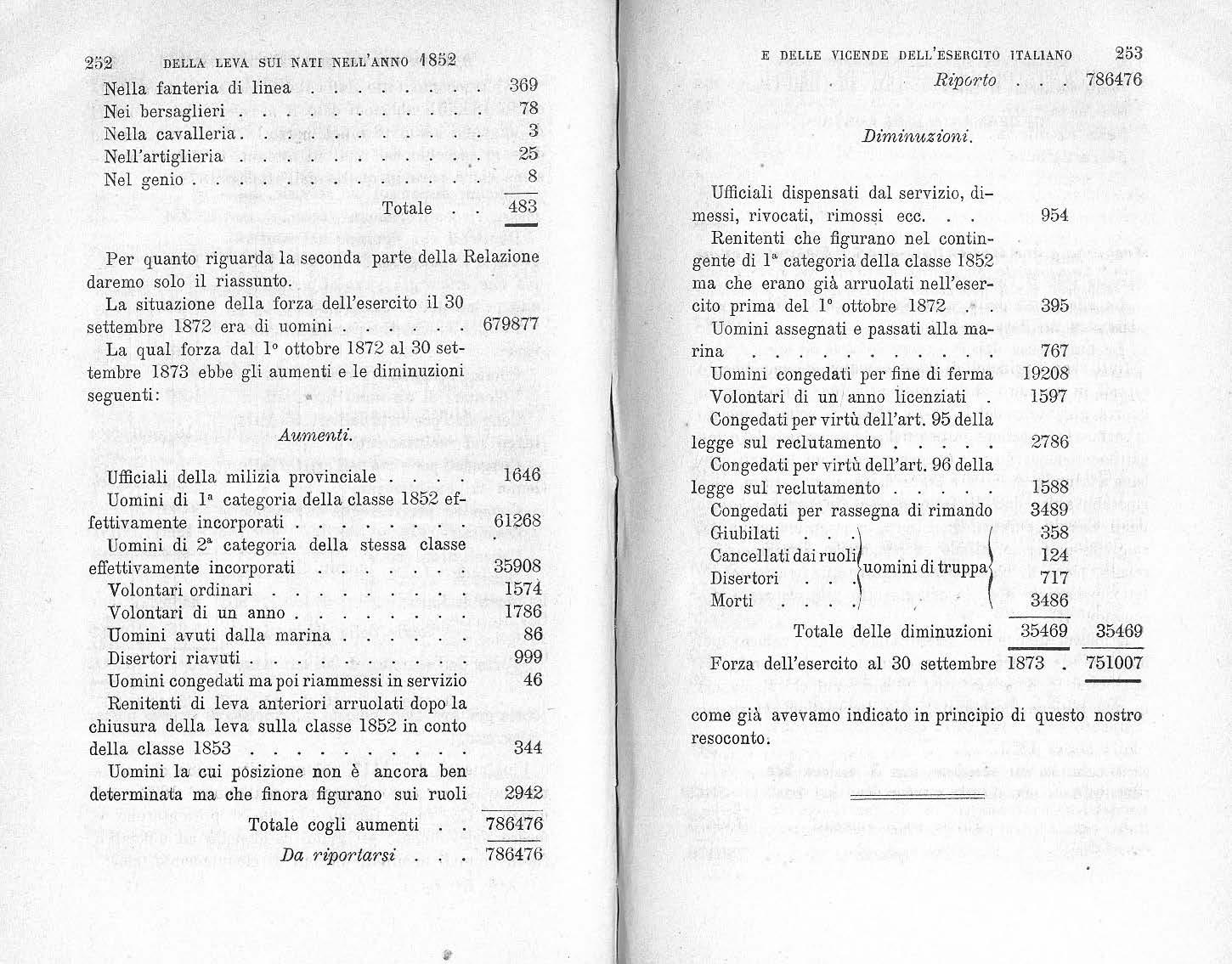
Ufficiali della milizia provinciale
Uomini di ia categoria della classe 1852 effettivame nte incorporati . . . . . .
Uomi ni di 2" categoria della stessa classe effettivamente incorporati
Volontari ordinari . .
Volontari di u'.n anno .
Uomini avuti dalla marina
Disertori riavuti .
Uomini congeda.ti ma poi riammessi in servizio
Renitenti di leva anteriori arruolati dopo la chiusura della leva sulla classe 1852 in conto della classe 1853 . . . . . . . .
Uomini lar cui pòsizione- non è ancora ben determinai;a
Riporto 786476 IJirninuzioni.
Ufficiali dispensati dal servizio, dimessi, rivocati, rimos~i ecc.
Renitenti che figurano nel contingente di 1" .categoria della classe 1852 ma che erano già arruolati nell'esercito prima del 1° ottobre 1872 . · .
Uomini assegnati e passati alla marina
Uomini congedati per fin e di ferma
Volontari di un / anno Ìicenziati
Congedati per virtù dell'art. 95 della legge sul reclutamento . . . . .
Congedati per virtù dell'art. 96 della legge sul reclutamento .
Co ngedati per rassegna di rimando
Cancellati dai ruoli · . . d' t D. t . uomm1 L .ruppa
Forza dell'esercito al 30 settembre 1873 . 751007
come già avevamo indicato in principio di questo nostro resoconto:
252 DELLA
Nella fanteria di linea Nei bersaglieri . Nella cavalleria. 369 78 3 Nell'artiglieria 25 Nel genio . 8 Totale 483
LEVA SUI NATf NELL'ANNO •1852
679877
1646 61268 35908 1574 1786 86 999 46 344
ma;
294:2 Totale cogli aumenti 786476 Da riportarsi . 786476 E DELLE VlCENDE DELL'ESERCITO ITALIANO 253
che finora figurano sui ruoli
Giubilati . . ·i
1ser
. . Morti .
. .; ,-
954 395 767 19208 1597 2786 1588 3489 358 124 717 3486
or1 .
.
·
Totale delle diminuzioni 35469 35469
RECENTI PUBBLICAZIONI DI .TATTICA
IN GERMANIA E IN AUSTRIA VI.
./Jm1(,ild,m9 tmdBesiclilig1mg, oder Rel,rutenlru11p t.md Compagn·ie (Ammaestramento ed ispezione, ovvero reclute e compagnia), per A. VON BOGUSLÌI. WSKY, maggiore e comandante di battaglione ne l 4° reggimento fanteria del Posen n° 59. - Berlino - Mittler, 4 873.
Noti sono i principii di Bo<WSLAWSKY , già ampiamente esposti in un libro che, venuto alla luce poco dopo l a guerra gigantesca del 1870-71 , ebbe tra' primi il merito di portare la questione tattica ne l recinto pratico de l combattimento moderno e di attingerne deduzioni, le quali , sebbene a taluno possano sembrare di sove rchio ardite, pure riposano sopra dati di fatto e sono in parte adottate. negli eserciti europei. Quel libro, palpitante di attualità, spigliato di forma, alieno da pedanterie o pregiudizii di scuola, pieno di idee fresche e giovanili, fu avidamente letto e discusso e diede origine alle più disparate discussioni (l ).
È questa una prova incontrast abile del valo re suo; ma non basta certamente a cancellarne le mende, da attribuirsi in massima parte alla foga di chi si slancia in una regione inesplorata, alle impressioni viv issime
(~) Taktische Folgerungen an s dcm J(riegc ·1870-71. - Il capitano Osio dello stato maggiore ce ne ha rega lato una bella traduzione italiana - Boguslawsky è autore di un'altra opera tattica: D ic Entwickelung del' 7'aktik 'tiOn l'i93 bis zur Gegcnwa1·t. - Berlin.
1\[ittler ,1873, della cui prima parte furono gi1t a qu9sfora pubblicate due edizioni.

·delle recenti battaglie non abbastanza attenuate dal freddo ragionamento, alla mancanza di relaz ioni sicure, alla fretta di compilazione .
Probabilmente se ne avvide lo stesso autore, ed a ciò forse dobbiamo il breve ma succoso lavoro, pubblicato quando dal cozzo di svariatissime opinioni incominciava a diffondersi la luce nella confusa ed intricata matassa de lla piccola tattica.
Il programma, nettam ente tracciato dal titolo, si limita all'istruzione elementare; la quale, quando razionalmente impart ita , scioglie in modo pratico ed evidente il prob lema tanto dibattuto dell'ordine sparso e de ll'ordine chiuso, dello sminuzzamento per serbare le forze e della coesione di queste per l'azione energica e vigor osa. Ed invero, supposto sol dati ab ili nella scherma del terreno e nel tiro, calmi al fuoco, vivaci nello slancio ·offensivo, capaci di socco1Térsi r eciprocamente, pronti a riunirsi ed a concentrarsi contro un punto, attenti alle indicazion i degli ufficiali e graduati, chi mai vorrà rinunziare all'ordine individuale in prima linea ed al fra·zionamento man mano minore nelle linee successive?
Del resto le virtù sopraccennate si trovano in embrione n ell a maggioranza delle reclute; fa d'uopo svolgerle con grandiss ima sollecitudine, con perseveranza infaticabile, con metodo chiaro, log ico, conseguente, che ftn. dalle prime abitui ed educhi il soldato ai veri casi di g uerra. ·Con soldati automi male si può profittare dello spicciolamento che sotto forma di cacciatori, di stormi, di bande è omai ammesso da chiunque tratta la questione dell'affrontamento moderno.
La quale veramente mi sembra rido tta a questione poco più che di paro le. Tutti vogliono coprire l o spiegamento , tasteggiare il nemico, velare le mosse, scaglionare l e forze, soccorrere man mano la ca.tena; tutti v ogliono assalto concentrico, il quale porta naturalmente
IlECEN'l'L PUOBLlCAZWNI DI TATTlGA. ECC. 255
RECENTI PUDDLlCAZIONI Dl TATTICA
al contatto dei gomiti, all'ordine chiuso. Le divergenze stanno nel più o meno largo frazionamento, nel modo di raccogliers i, nella maggiore o minore importanza attribuita al fuoco ed ai ripari, importanza che cresce o cala secondo le infinite condizioni del terreno e del combattimento.
Ond'è che nell'interesse comune mi parrebbe ornai tempo di stringerci la mano nel campo dei principii fondamentali , smettendo, come fa l 'ultima istruzione austriaca (1 ), tutte le espressioni, definizioni o sentenze assolute, le quali ci separano assai più in apparenza di quello che in sostanza.
. Cosi, a ~he serve ornai dire, come fa Boguslawsky, 11 combattimento in ordine sparso essere regola, il combattimento in ordine chiuso eccezione, quando egli stesso ammette l'ordine chiuso pei sostegni e riserv e della prima schiera e per la seconda e terza schiera? Quando confessa doversi ascrivere la dissoluzione degli ordini Lede,sch~ in parecchie delle ultime battaglie all'impiego dell ordme sparso non preparato da conveniente istru. z10ne.?E i per contro a quale scopo ornai proclamare la forma serrata unica per afferrare la vittoria, quando ~essuno nega che l'ordine sparso ha parte quasi esclusiva nella ~reparazione, chè, più o meno spesso, è d'uopo pcrco_rrere il terreno a sbalzi di bande più o meno grosse, quando in certi punti la decisione dipende dall'enerofoa azione di uno mano di cacciatori, qu ando lo star chiusi è talvolta causa di perdite tal i da abbattere in breve ora il brillante valore della truppa più sal da?
In Prussia le reclutè sono istruite per circa tre mesi e poscia incorporate nella compagnia. Quivi in capo a
(4)
lN GERMANIA E IN AUSTRIA 257
quattro settimane vengono sottoposte ad una ispezione a fìne di esaminarne le conoscenze teoriche e la destrezza pratica. Dopo quattro settimane altra ispezione analoga pel battaglione, e quindi evoluzioni campali e manovre applicate.
Il modo di addestramento e l'attuazione pratica di siffatto sistema garbano mediocremente all'autore, il quale compendia le sue idee nelle parole: altre ispezioni, altro addestramento.
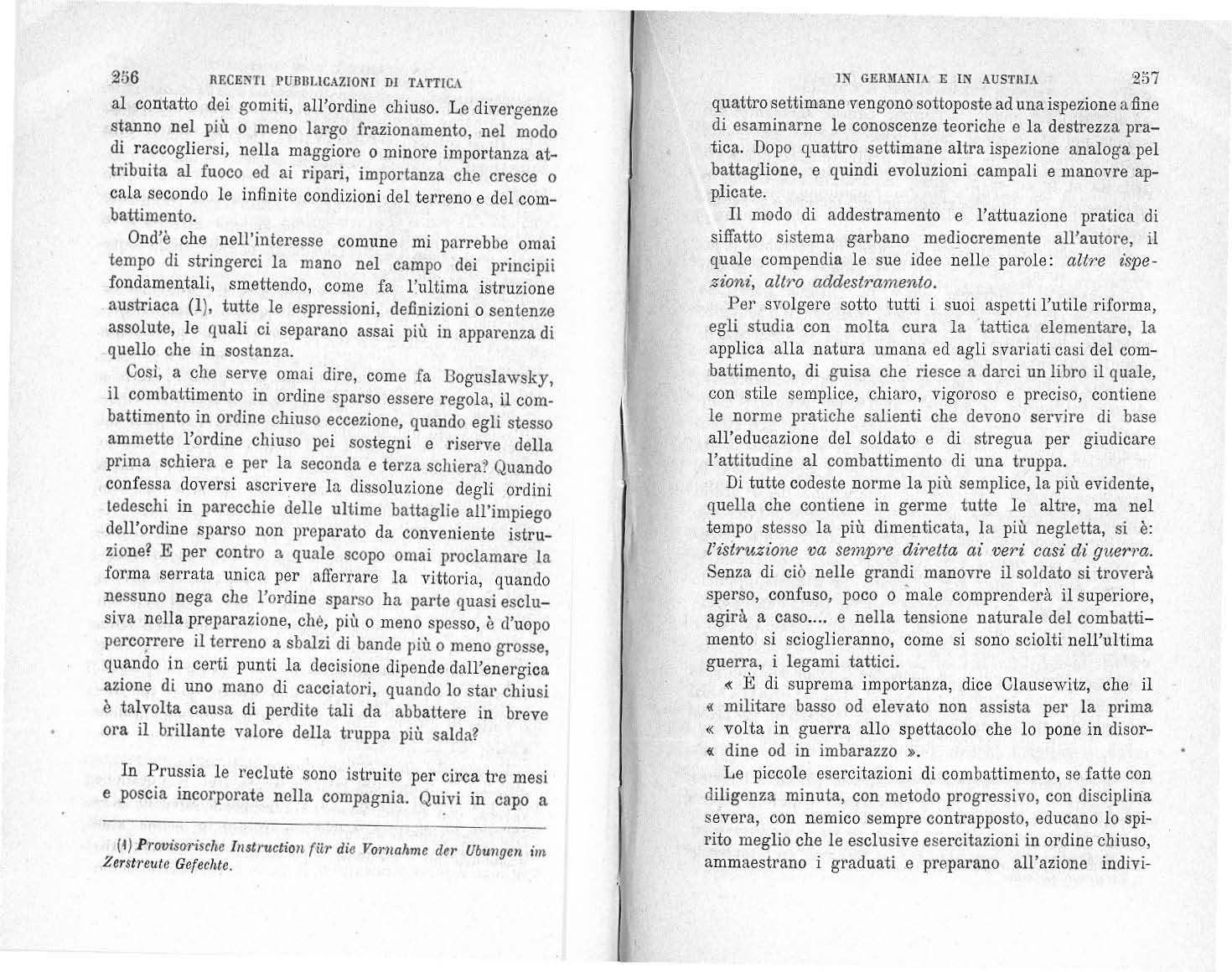
Per svolgere sotto tutti i suoi aspetti l'utile riforma, egli studia con molta cura la tattica elementare, la applica alla natura umana ed agli svariati casi del combattimento, di guisa che riesce a darci un libro il quale, con stile semplice, chiaro, vigoroso e preciso, cont iene le norme pratiche salienti che devono servire di base all'educazione del soldato e di stregua per giudicare l'attitudine al combattimento di una truppa.
Di tutte codeste norme la più semplice, la più evidente, quella che contiene in germe tutte le altre, ma nel tempo stess o la più dimenticata, la più negletta, si è: l''istruzio ne va sempre diretta ai veri casi di guer·ra. Senza di ciò nelle grandi manovre il soldato si troverà sperso, confuso, poco o Ìnale comprenderà il superiore, agirà a caso.... e nella tensione naturale del combattimento si sciogli eranno, come si so no sciolti nell'ultima guerra, i legami tattici .
« È di supre ma importan za, dice Clausewitz, che · il militare basso od elevato non assista per la prima « volta in guerra allo spetta colo che lo pone in disor« dine od in imbarazzo ».
Le piccole esercitazioni di combattimento, se fatt e con diligenza minuta, con metodo progressivo, con disciplina severa, con n.emico sem pre contrapposto, educano lo spirito meglio che le esclusive esercitazioni in ordine chiuso, ammaestrano i graduati e preparano all'azione indivi-
256
r.
P·rovisoriscl1e Instruction fiir die Vornahme der Ubungen im Zerstreut e Gefechte.
RECENTI l>UBJJLlCAUONI
Dl TAT'rICA
duale collegata dall'accordo di atti e di mosse indispensabile perchè non ne sorga confusione.
.Attualmente troppo differiscono le manovre campali ·dall'istruzione elementare. E necessario togliere il salto, riempire la lacuna coll'applicare scrupolosamente i principii che infqrmano i regolamenti ufficiali e col dimenticare le tradizioni di un tempo che fu.
Nell'istruzione elementare si sprecano settimane collo scomporre il passo in , guisa superfi.ua e noiosa, col dividere la carica in tempi, col badare soltanto alle mosse e contegno materiali; coll'innestare idee che poscia a fatica conviene sradicare. S'insegni alla recluta fino dal primo giorno il contegno del cacciatore, si progredisca dal semplice al concreto, la si ponga sempre di fronte ad un avversario effettivamente rappresentato, si profitti della sua innata accortezza per tutte le as t uzie di guerra in maniera da tener sempre vivo l'interesse, sempre desta l'atte nzione, sempre evidente lo scopo. Ad accrescere coraggio, energia, spirito di iniziativa, fiducia in sè, robustezza, mirabil mente servono la ginnastica e la scherma. Bensì la prima va fatta con sobrietà e semplicità; la seconda non deve consistere in col pi lanciati all'aria per un anno intero, ma nella viva rappresentazione della lotta.
Scherff raccomanda di consacrar, molto tempo alle grandi manovre, Boguslawsky pr eferisce minutissimo addestramento individuale; Scherff pensa più all'istruzione degli ufficiali e dei generali, Boguslawsky più a ll'educazione del soldato e del graduato; il primo ragiona da ufficiale di stato maggiore, colla grande tattica alla mano, il secondo da capitano che ha fatto la guerra qual comandante di compagnia. Del resto l'accordo fra loro è ben facile; si dia molto tempo e maggior cura ai principii fondamental i, e si prolunghino di qualche giorno le grandi manovre a spese di occupazioni meno importanti e meno guerresche .
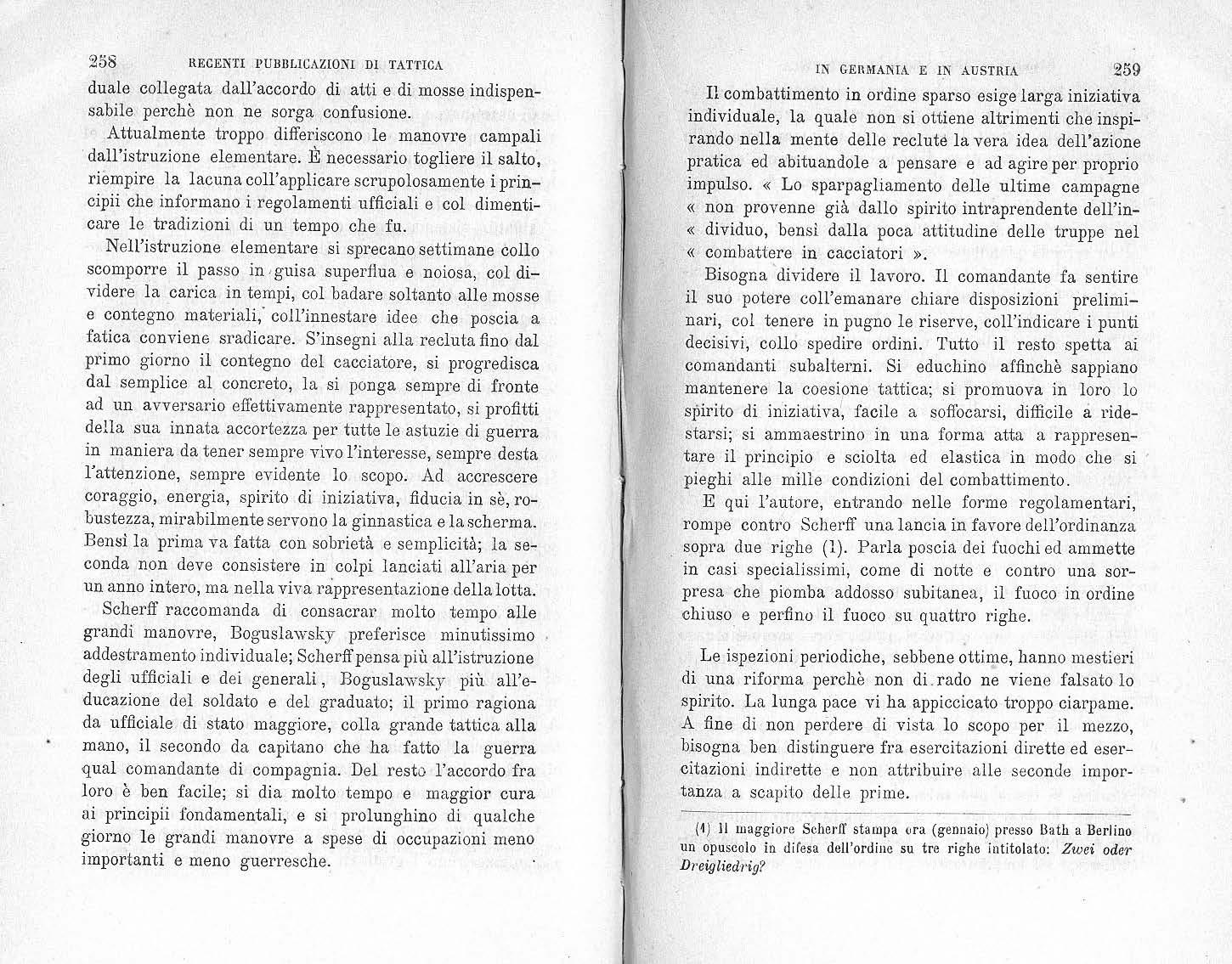
IN GERMANIA E IN AUSTRfA 259
Il combattimento in ordine sparso esige larga iniziativa individuale, la quale non si ottiene altrimenti che inspirando nella mente delle reclute la vera idea dell'azione pratica ed abituandole a pensare e ad agire per proprio impulso. « Lo sparpagliamento delle ultime campagne « non provenne già dallo spirito intraprendente dell'in« dividuo, bensì dalla poca attitud ine delle truppe nel « combatte re in cacciatori ».
Bisogna dividere il lavoro. Il comandante fa sentire il suo potere coll'emanare chiare disposizioni preliminari, col tenere in pugno le riserv e, coll'indicare i punti decisivi, collo spedire ordini. Tutto il resto spetta ai comandanti subalterni. Si educhino affinchè sappiano mantenere la coesione t attica; si promuova in loro lo spirito di iniziat iva', facile a soffocarsi, difficile à ridestarsi; si ammaestrino in una forma atta a rappresentare il principio e sciolta ed elastica in modo che si pieghi alle mille condizioni del combattimento.
E qui l'autore, ehtrando nelle forme regolam entari, rompe contro Scherff una lancia i n favore dell'ord inanza sopra due righ e (1). Parla poscia dei fuochi ed ammette in casi special issimi, come di notte e contro una sorpresa che piomba addosso subitanea, il fuoco in ordine chiuso _ e perfino il fuoco su quattro righe .
Le ispezioni pe rio diche, sebbene ottime, hanno mestieri di una riforma perchè non di . rado ne viene falsato lo spirito. La lunga pace vi ha appiccicato troppo ciarpame. A fine di non perdere di v ista lo scopo per il mezzo, bisogna ben dis tinguere fra esercitazioni dirette ed esercitazioni indirette e non attribuire alle seconde importanza a scapito delle pr ime.
(1 } Il maggiore Scherlf stampa ùra (gennaio) presso llath a Berlino un opuscolo in diCesa dell'ord iuc su tre righe intitolato: Zwei oder 1Jreigliedrig?
258
------·----- --·-···-----
..
RECENTI PUJJBLlCAZIONI DI TATTICA
Come hanno luogo le ispezioni in Prussia? « Le re..« clute sono disposte a righe aperte. L'ispetto re osserva « i l contegno di ciascuna ed ordina il manegg io delle « armi; segue lo sfilare per uno ~d il serrare le righe. « L'ufficiale che ha diretto l'istruzione fa esecruire O « di nuovo il maneggio d'armi, le conversioni ed al« c~ni movimenti di marcia. S.i forma poscia la catena « su terreno pia.no per esaminare se gli uomini com« prendono i segnali, ed infine, quando si è molto esi« genti, ha luogo un attacco in ordine sparso e la for« mazione dei gruppi ».
Tutto ciò .è uti le, ma non basta. Di maggiore rilievo sono il tiro al bersaglio, le mosse ed evoluzioni in terreno coperto di ostacoli, l'uso e disciplina del fuoco, gli sbalzi avant i, il profitto dei ripari, la raccolta. Eppure malgrado l a lettera e lo spirito degli ottimi regolamenti, pochi pensano ad esaminare la destrezza del soldato nei veri atti del combattimento, ed è perciò che gli ufficiali li trascurano e che i soldati si avvezzano a considerarli come cosa secondaria; per t al guisa si perpetua la vecchia i struzione, buona per la tattica lineare dell'epoca scorsa, che fu .
È innegabile tuttavia che ie ispezioni periodiche, quando fatte con in t elligenza, energia, scopo chiaro e definito, prod ucono Qttimi risultati. Forse sarebbe il caso di adottarle anche nell'esercito nostro . Il regolamento del 1869 prescrive per le reclute un esperimento ne ll'istruzione individuale e di plotone e nella scuol a di puntamento, il tutto appreso piuttosto frettolosamente nei quaranta giorni assegnati all'intero periodo. Abbiamo veduto come in Prussia il periodo abbracci tre mesi. In Austria si crede generalmente che non ba::;tino otto settimane. È vero che l e reclu te nostre continuano poscia .ad apprendere assieme ai soldati anziani, il che contribuisce ad amalgamarle più presto con qu:esti; ma è
IN GERMANIA E IN AUSTRIA 26 11 vero alt,resì che un metodo logico, costante, progressivo e comp~eto di ammaestramento meglio varrebbe a pr.epara;e 11 . terreu~ per l'ulteriore educazione (1 ).
L 1spez10ne po1 della compagnia e del b attaglione, oltre a destare l'amor proprio e la gara fra i rispettivi co~~ndan~i, favorirebbe altamente i principii di responsabilità, d1 autorevolezza e di au t onomia, i quali non vanno mai disgiunti, ma si correggono e si completano a vicenda.
Non è facil cosa (prosegue Boguslawsky} educare armonicamente l e facoltà morali, intellettuali e fisiche del soldato . Bisogna che gli ufficiali v i consacrino tutta la loro '.'3olle_citudine, bisogna che i l tempo si a saggia~ me ~t~ ripartito, cl}.e le ispezioni siano severe. I principii tatt1c1 non })Ossono essere insegnati dai sott'ufficiali la cui classe va ogni dì più scemando di valor~ e di ;restigio. Ai sott'ufficiali spetta l a pa rte materiale, il ma-. neggio d'armi, l'istruzione sugli onori, sulle competenze, sull'ordinamento dell'esercito, sul servizio di guardi a, ecc.
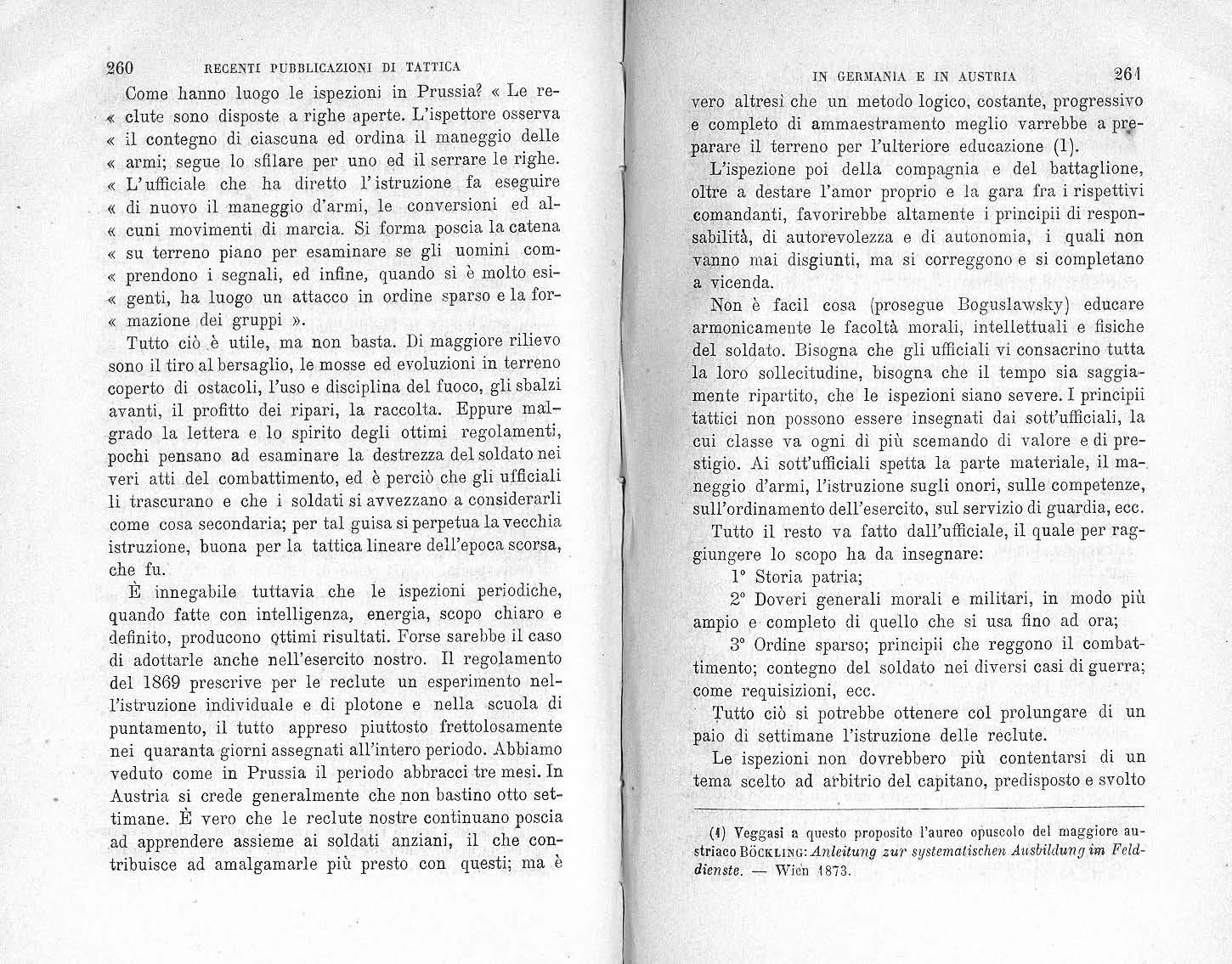
. Tutto il resto va fatto dall'ufficiale, il quale per raggiungere lo scopo ha da insegnare:
1° Storia patria;
2° Doveri generali ~orali e mi litari, in modo più ampio e completo di quello che si usa fino a d ora;
3° Ordine sparso; principii che reggono il combattimento; contegno del soldato nei diversi casi di cruerra· t) , come requisizioni, ecc .
!utt_o ciò si potre bbe ottenere col prolungare di un pa10 d1 settimane l'istruzione delle reclute.
Le ispezioni non dovrebbero più contentarsi di un tema scelto ad arbitrio del capitano, predisposto e svolto ~4) Vc~gasi a questo propos ito l'aureo opuscolo de l maggiore a11st~1 aco BoCKLIN~: Anleitung zur systenwtischen Ausbilclttrig im Feldd1enste. - Wicn ,1873.
.260
l
RECENTl PUil13LI.CAZI0NI or TATTICA
all'unico scopo di far vedere ordine inappuntabile, b&lla ~pparenza, evoluzioni teatrali. Solo col prescrivere il tema, col vederlo applicato in terreno man mano variato, si può formarsi un criterio della sicurezza della truppa e dell'abilità dei capi.
Nell'accennare a i punti salienti cui dovrebbe rivolgersi l'attenzione dell'ispettore, Boguslawsky si stende nel campo a lui tanto caro della tattica app lica ta e tocca con assai disinvoltura i difetti che generalmente si osservano nelle manovre prussiane. Così osserva che i comandanti dei sostegni spesso e volentieri storpiano ed abbreviano i comandi; che al quadrato si ricorre troppo sove nti offrendo non di rado lo spettacolo poco edificante e poco naturale di ritirarlo app'ena formato; che non si presta abbastanza attenzione al punt amento, alle distanze, alla raz ionale direz ione del plotone, il quale ' nel combattimento a bande, in terreno scoperto o frastagliato, negli sbalzi avanti od in ritirata, nella raccolta o nella disp ersione , ha assunto un'importanza essenzialissima.
E continuando ammette il fuoco marciando ed il fuoco simultaneo; consiglia combatt iment i notturni e proseguimento di piccole esercitazioni campali anche nel cuore dell'inverno, abitudine a framm ischiarsi ed a passare sotio gli ordini di altri superiori, distinzione marcata fra offensiva e difensiva; la prima caratterizzata anche al sempl ice soldato dall'avanzare a sbalzi fino all'ultimo slancio decisivo, dall'idea chfl col volgersi indietro si entra nel dominio della morte; la seconda dal fuoco a breve distanza, dal tirare da appostamenti o dalla posizione di a-tm·ra e dal cont r attacco .
In tanto progresso di idee e di forme tattiche, sorprende come l'autore ammetta solo lo sbalzo di plotoni e di mezzi plotoni , eccezionalmente lo sbalzo di squadriglie, mai quello di gruppi inferiori. Eppure potr-à soventi accadere, specialmente nelle piccole fazioni, o
nel lungo avvicendarsi di una lotta, çhe un riparto non trovi altro compenso per raccogliersi avanti, indietro o lateralmente di quello che gli offre lo strisciare od il balzare successivo di alcuni uomini verso un punto di raccolta, verso un riparo . Si p ensi . alle frequenti zone tempestate da fuoco vivissimo di un campo di battaO'lia ai mille bisogni di guadagnare inosservati terreno: ai cento casi di sorpresa possibili solo a chi strisciando carponi sa giungere inopinato contro un fianco nemi~o, al successo ottenuto da tale spediente in parecchi fatti d'armi dell'ultima guerra, alla non grave difficoltà di applica rlo e di sorvegliarl o. Da codeste considerazioni senza dubbio prese le mosse la Commissione austriaca, la quale. do po accmati esperimenti al campo di Bruck nella recentissima istruzione provvisoria attribuisce importanza singolare agli sbalzi di file, di quadriglie, di squadriglie, ecc. .
Il fuoco marc iando mi sembra pericol oso e forse impo~sibile alle brevi distanze stabili te dall' autore, il quale qui ed altrove si dichiara contrario aq incominciarlo a d oltre. 400 passi, dovendosi coll'arma a tiro più celere risparmiare cartuccie pel mome:nto dell'efficacia maggiore. La proposta, con tanta autorità e vigore sostenuta da Boguslawsky, di mescolare nelle manovre i battaglioni allo _ sc~po di offrire un quadro più vivo de ll a guerra e d1 ab1.tuare soldati e graduati a mettersi subito agli ordmi d1 un superiore qualunq1,1e, è suggerita da molti, ~a. praticamente usata da pochi. Infatti sorge spontaneo il timore che l'abito al soverchio disordine non faccia che accrescer)o, che il soldato nella lotta contro l'istinto animale di conservazione ne profitti per .sottrarsi al proprio dovere, che più lenta e diffi.cile riesca la ricostituzione dell'ordinanza tattica quando egli consideri il mescolamento in certo modo regolamentare, che meno efficace si eserciti il comando, quando di troppo si al-

262
j IN GEllMANIA E JN AUSTRIA 263
larghi. Con ciò non si vuole g ià in firmare il dovere assoluto che inco mbe agli individui isolati, ai gruppi, o riparti che trovinsi sottr atti dai loro natu r a li superiori di porsi agli ordini di superiori d'altri corpi e di . altre armi; ma codestq dovere si può imprimere anche senza costituire a bella posta sui campi di manovra masse informi, le quali per quanti sieno gli artifìzi impiegati, troppo di l eggieri fraintese, annebbiano la mente del soldato. Fino ad ora nessun esercito, non escluso il prussiano, ha adottato il frammischiamento artificiale ne~le manovre. Eppure in Germania scrivono i più caldi suoi fautori; eppure nelle :file tedesche si trovano in copia le v irtù che meglio servirebbero a dirigerlo e regolarlo, come esperienza, saldezza, calma, profondo sentimento di dovere, di onore e di obbedienza, spirito di fratellanza e di amore pel successo comune.
L'opuscolo finisce col consigliare: ammaestramento tattico speciale pei sott'ufficiali, frequent i eserci tazio ni di tiro al bersaglio combinate- cogli atti e mosse di cacciatori, servizio di pattuglia e di avamposti i nsegnato con maggior d iligenza e severità, assidua cura nel formare in ciascuna compagnia sol dati capi~pattuglie, diminuzione del penoso servizio di guardia nei presidii.. Sebbene frequenti vi si trovino le ripetizioni e senza benefizio d'inventario non convenga accettare ogni sentenza, pure il libro merita tutta la considerazione dei militari studiosi , perchè frutto di numerose esperienze fatte sui campi di battaglia e di manovra, so~toposte a critica: vasta, intelligente, colta, spassionata e ~evera, e condensate con diligèntissimo studio a vantaggio del1'esercito tedesco e ad incremento dell'arte militare.
A.usbildung eines lnfa11derie. B ataillo n s i m F elddienst (Ammaestramento di un battaglione di fanteria nel servizio di campagna) ; compilato in seg1:1ito alle nuove esperienze di guerra da H. voN BELow, luogotenente co lonnello e comandante di battaglione nel reggimento fucilieri dell'Assia N. 80 - Berlino, Mittler 4873.

Uno fra i più ardui problemi della tattica odierna della fanteria si è quello di limitare l'inevitabile frammischi-amento, di prev enire il d1sordine che ne suol nascere, di valersi di masse anche informi per decidere l'azione.
I mezzi suggeriti .' dai principali scrittori per ottenerne la soluzione possono ridursi ai due seguenti:
1° Esercizio di mescolamento nelle manovre di pace;
2° Accuratissima istruzione, ferma disciplina, largo sviluppo di facoltà individuali.
Il primo mezzo sorprende ed attrae per la sua novità ed al'dimento, per l'autorevolezza di chi lo sost iene e per l'apparente suo basarsi sopra i veri principii di guerra, sulle espe rienze recenti e sulla natura umana. Ma per l e ragioni accennate in sulla fine del precedente articolo sembra che le :file dei suoi fautor i vadino diradandosi, mentre invece nessuno pone in dubbio la potenza della salda educazione i ndividuale.
Uno dei modi più efficaci a promuoverla è, non v'ha dubbio, l'ammaestramento nel servizio da campo, il quale desta tutte le virtù morali ~d intellettuali latenti nei soldati e nei graduati ed educa: in loro lo spirito d'iniziativa, la coscienza del proprio dovere, la fiducia, il• coragg.io, il nobile orgoglio di provvedere alla sicurezza camune.
Ad uno scopo così nobile e così utile consacra ogni
264
RECENTI PUBBLICAZIONI DI TATTICA
I IN GERMA NIA E IN AUSTR I A
VII.
P UTIDUCAZIONI DI TATTICA
sollecitudine il tenente colonnello BELOW, tracciando un sistema di istruzione campale il quale dalla squadriglia va man mano allargandosi fino al battagl ione. « I mpri« mere confidenza nelle masse ondeggianti sul campo < di battaglia, senza rinunziare ad un ette della antica e salda disciplina prussiana, ecco la meta della via se« gnata in questi fogli » I suggerimenti sono anzitutto pratici, la ripartizione del lavoro razionale; lo stile facile e chiaro; brevi esem pi scelti specialmente dall'ultima guerra, avvalorano il ragionamento ed accrescono l'interesse; pratici temi di pi ccole esercitazioni campali servono di guida utilissima nella del icata missione di formare soldati .

L'anno militare incomincia in Prussia coll'arrivo delle reclute ai primi di ottobre. Fa duopo in ciascuna compagnia preparare anzitutto da 9 a 12 capi-pattuglia in sostituzione di quelli che furono congedati. L'istruzione richiede poco tempo e pochi uomini 'venendo poscia completata nelle esercitazioni ulteriori.
Col novembre devesi già aver intrapreso l'addestramento delle reclute al combattimento. Non può darsi perciò miglior stagione dell'inverno, perchè i campi coperti di neve gelata permettono dì girare in tutti i sensi, del resto un'ora di rapide mosse in una temperatura da 5 a 15 gradi di freddo non può servire che ad ut ile e sano diversivo delle noiose .istruzioni interne.
I due partiti vanno sempre rappresentat i. In sulle prime l e reclute assistono soltanto, poscia fanno da sè, infine sono mescolate con soldati provetti.
Si ammaestrino subito all'offensiva dando loro l'inearico di attaccare; solo più tardi, quando l'idea offensiva sia penetrata in loro, e ne abbia invigorito lo slancio e l'iniziativa, si addestrino nella difensiva retrocedente di posizione in posizione e poscia nella difensi va pura.
lN GERMANIA E IN _AUS TRIA ~67
La direzione di codeste esercitazioni compete escl usivamente agli ufficiali. Essa ha da guardare: all'agile procedere sia per sbalzi sia col valersi di ripari; al profitto del momento -opportuno pel fuoco rapido o lento; al pronto serrarsi intorno al capo; alle salve, ai brevi accerchiamenti, agli att acchi della linea dei cacciatori, alla lesta raccolta; all'inseguimento col fuoco .... il tutto eseguito ad un cenno o comando. Bastano 16 lezioni a svolgere il programma, giacchè in nessuna occupazione il soldato si mostra così sol.erte, intelligente e volonteroso.
Il desiderio di promuovere lo spirito offensivo conduce l'autore fino a sbandire qualsiasi esercitazione elementare nella quale si :rappresenti un attacco respinto.
Eppure sembra indispe nsabi le avvezzare la recluta a vedere in faccia anche questo abbastanza frequente caso di guerra, a non considerarlo come una catastrofe, a trovare i mezzi per resistere , rinfrancarsi, tornare alla carica, senza di che il suo spirito offensivo serve soltanto ad esaltarne le i mpressioni ed a preparare la strada al timor pan ico, il peggiore e più frequente nemico delle giovani truppe.
L'istruzione delle reclute va completata dall'esercizio di marcia, da prima a zaini vuoti, poscia a zaini pieni rigo rosam ente visitati alla sosta. In Prussia si marcia in colonna di sezioni sopra due o sopra tre righe e di fianco per due o per tre; il primo sistema .ingombra le strade ed esige scrupoloso mantenimento delle distanze; il secondo allunga di soverchio la colonna e richiede sfo rzo continuo a serrare verso la testa. Invece il per quattr o nostro ed austriaco evit a siffatti inconvenienti, e ci dispensa dal far ogget to di istruzione speciale le marcie, il cui esercizio viene appreso dalle reclute più tardo tnsieme ai soldati anziani.
La cura posta nel primo addestra mento rende facili
~66
RECENTI
ANNO XIX, VOL. I.
RECENTI PUBDUCAZIONl DI TATTiCA
le piccole fazioni di guerra della compagni~; le ~uali devono sem pre prefiggersi a scopo la soluzione d1 un tema semplice, chiaro, definito, adattato al terreno ed alle piccole forze. L' attacco e la difesa di una casa, dèll'ingresso ad un villaggio, di un ponte, d'un saliente boscoso ecc . offrono svariati te mi per le 6 od 8 esercitazioni che sogliono precedere l'isp ezione del battaglione . In generale due plotoni muovono in c~cciatori, il terzo rimane in pugno del comandante. S1 sfugga ogni complicato artinzio, ogni form a da spetta~o lo; si rintuzzi severamente qualsivoglia trascuratezza; il tuono del comando imprima l'energia dell'obbedienza.
Non si usi il segnal e di tromba che in rarissimi casi, e per solito soltanto ad indicare l'accostarsi del_la_ ca~ valleria; vi si sostituisca sempre, quando è poss1b1le, 1 cenni od il fischio. Quante volte il segnale dato per un riparto fu eseguito an che da un aH1·0! Quante volte gli ufficia-li alJituati dalla piazza d'armi all'immediata obbedienza, si lanciarono avanti in momento inopportuno es ponendo cosi ad enormi perdite i riparti loro? .
Si consumi nelle esercitazio ni buon numero d1 cartuccie . I 50 colpi per uomo e per a nno non so no sufficienti.
Si profitti della marcia al nemico pel servizio di avanguardia, di pattuglie, di protezione nelle fermate; si termi ni sempre col coprirsi di avamposti.
Altri 10 o 12 temi eseguiti da compagnie contro compagnie sulla scorta di questi principii e degli es empi pratici che fanno loro corona, completano l'addestramento e bastano a dar e ai soldati e graduati _quella sicurezza che col metodo attuale pur troppo non si raggiunge.
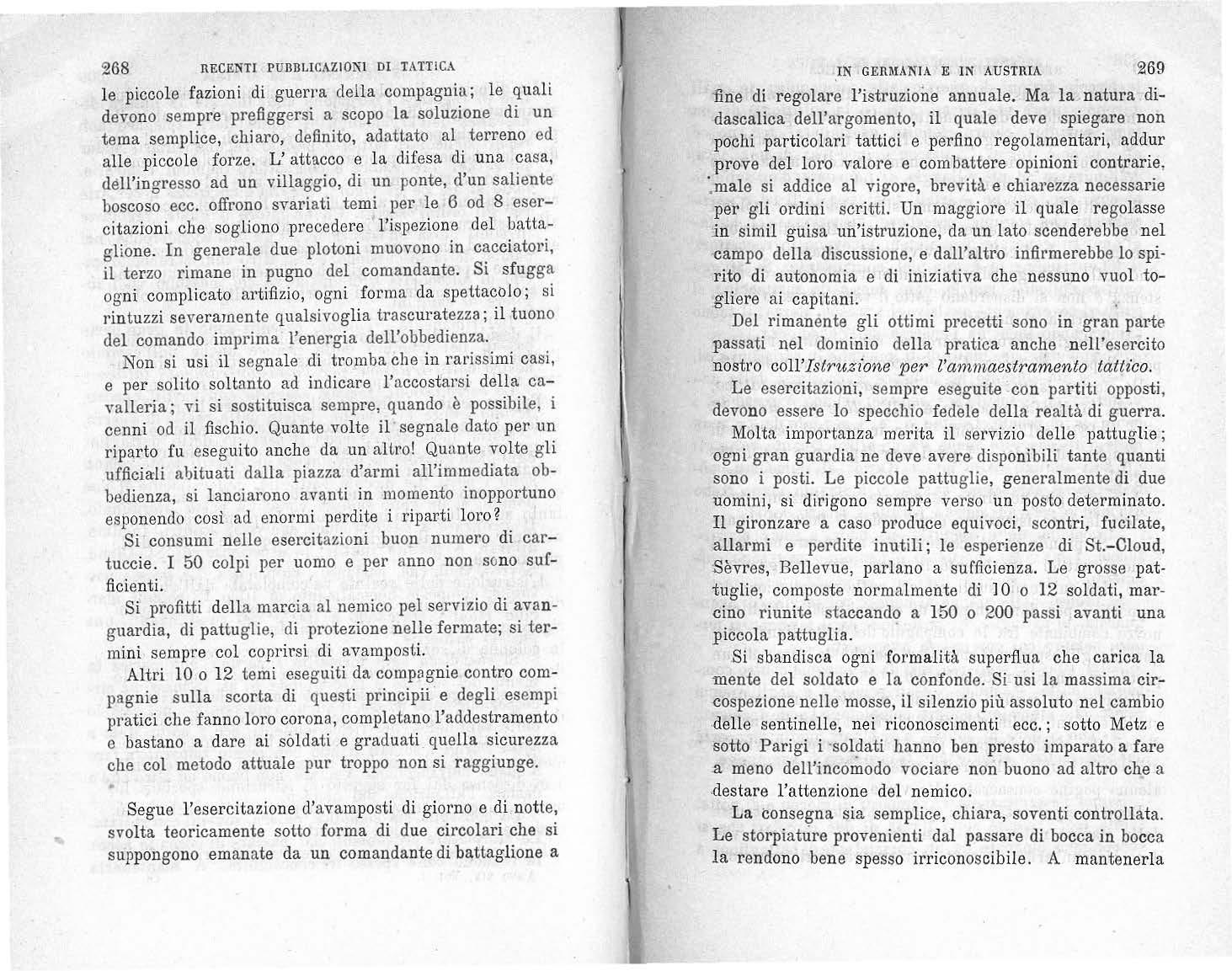
Segue l'esercitazione d' ava mposti di giorno e di notte, svolta teoricamente sotto forma di due circolari che si sup pongono emanate da un comandante di batta glione a
iìne di regolare l'istruzione annuale. Ma la natura didascalica dell'argomento, il quale deve spiegare non poc hi particolari tattici e perfino regolamentari, addur prove de l l oro valore e combattere opinioni contrarie, · . male si addice al vigore, brevità e chiarezza necessarie per gli ordini scritti. Un maggiore il qual e regolasse in simil guisa un'istruzione, da un lato scenderebbe n el ·cam po della discussione, e dall'altro infirmerebbe lo spirito di autonomia e di iniziativa che nessu no vuol togliere ai capitani.
Del rimanente gli ottimi precetti sono in gran parte pass ati nel domin io de lla pratica anche nell'esercito nostro coll'Istruzione per l'ammaestramento tattt"co .
L e esercitazion i, sempre eseguite con partiti opposti, devono essere lo specchio fe dele della realtà dì guerra.
Molta im portanza merita il se rvizio delle p attuglie ; ogni gra n guardia ne deve avere disponibili tante quanti sono i posti. Le piccole pattuglie, generalmente di due uomini, si dirigono sempre verso un posto determinato. Il gironzare a caso produce equivoci, scontri, fucilate, allarmi e perdite inutili; le esperienze di St.-Cloud, :Sèvres, Bellevue, parlano a sufficienza. Le grosse pattugli e, composte norm almente di l O o 12 soldati, marcino riunite staccando a 150 o 200 passi avanti una p iccola pattuglia.
.S i sba ndi sca og ni formalità superflua che carica la mente del soldato e la confonde. Si usi la massima circospezione nelle mosse, il silenzio più assoluto nel cambio -delle se ntin elle, nei ricon oscimenti ecc . ; sotto Metz e sotto Parigi i ·soldati hanno ben presto imparato a fare .a meno dell'inco~odo vocia re non buono ad altro che a ,destare l'attenzione del nemico.
La consegna sia semplice, chiara, soventi controllata. Le storpiatùre provenienti dal passare di bocca in bocca la rendono bene spesso irriconoscibile. A man tene rla
268
IN GERMANIA E IN AUSTRIA 2 69
IlECENTI PUBBLICAZIONI DI TATTICA
invariata serve assai dare il cambio al posto ·mediante la muta condotta direttamente dalla gran guardia e sempre dallo stesso graduato. Non di rado in campagna è impossibile o pericolòso il camminare colla muta lungo la catena delle sentinelle.
Si profitti del servizio di a"\'amposti per addestrar i sol dati a coprirsi artificialmente ed a valersi della fortificazione passeggiera. I piccoli posti vivamente attaccati si ritirino sulle gran guardie per concentrarvi fo.rza di resistenz~ e non si disperdano sotto il vano pretesto di celare la strada al nemico.
Le pattuglie devono marciare senza zaino, i piccoli posti . deporlo al pi.ede. Ciò si accorda col numero 129 della nostra Istruzione per l'mnmaestrarnento tattico; ma sta in diretta opposizione coll'o rdine prussiano 17 giugno 1870 sull'istruzione delle truppe pel servizio di campagna che dice: « I posti non depongono mai il ba« gaglio. »
A mezzo giugno, finite le minute esercitazioni, incomincia la v era istruzione degli ufficiali fatia dal maggiore. Si prende quest'occasione .per accennare ad alcuni principii tattici attual mente in voga, per svolgere alcune idee sui temi, sugli schizzi, sulla compil azione dei rapporti e per dare u n paio di esempi assai utili di manovre combinate fra le compagnie del battaglione, suggerendo gli espedienti necessari perchè la forza di un partito rimanga ignota all'altro .
Vengono in seguito le grandi manovre autunnali, le quali, sebb ene ordinariamente si ri~uc ano ad evoluzioni di brigata contro brigata, pure hanno sempre servito di utilissima scuola all'esercito tedesco. ·Notevoli sono le alcune pagine consacrate alle varie armi.
Dopo le esperienze de lla guerra, ampiamente discusse dalla stampa militare, è meno facile di una volta vedere ciascun' arma operante per proprio conto senza cu-
IN GERMANIA E IN AUSTRIA 27 f
rar:si delle armi sorelle. T uttavia non si raccomanda mai abbastanza Ì'intimo collegamento che deve sempre regnare fra loro perchè possano insieme afferrare -il successo tattico.
La cavalleria divisionale t rova di rado occasione nelle mano v re autunnali di esercitarsi in qualc he ·altra cosa che in ricognizioni; ma solo a questo generalmente si riduce il còmpito suo in campagna.
Nella fanteria i gruppi dividono ed impacciano l'azione dall'ufficiale; condotti ordinariamente da graduati poco esperti, tardo e male si soccorrono a vicenda ovvero si disperdono sui primordi del combattimento. E però il sistema va abbandonato ed i sott'ufficiali .vanno considerati quali semplici aiuti degli ufficiali.
La direzione ,delle compagnie e dei singoli battaglioni spetta intera al maggiore ; i l comandante del reggimento non ha da immischiarsene per non perdere d'occhio la direzione generale delle truppe. Guai a chi as sottiglia soverchiamente le sue linee per sinania di manovrare coi sostegni e colle riserve ve rso i fianchi e verso le ali. Regola sarebbe non frammischiare giammai le :file, ma troppo di frequente è impo,ssibile evitar ciò nel combattimento; si addestrino i soldati all'obbedienza assoluta a qualsiasi ufficiale, alla pronta raccolta e ricostituzione dell'ordine tattico .
I cacciatori (Jiiger) non hanno reso nelle ultime guerre i servizi che se ne attendevano, perchè assegnati come 7° battaglione ad una delle brigate di un corpo di esercito, furono ovunque impiegati come fantE:ria (1 ). l\iliglior consiglio sarebbe da rne un paio di compagnie a ciascuna di visio ne affìnchè nelle inani del comandante,
(1) Si rammenti che l'esercito prussiano ha soltanto 14 battaglioni di cacciatori reclutati ed istruiti ad hoc; perciò sbaglierebbe a partito chi pensasse farne il paragone coi nostri ber.:;aglieri.
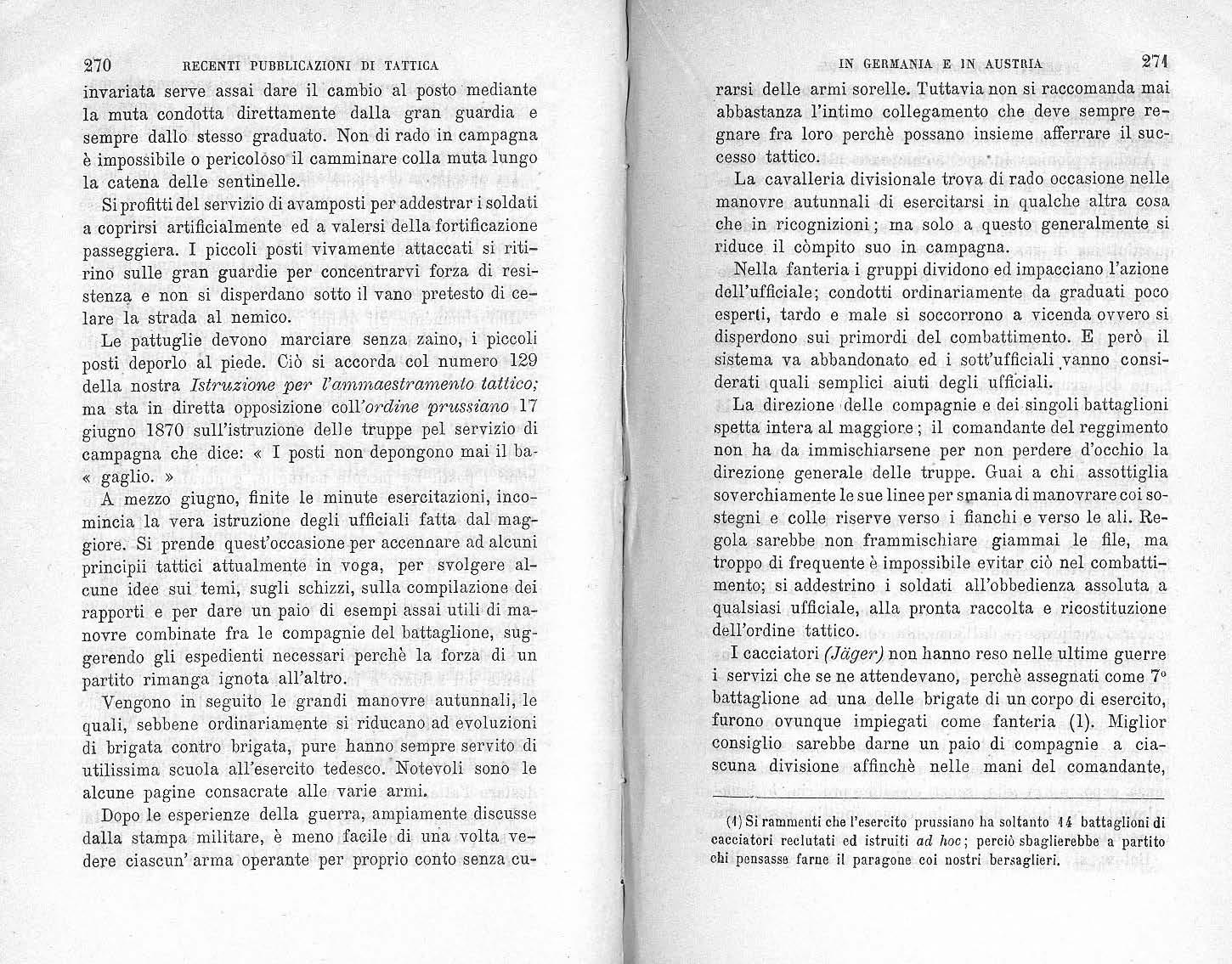
270
/
PUBBLICAZIONI DI TATTICA meglio possano corrispondere alla natura lovo difensiva, ovvero in circostanze favorevoli essere lanciati all'offensiva contro un punto difficile.
Anche i pionieri in ·aperta campagna non hanno fatto gran che per la pochissima abitudine alle manovre tattiche e pel poco collegamento colle altre armi e specialmente colla fanteria. Sarebbe utilissimo provvedere quest'ultima di vanghe leggi~re.
I giudiei di campo mutati ad ogni piè sospinto, non hanno tempo di orientarsi nè di acquistare autorità e profònda conoscenza di tutto il corso delle e·sercitazioni; pertanto sarebbe bene sceglierli permanenti in ciascuna divisione.
Di codeste idee e proposte -pare discutibile e l'aboli~ zione del gruppo, unità di fuoco e di raccolta neWordine sparso, gradino di riunione fra soldato ~d ufficiale nel combatt.imento, ed il frazionamento dei cacciatori, i quali in picco! nucleo . tenuti alla riserva di una divisione, ben di. rado si troveranno in grado qi agire come si conviene.
Omai sa di vieto la dibattutissima questione dell'unità tattica (nella quale i capitani ordinariaménte votano per la compagnia, i maggiori pel battaglione) ora che nessuno nega al battaglione ed alla compagnia autonomia propria dentro e fuori del combattimento, limitata dal soccorso reciproco e dall'armonia comune di atti e di mosse. D'altronde a che tanta apprensione per lo sciogliersi del battaglione nelle sue compagnie quando implicitamente si ammette la loro importanza, e quando il
deve stendersi non solo a loro ma eziandio ·a riparti d'ordine ben inferiore? Lo spediente poi di riunire due compagnie per formarne un'unità senza capo, senza vita, senza coesione propria, è generalmente respinto, non solo come inutile, ma anche come -dannosa.
Below si lagna che la bandiera venga per solito
1N AUSTRIA E IN GERMANIA :273 lasciata indietro sotto la scorta di . pochi uomini. « Non « era infreqaente il caso che la medesima venisse « recata al comandante impensierito all'indomani d'ella « battaglia ». L'inconveniente dipendeva dal capitano il quale preferiva condurre la sua compagnia dove più ferveva la lotta senza preoccupazione per quel segno d'onore. Ma chi vorrebbe fargliene carico considerando l'attual e sparpagliamento · che ne rende sempre più ardua la difesa e minore la pot enza morale, l'uso generalme~te adottato nella guerra del 1866 e più ancora in quella del 1870, ed il gran numero di bandiere prussiane (una per battaglione), da cui ne viene naturalmente scemato il prestigio?
L'istruzione tedrica degli ufficiali lascia a desiderare. Occupati da mane a sera nella educazione dei soldati e nelle moltiplici incomb enze, non hanno poscia nè serenità, nè freschezza di mente, nè tempo sufficiente per dedicarsi a studi severi. Pure non è difficile spronarne l'alacrità, l'amor proprio, lo spirito indagatore, la sete del sapere. Temi in iscritto su questioni tatt iche e tecniche, su ricerche storiche e scientifiche; narrazioni di battaglie; considerazioni sull'incremento o decadenza delle forze militari; monografie sopra eserciti stranieri . .. allargano allettando le idee, e promuovono la coltura. « La coltura soltanto rende libero lo spirito da pre• « giudizi ». L'autore propone ad esempio ben cento di questi temi, tutti pratici, utili, acconci a svariatissimi studi, non ampi tanto da spaziare nell'indefinito, nè . sì ristretti da comprimere il cervello.
Elaborati durante l'inverno, essi verrebbero poscia letti in conferenze, le quali ora son rare e trascurate e per solit9 non si occupano che di questioni di storia contemporanea. In ogni divisione dovrebbero altresì istituir.si, sotto la direzione di ufficiali esperti, viaggi cir-.
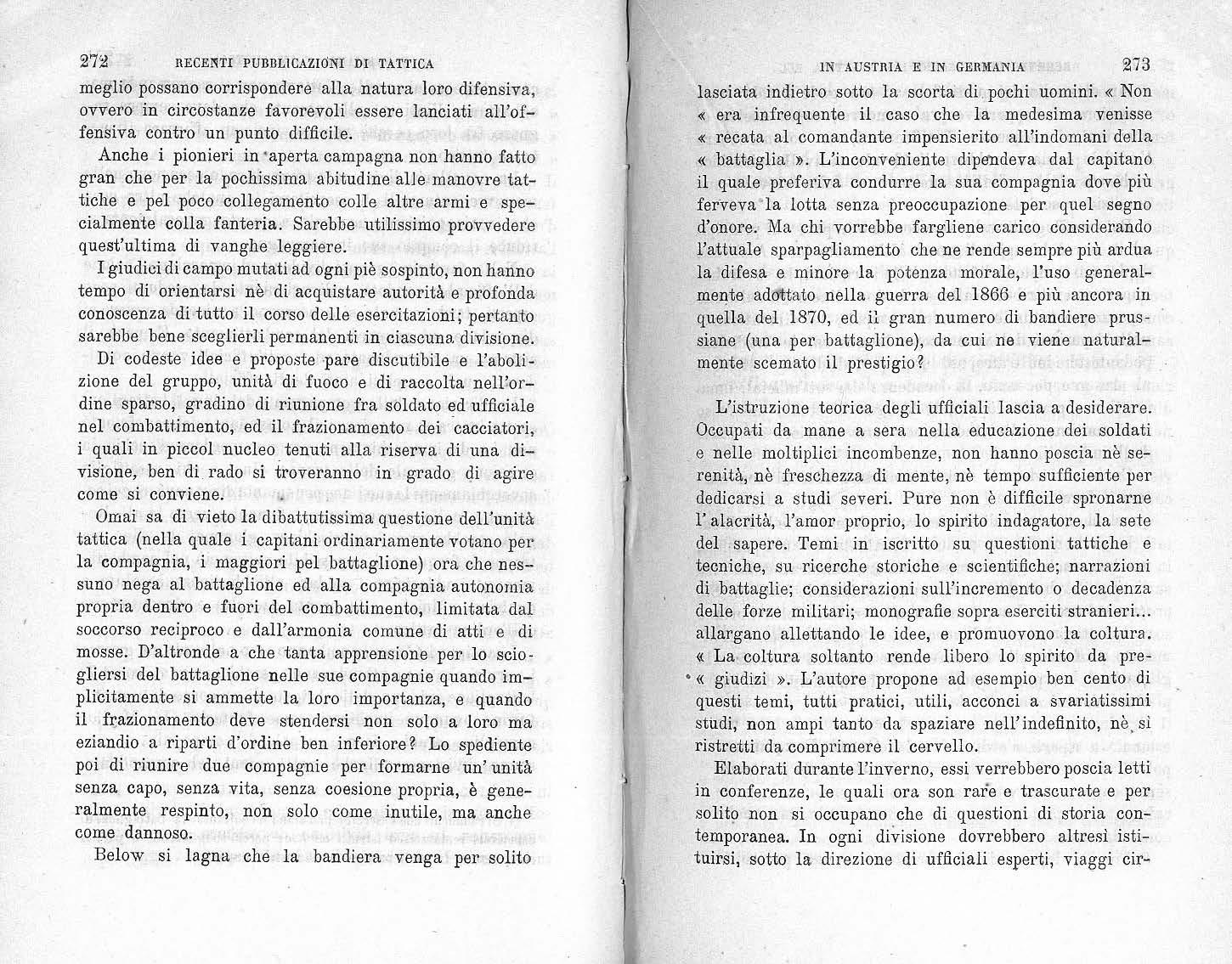
27i RECEl'lTI
fx_:azionamento
/
colari di studio 1ei quali fino ad ora gode il solo stato maggiore. I rapporti sopra manovre, sopra scelta di posizioni, riconoscenze, fortificazioni, ecc. coronerebbero l'edifizio e manterrebbero l'ufficiale al livello scientifico richiesto dalla civiltà moderna e dalla elevata sua condizione sociale.
Below e Boguslawsky si accordano in parecchi principii ed in parecchi appunti mossi all'esercito loro. Ambedue deplorano il metodo difettoso delle istruzioni, la soverchia importanza attribuita alle evoluzioni lineari, il salto che separa queste dalle manovre campali, la dimenticanza nelle ispezioni d~l vero scopo di guerra, le tradizioni pedantesche infiltratesi nel lungo periodo di pace anteriore al presente decennio, la decadenza dei sott'ufilciali ornai inetti a comando dirett o, il bisogno di studio indefesso e di continua sollecitudine pei loro inferiori da parte degli ufficiali.
Come si vede, gl i scrittori militari tedeschi non cullano i loro camerati nel dolce sonno degli allo~i; par quasi che temano di esprimere qua lcuna delle lodi di cui è larga no n solo la nazione innalzata a tanta poteuza, ma ben anche gli eserciti stranieri, ammirati delle loro virtù militari e de lle conseguenti splendide vittorie. .St"c itur ad astra. La potenza non si serba colla boria o colla iattanza, ma col lavoro serio e perseverante, coll'affetto profondo alle istituzioni che formano la foria e la g·loria di un paese e sopratutto col sentimento dell'onore • e del dovere.
RIVISTA BIBLIOGRAFICA
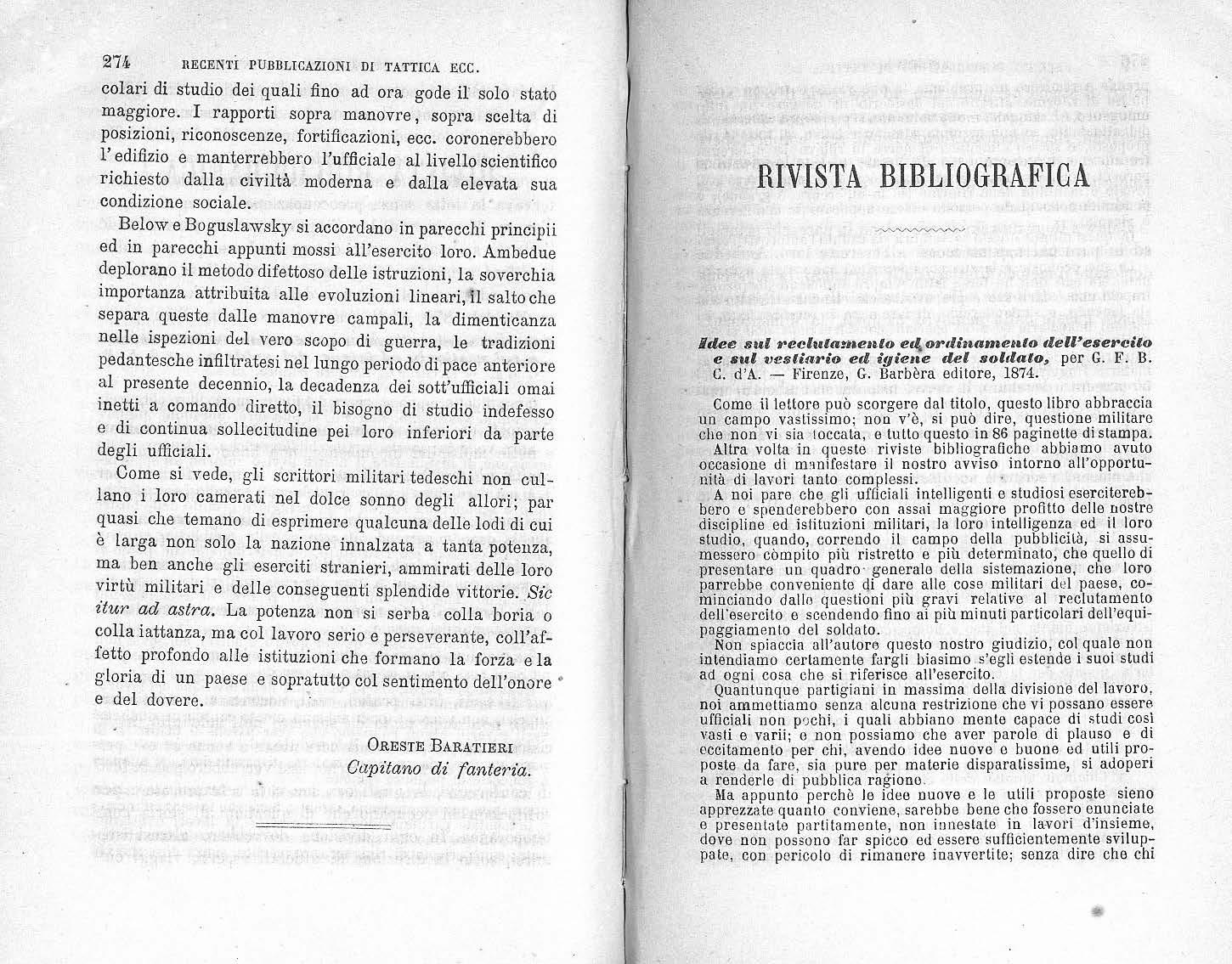
Idee sul t•ecluttunento et( or,linamento delPesercito e sul vestito-io ed igiene del sol,lato, per G. F. B. C. d'A. - Firenze, G Barbèra editore, 1874.
Come iì l ettore può scorgere dal titolo, questo lib.ro abh:~ccia un campo vastissimo; noa v'è, si può_ dire, qt!est1one_ m1htarc che non vi sia toccata, e tutto questo m 86 pagmolle d1 stampa. Allra vo l ta in queste riviste bibliografiche abbiamo avuto occasione di manifestare il nostro avviso intorno all'opportunità di lavori tanto complessi. ·
A noi pare che gli ufficiali intelligenti e slud10s1 eserciterebbero e spenderebbero con assai maggiore pr_ofitlo delle _nostre discipline ed istituzioni militari, la loro rnte lhgen_z~ ed .11 loro studio, quando, correndo il campo della J'.!Ubbltc1là, si assu ~ mossero còmpito pfo ristretto e più d~!termmato, che quello d1 presentare un quadro · general e della sis t~l_lla~ione, che loro parrebbe conve ni e nte cli dare alle cose m1l1tan de l paese, cominciando da llo questioni più ~ra~i relat!ve a.I rec_lutar:1ent_o dell 'esercito e scendendo fino a i p1u mrnut1 particolari dell eqmpaggiamenLo del soldato
Non spiaccia all ' a utore questo nostro g1~dtz10, col. qua l_e no~ intendiamo certamenle farg li biasimo . s'egli estende 1 suoi studi ad ogni cosa che si riferisce all'esercito. . ..
Quantunque pa rtigi ani in massim a _ della d1v1~10ne del lavoro, noi ammettiamo senza alcuna restrmone che vi possano essere ufficiali non p(; chi, i quali abbiano mente capace d i studi cos) vasti e varii; e non possiamo che aver parole d1 plaus?. e d1 eccitamento per chi, avendo idee _nuo.v e o b.uo_ne ed _utili pro: poste da fare, sia pure per materie d1sparat1ss1me, s1 adoperi a renderle di pubb lica ra giono
IMa appunto perchè le idee nuove e l e ulll1 proposte s1~no apprezzate quanto conviene, sa re~b e bene ~ho fosser:o e.~u~c1ate e present ato part itamen te, non 10oestate m_ la·vOl"l d ms1~me, dove non possono far spicco ed esse r e H_uffic1enteme nte sv1lup: pale, con pe ricolo di rimanere i navvert ite; senza d ire che chi
274 UECE NTI PUBBLICAZIONI
DI TATTICA ECC.
ORESTE BARA.TIERI Gapz'tano di fanteria.
prende a risolvere un problema troppo vasto e troppo comple~so di riforme, attratto dal desid e rio <li porgere un tutto omogeneo e raziona le, molto volte non si r.reoccupa abbastanza dell'attuabilità, sll non assoluta, almeno r ela tiva . di tulle le suo proposte, e spesso dimentica di porre in rilìeYO la differ enza fra ciò cbe si propone e ciò che l'sis te; il qual e confronto ci pare di nou lhwe impor tanza, giacr,hè vàle a dimostrarfl o il pregio o la utilità delle riforme (se la differenza ò grande), o la faci lità colla quale possono essere applicate (se la differenza è piccola).
In quest ' ultimo difclt.o ci stmbra sia caduto l'autor e dell'opusco lo di cui facciamo menzione
Le sue proposte e le sue considerazioni sono savie e ra gionate. Ma egli non ha forse fatto sempre sufficiente distinzione fra ciò cho è id ea sua e proposta. e ciò che già si è fatto o si sta facendo, o s'intend ereb be di fare e già si sarebbo fatto, se ragioni finanziarie od a ltre special i considerazioni non si opponessero. '11 che non può tornpre a vantaggio dello id ee che l'au tore intendere bbe far valere, potendo fra tanta varietà di materia sfuggire a:lla mente del lettore in alcuni punti la differenzA fra il vecchio e il nuovo, inducendo la a fa ll aci apprez, zamenti sui pregi del lavoro.
Premesse questo franche dichiarazioni, ci aITr e tliamo di sog~iungere, per debito di giustizia. che ma lg rado la convinzione nn qui enunciata, abbi amo trovato motto da lodare· noi libro di cui parliamo, il qualò è per lo meno una prova manifosta che chi lo ha scritto è un uffic iale intelligf•nte, che studia con profitto , che ha sano criterio, e che conosce perfeltamente l'arte sua.
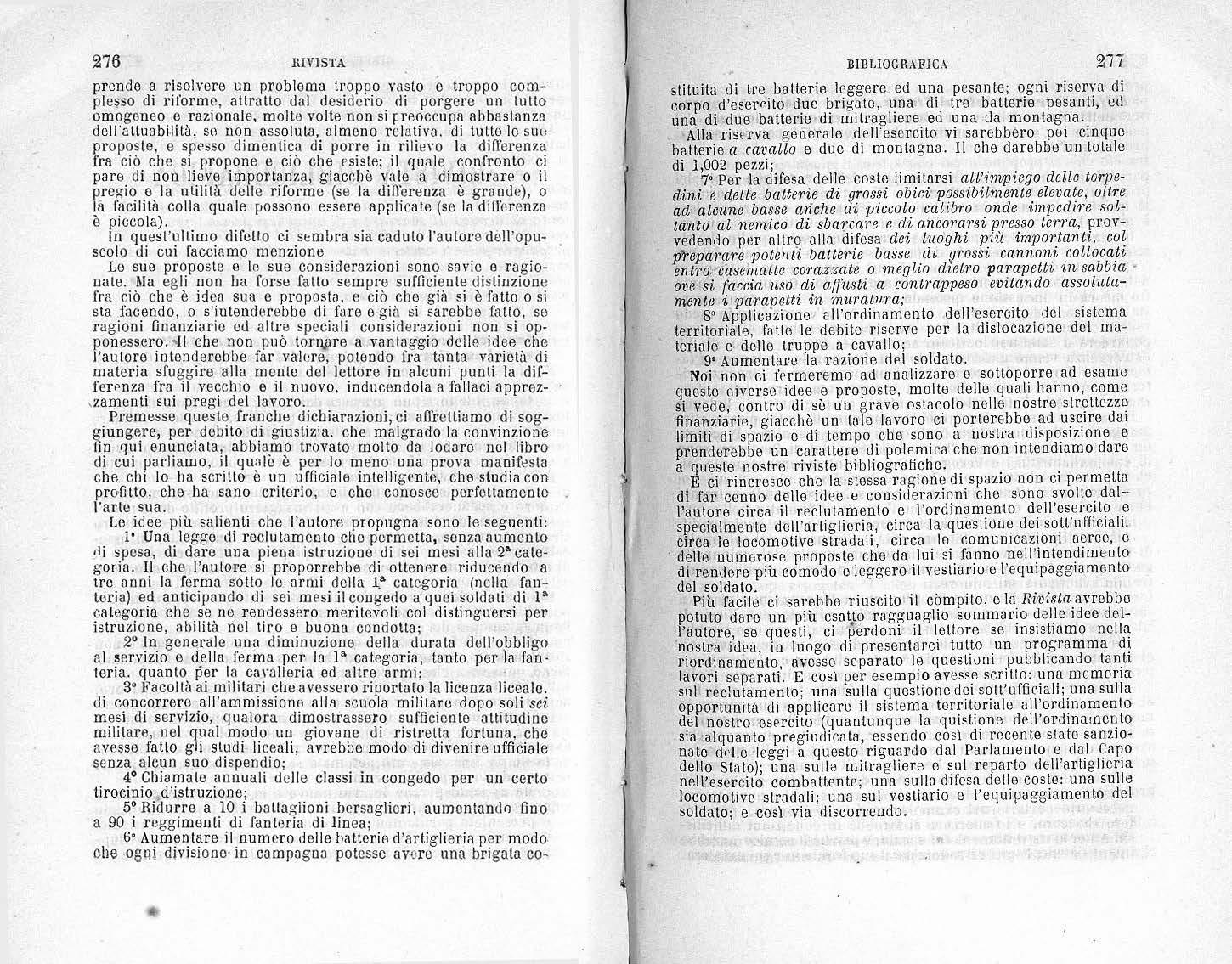
Lo idee più salienti che l'autore propugna sono le seguenti:
l' Una legge di reclutam en to cho permetta, se nza aumento di spesa, di dare una piel'ja is truzion e di sci mesi alla 2.. categoria. li cbe l'autore si proporrebbe di ottenere ri duc en do a tre anni la ferma sotto le armi della l., categoria (nella fanteria) ed anticipando di sei mt>si il congedo a quoi soldati di l" ca tegoria che se ne r endessero meritevo li co l distinguers i per is truzione, 11bi lilà nel tiro e buono condotta;
2° In generale unn diminuzione della durata doll 'o.bbligo a l servizio e della ferma per la l" categoria, ton to per la fan· teria. quanto per la canilleria ed a ltre armi;
3° Facoltà ai mili tari che avessero riportato la licenzn liceale. di conco r rero all'ammissione alla scuo la mililaro dopo soli sei mesi di servizio, qualora dimostrassero sufficiento attitudine militare, nel qual modo un g iovano di ristretta fortuna, che avesse fatto gli studi licea li, avrebbe modo di divenire ufficiale sonza alcun suo dispendio;
4° Chiamalo annuali delle classi in congedo por un cerio tirocinio d'istruziOJle;
5° Ridurre a 10 i batlagiioni bersaglieri, aumentando fino a 90 i reggimenti di fanteria di lin ea;
6• Aumenta r e il num ero delle batterie d'a rtig lieria per modo. che ogui givisione· in campagna potesse av ere una brigata co, 1
BIDLI0GRAF1CA 271
s tilu ita di tre ballerie lt>ggere ed un.a pesnn le; ~gni risor".a di coTpo d'eser" ilo d.ue ~rig? te, t)Oa d1 tro batterie pesanti, od una di due ba tter10 dt m itragliere ed una da montagna . .
Alla risHva genera le de ll'eserci to vi sarebbero poi crnqne batterie a cavallo e due di mon tagna. Il che darebbe un to ta le di 1,002 pezz i; . . . . .
7° Po-r la difesa del le cos to l1m1tars1 all'1'1npiego delle torped'ini è delle batterie di grossi obici" possibilmente elevate, oltread alcuné basse a'l'iche di piccolo calibro onde impedire soltwntd al nenvico di sba1'Care e di ancorarsi presso te1·ra, provvede ndo per altr9 a lla difesa dei Mwghi p_iù impm:tanti. co~ p'r'eparare potenti batterie basse di r;rossi cannon.i .colloca.ti ent1·cvcasematte corazza.te o meglio dietro paTapetti in sabbia, · ove si faccia uso di a/fu,st-i, a contrappeso evitando assolutamente i pa1·apetti in mura.t11.ra; , . .
s• Applicazione all'?rdn~ame nt o dell e~er c1to. del sistemo. terr itoriale, fa tt o le debite rise r ve per la rl 1sl ocaz1ono del materia lo e delle truppe a cavallo;
9• Aumen tare la razione de l soldato . Noi · n on ci t"errneremo ad anal izzare o sottoporre ad esaruo qnosle riiverse idee e proposte, mol te de ll e qua li ha n no, corno si vede, co n tro di sè tin ~rave ostac.o lo nelle nostre str~ ltezz~ fi nanziar ie , giacchè un tn10 lavoro c1 porterebbe .ad u~c1re dai limiti di s pazio e di tempo che sono a · nostra. d1sp~s1Z1one o prenduTeblJe u n carattere di po lemica che non 10lend1amo dare a queste nostre rivis te bi bliografiche. . . . . .
E ci rincresce che la stessa rag ione d1 spa210 non c1 pe1 me tta di far cenno de lle id ee e considerazioni che sono svolte. dal-l'autore circa il r ec lutamento o l'ordin~mento d~ll'es~rc1 t9 .e specialmente dell'art iglieri~, circa la ques tione de! so.Il uffic1ah, circa le locomotive strada li, circa lo com u rncaz1om a~ree, o · delle nu meroso pvoposte ch e da .lui si. fanno ;oe1t'.intend1meo to d i r ende ro più comodo e'Joggero 1l vestiar10 e I eq11 1pagg1amento de l sold ato . . . bb Più faci le ci sarebbe riuscito i l còmpito, e In nnnsta avre o potuto dare un piit esa t_to raggu.aglio sommar(o ~el_l e idee dell'a u tore, se questi , c i perdo ni 11 l_ett.ore se rns1sliamo nell~ ·nostra idra, in luogo di presentorc1 tut.to .un pro.gramma d~ r ior dinamento, àvesse separato l:- quos t1om _pubb ll ca n do lan ll lavo r i separati. E così per esempi~ avess~ scr1t10: rnemorrn: su l recl u tamento· uoa sullo questione oe1 son ufOc ia ll ; una su ll a opportl!lnitù di appl icare il s istema tcr~ ilo r iale oll'ord~namento del nos tro csr r ci to (quantunque la qu 1st1one de ll'owhnaine~to sia a lquanto pregi ud icata, essendo cosl d1 recente stato sanziono te dc•ll e leggi a questo rig uardo da l Par lamento e, da.I ça~o de llo St11to); una su ll a m itraglie r e o su l r eparto cie li ar llg l! er1a nell'esercito combatte n te · una sulla difesa de ll e coste: una sulle locomotive stradali; una 'su l vestiario o l'equipaggiamento del soldato; e -cos) via discorrendo.
276
RIVISTA
Difesa tei-rUoriale ,l'Italia. Studio relativo all'interno dell(l Valle del fo per BENl!OllTTO V1!ROGG10, colonnello del Gemo - Casale, tipografia Paolo Be.rtero 1874, con due schizzi litografali.
Già notammo nella dispensa precedente, rendendo conto del recente opusco lo del colonnello Ricci, come nell'importante questione della difesa dell ' ltalia . noi possiamo ornai riguardare come f?-tta la_ luc~ e slabi lito l'ac.cordo su tutti i punti più importanll del d1ffìc1le problema, tranne uno solo, quello che rig uarda il pern o ·centrale della difesa interna della Valle del Po. t questo un gran progresso, di cui hanno merito tutti più o meno color<? che _scrissero sull'argomento : Quanto al punto ancora in d1scuss1one, potendosi ora su d1 esso cpncentrare ì'attenlione degli studiosi, e potendo così l' esame farsi in modo più concreto e definito, è a credere, che anche su di esso non tar derà n stabilirsf lo stesso accordo. - Questo punto di divergenza venne già formu lato con due parole: Bologna o Aacenza? Dove è da notarsi che i propugnatori di Piacenza ritengono che questa sola possa bastare come perno della difesa interna della Va lle de l Po, m entre i propugnatori di Bologna ritengono come indispensab ili complementi di tal piazza altre piazze sull~ h_D ea d el Po. fra le quali;è compresaaltresì Piacenza. . I duo pr!nc1_pa)i, anzi fin<?ra soli campioni di Piacenzu, sono 1 co lonnelli R1cc1 e Verogg10. Quasi contemporaneamente a ll'_oµus_colo ~el pr imo mcì l'opuscolo del secondo, di cui qui r 1porllamo 1l litolo. Non è a stupire, se, patrocinando entrambi la stessa idea, essi abbiano molti punti di contano nelle loro argomentazioni, per cui avendo no i esposto con qualche diffusione il punto di quelle contenute nell'opusco lo del colonnello Ricci, saremo più brevi n el riassumere qu elle d e l co lonnello VE ROG G10, tanto più che queste han.no anche elì'ellivamente uno sviluppo assai minore. . li co lonnello Veroggio ha proposto a Piacenza una piazza a dimension i assai più ristrette di quell e -proposte dal Bici;i. li punto di Stradella deve bensì essere fo'rtificato, ma non farebb e parte <lolla p_iazza, la quale si ridurrebbe a quella attuale alquanto ampliata, m modo da essere collegata coll'Appennino .
çiò pref!!asso, eg li divi~c il suo la_v?ro in due parli. Nella prima ~gli confronta la piazza da lui ideata con quella di llologna, ideata dal c~lonnel)o Arald i, e trova che in questa la parte yeramente utile ed _importante sarebbe il cn mpo trincer11to di prnnura, troppo ~1stretto per la quantità di truppa che deve co_ntenere, mentre Il campo trinceralo di collina non darebbe riparo alle truppe che nelle valli parallele di Reno e Savena, dove esse dovrebbero considerarsi come "'ente inutiJizzabile,_ attflsochè, volendo le impiegare, s~re_bbo pur sempre necessario portarle . nel campo_ lr1ncerat<? d1 pianura, per potere sboccare, e lo sboccare si farebbe 10 condizioni difficilis;lime per la ristrettezza dello spazio, e perchè il nemico avrebbe rntanto avuto l'agio di ra fforzare il suo fronte in ogni maoiera.
BIBLlOGHAFICA 279
Del resto queste condizioni di poça a ttiludine all'?ffensi~a, il colonnello Veroggio le trova comun_i a qualunque ]?lazza s1 volesse coslrurre ai piedi dell' Aprenn)nO, mentre poi. trova che sarebbe dotata di poca forza d1fons1va qua lunque piazza fosse stabilila unicamente sul Po: donde trae la conseguenza che soltanto una piazza, la qu~le goda con _te'? pora u~amente de l\a virtù difensiva dell'App enrnno e della y1rtu o~en~1va del Po, sia alia a risolvere il problema. Tale è, secoI_1do lui, Piacenza. Entra q uindi in particolari relativi alla. modalità con ~m egli vorrebbe vedete fortificata Piacenza, specia lmente sotto 11 rapporto della capienza . . . . . Nella seconda parte 11 colonnello Verogg10 entra nel midollo della questiono, ponendo il pro_blema se C?nvenga ave~ molle piazze od averne una sola. Egli _tr ova nnz1Lu~to. che Prn9e?za si presta corno ridotto centra le cl~ due scacchieri strateg~c1 cor: rispondenti alla nostre due front1ero, mentre _Bo logna e. fuon di entrambi. Passando quindi nll'csame del triangolo proposto da altri , i cui vert ici sarebbero Piacenza,. M~n_tova e Bologn~ , . i due primi come punti di manoyra parz1al1, 11 terz_o como ._ri: dotto centrale, dimostra la differenza esistente fra d~~i rr1m1 che dovrebbero compiere ad un ufficio analogo, e 1 d1_let_l1_ che ciascuno d e i tre punti. av~ebbe, q ua_n_do fossei;o co~t1lu1h secondo quest'idea. Esnmma 11 caso d1 rillrata de ll ese rci to nostro sia da Piacenza, sia da Mantova, su Bologn_a, e m?s~ra. come in entrambe le even tunl ilà essa si farebbe m. co nd 1z1om d1flìcilissime mentre la r itirata da Mantova su P1a<:enza. potrebbe sempre farsi colla protezione del Po. Proseguendo m questo or dine di idee il colonnello Vorogg10, e. cons1_d~rando sei:npr e il probl ema in relazione co ll'azione degh eserc1t1 g~er,regg1ant1, consiglia all'Italia di attenersi al poco ma buo no , anz1che al m.olt? , e con chiudendo traccia un breve quadro della sto~·ia delle forl1: fica2Jìoni. i n cui pone in luce il fa llo, che, a :iv1sura ~he gl) eserciti àumentaronò dì mole e cr ebbero per ogm dove 1 mezzi di comuo-icazione, le fortezze andaron? n~an mano ~e~res cend~ di numero ed aumentando di proporz1001 supe1:fìc1ah; po1che dunque al giorno d'~g~ì gl i eserci_ti han no ra ggrnn lo n?II~ loro forza numerica un hm1to che sara d1ffic1lmente su_pe1ab1 l~. e poichè i pro.o-ressi nella viab ili~il _furono sì gra ?d1 , massime negli ultimi tempi, tut\O C\ _cons1gha, nel la SO lUZl?lle. de_l ,_rro-: blPma che abbiamo dinanzi, a seguire la l~nden_za 10~1catac! dalla storia, concentrando !n una _sola g1:ao piaz7:a nostri mozzi di resistenza. come pu re 1 nostn mezzi pecurnar1. .
Tale è il µ·unto del le idee svolte _in queslo opt~scolo, che rivola un coscenzioso e maturo esame della questione.
lllemae ·que.,tion ·i m.ililai~i (Estratto dal giornale l'EsercUo}
- Roma, 1873, Tipografia Voghera.
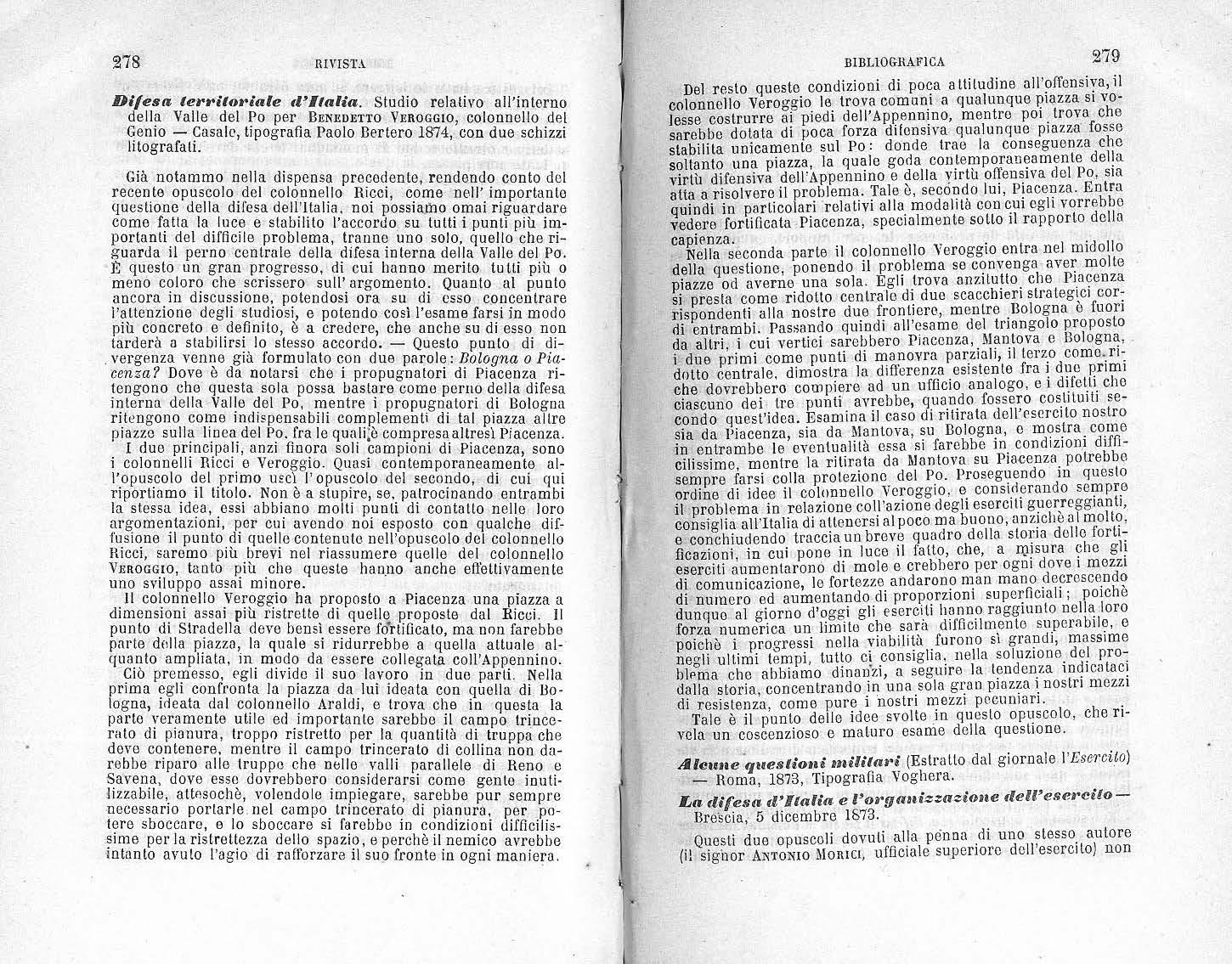
La dlfesa ,l'Italia e l'm•gan·iz::azione ,lell'ese,•ciloBre·scia; 5 dicembre 1&73.
Questi due opuscoli dovuti aHa pènna _di uno ~tesso_ autore (il signor ANTONIO Mon 1c1, uffic iale su,periore doli esercito) non
278 RIVISTA
fo~~ prfivi d'inleresso! e ci .Piacerebbe che fossero loUi porchè e 1 eo op_dan'!enlal1 10 ess i propugoale, astrattamente prose so no. assai ra g1o nevoli. e per conseaucnza le deduzioni eh~ l'autor~ ne trae, ci sembrnno tali da" mo ritaro l' onoro di un~ d 1scuss10ne, 1 ?.a lla qua lo _pot r ebbe es ser posto in evidenza se lo p rop_o_s~e de;I a~tore obb1ano tulio quel ca ratt er e di pratica al1.uab11lta ~b egh crede, e cho a noi sembra per ve rit à al uanto contes lal?1le sovratu .llo nell e presenti cond izioni del pao~e . Nel pr1~0. d1_ delt1 opuscoli l'autore prendo a ris olve re· due 1~portant1~s1m1 probl_cmi. ricercando qual sia la costituzione p1u acconcia da dars i all'ese rcito per ropporlo a porsona l pe rch è esso so ddisO nel mig lior modo ai hiso a ni della àifo~à ~lei paese. e secondari am cnto in qual modo possa assicurar-i 11 rccl1:1lamenlo dei s oll'ufnciali.
f A lui P?re _che il probl ema di dare il maggiore sviluppo alle fìorze mi i1tar1. della nazione P di trarre da esse il massimo pro~ .1.tto per la_ difesa 9el pa~se, t~ov orebbo la sua migli ore soluz10n.e 1,191 rip ar lo ~1 tali forzo JU due eserciti permanonlemenle ~ostitu 1ll: uno _d_e st!n a to esc.;lusivamonte a l sen-izio di campao-na 1altro al . scrv1z10 rnterno o territoriale. " '
Il C0!1lmgeulo a quest i due eserciti snreb he fornito dalle love an n,uah Ed a ~alo effetto l'outoro proporrcbho una divisione 9el~ele~~~)o d1 leva, ~econdo }a robustezza fisica delle r ec\\ito rn ue 1st1~t.o cat0!5~~1e. I p1u rolrn~li sarebbero asseg nati, nella. pro~orz10!1e d1 2,3 a l /3 all'esercito di campagna i più g ramh ali esero1to territoriale . '
Il ser_vizio sollo lo_ armi , tanto per l 'u na quanto por l 'altro. cat~goria, sar~bb e d1 due anni, ecce ll ochè 'per la cavalleria . L/~ ~r:c1t? d1 ca~pogna sarebbe pe rm anentemente costitu.ilo in , n ·~s1o~1 e cori~1 d:esercito, cd aLLonderebbo esclusivamente 11 lle p1opr1~ 1slr uz_1on 1 od.ose r citazio!1i. I co rpi d'esercito avr ebb~ro ~lanzct fissa 1!1. loc_ahtà le quali, non solo pi·esentassero le p1u fa\ orevoh _condmon1, per rapporto all'ist ruzi one de lle tru e m.a fos se ro st1niate I.o più conve nienti dal lato s tr ate g ico 1~.r i~ s \1co ed amm101strat1vo in previsione di una mohilizznzi~no" e rh un_ conc~ot r:am ento dcli' esercito per la difesa de l · aese In tali locali là I corpi d'~ so rcito ~ovrcbbero poter trovarr tull; quanto loro occ~r_ress~, 10 materrn le e risors e d'oo-oi specie per la loro mob1llzzaz1ono. " ·
L'_esc_rcilo terr i \oriale dovrebbe essere formalo in gross· battaglioni pe r rrov10~i~, i 9uali provvedo r ebboro io tem~o di pace a tutto 11 servlZIO d1 presidio o di pubblica sicurezza l'· li P:ob,l.em1t del rccl_ut~~onto dei sott'ufOciali parrcbb·e ·aluulo.1 e 11solto noi m1gl1or mod o quando si sistemas•ero le c~,se 10 maJ?tOra cho la carriera del soll'uffìciale r isultass; la via ~,u dconvern~nle r.:er,.r?g~iuoger o il grado di uffìcial1•, assicu·1 <1n o a q u e1 so tt uf,1c1~ l1 Cii? n_on P?tessero raggiungere un lal grado, dopo 12 o fa anm d1 se n '1Ziù alcuni vantaagi ma sempre coi carattere onorifico di pensione od inipic o o d so~ond~ opusco l? ( ~a difesa d'ItaUa e t'orgaffi;zazione e_ esercito~ I a uto re da maggio~e svolgimento alle id ee acc cunato nel primo, segnatamente circa l'ordinamento d ell'esorl!ito
di campagna o circa il modo di porlo in assetto di guerra, adope ran dos i a dimos tr are co me l'esercito ord inalo a quella maniera ch'egli propone non potrebbe a meno di rispondere a tulle quelle condizioni di solidità e di atliludino ad una sollecita mobilizzaz ione che si richiedono porchè il suo icnpiogo riesca i 1 più ol'ficaco possibile allu difesa d'Italia.
Belazit>ne del consigliere L NBGR0TTO CAirn1A.SO, Deputato al Parla mento, lettn alla Sezione ippica del Consiglio d'agricoltura . - Ro ma 1873, tipog r afia Si11imberghi.
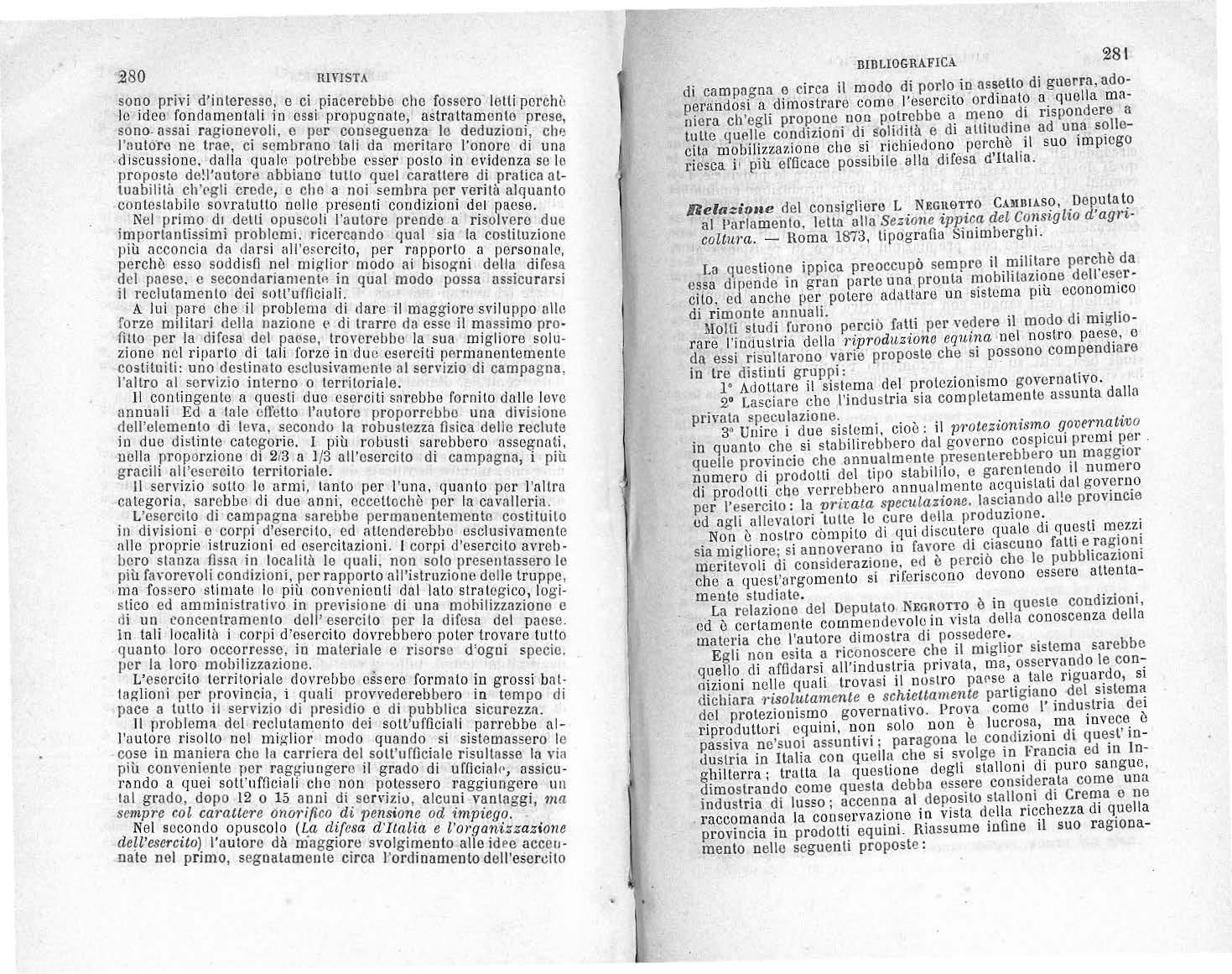
La questiono ippica preoccupò semp 1·0 il militare perchè da essa difende in gran parte una pronta mob ilitazione dell'esercito, ec anche per potere ada ttar e un sis tem a p iù eco nomic o di ri monte annuali . Molli studi furono perciò falli per vedere il modo di mi gliorare l' industria del lo 1·iprodnzionc eqiiina nel nostro paes~, o da essi risultarono varie proposte che si possono compendiare in tre distinti gruppi:
1• Adottare il sistema del protezionismo governativo.
2° Lasciaro che l'indust rio sia comp letamente assunta dalla privata speculazione. .
3• Un ire i due sistemi, cioè: il p1·otezionismo governativo in quanto che si stobilirebhero dal governo cosp icu i prom i l?er quelle provincie che ann u almente presenterebb ero U!1 maggior n um ero di prodoUi del tipo stabililo, e garantendo Il num er o di prodolli che verrobbero annuu lm ento acquistati dal gov~rn_o pe r l'esercito : la 'Ori1;ata speculazione. lascia ndo al!e prov1uc1e od agli allevolori ·tutte lo cure d e lla produzione . . . Non ò nostro còmpilo di qui discutere quale di qu es ti mezz~ sia migliore; si annoverano io favore rii ciascuno fatti e _ra g\OO\ meritevoli di co11siderazione, ed ò perciò cbe le pubbhcaz10111 che a quest 'a 1·gomonto si riferis cono dov ono essere aLt eo tamenle stud ia te . La relaziono del Deputato 't\EGROTTO è in queste condizioni, ed ò ce rtam ente com m eodevol o in vista de\!a conoscen za della materia che l'autore dim os tra di possedere . Egli non esita a ri conosce re che il migli!)r sistemo sarebbe quello di affidarsi all' indu stria privata , ma, osserv ando le con: oizioui n elle q ual i trovasi il no st ro parse a tale riguar:do, s1 dichiara 1·isotutamente e schiettamente partigiano dol S)slom~ de l protezionismo governativo. Prova corno I' indu~Lr1a de i riproduttori oq uini, non so lo non è luc rosa, ma mv ece è passiva nc'suoi assuntivi; paragona lo condizioni ~i que.sl' industria in Italia con qu e lla che si svol ge in l"r anc1n ed JO Inghilterra; trulla la queslione degli stalloni di puro sanguo, dimostrando come questa debba essere consid erala come una industria di lusso; accenna al deposito stalloni di Cre~a o ne raccomanda la conservaz ione in vista de lla r icch ezza d1 quel la provincia i u prodotti equini. Riass ume infine il suo ra gionamen to nello seguenti proposte:
280
RlYISTA
BIBLIOGRAFICA. 281
I\IVISTA BIBLIOGRAFICA
e Riduzione nel prezzo d!,illa monta.
e Aumentare gli stalloni fin dove sia strettamente necessario.
< Destinare secondo le regioni ~talloni adatti.
. « Ris~a~ilire esposizioni e concorsi regionali, provinciali o c1rc~ndaria!I, con un ben inte so sistema di premiazioni, alle quali dovrebbero assieme allo Stato contribuire le provincie, i comuni ed i comizi agrari interessati nella produzione equina.
. . pare precise istruzioni alle commissioni ippiche provin· ciah d1. non approvare od autorizzare stalloni privati di cattiva costru zio ne, o che abbiano vizi o difetti trasmissibili.
« Incoraggiare con. premiazioni le corse di resistenza al puro trotto.
e Assoggettare a tasse eccezionali le monto fatte con stallqni puro. san gue, procurando che non succeda l 'a ,:coppiamcn lo d1 stallom puro sangue con cavallo privo di distinzione »•
. Questo breve lavoro si riferisce dunque ad una questione che mtere_ssa grand ~mente l_'eser~ilo, e noi non possiamo ch e fargli una. lieta acco~heuza. g1accbu esso aumenta il numero degli studi. ben fatti su d1 un argomento relativamente al quale havv1 ancora molto da fare n el nostro paese.
ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA
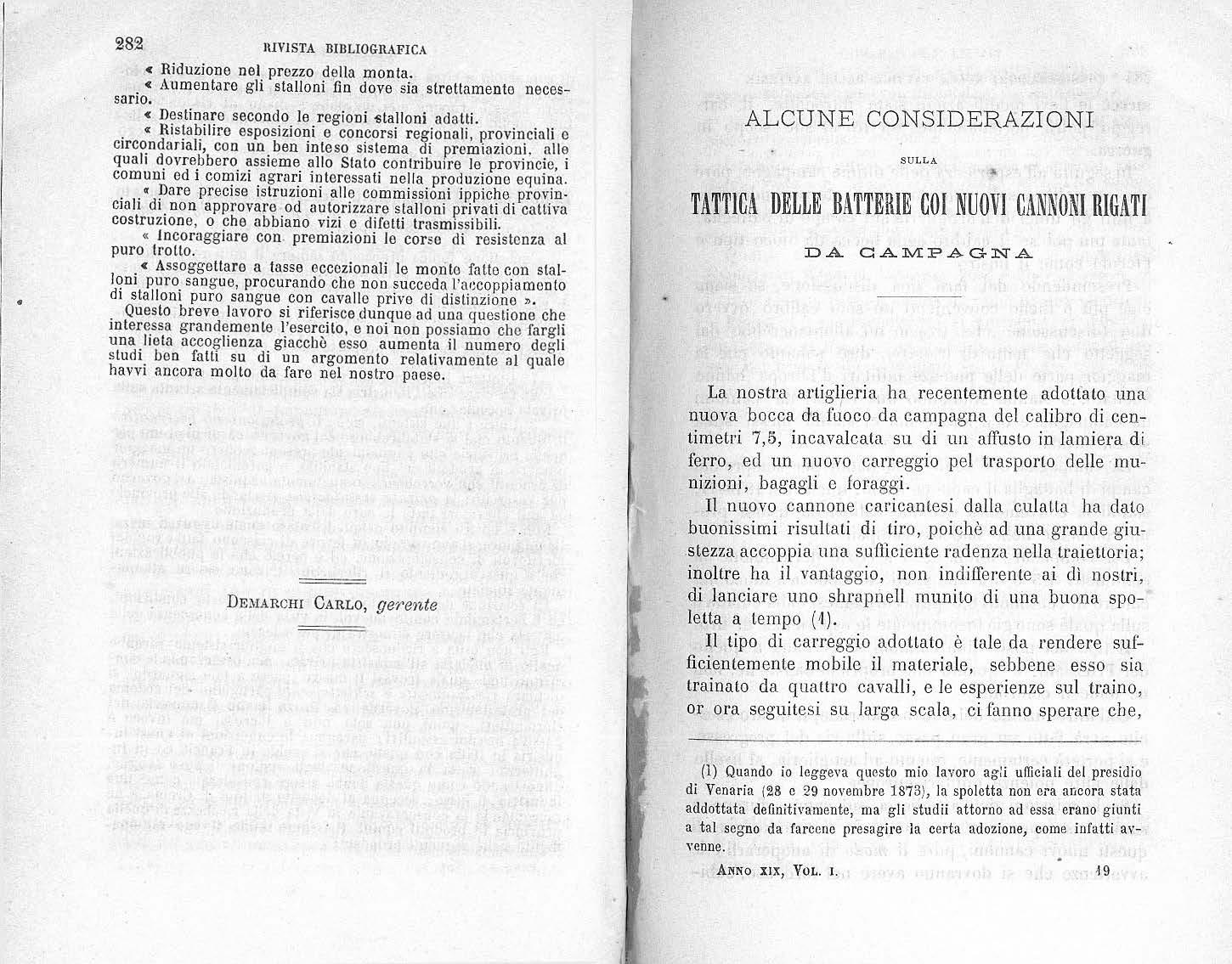
TATTICA DELLE BATTERIE COI NUOVI CANNONI RIGATI
DA CA~P.bGNA
La nostra arligljeria ha r ecen tem ente adottato una nuova bocca da fuoco da campagna del calibro di centimetri 7,5, incavalcata su di un affusto in lamiera di. ferro, ed un nuovo carreggi o pel trasporto delle ·munizioni, bagagli e foraggi.
DEMARCHI CARLO, gerente
Il nuovo cannone caricantesi dalla culaLtn ha dato buonissimi risullati di tiro, poichè ad una grande giu.stezza accoppia una suflìciente radenza nella traiettoria; inoltre ha il vantaggio, non indiffe rente ai dì nostri, di lanciare uno shrapnell munito di una buona spolelta a tempo (,1).
Il tipo di carreggio adotlato è tale da rendere sufficientemente mobile il materiale, sebbene esso sia trainato da quattro cavalli, e le esp erien ze sul traino, or ora seguite si su . larga scaln, ci fanno sperare che,
(l) Quando io leggeva qu esto mio lavoro ag:i ufficiali del presidio di Venaria (28 e 29 novembre 1873), la spoletta non era ancora stata addottata definiti1•amente, ma gli studii attorno ad essa erano giunti a tal segno da farcene pres,1gire la certa adozione, come infatti avvenne.
ANl'iO XIX, VOL. l.
• 282
CONSIDERAZIONI SULLA TATTICA DELLE BATTERIE mercè le lievi modificazioni state introdotte, il carreggio potrò perfettamente servire al suo scopo in guerru.
In seguito all'esperienza delle ultime campagne, pare che un calibro solo non sia sufficiente per soddisfare a tutti gli uffici d e ll'ar1igli el'ia sul campo di battaglia, t~n Lo più poi se il calibro della bocca da fuoco tipo è piccolo come il nostro .
Prescindendo dal fare una discussione , se siano cioè più o meno convenienti un so lo cal ibro ovvero due (discussione che troppo mi allontanerebbe dal soggetto che temo di trattare), dirò soltanto che Ja maggior parte delle potenze militari d'Europa hanno adollal o, o stanno studiando due calibri da cannon i da campagna e che anche noi ci siamo messi sulla s~essa strada .
La .ca !npagna. d~ll'anno 111366 bandì per sempre dai campi d1 battagli a 11 cannone liscio; quella del 1870-71 st~bilì la convenienza dei due calibri da u sarsi pro~ rn1scuamente nelle batterie campali. .
Per .comple tare adunq ue il servizio del cannone cla centimetri 7 . 5 è ora allo studio una boc ca a fuoco del calibrn di centimetri 8,5, pure caricantesi dalla culatta e sulla quale sono giù incominciai.e le esperienze di tiro.
~I tipo ?ei. nosrri due cannoni si avvicina a quello dei Pruss1a01, e, quanto alle proprietà. balist iche, non ne teme il confronto .
Coll'introduzione del nuovo materiale, il ·nostro esercit~ .avrà ~atto un gran passo sulla via del progresso e s1 portera certamente, quanto ad artiglieria, al livello delle altre pot~nze militari europee.
Se l e missioni dell'artiglieria sul campo furono e saranno sempre , le stesse malgrado l'introduzione cli questi nuqvi cannoni, pure il modo di adoperarli e le avvertenze che si dovranno avere nel loro uso, subi-
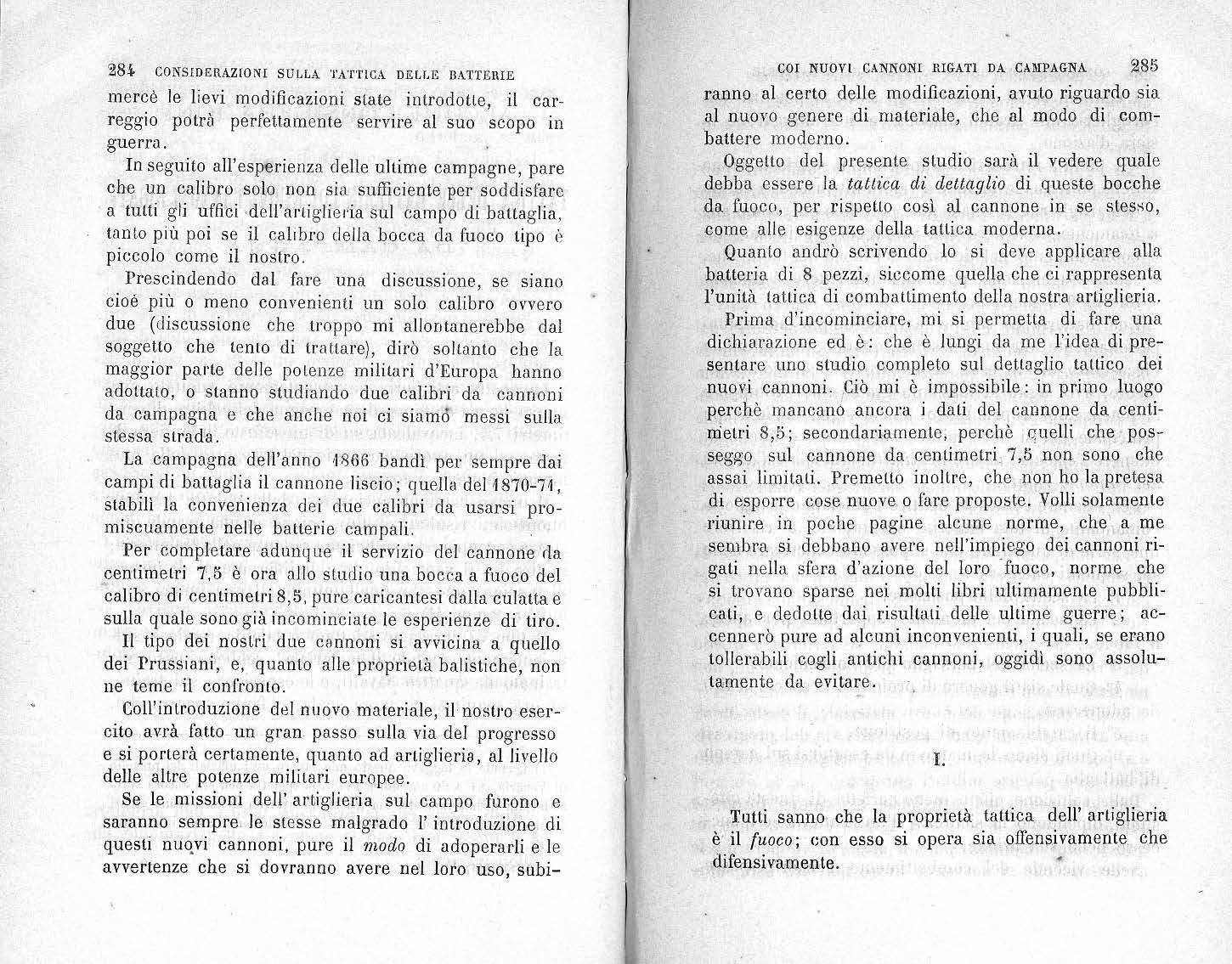
COI NUOVL CANNONI RIGATI DA CAMPAGNA 28f> ranno al certo delle modificazioni , avuto riguardo sia al nuovo ge nere di materiale, che al modo di combattere mode.mo.
Oggetto del presente studio sarà il veder:e quale debba essere la tattica di clettaglio di queste bocche .da fuoc(I, per rispetto cosl al cannone in se stesso, come alle esigenze della Lattica moderna.
Quanto and rò scrivendo lo si deve applicare alla batteria di 8 pezzi, siccome quella che ci rappresenta l'unità tattica di combauimento della nostra artiglieria.
Prima d'incomincinre, mi si permetta di fare una dichiarazione ed è: c he è lungi da me l'idea di presentare uno studio completo sul dettaglio tattico dei nuovi cannoni. ,Ci ò mi è impossib ile: in prin10 luogo perchè mancano ancora i dati del cannone da centinie.tri 8;5 ; secondariamente; perchè que lli che poss~ggo sul cann one da centimetri . 7,5 non. sono che assai limitali. Premetto inoltre, che non ho la prete~a di esporre cose . nuove o fare proposte. Volli solamente riunire in poche pagine alcune norme, che a me sernbr?, si debbanç> avere nell'impiego dei cannoni rigati nella sfera d'azione del loro fuoco, norme che si trovano sparse nei molli libri ultimamenle pubblica ti, e cleclotte dai risultali delle ultime guerre; accennerò pure ad alcuni inconvenienti, i quali, se e11ano toller~bili cogli antichi ca11nooi, oggidì sono assolut a.imente d a evitare,.
'futli sanno che la proprietà taltica dell' a-rtigFeria è- il fuoco; con esso si opera sia offensivamente. c}:ie d ~fe:nsi vamente.
28i
I.
CONSIDERAZIONI SU!,L.\ TATTICA DELLE BATTEllIE
I cannoni rigati aumentarono assai la po len za dell'ar tiglieria alle grandi distanze e ne allargarono l a sfera d'azione.
« I fu c ili a retrocarica ampliarono il raggio d'azione « della fanteria elevand on e il valorn intrins eco a danno « de ll'arlig li eria, la quale non potrebbe più, come an« ti camen te , sostenere con vantaggio od iniziare un « combauimenlo nel dominio de l fuoco del fucile che, « senza esagerazione, poss iamo ammellere si estenda « fino ai 900 metri ».
Una batteria da campo avrà àdunque adempiuto perfe lta men le a lla sua missione, quando, in qualunque circostanza in cui essa debba trnvarsi · al combattimento, avrà agito al ma ss imo grndo collo svil uppo e la potenza del proprio fuoco. Ne consegue che lo scopo principal e cui s i deve mirare sul campo è quello di otlenere l'efficacia di tiro nei limiti della sfera d'azione clel cannone 1·igato.
Per ottenere l'effi cacia del tiro l'ufilc iale d'artiglieria comandante di una balleria è ch iamato a ris o lvere una serio di queslioni, che si possono concretare nelle sei seguen ti categorie :
1 ° La scelta della posizion e .
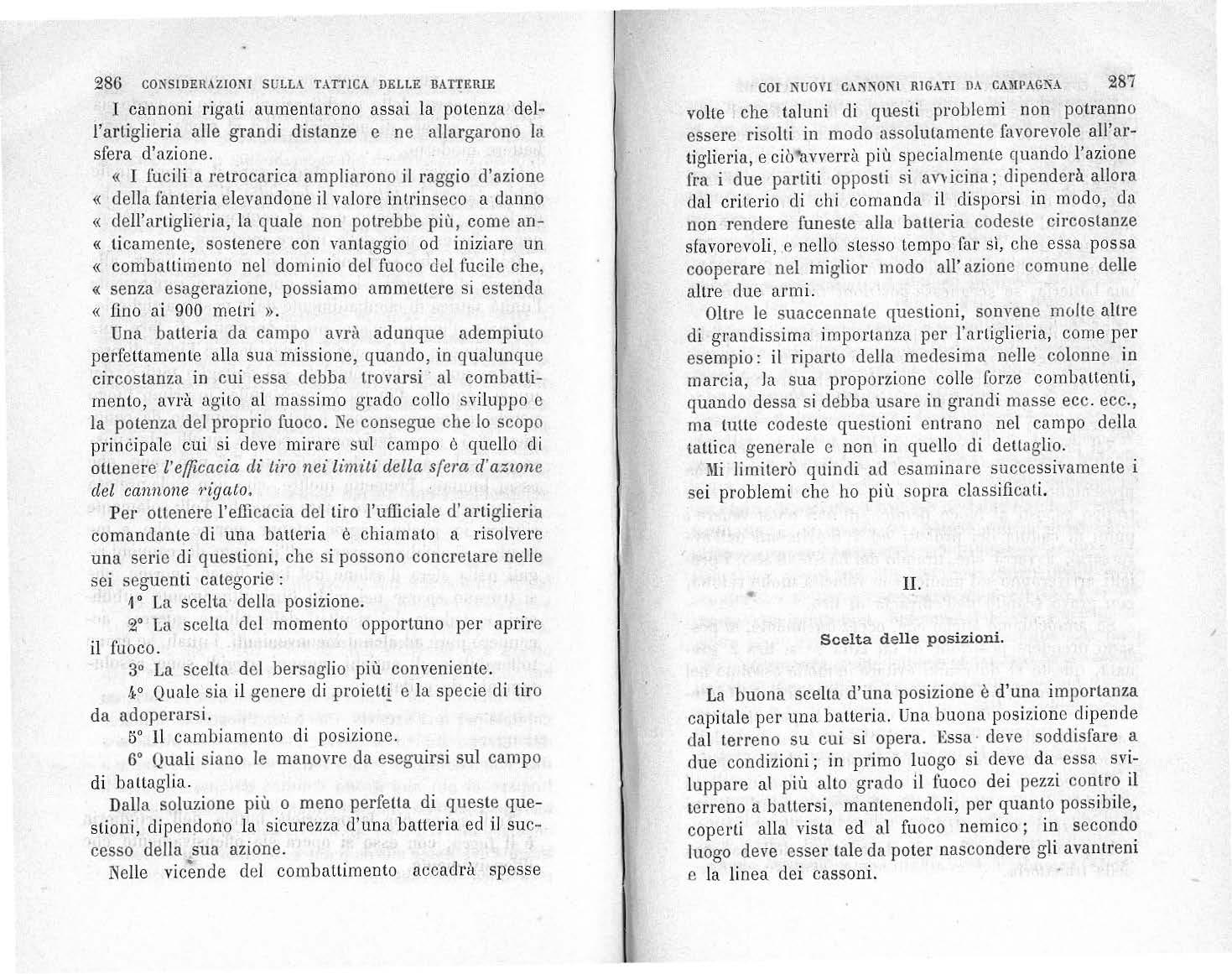
2° La scella del momento opportu no per apr ire il fuoco.
3° La scelta del bersaglio più conveniente.
4.-° Quale sia il genere di proietti o la specie di Liro da adoperarsi.
5° Il cambiamento di posizione.
6° Quali siano le manovre da eseguirsi sul campo di battaglia.
Dalla soluzione più o meno perfetta di ques t e questioni, dìpençiono la sicurezza <l'una batteria ed il successo della sua azio n e.
Nelle vicènde del combatlimento accadrà spesse
COI NUOVI CAN ' ONI RIGATI DA CAMI'AGl\A 5:l87 volle che ta l uni di questi proble mi non potrann o essere risolti in modo assolutamente favorevole all'artiglieria, e ciò 'avverrà più specialmente quando l'azione fra i due partiti opposti si a,",icina; dipenderà allora dal criterio di chi comanda il disporsi in modo, da non r endere fun es te alla balleria codeste circostanze sfavorevoli , e nello stesso tempo fat· sì , che essa pos sa cooperare nel miglior modo all' azione comune delle altre due armi.
Oltre le suaccennate ques t ioni, sonvene mùltc altre di grandissima importanza per l'arliglieria, come per esempio: il riparto della medesima nell e colonne in marcia, la sua proporzione colle forze combaltenti, quando dessa si debba usare in grandi masse ecc. ecc., ma tulle codeste questioni e ntrano n el campo d ella Lattica generale o non in quello di dettaglio.
}Ii limiterò quindi ad esaminare success ivamente i se i problemi che ho più sopra classificati.
II.
Scelta delle posizioni.
La buona scelta d'una posizione è d'una importanza capitale per una batteria. Una buona posizion e dipende da l terreno su cui si opera. 'Essa · deve soddisfare a due condizioni; ìn primo luo go si deve da essa sv iluppare al più allo grado il fuoco dei pezzi con:r? il terreno a battersi, mantenendoli, per quanto poss1blle, coperti alla vista ed al fu oco nemico; in secondo luogo deve esser tale da poter nascondere gli avantreni e la l inea dei cassoni.
286
.,
CONSIDERAZIONI SULLA TATTICA DELLE llAT'l'ERlE
Credo in utile il ramm e ntare qui l e condizioni parti colari cu i d eve soddisfare una buona po s izione avuto r iguard o s ia al terreno, ch e· alla dis tan zi\ a cui si d e ve tirare; qua lun que libro ch e tratti de ll'i mpiego d'artig lieri a l e descrive e l e discute; come pure non mi Lralterrò ad esaminare parti.lamen te i vantaggi e gli svantagg i delle dive rse specie di posizion e; solo vo g lio accennare agli inconveni e nti più gravi in cui cadrebbe u na batteria, se scegliesse posizioni troppo : dominate , o t1·oppo dominanti .

Queste due sorta di posizioni sono d'altra parte quelle che , a par er mio, danno luogo a i maggio ri svantaggi ne ll'im p iego del nuovo mate ri a le e che presso di noi (massime le posizioni t roppo dominanti) vengono più generalm ente occupa te .
Ne l pri m o caso (posizioni troppo do m in ate) ollre a tutti gl i svantaggi comuni agli altr i ca nnoni che presentano s imil i posiz ioni, come que ll o di essere troppo esp osti al fuoco nemico, cli non poter vedere i punti di cadula de i proielli ed i mov i menti dell'avversa r io, avverrà che, tir ando dal basso :ill'alto, i proi e tti a rrive nmn o sul ne mico con velocità molto ridolt a, con grave scap i to dell' effièacia d i tiro.
Se ammettiamo anche che , eccezionalmente , si pos sano prende r e pos iz ioni d i tal fat t a se si tira a granata, ques te si dov rann o evitare i n modo asso luto ne l tiro a shrapnel! ; poichè l' effetto di questo:pro ie lto è interamente dovuto al la ve locità con cui le pallottol e arrivano sul nemico, e questa è unicam e nte dip endente dalla vel oci tà r estan te del proieLto al momento dello scoppio.
Nel secon do caso _(posizioni t roppo dom inanti) si ca drebbe in una. Junga serie dì i nco nveni en ti, di cui accenn e r ò i prin c ipali.
In primo lu ogo, si pe r de il vantaggio della ra denza. de lla tra iettoria.
CtJI N UO YC CAN NONI R IGATI DA C.-UII'AG NA 28 9
I nuov i cannoni, a confronto degli an ti ch i li sci, hanno g randissima g iu s tezza d i tiro , ma una traiettoria meno ra den te, e qu indi g li s pazi ba ttu ti limitati. .Se la pos izi one è tro ppo dominante, qu es ti spazi dec rescono rapid amen te pe r chè aumen tano gl i angoli di caduta.
Fed e ri co il Grande ne lle s u e ord inan ze di Pos Ldam , in vista <li tale inconven iente, e del! a tendenza che . aveva l a sua artiglieria a prende r posizioni tropp o elevate, le raccom an dav a c aldam en te di s fuggir e la.l e error e. A maggior ragione non dobbiamo cadervi noi, che siamo armi.lti con cannoni l e cui truiettorie sono mol to più curve ch e quelle d e i cannoni di Fed e rico .
In seco nd o luogo, il pro i ello (sia esso g r anata. o shra pnel!, munito di -spoletta a percussio ne od a tempo, rego la ta. per un a. dur ala un pò lung a) p enetre re bbe tropp o nel terreno in ca.usa de ll a ma gg iore velocità ac quistala. L'effello dello scoppio diminu i rebb e se il terr eno fosse dL1r o; re s t erebbe poi a nnull a to, s f\ quest o fosse umido o molle. Se supponiamo infa tti che il t erren o occupato dal nemico sia resis t ente, il proietto, batten dov i so pr a con un an golo di caduta molto for te , scoppierà con poc o d anno, poicliè l e schegge saranno lanciale mollo in al lo. Se invece il terreno fosse molle, allora g r a n parte de lle schegge rim arr anno inte r rate . Che l' effe tto d el colpo sia null o nel ca so che il pl'oie lto lanciato fosse uno shrapnell a lunga dul'a ta è cosa e vid ente per se stessa, dovendo esso s copp ia re prima di toc care il t e rr e no.
Bi sogna inoltre aver l'avvertenza, n ella scelta delle posizioni, di n on occupure quelle poste in prossimità di ogge tti che fo.c ili tin o al nemi co la valutazi one de li a distanza, qu a li sarebbero a mo' d'esempio, case, alberi i so lal i, ecc . ecc.
Nella camp ag na d el 1866 una batter ia prussian a
' 28
8
CONSIDERAZIONI SU LLA TATTICA DELl,E BATTEH!E
aveva p1·es o una posi zio ne e g ià stava per i ncominciare il fuoé.o, quando ad un tratto, il terreno da essa oc cup ato fu l e tteralmente copert o da una g randine di granate; e ra una ba tt eria aus triaca, che sap endo la dis tanza cui si era portata l' a.vversaria in grazia cl i u n· punto del terreno da essa con osci uto e preventivamente misurato , tieava su d~ essa con grande sicu. r ezza (1).
Se p er caso un a ba tteria cadesse in tale err ore, potrà talune vo lte r im ed ia rvi, co ll'avanzare di qu a lche centina io di passi vers o il nemico; cosi i proietti lanciati da esso pass erann o al disopr a della batteria senza farle g ran male. Così fecero alcune batterie prussiane nel 1866, come ad ese mpio la 5° batteria della Gua rdi a (da 4) a Burgersdorff e la 2"pured e ll aG ua~dia(da4)
a Koni ggra tz (2)
.
Ogni qua lvolta sa1'à pos si bil e si dovrà cercare di nascondere i pezzi alla vista del nemico, sia che si prendano posizioni offensi ve, che difensive .
In questo sec ondo caso, sarà assai più facile che nel primo , ottenere ta l c ondizi one di sicurezza. Avve rlasi per ò, che le posizi oni nasco s te s i dov ranno prendere s ol o allorqua ndo g li ostacoli, die tro cui devono esser e dispost i i pezzi, non sia no per nuocere a ll'efficac ia del tiro. L'uffic iale d'a rti glieri a dev e, sop ra ogn i co sa, occuparsi de l modo di trarr e il miglior pa rti to da l tuoco de i p r opri i pezzì; le condizioni di s icurezza, la preoccu pazione de lla salvezza dei t:annoni, devon o se mpre esse re subordinate a ll 'efficac ia del tiro.
·E ben sei sepper o gli arti g li e ri prussiani i qua li , dopo
COl NUOY.1 CANNONI Rl vATf DA C,\MPAG-NA 2 91 la campagna del 1866, vennero acerbamente rimprove rati di a ver badato più a salvare i cannon i che a ritrarre buoni effetti di tiro ; dessi pei primi riconobbero tal mente questo errore , che noi li vediamo, nel 1870, completa mente ravvedut i , presentarsi al fuoco coh tale audacia ed in posiz ioni tali, da far convertire i rimproveri fatti loro dopo il 1866 ,- in u n co ro unanime di lodi e di ammirazione .
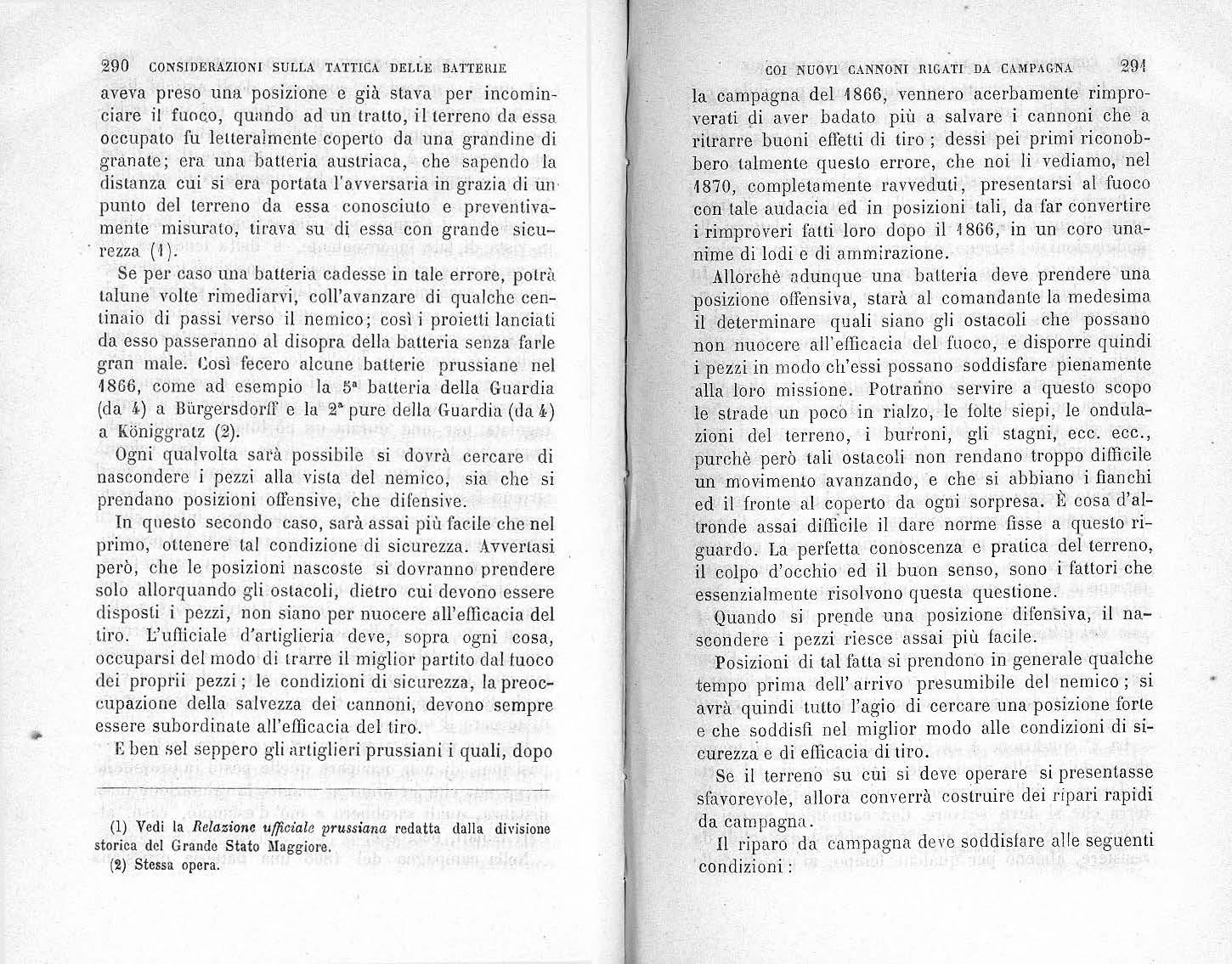
Allorchè ndunque una batteria deve prendere una posizione offensiva, starà al comandante la medesima i l determinare qua li siano g li ostacoli che possano non nuocere all'efficacia d el fuoco, e disporre quindi i pezzi in m odo ch'essi possa no s oddisfare pienamente alla loro missione. Potrarino s ervire a questo scopo le strade un poco in rialzo, le folte s iepi, le ondulazioni de l te rreno, i bufroni , g li sta g ni, ecc. ecc., pur chè però tali ostacoli non ren dano troppo difficile un mo vi mento a van za ndo, e c he si abb iano i fianchi ed il fronte al cop e rto da ogni sorpresa. t cosa d'altron de assai difficile il dare norme fisse a questo riguardo. La perfetta conoscenza e pra tic a del terreno, il colpo d' occhio ed il buon sen so , sono i fattori che essenzialme nte ris olvono ques ta ques tione.
Quando si preµcle una pos izione difens iva, il nascondere i pezzi riesce ass ai più faci le . ·
Po sizioni di ta l fatta s i pr endono in generale qualche -tempo prima dell' al'ri vo presumibile del nemico; s i avrà quindi tu tto l'agio di cercare una po sizione forte e che s oddisfi nel m iglior modo alle cond izioni di sic urez za e di efficacia di tiro.
(1) Vedi la Relazione ufficiale pr uss iana redatta dalla di\'isione storica del Gra nde Stato Maggiore.
(2) Stessa opera.
Se il te rr eno s u cui s i deve operare si prese n tasse sfavorevole, allo ra co·nver rà cos truire dei ripari rapidi da campagna .
Il r iparo .d a camp agna de ve sodd isfare a lle seg uenti condizioni:
29 0
CONSlDERAZlONI SULLA TATTICA DELLE BATTERIE
11° Essere coslrutto nel minor tem po possibile e coi serventi della batteria;
2° Riparar e , potendolo, i serventi ed i pezzi dall e granate nemic:he;
3° Essere nascosto alla visla del nemico.
Perch è possa soddisfare alla 1" condizione, il tracciato di qu e st'opera dev'essere semplice, adauarsi alle ondulazi oni del terr eno , ed essere costrutto pe-r sezioni, perchè .in tal modo .il lavoro resta più riparlito. In quest i ullimi te mpi, s u pressochè lutt i i giornal:i e ·r ivisce militari, vennero pubblicati innumere vo li tipi di ripari da campagna, parle dei quali propo s ti da ufficiali, parte stali eseguiti duranle le ultime guerre . Molte di queste opere io vidi descritte, tal un e altre vennero da noi cos trutte allo scopo d'es e rcilazione. Non neg:o che una volta fatte abbiano dei vantaggi real sopra quelle antiche, ma hanno tutte un grave difetto , que llo di essere troppo complicare, p er.: p oter e s sere tracciate e costrutte durante la notle ed in breve tempo. ll riparo semi-interra to rettilineo con ·uno o due fi 1mchi è, secondo il mio par.ere, il migliore, perchè più semplice, perchè si adatta più facilmenle a qu al unqu e te rr eno e si può costruire in brnviss imo _ tempo. Non bisogna mai dimenLicare che il t e mpo alla guerra è uno dei fattori pìù potenti della buona riusc ita delie operazioni mililarì e ehe spesse volle mane !,) . E poi credo , e molti con me lo credono, che in d efiniti va, s imili ripari . fa cciano lo stesso servizio d egli altri più compli cali.
La 2a condizione è an c h'éssa dipendente dal tempo disponibile, dalla pratica dei cannonieri in tal sorta di lavori, e dalla maggiore o minore resistenza della terra che si d eve scavare . Con cannonieri p1:a tic( in . 3 ore si può cos tru ire un riparo abbaslanza solido da resistere, almeno per qualche te mpo, ai proietti dell e
COI N:U OYI CAN NON I lUGATI DA CAMPAGNA 203' l:>atterie campali, ed iscavare déi fossi abbas tan za pro- . fondi da porre al riparo i s er venli.
Una volla costru ito il r ipa r o, sarà fadle sodd i sfare alla 3a condiz ion e se s i ha la preca uzion e di coprirn e il pendio e la scarpa con zolle o con arbo s celli , in modo da far prendere all'o pe ra l o stess o~aspetto del t_erre? o circostante . Questa avvertenza, sebbene se mbn futile a prima vista , h a grandiss imn i mportanza, se n on ~i vuo le che il riparo venga dopo pQchisshno tempo distrutto.
Di qua nt a utilità siano le s u ddette opere nelle posizioni d ifen sive, più che qua lunq ue ragionamento l o provano i fa lli de l ,1866.
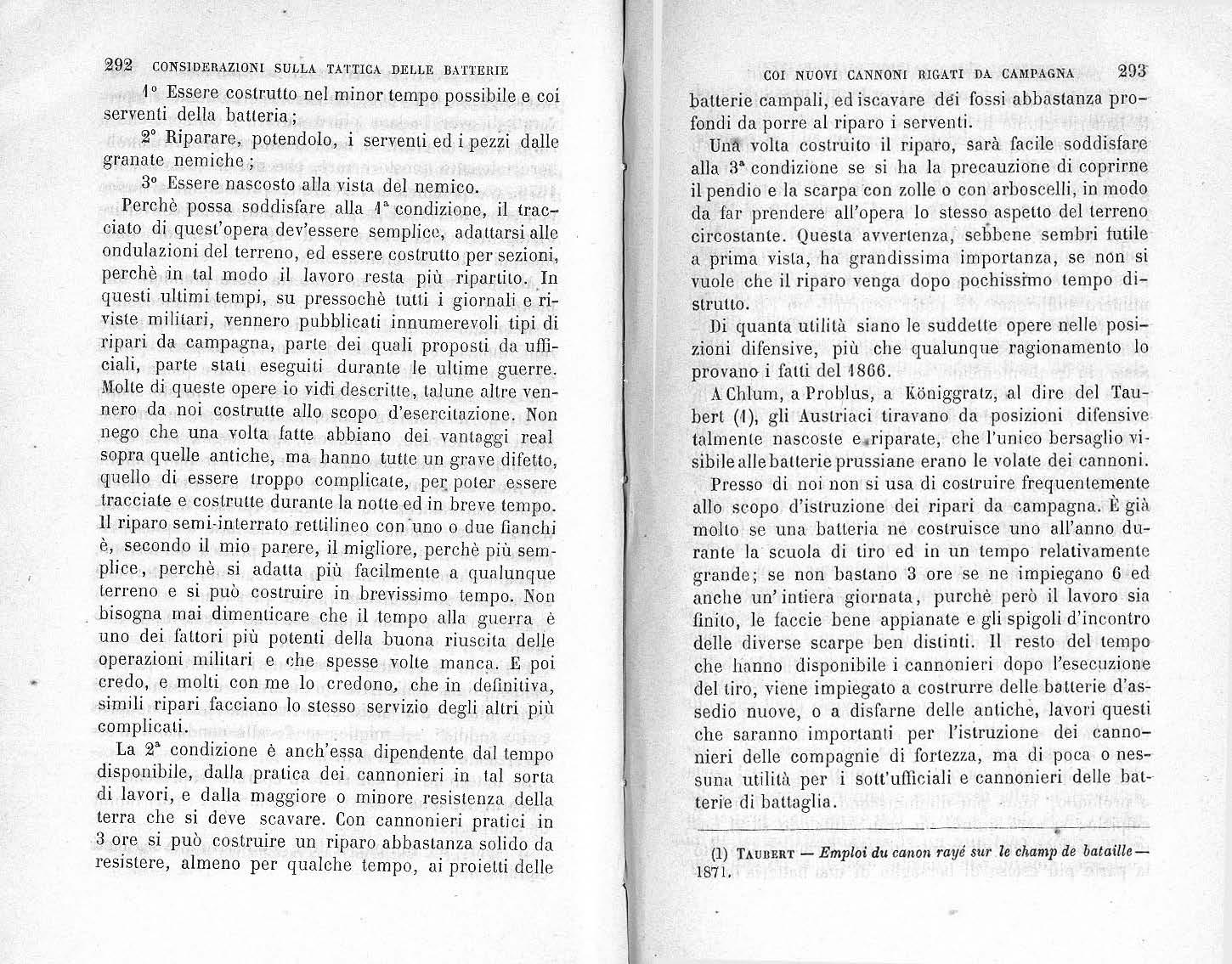
A Chlum, a Proq lus, a Kon iggratz, al dire del Taubert (1), g li Austr iac i tiravano da posizioni dife nsive t alm e nte n asc os! e e . ri parate, c h e l 'uni co b ersagl io v isibi le alle batteri e prussiane era n o le volate de i cannoni.
Presso di no i non si usa di co s truir e frequent e mente allo scopo d'istruzione dei rip ari d a c amp agna. È già m0llo se una. b a tte ri a ne costruisce uno a ll'a nno d urante ]a · scuola di tir o ed in un tempo r elativamente g rand e; se non bastano 3 ore se n e impiegan o 6 ed an che un' intie r a g i orna ta, purchè però il lavoro sia finito, le fac cie bene appianate e gli s pigoli d'in co ntro delle d iv erse s carp e ben dis tint i . Il res to del tempo che ha nno disponibile i cannonieri dopo l'es ecu zion e de l tiro, vi e ne impiega to a costru n e dell e batterfe cl' a s : sedio nu ove, o a di sfar n e del le anliche, Javon questt c he sara n no i mporlant.i pe r l'i s tru z ione de i cannonieri d elle compagnie di for tezza , ma di poca o ne ss una ut ililà per i s o tt'u ffici ali e cannoni e ri delle hat-· te ri·e di battagli a .
292
I
(1) TAUDRRT - Emploi d u ca11011 rayé sur le champ d e bataille1871
SuLLA TATTlOA DELLE DA'rTEIUK
Se invece, durante lé istruzioni lalliche ed i cawpi le ballerie giunte in posizion e fossero esercitate a co~ struire rapidi ripari , utilizzando gli ostaco li naturali che presenta il terreno e Yalendo s i degli strumenti da guastatore di cu i esse sono muniLe, io credo che si fareb be cosa di gr~nde vantaggio per l'istruzione, vuoi degli ufficiali, vuoi della truppa, e si riconoscerebbe ne.llò s t~ss o lem p_o che forse g li strumenti da guastatore, es1slent1 nel caricamento delle ballerie, non sono in n~un ero sufficiente da poter cosrrun·c un riparo per picco lo che sia . Si noti che d' ora innanzi la cos truzion e de lle suddette opere campali donà essere usata assai più frequen teme nte, se si vuole che una balleria pos ~é~ re star e, con qualche sicurezza, lungo tempo in pos1z1one, e non vada incontro alla probabilità di essere distrutta dal fuoco della fanteria od art igli eria nem ir:a.
Se fu ognora cosa importante il disporre O'Ji aran. . b treni rn modo da nascond erli alla vista del nemico, c?l mc1odo odierno di combattere co desta importanza s1 ac·crebbe d'assai, direi quasi che divenne un a necessità .
Se noi prendiamo a considerare i fatti delle ulcime guene, Yediamo che vi fu una tendenza piutloslo spiccaléJ a controbattere l' artig lieria nemica, masfì ime q~ando uno dei pactiti dovera allaccal'e. J.e bauag lie d1 Mars-l a-Tour, Gravelotte e Sédan ne fanno fede; le batteri e tedes che si avanzavano in una prima posizionè e di là aprivano il lor9 fuoco discrnuore contro le lince d'artiglierie nemiche, dando cosi airio alla fanteria di eseguire il suo spiegamenco. 0
È evidente che, quanto meno il bersaglio è esteso o profondo, tanto pit:1 diminuiscono le probabilità di colpirlo; sj avrh quindi un gran vantaggio se si potranno na.s condcre gli avantreni, che formano appunto la paete pn\ es tesa di bersag lio di una balleria in or-
CO! NUOVI CANNO N C IU(}Al'l OA CA~IPAGNA 205 dine di combattimento . A meno di operare in terren o piano e sco perto, non è d iffi cile il tr ova re, anche a distanza un po' grande dai pezzi in balleria, una piega . del terreno, una sie pe, un ostacolo qualunque insomma che copra gli avàntreni, mass ime poi nel nostro paese, inter~ecato com'è da a cc identalità di simi le natW'a. Osservisi però che non è conveniente l'esagerare la distanza degli avan treni cl ai pezz i , perché, oltre ad affaticare soverchiamente i serventi in ca ricati di porta rvi le munizioni, si cadrebbe nell'inconveniente d'incorrere in una perdila di tempo nel rimettere gli avantreni, quand o si do resse a van za re o retro cede re con qualche sollecitudine. Surebbe difiicile lo stabilire un ., ma x imum di questa dist anza; mi pare però che essa non debba superare i 50 metri. A tale di stanza i serventi non sono fuor di mod o aflaticatì, se si considera che essi po rtano 3 co lpi per volta ai pezzi, di modo che una ba lleria ha sempre a sua disp osizione una quarantina di col pi, per l' esecuzione dei quali ci vuole un tempo bastantemente considerevole. A ques ta distanza poi gli ava ntr eni , avan zandosi .al trotto, possono in brevissimo tempo essere riuniti ai loro affusti.
Un errore da ev itarsi è quello di di spo rre gli avantreni in clire7.ione paralle1~t al fronte della balleria, poichè così si acc res cerebbero g rand eme nte le probabilità di ess ere colpiti·, aumentando l' es tensione del bersaglio. Il pericolo poi sarebbe · magg iore se il nemico esegu isse contro la batteria il tiro a shrapnel!.
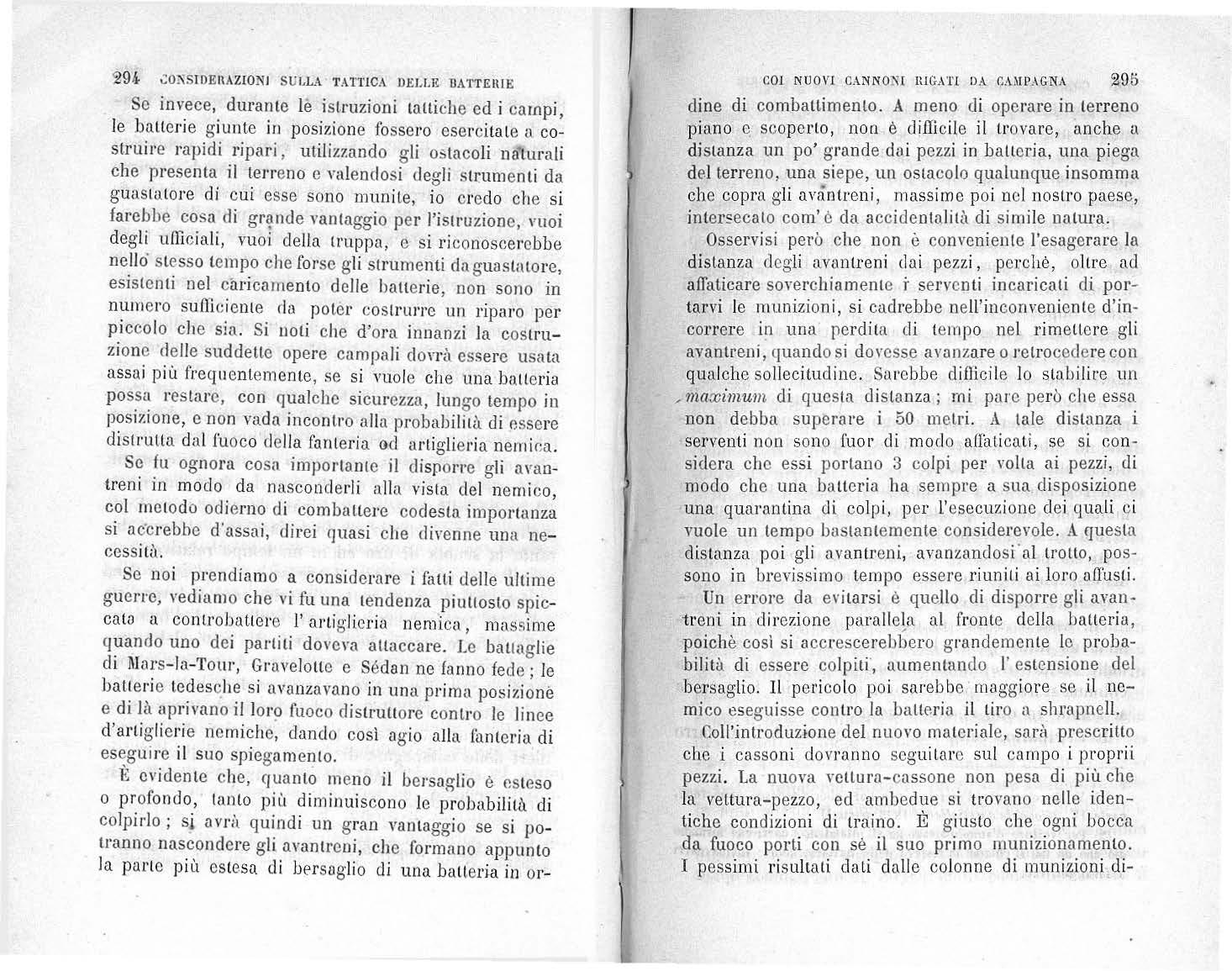
Coll 'introduzion e del nuovo materiale , sarà prescritt o che i cassoni dov r anno segu itare su l campo i proprii pezzi. La nuova vellura- ca sson e non pesa di più che la vettura-pezzo, ed ambedue s i tro vano nelle identiche con diz ioni di traino. È g iusto che ogni bocca da fuoco porti con sé il suo primo munizionamen to.
I pessimi ri s ultati dati dalle colonne di munizioni di-
294 .:oNSIOERAZiONJ
CONSIDERAZIONI SULLA TATTIC A DELLE JlATTERIE
st-accate da ll a propria balleria nel ,1866, più · ch e qualu'nque argomento, ci consigliano di restituire. ai pezzi -il pr.oprio cassone; tanto più che ora il munizionamento da 200 colpi che prima era, è ridotto a· 160 per pezzo.
Ciò posto, ognuno vede che se i cassoni fossero a poca distanza d·alla batteria e nella zona di fuoco, ,oltre ad ,es tendere soverchiamente il bersaglio e dar quindi grande presa al fuoc o nemi(:o, sarebbero cli grave impaccio nei movimenti che deve fare la batteria, tanto avanzando, quanto in ritirata. I cassoni quindi, per esser ben situati, devono esser posti all'infuori della sfern d'azione, od essere almeno nascosti .al . nemico e mantenuti in continua comunicazione colla risp e lliva batteria; non dev0 no inoltre riuscir.e d'inc aglio al libero avanzarsi delle truppe ch e si trovano dietro alla batteria stessa.
Il regolamento prnssiano ha, secondo me , risolto mo lto feliceme nte questo problema, e trovo r.he presso .di noi lo si potrebbe lelteralmente copiare.
Mi sia permesso di riassumere qui brevemente le d isposizioni regolamentari prussiane (·1}.
Quando una balleria marcia in prossi mità del nemico, essa si divide in due coloqne; la prima è formala da tutti i pezzi, la s eco nda da tùtti i cassoni , dalle vetture d'ammiili st ra zion e (2) . .Allorchè la prima colonna si avanza per disporsi in balleria, la secon da -si scinde in du e riparti o scaglioni .
Il 1° riparto, composto di tre casseni ·ed • un carro
COI NU OVI CANNONl RlG-ATI DA. CAMPAGNA 297 da balleria, del personale sanitario, degli uomi•n i e c:valli di riserva, si avanza çolla balleria nella cercbw. del fuoco nemico e si arresta, dice il r ego lamento, a: 50 o 100 passi dietro di un'ala della batteri~;
-soggi1.rnge lo s tesso rego l amento, questo. prmc1p10 e lungi de11' essere a ssolut?. ta nalt~r~ del terren.o, !a direzione de l fuoco nemico, la pos1Z1one delle p1 opI!e truppe devono essere consultate con cura in questa circosl.anza.
11 2° riparto, formato col r es to dei ca~soni .e d ella .riserva della batteria, si dispone dil:tro 11 1° riparto e ad una distnnza tale da essere all'infuori della zona del fuoco nemico, ed è p osto sotto gli ordini del capitaine d' armes. • ,' . . . . n ,t 0 r ip arto è mantenuto in con~mua comun.1caz10ne ·c olla lin ea de i pezzi e col 2° nparto, ~ed1~ nte un uomo a cavallo; il 2° riparto è in comunicazione ~ol 1° e colla colon-na di muniz ioni del corpo d'· esercito mediante un secondo uomo a cavallo. di'
I due · scaglioni sono posti sot~o la sorveglianz~ un ufficial e>, od in mancanza di esso, sotto un sott ufficiale ca.pace.
Quando gl i avantreni dei pezzi hanno ~onsumat? metà del loro .. munizionamento, due cassoni del 11° n·parto si avanz an o e , ri fo rnilili di munizioni, si ~e c?n~ .al -z0 il qualé, a sua volta, manda due cassoni piem .al ~·.
Quando il 2° riparto è senza munizioni,. man~a- alla -colonna di corpo d'eserc ito i suoi cassoni vuoti e ne riporla altrettanti pieni. ,. .
(n V. Regolamento d'esercizio per !',artiglieria tedesca, anno,H .67, parte IV, Giornale d'artiglforia U73, parte: II.

(2) Per vetture d'amministrazione si intendono .i carri cl1e formano ,ciò che da noi si chiama la riserva della batteria come: fucina, carri .a foraggio, ecc.
I due scaglioni devono sem pre stare all mfu.on dell e strade onde non impedirne il passaggio.
Sebbene sia raro il caso in cui una batteria debba in una g iornata campale consur:nare tu_tl? il s~o m~<I1izio11am ento , pure, merc è ta le disposiz10.ne s1 ha 11
°296
J
y~rò:
CONSIDERAZIONI SULLA TATTI CA DBLLE BATTERIE
vantagg io di aver sempre gli avanLreni pieni, e tull e l e vetture componenti la batteria sotto la mano d el rispe tti vo comandan te.
La pratica d'altronde sanzionò si mili prescrlZ!oni, non solo per rifornire di colpi gl i avantreni, ma ez iandi o per ri forn ir e l e colonne de i casson i mediante la riserv a del corpo d'esercilo.

No i ved iamo in fatti, n ell'ultima ca mpagna, qua ttr o ba tteri e a cavallo, a lla baunglia di R ézonville, seguilurc il fuoco senza inter ruzi one pe r ben undici ore , consu mando circa 200 colpi per pezzo, ossia 41 colpi di più del loro mu nizionam en to ord in ar io.
Ciò pro va a ù evidenza. la bontà delle disp osizion i r egolamentari pruss iane, ed al trns i c ne le comno i cazioni fr a le diverse colonne furono pi ennm~nte mantenute .
Oltre a i vantaggi suaccennati, questa disposizione ha anch e quello di non riuscire d' ingombro n e l ca so che si fo sse costretti ad una ritirata.
Da quanto venni fin qui clic.endo ri s ulta, che la scelta di una buona po s izione non è cosa tan to facile . 11 cap itano comand an te d'una batteria deve badare anzitutto al collocam e nto dei proprii pezzi, a lle linee di ritirala cd alle strade che permettono alla balleria di retrocedere o di avanzarsi, ai suoi fianchi, all e disposizioni delle trupp e colle quali si combatte , a nascondere i proprii avantreni. alle linee dei cassoni. Se si aggiun ge che la p os izion e deve essere scelta nel pi ù breve te mpo possibile al fine cli entrare immediatam en te in azion e , l e diffi co ltà s aranno certamente aumentate.
P er pote re in po co temp o e be.ne risoh•e re una qu estione così i mpor tante, si ri chiede n ell 'uffic ia le g rand e pratica ed uno studio profond o del terreno.
Per giungere poi con fac ilità e senza confusione allo.
posizione prescelta, è necessa ria n e i ~annonie~i molt~ abilità nel co ndurr e ; Tutte queste q uahtà non s1 acqmstano c he co l co ntinuo e perseverante s tudio del terreno, e colla mas sima diligenza e cura nello e seguire le istruzio n i cd esercitazioni ta tti c h e i n te mpo di pace .
I Prnssi an i n el 1866 vennero accusn ti di non aver saputo s cegliere a proposito le posizioni, e, u~a vol~a scelte, non averlè sapute prendere ch e con <l 1ffi colta, non cooperando in ta l guisa all'azione delle altre due a rm i. Ciò provenne dall'insnfficienza d'istruzione tattica neo-li ufficiali e dalla poca abilità di man ov ra o della tr uppa . . Quan to fecero gli a rtigli eri pru ssiani n e l lasso ~t tempo ,~he trascorse dal .'18~6 al rn70 per e,m:~d~rs!, lo si può vedere nel belhss1mo scrll_t o s~l alllgher1a prussia na del c a pitano 1Ia.zza pubb h ca tos_1 lo s_corso anno sulla Rivista militare (1). Il coro cli elog1 che vien tessut o ad e ssa da l utti gli scritt ori ch e si occuparono delle vicende de lla trasco rsa c~ mpag?a'.. prova, ch e le cure e l e fa ti ch e ~ura t ~ d~g h ~ffic1ah e tr uppa per p erfez ionarsi nelle 1s truz10m tatllche ed in quelle d i d ettagl io , n on rim.asero se~za frutt o, _e cosl l'artin·lieri a tedesc a riv e ndicò a sè 11 posto e minente che° le spetta sul campo di battaglia. . . Procuri a mo no i p a re di imitarla, e rammentiamoci che se saremo chiamali ad una guerra, è s ul nostro suoÌo che dovremo cornbi,ttere, e che qu indi ci è doppiam enle necessario il conos~erl~, a~fi~e di poter!o utilizzare per r agg iungere l'efficacia d1 tll'o, e sodd 1-:sfa.re nel miglior modo alle condizion i di sicur ezza d1 una batteria. (1) \Tedi
298
COI NUOVI CANNONI ll!GATI DA CAMPAGNA 299
ANNO xix , VoL. 1. 20
dispense del set tembre, ottobre e novembre ~872 .
Scelta de l mom ento opportuno per aprire il fuoco .
La soluzione, più o meno perfetta, della seconda ques tio ne dipende dal complesso di varie circostanze che appariranno nel cors o del cap itolo.
<< Le guer re del 1866 e 1187 0, di ce il Boguslawski,
« provano chia ramente che la potenza dell'artiglieria
« aumen tò di valore nel tiro alle gra ndi d is tanze, a « ca usa de i perfezionamenti s ta ti introdotti nelle bocche
« da fuo co; ma per contro il tiro alle piccole distanze
« din1i nu l d' imp ortan za a causa della riduzione dei ca-
« libri. e qu indi della .relati va dimin uz ione deg li effe tt i
« della mitraglia e della c r esciuta g ittata delle armi
« po rtati li » .
Ne vien e di conseg uenz a che il fuoco dovrà essere aper to ad una distanza ta le che sia la massima della porta ta efficace delle bocche da fuoco . Fondandoci, non su lle proprietà bali s lich e de l nuòv o cannone, ma sui risultati ou enu tis i ne ll e due ul tim e gue r re, cercheremo di de te rminare quole sia ques ta distanza.
Nel '1866, gli Au striaci i n ge neralo a priro no il fuo co fra i 2 , 000 ed i 3,00 0 metri ed. ouennero ri su ltati sufficientemente buoni. Faccio però osser vare che ess-i tiravano da posizioni difensive, e su punti la cui dista nza era stata quas i sempre mi su r ata esatta mente prima; è questo uno dei motivi per cui gli Austriaci ebbero soventi volte prepond e ra nza di fuoco s ulle batte rie prus s iane.
Queste all' in contro che agirono offensivamente, caddero nell' errore di tir at·e a distanze p resso a poco
COI NUOVI CANNONI ~IGATl DA CAMPAGNA 30 ,1 uguali, e molte volte da pos izioni do mina te. Ne
venne che i P russiani ebber o ognora uno svantaggw marcato di fuoco d'artiglieria (se s i ecce ttuano a mo' d'esempi o le bri llanti fazion i di Nach od e ~kalilz) perché dess i non conoscevano esa ttamente la distanza che li se parava da l nemico e perché non e ra dat o loro di vedere con ce rtezz a il risult a lo del tfr o pe r poterlo p oi correggere. Ciò avven ne malgrado che 1~ bo~ch_e a fuo co rigate prussiane per nulla fosser~ mfer10r1 '. quant o a proprietà balis ti che, a q uelle a us triach e, anzi ad esse superiori.
P o tr ei, a con!crma di quanto scrivo, citare un numero grand issimo di fatt i, ma per brev it à rimando il lettor e alle ope re del Tauberl, ed alla s tessa Relazione uffic iale de llo stato maggiore pr ussiano sulla campagna iu d iscorso.
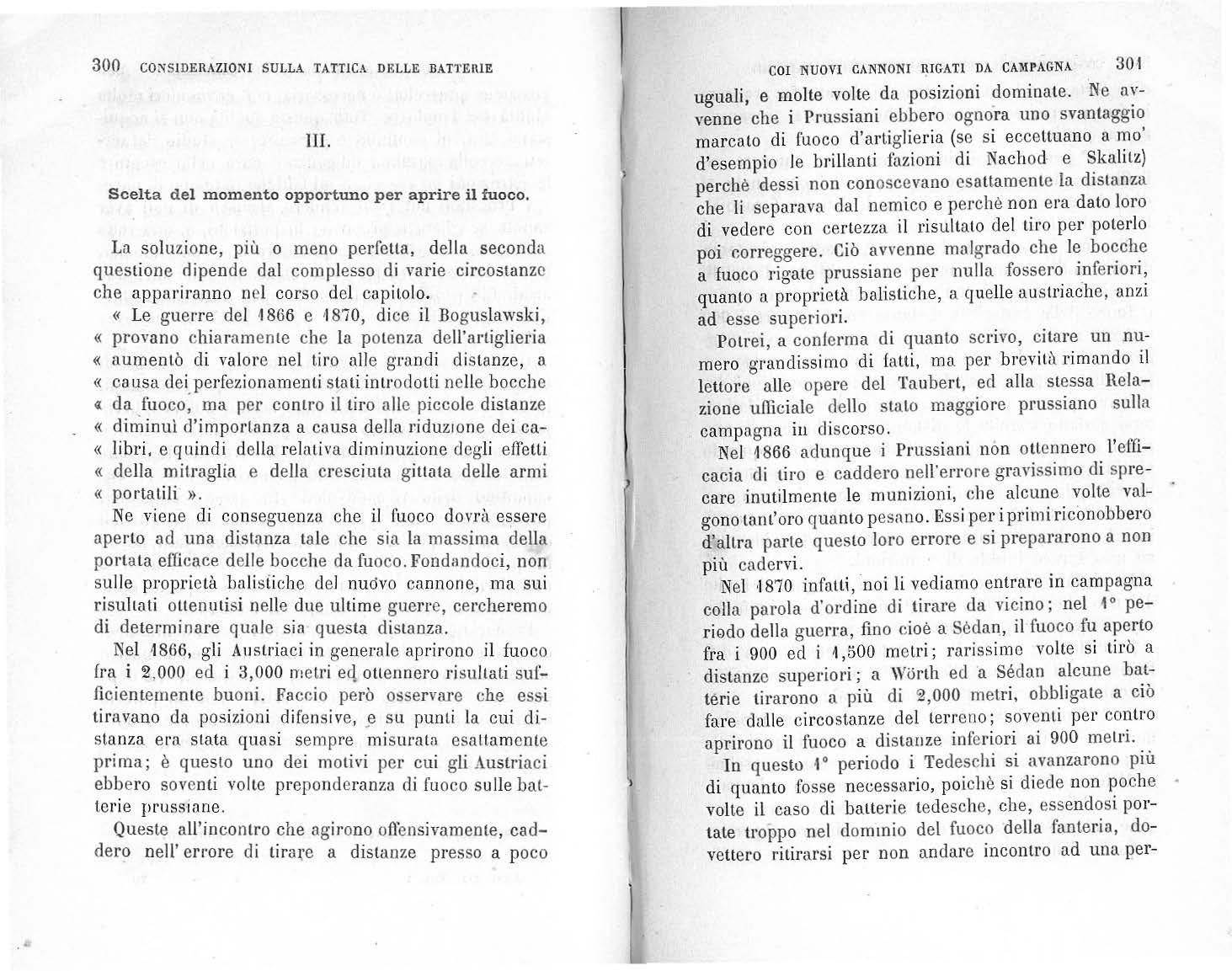
Ne l 1 866 adunq ue i Prussiani non otte nnero l'efficacia di tiro e caddero nell'errore gravissimo di s precare inuti l mente le munizioni, che alcune volte valgono tan t'oro qua nto pesano . Ess i per i pri mi ricon obb ero d'al tr a parte questo loro er r ore e si prepararono a non più cade rvi. . .
Nel ,J 870 infatti, noi li vediamo entrare m campagna co ll a parola d'ordine di tirare e.la vicino; nel 1° peri0d o de ll a guerra, fino c io è a Sèdan., il fuoco f~ aperto fra i 900 ed i 1,500 metri; rari ss i me volte s i tirò a dis tanze superiori; a Worth ed a S~dan a.lcune ba_l: terie tirarono a pi ù di 2,000 metri, obbligate a c10 fare da lle c ircostanz e de l terreno ; sove nt i per contro aprirono il fuoco a distanze infe riori ai 9 00 metri ...
In questo •1° pe r iodo i Tedeschi si avanzarono pm di quanto fosse necessa rio, po ichè si d iede non ~oche volte il caso cli batterie tedes ch e, che, esse nd osi po rtate troppo nel do m inio del fuoco della fanteria, dovettero ritirarsi per non andare incontro ad una. per-
300 CONSIDE RA ZIO NI SULLA TATTICA DELLE BAD'El\l E llJ.
a:-
CONSIDEUAZIONI SULLA TATTICA DELLE BATTE I\! & dita certa, e talune altre fiale si dovetle far ava nzare la -fanteria per sosiene r e le batteri e che si trovavan o a mal partilo.
Nel 2° pnri odo essi videro che, senza nuocere all'efficac ia del tiro, si po teva aprire il fuoco anche al di là dei 2,000 metri, ed i limiti di distanza furono allora s tabiliti fra 900 e 2 ,200 met ri.
Siccome i. nostri nuovi can noni, qua nto a giustezza di tiro, nulla hanno a temere al confronto di quelli prussiani , ne avve rrà che anche per noi si d ov rà aprire il fuoco delle ba tterie a dis tan ze co mprese fra i 900 e 2,200 metri, sebbene la loro portata sia assai maggiore . Al di là di 2,200 metr(si potrìt tirare , com e per lo addietro , quan do si debba no tenere posizioni difensive, qualora però s ia conosciu to il terreno da battersi e siano cognite le distanze dalla balleria di vari punti da cui possa apparire il nemico; oppure quando si abbia un bersaglio esteso, come un accampamento , un villaggio, ecc . In tali casi la distanza si potrà portare fino a 3,000 metri; pi.ù in là, il tiro sarebbe assai in cer to e di poco frutto, e si andrebbe allora inc~nlro ad uno sprec o inutile di mun izioni.
Le ragioni che consi gliano a non allargare il limite del tiro Gltre i 2,200 metri (limite che parmi p iù che suffici e nte) sono principalmente Je seguenti:
In 4° luogo ; al di là di 2,200 metri è cosa dii'.. ficili ss ima il g iudicare l'effetto d el tiro, anche avend o l'occhio arm ato d'un buon canoc ch iale.
In 2° luogo gli ang oli di caduta crescono rapidamente e dimin u iscono in conseguenza gli spazi battuti ; cosa qu esta da tene rsi in gran conto, massim e • se il bersaglio è una truppa amma ss ata in colonna .
In 3• luog o crescono le difficoltà per trovare, mass ime nel nos tr o paese, dei campi di tiro superiori a quelle distanze.
COI N UO VI CANNONl JUGATI DA CAM PAGNA 303
Una circostanza che per u lli mo consigli a di restringere il limite massimo del tiro an zichè all a rga rlo, è la poca probabilità di colpire il bersagl io quand o questo è in mQvim ento; eviden temente le probabilità aumenteranno quanto min ore s arà la distanza.
Il princip e di Rohenl ohe-Ingelfin gen a ques to proposito di ce :
« Se è difficile al cacc iatore cogl iere un uccello al « volo, sebbene ei pos sa seguirn e co l fucil e il movi« men to, si pensi quanto più ma lage vole esser debba « tira re contro bersagli mobili co n una macchina « s tabile quale è una balleria che funz iona a coma ndi, « i quali dev ono poi essere intesi ed esegu iti!» (1)
L'aspe tt o del terr eno e le condizioni atmosferiche sono pure cir cos tanze esse nziali per determinare la scelta del momen to opportuno per aprire il fuoco.
Siccome l'arti glieria deve coop e rare all'azi one delle altre arm i, l'ufficiale d'artiglieria dovrà conoscere quale sia l'obbiettivo loro affine di se con darie, e nell' apertur a del fuoco, e n el sno svolg im ento, dovrà ten er conto, vuoi delle moss e fot te dalle proprie truppe, vuoi di quelle eseguite dall'avversario .
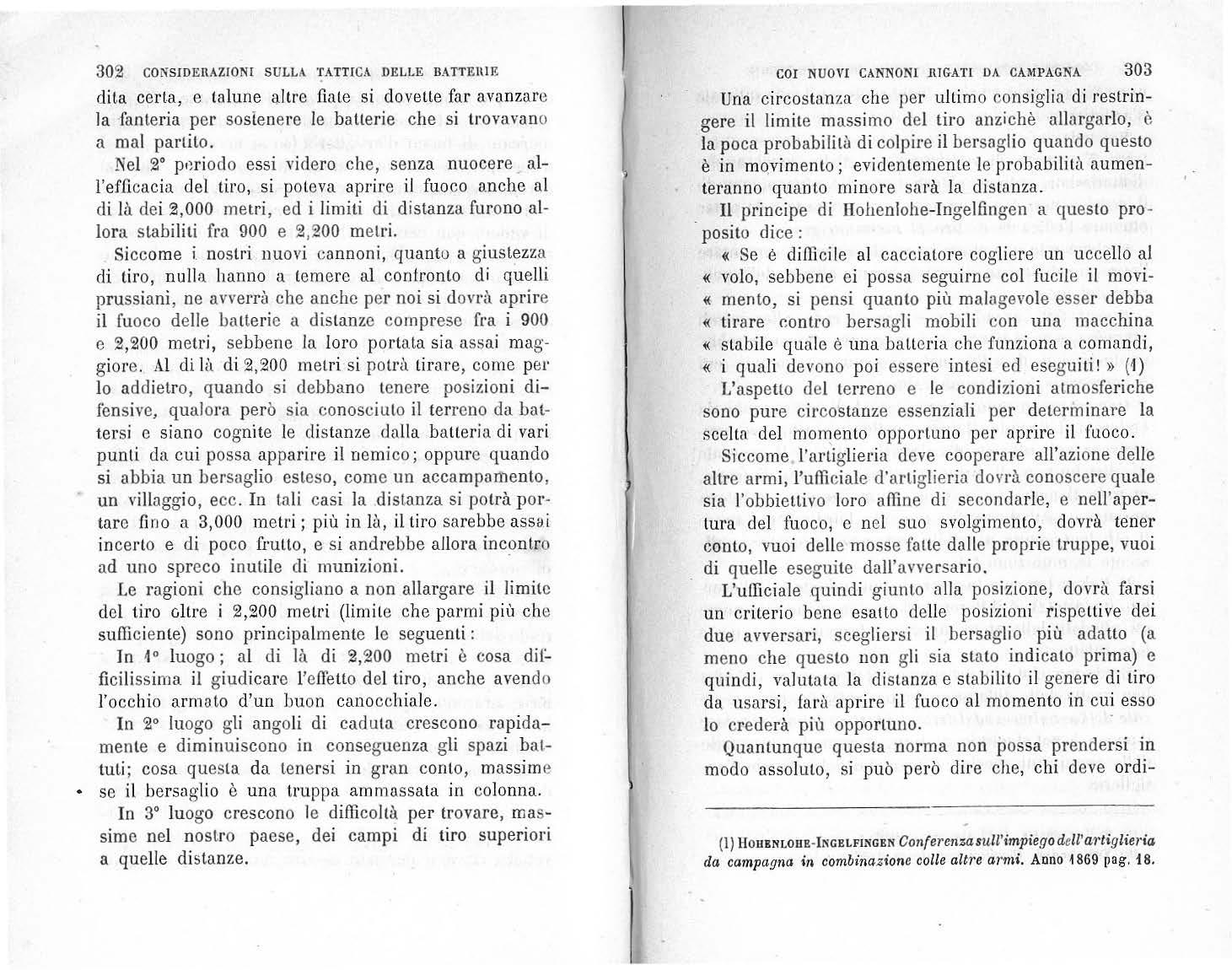
L'ufficiale quind i giunto alla p os izione, dovrà farsi un criterio bene esat Lo delle posizioni risp elli ve dei du e av vers ari, scegliersi il bersaglio più adatto (a me no che questo non gli s ia sta to ind ica to prima) e quindi, valutala la distanza e stabilito il gene re di tiro da usarsi, farà apr ire il fuoco al momento in cui esso lo crederà più opportuno. ·
Quantunque questa n orma non p os sa pre ndersi in modo assoluto, si può però dire che , chi deve ordì-
302
(1) HOHBNLOHB - INGELFINGEN Con{erenzasull'impiego dell'a1·tiglieria da campagna in combinazione colle altre armi. Aono ~869 pag. 18.
CONSIDERAZIONI SULLA TATTICA DELLE BATTERIE
nare l'apertura del- fuoco, debba essere il solo ufficiale d'artiglieria.
Succede infaui assai frequentemente e presso quasi tutti g li eserciti, di vedere ufficiali d'altre armi, anch e distintissimi, ordinare all'artiglieria di farfuoco, quando il nemico non è ancora giunto a portata tale da poter ottenere l'efficacia di tiro al massimo grado.
Così facendo non si arriva ad altro che .ad aumentare l'orgasmo che esiste già naturalmente all'atto dell'apertura del fuoco.
Questi faui accaddero, e non di rado alle grandi manovre, e se .si ripetessero in guerra s'ingenererebbe confusione e disordine nel momento appunto in cui -è necessari11 la massima calma :
Questo inconveniente era stato lamentato anche da Federico il Grande, il quale, nelle sue ordinanze, prescriveva ·agli ufficiali d'ar~tiglieria, che se . il generale d i di visione o di brigata ordina vano loro di tirare, quando il nemico non fosse giunto ancora a buona portata, qu esti dovessero eseguire l'ordine, ma tirare il più lentamente possibile onde non isprecare inutilmente le munizioni (~) .
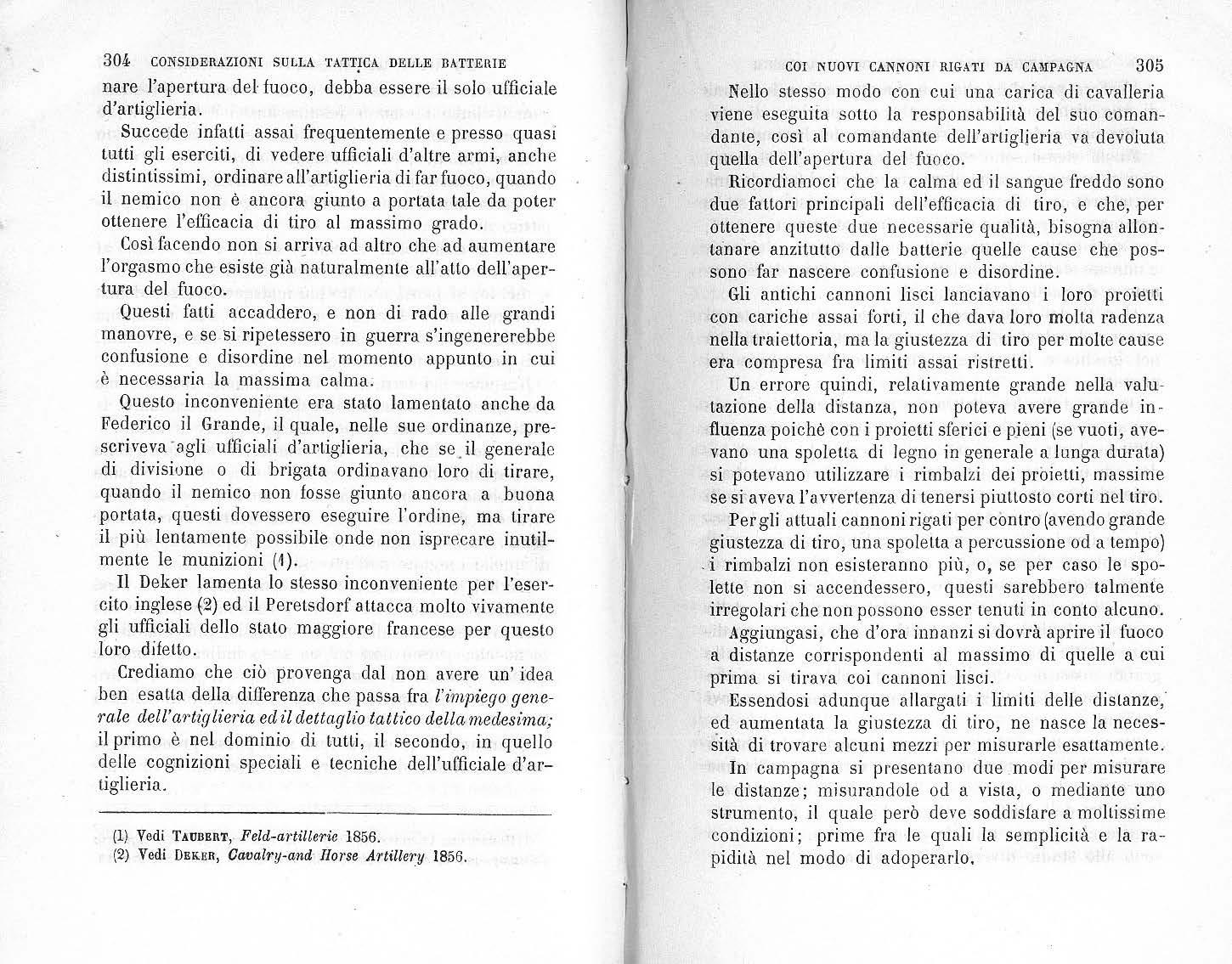
Il Deker lamenta lo stesso inconven·ien te per l'ese1·cito inglese ~2) ed il Peretsdorf attacca molto vivamente gli ufficiali dello stato maggiore francese per questo loro difetto.
Crediamo che ciò provenga dal non avere un'idea ben esatta della diflerenza che passa fra l'ùnpiego generale dell' a1·tig lieria ed il dettaglio tattico della medesima; il prirno è nel dominio di tutti, il secondo, in quello delle cognizioni speciali e tecniche dell'ufficiale d'artigl ieria .
(1 ) Vedi TAUOBRT, Feld-artillerie 1856.
(2) Vedi 0BKER, Cavalry-and Ilorse Artille1:y 1856.
COI NUOVI CANNONI RIGATI DA CAMPAGNA 305
Nello stesso modo c·on cui una carica di cavalleria viene eseguita sotto la responsabil ità del suo comandante, così al comandante de ll'a rtiglieria va devoluta quella dell'ap ert ura del fuoco.
Ricordiamoci che l a calma ed il sangue freddo sono due fattori principali dell'efficacia cli tiro, e che, per ottenere queste due necessarie qualità, bisogna allonta·nare anzituuo dalle batterie quelle cause che possono far nascere confusione e disordine.
Gli antichi cannoni lisci lanciavano i loro proietti con cariche assai forti, il che dava loro molta radenz a nella traiettoria, ma la giustezza di tiro per molte cause era compresa fra li miti a ssai ristretti .
Un erroré quindi, relati vamente grande nella valutazione della di:st.anza, non poteva avere grande influenza poiché con i proietti sferici e pieni (se vuoti, avevano una spoletta di legno in generale a lunga durata) si pote van o utilizzare i rimbalzi dei proietti, massime se si aveva l'avver tenza di tenersi piuttosto corti nel tiro.
Per gli attual i cannoni rigati per contro (avendo grande giustezza di tiro, una spoletta a percussione od a tempo) , i rimbalzi non esisteranno più, o, se per caso le spol ette non si accendessero, questi sarebbero talmente irregolari che non possono esser tenuti in conto alcuno.
Aggiungasi, che d' o ra innanzi si dovrà apri r e il fuoco a distanze corri spondenti al massimo di quelle a. cui prima si tirava coi cannoni lisci.
Essendosi adunque allargati i limiti delle distanze; ed aumentata la giustezza di tiro, ne nasce la necessità. di trovar e alcuni mezzi per misurarle esattamente.
In campagna si presentano due . modi per misurare le distanze; misurandole od a vista, o mediante uno strumento, il quale però deve soddisfare a moltissime condizioni; prime fra le qual i la semplicità e la rapiditii. nel modo di adoperarlo.
304
CONSIDEflAZIONI SULLA TAT'l'IçA DELLE BATTERIE
L'ertore probabile che s i commette nella valutazione di una distanza a vista è, al caso pratico, direttamente propo rzionale a lla lontananza del bersaglio.
Finchè desse sono comprese fra 900 e ,500 metri, non si potranno commettere grandi errori (avendo una certa pratica nella misurazione loro a vista) o se si commettono, possono veni re facilmente corretti poicbè ' ' fra quei limiti, si può, nella maggior parte dei casi, - giudicare dell'effetto del tiro dallo scoppio de lle granate e da quello degli shrapne'ls. ·
Al di là dei 11, 500 metri crescono grandemente ' o-Ji errori nel calcolo delle distanze a vista e le difficoltà nel giudicare il risultato del tiro dallo scopp io dei proietti .
Queste difficoltà d'altronde aumenteranno sempre più se si. considera che in pratica sarà eccessivamente difficile il saper scernere con sicurezza il punto di caduta di un dato proieuo, quando vi· siano a ltre batterie vicine che facciano fuoco, quando i gas svolti dalla polvere nascondono il bersaglio, quando la posizione nemica è coperta da accidenti del terreno.
Sappiamo d'ahra parte, ehe quanto più si aumenta l'alzo, tanto maggiori sono gli angoli di caduta, e minori gli spazi battuti, meno violento I; effetto dello scoppio e quindi le p robabilità d i colpire saranno diminuite. Ne nasce per conseguenza che il tiro alle grandi distanze diviene ognora più problematico, e che non si può più utilizzare la lunga gittata dei nuovi cannoni.
Per aumentare, almeno in,gran parte, la probabilità di co lpire ai limiti massimi del tiro, sarà cosa utilissima avere un telemetro che ci d ia con bastante esattezza la misura delle distanze. Questo b isogno si fa talmente sentire che pr esso tutte le potenze furono adottati o sono allo studio diversi tipi di telemetro.
COI NUOVI CANNONI RIGATI DA CAMPAGNA 301
Presso di noi, nel 1868 e nello scorso anno 1872, si fècero esperienze e studi su diversi di tali strumenti quali il Nolan, il Gastaldi, il Plebani, il Goulier, il Gauthier ed altri. La descrizione di codesti strumenti e le esp erienze eseguitesi su di essi si trovanò pubblicale nel Giornale d'artiglieria, parte 2", di detti anni. _ Pare ch e il telemetro Gauthier sia il migli ore per gli usi de lla guirra di campagna, sebbene non dia risultati così esatti come taluni altri, ad esempio il Nolan; ma la sua semplicità, il suo facile e spedito uso, . il vantaggio che ha cli poter essere trasportato a tracolla e maneggiD to anche da un solo osservatore lo fanno preferire agli altri .

Il Ministero della guerra, nello scorso anno, fece distribuire due di tali istrumenti a ciascuno dei reggimenti d'arti glieria allo scopo di esercitare gli ufficiali nel loro uso. La loro bontà venne esperimenta ta nei tiri annuali di battagl ia; buona parte degli ufficiali ne lodano le qualità,- da alcuni però non si ammetle a questo telerneLro tutta l'i mportanza che si merita la quale anzi viene impugnata.
Io non sono .di quelli che credono essere necessario che, ogni qualvolta una balleria prende posizione, il capitan o debba 1frima misurare la distanza col telemetro; accadrà per contro soventi volte ad una baLteria, giunta in posizione offensiva, di dover senz'altro cominciare il fuoco accontentandosi di valutarla a vista; ammetto però che questo caso debba succedere solo quando le di stanze cui si deve tirnre siano comprese fra i 900 e 1500m. Al di là il telemetro diviene una necessità, se non si vogliono sprecare inÌHilmente e tempo e munizioni per correggere il tiro. .
La perdila di tempo d'a ltra parte cui s i va inc ontro pelta misura della distanza (perdita di te mpo relativamente · assai piccola) viene largamente c ompensata
306
l
SULLA 'fATTICA DELLE BATTEnm
dalla maggiore esattezza di Liro che si avrà certamente ai primi colpi quando essa sia misurata collo strumento in questione.
Che il Lelemetr o poi sia utile quando si debbano occupare posizioni difensive, non credo sia il caso di dimostrarlo. Si potranno con esso m isurare diversi punti sul terreno circostante da cui presumibi lmente deve arrivare il nemico, e così si potrà aprire il fuoco anche alle maggiori distanze, utilizzando in tal guisa la lunga gittata e la giustezza dei noslri cannoni.
IV.
Scelta del bersaglio più conveniente.
Gli uffici che ha l'artiglieria sul campo di battaglia, sono anche attualmente quelli stessi che aveva allorché era mun ila di cannoni lisci. L' inlroduzione dei cannoni rigati ed il nuovo metodo di combattimento delle alt re due arm i , cambiarono per essa il modo di soddisfo.re al suo compito.
· Come ognuno sa, gli uffici dell'art iglieria si possono riassumere nei seguenti :
Iniziare il combattimento e sostenerlo;
Preparare gli attacchi;
Deviare dalle altre truppe il fuoco dell'artiglieria nemica;
Cooperare all'inseguimento ed intraprenderlo da so la quando le altre truppe ne s iano impedite dao-li osta· coli del terreno;

Servire di punto d'appoggio nelle ritirate.
Lasciando da parte quelle consideraz ioni che conduco no a determinare come debba l'artiglieria essern im-
piega ta per soddisfare al proprio servizio, considerazioni queste che entrano nel campo dell' impiego generale dell' artiglieria colle altre armi , cerch erò di vedere contro chi debba essa di preferenza dirigere il suo tiro nel corso ordinario de l combattimento, oggetto appunto del presente capitolo .
Dag li uffi ci dell'artiglieria più sopra esposti, si deduc e che le batterie saranno di gra nde utilità in tutte le diverse specie di combattimen to , le quali si possono ridurre a quatt ro:
Combattimento offensivo;
Id. d ifensivo;
Id . d'inseguimento;
Id. di ritirata.
Nei movimenti oflensivi una balleria può essere destin a ta a far parte dell' avangu ardia della divi s ione , oppure far parte dell'artiglieria divisionale o di corpo d'es ercito.
Qu~ndo una balleria ali' avanguardia deve entrare in azione, essa dovrà prendere una posizione verso la testa dell'avanguardia, ed eseguire dei liri sui diversi punti occupati dal nemico allo scopo di attirare a sè il° fuoco della sua art igli eria. . In Lal modo il comandante l'avang uardia potrà ingannare l'avversari o sulle sue intenzioni e preparare, se lo crede conveniente, l'attacco ('1). .
Quando il comandante dell' avanguardia ha deciso l'altacco e ne ha- notificato il punto p1·eciso al comandante la balleria, questa, se già non lo è, deve por-
(~) B110na parte delle idee svolte in questo capitolo riguardanti le fasi di\•ersc dell'az iono dell'arti g lieria nei combattimenti, le trassi dallo sc ritto del principe di Hohenlohe-lngenfilgen pubblicatosi a Berlino nel 4 869, idee che eb bcrv in g ran parte splendidissima conferma dai fatti della susseguente campag na .
308 C0NS1DE11AZIONI
0
COI
309
N UOVI CANNONl IIIGATI DA CAMPAGNA
CONSfDERAZIONI SULLA TATTICA DELLE BATTERIE
tarsi ad oc c~1p~re.:una posizione a distanza tol e da potere con proba bil1ta. d1 successo smontare l'al'liglieria nemica, e: questa una volta scossa , deve cercare di porre il disordin e fra qu elle truppe nemiche che, ancora intatte, potrebbero compromeltere la buona riuscila del}' operazione.
Se una batteria fa parte dell' arlio-lieria. division a le ? di corpo d' es~r~i~o, essa entrerà in azione quando 11 grosso della d1V1s10ne comincia il suo sp i egam ento.
I~ ~u~sto caso essa dovrà portarsi a rafforzare l' artigltena d~ ll'~ vanguardia già impegnata, avendo l' avver~enza di t1ra:e prefe ribilmente sulle co lo nne di fanten~ e cav~l~ena c.he ve~gono a sostenere la posizione , e d1 non dmgere 1 colpi sulle batlerie nemiche, che solo a}l?rquando le colonne nostre muovono all'attacco.
Not1s1 che !~artiglieria deve seguitare il tiro sulle al~r~ du~ armi finchè la sua fanteria é giunta nel doi~1mo !icw·o del proprio fuoco, fintantochè cioè essa s1 trovi a ooom circa dalla p osizione che si attacca..
, A~p~na. le nostre c?l.onn e sono g iunte in questa zona, I ar tr gliena dovrà dmgere un fnoco attivissimo sulle ~atterie _nemiche, o su quelle t?-uppe che mina cciassero i fianchi delte , colonne attaccanti, ma preferibilmente sull' arl(qlieri·a. ·
Rius?ito. l'~tt~cco ed ?ccupata la posizione conquistata, .1 ~r~1gl1ér~a deve dirigere i suoi colpi suJ!e truppe {:h~ s1 r1.L1eano m~ ped?.ndo lo.ro di riordmarsi ed agevo l.an~o m tal guisa I msegmmento alla cavalleria. Se po i vi fosse un ostacolo tale da impedire alle allre truppe .d~ continuare l'inseguimento, essa dovrà dalla sua pos1z1one ~eguitare il suo tiro allungandone le gillatè fino alla mass.1m_a permess~ dalla bocc<J a fuoco (3500m).
A meno che Il comball1mento abbia luogo per in~ont:o. o ye~ · sorpresa ( nei quali casi l' impiego delI art1gl1eria e dettato dal.le circostanze speciali in cui si
COI NUOVI CANNONI l\IGATI DA CAMPAGNA 31 •f trovano i due partiti opposti} l'incontrn, nell'azione offensiva, avrà generalmente luogo con truppe che occupano posizioni difensive e nas·coste dietro ostacoli di terreno.
A seconda del le informazioni avute, d elle osservazioni che sarà dato di fare; dovrà il comandante la batteria giudicare se gli ostacoli, d iet ro cui è nascosto il nemico, siano tali da poter essere abbattuti coi pezzi del calibro di cui dispone, oppure se sia il caso di usare allrc specie di tiro, che quello di lancio, per colpire il nemico nascosto.
11 principio . di non tirare che sulla fanteria nemica tanto nel preparare un attacco, quanto nell'impedirlo venne osservato dalle artiglierie austriaca e prussiana alla battaglia di Koniggratz .
Le batterie prusiiiane non poterono smontare le austri ache perchè troppo nascoste, mentre queste cannoneggiavano in p i e na sicurezza le colonne prussiane.
Ma quando i Prussiani presero la posizione tanto accanitamente disputata, le ballerie loro, occupatala prontamente, diressero un fuoco vivissimo conLro le colonne austriache battenti in ritirata senza preoccuparsi dell e incessanti scariche delle batlerie nemiche {·1) .
Allo scopo di smontare le batterie nemiehe s i arriva mediante l a preponderanza di fuoco. Questa si ottiene o col concentrare un maggior numero cli bocche a fuoco del nemico sul punto a batlere, o ponendo in azione artiglierie di calibro maggiore .
È questo uno dei motivi che indussero l'artiglieria prussiana ad adottare i due calibri <la 4 e da 6 per le batterie da campagna; e per la stessa ragione si sta ora studiando presso di noi il nuovo cannone del calibro da centimetri 8,5 da i ntrodursi nell'armamento delle nostre batterie di battaglia.

310
(4) V. opera citata del Grande Stato :Maggiore prussiano.
CONSIDEUAZLONJ SULLA TAT'l'ICA DELLE BATTERIE
Una delle cause dei disaslri sofferti dai Francesi, fu la costante inferiorità di calibro che ebbero a petto dei ·loro ~vversa1;ii. Le loro batterie da 42, ognora con?na~e ~n _fon~o delle colonne e non facienti parte dell. art1gher1a di. baltaglia, non giunsero che troppo tardi per prenùere parte de,:isiva ai combattimenti· di ciò fanno ampia fede i rapporti ufficiali di Frossa;:cle di Bazaine sulle battaglie di Mars - la- Tour e Ilézonville.
Nei combatlimenli difensivi, l'artiglieria si troverà già nella posizione stata prescelta; avrà. quindi avuto campo a nasconders i e coprirsi .
Da questa sua posizione la batteria dovrà cominciare il fuoco · sulle colonne nemiche n qualunqne arma appartengano, avendo pe1·ò l'avvertenza di tirare sul principio lentamente e di non ispieo·are tutta la sua . o pot enza. · Quando il nemico è giunto nel dominio del fuoco della batteri{), allora essa spingerà il tiro colla massima energia . . quando l'artiglieria nemica si presenta per meuers1 rn posizione od è giunta a buona portata ( distanza mass ima 2000m) , la batteria deve senz'altro rivolgere il proprio t iro su di essa, smontarla od a lmeno impedirle di mettersi in batteria.
Anche in questo caso il cap·itano determinerà, a. seconda della truppa su cui deve tirare e la distanza a cui essa si trova, i l proietto ed il genere dì tiro da adoperarsi . ·
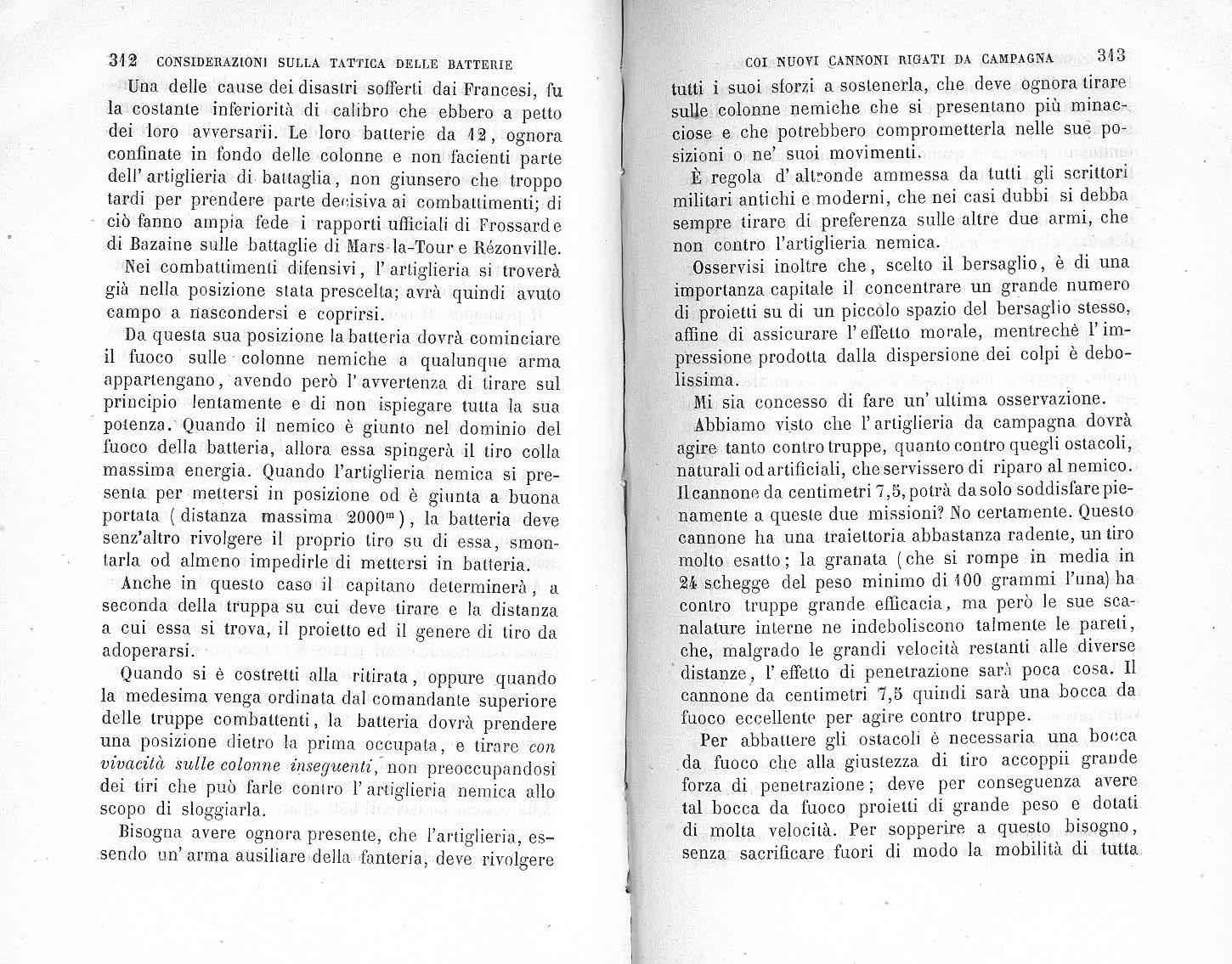
Quand~ si è costrett( alla rit irata, oppure quando la medesima venga ordinata dal comandante superiore delle tr~ppe co~battenti, la batteria dovrà prendere u?a ~o,s1z1one chetro la prima o ~cupala, e tirar e con vz ,~ac,it~ sulle c?lo~ine in seguenti, non preoccupandosi dei tm che puo farle coni l'O l' al'tiglieria nemica allo scopo di slogg iarla.
Bisogn a avere ognora presente, ch e l'artig lieria, es.sendo u n'arnia ausiliare della fanteria, deve rivolgere
tutti i suoi sforzi a sostenerla, che deve ognora tirar e sulle colonne nemiche che si presentano più minac- . c iose e che potrebbero comprometterla nelle suè posizioni o ne' suoi movimenti.
È regola d' alL:·onde ammessa da tutti gli scrittori m ilitari antichi e moderni, che nei casi dubbi si debba sempre tirare di preferenza sulle altre due armi, che non co,ntro l'artiglieria nemica .
Osservisi inoltre che, scelto il bersaglio, è di una importanza capitale il concentrare un gr.ande numero di proietti su di un piccòlo spazio del bersaglio stesso, affine di assicurare l' effello morale, mentrechè l' imp·ressione prodotta dalla dispersione dei colpi è debolissima.
Mi sia concesso di fare un ' ultima osservaz1one. Abbiamo vi.sto che l'artiglieria da campagna dovrà agire tanto contro truppe, qunnto contro quegli ostacoli, naturali od artificiali, che servi ssero cli riparo al nemico.
Il cannonA da centimetri 7 ,5, potrà da solo soddis fare pienamente a quesle due missioni? No certamente. Questo cannone ha una traiettoria abbastanzn radente, un tiro molto esatto; la granata ( che si rompe in media in 24 schegge del peso mio imo di 100 grammi l'una) ha contro truppe grande efficacia, ma però le sue scanalature interne ne ind ebolis cono talmente le pareti, che, malgrado le grandi velocità restanti alle diverse
· distanze, l' effetto di p enetrazione sarh poca co s a. Il cannone· da centimetri 7 ,5 quindi sarà una bocca da fuoco eccellentr per agire contro truppe.
Per abbattere gli ostacoli è necessnl'ia una boc:ca da fuoco cqc alla giustezza di tiro accoppii grande forza di penetrazione; deve p er conseguenza avere tal bocca da fuoco proie tti di grande peso e dotati di molta velocità. Per sopperire a questo bisogno, senza sacrificare fuori di modo la mobilità di ttitta
°SH~
COI NUOVI f ANNONI RIGATI DA CAMPAGNA 313
SULLA TATTICA DELLE BATTEll!E ECC.
l'élrtiglieria da campo, anticamente esistevano ed esistono lutt'ora presso di noi batterie da 12, dette di posizioqe, le qual i però erano, almeno dal 866 in qua , tenute in riserva e quindi molto lungi dal teatro dell'azione. Attualmente invece 6 necessario che i due cal ibri siano usati promiscuamente nell e batterie di battaglia, tanto per avere, come dissi poc'anzi, preponderanza di fuoco sull' artiglieria nemica, quanto per pote re , senza perdef'e tempo e munizioni, in ogni circos tanza sloggiare il nemico dalle sue posizioni, distruggendone i ripa ri col calibro maggiore, e molestandone Je truppe co l cannone di minor potenza.
Come conclusione di questo e del!' antecedente capitolo, rip orterò poche parole che il generale Mollkc scriveva sin dal 1865 a propos ito delle nuove armi che allora soltanto ricevevano la loro applicazione su grande scal a nell'esercito prussiano dopo la campagna di Danimarca (·I ) . Egli diceva:
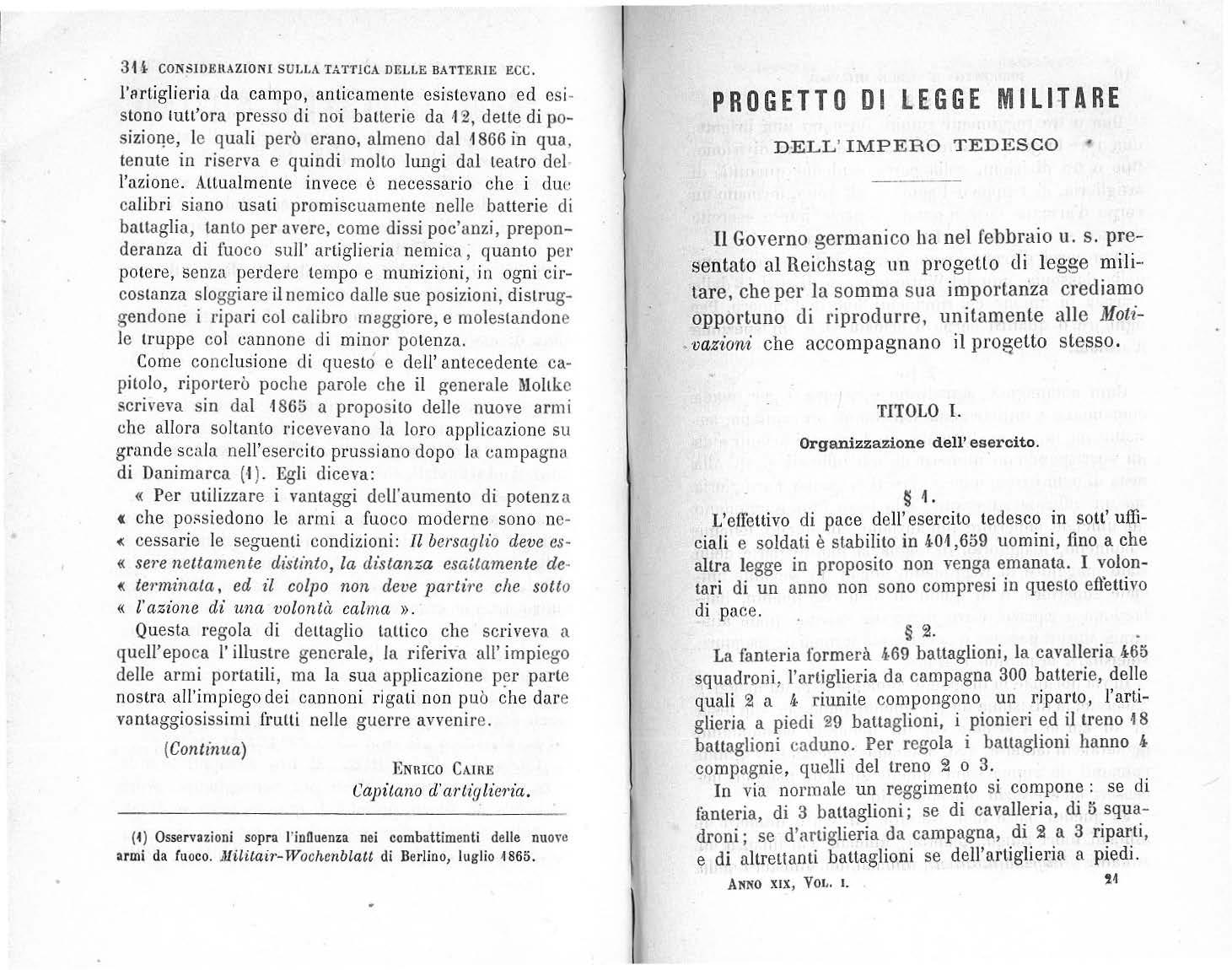
« Pe r utilizzare i vantaggi d e ll'aumento di potenza
« che possiedono le arrni a fuo co moderne sono no -
« cessarie le seguenti condizioni: ll bersaglio deve es-
« se1·e nettamente distinto, la distanz a esattamente de« te1·minata, ed il colpo non deve partfre che sott o « l'azione di una volontà calma » .
Questa regola di dettaglio tattico che seri veva a quell'epoca l'illustre gene ral e, la riferiva. ali' impiego delle armi portatili, ma la sua app licazione p~r parte nostra all'impiego dei cann oni rigati non può che da.r e vantaggiosissimi frutti nelle guerre avvenire .
(Continua)
PROGETTO DI LEGGE MILITARE
DELL ' IMPERO TEDESCO
Il Governo germanico ha nel febbraio u. s. pres~ntato al Reichstag un progetlo <li l egge mili-· tare, che per la somma sua importan·za cr ediamo opportuno di riprodurre, unitamente alle 1lfot i. ·vazioni che accompagnano il progetto stesso.
Organizzazione dell'esercito.
§ L
L'effettivo di pace dell'esercito tedesco in sott' ufficiali e soldati è stabilito in 401,659 uomini, fino a che altra legge in proposito non venga emanata. I volontari di un anno non sono compresi in questo effe ttivo di pace.
§ 2.
ENn1co CAmE Capitano d 'artiglieria.
La fanteria formerà t69 battaglioni, la cavalleria 465 squadroni, l'artiglieria da campagna 300 batterie, delle quali 2 a 4 riuni te compongono un riparto, l'artiglieria a piedi 29 battaglioni, i pionieri ed il treno 18 battaglioni cadun o. Per regola i battaglioni hanno 4compagnie, quelli del treno 2 o 3.
In v ia normale un reggimento si compone : se di fanleria, di 3 battagli oni; se di cavalleria, di 5 squadroni; se d'artiglieria da campagna, di 2 a 3 riparti, e di altrettanti battaglioni se dell'artiglieria a piedi.
ANNO XIX, Vor,. I !4
3H CONSIOEllAZlONI
(4) Osservazioni sopra J'ioOuenza nei combattimenti delle nuo\'o armi da fuoco. Militair-Wooh.enblatt di Berlino, luglio 865.
TITOLO l.
§ 3.
Due o tre reggimen1i riuniti formano una brigata , due o lre brigate di fanteria o cavalleria una divisione. Due o tre dirisioni, colla corrispondente quanti1.à di ar tiglie ria, di truppe d, ·I genio e del treno, formano un corpo d'armata . Così in tempo di pace l'intero esercito tedesco si compone di 18 corpi d'armata .
Due corpi d'armala son.o forniti dalla Baviera, uno da lla Sassonia, uno dal Wurlemberg e gli altri H dalla Pruss ia in unione coi rimanenti Stati dell'Impero. Per ogni tre o quauro corpi d'armata vi è un'Ispezion e d'armata.
§ 4. .
Ogni compagnia , squadrone e batteria è per regola comandata e militarmente istrulla da un capitano, assistilo da un primo ·tenente, da 3 secondi tenenti e da un co rrispond ente numero di soll' ufficiali (;;- 1). Alla testa di ogni baltaglione o di ogni divisione d'artig lieria sta un ufficiale superiore; aUa tesla di un reggimento un uflìciale superiore più anziano (co lonn ello, tenente colonnello, maggiore). J n regola fa inoltre parte dello stato maggiore di reggi mento anche un secondo ufficia le superiore, e di quelli di ogni reggimento, battaglione -e riparto d' arliglieria un tenente quale aiutan te, oltre il personale occorrente in medici, pagalori, veterinari, armaiuoli e sellai.
In via no r male la brigala è comandala da un maggi0r generale, la divisione da un tenente gene ral e. Alla testa di un corpo d'armata sla un generale comandante (generale di fanteria, ccc. o tenente generale) . Ai grandi comandi di truppa sono addelli gli stati maggiori necessari -al l'eserc:izio del comando.
Fa ancora parte dell ' esercì lo un certo numero di ufficiali fuori rango, generali, ufficiali d'ordinanza ed aiutatiti (Flugeladjutanten }, ufficiali del Ministero della
DELI:IMPERO TEDESCO 347 guerra, dello stato maggiore, del corpo del genio, degli istituti militari, ecc. come pure tullo il personale dell'amministrazione dell'esercito.
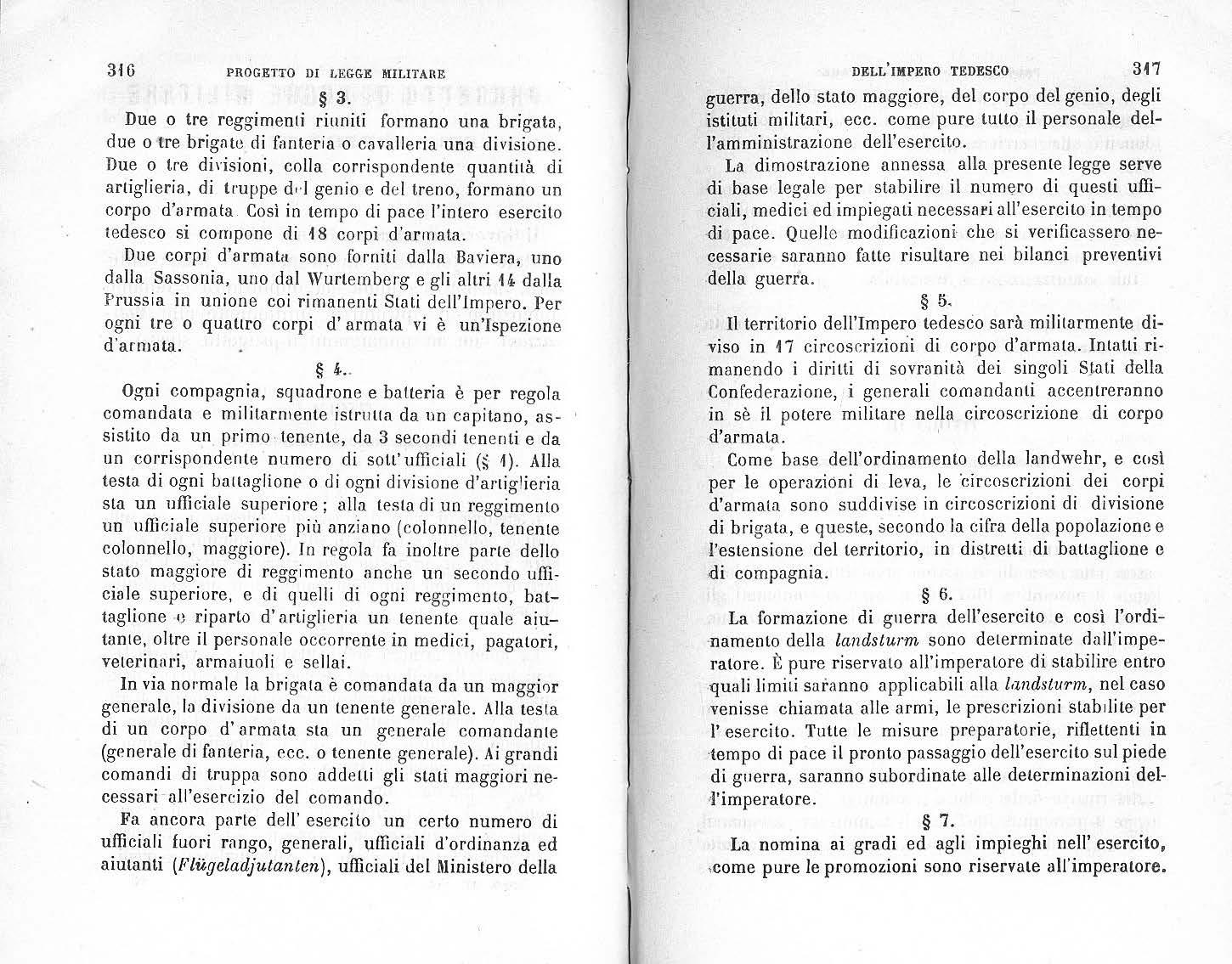
La dimostrazione annessa alla presente legge serve di base legale per stab ilire il numero di questi ufficiali, medici ed impiegati necessat>i all'eserc ito in tempo -di pace. Quelle modificazioni che si verificassero necessarie saranno falle risultare nei bilanci preventivi .della guerra.
§ 5.
Il territorio dell'Impero tedesco sarà militarmente diviso in 17 circoscrizi oni di corpo d'armata. Intatti rimanendo i diritti di sovranità dei singoli St ati dBlla Confederazione, i generali comandanti accentreranno in sè il potere militare nella circoscrizione di corpo d'armata.
Come base dell'ordinamento della landwehr, e cc,si per le operazioni di leva , le ·circoscrizioni dei corpi d'armala sono suddivise in circoscrizioni di divisione di brigata, e qu este, secondo la cifra della popolazione e l'estensione del territorio, in distretti di battaglione e <li compagnia.
§ 6.
La formazione di guerra dell'esercito e così l'ordi·namento della landsturm sono determinate dall'imperator e. È pure riservato all'imperatore di stabilire entro :quali li mili saranno applicabili alla l,1,ndsturm, nel caso ·venisse chiamata alle armi, l e prescrizioni ·stab ilile per l'esercito. Tulle le misure preparator ie, riflettenti in ·tempo di pace il pronto pnssaggio dell'esercito sul piede di guerra, saranno subordinale alle determinazioni delfimperatore.
§ 7.
La nomina ai gradi ed agli impieghi nell' esercito , ,come pure le promozioni sono riservate all' imperatore.
' 31G
PROGETTO DI LEGGE MILITARE
DELL'IMPERO TEDESCO 319
Pl\OGET'FO DI LEGGE MILITARE
Al posto d'impiegato nella giustizia militare· non può essere assunto che chi abbia ricevuto il diploma di idoneilà alla carriera giudiziaria in uno degli Stati della Confederazione.
L' autorizzazione alle persone che abbandonano il m~litare serviz.io di portare titoli ed uniformi militari deve essere accordata dal sovrano federale, o dal Senato da cui sono nominati gli ufficiali del contiHgente.
Tale autorizzazione è revocabile. •
§ 8 .
Le prescrizioni riflettenti la disciplina dell' esercito s ono emanate dall'imperatore.
TITOLO II.
Reclutamento dell'esercito.
§ 9.
Nella ripartizione del conlingente annuo, che dovrà esser fatta secondo le norme prescriUe dal § 9 della legge 9 novembre 1867, non saranno computa ti gli stranieri residenti nei singoli Stati della Confederazione, e neppure gli uomini presenti nella locali Là che si trovano in attività di servizio .

Quando pecÙiiari circostanze possano richiedere qualche eccezione alle norme stabilite pel riparto, sarà necessaria l'approvazione della Commissione per l' esercito e le fortezze, e le differenze saranno compensate nel riparto dell'anno seguente.
Nel riparto delle reclute i vo lontari (§ 1O e 4 della legge 9 novembre 11867) e gli uomini da assegnarsi alla marina debbono computarsi nel rispettivo circolo cli leva.
La Baviera, la Sassonia ed il Wurtemberg provvedono da sè a reclutare il proprio contingente, ed in tempo di pace non potranno essere te?uti a_ concorreré alle op8razioni di leva di altri co_ntmgen~1, se .n.on in quanto si presentassero alla leva m quegh Sta~.i m·div id ui appartenenti ad altri Stati della Confederaz10ne. Sta però che sono i bisogni militari quell i che determinano il ·riparto del contingente fra · l e truppe dell 'irnp · ero. .
Se un dis tretto di leva non potesse completare il co ntingente assegnatogli, spetta agl i altri distret~i, ed anzitutto più propriamente a quelli apparten_entL alla . circoscrizione militare immediatamente s upenore (§ 5), di colmare la deficenza.
Però , non potrà per questo essere aui:nentato il con.tingente di uno Stato della Confederazio ne, tran~e il caso che l'insieme dei circoli di reclutamento dr un altro Stato non siano in condizione di dare tutto il coni ingente assegnatogli.
§ 110 .
TutLi coloro che hann o l'obbiigo del serv.izio militare, se non entrano volontariamente nell'esercito (§ 10 e ,11 d"ella legge 9 nove mbre 867), sono soggett~ alla le_va a prin cipiare dal ,1° gennaio dell'anno 1~ cui comp10no -il 20° anno di età. A questo scop o essi dovranno prèsentarsi alle autorità di leva e tenersi a loro disp·osizione fin o a tanto che, conformemente alle prescrizioni .della presente legge, non sarà st_atayr~sa un_a.definitiva ,decisione intorno ai loro obbhgh1 d1 servmo.
§ H.
·Le persone che hanno preso stabile domicilio in Germania dopo di avere antecedentemente perduta la cittadinanza tedesca {§ 13° della legge 11° giugno 1870), qualora non abbiano acquistata quella di un altro Stato, 0 l'abbiano nuovamente perduta, sono soggette alla
318
leva e possono esser chiamale al servizio militare sino a che non abbiano compiuto il 3 I O anno di elà . U•ruale misura è upplicabile ai figli di quelle persone, ~ome P?re a coloro' che sebbene avessero acquistato ciuadmanza estera, foss .ero nuovamente divenuti citladini dell'Impero prima di compiere il 3·1° anno. ·
§ 12.
Ogni_ ciuadin~ soggetto alla l eva deve presentarsi a quel d1st re llo d1 leva n el qua le ha il suo domicilio fisso, qu~ndo non avesse domicilio stabile si presentera al distretto del luogo in cui risiede. Chi non ha domicilio stabile, nè r es idenza sul terl'ilorio della Confederaz ione, dovrà presentarsi al distretto di leva del luogo ,in cui è n~to, e se fosse nato all'estero si pres~nte_ru a ~ue_l drs~rc_tto di leva nel quale i suoi gemton o capi d1 fam,gha avevano il loro ullimo dom icilio nell' ·interno de llo Stalo. Gli inscritti di le va saranno chia~ati al serviz io nel distrelto presso i l quale sono tenull a presentarsi e sa ranno computati nP-1 contingente che questo distretto dovrà somministrare.
§ 13 .
L'ordine progressivo nel quale dovranno essere chia.mati gl'inscritti di leva nati nel medesimo anno sarà in ogni distretto di reclutamenlo, stabililo dall'estra~ zion e a s~rte. Soltanto eccezionalmente, e pèr importanti considerazioni mililari, si potrà fa r e astrazione dalla progressione dei numeri. Gli iscritti d i leva autorizzati al volontariato di un anno non prenderanno parte all'ultima estrazione (§ 14).
Gli inscritti di leva che, per aver estratto un nume ro ~Ilo, ~on so~o <:hiamati all'arruolamenlo nel primo anno m cm cominciano i loro obbliO'hi m ilitari potranno in d .b" 1:) ' caso 1 1sogno, essere chiamati nei due anni susseO'uènti . Gli inscritti di l eva che al 3° anno rimangono ini::, eccedenza saranno classificati nella riserva di leva (§ 23).
I giovani autori z.zati a l volon ta riato di un anno hanno l'obbligo di presentarsi all'arruolamento non più tardi del ~· ollobre di quell'anno in cui essi compiono il 23° ann o di età. Solo in via eccezionale può essere loro accordato di protrarre l'arruolamento oltre quell'epoca. In caso di guerra imminente tutti gli inscrilli autorizzati al volontariato di un anno, i quali abbiano raggiunta - l'età i n cui cadrebbero in leva, dovranno, dietro pubblico invito, presentarsi immediatamente per essere incorporati. Coloro clie trascurassero d i presentarsi in tempo all'arruolamento perderanno il diritto al volontariato di un anno. Tale diritto potrà però essere riaccordato, sulle proposte delle autorità di leva.
§ '15.
Gli inscritti ch·e, per imperfezioni fisiche od in tellettuali,fossero per sempre riconosc iuti inabili, sono totalmente d ispensali dal servizio, nonché dall'obbligo di comparire ulteriormente davanti all'autorità di leva.
§ 116.
Gli insc ritti che, per difetti fisici incurabili, siano ric:onosciuti idonei soltanto conùizionatamenle, dovranno essere assegnati alla riserva di complemento.
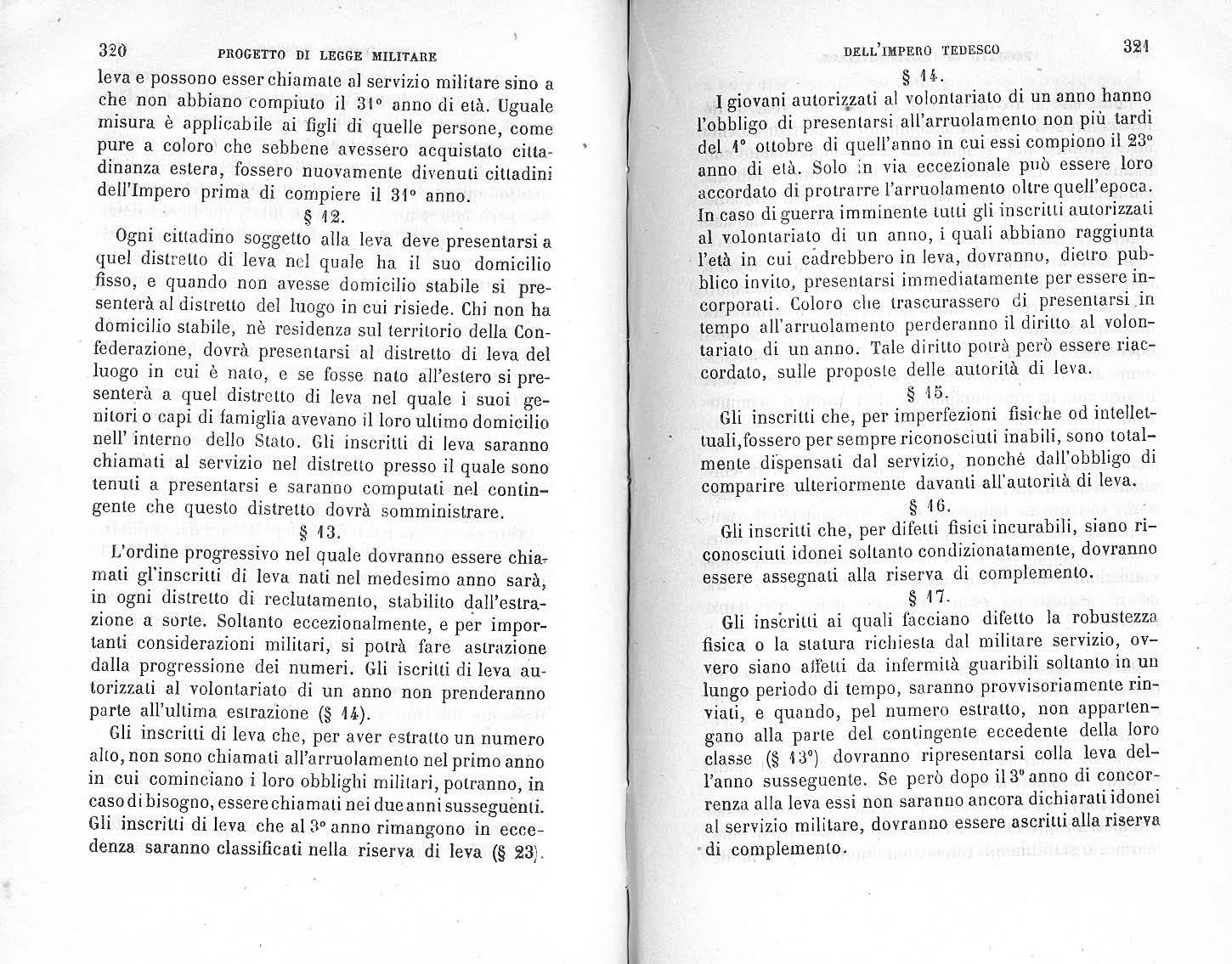
§ 17.
Gli inscriui ai quali facc iano difetto la robustezz a fisica o la statura richiesta dal militare servizio, ovvero siano affetti da infermità guaribili sollanto in un lungo periodo di tempo, saranno provvisoriamente rinviali , e quundo, pel numero estratto, non appartengano alla parte del contingente ecceden le della loro clas:;e (§ ·13°) dovranno r ipresentarsi wlla leva dell'anno susseguente. Se però dopo il 3° anno di concorrenza alla leva essi non saranno ancora dichiarati idonei al servizio militare, dovranno essere ascrilli alla riserva · di complemento.
32()
DI LEGGE MILITARE
PROGETTO
3lH
DELL'IId:PERO TEDESCO
§ H.
§ 18.
Colui che si trovasse sotto giudizi o per reati o del itti commessi, non sarà chiamato al servizio se non dopo pronunciata la sentenza, e co lui che è stato conda nna to da un tribunale alla detenzione o ad una am menda co mmutabi le nella detenzione, non sarà chiamato se non dtipo scontata, o dopo che g li sia staia condo na ta la pena.
Il rinvio di simili indi vi dui sarà ammissibile fino al 5 ° ann o di obbligo al servizio. Lo stesso vale per co loro che hanno perduto i diritti civili, fino a tanto che clnra questo ·Joro stato di s onorante. Tuttavia se essi dovess ero riacquistare i dir itti civili -prima della scadenza del tempo d el serv izio attivo, potranno essere incorporati in una compagnia di lavoratori, comput ando lor o il tempo di servizio.
§ 19.
I rinvii e le esenzioni dal militare servizio in considerazio ne di interessi privati sono per regola ammis-· sibili soltanto in tempo d i ·pace. Tali rin vii od esenzioni saranno accordati dalle autorità di leva dietro istanza degli inscritti o dei l oro parenti, a seconda delle condiz ioni e nelle proporzion i indi cate ai §§ 20 e 21 , cd in seguito ad esa m e speciale delle Clrcostanze add otte .
§ 20.
Possono essere rimandati per un a n no o due, ed essere as cl'itti al co n tingente dell'anno seguen te , a meno che, pel numero estratto, non app artengano ag li eccedenti il con tin gen t e della loro classe:
1° Gli un ici sostegni di famiglie povere o di padri o madri incapaci al la voro;
2° Quegli inscritti che, per eredità o d onazi on e , sono di ve ntati proprietari o loc atar i di t er reni, case di commercio, o stabilime~ti ind us triali, inguanto essi n e d e - ·
rivino i loro mezzi d'esistenza , e non sia loro possibile conservare in altra guisa la proprietà o locazione ;
3° Il figlio di un pro'prietario di terra, o fittabile, od industriale, . ch e sia incapace di lavoro e di sorvegiianza, se que s to figli o è il s uo unico ed indispensabile sostegno per la co ns erva zione della proprietà, della locazione o della fabbrica;
,i.0 Il fratello che segue in età un mil itare caduto davanti al nemico o morto in seguito a ferite riportate, o in conseguenza delle medesime re so ina bile al lavoro, qu alora i l rimando arrechi un reale sollievo ai parenti del medesim o;
5° Gli inscritti che sono intenti a prepararsi un a carriera o che atten dono a im parare un'arte o mes tiere , e che soffrireb bero danni considerevoli se ne fossero distolti.
§ 21 .
Gli inscritti che facessero valere, anche dopo il 3° anno di concorrenza, alla leva i titoli indica ti dal N. 1 fino al .i- d el § 20 sa ranno assegnati alla riserva di complemento. Se pe rò tali ins c ritti non dovessero att endere agli scopi pei quali furono esonerati dal militare servizio, potranno essere posteriormente reclu. tati prima della fine dell'anno in cui compiono il loro 25° anno di età .
Il rinvio degli inscritti indicati al N. 5 del§ 20 potrà essere prolungato in casi eccezionali fino ad una durata to tale di ,i, anni.
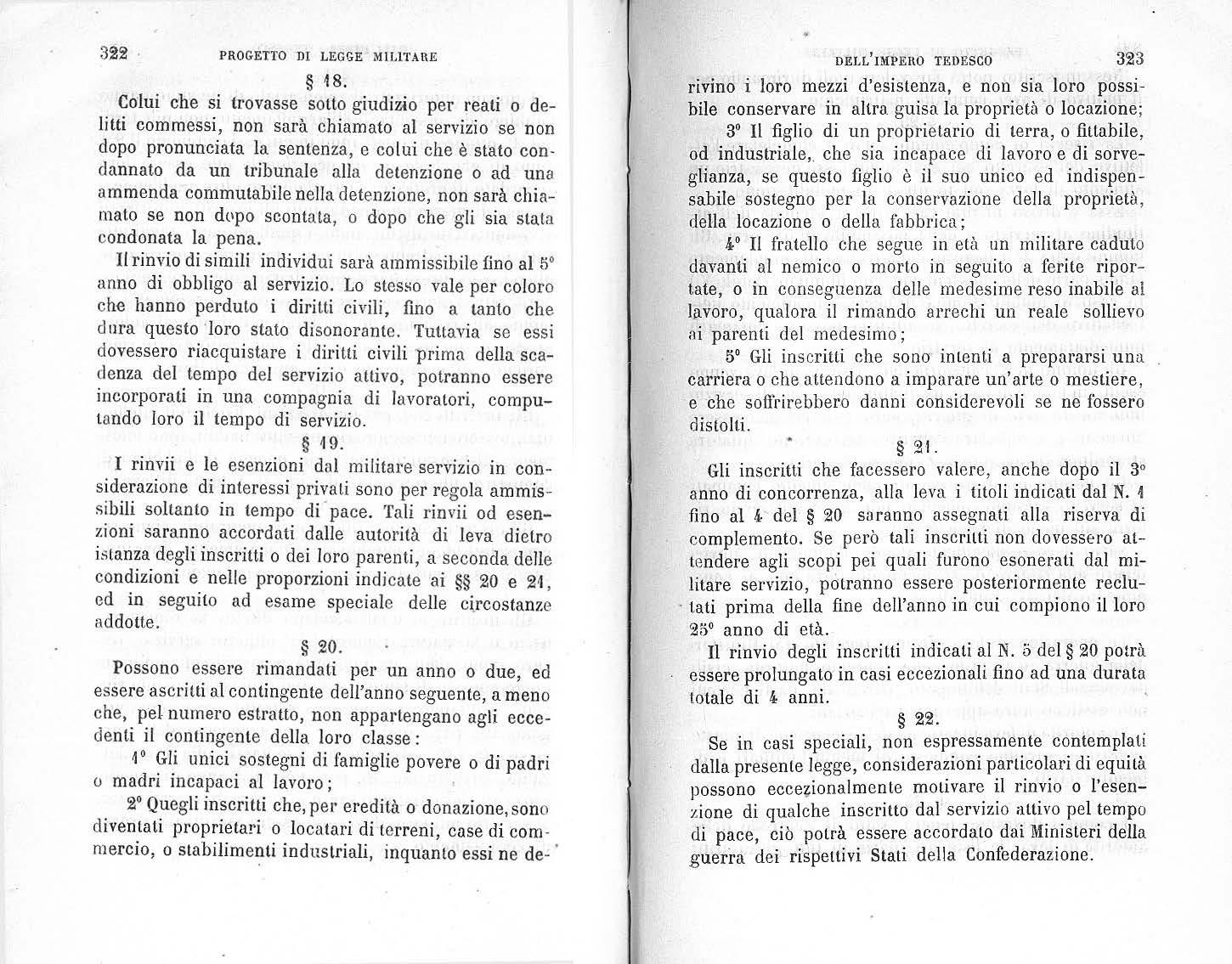
§ 2:2.
Se in casi special i, non espressamente contemplati dalla presenle legge, considera~ioni p_arti_col~ri di ~quità possono ecceiio nalmenle motivar~ ~l rm:10 o 1esenz ione di qualche inscritto dal serv 1z 10 attivo pel temp o dì pace, ciò potrà essere accordato dai Mi~isteri della g uerr a dei ri'spettivi Stati d e lla Confederazione.
322 PROGETTO DI LEG GE MlUT ARE
DELL'IMPERO TEDESCO 323
Nessun iscrilto polrà far valere liloli di rimando per il motivo di aver contratto matrimonio.
§ 23.
La riserva di complemen to serve a completare l'effollivo dell'esercito nei casi in cui fosse necessario un aumento di forza, od in quelli di mobili tazi one.
Essa è divisa in due categorie, a seconda dell' attitudine al servizio e della possibilità di disporne. Gli uomini della 1" categoria della riserva di complemento fanno parte delle classi in congedo illimitato (Titolo V.) In caso di mobi litazione o cli nec essa rio aumento dell' ·effellivo dell'esercito, le autorità possono chiam arli immediatamente al servi~io.
Gli uomini di 2"' ca tegoria della riserva di leva vann o esen ti, in tempo di pace, da qua lunque specie di servizi o militare. In caso di guerra, però, essi po sso no essere ch iam ati a completare l'effettivo dc ll'es erc-ito, qualora straordinari bisogni fossero per richiederlo.
Gli uomini de lla riserva di complemento chiamati al servizio saranno con gedali non appena l'eserdto ritorni sul piede di pace (§ i-6).

Salvo il caso speci fi cato al § 60, l'obbligo di appartenere alla riserva di complemento dura fino al com -pimento del 34 ° an no di età.
§ 24- .
Le operazioni di leva sara nno regolate dai Ministeri della guerra, d'accordo colle sùprerne autorità civili de i singoli Stati dell' Impero, per quelle parli per cui non esistcno altre apposite disposizioni.
Le autorità di leva incaricale dell'esecuzione di queste operazioni saranno composte di membri militari e di membri civili. •
§ 25. •
I comuni dovranno tenere, sotto il controllo delle autorità di leva, le liste originarie di tutli gli inscritti 1
DELL'lHI'EIIO TEDESCO
di leva, e so no responsabili dell'esnttezza loro. I giovani sogget ti alla le va, ed i loro_ paren _t i _deb~on~ notificare la loro regi strazione sulle liste or1g1oal'le d1 leva in conformi tà delle presc1·izioni esistenti, o di quelle che saranno emanate.
§ 26.
Le liste di leva sono compilate in base al registro dello stato civile ed alle notificazioni prescritte al paragrafo 25. Le autor ità e le persone, in caricale d~lla tenuta dei regislri dello stato civile, hvnno l' ?bbl1go di fornire gratuitame nte i documenti occorrenll per la. co mpilazione delle lìste di leva. § 91 .
I giovani soggetti alla leva, ed i parenti loro, che trascurano di fare le dichiarazioni prescriU e per la compilazione delle liste di leva, come pure gli ius~:itli che non si prese ntano puntualmente all'epoca ~ta?11lla ~al(? au torità d i lera, qualora non fossero perciò mcors1 gw. in una pena mao-O'iore, saranno puniti con una ammenda di 10 marchi (lire 12,50 ), o al carcere estensibile a gio rni tre. Essi potranno_inolt:e ess.ere prival_i del ~iritt~ di estrarre a sorte, e d1 tutti que1 van taggi s~ecdìcat1 nei §§ ~9 al 22. Se vi sia recidività, od intenzione manifestamente colpevole,potrannoessere immediatamen~e incorporati nell'e sercito come refrattari alla leva, ed m ques to caso il loro tempo di servizio sarà calcolato soltan to a decorr e re dall' epoca dell' arruolamento della classe di leva susseguente. .
Le prescrizioni contenute nel.§ _4 ~O c~d1ce_penale sono estensibili anche a quegli rnscnll1 .eh leva, che, senza autorizzazione, cercano di abbandonare il territorio dell'Impero per sottrarsi all'obbli go del serv izio attivo in tempo di pace.
32i PROGETTO
DI LEGGE ll!lLlTARE
32 5-
,
§ 28.
Quando le reclute arruolale non sono immediatamente inviate ai loro corpi, saranno considerate come in congedo illimitato, fino al momento in cui avrà luogo la loro incorporazione.
Nelle stesse condizioni delle reclute in congedo ill imitato si troveranno quei volontari che, dopo la loro definitiva accettazione in un corpo di truppa , siano provvisoriamente rimandati alle loro casè.
§ 29.
·Tutti i documenti e gli atti d'ufficio relativi alla leva, salvo quelli r i chiesti in caso di reati e di contravvenzioni, non sono soggetti ad• alcun ·diritto di bollo o di tasse.
§ 30.
Le spese occorrenti per le operazioni di le va da porsi a carico dell'erario imperiale, saranno quelle soltanto che risultano direttamente dalla cooperazione delle au·torità militari o persone militari incaricate di queste operazioni.
Spetta ai singoli Stati dell,a Confederazione di determinare da chi saranno sopportate le .rimanenti spese.
TITO LO III.
Esercito attivo.
§ 3·1.
Fanno parte dell'esercito attivo:
A.
I mil.itari appartenenti all'effotlivo di pace, cioè:
. 1° Gli ufficiali, medici e impiegati militari dell'effettivo di pace, dal g iorno della loro nomina fino al momento in cui abbandonano il servizio .
DELL'lMl'El\0 TEDESCO 327
2° I capitolanti, dal principio fino a l termine od alla cessazione del riassoldamento contratto.
3° I volontari ed i soldati di leva, dal giorno in cu i cominciano a percepire le competenze dell'amministrazione militare; i volontari di un anno, dal momento in cui sono definilivamenté assegnati ad un èor po dell'esercito, e tutti fino al giorno del loro licenziamento dal servizio attivo.
B.
1 (J Gli ufiìciali i medici, gli impiegati militari e i ' . . soldati richiamati in servizio dal congedo (Titolo V) a principiare dal giorno del loro r ichiamo sino a quello del nuovo congedamento ; ·
'
2° Gli ufficiali, i medici, g li impiegati militari e i soldati richiamati o rientra ti volontariamente al se rvizio in tempo di guerra, che non appartengono _a n.essuna d~lle categorie citatei da l giorno del loro · richiamo o deJia loro entrata volontaria , fino a quello del loro hcenziame!1to.
c.
Gli impiegati civili dell'amm ini st~azion e militare, dal gior no della loro nomina a quello m cm abbandonano il servizio.
§ 32.
I militari sono soggetti ad una special e giurisdizione, che è regolata da una legge dell'Impero, soltanto per le cose penali. . . . .
Per tutto quanto ba tra.li.o al diritto comune, 1 ~1.iltan dipendono dai tribunali del l~og~ di loro guarmg10ne. .· Questa disposizione è apphcab1Ie a quelle persone facienti parte dell'esercito, che ser<Vo no s olo per o?bli()'o di leva o che non possono avere domicilio proprio, nei soli ca;i di querele per affari di eredit~.. .
Rimangono in vigore tutte quelle prescr1ZLon~ d~ll~ leggi locali, in virtù delle quali, per quelle fraz10m d1

326
l'ROGET'l'O DI LEGGE MILITARE
PROGETTO DI LI~GGE MILITARE
truppa che in seguito a mobiliLazione hanno abbandonato la rispelliva guarnigione, o si tratlengono lungamente all'estero, la giurisdizione ' civile può essere affidata ad un tribunale del paese, ovvero agli a.uditori una volta per sempre, oppure dietro ordine emanato per ogni singolo caso.
§ 33 .
I militari dell'effettivo di pace e gli impiegati civili dell'amministrazione m ilitare non possono contrarre matrimonio senza superiore autorizzazione.
§ 3i-.
I militari dell' effellivo di pace e gl' impieg:iti civili dell'amministrazione m ilitare possono rifiutarsi di assumere le funzioni cli tutore, e, per accettarle, debbono ottenere il superiore consenso .
§ 35 .
I:e restrizioni leg!lli particolari, imposte a qualche classe spe·c iale di militari, riflettenti l'ocquisto, la vendita, l'ipotecamenlo di proprielà, sono abrogate. ·
§ 36.
I militari dell' effetlivo di pace, ed i membri delle loro famiglie abitanti in locali dello Stato, non potranno esercitare alcuna industria senza superiore autoriz zazione, a meno che quest'industria fosse legata coll'amminis trazion e di una proprietà fondiaria a loro appa rten en te.
§ 37.
Le persone appartenenti all'esercito attivo, le quali in seguito a mobilitazione o preparativi di guerra devono lasciare, per r agioni di servizio, le l oro guarnigioni o Ja loro residenza, non sono legate come locatari al contratto stabilito, a meno che sia e spressamente convenuto in altro modo, che fino al termine del trimestre nel quale essi abbandonano la guarnig ione o il domicilio.
§. ·as .
In tempo di guerra o durante lo stato J'assedio, le persone indicate al§ ;H, e quelle che a senso dei §§ 155 sino al •I 58 del Codice penale militare sono sottoposte alle leggi militari, posso no far testamen~o ~a~ido_ i~ forme partico larmente semplici (tP,Stamenl1 pnv1leg1at1 militari ) . Le prerogative delle persone militari riguardo alle loro d i spos iz ion i testamentarie consisto~o. p~ra: mente in ciò, che, in conformità delle prescr1z10m d1 cui qu i appresso, non sono soggetti alle formalità volute pei testamenti ordinari.
Le ·prescrizioni ad osservarsi sono le seguenti: .
4• La facoltà, per le persone indicate al § 31 dt estendere, in tempo di guer ra e durante uno stato di assedio, testamenti militar i privilegiati, incomincia dal mom (;l nto in cui lasciano le loro gua rn igioni, o, nel caso non ne avessero assegnate, dal momento in cui esse abbandonano per servizio il luogo di loro dimora, oppure questo si trovasse attaccato od ass·ediato.
I prigionieri di guer ra e g li os~aggi han~o questa facoltà per tutto il tempo in cui si trovano m potere del nemico.
2° Saranno redatti in forma valida i testamenti militari privilegiati:
a) Quando saranno scritti e firmati di proprio pugno dal testa lore;
b) Quando saranno firmati dal testatore_ e controsegnati da due testimoni, ovvero da un aud1tore od ufficiale.
e) Quando della volontà del testatore verbalmente espre.ssa sia redatto un documer~to scritto_ da ~n a uditore od ufficiale in presenza di due test1mom, ovverossia. di un secondo auditore od ufficiale, e che lo scriuo, dopo essere stato leuo al testatore, sia firmalo dall' a uditore od ufficiale e dai testimoni . .
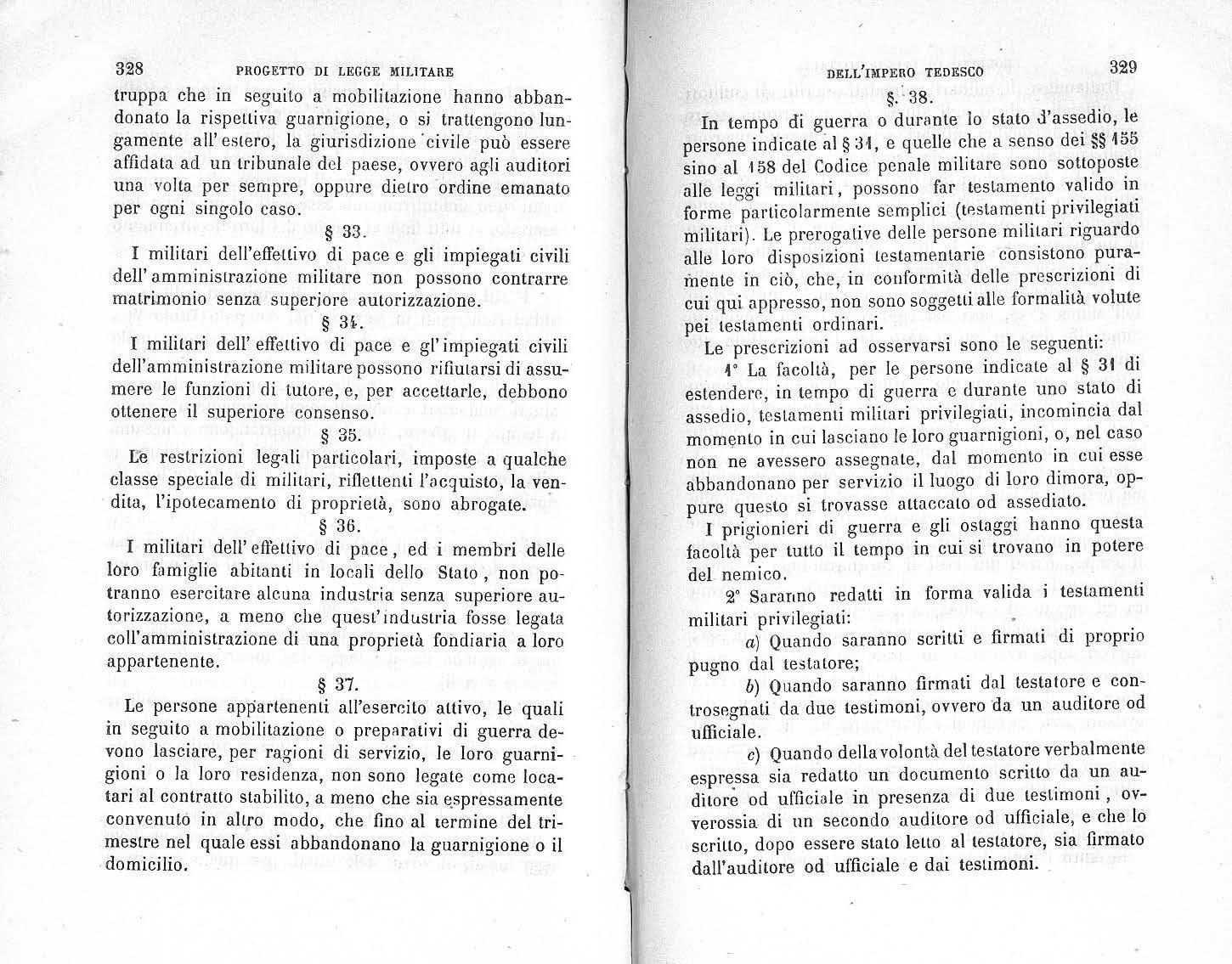
328
329
DELL'IMPERO TEDESCO
Trattandosi di militari ammalati o feriti; gli auditori od ufficiali indicati agli alinea b) e e) potranno essere sostituiti da medici militari o da impiegati superiori degli spedali od anche da sacerdoti militari.
3° Le deposizioni dei testimoni di cui al N° 2 costituiscono prova giuridica. Tali testimoni non hanno bisogno dei requisiti richiesti per fare da testimonio in un istrumento, e le dichiarazioni di uno di loro possono essere accettate come pienamente com provanti ,
4° Il documento redatto secondo le prescrizioni de ll'alin ea 2° e}, così per riguardo al suo contenuto co me alla data in cui fu steso, ha il valore di un atto pubblico.
Quan do un tes tamento, scritto e firmato di proprio pug no o solamente firmato {2 a 6), porta la data in cui ess o fu red atto, sin o a prova in con trario, si presume essere gius ta la da ta espressa.
Così starà la pres un zio ne che il testamento fu redatto nel peri odo di te mpo p el quale vige il privilegio delle forme speciali , se il testamento sa rà stato depositato presso un'autorità milita re superio re durante tal periodo di tempo, o non più tardi di 15 giorni dopo trascorso. quel periodo, od anche se il testamento sarà trovato fra gli oggetti di campagna lascia ti dal testatore.
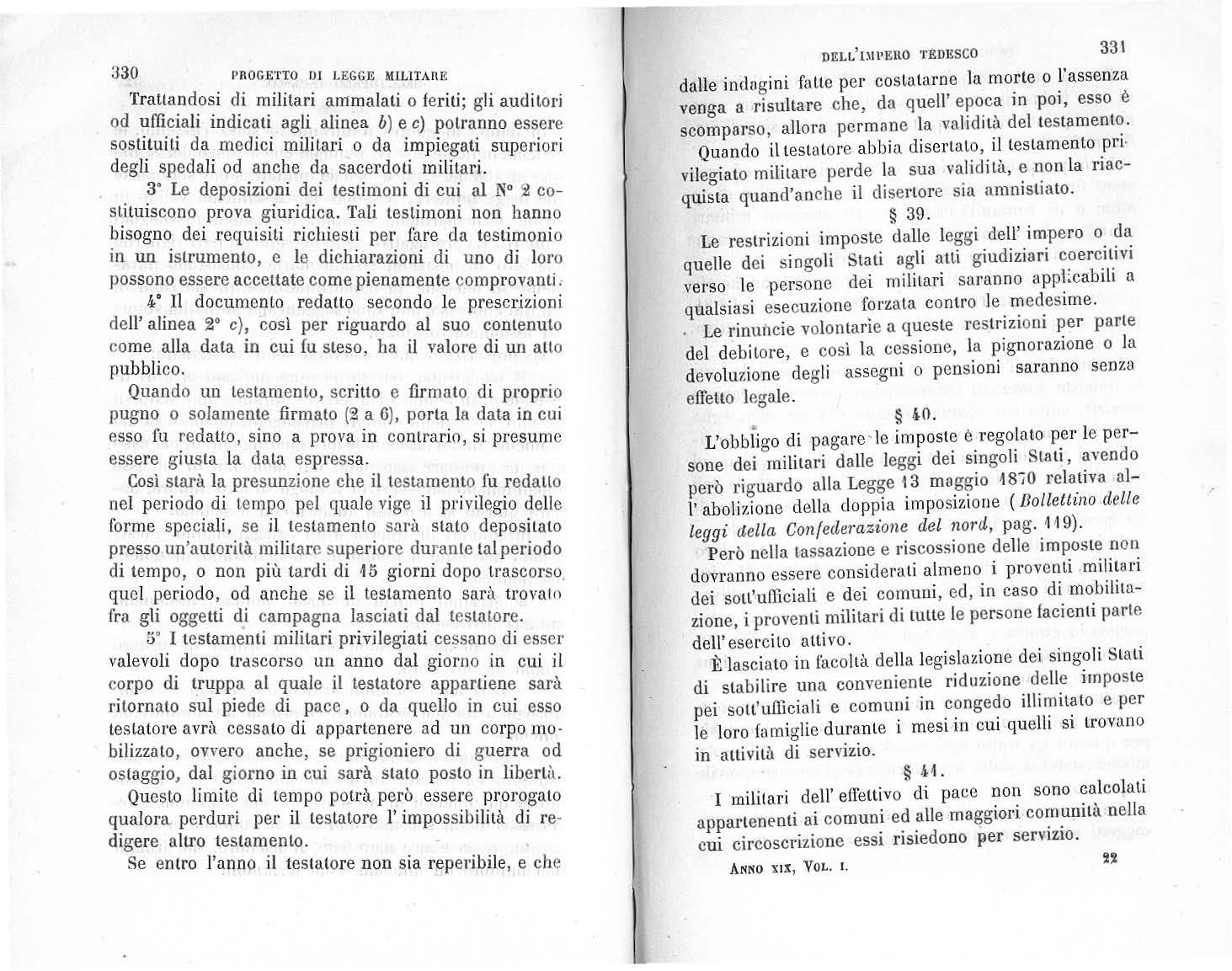
5° I testamenti militari privilegiati ce~sa no di esser valevoli dopo trascorso un anno dal giorno in cui il co rpo di truppa al quale il testatore appartiene sarà ritornato sul piede di pace, o da quello in cui esso testatore avrà cessato di appartenere ad un corpo mobilizzato, ovvero anche, se prigioniero di g uerra od os taggio, dal giorno in cui sarà s tato posto in libertà.
Questo limite di tempo potrà però essere prorogato qualora perduri per il tes tatore l' impossibilità di redigere altro tes tamento.
Se entro l'anno il testatore non sia reperibile, e che
dalle indagini fatte per costatarne la mo~te o ~·assenza venga a risultare che, da quell'epoca m poi, esso è scomparso, allora permane ~a validit~ del tes tament~. Quando il testatore abbia d1serLal?, _ 1~ testamento _Prt· vilecriato militare perde ]a sua vahd I La, e non la naco quista quand'an che il disertore sra amms tr ato .
§ 39.
Le re strizioni imposte dalle leggi dell' impero o_ ?~ quelle dei singoli Stati agli atti giudiziari c?erc_it_lVI verso le person e dei militari saranno app~~cab1lt a qualsiasi esecuzione forzata contro le. r~ ed_es ime.
. Le rinuncie volontarìe a queste rcstr~z10m ~er parte del debitore, e così la cessione, l_a ~1gnoraz1one o la devoluzione degli assegni o pen s1o rn saranno senza effetto legale.
§ 40.
L'obbiin-o di pagare ' le imposte è regolato p_er le p ersone dei i::,militari dal1e leggi dei singol i Stati, ~vendo però riguardo alla Legge 1_ 3 ma~~io 18,0 rela_uva all'abolizione della doppi a impos1Z1one ( Bollettino delle leggi della Confederazion~ del ~ord, pag. 1 119).
Però nella tassazione e nscossrone delle 1m~ost~ dovranno essere considerati almeno i prove~t1 m1l_1~ar1 dei sott'ufficiali e dei comuni, ed, in caso di_ mo_bilitazione, i proventi militari di tutte le persone fac1enll parte del!' esercito attivo. . . . .
È'lasciato in facoltà della legislazione dei srng?lt Stall di stabilire una conve niente riduzione delle im poste pei sott'uflìciali e comm~i in ~?nge~o illi~itato e per lè loro fo miglie duran te 1 mesi m Clll quelli si lrovano in attività di serviz io.
t1. .
I Tl . del\' effettivo di pace non sono calcolati m1 1 ari . . · , li appar tene nti ai comun~ e? ~lle magg1on co_~i~mla ne a cui circoscrizione essi risiedono per serv1z10.
330 PROG.E'fTO 01 LEGGE MILlTARE
DELl.'D!l'Eil0 TEDESCO 331
§
ANNO XIX, VOL. I.
Fino a qual punto il possesso di terre o l'esercizio di una industria stabile possano costituire una eccezione a questa regola, spetta alle leggi dei singoli Stati determinarlo .
Però, per poter esercitare i diritti elettorali od assumere funzioni amministrative o rappresentative di e.o·· muni o di comunità maggiori, gli anzidelli militari , quand'anche appartengano a tali comuni, dovrann o oltenere il consenso dei loro superiori .
Le precedenti disposizioni sono applicabili anche alle persone dei militari specific'ii Li alla lettera B del § 31 , per il tempo nel quale fanno parte dell'esercito attivo .
§ ,\2.
I militari dell'effettivo di pace vanno esenti da tutt e le imposte comunali (contribuzioni, somministranze e servizi), tanto nei comuni di città. che di campagna ove risiedono per servizio. Es si debbono però'" contribuire ai carichi municipali, imposLi alla proprietà od all'industria stabile, o alle rendite emergenti da tali sorgenti, qualora posseggano nella circoscrizione di un comune, una proprietà od un'industria stabile.
Goqono delle stesse esenzioni, per sè e per le loro famiglie, i mil i tari specificali alla lettera 8 del § 3·1, durante i mesi nei quali fanno parte dell'esercito att i vo.
Gli assegni dei militari resi in validi per ferì te riportale in guerra e degli utliciali in disponibilità con pensione vanno totalmente esenti dalle contribuzioni comunali dirette .
Tutte le altre persone che percepiscono pensione militare andranno esenti dalle contribuzioni comunali per quanto ha tratto agli anzidetti assegni, nella sola misura stab ilita dalle leggi locali per gl'impiegati civili in pensione.
Alle imposte comunali indirette (dazio-consumo) sono soggetti an·che i militari; tuttav i a le mense militari,
'Yivanderie, ecc., istituite pel mantenimento dei militari, saranno esenti da queste imposte nelle proporzioni finora stabilite.
§ 43.
. J privilegi accordati daÌla legislazio ne partic~l~re de~ -sino-oli Stati della Confederazi one ai supersti~1 degli im~iegati dello ·Stato, ?irca il paga~e?to d~lle imposte sulle pensioni, soccorsi o sovvenz10m u!5h ~tessi accordate dalle casse dello Stato, o dalle pubbl_1che cas~~ . di previggenza, saranno applicabili anc~e ai_supersl1t~ dei militari per le somme che allo stesso titolo essi percepiscono dalle casse dell'Impero, .da quelle dell? Stato, 0 dalle pubbliche casse d1 prev1ggenza.
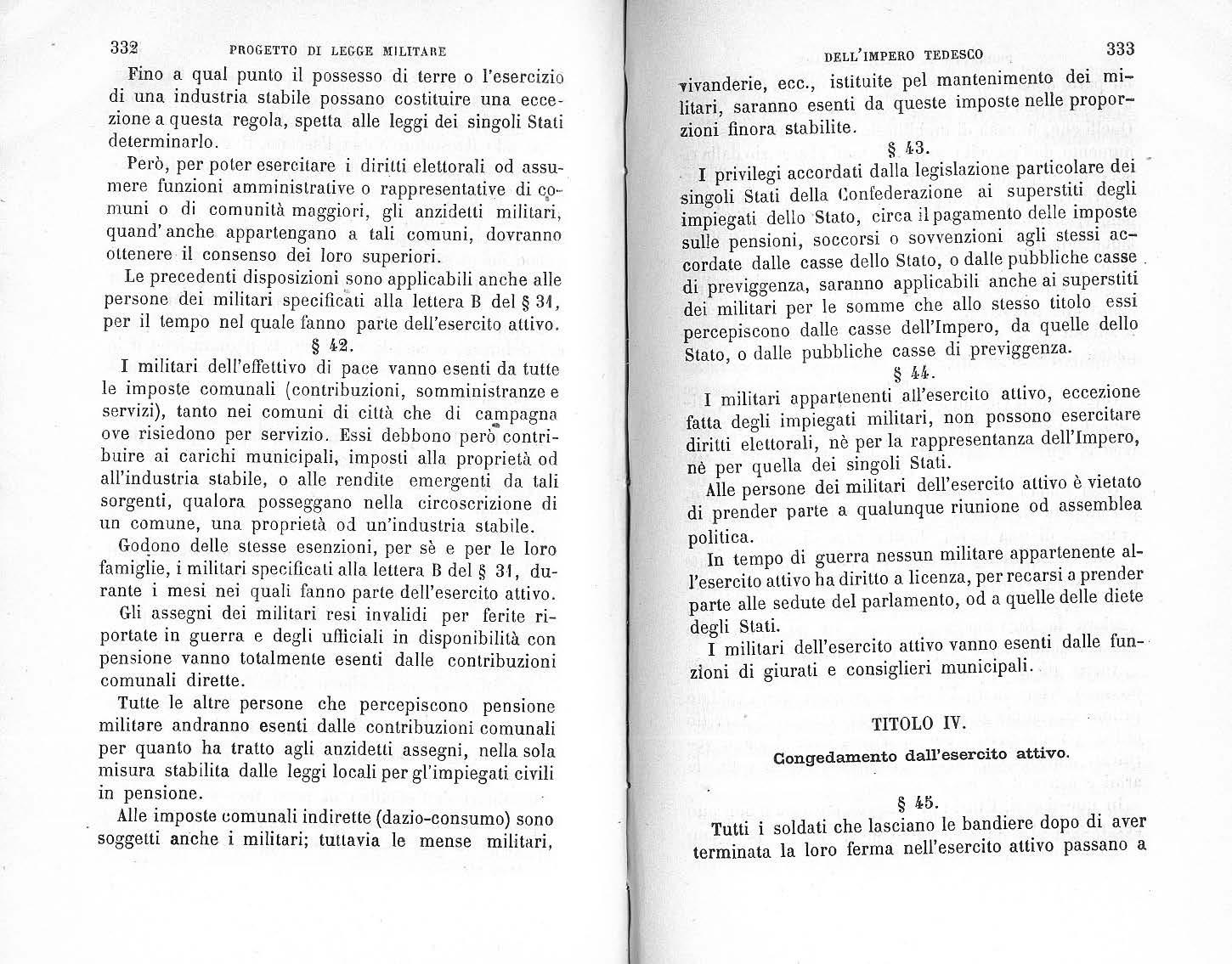
§ 44.
J militari appanenenti all'esercito attivo, eccez_ione fatta degli impiegati militari, non possono e~ermtare diritti elettorali, nè per la rappresentanza dell lmpero, né per quella dei singoli Stati. . . , . Alle persone dei militari dell'esercito attivo e vietato di prender parte a qualunque riunione od assemb lea politica. . .
In tempo di guerra nessun militare appar~enente all'esercito attivo ha diritto a licenza, per recarsi Il pren.der parte alle sedute del parlamento, od a quelle delle diete degli Stati. .
J militari dell'esercito attivo vanno esenti dalle fun- · zioni di giurati e consiglieri municipali . .
'rITOLO
IV.
Congedamento dall'esercito attivo. § 4-5.
Tutti i soldati che lasciano le bandiere dopo d i aver terminata la loro ferma nell'esercito attivo passano a
332
PROGETTO DI LMG-E MILITAR E
DELL'IMPERO TEDESCO 333
far parte della riserva c!ell:i. landwehr o déHa landsturm r a seconda del tempo compl ess ivo di se rvizio già fotto.
Quelli che, in caso di mobilitazione o di un' necessario aumento dell'esercito, sono chiamali al servizio dalla riserva di 'complemento e d i nuovo congedati tosto che l'esercito rilqrna sul ·piede di pace(§ 23), entreranno ·a far parte della 'riserva o della landwehr se hanno compiuta'l'istruzione militare e se si trovano ancora nell'età stabilita (§ 35 ), altrimenti ritornano nella riserva di complemento .
Quei voloQlari di un anno che, durante la loro pres enza alle bandiere, fossero per punizion e retrocessi a soldati di 2" classe perdono il diritto di essere congedati dopo un anno di servizio.
§ 46 .
'Quei soldati che, mentre sono in servizio att ivo, divengano inabi li al servizio, saranno congedati e messi a disposizione dell'autorità di leva ·(§ 40).
§ 47 .
Quei soMati che, mentre sono 1in 1atti vità d i ,ser•vizio, pe1· ragioni di eredità o di donazione, acquistano la proprietà di una terra, di una casa di commercio o di uno stabili·mento industriale in .cui siano impiegate parecchie ·person e, potranno dai generali comandanti essere rilasciati a dispos izi one delle autorità di Jeva, qualora la loro opera personale sia necessaria :alla conservazione de~la proprietà acquisita .
Anche gli · altri motivi d'esenzione, spec ificati al§ 20, possono determinare l'invio in congedo di un soldato prima che abbia compiuto il suo tempo di servizio attivo, purchè però i motivi d'esenzione si siano verificati dopo ·Ia chiamata del soldato ~tesso sotto le armi e senza il di lui concorso.
In questi casi, l'invio in congedo anticipalo non può per regola ·aver •luogo se ·non all'ep oca del prdss imo ·congedamento ,generale di ·una classe.
DELL'.IMJ;'ERO TEDESCO
§ 48.
In massima, le disposizioni del § 47 non sonp applicabili ai soldati che servono in corpi di truppp. IDR; bilizzata.
§ 49.
I soldati rinviati a 'd isposizione delle autorità di leva, fin.chè non sarà precisamente s tatuito int~rno a.Ila loro futura posizione militare, saranno cons1derat1 come in congedo illimitato (Titolo V) .
§ 50.
Le autorità di leva decidono intorno alla ulteriore J> Osizione militare d~i . s oldati . rim'.i~ti ~- ~ono ?i!po:;;izione cogli stessi cnleri apphcab1h agh mscntt1 non .ancora arruolati della medesima classe. .
Se però tali soldati hanno già fatt? ~n anno d1 ser-vizio attivo o nove mesi se volontan d1 un anno, non ,dovranno ~eI' regola essere nuovamente chiamati al :Ser.vizio attivo.
TITOLO V.
Delle classi in congedo illimitato.
§ 5·1;
Sono compresi nella categoria, dei militari 1n con(Tecl0 illimitato: .- . . . .
0
,io 6 Ii utnciali, i medici, gli nnpiega:t1 ed 1 soldati della landwehr; . . .
20 Gli uomir:ii della prima classe della nserya d1 complemento (§ 23); . . . .
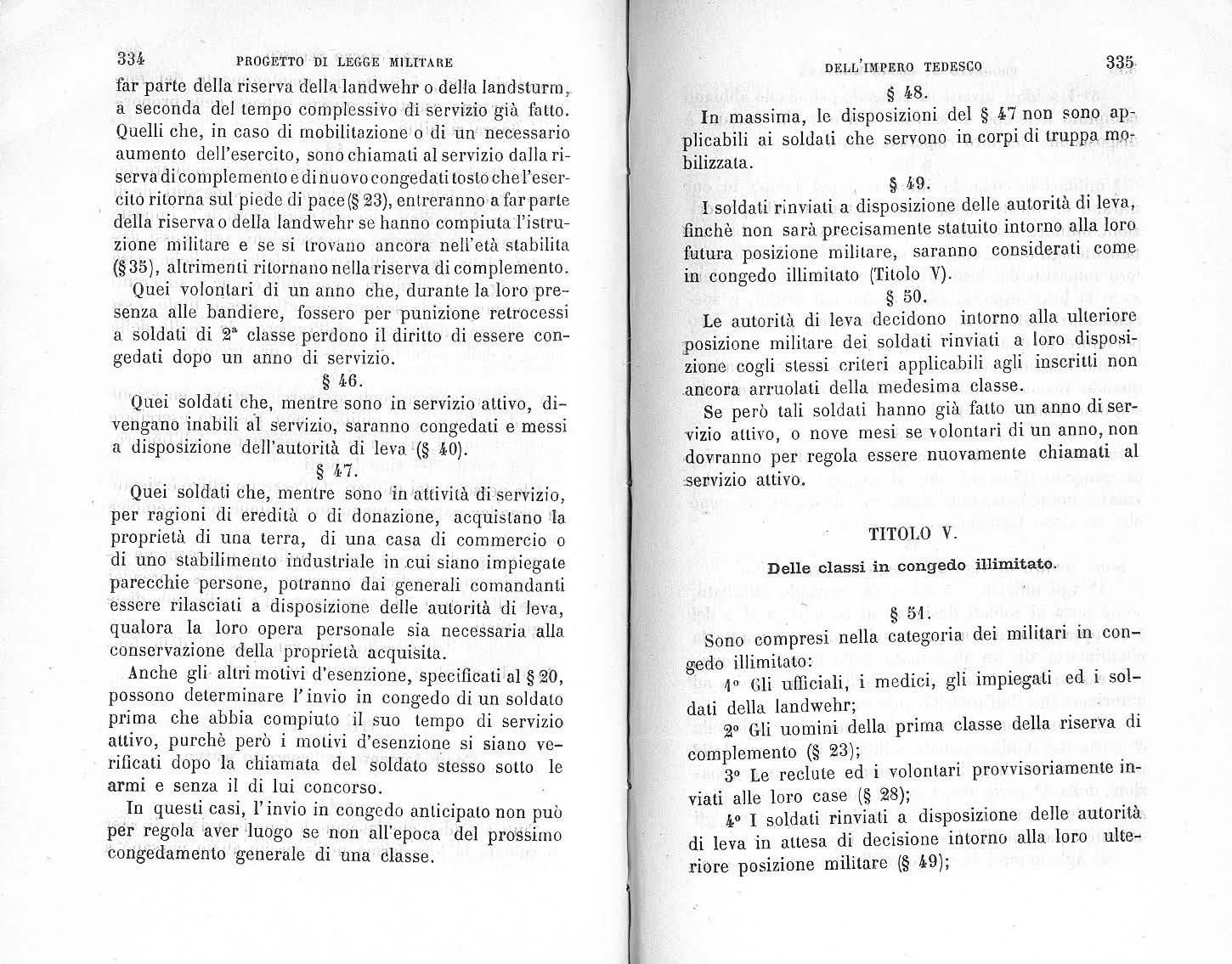
30 Le reclute ed i volontari provv1sona-mente mviati a.Jle loro case (§ 28); . ,
4o I soldati rinvia.ti a d is posizione delle autonta di leva 'in auesa di decisione intorno alla lor.o ulte-... riore posizione militare (§ 49);
334 PROGETTO
DI LEGGE
.
MlLITAIIE
.PROGETTO DI LEGGE HILITARE
5° I soldati inviati in congedo prima che abbiano, compiuto il tempo di servizio attivo e che restano a disposizione dei loro rispettivi corpi.
§ 52.
militari in congedo illimitato, pel tempo in cui durapo in questo stato, sono sottoposti alle prescrizioni militari. Essi debbono ottemperare incondizionatamente agli ordini che, per ragione di servizio, fossero· loro impartiti dai loro superiori e debbono provvedere· sotto la loro responsabili tà perchè tali ordini, e specialmente quelli di chiamata alle armi, possano loro pervenire in qualunque tempo.
Nelle relazioni di servizio coi loro superiori, o allorquando vestono l'l!-niforme, essi sono soggetti alla di,sciplina militare (§ 7).
§ 53 .
In caso di mobilitazione generale, tutti gli uomini in congedo illimitato che si trovano all"estero do-vranno immediatamente rientrare in paese, a meno che né siano formalmente dispensati.
§ 5.i.
Sono inoltre in _vigore le seguc3nti pre-scrizioni:
1° Agli ufficiali e medici in congedo illimitato, come pure ai soldati designati ai numeri 3 al 5 del § 51 (quando essi non comprovino d'aver ottenuta la cittadinanza di un altro Stato della Confederazione), può essere accordato l'espatrio, SQltanto in seguito ad autorizzazione dell'autori tà militare.
Inoltre, essi sono soggetti alle determinazioni della 3• parte del Codice penale militare 20 giugno 1872 per le assenze illegali e diserzione, e alle determinazioni della ,i." parte dell o stesso Codice per le mutila- · zioni volontarie e simulazione di infermità, .come gli uom in i appartenenti al servizio attivo.
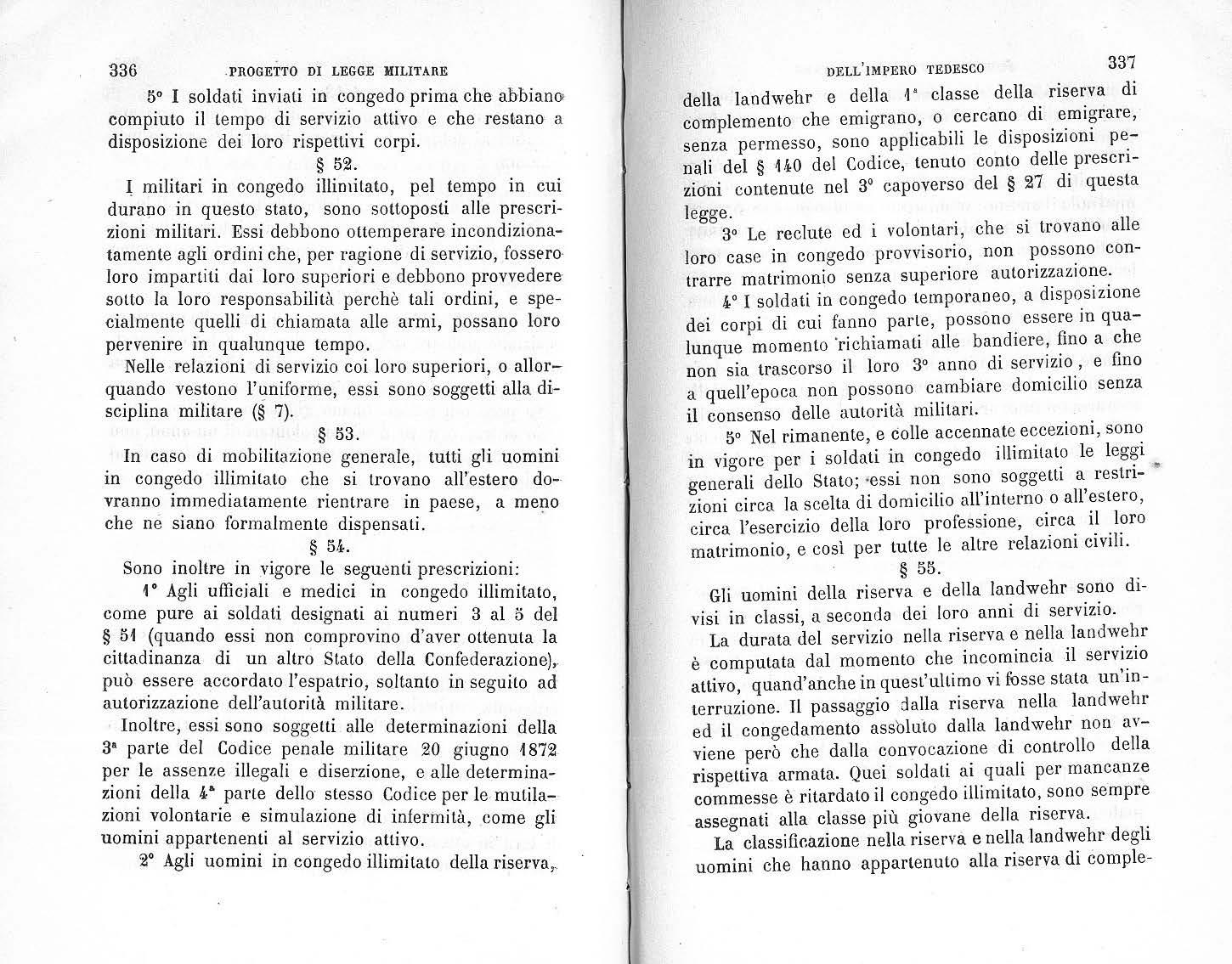
2° Agli uomini in congedo illimitato della riserva,.
1>ELL11MPERO TEDESCO 337
della landwehr e della 1• classe della . rise~va di complemento che emigrano, o cercan? di . e.m,?rare, senza permesso, sono applicabili le d1spos1z1om p~nali del § 140 del Codice, tenuto conto delle prescnzi6ni contenute nel 3° capoverso del § 27 di questa legge . . . . ll
30 Le reclute ed 1 volontari, che si trovano a e loro case in concredo provvi:Sorio, non possono con- o . . trarre matrimonio senza superiore auton?az1o~e:
,i. 0 I soldati in conO'edo temporaneo, a d1spos1z10ne o . dei corpi di cui fanno parte, possono. essere m qualunque momento 'richiamati alle ba~drere'. ~no a che non sia trascorso il loro 3° anno d1 serv1Z10 , e fino a quell'epoca non poss??o ~~mb_iar e domicilio senza il consenso delle autonla m1htan.
50 Nel rimanente, e èolle accennate eccezioni, son~ in vigore per i soldati in congedo illimitat? le leg1p .. generali dello Stato; ·essi ~o? . son,~ soggetti a, restrizioni circa la scelta di dom1c1ho all mterno.o all ~stero, circa l'esercizio della loro professione, c1_rca. 1! .I?ro matrimonio, e così per tutte le altre relaz1om CIV1l1.
§ 55.
Gli uomini della riserva e della landwehr sono divisi in classi, a seconda dei loro anni di servizio.
La durata del servizio nella riserva e nella landwehr è computata dal momento che incomincia il servi~io attivo, quand'anche in quest'ullimo vi fosse stata un'rnterruzione. Il passaggio dalla riserva nella landwehr ed il congedamento assòlu·to dalla landwehr non a vviene però che dalla convoca~io?e di .controllo della rispettiva armata. Quei soldati ~1 .q~ah per mancanze commesse è ritardato il congedo 11l1m1tato, sono sempre assegnati alla classe più giovane della riserva . .
La classificazione nella riserva e nella. landwehr degli uomini che hanno appartenuto alla riserva di comple-
336
PÌIOGET'fO Dl LEG(;:E MILlTAU E me~to (§ 45) dovrà essere fotta come se essi fossero stati arruolati nel primo anno che entrarono in leva.
· § 56.
, In caso di mobilitazione o di necessità di aumentare l es~rc1to, gli uomini in congedo illimitato sono chia.~11an_ ~Ile band iere a misura del bisogno, però entro 1 l1m~t1 dell~ d is~osizioni della Legge 9 novembre 1867, relati va ali obbl1~0. al servizio militare, e per quanto lo consentano gli Interessi militari, successivamente classe per classe, incominP,iando da quella meno anziana .
§ 57 .
. U_rgenti_ interessi privati ed industria.li potranno con~1.gl~ar~ dt protrarre il rich iamo di taluni riservisfi dopo 11 richiamo della class e più anziana della riserva della loro arma o categoria di servizio; e così quello di uomini del_la lan:lwehr; come pure, in casi ecceziona lmente ... s ~ri~gent,, anche quello di qualche riservista, dopo ìl richrnmo della classe più anziana dell'isfossa arma- 0 categoria di servizio della land,vehr.
La protrazione del richiamo non influ isce sulla ·durata lo tale del servizio.
§ 58 .
. I funzio~ari dell'Impero, degli Stati della Confedera z10ne e dei :-omun~, e così pure gli impiegati ferroviari , appart_enenl 1 ~!la _ riserva od alla landw eh r, possono, in caso eh mobil1taz1one, o di necessario aumento dell'esercito, essere richiamati dopo la c lasse più anziana della Iandwehr, qualora non fosse possibile lasciare vacanti anc?e provvisoriamente i loro posti o non si potesse farh occupare convenientemente da altri.
· . _Q ~elle persone, ~ppartenent_i alle classi in congedo 11!1 m1tato, che esercitano un mmistero spirituale presso qualche congregazione religiosa autorizzatà •tiel tetri torio federalè non saranno· rfohiarnatr al ~e-rihio òeUe a,rmi.
DEU/ IMPERO TEDESCO 339
§ 59.
Gli impiegati dell'Impero, degli. Stati o dei comuni, ri,ch<iamati al servizio militare, ·non poti:anno per qu€'sto moti.v·o essere danne ggiati nella loro carriera civile.
I loro impieghi, gli emolumen ti che ne traggono e la :loro anzianità, come pure tutti i loro diritti avvenire , saranno lor\O garantiti per tutto il tempo in cui essi staranno al mil itare se rvizio .
Se essi percepiscono s tipendio da ufllciale, l'importo netto di questo sarà loro dedotto dal!' assegnamento civi;Ie; però, per quelli aventi famiglia, con moglie e :fi.o-li tale deduzione sarl.t fatta solo nel caso in cui, · abb;ndonando il foro domicilio, l'assegnamento civile netto dell'impiega to sommato collo s tipendio militare oltrepassi la somma annua di 3,600 marchi (L. 4,oOO).
Gli impie gati civili in ritiro o in aspettativa che, in caso dì mobilitazione, entran9 in servizio attivo, saranno trattati, per ciò che si riferisce ~Ile loro pensioni od assegnamenti, in base ai medesimi p.rincipii.
Spetta ai governi degli Stati della Confederazione stabilire in proposito le dispos izioni di dettag lio.
§ 60.
A quei soldati delle classi in congedo illimita·to che per oltre un anno si sottraggono al controJ.lo, o che , senza plausibile motivo non eseguiscono un orrline di servii.io, oltre a subire la punizione di cui si saranno resi passibili, sarà prolungato il tempo del servizio, e saranno classificati nella classe immediatamente meno anziana di quella cui apparlengono. Se essi continuano a sottrarsi al contro llo per due anni o più, saranno cl assificali nelle classi corrispondentemente meno anziane.
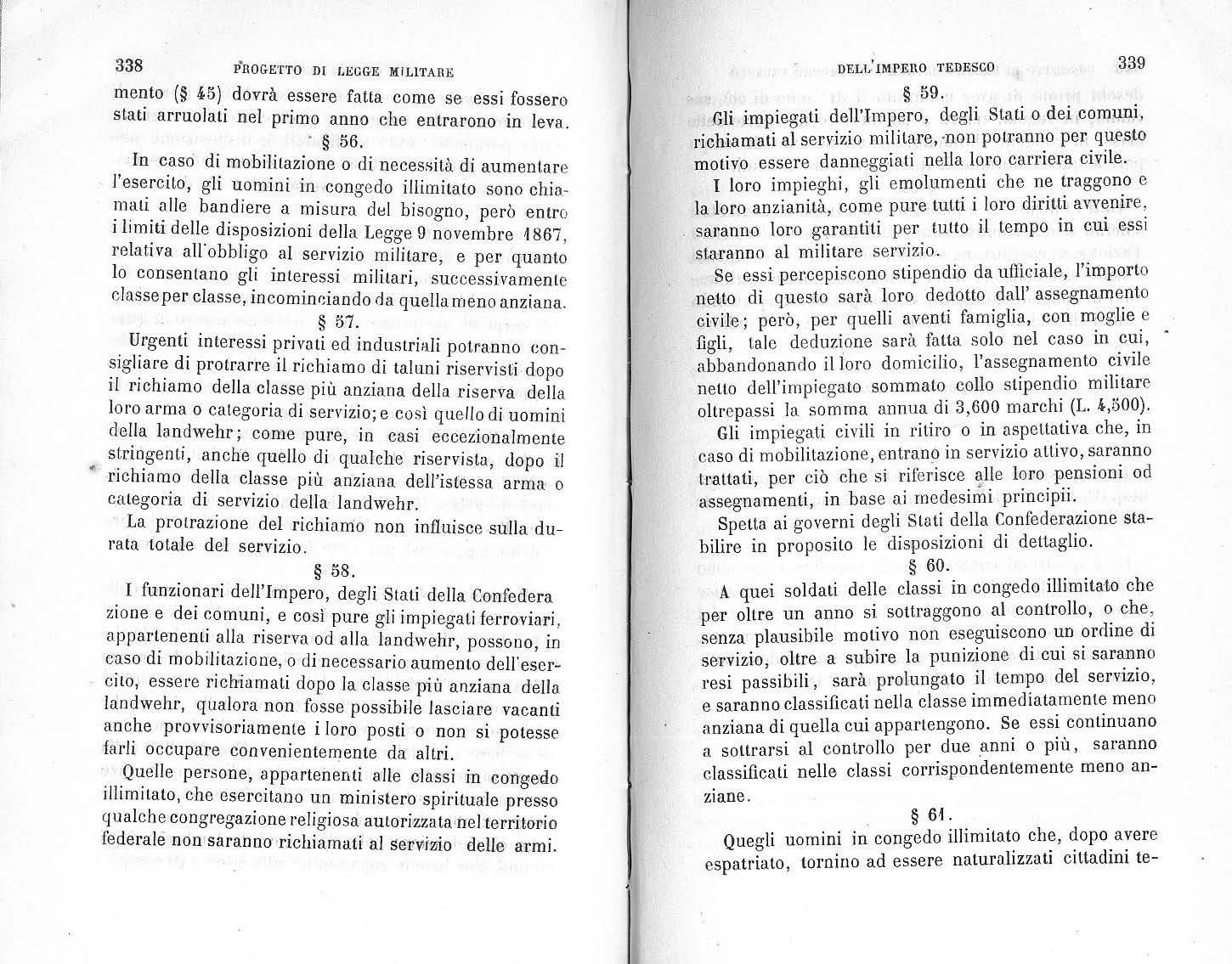
§ 6-1.
Quegli uom1m in. congedo illimitato che, dopo avere espatriato , tornino ad essere natu ra lizzati cittadini te-
338
34,0 PROGETTO DI LEGGE MlLITAllE DELÙMPEllO TEDESCO
deschi prima di aver compiuto il 31 ° anno di età, saranno, in regola, tenuti a tar nuovamente parte delle classi in congedo illimilato, per un periodo di tempo pari a quello durante il quale rimasero assenti.
§ 62.
Tutti i funzionari e impiegati dell'Impero, degli Stati federali e dei comuni sono obbligati, nella loro sfera d'azione, di coadiuvare le autorità militari nei conLrolli e nella sistemazione della posizione militare degli uomini in congedo illimitato, ed in special modo quando trattisi di richiamo di questi uomini sotto le bandiere.
Disposizioni finali.
§ 63.
Le disposizioni esecutive per le parti contenute nei titoli Il0 , I V 0 e V0 delÌa presente legge saranno emanate dall'Imperatore .
§ 64,.
Le disposiz i oni contenute nella presente legge sono app licabili alla Baviera, conformemente alle più precise disposizioni content1te nella Convenzione federale del ·23 novembre 1870 (parte JW, § 5), ed al Wur t emberg, conformemente alle più precise disposizioni della Convenzione militare del 2·1/25 novembre 1870.
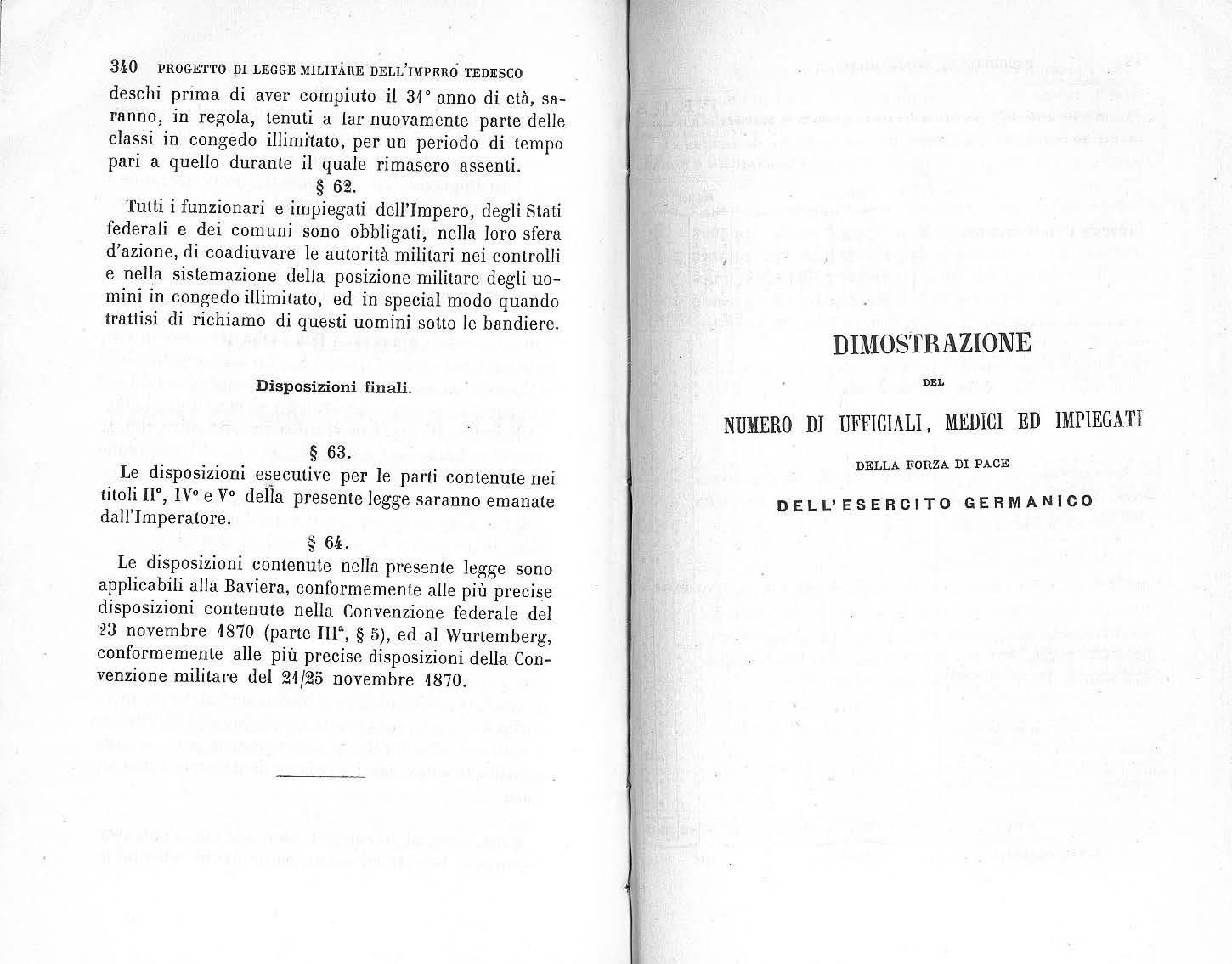
Dll\lOS1'RAZlONE DEL NUMERO DI UFFICIALI , MEDICI ED IMPlEGA'rl DELLA FORZA DI PACE D E L L' E s E R e I T o G E R M A N I e o
e con tingen ti della Germania d el nord
- esclusa la Sassonia - e compresi o le formazioni
come pure
l 14el7 Aiutanti di S. M. l'Imperatore, dei Principi di Germanra1 dei Heali P rincipi e dei Princ ipi ereditari.
Ministero d e lla guerra Casse milital'i
fnlendenze militari . . . .
Sacerdozio militare. . . . . . .
Amm inistraziooe d ella giustizia militare. . . . . ..... . .
Co mandanti s uperiori de lle tru ppe Coma ndan ti e maggio1·i di piazza . Corpo di stato maggiore
Corpo del genio
Truppe ecc ..
Ul1iciali in posizioni speciali
Amm inistrazione dei magazz ini.
Depositi per vestiari o . . . . . .
Ammm istr a1.ion e delle guarnigioni Is tituti invalidi . . . . . . . .
Amministrazione deg li ospedali
In ce tta rim onte. . . . . . . . . Depositi di rimo n ta. . . . . . .
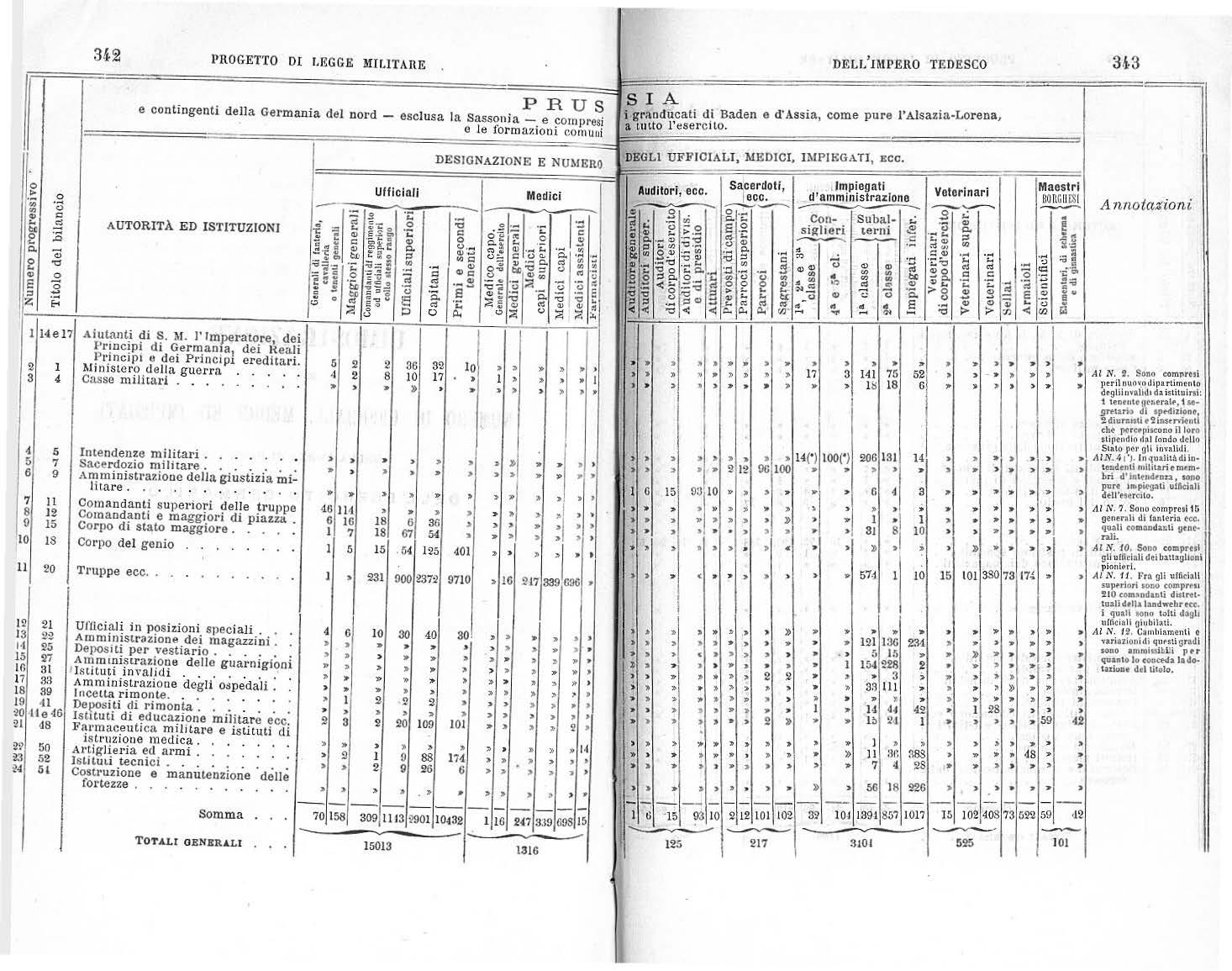
Al N. !. Sono comrreti > perilr'mow1 di parlimen10 deglii 1wo.lid1 d a is tituirti: t tenent ege,1en.lf' , 1 Slt• greurio di s.pf-dizione• 2diure 11d t!i.nservie11d che pe rce piscono il loro uiptndlo dnl Condo de ll o s,ato pe r oli invalidi.
> Al.N. 4 (J, Jn qualità diin> tendenti militari e fflf'ffl• bri d' Jn tt ndton sono pure tn,pif1Jiti ulftti 111i > dell'tH rcilo.
> Al N 1. So nocomprui1G ., gene uH di fan te ria tee. quali ,com.:mdanti 9ent· > ra.li.
> Al i.V 10 Sono oom prtsl g1i ufficiali dci batt11.9ll oni pionif'rl .
> At N. 11 Fra gli ufGci:l ll supf'ri orl ,or.o t.ompru 1 ~IO com~nduati dittret• tualidtl la laad wthrttC, j qul\1i 1ono tolti d:\9 11 \trn ciaH gi uhihti. ., Al N. 12, Ca mbi:!mcnli e > vui azioni di q uPsli g radi i ono an1misdbJJi per • qua.alo lo concedi tado• • t.a.zfon t dtl titolo.
PROGETTO DI LEGGE llfILlTAUE DEU.'ntPERO TE DESCO P R US
<:omuu i
SI A · L i
l'es
I=============== ===== =-·- '= I
UFFICIALI,
I,
======~D~E~S~J~O~Nl!AZ~IO~N~E~E~N~U~M!E!R~OJ F;:;~~~:~~Sacerdoti~i~==~~~==r.~=:==:=::,=1~~~1 , , Impiegati Veterinari Maestr 8 i Ufficiali Medici Audltori , ecc. Ieee. d'amministrazione A UTORITÀ ED ISTITUZIO NI ~---.. ------------- ~ ·r., o 0 J·- Cor\- Suba!- ..: ::= ., ;; ..: ·;; o ;;-li:; si"lieri te1·ni l:! "' C) " > .- "' · - " - ·• ;::, e Q. ::: t ----.. - - a ~ ,.,, i1 --: ii i t 1 .~ ~ , -! ·u ·i : ! i Ii ·i ·ii :1 <'s ,:;:a g t t g.~ ., e ,~ ·g. ,.. 8 ., :~ ~~ Q~ "tò:~cn!t.. ~~~,!:: :a~ 3éi3 An notazion i
granduca ti d.i Baden e d'Assia,
l'Alsazia- orena , a tutlo
erc ito.
DEGLI
MEDIC
IM PIEGATI, ECC.
2 I S 4 4 5 5 7 6 9 7 11 8 12 9 15 IO 18 11 20 12 21 13 2~ M 25 15 <J7 lll at 17 88 18 89 19 41 20 'I l e 46 21 d8 29 50 23 52 ~4 5 1
Artiglieria ed ar·mi
l sLitu Li tecni
Costruzione e manute nzio
fortezz e 5 2 ,J 2 . . ,. " 4.0 114 6 16 I 7 I 5 I , 4 G > • . . )) . . " . • l > • 2 3 . " • :l ) . ) 2 36 3\l 8 IO 17 . ) . • > • . • > ,. • • > 18 6 36 18 (;1 54 IO • • > I > . . . • • • > • » > • > " > > > > ,. > 15 54 125 401 > > 231 900 2372 9710 > 16 IO 30 4.0 30 , • • :a, > ., > > > ,., » > > ,. > > ,. ), > » .,, .,. ) > ,. .,, > > > > > 2 2 2 • > > > > > > >> 2 20 109 101 • > > » > > ::> , l 9 88 17,J > , 2926 6•• ,, .) 7t ' > :. ,. I > > > > ,., ,, > ) ,.. ,., ,. ,, • > • > > > • > > ,. , > .,, , » ,,, > > ,,. , > > Jt > > , , > :, , • > • 14 > > > , > > > , Somma TOTA.LI OENIIRA.Ll -- - -- ------ - - - -- --70 158 309 1113 2901 10482 I IG 247 339 698 15~---------15013 1816 • • > • > • > • ) I G > • ) . • • . . ) ' . ) . . I~ I • , .. . • • .. . .. . , . L.... > , 15 . . > > ,. ,. :., • .,, > ,. > > ) ,, ,,, > » > > 17 3 141 75 , 18 18 > > •>» >,.. • • . . , , • , 14( ) 100(' ) 206 131 \l 12 00 100 • " > > 93110 " > » > > ,. lt > > > •• > , > > • ,. > > l) ., è ) "' • , > » • > • > > e > > > > > > > J>>)> > ,. > > 2 2 • ) > ,. ,,., , l • .,. • » > >> •> 2)) ~I .. > G . I 81 » ) . 8 » 57-1 l )i, .,. > • ,. 121 13G • • > 5 u, I 154 21!8 ,. > 3 " • 33 Ili > > ,. I • 14 44 ,. ,. l à 21 .. 52 6 a ,; I 10 10 . l? > . .. 42 I ) > > . ,. I • ;. > l) » • li Br, 383 7 ·1 28 , 56 18 226 • , ,. • , > . .. . ,. . ..I .I • ,. > . .. ,. . . ,. , . ,. l) ,. ) . .... ,. . ,. ,. • > 15 101 380 73 17~ » • • . • > • > . > • ,. . .. ,. " » ,. > ,, > > > • > > , > > > > ,. ) » ,. » > • "' > > l 28 • , • >>,,.59 .. ,. > ) .. . • • ,. . 48 ,. ,. > 15 102 408 73 522 59 525 101 ,. ,.
Istituti di educazione militare ecc Farmaceuti ca militare e istituti di istl'uzioue medica
.
ci
ne delle
• • • 42 • ,. > ,12
AUTORITÀ ED ISTITUZIONI
==s=A = s=s~o !=~= I =A=========== - I
Aiutanti di S 111. il Re e dei Reali Prrnc1pt .. . . Mmis te ro della guerra· Casse militari
Intendenza. militare . Sacerdozio mili tare Afm inistra zione delÌa giÙstiz.i.'a Ìni~ !tare. . . . . . .
Comand~nti superio ri di 'trÙppe ·. · Comand.1 e maggiori di piazza . Corpo d1 s ta to m agg iore Corpo del genio
Truppe. e,cc. . : . . . . . . .
Uf fi c1~l~ rn P!JSizioni speciali Amm1mst raz10n e dei magazzini .
Depositi vestiario
Arom i nistrazione dei presidii. Is t ituti _per invalidi . . . . . Am m 1mstrazione degli ospedali I ncet ta r i mo ote . . . Deposi.ti d i rimonta. : : : :
Is ti t uti m1lltar1 di educazione ecc F~rmac_eutica militare a is tituti di istruzione medi ca
ed armi ·
. . : : · · · ·
Al N . 2. F ra gli impif!g-ati ,.jba unsegrt~riodispe· dbione che perce pisu il suo stipend io dal tondo dello Stato per gli innlidi .
• JtlN.4(") I»crualil.i. diin· > tendenti militari e: ,n.,nbnde ll e iutendente ,sòttO adib iti anche u lticia.li dell'esercito. ,. " » > > Al N. 1Q. Sono eompreal gli ufftc1aH p er il bat~ taglione pionierL
> A l N. 11. Fra gli uft\ciaH ,. su pe riori !ono comprei"i ,. 18 eoman ,fanti di stret~ tuali della land web.r i qu:\H sono t.olt i dai giubihui.

» ,U N. 14 t•) . nirettore del depo ;;ito ves ti:).ri o é un ult11.:ia l e dell' e,ercito a dò dest inato.
> Al N. 15 ("t . Direttore » dell' am naini struion c di > gus.rnigione é un uili ci ale » ~!~l;;::;;~to a tale scopo Il > .. >
3'4- PROGETTO DI LEGGE MILITARE OELL 1 1MPERO TED E SCO 3,i.5 Il , =========r===
DESIGNAZIONE E NUM ERÒ DEGLI UF FICI ALI, MEDICI, IMPIEGATI, ECC. I 1 17 2 l 3 4 4 5 5 7 6 9 7 Il 8 12 9 15 10 18 li 20 12 21 13 22 14 25 15 27 16 > 17 83 18 ,. 19 ,. 20 44e16 21 48 22 50 23 52 24 54
Istituti tecnici
Costruzione e mantenimènto
forte zz~
Somma TOTALI O JINRI\ALI ,. ,. ,. 4 ,. > ,. .. ,. .. .. > ,. > ,. > > ,. > ,. .. > > > ,. 7 l ,. > ,. 1 ,. ,. > ,. > > > ,. ... > > ,. 2 > > > > > l ... 18 2 ,. • ,. > ,. > ,. 1 > l} > > l 2 > ,. > ,. > > > > ,. ,. > ,. > 2 4 8 3 6 73 103 l > > > > > > > > > > > > > > 2 > > > 8 I ,. > > > ,. ,. > > > 788 > ,. > ,. > ,. > u > 4 ,. > > > > > > > > > ,. > ,. ,. > ,. > > > • ,. 1 > > ,. > > ,. > > > • > > ,. > > > > > ,. ,. > > > > ,. > ,. > > ,. > ) .. ' .. ' .. ' I > • , .. , , , )t > > , , ,. ,. . 19 28 51 ' ,,, "' .. ) > :, ) • ,. ' • > ,. • > , ) > ,. ,. "' > > ,. ' • > » » ,. > » ) > , > 1 ,. ,,, ,. y > )t ) ) » > ,. , ------- ---- --- -- --6 10 83 213 ~--- .....--._...._. 1159 823 > I 19 28 51 1100 .. ) > > ) ) > ) • I > • > > ) . . ,. • > > > . ,. ) .. ; • > • > ) > . > > ) > . ,. • > > ,. .. ,. > 2 • " " > ,. ,. > ,. > ,. ,. ,. > > > ,. 7 l > > > ,. ,. ,,, > > > > > > ,,, > > , ,. > '# > • • :I' ,,. » > > > > , > , • » > , > » > > li> )t> > 'I' ) > > " . > ,. . ,. » .. > > > ) > > > 2 > l (') 5 > ,. > ) > > > • > > > • • > > • > ) > > ,. > .. . ,. > ,. ,. ) > > ,. J ,. > s(·) > > > ,. . > > ,. . l (') l{') ,, . . » > > ,. > 9 5 16 ,. 2 > > 2 45 ",. l 8 l > > ,. . O 14 8 4 5 IO > ,. 2 6 ,. ,. ,. ,. l 2 > l} ,. ,. 2 2 l • Veterinari Maestri OORGHES l Annotazioni > 5 l ,. > ,. . 1 • 8 16 12 2 ,. > > > 3 . 21 3 1 ,. > > ,. ,. ,. > > > .. > . ,. .. ) • > > > > > ,. ) • > > , > » • > , ) "' » » ,. 'lt ) > .,. ,. > • > ,,. ,,, .,, ,. ,. > .,, ; » > ,. 'lt 'Il ,. > 829639» • > » > >> , » _, ,. » >) ,, ) ,. .. > " .. ,. ,, ,. 'lt ,. )) > ,. }) > > >> ,. . . ,. .,. » • > > " " > ,. ,. ,. ,. l) • > )) l} • > 9 )) > 3 > > > ,. >
Artiglieria
·dèllé
. . . .
>
- - - - - - - -- ----- - - - -- - -> l 2 7 I » I Oj 5 3 10; 102 50 74 1 8 29 6 42 9 li ,.__.,_,. 11 11 239 38 20
Aiµt!)n,t.i ,!li s. M. il Re e J>l'lDClpl .•.•. Mrnistero della guerra TesO\'eTia, di guerr a , Iotendenza mili tare .
DESIGNAZIONE E NUMEllO IDEGLI UFFICIALI, MED1CI, IMPIEGATI, :ecc.
Sacer,dozio militare
Amtpf,llistrazione delia giust.ìzia mihtare ........... , Comandanti superiori delle truppe Governatori, comandanti e magg iori delle. piazze . . . . . . Corpo di stato ,maggiore.
Corpo del gen io
Truppe. e.cc, . : . . : . . ,,_ , , Ufficiali rn pos1z1om speciah
Amministrazione dei magazzini .
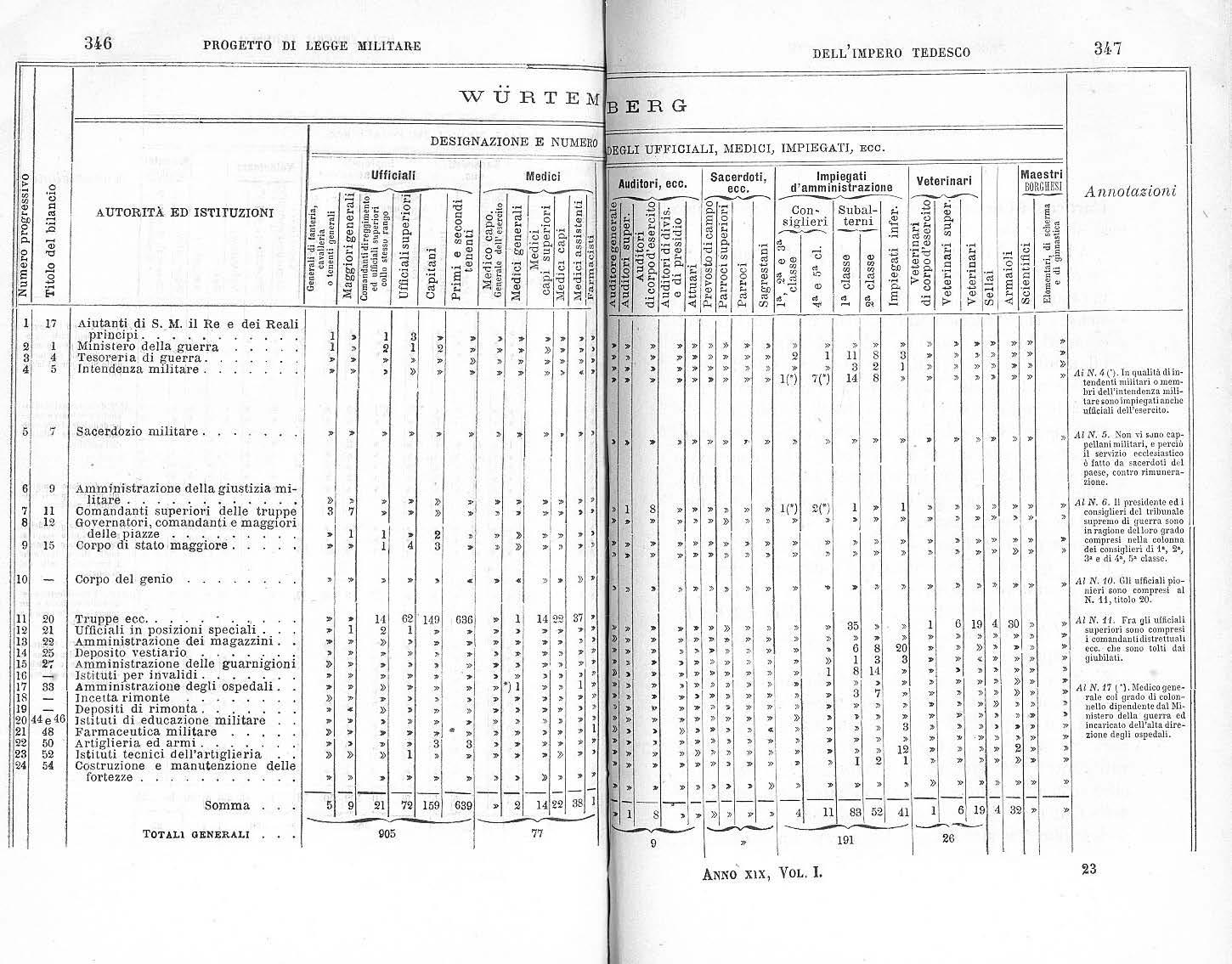
Ileposito vestiario :
Amministr az ione dello guarmg1on1
Istituti ;1e1· invalidi · _.
Ammimstrazione degh ospedah .
Jncet.ta rimonte . .
Depositi di r imonta.
Jst1tuti di educazione militare
Farmaceutica militare
Artigli_eria ed.armi .. .... .
Istitu
> > )) > < • > •
» " > • » • ,. ,. » » » » • • > .,, 2 ,. ».
Tnqu:ùHàdiintendc nti mi litari o mcm• bti dell'intendenza mili· lareiono hnp iegitti nuche u.fficiali den>eserdto
,, Al N. 5. Non vi SJU Oca p pellani miUt:lri, è pe1·ciò il ser,·izio eccl esiastic è fatto da s:1.cerdo1i de pacsC' , contro rimunera iione .
» Al N. 6. U p1 es identc cd con.sigl ieri dt'l tdJrn.JHl.1 , > comp resi ne11a colomì :t dei consiglieri di 1 •) 2• 3.t e d i •i• 5a cl asse . .,, Al !V·.10 Gli ui6c iali pio m eri ,ono compl'e!H a N . 11 > titolo 20
23 '
'I 346 PROGETTO DI LEGGE MIUTARE DELL'IMPERO TEDESCO 111=========,======"W==u=·=R= T=E=lv==fkB=E=R= G===== ====== = = = = =
l 5 I a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I G I 7 o 11 12 15 20 21 22 25 2';' 17 83 I S1920 44e46 21 48 22 50 23 52 24 54
AUT ORITÀ ED ISTITUZIONI
d~i l :I . I J ' j
ti tecmc1 dell'art1gheria
e manutenzione delle fortezze Somma TOT ALl OEN:&RALI =-.. =,_~=== -== =====. l > l > ,. > ,. ,, . ,. =I i ,. > . ,. l) ,, ,. ,, ,. ,. l) ,. . ' > > l) ,. ,. > » » I 2 H 2 » > » 905 3 I • » ,. ,. > 4 ,. 2 ,, " 62 , HO l " > ,. . .,. ,. > > , ,. ,. l ,. > . > ,, l) ,. ,, > > > ,. :> :, ;:e, , )) ,. > , , » ,. , :o, :, "' > » > ' :, • > • ! ., ! ,. . ,, » .' .' > • . ' • > » • ,. .. ,, !I 1: ~; s; : > > ,. , ) > " ,. > > " ,. 'J 1 ,, ,. > > » > > ,. • > ,. ,. > > ,., . il > • 7'1 " . ' . l • •• > • . ' • I . ,. . . > ,. • > > > • I > • . ,, > • > > ,. • , ,. • 8 ,. " 9 .,. " . > » » > » > 2 • > ,. l ('} > » » )) 7 · » » !(') ,. > » l > 7(' ) 2i·) > .. • ANrw' XIX, \'OL, I. I 1! 1 8 8 2 14 8 » » ,. . > » > > ,. o I » I » » > " ,. • ,. » . > > . > . " > > » > • > • • " .,, »,, " » Maestri BORG HES I Annotazioni ;; <l'l 11'--''-" " .,, » > > "» ,. . ... " .. »" ,. ,, » » Ai l\',/,("}
Costruzione
6 19 4 so • » Al N . 11 . Fr.i. !,H uiflci ali SUl)CrÌOl'i S0ll 0 compt~sl » > :.[ : : ,.
> i comao..tan thlistrettu.l li "' ecc. clu! sono 101\l dai » giubilati.
> » .,u N.17 t '} Medico gen e ral e col grado di colo~ >,eno d iltr.ml(-nle dal !',h, nistf!ro della guerra Cll in caricatQ dell'alta dire zione d egli o spedali.
ltl@'flVAZIONI.
L'articolo 61 della c.ostituzione dell'Imper0 germa~ico così si es prime:
« All'epoca della pubblicazione di questa costituzione << verrà, senza in dugio, introdotta in tutto l'Impero l'in<< tiera legislazione mi litare prussiana; sia, cioè, le leggi
« stesse, sia i regolamenti, le istruzioni ed i decreti
« emanati per l' esecuzio ne , od a schiarimento ed am-
« pliamento delle medes im e, e segnatamente il codicé
« pena le militare del 3 aprile 1845, l'ordinamento giu« dizi::irio militare del 3 aprile ,J8M), l'ordinanza del « 20 g iugno 1843 sui giurì d'onore , e le prescrizio ni ~< sulla leva, sulla durata del servizio, sulle competenze
« (Servis-und Verpfl.egunswesen), sull'acquartieramento, « sull'indennizzo per guasti alla campao·na, sulla mo« b_ilitazione, ecc ., tanto in guerra cheb in pace . .. l\'e « nrnane però escluso l'ordinamento eccles iastico mi« liture. Quando s ias i effettuata l'uniforme orcranizza« zione militare dell' cs8rcito tedesco, a ten o~e della « costituzione, sarà sottoposta alle dec is ioni del Rcich« star; e del Bundesrath una legge generale militare << dell'Impero ».
, L'ultimo capoverso dell'articolo 611 fu introdotto nella costituzione della Confederazione germanica del nord e più tardi fo quella dell'Impero, in seguito d'un emen~ <lamento del deputato Forckenbeck, app rovato con 13.t, voti contro 128. Questo emendamento non venne più oltre sostenùto dallo stesso preopinante nel parlamento ?ella Confederazione germanica del nord; al contrario , il deputalo Twestcn, senza incontrare opposizione al'j
DELL 1 IMPERO TEDESCO
3,i.9
cuna, parlando dello stesso e d'altro, si espresse colle
:Seguenti parole :
« lo credo qu indi che l'aggiunta proposta neli' e« mendameÌllo del sig. de l?orckenbeck, la quale altro « non contie_n e che la promessa di una. futura legge « federale m1htare, non sia di grandissima imp ortanza , « avvegnachè sia per se stesso inteso che le alluali « leggi abbiano vigore fino a che siane introdolla un'al« tr_a . Come pro-memoria, però, reputo quest'aggiunta « d1 urgente necessità; laonde possiamo vota rl a senza « esita nza >> . ( l.le!azione s tenografica sulle discussioni del parlamento della Confederazione germanica del nord, nell'anno ,J867, pag . 58 ,i.).
Anche le opinioni manifestate da altri nella discussione della parle XI, e specialmente dell'articolo 61 d:lla _costituzion~, ç,onfermano che l'aggiunta a que~ st ultimo non rrnrava che alla generale applicazione .delle leggi militari prussiane alla Confederazione germanica del nord, e dspettivamente all'Impero germanico.
Nel fratlempo, prima che fosse ultimata la uniforme orgaoizzazione dell'esercito delrJmpero, fu necessario emanare una serie di leggi speciali militari per la Confederazione germanica del nord, e rispettivamente per l'Impero germanico. Le principali fra .esse sono :
1° La legge riflettente l'ob bligo al servizio militare del 9 novembre 11867 (pag. ·13·1, Foglio delle leggi fe4erali), estesa ora a tutto l'Impero {alla Baviera con speciale determinaz ione del 21 novemb re 187,t, pagina 399 del Foglio leggi dell'Impero);
2° La legge sulle prestazioni d'alloggio per la forza ,armata in tempo di pace, del 25 giugno 1868 (pag. 523, Fogli'o leggi /ede-rali), es Lesa attualmente a tutto l'Imp ero, ad eccezione della Baviera e del Wurtembero"
3° La legge imperiale sulle giubilazioni e sulla
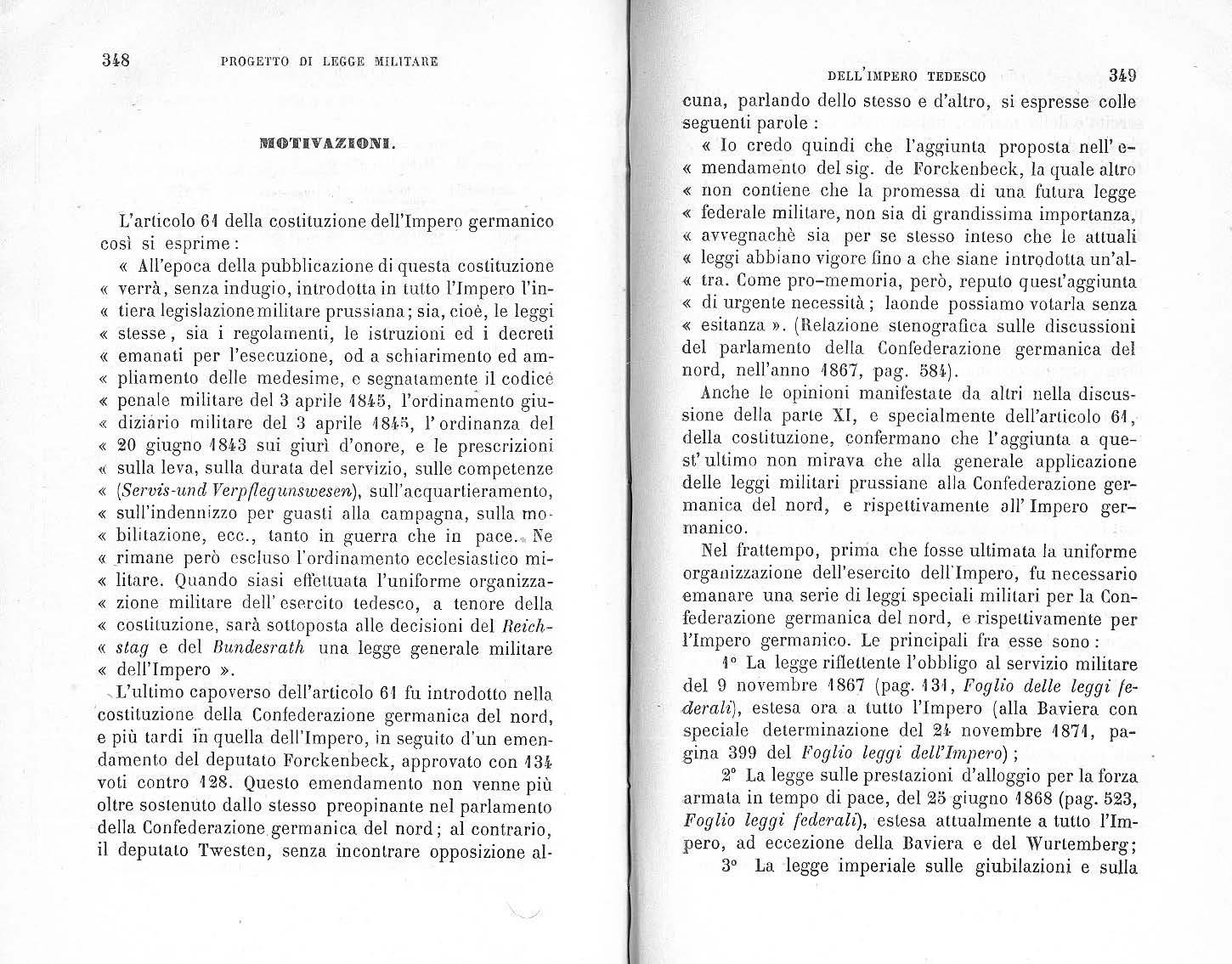
3i-8 PROGETTO DI LEGGE MI LlTA IU'.
b•
PllOGET'l'O DI LEGG E MILITARg
c oncessione di impieghi ( Versorgung) a mililari dell'esercito e della marina, nonché sulle concessioni ai superstiti dei medesimi, del 27 giugno 11871 (pag. 27o, Foglio leggi dell'.lmpe1·0);
4° La legge imperial e sulle servilù militari delle proprietà nelle adiacenze delle fortezze, del 21 dicembre 1871 (pag. 459, Foglio leggi dell'I1npe1'o);
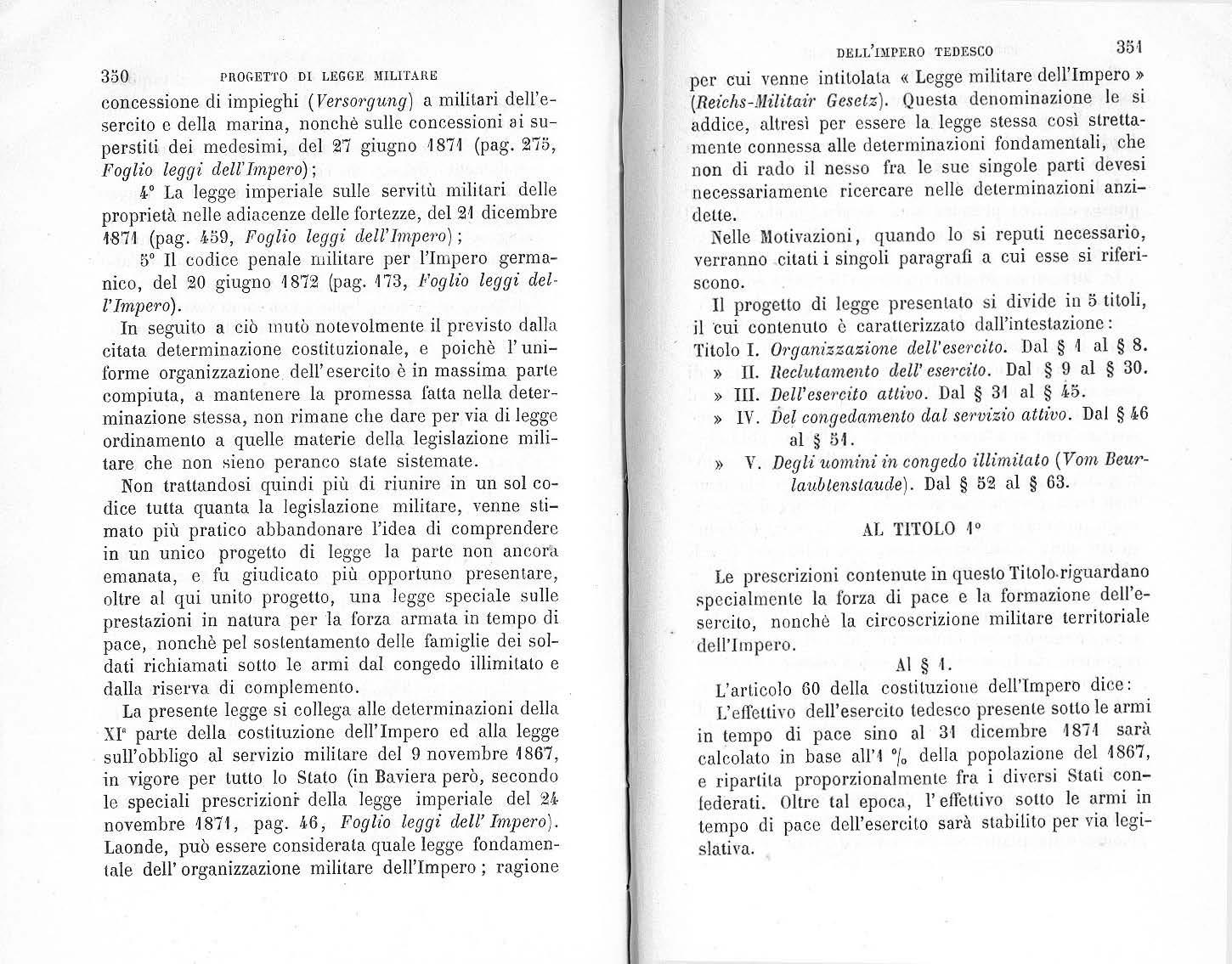
5° Il codice penale niilitare per l'I mpero germanico, del 20 giugno 11872 (pag. 173, Foglio leggi dell'Impero).
In seguito a c iò mutò no te volmente il previsto dalla citata determinazione cos tit uzionale, e poichè l'uniforme organizzazione . dell'esercito è in massima parte compiuta, a mantenere la promessa fatta nella determinazione stessa, non rimane che dare per vi a di legge ordinamento a quelle materie della legislazione militare che non sieno peranco state sistemate.
Non trattandosi quindi più di riunire in un sol codice tutta quanta la legislazion e militare , venne stimato più pratico abbandonare l'idea di comprendere in un unico progetto di legge la parte non ancora emanata, e fu giudicato più opportuno presentare, oltre al qui unito progetto, una legge speciale sulle prestazioni in natura per fa forza armata in tempo di pace, nonchè pel sostentamento delle famiglie dei soldati richiamati sotto le armi dal congedo illimiLato e dalla riserva di complemento.
La presente legge si collega alle determinazioni della Xl" parte della costituzione dell'Impero ed alla legge sull'obbligo al servizio mi litare del 9 novembre 1867, in vigore per tutto lo Stato (in Baviera però, secondo l e speciali prescrizioni- della legge imperiale del 24novembre 1871, pag . 46, Foglio leggi dell'Impero }. Laonde, può essere considerata quale legge fondamentale dell'organizzazione militare dell'Impero ; ragione
DELL'nIPERO TEDESCO 315'1 per aui venne intitolala « Legge milita re de ll'Impero» (Reichs -Milita.ir Gesetz ). Questa denominazione le si addice, altresì per essere la. l egge stessa così strettamente connessa alle determinazion i fondament ali, che non di rado il nesso fra l e sue singole parti devesi nec~ssa ri amente rice rcar e ne ll e determinnzioni anzidette.
Nelle Motivazioni, quando lo si reputi necessario, verranno citati i singoli pnragrafi a cui esse si riferiscono.
Il progetto di legge presentato si d ivide in 5 titoli, il ·cui contenuto è caratterizzato dall'intestazione:
Titolo I. Orgam·zzazione de ll' ese1·cìto. Dal § 1 al § 8.
» II. llecl'utamen to dell' ese1·cito. Dal § 9 al § 30.
» III. Dell'esercito attivo. Dal § 3,1 al § 45.
» lV. De? conr;edaniento dal se 1·vizio attivo. Dal § 46 al § 51.
» V. Degl-i uom·ini in congeclo illimitato (Vom Beurlau.bl enstaude ). Dal § 52 al § 63.
AL TITOLO 1°
Le presc rizioni contenute in questo Titolo. riguardano ~pecialmente la forza di pace e la formazione dell'esercito, nonché la circoscrizione militare territoriale dell'Impero.
Al § ,1.
L'articolo 60 della costituzione dell'lm pe rt> di ce : L'effettivo dell'esercito tedesco presente sotto le armi in tempo di pace sino al 3·1 dicembre rn1-1 sar à ca lcolato in base al n °{o del la popola zio ne del ,t867 , e ripartita proporzional mente fra i div0rsi Stat i confede rati. Oltre tal epoca, l 'effettivo sotto le armi in tempo di pace d ell'esercito sarà stab il ito per via legisl ativa.
350
Conseguentemente, a tutto il 3,1 d icembre 11871 , lu forza pres e nte dell'esercito sommava a 4-0 ·1,659 uomini, cifra che, per la legge del 9 dicembre 1870 (pag. 4 H , Foglio l eggi clell' lrnpe1·0), fu normalmente eonservata anche per g li anni 187~ , 1873 e 4874.

Nel § 1 del progetto si propone ora di mantenere questo elfeuivo presente so llo le armi an che dopo il 1874., fino a che s iar.o emanate altre disposizioni Je,ri1 . o s aove .
La forza sollo le a rmi in tempo di pace è cos'L strettamente con n essa nIla organizzazione gene r ale dell'eserciLo, che torner ebbe impossibil e regolare per Je o-ge l ' o una, senza contemporaneamente dare anche all'altra stab ile assetto . Rego lare d'anno in anno la forza di pace sulla si tu azione politi ca può essere aLLuabile, ed utilmen te, da Stati che mantengano in tem po di pace so llo le armi una forza pN!Ssochè su fficient e ai bisogn i della guerra. J\la ciò non è conc ili abile con un sistema di quadri, quale il nostro, in cui ogni cambiamento della forza presente in pa ce, in temp i in cui le eventualità. politiche sono im prevedibi li , sarebbe ta lm ente noc ivo che, a mo' d'esempio, una riduzione di so li 5,000 uomini caus erebbe dopo ,12 ann i una effettiva diminuzione della forza di g uerra di 20 ,000 uomini. Si vede dunque chia rame nte che tale mi sura av r ebbe per con seguenza dei mutamenti, sia nella formazione di guerra, sia in que ll a di pace dell' esercito.
Di tanta importanza essendo l'influenza eser ci tata dalla forzo. so tto le .armi in tem po di pace su quella di guerra dell' esercilo, ne consegue esse r e inammissibile , pe r ra gioni di s ic urezza dello StaLo, qualsiasi ridu1jonP della presente cifra.
Ness un a potenza si trova essere, co me la Germania , circondata per lu nga diste sa di confine da tr e gran di potenze e da quattro Stati minori, cd avere p_er di pi ù
un Iun"O tratto di costa accessibile. Le imm ed iate r e· 'o I . }azion i di confine con a!Ll'i Stati, la cui p opo azione europea ammonta a ,J iS7 mil ioni di anime, so no indubb iament e di rrrandc vantnggio, ma impongono altr esì obbl io-hi mno-:iori J)er la sicurezza della nazione. La O Ot> • fo l'za militare degli Stati vicini è pt·oporz1011ata alla loro grandezza; la Fran cia con 11 11a p opo laz!one d~ ~7 milion i di abitanti , dopo avere introtlollo Il se l'v1 z10 obb li gatorio per tulli con una Jurnta complessiva di ~O anni , ha s ta bil ito l'effettivo di pace d el s110 ese rcito in 428 mila u om ini, non compresivi ~6,738 ufiiciali (4).
In vista d i queste circ os wnze, per l'Impe ro germanico che conta circa 4·1 mi lioni di abitanL i, un ese r cito co n un effeuivo di pace di 1.01,659 uomini e con u11a durata complessiva di s ervi zio d i 112 anni, pub ritene r s i bcJs le,•o le sol quando si ponga fid ucia nella validità dello strumento di guerra preparato me r cè una stab ile organ izzazione, n onchè nell'approp ri ato impiego del medes imo.
Non r e putasi quindi ammissibile una diminuzione nella forza presente di pace dell 'ese rcito. E d'altron:de, dev esi rimar cnre come ; ri spe tto alla sempre crescenlc popolazione, il tributo al l' ese rcito s ia r ela ti v1J.rnen te scemato quando, coll'approvazione del § 11 del progetto,
(l) La forza bilanciata dell 'eser ci to francese, sul piede di pa ce, ammonta a 454YJ0 uomini. Per l'unno 1874 tuttavia, non essendo peroneo costituiti tutti i quadri, manclieranno alla stessa 18,000 uomini. Oltre la forza bilanciata è annualmente, o pe r una durata da 6 mesi a un anno chiamata sotto le armi, per l'istruzione, la j • porzionl' del co ntin o-;11tc; p,~r l'anno 1874 essa rimarr1.1 sotto le armi 6 mesi, nella (orza di !i4 mila uomini Cosiccllè per mezzo anno la forza dell'escr·cito sa rà di 451,1 70, e per l'altro mezzo anno di 508,170 uomini; in media quindi 4Sl,J70 uomini.
352 PROGETTO DI LEGGE MILITARE
DK f. L1 1AIP1mO TEDESCO 353
DI LEGGE nriLITARE
venga stabilito di mantenere indeterminatament~ l'attuale effettivo di pace. Infatti, mentre la forza presente di pace dell'esercito ammontava in Pruss ia, nell'anno 4816, a 1,25 °/. della popola zione, nell'anno 186·1 a 1 ,0615 °/o, e nell'anno 1867 venne regolato per la Confederazione germanica del nord, in base all'uno per cento degli abitanti , presentemente ascende solo a O, 978 °/o della popolazione secondo il censimento del '1871; e questo per cento and r à, d'anno in anno, scemando, sempre quando l'effettivo cli pace dell'esercito rimanga invariato.
I sott'ufficiali sono compresi nella cifra dei 401,6i:i9 uomini. Secondo· il, bi lancio p er il.1874., il loro numero è di 52,969, cifra che è prevedibile abbia ad essere approssimativamente mantenuta anche in avvenire. Questa cifra subì sempre finora piccole variazioni a seconda dei bisogni eventuali, per il che non importa fissa da perentoriamente pe1; via di legge.

Per ra g ioni di economia, i vo lontari d'un anno s ono stati negli ult im i anni compresi nella forza presente di pace fino al numero cli o per ogni compagnia e squaclr?ne, e 3 per ogni batteria. Questa m isura però ha ·avuto per conseguenza un indebolimento di forza nella riserva e nella lanclwehr, il quale non avrebbe potuto più oltre esser tolleralo senza pregiudicare l'organizzazione cli guP-rra dell'esercito . L'annuo mutarsi, inoltre, de l numero dei volontari presso i divers i corpi di truppa turba sensibi lm ente il regolar e andamento delle operazioni di leva.
Il numero dei volontari d 'un anno an1missibili annua!. mente nell'esercito , astrazione falla da alcune disposi zi oni eccezionali, in parte tuttora valide, sull'ammissione al volontariato d'un anno , dovrebbe variare fra i 3 , 500 ed i 4,000.
DELL' IMPEHO TE DESCO
Ai §§ 2 e 3.
In base ali' articolo 63 della co s tituzione, l'Imperatore fiss a la fo rza presente so llo le armi e la ripartizione dei contingenti de ll'esercito imperiale. Il dirillo della rappresentanza na zionale di fi ssarn e il bilancio no n ese rcita su tal e prer()ga tiva che una limitata influenza quando si trnlli di camb ia ment i d' organico c he to cchino il bilancio. Coi §§ 2 e 3 del progetto s i offre mezzo di stabilire nel corso della legislatura, d'aceord o colla rapprese ntanza nazionale, i principii fondamentali dell' orcl in amento cli pnce dell'esercito. L'organismo dell' eserc ìlo non de\'es i pe r ò racchiudere in rigide forme; che anzi gli deve essere lasc iata la necessaria latitudine perché possa tener d ietro a i rapidi progressi della scienza e tener co nco del mutarsi delle altre esigenze , sia per rispetto al modo di far la guerra, sia per risp e tto ad altre c ircostanze, senza c he per ogni singolo caso facc ia mestieri ripercorrere la lunga via legislativa. Laonde, mentre il progetlo fissa in modo stabile il num e ro dei bauaglioni, degli squadr oni, dell e 1 batterie, delle più grandi unità tattiche ed amministrative e dei corpi di armata:, si mantiene invece più sull.e gene rali riguardo a tulle le disposizioni concernenti le formaz ion i inte rmediarie e riguardo alla composizione de i corpi d'armata.
Base di tutte le disposizioni contenute nei §§ e 3 è l'attuale organizzazione .
Nel numero dei battagl ioni di fanteria che già contano tutti 4 comp agnie, sono compresi anche i battagl ioni cacciatori che però non so no reggim entali. J battoglioni cacciatori sono ripartiti secondo il bisogno tr a i corpi d'es ercito. e fra le divisioni, ed in Baviera anche fra le brigale . I reggimenti di fanteria cons tano di 3 battagl ioni, ad eccezione d'uno che ne ha 2 soli.
315,i. P HO GETTO
35 5
•
Per la cavalleria, 5 squadroni costituiscono g ià attualmente un reggimento.
Nell'ar t! glie1~ia da c_ampagna si hanno quasi in egual numero npart1 (Ji btheilungen) di 3 e di 4 bauerie ciascun?; nel ·1 _2° corpo di esercito (sasson e) vi è ancora un riparto d1 sole 2 batterie, .
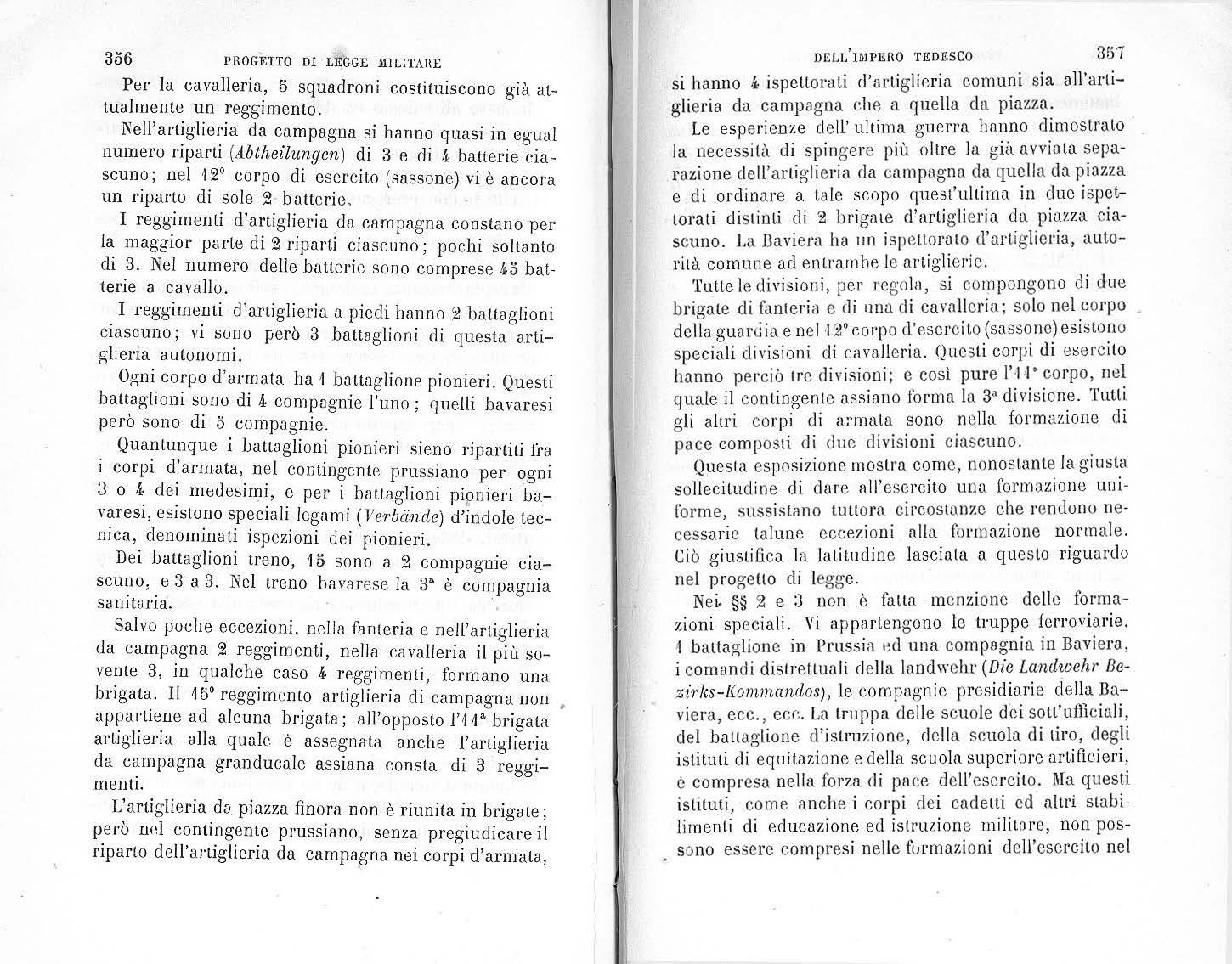
I regg_imenLi d'artiglieria da campagna constano per I~ magg10r parte di 2 riparti c ia s cuno; pochi soltanto d1 _3. Nel numero delle batterie sono comprese ,i5 batter ie a cavallo.
. I reggime?ti d'artig lieria a piedi hanno 2 battagl ioni c1as~uno; v1 sono però 3 battaglioni di questa artiglieria autonomi.
Ogni_co:po d ' armata. ha I battaglione pionieri. Questi bat~agl1orn s?no di 4 compagnie l'un o; quelli bavaresi pero sono d1 5 compagnie .
Quantunque i battaglioni pionieri sieno ripartili fra i co rpi d'.armata,_ n~l contingente prussiano per ogni 3 o i: de'. medes1m1, e per i battaglioni pi pn ieri ba.v~res1, es 1slo?o specia li legam i ( Verbiincle) d'indole tecrnca,. denom1?at~ ispezioni dei pionieri.
Dei battagltom treno, 15 sono a 2 cornpagnie ciascuno; e 3 a 3. Nel treno bavarese la 3" è compagnia sanitoria.
Sa lvo poche eccezi~ni, n~lla fanteria e nell'artiglieria da campc~gna 2 reggi menti, nella cavalleria ìl più sove~lle 3, rn qualche caso 4 reggi.menti, formano un a brigata . Il 115° reggim ento arliglieria di ca mpao·na non ap f:a~lie_ne ad alcuna brigata; all'opposto 1' 111" 0 brigata • artiglieria alla quale è assegnata anche l'artiglieria da campagna granducale assiana consta di 3 rerrgimenli . 0
L'ar ti gl ieria do. piazza finora non è riunita in brio·ate · , l . o , p ero nn con ting ente prussiano, senza pregiudica.re il riparlo dell ' a rtiglieria da campagna ne i corpi d'armata,
si hanno 4 ispettorati d'arti gli eria comuni sia all'artiglieria da campngna ch e a quella da piazza .
Le esp e rienze de ll' ulti ma guerra hanno dimostralo · la necessitù di spingere più oltre la gfa avviata separ azio ne dell'artiglieria da cam pagna da quella da piazza e di ordin a re a tale scop o quest'ultima in due ispe ttorati distinti di 2 brigate d'artiglieria da p ia zza ciascuno . La Baviera ha un ispellorato d'artiglieria, autorità comu ne ad entrambe le artiglierie.
Tutte le divisioni, per rego la, si compongon o di due brigate di fante ria e di 11na di cava ll eria; solo nel corpo della gunrù ia e nel ,t:2° corpo d'esercì to (sa ssone) esislono speciali divisioni cli cavalleria . Questi corpi di eserc ito hanno perciò tre divisioni; e così pure l'H • co rp o, nel gua le il contingente assiano forma la 3a divisione. Tutti g li altri cor pi di a:·rnata sono ne ll a formazion e di pace composti di due divis ioni ciascuno.
Questa es posizi one mostra come, nonosLante fa giusta sollec it udine di dare a ll'esercito una formuzione unifo rme, suss istano tuttora ci rcostanze che r endo no necess ari e talune eccez ion i alla form azi one normale.
Ciò giustifi ca la la litudin e lasciala a qu es to riguardo nel progeuo cli legge .
Nei. §§ 2 e 8 non è fatta menzione delle formazioni spec iali. Vi appartengono le truppe ferroviarie.
•I ballaglione in Pruss ia t-!d una compagnia in Bavi era, i c oman di dislrelltrnf i della landweht· (Di'e Landwehr Bezir ks-KommandosJ, le compagn ie presid iarie de lla. Da.viera, ecc., ecc . La truppa delle scuole d'ei sotL'uffi ciali , ciel battaglione d'istruzione, de ll a scuola d i tiro, deg li is tituti di e quitazione e de ll a scuo la superiore artifici e ri, è compresa ne ll a fo rza di pace dell'esercito. Ma questi istituti , come anche i corpi dei cadeui ed altri stabilimenti di educazione ed is truzion e rnilit:1re, non possono essere compresi nelle formazioni de ll' ese rcit o nel
356
PROGETTO DI LEGGE m LlTAHE
DELL'HIPEHO
351
TED ESCO
senso dei §§ 2 e 3. I batLaglioni, g li squadroni e le batterie citate nel§ 2 si ripartiscono nel modo seguente:
Co lle disposiz ioni di questo paragrafo e con apposito allegato al medesimo è stabilito il numero degli ufficiali, i posti di medici ed' impiega ti nell'ordinamenLÒ di pac e dell'esercito.

Nell'allegato stesso sono pure dimostrate e motivate le varianti al bilancio del 187.4.
È naturale che col tempo si mostreeanno necessari parecchi cambiamenti nel numero dei posÙ nell'esercito e che non sarebbe conveniente ernanare per ogni sin·go lo caso leggi speciali . Le annuali discussioni sul bilancio porgono occasione alla disamina di tali bisogni, e a tale scopo basterà specificare nel bilancio preventivo ( Etatsvorlag) le varianti rese necessarie, come è prescritto dal § 4 .
I posti di ,ufficiali, ec c., del contingente bavarese non sono compresi nella dimostrazione, poichè in forza della_ convenzione la Baviera ha un bilancio suo proprio speciale per l'amministrazione militare.
TEDESCO 31S9
Al § I>.
La circoscrizione ter ritoriale militare essendo la base della organizzazione della landwehr così a senso dell'art. · 63 della costituzione del Regno, quesla è devoluta. all'Imp era tor e. Es sa si collega. col riparlo dell'esercito per modo che ogni corpo d'a rm ata, ogni divisione, ogni brigata di fanteria h a il suo proprio territorio nel quale, per re go la , si reclutano i rispettivi corpi di trupp a, ed in caso di mobilitazione s i completano. Ad ogm rego-imento di fonteric1. di linea corrispondono orclinaria~cnte '.z distretli di battaglione cli landwc hr, co i quali in caso di mobilitazione si forma un reggim ento fanteria deJla landwehr di 2 battaglioni aventi lo stesso numero del ri spellivo reggimento di linea.
I corpi di truppa sono possibilmente di slo cati loro rispettivo dis tr etto di r eclutamen to o nelle sue v1c1nanze. Si danno però circostanze di varia natura che esigono parecchie eccezioni alla regola anzideu~. ~osì il ' corpo della guardia prussiana no~ ha un ternLor10 s~o proprio speciale, ma si recluta rn_ tutta la m?narc~ra prussiana; cosl le truppe che sono dislocate ne~! AlsazraLorena hanno i loro distretti di complemento m parecchie parti·del Regno, perché all'epoca della riannessione di questo paese alla Ge rm ania non fur~no c1~ea~i nuovi riparti di truppa, salvo che per le ar mi s peciali, ecc. I sovraccennati principii però sono sempre mantenuti cosicchè possono essere riguardati come il distinti ;o caratteristico del nostro ·ordinamento mil itare nazionale.
Al § 6 .
A Lenore del § 63 della costituzione spella all'Imperatore ordinàre la fo r mazione di guerra dell'esercito.• A
· senso del § ,16 della legge 9 novembre ,1867 riguardante
l'obbligo al servizio mili lare, la chiamata della Iandsturm è devoluta all'Imperatore quale generalissimo della Con-
358 PROGETTO DI LEGGE MlLITARE
358 865 231 22 14 14 2 Baviera. 58 50 31 4 2 2 3 Sassonia · . 29 30 !8 2 4 Wurtemberg . 24 20 l4 TO TALE 469 465 300 29 IS 18 Al § .t.
l Prussia e contingenti dipendenti dal!' amministraz10ne prussiana
• DELÙilll'ERO
l'H OGETTO Dl J,EGG E MI LITAllE
fe derazi one. Ne l proge tto di legge , a l § 6, vie ne inoltre stabilito ch e l'imp erat or e a bbia ad emanare altres ì t ulle le di s posizioni org anich~ necessa ri e in caso di chiamata sollo le armi de lla la nd s turm.
/ Un'u.nica dir ezi one è ass olutamente necess aria speci a lm e nte per le complicate op erazion i de lla mobilitazione de ll' eser c ito, per cui le re lative disposi zioni fondamentali Ùe Yo no es sere date da ll'lmp er a tore .
Al § 7.
4- tenore d ell' artic olo 6G della costituzione , le n omine de gli uffic ia li nei sin_g oli c ontingenti , ladd ov e sp ec iali conv enzi oni non presc rivan o a ltrim e nti , so no fotte dai sovrani confederati e resp e ui vam e nte dai loro s enati, colle restrizioni conte nuté n e ll' a rti c olo 64. Ad e c'Cezione de lla Bav iera , de ll a Sassonia, del Wi.irtemberg e del Braun s chwe ig, tulli gli Stati c onfe derati h a nno, mediante convenzi oni, cedut o q uesto diritto a ll a Coron a di Prussia. 'Ma an ch e n ell a Sas sonia, ne l Wi.irte mbe rg e n el Draun~ schweig le leggi prus s ian e, a me nte della c ostituzione, sono norma pe r l'ammissi one e le promozioni ai va ri gradi ed impieghi nell' esercito. Il 1° alinea del§ 7 si bas a s u qu esto prin c ipio. -
Fondamento alle prescrizioni del 2° alin ea è la considera zione: ess ere della massima importanza, laddove è in vigore l'obbligo ge neral e al s e nizio, ve{J'liare a che le alll'ibuzioni dell'autorità militare non sie~o compromesse indegnamente. Il c odi ce pen a le solo non bas ta ad impedirlo. li rilascio e il ritiro dei titoli di servizi o è devoluto allo stesso sovrano della Confederazi one o allo stesso s e nato dai quali sono nominati gli ufficiaÌi del contingente in cui la persona, all a qual e de tti titoli si riferis cono, ha da ultimo servito attivamente.
Al § 8.
La disciplina è la base fondamentale de ll'esercito. Uno solo essendo l'esercito è d'uopo che tulle le di-
sposizioni disciplinari sieno inspirate da un unico co ncetto e siano quindi emanate dall'Imperatere.
AL TITOLO Il.
L'articolo 59 della costituzione dell'Impero e la le?~ e dèl 9 novembre 1867 r iguardante l'obbligo al servlZlO · militare, formano la base fondamentale del r eclut?~e~to dell'esercito. Per l'esecuzione di queste prescr1z1001 a te nore del § 19 dell' or men tov ata lP-gge, s?nosi emanate speciali disposizioni, fra le ual i l'i struz1one sul. reclutamento militare pe1· la Contederaz.1one germamca del nord del :26 marzo 1868, occup;i il primo posto. li 'reclutamento dell'esercito in tut.to l'Impero di .Germania è regolato seeondo i principii esp~es~ i nella medesima; prin cipi~ che sono il risultato d, cmquant'anni di esperienza in Prussia. .
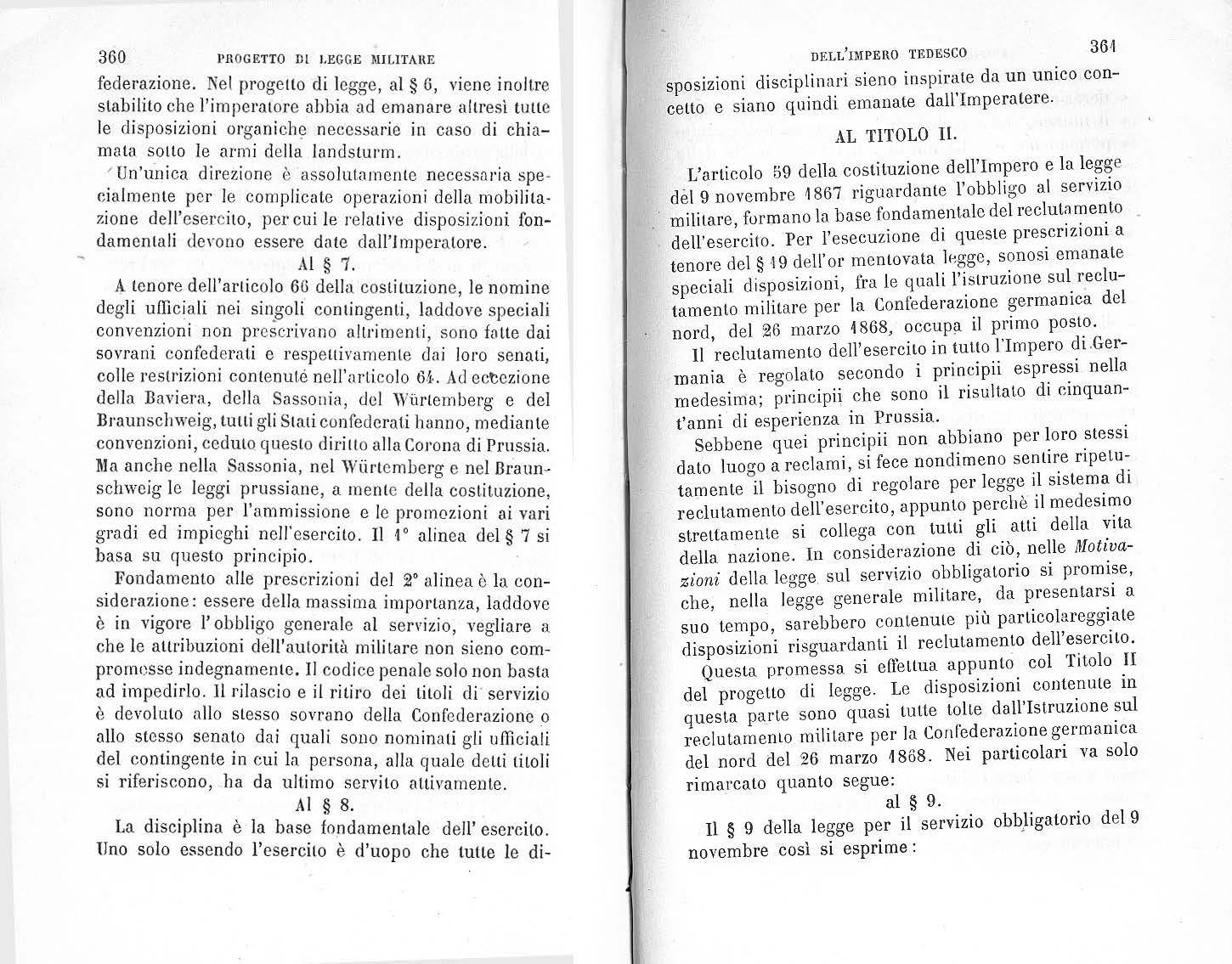
Sebbene quei principii non abbiano per ~oro ~tessL dato luogo a reclami, si fece nondimeno se~ t,~ e npetu~ tamente il bisorrno di rego lare per legge 11 sistema di reclutamento dell'esercito, appunto perchè' il medesi~o strettamente si collega con tutti gli atli della vita della nazione . In cons iderazione di ciò, nelle hlotiva.ziom: della legge. sul servizio obbligatorio si promi~e, che, nella legge generale militare , da presentar~1 a suo tempo, sarebbero contenute più particol~regg1_ate disposizioni risguardanti il reclutamento dell e~erc1lo.
Questa promessa si effet tua appunto col TLtolo .n del progetto di legge. Le disposizioni conte_n ute m questa pa rte sono quasi tutte tolte da~l'Istruzwne ~ul reclutamento mi li tare pe r la Confederaz10ne germamca del nord del 26 marzo 1868. Nei partieolari va solo rimarcato quanto segue: al § 9.
n § 9 della legge per il servizio obbJigatorio del 9 novembre così si esprime :
360
DELL'IMPERO TEDESCO 36 11
362
l'ROGET1'0 DI LEGGE MI LITAR E
« Il co mandante supremo dell'esercito de ll a Confe« ? e r azi one fissa annualm e nte in conformità della legge « il numero delle reclute da incorporarsi nell'esercito « perm ane nte e nella marina. 11 num e ro totale d ell e « recl~te va ripartilo fra i singoli Stati confedera li pro« porz1 onata mente a lla popolazione, e ciò per curà « de lla commission e fed e rale per l'esercito di terra e « p er le fortezze, coadiuva ta dalla commissione fede« rale per la marina.
« Nel còmputo della popolazione d'ogni singolo Stato « confed e rato vanno sottratti solo gli strani e ri che vi « dimorino; non già gli individui appartenenti ad uno « degli Stati confed erati » . ·
Il § 9 del progetto dà a lcuni schiarim enti riguardo a ques te prescrizio ni, i quali in parte sono tolti dai~§
-17 a '19 dell~ Istruzione s ul reclutamento militare per la Confed e raz10negermanica del nord del 26 marzo 1868 , e_d in pa r te ~urono dimostrati ·co nv enienti dalle esperi enze posterrormenle a cquisite .
Le persone mili tari in attivo servizio, presenti in una rlata località, de vono essere dedotte dalla cifra dell a po polazione, ciò ch e gi à praticasi in serruito ad una decisione del Bund es rath. i:, . Tal volta, c~m~ l'esperienza ha dimostr a to, speciali circo s tanze d1 d1 versa natura rendono ne cessa rio di scostarsi nel riparto del co ntingente dalla pr~porz ione fra (o stesso ed il n~mero dell e a nim e . Occo rr e quindi l~1sc1~r e a qu es to ri guardo n ella legge una c er ta latit 1tudme, guar entendosi co nte mporaneam ente contro l'abuso.
La disposizione che i regni di Baviera, di'Sasso ni a e del Wiirtemberg abbia n o a provvedere per proprio c onto al completam ento dei risp e ttivi c ontino·enti, e non o s1en? lenu~1 a somministrare pel completamento d'altri con tin ge nti ch e un numero di reclute corrispond ente
DELL'IMPERO TEDESCO 3 lì3
a quello degli indiv idui che hannò in essi domicilio cd appartengono ad altri Stati, risponde alla posizione occupata dai contingen ti di questi tre Regni nella forza militare dell'Impero .
È conform e a g iust izia e d ·al proced imento sinora usato che i volontnrì d'un ann o s ieno snppleitivamente computali ai loro distretti nell a distribuzione <lelle reclute, abbenchè non contino nella forza presente di pace. I vol on tari a rruolali n ell 'anno antece dente vanno c ompresi nella c ifra totale delle reclute da arruo larsi nell'anno in corso, e quindi nuovamente :;o ur alLi neU a sottoripartizione fra i distretti.
Il§ ·11 O dell'Istruzione s ul reclutamento militare del 28 marzo ·1868 determina in qual modo si debbano co lmare le lacune straordinarie c he si verificass ero nei soldati presso i corp i d'armata. Non s em bra perciò necessa~io di comprendere nella legge disposizioni a ques to riguardo.
Al § 10.
A tenore del § 6 della l e 0 ·ge del 9 novembre 1867 l'obbligo al servizio s ollo le ~rrni .in comincia.per regol; col ,1• gennaio di quell'anno nel quale chi è tenuto a prestarlo compie il 20° anno d' età .
Nei seguenti paragrafi del progetto è mantenuto il principio Dttua lmente esistenLe, che la decisione finale, se un indi viduo di leva debba o no arruolarsi, possa essere protratta sino all'anno nel quale il me des imo compie il 22° anno di elà (3° anno di concorrenza) eccettuato il caso di colpabilità dell'individuo (§ 18); caso che, ben inteso, si app licherebb e a ch i, essendo obbligìltO ul se rvizio, non si presentasse nel temp o prescritto alle auto rità di le va .
Al§ H. .
Ogni Tedes co che abbia perduto la nazionalità(§ ,t 3 deHa legge 1° giugno 1870, pag. 355, foglio delle leggi
ANNO xix, YoL. 1. i,
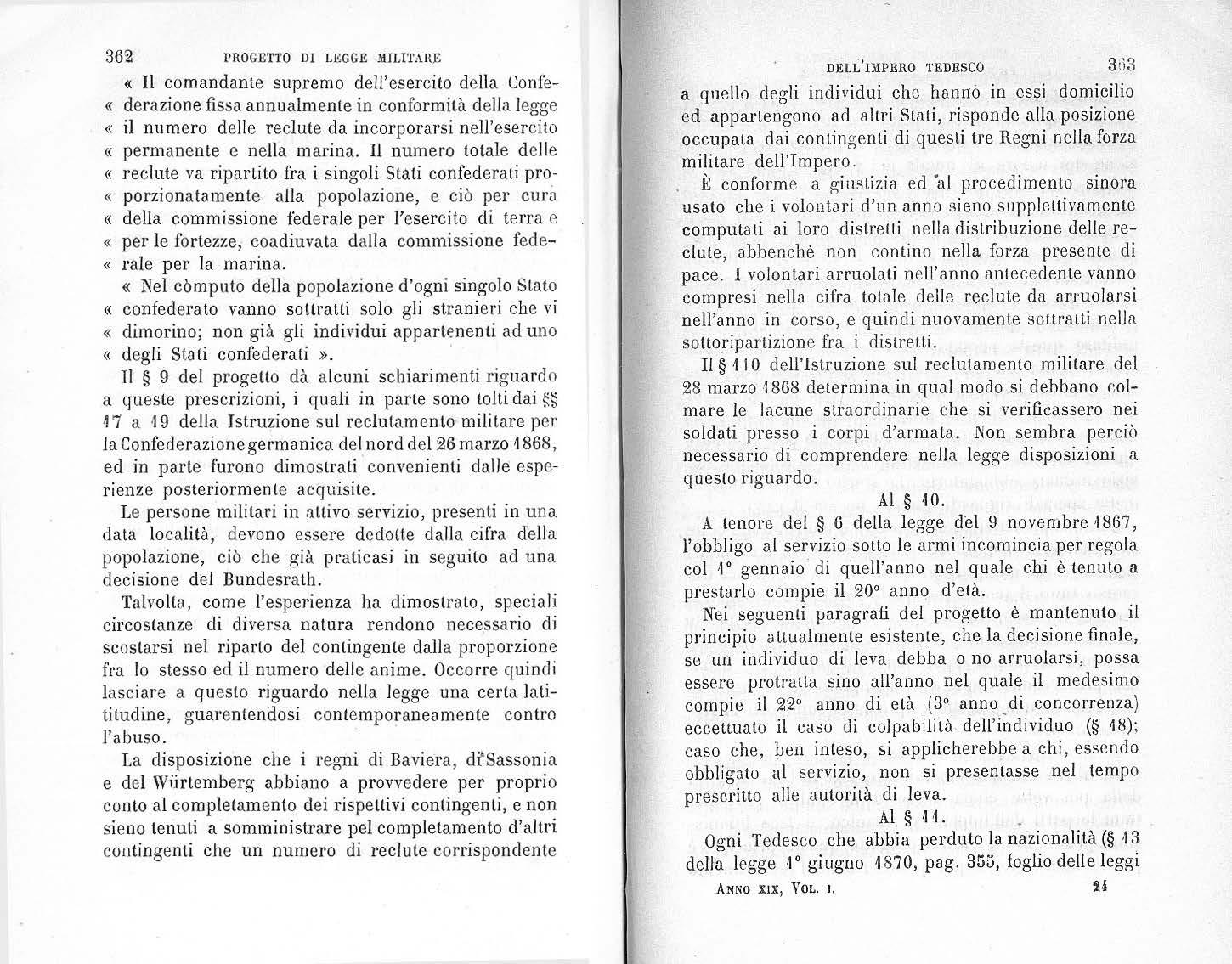
della Confederazione) non è obbligato a riaquistarla quànclo riprenda stabile domicilio nel territorio della Confederazione. - Ne consegne che, senza una prescrizione del tenore di quella del § ,t 1, ognuno che si troyi in tal caso potrebbe sollrarre sè e la propria discendenza all'obbli~o del servizio militare.
Nella maggfor parte degli Stati confederati sarebbe possibi le in simili casi d'intimare le sfratto; ina oltrechè questa mi'sura non è dappertutto legalmente ammissibile, questo procedere sembra essere per sè stesso più duro, che quello di sottoporre senz'altro al s ervizio militare queste persone ed i loro figli , quando non appartengano ad uno Stato straniero; con che, non solo è· tolta ~la cattiva impressione che la sottrazione aì comuni doveri deve produrre sulla massa di quell i che coscienz iosamente li soddisfano, ma si evita inoltre che altri possa eludere abusivamente la legge sul. servizio militare obbligatorio. Lo spirito del progetto· ammette speciali riguardi quando ne sia il caso.
L'ultima prescrizione del pnragrnfo tende ad impedire che individui i quali abb ia no perduto la nazionalità tedesca; e la riacquistino quando non sia anc;ora trascorso tutto il tempo µel quale sarebbero obbligati al servizio militare, obb iano a trovarsi rispetto a questo ùltimo in condizioni più fovorevolf che se non avessero ma i cessato d'appartenere all'Impero. - Senza tale prescrizione dopo aver cdmpiuto il 2:Z 0 anno di età, costoro non potrebbero più esser sottoposti a l servizio militare . ·
Al § ,12.
Là libera circolazione militare vige in base al § 17 della più volle citata legge 9 novembre ,f 867 per tutte le parti dell'Impero ge rmanico, e fece buonissima prova. Nel § 112 del progetto questo ·principio è perciò mantenuto, e per quanto rifleue il reclutamèhto
DELL'IMPERO TEDESCO 365
I9eglio definito; e 'benchè non esiga dalle autorità molto più lavoro, che il sistema tenuto in altri Stati dicostringere in qualsiasi caso i cittadini di leva a presentarsi al loro luogo di nascita, a quest'ultimo aggrnvio è però contrapposto il grande vantaggio che deriva ai cittadinì dalla libera circolaz ione rnilitare. Per sede cli domicilio (Wohnsitz ) nel senso del§ 11'2 debbesi intendere quel luogo in cui risiede il tt'ibunale ordinario dal quale dipençle l'individuo obbligato al servìzio.
Ai §§ 43 sino al 22 .
l quadri di pace dell'esercito non possono naturalmente impartire l'istruzione militare che ad un limitato numero d'inscriùi di leva.
Ne consegue che per solito un numero, sebbene proporzionatamente piccolo di individui idonei al ser~ vizio militare, ne resta esente in tempo di pace, colla clausola però cli chiama tu ul servizio in caso di guerra.
Trattasi ora di determ in are a quali individui debb'a essere accordata tale faci li taz ione nel!' adempimen to del loro obbligo al servizio militare.
Rispond e rebbe maggiormente agli interessi militari basare · in questo caso la decisione sul grado d'idoneità al servizio, in modo che le spese e le fatiche della istruzione militare in tempo di pace s1 impiegassero per la parte della popolazione più idonea alla guerra.
Per a ltro verso potrebbe anche sembrare più conveniente di dare, nella scelta degli indiviclu'i a rim·andar'si come soprannnmerarii , il maggior peso alla posizione civile ed alle circostanze di famiglia. '
Però, alla scelta secondo gli an:ùdeHi criterii o secondo uno di essi si contrappongono· importànti riflessicmi . La variabilità nel numero degl i inscritti di leva soprannumerarii nei vari distretti e nei singoli anni costringe re bbe ad adottare ffOn solo nei distretti viciniori', ma anche per le annate succes·sive iri· uno
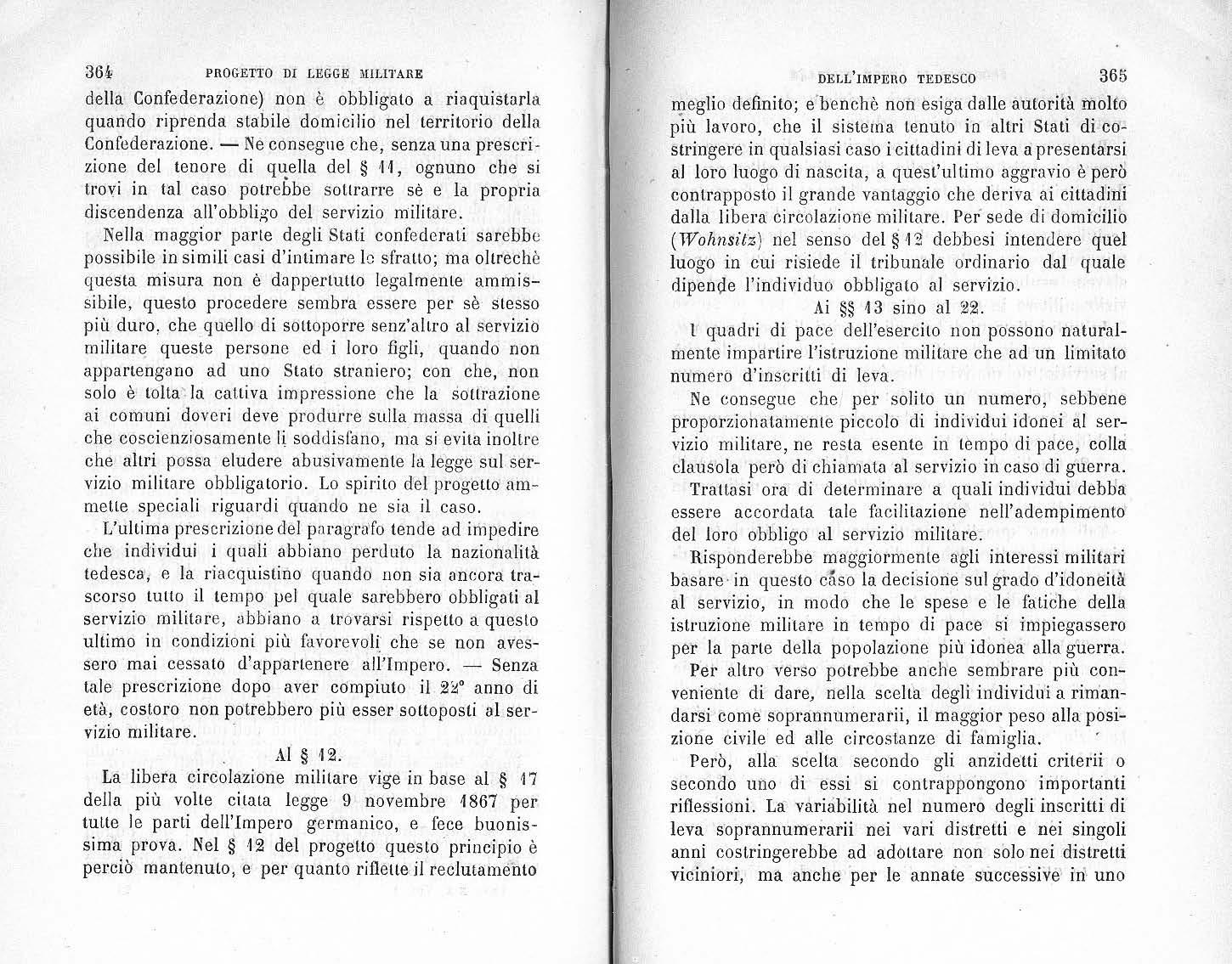
364 PROGETTO
DI LEGGE MILITARE
PROGETTO DI LEGGE MILITARE
stesso distretto misure tanto svariate da dare facilmenLe luogo a sospelli di a rbitrio .
Per questo_ ~ot_iv ~ s! è preferito di distinguere per legge le cond1Z1om cm h clie danno diritto all'esenzione dal servizio militare in tempo di pace, e di formulare del)e. norme ~r~cise per valulare l'altitudine degli inscrilll al serv 1z1 0, e, nel rimanente, di lasciar deterr~inare al caso ed alla sorte quali degli inscritti, quand o s'.a :7ene. ~suberanza, debbano essere dispensati dal serv1z10 m1l1tare in tempo di pace.
In tutti i distretti di leva g li inscritti di ciascun anno saranno p e r c iò class ificati rn ragione della. idoneità al servizio, dei motivi di dispénsa e del numero estrallo a. sorte, nel seguente modo :
1° Saranno sca rt a ti ·col oro che sono assolutamente inabili al servizio (§ 15).
2° Quelli che sono solo condizionatamente inabili al servizio saranno e sclusi dall'istruzione militare in tempo di pace (§ 16).
. Tali sono quegli inscritti che hanno difetti (com e ~1sta. corta, u~ito debole, dita storpiate ai piedi o mutilate alle mani) che non impediscono in modo assolut o di poterli util izzare in caso di bisogno, ma che non ne permetterebbero la perfetta istruzione mi lital'e .
3° Inscritti i quali al tempo della leva non abbiano peranco Io sviluppo fisico necessario o sieno affell i da. malattie di lunga durata(§ · 17), possono essere rimandati ad uno o due anni per po i essere sottomessi al servizio, se nel frattempo foss ero divenuti abili. Non sarebbe g iusto l'esentare tosto questi inscritti dal servizio militare, poiché essi mo lto spesso nel 2° 0 3° a.nno acyuistnno la. perfetta idoneità al servizio; in un tempo, cio è, nel quale i loro coetanei sviluppati prima, · sono ancora. al servizio auivo. · .
i-0 Gli inscritti i quali per riguardo a circostanze
DELL'IMPEIIO TEDESCO 367
'Civili sono da rimandarsi ed eventualmente dopo il 3° _anno da esonerarsi d al servizio militare in tempo di pace (§§ 19-22).
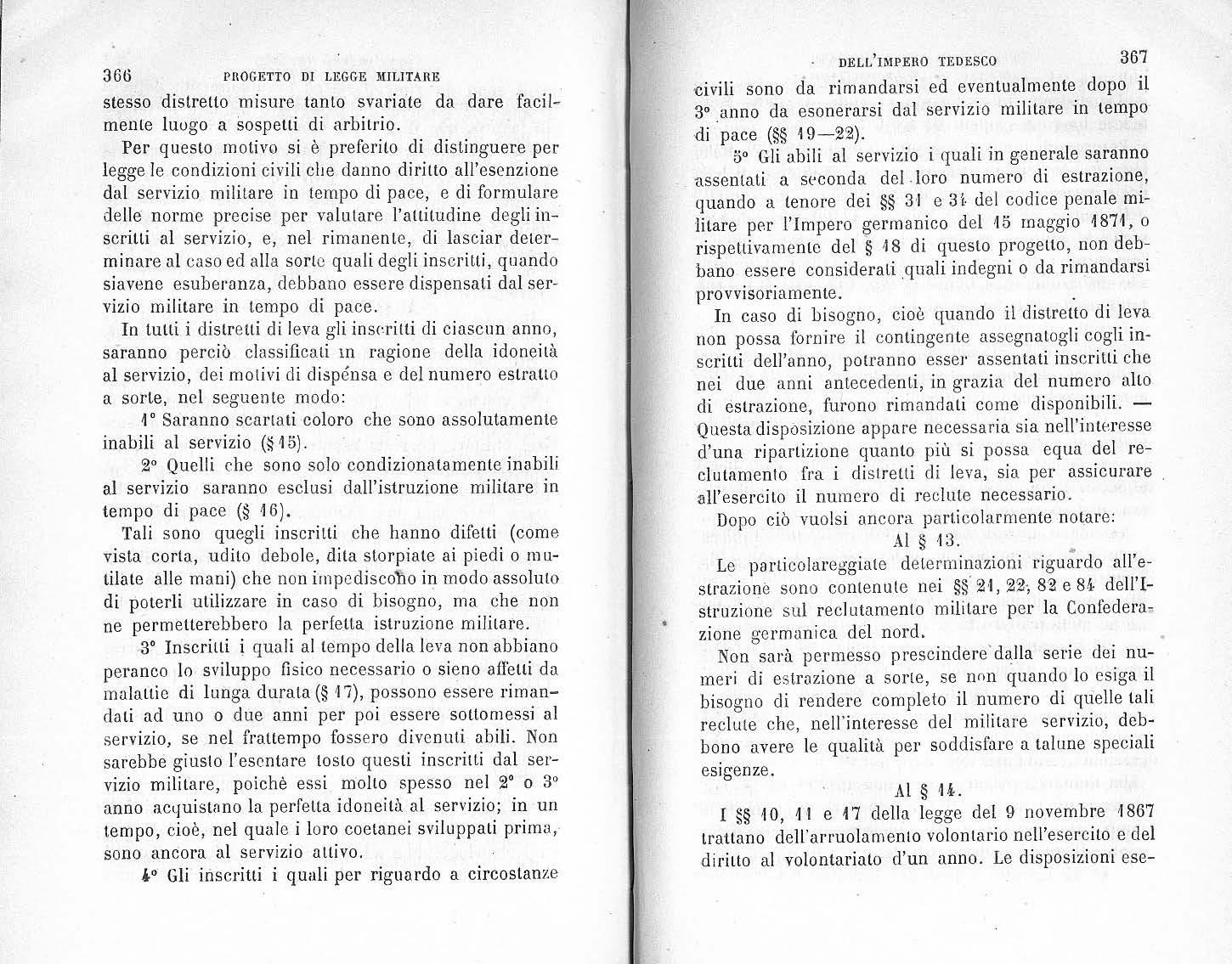
5° Gli ab i li al serv izio i quali i n generale saranno .. assentati a seconda del . loro numero di estrazione, quando a tenore dei §§ 3 ·1 e 3i, del codice penale militare per l'Impero germanico del '15 maggio 187 11, o rispeUi vamenle del § ,J 8 di questo progetto, non debbano essere considerati _quali indegni o da rimandarsi provvisoriamente.
In caso di bisogno, cioè quando il distreÙo di leva no~ ~ossa. fornire il con tingente assegnatogli cogli inscritti dell'anno, potranno esser assentati inscritti che nei due anni antecedenti, in grazia del numero alto di èstrazione, furono rimandat i come disponibili.Questa disposizione appare necessaria. s ia nell'interesse d'una ripartizione quanto più si possa. equa del reclutamento fra i distretti di leva, sia per assicurare -ali' esercito il numero di re cl ute necessario.
Do po ciò vuolsi ancora partico larme nte notare : Al § ·13.
Le particolareggiat e determinazioni rigu ; rdo all'estrazionè so n o contenute nei §§, 2 ·1, 22; s ·2 e 84' dell'Istruzi one sul recluta.mento mil ilare per la Confederazione germun ica del nord.
Non sarà permesso prescindere' dalla serie de i numeri di estrazione a sorte, se non quando lo esiga il bisogno di rendere completo il numero di qùelle tal i reclute che, nell ' interesse del mi. lita.re serv izio , debbono avere le qualità per soddisfare a ta lune speciali esigenze.
Al§ U..
I §§ •IO, H e 47 della. legge del 9 novembre 1867 trattano dell'arruolamento volontario nell'esercito e del dir ilto al volontariato d'un anno. Le disposizioni ese-
366
c uti ve a tal uopo s on o contenute nella IO" e i 3• parte dell'Istruzione sul reclutamento militare per la Confederazione germaniea del nord. - Di queste prescrizioni furono inserte nel progetto di legge soltanto quelle che per la loro natura riguardano l'obbligo di leva degli in::;critli autorizzati al volontariato d'un qnno. Il diritto dei volontari di entrare uel co rpo di loro scelta è naturalmente condizionato, e deve anche per l'avvenire, ne\l'interesse militare, rimanere sottopqsto alle restrizioni esposte nei §§ Hl9, 133,134,163 e 164 dell'Istruzione sul reclutamento militare.
Al § 18.
A tenore del § 34 del codic e peq.ale dell'IO')pero g~rmanico la perdita dei diritti civ ili porta con sè l'esc-lusione dall'esercito p er quel tempo che è determinato nella sentenza. Ora, se gl'inscritti di leva colpiti da pene infamanti dovess e ro, senza riguardo alla loro età, essere rimandati sino al tempo nel quale riacquiste. rebbero i diritti civili, per poi es sere assoggettati alla leva, ciò corrisponderebbe ad un aumento di pena.
Per tal~ considerazione il § 118 del progetto stabilisce un limite'"d' età anche per la leva di questa categoria d'iscritti .
• Dac chè riacquistano i diritti civili gli inscritti, dopo essere stati provvisoeiamente adibi~i ad una compa• g nia di layoratori, saranno transitali in un corpo di linea per ultimare il loro tempo di servizio.
· Ai §§ 19 sino al 22 . ·
Il contenuto di questi paragrMì è tolto dai §§ 42-44 dell'Istruzione ·sul reclutamento militare per I~ Confede razione germanica del nord.
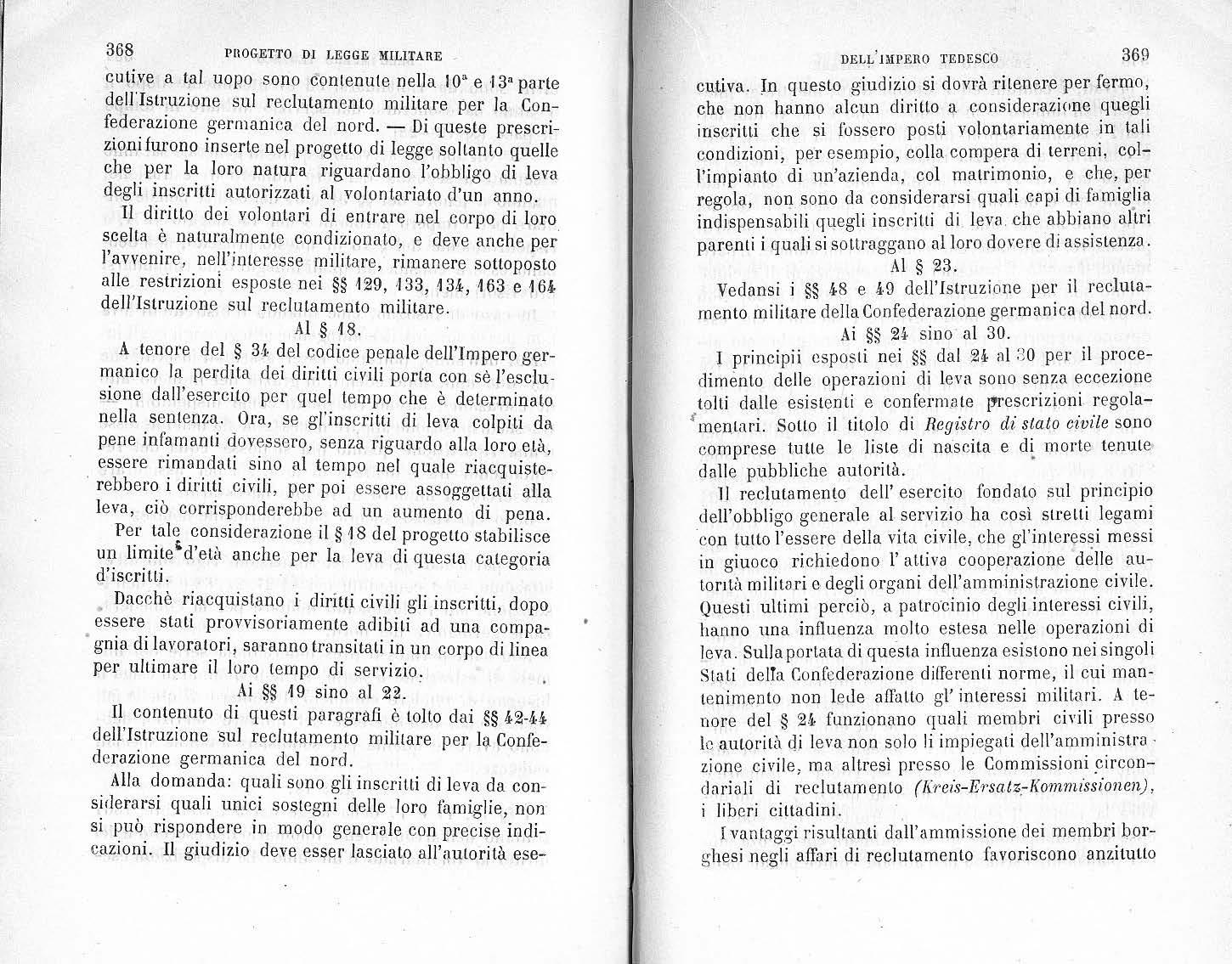
Alla domanda: quali sono gli inscritti di leva da considerarsi quali unici sos tegni delle loro famiglie, non si può rispondere in m.odo generale con precise indicazioni. Il giudizio deve esser lasciato all' !!,utorità ese-
DELL' IMPERO TEDESCO
cutiva. Jn questo giudizio si dovrà Tilenere per fermo'. eh~ non hanno ulcun diritto a considerazic1ne quegli inseritli che si foss ero posti volontariamente in tali co ndizioni, per esempio, colla compera di terreni, co ll'impianto di un'azienda, col matrimoni.o,. e. che,_ p~r regolu, noq sono da considerarsi quali eap1 eh. fam1g!1~ indispensabi li quegli in s critti di leva . che abbia_no altn parenti i quali si sottraggano al loro dovere d1 assistenza.
Al § 23.
Vedunsi i §§ 48 e ,i.9 del!' Istruzione per il reclutamen to militare de!Ia Confederazione germanica del nord.
Ai §§ 24- sino al 30 .
I princ1p11 espo s ti nei §§ dal 24- nl 30 per il pr?ceclimènto delle operazioni cli leva sono senza eccezione tolli dalle esistent i e confermate J1reserizioni regola, mentari . Sotlo il titolo di Registro d1: stato dvile sono comprese tulle le liste di nascita e di morte tenute dalle pubbliche autorità. . . .
]I r eclu tam ento dell' eserc ito fondato sul prmc1p10 dell'obbligo gen~rale al servizio ha cosi s tretti legam! con tutto l'ess e re della vita civile, che gl'interes~i mess1 in giuoco richiedono l'attiva coopera_zione_ delle _ ~utontù militari e degli organi dell' amministrazrnne_ c1_v1_l ~ .
Questi ultimi perciò, a pat.ro'cinio degli interessi_ c1:111J: hanno una influenza molto estesa nelle o-peraz10nt d1 leva. Sulla portata di que·sta influenza esistono nei singoli Stati del!a Confederazione differenti norme, il cui mantenimento non leJe affatto gl' interessi militn ri. A tenore del § 2.i, funzi on ano quali membri civili presso le autorità di leva non solo li impiegati de ll' ammin istrn · z.io ne civile, ma altresì presso le Commissioni _circondariali dì reclutamento (l( r eis -E rsatz.-Kornnu'ssfonen), i liberi cittadini.
J vant;:i.o·o-i risultanti dall'ammissione dei membri bor- b ·-=> ghesi .negli affari di reclutamento favoriscono anzitutto
368 PI\OGETTO DI LEGGE
MILITARE
36
9 . .
i privati, i comuni ed i singoli Stati ; mentre gl' intaressi dell'Impero co incid ono meo-lio colle vedute militari s oste nute sopratutto dalle :utori tà mi litari. Però è conforme a giustizia ripartire le spese di leva secondo tali criteri ed addeb itare alle casse dello Stato le .sole spese derivanti dalla partecipazione di autorità o persone militari alle ope razi oni di leva (§ 30 ); modo di procedere, d'altronde, che concorda coll'attua le. E parimente, il modo di procedere delle operazioni di re cluta . rr_iento non deve arrecare spese agl' inscri tti (§ 29). Non st possono ad og ni modo evita r e i sacrifici che essi devono sopportare per presenta rs i persona imen te all' e po ca s tabili ta (§ rn); ma an che in avven ire si avrà c ur a di diminuirli il più possibile colle prescrizioni regolamentari contenute nel§ H, capov ers i dal 2 al 5, e nel § i5 dell'Istruzione sul reclutamento mili ta re per la Confederazione germanica del nord de l 26 ma rzo 1868.
Or,co rre dnre particolare rilievo alla dispos izione pena i~ ad.oHata n el 3 ° alin ea de l § 27 Quantunque n ella leg islazione de ll'Im pero il di ritto di espatr io sia trattato conformemente ai principii lib era li , l'emiO't'azìone clandestina di persone sogg'3tte agli obb lighi mil itari ha d.a pa re ccl~ i anni ass unto tali proporzioni che, specia lmente m talune loc ali tà, mina cr, ia di preo·fodicare se riam ente l'interesse del comp le ta men to dell~ese rcit o, e, ad ogni modo, esercita cattiva influenza su i r estanti individu i s oggetti all'obb li go militare, in causa dell'aumento d'aggravio che loro ne deriva. Un sistem a ge ne r a lm ente diffuso di agenzie di emigra zione offre premurosamente i mezzi ed insegna la via per abbandonare segre tam ente il paese; l'obbli go mi litare è per tali agenti uno dei principali mezzi per promuove r e la vog li a di em igrare . Di fronte a tal e stato di cose è in dubbiamente g iusto du bitare che, senza motivi plausibili, esistano n ell' allual e codice penale de ll e
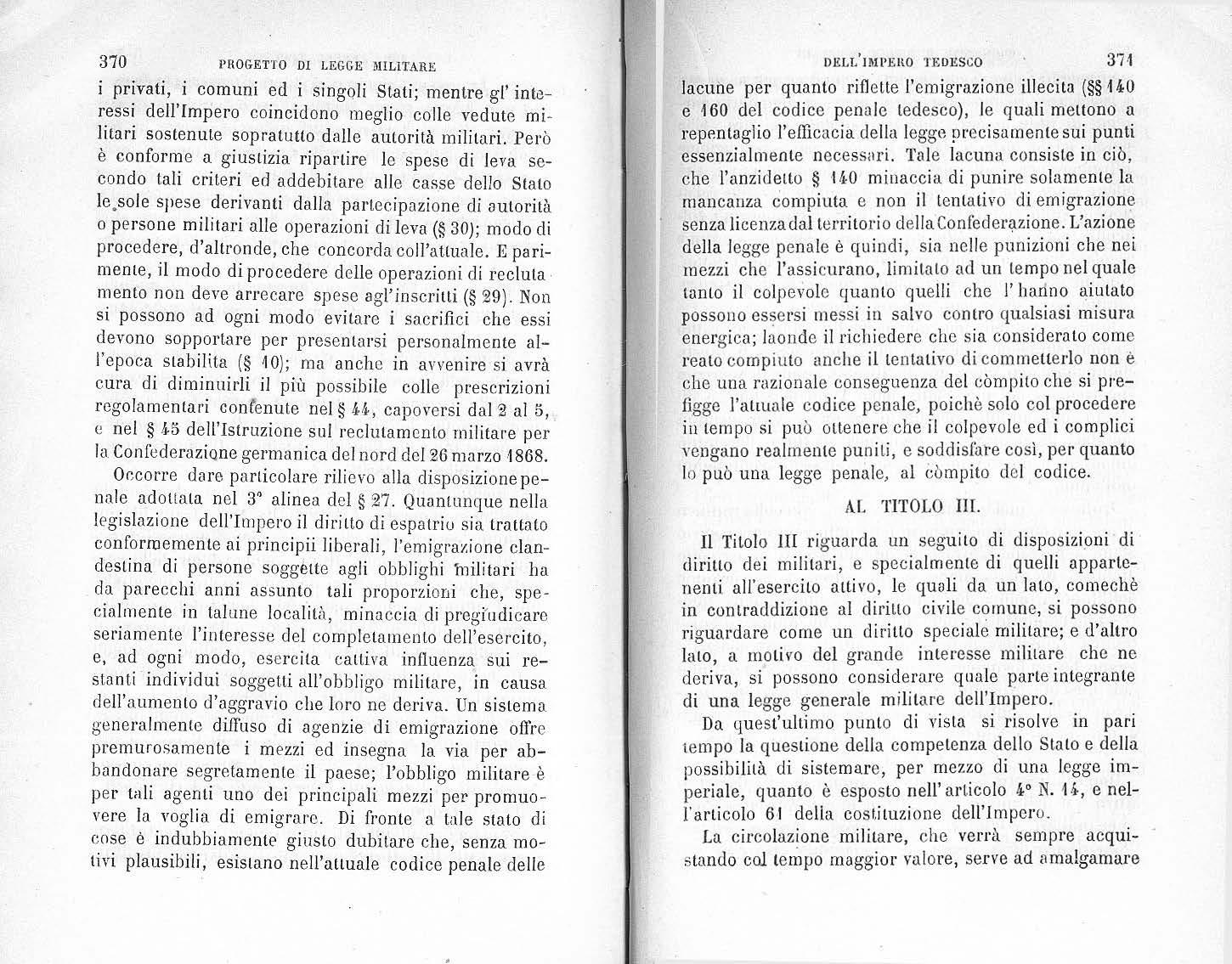
DELI.'!Ml'El\O TEDESCO 37-1
lacuòe per quanto rifl e tte l' em igraz ion e illecit a (§§ 140 e 1 60 del cod ice pen ale tedesco), le qua li melton o a r epimtagl io l'efficac ia della legge pr-ec is amentesu i punti essenzia lm ente necessari. Tale lacu na cons iste in ciò, che l'anzidetto § u_.o minaccia di punire solament e la mancanza compiuta e non il tentativo di em igrazione senza l icenza dal terri torio della Confeder<,tz ione. L'az ione della legge pena le è quindi , s ia nelle pun izioni che nei mezzi che l'assicurano, limitalo ad un tempo ne l quale tanto il colpe,;ole quan to quelli che l' harino B:iu lato possono essersi messi in salvo contro qualsiasi misura energica; lo.on de il richiedere ch e s ia considera to come reato compiuto anche il tentativo di commetterlo non è ch e una rnzionalc con seguenz a del còmpilo che si prefigge J'atiuale codice pe nale, poichè solo co l procedere in tempo si può oLtenere che il co lpevole ed i complici vengano r ealmente pu niti, e sodd isfare cos ì, pe r quanto lo può un a legge penale, al èòmp ito del codice.
AL TITOLO III.
Il Titolo lII ri gua rd a un seguit o di disposiz ioni di dirill o dei mi litari, e specialmente di quelli appartenenti all'eserci to at ti vo, le qua li da un lato , comechè in cont ra ddizione al cl irillo civile comune, si possono riguardare come un dtr illo specialè militare; e d'altro lato, a motivo del grande interesse militare che ne der iva, si possono consid ero.re qua le parL e integrante di una l egge generale militare dell'Impero.
Da qu es t'ulti mo punto di vis ta si risolve in pa ri tempo la ques ti one dell a competenza dello Stato e della poss ib ilit à di siste ma.re, per mezzo di una legge imperial e, quanto è esposto nell'ar tico lo 4- 0 .N . ·I .i., e nel!' articolo 6·1 della cos t,ituzi one dell'Impe r o.
La circolazione militare, c he verrà sempre acquis tando col te rnpo maggior va lore, ser ve ad Rma lgama re
370 PROGETTO DI LEGGE MIL ITARE
viemrneglio i singoli contingenti, e conduce per sè s tessa a ricerr.are, riconoscere e rinforzare gli elementi omog e nei in tutte le parti dell'ordiname nto militare . All o stesso scopo mira. il diritlo lascialo dalla costituzione all'imperatore di fissare la dislocazi one; dirillo i cui effetti sugli affa ri di ginrisdizione civile e sulle relazi oni e s ulle condizioni dei militari cagi one ranno difficpltà tanto mino ri quanto più tali rapporti sarannv regolati uniform e m ente in tutto il te rritorio dello Stat o. Finalmente va pure menzionala anche la circo s tanza caratteris tica delle c onv enzioni militari.
Il pas saggio della maggior parte dei contingenti sotto l'amministrazione prussiana ed il me scolarsi di questi contingenti con ele menti di diverso grado di servizi o appartenenti ad altri Stati della Conf'ederazione è di pregio indiscutibile , perchè in Lai guisa sarà vi e ppiù fac ilitala la costituzione omogenea di tullo l'es ercito imperial e e mantenuto vivo ne llo stesso il s entimento dell'unil~.
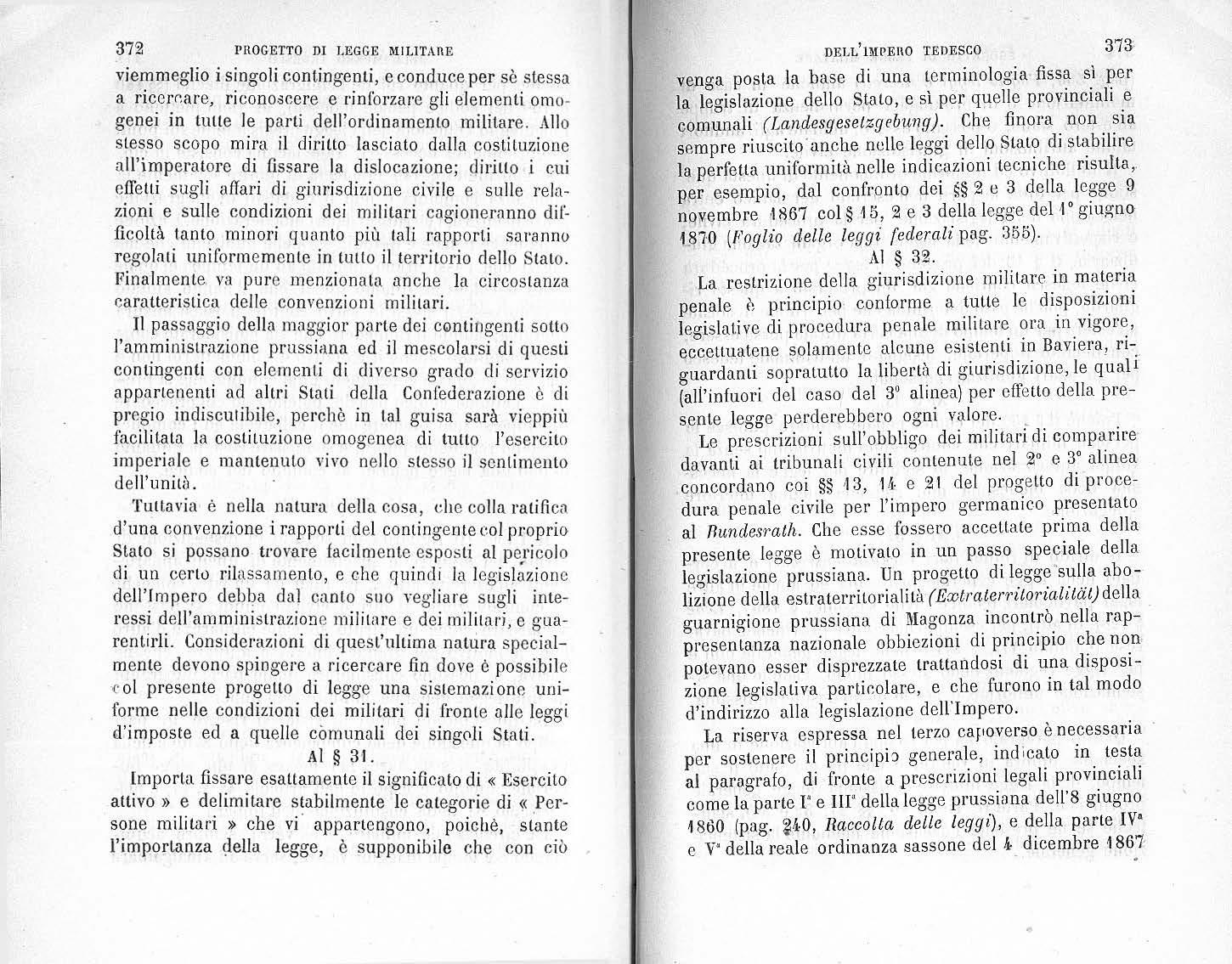
Tuttavi a è n ella natura della co sa , Glie coll a ratifica d'una convenzione i rapporti del contingente c:ol proprio Stato si possa no trovare facilm e nte es pos ti al pe ricol o dj un c erto ril assamento, e che quindi la legisJ;z ion c del!'! mp e ro debba dal canto su o veg liare s ugli interessi dell'amministrazion e m iliL nre e dei miliLari, e guarentirli. Considerazioni di quest'ult im a natura sp e cialmente devono spinge re a ricercare fin dove è possibile ,e ol pres ente progetto di legge una sistemazi onc uniforme nelle condizioni dei militari di front e alle leggi d'imposte ed a quelle còmunali dei sing0li Stati.
Al § 3 1.
Imporla fissare esattamente il significato di « Esercito attivo » e delimitare stabilmente le categorie di ~< Persone militari » che vi' apparleng<,rno, poiché, stante l'importanza ~ella legge, è supponibile che con c iò
DELL1 1Ul'EIIO TEDESCO 37~ ven(f.a posta la base di una terminologia fissa sì per la l~gislazioµe dello Stato, e sì per quelle provinciali _e coi;numlli (Lan.desgesetzgebimg) . Che finora non s1~ se~p r~ ~'iuscito ·anche ne lle leggi de llo ~tato di stabilire la perfetta uniformilà nelle indicaz ioni tecniche risulta,. p~r es~µipio, dal confronto dei s§ 2 e 3 della _1e!sge 9 nq~embre ·I S6'7 col§ 15, 2 e 3 della legge del ,1 grngno t8TO (Foglio delle leggi federali pag. :355).
, Al § 3.2.
La restrizion e della giu risdizione mi litare in materia pe~ale è principio • conforme a ~~tte le di~po~izioni }ecrislative di procedura penale nnlitare ora. rn vigore, ec~ettuatene sol[).mente alcune es is Lenti in Baviera 1 ri-. guarclanLi sop ratu tto la. libertà cli giurisd izion e, le quali (ali'infuori del caso del 3° alinea) per effetto della presente legge perdereQbero ogni valore . .
Le prescrizioni sull'obbligo dei militari di comparire· davanti ai tribunali civili contenute nel 2° e 3° alinea concordano coi §§ ,13, H.. e 21 del prog~~to di procedura p~nale civile per l'impero germanico presentato al flunde srath. Che esse fossero accettate prima della presente legge è motivato in un passo speciale della le()'islazione prussiana. Un progetto di legge ·sulla aboli~on e della estraterritoria\ iLà (Extraterrito1·ialitéit} della. . gu~rn igion e prussiana di Magonza incontrò nella rappresentanza nazionale obbiezioni di ~rin cipio c~e no,n· potevano esser disprezzale trauandos1 d1 u?a d1spos1zione legislativa partir.olare, e che furono rn tal modo d'indirizzo alla legislazione dell'Impero.
La. riserva espressa nel terzo cafioverso è necessaria pe~ sostenere il principb gener~le, ~od ica~o in . te_st~ al paragrafo, di fronte a prescnz1orn_legali P'.'ov,?ciah come la parte r e III" della legge prussrnna dell 8 gmgno 860 (pag, j.iO, Raccolta delle leggi), e della parte rva e v· della reale ordinanza sassone del ,i. . dicembre 1867·
372 I1 !lOGETTO DI LEG GE l\IIUTAUE
...
~ii.i, PUOGETTO Dl L E GGE Mll,l TARE (png. 560, Pogtio leggi e decreti) affinchè in caso di mob ifoazione o di prolungata permanenza di truppe all'estero siano, o poss a no essere, affidate ao-l i àuditori . o talune auribuzioni di giurisdizione civile.
ll definit ivo ed uniforme ordinamento di questa que stione per tulle le parti dell'esercito germanico entra nel campo della legisl az ione per la procedura civile , e rispettivamente della legge sulla organ izzazione giudiziaria. Il § '15 del progetto di legge -per la procedura ci vi le tedesca cont ien e giù un principio a questo rig1iardo, poichè esso determina che per truppe dislocate all'estero per uù tern po di una certa durata possa essere, con decreto . imperiale, designato un tribunale tedesco per gli a ffa ri giudiziari pers onali.
Al § 33.
Poichè il§ 150 c1·e1 codice penale militare· punisce le pers one miliwri che contraggono matrimonio senza la voluta autorizzazione, lo stabilire per lego-e la necessi tà della medesima non ri è hiede alcu~a ulteriore · spiegaz ion'e.
Al § 34.
Il diritto di rifiuto (das Esckusatimw·echt) è a ccordato ùe lla fogge gen e ral e prussiana ed anche in alt.re leggi particolari (codice civile sassone, § 189i, Codè § 42 8). In altri, per esempio ne l c odice provinciale bavarese (Capitolo VII, '.:H) e nella legge generale non è pe r legge l'figolato nello stesso modo. Laonde una sis temaz ione uniform e è per lo meno de s iderabiliss im a.
Al § 35.
Questo paragrafo ha per ìscop o l'abrogazione di una specialità tuttora in vig or e, e che ha già fatto il suo tempo, della legge militare pruss iana (le,we g · eneral e 00 p rovincial e, Parte II, TiLolo 10, §§ 27, 32 e 35), stantechè se ne presenta l'occasione mediante> la sis tema,.zione generale.
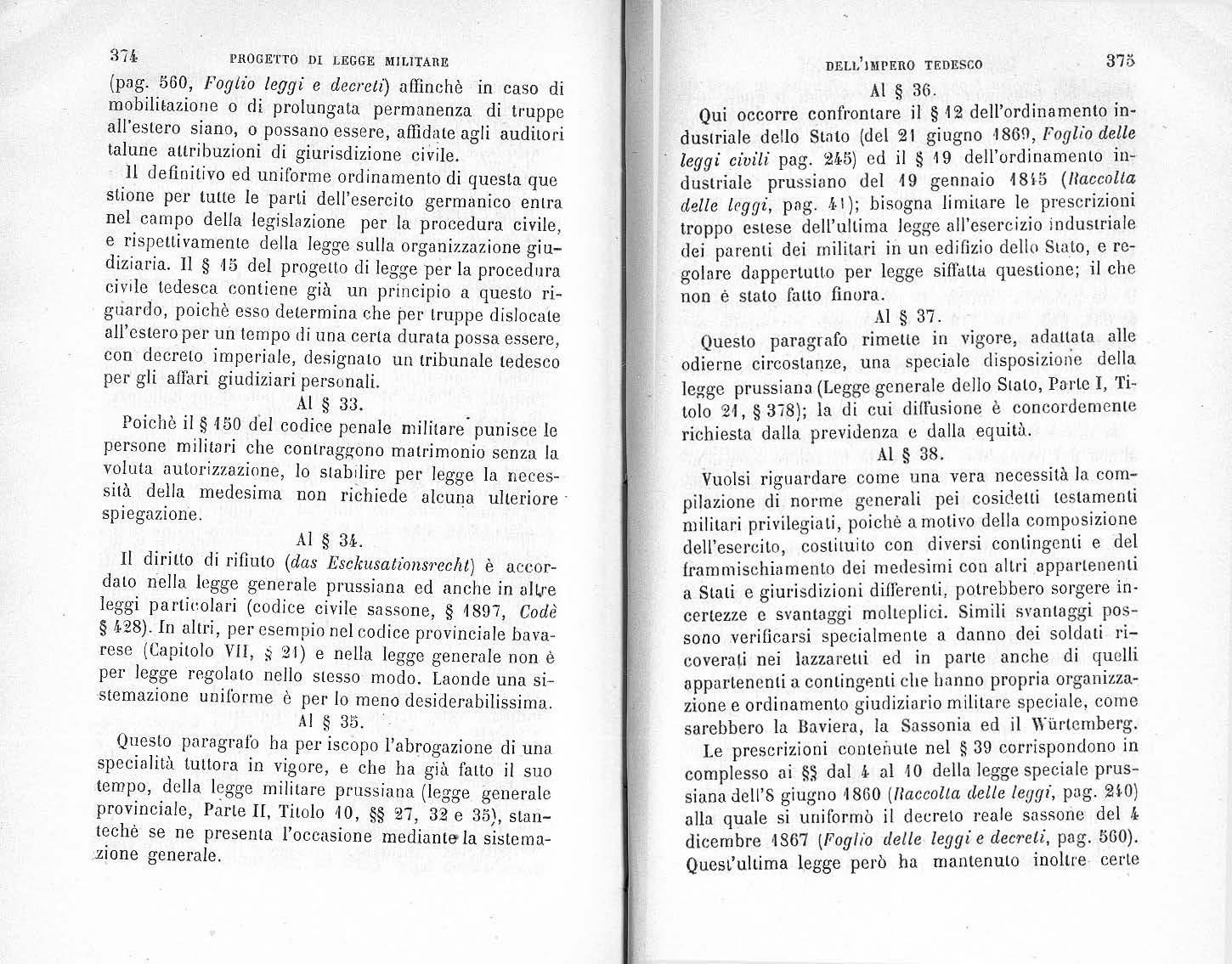
DELl.'JMPE RO TEDESCO 3'7 5
Al § 36.
Qui occorre confrontare il § '12 dell'ord inamen to industriale dello Slnto (del 21 giugno 186fl, Foglio delle leggi civili pag._ 245) e d il § 19 d~ ll'or di nt-!amen to industriale pru ssia no de l 19 gennaio 18k> (lla~c?lt~ delle leggi, pn g. 41 ); bisogna limitare le presc r1Z1_om troppo estese de ll'ulli ma legge a ll' ese r c izio i ndustriale dei par en ti d ei mi litari in un e difizio dello_Stato,_e r egolare dappertutto p er legge siffalla qu es tione; 11 ch e non è s ta to fa tto finora .
Al § 37 .
Questo para grafo rimelle in vigo:-e, ~d~ ll? la alle · odierne c irco staQze , una speciale d 1sposmo11 e della legge pru ssiana (Legge genera le d e llo Stato, Pa-rtc I, Titolo 2 1, § 318); la <li cui diffusione è concordemente ri ch iesta dalla previdenza e dalla equità.
Al § 38.
Vuolsi riguardare come un a vera ~e ce:sità la com~ pilazione di norme g~ nerali pe_i cos1de tu tcsta ~ ent1 mili tari privilegia ti , po 1chè a m?t1vo _d ella ~omp ~s 1z1 one dell' esercito, costituito con d,verst contingenti e de! frammisch inmento dei med esimi con altri apparLenent1 a Stati e giur isd izioni differe nti, potrebbero sorg~ re incerlezze e svantaggi moltep li ci. Simi li sv~ ntagg1 po~sono verificarsi specia lm ente a danno dei so ldati nco vera ti nei lazza reui ed in parte anche d i q u elli appartenenti a conting1rnti che banno propr ia organ izzazione e ordinamento g iudizi ar io rn ili tar e sp eciul e , come sa rebb e ro la Bav iera, la Sasso nia ed il Wiirtemberg.
Le prescrizioni con tenute nel § 39 conisp~ndono in com pl esso ai §~ dal 4 a l 40 della legge spe crn le prussiana de ll'S giugno 11860 (Il accolta (lelle leggi , pag . ~HO) alla qu a le si un ifor mò il decreto _reale sa:sone del 4 dicembre 4S67 (Foglio dell e leggi e decreti, pag . 560).
QuesL'ullima legge pe rò ha mantenuto inolt re - certe
-v Pl\OGETTO DI LEGGE MILITAHE
f~rme dei testamenti puramente verbali, le quali, nel1 mteresse della ma terial e s icm' ezza l'egale, non furono -comprese nella nuova legge prossiana, quii:nLunq'ùé' Io fossero nella antccede'ille.
Al § 39. ~e pre_scrfz~or~i legali particolari sulla procedura esecutl va gmd1!w ria a carico di persone rr1ili turi s1ono sul pun_Lo d1 essere rigorosamentè e generalmente si~tPm~Le merc'è' il riordinamento della pro·cedura civile, 11 cui progetto contiene le relative determinazioni nei
§~ 6i:>'I, 683, 7'18, 719 e 725. Q:iando un simile ord~n~me~to comune della procedura esecutiva giudi~ z1 ar1a _s1_a approvato, ne verrà com'e conseguenza ind1~cut1b 1le, che I~ re~trizioni iVi ammesse sie·no applic_ate an,che agli atti esecutrvi· ammin·istralivi. ..
_S1 dovr.J dare una speciale im portanza al second'o almea ?el paragrafo, laddove dà maggiore es tensio.ne al contenuto n el § 6 della légge suo-li imf)ieo-a.ti de · 11 S L,. o o o tato. mLeresse dell'amministrazione de!lé cass no~c?è l'i~ter~sse del servizio richiedono che hon sie~e~ v~hd1 t~t11 gli alti preventivi per la ritenuta dello st1pend10. .
Per I_e dispos~zio~i delle casse militari questù ih(-e:esse. s.L fa ~en~1r e_ 1_n. mo?o differente che presso I1:1 ammm1s_t~az1?m ClYlh, po1chè non vi hannò che poclie ~asse ~1htar1. co.stituite. L'amministrazione·delle casse presso l corpi d1 truppa è, il più delle volle, affidarla so~rattutto alle co~~issioni di cassa, Je quali, per 1ia 1010 ~tes_sa. co.mpos 1z10ne, non sono atte a risolvere I'e q~es~1?rn gm~1~1co-civiJi, che sarebbero p rèss6chè inev1ta~1~1 col. dm{to di disporre degli assegnament'i p'èl se rnuo {D1ens-teinkomrnen}.
Sembra quindi inclinato a giustizia raccom'andaire che, pe: le a~.mioistrazioni militari, sia man1e1ifofa l'aittuale d1spos1zwne legàle prussiana ( Append1'c·e, §· ,163
DEC,L'utl'ERO TEDES CO 377 dell'ordinamento generale g i udi:tian'o), quantunque per le amministrazioni civili qu esta proposta non sia stata approvata; che in parte, dal Reichstag. Al § 40.
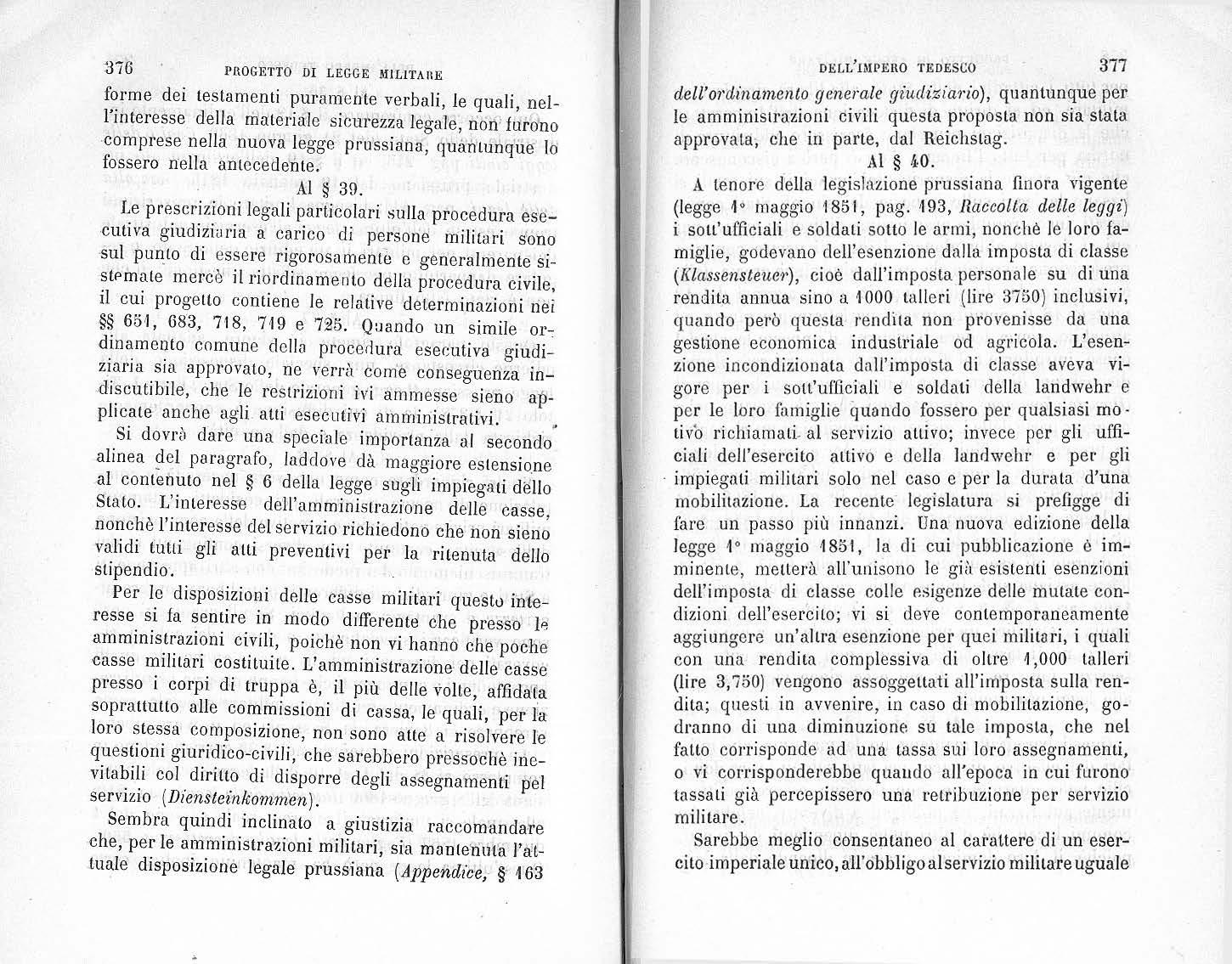
A ten ore della legislazione prussiana finora vigente (legge 1• maggio 1851, pag. 1193, Raccolta delle leggi ) i sott'uffièiali e soldati s otto le armi, nonché le loro famiglie, godevano dell'es enzione dalla imposta di classe (Kl assenste u e;·), cioè dall'imposta personale su di una rendita annua sino a ·1000 talleri (lire 3750 ) inclusivi, · q ua ndo però qu es ta re nd ila non prov enisse da una gestion e eco nornica industriale od agricola. L' esenzi one inco ndizi onata da ll'imposta di classe aveva vigore p er i sott'ufficiali e soldati della landwehr e p e r le loro fa miglie quando fossero pe r qualsiasi mo· ti vb richiamati. al servizio alli vo; invece per gli ufficiali dell'esercito attivo e della landwe hr e per gli
· impiegati militari solo nel caso e per la durata d'una mobilita zion e . La re cente legislatura si prefigge di fare un passo più innanzi. Una nuova edizione della legge 1° magg io 11801, Ja di cui pubblicazione è imminente, metterà all'unisono le già esistenti esenz ioni dell'imp osta di classe colle p,:;ige nze delle mutate condizioni de ll' esercito; vi si deve contemporaneamente aggiunge re un'altra esenzion e per qu ei militari, i quali con un a rendita complessiva di oltre 1,000 talleri (lire 3, 7 50 } ve ngono ass oggettati all'imposta sulla rendita; questi in avvenire, in caso d i mobi litazione, godranno di una diminuzione su tale imposta, che nel fatto corrisponde ad una tassa sui lorn assegnamenti, o vi corl'isp onderebbe quaudo all'epo ca in cui furono tassali già percepissero una retribuzione p er servizio militare.
Sarebbe meglio consentaneo al carattere di un esercito imperiale unico, all'òbbligo al servizio militare uguale
".)76
Ll!GGE ~HLl'rAnE per tutti i citladini dello Stato, alla lib era circolazione militare, ed al d1ritlo di dislocazione dell'Imperatore che le disposizioni prussiane servissero adcliriltura di norma per tutto l'Impero. Non è però a di sco noscere che ciò, stante la disparit.'I dei principii sui quali si basano le leggi sulle imposte dei singo li Stati confederati, in contre r ebbe grandi ss ime dilficolt~; motivo per cui si dov ette abbandonare l' ide u di uscire con un a prescrizi one assoluta da qu e lla situazione creata dalla legge sopra la duplice imposizi one d'aggravi del 13 maggio 11870. Sembra invece perfeuamente g iusto eù a tt uab il e, senza ledere il sistema d'imposte legale del paese, introdurre nel 2° capoverso del paragrafo alcune disposizioni di normo. per Je imp osizion i sugli stipendi (Diensteinkommen), disposizioni che g ià trovano n ella mnggior pnrle delle legislazi oni provin ciali un riscontr o in prescrizioni affini. (Si veda no per ese mpio la legge bavarese sulle impos te sulla rendita del 3 I maggio i ~56, arti colo 9; la, legge sassone del 1O marzo ·1868, § ,f.; la. legge wurtemberghese del 19 settembre 1852, § 3, al III. a; la legge bad ese de l 21 ott obre 4820, ed il decreto di esecuzione dell' 8 aprile 1857, § i?; la legge ass iana sulle im pos te sulla rendila del 21 giugn o 4869, art. 4-, N. 3, 4 e 5, ecc.}. L'ultimo capove rs o si limita a stabilire un principio generale circa più va ste esenzioni di tassa s u ll a rendita non proveni ente dnl servizio militare, la di cui esecuzione viene lasciata alle leggi provinciali.
Ai §§ 4•1 e 42.
Questi paragrafi mantengono la massima, ch e mil itari dell'efietti vo di pace, p el fauo solo di avere domicilio nella guarnigione, non possono essere politic amente autorizzati, nè obbligati a divenire me mbri dei co muni locali, 11è d'altri uffici dip e ndenti da questi, poiehè il loro domicilio precario dipende dalla loro
DEr.1.' !Ml'El\0 TEUESCO s ituazione di se rvì zio. In ,u·monia con tale disposizione essi non pnrlecipano nè attiva men te, nè passiva~ente
• al diritto di elezion e delle rnpprese ntan1.e comun~l,_, ecc: e Uelle ca1·iche comunali, esse ndoché questo ,dmllo d1 elezion e o si basa sulla appartenenza al comune., oppul'e questa dovrebbe esse1:ne immediata ~o.nse.gue n,za. ·1r al tra parte non v' ha ragLone, perchè m1.litar1 dell effe tti vo di pace sieno les i a priori a.nche m quelle Te~ lazioni verso i comuni, ecc., le qua li , secondo le leggi ciel paese, vanno per solito congilrnle al .po sse~ im ento di fondi stabili d' industrie, e che non d 1 rado in compenso d'aggravi speciali gocl?no speciali dir~t~i po ~itici: l: in teresse mil itar, : però esige ch e l' cserw·,_1 0 d~ ta li dìrilli richieda sempre una esplicila autori zzaz1one , perchè s i possono da r e facilme~te dei cas i nei quoli O']'in ter essi del servizio con tras tin o asso lutamente , coll'esercizio di tali diritti.
Non abbisogna di spec ial e motivazione il ter:zo ~;~po: verso del paragrafo, il quale dete:mi~a c)~e 1 m1h~o:1 i'n cono-eclò illimitato che fòsse ro 1ncl11arnall al serv1z1 0 au ivo, ~er In dura ta di tale p~sizio~e, abbiano ad e~~e1:e parifica ti a i militari dell'efiet11vo d1 pace. Questa m1,:,u1 a acquis terà una reale imp ortanza solo nel caso d una pi ·olungata mobilitazi o?e, la ~~H'. le , d'altronde, trascur a per se stessa le r elaz1orn c1vil1. . . . . . .·
Le prescrizioni del § 4~ sulle esen7:1001 d~1.m1ht~11, per quanto s i rifcri sco~o alle ~e rson e rn se rv1z1 0 atllvo.' sono intimamen te cd 10 special modo concat~n.ate alla posiz ion e di q~este rispe~to ai c~mu~i. I~ or1g1~e e~ s.~ non av evano \'1gore che m Prussia (v edus 1 p. e .. 01 di namento delle città del 30 maggio 485\ §§ 3 e 4 ; Ordina mento ci r condariale del ·13 dicembre ·I 8.'7~, §§ 6 e 9, legge del1' 114 lug lio 11822, § 1}; furono p~1, cq? d?creto de l ~'2 dicemb r e 118 68, estese a tu tto 11 tenr:1tor10 della ,Confederazione germa ni ca d el nord, e finalmen te AN)IO xix, Yot. ,. • · 11 'I l1Jc25 1
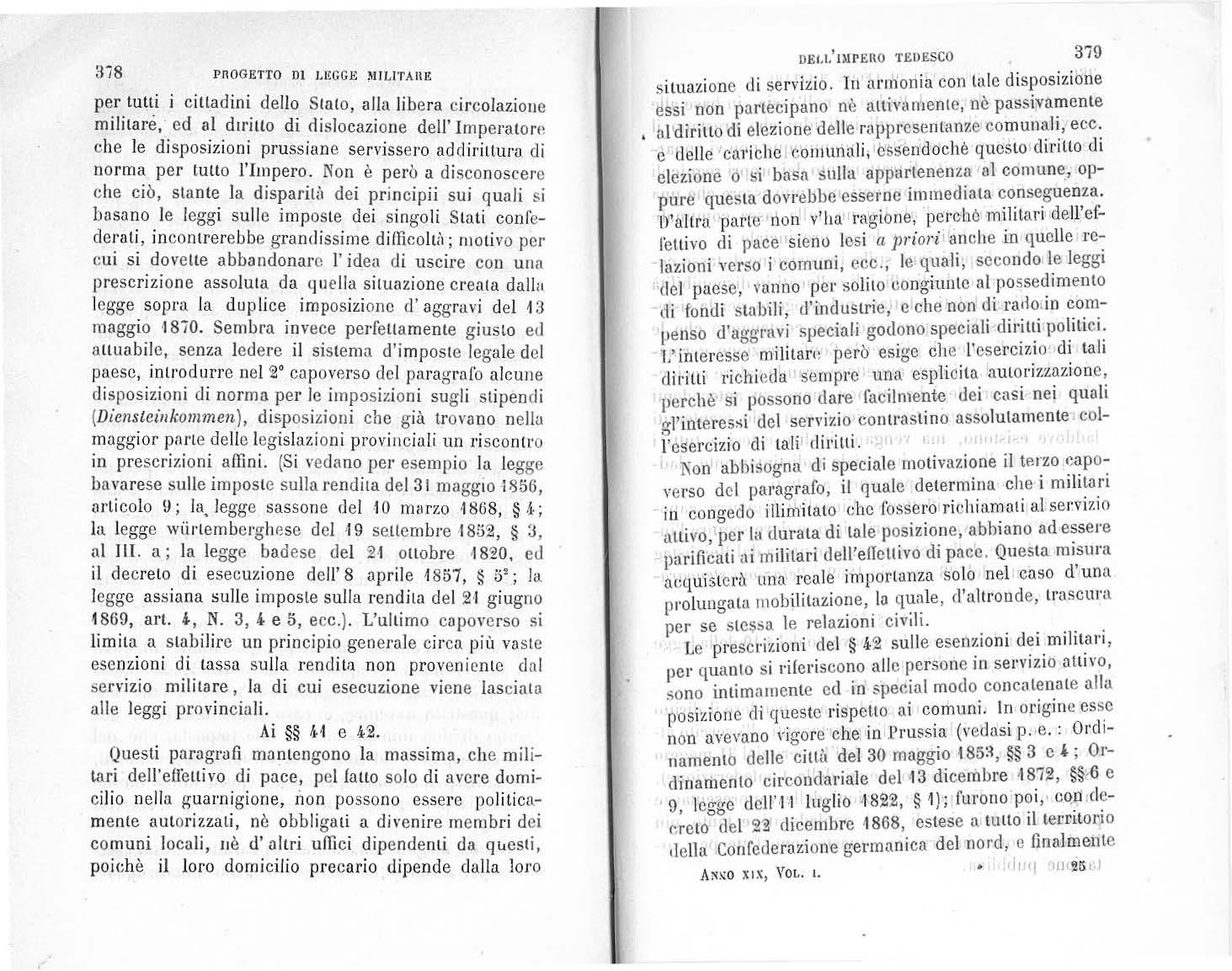
378 PRO GE TTO DI
3...,9
l'
I\OGE TTO OJ LEGGE MILITAR E
ha nn o pur valore nel Iladen e ne ll'AE'sia , in base a ll e convenzioni militari per gl i in div idui che prestano il se rvi zio militare in tali Stati, qu ant unqu e non vi appartengano . La di vers ità di trattamento de i p r op ri rerrni co li nei du e Stati ul timi nominati n on può essere che una ·ragion e di più per l'abo lizione della ta ssa comunal e pei militari, stabilita per legge prnvinciale .
Anche le disposizioni s ulla im posizione di tas se comunali a caric o degli uffic ia li collocati in d isponibilità e di. quelli giubil at i adottate n el proge tto per la sistemazione di siffatta questione, non contengo no ch e le n?rme legali vale:v oli già per la Confederazione germa01ca del nord. St deve anne ttere grande va lore ae ciocché ques ti privilegi basati n on meno su antecedenti sto ri ci che sulla g iustizi a, si eno non solo mantenuti laddo ve esiston o, ma vengano in oltre estesi a tutti i componenti l' eser ci to imperiale indis tint amente la ddove ess i non fu rono per anco adollati. '
La di s posizion e riflette nte gl' invalidi di gue l'ra (capove rs o 3°) è nuova com e principi o, e deve scrruire l'in•• t)
dmzzo da lole dalla determi nazi one presa da l Re ichstag nella seduta del 28 mn gg io "869 (U ela zioni stenografate, pag . i 139).
Al § 43.
Corr;( spo?de a l secondo capoverso del§ Hl della legge pe r gl 1rnp1egati dell 'lm pero .
Al§ 44.
Le ra g ioni ch e hanno g uidato a sospendere il diritto elctLorale pel Reichstag ag li appartenenti a ll' esercito attivo (§ 2 d ella legge elettorale dell'lmp ero del 34 maggio
1869, pagina 14 5, foglio Leggi della Confe derazion e), valgono eziandio per le elezioni de lle r appre sentanze provi nc iali dei s ingoli Stati confederati e tant o più là dove, come in Pruss ia, queste s ono fot te pe r votazione p ubbli oa. .
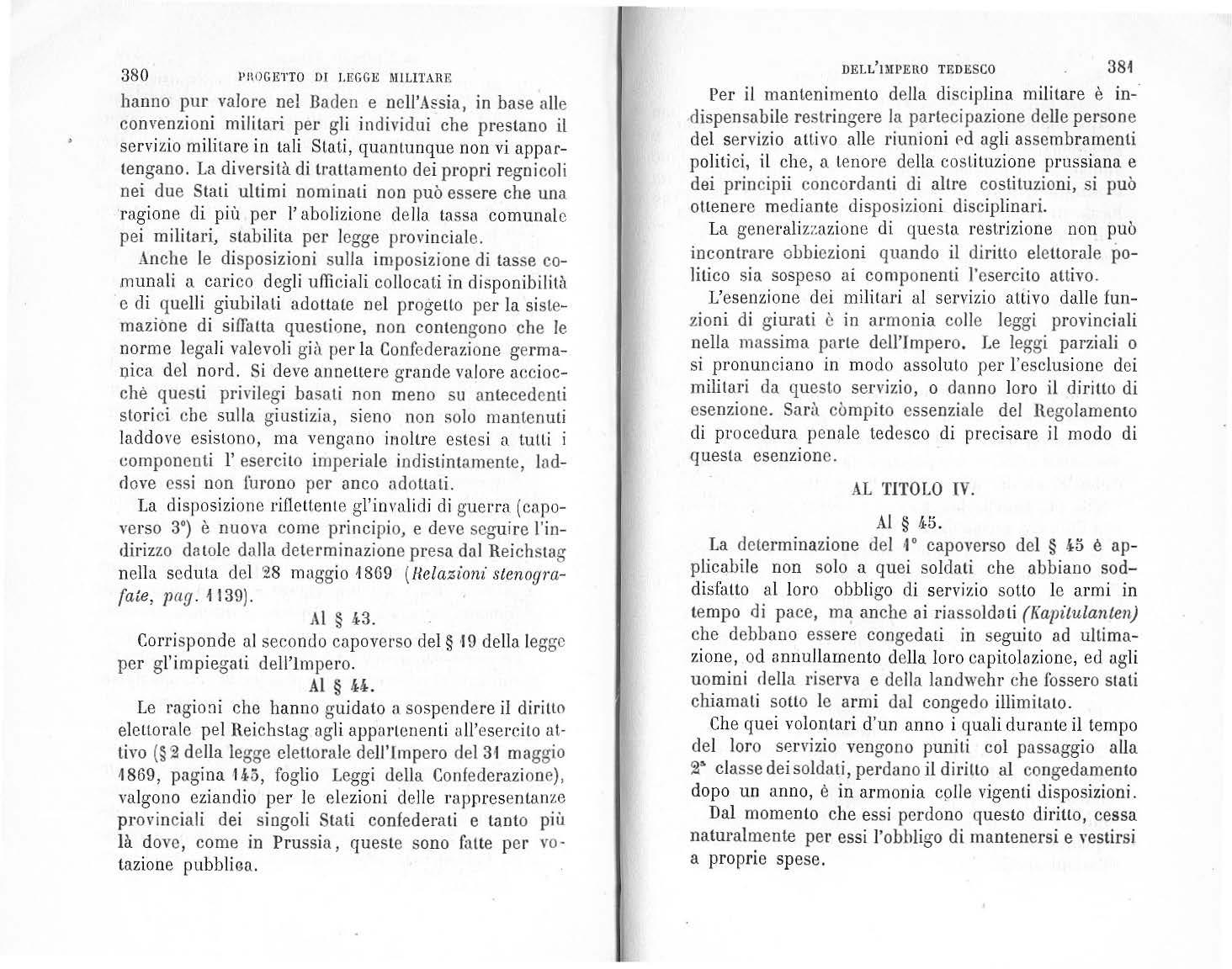
DEL L7 1llPERO TEDKSCO 38~
Per il ma ntenimento de lla di sc iplina militare e mdispensab ile restr ingere la par tecipazione delle persone del se rvizio attivo alle riunion i rd agl i as sem bramenti po liti ci, il ch e, a te nore de lla co stituzion e prus·siana e dei principii conco rd an ti di altre costituzio ni, si può ottenere mediante dispo s izioni disciplinari.
la generali zzazione di questa restrizione non può incontrare obb iezion i quando il diritto elettoral e poli ti co s ia sospe so ai componenti l'ese r ci to attivo.
L'esenz ion e dei m ilitari al servizio attivo dalle funzio ni di g iurati è in armonia colle leggi provinciali nella massima parte dell'Impero. Le leggi parziali o si pronunciano in mo do ass olu to per l'esclusione dei militari da questo servizio, o dan no loro il di ri tto di ese nzione . Sarà còmpito essenziale del ll ego lamemo di procedura penale ted es co di precisare il modo di questa ese nzion e. ·
AL TITO LO IV.
Al § 45.
La determin a zio ne del 1° capoverso del § 4-5 é applicabile non so lo a quei s olda ti c he abb ia no soddisfatto a l loro obb li go di servi zio sotto le armi in tempo di pace, ma anche ai ri assoldDt i (Kapitulanten) che debbano essere congedati in seguito ad ultimazione, od nnnullarnen to della lorn ca pitolazione, ed ao- li uomini dell a riserva e de ll a landwehr che fossero s1:ti chiam a ti so llo le armi dal congedo illi mi ta to.
Che quei volo ntari d'un anno i qua li durante il tempo de l loro SP,rvizio vengono puniLi col passaggio a lla 2" classe dei soldati, perdano il dirillo al co ngedame nto dopo un anno, é in arm on ia cplle vigenti Jisposizioni.
Dal momen to c he ess i perdono ques to di ritto, cessa naturalmente per essi l'obbl igo di mantenersi e vestirsi a proprie spese.
380
Ai§§ 47 e 48.
Il' cdngedamento cli soldati ·dal serviziò ( attivo non p'uò esser ' ordi'nalo che dalle autor iLà ·militari. · Ciò è ' affidato ai com'andanti generali, i quali naturalmente 1basano le proprie disposizioni sul parere dell'autor itù locale di ·rèclutarriento (Vedasi §§' 50 e 1186 sino al ·188 ·dell' Istruzione' sul recltttarnento mi'Htare per ·la Con-. federazione gerinànica del nord).
· Al § 50. Vedasi il § 51 della· anzidetta Jstnizione .
· AL Tl'fOLO V.
. Le disposi-zioni. -intorno ·alle relazioni di serviz io degli uòmini in congedo illimitato sono già comprese-nella 'legge riguardante· l'obb ligo al se rvizio militare del 9 novembre 1867, e più specialmente nei §§ dal 5 ·all'8, e dal H al 18. Nei singoli -casi sono inoltre applicabili i§§ 6, 42, 68, 69, H3 e 126 del codice penale militare per l'Impero germanico .
'' te ' p resc rizioni ·introdotte nella·'i)arte V del progetto -·es1s lev·ano finora s otto forma regolamentare, e sono ' ricavate in gran parte dall' ord inanza prussiana del 5 settembre· 1"867 riguardante ·J'organ izzùzione delle autor ità di landwehr, e le relazioni di ·servizio degli1 uom ini in congedo illi mitatò . Questa ·ordinanza è in vigore ·per tuLto il territorio della 1 Confederazione, ed analoghe dispos izioni vennero altresì emanate per l r1. Bavie ra, la Sassonia ed il Wurtemberg .
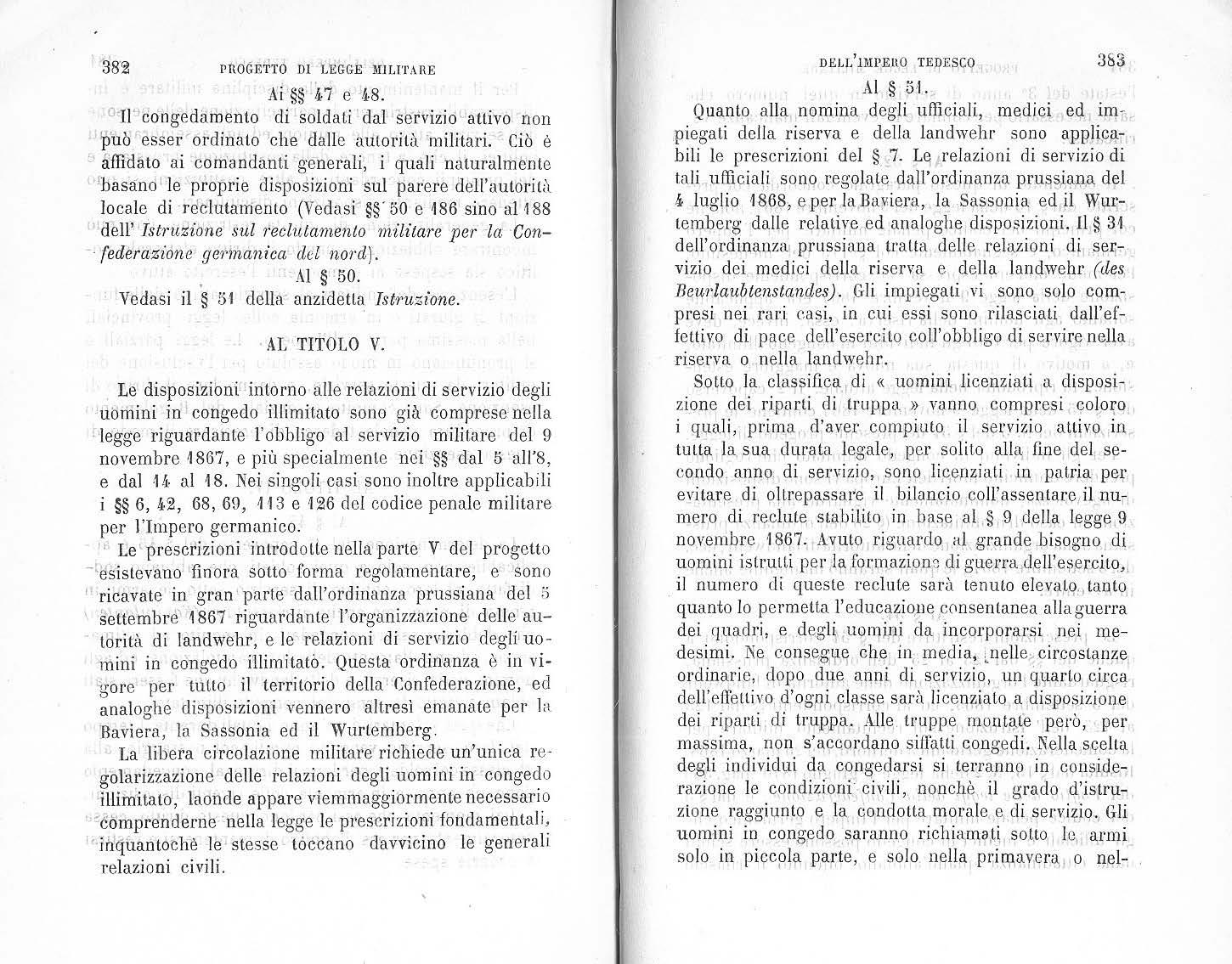
La libera circolazione rnilitare richiede un' u n ica regol'arizzazione delle relazioni tlegli uom ini- in congedo
laonde appare viemrnaggiormente necessario /còmprenderne :nella legge le prescr izioni fondamentali, i '·inquan to chè le ·stesse - t6écano a·avvicino le generali relazioni civili.
DELL'lMPEJtO TEf}ESCQ 383
Al § tH.
Quanto alla nomina deu-li ufficiali medici ed im...,, I i piegali de lla riserva e de lla landwehr s ono app,liPéJ.:- , bil i le prescr izion i del § 7. Le re lazioni di servizio di tali ufficiali sono reg9late dall'ord ip;:i,nza pruq?fai;t,a del i lugljp 18,6~, e per. la Bav. ier4, . la Sassopia ed)l Wurten'l,~erg dalle relative ,ed analoghe disposizioni. Il§ 3,t dell' ordin anza· pr uss iana ~ratta delle (·elazioni d i ser.vizio dei m.edic i ,della risen;a e cle.ll{l lanq.weµt (d~s, Beurlaubtenstan(/,es). Gl i impiegati ,vi sono solo compresi nei rari casi, in cui essi sono r ilasciati dall'effett~v,o di pace d1?ll'qercito coll' obbl igo di servire nella riserva o nella 1lç1.ndw~hr.
Sotto la classifica rdi « uomini licenziati a disposi~ione ?ei ~ipar,tiì di trup,pa » vanno, compres i coLo~q 1 q~1al1, pr.,ma d'aver .compiuto il seryizi.o aHivo, in tUL~a I la sua durata legale, p~r solito alla fine del1 seco~1do an?o d i serviz.ip,. so~9 )i~(;)P~ iati i.n patria ,per 1 ev1t~re . d11 ol lrep?-,ssare 1! b)lapç10 co]l'assen tare , il numero di reclute sta:bi\ito in b rlse , al ,§ , 9 d,eUa Ieggf:) 9 nov.embrc ·18f.?7. Avuto riguardo. al gr.1nqe .bisogno , di ~10,mini islrnlti per la ,f9nnazioç. c <;li g~1erra 1d~ ll'.e$ercitq, 1 . 11 numero di queste reclute sarà tenuto eleva,tq.1 tanto quanto Io permetta l'educazio.ue c(msentanea allaguerra dei . CJ\Wd~;i, e degl i uorryiJJi di in?o1:porars i ,ne i m~des1.m1 . . Ne conseg,t;t.~ cr.e ,rn, !1)e,d1a, ~~~lle , circosl~pze ordmane, dopo 1dn ~ armi. di seryiziq, 4p èp;1.arlo circa dell'effettivo , d'ogp:i. ,c.la pS(3 sarà licenz,i,ato a di.sposjzj one de i r!parli di trup9a. , .,µ.le . truppe mo9ti),(e però, per massima, no~ s'acco1:~i;i.p.o siffatti cong~di . Nell1,1. sc~lta degli inùividui dp. congedarsi si t~rranno ,in consj,J,e~ razione le condizionf civili, nopcJ+f . il grado d'.istruzione raggi,1;q1to e la c: ondotta mora\e,.e .cli sen;i~iq.., Gl i uomini io cong~do saranno ri chi a,r\\a,ti so.t,to I I0i armi solo in piccpla parte, e s olo nella prin;iaycra, o I).e!-
38'2
PRdGETTO DI LEGGE MlUTARE
·
·ìlliÌriitatd,
PROGETTO DI LEGGE MlLlTARE
l'estate del 3° anno di servizio in quel numero che· sarà necessario per colma1:e le eventuali mancanze ve · rificatesi.
Al § 52.
Il contenuto di questo paragrafo concorda col prescritto dal§ 115 della legge del 9 novembre 18 67, nonchè coi principii del codice penale militare per l'impero german ico, e segnatamente col § 1143 del medesimo. Pel modo ond'era espre ss a la corr:isp ondente .Jisposizion e della legge 9 novembre 1867 era app li cab ile soltanto agli uomini della riserva; essa, invece, deve aver vigore per tutti gli individui in congedo illimitato, e, a motivo di que s ta sua nuova e maggiore estensione, fu riprodotta ne lla legge attuale. Il 2° capoverso del § 15 della legge 9 no vembre 1867 contiene le prescrizioni del N. 5 del § 5.f. del presente progetto di legge.
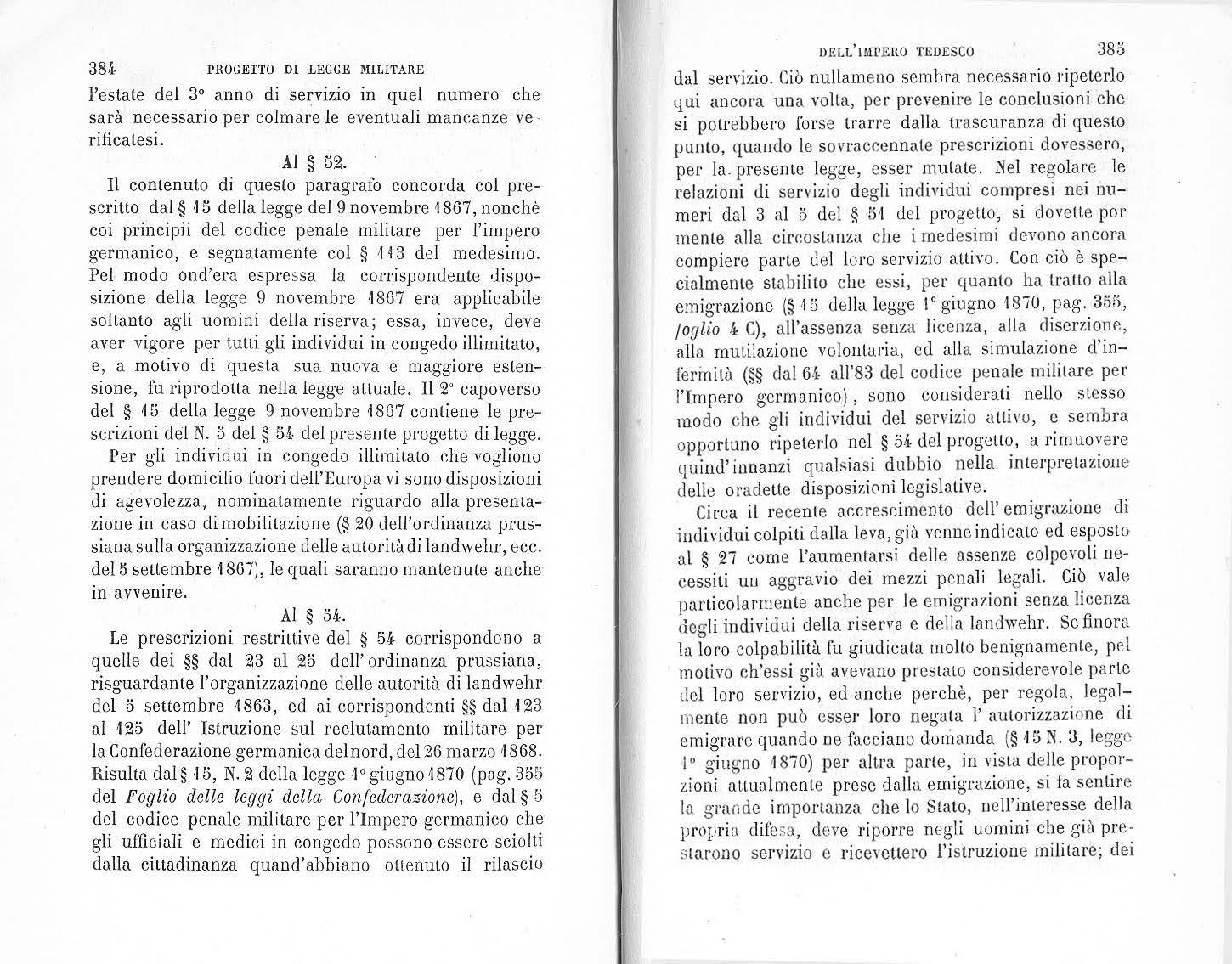
Per gli individ ui iD eongedo illimitato che vogli ono prendere domicilio fuori dell'Europa vi sono disposizioni di agevolezza, nominatamente riguardo alla presentazione in caso di mobi litazione (§ 20 dell'ordinanza prussiana sulla organizzazione delle autorità di Iandwehr, ecc. del 5 settembre ,1867), le quali saranno mantenute anche in avvenire.
Al § 54.
Le prescrizioni restrittive del § 54 c.orrispondono a quelle dei §§ dal 23 al 25 dell'ordinanza prussiana, rìsguardanle l'organizzazione delle autorità di landwehr del 5 settembre 1863, ed ai co rrispond enti §§ dal •I23 al •125 dell' Istruzione sul reclutamento mìlitare per la Confederazione germanica del nord, del '.26 mar zo 11868. Risulta dal§ '15, N. 2 della legge 4° giugno 4870 (pag . 315 5 del Foglio delle le.c;gi della Confederazione), e dal§ 5 del codice penale mil itare per l'Impero gcrmanìco che gli ufficiali e medici in congedo poss ono ess e re sciol_ti dalla cittadinanza quand'abbiano ouenulo il rilascio
Uf.LL'IMPE I\O TE DESCO 38:S dal servizio . Ciò nullam en o sembra necess ario ripet erlo qui ancora una volla, pe r prevenire le conclusioni che si potrebbero forse trarr e dalla tr ascura nza di que s to pun to, qu an do le sovraccennale pres crizioni dovesse r o, per la preseme legge , ess er mutate . Nel re ~ola1:e le re laz ioni di serv izi o deg li in div id ui comp resi nm numeri dal 3 al 5 del § 5•1 del progetto, si dovette por men te alla circostanza che i medesimi devono ancora compiere parte del loro servizio allivo. Con ciò è s pecialmente stabì lito che ess i, per quanto ha tralto alla emigrazione (§ rn de lla legge ,1° giugno 1870, _pag. _355, foglio 4 C), all'assenza senza licenza, . alla ~1scr z1 ~~e , alla mutilazi one volontaria, cd alla s11nulaz1one cl rnfe rrnit à (§§ dal 6:i- al l'83 de l cod ic~ pen ~le mi lit ar e pe r l'Im pero germ ani co } , so no co n~1?erat~ nello stesso modo che o·li in div id ui del servlZLO attivo, e sembra o . opportuno ripeterlo nel § 54 del progetl~, a r1muo :er e qu ind' innanzi qu als ias i d ubb io ~ella rn ter pre ta zwne de lle orade tle disp osizi0ni leg islative . . . .
Circa il r ece nte accresc imen to dell' e m1 graz.10 ne dt ind ividui colpiti dalla leva , già venne indicato ed es~osto al § 21 com e l'au men ta rsi de lle ass enze c?lpe".oh necess iti un aggravio dei mezzi pen ali le?ah. C1~ vale pa rticola rm en te anch e pe r le e migraz iom senza li cenza derr li individ ui della riserva e dell a landwehr. Se finora la loro co lp abilità fu giudicala molt o benignam ente, pel mo tivo ch' ess i già avevano pr es tato con sidere vole par te tlcl loro seL'v izio, ed anche pe rch è , per re go la, legai~ me n te non può esser loro negata l' autor izzazi one dL emigrare quando ne fac cian o dom ~nda_ (§ '15 N. 3, legge 1° o·i twno 1870) per altra parte, m vista delle propor- o o f . zioni allual mente prese dall a emigrazi one , s1 a sen Lire la oTa ndc import anza che lo Stato, nell'interesse della pro~iria dife sa, deve riporr e n egli uom ini gii'l pre: s1arono ser vizi o e ricevette ro l'i s truzion e militare; det
384
t : , , PJ!Q,C~IT O pi 1 LEf:GE mp'l'AllE
q.ual i appunto qui si traua. Sotto qtJest~ rappo~(o sembra gm~ to provvedere a ciò che ·1e disposizioni le quali ass1cur.ano J;assegnamento ,pel!' amministraz ion e militare sugli uomini in con gedo illimitato, di fronte all'em igrazione clandestina, siano per lo meno circondate du'lle s~e~se gua1·cnLigie penali che le dispqsizioni ,riilettent1 11 reclutamento. E s iccom e il rigu.:irdare com e contravvenzioni queste emigrazioni illegali d'uomini che hanno ?ià se!·vito, come ,s'è, fotto finora,, nop ha P.ro dolto efict.to d1 _sorta, al N. 2 di questo paragrafo s i propone d1 applicare all'emigrazione colpevole di individui obbligati al servizio le anzide tte leg n·i penali rn, 14.0 del codice penale mi litate, amp liato § 27 d1 ques ta legge) . ~o n incontrerà certamente difficoltù nlcuna ~he anche i riservisti di complemento rli prima c!asse. s ,e~? compresi in qu~sta di~posizione penale, c1ò eh è g1.t stato ammesso da alcuni tribunali io base alla legislazione attuale; ad ogni modo sembra convenien te cl1e, a , r~muoverç qua lsiasi d~bbio, ciò sia nettamen te specificato nella legge.
Al § 65.
L'epoca, , a datur ,daila qual~ ~evesi computare la durata del serviz io attivq, è determinata al § 6, 3° caP? ' 'e rso.,. della legge 9 novemb re 18 07 . Laonde il temp o d1 servJz10 data ~a l 1° ottobre per tutti, nd eccezion e del piccolo numero d'individui mcor~~rati fra il 4° aprile ?d il 30 .settembr e. A tenore del § 45 della più volte c.,tata ordrn.:inza del 5 se ttcm b 1·e 1867, le autunnalt riUJlÌ?nj di CO ntr:oilo , h~JlQO lllOgO fr a 'il fO Ottob re ed Il Hi nove mbre d'ogni anno, e sono la base pe r la compiJazione delle, liste e pei lavori preliminnri fi i mobi(it{l.zione per l'anno sussegue nte. Gli uomini della !andwehr presentemente non saranno più convoca ti-per le r~pnioni di controllo pri maYerili, ma devono però sempre p resenta rsi a que lle autunnal i fino al de-
DF. l, L01Ml'ERO TEDESCO 387 finitivo loro congedo dalla Jandwehr quand'abbian o co mpiuto il loro servizio militare . Dell'ouenulo congedo vi.en . loro rilasciato documento . I
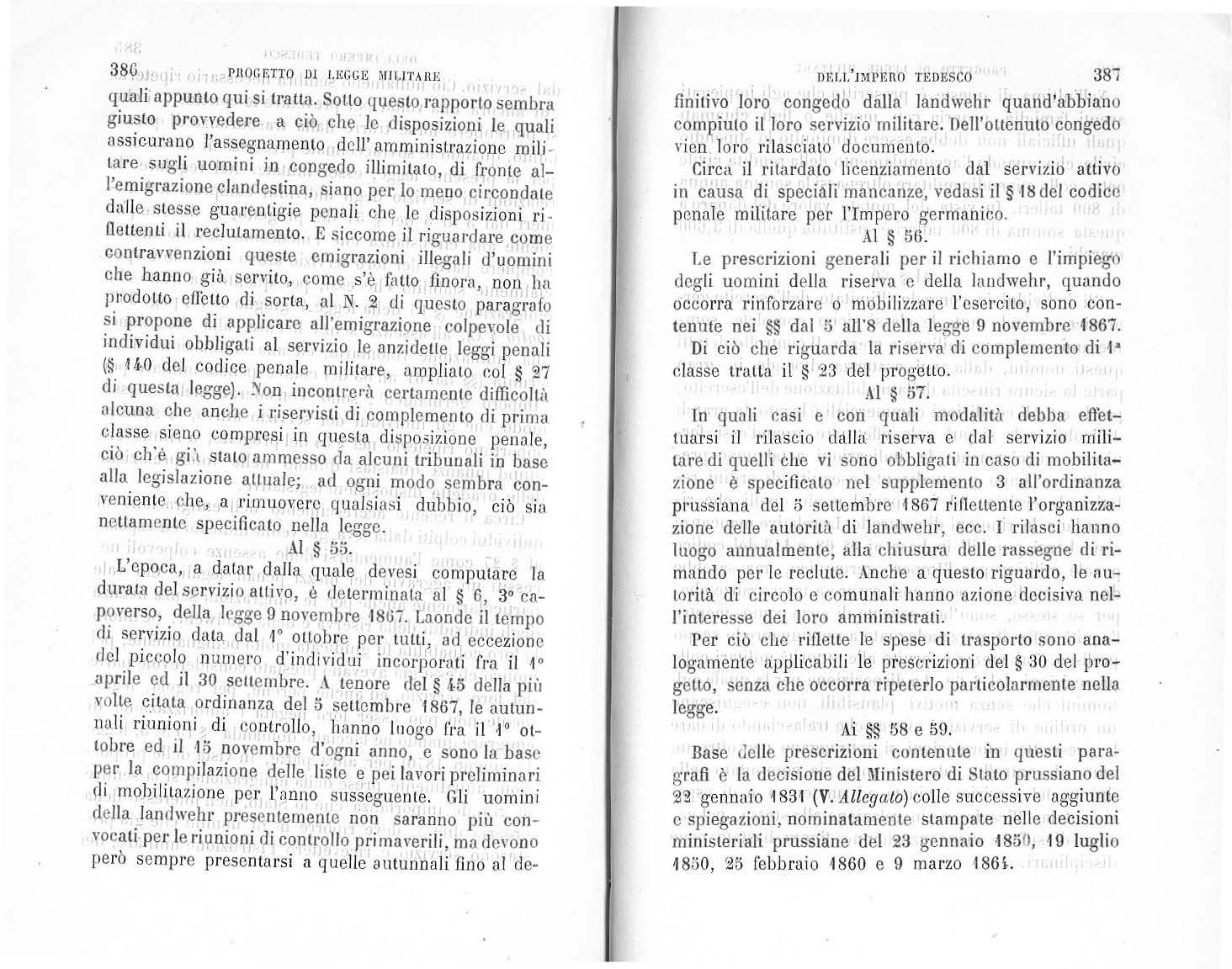
Circa il ritardato licenziamento aa.1 servizio attivo in causa di speciàli mancante, vedasi il§ ·18 del codice penale militare per l'Impero germanico.
Al § 56.
Le prescrizioni gene rali per il ri chiamo e l'impiego degl i uomini della riserva e della laudwehr, quando occorra rinforzare o rbbbllizzare l' esercito· , sono cont enute nei §§ dal 5 all'8 della legge 9 novembre 4867.
Di ciò che rigu a rda la riserva di co mplemento di 1• classe tra.lta' il § '.23 del p1'ogetto.
Al § 57.
In quali casi e con quali modalità debba effettuarsi il rilascio dalla riserva e da l serv.izio niilitare di quelli èhc vi sono obbligati in caso di mobilitazio ne è specificato nel supplemento 3 all'ordinanza prussiana del 5 se Ltembre 1867 rifl ettente l'organizzazione delle autorità di lan dwe hr, ecc. I rilasci hanno luogo annualmente, alla chiusura delle rassegne di rimando per le reclute . Anche a questo riguardo, le nuto rilà di circ olo e com unali hanno azione tlecisiva nell'interesse dei loro amministrati.
Per ciò che riflette le spese di trasporto sono analogamèn'te app li'cril:Jìl i ie pÌ'es'CL; izi on'i de l § 30 del 1)1'0getto, senza che o'cco rra ripeterlo pal'l icolarm ente nell.:i legge .
Ai §§ 58 e 59.
Base de lle prescrizioni contenute in questi paragrafi è la decis ione del Ministero di Stato prussiano del 2'2 gennaio 483~ (V. 'A lleg ato) coll e successive agg iu nte e sp iegazioni, nominatamente stampale nelle decisioni ministeriali prussiane del 23 gennaio 185 0, 19 lugli o 18f>O, 25 febbraio 1860 e 9 marzo • I 861-.
38{)
Nell'ultima di queste è prescritto che agli impiegati aventi famiglia propria con moglie o fi gli chiamati quali ufficiali non debba essere diminuito lo stipendio civile che quando l'accumulamento della rendila civile netta collo sLipendio militare oltrepassi la somma annua di 800 talleri. In vista del mutalo valore del danaro a questa somma di 800 talleri è sostituita quella di 3,600 marchi .
Al § (ìO.
Gli individui in congedo illimitato dell'esercito gerJ manico, quando tutte le classi sieno comple te, sornmeranno a circa un milione e mezzo. Il controllo di tutti questi uomini, dalla cui esattezza dip e nde in gran parte la sicura riusc ita delta mobilitazione dell'esercito, per le attuali condizioni commerciali è legato da grandi difficolU1, e lo si può solo effettuare quand'essi forniscano regolarmente le indicazioni a tal uopo pres c ritte, e siano puntualmtmte eseguiti gli ordini relativi al servizio, ed in !,peci.al modo qu elli che riguardano le riunioni di controllo. Le relative mancanze sono bensi punibili in base ai §§ 68 e 1,13 del codice penale militàre per l'Impero germanico, ma sarebbe durezza applicare pene così severe a trascuranze che, per se stesse, sono ben· sovente di poco como, mentre l'equità offre il mezzo adeguato a rag g iungere lo scop o prefisso. Tal mezzo è fornito alle autorità militari coll e prescrizioni del § 60. La disposizione per la quale agli uomini che senza motivi plau s ibili non eseguiscano un ordine di servizio, ovvero che tralasciando di dare le prescritte ìnformazioni si sottraggano per oltre u n anno al controllo, tale anno non sia computato nella durata del servizio è giusta ad un tempo e di esperimentata efficacia; e, in relazione alla stessa, pel castigo di siffatte mancanze hanno finora bastato pene <lisci plinari.
DELJ,' ml' E RO TE DESCO 389
Al§ 6.f.
Sec ondo la legge p el con seguimento o la perdita della nazionalità ge r man ica, del 1° g iug no 18i 0 (pag . 375 del Fogl'io dell e Leggi cle lla Con fe de razio ne g erm an ica del nor d), per reg ola, nè g li individui della la ri dweh r, nè quelli dell a r ise i·va ab b isogn ano per espatriare de l- · l' autorizzazi one de ll' a uto ri tà militare.
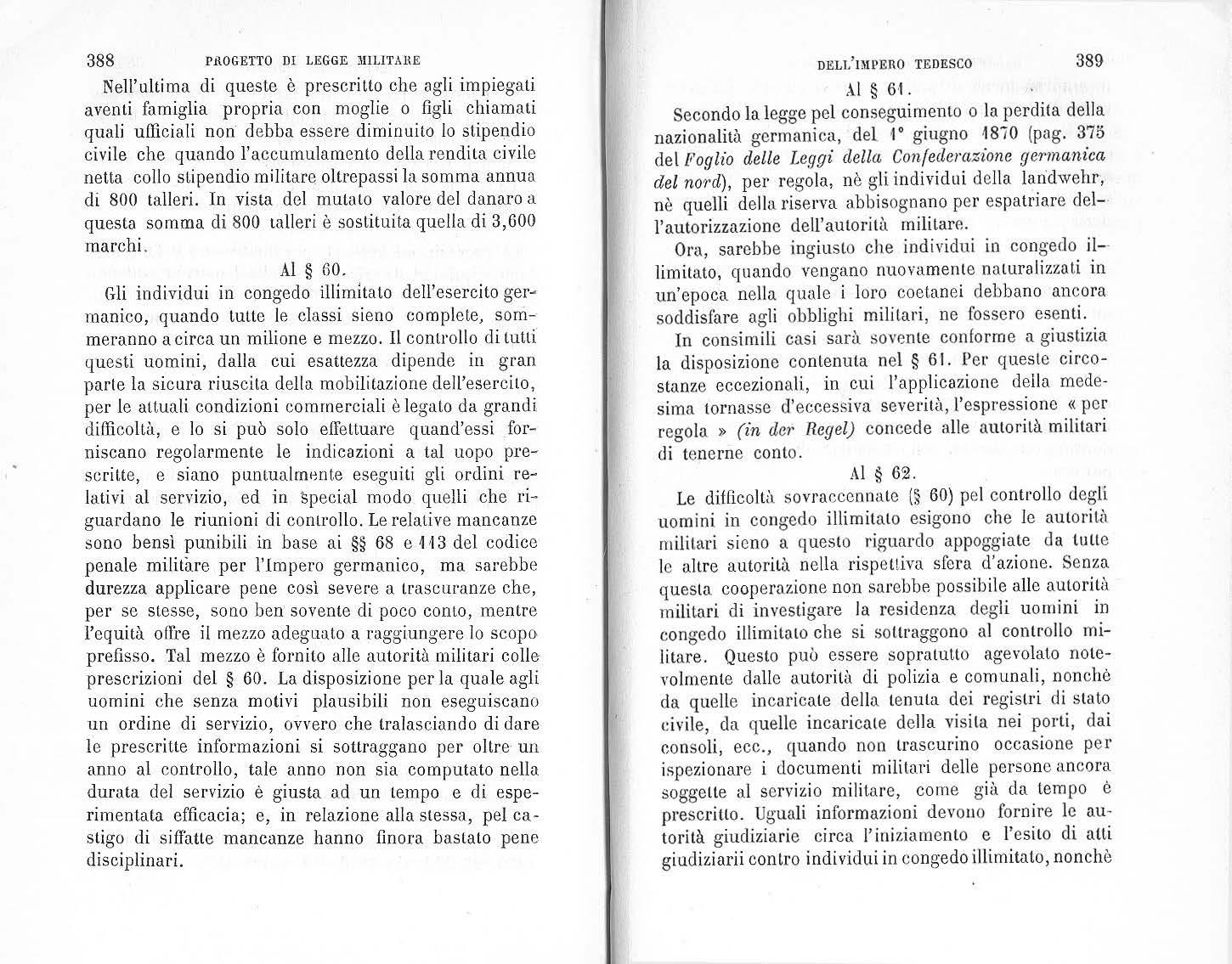
Ora , sarebbe ing iusto che ind ividui in co ngedo il- · limita to, quand o vengano nu ova ment e na turalizza ti in u n ' e poca nell a q uale i l oro coetan ei deb bano an cora soddisfar e agli ob bligh i mi li ta ri , ne fosse ro esen ti.
In co nsimili casi sarà sovente confo r me a g iustizia la d is posizion e contenuta nel § 61. Per quest e circosta nze ecceziona li, in cui l'applicazion e della medes im a tornasse d' eccessiva severità , l' espress ione « pe r l'ego la » (in dm· Regel) concede alle aut ori tà milita ri di ten e rn e co nto .
Al § 62.
Le difficolt.ì. so vra ccenn a te (§ 60) pel controllo degli uomin i in co ngedo illi mit a to esigo n o c he le au tor ità mili tar i s icn o a ques to rigua r do a ppoggia te d a tulle le altre autorità n ella ris pe ui va sfor a d' azione. Se nza qu esta coop e ra zione non sa rebbe po s si b ile alle autorità militari di in vestiga re la r esiden za degìi uomini in congedo illim ita to che si so ttr aggo no al controll o militare . Questo può essere s opratutto agevolato no tevol me nte dalle a utorità di polizia e comunali, n onchè da q uelle in caricate de lla tenuta dei r egis tri di s ta to civile, da qu elle in cari cate de lla visi ta n ei por ti, da i consoli, ecc ., qu ando non tras c urin o occasi one per ispezionare i documenti mili lari delle person e an cora sogge tte al s ervizi o milita re , com e g ià da tem po è prescritt o. Uguali in fo rm a zi oni d evo uo fornir e le autor ità giudizia ri e circa l' inizia me nto e l'esito di atti giadiziarii contro individui in congedo illimitato, non ch è
388 PROGETTO DI LEGGE
M!LlTAl\E
390 llllO G,E TTO or J,EGG-E MlLITARE le autorità I? ~ali. d.i p_olizia circa it rilascio di fogli di co ngedo agh md1VJdm della lan dwe hr e della ri ser va. S.olo, m~rcè l'interp?sizione dell e autorità d~ polizia e co~unr1Ir, p_uò s pecialm ente effeuuarsi la pronta rimess10ne _degh ordini di richiamo ag li in div idui sparsi su tutto 11 territorio, cosa questa della massima importanza per la mobi lita zione dell' esercito.
Al § 64.
La presente legge non lede i diritti convenzionali de ~ r~gni di Baviera e del Wurtem berg. ~e emerge qu rnd1 ~he la p rescrizio ne del § 3°, Ti tolo IV del progetto d1 legge è appl ic abile alla Baviera solo in confor mità de ll e disposizioni di cui atla Parte JJJ, § s N. 3 de lla Conven zi one federal e del 23 novembre 1870 e che le prescrizion i contenute nei §§ dal 6 all'8, ; nel § 63 de l proge tto, p er la Bavi era; a tenore della Convenzione stessa, sono ema nate da S. M. il r e di Baviera.
ALLEGATO.
Jo seguilo al piano di mobilitazione già stabilito abbiamo fallo oggetto d 'a mpi n discussione in consiglio le misu r e che dov rebber o adottarsi in ca so d'una futur o mob ilitnzion e dell 'esercito circa i vincoli militari dogli im piegati civi li , e dopo accurato osamo dei bisogni sia doll'esercilo, si a dolrammioistrazion e civile , a bbia mo pr esentato a S. M. il Re le dispos izioni da prendersi a ques to ri g llardo. Con ordine Rea le di gab inetto do! 18 co rro nte "' mese le soguenli prosc rizi oni ollennero la sanzion e sup r ema:
1° L'obbligo deg li impiega ti civili al se rvizio militare rimane tolalm e ote sottomesso all o norme gene rali su l comp letamento delle divers o par ti dt\ll'cscrcilo;
2• È re gola che ogni impiegalo civile, il quale già sia ascrillo alla landwe hr, ovvero possa esse rlo in seg uilo a seconda della sua e tà, in caso di mobilitazione del bullagliono a cu i esso appartiene, debba obbedire all e prescrizioni di s ervizio militaro e presentarsi;
3° Po trà so lo farsi eccezion e illle di s posizioni es posto al N· 2 quando il capo d' ufO cio cte.l quale dipende l'i mpiegalo dichiari, com'è suo dorare. che questi non potrebbe essero su rrogato ne lle su e att ri buzioni da alcun alt ro im piegato;

4! L'attestato conte nente simile dichiarazione non potrà anzilullo essere rilasciato che a queg li impiegali le cui civili attr ib uzioni hanno alline nza all e cose milita ri, come per esempio i co nsigli eri di d ipar timento militare presso LGovorni, i consig lieri provincia li, i sindaci ccc .
Esso però può, e deve anzi esse re negalo anc ho a qu esl11 ca tegoria d' impiegali tostochè le circostanze pormellaoo di ofrettuarne il ca mbio senza sca pito del serviz io c:vi le;
5• Oltre ch e agli impiegati d i cui al N° 4, potranno .essere ri lasciali dallo autorità prov incia li simili ce rtifi ca li agli im piegali isolati addetli alle regio casse che abhiaoo data cau zi one, nonchè ai maest ri di sc uola isolali che non sia eventual mente possibil e s urrogare;
6° Impiegali civili oou compresi nelle categorie indicate ai N. 4 e 5, sono dispensali dal sorvh io militare jn campag_oa in caso di mobilitazion e, so lo quando si an o sta ti in modo spc ciolo
DBLL'IMPimO TE DESCO 39 1
nnLITARE dichiarati indispensabili da! preposto Ministero o da i dipartimento centra lo;
7• Gl i impiegati civ ili, che in caso di mobil ilazioue dell 'esercito non potessero, comechè asso lutam en te ind ispensabili al servizio civile, ottemperare alle loro incombenze mi litari, saranno, a scanso di ulteriori inconvenienti, designati già.in tempo di paco ed ascr itti addir ittura alla landwehr della seconda ch iamata ;
8° Qua lora fra questi impiegati ve ne foss ero taluni ufficiali in un battaglione Jaodwehr, si dovranno preventivamente fare nuove nomine di uftìciali , acr:iocchè poi non siavi ' deficien za alcuna ne l quadro deg li uffic iali del battaglione;
9• Quando un impiegato civile d ichiarato ìndispensabi lo, vogl ia tuttav ia in r:aso di mohilitazione entrare volontariamonto al se!'vizio militare, ciò non gli sarà concesso prima che egli , previo consenso dell'au torità civilo superio re da cu i dipende, abbia provveduto a farsi surrogare nell 'impiego civi le;
10• In ness un caso si potranno considerare indispensabili a l se.rv izio civile gli impiegati non compresi nel quadro organ ico, ossia diurnis.li, od impi ega ti senza so ldo;
11• Impiegati che sieno bensì pagati sul bilancio d'un dato ramo amministrativo, ma che non ricevano quesla paga dalla Cassa d ello Stalo, d ovra nno tuttavia esse re trattati ne ll o stesso modo di quelli che percepiscono i loro stipe n di dalla Cassa dello Stato;
12' Ad ogni impiegato civile, che nel caso di mob ili tazione dell'esercito adempia le pr escrizioni militari, è conservato l'impiego civile e lo riprenJe non appena terminato il servizio militare;
13° Se l'im piegato civile era diurnista, ovvero non percepiva a lcun soldo, termina to il servizio di guerra, si dovrà fare tutto il possibile per ricollocarlo in a ltro luogo come d iurnista o per procurarg li uno stabile impiego;
14° Ogni impiegato civile entrando al servizio militare in caso di mobil itazione conserva il proprio stipendio.
Per il suo equipaggiamento gli si dovrà accordare un anlicipazione di due o tre mesate di stipendio.
Dello stipendio corren te egli può disporre come meglio gli talenta;
15· Se egli però percepisc~ stipendio da ufficiale, il relativo ammontare gli sarà sottratto dallo sti pendio civ il e .
Se però lo stipend io d'ufficia le fosse superiore a quello civil e,
DELL'IMPERO TEDESCO 393
allora cesserà il pagamento di quest ' ultimo per il tempo in cui l'impiegato percepisce lo stipend io di ufficia '. e! .
16• Le indennità devolute all' impiegato c1v1lo per sopperire alle sp ese d' uflì cio cesseranno dal momento della sua entrata al servizio mil itare. . . . .
All 'incontro, oltre la sua quota di stipendio civile, ha ?~r1llo allresì al soprassoldo di campagna devo luto al suo grado m1~1tar~:
11° Le prescrizioni di cu i ai N. 14, 15 e 16 sono appllcab1h anche agli individui impiegati con die te fisse . . . .· . .
Tali diritti peri> non si potranno accordare ad rndmclm impiegati con diete tempo r arie ; . . . .
1s• Le prescrizioni dei N._ 14, 15 e_ 16 sono ~ur? ap~\Jcab~1: per quanto riguarda I~ pensione. od 11 sol'.lo d, aspet_1.at1va ,_a"l~ impiegali giubilali od m aspetta lw_a . che . '.n caso d1 mob11Ita zione dovessero riprendere il surv1z10 m1htare. . .
Termina lo il servizio di' guerra hanno nuovamente. dmtto alla primi ti va pensione od al pri~ilivo . s~ldo d'asp~ltat1_va;
19• Impi egati comunali o patr1monrnh vanno tralla t1 come gli impiegali governativi. .. ~·-
Nessun comune vorrà, stante l'lrnportanza de l_lo sc~po_, 0.1 mersi dal somminis trare a questi impiegati quei suss1du che po tesse ro occorrere . ,
In caso d'impossibi:ità di farlo , vi provvedera la Cassa dello Stato.
Dove le au torità pri vate se n e interessano non occorre che una libera dec ision e per accordare eventuali so steg ni;
20• Gli impiegati ch e in caso di mobilitazione fosse_r? dalle amministrazioni provinciali assegnati all'In te nde nz a m1 l1 ta~e, o che ottengano in altro modo. u_n_ i_mpiego_ pre:s? la_ med_es1m,a, nonchè quelli che fossero ad1b1 t1 IU qua(1tà d1 _1~pie_gat1 _nella crj ustizia mi litare, di medici, di sacerdoti, o d1 11np rnga t1 po: lali per il servizio di campagna, han no diri~t~ allo :tesso tr?~tamento dl'gli imp iegati che ent rano al servmo attivo nellesercito permanente o n ella landwe~ r . .
Il persona!() impiegati per l' eserc1lc potra pure ess ore tratto da quegl i im piegati civi li che già appartengon~ al!a la ndwchr ;
21• Gli impiegali civili che io caso di mob1htaz1one entrano uell'esercilo o ne l personale degli impiegati del medes imo ~on dovranno per ciò risentirne alcun dan n o nella l?ro carriera
civile: laonde, anc h e nel caso che la loro ca tego na _ a~anzasse di ra~ go , sarà lor,o accordato il relativo ~umento_ d1 st1p~nd10; 22• In conseguenza anche gli assessori presso I Collegi pro-
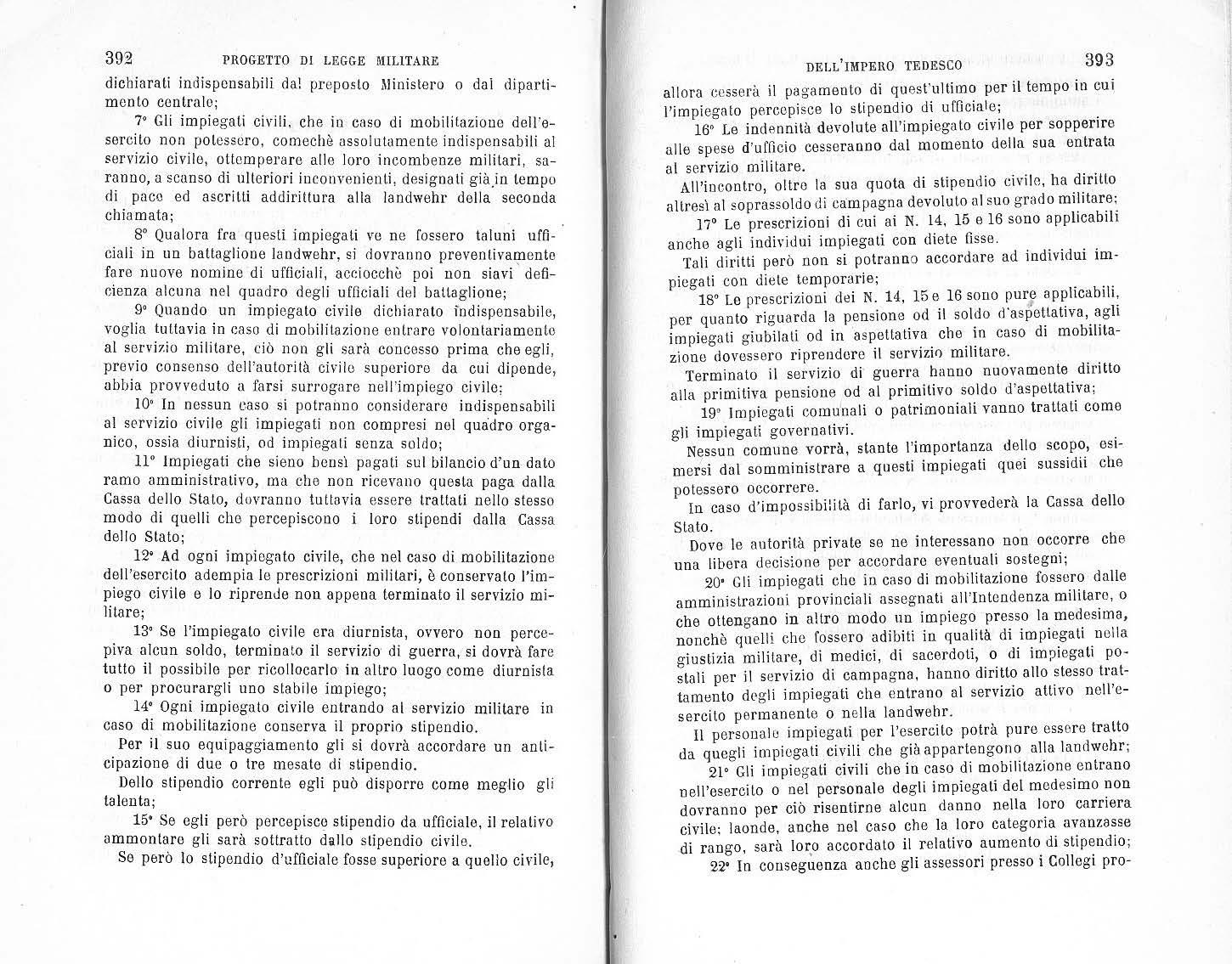
392 PROGETTO Dl
LEGGE
DI LEGGE MILITARE DE.LL'Hr PERO TF.DESCO f '(" I 1 _li
vi n cia li ~durapte il tep:igo 1 di Ipro presenza sotto le armi, o presso le amministrazio ni dell'ese r cito, con correranno ne ll e p'romo11 1 ! I 1; ioni 1 per ,apzi,~nità com~<se, f?sse~p ,sempre nello lo.ro condizioni civili· r " • 1 li I ,
23° Ai referendari obb ligati al serv izio m il itare e che a ll'atto de lla mobil itaz ione abbiano già otlen'Jto 'f attestat~ presicte1F ial e ,di id,ooe jtà 1agJi esd~i sup · eriori,1 ' si. dovra, sem pre ''• ~ ;_ ! V 1 ! 1 quan rlo le, ci r cos tanze lo p er me tt ano, accordare· una pro ro ga St;ffici ente ~CC ÌOCC h è essi po'ssano ' subire~ ' tali ' .esa'mi prima di • • ' • • J J I 1 en tr?,re al , se r vl7.lo m1hta,re; . ,
24• Quei referendari i qua li non avessero per anco d iri tt o a l sovracci tato attestato, dovran~o preJ~ 1rit!1 rsi .pel serviiio miljtare poa;i ~ tutti gli é).ltri richi 13 1Hç. li; mci 1 te~·mina ta ~la guerra. non, apJrnna ,abb iano . superato l'esame supe:r io re; saranno nominati assessori COllfi ,IOro, i\n zia nitù ; .sar,~qpo , cioò,' m.es~i innanzi a I qu ei ref~ r f3 D9,l)ri meno anzi!J nj c1he, ,duran te il temp o del loro serv.i~io n;ii litare,, fqs scr9 ,s!a t\ 1101,n !ra~i ~ss~s~ ori pri~à. di loro.
I n pari t'ompq, s,. I M, il ,R~ si è degnata ordi,n are éhe le sovr aesposte prescrizioni sieno appli Ci1tc'a~ c he al 'conc~n tramento di bal [ag]i o ni ,lanqvyo hr , O~<\ elfr tl ~a:tp'?i IfC l(e -~r?Vinde'' o.rient.9.]i; ed il , so ltosegna lo Min\stero di ~tato fu aulo ri zzato a' dare le u lt~~ i~ri dis posi~ io ~i \~' ar'm~h ia col la supr~ma apor ovazi one I} I• 'i p~tenu ta .
Lao n de i l Minis tero di Stato non manca di portar é a çon o;;cen z.;i dj , qµe~ to, rea, lo ecce lso, t\_\ in!s,ter~ . della , guerra le. disposizion i emanato al rigua r do, e di la~ciare io suo arbitr io l'or, di,nare' co n seg ue nten:ie nte 1quan to, n e lla sua, sfera I reputa I n ecessario.
I l 'Presiden ti sup remi sono già stati ed otti di qu an to r'iguarda i ' Go ve r~i. ,e ' a v~isa,ti di chiamar'e L'a t tetizione di qu e'sti ul timi , • · · , H1 • • • 1 perchè quel le disposizioni servano solo di norma nel disim~egno • (j I, , .i l I \ , de lle loro attn buz1om, ma non siano pub blicale. I I • '1 I
Berlino, , li ,22 qennaio 1831 1 • •
Rea le Min istero di Stato.
FEDERICO GUGLIELMO Princ i pe ereditctrio .
ALTENSTRIN - DE ~ CH UCK~l 1 !NN _:_ LOTTUM - IlllRNSTORFF -
' ' ' fIAAìrn''- M.A.ASZBN ' ...!...' BRriNNJ1' 1
1 1 Per p_ltfinistero di giustizia
, All.',epc:~l~o fi.ea lo 1
. Mii;i islero d~IIA Gu~qa ,
L'AVVENIRE DELLE STRADE FERRATE
CONSIDllRATB
SOTIO IL PUNTO DI VISTA DELLA LORO CRESCENTE IMPORTANZA
NELL A
DIFESA DEGLI ST.l.'l'I
Importanza delle vie di comunicazion~ pr:sso i R~mani. - La gran d e importanza de ll e vie d1 comu nicazione per la gue rra fu riconos ci uta fino dai Romani, i quali per mantenere soggette le vinte popolazioni cos trussero una rete di strade militari che partendo da Roma g iu ngevano alle provincie più remote del vastissimo Ìmpero, raggiungendo una lunghezza complessiva d i ben 53,0 00 mig li a romane. Ne s ia d'esemp io
* Verso la fine del 1872, distribuendosi all'8° reggimento d'artigl ieria i temi per le conferenze da tenersi t ra gli uffi~ iali, i_o ~c~lsi di Uattare « delle fcrrol'ic come mezzo di gue rr a », cd IIl prrnc1p10 del gennaio del •1 813 lessi infatti lo scritto che ora qui si stampa. .
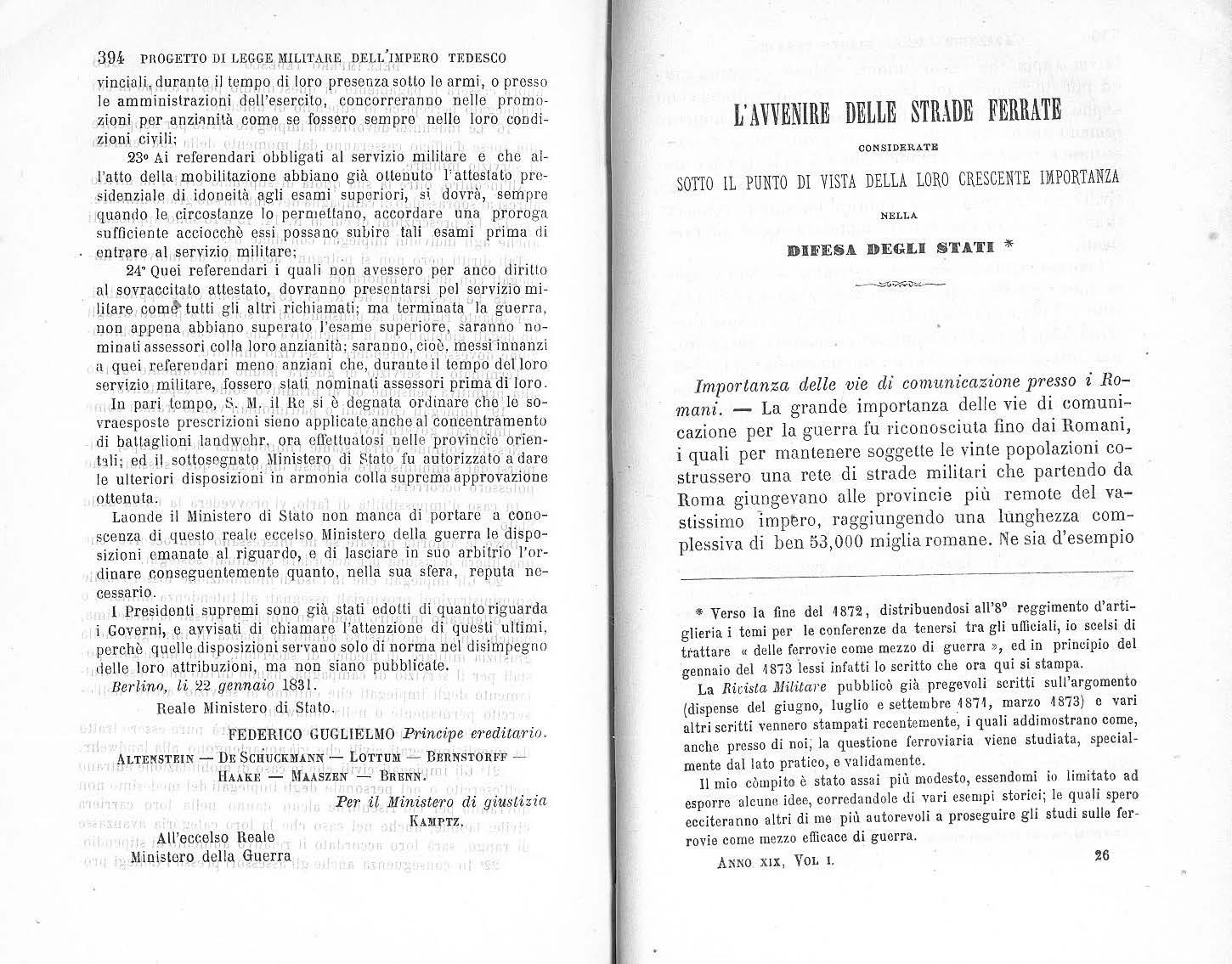
La Riiisla .Militare pubb licò già pregevoli scritt i sull'argomento (d ispense del gi ugno, luglio e se t tembre :I ~74 , ~ arz~ ·1873) e var i altri scritti vennero stampati recenteme nte, 1 quali add1mostra no come, anche presso di noi; la questione ferroviar ia viene stud iata, specialmente da l lato pratico, e validamente.
Jtrnrrz.
li mio còmpito è stato ass ai pi tì modesto , essendomi io li mitato ad esporre alcune idee, corredando le di vari esemp i _stori~i; le ~uali spero ecciteranno altri di me più autorevoli a proseguire g li studi sulle ferrovie come mezzo efli cacc di guerra .
ANNO x ix, VoL 1.
3~4 P RO GE TTO
I
I
.
26
396 L' AVVENIIIE DELLE STRAD E FERRATE la via Appia che es isle tutt ora, sebbene costrulla già da più di 2 mila anui, la quale co ngiunge Roma con Capua e l'antico porlo di Brindi si. Caduto l'impero romano anche le strade giù. co s trulle rimasero trascurate e deperirono grandemente per la lenta ma continua azione distruttrice del te mpo. Al ris orgere della civiltà si fece nuovamente sentire il bisogno di comode strade e s ~ trovò necessario migli orar e quelle già esiste nti .
Impo1·tanza lo1·0 non mai scemata. - Non è mio assunto ricer ca re quale importanza ebbero le strade, sotto il punto di vista militare, anche nella s toria moderna . Tu tti i grandi conquistatori anche dell'età nostra, non traseuraro no le vie di co munica zion e; mi basti cilare Napoleone I che fece costrurre la via del Sempione a ttrav e rso le Alpi onde rendere facile il transito dalla Francia in Italia.
Notevole sviluppo delle strade fer1·ate . -Tutto qua nto però venne fo tto per le vie ordinarie, non é da para.gonarsi coli' immenso sviluppo e la grand issi ma im-portanza che acquistarono le strade femlte in meno di mezzo secolo. Dall'e poca dell'inaugurazione della prima strada fe rrat a in Inghilterra per mezzo della loco motiva n el 1830 ( da Li verpool a Manchester), alla fin e del 1869 si contano già in Europa 96,000 chilo me tri di ferrovie in ese rcizio de' qua li 24-, 765 nella sola Inghilterra (1). È notevole ciò che disse nel 11823 Giol'g io Stephenson , il creatore si può dire dell e ferrovie , mentre lottava per la loro adozione contro tutte le difficoltà tecniche e l' opposizione sistematica di coloro c he non sanno comprendere il progresso. « Miei g iovani amici (diceva egli in un banchetto d'o perai), permettetemi ch'io vi

(~) 1n Italia si hanno attualmente 6647 chi lometri di strade ferrate in esercizio: se no avevano appena 20 68 nel 860 .
NELLA DlFESà. DEGLI STATI 397
esprima una mia profonda conv inzione: voi vivret~ abbastanza per veder sorge r e un gioroo nel qua le_ lutt~ i mèzzi di trasporto ora in uso s aranno det r onizzau dalla strada ferrala; i dispacci postali sa rann o tra sportati dalla forza del vapore, le strade fe rrat e serviranno egualm ente tanto il re quanto l'infimo de' _s uui sudditi». Questa missione fLl co mp letamente rnggrnnta dalle ferr ovie esse an zi la superaron o, p oichè sembrano crea le appo~ itamente per nvvicinare le s!i~pn tie e ~li ~n_t~r~ssi dei popoli e degli u omin i: e tutti 1 governi CIVIii s affrellarono ad orga nizza re (e continuano a comp le tarne le reti) a s ervizio dei viaggia tori , dell'industria e del commercio .
Imp iego delle strade fm·ate ìn tempo di guerra.Un còmpi to che forse non fu previsto da Stephenso~, ma che le guerre ultime hanno completame~te addtmostrato, è l'impiego utile delle s trad e ferrate rn_ tempo di guer ra . Ormai le ferrovie si possono c_o n~1clerare come appartenenti all'armnmenlo d~lle naz10'.~1. Ess e'. in origine destinate ad un'o~era d1 pac~, d mteresst e di commerc io div e ncron o rn te mpo d1 guerra un ' o potente mezzo p el tras porto di t.ruppe, di mun1z 10~1 , di approvi gio narn en ti: esse es erci tano una_ gran~e rn~ fltlenza sopra i pinni di campagna, sopi·~ 1 _ rn?v1mentt strate<rici e so pra i ri sultati Jelle operazioni d1 gue rra. Gra~ide influenza delle st1·ade ferrate nella guerra di Jme1·ica. - « È possibilé, disse il generale Lam a rqu e, che il vapore produca un g iorno un a rivoluzion e così co mpl eta n ell'arte dell a guerrn come l' invenzion e della polvere da cannone ». Questa r-ivoluz ionc for se ~uò dirsi si è compiuta (il). L'inlervenlo dell e strade ier-
•
(4) Credo oppo rtun o ricordare ciò che scriveva nel giugno 7 •1 ~I ma_g· g iore d~t genio Da CnAnBONNEAtJ, nella gi~ n?minata s~a pr ~g1evolissima Memoria starupata in questo stesso pcr1od1co: e Se I esperienza non
398 1'.HVENIRE DELI,E STRADE FERRATE
ra Le nelle operaz ioni militari ha mod ificato profon damente le condizioni de ll a strategia . La s toria di Sander sopra ·1a aue rTa d'America mostra come le operazioni o d . dec is ive di questa g rande lotta ebbero per oggello 1 impadronirsi delle ferrovie, e d i girare le posizioni s·trategiche che dominarono i punti d'incroc icchiamento delle ferrovie . In . definitiva tutta questa guerra ha consisti to nel disputar-s i le strade fe rr ate : Certamente ch e non si potrà dire così delle guerre in al tr i paesi, poichè bisogna tener conto dellP- spe cia li condizioni dell'America . Le strade ferrate devonsi d'ora i nnanzi oro·anizzare in modo, da servire eflicacemente alla dife;a dello Stato. ]!er rendere le str1clc fer r ate efficaci in guerra, bisog na che il persona le impiega.[~ siasi famig liarizzato colle condizioni cli questo serv1z10 speciale· e che gl i stati maggiori si·eno al éo r renLe delle es io-enze tecniche del serviz io. Scrittori francesi amo mettono che gli ufiiciali german ic i nell'u l tima guerra hanno date prove che conoscevano con prec isione le condizion i topografiche e tecn ich e delle strade ferrate, non solamente nel lo r o paese, ma ancora in Francia. Disposizioni alt' estero pet servizio delle . ferrovie in
ha co ufcrmato l'opinio ne d i quelli che nello ferrov ie vedevano quas i un co mpleto rivolgimento dell'arte del la gue r ra; se crron()o può oggi parere a ta luni i l giudizio d i J omini,, ill ust re scri ttore d i cose mili tari., il quale vide i n esse come una cagione che una larga l acuna si fos se fatta nei pri ncipi i della guerra: lac una che egli fa ce va inv ito a i s uoi contempo1'anci d i sollecitamente colmare; non è men \'e ro però che le ferr ovie si sono chiarite tra i fattori i pilì potent i, i più s:c(1ri ed i n pari tempo i più ind ispe nsabi li de ll'od ierno metodo d i guerre ggia ro ,; .....
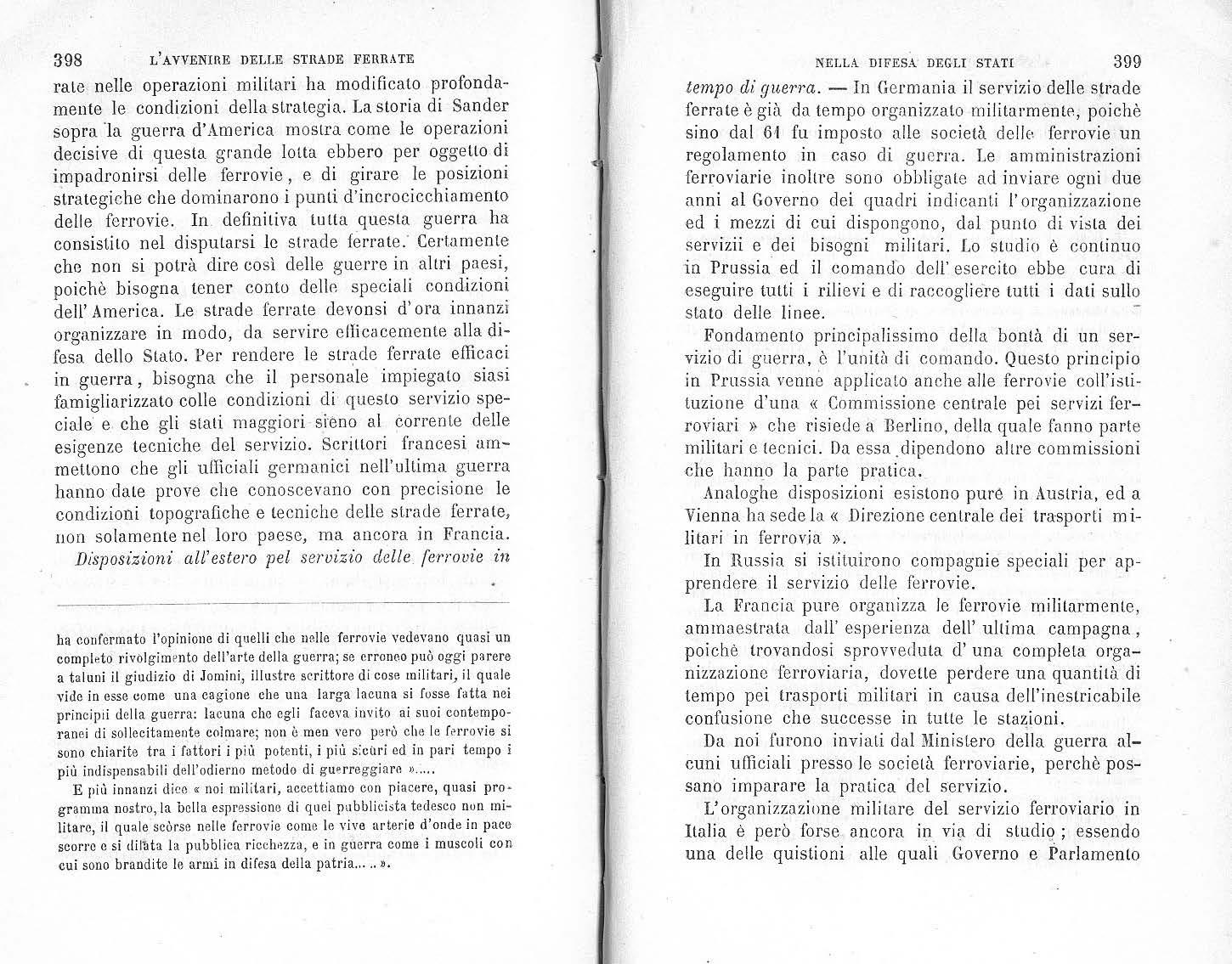
E più innanzi dice • noi mil itari, accett iamo con piacere , q uasi programma nostro, la be ll a espressi one di quel pabb lic ista tedesco non militare, il qua le scòrsc nel le fer rov ie come le vive ar te rie d' onde in pace scorre e s i d il?!ta l a pubbl ica r icch,izza, e in guer ra come i muscoli con cui sono brand ite le armi in difesa della patria ..... ».
NELLA DJFESA DEGLI STATI 399
t empo di guerra . - In Germania il serv izio delle strade forra te è g ià da tempo orgnnizzato rni li tarmentf\, po ichè sino dal 61 fu imposto alle soci.età de ll0. ferrov ie un regolamento in caso di guerra . Le amministrazioni ferroviarie i noltre sono obblignLe ad inviare ogni due anni al Gove rn o dei quadri ind ica nL i l'organiz za zione ed i mezz i di cui dispongono, dal punto di vista dei s erv izii e dei bisogni mi litari . Lo s tud io è continuo in Prussia ed il comando clell' esercito e bbe cura di eseguire tutt i i ri lievi e di raccogl iere tutt.i i dati sullo stato de ll e linee . -
Fondamento princip alissimo della bontà di un servizio di guerra, è l'unitù di comando. Ques to princ ipio in Prnssia ve nne applica.Lo anche alle ferrov ie coll'i:3tituzione d'una « Commissione centrale pei se.rviz i ferroviari » cbe risiede a Be rlino, della quale fanno pa r te mi li tari e !ecnic i . Da essa .dipendono altre co mmissioni che hnnno la parte pratica .
Analog he disposizioni esistono puré in Austria, ed a Vienna ha sede la« Direzione cen trale dei trasport i mililnr i in ferrov.ia » .
In Russia si istituirono compagnie spec iali per app rendere il servizio delle fel'rov ie .
La Franc ia pure orga n izza Je ferrovie militarmente , am maestrata dall'e sp eri en za dell'ul tim a campagna, p oi chè trovandosi sprovv ed uta d'una completa organizzazione ferroviar ia, dovette perdere una qua n tità di tempo pei trasporti militari in causa dell' inestricabile confusio ne che successe in tulle le sta~ioni.
Da noi furono inviati dal Min istero della guerra alcuni uffic ia li pr esso le soc ietà ferroviari e, perchè possano imparare la pratica del servizio.
L'organizzazione rnilitare del serviz io ferroviario in Italia è pe r ò forse ancora in _vi.,l di stud io ; essendo una delle quistio ni alle quali Governo e Parlamento
-
-----
-
400 1.' AVVENIRE DELLE STRADE FERRATE rivolgono ora princip,1lm eote la lo ro preoccupazione per una efficace soluzione ('1 ).
Uno studio serio di tutto quanto riguarda il servizio delle fer ro vie in tempo di guerra .abbraccia un campo assai esteso e svariatissimo.
(~) L' onoreYole deputato GABELLI (V. Nuo va Antologia, aprile e maggio ,1873 ) nel far vcuere che la nostra re te ferroYiaria in g.> ncrale, per essere ut il e in tempo di guerra , è deficiente nelle ampiezze de lle sta·zioni, negli sv ilu ppi dei binari di servizio, nell'armamento delle linee,. ne lla mancan za di pian i carica.t ori , di piat tefor me, e,cc. scrive : « Anche con cal coli che trnscurano tutte l e condizioni sfavo rev oli , in cui ci. troviam o noi risp etto alla Franc ia, giun giamo a questo bel risultato che, dato il caso di doverci difenclere, ei troveremo in difetto di 300 loco motive. È un nu mero grosso tanto e tanto eloq uen te, che mi dispensa dall'aggiungere co1.isiderazion i di sorta.Gli uomini che possono essere chiamati a comandare i moviment i de l nostro eserc ito, ci pensino un po' su, e giu dich ino q uanto assegname nto possono fare s11lle ferro1·ie ita lia ne come mezzo di guerra >.Ed io fine della dottissima Memoria sovra citata conclude: « La necessità d'u na organ izzaz ione, per la quale si ottenga l'uni tà di comando, di un centro, nel quale ent rin o e s'accordino e lavorino di conserva l'demento militare e l'elemento tecnico; di unlt istituzione completa, il cui còmp ito durante la pace sia di studiare e prop orre ed invigilare a ll 'attuazione di quanto può occorrere in tempo di guerra, e la qual<l possa meritare tanta fiducia da aflid arlc con tr anqu illa coscienza la direzi one di og ni servizio ferroviario quando le ferrovie, ahe costarono all'Italia tanti milioni e tanti sacrifici, siano chiamate al loro ufli cio più alto, ci oè di difendere la nostra unità e il nostro onore.naziona le; la necessità -ripeto - di questa organizzazione, di questo centro, di questa istituzione, esistente ed operante in Prussia ed in Austria, e della . quale ama rame nte si duole la Francia d'essere stata pril'a; parmi ch iara assai e tale da non poter essere da alcuno contraddetta o posta indubbio». li maggiore del genio C11 ,1. 111lONNE,1u scrisse si nQ dal settembre 71 (in questo stesso periodico) del servizio ferro\'iario in guerra con molt~ erudizione, propone ndo il modo di ordinarlo in Italia e concludeva: « E massima di ogreg io scri tt ore militare, che l a im pront a o come la consacrazione di un esercito fortemente ordinato e costituito, sia lo sviluppo largo e pieno dei servizii secondari. Facciamo voti J)e rch è, come si pensò giil ad altri di codesti scrl'izi, così ancora a questo tanto importante delle ferrovie, si voglia dare opera pronta e ;ndefessà ~-
 NEtLA DIFESA DEG.tl S'.J;ATI. 4 (),1'
NEtLA DIFESA DEG.tl S'.J;ATI. 4 (),1'
In quanto a me, non pos so asstunermi che un l;r;l;Odes'to còmpLlO ndatto alle mie forze; mostrerò brevemente: ·
,J O L'impiego delle strade ferrale ai grandi trusworti militari, ossia dal lato s lrategico;
2° L'us o delle strade ferrate in lutti gli: altri bi-, sogni de ll a guerra, e specialmente del. loro irnpieg0. ~auico;
3° Dell'importanza. della distruzione de lle ferrovie in tempo di guerra .
Cercherò poi di trarre alcune conseguenze e co0s1deruzioni generali.
Impiego delle strade ferrate nei grandi trasporti militari.
Le gra.ndi concentrazioni di. forze che hanno luogo per mezzo delle !erro vie e per riun ire un'armata. sul teatro della guerra prima dell'incominciamento -delle operazioni , oppure durante il corso di queste operazioni per condurre a ll' armata dei rinforzi, cadono sotto il dom inio della strategia.
Eccone alcuni esemp i presi dalle guerre combattute in questi ultimi anni.
T-raspo1·to cli t1·uppe germaniche.· 1° 11 primo tra· sporto militare esegu ito per mezzo delle ferrovie in Eur opa fo dai 1849 al 1l 8t>'I de ll e trnppe federa l i germaniche nella prima sped iz ione dello Schlesvig-Holstein.
Trasporto d'una divisione russa . - 2° Nel ,J 851 la divisione russa Paniut ine composta di U.,!500 uomini, 2000 ca valli, 48 pezzi di artiglieria, 4.54 vellure, e 88
•
1.
L'AVVENIRE DELLE STRADE FERRATE teste di grosso bestiame fu tr asportata in 2 giorni sulla ferrovia da Cracovia a Hradisch, distanti 30 · 1 chilometri .
Calcolando che una grossa co lonna di truppa in marcia può percorrere dui 21> ai 30 chilometri in media al giorno, si trova che qnesto trasporto fu eseguito da 5 a 6 volte più celeremente di qu ello che sarebbe stato poss;b ile effettuar lo a pied i. (S i ammette genernlme nte che dopo 90 ch ilomet ri di marcia, un a colonna di truppa ha bisog no di 2t ore di ri poso . Decker calc ola che un'armata in marcia, compresi i riposi, percorra 22 chil ometri al g iorno).
fra sporto delt' armata francese. - 3° Nel 11859 in 86 giorni, dal 10 aprile al rn lugl io, si trasp ortarono sopra le linee fronces i 604-,38 1 uomini e 129,227 cava ll i.
Il più grand e movimento ebbe luogo dal 20 al 30 aprile sopra la linea Pari gi-Lione ed in media s i trasp ortarono g iorna lmente 84-'.2 11 uomini e 5'12 caval li. In questo periodo d i tempo si tr asportarono alle front ie:rc sarde ed ngli scali del Med1tenaneo 76,000 uomini e 4-,500 cavalli i quali avrebb ero irnpiegato ·60 giorni pe r fare la medesima s trada in marcia per tappe. Il vanlaggio r elativo ne l rispa rmi o eh te mpo dov uto all'impiego delle ferrovie, si può quindi g iudicare anche da questo ese mpio, nel rapporto dn. 6 ad 1.
T r asporto d'un'armata austriaca . - 4° Tl 1° corpo dell' a rmata au s tr iaca ne l 1859 (Clam -Gall as), comp osto di 37,500 uomini, 40,700 cavalli, il 128 vellure e 96 cannoni, fu imbarcato a Praga il giorno 17 mngg io e, pa ssando per .Dres da e Uonoco , g iunse a Verona il 311. il 1° g iugno le due ·divisioni Cordone ì\1oncenuovo e ra no presenti sul campo di ba ttaglia di Magenta. Se queste trup pe ave;;sero marciato p e r tappa , seguendo la strada la più diretta, ossia per Linz-Insprifok e Verona, la di-
NEUA DIFESA DEGLl STATI 403
stanza esse ndo di 1084 ch il. , avrebbero im piegato un a sessantina di giorn i; ciò che non avrebbe pe rmesso al corpo d'armata di giunge re stù teatro della gue rra che alcun i giorni dopo la conclusione della pace . La vel ocità del traspor to per ferrov ia in questo caso , paragonala a quella per la marcia a piedi, può esp rimersi nel rapporto di 4,5 ad '1.
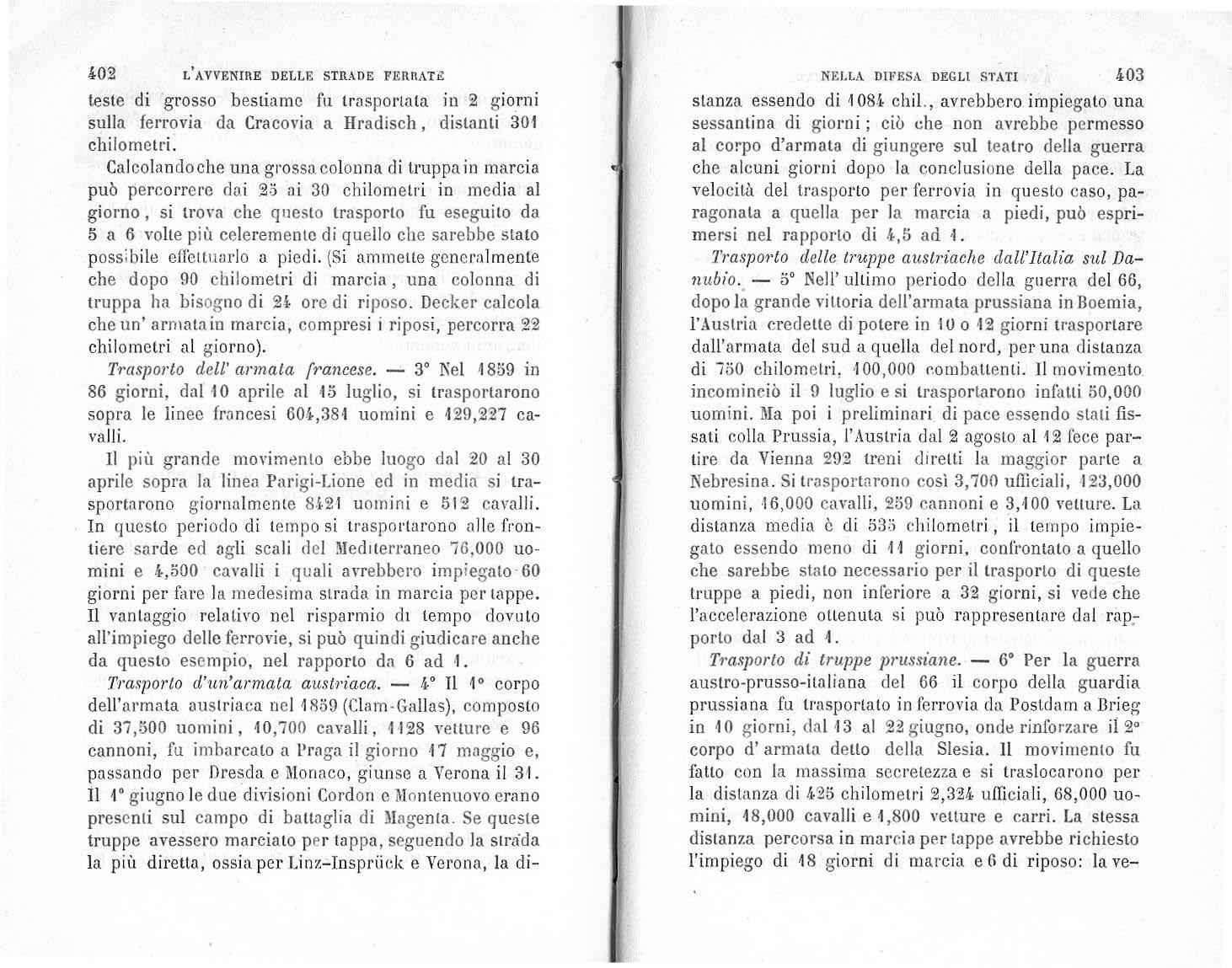
'.L'raspo1·to delle tritppe austriache dalt' Italia sul Danubio. - 5° .Nell'u lti mo periodo della g nerra de l 66, dopo la grande villoria dell'annata prussiana in Boemia, l'Aus tria credette di potere in I O o 12 gio rni trasportare dnll' arma ta d el sud a quella del nord, per una. dis tanz a di 150 chilom etri, 100,000 r.ombatLenti . Il movimento incomi nciò il 9 luglio e si trasportarono infatti 50,000 uomini. Ma poi i prelimin a ri di pace essendo stati fissati co lla Pruss ia, l' Austria da l 2 ago sto al 12 fece partire da Vienna 29:2 treni dire tti la maggior parte a Nebresina . Si tr nspor tar on o così 3,700 ufficiali, 123,000 uomini, 116,000 cavalli, 259 cannon i e 3,100 veuure. La dis tanza med ia è di 03 11 chilometri, il ternpo imp iegato essendo meno di •1·1 giorn i, confrontalo a quello che sarebbe stato necessa1·io per il t ra.sporto di queste trupp e a piedi, non inferiore a. 32 giorni, si velie che l'accelerazione ottenuta. s i può ra ppl'ese ntare da l rap.porto dal 3 ad 1 .
frasporto di truppe prussiane. - 6° Per la gue rra auslro-prusso-italiana del 66 il corpo della gua rdia prussia na fu tr- aspo rl ato in fe rro via da Postdam a Brieg in 1O g iorni, dal 113 a.I 22 g iugno, onde rinforz a re il 2° corp o d' armata detto della Slesia. 11 movimento fu fatto co n la mass ima sccretezza e s i traslocarono per la distunza di 4'25 chi lometri 2,3':M, ufficiali , 68,00 0 uomini, 18,000 cavalli e1,800 vetture e carri. La stessa distanza. percorsa in mar c:ia per tappe avrebbe richiesto l'impi ego di 18 g iorni di marcia e Cì di ripo so : la ve-
402
J,'AVVENlRE DELLE STRADE FERRATE locità quindi fu di 2 volte e mezzo più grande di quella d'una marcia a pied i. - Il co·nceotramento di quasi tutto l'esercito prussiano verso i confini della Sassonia e della Bo e mia fu fatto a datare <lDI ·16 mao-aio al 5 . . d bb grngno, in mo oc.hè (come scri sse il generale Mollke nella relazione su quella campagna) ·197,000 uomini, ::i5,000 cavall i, 5,300 vetture furono trasferiti a distanze variab il·i fra chilometri 225 e 678 in 21 giorni. L' accelerazione in media fo ne l rapporto da 3 ad 1.
Trasporto delle truppe germa.1u'.che. - 7° FinaÌmente coi:ne ult~mo esem pio di questi grandi trasport i militan cormene nolare quello compiuto dalla Germania nel 1870 per la guerra contro la Francia. In meno di 15 giorni essa ha potuto concentrare sulla frontiera francese compresa tra Weissernbourg e Forbach più di 300,000 uomini con una cavalleria e artiglieria assai numei'osa. L'organizzazione delle reti german iche colle sue vie multiple si è prestata meravigliosamente il questo grande sforzo, che ha preparato la villoria alla Ge:mania e l'ha resa decisiva sino dal'pr imo scontro. Furono trasportati per ferrovia dal 5 lugli o al 2 d'agosto 7 corp i d' esercito , altri 4 furono sped iti dopo il 3 cl' agoslo di rin forzo : più lardi si mandarono le d,ivisioni della landwehr. È così che la campagna una volta incominciata i mo virp emi delle truppe nell'interno de ll a Germania come sulla frontiera si sono compiuti regolarmente senza imbarazz i, e che l'arrivo non interrotto di rinforzi ha sempre assicurato ali' esercito germanico la superiorità numerica.
Condizioni necessarie ad osservarsi nei g1·andi trasport-i mi·titari f e1·roviari. - Le condizioni più favorevoli e ne.cessaricadosservarsi per questi grandi traspo1' ti sono:
1a Che il movimento sja, per quan to è possibile, continuo e durevole: quindi che il servizio sia stato calcolato con esattezza sopra lutti i dettagli;
NELLA DIFESA DEGLI STATI .i05
2" Bisogna assicurars i della huona conservaz io ne delle truppe.
Regolarità e continuità del serviz'Ìo. - Per la prima condiz ione non è da cred ers i ch e le strade ferrate abbiano sernplifi<.:ato il cò01p :to degli ufficiali incaricati di dirige1:e e far . eseguire le marcie delle truppe. La facilità di mettere le trupp e in una ·se ri e cli treni, onde far loro percorrere il cammino prescritto, non è che apparente; perchè non basta oceuparsi della direzio ne del la via e che quesla sia libera alla circolazione . Bisogna avere ben altre cure : rendersi conto dei maLerinle disponibile, clèl numero e della potepza delle macchine, degli sviluppi dei binari, de!la capac ità delle carrozze, delle dimensioni <lellA staz ioni d'imbarco e di sbarco: insomma d i tuui i dettagli tecni c i e locali (1). Tulle queste ricerche esigono studii specia li. Tra questi uno di molta importanza per lulli gli ufficiali, è quello delle avvertenze che si devono avere per eseguire il caricamento e lo scaricamento delle truppe sopra i treni.
I Prussiani hanno l'istruzione in data 1' maggio 61 e ehe stabilisee precisamente il modo cli riunione delle truppe alla stazione, i rapporti colle autorità ferroviarie, le avvertenze per l'imbarco e sba rc o dep;li uo-
(4) L'onorevole deputato GADEtLI $Cril"e be n a proposito: « Un servizio di guerra è cosa per molti rigu àrdi diversa dal servizio ordinario di via ggiato ri e merci. I sold ati sono uomini, le vettoxag lie e I~ muniz:oni sono cose; ciò è perfettamente \'ero; ma i soldati devono viagg iare per unità indil'isibili, dett e battaglioni, squndroni e batterie, essere seguitati o preceduti da cavalli, da cannoni, da pagnotte, da fieno: ad ore fisse in punti deter111inatis3imi, e tutto deve oggi andare per una via e domani tutto deve viaggiare per un' altra. I v:aggiatori vanno e vengono, un ese rc ito o va o viene, e assi e me agli uomini deve andaro e venire tutto il resto. l dati del quesito · sono radicalmente cambiati e le risoluzioni non possono essere le medesimo ~.

,i.O.i,
406
I.'AHEN JR.e DELLE STRA.DE FE!lT\ATE
mIIu e ca va lli , e c c. Questa islruz ione ha. fallo otlima prova nelle guerre de l 66 e 70 .
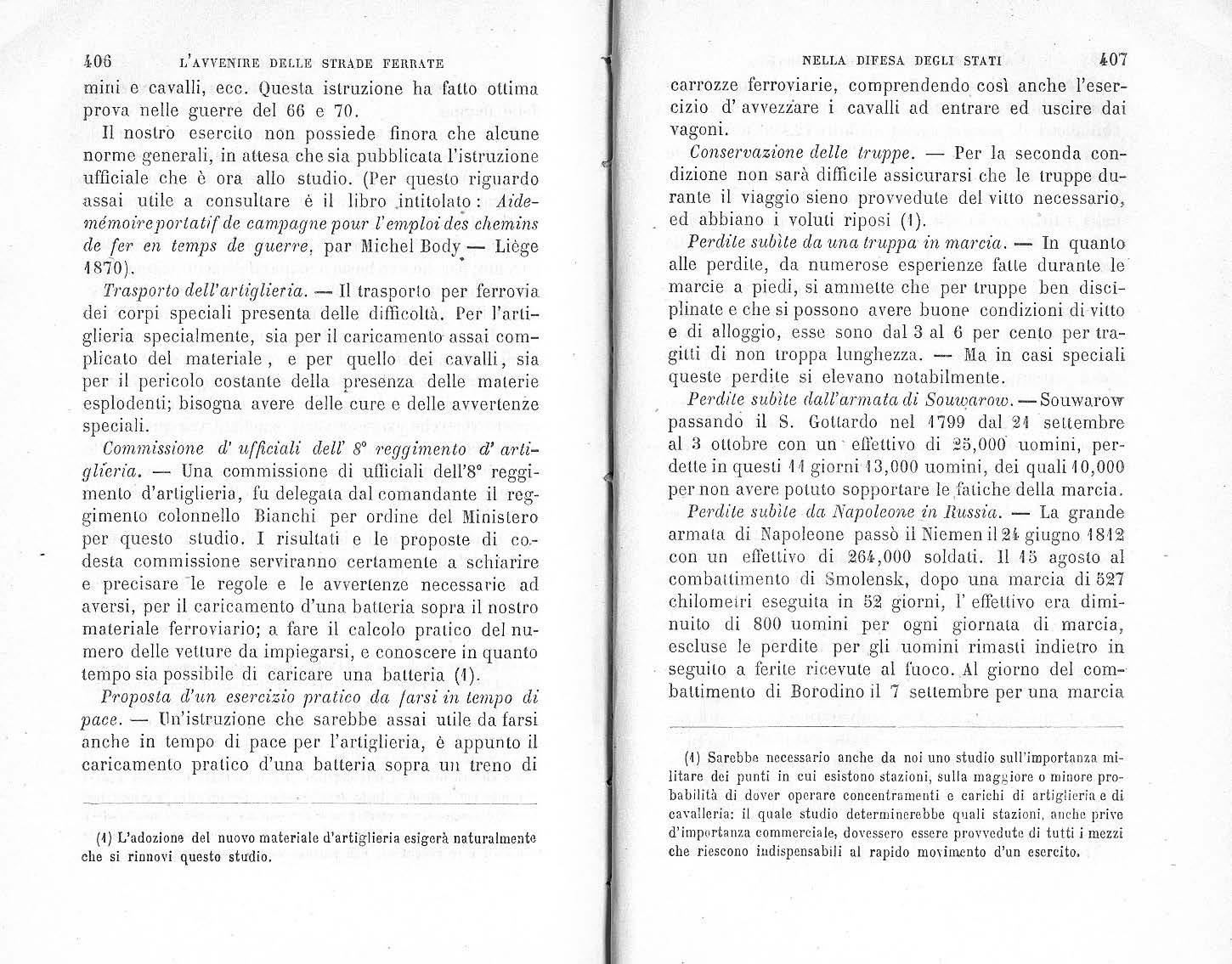
Il nostro esercito non possiede finora. che alcune norme ge nera li , in atlesa. che sia pub blicata l' istrnzion e uffic iale che è ora. a llo studio . (Per ques to riguardo assai u tile a consultare è il libro :i ntitol ato : Aidemémoire portat i{ de campagne pour l' emploi des chemins de fe ·r en t emps de guer1'e, pa r Miche ! Body - Li ège 1870) . •
Trasporto dell'artiglieria . - Il traspol'lo per fer ro via de i corpi speciali presenta delle d iffi collà. Per l'a.rliglieria. specialmente, sia per il caricamento· assa i complic a to del materiale , e per quello dei cavalli, sia pel' il per icolo costante della presenza delle malerie es plodenti; bisogna avere delle· cure e delle avvertenze spec ia li.
Co nimissione d' iiffì,ciali dell' 8° 1·eggimento d' artìg l{eria. - Una commissione di uflì c ia li de1l' 8° reggimento d'ar tig lie ria, fu de lega la da l coman da nte il regg i memo colonnello Bianchi per ordine del Mio is tero per questo sl udio . I r is ultoti e le propos te di co.desta co mmiss ion e serviranno cerlam e nle a sclii'arire e prec isare -1e rego le e le a vve r lenze necessarie a d aversi, per il cnricamento d'u na. balleria sopra il nos lro materiale ferroviario ; a. far e il ca lco lo pratico de l numero de lle vetlure da i mp iegars i, e conoscere in quanto tempo s ia possibile di caricare una balleria. (1).
Proposta d'un esercizio pratico da /arsi in tem,po di p ace . - Un'istruzione che sarebbe ass ai util e. da. farsi anche in tempo d i pace per l'artigl ieria, è appu nto il caricamento pratico d'una batteria s o pra un treno di
NELLA DlFESA DEGLI STATI 407
Ic ar r ozze ferroviarie, comprendendo cosl anche l'eserci zi o d' avveziare i ca.valli ad entrare ed u scir e dai vago ni .
Conservazione delle triipp e. - Per la se c onda. condizione non sa rà diffici le assicurarsi c he le truppe durante il viagg io sieno pro vved ute del vitto necessario , ed abbiano i voluti r ipo s i ('I) . '
Perdite subì te da una truppa in marda . - In quan Lo alle perdite, d a numerose esperienze falle durante le · marcie a piedi, s i amm e tte che per truppe ben disciplinate e che si pos sono a vere b u on<' condizioni di vitto e di alloggio, esse son o da l 3 al 6 per ce nto per tragilti di non tro ppa lunghezza . - Ma in c asi spe ciali queste perdit e si elevan o notab ilm en te .
Pe1'dite subìte dall'armata di Sou'U!arow. -Souwar ovr passando il S. Gottardo n e l 11799 dal ~11 settembre al 3 otto bre con un · effettivo di ~.5,000' u om i ni, perdette in quesLi H g ior ni '13,000 uo mini , dei quali 110 ,000 per non ave re pot uto soppor tare le ,fat iehe della marcia .
Pe1·di te subìte da. 1Yapole one in Russia . - La grande ar mata d i Napoleone passò ii Niernen il ~j. gi ugno '18if:2 co n un e ffett ivo d i ~64, ,000 solda ti. li ,15 agosto al combattimento di Sm ole nsk, dopo un a marcia di 527 ch ilometri esegu ita in 52 giorni, l' effett ivo era. di minuito di 800 uom ini per ogni g iornata d i marc ia, escluse le perdi te per ,gl i uom in i rimas ti indi etro in s eg uilo a ferit e ric:evute al fuoco. Al giorno del co mbatt imenlo di Bor odino il 7 s etlembre per u na. ma rcia
(~) L' adozione del nuovo ma teria le d'arti glie ria esigerà natu ralmente che s i rin nov i q uesto stlidio.
(~) Sareb be necessa ri o anche da noi uno studio sull'importanza militare dei punti in cui esi st ono stazioni, su ll a mag gi ore o mioore probab ili tà d i doV()r operare concenlr~me nti e ca r ich i di artig li er ia e di caYaller ia: i l qu ale studio dct <J rm i ncrn bbe qua li stazi on i, a nche priYo d'im por t~ nza commerciale, doYcsscro essere proVYedute di tutti i mezzi che riescono i udispc11sa bil i al rapido movimento d'un esercito.
L'AVVENillE DELLE STRADE FE!UlATE di 263 chil. che durò 23 giorni s'ebbero allri 15,000 uomini rimasti indietro per le fatiche: Gli ulli mi 114 c hilometri di marcia costarono altri '1'2,000 uomini, in modo che l' entrata in Mosca a l ,15 settembre si fece con 90,000 uomini oltre 13,000 che erano distaccati. La grande armala di Napoleone si trovò poi ri doua nella ritirata a 40,000 uomini. Questi esempi addimostrano quanto grand i possono essere le perdite nelle marcie .
Perdite quasi nulle mediante i trasporti per ferrovie. - Tulle le cause che possono modifìcare la durata d'una marcia a piedi, come possono essere: le crittive strade, l' allargamento delle colonne, il rilassamento de lla disciplina, il cattivo tempo, la cattiva nutrizione, ecc ., i trasp,orti per ferrovia non le presentano: inoltre la· fat ica essen<lo nulla, l'armata non subi rà nessuna perd ita. Un'osservazione che potrebbe essere fondata in apparenza è : che un solo disustro il quale accadesse sopra di una ferrovia potrebbe dare maggiori perdite, che l a riunione di tulle le call ive circostanze d'una marcia a piedi. Ma le statistiche de lle per;iite sulle ferrovie per accidenti dan no un numero così p iccolo di feriti e di morti, tanto da non superare in media il numero di 5 o 6 morti o fer iti per ogni milione di viagg iatori. E si può dire che le grandi masse di truppe che circolano sulle ferrovie hanno la. stessa sicurezza che i viaggialo ri isolati; - Le marcie presentano è vero, il vantaggi o d'al)ituare le truppe alle fatiche ed a lle intemperie, co_n tri buiscono c io è ad aggw~rrirle, cosa che non si ottiene coi trasporti in ferrovia ; ma diffìcilmente con questi s i giunge fino sul campo di battaglia, e l a strada che si deve percorrere pe r terminare il movimento, basterà per abituare le truppe alle fatic;he delle marcie . s .i è vedu to dai e.as i citati che l'impiego delle str.ade

N ELLA DlFESA DEGLI STATI 409
ferrate, abbrevia la durata delle marcie di cinque s~sti: questo numero p·erò nello stato attuale si può considerare come un massimo.
Vant~~gi reali dell'impiego delle fe1·1·ome nei trasporti strate,qici. - Da quanto ho esposto posso concludere: c_~e. l'i~piego del'.e strad e ferrale nei grandi tra.3porti n11l1tan . pres~nta 111 confronto d.elle marc ie a piedi dei vantaggi re?h per Ja raeidità dei mov imem_i, e per le poche perdite che le truppe subiscono.
(Continua).
408
ENlllCO PAGANI Tenente nell'8°regg. d'artiglieria.
LAVORI° DI DIFESA DELLO STATO
Discuss ionll alla Camera dei Deputati
Nelle dispense di g iugno e luglio 1873 di questa Ri- . vista si di ede conto della Relaz ione che la Giunta della Camera dei deputati aveva presentato nell' apr ile sui lavori di difesa dello Stato . È ,. noto come le vicende parlamentari dello scorso anno non abbiano concesso a questo progetto di l egge di essere discusso prima che fo ss e chi usa l a sessione 1872-73, di modo che il .Minis t ero dovette r ipresentarlo tosto aperta la sessione in corso.

Il nuovo progetto min isterfale partendo dalla somma di 152 milioni del pri mit ivo pr ogetto, presentato alla Camera li 12 dicembre 1871 per arm i, pro,;vigioni e lavori di difesa, e ritenuto che di una tale somma già erasi disposto per l ire 72,300,000 colle leggi 26 aprile e 12 lucrlio 1871 (1) e che qu indi non restavano dispon ibili b che 79,700,000 lire, si basava su questa somma resi(1)
duale e ne proponeva l'autorizzazione « per la costru~ione di fortificazioni permanenti e di fabbr icati militari in re l azione colla difesa generale, e per la provvist a dell'armamento de lle fortificazioni medesime »; non specLficava l e fortificazioni che si sarebbero dovute erigere con questa somma che naturalmente non poteva bastare nè all'attuazione del piano ridotto della Commissione . permanente di difesa, nè ~a quello proposto l'anno precedente dalla Giunta della Camera (1) .
Questa Giunta - chè fu riconfermata quella stessa della sessione precedente - invitava pertanto il Ministro della guerra ad indicare i suoi intendimenti; e questo dichiarava come fosse intenzione del Governo, col progetto di legge presentato, di provvedere per ora a quella parte ' -soltanto delle difese dello Stato che generalmente si ritenevano più urgenti, cioè a quella per tutelare le frontiere di terra e le coste e per assicurare Roma e Capua; ed aggiungeva che il l\ilinistero non avrebbe pel mo~ mento potuto accettare che si impegnasse una maggiore somma essendo suo fermo propos i t9 che le spese straordinarie per il ramo militare non dovessero oltrepassare i 20 milioni all'anno, finchè fosse fatto il pareggio della spesa e dellè entrate, e che di questi 20 milioni era indispensabile di consacrare annua l mente una parte ab?astanza considerevole per far fronte ai bisogni mi l itari anco più essenziali ed urgenti, cioè per completare il nuovo material~ di ar.tig1ieria da campagna e la dotazione di fucili, modello 1870, come anche i mater iali di mobilizzazione e le provviste di vestiario.
La Giunta della Camera accettava il concetto in~ormati;o della proposta m inisterial e e di alicordo col Ministro della guerra formu l ava un nuovo schema di legge
ANNO xix, VoL. J
Vedasi la Rivista di giugno 4873, pag. 436.
LAVORI 01 DIFESA OELLO STATO 4-11
(~) Vedasi la Rivista di luglio rnn , pag. 172.
ché avuta per base la detta somma di 79,700,000 lire, la ripart iva in 59,700,000 l ire (per fortificazioni), 16,100,000 per la difesa della frontiera terrestre; 20 ,000,000 per la difesa peninsol are; 23,600,000 per la difesa delle coste }; 10,000,000 per costruzione e sistemazione di magazzini ed altri fabbricati militari; 10,000,000 per armamento <l '.3lle opere di fort ificazione.
L'intera somma do vrà essere spesa in nove anni, cioè tra il 1874 e il 1882 colla graduazione seguente:
,~~875
La Giunta voleva inoltre che fossero localmente specificate le fort ificazioni da erigersi e specificata altre~ì la somma da spendersi per ognuna, lasciando però in facoltà del Ministero· tanto l'ordine di precedenia delle costruzioni, quanto di poter modificare le somme parziali conforme i progetti particolareggiati e l ' andamento delle costruzioni potessero richiedere; purchè gli assegnamenti complessivi delle cinque diverse partite a, b, e, d, e non fossero alterati; ma poi recedeva da quest'ultima sua idea e la legge fu. votata senza. l'indicazione delle somme parziali. I lavori da eseguirsi vennero stabiliti come segue:

A) Difesa delle fronti'e're tet·restri.
1° Per la costruzione dei forte di Capra Zoppa . . . . . • . . . . . . L.
2° Per la costruzione 'del forte di San Bernardo . . . . . . . . . . .
3° Per la costruzione del forte di Nava»
4° Per la costruzione.del forte d-i Tenda>>
5° Per il m igli~ramento del forte di Vinadio . . . . . . . . . »
6° Per il miglioramento del forte di Exilles . . . . . . . . · · · · • »
7° Per le fortifioazioni- di Susa . . . »
8° Per la c0struzione· del' forte di Edolo»
9° Per il miglioFamento ,della .fortezza di Rocca d'Anfo . . . . . . . . . »
10° Per il miglioramento della fortezza di Rivoli . . . . . . . . . . . . »
11° Per la costruzione delle fortificazioni di Monte Pipalo e di Monte Moscallo . >
12°. Per la costvuzione del forte al Passo delle Fugazze . . . . . . . . »
13° Per la costruzione del- forte di Primolano. . . . . . . . . . . . . »
14° Per la costruzione del forte di Castel .Lavazzo . . . . . . . . . >,
25° Per la costruzione del forte di Ospedaletto . . . . . . .. . . »
16>0 Per 1a costruzione del forte di Stu-
17° Per miglioramenti al forte di' Bard e p~r altre opere secondarie nelle, Valli Alpine»
412 LAV ORI 01 DIFESA
1877 dal 1878 TOTALI al 1882 a) Per la difesa della frontiera 16,100,000 terrestre .... .. 500,000 1,000 ,000 2,000.000 3,000,000 9 ,600,000 l>). Per !« difesa penrns u la r e 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000 ,000 u ,,500,000 20,000,000 e) Per la difesa 1 ,000,oooJ 1,000,000 delle coste 500,000 1,000,000 20,100,000 23,600,000 .à) Per costruzJOne e sistemazione di magazzini ed altri fabbricati mil i tari. 8 00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 6,200,000 10,000,000 e) Per l'armamento delle fortificaziooi ... . .. 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000, 000 6,800,000 10,000,000 -- -- -TOTALE 2,500,00ù 5 ,000,000 G,000,000 8,000,000 58,200,000 79,700,000
DELLO ST-ATO
»
500,000 500,0dò 500,000 500, 000 600,000 400,000 3,000,000 800,000 500,000 500,000 l',500,000 800,000 1,200,000 1,500,000 2,000,000
• • • • . . . . . . . .
1,000,00Q
pizza
. »
300,000
Totale L. 16,100,000
B) Dzfesa penz·nsulare.
l O Per trasformare Capua in un campo trincerato . . . . . . . . . . . . » 10,000,000
2° Per costrurre un c3:mpo trincerato a Roma . . . . . . . . » 10,000,000
Totale . . . . L. 20,0 00,000
C)
Difesa
delle coste .
• Per migliorare la fortezza di Genova da .terra e da mare . . . . . . L. 12,000,000
l
2° Per trasformare le fortificazioni della .rada di Vado. » 2,000,000
3° Per trasformare le fortificazioni di Bai·a » 2,500,000
4° Per la costruzione delle for t ificazioni negli ancoraggi di Monte Argentaro » l,600,000
5° Per migliorare la fortezza di Venezia da terra e da mare » 3,000,000
6° Per migliorare la fort ezza di Ancona» 1,000,000
7° Per migliorare la fortezza di Gaeta da terra e da mare » 1,500,000
Totale . L. 23,600,000
La giacitura e lo scopo di ciascuna delle fortificazioni A furono specificati sulla Rivt"sta di giugno 1873 e non ci torne r emo s op ra, non essendovi alcun mutamento tr a· le proposte di allora e le at tuali della Gi unta, tranne relativame n te al forte progettato a }.lfelogno sul colle di Settepani, la cui erezione non fu ravvisata di prima urgenza, perchè quello a Caprazop pa (1) inters.ecando la strada della Cornice ad ovest di Finalborgo, protegge
(1) Rivista di giugno, pag. 440 .
naturalmente la strada rotabile che partendo da Finalborgo valica l'Appenn ino al colle de' Settepani e conduce a Calliz;ano nella valle della Bormida; però non appena sarà compiuta la .strada rotabile ora in costruzione . tra Pietra e Calizzano per il colle di Monte Calvo bisognerà costrurre un forte sì a Monte Calvo sì a Melogno per padroneggiare la cresta' montana interposta. · Circa alla difesa peninsulare il progetto di legge non è che la rip e tizione della prima proposta fatta dalla Giunta e dal Ministro accettata, cioè di fortificare Roma e Capua, spendendo 10 milio.ni intorno a ciascuna.
Le fortificazioni sulle co s te si restringono a Genova, Vado, Baia, ·l\fonte Argentaro, Gaeta, Ancona e Venezia; e per quest' ultima la spesa primitivamente divisata in 10 milioni verrebbe ora limitata a 3 milioni.
L'attuale progetto tralas~ia quindi tutte le fort ificazioni nel bacino del Po, quelle del porto e della rada di Napoli, .quelle a 1' aranto, Brindisi, Chioggia e Brondolo, Civitaveèchia, Porto U mana, e quelle per la difesa delle isole che comprendeva il primo progetto: e ciò, come già ab b iam ·de tto, per non esci r e dal l imite della somma invariabilment e determinata da l Ministero.
Ma la Giunta pur consentendo che pel momento non veniss e discusso e votato se non il progetto di legge per le fortificazioni sopramenzionate e per la somma di 79,700,000 lire, in relazione alla proposta ministeriale: volle però <li sua iniziativa formulare un secondo progetto il quale abbraccia per lo appunto tutt ~ le fortificazioni tralasciate nel primo, e che nel concetto della Giunta occorrerebbero per far completo il nostro sistema difensivo.
Questo secondo progetto porterebbe la spesa di lire 88,500,000 (500,000 pel forte a Melogno; 40,500,000 per la difesa continentale (1) ; 36,500,000 per quella delle
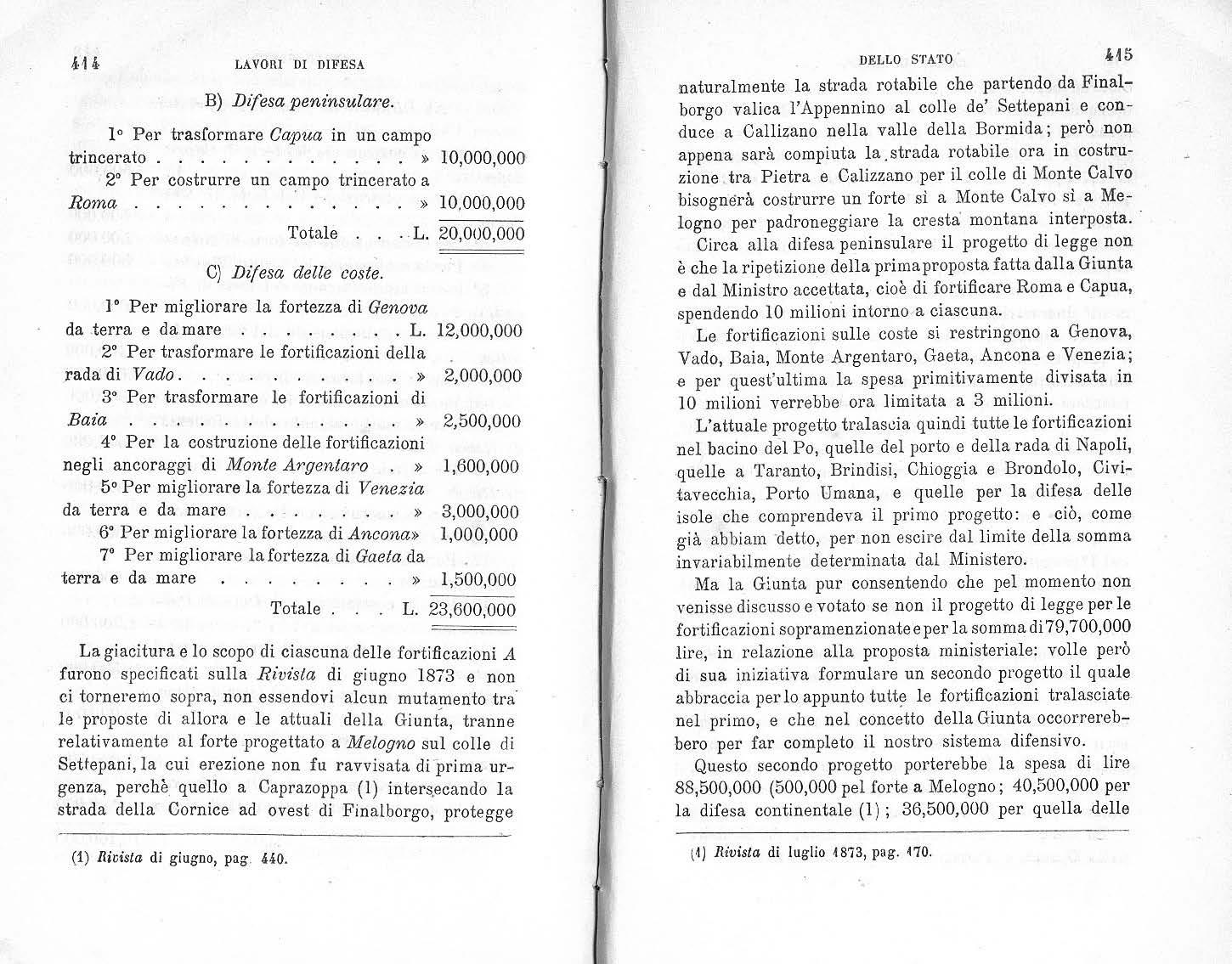
LAVO!\! DI DIFESA
DEL LO STA'l'O 415
{4) Rivista di luglio ~873, pag. 470.
LAVORI or DIFESA coste ed isole; e 11,000,000 per l'armamento delle nuove opere di fortificazione), la quale somma dovrebb'essere spesa dal 1874 al 1882 nelle quote annuali seguenti: nel 1874 L. 1,500,000; ne l 1875 L. 7,000,000; nel 1876 L . ~,'i00,000; nel 1877 L. 9,800,000; il restante dal 1878 al 1882.
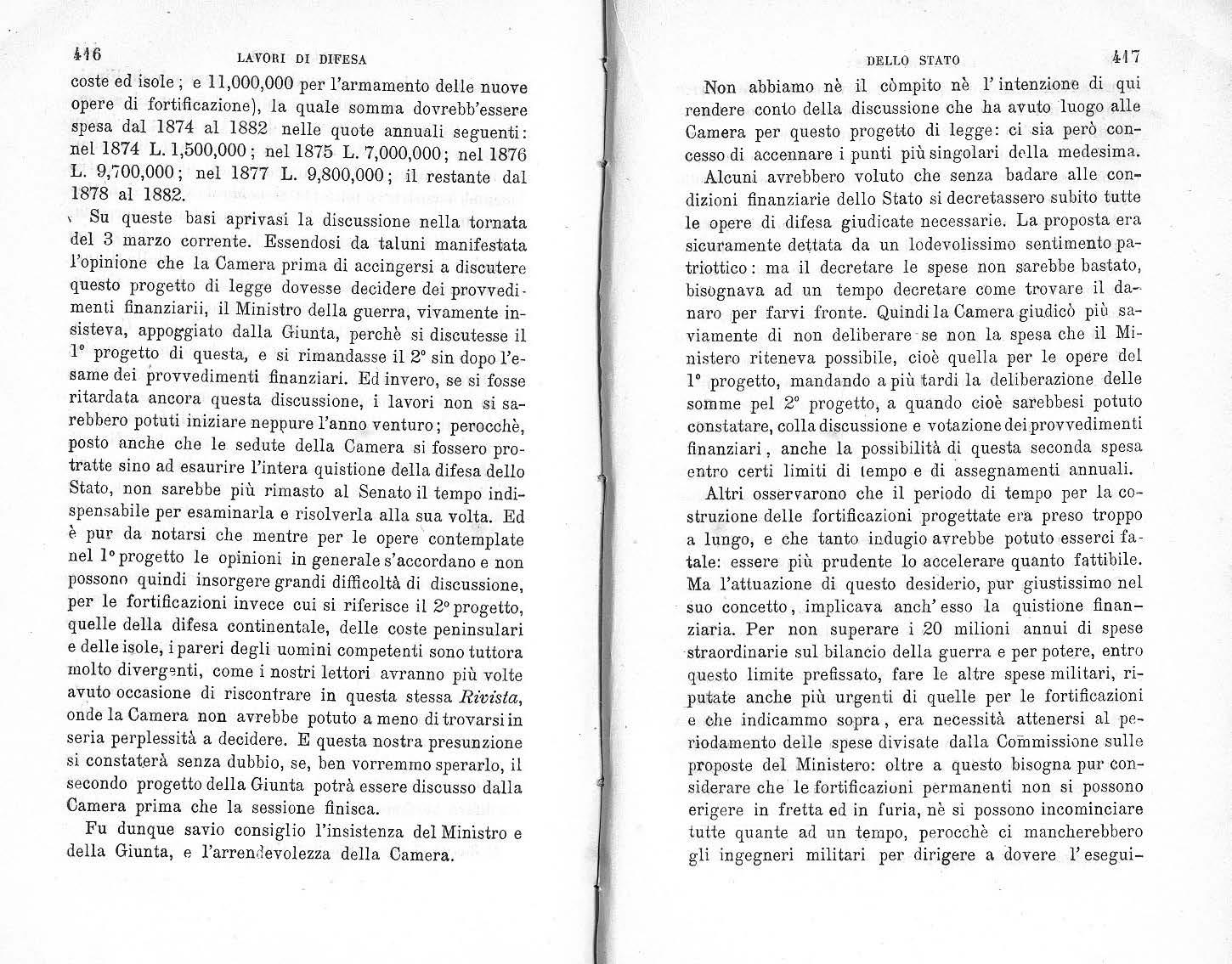
, Su queste basi aprivasi la discussione nella tornata del 3 marzo corrente. Essendosi da taluni manifes1iata l'opinione che la Carnera prima di accingersi a discutere questo progetto di legge dovesse decidere dei pr.ovvedi. menti finanziarii, il Ministro della guerra, vivamente insisteva, appoggiato dalla Giunta, perchè si discutesse il 1 ° progetto di qu esta, e si rimandasse i l 2° sin dopo l'esame dei provvedimenti :finanziari. Ed in vero, se si fosse ritardata ·ancora questa discussione, i lavori non si sarebbero potuti in~ziare nep~ure l'anno venturo; perocchè, posto anche che le sedute della Camera s i fossero protratte sino ad esaurire l'intera quistione della difesa dello Stato, non sarebbe più rimasto al Senato il tempo indispensabile per esaminarla e risolverla alla sua volta. Ed è pur da notarsi che mentre per le opere ' conte~plate nel 1° proge t to le opinioni in general e s'accordano e non possono quindi insorgere grandi difficoltà di discussione, per le fortificazioni invece cui si riferisce il 2° progetto, quelle della difesa continentale, delle coste peninsulari e delle isole, i pareri degli uomini competenti sono tuttora molto diverg':lnti, come i nostri lettori avranno p iù volte av~to occasione di riscontrare in questa stessa Ri"vz"sta, onde l a Carnera non avrebbe potuto a meno di trovarsi in seria perplessità a decidere . E questa nostra presunzione si constat.erà senza dubb io , se, ben vorremmo sperarlo, il secondo progetto della Giunta potrà essere discusso dalla Camera prima che la sessione :finisca.
Fu dunque savio consiglio l'insistenza del Ministro e della Giunta, e l 'arren <levolezza della Camera.
DELLO STATO
Non abbiamo nè il còmpito nè l' intenzione di qui rend~re conto della discussione che ha Muto luogo alle Camera per questo progetto di legge: ci sia però concesso di accennare i punti più singolari della mede·sima. Alcun.i avrebbero voluto che senza badare alle condizioni :finanziarie dello Stato si decretassero subito tutte le opere di ,difesa giudicate necessarie. La proposta era sicuramente dettata da un lodevolissimo sentimento ·patriottico : ma il decretare l e spese non sarebbe bastato, bisognava ad un tempo decretare c-ome trovare il da naro per farvi fronte . Quindi la Camera giu.dfob più saviamente di non deliberare · se non la spesa che il Ministero riteneva possibile, cioè quella per le opère del 1° progetto, mandando a più 'tardi la deliberazione delle somme pel 2° progetto, a quando cioè sarebbesi potuto co.nstatare, colla discussione e votazione dei.provvedimenti finanziari , anche la possibilità di questa seconda spesa entro certi limiti di tempo e di assegnamenti annuali.
Altri osservarono che il periodo di tempo per la costruzione delle for t ificazioni proget tate era preso troppo a lungo, e che tanto indugio avrebbe potuto esserci fa .
tale: essere più prudente lo accelerare quanto fattibile . Ma l ' attuazione di questo desiderio, pur giustissimo nel · suo concetto, implicava anch'esso la qu istione :finanziaria. Per non superare i 20 mi l ioni annui di spese straordin a rie sul U l ancio della guerra e per potere, entro questo limite prefissato, fare le altre spese m ili tari, ri-
J)Utate anche più urgent i di quelle per le fo r tificazioni e ohe indicammo sopra, era necessità attenersi al perioda,mento delle spese divisat.e dalla Commissione sull e proposte del Ministero: oltre a questo bisogna pur considerare che ·1e fortificazioni permanenti non si possono erigere in fretta ed in furia, nè si possono incominciare tutte quante ad un tempo , perocchè ci mancherebbero gli ingegneri militari per dirigére a èlovere l'esegui-
!16
LAVO Rl DI D[FESA
mento. Non neghiamo però che invece di nove anni , le opere del 1° progetto si potre b bero , se non fosse questione di danaro, ultimare in cinque o sei : come non neghiamo che i fortilizi di sbarramento potrebbero tutti quanti essere ' costrutti in 3 o 4 anni, non compreso , s'intende, quello in corso.
Altri avrebbero voluto che le prime somme si fossero consacrate esclusivamente alla difesa dei valichi alpini, e che le decisioni intorno alla difesa delle coste e della parte peninsulare fossero rimesse a quando si sarebbe potuto discutere anche delle fortificazioni del bacino de l Po. Ma ci sono delle fortificazioni a mare ugualmente e fors' anco più urgenti di quelle delle frontiere terrestri. Come dicevamo (1), quando rendevamo conto della prima Relaz ione della 0iunta della Camera, Genova ha urgenza massima di complementi difensivi; nelle sue attuali condizioni quella piazza che è di somma importanza strategica per l a difesa generale del paese, specialmente ne] supposto di offesa da occidente, è difettosissima. E sono altresì di prima necessità le progettate fort ificazioni a Monte Argentaro ed a Baia.
Quanto a Roma ed a Capua che taluni onorevoli deputati non avrebbero voluto veder 'entrare nella l ista delle fortificazioni prime a farsi, e che altri avrebbero vo luto si posponessero a quelle per la valle del Po, bisogna confessarlo, la questione d'urgenza è assai meno sostenibile che non per le difese di frontiera e a mare.
A parer nostro la C.amera si è però attenuta al miglior partito determinando che le fortificazioni di Roma dovessero essere tra le prime. Come il Ministro della gue rr a e;l il generale Bertolè - Viale avvertivano be nissimo nella discussione, la Capitale del regno essendo oggi intera-
(1) Rivista di luglio 1873,pag. 447
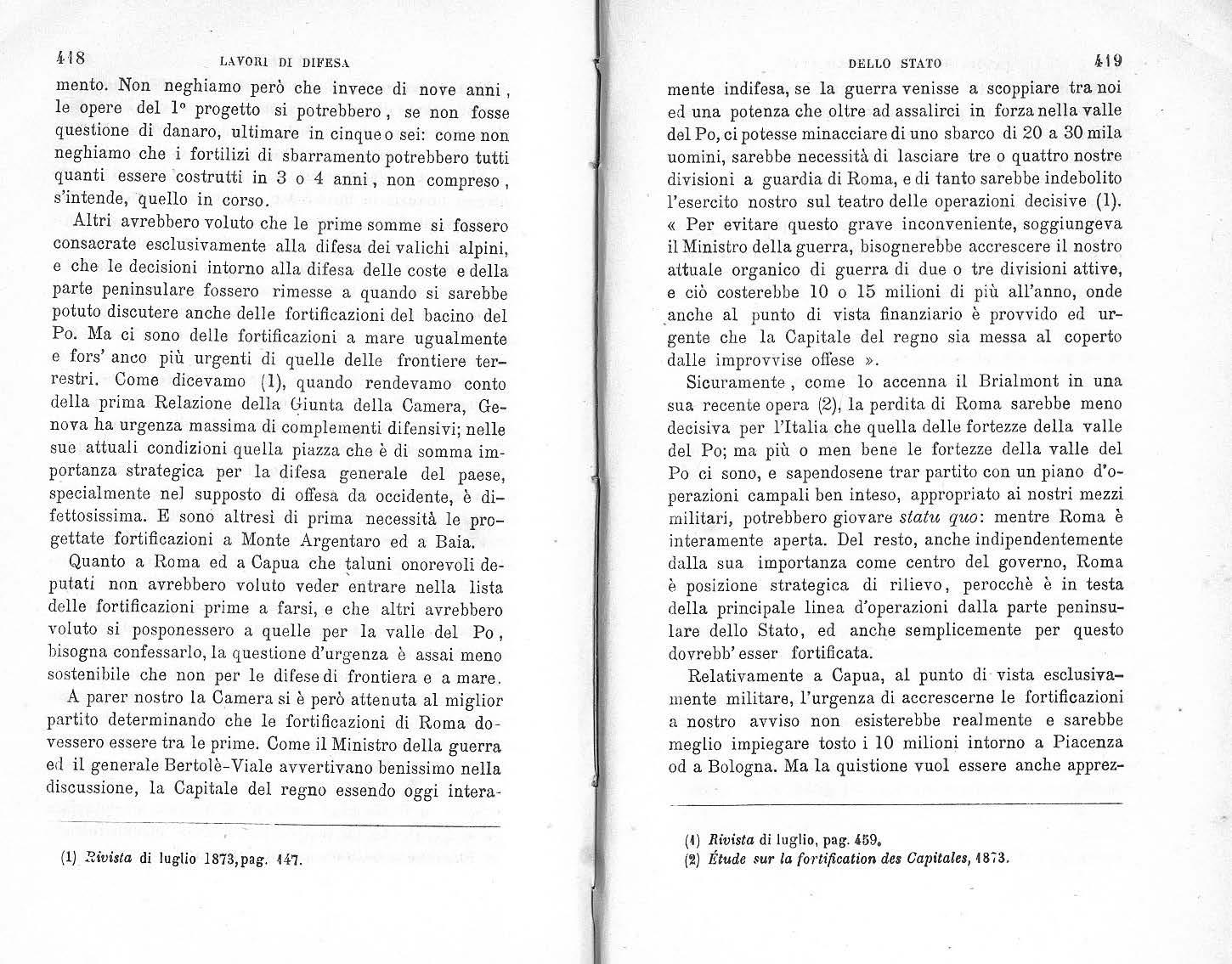
DELLO STATO il9
mente indifesa, se la guerra venisse a scoppiare tra noi ed una potenza che oltre ad assalirci in forza nella valle del Po, ci potesse minacciare di uno sbarco di 20 a 30 mila uomini, sarebbe necessità di lasciare tre o quattro nostre divisioni a guardia di Roma, e di tanto sarebbe indebolito l'esercito nostro sul teatro delle operazioni decisive (1).
« Per evi tare questo grave inconveniente, soggiungeva il Ministro della guerra, bisognerebbe accrescere il nostro attuale organico di guerra di due o tre divisioni attive, e ciò costerebbe 10 o 15 milioni di più all'anno, onde · anche al pu nto di vista finanz ia rio è provvido ed urgente che la Capitale del r eg no sia messa al coperto dalle improvvise offese ».
Sicuramente , come lo accenna il Brialmon t in una sua recente opera (2), la perdita di Roma sarebbe meno decisiva per l 'Italia che quella delle fortezze della valle del Po; ma più o men bene le fortezze della valle del Po ci sono, e sapendosene trar partito con un piano d'operazioni campali ben inteso, appropriato ai nostri mezzi militari, potrebbero giovare statu quo: mentre Roma è interamente aperta. Del resto, anche indipendentemente dalla sua importanza come centro del governo, Roma è posizione strategica di rilievo , perocchè è in testa della principale linea d'operazioni dalla parte peninsulare dello Stato, ed anche semplicemente per questo dovrebb' esser fortificata .
Relativamente a Capua, al punto di · vista esclusivamente mi li tare, l'urgenza di accrescerne le fortificazioni a nos tro avviso non esiste rebbe realmente e sarebbe meglio impieg are tosto i 10 mi lioni intorno a Piacenza od a Bologna. Ma la quistione vuol essere anche apprez-
(4) Rivista di luglio, pag. •59,
(2) Étude sur la fortification des Capitales, 43;3,
.i, 'f 8
. - - - -·-·-- - -
420 LAVORI 01 DIFESA DELLO S'l'ATO
zata sotto un altro aspetto: bisogna munir Capu-a per rassrcurare Napoli, poichè questa popolosa ed importantissima città non si può direttamente difendere: e noi crediamo che questo sia essenzialmente il concetto cui s' informava la proposta del Ministero della guerra, accettata dalla Giunta e votata dalla Camera.
Speriamo che il Senato possa occuparsi presto di questo progetto di legge affi~chè si possano iniziare prontamente i lavori. Sarà poco, ma sempre meglio poco che niente.
RECENTI PUBBLICAZIONI DI TAT1TICA
IN GERMANIA E IN AUSTRIA
Studlen iiber Trup11e,a-l.i'tU,r1mg (Studi sull'arte di condurre le Truppe) per T. V . V.& RDY ou Vlll\NOIS, colonnello e capo di stato maggiore ·del ~0 corpo d'esercito. - 4• di spensa . - Conclusione de l 1• studio sopra. la divisione di fanteria collegata col co rpo di esercito. - Berli no 873, l\littler (pag. . 86).
Ecco ornai appagato il desiderio generale, sorto già nel 1870 al primo apparire dell'opera interessantissima. Questa quar~a dispensa corona degnamente l'edifizio degli studi pratici sopra il combattimento di una divisione di fanteria, cui naturalmente si collegano _ tutti i precetti dell'arte di condurre le truppe sul campo di battaglia. L'autore ha felicemente seguito sino alla fine il suo sistema originale, dei cui pregi si è parlato in altro articolo (1). Non era facil cosa app licare teorie a fatti veri o supposti, senza troppo scostarsi dal campo scientifico dei principii, senza restringere l e questioni alla meschinità di particolari isolati, senza dimenticare lo scopo per il mezzo e crear casi a comodo di idee preconcette. Anche la tattica vuole essere trat tata scientificamente, e deve rimontare dall'analisi alla sintesi, dal particola-· reggiato esame nel laberinto degli avvenimenti al campo concreto dei concetti meditati e coordinati. Altrimenti poco utile se ne ritrae; gli esempi rimangono monchi,slegati, unilaterali; l'applicazione richiede sforzo di me-· moria, di intelligenza, di facoltà comparative, perocchè

i I I
vnr.
(~) Vedi Rivista militare, ottobre ~873.
nECENTl l'UODLlCAZ!ONl DI TATTlCA n essuna situazione si ripete identica in guerra, come non si dà verun viso umano eguale in n atura. I principii generali invece si piegano e si adattano ai casi i più svariati e formano quel corredo di dottrina cui s empre si ri feriva la più vasta mente dell'universo, Napoleone I, quando l aconicamente g iudicava le operazion i militari dei grandi capitani scrivendo in margine alla n arraz ione: ciò è, ovvero: ciò non è secondo i principii.
Ma badiamo a no n fra in tenderci . I principii nella tattica più che alt rove devo n o r iposare sopra un cumulo di fatti, scelti con sottile discernimento, studiati con cura diligente e p erse vera nte, con mente serena e profo nda, con giusta bilanci a nel pesarne la portata e l e conseguenze . Ciò ha saputo fare il colonnello Verdy dando alle sue c.onsidera zion i il carattere scientific o che pur tr oppo fa difetto negli scritt i dei suoi im itatori. Per-ciò il suo libro rimarrà guida sicura allo studio pratico del combattimento, modello ricercato di temi e di con ferenze, indiri zzo utili ssimo ai gi udici di campo n elle manovre e nel giuoco di gue1-ra . E p erciò ben merita il plau so col quale venne ac colto dal mondo militare europeo.
Si è veduto come colla conquista di Neu- Rogn itz e dei boschi circostanti andasse spegnendosi l'azione immaginaria sì ingegnosa mente tes s uoo. sull'ordito vero del terreno, s it uazione strategica, fo rze rec iproche e colla scorta dello stud io profondo del c uore umano e dei principii che reggono la sorte delle battaglie. Ma il comandante la divisione prussiana non spiegò abbastanza energia nel proseguire l'offensiva, n ell'attaccarsi al tallone nemico, nel gettare . nell a bilancia tutto quel po' d i forza che poteva rimanere ai suoi soldati dopo dodici ore di lotta. Non conviene tuttavia esse re troppo solleciti nell'e manare giudizi.
Le trup pe sono sfinite, fra mmiste, confuse; gli ordini
IN GERMANIA E IN AUS TnTA ,i.;23 scomparsi; manca un ità di comando; il n emico ripiega coprendosi abilmente; incerta la direzione, incerte le forze; ognuno crede soddisfatto il debito suo; su~entra <rià la cura per le mille occupazioni indispe~sabilI dopo ~na giornata campale . Egli è perciò che ben di ra clo si vede applicato il principio g iustissimo dell'inseguimento ad ogni costo . « La nostra storia militare, sì ricca di fasti, non ci offre un altro es e mpio pari a quello della sera 18 giugno 1815 ».
A Trautenau l a cavalleria non ha potuto gettarsi sul nemico in ritirata perchè costrett a a tenersi tro ppo lontina dalla prima sc hi er a . 'l'ale fu, e sarà la sua sorte nell a ma"gior p ar te delle battaglie. Decisa l 'azione, l'ino seguimento dip ende sempre dalla situazione reciproca. Meno il caso di rotta, il vi ncitore s i tro va bene s pesso senza coesione tattica, me ntre il vinfo, p rofittando della forza che le nu ove armi arre ca no alla difensiva, può opporre alla cav alle ria una barriera di fuoco.
Alla se ra di Waterloo gli ostacoli all'inseguimento non erano così enormi come dopo le recenti battaglie. L'esercito fra ncese contava circa 60,000 uomini, quanto presso a poco due corpi prussiani; aveva co mba ttuto fino al~ l'esau rime nto çompleto; non portava fuc ili e can nom della potenza a ttu ale e si ritir a va a prec ip izio sott~ l'impressione tremenda dell 'i mmim sa catas trofe. In i.ah cond izioni, quando in luogo dell'attesa col onna di Grouchy vide i battaglioni prus si::\ni, non pensò più a res is tenza di sorta e si disperse in modo da rimanere fac il pr eda del vincitore. Gneisenau t enn e dietro oltre 15 c hi lometri dal campo di battaglia con 1 battaglio ne, 2 pl otoni d i fanteri a e 6 squadroni ed a lui si unirono all'indomani pochi altri squadro ni. .
Cosa 'difficile assai è mantenere il contatto col nemico. « Nella c am pagna del 1866, negli ult imi giorni di giugno fino al 29 noi abbiamo avuto un a cate na quasi ininte r-

42:Z
PUBBl, ICAZIONI DI TATTICA
rotta di serii combattimenti con 6 corpi nemici, eppure il 2 luglio era,vamo ancora, affatto al buio sulla situazione dell'esercito avverso. La prima disposizione pel 3 lug.lio, poscia non emanata, incominciava colle parole: siccome malgrado una continua serie di lotte è andato perduto il con tatto col nemico ecc.. .. .. e dalla Relazione ufficiale risulta eome a1la sera del 2 luglio regnasse ndea completamente falsa che l'esercito austriaco si fosse già ritirato dietro l'Elba e soltanto allora. si accingesse a ripassarla ».
Ad evitare codesta eventualità· , così frequente e, cosi -dannosa, fa d'uopo lanciare riparti di cavalleria in tutte le direzioni, impor loro di spingersi ben innanzi e di non avere soverchio riguardo alla conservazione dei cavalli.

Il colonnello Verdy non entra in altri particolari, forse perchè il combattimento suo non gliene porge il destro. Ma la cavalleria è essa capace di sciogliere da sola l'arduo problema? Una mano di fanti appostati a dovere non può porla in imbarazzo, nasconderle ogni mossa, -costringerla ad appiedare od a volgere il tergo, e sacri·ncandosi alla morte ed alla prigonia, toglierle qualsiasi contatto coll'ese11cito retrocedente? Il 5 agosto 1870 uno squadrone usseri e 5 squadroni ulani, . avanzando da .Soultz sopra Haguenau, trovarono allo sbocco della foresta un ponte occupato da fanteria francese. Gli, .ussari appiedarono ed affrontarono il nemico; ma l'attacco andò fallito insieme colla missione di distruggere la .ferrovia.
La descrizione dei particolari sullo sgombro definitivo -delle alture di Staudenz e di Burkersdorf da parte di deboli nuclei austriaci e degli sforzi fatti dai singoli comandanti per mettere un po' di ordine in quell'intFieatissimo caos, porge occasione di' ut ilissimi ammaestramenti.·
I N GERMANIA E IN AUSTRIA 425
I combattimenti nei boschi traggono seco la più grande dissoluzione. Le . catene si ip.escolano, si confondono, si interrompono, si ammassano; i sostegni errano a GllSO fra le piante, si assottigliano, ,',compaiono , non giungono mai a posto a momento opportuno, nè riescono ad imprimere slancio e v,igore nei propri cacciatori che. combattono lu ngo l'orlo; la direzione superiore cessa affatto od è imbarazzatissima; qualcuno colla mano d'uomini che si vede intorno sorte ali' aperto e ,, non veduto, non aiutato da altri, si lancia, inutile vittima, all'attacco.
Una delle cure più difficili e più importanti di un combattimento è quella di ritardare e d~ limitar e al possibile il disordine. A tal fine è mestieri che ciascun comandante dal più basso al più elevato ricordi, ad ognuna delle frequenti pause più o meno lunghe dell'azione, di riunire i suoi uomini, di colmare alla meglio le lacune , di porl'ei al più presto un argine all'attrito dissolvente della lotta. Generalmente la pausa sopraggiu:qge di botto; l'ufficiale, titubante, ignaro della situazione generale, coll'anima tesa, coll'occhio rivolto al nemico, obblia lo scompiglio ed attende agitato un altro istante che lo strappi dall'igno ~o. Per tal modo si arriva alla fine con
· un frammischiamento- generale, che toglie modo di prosegui r e la vittoria o di proteggere la ritirata ed esige molto tempo e molta fatica prima che la truppa sia in grado di eseguire. la più semplice evol.uzione . « Noi rammentiamo di aver veduto al calar della notte dopo una battaglia i riparti. di un corpo di esercito scioHi e mescolati in guisa da dover mettere ufficiali sul loro passaggio lung@) la . grande strada percorsa, i quali gridassero con~i tinuaimente: tale divisione a destra, tale a sinistra». · Dopo una battaglia,. prima1 condizione si è ripl'istinare i ranghi in modo da poter guidare di bel nuo;vo lai truppa, all'azione ordinata .. Il nemico principale s,ta nella so-·
RECENTI
4-24
UECEN:rr PUBDJ,ICAZIONI Dl TATTICA verchia estensione del fronti:', alla quale i Prussiani inclin~no troppo anche in tempo di pace.
Molta . sollecitudine esige la scelta dei posti dove la sera hanno da riunirsi i vari corpi. I punti di raccolta devono spiccare chiaramente nel teatro dell'azione, essere a buona portata, corrispondere alle circostanze del momento ed all'ordinanza che vuolsi prendere nel bivacco. Altrimenti gli uomini spossati vanno girando ancora a lungo prima di trovare un po' di requie e' di cibo, ed il mattino appresso i battaglioni non hanno ancora i loro soldati. In caso di possi bilità è utile dirigere tutt; gli sban dat i lu ngo una strada, nella quale formano una corrente che puossi facitmente dirigere verso ·un punto dato.
Non mi pare se mpre vero che l'estensione del fronte sia ostacolo principalissimo al ripristinamento dell'ordine, perchè in generale i riparti meno ammassati meno <l i leggieri si mescolano, e lo spazio serve assai a separarne gli elementi eterogenei. D'altro lato dopo una battagl ia le sirade non bastano mai al numero infinito dei carri di ambulanza, di munizioni, di viveri , alla circolazione delle corvées, delle pattuglie, delle requisizioni, nè sembra quindi prudente ingombrarle con torrenti di sbandati.
A porgere un saggio del v igore, verità, colorito delle descrizioni che adornano il libro, mi sia permesso trascrivere le seguenti linee:
« Il luogotenente generale A. in Neu-Rognitz trovò già il suo alloggio preparato in una delle più belle case del p aese. Del resto nel v illa ggio regnava la più strana delle baraonde. Quasi in tutte le case s i trovavano fer iti e ne continuavano a _ giungere da ogni parte . Uom in i dei corpi più diversi gironzavano cercando di requisir viveri per conto proprio, mentre arrivavano riparti chiusi mandati a prender acqua dalle circostanti ti·uppe. I pio:nieri atterravano ancora un paio di muri delle case
bruciate che minacciavano rovina, e travi ed usci erano portati via da alcuni fanti per farne .fuoco. Lungo la via si notavano le vetture di un distaccamento sanitario, le quali, spedite dalla 1 di v isione, avevano trovato sbarrato lo sbocco dai carri di munizione della fanteria e della cavalleria; in mezzo a questi, curioso a vedersi, stav ano un paio di vetture di vivandiere. Nelle case non di soverchio ingombre da feriti, s'avean dato piacevole ritrovo le bande di tré reggimenti e vi si erano comodamente installate ».
Alla narrazione s'intrecciano considerazioni d'ogni natura, svolte man mano che l'occasione si offre spontanea. La teoria segue compagna indivisibile la pratica, ne sceglie i casi salienti e p iù o meno costanti, li raggruppa, ne studia le cause e gli effetti ed espone le une e gli altri con tutta semplicità e chiarezza. Fra tanti casi pratici, importanza nettamente rilevata ha sempre la natura umana, la quale nel campo dell'azione guerresca, dove si rizzano prepotent i tutte le virtù e tutte le debolezz e dell'animo, ha non solo parte essenziale, ma forma il sostrato dell'arte di condurre le truppe.
In verun'altra guisa meglio si potrebbe adattare gli ammaestramenti tattici alla realtà, alle infinite contingenze di una battaglia, tener conto di tutte le condizioni morali e materiali e conformarsi al grande principio: niente v'ha di assoluto in guer1·a. Scienza ed applicazione ari:ionizzano perfettamente completandosi e rischiarandosi a vicenda .
La via lunga ne sosping·e a riprendere i brevi cenni sugli insegnamenti, lasciando i l terreno del racconto a chi· vorrà assumersi il còmpito utilissimo della traduzione complet.a.
Il generale di divisione emana tutti i suoi ordini per il bivacco; non chiede istruzioni algenerale di esercito
ANNO xix, VoL. I 1s
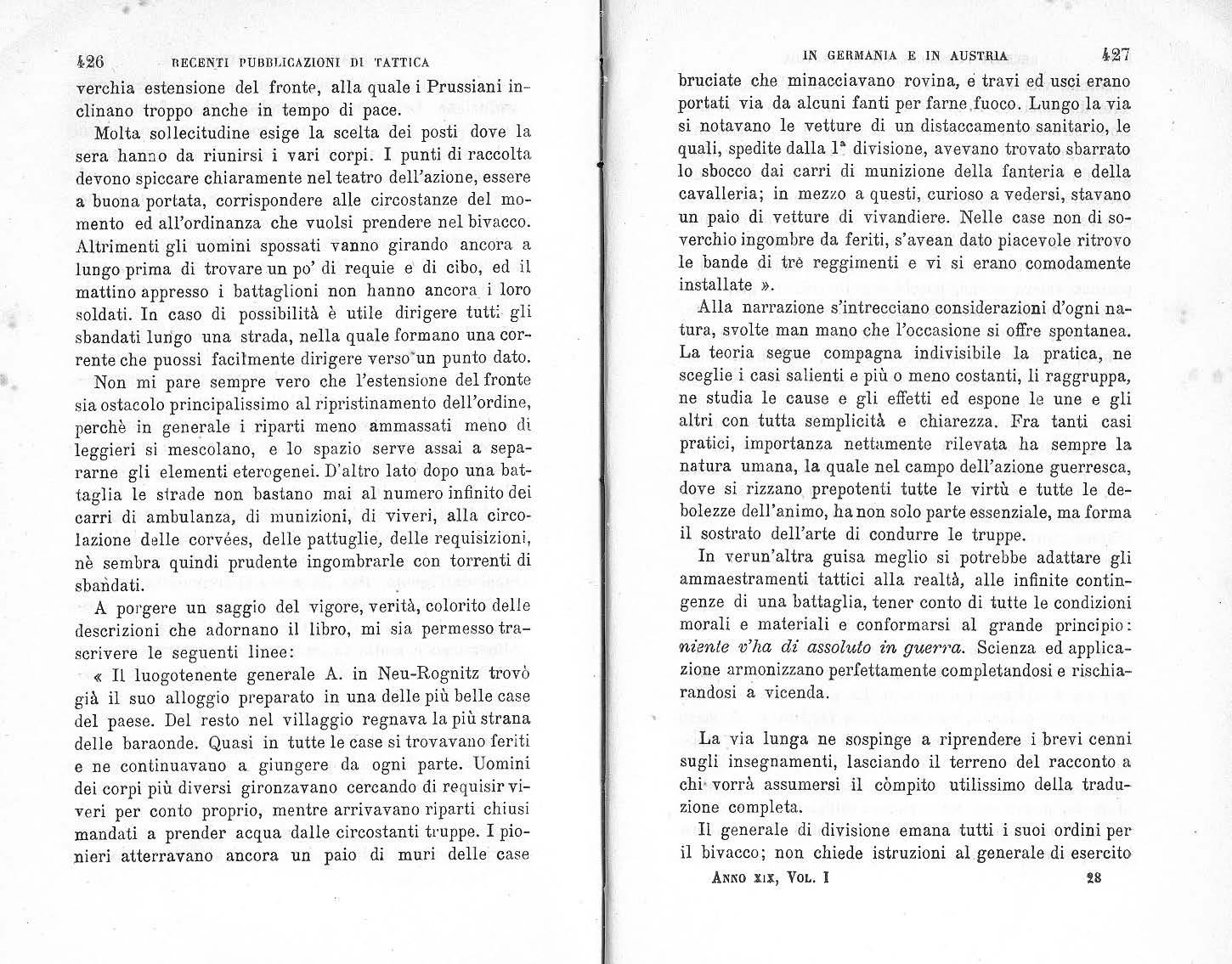
i-26
lN
l-27
GERMANIA E IN AUSTRIA
RECENTI PUBBLICAZIONI DI TATTICA
ancorchè vicino, ma gli ri ferisc e soltanto il tenor e delle date disposizioni. Il- generale d'esercito bada alla situazione strategica, al modo di impiegare l'altra divisione, a proseguire o ad interromp ere l'aziGne tattica. Per sfuggire fino alla tentazione naturalissima di occuparsi dei particolari di spettanza altrui, non si tiene accanto al generale di divisione, ma lascia a questo intera autonomia e responsabilità. Varie sono le vie che adducono ad uno sco po; chi ne sceglie una, chi l'altra; ambedue possono ess ere buone, purchè seguite coll'energia, chiarezza e vigore di un convinci mento netto ed assoluto.

I consigli, i suggerimen ti e peggio gl i ordini slegati e minuti, producono disgusto, ince rtezza, titu banza; cadon le braccia e si spezza la l eva più potente pel successo - la decisione.
Dopo il combattimento i due generali si ritrovano ed occupano una mezz'ora a discorrere del nem ico, dei morti, delle previdibili contingenze ecc. Ciò succede quas i sem~ pre, ed è male . Ogni minuto di ritardo nell'emanare gli ordini grava opprimente sul soldato che si è batttito l'in t era gio rn ata e che avanti notte deve ancora attendere a mille faccende .
Prima ed essenzialissima cura è il riposo e la sicurezza della truppa.
Gli av.ampost i o sono form ati da un distaccamento all'uopo scelto e composto (avanguardia), cvvero vengo n o somministrati dai singoli reggimenti o battaglioni che si trovano a contatto col nemi co. La prima maniera offre maggiore regolarità, compattezza e facilità a diramare gli ordini e quindi maggiore agio di rip osa re alle truppe coperte. La seconda ma nie ra è eccezione pei casi di tal~ vicinanza del nemico da dover passar l a not te colle arrm al piede, mancando ornai vigoria sufficiente di cac~iarlo più lontano. Quanto più vicino il nemico tanto mmore è la quiete notturna.
IN GERMANIA E IN AUSTRIA 4-29
Gli avamposti devono esse re for ti abbastanza da respingere l'attacco di piccole sezioni e da ritardare il procedere delle grosse, fino a che le truppe coperte sieno schierate in posizione opport una. Essi ha nno una sfera di difesa ed una di osservaz ione; non ·si può tracciare un metodo buono per tutti i casi .
Bisogna assegnare agli avamposti il punto di ritirata e, per regola ge nerale, non già in prim a linea, ma in riserva.
Si badi aJla sicurezza dei fian chi; basta per solito occupare i punti principali sen za disseminare le forze pe r copri rsi an gosciosamente dov unque.
L'appoggio reciproco richiede che gli avam posti sieno scaglionati n el senso della profondità. I rapporti devono succedersi con ordine stabile il mattino, al meriggio e la sera, eziandio quando nu lla sia ac caduto di nuovo. Il comandante dell'avanguardia e degli avamposti n el trasmettere informazioni esprime sempre il proprio parere; sul posto si giudica sempre meglio e s i ha sem pre occ asio ne di dare utili suggerimenti. « Il generale maggiore v. Katzl er, l'ideale di un comandante di avanauardia nel 1813 e 14, non mancava mai nei rapporti t> -0.i notare che li aveva compilati egli medesi mo. Quando circostanze eccezionali non pe rm ettevano la sua presenza personale, egli prima di trasmettere la notizia agg iungeva la propria opinione sulla fiducia che poteva meritare ».
La cavalleria, sebbene di rado possa lanci arsi all'inseguimento, pure ha il doppio còmpito di mantenere il con tatto col nemico e di proteggere il collocamento degli avamposti . Al primo còmpito servono piccole pattu glie com and ate da uffic iali intelligenti, i qual i r aggiungendo posti opportuni, attentamente osservano e fedelmente riferiscono . Al secon do còmpito servono gli ~quad ron i irragg ianti sulle peste dell'av versario , ma ritirati du-
&.28
RECENl'T RUBBLICAZfONI DI TATTICA
rante la notte, perchè la cavalleria numerosa non ha al buio verun campo di azione propria (1 ).
La ri partizi one de lle truppe al bivacco deve corrispondere ai progetti che si hanno per l'indomani ed alle esigenze della difensiva. La quale, dal battaglione in su, richiede ordinanza per ala, più conforme all'unità di comando, più pronta al soccorso, più maneggevole, più ordinata.
Una divisione, per poco che il terreno offra qualche appoggio, può assi c urare una zona di circa 3000 passi contro qualsiasi attacco frontale, mentre nell'offensiva, sia pure procrastinante, non conviene si allarghi più di 2000 pas si. È inutile aggiungere come siffatte cifre abbiano soltanto un valore approssimativo.
Ma anche approssimativamente è forse opportuno lo assegnare i limiti di espansione all 'offen siva? Le truppe devono avere largo cam po di evoluzione per evitare le mosse frontali, per manovrare contro i punti deboli, in particolare contro i fianchi, per sfuggire le zone nelle quali grandina la morte, pc~r non ammassarsi sotto il fuoco della difesa, per non soffocare nel ge rme le felici ispirazioni dei comandanti le varie uni tà . Probabilmente il colonnello Verdy, l'avvers ario più deciso de lle regole ri-strettive, il più autorevole ed efficace campione del-
IN GERMANIA K IN AUSTRIA !34 l'autonomia dei singoli ripart i, il più abile consigliere di manovre accorte e prudenti, mira soltanto a combattere l'abuso fatto dai Prussiani nel 1866 e specialmente nel secondo periodo della g uerra 1870-71, di stender troppo le bracci à per afferrar l'avversario e di gettare fin da pri ncipio nella bilancia tutte l e riserve.
A risparmio di tempo (prosegue l'Autore ) gli ordini pel bivacco vengono diramati a voce. Ma poscia tutti gli aiuta nti si radunano presso il capo di stato maggiore, narrano quanto sanno intorno alla parte presa al eombattimento, allo stato ed ai bisogni dei singoli battaglioni e ric evono gli ordini per scritto . Nella conversazione che ha luogo si parla di viveri, di munizion i, di perdite...... la situazione si rischiara, cento cose si rammentano, a cento si provvede; è possibile dar notizie coscienziose e scrivere la relazione.
Il paese atten de impaziente ; bisog n a ben soddisfare al suo legittimo interesse mediante un di spaccio telegrafico.
(4) Ma non sempre conviPne ritirare la ca,•allcria, spinta innanzi alla sera dì una g iornata campale, per rimandarla con grave sp reco di forze po: be ore appresso all 'avanguardia. Racconta il .mlitar-Wochcnblatt (N. 4 8), come dopo la battaglia di Worth la •a divis ione di cavalleria (30 squadr oni e 3 batterie) si fosse per la notte ritirata a Buxwei lcr, lont~no circa 8 chilometri, dopo avere <'On sforzi supremi (70 chilonrntri in 24 ore) raggiunto il contatto col nemico. E molto a proposi to soggiunge: e Ci;n una o due compa gn ie di cacciatori e davanti al fronte del bivacco, accon cio a difesa, si sarebbe potuto • senza pericolo attendere un attacs o, piuttostochè col ritirarsi rinun" tiare ai grandi vantaggi tlcll' i nseguimcoto ,.
E qui due scogli fa d'uop o evitare : il primo di esagerare la portata del s uccesso, il secondo di dar n otizie che possano giovare al nemico. Non si parli di trofei, ·salvo ehe se ne abbia accerta to de visu la conqui sta; non si dia il numero dei morti e feriti, impossibile a calcolarsi la sera di una battaglia; la verità vien presto a galla; si guardi che essa, abba ttendo l'edificio di un brillante -successo, non ecciti diffid enza e quindi disdoro. Il minimo particolare, come la data, il nome di un generale, di un -0orpo, di un paese, può talora servire di faro al nemico. E però le noti zie telegrafiche non so no per norma trasmesse che dal comandante in capo di un esercito o di un corpo operante per conto propri o. I telegrammi delle truppe fra loro vanno sempre scritti in cifra.
Ripristinati gli ordini col concorso ene rgico ed operoso di tutti, bisogna pensare alle munizioni ed ai viveri. I
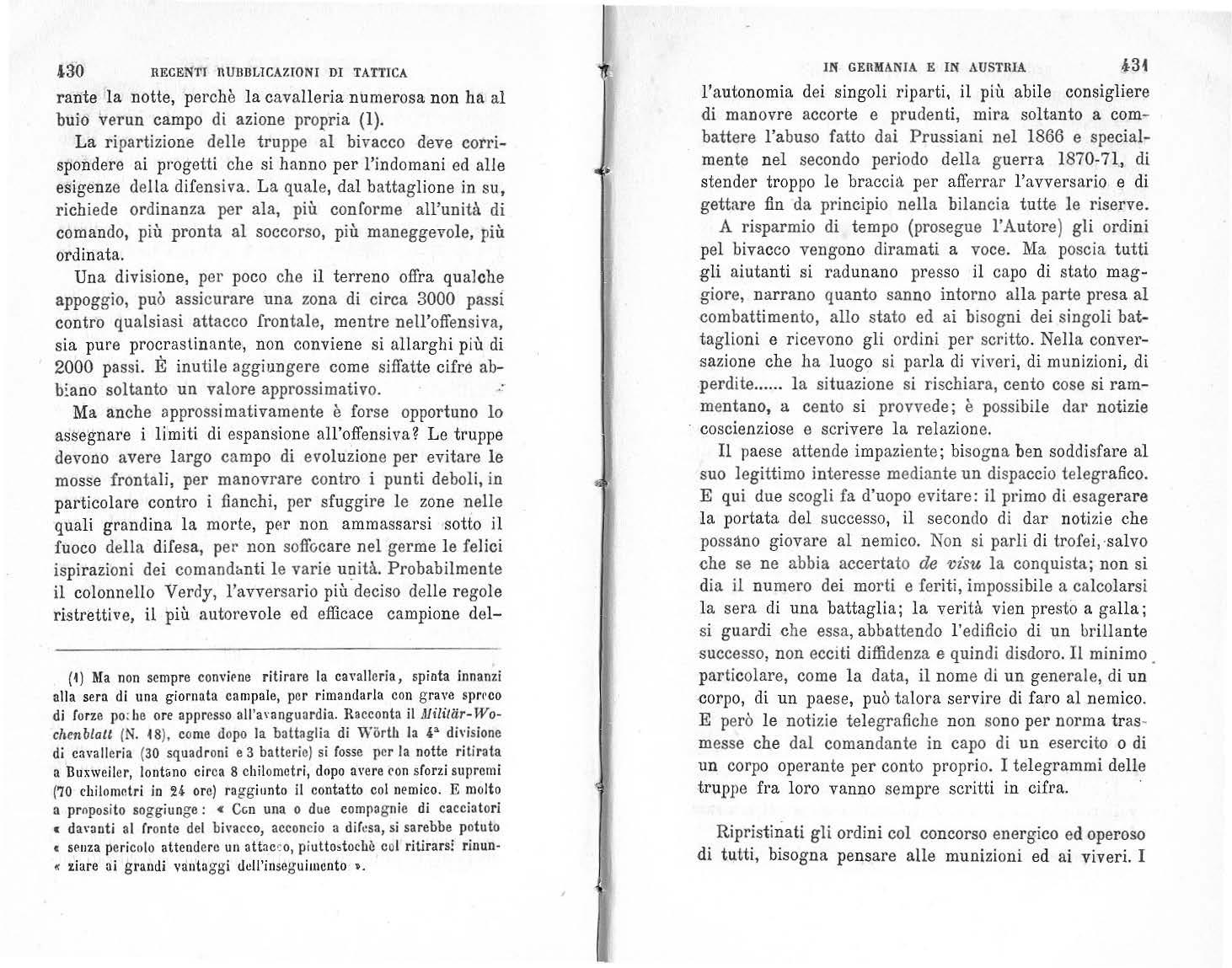
,1.3{)
PUBBLICAZIONI DI TATTICA
carri da cartucce so no possib ilmente riuniti e condotti sotto l a sorvegl ianza de ll'aiutante di reg gime nto. Quantomeno sono isolati, tanto è più facile trovarli e dirigerli. La pulitura e la rivista delle ar mi va fatta appena si può.
L'arti glieria, oltre che dei propri cassoni, dispo ne eziandio di 6 carri da munizione per batteria, ripartiti in due l inee . Quando non bastino, fa mestieri ricorrere alla colonn a cli munizione; è quindi utile avvici nare al possibile il primo scaglione della medesima al campo di battaglia.
Molte cure richiede la distribuzione de i viveri. No n di rado è ta le l a stanchezza, che il soldato si sente mag-· g ior v oglia di gettarsi a terra per riposare di quello che provvedersi di cibo. Spetta agli ufficiali di usare tutta la loro sollecitudine ed aut orevolezza perchè, malgrado l'indol enza apatica ch e segue agli sforz i supremi e malgrado gli infiniti ostacoli materiali, il rancio venga cotto a dov ere .
Sul campo di battaglia sarebb e folli a pensare a re-· quisi zioni: e perciò spesso convien ricorrere alla razione di ris erv a. Il soldato prussiano porta seco per tre giorni lardo, co n serve, riso, sale, caffè e galletta oppure pane . Ma il pane pesa tro ppo; per la galletta si h a grande avversione, la più seve r a disciplina soventi D;On basta a conservare anche una parte della razione. E pertanto indispensabile lo aver sempre alla mano le colonn e di provianda, le quali seg uendo il corpo di esercito so no in grado di arrivare nella no tte a portata delle truppe che si trovano i n testa e di somministrar loro vettovagli e per due giorni.
L'artiglieria tr ae seco foraggi p er tre giorni, la cavall eria per un giorno. A rifornire sono pri ncipalmente destinate l e colonne del parco.
L'esperienza .ha dimostrato la opportunità di assegnare
IN GERMANIA E IN AUSTRIA t 33 ad ogni divisi one due col on ne di provianda ed una col onna di parco. In paese nemico ogni divisione ha eziandio per solito un piccolo parco composto da 40 a 60 vetture, destinato a tr aspor tare i viveri raccolti per via di requ isizion e.
Quando i ;arri arrivano prima di notte ha subito luogo la distribu zione; in caso diverso si prepara t utto per l'alba ve gnente . I buoi so no tosto am mazzati affinchè il sangue abbia tempo di scol are, vuoi dai mace llai delle sussistenze, vuoi da soldati all'uopo comandati . I carri vuoti, quando non servano al trasporto dei feriti, rit ornano ai magazzini mo bili. Ogni giorno l'intendente fa il suo rapporto sulla quantità e qualità delle provvisioni e sui mezzi di rifornirle.
Ogni qual volta le circostanze lo permettono bisogna r icovrare le truppe al coperto, cosa tuttavia assai malagevole alla sera di una g iornata campal e. Dovendo bivaccare si sfuggano i prati, perchè umidi e malsani; ci cerchi terreno inclin ato e co perto dai venti; si permetta di costru rre capannucci e di frasc he ad ese mpio degli Austriaci ne l 1866; si scelgano gli orli dei bos chi , n ei quali, ad evitare disperdimenti, si segnino i limiti del bivacco con un a strada, una siepe, una rad ura, un solco d'acqua ecc.
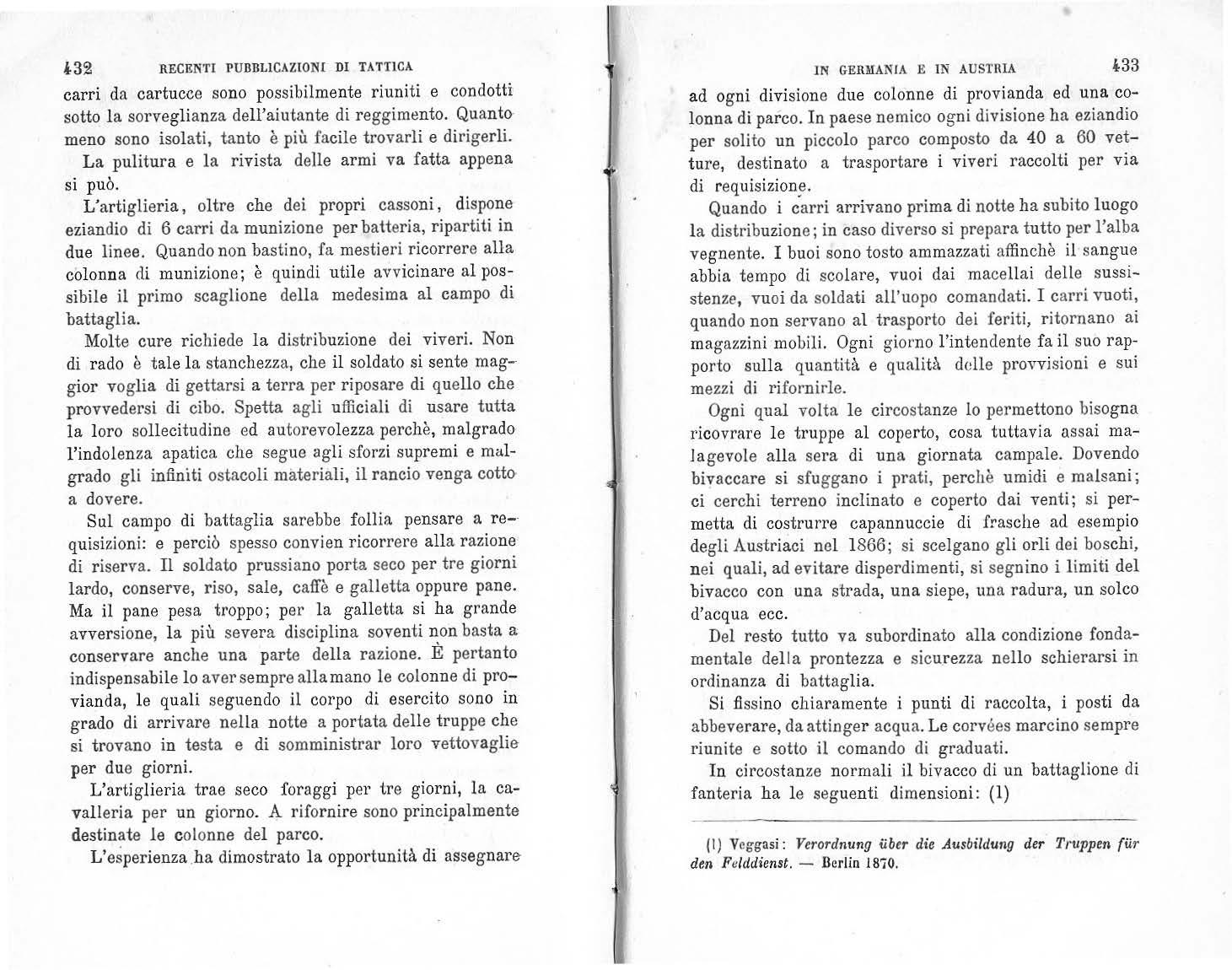
Del resto tutto va subordinato alla condizione fondamentale della prontezza e sicu re zza nello schierarsi in ordinanza di battaglia.
Si fissin o chi aramente i pu nti di racco lta, i posti da abbeverare, da attinge r acqua . Le corvées marcino sempr e riunite e sotto il comando di graduati.
In circost anze normali il bivacco di un battaglione di fanteria ha le seg uenti dimensioni: (1)
43~ RECENTI
{1) Vcggas i: Vcrordnung uber die Ausbildung der Truppen fur den F elddienst. - Dcrlin 1870.
RECENTI l'UBBLICAZlONl DI TAT'flCA
Fronte: 6 plotoni.
Profondità: piazza d'allarmi .
Dalla guardia della bandiera ai fasci
In Prussia il battaglione bivacca ordinariamente in colonna sul centro (il mezzo battaglione di destra formato in colo nna sulla compagnia o sul plotone di sinistra, il mezzo battaglione di sin istra formato in colonna sulla compagnia o sul plotone di destra); ma spesso per adattarsi al terreno, segnatamente nei boschi, si bivacca in linea di colonne di compagnia. Del pari variabile se·cond0 il terreno e la direzione del vento è il collocamento delle cucine e delle latrine; quando la truppa sia costretta a · bivaccare sopra parecchie schiere, fa d'uopo stabilire le seconde lateralmente , ovvero dietro l'ultima schiera.
Primo requisito per l'accampamento dell'artiglieria si è libero campo a fine di poter lestamente prendere posizione.
Parecchie pagine sono consacrate all'operosità del corpo sanitario durante e dopo il combattimento. Spetta al comandante l e truppe indicare l a direzione ai diversi distaccamenti sanitari ed i posti per le ambulanze parziali in collegamento coll'ambulanza generale. Soltanto egli trovasi in grado di prevedere approssimativamente verso qual punto l'offensiva possa spiegarsi con magg iore vigore e la difensiva essere più ostinata. Nel caso di mancanza di ordini provvede il medico capo, il qua le deve a tempo
IN GERMANIA E IN AUSTRIA 435 ricevere indicazioni dai . comandanti le tr.uppe ~d aiuto di carri, paglia ecc. dall'intendenza.
Incominciato il combattimento i feriti afiluiscono alle ambulanze; tutti domandano cure immediate e pronto .soccorso; ma non tutti sono egualmente aggravati, ma non· per tutti le fasciature, le amputazioni, le estrazioni di proietti sono in egual grado ind ispensabili; a distinguere l'urgenza occorre tempo e calma.
Val meglio che la pri ma visita si faccia altrove, presso la truppa com battente, dove le cure più pronte sono non di rado le più efficaci; e però si lasci ai battaglioni metà del loro personale sanitario.
Ad ogni modo la ·bisogna alle ambulanze è per solito tale da richiedere . la massima concentrazione di medici; i quali per accorrer lesti dalle schiere successive e dalle trup pe non impegnate, conservando le forze fisiche per la loro delicata missione, dovrebbero essere provvisti di cavallo.
Il medico di divisione assume la direzione dell'ambulan za generale e divide il suo personale in tl'e sezioni: la prima sezione riceve gli infermi, li colloca a posto e ne esamina le ferite; .la seconda si- occupa delle fasciature malagevoli e lunghe; la terza procede alle grandi ed indispensabili operazioni chirurgiche. Alla tarda sera il medico capo scrive il suo rapporto.
Sopra questo e sopra gli altri rapporti, sopra le cose vedute ed accertate, l'ufficiale di stato maggiore (capo di stato maggiore) compila il progetto di relazione da pre.sentare alla firma del generale.
L'Autore, che nu lla dimentica, ci offre un modello ingegnoso di codesta relazione, la quale ha importanza storica capitale, perchè base di tutte le narrazioni avvenire. Cura singolare si richiede quindi per imprimere ad essa il carattere della verità, per sfuggire ogni artifizio oratorio, ogni ass erzione men che esatta, ogni

i3.i,
delle compagnie Distanza :fino ai carri Carri . Fino alle cucine . Fino alle latrine . 50 passi 10 > 125 » 20 » 15 » 40 » 100 » 'l'otale 360 pass·i
Profondità
PUBBLICAZIONI DI TATTICA ECC. velo troppo pietoso alle debo l ezze od errori. Si lascino i particolari che molte volte sono trasfigurati o si contraddicono, si proceda guardinghi nel dare le cifre dei morti e feriti, non s'infiori la narrazione con elogi esagerati, con frasi oratorie; si indichi l'ora dei fatti, al qual uopo conviene prima dell'azione darne speciale incarico ad un ufficiale; si scrivano colla maggior precisione gli ordini ricevuti od emanati a voce . Si badi infine che tempo e spazio sul campo di battaglia nell'immaginazione umana assumono forme e grandezze ben diverse dall e reàli.
RIVISTA BIBLIOGRAFICA
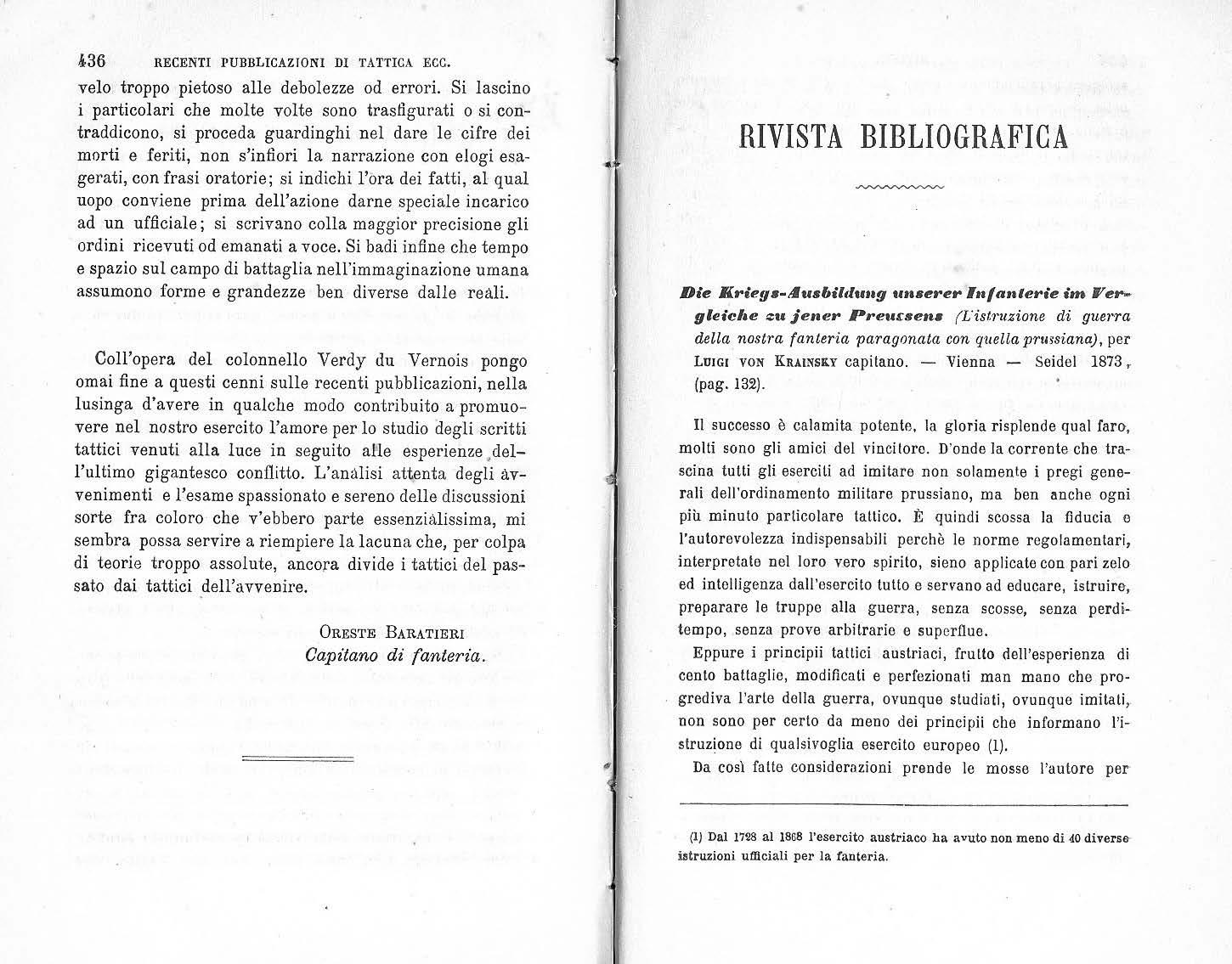
Coll'opera del col onnello Verdy ùu Vernois pongo ornai fine a questi cenni sulle recenti pubbl icazioni, nella lusinga d'avere in qualche modo contribuito a promuovere nel nostro esercito l'amore per lo studio degli scritti tattici venuti alla luce in seguito aHe esperienze , dell'ultimo gigantesco confl itto. L'analisi attenta degli àvvenimenti e l'esame spassionato e sereno delle discussioni sorte fra coloro che v'eb bero parte essenziàlissima, mi sembra possa servire a riempiere la lacuna che, per colpa di teorie troppo asso l ute, ancora divide i tattici del passato dai tattici dell'avvenire.
ORESTE BARATIERI Capitano di fanteria.
IJie H.rieg•-4uabiltltmg tm•erer 111/materie im Fer-gleicl,e ::u jener Preu1.11e1t• (Distruzione di guerra della nostra fanteria paragonata con q11ella prussiana), per LUIGI VON KRA.INSK.Y capitano . - Vienna - Seidel 1873, (pag. 132) .
li successo è calamita potente, la gloria risplende qual faro , molti sono gli amici del vinci lorc. D'onde la corrente che trascina tutti gli eserciti ad imitare non solamente i pregi generali dell'ordinamento mi litare prussiano, ma ben anche ogni più minuto parlicolare tattico. È quindi scossa la fiducia e l'autorevo lezza indispensabili pcrchè le norme rego lamentari, interpretate n el loro vero spirito, sìeno applicate con pari zelo ed intelligenza dall'esercito tutto e servano ad educare, istruire, preparare le truppe alla guerra, senza scosse, senza perd itempo, senza prove arbitrarie e superflue.
Eppure i principi i tattici austriaci, frutto dell'esperienza di cento battaglie, modificali e perfezionali man mano che progrediva l'arte della guerra, ovunque studiati, ovunque imitati, non sono per certo da meno dei principii che informano l'istruzione di qualsivoglia esercito europeo (1).
Da cos\ fatte considerazioni prende le mosse l'au to re per
(1) Dal 1728 al 1868 l'esercito austriaco ha avuto non meno di dO diver.s & illtruzioni ufficiali per la fanteria .
436
RECENTI
svolgere pa rall elamen to i punti sali en ti dollEI norme co nten ule n P. lle dive rse istruzioni austriache o prussiane . L'impresa non ò fac il e. Differenze ess enziali, come l'ordinanza su due o su tr e righ e, le divi sioni de lla materia, lo svariato sviluppo delle diverse parti, oppongono ostacoli pe r evi taro i quali si richied o tutt a la des trezza ed abil ità che possiede il capitono Krainsky. Il quale non si contenta già del semplice paragone, ma svolge le s ue id ee, le corrobora con esempi storici e coll 'autorità dei migliori scrittori e dimostra co me il regolamento aus tri aco del 1869 cor,ri spond a interam ente alle nuove condi,zioni imposte alla tattica della fanteria dall'accresciuta potenza dell9 armi e ,-dalla mo difi cata organizzazion e degli eserciti.
Infatti questo regolamento ad ogni piè sospinto inculca larga ap pl icazi one dell 'ord ine spa r so, sosten uto, ri nvigorito, collegato allo spalle da riparli successiva mente in grossan ti in ordino chiuso; all'ord ino sparso esso consacra 100 pagin e, mentre il r egolamento prussiano non ve ne a ssegna che 35.
A tale proposito ci sia permesso osse r vare come i migliori scrillori di la lli ca austriaci (1) bramino magg iore semplicità , la quale anzich è r estringere allargherebbe il campo del combaLlìmento a ba nde , lasciando maggiore libertà ai comandanti dei siDgoli riparti. Appoggiati ai medesimi scrittori, i quali in sistono nel do ma ndar e l'adozione di farn e poche e buone ed il rigetto di parecchio o supe r flue, non possiamo similmente dividere l'nllra asserzione - possede r e il re gol amento austriaco con 550 pagine me no for me del prussiano che no ha 235, Ma lo spazio ci vieta di seg uire passo pass o l'nutore in un argo, mento d el resto già trattato in questo periodico dal punto di vista italia no (2).
BIB LIOGRAFICA .f-39
All'esam e dei regolamenti . si vengono intrecciando digressioni affi ni, le quali contribu iscono a dare un 'iJ~a completa sulla tattica delle d ue fantni c.
Notevolissimo è il r e~critlo del Ministro dell a guerra generale J:..:uhn per le eserc itaz ioni del 1869. Intorossanto è :I parallelo fra i due mo,ii dl ad des tr amento pel tiro; mollo istruttive le descrizioni delle r ece nti manovro al campo di nruck , dello quali ha g ià. parlalo la nostra « Crorrnca militar e esl1ffa >; molto profittevoli le acconcie osservazioni, i molteplici appunti, le svariato notizie che se rvono non solo a collegar e ed a rannodare lo parli staccato ma ezia udio a daro colore , vita, br io ad una materia per so stessa abbastanza arida .
Forse rimane semp re qualche slogat ura; inco-nveniente ben lieve in paragono alla ricca cop ia di utili cognizioni ch e offre il libro, compilato con molta cura da ch i trovandosi comandato presso il Ministero della guerra di Vi e nna, megli o di ogoi altro era in grado di knersi al corrente di tull e le ques ti oni cbe con ablìondanza dic iamo pur so verchia hanno i nvaso il cam po tattico.
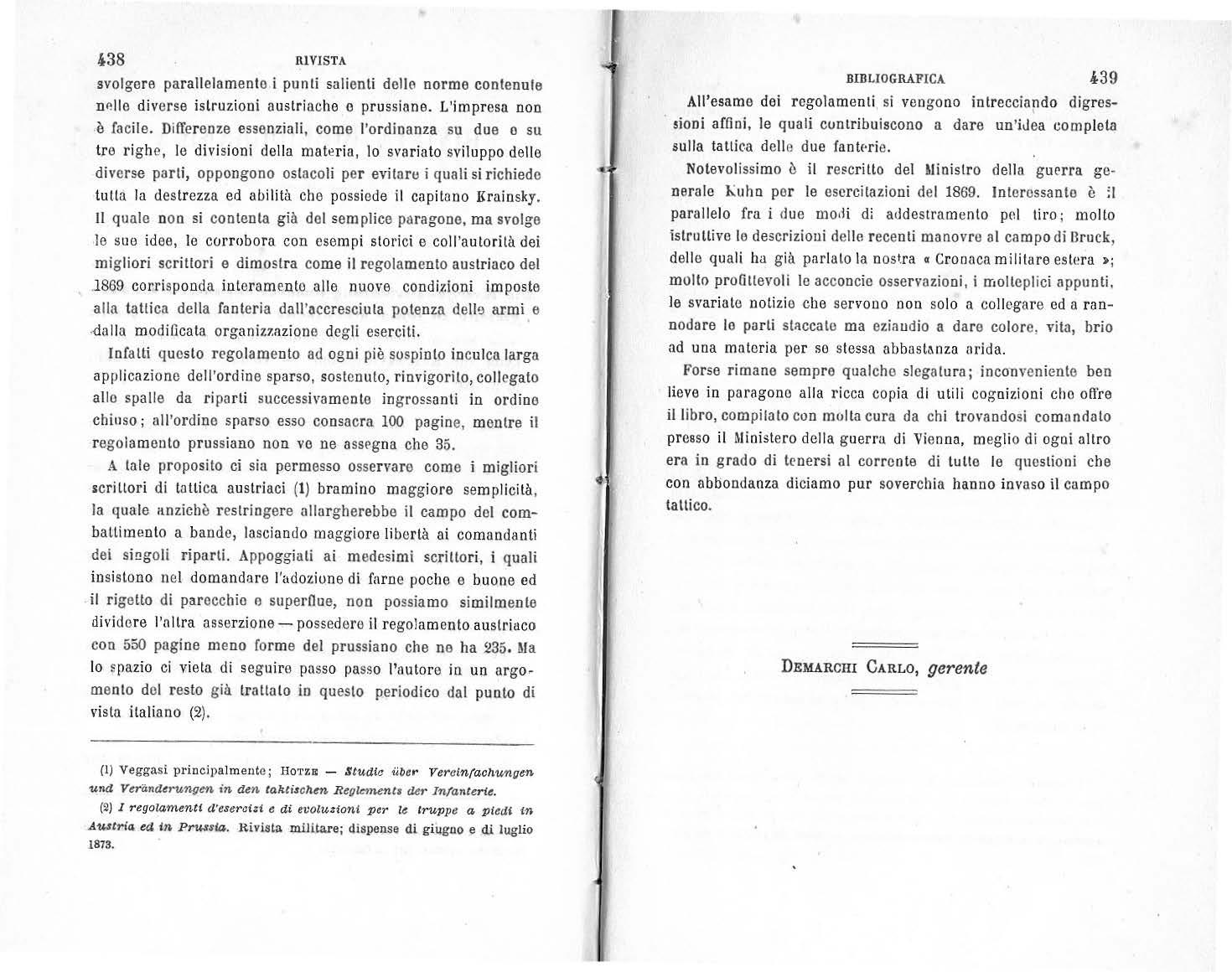
DEMARCHI
CARLO, gerente
(
!) Veggasi principalmente; HOTZB - S tuàtc «ber Ver etn(achu ngen u nà Vero11aerungen in de n tahtischen Reoletnents cler Jn(anter~.
(2) I regolamenti d'eserci: i e di evoluziont per l e trupp e a piedi 111 Austria ed In Prussia. Rivista militare; dispense di giugno e <li luglio 1873.
U8 RMHA
Gennaio.
' L'Esercito italia no nel 4873 - K. . . . . . . . . Pag. 5
Paralello del! artiglieria da campagna italiana con quella delle principali potenze -Gozzi GOFFREDO, capitano d'artiglieria > 20
Il nuovo rego lamento di serviz io per l'esercito austro-ungherese
Il nuovo regolamento di esercizi per la cavalleria prussiana (continuazione e fine) - l\lARZl!LB B I ANCHI D'ADDA, tenente di cavalleria
Al cune idee sul modo di misurare l'efficacia del fuoco delle truppe
Febbraio
Paraielio dell'arti0licria da campagna italiana con quella delle princ ipali potenze (c ont. e fine) - Gozzi GOFFREDO, capitano d'artiglieria . . . . . . . . . • • . Pag. rn9
Degli ordini da combattimento - Ordini un i ti ed ordini separati -G· V RNii'iI, tenente n el 73' fanteria > 158

Co nsiderazioni s ulle proposte di ampliamento, conse r vazione o spi ana men to delle fortificazioni di Verona - E. PAGANO, maggiore del genio . . . . . . . . . . . . . > 486
Della leva sui nati nell'anno 4852 e delle vicende dell'esercito ita lia no da l ~· ottobre ,1872 al 30 settembre 4873 . . » 240
Recenti pubblicazioni di Tattica in Germania e in Austria - VI e Vll - 01\BSTB BARATIERI, capitano di fanteria i> 254
INDICE DEL TOMO I ANNO XIX
-
44 Del
. . . . . . . . . . . . . . > 67
ORESTE BARATJBRI, ccpitano di fanteria • . • »
fulmicotone e del le dinamiti (cont. e fine) - C. ConVBTTI, tenente d' artiglieria
. . . . • . . . . . . . . . . » 400
.
fanteria - C. R. » 441 Rivista bibliografica . . . . . . . . . . . . . . • 429
di
.
Rivista bibliografica . . . . . . . . . . . . » 275
Alcune considerazioni sulla tatt icà delle batterie coi nuovi cannoni rigati da campagna - ENRICO CAmE, capitano d' artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 283
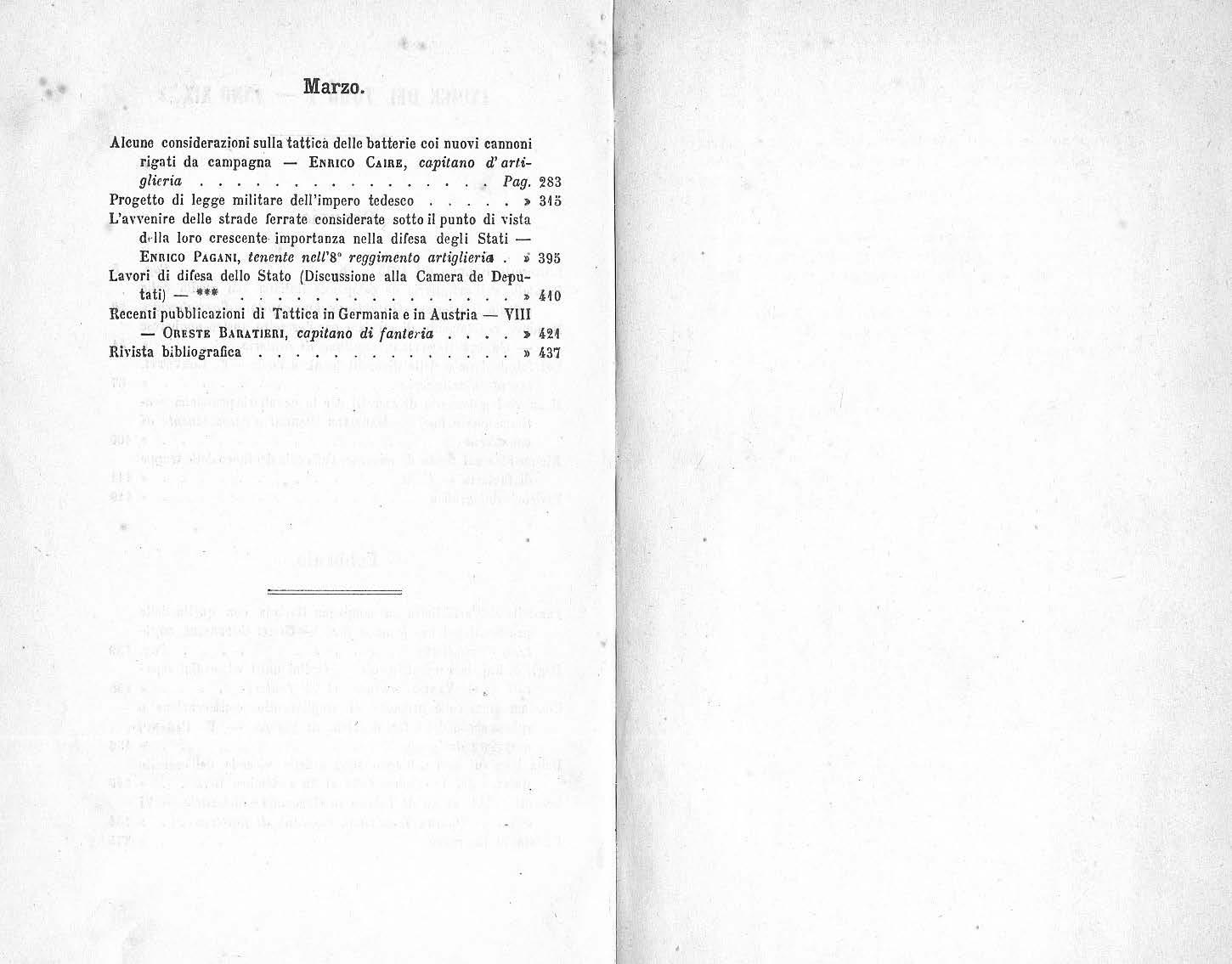
Progetto di legge militare dell'impero tedesco . . . . . > 3~5
L'a\'venire delle strade ferrate considerate sotto il punto di ,·ista d,·lla loro crescente importanza nella difesa degli StatiENn1co PAG,INI, tenente nclt's• reggimento artiglieria . » 395
Lavori di difesa dello Stato (D iscuss io ne alla Camera de Depu. tatiJ - "'*" . . . . . . . . . . . . . . . :.
Recenti pub blicaz ioni di Tattica in Germania e in Austria - Vlll
- ORESTE B.rnATIBRI, capit ano di fanteria > 42~ RMsta blbliografica . . . . . . . . . . . . . . » 437
Marzo.
,rn
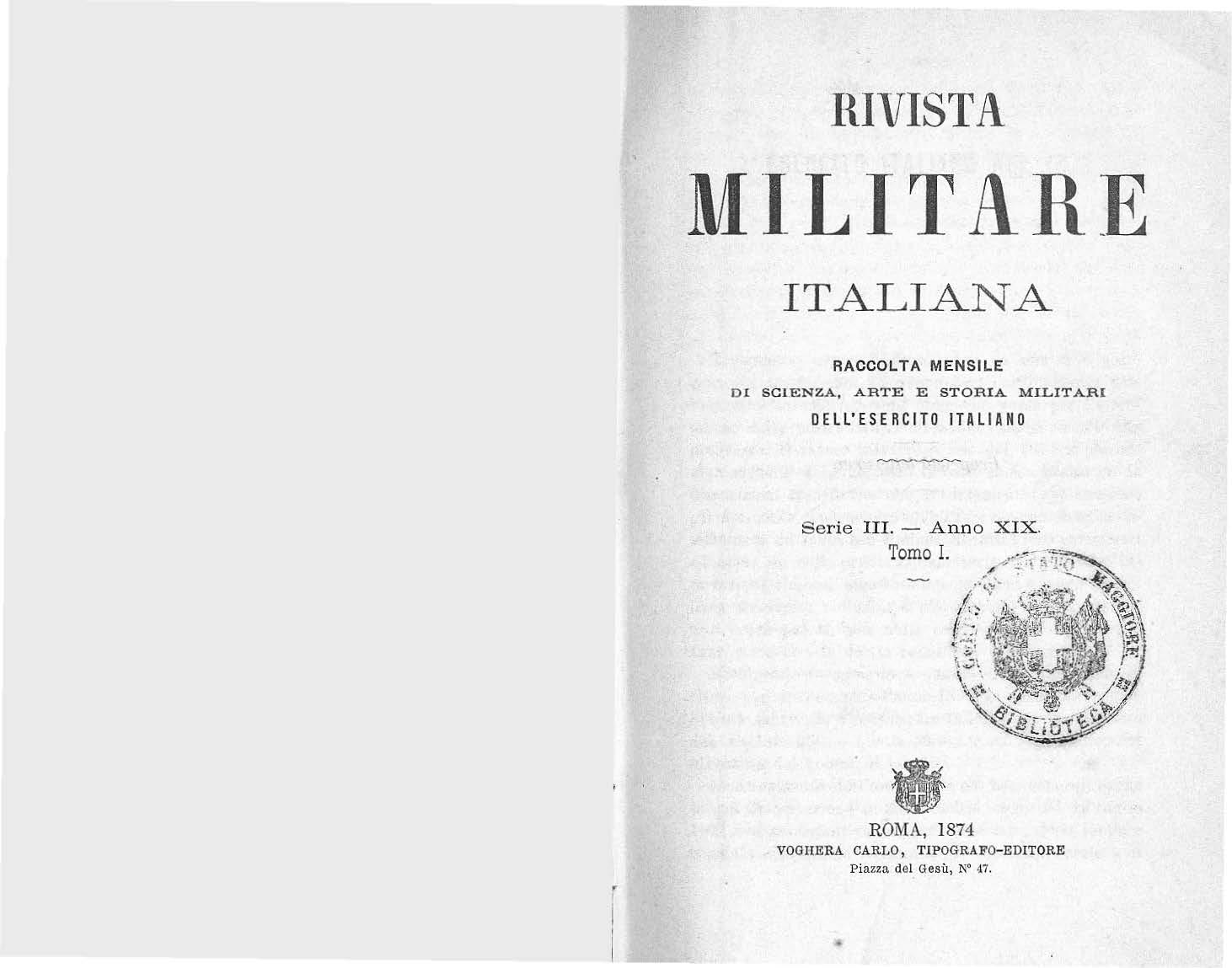
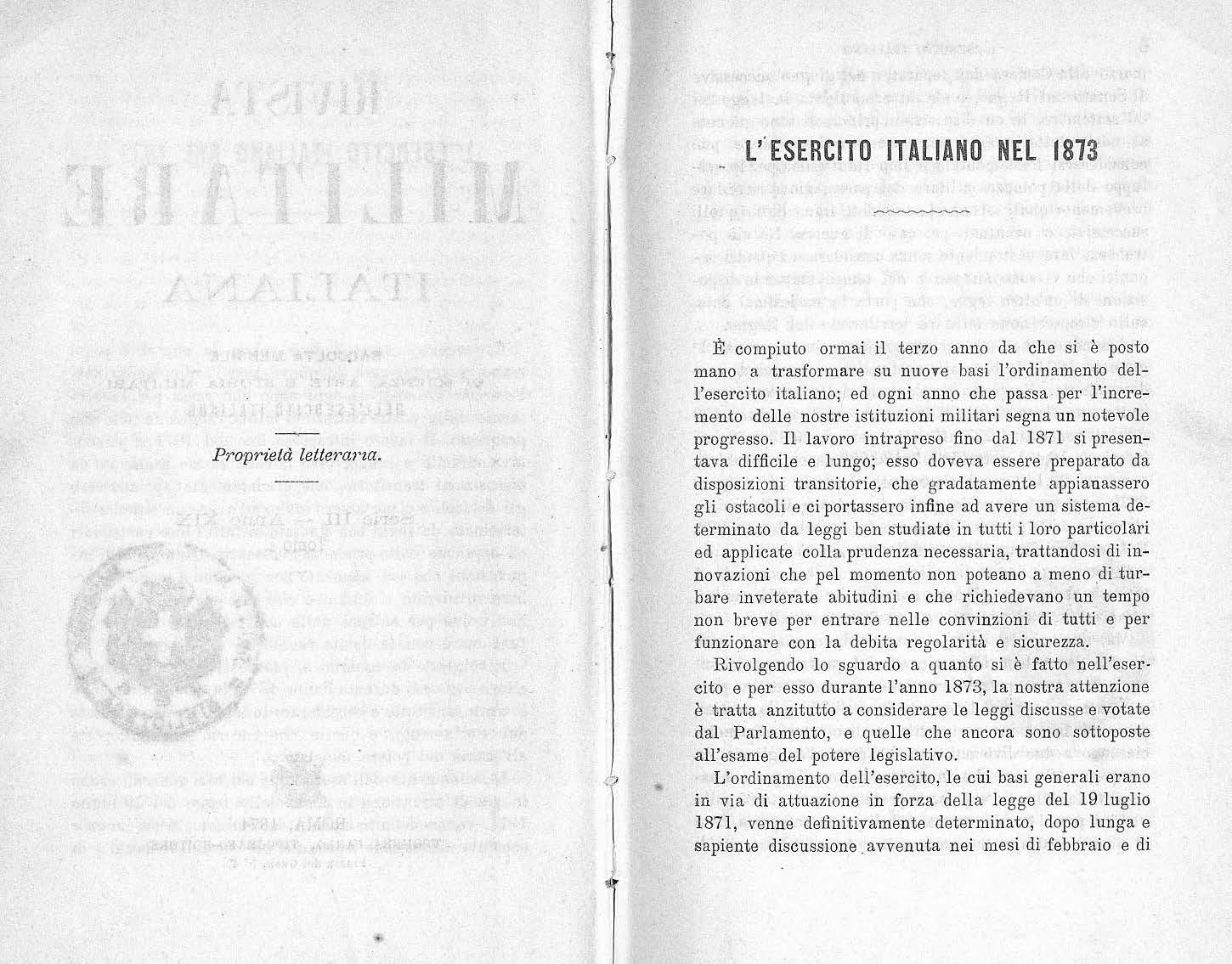



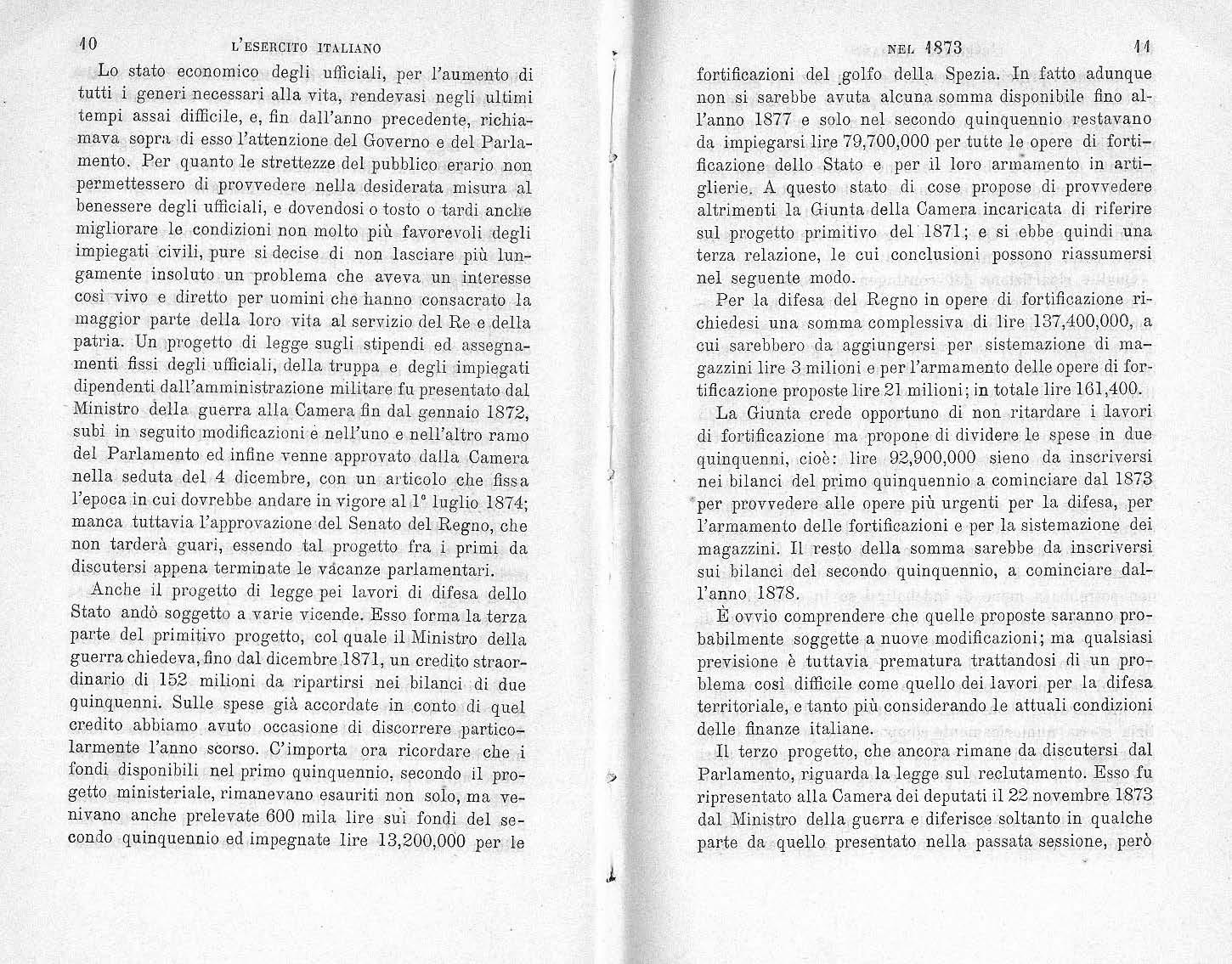


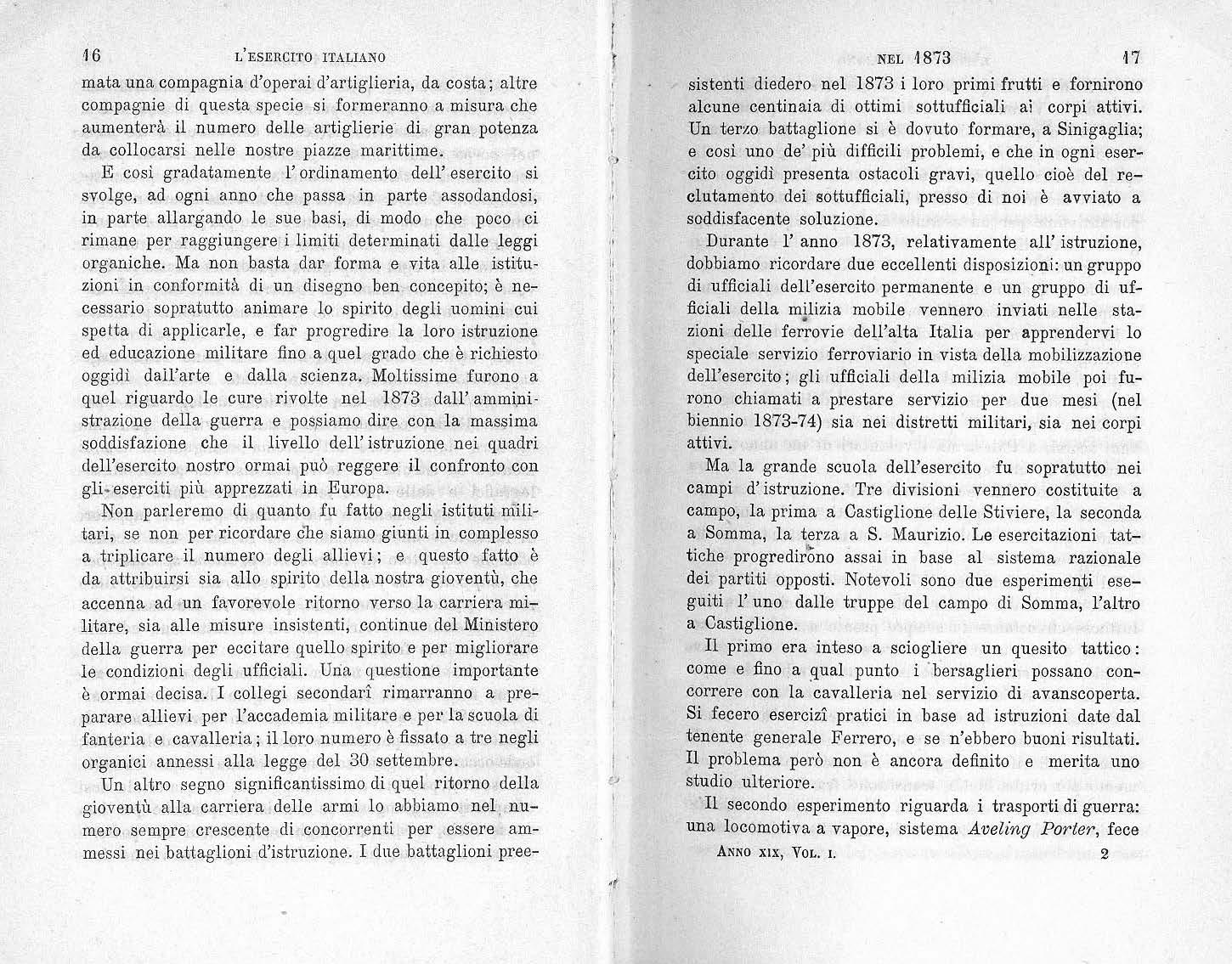


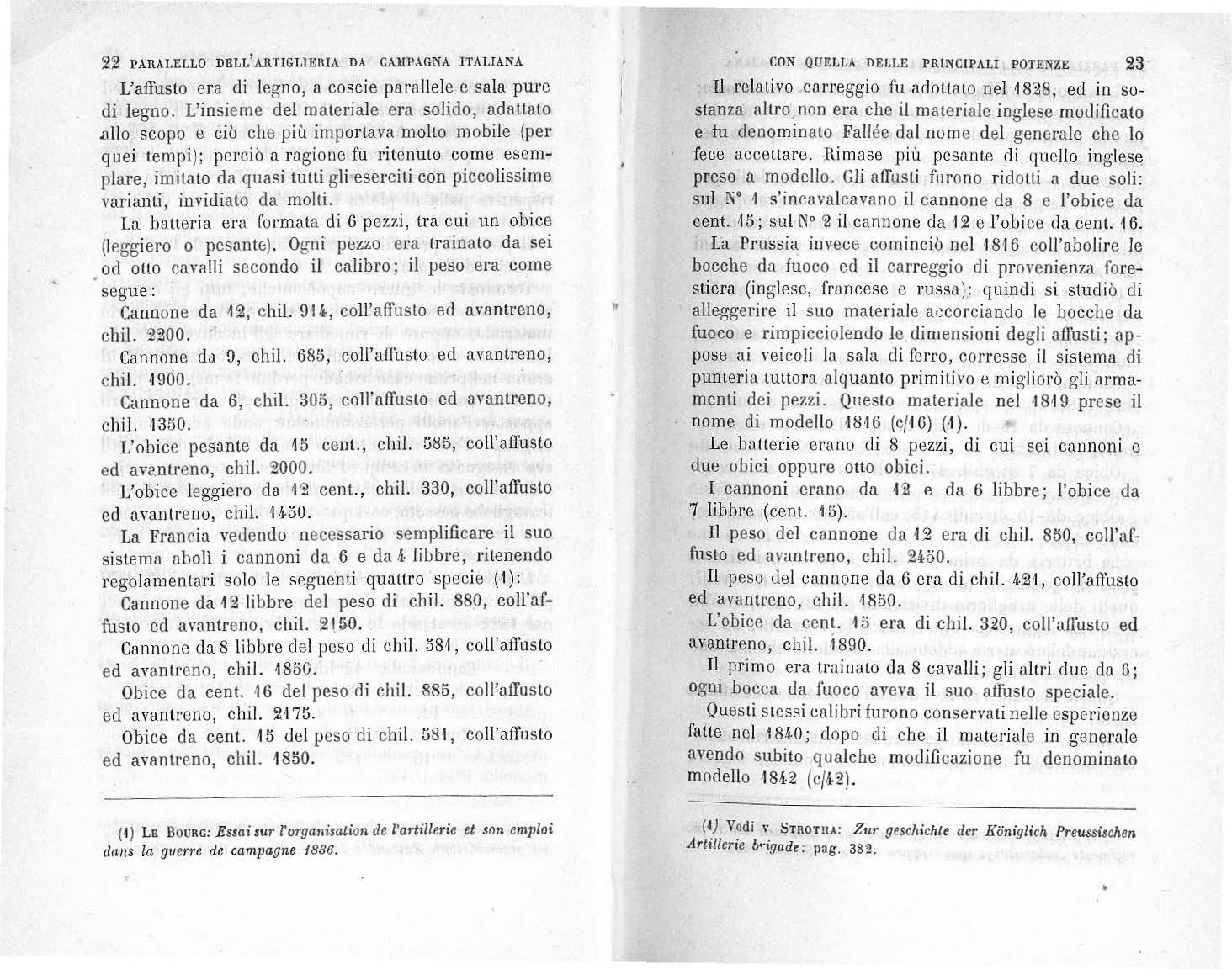

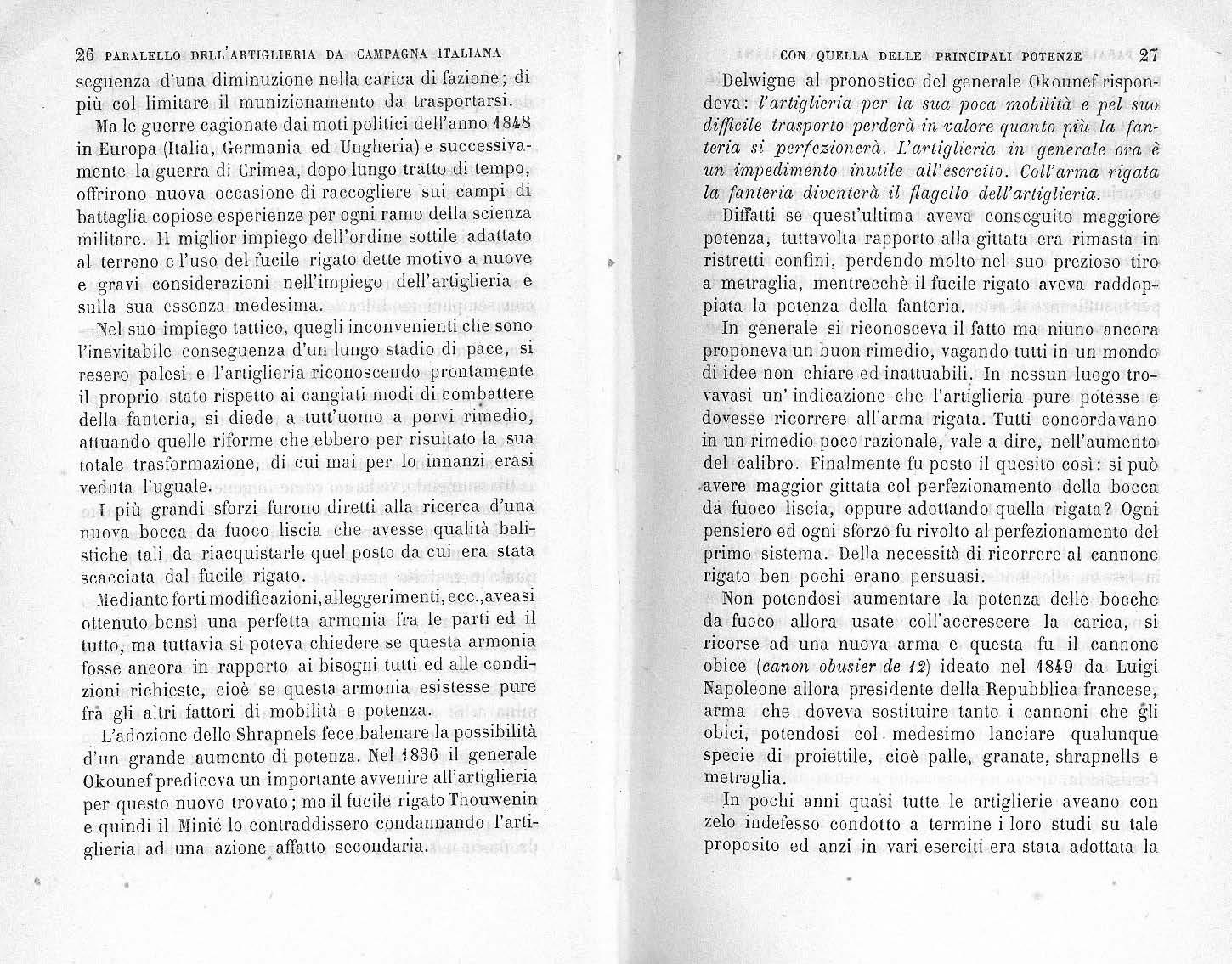
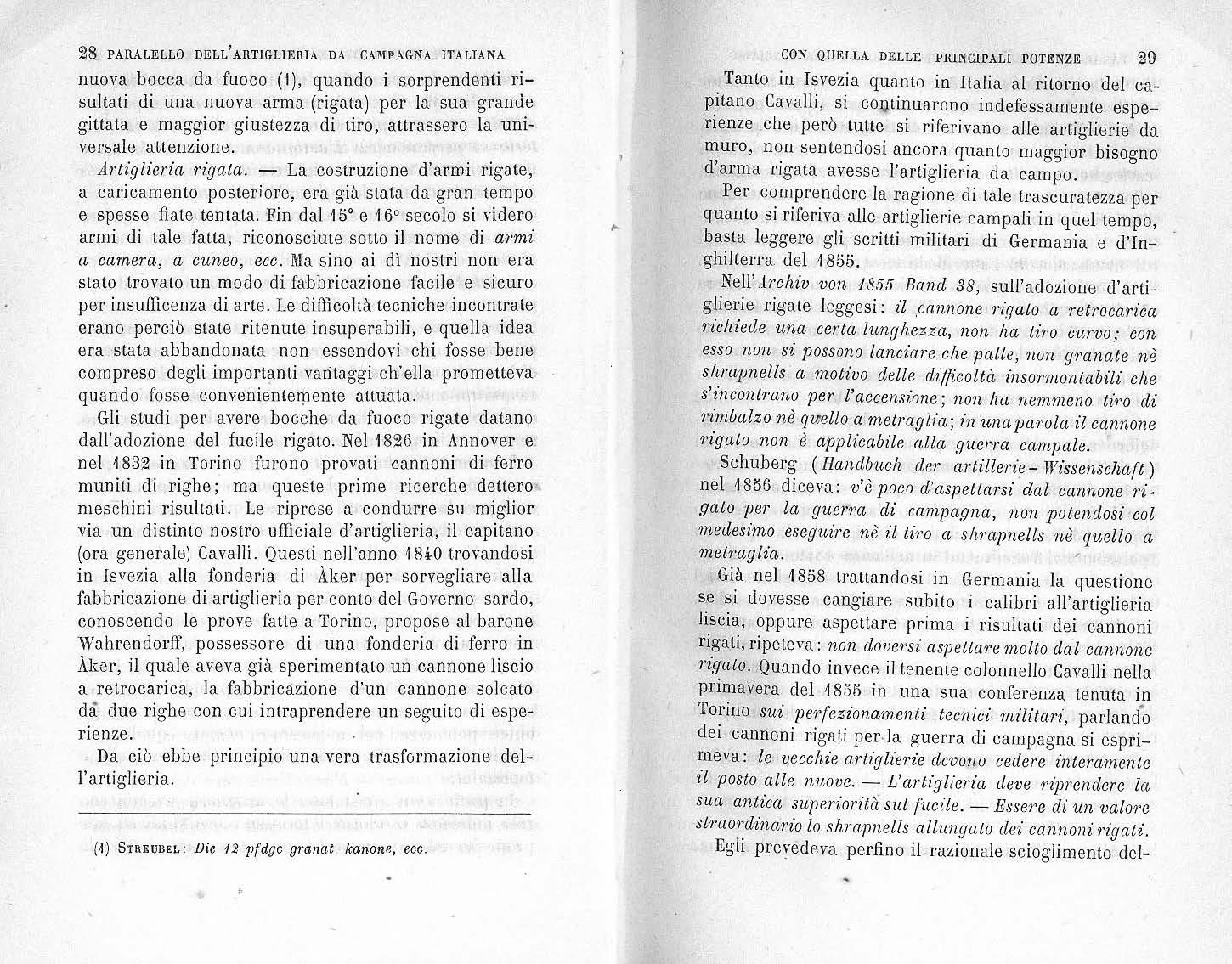
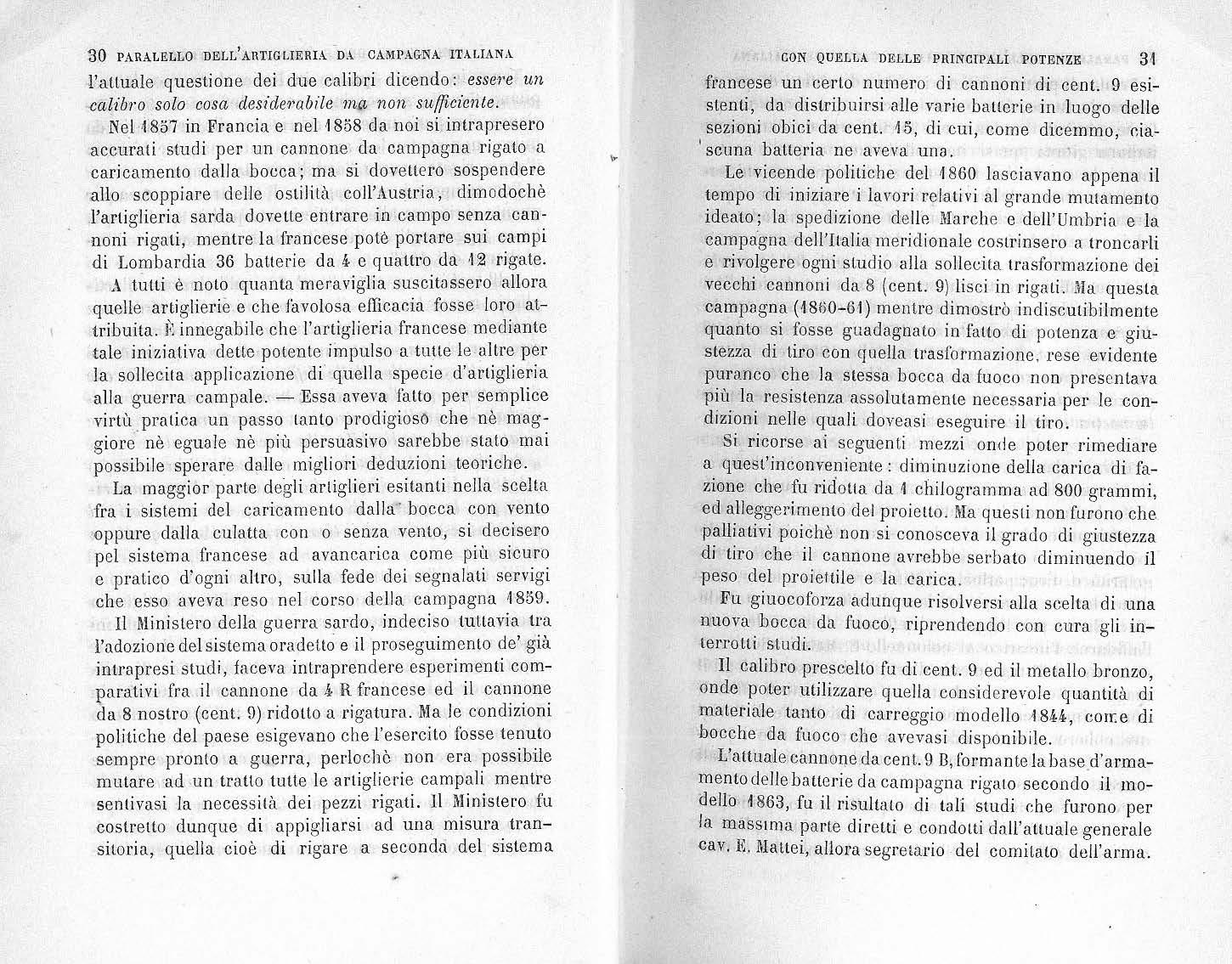
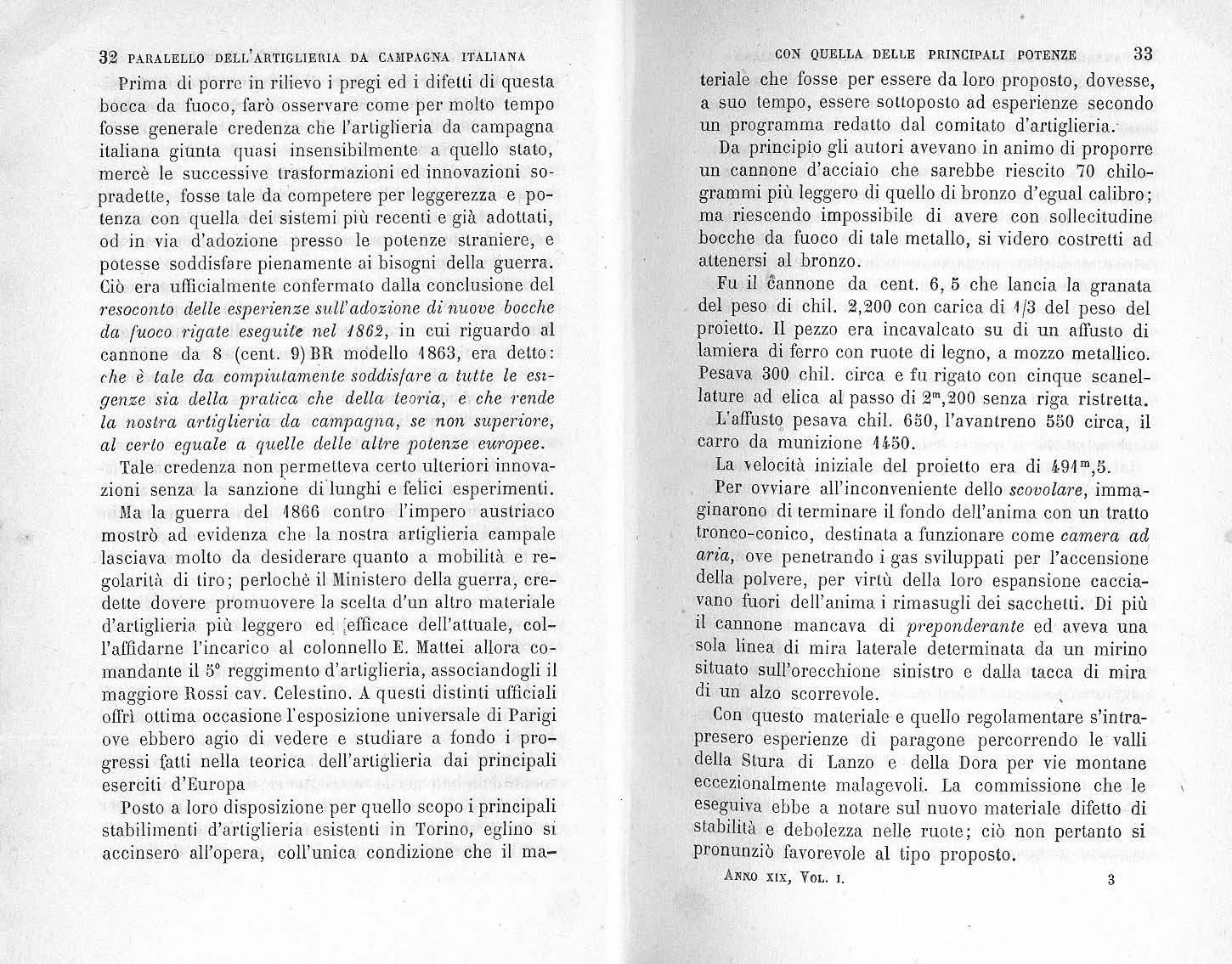
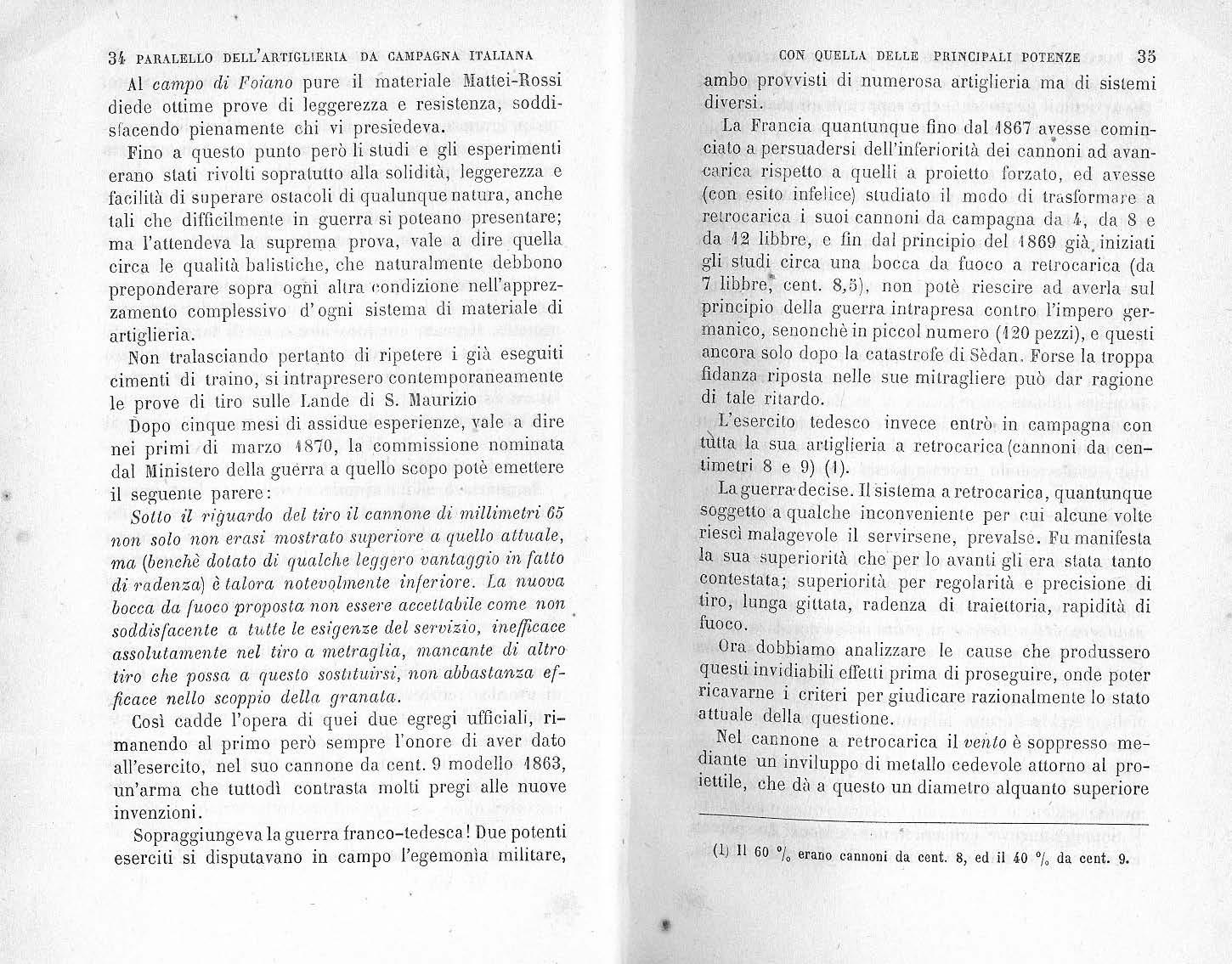
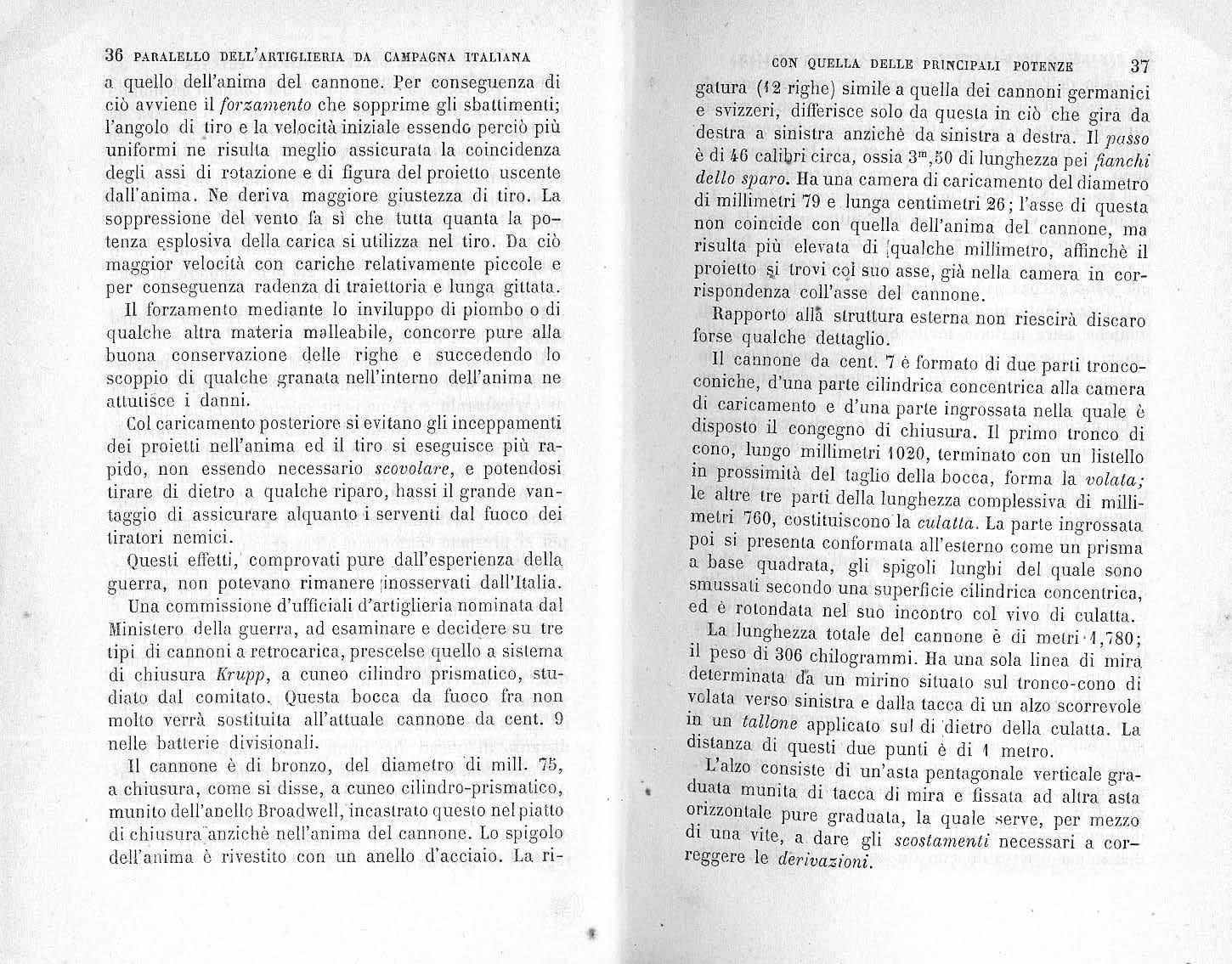
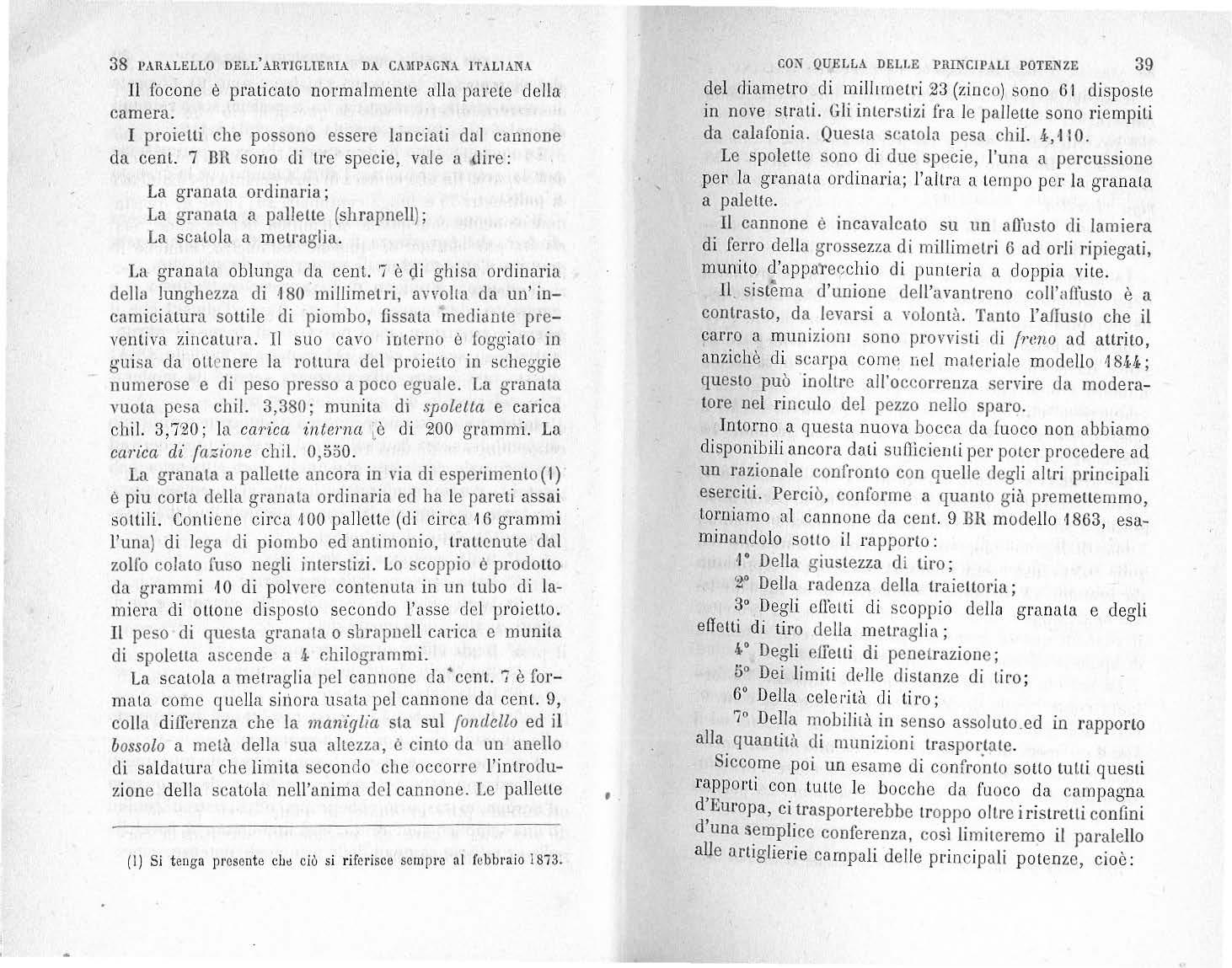
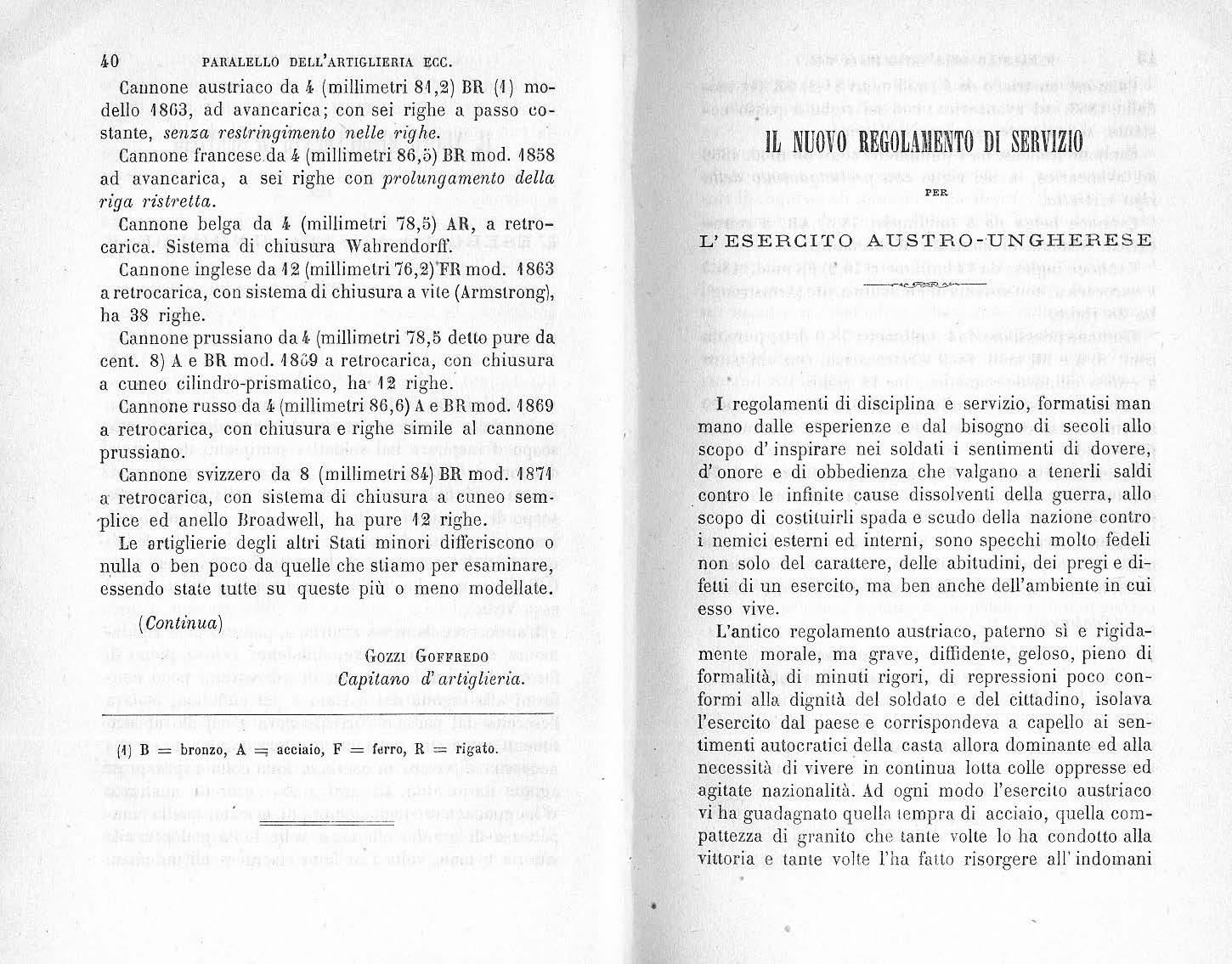
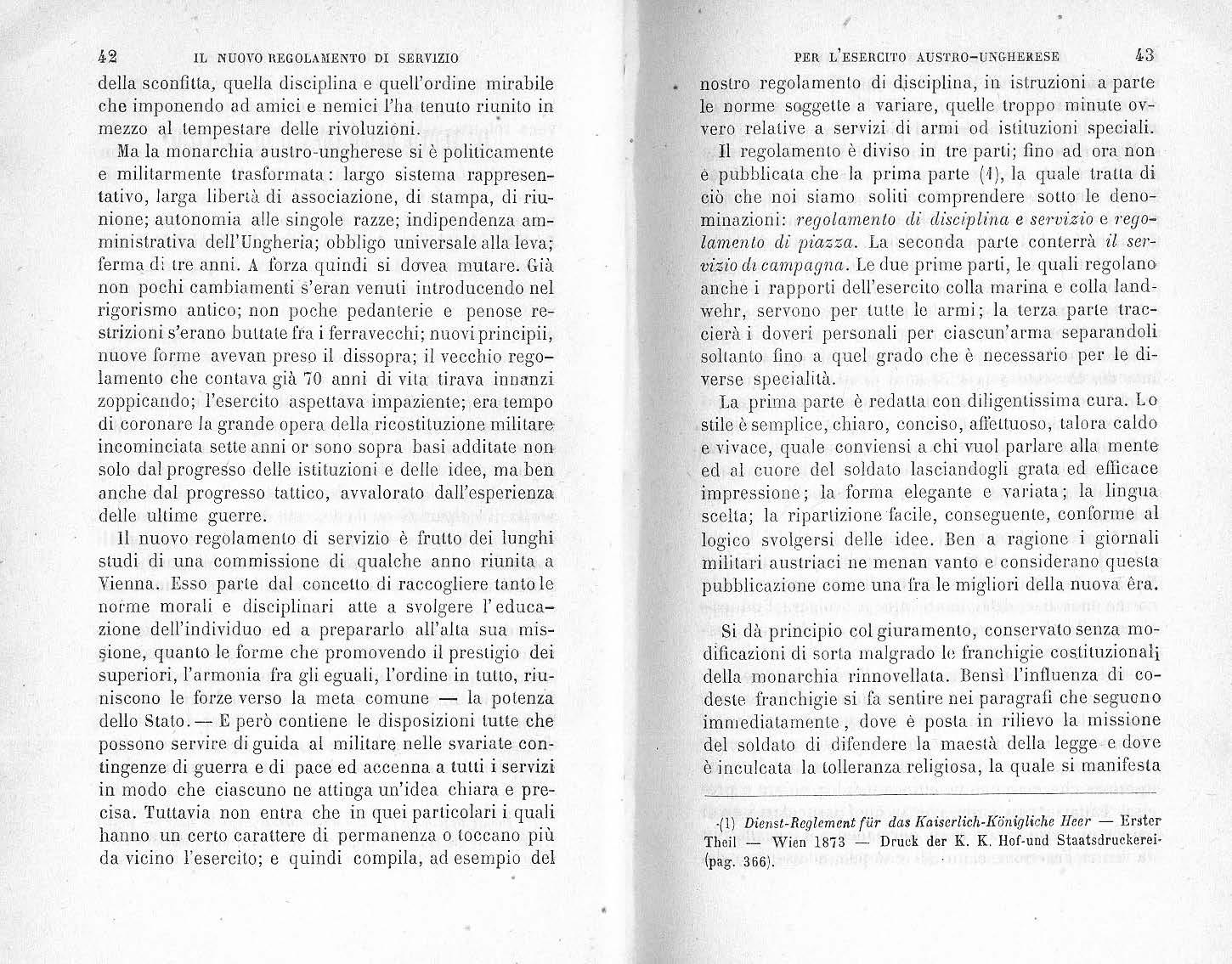


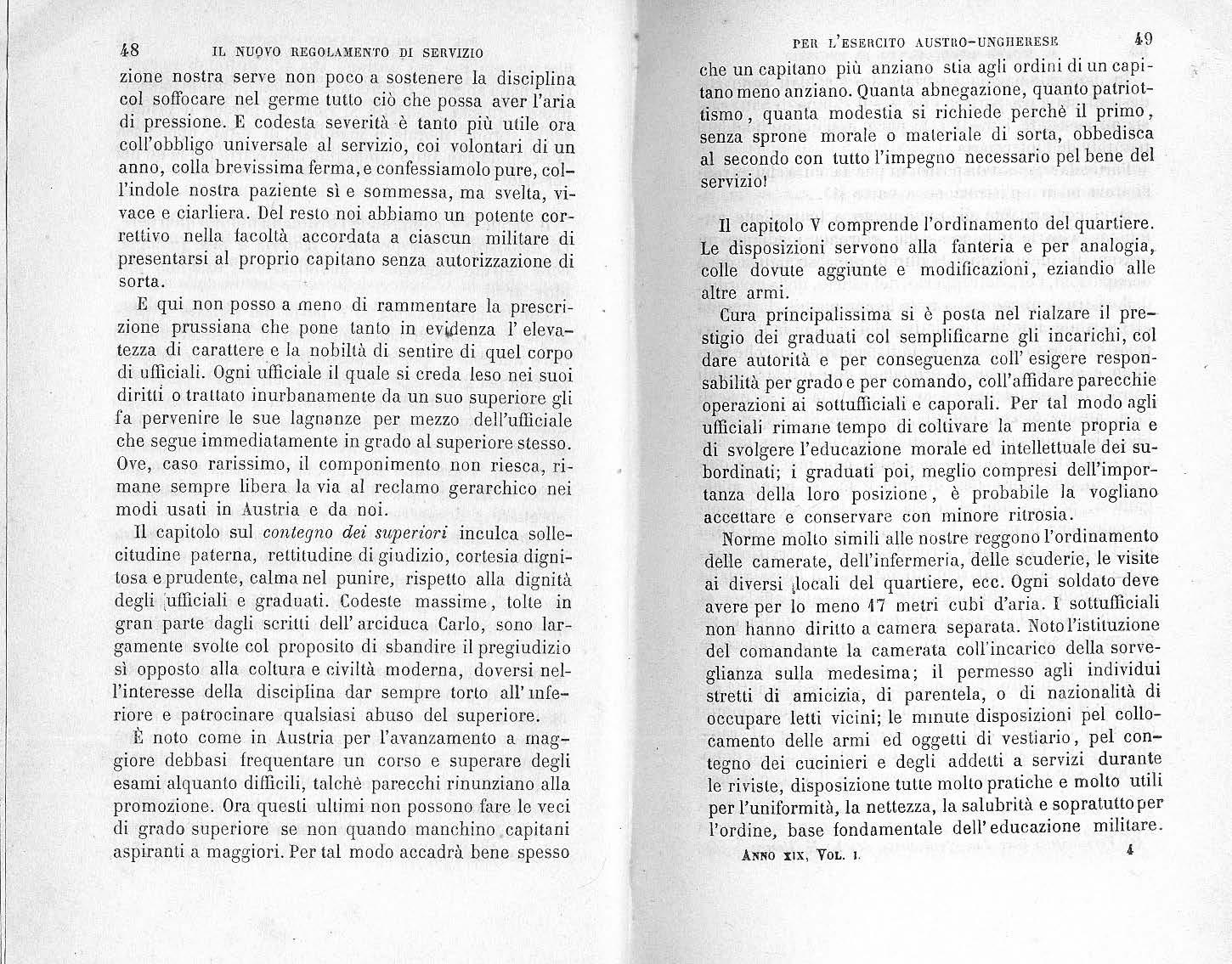

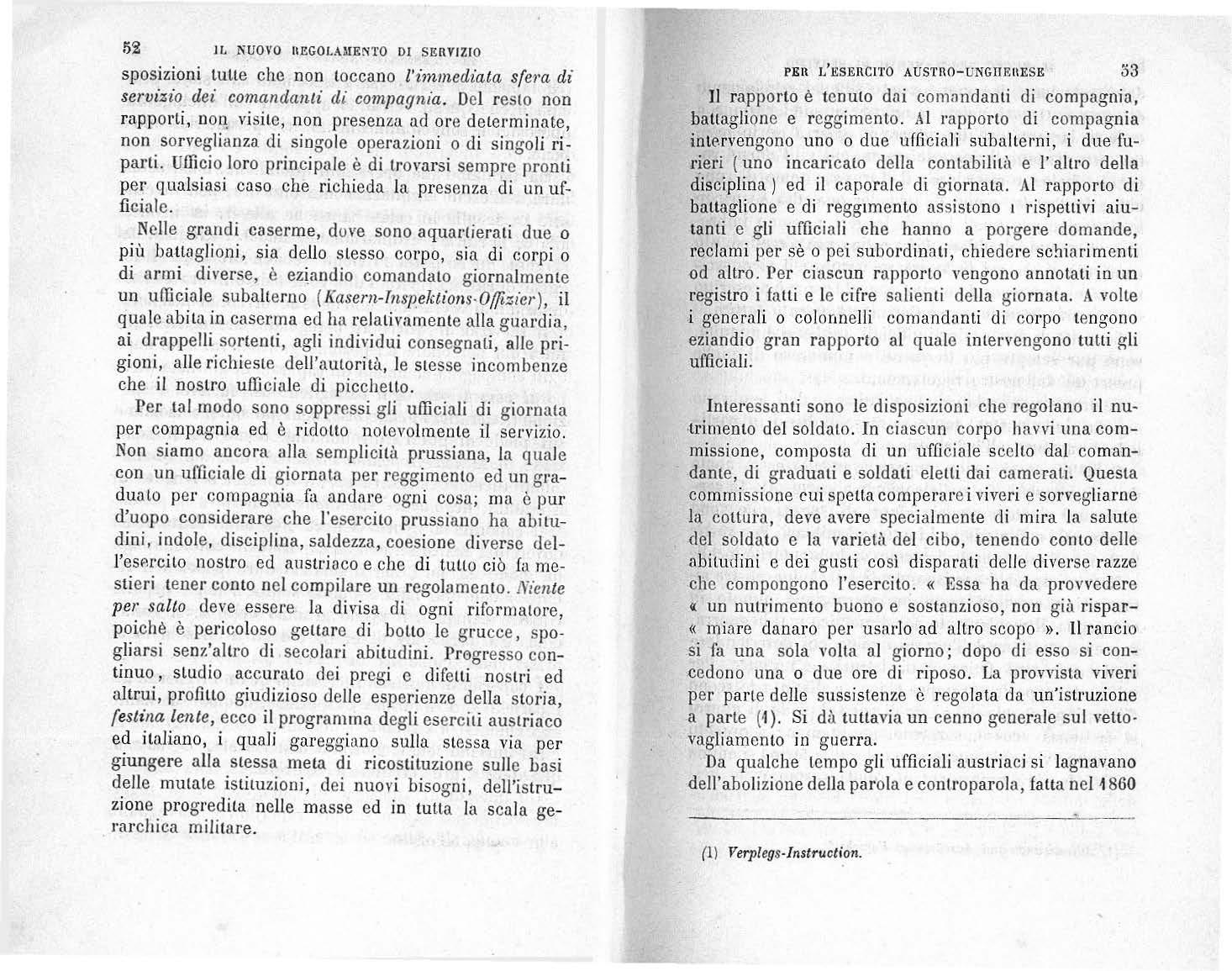
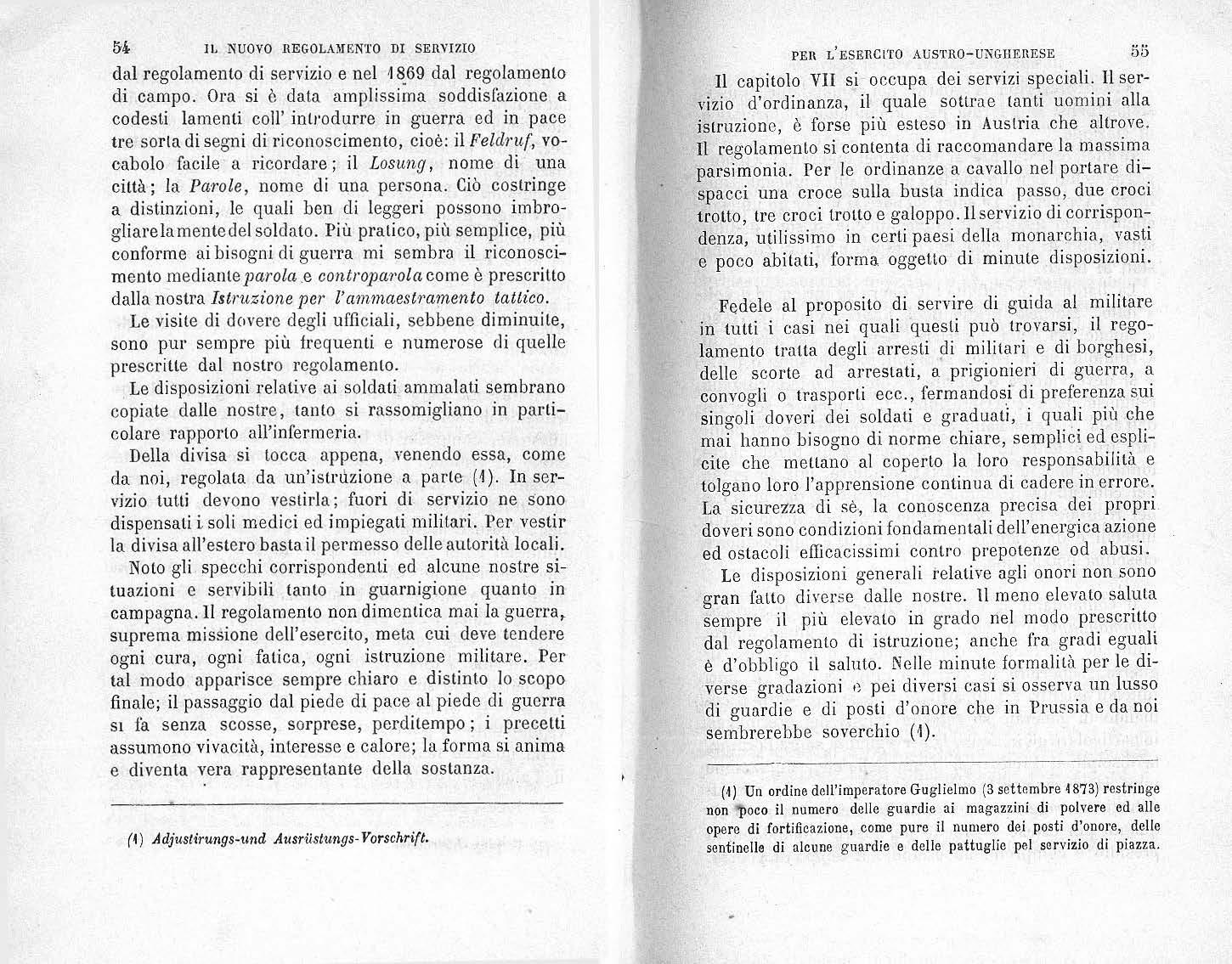
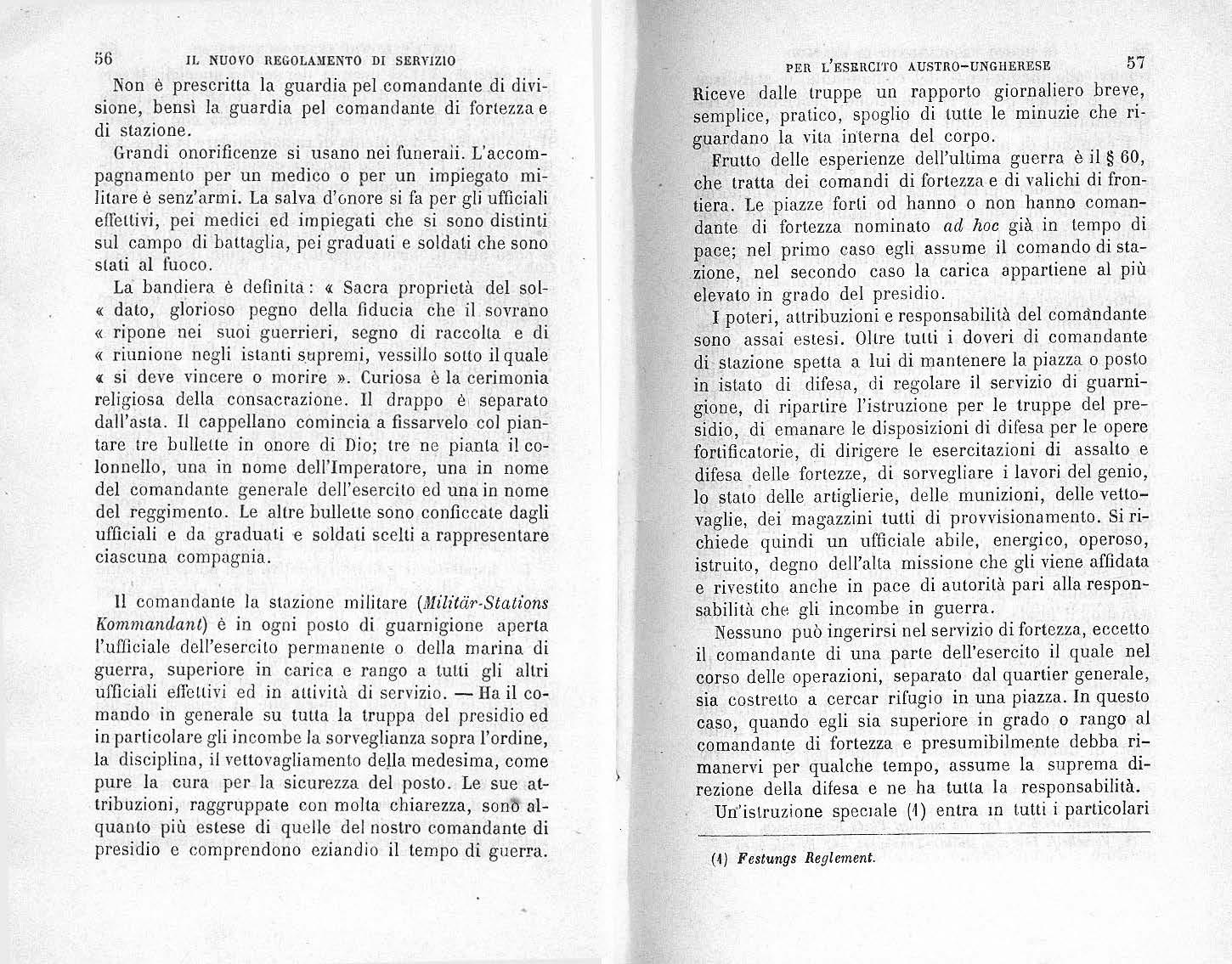
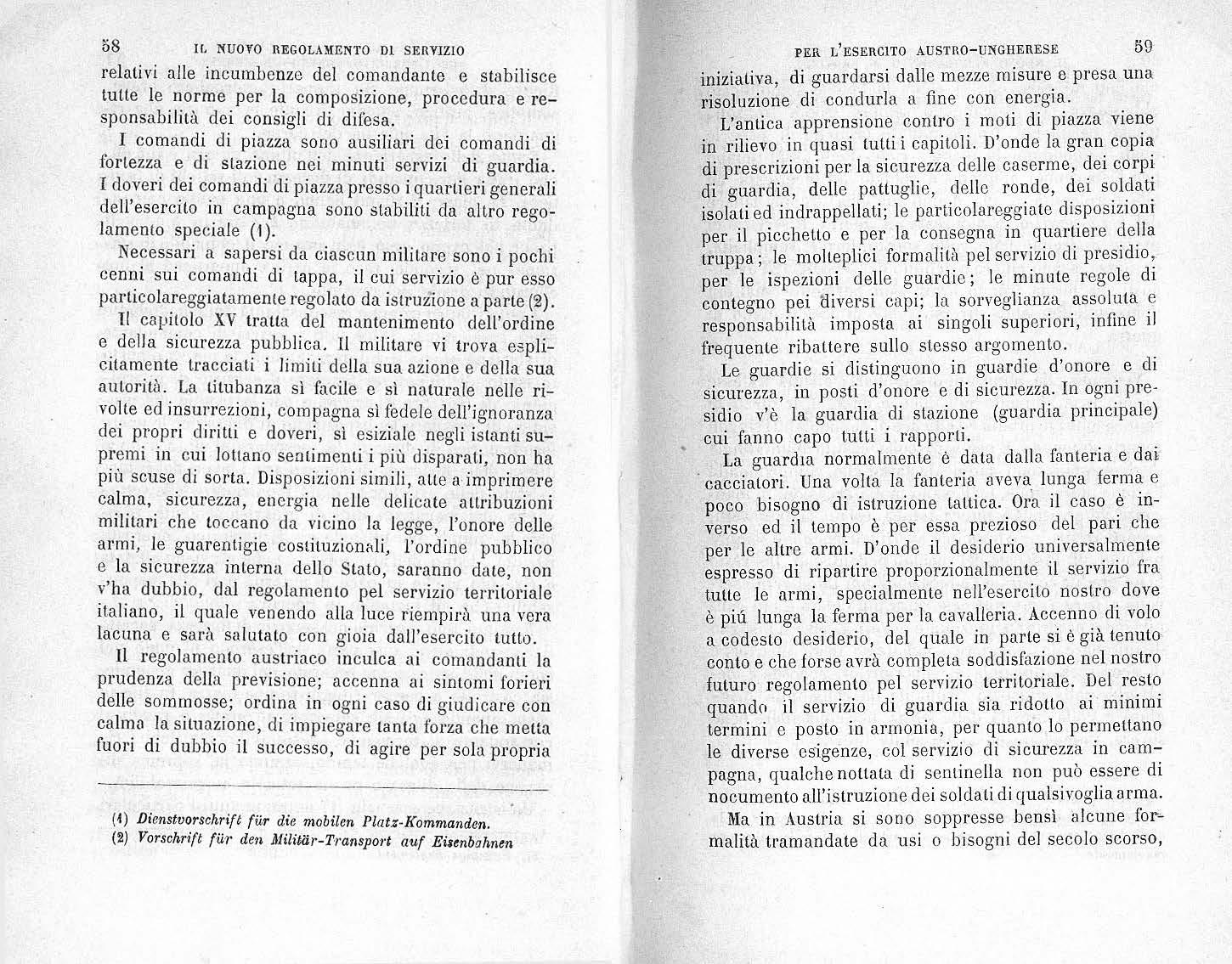

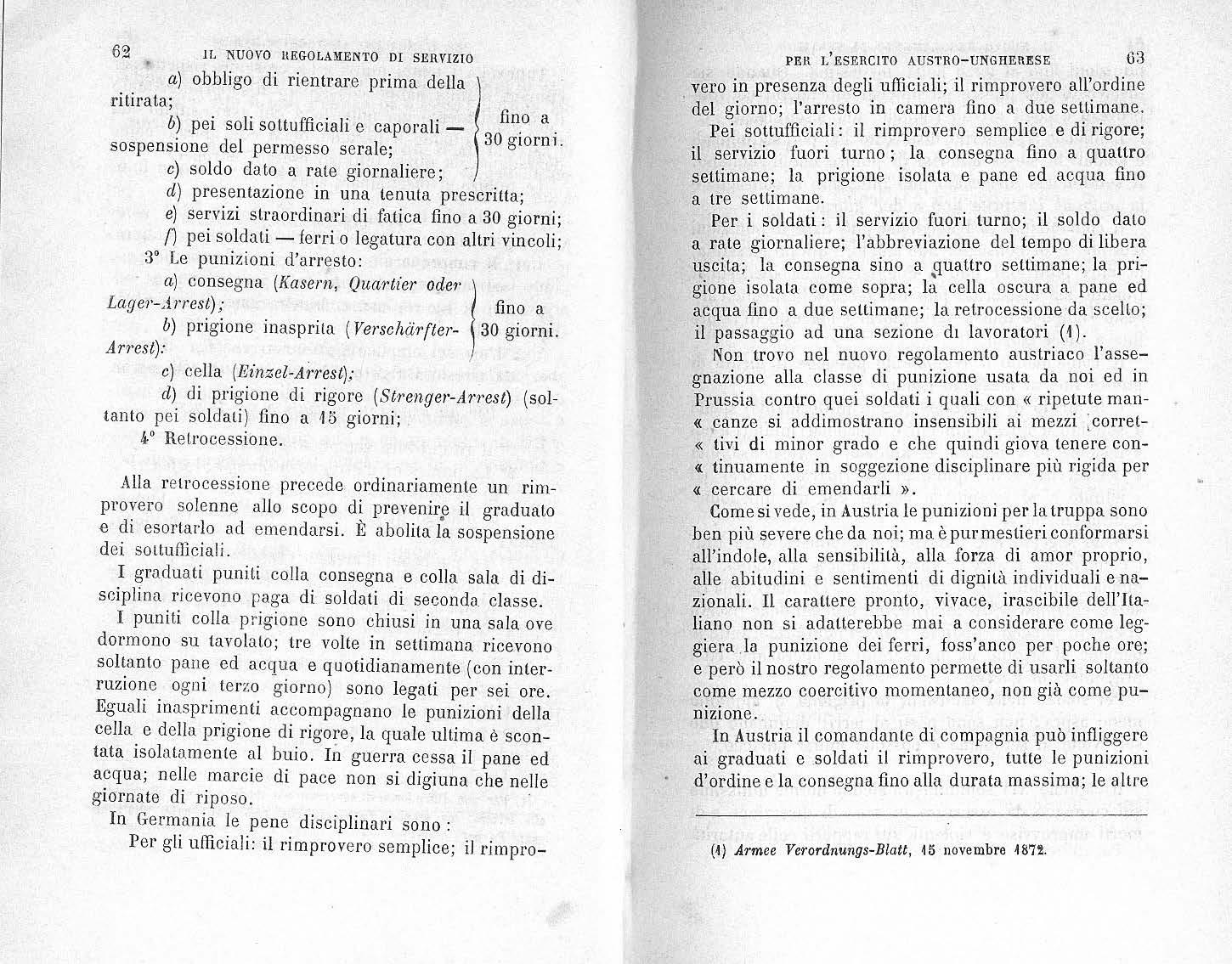

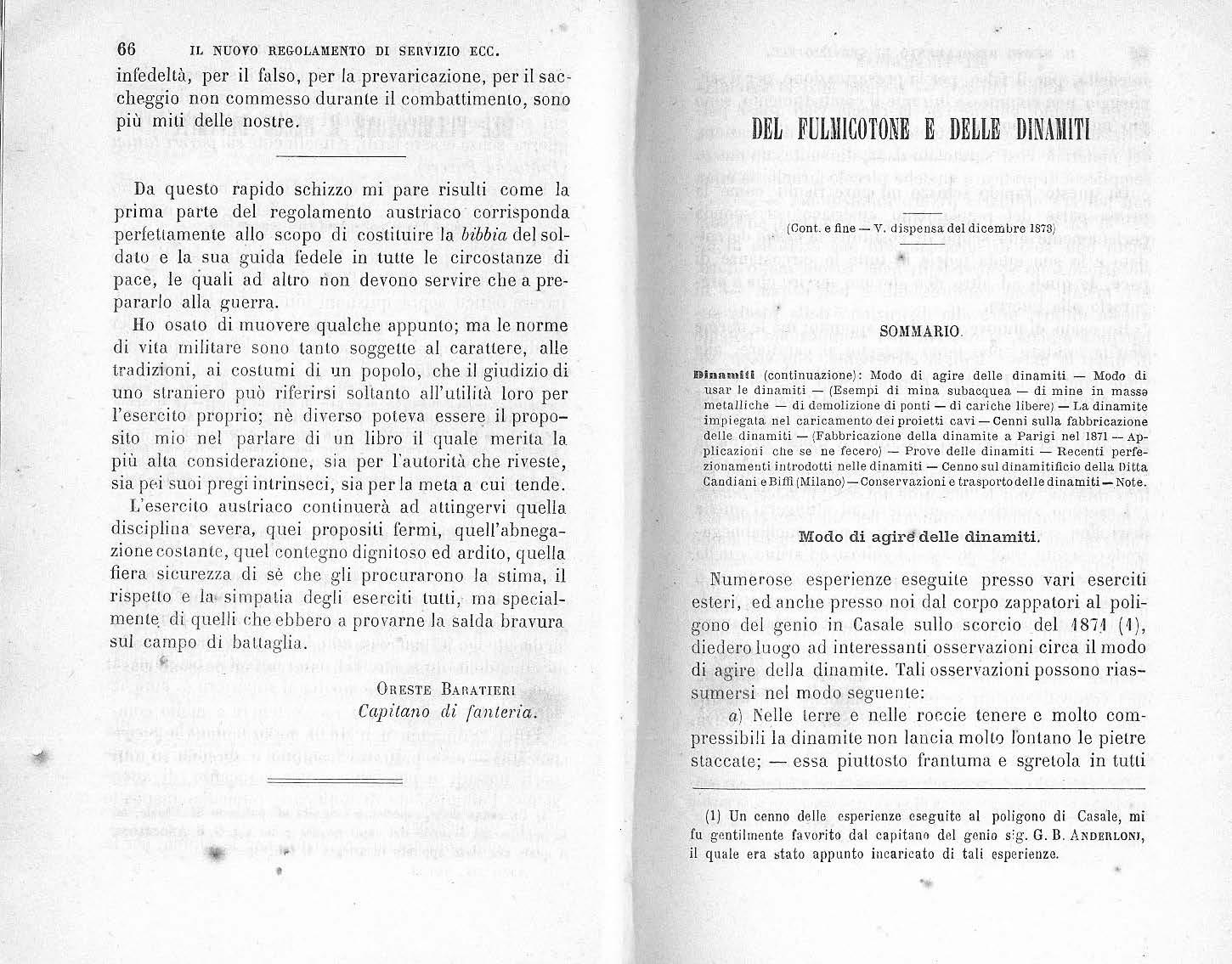
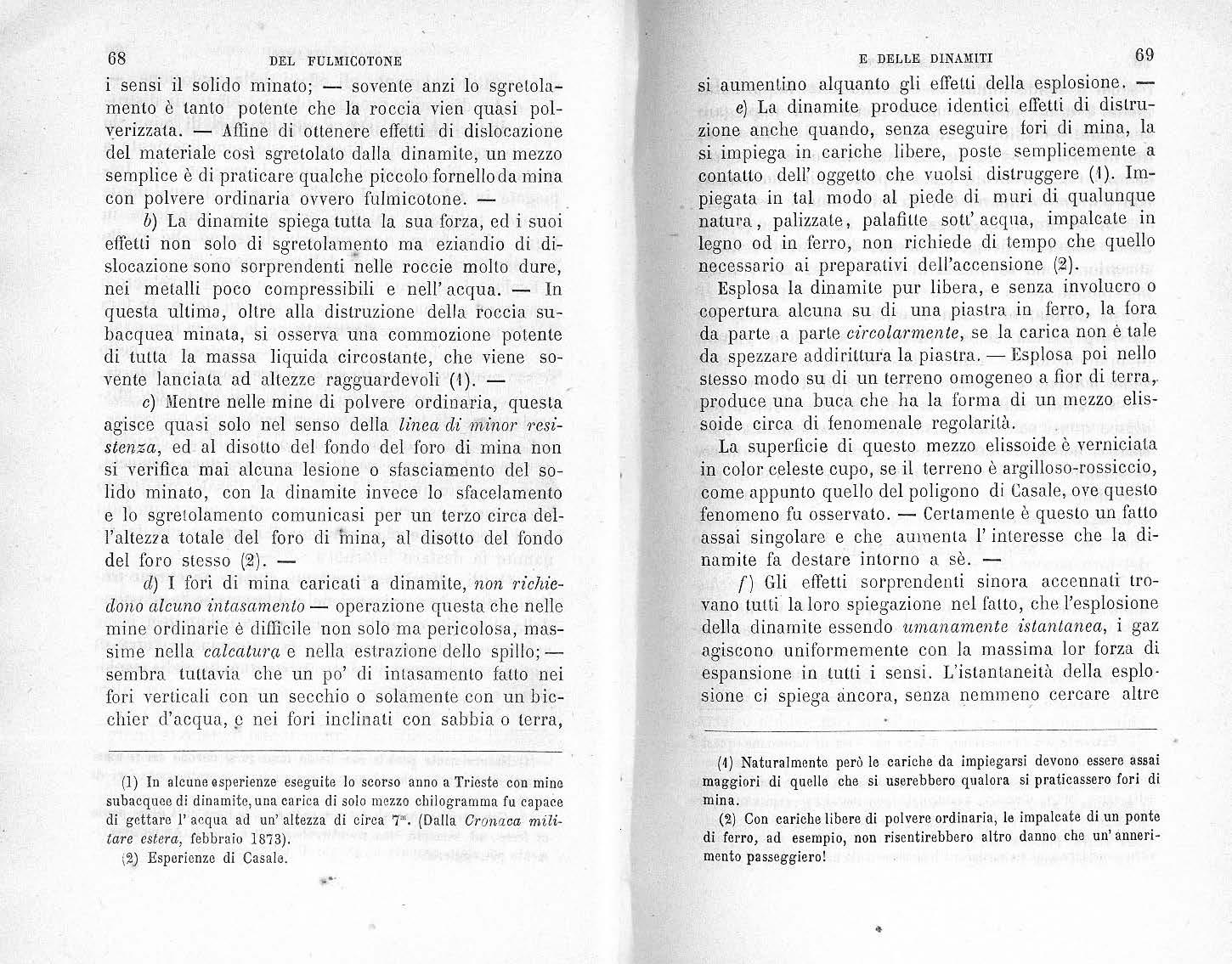

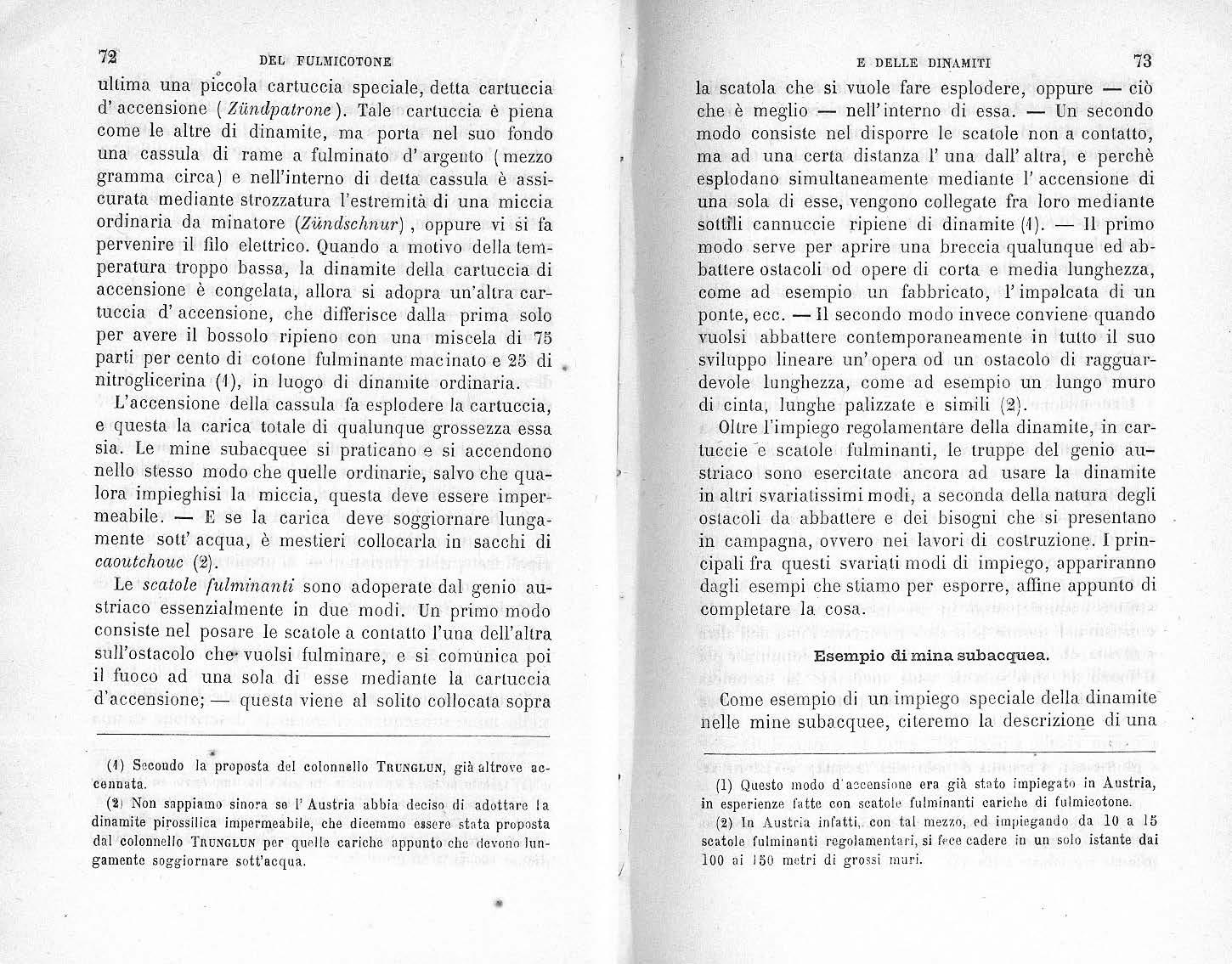
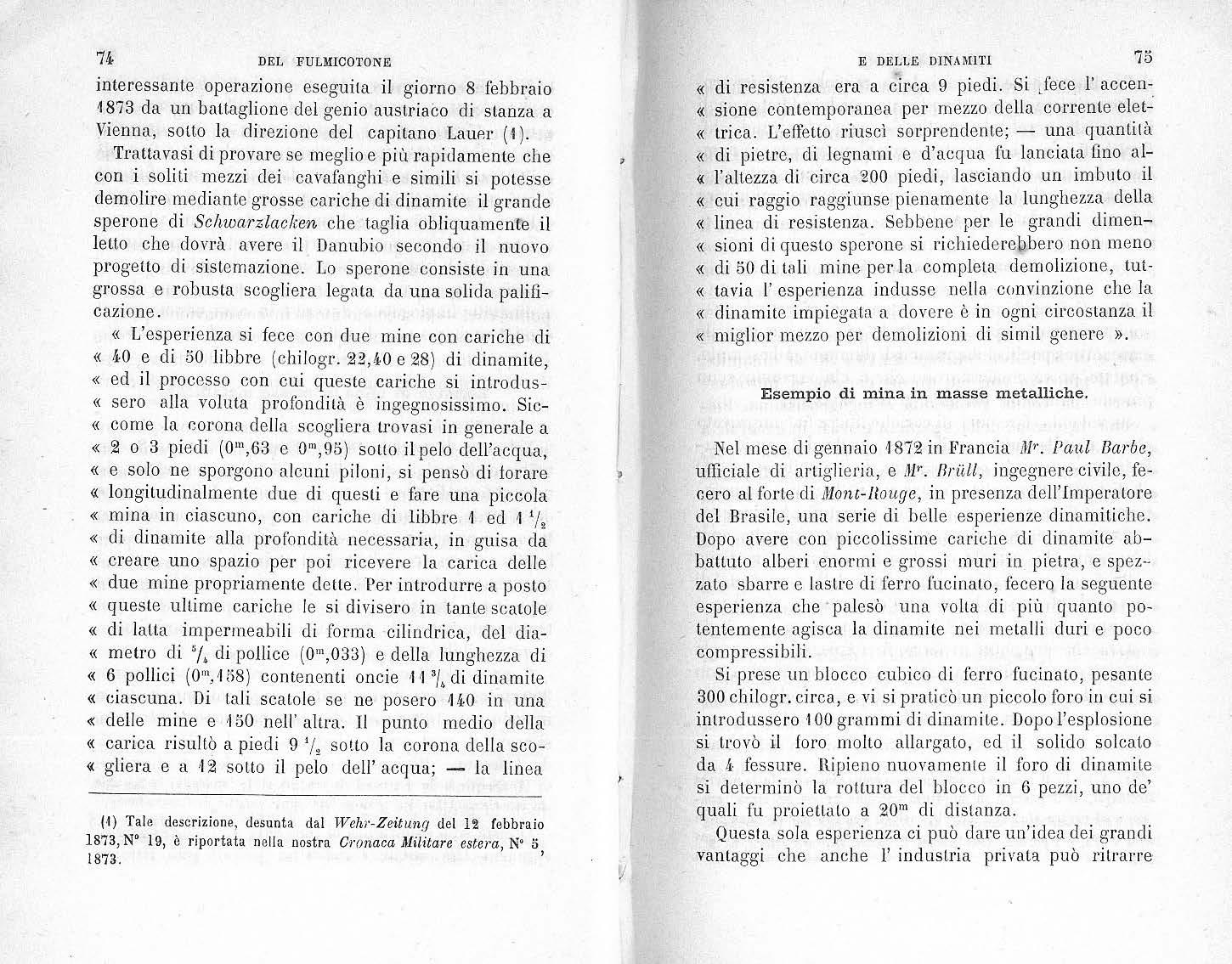
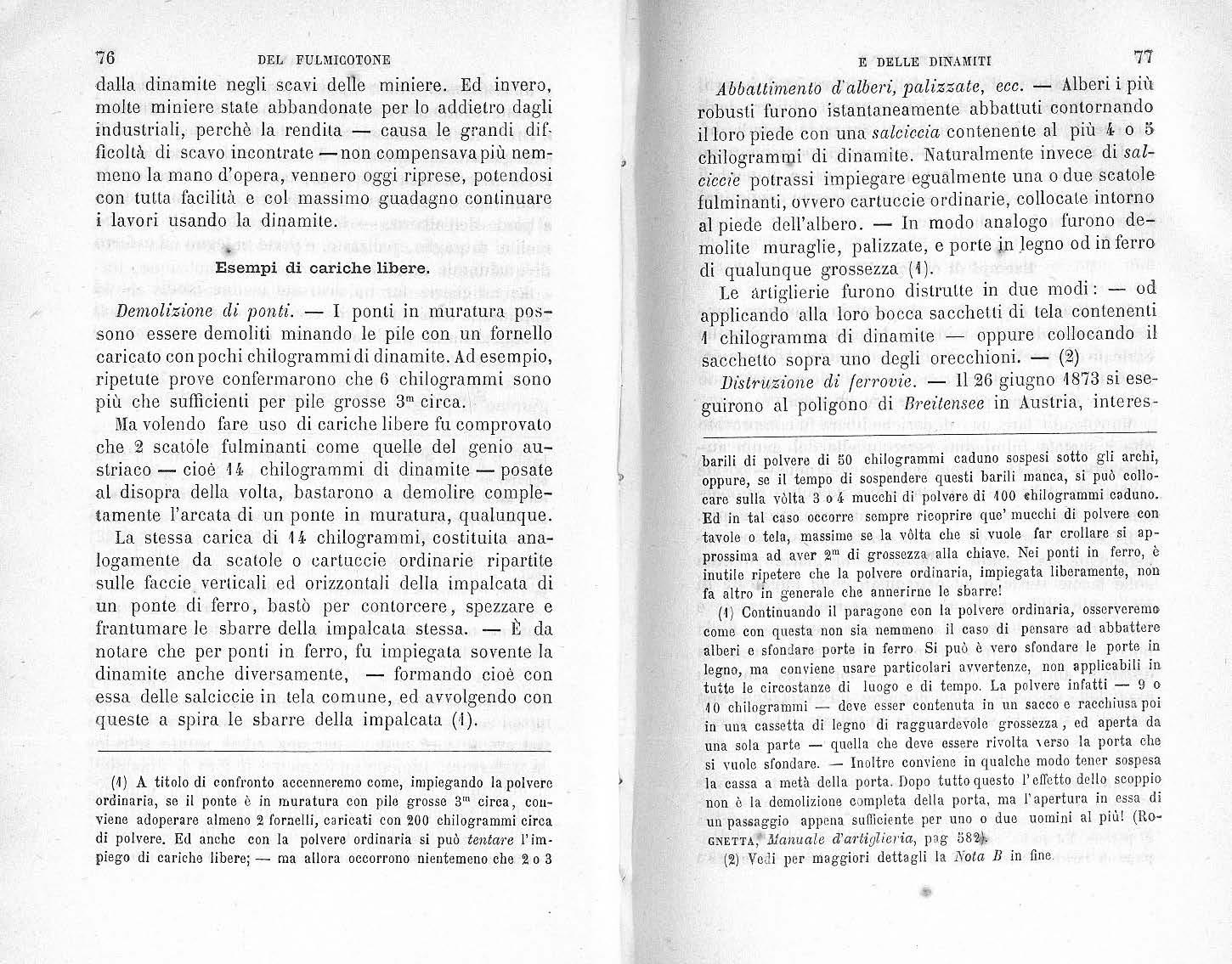

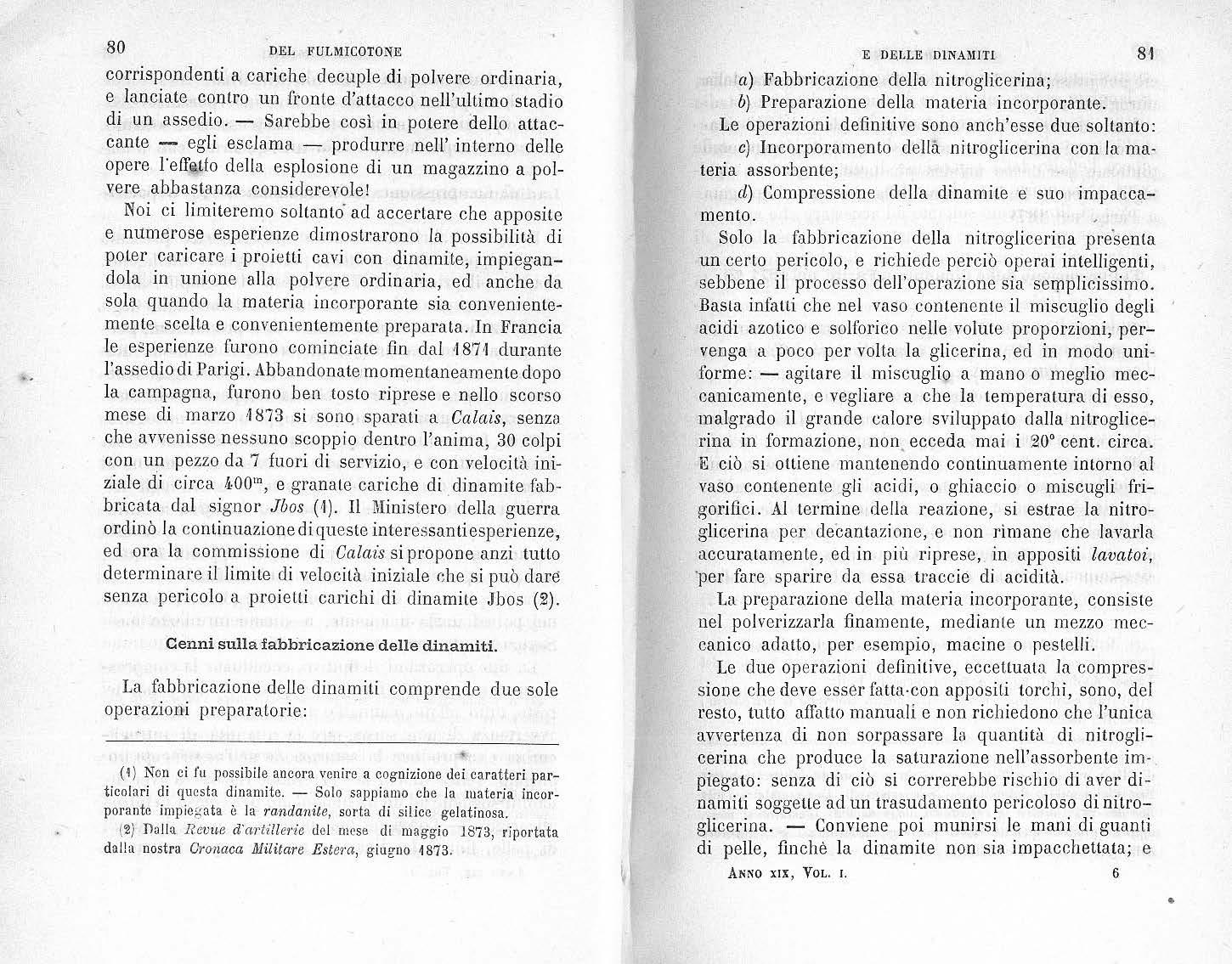
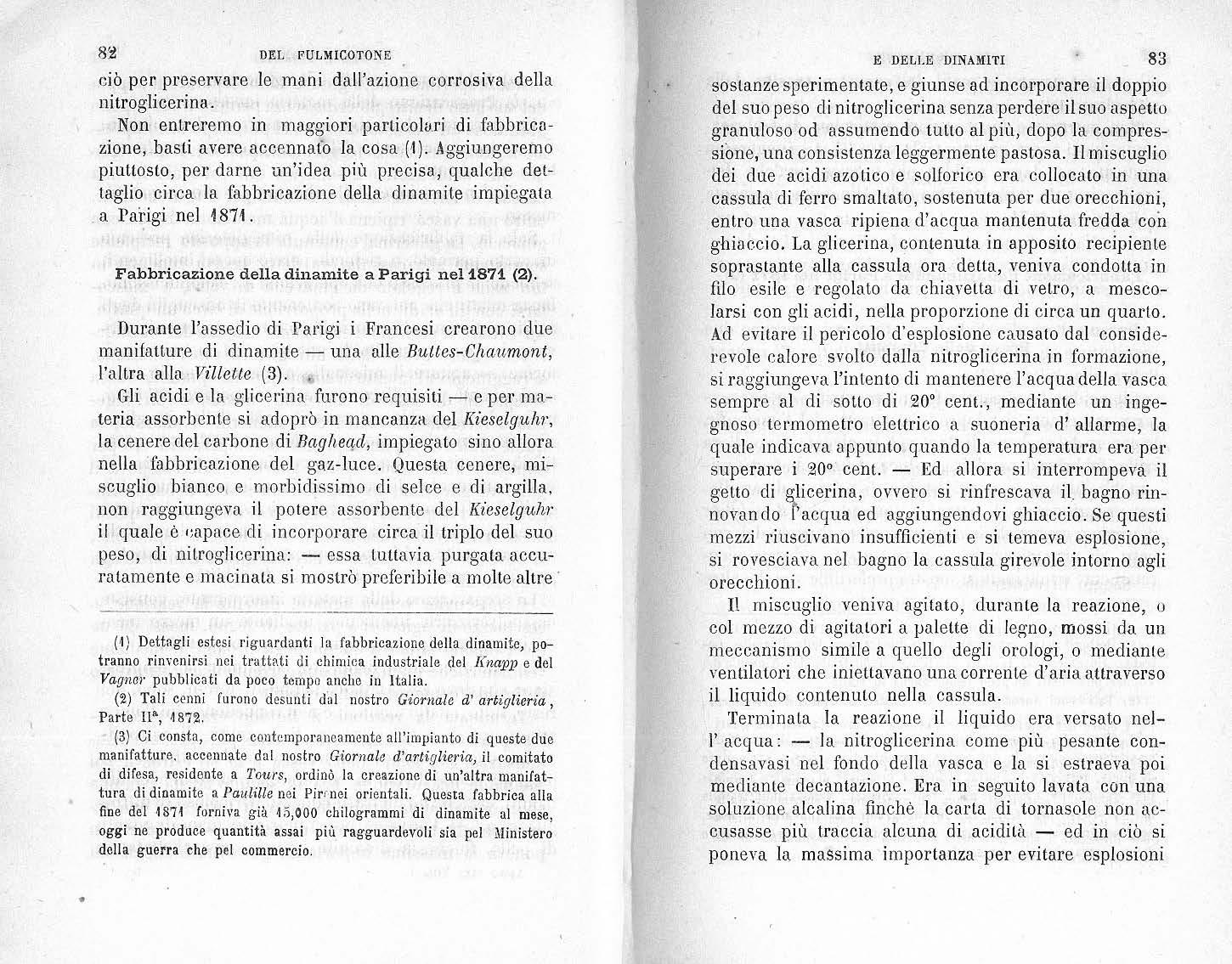

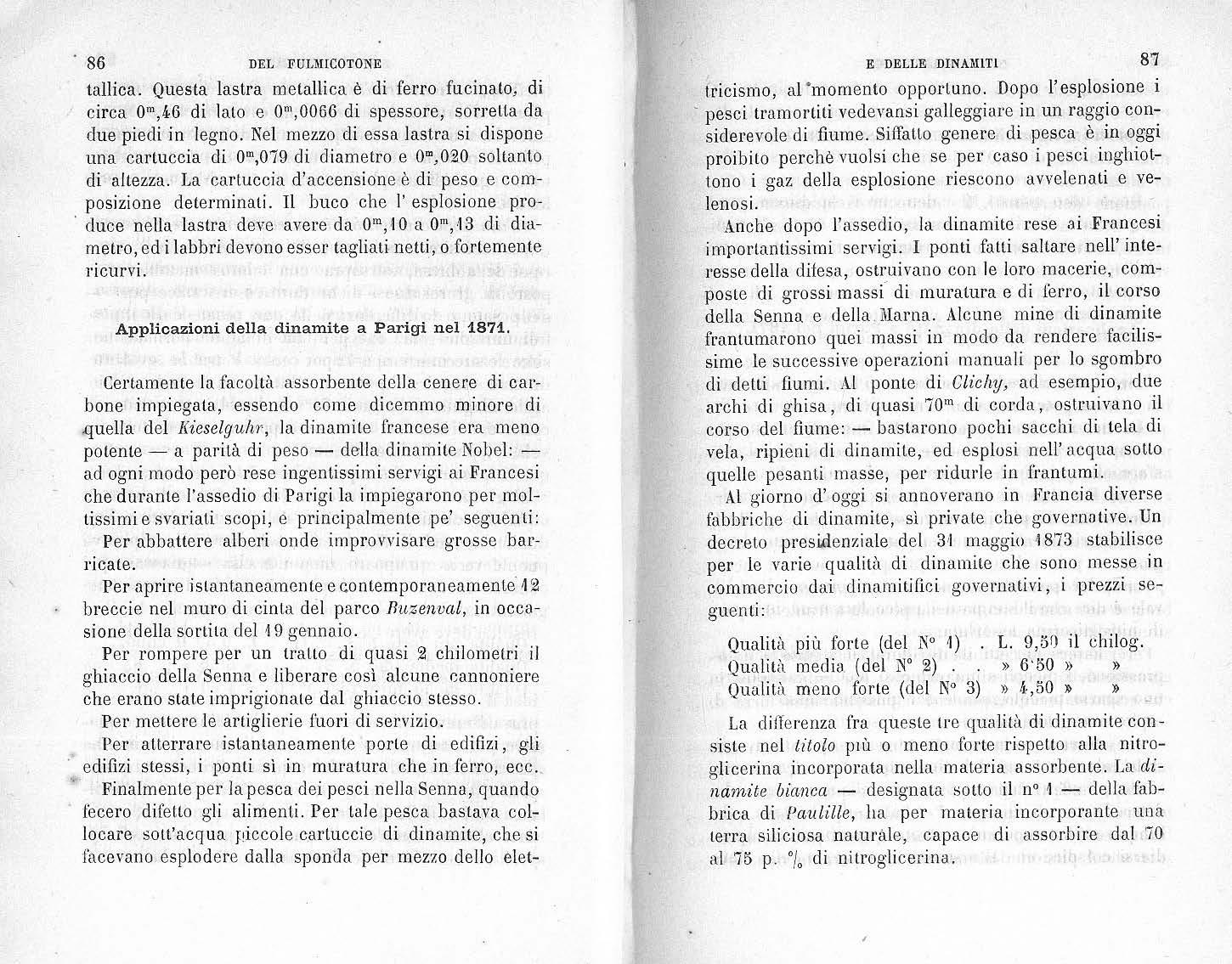
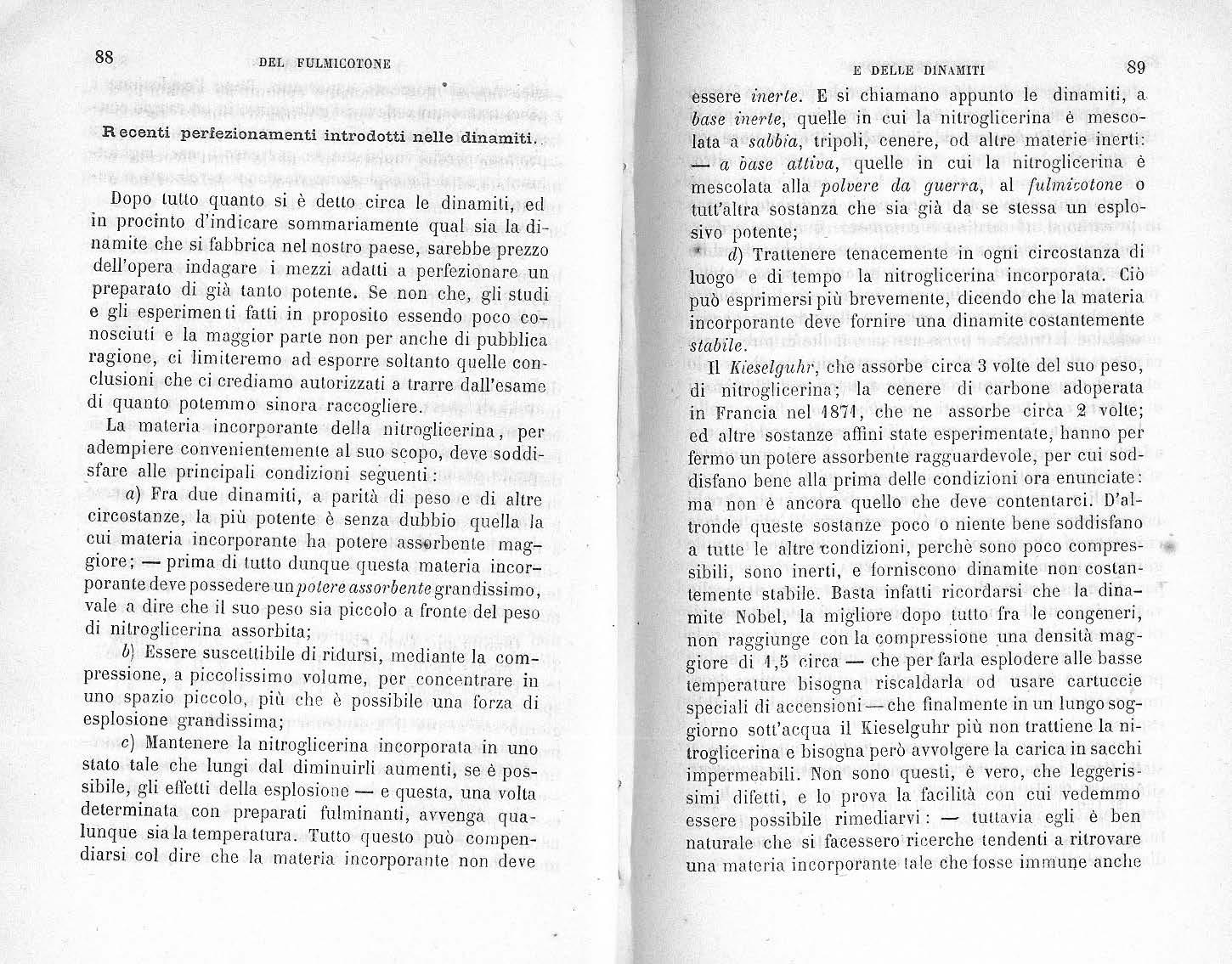
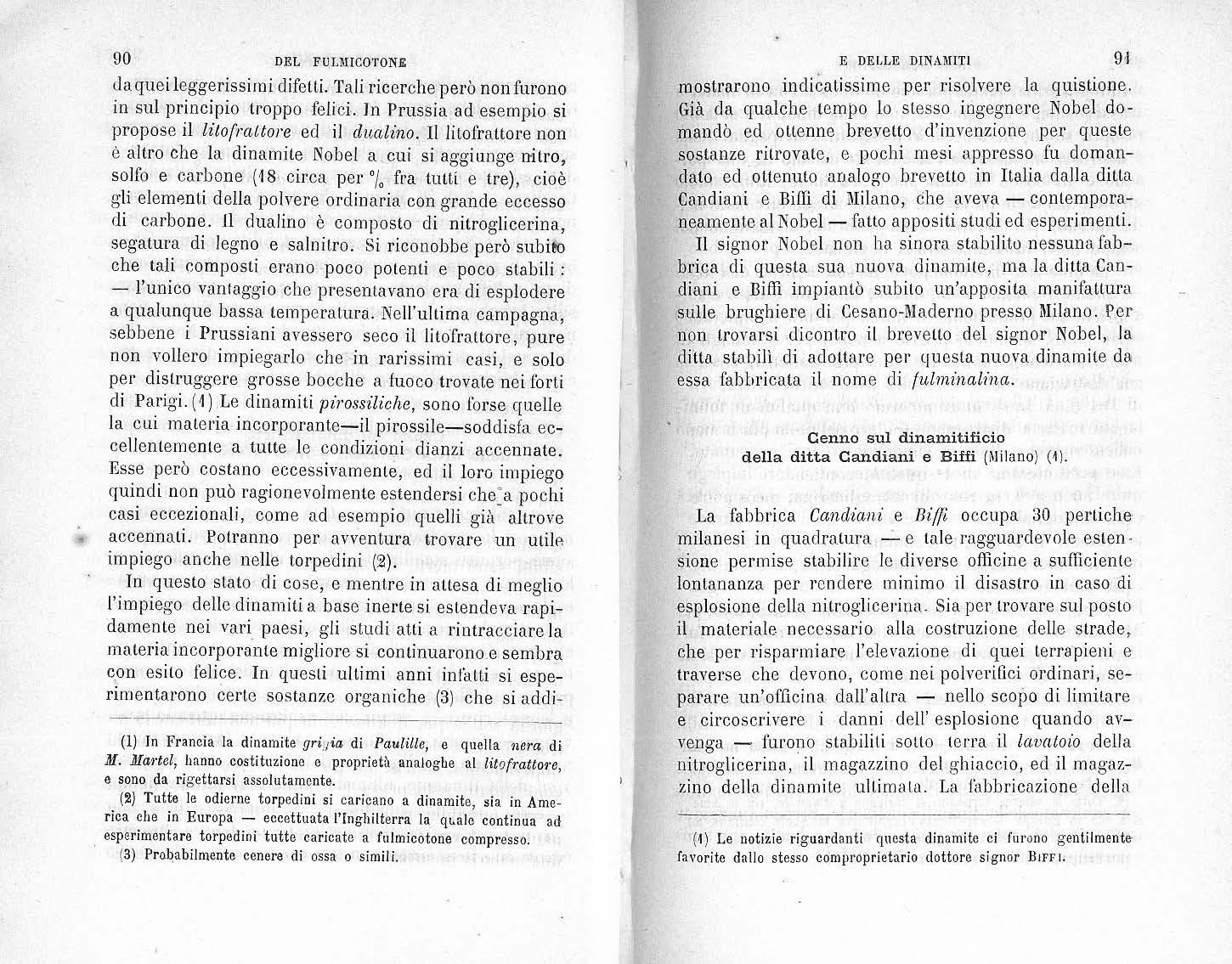

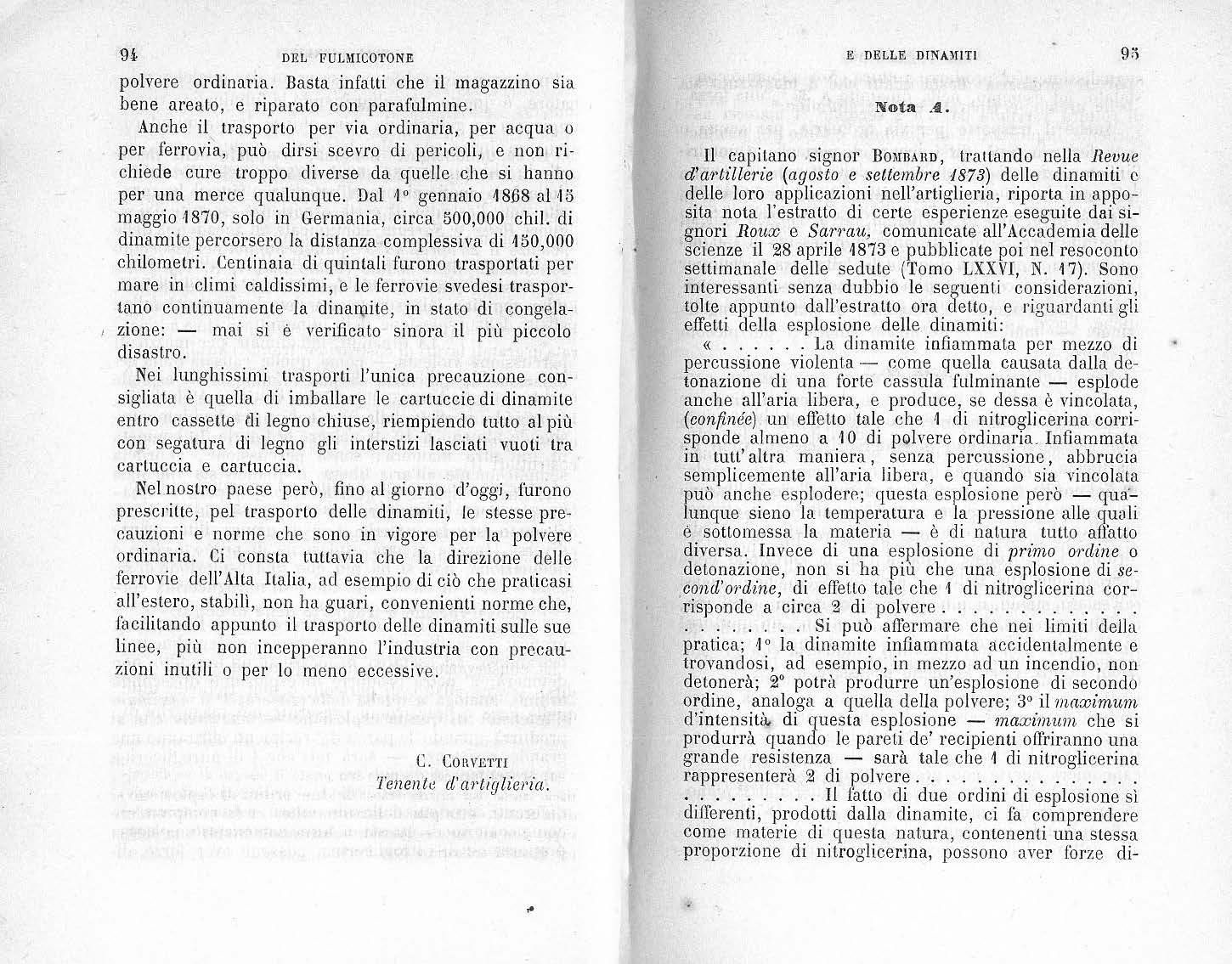
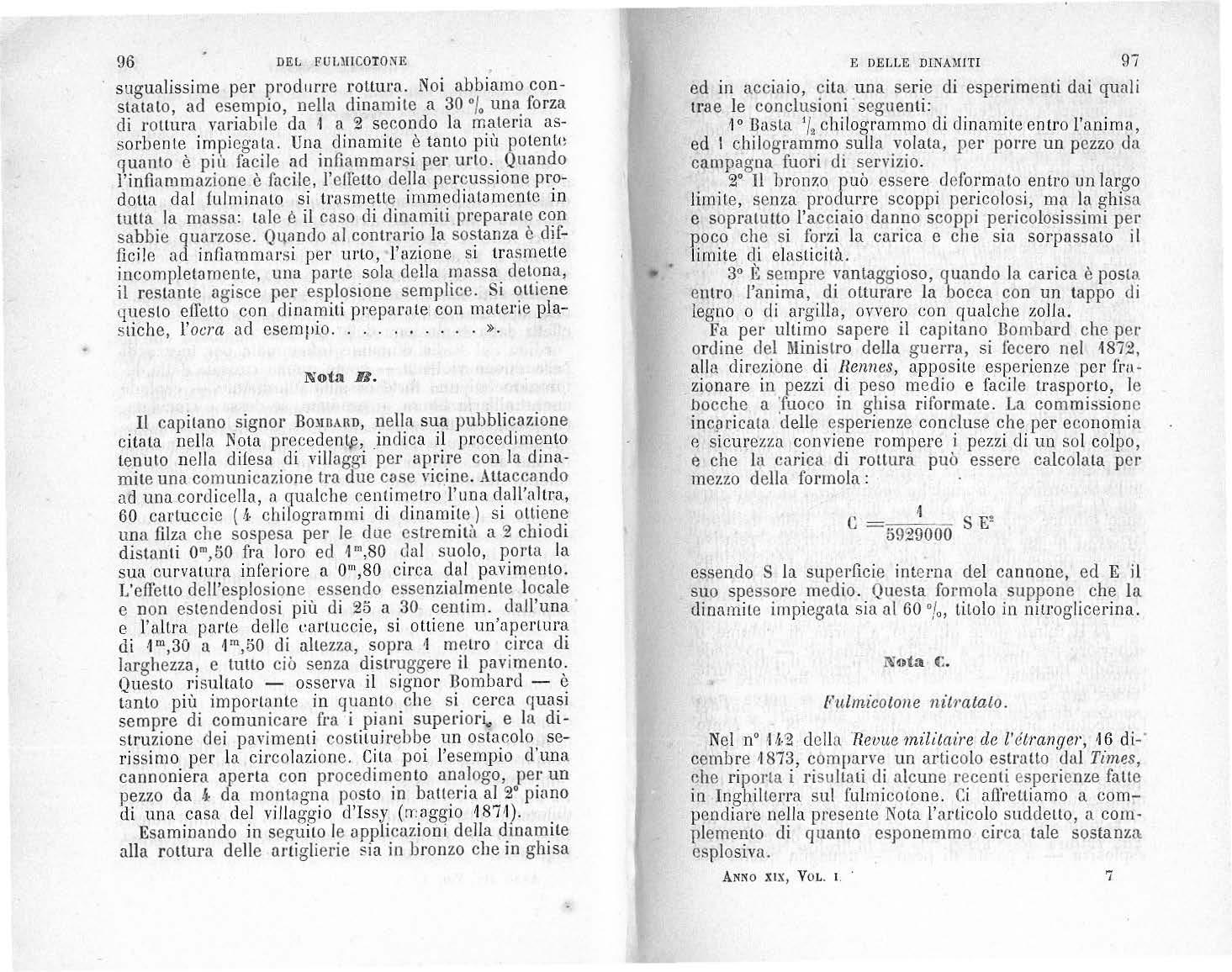
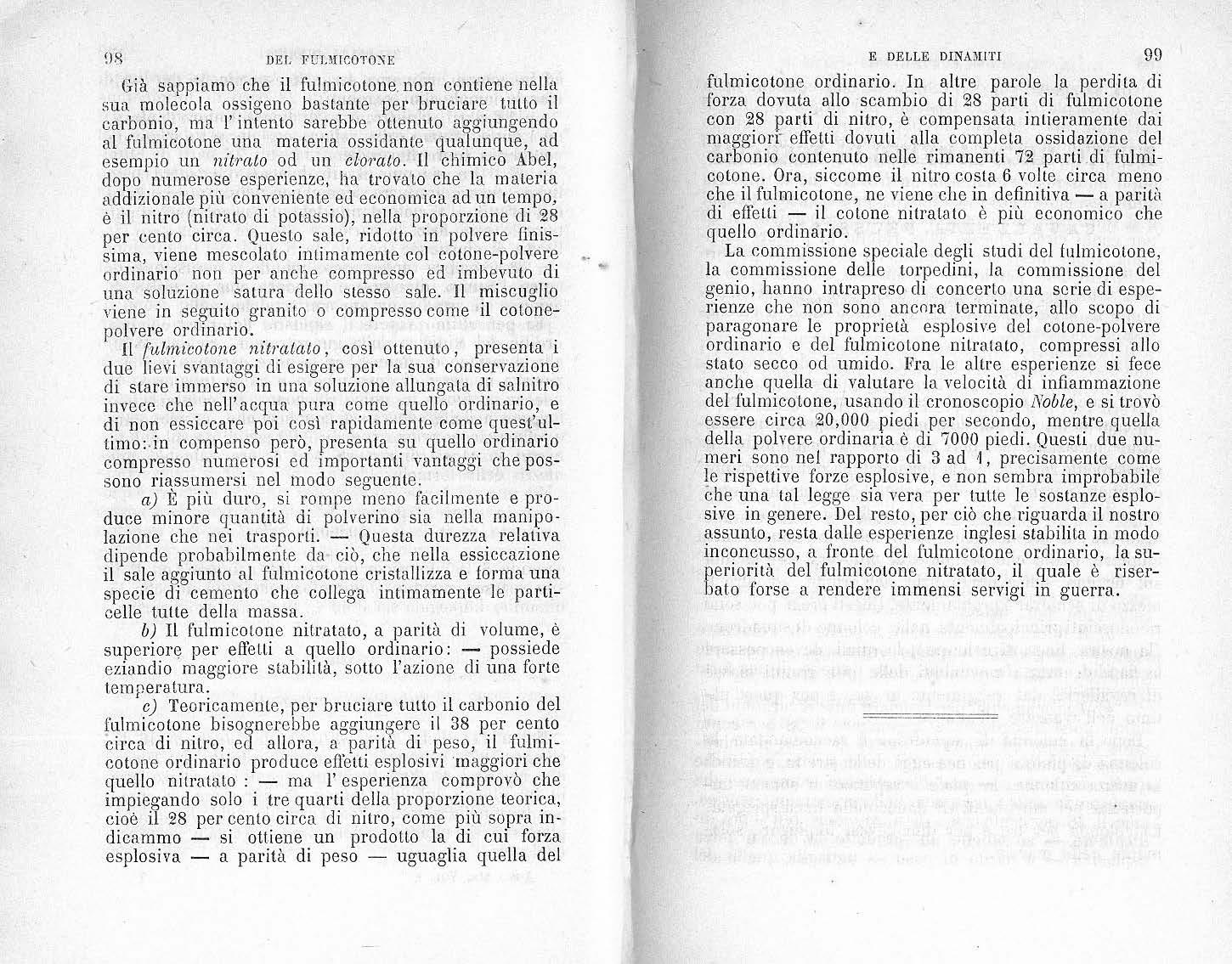
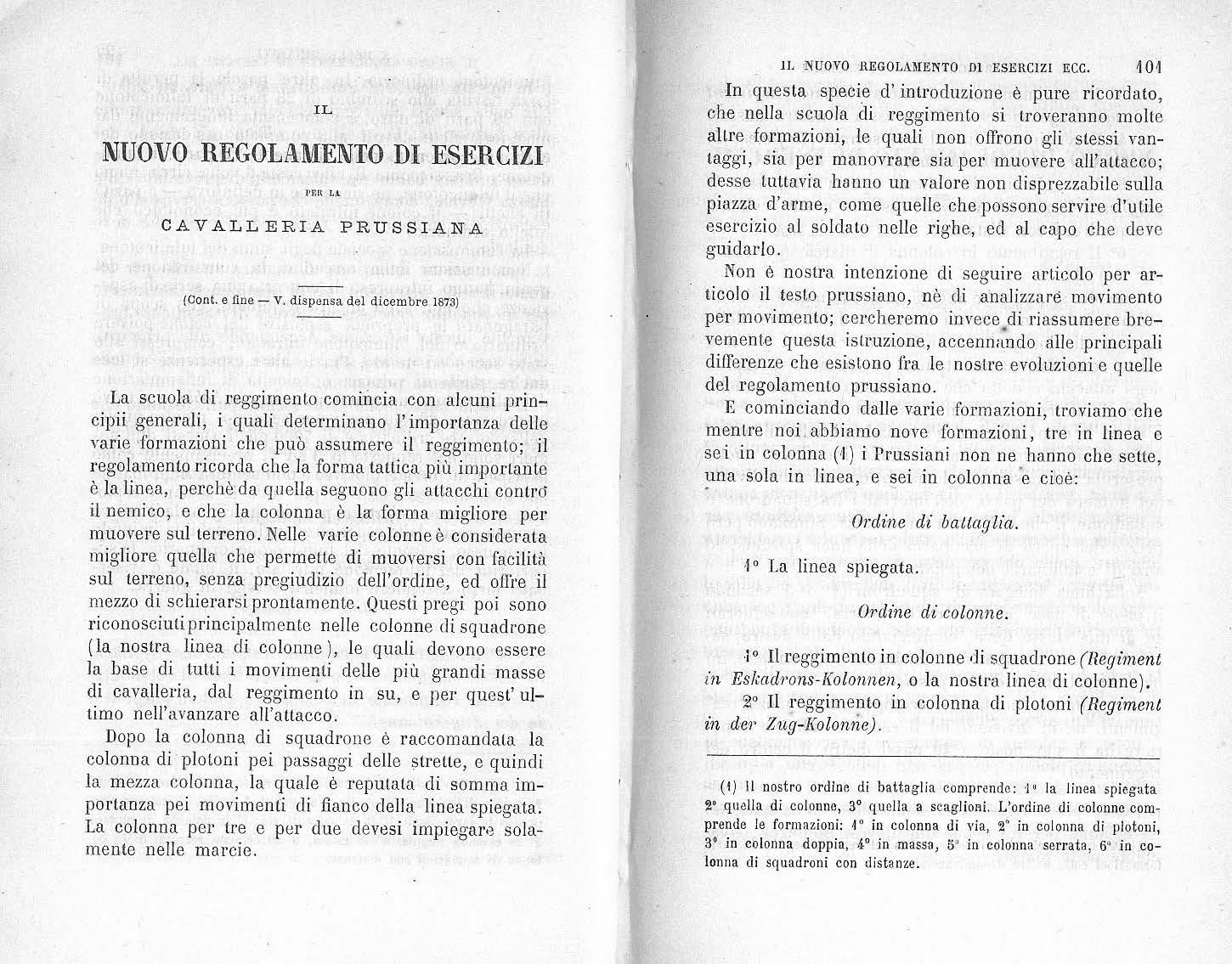
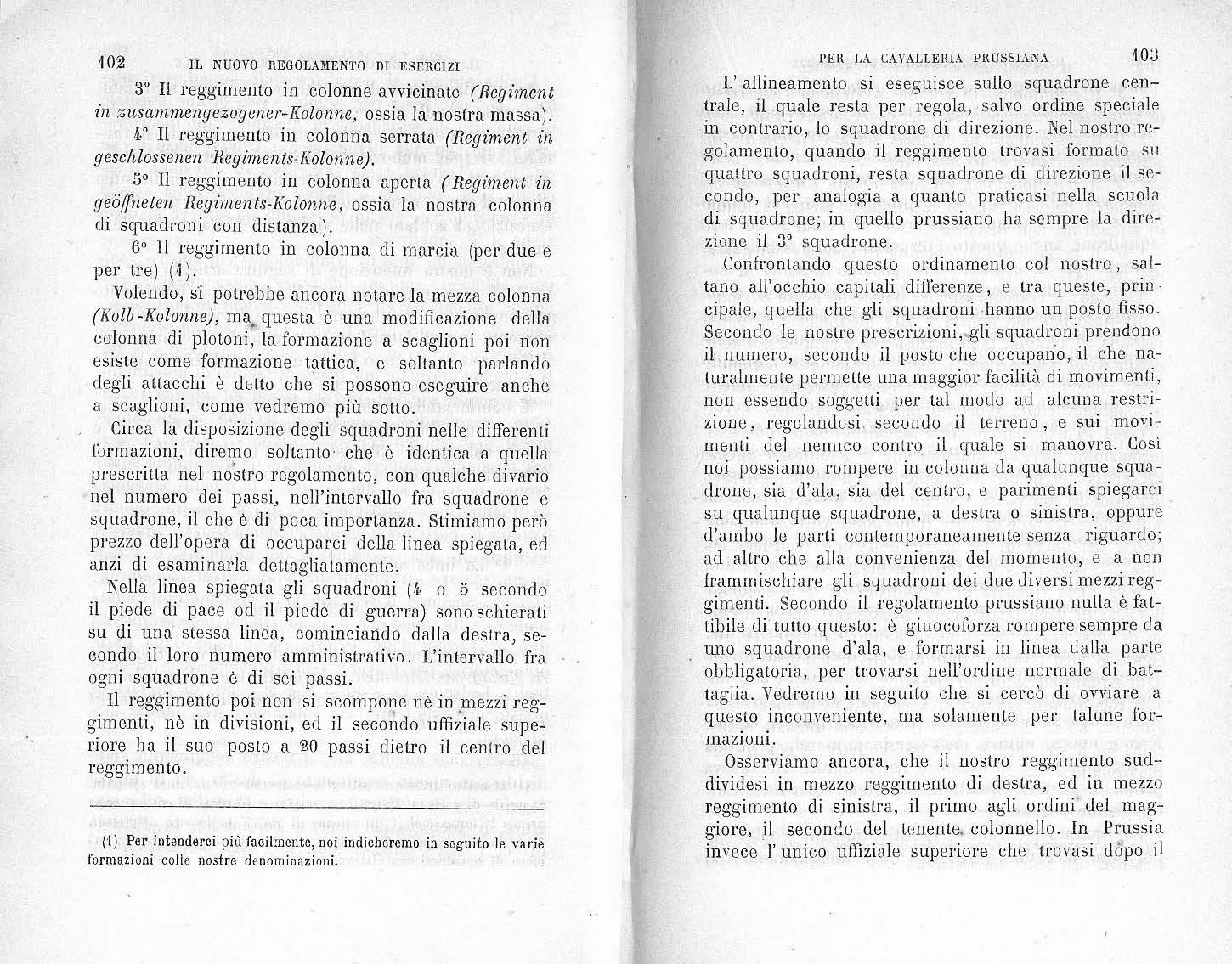
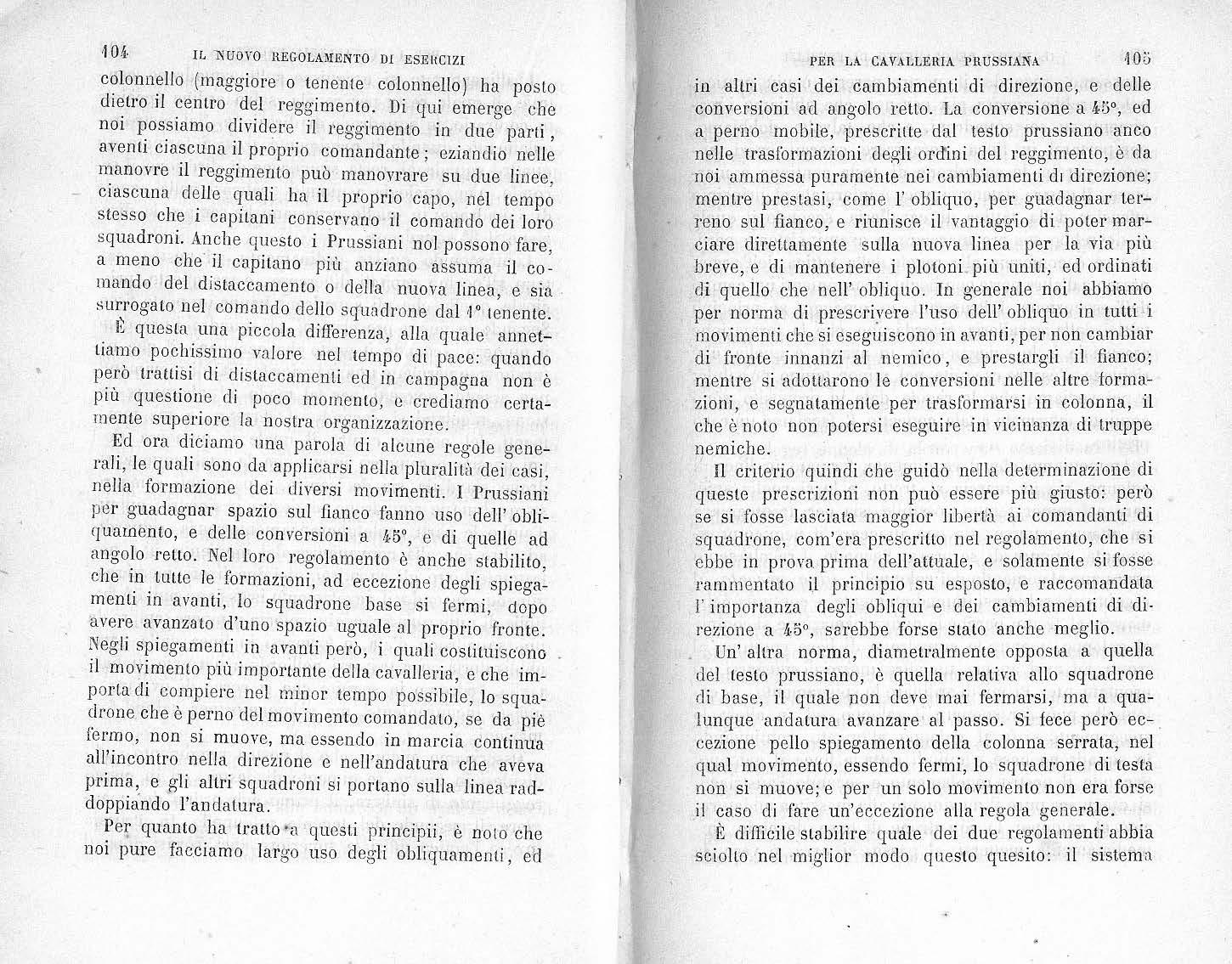
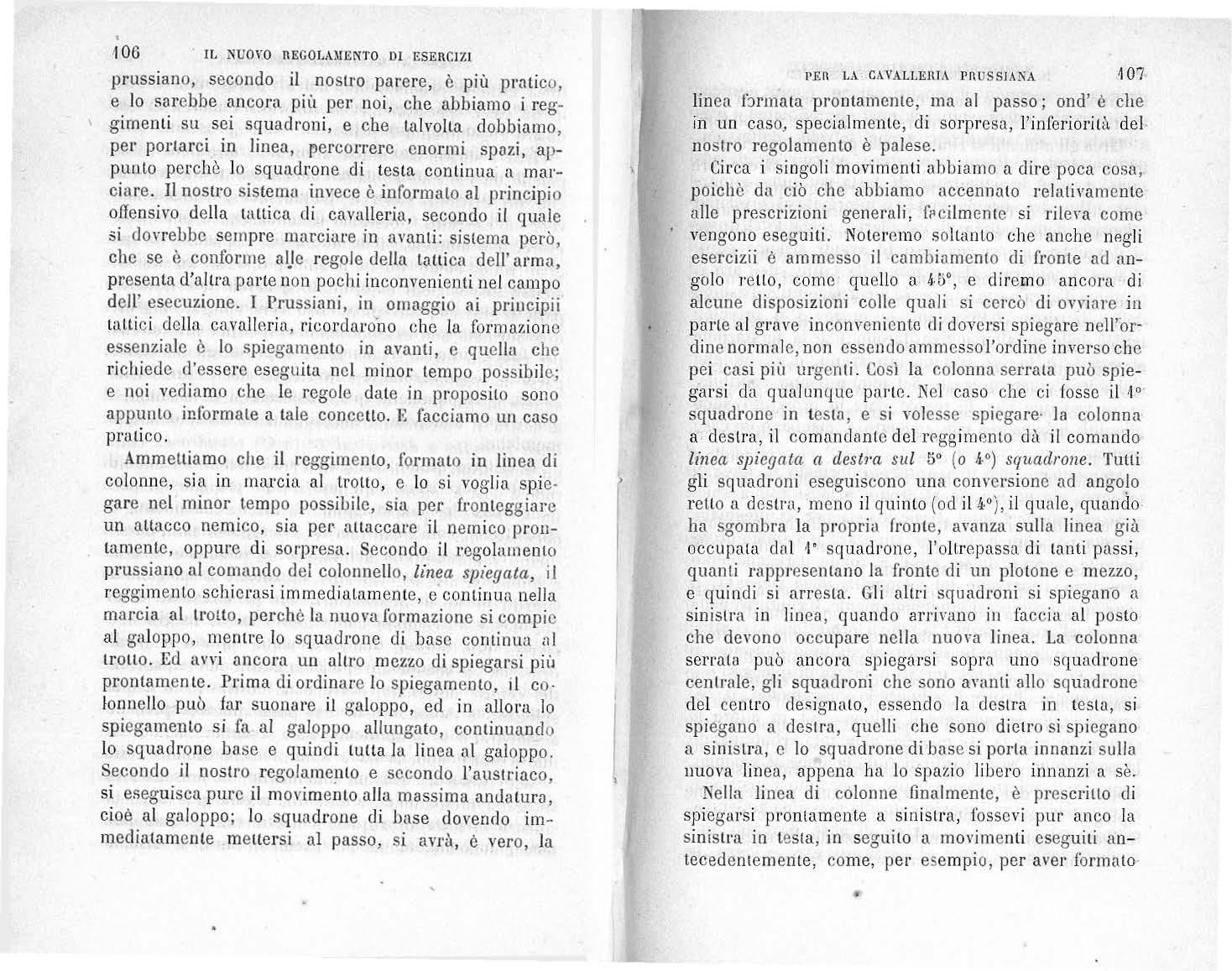
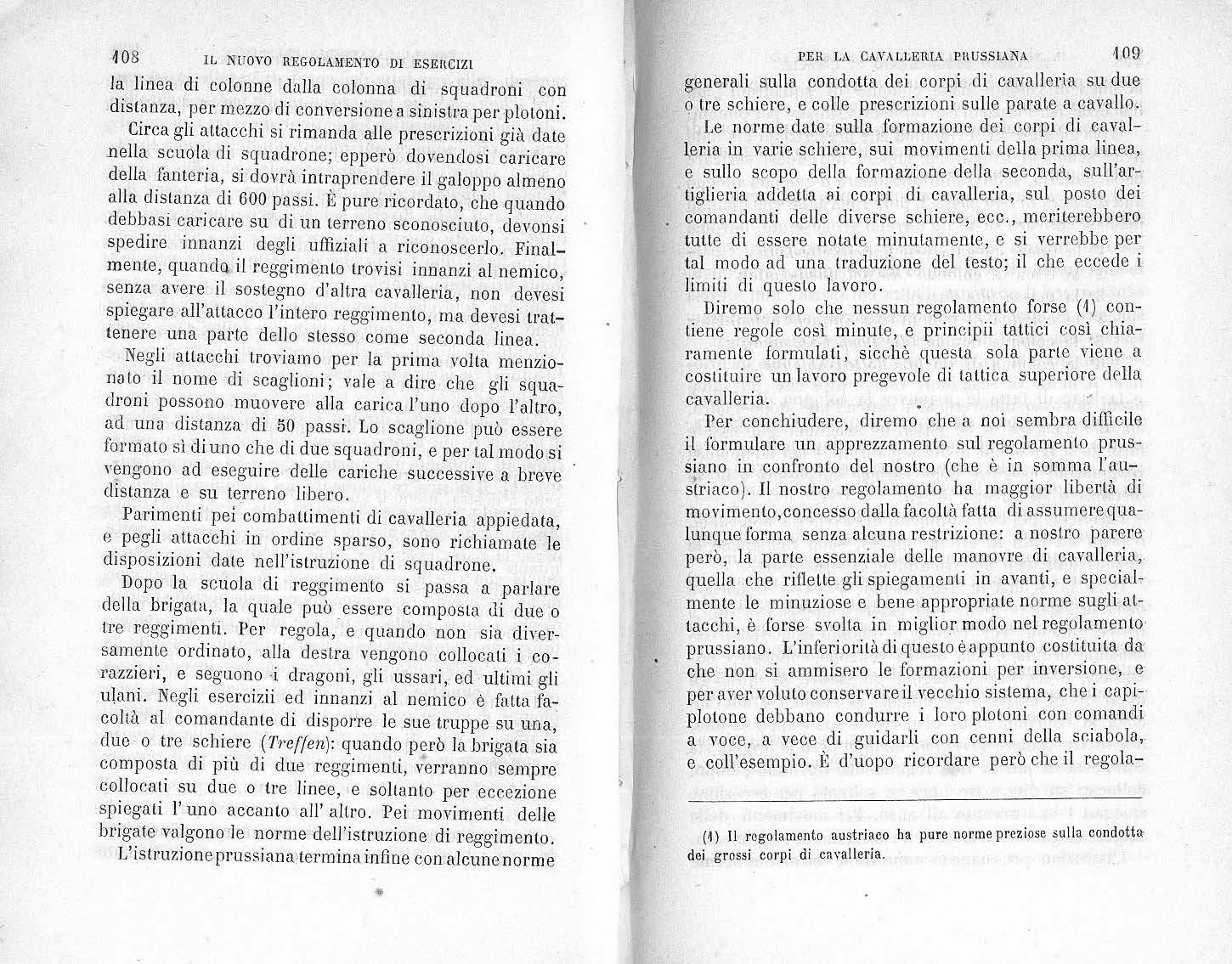


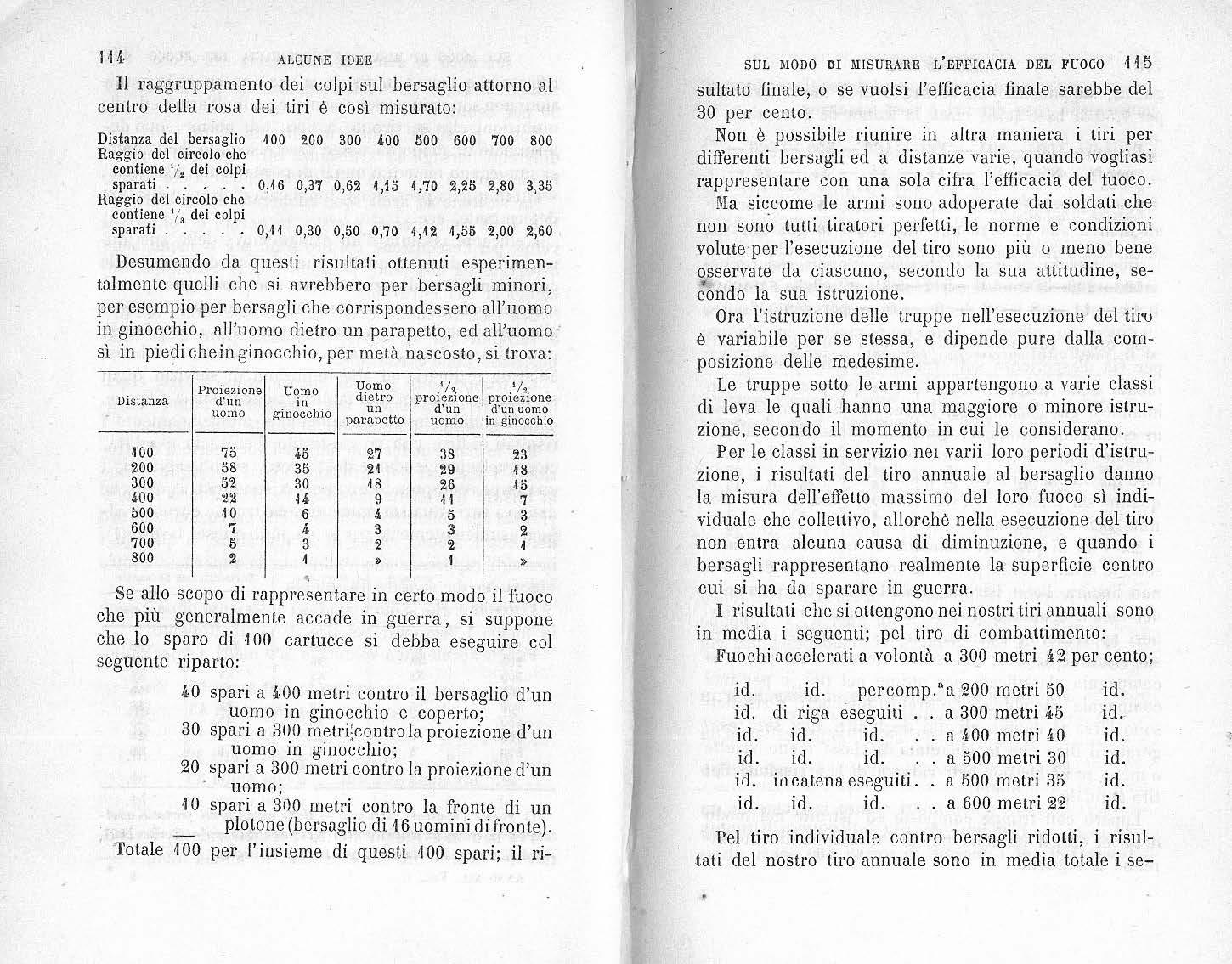


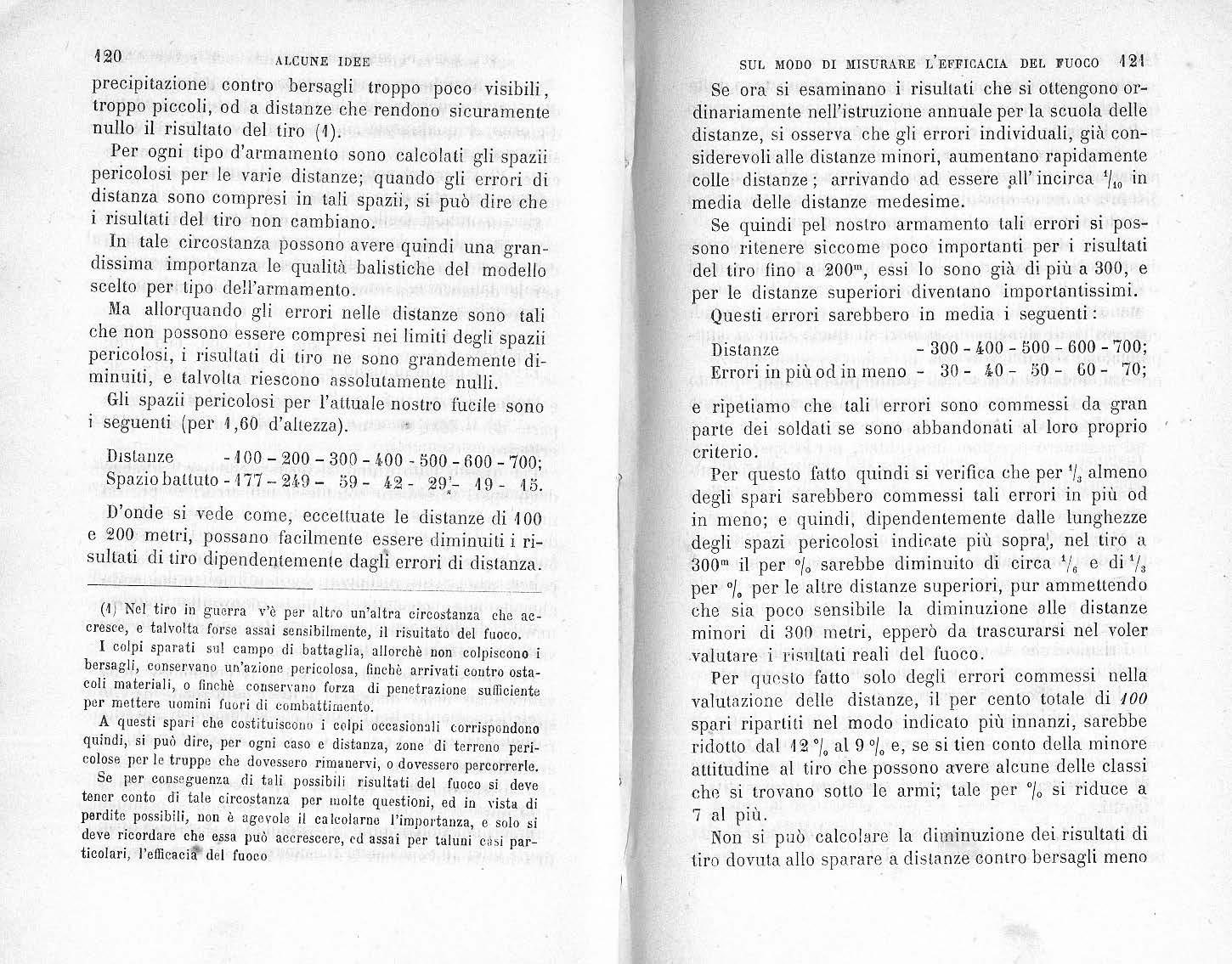




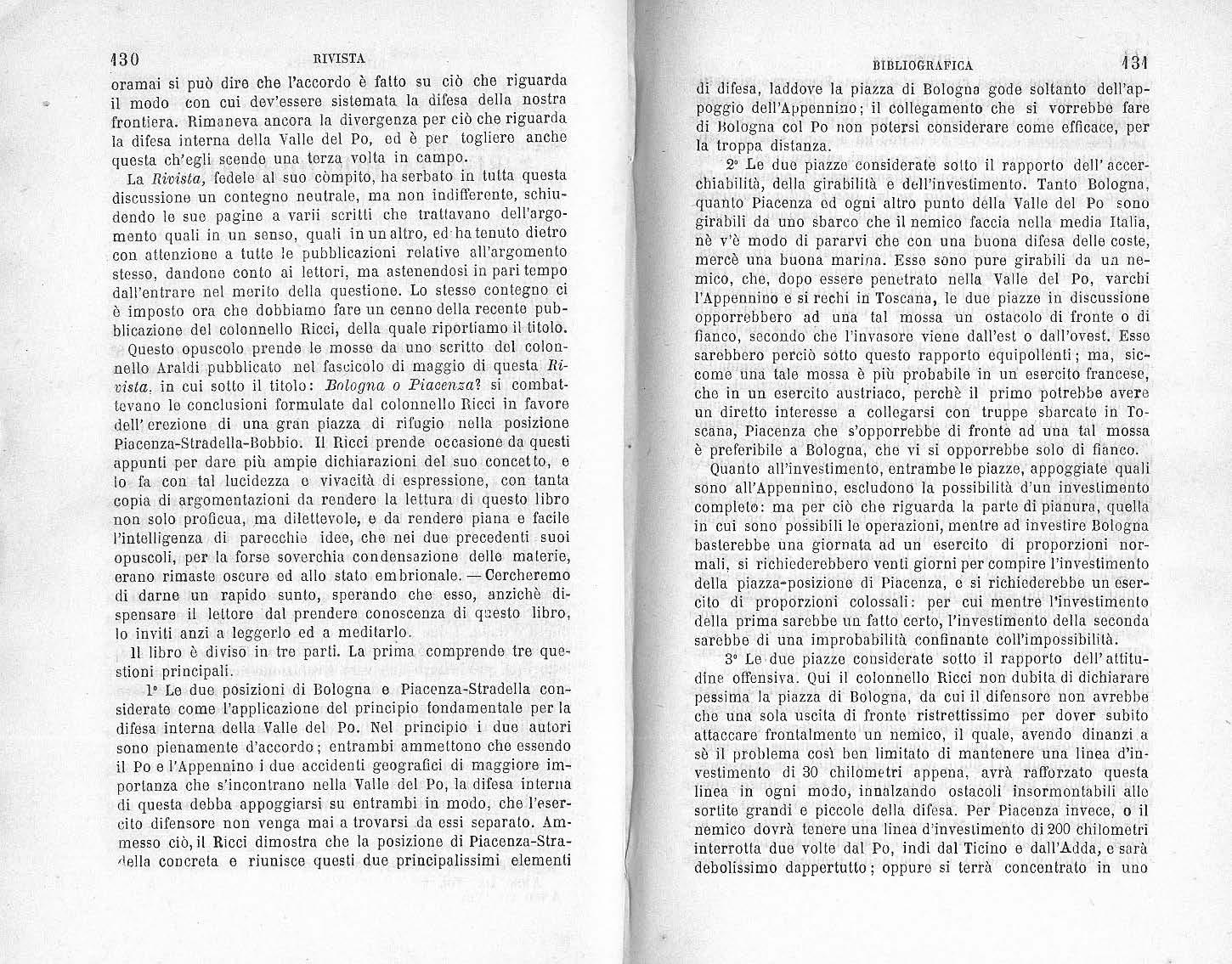

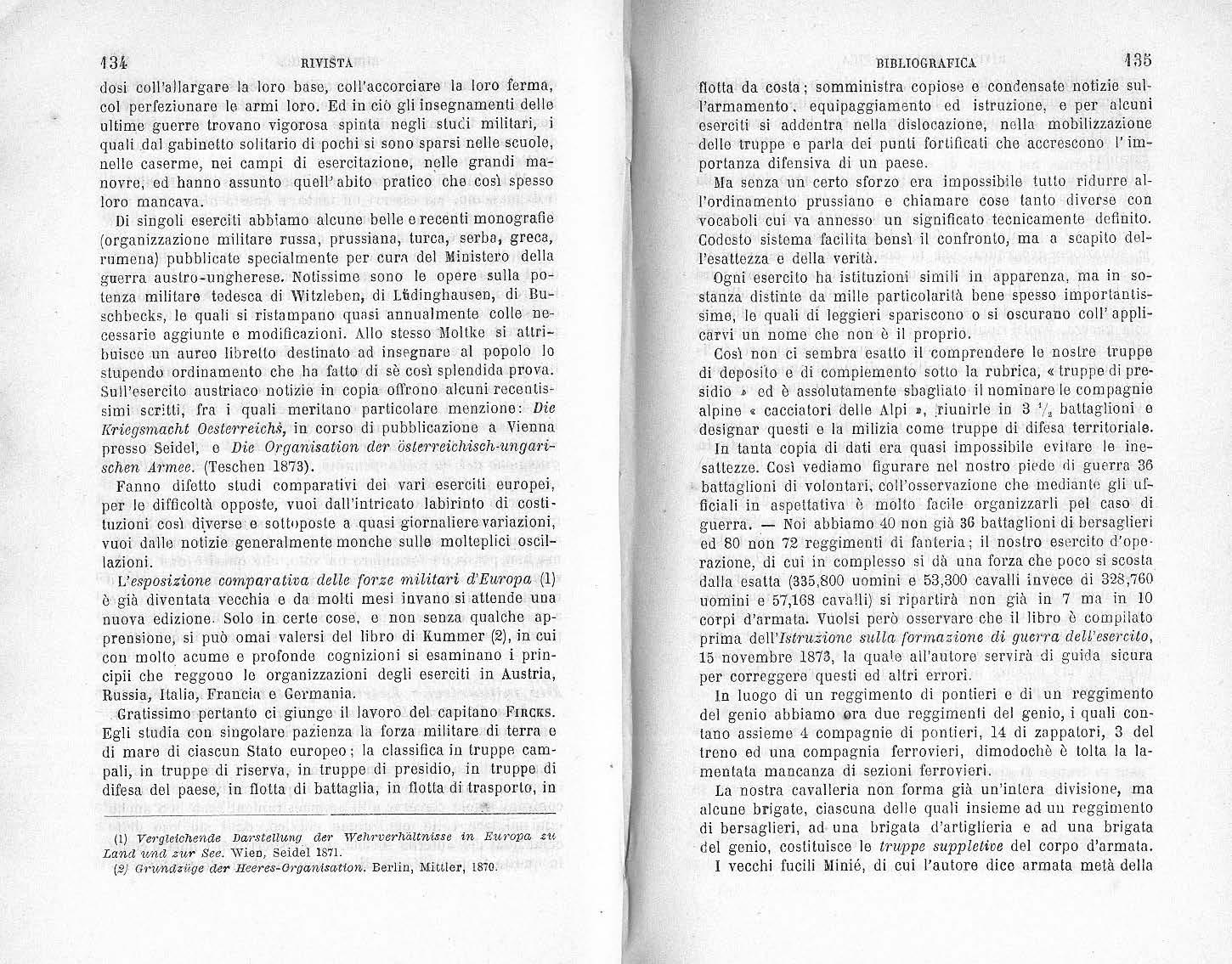
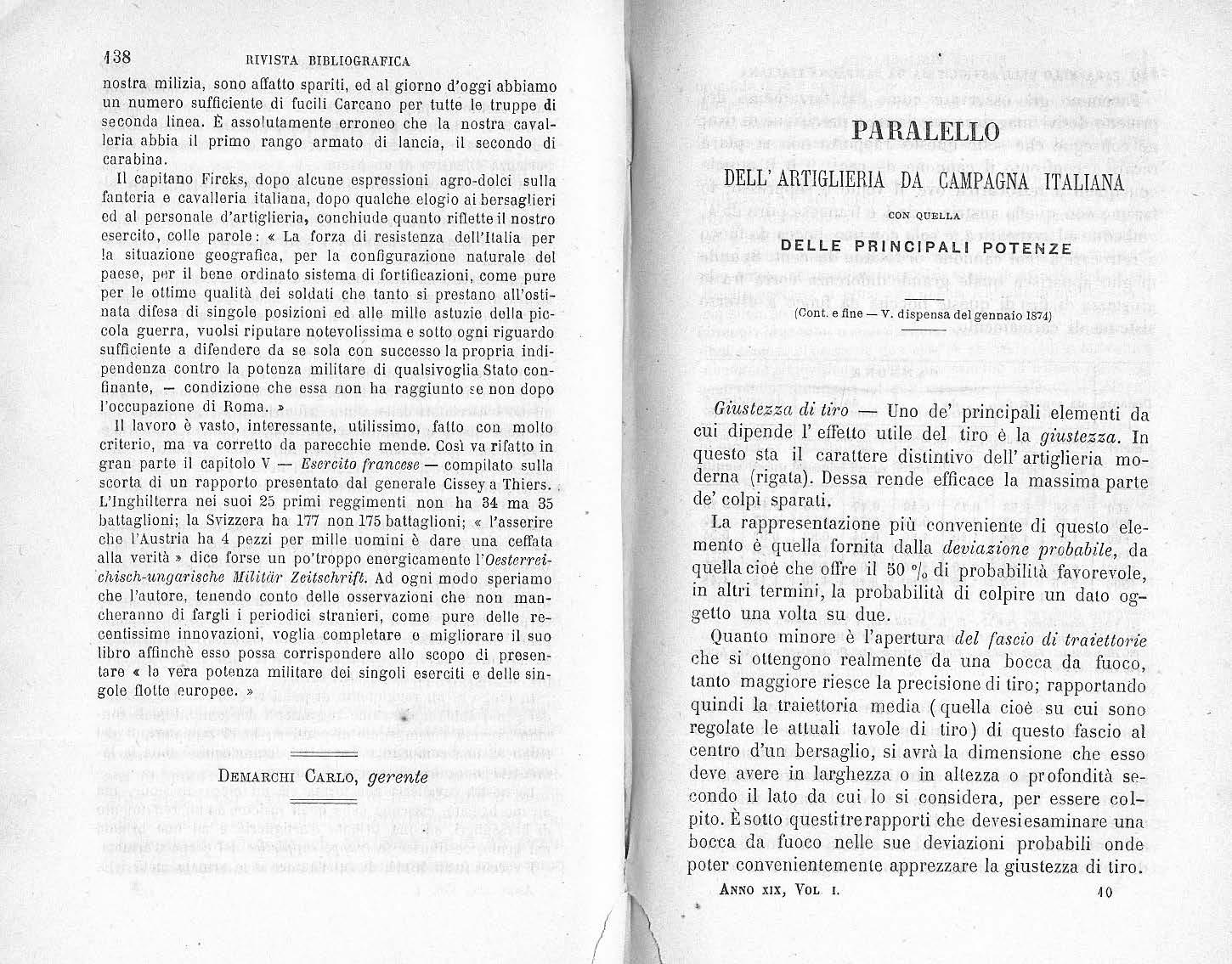


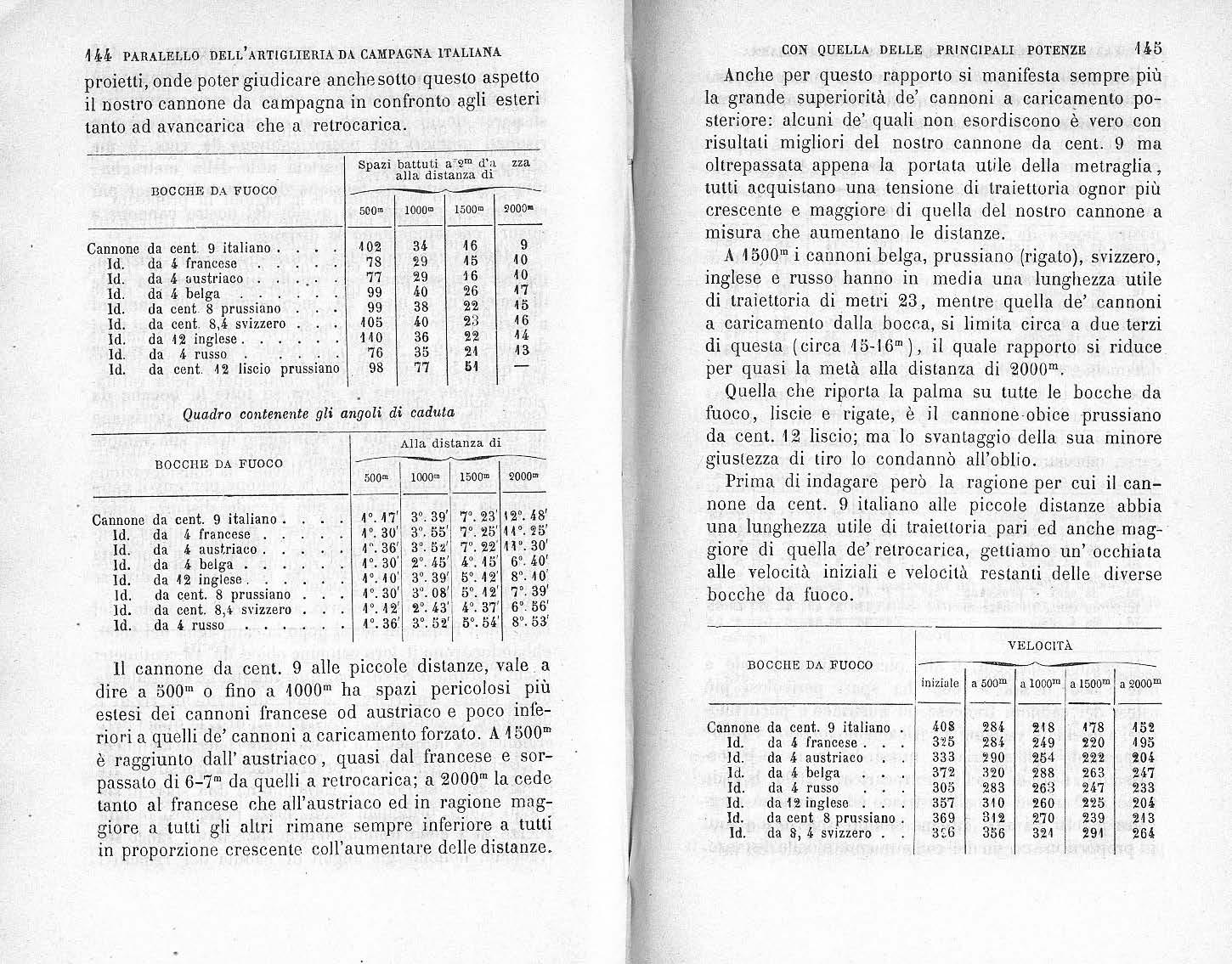
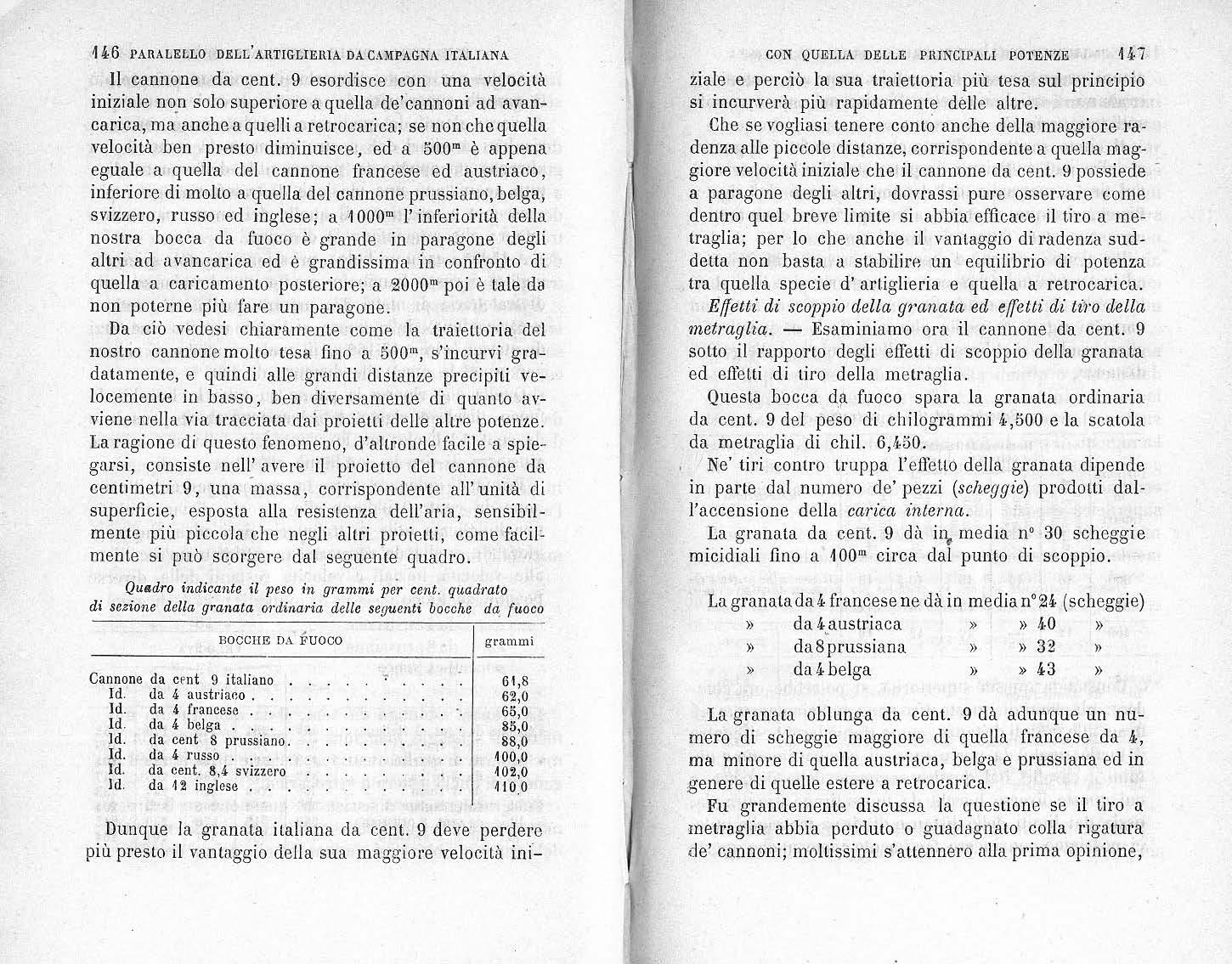
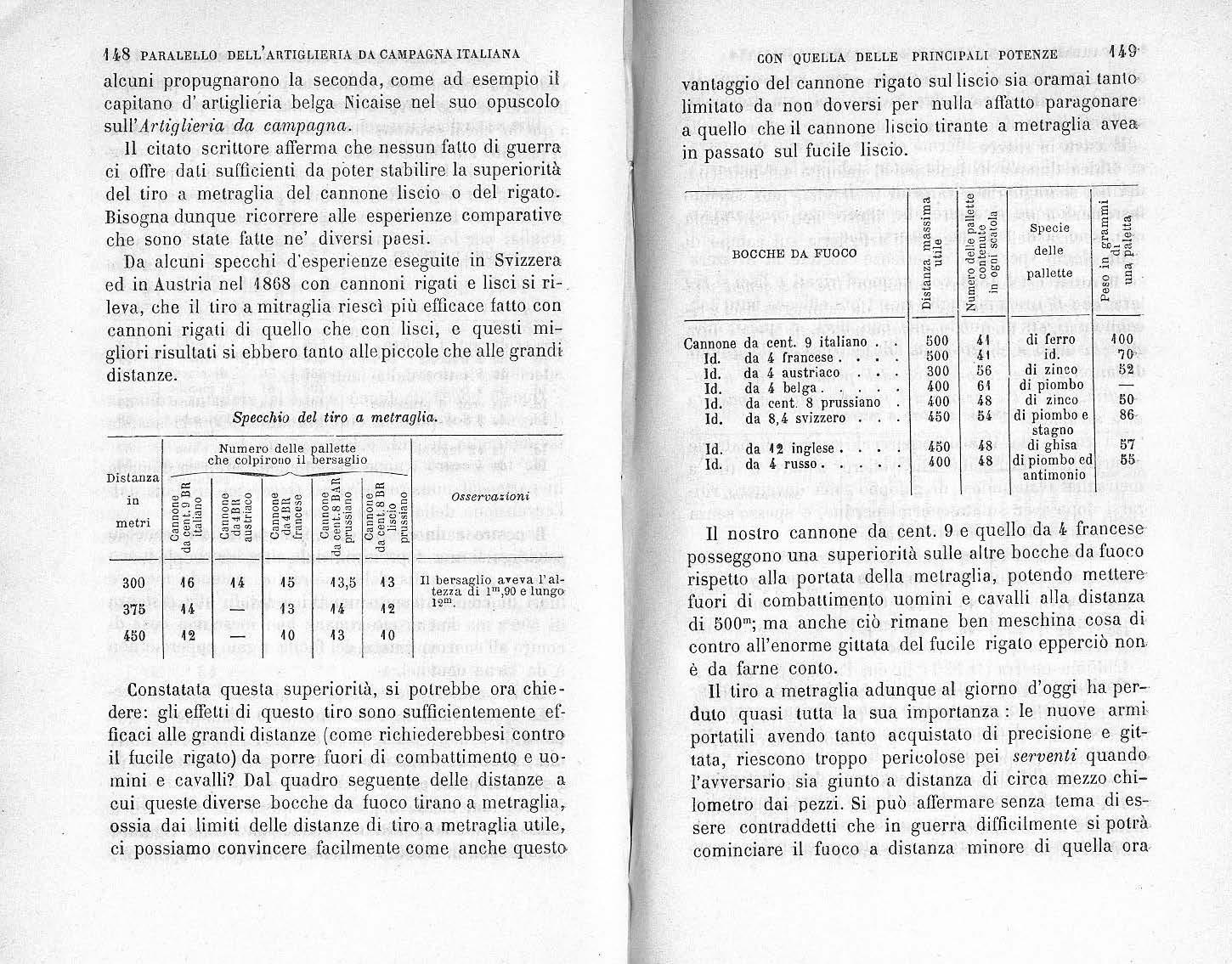
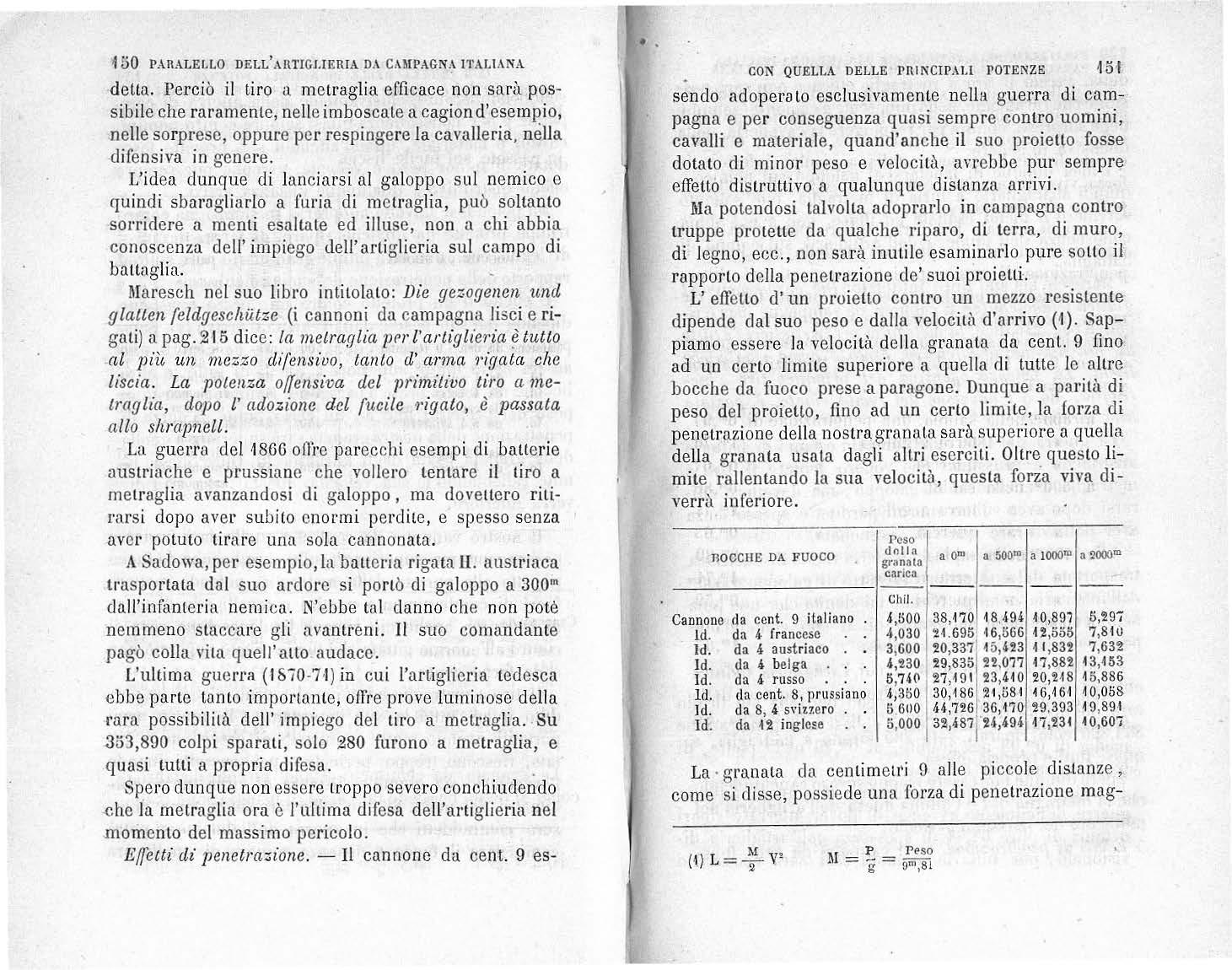

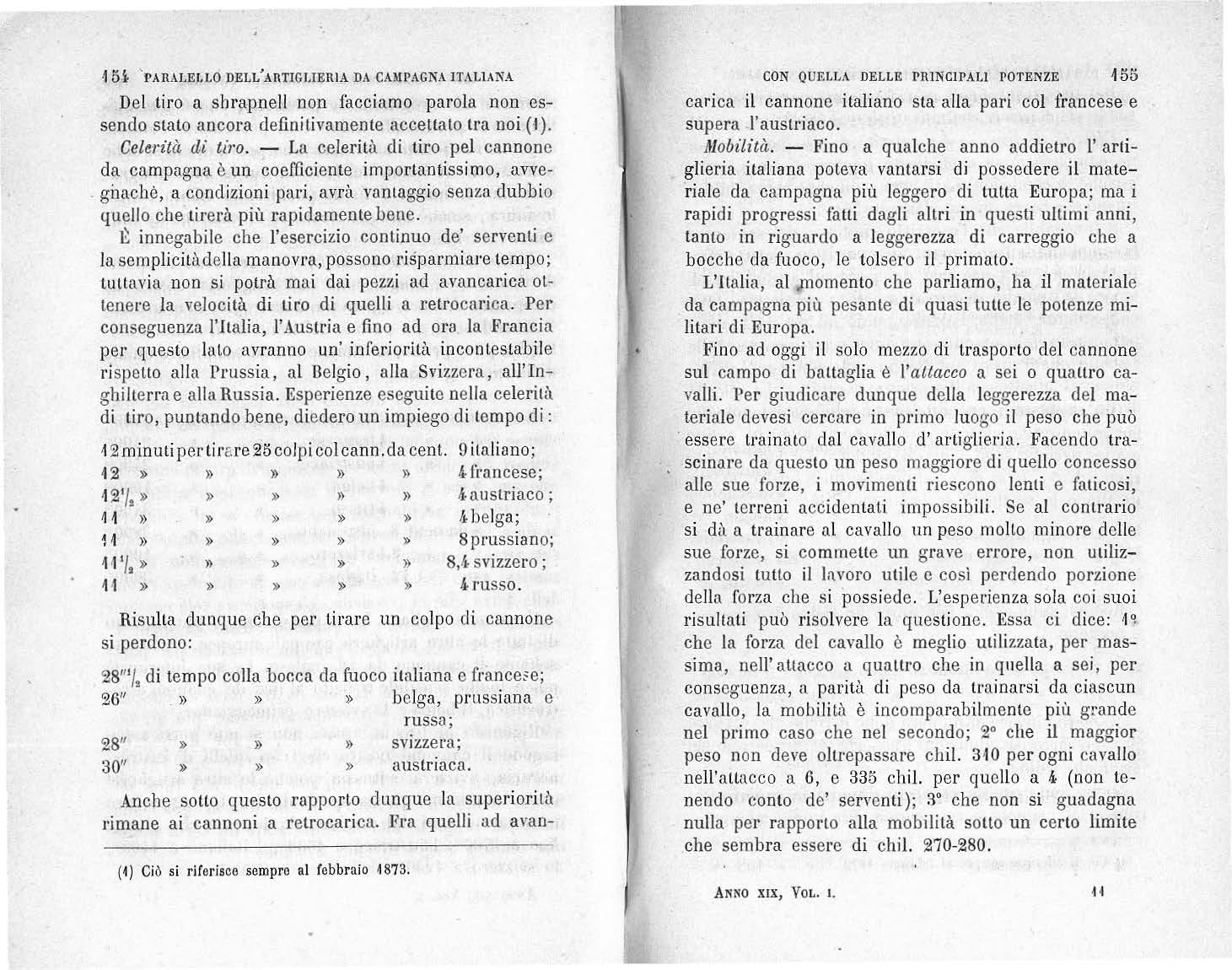
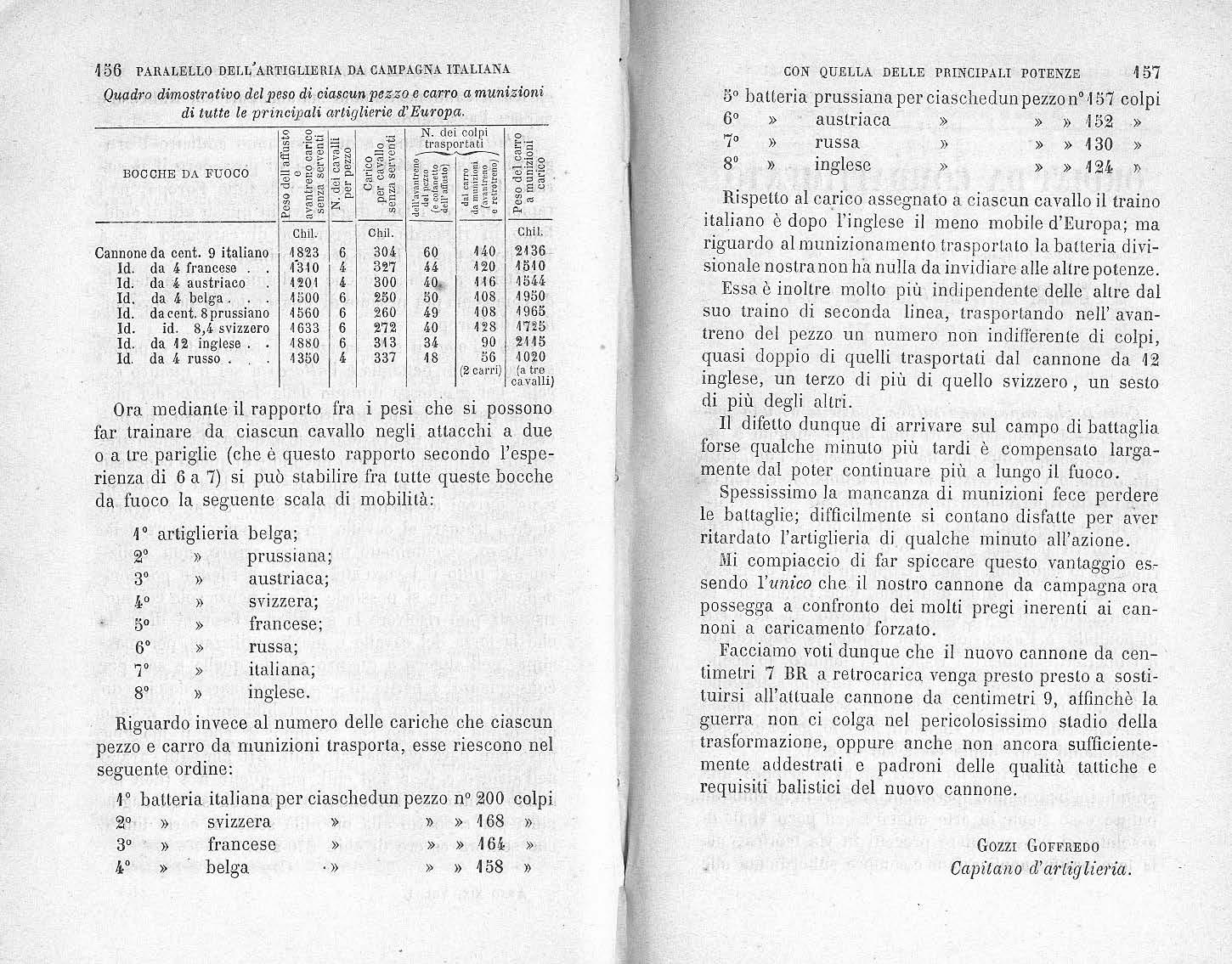
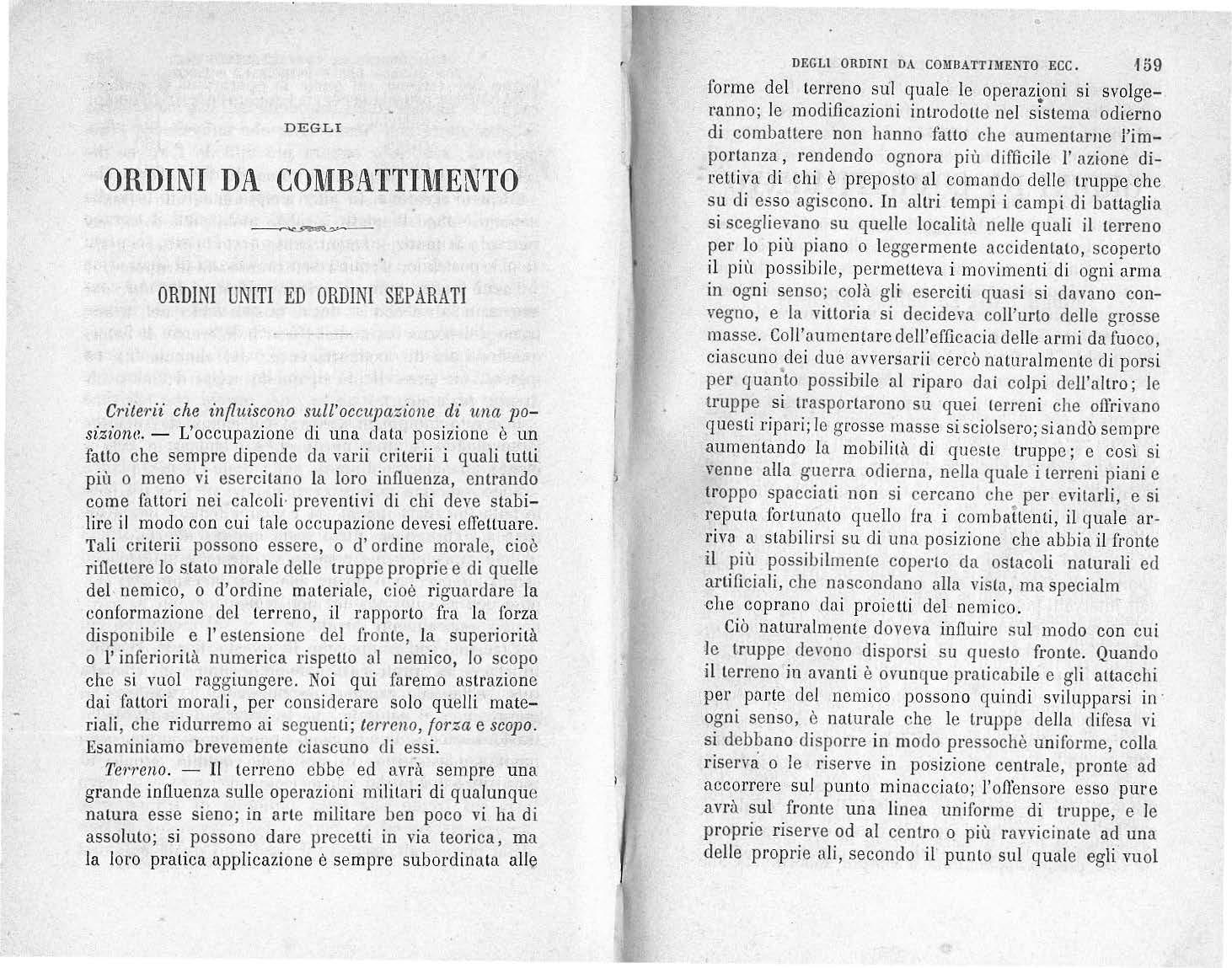






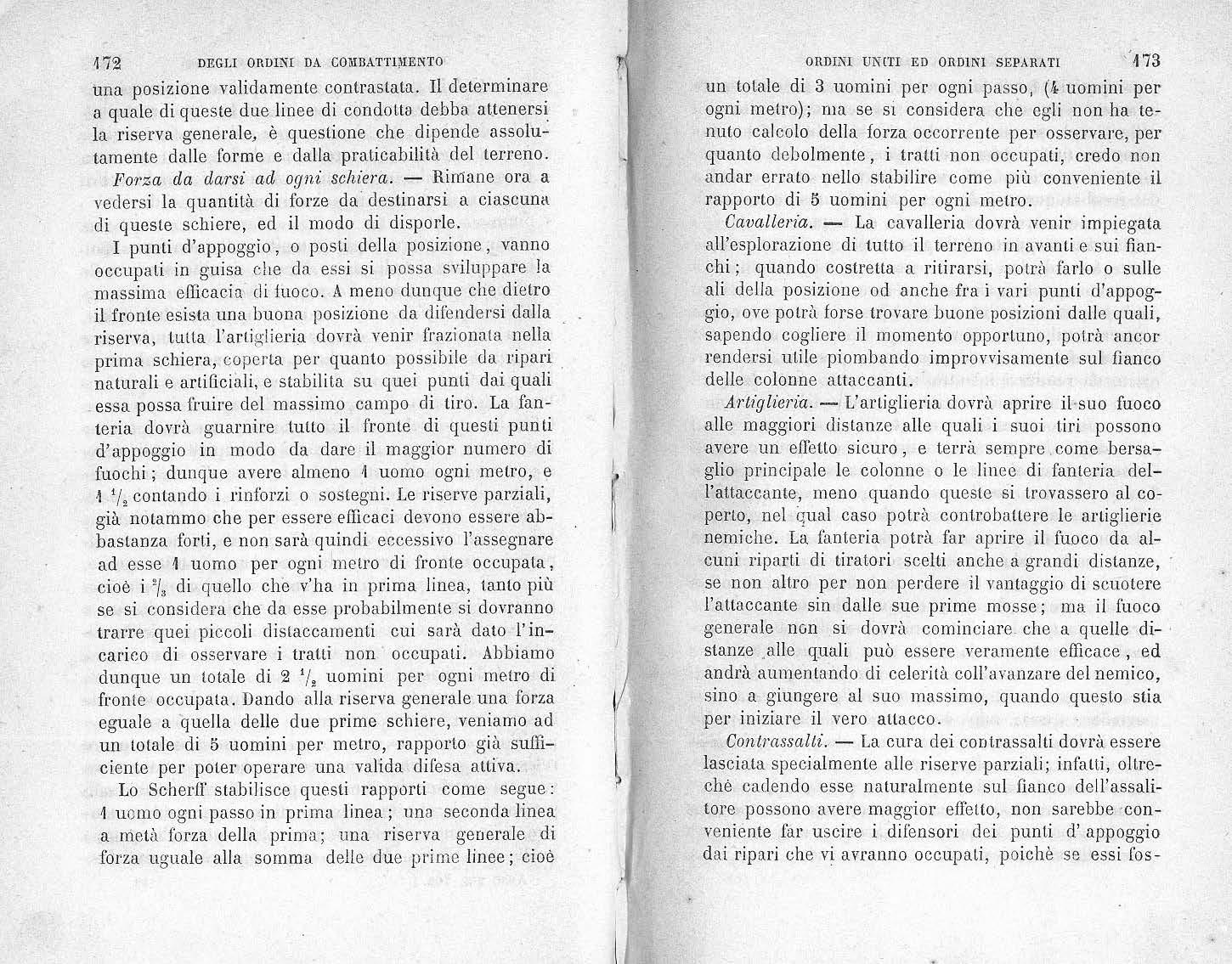
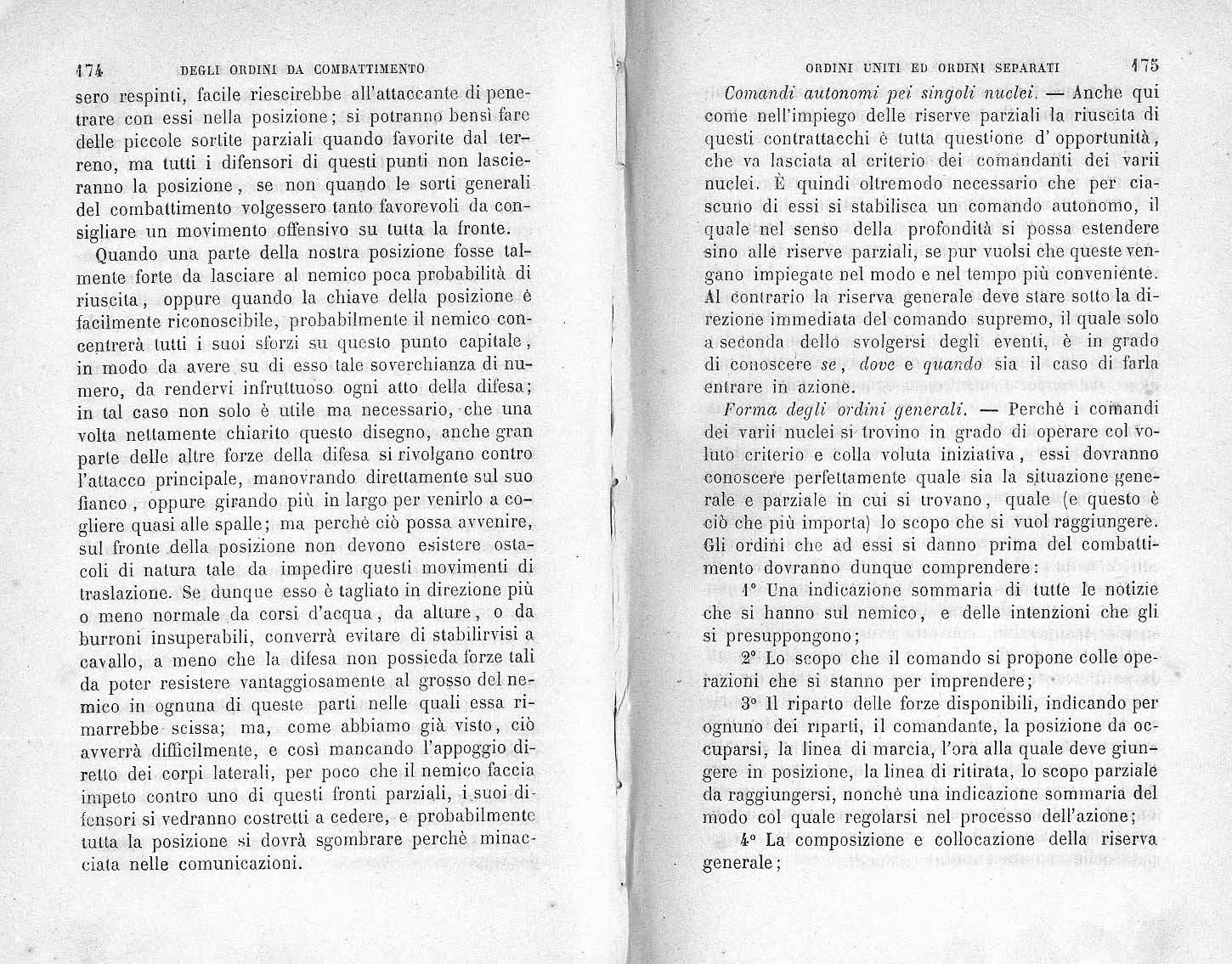
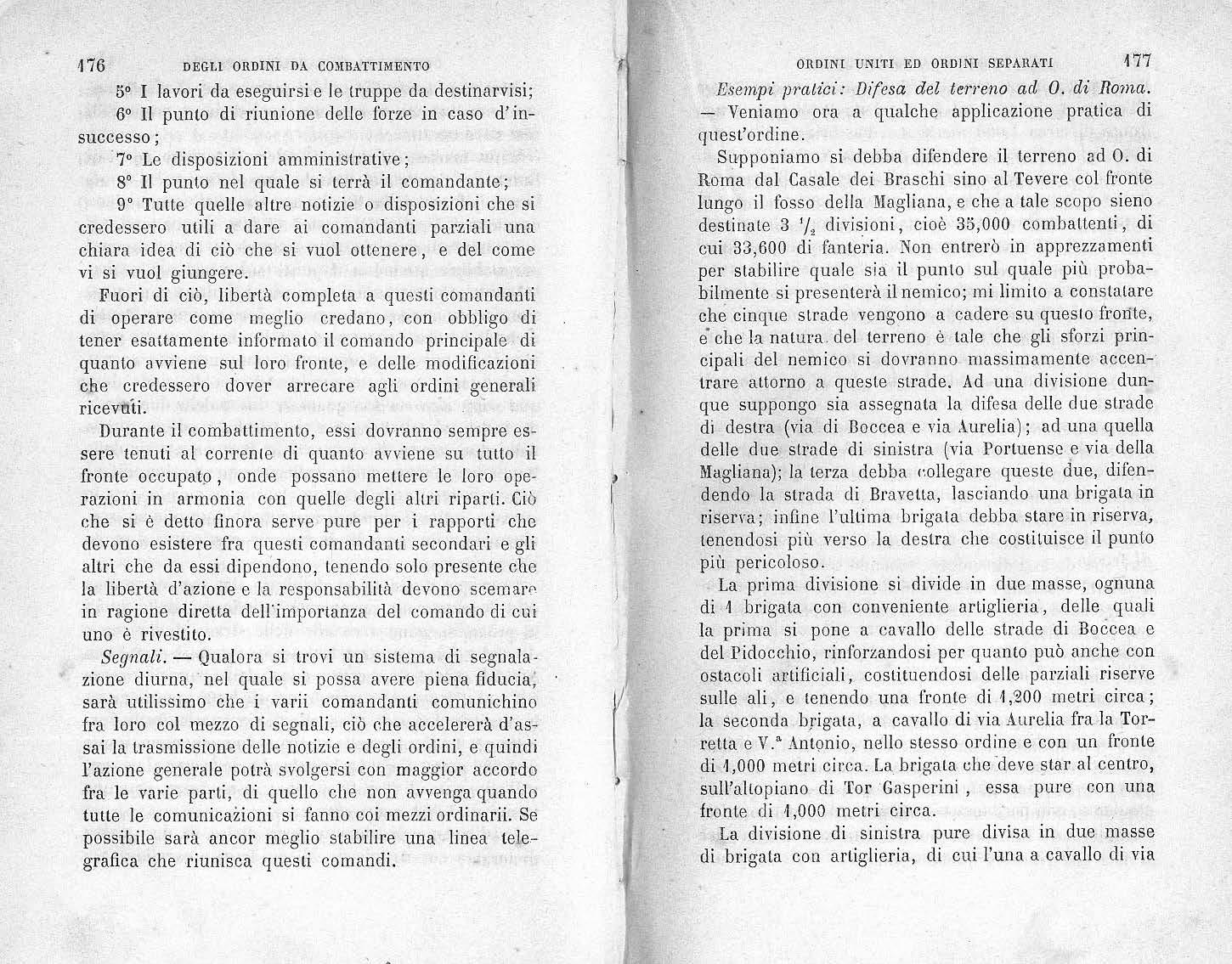
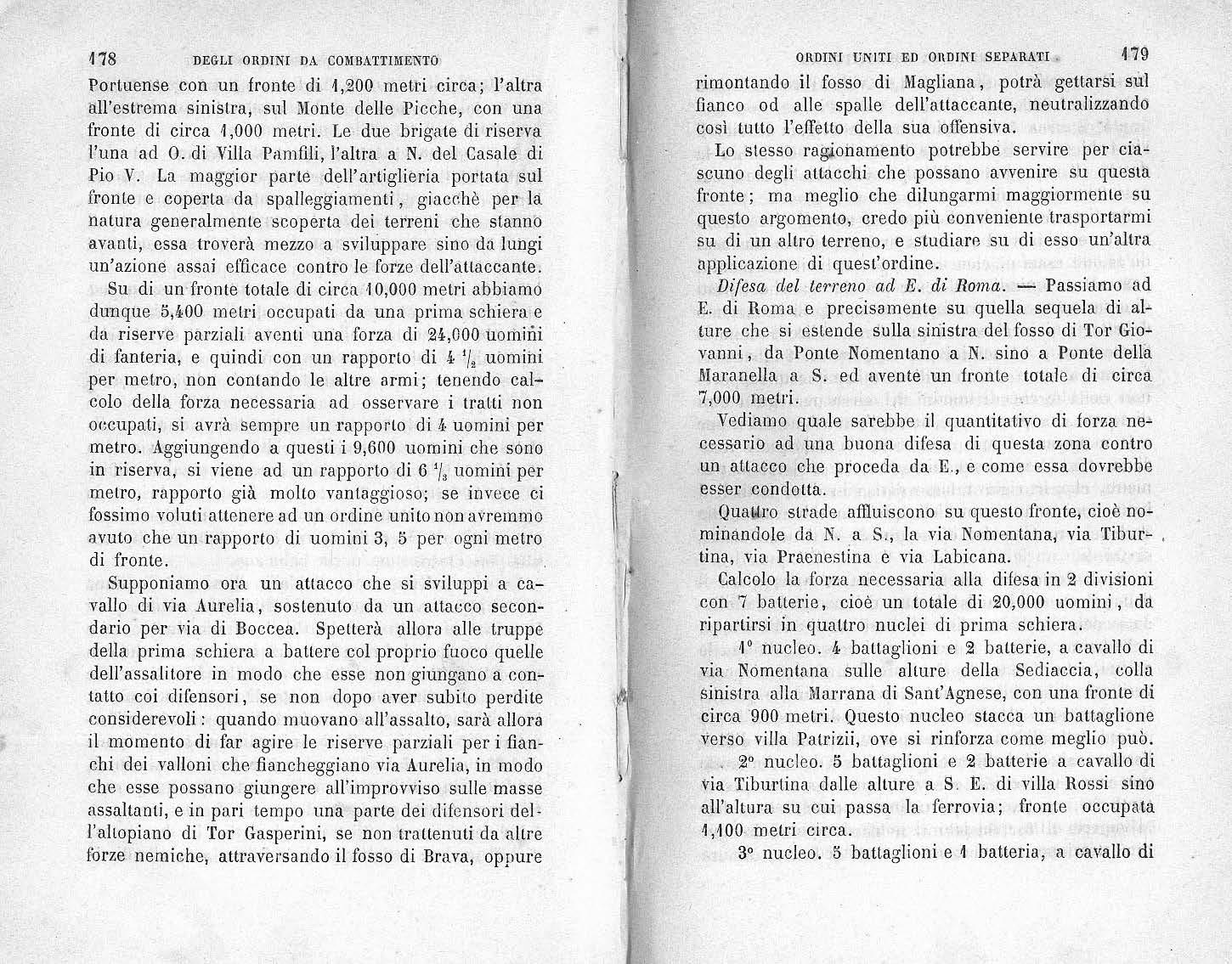
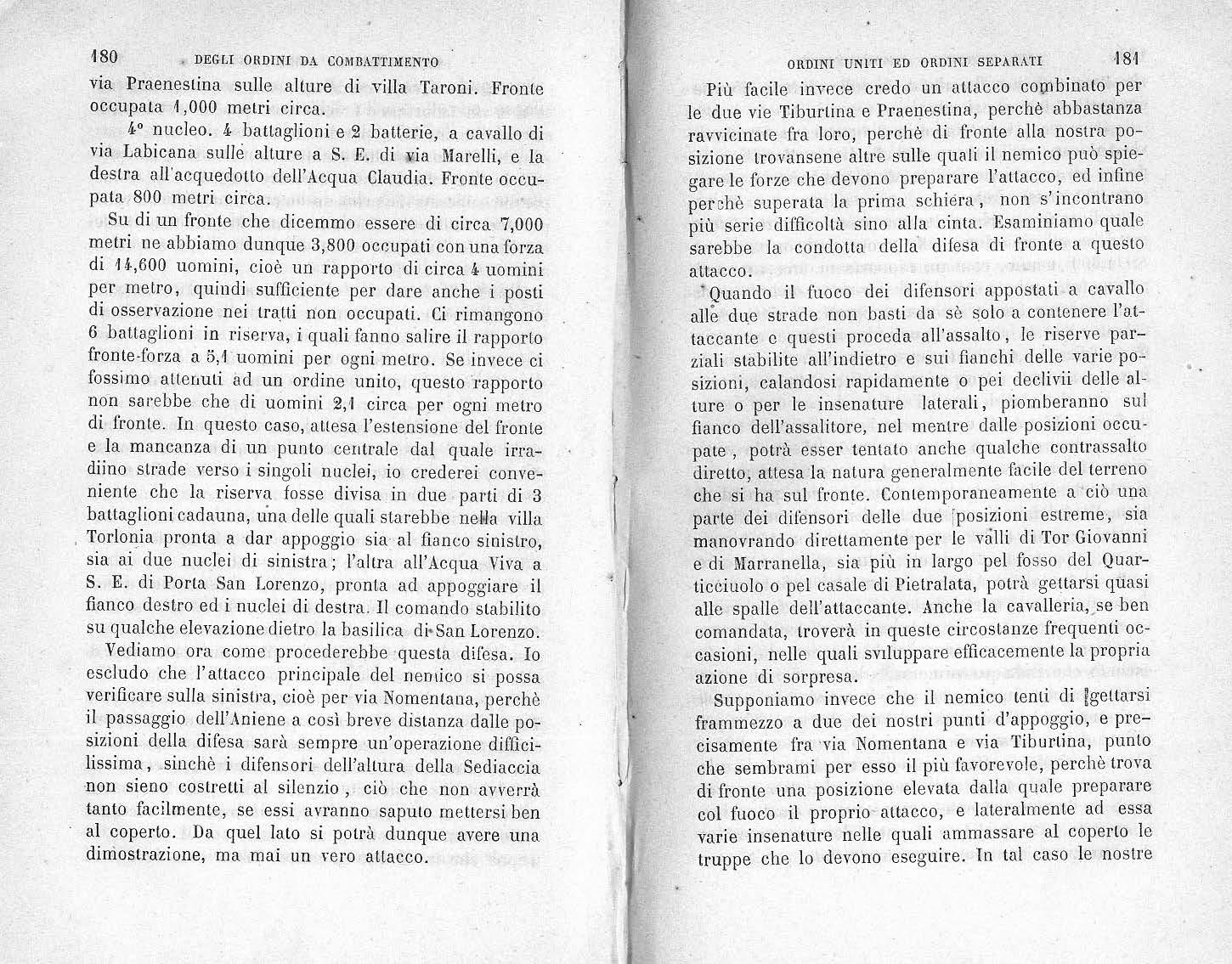
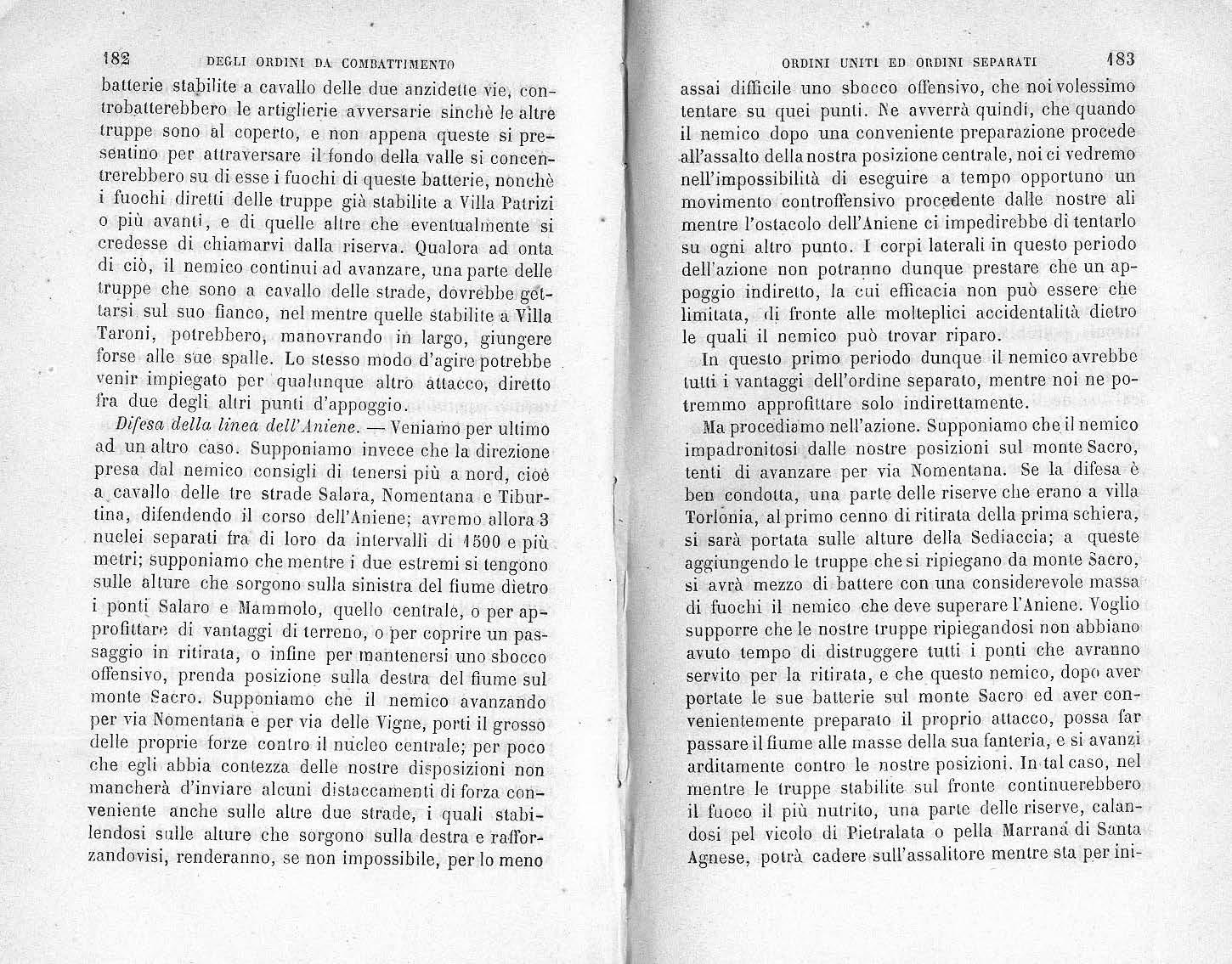
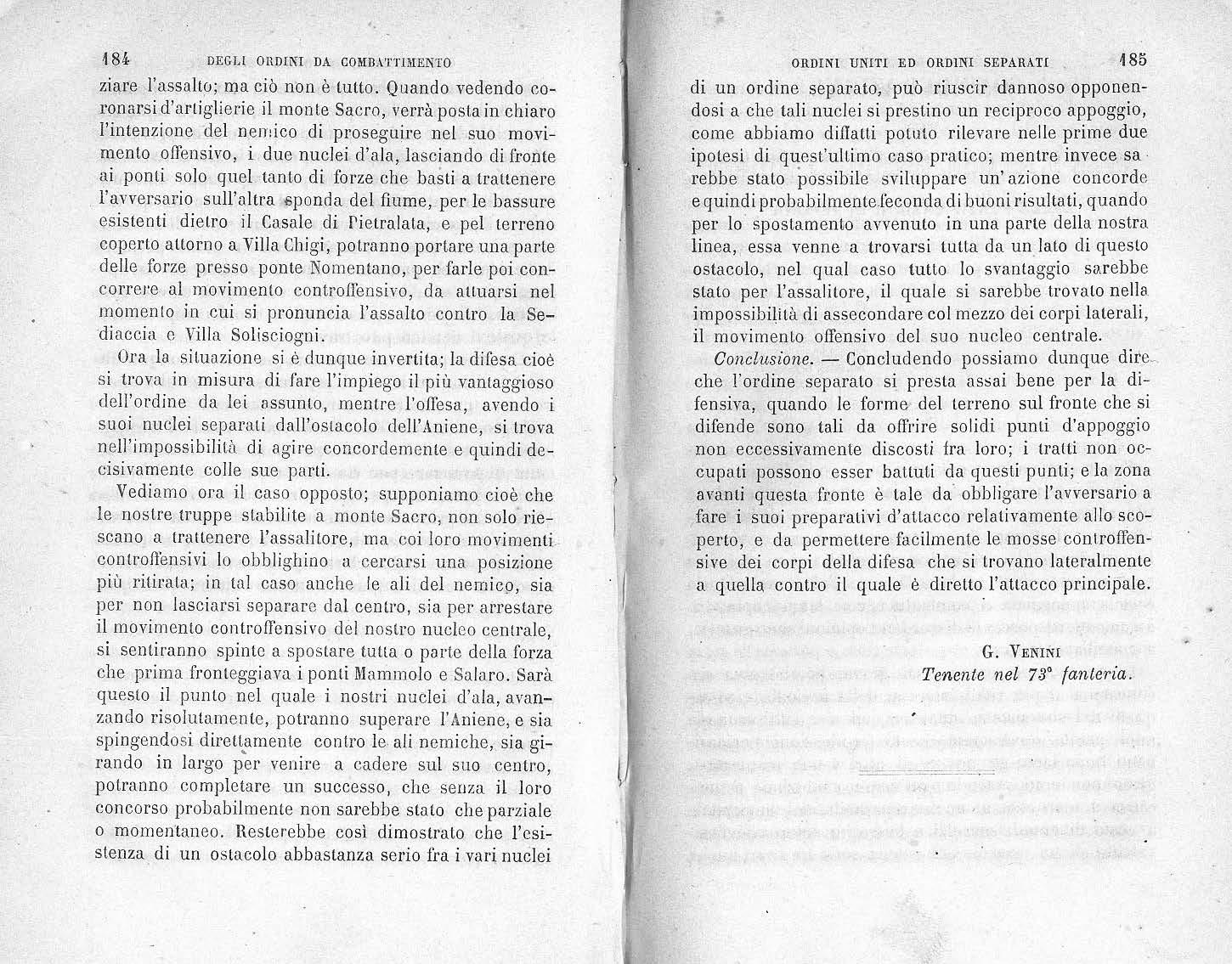

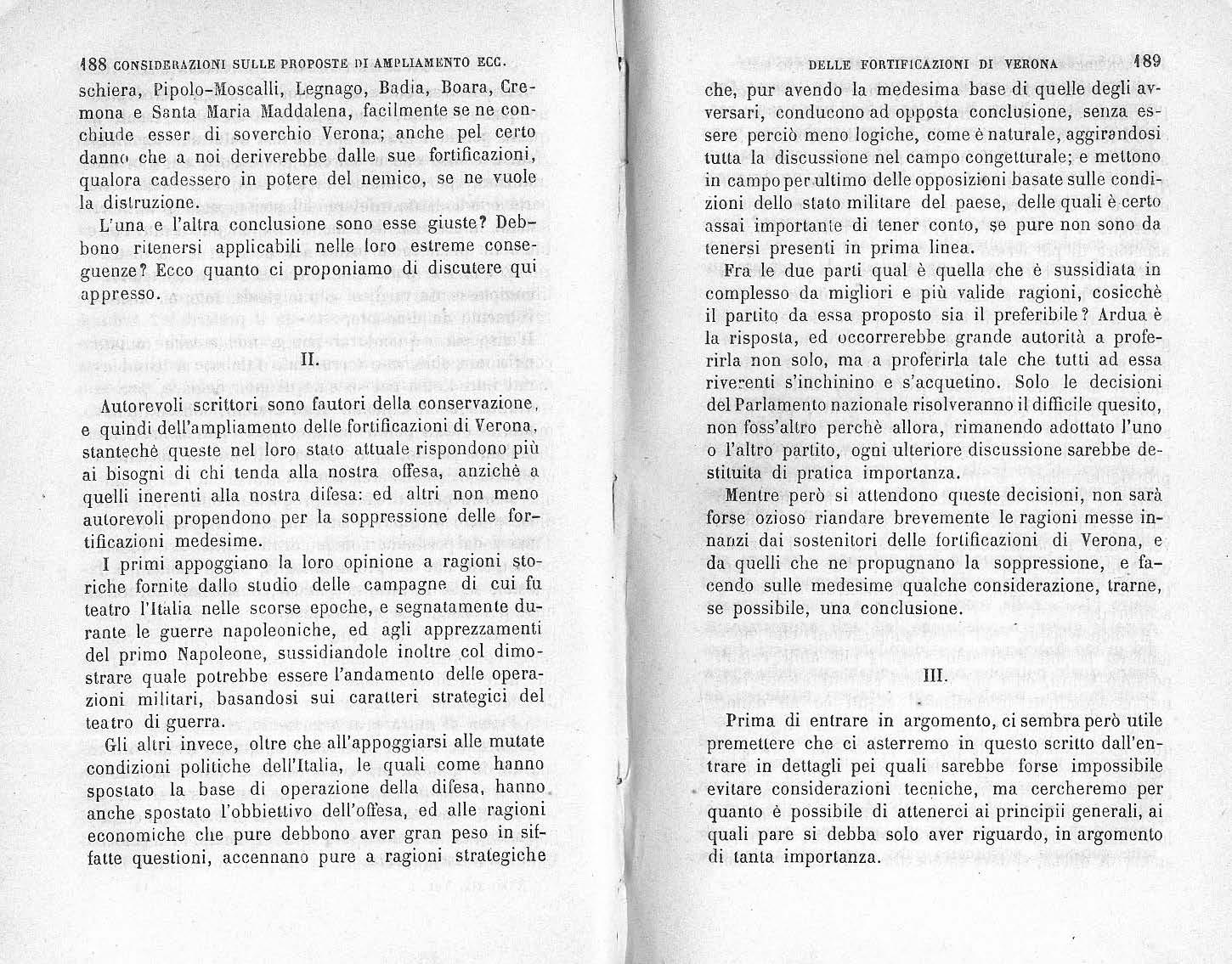
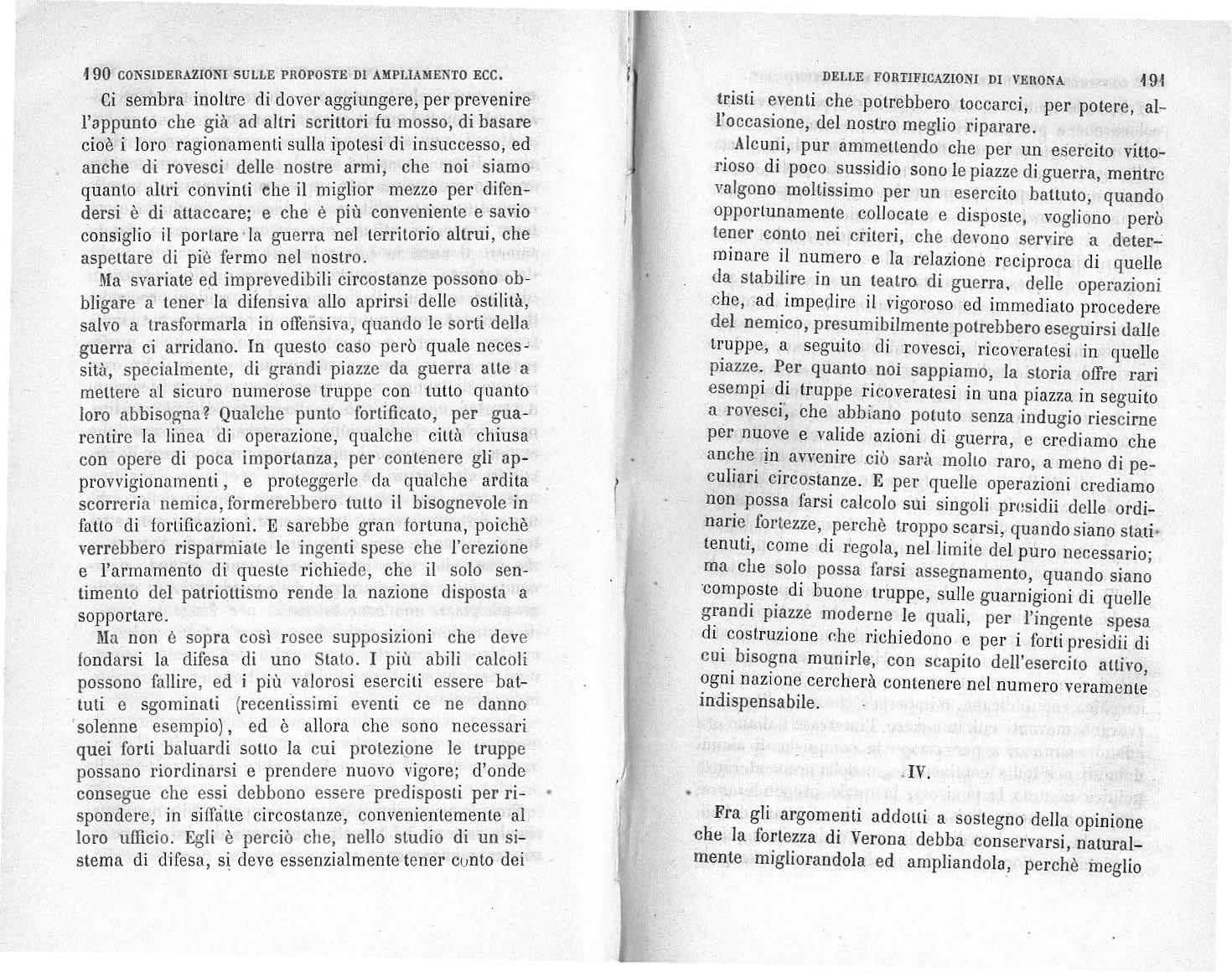

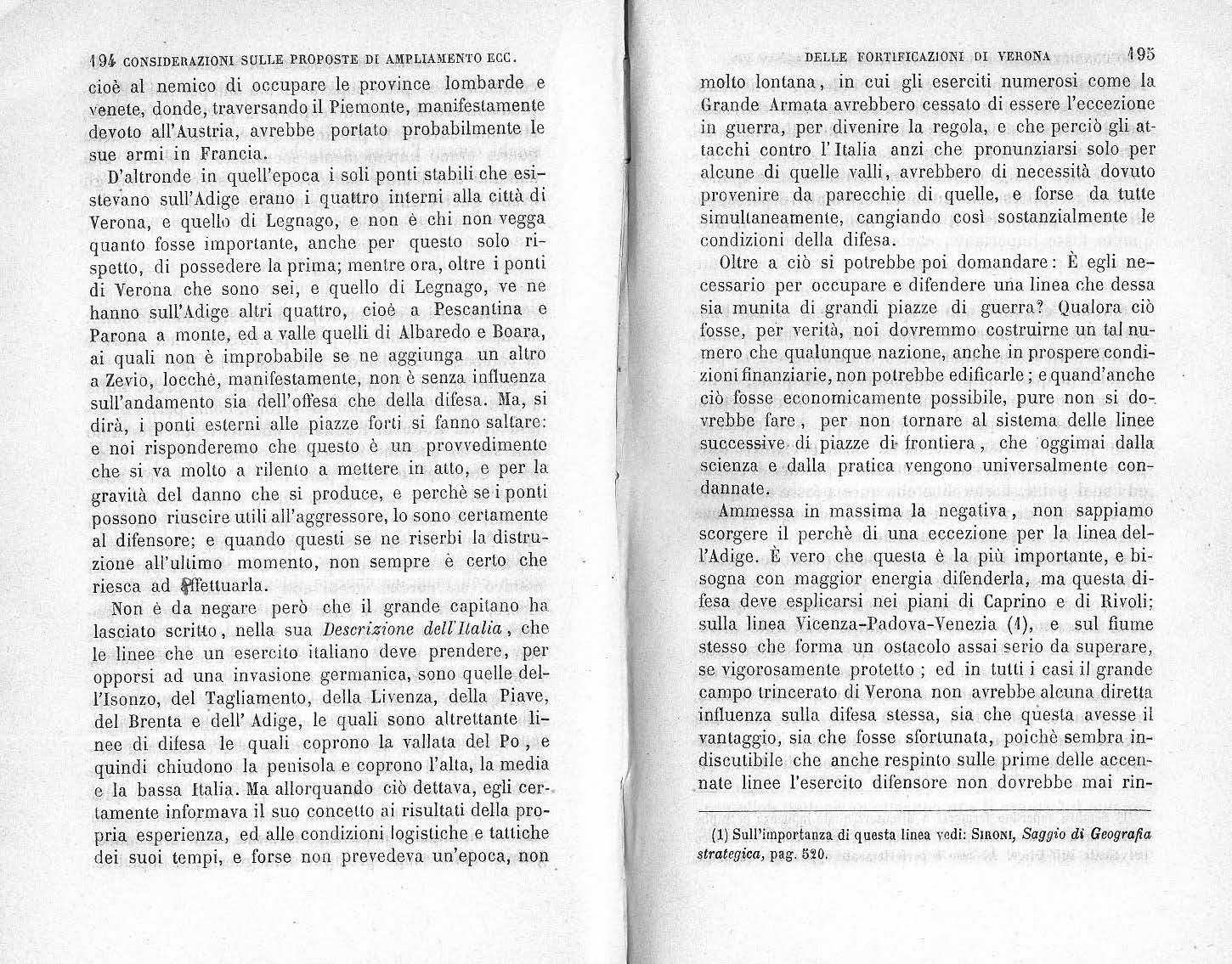
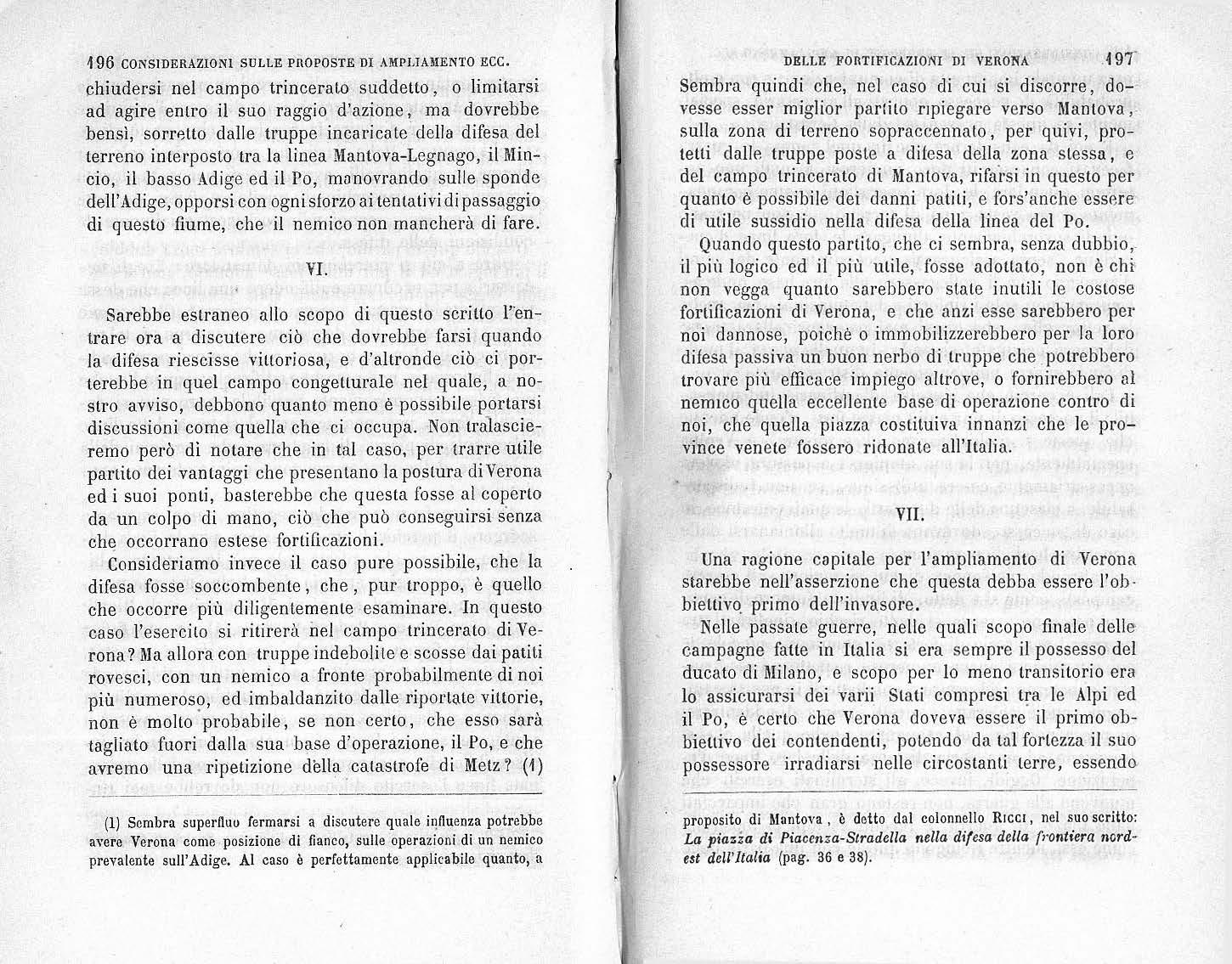
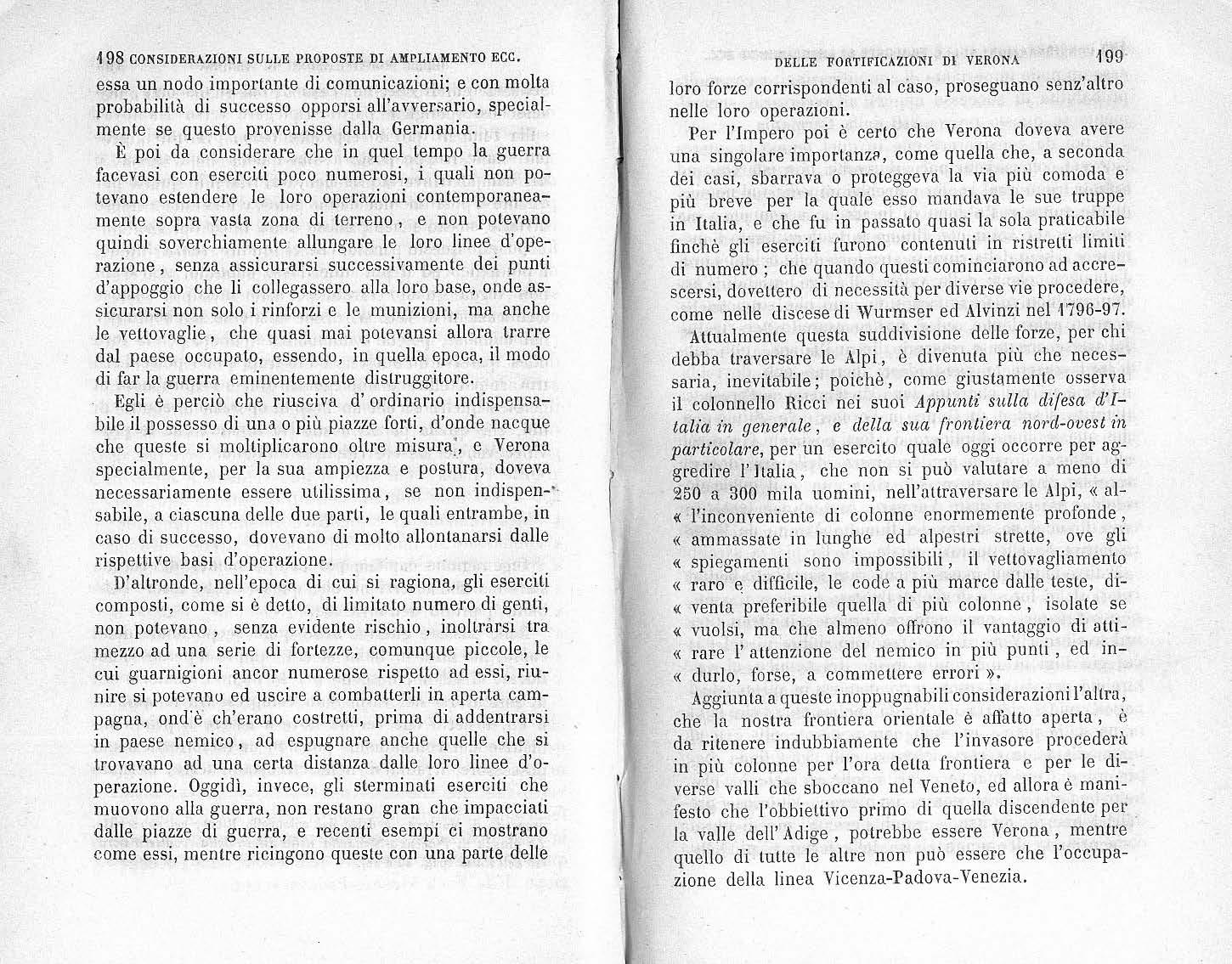
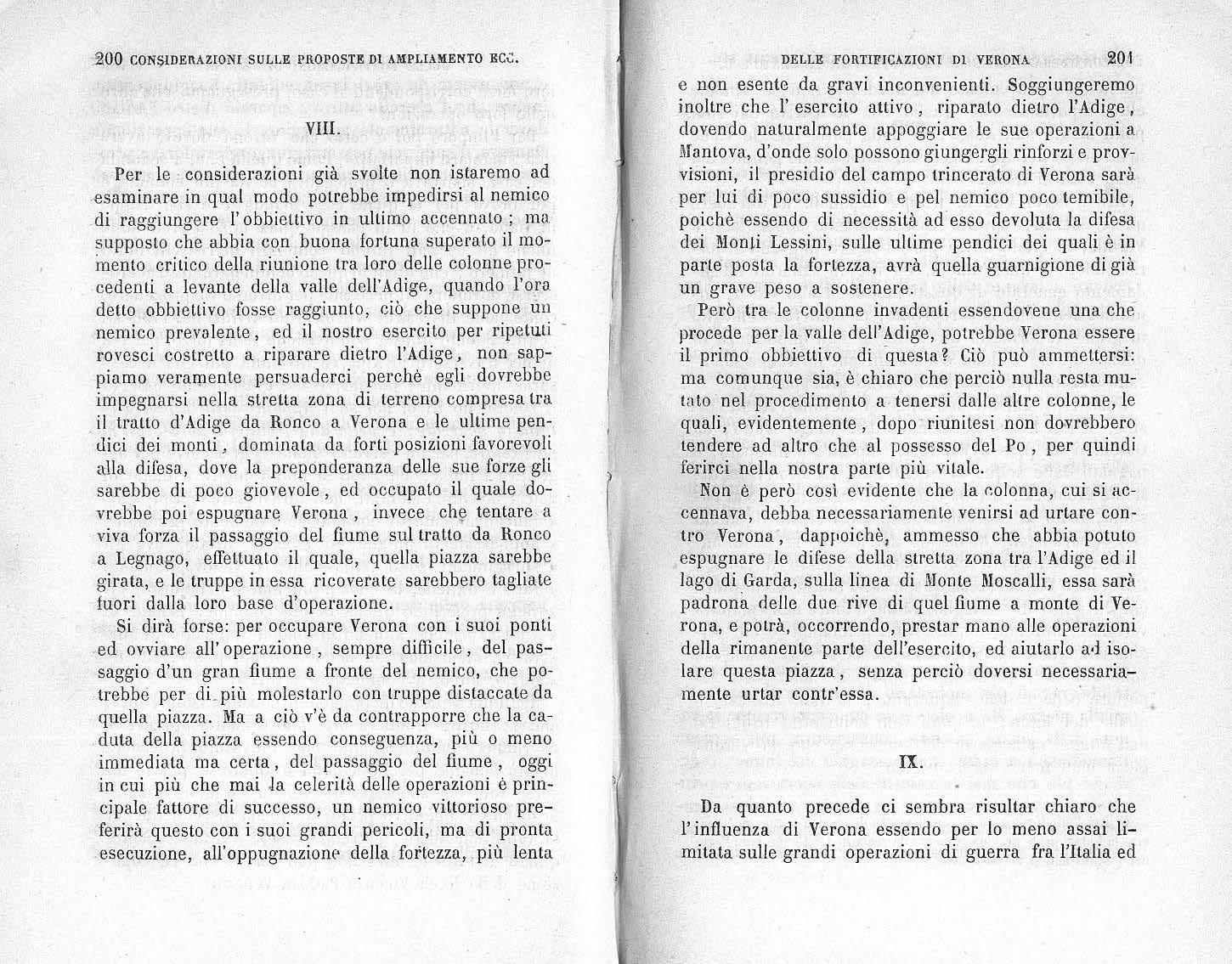
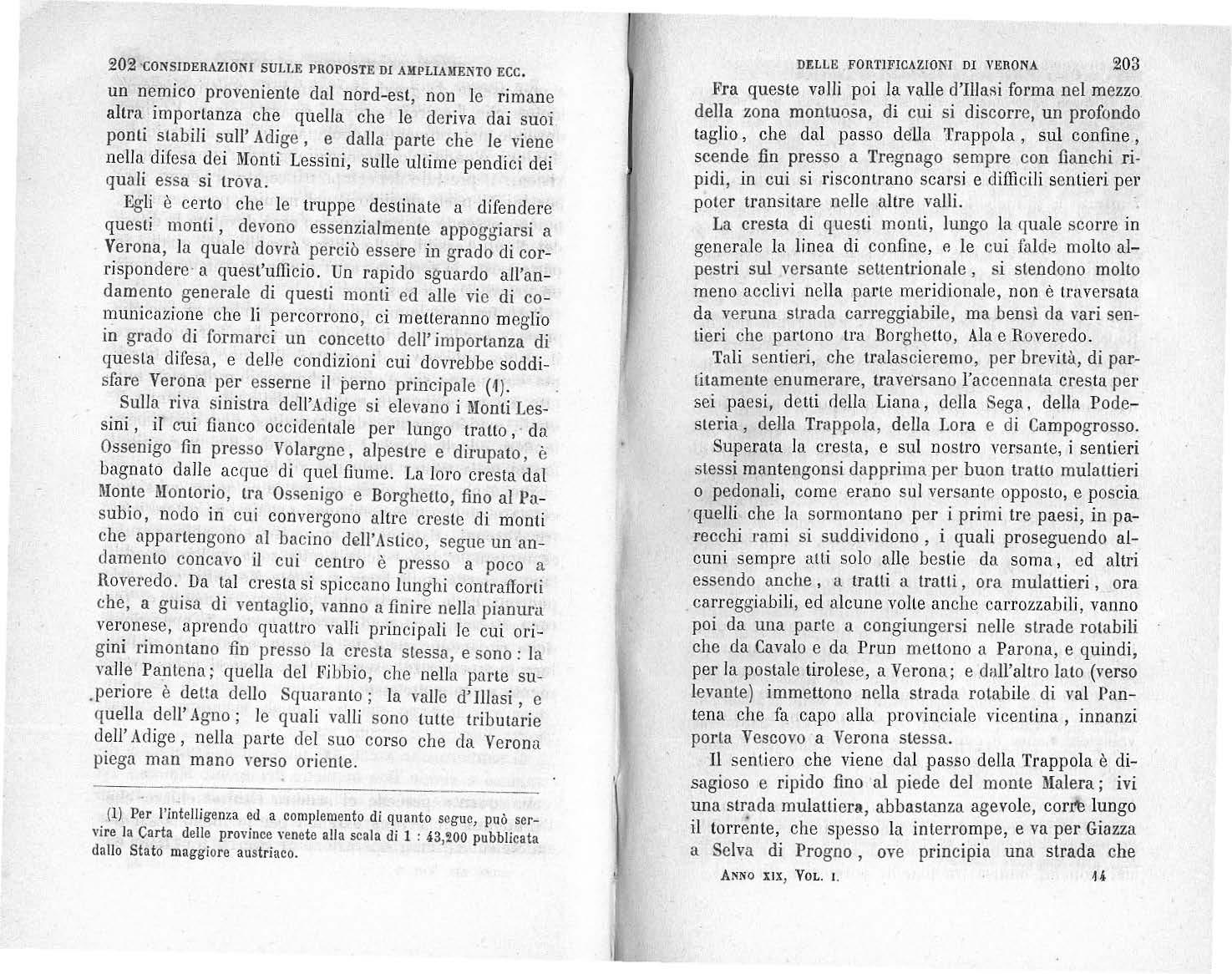
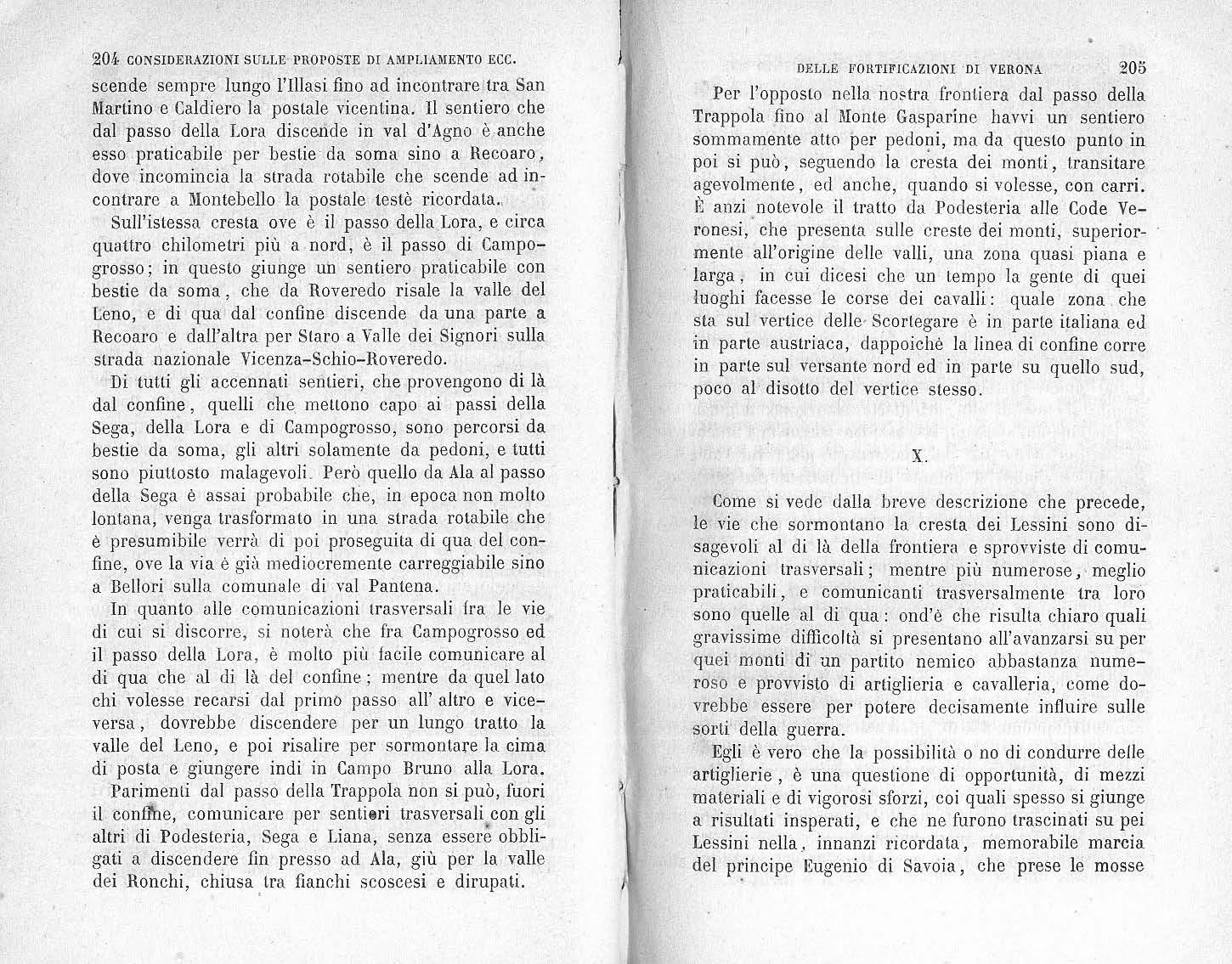
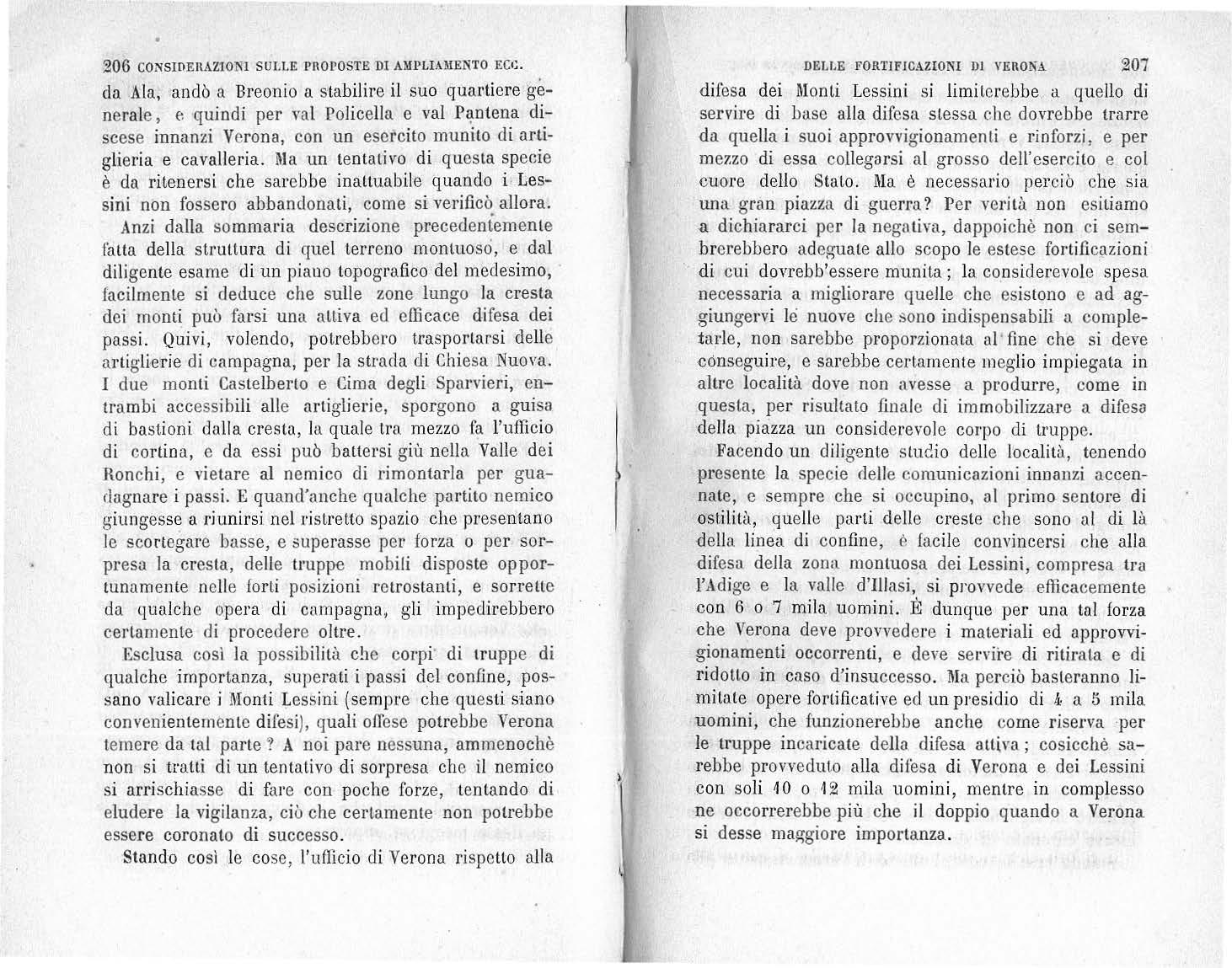

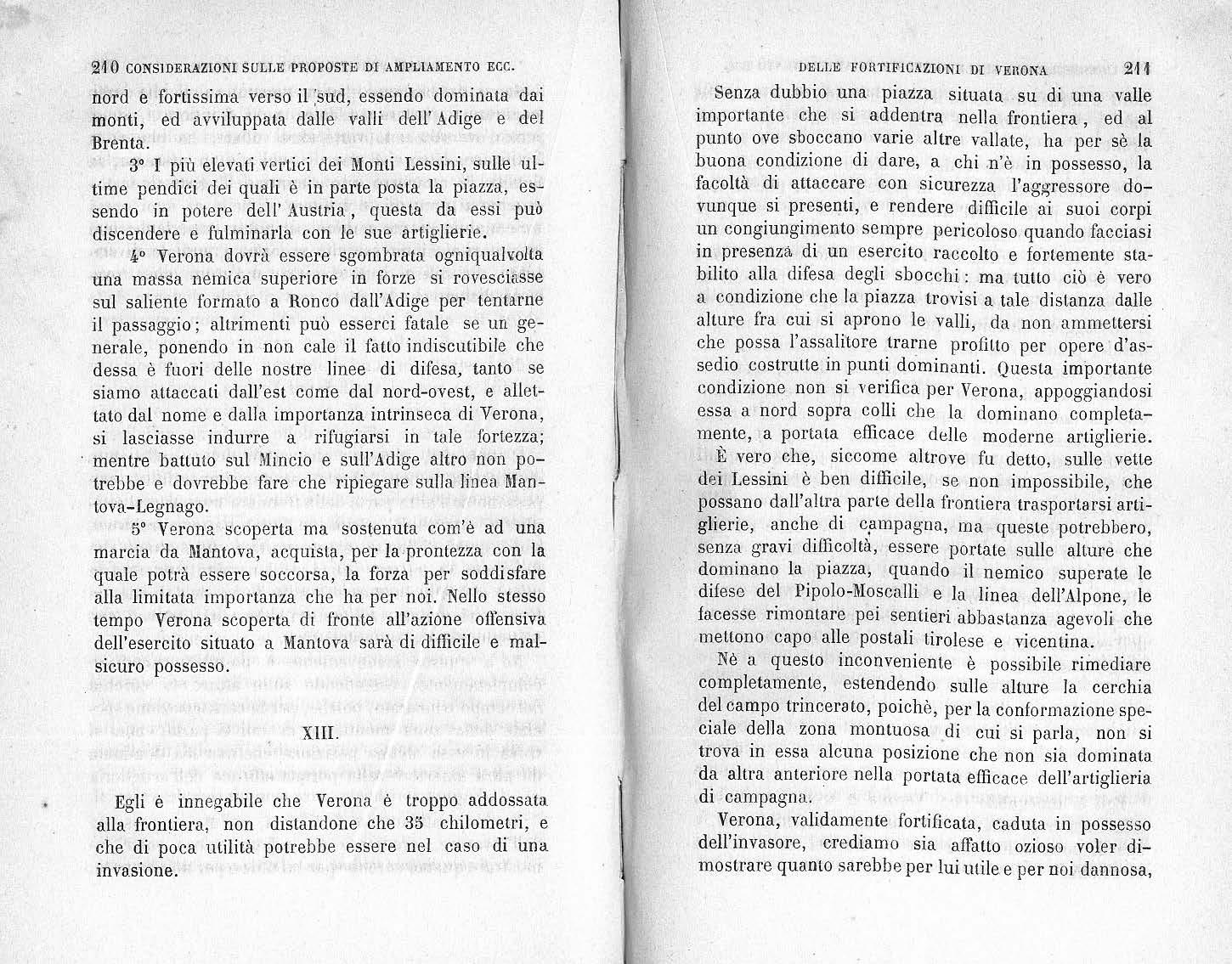
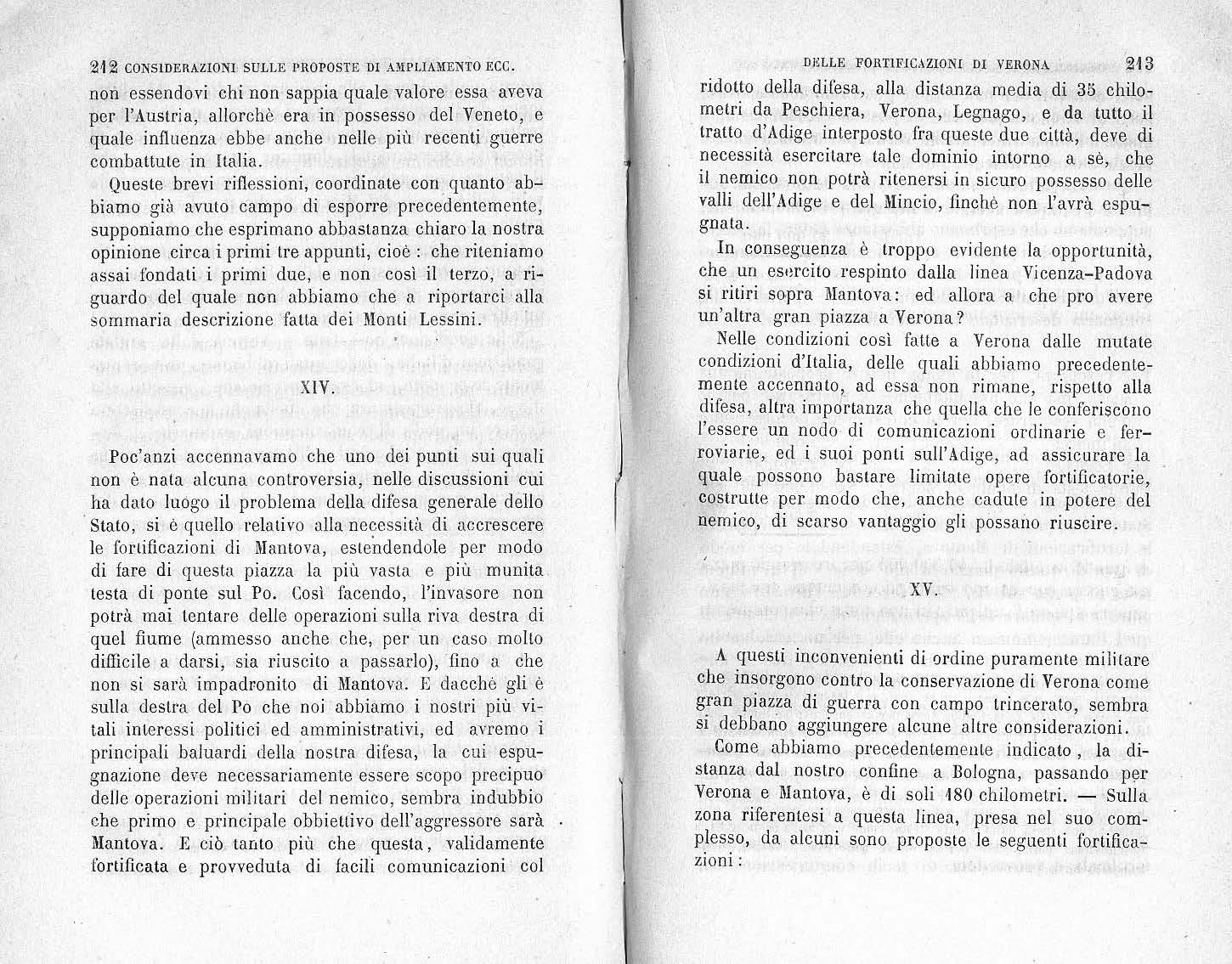
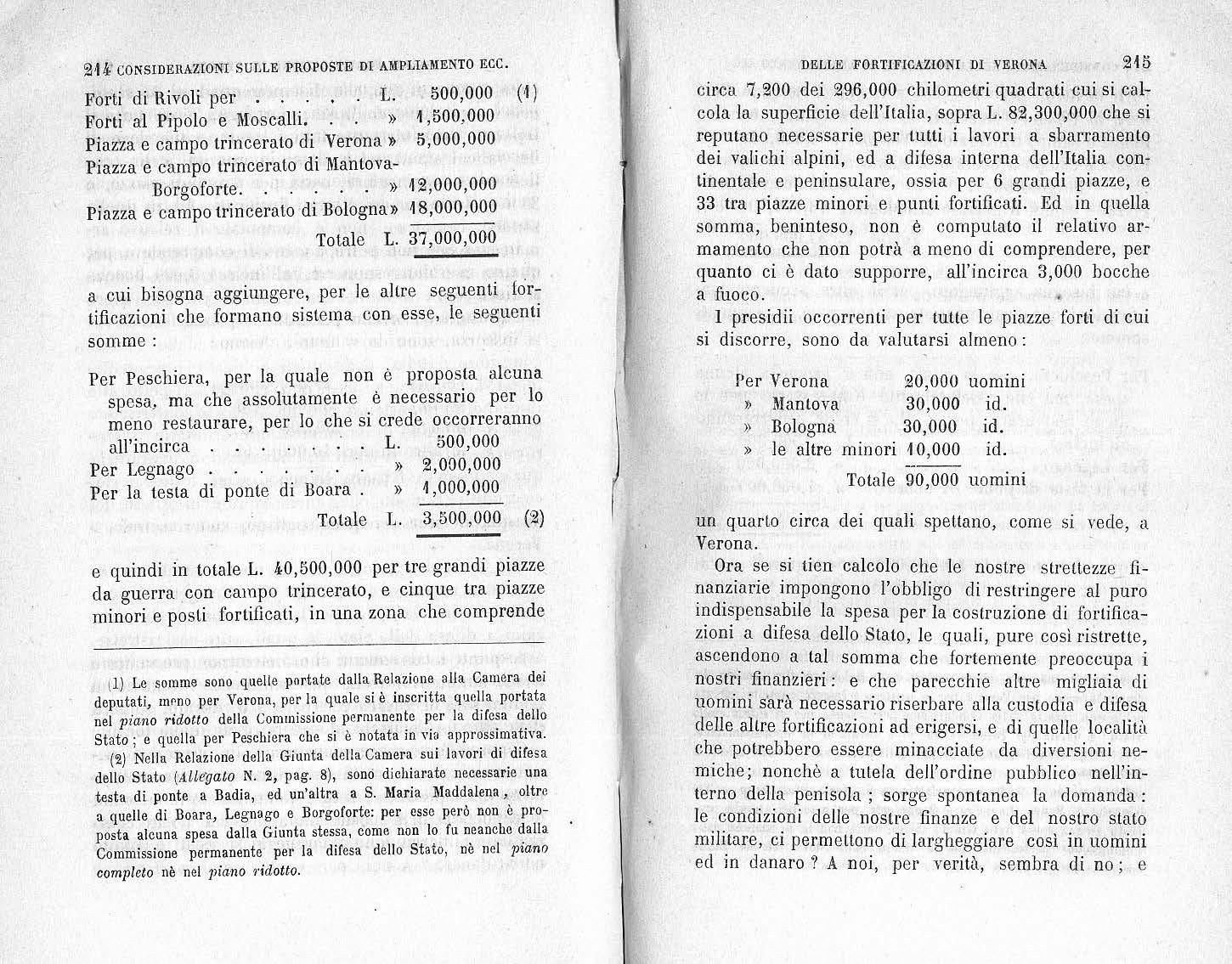
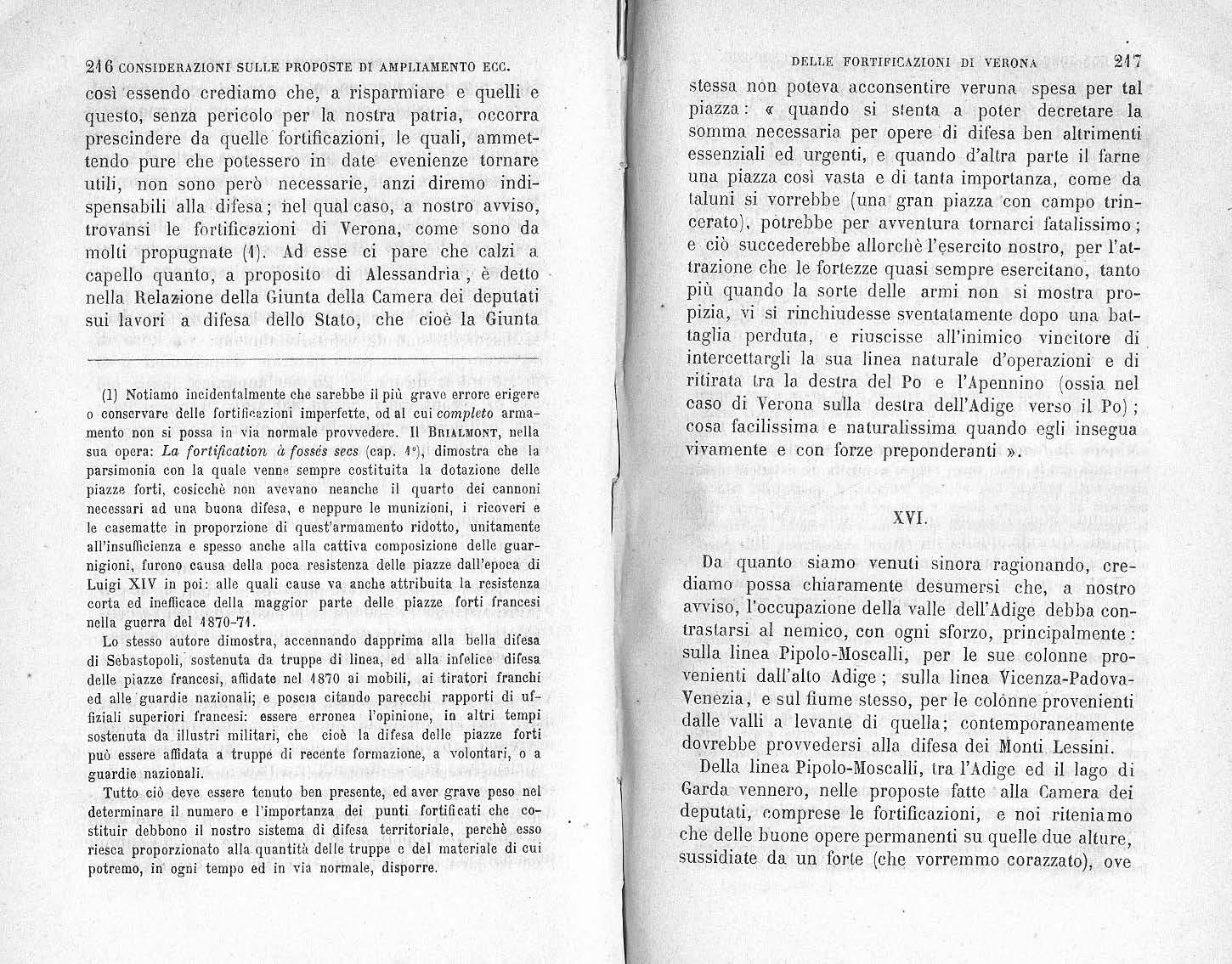
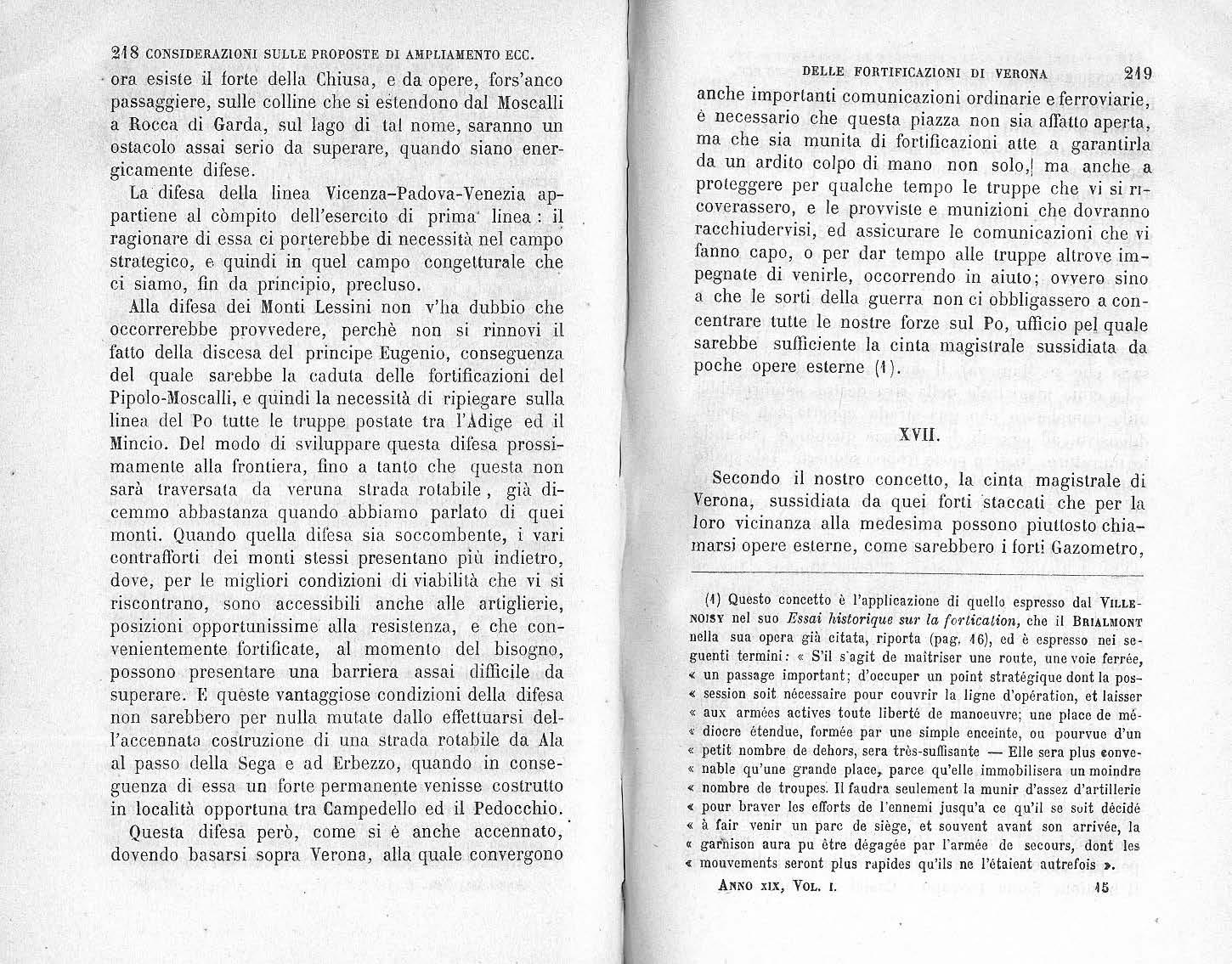
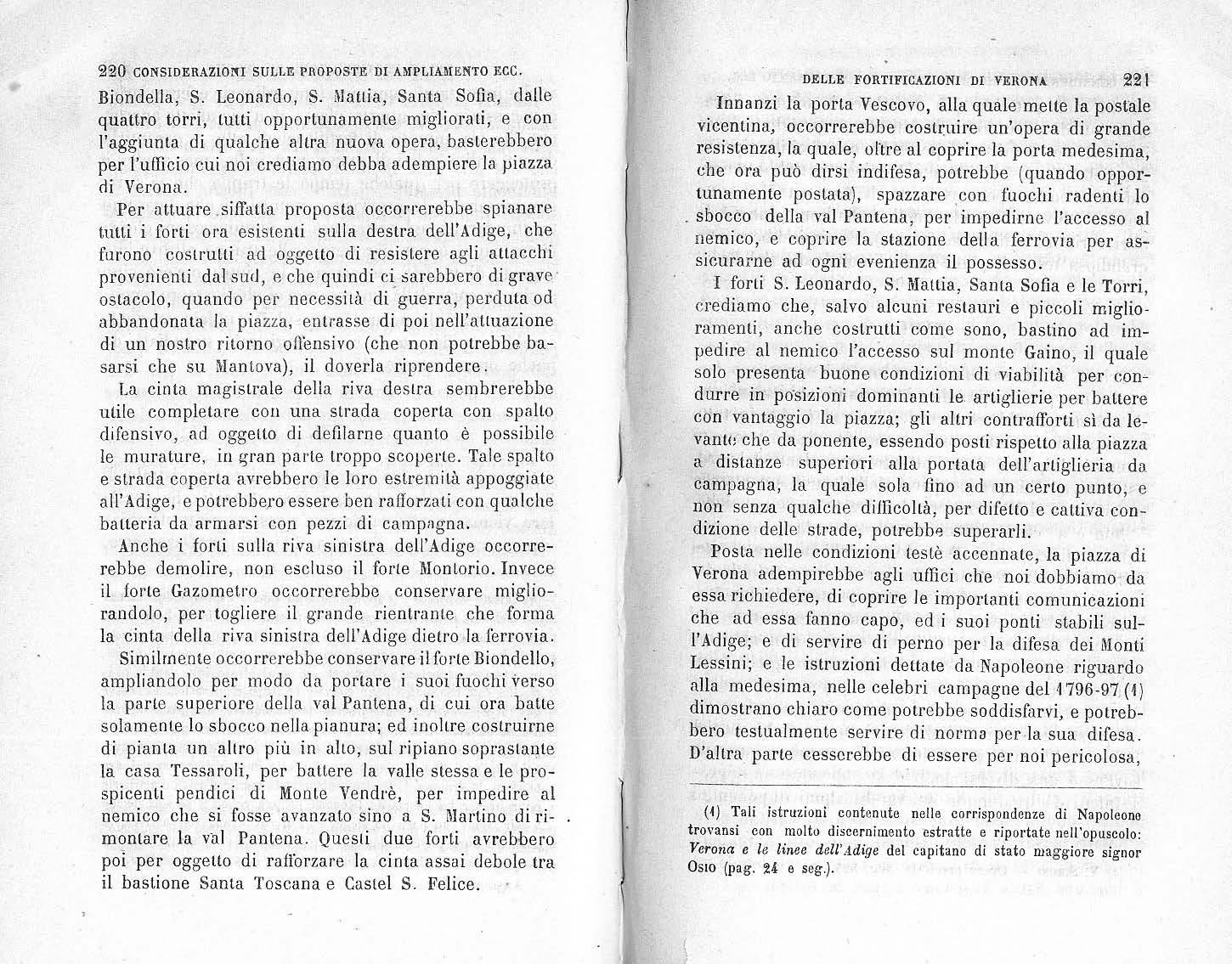
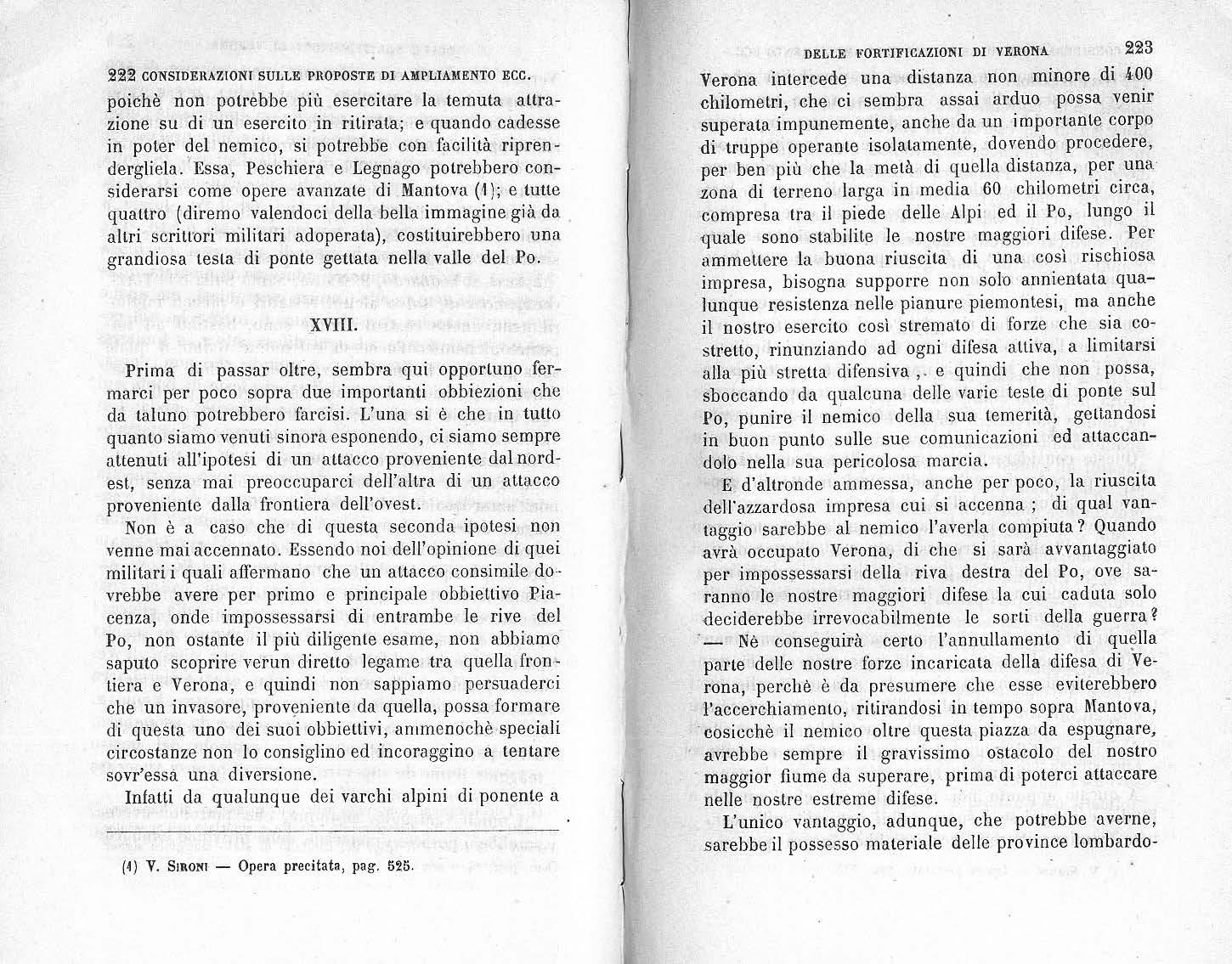


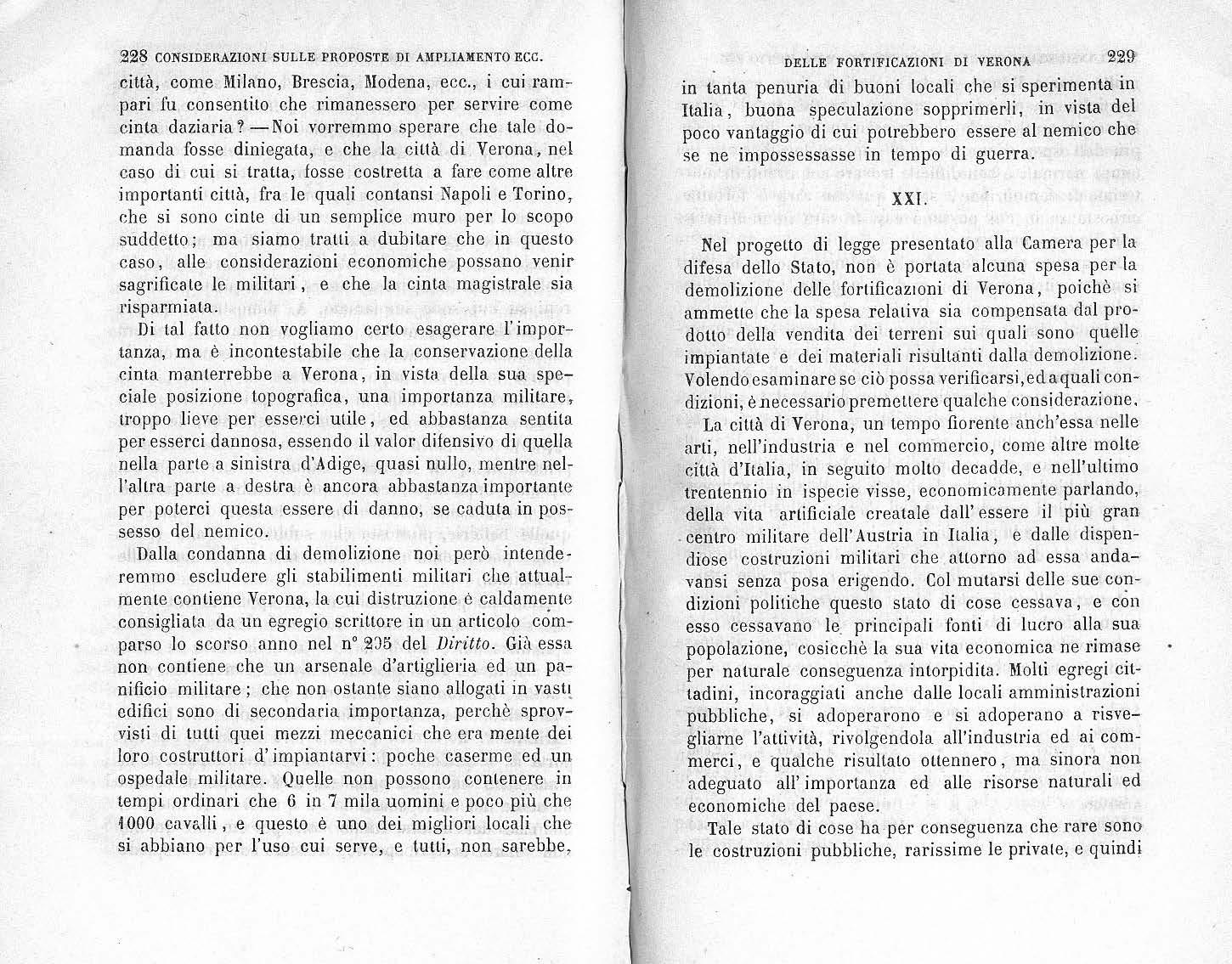
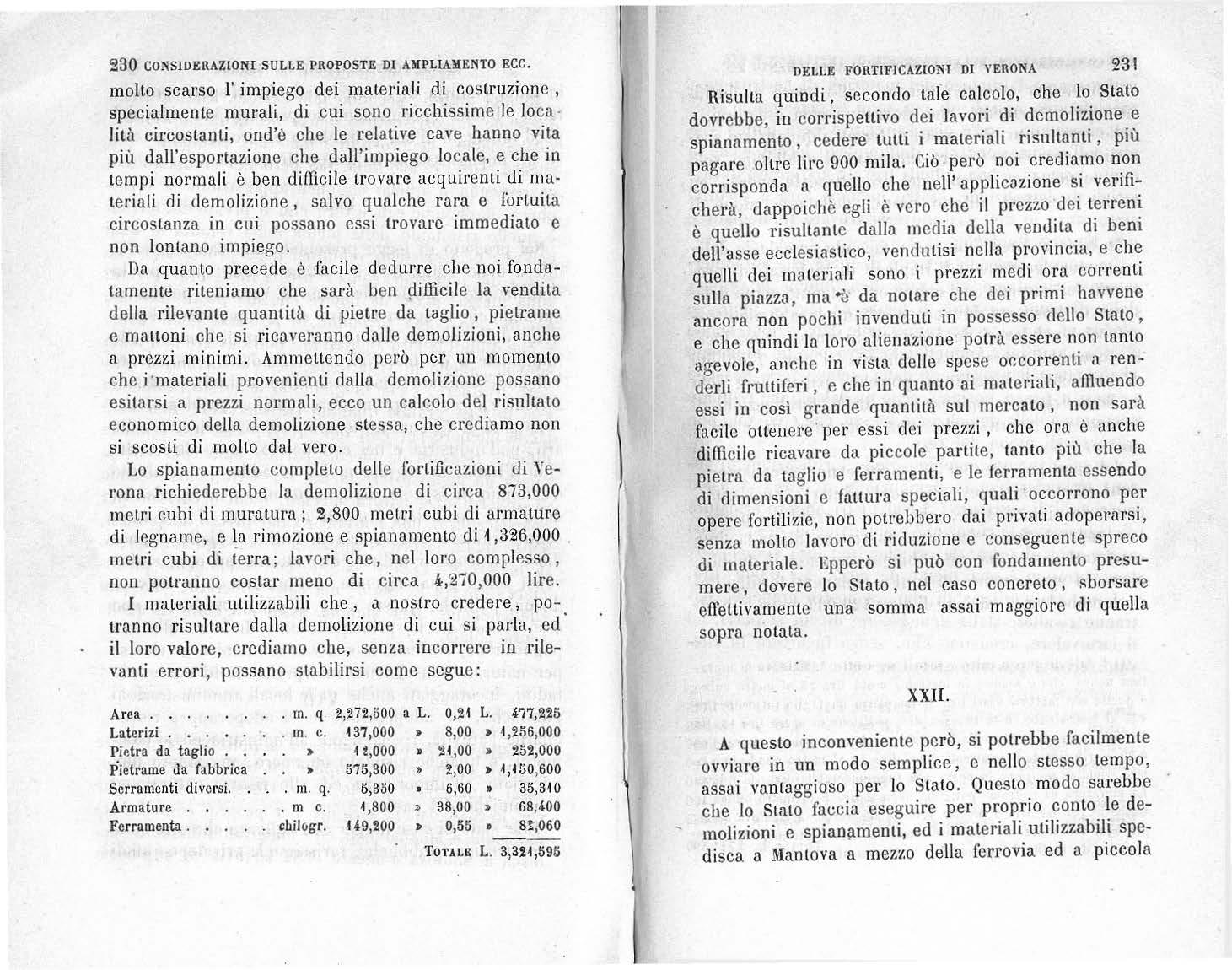



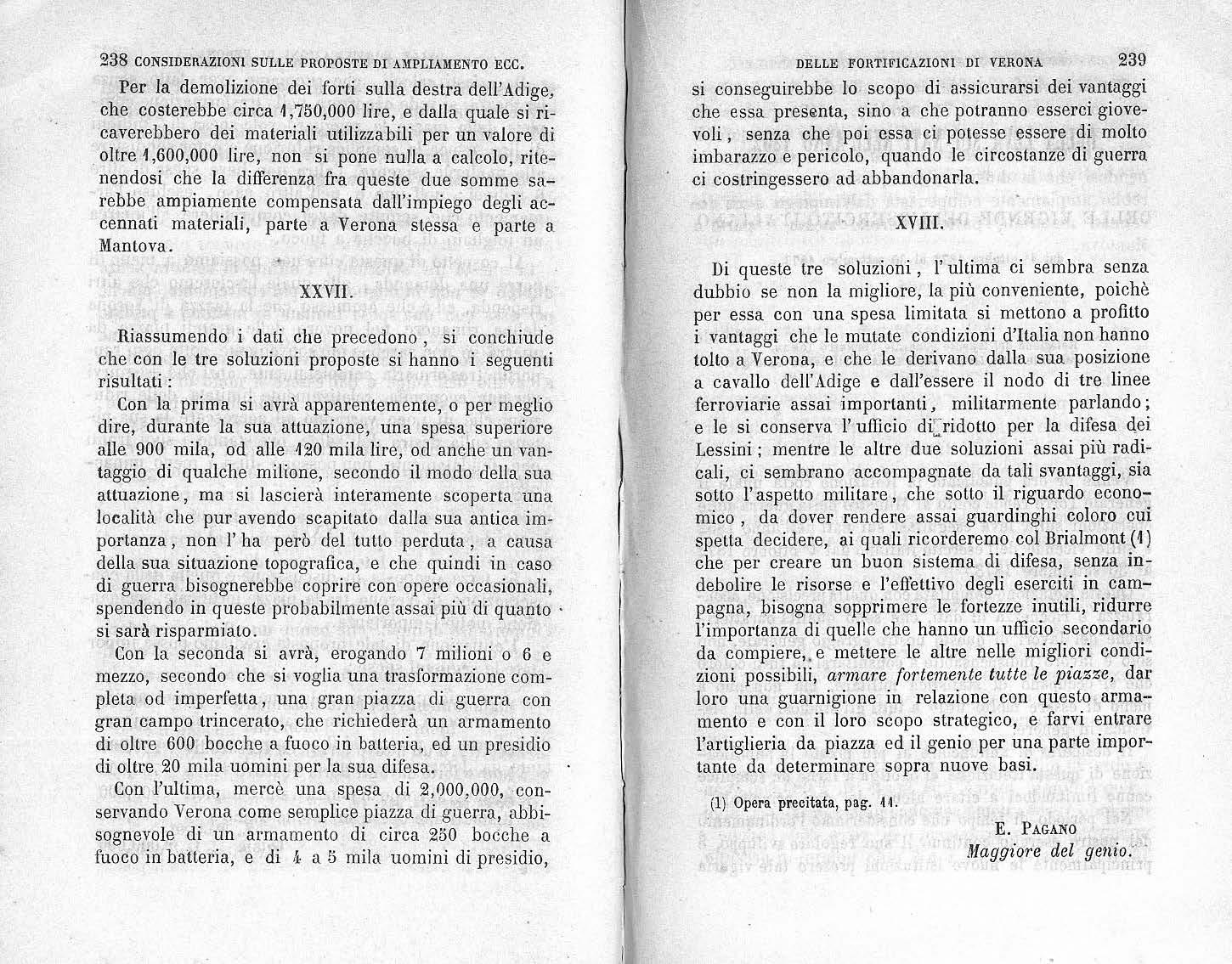
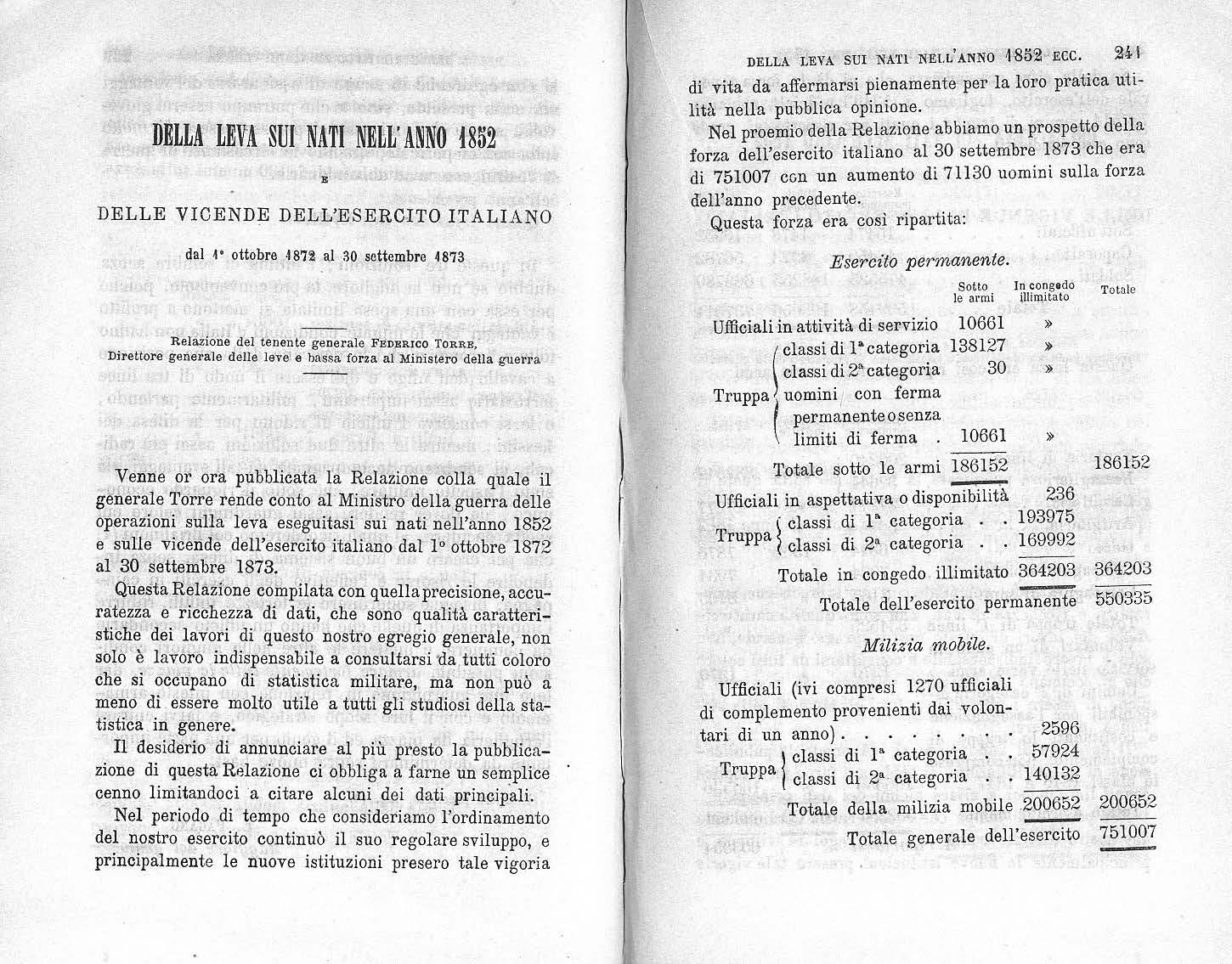
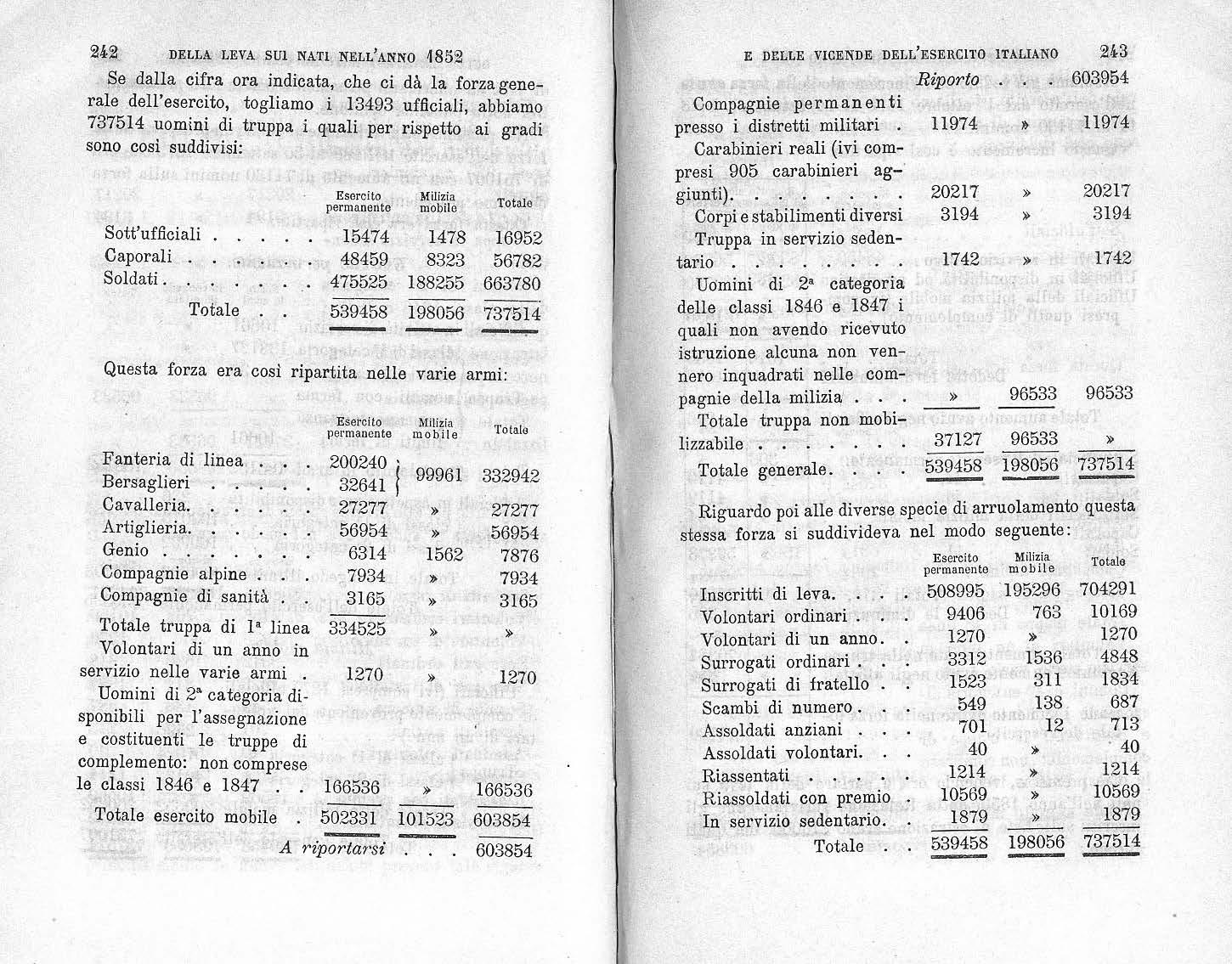
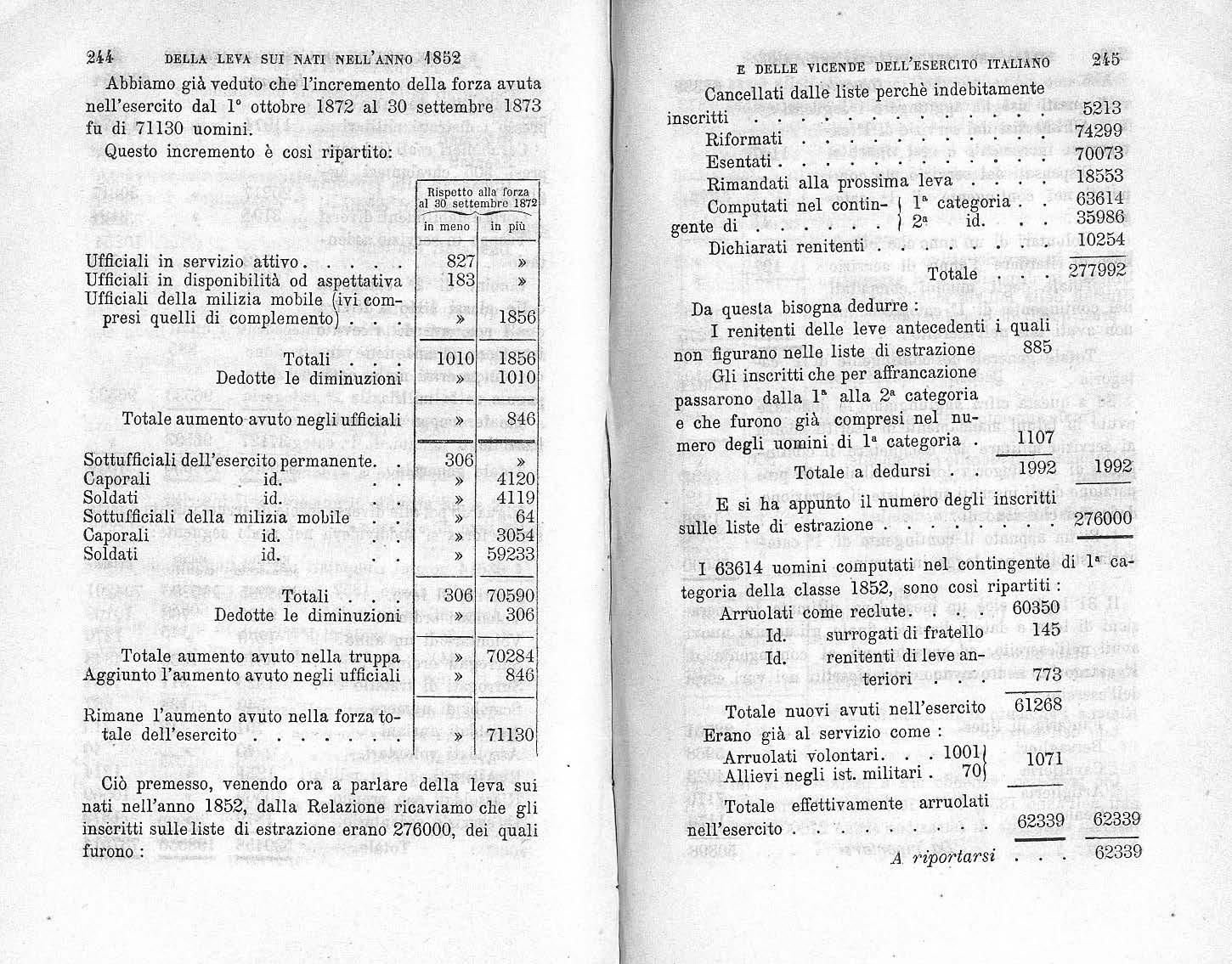
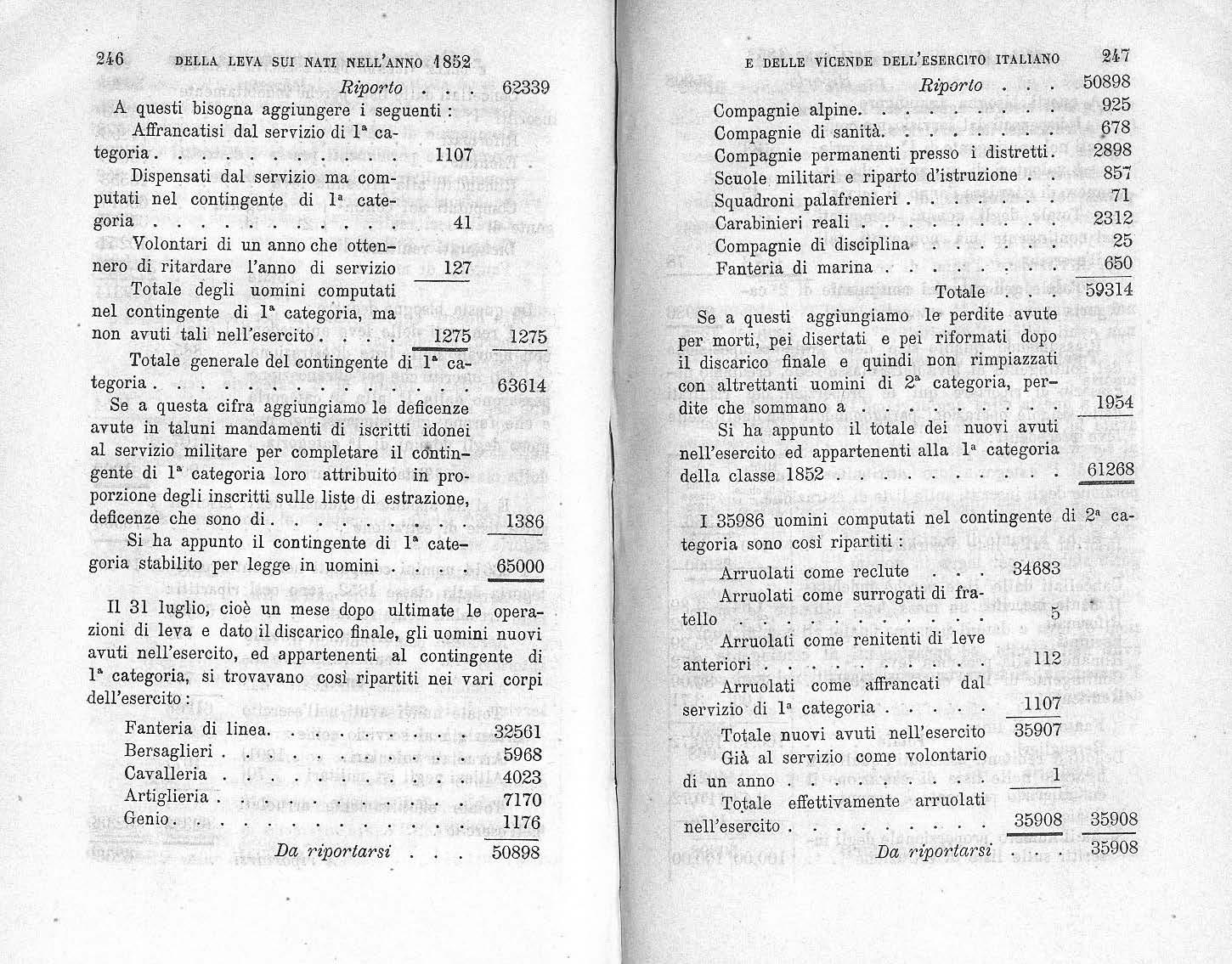
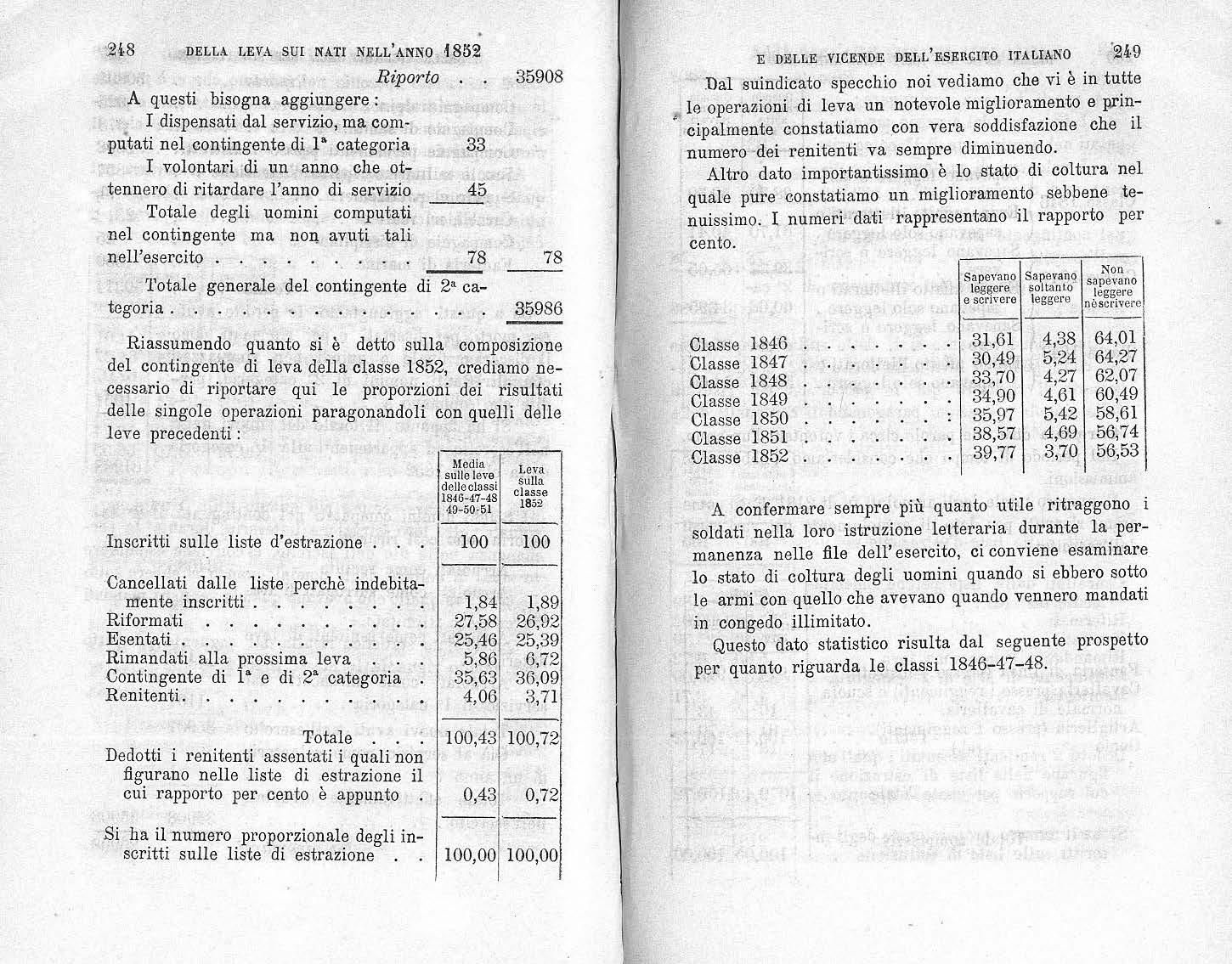

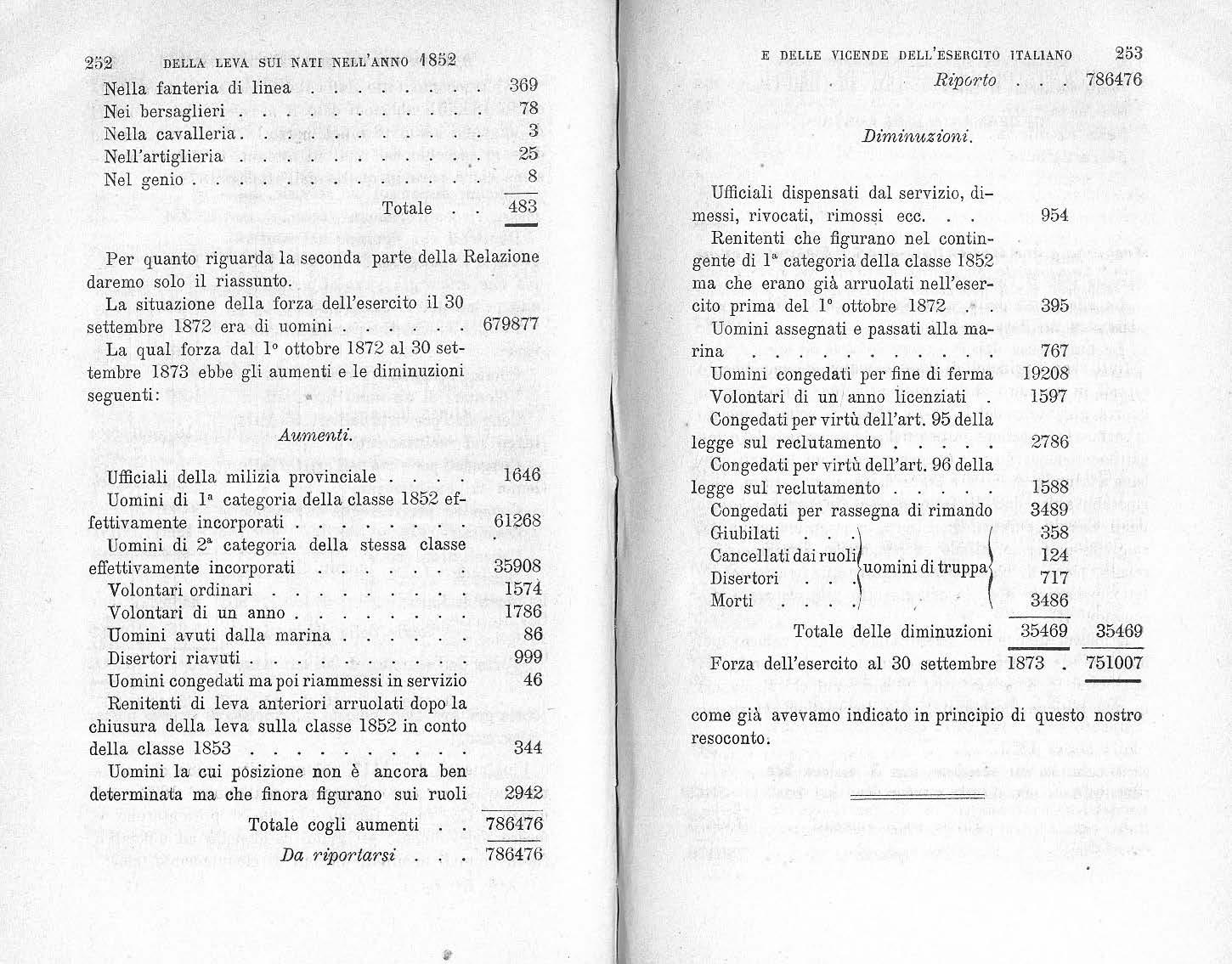

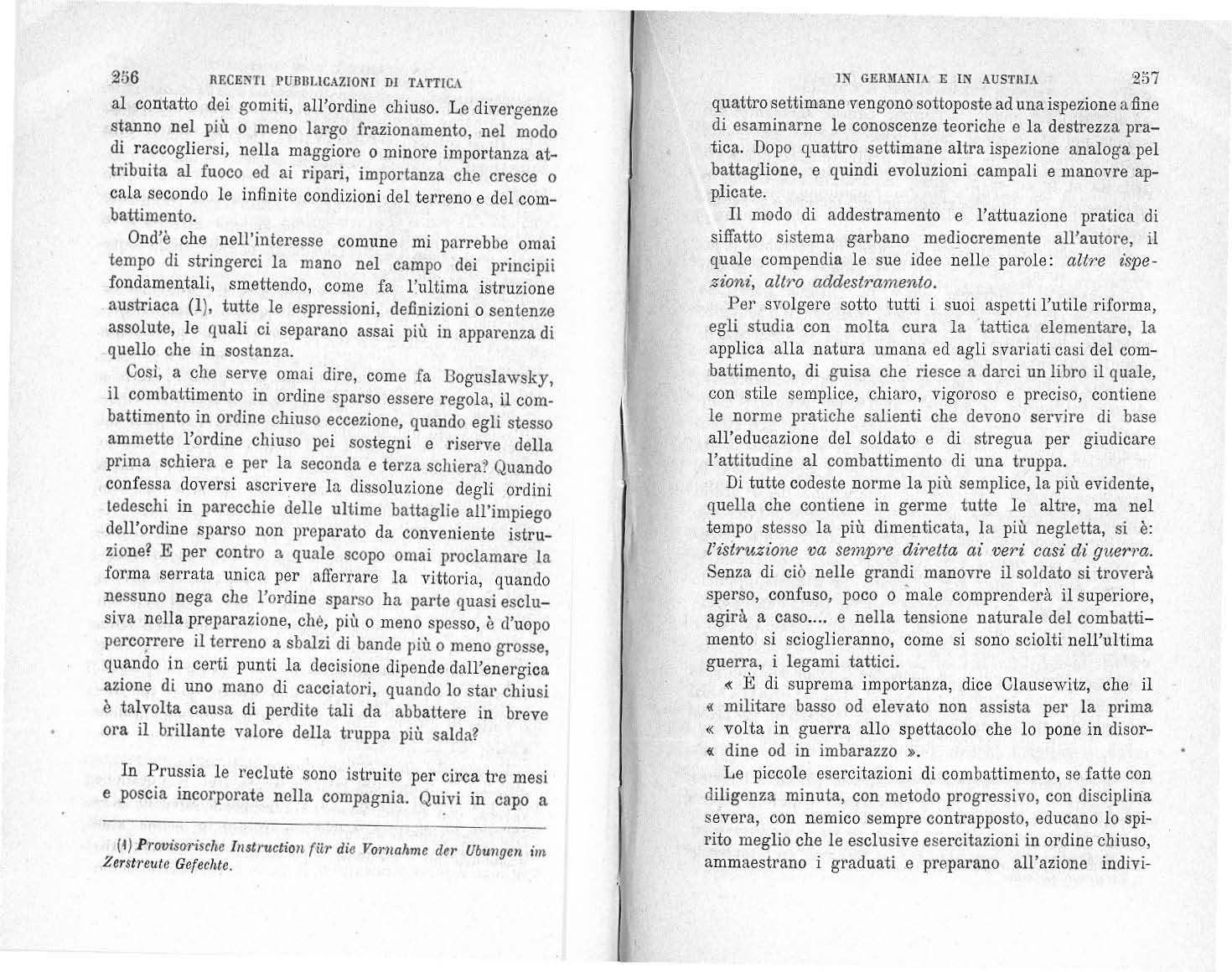
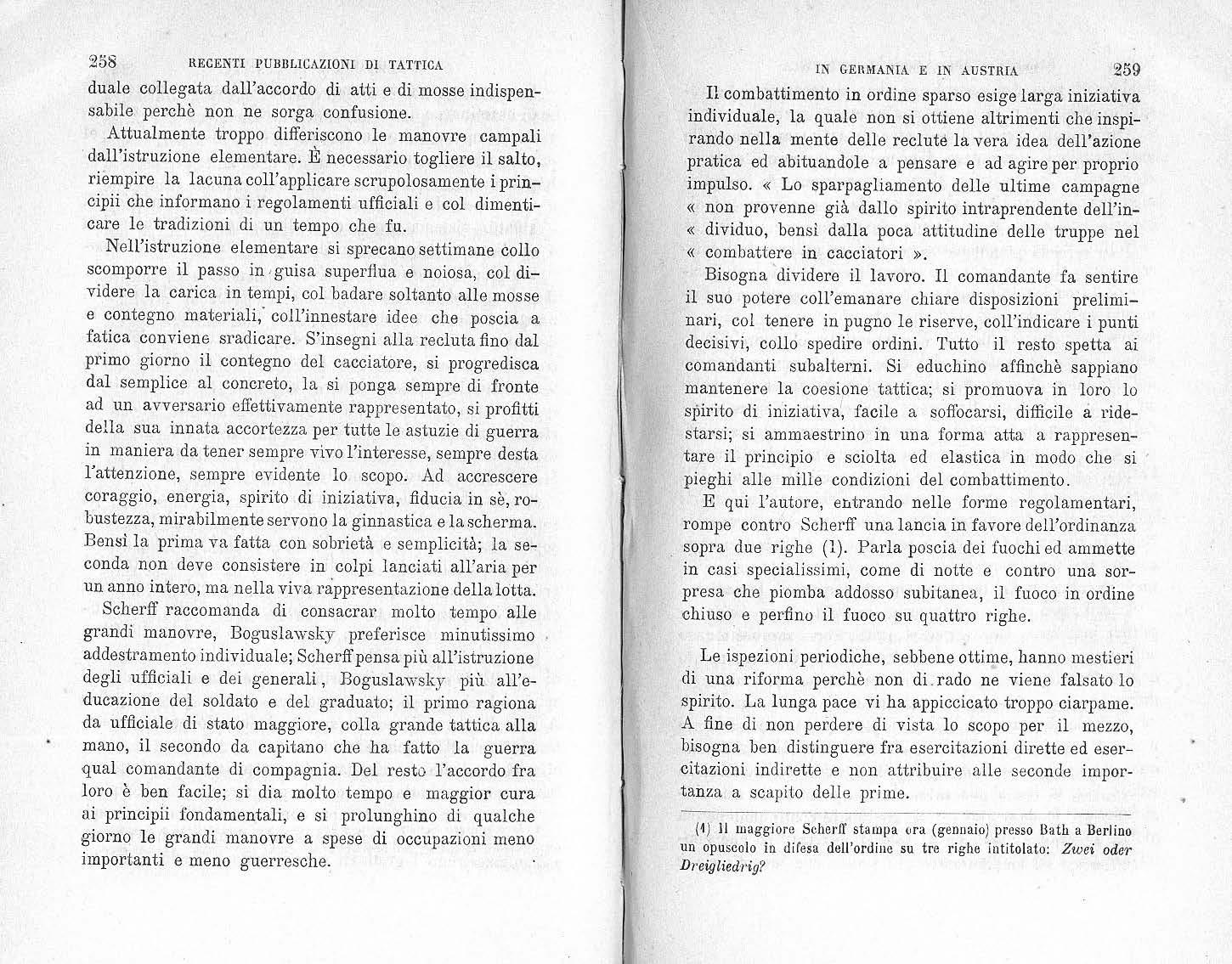
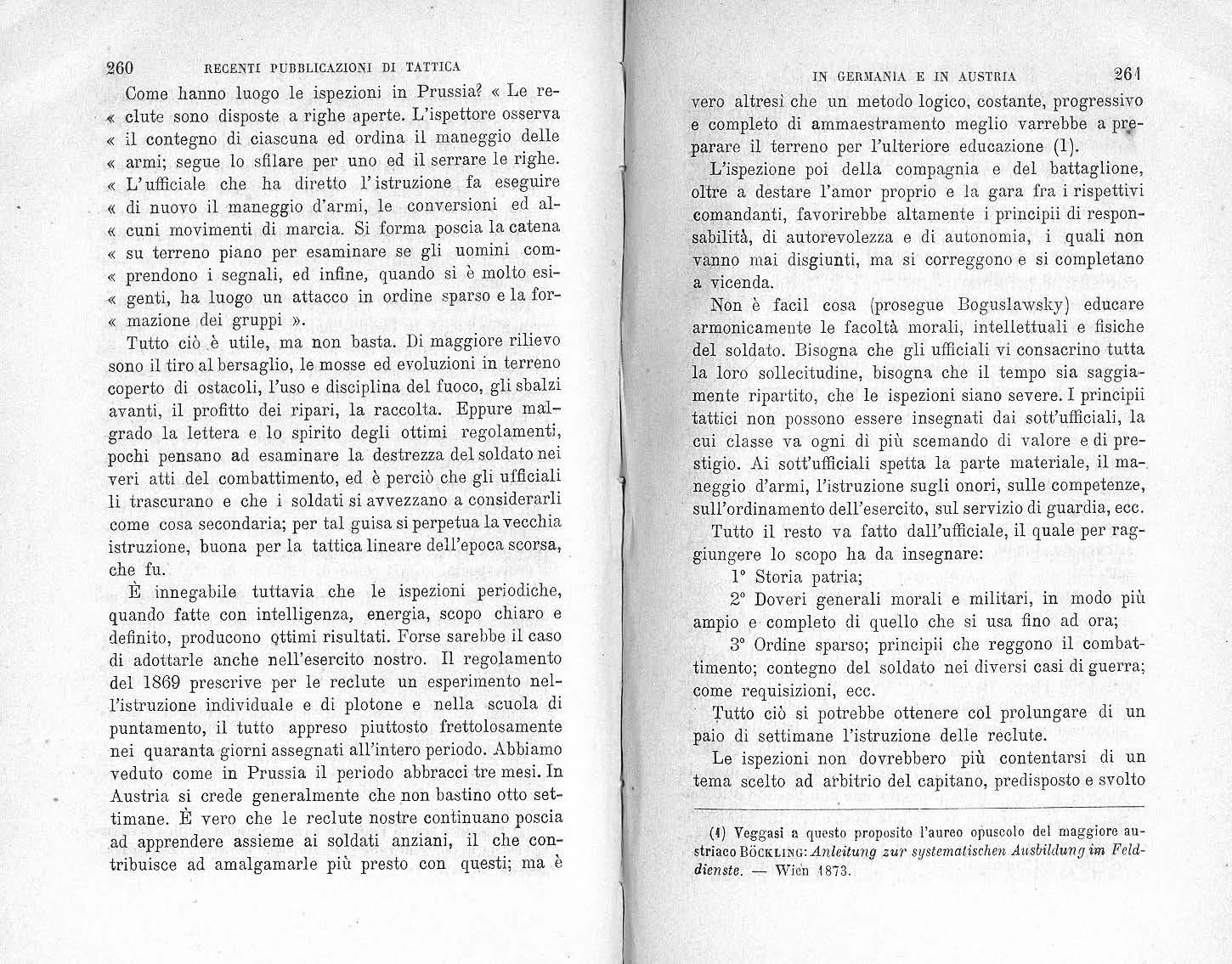



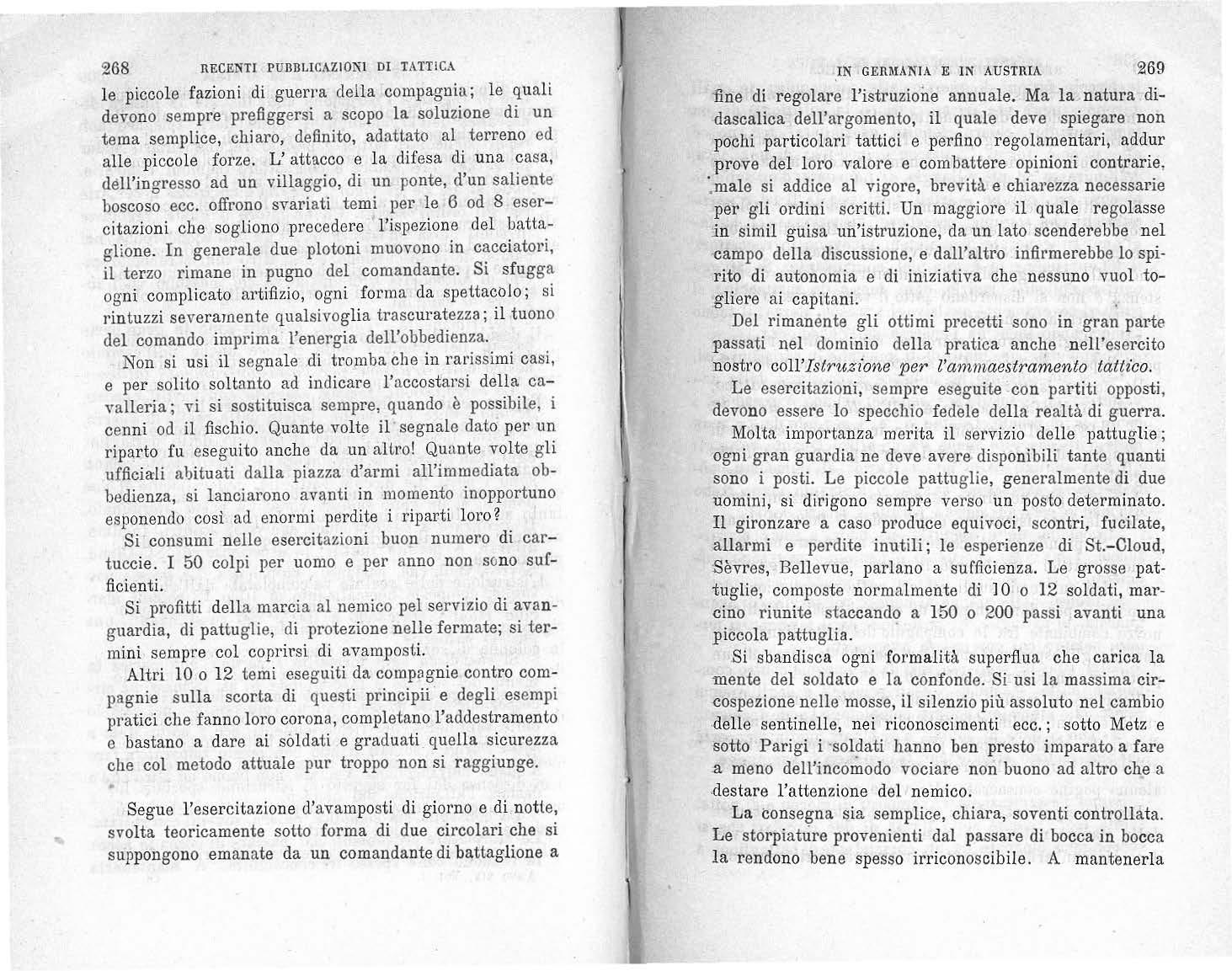
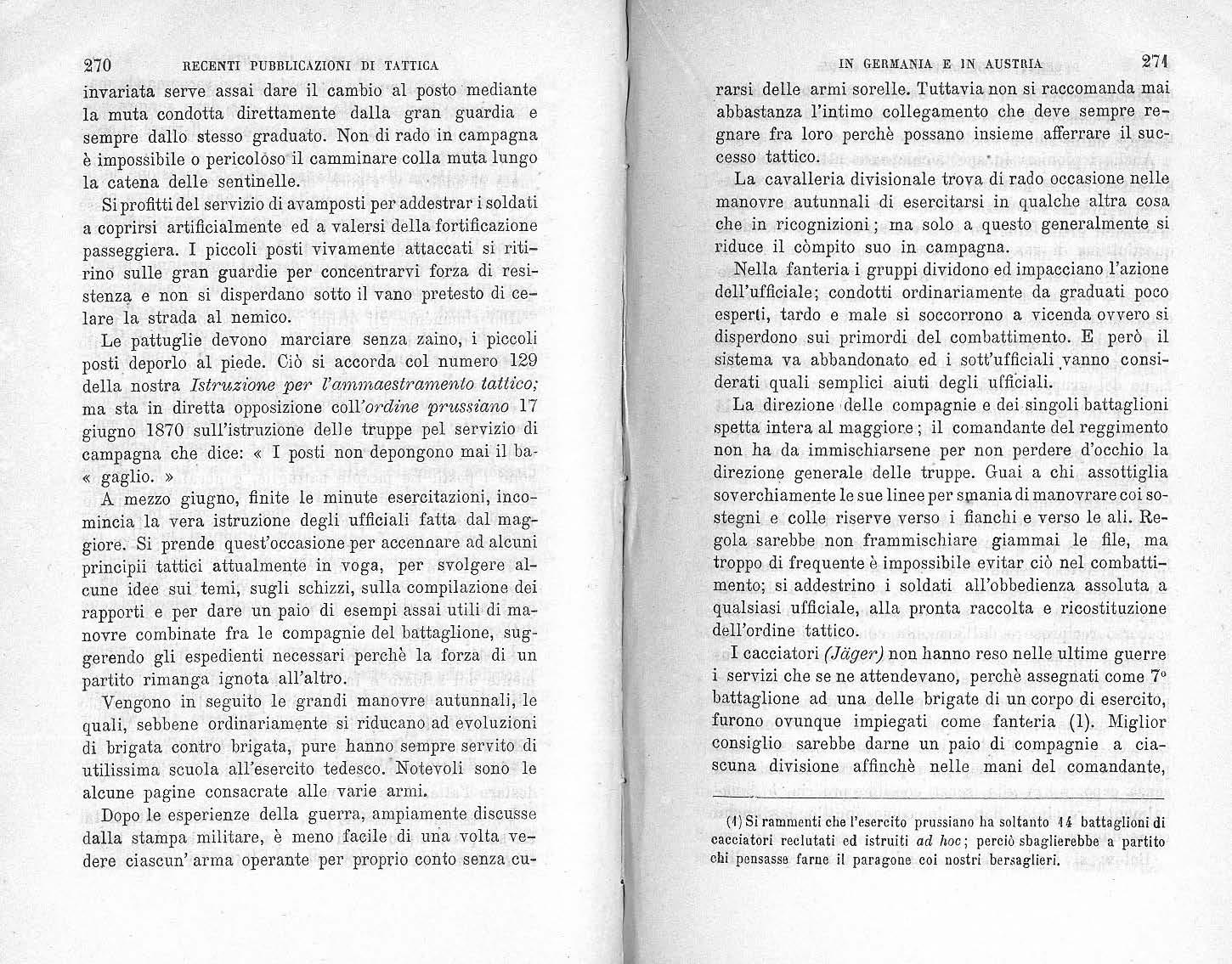
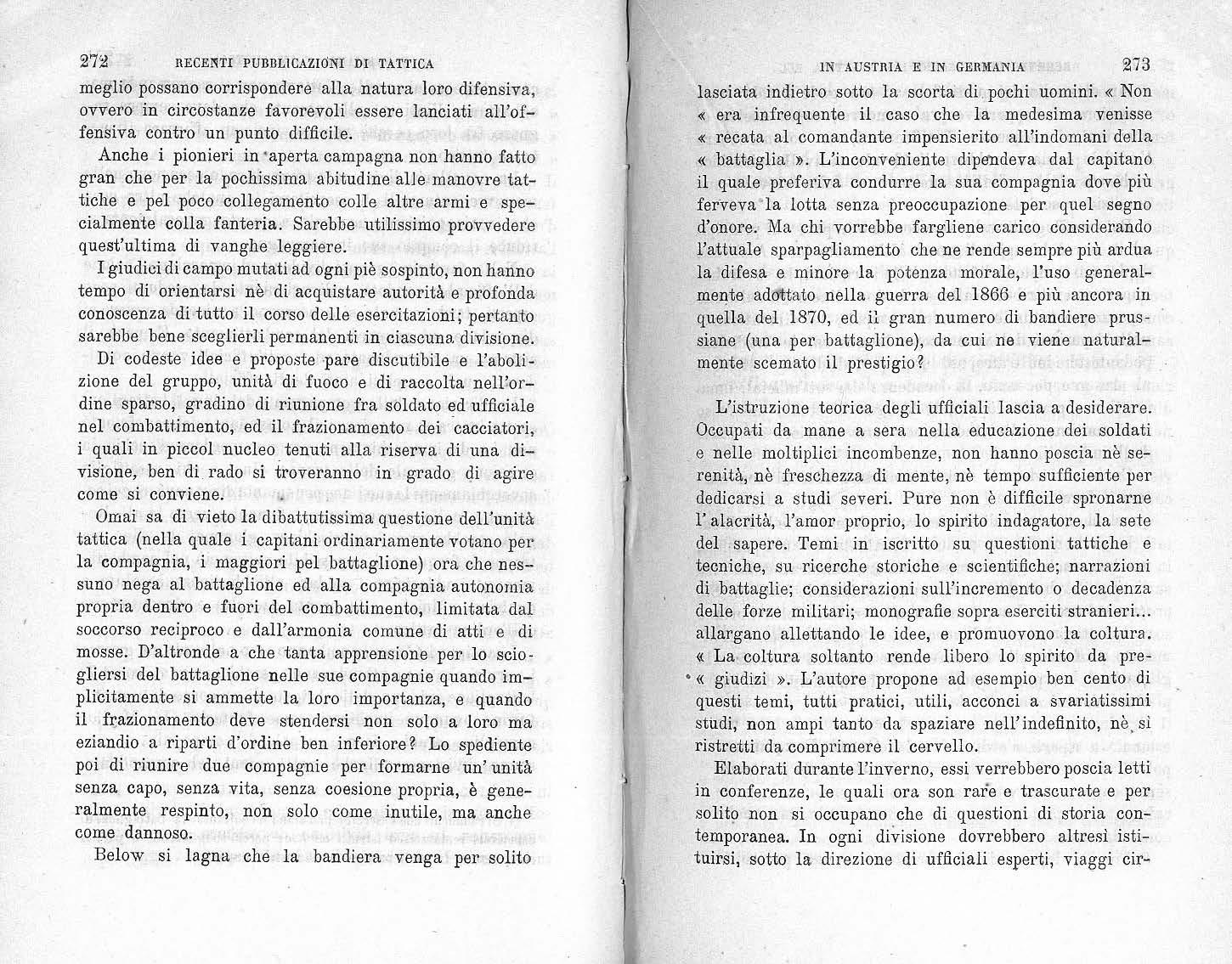
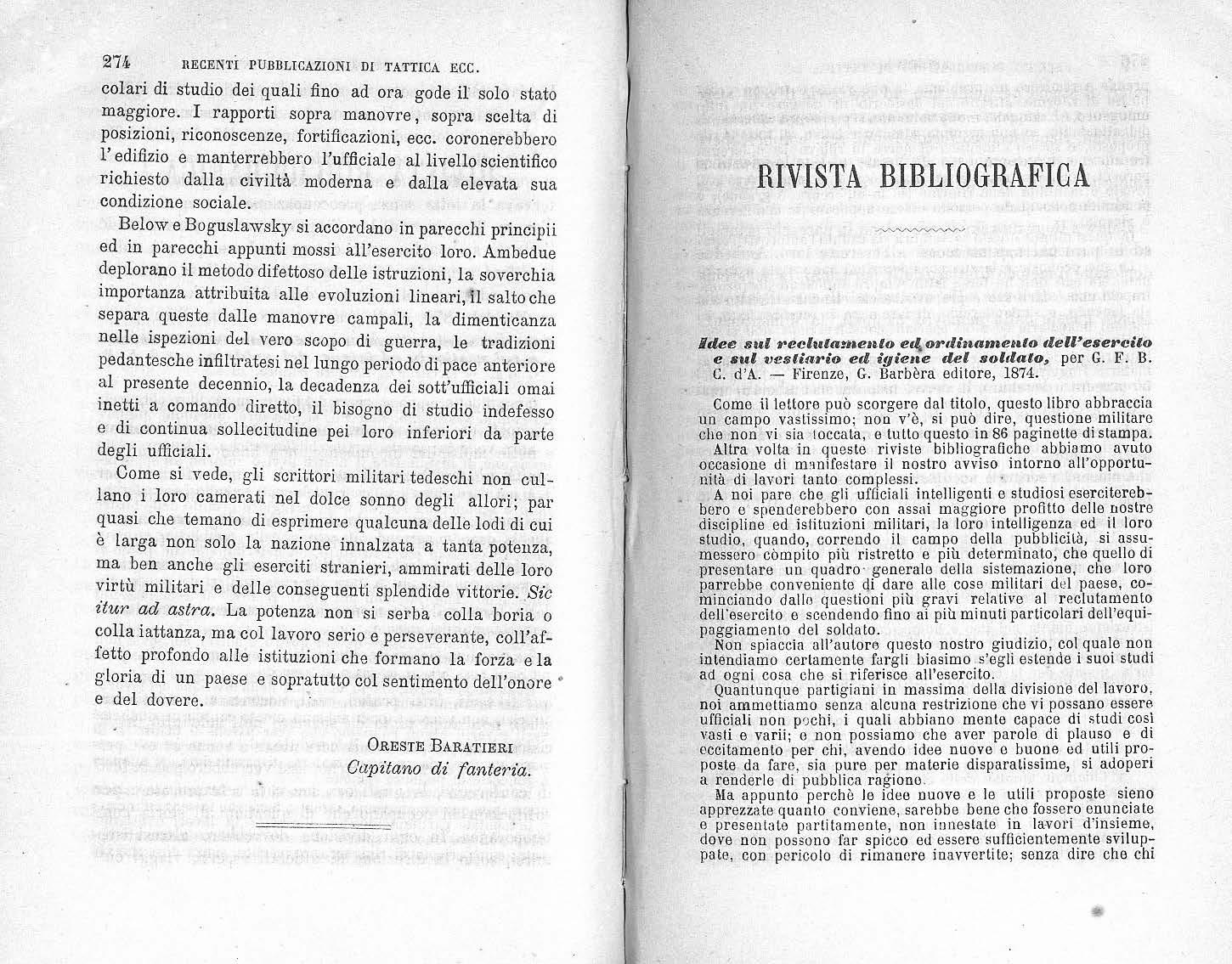
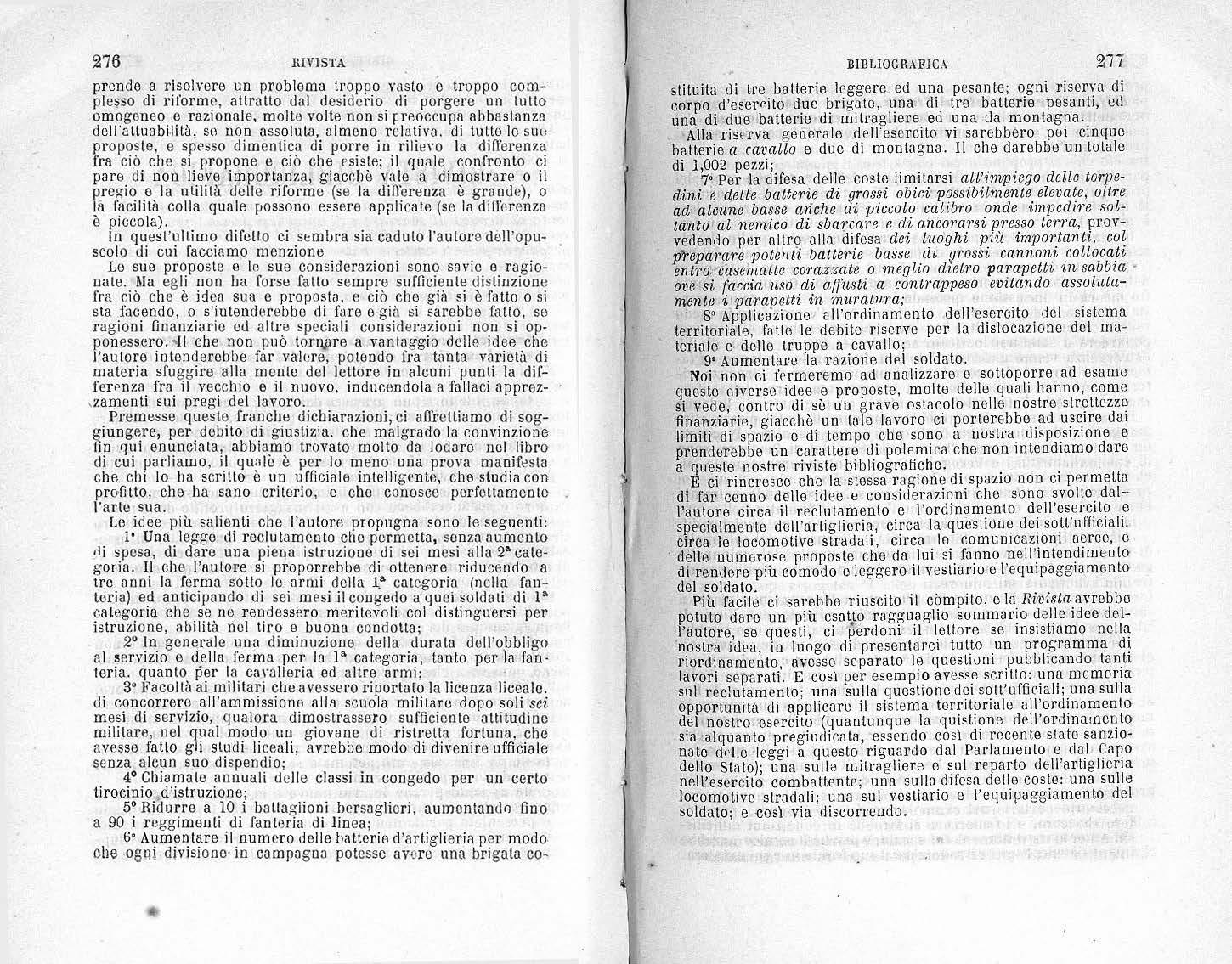
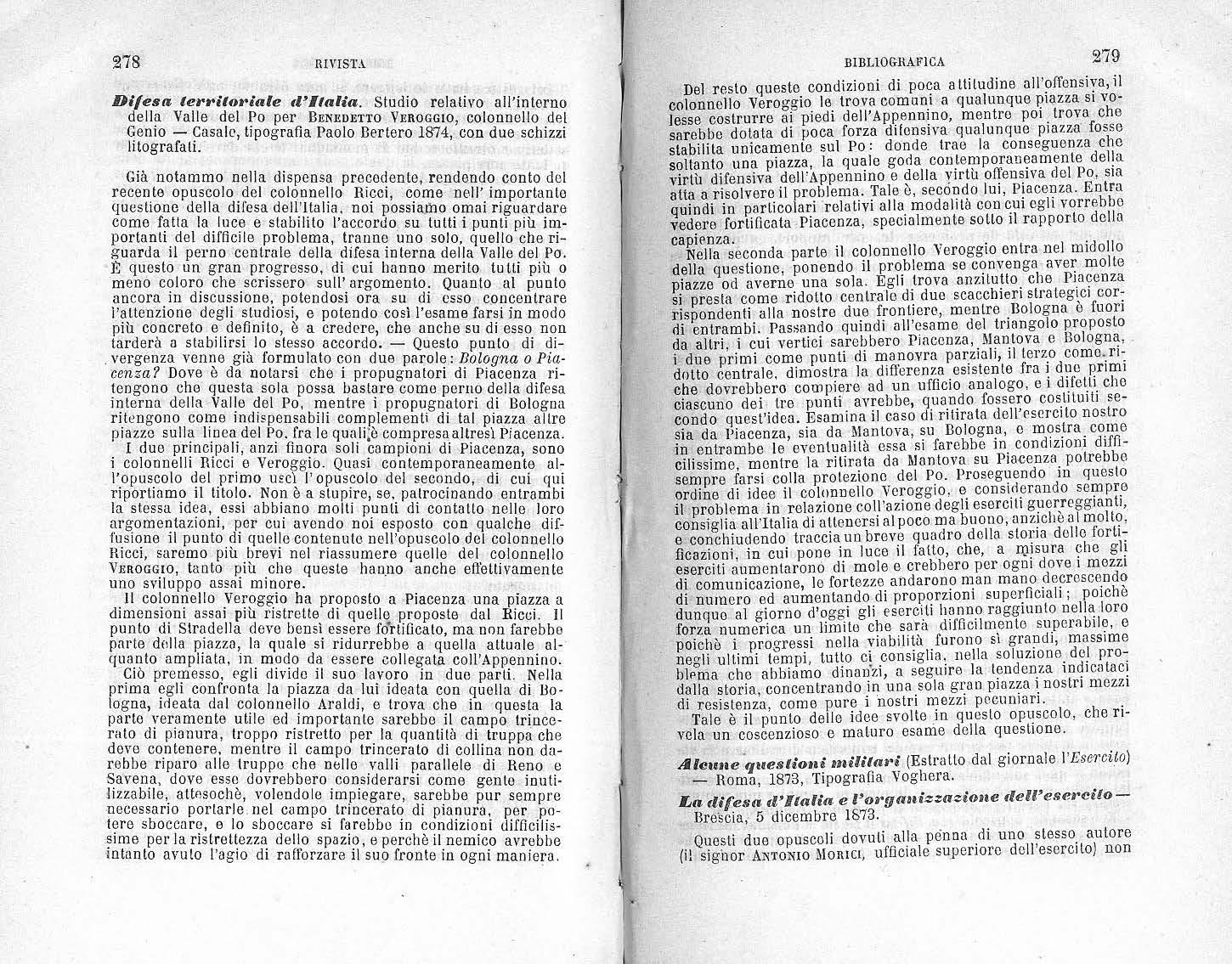
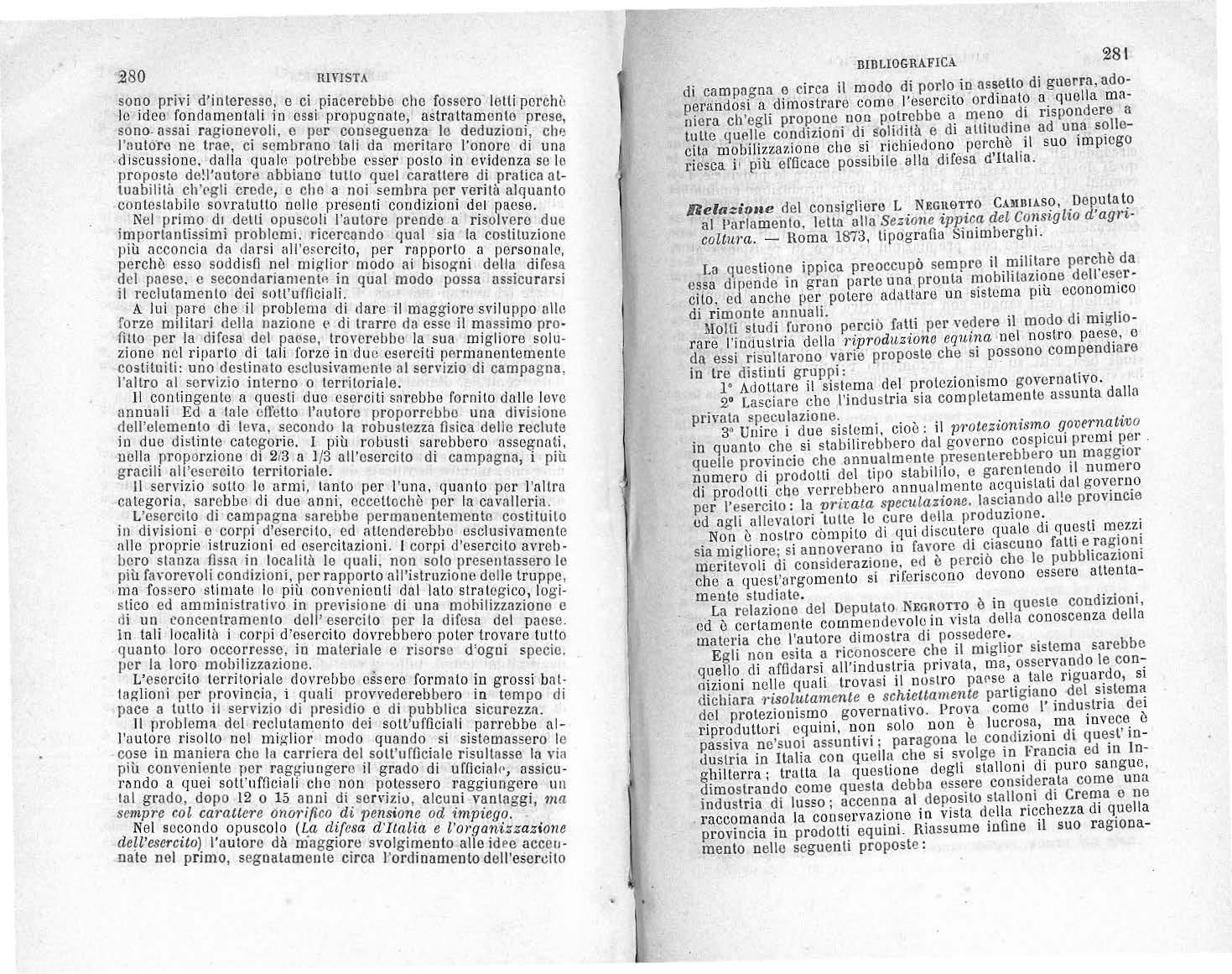
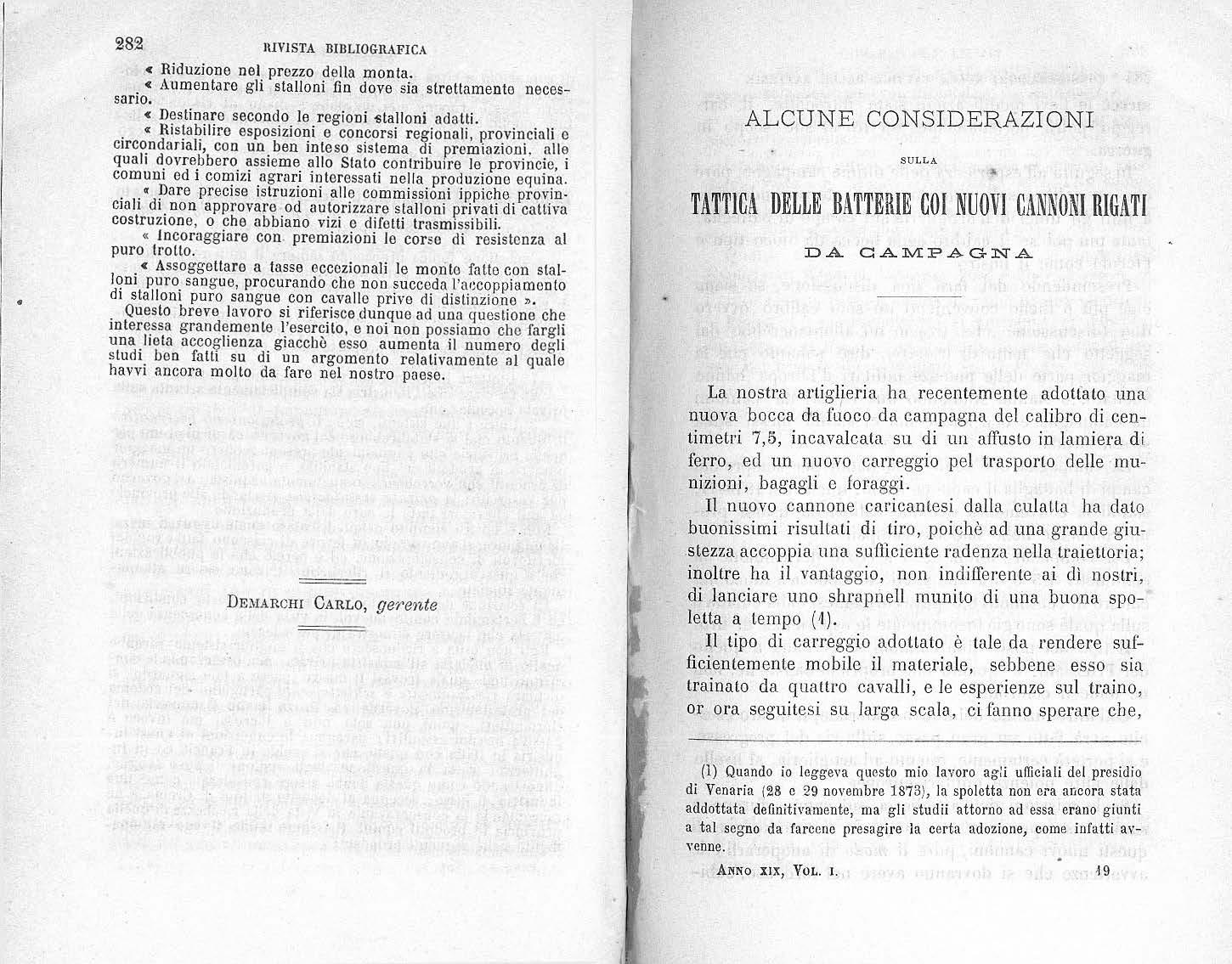
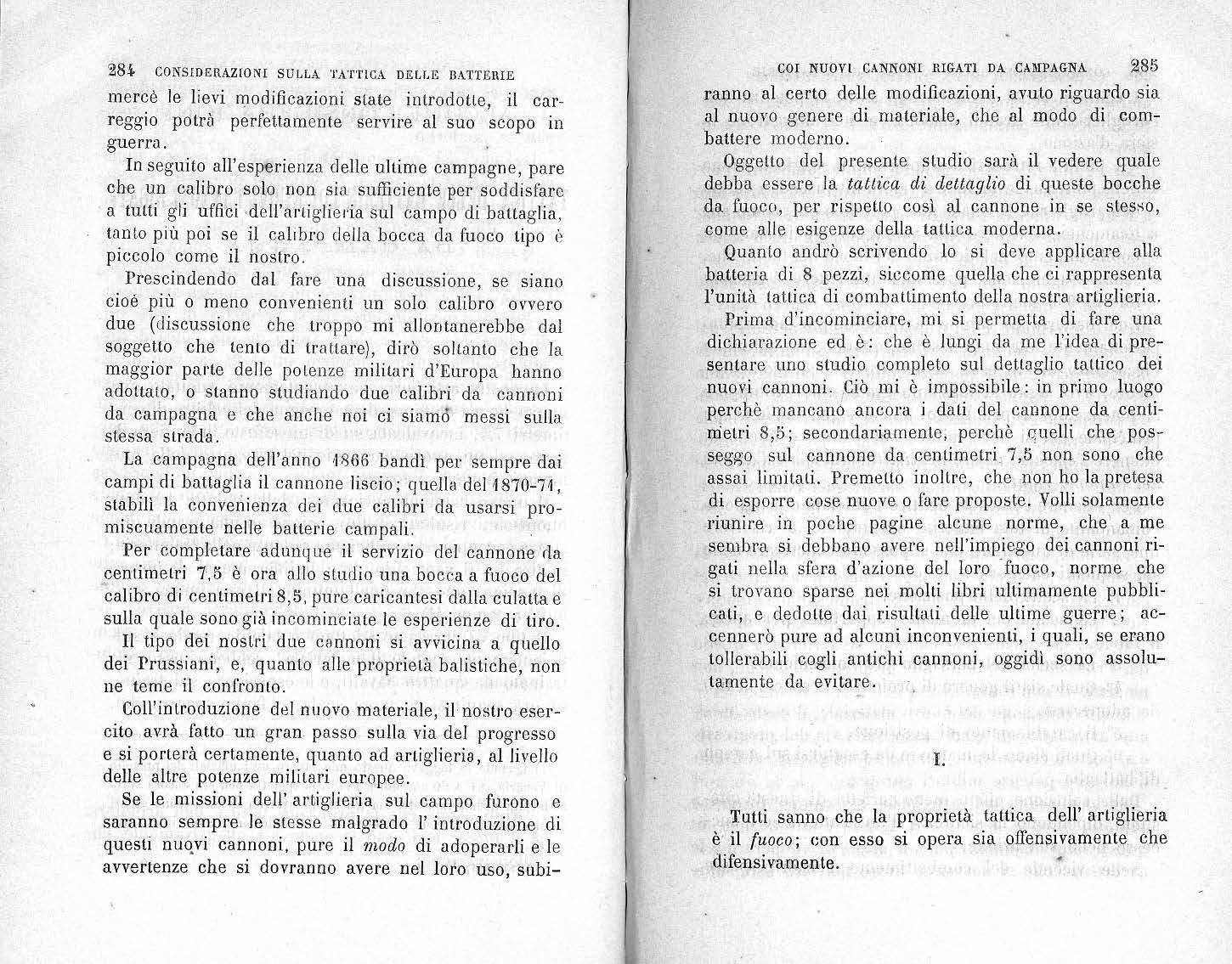
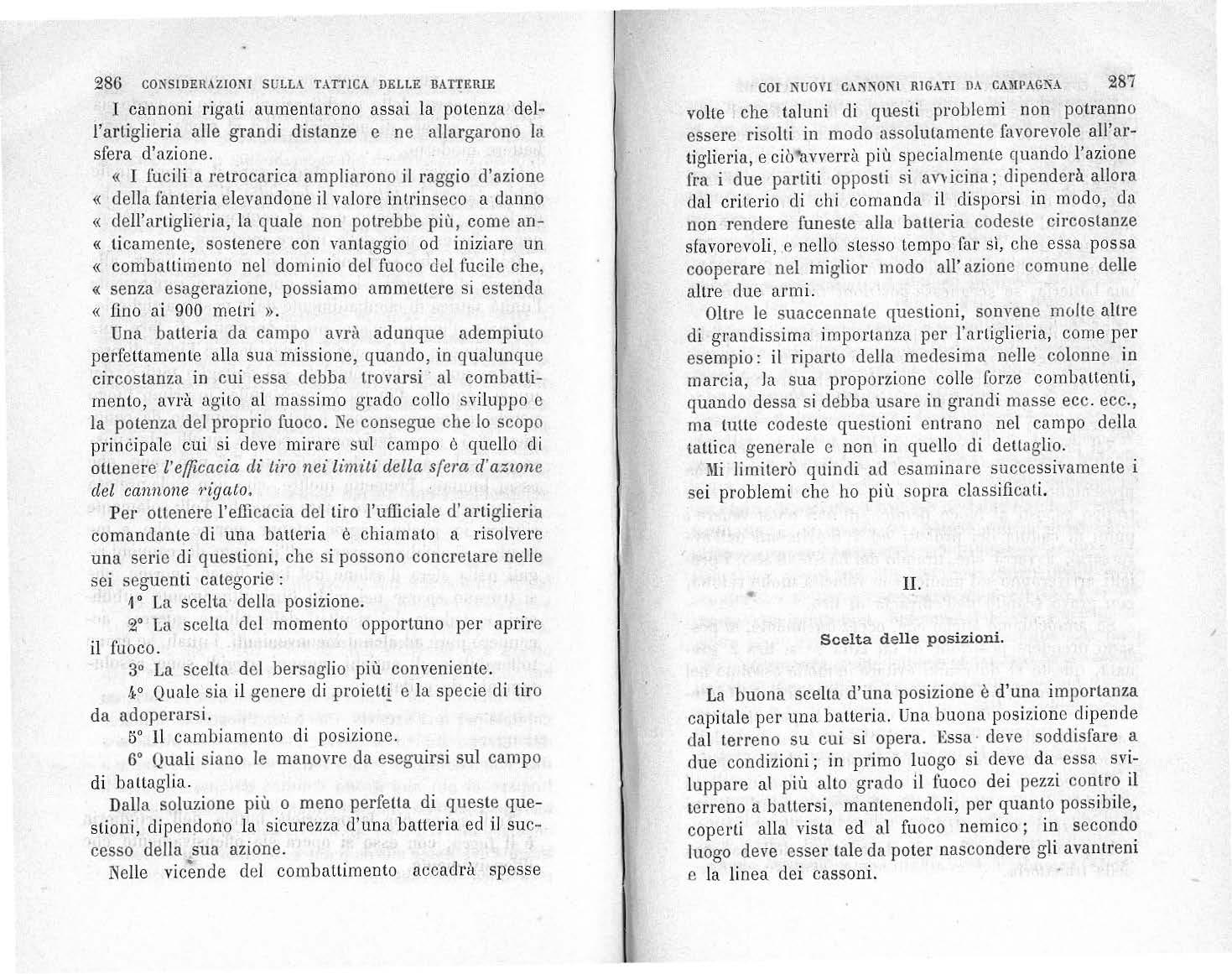

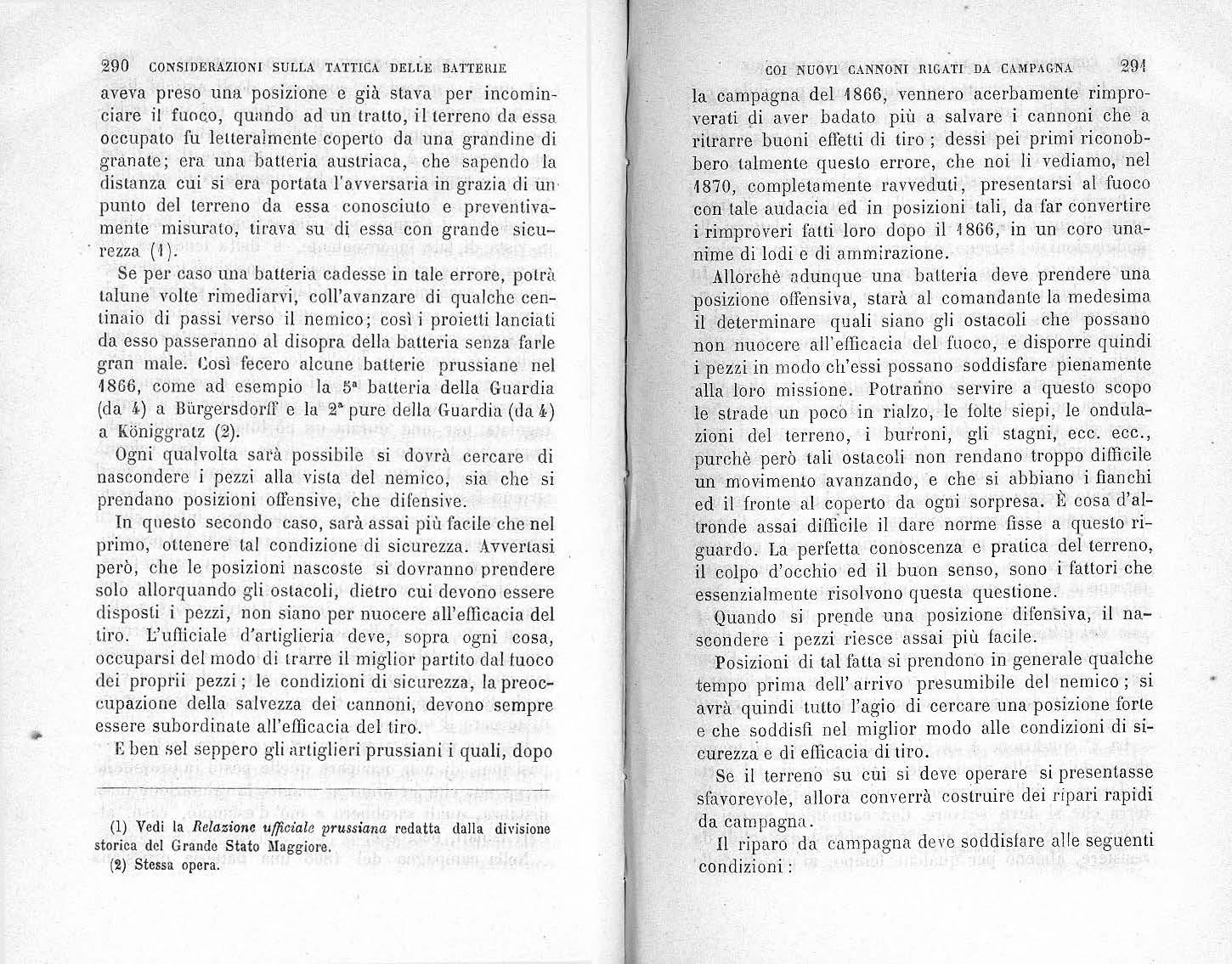
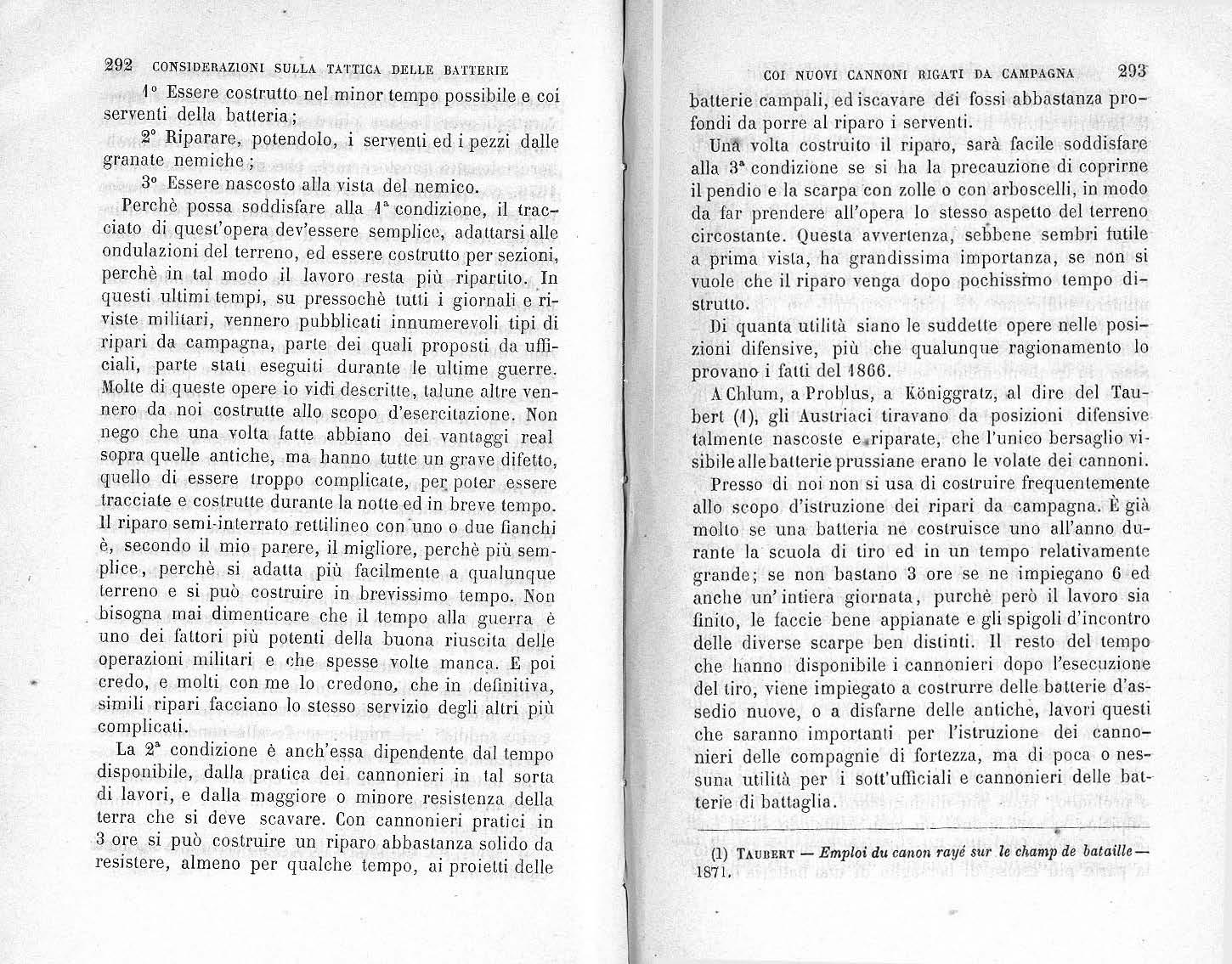
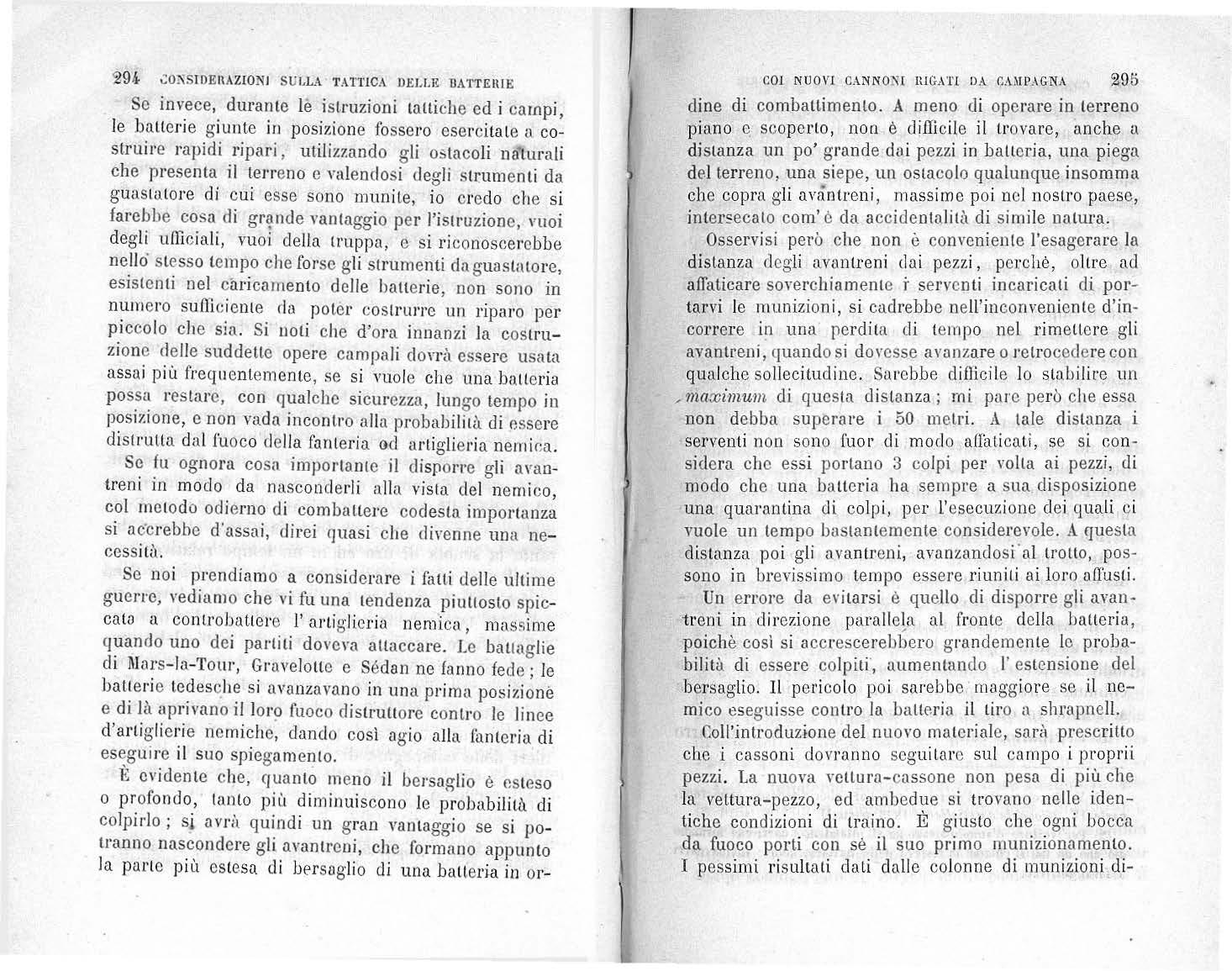


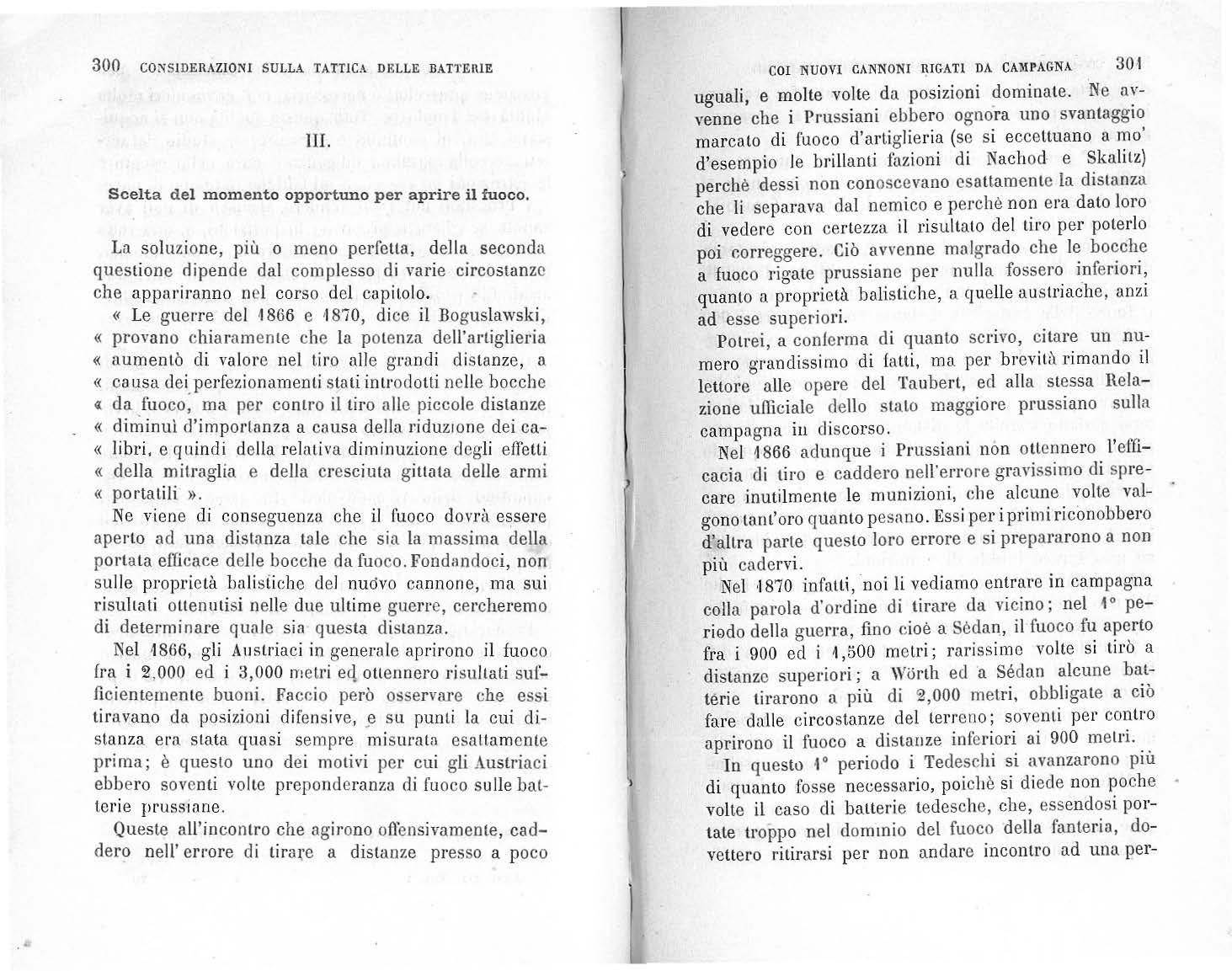
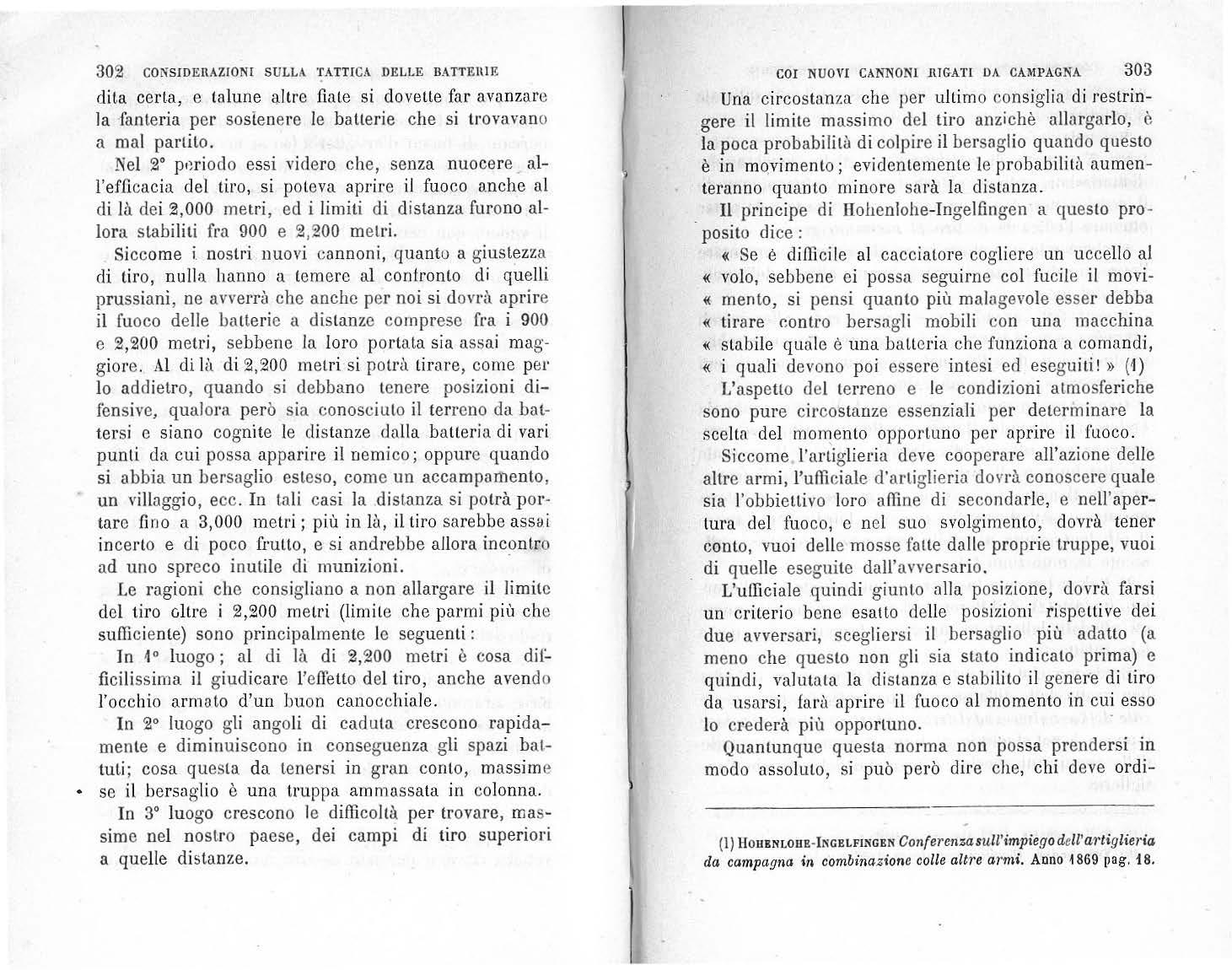
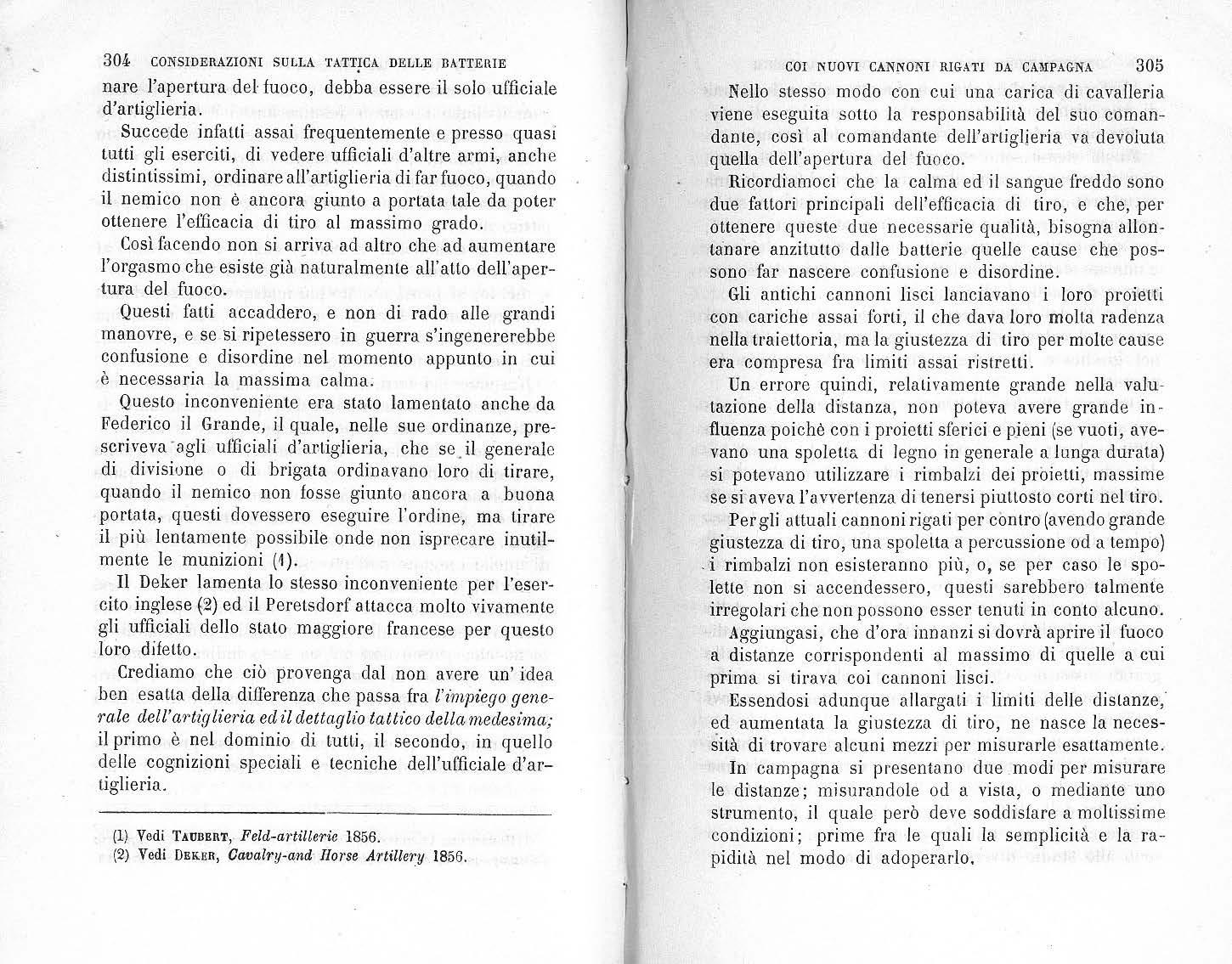



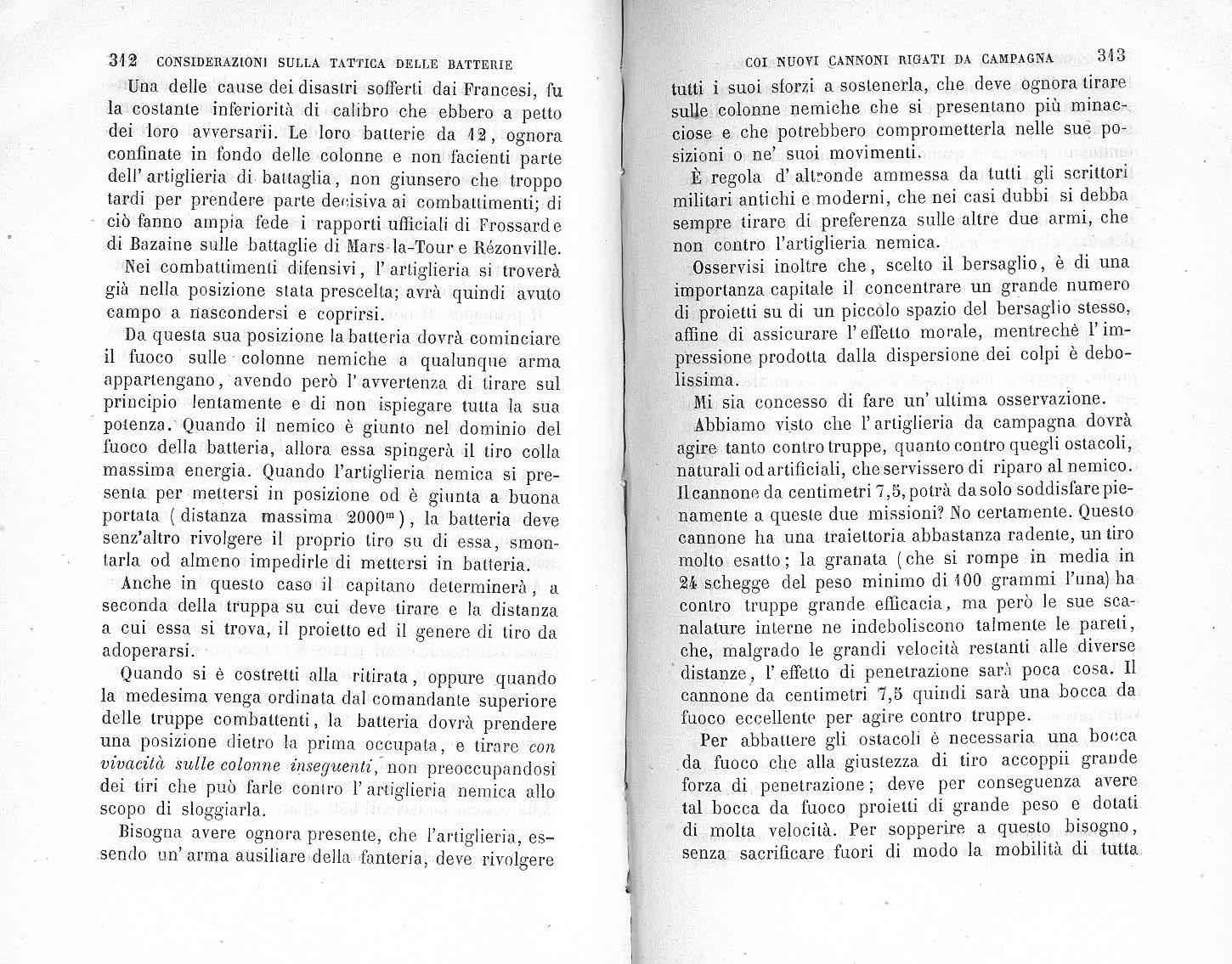
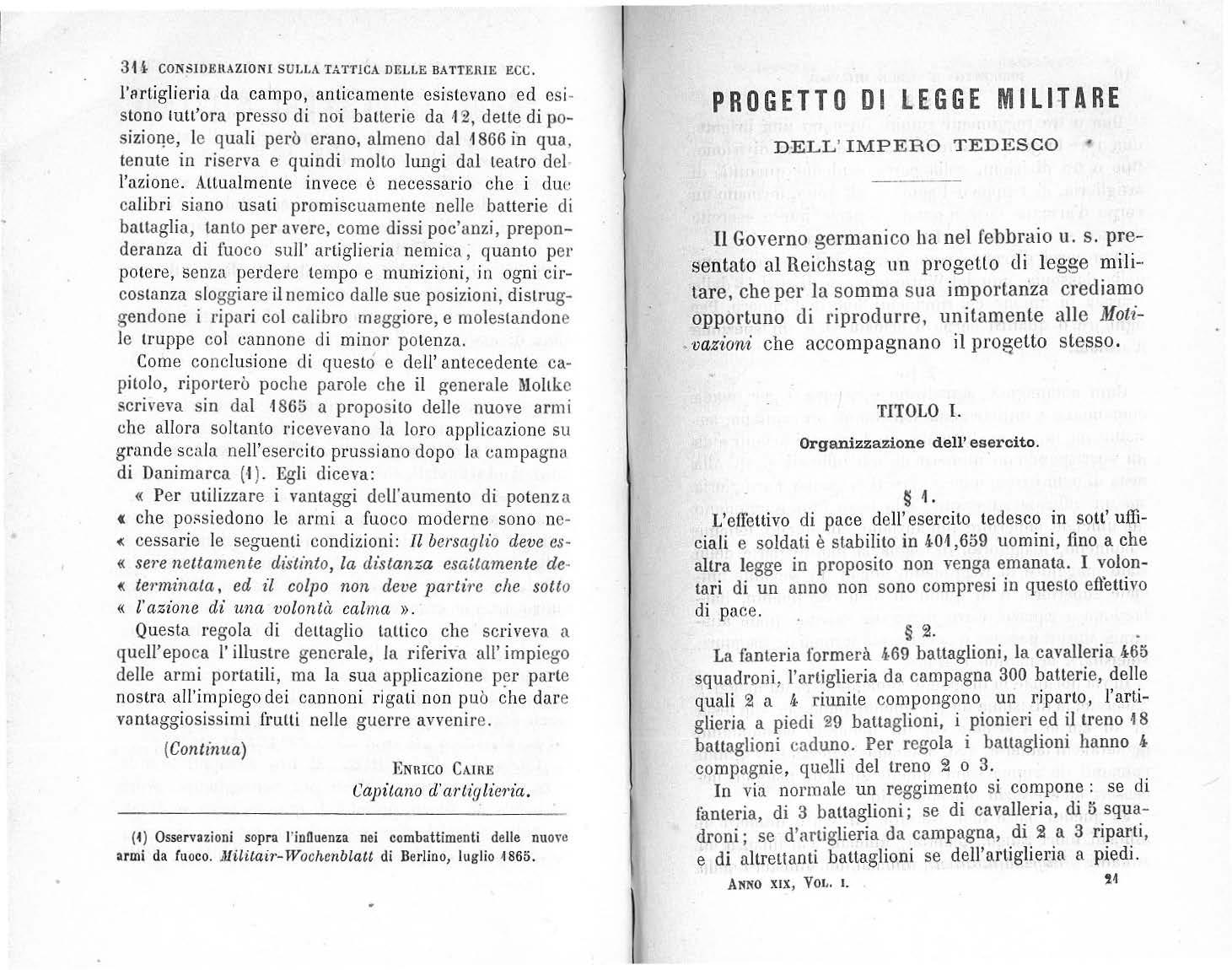
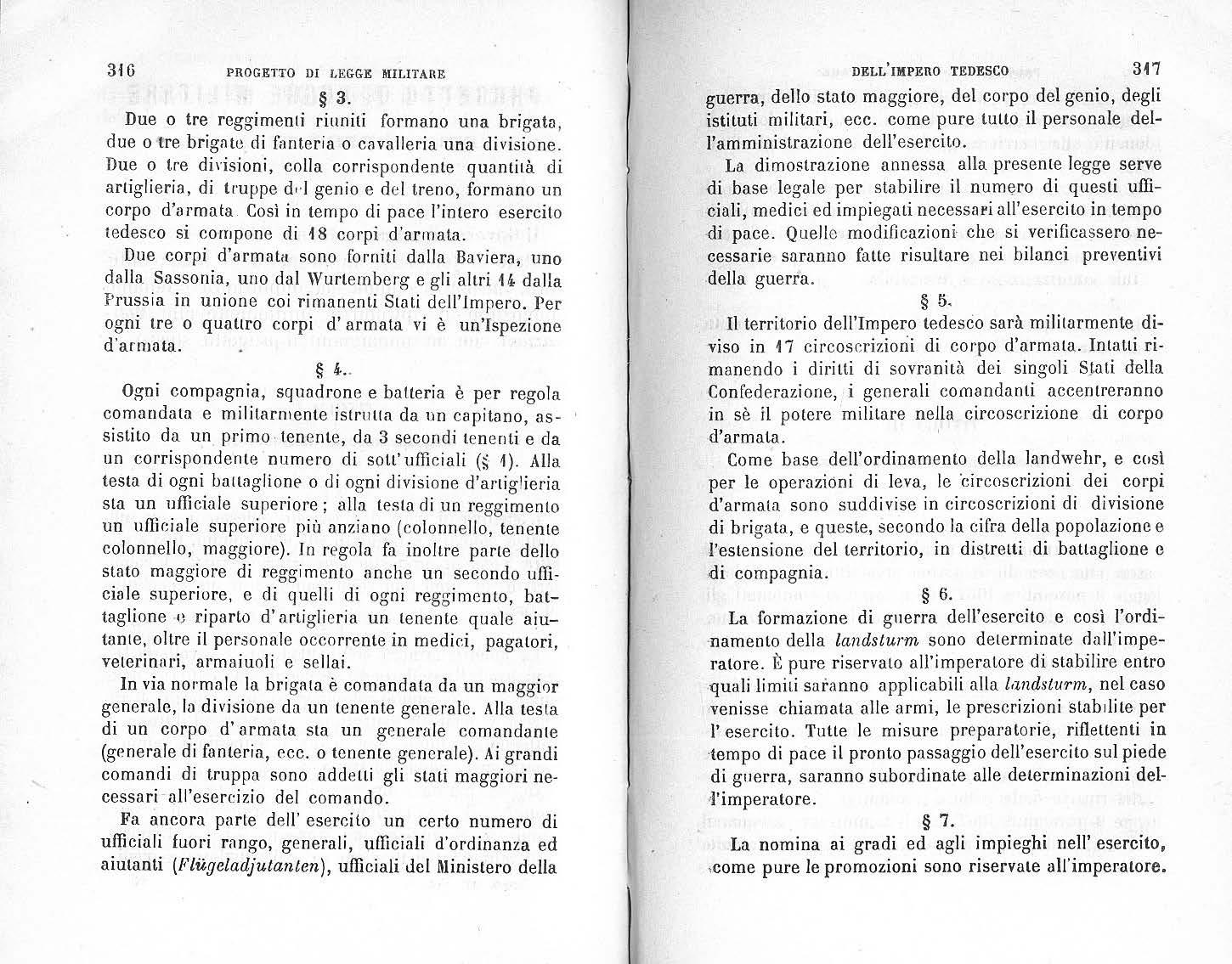

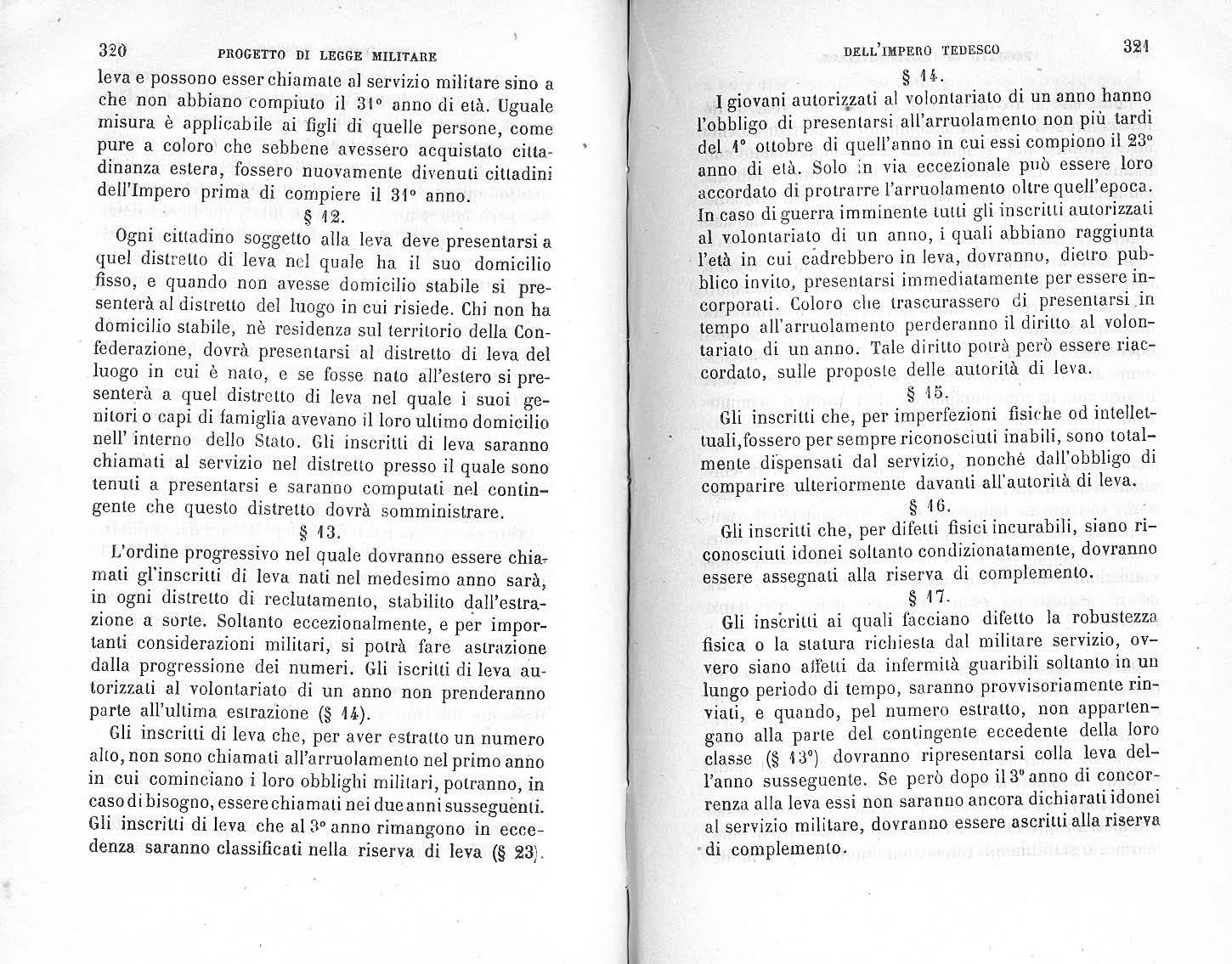
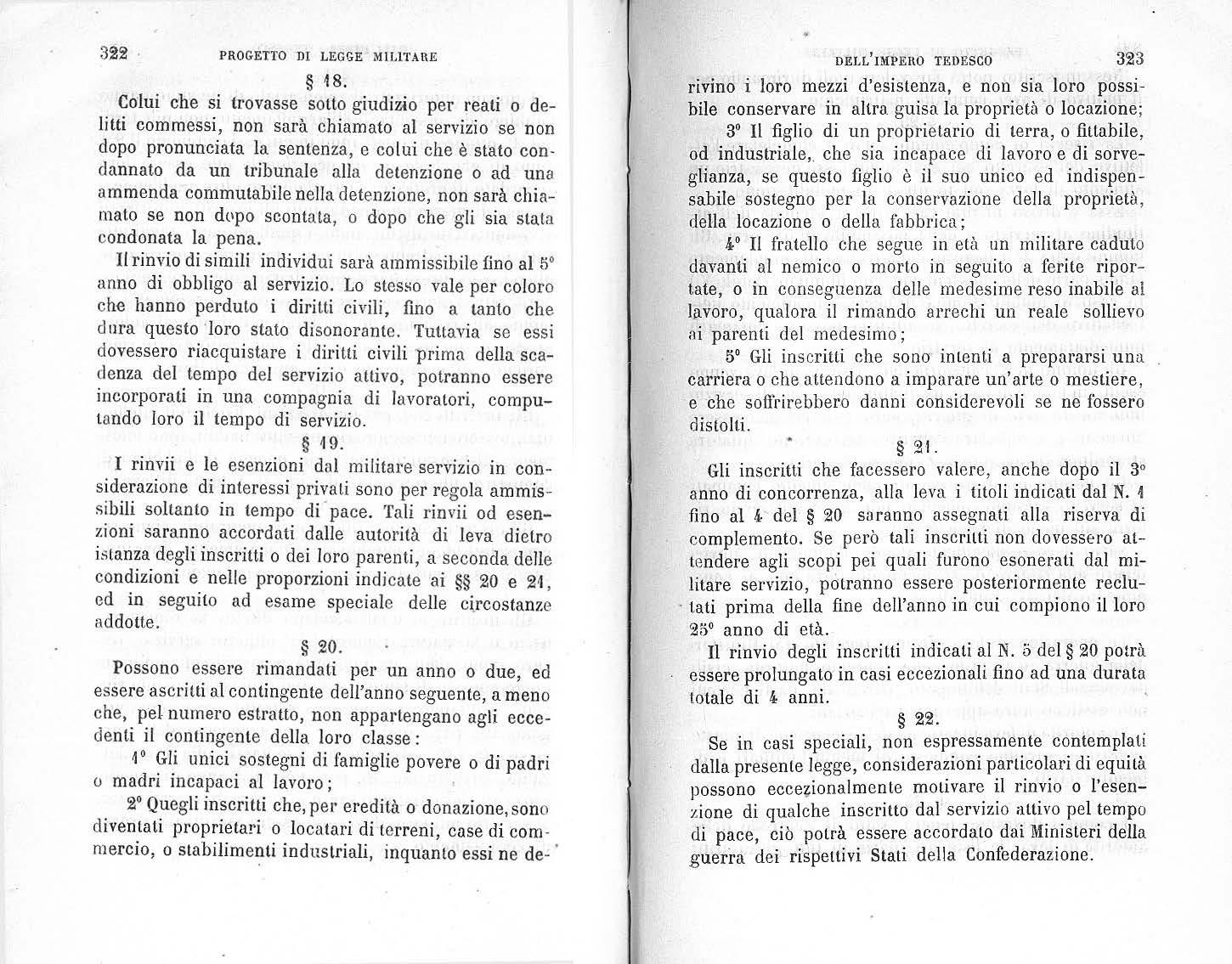


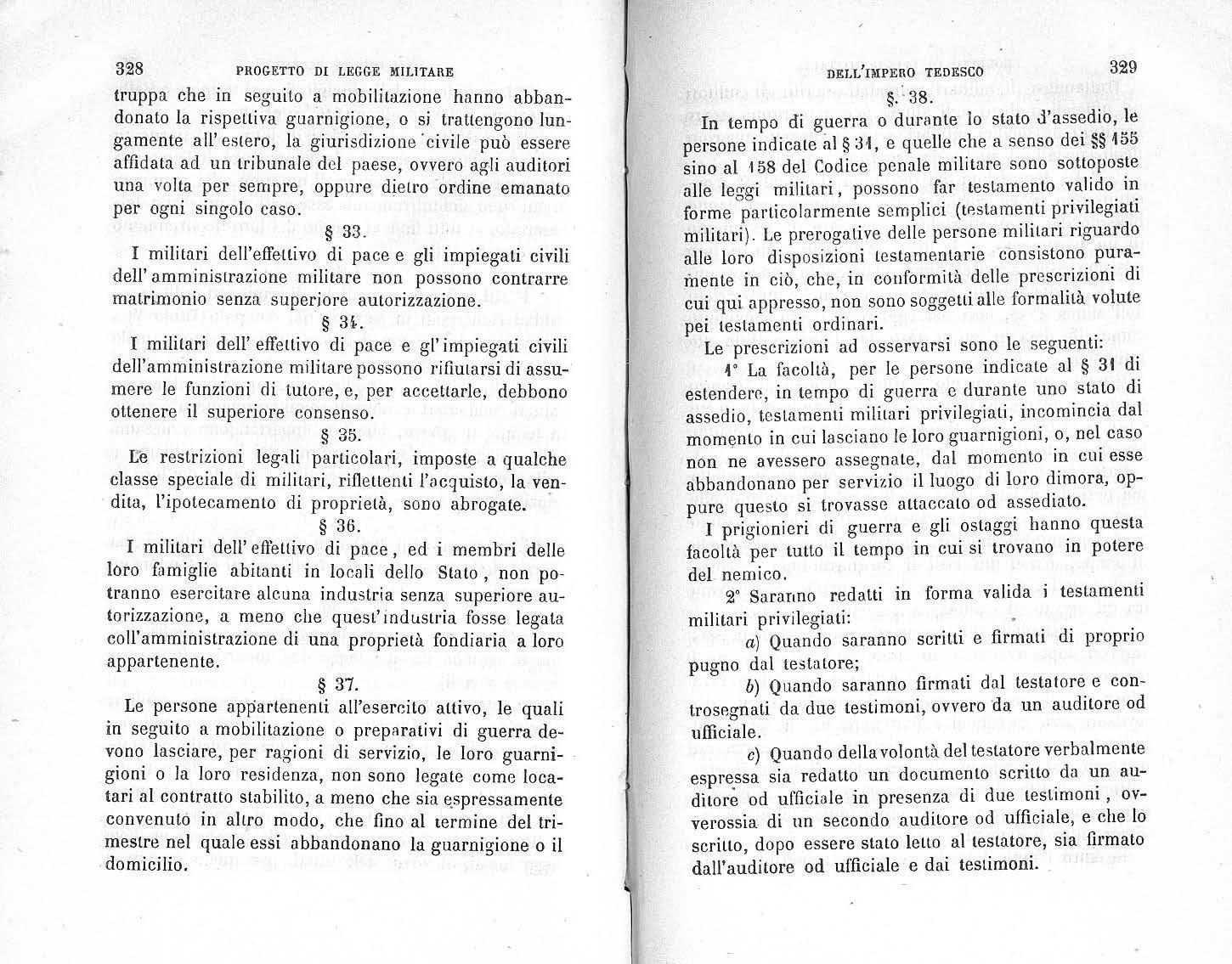
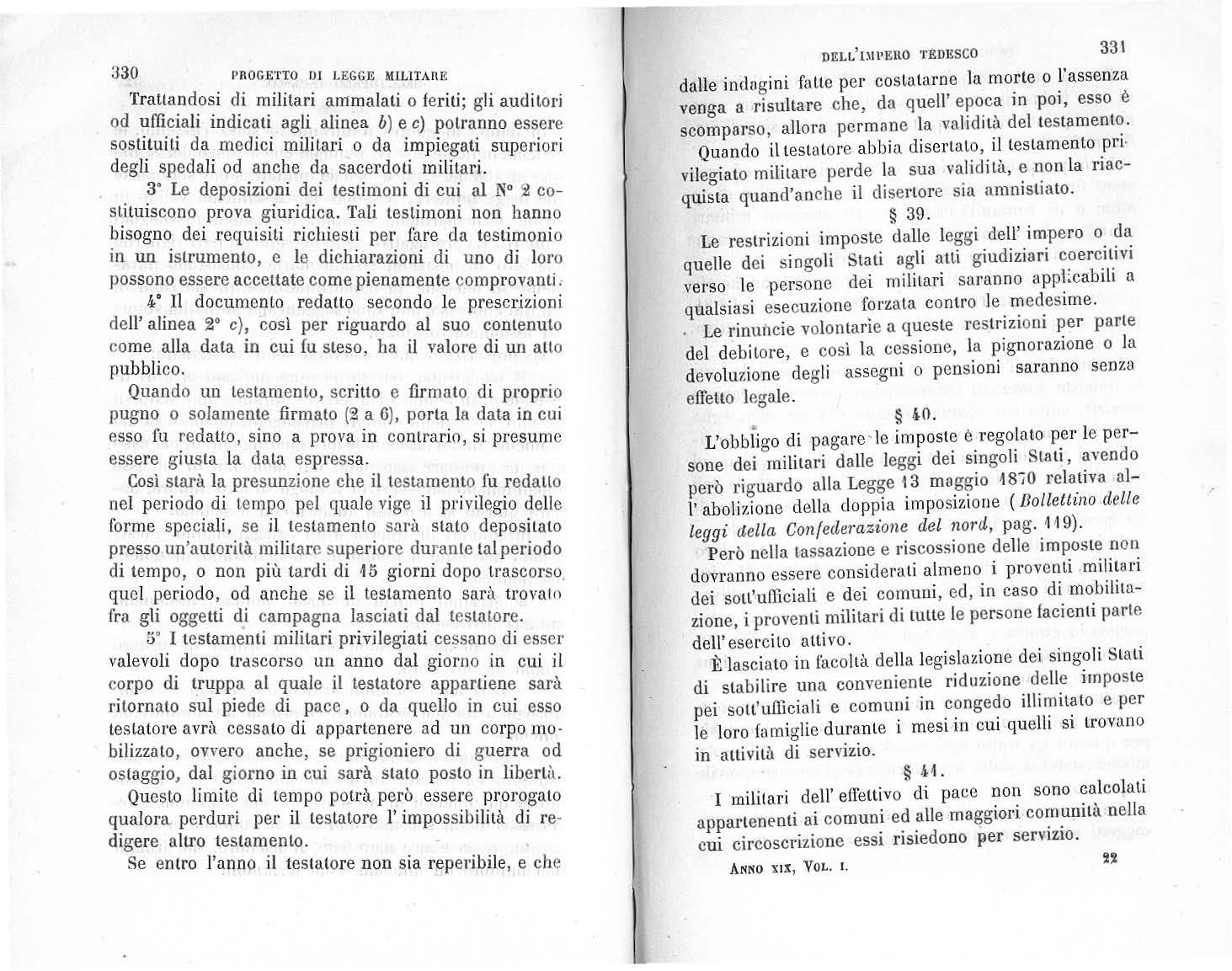
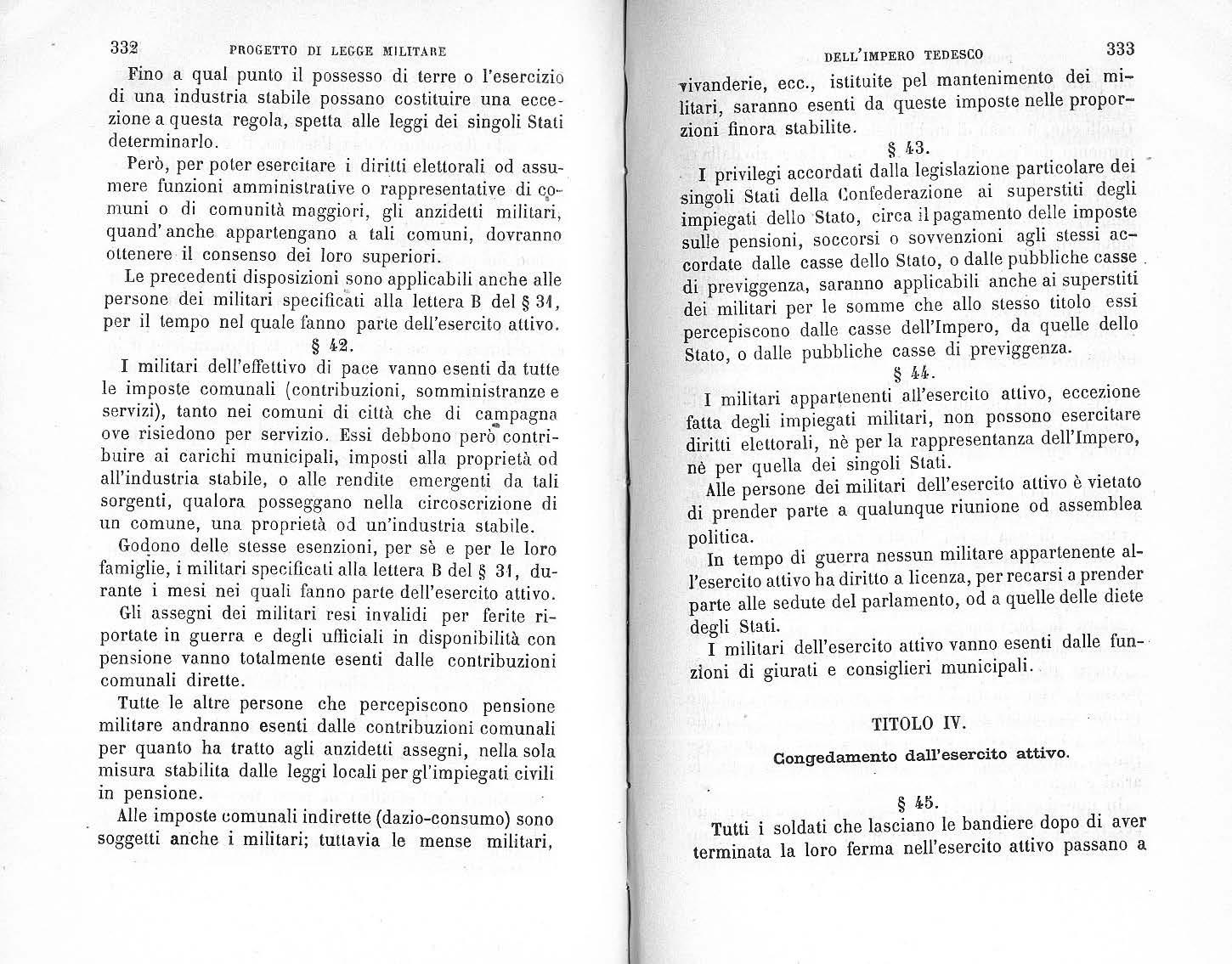
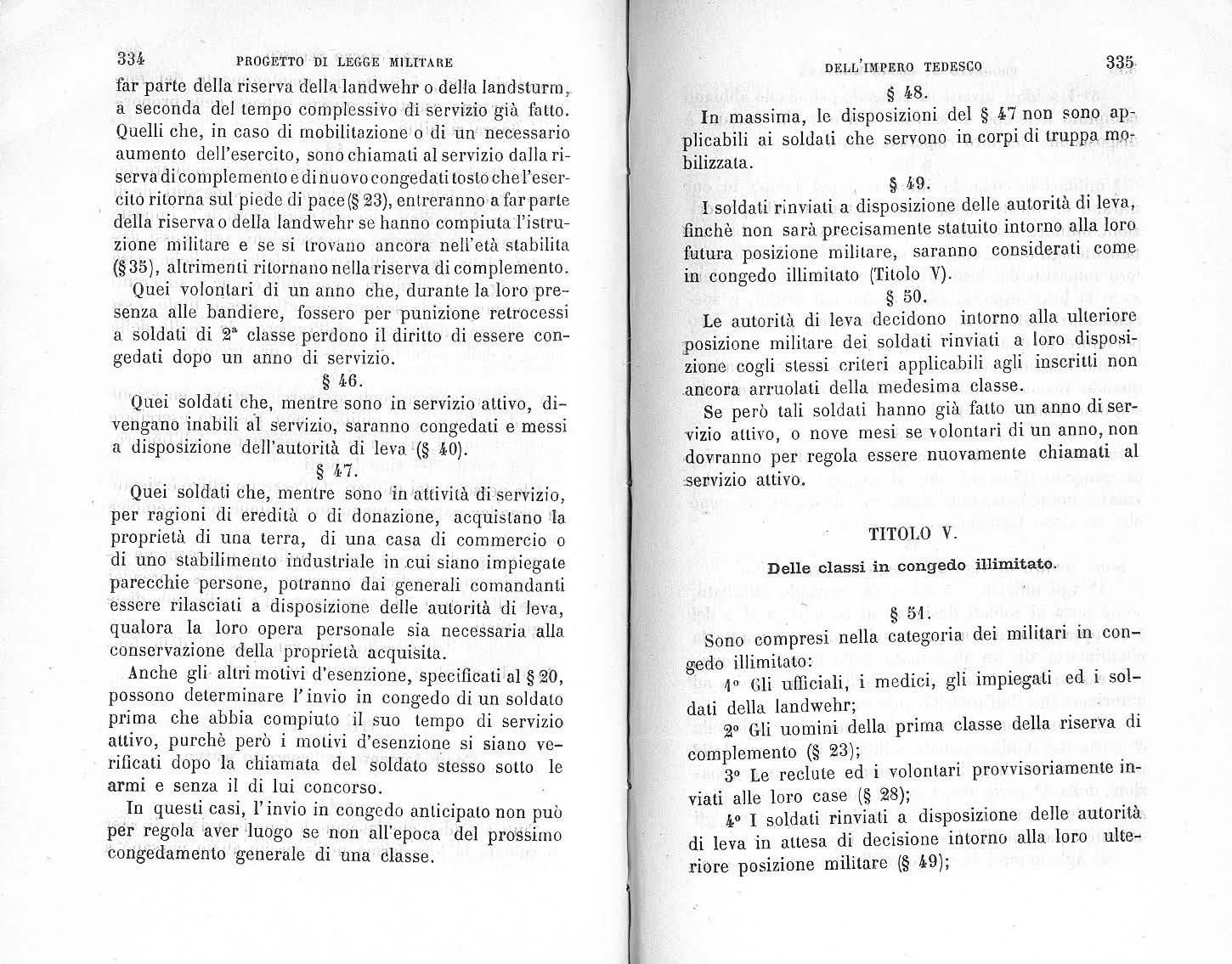
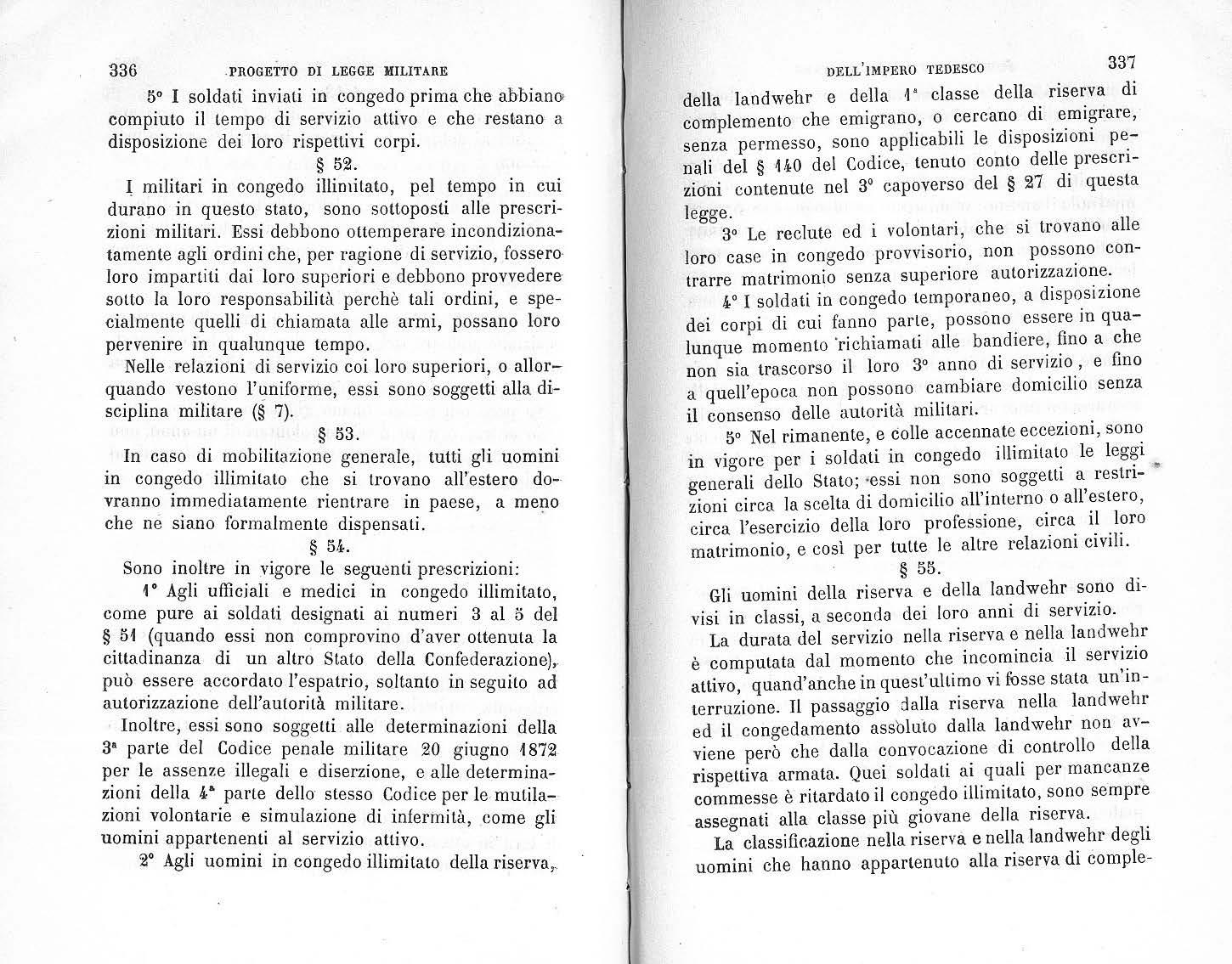
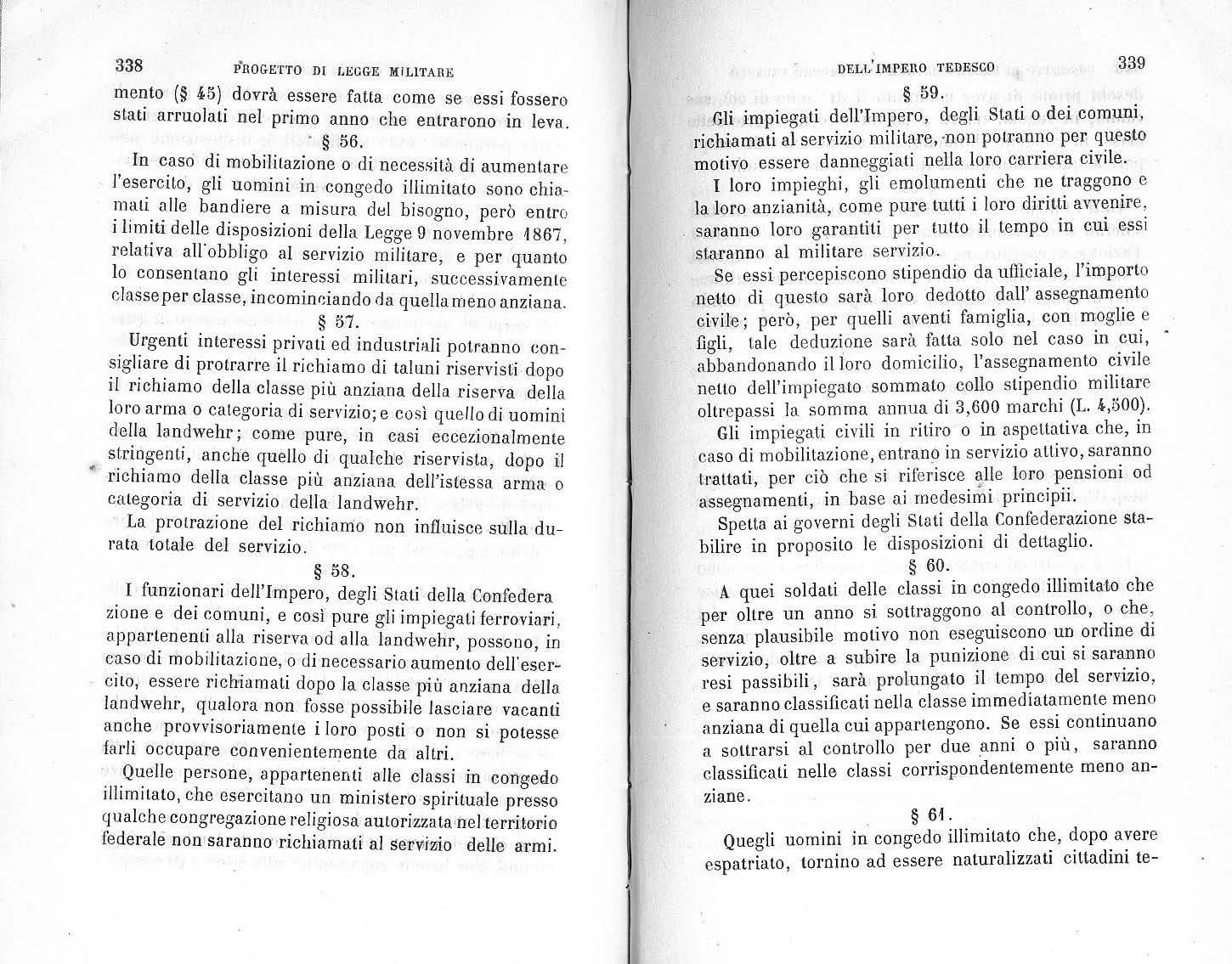
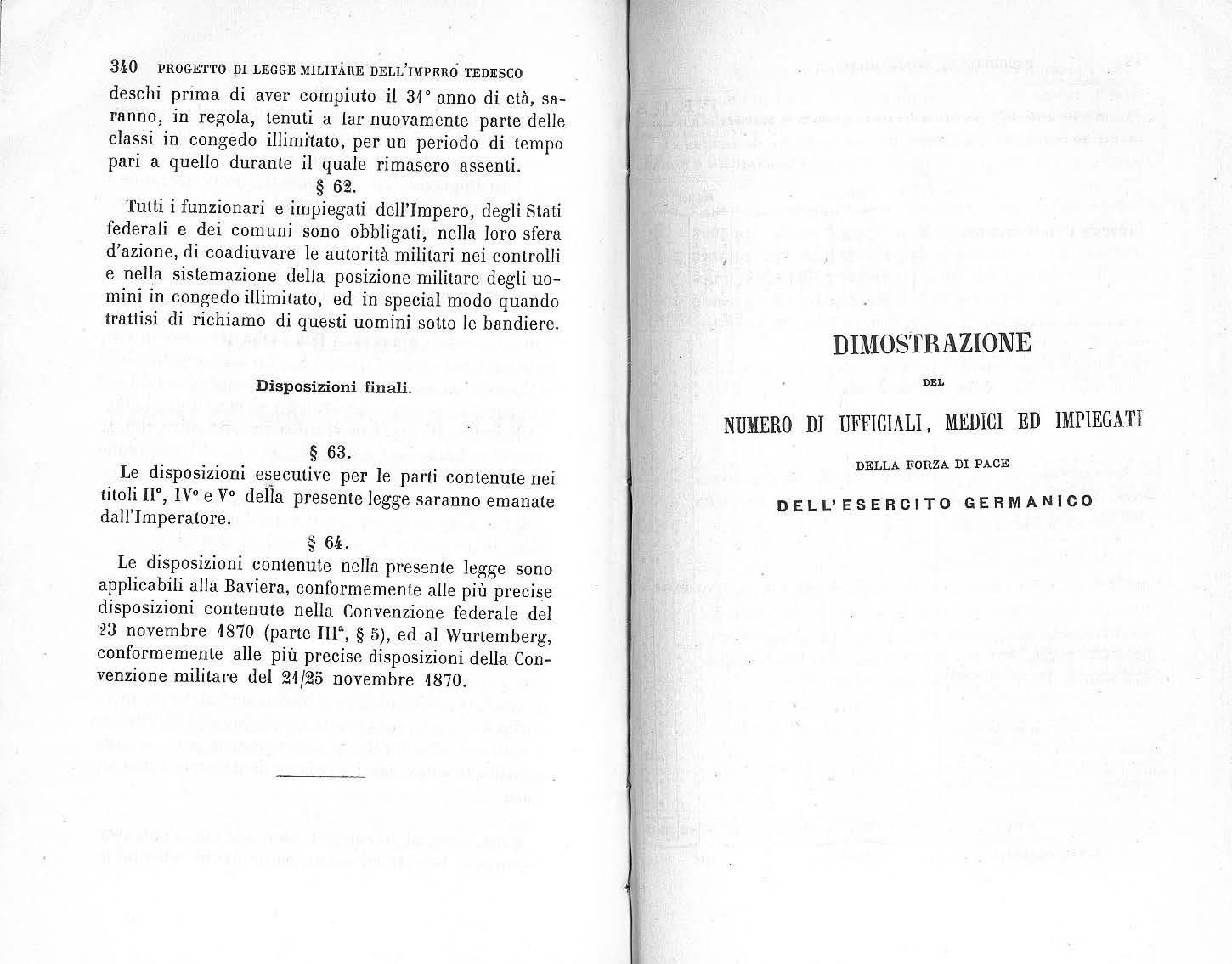
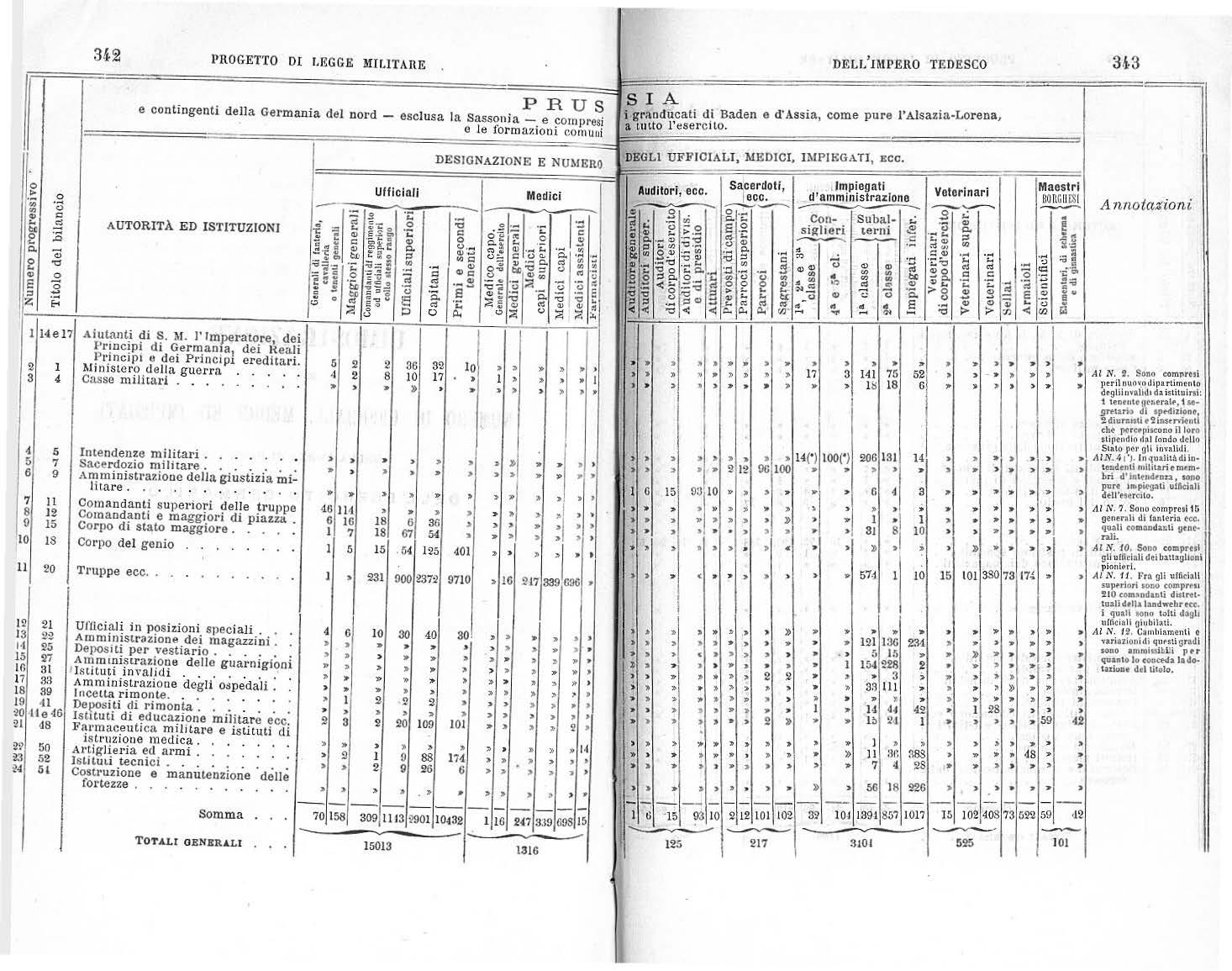

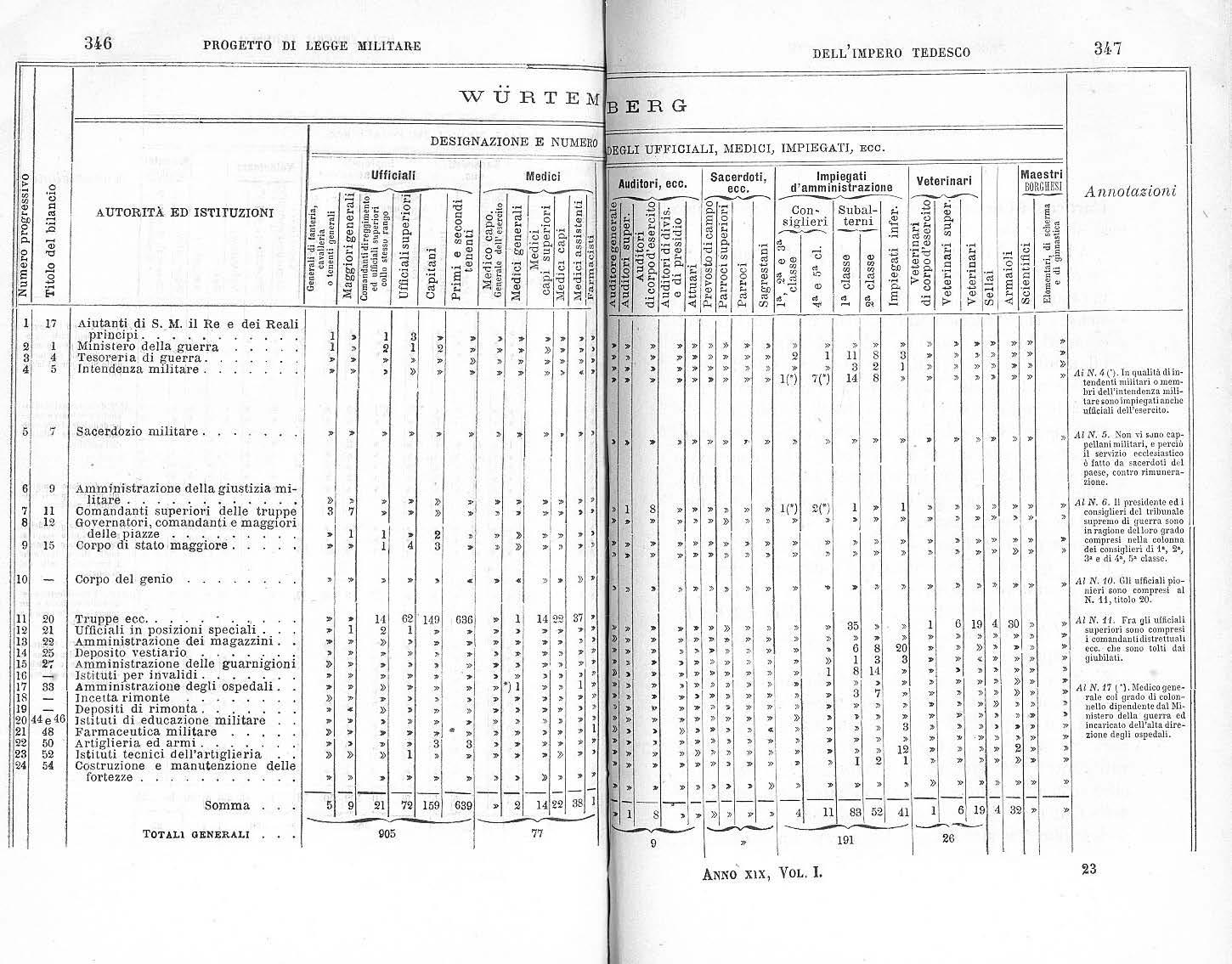
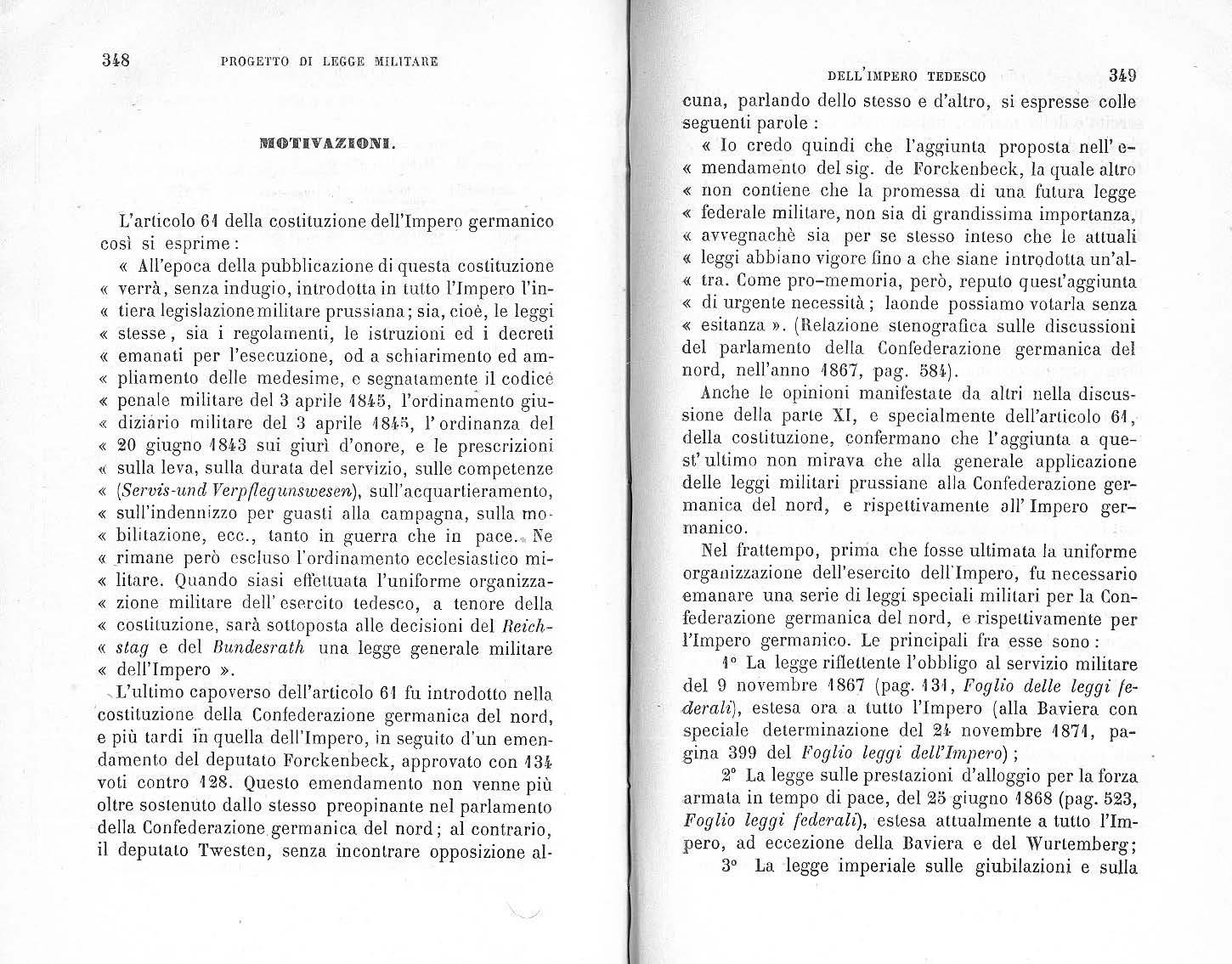
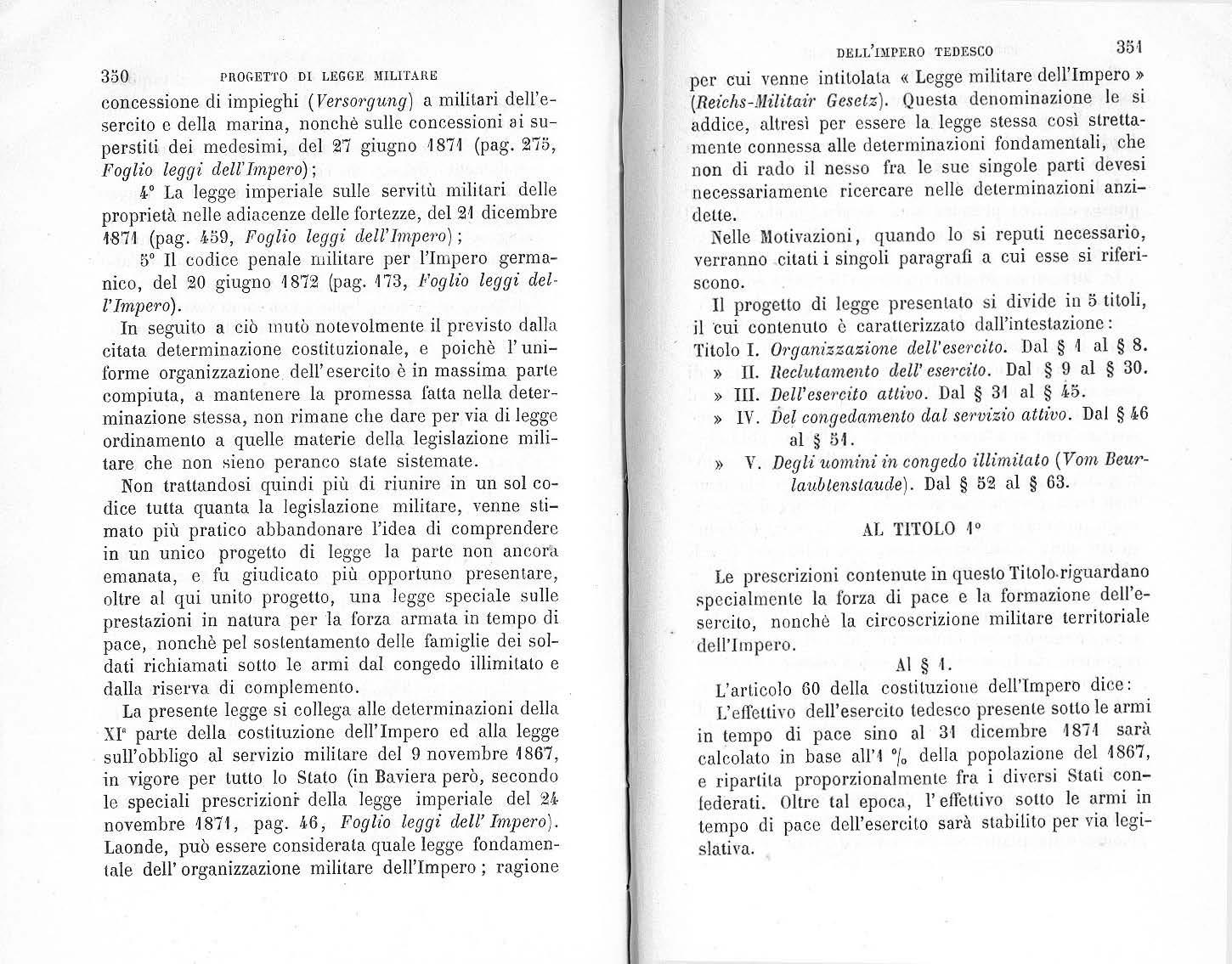


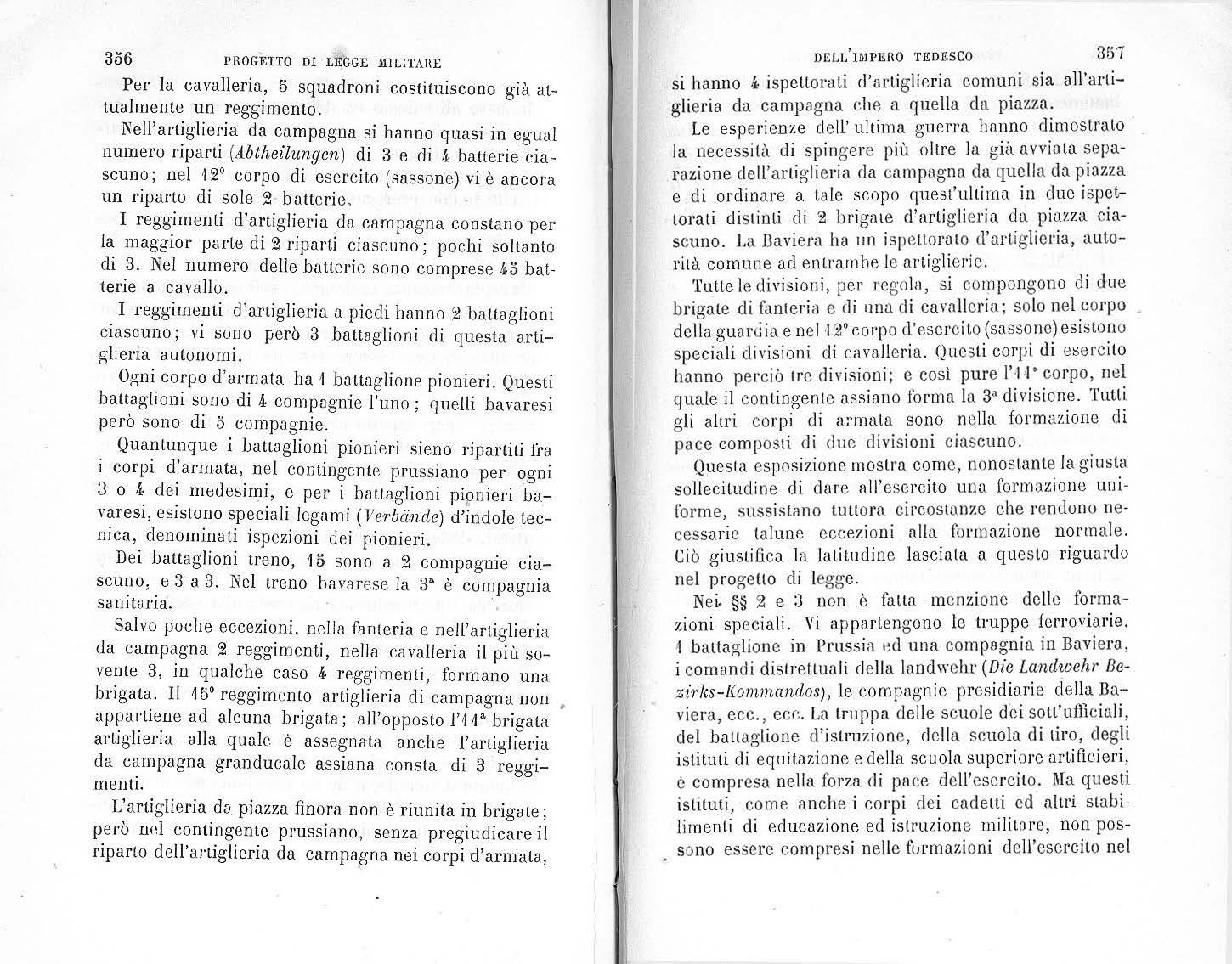

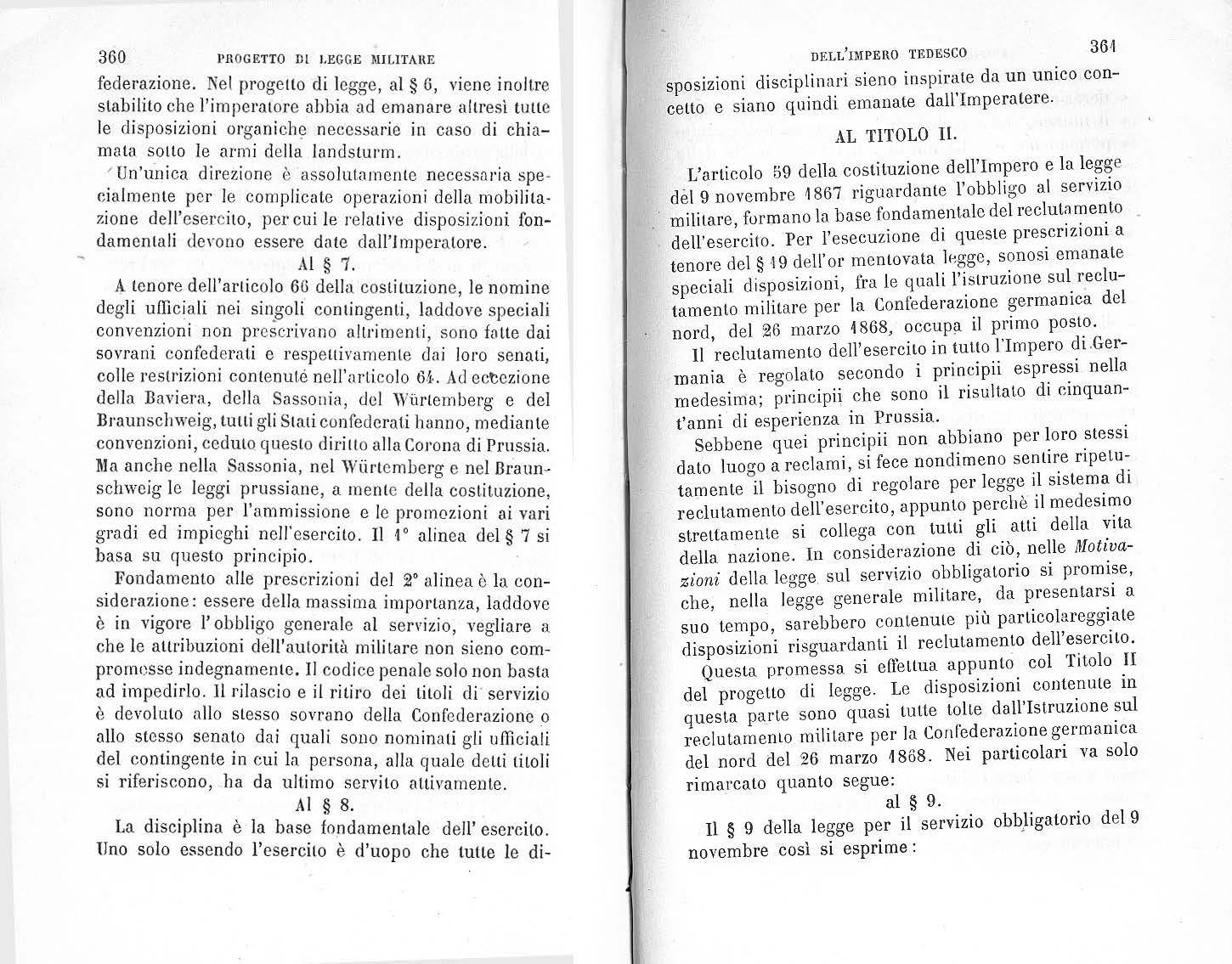
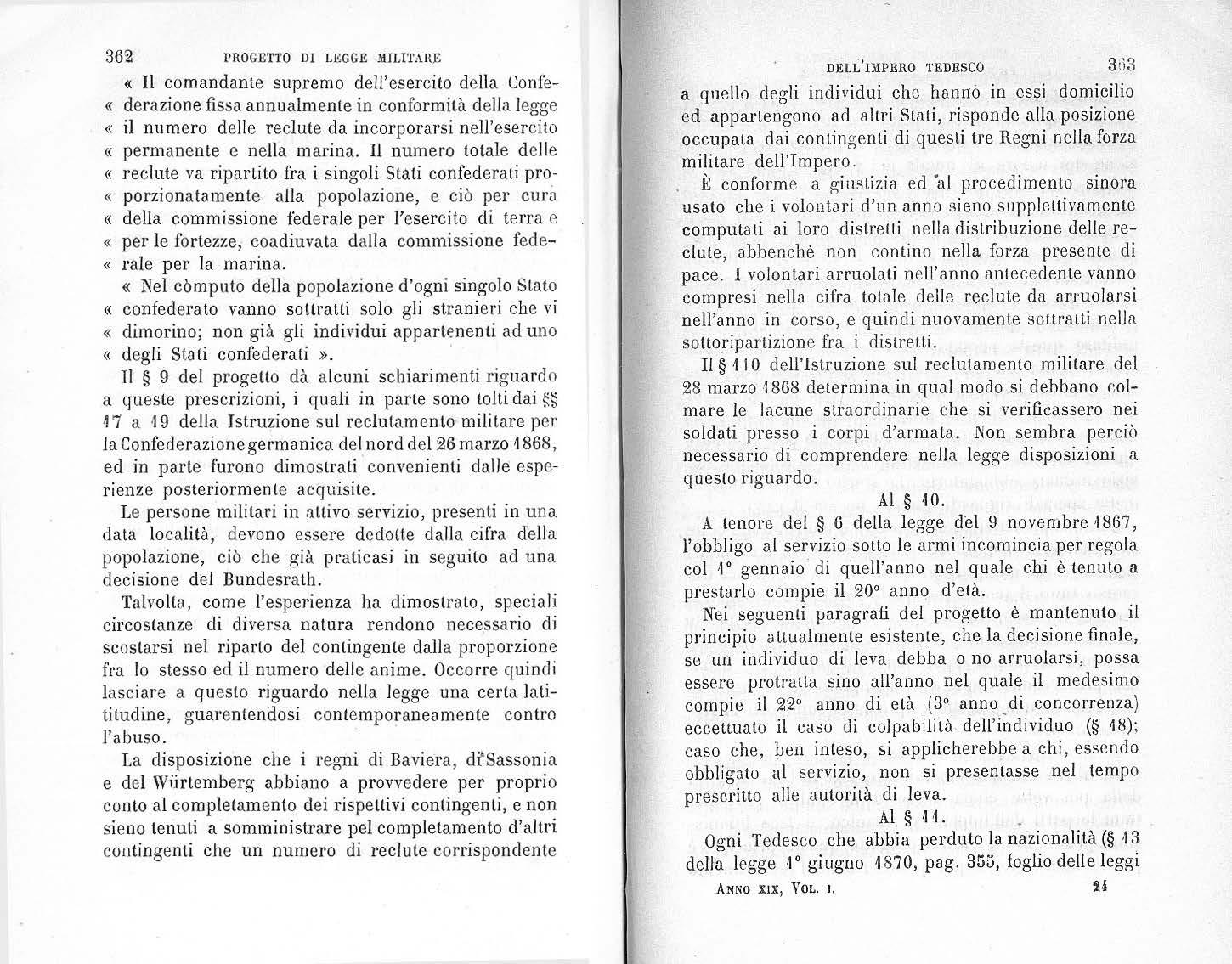
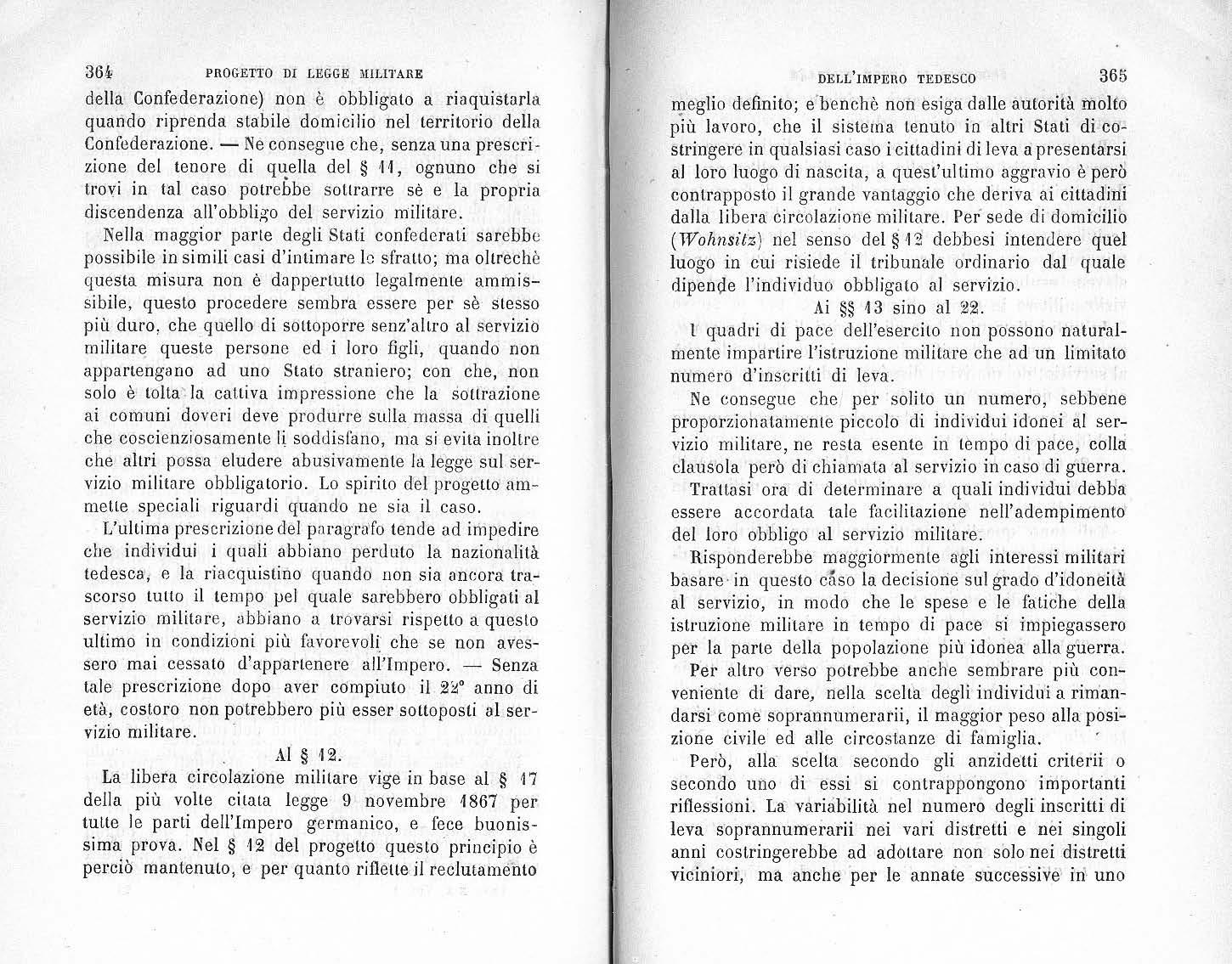
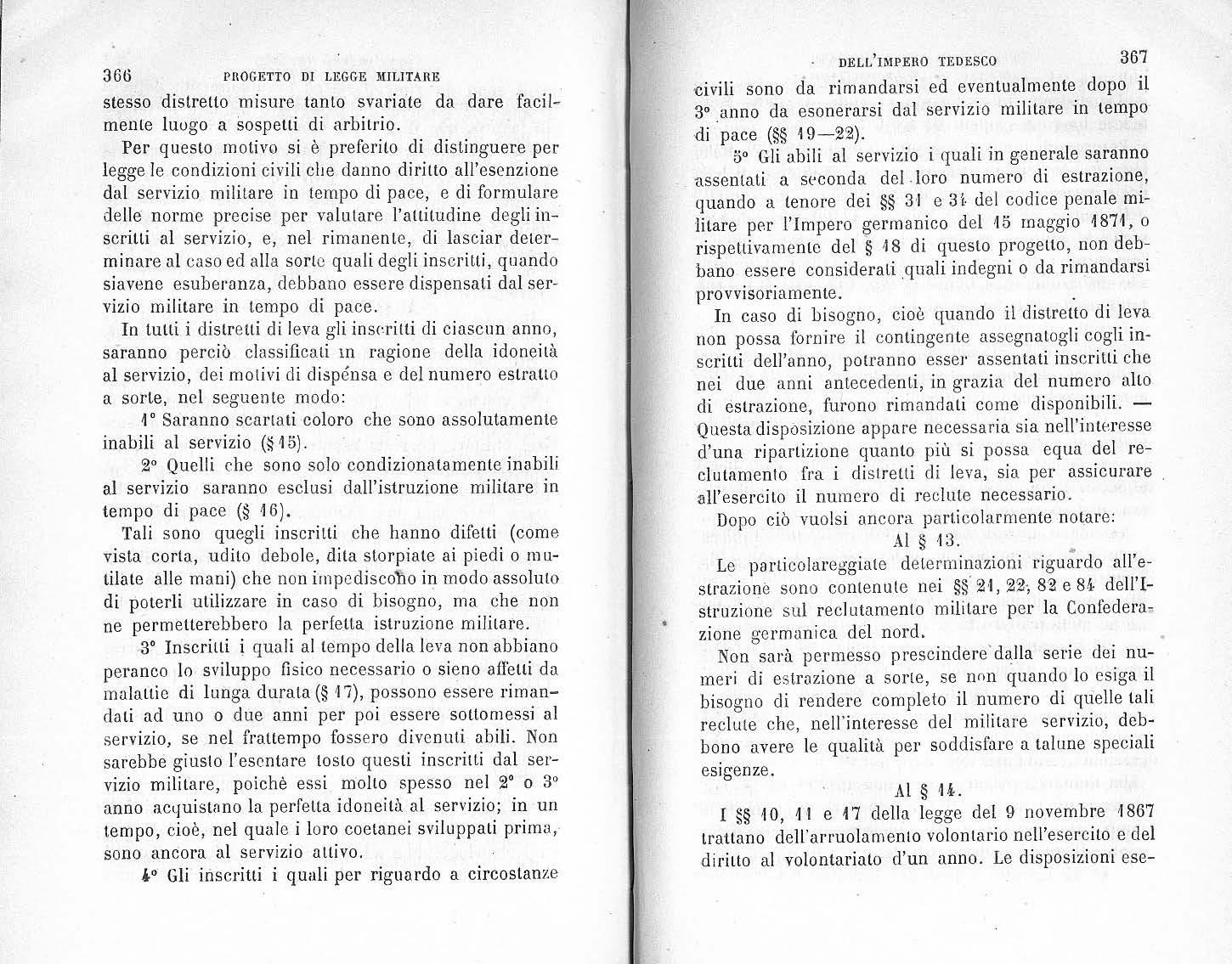
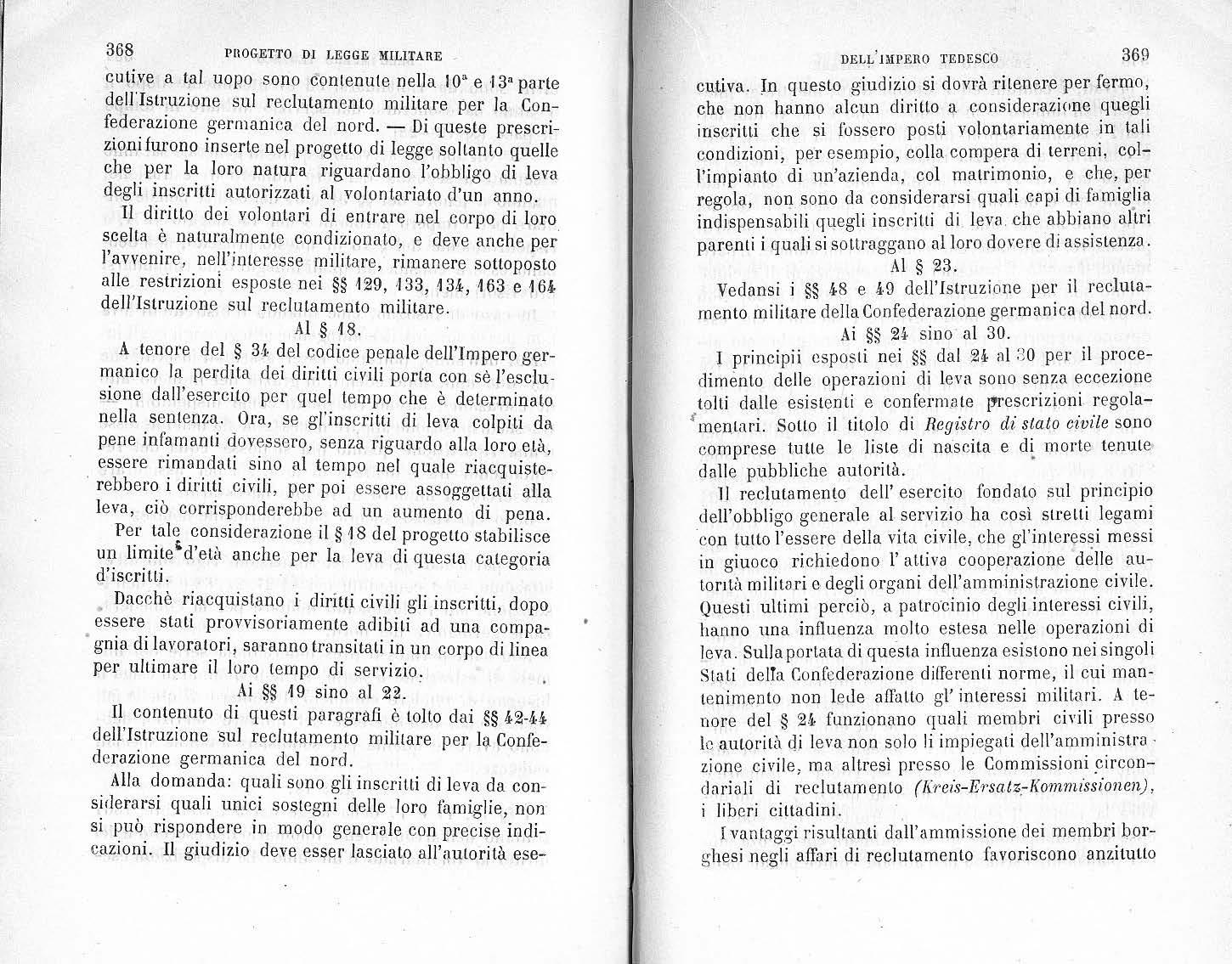
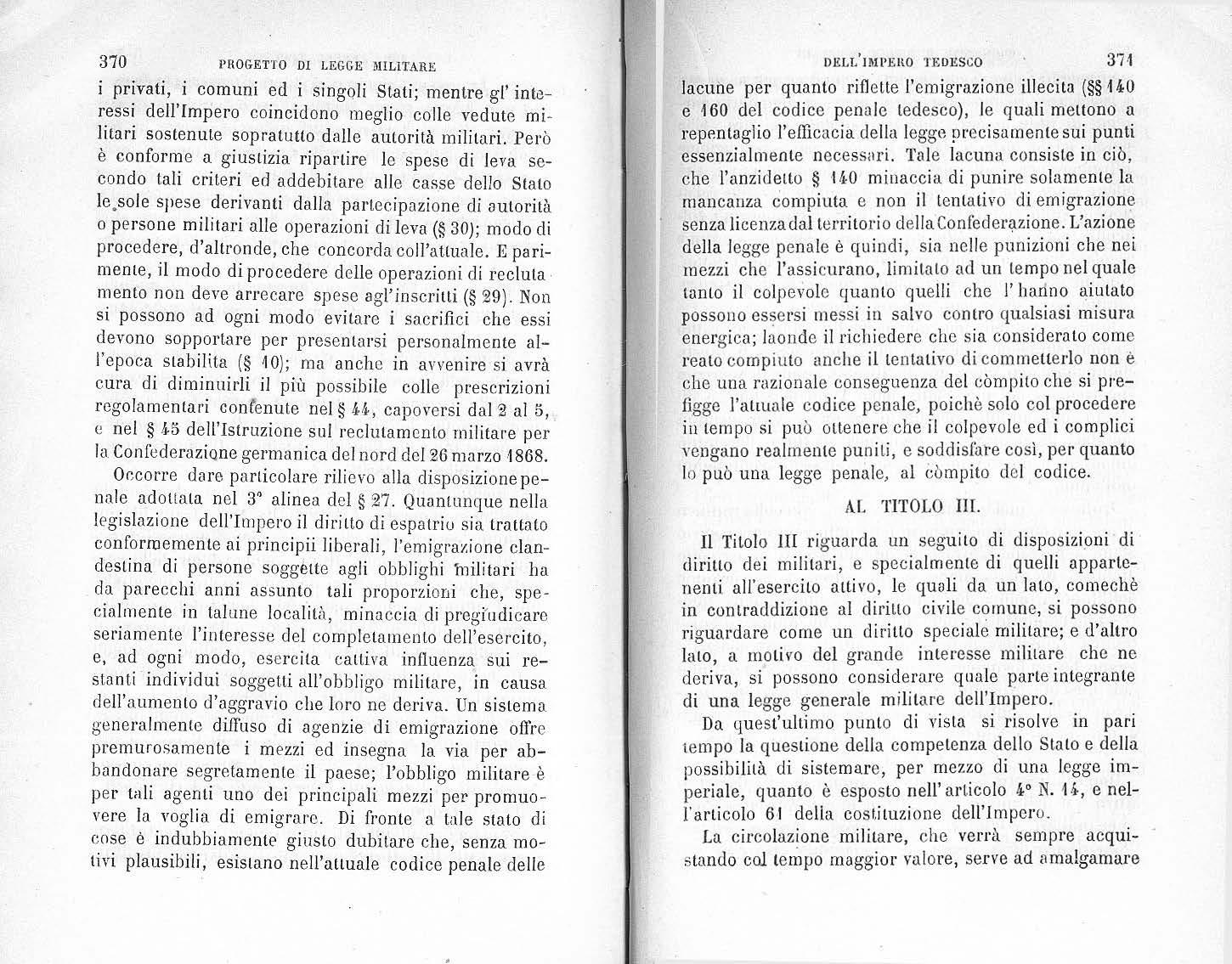
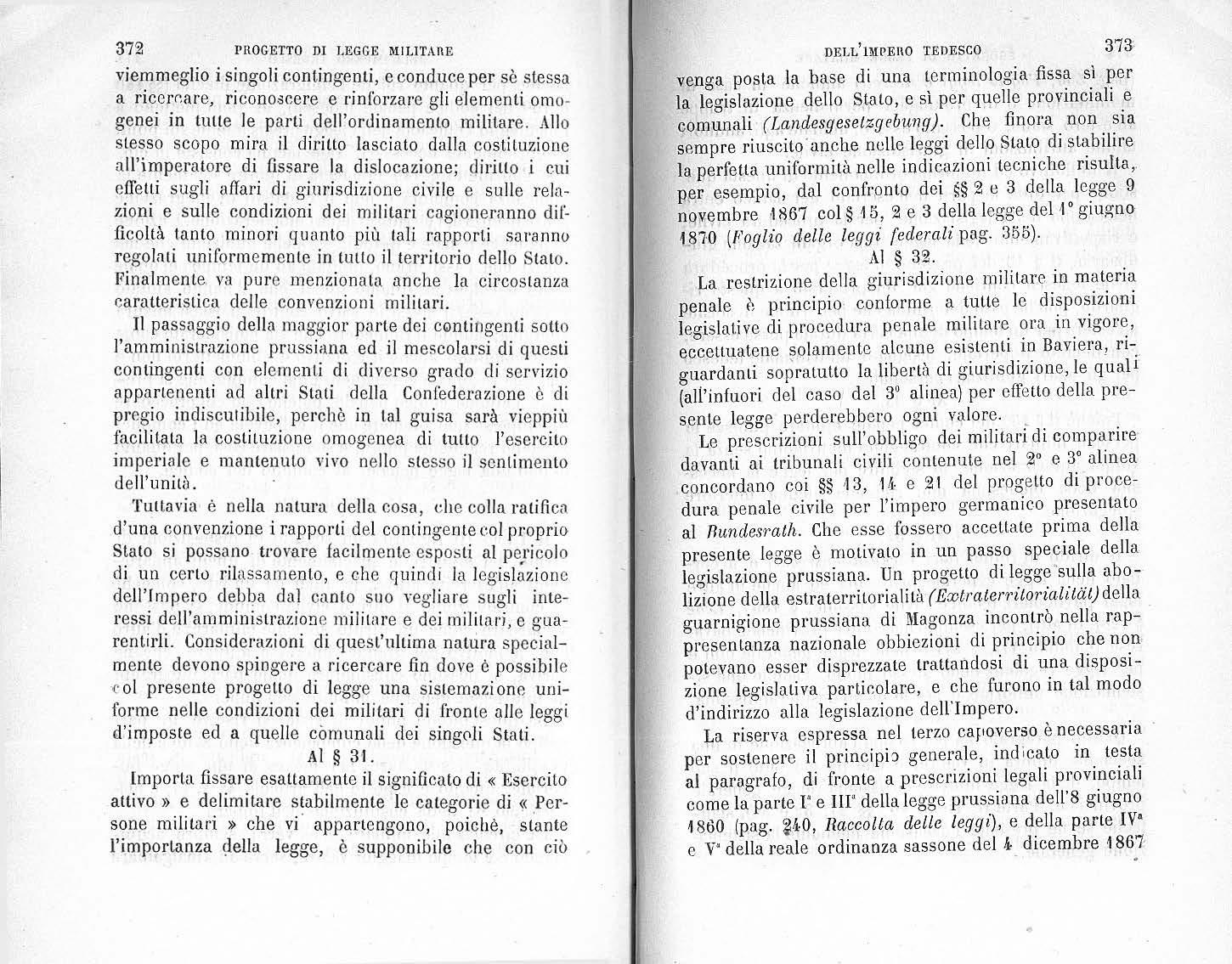
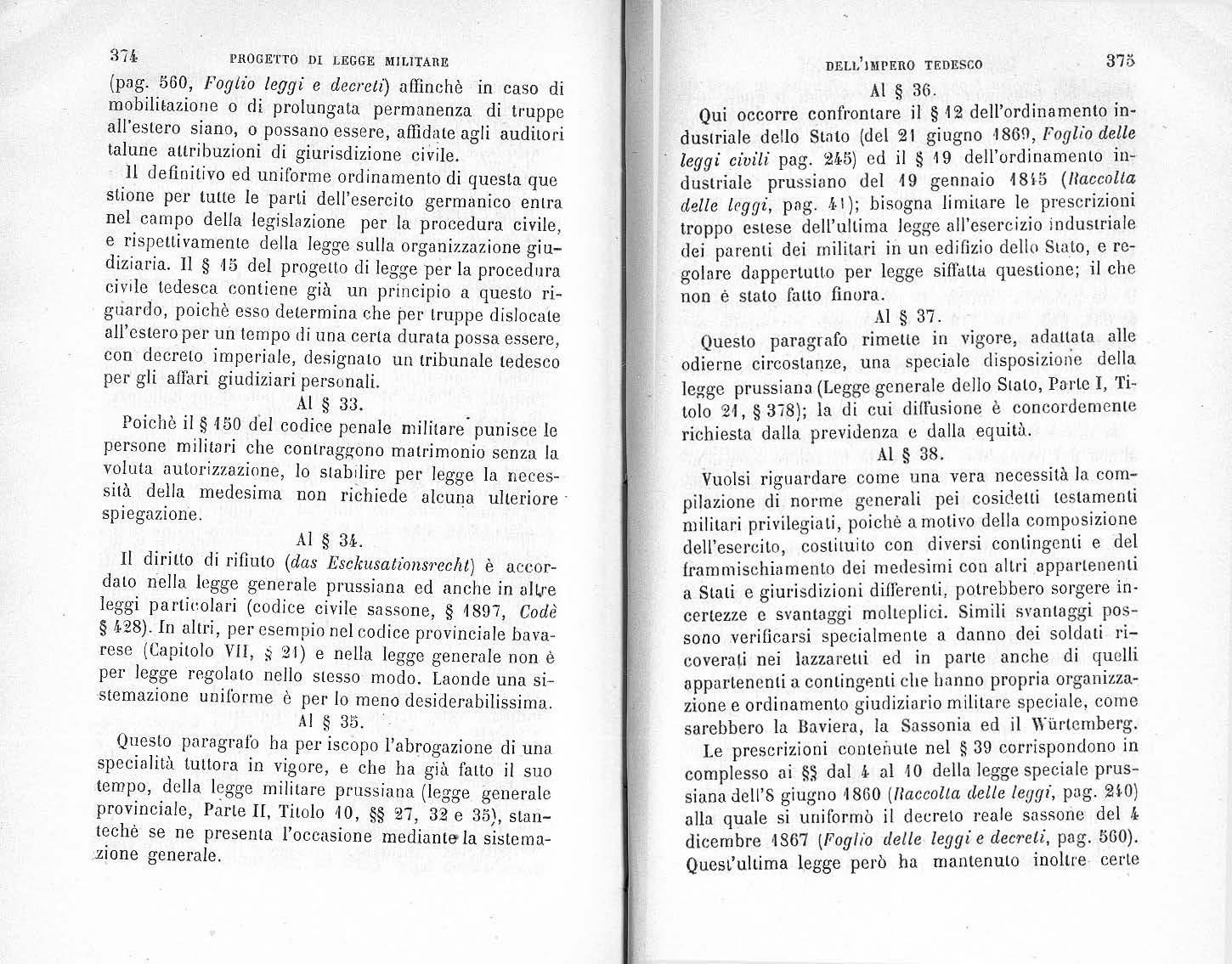
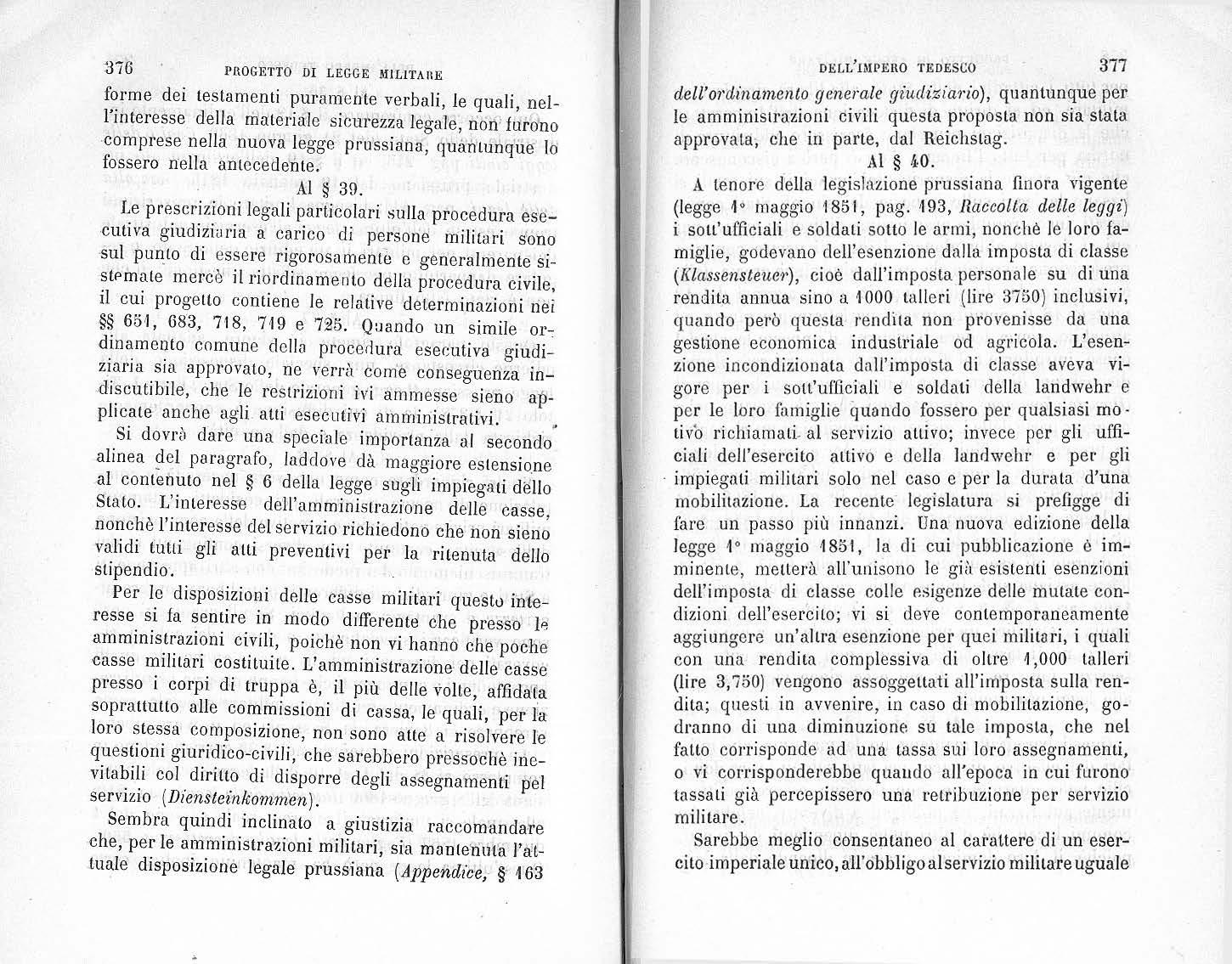
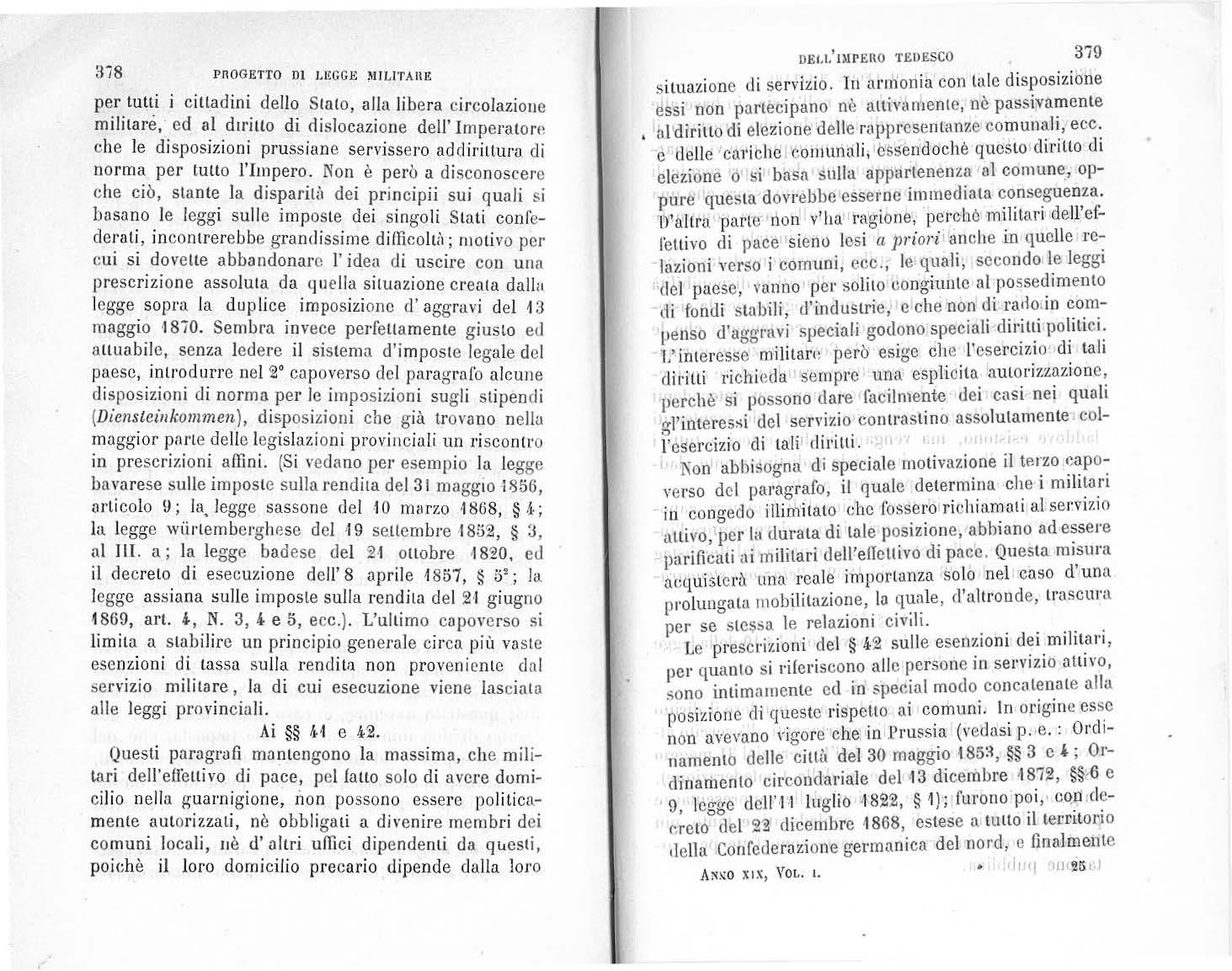
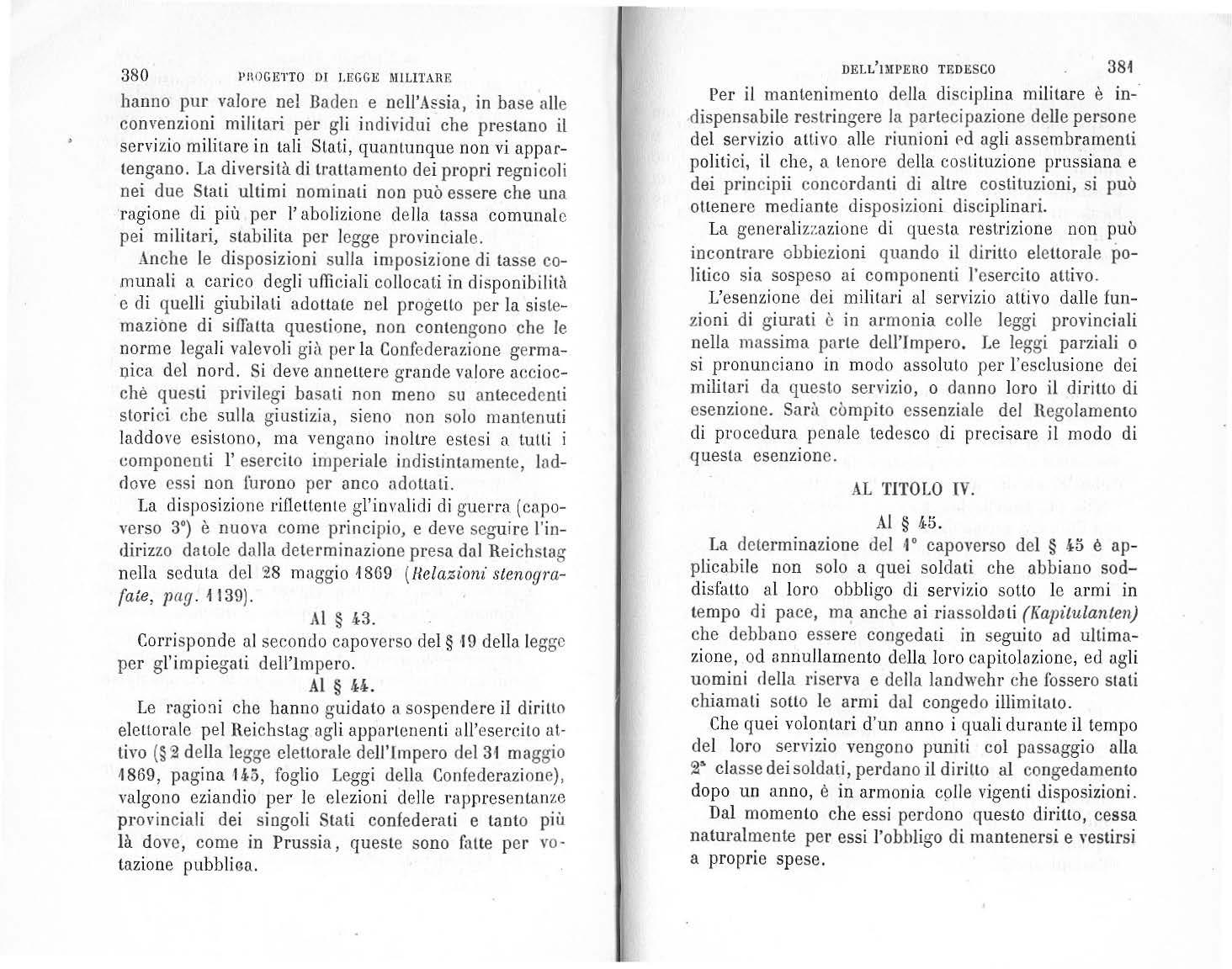
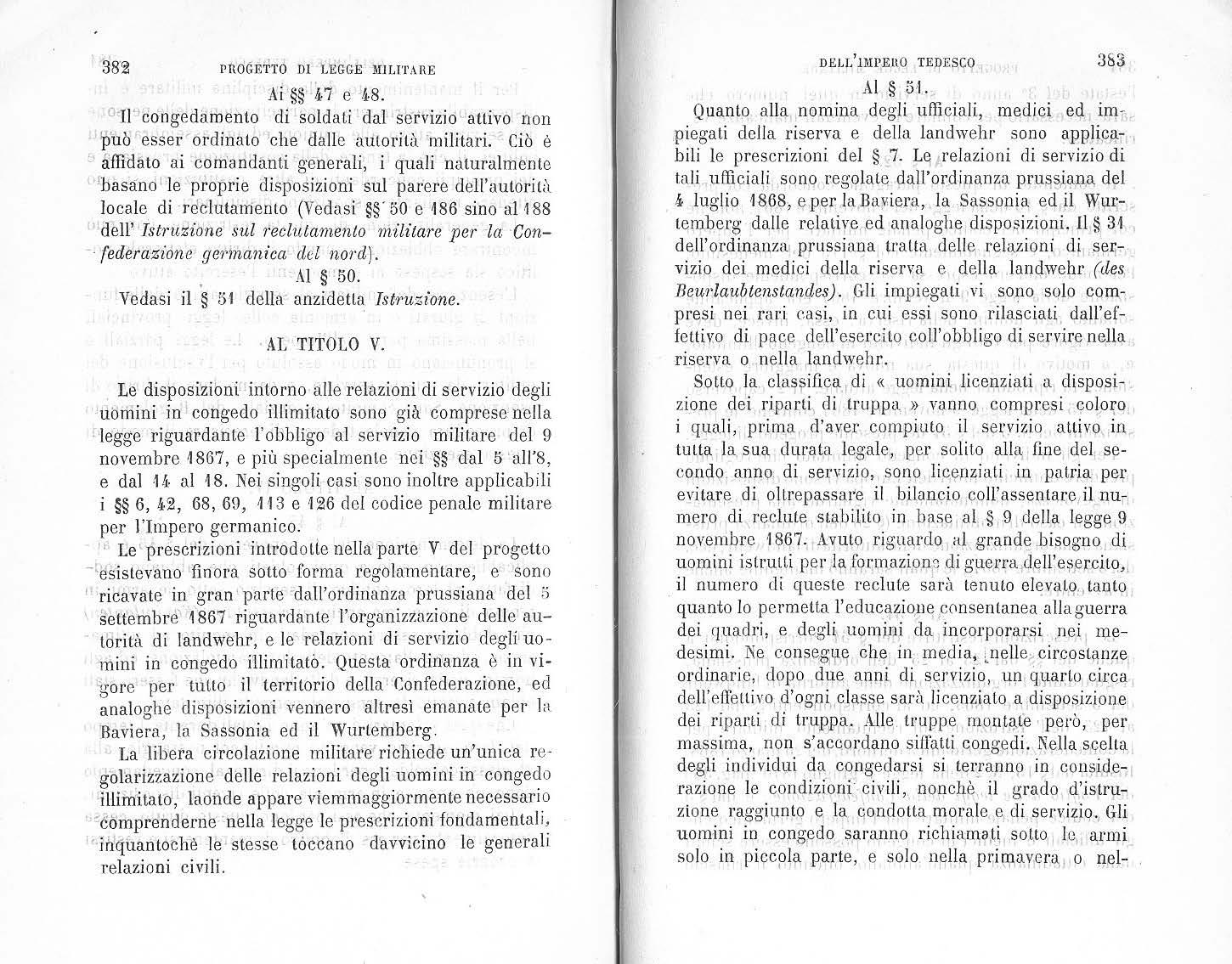
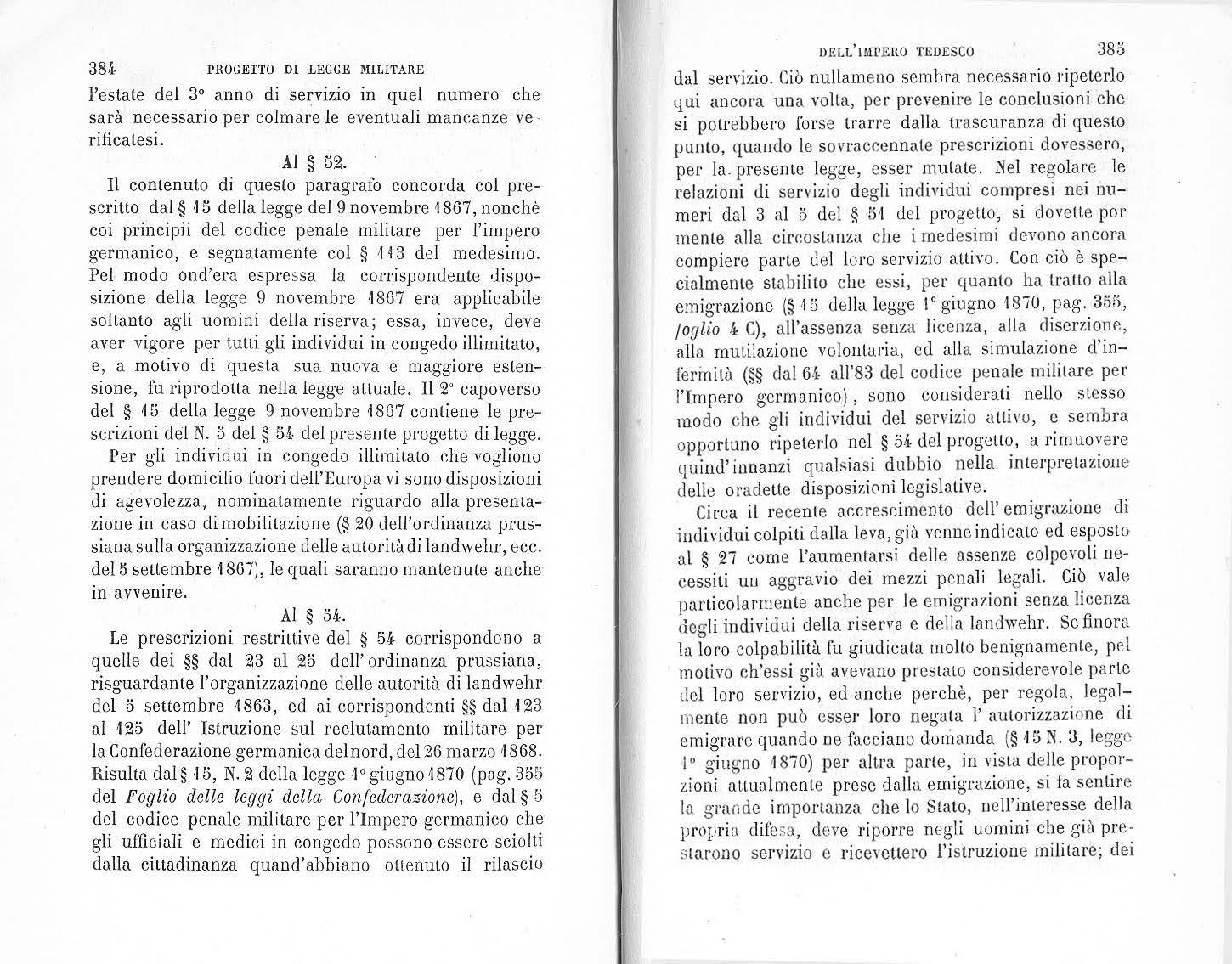
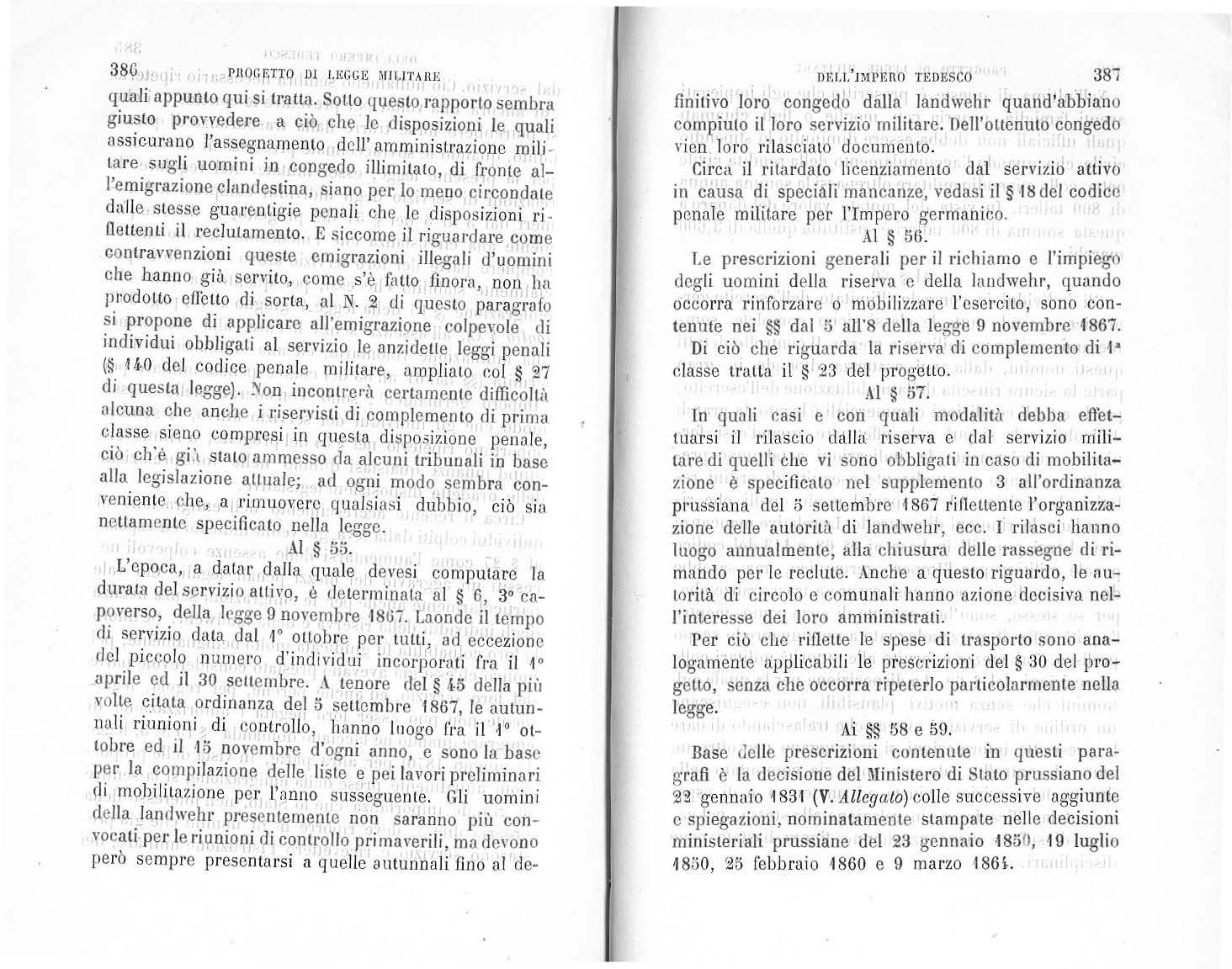
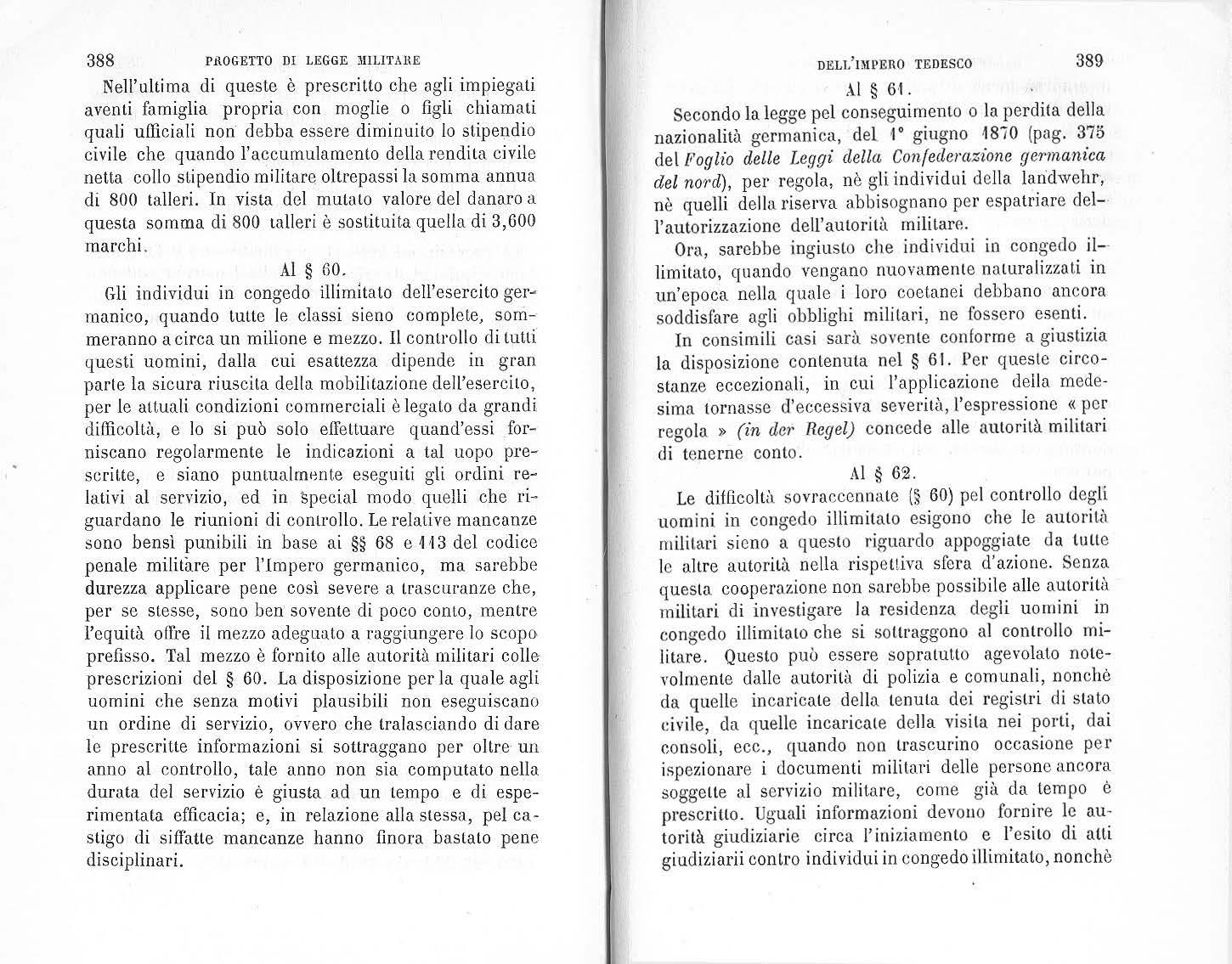

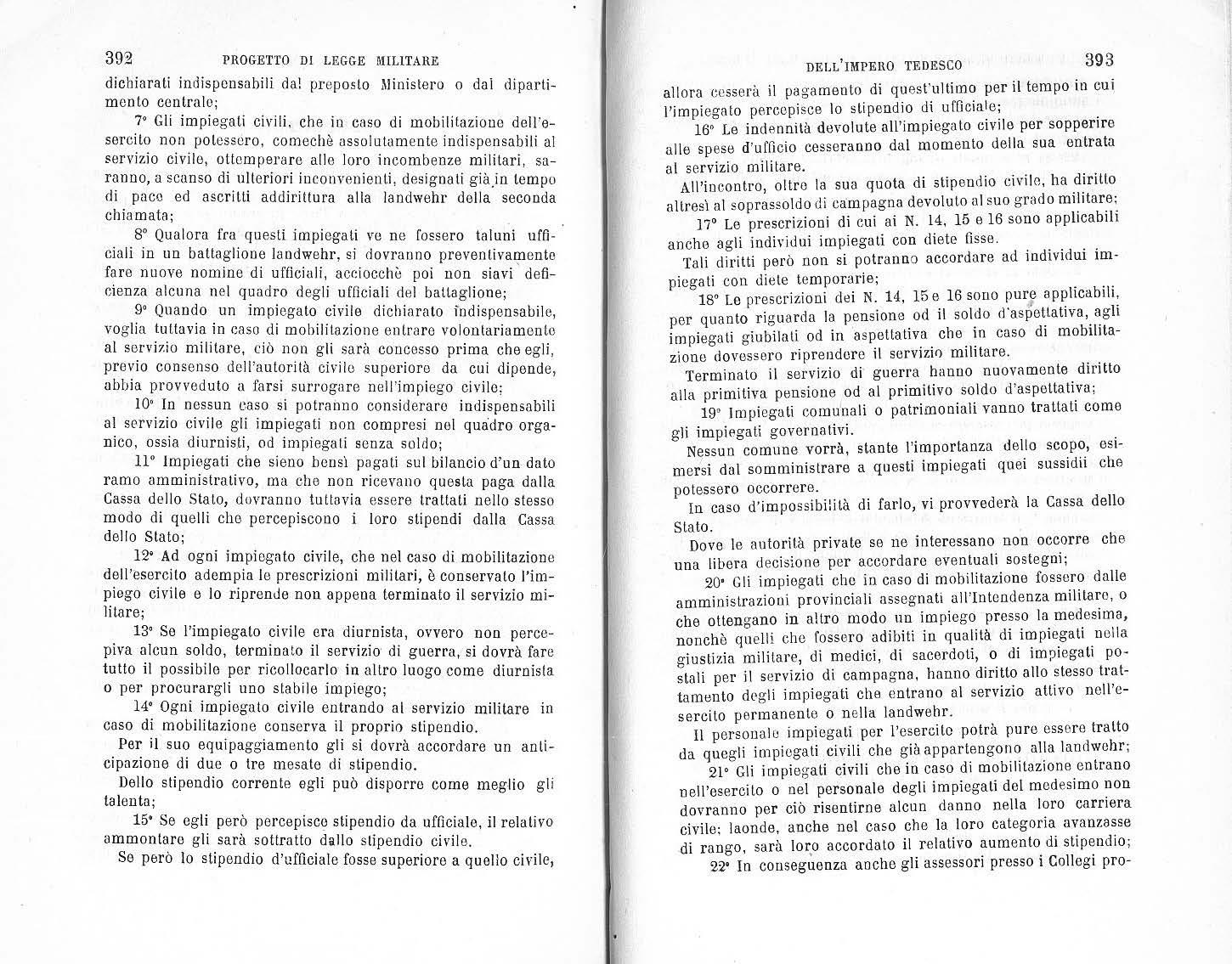
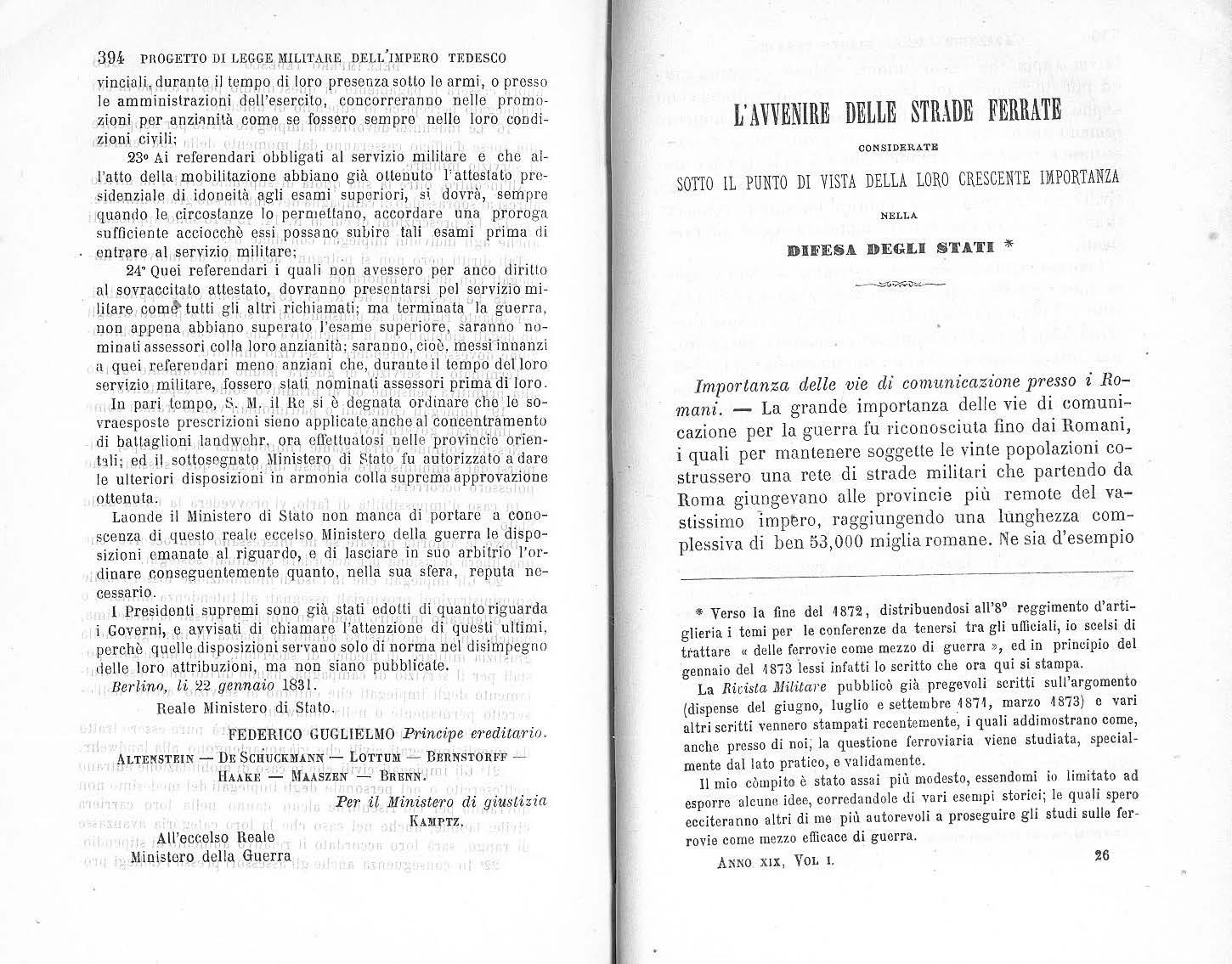

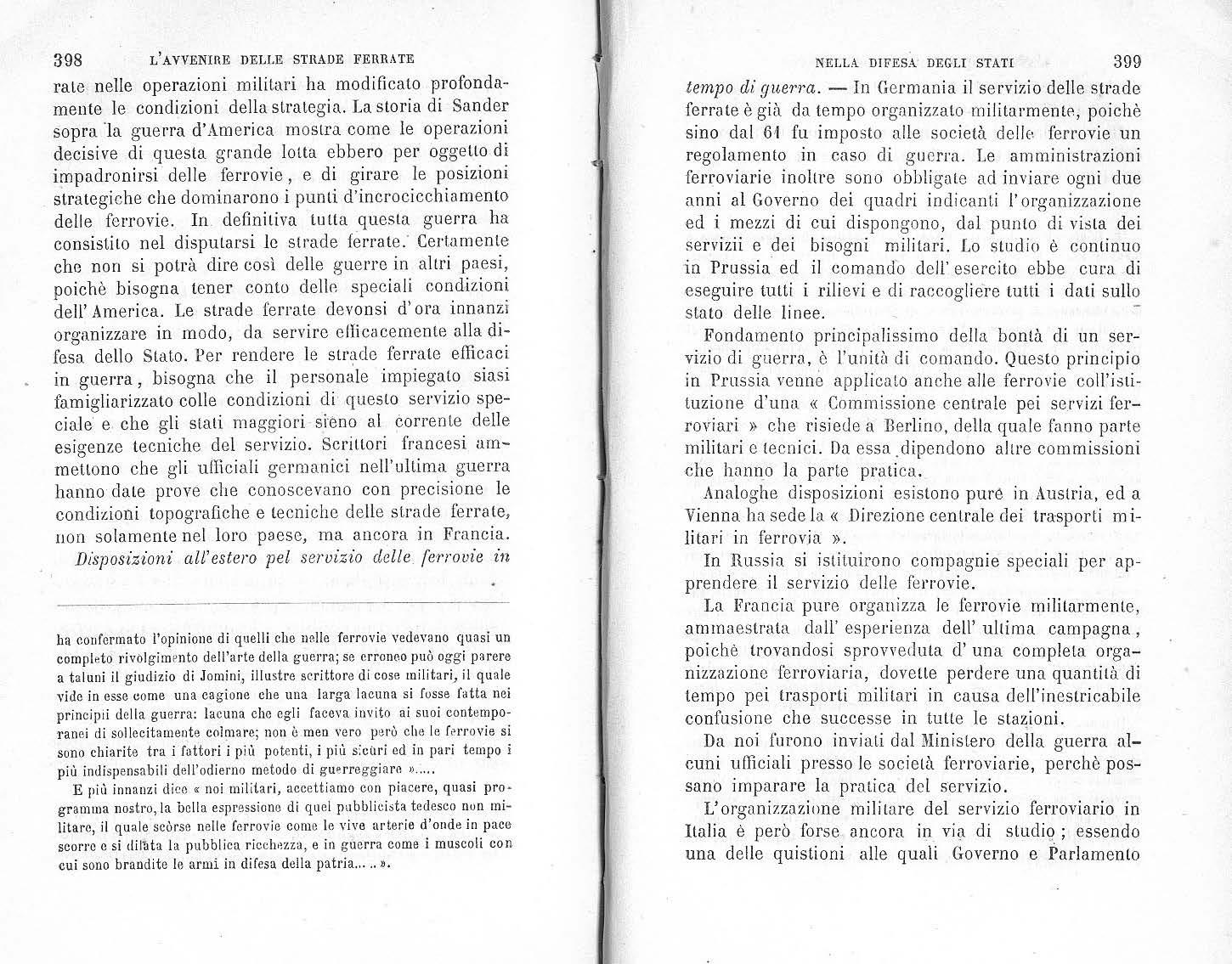
 NEtLA DIFESA DEG.tl S'.J;ATI. 4 (),1'
NEtLA DIFESA DEG.tl S'.J;ATI. 4 (),1'