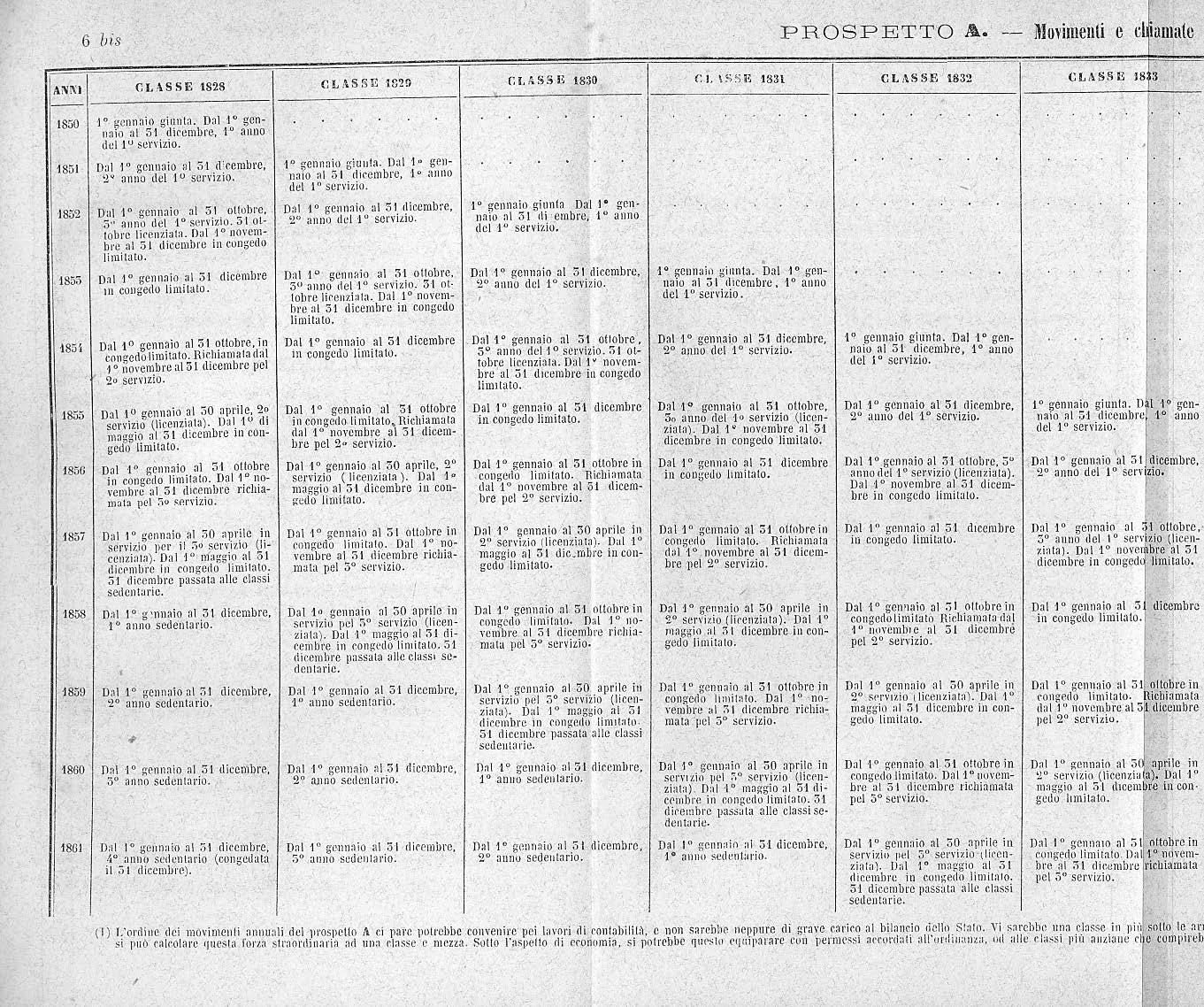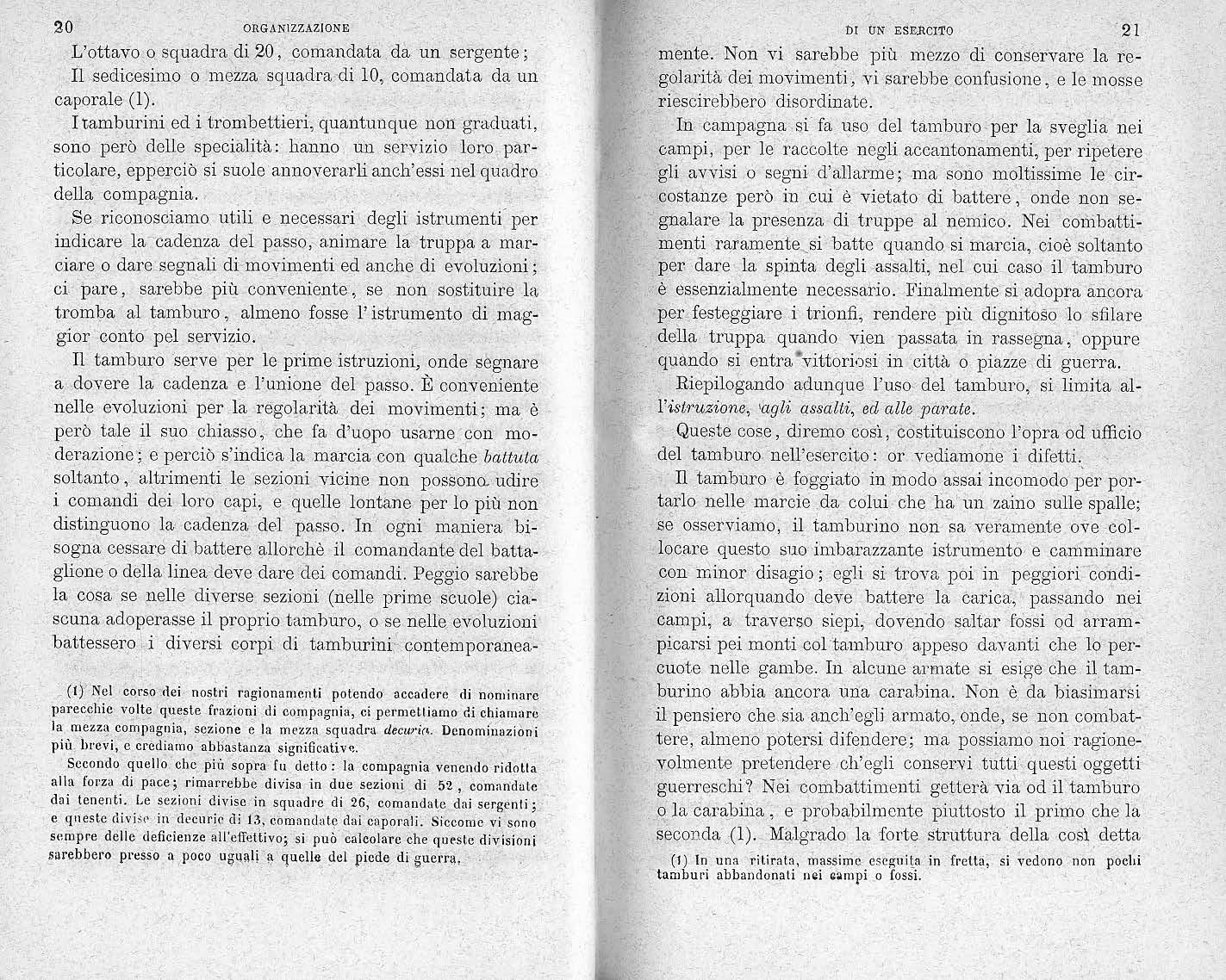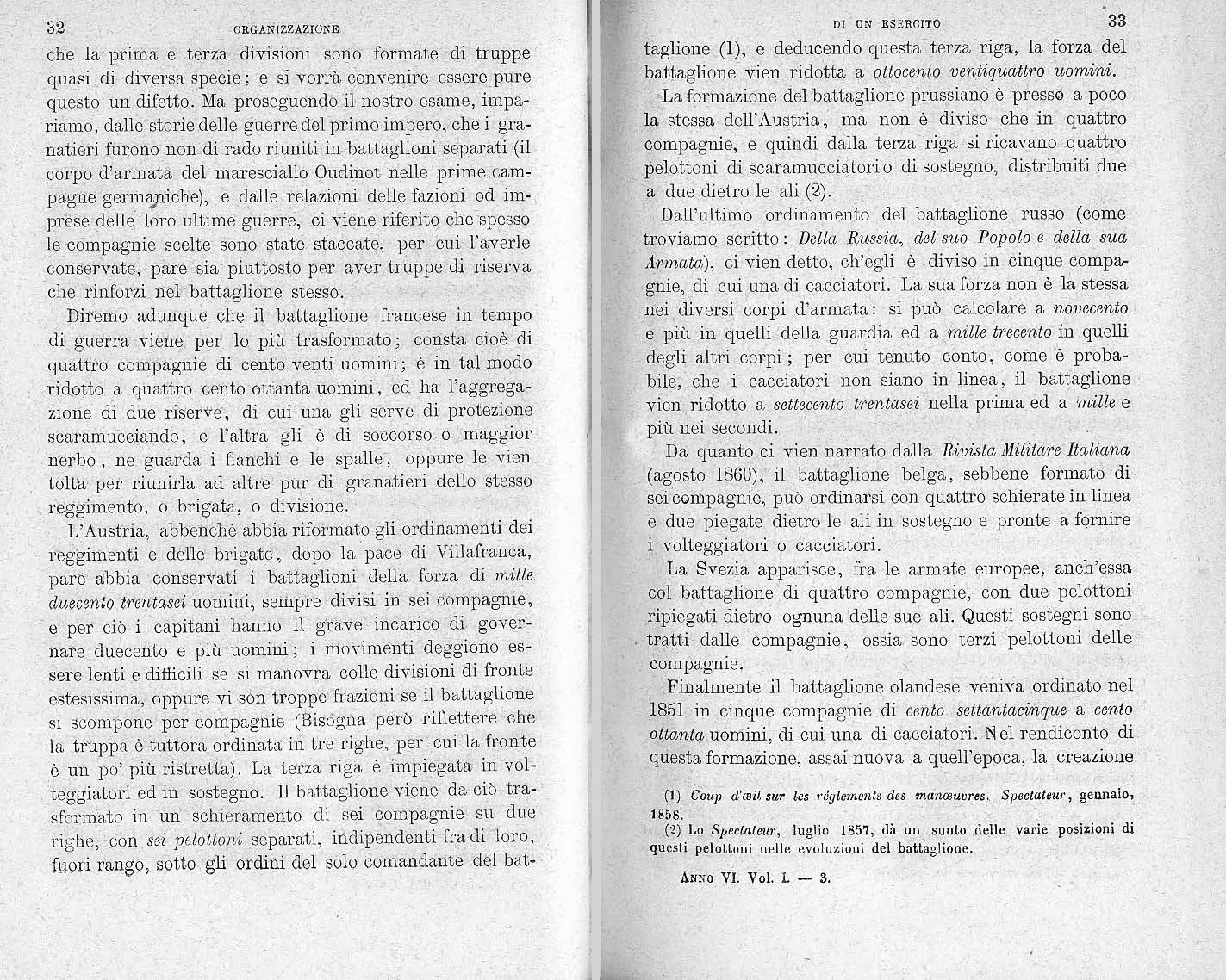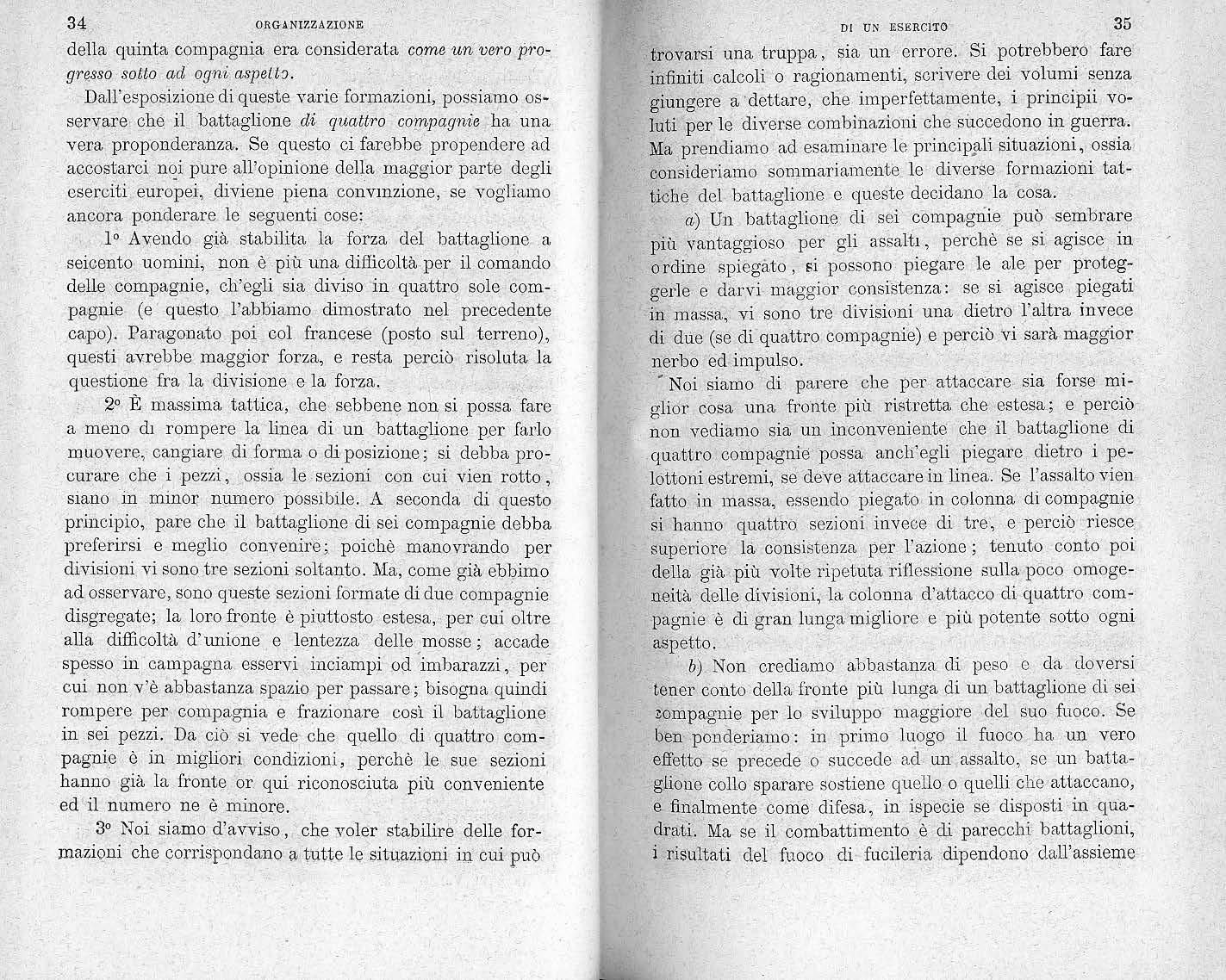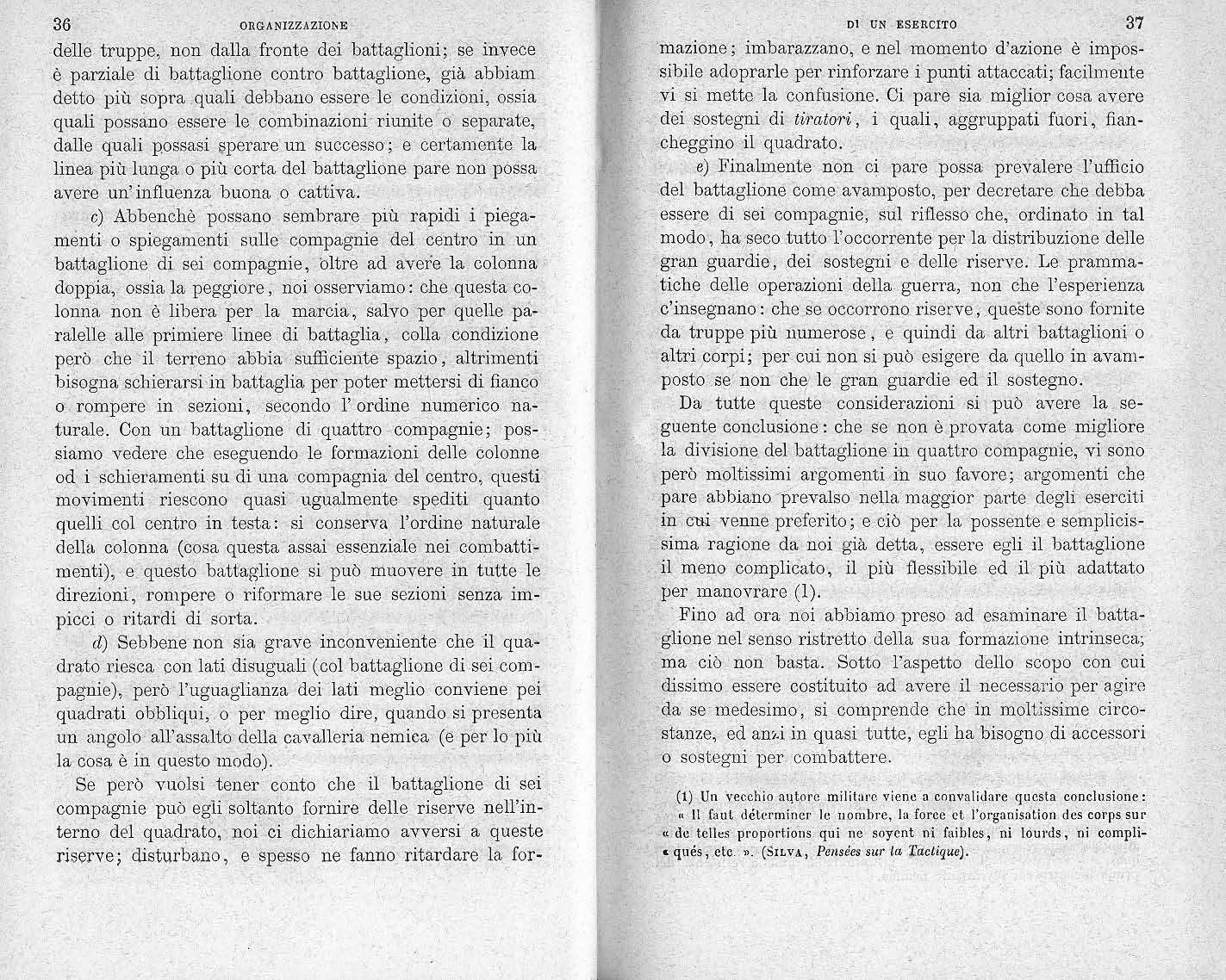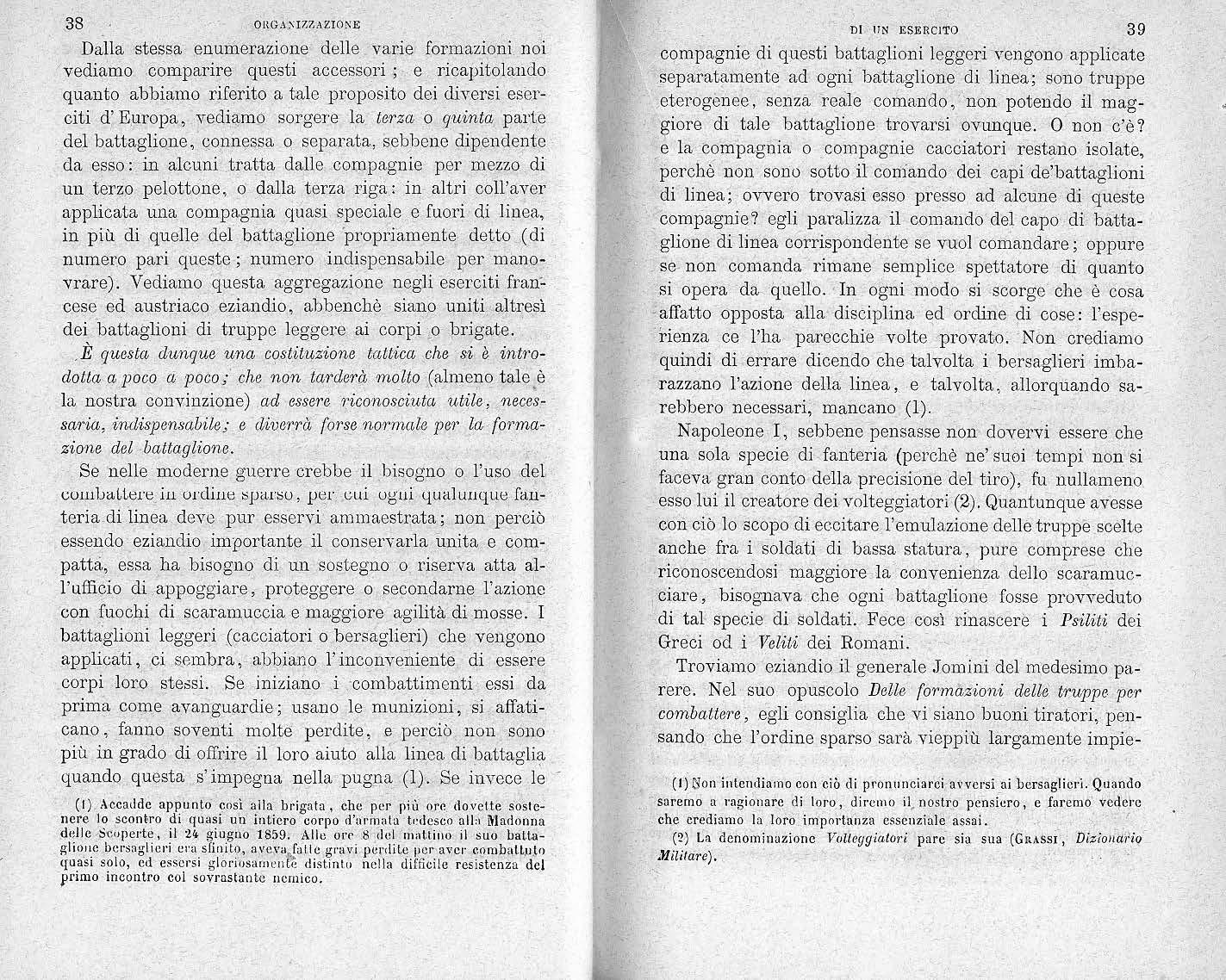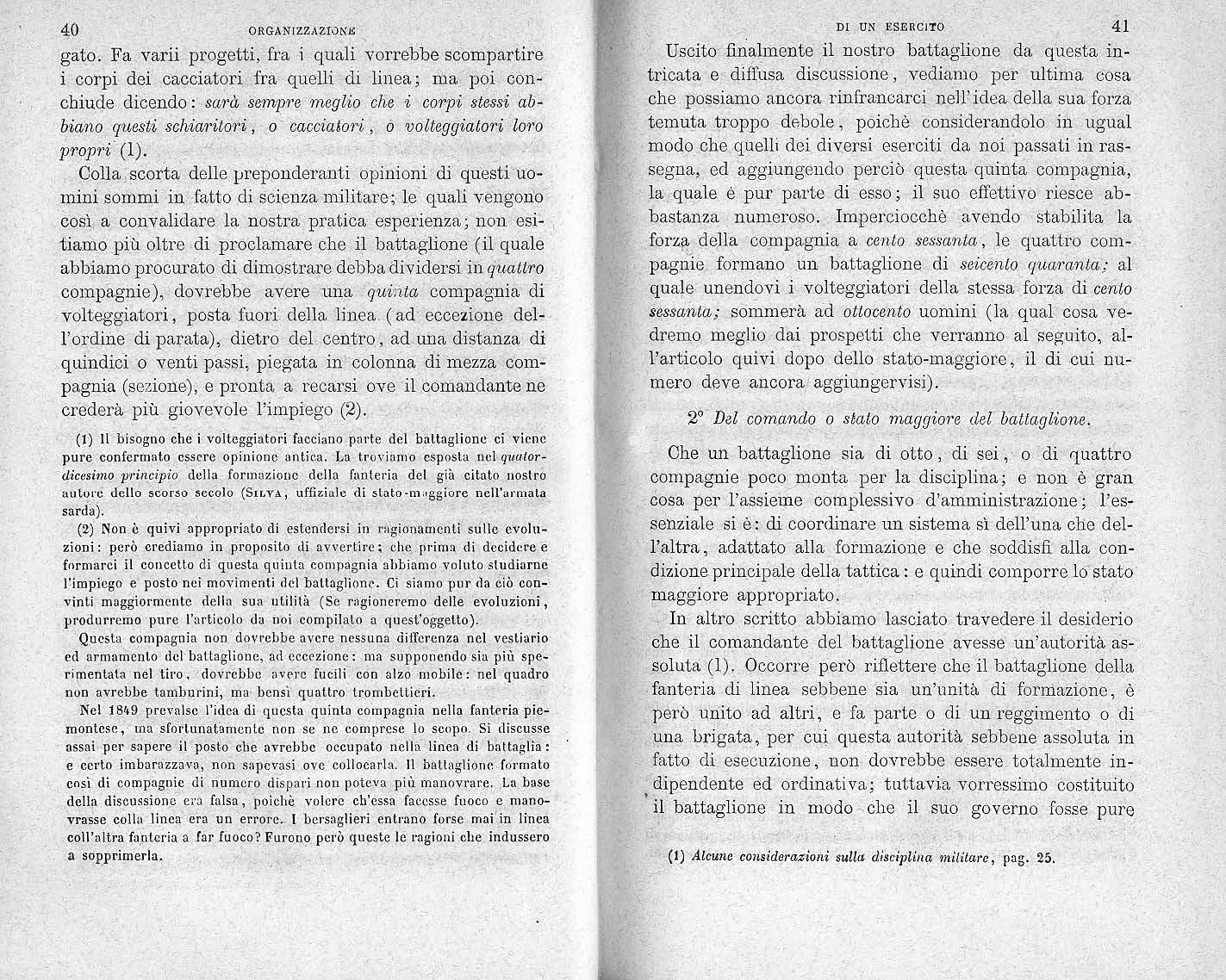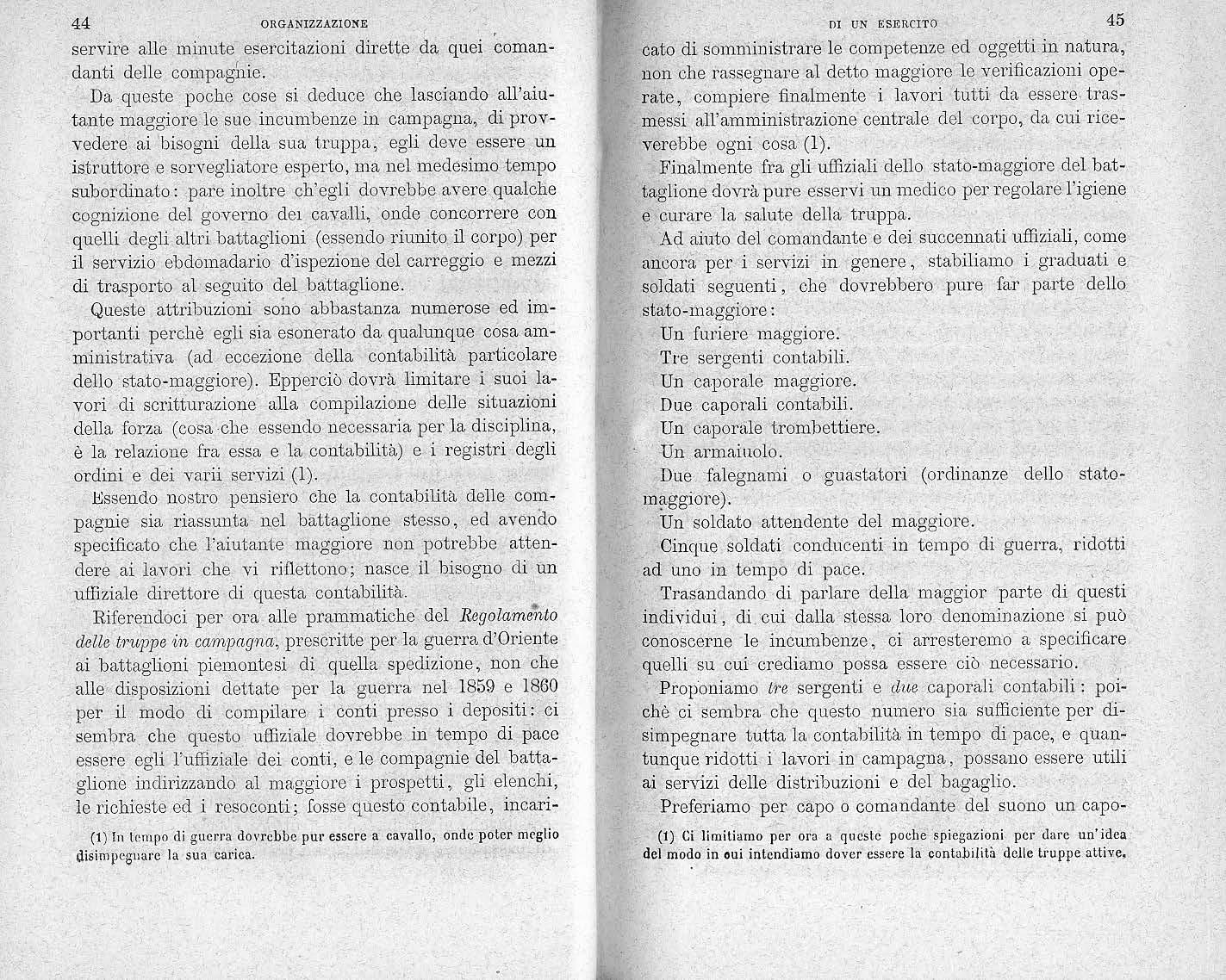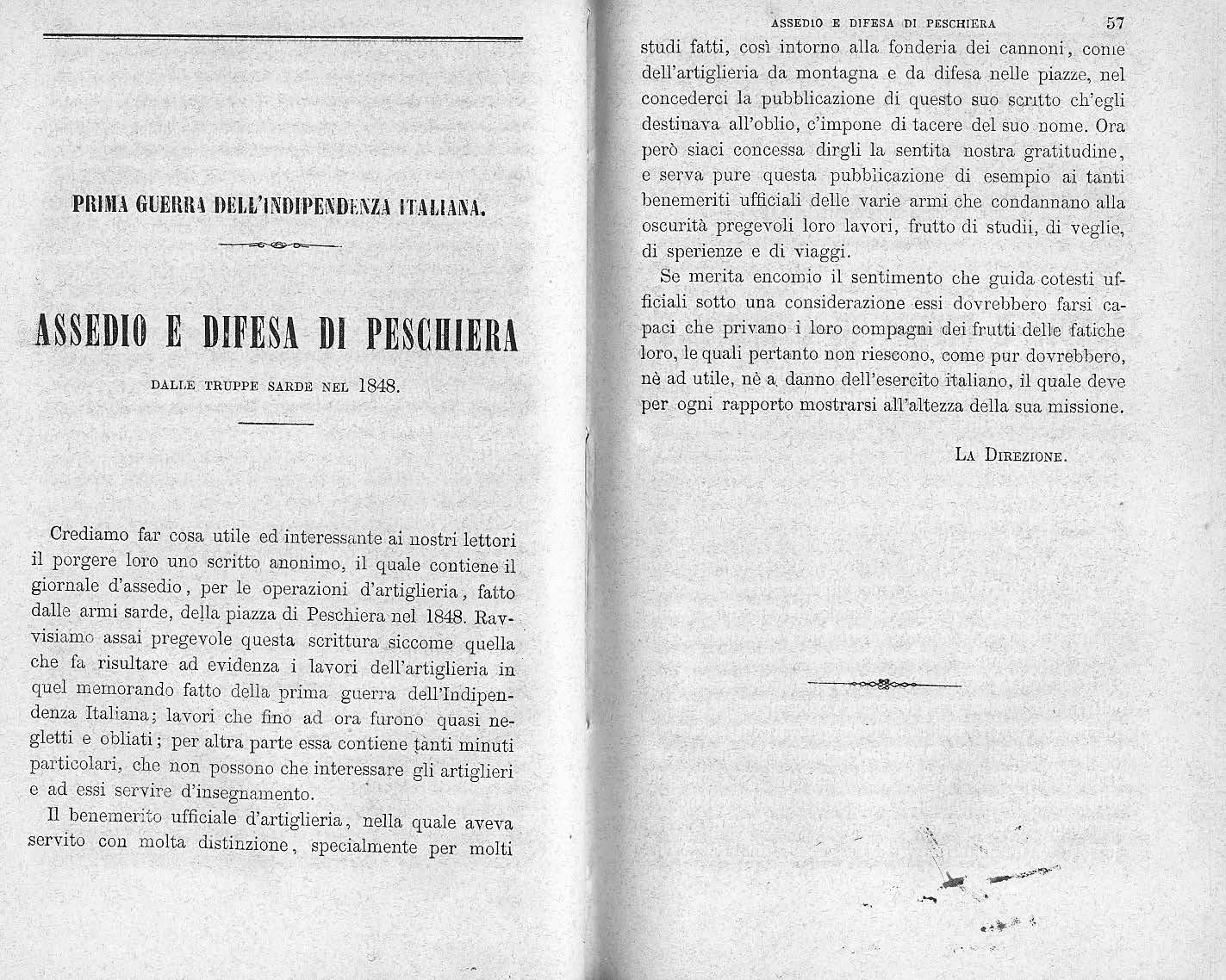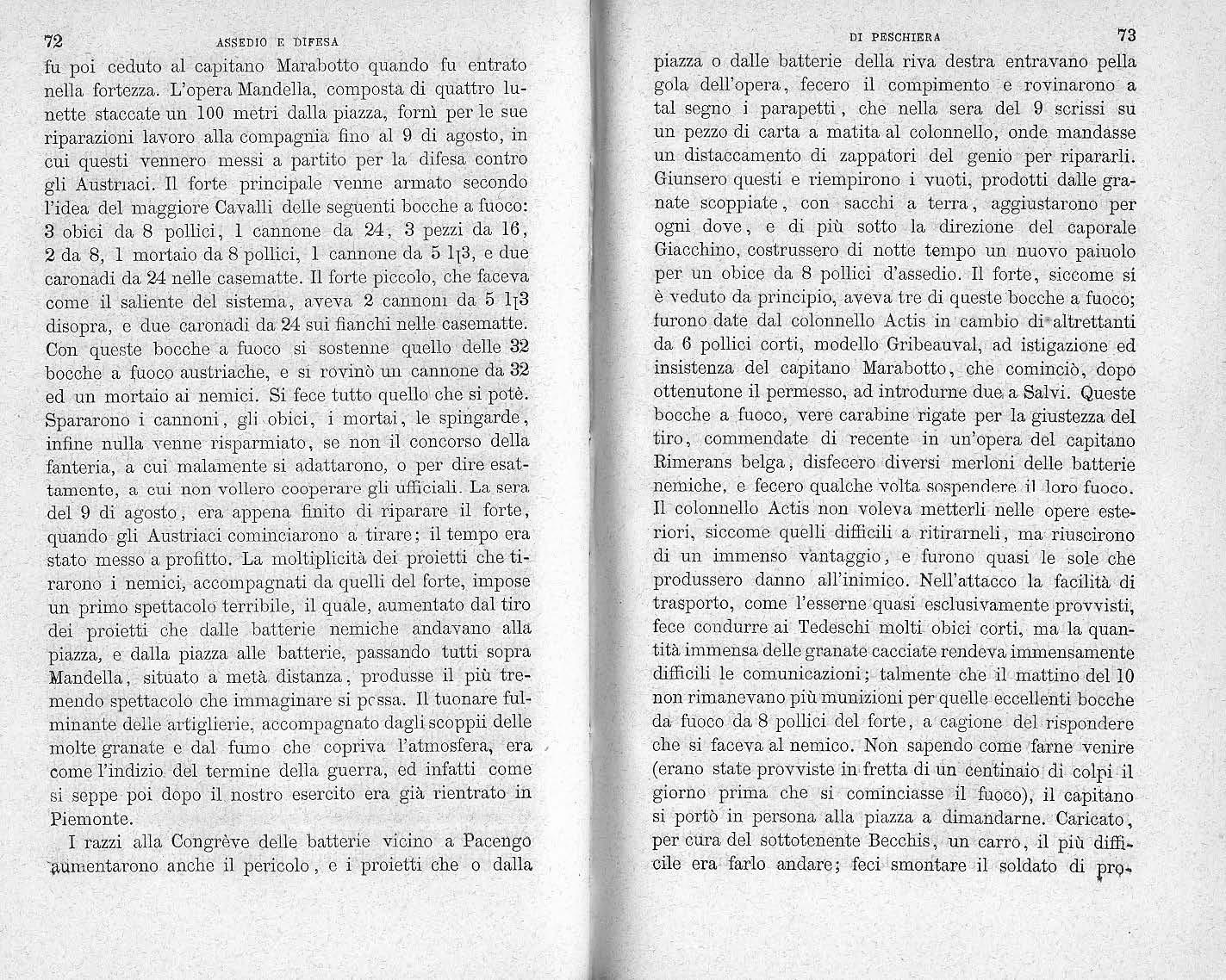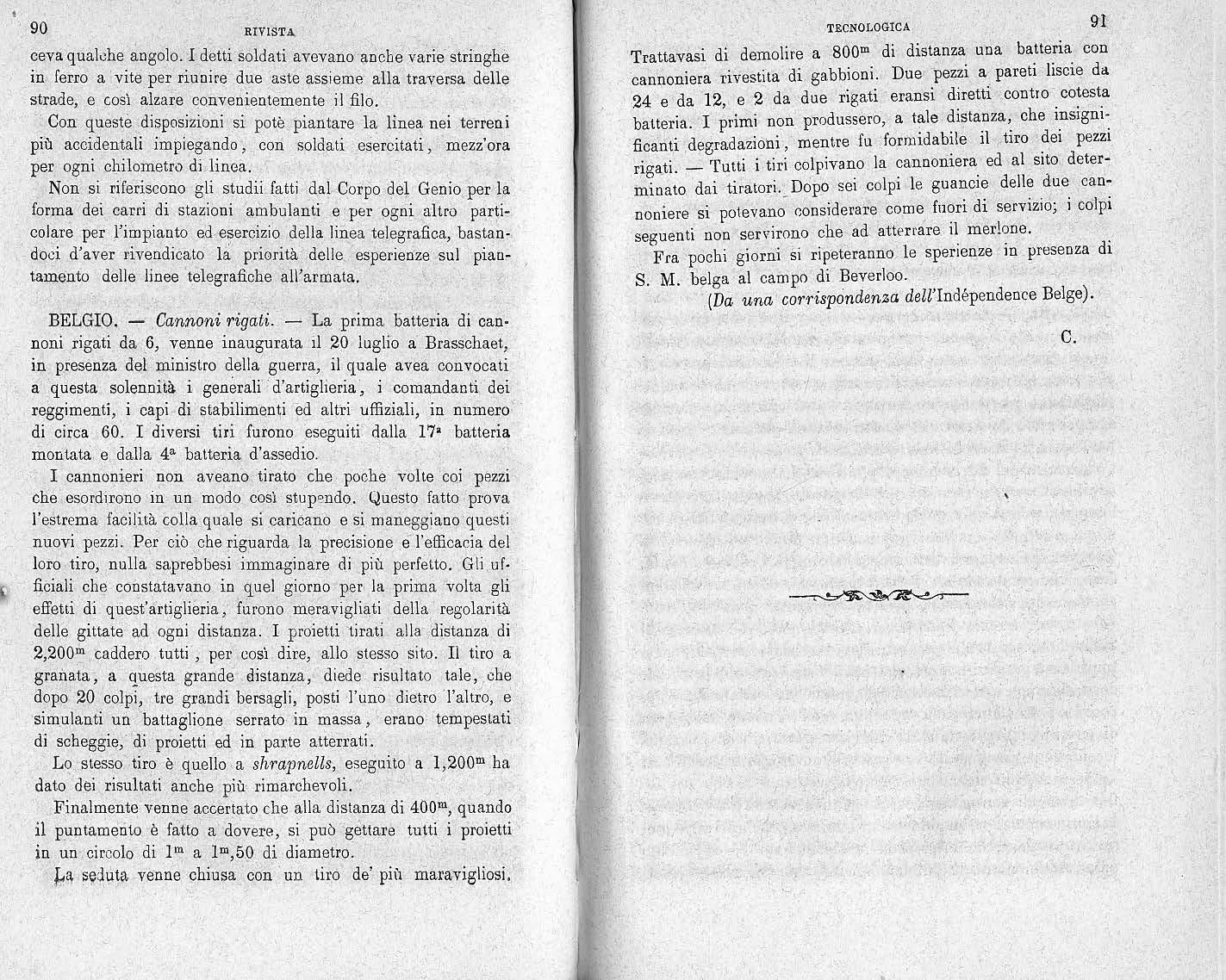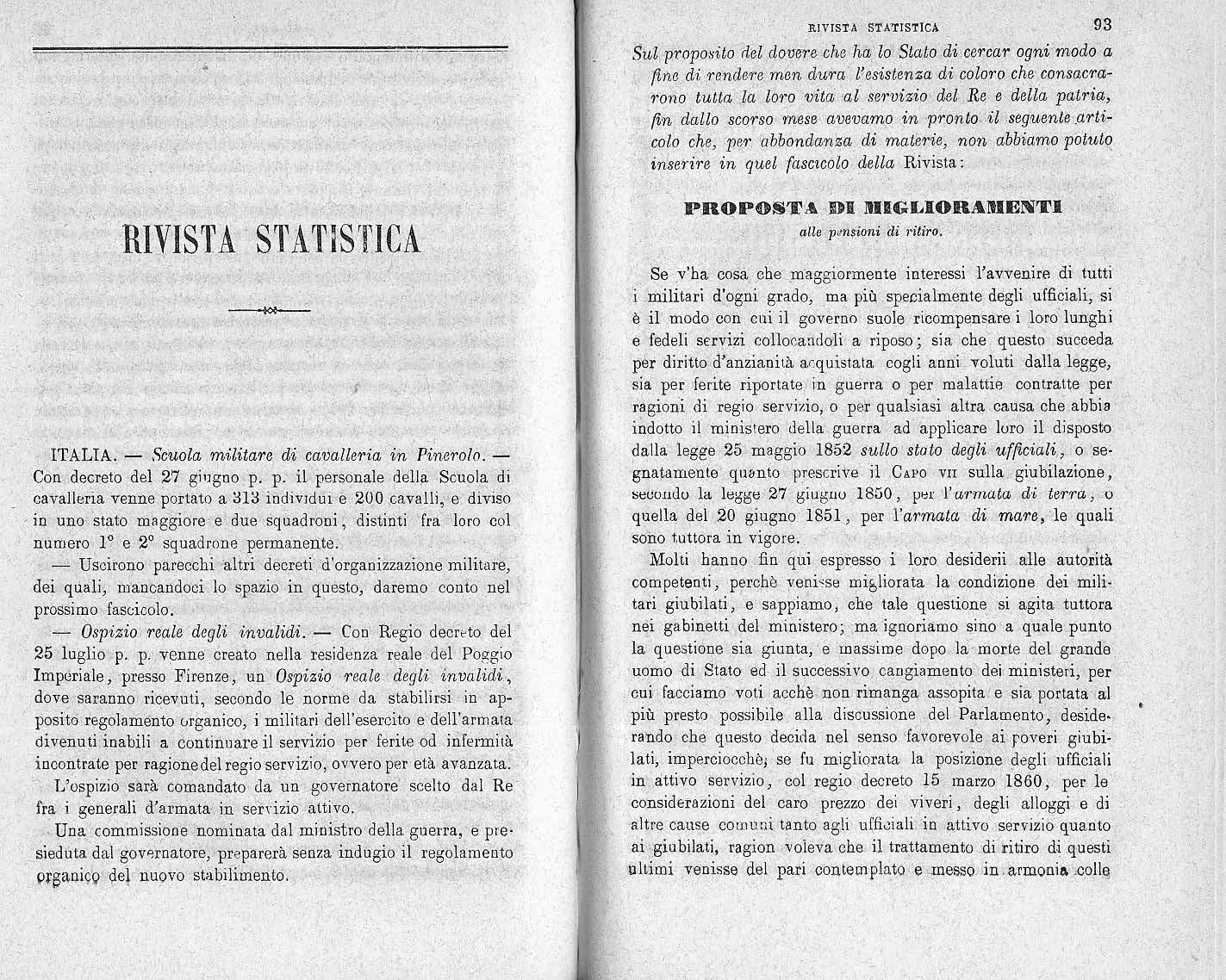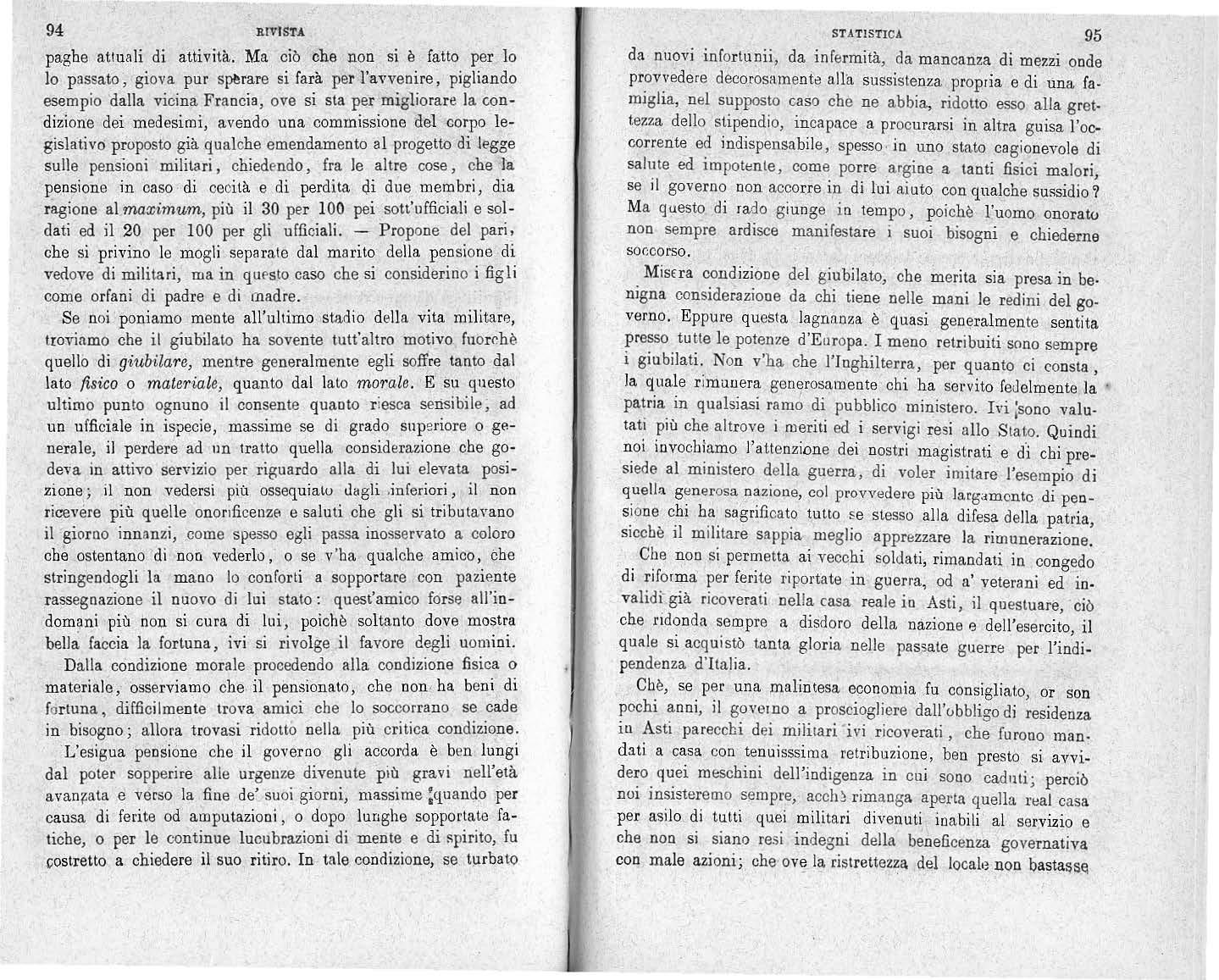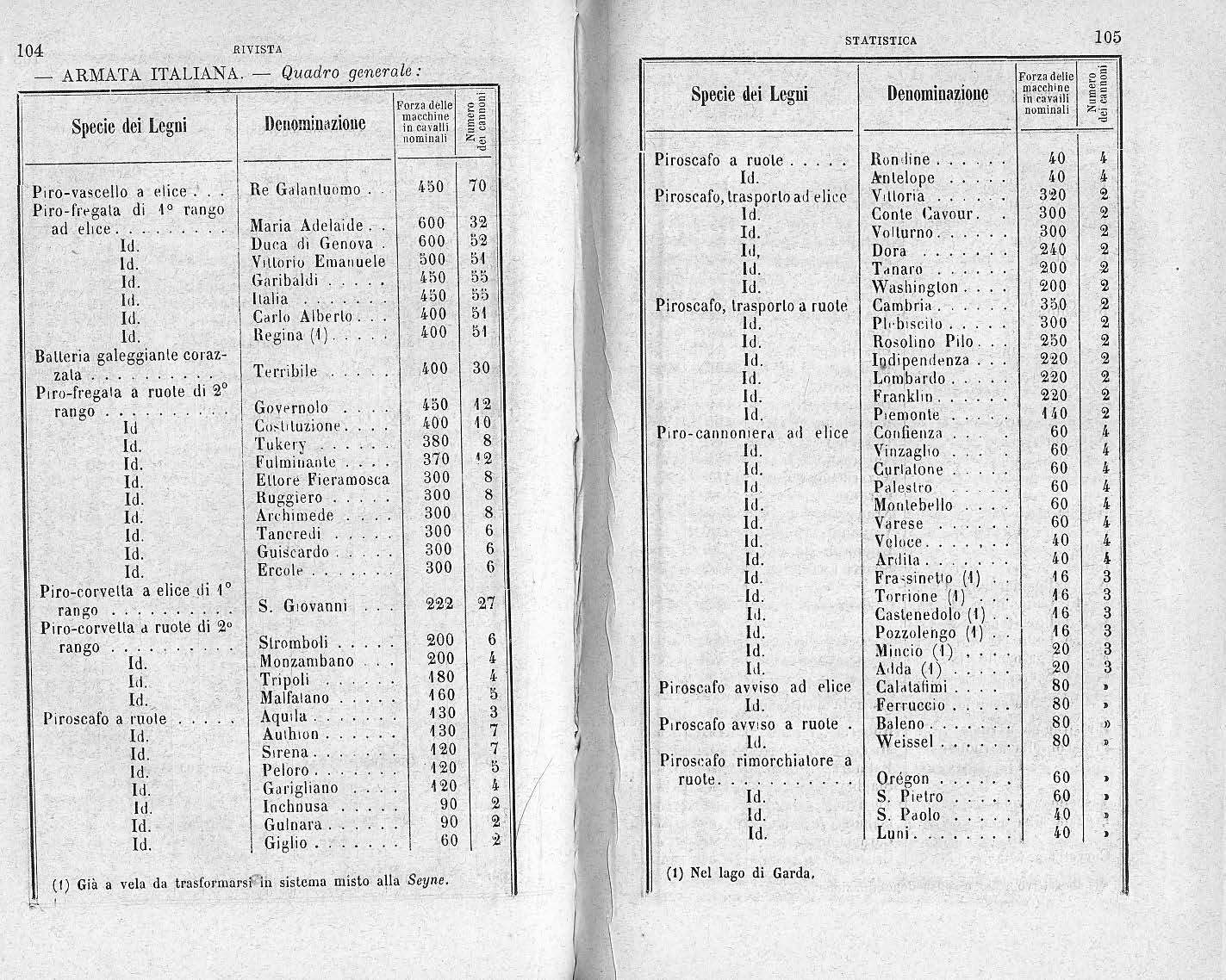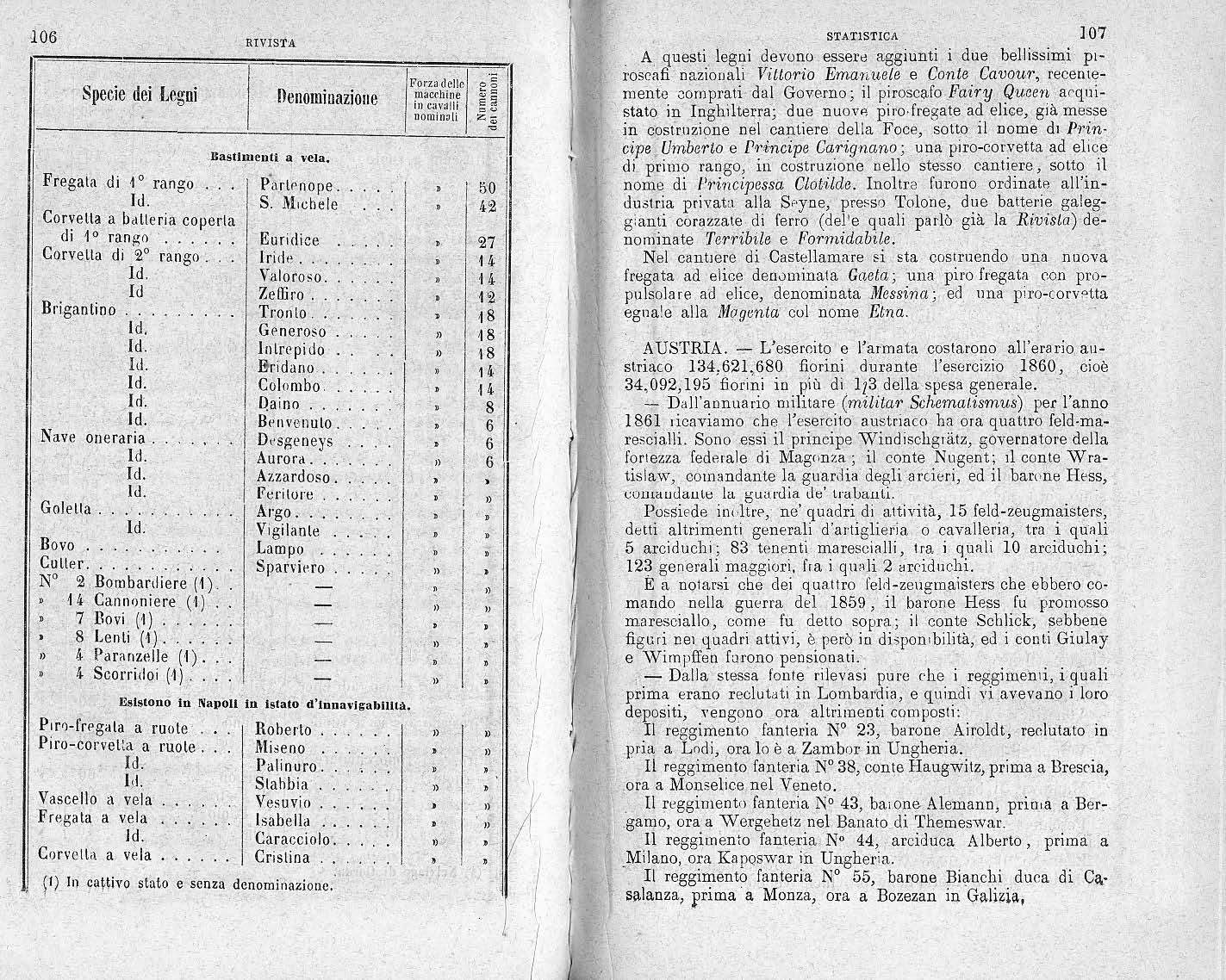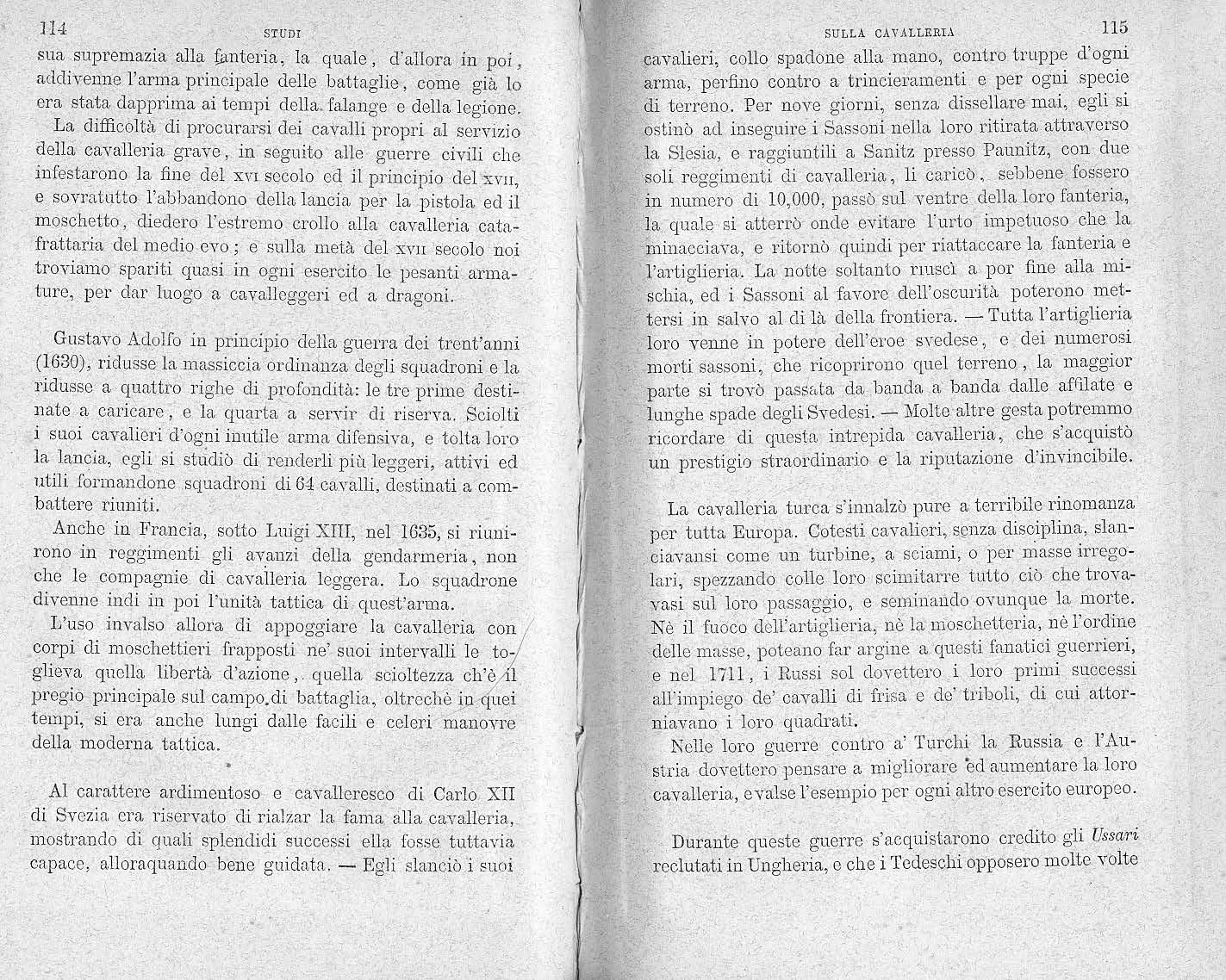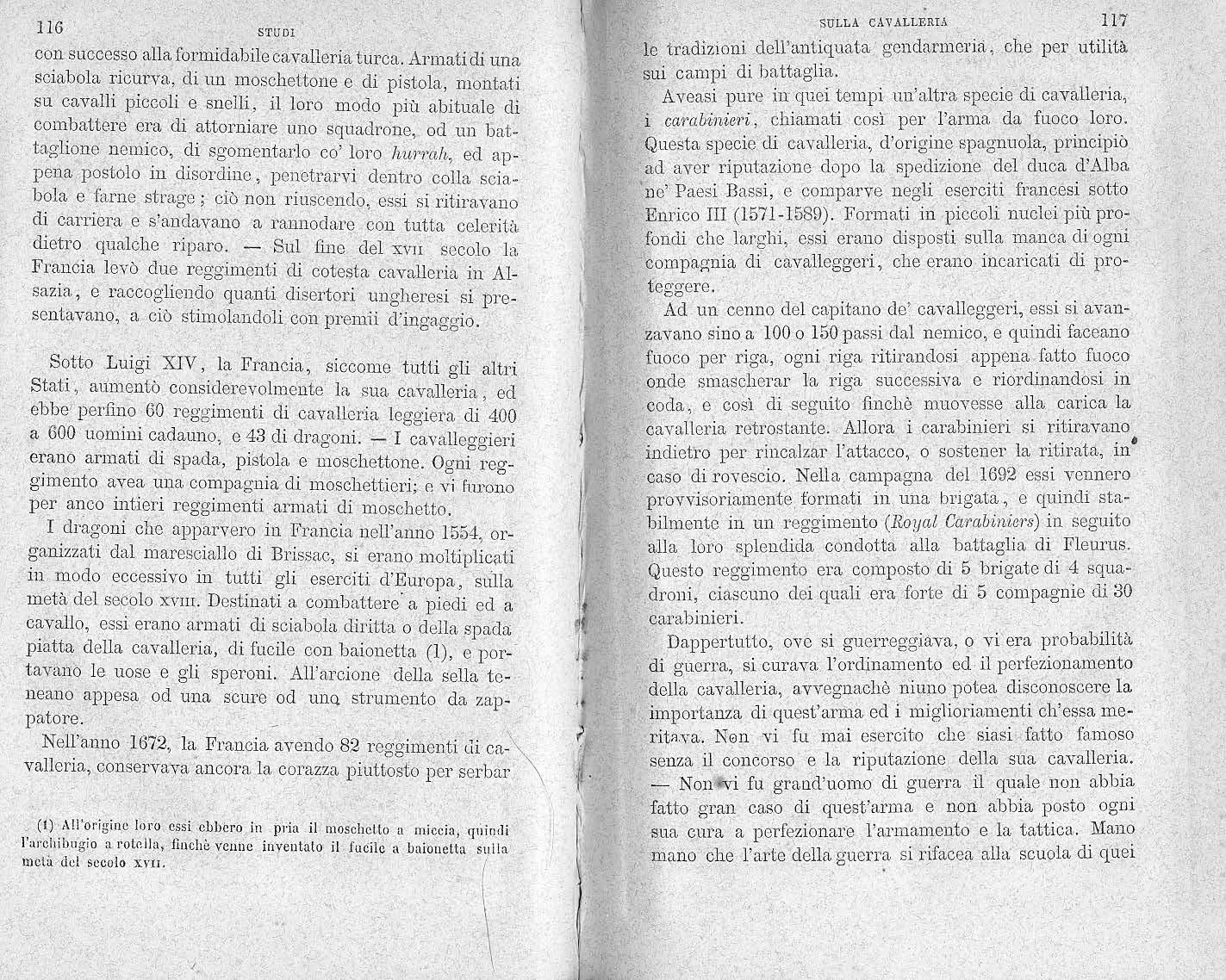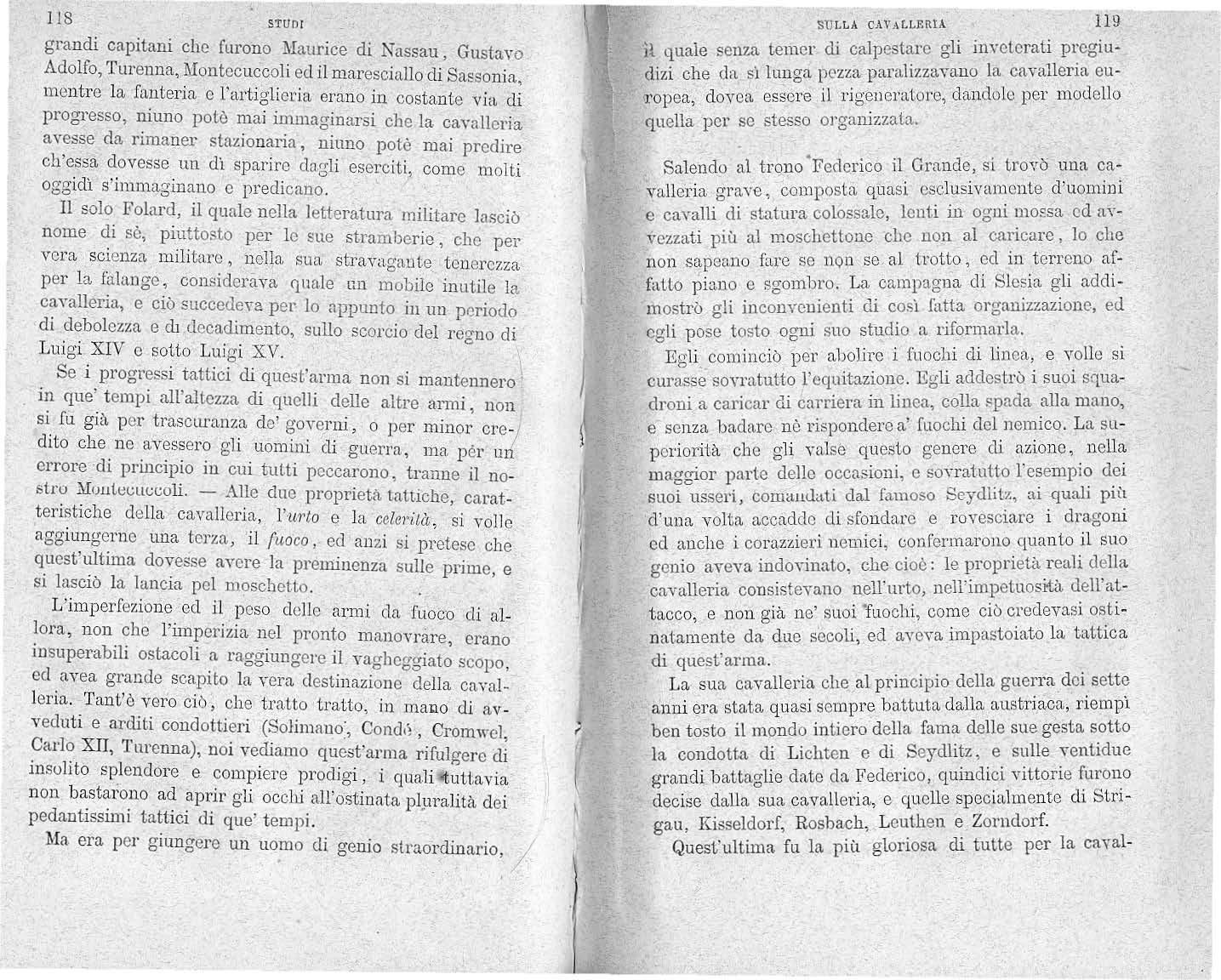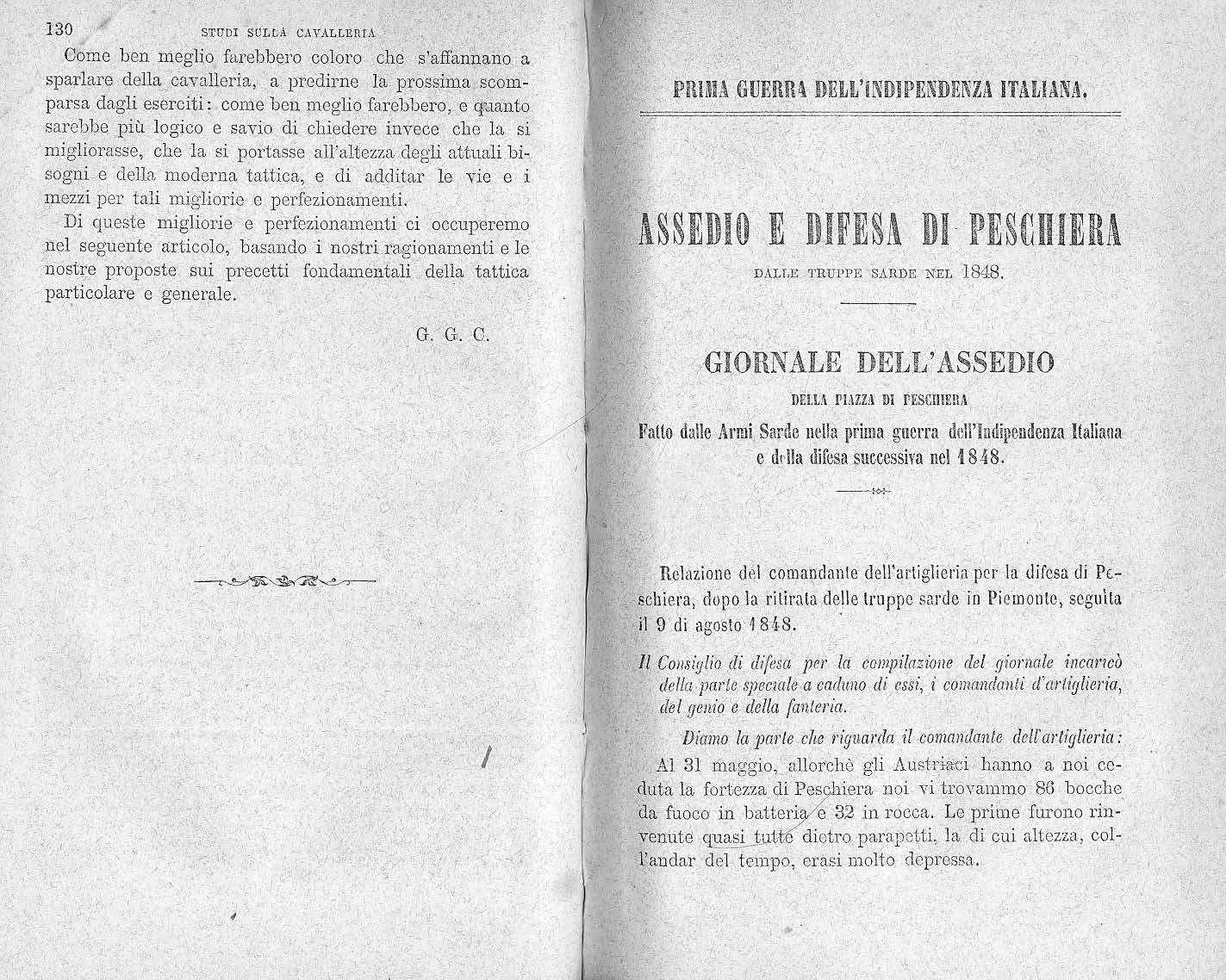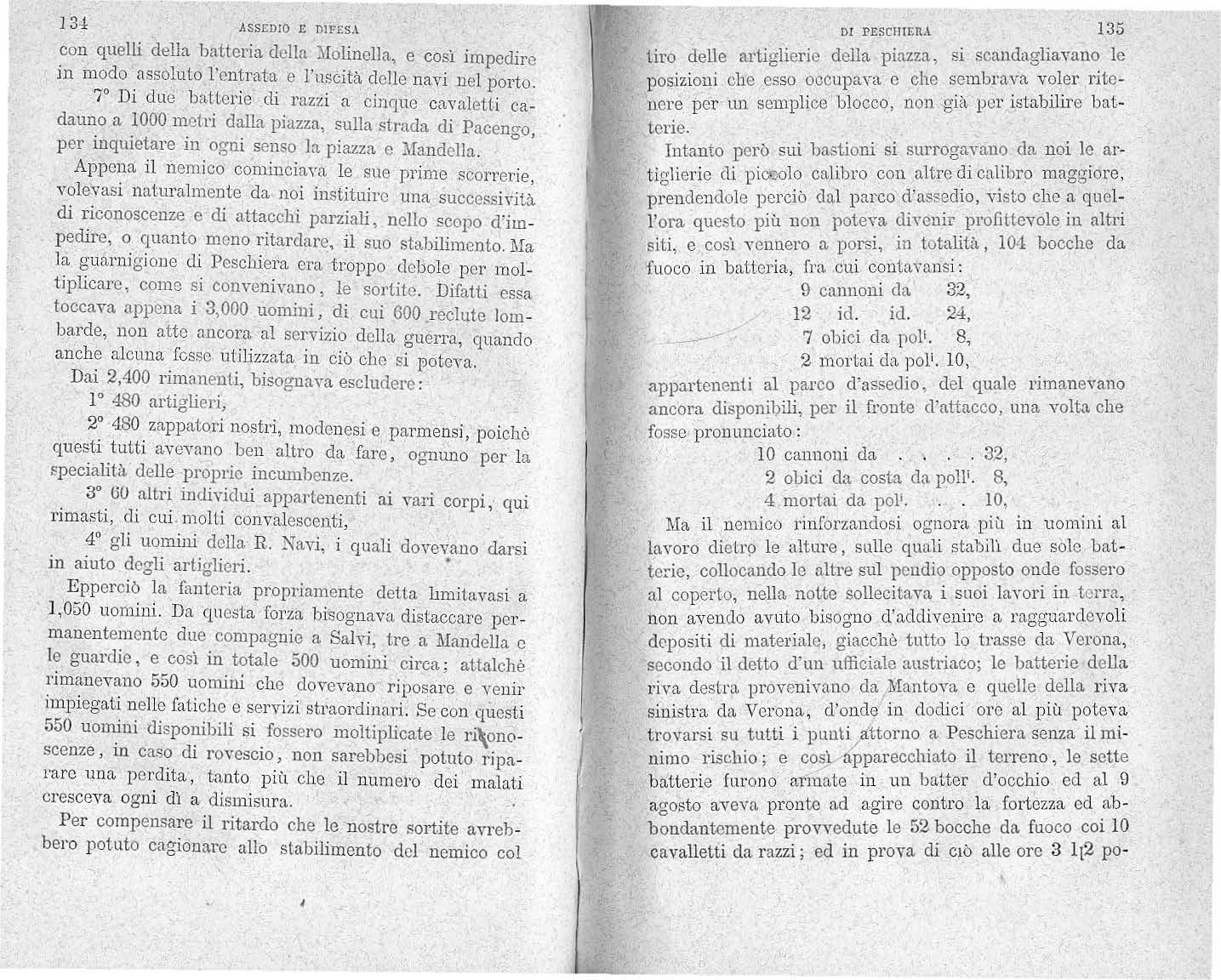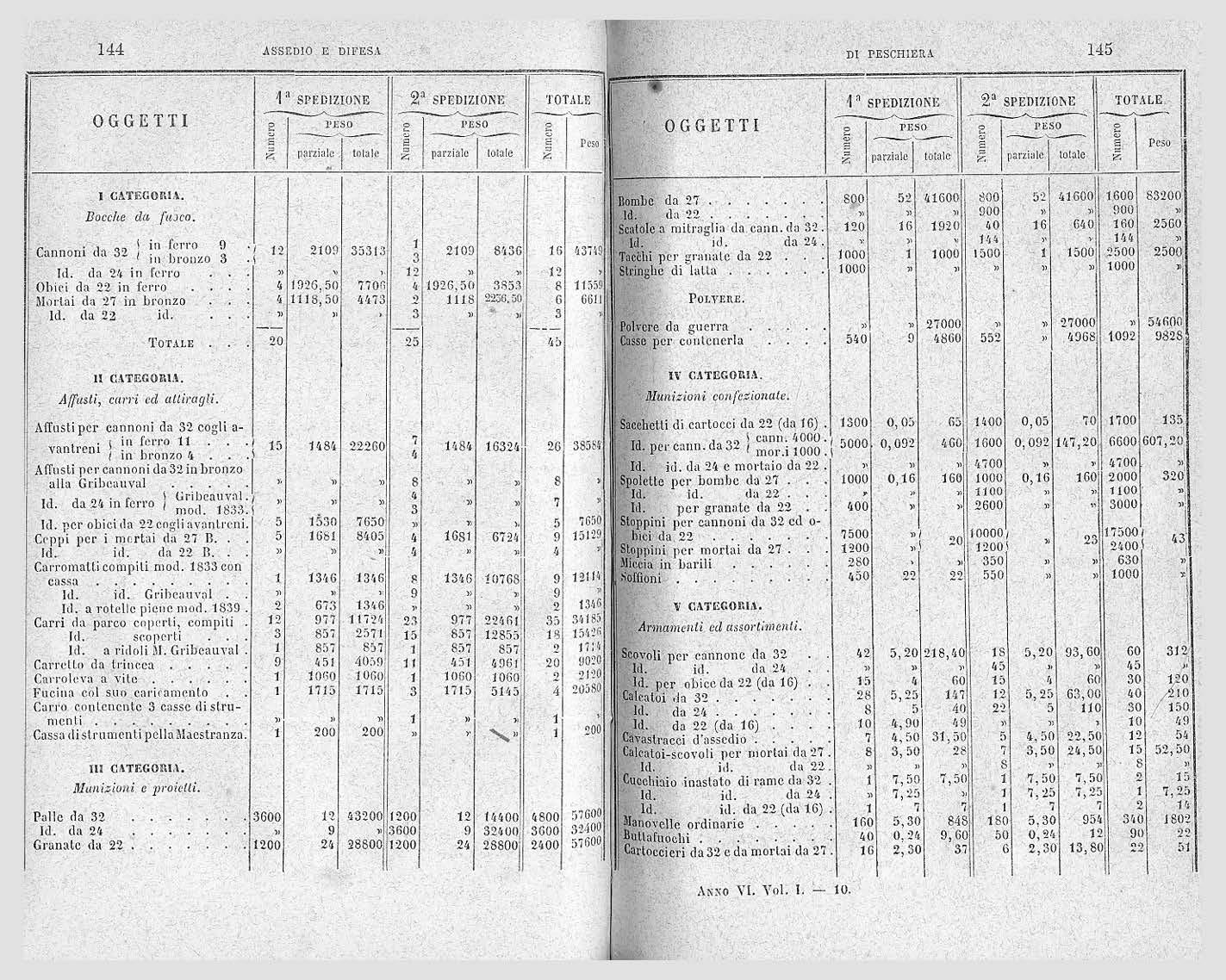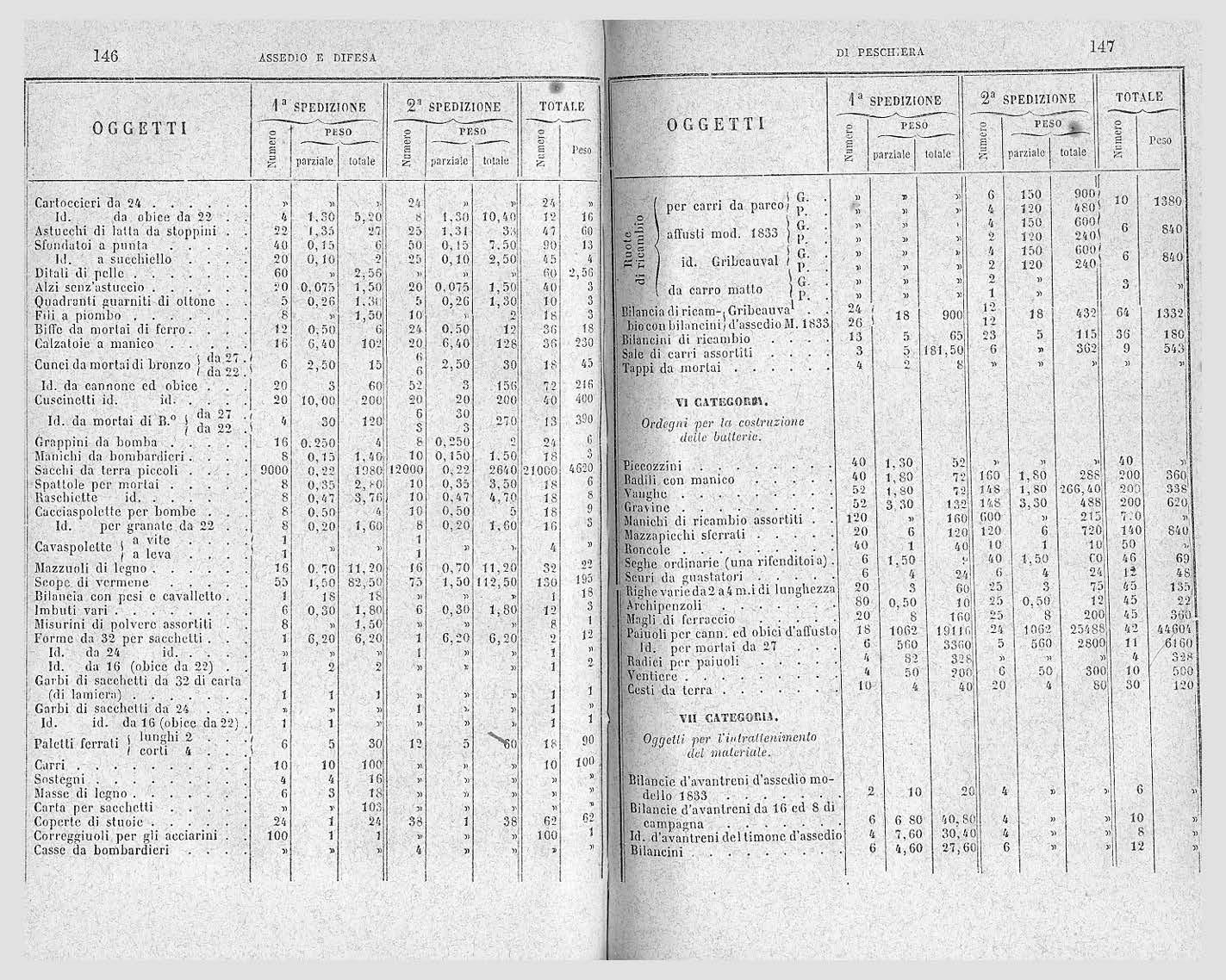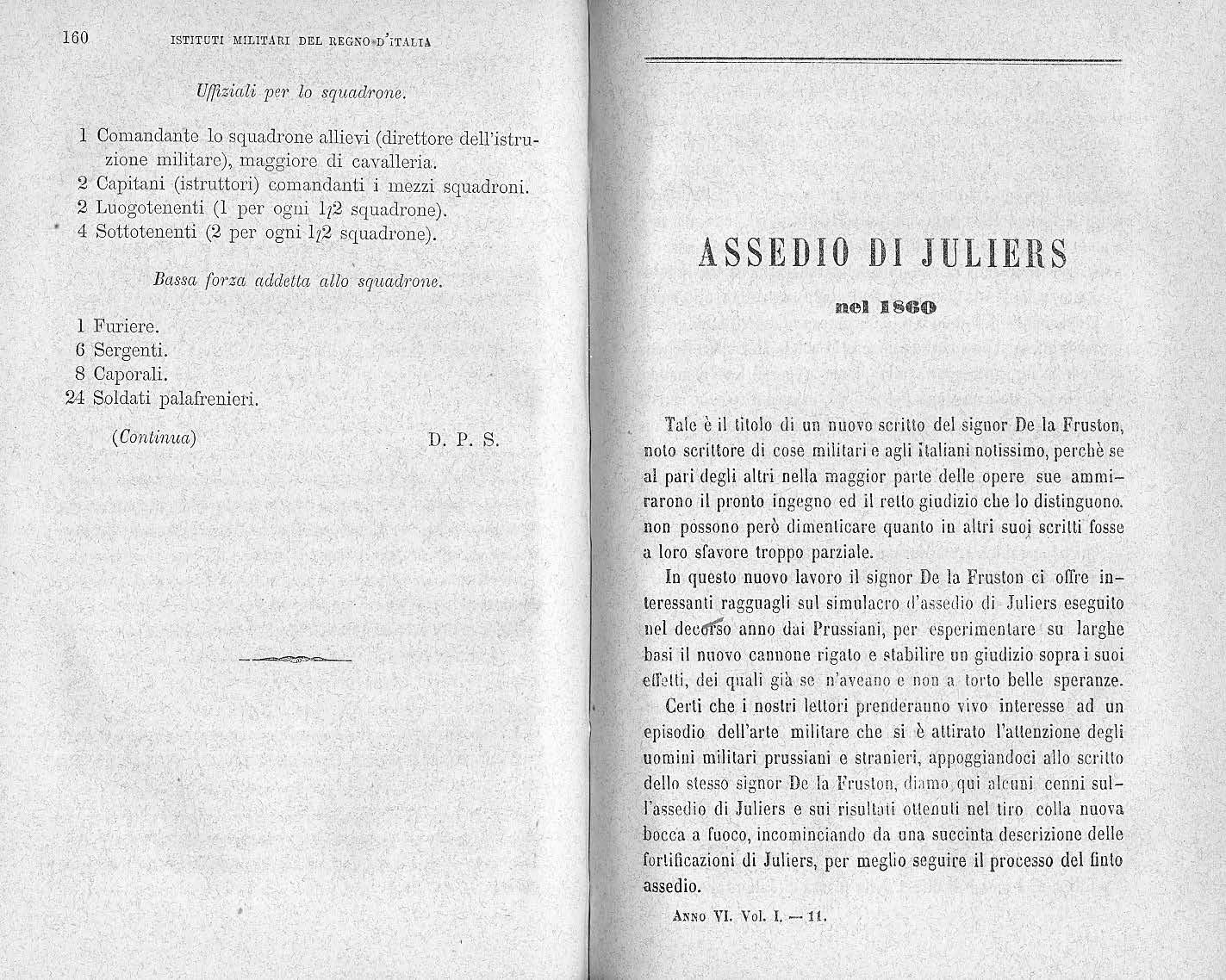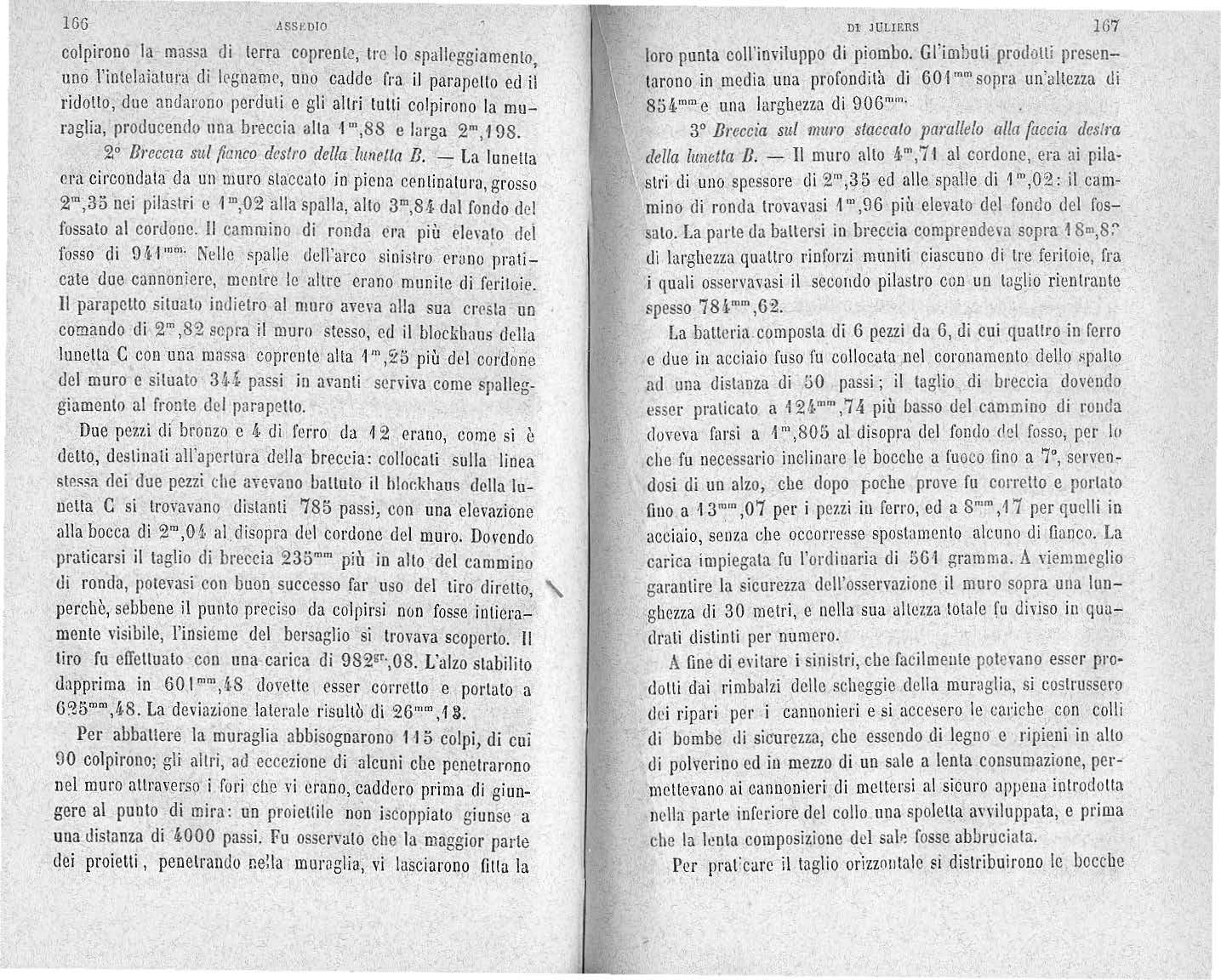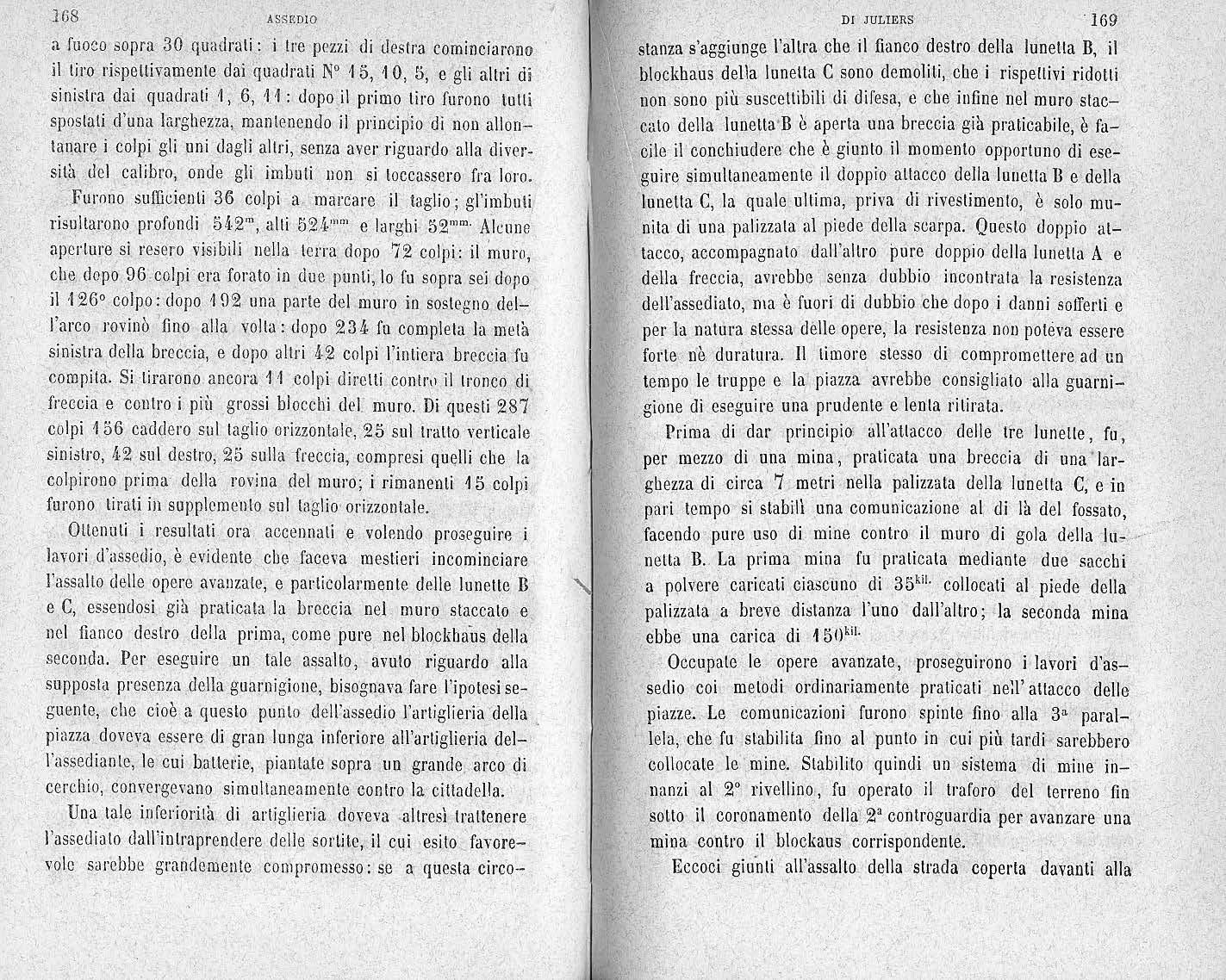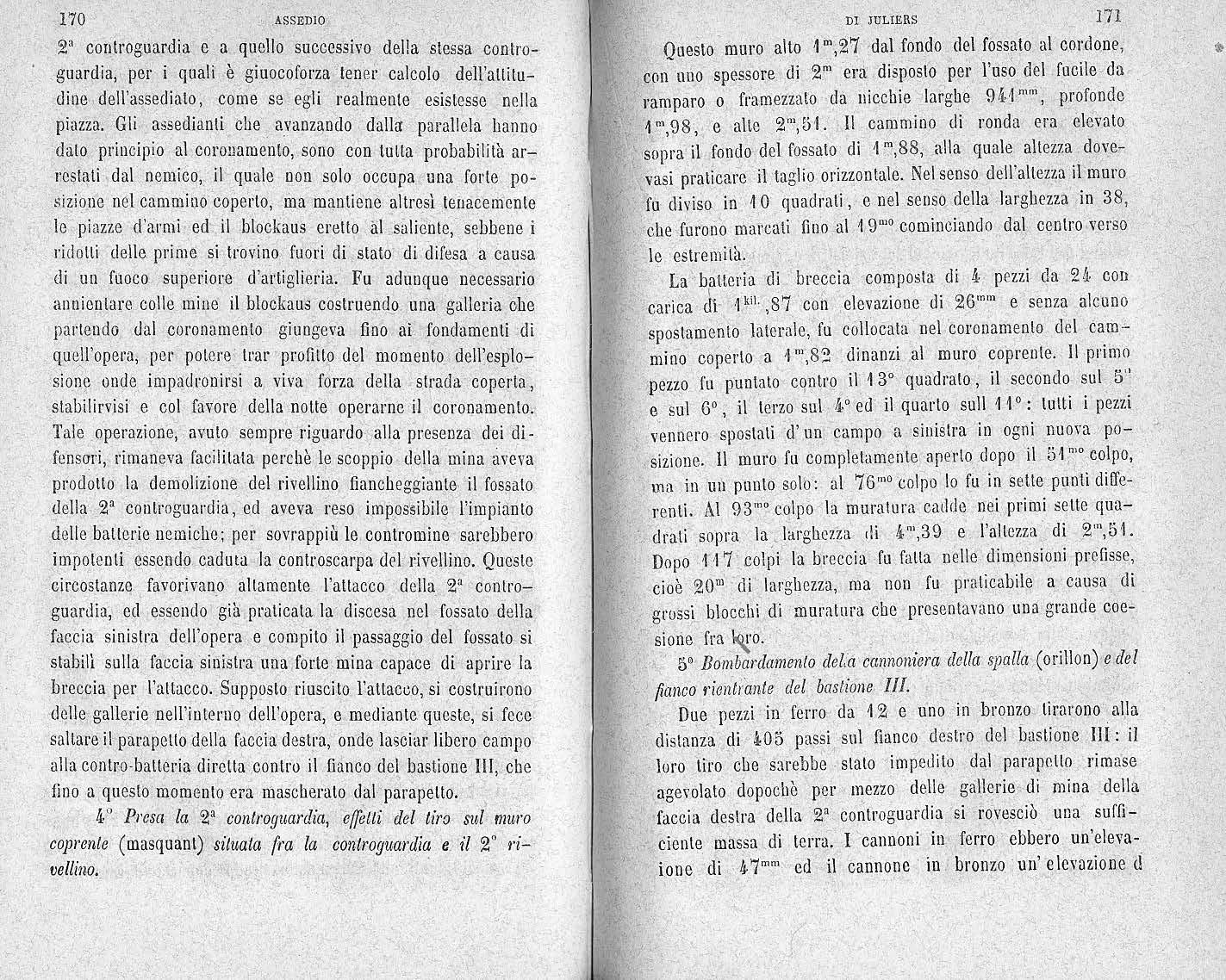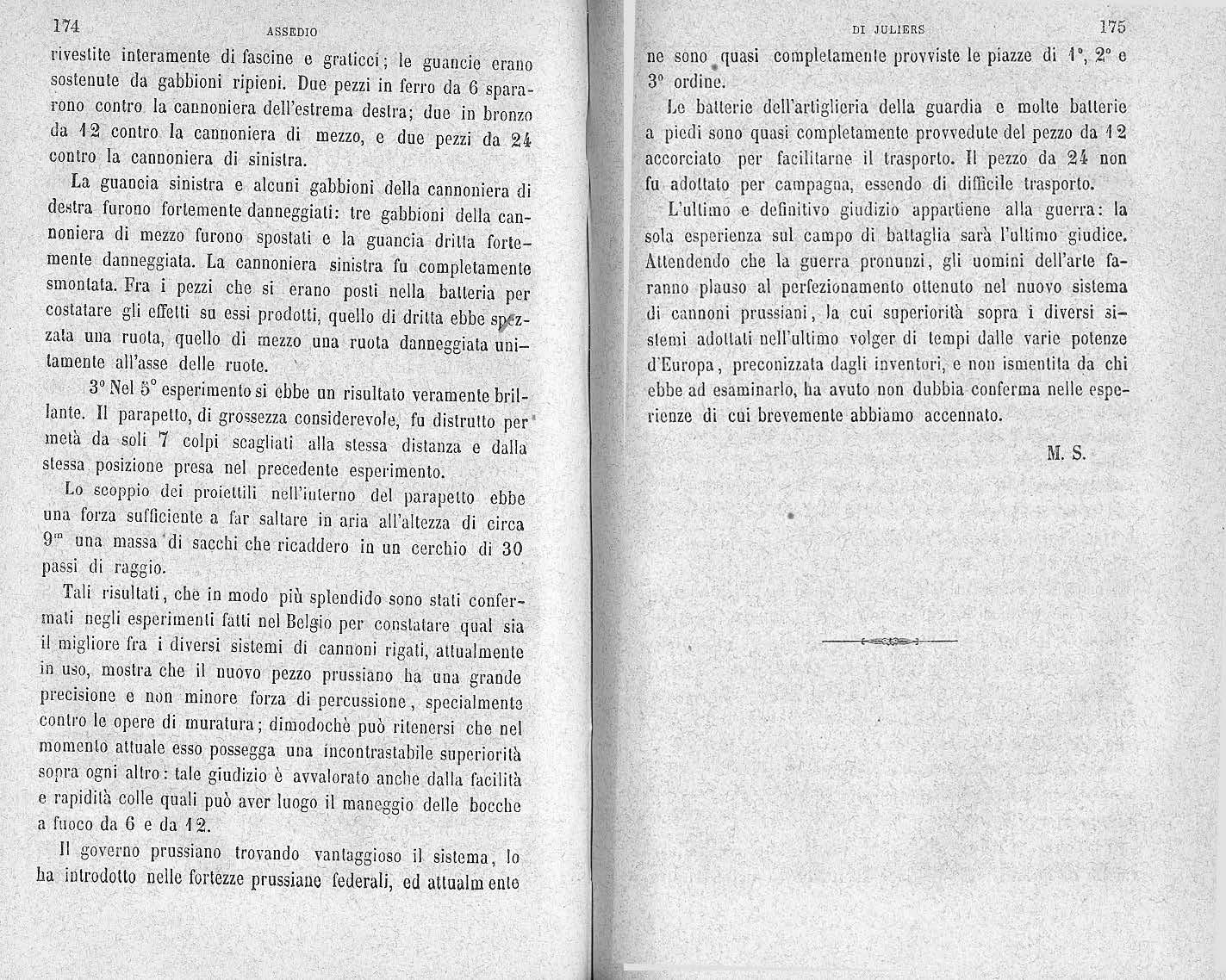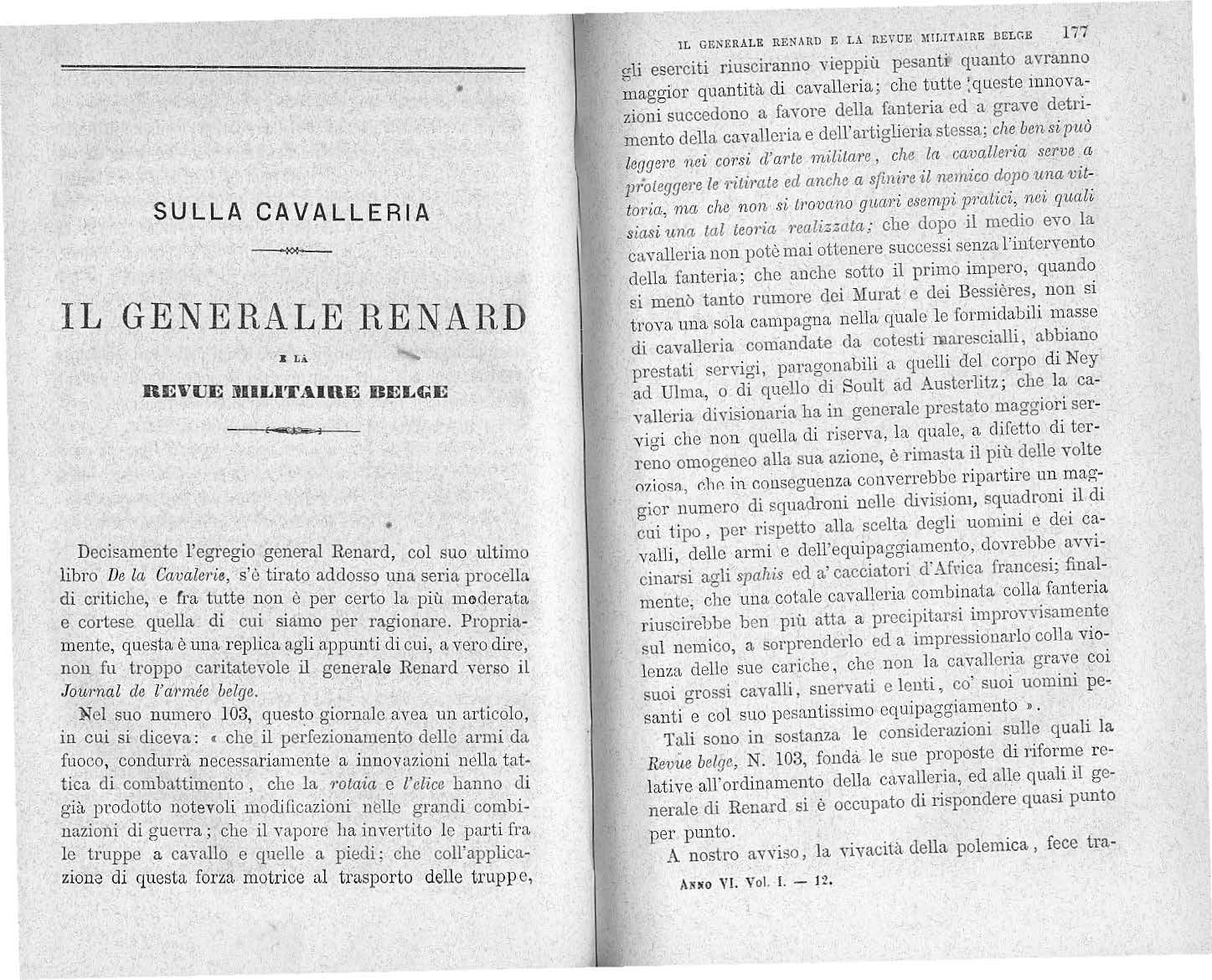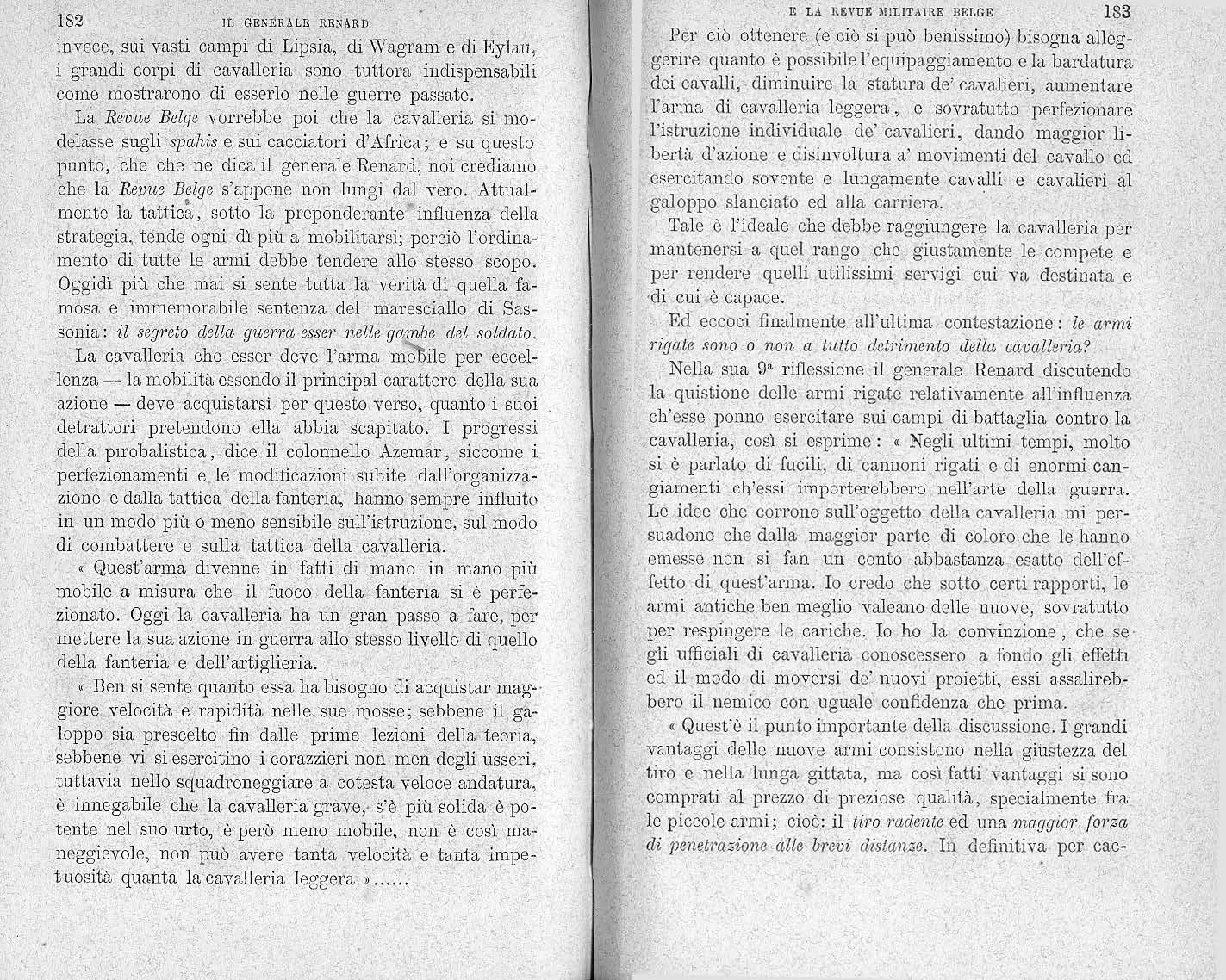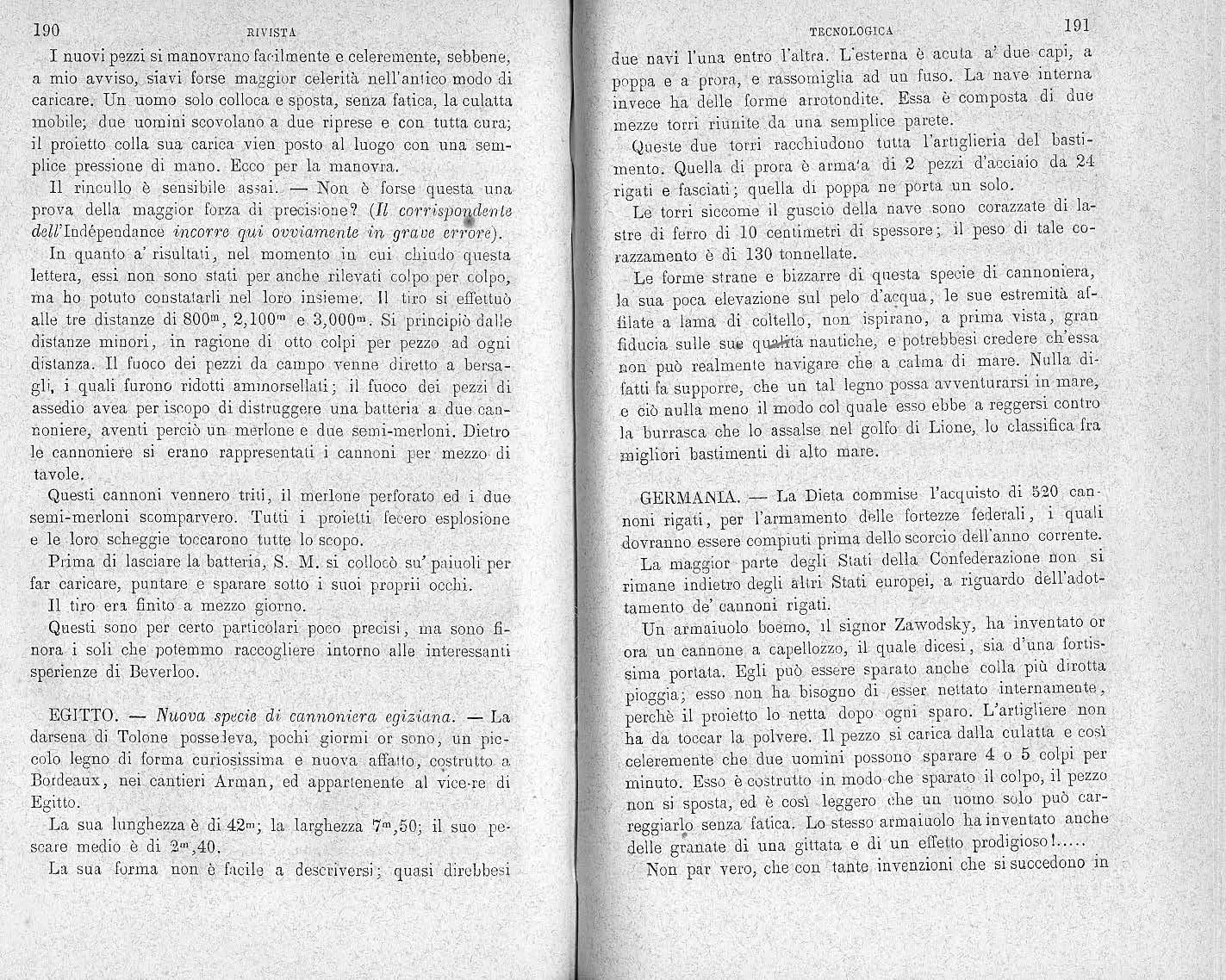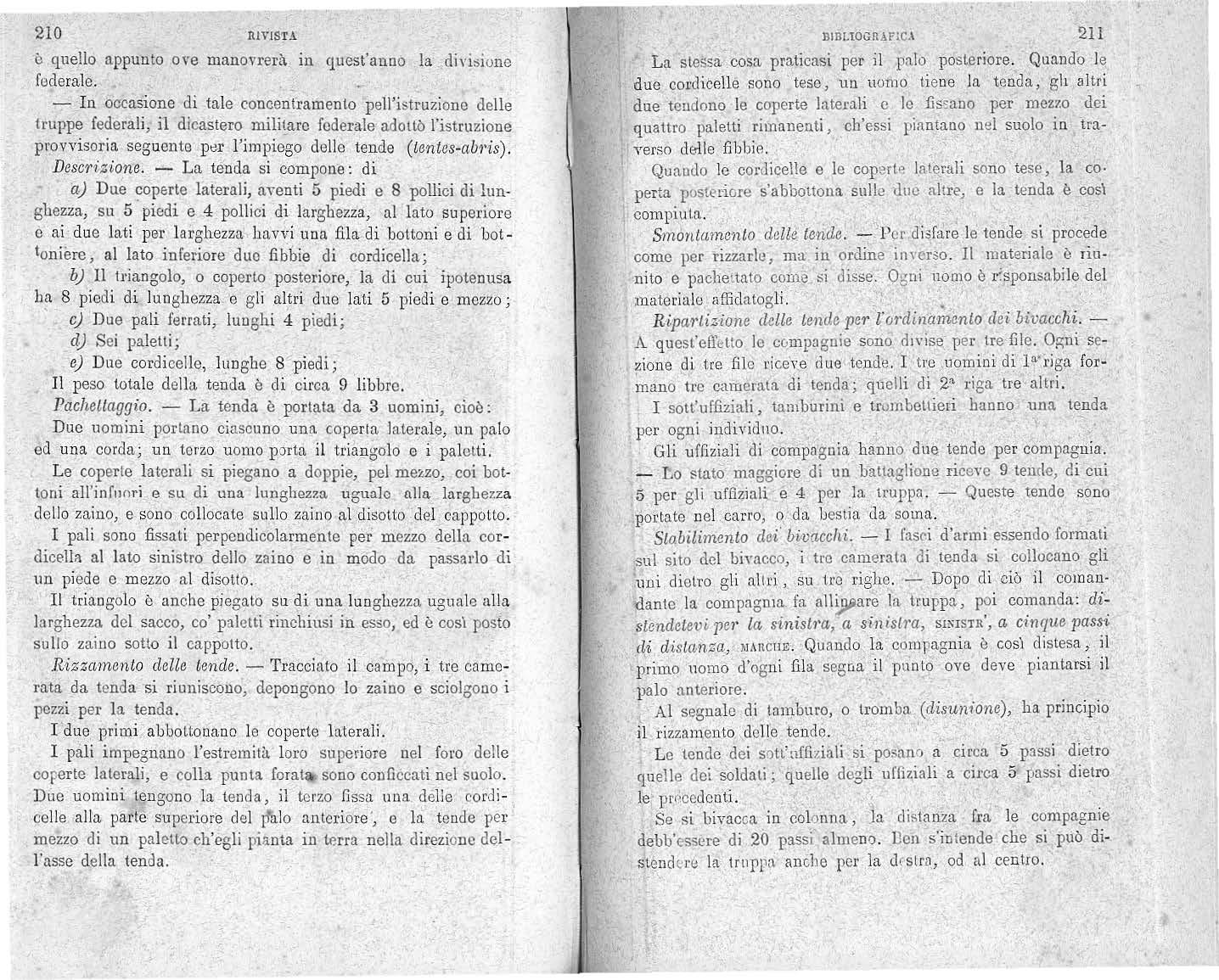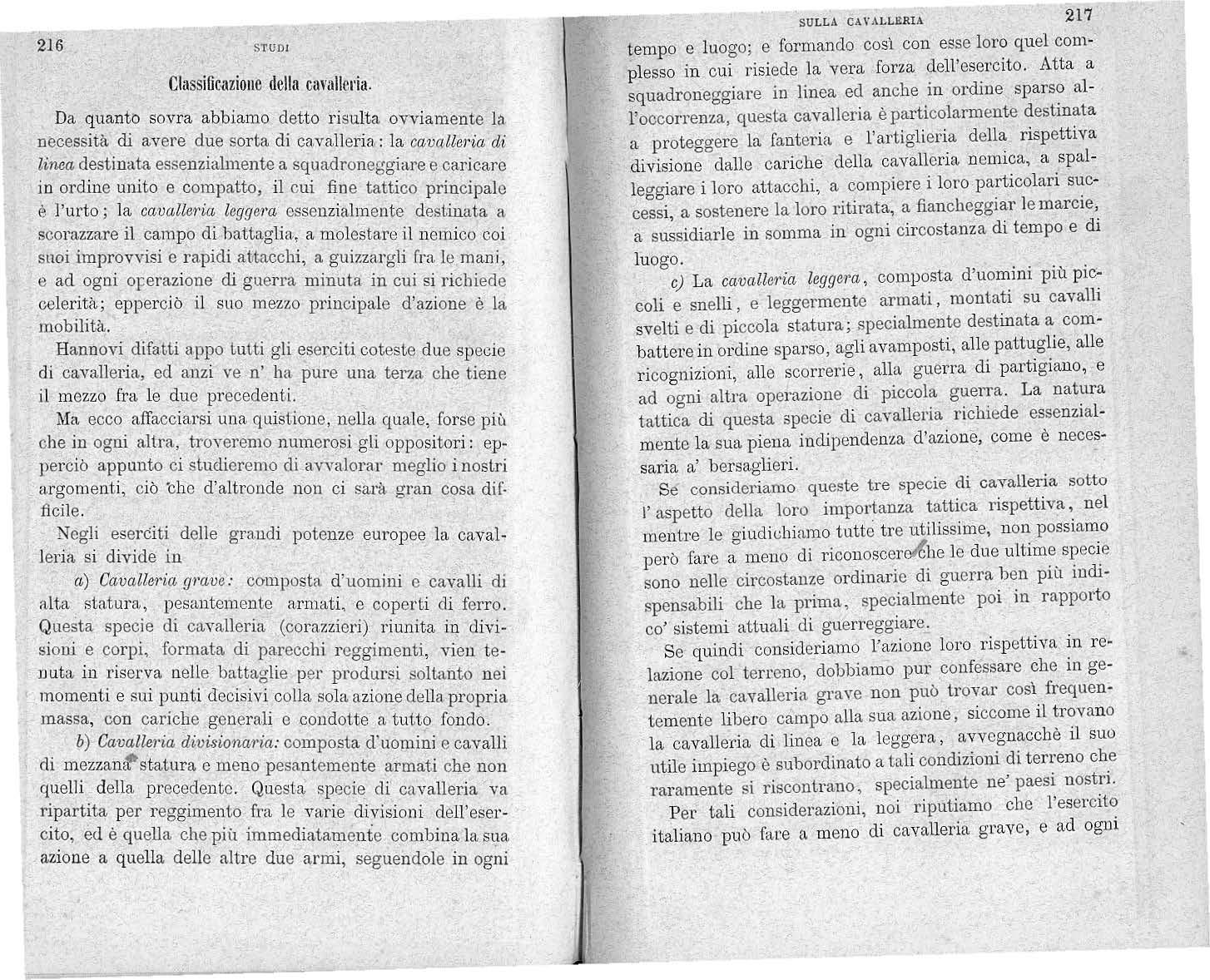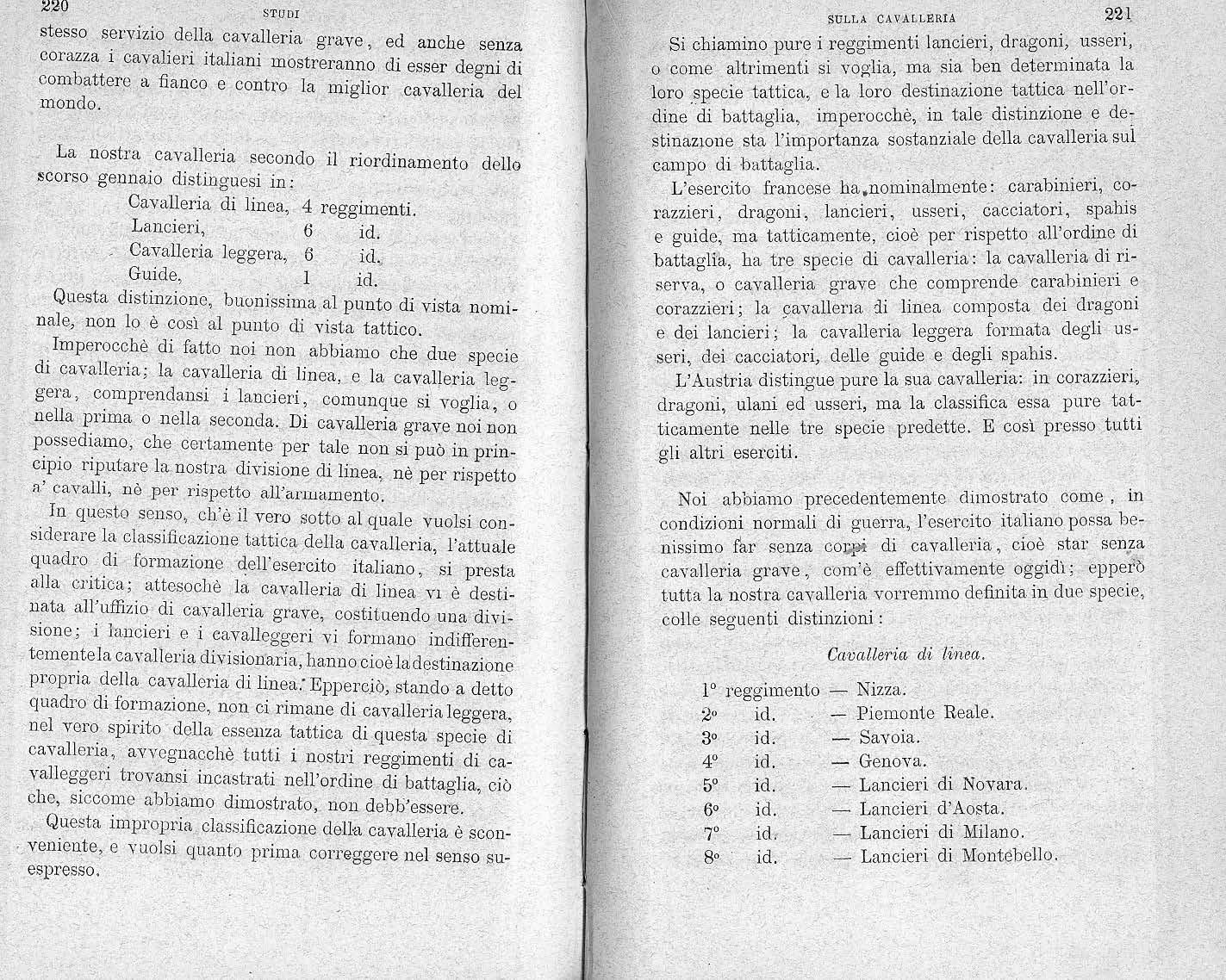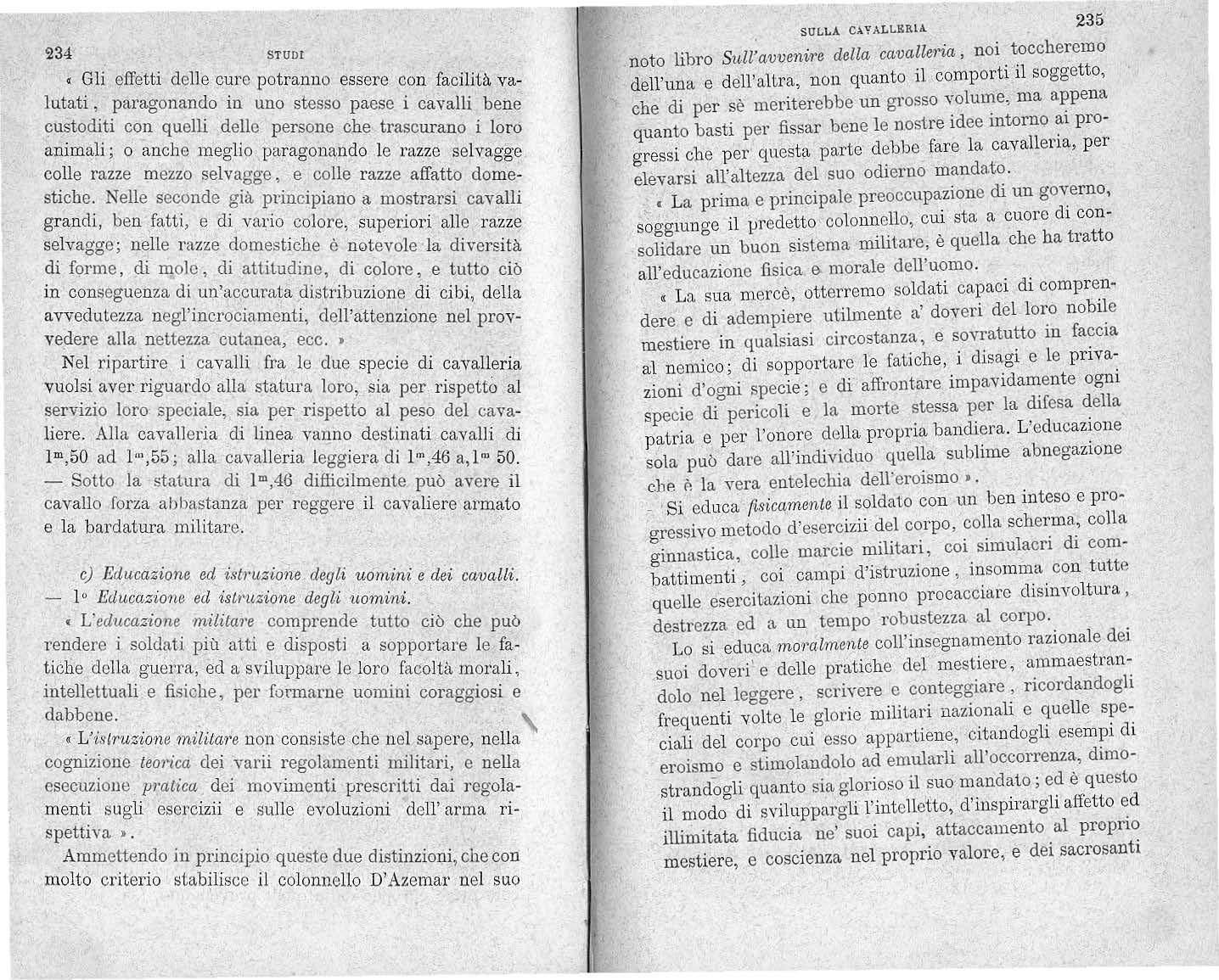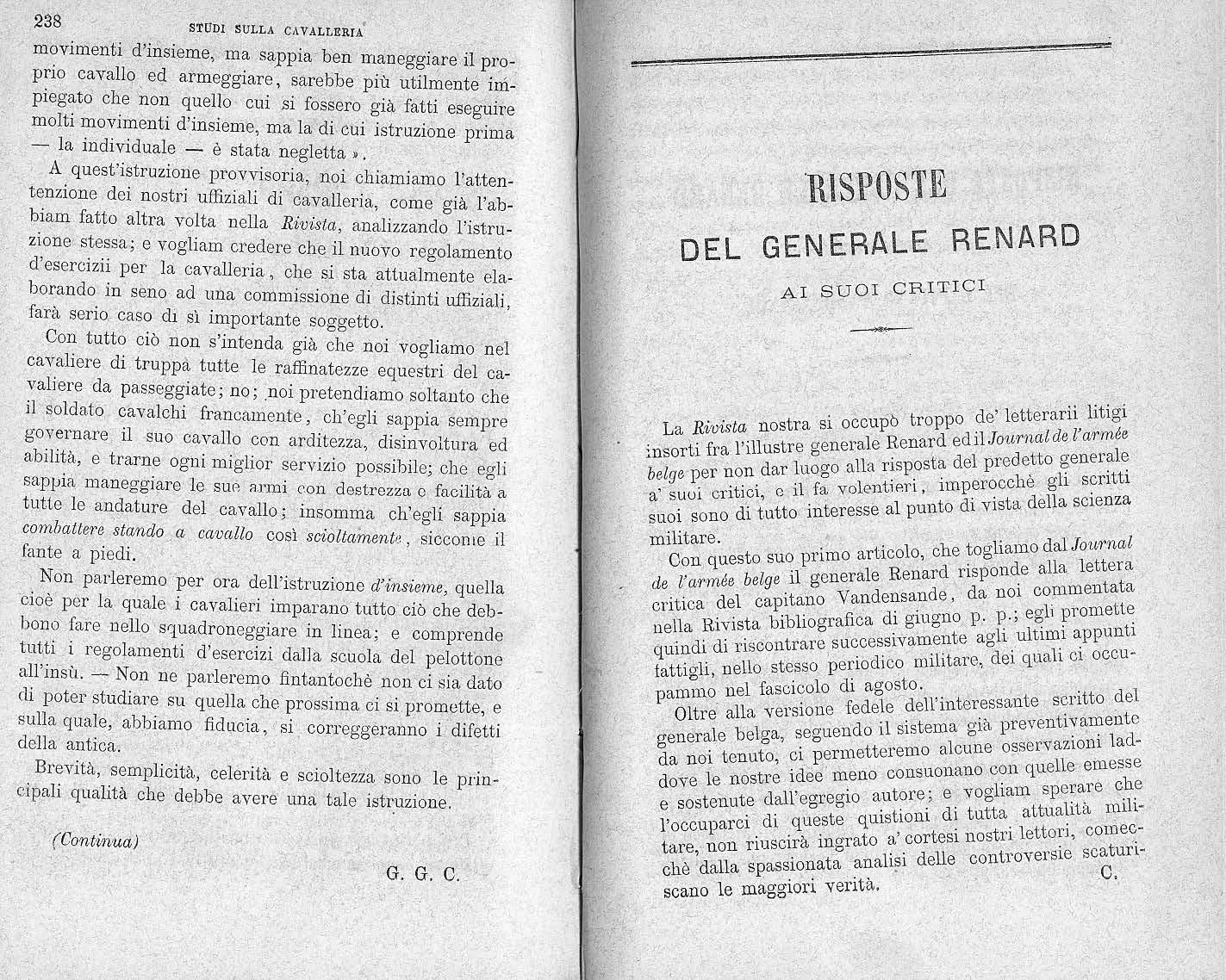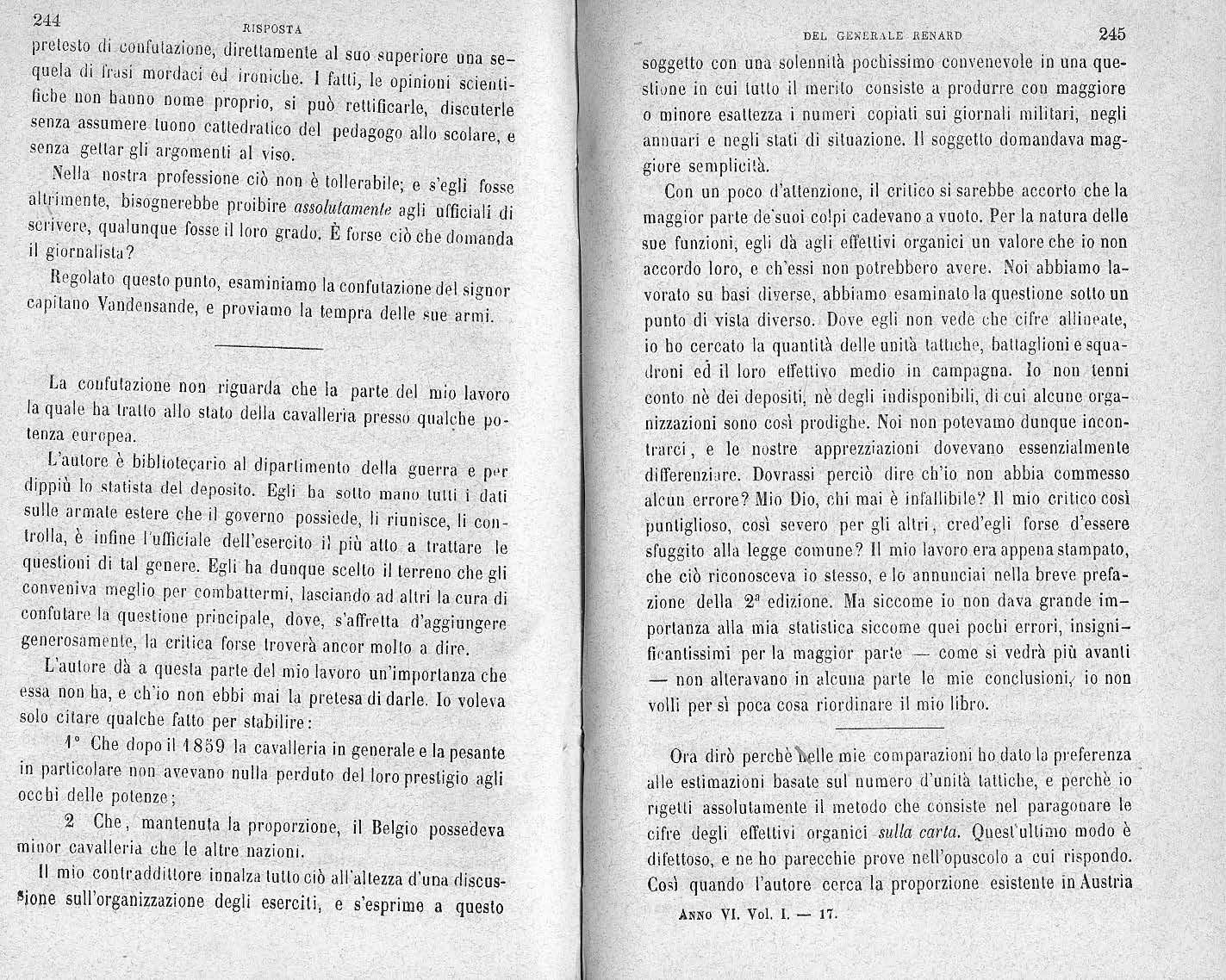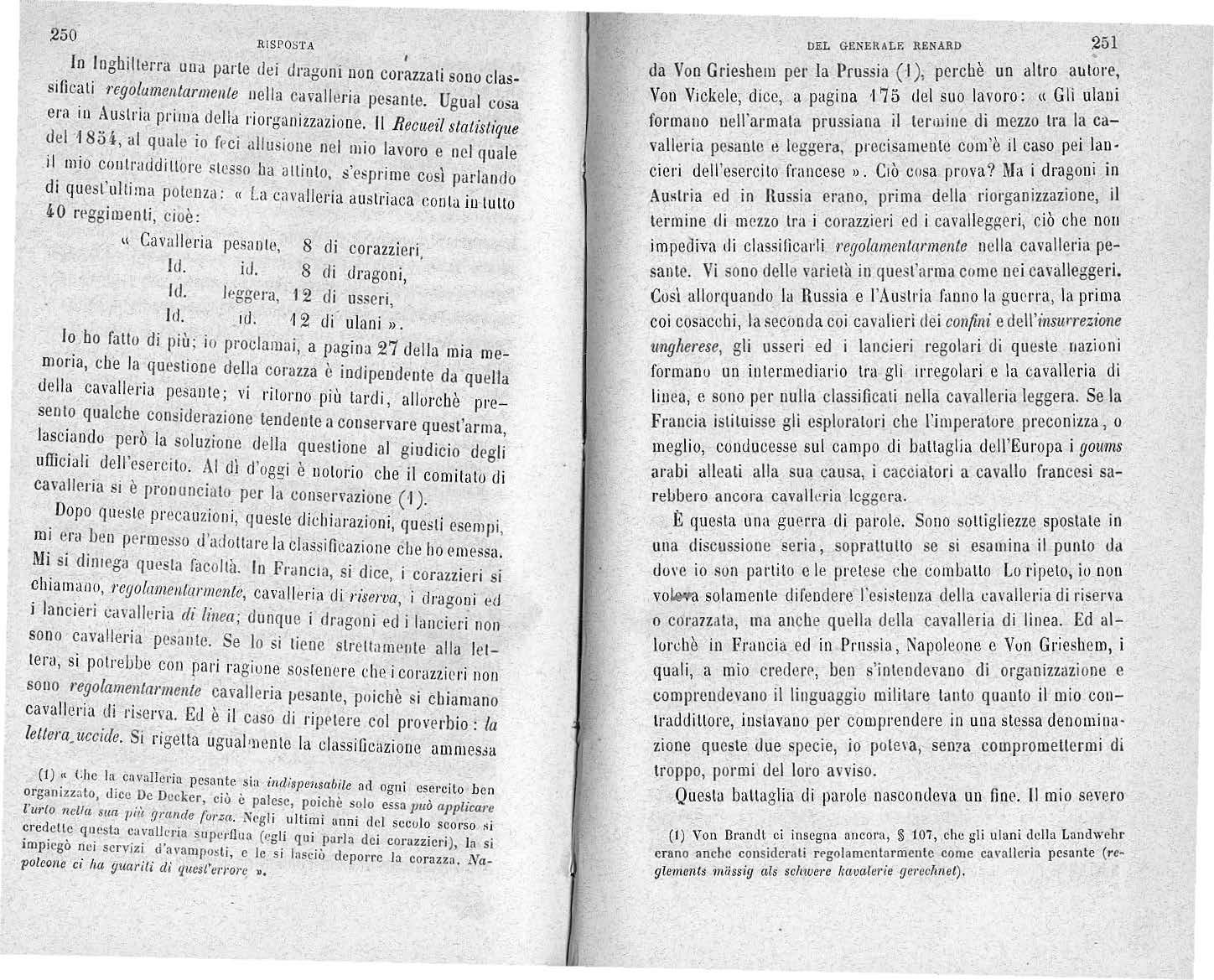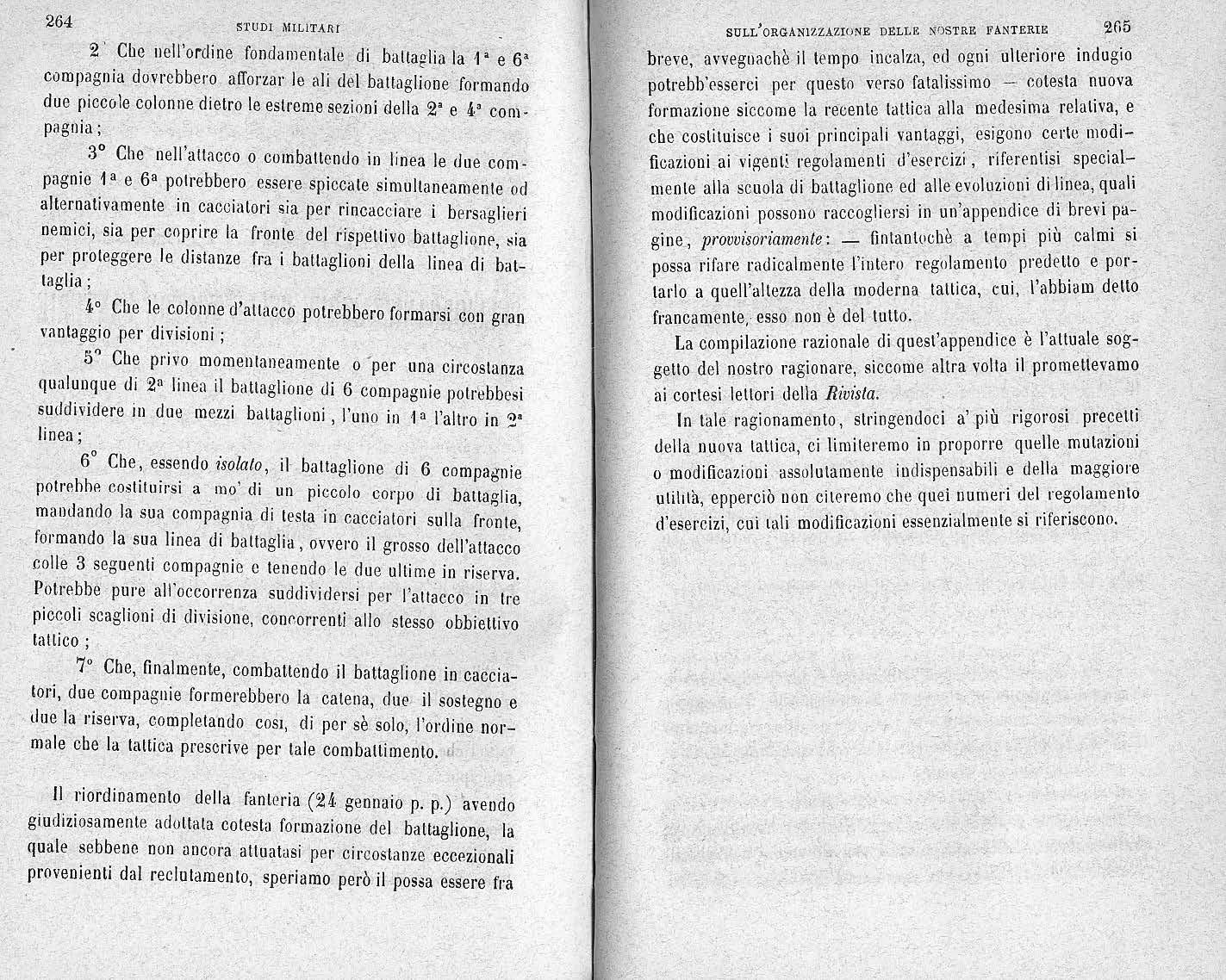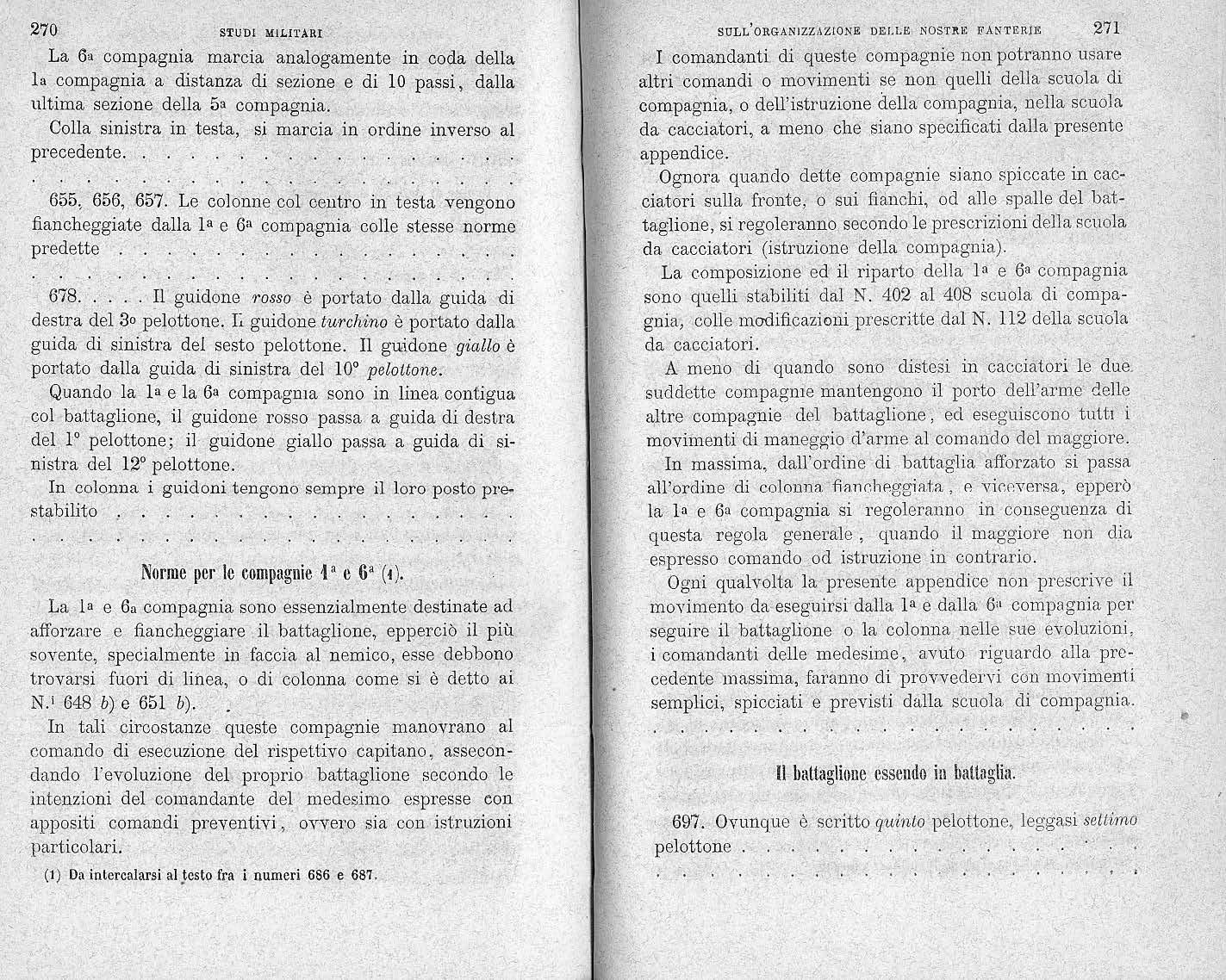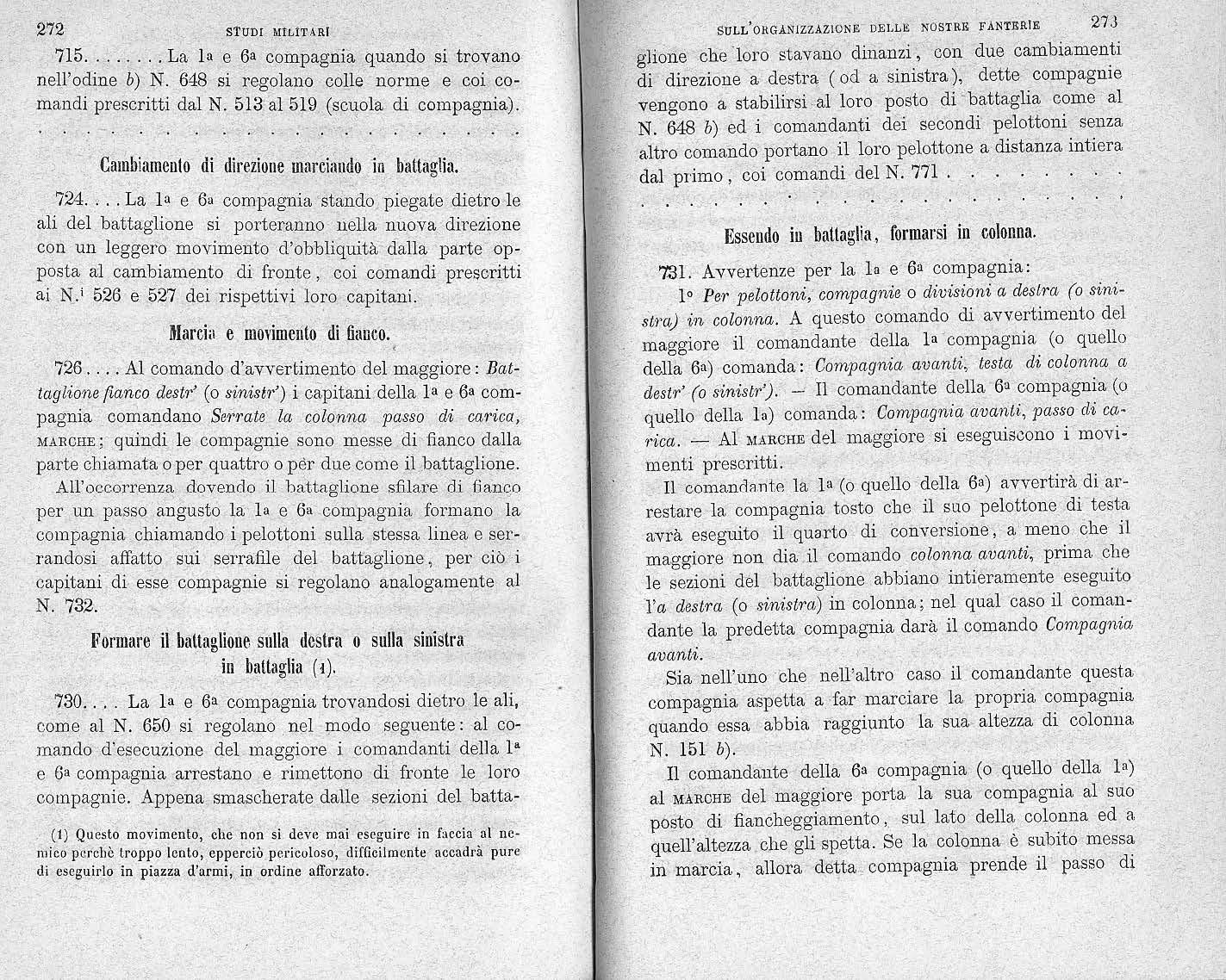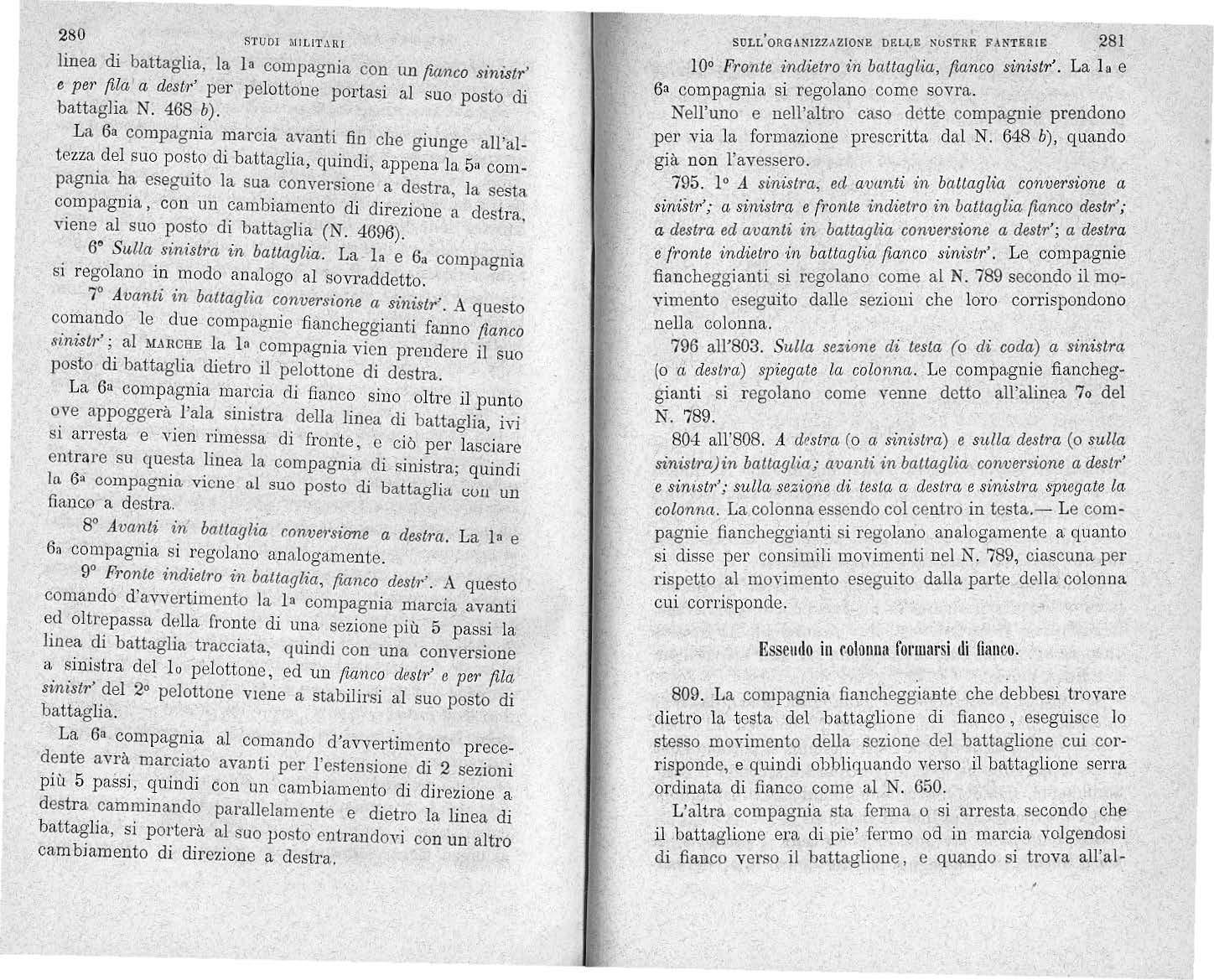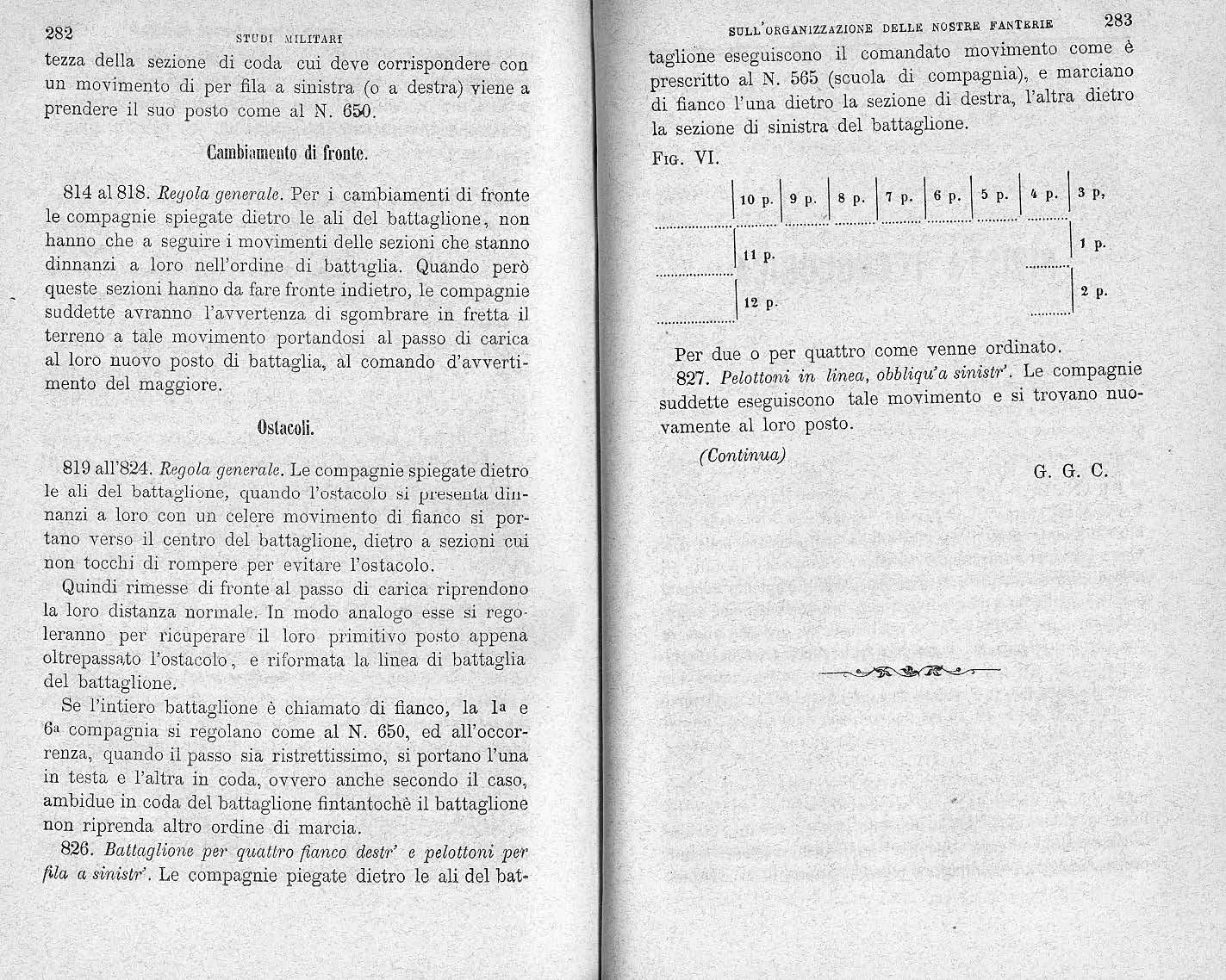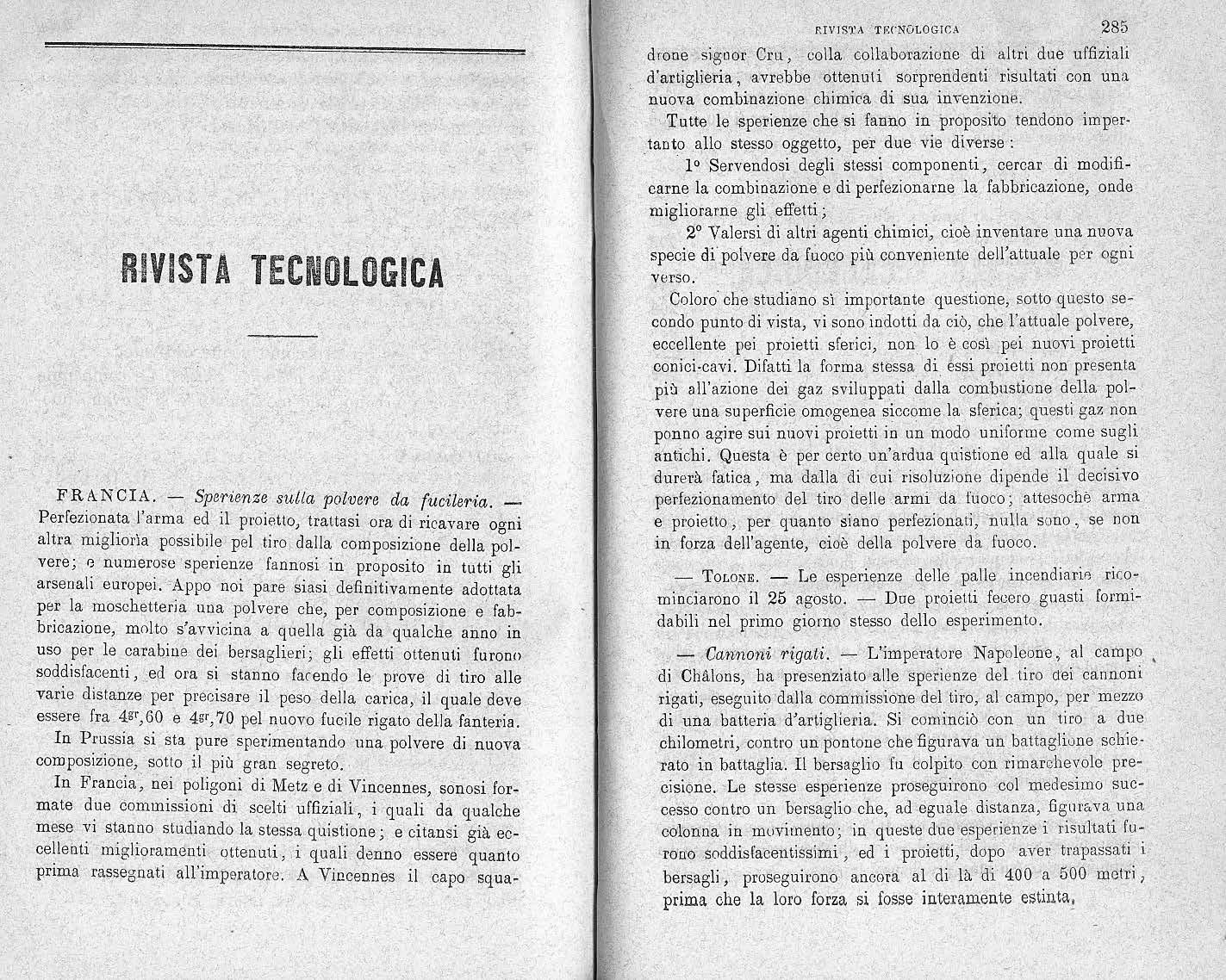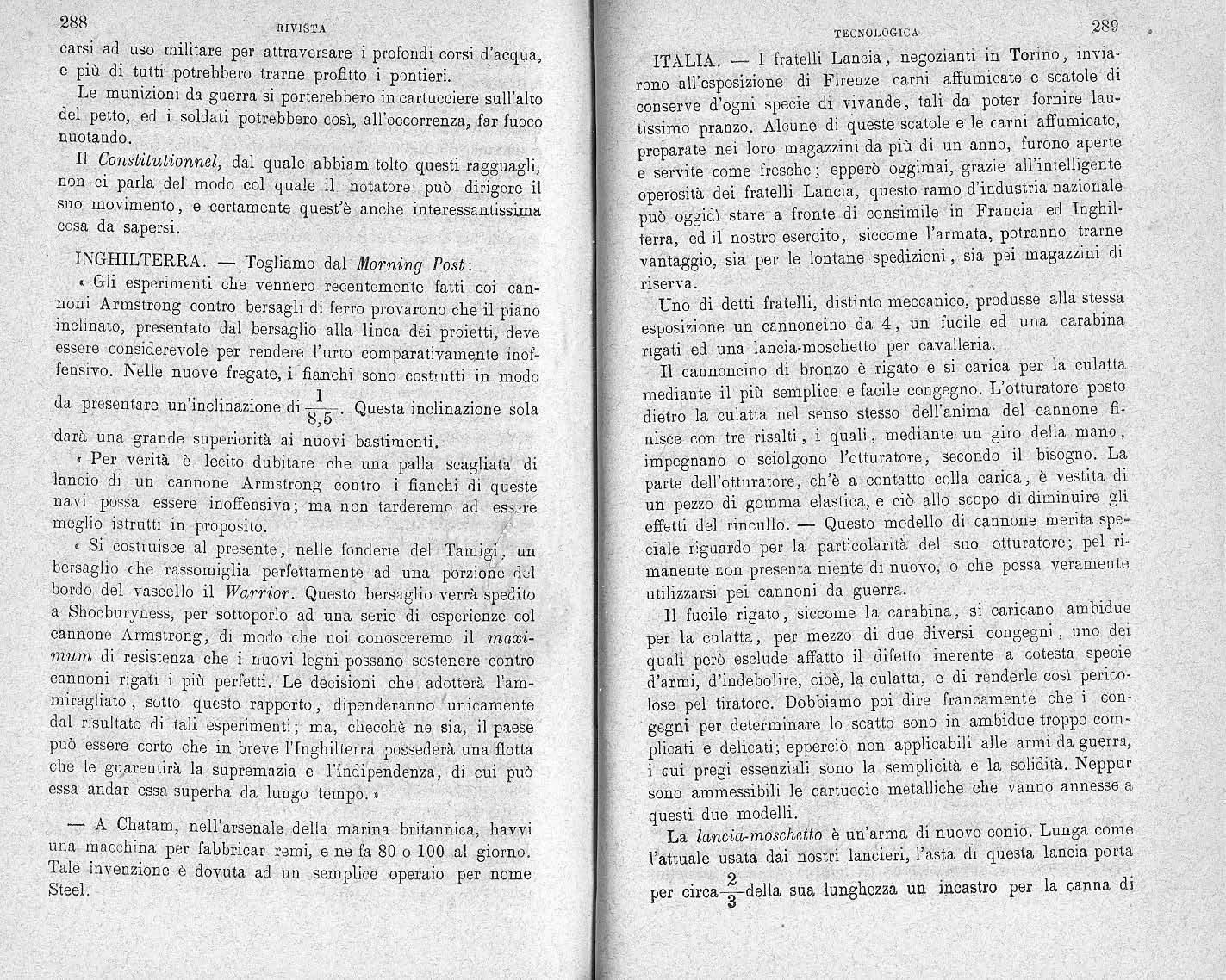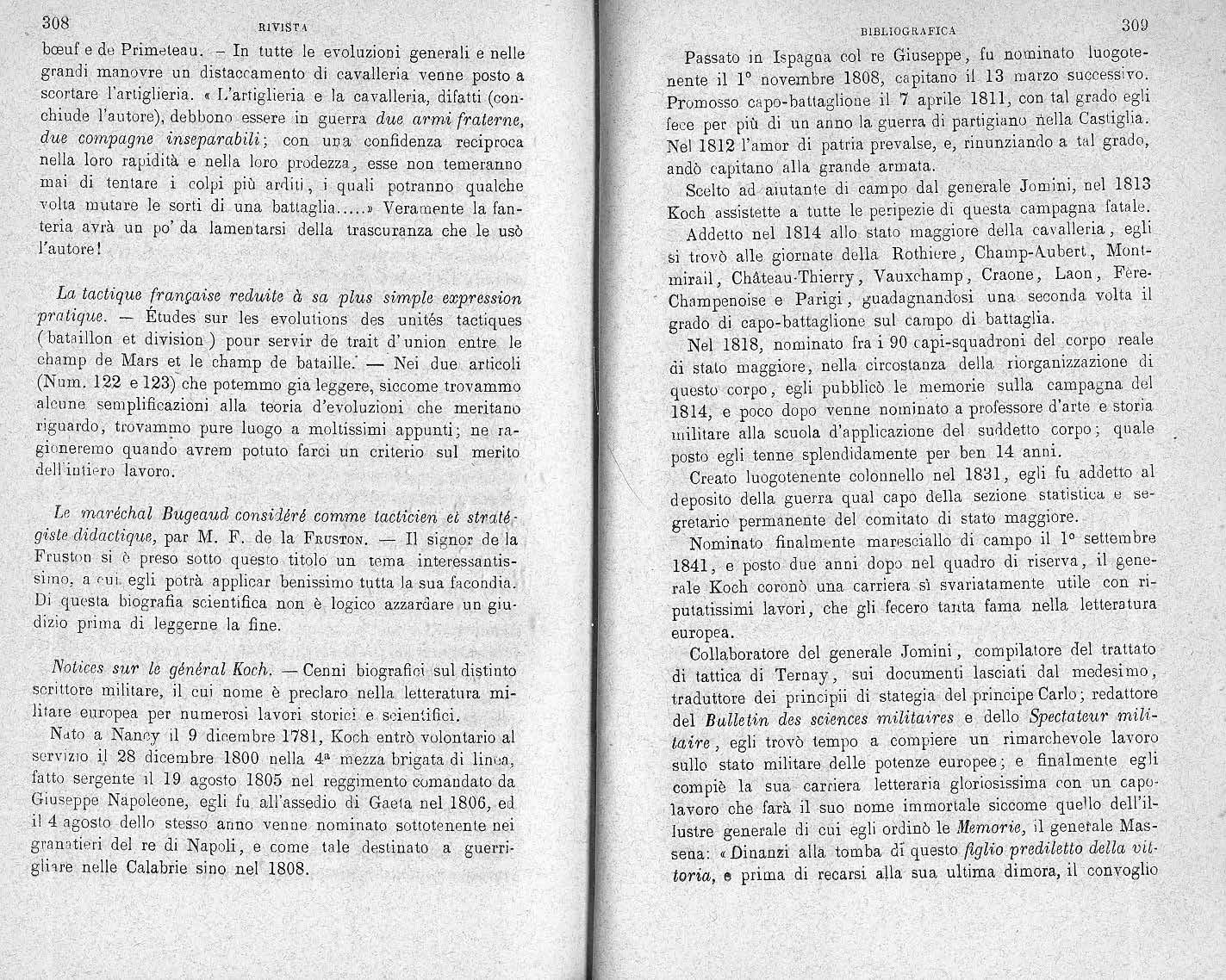RIVISTA MILITARE ITALIANA GIORNALErMENSltE ~nno 't·1. - V0Ju1ne I.
TOIUNO 1I 861 ' T IPOGRAFIA ED IT!II CE G. CASSONE E C0.\11'. Via S Francesco da .l'.aola, I! , 5 (O rosso)
t
S TUDI SULLA
ORGANIZZAZIONE D'UN ESERCITO
Prim a conseguenza del r eclutamento si è l'organizzazion e: e p erciò .'i p ensieri s volti nel nostro primo studio (dispense v1, dicembre 1860, vn , gennaio, e vm, marzo 1861 ) dov r anno riferirvisi, acciò ess a corrisponda alle prammatich e ivi dettate.

Ci pare quindi sar à utile di far precedere questo nostro secondo lavoro da alcuni calcoli, che dimostrino la forza nu merica dei soldati, còme ancora il r iparto d elle ferme e servi zio che appros simativamente risulterebber o dal sistema di cose da noi rngi o:i.ato nel suindicato primo studio.
Quantunque l a formazione dei corpi - sia in certo modo in dipendente da questa forza e genere di serviz io, noi crediamo p erò p ossa ci ò gio vare , onde m eglio intendere la concatenazione fra il reclutamento ed essi corpi . Ci offre per altra parte i mezzi per determinare (qualora
...
Proprietq f1J ttetaria,
COSE PRELIMI NA RI.
'.
Dl 'm; llSERCITO 5
il volessimo) il m.uuer o dej div ersi corpi , in proJJorzione della massa di t ruppe che la popolazio1{e dello Sta.to dovrebbe fornire all'esercito:
, 1° Abbiamo eletto che i contingenti annuali di leva deggiono sommmistrare il numero cl i reélnte necessar10 per conservare l'esercito . nepa proporzione del1'uno e mezzo per cento della popolaz,ioné : epperciò un milione di abi tanti, nel cor so cii dodici anni (co r so 'clell' intiero rivolgimento delle varie ferme di un continP-ente di leva) fo rnirà o ' quind1'.ci mila soldati; oss i a, secondo quello che viene detto dal generale Della Marmora, la forza di una divisione (1).
Dalle statistiche delle leve operate si può ricavare che gl'inscritti di leva d'ogni anno, i qu ali presumibilmente sopravanzano in un . milione d 'abit'antl .dopo somm inistrato il contingente cli reclute, possono sommare a mille seicento cir ca : e perciò le cinque leve (ossia il totale·degli iriscritti rimasti in tal modo dai 22 a.i 26 anni a disposizione dell'esercito) formerebbero una riserva di otto m ila, uomini . Alla quale riserva aggiungendovi i giovani dai 18 ai 2 1 anni d'età., i quali a tenore deHa l_egg e sono inscritti still e l ist'e a lfabetic h e di leva, caico l at i a tre mila per ogni anno, e così a nove milri per tre anni, la riserva totale sarebbe cl.i di ciasette mila uomini. Toghenclo però
(
I) Occor r e avl'ertire c h e n on t u tti i qui n d i ci mila uornini deggiono for p,ut.e d'una · divisione Sarebbe forse tropp<J numerosa. Vi sono d'altronde d e lle truppe o c o r p i che non appa rt engono a div is ioni , i quali ·peÌ·ò cssc'Orlo riforniti ,dal reclutamento dirctt.imcntc o d indi rcWnncnte, deggiono nullamcno essere comp r es i riel suindicato n u m e ro de'-qùindic.i mi\a. T ali sono le t rup pe applicate alla ·sicurezza pubbl i c a. la caval leriu di lin ea. l e guard i e spec ia li d e l sovra.-,o, i vcter\l,/1 i (esc l usi gl' i nvalid i, i qual i si , possono considerare qua li pensio nati ), i depositi dei corp i , l'artigli e ria di piazz3, batteriH e parchi di riserva, -i parchi del genio, il t.rcno per deLLi parchi; i cor.p i d'amministrazione, ecc., coll'o rdinàmento che n oi proponiamo, l e divisioni di nn cscrGito s arebbero della forza non eccede nte gli undici niì/11. uomini, " q nimli l'Ì rnarrebbero q1utltro mila- uomin i che ogni , milione d'abi t ant i fornirebbe al l'ese rcito per l a forma;i;ioue e forza cl i qucst.l · . ora d e tt i co r pi. · i
gli esenti p er differenti cause, gli assenti ed inabili, e · calcolando li. a clne mila, potrassi però -presuppori•e ch e jn -un m il io ne di ab itanti r esteranno a -disposiii ona per ingrossare l'esercito qui:ndici Jnila uomini d i -riserva o di guardia nazi onale mol)ile dai 18 ai 25 an ni . d'età (secondo che venne denominata nel 3° articolo sul reclutamento) (
1) .
2° Abb i amo prescritte delle fèrme e dei servizi di diversa specie, per cui ne consegue un progressivo movimento nel corso d'ogni anno per chi ama.re le classi sotto l e anni o l i cen ziarle . Ora vogliamo fissare le epoch e di questi movi~enti, e vecliamo cosa succederebbe n el periodo delle" fe r me .
Non cal colata la ferma d'ordinanza, la quale è una de. i·ivazione delle classi provinciali, noi abbiamo detto;
a) Che una classe provin ciale allorqua.11do sarebbe arruolata per dodici anni verrebbe desti nata ad un corpo, ove giunta farebbe un prim o servizio . Ora d'Unq_ue supponi amo che vi g iun gesse al principio dell'anno, dovrebbe rimauervi per tre an:ni consecutivi; però noi vorr e mmo fos.se l icenziata (in congedo ìimitato) due mesi prima dello scader e del terzo anno, cioè il 31 ottobre (2) . .
b) Qu esta classe dovrebbe poi essere r i chiam ata due volte ancora, nei ci n que- anni che apparterrebb e all'armata
(t ) Ve,li di s pensa vm , marzo 1861.

Qu esto ris ul ta t o c i fa vedere che qul·slo sisl.rma d i reclut amen to produce una forza ragguardevole assai di soldati, o r ise n 'C nazion,d i , istrutte e p iegate a l l a discip l ina mil i tare. È q n ,.st " cosa p1•pzi osissì m a per l a nxzi o n e ( e se ah biamo r i escito a p r ovarlo) . ,Si ottiene qu esta forza se n za d ov" r mob iliz za re l e milizie n aziona li d' età più - matura (ultima l'i serva) , "senza grav issi mi sacrifìzi o molestia delle po p o l az i on i n,~ i l<'mpi n ormali di p ac e :
(2) Qu e sto _p l'i mo serv izi o sarebbe così ri d o tto a ,lu'c ann i e d i cc i mes i , riduzi one- che non c r ed i amo d' i mportanza ta le che possa recar danno ~il a costituzione mi l i'tarc. •
Qurs La r iduz ione · è c:1g innal<1 ,lai h il:;ogno di comb inar e i di , ·ersi movi. mc~i ,-(~op r a espos t i) fìssat.i, o, pe,· meg li o dire, progett ati in divCl'Se dale d ' og'rff anno: e ci ò pcl minor disagi o d eJ J., p opohiz ion i, e perchè s i a no mrgl io rip art i le le operazioni sì co ulabili che d'is t ruzione, o le cure, ' di cui l e class i h a 11 110 maggior bis ogno nel l oro giuogcrc ai corpi .
4 ORGANIZZAZIONE
attiva, per un servizio qi sei mesi . Vorremmo peréiò che questo richiamo avesse luogo il 1° novembre; e ne con.segue che il licenziamento di questa medesima classe avrebbe luogo il 30 aprile de} successivo anno.
e) La classe 'che àvrebbe percorso in tal modo 8 anni di ferma sarebbe traslo·cata n ell'armata sedentaria il 31 dicembre dell'8° anno di',ferma; e perciò nell'ultimo_giorno d'ogni anno si effettuerebbe il detto passaggio ·d'una classe. Alla medesima epoca finalmente verrebbe liberata con ,congedo assoluto ·quella classe che, compiuti gli ultimi quattro anni in quest'armata sedentaria, avrebbe percorso l ' intera ferma di dodici anni.
Riepilogando queste cose in due Prospetti, vedremo, senza più dilungarci in maggiori spiegazioni, l'ordine dei movimenti annuali nel periodo dell'intero rivo lgi mento delle ferme (Prospetto A) ed il còmputo dei servii,i o pos1z10m durante le stesse ferme (Prospetto B).

6 ORGANIZZ;\7.10'.'IE
;.,_ 'y(f~ ., '\- \., Il
'1852
I
CLASSE 182S
1 ° gcnn-a i o gi on t:1 D31 t 0 gcnoai o al 5 1 dir.t!mbre, 1 ° a nno del 1° sèrv izio.
D:11 1° gcnuaio al 31 ,1:cembre, 2° nn no del 1 ° ser vizio 1,, gcnn nio g-i u 11!c1 Da l 1 ° gennil iO :11 51 d icembre, l" anno de.I I I') scn·izio.
0:11 •1° gen naio al 3 1 o ltùbre, Dal J 0 gcnn ni o al 5 1 ,ticc robre , 3 " a11 no del 1° sct·\1izio . 3 l ot.- 2° :rn no d~l i O se r vizi o.
tob 1·c liren:dalrL 1)~11 ·1 ° 11ov cmbrc al 5 1 d icembre in cùu3edo limila l0,
Da l ! 0 genna io :i l 3 1 rlicembre m cougedo [.i mitalo
Dal ,io genu:i io al 5 1 ~tlobre , i n congcdolim11ato 1l1 clu:11Jrn la d al 1° i1ove mb rc a l 3 1 cl icembrc pcl 2o SC l'\' Jl i O
Dal 1 o gen u aio a l 30 a p1'ile, 2 ~ ser vizio (licenm t:i) . Ua l _ 1 ° dt m:igs i~ a_\ 31 d1cc01b 1c rn co ngedo Jtm , tato.
Da l 1 ° •Ìmnaio al 5 1 oUob re i n congg,lo lì rni(ato. Da l 1_0 1 0vem br c al :H chcemb re n ch1am t3 p (II :=-io ~P. r \'izio.
Da l 1 ° gennaio al 30 a pr il e i n servi1jo per i l :io se rvizio (11ccn zi :i w) Da l 1° · nì:iggio al 3 1 dicrmbrc i n con gcr\ o li mi13,to. ;;1 d icembr e passa ta alle classi seden tarie.
0:1I 1° g'n n:-i io ::il 3 l dkcmb rc. 1° an no sedentar io
Dal 1 ° gennaio al 31 oHobrc. a 0 .nrno de l 1< 1 s.e rvi ;do. 5 l ott obre. 1i r cn2l:11 :1 Dal 1° nove mbre al 5 1 d icembre in congedo lim ita lo.
Da l 1° genn aio a l 51 di cemb re in congedo li rn ilato.
Da l I O ge nn ai o al 31 otlobre in congedo li mi l at o n iehiama tn <l ai 1 ° nol'Cmbre al 31 d icemb r e pel 2 servizio ,
Da l ·1° ge nn :-i io :1 \ 50 aprile , 2° sr,r vi,.i o (licen zia ta ), D:tl 1 • maggio nl :.H dicemb re i n con~cdo li mitato.
Dal 1 " genna io nl 3 1 o tloh re in congedo l i m i tal o 0:.1 1 l 1.1 110-vc mbre a l :=; I dicembre r icliiama la pcl 3° s c n izio
Da l 1 11 gcnn ~io :il 30 :1 pri lc 111 s r.n·izio pcl 71° se t vizio ( li cenzi,1ta) . Dal 1 ° nwggio a l ~ I dice mbre i n r.ongcllo li mi rn to. 3 '1 dieemhre 1,assata alle c lass, sede nta r ie ,
1859 0 :,1 1° genn :-iio nl r, 1 dicembre, 'i0 anno se denta r io
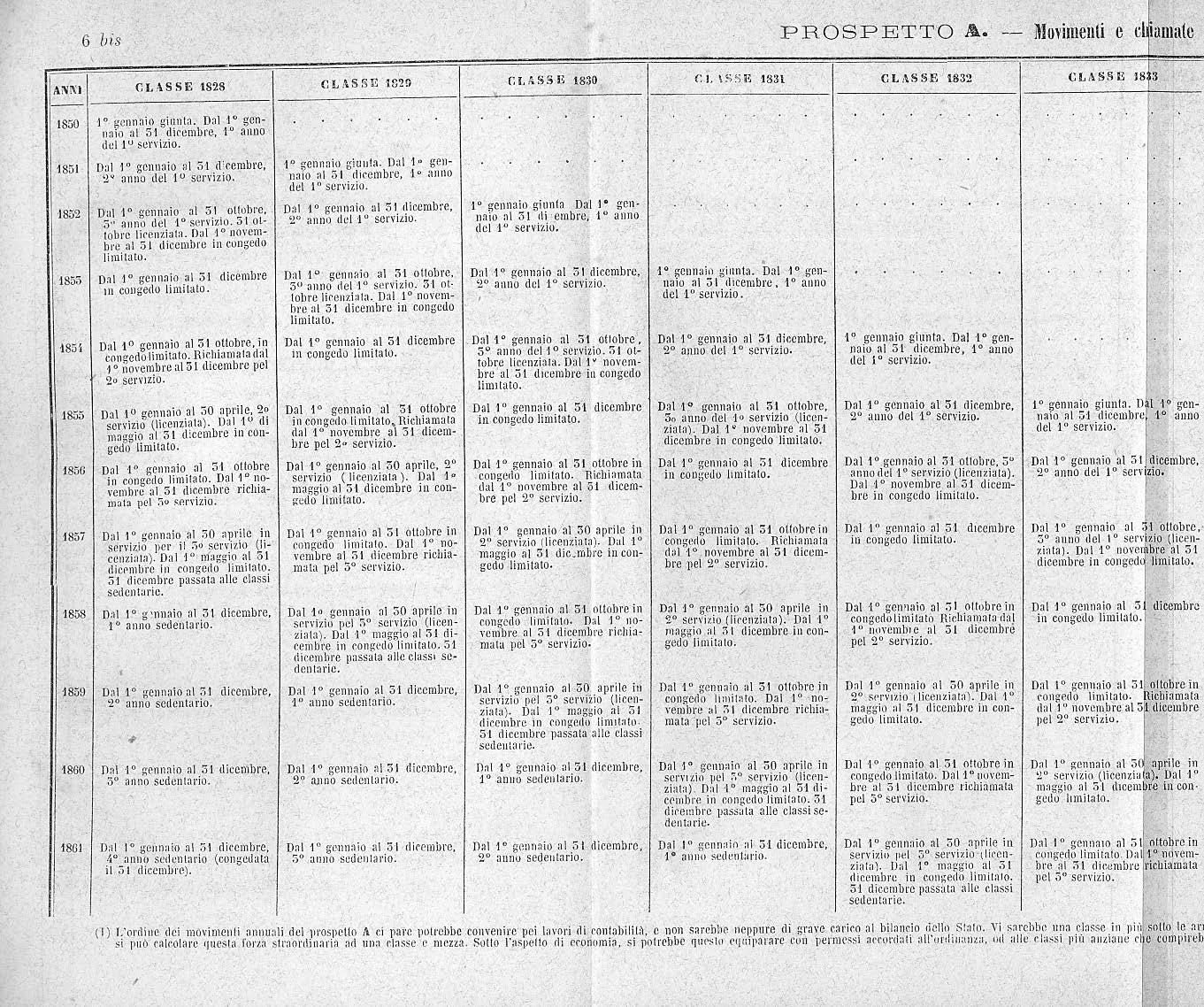
D::t l 1° genn nio a l :;;-i d ice mb re, 1 ° anno scdc1u ario .
ca ." ss lì 1&30
1 ° gcona io gio n ln Da l 1• gcnunio :1 \ 3 1 di embrc, ·l O anno dc. I -1 ° serv izio.
0,11 t O gcnn oi o :11 3 1 cl iec mbrc, i O gennai I) gin nt :). b31 1 ° gcn'20 nn no d ei "1 ° sen·i7,io., ' na i o al 3 1 di cembr e. 1 ° anno , del ·l O ser vizio.
Da l 1 ° ge ,maio al 51 otlob rc 5° anno de l l O servizio.~ -! ottobre li ce nz iarn Da l I ' novemb re ttl ~H dicembre i 11 congedo li m i t ato.
Dal 1 • g~nn aio al 5 -1 d icembre i n co ngedo limita to
Dalt O gennai o al I o!tobre in congedo li mi ta to. Ricbi :rnrnta tla l 1° no vemb re al 6 1 di cembre pcl 2° se rvizio.
D :11 11) gen na io al :5 0 :ip r i\c i n · 2° ser vi zio { liccn1.i a1:1) Da l 1° maig io :.I 5 l dic ..: mbrc in co ng edo li mi tato,
Dal 1 " genn aio al 3t ottobre in congctlo limif::ito. Oa l 1 ° no · r c mb re a l 3·1 d ice mb re r ichiama la pc l 3° serv izio-
J)al 1° gcnm1io a l 30 :1pr ilc i n sCl'\' izio 1>e l 3 ° scr vWo (licenz i al :1 ) D:d J O m~gi io a l "5 l d icemb re i n con gc,t u li m 1!:1!0 5-1 d icembre passa ta a ll e class i sc dent 1ri~
1860 Dal l O ~en naio al 3 1 d icembre, 5° ,rn no seden tario.
Da l ·1° gen naio a l 51 dicembre, 2 ° aJrno scdcn tn rio .
O;i l 1° gc111w io :11 51 il iccmb 1·e, 1 ° a n no sedc11 t;1rio
Dal 1° gennaio al 3 l dicemb re, 2-0 mrno el ci l O se rvizio,
C LASSE 1.832
1801 J),i l t • ~eìrn,, io a l o l d icembre , 4° :1 11110 sedcn l ar io (congcll ata i l 3 1 cli ccmh1·c).
D:i l 1° g~nnaio a l 5 1 d ir e mhre, 3" anno scc1c11 1a1•io
0 ,1 l • gennaio " I 3 t d icemb re.
2° ~111110 seqenlario
Da l 1" gennaio al 5 1 ottob re, 5o anno de l -1 o se1·vii io (l icc n• 1.i a l:1 ). Dal 1' nove mbre al 51 dicemb re i n congedo lim ita to.
Da l 1 • genna io al 3 1 d icemb re in cou1,c ùo hm ita to .
Da l 1 ° gc,ma io a l 5l o(tol>re in eoogt~rlo lim il :1to. R ichiam nra dal ·t O no r cmb re a l 3 ·1 dicembre pel 2° servizio.
Da l 1° ;;e1111ai o :il 50 apr il e i n 2° scn izio (lircniir,r n) Da l 1° rn;-igg io fi l 3 l d icembre in con~ gedo lim ita to.
J)a l 1• ge nna io al 3 1 ottobre in co ngeclo l imi l;ilo Dal t " novembru ,,I ~ I ctlcc mh rc richiama la 11cl 5() serv izio
Dal 1 ° gc nu:i in al :;o apr ile i n scn 1zio JJ l'l ~. 0 servi zio (l ic!'Hz 1al:1) D:1 1 l 0 m ::i ggi o al 51 dicr1nb rn i n co n~cdo li mW1to 31 diremb rc 1,assata ~Ile clas si sedcnt;.1ri c
Dnl I O gc nn;1ii1 :1 1 51 di ccmhrc, 1C;t anno :;cd uo l-Hr io.
-1° genn ai o g iun ta . Dal 1 • gcnn nio :il 5 -t d ice mb re , 1° anno de l l O scn•izio.
Dal 1° {;Cnna io a l 5 l dicembre, 2° an no de l 1° servi zio,
Da l 1 ° genn a io a l 31 ottob re, 3° :innoil l!I 1° se1wizio (l icen zia ta) Dal J0 no1'e mbre al 3 ·1 dicembre in cougcdo limitato ,
Dal t • gcun aio al 31 ch cemh rc itl congedo li mitato.
1° tennaio g iun ta D~ l ·1° gen11010 a l 5 1 tlicemb rc l '1° a n no ci el l O SCtl'iZiO
Dal 1° genna io 1 al :; 1 dicembre. 2° anno <l ei I O se rv zio,
Da l -1 ° gennai o al ~I o llobre. · 5° :urna d e l t O sct·\ izio (li cen,i :1t aJ , Dn l 1° 00\' Cl ' bl'e al 51 d ice mbre i n congcd( limi la lv ,
D3l -1 ° geninii o al 3 1 o tt ob re i n eongeflo li mitato Richi a mnt a rHtl I l\ tlllV~mlHC nl 5 1 dicemb re pcl 2° ser vizio.
Da l 1° genn aio a l 50 a pt·ile iu o f,('f\'H,iO li cen ziata } D:1 1 1() 1i'l agg io al 3 1 d icembre i n conged o li mita to
0,11 l O gen naio :i l 3-l ottob r e in congedo li mitato . Dnl ·1'1 novembre al 3 1 dic~mbrc richiamata pcl 0° sc.n 1izio
Dal I• gen naio a l ;;o apr ile i n ser v i zio pul 0° sen ·izio \ l i<:c n~ zi ;:itn ) D al 1° maggio al 31 <li r.cm br c. in con edo lim il nlo.
5 1 d icemb re pass,,t a alle c lassi sctleuta rie ,
D al 1 ° gen nnio al 5 <l iccmbrc in congedo limitato.
Dal I O gen11:1 io :11 31 o ltohre i n C'O ngedo lim it nto ni chi:1mata d:1 1 I O novcn,j) rc al l dlcelnbre ))C l 2° scniz. io
D;1 I 1° ~cnnnio :ll :5 ap rile in ~• ser vizio (licenzi :t a). Da l -1 ° mng~io al ,H dicem llrc in con , gcdu lim ita to
Da l I O gcn nnto al :; I ottob re in !:ongedo li mitato. n at 1 ° nnvc mb re a l :; I cl ic<>mbrc riclt i,una 1a pel 3• serv izio.
I r:ortliuc el c i rnòl'i tllcn li a nnuali del l!IOS1 l elfo A e, pare, putt·ebbc co n,ennc· pc , 1,110n rh ronf ab ilil,1 , e n on s ,rcbh~ nerpure eh gra,e ca11 co al h tlanc, o oc lh> S!;llo Vi sarebbe nna cl ossc 111 Jl ii, so tto le " " si pnò r.a lcol arn r1ucs1:1 fo r t::i st r:iordinn r i fl ;1(1 u n:i. cln ssc e rn e:u.3. Sollo 1"a~1>tl!o <li cronom i ;t, si pol rchbc riuc-:- lo t.'(l UJ l):\l'ill'C Cl)n permessi il(' t:<,nlal l a u u n lii1a11i:.1, otl all e c la:-s.i p i li :1 11 zi~111c cl e comp irl"'h
6 /Ji,s
i\N!\'
1851
185;\ 185 1 1855 1850 185i 1858
PROS PETT O & . - ~foyimeuli e 61 ~ama[c
C l. \S S E 1 33l
/
C LA SSE J8 3
I
CLASSE !837
CLASSE 1838
Cl dSJE 1839
Oi1Dli'l.1 NZA
Classe ·1828, avuta al 1• nùrc111b1e , 5° anno d i servizio
Classe 1828, 4° anno d i sc rri, io Id . 1829, 3° id. (d al 1° norcmbrc).
Classe 1828, 5° amo ,l i sc1 1·izi,) (d. 1829, 1,0 i(I. Id 185 0, 3° id. ·(da l 1° no vembre),
Classe 1828, 6° anno di se1·vizio Itl. I8.2D. 5° id .

Id. l'850 t,0 itl.
Id . 18:;J, 3° id . (dal 1° novembre) .
Classe 1828, 7° an no di~ r vi,i o .
Lei. 18 20. n• id
lei. '1830 , 5° id.
l1I. 1R~·I. 4° i cl. lii 1832, 5° . i d. (dal 1• novemb re)·
Glasse 1&28 , $0 anno d i serviz io (con~·e dila il 51 r,1. JS~9 7° ul. dii'embrc) lei. ·1830 , G0 id. fcl. -IR3'1. G0 hl. j d. 1s:;2, t, 0 irl.
HL 1835, 3° id . (,bi 1° nove mb re) ,
1° gen naio g i un la, Dal ·I O gcnnnio ril 5 1 d ir.c mb t·e, l O a nno del 1 • serviz io
D:11 t O ge nna io a l 31 ,litcmbre, 2° anno del 1° SCf't'i!!io
1° gcnn:-i io gi un ta. Dal 1 ° gen11:1i o al 5 1 di r crob rc , 1° anno del l O SCf l' i, io,
Da l ~I O :;c nirnio n_l l llobi·.c . :5 ° •Dii IC? gcmrnio a·. 31. cli re mbrc, ::i nno ll d -1° sen•1;,,10 ( l: c•c11;.,,1 :l13). 2<> anno del 1° se r vizio
Q;1I I O 110 \' Crnbrc al 51 d1cem • bn.! i n congedo li mi lfllO '
Da l 1° gen naio al 31 diC(,mbre i n Wll \;CU O i nn i l:\I O
t • prunaio g i 1111 l:1 - D~ll I O f;l!ll11 3!0 al ,;,i d icembre, 'l O anno del 1° S{•rviz.io.
0 31 1° {,('!1lla i o al 3 t otlobrr, 3°
Dal 1 ° .gen n:1io al 5 1 rl ircmbr e, :llln o elci I O _.::c:r -.ii~io (iircni ialal . .20 anno del 1° sc r yiz ìo
I O:i l l O noveml> re :11 5·1 c.l iccm• brc in congcclo .imi t:Ho
·i 0 ~('n n ~io gi 1rn~n. Da l 1° gen• n:1 i o ;1l 3 1 rHr· •mb r c, l O anno tl t•l l O sen' i:w.1
Cliss~ 1,1. 1,1. hl. Id . hl.
IR2D, 8° anno d i serri ,.iri 1850, 7° id •18;:;•\ , fiO i cl . 18:52 , 5° i rl. ·1$3~ 1, 0 irl. 1834, 3° id.
(conged,1 l.1 iI ;;I d 1r.emh re) _
(dii 1° novemb re).
Cl :nsc 1~30, 8° nnno d i srn?Z io (cong~dala il :il [cl. 183·1 7° iii. ili ccmbre).
1,1. 18a2-, G 0 id . 1,1. -IR:;;j, 5° icl.
1 41. 187J.1 ', 0 icl. d. 183G, 5° id (d HI 1° norcmhre)
Cl~::.se l~·l, 8~ ànno cl i SC't",•i zio (conge il rì lA il 3-1 fd. lS.02 . iu id . dit•c rnbrc) .
ld. 1833 6° ili.
lii 1B3-1. 5° id.
Id 185a, 4° irl.
Id 1836, ';.;0 id (d:1l j O norcmb r c) 1
Cl ns:;c ·1852 8° anno ct i se n 1 i1 io ( r on~r.-data il 31
Id 18,13, i 0 id. ,li,cmhrc).
J4]. 1851 (l 0 i(\
J1 J. ·1$..)5. :,0 il'I.
lii 1R56 4° i d
hl. 1837, :;0 iii. (•lai l 0 11orembn'\ ,l'o•n i :rn no : r.:i~ionnlo ques lo ,b i r iehi:nn i pc i 2" e 3° sc ni,,i se mcs lra li. Le classi r ich iama le csscn fo prm\ ridotlc ad in cll'cll i\'O minore ( la q nal cosa gia :i bbi nmo com1>rol' ;1l n ), ~i r ift ur n·hbc 1ltr<'iò ;.111c din }r~c i ndC't)Hi!ù cli ,•ij p('r c1ti esfc rhi:im~ té, lirctlz i:urwn ti e 11cr mcssi
a corniociarn dal ,t o gen naio 11850. --- - --CL A SSE
I
1S36
•
.
Vf , m l. I. - L
A,uo
P RO,'ENl~~TE DA QUs.S ·rF. C. l ,\~ St
... . .
PROSPETTO D
Computo generale della ferma dell~ classe t828 più anziana
· comP. dal prospdto ·A.
EPOCHE DEI MOV.~IENTJ f POSIZIONI percorso
Classe 1828. Dal 1° gennaio 1850 al
..
3 l ottobre 1852 . . . l O servizio . . . . 2 IO
Id. Dal 1° novembre 1852 al
3 1 ottobre l !:ìM ••. in congedo limitato 2 " I
Id. Da l 1° nov~mbre 1854 a l I
30 aprile 1855 .... 2° servizio .... »
Id. Da I 1° maggio 1855 al
3 1 ottobre 1856 ••. in congedo limitato 1
Id. Dal 1° novembre 1856 al 61
30 aprile 1857 ... 3° servizi o »

Id. Dal 1° maggio 1857 al s l
31 dicembr e tti57 in congedo limitato ..
Id . 'Dal 1 ° i::e nnaio 1858 al
31 dicembre 1 861 nell'armata scdcntaria . . ..
Id 31 dicembre 1861 . . . congPdo assoluto ..
DI UN ESERCITO 7
O
TEMP
;; e < --
:[
"
" . ' --1
.. 12 .. I
ToTALII: . . . . . .
ORGA NIZZAZIO NE DELL~ FANrrEHIA
· Suo elemento, ossia della Compagnia.
Se il recluta.mento è elemento organico d i un eser cito. l'ordinamento ne è i l p rimo ·e principal e regolatore per dargli forma e governo.

Il reclu tamento somministra il numero dei soldati : per rnezw. dell'ordinamento es s i sono ripartiti nei varii corp i ; e s iccom e·la, natura. e le inc umbenz e di questi corpi sono di diversa sp eci e, s i distinguono col titolo di Corpi d'armi dùJerse : e p erciò quelli di ciascheduna arma- h a nno forme special i., e l a forza è combinata colla topogr afia ; coi bisogni .e rist>rse del Paese; co m e pure co lle norme di proporzi oni vol ù t e g eneral ment e · nella composizione di un ese rcito . '
Prima condizione di buon ordinamento dovrà essere : che i Corpi siano organizzati in mani er a.. di poter in qualunqu e tempo o cir costan za pres enta r e una forma conv:eni e nte alle due situa:lioni di pace e di g -uerr ; . Vale a , dire: bisogna c he nella for m azione organ ica vi siano i mate riali nec essari di poter a u m e nta-re ~Ì'effettivo ordinario di pace on de passare al co m pl fòto armamento d i guerra, s e n,za esser e obbli gati di fare n essu n cangiarnento ' a qu esta organizzazione; e parim enti pote re r idurre la: for za d i g u erra e ritornare su quella d i pace senza diffico l tà.
Prem essa. q u esta massima; come b ase ., o fondamento dei' no s tro studio; imprendia,mo ad esaminare là fanteria,
Nelle diverse armi la fanteria tiene il primo e principal posto , perché è l a più essenziale , la più numerosa, e dalla su a - foTZa vien calcolata l a proporzione ora detta delle altre anni; le q u ali n e so no l'aiuto o gli accessori .
Si chiama fanter i a la t.ru1)pa a piedi, che comba;tte unita schierata in linea., o piègata in mas se; ovvero in ordine sparpagliatò . Vi sono quindi due sorta di fanteria : di l'inea la prima ; leggiera l a secon da~ : e sebbene a' giorni nostri la fanteria di linea sia ch1amata a comlJa,tte re a n ch'essa in ordine sparso, . in fattq d'organizz ~zione ella è consider ata co m e truppa messa in ordine serrato , regolare e cli n1~tura più . pesante . Essa è scompart.ita in corp i: e~ il battaglione n e è l 'unità .' -
Siccome i i batt aglione è la riuni one dì più centin aia ,li uomini, egli è perciò nece ss a-rio di doverlo dividere iri un certo numero 'cli fra.iioni, per poterlo muovet e , gov ernare, ad amministrare. Queste frazioni, sono c hiamate compagnie .
La compagnia n ella. fanteria di lin e(L d eve adunque considerar;s~ come sezi one tattica _ ed imil:à amministrativa: ma prima d 'ogni altra cosa essa è l 'elemento.
Essendoci proposti d i . studiare la fo r mazione di questo el~mento adattandovi i pensier1, o cose da noi contemplate nel reclutamento; d obb i amq eziàndio t ener conto delle tre co ndizion i c h e costit uiscono un es e rcito b en ordin ato . Vale a ·dire: fa d'uopo che l ' o.r:gani zzazione della comp agnia aqempja allo scopo della tattica e corrisponda ai b isogni della. d is ciplina e d'amministrazion e .
Se vogliamo ben p on derare, la.tatt ica è l'unico scopo militare , e per ciò la prin cipal e delle tre condizioni ora dette . Il nostro esame d eve . quindi ri".'olgersi anzitutto alla forza, la quale d0v rà d e t ern:i inai·si in maniera che sia fac ile l'azione delle altre d g. e cò ndizicmi or d e tte . La foì·mazione della compagnia deve nel m edesimo temp o con~tare d elle due spedè. di sold at i d'ordinanz a e pro.
8 OHGA:-i I Z7. •) 7H):,,F.
DI UN ESKRCITO 9
vinciali nell e proporzi oni da noi volute, ragionando d el r e clutamento: e finalmente affIBchè questi agenti operino ed abb iano potere, la compagni a dovrà essere dotata di graduati atti ad esercitare d elle funzioni .
Ciò pqsto esamineremo :
1° La f'cwza di una compagnia nelle sue due situazioni : di originaria fol'mazione in- tempo dì pzi,ce la prima, ma ave ndo i mezzi per passare allo stato di guerra: -dello stat o di guerra l a seconda. ·

2° La ripa1'ti zione 0 1 divisione in frazioni della compagnia e loro comando · ossia il quadro.
DI UN ESERCITO a sublimi ~oncetti ; e forma u n ·· tutto di questa denotnina ta compag ni a .
Una compagnia di fan t e ri a di linea messa sul piede 1 di guerra ed il di cui operato coni spon~aa11e_suip.d~c ate condizioni , deve avere un effett ivo non maggwre d1 160 uomini: ridotta allo stato ordinado di pace deve pre sen~ tare quello d i 110.
< Le rag ioni che ci inducono .a stabilire queste cifre, sono le seguenti : ,
a) Una comp~guia sul p i ede di guerr a d eve so vvenire a' suoi b isogni ed eventualità, e co n servare anco:a un numero d'uomini sufficiente ~:ffinchè :il battaglione d i cui fa parte presenti sempre una forza convenie n te . Dedotte le perdite (non straordinarie) e gl i assen ti di ogni qual unque specie ; tolti i co mandati; e face ndo larga supposizione, cp.e queste diverse rpancanze producano u~a dirninuzion e d el 25 per cento (40 uomini), la compagma rimarrà nullame no di 120 uomini prese nti , o sessaD;ta file schi erate .in linea. È questa una forza già- abbast a nz a ·impo rta nte, per cui si. :richiede per;izia e senno in chi'. la comancla, voce chiara e forte da fa r si sentire, autorità a poter sorvegliare e dirj ge_re , influenza morale che a·bbracci tutti ed infonda quell 'educazione mili.tare., potente <=>d inr,en erata che come scintilla scuote, elev a gli .animi "' i;) -
-Se la ' forza fosse maggior e d i quella ora détta, noi crediamo che ~ale riescirebbe l'azione direttri çe del suo ca.po . ed in minor grado sarebbe spe cialment e il potere moxale. Nè soffrirebbe poi l o scopo tattico, perchè di n (!)cessità le mosse ed eyol uzi oni sarebbero lerlte e facilm ente sconnesse; e mancherebbe così la ;6lidità d'uni on e nella truppa. Se poi l'effettivo ·fosse minor~; secondo il calcolo delle diminuzioni ora fatto, e · le maggiori perdite che nel corso d i po c hi mesi di campagn a su cc edono , la ridurrebb ero a dimensioni troppo esig u e e non sarebbe più in caso di mettersi in li nea e combattere (1)
b) Dai prospetti che vedrern0 in seg uito, ci verrà dimostrato che l'effettivo di 11 0 pel tempo di pace corrispond e convenientemente per preparare, diremo, ·il numero necessari o onde l'e care la compagnia alla fo rz a vol u ta dell 'armam ento di gr,erra di 160 uomini . Per ora r,j limite r emo a far osservare che se forse può scmbmre , un po' num eroso quest'effettivo, noi lo -crediamo però necessario : perchè l a c ompagnia possa in t e mpo di pace prestare i servizi sì interni che esterni a cui sarà richiesta e vi resti ancora un discreto numero di gente p r esso la medesima. Vale a dire, che l e file dei pr esenti, n on siano troppo diradate, onde essere obbligati a frammischiare due o più cò mpagnie per poter praticare le primi ere istruzioni. Se il comando del capo deve essere . assoluto in tempo di guerra, è necessario che sia la stessa cfosa su di un campo- di manovra od altra qu alunque situazio n e del tempo d i pace : cioè , diretia, sola, e :qon partecipata cla a ltri estranei . D'altronde il numero delle fi le ha una tal
(1) meno ~i motivi straordinari, ci pare che n nn com pug ni a ,di 160 uo,~1n 1 potreb be co?se1,vare un numero conv e nient e ·,li JJT'<'Seut i pe r du e mesi eh camp agn a circa srnza bisogno di ~sser rifornita. Ma ~·intende, dw 0 , 11 hu~n organ_i zzat o~c •de".e aver pr_eparat.i e semp re pronti ni depos ili i rinforzi da 10v1urc ,u1 corpi per ogni evcut o od occoneu:.:a.
10 ORG.ANJZZAZIONE
1° Della forza.
q_fal influenza morale su l soldato, e perciò sarà cosa vantaggiosa, ch e l ;apparenza, d' una rr on t e un po' -estesa <lia l'idea della forza propria; cosa questa che non si può ottenere se p er le esercitazioni i nvece di comp ag nie ci appari ssero piccoli drapp ol_li.
.. e) Esaminando ora la for m a zi one organi ca della compagnia , vecliam,o come possa svilupRarni . Per questo fa d' u opo clie già fiu cl' ora m ettiamo §ott' occhio il prqspetto O dell a nostra formazione, comprendendovi , il qu adr o ripa-r;tito seco ndo lo vo rressim o figurare ; onde a primo asp etto ra'Vvisare l ' intiera forza cli fo rmazione. Da questa forza poi procureremo di , climostrare il passaggi o pel completo a rmamento p er l a g uerra.
Da questo pro spetto risulta un effettivo generale di 180, • ossia venti Hon1.ini di più del num ero volut o . Tenen d o conto delle . perdite che succedo n o nel corso di d od ici . an ni - de ll.e ·ferm·e; fa d ' uopo v i sia, questo suppl emen to di forza percl1è non difetti qu ella reale del 'temp o d i g u erra di 160, essendo esse nz iale che la compa.gpi a -_ abhia il s u o effettiv o inti erameut e com plet o nel rriomento i n cùi si opera l'armamen.to .

Infatti arrestiamoci a, fu.m e un ·bre,,+e , calcol o .
Le classi provinciali da noi post& in questo prospetto O, della forza di venti uomin~, compr esi un caporale ed un sc elto per ci ascuna, allo scadere del terzo anno del primo servizio deggiono riempiere le vacan ze dell'ordinanza (!), Ora dunque; il t otale dì. questa ordinanza, come dal prospetto C., compresi i caporali, tamburino, trombe ttieri e soldati è in numero cli 40 . Fatto conto delle morti; d elle promozioni a sotto uffiziali della compagnia, non che della parte di graduati ch e può co mp (;lt erle dov er forn ire agli stati- maggiori _: . tenuto conto dei va.rii · r.ongedi assoluti, o di altra perdita qualunque; si può pre- _ s umere che qu es t e vacanze annuali saranno nella pr.oporzione del sesto a l quihto di el etto n·umero 40 : e perc iò l e classi che ultimato il loro primiero servizio-sono li,cenz iate, saranno diminuite di altrettanti individui passati n ell' ordinanza; ossia, per lo meno ridotte a gi&attordici u omini circa (ra,gione per cui nel medesimo prospetto O, s'ono calcolate a settanta soltanto le cinc1ue class i in co n uedo,t, limitato).
Richiamando queste classi per passare s ul piede di g u erra, oltr e alle perdite a n co ra suceodute duran te i l tempo rimasto in congedo, vi saranno alcuri.i soldati non più idonei _ ~l servi.zio; ovvero (nellé classi più anzian é in isp<;l oi e) se non iutier amente inabili , alcuni v i saranno pure t;he abbìsogn er{t ·collocare ai depo siti, od altrimenti pro,
( 1) Pr-imo sluilìo del reclutament-0, Lette ra A,
12 ORGAN! ZZAZ!ONE
C ' • Formazione della . Com1rngnia e sua situaiione nei tempi ordinari di ·~ace. ' I' ln sen-iz io e :3 I sott o Ie armi ., .., ------- ~:§ ,,: ,.., 'I I -~ == z DE NOMINAZIO NI ..::: ~ " == '-' • ·;:; "' e :'.l ·;;;~ <"l = •n := ,., ;. -e -=-:o .. - ? 9 ,... u- (,,) ,... o o: o -= o ,E-- E-' Ufficiali 4 » 4 }) 4 Fui-ieri I ,, 1 }) I , Sc rg èul i contabi li I » 1 » 1 Se r gent i 4 » 1, » 4 Car,01·a li 6 2 8 " 8 · 'l'a i h burini 1 " 1 " I '!'r om betti é r i .- :1 » 3 )) 3 So!clal.i scelti ( provinciuli ~clic due classi 8 2 10 10 più a n zi a n e s otto le a rmi} • ' . · ,.,, )) ld or di nari (d 'ordi nanza) 22 " 22 )) 22 Id. de l 3° anno di 1° s e r v izio (prov 11} I )) 18 , 1 S " 1 8 Id del 2° id. • id. ,, l!l 18 " 18 Id d c !' 1 ° id. ( rec l ute) .,, 20 · 20 ,, 20 Capo '.·~\ i pro~,inciali ! I )) }) " 5 5 d e lle 5 class i in )) .. 5 5 S r e l LI · 1d. ·coo gcc\o limitato ) 60 6Ò SÒ!daf.i ord inari id . )) }) " T 50- 60 ~o - - -70 180 01 UN, ESERC, 'rO 13
PR OSP ETTO
.
vedere, perchè non potrebbero sopportare Je fatiche della vita de i campi.
Finaimente crediamo sia necessario raddoppiare i graduati di bassa forza, n el spiegare, . come più volte dissimo, le intiere forze sotto le armi r,del che racioneremo ' o nel seguente articolo), ed abbenchè vi sia qualche , caporale nelle cinque classi richiamat~, bisognerebbe in , ogni modo tr,àrre gradatamente dai soldati qu~lÌi che : ancora mancherebbero .· : ·
Non crediàmo' adun.,que cli errare se dal numero dei soldati or.dinari d elle einque classi, al momento in cui verr ebb ero a prender posto nelle file, anno verati a numero sessanta nel ripetuto prospetto O, si debb~· togl'ierne quasi la ·metà; ossia se riduciamo quel numero a trentatrè
Questa deduziçme fatta 1 avremo così l'efl~ttivo di guerra di -160 uomini, com.e è dim?stratq nel segw~nte prospetto D.
PROSPET T O D
Situazione della Compagnia di linea sul piede di completo armamènto · di guerra (1). , ·
DENOMINAZIONI ..
Ufficiali .
Ftlricl"i . .
Scrgrnti contabili . . . .
Scrgent ( (onlinnnza o provinciali)
Caporali {ordinanza o pro\'inciali)
Tamburini . ·
Trombelticri . . . . .
Sol<lati scc,lti (ordinanza o provi11cia li )
Soldati orrliu"ri ·d'ordinanza · . . . . . .
. 1d , prov!nciali delle 3 classi già ~otto le armi .
Id. prov111cial1 delle 5 classi richiamate . .
{l) ' In questo prospetto havvi un . uffiziale di più del q'uale diremo quivi rn appresso. . . ·
Non abbiamo voluto fare gran~i variar,ioni nelle cifre deU:orclinanza
2° Divisione dçlla compagnia d i fanteria e comando , · os{iia quadr o. ·
Per stabilire l'effettivo della compagnìa, abbiamo dovuto annoverare n ei prospetti le cariche o . graduati ; e perciò è ora nostro dovere di· ragionarvi sopra; dire cioè i motivi che -- ce li hanno fatti in questa guisa concepire .

Ci fa . d'u,opo premettere: essere nostra t onvinziorie che i quadri, massime allorché Ie truppe si trova.no in campagna, qeggiono esseT numerosi. In questa maniera la compagnia può dividersi in un maggior numero cli frazioni; perci0 · l"autorità diretta essendo esercitata sopra · pochi individui, riesce più efficace., è 11?,eglio intesi), la sorveglianza e la direzione, più solido si ottiene lo spirito militare e più viva si manifesta l'energia. Dalle quali 'Cose tutte , ne derivano l e sublimi qualità di abrn~gazioll(~ e di ·amore della gloria. i ·
E saminando i quadri descritti nei due precedenti. pì:o• spetti , troviamo in quello D cinqv.,e utfiziali preposti ai princ_ipali comandi, dei qua.li i l primo sarà il capitano_. · degli altri, due· saranno tenenti e clue sottotenenti.
Le attribuzioni del capitaino sono specificate nella .seguente definizione, da noi altrove emessa: «·Essere una » autorit~ assoluta, ordinativa, diretta complessivamente • sulla truppa; e risponsahile » (1) Per cui si comprende che queste attribu?:ioni essendo doveri che si riferiscono all e
del prospetto C, per non recare confu~ione nel confronto' <lei due Pro~petli C e D: ma nel passare su°tpiede di guerra, 1:lovcndo~i aumentare '. graduali, e la ma~gio1; parte -traendosi dal l'ordi1'ianza, saril certo scemalo , 11 _ numero di essa . .I): pm· qilcstù la ragione per cui abb iamo credulo meglio dt m_cllere tu:li _i graduati neHa colonna , dell'ordinanza; s'intende però che '. prov111ciali suppliranno alla deficienza oppure indistinlam cn.J.c i graduati saranno sì dell"una che dell'altra spcci.e, senza che ciò possa a[tcrarc la forza complessiva c!imostrata in qt1csto prospetto D.
(1) •Àlc14nc con$iqera:i;ioni Sl!?lci di$ci pl,ina n1i/.it{t1·~, pa$. 2:;,
14 ORGANIZZAZIONE
" ' -;; "' C ' :3 ., "" e .., ·= ·> .., 9 ... è o li: ' ,... - ~-~ -5 )) 5 l 1 l » I 8 )) 8 ·16 D 16 1 • I 3 )) , 3 8 8 16 .20 ,, 20 • 56 56 33 33 -- -- -63 97 160
DI UN ESERCITO 15
condizioni gi; più volte ripetute.. di tattica, di disciplina e di amministra:zione; doveri, che pure si disse ., ~ono dìr etti ,td OQ'IlÌ individuo della compagnia; bisogna per e . . . prima tosa che essa ve!1ga divisa in princìpali fraz ~o1~1, alle quali siano preposti gli u fficiali subalterni . Qu esti , noi brameressimo poi che n e fossero, per così di re, i ~api' ti to lari , i con t inui e irremov ibili superiori ris p ònsabi1i verso di ess9 capitan o . Dividiamo p erciq la comt>agnia. ip d1.w mezze comp agn ie, d i . c ui vorres,s_i~o- ch e ognuna fos se comandata da uno dei te nenti . Suddividiamo le m ezz e compag nie in due .pelottoni ( quarti d ella compagni a) ed a capi d'ogn i secòndo pelottone stabiliamo i sottotenenti. Con ciò ògni uflhiale subalt~ruo co manderebbe una fra~ione cli quaran ta iwmini, di cui le pa ri sarebbero s u bordinate alle disp ari (l). · . VenendÒ poi la compagnia. messa s ul pied e cli pace, nèi limiti cioè d el prospetto C, qtieste frazion i sarebb~ro ridotte a ventidiie o ventitrè uomini, per cu i si potrebb ero 0 riun ir e i ·pelottoni du e a d1te, o co n servaee soltan to i coma.udi d elle m ezze compagnie: e sebb ene possano offrire ·una forza di ciziqu,anta, uo mini circa ( nu·mero non molto sup erioré a qud lo ·dei pel oito ni di guerra), trat: • tandosi di comando nei presidii e caserme , non pno esservi impiccio, non d ebbo.no esservi inconv~nie.nti d! sorta ,p er praticare questa riunione. Questo c1 da. cosi l'arbitrio di togli ere u n uffiziale subalter,no (ed appu nto lo troviamo in meno nel prosp etto C) . · .
Preferiamo che ·questo uffiziàle i n meno sia uh sot tçit enente e non ·un tenente ; perchè in tal modo non si cambia la natura del comando delle me.zze oompagme (smnpre devoluto ai di.le t ènenti), e vi resta il sotto tenente !
( 1) Per il, go~crno disciplinare della lruppa, ~e-_r le allribui:ioni •?;)~ha il furiere della cornpagnra (di cui pàrlercrno qu1v1 dopo) e .per I~- nJ1glwre ,1:,;:ecoz,ione delle evolu zioni, noi sia:no ù'an'iSo , siauo uc c e ssm1Jl q ua ttr o uffìz.iali' subalterni e non ~re soltanto .
nr UN 1<:s1mc1·ro l '7 a dispos izione · per aiuto di ogni s pecie d'incumb enze e per surrogare l'un o o l'altro tene nte assente, o temporariamente mancante. Ragi on vi:1ole adunque sia qtl'esto l'uffi cio d ' un u fflziale d i minor grado . ·D'altrond e .tenendo Conto de i Sflntim enti di amo r p ropri o o cli ambi,zione , e . quindi de l buo n volere e sp irito milita re; noi crediamo, ch e noi primi a nDi del la c, ~rri er a 'd'un u-f:fizi a1e , in t empo eh p a ce, in cui l'av an zamento s u ole essere ris tretto e l ento, sia v antaggi oso che i g iovani uffo:i a1i sco r gano una non t,ropp o- l ontan a p ro m ozion e : e possano lusingarsi cli u p·n d ov er fa r u na troppo hrnga stazione in quel primo ed inferi or grado; la qu a l ccisa s uccedere·bbe senza dubbio quando inve ce vi fossero due sottotenenti ed un sol tenente.

Quantun q ue gli u fiiziali ab biano il governo dell~ compagnia, egli è pur necessario vi sia u n sott'uffiziale supeF ior t• a tutti g li altri g radu ati di bassa forza, il qu ale tro_vandosi sempre ìn sfom e alla truppa, eserciti u n 'autorità generale per v egliare che qu esti graduati d elte d iverse s uddi:visioni eseg uis0a.11u u fac ciano esegui re g li urdin i del ca pit ano o degli a l tri uftì.c.iali con rnodi uniformi e contemporan eament e . Le sue principali attribuzioni saranno p erciò : raccogliere i ràpp6rti, comunicare gli ordini-, e diri gere l a parte contabile , e speqi alm ente l e paghe, il vitto ed altre so;mmi nistranze.
Queste inc umbenze quiv i sommariam ente esp oste, cos tituis co no i l foriere della compagn ia, ca.po d ei sott'uffiziaìi p er disciplina ed amministrazioirn. Vorrèssi mo però cbe l a. s u a ca r ica avesse maggior imp ortan za r elativ amente alht prima attrib uzi one . Il forie re dovrebbe certamente provve dere a tntti i b i sogn i , sì pec1..<niàri i c~he materiali deila t r uppa (a norma de' vo1 e(i del capitan o), e perci ò dovrebbe avere in tel ligenza e co gnizione dei l avori cor;itabili eh~ ·sì· r ife riscono a q ues ti bisogni ; m a non crediamo doverlo obbligare, ad occuparsi egli stesso deìla loro com~
J 6 01\GANIZZAZIONE
ANNO VL . Vol. I. - 2.
pilazione . P er questo indicammo dopo lui (nel prospetto) -il sergente contabile, il quale, sotto l a s u a sorveglianza, eél aut orità, avrebbe questo incarico ( 1). In q u est 9 mo do i1 fu riere è u~ superiore, che, non obbligato a lavori complicati di conteggio , ppò megli o occup·arsi d ella sorveglianza della dis cipli na; e questo rende più facile .ezi andi o rinvenire fr a i sott'uffi zi ali quelli che abbiano in maggio r copia le qualità richieste 0
Il ser gente contabile è un graduato speciale. In Francia è un sott ' u fficial e oppur e un caporale . In Aus tria, se no11 erriamo, d eve essere t uttora di ugual gra d o del furier e . Nell'armata sarda fu altr a volta m1 impiego parti colare (il cap orale furi er e), poi div enne un'incumbenza affidata ad un caporale senza distinzione di , sorta; ma in ogni modo non fu mai considerato se non che u n o scritturale dato i n aiu to al furiere (e già non poteva esser~ . altrimenti, essendo capor ale soltanto) e fu sempre i l furiere il . sol o r is p onsabil e d ei lavori e delle ope razioni contabili. Or d u nque volendo . che quest o graduato si a il vero cont abil e, noi" forse avressimo p ropensione di · accosta{·ci al sistema tedesco , po i chè l a sua posizion e nella . gerarchia sarebbe più in armonia colle sue a ttribuzioni. Siccome però il governo d ella . truppa, di q ualunq n e g~nere egli si a, non deve mai·scostarci dai prin cipii d ella subordin a:lione graduata, !'l sa rebbe un er rore ammettere questa a utorità cont ab il e a lato ed uguale a q uella di disciplina; non v i può essere che un sol capo : cioè il furier e : però noi op iniamo che il contab ile d ebba essere del grado im m ediatameJJ,te inferiore : ossia u g uale ad ogni altro sottouffiziale d~lla_compagnia; onde n on avere dei doveri di subordinazione per le sue operazi oni , salvo che ver so il furiere e gli uffiziali della compagnia.
(l) Q u esta br vc spi egazione d e lle uttribuzioni de l furier~ conforma quanto più sopra fu. detto, che non deve avere il com ando di un pdottòo.e <lç!l~ co inpagnfa , coJnandu dcvol uto a g li , uffizi a li subal t erni soltanto
Abbiamo già più sopra divisa la co mpagnia di ·guerr a in quattro pel ottoni comandati dagli uffiziali s u balterni . In aiuto di questi u ffiziali; _ e così ad ogni p elottone, noi v0 rr essim o app licar vi due sergenti i q u àli avreb bero la direzione d ella m età di ess o , ossia di un a squad1'a . Divid eressimo àncora p er u ltimo queste squadre in mezze s quadre a c u i sar ebbero capi i caporali .
•Cr edi amo inutil e- lo specificare l e attribuzi oni loro : l e _ possiamo r in:venire in . qualunque r egol a m ento -d i discip lina: osserviamo soltanto che questa ripar t izione è in correlazi on e; è , per così dire, la cons eguenza di quello ch e abbiamo espresso n ell' esordire di questo articolo s ulla sorveglianz a e direzione m inqta ·di tutte le parti e dei singoli indi vidu i; per ctù non v ' è altro mezzo per ciò ottene r e , se n on co l / fare divis ioni e s uddiv isioni .replicate della compagnia. Crèdiamo quindi che le diverse a utorità o , comandi, sebbe n e stat ui ti come in qua,c;i tutte le annate, sono però più appropriati n el modo da noi progettato pe1; l' a11damento éli governo in qualu nque circost<l.nza, e la conèatenaz ione delle autorità sotto quella assoluta del c,tpi t ano ri esce meglio intesrl e n e è più facile l' eserciz io ( 1). · ·

Per m eglio convinc erci di questo , vogli a mo app1icare qu este d ivisioni al n ume r o p resentato dal prospetto D, epperciò :
La c ompag nia essendo di 160, comandata dal.capitano ; La mezza comp agnia sarà <li 80, comandata da un tenente;
Il q uarto, ossia il pelo~tone sarà di 40, comandato da un ten ente o sottotenen te;
( I ) Sa r ebbe nostro pro ge tto 'di r agiona r e delle evo lu z ioni della fanteri a in a ltro st ud io . Da lle i dee che ci sia mo forri.1até a <11:1esto proposito, c rediamo ' i n tan to pot er d ire, che le sud d ivisate ripartiz i on i di com ando , sarebbero pu r con veni en ti cd a dottate per le cscrcitazio1, i o manovre d j com pagnia.
18 ORGANIZZAZIONE
DI UN ESERC I TO 19
•
L 'otta,vo o squadra di 20, c9mandata da un sergente; Il sedicesimo o nwzza sq Lrndra ·di 10, comandata da un caporal e (1) ._
!tamburini ed i tromqettieri, q uantunque non grad uatì, sono però delle specialità : hanno un servizio loro pàrticolare, epperciò si suole annoverarli anch'essi nel quaaro della compagnia . .
· Se riconosci amo utili e necessari ·.degli istrumenti' per iE.dicar e l a cadenza del passo, -animaré la truppa a mar- · ciare o dare segnali di movimenti ed anchè di evol uzioni; ci- pare, sarebbe più conveniente, se non so.stituire h troml:>a al tamburo, almeno fosse l'istrumento d i maggior conto· pel servizio . ' _
Il tamburo serve per le prime istruzioni, onde segnare a dovere la cadenza e l'unione del passo. È conveniente nelle evoluzioni per là regolarità dei movimenti; ma è però tale il suo chiasso, che fa d;uopo usarne con moderazione; e perciò s'indica la marci a con qualche battuta soltanto , altrimenti: le sezioni ,,icine non possono. udi r e i comandi dei loro capi, e quelle lenta.ne per l o più non distinguono la cadenza del passo . ln ogni maniera 'b isogna cessare di battere allorchè il comandante de l battaglione o della linea deve dare aei comandi . Peggio sarel)be l a cosa se ;nelle diverse sezioni (nelle prime scuole) ciascuna adoperasse il proprio tamburo, o se nelle evcil{izioni battessero . i diversi cç,rpi di tamburini - con~em poranea-
, ( 1) Nel corso .<le i no§tri rngionamcnti potendo accadere di nominare parecchie vol t e queste fraz ioni d i COJnpagnia, ci permell i amo· è i chiamare la mel!'z~ compagnia, ~czione e la mezza squadra decuri(I. Denominaz ion i più. hre,, i, e cred iamo -abbastanza signilìcativ<:.
Secondo q u ello che p i ù sopra fu deU.o : l a compagnia venendo ridolla alla forza d i pace; rimarrebbe div isa in due sezioni di 5 2 , comanda t e dai tenen t i. Le sezion i divise in squadre di 26, co~andale dai sergenti · ' . ' e qneste divi ;(' ·i n decurie di • ~, comandale da i eapo,rali. S iccome vi sono ' s e!Dpre delle defic i en ze a ll' effettivo; si può calcolare che queste divisioni sarebbero presso a ,roco ugq!\li a q u ello ~cl piede d i guerra, - :
m ente. Non vi sarebbe più mezzo di con·servare la regoJarita dei mov im enti; vi sarebbe confusione, e le mosse rièscirebbero disordinate . , ·
Ili campagna :f fa uso del tamburo per la sveglia nei càm pi, per le raccolte n egli accantonamenti, per ripetere gli avvis i o segni• d'al1arme; ma sorio moltissi me le circostahze però in cu1 è vietato di battere, onde non segnalare la presenza di truppe al nemico. Nei combattimenti raramente~si batte quando si marcia, cioè soltanto per dare la spinta .degli assalti, nel cui caso il tamburo è essenzialmente necessario. Finalmente si adopra ancora per festeggiare i trionfi, rendere più. dignitosq 1o sfilare della truppa quando vien passata in rassegna, oppure quàndo si entra •vittori,)si in città o piazze di guerra .
Riepilogando adunque l'uso del tamburo, si limita alI'ist?·uzione, •agli assalti, ed alle parate .
Queste cos.e, dire:rp.o così, costituiscono l'opra od ufficio del tamburo nell'esercito: or v e diamone i difetti.
Il taml)uro ·è foggiato in modo assai i ncomodo per por-t~rlo nelle marcie ;da colui - che h_a un zai_no sulle spalle; se oss erviamo, i l tamburino non sa veramènte ove coll ocare questo suo ·imbarazzante istrumento e camm inare con minor disagi o; egli si trova poi i n peggi orr-condizion i allo r quando de,,,e battere la carica, passando nei campi, a traverso siepi-1 cloven·do saltar fossi od arrampi cars i pei monti col tamburo appeso davanti che 19 percuote nelle gambe . In akune armate si esige che il tamburino abbia ancora una carabina. ·Non è da ·biasimarsi il pensiero che sia anch'egli armato, op.de, se non comba~ tere , almeno potersi difendere; ma possiamo noi -ragi onevol mente prete11dere ,ch'egl i conservi tutti questi oggetti guerreschi? Nei combattimenti getterà via 'od il tamburo o·la carab1na , e probabilm ente piuttosto il primo che la secon d<;l- -(1). Malgrado la forte struttura ·della così . e.letta ( I ) In nna 1'ili ral.a, massime esegu i ta in fretta, si vedono non pochi tam b uri abbandona l i n~ i ç~mpi o fossi.
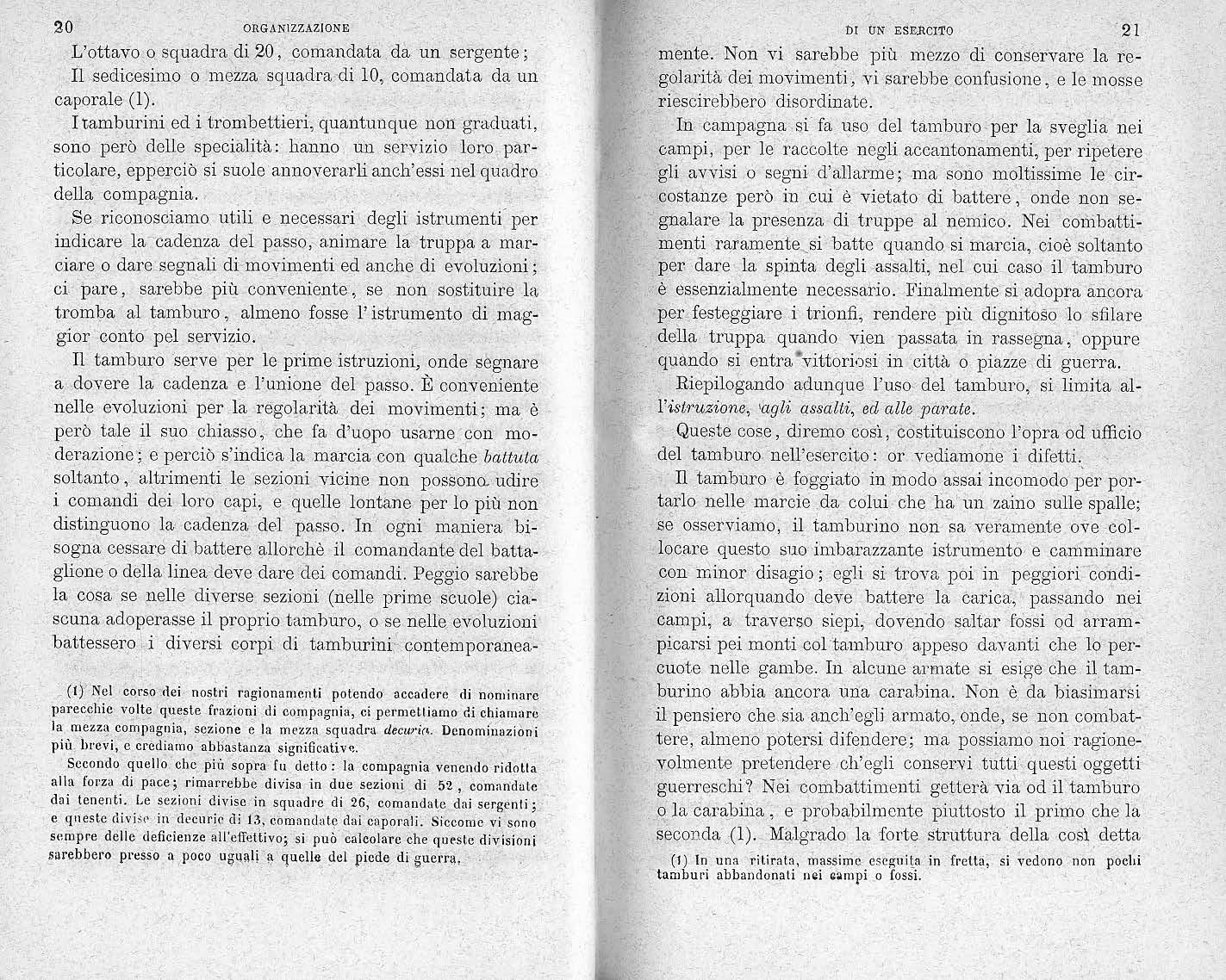
20 ORGl).Nl ZZAZIONE
DI ùN ESRRCI TO
cassa il tamburo fàcilmente e· bene spesso in campagna ' "'f -è g uasto : il caldo, l'umidità, deteriorano le corde, e le pelli; queste in ispecie .sono ' 'talmente delicate, che si rompono per ogni l_'Jiccolo urto o colpo mal dato battendo, 0 per ogni piccolo acddente . Non è certo .esagerazion e nostra se diremo esserci accaduto più d'una volta che di otto ·tamburini di un battaglione , non ve ne era neppur uno che avesse il tambu:ro atto ?,l suò servizio. Noi tempi piovosi si sente appena; e nei tempi sereni sto rdisce da vicino, ma non si distingue più l a specie di battuta ad una certa: distanza; e p er ciò non cònviene affatto per le manovre dei cacci àtori .
Ponderati adun que ì vantaggi ed i svantaggi; e più di ogni altra cosa, . considerando che il tamburino è un irt. dividuo di nessun conto come combattente; noi osiamo opp~gnare l e .antiche ed ancora vigenti COlì,sÙ.etudini col ridurre ad uno il 1mmero èl.ei tai11burini di una com- pagnia: Riuniti i - tamburini del battaglio ne o d el corpo, basterebbero pei bisogni è servizi: ora detti; epperciò
vc)l::remmo invece dotare di trombettieri le compagnie, i quali essendo armati di fucile _ al pari degli altri sold ati, servirebb ero nelle marci e fr ammi:!"chiati ai tamburini e musica. Li stabiliamo in 1;.umero ·di tre, p ercb è corrispondano al b i sogno . delle evoluzioni o com b attimen t i in ordine sparso, nei - quali, come abbiamo veduto più sopra, p uò ·es s ere e'ziandio impiegata la f~nteria di linea: massime nel servizio •dei posti avanzati- o di avanti • < g uardi e (1)
(!) Nell ' arm:Jta sa r da si fece un cspcrime,!to. Sic,1nme nellll organizzazione del 1852 vi èrano ·poch i tromb,·tticri non abbastanza · i11 numero per la scuola di caccia to ri , si fece l a p r ova d'insegna r e il suono del l a · tromba ~i tambur i ni <li qual c he corpo . La cosa r iesci egregiamente. Venne pèrò rivocata q uesta conccssio11c, sul rifl esso che p robabilmcnte in · camrrngna quei tamburini si sai·ebbcro disfàtli del t wmburo e i ·itcn 11/a lrL t-rombu s oltanto Sarebbe qol'Slo un male riprov ,w o l e c,mi"c l o è qualunque cosa contraria alt'ohbcdicnz,1, e di danno all' armnmN1to e d i scip l ina: mli

Questo tamburino e questi trombe.t'tieri dovrebbero essere d'ordi11 anza e la maggior pàr t e provenire da apposite scuole od istituti (1).
Se l 'esame del quadro è con ciò ultimato, ci occorre p erò cli completare quéllo d e-i prospetti .dati col far parola eziandio della prima categoria di soldati denominati scelti. Questi soldati, per la loro condotta ed anzia:nità. m eritan do ima particolare ' considerazion e, vien loro accordata una distinzion e ed un piccolo auniento di paga. Egli è adunque un premio dato il p iù soventi a que1li che per poca coltura od attitudine non · sono idonei ad avere un grado: Se è ben fatto - sia conservata questa ri compensa pei soldati d'ordinanza, noi vorremmo però t
q u esto p r ova il nostr~ assunto sia r.e!ativamcntc ~ll'istrumenl~ più utile e prefer ib i le, come pe r il magg io r comodo ,d ~ll'individuo. Osserveremo c h e generalmente i diso r dini o spreco in fatto d ' armi, \li vestiario o d'arncsi ( in nn esercito ordinato) proven g ono da cngioni non ~empre inginstc od i r ragionevoli . li so l dat(l co1nprcndr, ossia sa dislin~ gu<'rc gli ogge.tti cl!e gli sono utili e quelli che non lo sono; ,, qu i ndi: se lo può, c<irca sbarazzarsi dr.gl i inni.ili. I vete r ani dcll' tmna l a sarda s' ricordera nno come in u n tc01p;1 era difficile l'ottenc~ e cbc i soJ.-!nti nen si t,, glièsscro la cravatta nrllc mnrcic o viaggi : ciò ad1ivcniva d ~cchè la cravatta e r a di <lui-o cuoio: era un i nsopportal,ilc fastidio avere l a gola ed il collo r inserrato in quella specie di co l larP, vci7a gogna d1C condannato : era come ·una tormcnl"osa stecca che rendev a rigido _ogni movimento de l cHpo Non si potrà fo r se .-l i r e la stessa · cosn del tamburino? _ , Vog l iamo essere sinceri, cppcrciò non nasr.ondiomo i l nostro pens i ero, dichiarando ~he, se non foss e con ,provato non poters i far l! meno del t amburo per gli assalti, avremmo a,, uto l'ardire di proporne l ' assoluta abo l izione poichè anche que l solo t.amburino a·ncor lasciatò, noi l o ripuliamo un individuo male in arnese pel sen i zio d è ll a fante r ia
(1) Si dovrebbe stabi l ire u no o più depositi d i al[ievi, in nurncr_o sufficiente per riemp i re le frequenti vacanze clJc succederebbero nei corpi, poich è è nostro avviso che i tamburini e lron,hettieri deggiono concorrere n,•l\'avanzament o a l pnri degli nltri soldati , e cess are quella specie di · • riprovazione che tuttora rimane negli escreiti contro di essi, pe r cui <liffìcilmeotc r i escono a "'poter prog r ed ire. Noi crediamo qu esto un prcgiu1\izio, per cui talvolta. l'inge g no è sag r ificatci al grct~o p ensiero d i volere un corpo di tamlJurini perfetto ne ll a sua fragoro s a armonia .
I n altro capo parl eremo dell'armonia mi li tare.
22 ORG ,\N IZ7.-17. l(lr-;F.
DI UN ESERCITO 23
ÒR:GAN!ZZAZIONF. che non ne andassero affatto esclusi quelli delle cl a:ssi _provinciali ; epperciò d esiderer:.emmo che , percors0 il primo anno, -del p r-im 'o servizio in ogni classè, scelto c h e fo_sse il caporale ( di cui' discorre remo quivi dopo), _ fosse confetita questa distinzione ad u n o fra i suoi soldati .
A.bbiamo conservata l a stéssa qenomiuazione, pe1:chè è più appropriata , e specifica, che non ·solo deve · pxev·alere i'anzian:ità, ma prima d'ogni cosa la condotta.' È dunqu e·da preferirsi il nome di sc elto a quello di anziano o di p1·ima classe; la , parola classe dev e ' soltanto riferirsi alla l eva. '

Dagli argomenti svolti intorno a questa formaz i one della . com pagn ia, si possono trarre delle ;conseguenze, sulle quali ci pare sia ne c,essario meditare, anche forse per andare incpntro ai clUbb~ od obbiezioni c he si potreb befo fare .
, 1° La proporziqne dell'ordi n anza coi provincia.li si di;;ve calcolare dal prospetto -C, il quale rappresenta, l'6r- , ganica fomiazionè. ·E perciò , dedotti g li ufficiali, l 'ordin anza s omrria a qua1;antasei e l e otto classi provinciali a centotrenta. La forza total e 8ssèndo cento settantasei, vediamo quindi che l'ordinanza è n elle condizioni da noi stabil.ite nel reclutamento (vedi ivi della for z a e del servizio, l ettera C), pòichè sorpassa pur anche di quakhe cosa il quq,r·to di q1.1,esta forza totctle;
. 2° Nel passaggio dallo stato di pace a quello di guerra la -compagnia deve risultare come l 'abbiam descritta nel prospetto D; e se fossero minori le rnancanzè di quelle da noi ragionate, s i ç!ovrebbero nullameno togl i ere i meno idonei, onde non sià di -u11a fQrza maggi ore di qu ella ivi specificata. Ma se per contrario dallo stato di guerra s i ritornasse a quello di pace, egli è quasi certo che l'ordì-nanza sarebl)e considerevolmente scemata: or dunque nori si dov1'ebbe - completare, n el m9do da noi indicato, tutto in ;na volta, po iché potreb be succedere da ciò che l e \ 1ltime., classi arruol ate durante la guerra," alle quali spet-
terebbe riempire quel vuoto, sarebbero quasi intieraìnente assorbite. È meglio adunque resti 1'ordin a-nza incompleta e si 1jfornisca a poco a poco cqlle nuove classi che successivamente sa r ebbero ascritte.
Diciamo· q u esto per compl e tare così tutto ciò che si riferis ce alla 'forza nei rassa.ggi da una aJfaltra situ azio~1e, . di pace o di guerra.
3° Egli è ,necessario d efin ire ancora il mpdo con cui s_i 1:iotrebbero-trarre i graduati nel. tempo di guerra, onde, a ·norma del prospetto ·D, poterli duplicare e cons<::rvare a numero.
Sebbene, parlando dei quadri, nel primo -ragionamento abbiamo -decretato che i grad uati deggio no pr~venire _dall'ordin~nza, ed anzi abbiamo fortemente " sostenuto la necessità di questo elemento di so ld ati a ~questo scopo principalmente; non perciò ci pare -doYrebbero i provinciali essere esclu si dal beneficio dell'avanzamen to . È massima d i buona disciplina ossi a di buono spirito m ilitare che qualunque soldato abbia la sper.an,za di potervi aspi... rare. Questa è la ragione I5er cui avrem mo voluto che nelle class i provin ci ali , dopo il J)rimo ai:ino percorso del primo servizio venisse promosso un caporaÌe. .Ciò pre-· messo-, osser ve r emo che é).Ooiamo quq,ttro sergentCe dovressimo recarli ad Ptto. Pe~ avere questo numero sar ebbe megli o trarre i qu.a.ttro mi:i,nc.ant i dai c,aporali d' ordinanza, quand·o che ,& i opel'ç1,sse l'l.ì,umento per i l totale · armamento di gùerra; poich$ 1~ più antiche classi ricbia, mate sott o le. arm i giungereb·bero alquanto disusate· delle cose q.i ser vizio e della cli.sciplit1a; e sebbene con loro riton;ierebbero çinqu(;) ç~por~li' ll-,ll Qhe : s uppo sti anziani' 'non sarebb è ro probabi l mente a b basta nza capaci per quel i:uaggior grado . Da ciò ne deriva che d1 sei caporali eh ordinanza ne rimarrebbero due soltanto. Dovendo l i surrogare, ed. anzi recarli a,d otto,- nulla osterebbe che ve" 1 nissero promossi dei sol~ati meritevoli, p ur çl'ordinanza,,
24
• 0 1· UN ESERC!T0 25
Nf3ll e classi provinciali po i già vi sarebbero due capor ali · d elle classi sotto l e armi pel primo servizio, e giu n gendone cinqile con quelle richiamate, non occorrerebbe ·prom~overne ancor uno per compiere in tal modo il quadro . Ques t o pel primo riordin amento , come viene or -dettò, poiché nel t empo più o meno lungo ch e l a co111pagnia ri marrebbe sul piede d i gueri-a a nulla monta che i graduati venissero l)Oi prescelti sen za distinzion e alcuna pii:Ì nell'una 'che n ell'altra s pecie di caporali e soldati (1) .
II.
Del battaglione nrlla fanteria di linea.
Abb iamo detto che l a compagnia di fa n teria di line a è una sezi one tattica , sotto l'as p etto ci oè di parte ·di 1m tutto o di frazione di u n'unità, qual è i l battaglione· . Il battagliòne è dunqu e il -p r imiero assem bramento t attico della fa;nteria , su cui s i formano l e maggiori riunioni . Egli serve cl i ba.s;P- pe r l e evoluzioni. La forza della fanteria si calcola da questa unità . Il suo comando è il produttore od efficiente di quello di corpi maggiori.
Le condizioni espresse p er l a co m pagn ia sara1mo quindi più importanti pel battaglione, p er cu i allo -s copo tattico d e ve corrispondere l a forza , a qu ello della disciplina o d'amministrazion e dovrà soddisfar vi il comando, oss ia la formazione del suo s t ato maggiore.
· 1° Della for f a,,
Se volessimo prendere per nor ma i battag li oni delle . diverse armate eur opee per stabilire quest a forza, s arebb~
( 1) Quantunque le p romozion i non si facciono sempre nella stessa co mp agnia, tuttavia i l nostro calc o lo può approssimativamen te essere giusto, po ichè dovcnù ~s i dupli_care i qu.~d ri e somministrare i g r aduati agli stalim aggiori , si può c onghietturarc che il movimento sarebb e prcsslJchè ugualmei]lc r ipartito in tutte le compagnie di un corpo ,
· assai difficile la cosa, poichè, varie ne sono le fo rm azioni. Invero sono moltissime e g ra vi le discussioni che emer gono da questo soggetto . Non sono punto ulti mate e. no n ·ancora è decisa l a question e, e da ciò ne deriva • q uesta differenza di formazioni. Sarebbe adu nque insenS"ata p r esunzione nostra di volerci pronunzi are a guisa di Aristar cb i e decretare s enza p iù qual debba essere il battaglione . Ci l imitiamo quii:idi di espo rre la n ostr~ opini one, l a qua.le non è che i l risultato del modo di ravvisare il battaglione n el suo vero aspetto dì 1.vnità tattica.
Ta le essendo l a s u a costituzione ne deri va che il bat taglione in:· certo modo può essere considerato come un corp o ; essenao un corpo deve pot er agire da sè isolatamente, sebbene anche coor dinato con al tre truppe. La sua forza dev;e d_unque a:vere una tal q ual , consisten2,a, ma combinata colla mob il ità e fac il e comando. Vale a dire che la forza n on si opponga acciò l e mosse siano rapide ed ordin ate ; eh.e la. voce d i un solo (il comandante) sia s ufficiente per fars i sentire da tutti ·: che ques ta voce imprima in tutte le · parti il volere di chi C(:)manda : 'che questo v ole r e s' impadro nisca a!l' i stante de l / pe:iasierò ed animo di t utti . Epperciò questo comandantè non solo colla voce, ma collo sguardo ed a colpo d'occhio osservi, diriga e si assicuri' che la sua volontà sia eseguita ord inatam ente, immediatamente e simultaneamen te.
L'esperienza o .pratica d elle eose viene ad appoggiare quest e cons ider azi on i . Infatti osserviamo un battaglione sul campo dì manovra , o m~glio an cora schierato d i fron te al nemico: affiu.chè l'azione del c0mandante sia nelle condizioni or quivi indicate, n0n deve aver e una fronte maggiore di cento settanta a cento novanta metri (d1wcento venti à clA.wcento quaranta file ossia quattrocento quarwnta a · qu,attr·ocento ottanta i.omini) . Ora dunque tenendo conto d elle diminuzioni in proporzione di quelle da n oi caicol ate' per
-µna com p agnia, v iene ·a risultare che p er avere questo

... 26 ORGANIZZ,iZIONE
DI UN ESl?.RC'lTO 27
num~ro d'uomini presenti nelle file, si dovtà avere un - effettivo di numero ..seiceiito uomini (1).

· ' Sebb ene determinata la, forza in questi limiti, ci si presentano l e seguenti obbiezioni :
1° Esserè massima antica che i g1·ossi battagli oni,,vincono te battaglie;
2° I piccoli battaglioni avere iL grave difetto che i n pocò tempo, Ìn · camp:'!,gna, diminuiscono e divengono deboliss:i;ni;
3° Un piccolo battagliami non poter sté!.,re a fronte di un . altro nemico, se questi ha una formazione da ' cui r i;;ulti essere più forte.
Alla pr1ma obb i ezione r i sponderemo. che dopo i progressi della tattica nei nostri tempi, quella massima Bon ha più il medesimo valore . Dovrebbe cioè essere modificata e piutto.sto dirsi: che i niime1·0s·i battaglioni vi1icono le batla,glie sr/ben .,disposti e ben condotti : dalla qual cosa ne proviene che ' si deve . primierameute procm'are cl).e i battaglioni ;, i ano m:aneggevoli (espressione · che riassume tutto quello che ab}Jiamo voluto inte?,dere relativamente alla mobilità e comando) e questa massima è in favore de i battaglioni n on di troppo ·numerosi, ' · Sulla seconda obbiezione, osserveremo che se la climi. nuzione è causata dallo sebntro gagliardo o sfortunato col nemico, ovvero da epidemiche malattie che talvo\ta invadono gli esereiti écome in Crimea), sa.rehbe uguale il darino sì per un piccolo co me per un grosso ·bat taglione, e'd ,anzi , fatta la proporzione, potrebbe essere forse maggiore per il più fort e batta.gliene.
(1) Avendo g i1l stabilita la forza de lla compagnia, pare che ·quella del hallagli o n e debba ·dipendere da l numero di esse, ùa fissare ora quivi; ma s iccome il battaglione è l'unità, è più giusto, il d ire che i l nume r o delle . c~mpagnic dfpende dalla forza del battaglione. Con_questo vQgliamo speci6,:a rc che, se fummo coslreUi di pal'lare prima della compagn ia, si fu p<• rchè J',ihhiam ~ considerata come nucleo, però ne definimmo la for2:1 a seconda di quella eh.e già no i b)teadevamo di dare al lrnll agli'o nc -e(I a ~ec o11 J\I Jd la divisione che meglio ci pare possa convenire.
Sono eventi questi, se non . straordinari od affatto im- . preveduti·, nullameno aecidentali, che le storie ci narrano; per cui talvolta si , veggono scomparire iutieri corpi o d ivisio ni d'armata. Se poi la diminùzione moderata, ed a · poéo a poco, secogdo i calcoli presumibili della guerra , vi deggi ono sopperir e 1e riserve già pronte ai depositi per r i mpiazzare quasi continuamente 1 vuoti ·o surrogare quelli •ehe non sono -.più atti a ·fare la guerra (1) . Relativam ente alla terza; obbiezione osserviamo che, lo scopo · di un còmbattimeuto è di , ;ìncere: egli è ·qùindi essenziale procurare di mettere a. fronte del nemico una forza che possa ottenere il successo ; e· sarà certo una probal)ilità fa,ro'revole , se questa forza. contrapposta sarà maggiore. Poe.o importa po i che questa forza si11 riunita in un solo o sia scompartit.a in due Q più battti.glioni; come neppm~e sarebbe il caso d i ·fastid_iarsi delle d i cerie o relazioni eoll e quali si potrebbe crit~cai:e e diminuire i l merito d i un su0cesso , tenendo conto del magg ior nu~er o dei batta,glioni del vincitore rispetto a quelli de l vinto.
Nei combattimenti ' in cu i sono impegnati parecehi batta:glioni, non se ne éalcola più id nu m ero (sotto 1'asretto .di forza contrapposta), ma invece si t ien conto delle m asse, de1 i:nodo. di impieg"'rle, delle linee, de1l'ordine di esse, dellè posizioni, ecc.; per cui le cose ora dette su i combattim'e·nti dei battagljoni si riferiscono piuttosto a1le
( J ) In Cr imea la br igata Ci aldini ebbe la fo1•l,11nn di esse re d estinala a prender pat'tc a l l'assaltò ili Sebastopoli : Radunata la trnppa · , si Ìrovò avere battag lion i debolissimi. ,Si tenne conto di q ues to come d 'una ·conseguenza della fo r maz ione del battaglione piemontese non nbbastnnza rinme r osn.
A no s l l'o avvi~o , i l dife tt o proveniva piuttos t o da c i ò chr, qncl corpo rli spcd izione n on pvcva depositi ad una distanza convcni•'nLc (con , c san·bhr, stat o a f.ostant inopol i), ove rac co lLi i ri1Jfnrzi inviati rbl Pie m o11tc r,d i co11valesce n t. i s t a ti rin viati da l campo , vi fosse stn't.o cosi una ' l' iserv;1 pronLn sempre ·,a riforn ire i battag lioni combattènt.i; massime per ingrossqrc le file lle11'ardua e ~ublimc impresa di quel ·1,iomo,
28 ORGANIZZAZIONE
Dl UN ESERCITO 29
situazio ni di iso lamento , come 'nelle ricogni'.?io ni, nella occupazione di uu , posto, agli avamposti. ed altre circostanze simi li . Questi scontri parziali od isolati il piu so.vente sono impreveduti; epperciò un battagl io ne , secondo il caso, potrà essere più o meno forte del nemico. Nella p rim a supposi zi one, come già . si disse, è pr obabile la vittoria; n ella seconda, potrà forse·vincer e· ancora, se le circostanze le saranno favo r evoli ; cioè se la posizione sarà ·più o me no vantaggiosa, se la truppa sarà buona e ben disposta in fatto di morale; se chi la com anda saprà . trarne buon partito (per la qual cosa convien e un battaglione non troppo forte); finalmente se .vi sarà fortuna, poich é senza d i ess a nè scienza !}è m;mer o prevalgono. Tutto· questo ci comprova però ; che voler pr,evcdere gli eventi e far calcoli sul numero dell e tr~ppe, è impossibil e; vale a dire, .in guerra nòn vi è sempre l'arbitrio di destinare le forze che deggiono co mbattere, per la graJ1 ragione che non si conoscono spesso q uelle. del ·n emico; si può tutto al più giudicare deUe masse avversarie ma non mai dei singoli battaglioni . D'altronde consi deran do questa questione dal lato morale, egli è cer to che supposto anche si sappia ,doversi affrontare un baJtaglione nemico , forte, e voglia.mo anche di più di due nostri ; sembrerebbe però ai soldati di qu esti d ue nostri battagli or1i di ~ssere due contro ' uno; creder ebb ero quindi di dover p r evalere, e questa convimfone è g ià una garanzia cli v ittoria.
Da qùanto abbi am detto nel capo precedente (e secondo quello che il , b uon senso tatti co . indica), i l battaglione è diviso in compagnie, il di cui numero è diffenmt e in quasi tutte le armate. Vale a di re la divisione del battaglione essendo in relazione diretta colla for za, dipe11de in par te da essa: e da ci ò derivano le vari e divisi oni, (Diciamo · che la divisione dipende soltanto in pa~te della ,for za perchè il numero delle compagnie dipende

pur.e dal diverso modo di intenderne le mosse e le evo1uzio ni ).
· Seguendo lo spirito di meditazione, cbe ci è cli guida nei nostri studii, noi crediamo çosa uti1e il passar e in ras-segna le for:rµazioni dei prin cipali eser citi (come ci v,en~ gono riferite dalle Rev iste JfilitCt;ri), onde da ciò dedurr e dei precetti e pronu nciare il nost ro g iu9-i zio su questo im:po r tante soggetto tùttora ind~terminato della formazione d el battaglione .
In Francia il battaglione era divi so · in otto çòmpagnie. Questa d ivisione era soltanto çi,rnmin istrativa .e disciplinare, a:ffinchè il baita.g-lione, il quale sommava a novecento uo mini circa, fosse r ipartito in frazioni , non t roppo numero~e . Sul · terreno la compagnia spariva, essa diveniva U!1 pelottone, o m1zza sezione : e perci ò tatticamente il . battaglion e era diviso in ·qucittro sezioni (divisioni) . Stabilito per . massima che le tre condizi oni di costituzione deggiono essere in perfetta armonia in . ogui tempo o situazione, e~ anzì ,che l a disciplina ed amministrazione vogliono essere subordinate .alla tattica, no i rilevian10 q uivi il difetto (rimarcato generalmellte) che , le sezioni erano formate di due paTti estranee, ed una metà si trovava sotto ad un comandante che non le apparteneva . Osserviamo però, che i corpi nel mettersi sul piede cli g uerra (e ciò •specialmen t e nelle due ultim e guerre cli, Crim ea e d' Italia) , riducevano i loro l)attaglioni a sei compagnie, or ganizzand o un terzo o q u arto battaglione , Ora pare che · questa formaz i one in sei compagni e sia la normale: ma osserveremo che questo battaglione è compost.o di quattro compagnie [1,1,cilie?'i, d i una r;ompagnia di granatieri e di -iina di volteggiato1'i . Le r agi on i addotte ,per cui le ah constano di queste truppe scelte sarebb ero; che restano rafforzati i fianc hi o più solide sono la testa e , coda della colonna : però non essen~o stat o cambiato il sistéma d elle se zioni di manovra succennate, ne deriva
,
30 ORGAN I ZZ!ZIOm::
DI UN ESER CITO 3 1
che la prim,t e terza divisi oni sono formate di truppe quasi_ di diversa specie; e si vorrà cònveniTe essere pure questo un difetto. Ma. proseguendo \ l nostro esame, irnpa- _ ·r i amo, dalle stori e del1e guerre del primo imp!;!ro, che i granatieri furono non di rado riuniti in.. battaglioni separati (il corpo d'armata del maresciallo Oud inot nelle prime cam~ p agù e gerriuy:dche), e ~alle relazioni delle fazioni od imr,rese delle· loro ultime guerré, ci v i ene riferitQ che spesso le compagniè scelte sono state staccate, per cui l'averle cons-:ervate, par'e sia piuttosto per aver truppe di ris er va che r inforz,i nel ·battaglione stesso .
Dii<emo advnque che il ba:ttaglione francese in tempo di gue'rra viene per · lo pÌ.ù trasformato; consta cioè di quat.t'ro compagnie cli cento venti uomini; è in t~l modo ridotto a quattro cento ottanta uomini, e d ha l'aggregazione di due ris•erve, di cui una g li serve di protezione scaramucdando, e l'altra g li è di so·ccorso, o maggiornerbo , ne guarda i fianchi e le s pall e , oppure le vien tolta per riunirla ad a.ltre p ur di granatieri dello ste,5so reggimento, CJ brigata, o divisione.
L'Austria, abbenchè abbia riformato gli ordin amenti dei r eggi111e nti e delie brigate, dopo la , pace di Villafranca, paré a:b bia conserv'ati i battaglioni della forza d i mille duecento trentase·i uomini, sempre di visi in sei compagnie, è per ciò i : capitani hànno il g'rave incar icb di. gover~ nate dLtecento e p i Ll uomini ; i movimenti deggiono essere lenti e difficili se s i manovra colle divisioni di fronte estesissima, oppure y i son troppe- fra-zioni se il b atta glio ne si scompone per compagnie (Bisogna però r ifletterè che la tr'ù.ppa è tuttora ordinata in tre righe, per ' cui la fronte è m1 po' più rìstretta). La terza riga è impiegata, in volt eggiatori ed in snstegilO' , Il battaglione viene da ciò trasformato in un schi eramento d i .sei compagnie su due righe, -con se-i pe.lollowi separati, indip endenti fra cli loro, foori rango, sotto gli ordini del solo comandante del bat-
taglione (1 ), e deducendo questa terza ·riga, la forza del battaglione vien ridotta a ottocento ventiquatti·o itomini.
La formazione del battaglione prussian.o è preSSQ a poco l a stessa dell'Au stria, ma non è diviso che in quattro comp-agnie, e quindi dalla terza riga -si r i cavano quattro pelottoni di scara.mucciatori o di sostegno, distribuiti due a due d i et.ro le ali (2) .
Dall'L1ltimo ordinamento del battaglione russo (come troviamo scritto: Delta Russia, del suo Popolo e della sua kl"mata), ci vien detto, ch'egli è diviso in cinque compagnie, di cui una di caccia.tori . La sua forza non è la stessa nei , di versi corpi d 'armata: , si p u ò calcola,re a novecento e più in quelli della guardia ed a mille t1·ecento in quelli - degli altri corpi; per cui tenuto conto, come è probabile, che i cacciatori no n siano in linea, il battagl~pne vien ,. ridotto a settecento trentasei nella prima ed a mill-e e più nei secondi .
Da qLrnnto ci vien narrato dalla Rivista Jlfilitare Italiana (ag:osto 18G0), il batt aglione belga, sebbene formato di sei compagni.e, può ordinarsi con quattro schierate in linea e due piegate dietro le ali in. sostegno e pronte a fornire i volteggiatori o cac ciatori.
1a Svezia apparisce , fra le armate europee, anch'essa col battaglio n e di quattro compagnie, con due pelottoni ripiegati dietro ognuna delle sue ali . Questi sostegni sono . , tratt i dalle compagn ie, ossia sono terzi pelottoni de lle compagnie.
Final mente il battaglione olandese veniva ordinato nel 1851 in cinque c·ompagnie di cento settantacinque a cento ottanta .uomi ni, di cui u na cli cacciatori. Nel rendiconto di questa formazione, assai nuova a quell'epoca, la creazione
(l) Cottp d'reil, sur les réglemcnts des m«nreuvr es.. Spectalcur , genna io, 1858.
{2) Lo SpeclrJlew·, l uglio 1857, d à un sunto delle varie posizioni di questi pe lolton i nelle evoluz io11i del battagl ione.
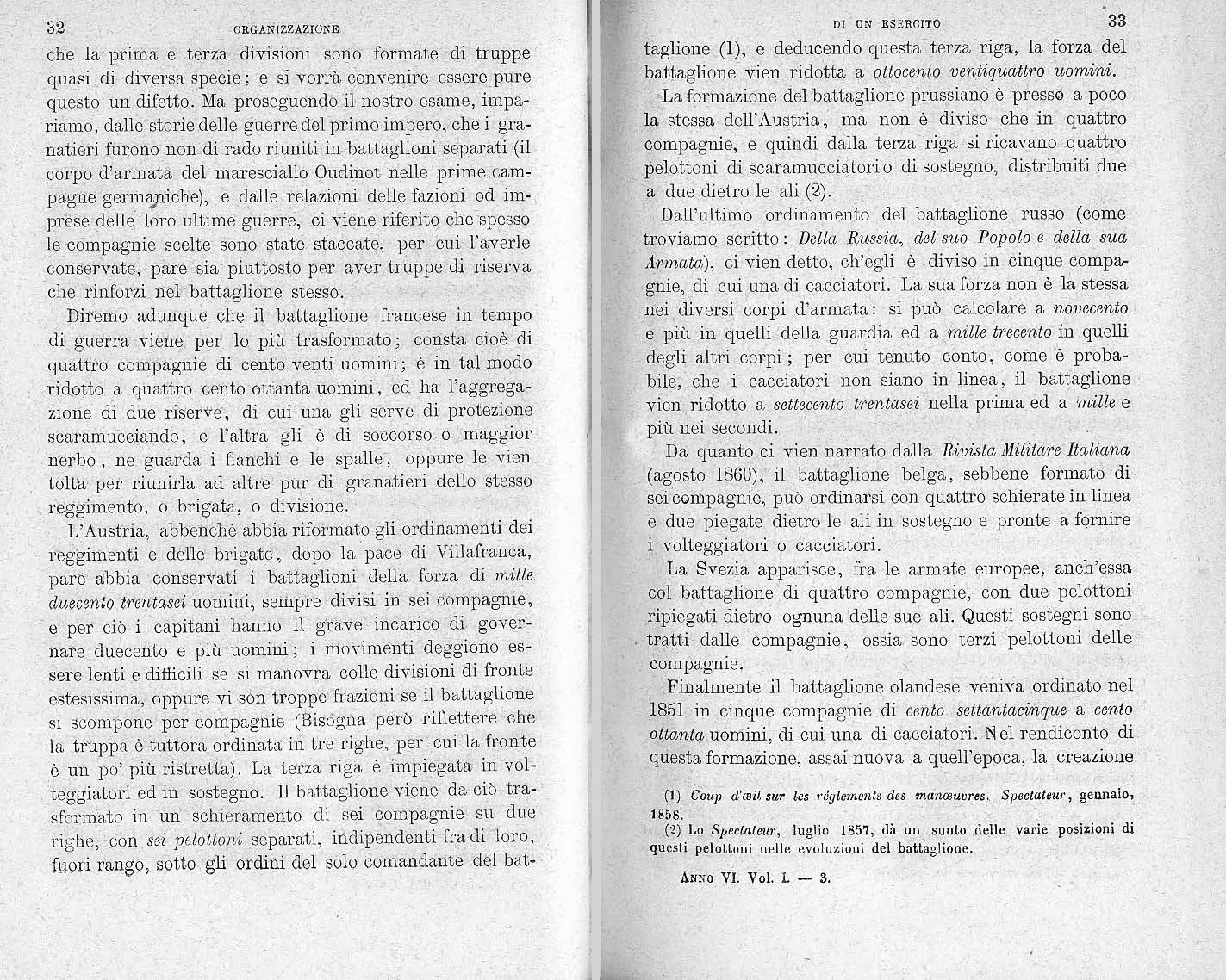
32 ORGAN!ZZA~IONE
DI UN ESERCITO 33
A.NNO VI. Voi. I. - 3.
della quinta compagnia era considerata come un vero ffro- · gre_sso sotto ad 0gni a;spelt'J .
Dall'esposizione d i queste varie formazioni, possiamo osservare che il battaglione di quattro compagnie ha ·una vera proponderanza. Se qu_esto ci farebbe propendere ad aeeostarci n~i pure all'opinione deHa maggior parte degli eserciti europei:, diviene piena convmzione, se vogliamo ancora ponderare le seguenti cose :
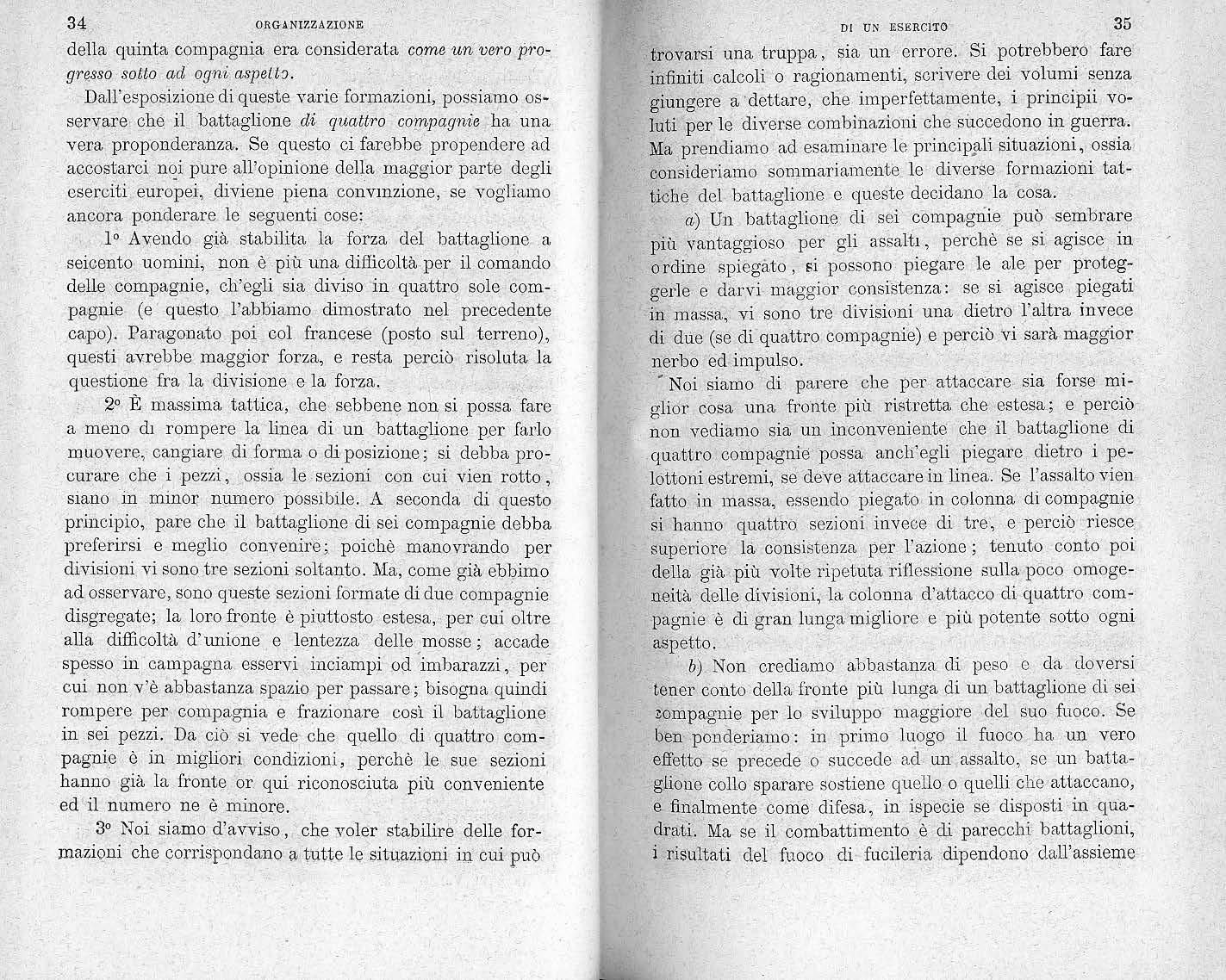
1° A\\endo già stabilita la forza del battaglione a seirrnnto uomini, _pon è più una difiicoltà per il comi ndo delle compagnie, ch'egli sia diviso in quattro sol e compp,gnie (e ' questo l'abbiam0 dimostrato nel ·preced~nte capo). I?arag01iato p0i col francese (posto sul -terreno), que·sti avrebbe maggior forza, e resta perciò risoluta la questione fra la divisionè €- la forza. ,
2° È massima tattica, ch e sebben~ non si possa fare a meno d1 rompere la linea di un battagljone p,er fal'lo muovere , cangiare di forma o di-posizione; si debba procurare che i .pezzi, ossi a le sezioni con cui vien rotto , siano in minor, numero possibile. A seconda di questo principio, pare che il battaglione d i sei compagnie debba preferirsi e meglio convenire; poichè manovrando per divisi oni vi sono tre sezioni solta]J.to. Ma, come già ebbirno ad osservare, sono queste sezi oni formate di due compagnie disgregate; la l oro fronte è piuttosto estesa, :per cui oltre alla difficoltà d'unione e lentezza delle - mosse ; accade spesso in ·campagna esservi inciampi od '.imbarazzi, - per. cui n on v'è abbastanza spazio peT passare; bisogna quindi rompere per compagnia e frazionare così il battaglione in sei pezzi. Da ciò si vede· che quello cli quattro compagnie è in m igliori condizioni, perchè le sue sezioni hanno già la fronte or qui riconosciuta più conveniente ed il numero ne è mino r e .
· - 3° Noi siamo d'avviso, che voler stabilire delle formazioni che corrispondano t1,1tte le sit-u.aziom in cui può
trovarsi una tr uppa , sia un errore. Si potrebber:6· fare ' infiniti calcoli o ragionamenti, scrivere dei vol umi senza giungere à ·dettare, che imperfettamente, i prin:cipii voluti per le 'diverse combinazioni che succedono in guerra. Ma prendiamo ad esamina.re lè princip,ìlli situazioni, ossia , considetiamo sommariamente le diverse formazio ni tattiche del battaglione e queste decidano la cosa.
a) Un battagl'ione di sei compagnie può sembr.are più vantaggioso per gli assalti , perché se si• agisce in ordine .c;piegàto, si possono piegare le ale per proteg~ gerle e darvi maggior c9nsistenza: se si agisce piegati in massa , vi sono tre divisioni una ' dietro l'altra invece di dtie (se di quattro compagnie) e perciò vi sarà maggior n·erbo ed impulso .
· ' Noi siamo di parere ·che per attacc·are si a forse miglior cosa una fronte più ristretta che estesa; e perciò, non vediamo sia un inconvènient0 che il battaglione di quattro compagnie possa anch'egli pi egare dietro i pelottoni estremi, se deve attaccare in linea. Se l'assalto vien fatto in massa, essendo piegato in colonna di compagnie si hanno quattro sezioni inve ce di tre · , e perciò riesce. superiore là consistenza per l'azione; tenuto conto poi della già più volte ripetuta,"riflessi one sulla poco omogeneità delle divisioni, la co lonna d'·attacco di quattro compagnie è di gran 11,mga migliore e più potente sotto ogni aspetto.
b) Non crediamo ab bastanza. di peso e da ~oversi • tener conto della fronte più lu nga di un battaglione di sei wmpagnie p ér lo sviluppo maggiore del suo fuoèo . Se ben ponderiamo : in primo 1t1;ogo il fuo co ha un ver o effetto se precede o succede ad un assalto , se un bat tagl,ioµe collo sparare sostiene quello o quelli che ·attaccano, e finalmente come difesa, in ispecie se disposti ·in quadrati. ·Ma se il combattimento è çli parecchi battaglioni, i risultati del fuoco di fucileria dipendono dall'assieme
34 ORGANIZZAZIONE
DI UN llS KRClTO 35
delle truppe, non dalla front.e dei battaglioni; se invece è parziale di battaglione contro battaglione, g ià abbiam detto più sopra quali debbano essere le condizioni, ossia quali possàno essere le combinazioni· riunite o separate, dalle quali possasi ~pera:re un successo; e certamente la linea più lunga o più corta del battagli6ne pare non possa avere .un'influenza buona o cattiva. ·
e) Abbenéhè possano sembrare più rapidi · i piegamènti' o spiegamenti sulle compagnie del centr,o in un battaglione di sei compagnie, bltre ad àvei;e la colonna dQppià, ossia la peggiore, noi osserviamo: che questa col 01ma non è libera per la marcia, salvo per qµelle paralelle alle primiere linee di battaglia, colla èo ndizione pe;rò che il terreno abb ia ·sufficiente spazio, altrimenti bisogna schierarsi in battaglia per poter mettersi di fianco o rompere in sezioni, secondo l'ordine numerico naturale. Con 1.in battaglione .· di quattro compàgnie; possiamo vedere che eseguendo le formazioni delle colonne od i schieramenti su di una co mpagn ia del centro, questi tnov imenti riescono quasi ugualmente spediti quanto quelli col centro in testa: si conserva l'ordine naturale della colonna (cosa questa assai essenziale nei co mbatti'menti), e . questo battaglione si può muovere in tutte 1~ direzioni, rompere o r ifo rmare le sue sezioni senza imp icci o ritardi cli sorta.
d) Sebbene non sia grave inconveniente che il quadrato riesca con lati d isuguali ( col battaglione di sei.c01;npagnie}, però l' uguaglianza ·dei lati meglio co nviene pei quadrati obbliqui, . o per meglio dire, guando si pr esenta un augolo all'assalto della cavalleria nemica (Ei per ·10 più lar cosa è in questo mo do). -
Se però vuolsi tener conto che il battaglione di sei compagnie può egli soltanto fornire delle r iserve :µell'interno del quadtat ò, noi ci dichiariamo avversi a queste riserve; dis tur bàno, e spesso ne fanno ritardare la for-
mazione; imbarazzano, e nel momento d'azione è impossibile adoprarle per rinforzare i punti attaccati; facilmente vi si m ette la confusione. Ci pare sia miglior cosa avere dei sostegni di tilrator·i , i quali, aggruppati fuori , fian, cheggi no il quadrato. , e) Finalmente nòn et pare possa, prevalere l'ufficio ,del battagiione come avamposto, per decretare che debba esser,e di sei compagnie, sul riflesso che, ordinato . in tal modo, ha seco -tutto l ' occorrente p ~r la distribuzi one delle gran guardie, dei sostegni e delle riserve . Le prammatiche d elle operazion i della guerra, non èhe l'esp~rienza c'insegnano: ch e se occorrono. riserve, ,queste sono fornite da truppe più munerose, ·e quindi da altri battaglioni o altri corpi; per cui non si può esigère da quello in avamposto .se non che le gran guardie ed il sostegno . I
Da tutte queste considerazioni si può avere l a seguente conclusione : che se non è provata come migliore la divisione del battaglione in quattro compagnie, vi sono però moltissimi argomenti in s·uo favore; argomenti che pare abbiano ~prevalso nella maggior parte degli eserciti in ·c'tli venne preferito ; e ciò per la poss ente e sempJicissima r agione da noi g ià detta, essere egli il battaglione il meno comp licato, il più- flessibile ed il più adattato per manovrare (1). · ·
· Fino ad ora noi abbiamo pres o ad esaminare il battaglio ne nel senso ristretto della sua forma:tione intrinseca; · ma ciò non basta. Sotto l 'aspetto dello scopo con cui dissimo essere costituito ad avere il necessario per agire da se medesimo , si comprende che in moltissime circostanze, ed am,i in quasi tutte , egli ba bisogno di accessori o sostegni per combattere.
(f) Un vecch io a4Lo rc milil :lrc viene n convaliJare questa conclusione: ' " Il fauL détcrm i ocr le nornbre, la force et .l'of'ganisalion des corps sur « & telles proport.ious qui ne soycn t ni faifiles , ni lourds, ni compiiqués, ,ctc "· (SILVA., Pensées su-r /.a ra ctique).
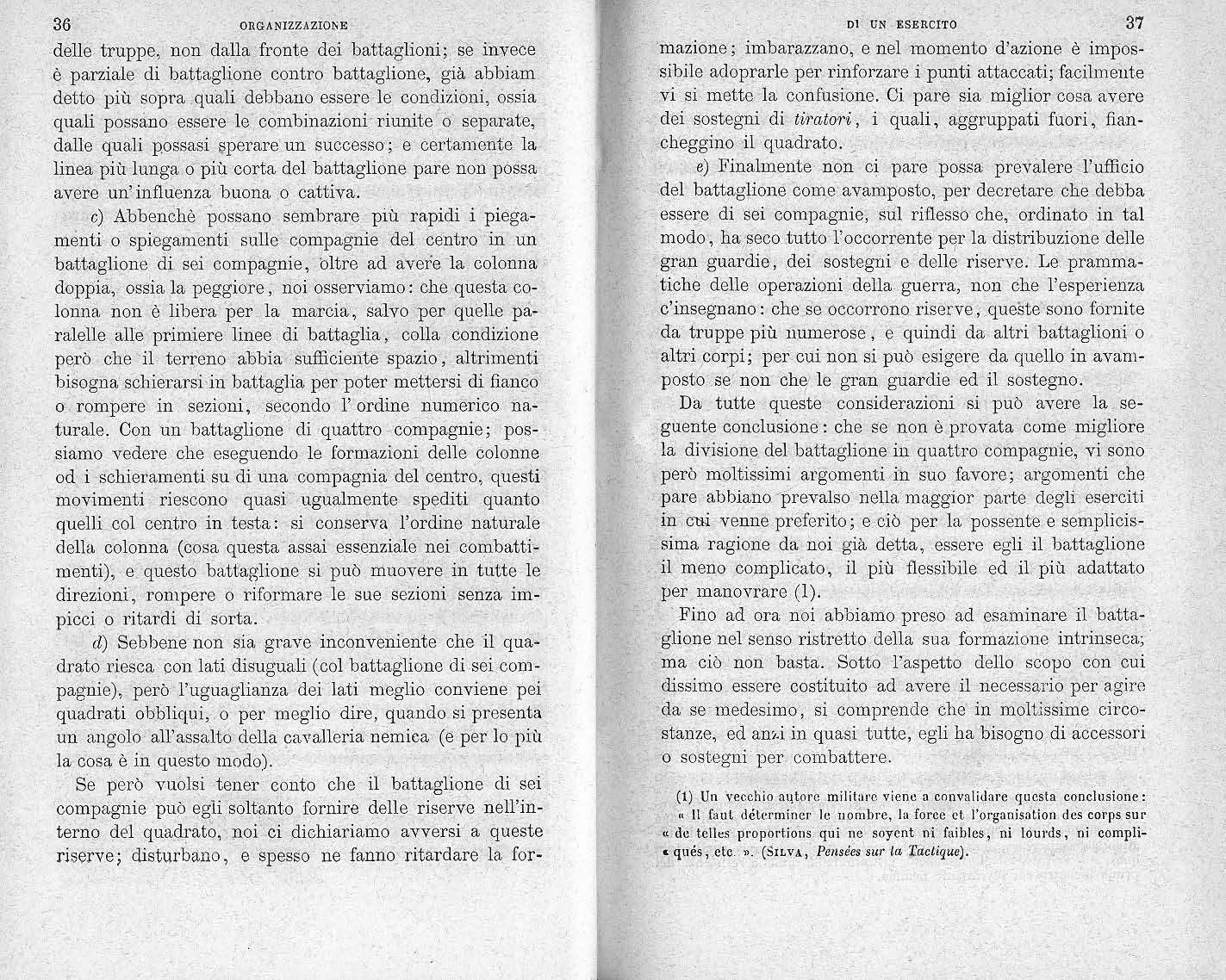
36 ORGANIZZAZIO!iE
DI ÙN ESERCITO 37
OltGA,:'-IZZilZIONE
Dalla stessa enumerazione delle varie formazi oni noi vediamo CO!llparire questi accessori ; e ricapitolaùdo quanto abpiamo rifer~to a tal e proposito dei diversi es0rciti d'Europa, vediéì,mO so r g ere la terza o quinta par~e del battaglione, connessa o separata, sebbene dipend ent e da esso: in alcuni tratta dalle CGJXJpagnie per mezzo di un terzo pelottone, o dalla terza riga: in altri coll'aver applicata una compagnia quasi speci al e e fuori di lipea, in più di quelle del battaglione 'p ropriamente detto ( di . numero pari queste ; numero inchsp ensabil e per manovrare). Vediamo questa aggregazione negli eserciti fran:. cese ed austriaco eziandio, ab benchè siano uniti altr esì dei "battaglioni di -truppe leggere ai corpi o brigate.
,/J questri dunque una costitv,zione tatt·ica che si è introdotta a poco d poco; ch e non tcwderà mo_lto (alm e~o tale è la nostra . convinzione) ad essere riconosciutcb ntile, necessq,1·ia, indispensabile; e diver1·à f 01·se norm,ale J)e?' la formazione del -battaglione.
Se nelle moderne guerre -crebbe il bisogno o l'uso deL cowlmLLer e)u onliue i:ìJJar:;o, per 0u i ogui qualunque fant eria di lin ea d eve pur esservi ammaestrata; non perciò essendo eziandio importante il conservarla u n it a e compattà., essa ha bisogno di un sostegno o riserva atta al- . l ' ufficio di appoggiare, proteggere o secondarne l'azio~rn con fuochi di scaram,uccia e maggiore agilità di mosse . I battagli oni leggeri _( cacc i atori o bersaglieri) che vengono applicati, ci sem bra, - abbiano l'inconveniente di essere corpi loro stessi. Se inizi ano i : combattimenti essi da prima come avanguardie; us an o le munizioni, si aifaticano, fanno soventi molte perdite, e- perci ò n on son.o più in grado di offrir e il l oro aiuto alla linea di battagli~ quando questa s' impegna nella pugna (1). Se invece .le -
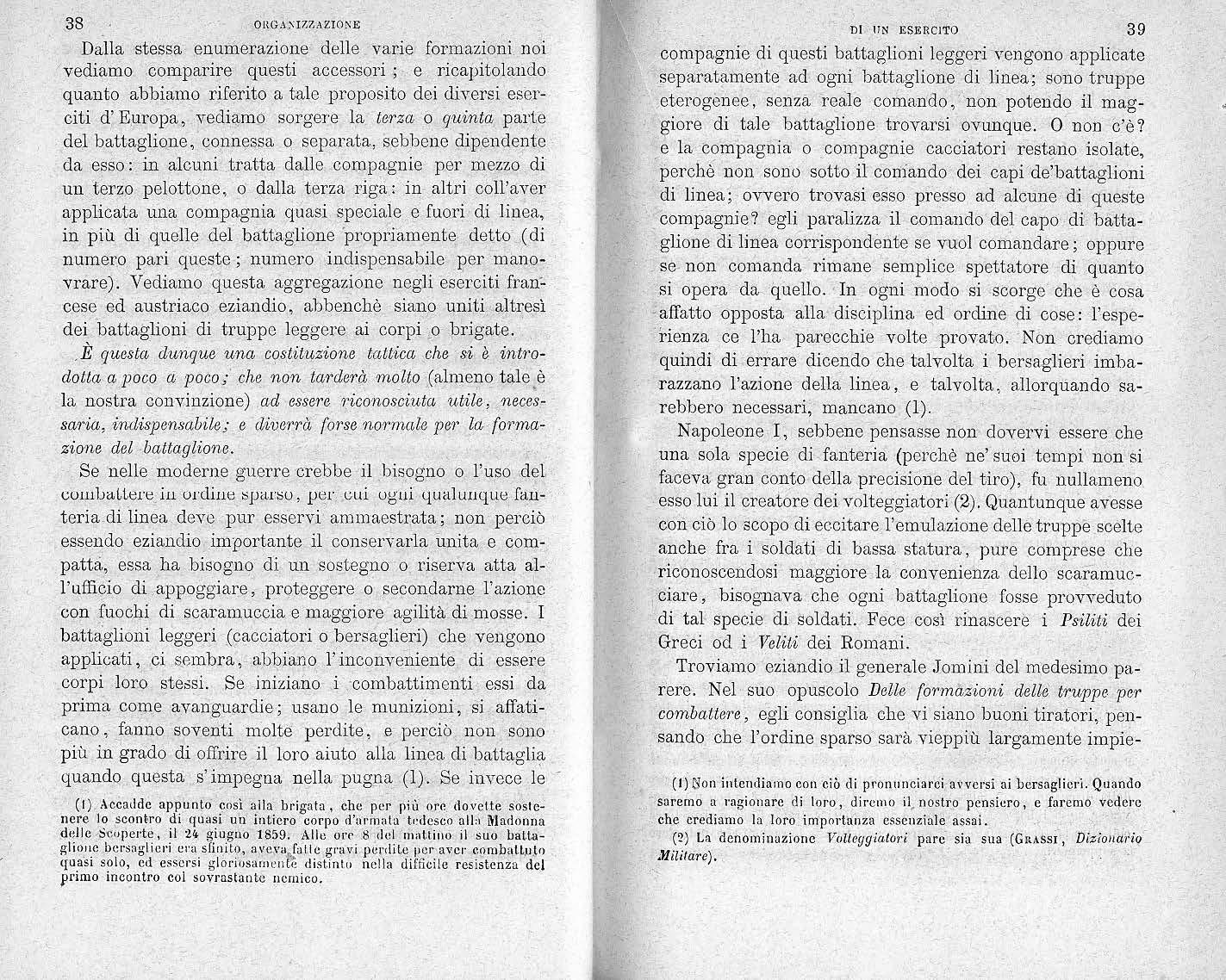
(I ) Acéaùde appunfo çosì alla brigata, che per più ore dovette sostenere lo s con~ro di quasi un intiero corpo d'u,·m.ilu kdcsco alh l't'Jadonna delle S<.:operte, il 2~ giu g,10 1859. Alle ore 8 del mattino il suo l.Jat.taglio11c l)c ,·sagl i cri cm sfinito, ave,var. fal,l é g r av,i perdite per aver r.omball11Jo qua'si so l o, cd essersi g l o riosa rMn tt d is tinto nella diffi cile res i stenz a del primo incontro col sovrastante nemico.
c9mpagnie di qµesti battaglioni l eggeri vengono applicate sepamtamente_ ad ogni battaglione di linea; sono truppe ,eterogenee, senza r eàle comando, . non potendo il magffore di tale .battaglione tr~varsi ?vun~ue . O n~n c'è? e la compagma o compagme cacciatori rest~no isolate, perché non sono sotto il coniando dei capi de'battaglioni di linea; · ovvero trovasi esso presso ad alcune di queste compagnie? egli paralizza il co mando·del capo· d i· battaglione di linea corrispond en te se vuol comandare; oppure se non comanda rimane semplice spettatore di quanto si opera da qùello. In ogni modo si scorge che è cos a - affatto opposta alla disciplin;:t ed ordine 9i cose: J'.esperienza ce l'ha parecchie volte provato. ~Non . crediamo quindi di errare dicendo che talvolt a i bersa.glieri imharazz~no l'azione della linea, e talvolta, allorquando sarebbero necessari, manca.no (l) .,
Napoleone X, sebbene pen sasse non, dovervi essere che una sola specie di fanteria ·(p erchè ne' s uoi tempi non. si faceva gran conto della precisione d el tiro)', fu nullameuo esso lui il creatore dei volte ggiatori (2). Quantunque 1,1;vesse con ciò lo scopo di ecc itare l'emulazion e d elle truppe scelte anche fra i soldati di bassa statura, pure comprese che rico noscendos i maggiore la convenienza d ello scaiamucciare, bisognava che ogni battagl i one fosse p rovveduto di tal specie di soldati. Fe ce così r inascere i Psihti dei Greci od i Yeliti dei Romani. · ·
· Tr0viamo ·eziand io il generale .Jom ini del medesimo parere. Nel suo opuscolo Delle fo1·1n àzioni delle' truppe. pe1· combatt~·re, egli consiglia che vi siano buoni t irat ori, pensando che l'ordine sparso sarà vieppiù largamente irnpi e·-
(1) ijo n intendiamo con ciò di pron,,'nciarci avversi ai bcrsagliçii. Quando saremo a ragionare d i loro, diremo il, nostro pensiero, e iaremo vc<Jc_rc che crediamo la l oro importtuiza esse nziale assai. '
(2) La denominazione V olteggiatori pare _ sia sua (G1uss1, Dizio11ai'-io Jlilit àre)
38
DI IIN ESERCITO 39
gato. Fa va:rii progetti, fra i quali vorrebbe scompartire i corpi dei caçciatori fra quelli di linea; ma poi conchiuq.e dicendo: sar·à SMIV[Jrç meglio che i corpi stessi abbiano qiiesti schiaritori, · ,o - cacciatori, o volteggiatori l01:o p1·opi·( (1) ,. Colla scorta delle !Jreponderanti opinioni di questi ·uomini sommi in fatto di scienza militare; le quali vengono così . a convali dare la nostra pratica esperienz a; non esi- , tiamo più oltre di proclamare che il battaglione (il quale abbiamo procurato di dimostraJ;e debba di vidersi in qt1,attro compagni e), dovrébbe avere una qiiinta comp agn ia di v òlteggiatori, posta fuori• de1la linea ( ad ecceziçme del~ . l'ordine di parata), dietro del centro, ad una distanza di quindici o venti passi, piegata in colonna cli mezza compagnia (s ezione), e pronta a recarsi ove il comandante ne crederà più giovevole l'impiego (2).
(1) Il bisogno che i volteggiatori facciano parte del b,altaglionc et viene pure conform ato essere opinione antfra. Lu t r oviumo esposta oc l qua tordicesimo principio della formazione della fanteria del già citato nostro autcirc dello scorso secolò (S U.VA , uffì~ ia l e di stato-m :.ggiore nell'armala sarda). ·
(2) Non è quivi appropriato di estendersi in ragi onamenLi su ll e evoluzioni: però cred iamo in p r oposito di avvertire; che prim ,l di decidere e fnrm arei il c oncetto d i questa quinta compagnia abbiamo vol~1to studiarne l'impiego e posto nei movimenti del battagl ionr. Ci s iamo por <la ciò eon,•inti maggiormente cfolla sua utilità (Se rngioncremo d e lle evoluzioni, produrremo pure l'artico l o da - noi compilato a quest'oggetto)
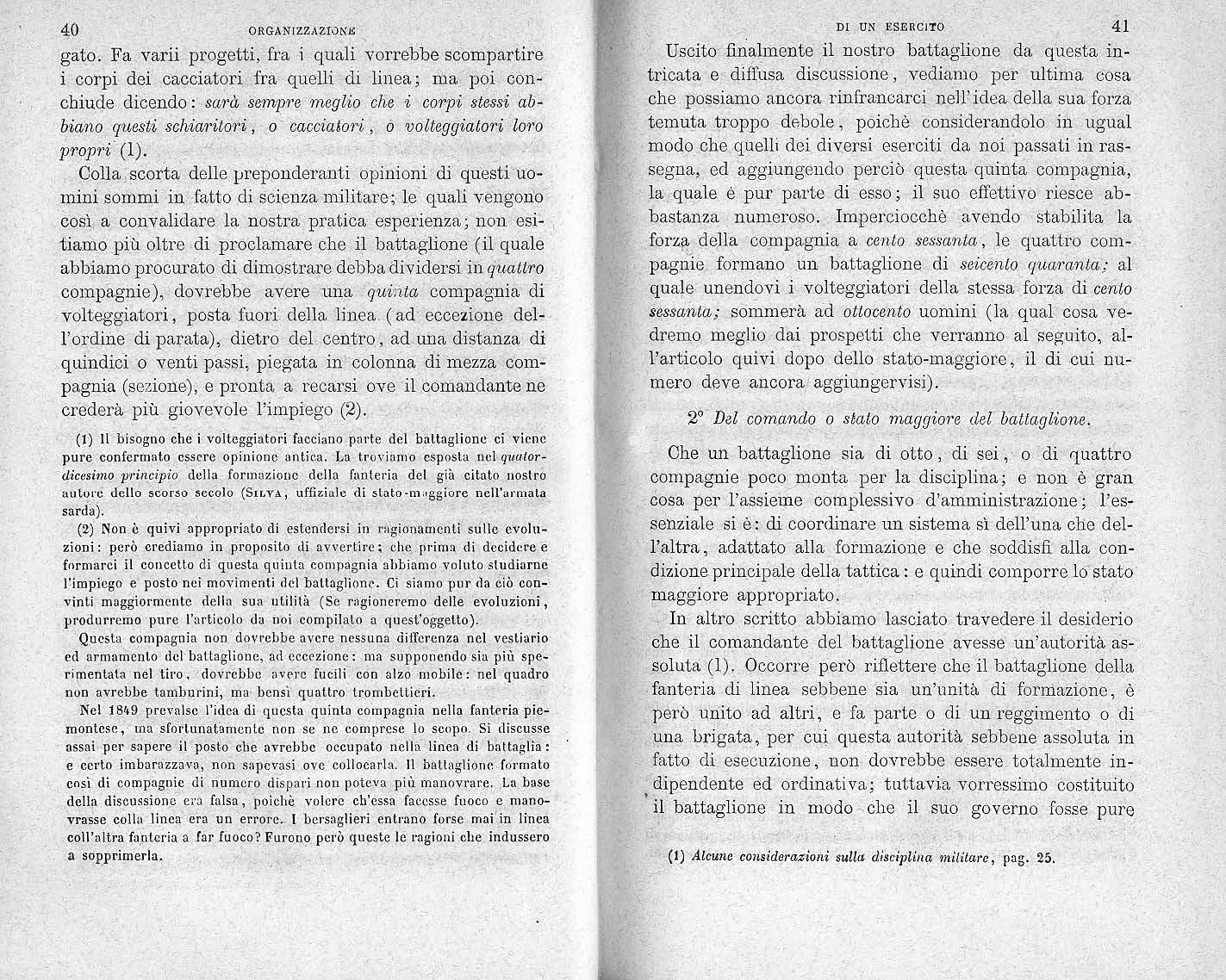
' Questa compagnia no n dovrebbe avere nessuna differenza nel vestiario · ed armam coto del battaglione, ad eccr,zione: ma supponendo siu più speri!11enlata nel tiro. dovrebbe aVPrc fucili con a'lzo mobile: nel quadro non avrebbe tamburini, ma- bensì quattro · trombettieri.
Nel 181,9 prevalse l' idea di qncsla quinta compagnia nella fanteria piemontese, ma sfortunatamente non se ne comprese lo scopo. Si discusse assai per sapere il postç che avrebbe occupalo nella linea di battaglia: e certo imbarazza va , non sapevasi ove co llocarl a. li baU~gliom1 , formato così di compagnie di numero dispari non poteva più manovrare . .La base della dìscussione era falsa·, po ì chè volere cb'essa facesse fuoco e manonasse coll a linea era un errore. I bersaglieri entrano forse· mai ' in l inea coll'altra fo,nteria a far fuoco? Furono però queste le ragioni che indussero a so~primerla.
Uscito· finalmente i l nostro battaglione da questa intricata e diff~sa discussione , vediamo per ultima cosa che possiamo ancora rinfranearci nell'idea della s ua forza temuta troppo df:bole, poichè' considerand olo. in ugual modo che quelli dei diversi eserciti da noi passati in ras~ segna, ed 'aggiungend o perci ò questa quinta compagnia, la quale è pur parte di esso ; il suo effettivo riesce abbastanza numeroso. Imp er ci occh è avendo stabilita la . forz~ della compagnia a cento sessanta, )e quattro compagnie formano un battaglione di seice;ito qua1·anta; al qua}e un enclovi i volteggiatori della stessa forza di cento sesswnta; sommerà ad ottocento uomini (la qu al cosa vedremo meglio dai prospetti che verran no al seguito, all'artico l o qu ivi dopo dello stato-m aggiore, il di cui numero deve ancora, aggiungervisj).
2° - Del comando o stcilo maggiore clel battaglione.
Ohe un battaglione sia di otto , di sei , · o di q u attro compagnie poco monta per la disciplina; e non è gran cosa per l'assieme complessivo · d'amministrazione; l'essenziale ,si e: di ce5òrdinare un sistema sì dell' una che dell'altra, adattato alla formazione e che soddisfi alla condizione prin cipale della tattica: e quindi comporre lo- stato maggiore appropriato.
In altro sçritto abbiamo lasci ato travedere il desiderio che il comandante del battagljone avesse un'autorità assoluta (1). Occorre però riflettere che 'il battaglione della fanteria d i linea sebbene sia un'unità di' formaziòne, è però _ unito ad altri, e fa parte o di un reggimento o d i una brigata, per cui questa autorità sebbene assoluta in fatto di esecuzione, non dovrebbe essere totalmente indipendente ed ordinati va; tuttavia vorressimo costituito ' ~ l battaglione in mo do che il suo governo fosse pure
(l) ·Alcune considera:zioni sulla di,ic·iplina miÌita·rc, pug. 25
40 ORGANlZZ,IZ!vt'\~
DI UN RSE RCJTO 41
maneggievole come fu detto rel ativ amente a lla tattica; e così sebbene dipendente ; in qualunque posizione o circos t anza, r i uni t o o separato .d al corpo a cui appart ien e; n on fosse mai i ncagliato dai doveri della disciplina o pastoie della contabilità , affinchè possa sem pre e subito esser e mobi lizzato (1) .
Dalle cos e ch e si r ife ri scono al governo deUe truppe più volte ripetute , si scorge che il comandante di un ba ttagli one (maggiore) d eve avere due agenti per -es ercire questo coro.anelo: l'aiutante maggiore ed il contabile: ufficiali s ubaltern i avendo uffici o o carica particolare .
Le attribuzioni d·ell'aiutan.t e maggi ore di un battaglione sono in diverso m9do intese. In Francia , egli è il direttore general e dell'istruzione, ed ha delle ingerenze nel servizio interno, che ci semb rano possano produrre un d ualismo d'autorità col capitano d' ispezione; egli ha perciò il g rado di c ap itano . Nella maggio r · parte delle armate della Germania egli è un uffi.ziale a dispo sizione d el maggi ore ; h a qualche anal ogia coll'uffiziale applicato presso uno stato maggiore , o cosi. detto uffiz i ale d'ordinanza. Nell 'armata sc,1rda l'aiutante maggiore iri 2° è p i uttosto l'aiut ante di quello in 1° i n tempo cli pace (2), ed uffiz iale a disposizione del maggiore i n tempo cli g uer ra . Ha finalmente qualche incu mbenza cont abil e .
(1) Sa r çbbe cosa assai lun ga se vo rressimo o h i s piega re qu est o sistema di coman d o e l e sue r el azi oni Nel capo su lfa for mazi one dell a b r ig a ta che fa rà seguito a questo si potrà m eglio comprendere l a cosa . D'altron de, indirizzando questi n ost ri studi agJi e sp erti conoscito ri delle pr a mm a ti c he m ilitari , crediamo qui ndi che queste poche p a role sono suffici enti p e r darne l ' idea, e pe rciò ci perm ettiamo di co nti nu are questo raziocinio senza bi sog n o di maggiori .;pi e gazioni o s chiarimenti.
(2) È q uesta l a co n seg uen za del sistema, che l e ope razioni di un Corpp sono r egolate comp l essi vame n te da u n sol o magg iore ( il maggio r e d i serviz io) e perc iò co m_ç comandanti <li ba ttaglione, i maggio ri non s i occupano delle cose pa rtir. o lari che l i conceroono, e perciò l 'ai-ut.ante ma gg iore di battapl ion c segue il med es imo andamento di cose nelle sve attribuzioni.
Da questo si v ede che la posizi one di questo ,uffiziale non è ben definita; fu il soggetto di alcune discussioni .
Si r.redette potesse essere un incaglio per .i comandi delle compagnie, od _ una pe rson a ch e possa pr·encler e un' infl~enza al d issopra d el suo grado, e qui~di si r ip utò potesse liinitari?i il suo uffi ci o alla direzio ne contabile del battaglio ne a guisa di qu anto p r atica si da.i bersaglieri.
S ebben e sia. nostro p en;iie r o cli tra t tar e l e mater i e che p rendiamo ad esam inare sotto l'aspetto gen erico ed astratto , siamo obbliga.ti di quando in quando cl i ven ire ai particolari -onde meglio spiegare la cosa. Tal ,si ' è d i qu esta. Osservando perciò cosà vènn e fatto allorchè furono or ganizzat i i b ersaglier i d e'll' esercito piemo n t ese, vedianio che il battaglione fu soltanto una riuni one amministrati va, p er cui il s uo aiu tante maggior e p oteva benissimo essere destin ato" a re ggerne la contabil ità, senza che si m ostrasse forse il bisogn o d'utilizz.arlo in altro modo: divenne perci ò un uffiziale •esclusivamen te contabile, non n;i.ai o qu asi mai p r esen te negli assembramenti d el battaglione; ed in _ campagn a. r imanendo ordinaria m ente p resso il bagi: ;;lio.
Non è e n 0n ' può essere la stessa cosa per un battaglione appartenente ad un corpo di linea, il q ual e agisce collettivam ent e , in cui la disciplina ed istruzione deggfono dipendere dall' imme diata direzione del suo capo . Dev e .perciò questi aver e un uffiziale a sua disposizione' per trasmettere g li ordini e- per coord inar e l ' azi one ,delle vari e parti , nell' un iforme union e d el battaglione. In fatto d ' i struzione : sebbene v i sian o i regolamenti scritti delle esercitazioni, e quantunque debba esser e dovere d ei com~ndànti dell e compagnie di ammaestrarne la truppa, ~gli è essenziale che si operi con p1~ecisa .esatt ezza nelle funzioni o movim ent i pa1-ti colari : p er cui è d i tutta. neGessiti!, ch e vi sia un capo istruttore special e pei graduati dl bassa fo rza, i quali :;;ianç> c9sì preparati , e possano

42 0RGANI7,z°A
E
Z!ON
DI UN ESERCITO 4 3
servire alle minute e.sercitazioni dirette da quei comandanti delle compagilie. -
Da queste poche cose si deduce che fasciando all'~iutante m aggiore le sue incumbenze in campagna, di provvedere ai bisogni d ella sua truppa, egli d eve essere un istruttore e sorvegliatore esperto, ma nel medesimo tempo subordinato : ,pare inol t re ch'-egli dovrebbe avere qualche co gnizione del gover:no d e1 cavalli, onde concorrere con quelli degli altri battaglioni (essendo riunito il corpo) per i l serviìio ébdmnadario d ' i spezione d el carreggio e mezzi di trasporto al seguito del battaglione .
Qu:este attribuzioni sono abbastanza numerose ed iin·portanti perchè egli sia esonerato da qualunque cosa amministrativa (ad eccezi one della contabilità _particolare dello stato-maggiore) . Epperciò dovrà limitare i ·suoi lavori di scritturazione alla , compilazione .delle situazi9ni · della forza (cosa che · essençl.o nec essaria per la disciplina, è l a relazion,e fra essa e la contabilità) e i re g istri d ègli ordini e dei varii servizi ( 1)
.b:ssendo nostro pensie1·0 che la contabilità delle compagnie sia riassunta nel bat~aglione stesso , 8€1 a vendo ' specificato che l'aiutante maggiore non potrebbe attendere ai lavori che vi riflettono; nasce il bisogno di un u:ffiziale direttore cli questa contabilità. ,
Riferendoci per ora alle prammatiche del Regola,me"iito delle tr'lippe in campagna,, prescritte per la guerra d'Oriente ai battaglioni piemontesi di quella spedizione, non che alle disposizioni dettate p er . la guerra nel 1859 e 1860 per il modo di compilare i conti presso i depositi: ci seml;lra che q uesto uffiziale dovrebbe in tempo di pace essere egli l ' umziale dei conti, e le compagnie del 1;>attaglione i ndi rizzando al maggi ore i prospetti, g1i elenchi, l e richieste ed i resoconti; fosse q uestò contabile, incar i(t ) In tcrn.po di guerra dovrebb e pur essere a. cavailo, onde poter mrglio disimp egnare la sua carica
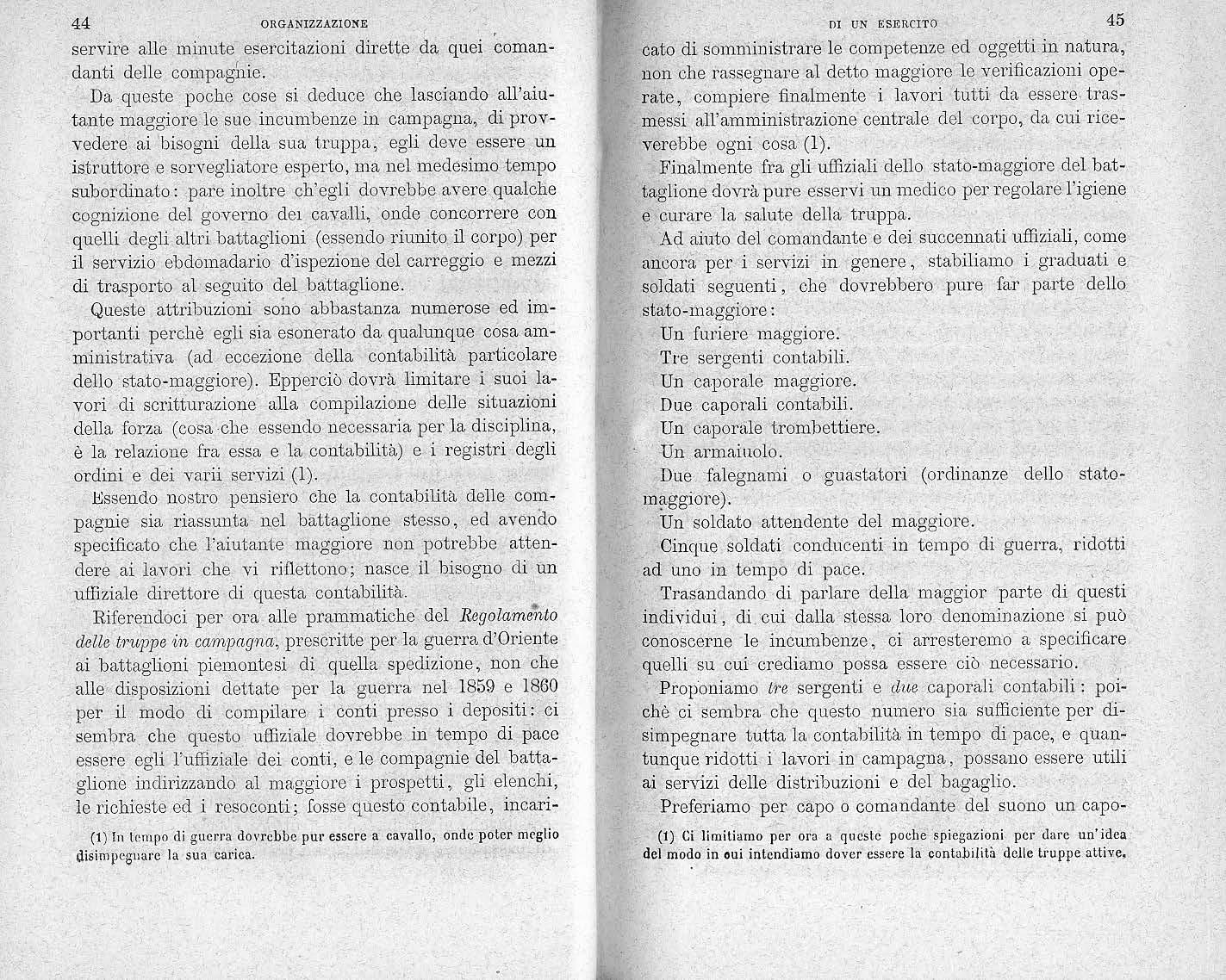
cat9 di somministrar.e le competenze ed oggetti in natura, non che rassegnare al detto maggio1~e le verificazioni op erate, compiere :finalmente i lavori tutti da esser e trasmèssi all'amministrazione centrale del cori)o, da cui riceverebbe ogni cosa (1) .
Finalmente fra gli uffiziali dello ·s t ato-maggiore del battaglione dovrà pure esservi un m edico per regolare l'igiene e curare la salute della truppa.
Ad aiutG del' comandante e dei succennati uffiziali, come ~ncora per i servizi in genere , stabiliamo i g r adu ati -e soldati seguenti, che dovrebbero pure fù , parte dello staito - maggiore : ' ·
Un furiere n_iaggiore.
Tre sergenti contabili.
Un caporale maggiore .
Due caporali co11tabili .
Un ç aporale trombettiere.
Un armaiuolo .
Due falegnami o guastatori (ordinanze · dello - statom~ggiore).
Un so ldato attendente del maggiore .
Cinque soldati conducenti in tem po çl.i ' guerra, ridotti ad uno 'in tempo di pace.
• Trasandando di parlare della maggior parte di q_uesti i n,d1vidui, di cui dalla stessa l oro denominazione si può co n oscerne le incumb enze, ci arresteremò a s pecificare quelli su cui crediamo - possa essere ciò necessario.
·P roponiamo tre sergenti e due capo ràli contabili: poichè ci sembra che questo ,numero si a sufficiente p er disimpegnare tutta la contab ilità in tempo cl.i pace, e quantunque ridotti i lavori in campagna, possano essere utiliai servizi delle distribuzioni e del 'pagaglio.
Prefer-iamo per capo o comanda"nte del suono un capo-
(t ) Ci limitiamo per o ra a queste poche ,spiegazioni per dare un'idea . del modo in oui intendiamo dover essere ·1a çontabijità delle ti"uppe attive,
44 ORGANIZZAZIONE
DI UN ESERCITO 45
rale trombettiere, perchè i trombettieri so no in maggior · numero dei tamburini, e perchè l'istruzione di questi si potrebbe fare dal tamburino maggiore e capor~le tamburino, di · cui parleremo in altro luogo. .
Destiniamo l 'attendente del maggiore allo stato-maggior e, perchè essendo uomo <;lisarrnato sarebbe un soldato inutile e di meno in una compagnia; e si evitano le traslocazioni od aggregazioni, di cui bisogni ·occuparsi ogni qnal v olta vien d1staccata una co mpagnia., qualora q tiesto · attendente vi appartenesse.
Essendo dimostrato i l bisogno di cinque carri ·al seguito di un battaglione in campagna, ne deriva dovervi essere i necessari conduc enti , allo stato-maggiore : ci s.erflbra poi sarebbe conveniente che uno di qùesti carri rimanesse pur -anche presso il battaglione uei tempi ordinari di: pace, affine di sopprimere certi servizi di fatica, di cui si s·uole vedete lo spettac'olo n~lle vie popolate ·d elle città, ed a cui è astretto il soldato di fanteria soltanto .
A nostro avviso, questo disdice assai al decoro dell'assisa militare, è un difetto nocivo a quella cons iderazione, ch e in ogni circostanza· dovrebbe inspirare Ùsoldato nel pubblico, ed è di danno alla tenuta, sciupandosi il vestiario . Queste ragioni ci suggeriscono quirrdi di comprendere un _ conducente nello stato-m~ggiore i anche riel tempo di pac(;l. Dai ragionamenti s.volti fin qui sull'organizzazione , del battaglione ricaviamo i seguenti prospetti, ché ne rappresentano la forza, Ìa divisione · di questa forza, ed il co mando.

46
istiota menlc messi nella slessa .colonna quelli d'ordinanza e provinciali.

. , PRO SPE TTO E
..,. I~ ~ =~~=~====~==:=====~==~=:-:== - - ,~ Nu~IEno dello STATO 3UG Gron8 e ' <:J o'" .tÌ) 1:,1) "' ,,., "; e .s ... o o f/l 1/) o ·o Cl) = i Cl) "' § Cl) ..., E ti> .:? Cli "' o 8 <.) ...; t,.; ;;: ~· .... D STATO MAGGIORE I ' ' I Il 1: 1.. 11 ··, ~. 11 I ' 1, 1;J . 'I, I •• , 1, ' 11 i', ' 1, ! I ·;: <.J -~ ·.:: ·'= · Cl) ::: i... I.... ·, o ;;:i I = = '" o ,Qe:.> "' ' é'i) '. t i) "' ,Q' Cl) ! ·-; ~ (,) 8 !~ ; i:l) Q ;:: o -e I "' 8 s o i3 '-' !; .9 ·s , ; i </j Cl) ..... ·... o .~ I ... -r:, ?. =- ,.., ::, i:: ::? ~-;Io... ...N o ,.., l:l) "' <Il ,, <=< ,.. , ... I c. c. c. a :si I; C" .... ::, Cl) ,.., <Il cc .. o e o ::, (/) l ù o (.) < r::: 1/l (J} E-' •, I• '·· ,. ' ;, ... = Cl) = .... ·;:: E = e:.> 8 Cl) Q, g :.. <C o :::l CJ e-< r/1 "" C0,1'1
I • .: I • Il 1• • <1l :.. <:J 'QI :.. <Il ::i .o ::, <.) s a <.J fil 'C = 8 'C 't: -~ ·e §~è_g to g_ e <:,.1 o.i ,e (/) (/) c.:, f:-c I'-' . L CLASS[ ' io co ugcdo limita to ,,.., ' --"• - N I '" s o ... ... r:, o: I, 'C g • !i o .... ,f. rJ) ... : , et ,.., t ·.:; = z c:i w .:: 'O .., :5 .... rJ) r.r W· w fil ,l .l "' .... ..l ..l 8 r:.-.: -,: "" -< .,e E-< "" o. •'C .. '" , o <'l o o o :> !;-- f.. u I oo (/) é--< E-< I - - --l:j t/l t;:J ::o C"l -.... Stalomaggiorc 1! 11i1 1 31 1"2 1 12 1 11 7 1,11 1, >> 1, )l ;1[11 1> , 11 1, 11 17 )) , 11 i 1, 17 3 fa Comp ag ni ,1 Il ! )\ , )l ) ) I )) l> n n )) )l )) )l n 1 2 J 1 1 '• s· 1 :1 10 78 1l0 . 11 0 5 5 ' 60 70 1so; 2a id. »1 » )> ,, 1, l i> » )) )) )' 11 11 » 1, 1 2 1 1 i 4 8 1 3 1O 78 11 O 11 O 5 5 60 7O l 80 3a id. )) l 1, ;, » 1> » )) )) )> i1 11 ii 11 » I 2 t 1 1 4 8 1 3 10 78 11 0 11 0 5 :, 60 70 1801 4a id » » )I )l )l ' l) )i 1 » \) » n )) )) )I 1 2 l 1 1 4 8 l 3 1O 78 11 O l t O 5 5 60 ~o 1801 1'otale. 1 1 1 1 1!s l 2 1l I 2 1 1 17-;; s-;; -;; l 16 32-;; 1211 0 312 ·,,50 -;;57 w20 210 2SO 7s, 5a Volteggia tori 11 1 >> )) l) I » 1 >> i i 1> ». n » » )) . )1 1 2 • j 1 1 4 8 11 4 10 78 110 110 5 5 60 70 180 'I'-ota legenerale 1! 1j 11 / 1 1 3l2 1 1 21 , 11 7 5~oj ·5~ 5~0140 1 it'l 'l 650390 55 0 56725 125300 \35 0917 I I ' l I I I .
sono ind
~,ormazione de l nau àg li one e sua si tua zione ud ·tempo ordinario di 11ace (1).
P AGNI E
(.1) Nella' truppa
F ,. Situazione del Balta~lione di fanteria di linea sul pi ede di ~uerra.
-.:, -.:, ... ... <.l .. Q) d o 8 C'il <.l e V) o ('l ... Q) ... .... ... -.:; ... ·~ .. s 8 Q) Q) - = ., .... (,I d -.:; Q) lll e.i o .; "' ., C'il ... ·.: e C'il !:I ·;::: .... .. C ... "' C ,Q ... ..l ..l -~ <I) Q) .. .. .. ., <d ., ~ ' Q Q) Q) Q.J ,_ .e E <d C'il < < N -~ o o o o

z t:>
·NUMERO DELLO STATO MAGG-lORE e COMPAGN I E Stato maggiorè 13 Compagnia . 2a id. 3a id. 4a id. TOTALE , , 5a Vollegg iatori TOTALE GENERALE ., . . STATO MAGGI OH E, COMP.-~GNIE T '"' ,-;e C'il (I) N I .. ... o e ;! ,n Il) 1i e o s .. -.:, e (I) e,) ... ,_ ., ·;: :a e o Q) ... .. ::i '.:J .... -.:, ..l Q) o ·~ e !:I e ..., :.. .. ;o ,Q f Q) :o .... < o 'til I :: <.l .. .:; :Il ,Q <.> Q) " -~ 5 tQ s -e ::) ! ::::: " 'O (Il l<l ....,, :E :;:: ,: e C 'O ;::: C 7. e s o o 3 ::: e .... .... ' .. Q) ;a tÌl ,: o -~lI o Q) 1,1 V) e I (.) <.l t .... .... ... o <.l
51:
:;;
< . ~ (/J cn E-, (J , f:-< µ.. IJ) (/} (.} t" E-, r/, Cl;) f-,e; O I O ' I . 11 2 5 21 D J » » » D » » » » )) 21 » }) » » » ,l) )) )) )) ! )) )) » )I l 2. 2 l 1 8 16 1 , 16 . 109 160 160! » 11 1> >> 11 >), »I » » nI >> » n >1 1 2 2 1 1 8 16 1 3 16 109 160 1601 » ,- » » )) )) ». 'Il )) )) )) )) )l 1 2 2 1 1 8 16 1 3 l fi 109 160 160 . ..: ..: .•..:..:..:..:I..:..:..: J.: _:..: 2 2i ~ 22! 16 2 1&1209 260 260 , 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 I 2! 1 5 21 I . 8 8 I 4 32 64 I 12 61 i436 6i0 661 • • • I » I » • • I I •I• I • 1 2 2 1 1 8 16 I 4 16 109 160 160 - - - - -· - 1-_ _ 1 _ -, ___- 1-- -- ---111I131 1 2 I I 2i1 521 5i1°1l0 5 ' 54080 41680 1 >45 600 82 1 -. --_, , __ 11~ ~ 11 21
PROSPETTO
1,/l ... .... tP c. c. o. 8 Q) -.:, f; ·;;. ci- ·;: 1,/l CD o. !3 o -.:, I< !'< ::, = ,_ ;; ... ... o ,,.
(I) C'il ('il , ., .. o e C'il <:) o <I) Q) "' .,., .. 0 o o ...
p (/} (.J
STUDI SULLA CAVALLERIA

D~L NUOVO ORDINAM E NTO
Une armèe manqua nl rle oa valérie obtlent raremen l de grands succl!s Jox 1s1.
È arduo, d elicato ed oggidì co ntrastatissimo l 'argo·mento che io imprendo a disc utere, quant'esso è i mport antiss im o, sp ec ial mente p~r noi, il cui esercito è in via di formazi one .
Il capitano Nolan in Inghilterra , ed ultimam ente il colonn ello Azémar in Francia ed il generale R enard nel Bel gio, trattandola , sollevaron o vivacissime po_lem ichc t a nto sul proposito tattico q uanto sull 'or ganico el e mentar e .... Avrò io ·forse la pretensione di r appaciarle , risolvendo compl eta m ente le suscitate quistioni ?.. .. Mai n o ....
chè a sì arduo còmpito potrebbe soltanto, ed a mala pena, cimentars i un m aestro n ell'arte, il quale entran do
ANNO VI. Voi. I. - r,.
E
NELLO SP IRITO DELLA TATTICA ftJODEllN,\
-
DELL'ESE RCITO I TALIANO
n ella liz za, e -porta n dovi tutto il peso e l' autorità d i un a fama p r estab ilita in co n s i m ile m ateria , irrepu g nabile e prepossente, n otom izzi con mano sicura e fredda il soo-getto, lib r i un o a d u n o i d ibatt uti arg omenti s ull a st:der ~ della logica dei fatti e li confronti al paragone della st ori a d elle guerre ed ai precet t i fon dam ental i ed im m utabili dell'arte militare , e quindi da cosifatto criterio es~r_a?ga u n g i~ dizi? rc~li zzabile e di pr on t a e p alpabil e u t ,hta .... E chi altri mai , se non un J om ini , potr eb be a t~nto p~ricli~a1:s i , senza n ep p ur la cer te zza, p er q uest'u lt i m o, di u sci r m col u me d all' un gh ie dea-li a rrabbi ati liti.,gant1 .... . ·
~pperò mancan domi e p es o e autor ità p er trattar l a tesi gener ale, mi li miterò a quella particolare r iflettente l' ~rdina me~ t o della n ostra cavall er i a , entr ando nella quis~1on ~ t~t~1ca _ ~uanto appena s ia indispen sabi le per ch i ar ire 1 m i ei d1v1sa menti e avval orare l e mie prop oste .
P AR TE I.
BREV I CONSIDERAZIONI SULLA NUOVA TATTICA
D ELLA CAY.ALLERIA
Tu tt i i prog ressi della taLtica tendono oggidì. ad i mprimer e l a maggior mobilità p ossib ile alle truppe , a fi n che possano co ll a massima rapi d ità p ercorrer e l e dis t anze d el cam po cli bat t aglia e p i ombare s ul n emi co, r iman endo _il m inor tempo possibile esposte agli e~etti m icidiali delle n uo ve ar mi.
Dovrebbe bastare questo solo fatto i n contr astab i le a p o:rci i n guar d ia con tro a ' s r a.gi on evoli ed im p r u denti giudizii di color o che procl amano l'inutilità d ella cavall eria su futuri carnpi d i b a ttaglia, e ne ri chieggono a t utta voce l' i mmectiata abol izione , onde ~gravarn e l a p ubb li ca fi na nza; come se l a cavall eria n on fo sse l'arm a m obile per eccellenza, come se la non fosse suscetti b ile di im mensi perfoz.iuname nti in questo sen so I
No n per ciò d obbi am cader e nell'eccesso contrario e p retende r e che l a cavalle r ia abbia da essere per l o innanzi più che m a-i necessaria, e la si debba p erciò accrescere, come il pret.ende, un po' troppo corri vam ente, il general e Ren ard. Ma ch,e q uest 'arm a niente h a scemato della su a utilità tattica i n fo rza di progr essi pirobalistici e pu r chè il s t,o or din amen to e l a sua tattica special e s iano p ort ati all'altezza delle altr e .armi, ciò che è fattibilissimo, essa sarà sempr e - di u n conc or so e ~senzia1 i ssimo n ell e future battaglie : di ci ò non si può ragionevol m ente dub itar?., a meno che si p r et en d a di p oter v incere p er l o i n n an zi senza mai muover p asso all'attacco, ma standosene sempre imm obili a for fu oco; ci ò ch e è u n assur do ev id ente e ridi col o . Spi eghiamoci megli o .. .. s' è p ur necessar io! .. ..

50 S TCJD !
SULLA CAVALLERIA
5 1
I pregi principali delle armi rigate, in genere, sono la maggìor gittata e la g iu ste zza clP-1 tiro: colla maggior gi ttata si aument arono g li spazii pericolosi del cam po di battaglia, colla giustezza del tiro si accrebbe l 'efficacia del fuoco; e in verità questi sono due vantaggi in tut,to favo re delia difesa, poichè l'el emento principale di questa è i l fuoco.
Ma possiam noi per tanto conchiudere che d'ora inùanzi si dovrà ab orrir dall'offensiva, e che gli eserc iti _ !Ìéthici battaglieranno oram ai di piè formo fintan tochè l'uno de' due sia to talmente distrutto dai fuochi dell'altro? Se ciò foss e ragionevolmente probabile, noi pure vorremmo il bando ad ogni specie di cavalleria, e che s'ingrandisse invece quanto più possibile l'artiglie ria.
La storia della moderna tattica , la quale, ben si può dire, altro non è che la storia delle armi da fuoco, ci dimostra che ad ogni progresso di queste in favor della difesa, l'offesa mai non si è rimasta indietro, ma studiò ed ha trovato sempre nuovi modi, non solo da controbilanciare, ma d a vieppiù avvantaggi arsi la partita, imprimendo sempre maggio r vigore e slancio all'azione sua.

Mano mano èhe il fuoco accrebbe la sua efficacia. l'attacco assòttigliò , alleggerì e mobilitò la sua ordinan~a, nè cedette 111ai 1a sua supremazi à, nè ce'Ssò mai di essere i l mezzo principale e l'an ima della vittoria.
Come si vinsero le ultime battaglie? A ùfontebello, a Palestro , a .J1agenta, a Marignano, a Solferino non fu égli fo r sé co n in cess anti e rapidi attacchi colla baionetta, collo slancio irresistibile degli impareggiabili soldati francesi e dei nostri, che ovunque si ruppe e si sbarattò l'inerz ia tattica degU Austria ci? Ed è tuttavia inn egabil~ cb.e, dalle ultime loro guerre, le a:rrni da fuoco deo-li A us~riaci si erano di molto m igliorate e per gittata 0 e per giustezza ed anche per çelerit~ di tiro.
Da ciò dunque noi siam costretti a concbiudere che qualuqque progresso ba listico .non torrà mai all'attacco il suo sopravvento naturale , e che anzi in ragione della maggior efficacia del fuoco, la tattica d ell'offesa consisterà sempre nell'imprimere la maggior mobilità possibile alle truppe , nel piombare con sempr e ma,ggior celerità e risoluzione su l nemico per giungergli sul corpo e far tacere i suoi fuochi, prima ch'essi abbiano avuto il tempo di dedmar troppo le file dell'attacco ; le cariche veloci ed improvvise, i soprassal ti , l e sorprese avranno, non v i ha dubbio, una parte rilevante nelle future battaglie.
Or bene, se la difesa non riuscirà mai a primeggiar la offesa, come mai puossi ragi onevolmente consigli are d i abolite e tampoco di diminuir la cavalleria , l'arma offensiva per eccellenza, la cui essen za t attica è di agire colla massima prontezza , con urti inopina~i, prepotenti e deci sivi?
Mai n o, mai no, , che per nulla scadde l'importanza tattica della cavalleria.
I pr-o g re ss i della pirobali.stica, come pure i perfe~ionamenti e i mutamenti recati all'organizzazione P-d alla tattica della fanteria, banno sempre influito in un modo più .o n1eno sen13ibile sul1 ' i stru zione, sul modo di combattere e s ulla tattica della cavalleùa; ed in q uesto senso le rimane oggidì da fare uu gran passo; epperciò inv ece di sparla.me , invece di predirla inutile , di minacciarla di rid1;1.zioE.e , ben sarìa più savia cosa e l ogica il chi~dere che la s1 mig li orasse e la si portasse ali' altezza del suo nuovo mandato, all'altezza de' moderni progressi della tattica , ciò che non .è affar diO:ìcile.
Così. la cavalleria sarà sempre l'utilissima ausihariFL della fanteria; impiegata a prop os iLo essa })rocurerà sempre splendidi ed anche talvolta decisivi ristùtati : e n0n le ne manch eranno l e occasioni nelle prossime gu.erre, anch e nei nostri paesi .
52 STUDI
$OLLA CAYAI.LERIA 53
SULLA CAVALLER IA ,55
Gli avversatori della eavalleria pretendono « che la lo comozi one a Yap_ore per ,terra e per mare, le rotaie e l'elice, hanno mutate le parti fra le truppe a ·cavallo e quelle a piedi; che coll'applicazione di cotal forza motrice al tri:1,sporto delle tru ppe, gli eserciti saranno d'ora innanzi tanto più pesanti quanto maggiore sarà la loro cavalleria; che tutte qùeste innovazioni, si fanno a vantaggio della fanteria ed a grave darn11,o della cavalleria ed at1che dell'artiglieria stessa; che trovasi bensì scritto riei libri, come la cavalleria serva a protegger e le ritirate ed
co~pleta: le vittori e, ma che non silì anno guari ·esempi m cm cos1fatta teori'a siasi messa in pratica; che dal medio evo in qua l 'importanza della cavalleria scemò costantemente ....
Che l'applicazione del vapore alla l ocomozione per t erra e per ~ar~ a~ha recato notevoli modificazion i nelle grandi . combmaz10m della guerra, ci ò bene sta in q uesto senso : che per terra colle ferrovie si ponno concentrare rapidamen~e grosse masse di truppe sui · punti strategici di u_na pnma fron~e d i op erazione al pri:Q.c ip io di una g uerra, s1 ponno _es eguire rapide mosse strategiche al coperto di q uesta, ~1 pu_ò speditamente all'orzare qualunque punto v_enga ~mac ciato della linea di difesa, si ritraggono pronti rmforzi d al centro dello Stato e ne sonÒ facilitati 1'avvettovagliamento _e l'ammunizionamento delle truppe·; per m_are, la loco~?z10ne a vapore permetté oggidì di coordmare con facilità e precisione ammirabili le mosse delle flott(3 e degli esercit i, di farli concorrere a tempo calcol~to yer determinate combinazioni di guerra, per diversio~1 i~nprovvi_se, . per im ponenti d imostrazioni, per le invas10m r~pe?t~ne ,_ per blocchi', per lontane sped izioni un tempo grnd1ca:e _imp ossibili, insomma per prestarsi un mutu~ appogg10 m modo e circostanze innumerevoli.
Egh è pur vero che la cavalleria e ·l'arti glieria ·i10n presentano alla locomozione loro ugual maneggevo l ezza
che la fanteria, ma si dovranno per ciò escludere da' moderni eserciti piuttosto ch'e studiarsi di facilitare lo ro questo metodo d i trasporto? - In che consiste il gmve dctr1,mernto che si pretende abbiano da r isentire dalla locoinozione -a- vapore? Oltre . a ~he ogni giorno si vanno perfezi onando i met odi d'imbarco e sbarco per ogni specie dt truppa (nè staremo . molto a v·eder caricarsi e s.caricarsi su · convogli ferroviarii la cavalleria e l'artiglieria colla stessa facilità che la fanteria), alla peggio andare , sembrami che il vapore non abb i a barra t o Ìe antiche vie a queste armi, e che per· tanto, in senso assoluto, l a loro mobilità non ne sia danneggiata.
A riscontro delle ultime · opposizioni circa alla decadenza delhL cavallerià, , ben si vale l' argomento che compulsiamo la storia.
Non parl eremo impertanto nè della cavalleria greca, cui dovette Alessandro le sue più splendide v ittorie, non parleremo di quella d e' Romani, neppur d.i quella dei Cartag ines i che sotto Annibale operò meraviglie e gli mantenne il piede per 1.6 anni in Italia. Ma prenderemo le mosse per lo appunto dalfo scorcio del medio evo, cioè dal rinasciinento dell'arte della guerra.

54 STUDI
». ·
)
-----,-~-- ,_
5}. G. c.
(Continua)
E D:JFESA DI PE'SCDIERA
studi fatti, così -intorno alla fonde ria dei cannoni-, come dg ll'artiglieria da montagna e da difesa -nelle piazze, nel concederci la pubblicazione di q,uesto su.o scntto ch 'egli destinava all'ob-lio, c'impone di tacere d el suo nome . Ora p erò siaci concessa dirgli la sentita nostr a gratitudine, e serva pure .questa p ubblicazione d i esempio ai tanti benem eriti uffic iali .delle varie aru'ri. che condannano alla oscurità pregevo ll loro l avori , frutto di s t udii, di v egl ie, di .sperienze e di viaggi.
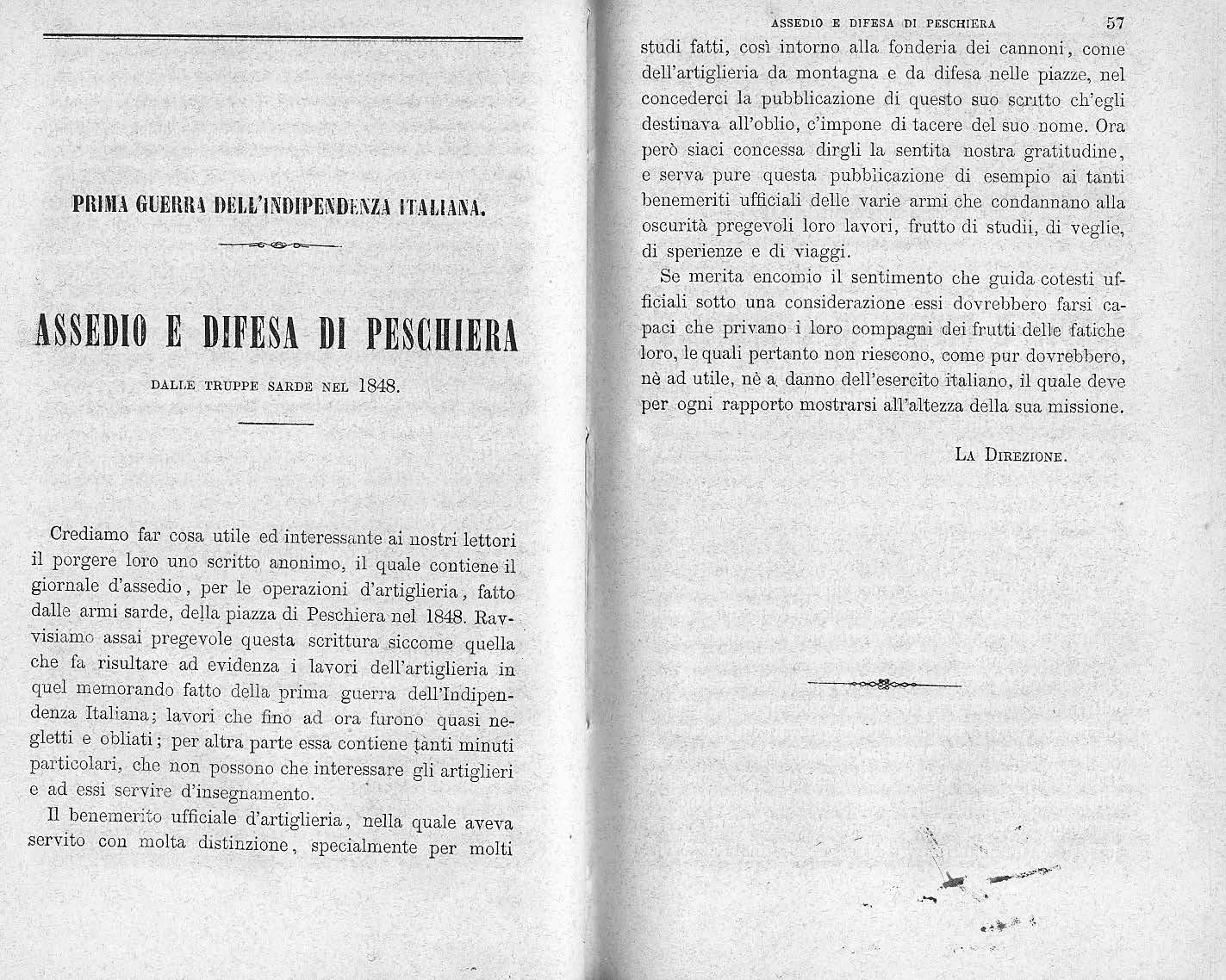
S e merita encomio il sentimento che g uì da -co tes~i 1:1-ffièi ali sotto una cons iderazione essi d òvrebbero farsi capaci che priv,ano :(foro ooropagrui~ .aJei fouiti <lene :fatrche loro, ·le quali pertanto n on riesoono, come pur d ov r èbbero , nè ad utile , nè -a. danno d ell' ese r cito 'italiano , il qnal e deye • I ·per ogni r a pp orto mostrarsi al't ~a'ttezza d ella sua missione. LA
.Crediamo far cosa utile ed .iat©ressante ài n ostr-i lettori il porgerè l or0 uno scritto wnonimo, i l quale conti ene il giornale d'assedio, pe r _ le op erazioni d'artiglieria, fatto d alle armi sarde, della piazza di Peschi era nei 1848. Rav- . visia'i:no assai pregevole questa scrittura sfocome quella che fa risultare ad evi denza i lavori . d ell'artiglieria in· quel memorando fatto della prima. guerra dell'Indjpendenza Italiana; l avori che fino ad or a forono quasi ne~ gletti e obliati; per altra parte essa c~ntiene ~tànti mi.nuti particolari , che n?n possono ch e in t eressare gli artiglieri e ad ess i servire d'insegn amento.
Il benemeri to ufficiale d'artiglieria, nella quale av eva . servito con mo lta disti n zi one, specialmente per molti
: .ASSEDIO
,, . . ' '' ,.
;PRHH GUEHIH 't)EUJ'INDW-ENDE~Z! l'lì.U I AìU ..
DA LLE 'rRUPPE S ARDE N EL 1$48.
ASSEDIO ,E DJFESA IDI PESCIIIE RA 57
: :§§ :. s ,
- DIREZIONE
d el parco d!assed10, ordinando ad un t empo la sua partenza per Alessandria:.
GIORNALE DELL'ASSEDIO -
DELLA PUZZA IJ! PESCIIIEllA
Fatto dalle Armi Sarde nella prima guerra dcll'l!!dipendenza Italiana e di Ila difesa successiva nel ·t 848.
. Le sorti avevano condotte, di combattimento in combattimentQ, le truppe italiane, capitanate dal magnan imo r e Carlo Alberto, alle sponde del Mincio. .
Il· 13 aprile 1848 essendosi fatta una dimostrazione sotto Peschiera dalla divisione sotto gli oràinf del generale Bès, ~on tre bat~erie di campagna, ed essendo questa riuscita mfruttuosa, il comando generale dell'esercito si ' deci se a ,far venire.. un parco d ' asse.dio di Piemonte, e ciò onde attaccare più validamente le fortezze che ·servivano di propugnacoli .agli Austriaci. L' ordine della formazio ne e della sp edizione , del parco si crede sia st~to fi rm ato dàl R e circa- il 20 dello stesso mese d'aprile.. Non avendo potuto avere visione del g iornale dell'assedio, componemmo questa qualunqu~ siasi memoria delle cose viste, operate od udìte. ' , ·
Il maggiore Cavalli, d'accordo con una commis;ione di altri ùfficiali, compose l'elenco del materiale pelle 45 boòche da fuoco che si stabilirono dover entrare in Lombardia.
Il 28 di aprile ;lilla lettera del comando generale d' ar. tiglieria giunse a . Gendva, e destinò l'ottava compagnia di i;iazza, ivi stanziata, a passare sotto il comando del capitano Ricaldone, avente sotto di sè il tenente Cravos io e ~ott9tene,ntè Pautriers, e ad · essere destinata al servizio

Il 30 del mese, l 'ottavà compagnia si metteva in IJ1ai:cia, giun gendo lo st esso . giorno a Busalla, i l 1° maggio ad Arquata, 11 2 a Novi, dov:e si riposava, qùando una staffetta portò al COIX\,~~dante di questa piazza l'ordine di immed i ata partenza . della compagnia per Alessandria, Camminan do quasi tutta léL notte, l'indomani essa si trovava priml;t del far del giorno sul sito, ed entrava, . ap-pena al)b!l,ssato il ponte, in cittadella. Il maggiore Cavalli vi giungeva dopo, e disponeva perchè essa potesse pi·endere imbarco sul Tanaro, e proseg.uire il suo viaaofo sul 00 Po fino a · Crerilona. .
· Il 3 di magg io adunque, alle .sette del mattino, la compagnii,' dopo aveue iucettato viveri e lasciato venti cannonieri per i lavori di cittadella, s'imbarcava ;u due barche da ponte riunite, con 80 uomini. · La compagnia, a Genova, prima di partire, era stata portata -'a 100 uomini; dovette lasciarne venti, e si approfittò di quelli che erano rimasti indietro nell' ultima téJ,ppa radddppiata. Tre pon tieri pratici, con due mugnai d' Al<i:ssandrfa, conoscenti la navigazione del _ fiume (1), guidarono il doppio legno, ci arrestammo una volta a ·comfJerar vino, ed arrivammo a notte chiusa a San Cipriano , vicino a P~n- · talbera, più sotto di diverse ore di Mezza~a Corte, dop0
• aver passato il ponte d t quel nome,' che si aperse per noi, e dopo aver visto l'.imboccatura del Ticino nel •Po' ed i più bei paesi e punti di vista del mondo.
Nei luoghi dove ci arrestammo il 1° giorno di via,gaio o , 11 fiume comincia ad allargarsi in vasti pelaghi, che si potrebbero chiamare la ghi, e non si può che .ben , ;icino alla uscita,dove esso ritorna alla sua solita larghezza, riconoscere da che parte sia il con_tluente . Un i nesperto ·noii saprebbe da che parte dover spingere la barca. Ricoverat& (1) Questi ultimi vennero poi licenziati I:,. sera,
58 ASSEDIO E DlFESA
DI PESCHIERA 59
ospitalmente a San Cipriano la notte, l'indomani la compagnia s i nm1s e in barèa, ed arrivava fra gli e'vviva all'It alia e gli scherzi d ei soldati a P i acenza., dopo sei or e · di viaggio.
A Piacenza sbarcammo gli u fficiali ed alcuni sott'ufficial i ·per incettare viveri in pane ed i n formaggio pella. compagnia. Fummo due· ore in 1'.>iacenzci ; vidimo l e c1 ue statue equestri Farnesi. Oi aggirammo per 'la città con alcuni bo rghesi, e dopo esserci leggermente -refezionati, falparnmò di n u ovo, si aperse il pont e, dove vidimo l'acqua molto rapida, osse,rvammo l'imboccatura d el Lambro, ed, arriv:ammo fra amenissim e ed italiane ri~•e a Cremona s ul far della notté.
Strada facendo vid1mo , sulla s pon~ a sinistra, u na cìttà, che con ghiett urammo dover essere Crema · ; e dopo di .essa l'imboccatura dell'Oglio, e dop o di ess a anGora:. a capo di due o tre altre ore di v iaggio., Cremona colla sua altissima torre .
Non conoscendosi il luogo dello sbarco, ci sbagliam mo , ed invece di passare tra la spondl;l, e l ' isoletta che vi è r impetto (come 11oi avevamo suggerito), l occh è ci avrebbe condotti alla strada che mena a Cremona, .passammo in fuori dell'isola, e fu me st i eri ch e un , uomo ci accompagnasse, fra il più cattiv'o tempo del mondo, . attraverso i boschi e la Tena , alla città.
Il maggiore Cavalli, che ci aveva prescritto di cp là, trovarsi fra due giorni, avev a: spedito il cannoni ere Galigaris ad attenderci, ma questi avendo perduto ·pazienza <li stare alla spiaggia, ed essendosene andafo, fu mestieri andare da noi soli , attraverso l a città, a domandare il nostro ricovero. C1 fu i ndicata la caserma di cavalleria, ove i n ostri soldati ebbero un riparo dal cattivissim o tempo. Gli uffi ciali fu r ono alloggiati nella ca.sa Àla-Ponzòni, e l'indomani matt~ua , sotto la direzione del maggiore Cavalli , ~Ile 4 del mattino, ci met temmo al lavo.r~ dello ~ba.rco 1
· ll 5' maggio adunque si avevano .già 1nolte barche di materiale giunt.è a Cremona. Il convo~lio di pontoni guidato dal signor sottotenente Giuliano, c he avevamo incontrato il primo giorno a Mezzan·a- Corte, ed il secon,do giorno prima di arri vare a Piacenza, nou -'era ancora arrivato, ma s i aspettava di momento in· momento. Molti altri ér1ì,no per la strada. _ Il maggiore Cavallì li aveva tutti nolèggiati colla condizione di un ribasso d~ un quinto sul prezzo~ di tra sportò, qualora oltrepassasl3ero quel dato . numern di ore . Alcune barche e rano g ià arrivate. i gio:i;~i prima, ed iÌ ser gente Cal7,,olar i , pratico delle manovre di forz ~i., aveva opel'a.to l o sbarco del contenuto; il- m aggiore Vittorio Seyssel, cbe stava dal m'.attino alla sera al fiume, dii·igeva il ritiro del1e bocche da fuoco per mezzo del_c_aprone, a bella postar' statoc i piantato dagli in gegneri dellà c:ittà, tl;tti gfi u fficiali e la compagnia sì misero con alacrità a cari care le vetture . Una ventina erano g i à in ordine . La città provvide un altro caprQne di sbarcò, fece p iaJ;Itare fanali sull a ri va , un casotto per il corpo di guardia, .diede viveri, e l a compagn i a fu distribuita in due parti , onde ·continùare il lav oro senza sospende rlo nè di giorno; nè di notte. .
Due· giorni dopo , cio$ il 7 maggio, un convoglio di · 120 cart1 era pron to. Il maggiore Seyssel, in continua r elazione col comitato di guerpi.._ e col muni ci pio , aveva fatto prtivvedere i cavalli n:ecéss:.tti per attaccarli ., e lo stèsso g i orno dop6 avere ai.utato egli ste sso i conducenti a mettere in sesto le mute, esso p_artiva per Manerbi o, a.vendo in sùo a i uto il tenente Cravosio ed il sergente Galetto . - Un grave incaglio furono i carr i rurali, i quali · entravano per l a metà . n el -numero totale. Riparati in fretta. dagli a1'tefrci di màestranza con traverse lat~rali, énd'e potesse'ro contene re i proietti, non fu possibile rinforzare le ~uòte, le qttal i si sfasciavano per· il minimo urto. Diversi carri dovettero i'_estare i,:rtdiètro h:mgo la

60 ASSEDIO E DIF r::SA
I )
Dl l'ESCHIE!tll
strada, e talvolta fecero arresta~e per ~diverse ore le colonne. Una precauzione çhe non si ebbe da principio, fu di bagnare i mozzi ed i •gaveW, talchè per il sommo caldo si disgiung.evano. ·Il tavolato di questi carri, che si usa piuttosto largo in Lombardia, si adattava assai bene a c<J,ricare robe di grosso vo lume, come i legnami dei paiuoli, ecc, Si misèro s-µ ciascuno 100 bombe da pollici 8, o 200 palle da 32, ma si, riconobbe che questi ·carichi era.ilo troppo . pesanti è che i carri non potevano resisterli . · -
Il maggiore Seyssel essendo andato avanti, rimase comandante del convoglio il 'tenen te Cravosio, del qua.le mai si potrà fare abbastanza elo gio, avendo dimostrato in • ogni tempo · grande cbi a.tezza d'intendimento, molta pratica nel servizio complicato dell'artiglieria d'assedio, ed in ogni occocrenza calma e bl!O na v olontà. Il giorno dopo la partenza. del primo conv oglio, g:iungev ano a Cre1nona i :venti uomini lasciati in Alessandria; giunse pure da Torino il signo l sottotenente Duplan, allora uscito · daÌl'accademia , con un distaccamento di 50 uomini.

Il giòrno 8 un altro convoglio e ss en do pronto , pai;tì sotto gli ordini del sergente Bellis. Esso s i componeva di 40 carri. Questo sergente era stato preso dalla ·setti ma piazza in Alessandria, e fu i vi imòarcato con noi . Esso si disimpegnò con zelo e .buona v olon tà d ?lle sue funzioni. Nel mentre che i convogli partivano, si lavorava con, temporaneamente al Po a prepararne degli altri, scaricando · i barconi e mettendone i pesi sui carri . .Ivi tutti i sott'ufficiali gareggiarono ·ai zelo. Al pa.rco il sergente Coller, che d iv enne poi furiere, teneva registì·o dei carri che ar- . rivavano e che partivano, facendo .così il contabile di quei m1merosi movim enti. Tenne pure registro dei movimenti delle- polveri che si agglomeravano nell'attigua polveriera, e che poi servivano a ri fo rnire i car,ri. :ryi molte batterie di campagna avevano inviati carri tedeschi e munizioni di ogni sorta.
ri 9 maggio partì i l capìtano Ric~ldone~ avendo in ~uo ai'uto il so ttotenente signor Duplan; 60 ca rri componevano questo· convoglio. Non sapendo ove di.ri gèrlo , p erch~ il ma.aaiore Seyssel non aveva inviato ni ssuna comumcaoo zion e dalla parte · del duca di Genova, comandante l'arti g1ieria all'esercito (e qui bisogna notare che il sergente · Bellis aveva avuto prescri zione di andare dove avr ebb e scope_rto esser s i diretto il primo convoglio), si fece una specie d i . consiglio tra il generale Bataill~rd, c?man c~ante . m i lita,re a Crenioria, i l maggiore Cavalli ed 11 èap1tano Ricaklone. Non si sapeva se si. -volèsse fare l'ass edi o di P éschiera o quello di. Verona:. Onde appurare la verità, si · analizzò una l ettera particolare del maggiore Seyssel: ti si valutò j l senso d' ogni sua parola. Essa parlava del fatto di Santa Luci~ il giorno 6 d el mese, ma norme per la condott a. del parco non n~ contèneva. · Si guardò l a car.tq, geografi.ca, si domandò e si congh1et!utò dalle posizioni dell'armata se si_.volesse piuttosto battere Peschiera che ·Verona, e st ·partì sulla base di battere ancora la strada che avevano calcata i p rimi cònvogli. Ci dirigemmo adunque per Mane~bi o e Montechiaro, dove arrivammo il giorno dopo. . , Col à l a sera., ·cioè il 10 corrente, vedemmo il maggiore Seyssel che tornava i ndi etro a Cremona, e- ci disse . che i due primi convogli era.no andati a Ponti, e che quello sar ebbe bene fosse r imasto a Pozzol engo, m1 miglio avanti di quel luogo. Co1à arrivammo il giorn o dopo, con una sola tappa . · ·.
Il viagg~o da Montechiaro a Pozzolengo, il giorno 11, fu }~boriosissimo Sul grande - stradale da Mon.tech iaro a Guidizzolo alcuni carri furo no strav,olti n ei fossali dai ·soldati di provianda, bisognò ripartirne i proietti, che ne formavano il cari co, sugli altri. Le sale - dei carri rurali prendevano fuoco, ·e le ruote si sfasciavano. Si ar- · . profittò d ella poca acq;a•.,éhe si trovò in qualche iuogo
-62 ASSEDIO E DIFESA
Dl PESCHIERA 63
AS~E-DIO E DIFESA
0nde. bagnarle. H maggiore SeysseI· èi ave\.·a speditè a Montech.iar~ 1 25l1, pariglie della provfan.da; fu mestierè fare un'altra ripartizione delle mute, onde combinarle coi ca- , wtlli dei comtaèlini che restavano, e le lagnanze, per gli scoucerti di dettaglio·inevitabili , non furono poche. Da, Guidizzolo a Volta; e sovratu..tto €1.a Volta a Pozzolengo, nelle colline che .separaino il Mantovano dal Bresciano, la. ri stPettezza delle strade, le pendenze rapide , fe•cero ritard&re di moltB ore gli ultimi carri del cohvogli9, ma arrivando noi sul l uogo, iÌ c-•rnandante i l ·parco d i carrt~ l?)[l;gna, cli~ era in ° q1'1el momento il tenente Biandrate, per Fassenza •del capitaho Revel, mandò nrolte pariglie · della pr.ovianda a riscontro dei carri che tardavano, e ne f~c ilìtatolio Farri:vo . Il convoglio parcò lungo le strade t eccetto afoune bocèhe a; fuoco, tutto lo spazio essendo già occupato dwl' parcò prib.cipale' di campagna. Così pure erano .disposti ì du.é primi a, F@ti, che stavano sotto lai direzi6ne del tenente Oravosio·, e che anela.i ·lo stesso gior,no a vedere. .
Eravam:o a pochi- miglia d~ Peschiera, , e l'ind0ma11i-, 12 maggio; mi l'ecai CO'l ca~pitano Revel dal' dl!lc'à- di @e~ nova , comandante g enerale l'artiglieria ~ a, Pct:cengo ru prendere. ì sa:er ottlini. E""i H principe col suo :capo di sfa~to maggjore gener11:l'e Ro~si , défìn't qmanto si d ovesse fate. Fu fls sailo· che si fàrè;i;Eie l'attace'd di ,Peschiera con Ì8 bocche da rll'oeo cl?a:st.l'èdtò 's1.!ilrà! ricv a sini'str'à, e cG>n 12 ·di c~ri:i-pagtia st'tlfa dè'Stra:. -Il gMè:talè 1fossi rrti cònseg;n'èJ il doppio della nota che lui teneva deI parco d i attaccd,- cioè ·
Oari:Woni da 32 N° J O
t>bic'i d à 8' pbUiei. Ji 4
Nforia'ì da lu po'l1ici , 4 ·
Tdtalè- N° 18
c'éli tùtt'i: i lorò nècess~:M:i: assortilrninti,, àrma.raéilti.,, G:arreggì , ptil:~ele è proietti pet J.loo· colpi., La, pr©>~ia,nda
D I pi,;SCHit:RA
avrebbe poi po:r:tato gj.ornalmente· da Po~zolengo le mt~riizion.i che si consÙmavano. Partii eol capitano Revel 11 mattino, e mi po rtai immediatamente a Ponti per c.om-. binare co l t enente Cravosio' che t eneva una groSSU: parte del parco, onde assortire il ·con.vòglio e far n e' fra ~ut~ due una p6rzion e sola. - Il capitano ·Revel avrebbe po\ tenuto in cust.odia, il resto . .
L'indomani, 13, il convoglio 15artiva in buon ordine ed arrivava per Monzambano a Oavaléc1,selle. Parcammo con infinita di.fficolfa dinanzi alla polve1~iera Mana,ra, .perdendosi delle ore intiere per far girare i pezzi, sia p :>r la impe~izia della provianda, quasi tutta composta di nuovi soldati, come p è r la difficoltà del terreno.
Il Ì4 ci recammo di nuovo dal duca cli Genova, il quale decise si 'sarebbe cqminèiatò l'istessa sera il tracciarnentq delìe batterie. In 'effetto ci ordinò di tenere pronti gli strumenti i:iec essarii, ma una parte di questi e:a g ià st~ta spedita ed s tata smarrita, ciò che portò un in~a~lio.
11 tenente Mattei fu incaricato col tenente Defornan della batter{a di 4 rnort; i 'e 2 obici da 8 pol l ir.i., il capitano Filippi col tenente Pallavicini cli quella dd:i .pez-zi ~a. 32, ed il tenente Rico t t i di quella di 2 obici da 8 pollici ed un can none. Queste tre batterie erano sul Mondano, quella . dei mortai un po ' più alta e riniÌ;ìetto all'opera Mandella, e le altre i1~ prolungamento di questa a valle del fi~e. · Il tenente Quaglia aveva là sua batteria di due ob1c1 ed · un cannone a destra del grai:;i straélale, facendo faccia alla .piazzà. Si lavorò il gio~no 14, 15 e 16. . . .

Il 17 a sera si dovevano armare le batterie. Perciò · - disponem~o fa éolonna dei carr{ sulla strada m~estr:~ nell'ordine seg uente per ciascheduna delle batterie; · S1
, fecero g irare i pezzi senza avantreni, ·cosicché si p~tE)roho poi far camminare . Essendovi una sol~ col.onna, v1 erano quattro porzioni cosi composte : 1° pàrnoh; 2° b.occ;he a , fuoco sui loro afflisti; 3° carri da parco coperti con la
64
ÀNNO
VI. Voi. I. - 5.
p,olvere; 4° p:çoietti ; 5° armamenti ed assortimenti di ogni sp ecie . Si misero gli sfondatoi, i quadranti per gli ob ici e mortai, i portamiccia, ecc ., ·per ciascuna pocca a fuoco de,ntro un aofan o da riparo, onde fossero tutti questi oggetti riuniti. La neg]jgenza e la difficolt.à del servizio avendo fatto perdere di questi oggetti, ne ebbimo ·amari rimproveri. Il maggiore Cava;W stabilì il laboratorio degli artifizi n ella chiesa di Cavalc aselle, e le officine dentro una bot!ega da maniscalco del paese. I carri da parco facevano iì servizio dei proietti cavi dal. parco alla chiesa, e le èarrette d a trincea dalla . chiesa, ove prendevano i proi etti carichi e li portavano più in su · che potevan.o a.rrivare . Queste trincee, quasi tutte direttamente infilaJ,e dal fuoco della piazza, diedero luogo a qualche morte ed a qualche carro rotto dalle palle nemiche. La sera, · coi, l'attività del maggiore La Marmora Alfonso , si armarono l.e batterie . Non giovando i cavalli a cagione dell'immenso fango, si fecero attaccare_gli uomini con manovelle . 11
sottotenente signor Viglietti si adoperò moltiss imo in quel1'occasione. Si condussero via gli avantreni e si riportaFono al parco (1) . · ·
L'indoll_lani ~8, . al mattino, fu spedito per tempo u~ ordine al capitano Avogadro di cominciare anche lu~ il fuoco, quando l'avrebb ero cominciato gli altri. Esso aveva gli 8 pezzi della sua batterii;t,, e 2 obici di un'altra, •di-stribuiti in 4 batterie, fatte costrurre antecedentemente dal maggiore La Marmora. Alle ore due dopo mezzogio~uo
(1) Il sottotenent,e V i'glietti ei-a in aiuto della batteria del tenente Ricotti. I sottotenènti Garrone e Bccéhis arrivarono al tempo dell'asse d io e fu~ rono impiega(i_ nella preparazione degli artifizi. Ir sergente Furno diwsse sotto il capitano Gard et le riparazioni di maestranza Il sottotenente signor

Suatton fu molto utile in Peschiera per la sua operusità perseverante. Nel lahorat9rio bombardieri , ossia nella· chiesa, si lavorò per diversi giç,rni anche di -natie con i Jumi accesi Dopo poi non si lavorò che di giorno Si stentava a provvedere 11n nuwei·o sufficiente di bombe, tanta era la consumazione, ·
si. a.p erse il fuoco colla batteria dei mortai. Il duca di Ge.nova ne dirigeva •lll!O; ben tosto t utte l e' batterie ri- ,. sposElrO al segnale, cumulando i loro colpi cont ro la piazza, che rispose con ·un fuoco sostenuto e terribile. h caporale Della Casa dei pontieri fu ucciso; alcuni altri cannonieri _ lo furono p ure qu.el g i orno stess o od in appresso . . Ben tosto fu terribile la circol azione per l'immenso numero . dei proi etti che infilavano le strade, onde tra il non ve~ dersi la piazza a· Gagione della fitta e battente pioggia, tra la difficoltà del terreno per il fango, ed il danno sop. portato dagli spalleggiamenti, si sospese il fuoco per non riaprirlo che quando le opere fossero riparate e le co~ municazioni r ese più prat i çabili.
La piazza di Peschiera, costrutta dal San Micheli, ingegnere dei Veneziani (1), e corredata di opere esterne dal generale Chasselòup , ha la particolarità di essere circondata da ogni parte di colline, senza p erò poter essère veduta, nemmanco fino al cordone d elle murature che la cingono . Da due sol e parti essa è un poco scoperta, cioè da iuella del Paradiso e verso Porta Brc;cia, vicino · al lago, ma da queste due parti due cavalieri, che si po.treb bero chiamare torri per la loro altezza, muniti di grossi calibri, .scuoprono tutto il terreno. ben d'intorno, e lo battono abbastanza Vitlidamente per impedire la costruzione di opere di attacco, ed in effetto ivi non se ne fecero nè dai Piemontesi, nè posteriormente dai Tedeschi. Il lago, che entra, per còsì dire, nE;llla fortezza, e si cambia ivi nel Mincio, si triparte in altrettanti corsi d' acqua, due dei quali paiono naturali per la loro considerevole velocità, e l'altro, quello di Porta Brescia, scavato ad arte, scorre · -lentamente e presenta poco ·ostacolo all'inimico. Le opere , di Mandèlla ' e Salvi, . che coronano tutt'intorno la piazz a,
(t) Si elle Peschiera. bello e forte arnese ' Pec fronteggiar Bresciani e Bergamaschi. . . ( DANTE, D-ivina Commedia),
66 ASSEDIO E DIFESA
DI PESt:rHERA 67
<lSSED!O
DIFESA la mettono quasi i n un'altra piazza; e tengono lontarr6 l'attacco almeno fino al primo periodo ,avanti di essere espugnate. . . \
Dal 18 al 21 si rii>ararono l e batterie , si misero delie fasciné nellé domui1icaii.oni con degli assi di sopra onde potervi un po' più facilmente passare, Il 21 venne riaperto il fuoco , .à.: cui rispose gagliardam~nte _ di nuovo qu~llo élella pfaiia-, ove fotti i Cro ati servivano cannoni, ed erano a· •c'fò itati addèstrati. s '.i cdntinuò poi fino al 3ò interot- . th\ili"e\:We h. tirai.:è . I · proi etfa ca:v i, sopratutto le bombe, faìna'rono un terzo dèlle case di Peschiera, ma gli altri jl'oco o nuffo effetto produssero, come cì accertammo al Paradiso , col duca d i Genova , ove vedemmo quasi tutti i proietti cadere nell' a cqua, Però l,a batteria F ilippi infil ò assai béne la fa:céia di Mandella, che le stava opposta, talmente che vi trovammo dopo là .~esa della piazza un à:lfo'stò' petforato da cinque palle. pubitandosi di questo fiisul-tamènto, si vollero cambiare questi cannoni, uno · fu sloggiàfo ed ebb'e' poi una r uota rotta da una palla, l'altro entrò appenà nella ccim.uniCa2'iione; affoni:lò e fu poi di fficilissimo l'estrarlo. Gli altri cannoni batterono di fronte la piazza e produssero, come si vide poi, as'Sa;i danno. L'opefa Mandella cessò di far fuoco il ·25, . In questo giorno, si -cominciò una nuova trincea .versò Pac ~hgo , in un sito pa lu dòso ed a:ssai ·disadatto per l'attacco. La poca coiiosèenza della · piazza aveva fatto prescegl1ere quel sito. Posteriormente, s1 credette che i Tèdeséhi avrébbe'ro tentato contro ai noi gli approcci tra 'il Miricio è Porta ' Brescia., ove 1. l te'l'rèno è asciutto, il forte Sal_vi fac.ilinè.:nte espl!lgnabile, e dove l e controguardie che separan,o _ il fosso del fronte di fortificazione servirebbero a trattenerne la breccia ed a riempirlo . -La trincea aduuque incominciata quasi perpendicolarmente · .alla strada che mena •a Pacengo e di fr<:mte a lla cascina dei ·Ronchi, fu pro~egtlit<1, con alacrità dalla fanteria, e
çlai zappatori del genio. Tre batterie dovevano 1:vi esser fatte dentro di essa. La pdma fu incominciata e doveva essere compiuta dal tenente Palla'Vicini. Essa t3ra a denti di sega, e doveva infilare la cortina di Porta Verona. Lé!seconda doveva essere fatta dal tenente Q1J.agli.a. ia terz a, di breccia contro la cortina ed il fianeo destro di Porta Ve.rona , · come molto esposta , doveva .essere cop~rtcJ, (blindée), composta di 12 pezzi da 32, ,e costrutta dai éap{tan1 Ricaldone e Della Royere (1). Qu13sta batte.ria esigep_do molti- preparativi, il capitano Gard.et Carlo fµ inc,ctricatq di comporne i legnami colla copertm~a rimap,_ente della polv eriera ,distrutt~ , che no.i abbi<l,mo :6.n q~i ch.iamat.a Man.ara perché da esso fatta scoppi.are per priyar,ne !sl\'Jh l ' µso i Tedescl;li, Una proposta di r~s:;t. er.a i;n.t.anto st.ata fatta dal maggiqre Della 1\'(armora a quei .di .d entro.; esJa ~ra stata; rifiutata, ma il g iorno 30 maggio, dopo la ii~pinta d,ei Tedeschi contro il loro . tentativo a ,Ca.lmasino , il magg~qre D'Etting.aussen ve11ne fuori , dopo c.essato il fu@cq, per l ' inalber azione d ~lla bandiera bianca, e patteggiò cql d4cw di Genova la capitol azione della piazza .
In conseguenza di ciò, il 30 maggio a sera il tenente Quaglia andava collw compagnia pontieri, a çui apparteneva, a prendere ·possesso dell'opera ;Ma4della, ed il mat';ti:0.0 su cce8sivo, 1°giugno, tutte ·1e .trupp.e -vi e~t:r:avano.La briga~a .di Pinèrolo, che avev.a -se:i;enatò per qua;a.ntaseì giorni consecutivi nel -fango , r,accqglieva il frutto delle sue fatj_ohe . L'artìglieda poteva ricoverare il suo ·rpateriale, .e l' ~serc;_it o aveva .un punto e passaggio si curo s,ul ,Mincio.

Questa ·supetpa riviera colle sµe acq\le limpiç1e divenivç1, in parte nostra.
( I ) Il possoggio del fosso, qualora si fosse fatto reg olarmente, avrebbe richiesto imq, énsi sforzi. Molte fascit,c furono radunate per colm,a r lo Il caporale i\lari z i dei pontie1:i andò d i nott e tempo al 11uoto a ~candagharne l a profond i t à che cn\ di tr.e met ri e più. Questo caporale si d l Sti1\sc' insicrnc a l -caporale Culbi per la loro provata intrepidità.
· I cannonieri Ga i etto e Bozza110 si distinsero molto nella difesa della · ..pjazza ; QQçgti furono f1:a i ·mig.liori dell'ottay a . p_i"az~a.
' 68
E
" ~ or PI>;SCHIERA 69
L'ottava compagnia di piazza restava incaricata del trasporto del materiale, che era in batteria, dentro P eschiera, e del disfacimento delle batterie stesse . Il giorno stesso le 18 bocche da fuoco erano messe s ui loro ·a:vantreni , tolte. dai campi alla ~orsa, per q uanto affondasse il terreno·, ed entravano nella piazza in un cogli altri carri . Il laboratorio degli artifi.zi veniva pm trasportato dentro, ed in1 tre g iorni le battèrie erano spianate. . . ·
Il giorno 3 la com.pagnia ottava entàwa nella piazza,. ed era- sµbito condotta al lavoro delle riparazioni a cui ·avevano g ià posto mano le altre. Oscura nel suo còmpito, ·essa non aveva meno sofferto d elle altre, ed aveva sicuramente faticato di più di tutte quelle dell'armata, ·dopo lc1 s ua part en..za da Genova. Essa perdette, tra gÌi altri, il cannoniere Micotti, unico sostegno di una numerosa famiglia . Ucciso in batteria questo povero g iov ane , il duca promise di aiutare .sua mogli~ ed i suoi figliuoli. I sott'ufficiali, sopratutto i sergenti Turina, Bellis e Priotto, si distinsero per sommo zelo e contribuirono più di tutti alla costruzfone delle batterie ~ for:mando così in gran parte la gloria del duca di Genova per . il fatto il più importante della campa gna. Fu tacciat9 sovra.tutto il capitano per cose dimen.tiçate; ma chi ha avuto occasione di vedere caricare un parco d'assedio, e massime coll'orgasmo, co1la, fretta con cui er a stato portato, carreggiato e ricomposto, saprà se vi era possibili¼ di fare esattamente e bene ogni cosa . In mezza g iornata si er ano disfatti tutti i caricamenti è rifatti di nuovo per arrivare sotto Peschi er a, e volere che tutto fosse in ordine , cpminciando dagli sfo ndatoi fino alle bocche a fuoco, era cosa più facile -ad imnia.ginars.i che a. farsi. Si trovaro110 in Peschi era 118 bocche a fuocò . Vottava compagnia fu incaricata delle ripa.razfoni dei forti esterni, denominati Mandella e Salvi, e dopo 1'ent1iata del capita.no Mara.botto colla -sua compagnia, del forte Mandell?, . si;>lamente. ·Il. forte Ma,ndella si compone di quattro
lunette, dµe delle qua.li solam ente sono rivestite in muratura; quello di Sa.lvi di due lunette sola.mente, tutte e due finite, una principale nel sistema ord1nario con galleria di CO!].troscarpa' e l 'altra nel sistema. Carnot èon muro separato dal terrapieno . I due denti riv estiti di Mandella 9omunièano insieme per galleria so.tterranea di controscarpa.. In molti lùoghi i parap etti non avevano pili eh~ 1m~20 di altezza., onde il genio militare ebbe molto che · fare per alzarli. Cqil ' aiuto dell'artiglieria e dei cavalli di provianda che tiravano delle carrette, vi riuscì, facendo pure. delle traverse · molto utili . In Mandella si distins e principalmente il capitano Ba~ab ino del genio , per un~ bo nnetta , ohe imp ediva l'infilata di _ una faccia dal ~fondano, e che riuscì molto utile co ntro l' attacco frttto poi dai· Tedeschi. · ·
Per dire qualche cosa sulle mie operazioni di · tre mesi a Peschiera.: quando l'ottava compagn ia.di piazza vi gi unse; andò ad occupare un pessimo quartiere verso Porta Brescia, dove 1mrrie.çliata.mente i soldati, per parentesi, tagliàrono alb eri che lì vi erano, ed accesero i l oro fuo chi per la cucina . Il capitano portatosi dal maggiore Cavàlli' di~ mandò i suoi ordini., e d isse che continuasse alla cura. del parco che gli era stato affidato fin da principio. Questo parco , che fu poi dopo, portato a 58 bocche a fuoco, con tre cannoni da 16 Junghi, presi a Pe schiera, poteva ampiamente -soddisfare il suo amor proprio, ma gl 'infiniti affanni che gli aveva procurato fino a~l ora, gli f~ce fare un movimento, forse involontario, di malcont ento, a c~i il, maggiore Cavalli rispose dicendo, che se io preferiva la cur?, d<:;lle opere ·esteriori, me l e avrebbe confidate, ed un altro avrebbe tenuto in custo dia jl parco. Dissi di sì, senza badare ad altro, ma il parco non era più in aperta campagna e diveniv:~ in quel tempo un sollievo. L' opera Mandella era pure importante, ed io ne p resi il comando per la parte dell'artiglieria, in un col forte Salvi, il qÙale . .

'70 ASSED IO E DlF ESA
DI PESCHJERA 71
ASSEDIO E DIFESA
fu poi ceduto al capitàn o Mai.•abotto quando fu ·entràto nella fortezza. L'opera Mandella, compostà di qùattro lunette stacc~te un 100 m ètri dalla piazza, fornì per le sue riparazioni lavoro àlla compagnia fino al 9 di ~gosto, in cui questi vènnero messi a partito per la difesa contro gli Austriaci. Il forte principale venne armato secoT).do l'idea dél maggiore Cavalli d elle segùenti bocc,;he a fu òèo: 3 obici da 8 pollici, 1 cannone da 24, 3 peìz i da 16, 2 da 8 , 1 mortaio da s ·pollici, 1 cannone da 5 113, e d u e caronadi da 24 nelle casematte. Il forte piccolo, che faceva come il salienté del sistema, aveva 2 canliom da 5 113 disopra, ·e due caronadi da 24 sui fianch i n~lle casematte. Con queste bocche a fuoco si sostenne q11ello delle 32 bocche a 1;'uoco austriache, e si ·rovinò un cannone d'a 32 ed un mortaio ai nemici. Si fece tutto quello che si potè. Spararono i cannoni, g l i , obici, i mortai, le spingarde, infme nuHa venne risparmip..to, se n ~m il. con corso della fanteria, a cui malamente si adattarono, o per dire esattamente, a cui non vollero cooperare gli ufficiali. La sera del 9 di agosto, era appena finito di riparare il forte, quando gli Austriaci cominciarono· a tirare; il tempo era stato messo a profitto. La m..omplicità dei pfoietti che tirarono i nemicì, accompagnati da quelli del forte, impose un primo spettacolo terribile, il quàle, aumentato dal tiro d·ei proietti che dalle batterie ~emiche andavano alht piazza, e dalla piazza alle batterie, passando tutti sopra Mandella, situato a metà. distànza , produsse il più tremendo spettacolo che immaginare si p,ssa. Il tuqnare fulroinante d elle ·artigli erie; accompagnato dagli scoppii delle molte. granate e. dal fumo ch e copriva l'atmosfera; era , come l'indizio. del termine della guerr~: ed infatti come si seppe ·poi dopo il_ nostro esercito era g ià rientrato in P~moow.
I razzi alla Congrève delle batterie vicino a 'Pacengo ~a-cimentarono ·anche il peri colo , e i proietti che o dalla
piazza o dalle . batterie della riva destra entravano pella gola ·dell'opera, fecero il compimento ·e -rovinarono à. tal segno. i pa:rapetti , ché nella sera del 9 .scrissi su un p ezzo di carta a matita al colonnello, onde mandasse un distaccamento di zappatori del genio per ripairar1i: Giunsero questi e riempirono i vuoti, prod0tti dalle granate scoppiate , con · sacchi a térra, aggì1:1starono per ogni . dove , e · di più sotto la direzi one del caporale Giacchino, costrussero di notte tempo un nuovo paiuolo per. un obice da 8 pollici d'assedio . Il forte, siccomé si è veduto da principio, aveva tre di queste bocche a fuoco; furono date dal colonnello Actis in ' cambio di· altrettanti da 6 pollici corti, modello ·Gribeauval, ad i~tiga,z;i9n e ed insistenza del cap_itano Marabotto, che comitrciò I dopo ottenutone il permesso, ad in_trodurne 'due. a Sa1vi. Queste bocche a fuoco, . vere carabine , rigate per la gìustezza del tiro, commendate di 1>ecente in un'opera ·del capitano Rimerans belga, disfecero diversi merloni delle batterie nert1iche, e, fecero qualche ·volta snBp P.ncleré j l loro fuoco . Il colonnello Actis ' non voleva metterli nelle òper? este.. ·riori, siccome quelli difficili ·a. ritiràrneli, ma, riuscirono di un imm enso vantaggio, e ·furono qÙasi le ·so!e che produssero danno · all'inimico. Nell'a:ttàcco la faéilità di tra.sporto, come l'esserne qua:si ·esclusivamentè prbvvisti; fece condurre ai .T écMschi' m•lti . obici corti, ma la quantità immensa delle granaw .cacciate rendeva .immensamente difficili le comunicazioni; ta1mente che i.il .inatti~o del 10 non rimanevano p iù "Ihmii,zioni per.quelle.eccellenti bocche dà- fuoco cl.a 8 pollici del fort'e, a ·cagione · del, risp6ndere che si faceva al n emico . Non sapendo cortie ~faFne venire .(erano state provviste in, fretta di un :6entinaib ·di. 'colpi ~il · g iorno prima che si comihcia:sse •11 •fooeo) , il capitano • si portò in persona alla piazza a dimahdarne . " 0arièato per cura del sottotenente Beccliis , un carro, ,il più di:ffi.. ·cile era- fa!'lo -andare; foà smontare ,il soldato .di p~• Ji
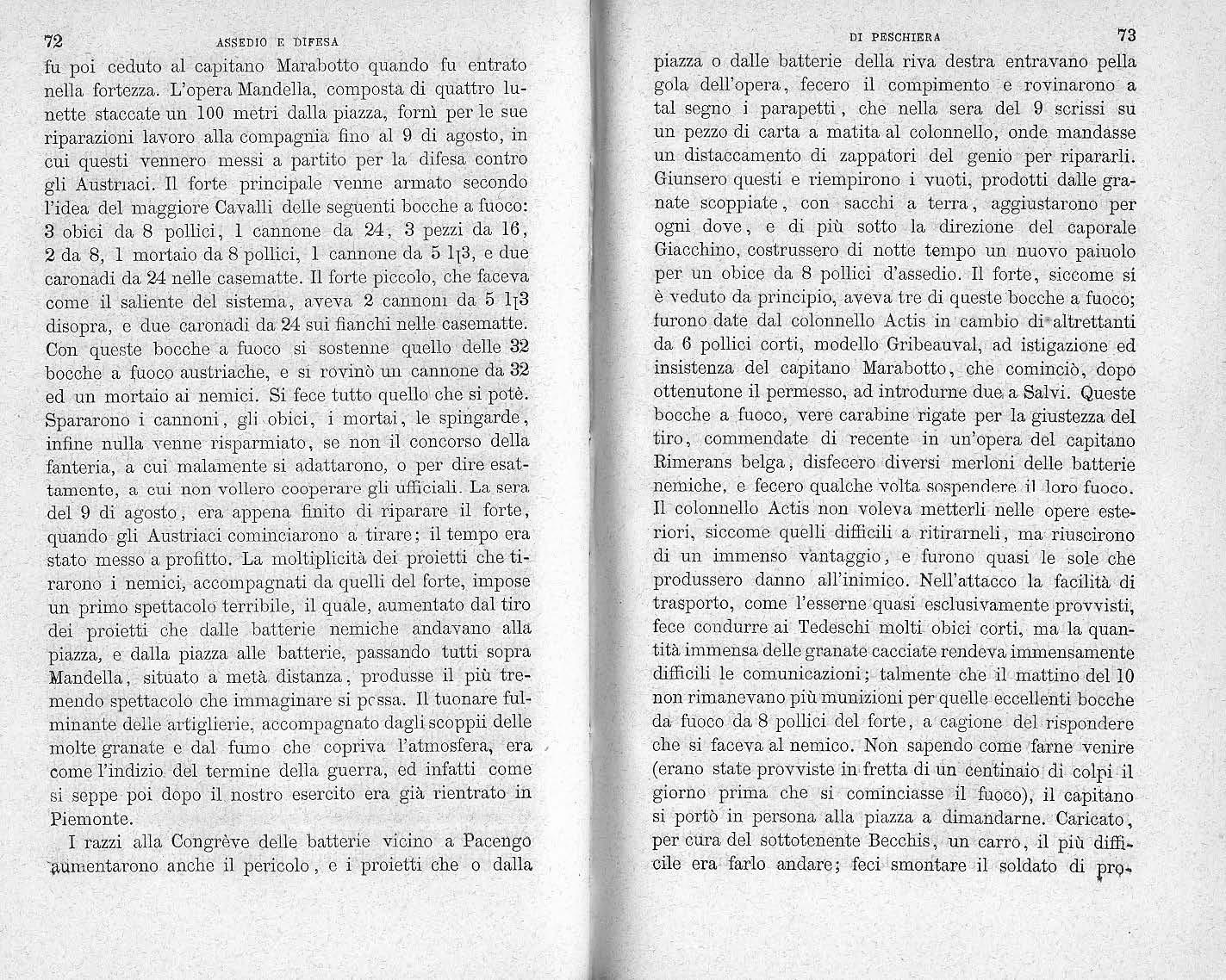
72
.
DI PESCHIERA 73
vianda, tenendo il suo cavallo per mano, mentre dall'altro uh cannoniere teneva pure il sottomano per ia briglia . Per tal modo i cavalli poterono andare malgrado i molti scoppii delle granate,che èadevano tra là piazza e Mandell,a, ed il carro arrivò fortunatamente al forte. Portai pure una sporta . con tanto pane che potei trovare, c~e d ivisi coi miei capnonieri, non avendo p iù essi mangiato dalla metà 'élel giorno antec.edente, per non aver osato il caporale comandato ai viveri attraversare il pericoloso spazio, ed essendosi perciò. nascosto n ei sotterranei di comunica~i~ne dei forti. Il t enente Crav-osio · , che io aveva lasciato comandante nel tempo di mia assenza., fece oosì continuare il fuoco, 9he durò poi dopo il mio ritorno fino alla sera,, quando venne poi sospeso per l'ingiunzione dell'armistizio Salasco di cedere la piazza. Nel tempo che i Tedeschi stettero ad aspettare questa cessione da]. 10 al 14, seppi da essi che i miei coÌpi erano stati un po' bassi, e che la. sera che venne il pa~·lam·entario , si dovevano piantare altre batterie contro Mandella a soli 200 paRRÌ, dietro un b urrone che avrebb e coperto gli assedianti; . noi avevamo fatto il nostro dov ~reper quanto l'avevamo -potuto, ~vressimo ancora cercato di ·' farlo all'avvenire, la coscienza era soddisfatta, m:a l'onta per l'armata piemontese era già allora immensa . Speriamo che verranno giorni ·-all'Italia per cancellarla e per far r ivi,·ere l'onore di una nazione una volta padrona d(;)l mondo . Finita la difesa, ritiràmmo le bocche a fuoco che avevamo tolte dal parèo d'assedio, il quale venne così completato a 58 bocche a fuoco come prima era, 45 cioè venute di Piemonte in prima volta, poi 10 obici aa 8 pollici da còsta, che diventavano d'assedio, tirando pall é piene, e finalmentè tre pezzi da. 16 da muro presi nella piazza.
glieria di battaglia st ava dei mesi iutieri a uull~ operare in- guarnigione a Sandrà, a Goito, a Villafranca, ecc. Accumular terra, scavarla, qualuuque cosa è meglio che far nulla. L 'autore di queste poche righe si rfoorèla poi per riguardo ai suoi sott'ufficiali di esserne stato richiesto dal generale Rossi il 18 maggio, quando si cominciò il fuoco, essendoché gli ufficiali prescelti alJe prime batteriè, giovani com e erano, non conoscevano nè manovra dei pezzi , nè costruzione ~i parapetti, ed i cannonieri provenienti in parte dalla fanteria, non sapevano le loro funzìoni. Dop9 ciò la loro coscienza gli darà quelle consolazioni, che furono ad essi soli negate fra tutta l'armata· .

L'ottava compagnia e la terza avranno per loro eterna ricompensr1 l'ono're di avere espugnato una ,fortezza austriaca in Italia, E sse furono premiate pel lavoro continuo Wr
tl tempo che durò la campagna, mentre l'arti-
74
ASSEDlO E DIFESA
t\lvtQ
DI PESCHIERA 75
/
C. R.
(Continua)
NUOVA
CIRCOSCRIZIONE }ULITARE TERRITORIALE
Con R. Decreto del 9 giugno 1861 vennero sciolti gli attuali corpi d'armata, creati sei grcvn comandi, stabilita una nuova circoscr izione militare territoriale sulle basi seguenti:

I.l t erritorio dello Stato viene diviso in ·sei g·rand-i dipartimenti rr,ilitari , ciascuno dei · quali comp renderà . un determinato numero di divisioni e sotto -divisio ni militari territoriali , e ciascuna di queste uù numero d eterminato di circondari. -
P er le due maggiori isole d el R eg~o, l a Sicilia e la Sardegna, è conservata la circoscrizione militare attualmente iri vigore.
.L'esercito àttivo· di terra conti,nuerà a , constare di di.:. cìassette divisioni attive, oltre ad una divisione di cavalleria, d i riserva, a norma di quanto fu prescritto con çlispaccio del 12 febbraio 1861.
I reggimenti di lancie;i, çavalleggeri ed ussari conti. nueranno a rimanere ordinati in brìg ate miste, q uali erano stati assegnati ad ogni corpo d'arma:ta.
I sei gran comandi militari, corrispondenti ai sei grandi dipartimenti militar-i; avranno la loro s,ede nelle citta seguenti :
,
Il 1° gran comando a. Torino, ed abbracci~rà le èlivisioni militari territoriali di Torino, Alessandria, Ge- . nova e la sotto-divisione militare di Novara;
Il 2° gran comando a Milano, e comRrende:cà _ le divisioni militari territoriali di Milano, Brescia, Cremona e la sotto-divisione militare di Pavia; .
Il 3° gran comando a Parma, colle divisioni militari territoria1i di Pa.rma, Modena e Piacenza;
Il 4° gran cc~mando a Bologna, e comprenderà le divisioni militari territoriali di Bologna, Forlì , Ancona e la sotto d iv isi ofi.e militare di Rimini;
Il 5° gran comando a Firenze; ed a:bbraccierà le divisioni militari ~erritoriali di Firenze, Livorno e le sottodivisioni niilitari èli Siena e Perugia;
Il 6'0 gran comando à Napoli-, e co~prenàerà le divisioni militari territoriali di Napoli, Bari, Salerno, Chieti e Catanzaro. , ·
. I comandi -d elle divisioni, e sotto-divisioni Ilil;~litar-i' ter• , rito~1ali saranno esercitati dai comandanti le divisioni · attive dell'esercito, od in ·loro difetto da . altri uffiziali genera li appositamente nomina.ti. · · -
Presso cias cu na divisione e sotto-divisione territoriale sarà stabilito un apposito stato maggiore territoriale, fatta eccezione per le divisioni che sono sedi di gran comando, qve saranno çl ue appositi stati maggiori con due capi èli stato maggiore ; l'uno , per l e truppe mobilizzate, l'altro che si denominerà Stato maggiore territoriale del gran comando.
Quest'ultimo , disi~pegnerà gli affari territoriali attri-
I
DEL REGNO D'l'l'A.Llil.
J
---+-E.,.__
CIRCOSCRIZÌONE MILI TARE DEL REGNO n'ITALIA 77
CIRCOSCRIZIONE MILITARE
buiti al- gran comando, e quelli, in pari tempo, della divisione militare territoriale dove trovasi la sede del gran comando. '
Questo Re~le Decreto avrà il suo effetto per l'esecuzione dal 1° luglio prossimo.
Ecco pertanto il quadro di Circoscrizione militare ~erritoriale del regno d'Italia-: -
DIVISIONI
DIPARTIMENTI e CIRCONDARI SOTTO-DIVISIONI

Torino I Alba
Aosta Bi ella
·' TORINO Cuneo· ,- (Divisione) Ivrea
Mondovì
Pinerolo Saluzzo Susa , I
ALESS:ANDfflA Bobbio (Dj.visione) Casale Novi
Alessandria .,. ) Acqui Asti
1° Gran Comando Tortona . Voghera . TORINO . ·' I .
Genova Albenga
GENOVA Chiavari - • Levante ·(D_ivisionc) Porto llaurizio Savona
Sanremo I .. \ Novara .
Lomellil).a
NOVARA Ossola
DIPARTIMENTI
DIVISIONI e SOTTO-DIVISIONI .
MILANO (Divisione)
CIRCONDARI l\lilano · Como
Gallarate Lecco
Monza Sondrio
Trcvigljo
Varese
2° Gran Com<1ndo
MILANO
BRESCIA ( Dit•isione)
CREMONA (Divi sione) ,, PAVIA (-Sotto-Divisione) . PARMA ( D'ivisione)
3° Gran Comando PARMA
I ) I )
Brescia
Bergamo
Breno
Castiglione
Chiari ·Clusone
Salò
Verolànova
Crem-ona
«!elle Sti(viere
PIACENZA (Di visione)
Casalmaggiore Crema I l
Pavia ' Abbiategrasso
Lodi
Parina
Borgo San Donnino Borgo taro ·(Valdi.laro) Pontremoli l1 I \ Piacenza
) Fiorenzuola I
, Guastalla
(Sotto-Divisione) l Pallanza
MODENA (Di visione)
Valsesia
Vercelli I
Modena )
Mirandola
Pavullo
Reggio I ,
78
\
1.
DEL REGNO o'I TALlA _ 79
Bologna .
Cento
BOLOGNA
Ferrara (Div i sione) Im ola , Vergato \ F orlì
4° Gran Comand o ( Divis ione) Lugo
FÒRLI' Comacchio ì Faen za
f\a vènna
BOLOGNA: < An co na .
Casoria
I NAPOL I Castellamare
Pozzuoli
Nola
CASER1'A Gaeta Sora · ' Picdimonte
NAPOLI Cerreto ( Divisione)
BENEVENTO S Bart olomeo in Galdo
Ariano
AVELUNO Saot' Angelo d ei Lombardi
I ( Divisione) Mnc~ rala
!,0 Gran Comando
FIRENZE
AN, C O NA ) Ascoli Fermo
Came rinr,
Rimin i RIMINI Cc,s ,: m1
\ (Sotl o-D iui.sione) Pesa ro
U1·bino
Fi re11zc
Ise rnia
\ CAMPOBASSO La ri no
Lan ciano
CHIETI \'usto
I
CHIETI :rERAMO \ Penne (Divisione)
So lmona
FIRENZE
L11cca ( Pistoia · ( Diuisir,ne) Rocca S. · Ciiscia n o s Mi niato
Livorno
Caslelnovo GarfagnanaMassa e Carrara
LlVORNO Piombino (D ivisi'onc ) Pis()
Porto ferraio Viareggio i Volterra
Sie na
SIENA Arezzo Grosset o (Sott o-Divisione) Montepnl ci~ no Orbetello
Perugia Foligno PERUGIA Orvieto (Sotto -Divisione) Ri èti
Spoleto 1'erni
AQUILA Avezzano , 6° Grati.
Città Du.ca le Barletta Comand o
BARI Alt.amura
BARI FOGGIA Sn n Severo -NAPOLI (D -iuisione)
BO\'ÌllO
Taranto
LECCE : ;Galli poli -
• Brindisi
Sala
SALERNO Campagna
SALIH\NO Vallo (Dioisione). Matera
POTEN ZA Me lfi
Lago negro Cotrone
CAT,\NZARO Monte leonc
Nicastro
CATA NZ ARO REGGIO Gerace (Divisione) Pa lmi

Castrovil! a ri
COSENZA Paola
ltOSS3OO
80 , CIRCOSCRIZlONB MILITARE OEL REGNO D'ITALIA ~1 DI.VISION I DIVI SfON I C!ll CO NDARI
• . CIRCONDARI
ISIONI I
PARTIMENT I e PROVINCIE o SOTTO -DI YISIO.N I DISTRETTI
DIPARTIM ENTI e
SOTTO-DIV
DI
I
l
.I
l
)
l
l
I
I
\
I
I
I
·\
ì
l
I
\
I
l
.I
')
l
I
I
l :· i
I I ANN O VI, Voi. I. - 6.
ISO~E SARDEGNA ~SICILIA
..NB. 11 Comandante dell a di• . Yision e di Palermo ha il coma ndo generale delle truppe mobilizzate nelrisola . . ,
DIVISIONI e SOTTO-DIVISIONI
.CIRCONDARI
Cagliari
Alghero
Igl esias
CAGLIARI (Divi$ione)
L anuse i Nuoro Oristano
Ozieri
Sassari
Tempio
Palermo
Alcamo
Bivona
Calt-anisetta
Cefalù
PALERMO (Divisione)
Codeone
Girgcnti nlazzara
Pinzza Scia cca .,l'ermihi
TCrrauova
Trapani
:ì\Jcssina Aci reale
MESSINA (S otto-Dillisione)
Caltagirone · Cas tro reale
Catania
àlistretta
.SIRACUSA (Sotto-Divisione)
Torino, 9 giugno 1861.
I )
Nicosia Patti Siracusa lllodica Nolo
+~ Osservazioni
; Allorchè il ministero della guerra stabilì-la nuova circoscrizione territoriale militare del regno, ha avuto per. · iscopo, senza dubbio, di riunire . sotto un medesimo gran comando parGcchie provincie, siano antiche, che d i recente • ~nn'essioiìe; non considerando l e divisioni arnminist~ative e pol1tiche in cui "furono scompartite dapprima, e eh~ per la maggi or parte hanùo conservata tuttora, mentre, in caso ·diverso, avrebbe dovuto lasci are sotto im. m~deI simò comando, o dipartimento militare, tuttociò che ap,parteneva ad una stessa regione territoriale. Tutto c?è siffatto sco·mpartim ento militare sia da ritenersi come provvisorio, avremmo pertanto desiderato, a modo d'es erp pio, che nello scomparti men.t_o del 5° gran comando (Toscana) , in tre divisioni e sotto-divisioni militari1 , il min·istero predetto a"\[esse assoggettato al comando di Li_vor~o g1i .antichi stati di Massa e Carrara, con Castelm19Yo di · Garfagnana e non una porzione so ltanto del . Pon~remolese, formando di Pontremoli stesso un comando di circondario separato e dipendente da Panna , e _ staccando
·. dal Lucphe~e Viàreggio che unì a Livorno, ·1asciando il paese intermedio di Lucca alla . divisione ai Firenze - - -
A noi pare., che l'ordine topografico avrebbe·meglio suggerito di l asciare l'intero stato di Massa e Carrara ).mito . col ·Pontremolese : o tutto sotto il gr'an comando della Toscana, od unirlo intierament e a quello . dell'Emilia (3° gran comando) ,. ;;enza smembrare l'ordine -aù~ministrativo di quelle provincie. Questi inconveni enti apparira:nno più sensibili, . quapdo si dovr~ procedere alle

82 CJRCOSCRJZI0NE MILITARE
,,
. DEL REGNO D'ITALIA 83
CIRCOSCR!Z!ONE 'IIILIT ARE
op~razioui della leva, o che per altre éalJSe si dovrà r i corrére a varie giurisdizioni civili, ecrlesiastiche e militari. L'unità negli scompartimenti territoriali, per quah1iasi ramo amministrativo, sembra"Va Ja più opportuna.
Per conseguenza, confrontando -la statistica ar~m-iuistrat:iva del regno d'Italia, pubblicata dal mini stero dell'interno in aprile 1861 colla cir~oscrizione militar e ema- . nrifa ddl ,tni"nistero della guèrra ll ro luglio 1861 , trovi'àr±ì 6 l è segue:b.ti di~crepanie:
fò -La pro ~incia di PAVIA - si compone amministra-tivHmènle dèi circondari di Pavia, Bobbio, Lomellina e VogH~:ra, e ·militarmente, quale so~to -divisione dipendente dàl · gran comando di Milano, abbraccia invece i eirconàari di Pavia, Lodi, Abbi ate grasso. ·
2° La provincia -di MrvANO, formata amministrati11amérité déi citcondarì di Milano, Lodi; Monza, Gallarate, è Abbiategrass~, costituisce nella divisione militare i co·mandi di M!lano, Como, Gallarate, Lecco, Monza, Sondrio , Treviglio · e Varese. E cosi dicasi di molte altre provincie lombarde smem!:>rate .in .tal modo. _
3° La provi1tcia amministrativa di FomJ, composta dei circondari di Forlì., Rimini., Cesena, fu ricomposta milita'rmente di Forlì, Com;cchio, Faenza,- iugo e Ravenna.
4° Di Rimini e.on Cesena, Pesaro, Urbino, .si formò uttà sòtt.0°divisione militare dipendente da Bol ogna.
· 5° A BoL'oGNA , capo-luogo d~l 4° gran comando , si ùniròho i circondari di Bologna, Cento, Ferra~a, Imola, Vergato.
A nòi sembra che tutte le antiche provincie dell'Emilia, cioè, Parma, Piacenza, Mode;na, Bologna, Ferrata, costit~itesi, comè da R . Decreto, 27 dicembre 1859, N. 79, avrebbero potuto formare un solo gran comando, tanto · pi'~ considèranao che il 3° gran comando di Parma è assai pìccolò in confronto degli altri cinque, e segnatamente

del 6° che comprende tutto l'ex regno delle, Due Sicilie, il quale, essendo sproporzionatamen1te troppo ".'astò, i:i.5m può dà un solo general~ in ' cap'o essere sorv~1gliato giuri di camente e militarmente, e meglio convenfva suddividerlo, nelle sue antiche pro,vinç;i~, almen9 i,µ t.re alt~i . g ran comandi.
· Giova pertanto sperare ·,,che, ove abbia luogo l'arµi~s~ sione d i al tri territori italiani al n uovo Regno, s'i procederà ad uno scompartimento meno in.comodo P~f i'a;wministrazione politica e per la gius~i~ia militare . . '
6° Oss erviamo ancora cli.e ri<=isce ' del pari fi1P,l~g~vqle per i circondari del capo settentrionale q~l1é!- Si;i.r~egµa il dover ricorrere sino a Cagliai'.i, ov'è la sede de~ '.qomando generale .d elri~ola. Pare che una sotto"?,iyi ~i o~e militare in Sassari, si ccome già. esiste per le cose -am~1nistrative e giuridieh~, sarebbe s~ata: più' opp()rtun.~, sìccome si è praticato nell'i~ola di Sicilia, ripartita ~n tré divisioni e suddivisio~i milita,rj . '
F~cendo ora il confronto fra il nurr.i'ero ·/!e.i .çi,rc;nnilii.ri militari (esclusi i forti ed jl distr~tfo di .Savigliai:i'.o), cpe ascendono J.D. tutto a 196, con quelli -dell'ammini~{razi9jie civile in nuniero di "193, troviamo in essi pure _qua 9'if~ · ferenza ne' pàe&i .che furono c~·èatn sede di drçoi;i.1.ari j ilitari, che nq1,1 lo so no p~r ,l;i, ,p,ar.t~ politica, qcjµ?,e V;iareggio, r'iombino e Portoferraio. Ju generale, pl:lr rispetto alla· Toscana, non si .s.ono disti'n,ti ~ella st?,t'istic.a a 1 mmin istrativa del :Regno, ,puhblicat~ d~l ministero -_ d ell~~n. ., . ,. t erno il 1° ;:iprile 1861, i 9.i~c on~ari, poichè v:i~e :ap.ogra per quello State l'antica suclcli)•Isi one ;n, cinque ._comp?.rtimenti ed ii;i nu~n~ro~,i ' s1-tstretii , Speriamo_pèrtanto :ç;he nel.la .prossiJna pubhl.içazigpe della statistica amminmfam,tiva ;si porterà rime.di o ano.be a tale anomalia.
Ecco l'attuale scompartimento del nuovo regno d'Ital.i,a nelle sue 59' pro'.vincie:
' o~ , D,EL RE GNO D lT ALlA <,j)
CIRCO NDARI di
OGNI PROVIN C IA
Chieti, Lanciano e Vasto. Teramo e Penne.
,tqui/u, Avezzano, Solmo na •C CiW1-duc.alc.
,1/ewmdri a, ,\eq ui , Asti, Casale, No1·i e Tort ona .
A11cona .
Aret:o .
AscQl i e Fermo. ,
l'o16nza. Lagonegro, Mater., e MelR .
Be11,'Ve,i/o, Cerre to e San Bartolo meo in Caldo.
Berg<t mo, 'fn,v igiio e Clu sone
Boto91ui, Im ola e V~rgato.
Brescia , Chiari, Orcno Salo, Casllgl ione e Verol anuova.
Caglia1·i, Iglesi as , Lanusei e Orista no ,
Cosenza , Castrovilla r, ; Pao la e Ross ano.
Reggio, Gcrace e Palm i.
Cat,mzaro, Montelcone Nìcastro e Cotrone
Catl!wisella, ·Piazza e Terrnnuova.
Foggia. Sanse\'ero e Bovino.
Cata11ia. Caltagirone. Nicosia e Acireale.
Co,no, Varese e Lecco.
Cremona, Crema e Casal maggiore.
C11nco, Alba. Mood~1•t e Saluzzo.
F erram, Cento e Comacchio
Firenze( \), (c irr.ondari 4) .
Fo,·li , Cesena e Rimi ni.
Gen.a, Albenga, Chi :1,-ari , Levante. e Savona .
Gil'gc11li, 1li1•011 a e Sciacca
Gro$$C o.
l.ivorno ( 1) , (circondari 2), Lucca, Macet·ata e r..,mr..r ino.
Massa e Cm·rara, Castcln. di Garfagnana e Pontremoli."
Jle8sina, Cast ro reale. l'atti e Mist rctta. ·
Mi/mio, Lod i, Mon,a, Gallarate e Aòb iategrasso.
Modc111,. Miran do la e l'avu llo.
Campobasso, Isernia e I.arino ·
Napoli , Ca stellamarc. Gasoria e Pozzuoli.
Noto, Modi ca e Siracusa.
Novara. Biella, Ossola , l'allanza , Yalsesla e Vercelli.
Palenno. 1'crmlni, Cefalù r Corleone.
Pa1·m1<, Bor~o San Donnino e Valditaro.
Pa via , 8obb10, Lomellina e Voghera.
Pesaro e Urbino
Piu ccnza e F'i ren'lUOla .,
Pisa (1), (ci rcondari 2)
Porto Ma11rizio. e San Remo.
Salerno, Sala, Cam pagn a e Vallo
,l velli,w , Aria no e SaÌ1 t'Angclo dei Lombardi .
R11vc11 ni1, Lugo e Faenza.
Reggio, e Guas1:111a.
Sam,ri , Alghero, Nuoro. Ozieri e Tempio.
Sirma (1 ), (Circondari 2 ) ' S0111/rio.
Bari, Bal'lctta e Altamura. ·
Ca8e1·ta, Nola, Gae1a, Sora e Piedcmonte .
Lecce, Galli11oli , Tarai1to e Brindisi.
Torino, Aosta, lvrca , Pi nerolo e Susa.
7'-,-r,prmi, Mazzara e Alcamo.
P er11gia, S11o lct0, Rieti,' Puli guo, •rerni e Orvieto.
RIVISTA TECNOLOGICA

/,
ITALIA. - Le prove che si fecero nella batteria della Cava in Genova sulla resiste nza delle lastre in ferro fuso, le- quali debbono servire . a corazzar le navi da guerra, riuscirono s oddisfacentissime e corris posero 'con pari esito alle esperienze che di te mpo in tempo si fanno al Ca,!llpo di S an Maurizi o sulle lastre che giungo no e che son aestinate al blindaggio de lle , piazze forti.
· Qu elle espe.rimeotate alla Ca va provengono, dalle officine dei fratelli Marre! in Rive del Gier; quelle sperime• ta.te a S. Maurizio dalle officine del signor Charrier ad' A llèva rd nell'Isère (Francia) ..
, Q ueste lastre di ferro esposte al colpo d ' un cannone da 40 e alla distan za di 40 a 50 metri, non ma• ifestano rottura di sorta, salvo che ·una lieve am maccatura della forma de l proietto; i proietti conici si spuntano battendo su di esse.
Secondo le condizioni che si esigono per la loro accetta.zione, una screpolatura qualun q ue cagionata in esse sotto l'esperimento è sufficiente a farle ri fiutare. Il numero che 1 sol"
86 , CIR<;OSCRIZ!ONÉ MILITARE
N OME delle P R OVINCIE 1 Abruzzo Cileriorc . . 2 Abruzzo Uheriorc I 3 Abruz~o Ulte riore II . 4 Al css ,rndJ ia 5 Ancona 6 ,Areno 7 ,\_scoli. 9 Jlasilicala 9 Beneven to 10 Dergamo . 11 Bulogn a 12 Brescia . . . 13 Cag liari , , 14 C:ilabria Cilcriore 15 Calabria Ulteriore l 16 Calab ria Ulteriore Il. 17 Calt anis c11a . 18 f.apitanata 10 Cat an ia . 20 Como. 21 Cremona , , 22 Cuneo 2:; Ferrara 24 Firen,e 25' J''orli 26 Geuorn . 27 Girgenli , 28 Gr osseto 29 Lirorno. :l() L ucca 31 Macerata. 52 Massa e Carrara 33 Messina 34 MIiano 35 Modena 36 Molise 37 Napoli . 38 Noto • 39 Novara 40 J> alermo , '\.I Parma 42 Pavi a l,5 Pesaro e Urbino 44 Piace111.a 45 Pisa 1• 46 Porto blaurizio . . . 4.7 Principato Cilcriorç 48 Princi pato Ulte riore. 1,9 Ravenna. r,o .Reggio M Sass ari 52 Siena 53 Sondrio • . 54 Terra cl i Bari 55 'l'erra di la voro . 56 Terra dì Otranto 57 'l'ormo . 58 1'rapani 59 Umbria
DEL REGl{O n'ITALtA
(1 ) Nella Toscana inl'cce dei circond,,ri esistono ancora I diSlrétll, che sono più_n~merosl. ~la nel Rias1111110 generale della s tatis ti co am mi nistrativa del reg\10 d'Itali a, com p1 laz1011e uflici~l é (Torino rnu1. I O aprile) a pag 223 e scg., già Jc pro vincie sono divise µer cirC-Olt· -~3ri1 dei quali pero il nome è indicato.
tanto pel servizio delle fo r tificazioni, se ne commise, sorpassa, se non erriamo, i l mil le ; esse ha,nno per lo più la lunghezza di circa due metri sopra uno d'altezza e da sei a otto centimetri di spessore.
- Fu testè casua l mente scoperta nel porto di Genova, mentre lavoravasi al nettamento dP.llo stesso, una delle antiC'he galere genov es i. Il gove rno diede imm ediatamente tutte le necessarie disposizioni per farne l'estrazione. Non potendos i metterla • a ga lla tutta in un pezzo, perchè si sfasci a a m isu ra ch e vien~ scavata, se ne estraggono mano mano J'ossatu ra e gli attrezzi. 'l!'ra le cose diverse che si raccolsero, havvi un antico can no ncino di ~ronzo, molte palle di pietra di vario calibro, lisce e rotonde come quelle di ferro, diversi oggetti di cucina, tutti di stag no, una grande secchia di rame, od una coppa di composizione, ricca di lav ori minuti
F RANCI A. Telegmfìa milita1·e. - In vari giorna li francesi leggesi: ·
• Verso la metà dd mese furono fatte, al campo di Marte in P a rig i, interessanti es perime nti di telegrafia vo lante da' soldati del ;reggimento d'artiglieria a cavallo della guardia, diretti da ufficìali dell o stesso corpo. - Un certo nu mero d'artiglieri a cavallo, seguiti da un carro sospeso e ben trainato, in cu i si trovavano lancie di Bii telegrafici, oltre il fi lo condutto re, si all ontanavano a tutta corsa appena che l'estremità di questo filo era stata fissata al suolo per mezzo di un paletto. - A 30m di distanza , un cavaliere scendeva da cavallo, prendeva una lancia che gli er~ sporta da un altro artigliere posto sul carro, e conficcava quest a la n () ia n el s u olo, facendole fare un mezzo giro su se stessa, di modo che 11 suo capo superiore si trovasse attorniato dal"filo t eleg r afico. - Il cavali er e assodava po i questa lancia col mezzo di due venti (haubans) fissati essi stessi a l suolo cori due paletti; poi la stessa operazio ne effettua vasi successivamente con rapidità da altri cavalieri; ma allora non si rinn ovava che di 1 00 in lOOm, mentre la distanza a cui erasi . piantato i l primo palo era, come si è detto, di soltanto 30m. - Queste prove mostrarono la possibilità di ;mprovvisare u na lin ea .tel egrafica, .in caso d'urgenza, p er ,gii
eserc1t1, in campagn a pe r eserì1pio, e ciò oertempo strettamente necessario agl i uomini ed ai cavalli per portarsi sul punto ài partenza e d'arrivo . Nel caso che tal un ostacolo ' del terreno s i opponi,sse alla corsa del carro, ogn i cavaliere incaricato di piantare una lanr,ìa -palo, porterebbe q uesta lancia al · braccio ed alla s ta ffa a modo lancieri ,
Questo sistema, stando a quanto è sovra detto, sarebbe riusci to bene; ma nella: piazza d'a r mi Ma in te rre no ac cidentato, duro, tagliato con fossi, noi crediamo fert.0ament•~ c he carro e cavalieri sarebbe ro stati impossibi litati a pr oseg uir e. '
Io sul proposito noi ravvisiamo opportuno di fa r rilevare ai nostri lettori, che nell'anno 1859, il nostro reggi mento del Genio in Ca s ale fece ripetuti sperimenti p er il pronto impianto delle dette linee telegrafiche.

Il ,pe rsonale, per questi espe r iment i , era. diretto dal signor capitano, ora maggiore, D ox; il materiale si compone"a del earrò c;he porta.va tutte l e provviste e di al cu ne b avelle ch e portavano nn ta mburo orizzontale sul quale si mettevano le matasse dì fi lo: si caricava anche sulla barell a alcune aste .
Queste aste erano preci samente aste di !ancia di cavalleria se I > non cbe invece della lama ave,rano un rn g lio pP.r il fi l o erl i l necessario appa recchio isolato re.
Ogni squadra di operatori si componeva d i dieci uonnn1 : un capo squadra, tre alla barella, uno con uno spuntone in ferro acciaiato, uoo con una mazza, due pe r drizzare le aste, due desti na t i a portare le as te ed il filo del carro alla barella.
La manovra pr ocedeva come segue :
Il carro prendeva uoa via , per esso praticab ile, la pitì prossima alla linea da stabilire. Il capo squadra marciava sulla linea da stabilire per indicarne i l preciso andamento ed indica va ai due soldati por tanti lo sp•tnlone e la mazza i siti ove fare i fori per piantare le aste, tenendo la distanza fra dì esse da 30 a 35 metri , seguiva la barella da cui, si svolgev:a il fìlp , e che lascia va a terra un' asta ad ogni foro. V enivauo ultìmi i due cbé drizzavano le aste . QU('sti due uomi n i aYevano co n essi alcuni paletti in legno du ro, ognu n o dei quali era guernito di un pezzo di filo-ferro l ungo ci re:i. metri due; q uesti paletti servivano a mettere dei venti .alle aste ove la linea fi\•
88 RIVISTA
TECNOLOGICA 89
TEONOJ.OGtCA
ceva qùal0he angolo. I detti soldati avevano anche varie·stringhe in ferro a ·vite per riunire due aste assieme alla traversa delle st-rade, e così alzare conven{entemente il filo. ·
· Con: queste disposizioni si potè piantare la linea nei terreni più accidentali impiegando, con soldati e~ercitati, mezz'ora per ogni chilomet ro di linea.
Non si riferiscono gli studi i fatti dal Corpo deì Geni o per la forma del carri di staz ioni ambulanti e per ogni altro particolare per l'imp ianto ed e~er cizi o della linea te legrafica, basta~dòci d'aver rivendicato là priorità delle esper ien ze sul pian~ , tamènto delle linee telegrafiche àU 'armata.
BELGIO. - ,Cannoni rigati. - La pri ma ba tteria di cannoni rigati da 6, venne inaugurata il 20 luglio a· Brasschaet, in presenza del m inistro della guerra, il qua le avea comocati a questa solennità i generali d'artiglieria, i comandanti.' dei reggimenti, i capi di stabilimenti ~ed altr i uffiziali, in numero di circ a 60 '. I di versi tiri furono eseguiti dalla 17• batte ria montatà, e dalla 4a batteria d'assedio.
I cannonieri ?,OD ave~no t irato che poche volte . coi pezzi che esordirono in un modo cosl. stupendo . Questo fatto pr o va l'estrema facili tà colla quale si cari cano e si maneggiano ·questi nuovi pezzi. Per ciò che r iguar da la precisione e l'efficacia de l loro t iro, nulla sap rebbesi immag inare di più perfetto. Gl i . ufficiali che .constatavano in q.uel g iorno pe r• la prima volta_,gli effetti d i quest'artigliéria, furono merav igliati della regolarità delle gittate ad ogni distanza. 1 proietti tirati al la distanza di . 2,200m caddero tutti , per così dire, allo stesso si to . Il tiro a granata, a questa grande distanza, diede risultato ta-le, , che dopo 20 colpi, tre grandi bersa,gli, posti l'uno d ietro l'altro, e simulanti un ·b attaglione serrato• ·in massa, era no tempestati di scheggie,' di proie tti ed in par.te attèrrati. ·
Lo stesso ti ro è' quello , a shrapnells, eseguito a 1,200m ha dato dei risultati anche p.iù· rim archevoli . "' )
Fina lmente·venne acceriato che alla distanza di 4ùom, quando. il puntamento è fatto a dovere, si . può gèttare tu (ti i proietti in un circolo di 1m a Im,50 di diametro . ·
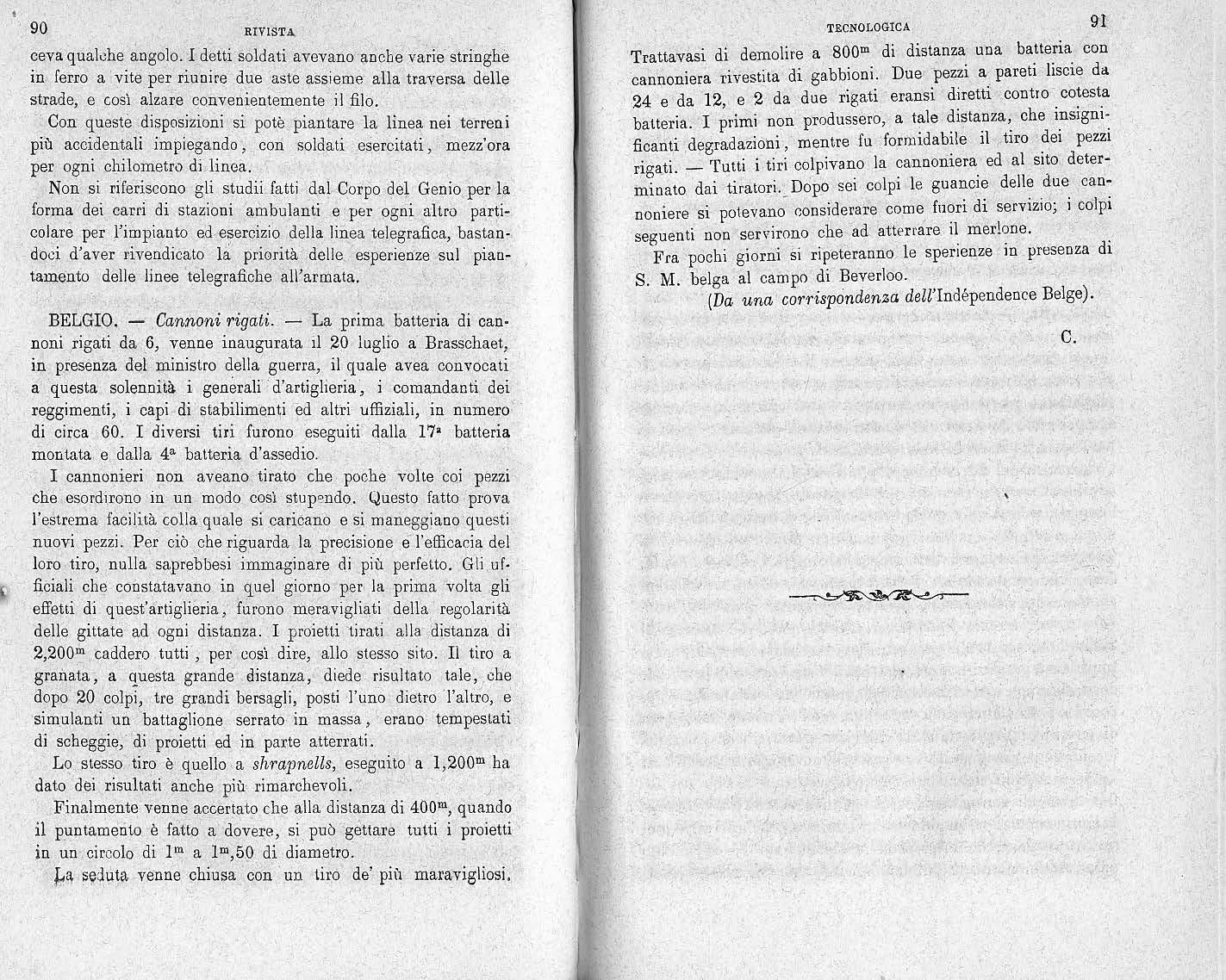
seduta venne chiusa con ·un tirò de' più mara-viglìosi.
Trattavasi di demolire a sòom di distanza una batteria con cannonie ra rivestita di gabbioni. Due ' pezzi a-_pareti liscie da 24 e da 12 e 2 da due rigati eransi diretti contro cotesta batteria. I ;rimi non produssero, a tale distanza: che i~signi ~ fica nti ,degradazioni , mentre fu formidabile il tiro ~e1 pezzi riga,ti. _ Tu tti i t iri colpivano la ?annoniera_ ed al s1~0 deter· mina to dai tiratori. _Dopo se i colpi le guancie delle due can~ noniere sì potevano consid erar e come _ fuori di servizio; i colp i seg uen ti non servirono che ad atterrare il_ merl~ne. · .
Fra pochi giorni si ripeteranno le sper1 enze m presenza d1 S. M. belga al campo di Beverloo. , (Da una corrispondenza dell'Indépendence Belge).
90 RIVISTA.
)
c.
·-RIVISTA -STATlSTICA
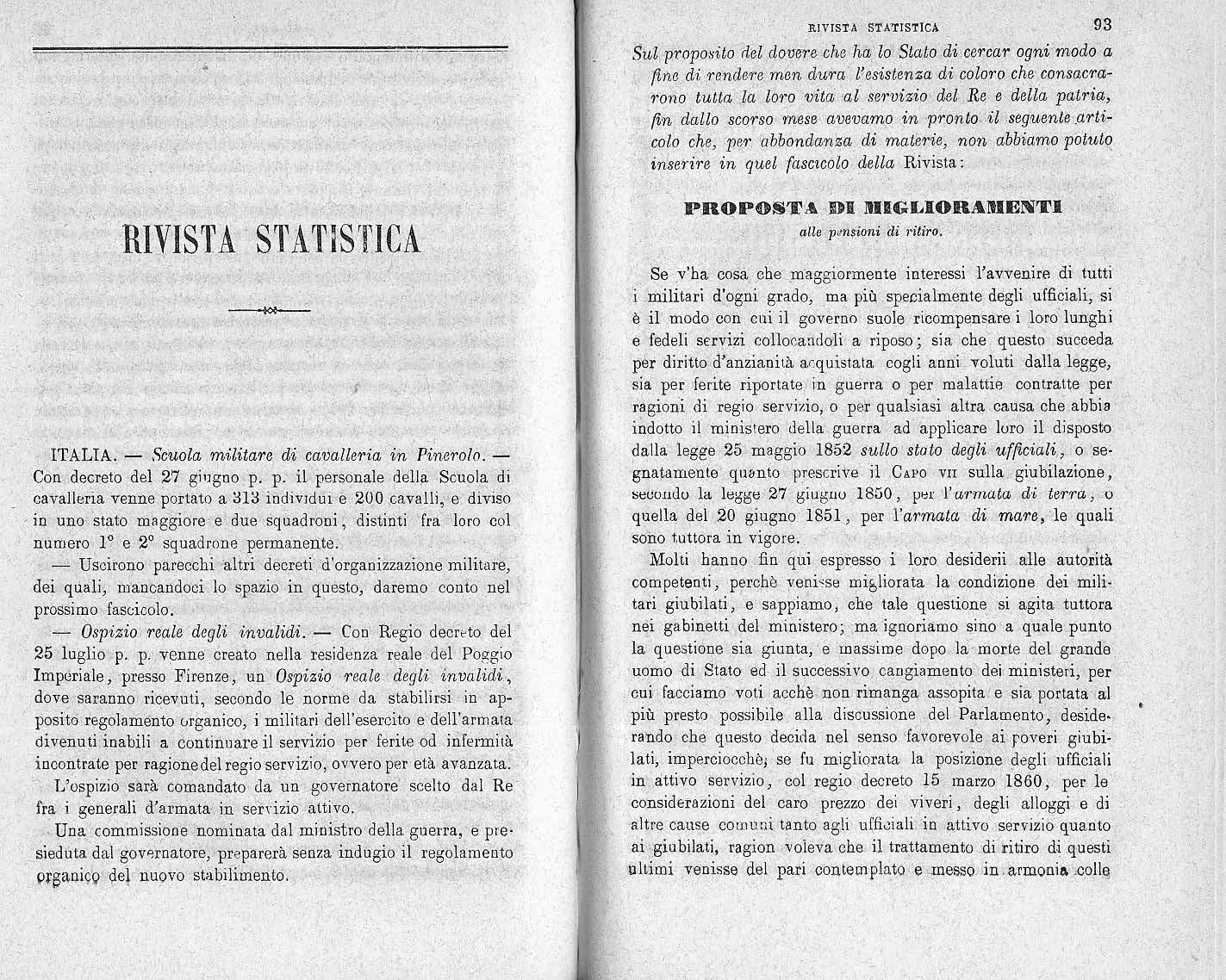
Sul propoi;ito rl'el dotr(Ire che ha lo Stato · di cercar ogni modo a fì ·ne di -r endere men du:ra fesislen~a di coloro che consacrarono t·utt_a la loro vi-ta •al servizio del .R e, e della patria., fin dallo scorso mese avevamo in pronto- il ,seguente _articolo eh.e, per 'abbondanza di matet·ie, non abbiamo potut9, inserire _ in quel fascicolo de.lla Riyista: ,
PROPOS!'r A , J}i llllGLIORAMENTI
..
a.ne p ~nfioni di i-itiro.
ITALIA, - Scuola militare di cavalleria in Pinerolo.Con decreto del 27 giugno p. p. il personale dellit Scu ola di cavalleria venne portato a :na indivi dui e 200 cavalli, e diviso , in uno· stato maggiore · é due squadroni, distinti fra foro col numero , lq e 2° squadrone permanente . _
- Uscirono parecchi a l tri ,decreti d'or ganizzazione militare, dei qual i, mancandoci lo spazio in quésto, daremo conto nel ( prossimo fasc.:icol o. ·
- Ospizio , r eale degli invalidi . · - Con Regio decreto del · 25 luglio p. p . . venn e c reato nell a residenza reale d el Poa;crio . ci Impèriale, presso F irenze, 1:1n Ospizio _ reale degli invalidi, dove saranno ricevuti, secondo le no rm e da stabi lirsi in apposito regolamento vrganico, i militari dell 'esercito e de ll 'armata d ivenuti inabili a continuare il sei;viz io per ferite od inferm i tà i ncontrate per ragione del regio serv i zio • , ovve ro per età avanzata.
-~ L'ospizio sarà comandato da un governatore scelto àa l Re · f'ra i generali d'armata in sen i zio attivo. ·
, Un a comm issione nomina ta dal ministro della guerra, ·e presieduta dal gov~rnatore, preparerà senza ·indugio il regolameato pt~aniç9 ~el nuovo st,ibilimento .
Se ,v 'lia ' cosa ehe .maggi0rmente interessi l'avvenire di tutti 1 nÌilltari d'ogni grado, ma più specia lmente degli ufficiali; si è il modo con cui il governo suole ricompensare i lor.o· lunghi e fedeli servi zi collocandali: a riposo; · sia che questo succeda per diritto d'anzian i tà acq,uistata cogli anni . ~oiuti dalla leg_ge, sia pe r ferite riportate in guerra o per malatti8 contratte per r?gioni di regio ser vi-,io, o per qualsiasi altra· causa che abbia indotto il minis tero della guerra ad applicare loro i l disposto dalla legge 25 maggio 18~2 sullo stato degli ufficiali, o segnatamente qn&nto prescrivè i l CA PO vn sulla ,. giub ilazìone, set:o.uùo la 'legge 27 gi ug.uo l SGO , · plclr ' l'armata d-i terra ; o quella del 20 giugno 1851, per l'armata di mare, le quali sono tuttora in vigore. _ · , · ·
Molti h .an no fin qui espresso i ~or o desiderii alle auto'.rità competenti, perchè veni~se mi~)iorata la condizione dei m ilitari giub i la~i, e s~ppiamo, che tale questione si agita tuttora n~i gabinetti del ministero; ,ma ignoriàmo s ino a quale p unto la qu estion e sia g i untà, e massime dopo la ··morte del grande uomo di Stato ed i l su'ccessivo. cangiamento de i ministeri, per cui facciamo voti acchè non rimanga assopita: e sia po rtata al più pr esto possibile alla discussione del Parlamento, desi de • rando che) questo decida nel senso 'favorevole ai -roveri gi~bilati, impe rcioccbè; ' se fu migliorata la posizione SÌdgl i ufficiali in attivo servizio, col regio decreto l5 marzo 1860, per ìe • consi dE:raz ioni del caro p rezzo dei viver i , degli alloggi e di a ltre cause comuni tanto agli uffi..:: ial i. in attivo servizio quanto ai giubilati, ragion .voieva che il trattamento .di ritiro di questi u Itimi ,:-enisse del pari . contemplato e messo.·,in . a rmoni 11. ,colle,
,,
t
RIVISTA STATISTICA 93
paghe attuali di attività. Ma ciò che no n si è fatto per lo lo passato; giov a pur sp!irare si farà per l'avveni re, pigliando esempio dalla vicina Francia, ove si sta per migliorare la condizion e dei m edesimi, avendo una commissione del corpo legislativo proposto g ià qualche emendamento al progetto di legge sulle pensioni militari, chiedendo, fra le altre cose, che la pensione i n caso di ceci tà e di perdita di due membri, dia rag ione al maximum, più il 30 pe r 100 pei sott'u ffici ali e soldati ed il 20 per 100 per gli ufficiali. - Propone del pari, che si p riv ino le mogli separale dal marito della pen s io ne di vedove di militari, ma in qu Psto caso che si considerino i figli come orfani di padre e di madre .
Se noi p oniamo mente all'ul timo stad io d ella vita mil itare, troviamo che il gfobilato ha sovente tutt'altro motivo fno rchè quello di gittbilare, mentre generalmente egli soffre tanto dal lato fisico o materiale, quanto dal lato morale. E su questo ulti mo pun to ognuno il consente quaoto r iesca sensi bi le; ad un ufficiale in ispecie, massime se di grado snpe riore o generale, il perdere a-0 un tratto quella consid erazione che godeva in attivo servizio per riguardo alla di lui elevata posizione ; il n on vedersi pi ù ossequiato ùagli ,inferiori, il n on ricevere più quelle onor ificeuzt1 e saluti che gli si tribut avan o il giorno innanzi, come spesso egli passa inosse rvato a coloro che osten tano di non vederlo, o se v'ba qualche amico , che stringendogli la mano lo conforti a sopportare con pazi ente rassegnazione il nuovo di lui stato : quest'amico forse all'i ndom iini pi ù non si cura di lui, poichè soltanto dov e most ra bell~ faccia la fortuna, ivi si rivolge il favore degli u om ini. Dalla condizione morale procedendo alla coodizione fisica o materiale, osserviamo che il p ensionato, che non , ha ben i di fo rtuna difficilmente trova amici che lo soccorrano se cade in biso~no; allora trovasi ridotto nella più critica condizione.
' L'esigua pension e che il governo gli accorda è ben lun gi dal pote r sopperire alle urgenze divenute più gravi nell'età avaniata e verso la fine de' suoi giorni, massime !quando per càusa di ferite od amputa zio ni , o dopo lungh e sopportate fatiche, o per le continue lucubrazioni di mente e di spirito, fu costretto a chiedere il suo ritiro. In tale condizione, se tµrbato
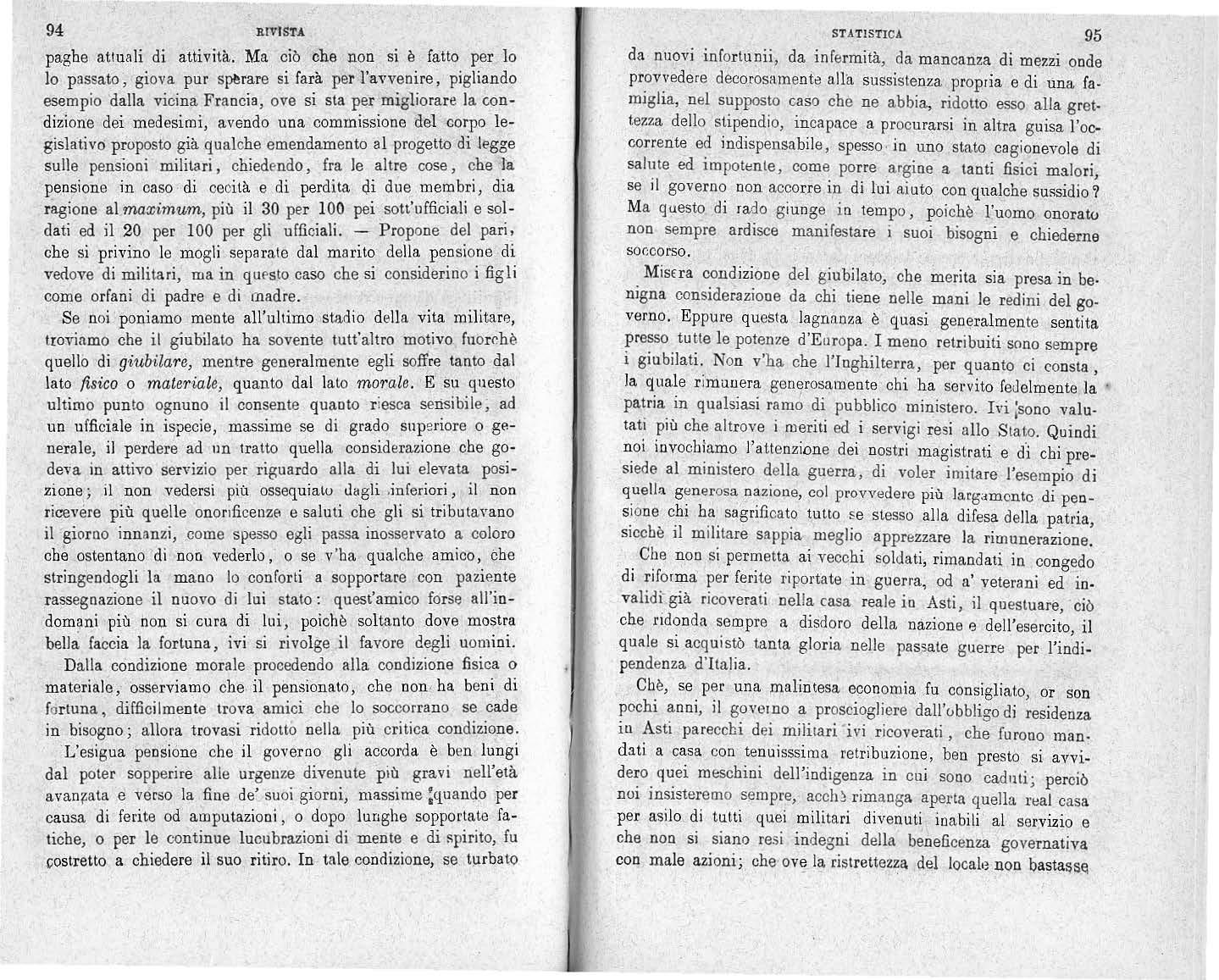
da nuovi infortunii, da infermità, da mancanza di mezzi onde provvedere dècorosamenttJ alla sussis ten za propria e di una fa. miglia, n el supposto caso che ne abbia, ridotto esso alla grettezza dello stipend io, incapace a procurarsi in altra guisa l'occorrente ed indispensabile, spesso , in unò stato cagionevole di sal ~1te ed impotente, come porre argine a tanti fisici malori, se il governo non accoi:re i,n d i lui ai uto con q u alche sussidio?
Ma questo di rado giu ng e io tem po, poichè l'uomo onorato non sempre ardisce manifestare i suoi bisogni e chiederne soccorso.
Misna cond izi one del gi ubilato, che merita sia presa in be, mgna considerazione da chi tiene nelle mani le redini del governo. Eppure questa lagnanza è quasi general mente sen t ita ?re~so. tu ~le le potenze d'E uro pa. I meno retribuiti sono sempre 1 gmbilat1. Non v'ha che l'Inghilterra, per quanto ci consta, la quale r imuner a gen~rosarnen te chi h a serv i to feùe lI+Jente la · patria in qualsiasi ramo di pubb lico ministero. Ivi ;sono valutati più che altrove i meriti ed i servigi re si allo Stato . Quindi ~oi invoch(a1:110 l'atte nz ione dei n osti·i mag ist rati e di chi presiede al ministero ~ella guerra, di v oler imitare l'esem pio di q_uell:.t g -inerosa n~z10ne, col provvedere più la rg<lmonto di pens.10ne c?1 h~. sagrificat? tutto :e stesso al la difesa della patria, s10cbè 11 m1htare sappia meglio apprezzare la rimunerazione.
Che n on si permetta ai vecch i solda ti, rimand ati in congedo d i riforma pe r ferite r iportate in guerra, od a' veterani ed iovalidt già ricoverati nella casa rea le in Asti, il questuare, c iò che ridonda sempre a disdoro della nàzione e de ll 'eserci to, il quale si acquistò tanta gloria nelle passale guerre per l'indipende nza d'Ital ia.
Chè, se per u na pial intesa econ omia fu consigliato, or son pochi anni, il governo a prosciogli ere dall'c.,bbligo di residenza in A sti parecch i dei militari ' ivi ricoverati, che furono mandati a casa con t enuisssima retribu zio ne, beo presto si av vide~o. q~ei meschini dell 'in digenza in cu i sono caduti; perciò noi Insisteremo sempre, acch:i rim anga aperta quella real casa per asilo di tut ti quei militari div enu ti i nabili a l servizio e che non si siano resi indegni della beneficenza governativa con male azioni; _ che ov ~ la ristrettez~a del locai,3 non bast-ass~
94 RIVÌSTA
STATISTICA 95
a capirM i tantr im-alidi accresciuti oggidì notabilmente di ' numero, si pe-nsi a fondarne altri, ma non si lascino gi rovaga re tanti oziosi accattoni, di cui pur troppo oggidì vedesi di nu ovo infestato il paese.
Ma rispetto ai militari, ripetiamo, che si debba andare tosi.o al .riparo, onde evitare mali peggiori, i qua-li per soverchia trascuranza petrebbero di venire incurabili. Pe rciò vediamo di migliorare la loro condi½ione con un trattan:iento cli ritiro consentaneo ai tempi, all'indole del paese, alla carezza dei viveri e degli alloggi, al decoro della milit a re divisa ed al rango della persona; sicchè non si d eg radi l'ufficiale, o ohi è più elevato in carica a prdtarsi nei più triviali uffici, per non poter pagare un inser,·iente. Cerchiamo a nzi di esaltare lo spiri to de l vecchio militare , che il pubblico riconosca sempre in lui un degno difensore clel'la patria, il sostegno del trono e dell a libertà nazionale. Prendiamo esem pio dagli antichi , i qual i solevan o onorare e premiare coll'assegno di beni e terre •il gue rriero che bene av eva meritato da l la patria, o che per mezzo delle ~ue opere, aveva accresciuta la gloria del suo paese.
Taluni, •fra i vecchi militari, si lagnano ezi andio, che la fo r mola oggid\ adottata dal governo per collocare a riposo un ufficiale, escludendo ogui so rta di e logi, non si a troppo lus.inghevole all'amor proprio di chi si aspetta va forse un attestato di 'ben servito, od una lettera di complimenti . A cui risponderemo , che tale è pure la formola adottata in Francia, da cui abbiamo attinte molte norme di regio servizio. Difatti il tenore ivi espresso è il seguente:
« Monsieur!
• Prenant en considération l'~ncienoeté de vos servic.es l'em-
• pereur a décidé, le ..... du mois de ..... 1861 , que vous seriez
• admis à fai re valoir !es drolts qu e vous pou vez avoir à la pen-
• sioo de retraile. Vouilfez me faire connaHre sans r elard le
• lieu Ou vous avez l'intention de i vous retirer.
, Le Minis tre de la Guerre, 0gnun vede, che questa formola è sufficientemente esplic ita, senza esser e troppo espansiva o benevole, e chiunq ue la riceve
j-u Franoia '.(come da noi) , se non è pre,,enuto di. mala .voglia,,
b én potrà comprendere ch'è tempo di andarsene per far posto ad u n a l t ro . - Ote -toi, que je m'y mets, dice il proverbio; ed ti no spiritoso france.,e ( i l signor A . P. A sseli n eau, l nogote• nente colonnello in ri tiro a V ersailles), prendendo com e una facezia ( plaisante1"ie) l'argomento che noi ora espon iamo , scrisse i n proposi to un lib r o intitolato : i'r1es lo i sirs; - ·ou de l'avenir des o(!ìciers 1·etrniles, Pa,,,.is 1861, 01-1,vrage dédié à la socielè frale1~nelle mililaire des officiers des armées de terre et cle mer r etirés à Versailles . - In esso l'autore svolge in un Eci capitoli ed un appendice l e vici~situdini cui può andare soggetto un povero giubilato. - Diciamo povero! giacchè ad un ricco non man cano mai le ris or se di una vita agiata, per cui la gin bil 1zione per lu i è s1~mpre un compenso bastantemente oner oso, ciò che non pr0\'3 ohi è privo di be ni di fortuna.
In quP.sto libro i! signor Ass elineau va rlimostranrlo, come io F ran:ci a , da l calcolo sta1 is ti co fattone, risolti, ch e i l m aggior num ro de' g iubilati m tJ riva entr0 i prim i cinque anni dall'epoeà del lo ro col! ocameuto a r ip oso .

N oi no n nodrerrio inv es tigando la cau sa di questa mortalità, s11ppo:1endo che i l militare ammesso al godim ento della pensione sia giunto a quel! età avanzata, in cu i 1~ fisiche imperfez, io ni più non pe rme '. teva n o un1 vita attiva; ciò ch1;; uun fu ~e rn pre osserva to Ja noi, mentr e si ammetteva n o p er lo pas sato militari alla giub ila iiooe ch'er ano ancora nel fior e deg li anni e di r obns ~is sima cos tituzione che avrebb ero pot u to prestareancorà u tili servigi allo Sta•to p e r m olli anni anc 0ra.
E su tal e propos ito ci facciam o lecito di avanzare ancora una proposizio ne utile al governo ed agli stec;si militari, segna·amente agli ufficiali, cio è : che in tempo di pace , ad onta d13g\i anni di servizio voluti dalla legge pe l comf' g11imento del la giubilazione, n un sia questa accordata fuorchè a colo ro che ne facciano domanda a l m ini ste ro, o che per infermità od altri fisic i malori pi ù non fosse in grado di r:outi n uare nell·auivo ser vizio, neppu rè nei posti sedentari i.
· Per maggiormente eccitare poi i buoni ed anziani ufficiali a continu ar.e n el l'attivo serv i zio, sem r rechè sia no gi udicati an -
c;o a idonei, sarebbe desiderabile che- il gove rno pensasse a rimunerarli o con avanzamento s~raordinario, od io altra guisa
96 RIVISTA
STATISTICA -97
NNO VI. Voi. I. - 7,
A
RIVISTA con pensioni equestri, sic chè eglino avessero a prova.re gli •ef- · fetti dell 'aggrad imento s ovrano · pei loro protratti servizi i. Anzi · tor• erebbe proficu q allo .stessò gove rno, che anche a gli ufficiali n('lllo s tato)naggiore delle p iazze si cont in uasse a dare _ l0 stipendio di attività co mè n e i regg imenti d i fanter ia e che si ienesse conto ·dei loro servizi pel èonsèguirn en to della pensione di ritiro dopo il 25° o 30° anno , e non più per m età s i:irv1 z10 come praticas i oggid ì. '
Fo;;;e t aluno, invaso da principii e <onomi ci, . dirà: che aumen t ando lo stipendio agli ufficiali nello stato - magg~ore delle p iazze , e mettendoli al li vello degli ufficiali della linea; si ecciterà in mo lti di questi il des ide rio di far p assaggio in un _ posto sedentario, ove nulla più avrebbero a perdere sulla paga e sui vantaggi per la g iub ilazione? A cui- rispondiamo : Che il min is te ro della g u è rra dovrebbe appunto scegl iere pel servi zi o d ell e piazze, n on già i meno idonei a ll a linea, ma ri,- . servare tali posti qv,ale premi o a coloro, che, o per a vanzata età, o pe r ferite riportate in guerra non po~sono più soppor- · tare le fatiche ne i corpi di linea, e che pertantò fossero giu0d1cat.i anc ora abil i a p ees tare un se rviz i o sedentar)o , ,sulla condotta dei qua li non s i av i r improvero a fare , Che in tempo di g uer ra si a. no s tati ri ch iar:nat1 da! la giub ilaz iòne aH'attivo servi r.io molti vecchi ufficial i i quali pres tarboo a ncora bu oni se r vizi, ne abbiamo avuto esempi durante l a scors a campagna; ma che parecchi i nvec e non a b biano dato soddii,facent1 _()rove di sè, ciò proced e e d alla provenienza di tali ufficiali e dalla mancanza .della nece ssa ria istruzione, o perchè era no .già inetti prima dei loro; cpllocamento a ripos~,' a prestare uti li serv igi. Che poi molti ufficiali siano sta ti ammessi in I attivo s erviz io, senza prev ent i vo e,a me della loro a n tecede • te concl,otta, per cui s i ebbero a lam e n tare le co• s.eguenze di sucr.essivi_ r,ea ti,' ciò procede dall a frettolos a com pos izione d ei nuovi corpi e da-lla mancanza dei neceS!?arii docume nti' e specchi caratter;stici e di condotta , massi me di co lo ro p r ovenienti dai corpi i r rego lari . G i ov a pertanto sperarii, c,he la commissione di scrutinio assumerà niio-lior i informazioni innanzi di procedere m o avvenire alla proposi7 io ne d 'u fficiali, che no n i spi rnssero ·quella .--, confidenza e gua renti gi a voluta pe r a,c.c attivars i l a stima dei
STÀ.TISTJC A
loro C(!pÌ e dei proprii colleghi. - Che i l punto d'onore sia la - guida d'og nì loro azione.
,Premessa quest:J. ~l igressione al t<1ma Eropostoc i, ci facciamo ora a proporre un emen damen tÒ al le legg i del 27 g iu gno 1850 e 20 giugno 185 1, -s ·1lle pensioni di rit ir o tanto per 1'0sercito di terra , quanto per l' arma ta di m a r ci, come apparis ce dalle qu i annesse ta be ll e, s • u.za al ter a re le norme stabili te, che àannn :ragi~ne al minim um od al max·imum delle pensioni m base a lle .11,ttuah paghe d i a t,t i vità prr la fante ria ,

t ) ) l
• t' ( ...
D'ENOMINAZIONE DEI GRADI
ES E . R CITO
PRIMA.o D- I TERRA
PENSIONI DI RJTIRO
STABILITE COLLA LEG GE 2 7 GIUGNO 1850 '.\ CHE SI PROPONGONO
Generale d'Armata

Ln ogotcnente Generale
Maggior Generale ...••
Colonnello •....
Luogoten e nte Colonnello
Maggiore ·
Capitano
Luogotenente
Sottotenente .
Gu a rd~rme
Maresciallo d'i\Jloggio dd Carabinieri
Foriere maggiore . . .
Tamlrnrino nrngi;iore .
1'rombcttie rn Maggiore
Capo musica .
·Foriere
Sergente o Capo armaiuolo .
Caporale o Capo calzolaio
Capo sarto, Capo morsaio
, Capo sellaio .. ....••
Brigadi e r e ca) ·
Vice-Bri gad ii,re (b)
Appuntalo nei Carabinieri Reali (e)
Carabinieri' a pic<li ., '
100 RJVÙlTA- I
I I·
i o, mors aio
armaiuolo ~Ja niscalco- .. .. .... Tamburo, Trombettierc. Soldato Vi vandiere. . . . .
Suonatore o Trombett.. di cavalleria SeHa
,
TAVOLA.
\ PAGA AN~llA > ST ABILITA PER LA FANTER L\ DIPFSRENZA
Rea li Decreti delli 25 marzo 1852 1 15 marzo 1.860 Lire c. Lire o. 9,GOO 15,000 n 8,400 " 12,000 1) 7,200 9,000 )) 6,000 )) 6,600 )) 4,000 l) 5,000 3,oOO 4,000 • 2,400 " 2,800 ,, 1, 450 1) 1,soo ,, 1,3(10 " 1 ,600 l) in pi ù nel 1860 Lire G. !1,400 3,GOO 1,,100 600 1,000 500 400 - 350 3()0 )) • :I v ' I 900 " t , W3 !163 (2) 1,050 )) l,2 13 ,, 163 648 )) 893 ,, 24:> 432 ,, 537 50 105 540 5 37 50 " 432 )) 537 50 10~ ,,32 " 67 1 , 2 1.t2 "(' :l i 5~ I J 360 )) 56'1 198 1) 351 162 1) 31;, 180 333 (a) 720 " 720 (b) 625 'W 6·l5 - (e;) 600 " 600 » " 216 V 370 162 )) 315 234 · 388 180 333 H4 » 297 H4 )) 297 ;,() 75 25 ~o 20 " " 25 25 50 " » 20 4 153 153 153 ,. )) » • 154 153 1511 : 1C.3 1:>3 !53 r 15 ( 25 50 I I STATISTICA 101
secondo i
0,fl.A Aumento Aum ento Mi nimum per ogni anno Maximum Minim um 1>er ogni anno di servizio di serviz io Maximum o campagna o Campagna Lire c. Lire c. Lire c . Lire G. Lire c. ; Lire c. 6,000 )) 10,0 » 8,000 )) 9 , 375 )) 100 " I 1,375 " 4,200 • 90 » 6,QOO )) 6,000 " 90 . 7, 80.0 1) 3,300 " 60 4,500 4 ,12 5 " » » 60 » 5,325 " 2,709 " 45 06 3,1>00 » 2,970 » 1,5 06 3,871 20 2,100 " 42 06 3,000 , , » 2,625 ·" 1,2 -06 3 ·,466 35 1, 800 )) 35 " 2,:>00 - » 2,057 " 35 )) 2,757 " 1,400 • 25 ,, 1 ,900 ,, 1,633 33 25 )) 2,133 33 920 )) 2,1, " 1,4,00 )) 1,142 07 24 )) 1,622 07 720 " 2,2 50 1,170 )) 896 15 22 50· 1,s,,1> 15 ( 540 . 15 840 ··523 82 J5' '· I )) , . 1) . ~.is 82 I i 360 )) 14 . 50 6!">0 )) 496 12 14 50 7 , 86 12 I 300 » 11 )) 5"0 )) 468 05 11 » !ì88 05 . " I I 220 . 9 ,, 400 )) :' 90 32 9 )) !)70 32 , ; ì ' ! I ' 200 » 7 r 50 350 .. 370 5 a 7 50 520 55 ( .. ' , ; ' I I , « ,,:; - .. , - ,., J ~ ) .' C ,_,, . . t
ARMATA DI MARE - TABELLA. DELLi PENSIONI DI Rl'rll\0 PEI
LEGGE 20 GIUGNO
GRADI
Ammiraglio Generale d 'a rmata , Vi ce-Amrniruglio - Lu ogo tenente Gene rale Conlr'..\rn miraglio - Maggiil r Generale

Capitano di vascello - Co lonn e ll o • , ." • r.upilano di fregata - Luogotc11<:11! c t:olonncllo
r:o pila110 in 2° •(i vasc ell o - M(1g_i;1or c .
Luo ao t encnlc d, vascello - Cap it ano - - Prim o P~olo - Piloto dì 13 ch,ssc ..... . . •. •
So Lt olc nentc di vascell o- Luogotenente - Pi• loto cli 2a classe .. .... ........ , .
Gual'dia mtHina di 2a classe - SottotenentePr imo capo cannoniere - Prim ~ n~1cch1_cre-: Pi lo l o cli 3a classe - Segretario elci d1 pn rllme_n ll
Nocchiere di 1a classe - Capo mastro ,h offic111n di I a cla sse . . . . . . .
Noc.,hicrc di 2 " e 3• cla sse - Cap o cannoniere di la e 2:1 c]usse - Se co ndo pilo t o di 1 à e 2:, c lasse - Ba ss'Ufficial e d i maggi orità - Mastro d'ascia di t a e 2• clossc - Cap o mostr o d 'o fficina di 2n c la~se . .... ... .. •.. , ... .
Capo cann o niere di 3a classe - ~l n~ ~r? d a~ c10 di 3a classe - 2° capo mas tro d olficin:1 tir 1a cla~se- Solto aiulauledi contabilità- Mastro veliere di 1 a classe - Foricrenrng g iore -- Capo guardia di balleria- Copo mu ~icn -Tromba ma""iorc - 1'amburinn 1nag1p o rc , • • 2" no~~hicre - 2° capo can non iere - 2° ~apo mastro d'officina di 2a classe - Guardiano d'arsenale- Mastro velier e di 2a e 3• c lasseMastro d'a sc ia - 2° mast ro _ ca lafa to - _Secondo mas tro arl!Juiuolo - Ser~cntc foncrc
- Alli e, o piloto - Sergente - ~ap~ sartoCnpo cal~o laio - Guarda balleria d , 1a e 2a classe - Alcaidc delle tor ri t ;apo tro mba
- Iuformicrc magg iore Qnarli c r~mastro -
Patrone di pontone - Caporal m,1gg1ore- Capo ra\ fori e r e .. ... .... . : ..... •
Capor ale - Snonatorc - T rombc ll1crc - A.r•
maiu o lo d e l Corpo Rea l Navi - Gu ardiano
delle t ol'l'i dita e 2a classe - Guardia palazzo
MILlt\RI D'OGN.I GBADO DEI CORPI DELL.\ HEGIA M\RINA,
RIVISTi\: 102 Tav 11.
11 - J11ferrni cre . . . . . . . Operaio di t a e 2a classe d~lla Macs tr_onz aSotto caporale - •r arnburi_no. Mar1m,ro :-Cannoni e r e - Sold:ilo - V1vand1ere -
Caporale prev osto
Mozzo
Mini mum At11nento per ogni anno di s,•rvlzio 6,000 » 4,'200 » 3,300 n 2,'iOO " 2,160 • 1,800 " 920 l) 720 » 540 " 4 50 " 360 " ' 300 » 220 l) 200 » o eampai;na 100 » 90 " 60 • 45 06 42 06 3:-; " 25 » 24 " 22 50 15 » 15 » 14 50 t 1 " 7 50 \ \ I I I I I I 'i ' I STATI 9TlCA 103
I 851 PE~SIONE PROPOSTA Aumento OSSERVAZION I llaximum Minimum per ogni anno Maximum di scn·izlo o t.'lmpagoa 8,000 . » 9,375 " 100 ,, 11 ,375 . Sebbene lo ~lipend io pel 6,000 » 6 ,000 ,, 90 " 7.800 » •ari gr:idi nei Corpi della I 4,500 l) 4 , 125 » 60 5,325 Regi a ~brina non sia l) " s tato aumentato sul piede I 3,600 )) 2,970 )) 1,5 06 3 , 87 1 20 di pace. tuuavi:, per mcl- I 3,000 • 2,625 ,, 1,2 06 3, 166 35 terc in armonia le pen2,500 " 2 , 057 15 35 » 2, 757 sion i dei militari dc11·e» sercilodi lerra con quelle 1,900 corrispondenti ali' ar)1 1,633 33 25 . 2,133 33 mala di m~re, abbiamo giudicato cli proporre gli 1,400 l) 1,H2 07 24 1,622 07 stess i aumenti propor· ,, zi onili per ogni grado . 1, 1'TO ll 896 15 22 50 t ,346 15 840 )) 623 82 15 )) 923 82 I 750 ,, I 596 12 1 15 )) 886 12 . 650 l) ,,96 12 14 50 786 l2 , 520 )) 468 05 11 l) 688 05 400 )) 390 32 9 l) 570 32 350 " 370 :\ 5 • 7 50 523 5 :1 -
- ARMATA ITALIANA. - Qu.adro generale' :
Specie dei Legni
· P iro - vascello a Piro - fr.. gala di elice .' . ad el1ce . . . Id . ld }d. Id. Id .· ld.
·I O rango
DcnQmJua ziooe , Re Galunlu otfO . . ,
Maria Ad ela ide .
Du ca dì Genova
V1llorio Eman uele
Ga ri baldi
l1alia
Carlo Alberlo.
Regina (·1} ·
Baller ia galeggianle co ratzala
P 1ro-frega 1a a ruote di 2° rango hl Id. Id. I d. Id . Id . Id . I d. Id.
Pi r o- co rvella a elice di •I 0 r ango .... . . . .. .
Pi ro'...c orv e lla d ruote di 2° rango Id . lei. Id . ,
Pir oscafo a ruote Id . Id. ld . Id. Id. Id . Id.
Terribile Gov .. rno\o Co,l,luz io ne .
Tuker y . . Fulmiuan\ e
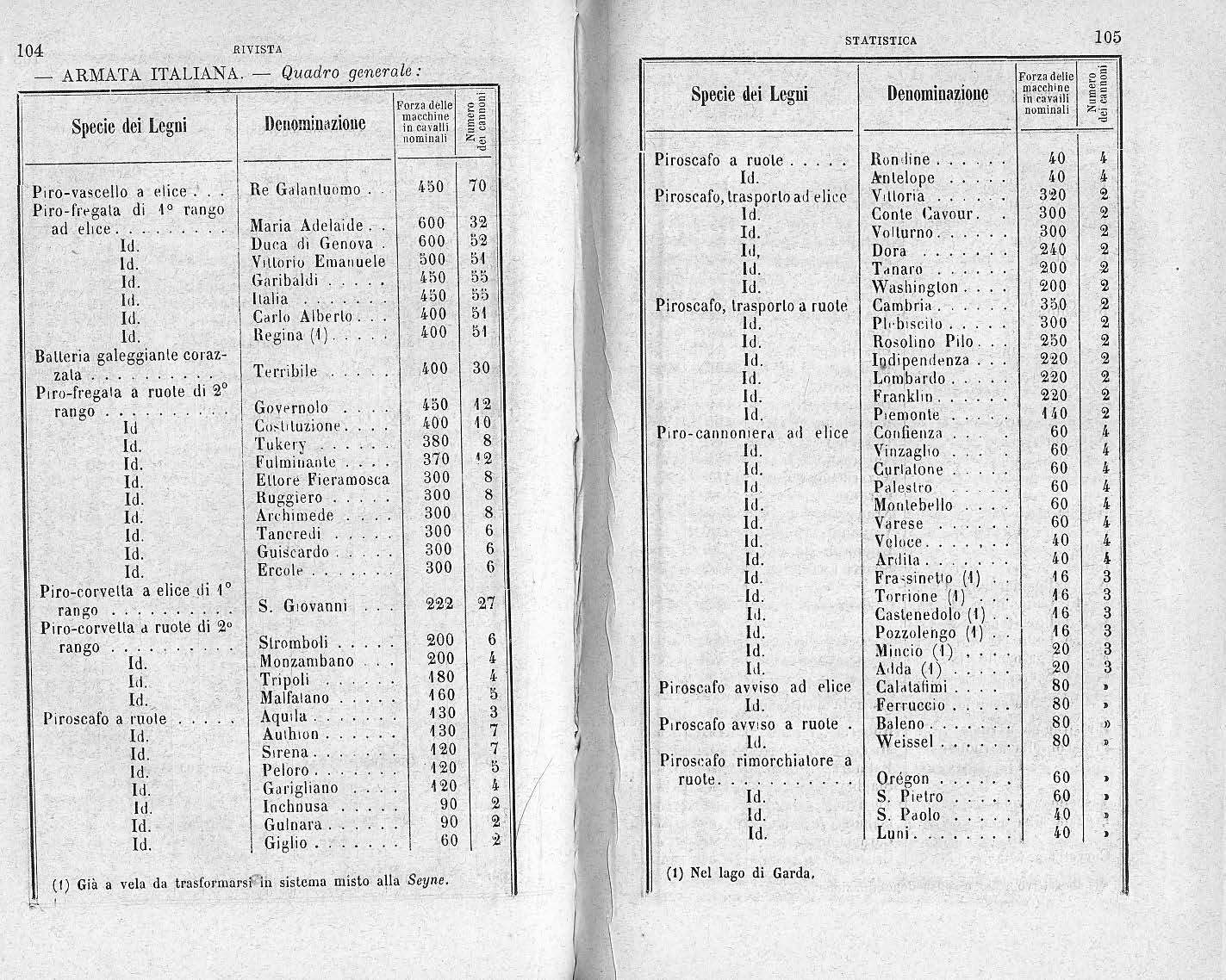
Elloré Fi era mos ca
Ruggi ero
Archimed e Tancredi
Guiscardo . Erc ol..
S
104 R I VI STA
. Giovanni Stromboli . Monzambano 'f r1 p'oli Malfalano Aquila . . Au 1h 1on . S irena . Peloro. Garigliano lnchnusa Gu lnara . Gigi.io. Forza delle maccl1 in e in cavalli nomina li · ,. 450 600 600 · 500 450. 450 400 400 · J.0 0 45 0 400 380 370 300 300 300 300 300 300 22 2 200 200 180 160 130 130 120 120 120 90 90 60 I ( 1) Già. a vela da ,trasfor01arsi""in sistema m isto aJla Seyne. !70 32 52 51 55 ' 55 o-I 5 1 30 12 1 O ' 8 42 8 8 8 6 6 6 27 6 4 4 5 . 3 7 7 ·5 4 2 2: '$ STATISTICA 105.. Forz a delle e·g Specie de i Legni Deuomiua~iou~ , macch ine or" s" i ' éà~·,1 ili = " nominali Z a "" ----· ,-Pi roscafo a ruote . R on di ne . 40 4 Id. knlelope . ' 40 A Piroscafo, trns porto ad eli ce Villoria . 320 2 Id . Conte Ca vo ur 300 2 - Id. Vo lturno . ,300 2 lii; Dora 240 2 Id. T rlnaro . 200 -2 Id. Washington . - 200 2 Piroscafo, lrdsporlo a ruote Carn,hria .. . 35,0 Id. · Pldi 1scilo . '300 2 Id Rosolino Pilo. 250 2 Id . IQ~ i pendenza 220 2 Id. I Lom;b ardo .. 1 220 2 Id . I?rankl in . 2'20 2 Id. P1e n1o n\e HO 2 P ir.o- cann onier,l ad eljce Coofienzà 60 4 Id . Vinz,aglio . 60 4 Id. C~1r11alo ne 60 } I d . - .J>;i) e,s l ro . 60 4 Id . '~òn ,lebt>llo 60 -4 Id. V~r~se . . 60 4 ld. Vl)loc e ... . _ 40 4 Id. J\.rd\la . 40 4 ) d. Fra ~si nrttp (1) . 01{ì .3 Id. Tor do ne (1) . H 3 l cl. Cas~enedolo (1} . 16 . 3 I~ Id. Poz ~o lehgo (1). -16 3 Id. Mincio ('I) , . "so 3 I ,l. Adda ( ·1) ' f60 3 Pi ròsc afo avviso ad e1ice Calalàfiini . . . ., So • ld . -Fe rrUGGÌO . • I 80 • P 1rqscafo avv.1s0 a ruole B,a le no . ,.8,0 _ )) Id. Wei sse l . .. ~o • Piroscafo rimorchiatore aruo t~,' . ' .Qrégon . . ' 60 • I d. S. l? iel ro 6,0 ,• ,. Id . S. Paolo 4,0 Id . L~ni. : 40 · , . (1} Nel lago di Garda.
Specie dei Legni Denominazione
,nasll~enli a vela.
Fregata di •1 ° rango ... hl.
Cor~ella a ba~teria coperta d, 1° rango · . .... • ·
Corvetta di '2° rango . Id. Id ·
Brigantino Id , Id . Id. Id. Id'. ., I d.
.Nave oneraria . Goletta .
Id. Id. Id. Id. -Bovo . .
Culler. . . i N° 2 Boc;nba rdier è (1)
14- Car]l)(rni e re ('1) .
7 Rovi (·I) . ... ' . 8Lenli(1) .... • •> 4 Parnnz!ll]e ('1) ..
p'.a,rtr-'nope. S. l\;l.1cbde · Euridic e Irid e . . . Valoroso. Zeffiro . . Tronto .. Grnero$O lnlr e pi do &ridano . Col ombo. Qaino ... Ben venuto. D,,sgeneys Aurora ... Azzardoso .
Feritoì·e
.. . .
. .
A . questi _leg q.i devono esserc1 a:gg iunt i i due bellissrm,i p1• roscafi riazionali Yittorio Emamtele e Conte Cavour, recen1~meì1tc -::omprati ·dal Gov e rno; il pirosc~fo -_Fairy Queen a<:'qu i' stato in Inghilterra·; du e nuovP. piro-frega te ad elice, già mes~e -in costruz ione nel cantiere della. Foce, sotto i l nome d1 Prinéfpe .Uinberto e I'1·i-ncÌpe Carigncmo; una piro-corvetta ad ~l ice di primo rango, in costruzion'e nello stesso cantiere, sotto il nome di h·inc-ipessa Clotilde, Inoltre fu r ono ordinate a ll'industria privata alla Sf,yne, pre$S0 T olo'ne, due batt.erie galeggianti corazzate - di ferro (deJie quali parlò già la Rivisla)· de• nominate Terribile e Fomiidab-ile. · .,
Ne l cantiere di Castellamare si sta costruendo una ,nuova fregata ad elice derr00:1inata Gaeta; una p i ro fregata con propulsola re ad e lice, denominata 11.fessina; ed una piro -corv i> tta egna!e alla Magenta cui nome Etna .
AUSTRIA. _:_ L'e~ercito e l'armata e-ostarono al l' erario, austriaco 134.621.680 fiorini durante J'eserci?.io 1860, cioè 34, 092,195 'iì.ori~i in r~\ù di _ lz3 della spesa gener~le.
- Dall'annuario militare (mil-itat· Schematismus) pe.r l'anno . H\61 . ,icaviamo che l'esercito austriaco ha ·ora quattro feld -ma• resciall i. Sono essi i l principe Windischgriitz, governatore della forte zza federa le di Magllnza; il conte Nugent; il conte Wrat isla w, comandante la guaraia degli arcie ri, ed il barPne Hess, comauùao le la guarùìa de' Lraba11ti,-
.
.
Esistono In Napoli In lstato d'innavlgabllllà.
P1M-frrgala a ruot e ·. . Roberto . · .
Piro-corvetta a ruote . Mi6eno .. Id. Palinuro.
l JL Sta~bia
Vascello a ve-la · Vesuvio .
.. ld.
Cara
PosSi ede in (,ltre>; ne' quadri di a ttività, 15 feld-zeugmaisters, detti altrimen t i general i d'artiglieria o cavalleri11, tra i qu-~li 5 arciduchi; 83 ten.en ti maresci,dli, tra i quali 10 arc;iduchi; 123 genera l i magg ior i, fra i qu~Ji 2 1Jrcidu ch i.
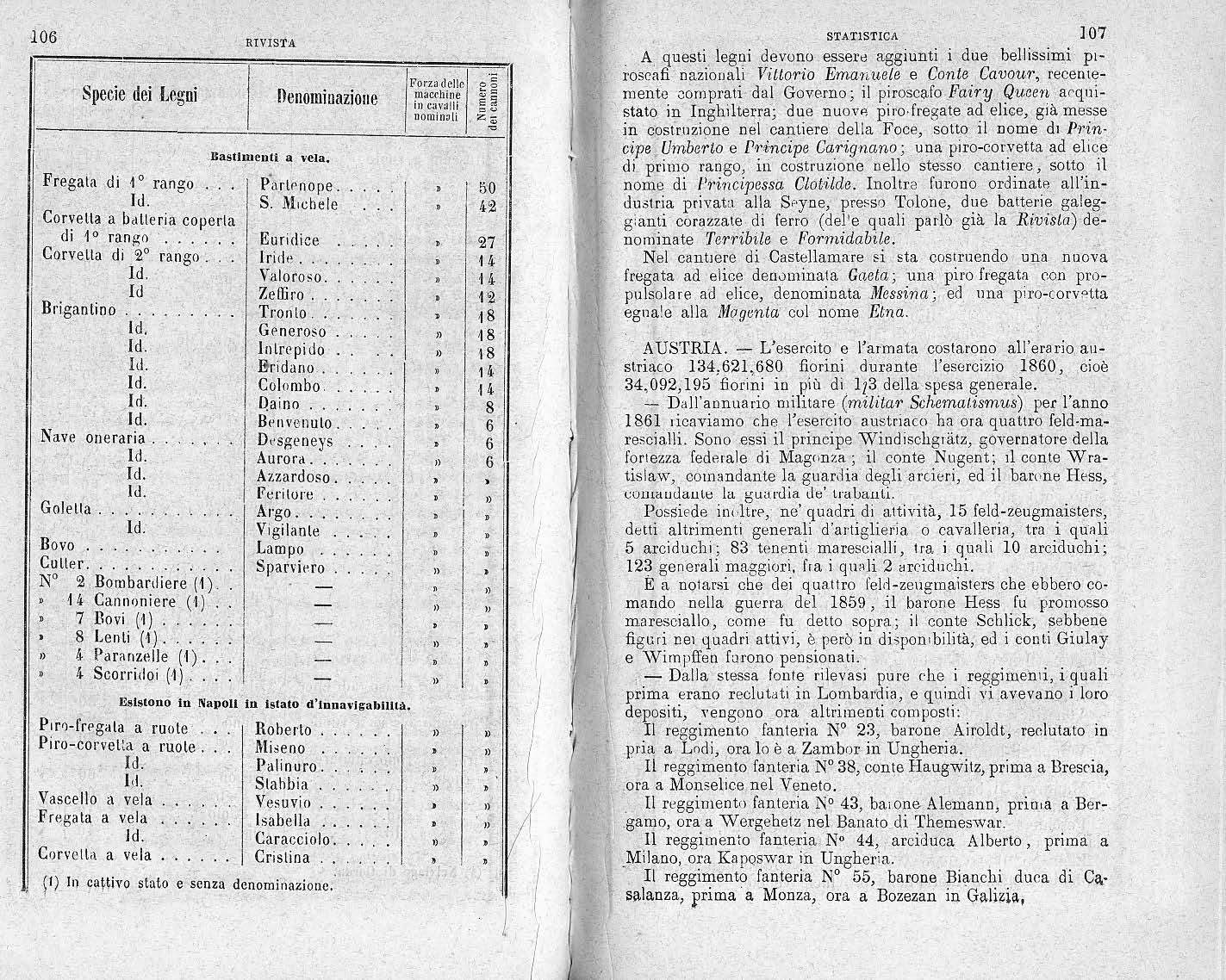
E a nqtars i che dei q uatt.ro fe ld-zengmais ters che ebbero comando n ella guerra d el 1859 , il barone Hess l'u promosso maresciallo, come fu_ detto sopra ,; il conte Scblick, se·bbene figuri nei quadri attivi, è però in d\.3pon 1bilità, ed i conti Giulay e \Virnpffeh forono pensionati .-
. - Dalla stessa fonte rilevas i pure che i. r eggi ru.en1i, i quali prima erano r eclutati in Lombartlia, e quindi vi avevano i loro depositi, vengono ora altrimenti cornpos1i:
Il reggimento fanteria N° 23, barone Airoldt, reclutato io .p,ria a Lodi, ,ora lo è a Zambor in Ungheria. _ '
Il reggimento fa n ter ia N° 38, conti' Haugwi tz, prima a Brescia, .ora a Monselice nel Veneto . ·
· Il reggimento_fant er ia N.0 43, ·ba; one- Alemann, prio,a a •Bér~ .gamo, ora~ We:rg ehetz nel Banato. di Themes,var. .
Il reggimento fanteria N° 44, arciduca Alberto, prima a Milano, ora KapQswar in Ungher ia.
Il reggimento fanteria W 55, barone Bia-ncl~i duca di Ca.· salanza l :prima' a Monza, ora a Bozezan in Gali.::ia,
,106 RTVISTA
Argo
Vigilante
Lampo
Sparviero
Forza delle
ti~
cav'1
4 Scòrridoi (1) : .. 50 42 '27 H ' H 12 ,18 )) ,18 · J) 18 H H 8 6 . 6 )) 6 J) , )) )) I) )) n ))
..
o macchine
in
lli g nomin~li _. z
. I) » )) l) • I) • . I) l) ( 1)
I ( i ! i / J f I I r I I I I ) i I ( '· I STATlSTICA ] 07
Fregata a vela Isab ell a
cciolo. Corve lla a ve la Cristina .
111 cattivo stato e senza dcnomirìazio11c.
D ei battaglioni cac ciato ri: il N° 6, prima reclutatG a Brescia, ora lo è a Krumau in Boemia.
Il N° 11, p~1ma a Pizzighettone, ora a Boruk.
Il N° 18, prima a Brescia, ora a K rumau in Boemia .
La L_ornbardia n on formava alc un rrggimento particolare di ca".all er1a o d ' artiglieria.
a notarsi che il solo reggimento lombardo che sia stato conser vato p el reclutamento iu Italia è il n,crcrim e nto Haurrwitz 1 1 . Id . oo o ' ne qua e s e rv~no I so. at1 d el la provincia di M an tova.
- Comandi austnac-i nel Veneto - In Austria un solo comando gen erale abbraccia il r egn o Lombardo-Ve • eto il Tirolo la Ca~inzia , la Carn iola ed il littorale. Ne è com~ndante i~ capo 11 c~valier~ B~nedek, gene rale d'artiglieria, personaggio ben noto. rn ~taha, m Polonia cd i o Unµ:heria e che ha fama d'essere ~l p~1mo fra gli .uomin_i di guerra dell'i mpe ro austriaco. Pres.so d~ lui, come primo arntaote generale, sta il barone Hen1kste1n tenente maresciallo.
L 'est::rcito. c~e presidia quel vasto termoiio si coni pone di quattro corpi d arrnata, che souo : ·
. Il teno, col quartiE-re generale a L aibach, romand ato dall'arc !du ca. Ernesto, tenent e marf)sciallo, già. brigadiere, indi divis10nar10 nell a gue rra d ' Italia del 1848-49.
Il quinto, col quartier generale a Verona, cornandato dal c?nte Stad1on, tenente maresciallo che fu alla testa del medesimo r.or_po n e ll a campa.gna del l85!J.
.Il ~ett 111;10, ~o] quartier gen e rale a Treviso, comandato dal prrnc1pe d Ass1a-Darmstadt, tenente- maresciallo, già brigadiere n~lla guerra del 1859 e che ebbe parte prec ipua alla bnttaglia d,1 -~Iontebello, nr,n troppo brillante per le armi austriache. Egh è frate ll~ dell'i_m.peratrice regnante di Rus5Ìa. Diventò rned1atore .per 11 r~vY1c1oamento delle due corti, il che gli valse la womoz1one ed 11 ~ornando d'un corpo.
. Lottavo, col quartier generale a Vi cenz a, comandato dall'arc~du~a Al~erto, gen.erale di artiglieria, che si distinse come d1V1s1~nano nella prima guerra d'Italia ed in qu ell a d'Ungheria.
Le for~ez~e lombardo-Yenete ha n no a govematvri :
Venez ia, 11 barone Alemann, tenente maresciallo, che già ama quel comando nel 1859.

Ve~ona, il barone Wernharòt, t.enentemaresciallo, che comandava 11 10° c~rpo d'armata alla battaglia di Solfer mo.
l\t~an~ova, 11 barone Szkankwics, tenente maresciallo, che nel! ult1r.na gu.erra era primo aiutante generale del conte Giulay.
Pe scl11er~, :11. barone Lang, tenent e maresciallo, che comàndava una d1v_1s1one nella guerra del 1859.
L egnag~, 11 cavaliere Woinowicb, gen erai maggiore, già/ coloniwllo d~ ~endarmeria nelle provincie venete. u: ( .
Palmanova, il ronte Corti, già generai maggiore, ispettore d el genio in Galizia.
FRANCIA. - Scuola di mariri ai-carinonieri. - Già da lungo tempo l'arm ata fran cese ha una scuola di marinai-cannoni e ri, stabilita oggidì sul vascello -mi sto il Jfo -ntebPllo del porto di Tolone. Questa scuola, che diede buoIJissimi caononi r.r i., contribuì non poco a grandi progressi dell'artiglieria navale in Francia .
L'importanza et.e ogni gio rno p rende maggiore la marina francese ha nece"sitato lo sv ilupp o di cotesta ist ituzione. Eppertanto veune decisa la Cl'eaz i0n e di una seconda sc uola di marinai- can n on ieri , a bordo, dicesi, del ,·ascello a vapore Luigi Xl V del porto di Brest. Lo stesso bastimento avrà contemporaneamPnte una scuola di gabbi'.eri destinata a formare i marinai a ll e man o vre d, lle vele, che il rnpore è ben luu g i dall'escludere. Qu esta dl p~•ia istituzione è eccellente e vorremmo che il governo italinno ne seguisse l'esempio, p oicbè n' ha m ol 10 bigogno la nost ra marina per innalzars i a quella forma cui ha diritto e debito
. - Tiragliatori Alge1·irii. - Le disposizion i seguenti riguardanti i tre reggimenti di tirag liatori algerini, furono adottate con una recm te deci~ione impe'riale .
L'effe ttivo di ciascuno dei J"eggimeoti è fissato a 2000 uom1n1.
Gli ioga ggi ameoti e rin gaggiamenti pei tiragliatori verranno ~ontratti . dinanzi i fu~ziona.ri dell'intendenza mihtare e per la !erma d1 quattro anm. ·
I t 1ragliatori . indigeni ricevbranno in tutte le posizioni j viv e ri di c11mp9gna.
p soldo dei soldati è :fissato a 60 ceot . al giorno per la pn ma classe, ed a 50 per la seconda. ·
. ! g radi francesi (sou'uffiziali, capora li , soldati, tamb urini e •~ombe)_ riceveranno le medesime co mpetenze dei reggimtnti d1 zuavi
Fin6ra n on e, i::1tevano se non tre bat tag lioni di tiracr iiato ri intl i ge ni, det~i 1'iwcos; uno per la · provincia di Algefi, uno pt>r qudla d1 Orano e·1 un terzo per quella di Costantina. Quesu tr e battaglioni furono il nucleo di ciascuno dei tre reggimenti che stanno formando attualmente.
108 RIVISTA
\ STATISTICA 109
c.
BOLLETTI NOBIBLIOGRAFICO TRIMESTRALE

La Campagna d1, guerm netr Umbria e nolle Ma 1·ch e, na rrar.ione milita re riel capit~ n o G. G . C . - 1 vol. d i 2 0 fogli d i s tampa , for mato de ll a R ivi s ta m i li tare ita li ana, co n ca.r-te e pi ani topogra fi ci - 'fo ri n o, t i p. G. Cassone e comp - L . 6.
La legislazione mil·itare del 1·egno d' Italw , oss ia Coordinamento ragi t•na to delle l egg i, d ecreti , regolamenti , ed ist ruzio ni att u alm• n ttl io vi gore so pra .ogni ramo d ell o staì o milita re div iso in 5 gra n a i p a rti ci oe : Tnst it uzi one e organizzazione dell' eser cito, e dei suoi diversi ser v izi . - R eclutam ento. - I struzion i e avam:am eato . - - Prerog.:tive . - Disciplina e giu ri sdizi on e territo ri al e . - Amm in ist r azione:fon da te ognun a Il i qu este part i sop ra i pr incipi i general i de lla sci enza, e mess a n ei pa r ti colari, a confro nto di quest i aforis mi, e de i sistemi i o uso pr esso i più rin om ati eserci ti .p er Luigi F HcH r - MA SSID A, sotto-com missari o di guer ra n e l Co rpo d'Inte ndenza mi lit a re.
Opere italiane.
Brevi cenni teorico-pra tici sul {11,cile rigato per la fant eria, modello 1860, con 1arnla litografica . - T orino, tip. G. Cassone e comp. - Cent. 40.
n'rnMINRN T F. P ORRl. 11:AZIO::,IR '.
Regolamento pel servizio m i li ta r e, nei dipa ?·li menti , circondar i, e nelle piazze, cornpi hto in massima s u quell o d el 1823, raffazzon a to p e rò e rim o,1erna to se co ndo le più rece nti e Yigenti prescrizion i. È questo u n lav o ro cosci enzios o il qu a le venne a ffid a to a •i es p n ti uffiziali , che speriamo si acqu isterà i l favore de l l'Ese rcito .
Codice d ell' u (lìzfol e, c ioè raccolta d.i tutte lfl leg~i e d ec reti che rifl.eLto oo l'u ffizi a le i n tutte le posi zio ni io cu i può trovarsi, ossi a o o : legg i s ull'ava nza men to , su lle giub1l az ionr, s11 110 st:1 to degli uffiziali, sull e pagh e, v antagg i e co m petenze, s ull'ordinam ento d ell'esercito ecc. , con t utte le modifica zioni ed a ggi ,rnte che ciascuna legge e decr eto ebbe a s ubi re da l tempo de lla s ua p u bb li cazio ne o rig inale ad oggi :
Q ues to s a rà un utiliss imo ma nual e io cui ciasc un individuo potrà rico nosce r e la propria posi zione in og ni circo · stanza d i l uogo e di tem po; ed è pe rciò c he gli edito r i avvisaro no di a n ti cipar ne la p ubbl icazion e .
Opere francesi.
Manu el d 'infa ntcr ie, par M. le capit.a in e PAI...R ON. Cours d'admi nistmti on mi li la i?'e , par M. VA ucH&LLE. - Qu at rième éditio n, 3 vol. 8 . - Paris. - 24 fr .
Jfo tiee s ur -les pistolets, tou1·nans et 1·ou lants, di ts revolver s, leu,· passé, teu,· p1·ésent, leur a vcnir , par A NQUETrt, 8.Pa ri-;, Taner a. - 2 fr. 50 c.
Résisterice d'·wn solide encast!·é dans les paroi s cylindr i ques, et soumis à une pression uniforméme-nt répa,·tie . A p pl ication . a u x can o os, se cb ar grant par la ,·ulasse, système ""v-,Tahren · d odf. Par . E . Tenss1rn , 8, av ec p l anc b es . - P a r is , J. Co rréarcl. - 3 fr.
H isto i re m édicale, d e la flotte fr an çaise, de la mer Noire, p endant la gu, ene d e Cr i-mée, pa r l e docteur A . ~'1AR RO rN
8. - J. B. Oaillièr e et fi ls. - 3 fr. 50 c:
Qua tre m ois d e l'expétl it i on de Ga ribaldi en Sicilie et cn l talie, par H. D uR ANO - BR~GER, 12 . - Paris , D e otu . - 3 fr . 50 c .
il1émo i res et cor r éspond a nce du roi Jér6 me, et de la, r eine Catherine. - T om. I , 8 . (495 p .) - Pari s , Dentu . - 6 fr.
- ( L'on vrage fo rmera 6 voi. )
I J. J i BOLLETTINO BI BL IOGR AFICO T Rn!ESTRA Ll!: 111
N0u1,elle m éthode de <juerre ba sée particv lièrement sur les pe1·fectionnrments dv, fusil et sur leiws conséquences nécessaires, par BoNNEAU no MurnAY. - 8 1 av ec pl anchcs. - A. L eneven. - 40 fr.
·carwn:s rayés' systè'rne11 Ar,mstròng et Wh itworth, lev.r con- slroction, leur puissance . - Expérien ces de Shoeburyness, de Southpo'rt', Forgéage des rao ons à Woolwi ch et a Allevard (I sère), par EoouARD BucHWALDER. - 8, a\'0c uoe plan che. (GE!ìiève). - P àris, J. Dum aine' - 2 fr.
Us czirab-ines d.e guerre, les fu,sils transformés et leu1·s balles, avec' dès no'IJ-ib'fis précises sur tous les projectilts d'armes à feu- por'tativtis dèpuis cinqcents· ans' par CnARRlN. - Avec flgurtfs, 1'2'. --" P iir iS',' J. Dùmàine. - 2 fr . 50 c.
Le canon rayé' proisien; - comparaison des systèmes fran1ça is et ' prussirln. I:e ca1tlrm'. p r ussien jugé par !es' A!l e mands. Par l<'ÉRÉOL F ouacAOLT. - 2 V()ls. 8. (Bruxelles). - Parìs, Ch. Tanera. - 3 fr. 75 r..
Canons rMJéS. - T héorie pratique sur l'application du principe de la rayure, aùx dno ns ei.' aux mortier's cle tout cali bre, pà rTH dSÌAs L'l'N'.iLL. -Traduction de N. Adts. 8, (Bruxelle s).

- P arìs, J. D umn,ine - 7 fr. 1:\ 0 e· .
Du mowiJerMnt _d'es projectiles lancés par les armesà fcu rayes, pn'f le' èon:ite· PAbL' l)),: SAINT-R')BB RT. - A vec plaaches , 8. - Pari~, Ch. .T anera. - 2 fr. 50 c.
Le 131 Ilu.~sards; types, profi ls, esquisses e t croq ni s mil itaires à pied et à cheval par EMrLE G.1BORI.1U. - 12. P a.r :s, Dentu. - 3' fr
Souvenfr dlu bataillon des zo1,1,aves ponti/u:aux (franco-belges), p'lr OscAR oE· P OL I. - 8. Pari, Car ion. - 6 fr .
Le chemin de l'épaulelte, histoire de l'e nròlé volontaire, par Au·G·osù Lrièòldl'TL,, p réface par Stani~la-; de L~peyrouse; illustra.~ions dé Worm s . - 12. Pari,, De1otu. - 3 fr . 50 c.
112 BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO
TRlliESTR.ÀLB
TAGLIANO GABHNO Gerente.
STUDI SULLA CA VAL LERrA
DE L NUOVO ORDINA1\1ENTO
PARTE Il.
L'invenzio ne d ella p olv ere J.a fuoc o, seg uìt a da vicino da quella del cannone stillo scorcio del xn seco lo, aum entò l a di stanza a cui s' appiccav a il combattimento. La cavalleri a ch e nell'evo medio era st ata quasi l'escl usivo elemento delle battaglie, lentissima nelle sue mosse, perchè tnt ta b ardata di ferro e p esantemente armata, d ovett e so ffri r grandemente di fronte alle nuove arti glierie, e p erder e fr equentemente l 'opp ortu nità di agfre, prim a d i aver percor so il terreno ch e l a separava d al nem ico e v eni re alle mani .

Le sue armadure, per quanto siasi tentato di aument arne l o spessore , erano insuffic i enti contro alle pall e , epperciò essa volse in discredito, cedendo p er sempr e la
ANNO VL Voi. I. - 8.
•
E
NELLO SPIRITO DELLA TA'!"f!CA nIOD!ìUNA
DELL'llSllRCITO ITAL1A.NO
DREV I RICORDI $TOR I CI.
sua su p remazia a1la f;;wteri a , l a . qual e, d'allora i n poi, add ivenn e l'ar ma princi pal e d elle battaglie , coiue già lo er:a sta~a dapp r ima ai tempi della . falange e d ell a l egi one. L a d1ffi.c0ltii d i procur arsi dei cavall i propri a l servizio àella cava'lleria grave, in seguito ' alle guerre ci vili ch e infest<J,r ono la fine de l xv1 f:1ecolo cd i l princip i o •del xvu, e sovrat~1tto l'abbandono della lanc ia per l a p istola ed il mosch etto, (liedero l'estr emo ar ol lo all a cavalleria catafratta.ria del med i o evo ; e su lJ.a metà de l xvn secol o noi trovi a:1Ùo ' spariti quasi in ogni esercito lo pesant(a·rma~ t ur e, per dar luogo a cav alleggeri ed a dragon"i.
' Gustavo Adolfo i n principio - della guerra dei trent'~nni (!630) , rid usse la massiccia ordinanza degli squ adr on i e la ridusse a quattro r ighe di profon dità: le t r e prime destin ate a caricare, e la quarta a servi r d i r iserv a . Sciolti · i suoi cavalieri cl'og~ii inutile ar ma d i fe n siva, e to lta lo.ro la l aucla, egli si studiò d i rnnderli piè1 leggeri, attivi ed util i formandone squadroni d i 64 cavalli , d estinati a combatter e r i un i ti.
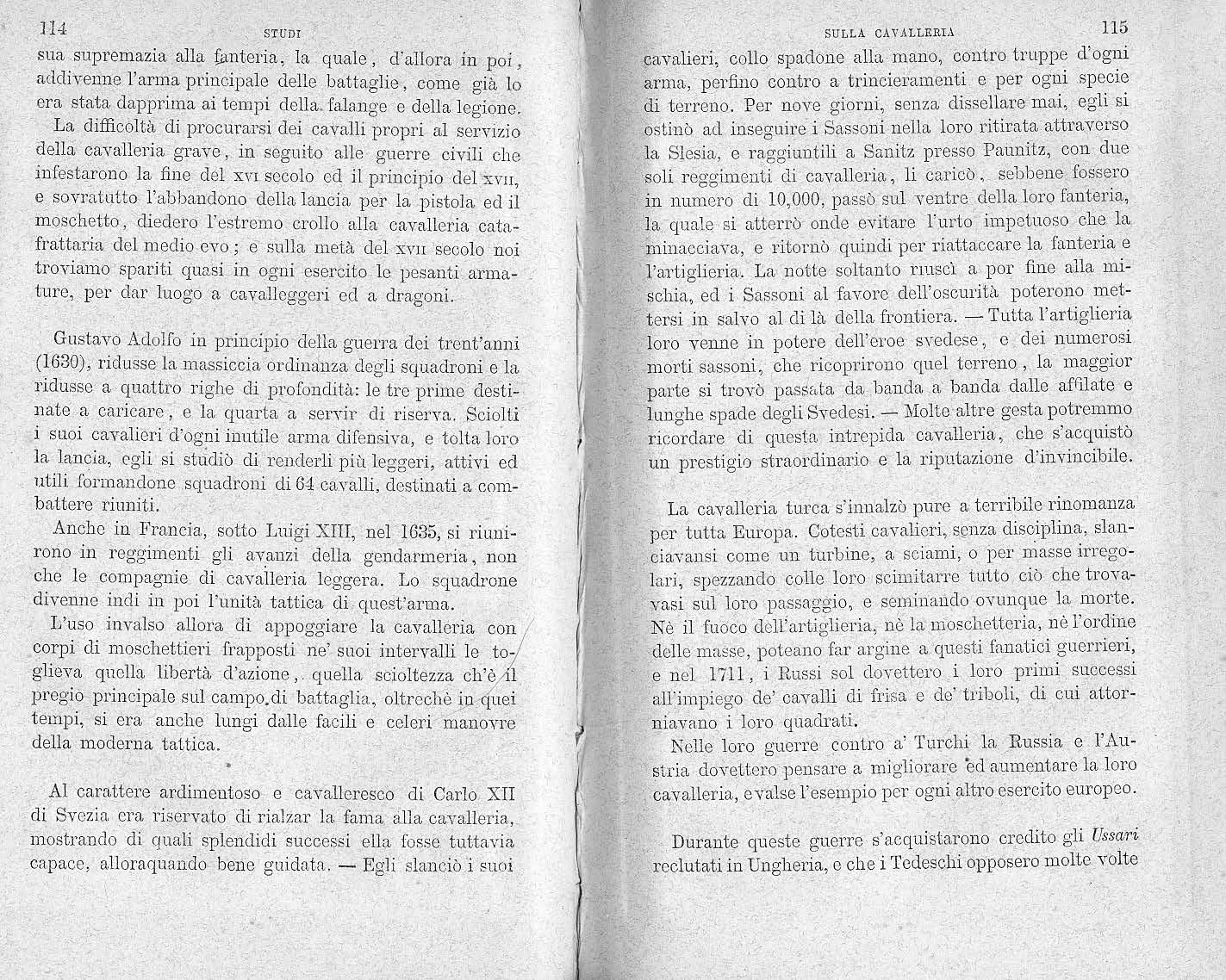
Anch e i n Franc i a, sotto Lu.igi XIII, nel 1635, si riuni • ro no in reggimenti gli avanzi della gendarmeri a , non ch é l e compagn ie di èavailer ia leggera. Lo squ adrone diven ne indi i n poi l'unità tattica d i quest'arma .
L'uso i nvàl.so allora di appoggi are la cavaller ia con / co:p i d i m os ch~tti e1~i frap?osti ne' suoi i~ter vàlli' l e toj glieva quella. liberta d'a.z10 n e,. quella sc10lt ezza ch' o/11 p r egiò prin ci p al e s u l camp o.di battaglia , ol trechè inAuei t empi, si era anche l u ngi dall e fac ili e celeri n:an ov r e del la modern a tat t i ca.
cé1valieri , collo spadone al b, mano, con tro truppe d' ogni arma, . perfino contro a trincieramenti e per og ni specie i.'l.i terreno . Per nove g i orni, senza dissellare mai, egli si osti n ò ad i nseau ire· i Sasson i n ella l or o ritirata attrave ì·so o l a SJesia, e raggiuntili a Sanitz presso Paimih , con due soli reggimenti di cavalleria , l i caricò, sebbene fosse ro i n numero d i 10,000, i)assò sul ,entro della loro fanteria, la quale si atterr ò onde evitar e l ' u rto impetuoso che l a m inacciava, e r i tornò quindi per riattaccare l a fa n teria e l 'aTtigli eria'.. Lal notte soltanto r rn scì. a poi; fine alla mischia, ed i Sassoni al favore d ell'osc u rità poterono mett ersi i n salvo al cl i l à della frontiera . - T utta l ' artigl ieria loro venne in po tere dell'er oe svedese, e dei 1~u merosi m orti sassoni , che r icoprir ono qu el terreno , l a maggio r part~ si trovò pàss&.ta da bançla a' banda dalle affì.late e . lungh e sp ade degli Svedesi. - Molte ·altre gesta potrem m o r i cordare di questa intrepida · cavalleria, che s'acquis t ò u n presti g io straordin ,ario e l a riputazione d'inv1ncibil e .
La cavaller ia tur ca s'innalzò pure a t err ibil e r inomanza p er tutta Europa . Cotesti cavalieri , sgnza dis~iplina, slan: ciava.nsi come un tttrbiue, a sciami, o per masse irregol a r i , spezzando collé l oro sc imitarre tutto ciò che t ro v a· vasi sul loro p assaggio, .e seminan do ovunque la m or t e. Nè il fuoco dell!arti glìer ùt, uè la moschetteria , nè l'ordine delle masse, poteano far argin e a questi fa n atici guerrieri , e nel 1711 , i Russi sol dovettero i loro primi s u ccessi all 'i m1)i eao de' cavalli cli frisa e de' triboli, d i cui att or, o :, .n i avano i loro qua.arat i .
Al carattere ardim entoso e cavalleresco di Carlo. XII cl i Svezia era r i servato di rial zar la fama alla cavalleria, m ostrando di quali splen di di suc cessi ella fosse t uttavi a capace, al1oraquan do bene gu id ata. - Egli sl ar1ciò 'i s u oi
Nelle l oro guerre ~onti'o a' Turchi l a Russia e l'Au• stria clovettero·pensa,re a m i gliorare e d aumentare la l oro cavaller ia, e valse l' eseiupio per ogni altro eser ci t o europeo .
Durante Cflieste guerre s'acqtùstarono cre dito gli Ussari reclutati in Ungh eri a, e c h e i Tedeschi opp.osero molt e v olte
Jl4 STUDI
f r SU L LA CAVALL ERIA 11 5
con successo alla formidabile cavaller ia turca . Armati di una sciab ol a ~-i c~r va , di un moschettone e d i pistola, montati su caval h pic coli e sneìli, il lo ro modo più abitu ale di con~battere era d i attorniare u no squadrone, od un battaglione nem i ?o, ~ i sg?rnF,mtarÀo co' l oro hu·J"'l'ah, ed appena postolo m d1sordme , penetrarvi d entro colla sciab?la e farne _strage; ciò non riuscendo, essi si ritiravano d: c arriera e s'and_a;vano a ra:n nod are con tutta celcr,ità dietr~. qualche r iparo . - Sul fine del J,;:VU se colo Ja F1:~ncia levò due r eggimenti di cotesta cavalleria in Al~a zi~ ' , e raccoglien~o quanti. disertori u ngheresi si presenta, ano, a ciò stunobndoh con premii d;ingaggi o.
S~tto Luigi XIV , 1~ Fran cia,. siccome t u tti gli altri Stati, aumentò c onsiderevo l me n te la s ua cav~illeria, ed ebbe' perfo~o. 60 r \')ggimenti di ,cavalleria leggiera di 400 a 600 . u omm.1 c~dauno, e 43 di dragoni . .7'"" I cavàlleggi eri ,erano armati d1 spada, pistola e moschettone. Oani re _ o·· t · · . o g o imen o avea una compagnia di moschetti eri; ·e vi furon o per a~co i1:tieri r eggi menti armati d i ~opchetto . ·
I dragoni che appar vero i n Francia nell'anno 1554 or?anizzati da,l rn~res~i allo d~ Br~ss,;1,c, si ' erano mo lt i plicati m 1:1odo eccessi vo . m tutti gli eserciti d'Eur:opa, stilla meta del se~o lo xvnr. Destin ati a combattere· a pied i ed a . c~vallo, essi er ano armati di sciabola diritta o d ell,a spada piatta d ella cavalleria, d i f\tcile con baionett~ (1), e por- · tavano l e uose e gli speroni. All 'arcion e d ella sella tcneano appes a od u na scu re od u nQ stnm1ent o da zappatore . • -
Nell'anno 1672, la Francia a.vendo 82 r eèwimenti t1i ca\ vallori a, conse rvava ancora l a cor~zz~ p iutt~:to per serbar
le tr'adizìoni dell'antiq uata gen da.rm crià, ch e per utilità sui campi di battaglia .
Aveasi pure in- q11oi tempi un'altra speci e di cavallèria , i ca1·abinie1·i, chiamati così. per l'arma da fuo co l oro. Ques ta specie di cavalleria, d'origine spagnuola, principiò ad aver riputazione dopo la spedizione del d u ca d'Alba ' ne' Paesi Bassi, e comparve negli es2rciti francesi sotto Enrico III (1571-1589). Formati in piccoli nuclei più p rofo nd i che l arghi, essi èrano disposti s ulla manca di ogni c ompagnia di cavalleggeri, che er ano i ncaricati cli protegg ere .
Ad un cenn o del capitano de ' cav·alleggeri, essi si avanzavano sino a 100 o 150 passi dal nemico, e quindi facea no fooco per riga, ogni riga ritirandosi appena fatto fuoco onde smasch erar la riga . sucéessiva e riòrdinanclòsi in coèla; e così di seguito finchè muovesse alla carie-a la càvalleria r etrostante. Allora i carabini eri si ritiravan o ind.i.eti'o per rincalz~r l'attacc o, o sost ener la riti1;ata, in' caso di .rovescio .. Nella campagna ciel 169;.f ess i vennero provvisoriament(;l formati in lllla brigata , e quind i stabilmente i n un reggimento (Roya l Carabin·iers) i n seguito alla lor·o splendida condotta alla battaglia di Fleµrus . Qu esto reggimento er a composto di 5. brigate d i 4 squa,droni, ciascuno dei .quali era ?forte d i 5 comragnie di 30 carabinieri.
Dappertutto, ove si guerreggiàva; o vi era probabilità di g uerra, si cu rava. l'ordjnarnento ed il perfez ionamen to della ,cavalleria, avvegnachè n iuno potea d isconoscere la importanza di quest'arma ed ì miglioria.menti ch'essa merit:tva. Nen vi fu ma.i esercito che siasi fatto famo so senza il concorso e l a ri putazione della sù.'a cavalleria.
(t) All 'o r·igine loro css l ebbe ro in Jfrin il n1oscl1cllo " · · · , u m1cc1a, qui n di l'a'rc hibugi o a ro fol la, iìn ch è ven ne~ inye nt.ulo il fuéilc n ba ion et ta s11ll a m c là del secolo XYU
Non cvi fu gr and'uomo d i g uerra il quale n on abbia fatt Q· g ran caso di quest'arma e non a·bbia post o ogni sua cura a perfezio n are l' armamento e la t attic a . Mano mano che l 'arte della guerra si rifacea alla scuola di que i
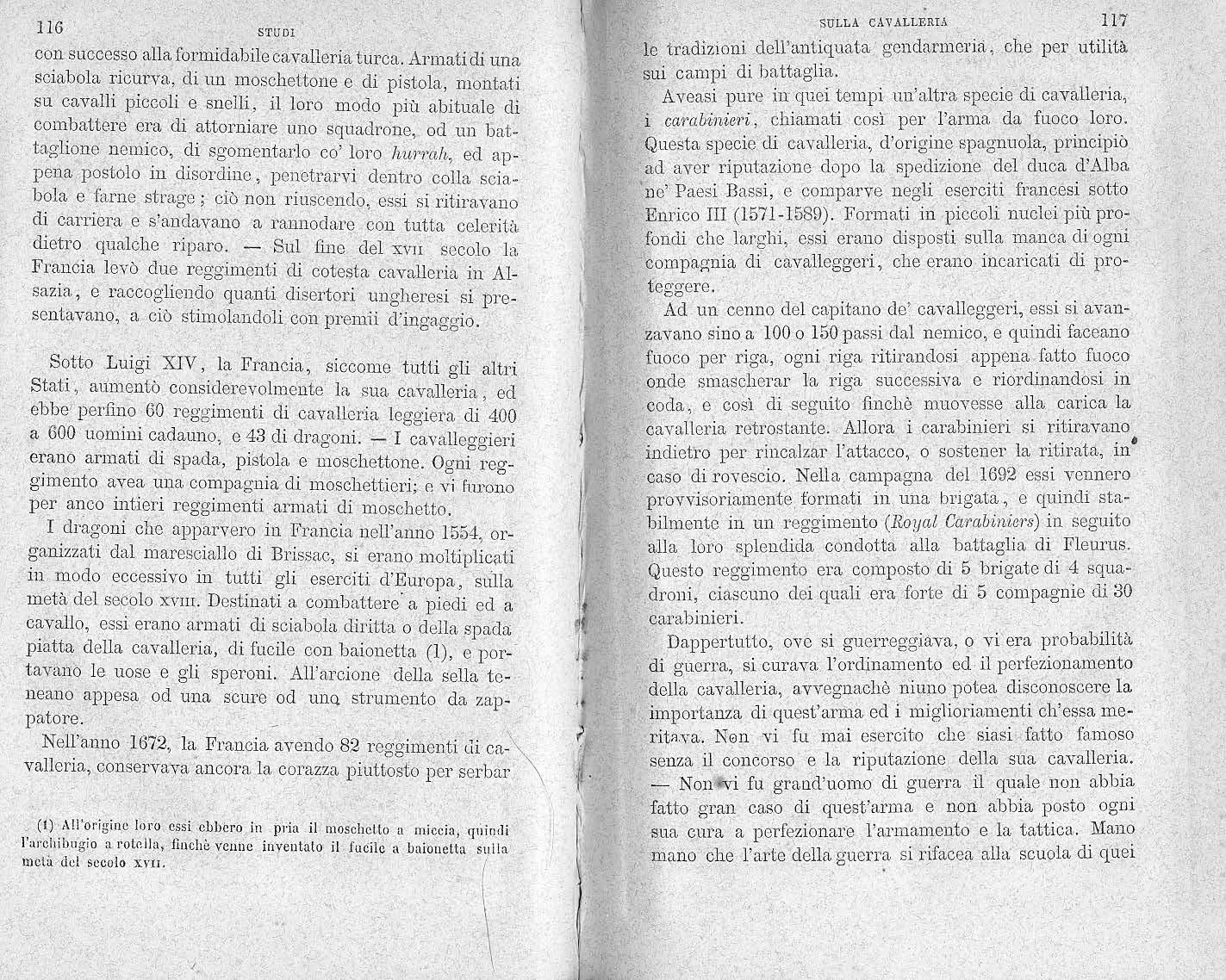
116 STUDI
-
\ 1· l l :~. SULLA CA V,~L LER I A 11 7
grandi capitani che furono Maurice di Nassau, Gustav o Adolfo, Tureuna, Montecuccoli ed il maresciallo di Sassonia, mentr e la fante r ia e l'artigli eria eran o i n costante via cli progresso, niuno potè mai immaginarsi che la caYallcria avesse da rimaner stazio n aria, niuno potè mai predire ch'essa dovesse un d't sparire dagli eserciti, come molti ogg idì s'immaginano e predicano .
Il solo Folard, il quale nella letteratura militare lasciò nome ~i sè, pi~1~to sto per l e sue stramberie, che per vera scienza militare , nona sua s tJ:avagante ten erezza per la fa lange, considerava qnale un mobile in utile Ia c~Yalleria, e ciò succecleva p er lo appunto in un periodo d1 debolezza e d1 decadimento, sullo scorcio del reo-no di Luigi XIV e sotto Luig i XV. , 0
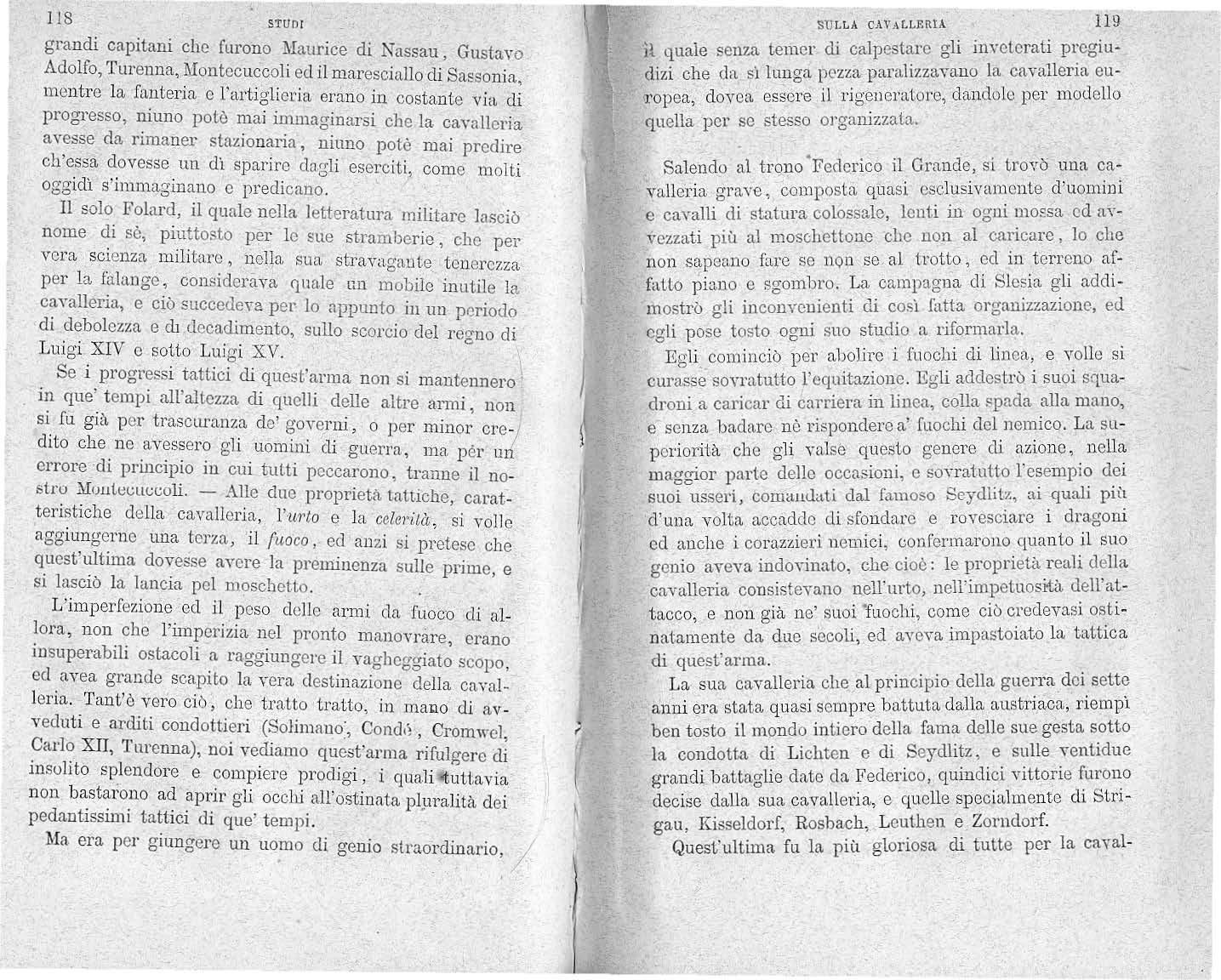
Se i progressi tattici di quest'arma non si mantennero 1 in que' tempi all'altezza di quelli delle altre armi non si _ fo già p er trascLU·anz~ de' ~o:er~1i, o per m ino; ere -; dito che ne avessero gh uom1m eh guerra, ma p ér uri errore di principio in cui tutti p eccarono, tranne il nostro Moute<;w.:<;oli. - Alle due proprietà tatt.iche, caratt eris tiche d ella cavalleria,, l 'iwto e l a celerità , si volle agg iun gerne ~ma terza, il fuoco , ed anzi si pretese che q_ucst'~tima dovesse avere la preminenza sulle prime, e s1 lasciò l a lancia pel moschetto. .
L'imperfezio n e ed il peso delle armi da fuoco di allora, non che l'ùnperizia nel pronto manovrare erano insuperabili ostacoli a raggiungere il vagheggiat~ scopo, ed avea grande scapito la v era destinazione della cavall eria. Tant'è ve ro ciò, ch e h·atto tratto, in mau o di avveduti e arditi condottieri (Solimauo:, Cond,~ , Cromwcl, ?arl~ XIT, Turenna), noi vediamo quest'arma rifulgere di msohto s~lendor e e compiere procligi, i quali -tu ttav ia non b~st~ro:10 a~ ~prir gli occhi all'osti nata p lJ.1ralità dei pedant1ssm11 tattici di que' tempi .
Ma era p er giungere un uomo di genio strao rdinario, /..
ìl quale senza temer di calpestare gli inveterati pregiudizi che da sì. lunga pezza paralizzavano l a cavalleria eu'l'Opea, do vea esser e il rigeneratore, dandole per modello quella per se stesso organizzata.
Sal endo al trono •Federico .il Grande, si trovò una cavalleria grave, composta quasi esclusi vamente d'uomini e cavalli di statura colossale, l enti in ogni 111o~sa cd aYvezzati più al moschetlone che non al caricare , lo che no n sapeano fare se non se al trotto, cd in terreno affatto pi ano e sg ombro. La campagna di Slesia gli addìmostrò gli inconvenienti di così fotta organizzazione, ed egli pose tosto ogni suo studio a riformarla.
Egli cominciò per abofae i fuochi di linea, e volle si curasse sovratutto l'equitazione. Egli adde strò i suoi squadroni a caricar di carriera in linea, colla f'pada alla mano, e senza badare nè rispondere a' fuochi del nemico . La superiorità cl1e gli valse questo gener e cli azione, nella macraior parte delle occasioni, e so,ratutto l'esempio dei suoi 0 usseri, cornauùati dal famoso SeydliLz, ai qua.li pitt d'una volta accadde di sfondare e roves ciare i dragoni cd anch e i co r a2i zieri nemici, c;onfermarono quanto il suo genio aveva indovinato, che cioè: le proprietà reali della cavalleria consistevano nell'urto, nelhmpeiuosrtà dell'attacco , e non g ià ne' suoi Ìuochi, co me ci ò credevasi ost inatamente da due secoli , ed avcva iropastoiato l a tattica di quest'arma.
La sua cavalleria che al principio della guerra,dei sette anni era stata qu asi sempre battuta dalla austriàca, riempì ben tosto il mon do iutiero della fama delle sue gesta sotto la condotta cli Li chten e di Seydlitz, e sulle ,eniidue grandi battaglie date da Federico, quindici vittorie ~uro~o decise d alla sua cavalleria, e quelle specia1rnente eh Stngau, Kisseldorf, Rosbach, Leu!.heu e Zorndorf.
Quest'ultima fu la pih gloriosa di tutte per la ca-val -
118 STUDI
SUI. LA CA V M.LRRtA 119
l eria pruss i ana. Seydlit.z c on 36 squ,aclroni v i cambiò la fortuna del combattimento che volgeva a . male per l e armi prussi~ne. Caricando colla so lita ,sua impetuosit~ , ed_ a prop~s1to, egl i salvòJa fa11;terià 8'Ì'artig lieria del --pro. pn~ esercito, gr~veJnente compromesse, sbarag-liò la ca• va.lléria russa che si avanzaya vittoriosa, poi ritomò sulla fanteria russa e _ la sbaragliò alla sua vorta, ma,larado la .. , . . o prn eroica resistenza . ·
. " In .Pfus~ia s.o.làmente (scrivev a Guibert nel s uo elogio dt Federico 11 Grande) i cavalier i ed i loro uffiziali hanno que~la franchezza, que.ll 'ard itezza a maneggiare i lo~o cavalli, la qu ale. p arendo confonderli cor;i. essi loro, ricorda i c entauri mitologici; ivi solamente, il numero delle evo• l uzioni è saviamente ristrett · a · quanto si fa ed è fattibil e in presenza d el nemi co. · ì, mettersi in col onna., percorrere, grandi distanze a dive e andature, formars i in batt~lia e por c·apo al mov"imento di carica ch'essa ricomincia ed. al qual e essa 'si famigliai'izza i:t;t~essantementé, ~cc,o ~iò cui s'informano tutte lo manovre di questa · cavalieri~ . I vi ~olt anto veggqusi riunioni di GO o 80 squadrom, e . eh squadroni di 130 o 14 0 cavalli effettivi, aventi d1e.tro cli 1~ro ~e' sovranumera11ii_(1) , fatr mo stra di quanto ' puo esegmre m gn erra un' ala cli cavalleria ben comau- . data ; ·~yi • soltanto veggo n si 8,,000 a 10,000 cavalli eseguir cariche generali per parècébie . centinai a di pass i a rresta r si i n O'rdine dopo averle condotte a fondo, e ta~ 1w1a volta ripr eu derl ~ · di un se o.ondo slancio contro un a. ~ove~a linea nemica , - ch 'è supposta presentarsi; in tu.tti 1 suoi campi di manovra , in tutte l e su~ reviste, ogni q u~lvolta Fe derico vdde h~ sua cavall~ria, ·a queste- çanche, egli nvol ge di . preferenza l a sua attenzione e v i npone il maggior pregio. Egli va collocarsi dinnanzi alle medesime e sul fianco l oro, fin gendo c0 ~1 alcun i cavalieri l 'ala n emica .
(1) Gu ibc rt i n t ende qu i la 3• riga .
: Ad u11 dato segnale l a lizza si apre, tutt o si mette in movimento, e d il movirn,ento · si accelera gradatamente, il suolo risuona, lungi, ben tosto p iù non si scorge che un nugolo di ,polvere , dal quale si ode come il ~omore di un torrente che si appressa; la _ linea sta per pJOmbar sul nemiGo , . essa abbassa la mano, si dirizza sulle· s!affe, e . presen ta il ferro .con alte g rida; lo scopo .è ragg iunto, ·repentinamente _ essa si arresta; più_ non s1 t> de c~e ,la voce de' comandanti che ra,,nn odano. 1 101:0 squadrom, ed at t rave;·so il polverio, che comincia a diradarsi, r i ap?ar e la li n ea int iera e perfettamente allineata . Che bel s p ettacolo offronò censim ili cari che; n on si pon n o vedere •senza risentire un frem ito misto d i ammirazione; viene fu mente questa bella e spressi one d ella Scrit tur a, quando essa comparn l e n}lbi ·portat e dai venti ad un :1-rag~no di cavalleri a : sfoil_t procellcvm eques trern . Oh I qu anto v ha luno·i da ci ò all' inutile e meschi1ia pompa· de' nostri antichi tornei! quale gr~ndc risult.~~to d ' ordi ne , di d isciplin a e d 'istruzione da porsi sotto gJi occ h i, per chi è sovrar: o, e quanto ben sì concepisce,: veden doli, come Fecler ~co abbia pot uto preferi rli al fasto d i una corte , e compiacervisi sino all'ulti mo giorno di su a vita ! »
Da 60,000 uomini ' di èui dispon eva Federi co il Grnnde all'epoca deÙa sua ascensi one al trono, egli portò il suo èsercito, s u ccessiv'amente, a 100; 000, a ·120,ooo e per:fìn? a 200,000 uomin i ·nel corso della gueri'a dei sette anm .

Di queste ·forze ; almeno f ni·on0 semp re cli cavaller ia..
Di ' qu~·s t 'arma egli ebbe : l ? r eg gime n t ~ di c_or~zzieri (dei quali u no GitC/.Jrclie de'l Cm·po), _ 12 ~e?g1ment1 ~h dragon i e 10 di usseri . . _ . .
· Il reggimento di corazzi eri , compon~vas1 ,di ;) squ adroru, ed ogni _squadron e di 2 compagnie di ·70 u omini cadun~.
·-{,a- m:Ui'~rdinan za era su tre r ighe di p r ofondità ; non già:
perchè Federico credess~ l a 3a riga necessaria ad a.cere~
120 STUDI
121
SULLA °CAVAL LERIA
SULLA C,ùALl,ERIA
scere la potenza dell'w·to, ma perchè egli la riputò util e qual riserva e p er riempi ere i vuoti che potessero suc cedere nelle cariche.
Questa ca.vaJleria portava la corazza sul dinnanzi del petto ., il cappello colla zucchetta metallica, spadone e pistole.
I dragoni erano ordiuati come i corazz ier i , eccettuati tre reggin:renti dei quali l ' uno aveva soli 3 squadroni, mentre gli altri due ne aveano 10 cad:'l,uno.
I reggimenti a ·usseri erano tutti di 10 squadroni ciascuno di circa 130 cavalli ed ordinavansi su due righe soltanto.
, Ninn' altra cavalleria mai s'ebbe le gesta della cavalleria prussiana di quei tempi.. L'arma sua era la sciabola; l a sua couf:ìdenz,i stava . n el coragg io e n el1a destrezza individuale de' caYalieri . La sua tatt,ica consisteva nella rapidità, e nella risolutezza . A'questo metodo ardimentoso venne attr ibuita l'insi gnifica~" ord inari a delle sue perdite in morti e feriti , . (1).
Federico, in campagna, forma.va la sua cavalleria in corpi di venti, tr enta o quaranta sc1uadroni ; sul campo di battag lia, egli la teneva coperta ed immobile, finché giungesse il buon mom ento di adoperarla; egli non l e dava ordini precisi, .ma contentavas i di indicarle le di• rezioni ge nerali, ed il suo obbi ettivo tattico, l'istante dell'attacco, lasc iando all'apprezzamento de' suoi generali , i quali per quest'arma erano scel ti con tutta special cura . Suonata la carica, gli squadroni si slanciavano sul nemico in ordine di battaglia , come in una manovra, ed a t utt'impeto gli si scatenavano addosso, nè s'a~;estavario fuorché avessero sgombro il campo di battaglia.
Federico non dissimulandosi che vietando il fuoco alla sua cavalleria e riunendola in grosse masse on de preva-
l · del suo maagior e1Tetto , quest'arma troverebbesi più ersi o~ 1 l t
c e ma1 espo , o_ -
h · sta a' danni dell'arLicrlieria e del a mosc 1e ·-
t · crl' si studiò di munirla di un potente aus1hano. ena, e 0 1 b'l
L'artiglieria a cavallo, la quale, compa~ua 1~sep.ara 1 e della cavalleria nelle marcie' no' cam~1 e_d 111 tu~te_ ~e f . ' l comhattimento serve a tener rn rispetto 1 att1- as1 ae , · h glieria e la fanler ia n emica: prepa,ra e domin~ 1: cane ~, v enne id eata da Federico il Grande ' o mosti ò t utto il g enio di questo grancl' uomo di guer~a. .
Ci si porteranno forse ad esem p10 gli eserciti della repubblica francese "I .... .
La Repubblica ebbe in vero, nelle sue prirn~ guerre, gran penuri a di cavalleria ., atteso.cbè la ma.g_g101~ par te de' suoi r eggimenti di quest'arma reclutand o _1 lor~ uffi. 1· f · b·11 · molti· di questi emio-rando. h lasciarono zia I ra· 1 no 1 , o , sfas cia ti. .
·oltr e a ciò i numerosi eserciti, ch'essa clovette_J.mprovvisare onde far fronte agli aUacchi che le ve~1vano da o crni sua fronliera, se poterono ingrossarsi g1gantesca;entc, mercè clell' entus ias mo in tutti ~uscitato _dallo im minente periglio in cui versava la patna, _certo_ il f~erono sol tanto di fante ria, nè già di cavalleria,, ne dar~ tiglieria, imp erci occhè queste armi non s'irnprovv 1sauo ~1 su due piedi, ma vogliono ess_er da l~ng~ mano preparati, con gra n spesa cli tempo e . d1 sollec1tudrne (1).
(.1) i'\ cl mese di ollobrc del 1193 la cavalleria francese componcvas i <li Grossa cavallc1'ia. _

2 Regg ime n t i ca 1·obir'.ic:i • \
1 Id. cornzziers . . 20,4 16 ca valieri.
26 J<l. cavalleria ..
C(wal/eria l e(J[Jera
20 Reggime nti dragoni ...
23 Id. cacciatori . . 76,140 cavalieri.
t I Id. ussari . ...
}22 STUDt
(I} NoLA~, Storia e tattica della cavalleria (test.o io glcsc).
123
Nè deve perciò meravigliare, se negli eserciti della repubblica la . cavalleria fu auèhe men di _!__ - Nè da tale
· 20 · , ·deficienza si prenda argomen to per sOstenere l a poca èfficacia di quest; arma, pretessendo che i repul-Jl)licani avessero tutt avia gli eserc iti meglio costi tuttf d'Europa , e d1 cavalleria riicbissirni: i ruperocchè quelle vittorie si denno attr ibuirn non tanto alle combina2i0ni strategiche o t atti ch e dei generali fran cesi, quanto allo slancio indomito .· delle masse 1~epq.bb1 ic ane ed al clifetto d'accordo
Nel 1813 la c a valleria fran ccsc aveva
'' He{\g imcnti guardie d'.o n orc ·
2 Id. c ara bini eti
40 Id. ,' corazz ieri :
21! Id. dri,gon i · · · • · · • • quasi 100,000 ' c;iva!icri.
9 , J,L" ca val l eggeri lancieri
28 Id . cacciat6ri ..... . '
l3 Id . us sa r i -
Tot . 93 · . · . - ·
Nel 1815, so tto la ·resta ' u r azi~ne , c_p oca di decadenza, Ja Francia ebbe
2 ·R cgg1rnent1 c.a r a b in i c ri,
fra gli eserciti coalizzat i a d anno d ella francese repubblica . Ed egli fu appunto p er la penuria di cavà1l@ria che quelle vittorie non poterono pressoché mai riuscil· complet e , t u ttoch è t anto san gue alla Francia costassero. Nè tale ve.rità sconoscc,•ano i generali della repubblica, poichè noi l eggiamo come tutti sollecitassero il comitato mi litare per aver quanto pi i::i possibile di cavalleria, e fra loro si disp utassero il possess o di p ochi squadroni : mentr e i l" comitato stesso adoprava ogn i modo e m ezzo p er accrescer e qu est' arma ù1 conveni enti proporzioni, t alment e che, n el 1794, il suo effettivo già riusciva a 96,000 cavalli , ci oè po co m en di dell' intera forza arma.ta .
10
•' ,
6 Id. ,cora·zzier i. · '
· !cl. , dra g oni., .
21, Id. , cacciatori.
6 ' Id ; uss ari.
·•rotale '1 8 ' i
Ogg i , sotto il r cgn ~ florid issimo di Ka p o.lconc IH, ess a ha '/
2 Reggi•rocnt i ca rabin ie ri.
12 1d . coraz.z icr i.
13 ! d. dri,goni . ,.,
9 Id. l an uicri.
'13
c acc i,1tori. u ss ari . ca ccia tori d'Africa sp a his. guide.
Qua.ud.o , v enuto a oapo d ella Franci a il più em inente capitano, il più gran genio de' tempi m oderni, essa potè passar ' d ecis ivamente d alla difes a all ' offesa, noi vediamo costantemente accrescersi la su a cava.llerja n e' suoi vitto)."io~i eserciti, e salir p erfino a 145,000 cavalie1:i . E tutti sanno a qual gra,do si al zasse quella cavalleria condotta dai Murat, d a i Kell ermann, d ai Bess'ières e d a altri famosi g ~neral i na,poleoni ci . ,
JP enetrato dall'i mportanza di qu est' arma, Napoleo n e l e fo sempre larg o d elle sue solledt ud in i .. ... Epp ure, chi pit1 d i lui avrebbe doyuto d ubitare o creder e all'inutilità d ella cavalleria,, egli ch e con men di 3000 cavalieri poté co mpiere la prodigiosa campagna del 1796, vincere quat~ tor clici b attaglie, settanta co mbatt.imenii pa.rziali , impadronir si cli 50o' cannoni e di 90,ooo·prigionieri ?
Eppure (l)« sulla rupe d i Sant'Elena , allorquando l'imperator e meditava fredd tun éntc sui vent'anni di gqerra che S<jlguirono la campagpa d el 1796, egli non variò d'opinion e i ntorno all'i ndisp ensabile utilità delle truppe I! ca-

Jd. Id. Id. - Id . . Id. ""' SO L I.A CAVALLERIA 125
(1) De la ;;a1m lc1·ic, p a r le gc:néral Rcnard, 2c éù ition, p,1g . 22 . ..
124 STOD1
' y· ·
9 3 3
vallo. « La fa n teria cl i uno Stato, eg1i dis::;e, essendo rap-
• presentata con uno, la cavalleria sarà J__ .. .. ma basta
». però che la cavalleria s ia -.;_ della fanteria dello Stato, t) a cagione dc' paesi montuosi » .
Altrove egli SOJgiunge : • un esercito composto cli 36,000 fanti avrà 9000 çavalieri, dei quali 4800 d i cavalleria leggera e 4200 cli cavalleria grave » . Ci onuJ laclirn eno l'i mperatore nelle sue Memori e fa un'eccezione speciale per l'Italia, d ella qual e nel secondo volume trovasi la stupenda descrizione. Egli prevede i destini che or si compiono sotto gli occhi nostri, egli calcola qual sarebbe, n el caso della r iunione di t u t te l e provinci e italia n e in un solo grande impero, la forza armata ch'csso potrebbe mant ener e, quindi egli così s i esprime : « L'Italia, per l a sua popolazione e per Io sue ricchez~1c, può mantenere 400,000 uomini di tutte armi, in dipend±temente d alla ma?'ina . La gtte?'ra nell'Italia 1~i chiede me o cavaUetia che nell'Allemagna : 30,000 cavalieri bastcr b-
bero » Cioè men o di, 1~ della forza to_talc, m eutre egli ne richiede per la Francia e per gli Stati settentrionali .. ... ». /
Ora cit e r emo noi l e ultim e nostre gu erre co m battute ... / Quella di Crimea e quella d'Italia nel 1859, delle quali per lo appunto si prevalgono più specialmente i detratto ri della cavaller ia per p r ed i carle rovina? /

Queste due guerre non sono da indicarsi uè a favore nè a sfavore della cavalleria.
In Crimea, non fu già percbè si riputasse inutile il concorso della ca valleria, ma furono bensì le innum ere-
v oli difficolUt di sì. l ontauo trasporto che limitarono il continO'cnte di quest'arma ne' va.rii eserciti di spedizione .
E cotale difetto ebbero pur troppo da risentire gli alleati, in par ecch ie circostanze, e specialmente nella gjorna'..a dell 'Alma, ove, se avessero avuto sufficienti squadro~1, avrebbero potuto d 'un sol colpo d istrug?ere_ l'es ercito russo com'ebbe a scriverlo il maresciallo d1 Samt-Arnaud all'il;peratore Napo~eonc III: - • Sire, s'io ~vessi a ·v~to d ell a cnivalleria, io avre i ottenuti immensi successi e Mensch.ikoff non avrebbe più esercito , . - E per certo, Sebastopoli piLL non sarebbe stato quell'oc:;so durissimo che fu.
Nella campagna del 1859 in Italia, le circostanze eccezionali di tempo e di l uogo in cui suc cessero tutti gl i scontri degli eserciti nem i ci, no n die_der ? largo campo all'azione della cavalleria : e sol peT ciò s1 può forse conc.J:µu d ero che d"ora inn anz.i l a cavalleria è ~uperflua e~ inefficace? Perchè nell'ultima guerra non s1 ebbero di battaglie ~tratP. g icamentc preconcette e tatticamente ordinate (1) si dove forse perciò argoment arne che d'ora
( J) A propos ito dc lJ'i mp icgo de lla cavalleria udi11mo n e ll a :ampngnn. del 1859 il ncneralc Renard: « l nd ipeadenlcmente del t erreno il ~ualc 1hfficilrocntc" prcstavasi all'impiego della ca\'alleria, qucsl'arml vide ancora di ininuire l :1 sua az ione per le seguen ti c irco sta nze : .
"La cavalleria anslriaca, appena forte d i 8 reggimenti, era fra~ 1ona t a · d e divisioni sollo nl i ordin i del generale MensdorfT e Sedw1lz. La ~~Ìln: era st ata po sta :0 centro fra Ca \'J'i ana e Guidizr.olo ( la seconda era stab il ila all ' es lrcina si1, blra, a due le ghe circ a d alla p r im a , cd era d eslin,ila ad operare coolro rcslremn rles tni dei Francesi. Questa se~oud a divisi one al pr i ncipio della giorna lu fu l'CSpinla vcrgognosomentc SJ110 3
G oito e n on prese po r le all'azio ne. I cup i :o lpcvo li fo1·?no s_cvc ran ,.~nl.e p uniti, rimossi <la' l oro gradi o condannai , ali,, rcclu~1one 111 forl,zze. McnsdorlT solo rim ase per soslencrc l'onore della sua a rm a. 11 · • 1cros a m en i io comondu la e " La cavai Ieria fronccse , se J Jcnc P1 u nu n ' , . " . l conccnlratu in una so la mnssu, fu tutluvia, sulle pri me, co nd an~~l.a a, assoluta possi"ilà e priva di qucJl'indipendenzo che sola p~1·mclle I
p ie r e grandi cos e Come g ià lo dissi, la ba tt aglia di Solfcnno fu una a -
12G STUDI
4
SULLA CAVALLERIA 127
c:~
-
ipnanzi tutte )e battaglie avverranno fortuitamente, d'incòntro ..... ?
Che se vogliam poi disce11dée a fatti parziali, anche in queste ultime guerre troveremo nmnerosi es~n;_p~, in cui. l'impiego della cavalleria fu utilissirno, éfficacjssìm o .
Da qu es ti rapidi- cenni storici sulla i cayalleria, ognuno può giudicare, se i progressi dell'arte moderna della g u erra fecero mai _ scapitare, i l v aio re , tattico ' della cn:vallei-ia; se è vero che quest'arma non abbia avuto mai .cli · seriaimportaii.za, se ri.on se ne' periodi di -dècadenza militare; se è vero che nelle epochè di spÌendore per gli esèrciti, ,sia ne'. tempi antichi che ne' moderni , essa sia sempre stata, se non affatto impo tente, molto al dissotto però di quel grado d'importanza e di utilità, di cui fa si vanta.
- E foro'1;10 forse · tempi cli decadenza militare quelli di Alessandro , d'Annipale, de' Scipioni e -de' Cesari? Oppure il furono quelli di Gustavo Adolfo, di Carlo XII, di · Turenna,, di Mon te cuccoli, di Condé, di Eù'genio di Sa'v-e.i ~
taglia forluita . Ciascuno dei corpi del l'ese rcito franco-sardo dovette combattere laddove in cont rò l'oste nemica . La coonlionziooc delle Jci·o mosse d i venne dal bel principio estremamente diffkile Fi'a i col'pi di ìlfac-Mnhon e di Niel si produsse tlll vuoto enorme, nell a parte 'più aperta ·cd access-ibiI'e §cl tcncno, ' pcl quale il nemico, prcc1!duto da J\lcnsdor[, poteva sbo ccare e tagliare in due -l'e~crcito dcll'i 1pperaLore. Questo vu .oto bisognava colma!'lò a qualunque costo In <li fe tt.o di fanteria dispon ibile, ·. , •i si adoprò l a cavalleria. Ilitiu i ta in tre- <livisioni sotto gli ordini di Morris , Desv:1nx e Pm'Looncaux, essa ycnnc a slab i l irsi in prima linea, fra il 2° ed i l ~ 0 co rpo, ba1:rauJo quest'apertura, che potcvs d i venir così funesta . I l'apporti de' mwescia'lli provano che in tal posiz i one essa non ~i rimase i n opero sa Con car i che ben intese essa spallrgg iò l e a li d~d1Jc corpi di fanleriu co s tantemente minacciate e mandò a vdoto gli attacchi che parécchic volle tentò lllensd"Orff, in prcscuza di un numero di squadroni tre volte m_aggiore dc' sno i. Da ambe le par~i imp er io se circostan~e h anno imped ito alla cavalleria di fai· sp.lcndide p t·ov c e di dar ·campo dc' suoi mezzi ps1,rticolari d ' azione. I cannoni cd i fuci l i riga~i v'entrar ano per nulla" ·

di Federico di Napoleone? Quale di tutti questi somnù capitan i non fece il più gran caso della cavalleria? Quale non n e ritrasse i più splend idi risultati , sapendola bene impiegare?
Non negheremo; che la tattica di quest'arma non abbia fatto , specialmente in questi uUimi tempi, tutti qu€\i progress i , d i cui però ess a, er a ed è tutta;yia suscetti bile , anche al cospetto delle fragorose novazioni della pirobalistica .
Di ciò vuolsi essenz ialmente accag ionare :.
1° La lunga pace dopo le ultime campagne napol eoniche, la guerra essendo la miglior scuolà. ove formasi la cavalleria;
2° Quel malinteso e pernicioso sp irito d' economia dei governi , di proibire assolutamente ogni strapazzo a' cav alli in tempo cli pace, r es tringendo gli eserciz i a poche ore di man egg i e di piazza d'armi, da cui provenne il catti vo sistema tenuto p er l'istruzione del cavallo e d el cava.liere;
3° Lo stolto ed invet erato pregiudizio che tutta la scienza dclhrffiziale d i cavalleria si riduca all 'equitaz i one e alla scher ma cli sciab9la (sciaguratissimo pregiudizio che nell'esercito nos tro si va da qualche anno sol tanto, à mala pena, estirpando!! ); ·
~s uffic iente sollec~tudine n ell'allevamento ec1uino indigeno, per cui, dovendosi in n1assima ricorrere a prodott i stranieri, per lo più se ne ries,ce senit i male e scaTSamente, malgrado ingente spesa d'acquisto.
'128 STU DI
. SULL A CAVALLERIA 129
(
ANNI>
9
VI. Voi. I.
.
CAVALf,ERTA )
Come ben megl~o farebb~ro col oro che s'affarù;ianÒ a · spa;rlare della.,. cavalleria, a predirne la ptossima scomparsa clagli eserciti; come ben meglio farebbero, e qaanto · sarebb~ più logico e savio di chiedere invece che la sì migliorasse, che la si P.ortasse all'altezza degli attu ali lJisogni e della moderna tattica, e di ad,çìitar le vie e i mezzi per tali migliorie e per feziona menti. Di queste migliorie e perfezionaménti ci occup·eremo il ~l seguente a:rtièolo, oasanclo i nòstri ragionamenti e le 'nostre proposte sui precetti fondamentali d@lla tattica par ticolare e genel'ale.
G. G. C.
PHHU ,G·ÙERR! »ELL'iNDJPENDENZA ITALIANA.
ASSEDIO E DIFESA DI- ·PE-SCDIERA
DALT,E 'l'RUl'PE SARDE NEL 1848. .
GIORNALE DELL'ASSEDIO
DEl,U l'IAZZA DI l'ESCIIIE!l,\·
Fatto dalle Armi Sanle n,clla prima guerra dell'lndi1iendenza Italiana
- e ddla difesa successiva nel 18 48.
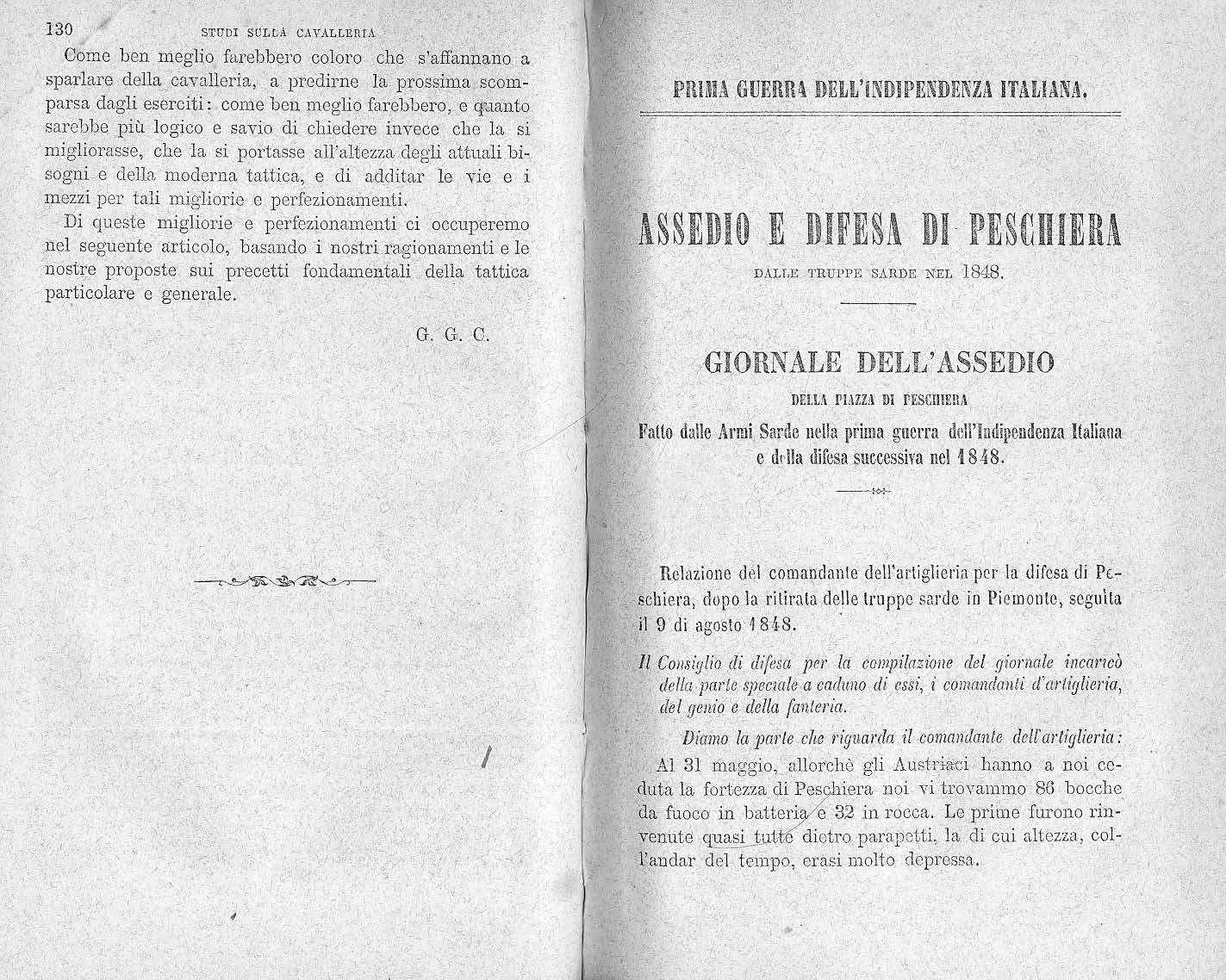
Rehlzione dt~l comandante dell-'art iglier ia per la difesa di Peschiera, dopo la ritiral~ delle trùppc sa rde i n Pi e monte, scgulta il 9 ' di agosto -184-8 . ·
Il .Consiglio di. difesa . per la co11ipilazio11e de l giornale incaricò della parte specwle .a cachmo di essi, i comandanti d'artiglieria, . .Ìèl genio è della fanteria . '
Diamo la pa'l'le che riguatda i:! coma11clante clell'artiglierfo : Al 31 rnaggio, allorché gli Aust~ i hanno a noi é.ccluta la fo~tezza _çli ~e~iera no i vi trova1:~mo 86 boc~he da- fuoco m b atte~e , 3.2 m rocca . Le prime fu.rono rmvenute ~e dietro parapetti, la di cui altezza, coll'andar de1 t empo, erasi molto depressa..
130 STUDI
SOLt,A
. . .
\ ' l ., /
,.
•
ASSEDlO E- DIFESA , Nei mesi -di giugno' e ,di lugl'io s' intraprcsero -da noi e si spinsero con f.\Jacrità i l avori in tena:, che reputavarisi ne~e.:,sarj i; ma p oche forze ci si la.sciarono, tut toot.:é, .a molte riprese , a vo9e e _ per i scritto ci fos~c rappres entata ,la convenienza di porre la fortezza in istat o di difes~ , ·.e tuttoché s i f osse domauclato un battaglione cli fant eri a, a · non altro destinato se nonchè ad aiutare i zappatori nei 111ovi ment1 di t erra .
· Int~nto il 20 luglio .i l avori trovavansi g ià a,l punto che s1 potèrono colloc are i n batteria, 76 bocche da fooco di quelle spettai1ti alla fortezza. · ·
Al ?3 lugli o all'arrivo di nostre truppe che erànsi frettolosamente , ritirate da Rivoli , più non si si)edir;no a Goito lo 1,2 l)occ~e da fuoco del parco d'assedio , che se• condo l' ord ine ricevuto, doveano, con tutti i loro access~rii e ~1.qnizioni , partire d4, Peschiera, ali' una pomeridiana di quello stesso giorno_, ond'esserc EcJi mandate sotto Mantqva . · ·
Alli 24 luglio, dopo la rotta di M:onzamb a.no e di . Sa.lionzo l e comunicazioni tra l'armata e Pesch i era furono addirit t ura intercettate ed i l 1blocco ebbe phncipi.o.
Il nemico accerchiava ogni eh maggiormente la fortezza, e stendendosi a d estra ' ed. a sinistra per arrivare ·. alle sponde del l ago, e ben presto, giungendo alla str2.cht d i Ponti, y ònne all'osteria d el Papa ed anelò a stabilire a lJordo tlel lago, pr~sso il molino, e dietro ad uno scar, p a mento, d Lw c~n no111 da 16 per. impcdi1~e il passo allo n avi, e sop r atutto ai due vapori, Nel tem po s t esso oc ~ . Cllpò varie posizion i ,, specialmente promontorii dietro ai quali _egli raccoglievti:si i ntanto che co ronava, le cii-1},! di ' quelli con u n semplice parapetto a zappa;volante , · ed in ques to modo .il:npiantava le batteri e :
1° Della 1-Yfolirwllà con 2 cannoni d à 16, a , 900 metri dalla piazza, per toglierci le comu nicazioni p e~ la via del lago.
2° Della Zcvnetta . c:on
2 canno ni da 32,, _
2 - id. d~ 16,
2 obici da poli. 6,
a 900 metri da Salvi, a 1200 dalla piazza, per battere i due Salvi ed il bastione N . 5, riliscendo tutti i tiri utili, giacché manc ato lo scopo di Sal:vi, tutti i col pi. giunge. vino nella fort ezza.
.3° Della ilfadonn ci del Prassine con 2 cannoni da 32,
2- id. -da 16, 2 obici da poli: 6 , a' 1200 metr1 cl.ai 2 Salvi, ,per battere quèsti due for.tì; per infilare l a .cortina N , 2, nonchè il cavaliere N . 5 il cavaliere od il bastio11e N. 3 e qùind i battere di r~v~scio il l~astione N . 1.

4° IJellci B1~d oai-a con 2 mortai da pol i. 12; 2 -id. id . .8, a \:lOO metri claì d ue Salvi, per bat tere qu es Li due forti, il cavaliere R 5, il cavaliere N , 3 e tormentare l a -piazza. con tiri curvilinei, .
5° mz Mànda-n~ ilfontepia-ni ed ~diacenze, con 4 cannoni d a 32, 8 ic1. id, · 2•1, 16 obici da pol i. 6, 2 mortai aa·pol• . · 12, 2 id. id . 8, ad 800 11-iet ,· da Mandella, per fulm inare i ,due forti -di tàt n0.m c , er battere di pien colpo le artiglierie d el bastion31/ r . 2, del cavaliere e bastione N . 3 e per bornbaraafc l a città~ _- .
6° Del F/nelazzo sulla _ r iva del lago, c_on:
2 · cannoni da 18, ·
a 1000 m ~tri daUa piazza •por incrocicchiare i suoi fuocEi
]32
., .. DI ._PESCH!EIU
133
con quelli della batteria della Molinella, e così impedire i n modo assoluto l'entrata e l'nscità delle navi nel porto.
7° Di dLte batteri.e di razzi a cinr1ue cav aletti cadauno a 1000 metri dalla piazza, sulla sirada di Paceno-o, per inquietare in ogni senso la piazza e Mandella. 0
Appena il nemico cominciava le sne prime scorreri e, volevasi n atur almente da noi instituire una successività di riconoscenze e di attacchi parziali , nello scopo d'impedire, o quanto me no ritardare, il suo stabilimento. Ma la guarni gione dì Peschiera era troppo debol e per mo ltiplicare, come si convenivano, le sortite . Difatti essa toccava appena i 3,000 uomini, di cui 600 reclute lombar~e, non atte ancora al serviz io della guerra, quan do a nche alcuna fesse utilizzata in ciò che si poteva.
Dai 2,400 rimanenti, bisognava escludere:
1° 480 artiglieri,
2~ 480 . zappatori nostri, modenesi e parmensi, po i chè que~ti _tutti avevano ben altro da fare, ognuno per la specialità delle proprie incumbenze.
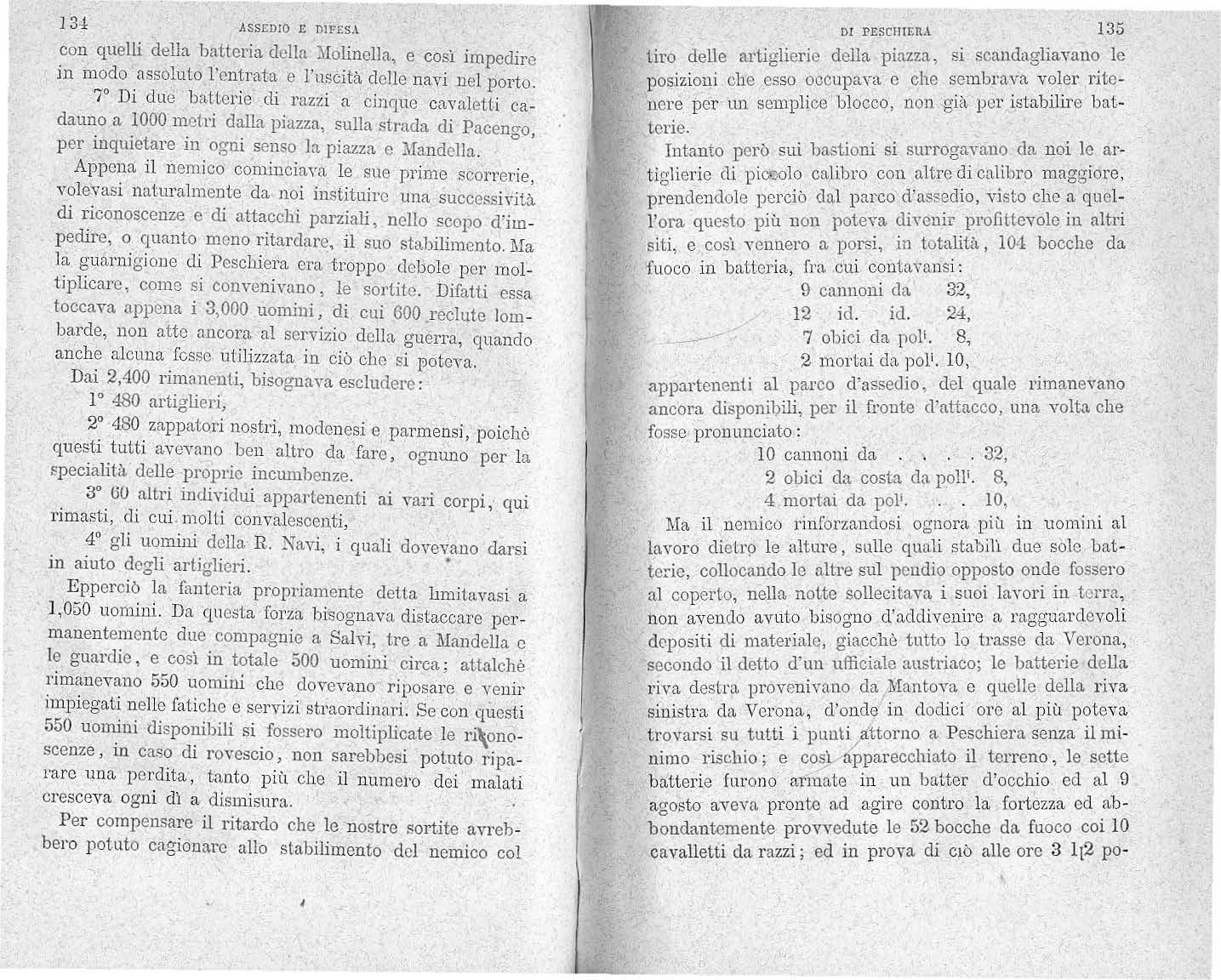
. 3°. t:iO _altr~ indi,'.idui appartenenti ai vari corpi, qui r1mast1, d1 cu1 moli1 conval escenti,
4° gli uomini della R. Navi, i quali dovevano darsi in aiuto degli artiglieri . •
Epp erci ò la fanteria propriamente detta hmitavasi a
1, 050 uomini. Da qu esta forza bisognava d istaccare permanentemente due compagnie a Salvi, tre a Mandella e le guardie , e così in totale 500 uomini circa; attalchè rimanevano 550 uomini che dovevano riposare e venir impiegati nelle fati che e servizi straord inari . Se con qÙesti 550 uo~iui disponibili si foss ero moltiplicate l e ri\onoscenze, m caso di roYescio, non sarebbesi potuto ripa -
1·are una perdita, tanto pi t'.1 che il num ero d ei mal at i cresceva ogni dì a dismisura.
Per compensare il ritardo che le nostre sortite avrebbero potuto cagionare allo stabilimento del nemico col
tiro delle artiglierie della piazza, si scandagliavano le posizioni che esso occupava e che sembrava v oler ritenere per un semplice blocco, non già per i stabilir e batterie.
Intanto però stù bastioni si surrogayauo da noi le art iglieri e di piccolo calibro con altre di calibro maggiore , prendendole perciò dal parco d'assed i o , visto che a quell'ora questo più non poteva di-venir profìitevole in altri s iti, e cos·1 Yennero a porsi, in totalità, 104 bocche da fuoco in batteria, fra cui contavan si :
9 cannoni da 32,
12 id. id . 24, ·
7 obici da poli . 8,
2 mortai da poli. 10, appartenenti al parco d'assedio, del quale rimanevano ancora disponibili, per il fronte d "attacco, una volta che fosse pronunciato :
10 cannoni da , . 32,
2 obici da costa da p olli. 8,
4 mortai da pol1• 10,
Ma il nemico rinforzandosi ognora piì1 in uomin i al lavoro di etrp le alture, sulle quali stabilì. due sole battc:ie, collocando le altre sul pendio opposto onde fossero al coperto, nella notte sollecitava i suoi lavori in t e rra, n on av endo avuto bisogn o d' addivenire a ragguardev oli depositi cli materiale, giacchè tutto lo trasse da. Verona, secondo il detto d'un ufficiale austriaco; le batterie della riva d estra p r ovenivano daÌ.fanto~a . e quelle ~-ella riva sinistra da Verona , d'onde m dod1c1 ore al prn poteva trovarsi su tutti i punti attorno a P eschiera senza il minimo rischio; e così fyparecchiato il terreno, le sette batterie furono armate in un batter d'occhio ed al 9 a.crosto aveva pronte ad agire contro l a fortezza ed abb~ndautcmente provvedute le 52 bocche da fu oco coi 10 cavalletti da r azzi; ed in prova di ciò alle ore 3 1[2 po -
134 ASSEDIO E DlF.ESA
DI PESCI-IIER,I. 135
meridiane - delio stesso gio rno, u n parl amentario portò una l ettera d el ten1;,nte m a sci allo barone Haynau., il q u ale a nnunz iando l a r itirata . delle t rnppe sarcl,e al di là çlel
Ticino, do.man dava la piazza ccl i l pnsiclìo, ing iu ngendo d i vol e r rispos ta fra due ore . .
Non trovandosi egli soddisfatto · della : risposta che ricevè alle ore 6 -suonate, cio è , 24 m im1ti d o,p o partito il ·parl'amentario, i l fuoco v enne aperto da tL1tte l e batterie nemiche sìmÙltiù1eameiite.
Qua11d'auche non s i s urw ouesse eh.e il nemico avrebbe immediatamente fa,tto fuoco , tuttavia gli u fficiali d'arti -' glieria piuttosto per ult im are _gli apparecchiarr:ient i , che per r ispondere ai tiri d ell'assediante , erano stati mandati ai posti cui erano destinati, n ell'ordine seguente:
Afandella Capitano conte RlOALDONE
Tenente sig. ORA.vosro '
• id . sig . DuPI,AN
-Salv· i Capitano si g . cç1,v . MAR1ÙlOTTO
T e nente s ig . MARRO id. sig . PEHOTTI
B astione N . 1 e ·Z - Capitanò cav . F'ILrPPI
Sottotenente sig. QARRONE
Bast i one N. 2 e 3 - Oapitan6 cav . ÙELEsuLuogotenente sig. O~èms
· Baistionc N . 4 e 5 - Oap1tano cav . SEYSSEL
~ottotenente sig. SuATON. , Pe1·sonale . - Maggìore cav . MORELLI .Paolo
1ifotantc maggiore, T enentè -cav. !30TTIGLIA
Arsenale, Maggiore sig. cav . GAJ.],DET (il qual e era mal a'to n ei giorni d ell'a,zione) . . I
Art·iffai, Sottotenente ·sig . BEGCHis
Jffaest rrmza, So tto t e nente sig. B :i.R'l'O~E
lfovimcnti dell'arsènale, Sottotenente sig . IAcornrr:r'.
A notte il fuoco diminuì, quindi cessò per qualche tempo , durando però a intervalli . Al matt ino del 10 ,alle
' 5, 112 ·i1 fuoco venne ricomj~eiato cop. molta gagli ardi a; diminuì ve:rso l e 9; continuò però sempre; quando ad .un 'ora e m ~zza dopo m ezzo dì una bomba da 12 pollici ca dde presso porta· VeTOna ; ml laboratorio, in cui v'ave .vano cariche i pronte ~cl- essere ~ str~Mite 206 bombe òa pollici 10, 40 da polhc:i. .12 e prn ~1 1,20? ~ranat~ da m ano: s entiss i allora una vwlenta·scoss a , poi 1 esplosio ne succe~siva dei p-r:oietti caricbi., che, a prima giunta s~Jnnlava un vivissimo fuoco d i fila. La Jnassa enorm e cli fumo ohe se ne elev ava indicò , b en presto c4e cosa fosse ac• caduto . Poi una detonazione p iù viva; cagionata clall' infian.1.mazione cli sci· casse di p.0lvere esi~tenti ~el laboratorio medesimo, d~i:tl:6 una .?recc1a n ell_angol~ al fianco d el" muro pfoJcipale della cmta presso 11 bast10nc N. 2. e t utto il fabbricato del labora torio, in cu i perirono
·- t r e ;rtificieri'. e d'ondè p erò quattro i ndivi du i ch'erano sul limita-re della p orta -sonosi _salvati, andò in a1:ia. · Allora lo svi luppo continuato del fumo pe:r lo scopp1ç> success ivo d ei proietti, per l' infiammazi one dell_e travi del soffitto . e della grande qu,an! ità cli miccia ch e 1v1 er~ rac- · colta, attrMse ben presto il fuoco cli tutte le batterie nemiche, le quali faéevano convergere i loro tiri verso quella parte, t a,nt o 1)erchè n ella prossimità della roc~a ~'aveva un altro laqoratorio, cli cui il n eniicò conosceva l'esistenza, qi.rnnto p-er frnpecltre che si spegness e l'incendio.' q ua:1oi;-~ da noi si fos'se .sperato di salvare una parte d e,1 pro1ett1 c a r i chi i vi raccolti'.
Da tutta q u esta con'<te rge nza d i tiri diveniva periGolosissima l 'esistenza di 1,200 gr:inate da pollic i 8.-cariche,

· eh~ s i teneva..no appareccbia~e - nell'-~ltro l~;J1:~torio accanto alla rocca, ed allora . s i prese 11 pa1t17,..,.,cL1 doman~
: dare l e r ecl~1t; Joml~arde ; se ne fecè U:/4'. cat:~a nel\a corte della rocca , e s1 tras port?,rono 1~ ,200 .~I <~na~e . 1 ~ u n sotterraneo d e1l?, rocca stessa, ;,1bn pote ndos i clrstnl)uire a ciascun forte o fro ~Le i proiett i carichi ; essendo
13 G ASSEDIO
E DIFESA
nt PE~CIIIERA 13'7
' .
ASSEDIO E DIFESA
che si mancav a totalmente <li magazzini e di ripostigli . Ma dopo quattro ore di fuoco vivissilllO, le batteri e nemi che ralleutaron o tutto ad un tratto la loro azione (poiché al generale Li clmovitz, comandaute l 'assedio, e ra perYenuta la lettera ufficjaJe della convenzione di :tifilano, a sens o della qu ale Peschiera doveva essere resa aali Auo stnac1) . .
Mal grado quel diluvio d i proieUi, per lo più cavi, l'artiglieria della piazza ri postò q u anto più poteva, e t utte le bocche da fuoco che avevano vista sulle batterie nem~che, n on vennero meno a motivo della 'massima energia sp iegata dagli ufficiali e dai cannonieri , e difatti ai 2,400 colp i fatti dal nemico , se n e i·ipostarono d,Li nostri non meno di l&-17, come r isulta dalla ta.bclla seguente, avendosi da noi a lamentare un numero minore di vittime di ci ò ch e ne abbia avute i l nem ico, avendo noi perdut~ soltanto un cannoniere a SalYi , ed un sergente ed un sol dato d i fanteria nell a piazza.
J 1~D ! C:A ZlO~E
ed alla spedizione dei proietti e delle mun~zioni fur on~ molt o solleciti nei l oro incarichi , e così cornsposero tutti degnissimamente alla loro missione. . . .
I sotto -nili.ciali , q u an cl'anche l a massnna parte d1 _iecentissima promozione, s'adoperarono quasi tutti con impegno. . . . :
) !andc\13 Dal 21 al 31 luglio
ll~Sli1111c !i0 1°
E qL1i il sottoscritto adempie ad un dovere particolare col dichiarare che g li uffici ali alle batterie furono z elan ti ed imperturbati; ch e quelli d estinati all'apparecchiam ento
I, cannonieri , tuttochè sta11ch1 per 1 molti lavon che si doYettero sollecitare negli ultimi periodi d el blocco, rimasero in b atter ia e fecero p i ù d i ciò che p ole'rnsenc aspettare, non essendo essi artiglieri, ma ves~ndo ne lamente l e d ivise , per chè recentemente tratti dai vam reggimenti . n fuoco delle batterie nemiche avendo cessato verso notte, prima che giu ngesse i~ parlamen~ari o , si. stabilì una catena d" uomini di fanteria, fra cm molte reclu~e lombarde, onde gettar acqua sui materiali del l al)~r atono i quali , dando origine ad una grande . quantità d1 fuoco'. a"Vrebbero ne11a notte lasciato, pel chiarore , un punto di_ mira al nemi co , stant echè la breccia fatta nel muro ~ 1 cinta mostni.vasi tutta. alla parLe sinistra della battena del Mondano , dal ci gli o d el parn1petto, fin o al livel ~o d ell'acqua del Mincio ; cli tanto in tanto però sc..,opp1avan? proietti a m i sura che il fuoco si estendeva fra l e trav 1 , e l a miccia, sepolta sotto alle rovine ; alla superficie di queste appariYa una bomba di 12 poll i ci , ~a q \1ale , scoppiando, poteva esse re cagione cli gravi mah agh uomini che erano più prossimi. a gettar acqua . Il magg10re cav. Mor elli, incaricato di diri gere l' operazion e , sente nd o eh.e il n omin ato Raimondo, artista di maestranza. , si afferiva di andar a togliere l a bomba, acconsentì ~he esso disc end ess e fra l e r ov i ne , per far1a rotolare fu on del pe-/ ricolo delle fiamme o portarla da solo; un altro artist~ di maestranza, Rimassa, esib ì volonta.riam.ente d-'-an-cTar gh in ai uto . F ra tutti due p or tarono via la bomba, calda ancor a del fuoco cha ebbe vicino, senza che n e avesse infia mm ata l a spoletta .

138
I
d~I 1" 0 1\TE O 11.I STJO~IC
Ual '.!S al SI Jd ]Il. 5 O li. Io tl½OStO lrl . 5 e ,1 2 e ;; i d. ld. 1• 2 e 3 id. Jd . 5 e 4 O id . Jd. G e /4 7 id !(I. 2 e:; 7 i• I. hl. 5 e I, 8 id. I d 1° 03 l flal 10agosto Sa!\·, Jr!. )1,rnrlclla . . Id. 8.1$.lionc 5 t lt I d . hl. 2 e 3 lii D \ 1'A CAN~ON! ml J\10117'~1 is: I ;---lè')l=--!~1~1 "' I- :1 1 .g _g 1~ _g - e"" - I 1--1 )I 2 il ,. 8 " " 5.'i 1 " 11 51 1 '' 1• I 1 n r, n )1 I J2 )\ 1-1 " il /a I' • lì ) i l\ 1 n 18 18 : )l )1 >I M l'I » 8 19 t o " : : : : : =I : : 1~ j 1§ 11 I• Il i 5 )I ')') 1 21 i,. Ml IO l'I I• H 6 '° lit iii ; I 5 " " " .,. -i · /4 l 15 " 2:ill 30 "" » jt.O G 320 1 I soo 82 Il ;)1 9 1 ~') ,1 '>U 5.39 '20 :: : r6 : I 12 ;o :t~ I 5 11.i )) • Il /40 •• I' . _ u02 , ~21i \3,11Js7l sj "i 226 j12-2 j ~ 1 Ios j 1847 1
DI rESClllE!U. 139
•
R~imon~o e R imassa sembrano dov ere ess ere presi iu cons1deraz10ne g iacchè 1 d . . . ' . , se ma e a essi non avven ne, non e già che essi fossero certi che l a bomba non sar ebbe scopp iata' m a so l o perch è la spol etta trovossi non buona.
L'~n~enzit:ne di allontanare il p ericolo di d anno agli . uom1ru destm~ti a spe~ner~ l'incendio, non potendo adunq ue e~cre post~ m clubb10, s1 spera che si vorrà ten ere conto ai due succitati individLt i.
Allo stesso giorno 10., a sera, giunse un parlamentario che po1~tava una l ctter-a del genera le Lichnovitz' il qu al e a~unz1ava essersi fatta una convenzione il giorno 9 in Milano, e t rasm etteva un dispaccio del conte Salasco riguardante la r esa della piazza. ma aià e1·a . 1· . st h ' o < · < s1g l nspo. O c e no~ bastava una lettera, e che per cedere l a piazza doveas1 l e_ggere il titolo autentico che si anmmziava . quando un ora dopo · , ' . 1 , sopraggmnse un a 1tro parl amentario I quale recava u n a lettera del t enente maresciallo barone H ·1 e a!nau, i quale mandaYa una copia oriO'inale della convc d" 11.1·1 o < . nz1011e i ~'- i ano, seg na la Salasc o e munita di bollo m conseguenza della quale Peschiera do_veva essere resa ; ~onsegnatc: {'l'a tre giorni; ma nel tempo stesso i l g.enernle Haynau ~omandava d 'avere un abboccamento col governat~r~ d1 ~es~hiera. . Ripartirono allora ì due parlamentan mc an cati di dire verbalment e eh 1 .. sarebbe resa. . . e a piazza
Alli 11 , alle 3 pomeridiane, il ge n eral e Federici ' accomp~gnat~ _d al colonnello Actis, si recò in Carnlcaselle ove s1 stabthrono gl" a 1· 1 . . ' ,. 1 , ccorc 1, seconc o 1 qua11 la cessione d ell a piazza avTebbe avuto luogo . Là il colonnello I_ comandant il d' . . . , con:,e . e . parco assecho' rns1stè p er poter ri man er e rn P eschie ra con una compagnia d'artigli eria on de dar sesto a tutto il mate,· 1 .· ua e nseryato al go,erno sardo m a nulla ottenn e . '
Al 12, alle 7 del mattino, il generale Lichnovitz ,enne
in P eschier a con un uffi ciale d'ogni arma per prendere la consegna; si provvide a tutto, ed il colonnello Actis tornò a r appresentowc i.~ necessità di rimanere con ufcia1i e un distaccamento, p er l' assestamento e per l a partenza del ptlI'Ct' a ·assedio , il gen erale Lichnovit:r, aceonscuti. accl,è tra. ufficiali; sott'ufficiali e soldati d'artiglieria rim anessero yeuti individui .

A1li 13, alle 4 pomerid iane , il generale Lichnovitz portò unalettera d el generale Haynau collaquale dichiarava:
· 1° Ch e gli indicat i. 20 individui d'artiglieria non che i commissari tutti non potessero rirn,.nere in P eschiera, prescrivendo anzi. eh~ ognuno partisse all·indomaui.
2° Che l e 60'0 reclute lombarde dovessero ri,n1ancre iu P eschiera e non già parLire- col reggimento di fanteria sardo.
ArriYato in quel mentre il maggiore cavalier Cava1li, v·enne d al colon nello Actis rna.nd.ato tosto a Verona onde r appresentare al generale Haynau l'indispensal)ihUt cli las c. iaro ìn P es chiera chi avesse cura del parco . Alla mezzan otte arrivò il maggi ore Cavall i, annunziando che - era staio concesso ai soli commissari di rimanere, che però a cag ione dello vi ve rimostranze fatt e, .il generalo Haynau aseva spedito a Milano il capitano Neiperg per vedere se il maresciallo acconsentiva che ufficiali d'artiglieria . qui potessero rimanere.
Al 14, alle 5 del mattino la guarnigione doveva partire da P eschiera,, nè avendosi av11to t empo cli r icevere r isposta del capitano Neipcrg, 1l co1onnello Actis parti esso pure comanda.udo t ut t a la gnarnigi one, stantechè il generale Federic.i ayeya. presa la strada di Brescia per r ecar si direttam ente a Torin o .
Al 14, alle 10 della sera il colonnello Actis riceYè in Valeggio uua staffetta con un piego all'indirizzo del gen erale Faderici, ed aper t olo vi trovò m1 dispacci o <lel generale Haynau, il quale scriveva che alcuni ufficiali cli
140 ASSF.DIO E DIFESA
• - DI PESCHIER.\ 141
artigli~ria avrebbero potuto ritornare ni Peschiera p er invigila re sul parco d'assedio. .
Al 15, a1le 4 del mattino , la guarnigione di PesclÌiera da Valleggio partì per Goito sott.o gli ordini del colònn~llo Delfin, ed il colonnello Aè'tis, col capitano Filippi e due sottonenti, Becchis e Suatou, ritornò a Pesch iera per i vi aspettare- l'arri.vo d i cavalli , o · d'impresa o del gòverno, riservandosi di 'far esegufre i caricarnent.i col mezzo d'uomini che si speravano iottenere cla.l generale austriaco, Pes.chicrà; il ·17 ag9sto 1848.
IL colonnello comandanti/ l' a1·tiglie1ria .
MATERIALE D'ASSEDIO

l,ENUTO Dli PllEMONTE
or;rllE DlECI OB ICI 'bA OT:'O POLLICI, DA COSTA, J QU ALI DOVEV.ANO ;l'lHARE :rALI.E , PIENE DA FABBRICARSI ..l :BRESCIA.
142 ASSEDIO E D IFESA ·•
.. ; ., I \ 'DI , PESCHIE RA 143
DEL
AOTIS .
STATO
OGGETTI ~" SPEDIZIONE 21 l'JlSO ___......___
1 parzia~ ,, lo lale
_ l CAT EGOJIU. .
Bocche dà (uJco
Cannoni 'da 3'1 1 \n fe r ro 9
I 111 brouzo 3
Id dn 21, in ferro
I . ; - 1 ·> • I • 2109 35313
Obi ci da 22 in fer ro
àh1rla i da 27 in bronzo 4 rn26, so nor, 4 1118, 50 1;1;73
I d. eia 22 id. . "
'fOT.-lLE 20
Il CATllGOntA .
Affusti, can"'i ed aUfragl-i
Affust.i per cannoni da 32 cogl i a- vantr eoi I !11_ fc ,·ro 11 · 15
I 111 bronzo 11 . . . I
Affusti rei· cannoni da 32 in brnnzo I all a Gnbcuuva l . . . . . ,,
Id da 2.1, in fo r ro ) (.;ri!J ca u :~1 · I » mod . 18.>3 . I
Id. per obic i ,la 22 cogli avan tr en i. 5
Cc·ppi pct· i m ort.i i \la 27 B. 5
Id. i cl . da 22 Il. "
Carro malli comp il i mod . 1 833 con cassa l
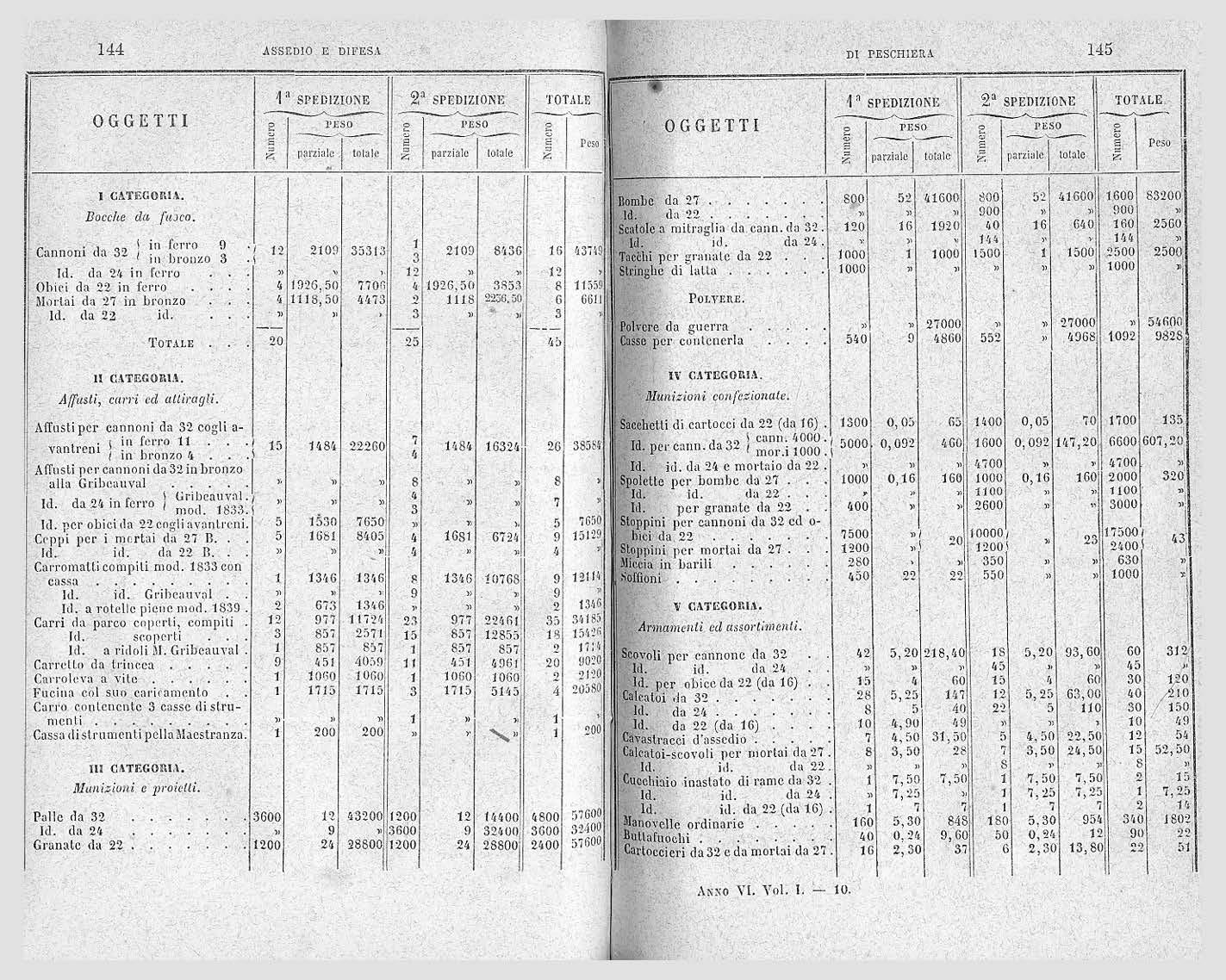
Id. id. Grihc:iuvol "
Id a rotelle piq11c mo rl. 1 839 2
Carri d a parco copert i, comp it i 1.2
Id. scopcrt i 3
I d. a ri do l i M. Gl'ibcauval I
Can e! Lo da Lr i ncca 9 ·
Carro l cv:1 a vile l
F ucino co l suo car i ramcnl.o 1
C,11 ·ro conl.cncnJc 3 casse di s trumen ti '))
Cassa di s lrnmenli peli a Maestranza. 1
lii Ci\TllGOIIU . . JJ,-Jwii;ioni e woiclli.
p er ca nnon i da 32 cd obi ci da 22 ·
per morta i da 27 l
barili
Scovoli p er cannone da 32 42
id . d a 211 . , »
per o'bicc da 22 (da 16) . 15
Calcatoi ,fa 32 . . . . . . 28 Id. da 21, . . S Id. da 22 (da 16) 1 0
Cavastracci d"asscdio . . . 7
Calcatoi-s covoli per n , orla i da '27 . 8
i d . du 22. ,, Ct<cchfaio inastato di rame d~ 32 . I
. id . da 24 " Id. i.!. da 22 (da 16) . 1
144 ASSEDIO E DIPESA
( I 11,84 22.260 I )) " 1530 l6Sl n 13~ 6 673 977 85i 857 451 l () <jO 17) 5 ,, 200 l) l) 7650 M05 1346 1 1; 21, 2571 85 i 405f) 106() 1715 )) 200 e l 1 li:SO '-' __________,____ ~I . parziale j 101ale 1 3 2109 12 ,, 4 1926,50 .2 111 8 3 l) 25 )) 385ll '>-?36 r,o -. ,.I 7 1, s 4 3 )) "'i 1©2:j 168 1 61,t, » • s 9 2~ 1 5 1 JI 1 3 1 "977 857 857 l1 :J'I 1060 17 15 ,, ,. )) 221,r,1 12855 857 496i 10601 5t.5 . , .. P alle cla 32 Id. da 24 (,ran:1tc d a 2.'l . 3600 12 ,,3200 I 200 12 11i400 !) 3240()1 24 ~88 001 9 • 3(i00 . 1200 24 ,SSOC 1200 DI PESCl-llERA 145 'J'0T,ILE 4' SPEDIZIONE 2 3 SPÈlHZ(OI\E 71'-i § Peso ;,: OGG ETT I ~I )'BSO <) -~ pa1ziale I tota!~ 2 I 1•1;so '-' ~.,___...._ parziale\ totale Bombe da 2 7 so.o \\ 52 '41600 800 » " QOO 5~ 1, 1 600 '1,600 83200 \\ " 900 ,, 120 l6 1 920 4 0 16 -640 160 2560 Id. da 22 . . . • Scatole a mitr:,gl ia da cann . da 32. JG 4374 9 Id. icl da 24 Tacchi per granal e da 22 . . 1000 1000 ,, " 1000 l 1500 2 500 2500Ì 12 , Stringhe di l ulla ,. " » » 1 000 ·i 8 115591 6 GGll 3 r --4:> I 26 3858t 8 7 5 7650 !) 15129 ,J 4 9 Hll4 9 • 2 131,6 35 34155 l f3 1:1l1t6 2 17! ; 20 9020 · 2 2120 4 20580 200 4800 !) 7600 3600 32400 2400 57600 POLYERE Polvere du guerra Casse p er. con tenerla IV Ci\ 1'EGOr.tA . Munizioni co11(c:::iom1te . t I ")) 540 » 27000 9 lt860 ,, 552 » 27000 " 51tfi°°' : "" ,,,. '"l Sacchet.ti di car tocci da 22 (da JG) 1300 O, 05 , 65 '140 0 0,05 70 1 700 135 Id p hr cann da 32 11 cnnn. t,ooo . , 5000 0,092 4G0 1600 0,092 1117,20 6600 607 , 20 1 · ' • · mor .i 1 000 I · Id. i d. d,1 '.!'t e mm·taio da 22 , » , " 11700 " , 1,700 ,,I Spolette p er bombe da 27 1000 O, 16 ° 1 60 1000 O, 1G 1 60 2000 320 1 I d. i c\ , 1.b 22 , " 1·100 ,. » 1100· l ei pe r granate d a 22 400 " ,, 2 600 " ,, 300 0 Stoppini
Sl_opvi11i.
Sofftoni V C1A1"EGOl\l.t,Armamcnti
7500 1200 280 450
hccia il\
çd asso,-1;mc11ti
Id.
ld.
.
160 Butt a fuochi . . . . . . . . 40 Cart occicri da 32 e da mo r l3i da 27. 1 G AN:SO VI. Vo l. I. '...o.. lO. 22 20 10000, 12001 " 350 22 550 ;,, 20 218,t,O 1s 45 15 12 22 l) 4 5 , 25 5 1.,90 1,., 50 3, ,,o » 7,50 '"l , 25 7 5,30 0,24 2,30 ,, 60 1!J 1 40 1,9 31,50 28 )) 7,50 ,, 7 848 9, 601· 31 " s 1 1 l 1 80 50 6 " 1, 5)25 5 17500 I 23 24001 , » 630 » 1000 93,60 "fio 6 3 , 00 11 0 . 60 3J 2, l15 ~ 30 !}O 40 / 210 30 1 50 " ' 10 1,9 4 , 50 22, 50 3, 50 ,24 , 50 ,, 7,50 7, 25 7 5 , 30 0,'lt, 2,30 " 7,50 7,25 7 954 12. 1 3,80 1 2 54 52 , ~o; 15 - 8 2 )\ 15 1 7, 25 2 H 31, 0 JS02 90 22 ~2 r,1 I
Id.
Id
lian oYelle ordin~ric . . .
.
d a 10 (o.bicc da 22)
G:, rbi di sacchetti d a 32 d i carta (di h1mi cra1 ) .
rb i di sacch c t i.i da 24 Jd . id. da t G (o bice da 22) .
Palclli ferral i 1 1 lungh i 2 · · · 1 corti ,,
er sac chetti Coperte di s tu oie
VI CATBCOl\ll\ ,
Ordcg11i ver In cosl>'11zio11e d ell e vulle,·ie I
Piccozzini '--
Badill con m a ni co
Manichi di ri camb io assortit i
Ma1tzapi cch i sferrali
'•ht11~hc ;._ · I Gr av inc
Ron.co le : :
Seghe onli na ric ( una rifcnditoit1) .
Scnri dli g n nstato ri : I
Righ~vari c d_a2a4m.icli l unghezza
Artl11p cn zo h . , . . . . . , •
Magl i d i fcrr.1cc1o -
Pai,1oli pe r cann. cd obic i d'affuslo Id . p,}r morl;, i da 27
Rn rl ici p er ' pu1 uol! . Vcnticre . . .
Cesti_ da terra
VII CATllGOl\U, Ogg ctli pc,· l.'i11.tratte11ù11c11to cfol mrtlcrialc.
Bil ancic cl'a.vantrcoi d' assctl io modello 1833 . . . • ll il aucie d' a va nlrcni da 16 cd S di carnp a ~na . . . . • • ·
Id. d'a.,a nlr eni de l timone d'assedio l.lilancini
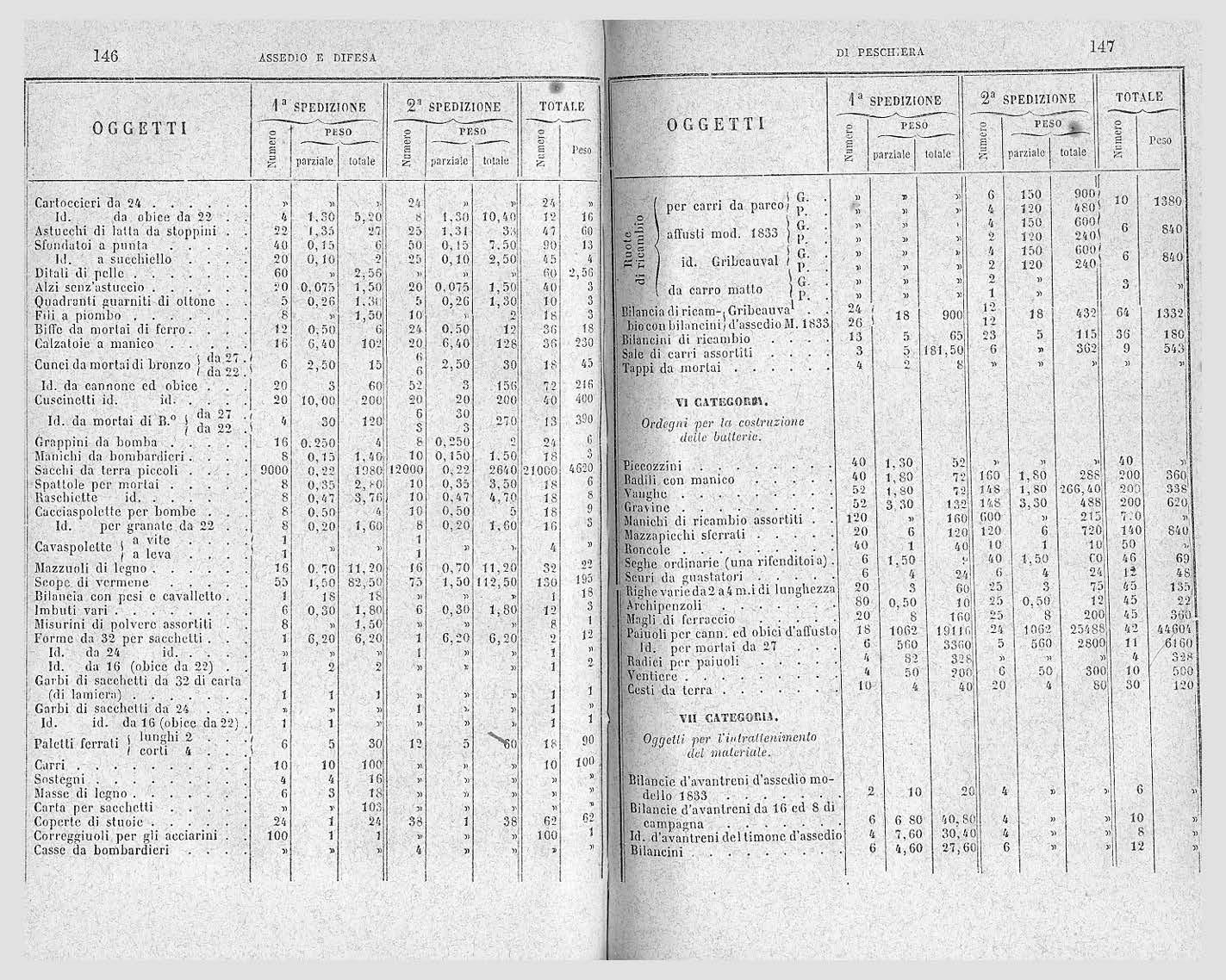
146 .ASSEDI O ,R DIFESA J:?l PESCH'.ERA 14'1 '=7 13 SPEDIZIOlSF. 23 SPEDIZIONE T;\ I P r: o G G ~, PESO ~I Pl\S0 ~1' .' ET T l c., • _____...._____._ 0 -__.. E Peso J •~----, l pi rzialo I 101,iJe j ;mzia!c·I tnlole I , Ca l't occic r i da 2 1, .. _...;..__---;---,,;---,-i-,----,,.[:;---2:""' , c..___"_:__ _:,jo:..__2_1...:_, _ 1 ~ I 1 • d i G. Id. da ob ice da 22 i, 1. SO 5, 201· 8 t ,30 10, 1,0 12 16 I o per ca r n a parco \ I'. - ~i~i~~~ ~'!id~ ~1::;;,a'1'1 st(lpp ini !~ 2~ ;i ~'~; 7 -~~ j 1~ S~ a!fns t.i mod. 1833 l ?,_· Id a succhiello 20 o; I O 2 2:. o'.10 2,50, ti:) • 3~ id Gribcauval ) (}. Dita li tl ipcll c 60 • 2 . 5~ » ,, ,, fi0 2,5 6 ' .... ,.. · ' I J>. ·' Alzi sc11z',1stuccio ;>O O, 07;; · <50 20 O. 075 1 :'>O tio 3 ;;; G ·, Qvadrnnti /!Uarn i ti , d i ot t on e 5 o, ~6 L :1u1 o, 26 1 '. so lO 3 cla carro malto \ 1,: . j l' i l i a pi o mbo ·s ,, 1, 50 lO ,, 2 l ti 3 Bi lanci a di ricnm- 1Gribcauva . . BilTe d a mor t ai di fcl'ro. . 12 0,50 61 24 0 . 50 1 2 3G 18 hioconbil a n cini 1d ' asscdioi\l .1833 , Ca' lzatoi e a man ico . . . l 6 G, 40 10? 20 6, ,,o 1 2$ :16 230 , Bilanci ni di ricambio Cunei ùa mortni di Jironzo I da 2 7 • I 6 -?, -~o :~ 0, (i Sal e di ca rd nssor l it.i I da 22 . I - V V 6 2 , 50 3 0 l $ 4:i Tappi da Jn o rla i Id rla cannone cd ob ice ·I 20 3 52 3 156 72 2 1 Cuscinetti id i d 20 10, 0 0 200 'lO 20 200 ,,o /4 00 I d . da mortai a· ' n o I da 27 1 1, 30 120 6 3o 270 13 390 1 1 · 1 da 22 , I s 3 Gr app ini d a bomba ' 1 6 o. 250 ,, 8 O, ~50 2 21, 6 M:rni c h i dah omba rdic ri 8 0, 1,, 1 ,4<, 100,150 1. 50 1 6 3 Sacch.i da t erra piccoli , 0000 o. 22 1930! 12000 0,22 261,0 21000 46 20 Spalto le p cl' mo rt a i 8 o, 35 2, ~o 1o O, 35 3, 50 18 6 Haschicttc id S 0 , 41 S,7fl 1 0 0,47 1, , 7.0 JS 6 Cac ciaspolotte per b ombe ,. S O. 50 4 10 O, 50 r, . 1 6 9 ld . pel'granatc . da22 S 0,20 J,60 8 . 0 , 2 0 1,tìO - 1 6 S Ca Yaspolcttc ·I n v ite - 1 1 1 ' 1 1 n leva 1 " " 1 nlazznoli di lrgno. .. 1 16 O. '; 0 11, 20 16 Scope di v erm c uc . 5~ 1,r,o 82,5 0 -7~ .Bi lo11cin con pesi e cava lletto . I J s 1S Imbut i v ari. . 6 0, 30 1,80 Misurini di polvere as~orliti 8 » 1, se Fo r ra e cla 32 pe r succhcl li . 1 6, 20 6, 20 Id.
Id.
da 24 iù .
Ga
Còl!'ri
Sos tegni
M~ssc
Car
Corrcggiuoli
Casse da
cri )) 1 6 10 6 )) 24 100 )) 5 10 ,, 3 2 )) ,.I30 100 16 18 1 03 24 6 )) )) 1 ,,, ,, ,, 38 " ,. 0,'10 1 1 , 20 1,50 t 12,50 0,30 ,, 6,~o " ,. )) ,, )'i ,, " 1, so G, 20 )) " "-so ,, )) ,, 32 1 SO ! 12 8 2 1 I 1 I 1 1~ 10 62 100 22 ! 95 18 3 12 2 1 90 10 0 62 l
I
. . . .
. . .
di leg no .
ta p
per gli a ~cia rini
bon)bard i
,'
4 3 SPE DIZIONE 2 3 SPEDl'l:IONE ~ 1e I \ ~-1~1 fì,arziale I tolale )) .. )l ,, )) )) )) )) 2ti ; 26 I J;_\ 3 )l ,, " ,, )) )) 18 ,,l :·1 )) )) )) )! 90 0 5 65 5 18 1 ,50 ' 2 8 52 1 ! paniate I totale l1cso I ' Il 6 1 , 1, 2 1, 150 120 150 1'20 150 120 900 / ,,sol io 600/ NOI (;QOI 24.0 1 380 1 I 2 2 1 1~ 12 23 6 )) ,, 18 5 n )) ' 432 1 I 5 362 6 6 3 61, SG 9 )) s1,o 84 J ,,I 1332, 1so1 5~~: /1() 40 5'l r,2 1 , 30 1, 80 1 , so 3 , :,0 72 160 1 ,,SO 28!\ 1, 80 266, ~01 40 200 200 200 r; -: o fW 20 1,0 G 6 20 so 20 lo G 4 I O 2 6 1, 6 )l , 6 1 1. 50 • /j 3 0,50 s 1062 5G0 S·! 50 4 ,. 10 6 $0 7, 6 0 11,60 r, 2 11,s 132 160 no \ 20 !10, so 30, 11( 27,6 0 111.8 H00 ·120 t0 5 ,1 6 20 . 3,SO 4 88 ) J 21 5, G 720 1 1 ul 1 , 50 !:O 4 24 3 75 0,50' 1 2 8 20 0 106'2 2518 81 5f,0 2800 50 30~1 • sol . ,: 4 • 1, )) )) " 6 HO 50 46 IÌ G 10 s 12 " )) l
OGG~TTI
Code di fucine di campagna 11° 1 830. Coscii1li d 'i1n111trcni t1·assedio mod ello 1 8;13

Cosciali di carTi da pnrco Gavclli di ruo t e del Nu t
i ij".1ffusti d·a~scrlio .
Sugna Pan con i da 32
!•'erro assorl iLo
Ivm CAT llGon,., Arli (ìzi
OG GET TI I
Martinelli vile Cofaoi ,b ramparo
Carr iu oli eia bom be Id. or\liunri
Barelle co0 piedi
T . li I doppie ,, ·{ nnc e / semp li ci 6
Romane co n ca\';tl l cllo completo Cov i di ricambio
Lungh e doppie
Id. scmplk i 1,1. da irohallo
Funicellà per trinelle (
Spago d i t m ili. d i diametro
Corda fuori nso per supplira i tacchi
Fetuccia p e lk gn,nate
Gomen a lunga 3~3 metri di diamelro 4:3 millimetri •
Chiave d oppia pr r dadi
llacchina p e r 1·imeUere i g rani
Lucche tti pri cofan i da ramparo
X CATEGORI.\, 09gct1,: dit1tl'Si.
Paline di 2 metri in legno
Coperte i111·erniciatc . . .
Lanterne dì lalta . . .
Candel e di c1ira o steariche
Registri
Carla, penne, lapis, Assorliccral acea . . . mento
lnchiosl,r o.cnla rnai. di lullo
Forh ici, ughi , fil o .
Temperin i dop pi . .
llctri per lasca
Colla i n tavolette . .
R~sptJ da legnaiuolo .
Ln,cl(i a bu ila d'aria
Cat ene d'agrimrnsore
Doppi decimetri
Tavole di logaritmi
Casse d'imhallo d i ve r se Barili per miccia, spolclle e stop- I pini. . . . . . . . .
148
ASSED IO E D IFE SA 1 a ~Pf:O IZIO NE i/~ z pmiale I 1o tale 1,0 ,iol . !lOI 2' SPF.DIZIOi\'€ ------------I---.'.'..r~ pa rzlalc l !olale ,, TOTALF. Y-/ : Peso M. " 2, H. _ ltl » 3 l ei. n 4, 15 .
s
Id .
d. scoperti . s 5 4 12 1, 20 fì fi 6 2 30 17 , 40 12. 40 6,60 7,60 5,AO G.80 5,60 4,60 87 49,GO 79, 20 30,1, 0 11 ~ 40, so 37.60 2 5 4 1~ 3 8 20 6 6 20 50 50 " " " • " " " ,, 10/ 5 JO s 26 7 ,, 5 14 26 12
1 . lcl. " 2 , 14 Id. » 1, , l :,
di
. . . . . .
Li
i roni da curro da parco coperti .
i
~fasfal on i id. eopcrli . Id . icl. sco perti Unzzi di ruote N°
TaYole
abete
Stangbe di carro da parco . . . ) 'l'r:n•c1·sini, ùl. . . . . Timon i da ca r romall o Cribcauval . Id. da carreggio di campagna . Aloni digrossal
I
IFaoali da ramparo
!lazz i da segnai i
• Torcic a YCuto lu nghe I metro fioccafaoco Fastelli ari ifizial i T o ,·tcl)i id. Materie p er nrtifiz i· Cera l'ergine IX CAìEGOla ,\. Ordrg11i e co rdai/li, r. ~pre compile . Sculclle colle lc,·c 20 5 0 50 112 - 8 ,, 6 6 2 • 2 " G 2t, 50 ,. :,oo 500 2 :; 1 3,90 ,,, 20 2,50 24 ,,o 15 Si 21,50 72 38:, 2 i, 6gl! 78 210 125 266H 320 60 100 1~ 8 222 5 Jt!) 5 14 ,, 1 1 08 " 7 70 2 » IOOO " )) )) " "21 ,", » ,. " 9 4, 25 /1 8 70 500' 500 500 36 2 50 ,, ~o )) 500 500 )) " . • ,, • I , 20 290 G:, 5S0 32; . 1 :'90 7 6:l 24001 )) )) ,, li 100 1000 38, 25 7 2 70 5001 500, "-ioo5001 " s I,() 100 100 :I " " 212 5058 20 " 12 • 11 • li • 3 • 20s I 4 " " 1000 I 15 60 100 1\0 " 1000 1000 1000 ! 000 1000 500 !'>00 :i s,o 12 1.ìO
Artifì:.i con(c:.io11ccti.
. .
!
DI PESCIIIERA 149 1 3 Sl'tulZIONE 2;' SPEDIZIONE TOTALE ------------- -----e l>ESO o Pl!SO ti , __.. Ipm iulc I iotalc ' Ipmia to 1 tola te n= 2 4 2 )) 2 25 97 :)3 )) 15 12 0,70 1 90 4 r, 3 1'I 35 20 12 ,, l) 30 0m )) 1 )) 4 » 1 2 20 150 " 2 1 )) 24 ,, )) )) » r, )) " » 20 0, 60 " )) 50 355 66 ,, 30 5 90 172 350 240 100 1,67 1, 50 )) )) ,, » )) 240 1 6 1 0 1 8 0,50 I 4 2 18 3 )I 1 2 10 10 " " » " 3:! 1 8 2 0 1.5 0 ,, )) )) 1 25 97 3 ,, 15 " 90 4~ 25 12 " )) ,, )) V • )) • 20 o, so ,, )) ,, 25 388 66 4!'> ,, 9 0 86 250 12 0 300 3 8 ,, 1 S 5 12 2 6 2 4 30 " )l l~ » 30011l » 1 " 1 " 1 » ,, 32 360 :ìo 1 r, ,,o 1 0 300 ,, ,, " » 75 7~G 13Z ,, 75 )) 1 80 25S 600 360 t,61 1, 50 )) 5 .,, ~1 " 600 32 20 1S 0,50 " » »
RIORDINAMENTO
·DE.GLI - ISTI T U TI MI L ! T ARI
DIH, REGNO D 1 ITALIA C)
Contrarre l'arruolamento volontario p er la ferma di due anni, se con do l e l eggi e i vigenti regolamenti . per l 'eserci to.
Esami d 'ammessione sull'intiero programma dei collegi militari.
Cons tatare i mezzi di pot er s opp erire alla spesa di p ensione' (} corredo p ell'in tiero corso. '
Atti tudine fisica al servi'zio dell'arma di cav alleria. Attest~,zione d i precedente b ~ona co n dotta , e di appartenere ad on or ata fajnigli a .
Consenso dei legittimi parenti ad intrapr endere il ser~ vizio militare nell'arma di cavalleria. '
, De i posti e m ezzi p osti grcituiti.
V.
3° SCUOLA' DI CAV1~LERIA .
Effettivo numerico e sua ripartizione organica.
Stando ai nostri calcol i preced enti ed avuto rigu ardo alle ci rcos tanze attuali, l'effettivo numerico della s~uol a di cavalleria risul terebbe di- ~irca-120 allievi ·da ripartirsi i n due corsi annua.li.. ·
Potre bbesi così fo rm are uno squadrone d ell'-intiero -personale allievi; ogni corso annuale cor~ispondendo a lf2 squad,rone. · ·
Condi zioni pei· l'amrnessione:
Le condizioni per Pammessiòne alla scuo1a d i cavalleria, vogliono e_ssere le stesse di quelle ·eh.e ablJiàmo stabilite p er l'ammessi one all~ scu ola di fanter i ~ ,, ci oè; Età dai 17 a i 19 a n ni. '
S t atura n on infe1;io r e, a lm ,50. . (~J V cdi An no V , vo l 3, p a g. 120 e voi. ~, pag . 113 ' ~ 233.
:I?artendo dal principio che iL 1:ervizi o n ell' arma di cavalleria è d ispendiosi ssimo, alcu ni vorrebbero che se ne ; e sclud essero i posti gratuiti nella scuola militare ri spettiva . , Se, d icono essi , il giovane ha mezzi di fortuna tali da riotcr se rvire in quest'arma., egli ne deve avere abbondantemente per pagai-e tutta l a su a p ensi one e le altre spese di scuola. ; epper ciò non è g iusto che s'aggravi l'erario di posti e mezzi posti gratuiti, il benefizi o d ei quali debb'essere un icamente acconsentito. a ' bis ogm,si » .

' Se partiamo dallo' stesso princ1pl0, noi pure veniamo alla 'medesima concl usione : ma vi son o altr e considerazioni d i l oro natur a essenzial issime, le quali ci costringono a mod ificil,rla .
Innanzi t utto, ne' su oi calc oli in basè organica, il go~ verno nè può, nè debbe far assegnamento sulle condizioni di fortuna degli in d ividui. È suo d ebito, p er mandato della nazion e, di fornire a chiunque si dedica a ll'esclusivo servigio d ella p atria, tutti i m ezz i necessari di vita conveniente e decorosa relativamente all'impiego occupato ed
ISTITUT( MILITARI DET, REG~O o'rraLIA 151
alla posizione soci ale del grado e dell'ufficio, fatta totale astrazionè d ella condizionè privata dell'indi~iduo.
Ed invero . ~el. nostro , come i n ogni . altro esercito l'uffiziale di cavalleria, a1Jp1mto pet l e maggiori spese iue~ renti al _suo speciale servizi o, ha maggior paga cli quello . d'ogni altn'arma; provvede lb Stato ·al nudrimento di quel numero d~ cavalli. ·che g}i sono net(';)ssari pel suo servizio, e gliene . facilita la provvista. . · .
Se _questa _m a~gi~r paga, se questi speciali vantaggi sono rnsuffic1enti, s1 ai;mentirio ·quanto ragionevolmente è necessari o, ma non fia mai che in quest'arma 1).0U si ' possa serYire ,senza ptiì:ati mezzi di fortuna .. . ,. . . che la . dignità del~a na,,;ione nol può consentire . .
D'altronde ·po i n on è .così facil 'co.\.a il trovare de i buoni .uffic iali di cavalleria, perchè si abbiano esclusiva.men.te da reclµtar fra' dovizio si . '

Epperò . noi con$igliamo 'anche per ' la scuor~ -, di caval- · leria uù certo numero di posti e mezzi posti gratuiti, così i
Tre posti · intùwi e t1·e rn;ezzi posti per concorso an i;m o sul programma -d' ammcssione a' sott'uffiziali e soldati de~l'~rma di, ca:7all:ria dell'esercito, che, dietro p roposta dei con1andant1 di corpo , aspirassero ad entrar nella scuola e ne avessero le condi~ioni richieste (per quantol'età utile, potrebbesi portare ~ino a 21 anno). ·· _ ·
Ouatt1·0 mezzi posti, cioè un mezzo posto pét quell'allievo d'ogn i collegio m i litare, il qÙale, aspiranç!o alla ,cavalleria, riesca il primo del suo corso all'esame finale del 5° anno . ·
~)re . mezzi PQSli da accordars i per concorso ai tre primi. ~lhev1 del 1° anuo d i co1·so µella scuo la, in S€lgui to alI esam e de'l corso annuale stesso. ' .
Ben. inteso che tutti i P,0sti e mezzi posti gr·atuiti acco~·~ati_ dal governo e acquistati per concorso..ne' collegi · .m:ibtan s1 dovrebbero conservare nella sc uola cli cavalleria.
Ben avversi all'opin ione di coloro ·i quali vodehbero far consist ere l 'attuale scienza <ll.ell'uffiziale d'i cavall~ria nell'eqtùtazione e , nella teoria. cl'esi:;rcizio, noi si amo in. vec e fermamente co1wil;ti, che per essere un buon u filziafo di c.avalleri a è indispensabile inoltre un corredo d'istruzione scien t ifica e tecnica, pel qnale non sono certamente troppo i due anni cli corsq della scuola.
0ggidì più che mai - oggid1 .che la cavallerìa ha trovato tantj detrattori fra gli entusiasti delle armi rigate, i · quali , le predicano morte e rovina - oggidì più che 1nai è necessario che la cavalleria s'abbia uffiz 1 iali i strntti e capaci ·di far progredire quest'arma all'altezza dell'arte modernai , •e · d i mostrare con prove ' di •fatto quanta è la $Ua i mportanza negli eserciti.
I progràmrni dì corso della cavalleria dovrebbero es~ sere, a pare: nostrio, i seguenti:· - l O Anno cli corso.
Studio razionaÌe del r~golamento di disciplina speciale e., d el - codice p·enale militare. - Teoria cl'eserc.izì della çavalleria (Basi dell'istruzione, istruzione individuale a pièdi, ùitrqiio1Ìe dçl soldato a cavallo, istruzione d~l pelottone a cavallo I i struzione sul maneQ'O-oio delle armi ' bianche e di quelle da fuo co ·della cavalleria). - Nozioni· elementari teoriche cli to po grafia. - Nozi oni eleÌnenta.ri di fo1·tifiqazione èampale. - Cenni preliµui1ari sull'arte dell a guerxa: él.efin izioni e divis ioni generali dell'arte della guerra, ~nozi oni sull'ordinamento degli ésercitL - Operazioni secondarie di g uetra . - Brevi nozioni sul tiro delle armi da fuoco .in generale . --: Elementi d'ippologia . - Con-· tabilità m ilita.re. - Nozioni el ementari e contabilità dello
• squadrone . , ' .
152 I STITUTI MILITARI
\ OEL REGNO D' ITALIA ,153
'. 1,..... I
Stiid,i
1
EsERCIZII PRATICI
Disegno topogr afico- e di fortificazio ne . - Eser citazion i pratiche su i varii regolam enti d'esercizio dell'arma tiro al b ersag1io a piedi, scher~a a pic<li, nu ot o, equita,zione (due ore del giorno almeno), passeggiate militari a piedi e d a cavallo .
2° Anno di corso .
R ~~ol amento sul servizio di p ia zza . - Regolamento sul servmo delle trup pe in campagna. - Teorin, d'cse rcizii (tu~ta intiera) . - Leggi e r egolamenti varii sull' organizzazion e attual e dell'esercito italiano , sul r eclutamento, sullo stato degli uffiziali, sulle giubi lazioni, sulle licenze, s ulle competenze, sn1l'ord inam cnto tattico e am ministrativo,_ sulla circoscrizione territoriale ecc. - Topografia p~at_ica. - Geo~rafia militare d'Italia. - Cenni Gom pend10st sulla fortificazione permanente . - Storia dell'arte della g u erra ~ntica o m oderna al ptmt o di vista speciale d_e~la cava~ena. - Nozioni statistiche sui principali eserciti europei. · - A r te d e lla guerra: uozioui sulla fil osofia e sulla p oliti ca militar e, sulla strategia e sulla logtst ica. - Corso di tatiica. - Elementi d'ippologia.
ESERCIZI PR,\ TIC!.
Di$egno e l evate topografiche a vi st a, memorie d esc rittive e ricognizioni militari. - Temi d 'arte militare.Varie praLiche mi l itari sul servizio di qu ar tie re , d i piazza .\ e d1 campagna. - Esercitazioni sui r eaolamenti d'esercizii al di sirnpiego delle vari e cariche O sin o a q uella di comandante di squadrone . - Tiro al bersaglio da caval!o . - Scherme varie a cavallo. - Nu oto. - Equitaz10ne (tre ore al giorno -alm eno) . - Didattica di manegg io. - Passeggiate militari, ed intervento ad un campo d'istruzione, fac end o servizio alternativamente presso i r eggi ment i d'ogni specie di cavaller ia.
Qui non ripeterer1.10 quanto g i à abbìamo detto, parlando d ella scuola di fanteria, intorno al metodo d'insegnamento, alla scelta de' professori e a ' libri di testo, m entre quelle n ostre osser vazi on i vogl ion o riferirsi ad ogni istitnto d'educaz ione in generale . ·

Con identico mandato a qu ello della scu ola di fanteria, l a scuola di ca,alleria debb'aver es~a pure un consiglio d'ist1·uzi one, che noi v orr emmo così formato :
Il comandante della sc uol a : presidente.
Il direttore deg li studi : /
Il c~rettor e clelr~stru~ione : ( memb1·i fissi.
L'amtante magg10re. m l O 1-
3 Professori : membri varicibili .
L'uffic iale bibliotècari o : segre,tario .
Quando si avessero a trattare questioni. radicali e general i sull'istruzione, o di mutamenti di programma, tutto il corpo ins egnante dell'isti tuto deye prendere parte deliberativ a al consiglio d'istruzione.
Quadro del 1m sou alc iu scgnantc.
1 Direttore deg li sti1.,dì, comandante in 2° della scuola.uffizia}'; superiore.
1 Professore di topografia.
2 Professori di topografia e m aestri di disegno.
1 Professore di for tificazione . ·
1 Rip etitore di fo rtifica zione e maestro di disegno .
2 Profess ori d' arte e sto ria mi litare.
2 Ri p etitori id. id .
1 Professore d'artiglieria e balistica.
1 Pro fe ssore cli am ministrazion e m ilitare.
1 Ripetitore id. id.
1 Profess ore d'ippologia .
l Ripetitore id.
154 I STITGTI lfJLlTARI
DEL m:GNO o ·ITALU. 155
Istruttori.
.1 Direttore d ella cav~ll;erlzzà - capitano . ·
2 Uffiziali i struttor~ d'e.quitazione - u ffiziali subalterni.
4 AiutarJ.ti i struttori d i cavallerizza - sote~ffiziali.
I . Direttore della sch e rma ;
2 Maestri di scp.erma
2 Sotto-maestri
2 Maestri cli nuoto
1 Sotto~maestro
1 Maestro di ballo
. sott'uffizi ali o botghesi:
' L'inseg n ari1e nto dei var ii regolameµti e le ·varie istru• zioni p r~ti che rilitaij debbono esser e affidate a qu e.crli uffiziali di go v:erno i qu,alì non comul erànn o l a carica ~li professore , . ciò . che per econçm:;_ia · _ deb be fars i sen~pre quando .possibil e . .. . ma giudizio samente, comè osser vammo pre~èdentem énte, trattan do lo stesso argomento in p r op os~to della scuol a d i fo. nte.ria.
A~fMINIS 'J'TuAZIONE , VITTO E-CC
Aw lei scuola ct, i càvalleria , n oi abbi a m d e t t o u ella part e terza d i questo Ì'ag ionameut o (1), dipende1Ì,clo 1.micamen te clallci volo~tèi degli inchvi~!Jui , la scelta di q'twst'ctrma disp endiosiss(niµ, piiittostochè cli 'i/Jri'alt1•a,, giustiziçi vr.iole che le maggiori .spese prov enienti pel mantenimento de' cava lli delf' ,ist;~tu,to , siano ci ca1·ic o degli allievi; epper!Yiò 1'itenendo che pe1· ogni due allievi o ccon·a im cavallo cla maneggio , e che questo costi .al governo L. 2 al gio;·n o , la p~/isfone men sile asce nderebba lt L. 80, cioè an:nualment.e a L. H60 .
Tal e so m ma vorrebb'cssere ripartita mensilmente n ell e segu enti categorje: ,
L. 35 p el v i tto (2 pasti al giorno).
» 15 p e r spese cancelleri a, bianche ria, parrucchiere, e,c.
» 30 p e r spese di cavall i e scude ri e . · ·
L. 80 totale .
Con L. 35 al mese (epar tì a m6 per ciò da calcoli compi.:ovati àa lun ga .sp e ri enza) si . i1uò fornire all' aHievo un v itto s uffici ente e 'sano per due refezi oni al giorno, dando alla cv le ziona :
Una• lJ uona m inestra ;
Un piatto d'i carne guernito di verdurn ;
p'~r questo ·punt o ci rifei-i am pure l etteralmen¼ a q uant~ _ a bbiam detto p er la scuola d i fan teria. La. sol a di fferenza consisterebbe n ella fo rmazione del Co nsig lio di dùciphn a c he dov rebb'esser e cosi co mp osto :
Uno d egli uffiziali ·superiori ·per turn'.o , presidente . -
Due capitani · i d . / ,
Due u ffi ziali subalterni id .. I rnembr i .
L'aiutant e maggiore in 1°, 1·elatore .
La riuni?ne 9-ei due consigli cl'istniz,ione e di q,iscipHna formerebbe .ancJ?.e p er q uesta scuola il Cons-iglio. supe- , t·iore; d elle cui attribuzion i parlammo, trattando d ei collegi militari
Un pezzo d i cacio; .
Mezzo li tro d i v ino; ,
Pan e di muniz.i.one a d i screzio ne.
Al prc.nzo :
Una mines t ra.; .
Un piatto d i carne a l esso ;
Un 'altro via tto , qualunque d' umido;
Frutta;
Mezzo litro cli vino; ·
P ane di mlln jzion\') a d~cr ezion e . ,
(1)· Anno V; voi. IV . pag. 129

156 ISTITUTI Mi LITARI
D1sCll'LI'N'A
r ' DKL .RE GNQ n'1TALJA 157
Ciò che in media annua importa uno scotto giÒrl)aliero di L . 1, 075; cioè L . 32,787 al mese (tenendo conto del g iorno 31°) .
Sul totale della mensa esce abbo nd antemente i l vitto degl'inservienti d ella tavola e della cucina . ,Rimangono. inoltre per ogni .allievo L. 2,213 al ni.ese pel pagamento de' cuo cp.i ed ait!e ,spese ordi narie di men·sa; e bastano all'L10po. ·

Le l i re 15 mensili che arJbiam destinato alle piccole spese, va1;mo così impiegate :
L. 2 al mese pèl bucato indiv i duale . f 2,50 spese di cancelleria.
• 1 . spesa d i parrucchiere.
L. 5,50 . · ,
Rìman g ono L . 9,50 mensili per le spese , d éll'illumi11azione, man utenzione çlei mobili ed altre s12esE;? gen era1i dello stalJ ilim ento.
Colle altr.e 30 lirè al mese che ' l'allievo paga per l a ·càvalleri',,:za s i può m antenere . abbondantemente un nu. niero di cavalli uguale alla. ID$tft dGgli allieyi, . cioè 60 cavalli; e d al.la fine ? ' ogni mese l a massa 9,'economia della scuola può, introitare ccmodamente L . 900 su questa sola categoria .
. C.on vien però che il governo fo}'nisca ·alla scuol a d ei buoni e robusti cav all~ d'ogni statura,. e non de' ronzin i incapa çi del fati cos o servizio cui sono iv i destinati,.
Pel vestiario, libri ed altri ·qggetti- di corredo pro vveg·gonò ·le lire 250 an1111e che abbiam all'uopo prest;:i,b ilìte ' per ,la ~cuol a di cavalleria, lè qu ali, poichè economicamente e giudizio~amente amministrate, saranno sufficiénti~sime al bisogno . .
In quanto al vestiario, già si è detto, esso dcbb'essere affatto coriformè a q11ello dell 'arma c ui la scuola è ded~cata, epperciò troviamo conveni'enti ssimq l ' attuale della scuo l a d i Pinerolo, se non che vorremmo dare un distin- '
tivo agli allievi d el 2° anno di coif'so ·da quelli del 1°, così, p er esempio, una d i vers ità di Golo're n~lla criniera del keppy: ·
Quadro del 11crsonalé di goYer.~ o e di, amministrazione. , Stato maygiore - U(fiziali.
1 Comandante della scuola, colonnello di c·avall eria.
1 Comandante in 2° (direttore degli studi), luogotenente colonnello . .
1 Aiutante maggio.re in P, capitano di cavalleria. .
1 Aiutante maggiore in 2°, l uogotenente di cavalleria.
1 ·Economo, capi t!ano .
1 Uf:Iiziale d'amministrazione, subalterno ;
1· Uffiziale a disp~sizione, subalterno .
1 Direttore deÙ'infermeri a, uffiziale s ubalterno.
1 Cappelhno .
1 Medico di re·ggim:ento .
1 Medico d i battaglione.
2 Veterinari (pròfessori d'ippologia) .
S tato. 'maggio1·e ~ · Bass~ forza ,.
\.
1 Furiere maggiore .
1 Furiere .d'amministrazione.
Se r genti . fd.
2 Caporali id.
1 Sergente i nferJJ?,iere ;
4' So ldati id.
4 Sergenti p0l servizio di quartiere
4 Caporali id '. id. ·
25 Soldàti pel servizio domestico
Veterani' d ell';rma di cavalleria.
158 J $T ITUT I MIL I TARI
DEL REG '.\O u'rrAL!A ]:i9
·•
U(!ìziali p~r lo squadrone . ·
1 Comandante ~o squadrone allievi (direttore dell'istruzione militare), maggiore di cavalleria. ·
2 Capitani (istruttori) c.oniandanti i mezzi squadroni.
2 Luogotenenti (l ·per ogni, l z2 squadrone).
4 Sottotenenti (2 p er ogni lz,2 squadrone) . .,
Bassa forw addetta allo ' ~q,iiad;ro1::.
1 Furiere.
6 Sergenti.
8 Caporali .
24 Soldati palafreniei-i.
ASSEDIO DI JULIERS
nel 1860
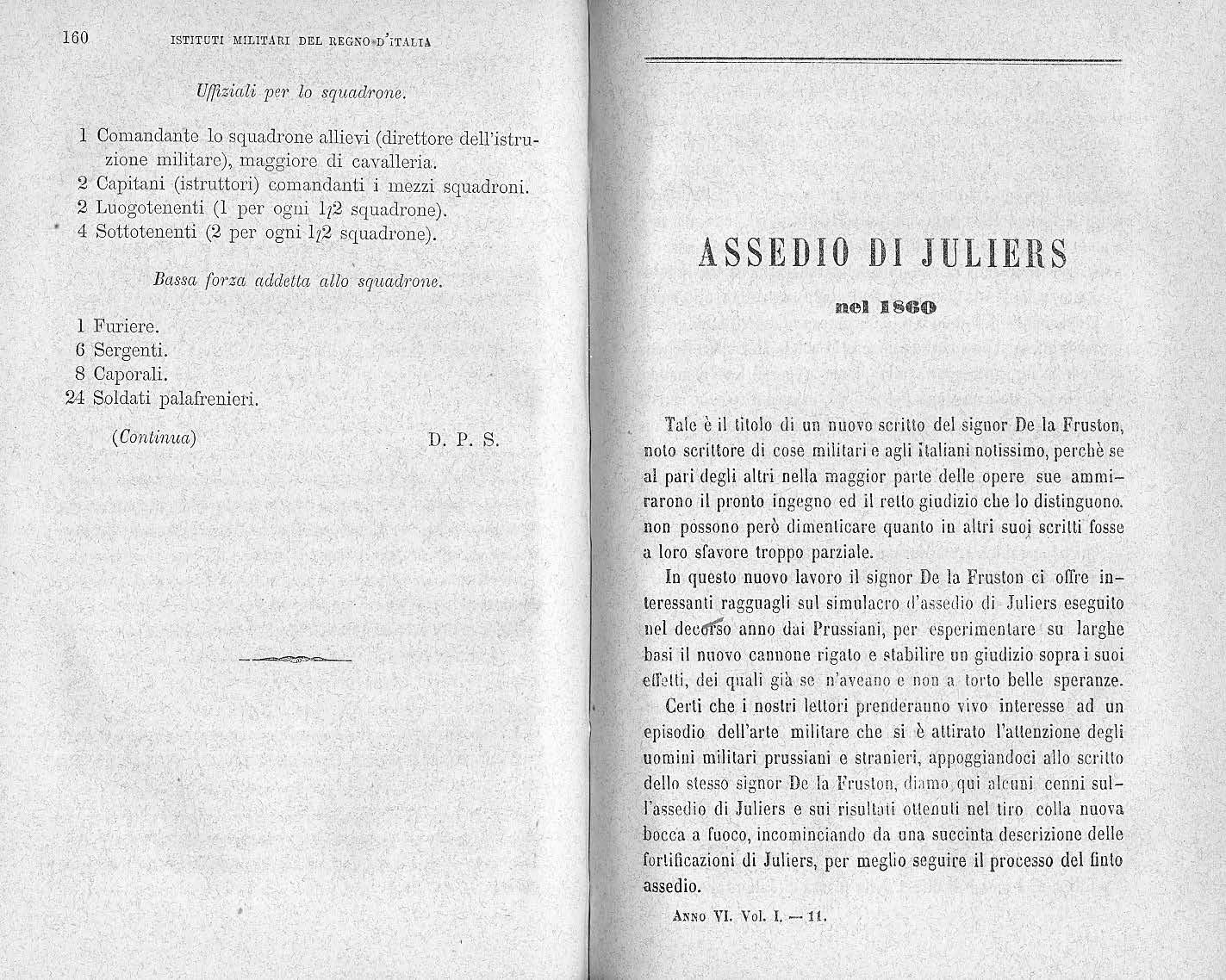
Tate •è il tit olo di un nuovo scritto del sig nor De la Fruston, noto scritto re di cose militari e agli italiani notissimo, percbè se al pa1'i'degli altri nella maggior partè ' delle opere sue ammirarono il pronto ingegno ed il retlo giudizio elle lb distinguono. non pòsson6 però dimenticare quanto in altri suoj scritti 'rosse a lor9 sfavore troppo parziale.
In quest-o nuovo l avoro il signor De la Fruston ci· ·oITre interessanti ragguagli sol simulacro d'ass edio cl i Jnliers eseguito uel dec ~ o anno dc1i Prussiani, per espe rim enta re su larglle -basi il nuovo cannone rigato e $labili're un giudizio sopra i suoi effett i, de i qnali già se n'avcano e non a torto belle spe ranze.
Certi che i nostri lettori prenderanno vivo interesse ad un episotl io dell' arte . militare che si ·è attirato l'attenzione degli uomini militari prussiani e stranieri, appogg iandoci allo scritto dello stesso signor De la :Fruston, diam n, qoi alc:11ni cenni sulf'ass ed io di Ju li ers e sui i-i su!Li ii ottenuti nel tiro co lla nuova bocc·a a fuoco, incomin°cianclo da una succinta descrizione delle fortificazio~i ·<li Juliers, per meglio seg uite il processo del finto assedio.
' 160 1sT1T uTr' MrLITA 1u DEL nEGNo -n';TAL r A
•
'-' ' ( Cont·iwua) D. P. S. ') ,,-
',
ANNO VI. Vol. I, - U.
Juliers è piccola ci tt à della prov"incia r enana di Prnssia prèsso la sponda destra della Hoer, a 2t cb ilom,etri da Aix-l aCbapelle; ha soli 3000 ab itanti . Essa è celeb re per ro cc upazione follane nel 170.8 dal l'ar mata repubbli ca na di Francia , la quale ne fece cessione a l\a Pruss ia' nel ·18 •1 if La cillà è situata sQpra un terr~eno affa tto piano dominalo a nord-est , dalle ~!ture dette Merschei:-Holien, di stanti circa · 300 passi, éÒn un comando sopra la cittade ll a di 16 metri. L~ fortifica~ione si ,com• pone essenzialmente di un a cittadella ra ffo rzata da tre lun ette avanzate a nord - est, di ur.ia testa di ponte cos.trult a sulla sinistra :del ponte de( fìum~ , e delle mura dell a ci"~I~'. A que sti mezz i di. difesa si posson o aggiu ngere le stesse Me rscher -Ho hen, · che per la loro prossimità alla piazza e per il. loro com an do sull a circostante ca inpagna po trebbe rQ, il~ C,)90 d'assedio, essere or; cupate dall'assediato, i l quaJe ne ti tra rrebb e sommo van tagg io alla difesa , specia l mente rafforzand ov i la SU!} posizione con· i mezzi sommminislrati da ll'ar.te. - E qu i cade in aèconcio il dire elle Nnpoleohe I, allo scopo ùi coll ega re·quelle alture alla, ci tta-della , aveva ordinato so pra tre punti di ·ess i la coslruzione di . alcuni trinceramenti cbe furo no so ~pes i appena co{ll incia\ La cittadélla , in forma d i 'quadri lat ero a qual lr o bastio ni è costitòita,-da un rarpparo princ ipa l(\ ùa un cav al iere e da un ri.vellir;o a controgliardia, eJ è 1frotetla dall e tre lun et te avanzate, di cui accennammo superiormente, di recente coslroite da'Prossiani. Per megli o tene r diel rp allo svolg,imènlo del programma d'assedio , notcrem~ cofle lettere A, B, C le tre lun ette, com inciando dall'es tr em a sin ist ra. Il bastion e N° 3 trovasi di ~tro I.a lunetta · A, ·il ba~tio ne N° 2 di!)tro la lunetta C, e il ri ve llin o N" :2 diet ro la Junetta B.
li sistema bas'tionato de l Va uban predo1~ina riella ' costruzion e ,, I- • delle vari e opere; i cu i ·fossi po ss ono essere corilpl etamente . innorìdat i in bre vissim.o tempo. < , Tuli ·sono 'i mezzi di dife sa della. piazza· di Juliers cbe i' Prus •

sian i prescelsero a te.atrn <lPÌle espf>rienze di cui parl iamo, avend o da. qualche te mp o i'iconosc iute qur.lle fortific.azio ni affatto inutili alla difes~ della provincia ren ana , .
Pr ima di far entra1·e ·in azi on e l' artiglieria, co m'è . natural'e, era mestieri che fosse dall'a r ma del genio preparato il· terr~no. Appena cqmpito Ù simulacro de ll'in ves ti me nto dell a piazza, e dell 'occupazione delle altur.e, il genio stabilì. sopra una lungh ezza di ·180·0 passi ed a 800 pa-ss~ di . distanza da l sal iente ,delle op ere av anzat e la prima paralle la _ che venne raO'orzata 9a una batteria da smontare. La seconda para ll el.a fu costiu ita alla zappa vo la~te sopra la breve lo ngh1ii.za di 350 pass i, accennando però il tracci.alo del suo proluugamento: si stabilìropo quind i gli zig-zag ?ella seçouda parall el a e'clelle mez ze para ll ele, elle furono pu,·e ·eseguili alla zappa yo lun te ; e- completa ti questi la,·ori e il coron amento de ll e due ·1unelle B e C, si costrui ron b le batt,erie di breccia contro la faccfa des tra dell a lonella B; infì ne ebb e lu ogo lo sta bi limen to della · 1ri11 cea •,' • ape rta e della disce~.r dall'al to del coronamento.
Essendo ora giunl} al momento iri cu i l'artigl ier ia entra •fr1 az ion e, ,diamo l a , spec ie delle boc di c a fu oco imp iegale negli . , espe rimenti éù i principali pro.blem i cbc si vol lero risolvere.
I,:'•
·, Specie delle bocchd e a fì,h>CO .
1- 0 Quattro pezzi d'assedio da 6 . \
2° Dne pen i in acciaio fu so .da 6 I
3° Q,rnllro p.cz~i in .ferro da ·I 2 . )
·t 0 Due p<'zz1 d1 bconzo da 12 .. l
5° Quattr~ pezz-i , <\ i ferro ct'a 24- . )
Pcso ·6k il 328 . ,. ,
Carica 561g\ ·19.
Peso 1 31.ù,606 .
Car ica 982g',08.
· Peso 26kil,·I 7' 4.
Carica 1~i\,87L
JG2 ASSEDIO
1 63
,1
° Mettere fuori di stato di difesa il blockhaus della lunetta C, usando un pezzo di bronzo da campagna . da 12, e il ridotto in terno della lunetta çon quallro pez~i di ferro da 12;
2° Abbatte.re il: muro staccato paralldo al fiancò Jeslro d ella lun etta B con. qu a ttro pezzi di ferro e due di bronio Julli da ,12; . ; . \,
3° Battere melod icamente in breccia con sei pezzi di fe rro da 6 il mmo stacc!,llo della faccia ,destra d°e.lla lunetta B prendendo per punto di partenza la eresia dello spalto;
4° Battere in brecci a il muro che maschera il bastione N° 2 e ia ,faccia sini stra dello stesso bastione situala indietro con quattro pezzi di · ferro .da :H posti in battei·ia sulio spallo dinam.i \a faccia. · · ·
ficientemente eleva ta e colpire i punti nascosti alla v-isla. I muri avevano 0,96 di grossPZza ed erano monili dderitoie. A fac ilitare l'osservazione degli , effetti deÌ tiro il muro fa diviso in tutta la sua l unghezza in quadrati di om,62, marcati con strisce in bianco larghe om,,1 O, L'alzo, a causa dello spallo che lo copriva., era di om ,22 e lo sposlamenlo a sinistra di 16mm.
. Sopra 32 colpi ' , otto soltanto colpirono il muro, 3 le travi e I~ massa di terra coprente; 7 si abbatterono affatto contro il ~nuro e 14. sullo spalto . Due granate non scoppiar ono, e nes-

. suna colpì la murag)ia, ma 11 blocka_us era già aperto dopo 2.8 colpi, dQ i quali 8 avev ano ra gg iunto il gius·to segno. ·
,
5° Diriger~ una controbatteria di i pezzi da 12 con tro la breccia del . fianco destro dèl bastione N° 3, facendola entrare in azione quando la còntrog,Ùardia anteriore al ·bastione N° 2 fosse in parte saltala. .
Sebben~ anche distanza ' si pot esse, scorgere l'effetto dei proietti, per a~•ere n1aggior cer.tezza.,à,i. ·g(udizio, furono appostat i nell'i,~terno .delle fo,rtifi cazi oni in. apposite posizioni di :Sicurezza alcuni uillciali in lèlligen li che fecero uso di due specchi da ramparo ._
Rliìl:L:l'A'Pl OTTENUTI. '
, 1° l,peai l: he ·sparavnno contro il blockhaus della lunel1a Cerano ·1 m,88 più i11 basso del ·punto più alto de1, blockbaus, il quale era inli eramentè èoperto ·qallo spallo di.stante 4-0 passi: la balleria fl1 collocata a 1;;).00 passi dal punto d~ colpi rsi, im·pie~nndo u1w carica di 5·14• grarnrna, cioè una ca rica di poco rn aggio1:e alla carica rea1e: Tale di(ferenza nella ca ri ea di prova era assolutamente necessaria per ollénere U11a )i:a ie.ll~i'ia suf-
· l ·quattro pezzi in ferro da 12-, destinati a ballere il ridollo ilella l~n·etta, collocali a sinis tra della li nea so Ila quale ·erano · posti in balleri"a i due · pezzi puntati contro il bloc kha ns, sparavanò durante i l cannoneggiamento del blockhaus. Essi colpirono il fiai1co anteriore del ridollo sotto l'inclina zione di ,H{0 ' essendo stati puntali in linea obbliqua, pel' non danneggiare i circostanti giardini.~
Il moro del rido llo sopra una' lun ghezza di 1 sm,20 e ·un'altezza di 2m,9J9., a,,eva umi g1:ossezza di ,1m,25 . L'a ltezza totale del ridotto; tenuto conto dell'intelaiatura superiore in legname e della massa di terra soprapposta era di 4,m,28 . Il parapetto cl.i spalleggiamenlo distante p:assì. (H era più elevato di 470mm del , punto cu lmin ante del ridotto, il quale era più b~sso d i , <zm,66 del punto in cui i pè.zzi erano posti in batteria. li ca11noneggiamento .cominciò colla carica min.ima di 4-7 gramma; cou.. una elevazione di 279nm,, che, ricon osciu ta e rronea .. fu corretta fino a· 288mm. Lo spostamento a sinistra giunse fin 1 0 a 24""" ,52. In media · gli imbuti _ prodott i da i proiettìli nella muraglia riuscirono 'profondi t09"'m ,7 4-, alti 7 ~.9"'"' 75 lar~bi , } b ry55mn , ,90. Cinque · proietti, U '.lO dei qùàl'i colpì la massa di terra coprente e quattro la muraglia, non iscoppiarono.
Sessantaquattro furono i co lpi ti,rati contro il ridotto : dieci
'
PROBLEMI.
165
colpirono la massa di terra copre nte, tre lo spal!(_,ttttiame nt o C\O ' uno l'int elaiatura di ll'g name, uno cadde fra il parap etto ed il ridotto , dne andarono perduti e gli altri tutti colpi rono la muraglia, produce ndo n na breccia a lta 1 m ,88 e larga 2"', 198.
2° Breccia su l fianc o destro della lunetta B. - La lanetta era circondata da un muro stac ca to io piena cen tinatura , grosso 2m ,35 nei pilast ri o 1m,02 alla spa lla, alto 3m,84 dal fondo del fossato al cordone. Il cammi no di ronda e ra più elerato dei fosso di 9,i.,J'°"'· Nelle spalle dell'arco sinis1ro erano 0 praticate due cannoniere, mentre le altre erano munite di feritoi e. Il par apetto situa to i ndiet ro al muro aveva alla sua c rrs ta un comando di 2'" ,8 2 sopra il muro stesso, ed il blockbaus della lunetta C con una ma ss a coprente alta 1"',¾5 più del cordÒne del muro e si tua lo 3q..i; passi in avanti se rviva come spa ll eggiamento al front e del parapetto.
Du~ pozzi di bronzo e 4 di fe rro , da 1 2 era no, come si è detto., destinati al l'apertura d el la breccia: colloca li sulla linea stessa dei due pezzi <:he avevano balluto il hlo r:khaos della lunetta C si trovavan o distanti 785 pa ss i, co n una elevazione alla bocca di 2m, O.1, al .disopra del cordone de l muro. Dovendo praticarsi il t agli o di breccia 235mm più in allo del cammino di ronda , potevasi con buon successo far uso del tiro diretto , percbè, sebbene il punto preciso da colpirsi non fosse intìera.mente vi sibile, l'insi eme del bersaglio si tr ovava scop erto . Il tiro fu effelluato con una cari ca di 982sr., os. L'alzo stabilito ùapprima in 60 I mm ,4'8 dovette esser corretto e portato a G~5mm ;~,8. La deviazi one laterale r isultò di 26"'m, U.
Per abbattere la muraglia a bbi sog naron o 115 colpi, di cui 90 colpiron o; gli altri, ad eccez ione di alcuni che penetrarono nel muro at~raver:so i for i cl.le vi erano, cadd ero prima di giungere al punto di mira: un proi e llile no·o isco ppialo g iunse a una distanza di 4000 passi. Fu osservato ch e la maggior parte dei proietti, penetrando r.~!la muraglia, vi lasciarono fitta la
loro punta coll'inviluppo di piombo. Gl 'imbuli prodolli presentarono in media una profondità di 60 ,1mm sop ra un'altezza di 854'°me una largh ezza di 906mm
3° Breccia sul muro staccalo parallelo alla faccia destra della lwwtta B, - Il muro alto 4,m ,7 ·1 al cordone, era a i pilast ri di uno spess ore di 2'" ,3 5 ed alle sp alle di 1m ,02: il ca mmin o di ron da trova va si 1 m ,96 più elevato del fondo del fossa to. La part e da ball ersi in breccia compreod e,a sopra 18m,8:' di larghezza quattro rinforzi muniti ciascuno di tre feritoie, fra i quali osserv avas i il secondo pilastro con un taglio rie ntran te spess o 784."'m ,62.
La batteria . composta di 6 pezzi eia 6, di cui quatt ro in ferro e due in acc iaio fus o fu co ll ocuta nel cornnamento dell o spa llo ad una distanza di 50 passi; il taglio di breccia dovendo esser praticato a 124mm ,7 4 più basso del cammino d i ronda dov eva farsi a 1 01 ,805 al disopra del fon do dd fosso , per lo che fu necessa rio in clinare le bocch e a fu oco fino a 7°, se rvend os i di un alzo, che dòpo pocbe prove fu corretto e portato fino a 13"'.'" ,07 per i pezz i in ferro, ed a 8"'m ,11 per quelli in accia io, senza ~be occ orre ss e spostamento alcun o di fianco. La carica impi ega ta fa l' ord inaria di 56 11 gramma. A vjemmrglio garantire la sicurezza dell'osse rvazione il muro sopra una lunghezza di 30 met ri, e nella sua altezza tot ale fu diviso in quadrati distinti per num ero.
A fine di ev itare i sinistr i, che fac il mente potevano esser prodotli dai rimbalzi dell e scbeggie della mura gl ia, si cos tru sso ro dei ripari pe r i cannoni eri e si acc esero le ca ri cbe co n colli di bombe di sicurezza, cbe essendo di le gno e rip ie ni in alto di polverino od in mezzo di un sale a lenta consumazione, permettevano ai cannonieri d i mettersi al sicuro appena introdolta nella parte inferio re del collo una spo le tta avviluppata, e prima che la l~nla co mp os izion e del salr. fosse abbru ciala.
Per prat:care il taglio orizzolltal e ~ì distribuirono le bocche
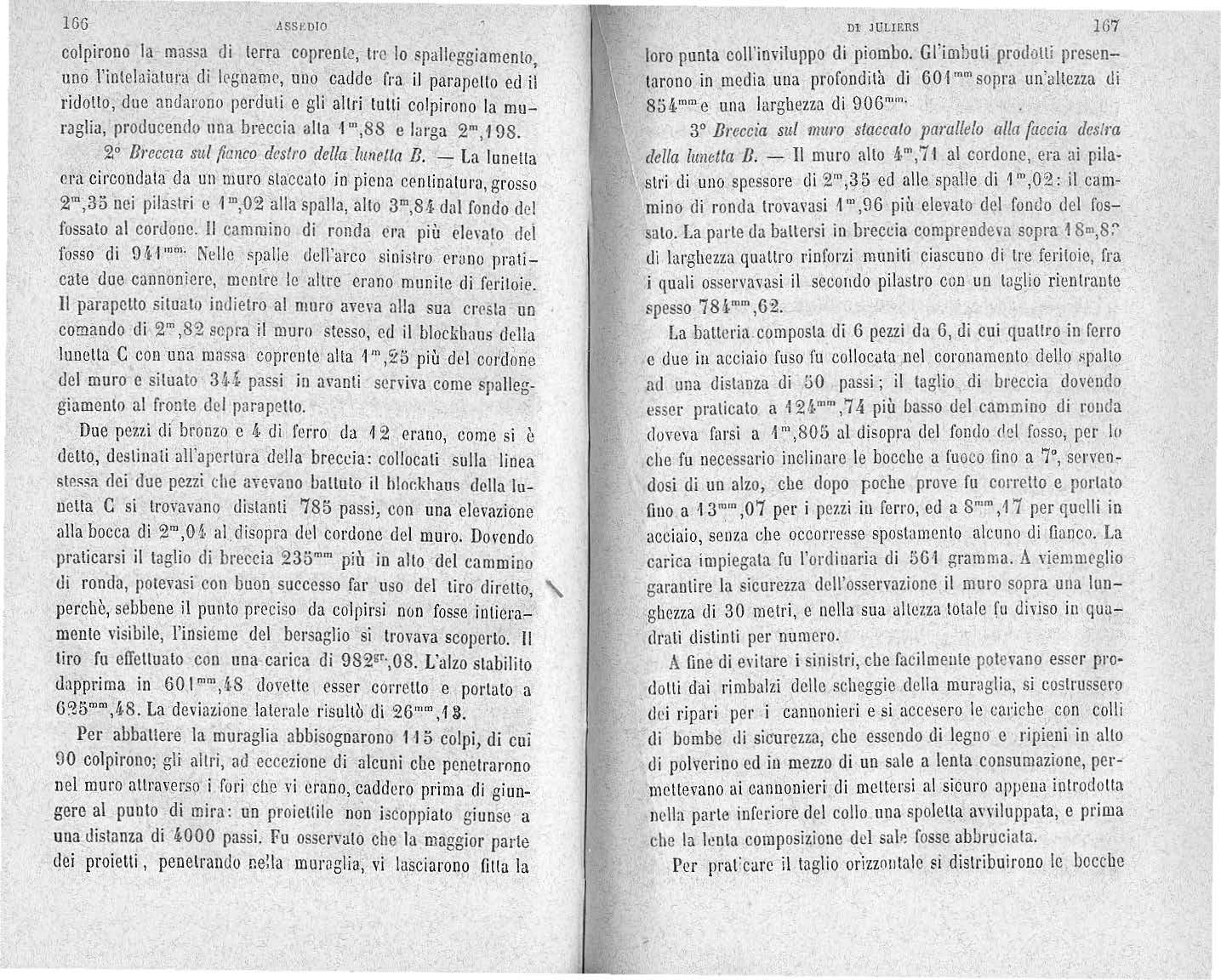
166 ASS l!O IO
Dl JULmns 167
DI
a fuoco sopra 30 qu ad rati : i tre pezzi di deslra cominciarono il tiro rispQUivamenle dai q uadrat_i N° 15, ,1 O, 5, e gli altri di sinistra dai quadràti '1 , 6, ,J ,1: dopo il primo tiro furono tutt i spostal i d'una larghezza, mantenendo il principio di iion allonlaQare i colpi gli uni dagli altri, senza aver rigu ardo alla diversità del . ?alìbro, onde gli imbuti uon si toccassero f/a loro. . Furnno sufficienti 36 colpi a marcare il tag lio; gl'imbuti. risultarono profondi · 54-2"', alt i u2t""' e larghi ·52"'"'- Akmrn aperture si resero ·v~sibili nella terra dopo 72 co lpi: il ~nuro, che dopo 96 .colpi era forato in due pun ti , lo fu sopra sei dopo il -126° colpo: dopo ,J U2 nna parte del muro in sostegno del.,,. l'a r~o rovinò ' fino alla volta: dopo 234, fu completa la mela sinistra della ~reccia, e dopo a ltri 42 colpi l'i nt ie-ra breccia ,fu compita . Si Liraron.o ancora 11 colpi diretti con tr11 il tr onco di J r~ccia e contro i più gross i blocc.bi de[ muro. Di questi 287 colpi ·156 caèldero sul Laglio orizz ontale, 25 sul t ratto verticale sini stro, 42 spi destro, 25 sulla -freccia, compres i quelli che la colpiéono pr i o:ia della rovina de l muro; i rimanenti 15 colpi furono tirati in suppleme11lo sul taglio · orizzontale. · Ottenuli . i .resullati ora accennali e . volendo pro3eg uire i lavor i d'assedio, è evid ente elle faceva mestieri incominciare l'assalto dell e opere avanzate, parlicolarmente delle lunette B e C, essendosi già prati.cata la breccia nel muro staccato e nel fianco destro del la prima, çome pure nel blockbaus della seconda . Per eseguire un tal e assalto, avuto . riguardo alla suppos ta presenza de.Ila guarni gione , bisognava fare l'i pot (tsi seguente, che cioè a questo punto dell'assedio l'urtiglieria della , piazza doveva essere di gran lunga inferiore all'artiglieria del- • l'assediante, le cui batterie, pianta.te sop ra un grande. a rco di cerchio, convergevano simultaneamente contro la cittadella.
Una tale inferiorità. di artiglieria doveva -all resì trattenere l'assediato dall'intrap rendere de ll e sortite, il cqi : esito favorevo le sarebbe grand emente compromesso: s~ a; questa circo--
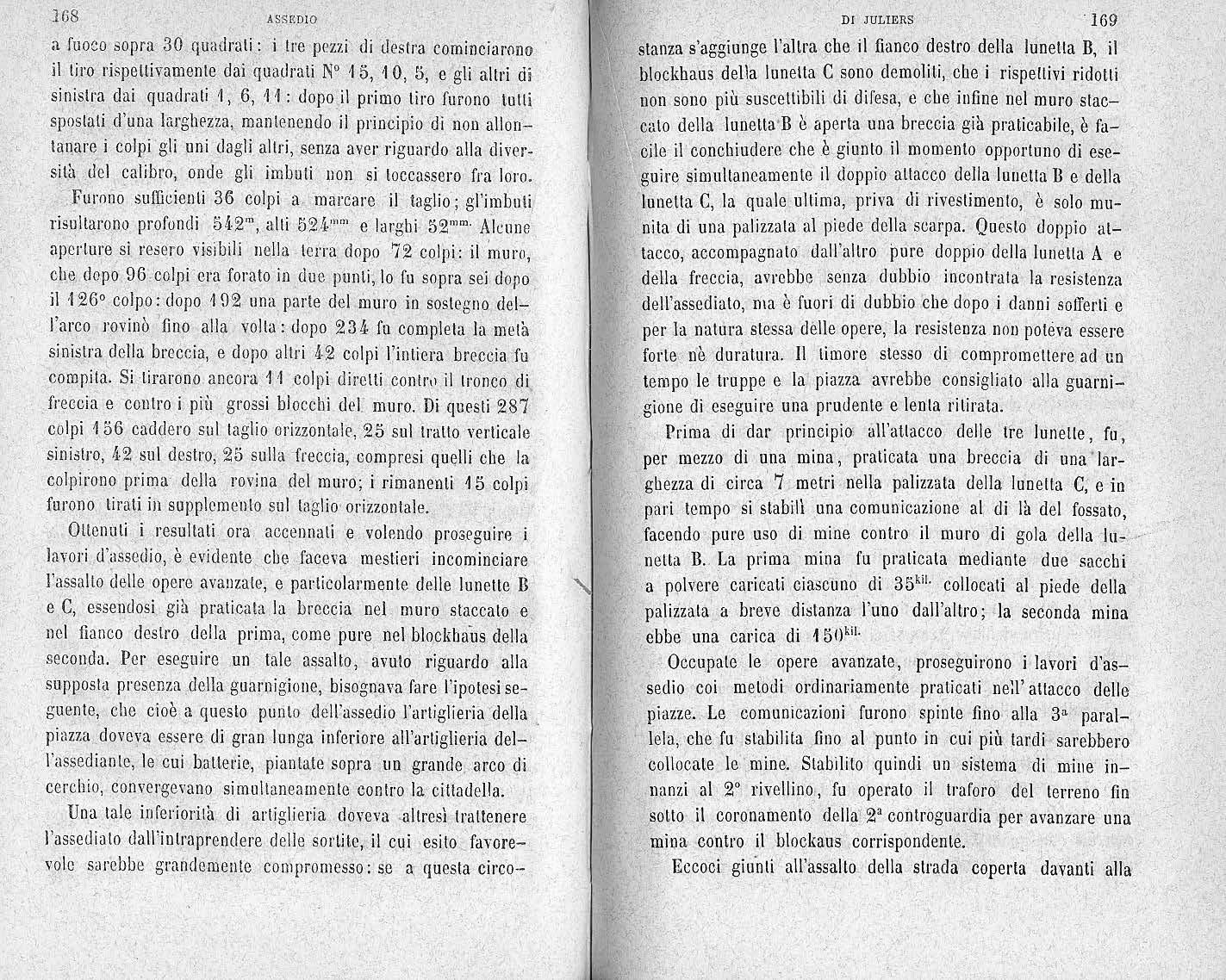
stanza s'aggiunge l'altra che il fianco destro . della lune tt a B, il blockhaus della lunelta C sono demoliti, che i rispe!livi ridotti non sono più susceliibili di difesa, e che' infine nel ·muro staccato della lune~ta·B è ap erta unà breccia già praticab ile, è facile il concbiudere che .è giunto il momento opportuno di eseguire sin;ultaneamente il doppio attaéco della lnuetta B e della Iunella C, la quale ultima , priva di rivestimento, è solo mu- ' nila df · una palizzata al piede dc1la scarpa. Questo doppio altacco, acco~pagnato dall 'alt ro pure doppio della lunetta A e tj ella freccia, avrebbe sen za dubbio incontrata la res isteiiza dell 'assediato, ma è fuori di dubbio che dopo i danni solferlì e per la natura stessa dèlle opere, lil resistenza non poteva essere forte 1fè dural[!ra. Il . limore stesso di• comprom e ttere ad un tempo le truppe e la piazza avrebbe consig li ato ·alla guarnigione di eseguire una prud ente e lenta ritirata.
Prima di dar prinçipio, <1ll'aUaèco delle t re lunetle , fu, p~r mezzo di una mina, ' praticata una breccia di una ' larghezza di circa ' 7 , metri nella palizzata de ll a lune.Il-a C, e in pari tempo si stabilì una comun ic~zione al di là del fossato, _ face ndo pure uso di mine contro il muro di go la della lu::- .,-· netta B.. La prima mioa fu praticata mediante due sacchi -a polvere caricati ciascùno di 35ti1. collocati al piede della palizzata a breve distanza Ì'uno dall'altro; , Ja seéonda mina ebbe· una carica di 15()kil.
Occupale le opere avanzate, proseg uirono i lavori d'assedio ·coi · metodi ordinariamente praticati nea' attacco delle piazze· . Le comunicazioni furono spinte fino, alla 3"- parai-. !eia, che fu stabilita fino al punto in cui più tatd i sarebbero collocale le mine. Stabililo quindi ·un sistema di mfoe iill)anzi al 2~ rivellino , fu operato il traforo de l terrepo fin sotto il coronament'o della" 2a contròguardia pe1~ avan zare una mioa. contro il blockaus corrispondente..
Eccoci giu.nli all'assalto della strada coperta· davanti alla,
168 AS S RDI O
JULIEìRS
2a controguardia e a quello successjvo della stessa contro-· guardia, per i quali è giuocofòrza tenei· calcolo deìl'attitucline , dell'assediato, come se e~li Ì·ealmente esistesse nella piazza. ,Gli assed ianti che . a.vanzanclo dalla paràllela ha\rno da to principio al corouarnenlo, sono ·con tutta probabilità arrestati , dal nemico, il quale non solo occupa una forte posizione nel cammio•--coperto, ina manti ene altresì tenacenicnte le piazze d'armi ed~il -blockaus eretto àl sàliente, sebbene i ridotti delle primé si trovino fuori di ·. statò • di dife sa a causa di un fuoco superiore d'artiglieria. Fu adunque· necessario annientare colle mine il blockam, costruen q_o una gàlleria ohe partendo dal coronamento giungeva .fino ai fondamenti di queJI'opern; per potere trar profitto ùnl , momento dell'esplosione -onde i mpad ronirsi a viva forza della strada coperta, r , stabilirvisi e col fav'òre della· notte operarne il 'coronamento. Tale operazione: avuto sempre riguardo a lla presenza dei difensori, rim4nevà facililata perehè le scoppio della mina àveva prodotto la demolizione del rivellino fiancheggiante, il fos~ato della 2a -controguardia, ed aveva reso imp ossibi.l~ l'impi àntò delle batlerie Iiemiche; pei· sovyappiù le contromine sarebbero impot en ti c.sscndo caduta la controscal'pa del riv,llino. Que·ste circostanzq favorivan.o allamente l'attacco della -za contro, guardia, ed essendo -già praticata. la discesa nel fos.sato della ·fa~cia sinistra del!;ope ra e compito il , passaggio del fossato si stà.hilì su ll a faccia 'sinistra una forte mina capace di aprire la breccia per l'attacco. Su'pppslo riusdlo l'attac00, si costr.uirono delle gallerie nell'interno dell'opera, e mediante queste, si fece saltare il parapello della faccia destra, ·ondé lasciar libcl'o campo alla contr9-batt.eria di rcua ,contro il . fianco del bastione III, che fino a q uestb mon;i ento era mascherato dal paràpetto.
• 4° Pr~sa la 2a controguardia, effetti del tiro sul mùro coprente ( masquant) situata fi'a la controguardia e. i'! 2" nvellino, ·
Questo muro alto •1 m,27 -dal fondo del fossato al c.ordone, con uno spesso1·e di 2m era disposto per ruso. del fucile da raT11paro o fràme·zzato ,d~ nicchie ~lar'gbe \Hd "''.n, profonde 1"' 98 e alte 2"',51. · lÌ cammino di rond a era éleva to , , · sopra; il fonqo dei fossato 'di 1I ~,88, alla quale altezza dove:\iasi praticare il ta glio oriz~ontale. Nel senso ~ell'altezza irmuro fu diviso. in 1 O quadrati, e nel senso de\la largbezza ' in 38, che furono marcati fino al 1 9mo comin ciaoclo dal centro verso le estremità.
La balleria d,i breccia co~posta· di 4, pezzi da 2i\.. CO!l carica cti- ·1 kiL ,87 coh ,elevazione di 26mm e senza alcuno ;pos lam enlo laterale, fu colloèata nel ·coronamento del cammin'o coperto a 1 "',8'.:! ' dinanzi al muro coprente. Jl ,pri•mo pe~o fn p·unt,ato cqntro il _ 13° quadrato, il secondo sul , t't e sul 6°, il terzo su\ 4° eù il quarto sul! 11 °: lutti i pezzi
. v·ennero spostati d'un campo a sinistra in ogni nuova posizione. Il ·muro fu completamei1ie aperto dopo il 5,1 :"' 0 colpo, ma in uù punto so lo: al 76"' 0 colpo lo (u in sette .punti differ e~li. 41 93"' 0 colpo l.a muratura cadde 1~e i primi sette quadrat i sopra la , l'arghezza ili 4"',39 e , l'alt ezz a . di 2"',5'1. Dopo • I ,17 · colp i la breccia fu fatta nelle dirnensioni prefisse; cioè 20m -di " largh ezza, rna non fu rfr aticab il e a causa . di · grossi blocchi di ~uratura cbe _presentavano una grande cÒe, -- siorìe fra ~b . · , . . _ . , ·
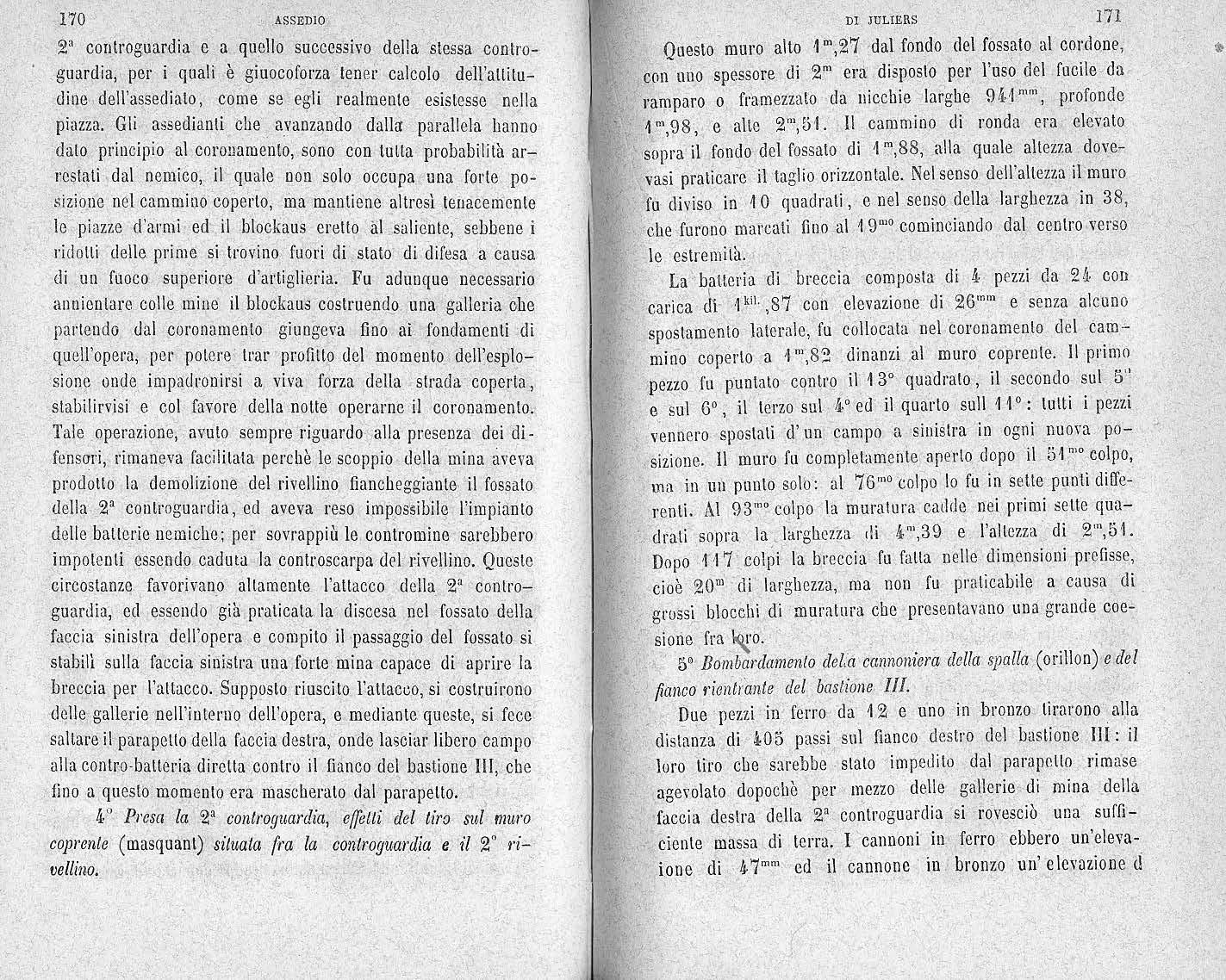
· . ' 5° Bombardamento r]e,lia ca1,1noniera della spalla (orillon) e del fianco rie1itiante del bastione Ill. .
Due ·pezzi in ferro , da 1I 2 e uno in bronzo tirarono alla distanza cli 1105 passi ·snl fianco destro -del bastione III: il loro tìro che sarebbe stato ' impedito daJ parapcllo 1:im ,ise agevolato ·dopocbè per mezzo delle gallerie di mina . del\~ •faccia destra della 2a controguarclia si ro:ve$Ciò una suffìéiente mas.sa . d'i terra. I ·cannoni in ferro ebbero un'elevai_one di . 4, 7mm ed 'il cannone · in bronzo. un' ·e levazione ci
1"70 · .~SSEDIO
DI JULIERS 171
t' I
41 '°"' con ispostamento latera le che variò di 1mm,63 e 3.,;m,26. La carica fu di ·9s2sm. cioè l'ordinaria. La cannoniera fu smontata dopo sellantadue colpi, di coi cinque penetrarono nell'interno, e nove servirono p'er .allargare l'apertura ,già praticala. Conseguiti questi elTetti, la cannoniera· fu riempila di sacchi a terra per una profondità di 2m,50 e mfforzata con graticciate e blindaggio nella sua parte anteriore. Continuossi allora il ·tiro contro la cannoniera che dopò il 1 8° colpo · ebbe gu"aslo il blindaggio sal lato sinistro e rimase completai;nente aperta ' nella parte~superiore.

Il fianco rientra·nte, di un'altezza di 5m·,20 dalla superficie delle ac que "del fossato al cordone, era coperto da una massa di terra alta ·I "',2/S .e munito di due cannoniere, dietro le quali faro.no posti due pezzi di antica costruzione, ' onde esperimentare sovra es~i' i ·danni arr.ecati dallà nuova arti-:glie"ria. La grossezza del moro era di 1 m,56 alle, cannoniere, e di 3m, 7 6 ai pilastri. Sette soli col pi bastarono a danneggiare
completamente .le due cannoniere e ad abbattere la muratura
che le separava; 11u\ladirneno _ i pezzi che vi erano posti in batteria snbirono .lievissimi danni.
·6° Breccia sulla faccia sinistra del bastione, II.I. Caduta la · porzione del muro coprente, situata . fra la faccia sinistra e la batteria 9a 24. destinata ad operare, ebbe princ·ipio l'apertura della breccia sulla faccia. ·
La grossezza del muro non era eguale .alle diverse • altezze e diminuiva fino nl , cordone; all'altezza di 1 m,88 sul livello delle a:cque, alla, quale· era fissato il Ìaglio orizzontale, era di 3m,80. Esiste ndo , posteriormente al muro .tre vòlte, l' una ' all'altra sovrapposte, delle quali l'inferiore era ripiena . di terra e tulle sorrette da grossi pilastri, ne risulla·va che Ìa forza totale che il muro avrebbe òpposto, e che ~nècessitava vincere, ugµagliava sm,20.
La b~1lteria di breccia·ebbe un comando ·d( 7'\113 sopra
la prefissa direzione del taglio orizzontale e fu piazzala alla bre ve distanza di I 33 ·passi. La carica fu di 11<.;i. ,87, l'alzo di 18"'m senza alcano spostamento lateral e. Come erasi praticato nell'apertura delle altre breccie, il muro fu diviso in quadrati numerati e varie furono le posizioni che rispetto ad essi furono ·date ai pezz i componenti la batteria. Senza entrare nei più minuti dellagli di tale operazione, dirèmo solo che 259 colpi bastarono a far cadere la m"uraglia fino al cordone ed il para~ petto, non che le volte situate indi etro; però là breccia non . potè esse re resa praticabile stante il pericolo ·che il proseguimento · .del tiro mlnacciava alla cillà.
Po'sto termine in tal modo alle operazioni per lo stabilimento delle varie breocie, si vollero ancora eseg uire alcuni esper imenti sopra i lavori alla zappa, di cui i seguen ti fn. rono i principali: .
1
° Cannonc9giamenlo su-Ila testa di zappa esegu,ito_ col pezzo da 6 alle dùtanze di 500 e '1 ,000 pass{
~o Distruzion e della batteria d'infilata eretta su1l'alt-ura detta bfersohers -Holten.
·
3° Effetto del tiro eseguito col pezzo da 211 sopra un parapetto di sacchi a terra.
,J O Nel primo esperimento mentre alcuni colpi parziali
· si ebbero effetti grandi ss imi, nèlla totalità dei tiri uon si polè constatare un re sultato soddisfac ent e, "chè anzi, ·si fece ma-· nifes to che i proietti esplosivi in para go ne della palla piena hanno sulle opere di terra una forza mino·re di quel\a. avuta contro le opere in mnratura. Amore di verità obbliga però a soggiungere, che se la posizione della batteria fosse stata più vantaggiosa, l'effetto sare bbe stato ' pit1 deciso.
, 2° I pezz i diretti contro la balleria dell'altura l\:lerscbers
furono collocati a 1,1 5 0 p;ssi e , 1 5m,7o più in basso della balleria da controbattere : cons eg uen temente si trovarono in posizione assai svantaggiosa. La balleria aveva tre cannoniere
172 ASSEDIO
..,
_.._
L DI JULIER S 173
r ivestite interamente di fascine e gi'aticcf; le guancie · erano sostenute da gabbioni ripieni. Due- pezzi if\ ferro da 6sparar.ono contro. la cannoniera dell'estrema destra; ùue in bronzo da 12 contro. la ca1moniera di mezzo, q .due pezzi ' da.. 24 , contro la cannon ie ra di sinistra.
La guancia sinistra e alcuni . ga bbi on i della canno~leÌ'a di · destra furono fortemente d~nneggia ti; tr e gabbioni della cannoniera di me zzo furono 'spostati e la guancia' dritta fortemente dann ~gg iata. La cannoniera sinistra fu ,completamente smontata. F1'.a i . pezzi c~e si erano posti ne.lla .balleria per co;tatare gl i ~JI~tti so es~i prodotti, quello di drittà _ ebbe Sl)ézza,a una ru ota , quello d1 mezzo una ruota danneg gi ata uni-tamente all'asse delle ruote. ' · . - ·
· 3° Nel 5° esperimento si ebbe un risul tato veramente brillante. Il par ~pe'.to, di grossezza cons ide revo le; fu .distrutto per • metà . d_a so li 7 colp i scagliali alla stessa distanza e dalla stessa. posizio ne pre sa. nel precedente· espe riment o. ·
Lo scoppio dei proiettili nell'inteì·no · del, ·parapetto ·ebbe una forza suffi ciente a _ far saltare ·in a,ria all'a ltezza di ci 1:ca 9m un'a . d. r h' b massa I sacc 1 c. e ric addero in un · cerchio di , 30 pa ss i di ra&g10 .
.Tali risultati, cbè in modo più sple ndi do -sono stati confermati negli e~per imenti _ fai.Li nel Belg-io pe1 1 cons tatare qual -s ia-il mig li ore fra i diversi sistemi di cannoni rig at i, attu almente . in uso,. mostra cbe il nuovo pe~zo prus siano ha. un-a g1·aode · precis ion ~ . e non m!nore forza di pe rcussio ne,' sp ecialmente contro, le opere di . muratura; dimod0chè può rit enersi che ne l- ' mome nlò attuale ' ess o pÒssegg a una incontrastabile superìorità sopra ogn i altro ~tale giudizio è avvalorato anche dà Ila facilità e rapidità colle q'uali può aver luogo il maneggio delle bocche a fuoc~ da 6 e da 12. - ·' . · · ·
11 governo prussiano trovando vantacrrrioso il, si ste ma ·· !o , 00 , , ha introdotto nelle fortézze prussiane ~federali; ed attualmente
ne so no _rrua~i compl etamen le provviste le piazze di ·1°, 2° e 3° ordine.
Le balle.rie dell 'artiglieria della guardia e molte batte11ie a piedi sono qu as i completamente provvedu te de l pe~z,o da 12 accorciato pe r fa cilitarne. il trasporto. Il pezzo da 24 non fu adottato per campagna, essendo di difficile trasporto. ·
L'ultimo e definit ivo giud izio ·· 'ap partiene alla guerra: la' sola esperienza su l campo di. battaglia sarà l'ultimo · giudice. Attenden·do che la .guerra pronunzi , gli uomi ni dell' arte faran no plauso al perfezionamento ottenuto nel nuovo s'istema ùi cann oni prussiani, _ la cui supe(·iorità sopra i diversi .sist em i aùo ll ali nell'.u ltim o v9lge r di tempi ùalle varie potenze d'E uropa , preconizzata dagli inventori, e non ismentita da chi ebbe ad esamin arlo, ha avuto non du bbi a co nfe rma nelle ('Speri enze di cui brevemente abbiamo accenna~o.
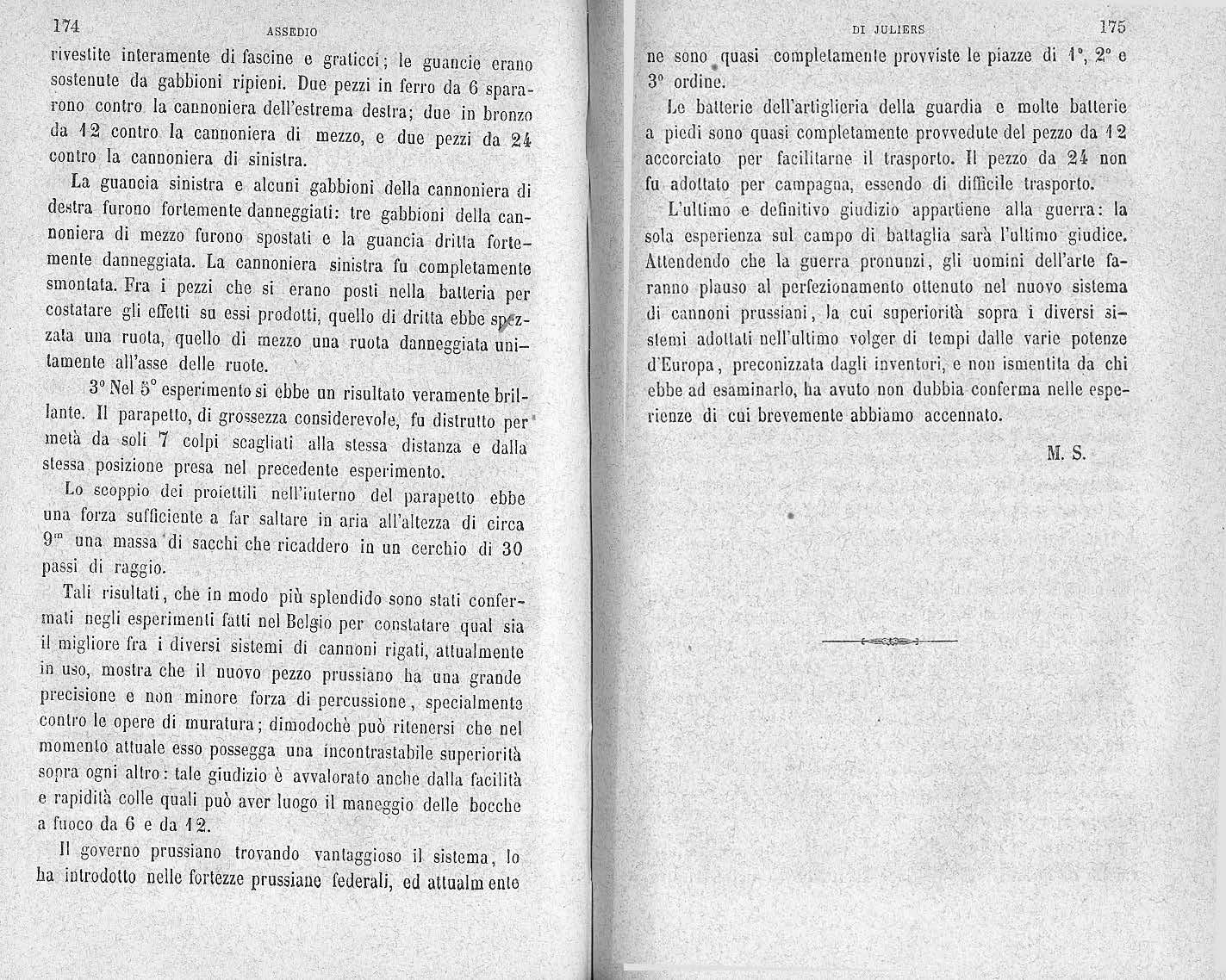
174 .ASSllD!O·
DI JU'LIERS 175
SULLA CAVALLERIA -
IL GENERALE l1ENARD
Decisamente l 'egregio genera! Renard , col suo ultimo libro De la Cavale1'ie, s'è t ir ato addosso una seria procella d i critiche, e fra tutte non è p er c erto l a più moderata e cortese quella di cui siamo per ragionare . P ropriamente, questa è u n a replica agli appunti cli cu i , a vero dire, non fu troppo caritatevole il generale Renard verso il Journal de l' wrniée belge.
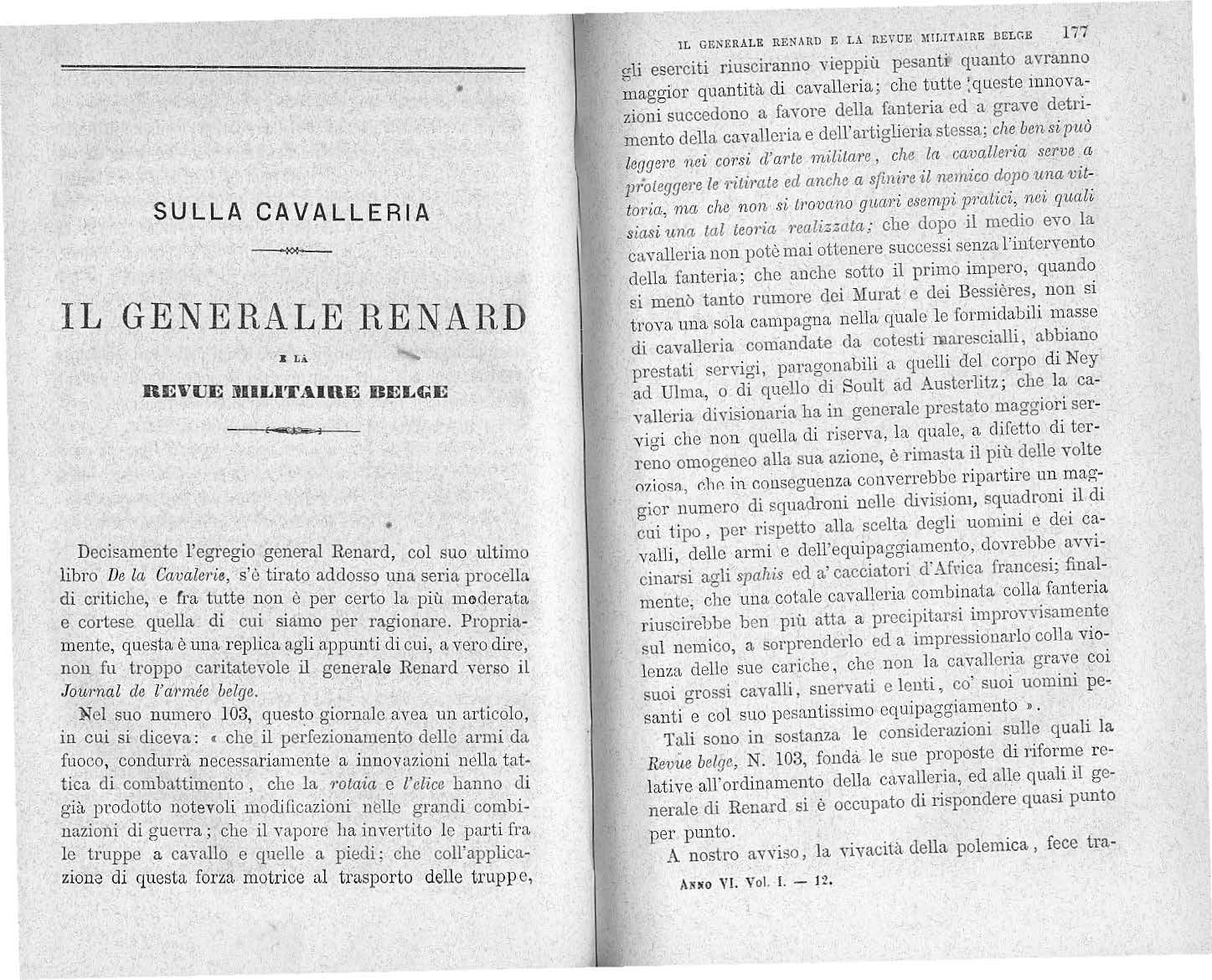
Nel suo numero 103, quest_o giornale avea un a rt ico l o, in cui si diceva : « che il perfezionamento delle armi da fuoco, condurrà n ecessari amente a innovazioni n ella tattica di combattimento , che la rotaia e l'elice hanno di g ià pr od otto note-voli modi!lcazioni nelle grand i combinazioni di guerra; che il vapore ha invertito le })arti fra le truppe a cavallo e quelle a piedi; che coll'applicazione di questa fona motrice al trasporto delle trupp e,
Gli eserciti riusciranno vieppiù pesanti quanto avranno ~ 1 aggior quantità di cavalleria; che tutte :queste i n n ov~zion i succedono a favore della fanteria ed a grave detrimento della cavalleria e dell'artiglieria stessa; che ben sì può leggere nei corsi d' ar te miWa1'e, che la cavalleria serve a JJ;:oleggen le 1·itirate ed anche a sfini1·e ii, ne~nico ~?o u~ia vi~ torici. ma che non si trovcmo giiari esem1n pmlici, nei qi iali siasi ~ma tal, teo1·i-a 1·eali:::;zata,; che dopo il medio evo la cavalleria non potè mai ottenere successi senza l'intervento d ella fanterja ; che anche sotto il primo impero, quand~ si menò tanto rumore dei :Murat e dei Bessières, non s1 trova uria sola campa,gna nella quale l e formidabili masse di cavalleria comandate da cotesti marescialli, abbiano prestati servigi, parag~nabi1i a quelli de~ corpo di Ney ad Ulma o di quello d1 Soult ad Austerhtz; che la cavalleria.. di visionaria ha in generale prestato maggiori servigi che non c1uella di riserva, l a _quale, _a cl_i:etto di terreno omogeneo alla sua azione, è nmasta ~l pn1: d elle volte 01.ios:i, r.h r. in conseguenza converrel)be ripartire u n _r~ag~ gior numero di squadroni nelle divisi~ru , sq~t~drom _11 d1 cui tipo, per rispetto alla scelta degli u ormm e d e1 c~valli, delle arm i e dell 'equipaggiament~, dovrebb~ avvicinarsi arTli spahis ed a' cacciatori d "Afr1ca francesi; fina~mente che una cotal e cavalleri a combi nata colla fante ria riu scii'.ebbe b en più atta a precipita.rsi improvvisame~te sul nemico, a sorprenderlo ed a impressionarlo colla v10~ lenza delle sue cari che , che non la cavall eria grave coi s~oi grossi cavalli, snervati e l ~nti, ~o' suoi uomini pe"' santi e col suo p esanti ssim o equipaggiamento n 'l'ali sono in sostanza le considerazioni sulle quali la Bevùe belgc, N. 103, fonda le sue proposto di r :ifor ~e r elative all'ordinamento della cavalleria, ed alle quah 11 generale di Renard si è occupato di rispondere quasi punto per punto . .
A nostro avviso, la yivacità della polemica, fece fra-
:I Li •
lL GENF.RALB RENARD E LA REVUK Mlf.If,IIRE BELGE 177
Alilio VI. Voi. I. - 12.
scendere ambo i '.htiganti ad. ·esager~zioni, l e qual i inveee di appoggi are fanno sc:apito alla rispettiva tesi'. È ·.senza darci la posa di vo l er moralizzar e , b en po ssiam dil~e che l.e discussioni rµ.ilitari non comportano la.passione, e che quando in esse un o si scosta dalla fr edda ·via della logica e d ella moderazione, - per dare sfogo a' puntigli è d alle sofisti cherie, cade facilment~ n el fiu~ opp osto a quello che volea. r i');ggiungePe, e coteste discussioni non riescono mai :utili, .anzi dannose e screditevoli .·
Non si può rngionev0lm ente contestare al generale Re~ nard l a giusta fa ma ac quistata n ella milihare l etteratura . Le sue Con s'iclm·azioni sulla tcittica della fanteria, in contra~ rono il fav ore di tu,tti i dotti mili t él,ri, ecl"':i.,,. parte alc un e ·inesatte stati stìch!') , di ,poco peso e perd on ab ili ss im e pe1; le g r av i .difficoltà che si hanno ad ottene1·e documeuti pr'ectsi su tal materia; niuno v i ha che non possa chi amare eccell e!;}t.è ed util e cotesto libro ;, e n oi udiam o uo, mi ni distirìtissimi nelle s cienze militari, epperciò g i~dici competeri.tissi rili s ul proposito, class ifical'lo ,quale jl mig liore fra gl i s cr i tti tatti ci di questi ul timi tempi . Non è qu esto, è vero , il lu ogo d i far l'apologia· d i q uesto libro d el g en erale Rena1: d, ' come n eppur n'ha il b i sogno, at.tesochè po chi sono, indubitatarnei1te , -quelli fra i nostri l ettori che n on ne ·cònoscono il pregi o; ma d i. ci ò abbiai:n voluto t occa r e per mvstrar e quantò d isapproviamo l e stiz, zo se e in giuste querimonie còlle quali i i N. 11 8 d ella Revue belge inizia cj_ùella c11i tica alle -11ifles.si01ii sitlla cavallerìw·, d@l ge n erale Rena rd, sçaten andosi fu,ori di ·proposito e troppo tar di ~ontro q uel pri mo l aVcoro d ello st esso g e., nera.le, il qu a}e ci compi aciamo in 'ripeterlo , oggim ai si è meritament e acquistatò un brillant~ ed irremovibile posto n ella l etter.atura milit~re . - Gli appunti si trovan o a tutto .ciò ch'è di mano d'uomo, •ma es~i vogliono essere ·lo gi ci e ragionevqli , e d allora la· discussioùe' e la stessa critica, essendo sens~te ed imparzi al i, rie scono utili !3· co nvenienti. - Uà torni.amo all' a.rgòmeµt; nostro.
P er com.battere l 'opinione di coloro i quaJi, a1;>1iÒggiand osi s ulle _ ultime gue1,re, sdstengono ch e ic.1rno vi meto d.i: cli g uerra· p ongono a discredito la · cavalleriç1, e sp eci almente l a grnve, e ch e per ci ò quest'atma deve trasformarsi negl i eserciti ; il generale Reuard , n ell e su @pri me _ quat tro rifl essioni, cer ca di é om provare con fatti alla manp l'opini on~ contrari a. « La campagna del 1859; egli ·dice, rion è qu ella a1la q1.1ale si debb ono a.ttingere esemp i per fond are d~Ìl e . riforme . .Egli è da, tem po immemorab ile riconosc}uto che q u el teat ro · di g1.terra ·no n è favo~ r e,:ol e . Nè gli tn st r i aci ,, n è g li .alleati contavano, sulla cavalleria per vin cer e, e d i ciò n'è prova l à ,comp osi ziOD estessa de' loro ese rciti : » ov e real mente l à cavalleria fu in deb oli \:,r oporzioni, e sovratutt o la g rav e. « E pperciò, egli prosegue, da u na parte la g uerra d 'Italia nulla potè p rovare cont ro la cavalleri a gr ave , mentre l e potenze bellig ~ranti no n n e hann q i mpi egat o , e ciò di proposi to e ~er sistema, non avendone esse prodo!t o in càmpo se non l a q1.lan tit à r igorosamente indis p ensabil e pei; servi r d i sostegno ag1i squadr oni l eggeri . .D'altronde se è vero che la cctvalleria abbja a ssolutamenté fatto niente in It,alia, s~ per ciò u nÒ de' suo i elen~enti ha potuto essere comp rom esso , qu est'è certame nte fa cavall eria leggera, percl;lè ' essa sola ebb e ad entra;re r,eri amente in azion e_. 1 Questo è un 1~ad ornal e sofism a :.c;] ifat ti, ·se a-ca.giÒne del t erreno la cav alleria l eggera no n cbhe a fare l e sue spl endide prove, che · avrebi)e ma.i potuto in i denti che condizioni topògrafi.che e tattiche ' la grave , ,,tta solo al compatto squadroneggiare? E qu est_o ,sofisma non p ensò di r ilf)vare direttamente. il critico .della Revuq 13e lge, ma volle inve ce · incocciarsi a sosteneré, ch e i pochi successi d ella cav alleri a in quella cam pa gna s~ clenno\mi camen:te 'accagionare alla s.ua d eficienz a num.eTic ~, proveniente dalla d i fficoltà. di traspoTto, per· 1·o taia od elice .
Il g enerale Re1~arc1 ( passartdo -in revista le cavalleri e ·

178 IL GEN-E RALE R F.NARD
E LA RÉ l 'UE :Yllj:, l TA l R E BE L(;E , 179
de' varii €S:er citi europei, viene a concbiudere che dappoi le u ltime guerre 'di Crimea e d'Italia, l 'arma a cavallo 'ben l ungi dal decrescere a u mentò dapper t utto e specialmei:ite la gra,;e. « S i pretendeva, egli d i ce nella sua 4a riflessione, che la cavalleria avesse perdut o il suo prestigio, che è forz ~ \ perciò diminuirla CQnsiderevoln;1ente, ·ed in particolare la grave., -che le nuove armi hanno resa completamente impotente . Mi parve allora, che se cotale necessità era reale, se l a sp erienza era stata de cisiva, sarebbesi pur t rovato , . in Europa, . almep.o una potenza, , la quale, riorganizzançlo il s u o esercito, ;:i,vrebbe tenuto conto di questi principii che ci si presenta:q.o . quali i ncontestabili, , e l i ~,rel;>l:i,e con~ cr etati ....... P uò forse credersi che gli s t't.lti ..maggiori di queste na7,ioni', parec ch i de' quali annoverano illustri e sperimen tati generali, siano rimasti ciechi fino a questo p u nto e ch'.essi abbiano a.spettato, per intravedere la luce , le lezioni che si preten de d i dar lo r o? »
Nella su a rev i sta statistica delle cava.llerie europee il gcncrn.lc Rcnard, apprezz;,µdo la cos~ a ll 'i n grosso, commise ·alcune inesattezze assai _ sensibili , ' Che il capitano
Van dens anden si occupò n;iol to minuiiosameute di ril evare nella R evue stessa (v~di R-ivistci ilfilitcwe , an no v, voé lume 1v, pag . 336 e seg .), ed$ certo da t ali inesattezze ch'egli fu indottò a conchiud ere che presso varii !3sercit i si accrebbe l e!, .cavalleria grave, ciò che renlmente non fu', Quèst' esag·erazionf? non togì ie però forza al vero argorgcuto , mentre se non si accrebbe,nepp ur s'è diminuita queshsma,. . n g en eral e pvodiga p oi unà quan tità di esempi storici d'ogni tempo per addi rnostrare l'efiìcacia' della cavalleri a n elle varie ci r c0stanze di gug rré!,; _ e vera.mente., a, parte il p iacere ch e provannu0 in leggete così'rnaestrevoltnente ricordati i più brillan t i episodii della cavaller i a, nq i crediamo che l'egregi o general e s'affaticò sovverchi amente ·per redargutre asserzion i futilissi ril!; e d i loro natura in ~ sti'ssi stenti, siccoi11e quella che l'i1 tilità clella cavallerict la
p.1·eclicano . i trattali, m,a non se 1ie pon.no trovo,re es~mpi p1·atici. . . .
Per .poclii libri d i guerre che s' abbum.o let ti, ~h1 non r i corda a volo di niente molti ·esempi a confntaz1one d1 · sì er,ronea asserzione'?

Ben e sta, che la cavalleria sia un'ar ma seconda.ria, e difatti essa non, pensò di contestare il prJrnat o. a11a f~nteria negli eserciti rnoderni ; bene sta, che ella non possa operar grandi cose l',_;enza l'appogg i o ~~lla fanterìa e de1l'artigheria; ma. che ,quest'arma non alJb1~ essa p u re 1~ sue gesta da meritarnénte vant ar~, che _ dm temp1 fe~1çlaJ~ acl oa'o-i sia stata in continua decadenza, che tanto nei Ob l 11' . temp i antichi ,· quant.o nei moderni, ed anc 1e _ne . evo medio, essa non abbia guarì ottenuto sei'ii successi, questo è quanto ci pare impossibi le s~as i P?tu~o- scrivere cl~ tiri sei·i o militare, ci pare imp ossibile che s1 possano cosi negare i fatti più patenti della storia: . · . ·.. ·
In , quanto po i alb quistione dibattuta fra 11 genenale Renard e l'tn011imo scrit to r e della R1v1u•, Belge, sulla formaztorìe d i grosi i ' corpi cli cavaJle'.ria, sulhL cavu.llcria. cH-:visionaria, ovvero sia sulle , proporzioni fra la cavallena pesa1ite e . Ìa leggera, questa è tr9p_po gra~e question e, nè anche ben maturata, perchè noi azzardiamo . un g1qdizio assoluto . I n senso relativo daremo r agione id ambidue i litigant i i n quest o sel').so; che trattandosi d i gr ossa guerr a: in conttade apf!rtè , convien for ma r alct:11 cor~o . ò i cavalleria per grossi colp i di mano; mentr e mvece 1~ ·còntrade fras t agliate · , e tr attandosi d i p i cc~la guer ra, d1
· -011eràzioni d istaccate, non occo~ronçi i gros_si corpi_ ~i cavalleria, e conv ien meglio aJfor zarne l e srngol e dw1sioni . Così, appò noi, qualunque gue r ra si èombatta , ·i . grossi ·corpi di ,cavalle~·ia non trovete?be~·o . mai liberi c ampi per 1,t lor o azjone comp~tta ,e mass1cc1a_, ~1.ent~e il servizio dellà cavalleria d i visi onaria è efficac1ss1mo 111 ogn\ èircostanza-. Nelle vaste pianure delfEui:opa centrale,
180 IL GEls&JU L E RENA RD
• )I L J). R EVUE MI LITA IRE BÈLGE _ J8 1
lt GEiiRA LE RE~ÀAn
invece, sui vasti campi di Lipsia, di Wagram e clj Eylau1 i gi:auèli cor:pi d i cavalleria so-no tuttora i ndispensabil i ' . \ Qome mostrarono d1. esserlo nelle gùerre passa.te. '
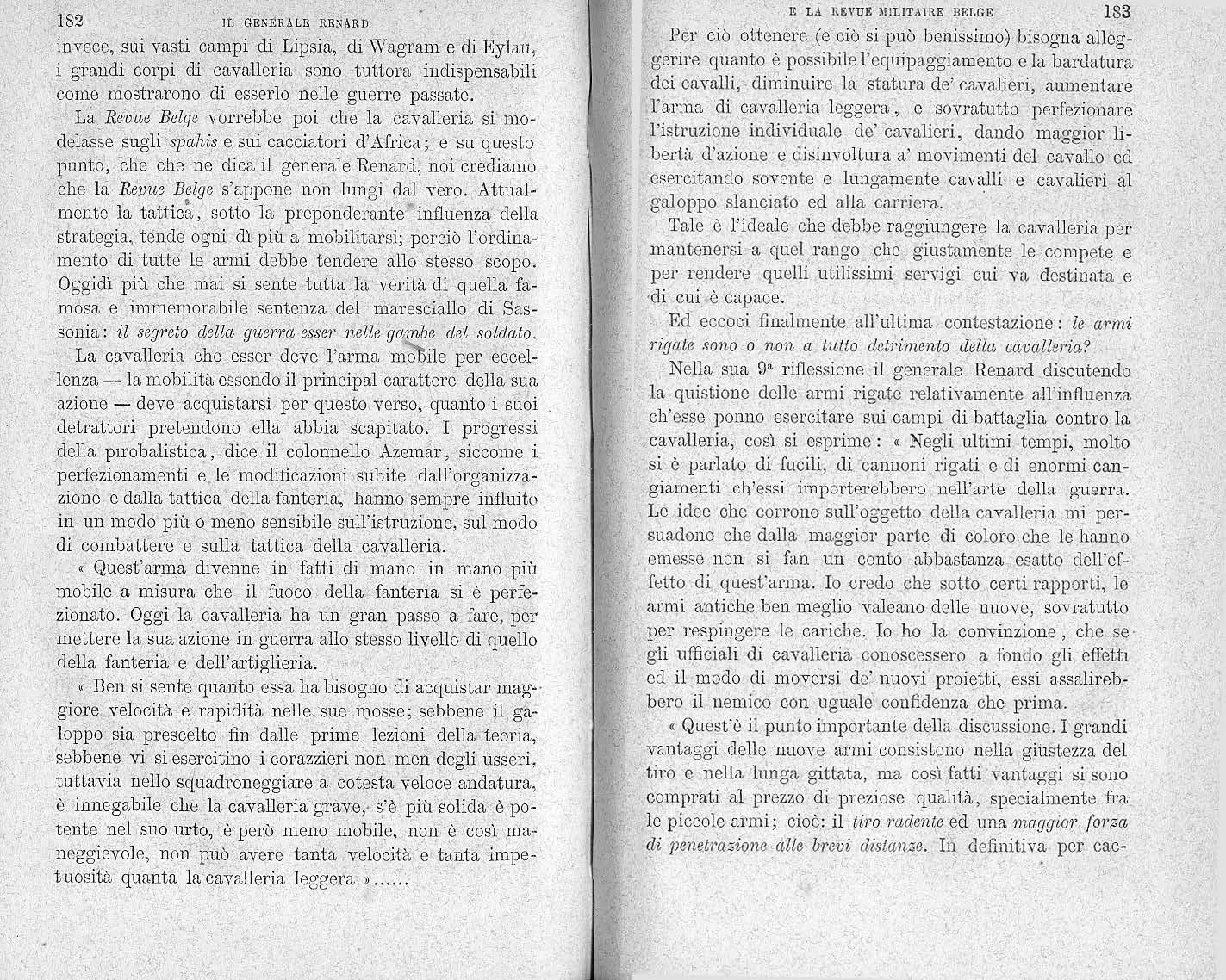
· La _ Rwviie Belge vorrebbe poi ch e la cav alleria si mod elas ~e sugl i szJahis e s ui cacciatorj cl' Africa; e su questo punto, -che che ·ne dica il general e Rena1·d, noi' crediamo ch.e la Rem w B: lge s'appone non lungi' dal vero, Attùalmente la t attica, sotto la prepoud eranté influenza della strategia,. t énd~ ogni qì più a mobilitarsi; per ciò Ì' ordina·mento di tutte l E\ armi debbe ten d ere à l10 stesso scopo. · Ogg idì più che mai si sente tutta. l a v erità di quella· famosa e immemorabile sentenza del 1narésciallo di Sasso n ia : il segi·eto della giwrra essm· n elle gamb; del soldato. La cavalleria che esser dev e l'arma m~ ile per eccellenza-;- la mobilità essendo il princi pal ca_rattere d ~lla sua azi one. dev,e ·acq\,listarsi per questo verso, quan to i •sh~i c}etrattoii pret enddno ella abl).ia ·scapitato. I progtessi della pirobalistica, d ice il col onnello Azemar, sicco'me i perf~zio~amenti e . le modificazi oni subite ,dall'organizzaz1one e dalla tattica .d ella fanteria, harn;10 sempre i nfluito in un modo più o meno sensibile s uU'istru i ione, sui modo d i co mbattere e sulla tatti@a de)la cavalleria.
• Quest'~rm,à div.enne in fey,iti .di 'mano in mano p iù mobil~ a misura che il fuoco della fanter i a si è pe;fo. zìbnato . Qggi l a èaval,eria ha un gran passo a far~, per mettere la sua azione in guerra ano stesso IiveHò di quello de1la fanteria e dell'ar,tiglieri a . · ' .
.
• Ben ·si sente quanto essa ha b isogno di .acquistar maw ·
- f$'1•re velocità ,e rapi di tà n elle sue ~osse; sebbene il , galoppo sia prescelto fia dalle pri me leziioni della teoria sebbene vi si esercitino i corazzieri rÌo n ~en degli uss eri'. tuttavia nello sqtiadròneggia,re a cotesta veloce andatura, è innegabile che la cavalleri a g r a,v,e, • ~'è più solida è, potente nel ,suo urto , è però men o mobile. non •è cos't rnan eggievole, non l)Uò ' av ere tanta velo ~'ità e tanta impet u?silà quanta la cavalleria leggera » ,. ,. • ; · '
P_er ci ò ott<mero (e ciò si può benissimo) bisogna alleggerire guai1to possibile l' eq uip aggiamen.to e la bardatura dei cavalli, , d iminuire 1a · statu.ra d e' cav alieri, aument are l'arm a 'di cav alleria l eggera, e sovratutto perfezionare l 'i struzi one indi viduale d e' cavalièri, dando maggior libertà d 'azione e disinvo ltura a' mo vimenti d el cavàlio ed e ser citando sovente e lungam ente cavalli e cavalieri al galoppo slanci~-to ed a lla carriera. ·
Tale è l'.i deale che debb e raggiunger~ la. cav all eria p èr mantenersi ·.a quel rango che g iu stamente le compete e per r~ndere quelli u ti lissim i ser v i g i cu i va d estinata e •çli cui è éap ac e .
E d eccoci finalmente all'ul tima con testazione : le rormi ri,gate sono o n on a tutto detrim,ento della cavaUerù1,'r
Nella sua 9~ r iflessione il generale R ep.ard discutendo la quistionc delle armi ri gate relativamènte all'iniluenza ch ' esse ponno es ercitare sui campi di battag lia contro la cavalleria, così si esprim e : « Negli u ltimi tempi , molto si è parl ato di fu cili, di cannoni rigd.ti e di enormi cangia1:1enti ch' ess i importerebb ero nell 'ar te della guerr a .
Le 1clee che corrono s ull'oggetto d ella caYaller ia m i persuadono che dalla m aggior p arte d.i coloro che le hanno emesse non si f an un conto abbastanza esatto cfoll'e ffetto di que st'arma . Io credo che sotto certi rap •)o r ti le armi antiche ben m eglio va.leano d elle n uo ve, so~rrat~tto per respingere l e cari che . Io ho l a convinzion e, che se. g li :1fficiali di cav alleria conoscess ero a fondo gli effetti ed 11 modo di moversi d e' nuovi proiet ti·, essi a ssalir ebbero il n e mi co co n u g ual e con fid enza che prima.
« Qu est'è il pun t o i'mportante della di scussione . I·grandi v,antaggi delle nuov,e armi consiston o n ella g iust ezza- del tiro e n ella lunga g i ttata , ma così fatti vantaggi ·si so no comprati al prezzo di pr eziose qu alità, specia.linen te fra le picco le armi; cioè : il ii1·0 rctdente ed una m aggior forza cli penetta;:;ione cille bi·evi distanze . In definitiva per cac-
}82
E LA. RE VUE l!ILIT,IIRE BELGE }$3
ciare il nemic0 da una posizion~, è ' pqr necessario di finir col camminare su di lui per prenderlo corpo a corpo, . s'ei non, cetle;. egli è dunque pèl momento èlecisi:vo, pell'istante dell'urto, che importa di possedere. i mezzi di res istenza e di distruzione i . più formidabili,. Perciò si dovrà forse tornar indietro? No certaniente, e . ne dirò fra poco 1~ ragione . Ma no n debb~si• csage1:are il periglio, 'nè i rùmaginarsi perciò che le gittate t6plicarono e che le probabilità di ' colpire i bersagli di , un p oligono _sian~ 'accresciute Ìn r agfone delle gittate, che u n esercito s1 p otrà mietere in poche ore, come farebbe un; mietitore delle spiGhe di un campo . · • .
« L e cose. c'0sì non succedono i n guerra, e la prat1c~ donne soit'vent cle 'Olwisants souffiets .à la thé01·ie » • E1qui pti· comprova.i'e_' ch(/le armi rigate ~ono meno micidiali che le antiche a pàreti liscie, il generale Renar~ riporta dal. l'opuscolo die Ccl!vaUerie der Jet~tzeit, le proporzioni delle . perdite subite nelle guerre dell'impero e di quelle dell:ul_tirna guerra d'Italia, ove sebbene si siano usat0 armi n~ ga,te , le perdite furono inferior~ (Vedi . R i'~ùt~ iìfili~wre Jt alia_na, anno v, vol. 1v) . Egli cerca qumd1 d1 spiega.re tal e fenomeno colle segu:enti ragioni :
1° Anche l 'arm a :r:igata è di'troppo delicato e difficile maneggio; , , .
2° La sua traiettori a è elevatis,si,ma, ed a ll e granch distanze il proi ett o si fitca e Jo ,spazio pericolos,a ri<luc es i a qualche metro'; ,
pel fucile rigato; il soldato è sogge tto alle stesse 'Variazioni.
La t?·ciiettoria è anc01·c1, abbastanzc1, elevatci perchè un fante ed anche wn w valie1·e cwricando inclinato sul sw> cavallo, nulla abbiano a temere essendo a rnetà di tale distanza-, se l'arma rimane orizzontale.
E l 'egregio generale è quindi indotto a conch i uclere, che le a.rmi rigate non sarebbero di vertm' efficacia se non se -nel combattimento alla spicciolata, mentre in linea i lor• effetti sarebbero di gran lunga inferiori a ·quelli dell e, a.rmi a pareti liscie.... I
Ne siam dispiacentissim i, ma qui il generale è incors o in madornali errori , ch e violano i principii più elemen ~ tari della pirobalistia a. Questi errori si studiò in parte di rilevare in un 2° articolo del N. 118 della Rewe Belge (l);
. La propri età fondamentale d elJe armi ri g~t:, ~ropr~età fatta oramai in contestabile da numerose e svanatiss nue sperienze, si è q u esta appunto, éhe il g~nerale Rcn~rd vuole disconoscere, che le a1-nii rigate abbu11no ~ma t1rawttoria mollo più tesa, eppeniò radente, che non le m·mi liscie ço1·rispondenti, e che i prnielli di qv,dle impi/>,gan,o molto maggim: tempo a prendere la lo1·0 velocità iniziale , ed in , c~nseg~nza la loro (o1'Za di penetmzione. Ciò ammettendo, cadono di per sè tut t e le altre erronee asserzio ni del generale Renarcl, le quali non sono che un corpllario d el suo primo e capitale p aradosso . -
·
3° IJ -soldato, servendosi deH'alzo, non può pnntarespeditamente-e facilmente, egli è continuamente preoccupato n ell' indqyinare le g ittate ed a combin ~,rle co_lle grada;lioni dell'alzo e colle altezze del punto 1mberc1ato per ogni distanza » • Ciò che non. è troppo facile d i o~tenere · nell'emozione de l combattimento, tra la p olvere e 11 fumo delle battaglie . ,

' 40 Al di qua del punto in bianco, (issato ', n 250 passi
È b ensì vero, che l'alzo è incomodo ne' fuochi in rigà, nè crediamo che in tali casi s'impiegherà mai, a meno che dietro a' parapetti ; esso .. è però j ncontestabilmente utilissimo p e' tiTi aggiustati de' cacciatori e de ' b e rsaglieri, 'ed ogni qualvolta il soldato può tra.nqui~lam ente imberci are l 'arm·a sua. ·
È pur vero, ch'è un grave inconveniente pe' soldati quello di non poter sempre punta.re nel purito stesso che ' .
184 IL G!\NERALE REN A;<D
l . ' E LA RJ\VUE MILITAl!lR DELGE HScJ
·
(1) Quclques obsc,,valiO)l~ su~ la reficxion 9e du généra l ficnard cn cc qni conccrncnt rinfa ntcric, par un officicr dc celte arrr~c.
GENJ;;RALE REN,\ll,1) vuo l colpire, e · clH-} eiò è difficiliss1rt10 a potersi os,'jervare nel calore dèlla mischia, nel frastuono de-lla battaglia; rn a fo r sechè ciò non succeàeva anche pe' fucili lisci, ed anche in peggiori condizioni 'I
In quanto p oi all a J?laggiore o mino1· pen etrazi one dei p1'oiett1, è ' questa un?, q1..i.stione etèmentare della piroba. listi ca 6gginiai esperimental rnen te risolta, che ci oè s ino a 40m la forza .di penetrazione . del proietto sl anciato da . iin f1,1.cil e rigato è al qùanto minore di quello sl anciato da un fucile a ·pareti_ liscie di ugu~ calibro e . con carica relativamente maggiore ; indi Ìn po i , :ri10 n tre l a fqr za d i penetrazione ' del secondo decresce rapid::m1~nte è div i ene affatto nulla pri ma dei GOOm, quella dell'altro si .mm;,; tiene invece se nsibilissima sino oltre 1OOOm. -
Ciò non poteva per certo disso noscere i l geµerale Renard, epperciò ·non ·sappiamo spiegarci come 'egli abbia p otuto sostenere il contrari o. VoPrebb'egli forse crede1°e per an'nn ettere , cl~e prima de i A Om il proi ett o del fucile rigato non abbia bastante efficacia micid ial~ come l a pa.lla del fm:ile anLic.;o? A 3~m, egli d i ue aYl:}1' veùulu,irperie,nze ' nelle quali l a paUa ant ica p·erforava una cora7,:za,, mentre il nuov9 proietto non fece ch;e ar.nmaccarlà (la faiisse1°).
· Nòn vogliamo sieuramente porr e in dubbi o una sì èàtegorica as~erzì one dell'illu stre scrittore; ma egli però ci voTrà permettere di osservargli, Ghe anche n oi avendo assistit o a consimili sperièrize , veden?JllO a 65 passi d i di_r,tanza l a c orazza del coraz,zi ere ',francese perforata dal proietto oggi usato dalla nostra fanter i a, c osicÒbè la invocatissima nia:ssima . dèl generale Tro.chu i:i'otrà, ~ercè ··de' fucili rigati, con. maggiore ed incontestalJile utiliti modi ficarsi n elléli seguente : contro alle w1°iche cli ca"IJalleria sr!rb~i~ il voslr; fuoco sino a 65 ,po,ssi, poi c1°ocia,le lct 'baionetta. - ' Qui porrem fine al1e nostre osse.rvazioni intorno a' capi tali liti gi del ge~erale Renard- colla Rd;u,e Belge, -seb.ber1e e l ' uno e l'alt r~ ci presentino ancora molti altri punti
a discussion e . Era nostro scopo d i {ar risaltare qu esta
, conclusione : ché , cioè , malgrado gli incontestabili e . prodigi9si perfeziona:nrenti delle armi da fuoco , e dei conseguenti progressi d ella tattica, la cavalleria è tuttavia un'ar ma essenzialissima ed indis pensabile per ottenere decisivi e compl eti successi; ed è suscettibilissima dì que' p erfezionamenti che l a ponno alzare al livello delle altre armi, e ch'essa ben v~le.

Nella nostra cavalleria àbliiamo uffiziali capacissimi, appq,ssionati dell'arma loro , intraprendenti e caldi d'amor patri o, a quelli ci rivolgiamo .. . . Noi siamo convinti che nella prossima prova, a ' gloriosi ricordi di Past,r engo ,Goito e Moutebello ne vedremo aggiunti de' nuovi, e l a çavaUei:ia italiana s'avrti, quella giusta fama cui ha dirìtto e valore.
Tori l'.).o, 12 · agosto 1861 .
186
li
E LA' !.EYtJE MlL1 1 AlllJi: DE LG È lì:),
X.
RIVISTA TECfJOLOGICA

Dal carosell o, la famig lia r&ale s i portò immediataruenie al poligono , ove clo,·eano effettuarsi non più semplici prove e spe riooze, ma b e nsì t iri su cc essivi a gra ucli d istanze , al l'oggetto dì comprovara il merito d e l sistema adottato nel Be lgio pe r la tras fo t'lna:r.ione dell ' artigli eria d'a ssedio e di ca mpag na. La prova riuscì conchiudente, de,:isiva; es, a venne falla in campo ape rto e pubblicamente . Più non Sllss isto no o ra mai misteç~ n è alcuna sp<-1cie di segret i ìntnmo ai ca n n o ni ri ga ti sia nel m ecc ani ,;m o de lla culatta, s ia n ella mano vra. del pez zo, neppur no' proi f:ltt i, i quali s i passa van o dalle mani alle mani di tutti. Tu tt i po t erono raccog li e r e e serbarsene delle scheggie... .
Il tiro ve nne eseguito da quat tro pezzi da campagna da 6 di acciaio e da due pezzi d'assed io da· 12 dì bronzo.
I pe zzi da campo son o d i nu ova costruzione; quelli d'as,sediy's o n o pezzi trasfo rmati.
I sei p ezz i sono stabili.ti su paiuoli, a liv ell o d e l suolo, pe1 rezzi da c.ampo, e d in ba r b e t ta per qni::l li d ' assedio .
ITALIA. ~- Spcri~ento mil ita re sulla luce elettrica, _ In Alessanina, ai fort1 arn?zati della Bormida, si fecero, n a lla n o tte del 2v co rren te,_ alcuni esp e rim ent i relativ i a ll 'app li c azi one dalla . luce elellnca a1 . segnali di gm.>rra . Questo t e ntativo è c ?~ì 1rnportanle pE-_r I~ r e l11zioni notturne, ' che si p osson o stabilire n_e lle operaz10~1 a cui partecipassero ad un t e mpo i corpi terres! rr e le fo rze d1 m a r e. D iresse i lav ori il t enen te-co lon~ ello R iccardi, alla presen za dal comandante la divisione militare gene rale Ca rd ~rina co l su o stato m aggio r e, e d e l colonnello ~ esce t~o, _ sov r a1~tendente della divisione locale del genio, e d eg li ,uffic1ali addetti alla m edes ima.
B~LGIO - Cannoni r igati . - N e l l'u lti mo numero de lla R ivista, accennammo le spe1ieoze fatte su cannoni ri"ali bel" i a B rassch aet, i n attesa di quell e su maggior scal a ~h e s i a 0 '. weano attuare, e il furono a l campo di Beverloo in presenza <li -S. M_. Belga. In to:no a qt1 est' ult ime togliamu i segi:.enti parti.colan da una cornspondenza de!l'Indépendance.
L a mano v ra è fatta da gli inse rv ienti delle batterie senza dis t i nzioni·; l e funzioni di puntato re, cb e i rego l ame n ti asse~ gnano a' cannonieri di prima ·classe o a brigadieri , son o di~'i.mp egn ate da' sott'uf!h.iali an zia ni.
Cer tamente, i pezzi da campo non sono d estinati ad essere sparati su' paiuo li , e i sott'uffiz iali scelti non deb bono atte ndere tJ,' dove ri di semplici s o ldati; ma quando si voglior.o constatare le qual-ità di un'arma, n o n la s i deve essa forse prova~e nelle migliori c o nd i zioni passi bil i di tiro? Niuno ebbe a crit icar e come a l recente con co rso d i T 1Hvee re o si s iano p rovate le armi al cava ll etto per feziona t o , p e r mano de' più riput at i tirato ri ? Amme lt iamo a,Junque che i nuov i can non i siansi sp:irat i al cavall e tto. Ec co tuito ciò che si potrà d ire sulle dispo s izioni di quC!sta mane.
Il periruet , o della batteria, su di un r istrettissimo spazio, , •enne c i~cuito di u na barri e ra ad a l tezza d'appogg io . N ell' int ern o, s0li vi furono ammessi i ge n e r a li colla rea l fami gl ia, che uoa Ira versa presP.rvava da og ni accidente prévis t o od imprevisto. D ietro l a barriera eraYi libero accesrn per tutti, e per t utti facil ità grandiss i ma di osserv are ogni op erazione del t;ro.
RIHSTA TECNOLOGICA 189
, I nuovi pe zzi si manovrano fa<,i l men te e c eleremente, sebben'e, a m io avv iso, s i a vi forse mag gior celerità ' nell' anlico modo di ca r icare : Un u 0mo _ solo col loca e spo~ta, senza ,fati ca, la culatta mob il e; due uomì nì scovolano a due riprese e , c on tutta cura; ·i I p r oietto qo lla sua carica vien posto a l luogo. co n una sempliqe pressione di mano. Ecco pe r la manovra. _ , ·
11 . ri nç:ullo è sens i bi le assai. - Non è forse ·questa una ' prova dell \l maggior forza di prooi s:5:rne.? _ (Il cor'l·i spo*lente dell' Iu dépendancè vnco?·re qMi ovviamente in gra'l)e errore) .
In ,quanto a' ris ultati, n el momento '"'in cui chiudo questa lettera, essi n on sono stati per anche ri levati colpo per colpo, ma bo p o tuto constatarli nel l oro ins ieme: Il t iro si effettuò alle t r~ dis tanze di 8QO<l1 , 2, 1 00"• e , 3,00Qm . Si principiò dalle dis l iJ,,nze minori , in ragione d i otto colpi per pezzo ad ogni distanza. Il fooco dei pezzi da campo v enne diret~o a bersagli, i quali ·forcino ridotti ami norsellati; il · fuoco dei pe zz i di assedio avea per iss:opo di distruggere una batteria a due è ~ nn9niere, , itveuti perci ò un merlone e due semi -merlo ni. Die tro le cannoniere si erano r appresentati i canno ni pel' mezzo di favole. '
Ques ti cannoni vennero triti , i l nier\o ne perforato ed i due semi~merloni scoinparv(;'~O . ' ~ utti i 1rn;>ietti fecero ,esp l0sione e le -loro_. sdieggie to cca rono tutt~ lo scopo .
P /ja~a di l asciare la batteria, S. M si co!l~cò su' p,\ iuol i per fa r caricare, puntare e sparare sottò i suo i propriì oCchi.
Il tiro en. finito a n:ézzo giorno .
Ques t i sono per certo pa.rl i cola ri J:!OCO precis i , . ma sono finora i soli che· potémmo r accog li e r e intorno alle in teressanti sper ienze d i Beverloo. ·
·EGIT TO .. Nuova specie dì c~innoniera egiziana . - La darsena ' di T o l9ne posse.leva, pochi giormi Ol' sono, un picco l o legno di forma cu{iosissima e nuova. aff.:1110 còstrùtto a Bordeaux , nei c·an t ieri -Ax~q:ian , ed appartenente ~l ; ice -re di Eg itto . . ,.
' La sua lunghezza è di 42m; l a làrghe~za· 7r1 ,50; i l suo pe • scare med io è d i 2"' ,40 · ·
La sua · fon'na non è' facile · a descri"ver s i ; quasi · dircùbes i
du~ navi l'u1la entro l'altra . · L ' este rn a è. acuta a'· due cap i, a poppa e a ' prora, e rassomig1ia ad un fuso. La nave i r'.terna invece ha delle (orme anotondite . Essa è c?mpost a d i. due Inezze torri r i uuite da unà semplice parete.
Que~t e d ue t orri r ~cchi.u dono tu tta l'a rtiglieria def bast i'ment~. Quella di prora è acma '. a di 2 pezzi d'.acciaio , da 24. rigat i ·wfasciati; quel la di poppà ne po rta un solo.
• .., .Lè - t orri siccome il guscio della nave sono corazzate ai . l as_tre di ferro d i 10 -éentiroet r i di spessore; il peso di tal e corazzamento è d i 1 30 tonne llate .
Lè forme strane e bizzarre -di q nesta specie di ·cannonier a, J.a s u a poca elevazione sui p~ lo 1'a9qua; le sue es trem ità a[- , j • • • filate a l amà:' di coltello-, non 1spua no , a ·pnma v i sta, gran fiduc ia s~lle s1.i:e q~ta riautiche, e ' po t rebbe_si credere ch'èssa r,i~n può 1;ea,l m enl e navigar~ clÌe a c a l ma di piare. Nu ll a d i - · {atti fa suppoì::re, che un tal legno possa avventurarsi i '.1 mare, ,e c iò au lla meno il modo col q uale esso ebbe a r eggersi co1~tro la bu.rrasca che l o àssalse ne l go lfo d i Lione, lo classifica fra miglio ri basti.rn~nt i di alto mare .
GERM±tNIA. La' Dieta commise l'acquis t o d i . 520 can' noni rigati, p e r l' arm am.e'nto delle fortezze federali, i quali dovranno esse re·c0m.piuti prima de1lo sco1;cìo de l l'anno corrente.
La maO'«io r parte degl i Stati della Confederazione non si ; i mane i~di etro degli a-ltri Stati ~uropei , a rigua rdo dell' adottarueu to dè' c a_nnon i rigati. .
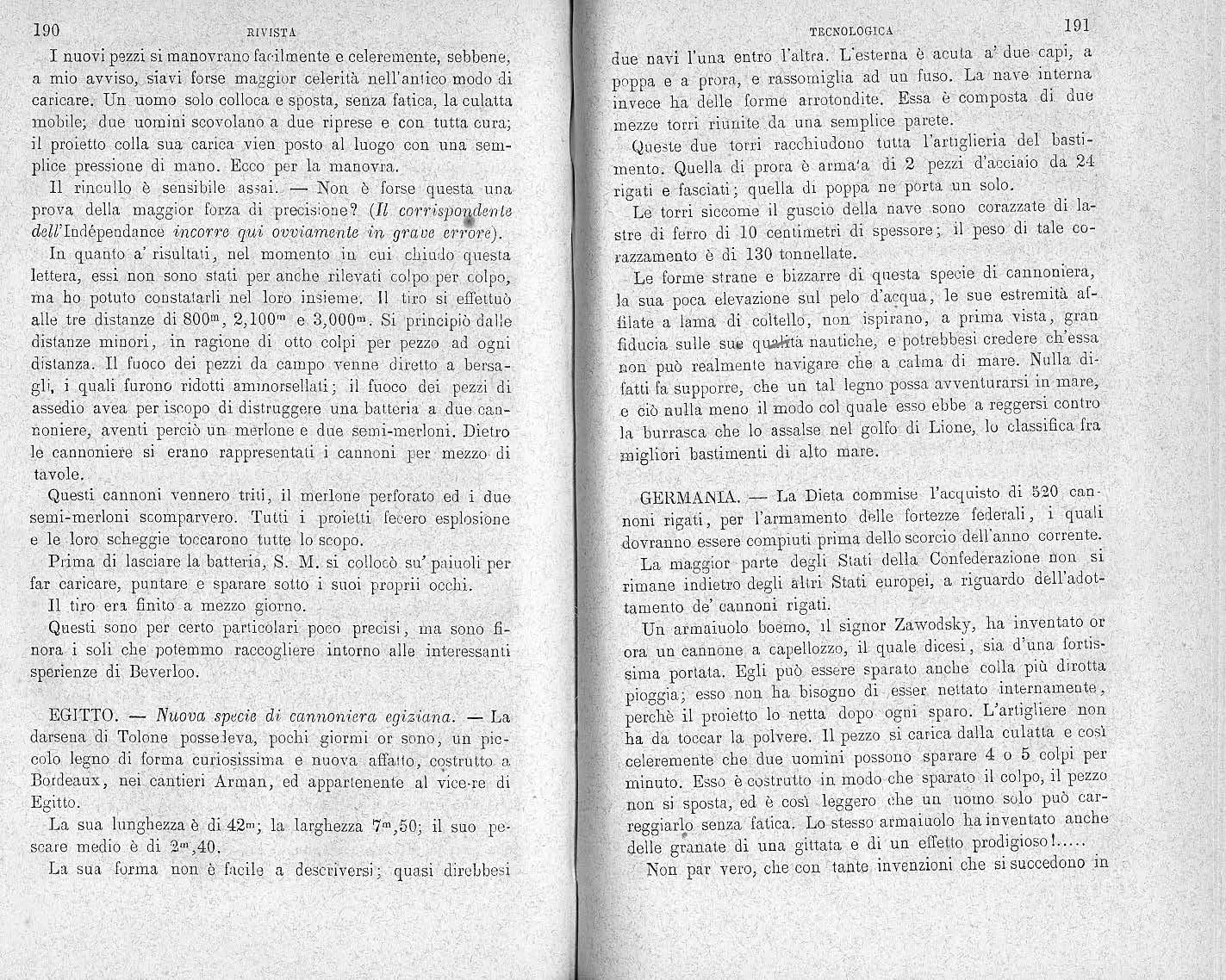
Un arm ai uolo boemo, ' 11 s i gno r Zawodsky, ha inventato or , ora· un cann one , a cape ll ozzo, il qua le dicesi, sia d'una fortissirn~ , perlata. Egli pliÒ esse r e spara_to ~ nche co lla più dirotta pi~ggia; esso non ha bisogno d.i ess~r n ettato ;m t~r~:a meote, perchè il proi etto lo net ta dopo ogm sparo . L art1g11ere non · ha da toccar la polve:ye. Il pez20 s i carica dalla, c~làtta e così .celéremente che due uomi nì possono sparare 4 o 5 éolpi ,per m i nuto . Ess,) è costrutto in modo che spara t? , i l colpo, i l pezzo ·non si sposta, ed è cos1 , leggero che un nomo s o.lo può carreggiar\o senza _fatiça'. _Lo st~sso _annai uol o ha inventato anche delle granate. d1 un a gittata e d1 un eù'etto prod 1g1oso L . ..
, Non pal' vero, che con ' t ahte ,. invenzioni che si succedon o in
190 RIVISTA
,..,
TECNOLOGI CA 191
,.,
q,ue' paes i rapide come il p ens ie ro - e •l a; sola Rivi~ta potrebbe rabberciare nell e _sue pagine i l nome d i qti a~ch e ce ntin ~io di cotest i in , ventori . ... n o n pare vero ch e , fi n 'oi:11, l'Austr ia sia ,la più malconcia s ull'ogget lo · de ' can no n i r iga ti. ·
FRANCIA. - A pro posi to ·de l r e ce~te varam e n to de l vas cello corazzato il Solferi n o, to g lia m o quan t o seg ue da u n .giorna l e fq111ces e:·
• L ' avvenire c i dirà s e i vascelli cora zza ti, , ri p uta ti s~ nor:i. invulnerabili, fo r m e ranno in a i l' e lemen (o d'' u na sq uadra. Ai nostri occhi la lo ro miss ione. d ovrà l imi tarsi alla di fesa delle rade e di pas saggi, s o lo mezzo di ut,ilizz a r e l e enormi somme ch'es si avranno cos tato.
e, Tale nos tra opi nione si basa su i 1 ~'isul t ati rli p.en etr a zi on e dati dall'-artiglie1:ia, ' che, tuttora in ·es perien ze, ha gi à fa t to p revedere un ' inti e ra rivoluzione navale .

.
• La rig atura è al dì d'oggi d iv entata cosa seco ndaria.
« Pezz i d'acciaio ce r ch ia t i, d'una lunghe zza d i più d i 6 metri e del peso di - circa 4000 k i log rammi, im primono ~n un pro• ietto cilindro-coni co, del, peso di 45 kilogrammi, una vèlc c itit iniziale di 400 me t ri ' , sotto rimpulso cli 12 kilog rammi di polve re.
• Alla dislanza di' 1000 _)Iletri, 9Yv e ro a quella di 600 braccia (5 encabl.ur es), l a ' veloci t à è ·anc q ra d i 300 metri e perm e tl e a l proietto d'acciaio d i fora re una corazza .d i 16 c ent imetr i di spessore , e di fa r.vi sopra l' e ffet to d' uno sl a m po. Q uale n e sa· r ebbe l'effetto ad una più vicina dist~ nza ?! .
· • La manovh di q u es to nuovo ca nnon·e è ? f::l le più fa cil i. Carica)ldosi pella cu latta, dà. al ' tiro una rap id i~à prod i g iosa, -mette al coper to gli i_nservi en ti e tutte l e rna,nov re de lle ba tterie.
• Sem:a dubbio il peso di questo nuoy o P\?ZZO è cons iderevole; ma ; sicco m e , Q_a ~ta s tab i lirne so l am en t e qualcuno bordo, l'obbiezio ne · è di poco valore . · , Se in questo . nuovo sistema, che toglie og ni 1 vanto al cannòne AnusLrong, v'ba nulla di nuovo, , \ ili .i·i.co n os.ce p.e rò un'applicazione di parti co lari mecca.ni ? i g ià couose iu ta , e s olo un uomo d i sapere e d'esperienza poteva giunge r e a qu esta e l evaz ione . di co nceito . . .
• L 'imp e rfez ione della fon d ita d e i pr oie t ti può s olo togl i e t e a i r isultati t1:1 t ta l a loro imp ort anza e fors e 'il fumo , •µ on il g a z, che si spa~de t ol to l' o tt ùrato·re, s a r1~ fo rse la so\a_imperfe zi ~ne a segn ~l nrsi
Ciò n ulla m eno , d a quan to p r ecea e ,; risult a _ o v viam en t e ch e le n~azioni s oìio oraµiai irresis tibil mente i n do tt e s op ra una :via s t.1l]à quale d eb bo no d'01· i nna nzi p r?gr edirn a q u a lunq u~ cost o .
. • Solo i port i i'n te rni sa r anno d ' or in nanzi a l coperto dei t iri pro veu iè n t i da-1 mare . •
192 RH ISTA ,'
A 193
T RCNOI ,OGIC
,\1;115 0 V I. Vol. I. , - 13 .
c.
RIYIS TA ST ATI . STICA
T URC HIA . - Il nuovo su l tano serubra voglia concentrare le sue m aggiori so ll ecitudi ni suH'eserc ilo, e n'ba ben r:igione. U n o dei maggiori scouc i di qu ell'esercit o ·s i è il n u mer o s trag rande d i ufilziali che, figurando sui ruoli, godono la paga d' attività nell'ozio . Un decreto i mperiale loro toglie m età. pag a, e li p one in avver tenza che,' fra breve, n on r ien trando a l servizio in seg_uito o.d esame d 'idoneità, essi saranno defini t ivamente l icenziati.
FRANCIA . - La Rivista militare italiana ebbe parecchie volte a òtare la scuo la mi li tare francese ài St-Cyr, m e ri tam e nte cele bre per gli ill us t ri gen era li che n ' usci rono, e da ll a · qu a le l'esercito francese recluta i suoi migliori uffiziali di fanteria e di cavalle ria ; eppe rciò ci compiaciamo in dar e ai nos tri lettori a lc uni p a rt ico lari intorno a ques to ripulat issimo i st itnto, al quale le sollecitudini imperiali sono costantemente rivolte, e gius tament e .
, L a casa di St-Cyr venne edificat a nel 1686 da L uigi XI V, d iet ro so lleci tazione d i madama di Maiu ten on, al l'ogge tt o di
ed ucarv i 2 5 0 _ da1n ige ll e a pp ar te n en ti a p ò, •e r e fa miglie d i gentiluom in i mo rti i n servi zio m ili tare . Qucst'is li tuzione venne aboli ta nel 1792; trasformata quind i success i-ramante in ospedale mi lita re, in s ucc u rsa le per g li i nva lidi, in pr i ta neo; ne ll' a n no 1808 Napo leo n e I v i stabilì l a sede della scuola speci a le milita re, se i anni prim a da lui fondata a Fo n ta inebleu .

Q uesta sc u ola ven ne sc iol ta nel 18 15, al rient rare dei Reali cli Francia, e solo n e l 18 18 s i r iaperse so tto il tito lo d i Scito la r eale speciale milita1·e.
Gli all iev i ,, i s ono in num e ro di 6 0 0 ; il cors o di studi vi d ura d ue anni , P er esserv i a mmessi : g li a ll ievi denno avere da 17 a 2 0 ~n ni , subire un esame d'idon ei tà e pag are una. p ensio ne an nua d i L. 10 00 .
Si no ad oggi i ser vigi militari de i pad ri costitui van o gli esclu si v i titol i d a i n voca rsi d alle fam ig li e per ottener vi posti e m ezzi pos ti g r atui ti pe i fi g li. Ma, g i u sta un proge tto di legge poc'a n zi sott1Posto a l consiglio di Stato, i servigi civil i saran n o ug n al men tc co mp utati pe r ta le v a ntaggio. Questa nuova l egge a brogherebbe ezi and io la facoltà, accordata da lla l ogge 1 4 ap rile 1832 e pe r decreto del successivo settembre, a tutti i m ili tar i dell' e se rcito di ess e r e am messi a 1m:,seut à r;; i :si u o all' età d i 25 a n ni , a l con co rso d' ammessione. - Speriamo che s i vorrà r idurre l'età a 2 3 a n n i, ma cho non si vorrà togliere a i sott'u ffi zia li d ell'es ercito u n t ale i n centivo a llo st udi o ed all a carri er a .
Dopo superati gl i esami d'nscita, gl i allievi entrano nell'eserc i to q uali uffiziali d i s tato m ag giore , di fanteri a o di ca,va lleria .
Il fa bbricato d e ll a sct1ola è comodo e vastissimo .
I dormito i occupano i l 2° ed il 3° piano d i cinque corp i di fab b ri ca . Con sis to n0 in l ungh e sale co mun ican ti tutte fr a loro , e divise nel sen so della loro l unghezza, di m et ro in metro, da tra m ezzi aperti v erso il centro . A questi tramezzi sono app oggi at i, d a ogn i p a rte, l atti cini di feno, sovraposti a i q u a li l1•o va nsi un casiere per l a vestimeuta ed un asse pel pane e per lo za i no d.ell' a llie, •o. A destra del letto una c avicchia fungoforme sos tie n e il scbakò , la scia b ola ed i l ri manen te d ella huffetteria . Alla sinistra h avvi un forzier e pei m inuti arnes i . D i fr onte a i letti st an n o le rastrelliere pe r le armi .
A NNO VI. Voi. 1. - H.
i\ RIVIST A STATISTICA 195
, Durante la notte i dormitoi, siccome t utto il ' ~i manente dello , stabi limento sono i'llu,m i na ti a g<1,z. Aiutanti e sergenti vi passeggiano incessan temente, ed j} capitano ' d'ispezione, ch e ];a un gabinétto apposito, ove rimane sempre in comp leto uri'iforme, vi prs,tica, f~eq Ùenti nm?e. , . .
Al mattino gli a ll ieyi vi sono risyegl ia-ti, al far del g i orno, da tambur ini che percorrono ··i do r mitoi battenào la cUana. Allora .gli allievi si vestono, ripu l iscono i loro ·ab i ti e l e anni ; quindi passa no la r i vista del' sergente-maggi ore e dell'uffizia le ili settimana del la rispettiva compag~ia, d isceodono poscia ai lavatoi ad un colpò di bacchetta, in rango e pe r compagnia, co ll '.asci ugamani ·sulla spa ll a .. , ·
Questi lava toi .sono ·picco li bacin i praticati lun'ghesso il cor• r idoìo deldefettorio ' e . sovra i quali si aprono numerosi robinetti d'acqµa.
, Le sale di studio occupano tutto il primo pi an0 dj tre a l i ·del fabbr icato, e sono i n n ~mero di t re : due pe r l a prima divisione ( composta degl i all ievi del 1° anno); : una per la secon/la cli - ' v isione (allievi de l 2° ann o). G li allievi vi sonq dist~i bui ti per tavole di 1O a ll ievi, ed ogni t avol a è comandat a da u n graduato. U n luogotenep. te d i servizio s orveglia a t ut ta la sala.
Gli anfiteatri per scuola sono disposti in tutti gli :angol i del piano terreno . De' grad in i d i abe te anneriti per gli aUiev i , un 'cjuaclro ne ro pe r le. di mostrazi oni, déi becch i à gaz~ ~cc., ·e· tutte 'le masse r izie della scuol a. r , .. La sal a d'armi è posta a l pian ' ter reno,. e solo vi hanno accesso gli al li ev i della P divisione.
Il refettori o è una. vasta sala del pian t erreno, sostenuta. da un colonnato. Gli a ll ievi . vi si recano in or~i n'e, portando éiascuno sottb i'l bra,ccio il proprio pane di munizione e v1 s i edono a 12 per tavola sot lo la . pres idenza d i un grauuato. La 'durat a della refezione è fissata a 20 minuti.
L'i nfermecia sta in un grosso fabb r icato a tre piani, comt letameute isolato dalla scuola e dai giarcl1ni, e sito su di una eminenza presso lo stradale di Br etagna. Il servizi o sanitarip · vi è fatto da un medico-capo, da due chirurghi, da sei suore dì -S. Vincenzo da Paola e da due inferm ieri. 1 , - •
Pei corsi d'equitazione ' ora si provvede alacremente c~n ap•
posìte costruzioni di scuderie e di un maneo-gio dovendovisi . o ' stabilire una, succursale della scuola di ·cava ll eria, èon 40· ca-".alli di dotazione .
Gli al l ievi formano un ba ttagl ione di 6 com.pa,gni e ed . uno squadrone di cavalleria per col oro che si destin'ano a q,uesta arma.
L ' uniforme è a poco pres.~o quelÌa del-l'arma di fanteria èolle most:re azzu r re. - '
Alla domenica gl i -alli evi ·hanno l'uscita libera, e ponno, ricevere n ,ello stàbilimento le v isite dei parenti e degli amici in 11;pposito parlator io. ,
La discip'iina mil,i tare vi è in pieno vigore·; e certamente ~ on ., v i ha .in Europa a l tro stabilimento di educazione che lasci . meno a desiderare di quello di St:Cyr tanto per la t enuta, che per Tedu_caiione ed il trattamento , degl i allievi.
Ripartizwne del contingente deUa classe
,oon1ingente· mi l itare della classe 1860 :fissato, i n . . . . . ,

1860. - Il 100,000 110m 101, viene rn q uer,t anno così ripartit o : ..-:· r Armata. , r • ç. ,,. ,
Equip~ggi l Co~p~gnie di _deposito meccanici della flotta. I Alhev1 marmai. . . 600. 3,100. 411. .. 338. 2,3 46.
Reggimento d'artiglieria Operai d'artiglieria Fanteria.
Cavalleri a Artiglieri~ ·,· G~nio.
Equipagg i mi litar i .
' 6,795. 80,005. 8,ÒO0~ 4,ooo : G00 . 000. -93,205. ·
La pr i ma metà di questo contingente- è chiai:nata al servizio a.tti vo pel I O settembre ; l'altra parte rimane a casa formando la riserva. · ·
196 R!VISTA
STATI ST! CA 197
._ ,,,, . . ,
.
Totale Esercito
,
{ : ,, '
. ·
Fanteria
Totale
. I gi ardini p1·esso i l campo di , OMloris. · L'imperatore Napoleone anndo ord inato a l la fine dello , scor so .i nverno, che dietro il ' campo ' d'ogni reggi mento dl fante r ia e cavaJleria fossl;l. piantata un'ortag li a (jai·cl ·~n potager), destinata a provvedere di legumi e verdU're l'o,rdiuaria mensa èlei. so ld at i, il gen io h a tracci ato simili verz i e ri , g ia rdini die tro l'uhima linea di t ende o ba racche al campo di Chalons. - Ogni r eggim~n to è s tato messo al possesso del suo t erreno, che venne lavorato e · coltivato nel miglior modo possi bi) e: Il g e nio lo fece copri re di ~trati coltivgbili (couche s), e _v i· s eminò piante di cavoli in gra1!,dissi roa g_uan tit?, . · Ne assegnò poscia molte migli aict di piedi ad, ogn i r'éggi mento. Si fece r o 'venire da Parigi, per essere distribu i te a tu tti i cçirpi, va ri e specie di r!j,vanell i, cip@U<?,' lattughe, carote, rape , fagi uol i, pise lli, ecc,, per inca.. - lllinciare . a , for1;0are l'ortag lia (potager). :-- Tutt i q uesti l egumi hanno ora un aspet to m agni fico, e potranno già in quest'annata servire t>.l consumo p e r l'ordinario : della t ruppa . - Oggi dl s~ annove rano già ne l ~•i vaio - d'ogni r egrximen to da 12 a, , o , 13 mila pied i di cavol i , da , 8 a 6 mi la piedi d i p or,ri, , ed a ltrettanti di cipoll e della p iù b ella riuscita . - Vi sono in.o l tre quantità di fagiuoli, che i s oldati potranno m ; n ,,. iare ,fr eschi., ' - o , Nell ' anno ~,ent uro e nei successivi le raccol te sar anno di qualità molro superiori ancora, poichè l e terre avranno a voto il tempo q'essere . m ~g li o pr eparatf-' e ruà g g lormente conci diate. Ogni reggim ent o vi mette, mol to. amol' proprio a ben co ltiv ai;e il s uo t erren o · , e si andrà a ·gara a chi otterrà i p i ù bei l egum i , D'altronde i l solda t o si com pi a.ce di vivere in mezzo .a gu este terre, che gli ~i chiamano alla memoria il pa ese na ti vo ed il qi a rdirio pate rno . Dal tutto i ns i,eme si . ravvisa aJ cam po l'idea eccellente di Napoleon e III-, id e a che •si colle ga ad u n p iano d i c oltµra, il qua.le; dopo questi esperiment i , p9trebbe, a qua nto si·assicura, veni re ·escgùÌto su · più vasta' scala:( l a Pa tri e, 16 l uglio). 1 ,
Noi desi de reremmo èhe un sim il e pia no v en i sse pure messo in oper lll su ll è laia ~le . di S . Mamizio, ove so no ra ccol te trupp e ·per le autunI\ali eseroitaziion i .
colon·ialè fornisce i $eguenti ragguagli su ll a marina imperiale •
russa.
Personale.
L'effett ivo del personale della flotta r ussa si componeva come segue: -
Ammir agli e genérali .-. .
Officiali maggt o ri e subal terni
Funzio n a ri c ivi li . _
Soldàti e marinai.
Guardie marine e condutt6ri ltiateriale.
1 STATIS'l'ICA 199
1860. 114 , 3, 569 1,319 53, 05 4 •: 1861. 95 3,245 966 55,216 · 169
Ba! t·imenti a va,pore: vascell i di linea; 9; fr~gate, 13; cor-yette, 22; cl ippers,: 12; fregate a v a por e, 9; scia l uppe cannoniere, 79; · YJ Ohts, 2; schoon er s , 25; traspor ti,. 8; pi ccoli. bat~ telli a v apot e, . 49 scialuppè di vasce1l i A ha1•ch a , 1 l ; rlor,k~ gallé ~gianti ,, ~; totale 242 . - La forza ',mo trice totale di q1,10sti · l egni era di 36,935 cavalli, ed erano armati da 2 ,3 74 canno'ni .

. Bast'irnenti a v ela : vascell{ di lin e a ., 10 : fregate, 6;, -corve tt i>, 3; bricks, 5; schosmers, 17; long res : 2 ; ·i ender s, 3, trasporti, 13·; yachts , 12; totale, 7 1.
. Qu esti legni ér atw armati d~ - 1,4 77 cannoni. Ecco ora l'enumerazione dei legn.i° c he fu ron o messi i n acqua durante l'anno. . . · ~. · .
A Pietro b urga il va:~ceUo d i li nea Jm,peratoq•e ·Nicolò ·I -d i 111 ca.n,uo ni ; l a fregata. Gs-simb,ia di 45 cannoni; l a coivett a, .~ogaty1· di 1 7 can non i ; un dock, gall~ggiantè com posto di . c~ nqu e sco.inpaJ·timenti, che sérvi a condur re· l'imperatore ' a faonst,adt e molte p i ccole imbarcazion i.. · - ·
A Gronstadt,,la fregata ·a d , elice Oleg di- 5'7 cannon i e i vaiscelli Sinqpee e Cesarév·itch., '· . • · ·
Ad Arcangelo la'· fr~gata Pei•es vete di 53 canncin i e il battello a vapore · Solombola dj 240 cavalli e 8 can n om.
198 RIVIST .1
RUSSIA. Marineria m ili tare. -:-- La Rev~w mcM·i time et 4
Là flotta, compresi i legni in costruziahe , s i componev a , nel l ~ O, come segue: , . .
·. A Nicolaieff ki corvette Ya$l1·cb . e Kretc hète di O cannonì
i battelli a vapore Aloutcha e · Tchetyrdagh di 2 cannoni ; una scialuppa ì.q ferro ad elice.
Ad Abo un _ y ach t a vele Zobava appartenente . a S. A. I. ~l granduca À lexis Al exan drov i tc h. ·
A Bloneborgei cl ipp ers armati d i 5 cannon{ Abrek- e Vsa·derik
In Inghilterra Nortbfleet il ·cli pp èr ~rmato di 7 can,noni , Jla i dama ck . · . , , - · .
In Franc ia ' à ll' Hav re le scialuppe ca,nnon,ierc M01·1·e di seconda class e e Twléne di terza classe. . .
Al tri ba.stimen ti furono posti in co; truzio n e nel ' 1860 tanto n ei porti. russi come all'es tero. '
I~ALI~. -_ Statis ti ca dell'a1"rnata Stato~mag gioré 1ie·f
3 dwpa1·ti1:1e_nti ~settentrionalè, meridionale e defl'Adria tico )
3 v1ce-am ro iragh; 10 contr'am1IJi ragli; 10 capitan i d i vascello di l"· classe ; 12 di 2" classe\ 2 direttori d elle maccbi ~e · 2 direttòrj delle a rti glier ie; 16 caiJi tani di frer:rata di P c'l asse · [ O r-'\ 1
2? d1 2~ classe; 60 luogotenen ti di vascello di l" classe; 2 so ttoduettori delle macchi ne; 2 sotto -direttori delle arti"'Jierie · 90 , luogot~ n en \i di vàsc ello di za classe; ·J50 sottoten;nti di- v a· scello; 50 guardi a :in'arina di 1a. class!3,. '· 1'otalé 429. ·
· Piloti : 9 piloti d1 l " cl a:Sse; 14 di 2"; 20 di 3a. , Totale 43 .
Cappellani : 14 ca ppella ni di l <' catego~ia~ 7 di 2a. ·Totale 21.
,
Uffì~ial:i -d_i m aggiorità ; l ,maggiote r ela tore del consiglio ;
6 capi tam d1 Ja classe; 2 c~pita ni d i za; 14· luogotenenti '; ~5 sottotenenti . Tot ale 48. 1 • ; •.
D[fizia li, d'a'rsenale: 2 ~a,pì tani di Ja classe; 2 di 2• classe; 5 luogotenenti; 5 sottotenent i. Totale l ;J,. · ·
S egrete1·fo di ,comando generale : i· segretar,io capo : s·se~ gretari; 5 sotto-segret ari; ' 5 scrivani. · Totale · 16. · Stato-maggtf,ore del corpò dei "ca·iinonii3ri e marinai in Napoli: l capit a·no di ya~èqllo comandante; 1 capitano di fregata. comandante rn ·2°; 1 ' m aggiore; 2 · càpitani aiutanti ma{"fo-iori • 1 ten~nte_ d! ~ascella istruttore di man ovr e i ·1 capitano 0 istru/ tore d ar!1ghe1;1a; . 1 sottotenente quartier -mastro; l sottotenente d i dettaglib; 14 t epeati di v:a,scello; 4 c;pitatii; 14 alfieri di ., '
I. Ya scello; o primi ten enti; Ì8 t enen ti; I capita no a l seguito;
2 secondi t en en ti. Tòtale 67. ·
Stato -magi ore delle co·mpagnie cannoni eri artefìoi i n Na -
p_oz.i: I- , colonnello ~·sotto is pe tt ore ; , 1 capitano di 1a. cl a,sse ;
' i' ·di 2a. classe; 1 primo tenep.te; 1 alfiere. To/ale 5 .
IBassa fo rza - - Corpo r eale equipaggi. · - Dipa r limen to · sett e-1?-t1·ionale: 30 sott' u fficiali di magg;o·r i tà; 30' allievi di mag~ gio rità; 40 marin ai addetti alla maggiorità; 2 4 secondi piloti ,di Jà classe; 30 di 2a classe; 60 all ievi - di pilotaggio; .8 no cch ie ri di P· classe, 12 di 2 " , 14 di, 3"'; 6 capi c a nnon ier i, di Ja cl asse , 8 di 2", 10 di Sa.; 50 secondi n occhieri; 40 secondi caJ?i ca~ non ier i; 230 timo nie ri; 48 ti~on ieri ca~noni eri ;; 60 0 mar inari di l" classe,, 600 di 2a, 1,200 di 3" , 1, 200 di 3• classe di ~upplemento; 200 marinari novizi ; 400 m ozzi; 1 capo mu s ica; 1 sotto-capo musica ; 20 musicanti; 16 caporali prevosti; 18 .guardia n i invalidi. · Tota ,e 4 ,896. . _
Sezione ma1·inai . guarcLiani : 18 secondi n occh ie ri" ; 18 secondi capi cannonieri; 24 timonieri; 35 marinai di 1a cÌasse; 15 id. di , 2"' classe. · T.,Q._tale 210. 1.'otale ge~erale della bassa fo1·za del di pq,rtimento: 5,106 . . , _

D-i,pa1·timento meridionale: cannornieri ma1·vnai : 3 ai utant i compreso il capo -fanfara; 30 porta-bandiera, primi nost romi; 18 , id .. contabjli; ~3 primi ' sergenti; ·74 se condi sergenti di I aclasse ; 102, id. di 2" classe; 18 capoya li furi ~ri; 139 papora li .di 1" ·classe; _ 120 id. - di 2"' classe; 502 cannonieri di l" classe; ·465 id. d i 211 classe; 999 id. 3a. classe ; 1-344 mar in a i di nu ov a J eva; 64 grumette (mòzzi) [i.ori pianta: 7 a iuta:nti contabili; I port a-bandiera, 1° nostromo; 3 serge n ti di l" cJassè;' 2 id . 'ai 2"; 2,2 caporali di 1~ classé; 12 Ìd. di 2 a. ; 66 2 marinai di nuova leva. Totale 4,610. . ?
çompagnia cannonie1·i artefici: - l capQ fu ochista ; 2 capi artefici ve terani; 3 · sotto-capi artefici veterani; 4 artefici vete• rani; l: pri mo serg~nte; 4 sergen ti; 1 furiere; 4 ~-aporali; 4 sottocaporali ; ·12 .artefici di- l" cl asse; 12 1d . di 2"; 16 id . d i 3"; l . tambùrinf · To tale 65.. _
, Dipa1•tirµènto dell'Adria tico : 5 sott'ufficiali di maggiorità;· 5 allievi di maggiorità; 6 ·. marinai di maggiorità; 3 second i pilot! _ di l"' classe; 3 'id. ,di 2"'t 8 "àlli~vi' di pilotagg io; 1 noc~
200 RlVlilTA
[
STATISTICA. 201
ch iere di 2a cl asse; 3 detti d i 3a. classe; I capo cannonier e di 2a class e; 2 di 3a; 8 seco1;1d i n0cchieri;• 6 se cond i éapi nocchieri; 3'0 timon i er i ; 8 timon ier i canno nie ri; 100 ma rinai di l"' classe; 100 eh 2 \ ; 2DO di 3\ 50 m a rinai n ovizi i ; 100 mozzi; 3 guardiani inva]idi. Totale Jì 4 2. ·
l}farinai gua·r di ani : 1 se cond o nocchiero > 1 secondo capo oannòniere; 2 timon'ieri; 6. m'lri nai di l a cl asse j 6 id. ·di 2". 1'otale 16. Totq,le generale 658. ·
MACCHl !)i JSTj, FUO!l:HISTI E MAESTRANZA.
Dipartinicnto seUent1·i onale : Ma cchinisti: l capo macchinista; 8 primi macchi n is ti d i l" classe.; l O i d . di za; 20 s ~cond{ macch,inisti cli 1a cl asse e 24 ,io . di , 2a} 30 a ll ie-i,i rnacohinis~i ; 60 operai fuochis t i di l ' classe; 65 id. di za~ 65 mari na i fuochisti d i l" classe; '70 i d . di 2• 100 st iva tori. Totale dei macchinisii 453.
'bfaeskanza :· l' capo calderai'o; 17 capi mast ri~d'o'rfìci na; 20 ·second i capi ·mastr i di I o, c lasse; 4· i d. di 2a; 6 mas.tri ·d'ascia· di 1a cl asse; 16 id di 2"; 14 id . di 3 a; 4 mastrì ve lieri: di l" classe;' 10 id. di 2"; 10 id . d i 3 11; 44 s eèond i mastr i d' a1'ti diYers e; 72 operai d i 1a clas se; '7':ù 'id. di 2a cla sse. Totale 290. · D,i,pa1·timen to rner id ion à lè: ;na cchinisti.: 18 ·primi m'.acchinis ti; 25 secondi macchin i sti; 24 ) erz i macchin isti; 50 alu nni di J.a classe; 60 id di 2" classe . Totale 177.
Fuochis ti e carbona.i: ~2'10 f~ochisti; 131 c~; bonai. 1'otale-40l.
lVIaestrcinza: 18 ~api mastri di 10. classè; 2-1 · id .. d-i: 2 "'; 2·7 aiutanti capi mastri di l " classe; 33 i d . -di 2 " ; 300 mastri d i 1 a classe; 300 id di 2• ; 60 a l tri ar tisti -, di maest~aoz~ a ·vari se r vig i. Tota.te '759.
Dipartimento dell ' Adria~ic?: macchfriisti e fiiochisti: 4 primi macchin isti di 2" classe; 2 seco ndi- macchinisti d i 1a clasife· 3 id ·' di 2 a; alliev i ~ac;hin.ìsti; 8 operai fuoc his ti · di l ; ;Ìa~s~-~ 8 id. di za; 8· m arinai fuo!)liist.i d i P cl a ssl3; 8 i~. di za; 12 stivat ori. Totale 58 . ·
.ntae~tranza : 3 ·ca p i mas tri d' officin; ; :2. secondi' ca:pi mastri di I• classe; 2 id. di 2a; 1 mastro d 'ascia 'd i • 2a cl.~se; 1 . id . d i 3" ; 1 mastw vel iere -d,i za classe; 1 Ìç! . di' 3a; '. 12 ·ope;ai di l " classe; 12 i d d i 2'1-. Tota.le 40
COMM-fDO DEJ PORTI, , '
Uflìziali i· 11 capit ani d i port o; l '7 l uogotenenti d 1 porto; 6 piloti cìi por to "Totale , 34 . • • ·"
Bassa fat'ZCL :. 1 s.econ.i.10 pilotà; 14 see0ndi noèch i eri ; 8 t i" mon i eri ; 25 mar i nai d i l" cl ass e ;' 26 di 2"; 30 d i ·3a; 36 / guard iani di porto; f4 ·ìnsèrv i ent i d' uffoiio ; 42 ,guardia sp iagg ia ; -2 sec6ndi nocchieri segna l is ti; 2 mar.i n ai ' segna li sti; 4 ,id .- secondi segua listi . 1'o_t.ate 20'7: ·
Compag1~ie dei soçcat·si nfa-rittìmi: · 1 capitano i n 1°; 1 id. i1:1 2~; 1 O capi sq uad,re; 90 marinai battell ier i ; 1 .cus~.ode del m agazz ino: "'11otafo Ì 03 .

Istituti di ·educazione . ed istruzìone militare marittima.
DiJJa?' tirnento settentrionale. - E,egia sciwla di ma rin a in Gertova :, 1 comandante; 2 luogotenenti di' vascello ; l capitl\no· d i ~aggio r ità contabi le ; 4 uffic ia li d i magg iorità, a iutali). ti (subaltern i);, 1.1 p rofes~ori; duè lll:aestri'. Totg,le 25 .
Sm~ola navo,l~ !J,e,i n ov-i z ·i e }no-zti : 2 m aes tri, oltre a l personale ordinario di . bordo- del l eg no su cui è Jà scuo i.a.
Dip~1•tìmen,tò mer-i'° iiaiè: .:.....: Regi~t sci wla _ di '.ncwina in Na,p o)i. : 1 coman_dante; uffi.c1alo superiore, navigante ; 1 q uar• tier-lll;aSt-ro, l(;) nente µi va§cello; 4 u ffiz iali nav i gan ti; 1 istruttor e m o:i;ale; 3 çapi:ie.l! a nj.;_3 chìr ùrghi; 3 professori; 12 m aestri; 5 ·isfru~ori ;' 1 custode. d~Ua bi bli oteca; ' 11 g ua rd ia marina; 83 aspi.ranti; 13 pers9 n.e di se1wiz i.o .1 Totale 151.
$c?J,Òla. cleg li a,~un1ii ma?iinai : l comand:antè , u fficial e su- peri0re navigante ; 1 q11ar t.i er- mastro pi l9ta; 6 prefetti , 2 chi_- rurghi; 4 cappellan i ; 1 dirett0re d~gli studi; ' 5 p r 0fessori ; 9 mae~liri; 4 istruttori; 1 capo 'mast ro per I~ costr·u.zione;-42 a:l_liev i; 3 operai v._a rii. Totale 79. · - - '
-
CORPO SA NITARIO MARl'.['T JMO ,
,· , D~partimento sette ntl'ion ale : l meq ico capo; 5 med i ci di v.ascel!o; 5 i d . d i 2"; :·1 O medici dì fregata di Ja classe; 10 ia. di 2a; 10 méd ici di corvet ta ; 1 farmacisla; 1 u fficia l e d1 mag. _gforità contab il e; 1 id . per la d is ciplin a ed altri servizi; 1 cap-
202 R!V TS'l'A
S'l ' .A.TI$T IC.A. 203
' '
.,,. ,
P ellano,· 2 sott'ufficiali di maggiorità,· 2 al11·ev1· 1·d 8 tt' ffì. . ; . so uciali infermieri; 40 infermieri.
· Dipartimento meridiortale: 2 comandanti di sped:ali ( • ffi . ziali superiori); 8 càppellani; 3 medici d,i 1~ classe; 3 medici di 2"; 10 chirurghi di l8· classe; 18 di 2a; 30 di 3"; 13 farmacisti; 51 flebotomi. Tot ale 138. .
Dipa1·timent6 dell'Adriatico: i medico -di fr~gata di l" classe, 1 id. di 2\ 1 llJ,edico • di corv; t]a; .5 infermieri. Totale 8. ' ,.
GENIO MILITARE. !
Dipart·imento setténfrionale: 1 ingegnere direttore delle costruzioni; 2 ingegneri; 2 sqtto ingegneri; 3 allie~i ingegne ri ; 1 assistente del genio; 4 assi.stenti, Totale 13 .
· Dipa;rtwnento mci·id-ionale: 1 di;ettore dellè costruzioni na• vali; 2 in gegne ri di 1a classe; 4 id. di '2a; 6 id. di 3a; 6 alunni. Totalè 19. ·
In Sicili a ·: ' 1 i ngegnere costruttore navale; 3 aHievi . ingegneri . .Totale 4. . _ . .
N . .B. Il quadro dei, 2 reggimenti Real Marina venne dato· nella Rivista, miUtare italiana, anno v, vol. qr, ·pag. 312, 313.

- Campo siill"e lande di San .,ia'lwizio. - Onde procedere
al riordinamento de' Ùumerosi sbandati dell'ex ~s~rcito delle ·. Due Sicilie, che ogni giorno giungono dalle provincie meridionali, il giorno 29 corrente, . si -è , aperto un campo d'istr,uzione . sulle lande di S '. Maurizio, ove cotali sold ati verranno passati a :rassegna, assentati ed istrutti nel-le , prime pratiche militari , d ell'esercito italiano. - Il com a~ do del campo venne dato al luogote• ente generale Deéavero. - Il quad!'o de,lle 3e com~ pagnie di 25 depositi d~ f anteria servono di quadri a' . ~oldati predetti. - Un battaglio l).e del 45° ·reggimento, un altro del 470 -provvedono a.L servizio ~il,itare . del campo. ' <. , '., ,
'.:Aperç'u historique siw les fort ifi cations, les ingénieurs et sur . le corps du gé~ , 4° partie, par le colonelApGoYAT (10° articÌe).
Congiiingimento della Lys coll'Aa, media nte canal~~naviga-bile, diretto dal brigadi ere ingegnere Fiiley e dal signor. De la Salle, -a l tro ing egner e m i litare .francese .- ' · ·
Riunione dei' corpi ·del gqniÒ e · d~~l'drtJiglie1·ia in' uh sol co1·po, per regio decreto dell'8 dicem b~e ,1755.
P1·iri,,cipio dellà gue1·r.a dei sett'anni . ';-- Assed i o del forte
S. Filippo di Mah on, porto n@ll'isola :VIinorica: à di fesa del l?,or.to.-Mahon, ch' è un , eccellente posizi ~n~ maritt ima nel l\ifo. , ditérraneo. Popò 43 giorni ctel piò. vigoroso assedio, èd ·in seguito · ad u n assalto micidiali~simQ• delle opere avanzat~, la Piazza fu ·resa dagli Inglesi in man d e ' Francesi. I ,
. Isola di' Corsica, del la, quale i Fr:ancesi; in seguito al trat. tato 19 luglio 1756 ,- d i Luigi XV co' G!"novesi' ," occ'tiparono
S. Fiorenzo nel ti!llore che gli I nglesi •tentassero d'impad:ronirs i àell'isola . · '
204 . RIVISTA
STATISTICA
• •
• <., ( ? -RIVI-STA,
• ,, Spectàtéur militail'e - "t 5 jnillct t ~6:1 - 12 t lirraison.
BlBLIOGRAFIC·A·
' (
Fortifìcazioni rnaritt,i;ne delle coste del Med iterraneo e dell' Oc~ano . .
. Fatto d'armi dell'isola d~Ain nel 1757: due ' ~ascelli inglesi, dopo_ ~n cannoneggiamento di tre quarti d'ora, ricevono prigionie ro -il presid io , imp ad ronen dosi dei 34 pezzi dei q uàli era armato il for te dell'isola . · . . . ' . -
Carnpagna -dal 1757. in Ge_1·mania : assed io e presa della ci ttad ell a . d i _IIashourg per parte clei l'esercito annòvrese sui Francesi. - As~edio d~ Sc~weidn itz ., (su ]Ìa manca ripa della vVeist ritz, affluente dell'Oder, a_ 5.0 chilometri · a greca,le di Breslavia); dopo 17 giorni d'assedi9, in seguito ad un vigoròso assalto, la piazza si . rendeva a ' ' Erancesi dava. loro 6,000 . . . . . pr1g1omen.

Cenni sitl.la sc'l!,ola co·113 pleriwnta1·e del genio di Aiezié?·es . ove entravano g li uffiziali dopo il corso preliminare fatto a • quella · di la Fè1;e. . .
Soitvenirs de la campag;,e ~de Orir.née. ' - Jou1·nai d'un médéciri, traduzione dal tedesco del signor Gtudo BlAISSAc.
È qt1esto jl diario storico del dotto r Ferdiijan do •Pflug, addetto a l quartier gener a le principale russo, di cui parla rono con meritate lodi molti · giornal i di a lcuni anni · fa. Il brio e ì'i ngE)nùi tà di que_:;ta narrazione· {a.t t~, per così dire, sul luogo del l uogo, so tto le sincere impression~ del momento, ]a n a tur alezaa verid rca deL quadri ' .e lo sti l e famigliare e scorrevole dann·o lin. vero dllet[o alla lettùra . di qu.esto librò, il quale t radotto g i à in in g lese, lo· è, ora _ in francese, e noi vorrerruno. pure il foss e in italian ~ .
Gue1·1·e~ et (Y.f,péditfons militaires m.1, Sénéga(de 1855 à 1a61, par F. HCJGUONET. -:- e ~arlerema. a narrazioiì.é compiuta.
· Siège' de J,1.1,lders en 1'860. pdr iVL ·F. DE i;.A ,FRJJSTPN. · (vedi a ' pag. '164 .di questo stesso fascicolo). . _ ,' , lntrod~ict-ion des cM·~ies .à feu dans les troupès à cheval. Quest,'anonimo. art~colo int~nde .a . pvovare · che lè ti1u1? p e di ~ cavalle~ia denno. far :d:taggior caso dell:impiego delle -loro armi da fu,000. • Dopo riassunta nella prima- parte la storia deHe armi dà fuoèo us..ate dalla cavalleria, nella seconda) pari~ v.ien ·trat -
tata la qu istio ne. dell' a ttuale efficacia del f~oco. de' tira:gli~tori a cavallo . Enumerati .quin~i. gli' inconvementl delle a11 t10he armi da fuoco usat e dalla t ruppa a cavallo, pistola e mosG'hetto, per cui il fu oco .dell a cava1leria cadde i u dispreg~o, si ce~ca ~i •dimostrare come il ·fuèi le rigàto sia esente da tah rnconvement-1, e debbas i perciò utilmente adottare dalle t r uppe a c~:allo:
- Col fucile portato ad armacollo il· sold~to ~~n,ta fac1lro~nte
• a cavall o, egli non incomoda il p-roprlo vwmo n ella :·1ga;
• n on soffre egl i stesso g li scrolli dell'~rm~ nf31le vol?c1 a:n-
• dature, pu r chè •la cibghi!l Si!l ' convementem,ente · ~g~rn~tata:
• l' arma non può cadere, i cavalli' non vengon o ur1tat1 .da1
« battimenti dell'ar ma;, la carica non si sposta perchè la bocGa
• del la canna è -volta all' i n~ù e la palla léggiermente forzata.
, Il tiro -è efficace a 600m . . Finalmente la lunghezza
• d('!ll'armà rende. l'~splosione toll erab i)'? a1 le orecchie - ed asl i
« occhi de ' cavalli; lo red ini rimangono a llentate, ' nè · v i sue~
, cede di sbr:crliata all'atto di fa r ,fuoéo » 0 • · fylentre beù 0 avversi cli .co~oro eh~ incapocchiti sul}e vecchie us~nze, chiudono le oreç cb'i e o d isprezzan o ta tto ciò che da quel le si dipar te, noi· rì'conosciamò tutti i · pregi ~elle nuo".e armi da fuoco _perfoz+onate, a nche; por la caval leria ; t1c:,ttavia credi~mo non convenc:ra t rapassare da ecces::;o .in eccesso . ·Che o l' arma da f~o possa •essere i n ~p:iolte circostan~.e _ uhlfss1ma per la cavalle ria , spezialme nte per la _l eggera , _ci ò . è J?COJ?.· t estabile, ma che l'arma da fuoco a:bb1a da, add1vemre .l arma principa le pel . cavalier~, ciò non ~ossiai:no ragionevolme~te ammettere, poich è ' ciò saria affatto COJ'.!trar10 a ll'_essenza ta! t1ca del la caval leria ch'è immut.'1.bile. - IJa proprietà essenziale, · la - proprietà caratteristica . di quest'a r:rr(~ è l'ur lo : n e~l'm:o e _ nella v elocità sta là sua v era forza, : la sua vera destrnaz1o n e tattica. Epperciò l' armà bi.a.nca vù0l essete e sarà sempre }a pri,n• . ~ip ~le pel cavaliere. . .
Noi abbiamo applaud i to all'i stmzione emanata da l mm1st~ro del la guerra di Francia.., il ·20 gennaiC> 1861, sul . ~iro de l fu. cile a:Cl u so della cavalleria, siccome lo avevamo pur fatto per la 'sua · i~tru iio ne sul l avoro io cli vid~1àl e del cavalie!e; e r,una e i'al tra ràccom anclanimò; com8 ambièue "utilissimi ese mpi da . s "gu irsi pe r . la n os t ra cavalleria. lVIa . non .consiglieremo mai
206 RIVISTA
,, · BI BLIOGRAF I CA · 207 -i. .•
che pel tiro delle armi da - fu oco abbia da soffrire scap i to qnalc h'alt,·a parte dell'istruzione d ella cavalleri a, la quale più iatimamenle si riferisca alla sua essenza tattica. - Non ci dilungheremo su questo argomento, poichè esso do vrà trovar luogo negli stud/4i nostri into1·no all'01·dinamento della cavalleria.
Un mot su1· la cavalerie . - Leltre d'un o(ficier des h'ltssards à un offici 1Jrs d'état-majo1·. - II lettore nostro cortes e vorrà forse lamentarsi come nella R ivista Bibliografica dello scorso giugno, rendendo conto dell'l!,rticolo dello Spectateur di giugno, intitolato, obse1·vations sur les noùvelles mano:iuv1·es d'infante1·ie, appuntammo la fatidica chiusa di tale articolo, poco favorevole per certo alla cavalleria : la cavalle1·ia non pot?'à pvù essere di quell'utilità che n ei tempi passati e dovrà spa1·ire qual a1·ma tattica dal campo di battaglia .. . .I - Or bene un uffiziale degli usse ri pigliat'? il broncio, per sì cattivo p resagi o, coll'uffi.z ia l e di stato-maggiore, g li si fa addosso con argomenti assai più logici e concludenti che non quelli da lui usati. - Al , punto di vista tecnico, tale polemica non è gran fatto interessante.
DtJ l'itsage de la photogmphie dans l'armée par ]H. F. nE u CoMoe - L 'eg regio maggiore enumera tutti i vantaggi che l'arte militare e gli eserciti panno ricavare dall'arte fotografica, la quale in qùest'ultimi tempi fece cosl prodigiosi progressi; eg li b en meritamente plaude alla decision e ministeriale francese, del 19 febbraio scorso; colla qual e veniYa affinata al signor Di sdori, dist intissi ro o artista fotografo, la propagazione di questa arte utili ssima ne' varii corpi dell' eserci to
Cosmos, 19 luglio · 1861.

L'organizzazione delle fotografie militari, in Francia, è pres-· sochè completa in tutti i corpi . I! personale si compone di un uffiziale, di due sott'uffìziali aiutanti fotografi e di sei preparato ri: Gli a,pparecchi sono poco numerosi; s i compongono di obiettivi a lunga portata, e possono venire facilm ente caricati (i mba llati) ia un so lo forgone .
Anche l e esperienze in fotografia a col ore ,,anno facendo in Francia alcuni progrtssi, sotto la direzione del signor Niepce de St- Vietar.
D hè er cortesia del!' egregio d irettore del catasto itali ano, - 1 acRc bbpin 1 • ebbi mo ad ammirare alcune prove fotogracava 1er a , . · · d l d ' fiche di riduzioni di carte e piani _fotog_ra~c1 , eseg~1t1 a ~stinto e simpatico nos tro conci~tad100, il ~1gnor Ch1appella, I~ 1 , da un a vera pass10ne per 1 arte fotografica, tutt i qu a e prnso . d" a· d. posponendo i suoi privati interessi, e con grave ispen io . i danaro e salute, vi si dedi cava, anima e co~po, talment~chè m h . . l' ebbe ad acquistarsi ben meritata fama m que- poc I anm eg 1 r d l di st'arte, e testè venne nominato fotogra10 capo . e co~~ . . dacchè seppimo come sotto gli ausp1c11 di statc,-magg1ore, · uell'infaticabile capo ch'ha l'u ffizio supel'lore}ell? s tato~magq_ . ta a tutta soll ecitud ine attuando l unp1aoto d1 una g10re, SI S . · j" • t . fotoll'rafia mil itar e' ci v enne il p en,s1ero di a pp icare i ~os ri 0 • · tto epperò ne offnremo studi i a questo importantissimo sogge , prossima m en te i risultati .
La Gue1·1'e et la l1cvix, par P. J. Pnou?HO M . - Quanti ha?no let to u esto n~ovo sogno del noto utopista francese_, am~11rer an110\a longanimità che ci volle al s igno~ E. P. d1 ~ab1 tolle'. " ' t . l s20 a1· linea per torre a discutere SUI sofismi sotto ,eneo e ne , d · l e sulle enfatiche sentenze del signor Proudhorn' che a n· a schietta non ci parve posst i e si avess er ·b" l · 0 da prende re su I ' ' , serio da verun militare!
..-Revuc !Iilitairc Suisse.
No 13, 20 ·luglio - S eg ue il iapporto d_el dica.ste ro mi~itare federale sulla sua gestio ne d el 1860 ' rnto~n_o alle vane scuole e corsi di r ip et izioni pe r ogni arma tenu t1 m ta le anno.
No 14 5 agosto. - Les combats du St-Gotha1·d, en 1799, decliée a~a; militavres du rassemùle~ent de t1·?upcs de 1861 - È èJ.uesta una bella e particolaregg iata nanaz1on e de~la cam pagn a che tanto illustrò Mass;n~' ristretta però specialme~t~ a fat ti cli'ebbero per campo dazi one la r eg1o~e ~o~t~os~ e S Gottardo . Cert ame nte :Q.0n poteva~i dedica re _a m~l-•tari d.el c~ncentramento federale di quest'anno un epis~d10 militare più ap pro pri ato allo studio militare •della guerra d1 m~ntagn n,. a:-
1•egoachè la campagna del 1799 è dai p ;ù illustr ~ maestri npulata come un classico mo e o 10 pro 0, . d 11 · p <:Ìto ed 11 suo teatro
820 BlBLtOGlUFICA
DIDLIOGRAFICA 209
è quello a ppun to ove ma novrerà i n q u es t'anno l a .diYisìone fod erale.
- In occasione d i tal e concen tram en to p e ll' ist ruzione delle truppe federal i , i1 dicastero militare fede r ale adollò l'istruz ione provvis or ia segu ente p\}r l'im piego d e ll e tende (ient es-ab1·,is) .
Descr izi one - La t e n da s i compo n e : di
a) D ue ?Op6rte laterali , a,·e n t i 5 pi ed i e 8 poll ic i di lunghe zza , su 5 pied i e 4 p olli c i di l a rghezza, al l a to sup e r io re e a i du e l a ti per l a rghezza havvi un a fila di b o tton i e d i bot -
1on i è r e, al l a to i nferi o re duo fi bb ie d i co rdi cella;
b) Il IJ•iangolo, o coperto p osteri o re, la di cu i ipote n u sa ha 8 pi ed i di lu u g bezza e g li alt ri d ue l ati 5 p iedi e m e zzo ;
e) D ue pali fe r rati, l ungh i 4 p ied i ;
d) Se i pal ett i ;
e) Du e cordi celle, l un ghe 8 pie di;
Il pes o totale d e lla tenda è di c i rca 9 libbre .
Pachettaggio . - La tenda è por tata da 3 uomini , cioè :
Due u om ini portano c iascuno una coperta l ate ral e, u n pa lo e d un a cord a; un te rzo u om o po rta il t r ian gol o e i p a l et ti.
Le coperte l aterali s i piegano a doppie, pel mezzo, coi botton i a ll'inrnor i e su di una lunghezza u g u al e nl la. larghezza de llo zaino, e s o no collocate s ul lo zaino a l d is o tto d el .. cappotto.
I p a li sono fissati p e r pe nd icol a rmente pm· mezzo della cordicella a l l ato sinistro dello zai no e io m odo da passarlo di un p iede e mezzo a l diso t to .
Il tri a ngolo è anch e piega t o su di una lun g h ezza u guale a ll a larghezza. del sacco, co' paletti r inchiusi i n esso, ed è cos\ posto sullo zaino sotto i l capp otto
Rizzmnc nto delle tende. - T r acc ia to i.I ca mpo, i tre cam erata da tend a s i r iuniscon o, depon gono l o za i no e sc iolgono i pezzi per l a t e n da .
I due p rim i abbo ttonano l e cope r t e l a tera l i.
I pa li i mpegnano l ' estrem i U~ l oro superi orn nel fo ro delle coper te lateral i, e coll a punta forata sono conficcati nel suolo . D ue u om in i tengono la. tenda, i l t e rzo fì ss a u na del le co rdicell e alla parie su peri ore de l JJa lo a n terior e · , e la t e nde per mezzo di un pal etto ch' egl i pianta in terra nella di re z ione dell' ass e d ella tenda
L a stessa cosa praticas i per il palo poste riore . Quando l e due co rd i celle son o t es e, un u omo ti e n e l a te n da, g h al t ri d u e tendono l e coperte laterali e le fis~ano per mezzo dei quattro paletti rimanenti, ch'essi pi11.ntano nel s uolo i n t raYers o d elle fib bia . ,
Quando le cord icelle e le cop ertP. laterali sono tese, l a co, per ta p osteriore s'abbottona sulle due altre, e la tenda è cos\ c om pi uta . ,
Smontamen to delle tende.' Per d isfa re l e te nde s i pr oced e come per r i zzarle, ma jn ordine in Yer,,o . Il materiale è riun i t o e pache ttato come si disse . Ogni u omo è l".sponsab il e de l m ate ri a l e affi datogli. ' . · ·
R iparliz·ione delle lemlc per l'ordinamento dei bivacchi . -
A quest'effetto le cc,mpagoie sono div ise, p e r tre filo . Op;ni sez ion e di t re fil e rice ve d ue tende . I tl'c .u omin i di 1a.- r i ga for~1ano tre camerata d i tenda; quelli di 2" :riga tre altri.
I sott'uffiziali, tamburini e trombettieri hanno una ten da per ogni i nd i vidno . , Gli uffiziali di compagnia h ànno d u e t ende per compagni a . - Lo ~lato maggiore di un ballaglione r i ce ve 9 tend e, di cu i 5 pe r gli uffir,iali e 4 per la t ruppa . - Quest e tende so n o p01'tate nel carro, o d'a bestia da s01na . .
Stabilimento de{ bi:vacchi. - I fasci d'armi essendo formati sul sito del biYacc o, i tre came rata di tenda si collocano g li u n i die tro g li a l tri, sn t re righe . - D opo di ciò il comandan te l a compagnia. fa all~are la t ruppa, po i comanda : distendetev i per la sinist1·a, a, sin islra, s1~1sTn', a cinque passi (~i distanza , 1JAnc11E . Q uando la compagnia è cos) ~istes a '. !l p rimo u omo d'ogni fila segna i l pu nto ove dev e · prnnta rs1 i l palo anteriore .
A l segnal e d i tamburo, o tromba (clisunionQ ), ha p rin cip io il ri zzamen to de ll e t e n de .
L e tende de i s otl'aflìzial i s i posano a circa 5 passi dietro quelle dei soldati; quelle deg li uffizia li a cil'ca 5 passi d ietro le prncede nt i.
Se si bi vacca i n col onna, .la distanza fra le compagrne debb' esse re di 20 passi almeno . Don s'intende che si può d1s t e n d c: ro la trnppa a n che pe r la d est ra , od al ce n tro
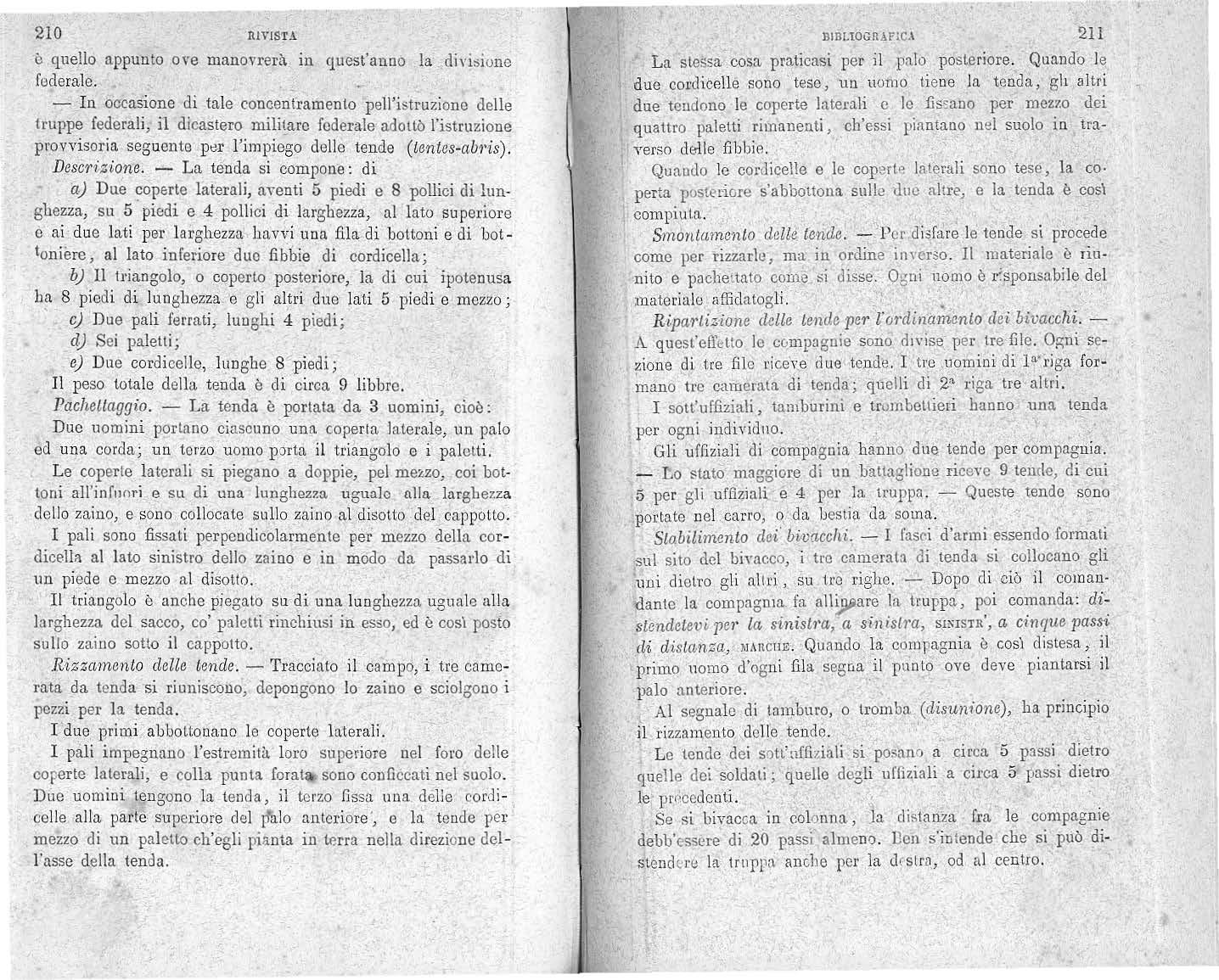
210 RIV ISTA
BIBLIOGRAFlC.\ 211
_
N,0 15, 21 agosto - Les combats dii St - Gotha1·d, en 1799.
- (Segue). - Rcissembteme-n t de t1·ov.pes cltt St-Gothard: orùin ì dél gio rn o relativi; s up posta ge neraJe delle manovre, esecuzione delle operazioni e<l ordinamenlo nom i nativo ùclla cli visione, norme sulle suss;stenzc, rapporti, seryizi o i nterno, bivacchi e accantonamenti . C.
- T ogliamo dal Cosm.os (16 luglio 186 1) che il generale Konstautiooff, direttore della fahbricazionc e dell' im piego dei rnzzi da gue rl'a in RL1s'Sia, ha test/i pub blicato j l seguente libro~ ,

Lectures sui· les f usées de guer1·e, (a i les en 1860 pa1· 01·cl?'e de S. A I. te grand-,luc - iJlichel, grand-m aH1·e de l'a1·tillerie
1·u.sse, publiées avec t ' au tor•isation cle S. 111. l'cmpe r eu r de toutes l es RussÌf8. - I val. avec 32 plcmches. .
È un trattato qua si comp!e:o dei razzi , poco st udiati fin o al g iorn o d'oggi . Il dotto generale tratta gradatamente della oppm tunità dei ra zzi, impiegati qua1i armi da guerra , e dei se r vi zi ch'es si hannb git~ r esi; Ja cono s~ere la l oro _ fabbricazione, la 1:nisura della loro forza motr ic e, del mate riale da tiro
A r!:i. trasporto, dei perfezionamenti arrecati ai razz i in Ingh ilteL01a, i n Aus tria, in Francia, in Russia; dice essere uoa specie tu Ha nu•va di materi;i le da fa bbrica.zione r i iwenuta dal mede- · simo gen era. le e cos t ru tta n e lle celebri offic ine d e l sig Fareot; tratta dell'organizzazione dell'arma dei r achettieri (fuséens). Noi raccomandiam o quest'opera quale perfeziona ment o nell'arte incendiaria in g uerra, al quale oggetto essendo stato in1erpellato l'autore> se non vi era f el lo~ìa e crudeltà a servirsi di simili mezzi in guerra? risponde : • essere in se stessa
In. guerra nna delle più grandi calamit/1, contraria a tutti i sen timenti d 'umanità ; m a> d ivenutà a lfi oe i n ev itabil e, bi sog na subi i·ne tutte le co~segucnze e cercare ogni mezzo per affie'.. Yolire le forze dell'avversario • .
Ci ri serbiamo a ·parlaL'e più in esteso , tostochè avrem o l e tto per ioter o CJUl'st'opera . D. B.
212 RIVISTA BIBLIOGRAFI CA
TAGr. r,nw GAETA NO Gerente.
PARTE . ru.
Le propri età tattiche car;tteristiche \ c:1 essen ziali della . cavalleri a . in genèrale sono la mobilitò, e l'11.,rto: - Ja prima ·è il .m~zzo: la séconcla l 'effetto.' _:_ Epperciò queste due proprietà s0110 indi'spensabili a qualù.nquesiasi spe_c1e di cavalleria.'
Siccome però nel coml:>attimentb si presentano s;ra:ria- , tissime cir cQstanze r èlativarrien.te · terreno , _ alle trup pe comha.ttent i , ed alle fasi del combattimento ·stesso , si cch è -.,. ,. richleggonsi modi diversi d'azione , ovv erossia _ di ~nl;I.- · novra, non solo fra le trupp e d'arma , diversa, ma ben . , ( ' anèo fra quelle della stessa atm?' ; · cosi fra le · trupp e di una médesìma -arma nacquero d isti.n;z;io1;ii organiche per rispettò a quel modo di Òombati\3re cmi sono p~ù special.mente destinate .

E ·n~ L NU.OVO
NE l, LO SPIRITO ])ELLA TATTiçA MODERNA
DRDINA11ENTO
DÌlLL'E SBIICl'fO ITALIANO
_, OONSID);;'R.faION ! ' 'J'.~ TTIGHE" EL~;IBNTAiR.T.
ANNO VI. .Voi. I. - 15.
Si combatte in ordine chiuso od in ordine sparso, cioè in line~ od in ben;,igiieri (1) Epperciò due speci e di truppa m o_gn:- arma: fanteria :di linea e fanteria, leggera o bersa~h~ n;. cava~leria di linea e cavalleria l eggera ; artighena .d1 linea o di battaglia, , e artigli eria· leggera o a cavallo. -Letru ppeclil~nea destinate spec ialm ent e al combattere _ in linea, in orcli1)anza, chiusa e regolare, ladùo,,e sonovi linee di battaglia nemiche _da . rompere o da r espingere, e dov e il terreno consente cotale _ ordinanza . . Le truppe leggiere invece combattono in ordine sparso, p1ù o meno afforzato secondo il bisogno per attaccare o
{1),Usiamo qucst'espr cssio nc, pel'chè nppo noi consacrai.a, ' o~gimai, e glor1~same11te, -~all'~s0·1 sebbene t,1t t'alfro ne sia il senso et im ologico.
B~, sa_gliere der1 vas1 ovviamente , s iccome il verbo bqrsag:liai·e, da ' bersagho, paro la d'ol'jg inc propriam ente ita liana per indical'c lo scopo cui imb~rcia _ii tirator11. Epperciò be,·sagliere dovrebb'esscrc ql) ello il q·;,ale mun ito d1 un'arma di tulla precisione , è spceialm_c;nt e destinalo a decimar ,: da ' lungi_ ed_"! c:~ JÌer to, le ii!e 'del nemico COIJ tiri uggiust,at.issimi, C<llllc sono I ca.,•abmier,., nel! cser~1t.o svizzero. Tal e non è atlua lmente la dcst,inazio '.ic propria dc' nostri b ersnglicri avvegna cchè ess· i piutlosto che al ber5a g lwre 111.:!I_o _ stretto $Cnso eN molog ico della pa r ola, vengono ç:on brn m~gg10 1:e ut_i!1t~ impi1•gat.i nel combal.lerc alla spicciolnfa pci celeri a_tt,1cd 11 , ?e c_olJ)l d1 mano, per le scor1;eri,e cd i !1 somma pcll'importantiss'.mo_ u:fìz10 d1 truppa leggera nel quale cotesta t,ruppa si acquistò mer1tat1ss1ma foma. ·
'l'a_lc r,cr ò non era h dcstinazi01Ì:c prima ' de' }lrrsaglicri, ma quella bens1 che s t a nel vero sen~o della parola. L'lllust.i·c generale La Marmora Alessa ndro, <l'imperitura , memoria, coi deve'l'escrcito sì uti le istitu~ione, vo!Pva formare un corpo di sce l ti: tiratori, i quali dotati di grandissima mobili\à, P?tess~ro ' vccorrcre cli contro a.i punti import-an 1t,i del campò Ili battaglia, per 1sloggip.rne il ,nemico co' tiri loro ben aggiustati, od almeno p er prepa rarne l'a.tta cco ·all a ,fanteria . ,, Con ciò, noi non· fotcndiamo insinu are che si debba mutar il nome ai bersagli eri nostri ovvero la destinazione lattica loro no sic11rame~te im- h' . ..,._ ' , peroc? e_ a qnesta denominuzio ne sono annessi troppo glor iosi ricol'fli, pcr_chc S; possa pensar ili spog liarnc una tr·u ppa che ha reso e renderà ma,_ sempre s~•gna lati_ servigi co_ll'at,1u al11 sua taltica. E convien piuttosto, ,a ,rl1spetto . de , :filolog1, ,. mutar 1I senso , alla paro la c ome noi abbiamo fatto. - Ci perdoni il·co rtes e l etto r e questa di"ressionc cui fummo indotti . " ' per rispondere a taluno che più tenero di filologia che di vera utiliti1, proponeva tcstè si mutasse i~ altra !a denominazion!l ~• bersaglieri ,

respingere le trupp? leggiere nemiche J per inquietare le batterie ne m iche, per i11izia;re il combattimento , per cuoprire e :spalleggiare gli attacchi co11centrati ai centri di difesa, per ingannare il nemico sui veri punti d'attacco, t enendol o a ba:da~lungo tutta la sua fronte, per guernire, ,occupando estesamente quelle parti della posizione meno imp01-tanti per rispetto all'obbiettivo del combatti~n~nto stèsso, permettendo co sì. di concentrare le truppe d1 lmea sui punti più imp ortanti ' e decisivi, per molestare inces~ santemente il :q.emico s ul campo di battagli~, ne' suoi bivacchi, nelle sue marci e . S' impi egano insomma, in ogni circostanza di luogo e di temp o.
$ebbene sia necessario che tutte le truppe di 1,m:arma sappiano agire e neJl',un modo e nell'altro; per ,poter far fronte per se stesse a qualunque improvvisa contingenza, tutta.via è indispensab ile che il l oro otclinarnento elementare s'informi più particqlarmente alla loro destinazione ~.ttica speciale, per modo che loro diventi quasi .in stint u alè . Rao-o-iuug·erebbesi certament e un mass imo d i perfezione, 00 ,. -. quando ·tutte le truppe de.Ha stessa f,rmà venissero _ ugualmente perfez ionate in ambo i ~n:od1 cli azion~ ma _oltre a. che, non tutti ,gli ttomi111 sonom differentemente atti a-llo stesso servi:r,io, s'aggiunge che le pratiche sia cl ell\mo che dell'altro servizio scino di per loro stesse già abbastanza svariate e gravi, percbè "ragionevolmente non si .possa pretendere di cnrnularl e sull~ stesso individuo. Una truppa ·v uol esser e ordinata ed 1strutta per u_n fine principale determinato, in gi'.ùsa che, ove le circ~stame eccezio na.Ji l'abbiano costretta a dipartirsene, ella v1 possa instintualmente far ritorno appena sia no quell~ eniergenze CE)ssate.
Premesse quéste brevi osserva~ioni ·generali, torniàmo alla· nostra. t es i particolare .
214 S:t' U DI
SOLI.A G,I Y ;ILf, o:R IA 215.
'
Classific,azion o dolla cavalle ria.
Da q uanto sovr a abb i amo detto ris ulta ovviam ent e la, necess ità di avere due s orta di cavalleria, : la cava lleria di linea destinata essenzialmente a squadron eggiare e cari care in ordine unito e com patto, il cui fin e tattico principale è l'urto; la cavallfYl'ia legge1·a essenzi al mente destinata a scorazzare il can.1po d i battaglia,, a molestare il n emi co coi snoi improvvisi e r apidi attacchi, a guizzargli fra. le man i , e ad ogni oi::erazione di guerra minuta in cui si r i chiede celerità; epper ciò il suo mezzo principale d'azione è la mobilità.
Hannovi d ifa tti appo Lutti gli eserciti coteste due specie di cavall eri a, ed anzi ve n' ha pure una terza che tiene i l mezzo fra le due pr ecede nt i.
Ma ecco affacciarsi una q uist ione , nella quale, fors e più che in ogni alt.ra, troveremo numerosi gli oppositori : epperciò appunto ci studieremo di avvalo r ar meglio i nostri a rgomenti ; ciò ·che d'altro nde non ci sarà gra n cosa di ffic il e .
Negli eserci ti delle g r and i potenze europ e e ht cavall eria si divide in
ci) Cavalle1'ia g•rave: composta d' uomini e cavalli di ::tlta statu r a, , pesantemente a r mati , e copert i d i ferr o .
Questa specie d i cavalleria (corazzieri) r i unita in divisi oni e cor pi, formata di parecchi r eggimenti, vien t enuta i n riserva nell e batta.glie per prodursi soltanto n ei momenti e su i punti decisivi colla so l a a zi one della propria massa , con cariche genera.li e condotte a tutto fon do .
b) Cavalle-ria divi.sionwria : composta d'uomini e cav alli di mezzamfst atur a e meno pesantemente armati che non quelli d ella precedent e . Qu esta specie cli' cavalleria v a r ip artita p er r eggimen,to fra l e v arie division i dell'esercito, ed è q uella che più immediatamente combina la sua azione a qu ella delle -altre due armi, seguendol e in og;1i
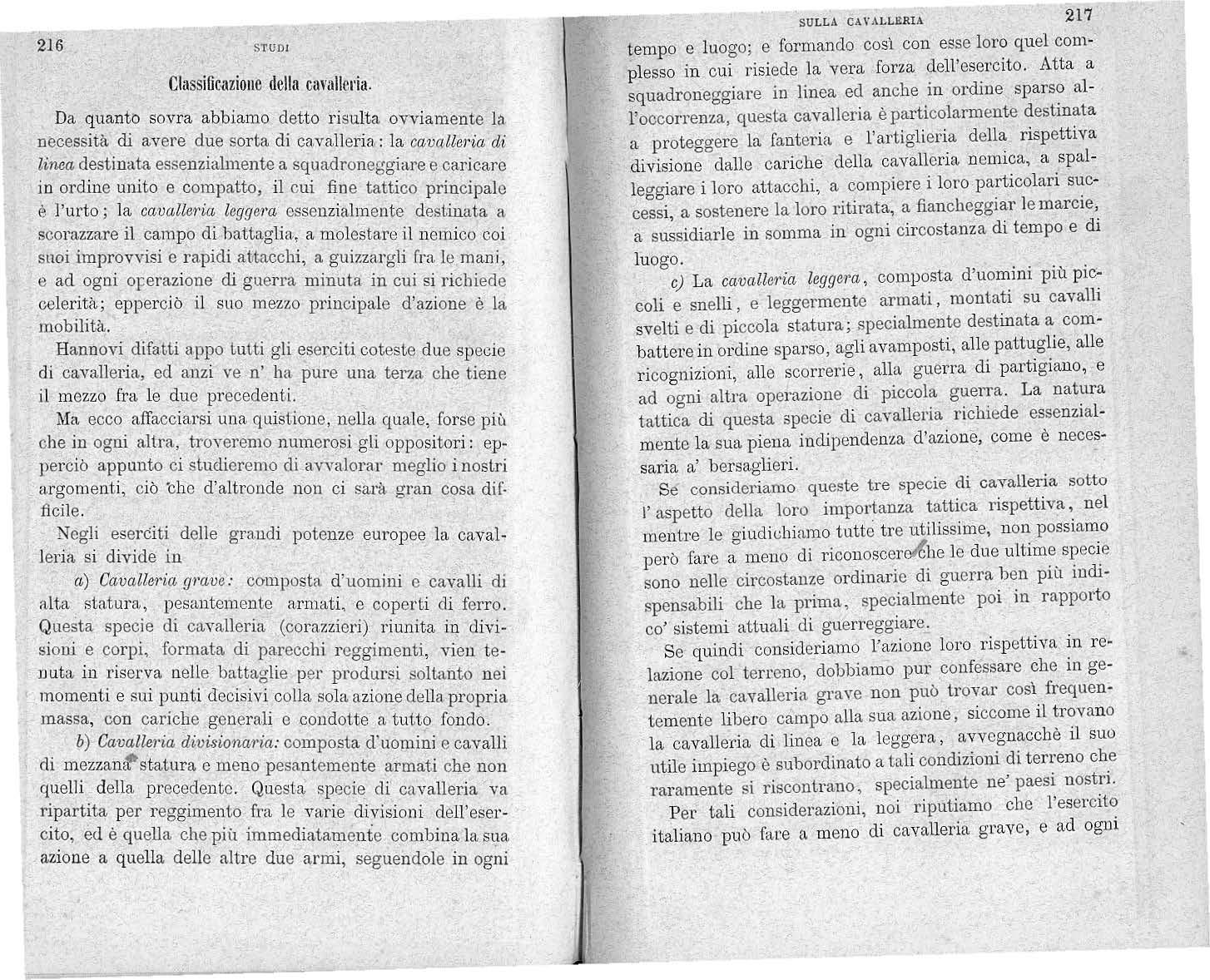
tempo e luogo; e formando co sì. con esse loro quel compl esso in cui risiede la vera forza dell'eserc ito. Atta a squadroneggiare i n linea ed anche in ordin e spars~ al1'occorrenza, questa cavaller ia è particolarmente destm at a a proteggere la fanteria e l'artiglier ia d ell~ rispettiva d i visi one dall e cariche della cavalleria n emica, a spalleggiar e i l or o attacchi, a compiere i loro p a ~·ticolari s~ccessi a sosten ere la loro ritirata, a fiancheggiar l e marc1e, a s~sid iarle in somma in ogni cir cost anza di tempo e di luogo. . . . . - e) La cava lle1·ia legge1·a, composta d'uom1m più p1C'coli e sn elli , e leggermente armati, montati su cavall i svelti e cli piccol a statura; specialmente d estinata a combattere in or dine sparso, agli avamposti, alle pattuglie, alle r i cognizioni, alle scorrerie, alla g uer ra di partigiano , e ad ogni altra operazi one di piccola guer ra . La nat~ll'a tattica di questa specie di cavalleria richiede essenzia lmente l a sua p i ena indip endenz a d 'azione, come è ne cessaria a' b er sagli eri .
Sé consideri amo queste tre sp ecie d i cavalleria sotto I' aspetto della loro impor~anza tattica rispettiva~ nel mentre l e g iudi ehi amo tutte tre utilissime, n o~ poss1aro o p erò far e a meno di l e due u1tim ~- s~ ec1.e son o nell e cìrcostanze ordinari e di guerra ben prn indispensabili che la prima, specialmente poi in rapporto co' sistemi attual i d i guerreggiar e.
Se quindi consider i amo l'azione l oro risp ett i va ~n relazione col terreno, dobbiamo pur confessare ch e in generale· la cavalleri a grave non può trovar così frequen~ t em ente libero camp o a lla sua azione , siccome i l trovan o la cavalleria di lin ea e l a l egge ra, avv egnacchè il suo utile imp iego è sub ord inat o a tali co ndizioni di ter~·eno eh.e rar amente s i riscontr ano, specialmente ne' paesi nostri.
P er tali considerazi oni , noi riputiamo che l'esercito italiano può fare a m eno di cavalleria grave, e ad ogni
216 STUDI
SULLA CA\' Al..LERIA 21 7
modo, e$so debba innanz i tutti rifornirs i di cavalleria -di linea e di cavalleria l eggera.
. Esamini_amo pure la questione sotto questo punto di :v~sta p-a~ticolare, in rapporto al terrenq, agli uomini ed ai cavalbi, e vedremo che il reèlutamènto é il manteni~ento ~el~a cavalleria grave , ci presentano troppo serie difficolta, e mgent1 snese, perchè possano essei'e com~ pensate dall e, rarissime ed affatto eccez ionali occasioni d 'impiegarl~ secondo là sua .vera destinazione . · . '
.Pà n:~p~tto al ter•l'(H'l,Q; l e nostre contrade uv e non $0110 montuose, sono _ i1:1tersecatiss'iJne · da numerosi corsi di acqu~, e ~a fossati irri gatorii, e dappertutto ingombreda ngoghosa vegetazione, per cu i non si i;icontrano - a pert1 e spaziosi campi di battagl ia , come rich i ede l'a, z10ne ~ell~ cavalleria grave i-n grossi corp i. · ·
. E difatti, s~ oompulsiamo l?, stoi'ia delle o·uerre dàlle più remot~ a.Ue più recenti, no i vedi amo e~me ;otesta cavalleiia sia rimasta press o che ·sempre · i noperosa in ItaJ1a, nel s~nso delta sua vera des:ti n~.zione tattica .
Nell'li1tima campagn a del 1859, gli eserciti combattenti avev~no seco '.oro pochissima cavalleria g r ave , e neppur questayoch1ss1ma potè trovi:~1' occas i one d i! fars i valere .
P:r no 1 qu~nto ben più utili sarebher<? i n ~g~i caso corpi di . cavalleria _leggera e meglio ancora c'oppi compost.i unicamente d1 truppe l eggiere d'ogni arm a, la quale id ea svil~pperemo dist_esamen.~e a suo lu9go nel , process o di · questo nostro rag1011arne11to .
Per 1·ùpetto agli i~omini: oltre al non abbondare fra ·noi per corporàtura gli uomini macchinosi atti al servizi o de' corazzieri, l'indole stessa degli Italian1 non si confà a quel fre~do e èompas$ato squadroneggi are ch'è proprio e _n~cessa~w a quest'arma. Quando il cannone ttiona davv' l ClllO ~01 be~ sapp iamo quanto .sia malagevole il trattenere l n ostri s oldati coUe mani . allà . cintola! ,

Per 1•isnet1 0 a' · tt · . · • . . _ ;- " cavci i noi non abbramb raz-ze JJ1d1gen é
di grandi cavalli, come s'addicono alla grossa cavaller.ia ; epperciò si amo , costretti pr ocurarceli dagl i altri paes i . Coteste rimonte pro-venienti da1l'ester0, ol tre al costare enormemente, · non danno mai troppo buoni risultati, sia perchè i m i gliori cavalli sono reclutati dal rispettivo Stato, sia perché è fÒrza di passar fra l e, mani d i esosi spe~ul a~ tori . D'altronde non è l ungi da noi il caso, in cui d ai paesi da cui solo possi amò .tiforn irci di tali Cl!,valli, ci fu vietata rigorosamen te e _ indila.ta.mente l' esportazio n e . · Per tutt e queste r~gioni noi siamo d 'avv i so che convenga escludere dall'esercito nostro la cavalleri a grave, co:ç.centrando invec·e ogni cura e spesa a favore della cavalleria di l i nea e della leggera, le quali ci potranno in ~gni occorrenza amp i amente compensa~e de' fatti . sagrifizii .
Ci si opporrà, in riguardo al terreno, · ohe l ' esercito nostro no n debb'essere esclusivamente destinato a combattere sul proprio territorio, potendogli accadere di dover portaré ' la guerra in , co n ttade stra,niere, ove l'ip1- . piego della cavalle ria grave possa tornar utilissimo . -
A tale appunto nory scal)rosa _la risposta: Nell'ordinamento d1 un, esercito, la ragwne che deve aver maggior p eso si è la d ifesa del proprio territori o , spec ialmente, t rattandosi dell'ese r cito di una nazione retta a' liberi principii, siccpme l'Italia, · È indisp ensab ile che i sagrifizi che il paese s'imp one pel manten imento de11'°èsercito, siapo giustificati da, una necessità assoluta e d immedi ata . Or bene, può beni ssimo succedére che una parte dell'eseréito italiano, o comb attendo g uerra sua propri a, o combattei;ido pe' generosi alleati che gli pres~ar?no testè sì valido c oncorso,. abbia da uscire dalle p1~oprie frontiere; per tale eccezion e, la nostra cavalleri a di linea riu nendosi in divisioni potrà benissimò attendere àllo
218 STOD1
SULLA CA YAJ.LER IA 219
SULLA CAVALLERIA
stesso servizio della cavalleria grave, ed anche senza corazza i cavalieri ita li ani mostreranno di esser degni di combatter ~ a fianco e contro la iniglior cavalleria del mondo.
La .nostra cavalleria secondo il riordinamento dello scorso .geunaio distin guesi i11:
_
Cavalleria di lin ea, · 4 reggimenti.
Lancieri, 6 id.
Cavalleria leggera, 6 id.,
Guide, _1 id.
Qi1esta distinzione; buopissima al punto di v ista nominale, non lo è così al punto d,i vista tattico .
. Imp erocchè 'di fatto noi non abbiamo che due · specie d1 cavalleri a; la eav~lleri a di lin ea, e la ca valJer i a l eggera, c?mprenqansi i l ancieri, comunque si' voglia, o nella prima o nella seconçl.a., Di cavalleria grave noi non ?os_sed~amo, ch e certamente per t,ale non si può in princ1p10 n putm·e l a nostra divisione di linea, nè per r i spetto a' cavalli, nè per rispetto all'armamento; ·
In questo senso, ch'è, il vero sotto al quale vuolsi ~ousiderare l a classificazione tattic1t della cavall eria, l 'attuale quadro _ ~i fo r maz ion e . ~ell'esercito italiano, si presta -alla ç;1·1t1ca; attesochè la cavalleria d i linea v 1 è destin ata all'uffizio d i cavalleria grave, costituendo una divisione; i lancieri e -i cavalleggeri vi formano indifferent emente la ca valìeria div i sio_p:ari a, hanno cioèladestina-zione . prop ria della cavalleria di linea: Eppercjò, sta~do a d~tto quadro di formazione, n9n ci rimane di cavalleria leggera, nel ver~ spi1~ito d ~lla essenza tattica di questa specie di cavallena, avv egnac chè tutti i nostri reggimenti di cavalleg~eri trovansi incastrati nell'ordine di battaglia, ciò che, siccome abbiamo dimostrato, non debb'essere. , , , Questa impropria class ific azi one dell-a ca~alleria è scon· . venien,te_, e vuolsi quanto p rima correggere ,nel ·senso s.uespresso.
Si chiamino pure i reggimenti lancieri, dragoni, u sseri, o ·come altri~enti si vogl i a, ma sia ben determinata 1a 'loro _specie tattica, e la loro destiriazio"ne_ tttti:a 11ell' ordine di battaglia, imperocchè, in tale d1stmz10ne . de: stinaz1one sta l 'importànza sostan zi ale della cavallena sul campo di battaglia . . . .
L 'esercito francese ha.nomin almente: carab1men, corazzieri, dragoni, larici eri ,' usseri , éacciatori, s_pa·hi~ e gu i de, ma tattìca.mente, cioè per rispetto_ all'o~d171 e d1 battaglia, ha tre specie di cavaller'ia : la cavalleri_a d i ~-1serva o cavalleria o-rave che comprende. cara.bnnen e coraz;ieri · la cavall:r1a -:li linea composta d ei dqJ..gorii e dei lan;iéri; - la cavalleria leggera formata degli usseri, dei cacciatori, . delle '_guide e ·degli spahis. . .
L'Austria distin_gue pure l a .sua cavalleria: in corazz1en, dragoni, ulani ed usseri, ma la classifica essa pure tat~ ticamente nelle tre speci e predette. E così presso , tutti .gli altri esetc iti.
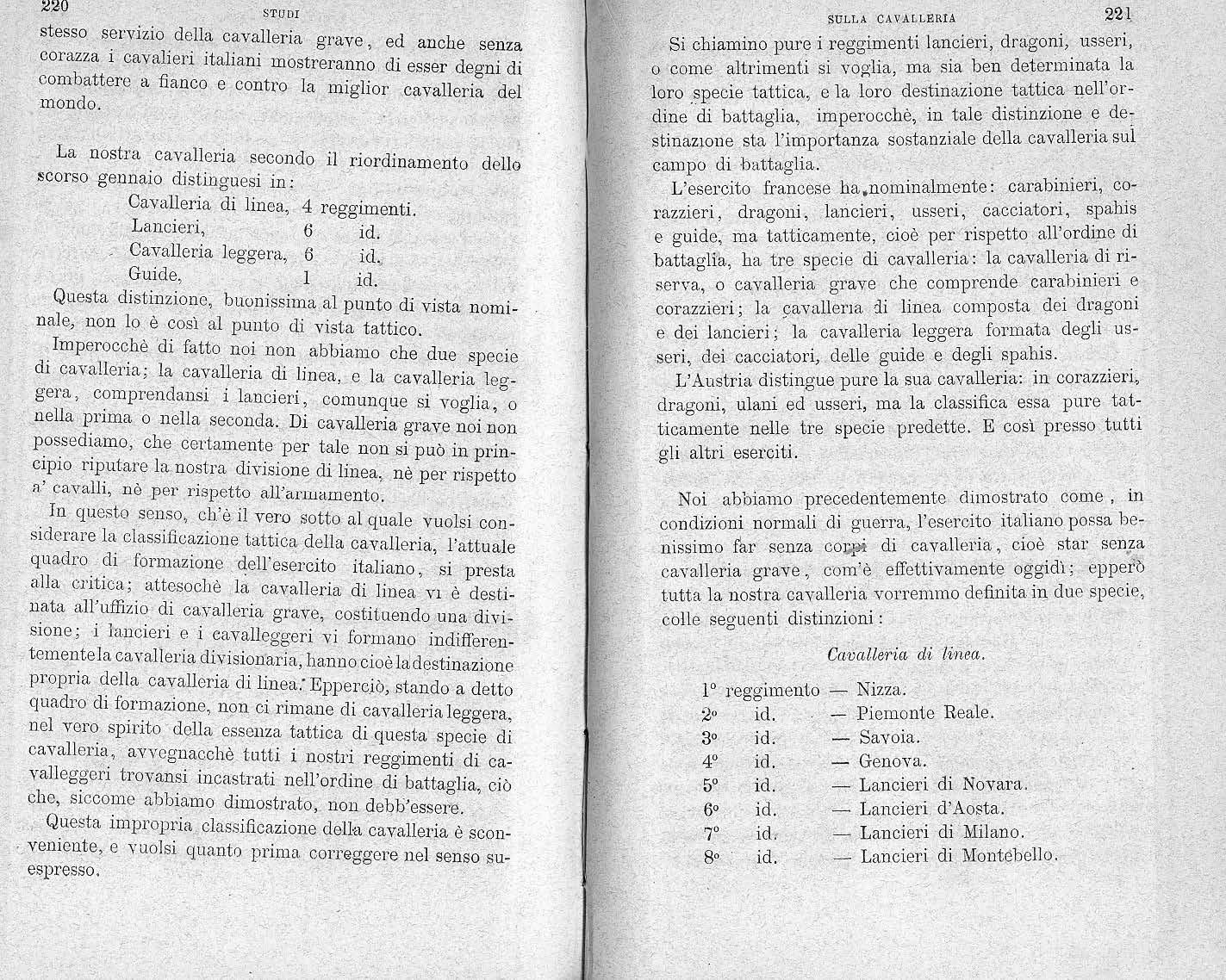
No i abbiamo precedentemente d ù nostrato come , in · condizioni nonrnili di g u err a, l'esercito italiano possa ben i ssimo far ·senza CO)~ di cavalleria' cioè star sen::a c avalle-ria grave, c·~m ' ~ effettivamente oggidì; eppe_rò tutta la nostra cavalleria vorremmo d efinita iI?- due .s pecie, colle seg uen ti d istinzioni : Cavalle;ria di linea.
1° reggimento, Nizza.
zo id . - Piemonte R eale.
3° id : - Savoia.
4° id . - Genova.
5° i d . - Lancieri di Novara.
6° id. - Lancieri. d'Aosta.
7° . id t - Lancieri di Milano.
8° i d. - Lancieri di :M.ontèbello.
STUDI
9° r eggimen to - Lancieri Vi t t or io Emanu ele .
10° , id . - Lancieri di Firenze.
· Ed altr i sette da forma;si per modo che ve ne sia uno per caduna divisiOJ:!e dell'esercitq.
1° reggim~nto
2° id . id . id . i d., , id .
CavallM'ia leggera.
Cavalleggeri , id. id . . id .
di Saluzzo . d i Monferrato . di Alessandria.
d i Lodi . ,,. :id . di Luc ca. · _ Usser i di Piacenza. ~ Giiide.
Questa cavalleria per s u o particolar servizio deve fare categoria a parte. ·
:POpo aver fissate ·le nostre idee sulle d istinzioni el e1'.rreiitari della cavaller ia, discendiamo ora Ml'esame delJ a qu istione orgànica di ciascuna · d e ll e due specifl di cavalleria..
Cousidcr~zioni su ll'ordio,\mento della cava ll eria ,io generale.
La bontà dell'ordinamento della cavalleria in generale, è basat a sulle tre se.guenti c ondiziòni :
a) Scelta degli uomini .
b) Scelta dei cavall i.
e) Istruz ione . degli uni e degli altrì.
a) Scelta d egli uomini - Non tutte le recl ute son i atte, od ·egualmente• atte al servizio a cavallo . Fra glo idonei ·alla cavalleria, altr i sono pi ù p r oprii. al servizio di linea, altri al leggero, siccome ciò s't1ccede analogamente per le fanterie .
L'uomo di .mezzana statura (fra Jl'' ,62 e lm,75) è il più idoneo al servizio a cavallo . Gli uomini troppo grand i aggravauo soverchian:iente ·il ·cavallo, e difficilmente rie -
• sco n o bene in sella:; i trop po piccoli vanno pure s oggetti a quest 'ult i mo inconven i ente, ma in sens o opposto ai pr imi. Non però vi son·9 degli uom i 11i piccoli atti~s imi al1a_ ca~ -.;, aperia leggera, e sono qnel li dall 'infanzia avvezz i al ca valcare .
Il caval iere vuol essere però in g·enerale di mediana statura, El sov~attutto ben conformato e robusto. Gli uomini pii.Lt archiat i vanno destinati alla cavalleria d i linea; i meno' alti (fra lm,62 e lm,70) ed i più snelli alla ca valleria leggera.
Nel r i parto del contingente fra l e due specie di cà. valle rie, bavvi pure un altro rìgu ~rdo che debbes1 osservare . Il cavalleggero d est in ato particol armente al combattere in ordine sparso, pel suo speciale servizio potendosi trovare moltis'sime vol te .isolato, epperciò i1~
balìa a l proprio sen,no, ha mestieri di buon senso e d1 una certà èiose - d' i niziativa .intell e t.t,:uale, che sebbene de-. siélerabi lissima in tutti , non è così 1~ecessaria per qu ella di linea.
Di più - ed è pur questo un imp ortante rigmirdo da, aversi nel' ripàrto d el contingente - alla cavalleria voglionsì d{ preferenza assegnue que1le reclµte c~e ~1ann o o·iil. qualch e cognizione e pratica i nton:10 ai cavalli, talt o ' ' ' i postiglio n i , i co·cchieri, i palafrenieri, i carrett!er1, mulattieri; nonchè i manescalc.bi e sellai; ciò che, lo direm? francamente, seb!Jerie imposto categori caiì.1.ente dal vigente regolamento sul reclutamento dell'esercito:, n.01;1 viene, · come dovrebbesi, strettamente osservato.
E non è raro trovare tra fanti eccellenti palafrenieri, mentre al1a cavalleria toccano s p esse volte ii1dividui che cavalli non ha4no gianrniai tla1,tu,to, e, qLrns1 diremmo 1 veduto.

ST UDI
$UU.A CAV ., LLE RIA 2,23
Cotestora , in generale, giungendo al reggimento, a vvicinano a malincuore e con grandè a1Jprensione . lli . . 1~ va , e quasi vedono un n emico in quel nobile an i mal~ eh~ debb'essere invece il loro migliore amico. E quanta • fatica debbasi durare a far loro sormontare cotale avvera ~wne, ~en il san~o p er prova i .nostri sott' uffiziali 1st.r utton.
G,l'Ita~iani, siccome in gen ~ral è tutti glì .altri pop~li dell ~ -c~1~eut~ e del No rd, non hanno -all'equitazione tutta quell mclm_az10ne degli orientali, i quali famigl"iarizzati fin dalla loro mfanzia agl i eseroizii equestri, fanno d el cav allo la ~oro magg iore e predilétta occupaz i one .
Tuttavia non abb iam difetto a reclutare conveniéntemente la nostra cavalleria . -
La Sicilia ' la Sardegna ' e la Calabria c1· dare 11 po~mo :cce~ : nti cavalleggeri , .i quali mediante conve nien te rntruz10ne ~onno stare al confronto dei migliori d i ogni altro e~erc1to. ·
Le altre ~ro vincie italiane pouno forniré abbondantemente al bisogno tlella cavallerià ddinea., il cui r e cluta~ento, come preced entemente abbiarn notat~, non è così d1ffic1le come quello della l eggera . . Su 25.,000,000 d'àb i tanti non . v'ba dubbi·o b . e e si trovmo 30.,000 buoni cavalieri.
lJ) Scelta de' cavalli. - Il soldato di cavalleria ritrae il suo val~re intrins eco dal suo ea~allo. - Mal -montata la cav alleria non riuscirà mai a ni1mte di bt d · T d. , , . · tono, e m\ece 1 ~uell amto efli~ace ch'essa è ehiamata a pì'estare, sarà Jl p iù sovente d'1mpaccìo . "Epp erc iò piuttosto di a.Yere n~merosa cavalleri a mal montata, meglio vale averne poca e buona, e piuttosto ni ente' che · cattiv-~, - Da queste verità che leagiamo ii; tutti i buon·1· 1•b : . T · , o 1 11 1 ~ 1 1tan;. e che furono in bocca a _ tutti i grandi ·capitani, nl uc e _l impor.tanza della scelta pe' cavalli della cavalleria e quah sollec1tudìni mèritino le rimonte nazionali.~ ,
Il dover ricorrere all;estéro, oltre ad essere u n tributo gravosissimo per l'erari.o, dà sempre poco bu~ni ris~ltati: Ben più, co t esto mezzo di rimonta, esseJJ.do m ba.ha· d e~ governi esteri~ può facilmente andarci fallito, e vemrc~ -precluso in ·quel momento àppun.to in cui l'urgenza d1 cavalli è maggiore; e . ci ò avvenne poc'anzi, come . g ià ebbimo a notarlo.
Noi vediamo la Francia, tributaria anch'ess.a per lo · passato all'Allemagna ed all'Inghilterra p e ' cavalli, oggidì sotto l'operosità intelligente ·ed i n esauribile dell'imperatore, attivar con sollecitudine straor d inaria i mezzi di i~i. monta "nazionale . indi gena; , e la scelta de1 generale Fleury a d ispettore generale -d ~lle mandrie militari ch e i!f, questo · ultimo anno si mqltiplicarono, è una garanzia di buono e pronto successo a quest'importan t issimo ramo di militare serv i zio e cli nazionale ricchezza.
' Accorato dalla decadinza dell e raz7, e equine francesi, e spronato, come sempre, ad ogni s pecie di miglioria ch_e · possa i·ecar lustro e vaJ?.taggio alla nazione francese , l'imperatore neg1i ultimi mesi del 1860 incaricò una com~ missione presieduta dal principe Napoleone e formata, d1 eminenti personag g i in tal materia vrrsatis simi, cli fare gli occorrenti studii Slllla importa.ntissin:ia quis tion e delle rimonte e d ell'all evarileuto e~10. La comm i ssione non riusciva ad accordarsi iutorno al si stema di migli oramenti da p'roporsi: gF uni volendo che il go verno assumesse l'immediata e quasi esçlusiva in gerenza nell'allevamento; gli al tri pretendendo invece che la produzione equina fosse consi dei'ata come ogni altro ramo di pubblica e libera industria , epperciò lasciato a mano dei privati , lì~ita;ndosi l'azione del governo ad incoraggi amenti dire tti ·transitorii. !} imperatore tro ncò tali discrepanze togliendo i l servizio ·delle mai1drie dal ,dicastero deH'agr i- · coltura, del commercio e dei lavori pubblici per affidarl o al ministro cli, Stato il conte W ç1lewski , coll'ip_carico a

224 STUDI
SUL
RlA. 225
LA CAVÙLE
questi di riassu m ere le ·discussioni della commissione ippica , e di Gompilare · un progetto pe~ -r iordi namento delle mandrie :
Sullo s_corci~ dell'anno il sign~r Walewski pr esentava, alla s:nz,10ne ~~peria_le un pnogetto nel senso seguente : l_ ammm.istra,z10ne delle mandrie con 1250 stalloni, di cm 50 pei nuovi dipartimenti, doversi mantenere nelle mani del governo; ·
~: Sopprime_re _ l a mandria di _ca valle d i ~om.paclou(; .
3 Accrescete il numero degli rnporaggiamenti per l 'allevamento privato , e per estendere maggiormente il numero deglj stalloni approvati; e fra le istitu,,ion i chiamate •a fruire di cotale sovvenz i one, si annoverano le scuole di addestramento e di equitazione , e le ·corsé al trotto . ·
4° Porre a capo dell'amministrazione delle mandrie un direttore generale dipendente ç1irettamente dal ~ ì nistro di Stato . Questi, coadiuvato da un comitato su1;eriore, nommato appositamente dal dc:tio ministro fra P"]i alti funzionari i ·d e~o. Stato, e fra i generali, deve tras~ettere ogni anno al mm1stro una relazione sull'andamento del servirz,~o affi~~togli_, e sui progressi deU 'ind9st1:ia jppicà privata. Questo direttore general e deve inoltre i spezionare frequent.emente i depositi cli r -ifoonta per imprime;e loro una ma?gio~ '_uni ~~ di viste e di direzione, facendo rapporto d1 tah 1spez1011i a.l ministero. ·
• In c~tal modo ' (conèbiudev3: la relazione del signor ~Valewski) t utta la quistione equina sarebbe,'per ,così dire, m . una sola · mano, -e l e mandrie e la r i monta tenderebbero ugualmente verso lo scopo l)en inteso cui sarebbero dirette :. proteggere ed incoi·aggiar13. La produzione di lusso, riconducendo il commercio su i nostri merca.ti, non tarderebbe a dar fama e fa v o1'.e al cavallo francese, epperciò assi curerebbe mezzi più laro'hi alla r imonta della . e ' nostra c~valleria e presenterebbe al commerci o quei Y<i,sto• e libero campo cui ogni industria ha diritto n •

Il generale Fleury non falliva alla fiducia in l~i riposta qal governo dell'imp er atore, eél appena nommato direttore generale delle mandrie, concentrò ogni sua sollecitudine al riordinamento d i tale servizio nello spirito dell'imperiale decreto suacceimato, ricpia~andovi l_'attività e l a viail anza degl' i spettori generah, e tracciando loro la via d'az i one con apposite istru~ioni le '1ual~ ben si meritano di e~sere prese in gran considerazione da chiunque si occupi di simile soggetto. 1 .
Coteste istruzioni ponno , riassumersi nei sommi capi secruenti : · . . 0 1° I cava11i scel ti , destinati ad essere veud'nti quali stalloni, saranno v isitati nella primavera appena avranno l'età di due anni, etutti quelli che saram_:io r iputati degni di essere impiegati alla riprod:uzione, -v erranno distinti con una dichi ara d'attitud ine rimessa ai lo ro proprietarii , quale d·icbiarn loro darà diritt o di concorrere all'età, di tre anni alle prove che precederanno le compre ; queste . prove1 cui so no riservati prRmii -specia.li ed importanti, si riafl sumqno in corse al trotto pei cavalli da trotto, ed al galoppo con ostacoli per quelli · da sella: l'ammi:qist:·azione sce~~rà allora, fra quelli che avran dato magg10r o d . ·saggio di sè . QL101li non giudicati utili alla pro · uz10n_e do~,ranno a norma dei consio·li degli ispettori generali, ' ' o essere castrati al più presto , e dopo ·guariti potranno prepararsi al co ncorso pe' premii di castrazione a~cordati alla conformazione ed al merito delle andature d1 mano; essi subiranno l e prove d i addestramento a tiro ed a sella. ed alla corsa di galoppo con ostaçoli ; 2° Anche l'allevamento delle cavane del:>b'essere premi~to non m en di que1la dei cavalli, ma all'esplicìta condizione che dall'età di tre anni in su esse sa.ranno state ben nutrite, addes trate, sottoposte ad , mi lavoro appropriato alle loro forze, ed avranno acquistato quello svi~ luppo che ponno offrire a tale età?
226 STUDI
:5ULLA CAVALLERIA 227
30. Si aumenteranno le scuole di addestrame·nt d ' . . _ o e eq mtaz10n e, quali possenti ausiliarii dell 'ind t . ·_ Il . us na ca va 1na;,
4 ° Lari:rhi incoraggiamenti· conti· d · nueranno ·a essere impartiti alle corse.
« _Per riassumere l a mia opinione sulla produzimie ca~allma (così conch iude il general e F l eury le sue istruzioni) 11 ca.vallo pur o sangue sarà sempre la bnse del miglioratne~to.
_ Il cavallo ~rabo sarà •i ntr odotto .per gli incr_ociamenti, l addove ne ricor1osceremo l'utilità. Gli stalloni di mezzo sangue e trottatori indigeni e strani eri c he r i·u · . . _ · , - m scano le c~ndiz10rn fon~amen~ali dLcoriformazioni e di merito , contmuerann o ad essere im p i egati negli stabilimenti dello S~a to; ma dovrassi -pure usare fa massima prudenza· nel t?cc~re alle _ r~zze da tiro, l e quali, salvo poch e eccez10m, sonos1 smo ad oggi conservate da loro stesse~
« In cotestQ modo _ l'~mministrazione d elle mandri e, a-p~~ofit~~ndo delle lez~o ru della sperienz a; potrà segui're una , ,1a prn larga_, - un sistema pltl popolare, e dar bentosto, com~ lo speriamo, un grande sviluppo all'industria cavallma in Franci a ».
:~ certamen t e i:;isu'. ~~~i corrisponderanno a tale aspettaz10ne, .se cotah sav nss1me istrnzi ~ni saranno messe in p_ra~~ca nello . spi r ito cli chi l e dettò, e se il gove rno non s~ nstarà c~a "q~e~ sac:ifizi i pecm: i arii che es igono specialmente 1 prnm. anrn; quali sacri:fizii saranno tra- non molto più ehe a,mpiamente compensati .
~naloghi_ .provvedi1;nenti è desideralJile vengano quanto p~·u~ a - presi dal g~v~rno italiano, _ chè n'abbiamo grand1ss1mo ed ur;gent1ss1mo bisogno. . ·
L?(alia e_ra un tempo van tata per le sue razze equin e, ed 1 cava~h napo ~itani ern~10 ric(;)rcatissimi 'per tutta Europa quah cavalli da sella . Ha: principalmen t e -c:.:on tr:ibuito al foro scadimento, e qùindi alla diminuzione del l oro valore1 l'incro çian1 en.to çhè- n. 'è stato fatto con razze tra-

lignate del settentrione; mentre i nvece gli stalloni van no scelti esclusivamente nelle razze puré d el mezzodi.
« Nei climi caldi, scrive il Gberardi , l a poten za vitale, là ~nergia prolifica, sono ma:ggiori che nei climi freddi, . e gl'individ ui a l pari delle razze pigliano più agevolmente la tempra del clima passando dalle regioni meridiol)ali nelle bore~li, d 1 quello che innoltranclosi in direzic;me contraria.
, La più b ella razza equina è apparsa .e si ma.nti ene ' eia remotissimc1i étà sotto il ci elo ardente , comechè :qon rwcess iv amente ·caldo dell'Arabia; inoltre, eglr è fuori d i controversia, che in qualunque caso è avvenuto eone razze meridi onali il miglioramento di quelle più l on t ane dall'Equa-tore » . ·
Senza il gràn bisogno d i accattare all ' estero, noi già abbiamo sulle terre nostre gli elementi principali per procacciarci da noi stessi ·econom icamente e in pochi anni u~a eccellen te razza, att1ssima al servizio delle nos tre cavallerie .
L e ·grandi razze del Polesii1e, delle Romagne e·de) Napoletano pouno fo rnirci bu oniss ime Qavalle, e la Sardegna gli staìloni. · ' . · ..
Il cavallo sardo ha sàngue e ardore oriental e, -e compra alcune imperfezioni èli belle zza con pregi tutti suo i speciali d i bontà. · - La, cavalla italiana ha fibra ferrea, , tempetameùto nervoso e robustissimo, e ' statura conver;ien t e. - A mbi due sobrii, fa tti alle privazioni ed a.lle fat i che, p r esen t ano il vero tipo per l a 'cavalleria mezzana e lèggera . , _
Se poi vogliawo r azze più fine per le rimo n te d'uffiziali o pel commercio: cavalle indigene aventi al più alt~ grado i caratteri espressiv i della r azza i taliana e stallom arab i puro sang u e, ci ponno produrr~ belli e buoni cavalli portatori. .
L'Italia, i;i_1ol tre, più d ' ogn i altra contrada europea, è ANNO VI. Voi. I. - 16.
228 STUDI
SULLA CAVA LLERIA 229
favorita pel clima appropriato all'allevamento cavallino. La central e e meridionale offrono copiosi ed eccellenti pa.scoli, e luoghi attissimi a stabilirvi grosse mandrie. Neppur e ci d ifettano g li uo mini capaci ssimi cui affidare la direzione di sì importante industria. Nella no stra cavalleria sonovi provetti ufficiali in tal materia , ,ersati ssimi, e che fecero tutta la loro vita studiando il cavallo.
· I generali Di P amparato, CigaJa , Griffini, i colon nelli Reb aude ngo, St-Andrè, Castell~ngo e Firao e non pochi altri hanno meritata fama nell'esercito per cognizioni ippologiche, ed a qu esti po trebbe si in tutta fiducia affidare il còmpito di r i al zare le razze equine ita l iane a quel valore e pregio di cui sono su scettibilissime.
Ci siamo dilungati sull'argomento delle rimonte, forse un po' più di quanto nor comportassero i ristrettti limiti di qu est'arti colo, ma era troppo importante il soggetto e vitale per tacerne, e per quanto ne abl)iamo d etto n on abbiam potuto che s uperficialmente ed imperfet tamente toccarlo, come che è materia d elicatissima quanto estesissima.
Torniàmo ora a trattare della scelta d ei cavalli per le trupp e .
· Il cavallo da truppa d ebb'essere buono preferibilmente che b ello; meglio è poi se accoppi a le d u e q ualità . For za, robu stezza, agilità, attitucline a sopportar le fatiche e le privazioni , sobrietà e docilità : tali sono l e quaìità che i ndi spensabilmente si richieggo n o in ogni cava llo da sella per truppa .
Gli elementi d i queste qualità stanno n ella natura del cavallo, cioè nella ra:iza , ma non tutte si sviluppano se non se per la man o e per le cure dell'allevat-0re e d el cavaliere, cioè c9n un b uon metodo di allevamento e di addestramento . - Gli aJimenti, i-1 clima, l'esercizio e il lavoro, l e cure , e !'ab itazioni han:io un' influenza imme•
cliata e potentissima s ulla costituzione fisica. del c~vall~, 011 meno che sulla su a utilità all'uso cui vuole destinarsi. n L'effetto deo-li alimenti proviene dalla quantità e dalla qualità e dal ~etodo di somm_ini str ar~i o reg~m~ - Ciband~ abbondantemente il cavallo mgran<llsce, s1 rinforza, corpo d iv en ta complesso ed i muscoli in_grossan~. G~1 animali sc arsam ente nudr iti non p onno sv1luppars1, rimangono piccoli, magri , :flosci, f~a ~chi,_ ~ig_ri, e non ~avalli ma ronzini incap aci al servlZlo ro1htare. - Il cibo s ugoso , sostanziale e sanò , a.ifinchè il cavallo possa n udrirsene senza doverne man giare un tro ppo g rosso volume , poiché altrimenti il corpo_loro_ ad~iviene tro~)p o massicci.o , il ventre dilatato e ri gon fio, 11 sangue sca1seggia d i principii nutritivi e l'animale non pu~ a'.'ere 1~ voluta robustezza e vigorìa . - Non basta che gh _ahme~ti siano copiosi e buoni, ma bisogna in_o~tre · c~e siano giudiziosamente e regolarmente somm1mstr ah . Il . regim~ non ha minore influenza ch e la quantità e qualità, s ugli effetti degli alimenti. .
Il clima, hn. molta p ar te n el dete.rmrnarP- le forme e l'indole d el cavallo, come d egli al tri animali in gener~le, opera.udo O diretta~te mediante l'ab~taz~one, il calanco, la luce e l'el ettricità atmosferica,, od mdirettamente mediante l e sostanze alimentarie e l e bevande .
I cavalli che vivono in contrade umide e ~as~e no~ acquistano mai quel vigor e che h anno i c~v_al!1 d1 p~es1 asciutti ed alti, ove gli alimenti sono nutntiv1 e saru , e l'aria vi è rarefatta e salubre .
Nelle r egioni caldissime, il suolo è arido, l e e_rb e sca~. ano il gt·ande eccitamento produce perdite cons1seggi ' d . 11' t it h, derevoli per via dell e traspirazioni e 1 cava 1 u, oc vigorosi e ardenti , vi. crescon~ po~o, ~entre _n~ _paesi fr e ddissi mi i cavalli vi sono piccoli ed mtorp1d1t1._ E~però le zone temperate qu elle sono ove si hanno 1 migli ori cavalli .

!30 S1'UOI
SULLA CA YAJ.LER l A -'" J.
Siccome reccessivo lavoro rovina il cavallo , cosi il difetto d'esercizio lo r ende snerv ato, lan guido, pingue, irrigidito, infi ngardo , esposto da un momento all'altro a forbatura, o congestione sanguigna a' piedi, od a flussione di p etto , epp erciò inc apace d i buon servizio , all'occo rrenz a. Sottoposti ad un conveniente eser cizio, cioè ad un lavoro giornaliero, moderato e proporzionato alle loro fo rze, i cavalli ac qui stano in robustezza, gagliardi a, agilità, de'strezza e docilità. - Così fatto esercizio pel cavallo desti·nato a se11a dovrebbe consistere in percorrere ogni giorno alle diver se andature la distanza di 7 chilometri almeno, prolungando soventi volte la di stan za a 20 chilom etri e talvolta a 30 e 35. Ben inteso che per tale esercizio il ca vallo debb'essere montato, e p ortar la bardattll'a d'ordinanza se non sempre, almeno frequentemente onde abituarlo . Oltre al peso del cavaliere è pur necessario che il cavallo si avvezzi a p ortar qualche p eso rnaggiore, con che p erò il peso total e non oltrepassi di gran cosa il lel'zo del peso del proprio corpo. Ed è questa la regola cui si debbe aver essenziale rigua rdo nel proporzionare i l cavallo al cavali er e.
L' esercizio ha poi una speciale influenza sulla riuscita de' pul edri. Qu est'esercizio debbe però consistere in u n lavoro m eto dico , progr essivo e proporzi onato all a l oro età ed al l a loro forza . Solo nel terzo anno d'età debbe cominciare qu est'ese r cizio avezza.ndo il cavallo di piè fermo al po rto d ella sella , ed a quello dell'uomo, non che alla corda . Nel quarto anno si può monta r e il cavallo m a da u n espe rto e leggero caval iere, per un 'or a del g iorno e fac endolo ·cam mi nare es clusivam ente a l pass o.
L'addestramento mcntato in maneggio deve principiare dopo il quinto anno e progressi vo per r ispetto al l avoro, mezz 'ora al mattino e m ezz 'ora a l pomeriggio.
Il vero se rvizio del cavallo non dov r ebbe cominciare che pr esso a 6 anni, e se molti cava.Ili di truppa si hanno
SULLA CAVALLERIA
frequ entemente da riformar e, se ~e può ben princip~lmente accagionare lo averli posti pr ematurament~ m servizio . . l'

Vero è ch e il mantenere p er sì lun go tempo_a~1ma 1 senz a trarne alcun utile immediato, è cosa assai dispendiosa ma se si fa calcol o dell'utilità che potranno render e in se~uito , si troveranno abbondant emente compensate le sollecitudini e le spese , m entre alla lunga ne ri sult a una r eale economia. ,.. .
I primi anni del cavallo si hanno da spender~ m educarlo convenientemente a l serv izio cui è destmato , e questa è nè leggera, nè bre,ve bisogna, chè _d,a e_ss~ ?1: pende l'assoluta riuscita dell a~1~~le . I cavalli I etnVl, m fingardi, catt i vi, rigi di e in~oc1li fann? pro~a de~la po c~ cura avutasi dall'allevatore, rmperocche è ~osi nobile e ge. n er oso l'ist into del cavallo' che ogni suo t~av_1~m en to de~bes1 esdusivamente a ccagio nare al suo prurutrvo educatore. Non vi ha esempio in cui colla pazienza, co~a ~o~cez~a, colle cure' e 0011 in telligente maneggio non s1~s1 riuscito a "d omare ed adde str are anch e il più sel vaggio cav~llo, mentre coi maltrattarnet}li si hanno sempre _cavalli testardi, ricalcitranti e maligni . - Su di questo impor tante argo men to ri diremo fr a brev e . .
« Spesso riesce cosa difficil e i l r endere r a~10ne. perché mai n'li animali siano sì essenzialmente m~d1ficati_da assidue°cure (così scrive il già citato Ghe:·ard1); pure 11 fatto n on importa contradd izione . Gl'Ingles1 . h~un ~ cr eato l_a loro prezi osa razza· di ca-valli col sussidio d1 pro,~ed1t .. ·en·c·1· confac enti a fare e mantenere n etta l a men 1 1 g1 1 , · d · p elle e adoperati r egolarmente ; coli uso d1 modi o i t '. datti ad Mevolare la traspirazione cutanea; col- agen 1 a o . t l'avere scud eri e asc iutte, ampie, ario se , mantenu e pud . b · l'menti con accorte lite; colla sommini strazione 1 UOlli a 1 .' . .· . I ·alli selvaug1 di Amenca scelte per la J?rocr eaz1one. ca, . . 0 • son o tralign ati, e più piccoli eziand10 d1 q u elli delle pi ccole razze europee d alle quali p ro-vengon o .
232 STUDI
233
« Gli effetti delle cu re potr anno essere con facilità v alutati, paragonando in uno stesso paese i cavalli bene ~ustoditi con quelli delle persone che trascurano i loro animali; o anche meglio paragonando le razze selvagge colle razze mezzo selvagge, e colle razze affatto domestiche. Nelle seconde già principiano a mostrarsi cavalli g r andi, ben fatti, e di va~·io colore, superiori alle razze selvagge; nelle razze domestiche è notevole la diversità di forme, cli mole , di attitudine, di colore, e tutto ciò in conseguenza di uo'accurata distribuzione di cibi, de ll a avvedutezza negl'incrociamenti, dell'attenzione nel provvedere alla nettezza cutanea, ecc. , Nel ripartir e i cavalli fra le due specie di cavalleria vuolsi aver rigu ardo alla statura loro, sia per rispettò al servizio loro speciale, sia per rispetto al peso del cavaliere . Alla cavalleria di linea vanno destinati cavalli d i }m,50 ad l"',55; alla cavalleria l eggiera di l'",46 a,lm 50.
- Sotto la statura di lm,46 difficilmente può avere il cavallo forza abbastanza per r eggere i l cavaliere armato e l a bardatura militare.
c) Educazione ed ist1·uzione degti iwmini e dei cavalli. l O Eclucazione ed istr,uzione degli uomini.
• L'educazione milita1·e comprende tutto ciò che può rendere i soldati più atti e disposti a sopportare le fat iche della guerra, ed a sviluppare le loro faco l tà morali , intellettuali e fisiche, per formarne uomini coraggiosi e dabbene.
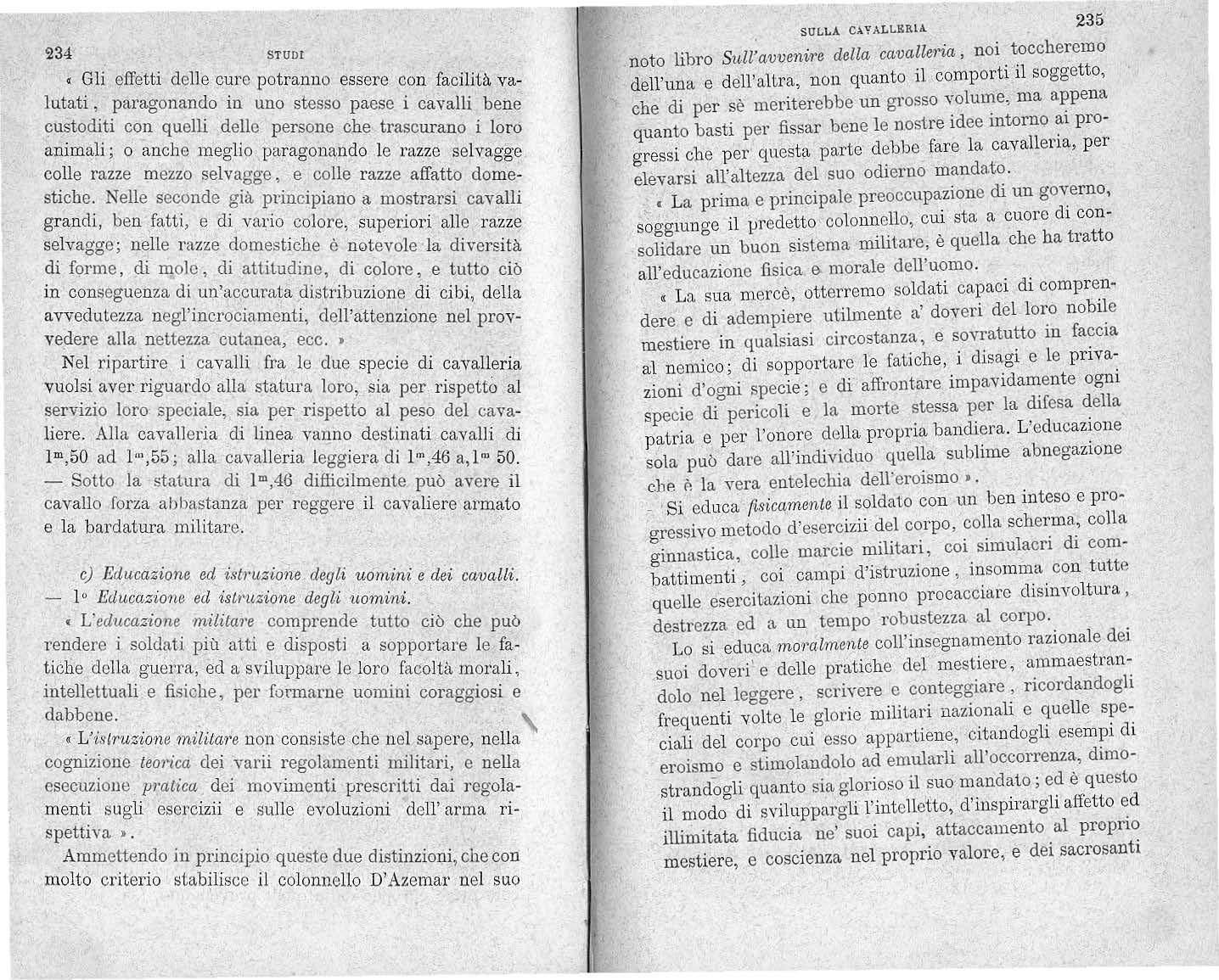
« L',istruzione militare non consis te che nel sapere, nella cognizione teo1•ica dei varii regolamenti militari, e nella esecuzione pmtica dei movimenti prescritti dai r egolamen ti sugli esercizii e sulle evoluzioni dell'arma rispettiva , .
Ammettendo in principio questo due distinzioni, che con molto criterio stabi l isc e il colonnello D' Azemar nel suo
SULLA CAY ALLERlA
noto libro Sull;avveni1·e della cavall~1·ia' noi. t occberemo dell' una e d e1l'altra, non quanto il comporti 11 soggetto, che di per sè meriter ebbe un grosso ~olurr.te, ma a~pena quanto basti per fissar bene le nostre idee mtorno ~ 1 progressi che per questa parte debbe fa.re la cavallena, per elevarsi all'altezza del suo odierno mand at~ -
« La prima e principale preoccupazione cli un go~erno, soggiunge il predetto colo1mello, Clll sta a cuore d1 consolidare un buon sistema militare, è quella che ha tratto all'educazione fisica e. morale dell'uomo.
« La sua mercè, ot t erremo soldati capaci di cornp r endere e di adempiere utilmente a' do-veri del lo~o nob1~e mestiere in qualsiasi circostanza, e soVl:·atu~to m fa~cia al nemico; di sopportare le fatiche , 1 d1s~g1 e le p rrva~ zioni d'ogni specie; e di affrontare imp av1da~ente ogni specie di pericoli e la morte stessa per la difesa ~ella p atria e per l'onore della propria bandi~ra. L' edu~a~~one sola può dare all'individuo quella sublime abnegazione cbe 0. la vera entelechia dell'e roismo , . .
_ ·Si ed u ca (i~icamente il soldato con un ben mteso e pro·vo metodo d'esercizii·del corpo, colla scherma, colla greSSl . . . · d" ginnastica, colle marcie militar_1 , c01. srmulacr1 1 combattimenti coi campi d'istruzione , msornma con tutt e quelle ese:citazioni che ponno procacciare disinvoltura, destrezza ed a un tempo robustezza al corpo .. . Lo si educa mo·ra.lmente coll 'insegnam ento razionale dei suoi doveri' e delle pratiche del mestiere, ammaestran~ dolo nel leggere , scrivere e conteg~iare ricordandogli frequenti volte le glorie milita~·i nazionali o ~uelle s~e~ ciali del corpo cui esso appar tien e, citan d ogli esem~1 d1 eroismo e stimolandolo ad emularli all'occorrenza, diroostrandc)P'li quanto sia glorioso il s uo mandato; e~ è questo il rnodc° di sviluppargli l'intelletto, d'inspirargli affetto ~d illimitata fiducia ne' suoi capi, attaccamento _al propri~ mestiere, e cosci enza nel proprio -valore, e dei sacrosanti
234 STUDI
235
doveri clie gl'imcumbono verso la patria, il re e la sua bandiera. - In una parol a, coll'educazio n e s'info n de al soldato lo spirito di corpo e lo spirito militare, che sono 1 principali agenti delle grandi gesta.

L' istruzione m ilitare dividesi in teorica e pratica.
L' i stru zi one teo1·ica consiste n ella coo-nizione r azionale o ' e dim ostrativa dei precetti e delle prescrizio ni date dai ·varii regolamenti .
Cotest' istruzione è indisp ensabile ad ogni militar e per quella parie d el servizio che concerne l a sua p osizione, quella de' suoi s ubòr din ati e quella del g ra do immediatamente superiore al suo che in molti casi potrà esser e d estin ato a ri em piere.
Il so l dato non va consi derato com e un automa , cui per me zzo dP-lle molle dell 'abitudine si fanno eseguire macchinali m ovim enti , no, per Dio, avvegnachè quando più non vorrete l' automa , ma avrete b isogn o dell ' uomo , della sua effe rv escenza, del suo slancio , di tutte insomma le sue snhli m i. potenze d oll'a,nimo e dell'intell etto, non l e p otrete ottenere. Eppertanto l'i struzione teo1·ica è anche indispensabile pel sem plic e soldato, sia p erché a ppr ezzando le ragi oni, i motivi ed il fine d egli atti materiali d el m es tiere egli sa.ppia criterios amente eseg uirH, sia anche per ah ili tarlo a progredire nella carri era delle. armi.
Nell 'istruzione -teorica del soldato di cavall eria oltre a gli eser ciz ii , ed alle armi, è pur n ec es sa.rio compr ender e alcune cognizioni sempl ici ed elementari d'ippologi a, pet q~anto ha tr atto a lla nom en clatura esterna del corp o del cavallo , all'i g iene cd al governo; non parolo ni t ecnici g reci o l atini, che vanno lasciati a' sci enziati, ma indicazioni chiare, informazioni e pr ecetti di utilità immed i ata ed a portata delle intellig enze anche più limitate .
L'istruzio ne p1·atiea com prend e le pratiche del mestiere , cioè l 'e!-ecuzi one effettiva di quanto prescrive il rego'la-
su1.L.1 CAVA LLER!4 mento d' esercizii cd evoluzioni, e degli altri servizii materiali d el soldato . . . . .
Cotest'istr uzione v uolsi oyviainente sud d1v1dere in vndividtuale ed in istmzfone' d'insieme . .
Colla prima il cav alier e deve impar are tutto quanto s1 contiene nella scuola del sol dato a piedi e~ a cavallo, _ e sp ecialm ente ad essere padr one d el propno cava~lo in o ani cir costanza. Su qu est'ultimo punto l'attuale s~st~m a d~struzione regolamentare è difettoso; al l~voro 1~d1v1du ale n on si dà tutto quel tempo e pregi o ch e s1 ~crita ; il cavalier e ed il c1tvallo vengono troppo presto lll ~ castrati nella ri ga, donde a-vv i ene ( ciò che v~drnm cos i sov enti) che un soldato d i cavaller ia il q uale c1 p are fortissim o in sella, m anovrando n ello squadro~e, barcolla ' non sa bene p adroneggiare il proprio d estnero, e sembraci invece m eschinissimo cav ali er e , ogno ra q\,mndo por un serv izio qu a lunque trovasi isolato . . , La caYall eria esclusivamente destinata a caricare quadr ati , ed a combattere sempre in ordi1:e co1~patt ?'
trebbe aver minore bisogno di cotale i stru~1one m<ln iduale . Ma noi non possiam o avere cavall emi per cotesta esclusiva dcstina2ione . Con i nsistenza l o . d1_m_o stra~mo. · t · hen un r)arino a Epp erò è n ecessario che 1 n os n cav~ star e saldamente in sella, cd a maneggiare fra u~am ente i lor o cav alli e d arm eggiare in ogni circostanza ~1 te mp ~ e di terreno ' sia nello squadrone che isolati ; ciò che s1 ottiene, t rattenendo quan t o t empo basti cavallo e cavaliere nel lavoro individ ua l e . . . · · t del proaetto d'1stru- La com missione francese mcanca a o · a· ·a l ·1 qu a1e venn0 zione provvisoria sul l avoro lll 1v 1 ua e , 1 . . . san cito colla data d el 15 novembre 1859, e di ede g1a eccell enti risultati, nella sua relazione, che accompagnava esso prog etto, scriveva: · . .1 e Si J)tlò es ser certi che qualunque siasi cavaliere l h h nozioni sui quale sebbene non abbia ancora e e p oc e
236 STUDI
237
?~·
SULLA CAVALLE RIA
movimenti d'i nsieme, ma sa_ppia ben maneggiare il pr9-_ prio cavallo ed armeggiare, sarebbe più utilmente irri.pièg ato che non quello cui s i fossero già fatt i eseguire mohi movi m enti d ' insieme, ma la di cui istruzione prima - la individuale - è stata negletta »
A quest 'istruzi one provvis ori a, nqi chiamiamo l 'attentenzione dei ~ostri Ùffizial i di cavalleria, come g ià l'abbiam fatto altra volta nella Rivista, analizzando l'istruzione stessa; vogliam credere chejl nuovo regolamento d'es er cizii per la cavalleria, che si sta .attualmente el aborando in seno ad m'la commissione di distinti uifìziali, farà serio caso di sì importante soggetto.
Con tutto ciò non s'intenda già che noj vogliamo ne1 cavaliere di trupp à tutte le raffinatezze ·equestri del cavaliere da passeggiate; no; .noi pretendiamo soltanto ehe il soldato, cavalchi francame nte , ch'egli sappia sempre governare i l su o cavallo con arditezza;, disinvoltura ed abil ità, e trarne ogni miglior servizio possibile; che egli sap];>ia mane g giare le SUA mm i eon d estr ez~a e facilità a .tutte l e andature del cavallo; insomma ch'egli sappia combattere stando a cavallo così scioltament,J , siccon 10 il fante a piedi. . '
Non parleremo per ora dell'istruzione d'insieme, quella cioè per la. quale i · cavalieri impa;rano tutto ·ciò che debbono fare nello ·squadroneggiare in linea; e comprend e tut,ti . i r ego+amenti d'es er cizi dal la scuola d el pelottone all'insù . - NoI1 n e parl erelllo fintantochè non ci sia dato cli potel' studi are su quella che prossima ci si promette, e s ulla quale, ab biamo fid t,1.c ia, , si correggeranno i difetti della antica.
Brevità., semplicità, celerità e sciol tezza sono le principali qualità che debbe avere una tal e isti~uzione . .
Continua)
DEL GENERALE RENARD
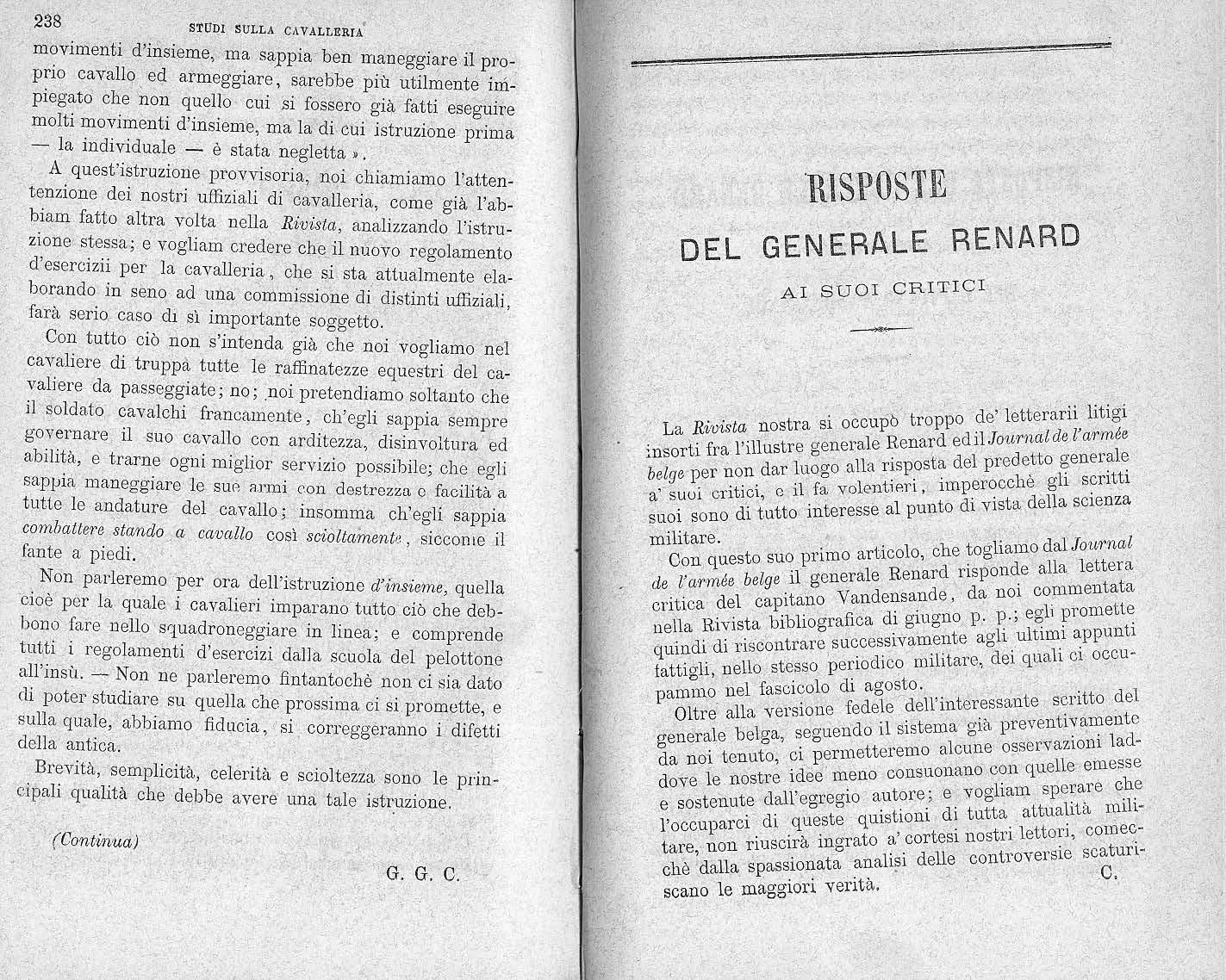
AI SVOI .CRITICI
. . . tro . o d e' l etterarii l itigi La Rivista nostra s1 occup~ ied ilJournalde.l'armée ;nsorti frfl. l'illustre generale . en art d,el predetto generale 1 Ha nspos a • . · belge· per non dar uogo .a . . . nperòcchè gh scntt1 . . . . ·1 fa volent1.en , 11 , 11 · za a' suui cntie1, e i , 1 to di vista. de a scieu . o d1· t utto interesse a pun . , SUOl son .
militare. . , . 1 he togliamo dalJoiimal Con:. questo su~ primo arti~e~~;d risponde alla lettera de l' a·rmée belge il generale . d da noi comment ata critica del capitano Va~de~sa_n ~o p . p.; egli promett~ nella Riy·ista bibliografica d: gmge11te aoli 1ùti mi appunti . . . • , ' t · re success1v am o .- uq . u mili d1 nscon ra , . . ·• ·t re . cle1 quali c1 occ . . 11 t ess o periodico m11i a , . fatt1gh, ne O, s . d' osto parnmo nel fasci~olo 1 ;~ d °il''nteressante scritto ~el Oltre· alla versione fe e_ e . e i . · : p · reventivamente i rìdo 11 sistema gia . . . 1 cl~ g enerale belga, segt e . lcun · e o~serv az1om a · · metteremo a u da noi tenuto, ~1 p ~r consuonano' con quelle emesse dove le nostre 1clee i~e~o t . e vogliarn . sperar e e sostenute dall'egregio a:n ?re _, d' tutta attualità ro1h· · · · d. leste quistio m 1 · :nec- l'occuparc1 1 _q e . t 'cortesi nostri l ettor1, coi '.·
tairè, non riusci:'à mgra o t . d lle controversie scaturi• chè dalla spass10nata . 1~1 e .C. scano le maggiori venta.
. STÙDI
·
·
(
,, G. G. C. '. .'R\SPO.STE
RISPOSTA DEL .GENE·RALE RENARD ALLE CRITICHE DEL CAPITA NO VANDENSANDE
Il sirrnor capit d" 1 , o . ano i s alo maggi<We Vandensand . , r\ . I onore d1 confutar ·1 . . e m1 iHe
I ·~ < e I m,o opuscolo Della cavall'eria • Il st10 · llll'O porta . r I . .
• < pe1 '.!o o : _ lettera al signor generale Renard. Eo Ii me .ne mandò copra col viglietto s~guenre: o '

(( !Ilio generale I
<< Ho . l'onore di trasmett ervi una cop·,a d li ·1 -h bbl' • . . e a ettera cbe . o p~ icato fil rnposta al ·vos tro lavoro sulla cavalle ria
, e< ~~n:e ho dello nell'introduzione, a llo scrillore milit;re f non al comandante del corpo di stato maggiore essa è dire . tta
(< Io ~pero ·h · - · ' · 1· . ·• e ~ . "?1 ~on ~n1 avrete a male d'~ver discusso ib e1a mente quest10n1 di scienza mi11·t··•1·e e I' . di . , , · · . . . '-' , caver cercato
. ~OSèlle I '.alti sotto r! loro vero punto di vista. C1:edo ai a ve1 usalo dr que~to diritto · . · con lu!la la defenmza possibile
< \ Aggrad1 te ece. ·».
IUSPOST,\ DEL G:DNÉ!U L'E RE~ARD 241
so·no fortunato elle il cJ.pil ano VJ.ndensande abbia acco.nseotilo d,i osare del suo diritto éo n deferenza. Difalli, egli m'indirizza delle frasi come qu es te: « Le armi di cuì mi servo non sono così. maestrevolmente cesellate. come le vostre, _ ma io le credo di 1uì.glior tempra. - Tutti i rigiri di parole non distrurranno questi fatti incontestabili. - È necessario che i _ fatti . siano presentati sotto il loro ve ro punto- di vista .e non snaturati ecc. ecc. )>. Ed altre espressioni che noi incontre remo più avanti . lo bo dunqu e mille ringraziamenti a far.gli · per la sua condiscend en za.
, Risposi il' giòrno ·stessù a _questo vigli etto colla lettera seguente: << Signor capitano
<l Ho ricevuto l'opuscolo che voi nl°avete mandato. Vi rìngrazio mollissimo di qu esUì co!nun ieazione. L'lio let to se nza · int;i ,Tuzione, e vi ·bo trovato particolari statistici interessantissimi. Conw. voi dite egregiamente, essi non potrebhero emanare che da ùn uomo èbe fa di tali ricerche .una occupazione speciale e che può rnéi'tere in op era i rapporti ufficiali ·e le - risorse dell n quaH il governo. dispone. Mi rincresce .che non ., pubblichiate di quàndo in quando i risultali delle vost1;e pa- . 'zienti elocubrazioni; ciò interesserebbe tutto · il mondo.
« Voi _ m\111.ele ben giudicato, . pensando che non ,,i avrei a male se cercale a confutarmi. Son tròppo partigiano della discus~ione per non a1}pl audir sempre agli ufficiali che si occupano delle q ~ tio~i le quali banno raRporto alla loro nobile , ca r riera.; in secondo luogo, allorchè ìo pubblico uO' li~ro, non sòlamenle so ehe mi espongo alla critica, ma anzi la desidero poicb è io non scrivo per un partito preso, ma 3crivo per con,;iozione.. Nè v'ba nulla di peg.giore che· le verità imposte coll'aulorilà; si finisc e sempr('c pe r confonderle ccll'errore. Uu critico leale, al contrario 1 le depura, e le fa penetrare nello spirito di tutti.
·
r
·
oEL GENERALE RE NAao
cc Ora permettete alla mia esperienza di sc riltore di darvi mi consi gljo. Voi mi risponderete ancora a ltrè volle. · Se le anni <lì cui vi . servite sono di tempra eccellente, le avete ma negg·iate ìnfelicem énte, e presentate ·dap,perlulto il fianco ad ·.una /aci le confu tazione. Ne approfitterò adupqu~ largam ente .quundo ·sarà venuto il momento, éd all orchè 0 1i al!acchì in t, doppia e tripla spedizione cli cui mi sento minacciato saranno compars i: amn J.i fare tre colpi con una sol pietra. Ebbene , ali .ora, se vo i mi date retta, acloprel'ete_altra maniera. Compr~ndo come il due~ d'A u male scriv~ direttamente al principe Nap oleone; che il conte di l\fonlal e-mbert scriva al conte di Cav9ur, dai · quali avevano avuto pers onali auaccbi. Ma che il capitano Vand e nsande scriva una lett era al ge11 erale Renard per confutare un lavoro, in cui nè la sua pers ona nè le sue opinioni son.,o citate, ciò non so capirlo. Attaccate il libro ne ' suoi errori ciò sta bene· evi i ' , / , o è là per ciò; peggio pe r l'autore se egli s' è in gannato. Ma se ,wi indi rizzat e queste cri li che e le riflessioni mordaci, qualunque sian e il cont enuto, \lll 'aulo re in fo rma di lettera, ciò non è più una leg ittima d iscuss ion e d'qpinioni, rna è una lezione che vo i avete la pret esa d'infliggere ad un l)ffizia)e genera.le, poichè, parlando a lui stesso , non potete separare l'uomo dalla sua posizione. L'uomo pru d1~nle vedrebbe in ciuesta reiterata fòrmo la un giµ- d iz io dubbio so; i vos tri nemjci ed i vostri ·invidiosi, poichè tutti ne abbiamo, la tacci erebb ero d'org oglio e di !racotanzà; io non ci vedo che un manco di riflessione che ·mi bas\a farvi notare» .
,.Non avrei fatto allu.sione a questa lettera e sarei immed.iatamente entr;ato nella discussione, se non avessi trovato in un giorna le di Brnx:eJles del 16 giugno p. p. il passo seg-u'ente:
« ·un rec entissimo aneddoto, che noi c.onfidiamo ai nostri leltor-i sotto il suggello del secreto, dimostrerà una volta di più come sia dannosli per un militare, sotto il regime cos tituzionale, di 1100 cùrvare la, fronte n~lla polvere alla a~gust.a prese1iza dei pascià a cappello gitus. · , "'

(< Ecco il follo: Il si gnor Cbazal non era ancora a Pau. Un officiale si perm ett e di contraddire, in un lavoro scientifico no. tevolissimo, le opinioni emesse da un suo superiore s~ un s?get.lo di scienza militare, e riceve all'istante una lell era istruttiva, t11a quale la nostra memoria ha ritenmo il ~ra~o segu~,nl_; : ·
« Comprendo che il duca d'Aumale pobb\Jch1 un~ risposta << 'al principe Napoleone; compr.endo che, il si~n~r di Mo~ta« \embert critichi le circolari e gli atti (f'un m1n1slro del\ im-:<( ' peratore , m~ non ~osso amme1te1:e. cb_e il signor X. ..... << prendasi la libertà di attaccare le op1mom del suo capo.
« Noi ri spo ndiamo del )~s lo, se non assol~tam~nte esatto, almeno molto appro ssiinativo, di questa fra se p1ram1da\e:
<< ·oopo ciò, ci meravigli eremo ancora de\\'.esemp\a'.·~ n serv alozz·a di cui fanno prova mo'llì ufficiali tanto erud1l 1 q~rnnt~ bravi? La disciplina loro impone il silenzio, anc.he quand~ un snp eri ore si permette verso l o.ro simili uffronti, in cui la spiem, . . piaggin e la dispu.la all'insolenza >) : • , _
Fui dunqùe obbligato, mio malgrado, di pubb\J~,\le 1~ IDI~ lellera jier dare ai fatti il foro vero carattere. l\ _g1orn~Ji sta e stato audaceme11te ingannato, e si è fallo del mw s,cntto u~ condanne vole uso (1 ). Non solamente ìl b1~ano che vénn~g\1 co muni cato è stato tronco, ma. mi si presta - un'opinione dia!Jlelra\menle opposte/, a qt~ e.1,la çhe io, profess.o e -~Ire ~o ~e lJ)pre _ professat o. 11 redattore dell'arti,colo sarà i:lnnque il pnmo a deplorni:e l'errore nèl quale lo si è fatto cadere. .
· Ammetto u.na cliscussion·e largc1, i\\ lier<1,, compl eta, ma sotto forma conv~n evorc · Io non ammetto che, per ciò appunto _eh: ffi . l •bb • ica un 1·ibro uno de i suoi inferiori immeò1all, . un u 1c1a e pu , , . . : . . . del quale nè il nòme nè le opinioni furono citat.e, rnd1nzz1, col
1 Riceviamo · in questo punto dal signor ;_capitano Van d ensande copi a d'~1a lettera da 1;1i diretta il 29 luglio al signor genera_le Renardb colla I ' declina ogni pai-tecipazione alla pubblicaz~one d1 questo rano qua e l' · · b 1 )
_ (Nota della Reda;zione dçl Journ,al de armce e ?e
242 RISPOSTA
243
pretesto dì confutazione, direttamente al sao -soperiore ona se..: quela di l'n.1si m.ordaci éJ ironic!Je. I fatti, le opìnionì scie_i1tifkhe non banno nome proprio, si può rettificarle, discute'rle senzq. assum ere tuono cattedratico de l pedagogo allo scolare, e senza gettar gli argomenti al viso. · · .
Nella nostra professione ciò non è tollerabilf'; e s'egli fosse , all{imente, bisogriereub e proibire assolutament,1 agli •ufficiali di sèriverE1, qua lu nque fosse i1 loro grado. È forse ciò che domanda il g iornalista? · ,
Regolato qu esto punto, esaminiamo la confutazioned ~l sigo-or capitano Vand ensai1de, e proviamo la tempra delle Bne armi. ,
La ,coufut~zion; non rig uarda che la parte. del mio lavoro la_qual e ha tratto allo stato della cavalleì·ia presso qualcbe potenza europea. .
L'autore è bibliote'ça rio a l dipart i mento della guerra e p,•r dippiù lo -~tatista del depos ito. Egli ba sotto mano tutti i eia ti sulle • armate estere che il goverqo possiede, li riunisce, li controlla, è infine l'ufficiale dell'esercito il più atto a trattare le q1iestioni di tal g!'nere. Eg li ha du-nque scelto il terr eno che gli coi:iyeni~a meglio per rornbatter mi, lasciando ad ,altri la cura di confutar<~ la que g( ione princip ~le, dove, s'affrf'tta d'aggiungerfl generosamPnle, la er'ilica forse lrovei·à ancor molto a dirr.
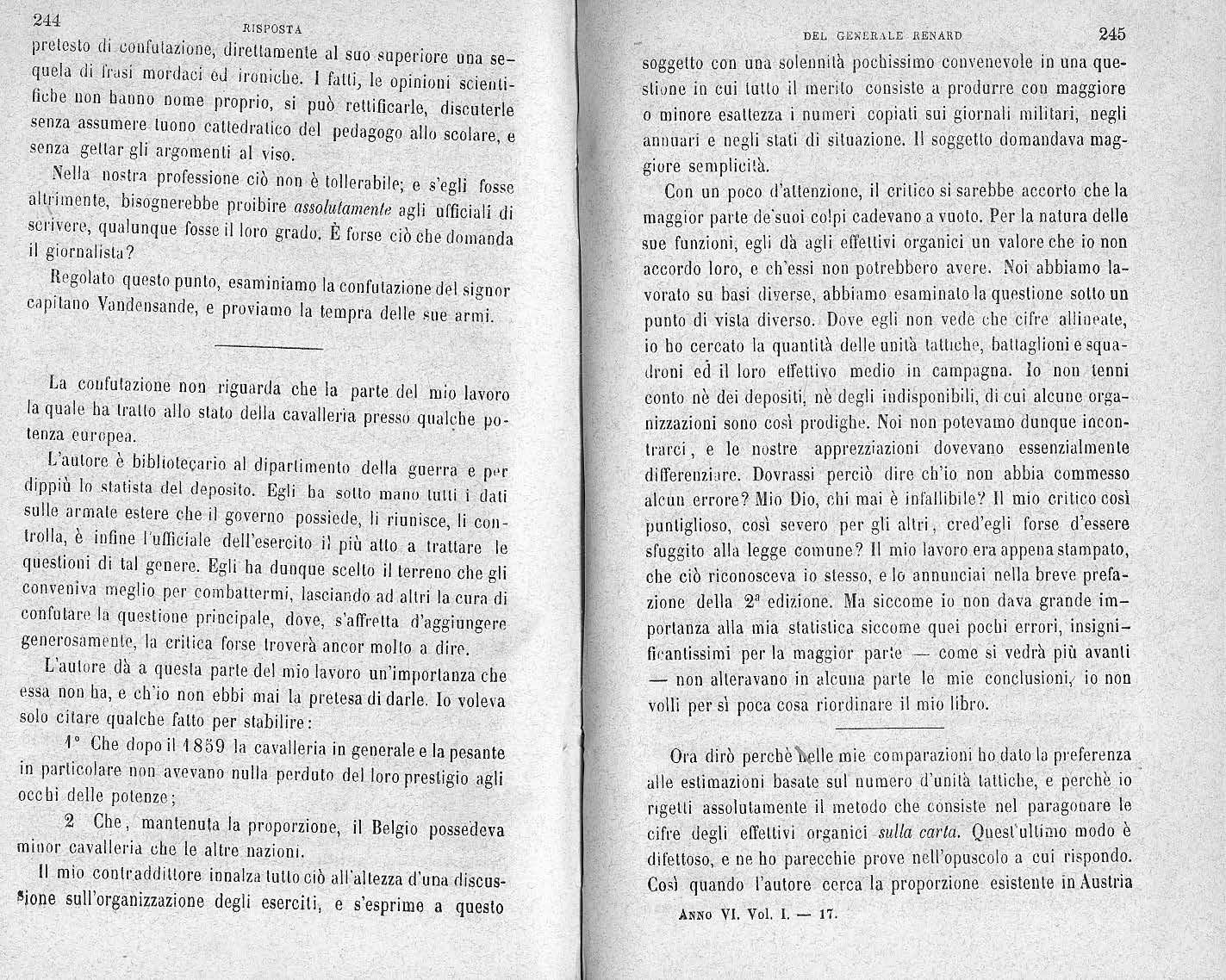
L'a ut ore dà a questa parie del mio lavoro un'importanza cbe essa _ non Ifa, e ch'.io non ebbi mai la pre tesa di darle. Io voleva solo citare qualche fatto per stabilire: ·
1° Che dopo il ,1859 la cavalleria in generale e la pe,sante in partiéolarn non avevano -nulla perduto del loro prest igio agli occbi delle potenze; . .
2 Che, ·mantenuta la proporz\one, · il BelgiÒ possedeva mìu rfr cavalleria che le altre naiioni.
11 mi'o contr,addfllore inna lza tulio ciò all'altezza ·d' una d iscu s~lo11e s!]ll'or~ànizzazione degli eserciti, e s'esprime a questo
soggetto con una solennità pochissimo convenevole in una questiùne in cui lutto il merito consiste a, produrre cou maggiore o minore esallezza i num~ri copiati sui giornali militari, negli annuari e neg li stati di siloazi_one. Il soggetto domandava maggiore sern pliei tà . . -
Con un poco d'attenzione, il critico si sarebbe accorto cbe l a maggior parte de'suoi co!pi cadevan,o a vuoto. Per la natura delle sue funzioni eo-li dà ao-li effettivi organici un valore cbe io non 1 b , 1 t> accordo loro, e ch'e.ssi non potre,bbero av ~re. No i' abbiamo lavorato su basi di i1e rse, abbiamo esaminato 1<! quP.stione sot.to un ponto di vista diverso . Dove egli non vede· die c ifre allineale, io bo cercato la quantità delle unità tatt1ch e, .,batlaglioni e squadroni ed il loro elfellivo medio in campagna. lo non tenni conto nè dei depositi, nè degli indisponibili, di cui alcu,ne orga1~izzazioni sono co sì prodigb ~ . Noi n9n potevamo dunque incontrarci, e le nostre apprezziaz ioni dovevano essenzialmente d iffe renzi ,ire . Dovrassi perciò ·dire ch'io non abbia commesso alcun errore?- Mio Dio, chi mai è infallibile'! H mio critic.o così ÌJllnliglioso, così severo . per gli altri, cred'egli forse d'essere sfuggito alla legge ·comune? 11 mi . o la,v,oro era appena stampato, che ciò. riconosceva io stesso, e lo annunciai _ nena çreve prefazione della 2a ediziorre: Ma siccome io non dava grande im·portar\ia alla mia s!ati.stica siccome qori poc!Ji errori, insigniffcant issirn'i per la Jl)aggior par:'e - come si v~drà più avanti __,_ non alteravano in alcoua parte , le mie conc lusioni1 i.o non volli per sì poca cosa riordin are il mio libro. . '
Ora dirò percbè ~ Ile mie comparazion i ho dato la preferenza . alle esumazioni basate sul num ero d'unità tattiche, e p'erchè io rio-etti assolutamente il metodo cbe consiste nel paragonare le " ' '
· cifre .ùegli 'effettivi organici sulla carta . Quest' ultimo modo e difelÌoso, e ne bo parecchie prove nell ' opuscolo a cui ri sp ondo. Così . quando l' autore cerca ' la proporzione esistente in Austria , ANNO YI. Voi. I. - 17 .
244 RISPOSTA
245
tra la fanteria e la cavalleria, egli prende dal suo quadro l'effellivo compl eto 'dellla prima arm a, 435,080, e lo para gona a quello della cavalleria. 52, 7 I 8. Ora qui non si traila solo di cavalieri (po icùè il numero dei cavalli non è cbe di 44 8 ·1oi,) ma di 7904 uomini smonta li, vale a di re ell e a sol dati di fon~ te r ia capaci di render e sen•ig i, appena banno fucile e cartnccie, egl i oppone in parte cavalleria a piedi. Qu esto sistema è forse ammesso nella scienza dei fatti sociali, espressi co•1 termini numerici, come lo dice l'epi grafe dell'opu sco lo, ma al pu.nlo di vista della guerra, non mi pare ammessibile.
Ciò che i mp orta di conosce re è il numero esa tto d i sciabole 1' di' baion ett e disponibili, tullo il rimanente non è che illusione. PN giudicare della forza relativa dell'artiglieria di duè Stati, si dovrebbe, seguendo il metodo dell'au tore, ri ce rca re la qunutità degli uomini compres i nell'e ffetti vo organ ic o s ulla carta; io invece non mi cu ro che del numero di cannoni di ditforenti cal ibri che si puonno da una parte e dall'altra condurre contro il nemico. Tale ò il sislema ad ottalo da lulti i generali cbe ban fallo la g uerra, e noi cbe non l'abbiam falla, faremo ben is&i mo a segui re le loro lezioni. Essi calcolano la forza della fanteria dalle baionette, quella della ca,·alleria dai cavalli, e qu ella de ll' ar tigli eria dai cannoni. La cavalleria ,A. piedi non è mai en tra la ne i loro calcoli.
Un'àltra ragione, a parer mio, tull'affatto pi>rentoria,• s'oppone ancora a questi parago ni basa ti sugl i effettivi organici sulla carta. E si è che gli effetti vi non sono della siessa ,natura e che le organ izz azioni alle quali essi si riferisc ono non si rassomigli an o. Si vie n cos ì in rlotti a paragonare non dati uguali, ma <fati differenti, ciò che è illogico. Esaminiamo per esempio gli e ffettiv i degli sq uadroni del Belgi o e de ll'Au st ri a. Jn Austria la differe nza dal piede di pace al pi ede di oue rra è di 1 O cavalli • o ' qui è di 55. L'A ustria è una delle più grandi pote nze militari d'Europ a. Pe r attaccarla, ahbisognano mezzi i mmens1. Ella non impegnerà una grande guerra ove tulle le sue forze entreranno

in azione, se non allorquando ella lo vorrà. Avrà dunq ue sempre tutt o il tempo cli prepararsi e di ri emp ire a suo agio i vuoti delle s ue unità talli cbe, sopratt utt o quaudo questi vuoti sono sl piccoli. Bisogna aggfongere che l'Austria è ri cc hi ss ima in caval li ria sella, c he ivi si acquis ta no a prezzi rela tivamente infimi, 11 l.lclgio è egli in uguale cond izioni? La sua posizione po litica non gli consente di prepararvisi lungo tempo pr ima. Ess11 subirà la guer ra passiva men to, fatalmente; e forse, in sul prin cip i?, sa rà ridot to alle sole sue forze . Tutto quanto possiede <>ntrerà subilo in azion e. Le classi in congedo, delle quali l'armamento è prep arato nC'i d(.'positi, rispontlf•ranno all'apprllo. numerosi volontari si presen terann o da ogni dovr, ne so no sicuro, le guardie nazion él li si glorieranno di. concorrere alla guarnig ione dei pun ti fo rtifi cal i, il nostro paese, uno dei piÌl ri cc hi de l mond o in cavalli eia Li ro, offrirà immense risorse per trainare i nost ri carri d'artiglieria, del tr eno e dell'amb ulanza; ma sa rà la stessa cosa pe i eavall i de ll a ca vall11ri a?
Trover emo noi 2000 cavall i di truppa? AvrP.mo noi il tempo di add estrarl i? Tutto ciò non domanda so ltant o gio rni o selli mane, ma richi ede mesi . Avr emo noi a nos tra disp os izione mesi, se ttimane, o solamente giorni? Da ciò si scorge ad unqu e c be è impossib il e di paragonare gl i e!Tetlivi organ ici s ulla ca rta di d ifferenti pa<~si , senza ten er co nto della cond izi onP, della situazione, e della g rand ezza degli Stnti. Cì q_ che è vero cd è possibile per una gran nazione, non lo è per una piccola, posta come la nostra al centro cl e i conflitti e urop<~i. E questo para go ne tra i d ue citati esPrciti è d'altrellant o me no acceltabilo, pcrchè quello dei due il qnale per co ntrobila nc iare le sorti, dorrebbe offrire Ira il pièd e di pace e qu ello di guerra la minor differenza, l' ba inv ece più cons iderevol e. Così, gius ta l'organizzazion e aus triaca, abbi sog nerebbero 380 cav alli prr for passare i nostri squ .id ron i dal piede tli pace al completo di g uer ra; a seconda•ctclla nostra . organizzazione ne abbisognano 2,090.
246 -RISPOSTA
' OEL GE~ERALr. RENARD 24'7
Dopo ciò, che si continui pure a prestare un carattere sacra"~ mentale alle , quantità numeriche; sarà conveniente per coloro i quali scelgono guesto modo di operare; quanto a me, continuerò a no·n accordar ·loro che un valore relati-vo, molto contestabile ,e soggello ad erroi•i.
Il mio oritico s'è. assunta la missione- di co1itraddire tutt e le mie asserzioni, Egli attacca ogni mia fr ~se e nulla vu ol las ciar dimenticato. Per arrivare al suo scopo impi ega mezzi di differeo~i s_pecie, ed eccone· uno che ritl'oviamo spesso e che dipinge bcn1ss1mo la natura della · p.olemica. · ·
Qual era lo scopo della mia pubblicnione? Io voleva difendere l'organizzazione attuale della·nostra cavalle ria dagli attacchi di ~ui ella era stata qggel to da parte dell'Écrmomiste e dell'Jndépendan~e Beige. Cosa volevano questi giornali? ' ll primo neo-ava l'utilità di qu est'arma e domandava la sua ri d uzione ' ed an°zi la sua soppressione, il serondo annunziava una trasformazione completa di lutti i reggiment i, in cavalleggeri , armali di nn fu~ile a p~·ec isione, e sopprimeva ,n pari ~empo i corazzierl,....J.e _ gn,de ed I lancieri, percbe l'impiego del fucile a precisione è incompatibile colla lancia. Ho respinto, a nome dc.Ile due specie di cavalleria sacrificate (la cavalleria di riserva e la cavalleria .di ' linea), gli attacchi e l'ostracismo contr'esse diretti. Io non avevà in vista piulloslo l'una cbe l'alì:ra, ma sibbene tutte due alla volta, e, per semplificare la qu estione, le bo comprese nella unica denominazione di cavalleria pesante.
A prevenire qualunque falsa inter:pretazione, m'ero circ ondalo di precauzi on i. << Egli è necessario, io diceva a pagina ,f 6, di intenderci sul valore delle espression i. La cavalleÌ·ia' si divide !n pesante_e leggeri;. La cavalleria pesante ·div.idesi essa pure 111 cavalleria (li linea eçl in cavalle ria di r is erva; ques,ta è-co. razzata. - Così in F'rancia i dragoni ed i lancieri, nel Belgio le
guide, essendo reggime nti di cava lleria di lin ea appartengouo alla cavalleria pesante,.» -- Avrei potuto aggiungervi i-dragooi in Austria , in Russia, in Ingbilterra, e gli ulani in Pr~ssia. Avevo' stabilita arbitiariamente questa dassificµzione? No. Io m'appoggiava sulle autori,tà le più inc on testab ili. Napoleone disse . nelle sue Memorie: « Tutta la cavalleria di linea non dev'es- - ' sere corazzata. I dragoni devono far parte della cavalleria pesante. I cavalieri devono dividersi in quattro spede: due di cavalleria leggera e due di cavalleria p~san'le; cioè: gli esploratori, la ia valleria leggera, i dragoni ed i corazzieri >). In Pru·ssia, i generali Von Grieshem, nelle sue lezioni alla scuola gener!)le di guerra, Von Bran'dt nel suo ecce.llente e notevole trattato di tat· tica, pubblicato nel 1860, Decker nella sua tattica delle tre armi; divid on o, per il loro paese, uguale opinione. li primo dice:
<<· No i annoveriamo gli ussari ed ,i dragoni (dragon i leggeri') nella cavalleria legg era, i corazzieri e gli ulani ne!fa pesante, noi cosl abbi.imo ugu almen te cavalleria leggera e pesante)>.
Von Griesbem, pa g. ,129, sp ie ga ugualmente elle la Francia ha Ire specie di cavalieda, di riserva, dì linea e leggerà, ciò che non le impe,Llisce di riunire le Llue prime sotto l'unica denomi: nazion~ di cavàlleria pesante, la quale, dic'egli, s~a alla cavalleria legge ra come 3: 2. A piè di pagina aggiunge : t< La quantità di cavalleria legge ra in Russia ed in Austria è d1 molto maggiore della ca valler.ia- pesante, rn ent.reèbè in Prancia ha luogo il co ntrario ». _
Von Brandi incomincia così il -§ 78 del suo libro: « La ~avalleria si divide come la fanteria, in leggera e pesa1ile, le quali devono avere tra . esse una tal quale relazione. I corazzieri, sotto qualunque forma, e sotto qualunqne denominazione, sostituiscono la cavalleria pesante. ·111 qualche esercito vi ili aggiunaono ancora gli ulani ed i dragoni, - ma dappertutto i o , cacciatori e g!,i ussari Cormano la cavalleria leggera)) .
In Russia Oukouneff chiama i corazzieri cavalleria di linea.

248 RISPOSTA
DEL GENERALE I\ EN ARD 249
.
In _loghi Iterra uoa parie dei dragoni non cor~zzati so no class 1fical1 regolumentarmente uella cavalle ria P" •anle Ug . l . . --~ . ua co;;a era rn Austna prima della rior"anizzaz1·()ne Il R e ·1 t t· t· o • . cuei s a 2s 1que <lei I ~ 854, al qual e io frci allusione nel mio lavoro e nel qua le 11 _ mro c,oul_raddrllore stesso ba at tinto , s'esprime così parlando dr quest ultima pote11z·i · e [ a .. !I • . .
• • • < • c,iva eria austnaca conia 111 tutt o 40 rPgg11ne1ll1, cioè :
\{ Cava ll eria pesante, ltl. itl. 8 di corazz ieri, 8 di dragoni, lei. l~:ggera, 12 di usse ri, Id. itl. 12 cl( ul an i ».
I~ ho fallo di più; io proclamai, a pagina 27 del la mia memona, che la _questione della corazza è indipendente da qu ella del la cav all ena pes ante ; vi rit orno più tardi, allu rchè present o qualche considerazione tendente a co nse rva re qu est'arma, la s.c ,_ao_do P:rò la .soluzio ne della ques l.i one al giudicio deg li ufficiali . del l esercito . Al dì d'oggi è notori o che il com ita to di cav ailena s1 è pronunciato per la conservazione ( •I ).
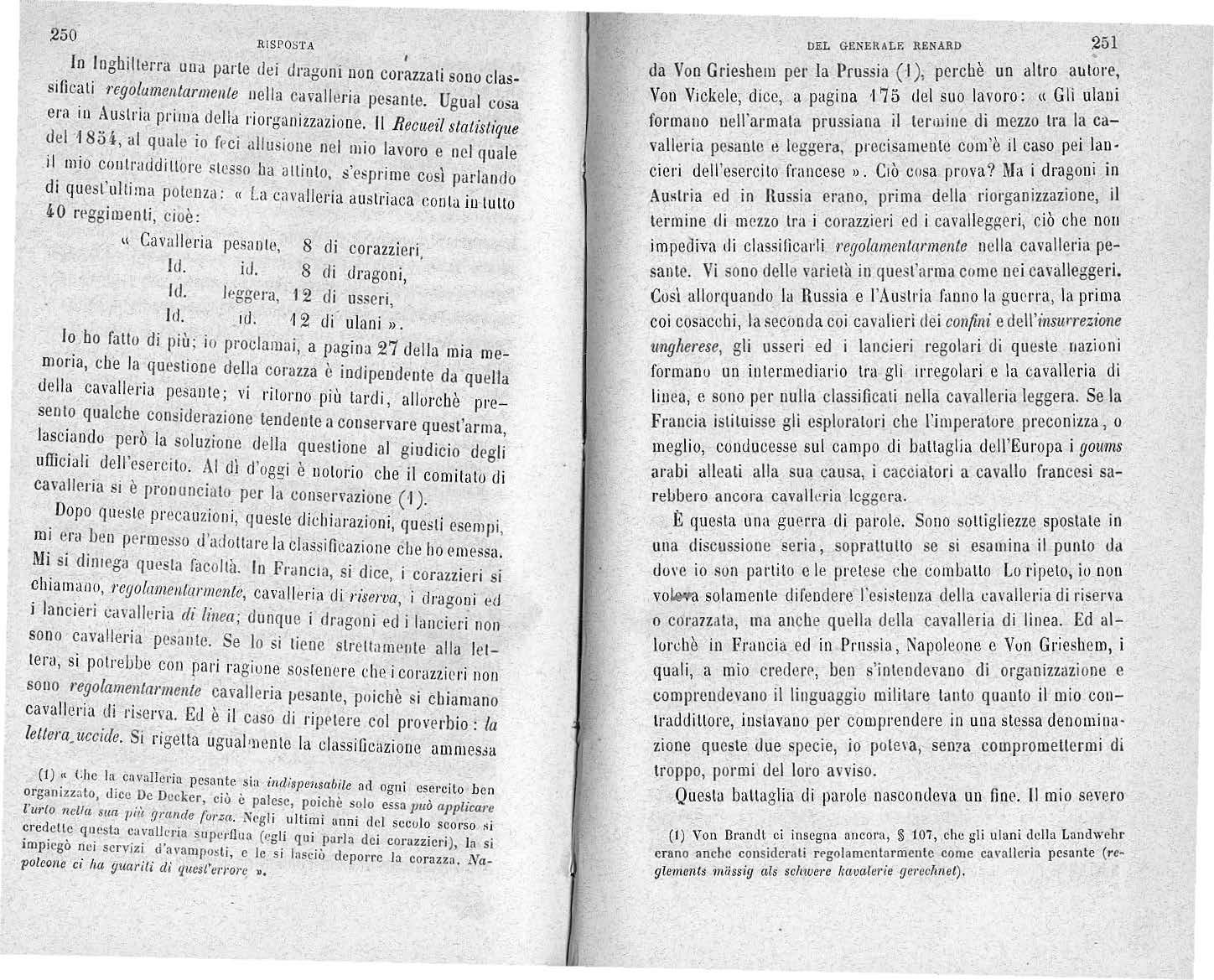
. Dop o qut>sle pr eca uzion i, queste dichi a razioni, questi ese m )i m! ~ra _ben permesso d 'atfotlare la classifi cazione che ho e mes~a: Mi 51 d1111 eo-a qu es ta facolta' I F. , · d.. o · n I a nc, .i, s1 ice, , corazz ieri si ?h1am_an~, regolan~entt~rmente, cava ll eria dh ·iserva, i dra go ni ed 1 lanc,en cavallena di linea; dunque i dragoni ed i lancieri non son o cavalleria pesa nte. Se l o si ti ene strettamente alla lette ra, si pot rebbe con pari r·1,.,·1u le r . 1 . . . , o I sos ene re e le I cora zz1er1 non sono regolame11tarm e11 te cavalleria IJesan te, poic hè si chia mano cavallena _di risen•a. Ed è il caso di rip Plere co l proverbio : la lettera_1iccule. Si r igelt.a uguahrnnte la cla ssifica zion e ammes.,a
{1 ) '.' Che la_ cavallorin pesan te si a ·indispe1,sahile nd O"'n i csc1'c ito b en organ iz z a t o, tl1cc De Dccker .. •, 1 . , 0 1 · , CIO e pa csc, po1chc solo essa [Jttò ripplicarc urto nclltt sua 7mì grande 'i11•zn Negli ult1·m·, ·1 I . d 1 ' · · 1 an m ee secolo sco rso si ~re _e.Il: qu_csta ~a '.•all,c ria supcdlua (egli qu i purla de i c o razz ieri) la ~i _1mp1cgo ': e' sc r v1 z1 _ d ~varnpost i, e le si l,1sciò deporre In corazza'. Napol couc ci ha gua.r,t1 dt quest'errore ». ·
da Voo Gri esbem pe r la Prussia (-1), pcrcbè uo altro au tore, Von Vick ele, di ce, a pagina ·175 del suo la,•oro: < t Gli ulani form an o nell'arma ta pru ss iana i! ter mi ne di mezzo tra la cavall e ria pesanto e leggera, prec isamente com ' è il caso pei lan • cie ri del l'esercito francese ii Crò cos a prova? Ma i dra go ni in Austria ed in Ru ssia era no , pr ima de lla riorganizzazione, il termine di mezzo tra i corazzieri cd i caval legge ri, ciò che no11 imp ed iva di classificarli rngolamenlarmente nella cavalle ri a pesante. Vi so no dell e varietà in quest'arma come nei cavallegge ri. Cosi a llorquando la Russ ia e l' Aust ri a fa nno l a guerra , la prima coi cos acch i, la seconda co i cava li eri de i con/b1'i e dell'insurrezione ungherese, gli asseri ed i lanc ieri regol ari di qu es te nazioni formuoo un in te rm edia rio tra gli irr ego lari e la cav all er ia di lin ea, e sono per nul la classificati nella cav aller ia leggera. Se la Francia istituisse gli esploratori che l'i mpe r atore preconi zza , o meg li o, conducesse sul ca mp o di ballaglia dell'E ur op a i goums ar ab i all eati alla sua causa, i cacciato ri a cav allo francesi sar ebbero ancora cava ll <' riu leggera.
È questa una gu{w ra di parole . Sono so lli glie zze spostale in una d iscussione seria, sop rallullo se si esamina il punto da . ùo,'e io son par til o e le pre tese che comba ll o Lo ri pe to, io non vo~ solamente difendere l'es i,; tenza della cavalle ria di ri serva o cora n ala, ma anche quella d ella cavalle r ia di linea. Ed allorcbè in Fra ncia ed in Prn ssia, Napo leo ne e Vun Gri eshe m, i qu al i, a mio cred e re, ben s' intend evano di organizzazi one e comprendevano il linguaggio militare tanto quant o il mio co ntr addillore, in stava no per comp re ndere in un a stessa den omin a• zioae qu es te due specie, io po te\'a, sen?a comproroellcrmi di tr oppo, pormi del loro avv iso.
Questa batlaglia di paro le nasco ndeva un fine . Il mi o se vero
(1) Von Ilrandt ci inseg n a ancora, § '1 07, che gli ula ni della Landwch r erano ~oche considerali rl'go lamcn ta rmenlc come cavalleria pesante (reglemen ts miissig als schwerc lw·valel'ie gcrcchnet)
.250 IUSPO~l'A
DEL GENERALE RENARO 251 .
aristarca non lasciando· sussistere, come già dissi, · alcun mio giudizio, infirrna v;i d'un s,11 tratto l\ltli i ruiei paragoni tra fa cavalleria p esan te e quella leggera., lo comprendeva nella prima la cavallerie\ di riserva e di lin ea riunite , egli non vi arnmellev_a il più so: ent i cb~ i corazzieri, facendo co mpleta a·strazione dei secondi. E seguendo questo strano sistema che. l'aut ore ba tracciato le colonne 11 e s ·del s.uo fam oso quadro finale, inserto a fH!gina 4-8 del la sua l~ttera. Così eg li trovava l' occasione di ripel e-rm i per ciascuna potenza: « Voi dite che la proporzione della grossa cavall e ri a a lla . legg era dà il ta r rapporto; no; ma dà il lai altro,>; e ciascuna volta metteva in vista dei para"oni t, duna, drtTerente n,1!ura, e cpmpost i d'e leme nti diversi. - - Ciò che; abbiam di meglio a fore, si ò d i considerare le colonne 1 e 3 come non al'venule. ·
Capirei meglio la ri gid ezza del mio critico, se nel suo lavoro non lo si sorprende ~s e in flagrante conttaddizione, e se da · · se stesso non de sse più d'una smentita alla sua teoria. Secondo lui , abbiam veduto; elle i soli corazzieri e non i dragon i costituiscono _ la cavalleria pesante. Egli ba cura di ripeterm elo: <( Voi mettete arbitrariamente i dragoni ed i lanci e ri nella cavalleria pesantE'; _ ora la realta protesta contro questa clc1ssificazione >). E più lun gi : << Non si puonno classi"Ocare i dragoni ed i lar1ci eri nella cavalleria pesante, .come voi fate ». ·
Ebb ene, apriamo il suo opuscolo pagi na 43, articolo lnghi!terra.; cosa ' vi trovi;1mQ? 9 reggimenti di dragoni clas~ificali sotto la denominazione dì grossa cavalleria:
~llora cos~ s iguific ~no le - lezioni che mi si indiriz~ano? M-a v'ha di p iù; le gu,icle nel Belgio sono dall'a.utore classificate nella grossa cavalleÌ·ia. Non é 0iò ,· come già dissi, una guen·a di parol e, una fanciullaggiuè? Così; perchè in Francia i
dragoni sono chiama·ti cavalleria di linea, il mio autore sosJiene cb'essi non appartengono alla grossa cavalleria; perc hè in Iqghilterl'a e nel Belgio si classificano nella cavalleria pesante, egli sosiiene .che sono di grossa cavalleria. Pel mio contraddittore, ciò che costituisce la specie di cavalìeria non è nè la .forza degli uomini e dei cavalli, nè la natura dell'armamento o del s ervizio , i;na bensì la denominazione che ciascmi Stato . le accorda. Vale a dire che la specie di cavaller ia sta nel nome e non nella cosa. I-o tunmetto questa maniera di :-agionare quanto i paragoni falli ·col mezzo Jei c-aval ieri a piedi sulla carta. Se i dràgoni· ingl esi e le guide appartengono alla grossa cav;\leria, i drago ni francesi essi pure sono di grossa cavalleria . E siccome le delìnizi,H1i di Napoleone e di Von Grieshem per la Francia e pe r la Prus~ia concordano coli.a classificazione regolamentare delle altre nazioni, io le consid e ro . come le sole buone e le sole proprie ad allont anare le anomali e _ che sto- additando.
Dopo ciò. uon son io autorizzalo a dire che la guerra di parole che mi si fa è disad~ttatiss ima? · Se il lettore ha- la pa~ zienza di seguirmi più, lungi, sarà convinto che la gue rr~ d1 cift:e non è pme più felice.
' Esaminiamo i rimprov eri che mi si indirizzano, potenzo pr'r potPuza, nell'ordine in cui l'aut ore li ha posti . .I o suppongo, pe'r ev itare oziose ripetizioni, ebe il lettore abbia letta la lettera ali~ qoa le rispondo, e che abbia 'soll'occhio le Jiverse citazioni (l',.
( t) Cli c il ~~nc r~lc Henard chia mi futili sofistiche rie le distinzion i nominali , o ., • r bene stu · ma quelle di cui e o-Ji qui discorre non si ponno cometa I con, ., d" ' a sidcrar e, imp crocchè la distinzione fra r.a v alleria_ g ros.sa o 1 _ nscn _
• (corazzieri) cavalleria di l inea e ca va lleria l eggera e lult affatto 1 nercnte ' · l · t per alla loro destinazione tattica, epperciò non si panno og,c~mc'.l e e .
nu ll a l'una coll'allr~ confondere n1ai. - La cavalle ri a g1,oss a e escl usi: vamentè destinata per fòrmare i o guerra grosse masse di '.'iscrv a e di riscossa all'i'ntcro esercito La cavall eria di linea _-v a in ma~sima addetta

252 RISPOSTA
DEL GENERALE RENARD 253
Mi si rimprovera d'aver dimenticato di menzionare, a pag. 3 f, nell'infànt eria dell'esercito austr iac o i 14 n•gg imeuti di fronti era ed il ballagliune del Tit el. La noia arposla a piè di pagina del brano incriminato avrebbe dovuto indicare al crilico il motivo di tale apposita orrezione. Io non alludeva elle al grande piede di pace ed il mio contrarldillore slesso, nel suo specchio della 4• pagina del la sua confutazione, s'att iene esattamente alla stessa maniera, poichè qu ello speccbiu non contiene che i quad r i di qu elle trupp e, ma non un sol so ldato.

Benehè organizzali reaolarm enl e e militarm eu te i re,rni00 OlP,Dti di confi1~e cos tilmscouo cionulla1ueuo colonie mi1ita ri crea te ad uuo scopo speciale. Essi sommiuistrano all'esercito -un 1.:erto numero di battaglioni in caso di g uerra (c'redo che nel 1859 all'esercito d'Italia ve ne fossero dodici ) ; essi non appartengono alla fan teria regolar e propria1ueute della levata o trattenuta in Lem po di pace nello Stato. Non citandoli avrei potuto appoggiarmi sulla ragione cbe io aveva egualmeute omm esso in Rus~ia le colonie militari del Caucaso, del mar-Nero , del mar Casp io, dell a front iera di Siberia, e del fiume Amore. Potrei qui, io credo, r ilevare 110 primo errore da parie del mio contraddittore. Egl i comprende il battaglione del Titel fra le lruppe di fanteria dell'es erc ito austriaco. lo nou so perc~è
nlle divisioni dcll'cscl'Cito, cd è l 'arma l oro parlicolarc in ogni circostanza L a cavalleria legger.a pd suo spcciulc servizio di scorazzare ia forn;;g icri, di portare improvyisi allacchi, di esplorare il terreno, di fìanchrgg iarc le marcie ccc. è ben diversa d alle precedcnli pel suo uffìzio lùUico nou solo, ma beuonche p cl suo specia l e ordinamento. E sollo quest'ultimo punto di vi s ta sono pu1·c ben diverse fra l oro le tre specie di cavallerie so ,,ra d c tte. EJ il sono adunquc inconteslabilmcnlc e sollo l'a~pcllo tallito, come il sono sotto al rapp,,rto degli uomini, dei cavalli e dcll'urmamcnto. C.
DF.L GEN ERALE RKNARD
non vi comprende pure il reggim ento di fanteria di marina, od il balla•r\ iou1: pontieri, percllè i Tcba'ikisti (batlellieri)ba~rno del ~ l'uno e ~iP,ll'allro. Questa truppa speciale è composta dt soldati marinai che servono la numerosa fl ott iglia di scialuppe cannoniere cbe l'imp ero mantiene al contluente della Tll eisse e del Danubio. Si sono ugu almente impiegati nel 184-8 e_ 1 ~49 a bordo delle navi della marina imp eriale a Triestr. in nmp1az. . 1 · . ·. · cbe avevano abbrac- zameuto dei mannat da mali e venez1a111
ciato la ca us a dell'indipt• ndenza d' Italia. Ecco dunque on battaoli one ch(~ noi possiamo cancellare dalla nomenclatura 6:lt•I mfo crilico, a meno ch'esso non abbia qnalcbe cosa ca~1biato . . d ·1 81.9 Eo\i può comparire fra nella sua dest111az1one opo 1 ·1 'I, • o . gli eserciti, ma come i baltaglioni di marina della goardia imp eriale di Napoleone.
·' Se l'autore della leltera alla quale io risp ondo fa entra re nei suoi ca lcol i sin l'ultimo uomo dei reggimenti di con(ine disponibili pella guerra, sarebbe stato di tutta equità av~s5e tenuto uoualment.e conto di tutti i cavalieri, di cui l'A ustna disponi:' '. aU'infuori delle sue truppe regolari . Ma ciò non è quanto egli fà. Siccome il suo scopo è di provar e che il Belgio h~ 1/rop~rziunalmente maggior cavallàia ti e ll e altre nazioni, c~h e 1_slinlivamente _ portalo ad aumentare la fanteria ed a d11n 111_u 1re la cavalleria dei diversi ~ali ch' eg li pres e come ~u~to di pa'.·a• gone. Nel caso parti colare ch e ci occupa, cbe s1 direbbe ti un critico il quale parlando della cavalleria ru ssa, non tenesse alcun conto dei cosacchi, ell e formano frattanto \a vera c~val~ leria leo.,.era dt>irli esertit i dello Czar? A meno che nou siansi 00 O i • introd otte, da qualcbe anno, nell e instituzi oni dell ', ~ustna, mo~ dificazioui ch'io ignori (ed in questo caso io farei volontien
254. RISPOSTA
AUSTRIA.
ammenda onorevole), il mio criti co co mm elle una dim en ti ca nza dello stesso genere.
Dal la lo ro c reazi one le trupp e confina ri e dell'Austri a eran nuo sola m ent e composte di fa nt eria, ma anche di cavalleria . Illi sch ing cita tre reggime nti di us sari in Croazia, ed uno in Slavouia. Rig uardo a quest'ultimo ('gl i dice: << Il reggimen to di ussari è d i più di 2000 aomiui in te mpg di pace, armali, come lulli gli ussari di fronti era ·io Ungh eria, non so lamen te di carabina, di pistole e di sciabola, ma ancora di lancia, cbe manegg iano sl rnaest revolmeole da essere capaci di colpire al gran galop po un bersagl io largo come un o sc udo ,, . Questi cavalieri c~is teva no_ a ncora nel 11859 , pcrchè uei quadri della composizione dl'gli eserciti europei sul p ier/e di guerra , pubblicati a quell'epoca da l capitano di stato rnag~iore Vandensande, si trovano
1:ornpresi nella ca vall eria leggera dell'Aastria 28 sq uadroni di cava lleria irr ego lare da somministrars i dai confi ni. Io credo pu re che non s i devono confondt're con un'allra specie di cava ll e~·ia feudale d ella Croaz ia, esigib ile in tempo di gue rra, conosci uta sollo il nom e di Bandiera kavalerie e che accomp.ignò il Ban o l el lacbi ch nella sua marcia attraverso l'U11 rrlwr ia per liberare Vi enna.
L' Ungheria medesima poss iede truppe Jella stessa spec ie. Esse sono comprese so tto il nom e di insurrezione ungherese; etl è ques ta la vera forza a r:n ala nazionale di questo paese. Conformemente alle leggi antiche, che rimontano alla bolla d'oro d'Andrea lf ( 1222) se la guerra aveva luogo sul suolo stesso de lla patri a, quest'esercito si mant ene va a proprie spese, ma fuori paese ri cevev a paga dal re. Qu<>s te troppe sono indip endeu~_i tlai reggimcuti permanenti re clu tali e mantenut i a spese d('II impero; essa è la leva regolare del Bano della Nazion e le c ui iuslituzioni nazionali rego lan o la ri partizione. Così nel 1 Ù5, ve nti lavorato ri dovevano somminis t rare on caval iere, e Ja l nome maggiaro busz (venti) derivò la denominazione di _ Uszar.
Qu est a ist it uzione s'è perpetuata attrave rso il corso dei secoli. Napoleone trova dav an ti a sè qu este truppe uazionali ne l 17 07, 1805 e 1809 ( 1).
M'è impossibile stabilire con cifre esalle la forza dell"instituzi one. Nel 1 809, essa non era stata messa in azione cbe parzialmente, poicbè prese ro parte solta nto dodici comitali della bassa e nove dell'alta Ungheria, e ciò nullamen o, secondo Slut• terbeim lo fo rze riun ite sotto gli ordini del Palatino arciduca Giusep~e, so mmavano già '.1 •I 8 ballag\ion i e 98 sq uadroni (2) .
No i rester emo danqu e al dissolto della realtà a ffer mando che l'Austria, col favvre di queste levale naz iona li dei confini e dell'Ungheria" può agg iun gere alla cavalle ria regolare 1 5 0 sq uadroni di cavalieri irreg olari i più rimarchevoli d'Europa. cc I noslri Ungheresi, dice il principe di Lign e, fanno nella lo ro gioventù la guerra ai loro cavall i quasi sei vagii , a i lupi che alle ntano ai loro g re gg i, e ciò nel rigore de l verno. Guarcla_te le reclute; arrivale nella gioruala a i noslri avamposti, pallugl,ano, va nn o in ri co nos ce nza, S(;aramucciano tanto natural mente, come un ca ne d i Spagna arresterebbe un volo di pernici la prima vo lta cb e si cond ucesse alla caccia n.
Se dunque, nel 18 59, il mio c ritico non s'è sbagli ato al sogge tto della cavaller ia dei confini, ~e la.costituzione del 1 84-8 ba nulla cambia lo all'ìnsl ituzione de\ l'insu.rr ezfone ungherese,
(I) La legge del 1808 regola nel modo seguente l'insu r rezio111: ungherese 1o Caduna famiglia nobile somministra un soldato: c~lu1. che ha 3000 fioriui di rendita v iene a cavallo, colu i eh? h~ men o d1 . ~11le fiorini vien e a piedi; cionull nm rno colui che ha p1u eh t ?00 fiorm'. e mc_n~ di 3000 se possiede un cavallo, ha dirillo al forngg10; 1 ge~L1luomin 1 poveri dell'i1lst1rrezio11c sono ~ti; 2.0 I lazyges, i Cumans, gh _Haydou~ con 3000 fiorini di r en di ta sommiuislruno un uomo a çaval~o, •. co ptlo!• d . canoni ci un u omo a cavallo; i vescovi, i pnla ti, i prevosti, gh ubbat1, 1 • • o ca ' · i monasteri somministrano un uomo A cava ll o; le 01tta, u n uom a ,•allo e dei sussidii secondo le rendite. Il (n) li qimdro dcn'ai·mata austriaca, incerto alla fine del tomo JV de .. I r ·1 d tta~llo dt Memorie sulla guerrci del 1809 , pel scner~Iç Pe et, e a I e 'o questo trupp e.

256 RISP OS TA
0
DEL GENEftALE RENARD 257
l'autore della confutazione commoLte un1 piccola ommis~ sione di circa 150 squadroni nella, enumerazione delle forze della cavalleria aust1·iaca sul pied e di guerra. E quPsti no-o sono già cavalieri sulla carta, ma uomini e cavalli in carne ed ossa che com1,a~vero sol 0amp o di battaglia ogniqutilvolta l'impero era in pericolo ('1).
staliira d~i cavalli, rimpi azz,\ perfettamente, su - certi riguardi, la cayalleria di !jnea degli nitri paesi.
Noi siamo d'acco rdo col rioslro critico quanto alla composi'lione attuale ddla cavalleria austriaca . El\a si compone ri i 12 , re"aimenti di corazzieri, 2 di drago ni , 12 di ulani, 12 di ussa;i\ 3 reggimenti leg geri di volontari, di cu i 2 di ussari ed ,, di ulani. Noi differiamo sui punti seguenti:
_.
Questa certezza di reclutare, in tempo di guerrà nazionale , altr ettanta cavalleria irregoh1re quanta ne abbisogna, ba, senza dubbio, deter-rninato . l'Austri.a a dare alla sua cavalleria leggera un aspetto -che, essa non présC'Dla, p'erchè può lottare per la f~rza dei suoi caval li colla cavalleria di linea ed in pàri tem po coi corazzie ri delle , altre nazioni. Di falli, io leggo nel la lettera a cui rispondo, che la statura dei caNalli della cavalleria l~ggera austr,iaca è- di 'I rn,55 a 1m,58 . O~·a in Prussia, sempre secondo il mio auiore,- si trova pel ia caval leria . di line; di ,1rn,57; pei corazzieri della lin ea, di ·I m,59 In Fr:ancin, per la cavaller ia di linea, di 1 m,50 a 1m,iH ; pei corazzieri, di 1 rn,5 -i, a 1m,60_ f n Sa rdegna, pei lan cie ri, di ,1m,50 a 1"\~4; pei corozzi eri , di ,1rn,54 a 1ni,60, Nel B~lgio, pelle guide, di ,1m,n4 a 11m,58; pei corazzier i di 1 m,56 a ,J m , 60. A cavalli di tale statura sono necessari uomini proporzionali per montarli, sellarli ed accudirli _ Quanto all a statura dei cavaili di cavalle.ria leggen:i: in Prnssia è di irn,52; in Francia, di 1m,4ò a 1m51; in Sardegna,di 11rn,46 a 1rn,50; nel Belgio, di 1m,50 a •Jm,54,; vale a dire, dappertutto inferiore all'Austria. Da .ciò deduco che se l' Aoslr ia non ba più, regolament;rmente parlando, che corazzieri· e cav.[\lle1'ia leggera, qu esta · cavalleria leggera, per la
{ I) Se I' Anstda poi è , pc! passato , :rare assegnamento su qu esti 150 squad roni, lo crede e1;1li scrinmente , il genera le Renard, che uguale a 1 s. segnamento potrebbe fa~ne oggidì/._ Ne dubitiamo moltiss imo,_.! c. ,
,1 ° Eali fa entrare nei suoi calcoli lo squadrone di depo- o ~ito, mentrecbè io non vi computo ébe gli squadroni di gnerr~. Così i' miei reggimenti di grossa cavalleria sono di fi sq uadroni , ed· egli li p~rta .a 7; i mi ei r eggimenti di caval~eria _leggera, prima dellé1 riorg anizzazione, sono di 8 squad rom, eg\t 11 po1_-1a a 9 · da ciò le notevoli differenze ch'rgli avrebbe pot?to sp regare', ma éhe non spiega. Io mi ·tengo alla mi a- maniera d'. calcola re con altrettanto più di ragione, chè il mio contradd1llore segue esa ttam ente la stessa via pella Prussia, e così noi co nco~·cliamo sul numero di squadroni cbe é1uesta ' potenza possiede, La sua maniera di proc-erJere offre adunque tfoa contradd izione. In tempo di guerra, difatti, ciascun reggimento di caval_lerra dell'esercito prussiano· crea uno squadrone supplementarr?, o · di deposi1o (E rsatz-Escadron) di 150 cavalli pella guardia e di ,125 pella linea-. · ._ 2° Il mio critico differisce completamente, cla1 clocumcnt1 au~triaci ch'io seguii, . in ciò che c,oncerne la riorga~inazione d ell a cayal\eria leggera. A pagina 5 egli dice che, pnrna della .riorganiz·tazione, la cavalleria leggera contav'a 1,2 reggi~1enli di ussari e 12 di ulani, cio/ 2 1! 6 squadroni, di cui ?4 di_ <le.po. sito, ·ciò che impoda 8 squadroni di gue rra per _regg1~01:to.
La 1Ui litar Zeitung del 2'1 gennaio 1860, molto meglio 10formala, è per ~ulla cli questo avviso; essa ci ad dimostra eh~ la cavall eria leggera del!' i\ustri<! contava 1<z re~gim en ti

.258 RISPOSTA
DEL GENlW,\L!s RENAltD 259
41
ulani, di cu·i 'I.O ad 8 squadro ni di guena e 2 (il 6° e 1'1 l 0 ) a 4 squadroni soltanto; e 1 4- squadroni di ussari, ' i cui 12 prim i aJ 8 squadroni, ed i due ultimi a 4. Per effetto della riorganizzazione, tutti i reggimenti di 8 squadroni sa110 stati portati a 6; il 6° e !'1 ,1° ulani hanno ric evu to 2 squadroni di aumento ; il 113° us~ari è diventato il 1 0 reggimento di ussari volontari ad 8 -squadroni; di più è stalÒ formalo un reggimento di ulani volontari ad 8 squadroui. Così:
quanto a quella di ll e spade ga llicbe che si piegava Ilo a ciascun colpo e che il guerriero celta dovev a -ca duna volta raddrizzar-e col piede prima di continuare il combatUmen lo.
Totale 168 ·
Differenza in meno, come già notai, -di 24- . squadroni. Havvi qualche cosa di sorprendente nel vedere uno . statista purista e puntiglioso, co~ì inOessibile per gli altri, esaminante i numeri e le parole con , un rigore senza pari, ignorare l'esisti>nza di due reggimenti. Ciò prova che ogni uomo, per quanto valente si creda, è soggetto ad errare, e cbe l' indulgenza non è mai cosa sconvenevole. In pres enza di tali precedenti e della accani ta gnerra di cifre che mi si _fa, '16' il diritto di creqere cbe la t~rùpi·a' delle ar mi ·del mio avversario rassomiglia al-
3·0 Non ten e ndo conto dei depositi, e contiu uand_o a co nsiderare i 2 reggimenti di drngoni esistenti come cava\Leria pesant e, ciq che io dissi della cavalleria austriaca è _-rigorosa~ mente esatto. Ma il mio cr i lico mi fa osservare- che 1 ·dragom sono al dì ·d'oggi class!ficati nell a cavalleria leggera; e difatti qnesta classificazione si trova nell o stesso numero dell~ ~fil'.la·r Zeitung che bo citato. Ciò mal grado persist e nella mia . pnn'.a opinione, ed ecc o _ il percbè-: lo aveva ugualmente solt occ hio il dec reto imperiale sulle rim onte1 del quale parla lungamente l'autore della lettera. Etco come si espì·irue quest'ultimo, del quale seguirò l'interpretazione: <1 Nella cavalle ria leggera « un quarto dei cavalli di rimonta deve avere 1m,63, ur~ <( qnarto 1m, 0 8, ed i riman.enti due quarti 1ro ,55 ,1 . Dove~t1 pensare, ciò eh.e del resto è vero, che i reggimenti di ~ragon 1'. possed e11do i cavalier i i più alt i, ri ceverebbero pure I cav alli i più elevali. Se pertanto noi osserviamo, d~ un~ parte, che la statura dei cavalli dei corazzie 1·i, in Austna, e fissala come sègue: un terzo di 1ro,66 ed al disopra, un terzo di P',63, un terzo di 1m,61; e, ù'altra part e, cbe la . statura dei cavalli de i corazzier i presso le altre nazi on i è: in Pru ssi a di ,1m ,595 ad ,1m62 · in Francia di 1 ro,54- ad 1m,60; nel Belg io di ·1 m,5'1 ad' 1m 60; noi consta tiam o che in Aust ri a bannovi re.ggimenti lii cav~lleria leggera, le di cui monture sono più alte di quelle dei corazzieri deo-\i altri par.si , più alte, e così alte che quelle dei due terzi d~ corazzieri dello stesso impero. A cavalli di im 63 voo-lionsi uom ini altj per mon tarli, acc udirli, insellarli, ed 'armi df una lunghezza proporzionata. Dopo ciò, si avrà be \l'app1Jrmi. tutte l e classificazioni che si vorrà, ma i~ non so-

• sterrò meno che. l'Austria, per tutto il tempo che su~s,slPrà tale stato <li cose, avrà della cavalleria pesante olt re i suo i co raz-
ANNo VI. voi. I, - l S.
260 RISPOSTA. _
Prima d!lla riorganizzazione 1O Reggin1<:1 nti di ulani .... _.. Sqnadronì 80 ' 8 2 >> it _ ( (i 0 e 1 11°) . 112 J) di USSal'i . . , . 2 lJ l) (1 3o e 1 4°) Dopo la rior9rmizzazione. . -1 2 Reggimenti di ulani .... . ,1 2 ir, di us sari .. . ' . . • ,J O e 2° )) di ussari volontari Ulani volpnlari . . . _ . 96' 8 Totale ,192 Squadroni 72 . 72 16 8
DEL GENFR n L g REN,IRO 261
zi eri. Cambiare il nome delle cose, senza cambiarne la natura è esatta~ente come se non si facesse nulla. Si conservi nell; cavallPl'la belo-a I I • .· . .o qua c ie regg11n en lo monluto co me i cavallegge ,,. austria c,: su cavalli di baUag lia di 1m,58 a ,f m63 rporz t· •
iona amenle montali, qu1nd, si designi se si vuole lulla la ?ostra cavalleria sotto la denominazione di cavalleria leg"era Jo per certo non re clame rò. " '
C. e V. . STUDI MILITARI
SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE NOSTRE FANTERIE
Progetto di modificazione al Regolamento d'cscrcizi , nello spirito del nuovo riordinamento della fanteria di linea.
Alloraqoando, nell'agosto 1860 , occu pand oci del r io rdiname nto dell e nostra fant eri a, ci mostrammo cald i fautori della formazione del batta gl ione su 6 compagnie, pe r tutti i van taggi tattici che una tal e forma zion e presen ta: noi abb iam stabi lilo in principio: '- -
1° Cbe due compagnie, qur\le d' ala, dovrebb ero cos tantemente trovarsi fuori della lin ea delle altre i compagnie del battaglione, mentre q~este formerebbero normalmente la vera linea di battaglia del battagli one;

262 RJS~O STA DEL
GE~ERALE RENARO
• • P 0
frtt:itPS J CAPO VI.
· Cb~ uell'ordi ne fondarnen tale di batta gl ia la P e 6 • compagnia dovrebbero afforzar le ali del battaglione,-·formando due piccole colonne dietro le estreme sezi oni della~~ e 4_; com- . pagnia;
3° Cbe nell 'at tacco o combattendo in linea le dne ' com, pagnie 1a e 6 3 potrebbero essere spiccate s imultaneamente od ~lternàtivamente in cacciatori sia p~r rincaccia re i b ersaglieri nemici, sia per coprire la fronie del rispettivo bat taglionf', ~ia per proteggere le. distanze fra i battaglioni della linea di battaglia;
4.° Cbe le colonne d'attacco potrebber~ for·marsi con g11aa van taggio per divi sioni ; '
5" Che privo momentaneamente o ' per una cir·co~tanza qualunque di 2° linea il battaglio11e di 6 compagnie polr'ebbesi suddividere in due mezz i battaglioni , l'uno in 1a l'altro in '.2' linea; . ·
6° Che, ésse nclo ?°solato, _il· battaglion e di 6 compagnie potn:i hhr. co~tituirsi a mo' di un piccolo corp·o ùi battao-Jia ,:, , mandando la sua compagnia di lesta in cac ciatori sulla fronte , formando la sua lin ea di battaglia, ovvero il grosso dell'attacco collé 3 seguenti compagnie e ten e ndo le due ultime in riserva. Potrebbe pure all'occol'l'eoza suddividersi per l'att~cco in tre picc,oli scaglioni cli divisione, conr,orrenti allo stesso obbiettivo tattico ;
7° Cbe, finalmen'te, combattendo il battaglione in cacciatori, due compagnie formerebbero la catena, due - il sostegno e due la riserva, co mpl etando cosi, di per sè solo, l'ordine normale che la tattica prescrive per tale combattimento. J
bi·eve, avvegnachè il tempo incalza, ed ogn i ulteriore indugio potrebb'ess~ rci per questo verso fatalissimo - cotesta nuova formazioue siccome la recente tattica alla medesima relativa, _ e che costituisce i suoi principali vantaggi, esigono cert e modificazioni ai vigenti regolamenti d'esercizi , riferentisi specialmente alla scuola di batt ag lio ne ed all e evo luzion_i di lin ea, quali modificazioni possono raccogliersi in un'appendice di brevi pagine , provvisoriamente: ..:... fintantocbè a te mpi pi~ calmi si possa rifare ra dicalme nte l' iul er \> rego lamento prellello e portarlo a quell'altezza cle lla moderna tattica, cui, l 'ab biam detto francanfen te, esso non è del tutto.
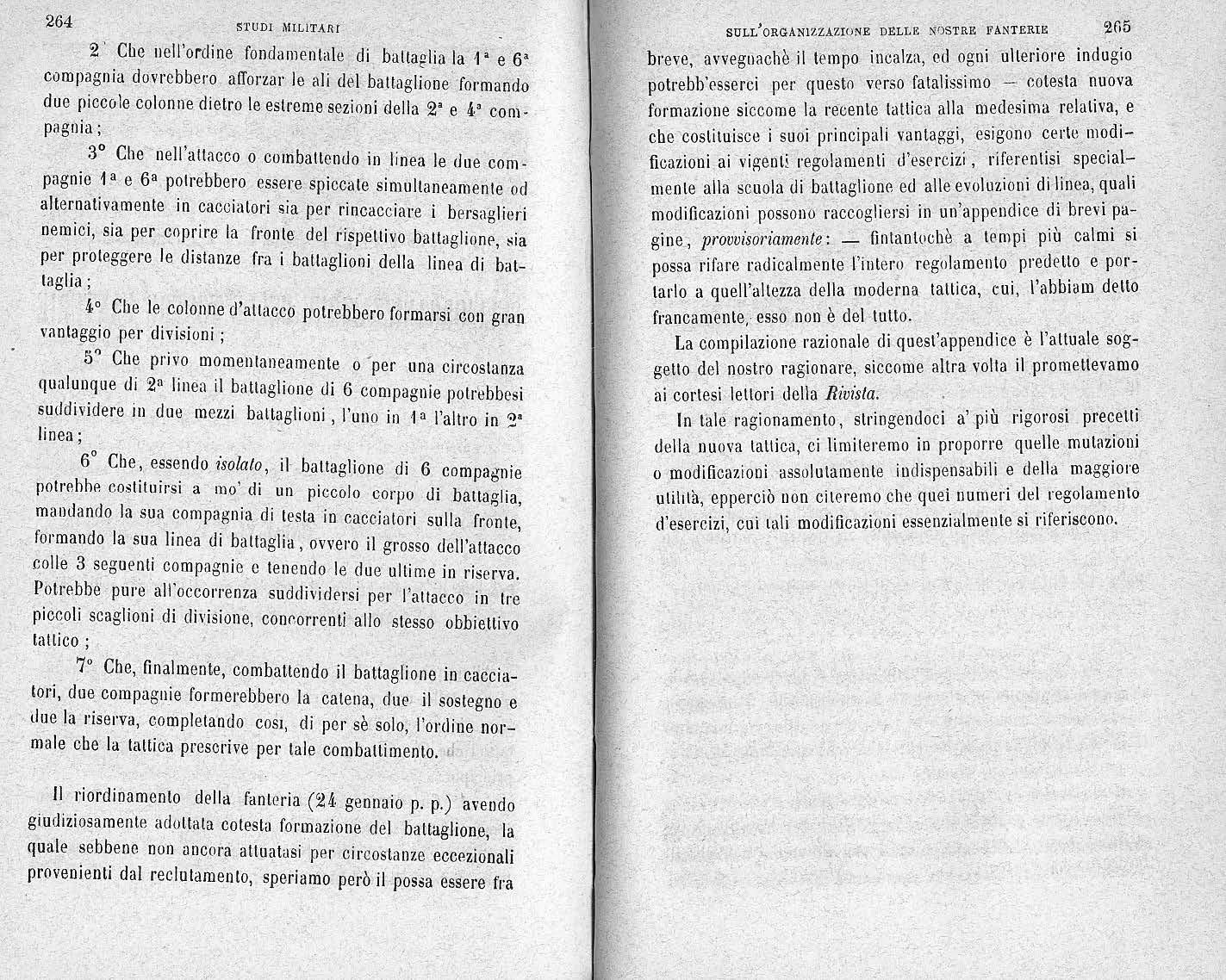
La compilazione razionale di quest'appendice è l'attu ale ·so g. getto del !)ostro ragionare, s·ìcc ome ali ra volta il promettevamo _ ai cort es i leltori della Rivista.
In tale' ragionamento, stringendoci a' ,più rig orosi precètti d ella nuova tattica, ci limiteremo in proporre quelle mutazioni o modificaz i·oni assolutam ente indispensabili e della maggiore utilità, -epperciò non citeremo ch \i quei numeri del regolamento d'eser~-izi, cui tali modific t1zio ni essenzialmente si riferiscono, .
11 riordinamento della fant eria Ui4 gennaio p. p.)' 'avendo giudiziosamente adottata cote.stu formazioné de l battaglione, la quale seb ben e non ancora attuatasi per circostanze eccezionali provenìenti dal reclutamento, speriamo per~ il possa essere fra
264 ~'l'UD! MLLlTARI
SULL'ORGANIZZAZIO NE DELL& NOSTRE FANTERIE 2fì5
SE:t.lONB t, SCUOLA D I BATTAGLIONE.
Composizione e riparto.
642 . Le sei compagnie sono composte ciascuna come ~1 N . 402, meno i tamburini che sono tutti riuniti sotto 11 capo.
I tromb ettieri della I~ e 6"' compagnia stann o presso le nspettive compagnie, mentre gli altri sono riuniti ai tamburini.
Ordin i di formazione.
6~. - Il .ba ttaglion e essendo ordinato come al N . 548 le sei compagnie sono numerate da destra a sinistra in prima , seconda . . . . . . . sesta compagnia.
I pelott oni sono numerati nello st esso ordine in primo . .. dodicesimo .
. La 1°_ e 2" compagn i a form~no. la. 1: div·is~on~ o c/;ivisi~~e. di destr·a , la 3• e 4• compagnia la 21.1 divisione o dw~i~~e del cent?·o, la 5a e 6a compagnia la 3a divisione ? divisione di sinist?·a . La l '', za e 3• compagnia formano 11 mezzo batt~glione dì dest1·a, la 4a, 5a e 6n compagnia il mezzo battaglione di sin istra
_648. ~td·in~ cl-i. b~tta~li~. L'o.rdi~~ ·di ·ba;ta~li~ si. di~ stmgue_ m a) orcune di battaglia semplice, e b) ordine di batt.agha a(fo1·zato.
SULL'ORGANI ZZAZ IONE DKLLE NOSTRE.
a) Nell'ordine di battaglia semplice le se i compagnie su una stessa linea, ordinate ciascuna come al N. 4 10 (1). . . . . -
b) Nell'ordine di battag1ia afforzato la 2"', 3a, 4a e 5"' compagnia sono ordinat e in b attaglia come so~~a, mentr~ la l• e 6a compagnia sono formate in colonna d1 pelotto~1 colla destra in testa a distanza intiera dietro l'ala corrispond ente del battaglione .
La l • compagnia sta dietro il pelottone di destra della 2" compagnia a distanza di pelottone, più 5 passi; la 64 compagnia colla d estra in testa sta analogam ente dietro il pelottone di sinistra della 5" compagnia
L'aiutante maggiore, sempre a 10 passi dietro al centro del mezzo battaglione di destra.
Il furiere maggiore, sempre a 10 passi d i etro il centro del mezzo battaglione di sinistra (2) .
In quest'ordine di battaglia l'indicazione pelottone o compagnia di destra ( o d i sinistra) va riferito al pelottone od alla compagnia, ch e si trov a effettivamen te a destra ( od a sinistra) della linea di battaglia del batta-
( t) Sebbe ne, in massima, l'ordine di battaglia del battaglione abbia _da essere afforzato, come abbiamo premesso, tull,1via ponno ar.cadere c1~costanzc in cui il bntlaglionc debba schierare tutte le sue co'.°pagnie sulla stessa linea; epperciò distingueremo l' ordin e di battoglia '.o sempl ice ed afforzato. E vedremo che 4ucsla dis tinzi one non portcra allungamento nè confusioni nei com andi.
(2) Le altre cariche conservano il loro posto come al N. 6118 dell'altualc scuola di ba ttagli one.

266 STUDI YILIT..uu
FANTERIE. 267
FIG. I. 10° p . 9• p. s0 p. 1° p. 6° p. 5° p. ~• p. 3° p. -- - ----- - --11 • p . 1• p. 1• Comp. 1 io p. 2• p.
gliene, _ cioè al 3° pelottone, 2· compagn i a (o 11 ° pelottone, OY'i,...ero 5a compagnia) .
649. Ordine di pcwata. - Il batta:gliorre ordinato come in ordin e di battaglia semplice . ... , ecc .
650. 01·cl-ine di fi anco . - Tutti al loro posto cli battaglia vo19 di fianco a destra (od a sini:3tra), _ ecc .
· Quando il battag lione dall'ordine di l)attaglia afforzato pa~sa a quello di fianco, la la e 6" compagnia serrano in massa sull a s ezione del battaglione che sta loro dinnanzi, é 'si vo l gono di fianco a destra (od a sin istra) . ·
.· 65 1. Ordine di colonna. -;- L',o rdine d:i colonna distingue la colonna a) semplice, dalla co l onna b) fiancheggiata.
a) Per la colon na semplice, quanto è detto al .N: 413 per le . colonne n ella scuola di compagnia, va inteso pel battaglione. .
bj' La çolonria fì.ànèhegg.iata ha in colonna la 2•, 3a, 4a e 5a compagnia, mentre-la l• e la 6" compagn i a fiancheggi ano la colonna, a 5 passi di distanza , a destra ed . a sinistra all'altezza della t esta , del r.Antro o de lla coda della colonna, a _ seconda delle particolari prescrizioni del CO.mandante del battaglionè.. .
Per tale fi.anc"heggiamento la l • e 6• compagnia ·sono formate ciascuna in co l onn!l- di pelottonì o sqµadre colla destra (o colla sinistr a) in testa, a d istanza ·intìera (mezza distanza o serrata) secondo. che la colonna pri ncipal e è formata per divisioni , compagnie o pelottoni colla destra ( o coll a sinistra) in testa ~-a distanza intiera (mezza distanza sert~ta) e secondo gli ordini espressi del ~omand ante d èl battaglione a norma delle circostanze .
. In generale l e co1onne fiancheggi anti sòno sempre formate-in sezioni eh una m .età di quelle della Golorina prin• ci pale .
. · Nelìe · colonne fiancheggiate i . capitani d~lla colonna princip ale staniio a due passi • sul lato della d ireiiGne, all'altezza della metà delle loro ,compagnie .
S ÙLL'ORGAN!ZZAZIONE DEl,LE NOSTRE FA NTERIE
I tamburini e i faleg·nami, sul lato destro (~ _sinistro) della colonna seco ndo si ha la destra (b la s1mstra) 10 testa, dietro o dinanzi la compagnia ' fianch~?giante ., ;;ecemdo: che questa fiancheggia la colonna rn testa, al centro, ovvero in coda (1) .
Ordine di colonna oanchegglata di compagnie a d istanza IDtler11 colla destra I n testa.
FIG . II.
6• Comp.
2• Comp.
3• èomp .
Tamburini
4• Comp .
5a Comp. ' .
654. Colonna di divisio·ni . - La colonna semplice di divisioni · è formata dalle tre d i visi oni deJ battaglione, ecc.
La ~ol~nn~ fi~ncheggìata di - divisioni non si deve u sare che fo rmata col èeritro in testa, N. 656 (2). .

Facendo stmda. Colla destra in testa l a la compagnia _ marcia in, testa a 1O passi dinanzi . ai falegnami, forma.ta come ·1a retro;yeniente colonna.
(1 ) Qu.esle norme .generali- van.no applicate ai ~nmeri 6~2, 653 e 6~4. s ·mprechè si tratta di colonne sempl ici bisogna ivi mutu re 1! numero •~elle e · d I f • · d I battagli one sezioni in quello conisponden te, secon .o a orma~1onc . e . in sei compagnie Per le colonne fianchrggiatè colla denom10oz1ooc q"atl t o corn.-pagnù, , s pelotloni , 16 squadl'c s'in~cndon o sempre qne-l le deJl a seconda, terza, quarta e q uinta cornpagnrn. . . . .
(2) La colo nn a semplice di divis ione può tro~a 11~ ~!:un~ cas1 ove 1m'~'1:• · . · a 1·l1 pri ' ric ipi o "Cncrale le colonne d1 d1v1s1olll s1 usano mc,,ho gars1,ru, _ " . , . .1 · r,. o! cen tro in testà siano semplici, sia no fiancheggiate; oltre a c_ic 81 .°1 e ' · • I - ·1 t ,rn·o eh lascmre mano, si spiegano più speditamente, s1 ia _cosi, 1 van..a.,,,1,, .. " _. sciolte per ogn i occonenza Je due compag111c '.l ala, ~JO e~ e n cccssai 10: Pel processo di questo nostro progclLo apparira mcgli_o I 1mpo~tan_za d1 questa innovazione ed il modo di ~pplicarla nelli varie formaziom.
268 STOtll MILI TARI
La 6a _compagnia marcia anal ogamente in coda della · la compagnia a distanza di sezione e di 10 passi, -dalla ultima sezione della 5~ compagnia. ·
Colla sinistra in testa, si m arcia in - ordine inverso al precedente.
655, 656, 657. Le colonne col centro in: testa vengono fiancb.eggiate dalla la e 6a compagnia colle stesse norme predette
678. . . Il guidone 1·osso è portato d alla guida- -di d estr a del 3° p~lottone. I~ guldo ne turchino è portato dalla guida di sinistra de l sesto pelotto:rie . Il gu,idone giallo è portato dalla guida di sin istra del 10° pelottone.
Quando la la e la 6a cornpagma sono in linea eontig ua col battaglione, i l guidone rosso passa a guida di d estra del 1° pelotto ne ; i l - guidone g iallo passa a guida .di sinistra dei' 1~0 pelottone.
In colonna i guidoni tengono sempre il loro posto presto}bilito · , No rme per le compagnie P e 6a (4).
+'a la e . 6a compagnia sono ess enzialmente ·d estinate ad afforzare e fiancheggiare il bat taglione, epperciò il più so v ente, speci <!--lmente in facc:ra al n emico, esse debÌ)ono trovars i fuori di linea, o di colonna come si è detto ai N. i 648 b) e 651 b)_.
In tali circostanz e queste . compagnie - manovrano al comando di esecuzione del rispettivo capitano, a~secòndando l 'e voluzion e del. proprio battaglione · secondo- le i ntenzioni del còµiandante d e~ medesimo. espr,esse con appositi co mandi preventivi, ovyero s ia con istruzioni pfl,rticolari.
(1) Da i ntercalarsi al Jesto fra i numeri 686 e 687 .
I comandanti di queste compagnie non potr-anno u sare altri comandi o movimenti sè non quelli dell a- scuo1a di compag~i a, o dell'istruzione della compagnia, nella scu ola da cacciatori , a meno ché siano s pecificati dalla presente appendice . ,Oguora quando dette compag ni e siano spi ccat e in cacciatori sulla fronte, o sui fianchi, od alle spalle del battaglione, 'si règoleranno seconµo l e prescrizioni delJa scuol a da cacciatori (istruzione della compagnia).
La composizion e e~ il riparto d ella, la _ e , 6a compagnia sono quelli stabiliti dal N . 4 02 al 4Q8 scuola di compagnia, colle mo-dificazioni prescritte dal N . 112 della scuola da cacci atori.
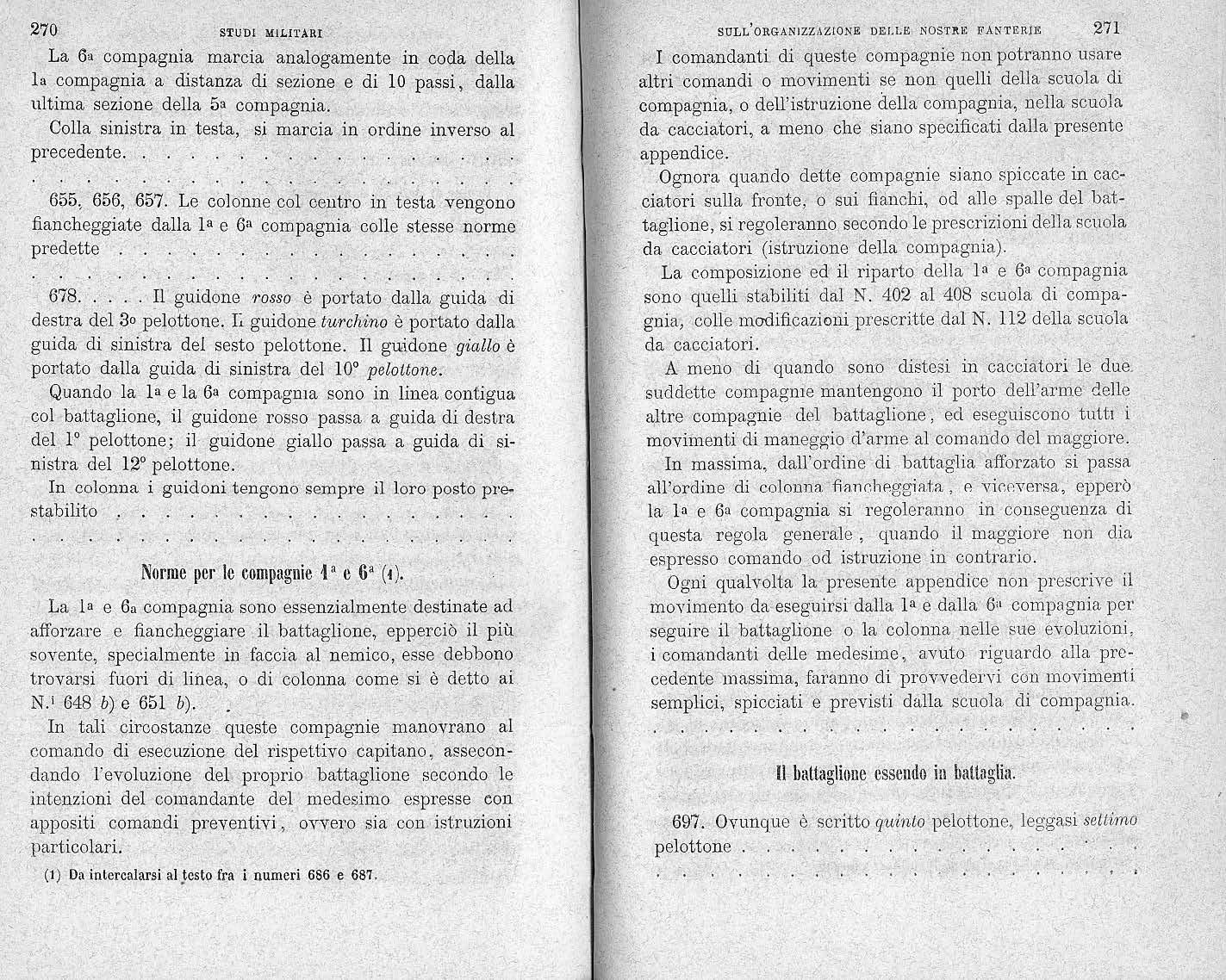
A me110 d i quando sono distesi in cacciatori l e due . suddette compagn~e mantengo nÒ il porto dell'arme delle a).tre compagnie del battaglione , ed eseguiscono tutti i movimenti di man eggio d'arme al comando del maggi ore .
In massima, dall'ordì.n e cli battag lia 'afforzato si passa àl l 'ordine di co1ouna fian ch P.ggi afa , P. v i r.0.versa, · ep)_)erò la 1:1 e qu compagnia si regol eranno i n couseguenza di questa règol a generale , quando il maggiore non dia espresso comando od istruz ione in contrario. _
Ogni qualvolta là. _presente appendice non prescrive il movimento da eseguirsi dalla la e d~lla 6a compagnia per sBgu ire · il battaglione o. la colonna, nalle ::me evoluzioni, i comandanti d ell e me<lei;iime, avuto riguardo al1a 1~recedente >massima, faran n o di provvedervi con movi menti. semplici; spicci;ati ·e previsti dàlla scuola di com pa gnia.
270 STUDI Ml.LITARI
SULL'ORGA NI ZZ ,IZIONE DEJ,L'E NOSTIU: FA NTERrn 271
U battaglione essendo in battaglia.
•
097.. Ovunque è scritto qwinlo pelottone, l eg gas i•settimo pelottone .
715 ... . .. . . La la e 6a compagnia quando si tro-vano nell'odine b) N . 648 si r egolano •colle norme e coi comandi prescritti dal N. 513 al 519 (scuola di compagnia).
Cam,biamento di . direzione marciando ·in battaglia. .
7.24. ... La la e 6a compagnia stando piegate dietro le ali del battaglione si porteranno nella nuova direzione con un leggero mo\'·imento -d'obbliquità dalia parte ·opposta al cambiamento di fronte , coi comandi prescritti ai N_,i 526 e 527 dei rispettiv i loro capitani.
·!farcia e movimento di fianco.
726 . . .. Al comando d'avverlimento del maggiore: Battaglione fianco dest1·' ( o sinist1•') i capitani ' della 1a e ()a compagni<J. comandano Se1·rate· la colonna passo cli cariea 1 MARCHE; quindi le compagnie sono messe di fianco dalla parte chiamata oper quattro o p èr due come il battaglione. All'occ orrenza dovendd il battagli one sfila.re di fianco per un passo ang usto la: la e 6a compagnia formano la compagnia chiamando i p elottoni sulla stessa linea e serrandosi affatto sui serrafile del batt'aglione , per ciò ·.i ç apitani di esse compagnie si regolano analogamente al N. 732.
Formare il battaglione solfa 1lestra o sulla sinistra in balta glia (i).
glione che ·ioro stavano dinanzi , con due cambi~men~i di direzione a destra ( od a sinistra), dette compagme vengono a stabilirsi -al loro posto di ·battaglia come al N. 648 b) ed i comandan.t i dei secondi pelottoni senza . altro cGmando portano il l oro pelottone a distanza intiera da} primo , coi comandi del N. 771 .
Essendo in battaglia , formarsi in colonna.
731. Avvertenze pèr la la e 6a compagnia:
1° Per pelottoni; compagnie o divisioni a clest?-a (o sinisl/1'~) in colonna. A questo comando di avvertimento del maggiore il coman dante d ella la compagnia (o quello della 6a) comanda : Compagnia avanti, testa di col onna a destr' -(o sinistr').· . I l comandante della 6a com1)agnia (o quello della lt1) comand~ : Compagnia avanti, passo cli carica . Al M a RCHE del maggiore si eseguiscono i movimenti prescritti.
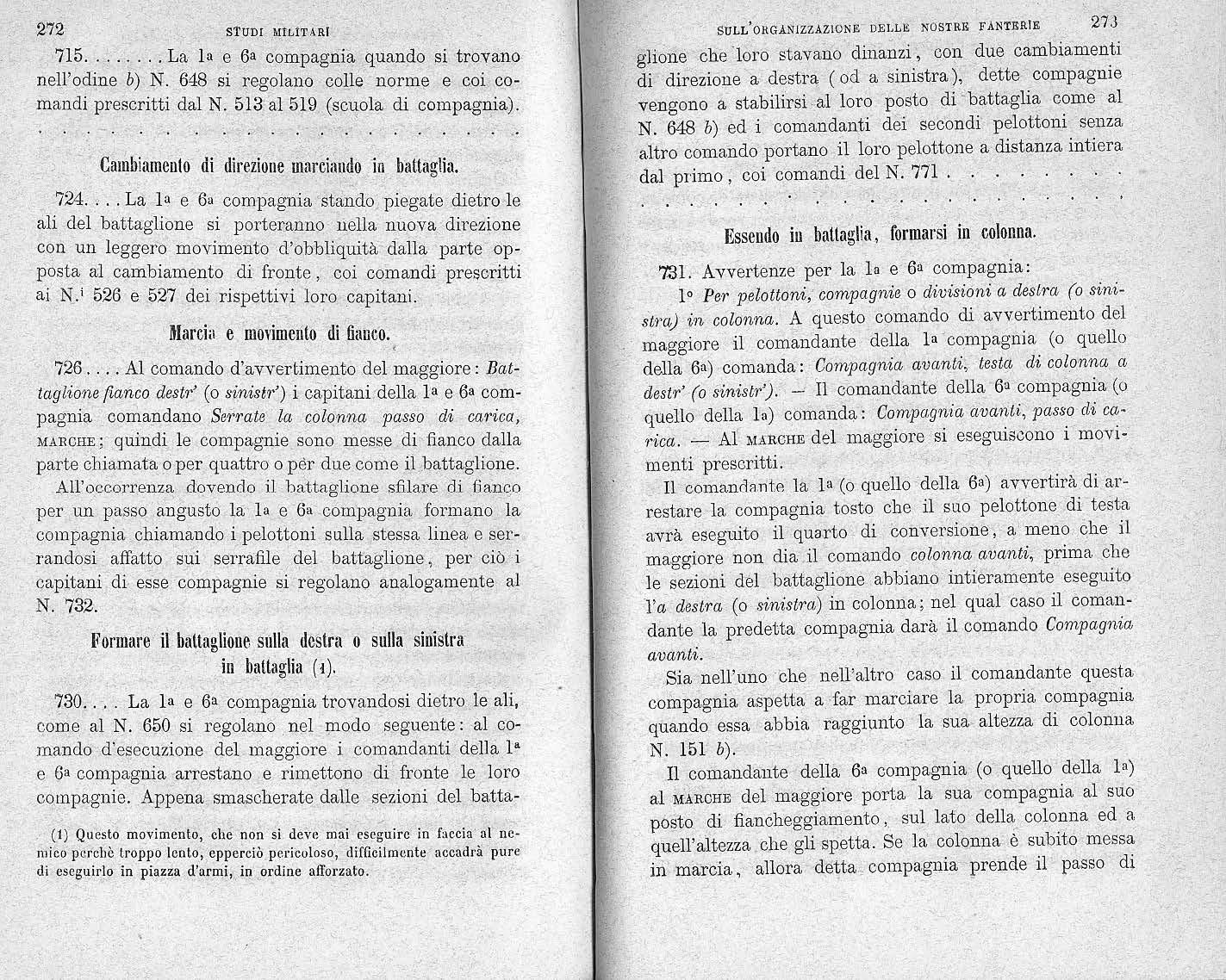
Il comandante la la (o quello ··d ella 6a) avvertirà di a rrestare la compagnia tosto c'he ·n suo pelottone di testa avrà eseguito il qua.rto di conversione, a meno che i l . maggio i::e non dia .il comando colonna avanti, prima ,ch e le sezioni del. battaglione abbiano inti ~ramente esegui to "l'd clestra (o sinistra) in colonna; nel qual caso il cou:iandante la predetta compagnia darà il comando Compagni-a avanti.
.
730. . .. La la e Sa compagnia trov ~ndosi dietro le ali, c ome al N. 650 si regolano . nel modo ·seguente : al comando d'esecuzione del maggiore i comandanti délla 1a e 6a compagnia arrestano e rimettono di · fronte le loro compagn ie. Appena smascherate dalle sezioni del batta-
(1) Questo movimento, che n on si deve mai eseguire in faccia · al ne• m ico p erchè troppo !colo, e p pe rciò pericoloso, difficilmente accadrà pure di eseguirlo in piazza d'armi, in ordine afforzato .
Sia nell'uno che nell'altro caso il comandante questa conrpaguia. aspetta a far marciare la propria compagnia quando e~sa abbia raggitmto la sua altezza di colonna N. 151 b). · -
Il comandante della 6a compagnia (o quello della l a) al :r-,Ù.RCHE del maggiore porta la sua compagn ia al suo . posto di fiancheggiamento ,. sul lato della colonna ed a quell'altezza c.he gli spetta. Se la colo.nna è subito messa in marcia·, allora. · detta , compagnia pren~le il passo di
272 STPDI MIL1TARI
SU LL'O I\GAN lZZAZ IONfs DELL1' NOSTR!l FANTERIE 273
s·roo1 .IIILJTARI cor~a fìnchè abhia raggiunto il proprio posto di colo nna, N . 651 b). ,
2° Per pelottoni (corn,pagnie o divisioni) a destra (o sinistra in colonna), la desf;t•a (o la sinistra) avanti .
Il comandante la l a e 6a comp agnia si r egol a n o i n modo analogo a quanto venne sovra detto , andando sempre a portarsi al più presto al loro posto di colonn a.
3° Per pelottoni ( comp agn i e o d-ivisioni) ro mpete dalla sinist1·a e mm·ciate a destm ( o dalla dest?·a e marciate a sinistra .)
Il comandante l a la ( o 6a ) comp agnia si :regola in modo analogo al sovradetto. Quello della 6a compagnia (o della la) aspetta a prendere il suo posto di colo n na, fi n ch é la sezione della co l on na prin cipale, a lla cui altezza deve trovarsi, l e sfili dinnanzi.
4° Per pelottoni (compagnie o divisioni) indiet?·o a destra ( o a sinistni) in co lonna.
Il capitano della la (o 6a) compagnia comanda: Compagnia front' incliet1·0 , FRONT; f:nmpagnia avanti, testa- di colonna a destra (o sinistrci) .
Il capitano della 6a (o In) compagnia comanda : Compagnia avanti, passo di ca1·ica.
Al MARCl-IE del maggiore si oseguiscono i m ovimen ti avver t i ti . Il capitano dell a la (o 6a) compagnia sgombrando al pi LL presto il terreno per le sezioni dinanzi alla sua, che rompono: in colonna, portasi tosto al suo pos t o d i col onn a . Il capitano dell a 6a (o la) compagn ia la porta come p r ecedentemente si è detto al suo posto di colonna.
NB . Ognora quando il piegamen to in col onna n on succedesse che per passare immediatamente ad un'altra formazione in battaglia, il maggiore avrà cura di prevenirne i comandanti della la e 6a com p agnia, che si r egoleranno in proposito, senza che occorra per ciò di portarsi al posto prescritto loro dal N. 151 b); in tale caso essi seconderanno il movimen to, ma t enendosi però alla
altezza delle sezioni che loro corrispondono n ell'ordine di battaglia.
Quando il battaglione rompe per pelotton i, è regola, generale che l e compagnie fiancheggian t i rompine pe~ isquad r e . Qu ando il batta glione si p iega in colo nna d1 squadre, le compagnie suddette marciano di fianco pe r q uattro nella stessa direzione che la colon n a, ed a 5 passi da qu esta.
F m. III.
o v eramente per mezze squ adr e .
50 Colonna serrata sul pelottone (o compagnia, ecc.) di ·ctes//l'a colla destra in testa:
La la compagnia con un fianc o desti·' sgombra il .terreno, e p r ende poscia il s uo posto di col onna.
La 6a compagnia con u n fianco dest1·' viene pure a l)ren · dere il suo pos to , appena forma ta la col onn a; ed ambo le compagnie serr ano le distanze sul pelotttone d i testa col comando del N . 761.
Analogamente, se l a colonna vien for mata c olla sin i stra in testa .
Inversamente, se la colonn a vien formata su di una sezion e di sin i stra.
Se la col onna si forma su di u n 'altra se zi one qualunque la l a e 6a compagnia vengono prendere il loro posto di c olonna con un m ovimento di fi an co verso l a col onna s t essa.
Lo stesso intendasi per tutte le altre formazioni in colonna dal N. 735 fino a l N. 741 .

274
SULL'ORGANIZUZIONE DEl,U NOSTRE FANT &lUE 275
,Nel caso dei numeri 742 e 744 l<J; la e 6a compagnia vanno a prendere il loro posto di colonna marciando obbliquamente --verso li direzione deÙa colonna.

6° 746 ...... Se il battaglione chiamato in colonna de,,e continuare a marciàr~ nella stessa direzione in, cui marciava di fianco : il - comap_dante della compagnia (la o 6a) dieiro la testa del battaglione al comando d'avvertimento del, maggiore, fa eseguire un per fila dest1·a od · a sinistra ai suoi due pelottoni, secondo qhe il battaglione marcia pel fianco destro o sinistro , ed al passo di carica o di corsa se deve , sgombrare il terreno alla formazi,one in colonna del battaglione, portasi ad occupare il suo posto di colonna, cjuindi fa prendere le dist9-nze a' suoi pelotto4i col: comando del N. 774. Il comandimte del11:1, (6a o _la) compagnia d i etro la coda del battaglione, appena smascherato; porta l a i;;ua. compagnia al passo di corsa al suo posto di colonna passando dietro la colonna, e prende quindi le distanze come sovra.
Se la colonna formandosi successi'(amente deve mar~ ciare perpendicolarmeute alla primitiva direzione, la (l • _ o 6a) compagnia dietro la s~zione di testa della colonna portasi al suo posto cli colonna marciandovi obbliquamente . L'altra compagnia appena smascherata portasi di fianço al suo posto di colon na.
il suo posto di colonna, segue la 'marcia -ne11o st~sso ordine della colonna. L'altra compagni a marçi ando di fianco · verso la colonna portasi al passo di corsa all'altezza del suo posto d i colonn~, ' e quindi rimessa di fronte, marcia per la. seconda riga come la colonna P~'in cipale.
Se la colonna venisse_ formata p.er la seconda riga, il comandante la (la .o 6a) compagnia dietro fa sezi,one di testa, sgombr~1 tosto il terreno ad essa sezione con una rparcia di fianco in fuori ,del battaglione, quindi raggi1;illtO
749 al 751 . La la e 6a compagnia seguono tutti i. mo, vimenti della colonna, regolandosi sulla .~ezione alla di cui altezza si trovano .
752. Dovendo la col onna cambiare di direzione marciando, il maggiore avrà cura di prevenirn e , qualche passo prima, il comandante la coinpagnia :fiancheggiante della parte della nuova direzione; questi fermerà la s_ua c?m ~ pagnia a distanza-di sezione dal per~o, pi~1 5 passi, q~m~1 farà eseguire il cambiamento, di d irezione alle sue sez10m, ' di modo· a mantenersi nella . nµova direzione, all'altezza della colonna che già- prima a.vea .
Quando i l maggiore non avesse prevenuto detto comandante di compagni a, questi allora ,al com~ndo del maggi.ore: Testa di colonna a dest1·a (o si11;istra,), arresterà l a sua compagnia, ·e to sto postala cli front e indi:etr~ l a far_à marciare pel tratto di una sua sezion e, più 5 pass~, o'bbhquando in fuori. Arrestatala poscia e rimessa.l a d1 fronte: fa~à · eseguire alla sua volta iL rispettivo oainbiam ento d1 direzione.
276 S'.J'UD1 ~lLfTARI
2• c. "'· - /, <:> 5; C. ~5;C. ............... ... .. . . 3• c. 1• c. ,
FIG. IV .
SULL'
i7't
ORGANl ZZA ZlOXE DEL"(,~ N OSTRE FANTEl\llt
c. 3• c. 2• c. 6•
.................. :::::::;::::::::::: 1• . c. up. 12 p. 5• c. 4• c. 2• c. ft10YiJI1cnti essendo in colonn~. l p. 2 p.
FIG. V. 5• c. ,.
c.
ANNO VI. Voi. I. - 19.
.
La compagnia fiancheggiante dalla tyarte opposta, fa il suo cambiamento di direzione contemporaneamente all e sezìoni della colonna ' principale cui corrisponde.
754 . Cambiamento di direzione s11l fianco sinistro: A •q~esto cor_n~ndo d'avvertimento la compagnia fiancheggiante a sm1stra, per sgombrare il terreno portasi tosto marciando avanti e quindi cambiando di direzione a destra al suo nuovo posto di colonna.
Il comandante l'altra compagnia_fiancheggiante comanderà Compagnia front'vndiet1·0, testa · di colonna a destra . Al MA'RCHE d el maggiore la compagnia · avviasi al suo nuovo posto; giuntavj, vien rimessa di fronte ed alineata.
755.. Cambiamento di direzi~ne sul ficmco destrn. Si eseguisce in modo analogo. .
756. ~a colonna essendo in marcia di fianco: Battaglione, . ·corwe1·swne a destra (o sinistra). La }a e 6n compagnia si mantengono in ,testa e in coda come sono ~seguendo la chiesta conversione.
7fi8 al 780. Le comp~.gnie fiancheggianti eseguiscono gli stessi mov i menti della colonna, avuto però r i guardo alle r eg0le . loro speciali precedentemente fissate .
. 788. Sia nel formare i pel ottoni, cÒmpagnie e d1v1s10m, cl~·e nel romper e per isquadre, pelottoni, compa:gnie della colonna principale, i comandanti delle compagn i e fiancheggiant i oltre a.I formare e rompl\lre essi pure le sezioni colle avvertenze del N . 651 b), devono bad~r e a mantenere la prescritta distanza di 5 passi col fianco deJla . colonna obbliquando , in temp~ , a destra o a sinistra, secondo i l caso, quando la colon na è in marcia, ovvero con movimenti dLfi.anco, sè l a colonnà è ferma.
Essendo iu colonna, fotmarsi iu battaglia.
789 . lo A sinistra i,n battaglia. A qu esto comando d'avvertimento- del maggiqre la 6a compagnia fa fronte indietro , e quindi al passo di cor sa portasi dietro l'ala sinistra del battaglione come al N. 648 b) , r ase ntando la sinistra della linea di battaglia e venendo al suo posto con un (ianr.:o a destra e per fila a sinistra per pelottone. La la compagnia al MARCHE del maggiore, marcia avanti (se occorre) fino. all'altezza del suo posto d ~ battaglia, quindi va. occuparlo con un cambiam ento di direzion e a sinistra . . · ·
' Se rotte per isquadre, mezze squadre , o di fotnco, dette compagnie avvertiranno di prendere la forma.zioue del N . 648 b), prima d i giungere a.I loro posto, coi movimenti e com andi della scuola di compagnia .

zo A destra in ' battaglia La h e 6a compa.gnia si regolano analogamente al N. 1°. .
3° Per fianco destr' e per fila a sinistr' in battaglia . A questo ' comando la la compagnia marcia. avanti sino alla altezza G:lel suo posto di , batt~glia (se pur già non vi è); al MARCHE del maggiore il 1° pelottone fa un quarto di conversione a sinistra, il 2° pelottone con un per fìancq__ de_str' ~- pe1· fila a s·inistr' viene a collocarsi dietro il l O come al N. 643 b).
La 6a compagnia si regola come si è detto poc'anzi
N. 54G .
4° Per (irptco sinistr' e per fila a des tr' <in batta glia .
La la e 6a compagni.a si regolano in modo analogo al sovradetto .
50 Sulla destr,a in bo.ttaglia . A questo comando .d'avv ertimento il comandante la la compa.gn-ia a.rr es,ta l a sua compagnia., se qu esta marcia all'altezza della testa della colonna. Quindi appena la ·2a compagnia è giu-nta sulla
278 S1ùDI Mll,ITA \Il
· o N SULL' ORGANlZZA Zl Q'<E (>ELLE NOSTRE FANTERt't: 279.
linea di battaglia, la la compagn ia con e pe1· fila a desM·' per pelottone portasi battaglia N . 468 b).
un fW,nco sinistr' al suo posto di
La 6a compagnia ~arcia avan ti fin che gi un ge a ll'altezza del suo posto d1 battaglia, quindi, app ena la 5a compagnia h~ eseguito la sua conversione a d estra, Ja sesta c?mpagma, con un ~.ambi amento di direzione a destr a, vien e al suo p osto d1 battaglia (N. 4696).
10° Fronte indiet·ro in battagbia, fianco sinistr'. La la e
6a compagnia si r egolano come sov ra . Nell'uno e nell'altro caso d ette co mpagnie prendono per via la formazione pres critta dal N. 648 b) , quando già non l'avessero.
.
6° Sul la _ sinistm in battaglia . La - la e 6a compagnia s t reg olano m tµodo analogo al s ovraddetto .
70 Avanti in battaglia conversione a sinist1·' . A questo c?~1a~do l e due compagnie fian cheggianti fanno fianco S'ln'l,St r ; _ al M.ARC!IE la ln compagnia vi en preudere il suo posto d1 battaglia dietro il pelottone di destra.
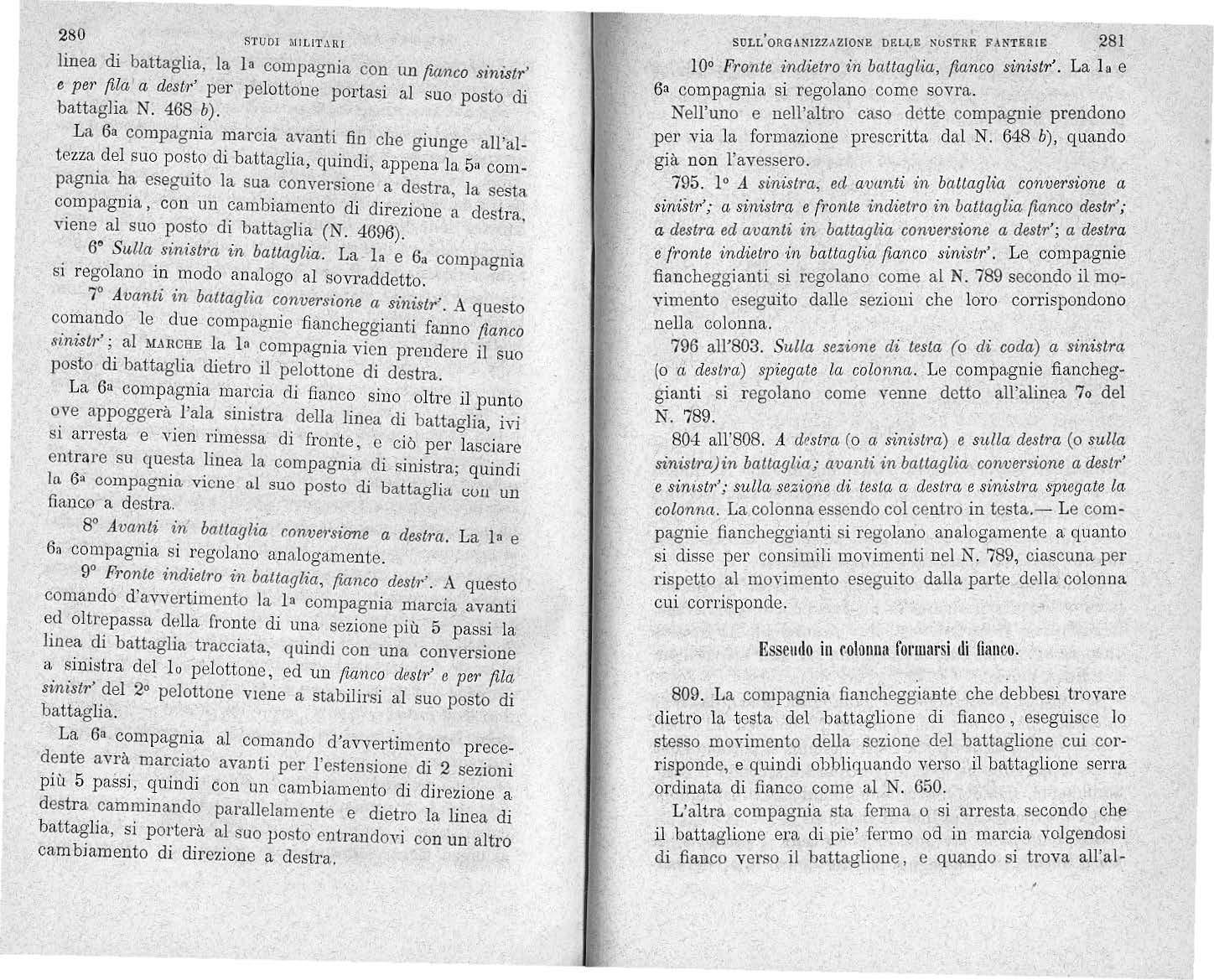
La 6a comp_ag~ia m ai~cia di frane~ sino oltre il punto o_ve appogger a _ 1 ala sm1stra della Jm ea di battaglia, ivi s1 arr es ta e vien rimessa di fronte e ci·ò pei· l · , asc iare entr:re su que_sta !inea la compagn ia di sinistra; quindi l o. 6 com pa,gmo. viene o.l suo posto di b attagli <l. con un fianco a d es tra.
8° Ava1iti in battaglia conve1·s-ione a destm. La 1a e 6a compagnia si rego l ano analogamente .
9° Fron,te indi~tro in battaglia, fianco dest?•' . A qu esto comando d avvertimento la l a compagnia marcia avanti e_d oltr~passa d:'lla fro~tc di una sezione pi ù 5 pas si la linea di battaglia tracc1ata, qui n di con una conversione a_ ~ini,stra del 1o p elottone, ed un fian co clestr' e per fila S'/111,tst?· del 2° pelottone viene a stabilirsi al s uo posto di battaglia . ·
La 6a compag 1_1ia al comando d'avvertimento precedente av rà mar ciato avanti per l'estensione di 2 se · ·
"ù 5 · · ZlOlll P1 passi , q uindi con un cambiamento di dir ezion e a d estra cam~i nando parallelamente e dietro la linea di batta~ha, s1 porte rà a l suo po s to entrandovi co n un altro cambiamento di direzione a destra.
795 . 1° A sinist1·a, ed avanti in battaglia conversione a s inistr'; a sinist1·a e fronte vndietro i n battaglia fianco destr'; a destra ed avanti in battaglia conversione a destr'; a destra e fronte in dietro in battaglia fianco sini.str' . Le compagnie fian cheggi an ti s i regolano come al N. 789 secondo il m<,>vimento eseg uito dalle sezioui che lor o corrispondono nella colo n na.
796 all'803. S ulla sezione di testa (o di coda) a sinistra (o a destra) spiegate la colonna. Le compagnie fiancheggianti si r egolano come venne detto all 'alinea 7o del N. 789.
804 all'808 . A destra (o a sinistra) e sulla dest·ra (o su lla sinistra)in battaglia; avanti in battaglia conversione a destr' e s'ini st?·'; sulla sezi one di testa a destra e sinist1·a, spieg ate la colonna . La colonna essendo col ce n tro in testa.- Le compa gn i e fian cheggiant i si r egolan o analogamente a quanto si disse per consim ili movimenti n el N. 789, ciascuna per rispetto al mov i men to esegu i to dalla parte della colonna cui corrisponde.
Bsseudo in t' olon na for mars i di fian co.
809. ·La compag nia fiancheggia.e.te ch e debbesì trovare dietro la t esta d el battaglione di fianco , ese guisce lo stesso mov imento della sezione del battaglione cui corrisponde, e quindi obbliquando verso il bat taglione serra ordinata di fian co come al N. 650.
L' altra compagnia sta ferma o s i arresta sec ondo che il batta,glione era d i pie' ferm o od in marcia volgendosi di fianco verso il hattaglione, e quand o si trova all'al~
280 STUDI MILIT AR I
SULL'ORGANIZ7.AZIONE DP.q.E NOSTRE FANTE RIE 281
STUDI .\!ILITARI tezza della sezione di coda cui d eve corrispondere con un mo v i mento di per -fila a sin i stra (o a d~s trà) vien~ a prender e il s uo posto come al N. 650 . ·
Cambiamento di fi:onte.
814 al 818. R ego la generale . P er .i campiamenti di ·fronte le compagni e spiegate di etro le aJi del battag-lione_, non hanno che a . seguire i movimenti delle sezioni eh~ st~nno dinnanzi a loro nell'ordine d i batt1.gl ia. Quando però queste sezioni hanno d a fa r e fronte indietro, !è co mpagnie suddette avrannò l 'av-ve rtenza d i sgombrare _in fretta il t erreno a tal e movim ento po rtandos i al passo di carica al loro nuovo posto di bat taglia, àl comando d'avv erti.~ mento d el maggiore.
Ostacoli.
819 a11'824 . Rego la generale. Le compagni e .sp ie gate dietro le a li del b attaglione, quando l 'ostaco lo si presenta ùi11nanzi a l oro con un cel e,re mov i men to di _ fian co si portano verso il centro de l battaglione, dietro a sezioni -cui ·non tocchi di rompere per evitar e l'ostaco l o. Quindi rimes se di fronte ' a l passo di carica riprendono la loro distanza uorniale . In modo analogo esse si reg o • leranno p er 1'ié uperare il loro primitiv o posto app ena oltrepass;i,to l'ost aco l o, ' e r ifor mata la linea di battaglia del battaglione . ,
Se l'int i ero battaglione è chiamato di fianco, la la e 6a com pagn ia s i r ego l ano come . al N. 650, ed all' occor~ renza, quando il passo sia ristrettissimo, si port ano l'una - in te sta e l'aìtra in coda, ovvero anche secondo il ca~o, ambidue· in coda del battaglione fintantoché il battaglione non riprenda altro ordine di marcia.
826. Battaglione pe1· qitattro fianco destr' e pelottoni per fila a sinist1•' . Le compagnie piegate dietro le ali del bat•
taglione esegù iscono il comandat o mov~ento •co~ è é prescritto al N. 565... (scuola di cò~pagma), ' e marc.1ano di fianco l'una dietro _ -la se zione d1 d estra, 1 altra di etro la sezione di sinistra dei' b attaglione.FrG.
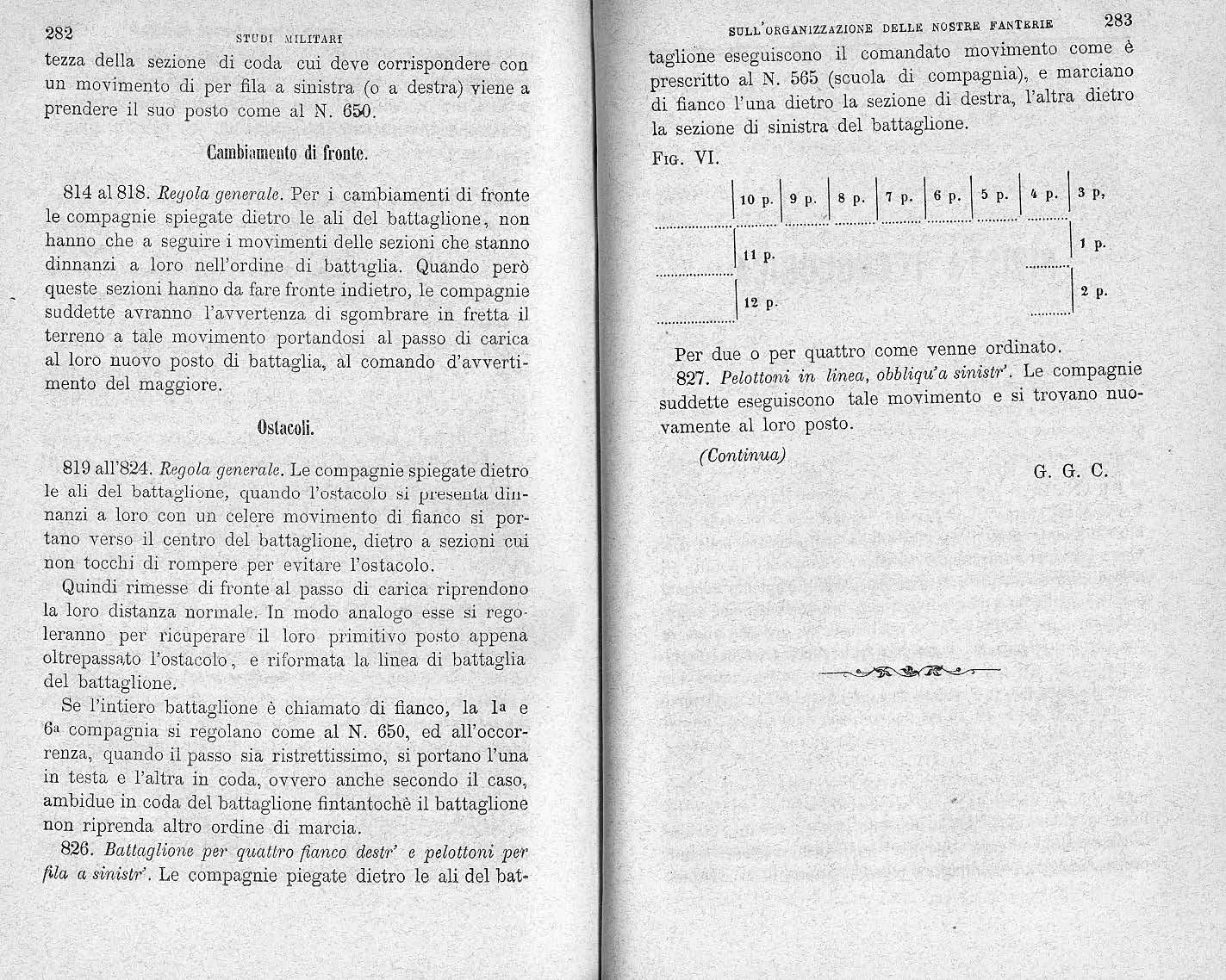
Per due '° per quattro come venne ordinato. .
827. Pelottoni in lvn~a , obbliqu'a sinistr' ._.Le compagfl~e s~ddette eseguiscono t al e movimento e s1 trovano nuo,vamente_al loro posto.
SULL,ORG..l:NlZZAZIONE DELLE NOSTR,E FANTERIE 28~
I10 p. \- 9 p. J8P·J .~...~·...\. .:...:.:...\-.~.. ~.·... ............... ......r·;·~···~ ·: ·········-········............J 1: P· 14 p. I3 p............ \ , p . .·········~·.·.·.·:J -2 p.
VI.
(Cont-irvua) G. G. C. - "' Il' ~·
IUVIST A TECNOLOGICA ..
FRA.NOIA. - Spe rienze su.lta polvere da fucile1·ia. Pe.rfezio nata l'arm a ed il- p roietto, trattasi or11, di -ricavare o cr ni alt~a rnigli6rìa poss i bil~ p eLtiro dalla composizio~e della p~lvere; numerose ·speneme fan n,,.osi in proposjto in tutti gl,i arsenali europei. ~A.ppo noi p are siasi definiti v amente adottata pe: la moschetteria una polvere che, per com posizione e · fabbr1caz1one, molto s'avv i c ina a qùella g ià da qualche anno in uso per l e ca1·abiu e dei bersagli eri; g l,i effetti o tten uti furono soddisfacenti , ed ora si stan'no facendo le prove di tiro alle vari e dista-nze per precisa r e i l peso della cai·ica, il quale deve es sere fra 4gr,60 e 4gr, 70 pel n uovo fucil e rigato de1la fanteria.
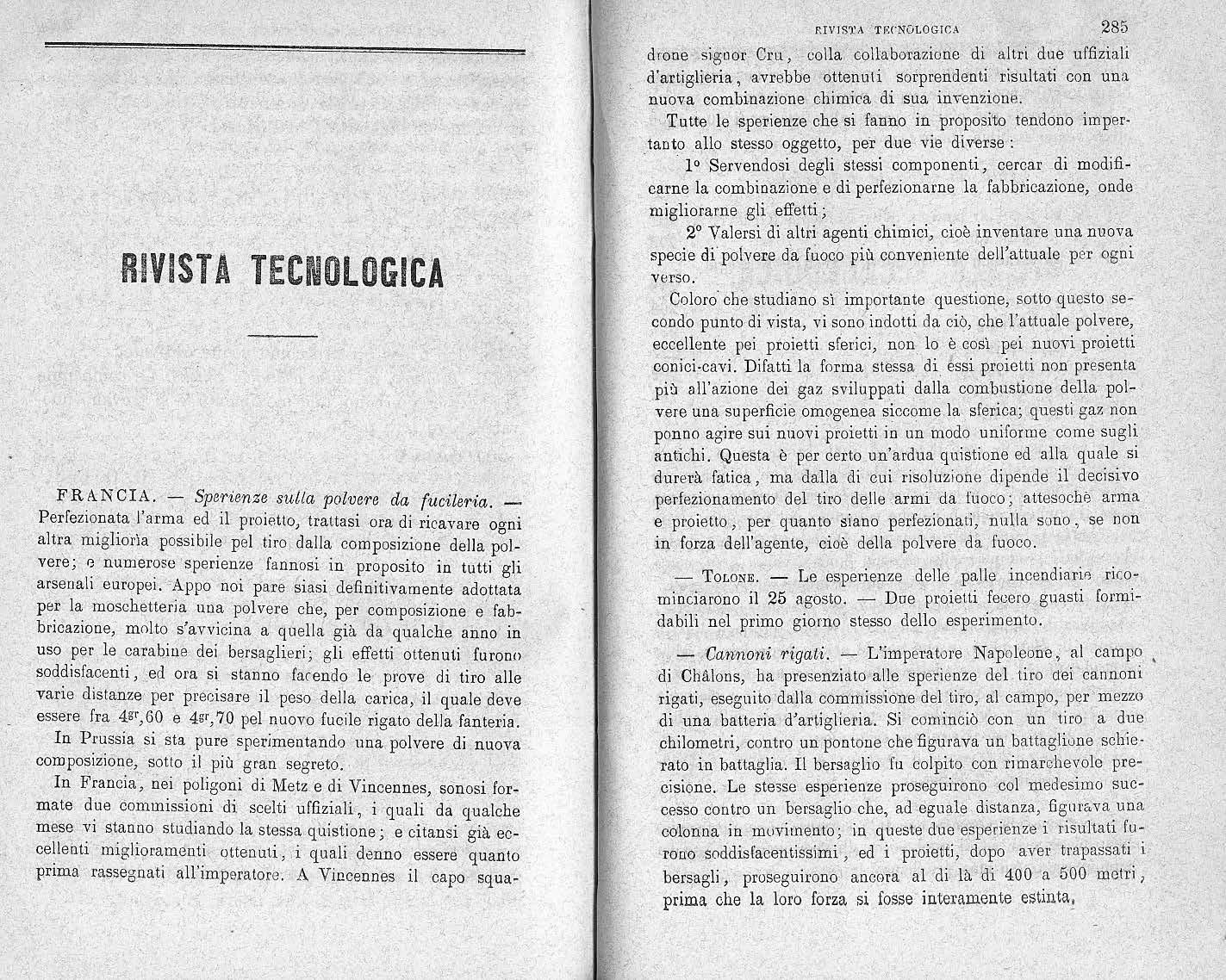
In Prussié\- si sta pure sperimentando una po l vere di nuova . compos izi one, sotto i l p iù gran se"'reto. ,. o
In Francia, nei pol igoni di Me,tz e di Vincennes, son osi for, mate due commissioni di scelt i uffiziali, i quali da CJ:Ualche m ese vi stanno s tudi ando la stessa qh istione; e ci tansi oi à ecce!lenti m i g lioramenti . qttènut i, i qua li d<3nno esserè ~uanto ~ rima rassegna-ti a ll' imperat ore A Vinceones il 'capo sq,ua~
d rone signo r 8r_u, colla co lta·boraz i one di altri du e u ffiziali d'a;rtiglieria, ,avr eb be ottenut i sorp rendenti risu ltat i con una nuova combi.nazione chimica di s_µa i,n,te nzione. ·
· Tutte le ;gp erienze che si fanno in 'proposito tendono i mper• tanto allo ste;;so oggetto, per due vi e divBrse:
· 1° Servend osi degli s tessi componenti, ce_rcar di modi ficarne la combio~zione e di per fezionarne l a fabbricaziont=1, onde miglio farne gli , effetti; ,
2° Valersi di altri agenti chimici, cioè inventare una nuova specie di . polvere dk. fuoco p{ù co nve n iente dell'attuale per ogn i v erso .
.,, Coloro· che studiano s ì im portante quest ione; sotto qu es to se-· co nd o punto di :vista, vi s o no' i ndotti da ci?, ch e l'attuale polve re, eccellente pe i proietti s fe r ici , nor{_lo è co sì pei nuovi pr0ietti ,con ici-c avi . Difatti l a forma stessa _ di _ éssi p roietti non presenta pi:'! all'az ion e de i gaz svi l uppati dalla comb us t ione dErl la po l -
··ver e un a superficie Òmogenea s'i ccome la sferica; questi gaz non ponno agire sui nuovi 'pro i ett i in Il~ modo uniforme come sugli antichi . Ques ta è pe r certo un'ardua guisti on e ed al la qua le si dure rà fa t ica, ma dalla di cui riso lu zio n e di pende il decisivo perfeziònameoto del tiro delle arini da fuoco; a t tesochè arma . e proietto ; pet quanto si ano perfezion1J,ti, ·-=nul_la s o no, se non i n,· forza dell'agente, ·c i oè de ll a polvere da fuoco .
· - TOLONE. - Le esperienze delle palle incendiar i e ricominciarono il 25 agosto. - D oe prqietti__fecero guasti formidab ili nel primo giorno stesso dello esperi mento.
·.,, - Cann oni 1·i ga li , L'imperato re Napoleone, al campo , d,i C ha \ons, ba presenz i ato alle spe rienze del tiro ct'ei _cannon i rigati , eseguito ' dalla comrnission:e del ti1·0, al campo, per ' ui e zzo di una batteria d' artiglieria . Si cominciò con u n tiro a d110 chilomet ri , contro un pont o n e cbe figurava u n battagli0ne schier a t o i-n batta al ia . Ìl be rsa&lio fu col-Àito con rimar ~hevol e pre, o o r 7 cii,ione. - Le ste 3se esperienze prosegu-irono col medesimo successo cbntr_o un be rsag lio che, a d ègual\l distanza, figu r« v a una cdlonoa in muvirnento; io queste due espe rienze i risu ltati furom:> soddisfacentissimi , ed i proiett i, dopo aver tr a passat i i . bersagli, proseguirono ancc-na · al di là di 4'00 a 500 met1:i 1 prima che la l oro forza si fosse interamente esti nta ,
.
;
IÙV IS'r,1 T IU"N0 LOG ICA 285
BELGIO. La commissione belga, iaca; icata di ·r i ferire slllla sce lta dell'arma migliore da adottr..rsi per l'eserèito, pubblicò il suo rapporto sull e esperi e nze .di T e rv uerèn. .
La superiorità per le arm i sparate alla distanza di 50 a 1000 metri venne stabilita come seg ue:
Palle che colpirono' il bersaglio. ,J
1° N. 23 fucili di fanteria delJa : Norvegia (Gri.irier) N. 281

2° , 5 fuci li Montigny
3° · • 24 carabine dei cac ciatori a piedi di Norvegia (Gri.iner)
4° • 27 Doflein :
5° >> 11 Lendern .
6° • 22 L a r dinois
7° 1 L. Ghaye 8°
La com~ issione pbse i l quesito quali sarebbero le basp di apprez~amento che essa adotterebbe per decid'e re del rango che a ssegnerebbe ad ogni arm a; se, , cioè, ca lcoler ebbe in prima linea i l numero delle pal le che colpirono nel bet.;agl io ,( o se dare bbe la pri or ità alla traiettoria . Dopo discussione / d°fu cisè c~e essa si_ p '.or1unzierebbe secondo l'una e _ l'al tra . basr , é:ombman-ìo le 10~1eme; che a quest'effetto misurerebbe geome tri. I . . I fi \ çamente o spazio per1co oso, ssato per ciascuna tn i ettoria , all ' altezza de l rango della · fante ria ( l m,80 ), prima e dopo il termine di 4ÒO met~i, e che ques to spazio pe r icoloso sare~be .molt iplicato pel nu mero dell e palle che i toccarooo la., mira ,a t utte le distan ze. Il prodotto , indicante in med ia , rer .ciascuna arma , il nn1n,.8ro dei . metri di spazio p e rcorso dall e palle, ~vre b be offerto ()OSÌ il risultato segueqte :· ,
1 Mon tign y; 2 Ghaye; 3 D oflein; • 4 L ardinois; 5 D elézaack; 6 Lenders; 7 Fitz- Kar.' 1 •
.:_· Scrivono da Ostenda che il 5 corrente ebb ero princip io, s ulla sp iaggia all'est di quel porto, g li sperimenti del tiro dei cannon i rigati (si$tema• prussiano).
-Tre pezzi da 12 trovarrsi in lin ea, ma benc~è s i cari chi no tutti e tre daHa culatta, differiscono pel metodo d.1 me ccan ismo .
L'esperienza ha preci sarntJn te luo g~ -per ~~nstatar~ _q uale di q u esti tre s is tem i sia preferibile. Gl i ese.r c1z1 ~ 'l~ O d1ret1l da~colonnello d'àrtiglieria Donny, e da altn uff1z1ah della· stessa ar~a. Pare che questi espe r im ent i •d'urera n oo da un mese a sei settimane e s·i eseo-uira nno durante le · basse maree. Pen, o ' dente l'alta marea vertanno r itirati i pezzi, l e mumziom, ecc . ' , e posti nei magazzi ni vicini al porto .
- Notatoio . ·- Sullo scorcio d'ago~ to ultimo, alla sctio~a d i n uoto milit;re del pont<" di J e na, venne spe~im c:ntato dinanzi una com.missione milita re , delegàta espressame nte, dal minist e ro dell~ g u erra, un appareceh io notatoio, in ven tato dal siaoor Lejuste, archite tto di Doua i. · 0 Quest'apparecchio• consiste in una foggia di con o tron ç0 , di m,itallo, il quale ci gne peFfettameo te l'in d i vi duo che se ~e riveste a metà il cor po. Questo con o è divis0 in tante picco le scatole ttarnezzate ed i mpermeabili per ta l mo do, che, . se l'un·.) d i . essi compartimenti ven i sse a r om persi ed a lasciar penetrare l'acqua, gli altri basterebbero sempr e a so.;; L~ue'.·e il· no· ta't ore. Pochi minuti secondi bastano per · v estirs i d1 . co test o apparecchio, il quale coi suo i gamba'li .e coll~ sue suole, contr appes i, non pesa più di 3 o ·4 ch i logr amm1, . . Le prove riescirouo -b enissimo, .éd.anz1 superarono, a quanto crede::li, l'aspettazion e dell a comm1ss1ooe . Esse fu rono - fatt e da .un maestro da n u oto e da un sòt t'u ffiziale della s cuola de l nuoto :
L a Serina ven n e altra vers ata e ~i tra ve rsata in poc hi m in q ti . I - n ota tori , av ~ano ·il fu ci l e .ad armacollo, e conser vavano la posizione ; verticale e tutto il bus to ciel CO:'P() !uori l' a~q ~a, si~~ chè parea camminassero nel fiume . G1nnt1 - a me ta il cor3o - 'd'acqua, 'accesero u no zi ga ro, poi fece ro l'atto - come_ d' i n:1he rciare i l mosch etto ; te ntarono -c1ui ndi ripe t utamen t e d1 supmare e di pors i bocconi' sul l'a cqu a, _ ma l'appa recchio 1~ ra.d~rizz,ava instantaneamente; nè loro fu possib ilè di ·rovesc1ars1 m qu a~ lu • que gùisa . . Cotesto notatoio , in tali termini, po tre t)be beni ssimo_ appli •
286 RIV ISTA
• .
278
·
. r , .. » 268 ' • 266 • . 235 227 , 1 92 ,189 1 8 7
• 26 Del ~zaack 9° 25 Fitz-R'ar
TE~NOLOGICA- 287
RIVIST,~ car~i ad_ uso _m i litare per attraver~are i profondi corsi d_'acq1,1a, e più d1 t~t_tr ,potrebbero trarne profitto i pontieri. '
Le mum z1001 da guerra si porterebbero in cartucciere sull'alto del petto, 0 ed i .soJdati potrebbero così, all'occorrenza, .far fu0co nuoti.l,udo. .. · , n Il ~ons!ìtutio~nel, dal quale' ab,bi~m tolto questi ragguagli, on , c1 p_arla del modo col quale 11 · notatore · può dirigere il suo moviniento, ··e certamentE: q uest'è anch!=) interessantissima co.sa da saper.si, . · ,
ING~ILTERRA : - Togl'iamo dal · A1orning Post: · , ' Gli esperimenti che vennero recent emente fatti coi can·~on i Armstr'OI!g èontro. persagl i di fer ro provarono che il piano mcl mato, presentato 4éll be rsaglio alla linea dei proietti, d'eve esse.:e consid erevole pe:r rendere . !',urto comparativam~le i no ffensivo. Nelle nuove fregate, i - ~anchi sono costrntti in modo da presentare ' un'inclinazione d i1 - Questa inclinazione so la ' 8,5 darà una grande s~perìe>rità a.i nuovi bastimenti.. · , • -Per verità è lecito dul:5itare c he una palla scagliata' di fanc_10 d 1 un c&nnone A r mstrong contro i fianchi <li qu~ste navi possa essere in offeà siva ; ma non tarderemn àd ess ,fe megli~ is t rutt! in proposiw f
. • 81 costrn1sce a l presente, nelle fonde n e del Tam i~ ' . un _ bersagl io c-he ras so '.ui gEa p~rfehamente ad una porz io µ~ ,fa) bordo1 del ;ascello 1~ Wa.rrior. Questo bersag lio verrà $peé:ito a Sbocburyness, per sottoporlo ad una serie di esperienze ·col cannon e Armstrong, di modo che noi conosceremo il rnaxim'!l'm di resistenza che i· nuovi legn-i possano sostenere ·~ontro cannon i rigati i p i ù perfetti. Le dec i s ioni che , adotte rà l'ammira.~ liato, sotto questo rapporto, dipender.'l.nno l unii::amènte dal rfsultato di tali esperimenti; · ma, checchè ne sia, il paesè può essere certo che in br eve ·i'Inghilte1ra po$st:Jderà una flo tta che le gq,arent irà la supremazia e l'indi pen denz a, d'i cui pu'ò essa andar essa supe rba da lungo tempo, , .
- .A Chatam, nell ' arsenale della marina 'britannica havvi una _ 1:1acc h i~a ·per fabbr.icar rem i, e nè fa 80 o 1.00, .al ~iorn~ . Tal~ ln\' enzwne è dovuta ad un semplice operaio per nome SteeL
ITALIA. - I fratelli Lancia, negozianti in Torino, inviarono :all'esposizione di Firenze carni affumicate e scatole di conservè d'ogni specie di vivande, tali da pote_r fornire_ lau• tissi~o pranzo. Alcune d i queste sc·ato le e · le carni affumicate, preparate nei l oro magazzini da più di un anno, furono aperte e servite come fresche; epperò oggi mai, graz ie all'intelligente operosità dei fratelli Lanc ia, qu'esto ramo d'industria nazion~le può oggidì stare à fronte di consimile in ' Francia ~d Iogh1\térra, ed il nostro esercito, siccome l'armata, potranno trarne vantaggio, sia• per l~ lontane spedizioni, sia peì magazzini d i riserva. ,
'C'no di detti fratelli, d istinto meccanico, produsse alla stessa esposizione un cànnoneino da 4, un fuci:le ed una ça rabi na r igati ed una lancia- moschetto per cavalleria.
Il cannoncino di bronzo è rigato e s i carica per la· culatta n:iediant~ il • più semplice e facile congegno, L ' otturatore posto dietrÒ la cu latta nel senso stesso dell'anima del cannone finisce con tre risal ti , i quali, mediante u~ g i ro della mano , im 1 pegnano o sciolgono l'otturatore, secondo il b isògno, La pa rte dell'otturatore, ch'è a contatto colla carica, è vestita di un pezzo di gomma elastica, e clò allo scopo di diminuire gli effet ti élel rinc ullo. - Questo model lo di , cannone merita speci~le r ;guardo per la particolarità.. del suo otturatore; pel rimanente non presenta ni e i;ìt e di nuovo, o che possa veramente utifrzzarsi pei cannon i da guerra. '
Il fuci le r igato, siecome la carabi na, si caricano am bidue per- la 'culatta, pe,r · mezzo di due di versi congegni , uno ,d:i. quali perb esclude affatto il difetto inerente a cotesta specrn d'armi, d'ind·e~olire, cioè, 1~ culatta, e di r E) nderle così p ericolose pel' tiratore. Dobbi~mo poi ·aire francamenté che i con. gegni per determinar e lo -scatto sono i i1 ambidue troppo comp1icat.i e delicati; epperciò non applicabili alle armi da guerra, i cui 1prègi essenzia,li . sono la semplicità e la solidità.. Neppur sono ammessioili le cartuccie metalliche che vanno annesse a questi due model li.
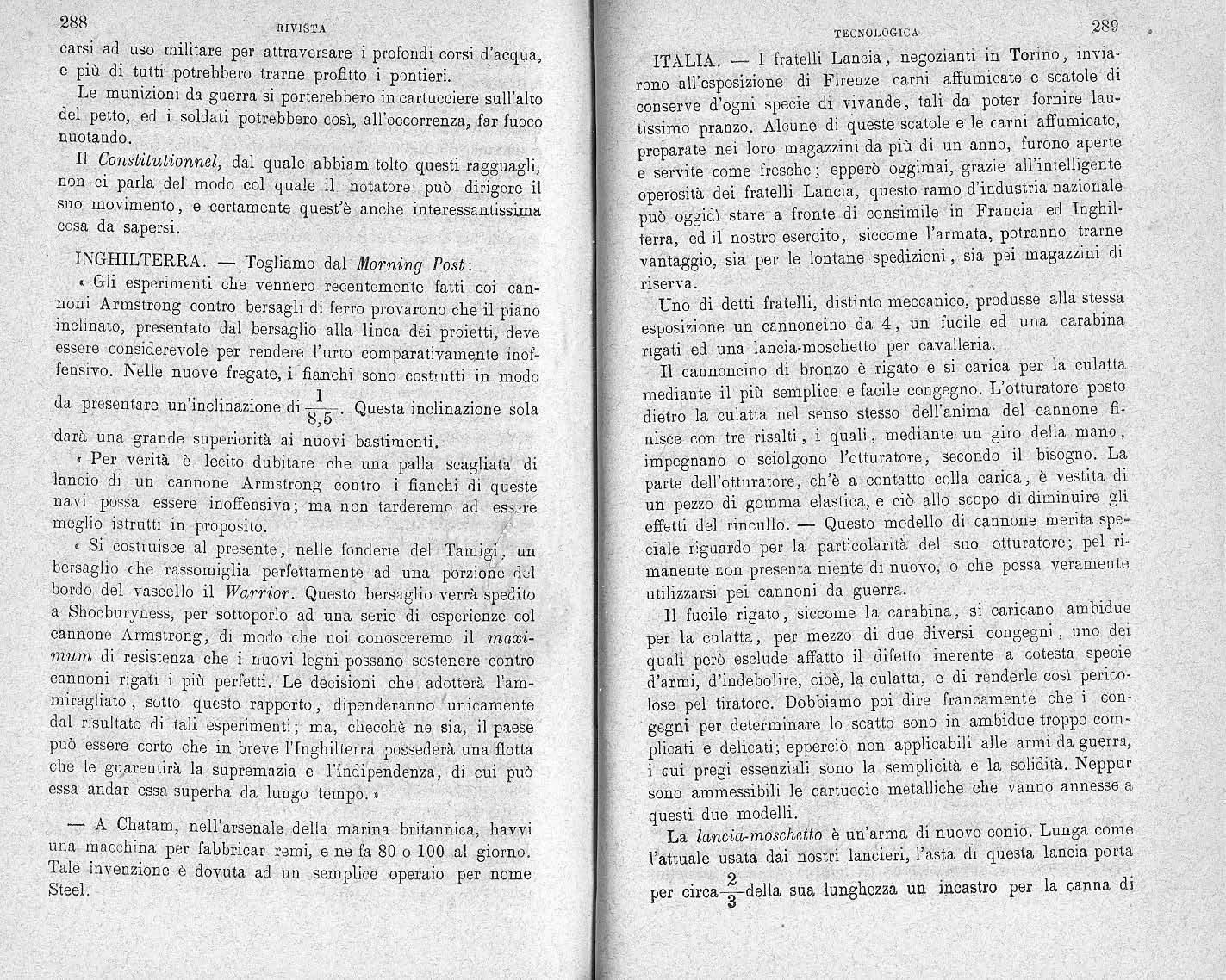
La lancù:i:moschetto è un 'arma di nuov'o conio. Lunga come l'attuale usata dai nostri lanéieri , l'asta di q11esta lancia pol'ta
- d. per circa3 ~ella su& lunghezza un h1ca$tro per la çanna 1
288
T&CNOLOGIC.\• 289
'
2
una car?-bina di picco lo calibro, la quale è congegnata i n modo da sparare 20 colpi continuati. Al calcio della lancia un becco ricurvo, di !egno, serve per aggiU:s;tar l'a rma alla spalla n ello spallare . Se ·que1;,ta, s iccome le armi precedenti svela l'ingegno inventivo d el sig. Lancia, ha tu ttavia , al pàri de!Je a l ~re, tali in co nven ie nti al punto .di ,~is ta mi li tare da n on p0tersi uti l izzare senza ra dicali modificazioni . ·
Prit~a di tutto, tasse della canna · trovandosi par!lllelo e rav,•1cmat 1ss1mo a quello della lancia, incomoda considerevolmente il ~nntamento ed il tiro, ed inoltre la vampa della polvere deteriora ad ogm colpo la parte superiore de ll' asta. V'ha di più che la parte inferìore dell'asta, no.n essendo ci l{ndrica ma~~- s' (mpug~a, nè si può dest ramente ·-~anegg iare- ·per I~ sqm,1brro della.sta stessa. - Le cartuccie per la lan.cia- moschetto •son9 cartuccie-capflellozzj, sul sistema Lefaucheux, lr, quali, disposte in fì.la in un'appendice alla canna, sono spi nte nel la camera della cu l atta da una molla a spirale , l'una fa. cencio po.-;to a ll'alt ra di mano in mano che vengono sparate. Ad ogn i modo, malgrado le cri t iche numerose che il' sig~or Lancia potrà incontrare pe r parte dei m ilitari, egli è meritevole d'ogni e!ogio, se uon per altro, per essers i applir.ato a .tale soggetto, e d'alt.ronde n oi pensiamo che con ulti riori s t n 8i ; 1 ' ~d av~a lo_ra ndosi dei consigli pi pra:ici artiglie ri, a l? rne r el le mvrnz1om s~e potranno t rovar la via .a qualche ntile f-pplicaz10ne., \
- Cannone con affusto cli fe'rro. - Il sig:!lor C , distinto cesellatoré gènovese, esegui nn modeI!o di canuone ri - · gato , in brori~o, montato su cti un affusto a ruo te di ferro, come Yedesi alla lettera A della Tavola qui unita. Il cannone è solcato da: 6 righe B diritte, a risalti morg.e~t.i ed è destinato a cai:ica rsi per la boc ca. - Le coscie del cai;inone sono piane e diritte . - Le ruote banno per d ii.m etro· la · lunghezza del cannone, ed hanno sedici fusi di forro pieni · ,i nca;trati in un cerchione formato da tre lamine di" ferro. ' . . 1
. Questo cannone sare bbé destinato - dall'inventore a scaglia.re una gr:anata "cilindro-ogi,;ale molto allungata; le figure ·c, D, E, F mostrano . la forma ester.J.'.)a ed in terna d i esso ·proietto.
Questà granata è 1mmita ester namente, _sulla su~ parte cìli~ -

. a· · a· 6 denti di ferro destin ati ad incastrarsi nell e COrrl· rtca, 1 , • sporfdeuti ri ghe del cànnone: alla sua parte ~nter1~re e a~ert? un foro vitato, dest inato a ricevere una spoletta. di bronzo E v i tata p er Ja metà sua , traforata per !'esca fulm1 nante, come Yedesi alla figura F, e munita sup eriormente. d1 un cappe lletto . metallico esag ona le .
La forma oblunga del proietto; ma11tenendolo ~el suo tragitto colla punta in avanti ; fa _ sì c?e , cozzan~o 11 cap pell etto del la spoletta 'contro il bersaglio, v i en deternunato lo_. scoppio d li ' ca fulminante e comunicato il fno co alla cari ca della e es ' , . b 1· D · ta · ch'è contenuta nella cavit à. a forma di ottig ia • gr ana, , . . · ·1
· Il signor C... .'... non è inv entore , ma copiatore_, epperò 1 pregio principale. di questo sùo lavoro è ~utto ~rt1st1co'. e come -avrebbe potuto figu rare distintamente ali espos1Z1one d1 Firenze
. cui è destinato ., · . . _ . .
Ad ogni modo, la Rivista militare it~liana gli grata ?el di.segno genti lm ente inviatole, e cbe qm rende· di pubblica ragione .
290 RIVISTA
TfiCNOLQG-!CA 291
RIVJSTA STAT[STICA
Il nu mero degli arruolamenti volontari in segu it o a fiue di ferma, contratti nel 1860, nelle stesse condizioni, c ompresi 53 uomiui arr:uolati per l'armata, fu di 2192. -.- Totale dei ringaggi e degli arruolamen ti 31693.
Nel 1859 i ringaggi ascesero a 16372, e gli arruo lam enti volontari, dop0 fin e di ferma, a 2244. Nel 1860 , . pei pr imi havvi la differenza in più di 13129; ed in meno, pei second i, d i 5'2, cioè sul totale dei ringaggi ed arr uolamenti un aumento di 13077.
I ri.ngaggi dei sott'uffìziali, che n el 1859 erano del 22 °1 0 , discesero n el 1860 al 19 •10 , mentrechè que lli dei soldati , da l ,65 ~io ch e erano n el 1859, ascese ro nel 1860 al 69 °1 0 : que , to risult1to constata che i vantaggi ddla legge del 26 aprile 1855 sono in ciascuna annr; ta vieppiù apprezzati dall'infima bassaforza .
L e surrogazioni in v ia a.mministratirn hanno continuato ad essere aperte nel 1860 come nel 1859, a te rmin i dell'art. 15 della legge del 26 ap ril e 1855. Al 31 di c-embre erano ascesi a 9639.
Qu8ste 9639 surrogazi oni amministrative, con t r atte quasi tutte per 7 ann i, compensano 9531 esooe razi oui di 7 anni.
~RAN?IA. - La comm1ss1one superio re della dotazioile de l! ese rcito ba recen tem ente p resentato all'i·m · ·1 perato re 1 st; o rapporto annuale ~ull a situazione generale di q uest'istituzi,me sulle sue_ op:ra~1~m ~urante i l 1860 . Questo rappo r to, co me l precedenti, Sl d1v1de IIl due parti distinte : , . La pri ma abbraccia i faui essenziali concernenti l'esecuzi_one della legge del 26 aprile 1855, sotto il triplice punto di vista della po pol azione, dell 'eser cit o e d ella dotazi one stessa· L a d · 1 ' ' . se~on a _ prese_nta, m una serie di quadri, dati statistic i m1,nut1 ss1m1 s ui r1n g agg i, su ll e esonerazi on i sulle esazioni e sulle spese fatte e da farsi. '
Il \n um~ro de i ringaggi r ic evuti nel 1860, nell e con d izioni delleileggi del 26 aprile 1855 e del 24 luo-lio 1860 è salito '38 ° ' ' com presi 4 uom ini dell ' arma ta a 2950 1 Q i· · · f . . , . ues 1 no gagg1 urono _contratti In numero di 5640 da sott'uffiziali 3403 da capo rali o bri~adieri, e 20,458 da sold ati. '
I ri ngaggi , gli arruolamenti volontar i, in seguito a fine di ferma, e le surrogazioni amministrative ricevu ti nel 1860, e des ti nati a compensare le esonerazioni dell a classe del 1859, furono di 41332. Aggiunt i ai 99255, contratti n el 1855, 1856, 1857, 1858 e 1859, dànno no totale di 140587, rappresentante 124254 esonerazioni di 7 anni . Ma le esone razioni pr onunciate nel 1860 dai consigli di revisione, sono siate di 23275, le quali, collo 94481 degli anni 1856, J8 5 7, 1858 e 1859, fo rmano un totale di 117'756, alle quali aggiungendo le 16074 , pronunciate dal 1835 al 1860 d ai cons i gli d'amministrazion e dei corpi, fo rma no il totale di 133830; di modo che al 31 dicembre 1860 esist eva un àeficit di 9576 esoner azioni da compensarsi .
La legge del 24 luglio 1861 ed il decreto del 6 ottobre susse~ guente, accordando maggiori facili tà ai riogaggi ed agli arruolamenti volontari , dopo fine di ferma, ebbero per scopo di permette re ad un grandissimo nnmero di ro il\tari di contrane
ANi< ? VI. Voi.

Rl\'f~T.\ STA Tl5TICA 293
I. - 20 .
,impegni di simil natura.'Per la qual cosa al 1° giugno 1.861 i l de.fiòt di 9~'.7 6 n on solamente era coperto , ma avevas i di piìi un eece.dente di 8480, appli r'aibile a l le prossime esanerazioni della classe del 1860.
Il progressivo aumento numerico delle esonerazioni , nei iru .eotre at1Psta c<Dme Je popolazi cDll i , ad esempi@ dei so l dati abbi ano compres! tut~i i vantagg i della legge del 1855, prov~ ancora l~ necessità d1 f~r annualmente seguire al i:,rezzo della esonnaziooe la progressi~ne de lla ricchezza pubblica, la qua le pone m gr~do tante famiglie ,di esonerare i loro figl i. Per 1q_uest:o motivo., e su ugua le proposta de l la commissione superior-e, un decreto del signor ministro della guP-rri~, in data del !0 ~ ~ggio 1860, ~a. fissato a 2300 fr . il tas:;o della imposta rndnr1duale che gh J,nscri t t.i ne l contingente della classe del 1859 avrebber o a pagare, per ottenere l' esenzione dal sel'V izi o militare.

Un p.ro p? rzinnale aumrnto pa1ve dovess' essere, io pari , teinpo, aggrnnto al prezao d'esonerazi,me dei militari sotto l e armi. E su egua le a v,•iso della comm issione 'sup eriort.'l, per decreto dt~I ministro della guerra in da ltt I o maagio 1860 fi o , ven n e s.sato a 500 fr. pe.r cad11n anno o frazione d'anno di sery1z10 res t~nt.e a com pi re la forma . l
Mal grado 1 2 300 frnnchi di tasso dell'impo;;ta individua l:e 23275 giovan i deUa clai,se del 1859 approfittarono nel 1860 del. ~enefici o della legge e si fece ro e:,onerare da.i consigli rii revJ,s1~i;i.e, Senza t ene~ cont0 de l 1859, in cu i, in ragione della mod1c1ta de l !:)rezzo di 200 0 fr. in tempo di 11:nel'ra esse si eleva~on~ al 1:0 d, 38325 ('.?-7, 37 °1 0 de1 conti~gente), le esoneraz1om contmuarono costantemente ad aumentare .
NeJ 1856 e 1857 la proporzione per ce:.ito, tra il numero degl i es,o,nei:ati e qu ello del contingeute, è stato •ileÌ 16 0[ 0 ; nel 1855 de l 18 °10 e nel 1860 del 32, 76 °1 0
U numero dl;li giovani tolti cos) al reclntamento dell'esercito tend e ~d ac?re_sc ere in ciasc nn anno, e l'eguilibrio t ra le eso~e~aziom ed 1 rrngaggi, ' r otto 11.e l 1859, n on era aneor ris tabilito a.I 3 l dicembre 1860, anche coli 'aiuto delle surrogazioni amministrati ve, ed es,<;o non fu ristabili to che nei primi tQ.esi de l 1861.
Un quadro, unito al rapporto della commissione, dimostra, per rlipartimento , la proporzio'l e d el numero clelle eson e razioni compara ta al n1i1,mero del contingen,te, ed in pari, tempo i versam enti eITettua ti per conto dei chiamati della elasse. Un altro quadro presenta la classificazione dei dipa~timenti, g iusta il rapporto num erico tra il numero del loro contingente e, que llo dell e pron une i ate esoneraziooi , e segL1 endo' l' 01•dine quale si pr<~s ta bilisce tra i dipa rtimenti la p r,1porzi0ne delle esooerazioni r e iativamente a'l'effe tti,·o numerico del contingente .
Questi quadri ufficia1i constatan(l che la proporzio ne per cento tra il numero rlelle esenz ion i a:m111 ess e in ci asc un- d'iparti mento e quello d ti l conti n gente dipartim entale, è a.I maroim1,m di 45 °1 0 (Eme), al m inimi.m del 2 °10 (Corsica), ed i~ i:nedia per tutfi i d i pa.rtim enti del 22, 76 °1 0 ; è il 6, 76 °[0 d1• più J·el, 1856 e 1857, i\ 4, 76 °r 0 di più del 1858, ed i l, 4 , 61, 0 [ 6 d,i: meno del 1859.
Le esonerazioni pronunciate dai consigli d'amministrazione dei cor pi s i el ev arono, in tutto il 1860, ivi comprese 297 esonérazi0ni pe1· l'arma.ta,, a 6085, e, .d edo t te 1 7 anruu llazion i, restarono 6068, liapprese ntanti 2720 esonerazioni di 7 anm; queste, noi 1859, erano state di 3893; differenza. in meno 1173 , · Questa specie d ' esoner.azion,i, essendo sempli cem ente faco'ltativa, l'imerP.sse dell'orga nizzazion e 9 della disc iplina dell'esercito obbliga ch' esse siano l'in~hiu se in stretti limiti. Pertanto i l numero d ell e domand e accettate r!ai corpi, nel primo tr.imestre del 186'0,, ha so rpassa-I.o l e eque pro porzio n i e p er ristabilirle, una circola re del ministro' della gùerra, in data 19 magO'ÌO 1860, ha prescritto, conformemente al voto espresso o dal la rnmmis~ione sup eriore, ch e dal 1° grngno nei c0rp1 non potreblòes i più 1far c0rso a:He d om.6nde à'e~ooeraz,ion~ i n:~oltmte dai militari' sotto l e armi, senza speci a le autor1zzaz1 oue del ministero . I benefici effetti di questa misura sono stati immediati : da, 4407' che esse erano srate nel 1° semestre 1850, n e i. tre ultim i t ri,mestri del L'anno le es0nerazion•i disces ero; a... 1678.
I particolari che prece dono, attest ano la fortunata i~fl~enz_a esercitata sulla. composizio ne dell'esercito per i success1Vl m1-
294 RIVISTA
STATISTICA 295
g li oramenti di cni S . !VL ba provocato el!a StP,ssa ed a·pprov~ta l'introdu i ,ione nella legge del 26 ;3-pri le 1855 .
La situa~ione finanziaria della dotaziorlf3 continua àd offrire Ot:li sìcurtà pos sibile. ,
·- Te rminando l'espos i zione delle sue operazioni nel · 1860, la commissi0ne s up r:-,riore i;i compiace d i eonstatare che · i prògressi · deU'utile c r eaz ione del 1855 s on o dovuti aH'auo-us t a sollecitndine che 'si preoccupa incessanternente p e r m i"liorare le , con diz i oni pres1~ nti e fu t ure delle popol az i0 ni .de ll' i rr~pero -'frances~, ed in ~ particolar e quelle d è.lla famig,l ia _ miÌitare . '

Le modi ficazioni che questa instit uzi,rne n,az ic,naie può at.cora desidernre , sa1'a~no l'opera del tempo e dell' e sperienza, e pe: ~utte quelle di cui sar à riconosciuta l'op purtu i;li-tà, la comm1ss10oe s u periore sarà sempre _pro n ta a .secon ila re l'imperatore nel compim ento delle sue viste generose. ·
- Mè r ifa credito la voce spars a c he il g oYerno francese intend'Eìr ebbe fondere ì: suoi reggime nt i di fante1·ia di mar,ina nell'esercito terres t re , sicchè ' la Francia verrebbe ad ave'r'é .125 reggime nti d{ fon t e,;i a di l in ea, i quali tuttì concorrerebbero per -turno al sérvizi o mar i ttimo. Sarebbe questa un' ecce llen t e cosa, poi chè t enderebb e ~ll'avv e zz a r e così tu tt{ i soldati alle l arghe t~aversate . L'imbarco , lo sbarco, l'installaiip1t e a b~ r,d o dei bas ti men t i, i l loro serviz io , speciale, la loro disciplina e d il _ combatti men to mari tt imo presentano :;erie diffico l tà a chi 110 è affatto novi zio. Ed oggidì che eserciti ed armate si trovano' quasi s em pre a coope rare nelle g r an di c ombinazi 0ni strateoiche , o è indisp ensabi le ch e tutte le t ru ppe siano iJ,V\'0ZZate a spperar facilmente t a li diffi.colà.
- D 'altronde poi il servizio cu i sono attualrri'e nte desfinati i reggimen ti di fa n teria di m ari na ' fra ncese è pure serv i,:,io di fanteria terrest r e, impe r occhè desti n ati esc lu s ivam e nté a l servizio mi litare ·del le co!o n'i e, non stanno a bordo che ' di -pas~ saggio p er cambio di :resi denza; quale uffizi o può ' .-benissimo affidarsi a qualunque siasi reggimento' di fanteria · terrestre.
Il c orpo d ' arti gl i eria di mar in a comprende 3 uffìziali genera li, uno stato maggiore particolare e l e troppe.
I t~e generali sono i s i g no ri di Preo~l-ly, gent ralf\ di div is io ne, ispettore gen erale; Pelis sier, genera le di br iga t a , aggnrnto al l'i,:pezio mi, e Frebault, a lt ro generale di brigata, a t -tua lm e nte comand ante la Goadaluppa e le sue atti ne nze .
L o stato maggio r e pa r tic olare annove r a 6 c olon111?l li , 7 luogolenenti col0nu e lli, 7 rapi di squadro,ne, 17 capilani di 1a class e e 7 cli za., 25 guardie ( sezione con t ab ili), 25 guard i e ( sezione controlìo d'ar illi), 12 m a estri e capi artificieri e 4Q op er ai.
Le. truppe formano .un reggirnenlo a pied i, sei cor pi d'ope rn i, u.na sez ione di art i fic ier i, e un corpo d'arniaiuo! i.
Il reg gi m e n to compreude uno stato m nggiore, un pel ottone fuo ri ran go, 28 batterie a p:1,d 1, u ua compagn ia di cann on i e ri coodutt<:ri .
Hayvi perciò un aumento d i 3 b atterie a piedi della comragnia condutto ri e de ll a sezione art i ficieri.
I _:_ Corre anche voc,e che gli attuali battaglivni di cacciatori a pie di , _:enan no fusi nella 'far,teria: d i lin.ea.
- Dicesi pur e che ad ogni co rpandaot.e d i d ipartim e n to verrà. dato no comand<1nte in 2°, onde ògn i m.aresciallò abbi a cam~o . di seg uir e le sedu t e del ~enato, o qn ~g li a l t~i la,:ori che esigono l a ... sua presen,za fuori della s ede del ri"spettrvo conian d o . ·
- Sullo ' sco.rcio del passato agosto S . E. il maresci_allo Randon, ministro della guerra, dirige va a ll 'i mperatore un rap · port o in torno a ll a za ispez io ne passata a i cavalli e mu l i da _ t iro, i q,ual i, d o po la ~nerra d' Ita l ia,' trov'andosi in eccedenza rlell'effettivo ,nei co rpi de l l'ar tiglie r ia , del ge nio e çle l treno, furono àffi dati io deposito p resso. g l i agricolto i·i, col l'i ncarico a costoro ,di nudl'irli, di int r attenerli e ni i mp :egarl i esclusi• vamente_ a la vo ri agri co l i . .
,, - L 'g,,rt iglier'ia di mm·ina venné Tiordinata cpn un imper i ale decreto di questo mese . _-
Le commission-i d'ìs~ezione furono compo ste di uffìz i ali d i artig li e ria, d i uffizial1 acldett i a l s ervi zio delle rimonte e d i
veteripa1i .,
, ANNO VI. •Voi. L - 21.
296 RI Vl:lTA
•'
S;I'AT1ST (CA 297
L'ispezione venne pitssa1a a 1938 1 ani•mali ( 802 g c_avaUi, 10089 cavalle e 1272 muli):
12322 fu rono ritrovati in buono stat0, _
4384 in a ssai buono stato,
1758 in passa?ile e mediocre stato, 143 in cattivo stato e yenner~ ritirati , 18 furono rifor ,nati ~e venduti, 250 ri format i e ]~scia ti a' dyposi ta'rii .
2.63 vis ita ti su l lnogo dalla gendarmeria (riin lat i, ecc ,) . 243 venn ero restituiti vo lontariamente dai depos it arn al momento clell"1s pezio'le r ·
Dal 1° lu glio 1860 al 30 giug no 1861 le pErd i te ·furono nella pr oporzion e cli 22 su 1000. - Nei corpi che hanp.o fatto cessioni a'colti1·atori, le perd ite dl)ran te il primo pe riodo, fra gli ·11nimali dw ess i han • o conscrvi!tO , furono di 37 su 1000; epperò appo i roltivatori si ebbe ro 15 per 1000 perqite 0. i meno. ., Per eccitare l' emulaz ione; ve nnero pubblicati sui g iornali. i nomi degli agricol tori qepositari di cava lli de llo Stato, i quali furono segnalat i per a•vP.rli meglio conservati . Pe 7 Jo , scòpo ·contrnr io forono pure pubblicati i nomi di c1I: l oro cu i, per\rascuranza ed ab;s o d 'impi ego; vennero ritirati i cavall i.

I coltiv atori si mostrarono prn:;,sochè tutti soJ•,~citi a far cop;ire le cavalle l oro affid a te da sta lloni de l governo, od ap.provati: è però da osservarsi che i l nnm er o dei prodo tti (1722) non è in rappor to con - quel lo dell~ ca valle coperte (63G::3). Qu1!l<'l risult9t o è.. g eneralme nt e attri bu ito ·all'in çonveoieo te di far percorrere lun ghe d istan ze alle ca vall e -per rend ersi alle :;tazi r,ni di stal!olli, o.. dal num e ro insu'flì.ciente di queste. , Le comm issirrni riconobbero bensì ch e, fra la nn\ura dei la, v ori cni venmiro impìega.ti, l'and a tura dei cavalli ven n.e un po' più pes~nte; ma non vi ha dubbio che, se ven i sse ~.acessari9 di ripreoderli nell'esercito, q uEJsto troyerebbe anco ra un contingente di 16,000 buoni e . solidi cc1valli fat ti al li,voro e atti a soppor'tare im mediatameute le ·esigenze dei serv,izio in r.ampagna.
Sarebbe ben desi drrabile che cotesto provvedimento venisse ' anche attua lmen te adottato pre~so ·di noi, per ridt1rre l'effettivo di cavalli e muli da tiro ed economizza re sul . .lo ro · ,1itt0, ·
piuttòsto che venderne, Gome si fa , a:' pubblì ci incanti, a prezzo vile, mentre probab ilmente qu esta primavera ~i sarà costretti a riscattarli, o qnanto meno a rimpiazza rli a p rezzo a_oppio, triplo ed anche q ùa.druplo. E boi sia1rio certi che numerose domande si avrebbero é:lai nostri agricoltori , e che) nostri caval li ,:;fon avrebbero · g r an fatto da scapitare nelle _ mani _loro.
I NGHI LTERRA : - Stando a:ll'ultimo numero del Navy List, il pe rs~nale attiYo · dell'armata bri tanqica è i seguente: · ·
r U(!ìziali g~nernli : 1 ammi~agli~-ca~o, ammiragli, 27 vl~-am!,11Ìrag1 .e 51 0ontramm 1ragli, r1part1t1 p.er terzi fra le tr squadre 1rossa, bianca e bleu. . -.
~esta d istinz!one consiste n~l co~o re dt-J I p~,,i!3l_i1.rn_e. che ru ffizial~genera le _1_nalbera e~ md1~a m mare l an ztarnta, rela,ttva dei co:rrra ndan t1 rn ca·po, 1 quah passano per tumo dal! una squad ra all'altra, cominci ando da l co l or bleu .
U(fìzfoli supM·io1·i: 345 capi tani, 443 commodori, 14 masters della flotta - con rango di commodori.
i U(fìziaU inferiori : 8:14 l uogotenenti, 358 master s, 116 sottotenenti, 75 sotto -rnastérs .
_Totale, uffiziali, 2297.
Oltre a questi , il corpo della mar ina comprende ~n personale di . uffi ziali meccanici mari ttim i, c'osi composto :
11 I spettori de ll e macchiµe naviganti con rango cl'uffiziali superiori e 182 meccan i ci capi con rango d'uffìziali i'nfe riori:
A questi debbon si pure aggiungere m olti m eccanici è aiqtantimeccanici aventi rango di uffiziali.
- Il colossale vascello •in g lese il G1·eal-Easlern compiva testè il suo v iaggio d'aoda.ta e ritorn0 fra l'Inghilterra e gl i Stati-Uniti; in 8 giorni da Liverpool fn a Quebec..- -
Il vascello, tutto iu fe rro, ha · 21 1m di lu nghezza ; 25 111 di larghezza, 22500 tO'nnellate di portata ; le sue m .:1cchine adelioe sono della forz a d i 1600 ca valli, qu ell e a. ruota della forza di 1000 cavalli e pesca, i n mediai 7 01 ,63.
La sua ·costruzione costò 25 ,000,000 di lire n ostre.
Il consumo medio giornaliero di carbone è di 300 tonnel late. Lfi sua veloc ità massima fu pressochè di 15 nodi.
_ 298 , RIVJ$'f ,\. ;
W!'., 1'TST1C A l 29.9
Può ricevere 10,.000 passeggeri, di cu i 300 d i 1 a. classe .
Qu esta costruzione gigantesca è dovuta al sign o r Brun et . Con tutto ciò egli non lascia di avere i s uoi incoovcmienti . che I~ ~r~tic~ svelò di non lieve r~omento . Il principale di qul·st1 1;1 e d1 n o n pot e r fare assegnament o su ll e proprie v t, !P, si cchè privo pe r qualche irreparabile avaria, o, venendo mancante dì carpo n e , esso dovrebbe rimanere inerte io mezzo al m a re aspettando ri m orchiator i, come già avven n e . Altro i n con• ven i.ente si è q nello <li non po ter dar ·fondo che io ben po chi porti.
Ciò nnllameno esso è un'opera me ra vigl iosa a testimo ni are la potenza meccanica dell'uomo.
RI ViST A BIBLIOGRAFICA
Spect.1tPur militaire - 15 aot'll 1861 - 1228 livraison.
Aperçu historique sur les fortifications, les ingénieurs et le corps clu génie, par M. le colone! AoGOYAT ( 4• partie, 2oe articl e) .
Ritirata degli eserciti dq,ll-i Germania (1758). - Sepai•azione dell'a,•ma del genio da quella d'artiglieria ( 5 maggio 1758) . - Campagna del 1758 in Germnnia: battagl ia di Creveld (23 giugno) perdu t a dal con te di Cler mont, ge neralissimo fran cese, contro 11 principe F erdinando di Brunswick. - Rimessione del comando in capo al maresciallo Contades : · battag li a di Sondershausc-m (23 l uglio) vinta dal duca di Broglia, comandante l a vanguardia fr a nc es A sull'esercito as 0 iatico e presa di Cassel; - Battaglia di Lu tzelbou rg (10 ottobre) vinta da l principe. di Soubise su l le t ruppe alle ate a s s i aticoprussiane, capitanate dal prin cipe di benbourg e da l general e d'Obe rg, prussiano; - Sorpresa del cas t e llo di Spaogenberg (9 agosto); - Presa dei quartieri d'inverno dei Francesi sulla

300 RIVISTA
8T ATI STICA
\
manc a d e l R •·no. - Discese ma1·ittime degli Inglesi. - Armamento delle coste di Francia . - Nuovo' 1·egolamento del co?·po del genio (1759).
Cam pagna del 1759 in Germania. Gen era li ssimo pei Francesi il maresciallo di Contades, pegli alleati ge rmanici il pri ncipe F erd innnlo di Brnns wick; - ComLattimento di Ilero-en (13 april e) favorevole oj duca di Bro gf1it1 , co mand ,mte la 0 òs e r va francese; - Iogresso de i Francesi ne ll a Vestfolia ·Presa, p er sorpre;a, di Minden ( 9 luglio). - Assedio di Mun;te1·: dopo 5 n o i.ti di t rincea la p iazza è r esa al marc hese d'Armentières, ge nerale pe r l e armi d i Fran c ia. - Ba tt aglia di iJfinden ( 1° agost~). perdnta dai Fran cesi - loro ritirata su Marb o urg; R edd 1z1 one del castello di Marbou rg agli alleati; - Mem o ra bile ~lifesa di Muostur, fattà dal mar esci allo di cam po fra ncese d1 Goyon, da l 25 agosto al 21 novembre; - Resa della pia~za per capitolazione ; - Kom ioa del duca di Broglie a maresciallo e comandan te l'esercito franc ese in G erma n ia.
Sou1;enirs de la campayne de Ct·imée . - J ou rnal d'u n médecin a ll em and au s e rvi ce de l'armée russe ($ui te). Battaglia de ll'Al ma.
Sénégal. - G·uerres et exped·itfons milituires de 1855 1861, par M. F. HuGOONNJ;'l'.
Camp de GhtUons en 1861 : manreuv,·es des trnis armes.~héo1·ie de _ la no1we lle gu erre . - Questo artico lo m,erita s pecia l e meozwne pe r il soggetto interessante che esso tratta.

Prendendo le mosse dalla dibattutiss ima quistione dei wodi migliori che la fante ria debba usare per resiste re a ll e ca riche della ~avall e ri a, l'autore si occ u pa dei b ersag li e ri, della cavalleri a e dell'artiglieria, appoggiando alcune oovelfo idee evocate dalle manovre t es tè com piut es i al campo di Cbalons -sotto g li . o rdini di S. E. il mare~cial lo duca di M agen ta . . ' Oo de 11 campo potesso dare tutti i migliori risultati possibili non solo alla trnppa, ma be n anche al punto di ,•ista scientifico rnililare, l ' imperatore v olle che parecchie commissioni,
format e dei più P.sperti uffiz i a li d'og ni a rma , s egui ssero le grandi manovr e delle truppe ed atteridPsse ro giornalmente ad am pie sperienze sul ti.ro della fanteria e dell'artiglieria ed a llo im piego del la cav alleria , allo S"OJ)O di ri solve re le pri n ci pal i quis ti on i dell a nuova tattic~, in vista dei perfezionamenti ultini a meote sub\ti da ogni specie d'arm e da fuoco. Finora n on si coooscooo i risultati di coteste commission i, ma vogliamo cred e re che l e loro deliberazioni, se n on rese d i pubbl ica rag ione , trapele ran no d a pros sim e modificazioni ai r ego lamenti d•éser,izi . Siam be n lun gi però dallo sperare che per esse si aoo stat e assolutamente d, finite l e contr oversie seriis~i me che agitan o i tattici d e l giorno, avvegna c hè qu ~st o no i ponno ess e re che dàlla vera guer ra, dalle prove assolute d i fatto, e, p e r quanto ,siasi fatto al cam p o di Cbalons per con cretar la sanzinn e, ,,'ba semp r e una d ista nza insuperabil e e perenlorìa tra i l simulacro e la real tà, quanta ne passa fra la t eo r ia e la pratic-a. -
la, fanteri a (a1·mata di fiwile 1·igato) minacciata da 1.ma carie.i, di cavatle1·ia, dev'essa allenden che questa le giv,nga a 30 o 40 passi di distanza pe?' fa1· fuoco, ov·vero cominciare il suo fuoco sulla cavalleria appena questo, si muova ul trotto ad una disl r;mza di 700 od 800 rnetri ed olt1·e? - Que st' è l'illlportant issima quistio ne cbè l'autore JJ<J ne i n principale r ili evo, e certamen! e lo mie, p oichè è oggiàl la più controverS3.lll. A qu es to pr 0 p o~ it o egl i ri porta akune op inioni em a na t e d al lllar ~scial lo di M ac• Mahon sulle istruzioni c h 'eg li fece d istribuire agli uffiziali general i e superiori del suo co rpo d'eserci to: _
_ • A J ena, il mar esci all o Ney, n on a~•endo seco c he due r eggi m e n ti di fanteria e due reggimenti di cavalle1·ia leggera, trovas i ad un tratto in presenza d1 30 squ~droni d i corazzieri, ovv e ro dragoni p russiani, appoggiali da una batte ria .
• Egli forma cia:;cheduno di questi due reggim ent i io quadrato, e, pieno di CuHfìJe oza ne' suoi vecchi soldati , lasci a avvic ina t e l a ca valleria n em i ca s ino a 30 passi dal le su e bai on e tte; ad un suo segnale; una scarica qu asi a bruciapelo copre il terreno di morti e di feriti.
302 RIVIST,\
BIB L !ÒGRAFICA 30~
Assa l iti riù volte, i due quadrati ripfltarono la stessa manovra e fn:vo no in crollabi li.
« Ad Auerstaedt, ad Eylau ved iam o Davoust e Morand aspettare gli squadroni nemici a 30 o 40 passi prima di far eseguire contr'essi fuochi d'insieme.
• Però è a n otarsi che alla batta,, lia dell e Pi ramidi il q . ua- r\ drato, coman<lato dal genera le D csa ix, fu comp romesso per un momento, causa un co mandante d'u n lato che fece i ncominciare i l fuoco troppo tardi . •_È al co mandant e di ciascuna porzi on e di truppe che a ppartiene, ~econdo le circos tanze, indic are il fuoco da esegui re.
• Co n tr o la cavall e ria, che s'avanzerà io una s o l linea si ' può ammet t ere la circostimza in cu i sarebbe vantagoioso atte n_der_e l a ca ri ca a 30 o 40 passi di di s tanza, ed 0 eseguire q u1nd1 un fuoco d'insieme~ ma cont ro cariche in colonna, pare ~iù u~i le im p iegare i fuochi di r iga, soprattutto dopo che la lanter1a v e nne armata con fucili d i lunga portata . , Toccando poi l a formaz1one dei quadrati per resist ere alla cava ll eria, altra questione qu esta ogg id\ controve rs a t issima, l'autore_ v_ieo c al la co nc lusione la più r azionale e pos itiva che tale qmst1one possa com po rtare, c ioè, che i soldati v a lorosi soli d i e bon co m anda ti sanno v i nce r e in qllalunque sia.si ~/ dine di formazione . , I :;uccessi di un'arma eontro a ll'altr& sono quas i s em pre dete rminati dalla supe r io rità deg!i uomi o: che la compongon o . Eccelle11te cavalle-ria vincerà sempre far~t er ia rnecliocre, e vi ceversa, e ccell e nte fa nteria non s i l asc ierà sfonda r e da mediocre ca va ll e ria >>.
Poi ch è è oramai inneg abile che l'ordine spa1s0 è il più frequentemente urnto n e l combattimento, i l maresciallo ' di MacMah o n vo l le c he tutte l e sue t rupp e avessero s pecialmen te da ese rc i ta rvi si. EJ in pro pos ito me1ita no di essere ri portate le seguenti istruzioni:
• Quand o il comandante d'una • truppa vuol fa r rientrare i ~uo i cacciAtori , l'importante si è di fa r eseg u ire il movimento lll modo da smascherare rapidamente la fronte delle tru ppe e per°:1e~tere a queste d'incomi nciare i loro fuochi il più prestu poss1b1le, senza aver gran riguardo alle suddivisioni cui essi appartengono.
, I • un caso pre mur0so si pu ò a nche p e rm et tere che i cacciato ri si portino direttamente s nll a l in ea . In questo cas o essi pass ano tra g li in lervall i de i pelouoni, oppure si prmgo110 a gvnocch'terr ' d ina nzi la prima riga, in m a ni e ra da pPr m e tt e r e alla linea di fa r fuoco immediatamente .
•· ..... La teo ria prescriv e d i sbarazzar~ il più pres to possibi l e la fronte de i battaglioni; in ::eguito ammet te i l rannodamento al passo ordinario o di co rs a
• Si comprende il ·rnntaggio d e lla celerità del p asso n e ll'eseguire qu esto movimento ogniriualv olt a i cacci a tori potra nno rannod ar si. pri ma che la cavall e ria li r a gg i ung a .
• Ma s e la cavall e ria novesse raggiungerl i prima c h e il lo ro rannodamento fosse e ffettuato , vi sarebbe r Pale u ti l ità a non riun irsi che a l pass o accelerato . l cacciato ri devono al lora formars i rapidamente in g ru ppi di quad ri gl i a e ce rr are d i riu n ì rs i pe r m e zze squadre e per squadre
, Se i caval ieri ritJs cono fr11 mn1isc hiarsi a lo ro, devon o a rrestarsi e m inac ciarli d e l loro fuo co Sove nh i cav a lie r i passe ranno senza colpi rli, che, se sono iso lati e s e loro v ol Lano le spalle, saranno senza dubbio s c iabo lati•.
A vendo qualche giornale acce nnato all'intenz ione del g oYerno francese di ridurre l' effettivo r eggi m e ntale dei caccia t o ri a piedi , l'autore si mostra avve rso a ta le di min uzione , appog~iandosi sul noto aforismo di F ed e r ico il Gra nd e : • V a l m egl io con -

• servare ad un e se rcito un 'orninauza m edi oc r e , coll a qua le , e"'li s 'è fami cr liari zzato che obbliga rlo a. wend erne una nuova, o o , r
• foss'ella vicina alla perfez ione n E qui n o n gl i poss iamo dar rag ion e, p oichè, se il princ ipio ch ' egli pro p ug na fossesi s e mpre osservato com'egli vorrebbP. , oggidì n oi sa r e mmo an co ra fala n gizzat i co me i Greci all ' asse dio d i Troia I Uguale, ed anz i ma ggiore i n s istenza im pi e ga l'a u tore pPr ch i ed e re col maresc iallo di S asso nia, che non si t occhi alla cavalle,.-ia, ma se n e prococ c i'no tutti i m ig lio ra m rn ti poss ibili col rec l otamen t o e special mente col modificare la bar datura dei cavalli io - quanto ha di dife tt oso, seg 11ondo insom ma i con · sigli de l ro lonnello d' Azemar n e l suo libro s ull' Av-venire della cavalleria : • Venite (dice l'autore agli avv e rsa ri · della caval_leria) , v e nite al campo di Chlllons, v enite a s t udiare sotto 11
304 RTVISTA
Bl BLTOGRAFICA 305
•
capo i llustre che lo coma nda, co m e s1 1mpi0ga la cavalleria· e qual profitto se n é può trarr e, Ma, · ahimè! che éotesti avversa ri s ono più t es té recci che n o n s~ l o creda l'a.utore, e, q uand' a n(:he av'essero assistito. a ll e b ril l an ti evo ìuz ioui de l campo fra n cese, non muterebbero di n dll à le loro opi n ion i. Fra l e vari e. co m m issiòn i s ucc i tate, una coufm\ssione mista si occ upò a determi n are spe ri mental m e nte quanto te m po è n ecessa rio • ad uno squadr.ou e, a d un reggimento, p e r correre al la cari ca, partendo dà una d istan za ' di 800 a 10 0 0 m etr i, ondl~ poter fis~are in v ia normal è quanto temp6 gli squadi:oni dov r anno c1mm i aa r e a l trotto, a l ga loppo ' ed alla carica Tale commission e cìov e a pure stab ilire quan to tempo sia n ecessario pewhè un reggim ento, per esenJpio, car icari'do in prima l i nea, smascheri - la se co n da, ne l caso c h e la p rima ca6ca non rièsca . -Vol e vasi pure de terminare se la fante ria , · assal ita così da due lin ee di cavalleria, dopo aver fatto fuoco · sulla prima, ~v ; ebbe . · i l ternpo di ricaricare l e s u e a rmi e di fare una seco:ù d,a scar ica su ll a seconèla Jin e a, prima che questa giunga ' a 30 o '4Qm. L'a utore vi en quind r a d iscorrere delle ca1"iche 1in colonna serrata e delle eariche radrnti . Sul p rop osi10 de)le ca ri nhe i n , rna ssa eg li c i ta uno squar ci o de l noto l ibw del , ge ~e f!l,l e R:e, nard, Sulla cava llerici, 9ve d im os t-ra si l'uti li 1à delle cariche i~ , massa, nei mom e n ti dé cisi vi d el la battag li a , e sulla necessi\a 1 p e r c iò pe l gener alissimo , di av e r so t to l a mano gr()ss i cor pi d ~:,, c a:vAl leria pe r tali cariche c oncen:t ra t e . I n • :u i un altro caso· può gius ti ficarsi u na carica i n colonna serrata,, a·vv e gnachè• cotesta ord i nam, :i pr es e n ta troppo facile b e rsag lio al fu oco Gel nèmi co . L'au·tore vuo l qui conch iud e rn co l gene ra l e Renard sulla neces s i1à d ì conc entrare la cavali e r i.a in cor pi d'eser cito, e be i>, più vorrebbe che, all ' us o antico, i l ccimando de lla ca\,a ll e ria fosse ci a to a l comandante iµ ' secondo d e ll' es erci tò, • il qual e saprebbe fa re un g i11,dizioso im r i e go dell'a ri~a sua, intratte nerl a , condurl a su l cam po di battag l ia numerosa e:1 ·i n. buo no sta to, farl a a g ire p a r zia lmente, i n linea, in . foraggieri od in ma:;~a , secondo l e ci rcostanze, e deéidere sov en ti dell'esito de ll e ba t taglie. • È fa. c i'le · ricònoscere che l'autore q ell'ar ti col o, · per comba tte re fo smembramento - dell a cava ll e ri a fra l e varie d i vis i oni de ll'eserc i to, cade nell'ecces~o affatto contrari o, c i oè in uù accent1·a-

mento ge ne rale, che tatticame n te veste anche peggiOT i d ife tti che non - i l primo . D ifatti, formando esclusivamente colla ca,•all eria e;orpi d'es erc ito a ' parte, la fanter i a e l' a rt iglier ia sono private dell'immedia to concor~o d i ~ssa ar m a, .i ~q ui eifotti pi ù uti l i e freq u ent i co nsistono per lo appun to nell' i ntima cow binazione della s ua az ion e con q L ; ella de ll e a l tr e due a r mi ; olt re a ciò l a forma zi o n e dell a cavalle ri a i n grnss i, corpi p res enta grav i incçmven ie nt i per l·a suss istenza in campag na Epperò i l s iste ma più rnz i ònale è cpie:l lo oggidì adottato da près ~ochè tu tti gli esercit i, cioè d i da re ad og n i d i visi o ne d'es erc ito una ce r ta for za d i cavall eria, p rnpori io • at a a ll a nat ura del. teatro della gu e rra ed a i -suo i b isogni ' ta.t.tici, e di formar e, colla rima n e nt e, de i corpi particolari di riserva . .
In quauto poi a ll e _ca ric ~ie ra den ti, d i cui pa r ~a l ' articolo in d is corso · esse non m er i tano seri a consi der az io ne; e se taluna - v olta p ~ttl!'ono r i uscire nell e guerre deH 'i rnpéro (e cònJessi a m o l a nos t m ignora n za di n on avern e cioè mai ud ito parlare ne ll a s t oria d i quel le guerre), c ièJ fu s ol à m e nte p e r l a ' novità de ll a cosa e cout ro tl'up pe ben poco agguerrite . « S i ca mmina a mano des tra, ad 1 o zm rli d is t anza ( be n i n t eso sfilando per un o) e si concep-isco (s ic) che il · fante, n o n potendo far ·u so del suo· (uoco e pochi ssi mo dell a' sua baio nettci per parare le s c ia bolate, s i a u cc is o o fer it o senza p o t e r fare graò ~a le al cava lie re slanciato alla carr ie r a . -o Noi inve ce concepfo·cno t utto il co ntrario . Sàrà forse di fe tt o d'i nt el li genza, ma non sappiamo. cap i re che cosa possa ' im pe di re a\ fa n te d i prima l'iga di piantare la propria baione t ta n el ventre de l cavallo ehe gli sfila d'innanzi, parandosi la sci abÒ lata n e ll o stesso meutré col calcio de l suo fuci le ; ch e ccis a poS5a - i mped ire alla , seconda. riga di fa r fuoco a bru c ia- pe lo n e l fianco d e i cav a li e ri, come nep pure sapp iàrn intendere in qual mod o , co sì s ciabolan'do alla s fu ggit a, possa la cavall eria r iuscire a sfondare u n quadrato od una l'inea di bartaglia; e v orre mmo pùr veder e, per san are là rÌ'os t ra incredulità , co m e pot r e bbe una ' ta l car ica continuare a lloraquando ·tre o quattro cavalli, fatti cadaveri, i ngo mbrassero la v ia a ll o sfi la men to Chi ud o no l'a r ticofo alcune brev i ssi me pa r ~le sull'ar ti glieria , di cui le . sper ieuze a l campo furono- <lirette dai g e n e rali L e•
306 R!V!S'l'A
D11ll..!OGR liF l€ A 307
bceuf e de Prirndea u - In tutte le evoluzioni genera li e nelle g~andi mç1novre un ·distaccamento di cavalleria venne posto a scortare l'a.rLig li éria . « L'artiglieria e la cavalleria, difatti (coùchiude l'autore), debbono essere ·in guerra due. airmi frate1·ne, due compagne i.nseparab-ili; con UJìa confidenza r ec iproca nella loro r~pidità e nella loro prodezza, esse non temeranno m ai di tentare i co l pi più arri.i li, i quali potranno qualche vo l ta m1.1tare le sorti di una battag lia » Veramf' nte la fante ria avrà un po' da Jame n'tarsi della trascuranza che le usò l'autore!
. La' tactique [rançaise reduite à sa plu; simpla expression ptat•ique. - Etudes · sur les evoluiions des unités tactiques ( batail'lon et d iv ision) pour servir de trait d' 1mion entre le cbamp de Mars et le champ de bataille." - Nei due. articoli (N11m 122 e 123fche potemmo gia l egge re, siccome trovammo ,alcune semplifieaziòni alla te·oria d'evoluzio n i che meritano rigu~rdo, trovam~o vure lu ogo a moltissimi appunti; ne ragi onere mo quando avrem po,tu to farci un criteri.o sul merito dell"intir r o ' lavoro. ·
Le maréchal Bugeaud ço1Ìsidfré comme tacticien ·et str,a./é · • \ I giste didactique, par M. F. de la Fn.usTON. - Il sianor de la ' o t Frusto n si ò preso sotto questo , titolo un tema inte re.ssantissirno, a r ui \ egli pot'rà applicar bèn issimo t~tla la sua facondià.
D1 qu0sta biografia scientifica non è logico azzaréìare un g i udizio prima di leggero.e la fine. ·
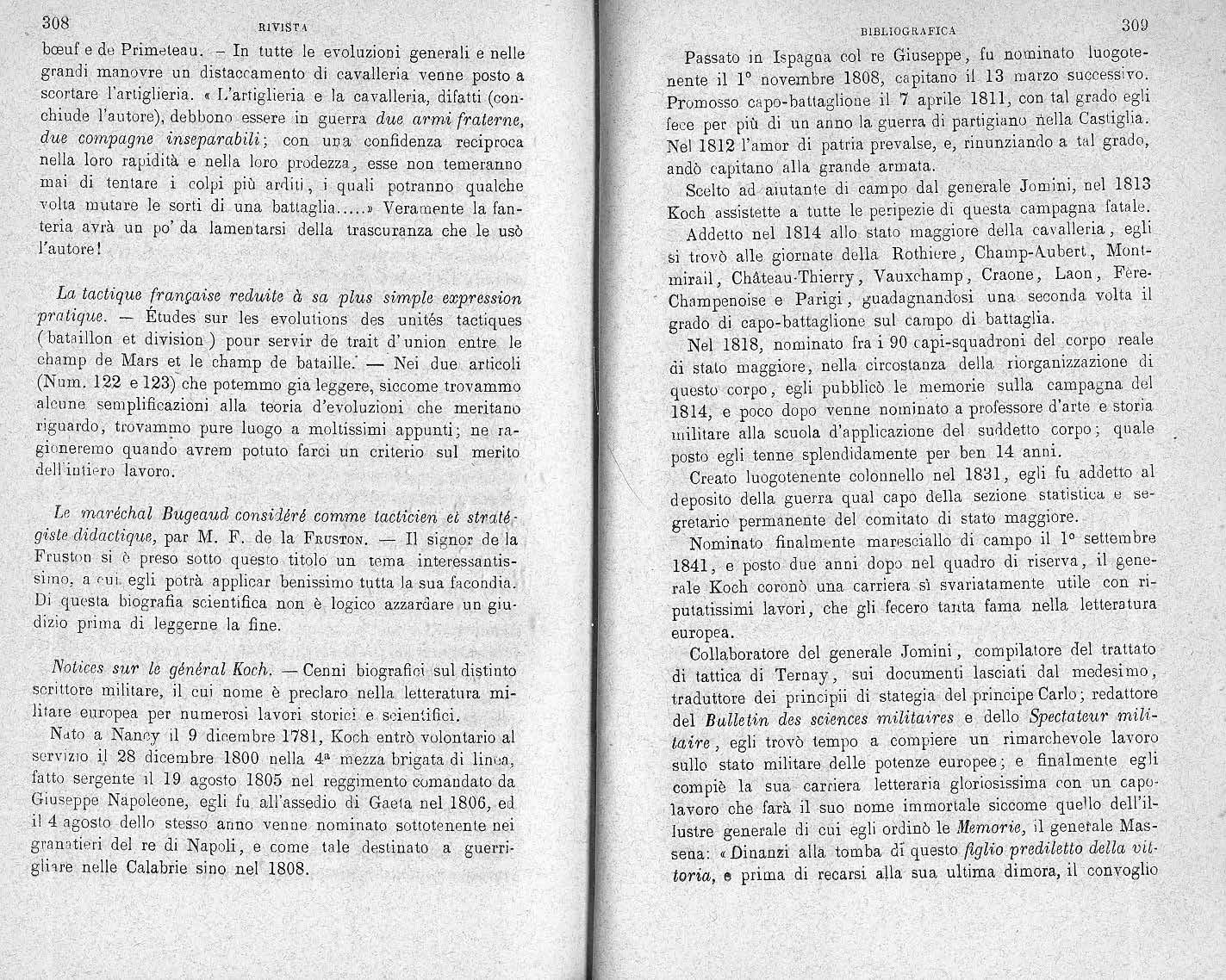
Notices sur le gé11éral Koch . - Cenni biografici sul c),i,fJti u:to scr ittore militare, il cui nom e è preclaro nella letteratnra mili tare ewope a p er numerosi l avo ri storici ·e , s,)i entifici.
Ndto a Naur;y il 9 ·dicembre 1781, Koch entrò volontario al serv izio i_l ~8 dice II/ bre 1800 nella 4a mezza brigata di linD1.1, fatto sergente il 19 . agosto 1805 nel reggimento comaoda:to da Giu seppe Napoleone, egli fu all'assedio d•i Gaeta nel 1806, ed il 4 agosto d ell0 stesso · anno venne nominato sottotenente nei g,ran ati e ri del re di Napoli, e come tale destinato a gl).errigli~re nelle Calab rie sino nel 1808.
Passato in Ispagna col re Giuseppe, fu, nominato luogotenente il 1° novembre 1808, ca pitano H 13 marzo succes-s ivo: Promosso c a po-ballaglioue i l 7 apri~e 1811, con tal grad? egh fe ce per più dì un anno la guer ra di partigiano nella Castiglia. Nel 1812 l'amor di patr~a prevalse, e, rinunzi1.1ndo a t a l grado, andò capitano al la grande armata. . .
Scelto aa aiutante di campo dal generale Jom1rn, nel 1813 Koch assistette a tutte le peripezie di q u esta campa9n~ fatale ._ Addetto · n el 1814 allo stato maggiore qella cavallena, egli si tiovò alle g iornate della Rothì ere , Champ-Aubert, :tlfonlmirail, ChMe'au-Thierry, Vauxc-hamp, Craone, Laon, F èr~Champenoise e Pa rigi, guadagnandosi una s~conda volta 11 grado di capo-battaglione sul campo d1 battaglia. , Nel 1818 nominato fra i 90 çapi- sq uad ron i del corpo reàle ài st~lo ma~giore, n ella ci rcostanza della riorganizzazi one di questo co rpo , egli pubblicò le memorie sulla c~mpagna de l 1814, e poco dopo venne nominato a professore d arte e s tor ia milìtare a-Ila scuola d'applicazione del su<ldetto corpo; quale
· posto . egl i tenne sple nd idamente per b en 14 an~i. '
· Creato luoa otenente colonnello nel 18::ll, egli fu addetto al 0 , deposito della o-uerra qual capo della sezione stat1sl1ca .e seo . gretario · permanente del comitato di stato mag~1ore.
. , Nominato finalm en te mar11sciallo di campo 11 1o settembre 1841, , e posto - d0e anni dop'.J nel quad r o di r iserv~, il.generale Koch coronò una carr iera sì svariatamente u t ile con r1' puta~issimi lavori, che gli fe cero tanta faina nella letteratura europea.
Collaboratore del _ generale Jominì , compilatore del tratt ato ·di tattica di Tern~y, sui documenti lasciati dal medes,imo, traduttore dei pr i ncipii di sta tegia del principe Carlo; r edatto~e · del Bulletin des sciericas mil·itaù·es e deìlo Spectateu1· militaire , egli trovò tempo a compiere un rimarchevole lavor~ sullo stato militare delle potenze europee; e ,finalmente eg h com piè la sua. ' carriera letteraria glorio~issirna . c:on un ca~olavoro che farà. il suo nome immortale siccome quello dell 11-
. lustre generale di cui ègli ordinò le Memorie, i l generale Massen.a: . « Dinanzi alla tomba di questo figlio predfletto della vittoria, e prima di recarsi alla su él;, ultima dimora, il
308 RIVIST
DIB.LIOG!tAFICA 309
·coµvo~lio
funebre del g en erale Kor.h venne - c;ndotto e si fermò i . tamburi _ batten~lo al éam p o, ·in , adern p irnento del desideri; soventi man 1fostato pri_ma d i m orire, di ren dere àl gran capitan o, col quale ,aveva v1ss~ to in.!ellettua l rnente durante q·ui ndici anni qne~to nobile e commovente omaggio t deg no e dell'eroe eh; lo ricev ette, e _ d ei sentimenti pa tri ottic i del dotto modesto ed ins lancabile che il paese ha perduto ». - ' - C .
Quando que,;te condi zioni so no ,soddisfatte, saranno:
« I• Le velocità de' p rçiietti ne i punti omologhi del le due traiettor ie, ed i temp i- n ece.:;sari p er giunge;rvi, propo r ziona li aH e radici quadrate de lle di'ruen sion• i l in eari dei proie tti :

< 2"' Le dimension i lineari delle due traie ttorie , nella ·stessa rao-ione d elle dimens ion i lineari dei proietti • . ·
Dalla ri sol uzi one di questo t eorema fondamentale, il cui sviluppo qui sarebbe fuori di proposilo, si vi ene a l segurnte teorema d'applicazi one all e a r mi da fuoco ri 6ate: . ·
Teorema sulla siinilitud·ine delle traiettorie desc1·i1te dai proi~tli n èi mezzi_. 1·esislenti. - Applièazion~ al tiro · delle a1·mi - ~a (uoc_a - Mernoriit de! conte PAo.C:o di S .- Roll'ERTO • Nei tasc1coli d i magg io e g i ugn o p. p_- de l Nuovo Cimento l'egregi~ cnltò:e del la sc ienza ba listica, b en noto' ed app r ez~ zato da1 le ttori dell a nostra Ri vista, p ubb licava una studia:tiss_i ma ,ùimos:razi one sulle trn i ettorie si mi li descritte dai pr Ò1~tt 1. L enu n z!ato de l te9rema, p rofondamente . discusso dal ,<::1gnor _ S ,m R oberto, è - il segu en te : ·
· « D t1e pro iet ti qualunque · che si muovono in m'eizi d i Y'ersì la cui i:es~st.enza è in ragion e comp ost:a del quadrato della v:. , loc1tà , <lAI I are a de lla s uperficie su c ui si esercità e ' della densità del mezz~, a_escr ivono_ t.raie ttor ie simili quando sono . ade~n -p i nt~ le con9 1z10rn seguenti: - · '1
« ·1a E,;s er~ i- due "p roietti s:im ilì cos\ r1spet;; al11!, forma esterna, _ com.e rispetto a lla cost ituzione interna · , :, . \'
. « 2 "' Tro 'i,a rs i s u ci a sc una traie ttòri a un punt~, OVP, la direz10ne d~lla v e locità ~el ceiitt:o di g ravità del proietto sia .la· st_essa :1ell 'una n el l'alt ra traie tt qrìa ; ove i due proietti siano d1sp0st1 para li efamente; .ed ove i loro a ss i ist~n t anei di rotazione s ia n o purè pa r a ll eli; · '
« 3a E ssère ," i n qu est i pu n ti omo]o.o-hi, le -yeloc it'à <l èl centro di· grf vÌtà dei pr oiet ti pr ,,pr•1·ziona.li alle· radic i·q~adra t-e de!le loro d1m en s1o m line ari·
, .Due a rn) i r igate danno tr aietto.r ie ·simili, ogm vo lta che
, 1° Son o spara te collo ·s te sso ango lo; ·_ - · _
« 2° Lanci ano proiett i sim ili così ri spetto· alla fi.~ura, carn e rìspetto ·alla cQstituzionr. in terna ; . . .
« 3° Hanno i passi dell e eliche propo~z1onah a1 di a metri · ~ei proi ett i ;
« é Comunic ano ai rroietti · vel ~ci tà inizi a li i n . r agione d ir etla ·de lle radici quadrate dei loro diam et ri e delle loro d:n • sità, ed in ragi one inversa delle radici quadrate del le dens ità, de i mez zi resiste~ti >~
Essendo queste co ndi zion i sod disfa tte, ne SPgue :
.
« i° Cl~e l a velo cifa d e i proie1t i nei pun ti omol oghi rlRll A traie.ttorie s i mili, I?,OÌl mano che .i t E·mpi per giungervi, sono ~ella stessa rag io n e delle ,,elor.i là inizi. al i;
« 2° Che 1,; dimensioni lineari dell e due traiettorie sono proporzi~i;iali é). i· dia met ri dei proietti» . · ·
. E finalmente a <J,uesti due altri d'applica zione all e armi da fuo co li scio , c io è :
• « 1°·Usando proietti sfer ici eccentric i: Due p r oiettti
.
«.' 4~ Es~~ re nei detti pu~ti le veloc ità an~ola 0 r i di r ot;~ z10n ~ d ei proi e tt i re.ci pro camente. prnporz iona li alle radici quad rate delle loro dim ensioq i lin e.ari ;
« 5"'_ Ess~ r e le densilit dei pro ietti. pr opornionali alla densiti.i, d ei m ez-z1· resistenti »
-sferici concent r ici ri rni li pe r la disposizione della ma teri a., dànno traiettorie sim iii in mezzi resistent i dì densità proporz icn,ali alle d en si tà dei proi etti, quando sono lanciati collo stesso ang olo, con ve lo ci tà ini.zia li i n _- i;agione delle radici quadrate dei lo~o diametri, e con velocità di rotaz ion e reciprocamente proporzionali. all e rad ici quadra.te d ei medesimi diametri . . In questo caso le ve locità de i pun ti omologh i ed i tempi necessar.i per per-
,co rre re archi s imi li sono come le radi ci .quadrate dei. diamet ri, le dimensioni lineà ri delle traiettrlr ie i;;o no comi? i diametri deiproietti;
310 RIVJSTA
• -
', l • •
B!BL! OGR AF!CA 311
· · ,
• ,
« 2° {Jsando proietti sferici concentrici: - Quando, le -velocità i~izial i di due proietti sfer ici, lanci-ati col medesimo an g olo di elevazione , sono proporzionali alle radici quadre dei diametri, al le _rad ici . quadre de l le densi tà lor o, · e rE;) cip roc~m ente a ll e radici quadre delle densiti\. dei mez~i resistenti, i d1ie pro ietti descrivono tra iettorìe sim il i . A llora 11 r appor to delle velocità nei punti omologhi f:ld i l r apporto dei tempi per giunge re a qllesti punttsono uguali al rapporto delie -velç,cità ,.in iiial i; il rapporto li nea re di s imili tudi ue de lle traiettorie è ugua l e al - quadrato del r apporto delle vel ocit à» .
Quest'ultimq è i l teorema di Borda cbe ,' fra gli enunziati, va. considerat0 come un teorema pa r ticolare rife rentesi al generali), . ch'è l'argoment0 principale dell'opuscolo e de l si gnor conte di San Roberto. ·
Sebbene giudici incompetenti a pronunziare sul · meri to •intrinpe co di questo scritto ·di balistica sublime; ciò itullarneno, dal la espos izione d iia rissima e fac ile, abbiam dovuto con-vincerci che m olte -verità balistiche, a primo aspetto astrusissime e quasi pa radossali, e come ta l i d ai molti pred.ièate, · sotio la gu ida di un valent e maestro, come a ben g iusto titolo --va -riputato il signor di San Robe rto, divengono , faci lissim~ e commisurab i li . - Ta li scr iui, ben lo , sappianio, , non i ~contraµo gran fa-vore, perchè ai molti·le cifre algebrich e fa nno spavent0, e piutt os to che stud iar le si pre feriscon o d ichiarar corri. vamente stucchevo li ed inu ti li ..... ed è questo un grave danno, pel pro·• grE;)sso scientifico, ii , quale, checchè n e d icano g li anLi te 0Pici, è la base fondamen ta le de i pr ogressi prati ci e rea li. X .
L'egregio sign,Jr Lecomte, co3l vantaggiosameote conosciu'to nella l etterat ura mi litare eu ropea per la s ua bellissima Relàz1:one storico-critica della campagna d'I talia n él 1859 ,' ci volle _ cortesemente in:v i are questi du e ultimi suoi lavori, invitan doci francamente ad espor_re le nostre critiche.

' S e, a formare uri -vero criterio sul merito di un'opera, bas tass e la prima impress ione, noi non ·potrémmo c_he tribu tare illimi tati ;elog i all 'au tore ' , tanto fu , fa-vorevole . qqella in noi avuta dalla r~ pida 1ettura fattan~. Ma la materia tvattata è di quelle ch e esi go no accurato studi o per giudicarne; epperò limì¼n doc i pe r · ora a 'questo semp lice an nunzio bibliografico, ci ~iserbiamo in un prossimo fascicol o a rende r conto a i nost rì lettori di questi prege%li scr itt i, ed il faremo con ogni ma'gg10r cu ra .
L' ftalie en 1860, par FERDJNANo LEcOMTE, majo1· à l'etat major f édéral
- Le généml Jomìni, sa vie et ses éciri·ts - esquisse bfographìque et stmtégiqiie·, avec atlas par FERùINAND Lil:òoiirE1i major ' à -l'état rr.a101· fédéral . Paris, chez Tanern - Lau;;annA, . chez Corbaz et RouiiUer fils. - l O fr. ,
312 RIV !ST A
BlTlLIOGRAF ICA 313
C.
T,w1..uN°O G.&.&TANO Gerente
DEL VOLtJM~ I. ANNO VI.
Ln;;Ho .
Studi sul)'organizzazionc di un eserci1o . . . Pag.
Prima guerra dell'indipendenza 'italinna. - Assedio e difesa di
Studi sulla cavalleria nello spirito della tattica moderna e del nuovo ordinamento dell'esercito itali::mo Pag . 113

Prima guerra dell'indipendenza italiana . - Assed io e difesa dì
1848
Sulla cavalleria. - Il generale Renard e la Rcvue miWaire beige ,, 176
INDICE
Studi
sulla cavall eria nella spirito della tattica moderna e del nuovo ordinamento dell'esercito italiano - • 49
'I,
ra dalle truppe sarde
,, 56 Nuova circoscrizio ne militare
(con ca rta g cogri1fica) 76 Rivis~a tecnologica . » 87 Rivista statistica . » 92 Bollettino bibliografico-trimestrale. 100 .,./
Peschie
nel 1548 •
territoriale del regno d'Italia
A;;osio.
Assedio
P.eschicra dalle truppe sa1 de nel
(con tavola litografica) » 131 Riordinamento degli istituti militari del , regno d'Italia ,, 150
di .Juliers nel 1860 . » 161
Rivista tecnologica . .. 188 Rivista statistica 194
Rivista
,
bibliografica " • , io5
Settembre.,
Studi sulla cavalleria nello spirito della tattica moderna e del nuovo ordinamento dell'esercito ila liano

Risposte del generale Renard ai suoi critici
Stud'i militari sull'organiMazione delle nostre fanterie
Rivista t ecnologi ca (con tavola litografièa)
316 INDIC!
statistica . Rivista bibliografica ;,, i Pug. 213 n 239 ,. 264 "28~ " 292 .,, 301
Rivista