SCUOLA
DI PRIMO GRADO

SCUOLA
DI PRIMO GRADO
IN PIU TEST D’INGRESSO PER LA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Prova primo quadrimestre
6 allenamenti sui 4 nuclei tematici
Prova ufficiale guidata
Prova simulata completa
Percorsi per l’Esame di Stato
RAFFAELLO PLAYER è l’applicazione grazie alla quale puoi fruire dei libri digitali, in classe e a casa.
CONTENUTI DIGITALI INTERATTIVI

UTILIZZA CON I DEVICE
CONDIVIDI NELLA CLASSE VIRTUALE
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
DIDATTICA INCLUSIVA CREA E PERSONALIZZA
Per attivare i contenuti digitali, registrati al sito raffaellodigitale.it
Successivamente scarica, installa e avvia l’applicazione Raffaello Player: effettua il login, seleziona il testo da attivare e inserisci il codice di attivazione riportato sotto.
Collegandoti a raffaellodigitale.it puoi scaricare l’applicazione.
Digitando raffaelloplayer.it puoi utilizzare l’applicazione senza effettuare nessuna installazione.
Ti serve aiuto?
Inquadra e installa. con il TABLET e lo SMARTPHONE


Leggi le F.A.Q. o richiedi assistenza collegandoti all’indirizzo supporto.raffaellodigitale.it oppure scrivi una e-mail a supporto@raffaellodigitale.it
Le condizioni generali di contratto sono disponibili su raffaellodigitale.it
Ideazione e stesura Prepariamoci alle Prove INVALSI: Barbara Giuliodoro
Ideazione e stesura dei commenti alla Prova ufficiale guidata e dei Percorsi interdisciplinari: Cecilia Favi
Ideazione e stesura Prepariamoci alla scuola superiore: Centro studi AMA
Coordinamento redazionale: Stefania Bigatti, Silvia Civerchia, Nicola Giulioni
Coordinamento digitale: Paolo Giuliani
Progetto grafico: duDAT Srl
Redazione e impaginazione: duDAT Srl
Referenze fotografiche: Istockphoto, Archivio Raffaello
Copertina: Alessandra Coppola
Stampa: Gruppo Editoriale Raffaello
Il Gruppo Editoriale Raffaello mette a disposizione i propri libri di testo in formato digitale per gli studenti ipovedenti, non vedenti o con disturbi specifici di apprendimento.
L’attenzione e la cura necessarie per la realizzazione di un libro spesso non sono sufficienti a evitare completamente la presenza di sviste o di piccole imprecisioni. Invitiamo pertanto il lettore a segnalare le eventuali inesattezze riscontrate. Ci saranno utili per le future ristampe.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2024
Raffaello Libri S.p.A Via dell’Industria, 21 60037 - Monte San Vito (AN) www.raffaelloscuola.it info@grupporaffaello.it
È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, comprese stampa, fotocopie e memorizzazione elettronica se non espressamente autorizzate dall’Editore.
Nel rispetto delle normative vigenti, le immagini che rappresentano marchi o prodotti commerciali hanno esclusivamente valenza didattica.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.
Ristampa:
6 5 4 3 2 1 0
2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024
2
Percorsi interdisciplinari
3
1
Nel Libro digitale:
• Allenamenti e Prova simulata CBT
• Prova simulata extra CBT
• Percorsi interdisciplinari personalizzabili
• Tracce guidate d’esame
• Ripasso grammaticale e delle tipologie testuali
Il presente volume è un valido strumento di preparazione metodologica ed esercitazione pratica alla prova INVALSI, ed è articolato in tre sezioni: la prima è dedicata alla Prova nazionale INVALSI e comprende una prova per il primo quadrimestre, un allenamento guidato per apprendere il metodo, una prova ufficiale guidata, sei allenamenti e una prova simulata completa; la seconda propone tre percorsi interdisciplinari per prepararsi al colloquio d’esame; la terza parte propone tre prove di ingresso per la scuola superiore.
Nel progettarlo e realizzarlo si è fatto riferimento ai documenti ministeriali presentati dalla ultima normativa1 e agli esempi esplicativi che il Ministero ha fornito per preparare le studentesse e gli studenti rispetto alle richieste di competenza di lettura dei testi e di riflessione sulla lingua, elementi che sono oggetto di valutazione da parte dell’INVALSI.
Lo spirito del volume è invitare ciascuno, oltre che a esercitarsi, a riflettere sul proprio modo di condurre il compito da svolgere perché possa, adeguatamente sostenuto dall’insegnante in questa fase di preparazione, riconoscere e valorizzare meglio i propri punti di forza e controllare e minimizzare invece gli aspetti critici del suo essere studente, primo tra essi e comune a molti l’emotività: l’esercizio stesso e soprattutto riflettere sul come lo si fa aiutano ad alleggerire il momento della Prova nazionale dall’ansia e dagli elementi di contesto che potrebbero condizionare negativamente la sua prestazione.
Gli allenamenti e la prova simulata sono disponibili sul Libro digitale in versione digitale CBT (Computer Based Training), per permettere di acquisire familiarità e dimestichezza con la procedura della Prova nazionale INVALSI.
Sul Libro digitale si trova anche un utile compendio per avere sempre a portata di mano tutte le conoscenze di base.
La prima sezione si apre con una serie di esercitazioni propedeutiche: una prova del primo quadrimestre, pensata per essere svolta nella prima parte dell’anno, un allenamento per apprendere il metodo e una prova ufficiale guidata, in cui ogni domanda è accompagnata da un commento che guida nella comprensione della richiesta e nella risoluzione del quesito.
L’allenamento guidato si basa su un approccio risolutivo in tre passaggi, utile per acquisire un metodo per affrontare tutti i quesiti presenti negli allenamenti, nella prova simulata e, in generale, nella Prova nazionale INVALSI.
Si consiglia di svolgere in classe questo allenamento guidato, per analizzarlo e commentarlo insieme in modo da aiutare la classe a cogliere la ricorsività dei passaggi proposti.
Seguono sei allenamenti pensati per poter essere svolti in classe nel corso di un’ora di lezione. Ciascun allenamento è composto di 20 quesiti così divisi: 15 quesiti di comprensione della lettura su brani di varie tipologie testuali; 2 quesiti di lessico; 3 quesiti di riflessione sulla lingua.
1 D.lgs n.62/2017: Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
Circolare 1865 del 10 ottobre 2017: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Nota 2936 del 20 febbraio 2018: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.
D.M. 741 del 3 ottobre 2017: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
D.M. 742 del 3 ottobre 2017: Finalità della certificazione delle competenze.
Gli allenamenti proposti sono finalizzati alla puntualizzazione dell’esercizio delle competenze relative all’italiano secondo quanto testato dall’INVALSI in relazione a una precisa tipologia testuale. Essi restituiscono perciò in primo luogo un livello di competenza a chi li svolge; è possibile però, per la maggiore familiarità che gli alunni e le alunne hanno con la valutazione numerica dei propri elaborati, mostrare la corrispondenza del livello INVALSI raggiunto con un voto espresso in decimi. Forse è superfluo ricordare in questa sede che la competenza si dà o no e che essa si esprime in modo positivo, quindi (in sintesi e per semplicità) in ordine alla valutazione degli allenamenti, è possibile identificare il livello soglia di sufficienza in quello che si ottiene con 12 risposte corrette (su un totale di 20), delle quali 10 relative alla Comprensione del testo (su un totale di 15) e 2 relative a Lessico/Riflessione sulla lingua (su un totale di 5). In questo modo si possono assegnare 12 punti, ovvero un voto in decimi pari a 6. Per le ulteriori risposte corrette, di qualsiasi tipo, successive alle prime 12 vengono assegnati punti in più secondo la seguente tabella, l’ultima colonna della quale riporta la corrispondenza al livello INVALSI.
La sezione si conclude con una prova simulata completa da svolgere in 90 minuti, il tempo stabilito dall’INVALSI: sono proposti per la lettura 4 testi, di tipologia diversa, con 8 domande di comprensione per ciascun testo; seguono 3 domande di lessico e 5 di riflessione sulla lingua.
Per la prova simulata non è prevista la possibilità di avere un voto espresso in decimi, essendo i singoli descrittori afferenti a ciascun livello di competenza opportunamente distribuiti nelle singole parti che compongono l’intera prova.
Comprensione della lettura 1
Comprensione della lettura 2
Comprensione della lettura 3
Comprensione della lettura 4
Lessico
Riflessione sulla lingua
Totale prova
Livello di competenza
Punti: …/8
Punti: …/8
Punti: …/8
Punti: …/8
Punti: …/3
Punti: …/5
Punti: …/40
Livello: …/5
Questa sezione si compone di cinque parti:
• una prova del primo quadrimestre;
• un allenamento guidato per apprendere il metodo;
• una prova ufficiale guidata;
• sei allenamenti;
• una prova simulata completa.
Rosa Dream Catcher (Cacciatrice di Sogni), miniatura dai piccoli fiori di colore rosa confetto che tende al camoscio verso il centro. L’arbusto, rifiorente, raggiunge al massimo i 75 cm di altezza: viste le sue dimensioni ridotte, la rosa è adatta alla coltivazione in vaso.
«Più tempo trascorro immersa nella matematica, più mi entusiasmo.»
Maryam Mirzakhani voleva fare la scrittrice. Da piccola, quando usciva da scuola, le piaceva andare a comprare ogni genere di romanzo. Siamo a Teheran nel 1989, e la guerra tra Iraq e Iran è appena terminata. Maryam si considera una bambina fortunata: ha appena finito le elementari e l’aria nuova che si respira nel Paese le permette di scegliere una buona scuola per continuare gli studi con orgoglio. Non è portata per la matematica, preferisce scrivere e immaginare storie, ma quando intravede le meravigliose avventure che si nascondono in una forma geometrica, meglio se inusuale e iperbolica, scopre una nuova passione, persino più travolgente della letteratura. Qualche professore ammuffito una volta ha dichiarato che le donne non sono portate per la matematica. È stato ricoperto di repliche sarcastiche dalle scienziate di tutto il mondo, ma i pregiudizi vengono da lontano e faticano a morire. Eppure Maryam non si ferma davanti a niente e continua i suoi studi con entusiasmo, tanto che a 17 anni ha già vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi internazionali di Matematica di Hong Kong. Un’emozione incredibile per una ragazzina che sembra uno scricciolo ma con grandi occhi verdi, due fanali spalancati sul mondo. Maryam vede la bellezza nella matematica e attraversa i problemi come un’esploratrice nella giungla, scovando sempre nuovi sentieri invisibili ai più. «Per la maggior parte del tempo fare matematica per me è come una lunga escursione senza un sentiero tracciato né un traguardo visibile.» Nei tanti filmati che la ritraggono durante le sue affollatissime lezioni, quando Maryam disegna sulla lavagna infinite formule matematiche e figure geometriche per noi profani totalmente misteriose, intuiamo l’immensa gioia che le procura questa totale immersione nella ricerca, e rimaniamo estasiati dal guizzo intelligente del suo sguardo ispirato. Si definisce «lenta» ma − potremmo aggiungere − «implacabile» perché non molla mai la presa e arriva sempre in cima alla montagna dove l’orizzonte, alla fine, appare chiaro e comprensibile per tutti.
E proprio la scalata di una di queste cime le vale, nel 2014, a soli trentasette anni, la medaglia Fields: il premio più ambito per un matematico. Maryam è la prima e finora l’unica donna al mondo ad aver conquistato questo prestigioso riconoscimento che equivale al Nobel. Per avere un’idea dell’importanza di questa affermazione bisogna pensare che fino agli anni Sessanta nella democratica America le ragazze non erano ancora ammesse ai dottorati in matematica. Mirzakhani è una piccola pioniera che con il suo esempio ha autorizzato tutte le donne che scelgono questo campo a sentirsi più forti e coraggiose; non tanto per affrontare gli studi, ma per sfidare il bombardamento di pregiudizi che le aspetta al varco. Maryam è una combattente paziente: «Magari parte piano − come fa quando va a correre − ma poi arriva prima di tutti», così racconta il marito, un altro supermatematico che l’ha incontrata alla prestigiosa Università di Stanford, dove la scienziata si era guadagnata una cattedra e insegnava dal 2008.
Purtroppo tra tante scalate e battaglie vinte Maryam ha perso il combattimento più insidioso e subdolo della sua vita. Un cancro al seno se l’è portata via il 15 luglio 2017, a soli quarant’anni, con una montagna di progetti ancora da realizzare. Mirzakhani era già malata quando le hanno annunciato la vittoria della medaglia Fields, e ha dubitato a lungo se presenziare alla cerimonia di premiazione, aveva appena concluso un ciclo di chemioterapia e temeva di non avere la forza di affrontare lo stress mediatico. Ma la fisica belga Ingrid Daubechies, all’epoca presidentessa dell’Unione Matematica Internazionale, organizza per lei un gruppo di amiche scienziate che si impegna a proteggerla e sostenerla per tutta la durata dell’evento: una vera task force che scherzosamente verrà ricordata come la M.M. Shield, ovvero «lo scudo di Maryam Mirzakhani». Un bell’esempio di solidarietà femminile che ha permesso alla vincitrice di godersi il meritato trionfo in tutta tranquillità. Maryam va ricordata per tutti i motivi che vi ho raccontato e anche perché rappresenta un meraviglioso esempio di come vorremmo il futuro delle ragazze e dei ragazzi del mondo: liberi di volare senza barriere né confini, grazie alle ali del merito e del talento.
Come instancabile «cacciatrice di sogni», le spetta senza ombra di dubbio la rosa Dream Catcher.
da S. Dandini, Il catalogo delle donne valorose, Mondadori
AREA 1 Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo
1 Dove trascorre l’infanzia Maryam?
A Iraq.
B Teheran.
2 Quale desiderio ha Maryam da bambina?
A Creare e coltivare rose.
B Insegnare matematica.
C Fare la scrittrice.
D Fare la scalatrice.
C Stanford.
D Hong Kong.
3 Quale competizione vince Maryam a 17 anni?
A La scalata del Monte Fields.
B Le Olimpiadi internazionali di Matematica di Hong Kong.
C Le Olimpiadi internazionali di Geometria di Stanford.
D Il Nobel per la Matematica a Oslo.
4 A che cosa è riferita l’espressione «fanali spalancati sul mondo» (riga 20 )?
A Alle luci che illuminano gli studi di Maryam.
B Alla capacità di Maryam di capire la matematica.
C Alla curiosità di Maryam.
D Agli occhi di Maryam.
5 A che età Maryam vince la medaglia Fields?
A Dodici anni.
B Diciassette anni.
C Trentasette anni.
D Quaranta anni.
6 Dove ha insegnato Maryam dal 2008?
A All’Università di Stanford.
B All’Università di Teheran.
C All’Università di Hong Kong.
D All’Università di Fields.
7 Chi è la presidentessa dell’Unione Matematica Internazionale?
A Belga Nobel.
B Ingrid Daubechies.
8 Che cosa non è la «M.M. Shield»?
C Rosa Catcher.
D Maryam Mirzakhani.
A Una task force che protesse e sostenne Maryam per tutta la durata dell’evento relativo al conferimento della medaglia Fields.
B Un gruppo di amiche di Maryam: è un esempio di solidarietà femminile perché grazie a loro la matematica poté partecipare alla cerimonia di premiazione della medaglia Fields.
C Il gruppo di scienziate, amiche di Maryam, che fanno parte dell’Unione Matematica Internazionale: accompagnano le socie a ritirare la medaglia Fields.
D Il gruppo di scienziate, amiche di Maryam, che l’hanno accompagnata a ritirare la medaglia Fields.
9 Come definisce se stessa Maryam?
A Lenta.
B Lenta ma implacabile.
C Combattente paziente.
D Instancabile cacciatrice di sogni.
10 Quale varietà di rosa, coltivabile in vaso, raggiunge l’altezza massima di circa 75 cm e ha i fiori piccoli e rosa confetto?
Dream Catcher
Attenzione!
La domanda chiede che cosa non è la M.M. Shields.
Attenzione!
C’è una differenza tra come Maryam definisce sé stessa e come la definisce l’autrice del testo.
2 Ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale
11 Qual è l’inclinazione di Maryam da bambina?
A L’esplorazione delle foreste.
B La matematica e la geometria.
C La scrittura di storie che immagina.
D La lettura dei romanzi d’avventura.
12 Quale primato ha Maryam?
A È stata la prima donna a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica di Hong Kong.
B È stata la prima donna a vincere la medaglia Fields.
C È stata la prima e unica donna a vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica di Hong Kong e la medaglia Fields.
D È stata l’ultima scienziata iraniana a vincere la medaglia Fields.
13 In che anno è nata Maryam? ....................................................................................................................
14 Perché Maryam può continuare a studiare dopo le elementari?
A Perché la guerra è finita e in Iran c’è una situazione di relativa tranquillità.
B Perché la guerra è finita e in Iraq c’è una situazione di relativa tranquillità.
C Perché la sua famiglia ha lasciato le zone di guerra per una zona pacificata.
D Perché la famiglia di Maryam è ricca e può pagare una buona scuola, anche se c’è ancora la guerra tra Iran e Iraq.
15 Che cosa significa che Maryam «è una piccola pioniera» (righe 34-35 )?
A Significa che la sua vicenda è un esempio per tutte le scienziate del mondo.
B Significa che la sua vicenda ha insegnato ad altre donne ad affrontare i pregiudizi della comunità scientifica.
C Significa che la sua vicenda ha aiutato altre donne a intraprendere studi di tipo scientifico e a resistere ai pregiudizi che ci sono in questo campo.
D Significa che la sua vicenda ha incoraggiato altre donne a intraprendere studi di tipo scientifico.
16 Qual è l’esatta successione cronologica delle «vittorie» di Maryam Mirzakhani?
A Cattedra a Stanford, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica di Hong Kong, medaglia Fields.
B Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica di Hong Kong, cattedra a Stanford, medaglia Fields.
C Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica di Hong Kong, medaglia Fields, cattedra a Stanford.
D Medaglia Fields, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica di Hong Kong, cattedra a Stanford.
17 Perché Maryam non va da sola a ricevere la medaglia Fields?
A È convalescente da un ciclo di terapie mediche.
B È stanca.
C Non è in grado di affrontare il viaggio.
D Non vuole ricevere il premio.
18 Qual è l’argomento del brano?
A Le teorie matematiche di Maryam Mirzakhani.
B La vita di Maryam Mirzakhani e ciò che essa può significare.
C L’opera di Maryam Mirzakhani.
D I premi che Maryam Mirzakhani ha vinto.
19 Che cosa provoca a Maryam Mirzakhani un’«immensa gioia» (righe 25-26 )?
A Il fatto di poter scrivere moltissime formule sulla lavagna.
B Il fatto di essere ammirata dai suoi studenti.
C Il fatto di non essere compresa da nessuno, se non dai suoi studenti.
D Il fatto di essere totalmente immersa nella ricerca. 1977
Attenzione!
È un pioniere chi si lancia per primo in un’iniziativa, o chi diffonde per primo un’idea.
20 Quale pregiudizio ha «qualche professore ammuffito» (riga 15 )?
A Le donne non sono portate per le scienze.
B Le donne non sono portate per la matematica.
C Le donne non sono portate per lo studio in generale, per la matematica e le scienze in particolare.
D Le donne sono portate per la letteratura, l’arte e i romanzi d’amore.
sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli
21 Com’è il linguaggio del testo che hai letto?
A Semplice, familiare, senza termini ricercati.
B Apparentemente semplice, ma con termini selezionati e a volte ricercati.
C Abbastanza difficile perché presenta pochi termini semplici e di uso comune.
D Difficile perché presenta molti termini ricercati e appartenenti al linguaggio scientifico.
22 Qual è il legame tra la Dream Catcher e Maryam Mirzakhani?
A Dream Catcher è il nome di uno dei riconoscimenti che la protagonista del brano ha ricevuto nel corso della sua vita.
B Dream Catcher e M.M. Shield sono i nomi di due gruppi di scienziate dei quali la protagonista ha fatto parte nel corso della sua vita.
C Secondo l’autrice del brano, la vicenda biografica della protagonista può essere associata a questa varietà di rosa.
D Secondo l’autrice del brano, a Maryam Mirzakhani può essere attribuita la creazione di questa varietà di rosa.
23 Qual è lo scopo del brano che hai letto?
A Mostrare un esempio di come l’autrice vorrebbe che fosse il futuro dei giovani di tutto il mondo.
B Fornire un esempio di come l’autrice non vorrebbe che fosse il futuro dei giovani di tutto il mondo.
C Mostrare un esempio di come l’autrice pensa possa essere stato il passato dei giovani di tutto il mondo.
D Fornire un esempio di quello che l’autrice vorrebbe che i giovani di tutto il mondo non facessero per il loro futuro.
24 La disposizione degli elementi del testo è funzionale alla narrazione?
A Sì: il cappello introduttivo relativo alla rosa introduce alla reale protagonista della vicenda narrata, la Dream Catcher.
B No: il cappello introduttivo relativo alla rosa è un pretesto che l’autrice inserisce solo a scopo estetico, per riempire la pagina.
C Sì: il cappello introduttivo relativo alla rosa è richiamato alla fine del testo.
D No: il cappello introduttivo relativo alla rosa resta fine a se stesso.
Attenzione!
Per rispondere puoi chiederti: di quante parole non conoscevo il significato? Ho fatto fatica a comprendere il testo?
25 In quale parte di testo è individuabile, isolato, il tratto più importante del carattere della protagonista?
A Nel cappello introduttivo.
B Nella citazione tra il cappello introduttivo e il brano.
C All’inizio del brano: «Maryam Mirzakhani voleva fare la scrittrice».
D Nell’ultimo capoverso del brano: «Come instancabile…».
26 Come definisce Maryam il suo fare ricerca matematica?
A Un’avventura nella giungla.
B Una lunga escursione.
C Una scalata.
D Un’immensa gioia.
27 A che cosa è paragonata Maryam quando studia i problemi? (quattro parole)
Un’esploratrice nella giungla.
28 Quale figura retorica è presente nell’espressione «i pregiudizi vengono da lontano e faticano a morire» (righe 16-17 )? (una parola)
Personificazione.
29 Quale figura retorica è presente nell’espressione «le ali del merito e del talento» (riga 54 )?
A Similitudine.
B Metafora.
C Paronomasia.
D Personificazione.
30 Il testo che hai letto narra anche di un tragico punto di svolta nella vicenda personale di Maryam: all’apice della sua ricerca scientifica infatti morirà, molto giovane e con molti altri progetti da portare avanti. Quale indicatore sintattico lo segnala nel testo (riga 41 )?
A Il nome sottinteso «Mirzakhani».
B Il nome «Maryam».
C L’aggettivo «Purtroppo».
D L’avverbio «Purtroppo».
31 Quale tra quelle proposte è la corretta grafia?
A Taque.
B Tacqe.
C Tacque.
D Taccue.
32 Nella seguente frase: «Laura ne ha combinata un’altra delle sue», la parola sottolineata è:
A un aggettivo possessivo.
B un aggettivo qualificativo.
C un pronome possessivo.
D un pronome identificativo.
Attenzione! Conta anche gli articoli e le preposizioni.
33 In quale delle seguenti parole le sillabe «anti-» non hanno valore di prefisso?
A Antipodi.
B Antichità.
C Antisismico. D Antimeridiano.
34 Quale tra i seguenti non è un nome composto?
A Piattaforma.
B Altoforno.
C Francobollo.
D Sempreverde.
35 Qual è il modo del verbo nella frase «Non fate rumore»?
A Indicativo.
B Imperativo.
C Futuro. D Infinito.
36 Nella frase «Volesse il cielo che tu possa partire con Marco!» i soggetti sono:
A ce n’è solo uno: «tu».
B «il cielo» e «tu».
C «volesse» e «tu».
D «tu» e «Marco».
37 In quale delle seguenti frasi non è presente il complemento di termine?
A Chi ti ha offeso?
B Mi piace ascoltare della buona musica classica.
C Hai creduto alle sue parole ciecamente.
D La cassiera mi ha consegnato uno scontrino sbagliato.
38 Nella frase «Vorrei offrirti un gelato alla crema con gocce di cioccolato e variegatura alla menta» è presente:
A un predicato nominale, ossia «vorrei offrir-ti».
B un solo predicato verbale, ossia «vorrei offrir-».
C due predicati verbali, ossia «vorrei» e «offrir-».
D un predicato verbale, «vorrei», e un predicato nominale, «offrir-ti».
39 Se leggendo la frase «Le ragazze belghe sono biondissime e di solito si spostano in bicicletta» non conoscessi il significato delle parole sottolineate, quali voci dovresti cercare nel dizionario?
A Belga, bionda, spostare.
B Belgio, biondo, spostare.
C Belga, biondo, spostare.
D Belgi, biondo, spostarsi.
40 In quale frase la punteggiatura è usata in modo corretto?
A Giovanna, la ragazza che è stata appena assunta, all’ufficio postale di Jesolo, si è appena laureata in lingue orientali a Venezia.
B Giovanna, la ragazza che è stata appena assunta all’ufficio postale di Jesolo, si è appena laureata in lingue orientali a Venezia.
C Giovanna la ragazza, che è stata appena assunta all’ufficio postale di Jesolo, si è appena laureata in lingue orientali a Venezia.
D Giovanna, la ragazza che è stata appena assunta all’ufficio postale di Jesolo si è appena laureata in lingue orientali a Venezia.
Attenzione!
Per aiutarti pensa alla radice delle parole (la parte iniziale), che non è variabile.
Il primo allenamento che proponiamo è guidato: ti forniremo una serie di strategie e suggerimenti per affrontare le domande, per acquisire un metodo che potrai poi utilizzare negli altri allenamenti, nella prova simulata e, soprattutto, nella Prova INVALSI ufficiale. Cerca di svolgere con attenzione questo allenamento e confrontati con l’insegnante nel caso di dubbi su come procedere o per chiarimenti.
Durante la Prova INVALSI è importante controllare e utilizzare al meglio il tempo che hai a disposizione: capire bene le domande e applicare alcune strategie per individuare la risposta corretta, ti permetterà di gestire il tempo in modo efficace.
Per questo ti proponiamo un metodo articolato in tre semplici passi, che abbiamo visualizzato con delle icone:
Leggi bene la domanda; rileggila e focalizzati sulle parole-chiave o sugli elementi centrali; chiediti che cosa significano e a che cosa rimandano.
Leggi con attenzione le risposte date, se ci sono; torna sul brano letto, soprattutto se nella domanda sono indicate righe di riferimento. Ipotizza la risposta corretta.
Fai un ultimo controllo sulle risposte che hai scartato per verificare che in esse siano presenti elementi non appropriati alle richieste poste dalla domanda.
Iniziamo? Per prima cosa leggi il brano e poi rispondi alle domande seguendo i suggerimenti. Vedrai che sarà tutto più semplice.
Quando mi ritrovai in possesso di una facoltà così strabiliante, esitai a lungo sul come utilizzarla. Avevo la capacità di infondere la vita, tuttavia preparare un corpo, con i suoi intrichi di vene, muscoli e fibre, atto a riceverla restava pur sempre un’impresa difficile, una fatica improba. Mi domandai dapprima se dovessi tentare la creazione di un essere come me o di struttura più semplice, ma la mia immaginazione, infiammata dal successo, non mi faceva dubitare di riuscire a dar vita a un animale complesso e meraviglioso come l’uomo. Anche se i materiali a mia disposizione in quel momento sembravano inadeguati a questa ardita impresa, ero fiducioso che sarei arrivato alla meta. Mi preparai ad affrontare una quantità di rovesci: i miei tentativi potevano risultare vani e la mia opera alla fine rivelarsi imperfetta ma, considerando i progressi che si verificano ogni giorno in campo scientifico, mi sentivo incoraggiato a tentare; avrei, se non altro, gettato le basi per un successo futuro. Neppure la vastità e la complessità del progetto erano argomentazioni sufficienti a farmi considerare inattuabile quanto mi proponevo. Con questi sentimenti intrapresi la creazione di un essere umano. Poiché le piccole dimensioni costituivano un grave intralcio alla rapidità del mio lavoro decisi, contrariamente alla mia prima intenzione, di costruire un essere gigantesco, alto circa otto piedi e di corporatura in proporzione. Stabilito questo punto, e dopo alcuni mesi impiegati a radunare e predisporre il materiale occorrente, cominciai. Fu in una tetra notte di novembre che vidi il compimento delle mie fatiche. Con un’ansia simile all’angoscia radunai gli strumenti con i quali avrei trasmesso la scintilla della vita alla cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già l’una del mattino; la pioggia batteva lugubre contro i vetri, la candela era quasi consumata quando, tra i bagliori della luce morente, la mia creatura aprì gli occhi, opachi e giallastri, trasse un respiro faticoso e un moto convulso ne agitò le membra. Come posso descrivere la mia emozione a quella catastrofe, descrivere l’essere miserevole cui avevo dato forma con tanta cura e tanta pena? Il corpo era proporzionato e avevo modellato le sue fattezze pensando al sublime. Sublime? Gran Dio! La pelle gialla a stento copriva l’intreccio dei muscoli e delle vene; i capelli folti erano di un nero lucente e i denti di un candore perlaceo; ma
queste bellezze rendevano ancor più orrido il contrasto con gli occhi acquosi, grigiognoli come le orbite in cui affondavano, il colorito terreo, le labbra nere e tirate.
La vita non offre avvenimenti tanto mutevoli quanto lo sono i sentimenti dell’uomo. Avevo lavorato duramente per quasi due anni al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo avevo rinunciato al riposo e alla salute. L’avevo desiderato con intensità smodata, ma ora che avevo raggiunto la meta il fascino del sogno svaniva, orrore e disgusto infiniti mi riempivano il cuore. Incapace di sostenere la vista dell’essere che avevo creato, fuggii dal laboratorio e a lungo camminai avanti e indietro nella mia camera da letto, senza riuscire a dormire.
da M. Shelley, Frankenstein, trad. di M. P. Saci e F. Troncarelli, Garzanti
1 L’impresa che il narratore sta per compiere è definita «una fatica improba» (riga 3 ).
Che cosa significa?
A Che l’impresa è molto faticosa ma semplice.
B Che l’impresa è facile e avrà successo.
C Che l’impresa è degna di un premio.
D Che l’impresa è molto difficile e complessa.
Parole-chiave: «impresa» riferita al «narratore» e «fatica improba» riferita a «impresa». L’impresa del narratore è una fatica, qualcosa di difficile per qualche aspetto. Per spiegare perché è anche «improba» dobbiamo conoscere il significato di questa parola. Non avendo a disposizione il dizionario, si deve far ricorso al testo, in particolare alle frasi in cui il termine compare.
Il narratore dice di aver lavorato a lungo alla sua impresa, che ha avuto dei problemi nel compierla, infatti la definisce «una fatica». Le risposte da scartare, alla luce di quanto si ricorda, sono per ora solo una: la B.
2 Di quale facoltà è in possesso il narratore?
A Preparare un corpo umano.
B Infondere la vita.
Parole-chiave: «facoltà» e «narratore»; la prima rimanda a una qualità della mente, indica che si è capaci di fare qualcosa; «narratore» è un elemento tecnico e indica la voce che racconta la storia.
Il narratore in questo testo è un uomo che ha fatto un esperimento: ha creato un essere umano. Le risposte che soddisfano la prima impressione avuta
Dalla rilettura del testo però, alla riga 3 , si trova che l’«impresa», descritta come «difficile», è definita anche «una fatica improba», espressione questa dalla quale risulta separata da una virgola: quindi «improba» deve significare qualcosa di simile a «difficile». Considera quindi come risposta esatta la D.
Qui controllare le risposte scartate è utile: se l’«impresa» è definita «difficile», cade subito la risposta A perché non può essere «semplice»; d’altra parte, non essendoci traccia nel testo di premi per questa «impresa», anche la risposta C è sicuramente da eliminare.
C Impressionare la comunità scientifica.
D Resistere alle fatiche.
dalla lettura sono la A e la B e la «migliore» è la B. Rileggendo il testo, infatti, alla riga 2 c’è scritto: «avevo la capacità di infondere la vita».
In questo caso, avendo trovato alla riga 2 le parole precise di una delle possibili risposte, ogni controllo ulteriore è superfluo. Risparmia il tempo per i prossimi quesiti.
3 Per quanto tempo il narratore ha lavorato alla sua impresa? (tre parole)
Quasi due anni.
Parole-chiave: «quanto tempo» riferito al «narratore» e «alla sua impresa». È prevista una risposta aperta: significa che la ricognizione sul testo dovrà essere molto precisa e orientata al reperimento delle indicazioni temporali.
Dalla rilettura del testo si trova, dopo qualche indicazione di orario puntuale e di durata, alla riga 29 , esplicitamente scritto che il narratore ha lavorato al suo progetto per «quasi due anni».
Sono richieste tre parole: «quasi due anni» è corretto anche dal punto di vista della forma ed è risposta esatta.
4 Quale «ardita impresa» sta per compiere il narratore?
A Riprodurre in laboratorio vene, muscoli e fibre.
B Creare un essere vivente.
C Creare un essere umano.
D Collaborare alla creazione di un essere umano.
Parole-chiave: «narratore» e «ardita impresa» da compiere. Visto che ci sono delle parole tra virgolette, cerca l’espressione nel testo per risalire a ciò a cui si riferisce dal contesto.
«Ardita impresa» richiama l’«impresa difficile» e la «fatica improba» della riga 3 : questa espressione si riferisce allora alla medesima impresa, cioè alla creazione di un essere umano. Nel testo, l’espressione «ardita impresa» si trova alla riga 7 ed è riferita
alla creazione di un essere umano, come si legge alla riga 13 : dunque la risposta esatta è la C.
Rileggendo le possibili risposte, la A rimanda a una fase dell’«impresa», la B è troppo generica, la possibilità infine che qualche altro scienziato stia lavorando alla medesima impresa è esclusa dalle righe 10-11 dove si fa riferimento a «gettare le basi per un successo futuro».
5 Perché secondo il narratore è più facile costruire un essere gigantesco?
A Perché le dimensioni ridotte rallentano il lavoro.
B Perché sulle grandi dimensioni si notano di meno gli eventuali difetti.
C Perché le dimensioni ridotte richiedono una vista acutissima.
D Perché è più facile trovare parti di grandi dimensioni da unire.
Parole-chiave: «narratore», «essere gigantesco» e «più facile costruire». Con questi riferimenti, torna sul testo.
Alla riga 14 si trova esplicitata la decisione del narratore di «costruire un essere gigantesco», «contrariamente» alla sua prima intenzione. Per conoscere il perché risali alle righe 13-14 : le piccole dimensioni rallentano il lavoro.
La risposta giusta è dunque la A.
Fondata la scelta sulle righe 13-14 , le risposte B e D cadono immediatamente perché si riferiscono a vantaggi legati alle grandi dimensioni, mentre la C va scartata presentando essa un dettaglio che potrebbe essere fonte di rallentamento ma non ha riscontro nel testo.
6 Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.
a. Il narratore è uno scienziato.
b. Il narratore pensa che il suo progetto sia inattuabile.
c. Il narratore impiega pochi giorni a radunare e predisporre il materiale occorrente per la sua impresa.
d. Il narratore crede nei progressi della scienza.
Parole-chiave: in questo caso, per ciascuna affermazione va fatta un’analisi. Gli elementi da considerare per rispondere sono: «narratore» (item a), «progetto» (b), «materiale occorrente» (c), «progressi della scienza» (d). Si può rispondere solo vero o falso, ma anche in questo caso la ricerca delle informazioni o degli elementi che permettano di dedurre se quanto affermato è vero o falso, va fatta riconsiderando il testo nel dettaglio e in generale.
item a) vero: alle righe 2-3 pare verosimile che il narratore sia un medico, alle righe 9-10 si fa
riferimento ai progressi che si registrano in campo scientifico e che lo incoraggiano a tentare; tutti questi elementi ci autorizzano a rispondere «vero». item b) falso: alle righe 7 e 10 si dice che il narratore è incoraggiato a tentare la sua impresa. item c) falso: si trova informazione esplicita contraria alla riga 16 . item d) vero: dalla riga 9 alla 12 si evince che il narratore ha fiducia nel progresso scientifico.
In questo caso, il riscontro è già implicito nella scelta della risposta corretta.
7 Completa la seguente affermazione nel modo corretto. (due parole)
più difficile
Rispetto all’impresa che sta per compiere, il narratore pensa che è preparare un corpo in grado di ricevere la vita che infondere in esso la vita stessa.
Parole-chiave: «completa». Per rispondere correttamente bisogna analizzare il testo da completare: è presente una comparazione introdotta da «che» («che infondere»), quindi dovrai riflettere sulla relazione che lega i termini espressi («preparare un corpo»; «infondere la vita») per trovare il completamento corretto.
Le righe 2-3 sono quelle utili per dare la risposta corretta: il narratore ha la capacità di «infondere la vita» ma considera «un’impresa difficile» «preparare un corpo… atto a riceverla». Dunque la risposta da scrivere è «più difficile».
Il controllo qui sarà guidato dalla domanda: si può esprimere lo stesso concetto in un altro modo? Si può essere più precisi?
8 Nel testo il narratore si riferisce a una tecnica di riproduzione degli organismi viventi (molto amata dagli autori di romanzi di fantascienza). Quale?
A Partenogenesi
B Clonazione.
Parole-chiave: «tecnica di riproduzione degli organismi viventi». Dove se ne parla nel testo?
Le possibili risposte propongono termini non presenti nel testo, quindi, oltre a rintracciare passaggi utili a definire la risposta, dovrai fare ricorso al tuo personale patrimonio culturale. Alle righe 4-5 si parla di creazione di un essere «come me»; alcuni termini sono riconoscibili come appartenenti al campo delle scienze e anche della letteratura di fantascienza; uno, quello della risposta C, sembra inventato.
C Propagazione clonale.
D Meiosi.
Lasciando cadere C, tra gli altri tre possibili, quello usato anche in fantascienza è B perché «clonazione» è l’unico termine in cui i due aspetti richiesti dalla domanda (essere tecnica di riproduzione degli organismi viventi e uso frequente nella letteratura di fantascienza) sono presenti.
In questo caso, ciò che porta a escludere le altre risposte è il fatto che manca loro uno degli aspetti richiesti.
F
F
9 Quale delle seguenti frasi riassume meglio il significato generale del brano letto?
A Il narratore racconta la sua esperienza di vita come scienziato.
B Il narratore racconta un esperimento che ha condotto in passato.
C Il narratore vuole convincere il lettore che ogni giorno si verificano numerosi progressi in campo scientifico.
D Il narratore spiega al lettore un’importante scoperta scientifica.
Parole-chiave: «frasi», «riassume» e «significato generale».
Trattandosi di «significato generale» del testo, valuta le possibili risposte in termini di maggiore o minore aderenza all’intero testo: ciò di cui il testo narra è un esperimento, dunque la risposta corretta è B.
Se si considerano le risposte A e D, esse sono, rispettivamente, troppo vasta («esperienza di vita») e troppo circoscritta («un’importante scoperta»). La risposta C infine non trova fondamento nel testo.
10 Qual è l’atmosfera della notte in cui lo scienziato tenta l’esperimento?
A Carica di tensione.
B Allegra e spensierata.
C Non si avverte nulla di particolare.
D Attesa fiduciosa.
Parole-chiave: «atmosfera», «notte», «esperimento». Dove si combinano le informazioni relative all’esperimento e alla notte per permetterti di capire qual era l’atmosfera?
Alla riga 17 si legge «tetra notte», alle righe dalla 19 alla 21 sono descritti altri elementi utili a creare l’atmosfera di quella notte: l’ora (una del mattino), la pioggia, l’illuminazione della stanza (la
11 Chi è Frankenstein?
luce della candela). Inoltre, alle righe 17-18 , il narratore parla di «ansia» simile ad «angoscia». Facendo dunque le somme, la risposta giusta è la A.
Da quanto raccolto e dedotto sopra, il riscontro della non esattezza delle risposte B, C e D è immediato: nessun elemento presentato nel testo va nella direzione delle risposte B e C; riguardo invece alla possibilità D, essa è cancellata dalle righe 17-18 .
A Lo scienziato: è anche il narratore interno della storia.
B Lo scienziato: è anche l’antagonista della creatura.
C La creatura: è anche il narratore della storia.
D Lo scrittore e narratore della storia.
Parole-chiave: il nome «Frankenstein» e la domanda «Chi è?». Controlla le possibili risposte.
«Frankenstein» è citato solo nel titolo del brano. Tra le possibili risposte l’unica plausibile è A perché se un nome compare nel titolo, esso è riferito a qualcuno di importante nella storia: in questo caso l’unica figura importante è lo scienziato, che è anche il narratore.
Per escludere con certezza le altre risposte è necessario fare ricorso agli elementi di narratologia studiati nel corso del triennio.
Quindi: la risposta B non è corretta perché, pur potendosi chiamare Frankenstein, lo scienziato non è l’antagonista della creatura; non è corretta la risposta C perché, pur potendosi chiamare Frankenstein, la creatura non è il narratore; infine, non è corretta neppure la risposta D perché scrittore e narratore non coincidono, come si legge anche nella nota in calce al testo.
12 Quale effetto ha sul narratore la sua creatura?
A Ne è entusiasta.
B Ne è impaurito.
Parole-chiave: «effetto sul narratore» e «creatura». C’è una parte di testo dalla quale si può comprendere quale effetto ha suscitato la creatura nel narratore?
La seconda parte del testo (righe 17-27 ) e l’ultimo capoverso (righe 28-33 ) permettono di scegliere la risposta C come esatta: le riflessioni del narratore giustificano la scelta fatta.
13 Che aspetto ha la creatura?
C Ne è profondamente turbato.
D Non riesce neanche a guardarla.
Dalle righe esaminate nel testo appare evidente che le risposte A e D sono infondate, mentre la B, pur verosimile (riga 32 : «fuggii dal laboratorio»), non è tuttavia corretta per il fatto che tale fuga non è espressamente messa in relazione con il fatto che la creatura fosse animata, e anzi tutti gli aggettivi presenti in questo segmento di testo descrivono il campo semantico del disgusto e dell’orrore per qualcosa di mostruoso.
A È gigantesca, ha la pelle gialla, capelli neri e radi, occhi acquosi, colorito terreo e labbra nere.
B È minuta, ha la pelle gialla, capelli neri e folti, occhi opachi e giallastri, colorito terreo e labbra nere.
C È gigantesca, ha la pelle di un candore perlaceo, capelli neri e folti, occhi opachi e giallastri, colorito terreo e labbra nere.
D È gigantesca, ha la pelle gialla, capelli neri e folti, occhi opachi e giallastri, acquosi e grigiognoli, colorito terreo e labbra nere.
Parole-chiave: «aspetto» e «creatura». Quale immagine ho in mente della creatura? Da quali parti di testo si è formata nella mia immaginazione?
Rintraccia nel testo gli elementi che descrivono la creatura: righe 14-15 («essere gigantesco…»), righe 20-21 («gli occhi opachi...») e righe 24-25 («La pelle gialla…»). Cerca tra le possibili risposte quella in cui compare la descrizione più precisa: si trova nella D.
Per escludere la risposta B basta la parola «minuta» perché la creatura è gigantesca; riguardo alla risposta A, pur essendo corretta, è meno completa della D; la risposta C infine non è corretta perché confonde degli elementi («pelle di candore perlaceo»: nel testo tale colore è attribuito ai denti).
14 Quale figura retorica è presente nell’espressione «luce morente» (riga 20 )?
A Metafora.
B Similitudine.
C Personificazione.
D Nessuna figura retorica.
Parole-chiave: «figura retorica» e «luce morente». Per rispondere va studiata l’espressione «luce morente»: è necessario ricostruirne il significato per definire di quale figura retorica si tratta. In particolare, che tipo di immagine si forma nella mente a partire da questa espressione? Quali campi semantici si mettono in contatto?
Le risposte possibili sono solo tre poiché la D è esclusa dalla domanda stessa! Nell’espressione «luce
morente» si ha un’azione (morire) attribuita a una cosa (la luce), dunque si tratta di una personificazione: la risposta corretta è la C.
Come detto, il controllo va condotto solo su tre possibilità: le risposte A e B non sono corrette perché l’espressione «luce morente» non presenta alcun confronto tra elementi, né implicito come vorrebbe la risposta A (metafora), né esplicito come nella risposta B (similitudine).
15 Alla riga 24 compare per due volte la parola «sublime»: quale significato assume tale ripetizione per il lettore?
A La parola è ripetuta con significato diverso: nel primo caso significa qualcosa di molto positivo e bellissimo, nella frase nominale invece il termine è usato in modo antifrastico.
B La parola è ripetuta con significato diverso: nel primo caso costituisce una frase nominale e significa qualcosa di bellissimo ma pericoloso, nel secondo caso invece il termine è usato in modo antifrastico.
C La parola è ripetuta con significato diverso: nel primo caso si ha un uso antifrastico del termine, nella frase nominale invece il termine è usato per significare qualcosa di molto positivo e bellissimo.
D La parola è ripetuta con il medesimo significato: in entrambi i casi fa riferimento a qualcosa di molto positivo, bellissimo, seppur estremamente pericoloso.
Parole-chiave: la parola «sublime», inoltre «significato» e «ripetizione». Per rispondere bisogna cercare di capire che effetto fa questa ripetizione al lettore, cioè a te. Pensaci e leggi le possibili risposte.
Le risposte in questo caso sono particolarmente elaborate, con espressioni e termini tecnici (frase nominale, antifrastico). Per selezionare la risposta giusta devi capire cosa vuole dire «sublime» nei contesti in cui è usato e considerare la forma in cui si presenta. Considerando questi due parametri congiuntamente (il significato del termine e il fatto che la seconda volta «Sublime» è una frase nominale), la risposta giusta è la A.
Pur non conoscendo il significato di «antifrastico», ma partendo dal parametro che «Sublime» è sicuramente una frase nominale la seconda volta che lo leggi nella riga 24 , la risposta B è da scartare perché il primo uso di «sublime» non è in una frase nominale; la risposta C non è corretta perché il significato del secondo «sublime» non è quello di «bellissimo», anzi è il contrario; infine, la risposta D è da scartare perché attribuisce al termine il medesimo significato in due circostanze d’uso diverse.
16 Forma una collocazione lessicale, ovvero ricostruisci una «frase fatta», scegliendo la parola che completa quella proposta.
Mangiare…
A …la muffa.
B …l’alga.
C …la foglia.
D …l’edera.
Parole-chiave: «collocazione lessicale». A volte nelle domande, soprattutto quelle relative alla parte grammaticale, sono presenti espressioni che potrebbero non essere note, ma di solito sono anche spiegate nel testo della domanda stessa con altre parole. Infatti, continuando a leggere il testo della domanda, si comprende come cercare la risposta corretta.
Se quello che si deve ottenere è una «frase fatta», semplicemente leggendo le quattro possibili combinazioni, si è in grado di identificare la risposta C come corretta.
Per essere sicuri di aver trovato la risposta giusta, va ricordato che la «frase fatta» è di solito usata non in senso letterale. Quindi, le risposte A, B e D, che non rimandano ad altro significato condiviso dai parlanti, sono da escludere.
17 Individua la parola mancante in ciascuna frase sapendo che è la stessa per tutte e tre, ma usata con significato diverso.
mercato
a. La polizia ha ritrovato il quadro rubato nel circuito del nero.
mercato
b. Ieri la quotazione del grano ha subìto un forte rialzo sul internazionale.
mercato
c. Nella mia città, il martedì è giorno del delle erbe in piazza.
Parole-chiave: «parola mancante», «stessa» e «significato diverso». Si tratta cioè di trovare una parola che soddisfi contemporaneamente due richieste: essere la «stessa» ma acquistare «significato diverso» a seconda del contesto in cui è inserita.
Con richieste di questo tipo, se il colpo d’occhio non ha aiutato, si deve procedere in modo scientifico, anche per prove ed errori. Per prima cosa è quindi opportuno leggere tutte le frasi per capirle e contemporaneamente completarle. Se con questo tentativo non si è trovato il minimo comune multiplo delle frasi
da completare, niente panico perché semplicemente si riparte dalla frase che più facilmente si riesce a completare per «fermare» una parola e provarla nelle altre frasi: se anch’esse avranno senso compiuto, ci siamo. In questo caso, la parola che soddisfa tutte le possibilità presentate è «mercato».
Controlla velocemente che tutte le frasi completate siano dotate di senso e corrette dal punto di vista morfosintattico: è ciò che conferma la correttezza della parola scelta.
18 Nella frase «L’angolo giro misura 360°», il verbo è un presente:
A semplice.
B di consuetudine.
Parole-chiave: «verbo» e «presente». Per domande di questo tipo, oltre a ricordare la grammatica per circoscrivere l’ambito d’uso dell’elemento richiesto, è importante considerare con attenzione la frase in cui l’elemento da studiare è inserito. In questo caso si tratta di una proposizione che esprime una definizione di geometria.
Individuato il contesto d’uso del verbo da studiare (il fatto cioè che si è di fronte a una definizione), la risposta corretta è la C e l’uso del presente atemporale
C atemporale.
D storico.
è in questo caso d’elezione: in una definizione di geometria, infatti, il contenuto espresso è dato come certo e stabile nel tempo.
Date le premesse, le risposte B e D risultano errate, così come la A, in virtù del fatto che ciascuna di esse rimanda a usi diversi da quello individuato nella proposizione data. In particolare: A indica qualcosa che accade nel momento in cui si parla; B indica un’azione ripetuta regolarmente nel tempo; D è usato per attualizzare fatti narrati.
19 Nel periodo «Rischi di fare tardi, perciò sbrigati!» la frase sottolineata è una proposizione:
A subordinata consecutiva.
B subordinata temporale.
Parole-chiave: «periodo», «sottolineata» e «proposizione». La domanda chiede di identificare una proposizione all’interno di un periodo: ancor prima di considerare le possibili risposte, si tratta quindi di fare una veloce analisi del periodo per individuare la proposizione principale e capire se le altre sono coordinate a essa o subordinate.
C coordinata conclusiva.
D coordinata esplicativa.
Il periodo proposto nella domanda presenta una principale e una coordinata introdotta da una congiunzione conclusiva («perciò»); considerando che la proposizione sottolineata non è una subordinata, la risposta esatta è da cercare solo tra due possibilità (C e D): la risposta è la C in virtù della congiunzione che la introduce.
Nessun riscontro in questo caso: tutti gli elementi risultano coerenti dall’analisi condotta sul periodo.
20 In quale delle seguenti frasi è presente il predicato nominale?
A Giorgio è caduto dal motorino.
B Il gangster si sistemò il cappello.
C Le rondini sono tornate.
D Marta è davvero simpatica.
Parole-chiave: «in quale» e «predicato nominale». Dato che in questo caso si chiede di rintracciare il predicato nominale in una serie di frasi, il primo passo sarà ricordare la «fisionomia» del predicato nominale.
Essendo il predicato nominale composto di una voce del verbo essere (copula) e una parte nominale (nome del predicato), scorrendo le frasi proposte ci sono due passi da compiere: isolare in ciascuna di esse il predicato, quindi studiare la natura del verbo essere,
dove presente. Con questo criterio, risulta evidente che la frase B è subito esclusa, mentre nella A e nella C il verbo essere è un ausiliare (per i verbi cadere e tornare). Resta la sola frase D come possibile risposta esatta ed è così, essendo «è» copula tra il soggetto «Marta» e «simpatica» (nome del predicato).
Nessun riscontro neanche in questo caso: tutti gli elementi risultano coerenti dall’analisi condotta sulle frasi prese in considerazione.
Idee politiche il maestro Bordigoni si procurava il piacere di non averne; e se ne aveva, si negava il piacere di manifestarle. Il fascismo a quei tempi badava solo a crescere e a fortificarsi; più tardi, verso il ’28 o il ’29, diventato esigente, si accorse del Bordigoni. Il maestro Cometta, fiduciario dell’Opera nazionale Balilla, un giorno lo avvicinò e cercò di fargli capire che il nuovo clima in cui doveva crescere la gioventù italiana, esigeva dagli insegnanti una partecipazione attiva nel formare anche i più piccoli all’amore e alla devozione verso la patria fascista. Il Bordigoni ascoltò, ora fissando attraverso le lenti il piccolo Cometta, ora guardandosi intorno con il suo sguardo che non vedeva nulla e sembrava rimandato indietro dalla concavità delle lenti a illuminargli la fronte. Ascoltò e non rispose. Dopo qualche mese il Cometta lo condusse dal professor Bistoletti, fiduciario del partito per la classe insegnante, perché l’esortazione si trasformasse in un ordine perentorio. Il Bistoletti se ne lavò le mani e lo rinviò al segretario politico. Il segretario politico, che era alto quanto il Bordigoni ma molto più giovane e magro come un chiodo, quando se lo vide davanti lo prese in simpatia e gli parlò bonariamente, mettendogli le mani sulle spalle e avvicinandolo fino a sfiorargli la pancia. «Camerata Bordigoni» gli disse «tu sei dei nostri. E lavorerai con noi, non solo nella scuola, ma anche fuori. Domenica ti voglio qui in sede. Per me sei già iscritto al Partito».
Ma il Bordigoni la domenica dopo dimenticò di andare in sede e a scuola non gli venne mai in mente di parlare del fascismo che probabilmente non sapeva neppure cosa fosse di preciso. Finirono col dimenticarsi di lui. Il segretario politico si giustificò dicendo che il Bordigoni, in divisa e camicia nera, sarebbe stato ridicolo e avrebbe dato un’idea sbagliata del fascismo che era una cosa dinamica, agile e soprattutto giovane.
In verità sarebbe stato una caricatura; e fu la sua mole a salvarlo dai cortei, dai saluti romani, dagli alalà e dalle altre prescrizioni di quegli anni.
Con tutta la libertà di cui disponeva, e col tempo che la scuola gli lasciava per molte ore del giorno e per tutti i mesi dell’estate, Anselmo Bordigoni poteva coltivare i suoi piaceri e incrementare i suoi guadagni mettendo a profitto due profonde conoscenze connaturate alla sua personalità: la pesca e la musica.
La pesca per lui era forse più un riposo e un capriccio che un espediente per integrare il suo salario di maestro elementare. Gli rendeva sì e no in un anno una cinquantina di pasti a base di agoni, persici e alborelle. La musica, invece, oltre ad essere la sua grande passione, gli serviva come mezzo di sussistenza.
Dava lezione di qualunque strumento, generalmente di flauto, di clarinetto o di cornetta a operai o barbieri con buona inclinazione, e di pianoforte a qualche figlio di famiglia. Le sue lezioni erano una o due al giorno; e le impartiva sul tardi, a pesca finita, diffondendo sulla chioma degli ippocastani, dalla finestra aperta, le note del piano o del clarinetto.
Dopo cena, alle otto in punto, andava a sedersi al pianoforte del Cinema Tiraboschi, sotto il bianco telone, con la schiena rivolta al pubblico. Attaccava subito a suonare mentre la gente entrava ancora, e si fermava solo dopo il primo tempo. Insieme al riaccendersi delle immagini sullo schermo riprendeva la musica, per sostare brevemente negli intervalli fra un tempo e l’altro, fino alla farsa finale. Cosa suonasse, nessuno era in grado di dirlo; ed era opinione comune che egli pestasse sui tasti come veniva, ispirandosi in qualche modo alle scene che vedeva succedersi sul telone, se pur gli era possibile vedere qualche cosa stando ai piedi della ribalta.
A1 In quale periodo storico si svolgono le vicende narrate nel testo?
A All’epoca del Risorgimento italiano.
B Durante la Prima guerra mondiale.
Per rispondere a questa domanda devi soltanto riflettere un po’ sui periodi storici a cui si fa riferimento: ricorda che il Risorgimento è un periodo che precede l’Unità d’Italia, quindi dal 1820 circa al 1861; la Prima guerra mondiale copre gli anni dal 1914 al 1918; gli anni tra le due guerre mondiali vanno dal 1918 al 1939; infine il secondo dopoguerra si riferisce al periodo che segue la Seconda guerra mondiale, che si è conclusa nel 1945.
C Negli anni tra le due guerre mondiali.
D Nel secondo dopoguerra.
Nel testo si citano due anni precisi (riga 3 ), il ’28 e il ’29. È questo l’indizio per trovare la risposta giusta, che è la C: infatti il fascismo è un movimento politico che nasce tra le due guerre mondiali. Sai che cosa significa «secondo dopoguerra»? Il «dopoguerra» si riferisce agli anni che seguono la fine di un conflitto. Nel caso delle guerre mondiali esistono il primo e il secondo dopoguerra, che fanno riferimento agli anni rispettivamente successivi.
A2 La frase «diventato esigente» (evidenziata nel testo) ha il soggetto sottinteso ed è implicita. Qual è il soggetto della frase? Scrivilo.
Per trovare il soggetto rileggi la frase precedente: «Il fascismo a quei tempi badava solo a crescere e a fortificarsi; più tardi, verso il ’28 o il ’29, diventato esigente , si accorse del Bordigoni.» Nella frase prima del punto e virgola il soggetto è esplicito ed è «il fascismo»; dopo il punto e virgola segue una frase implicita che non introduce altri soggetti: il verbo utilizza lo stesso soggetto della prima frase lasciandolo quindi sottinteso per il lettore.
La risposta alla domanda è dunque «il fascismo», che viene personificato: non solo «diventa esigente», ma
A3 Il fiduciario dell’Opera nazionale Balilla vuole:
«si accorge» anche del maestro Bordigoni come un attento datore di lavoro.
Sai che cosa significa «frase implicita»? In analisi del periodo le frasi possono essere esplicite, se il verbo è espresso con un modo finito (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo), o implicite, se il verbo è espresso con un modo indefinito (participio, infinito, gerundio). Nella frase che devi analizzare è presente un participio passato, dunque siamo nell’ambito delle frasi implicite.
A far crescere la gioventù italiana in un modo nuovo e attivo.
B iscrivere tutti gli insegnanti al partito fascista.
C coinvolgere i maestri nell’educazione fascista dei ragazzi.
D far partecipare anche i ragazzi più giovani alla rinascita dell’Italia.
Per questa domanda devi rileggere bene le prime righe del brano, specialmente quelle in cui si parla del fiduciario dell’Opera nazionale Balilla e dei suoi tentativi di convincere il maestro Bordigoni a partecipare attivamente al movimento fascista; nota che non gli sta chiedendo di iscriversi al partito (non siamo ancora al momento in cui i docenti erano costretti a giurare fedeltà), né sta prodigandosi per far sì che la gioventù italiana cresca con nuovi princìpi, perché non si rivolge direttamente agli studenti. Stiamo dunque escludendo la risposta A e B. Potrebbe venirti il dubbio che la risposta giusta sia la D, perché si parla del «nuovo
clima in cui doveva crescere la gioventù italiana», ma, anche in questo caso il fiduciario si rivolge al maestro, per coinvolgerlo nella nuova educazione fascista: la risposta corretta è la C . Sai che cosa significa «giurare fedeltà»? È un atto che affonda le sue radici nel sistema feudale, quando il sovrano assegnava terre al suo vassallo e questi gli giurava eterna fedeltà; nel periodo fascista molti lavoratori dovettero fare lo stesso: una legge emanata nel 1931 obbligò tutti i professori di ruolo a prestare giuramento, pena l’abolizione di stipendio e pensione. Il fascismo.
A4 Indica quale tra gli esponenti del partito fascista nominati nel testo compie le azioni elencate nella prima colonna.
Il fiduciario dell’Opera nazionale Balilla
Il fiduciario del partito per la classe insegnante
Il segretario politico
a. Sollecita Bordigoni a condividere le nuove idee e a mettersi al servizio del partito.
b. Coinvolge Bistoletti per dare più forza al suo tentativo nei confronti di Bordigoni.
c. Non interviene e passa il caso al suo superiore.
d. Tratta Bordigoni come se fosse già iscritto al partito.
e. Giustifica il comportamento di Bordigoni con i superiori del partito.
Per rispondere rileggi la prima parte del racconto, analizzando la sequenza di azioni dei personaggi, elencate in tabella: le prime due azioni (a. e b.) sono compiute dal maestro Cometti che è il fiduciario dell’opera nazionale Balilla . Quando Cometti vede che i suoi tentativi non stanno funzionando, cede il passo al fiduciario di partito per la classe insegnante , il professor Bistoletti, che però se ne lava le mani
e passa il caso al suo superiore (c.) e cioè al segretario politico. Questo anonimo personaggio dapprima lusinga il maestro considerandolo già un membro molto gradito al partito (d.) poi si giustifica con i suoi superiori e ammette che il maestro non era il tipo adatto ad indossare la divisa di partito (e.) in quanto poco adatto a rappresentare il fascismo.
A5 Rileggi il capoverso evidenziato nel testo. Dal contesto, si può dedurre che «agoni, persici e alborelle» sono dei tipi di:
A carne B pesce C verdura D frutta
La risposta a questa domanda è molto facile da intuire: nel testo, poco prima, si parla dei passatempi preferiti del maestro Bordigoni e cioè la pesca e la musica. Della pesca si dice addirittura che gli procurava
una cinquantina di pasti all’anno a base proprio di «agoni, persici e alborelle ». Deduciamo quindi che sono nomi di tipi diversi di pesci e che la risposta giusta è la B .
A6 Quale delle seguenti frasi può sostituire «se pur gli era possibile vedere qualcosa stando ai piedi della ribalta»?
A Ammesso che gli fosse possibile vedere qualcosa stando ai piedi della ribalta.
B Dal momento che gli era possibile vedere qualcosa stando ai piedi della ribalta.
C Sebbene gli fosse possibile vedere qualcosa stando ai piedi della ribalta.
D Quando gli era possibile vedere qualcosa stando ai piedi della ribalta.
Per rispondere al quesito dobbiamo fare attenzione alle funzioni delle congiunzioni : le congiunzioni «se pure», «pur se», «seppure» ecc. hanno valore condizionale-concessivo, cioè indicano che un dato evento accade, «ammettendo» che si verifichi una determinata condizione. Nella frase si dice che il maestro accompagnava con la musica alcune scene che vedeva susseguirsi sul telo del cinema, se pure gli riuscisse di vedere qualcosa dalla scomoda posizione in cui si trovava a suonare, e dunque ammesso
che gli riuscisse di vedere qualcosa da dove era: la risposta giusta è la A . Sai che cosa sono le congiunzioni? Sono le parti invariabili del discorso che permettono di congiungere più parole nella stessa frase o più frasi nello stesso periodo senza usare per forza la punteggiatura. Esistono congiunzioni coordinanti, che collocano gli elementi della frase sullo stesso piano logico, e subordinanti, che pongono le frasi su alcuni livelli «sottostanti» alla frase principale che le regge tutte.
L’acqua è una risorsa naturale indispensabile per tutte le forme di vita e ricopre per oltre 2/3 la superficie terrestre. Tuttavia appena il 2,5% delle risorse idriche è costituito da acqua dolce, che è per lo più immobilizzata nei ghiacci polari e in quelli delle montagne e quindi solo in piccola parte è disponibile per la popolazione umana nelle falde sotterranee e nei fiumi. Sarebbe una quantità teoricamente sufficiente per tutta la popolazione del pianeta, ma oggi l’acqua in realtà è una risorsa sempre più scarsa. Infatti il consumo idrico mondiale aumenta sempre di più (di oltre 10 volte nell’ultimo secolo) e soprattutto sono esplosi i problemi dello sperpero e dell’inquinamento dell’acqua causati da: attività industriali, uso di sostanze chimiche in agricoltura, incremento della popolazione e delle città, crescente produzione di rifiuti e scarichi fognari. Oggi circa 2 miliardi di persone vivono in paesi con problemi di approvvigionamento d’acqua: in 26 paesi africani e mediorientali, dove abitano 230 milioni di persone, scarseggia l’acqua. Entro vent’anni si prevede che altri 25 paesi (alcuni dei quali europei) saranno nelle stesse condizioni. Attualmente il consumo medio per ogni abitante del globo è di 800 metri cubi l’anno. In realtà vi sono enormi differenze tra i consumi delle popolazioni dei paesi ricchi e quelli dei paesi poveri: uno statunitense consuma 600 litri di acqua al giorno, un europeo 300 e un africano solo 20. Più che alle differenti condizioni ambientali, dunque, l’ineguale consumo di acqua è legato al grado di ricchezza e allo stile di vita. Nei paesi arretrati oltre 1 miliardo e 400 milioni di persone, infatti, non ha accesso all’acqua potabile e oltre 2 miliardi e 400 milioni non hanno i servizi sanitari in casa. In molti paesi poveri, inoltre, dove le risorse idriche sono gestite da grandi imprese multinazionali, l’acqua potabile è sempre più costosa e sta diventando un bene per pochi privilegiati. Si prevede quindi che nei prossimi decenni il calo di disponibilità di acqua e la tendenza a trasformarla in «oro blu», cioè merce molto costosa, farà aumentare, specie nelle aree meno sviluppate del pianeta, i contrasti sociali e i conflitti armati. A fronte di questa situazione problematica, nel 2002 il Comitato dei diritti umani, civili e sociali dell’ONU ha affermato che l’accesso all’acqua è un diritto umano universale.
Figura 1: areogrammi che raffigurano destinazioni d’uso dell’acqua nel mondo e in alcuni paesi.
Figura 2: diagramma sull’aumento del prelievo mondiale d’acqua nel Novecento (m3 per anno)
domenstico agricolo
B1 Nel primo capoverso del testo, quale espressione è usata come sinonimo di acqua?
Risorse idriche.
Questa domanda ti chiede di indicare il sinonimo o l’espressione alternativa con cui viene definita «l’acqua» nel primo capoverso. Il primo capoverso è composto da otto righe e la parola «acqua» ricorre spessissimo ma vi è un punto, nella riga 2 , in cui viene sostituita dall’espressione «risorse idriche ». Come il sostantivo «idraulico» anche l’aggettivo «idrico» usa
il prefisso «idro-» che in greco significa appunto «acqua». La risposta corretta dunque è «risorse idriche». Sai che cosa sono le risorse? Sono una riserva di cose o mezzi disponibili, di natura materiale o spirituale. Molte volte vi si fa riferimento parlando di qualsiasi mezzo che possa fornire appoggio o sostegno in caso di necessità.
B2 Le acque dolci rappresentano:
A i 2/3 della superficie della Terra.
B il 2,5% del totale delle acque.
C il 66% circa del totale delle acque.
D 1/3 della superficie della Terra.
Per rispondere correttamente a questa domanda devi fare attenzione a ciò che ti viene chiesto, cioè indicare esattamente qual è la percentuale di acque dolci, e non la quantità totale di acqua sulla Terra (che comprende anche l’acqua salata del mare). Globalmente, l’acqua ricopre i 2/3, cioè il 66%, della superficie terrestre: questo ci consente di escludere le risposte A e C, che si riferiscono a tutta l’acqua, non solo a quella dolce. Puoi escludere anche la risposta D, che contiene una frazione (1/3) non menzionata nel testo. Dunque, anche solo per esclusione, la risposta giusta è la B .
A conferma di ciò puoi rileggere il testo, che, nella riga 2 , afferma che il 2,5% delle risorse idriche del pianeta è costituito da acqua dolce.
Sai come si calcola una percentuale? Le percentuali sono proporzioni che mettono in relazione le grandezze che conosci con un totale che corrisponde a 100. Se so che le acque ricoprono 2 parti su 3 della superficie terrestre, e se il numero 3 corrisponde a 100%, a quale percentuale corrisponde il numero 2? Scriviamo 2 : 3 = x : 100, e troviamo x moltiplicando 100 × 2 e dividendo il risultato per 3. Otteniamo in questo caso 66,6.
B3 Dove si trova l’acqua dolce disponibile per il consumo umano?
A Nei ghiacciai delle montagne.
B Nelle zone polari.
C Nei corsi d’acqua e nelle falde acquifere.
D Nei bacini artificiali.
Per rispondere devi rileggere molto bene la seconda frase dalla riga 2 alla riga 4 . Come nella domanda precedente, non ti viene chiesto dove si trova tutta l’acqua dolce sulla terra ma solo quella disponibile per il consumo umano. L’acqua dolce è immobilizzata nei ghiacci polari e nei ghiacciai delle montagne, quindi non è adatta ai bisogni primari dell’uomo: puoi così già escludere le risposte A e B. La risposta D fa riferimento a dei bacini artificiali che non vengono citati affatto nel testo, quindi puoi
escludere anche questa. Resta la risposta C : l’acqua disponibile per la popolazione umana si trova nelle falde sotterranee e nei fiumi.
Sai che cosa sono le falde sotterranee? Sono bacini d’acqua che si trovano sotto la superficie terrestre e non riescono a infiltrarsi ancora più in profondità perché incontrano delle rocce impermeabili; spesso alimentano gli acquedotti che trasportano acqua negli impianti civili e industriali.
B4 Tenendo conto di quanto il testo dice, completa la seguente frase: L’acqua dolce disponibile «sarebbe una quantità teoricamente sufficiente per tutta la popolazione del pianeta...»
A se fosse distribuita equamente fra tutti i popoli e non vi fossero sprechi.
B se i Paesi poveri avessero la possibilità di aumentare il loro consumo di acqua.
C se le multinazionali che gestiscono l’acqua ne diminuissero il costo.
D se il clima delle zone calde della Terra divenisse più mite.
La risposta corretta si desume leggendo le parole che seguono l’affermazione richiesta (da riga 7 in avanti) in cui si spiega diffusamente il motivo per cui l’acqua non è sufficiente per tutti gli esseri umani: con l’inquinamento e l’uso sbagliato che ne facciamo, ne sprechiamo tantissima e inoltre la distribuzione tra le popolazioni non è equa . La risposta giusta, quindi, è la A . Le opzioni C e D parlano di altre motivazioni plausibili, ma che vengono citate più avanti nel testo
e possono quindi essere escluse. L’opzione B potrebbe trarti in inganno, ma si tratta di una risposta incompleta perché il testo parla espressamente anche di «sperpero» di risorse idriche (riga 7 ).
Sai che cosa significa «equo»? Un sinonimo di «equo» è «giusto»: una distribuzione equa di risorse prevede di dividerle in modo che a ciascuno ne tocchi una parte commisurata alle sue esigenze, evitando sbilanciamenti tra individui.
B5 Nei prossimi decenni, quanti saranno, presumibilmente, i Paesi che dovranno affrontare il problema della scarsità d’acqua?
A 26
B 25
Puoi rispondere a questa domanda eseguendo una semplice operazione matematica: per trovare il numero dei Paesi che si ritroveranno presto privi di acqua da bere, devi sommare il numero 26 (riga 12 ), corrispondente ai Paesi che già oggi hanno scarsità di acqua, al numero 25 (riga 13 ), numero di Paesi che nei prossimi venti anni si ritroveranno nella stessa situazione precaria: dunque escludiamo le opzioni A e B e individuiamo come risposta esatta la C , cioè il totale
C 51
D 230
della somma, 51. L’opzione D può essere esclusa perché propone un numero che fa riferimento ai milioni di persone con poca acqua che abitano attualmente nei 26 paesi africani e mediorientali . Sai che cosa significa «mediorientale»? L’aggettivo si riferisce a una specifica zona della Terra che va dall’Iran alla costa orientale del Mediterraneo, per un totale di quindici Stati, e che viene indicata con il nome di «Medio Oriente».
B6 Qual è la causa principale delle differenze nel consumo di acqua tra i vari Paesi del mondo?
A Le diverse condizioni ambientali.
B I modi di vivere e il grado di sviluppo economico.
C L’inquinamento delle acque che le rende non potabili.
D Le diverse abitudini igieniche.
Nelle righe 16-17 si dice che «l’ineguale consumo di acqua è legato al grado di ricchezza e allo stile di vita»: questa frase deve guidarti nella risposta a questa domanda. Lo «stile di vita», a cui si fa riferimento nel testo, corrisponde al «modo di vivere»; allo stesso modo, anziché parlare di «grado di ricchezza», possiamo usare un’espressione simile, cioè «grado di sviluppo economico». La risposta esatta corrisponde alla B. Puoi escludere le altre risposte perché le differenze nel consumo di acqua non dipendono dalle diverse condizioni ambientali, né dall’inquinamento
delle acque (in cui purtroppo siamo coinvolti tutti), né dalle diverse abitudini igieniche . Sai che cosa sono le abitudini igieniche? Sono delle pratiche e comportamenti regolari che le persone adottano per mantenere pulito il corpo e l’ambiente circostante, al fine di prevenire le malattie e promuovere la salute e il benessere generale. Queste abitudini includono il lavarsi i denti, farsi la doccia, lavarsi le mani, usare abbigliamento pulito, pulire gli ambienti in cui si soggiorna e lavare gli alimenti che si consumano.
B7 Basandoti sulle informazioni date dalle figure 1 e 2, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. A livello mondiale, l’acqua destinata agli usi agricoli rappresenta la percentuale maggiore. V F
b. Nell’Unione Europea il consumo di acqua per usi domestici è superiore a quello per usi industriali.
c. Nella seconda metà del Novecento il consumo di acqua è cresciuto allo stesso ritmo della prima metà del secolo. V F
d. Nel diagramma di figura 2, si prende in considerazione tra le fonti del consumo di acqua anche una causa naturale.
e. Nel 1960 il prelievo totale di acqua era pari a circa 2.000 metri cubi. V F
f. Gli Stati Uniti sono il paese dove si fa il maggior uso di acqua per scopi industriali. V F
Per rispondere a questi quesiti devi osservare con attenzione gli areogrammi che rappresentano l’uso che si fa dell’acqua nel mondo, in Europa, in Africa e USA, e il diagramma cartesiano che rappresenta l’incremento della quantità di acqua utilizzata nel corso dell’ultimo secolo.
Analizzando gli areogrammi puoi verificare che a livello mondiale l’acqua per il 70% viene utilizzata soprattutto in agricoltura [a. vero], puoi vedere che in Europa si sfrutta più acqua per l’industria (54%) che per usi domestici (13%) [ b. falso] e che gli Stati Uniti sono il paese in cui si usa più acqua per scopi industriali, con l’83% sul totale [f. vero]. Leggendo i dati sul diagramma cartesiano puoi invece vedere che dal 1940 in poi i consumi di acqua sono aumentati enormemente e non con lo stesso ritmo rispetto ai decenni precedenti [c. falso], che il grafico prende
in considerazione anche una causa naturale e cioè le acque perdute a causa del prosciugamento dei bacini artificiali [d. vero] e infine che nel 1960 il prelievo totale di acqua non corrisponde a 2000 metri cubi, perché occorre sommare i dati di tutti e quattro i settori [e. falso]. Sai che cosa sono gli areogrammi? Sono elaborazioni grafiche di dati, dette anche «grafici a torta» perché rappresentano visivamente i numeri come se fossero degli spicchi di una torta. Questa torta è divisa in 100 spicchi, ognuno dei quali corrisponde all’1%. La dimensione di ogni spicchio aumenta in proporzione alla percentuale che rappresenta. Gli areogrammi sono molto utili per avere un colpo d’occhio rapido delle quantità, ma necessitano di una legenda precisa per essere interpretati.
B8 Perché nel testo si usa l’espressione «oro blu» in riferimento all’acqua?
A Il prezzo dell’acqua potabile è destinato a crescere nel prossimo futuro.
B Come l’oro, sarà sempre più difficile estrarre l’acqua dal sottosuolo.
C Il consumo d’acqua nei Paesi meno sviluppati diventerà pari a quello dei Paesi sviluppati.
D Le guerre e i conflitti sociali renderanno difficile alle popolazioni approvvigionarsi di acqua.
Puoi trovare la risposta a questa domanda nell’ultimo paragrafo dove, nella riga 22 , l’acqua viene paragonata all’oro blu in quanto diventerà in breve tempo merce preziosa e sempre più rara.
Il paragone tra acqua e oro non dipende dalla relativa difficoltà di estrazione dal sottosuolo, e il fatto che le guerre renderanno difficile l’approvvigionamento di acqua è una terribile conseguenza dei conflitti. L’opzione C può sicuramente essere esclusa perché
non se ne fa menzione nel testo (anzi, purtroppo sarà una condizione difficilmente realizzabile). Dunque la risposta corretta è la A Sai che cos’è il paragrafo? Paragrafo è un sinonimo di capoverso, una parola che hai già incontrato, e corrisponde a una porzione di testo formata da uno o più periodi e isolata da ciò che precede e ciò che segue con uno spazio. Puoi facilmente vedere che il brano che hai appena letto consta di tre paragrafi o capoversi.
B9 Nell’ultima frase del testo, come si può sostituire «A fronte di»?
A Vista questa situazione problematica.
B Nonostante questa situazione problematica.
C Oltre a questa situazione problematica.
D Invece di questa situazione problematica.
Per rispondere alla domanda devi sostituire la locuzione prepositiva «a fronte di» con un’espressione di significato simile, tipo «di fronte a» «in presenza di» oppure «visto/a ciò» ecc. In questo caso possiamo tranquillamente dire che « vista questa situazione problematica, l’ONU ha affermato che l’accesso all’acqua è un diritto umano universale», indicando come giusta l’opzione A . Puoi escludere le altre perché «nonostante» (opzione B) ha un valore concessivo (sembrerebbe che l’ONU abbia proclamato un nuovo diritto umano a discapito di una situazione difficile); «oltre a» (opzione
C) descrive un evento che si aggiunge a una situazione già problematica (ma non è questo il caso); «invece di» (opzione D) presenta una sfumatura avversativa (sembrerebbe che l’ONU abbia approvato una diritto in contrapposizione a una situazione problematica). Sai che cosa sono le locuzioni prepositive? Si tratta di insiemi di parole che rafforzano le preposizioni semplici e articolate e riescono ad assumere il loro stesso significato, facilitando il riconoscimento dei complementi. Sono una parte invariabile del discorso nella morfologia grammaticale.
B10 Un Comitato dell’ONU ha dichiarato che «l’accesso all’acqua è un diritto umano universale». Che cosa significa l’espressione sottolineata?
Per rispondere completa la frase che segue.
L’acqua è un diritto
di tutti gli esseri umani.
Questa volta per rispondere devi inserire delle parole e il testo non ti specifica quante. Dicendo che «l’acqua è un diritto umano universale», possiamo affermare allo stesso modo che l’acqua è un diritto di tutti noi, nessuno escluso. L’aggettivo « umano» qualifica ogni cosa che ha attinenza con la specie dell’essere umano: avrai sentito parlare di
«valori umani, paesaggi umani, diritti umani, ecc.» e ogni volta puoi sostituire quell’aggettivo con l’espressione «dell’essere umano». L’aggiunta dell’altro aggettivo «universale » fa appello a tutti gli esseri umani viventi sulla Terra senza distinzione di sesso, religione, genere e lingua. Dunque la risposta esatta è: «di tutti gli esseri umani».
Il padre della scienza moderna è lo scienziato pisano Galileo Galilei (1564-1642). Prima di lui altri studiosi come Copernico e Keplero, avevano fatto scoperte importanti, ma fu Galileo il primo ad accompagnare alle scoperte l’enunciazione dei princìpi del metodo scientifico, detto anche metodo sperimentale. In base a questo metodo le leggi della natura devono essere indagate per mezzo di esperimenti e verifiche e non dedotte dalle Sacre Scritture o dai testi dei grandi filosofi del passato. Se un’affermazione non può essere verificata con un esperimento, essa non può essere accettata. Il metodo sperimentale prevede 4 fasi:
1. osservazione del fenomeno;
2. formulazione di un’ipotesi;
3. verifica sperimentale dell’ipotesi;
4. conclusioni: se l’ipotesi è confermata dagli esperimenti diventa una legge.
Nel trattato Il Saggiatore Galileo sostiene la necessità per lo scienziato di imparare a leggere la «lingua matematica» in cui si esprime la natura:
«[l’universo]… non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua, e conoscere i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola».
Galileo Galilei avrebbe potuto essere un ottimo musicista come il padre Vincenzo e il fratello Michelangelo, invece divenne il padre della scienza moderna. Galileo fu un grande matematico, un inventore, uno sperimentatore, ma anche un fine liutista, un poeta e un critico letterario innamorato di Ariosto e del suo paladino Orlando.
Galileo era ironico, gaudente, a tratti depresso, polemico, e anche vendicativo, detestava la regola accademica pisana di indossare la toga, e se voleva stroncare un avversario era capace di farlo con un poemetto satirico. Un «brutto carattere» diremmo oggi.
Forse non sempre faceva davvero gli esperimenti che descriveva, come quelli sulla torre di Pisa; a volte descriveva risultati sperimentali più accurati di quelli realmente ottenuti. La grandezza di Galileo non va per questo ridimensionata. Galileo resta colui che ci ha insegnato che la matematica è il linguaggio in cui è scritto il libro della natura, e che ci ha spiegato il legame tra necessarie dimostrazioni e sensate esperienze, cioè tra teoria ed esperimento.
Galileo fu poi capace di richiamare l’attenzione dei contemporanei su alcuni problemi scientifici fondamentali, evidenziando le incongruenze del sistema di pensiero aristotelico. Per esempio le osservazioni di Galileo sulle irregolarità della superficie lunare, che facevano pensare alla presenza di un manto roccioso lunare, resero la Luna più simile alla Terra. Diversamente da quanto sostenuto da Aristotele, il Satellite terrestre non era fatto di una speciale materia incorruttibile. Da quel momento non si poté più tener distinte le questioni celesti da quelle terrestri.
Ciò che rende la fisica e in generale la scienza, così potente, è il fatto che una volta che abbiamo compiuto abbastanza esperimenti e misure siamo in grado di enunciare delle leggi; le leggi ci permettono di prevedere come si comportano anche oggetti che non possiamo osservare o non abbiamo ancora osservato. Possiamo prevedere con che velocità una mela cadrà a terra anche prima che si stacchi dall’albero, o quando passerà la prossima volta la cometa di Halley anche se al 2061 mancano ancora molti anni. Queste leggi sono espresse con equazioni matematiche: per dirla con le parole di Galileo, il grande libro dell’Universo è scritto in lingua matematica.
C1 Nella prima riga del testo si dice che Galileo è «il padre della scienza moderna» perché:
A si è ispirato alle Sacre Scritture.
B ha derivato le sue teorie dalle opere dei grandi filosofi dell’antichità.
C la fama delle sue scoperte ha superato quella di Copernico e di Keplero.
D ha inventato il metodo sperimentale.
Per rispondere a questa domanda rileggi bene dalla riga 1 alla riga 4 , dove si dice che Galileo ha formulato il metodo sperimentale . Galileo non scrisse le sue opere ispirato dalle Sacre Scritture , né imitando gli antichi filosofi, e non è il padre della scienza moderna perché è più famoso di Copernico e
Keplero. Dunque la riposta corretta è la D Sai che cosa sono le Sacre Scritture? Si tratta di opere o documenti ritenuti sacri da una religione; per la religione cristiana le Sacre Scritture corrispondono alla Bibbia, per la religione ebraica alla Tanakh e alla Torah e per la religione musulmana al Corano.
C2 Il dizionario riporta più significati per la parola «principio». Indica fra i seguenti quello con cui è usata nel testo (parte evidenziata).
A Inizio
B Origine
Per rispondere devi rileggere con attenzione la frase di riga 3 e prestare attenzione alla parola polisemica «princìpi». Nel dizionario uno dei significati di «principio» è «inizio, origine» (opzioni A e B): non si tratta, però, di sinonimi che puoi usare in questo caso perché la frase perderebbe totalmente di significato. Avrai sentito anche parlare di «princìpi attivi», che, in Chimica e in Medicina, sono i costituenti base
C
Concetto fondamentale
D Costituente base di una sostanza
di una sostanza o di un farmaco (opzione D): nemmeno questo significato si applica alla frase che stiamo analizzando. Rimane dunque l’opzione C . Sai cosa vuol dire «polisemico»? L’aggettivo si riferisce a parole che possono assumere significati completamente diversi a seconda del contesto in cui si trovano, pur essendo scritte sempre con la stessa sequenza di lettere.
C3 Qual è la condizione perché un’affermazione possa essere ritenuta accettabile sul piano scientifico? Per rispondere completa, con una sola parola, la frase che segue.
verificata
Un’affermazione, per essere accettata, deve poter essere .
In questo caso devi usare una sola parola per rispondere e devi scegliere con attenzione. Rileggi riga 6 : il testo dice che ogni affermazione può essere
accettata solo se può essere verificata almeno con un esperimento. La risposta è quindi « verificata».
C4 Perché la parte di testo evidenziata è scritta in corsivo? Per rispondere completa la frase che segue (una sola parola per ogni spazio vuoto). È in corsivo perché è una ...................................................., tratta dal .................................................... di ....................................
citazione Saggiatore Galileo
Per rispondere devi sapere che nei testi espositivi che riguardano scienziati o scrittori si possono inserire brani presi dalle opere dell’autore di cui si parla. Il brano, solitamente scritto in un carattere corsivo, è chiamato «citazione». In riga 12 è riportato il titolo del libro da cui è tratta la citazione: è il trattato Il Saggiatore di Galileo. La frase finale da comporre
per la soluzione è quindi: « È in corsivo perché è una citazione tratta da Il Saggiatore di Galileo». Sai che cos’è un trattato? Il termine indica sia un accordo diplomatico tra Stati, sia un’opera che sviluppa in dettaglio un argomento di tipo storico, letterario, o scientifico, come in questo caso.
C5 Il pronome «Egli», evidenziato nel testo, quale termine sostituisce?
L’universo.
Trovi la risposta a questa domanda rileggendo bene la citazione tratta dal Saggiatore ; la prima parola della citazione è messa entro parentesi quadre [l’universo]: ti fa capire che l’universo è il soggetto della prima frase, ma viene messo tra parentesi perché è stato espresso in un punto dell’opera precedente alla frase citata. Senza questa specificazione non avresti potuto capire a che cosa si riferisce il verbo «non si può intendere». Dopo il punto (riga 15 ) il nuovo soggetto è il pronome personale «egli».
Dal momento che non sono stati introdotti altri soggetti e dato che si parla del linguaggio dell’universo, puoi facilmente dare la risposta: «egli» nel testo sostituisce il termine «universo».
Sai che cos’è un «soggetto»? In grammatica il soggetto è colui che compie o subisce l’azione espressa dal verbo: può essere espresso o sottinteso e può essere costituito da ogni parte del discorso, variabile o invariabile; a volte non c’è affatto, come nel caso dei verbi impersonali.
C6 Secondo Galileo, qual è lo strumento essenziale per comprendere l’universo? Rispondi con una sola parola (senza farla precedere dall’articolo).
Per rispondere alla domanda devi solo rileggere la citazione dalla riga 14 alla riga 16 : Galileo dice che l’universo ha un suo linguaggio che non può essere compreso finché non si è appreso l’alfabeto con cui è scritto. «Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono i triangoli, i cerchi e altre figure geometriche». Con questa bellissima metafora Galileo ci dice che l’universo «parla» il linguaggio della matematica, il cui alfabeto è costituito da figure geometriche. Dunque secondo lo scienziato lo strumento essenziale per
matematica polemico vendicativo
comprenderlo è la «matematica»
(Attenzione! Ti viene espressamente richiesto di non inserire l’articolo, quindi dovrai scrivere solo «matematica»).
Sai che cos’è una metafora? È una figura retorica, molto usata in poesia e in letteratura, che consente di esprimere un concetto utilizzando un linguaggio simbolico che rievoca alla mente delle immagini: nel nostro caso Galileo paragona la matematica a una lingua che ha il merito di consentirci di capire l’universo.
C7 Nel testo Galileo è descritto con una serie di aggettivi. Due di essi sono riferiti a tratti della sua personalità che lo rendevano una persona con un «brutto carattere»: quali? Scrivili qui sotto. a. b.
Rileggi il testo soffermandoti sulle righe da 21 a 23 e ricerca gli aggettivi qualificativi che fanno riferimento a qualcosa di negativo e non piacevole. Escluderai «ironico» e «gaudente» che sono delle qualità positive, e «a tratti depresso» che descrive una condizione psicologica. Ti restano «polemico e vendicativo», che, in effetti, descrivono difetti che possiamo attribuire a chi
ha un brutto carattere. Le risposte corrette sono quindi: «polemico» e «vendicativo».
Sai che cosa sono gli aggettivi qualificativi? Sono una parte variabile del discorso ed esprimono appunto qualità e caratteristiche del sostantivo a cui si riferiscono.
C8 Nella frase evidenziata, con quale altro connettivo si può sostituire «poi»?
A Inoltre B Invece C Infatti D Dopo
Per rispondere a questo quesito rileggi la frase da riga 29 a riga 30 . Il connettivo «poi», in questo caso, non si riferisce a una sequenza temporale, cioè non ha il valore di «dopo»(opzione D); non è un connettivo avversativo (opzione B) né un connettivo dichiarativo (opzione C), perché non può essere sostituito con «invece» o con «infatti» senza modificare
il senso della frase. Dunque il connettivo ha valore «aggiuntivo» e potremmo sostituirlo con il termine «inoltre», quindi la risposta giusta è la A .
Sai che cos’è un connettivo? Il connettivo è un elemento grammaticale di collegamento, è di solito una «congiunzione» ma talvolta può essere un avverbio o una locuzione prepositiva.
«Ciò che seminai nell’ira crebbe in una notte rigogliosamente ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente maturò tardi ma in benedetta abbondanza».
Per scrivere sugli animali bisogna essere ispirati da un affetto caldo e genuino per le creature viventi, e penso che a me questo requisito verrà senz’altro riconosciuto. Ma ho voluto citare i bei versi di Peter Rosegger, perché questo libro è scaturito non solo dal mio grande amore per gli «animali», ma anche dalla mia ira contro i «libri » che trattano di animali. E devo riconoscere che se mai nella mia vita ho agito sotto l’impulso dell’ira, è stato proprio nella stesura di queste storie di animali. Ma di che cosa mi adiravo? Delle molte storie di animali, incredibilmente false e cattive, che ci vengono offerte oggi in tutte le librerie; dei molti pennaioli che pretendono di parlare degli animali senza saperne un bel nulla. Chi scrive che le api urlano e spalancano le fauci, o che i lucci, lottando tra loro, si prendono per la gola, dimostra di non possedere neppur la più pallida idea dei caratteri di quegli animali, che pretende invece di avere direttamente e amorevolmente osservato. Se per compilare un libro sugli animali bastassero alcune informazioni delle esistenti società di allevatori, persone come Heck senior, Bengt Berg, Paul Eipper, Ernest Seton Thompson, o Wäscha Kwonnesin, che hanno dedicato tutta la vita alle ricerche sugli animali, sarebbero da considerarsi sciocche. Non si possono sottovalutare gli innumerevoli errori che queste irresponsabili storie di animali diffondono fra i lettori, e soprattutto tra i giovani, vivamente interessati a questo argomento. E non si obietti che queste falsificazioni sono una legittima libertà della rappresentazione artistica. Certo, i poeti hanno diritto di «stilizzare» anche gli animali, come qualsiasi altro oggetto, secondo le necessità del processo artistico: i lupi e le pantere di Rudyard Kipling, il suo impareggiabile mungo Rikhi-tikkitavi parlano come gli uomini, e l’ape Maja di Waldemar Bonsels può esibire un comportamento non meno corretto e gentile del loro. Ma queste stilizzazioni sono permesse solo a chi conosce veramente l’animale. Anche gli artisti figurativi non sono tenuti a rappresentare le cose con precisione scientifica, ma guai a colui che non conosce l’oggetto che pretende di rappresentare, e che si serve della stilizzazione solo per mascherare la propria ignoranza! Io sono uno scienziato, non un artista, e quindi non mi permetto nessuna libertà e nessuna «stilizzazione». Inoltre ritengo che queste libertà non siano affatto necessarie, e che sia molto meglio attenersi, come nei veri e propri lavori scientifici, semplicemente ai fatti, se si vuole dischiudere al lettore la bellezza del mondo animale. Le verità dell’universo organico si impongono infatti sempre più al nostro amore e alla nostra ammirazione e divengono sempre più belle quanto più profondamente si penetra in ogni loro peculiarità, ed è proprio insensato credere che l’oggettività della ricerca, il sapere, la conoscenza dei fenomeni naturali, possano far diminuire la gioia procurataci dalle meraviglie della natura. Anzi, quanto più l’uomo impara a conoscere la natura, tanto più viene preso profondamente e tenacemente dalla sua viva realtà. E in ogni buon biologo che sia stato chiamato alla sua professione dal godimento interiore che gli procurava la bellezza delle creature viventi, tutte le conoscenze acquistate attraverso la professione non hanno fatto che approfondire il godimento e l’amore della natura e del proprio lavoro. Per il campo di indagine cui ho dedicato la mia vita, cioè lo studio del comportamento animale, ciò vale ancor più che per ogni altro campo
di ricerca nel mondo vivente: questo studio esige una dimestichezza così immediata con il mondo animale, ma anche una pazienza così disumana da parte dell’osservatore, che non basterà a sostenerlo il solo interesse teorico per gli animali, se mancherà l’amore che nel comportamento dell’uomo e dell’animale riesce a cogliere e constatare quell’affinità di cui aveva già da prima un’intuizione. Oso dunque sperare che questo libro non mi venga distrutto dalla pioggia: ammetto infatti io stesso di averlo concepito nell’ira, ma quest’ira è frutto a sua volta del mio grande amore per gli animali!
Altenberg, estate 949. KONRAD LORENZ
D1 La parola «premessa» evidenziata nel titolo significa:
A giustificazione.
B introduzione.
C previsione.
D contrapposizione.
Per dare questa risposta considera il significato letterale delle parole e pensa a che cosa significa «premessa»: il prefisso «pre-» che compare all’inizio del vocabolo fa riferimento a qualcosa che «viene prima»: la premessa è qualcosa che «viene messo prima», di solito per introdurre un discorso, un’ introduzione (opzione B). Anche l’opzione C ha lo stesso prefisso, ma una «previsione» lascia intendere qualcosa «che si suppone accadrà» e in questo contesto l’autore non fa nessuna previsione in atto. Puoi scartare le altre opzioni, perché la poesia in premessa non è certamente
una giustificazione né una contrapposizione . Sai che cosa significa «contrapposizione»? Il sostantivo deriva dal verbo «contrapporre» che significa «mettere contro qualcosa, opporsi in qualche modo a qualcuno o qualcosa»; in un dibattito due persone possono sostenere posizioni in contrapposizione, per esempio una può sostenere che è giusto che le ragazze e i ragazzi vadano a scuola vestiti come vogliono e l’altra sostenere che a scuola occorre adottare un abbigliamento adeguato e il più possibile neutro.
D2 Qual è il senso della poesia di Peter Rosegger che apre il testo?
A L’amore e la rabbia sono i sentimenti che dominano i nostri comportamenti.
B Un amore eccessivo per qualcuno può suggerire comportamenti sbagliati.
C Solo le azioni che si compiono per amore e non per rabbia hanno un esito felice.
D La rabbia è una cattiva consigliera e porta a compiere azioni di cui poi ci si pente.
Rileggi bene la poesia per rispondere. Rosegger scrive che tutto ciò che ha creato o prodotto mentre era dominato dall’ira è cresciuto rapidamente, ma è andato facilmente distrutto; per contro, tutto ciò che ha creato con amore è cresciuto più lentamente e magari in ritardo, ma ha avuto una durata più lunga. In altre parole potremmo dire che tutto ciò che è prodotto dalla rabbia è effimero mentre ciò che è prodotto dall’amore è stabile e produttivo. È vero che la rabbia è una cattiva consigliera (opzione D), ma la poesia parla anche di amore e non possiamo ignorarne
il messaggio. Amore e rabbia sono i sentimenti che ci dominano (opzione A), ma bisogna assolutamente specificare quali azioni ci fa compiere l’uno e quali l’altra. L’opzione B è del tutto fuorviante, dunque la risposta corretta è la C , per cui solo le azioni che si compiono per amore hanno un esito felice.
Sai che cosa significa «effimero»? È un aggettivo che si usa per indicare qualcosa di transitorio e di breve durata: è effimero tutto ciò che non produce effetti significativi dopo il suo svolgimento o il suo passaggio.
D3 L’autore mette tra virgolette la parola «libri» (evidenziata nel testo), per indicare che vuole riferirsi a:
A tutti i libri che descrivono gli animali.
B libri di animali scritti con interesse scientifico.
C libri che trattano di animali scritti da lui stesso.
D libri che trattano in modo errato di animali.
Per rispondere devi rileggere il testo in prosa dalla riga 11 alla riga 13 . Lorenz fu un grande studioso di animali (vinse anche il Premio Nobel) e rivolge la sua ira verso coloro che ne scrivono in modo sbagliato (opzione D); non se la prende con i suoi scritti (opzione C), né tantomeno con tutti i libri che parlano di animali (lettera A) o che ne trattano da un punto di vista scientifico (lettera B). Usando la punteggiatura, l’autore sottintende che i libri che trattano in modo errato di animali non si possano nemmeno definire libri, sono libri per modo di dire, cioè «tra virgolette». Sai chi era Konrad Lorenz? Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989) è stato uno zoologo ed etologo di nazionalità austriaca.
È considerato il fondatore della moderna etologia scientifica, da lui stesso definita come ricerca comparata sul comportamento animale. A lui si deve l’elaborazione del concetto di «imprinting» che ha definito come «la fissazione di un istinto innato su un determinato oggetto» e che determina per un animale la scelta del proprio genitore, naturale o di altra specie, fin dalle prime ore di vita.
Per i suoi studi sulle componenti innate del comportamento, Lorenz è stato insignito del premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1973.
È tuttavia divenuto molto noto soprattutto per la sua opera di divulgazione scientifica. È stato un ambientalista convinto.
D4 L’autore espone alcuni motivi che lo hanno spinto a scrivere il libro «L’anello di re Salomone».
Indica se i motivi elencati nella prima colonna corrispondono o no al suo pensiero.
L’autore ha scritto il libro perché:
a. è irritato da coloro che scrivono di animali pur non conoscendoli.
b. è preoccupato per ciò che i giovani potrebbero imparare leggendo storie di animali senza fondamento.
c. è convinto che dedicare tutta la vita allo studio degli animali sia poco utile.
d. è stato ispirato dai versi di Peter Rosegger che parlano di animali.
e. è spinto da profondo amore e rispetto nei confronti degli animali che studia.
Per questa domanda devi cogliere le linee essenziali del testo: l’autore è molto irritato da coloro che scrivono di animali senza conoscerli (riga 14 ) [a. sì ] ed è preoccupato perché i giovani potrebbero imparare dei concetti sbagliati (righe 22-23 )[ b. sì ]. Lo studioso dimostra un grande amore per gli animali (riga 47 ) [e. sì ]. Naturalmente Lorenz non pensa che sia inutile dedicare la vita gli animali [c. no]. I versi di Peter Rosegger infine non lo hanno ispirato perché parlano di animali [d. no] ma per il senso veicolato dalla metafora.
Sì No
Sai chi era Peter Rosegger? Peter Rosegger (18431918) fu un poeta e scrittore austriaco che compose opere celebrando i paesaggi alpini e la vita delle campagne. Di umili origini, da autodidatta si formò una cultura che gli permise di esprimersi come artista e come intellettuale. Fondò a Graz la rivista letteraria Heimgarten . Una delle sue frasi più celebri e più citate è: «Paralizza i tuoi nemici con l’amore!»
Questa massima sintetizza proprio la suggestione che Lorenz cita.
D5 Quale verbo utilizza l’autore col significato di «rappresentare qualcuno o qualcosa secondo un modello che semplifica o modifica la realtà»?
Stilizzare
Per rispondere dobbiamo cercare il verbo che corrisponde alla definizione proposta. In riga 25 riferendosi ai poeti, Lorenz scrive che essi hanno «diritto di «stilizzare» anche gli animali » in base alle necessità artistiche e possono quindi parlare di lupi, pantere, insetti ecc. in ambito letterario come personaggi , senza trattarne gli aspetti e le caratteristiche da un punto di vista scientifico. Nelle loro opere i poeti possono rappresentare gli animali in modo semplificato,
ma devono comunque «conoscerli veramente» per evitare di risultare ignoranti. Il verbo da usare nella risposta è « stilizzare ».
Sai chi sono i personaggi? Nei testi narrativi, i personaggi sono i protagonisti: possono essere principali o secondari, corali o comparse, a seconda del ruolo e dell’importanza che rivestono nella narrazione. Possono essere persone reali o realistiche, creature fantastiche o animali.
D6 Inserisci nel testo che segue le parole o espressioni mancanti.
Attenzione: ci sono due parole in più.
anzi • invece • prima • ma • quanto più • anziché • mentre • tanto più
mentre invece
Konrad Lorenz afferma che .................................................... l’artista può concedersi delle libertà nel descrivere la natura, lo scienziato deve .................................................... attenersi ai fatti.
Ma anzi quanto più tanto più
è sbagliato credere che l’indagine scientifica dei fenomeni naturali non permetta di apprezzare la bellezza della natura, questa bellezza diviene evidente ai nostri occhi i fatti sono studiati e indagati.
Per completare il testo devi inserire le opportune congiunzioni negli spazi bianchi, creando frasi di senso compiuto. Come dice la consegna dell’esercizio, ci sono due parole in più che non vanno usate.
Nella prima frase si avverte una contrapposizione tra ciò che può fare l’artista e ciò che invece deve fare lo scienziato. Dunque potremmo articolare la frase così: «mentre l’artista può concedersi delle libertà… lo scienziato deve invece attenersi ai fatti». La frase successiva contrappone un argomento al primo, e deve essere introdotta da una congiunzione avversativa, come «ma», che è presente tra le opzioni: potremmo
quindi dire «Ma è sbagliato credere che...». Nello spazio successivo trova posto un rafforzativo, come «anzi», seguito da due congiunzioni correlative: la frase diventa dunque: « anzi questa bellezza diviene tanto più evidente quanto più i fatti sono studiati». Le congiunzioni da inserire nell’ordine sono quindi: mentre, invece, ma, anzi, tanto più, quanto più Sai quali sono le congiunzioni correlative? Sono congiunzioni che mettono in relazione due elementi della frase stabilendo tra loro un parallelismo. Sono correlative, per esempio, «sia… sia», «non solo… ma anche», «chi… chi», «né… né», «tanto… quanto».
D7 A quale campo di indagine l’autore ha dedicato tutta la vita?
A Lo studio comparato della biologia umana e animale.
B La descrizione delle caratteristiche fisiche degli animali.
C La comprensione dei rapporti fra uomo e animale.
D Lo studio del comportamento degli animali.
Per rispondere alla domanda devi rileggere il testo in prosa dalla riga 43 alla riga 44 . Lo scrittore dichiara di essersi dedicato allo studio del comportamento degli animali (opzione D): Lorenz è infatti considerato il padre dell’etologia Sai che cos’è l’etologia? È la branca della biologia (cioè la scienza che si occupa degli esseri viventi, dei
fenomeni della vita e delle leggi che la governano) che studia le abitudini e i costumi degli animali, ma anche l’adattamento delle piante all’ambiente. Propone uno studio comparato del comportamento animale permettendo di riconoscere caratteristiche simili anche in specie diverse tra loro.
D8 Perché il libro di Lorenz potrebbe essere distrutto dalla pioggia?
A Perché accade che i manoscritti siano distrutti dagli agenti atmosferici.
B Perché è stato scritto sulla spinta della rabbia.
C Perché l’autore scrive stando all’aria aperta.
D Perché le convinzioni che esprime potrebbero essere contestate.
Per rispondere alla domanda rileggi la poesia iniziale e il testo in prosa da riga 49 a riga 50 .
Nella poesia, Rosegger parla dei frutti della rabbia e dell’amore, dicendo che i frutti della rabbia possono essere distrutti dalla pioggia. Lorenz dichiara di aver concepito il libro nell’ira e per questo teme che la pioggia potrebbe distruggerlo (opzione B); spera però che ciò non accada, poiché alla base c’è il suo grande amore per gli animali, che prevale sull’ira.
Escludiamo le opzioni A, C e D che fanno riferimento alla distruzione provocata da agenti atmosferici , o al fatto che l’autore abbia scritto il libro all’aria aperta, o che le sue convinzioni possano subire critiche. Sai che cosa sono gli agenti atmosferici? Si indicano con questo termine tutte le precipitazioni e i fenomeni che avvengono nell’atmosfera terrestre: pioggia, vento, neve ecc. In Geografia vengono definiti anche forze esogene perché avvengono fuori dalla superficie terrestre.
1 Scrivi la parola che corrisponde alla definizione.
Esempio: Edificio adibito ad abitazione dell’uomo: casa (nome che inizia per c ).
Buttarsi, lanciarsi in acqua: (verbo che inizia per t ).
Per rispondere a questa domanda devi semplicemente trovare la parola che corrisponde alla definizione richiesta. Come vedi nell’esempio, ti vengono date una definizione e la lettera iniziale con cui la parola comincia.
Devi trovare il verbo che corrisponde all’azione di buttarsi o lanciarsi in acqua: se iniziasse con la G potrebbe
essere «gettarsi», ma sappiamo che l’iniziale è la lettera T: l’unico verbo possibile è quindi « tuffarsi». Sai che cos’è una definizione? È la spiegazione del significato di un concetto tramite la combinazione di altri concetti che si ritiene siano noti a chi legge o ascolta.
2 Nelle frasi che seguono manca la stessa parola, usata con significati di volta in volta diversi. Scrivi la parola mancante nella casella corrispondente.
Esempio:
a. Al telegiornale hanno trasmesso un interessante sul tema del riciclo dei rifiuti.
b. Il da tè in mostra è decorato in oro.
c. Il ................................................. di leva obbligatorio è stato abolito per legge.
Parola corretta: servizio
a. Durante la prova d’orchestra, il direttore ci ha fatto fermare alla settima .
b. Il professore ha fatto una che ha provocato molte risate nella classe.
c. Nel tennis, la deve essere eseguita dal giocatore fermo oltre la linea di fondo.
Parola corretta:
In italiano esistono molte parole polisemiche, che si scrivono allo stesso modo ma che assumono diversi significati a seconda del contesto in cui sono inserite. Per rispondere a questa domanda devi leggere bene le tre frasi e, in base al contesto, capire qual è l’unica parola che le completa correttamente. La parola da inserire è «battuta», che sul dizionario corrisponde a ben dieci definizioni differenti!
Nella prima frase si parla di musica, il direttore fa fermare l’orchestra alla settima «battuta», che è la suddivisione di un brano in porzioni di tempo. Nella seconda frase un professore fa ridere i suoi alunni facendo una «battuta» spiritosa.
Nella terza infine siamo in ambito sportivo e si parla del colpo di racchetta iniziale con cui comincia un match di tennis, che si esegue da fondo campo e si chiama appunto «battuta».
Sai cos’è il contesto? È l’ambito o la situazione in cui si colloca il messaggio della comunicazione verbale. Per «capire il contesto» occorre leggere tutto il messaggio e capire chi sono gli agenti e quali sono le azioni, i luoghi e le cose citati e farsi un’idea dell’argomento di cui si sta parlando.
Solo in questo modo si può dare il giusto significato a tutte le parole polisemiche, che possono essere fraintese, se prese, appunto, «fuori contesto».
3 Indica se la parola sottolineata nelle frasi che seguono è usata:
• in senso informale (registro basso);
• in senso neutro (registro standard);
• in senso formale (registro elevato).
a. Non capisci mai quello che dico! Cos’hai in quella zucca vuota?
b. Stamattina mi sono alzato con un gran mal di testa.
c. L’avvocato alzò fieramente il capo verso la corte e principiò la sua arringa.
Nel quesito devi scegliere se la parola sottolineata appartiene al registro basso, standard o elevato: ci si riferisce al registro linguistico della comunicazione e cioè all’utilizzo delle parole a seconda del contesto e dell’interlocutore a cui ci si rivolge. Un registro basso è usato in ambito familiare o domestico, può comprendere termini dialettali o colloquiali; il registro elevato di contro è usato per un pubblico colto e fa uso di termini ricercati; il registro standard si colloca a metà tra il formale e l’informale. Le parole sottolineate nelle tre frasi si riferiscono allo stesso oggetto, la «testa», che però in una frase è detta «zucca» e in una è detta «capo». Per rispondere ti basta pensare a come tu usi queste parole: se parli con gli amici o i
tuoi familiari potresti usare il termine «zucca» (registro basso) mentre se leggi un libro di un certo livello potresti trovare la parola «capo», che di solito non si usa tutti i giorni (registro elevato). Nel linguaggio comune neutro usiamo la parola «testa» che vedi infatti scritta nella seconda frase (registro standard ). Sai cos’è il registro linguistico? In ciascuna lingua, i registri descrivono i modi con i quali comunichiamo nei diversi contesti, scegliendo e usando determinate parole a seconda degli interlocutori. A casa si parla un registro informale, se parli con il Preside userai un registro formale, mentre di norma a scuola, quando si scrive un tema o si parla con l’insegnante, si utilizza un registro standard.
1 Indica in quale dei seguenti periodi il pronome «ne» si riferisce a un’intera frase.
A Ieri gli Azzurri hanno vinto sulla fortissima Spagna con quattro gol di scarto, e naturalmente ne parlano tutti.
B Mio fratello ieri ha visto il film che ha vinto il festival di Berlino e me ne ha parlato molto bene.
C Parla sempre di musica pop, ma secondo me non ne capisce proprio niente.
D La professoressa dice che i libri della serie di Harry Potter sono molto divertenti, ma io non ne ho letto nessuno.
La particella pronominale «ne» può essere usata al posto di un certo numero di parole, può sostituire alcuni complementi, oppure può sostituire intere frasi. Vediamo i casi proposti. Nell’opzione D, la particella è al posto di un complemento partitivo «non ho letto nessuno dei libri ». Nell’opzione C, la particella sostituisce un complemento di argomento «non capisce proprio niente del pop». Anche nell’opzione B, «ne» sostituisce un complemento di argomento «mio fratello mi ha parlato molto bene del film ».
Dunque rimane da confermare come giusta l’opzione A . In effetti, in questo caso, «ne» sostituisce l’intera frase «Tutti parlano del fatto che ieri gli Azzurri hanno vinto sulla fortissima Spagna». Sai che cos’è un complemento di argomento? In analisi logica risponde alla domanda «di che argomento?» e si associa ai verbi «parlare, scrivere, studiare…» dopo i quali si specifica qual è l’argomento di cui si tratta nella frase in oggetto.
2 Per ognuna delle seguenti situazioni comunicative indica quale tra le due frasi proposte è adatta al contesto.
a. Il tuo stendipanni si è rotto. Entri nel negozio e chiedi:
A Buongiorno, vorrei uno stendipanni.
B Buongiorno, vorrei lo stendipanni.
b. La mattina hai ordinato al tuo fornaio di tenerti da parte la tua pizza preferita.
A pranzo vai al forno e dici:
A Salve, sono venuto a ritirare la pizza.
B Salve, sono venuto a ritirare una pizza.
c. Nella vetrina di un negozio è esposto un solo vestito rosso. Entri e chiedi:
A Vorrei provare il vestito rosso che è in vetrina.
B Vorrei provare un vestito rosso che è in vetrina.
d. Vuoi trascorrere una serata con i tuoi amici. Telefoni a una pizzeria e dici:
A Buona sera, vorrei prenotare il tavolo per quattro persone.
B Buona sera, vorrei prenotare un tavolo per quattro persone.
Per rispondere a questi quesiti devi avere ben chiara la distinzione tra l’uso dell’articolo determinativo e dell’articolo indeterminativo: il primo indica una persona o un oggetto ben preciso e chiaro a chi parla e a chi ascolta, mentre il secondo indica qualcosa di generico, una scelta tra più esemplari non meglio identificati. Quindi se il tuo stendipanni si è rotto [a.] entri in negozio e ne chiedi uno (generico, va bene uno qualsiasi); se hai ordinato al fornaio la tua pizza
preferita [ b.] quando vai a prenderla chiederai di ritirare la pizza (tu e il fornaio sapete a quale pizza vi riferite); se in un negozio vedi esposto un solo vestito rosso [c.] entrerai e chiederai di provare il vestito che è in vetrina (ti riferirsci all’unico esemplare e il commesso lo può riconoscere); se vuoi andare in pizzeria con gli amici [d.] chiederai di prenotare un tavolo (generico, uno qualunque andrà bene).
3 Per ognuna delle seguenti frasi indica se il verbo è alla forma attiva o passiva.
a. I miei genitori vanno spesso alla fiera del libro. A P
b. Mio fratello è convocato spesso per le partite in trasferta. A P
c. Questi moduli vanno spediti entro la fine del mese. A P
d. Dalle Olimpiadi di italiano vengono esclusi gli alunni con un voto inferiore a sei. A P
e. Luigi è salito sul treno all’ultimo momento. A P
f. Oggi pomeriggio vengono a trovarmi degli amici messicani. A P
Per rispondere a questa domanda devi tenere a mente la differenza tra i verbi attivi e passivi: ricorda che nei verbi attivi il soggetto compie l’azione, mentre nei verbi passivi il soggetto subisce l’azione. I verbi attivi sono seguiti dal complemento oggetto e altri complementi, eccetto il complemento d’agente o causa efficiente , che invece caratterizza i verbi passivi e corrisponde alla domanda «da chi? da che cosa?». Analizziamo le forme verbali presentate: nelle frasi a., e. ed f. i verbi sono «vanno», «è salito» e «vengono» e
4 Leggi la seguente frase.
sono forme attive . Nelle frasi b. , c. e d. sono presenti verbi di forma passiva in cui i soggetti subiscono l’azione: mio fratello viene convocato da qualcuno , i moduli devono essere spediti da qualcuno , alle Olimpiadi gli alunni vengono esclusi da qualcuno… . Sai la differenza tra il complemento d’agente e quello di causa efficiente? Il primo si riferisce a persone o altri esseri animati in generale; il secondo, invece, alle cose inanimate.
«Maria ha ricevuto assieme a me il premio dell’amicizia.»
Solo una delle seguenti affermazioni è vera. Quale?
A Il soggetto si trova alla fine della frase.
B Il soggetto non compie l’azione.
Come sai, il soggetto è sempre colui che compie l’azione contenuta nel verbo della frase. La risposta a questa domanda è piuttosto intuitiva: il soggetto che compie l’azione, cioè colei che ha ricevuto un premio, è Maria, non è un pronome personale (opzione D), non si trova alla fine della frase (opzione A) e non è sottinteso (opzione C) perché è espresso. Puoi affermare quindi che l’opzione B è giusta: Maria riceve un premio e in qualche modo «subisce» l’azione fatta
C Il soggetto è sottinteso.
D Il soggetto è un pronome personale.
da qualcun altro, pur non essendo in presenza di una frase passiva.
Sai che cosa significa soggetto sottinteso? In grammatica si dice che il soggetto è sottinteso quando è facilmente desumibile dall’analisi della voce verbale, che, in base alla desinenza, può riferirsi alla prima, seconda o terza persona singolare o plurale. Molto spesso, per comprendere il senso della frase in italiano, è sufficiente leggere il verbo coniugato.
5 Indica in quale delle seguenti coppie le due parole che le compongono sono formate da un verbo + un nome.
A Doposcuola, soprabito
B Colabrodo, apripista
Per rispondere a questa domanda ripensa alla categoria grammaticale dei nomi composti. Devi trovare quelli composti esclusivamente da un verbo e un nome. L’opzione A propone due parole composte da avverbio più nome quindi non è la scelta giusta; l’opzione C propone «fermoposta» e «monopattino» che sono composte da aggettivo più nome. L’opzione D propone «pescecane» e «cassapanca» composti da due nomi. La risposta corretta è quindi la B.
C Fermoposta, monopattino
D Pescecane, cassapanca
Sai quali sono i nomi composti? I nomi composti in grammatica sono sostantivi costituiti da due parti del discorso affiancate, come nome più nome, nome più aggettivo, verbo più nome, avverbio più nome ecc., che, insieme, formano un’unica parola di senso compiuto. I nomi composti seguono delle regole particolari nella formazione del plurale, specialmente quelli composti dalla parola «capo» più nome, come per esempio capocuoco, capostazione ecc.
«Tutto quello che si può mangiare in questa galassia, noi ce l’abbiamo», diceva modestamente l’intestazione del menù computerizzato, con una tastiera a centoventi voci.
«I signori desiderano?» disse in perfetto sineuropeo.
«Ci aiuti lei,» disse Chulain, «non è facile scegliere in un menù di sessantamila portate». «Se permettete, signori, vi consiglierei le minestre misteriose. Sono buone, ed è emozionante non sapere cosa ne salterà fuori. Come secondo piatto, se siete robusti, potrei portarvi un prupus venusiano». «E perché occorre essere robusti?» chiese Kook.
«Se volete rendervene conto, al tavolo vicino ne stanno servendo uno».
Al loro fianco, infatti, due russi panciuti stavano scoprendo una zuppiera da dove veniva un ottimo odore di bollito. Il primo russo infilò una forchetta, ma dalla zuppiera saettò un tentacolo azzurro che lo afferrò per la testa e lo tuffò dentro al brodo, tenendolo sotto. Due camerieri intervennero e con una coltellata liberarono il cliente. Ci provò l’altro: ma il prupus, un incrocio tra un polipo e una medusa, uscì decisamente dalla zuppiera e ingaggiò una furibonda lotta corpo a corpo.
«Come vedete,» disse il maître con un sorriso, «non tutti hanno il fisico per mangiare il prupus. Noi lo portiamo bollito, ma a lui non fa molto effetto, perché su Venere vive in un magma a duemila gradi».
«Io credo» disse Mei, «che preferiremmo qualche altra vostra specialità… non semovente, per favore». «La nostra specialità è il fungo “semipiaci”. È un fungo scoperto sul pianetino gioviano Antilochus. Siamo i soli a possederlo, nella galassia, è veramente un cibo rarissimo. Veramente pochi lo hanno mangiato, sottolineo, pochi».
«Molto bene,» disse Chulain, «allora quattro minestre misteriose, e un fungo “semipiaci”. Ah sì, e una camelia poco condita per Sara. Deve mangiare in bianco». Furono serviti in pochi secondi.
Ed ecco che quattro camerieri portarono sul tavolo una massiccia zuppiera d’oro.
«Signori! Vi devo spiegare brevemente qual è il modo di mangiare il fungo “semipiaci”. Questo fungo è dotato di un… diciamo così, carattere un po’ particolare. Egli si può presentare in tre forme. Io ora scoperchierò la zuppiera: il fungo vi apparirà di un colore bianco, neutrale. Così non ha alcun gusto. Ma se voi gli siete antipatici, ebbene, se gli siete antipatici, diventerà verde, grinzoso e molliccio, e non lo potrete mangiare, perché sarà velenoso come poche cose nell’universo. Se invece gli piacete, il fungo si accenderà di un bel colore rosso e giallo, e sarà un boccone squisito, quale forse mai avete gustato!».
«Incredibile,» disse Kook, «e cosa bisogna fare per essergli simpatici?».
«Nulla,» disse il maître, «il fungo decide di testa sua… o di cappella sua, mi si passi la bêtise. Voilà, madames e messieurs, il fungo “semipiaci”!».
Sul piatto apparve un bellissimo fungo candido e panciuto, una decina di chili almeno. Ruotò un po’ sul gambo esaminando i commensali. Poi cominciò a coprirsi di sfumature arancioni, il gambo si illuminò di rosso, e in pochi istanti il fungo diventò meravigliosamente colorato.
«Complimenti, signori!» disse il maître, «Siete piaciuti al fungo. Ora, non ne dubito, sarà lui a piacere a voi!».
«Già, naturalmente, su, comincia ad assaggiare tu, Chulain».
«Sentite ragazzi, io non mi intendo di funghi, taglialo tu, Kook».
«No,» disse subito Kook, «io, ecco, mi ero dimenticato di dirlo, ma da piccolo feci una indigestione di funghi chiodini… Mei, comincia tu».
«Eh no!» disse Mei, «Mi dispiace, ma non posso accoltellare chi mi ha appena manifestato la sua simpatia».
«Devo dedurre» intervenne il maître, «che non volete mangiare il fungo?».
«No,» disse Chulain, «gli siamo simpatici, come possiamo tradire così la sua fiducia?».
«Bene, signori, non avevo dubbi,» concluse il maître, «perché, vedete, il fungo “semipiaci” ha una particolarità. Diventa verde e velenoso in presenza di persone malvagie e voraci. Diventa colorato e gustoso in presenza di persone dotate di dolcezza e sensibilità. E certamente, nessuna persona sensibile potrà mangiare un fungo che gli ha dimostrato tanta simpatia».
«E quindi?» disse Mei.
«Quindi, è per questo che il fungo “semipiaci” è un piatto così raro. Perché nessuno lo ha mai mangiato».
da S. Benni, Terra!, Feltrinelli
1 Quanti sono i commensali al ristorante?
A Tre.
B Quattro.
C Due. D Sei.
2 Che cosa può significare la parola francese «bêtise» (riga 33 )?
Deducilo dal contesto in cui è usata.
A È la traduzione francese della parola «testa».
B È il nome della preparazione enogastronomica del fungo.
C Significa «sciocchezza».
D È il nome della posata da usare: la forchetta a dieci punte.
3 Quale pietanza consiglia il maître ai commensali come primo piatto?
A Minestra misteriosa.
B Camelia in bianco.
C Prupus venusiano.
D Fungo semipiaci.
4 A quale genere letterario appartiene il testo che hai letto?
A Storico.
B Horror.
C Fantascientifico.
D Epistolare.
5 Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.
a. Il prupus ha almeno un tentacolo azzurro.
b. Il prupus è un piatto tipico russo.
c. Il prupus è un incrocio tra un polipo e un granchio.
d. Il prupus vive su Venere.
e. Il prupus vive nel magma a tremila gradi.
f. Il prupus viene servito bollito.
V F
V F
V F
V F
V F
V F
6 In quante forme può presentarsi il fungo «semipiaci»?
A Solo una.
B Tre.
C Dipende da quante riesce a cucinarne il ristorante che lo serve ai tavoli.
D Dipende da chi lo ordina dal menù.
7 A quale condizione si può gustare il prupus venusiano?
A Bisogna essere russi.
B Bisogna essere molto affamati.
C Bisogna essere amanti del pericolo.
D Bisogna essere robusti.
8 Collega con le frecce l’aspetto che può assumere il fungo «semipiaci» con la causa che lo provoca e con l’effetto che il fungo provoca in chi lo mangia.
Causa
1. Il fungo prova antipatia per chi lo vorrebbe mangiare.
2. Il fungo prova simpatia per chi lo vorrebbe mangiare.
3. Il fungo è neutrale rispetto a chi vorrebbe mangiare.
Aspetto a. Bianco.
b. Rosso e giallo.
c. Verde, grinzoso e molliccio.
Effetto
1. Il fungo è immangiabile perché velenosissimo.
2. Il fungo non ha alcun gusto.
3. Il fungo è squisito.
9 Quali persone risultano essere antipatiche al fungo «semipiaci»?
Rintraccia le parole usate nel testo per definirle e riscrivile. (tre parole)
Malvagie e voraci.
10 Che tipo di persone sono Chulain, Hook e Mei?
A Timide e timorose.
B Dolci e sensibili.
11 Che cosa mangerà Sara?
A Una camelia in bianco.
B Una minestra misteriosa.
C Sanguinarie e crudeli.
D Dolci ma insensibili.
C Un prupus venusiano.
D Una camelia poco condita.
12 Chi dovrebbe assaggiare per primo il fungo «semipiaci»? Scrivi il nome del commensale.
Chulain.
13 Che cosa significa che Mei e gli altri commensali preferirebbero «qualche altra [...] specialità… non semovente» (riga 17 )?
A Che tutti mangerebbero volentieri qualcosa di fresco.
B Che Mei preferirebbe qualcosa di «non semovente».
C Che tutti preferirebbero una specialità non dotata di possibilità di movimento autonomo.
D Che tutti mangerebbero il prupus, ma non bollito.
1. c. 1.
2. b. 3.
3 .a. 2.
Attenzione!
Non contare solo i sostantivi, ma tutte le parole.
Attenzione!
È importante trovare nel testo il termine esatto.
14 Che cosa significa che «Sara deve mangiare in bianco» (riga 22 )?
A Che Sara è allergica a tutti gli alimenti colorati.
B Che Sara è a dieta.
C Che Sara sta per sposarsi.
D Che Sara deve mangiare solo il cibo servito in piatti bianchi.
15 Nel periodo «Devo dedurre… che non volete mangiare il fungo?» (riga 45 ) sono presenti due verbi servili: riscrivili.
16 Leggi le definizioni e trova le parole a cui si riferiscono.
a. Confezione fatta di due fogli, uno rigido e l’altro trasparente, che racchiudono un prodotto medicinale: ...................................... (sostantivo che inizia per B).
b. Contrastante con l’igiene e la pulizia: (aggettivo che inizia per S).
c. Piegare qualcosa a forma di arco: (verbo che inizia per C).
d. In modo freddo e distaccato: (avverbio che inizia per G).
17 Forma una collocazione lessicale, ovvero ricostruisci una «frase fatta», scegliendo la parola che completa quella proposta. Umore…
A …bianco.
B …blu.
C …giallo. D …nero.
18 Nella frase «Il mare era calmo», il verbo è un imperfetto: A storico.
B di consuetudine. C di contemporaneità. D descrittivo.
19 In quali delle seguenti frasi è presente il predicato verbale?
A Mia nonna è un’amante della musica lirica.
B Questo non è studiare.
C Marco è stato interrogato sugli antichi Romani.
D Sofia è un’infermiera.
20 Completa le parole nel modo corretto.
a. Questo gatto non è per niente inno.................................o come sembra.
b. La sciarpa di Francesca era piena di fran colorate.
Devo - volete blister sporco curvare gelidamente cu ge scie
c. Ci sono persone che non hanno pesi sulla co nza.
In un piccolo villaggio del XV secolo a.C., nella Valle dei Re, prende forma il mito di Ramses II. Oggi Deir el-Medina rappresenta uno straordinario spaccato della società egizia.
Nel XV secolo a.C. il faraone Thutmosi I stabilì che le tombe andassero nascoste: le piramidi erano troppo difficili da difendere dai profanatori, bisognava tornare a scavare sottoterra. Scelse per questo un’area sufficientemente isolata, ma i lavori previsti erano ingentissimi e c’era bisogno di manodopera: moltissime braccia e gambe pronte a tutto per lui. Si iniziò così a costruire una piccola città che doveva ospitare gli operai.
Una volta fondata, per i tre secoli successivi Deir el-Medina darà un tetto e una vita a numerose famiglie: si arriverà a contarne 120 nel periodo di maggior splendore durante il regno di Ramses II. Chi viveva quindi a Deir el-Medina? Operai specializzati, tagliapietre, stuccatori, intonacatori, disegnatori, incisori, pittori, scribi e molti altri con mogli e figli al seguito. È per questo che possiamo considerare la città come una specie di Egitto in miniatura. Una rappresentazione in piccolo della società egizia al tempo di Ramses II.
Alloggio incluso. «Servitori nel luogo della verità», questo è il nome che veniva dato a coloro che lavoravano a realizzare i monumenti funebri. Il faraone offriva incentivi a coloro che decidevano di prestare la propria opera a queste imprese. Chi veniva assunto come artigiano riceveva automaticamente una casa per sé e per la propria famiglia, oltre a una capanna a ridosso del posto di lavoro e, immancabilmente, anche una tomba.
Ricevevano inoltre un piccolo appezzamento di terreno con qualche animale, un asino, una capra, una vacca o una pecora.
Orari di lavoro. Sulla base di una serie di documenti redatti dagli scribi, i quali tenevano la contabilità delle candele distribuite agli operai per illuminare gli ambienti in cui questi si muovevano, si è potuto risalire con una certa precisione agli orari di lavoro. Accanto ai giorni di vacanza per occasioni speciali, c’erano i giorni di riposo fissi. Le sessioni di lavoro erano divise in blocchi da dieci giorni; il decimo giorno era dedicato al riposo e gli operai, che fino a quel momento avevano dormito nelle capanne o in abitazioni temporanee a ridosso del cantiere, potevano tornare a casa. Le giornate erano a loro volta divise in due blocchi distinti da quattro ore l’uno, separati da una pausa. Gli orari potevano variare visto che, con i sistemi di misurazione dell’epoca, le ore estive duravano dieci minuti in più delle nostre, e al contrario quelle invernali si aggiravano intorno ai cinquanta minuti. Se facciamo quindi un rapido conto, nei mesi più caldi le ore in cui si faticava sotto il sole erano più di nove.
da A. Angela, in «Focus Storia», n. 137, marzo 2018
1 Da quale rivista è tratto l’articolo che hai letto?
2 Che cos’è Deir el-Medina?
A Una piccola città di operai risalente al XV secolo a.C.
B Il luogo dove sono sepolti molti faraoni.
C Una residenza del faraone Thutmosi I.
D Un villaggio di agricoltori.
3 Quante famiglie vivevano a Deir el-Medina durante il regno di Ramses II?
4 Dove si trovano le tombe costruite dalle maestranze a Deir el-Medina?
5 Come veniva chiamato chi lavorava alla realizzazione dei monumenti funebri?
A Servitore della verità.
B Servitore nel luogo delle sepolture.
C Servitore nel luogo della verità.
D Servitore del faraone nel suo luogo preferito.
6 A che cosa non ha diritto chi viene assunto come artigiano?
A Una casa per sé e la sua famiglia e un appezzamento di terreno con degli animali.
B Una cassa di candele per ogni settimana di lavoro.
C Una capanna a ridosso del posto di lavoro.
D Una tomba.
7 Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.
a. Gli artigiani che lavorano alla costruzione dei monumenti funebri ricevono una casa, una tomba, ma non anche un appezzamento di terreno. V F
b. Le giornate lavorative a Deir el-Medina erano divise in due blocchi distinti da quattro ore ciascuno ed era previsto un intervallo tra i due. V F
c. Le sessioni di lavoro erano divise in periodi di tempo da undici giorni, di cui l’ultimo dedicato al riposo.
d. Non erano previsti giorni di riposo fissi.
e. Di norma gli operai vivevano in capanne o abitazioni temporanee costruite a ridosso del cantiere.
f. Erano previsti giorni di vacanza per occasioni speciali.
V F
V F
V F
V F
8 Chi teneva la contabilità delle candele distribuite agli operai?
A Gli scribi.
B I sacerdoti.
C Il faraone.
D Il capo degli operai.
9 Per volontà di quale faraone è sorta Deir el-Medina?
Thutmosi I
10 Quante ore si lavorava a Deir el-Medina nei mesi più caldi?
A Meno di 9 ore.
B Da 7 a 9 ore.
11 Perché è sorta Deir el-Medina?
C Non più di 9 ore.
D Più di 9 ore.
A Perché ci fosse molta manodopera che lavorasse alacremente alla costruzione delle sepolture dei faraoni.
B Perché, essendo più comodo per gli operai raggiungere il luogo di lavoro, essi fossero più felici.
C Perché il faraone potesse in qualunque momento controllare gli operai.
D Perché operai, scribi, incisori e pittori potessero vivere tutti insieme mentre lavoravano alla costruzione delle tombe.
12 Come si è potuto risalire all’orario di lavoro degli operai a Deir el-Medina?
A Dai documenti redatti dai faraoni.
B Dal numero delle candele ritrovate.
C Dai documenti redatti dagli scribi.
D Dai documenti redatti dagli operai.
13 Qual è lo scopo dell’articolo che hai letto?
A Spiegare come si viveva nell’antico Egitto.
B Spiegare perché il sito archeologico di Deir el-Medina è importante per gli archeologi.
C Spiegare come vivevano operai e artigiani al tempo del faraone Thutmosi I.
D Spiegare perché Thutmosi I decise di nascondere le tombe dei faraoni.
14 Perché Thutmosi I decise che le tombe dei faraoni andavano scavate?
A Perché per gli operai sarebbe stato più facile costruirle.
B Perché le piramidi erano troppo spesso profanate.
C Perché il faraone vuole essere ricordato per aver fatto costruire qualcosa di nuovo.
D Perché la mummia del faraone si sarebbe conservata meglio sottoterra.
15 Quanti minuti duravano mediamente le ore estive a Deir el-Medina all’epoca di Ramses II?
16 Osserva la tabella e indica in quale modo è stata usata la parola sottolineata.
Uso specialistico/ tecnico
Uso metaforico/ figurato
Uso comune
a. Il mattino ha l’oro in bocca.
b. La bocca o cavo orale (lat. cavum oris) è l’orifizio attraverso cui gli animali si cibano.
c. I bambini piccoli portano ogni cosa alla bocca
17 Forma una collocazione lessicale, ovvero ricostruisci una «frase fatta», scegliendo la parola che completa quella proposta.
Contrarre…
A …un regalo.
B …un’infezione.
C …una lite.
D …una discussione.
18 In quali delle seguenti parole il prefisso «anti» significa «prima» o «contro»?
antiatomico • antibagno • antibiotico • anticamente • antidiluviano • antilope • antiquariato
a. Anti = prima:
b. Anti = contro:
19 Nella frase «Questa poesia è di ispirazione dantesca», l’aggettivo sottolineato di che tipo è?
A Primitivo.
B Alterato.
C Composto.
D Derivato.
20 Leggi questa frase: «La frutta che hai raccolto in quella cassettina è davvero asprissima. Ora berrei caraffe d’acqua!». Se non conoscessi il significato delle parole sottolineate, quali voci dovresti cercare nel dizionario?
a. Cassettina:
b. Asprissima:
c. Caraffe:
Attenzione!
Non tutte le parole corrispondono alla richiesta dell’esercizio. antibagno, antidiluviano antiatomico, antibiotico Cassetta Aspra Caraffa
SHOPPING VIRTUALE Vetrine, manichini e salottini di prova cedono il passo a tour negli e-store, capi da provare in realtà aumentata, chat con assistenti personali. No, fare compere non è più come una volta. Ma resterà un’esperienza divertente. Seguici e scoprirai perché.
Hai presente i camerini? Bene. È possibile che diventino un reperto storico della moda, come le stecche di balena1 o i mutandoni alle ginocchia. Sì, perché se c’è una cosa che il virus ci ha insegnato è che l’e-commerce è una gran bella invenzione. Spinte dalla necessità del lockdown si sono convertite persino le meno smanettone, che hanno imparato a tracciare il pacco e ad accordarsi su orari e punti di consegna come veri corrieri.
«La pandemia» spiega Eugenio Gallavotti, docente di Moda e comunicazione all’Università IULM «ha semplicemente dato un’accelerata a un processo già in atto in tempi pre-virus: quell’irresistibile rivoluzione copernicana nella relazione tra cliente e punto vendita, che sta trasformando il pc di casa (o il cellulare che teniamo in tasca) nel camerino del negozio virtuale più rifornito e smart».
1. CROSS-SELLING
Il sistema con il quale, quando acquisti un capo, ti vengono proposti pezzi e accessori complementari, suggerendo un look totale, dalla testa ai piedi.
2. LIVE STREAM
In diretta con il negozio, le clienti connesse alla piattaforma chattano con le venditrici per avere, in tempo reale, consigli e dettagli sugli acquisti.
3. MARKETPLACE
Piattaforme di vendita che ospitano diversi produttori. Tra i più cliccati per l’abbigliamento, in Italia, ci sono Zalando, ASOS, Amazon, YOOX, eBay e Alibaba.
4. OMNICHANNEL
Strategia di vendita che utilizza canali diversi (online e in negozio) per rendere gli acquisti più semplici e piacevoli.
1 Stecche di balena: lamine presenti nella bocca di
5. REALTÀ AUMENTATA
Permette, con lo smartphone, di misurarti, scansionare una tua foto e provare virtualmente abiti e scarpe.
6. SITI AGGREGATORI
Raccolgono brand diversi in base a criteri come saldi o offerte speciali. In Italia il sito aggregatore più noto è Stileo.
7. SHOWROOMING
La pratica di chi va in negozio, misura la taglia del capo e poi lo compra online (tecnica detestata dai negozianti in carne e ossa!).
8. WEBROOMING
Contrario dello showrooming: prima si visita un negozio virtuale per studiare i prodotti, poi li si acquista in un negozio fisico.
9. WISHLIST
Se un prodotto ti piace ma non sei ancora convinta, puoi aggiungerlo alla tua wishlist, la lista dei desideri. Non lo perderai di vista e potrai decidere se e quando comprarlo.
al posto dei denti che, in passato, erano usate per irrigidire i busti degli abiti femminili.
I «clic» hanno fatto boom
Ma vediamo qualche numero. Secondo l’ultimo Netcomm Forum Live (fiera del commercio digitale), i consumatori italiani online sono triplicati, passando da 700 mila (dati gennaio-maggio 2019) a 2 milioni (stessa forbice temporale nel 2020).
L’e-commerce ha registrato un boom durante la pandemia che, secondo gli esperti, a fine anno segnerà una crescita mondiale del +55%. Il settore della moda, all’inizio, si è trovato spiazzato: sfilate sospese o in versione online, trasporti bloccati e negozi chiusi hanno fatto gelare il sangue agli addetti ai lavori (e alle fashioniste). Ma il tasto «shop» che compare nei menù a tendina di ogni sito si è rivelato la salvezza.
«Per fare qualche esempio,» continua Gallavotti «il colosso francese Kering (di cui fanno parte nomi come Gucci, Saint Laurent e Alexander McQueen) ha registrato sì una flessione di vendita nei negozi che ha raggiunto il -30%, ma ha avuto un aumento delle vendite online del 47%». Non solo: il marchio Moncler ha interrotto la collaborazione con il marketplace YOOX e ha deciso che, dall’anno prossimo, farà da sé. Segno che le potenzialità dell’e-commerce sono tutte da sfruttare senza bisogno di ricorrere a siti intermediari.
Gli spazi si trasformano
Ma come sarà lo shopping che ci aspetta? «Mi sembra che i brand più attrezzati si stiano muovendo nella medesima direzione, cioè non penalizzare i loro negozi ma trasformarli in altro rispetto al passato» dice l’esperto Gallavotti. «Il punto vendita diventa un hub, magazzino e centro di smistamento dove il cliente può andare a ritirare il capo acquistato via web». Sembra questa la strada intrapresa da colossi come Zara (nonostante la chiusura di ben 1200 dei suoi punti vendita) o Yamamay.
Il gruppo Miroglio, invece, punta su una strategia omnichannel per i suoi marchi Motivi ed Elena Mirò: con il servizio Go Instore, le clienti possono collegarsi al sito e farsi consigliare dal personale addetto come se fossero in negozio. La modalità Shopping Smart Box prevede anche l’invio a casa di una selezione di capi per prova e, eventualmente, acquisto.
Molto interessante anche servizio StyleSnap offerto da Amazon. Come spiega Tommaso Debenedetti, responsabile di settore di Amazon Italia: «Suggeriamo a chi cerca un capo di fotografarlo, inserirlo nel motore di ricerca che mettiamo a disposizione e selezionare tra un’ampia gamma di prodotti simili».
Acquistare virtualmente aiuta a scegliere meglio anche in termini di sostenibilità. Spiegano a Zalando: «Online è più semplice localizzare i brand attenti all’ambiente. La prova del nove? Durante il lockdown oltre il 30% dei clienti si è indirizzato sui capi di abbigliamento più eco-virtuosi della nostra offerta».
Altra possibilità affinata dal distanziamento è fare un tour virtuale del negozio, magari in realtà aumentata. È questa la soluzione coinvolgente scelta da grandi maison come Ferragamo, Prada e Valentino. Cliccare per credere.
La rapidità fa la differenza I problemi nodali dello shopping online? La consegna e i resi. Per quanto riguarda la prima, molte case si stanno organizzando affinché sia non solo veloce ma anche gratuita. La novità più attesa è senz’altro la consegna con i droni: rapidissima, è la nuova promessa di Amazon, che tra poco inizierà la sperimentazione in USA per pacchi sotto i 2,3 kg. Per quanto riguarda i resi, il nostro Paese è al quarto posto in Europa: il 43% dei clienti online restituisce almeno un prodotto, con abbigliamento e accessori al primo posto (con l’11%). I motivi? Nell’80% dei casi si tratta di taglie errate. In questo caso non è solo fondamentale leggere bene e verificare, metro alla mano, le misure ma anche scorrere le recensioni di chi ha acquistato prima di te e che spesso danno utili info su vestibilità e materiali.
Le tradizioni si aggiornano
È una domanda che tutti oggi si pongono: se, cioè, l’impennata dello shopping online si confermerà anche in futuro o se, nei prossimi mesi, torneremo gradualmente a modalità d’acquisto più tradizionali. Secondo una recentissima indagine svolta da Ipsos Strategy3 non ci sono dubbi: il 37% degli italiani ha intenzione di acquistare online addirittura di più nei prossimi 6/12 mesi e l’aumento degli acquisti di vestiti e accessori è previsto intorno al 44%. Ma se preferisci ancora l’esperienza fisica, con camerino & Co, puoi provare la nuova app ShoppinTime: la scarichi, cerchi il tuo negozio e fissi un appuntamento per essere accolta a braccia aperte. Ma a distanza di sicurezza e senza assembramenti.
adatt. da C. Ghirardato, in «Donna Moderna», 17 settembre 2020, n. 40, Mondadori
1 Che cosa significa che siamo in presenza di una «rivoluzione copernicana nella relazione tra cliente e punto vendita» (riga 11 )?
A Significa che il rapporto tra cliente e negozio è in una fase di stasi per cui non ci saranno cambiamenti in futuro rispetto a oggi.
B Significa che il rapporto tra cliente e negozio è in una fase di cambiamento epocale.
C Significa che il rapporto tra cliente e negozio è in una fase di cambiamento lento e inesorabile ma reversibile.
D Significa che il rapporto tra cliente e negozio è in una fase di cambiamento veloce e non più controllabile.
2 Quale pratica può essere considerata opposta allo showrooming?
A Il cross-selling.
B Il marketplace.
C L’omnichannel.
D Il webrooming.
3 Dove insegna il professor Gallavotti?
A All’Ipsos Strategy3.
B Alla IULM.
C Alla YOOX.
D A Miroglio.
4 Quali sono i problemi principali dello shopping online? (tre parole)
Consegna e resi.
5 Quale effetto ha avuto la pandemia sul settore della moda?
A Le case di moda si sono alleate per fare fronte alla crisi.
B I brand della moda hanno sviluppato app per prenotare la presenza alle sfilate.
C Le sfilate sono state sospese.
D Le sfilate sono state fatte solo in alcuni Paesi.
6 Quale necessità ha fatto in modo che i negozi di brand come Zara e Yamamay diventassero hub per i clienti?
A Quella di trasformare i propri punti vendita per non penalizzarli durante la pandemia.
B Quella di trasformare i propri punti vendita per aumentarne la visibilità durante la pandemia.
C Quella di non penalizzare i propri punti vendita e aumentarne la visibilità durante la pandemia.
D Quella di dover chiudere i propri punti vendita durante la pandemia.
7 In che cosa consiste il live stream?
A Si tratta di una modalità di recesso dall’acquisto: i/le clienti sono in chat con gli/le addetti/e alle vendite che ascoltano le problematiche riscontrate nel prodotto acquistato e spiegano loro come avere il rimborso in tempo reale.
B Si tratta di una modalità di acquisto da remoto: i/le clienti sono in chat con gli/le addetti/e alle vendite che li/le consigliano in tempo reale.
C Si tratta di una modalità di acquisto da remoto: i/le clienti sono consigliati/e dagli/dalle addetti/e alle vendite che propongono loro un look totale.
D Si tratta di una modalità di acquisto esclusivamente online: i/le clienti sono in chat con gli/le addetti/e alle vendite che li/le aiutano a trovare le taglie degli abiti ed eventualmente effettuare il reso.
8 Quale termine indica la strategia di vendita multicanale?
A Cross-selling.
B Marketplace.
C Omnichannel.
D Siti aggregatori.
9 Qual è lo scopo del testo che hai letto?
A Spiegare una serie di termini tecnici che interessano il settore delle vendite nel campo della moda dopo la pandemia.
B Spiegare come la pandemia ha trasformato in modo irreversibile il settore delle vendite nel campo della moda.
C Informare in merito alle trasformazioni del settore della produzione nel campo della moda.
D Informare in merito ad alcune trasformazioni del settore delle vendite nel campo della moda legate alla pandemia.
10 Il testo che hai appena letto è:
A un saggio inserito in una pubblicazione scientifica.
B un articolo presente, tra gli altri, in un giornale di attualità.
C un articolo presente in una rivista per addetti al settore della moda.
D un articolo di approfondimento inserito in una pubblicazione periodica di studi storici.
11 Che cosa renderà i camerini obsoleti? (due parole)
L’e-commerce.
Attenzione! Devi contare tutte le parole, non solo i sostantivi.
12 Cosa potrà velocizzare consegne e resi? (due parole)
13 Quali accorgimenti vanno ricordati, da parte del cliente, per limitare gli errori negli acquisti online?
A Misurare il prodotto con il metro; leggere attentamente le etichette presenti sul prodotto stesso e chiedere a chi già lo ha acquistato in negozio.
B Verificare le misure del prodotto con il metro; leggere attentamente le indicazioni sul prodotto; leggere le recensioni degli altri acquirenti.
C Verificare le dimensioni del prodotto con metro e bilancia; leggere attentamente le indicazioni sul sito del venditore; leggere le recensioni degli altri acquirenti.
D Verificare le misure del prodotto leggendo le recensioni degli altri acquirenti; leggere le indicazioni sul prodotto presenti nel sito.
14 Acquistare online aiuta a fare scelte ecosostenibili rispetto ai prodotti?
A Secondo Zalando sì: le vendite di prodotti più eco-virtuosi sono aumentate presso i clienti dell’azienda.
B Secondo Debenedetti sì: acquistare online significa avere meno merci nei negozi al dettaglio dove devono arrivare più mezzi di trasporto, con conseguente aumento dell’inquinamento ambientale.
C Secondo Kering sì: le vendite di prodotti online sono aumentate sensibilmente e lo smog è diminuito, non solo nelle grandi città.
D Secondo Miroglio no: le vendite di prodotti più eco-virtuosi non sono aumentate presso i clienti dell’azienda perché sono più costosi di altri.
15 Quale elemento dei menù a tendina dei siti è stato importantissimo per il settore del commercio durante il lockdown? (tre parole)
I droni. Il tasto «shop!»
16 Osserva la tabella e indica in quale modo è stata usata la parola sottolineata.
Registro basso Registro standard Registro elevato
a. Edipo spiegò l’enigma della Sfinge e la sconfisse.
b. Il detective arrivò a risolvere il mistero dopo una lunga indagine.
c. Che cos’è questa storia?
Parla chiaro! Senza indovinelli!
17 Individua la parola mancante in ciascuna frase sapendo che è la stessa per tutte e tre, ma usata con significato diverso.
a. Quell’azienda è a di fallimento perché troppo esposta con le banche.
b. Gli incursori intervennero solo dopo aver calcolato il di non coinvolgere gli ostaggi nella sparatoria.
c. Non correrò questo per te!
18 Nel periodo «Vorrei sapere che ore sono», la frase sottolineata è una proposizione:
A coordinata copulativa.
B subordinata interrogativa indiretta.
C subordinata oggettiva.
D subordinata temporale.
19 Un’espressione come «a furia di» è detta polirematica perché le parole che in essa compaiono assumono un significato unitario. Indica in quale delle seguenti frasi ne è presente una.
A Se vuoi la luce qui, devi accendere una candela.
B Senza un’accurata indagine non si riuscirà a fare luce sul caso.
C La società AcLux è il nuovo gestore nazionale del servizio di acqua e luce.
D In ventiquattro ore si alternano luce e buio.
20 Leggi questa frase: «Sentiva un dolorino al braccio, così consultò diversi chirurghi per farsi urgentissimamente operare: era davvero esagerato!». Se non conoscessi il significato delle parole sottolineate, quali voci dovresti cercare nel dizionario?
a. Dolorino:
b. Chirurghi: ...................................................
c. Urgentissimamente:
Attenzione!
La risposta è la stessa per tutte e tre le frasi. rischio rischio rischio dolore chirurgo urgentemente
Di che colore è il tuo fiocco?
Vi siete mai chiesti perché è così importante sapere, quando nasce un bambino, se è un maschio o una femmina o perché sui portoni o sui cancelli delle case vengono appesi bei fiocconi rosa o azzurri per indicare con precisione l’appartenenza ad uno o all’altro sesso?
Si sa che il sesso del nascituro è determinato dai cromosomi di mamma e papà ed è quindi un dato genetico, ma il modo di essere maschio o di essere femmina è sempre uguale o cambia nel corso della storia e da una civiltà ad un’altra? Nei suoi studi sul campo l’antropologa Margaret Mead, per esempio, ha conosciuto e studiato popolazioni in cui il maschio era dolce e accudiva i figli e altre in cui la donna aveva potere ed era molto attiva. Nella nostra società invece storicamente la donna è considerata più dolce e remissiva e l’uomo più attivo e deciso. Questo «modo» di essere maschio o femmina è un dato sociale ed è il modo in cui in una comunità vengono percepiti e intesi i due sessi. Anche se è difficile capire quanto il dato genetico e quanto quello sociale determini la differenza tra i due sessi, quello che si può dire è che, all’interno di ogni società, esistono degli stereotipi sessuali, a cui in genere tutti si conformano; ciò significa che in ogni società si ha un’idea precisa, anche se non sempre consapevole, di che cosa sia un maschio e che cosa sia una femmina e chi non vi si adegua o viene giudicato male o viene giudicato «diverso».
Che cosa fa la mamma, che cosa fa il papà?
La giornalista Elena Gianini Belotti già negli anni ’70 nel libro Dalla parte delle bambine sosteneva che non esistono qualità femminili o maschili esclusive, ma qualità umane che appartengono a maschi e femmine in ugual misura. Nessuno insegna come essere padri o madri e di solito, quando si diventa genitori, si riproduce con i figli il rapporto e il tipo di educazione ricevuta nella propria famiglia d’origine. Sono gli stessi genitori che modellano la personalità dei lori figli. Il bambino assimila nel proprio nucleo familiare di origine, per imitazione e tramite l’identificazione con il genitore del proprio sesso, dei modelli di comportamento ritenuti più adeguati per il proprio sesso e quando sarà a sua volta genitore li riproporrà da adulto.
La famiglia «tipo» degli anni ’50 riteneva necessaria per un suo buon funzionamento una rigida distinzione dei ruoli tra i due genitori: da un parte alla donna spettava il ruolo di moglie e di madre, dall’altra all’uomo spettava di essere bravo nel lavoro e di sostenere la famiglia. Oggi la famiglia è cambiata e gli uomini e le donne hanno un rapporto democratico tra loro e con i propri figli. La donna studia e, quasi sempre, lavora, l’uomo collabora in casa, ma le consuetudini, la tradizione, e le convenzioni sociali cambiano molto lentamente e l’arrivo di un figlio spesso riproduce gli antichi ruoli.
Una ricerca sugli stereotipi sessisti negli albi
Nel 2003 l’Assessorato al Sistema Educativo e alle Politiche di Pari Opportunità del Comune di Torino ha promosso un’indagine sugli albi, ovvero sui libri e i materiali didattici in uso nelle scuole dell’Infanzia e Primarie, per guidare al riconoscimento degli stereotipi sessisti in essi contenuti. L’indagine è stata pubblicata nella Guida alla decifrazione degli stereotipi sessisti negli albi.
L’immagine che segue è ricavata da questa ricerca e conferma la forza e la permanenza degli stereotipi sessisti. Secondo 153 bambini su 204, di età compresa tra i sette e i dieci anni, l’orso con il grembiule è una femmina perché «i maschi non mettono il grembiule», invece quello che legge il giornale è un maschio, perché «la mamma non ha mai il tempo di leggere. Deve fare i lavori…».
La ricerca di cui ti abbiamo mostrato alcuni dati è un buon esempio di come si possano concretamente interpretare le «politiche per le pari opportunità». Infatti è importante non solo che il ruolo delle donne sia tutelato dalla legge, ma anche che iniziative specifiche ne combattano la discriminazione all’interno della famiglia, della scuola, del lavoro e della società nel suo complesso.
da D. Lippera, Lettori senza frontiere, Vol. 3, Gruppo Editoriale Raffaello
1 Che cosa sono le «politiche per le pari opportunità» (riga 43 )?
A Sono iniziative politiche e leggi volte alla discriminazione sociale tra uomini e donne.
B Sono iniziative politiche e leggi volte alla promozione della parità tra uomini e donne in ogni campo: sociale, familiare, civile e lavorativo.
C Sono iniziative politiche e leggi volte alla tutela, in campo sociale e lavorativo, delle donne a danno degli uomini.
D Sono iniziative politiche e leggi deputate al mantenimento delle divisioni di ruoli tra uomini e donne in campo sociale e lavorativo.
2 Da che cosa è determinato il sesso di un bambino che sta per nascere?
A Dalle cellule staminali.
B Dai cromosomi.
C Dalle cellule somatiche.
D Dalle cromotipie.
3 Chi ha scritto il libro Dalla parte delle bambine?
Elena Gianini Belotti.
4 Come viene considerato storicamente l’uomo nella nostra società?
A Attivo e deciso.
B Dolce e remissivo.
C Cattivo e deciso.
D Aggressivo e indeciso.
Attenzione!
Nel testo trovi la risposta espressa esattamente con gli stessi termini.
5 Com’era la famiglia tipo degli anni ‘50?
A Prevedeva la costante presenza in casa del padre.
B Prevedeva una rigida distinzione tra genitori e nonni.
C Prevedeva che la donna lavorasse fuori casa.
D Prevedeva una rigida distinzione dei ruoli tra i due genitori.
6 Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sulla famiglia di oggi sono vere e quali false.
a. Nella famiglia di oggi c’è un rapporto democratico tra uomini e donne tra loro e con i propri figli.
V F
b. Nella famiglia di oggi la donna resta in casa ad accudire i figli. V F
c. Nella famiglia di oggi l’uomo collabora in casa. V F
d. Nella famiglia di oggi l’uomo deve preoccuparsi solo di essere bravo nel lavoro. V F
7 Chi è Margaret Mead?
A Un’archeologa.
B Un’antropologa.
C Un’astrologa.
D Un’antropomorfa.
8 Che cos’è uno stereotipo?
A È un’idea precisa e generalizzata, sempre consapevole, riguardo a qualche argomento, rispetto alla quale in genere tutti si conformano.
B È un’idea generale e non sempre consapevole riguardo a qualche argomento, rispetto alla quale in genere tutti si conformano.
C È un’idea precisa, anche se non sempre consapevole, riguardo a qualche argomento, rispetto alla quale in genere poche persone si conformano.
D È un’idea precisa, anche se non sempre consapevole, risultato di una generalizzazione riguardo a qualche argomento, rispetto alla quale in genere tutti si conformano.
9 Che cosa ha promosso nel 2003 l’Assessorato al Sistema Educativo e alle Politiche di Pari Opportunità del Comune di Torino?
A Un’indagine sui quaderni delle scuole dell’Infanzia e Primarie.
B Un’indagine sui disegni dei bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie.
C Un’indagine sugli albi delle scuole dell’Infanzia e Primarie.
D Un’indagine sui manuali delle scuole Primarie.
10 Che cosa sostiene l’autrice del libro Dalla parte delle bambine? Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.
a. I genitori non ripropongono ai figli il modello di educazione che loro stessi hanno ricevuto. V F
b. Non esistono qualità femminili o maschili esclusive. V F
c. Il bambino assimila, per imitazione e identificazione, i modelli di comportamento ritenuti più adeguati al proprio sesso. V F
d. Ci sono scuole che le persone possono frequentare per imparare ad essere genitori. V F
11 Secondo quanti bambini, di età compresa tra 7 e 10 anni, l’orso con il giornale del disegno non è un maschio?
12 Qual è la tesi sostenuta nel brano che hai letto?
A Le differenze tra maschi e femmine sono un dato genetico.
B In ogni società esistono degli stereotipi sessuali.
C I genitori modellano la personalità dei propri figli.
D Il ruolo delle donne nella società deve essere tutelato dalla legge.
13 La parola «fiocconi» (riga 3 ) è un sostantivo:
A derivato.
B alterato.
C singolare. D maschile.
14 Nella famiglia di oggi «gli uomini e le donne hanno un rapporto democratico tra loro» (riga 29 ). Che cosa provoca spesso l’arrivo di un figlio?
A Il rapporto tra i genitori si consolida.
B Il rapporto tra i genitori tende a tornare «tradizionale».
C Lo stesso rapporto che c’è tra i genitori si ripropone con i figli.
D Il rapporto figli-genitori cambia a seconda che essi siano maschi o femmine.
15 Come viene interpretata l’immagine presente nel testo, secondo lo stereotipo sessista?
A L’orso con il grembiule è sicuramente la mamma.
B L’orso con il grembiule è sicuramente il papà.
C Non si può stabilire con certezza se l’orso con il grembiule sia la mamma.
D Non si può stabilire con certezza se l’orso senza il grembiule sia il papà.
16 Osserva la tabella e indica in quale modo è stata usata la parola sottolineata.
Uso specialistico/ tecnico Uso metaforico/ figurato Uso comune
Attenzione! Per rispondere a questa domanda devi svolgere una semplice operazione aritmetica.
a. Forse l’orologio non funziona perché si è rotta una molla.
b. Giorgio era carico come una molla per la partita da giocare.
c. Il dinamometro è uno strumento di misura costituito da una molla e da una scala graduata parallela al vettore forza da misurare.
17 Leggi le definizioni e trova le parole a cui si riferiscono.
a. Cosa inaspettata: (sostantivo che inizia per S).
b. Sconveniente, riprovevole in quanto contrario all’educazione comune: (aggettivo che inizia per D).
c. Scegliere tra varie possibilità: (verbo che inizia per O).
sorpresa disdicevole optare molto
d. In grande misura, usato anche per formare il superlativo assoluto di aggettivi o avverbi: (avverbio che inizia per M).
18 Nella frase «Avrete certamente sonno a quest’ora», il verbo indica:
A un dubbio.
B una supposizione.
C un’azione futura.
D una concessione.
19 In quali delle seguenti parole «bis» è un prefisso?
A bisogno
B bisonte
C bisdrucciolo
D bisturi
E bisnonno
F bisbetico
20 In quali delle seguenti frasi è presente contemporaneamente un attributo e un complemento oggetto?
A Ho invitato degli amici simpatici alla festa di domani.
B Perché non chiedi a Giovanni la bici in prestito?
C Il gatto, salito sull’albero, non riusciva a scendere.
D Lucia ha curato il cane della sorella fino a ieri.
Attenzione! Le risposte a questa domanda non si trovano nel testo.
Tri tri tri, fru fru fru, uhi uhi uhi, ihu ihu ihu.
Il poeta si diverte, pazzamente, smisuratamente!
Non lo state a insolentire, lasciatelo divertire poveretto, queste piccole corbellerie sono il suo diletto.
Cucù, rurù, rurù cucù, cuccuccurucù!
Cosa sono queste indecenze?
Queste strofe bisbetiche?
Licenze, licenze, licenze poetiche. Sono la mia passione.
Farafarafarafa, Tarataratarata, Paraparaparapa, Laralaralarala!
Sapete cosa sono?
Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie.
Bubububu, fufufufu, Friù!
Friù!
Ma se d’un qualunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso?
Bilobilobilobilobilo blum!
Filofilofilofilofilo flum!
Bilolù. Filolù. U.
Non è vero che non voglion dire, vogliono dire qualcosa. Voglion dire… come quando uno si mette a cantare senza saper le parole. Una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace di fare.
Aaaaa!
Eeeee! Iiiii!
Ooooo!
Uuuuu!
A! E! I! O! U!
Ma giovinotto, diteci un poco una cosa, non è la vostra una posa, di voler con così poco tenere alimentato un sì gran foco?
Huisc... Huiusc… Huisciu… sciu sciu, Sciukoku… Koku koku, Sciu ko ku.
Ma come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese, sembra ormai che scriviate in giapponese.
Abì, alì, alarì. Riririri!
Ri.
Lasciate pure che si sbizzarrisca, anzi, è bene che non lo finisca, il divertimento gli costerà caro: gli daranno del somaro.
Labala falala falala eppoi lala. Lalala, lalala.
Certo è un azzardo un po’ forte scrivere delle cose così, che ci son professori, oggidì, a tutte le porte.
Ahahahahahahah!
Ahahahahahahah! Ahahahahahahah!
Infine, io ho pienamente ragione, i tempi sono molto cambiati, gli uomini non dimandano più nulla dai poeti, e lasciatemi divertire!
1 Nella poesia che hai letto, sono presenti strofe:
A sempre composte di tre, quattro e otto versi.
B i cui versi sono legati da rime alternate.
C interamente onomatopeiche.
D i cui versi sono tutti endecasillabi e novenari.
2 La poesia ha la struttura di un dialogo tra il poeta e chi?
A Qualcuno che giudica provocatorio questo modo di scrivere le poesie e lo critica.
B Qualcuno che non comprende il suo modo di scrivere le poesie.
C Qualcuno che apprezza il suo modo di scrivere le poesie, lo trova divertente.
D Qualcuno che, pur criticando questo modo di scrivere le poesie, lo giudica comunque innovativo e lo apprezza.
3 In un verso preciso, uno degli interlocutori del poeta si rivolge direttamente a lui apostrofandolo. Puoi indicarne il numero?
4 Come è definito il poeta nei versi che hai letto?
Attenzione!
È riportato il numero di un verso ogni 5, conta a partire dall’ultimo numero che vedi prima della riga che ti interessa. 57
A Poveretto ma insolente.
B Giovinetto e bisbetico.
C Somaro e insolente. D Poveretto e fesso.
5 Quale funzione ha la poesia secondo l’autore?
A Insegnare ai lettori come comportarsi.
B Insegnare agli altri poeti come comporre versi moderni.
C Puro divertimento.
D Intrattenere altri poeti.
6 Quale figura retorica è presente nei versi 18-19 : «Licenze, licenze, licenze poetiche»?
A Anafora.
B Metafora.
C Onomatopea.
D Allitterazione.
7 Secondo l’autore, la poesia è ancora utile all’uomo?
A Sì, è sempre un piacere leggere poesie.
B Sì, eleva l’animo del lettore e del poeta.
C No, non vengono più poste domande ai poeti ed essi non hanno quindi risposte da dare.
D No, leggere poesie scritte da altri è noioso oggi come lo è sempre stato.
8 Come sono definite le strofe scritte dal poeta?
A Corbellerie.
B Bisbetiche.
C Poetiche.
D Grullerie.
9 Secondo uno degli interlocutori del poeta, è diventato così difficile comprendere i suoi versi che sembra che egli scriva in un’altra lingua. Quale?
Giapponese
10 Che cosa rischia il poeta se continua a scrivere poesie come questa?
A Nessuno leggerà più quello che scrive perché incomprensibile.
B Sarà giudicato dai lettori un poeta giocherellone e superficiale.
C I lettori diranno che il poeta è un somaro.
D Il poeta avrà grande successo.
11 La poesia che hai letto è strutturata in strofe i cui versi sono:
A sparsi.
B liberi.
C misti.
D legati da rime ed enjambement.
12 Quale può essere la parola chiave della poesia che hai letto?
A «Insolentire» (v. 8).
B «Divertire» (v. 9).
C «Cantare» (v. 47).
D «Si sbizzarrisca» (v. 75).
13 Rileggi i versi dal 13 al 15 : c’è una allitterazione. Di quale vocale?
U Attenzione!
La domanda chiede la vocale, non l’intera sillaba.
14 Quale caratteristica hanno le poesie di questo autore secondo uno dei suoi interlocutori?
A Sono senza legami con la realtà.
B Sono senza rime.
C Sono senza nessi.
D Sono senza utilità.
15 Che cosa indica l’espressione «gran foco» al verso 62 ?
A L’arte della poesia.
B Un grande fuoco.
C L’arte dello scrivere in italiano corretto.
D Un grande sentimento.
16 Forma una collocazione lessicale, ovvero ricostruisci una «frase fatta», scegliendo la parola che completa quella proposta.
Sgominare…
A …una banca.
B …una banda.
C …un’orchestra.
D …un campo minato.
17 Nella frase seguente è presente un errore: la parola sottolineata somiglia a quella giusta ma non lo è. Scrivi tu quella corretta e appropriata al contesto della frase stessa.
madida
La ragazza era matita di sudore per la lunga corsa. ...............................................................
18 Indica in quali delle seguenti parole il prefisso «post» significa «dopo».
A postbellico
B postale
C postilla
D postdatato
E poster
F postulato
G posteggio
19 Un’espressione come «di punto in bianco» è detta polirematica perché le parole che in essa compaiono assumono un significato unitario. Indica in quale delle seguenti frasi ne è presente una.
A Nella sua vita ha conosciuto molti alti e bassi.
B Il cruciverba ha definizioni orizzontali e verticali.
C Il pied de poule è una fantasia optical a scacchi bianchi e neri.
D Questo telo è troppo lungo: ci sarebbe servito più largo.
20 Nella frase «Non ho nessuna voglia di ascoltarti», che tipo di aggettivo compare?
A Indefinito.
B Dimostrativo.
C Qualificativo.
D Negativo.
In questo laboratorio ti proponiamo di realizzare insieme ai tuoi compagni un manifesto che promuova l’educazione alla pace. Potrete divulgarlo a scuola, nella vostra città, oppure spedirlo al Ministro dell’Istruzione, per promuovere l’educazione alla pace nelle scuole e sensibilizzare i giovani e tutti i cittadini al rispetto e al dialogo tra le persone.
Step 1 - Raccogli dati e informazioni
Un manifesto che voglia promuovere il rispetto degli altri, la pace e il dialogo tra le persone deve contenere dati e informazioni attendibili: dire soltanto che dobbiamo essere a favore della pace non sarà sufficiente per convincere i compagni di Istituto o il Ministro. Per raccogliere informazioni e prendere spunti per il tuo manifesto, puoi affidarti a internet, per esempio collegandoti al sito Human right watch, www.hrw.org, oppure al sito di Emergency, www.emergency.it.
Step 2 - Organizza i materiali raccolti
Dopo aver letto gli articoli, prendi nota delle informazioni più importanti: questa procedura ti aiuterà a individuare le parole che ritieni più significative e appropriate al tema. Ricordati di inserire anche immagini e simboli che evochino la pace e il dialogo, che ti saranno utili per completare il manifesto insieme ai tuoi compagni.
Step 3 - Elabora le tue proposte
Ora puoi cominciare a elaborare delle proposte: per esempio, per rendere più efficace il tuo messaggio, potresti inserire alcune frasi sulla pace e il dialogo tra i popoli pronunciate da persone importanti.
Per aiutarti ti suggeriamo qualche esempio:
• «La pace non è il lavoro di un uomo solo, di un partito, di una nazione. Non c’è una pace delle nazioni grandi o piccole, la pace è il frutto della cooperazione di tutto il mondo». Barack Obama
• «Non si può separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in pace senza avere libertà». Malcolm X
• «La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro». S. Giovanni Paolo II
Step 4 - Clil Project - Write in English
Tutti i manifesti contengono sempre uno slogan e in molti casi sono scritti in inglese; ideate anche voi uno slogan in inglese da riportare sul vostro manifesto. Per facilitarvi nel compito ecco alcuni esempi:
• World Peace
• I Love Peace • Peace Forever • No War
Step 5 - Condividi il tuo lavoro con i compagni
Utilizza le funzionalità del M.I.O. BOOK per condividere con i tuoi compagni il risultato del tuo lavoro. Insieme mettete a confronto le vostre idee e le vostre opinioni. Scegliete lo slogan che vi sembra più significativo e riportatelo sul manifesto. Completate il manifesto con il disegno del planisfero sul quale indicherete i Paesi dove si combattono ancora guerre.
Step 6 - Presentate il vostro manifesto
Presentate il vostro manifesto. Diffondete e condividete con le altre classi la vostra proposta e organizzate tutti assieme un evento a scuola per promuovere la pace.
1 Qual è lo scopo del manifesto che il laboratorio propone di creare?
A Promuovere l’educazione alla cittadinanza.
B Promuovere l’educazione alla pace.
C Promuovere l’educazione alle nuove tecnologie.
D Promuovere l’educazione interculturale.
2 A quale istituzione potrebbe essere spedito il manifesto da creare?
A Alla classe parallela alla tua.
B Alla tua scuola.
C Al Comune della città in cui vivi.
D Al Ministero dell’Istruzione.
3 Nell’espressione «deve contenere dati e informazioni attendibili» (riga 7 ), con quale parola può essere sostituita la parola «attendibili» senza cambiare il senso del messaggio?
A Verificati.
B Credibili.
C Ammissibili.
D Verosimili.
4 Dopo aver letto gli articoli utili alla creazione del manifesto, è bene prendere nota delle informazioni più importanti. Perché? Rintraccia nel testo la risposta e riscrivila.
Questa procedura ti aiuterà a individuare le parole che ritieni più significative e appropriate al tema (rif. righe 13-15).
5 Nello step 5 è previsto che nel manifesto sia disegnato il planisfero. A che scopo?
A Abbellire il manifesto.
B Mostrare le zone di guerra nel mondo.
C Usare il manifesto anche per studiare la geografia.
D Arricchire la presentazione dell’attività svolta.
6 Basandoti sul testo, indica quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.
a. Il laboratorio prevede che una parte del manifesto sia in lingua inglese. V F
b. Il laboratorio promuove alcune competenze base di Cittadinanza.
c. Nel testo di presentazione delle attività del laboratorio non sono presenti esempi.
d. Negli appunti da prendere allo step 2 non devono essere inserite immagini o simboli di pace.
V F
V F
V F
e. L’attività proposta dal laboratorio è organizzata in sei step. V F
f. I siti internet consigliati per raccogliere informazioni per l’attività promossa dal laboratorio sono: www.hrw.org e www.emergency.it.
V F
7 Il laboratorio prevede un momento di socializzazione finale dei manifesti prodotti. Che cosa si suggerisce di fare?
A Organizzare un evento per promuovere una raccolta fondi.
B Organizzare un evento a scuola per mostrare a tutti i manifesti.
C Organizzare un evento a scuola per promuovere la pace.
D Organizzare un evento a scuola per promuovere la solidarietà.
8 Come si possono condividere le informazioni di lavoro sul manifesto tra compagni?
A Usando una piattaforma digitale.
B Scambiandosi foglietti e disegni.
C Telefonandosi.
D Solo vedendosi a scuola.
9 Che cosa significa la parola «step» che ricorre nel testo?
A Un gradino da superare.
B Un momento del lavoro da svolgere, anche non obbligatorio.
C Un momento obbligatorio del lavoro da svolgere.
D Un momento del lavoro da svolgere in ordine casuale.
10 A quale personaggio è attribuita la seguente frase: «Non si può separare la pace dalla libertà perché nessuno può essere in pace senza avere libertà»?
Malcom X.
11 Che cosa permette di fare il M.I.O. BOOK?
A Condividere il lavoro con i compagni.
B Presentare il manifesto realizzato.
C Creare manifesti come quello chiesto dal laboratorio.
D Trovare slogan sulla pace.
12 A quale progetto fa riferimento la necessità che lo slogan del manifesto sia scritto in inglese?
CLIL Project (Write in English).
13 Qual è lo scopo del testo che hai letto?
A Dare istruzioni per condurre un’attività didattica.
B Spiegare come costruire manifesti e poster a scuola.
C Dare istruzioni per condurre ricerche in internet.
D Spiegare a tutti, studenti e genitori, che la pace è importante.
14 In quale step si possono cominciare ad elaborare delle proposte di lavoro?
15 Nell’espressione «la pace non può regnare tra gli uomini» (riga 25 ), quale figura retorica è presente?
A Metafora.
B Similitudine.
C Allitterazione.
D Personificazione.
16 Individua la parola mancante in ciascuna frase sapendo che è la stessa per tutte e tre, ma usata con significato diverso.
a. Gli amici di Marta i pettegolezzi su di lei.
b. I gas tossici .............................................. i soldati in trincea durante la Prima guerra mondiale.
c. I pompieri l’incendio in pochi minuti.
Attenzione!
La risposta è la stessa per tutte le frasi. soffocarono soffocarono soffocarono
17 Nella frase seguente è presente un errore: la parola sottolineata somiglia a quella giusta ma non lo è. Scrivi tu quella corretta e appropriata al contesto della frase stessa.
Cavour adottò una politica libera nello Stato sabaudo.
liberale
18 Nel periodo «Non vi permetterà di offenderli», la frase sottolineata è una proposizione:
A subordinata oggettiva.
B subordinata soggettiva.
C subordinata consecutiva.
D subordinata finale.
19 Un’espressione come «carta da lettere» è detta polirematica perché le parole che in essa compaiono assumono un significato unitario. Indica in quale delle seguenti frasi ne è presente una.
A I fiori d’arancio sulle pergole erano bellissimi.
B Porta fiori e cioccolatini alla nonna per il suo compleanno.
C Ho i brividi a fior di pelle per quello che mi stai dicendo.
D Quale crema prendo per proteggere pelle e capelli dal sole?
20 Completa le parole nel modo corretto.
a. I risultati elettorali nelle provin del Centro sono già stati pubblicati.
b. Questo modo di fare non è prof o per noi.
ce cu
c. Chiediamo all’us re dov’è l’ufficio A37.
cie
La stanza dove i ragazzi prendevano i pasti era grande e disadorna, con una caldaia a una delle estremità. Il direttore, piazzato lì davanti, all’ora dei pasti distribuiva la farinata, avvolto per l’occasione in un grembiulone e aiutato da due donne. Ogni ragazzo ne riceveva una scodella e niente altro, salvo che per le grandi ricorrenze, quando venivano distribuite due once e un quarto di pane. Le scodelle non avevano bisogno di essere lavate; i ragazzi le pulivano con i cucchiai fino a che non erano perfettamente lucide, poi se ne stavano seduti fissando la caldaia con occhi famelici come se volessero divorare persino i mattoni del focolare e intanto si leccavano le dita con la ferma intenzione di spazzar via le minime tracce di farinata, che potevano esservi rimaste. I ragazzi di solito hanno un ottimo appetito. Per tre mesi Oliver e i suoi compagni soffrirono le torture di una fame sempre più insopportabile; alla fine erano così esasperati e inferociti che uno dei ragazzi, più alto e sviluppato degli altri e non abituato a quel regime così stretto perché suo padre un tempo aveva una piccola taverna, dichiarò cupamente ai compagni di sventura: «Se non raddoppiano il numero delle farinate, una notte o l’altra finirò per divorare il mio vicino di letto, che è piccolo e debole». Ed era così arrabbiato, c’era tanta determinazione nella sua voce e nei suoi occhi che gli altri non stentarono a credergli. Venne tenuto consiglio e si tirò a sorte il nome di colui che quella sera stessa, dopo la distribuzione della farinata, sarebbe andato dal direttore a chiedere l’aumento delle razioni. Venne estratto Oliver Twist.
Giunse la sera. I ragazzi si misero a tavola, il direttore avvolto nel solito grembiulone prese posto accanto alla caldaia insieme alle due aiutanti. Venne servita la farinata, più allungata del solito, condita da una lunga preghiera di ringraziamento. I ragazzi confabulavano sottovoce e sbirciavano Oliver, i due più vicini lo presero a gomitate per sollecitarlo ad agire.
Sebbene fosse solo un bambino, Oliver, esasperato dalla fame, riuscì a trovare il coraggio sufficiente per alzarsi, con il cucchiaio e la scodella in mano, avvicinarsi al direttore e dirgli, un po’ stupito della sua audacia: «Per favore, signore, ne vorrei ancora».
Il direttore era un uomo robusto, grasso e ben piantato, con un’aria decisa, tuttavia nel sentire quelle parole impallidì. Per qualche secondo fissò strabiliato il piccolo ribelle, poi si appoggiò alla caldaia per sostenersi. Le sue aiutanti erano come paralizzate dalla meraviglia; i ragazzi dallo stupore. «Che hai detto?» riuscì finalmente a balbettare il direttore.
«Per favore, signore,» ripeté Oliver «ne vorrei ancora: di farinata».
Il direttore assestò un gran colpo di ramaiolo sulla testa di Oliver, poi lo afferrò ben stretto e strillando come un’aquila chiamò il sagrestano.
Il consiglio era solennemente riunito per la seduta serale quando il signor Bumble si precipitò nella stanza e rivolgendosi al signore che sedeva sulla poltrona a braccioli annunciò, in tono eccitatissimo: «La prego di scusarmi, signor Limbkins! Oliver Twist ne ha chiesta ancora!».
Tutti quanti trasalirono, orripilati.
«Ancora!» esclamò il signor Limbkins. «Per favore si calmi, Bumble, e cerchi di essere più chiaro. Lei intende dire che il ragazzo, dopo aver mangiato la farinata concessa dal regolamento, ne ha chiesta ancora?».
«Proprio questo ha fatto, signore» rispose Bumble.
«Quel ragazzo finirà impiccato prima o poi» disse il signore dal panciotto bianco. «Ci giurerei che farà quella fine».
Nessuno contraddisse la profetica opinione. Subito dopo ebbe luogo un’animata discussione, al termine della quale Oliver venne condannato all’immediata segregazione e la mattina seguente venne
appeso al cancello dell’ospizio un cartello nel quale si offriva una ricompensa di cinque sterline a chi avesse sbarazzato la parrocchia dalla presenza di Oliver Twist. In altre parole, Oliver e cinque sterline in contanti sarebbero state elargite a chi, uomo o donna, avesse avuto bisogno di un apprendista per qualsiasi mestiere.
Per una settimana, dopo la scandalosa richiesta di un aumento della razione di farinata, Oliver rimase prigioniero in una stanza buia e solitaria a riflettere sui suoi misfatti.
adatt. da C. Dickens, Oliver Twist, Fabbri
1 La farinata è l’alimento che viene distribuito durante i pasti. Secondo te, quali possono essere gli ingredienti base?
A Patate e farina.
B Acqua e farina.
C Burro e farina.
D Pomodoro e farina.
2 Nella frase «come se volessero divorare persino i mattoni del focolare» (riga 7 ) è contenuta una figura retorica. Quale?
A Metafora.
B Esagerazione.
C Ellissi.
D Anafora.
3 Da quello che hai letto, dove vivono i ragazzi protagonisti della storia?
A In un ospedale.
B In una caserma.
C In un orfanotrofio.
D In una prigione.
4 Per definire lo stato d’animo dei ragazzi, messo a dura prova dalla fame, l’autore usa due aggettivi. Quali?
Esasperati, inferociti (riga 12).
5 Per quale missione viene sorteggiato Oliver Twist?
A Per lamentarsi con il direttore.
B Per chiedere al direttore di aggiungere altri ingredienti alla farinata.
C Per chiedere l’aumento delle razioni di carne.
D Per chiedere l’aumento delle razioni di farinata.
6 Rileggi le righe 25-27 ed escludi per ciascun personaggio il termine che non ne descrive lo stato d’animo del momento.
a. Oliver felice esasperato stupito
b. Direttore impallidito strabiliato sicuro di sé
c. Aiutanti del direttore meravigliate obbedienti paralizzate
d. Ragazzi incapaci di muoversi confusionari stupiti
Attenzione!
La domanda chiede quale NON è lo stato d’animo dei personaggi.
7 Perché Oliver Twist viene punito severamente per aver chiesto un’altra porzione di farinata?
A Per l’arroganza.
B Per la disobbedienza.
C Per l’ingordigia.
D Per la maleducazione.
8 Quale immediato provvedimento viene preso dal consiglio per punire Oliver Twist?
A Viene appeso al cancello dell’ospizio.
B Viene venduto per cinque sterline.
C Viene rinchiuso in una stanza buia.
D Non viene preso nessun provvedimento.
Wittenau, 27 aprile 1945
Il giorno della liberazione è venuto. Scrivo solo oggi dopo una settimana di incubo, tre giorni di rifugio e un giorno di riposo.
Ero al campo di Jungfernheide quando una notte sentimmo le prime cannonate; il fronte si avvicinava, dato che i russi premevano sulle truppe tedesche proprio in direzione di Jungfernheide. Immediatamente la vita al campo divenne piena di elettricità e di incubo. Due pensieri passavano per la mente di tutti: la gioia della prossima liberazione da questi tedeschi che negli ultimi giorni erano diventati feroci e la paura dei prossimi giorni che certamente sarebbero stati duri e pericolosi. Ad un certo momento le prime granate cominciarono a piovere nel campo, rade e isolate dapprima, fitte e frequenti poi. In baracca non ci si poteva stare che a rischio della vita, poiché le schegge passavano il legno in ogni direzione. Due compagni che erano rimasti imprudentemente all’aperto ebbero uno le gambe staccate di netto e l’altro due schegge al torace. Pur tuttavia rimasi ancora molto tempo in baracca resistendo alle granate. Non che avessi una gran dose di coraggio, ma si era impossessata di me una curiosa tranquillità che rasentava l’incoscienza. In mezzo agli scoppi gli amici si meravigliavano di vedermi girare dalla camera al lavandino o al gabinetto. Mi sentivo invece stranamente sicuro. La fame si faceva sentire perché provviste per il campo non ne arrivavano più; si cercavano patate. Un giorno si sparse la notizia che vicino alla linea del fuoco i tedeschi avevano aperto un deposito di patate. Mezzo campo se ne andò, o meglio fuggì, i sacchi e i tascapani sulle spalle. Anche io con il tascapane mi avviai. Bisognava attraversare tratti allo scoperto martellati dalle granate, ma all’andata tutto andò bene, non essendosi i russi accorti di nulla. Presi le patate, ma quale fu diverso il ritorno! I russi si accorsero del movimento di persone e cominciarono a tirare. Con il sacco pieno sulle spalle, mi misi a correre tra gli scoppi, celandomi tra i radi cespugli; stavo correndo quando vidi improvvisamente uno che mi correva innanzi cadere con la fronte spaccata in due in un lago di sangue. Era il primo compagno che vedevo morire così, mi fece così tanta impressione che, arrivato in baracca, non riuscivo più a parlare.
Da quel giorno ricevemmo l’ordine di sistemarci nei rifugi ed attendere che passasse la furia. Siamo stati tre giorni nel rifugio al buio, nutrendoci di patate lesse, quattro per pasto, tra milioni di pulci, in mezzo ad un letamaio di paglia, bucce di patate, carta, terra bagnata e perfino orina, poiché per una giornata intera non si poté uscire. Di fuori fioccavano pallottole di tutti i calibri. Per creare un ponte sul fiume vicino, i russi battevano tutta la zona con un fuoco infernale. Tre giorni durante i quali i miei nervi, il fisico tutto e buona parte del morale subirono un abbassamento dannoso. Dentro al rifugio non si capiva più nulla tra il fragore delle granate, il chiacchierare di tutti. Seduto sulla valigia mi sentivo diventare matto. Milioni di supposizioni si facevano sulla situazione all’esterno e quei pochi che avevano messo il naso fuori riportavano notizie sconclusionate e contraddittorie. Il fuoco cresceva ancor più di intensità ed il rifugio sembrava una nave in tempesta.
Fu precisamente alle ore 24,25 della notte tra il 25 e il 26 che il primo soldato russo, sorridente e curioso, si affacciò alla porta del rifugio. Da tutti i petti scoppiò un urlo di gioia e sembrava che tutti fossero impazziti. Uscii anche io insieme a molti. Il campo non si riconosceva più, la terra sembrava una schiumarola, le baracche erano mezze crollate ed in mezzo al campo c’erano tre carri armati russi che sputavano fuoco come vulcani. L’aria della notte mi solleticava piacevolmente le nari e l’odore della polvere mi eccitava.
Strinsi la mano al russo che mi sorrise. Dopo mezz’ora arrivarono altri russi che ci fecero andare via, indietro, verso le colonne russe che avanzavano. Feci a piedi dieci chilometri, quella notte,
rifacendo il percorso dell’avanzata russa su luoghi ancora fumanti del combattimento. Dappertutto mucchi di armi abbandonate, elmetti, panzerfaust1, soldati tedeschi morti rovesciati in mille pose. Tutte impressioni che gli occhi ricevevano per la prima volta in vita mia e che facevano battere il cuore d’emozione.
Quando si fece giorno, mi apparve anche l’aspetto delle case completamente sfondate e svuotate. La popolazione aveva abbandonato in massa e precipitosamente le località e la truppa vincitrice era penetrata ovunque. Mi assalì la febbre della vendetta. Entrai in molte case a far bottino: trovai farina, scatole, pranzi pronti, piatti e recipienti pieni di ogni ben di Dio, vestiti. Mangiai, mi satollai, mi sporcai di zuppe e di farina, mi nauseai. Sbocconcellavo pane barcollando per lo stordimento e la stanchezza.
Avevo trovato un carrettino a mano che riempii di farina, scatole, bottiglie, ecc. e me lo trascinavo dietro, soffiando. Contento. Felice di questa nuova voluttà mai provata, avevo diritto a depredare (i russi mi guardavano approvando) perché anch’io, in quanto straniero, facevo parte dell’esercito vincitore e lo facevo con voluttà, con febbre frenetica. Così dovevano fare in tempi antichi le orde dei vincitori che si riversavano sui paesi vinti. Era già giorno fatto quando giunsi a questo campo internazionale di Wittenau dove mi trovo tuttora. Dovevo avere un aspetto fantastico: la barba lunga, il viso sporco e imbrattato di marmellata e di resti di zuppe, i capelli arruffati, con un paio di pantaloni grigi e una palandrana marrone trovati in un armadio. Le maniche erano sporche di farina e unte ed i pantaloni avevano i segni di tutti i luoghi dove mi ero inginocchiato a raccogliere. Ridevo, però, ed ero felice. Avevo incontrato molti russi che mi avevano regalato sigarette e caramelle, i tedeschi e la guerra erano molto lontani, tutto avevo lasciato alle spalle.
da T. Di Leo, Berlino 1943/1945: diario di prigionia, Quattroventi
1 panzerfaust: lanciagranate individuale anticarro.
1 La «liberazione» di cui si parla alla riga 1 è:
A la liberazione dai russi.
B la liberazione dai fascisti.
C la liberazione dai tedeschi.
D la liberazione dagli italiani.
2 Quali sono i due sentimenti che si alternavano nella mente e nei cuori dei prigionieri, nei primi momenti in attesa della liberazione? (tre parole)
D Perciò. Gioia e paura (righe 7-8).
3 Nella frase «Pur tuttavia rimasi ancora molto tempo in baracca», alle righe 11-12 , con quale altra congiunzione puoi sostituire «Pur tuttavia»?
A Però.
B Nonostante questo.
C Finché.
4 Alla riga 13 , perché la tranquillità del protagonista viene definita «curiosa»?
A Perché è un comportamento insolito nel protagonista.
B Perché in tanta agitazione il protagonista è diventato molto curioso.
C Perché tutti i suoi compagni si sono incuriositi nel vederlo così tranquillo.
D Perché è un atteggiamento inaspettato in una simile situazione.
5 Alle righe 38-39 , nell’espressione «c’erano tre carri armati russi che sputavano fuoco come vulcani», quali figure retoriche riconosci?
6 Qual è il nome della località in cui giunge il protagonista alla fine della sua fuga?
7 Il narratore è:
A lo stesso protagonista.
B un prigioniero amico del protagonista.
C un soldato.
D un narratore esterno.
8 Il testo che hai letto è:
A una cronaca.
B una pagina di diario.
C una lettera.
D un racconto. Personificazione; similitudine. Wittenau.
Attenzione!
Nel caso in cui la località non fosse nominata nel testo, all’inizio di una pagina di diario puoi sempre trovare il luogo e la data in cui la pagina è stata scritta.
La mamma non è molto contenta di com’è andato il mio primo giorno di scuola.
«Marco, cosa ci facevi con il telefonino?!» mi urla.
«Ma non lo stavo usando» reclamo.
«Allora perché te l’hanno sequestrato?» incalza lei.
«Dragan dice che lo fanno sempre, altrimenti i genitori non si presentano mai a parlare con la preside!».
«E chi è Dragan?» insiste mamma.
«Il mio nuovo compagno di banco» dichiaro.
«Pazzesco!» esclama lei. «Comunque, visto che te l’hanno sequestrato, adesso per un po’ resterai senza!» sentenzia.
«Ma non sono stato io» piagnucolo. «Ha cominciato lui».
«Non mi interessa! Hai fatto proprio una bella figura…» ribatte mentre infila i piatti nella lavastoviglie.
«Però non posso stare senza telefonino» controbatto.
«Perché?».
«Perché come faccio a parlare con papà?! Mi presti il tuo?».
La mamma tace. Ha un’espressione cupa. Stringe i denti.
«Dovrei dirglielo…» annuncia seria avviando il programma di lavaggio.
«No. Ti prego. Per favore…».
Lei mi scruta, poi inspira profondamente.
«D’accordo… Andrò a parlare con la preside e me lo farò restituire. Però tu da oggi in poi il telefonino lo lascerai sempre a casa. Siamo intesi? Ora fila a fare i compiti, e per stasera niente tivù».
Stamattina a scuola mi guardano tutti in modo strano. Mi osservano e poi parlottano tra loro. Due ragazze che non conosco mi fanno ciao con la mano.
Io rispondo timidamente al saluto, poi infilo le mani in tasca e avanzo verso l’ingresso a testa bassa. Dragan mi viene incontro raggiante.
«Ma che hanno tutti da guardare?» chiedo. «Sono così strano?».
«Allora non sai niente?!» esclama lui.
«Cosa dovrei sapere?».
Dragan incalza: «Ieri Xorro ha pubblicato sul suo profilo di Facebook un video della tua scazzottata con Francesco».
«Zorro1?!».
«Ma quale Zorro! Xorro!» insiste lui.
«Chi?».
«Xorro, con la ics» precisa.
«Con la ics?» esclamo incredulo. «Che razza di nome è?».
«Un nome in codice» sussurra il mio compagno di banco. «Una versione moderna di Zorro, ma più misteriosa…».
«E chi è?» domando ancora.
«Non lo sa nessuno! Te l’ho detto: è un’identità segreta. Ma deve essere uno della scuola».
«Come fai a dirlo?» azzardo io.
1 Zorro: celebre personaggio di fantasia, eroe mascherato e bravissimo spadaccino, le cui avventure si svolgono in California nel periodo del dominio spagnolo.
«Lo è per forza! Altrimenti come avrebbe fatto a riprenderti col telefonino?! Ha pubblicato anche una didascalia. “Condannato ingiustamente un innocente”» conclude serio.
«Scusa, e tu come hai fatto a saperlo?».
«Perché Ghigo, un emo2 della F, ha condiviso il video sul suo profilo di Facebook. Comunque ieri sera il video l’avevano condiviso praticamente tutti gli alunni della scuola».
«Tutti?!» esclamo sorpreso.
«Beh… Non proprio tutti… Tutti quelli che non sopportano Francesco e che hanno il profilo su Facebook. Ora sei una star, goditelo!».
«Esagerato» rispondo ridendo.
«Ti dico di sì. Borghetz3, se avessi Facebook lo avresti visto anche tu».
«Ma non ce l’ho!» rispondo lamentandomi.
«Senti…» azzarda lui. «Perché oggi non vieni a casa mia così te lo mostro?».
«Non posso… Sono in castigo…».
«Perché?».
«Per la storia del telefonino…» dico rammaricandomi. Non è giusto che mia mamma sia così severa quando prende una posizione «educativa», come dice lei, però taccio e il pensiero me lo tengo per me.
«Trova una scusa!» propone Dragan.
«No. Mia madre lo scoprirebbe e poi sarebbe peggio».
«Dici?».
«Fidati, conosco mia madre».
adatt. da D. Conati, Amici virtu@li, Gruppo Editoriale Raffaello
2 emo: ragazzo che si veste secondo la moda emo, uno stile punk-rock.
3 Borghetz: soprannome di Marco, che deriva dal suo cognome, Borghesi.
1 Per quale motivo la mamma è arrabbiata con Marco?
A Perché era stato assente a scuola.
B Perché aveva il telefonino a scuola.
C Perché non ha fatto i compiti.
D Perché è arrivato in ritardo a casa.
2 Perché tutti guardano Marco all’ingresso a scuola?
A Lo hanno notato perché è nuovo della scuola.
B Lo hanno notato perché è vestito in modo stravagante e non ha la divisa della scuola.
C Lo hanno visto in un video su Facebook in cui si picchia con Francesco.
D Lo hanno visto solo e triste perché non ha il telefonino.
3 Chi è Xorro?
A Una persona sconosciuta.
B Un compagno di Marco.
C Un emo della F. D Il preside della scuola.
4 Chi ha postato il video di Marco e Francesco?
A Xorro.
B Dragan.
C Ghigo.
D Francesco.
5 Marco è l’unico a non aver visto il filmato che lo ritrae; che cosa gli propone di fare allora Dragan?
A Di iscriversi a Facebook.
B Di andare a vederlo a casa sua.
C Di andare a vederlo a casa di un amico.
D Di vederlo sul computer della scuola.
6 Per quale motivo Marco, nonostante sia incitato dall’amico, non vuole mentire a sua madre?
A Perché teme che la madre lo metta in castigo.
B Perché è convinto che la madre lo scoprirebbe.
C Perché non riesce a mentire a sua madre.
D Perché non si fida dei consigli dell’amico.
7 All’interno del brano sono presenti diversi personaggi. Collega ogni personaggio al suo ruolo corrispondente.
a. Marco 1. Aiutante
a. 3
b. Xorro 2. Personaggio secondario
b. 1
c. Francesco 3. Protagonista
c. 4
d. Ghigo 4. Antagonista
d. 2
8 Che cosa è successo a Marco il primo giorno di scuola?
A Ha conosciuto Francesco e Dragan, gli hanno sequestrato il telefonino, si è picchiato con Xorro.
B Ha conosciuto Dragan, gli hanno sequestrato il telefonino, si è picchiato con Francesco.
C Ha conosciuto Xorro, gli hanno sequestrato il telefonino, si è picchiato con Francesco.
D Ha conosciuto Dragan e Ghigo, si è iscritto a Facebook, si è picchiato con Francesco.
Caratteristiche del documento
La carta di identità elettronica (CIE) è l’evoluzione della carta di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di un bancomat ed è costituita da:
• un supporto di materiale plastico in policarbonato, su cui sono stampati a laser la foto e i dati del cittadino, protetti con elementi e tecniche di anticontraffazione1, come ologrammi2 e inchiostri speciali;
• un microchip contactless3 .
Su ciascuna CIE è riportato un numero di serie stampato sul fronte in alto a destra e avente il seguente formato: 2 lettere – 5 numeri – 2 lettere (ad esempio CA00000AA). Tale numero è il Numero Unico Nazionale.
Numero di serie del documento
Dati anagrafici del titolare 2 1
Data di scadenza
Validità per l’espatrio
Codice fiscale in formato alfanumerico 3 4
MRZ - Codice a lettura ottica Codice fiscale in formato barcode
1 anticontraffazione: che ostacolano la falsificazione.
Card Access Number
1
Indica la presenza di un microchip contactless conforme alla normativa internazionale di riferimento per i documenti di viaggio elettronici, come il passaporto


Codice numerico utilizzato dalle autorità di controllo per la lettura dei dati memorizzati nel microchip
3
4 2
Permette di leggere, decodificare e verificare in automatico, con strumenti a lettura ottica (OCR), le informazioni contenute nel documento
Codice fiscale leggibile mediante uno scanner ottico
2 ologrammi: immagini tridimensionali realizzate con una tecnica fotografica specifica.
3 contactless: tecnologia che consente la trasmissione di dati senza contatto fisico.
Elementi di sicurezza
La CIE è un documento sicuro realizzato con un materiale, il policarbonato, che, mediante l’applicazione di specifici elementi di anticontraffazione (ad es. ologrammi, inchiostri speciali…) e l’utilizzo di particolari tecniche di stampa, assicura una efficace barriera contro i tentativi di contraffazione.
Tecnica di personalizzazione
I dati variabili presenti sul documento (dati anagrafici, fotografia, codice fiscale…) sono stampati in bianco e nero con la tecnica laser engraving che incide gli strati di policarbonato intermedi di cui il documento si compone, rendendo complessi eventuali tentativi di falsificazione. La disposizione dei campi sul documento (nome, cognome, foto…) è conforme agli standard internazionali di riferimento per i documenti di identità e di viaggio al fine di favorire il controllo del documento sia in Italia che all’estero.
Immagine del volto
La riproduzione dell’immagine del volto del titolare sul documento è un elemento essenziale per un efficace riconoscimento. È stampata in bianco e nero con tecnica laser engraving sul fronte, protetta da un ologramma trasparente sovrapposto all’immagine, e sul retro con tecnica ghost.
Grafica del documento
Le immagini e i motivi grafici vengono riprodotti con un effetto a rilievo, mediante un intreccio di linee sottili, con deformazioni e variazione di spessore (guilloche) atti a rendere evidenti eventuali tentativi di falsificazione e contraffazione.
La CIE presenta elementi grafici caratteristici dello Stato italiano, quali l’emblema della Repubblica Italiana sul fronte e la geometria della Piazza del Campidoglio in Roma, opera di Michelangelo Buonarroti, sul retro.
Il microchip
Il microchip contactless integrato nel documento rende la CIE uno strumento unico e sicuro per la verifica dell’identità del titolare e per l’accesso ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese. All’interno del microchip sono memorizzati in maniera sicura i dati personali e biometrici del titolare (foto e impronte digitali), nonché le informazioni che ne consentono l’identificazione online.
Verifica dell’identità del titolare
Come il passaporto e il permesso di soggiorno, il microchip contenuto nella CIE è conforme alle raccomandazioni internazionali ICAO 9303 che regolamentano le caratteristiche dei documenti di viaggio elettronici. Ciò consente, ad esempio, di utilizzare la CIE come documento di viaggio riconosciuto dai Paesi dell’area Schengen4
Accesso ai servizi online
La CIE estende il tradizionale concetto di identità, fornendo ai cittadini una chiave digitale unica e sicura per l’accesso ai servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese, anche in mobilità.
La richiesta al Comune
La carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora per i cittadini residenti in Italia e presso il Consolato di riferimento per i cittadini residenti all’estero. Per questi ultimi le modalità di rilascio sono indicate sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
4 area Schengen: comprende molti Paesi europei entro i quali è possibile viaggiare senza controlli alle frontiere.
La durata del documento varia secondo le fasce d’età di appartenenza. Nel dettaglio:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione. Prima di avviare la pratica di rilascio della carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti, quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare il numero della ricevuta di pagamento.
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
adatt. da www.cartaidentita.interno.gov.it
1 In quale materiale è realizzata la CIE?
A Poliuretano.
B Policarbonato.
C Plastica. D Silicio.
2 Quale tecnica non è impiegata nella realizzazione della CIE?
A Laser flashing .
B Laser engraving .
3 Dove si richiede la CIE?
C Guilloche . D Ghost .
A Presso il Comune di residenza o la Provincia se si è cittadini stranieri.
B In qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione presente dove si abita, anche se si è cittadini stranieri.
C Presso il proprio Comune di residenza, di dimora o, se si è cittadini stranieri, presso il Consolato di riferimento.
D Presso gli uffici della Pubblica Amministrazione a Roma o, se si è cittadini stranieri, presso la Capitale dello Stato di cui si è originari.
4 Qual è lo scopo di questo testo?
A Informare il cittadino delle possibilità offerte dal microchip della CIE.
B Aiutare il cittadino a riconoscere le truffe a mezzo bancomat.
C Informare il cittadino sulle caratteristiche della CIE.
D Mettere in guardia il cittadino sulle possibili truffe a carico della CIE.
5 Qual è la durata della CIE per un bambino di 3 anni?
A 3 anni.
B 5 anni.
C 10 anni.
D Non si può fare la CIE per un bambino così piccolo.
6 Che cosa serve per chiedere il rilascio della CIE?
A Una fototessera, il codice fiscale (o la tessera sanitaria), la ricevuta del versamento della somma dovuta al Comune quale corrispettivo per il rilascio della CIE e, ove previsto, il versamento dei diritti fissi e di segreteria.
B Una fototessera, il passaporto, la ricevuta del versamento della somma dovuta al Comune quale corrispettivo per il rilascio della CIE e, ove previsto, il versamento dei diritti fissi e di segreteria.
C Una fototessera, il codice fiscale, la ricevuta attestante l’avvenuto versamento al Comune dei diritti di segreteria per la produzione della CIE.
D Il codice fiscale (o tessera sanitaria) e la ricevuta del versamento della somma di € 16,79 dovuta al Comune quale corrispettivo per il rilascio della CIE.
7 Che cosa non è consentito con la CIE?
A Viaggiare nei Paesi dell’area Schengen.
B Avere accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione.
C Essere indentificati online dalla Pubblica Amministrazione e/o dalle imprese.
D Guidare l’auto avendo compiuto 18 anni.
8 A che cosa serve il simbolo ICAO?
A Indica la presenza, nella CIE, di un dispositivo anticontraffazione dell’identità personale conforme alle raccomandazioni internazionali relative ai documenti di viaggio.
B Indica la presenza, nella CIE, di un microchip conforme alle raccomandazioni internazionali relative ai documenti di viaggio.
C Indica la presenza, nella CIE, di un microchip contenente i dati anagrafici e biometrici necessari per i viaggi fuori dell’Europa.
D Indica l’assenza, nella CIE, di un microchip conforme alle raccomandazioni internazionali relative ai documenti di viaggio.
1 Individua la parola mancante in ciascuna frase sapendo che è la stessa per tutte e tre, ma usata con significato diverso.
a. Nel 31 a.C., Ottaviano schierò tutto l’ bellico a sua disposizione contro Marco Antonio.
b. L’ critico su Petrarca è vastissimo perché molti storici della letteratura si sono occupati della sua opera.
c. I vermi platelminti non hanno l’....................................... respiratorio.
Attenzione!
La risposta è la stessa per tutte le frasi. apparato apparato apparato
2 Forma una collocazione lessicale, ovvero ricostruisci una «frase fatta», scegliendo la parola che completa quella proposta. Dirimere…
A …una rissa.
B …una matassa.
C …una controversia.
D …una notizia.
3 Osserva la tabella e indica secondo quale registro sono usate le parole sottolineate.
Registro basso Registro standard Registro elevato
a. L’oratore riuscì a concentrare l’attenzione su di sé per tutto il tempo della conferenza.
b. Francesco è stato davvero bravo ad attirare tutti gli sguardi su di lui.
c. Sei proprio una calamita per i guai!
Attenzione! Per rispondere correttamente prova a pensare a come ti esprimi con i tuoi amici (registro basso), con qualcuno che non conosci (registro standard) e quando devi scrivere qualcosa di più formale, come un tema (registro elevato).
1 Nella frase «Il Po è più lungo dell’Adige», di che grado è l’aggettivo sottolineato?
A Positivo.
B Comparativo di maggioranza.
C Superlativo.
D Comparativo di minoranza.
2 Completa le parole nel modo corretto.
a. Luigi ha fatto davvero un buon a isto ieri.
gnu cie
b. Se o no di noi facesse del bene, il mondo sarebbe migliore.
c. Il meccanico tiene il motore in piena effi nza.
3 In quale delle seguenti frasi non è presente il predicato nominale?
A Arianna è stata sgridata dalla zia.
B Il mare oggi è calmo come una tavola.
C In quella discussione fu difficile non essere d’accordo con lei.
D Questa moto è la tua!
4 Leggi questa frase: «Il cattivissimo bandito estrasse un coltellaccio dalla tasca e – tra lo stupore generale – tagliò il pane». Se non conoscessi il significato delle parole sottolineate, quali voci dovresti cercare nel dizionario?
a. Cattivissimo:
b. Estrasse: ...................................................
c. Coltellaccio: ...................................................
Attenzione! Aiutati con la radice della parola, che rimane invariata. cattivo estrarre coltello
5 Nel periodo «Matteo, eletto capoclasse, è davvero un bravo studente», la frase sottolineata è una proposizione:
A incidentale.
B coordinata copulativa.
C subordinata relativa implicita.
D subordinata temporale implicita.
Questa sezione contiene tre esempi di percorsi interdisciplinari per il colloquio d’esame, con tanti spunti per collegare tra loro le diverse materie.

Un tema spinoso che affonda le sue radici oltre due secoli fa ma che è ancora molto attuale.
Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento in Europa e anche in Italia si diffonde una nuova tipologia di romanzo, definito «sociale» perché porta all’attenzione dei lettori le condizioni di vita delle classi più umili, rendendo così protagonisti i reietti della società al tempo della Seconda rivoluzione industriale. In particolare potresti prendere come esempio la novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga (1840-1922), la storia di un ragazzo analfabeta che lavora come minatore in una cava di rena rossa e il cui tragico epilogo ben rappresenta la parabola discendente della vita dei poveri del tempo.
Il lavoro minorile è l’attività lavorativa che priva le bambine e i bambini della loro infanzia e della loro dignità, e influisce negativamente sul loro sviluppo psico-fisico. Purtroppo ancora oggi il lavoro minorile rappresenta un fenomeno di dimensioni globali, tanto che, secondo le ultime stime, sono ancora 152 milioni i bambini e gli adolescenti ‒ 64 milioni sono bambine e 88 milioni sono bambini ‒ che ne sono vittime. A questo proposito potresti citare il Target 8.7 dell’Obiettivo 8 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con il quale tutti i Paesi si sono impegnati ad adottare misure immediate per eliminare le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2025.
La Rivoluzione industriale ha portato fin dall’inizio grandi cambiamenti nella vita delle persone, in particolare nella vita di molte bambine e bambini che, per sopravvivere in famiglie proletarie indigenti, avevano la necessità di lavorare nelle manifatture e nelle fabbriche. Ricorda che essi lavoravano per molte ore consecutive in luoghi insalubri e spesso pericolosi, venivano puniti e malpagati e soprattutto venivano scelti dai proprietari delle industrie perché, a differenza degli adulti, tendevano a non ribellarsi e a non avanzare mai pretese sui loro diritti ignorati e calpestati. Le cose migliorarono un po’ con alcuni provvedimenti legislativi, come per esempio i Factory Acts del 1819 in Inghilterra.
L’India è stata la culla delle civiltà orientali, ma col tempo purtroppo si è guadagnata un posto tra gli Stati più poveri del mondo, sopraffatta da un incontrollato aumento della popolazione e vittima degli abusi perpetrati da secoli di colonizzazioni. Aiutati con questi dati: è il Paese del mondo con il più alto tasso di bambine e bambini sfruttati nel lavoro, con più di 42 milioni di giovanissimi che non vanno a scuola e oltre 10 milioni costretti a lavorare. Addirittura il 23% del PIL nazionale è garantito dal lavoro di bambine e bambini. Milioni di persone vivono con poco più di un dollaro al giorno: lo sfruttamento minorile è diffuso, infatti, dove dilagano la miseria e la povertà.
L’Inghilterra, come sai, è stata la prima protagonista di entrambe le rivoluzioni industriali ed è lì che sono iniziati i problemi dello sfruttamento degli operai, tra cui i minori, impiegati nelle manifatture. La penna più prolifica e significativa della letteratura inglese su questo importante tema è stata quella di Charles Dickens (18121870) che, con opere come Oliver Twist o David Copperfield, ha tentato di denunciare i vizi e i mali della sua epoca, la corruzione nata sotto la spinta inarrestabile dell’industrializzazione e lo spietato sfruttamento dei più giovani a opera di industriali senza scrupoli.
Il lavoro minorile ha serie conseguenze sulla salute e sullo sviluppo di bambine, bambini e adolescenti, che corrono rischi molto più elevati rispetto a un adulto impiegato nello stesso lavoro. La casistica di infortuni e malattie che colpiscono le giovani e i giovani sfruttati è molto ampia e comprende fratture, ustioni, malattie della pelle, malattie respiratorie e gastrointestinali, fino ad arrivare a invalidità permanenti. A questo proposito, puoi parlare del sistema muscolo-scheletrico, sottolineando che il lavoro minorile può avere anche conseguenze a lungo termine, poiché alcuni lavori costringono le ragazze e i ragazzi a pose innaturali che interferiscono con un corretto sviluppo fisico.
Il tema del lavoro minorile, non tanto come elemento di denuncia, piuttosto come specchio della società del tempo, è stato rappresentato anche in diverse opere d’arte tra Ottocento e Novecento. Ti sarà capitato di imbatterti in opere pittoriche che hanno come protagonisti i poveri, gli emarginati, gli sfruttati e le condizioni misere in cui erano costretti a vivere e lavorare. Puoi citare per esempio i dipinti di pittori come Gustave Courbet (1819-1877) o Jean-François Millet (1814-1875), esponenti del realismo francese, che volevano rappresentare la dura realtà dei lavoratori proletari senza allegorie né idealizzazioni.

Iqbal è un bambino pakistano che inizia a lavorare a soli quattro anni e viene poi venduto come schiavo a un fabbricante di tappeti da cui tenta di fuggire, senza successo. Quando tempo dopo riesce finalmente a liberarsi definitivamente, è vittima di un tragico incidente. Nel libro Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo, Iqbal dice: «Nessun bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite. Da grande voglio fare l’avvocato e lottare perché i bambini non lavorino affatto».


Un sentimento prezioso che inizia da quando compare l’essere umano e di cui nessuno può fare a meno, nella vita e nel lavoro.
Nella storia della letteratura sono innumerevoli le poesie e i racconti che parlano di amicizia, ma tu potresti fare riferimento al rapporto particolare che legò uno degli scrittori italiani più famosi e uno dei compositori più importanti al mondo: Alessandro Manzoni (1785-1873) e Giuseppe Verdi (1813-1901). La loro ammirazione reciproca fu resa ancora più solida dalla condivisione dello stesso progetto politico: vissero entrambi al tempo dei moti rivoluzionari, e furono strenui sostenitori degli ideali liberali, che diffusero nelle loro opere. Manzoni, per esempio, scrisse l’ode civile Marzo 1821, mentre Verdi compose opere come il Don Carlos, che lo resero uno vero e proprio simbolo della lotta per l’unità d’Italia.
«We have a dream» potrebbe essere la frase con cui riassumere una grande amicizia, un rapporto speciale tra due grandi personalità che hanno combattuto strenuamente per difendere i diritti delle persone afroamericane in America: Rosa Parks e Martin Luther King. I due facevano parte della stessa associazione, nata per sostenere gli afroamericani: lì si conobbero e divennero amici. Quando lei fu arrestata per non aver ceduto il suo posto a un bianco sull’autobus, Martin organizzò una protesta lunga un anno per far abolire quella legge così ingiusta, che da ragazzino aveva coinvolto anche lui (che però all’epoca non si era ribellato). I due continuarono sempre a combattere insieme contro la discriminazione
Sicuramente hai affrontato il tema della legalità e della lotta alla mafia, dunque di certo hai studiato uomini importanti del calibro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che hanno dato la vita per i valori in cui credevano, ma forse non conosci la storia della loro amicizia. Erano cresciuti insieme per le strade di Palermo, ma presto avevano capito che nella loro terra qualcosa non andava. Decisero quindi che avrebbero fatto di tutto per diventare giudici e combattere insieme quel male che si annidava ovunque: coordinarono indagini, catturarono capi, convinsero alcuni malavitosi a collaborare, affrontarono situazioni molto difficili… ma ebbero sempre la certezza di essere nel giusto e di poter contare l’uno sull’altro.
Sapevi che la scoperta più sensazionale della storia della genetica è avvenuta grazie al talento e all’affiatamento di due grandi amici? Francis Crick e James Watson erano due ricercatori del Laboratorio Cavendish a Cambridge e nel 1953 scoprirono la struttura a doppia elica del DNA. Incontrarono però l’ostilità del direttore del laboratorio, che voleva favorire un altro ricercatore. Uniti e fieri, i due non si lasciarono abbattere, ma dimostrarono al direttore la validità delle loro idee costruendo un modello di DNA in ferro e cartone, e a quel punto tutti capirono che avevano appena cambiato la storia della scienza.
Nella letteratura inglese sono narrate alcune celebri amicizie, come quella tra Frodo e Sam, ne Il Signore degli anelli, o quella tra Holmes e Watson, ma ce n’è una un po’ particolare meritevole di considerazione, perché connessa a tanti temi sociali, storici, filosofici e morali: il rapporto tra il celebre naufrago Robinson Crusoe e il suo servo Friday, così chiamato dal giorno in cui Robinson lo salvò dai cannibali. È vero che questo romanzo è stato definito una «allegoria del colonialismo», perché inizialmente Robinson si propone di insegnare a Friday l’inglese e la fede in Dio, tuttavia è innegabile che tra i due ci sia un legame profondo che col tempo è diventato un rapporto di reciproco sostegno e collaborazione.
Il mondo dello sport non è dominato soltanto dal senso di rivalità e dallo spirito di competizione: più spesso di quanto si pensi, tra i grandi campioni che tutti ammiriamo nascono anche legami indissolubili e tenaci. Fai riferimento per esempio all’amicizia tra Fausto Coppi e Gino Bartali, due grandi ciclisti del secondo dopoguerra, che diedero un significato nobile e leale alla parola «rivalità»: trascinavano nelle loro salite anche le speranze e i sogni di tanti italiani. Celebre è lo scatto che li immortala mentre si passano la borraccia durante una competizione, anche se non hanno mai voluto rivelare chi ha aiutato l’altro.
La Francia ha dato i natali a molti artisti e letterati famosi, che tra loro potevano essere concorrenti ma talvolta anche amici, come nel caso di Paul Gauguin (1848-1903) e Vincent Van Gogh (1853-1890). La loro amicizia era profonda, ma anche segnata da asperità e conflitti; la critica ha cercato a lungo di capire questo rapporto mettendo a confronto, per esempio, le due famose sedie dipinte da entrambi, simili ma al contempo diverse e cariche di simboli. Potresti parlare però anche dell’amicizia raffigurata nell’arte, citando Renoir (1841-1919) e uno dei suoi quadri più famosi, Le déjeuner des canotiers, dove alcuni amici scambiano quattro chiacchiere nella veranda di un ristorante.


Pierre Auguste Renoir - La colazione dei canottieri
L’amicizia è uno dei temi preferiti dai romanzieri di tutti i tempi, ma uno spunto molto recente ti viene offerto da Elena Ferrante, autrice del libro L’amica geniale, il primo di quattro volumi. La vicenda si svolge alla periferia di Napoli a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso e ha per protagoniste Elena e Raffaella, due inseparabili amiche molto diverse tra loro. La scuola, la famiglia, gli amori fanno da sfondo a tutte le loro vicende che portano le due ragazze anche ad allontanarsi, senza però indebolire il loro legame.
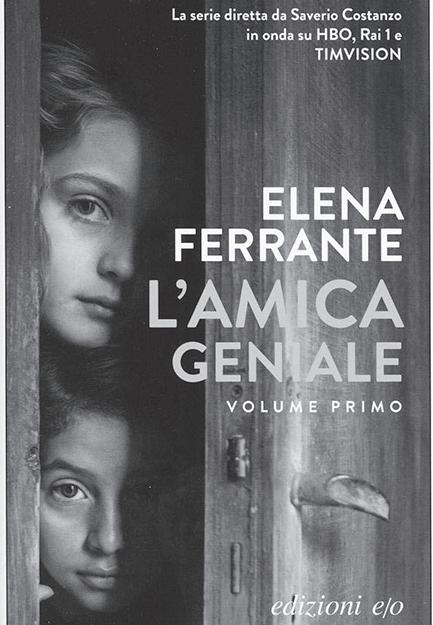
Un tema trasversale dalle molteplici interpretazioni: percorso interiore, voglia di evasione o necessità?

Il viaggio in letteratura consente tante interpretazioni: c’è il viaggio simbolico, c’è quello introspettivo, c’è quello di formazione… ma esiste anche il viaggio in senso letterale, quello che porta l’artista a toccare sempre nuovi luoghi e città, spinto da un desiderio di connessione con il mondo e di rinnovamento dell’anima. Giacomo Leopardi, per esempio, in fuga dal suo piccolo borgo, era costantemente alla ricerca di nuovi stimoli e girò per molte città italiane; ma pensa anche a Giuseppe Ungaretti, che trascorse vari periodi della sua vita in diversi luoghi del mondo: in riferimento a ciò potresti citare la poesia Girovago.
I flussi migratori sono un fenomeno tangibile del mondo attuale, ma si tratta di un fenomeno che caratterizza l’essere umano fin dalla sua comparsa, quando agli albori della sua esistenza si muoveva alla ricerca di cibo e nuove risorse da sfruttare, e da allora non ha mai smesso di spostarsi. Oggi le esigenze di migrare sono diverse, dalle più semplici, come il desiderio di un nuovo posto in cui vivere, alle più gravi, come la ricerca di lavoro o la fuga dalla guerra e dalla carestia. Tieni presente che l’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 mira proprio a ridurre le disuguaglianze all’interno dei e tra i Paesi, affinché nessuno debba più sentirsi obbligato a scappare dalle condizioni di vita in cui vive.
Il tema del viaggio è il motore di molti eventi della storia: pensa alle scoperte oceaniche o alle colonizzazioni di nuove terre. Spesso, però, gli esseri umani sono stati costretti a partire spinti non dal desiderio di scoprire e commerciare, ma dalla pressione di circostanze che impedivano loro di proseguire un’esistenza dignitosa: si tratta dei viaggi che hanno portato milioni di persone a emigrare alla ricerca di lavoro, in particolare gli italiani che tra fine Ottocento e inizio Novecento sono emigrati in America per cercare fortuna, vivendo sulla loro pelle la discriminazione e l’odio di chi li considerava dei «pericolosi invasori».
Come sai, molte persone nel mondo si spostano per vivere altrove, ma ci sono anche coloro che semplicemente hanno i mezzi economici e il tempo per compiere viaggi più o meno lunghi, raggiungendo mete più o meno lontane. E questo grande mercato dei «viaggi di piacere» alimenta in larga parte il famoso e redditizio settore terziario, composto da attività commerciali e servizi rivolti alla persona. Il primo posto tra i Paesi più visitati al mondo nel 2023 è occupato dalla Francia, e tieni presente che nello stesso anno sono stati registrati in tutto il mondo 1 miliardo e 286 milioni di turisti internazionali, con un aumento rispetto al 2022 che diventa ancora più consistente se paragonato ai dati rilevati in periodo pandemico nel 2020.
«Sì, viaggiare, evitando le buche più dure…» cantava Lucio Battisti nel 1977. E da allora forse qualcosa è cambiato nelle nostre strade, ma la tecnologia prevede nel prossimo futuro alcune migliorie che renderanno confortevole e soprattutto sostenibile ogni tipo di viaggio: dall’arco solare, che produce energia pulita e nel frattempo protegge il manto stradale da grandine e ghiaccio, alle turbine E, che sfruttano il movimento dell’aria prodotto dal passaggio dei veicoli in autostrada, fino ad arrivare alla jet stream super-highway, una carreggiata concava che produce in galleria un flusso d’aria continuo tra la strada e l’ambiente circostante sfruttando l’energia di ritorno del vento.
Il tema del viaggio e della fuga alla ricerca di qualcosa di diverso è ben rappresentato da Paul Gauguin (1848-1903), il pittore post-impressionista che ha trascorso la vita in continuo vagabondaggio verso mete sempre più lontane, come la Polinesia. Questi viaggi nascono dalla volontà di evadere verso luoghi incontaminati, ma anche dal desiderio di ritrovare sé stessi e ricongiungersi con la natura. Il suo è un ritorno alle origini e agli istinti primitivi dell’essere umano, che sente il bisogno di ritrovare la purezza perduta. Tutto ciò emerge chiaramente nei paesaggi esotici e nelle colorate figure femminili delle sue opere: analizza per esempio Donne di Tahiti sulla spiaggia del 1891.

Non c’è niente di meglio che accompagnare un viaggio con della buona musica… ma hai mai pensato invece a quanti autori e musicisti hanno scritto canzoni dedicate al tema del viaggio? Tra i tanti brani disponibili, più o meno attuali, un posto speciale è occupato dai canti dei migranti italiani, una preziosa testimonianza di un fenomeno collettivo, sociale e politico che ha segnato l’esistenza di milioni di persone e da cui emerge tutta la tristezza legata al distacco dalla propria terra natìa e l’incertezza del futuro. Puoi citare per esempio il canto Merica Merica oppure Italia bella mostrati gentile, un’esortazione rivolta al Paese per invitarlo a trattenere i suoi abitanti in fuga.
L’approdo di Shaun Tan è una pietra miliare del fumetto moderno. Una storia di migranti raccontata da immagini senza parole: un uomo lascia sua moglie e suo figlio in una città povera, alla ricerca di un futuro migliore e parte alla volta di un Paese sconosciuto. Alla fine del viaggio si ritrova in una strana città a fare i conti con usanze astruse, un linguaggio indecifrabile, animali incredibili e curiosi oggetti volanti. Con una valigia e qualche spicciolo in tasca, l’uomo dovrà trovare il suo posto nel mondo e sopravvivere in mezzo alla violenza della xenofobia, all’ansia della nostalgia e alla speranza di riuscire a farcela.
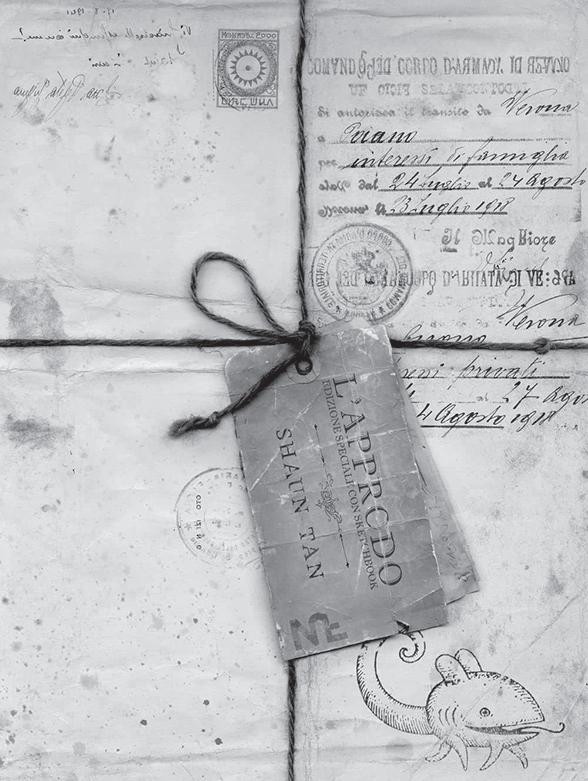
In questa sezone trovi tre prove di ingresso di diverso livello per la scuola superiore. Puoi esercitarti con una prova di livello base, una di livello intermedio e una di livello avanzato.
LIVELLO BASE
Indica le costruzioni errate nelle espressioni che seguono, proponendo una possibile correzione (attenzione: alcune frasi sono corrette).
1 Leonardo cammina il marciapiede.
Leonardo cammina sul/lungo il marciapiede.
2 Ho telefonato alla nonna.
3 Luisa ha chiamato al suo compagno.
Luisa ha chiamato il suo compagno.
4 Ebbi paura con il temporale. ......................................................................................................................................................................................................
Ebbi paura per il temporale.
5 Un fulmine ha schiantato gli alberi intorno casa mia.
Un fulmine ha schiantato gli alberi intorno a casa mia.
6 Egli correva lungo il viale.
7 Il cane inseguiva al gatto.
Il cane inseguiva il gatto. Il motorino mi è stato regalato dai miei genitori.
8 Il motorino mi è stato regalato con i miei genitori.
9 La magnolia è fiorita da un mese.
10 Andrea è il più alto per la sua classe.
Andrea è il più alto della sua classe.
1 punto per ogni risposta esatta _____/10
Scrivi per ogni termine la funzione che svolge all’interno della frase.
1 D’inverno i marinai temono le burrasche improvvise.
D’inverno: compl. tempo determinato; i marinai: soggetto; temono: predicato verbale; le burrasche: compl. oggetto; improvvise: attributo al compl. oggetto.
2 L’ingegner Antonelli è stato nominato responsabile del progetto per la ricostruzione del Borgo Antico. ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
Antonelli: soggetto; l’ingegner: apposizione al soggetto; è stato nominato: predicato verbale; responsabile: comp. predicativo del soggetto; del progetto: comp. di specificazione; per la ricostruzione: compl. di fine; del Borgo Antico: compl. di specificazione.
3 Il contratto è stato consegnato dal notaio ai compratori scelti tra molti candidati.
Il contratto: soggetto; è stato consegnato: predicato verbale; dal notaio: compl. d’agente; ai compratori: compl. di termine; scelti: attributo al compl. di termine; tra candidati: compl. partitivo; molti: attributo al compl.di termine.
4 Il docente ha valutato insufficiente la verifica per i tanti errori. ......................................................................................................................................................................................................
Il docente: soggetto; ha valutato: predicato verbale; insufficiente: compl. predicativo dell’oggetto; la verifica: compl. oggetto; per errori: compl. di causa; tanti: attributo al compl. di causa.
5 In giardino il vecchio olmo è stato abbattuto con violenza dal vento impetuoso.
In giardino: compl. di luogo (stato); olmo: soggetto; vecchio: attributo al soggetto; è stato abbattuto: predicato verbale; con violenza: compl. di modo; dal vento: compl. di causa efficiente; impetuoso: attributo al compl.di causa efficiente.
6 L’imputato è stato condannato per corruzione a dodici anni di prigione insieme ai suoi complici.
L’imputato: soggetto; è stato condannato: predicato verbale; per corruzione: compl. di colpa; a dodici anni: compl. di pena; di prigione: compl. di specificazione; insieme ai complici: compl. di compagnia; suoi: attributo del complemento di compagnia.
7 Sono uscito in bicicletta con il cestino per la spesa. ......................................................................................................................................................................................................
Io (soggetto sottinteso); sono uscito: predicato verbale; in bicicletta (compl. di mezzo); con il cestino: compl. di unione; per la spesa: compl. di fine.
1 punto per ogni risposta esatta ______/44
Indica se le proposizioni che compongono ciascun periodo sono fra loro subordinate o coordinate; delle subordinate indica il grado.
1 Durante il mese di dicembre, ci sono varie festività e molti degli alunni e delle alunne aspettano le vacanze.
proposizione principale + proposizione coordinata
2 Il termine «docente» deriva dal verbo latino docere, che significa «insegnare».
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado
3 Negli ultimi Campionati mondiali di calcio sono emerse nelle semifinali squadre nuove, che hanno attirato l’attenzione del pubblico, poiché erano composte da giocatori poco conosciuti e mostravano modelli di gioco particolari.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado + proposizione subordinata di secondo grado + proposizione coordinata alla subordinata di secondo grado
4 L’eroe greco Ulisse, re di Itaca, viaggiò per dieci anni prima di ritornare a casa, perché era perseguitato dal dio Poseidone, a cui aveva accecato il figlio Polifemo.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado + proposizione subordinata di primo grado + proposizione subordinata di secondo grado
5 Ora prenderemo il treno, giungeremo a destinazione, parteciperemo al convegno e incontreremo molti colleghi e molte colleghe.
proposizione principale + proposizione coordinata + proposizione coordinata + proposizione coordinata
1 punto per ogni risposta esatta _______/16
5
Leggi il testo che segue e rispondi alle domande proposte, segnando quella corretta fra quelle elencate.
Un giorno i topi si riunirono a congresso per escogitare il modo di sfuggire all’orribile gatto che abitava nel loro stesso appartamento. A un tratto un giovane topolino esclamò: «Vi dirò io che cosa dobbiamo fare... una cosa semplice: attaccare un campanello alla coda del gatto. Quando si muoverà, il campanello suonerà e noi sapremo dov’è la bestiaccia!»
I topi si misero a strillare saltellando di gioia finché un vecchio topone domandò: «E chi andrà ad attaccare il campanello?» Tutti tacquero. Nessuno dei topi era disposto a tentare l’impresa. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
1 Chi è il protagonista della favola?
A Il gatto.
B Il vecchio topone.
C Il giovane topolino.
D Esopo.
2 Quale soluzione viene proposta per localizzare il gatto in casa?
A Usare un campanello infilato alla coda del gatto.
B Fare turni di guardia.
C Inviare alcuni topi a negoziare con lui.
D Lasciare la casa.
3 Perché il vecchio topone pone la sua domanda?
A Perché vuole opporsi alla proposta.
B Perché vuole sapere chi avrà il coraggio di portarla a termine.
C Per mettere in evidenza la pericolosità dell’impresa.
D Perché vuole offrirsi volontario.
4 Perché nessuno dei topi accetta di compiere l’impresa?
A Perché pensano che non avrà alcun risultato.
B Perché hanno paura di venire catturati dal gatto.
C Perché non si trova un campanello adatto.
D Perché non condividono il progetto del topolino.
5 Quale significato ha la morale finale?
A Per ottenere un risultato bisogna attraversare il mare.
B È inutile iniziare un’attività quando non la si conosce a fondo.
C Non è possibile portare a termine un’impresa senza la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.
D A parole son tutti bravi, il difficile è fare realmente e concretamente le cose.
1 punto per ogni risposta esatta _______/5
Indica le costruzioni errate nelle espressioni che seguono, proponendo una possibile correzione (attenzione: alcune frasi sono corrette).
1 Mio cugino ha invitato a me e ai miei genitori al suo compleanno.
Mio cugino ha invitato me e i miei genitori al suo compleanno.
2 La riforma attuata da Clistene favorì una redistribuzione del potere tra le varie componenti sociali.
......................................................................................................................................................................................................
3 L’annuncio dell’elezione del Presidente della Repubblica è stato dato in reti unificate con tutte le stazioni radiotelevisive.
......................................................................................................................................................................................................
L’annuncio dell’elezione del Presidente della Repubblica è stato dato a reti unificate da tutte le stazioni radiotelevisive.
4 Abbiamo prenotato un tavolo con il ristorante per essere certi di pranzare l’orario previsto.
Abbiamo prenotato un tavolo al ristorante per essere certi di pranzare all’orario previsto.
......................................................................................................................................................................................................
5 Achille abbandonò l’esercito greco per l’offesa arrecatagli con la sottrazione della sua schiava.
......................................................................................................................................................................................................
6 Sono andato a trovare la mia compagna di banco ammalata e gli ho portato un regalo.
Sono andato a trovare la mia compagna di banco ammalata e le ho portato un regalo.
......................................................................................................................................................................................................
7 Abbiamo percorso l’intera pista da sci tramite il maestro.
Abbiamo percorso l’intera pista da sci con il maestro.
8 A me non mi piace né lo zampone né il cotechino. ......................................................................................................................................................................................................
A me non piace né lo zampone né il cotechino / Non mi piace né lo zampone né il cotechino.
9 Ne hai pensato alla mia proposta?
Hai pensato alla mia proposta?
10 Non sono ancora state completamente individuate le tecniche poste in essere dalla civiltà egizia per l’imbalsamazione dei cadaveri.
1 punto per ogni risposta esatta _____/10
Scrivi per ogni termine la funzione che svolge all’interno della frase.
1 La scuola ha fornito il biglietto per lo spettacolo delle classi finali di ogni indirizzo di studio.
La scuola: soggetto; ha fornito: predicato verbale; il biglietto: compl. oggetto; per lo spettacolo: compl. di fine; delle classi: compl. di specificazione; finali: attributo al compl. di specificazione; di indirizzo: compl. di specificazione; ogni: attributo al compl. di specificazione; di studio: compl. di specificazione.
2 L’imputato, accusato di corruzione, è stato condannato a dieci anni di prigione, ma il suo avvocato ha presentato ricorso.
L’imputato: soggetto; accusato: predicato verbale; di corruzione: compl. di colpa; è stato condannato: predicato verbale; a dieci anni: compl. di pena; di prigione: compl. di specificazione; ma: cong. (coordinante avversativa); l’avvocato: soggetto; suo: attributo al soggetto; ha presentato: predicato verbale; ricorso: compl. oggetto.
3 Abbiamo affittato una casa al mare per un mese per le vacanze della prossima estate, ma non so se vi andremo. ......................................................................................................................................................................................................
Abbiamo affittato: predicato verbale; una casa: compl. oggetto; al mare: compl. stato in luogo; per un mese: compl. di tempo continuato; per le vacanze: compl. di fine; della estate: compl. di specificazione; prossima: attributo al compl. di specificazione; ma: cong (coordinante avversativa); non: negazione; so: predicato verbale; se: congiunzione (subordinante ipotetica); vi: compl. moto a luogo; andremo: predicato verbale.
4 L’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale fu giudicato da Giolitti un grave errore.
L’intervento: soggetto; dell’Italia: compl. di specificazione; nella guerra: compl. di moto a luogo; prima: attributo al compl. di moto a luogo; mondiale: attributo al compl. di moto a luogo; fu giudicato: predicato verbale; da Giolitti: compl. d’agente; un errore: compl. predicativo del soggetto; grave: attributo al compl. predicativo del soggetto.
5 Il mio direttore è un uomo giovane, di circa quarant’anni.
Il direttore: soggetto; mio: attributo del soggetto; è: copula; un uomo: nome del predicato; giovane: attributo del nome del predicato; di circa quarant’anni: compl. di età.
6 Noi tutti in classe chiamiamo Roberto, il mio compagno di banco, «Pitagora», per la sua abilità nella matematica.
Noi: soggetto; tutti: attributo al soggetto; chiamiamo: predicato verbale; Roberto: compl. oggetto; il compagno: apposizione del compl. oggetto; mio: attributo dell’apposizione del compl. oggetto; di banco: compl. di specificazione; «Pitagora»: compl. predicativo dell’oggetto; per la abilità: compl. di causa; sua: attributo al compl. di causa; nella matematica: compl. di limitazione.
7 L’albero più alto del giardino è stato abbattuto da un fulmine.
L’albero: soggetto; più alto: attributo al soggetto; del giardino: compl. di specificazione; è stato abbattuto: predicato verbale; da un fulmine: compl. di causa efficiente.
8 Ho una bicicletta più vecchia della tua, con la quale però attraverso la città a tutta velocità.
Ho: predicato verbale; una bicicletta: compl. oggetto; più vecchia: attributo al compl. oggetto; della tua: compl. di paragone; con la quale: compl. di mezzo; però: avverbio; attraverso: predicato verbale; la città: compl. oggetto; a velocità: compl. di modo; tutta: attributo al compl. di modo.
9 Ieri, liberi dai compiti, siamo usciti con il nostro nuovo compagno.
Ieri: compl. di tempo determinato; liberi: attributo al soggetto; dai compiti: compl. di separazione; siamo usciti: predicato verbale; con il compagno: compl di compagnia; nostro: attributo al compl. di compagnia; nuovo: attributo al compl. di compagnia.
10 Sono uscito con l’ombrello insieme al mio amico James, di origine irlandese.
Sono uscito: predicato verbale; con l’ombrello: compl. di unione; insieme a James: compl. di compagnia; amico: apposizione al compl. di compagnia; mio: attributo al compl. di compagnia; di origine: compl. di origine; irlandese: attributo al compl. di origine.
1 punto per ogni risposta esatta ______/90
Analizza i periodi che seguono, indicando se le proposizioni sono principali, coordinate o subordinate, di queste ultime indica la tipologia e il grado di subordinazione.
1 Andrea mi ha detto che non è andato a scuola perché ha avuto una forte febbre.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado oggettiva + proposizione subordinata di secondo grado causale
2 È chiaro che nessuno prenderà iniziative per chiarire la situazione.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado soggettiva + proposizione subordinata di secondo grado finale
3 Il direttore ha informato i suoi collaboratori che o scelgono l’orario flessibile o optano per quello rigido.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado oggettiva + proposizione subordinata di primo grado oggettiva alla subordinata oggettiva
4 Dopo la battaglia di Maratona, benché fosse sfinito, Fidippide corse immediatamente verso Atene per annunciare la vittoria.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado concessiva + proposizione subordinata di primo grado finale
5 Il Comune ha dichiarato che, quando la stagione lo permetterà, provvederà alla riasfaltatura delle strade per evitare altri incidenti, poiché sono pervenute molte segnalazioni.
proposizione principale + proposizione subordinata di primo grado oggettiva + proposizione subordinata di secondo grado finale + proposizione subordinata di secondo grado temporale + proposizione subordinata di terzo grado causale
1 punto per ogni risposta esatta _______/17
Leggi il testo che segue e rispondi alle domande proposte, segnando quella corretta fra quelle elencate.
Erodoto racconta nella sua opera che il re della Lidia, Creso, prima di marciare contro il regno di Ciro, interroga l’oracolo di Delfi sull’opportunità della guerra ed esso vaticina che se Creso marcerà contro i Persiani, distruggerà un grande impero. Creso non può che contare sulla propria vittoria preannunciata dal potente oracolo. Purtroppo, però, l’oracolo si rivela menzognero e Creso viene sconfitto da Ciro che annette il regno di Lidia al nascente impero persiano. Creso, sorpreso, interroga allora nuovamente l’oracolo per capire le ragioni della sua sconfitta. E la Pizia, la sacerdotessa dell’oracolo di Delfi, risponde che al di sopra degli dei c’è il Fato, il destino. Apollo ha cercato di aiutare Creso, che aveva inviato sempre ricchi doni a Delfi, rinviando la presa di Sardi, e ha impedito la morte di Creso che, fatto prigioniero, stava per essere arso vivo su una pira fatta innalzare da Ciro, ma di più non ha potuto fare. A proposito poi della risposta dell’oracolo circa l’opportunità di fare guerra a Ciro, la Pizia sottolinea che Creso avrebbe subito dovuto domandare a quale impero Apollo stesse pensando, se al suo, oppure a quello di Ciro. Insomma l’oracolo aveva predetto in modo corretto ed era avvenuto esattamente ciò che era stato vaticinato. Aveva però usato un linguaggio ambiguo, che poteva ingannare.
Un altro esempio. Gli Ateniesi, davanti alla minaccia della spedizione di Serse, interrogano sul da farsi l’oracolo di Delfi e hanno come responso che la loro salvezza sarà nel muro di legno. Ancora una volta l’oracolo è ambiguo e non è chiaro a cosa si riferisca con l’espressione “muro di legno”. Poteva essere l’acropoli circondata in antico da mura di legno, ma potevano essere le navi. E fu quest’ultima interpretazione dell’oracolo a prevalere e a convincere gli Ateniesi a combattere per mare, vincendo la battaglia navale di Salamina.
1 Creso decide di intraprendere la spedizione contro la Persia perché:
A vuole difendere i suoi sudditi dalla minaccia persiana.
B l’oracolo che ha consultato gli predice la distruzione di un grande impero.
C vuole espandere il proprio dominio.
D vuole aiutare gli Ateniesi in lotta contro la Persia.
2 Qual è stato l’errore di Creso?
A Non ha chiesto quale fosse il grande impero che avrebbe distrutto.
B Si è fidato di un oracolo notoriamente menzognero.
C È stato arrogante, comportamento inaccettabile per la cultura greca.
D Ha offeso il dio Apollo.
3 Qual è la caratteristica degli oracoli?
A Essere menzogneri.
B Essere manovrati dai sacerdoti che li gestivano.
C Usare un linguaggio poco chiaro.
D Rispondere ciò che i postulanti si aspettavano.
4 Perché gli Ateniesi si rivolgono all’oracolo di Delfi?
A Perché vogliono invadere la Persia e chiedono consiglio ad Apollo.
B Perché vogliono rinforzare l’acropoli.
C Perché vogliono mettere alla prova l’oracolo.
D Perché cercano una soluzione contro la minaccia di invasione persiana.
5 Che cosa si rivelò essere il «muro di legno» cui accennava la Pizia?
A Il muro di cinta dell’acropoli.
B Una flotta.
C Una costruzione difensiva ordinata dall’oracolo.
D Non esisteva.
1 punto per ogni risposta esatta _____/5
Indica le costruzioni errate nelle espressioni che seguono, proponendo una possibile correzione (attenzione: alcune frasi sono corrette).
1 Se vuoi notizie sulla partita non chiamare a me, ma telefona tuo amico.
Se vuoi notizie sulla partita non chiamare me, ma telefona al tuo amico.
2 Ho incontrato le mie cugine e gli ho detto di continuare la passeggiata con me.
Ho incontrato le mie cugine e ho detto loro di continuare la passeggiata con me.
3 Se mi avessero detto che sbagliassi, ti avessi avvertito.
Se mi avessero detto che sbagliavi, ti avrei avvertito.
4 Il vento ha travolto tramite la velocità l’albero più alto del parco.
Il vento ha travolto a causa della velocità l’albero più alto del parco.
5 Hai salutato al nonno prima di uscire di casa?
Hai salutato il nonno prima di uscire di casa?
6 Andrea avrebbe avuto bisogno di un sostegno in un momento difficile, ma non lo avesse avuto.
Andrea avrebbe avuto bisogno di un sostegno in un momento difficile, ma non lo ha avuto.
7 Anche se andassi alla ricerca del tempo perduto, non lo ritroveresti.
8 Mi andresti a comprare il giornale se ti dassi il denaro necessario?
Mi andresti a comprare il giornale se ti dessi il denaro necessario?
9 Il Ministro ha inaugurato al nuovo auditorium del Teatro Comunale alla presenza di tutte le autorità.
Il Ministro ha inaugurato il nuovo auditorium del Teatro Comunale alla presenza di tutte le autorità.
10 Il mio vicino di casa è stato indagato per falso in atto pubblico.
1 punto per ogni risposta esatta ______/10
Scrivi per ogni termine la funzione che svolge all’interno della frase.
1 Quella borsa non è adatta per la cerimonia; sarebbe meglio comprarne una intonata all’abito.
Borsa: soggetto; quella: attributo del soggetto; non: negazione; è: copula; adatta: nome del predicato; per la cerimonia: compl. di fine; sarebbe: copula; meglio: nome del predicato; comprar: predicato verbale; ne: compl. oggetto; una intonata: attributo al compl. oggetto; all’abito: compl. di termine.
2 Luisa ha ricamato con grande accuratezza un centrino di pizzo, ma l’ha fatto quasi tutto con fili multicolori.
Luisa: soggetto; ha ricamato:predicato verbale; con accuratezza: compl. di modo; grande: attributo del compl. di modo; un centrino: compl. oggetto; di pizzo: compl. di materia; ma: congiunzione avversativa; l’:compl. oggetto; ha fatto: predicato verbale; quasi tutto: compl. predicativo dell’oggetto; con fili: compl. di mezzo; multicolori: attributo del compl. di mezzo.
3 A causa della verifica insufficiente, Marta si mise a piangere, ma fu consolata dalla mamma. ......................................................................................................................................................................................................
A causa della verifica: compl. di causa; insufficiente: attributo del compl. di causa; Marta: soggetto; si mise a piangere: predicato verbale; ma: congiunzione avversativa; fu consolata: predicato verbale; dalla mamma: compl. d’agente.
4 Siamo andati al ristorante, ma avevamo dimenticato che di domenica è chiuso; allora il pranzo è diventato una spaghettata insieme agli amici a casa di Carlo.
Siamo andati: predicato verbale; al ristorante: compl. moto a luogo; ma: congiunzione avversativa; avevamo dimenticato: predicato verbale; che: congiunzione subordinante; di domenica: compl. di tempo determinato; è: copula; chiuso: nome del predicato; allora: compl. avverbiale di tempo; il pranzo: soggetto; è diventato: predicato verbale; una spaghettata: compl. oggetto; insieme agli amici: compl. di compagnia; a casa: compl. stato in luogo; di Carlo: compl. di specificazione.
5 L’allenatore considera Giuseppe il più bravo fra gli atleti della sua squadra, che si allena nello stadio vicino a casa mia, nel palleggio. ......................................................................................................................................................................................................
L’allenatore: soggetto; considera: predicato verbale; Giuseppe: compl. oggetto; il più bravo: compl. predicativo dell’oggetto; fra gli atleti: compl. partitivo; della squadra: compl. di specificazione; sua: attributo del compl. di specificazione; che: soggetto; si allena: predicato verbale; nello stadio: compl. stato in luogo; vicino: attributo stato in luogo; a casa: compl. stato in luogo; mia: attributo compl. stato in luogo; nel palleggio: compl. di limitazione.
6 Il Dottor Rossi, amministratore delegato, fu accusato di evasione fiscale e condannato ad una pesante multa, ma è fuggito dall’Italia ed è tuttora latitante.
Rossi: soggetto; il Dottor: apposizione del soggetto; amministratore: apposizione del soggetto; delegato: attributo dell’apposizione del soggetto; fu accusato: predicato verbale; di evasione: compl. di colpa; fiscale: attributo compl. di colpa; e: congiunzione (coordinante copulativa); condannato: predicato verbale; ad una multa: compl. di pena; pesante: attributo al compl. di pena; ma: congiunzione avversativa; è fuggito: predicato verbale; ed: congiunzione (coordinante copulativa); è: copula; tuttora: compl. avverbiale di tempo; latitante: nome del predicato.
7 Annibale marciò attraverso l’Italia, devastando per molti giorni alcuni territori nonostante la resistenza dei soldati romani, che combattevano spinti dall’odio.
Annibale: soggetto; marciò: predicato verbale; attraverso l’Italia: compl. moto per luogo; devastando: predicato verbale; per giorni: compl. di tempo continuato; molti: attributo del compl. di tempo; compl. oggetto; alcuni: attributo compl. oggetto; nonostante la resistenza: compl. concessivo; dei soldati: compl. di specificazione; romani: attributo del compl. di specificazione; che: soggetto; combattevano: predicato verbale; spinti: predicato verbale; dall’odio: compl. di causa efficiente.
8 Renzo si allontanò dal paese con il solo abito festivo e pensava: «O Lucia, Don Rodrigo agisce contro di noi, ma la Provvidenza agirà per il nostro bene».
Renzo: soggetto; si allontanò: predicato verbale; dal paese: compl. di allontanamento; con abito: compl. di unione; il solo: attributo compl. di unione; festivo: attributo compl. di unione; e: congiunzione (coordinante copulativa); pensava: predicato verbale; «O Lucia: compl. invocazione; Don Rodrigo: soggetto; agisce: predicato verbale; contro di noi: compl. di svantaggio; ma: congiunzione (coordinante avversativa); la Provvidenza: soggetto; agirà: predicato verbale; per il bene: compl. di vantaggio; nostro»: attributo compl. di vantaggio.
9 Mia cugina è più grande di me, ha quasi quindici anni e io la stimo molto, soprattutto quando discutiamo di scuola per la sua competenza.
Cugina: soggetto; mia: attributo del soggetto; è: copula; più grande: nome del predicato; di me: compl. di paragone; ha: predicato verbale; quasi quindici anni: compl. di età; e: congiunzione (coordinante copulativa); io: soggetto; la: compl. oggetto; stimo: predicato verbale; molto: compl. di stima; soprattutto: avverbio; quando: congiunzione (subordinante); discutiamo: predicato verbale; di scuola: compl. di argomento; per la competenza: compl. di causa; sua: attributo compl. di causa.
10 L’automobile che abbiamo comprato proviene da una collezione privata: è lunga più di quattro metri ed è costata oltre 100.000 euro. ........................................................................................................................................................................................................
L’automobile: soggetto; che: complemento oggetto; abbiamo comprato: predicato verbale; proviene: predicato verbale; da una collezione: compl. di origine; privata: attributo compl. di origine; è: copula; lunga: nome del predicato; più di quattro metri: compl. di misura; ed: congiunzione (coordinante copulativa); è costata: predicato verbale; oltre 100.000 euro: compl. prezzo.
1 punto per ogni risposta esatta _____/140
Analizza i periodi che seguono, indicando se le proposizioni sono principali, coordinate o subordinate; di queste ultime indica la tipologia e il grado di subordinazione.
1 Cesare mandò nell’accampamento avversario alcuni centurioni che trattassero una breve tregua per raccogliere i feriti.
proposizione principale enunciativa + proposizione subordinata di primo grado relativa impropria proposizione principale enunciativa + proposizione subordinata di primo grado relativa impropria
2 Gli psicologi stessi sono in dubbio su quali siano le motivazioni alla base del tifo violento.
proposizione principale enunciativa + proposizione subordinata di primo grado interrogativa indiretta
3 Alessandro Magno stimava tanto le opere di Omero, che era solito portarle sempre con sé in una cassetta.
proposizione principale enunciativa + proposizione subordinata di primo grado consecutiva
4 È stato tramandato che Archimede fu ucciso da un soldato che ignorava chi egli fosse.
proposizione principale enunciativa + proposizione subordinata di primo grado soggettiva +proposizione subordinata di secondo grado relativa + proposizione subordinata di terzo grado interrogativa indiretta
5 È evidente che gli uomini, pur essendo inferiori a molti animali per la forza, sono di gran lunga superiori ad essi per intelligenza e per abilità.
proposizione principale enunciativa + proposizione subordinata di primo grado soggettiva + proposizione subordinata di secondo grado concessiva
1 punto per ogni risposta esatta ____/14
Leggi il testo che segue e rispondi alle domande proposte, segnando la risposta corretta fra quelle elencate.
Ecco perché le donne non vengono elette
Dopo le ultime amministrative sono il 15% del totale (compresi i mini Comuni) e per lo più guidano centri con meno di 5000 abitanti. La legge sulla parità di genere esiste, il punto è che nei partiti prevale la cooptazione: «Gli uomini scelgono gli uomini». Alle elezioni del 12-26 giugno scorsi le uscenti erano due, quelle elette sono state tre. Chi vuol esser lieto sia, ma c’è davvero poco da rallegrarsi di fronte al numero di donne elette alla carica di sindaco in una tornata che ha visto chiamati al voto 26 capoluoghi di provincia.
I numeri nella loro aridità sono sconsolanti. Katia Tarasconi a Piacenza, Chiara Frontini a Viterbo e Patrizia Manassero a Cuneo vanno ad “ingrossare” lo sparuto drappello di prime cittadine elette nelle città più importanti. Che ora sono “ben” 7 nei complessivi 108 capoluoghi di provincia italiani. Con l’uscita di scena, lo scorso anno, di Virginia Raggi a Roma e di Chiara Appendino a Torino, non c’è grande città che veda un volto femminile alla sua guida. La realtà più rilevante amministrata da una sindaca è Ancona, capoluogo anche di Regione, dove dal 2013 guida la giunta con piglio battagliero Valeria Mancinelli. Quando va bene, i sindaci chiamano una donna a ricoprire il ruolo di vice. A Milano c’è Anna Scavuzzo, a Roma Silvia Scozzese, a Torino Michela Favaro, a Napoli Maria Filippone. Di norma, si preferisce affidare altri incarichi. Fra i sindaci le donne rappresentano solo il 15 per cento, più alta la percentuale tra i vicesindaci (30 per cento), mentre i presidenti del Consiglio sono di sesso femminile nel 32 per cento dei casi e le assessore superano il 40 per cento. Come si vede, in qualunque caso si è molto lontani (a volte la distanza è siderale) da quella parità che dovrebbe essere semplicemente normale. Ma non lo è, non lo è mai stata.
Che ci fosse disparità fra uomini e donne, visti i retaggi storici, era un dato di fatto scontato nel lontano 1946, quando le donne furono ammesse per la prima volta al voto. Il debutto avvenne proprio in occasione di una tornata amministrativa: 5722 i Comuni interessati, dieci le donne elette sindaco (duemila circa le consigliere comunali). I loro nomi sono scolpiti nella storia: Ninetta Bartoli, Elsa Damiani, Margherita Sanna, Ottavia Fontana, Elena Tosetti, Ada Natali, Caterina Tufarelli Palumbo Pisani, Anna Montiroli, Alda Arisi e Lydia Toraldo Serra. Da allora sono stati sicuramente fatti passi in avanti, ma rispetto alle aspettative le distanze rimangono ancora molto marcate. Anche in questo caso, vengono in soccorso i numeri. In quarant’anni le sindache sono passate da 10 a 145. Poi c’è stato un salto in avanti, visto che nei successivi trent’anni sono salite a 1066 (il dato è del 2015), quasi dieci volte tanto, pur se va sottolineato che in 790 casi si trattava di Comuni con meno di 5 mila abitanti. Forse perché nelle realtà più piccole, meno assorbenti, era più facile conciliare impegno pubblico e incombenze private. Quella crescita, già di per sé non al passo con gli spazi e i ruoli sempre maggiori conquistati dalle donne nella società e nel mondo del lavoro, ha fatto registrare negli anni successivi un incremento non trascurabile ma comunque non adeguato. Nel 2022, infatti, le sindache sono passate da 1066 a 1146. «È un tasto dolente» conferma Lorenza Bonaccorsi, responsabile del Dipartimento Pari opportunità di Ali (Autonomie locali italiane), già sottosegretaria ai Beni culturali, ora presidente del primo Municipio di Roma. «Si continua a fare una fatica terribile a guadagnare spazio. Soprattutto sul piano amministrativo, il sistema politico maschile tende all’autoconservazione e a procedere per cooptazione nello stesso ambito sessuale. Eppure, in sede locale il ruolo delle donne è sempre più apprezzato e si fatica a capire perché i partiti, a partire dal mio (il Pd, ndr ), non se ne rendano conto».
Il miglioramento c’è stato nel numero di consigliere comunali perché è stato introdotto l’obbligo di rispettare la parità di genere. Nel marzo scorso la Corte costituzionale con propria sentenza ha stabilito che debba essere obbligatoria anche nelle liste elettorali dei Comuni sotto i 5mila abitanti: la mancanza di un numero sufficiente di candidature di entrambi i sessi determina l’esclusione della lista. In Parlamento questo obbligo ha dato risultati concreti: nel 2018 sono state elette 334 donne, pari a poco più del 35 per cento, oltre la media europea che si attesta al 32,8 per cento. Nella storia amministrativa italiana si trovano sindache che hanno lasciato un segno profondo. Le più famose, in tempi recenti, sono state Raggi e Appendino, figure dirompenti anche dal punto di vista politico, elette nel momento d’oro dei Cinque stelle. Ma andando a ritroso ci si imbatte nei nomi di Letizia Moratti a Milano, Rosa Russo Jervolino a Napoli, Maria Magnani Noja a Torino, Elda Pucci a Palermo, Adriana Poli Bortone a Lecce. Tutte hanno dimostrato che l’essere donna non è un ostacolo al rivestire un ruolo pubblico. Appendino lo ha confermato combattendo nel 2016 la sua campagna per l’elezione a sindaca di Torino con il pancione: aspettava la primogenita Sara. «Io sono fortunata» ha spiegato in un’intervista «ho potuto scegliere di fare politica perché ho un marito che mi sostiene, l’aiuto dei genitori con la bambina. È una serie di condizioni su cui non tutte le donne possono contare. La domanda è: con l’attuale sistema di welfare quante donne sarebbero concretamente in grado di scegliere la politica come ho fatto io? Secondo me ancora poche». Le normative possono aiutare, anche se alla base resta un grande nodo culturale irrisolto. La legge Delrio del 2014 prevede che nelle giunte dei Comuni con più di 3 mila abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. Una prescrizione che poi ognuno ha interpretato a suo modo. Qualche esempio? A Torino c’è la parità perfetta: 6 assessori donne e 5 uomini più il sindaco (Stefano Lo Russo). A Milano, Roma e Bologna gli assessori sono in numero uguale per ambo i sessi e lo squilibrio è dato solo dal primo cittadino uomo. L’unica stecca nel panorama nazionale viene da Trieste dove il sindaco Di Piazza ha nominato solo 4 donne su 11 componenti la Giunta (lui compreso), non rispettando il tetto del 40 per cento.
da C. Zapperi, Corriere della Sera, 18 luglio 2022
1 Perché è stato registrato un miglioramento nel numero delle donne che ricoprono il ruolo di consigliere comunale?
A Perché tale ruolo è considerato non interessante dagli uomini.
B Perché è stato reso obbligatorio il rispetto della parità di numero fra gli eletti dei due sessi.
C Perché è intervenuta la Corte Costituzionale.
D Perché le donne sono più attrezzate a ricoprire questo ruolo.
2 La più alta percentuale di donne che ricoprono ruoli istituzionali nei Comuni è detenuta dalle...
A sindache.
B assessore.
C vicesindache.
D presidenti di Consiglio comunale.
3 Cosa accade alla lista elettorale che non presenta un numero sufficiente di candidati di entrambi i sessi?
A Nulla.
B Viene corretta.
C Viene esclusa dalla tornata elettorale.
D I candidati vengono distribuiti nelle altre liste.
4 In quale città fra le seguenti nei tempi passati non c’è stato un sindaco donna?
A Napoli.
B Palermo.
C Bologna.
D Torino.
5 Qual è la regione che, al di là della posizione nella graduatoria, ha riportato il maggior incremento percentuale nel numero di sindache dal 2012 al 2022?
A Valle d’Aosta.
B Friuli Venezia-Giulia.
C Toscana.
D Emilia-Romagna.
1 punto per ogni risposta esatta _____/5





L’Alternativa in Agenda è un volume rivolto agli studenti e alle studentesse di scuola secondaria di primo grado che non frequentano le lezioni di religione cattolica.
Volume unico per tre anni 18 unità multidisciplinari
Più di 70 lezioni strutturate e progettate per coprire il tempo di un’ora settimanale
Educazione civica, Agenda 2030, tematiche socioadolescenziali
Letture e attività per lavorare su sé stessi e con gli altri
pp. 296
€ 14,90
ISBN 978-88-472-4167-1

SPAZIO INVALSI è un sussidio didattico per le studentesse e gli studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado che si apprestano a svolgere la Prova nazionale INVALSI.
Il volume si articola in tre sezioni:
PREPARIAMOCI ALLE PROVE INVALSI
• una prova propedeutica da svolgere nel primo quadrimestre
• un allenamento guidato per apprendere un metodo efficace in tre semplici passaggi
• una prova ufficiale guidata, con quesiti commentati
• sei allenamenti
• una prova simulata completa da svolgere in 90 minuti, come la prova ufficiale
PREPARIAMOCI AL COLLOQUIO D’ESAME
• tre percorsi interdisciplinari con tanti spunti per collegare tra loro le diverse materie
PREPARIAMOCI ALLA SCUOLA SUPERIORE
• tre prove di ingresso di diverso livello per la scuola superiore
I CONTENUTI DIGITALI CON L’APP RAFFAELLO PLAYER
• gli allenamenti e le prove in versione Computer Based
• una prova simulata extra
• le tracce guidate d’esame personalizzabili
• un utile compendio per avere sempre a portata di mano tutte le conoscenze di base
• per l’insegnante, tutte le soluzioni del volume
Prezzo di vendita al pubblico € 7,00