INTRODUZIONE
Nel presente porfolio sono presentate sinteticamente alcune esperienze progettuali svolte in gruppi di lavoro affrontate nel corso degli studi.
I progetti sono stati scelti per mostrare il percorso didattico progettuale da me svolto con casi che mostrano una varietà di contesti, scale e obbiettivi da perseguire, lavorando sia ex novo sia su preesistenze.
Tashkent Modernism: Uzbekistan Hotel
Progetti curricolari _2021-2020
Mend Identity Living Opportunity: Abitare Lorenteggio, progetto di recupero di case popolari
Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione:
Progetto di un’infrastruttura ospedaliera a Torino
Innesti:
Progetto di edifici a destinazione mista inseriti all’interno della cava in disuso di Lecco
Tesi di Laurea MagistraleTASHKENT MODERNISM

Uzbekistan Hotel
Questa tesi consiste nello studio, nell’analisi e nella definizione di interventi progettuali minimi riguardanti l’Uzbekistan Hotel. Il lavoro di tesi si articola in diverse fasi che comprendono una prima parte molto rilevante e corposa di analisi, una fase di ricostruzione delle fonti e un’ultima fase di proposte progettuali. La prima fase ha riguardato l’analisi delle fonti a disposizione che non risultavano sufficienti per un’adeguata conoscenza dello stato attuale, con la possibilità di consultare solo poche fonti fotografiche storiche, articoli e manuali. Avendo scarse informazioni dal punto di vista geometrico, il rilievo con il laser scanner (svolto insieme allo studio Geogra durante il sopralluogo a marzo 2022 a Tashkent, Uzbekistan) è risultato fondamentale per la ricostruzione di tutti gli elaborati architettonici bidimensionali e tridimensionali. Il sopralluogo è stato altrettanto utile per avere un approccio diretto con il manufatto, andando a toccare con mano l’oggetto di studio. Il materiale raccolto in situ, combinato con il materiale già a disposizione, ha dato luogo alla seconda fase del lavoro di tesi in cui si ha una ricostruzione fedele dello stato di fatto con la finalità di comprendere ogni aspetto dell’Uzbekistan Hotel. In particolare, è stato approfondito in dettaglio il sistema di facciata principale dell’hotel mediante la foto-analisi delle foto storiche di cantiere e quelle odierne, che ha permesso di comprendere gli elementi di cui è composta e di ipotizzarne il processo costruttivo.

TASHKENT MODERNISM
ANALISI STORICA
Città Vecchia

Città Nuova
Assi principali città nuova
Grazie alla raccolta e ricostruzione delle fonti è stato possibile analizzare l’Uzbekistan Hotel da un punto di vista critico, facendo emergereipuntidiforzaedidebolezza.Apartirepropriodaqueste considerazioni, la terza ed ultima fase della tesi propone degli interventi progettuali mirati al riordino formale e alla conservazione materica delle facciate, in particolare quella principale e della conseguente riorganizzazione interna rispettivamente del piano terra e del diciassettesimo piano. Questi interventi intendono far risaltare le qualità architettoniche moderniste dell’Uzbekistan Hotel, senza stravolgerne irrimediabilmente lo stato odierno e portando alla luce i suoi tratti peculiari.

ANALISI DEI TRASPORTI
Linee metropolitane
Stazione ferroviaria
ANALISI AREE VERDI
Parchi pubblici
Aree verdi private
ANALISI VIE FLUVIALI
Corsi d’acqua
Specchi d’acqua
ANALISI DEI SERVIZI CIRCOSTANTIANALISI DEL VERDE URBANO





ANALISI DEI TRASPORTI PUBBLICI
Metropolitana linea rossa
Metropolitna linea verde
Fermata metro Amir Timur
Edifici d’istruzione
Edifici istituzionali
Edifici commerciali
Parchi urbani Sistema del verde
Fermata metro Yunus Rajabiy Parcheggi pubblici
Altri complessi alberghieri
Fermate autobus









LEGENDA
1. Muro divisorio in calcestruzzo prefabbricato
2. Trave primaria in acciao rivestita lateralmente in calcestruzzo
3. Sostegno in acciaio per travi a sbalzo
4. Pilastro scatolare in acciaio
5. Sistema di aggancio serramento
6. Controparete in cartongesso
7. Cordolo in calcestruzzo
8. Trave sagomata in acciaio, rivestita lateralmente in calcestruzzo
9. Orditura secondaria metallica
10.Trave sagomata con profilo UPN in acciaio rivestita in calcestruzzo nella parte centrale
11.Piastra di aggancio in acciaio
12.Modulo di facciata in calcestruzzo prefabbricato







13.Sistema di ancoraggio illuminazione
14.Rivestimento esterno in pietra locale
15.Sistema di illuminazione
LEGENDA
1. Pavimentazione
2. Massetto












3. Solaio alveolare precompresso in calcestruzzo
4. Trave secondaria in acciaio
5. Controsoffitto sospeso














6. Trave primaria IPE 600 , rivestita lateralmente in calcestruzzo
7. Elemento di sostegno a cui viene imbullonata la trave a sbalzo
8. Trave a sbalzo

9. Setto in calcestruzzo
10.Serramento
11. Piastra di aggancio con bulloni tra trave a sbalzo e mensola inclinata
12.Mensola inlcinata in acciaio,rivestita lateralmente in calcestruzzo
13.Trave sagomata con profilo UPN in acciaio, rivestita in calcestruzzo nella parte centrale
14.Piastra di aggancio in acciao
15.Modulo di facciata in calcestruzzo prefabbricato
16.Sistema di ancoraggio illuminazione
17.Rivestimento esterno in pietra locale
18.Sistema di illuminazione















MEND IDENTITY LIVING OPPORTUNITY
Abitare Lorenteggio, progetto di recupero di case popolari
Il progetto si colloca nel quartiere di Lorenteggio-Giambellino, situato nella parte Sud Ovest- di Milano. La tipologia edilizia della zona è caratterizzata da interi lotti occupati da una serie di condomini di grandi dimensioni organizzati secondo un cortile interno. Il quartiere risulta ad oggi in una condizione di degrado, dovuto principalmente alla condizione sociale ed economica degli abitanti. In particolare il progetto si concentra su un comparto del lotto limitato dalle vie Giambellino, Inganni, Lorenteggio e Odazio.

L’obbiettivo progettuale era quello di creare dei fili con cui riallacciare il quartiere Lorenteggio con il resto della città, in un rammendo (Mend) delicato e puntuale che agisce sulle urgenze generate da un lungo processo di degrado direttamente dall’interno, attuando una riqualificazione che possa migliorare la qualità della vita. Le periferie sono ricche di umanità e carattere, una premura del rammendo sta nell’”entrare il più possibile in punta di piedi”, cercando di non modificare quella che è l’identità propria del quartiere e la sua anima (Identity). Pur non volendo modificare il carattere del luogo, MiLo si propone come un intervento di riqualificazione che ha lo scopo primario di cambiare la condizione di disagio sociale ed economico ora presente nel quartiere di Lorenteggio, in modo che gli abitanti delle periferie possano costruirsi una vita migliore avendo più opportunità e mezzo per farlo (Living e Opportunity).Il progetto pone l’attenzione su alcuni temi, primo di questi il ridisegno degli spazi pubblici; il cortile interno diventa un unico parco lineare

MEND IDENTITY LIVING
attrezzato in modo da promuovere modelli il più possibile inclusivi data la eterogeneità degli abitanti, studiandolo in modo da invogliare i cittadini alla “cura spontanea” dello spazio. L’intervento sull’edificato verte su un importante modifica delle sembianze generali e dei suoi sistemi distributivi. Le residenze vengono abbracciate da una” gabbia” esterna di travi e pilastri in acciaio che si accosta alla facciata cercando un contatto il meno invasivo possibile, costruendo il nuovo sistema distributivo. Esso viene traslato all’esterno verso il cortile con uno sviluppo a ballatoiochecorrelungol’asselongitudinale.Accantoalballatoio viene posizionata una scala in lamiera a rampa unica in facciata che distribuisce verticalmente flussi insieme ad ascensori posti ai suoi lati. Oltre a sostenere la struttura della distribuzione verticale, la gabbia strutturale si eleva sul prospetto degli edifici fino a sopraelevarsi di un piano rispetto alla quota esistente, ospitando un nuovo studentato; la gabbia strutturale prosegue in altezza e diventa la copertura dell’ultimo piano, una terrazza praticabile con sedute e orti. Un successivo tema riguarda le tipologie di alloggi e i residenti a cui essi sono destinati. Le unità residenziali si articolano secondo una griglia modulare, che permette una facile articolazione e un’articolazione degli alloggi. Gli alloggi sono stati studiati e progettati nella gestione degli spazi interni e arredi con una particolare attenzione a quello che è il fruitore dell’alloggio stesso e alla questione della soglie e dell’ingresso, segnalato con un cambio di pavimentazione.












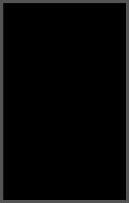




















LEGENDA
PARETE PERIMETRIALE ESITENTE (55 cm)
U 0,267 W/m2 K
1. Rivestimento in fibracemento-Equitone
2. Intercapedine ventilata
3. Isolante in schiuma polyiso espansa rigida- Stiferite SK
4. Intonaco esistente
5. Muratura in mattoni pieni esistente
6. Intonaco- Knauf
7. Serramento in alluminio con triplo vetro- Schueco
PARETE PERIMETRALE ESISTENTE
LEGENDA
SOLAIO INTERPIANO ESISTNTE (60,13 cm)
1. Piastrella in gres/laminato

2. Foglio di alluminio
3. Polistiene espanso per pavimento radiante- Radial Alu G
4. Lastra gesso fibra-Knauf Brio

5. Argilla espansa- Knauf Forme
6. Pavimentazione esistente
7. Solaio in laterocemento esistente
8. Intonaco esistente
9. Intercapedine impianti
10. Montanti pere fissaggio controsoffitto- Gyproc
11. Lastra cartongesso-Gyproc Habito
SOLAIO INTERPIANO ESISTENTE
PARETE PERIMETRALE PROGETTO
PARETE PERIMETRALE PROGETTO (40 cm)
U 0,112 W/m2 K
1. Rivestimento in fibracemento-Equitone
2. Intercapedine ventilata
3. Isolante in schiuma polyiso espansa rigida- Stiferite SK
4. Lastra Gyproc Glasroc X
5. Lana di roccia Isover Arena 34
6. Lastra Gyproc Habito Forte 13
7. Lana Di vetro Isover PAR 4+
8. Lastra Gyproc Habito Forte 13
9. Lastra Gyproc Habito Forte 13
10. Serramento in alluminio con triplo vetro -Shueco
LEGENDA
LEGENDA COPERTURA PRATICABILE PROGETTO
COPERTURA PRATICABLE (51,50cm) - U 0,151 W/m2 K


1. Piastrelle in gres
2. Lastra in cemento rinforato-Knauf Aqupanel Rooftop
3. Isolante in schiuma polyiso espansa rigida- Stiferite GT
4. Isolante in EPS 150-Stiferite
5. Lastra in cemento rinforato-Knauf Aqupanel Rooftop
6. Lamiera grecata strutturale
7. Intercapedine impianti
8. Montanti per fissaggio controsoffitto -Gyproc
9. Lastra cartongesso- Gyproc Habito
PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Progetto di un’infrastruttura ospedaliera a Torino
Il progetto si inserisce nel Parco della Salute della città di Torino. L’obbiettivo progettuale era quello creare uno spazio che avesse una propria gerarchia: gli edifici inseriti sono volumi di grandi dimensioni per rispondere alle esigenze di funzioni e ad un disegno urbano, caratterizzato da “giganti” della città come il Lingotto, l’Oval Lingotto e la Torre della regione. In particolare vengono studiati percorsi differenti che possano portare il visitatore all’interno del sistema della grande piazza antistante al palazzo delle regione già presente. Partendo dall’idea che una piazza si renda riconoscibile se i suoi bordi sono limitati da cortine edilizie, vengono posizionati in corrispondenza dei suoi lati lunghi i volumi della struttura ospedaliera a Nord e del centro universitario e di ricerca a Sud.

Per carcare di rapportarsi con l’imponenza della torre della regione, in posizione frontale viene inserito una seconda torre contenente uffici che in pianta ne riprende le esatte dimensioni mentre l’altezza risulta esserne la metà. La nuova torre è inserita in un altro volume che le fa da basamento in cui sono inserite funzioni prettamente commerciali. Questo sistema lega ad un altro corpo che che in corrispondenza della stazione si allunga sopra i binari a creare un ponte sopraelevato per poter connetter due parti di città. Nella parte Sud -Ovest del progetto sono state inserite dei volumi che formano un complesso residenziale.

PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE

In particolare è stato approfondita la progettazione della struttura ospedaliera, pensato come un volume compatto che si articola in due parti differenti in base alla funzione. L’ospedale sfrutta anche i piani interrati in cui sono posizionati parcheggi, la centrale tecnologica e il blocco operatorio. Al piano terra l’edificio si articola in due ingressi posizionati ai lati opposti l’uno dall’altro: in corrispondenza della piazza troviamo un accesso pubblico con funzioni di accoglienza e ambulatori, mentre sul lato retrostante è presente l‘area del pronto soccorso e la terapia intensiva, che hanno accessi dedicati per ambulanze ed esterni. Per portare più luce negli spazi interni è stata inserita una corte interna con un giardino attrezzato che può essere usato per la terapia dei pazienti. Sopra la piastra ci sono due volumi a L in cui sono contenuti le degenze, l’area di ricerca e formazione clinica. I volumi a L sono posizionati arretrati rispetto al filo generale dei piani sottostanti in modo da creare un giardino agibile sulla copertura dell’ultimo piano di piastra. Le degenze sono articolate con bow window vetrati che danno al paziente la possibilità di avere un luogo luminoso con una vistasulgiardinoesullacorteinterna.Iprospettidell’edificiosono anch’essi divisi principalmente in due parti: la parte sottostante di piastra è formata da aperture verticali che corrono lungo il prospetto mentre la parte soprastante è caratterizzata da una serie di listelli in legno che in corrispondenza delle finestre con un sistema automatico permettono l’oscuramento dell’ambiente interno.




SEZIONE LONGITUDINALESEZIONE TRASVERSALE








INNESTI
Progetto di edifici a destinazione mista inseriti all’interno della cava in disuso di Lecco


Il progetto si trova in prossimità di una cava artificiale in disuso nella città di Lecco; uno scenario insolito che prevede una metodologia di intervento nuova. L’obbiettivo progettuale consiste nel riutilizzare l’area della cava per darle una nuova vita fruttando la componente turistica. L’attenzione maggiore è rivoltaallapareteverticale,chepuòesserevissutainunaduplice modalità: in una forma più ordinaria, con una cremagliera che portano all’hotel a nord della cava e il percorso panoramico sulla cresta della parete con un belvedere, oppure con un approccio più stimolante e impegnativo legato al mondo dell’arrampicata, utilizzando percorsi sulla cava e rifugi per scalatori.
Sono stati applicati differenti approcci in base alla funzione del singolo elemento: i bivacchi sono interventi piccoli e puntuali il cui volume si riferisce a quello di un cristallo, come se esso fosse il risultato di una gemmazione della roccia, mentre l’hotel con l’impianto di risalita è più visibile nel contesto ed è concepito come se fosse un sottile velo che increspandosi si adagia sulla parete.
In particolare è stato approfondito il linguaggio dei bivacchi, di cui è stata studiata la posizione sulla parete in punti strategici per panorama, venti ed esposizioni. Nella loro progettazione, oltre la forma a cristallo, importante è anche il concetto del “vivere obliquo”, ragionamento derivato dalla teoria di Claude Parent che viene preso come spunto per inclinare la superficie dei rifugi in modo da un vivere uno spazio che si libera dai suoi dogmi tradizionali dialogando con la situazione non tradizionale del costruire su una parete verticale. Sulla Cliff troviamo 10 bivacchi che sono riconducibili a quattro tipologie principali distinte da forme differenti e diverse capacità di ospitare scalatori. Tutte le tipologie hanno uno scheletro in acciaio che si inserisce nella struttura di cemento armato innestata nella montagna. Per mediare l’imponenza della parete verticale con la città viene inserito uno spazio verde ai piedi della montagna, in cui l’intervento progettuale si presta ad evidenziare vari livelli del terreno già presenti, creano percorsi e spazi differenti che possono essere utilizzati come luoghi per allestire mostre o svolgere altre attività collettive .








