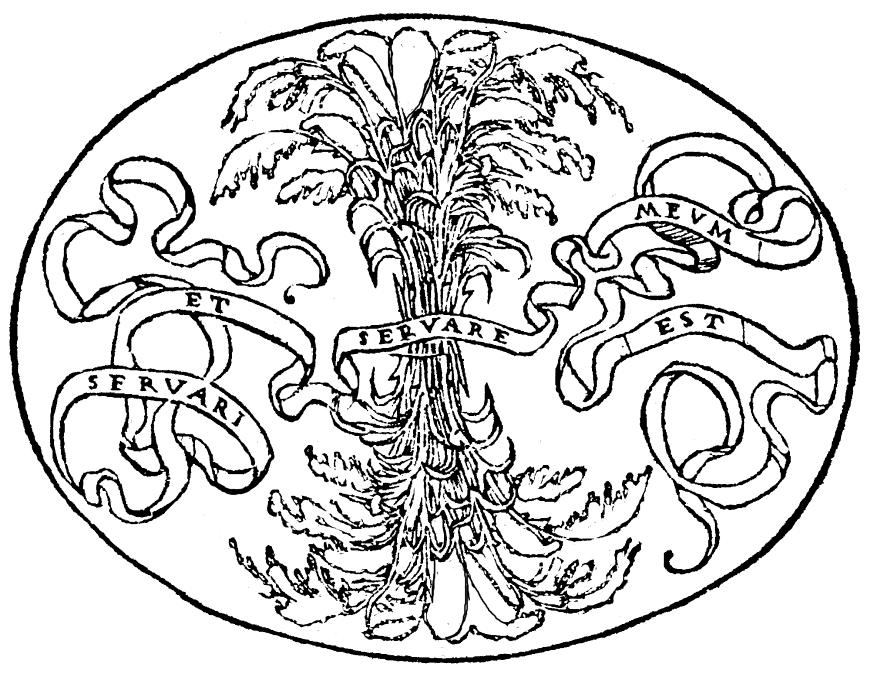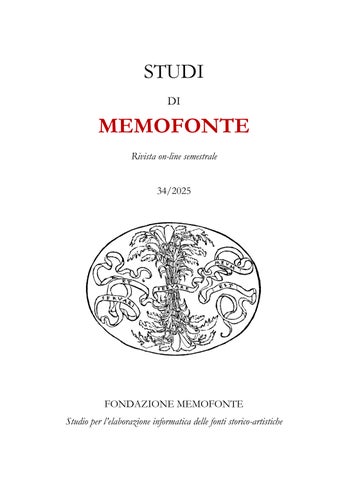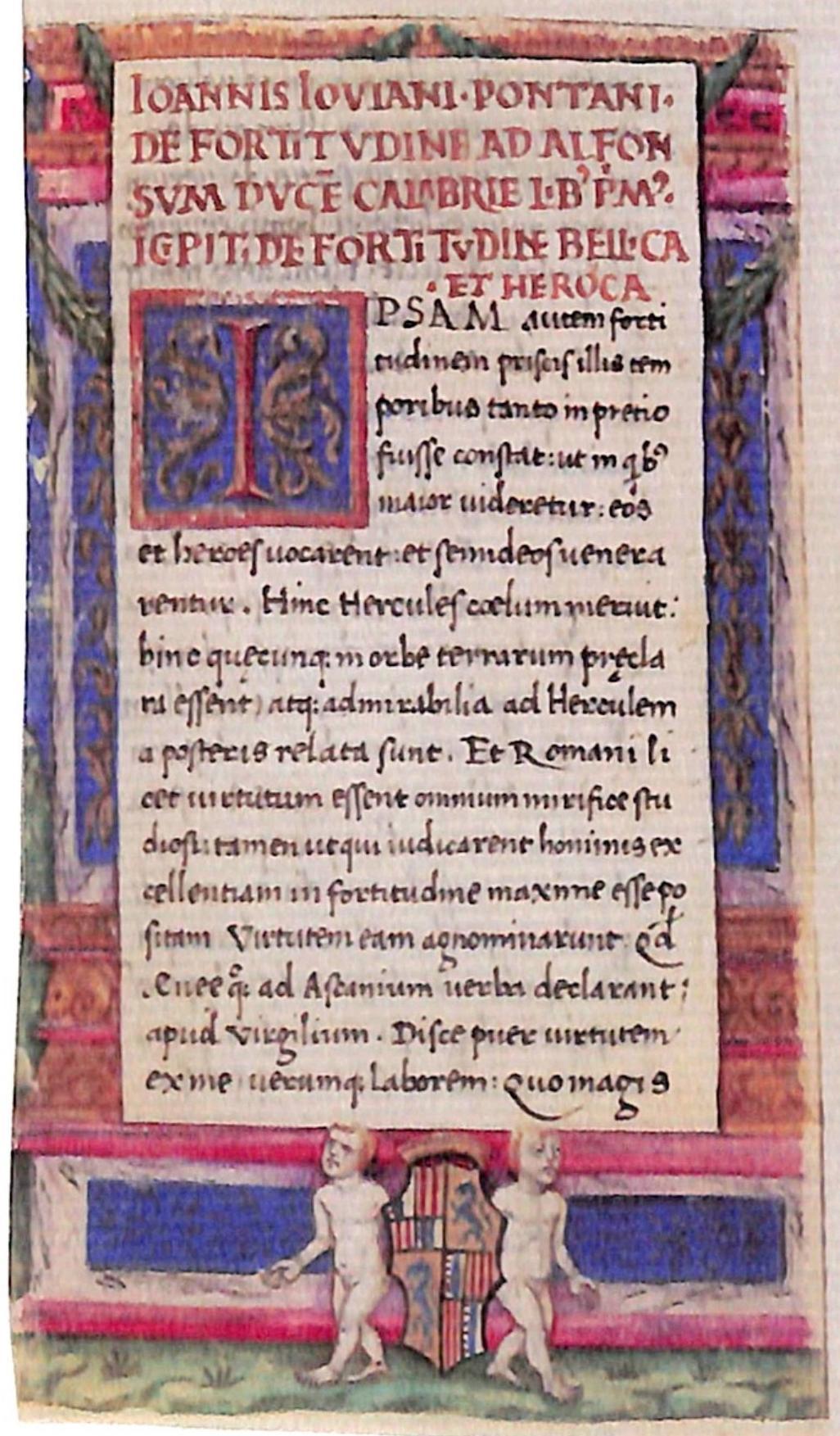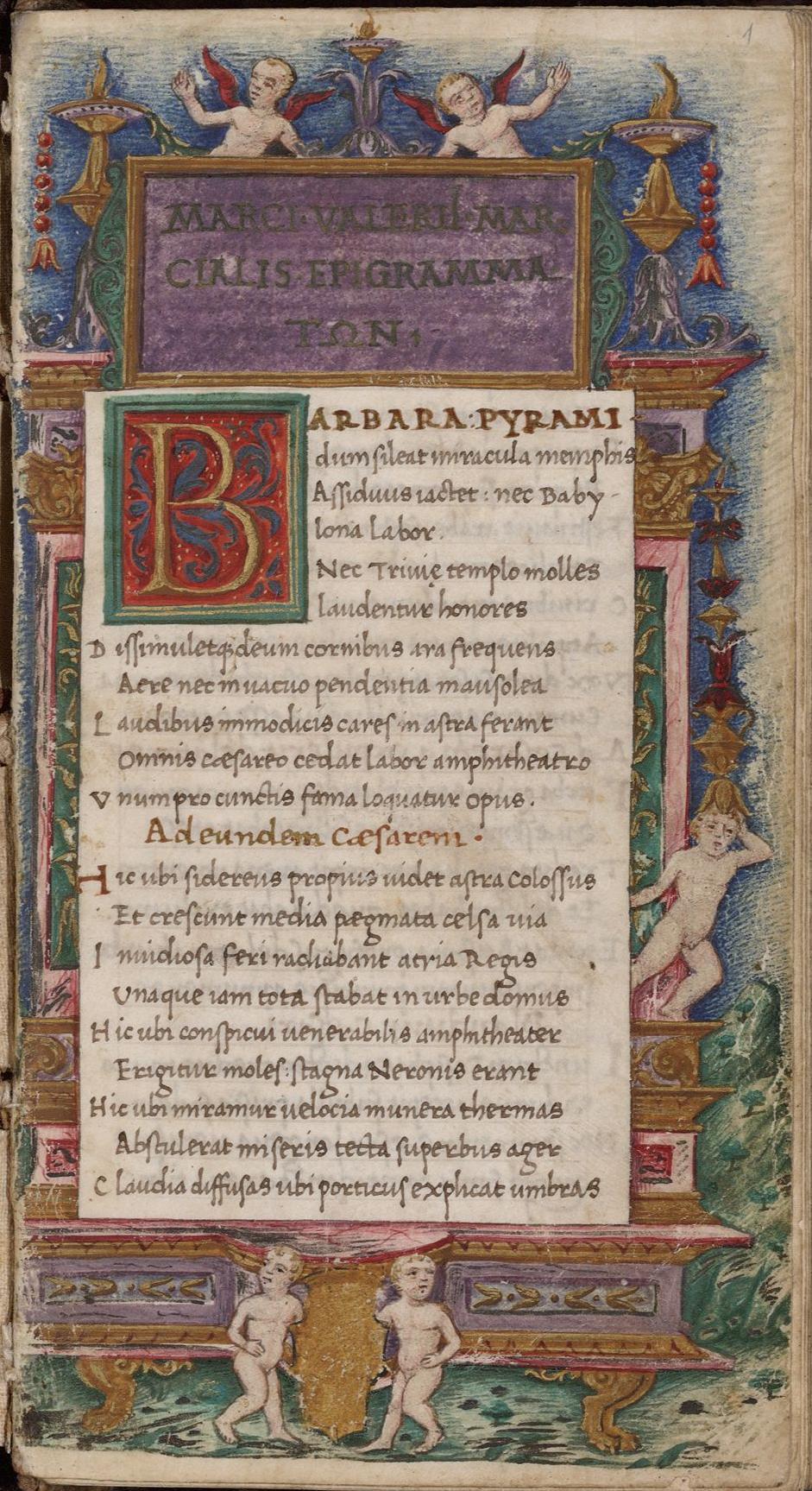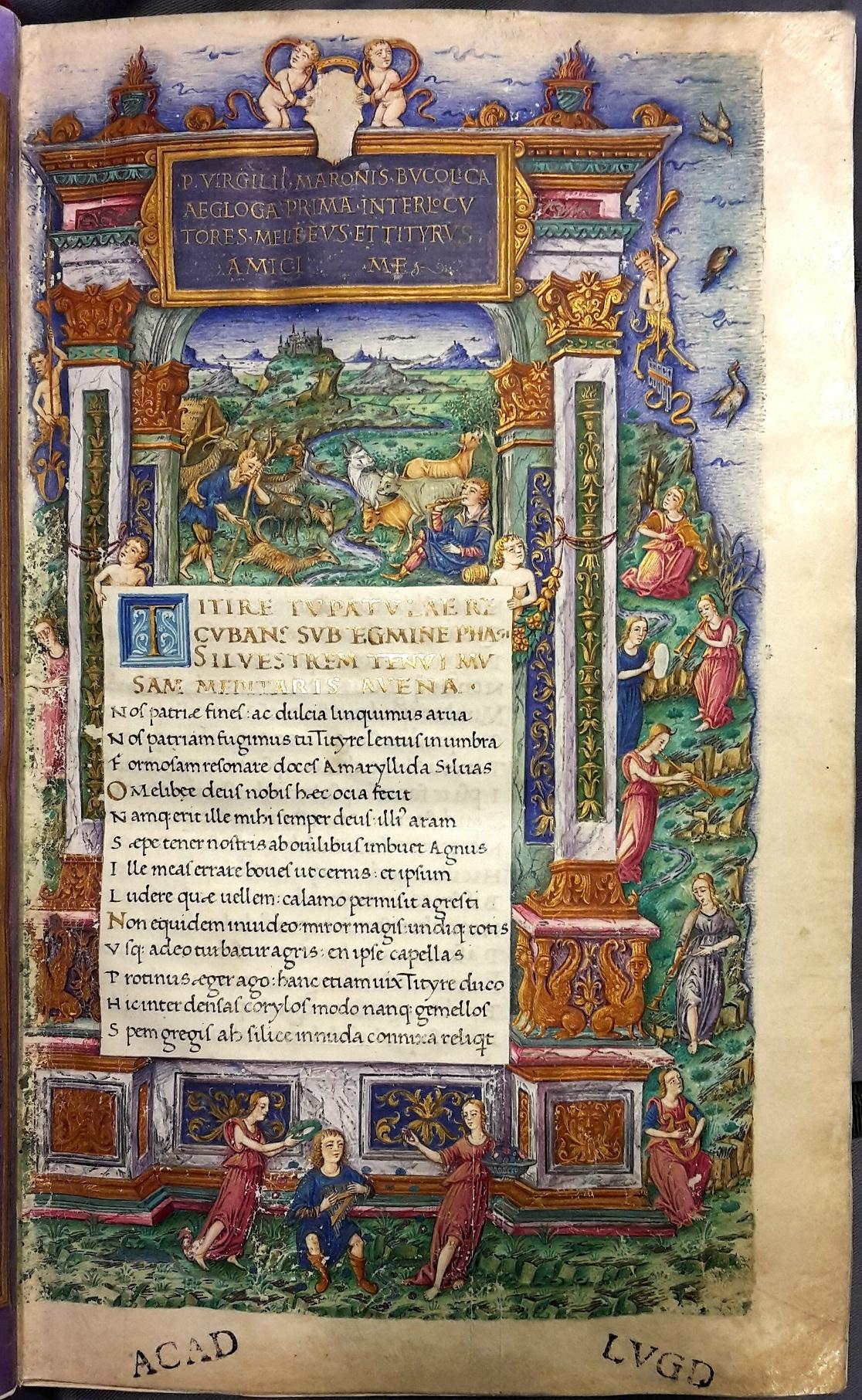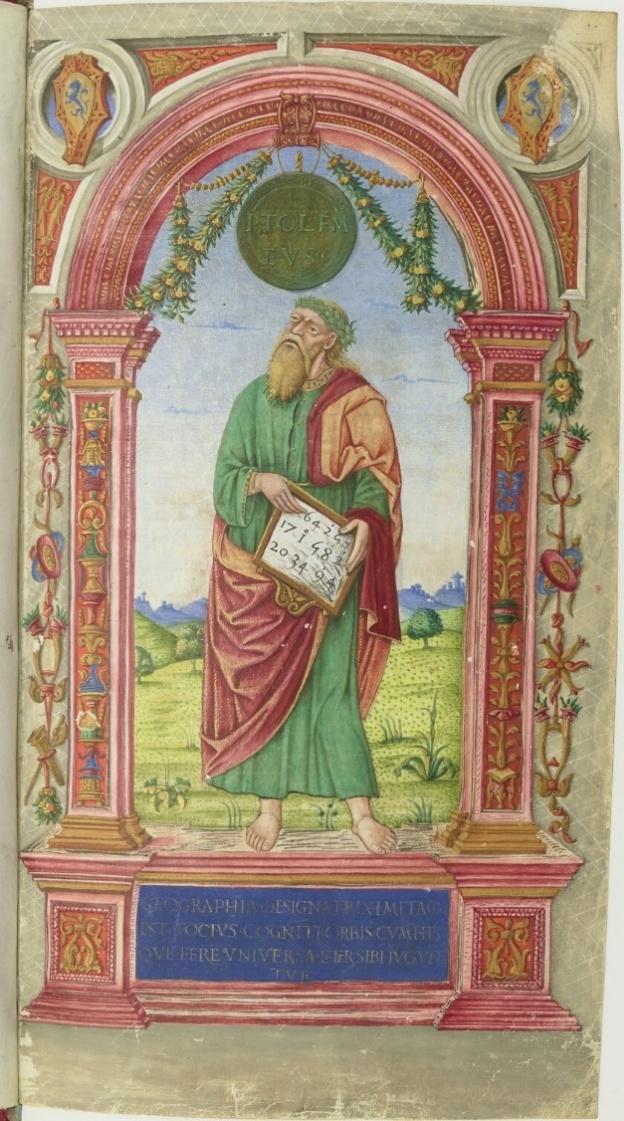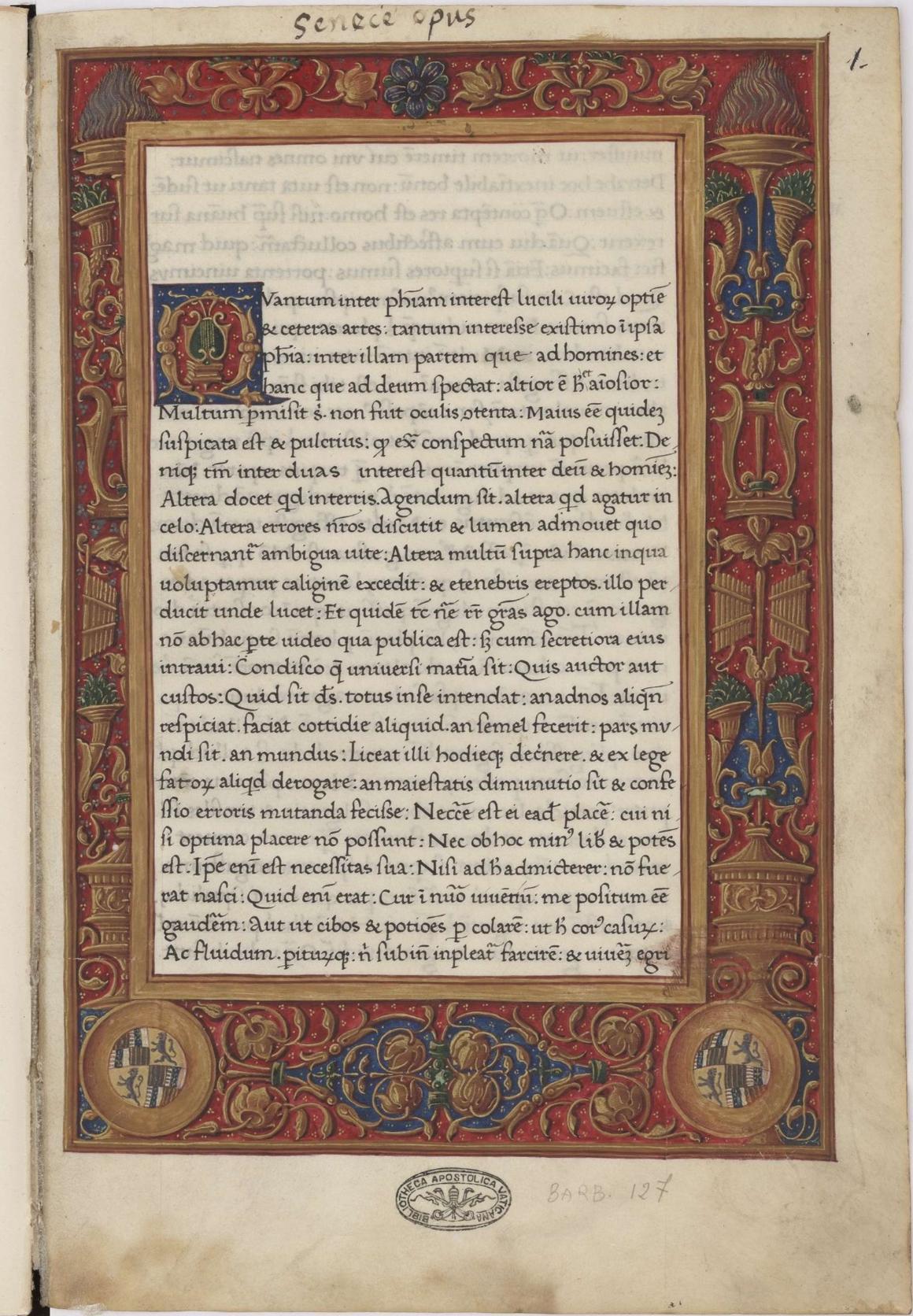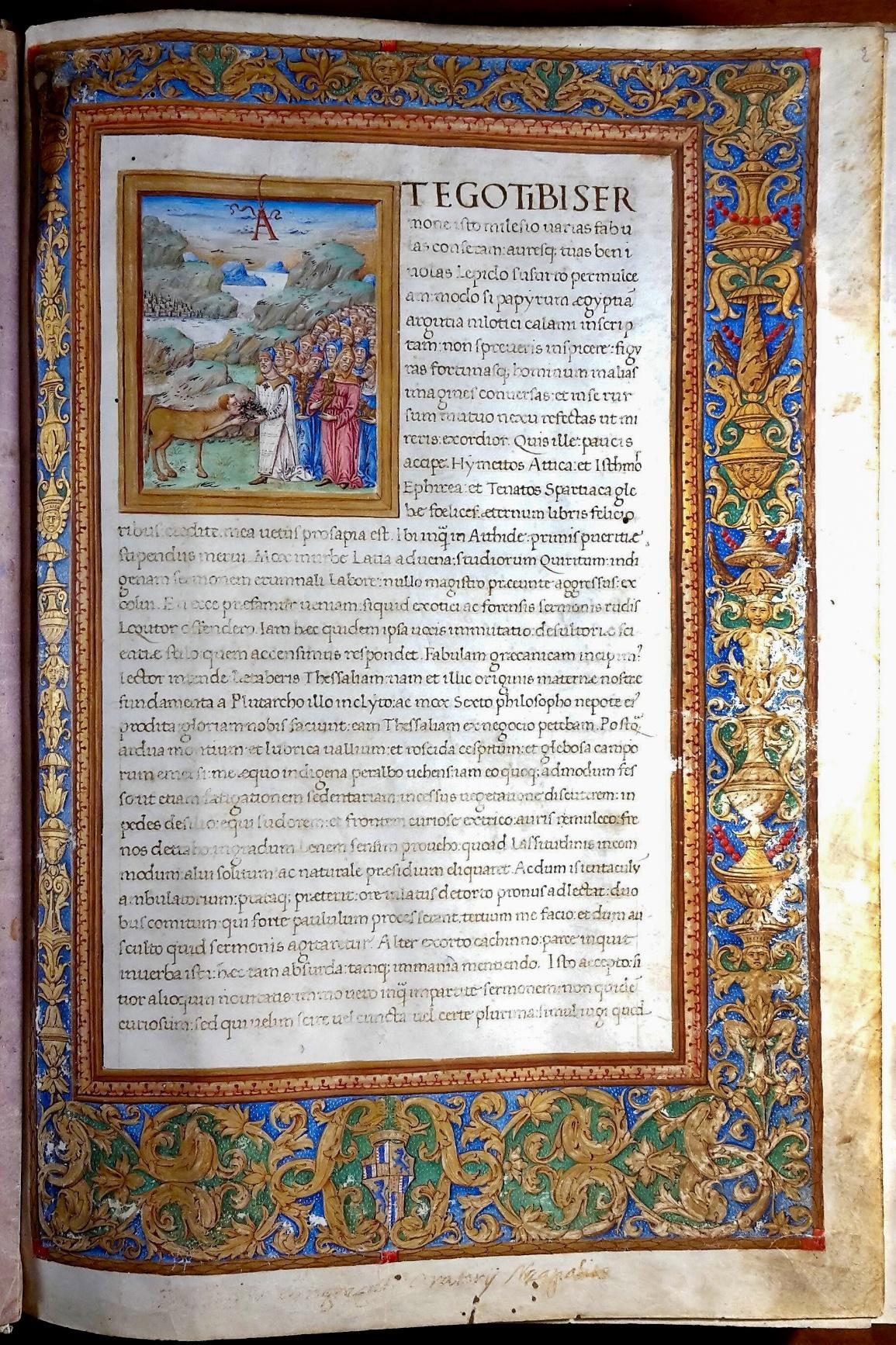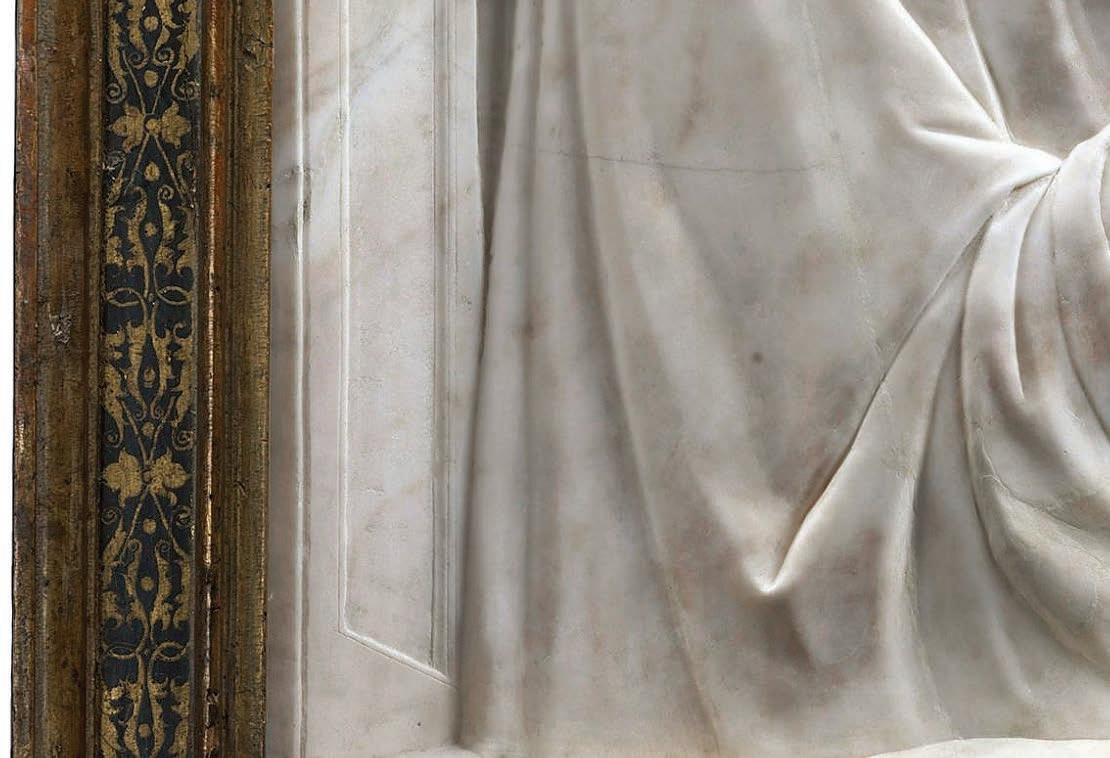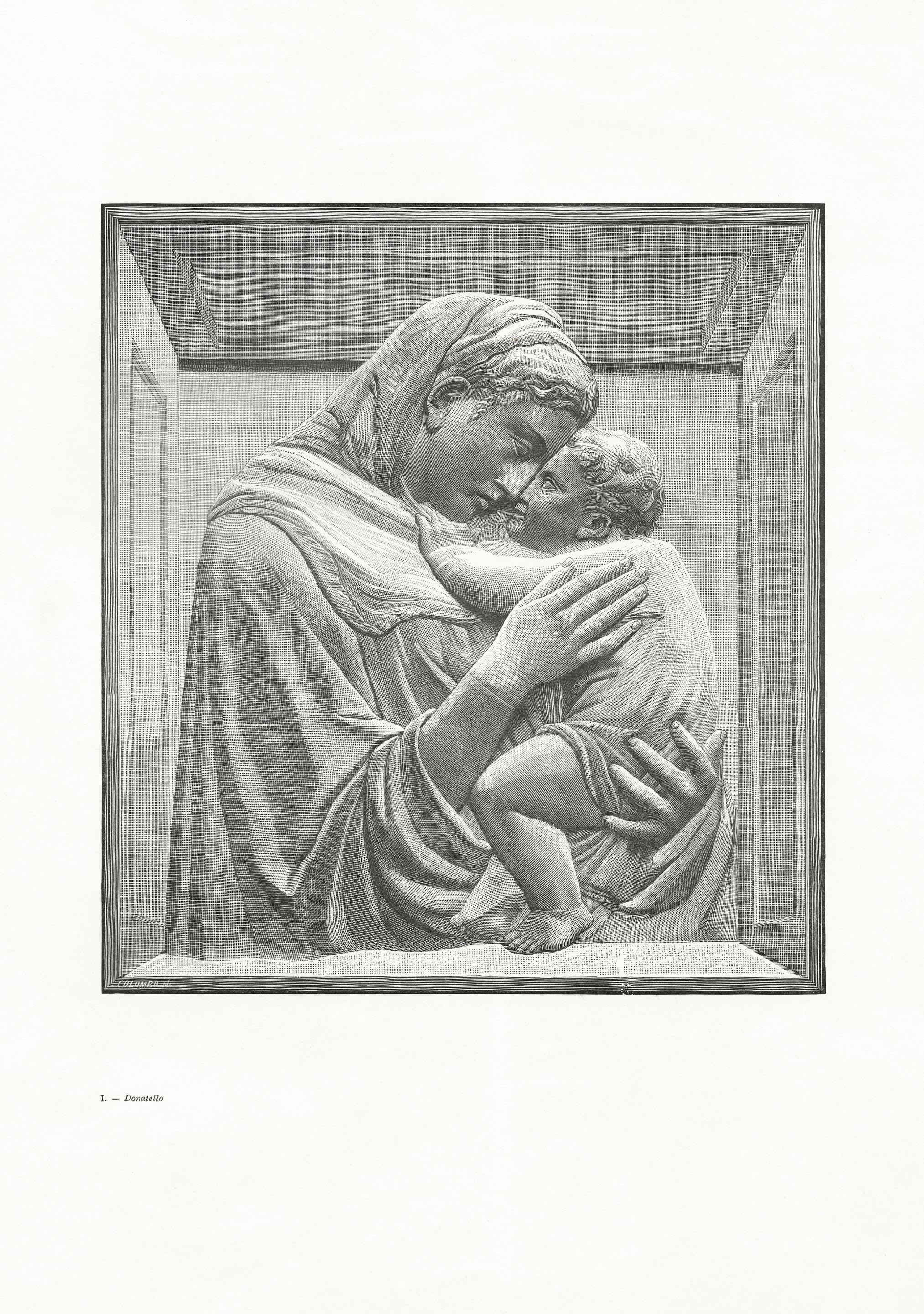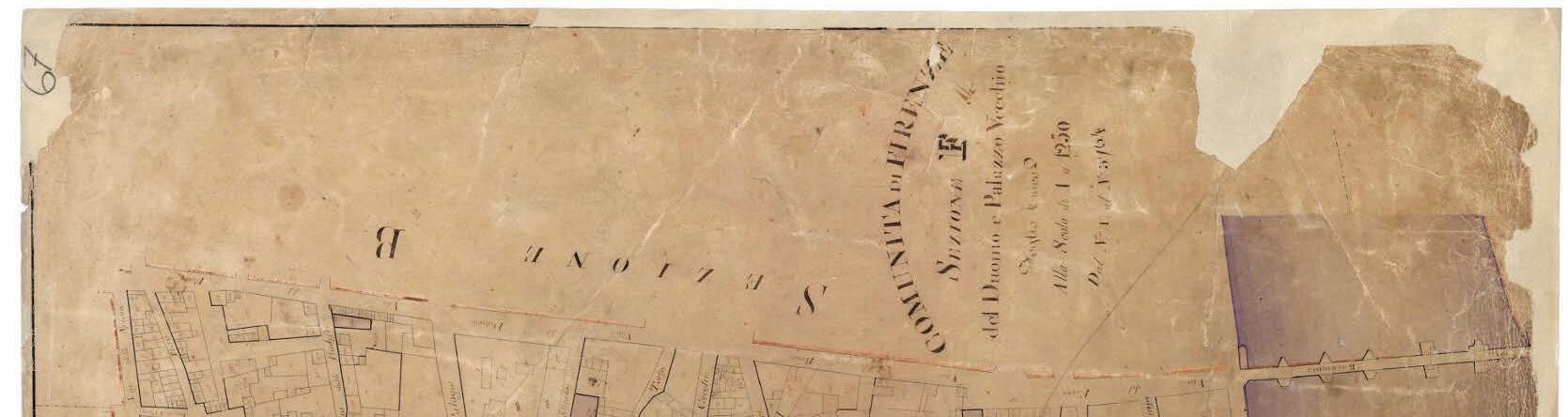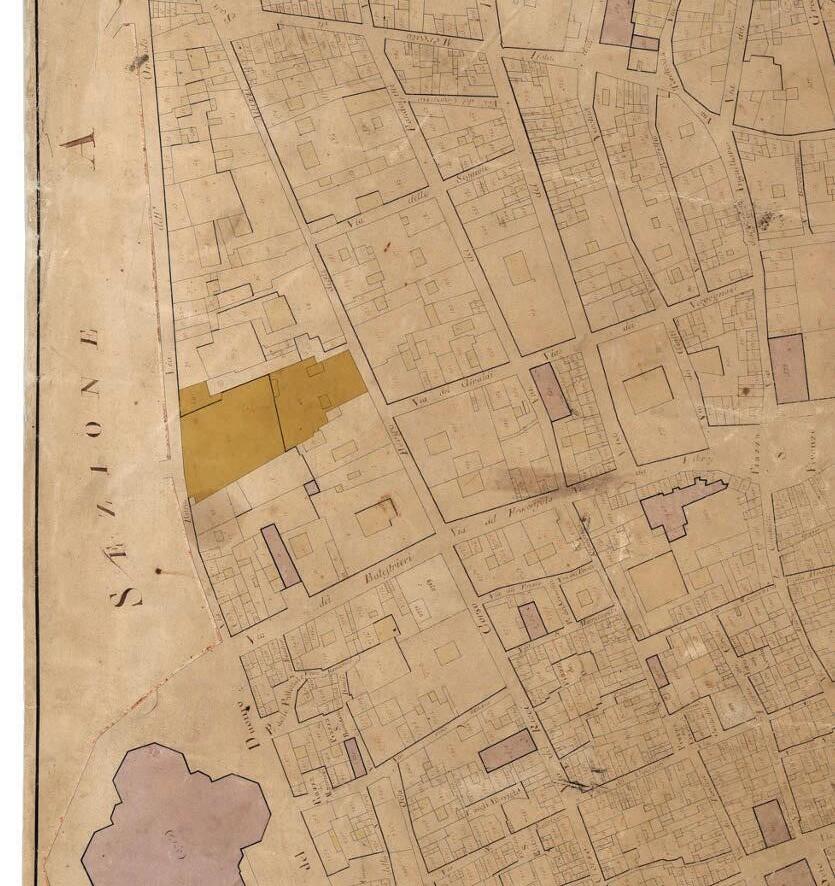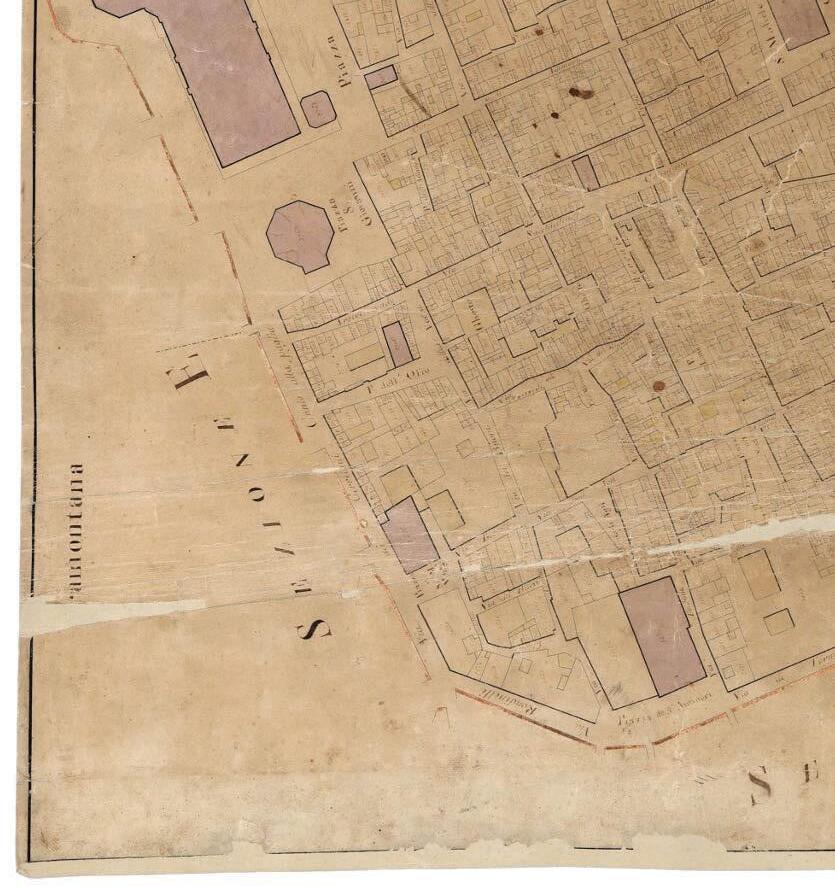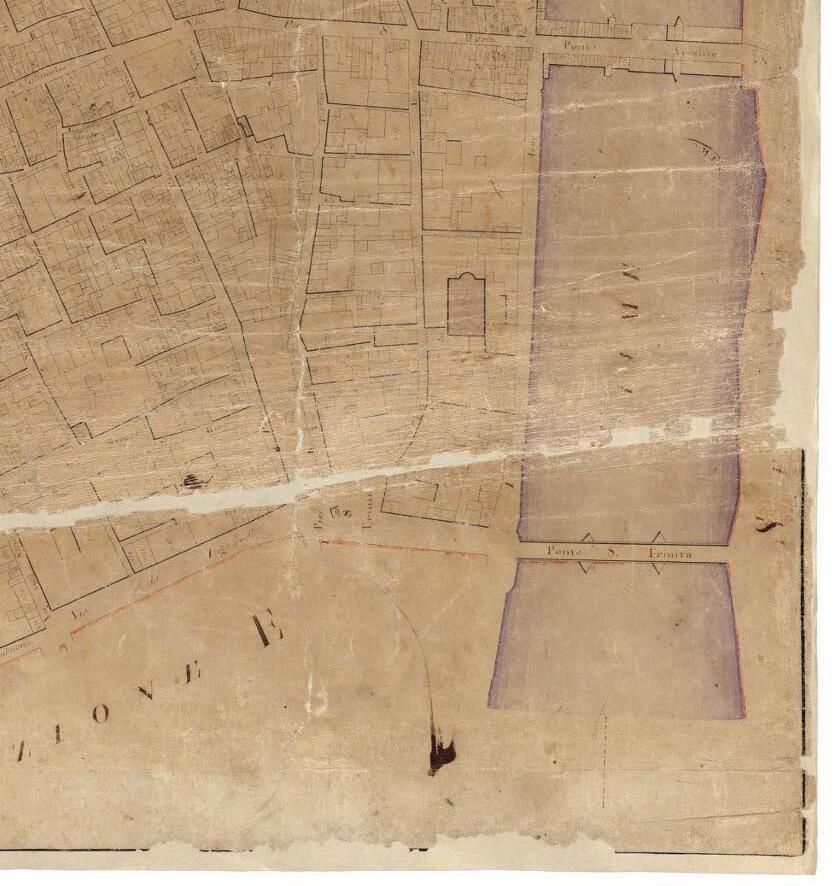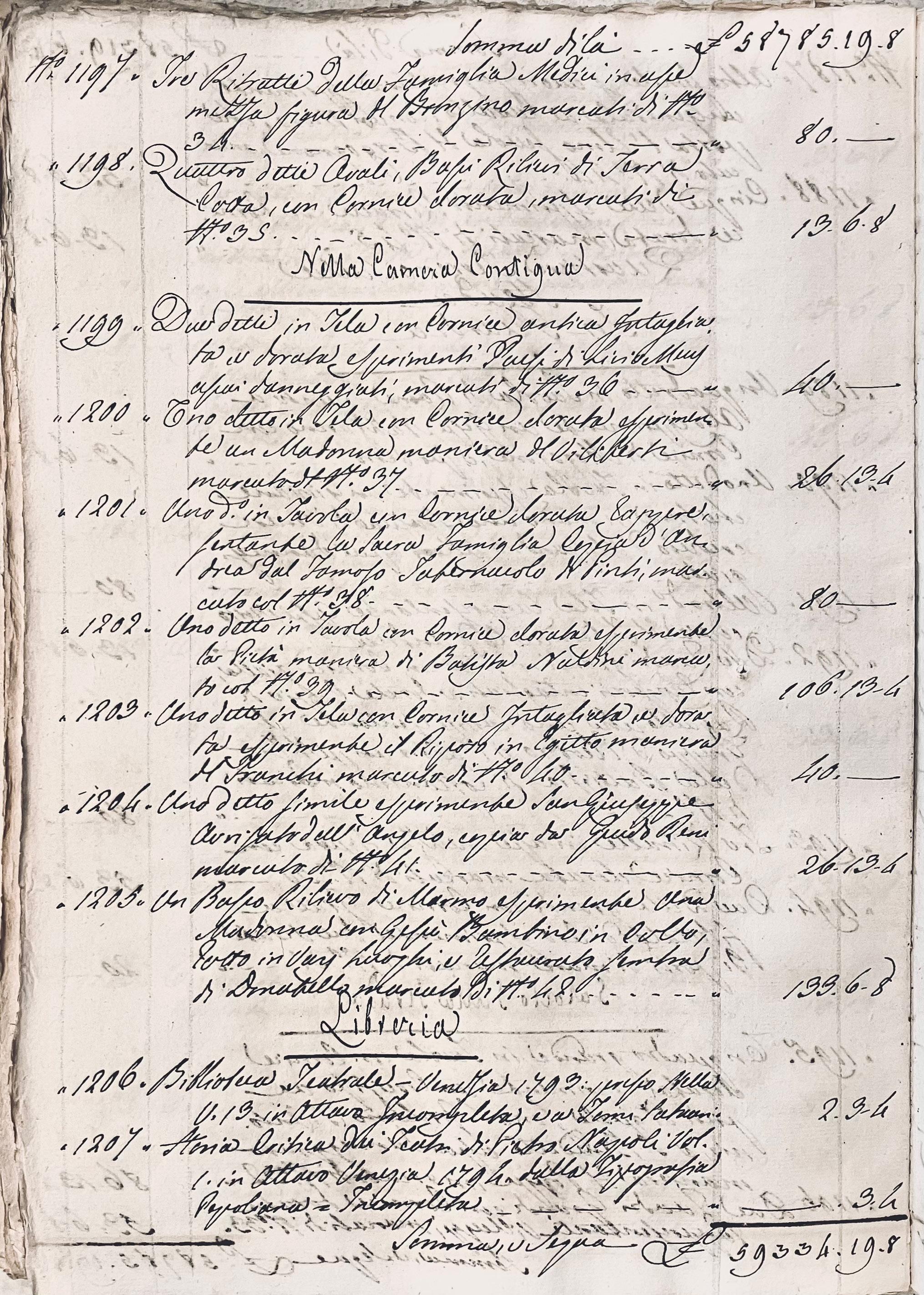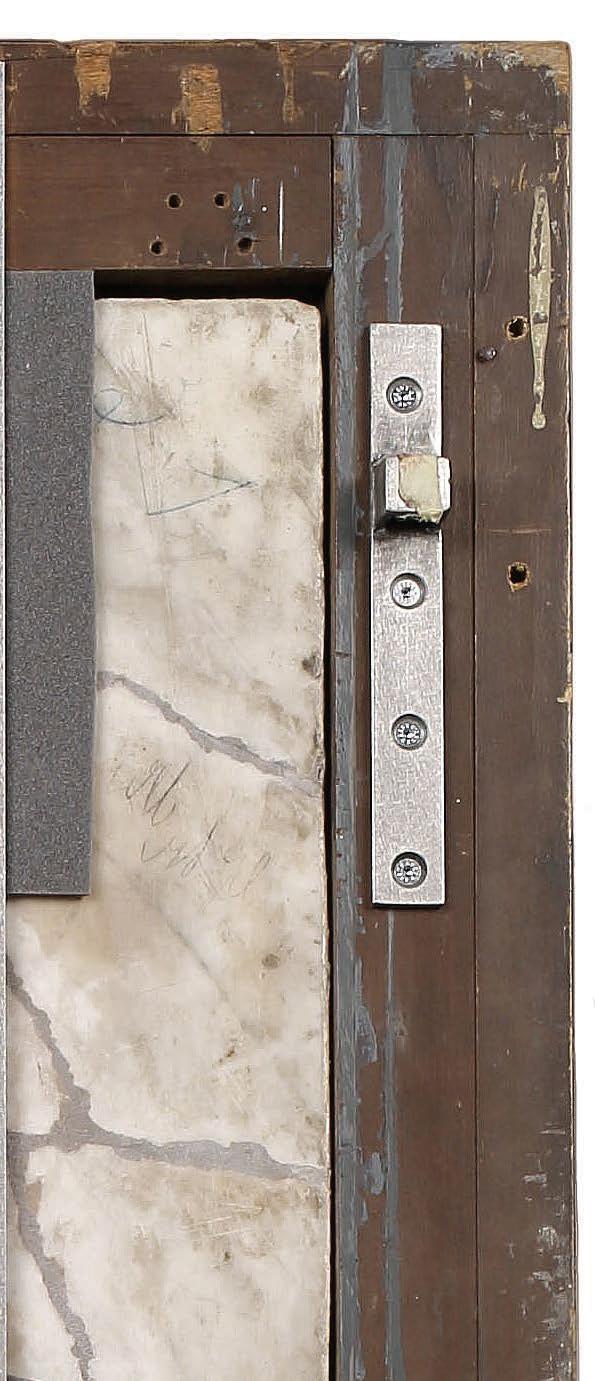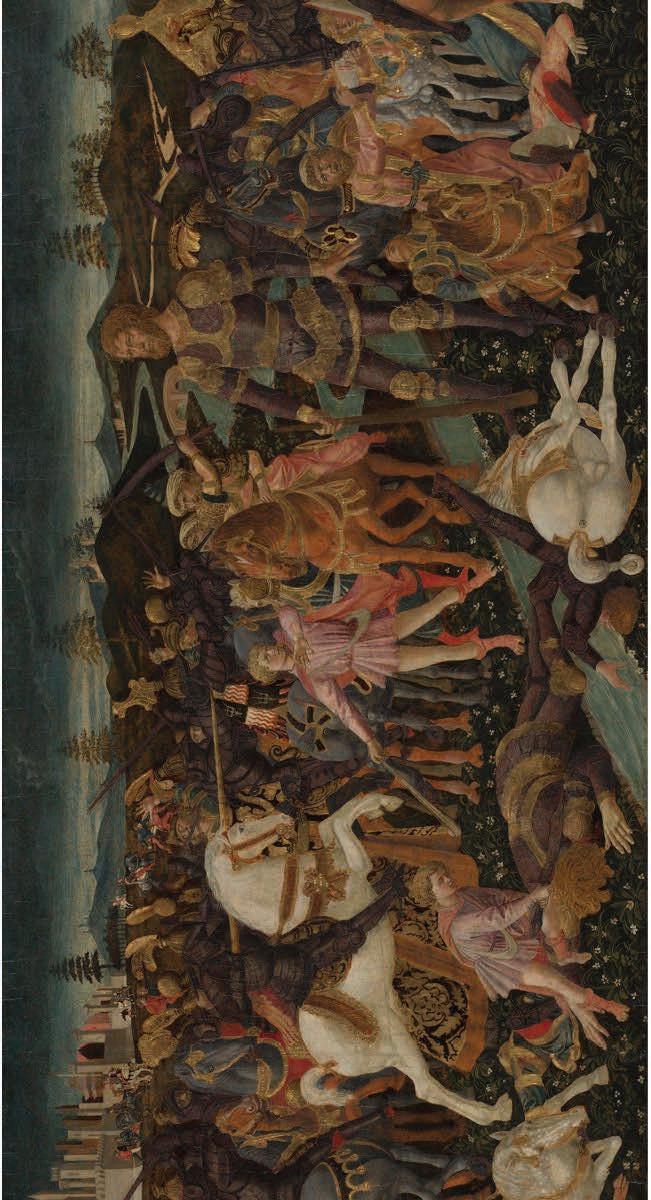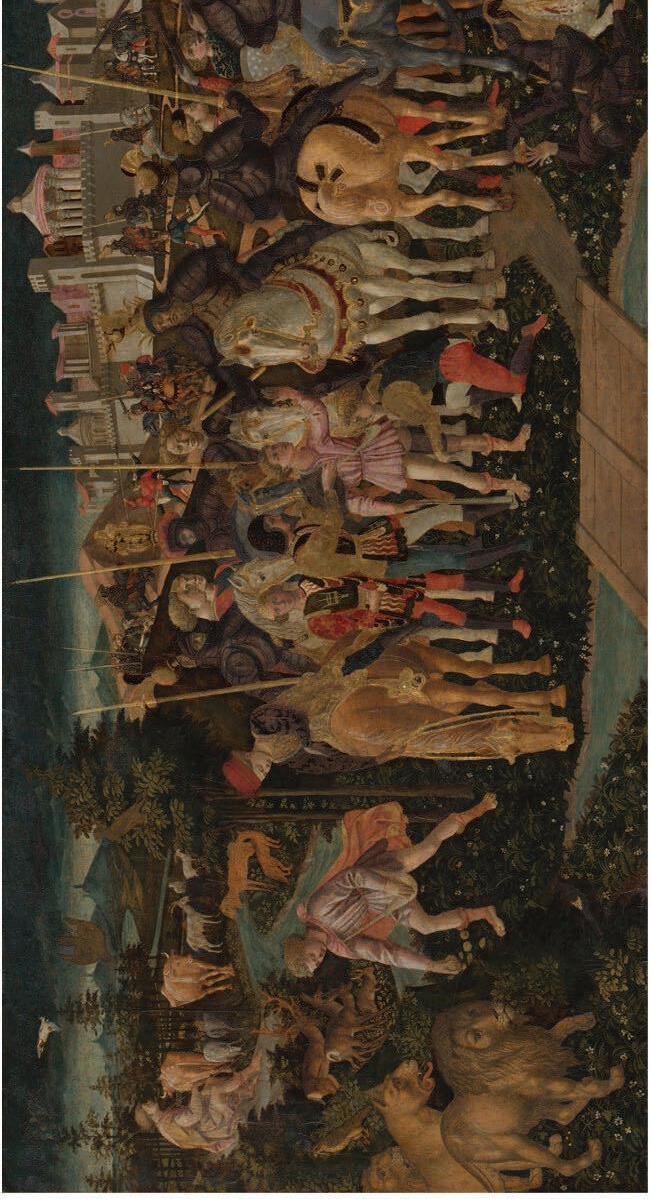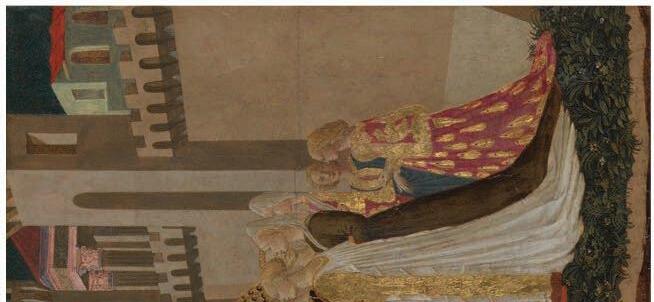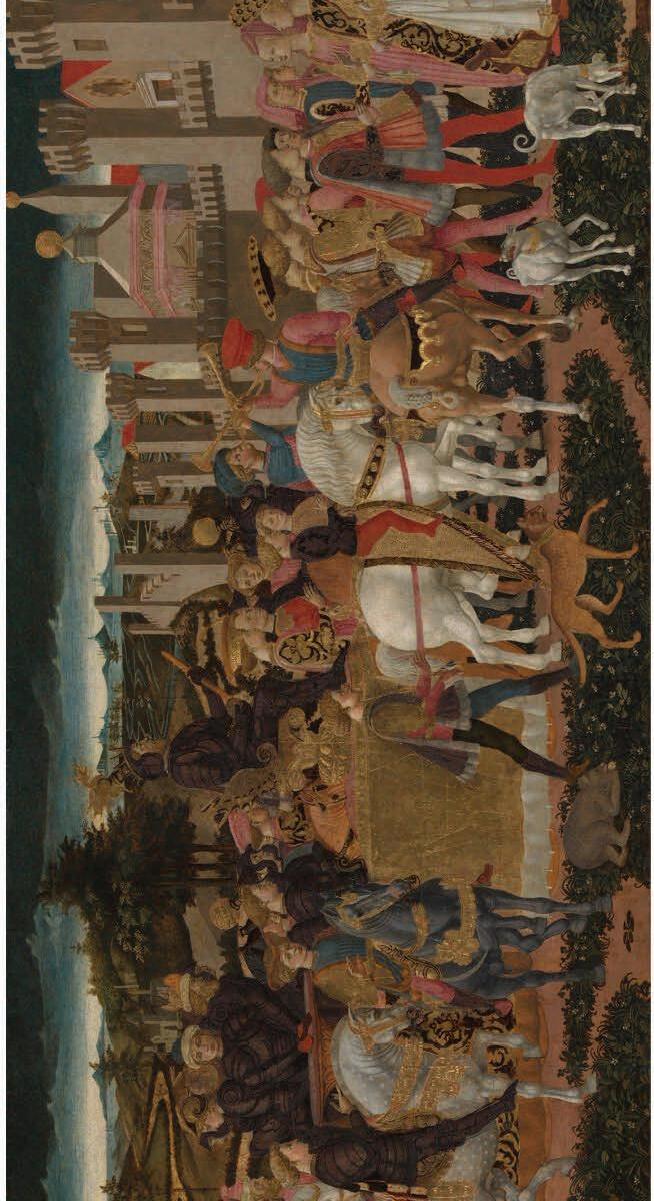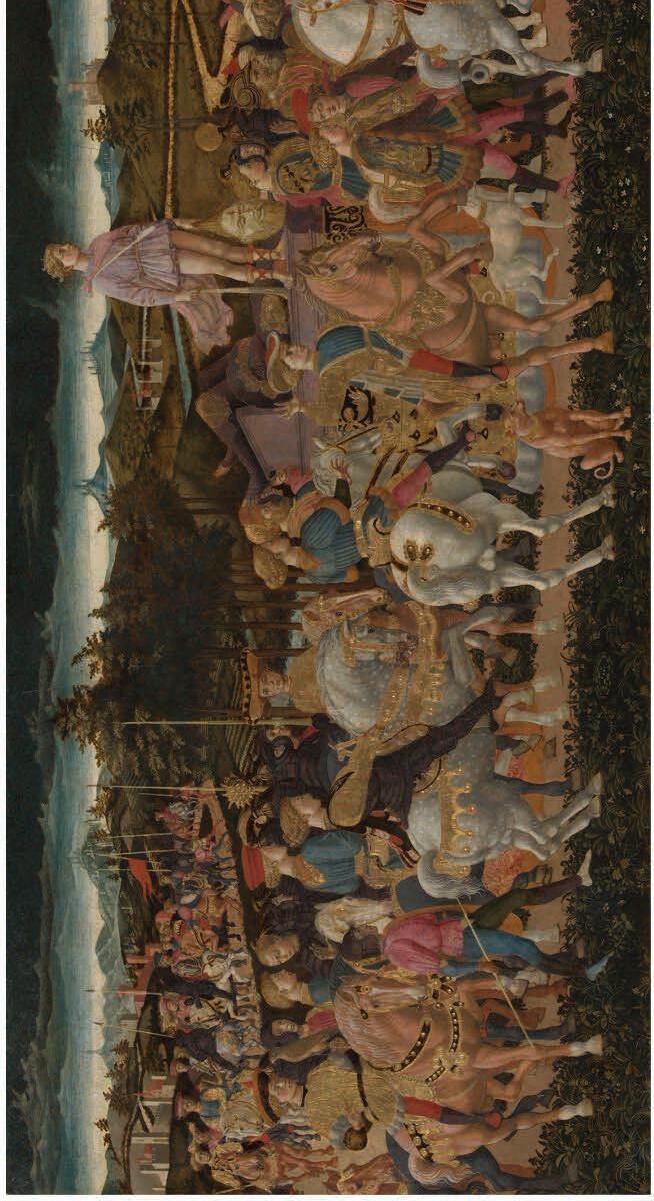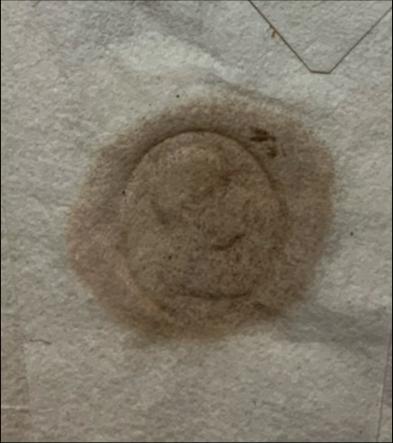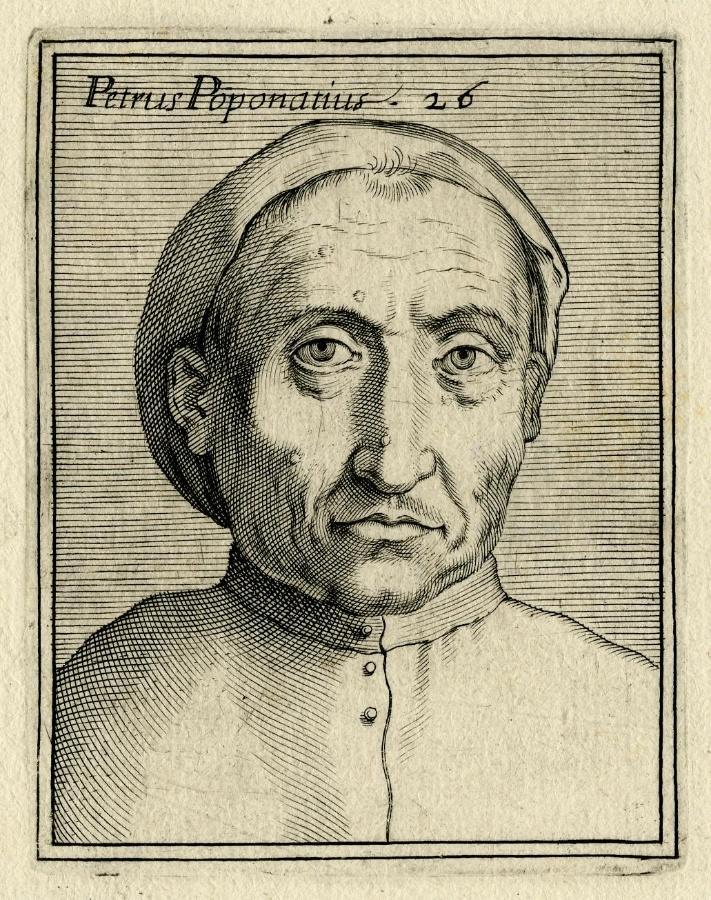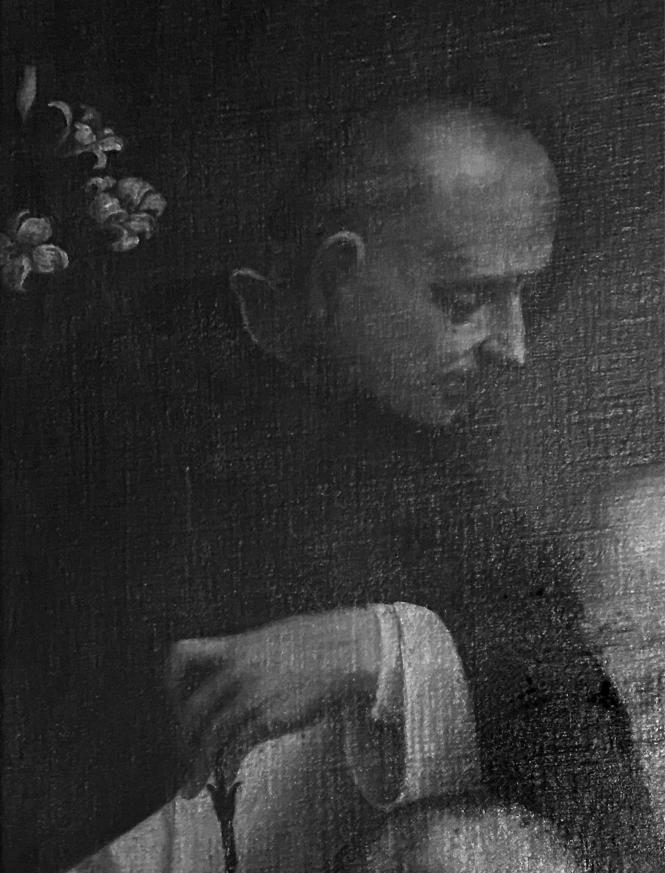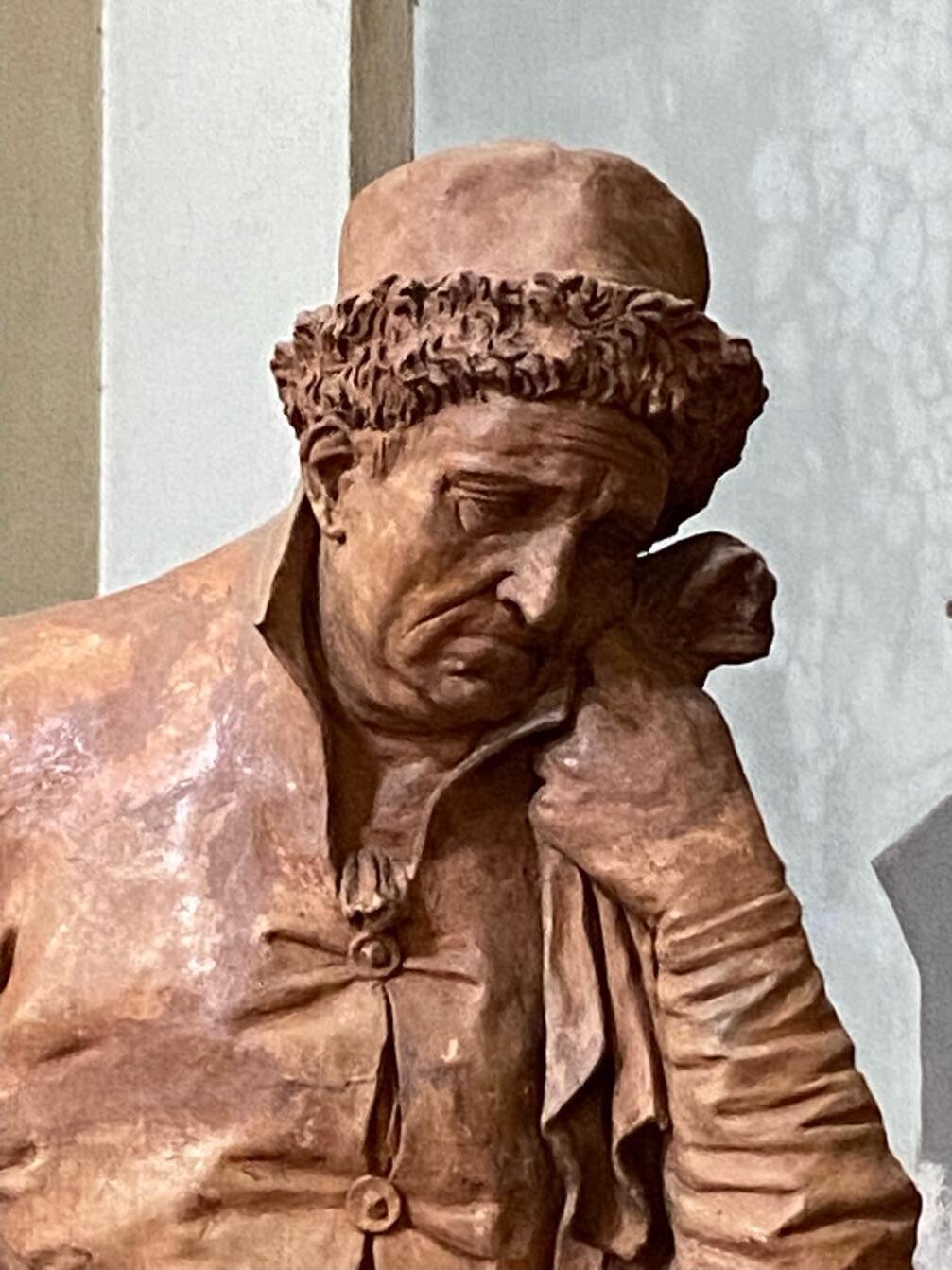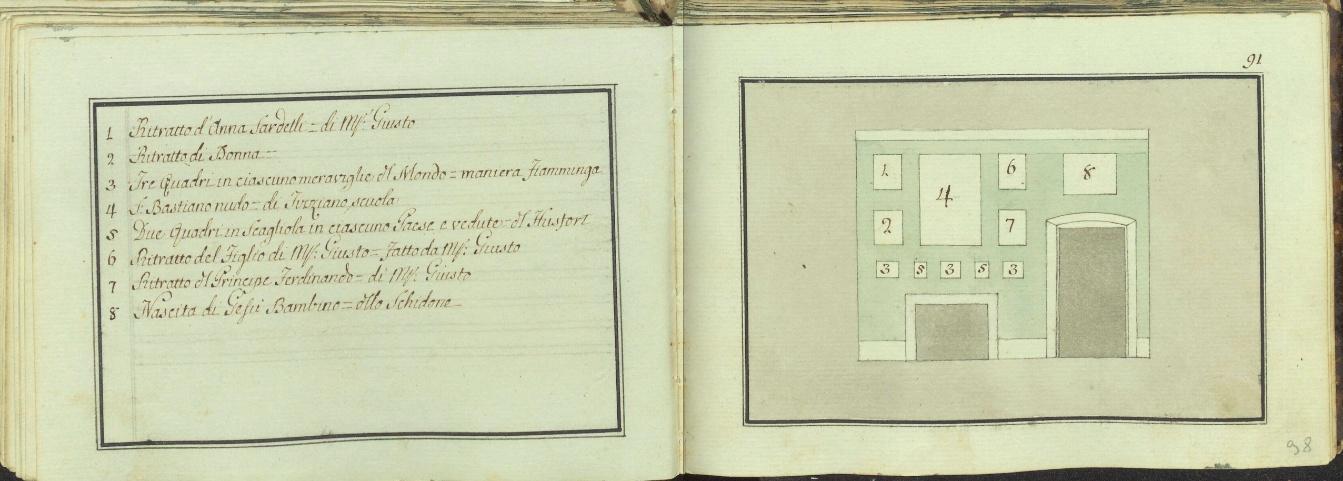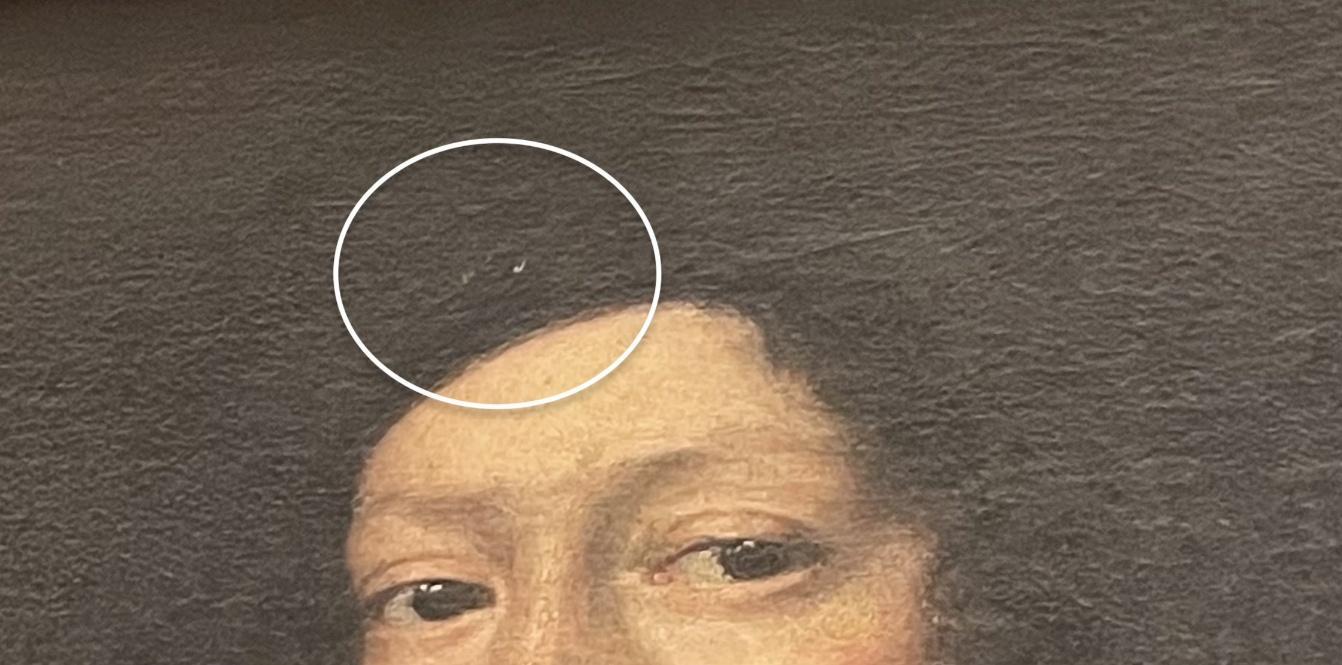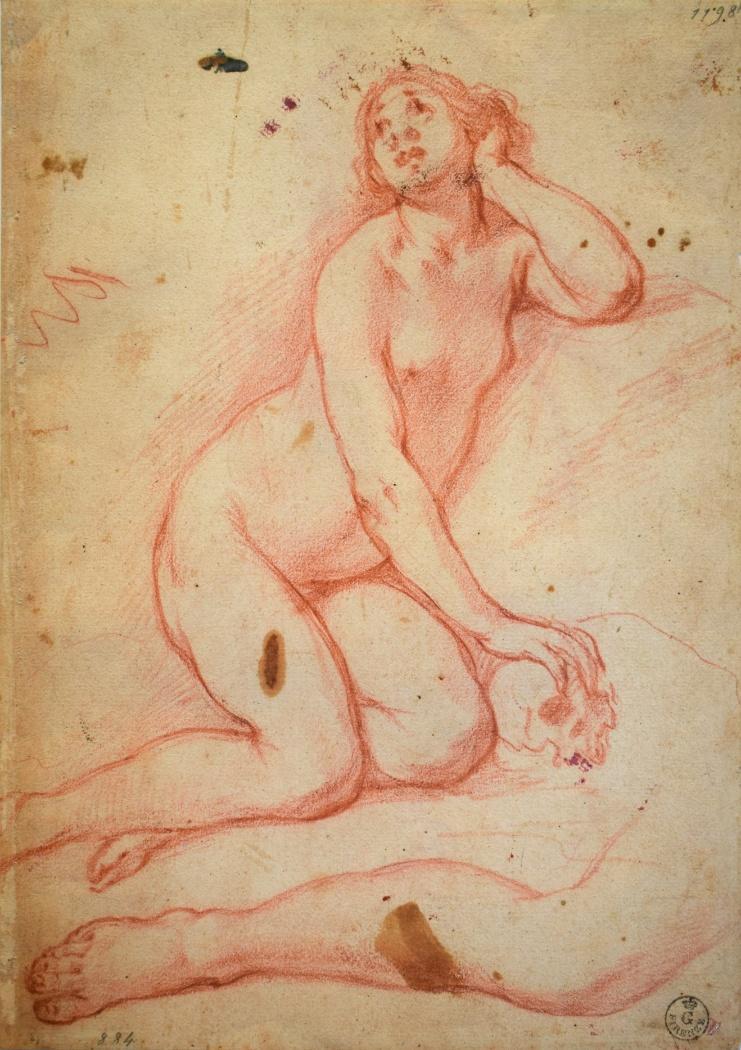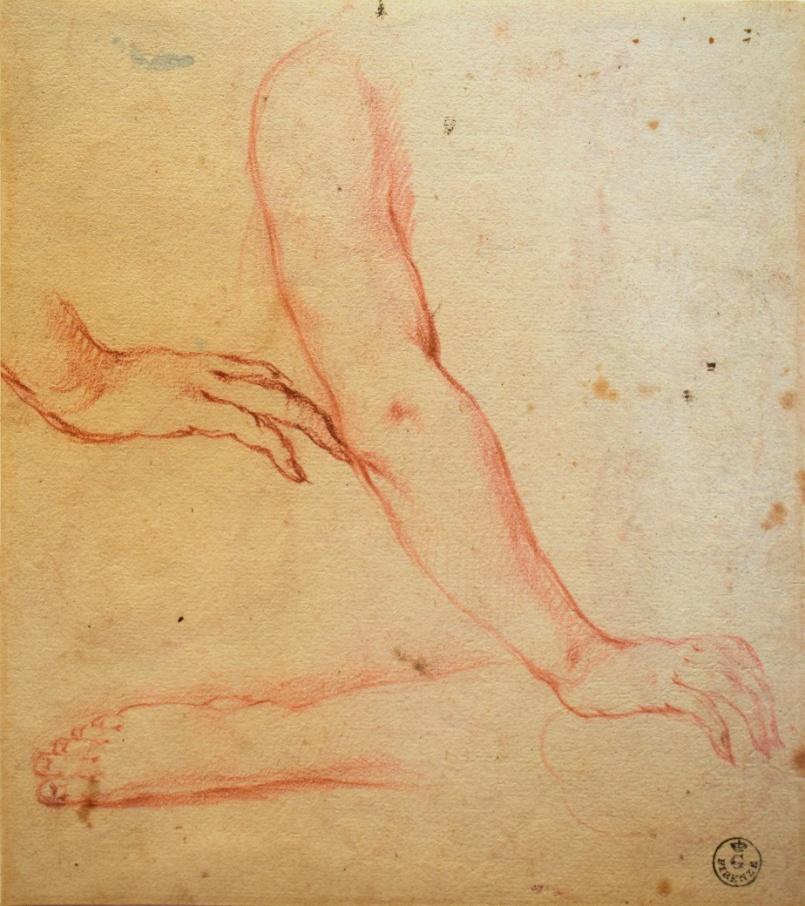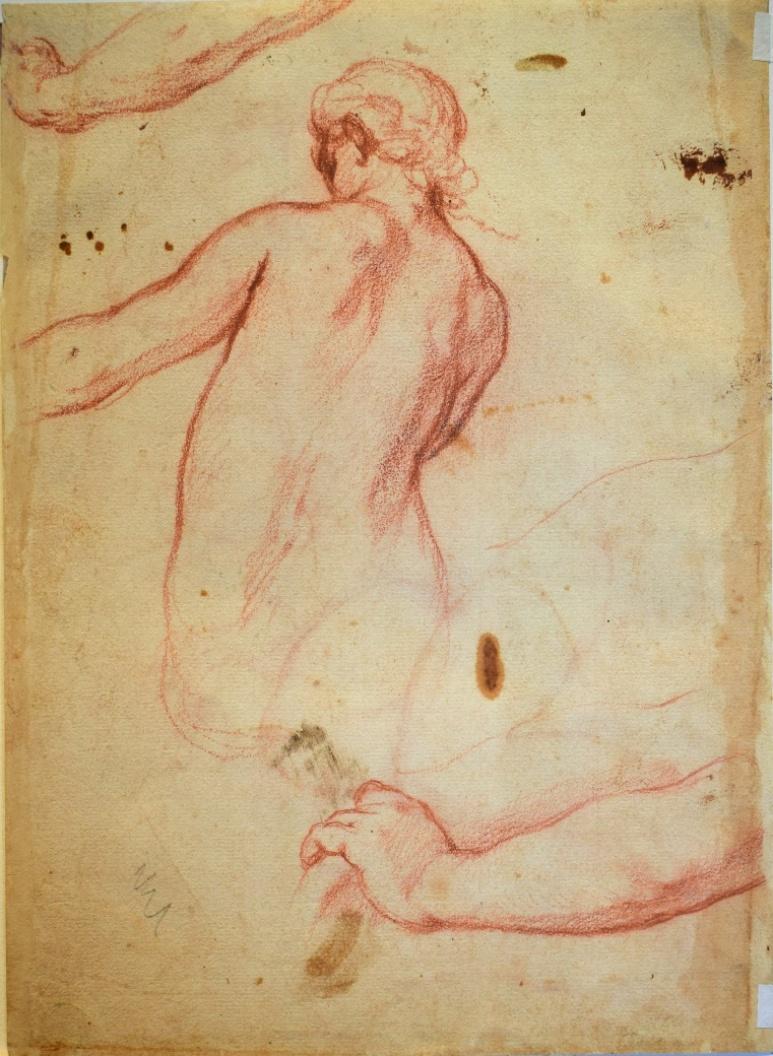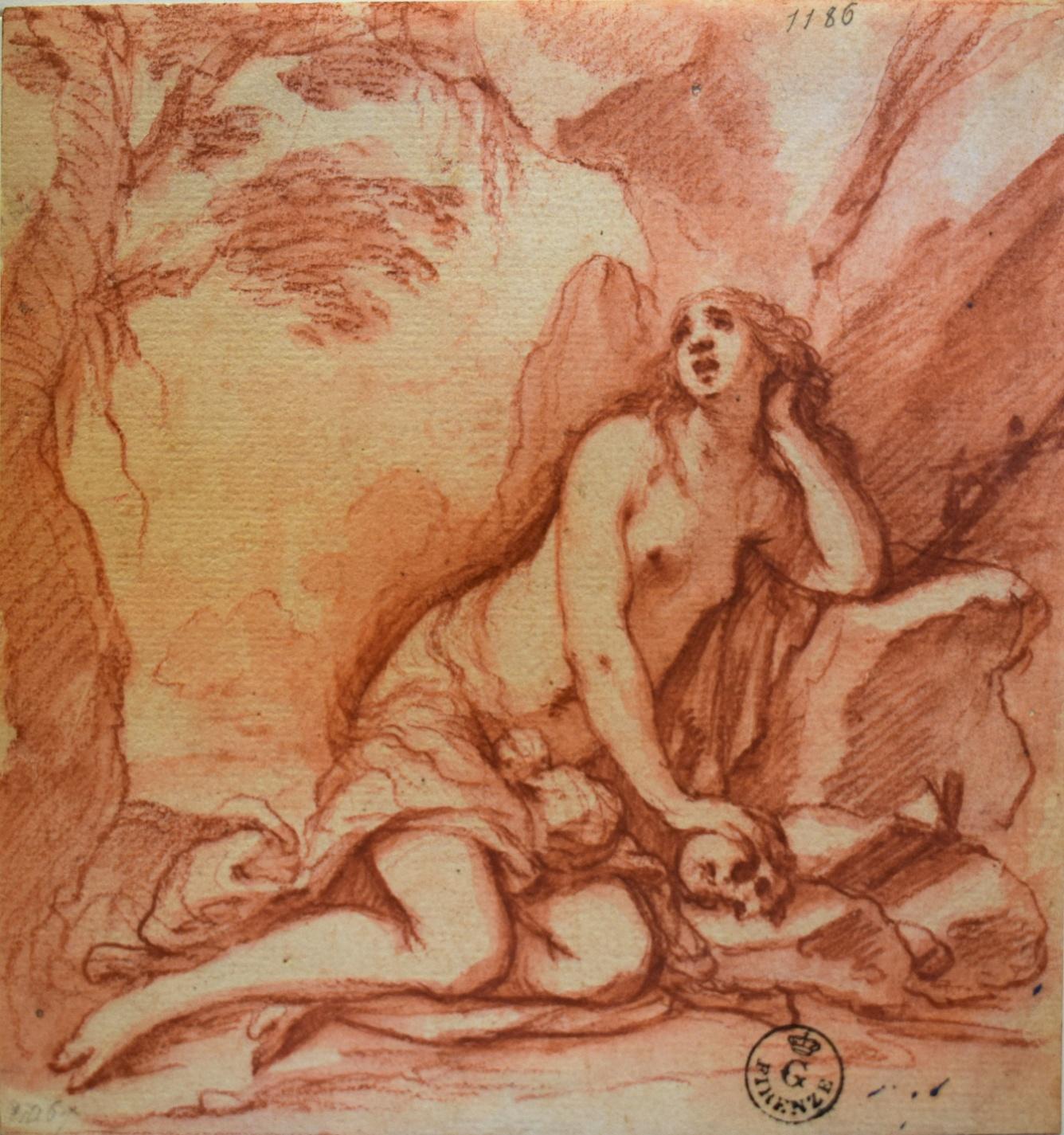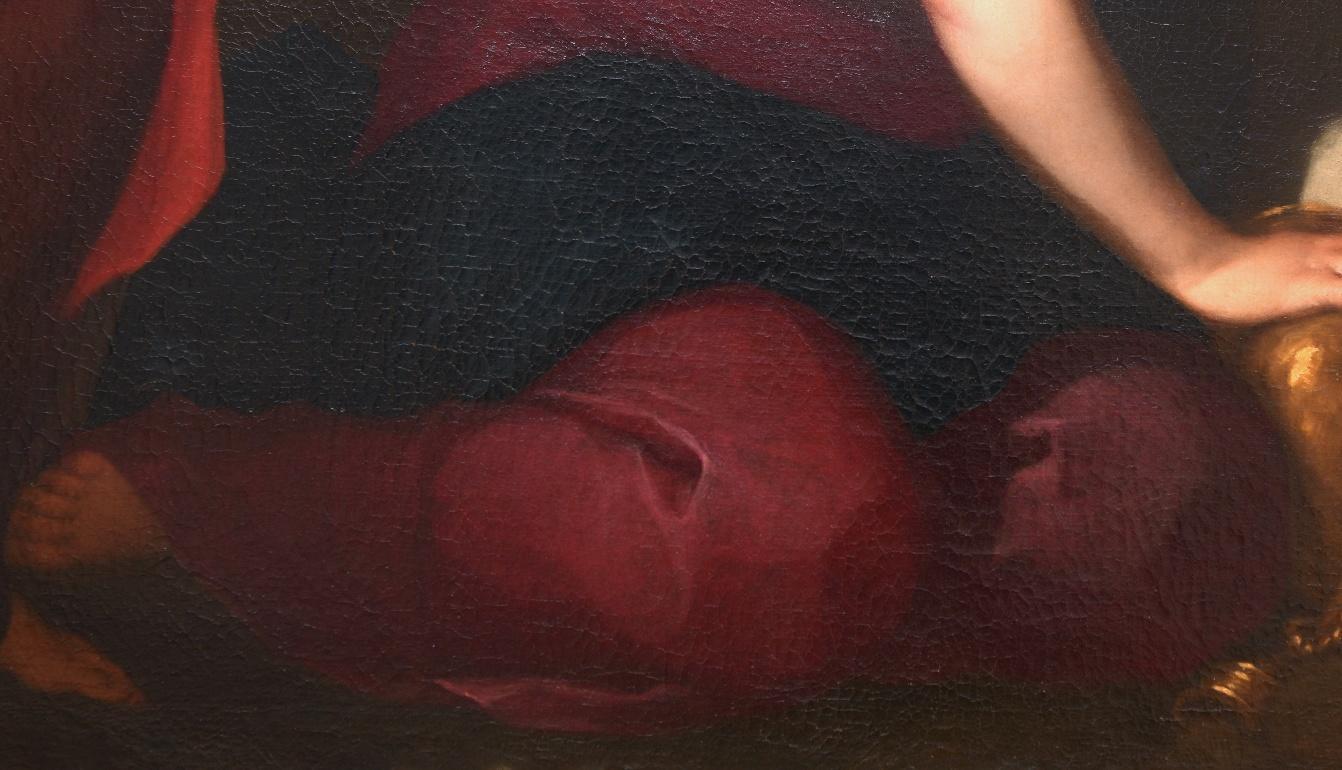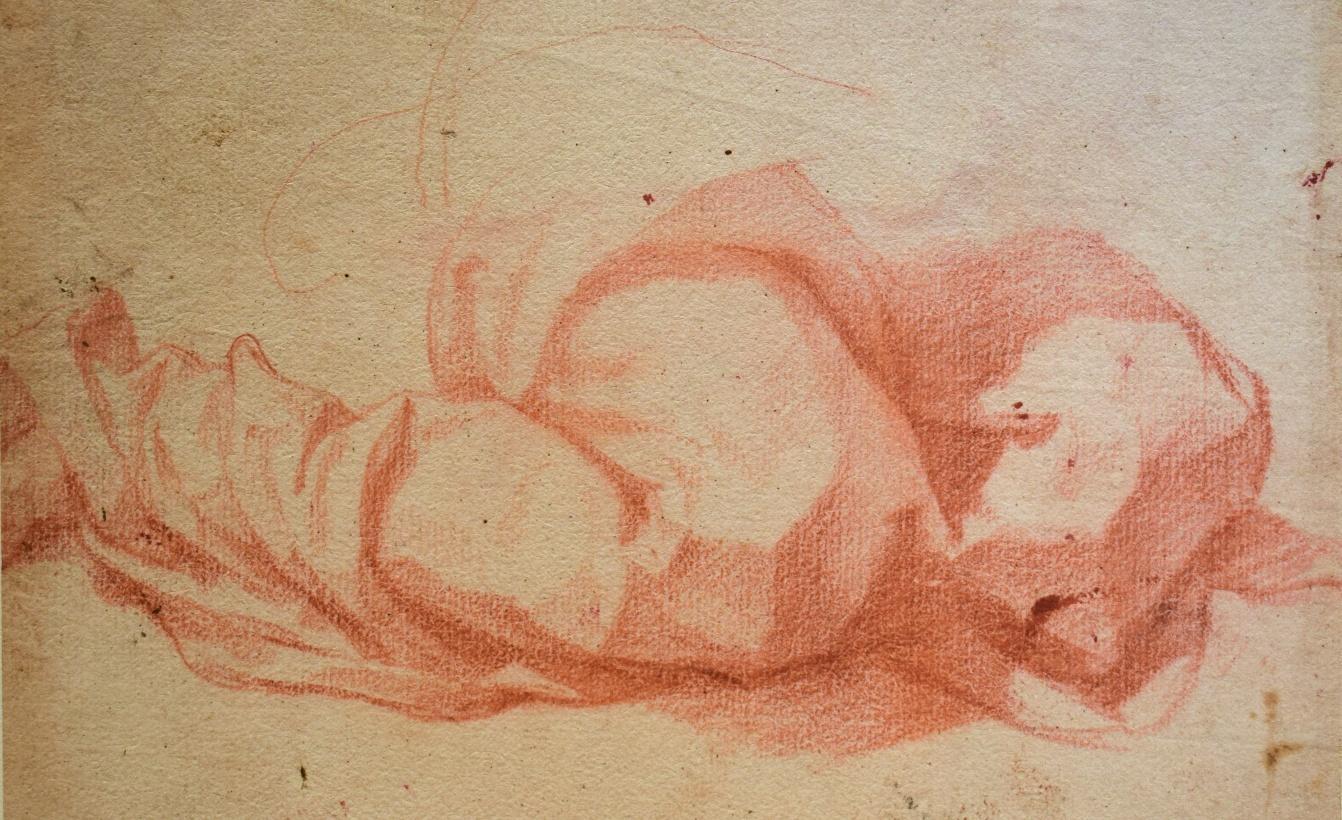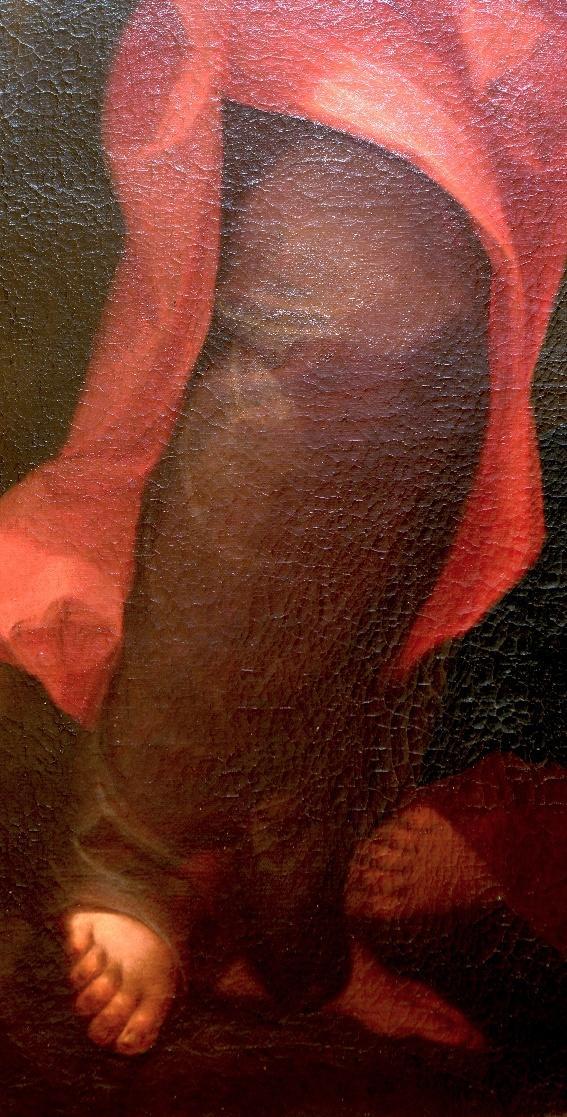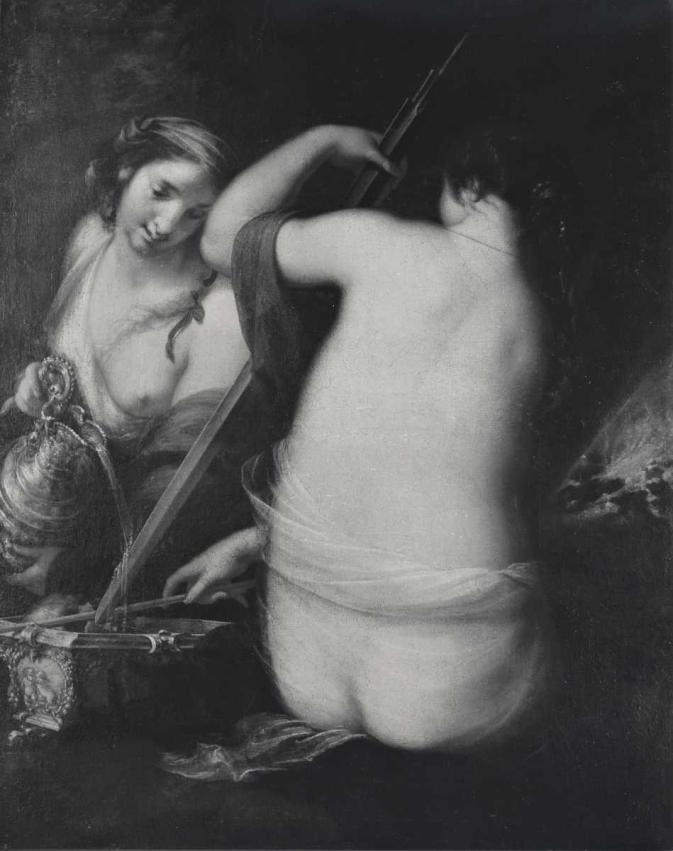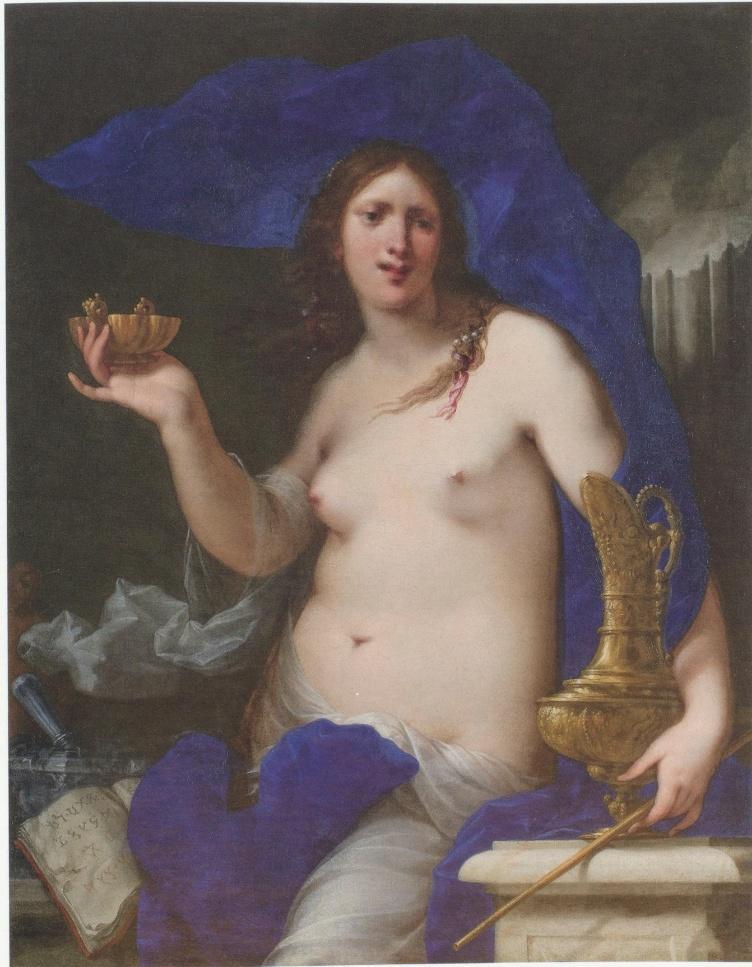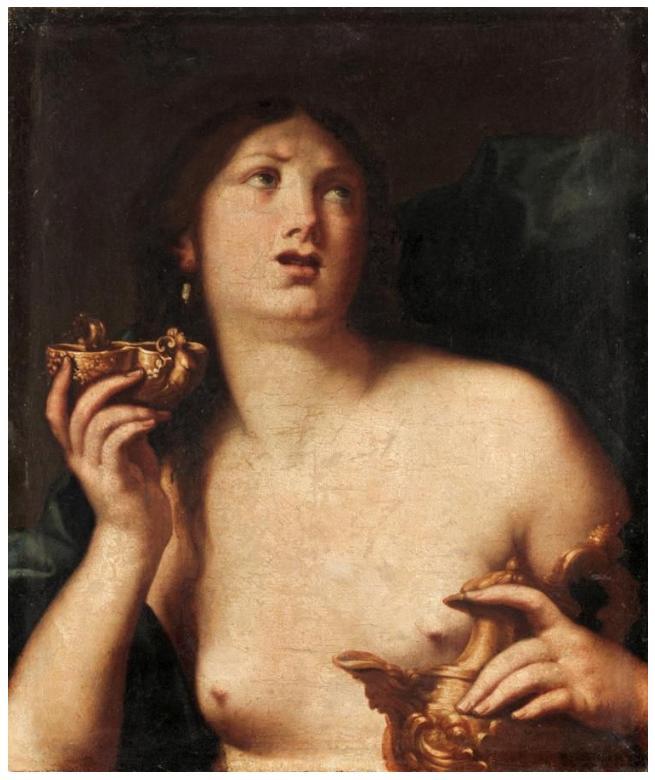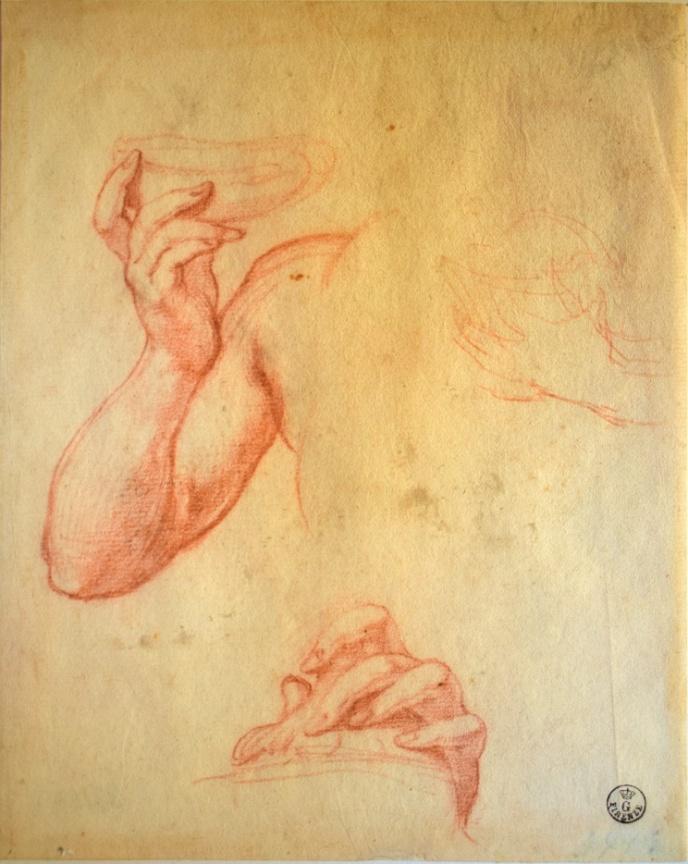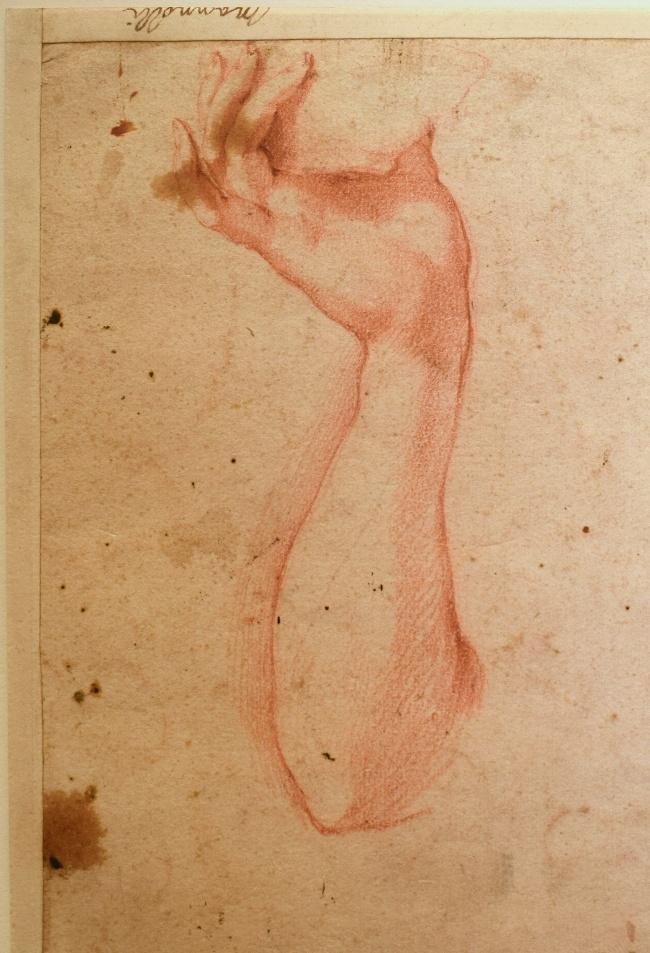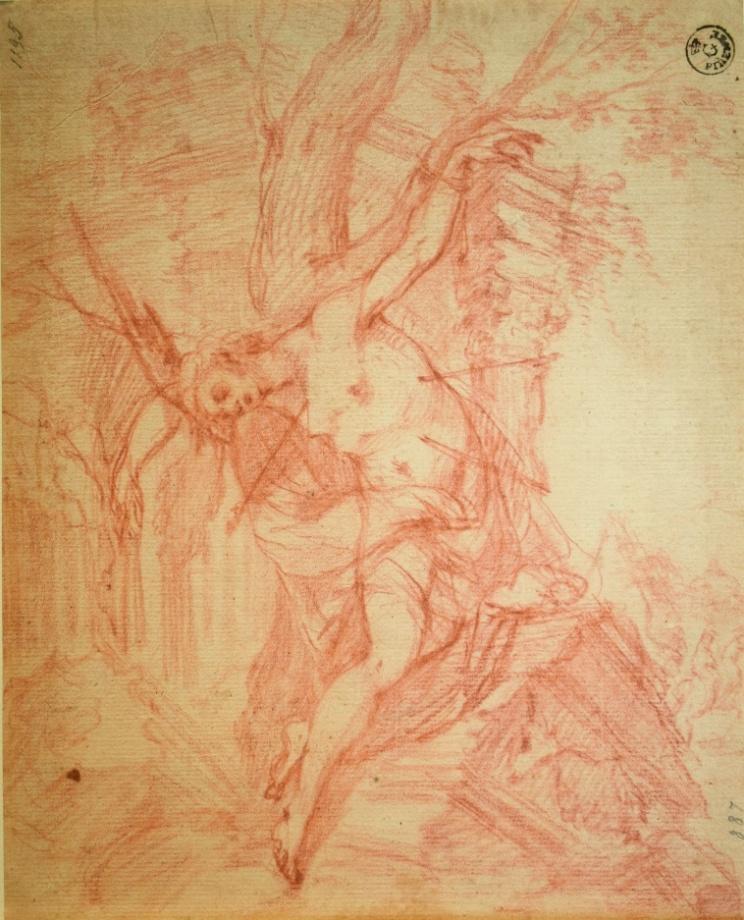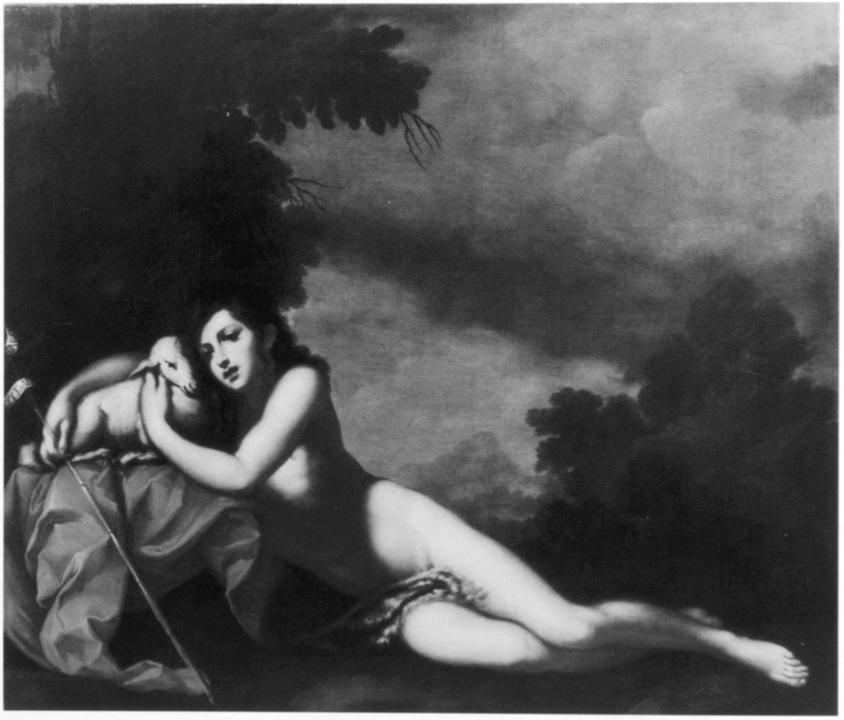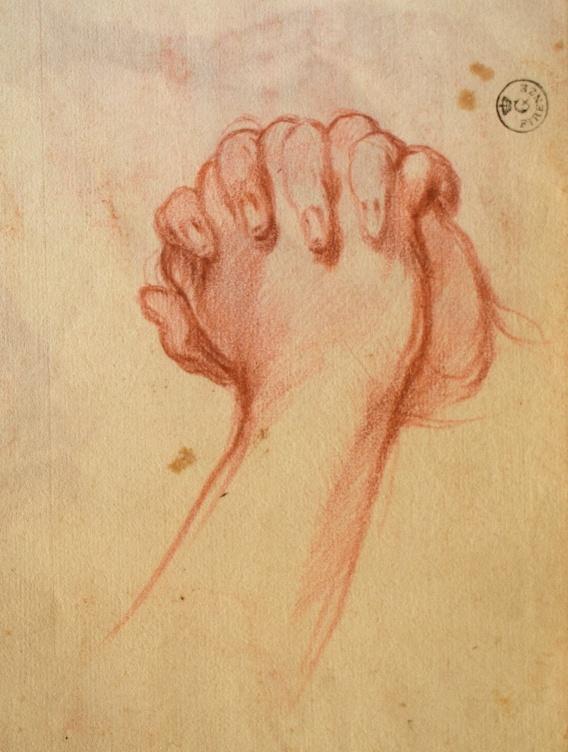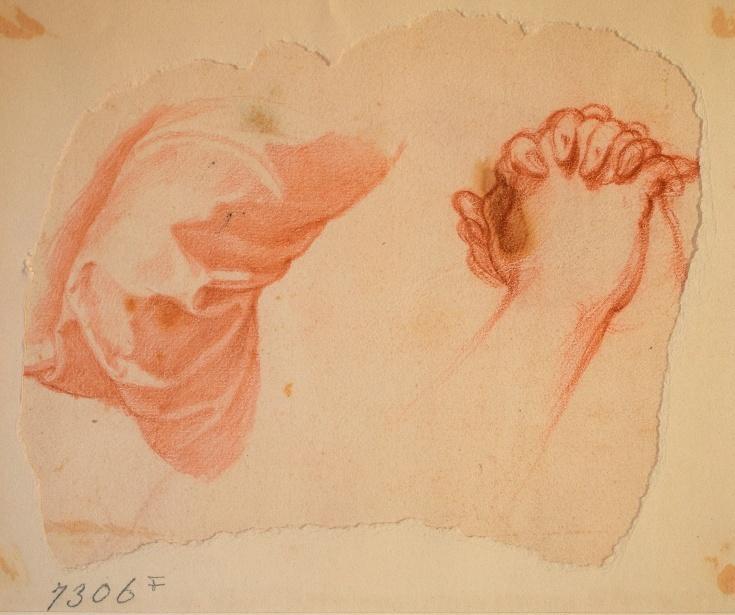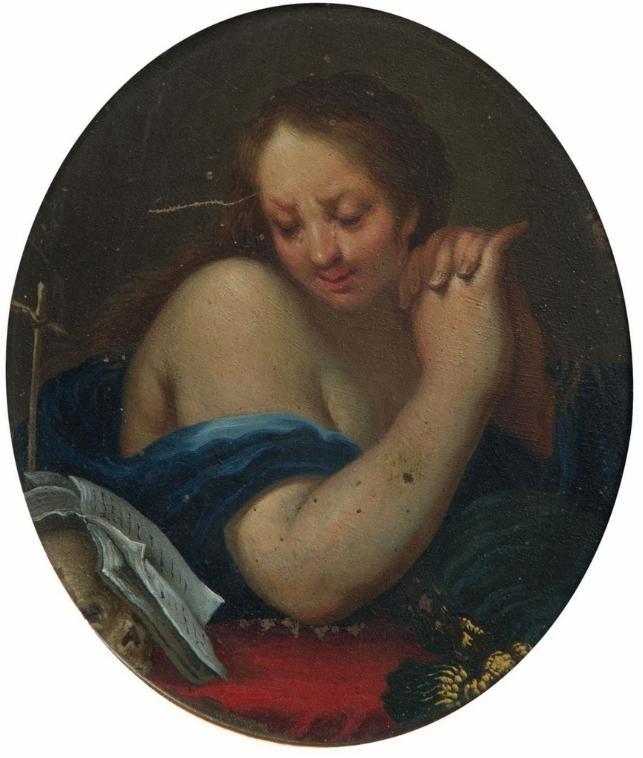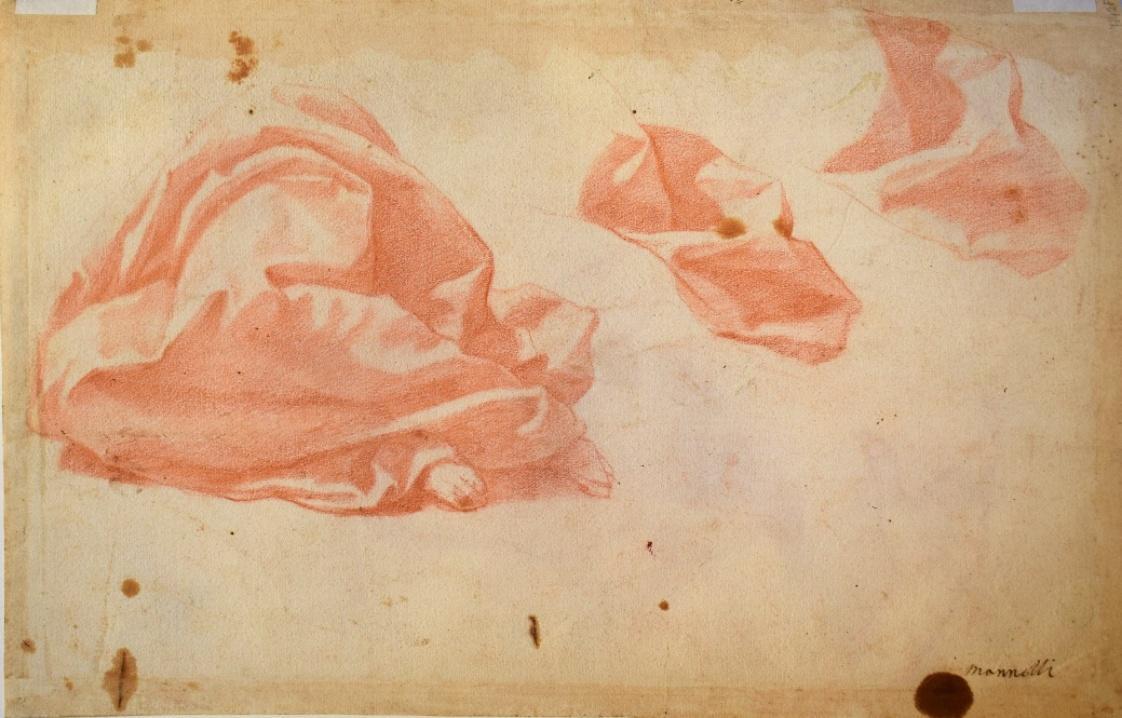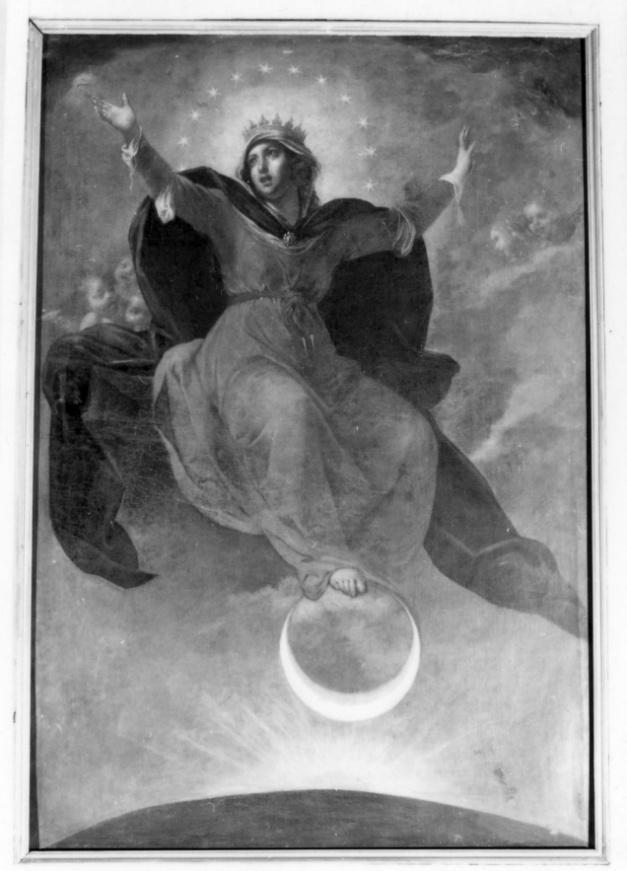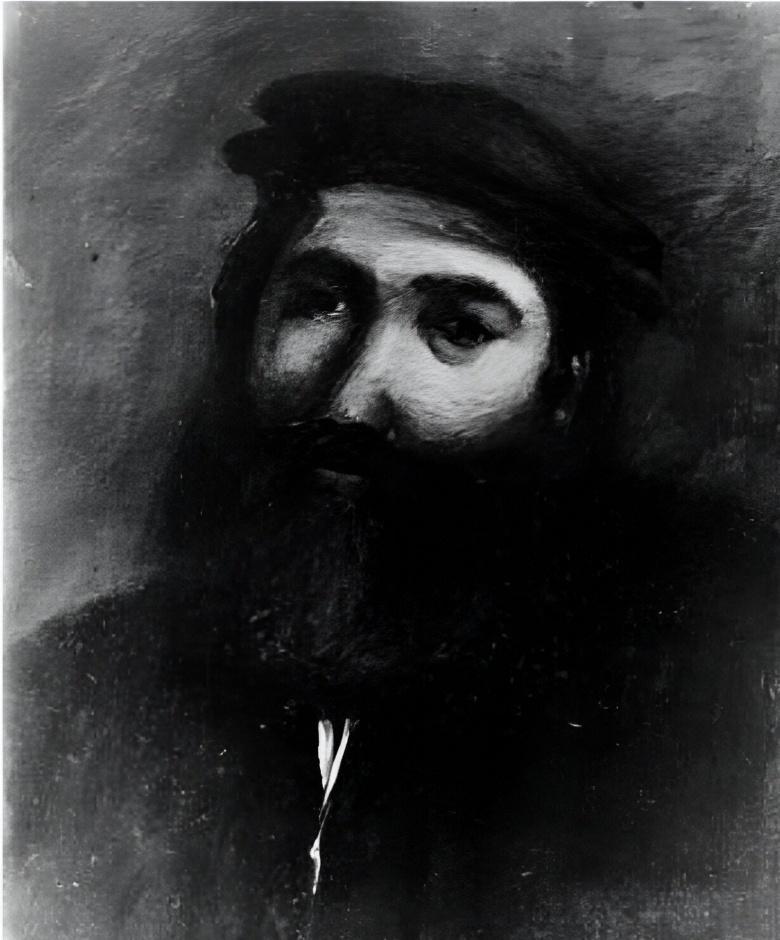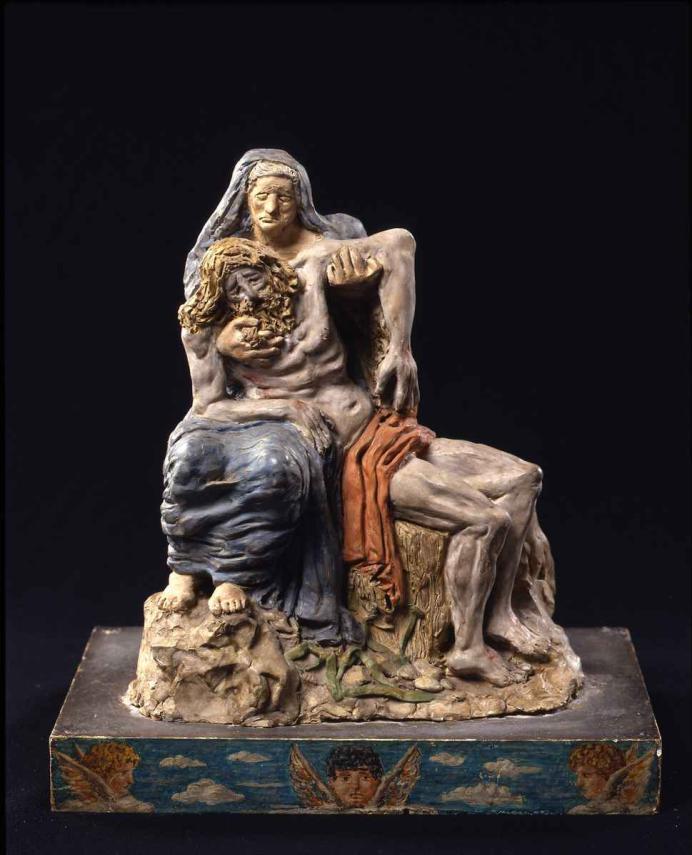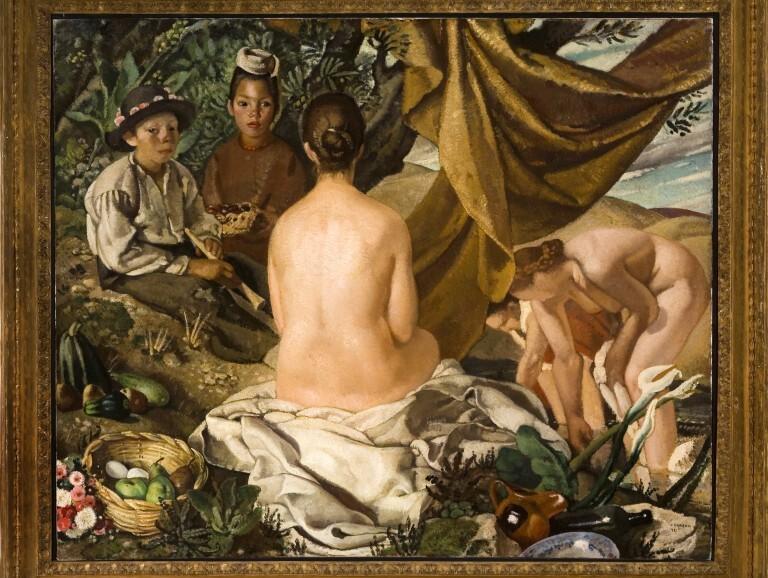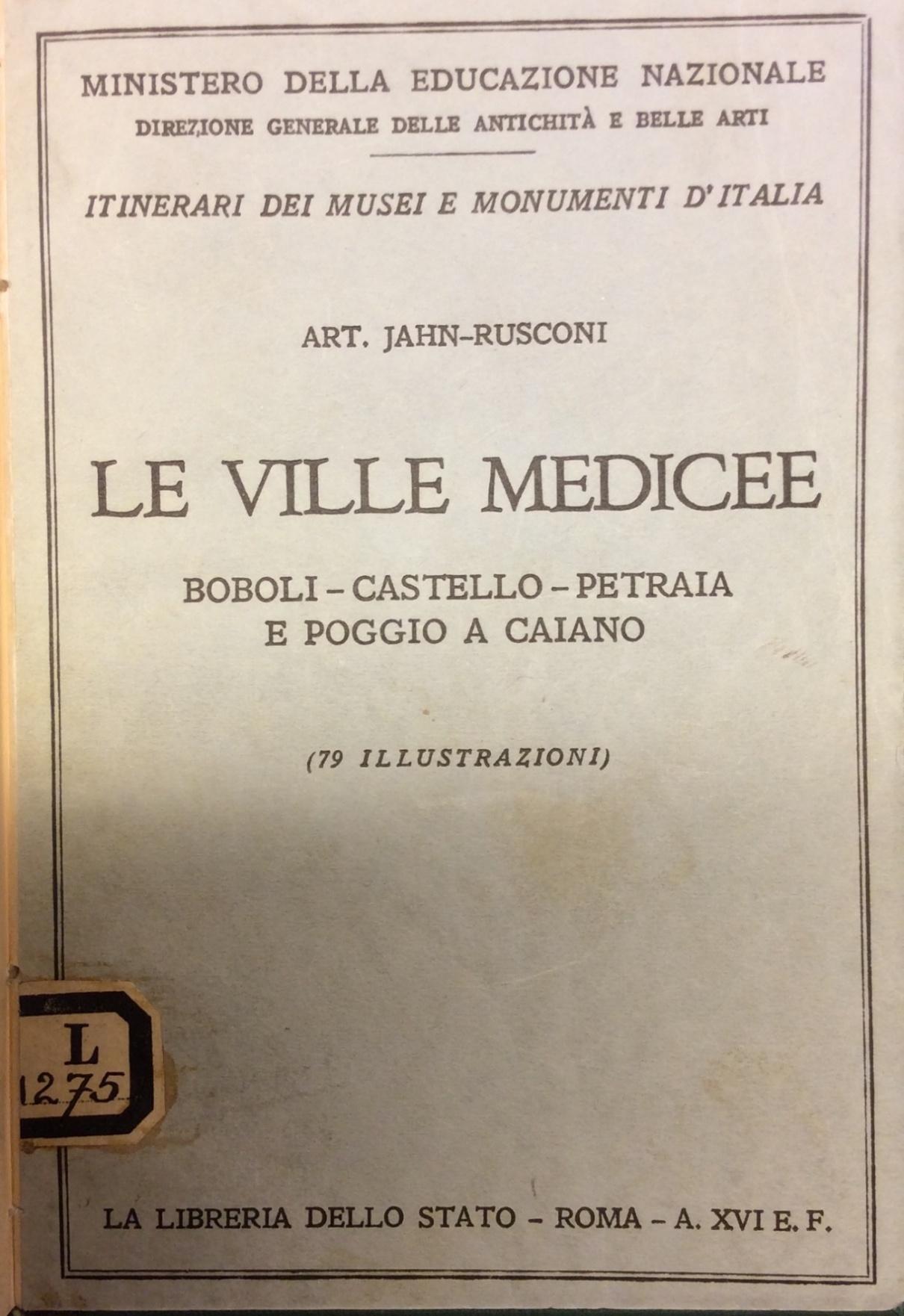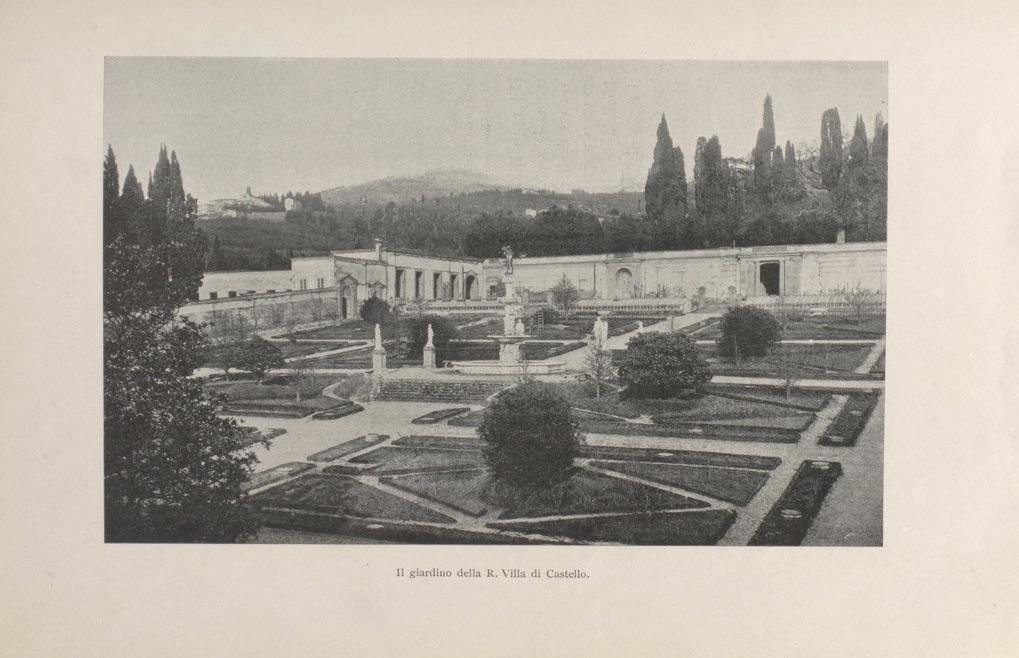INDICE
LUCIO ORIANI
Su Andrea Matteo III Acquaviva duca d’Atri e Cristoforo Majorana miniatore
FABIO GAFFO
Tra mobili e immobili: la Madonna Pazzi e altre opere di famiglia
ELEONORA ONGHI
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
PASQUALE FOCARILE
Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli
ALESSANDRO GRASSI
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
ALICE OTTAZZI
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
WILLIAM CORTES CASARRUBIOS
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
MARCO MOZZO
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
CAMILLA PARISI
Breve argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi
pp. 1-25
pp. 26-58
pp. 59-91
pp. 92-109
pp. 110-158
pp. 159-170
pp. 171-191
pp. 192-209
pp. 210-226
SU ANDREA MATTEO III ACQUAVIVA DUCA D’ATRI
E CRISTOFORO MAJORANA MINIATORE
Questo articolo si propone di rendere noti alcuni manoscritti commissionati da Andrea Matteo III Acquaviva, duca d’Atri e conte di Conversano1 , e miniati da Cristoforo Majorana, uno dei più prolifici artisti del libro attivi a Napoli nell’Età aragonese e poco oltre2. Tale contributo apporta, quindi, una piccola aggiunta alla Biblioteca Acquaviva, la cui ricostruzione è tuttora in corso a opera di Teresa D’Urso3, ma approfondisce, al contempo, i rapporti tra il grande feudatario abruzzese e il miniatore partenopeo, già messi a fuoco dalla studiosa e pienamente confermati dai materiali che in questa sede vengono presentati4. In particolare, questo scritto si concentra su tre codici, ornati tutti da una splendida decorazione, sebbene di qualità diversa a seconda dei singoli casi: di tali volumi, due sono già noti alla critica, ma, per una serie di ragioni, non sono stati finora concordemente collegati ad Andrea Matteo III, mentre l’altro risulta a oggi quasi del tutto sconosciuto. Nelle pagine che seguono, questi libri saranno analizzati soprattutto da una prospettiva storico-artistica, per essere poi considerati nel quadro dei rapporti tra l’Acquaviva e Majorana e, infine, in quello più ampio della Biblioteca Acquaviva. Si può avviare la trattazione sollevando una questione di metodo che va affrontata in via preliminare. Infatti, la ricostruzione della collezione libraria di Andrea Matteo III, dispersa – per quanto al giorno d’oggi è possibile saperne – senza essere inventariata qualche tempo dopo la morte del suo proprietario (19 gennaio 1529)5, è in buona parte affidata al riconoscimento degli stemmi di frequente dipinti nei volumi, sebbene di grande aiuto siano talvolta pure altri elementi: si pensi, per esempio, alle annotazioni lasciate nei margini delle carte dal condottiero in persona, sulle quali si tornerà alla fine di queste pagine. Sulla base degli studi precedenti6, è noto che Andrea Matteo III impiegò, se si prescinde da quelli in cui sono inclusi anche i colori della prima moglie Isabella Piccolomini, almeno due diversi stemmi, in ogni caso sormontati, in linea di principio, da una corona costituita da un cerchio d’oro gemmato Quanto al primo, e cioè il ‘tipo Acquaviva’, esso coincide con il blasone della famiglia Acquaviva, che è d’oro al leone azzurro lampassato di rosso; quanto al secondo, e cioè il ‘tipo Acquaviva d’Aragona’, esso è inquartato e presenta i colori della nobile casata nel secondo e nel terzo e quelli degli Aragonesi di Napoli nel primo e nel quarto, i quali sono a loro volta bipartiti o, più frequentemente, inquartati: nel primo, o nel primo e nel quarto, d’oro a quattro pali di rosso, e nel secondo, o nel secondo e nel terzo, interzato a otto fasce d’argento e rosso, d’azzurro disseminato di gigli d’oro e d’argento alla croce potenziata d’oro e accantonata da quattro crocette d’oro (non è comunque raro osservare per i colori aragonesi, qualora inquartati, una disposizione inversa)7. Un punto fermo è che Andrea Matteo III poté impiegare lo stemma del secondo tipo solo dopo il 30 aprile 1479, data della concessione da parte del re Ferrante I d’Aragona a suo padre Giulio Antonio del privilegio di aggiungere al proprio cognome quello della dinastia regnante8, mentre è ancora poco chiaro se dietro l’utilizzo da parte sua ora dell’uno e ora dell’altro vi fu o no una logica.
Ringrazio Francesco Caglioti per i preziosi consigli forniti durante la stesura di questo contributo.
1 Sull’Acquaviva si veda ACQUAVIVA D’ARAGONA 1960
2 Su Majorana si vedano TOSCANO 2004 e SAPIENZA 2006, ma anche D’URSO 2014
3 D’URSO 2020
4 Ivi, pp. 221-224. Si vedano, inoltre, D’URSO 2021 e 2023b.
5 DE MARINIS 1956, p. 4. La biblioteca fu venduta probabilmente all’epoca di Giovan Girolamo I Acquaviva (15211592) (cfr. BIANCA 1985, p. 161). Su questa scelta dové avere un peso non indifferente la drammatica situazione in cui le finanze della famiglia versavano (cfr. SODANO 2012, pp. 140-141)
6 HERMANN 1898. Cfr. anche D’URSO 2023a.
7 Si vedano gli stemmi della famiglia Acquaviva d’Aragona descritti nel sito www.nobili-napoletani.it <15 aprile 2025>.
8 DE MARINIS 1956, p. 3
Ciò è in realtà possibile, poiché in un celebre volume proveniente dalla sua biblioteca, vale a dire nel manoscritto Latino 10764 della Bibliothèque nationale de France di Parigi, contenente la Geographia di Tolomeo nella traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia e risalente al 1490, con miniature di Majorana e di un anonimo artista di cultura veneto-romana9, si osserva distintamente la sostituzione degli stemmi del secondo tipo con quelli del primo in corrispondenza, per esempio, del Mappamondo (cc. 234v-235r). Non è però questa la sede per dilungarsi in interpretazioni che, in mancanza di un’analisi sistematica dei libri appartenuti a tale personaggio, potrebbero portare a conclusioni infondate, ed è, al contrario, opportuno spostare l’attenzione sui codici oggetto del presente contributo.
Si può senz’altro cominciare da un manoscritto contenente il De fortitudine di Giovanni Pontano oggi di ubicazione ignota, transitato l’ultima volta per il mercato antiquario ormai quarant’anni or sono (1985)10. Il committente di questo codice può essere, infatti, agevolmente identificato, perché, stando alle immagini disponibili, il volume presenta tuttora nel margine inferiore della pagina d’incipit lo stemma del ‘tipo Acquaviva d’Aragona’ (c. 1r; Fig. 1). Tale blasone è certamente da assegnare, come precisato già da Tammaro De Marinis11 e ribadito poi da Concetta Bianca12 e più di recente da chi scrive13, ad Andrea Matteo III e non, come si è invece talvolta creduto a partire da un vecchio catalogo d’asta14, ad Alfonso d’Aragona duca di Calabria, che, come a breve si vedrà, si servì di uno stemma differente ed è solo il dedicatario del trattato pontaniano15, composto – vale la pena di ricordarlo – nel 1481 circa16. In questa sede è interessante considerare tale codice soprattutto perché esso si configura, a uno sguardo complessivo, come un prodotto di lusso, sebbene di livello non eccelso e dalle dimensioni modeste, caratterizzato da una facies che è tipica dei libri ordinati dall’Acquaviva negli ultimi due decenni del XV secolo. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla scrittura umanistica corsiva e dalla decorazione ‘all’antica’ presenti sulle carte del volumetto, le quali, come proposto da Albinia de la Mare, sono rispettivamente opera del copista Clemente Salernitano e del miniatore Cristoforo Majorana17. Tali artefici furono infatti ingaggiati in quegli anni in varie occasioni dal duca d’Atri, diversamente da quanto avvenne in relazione al duca di Calabria, che, allo stato attuale delle conoscenze, non si servì mai del Salernitano e sempre con minore frequenza richiese, dopo i numerosi ordini del 1470-1480 circa, opere a Majorana, e, in ogni caso, quasi mai opere che non fossero di qualità sostenuta18. In effetti, precisando quanto ipotizzato dalla studiosa inglese, la decorazione del manoscritto in esame va ricondotta alla bottega del miniatore partenopeo, dal momento che la pagina incipitaria, ornata da un’iniziale vegetale e da un frontespizio architettonico indubbiamente basati su suoi modelli, risulta caratterizzata da una condotta pittorica poco salda e da una resa a tratti corsiva, aspetti che lasciano supporre, appunto,
9 Sul codice parigino si vedano F. Avril (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 156, in DIX SIÈCLES
D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, p. 177, e J.J.G. Alexander, scheda n. 55, in THE PAINTED PAGE 1994, p. 129.
10 Sul codice si veda WESTERN MANUSCRIPTS AND MINIATURES 1985, lotto 83, pp.n.nn.
11 DE MARINIS 1969, I, p. 80.
12 BIANCA 1985, pp. 170, 172, n 6
13 ORIANI 2024b, p. 140
14 A SELECTION OF PRECIOUS MANUSCRIPTS 1950, lotto 91, pp.n.nn.
15 L’errore è ripreso, da ultimo, in GUERNELLI 2018, p. 305.
16 MONTI SABIA 1962-1963, pp. 243-244, nota 29. Cfr. FIGLIUOLO 2015, p. 737.
17 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.
18 ORIANI 2024a, pp. 85-86, 105-107, 113-117, 139, 160. Per questa stessa ragione si tende a escludere, dal novero dei possibili committenti, Federico d’Aragona, principe di Taranto, il cui stemma coincide con quello dei reali aragonesi, tranne che per una corona costituita da un cerchio d’oro gemmato che egli vi abbinò: in effetti, il principe si rivolse solo occasionalmente all’artista napoletano, perché si indirizzò più che altro, stando a quanto oggi noto, verso opere di area francese. Cfr. D’URSO 2019, pp. 126-127
l’intervento di aiuti nell’ambito di una produzione tendente alla serialità19. Inoltre, l’utilizzo di modelli del genere da parte di autori gravitanti intorno a Majorana suggerisce di collocare il lavoro non prima della metà del nono decennio del Quattrocento, sarebbe a dire poco dopo la loro messa a punto da parte del maestro, operazione che risale, come di qui a breve si dirà meglio, all’incirca al 1480.
Tale codice è fondamentale per introdurre il secondo libro di cui si tratta in queste pagine, e cioè il manoscritto 23145 della Biblioteca Nacional de España di Madrid, contenente gli Epigrammaton libri XII di Marziale20. Quest’ultimo, diversamente dall’altro, presenta però una pagina d’incipit nel cui margine inferiore figura uno stemma ormai quasi del tutto illeggibile (c. 1r; Fig. 2) – circostanza nient’affatto rara a verificarsi nei libri antichi –, con buona probabilità in origine appartenuto, come qui si propone, proprio ad Andrea Matteo III. Infatti, l’esame della carta rivela, nello spazio riservato alle insegne gentilizie, la presenza di elementi tali da consentire di ipotizzare che quello oggi eraso fosse in origine uno stemma del ‘tipo Acquaviva d’Aragona’. È utile ricordare che in un primo momento questa specifica occorrenza del blasone era stata assegnata ad Alfonso duca di Calabria da de la Mare, la quale, descrivendo il codice al tempo in cui era nella collezione del maggiore John Roland Abbey, aveva messo in luce la presenza di elementi compatibili con lo stemma impiegato dal duca21: nel primo e nel quarto d’oro a quattro pali di rosso e nel secondo e nel terzo d’argento alla croce potenziata di nero (anche se non è raro osservare nei libri contrassegnati da questo stemma una disposizione inversa dei colori), con al di sopra una corona costituita da un cerchio d’oro gemmato22. L’attenzione della studiosa inglese si era a ragione appuntata sui piccoli lacerti dorati e rossi in posizione mediana all’interno dello scudo e sul profilo superiore curvilineo dello scudo stesso, elementi che hanno indotto anche chi scrive a riprendere in prima battuta l’idea di connettere il volume all’Aragonese23 . Tuttavia, una più attenta osservazione di tali tracce conduce a ipotizzare che il codice sia piuttosto da dirottare, per l’appunto, verso il duca d’Atri, poiché i residui dei pali di rosso sul lato sinistro dello scudo appaiono così ravvicinati da far pensare a un blasone doppiamente inquartato, quale fu, in effetti, quello da lui utilizzato. Pur volendo prescindere da questi elementi, a parlare a favore di Andrea Matteo III è una valutazione complessiva del codice in questione, che rientra, alla pari di quello discusso di sopra, nella tipologia del libro di lusso di piccolo formato D’altra parte, anch’esso fu esemplato e miniato rispettivamente dal Salernitano e da Majorana, come suggerito di nuovo da de la Mare, cui si deve pure la datazione del volumetto al 1480-1490 circa24. La proposta di assegnare questo manoscritto all’Acquaviva si fonda, allora, soprattutto sul fatto che esso è, in buona sostanza, gemello dell’altro. Ciò risulta particolarmente evidente confrontando la decorazione presente nei due codicetti, della stessa tipologia e del medesimo livello qualitativo, poiché anche nel caso in esame l’apparato ornamentale dispiegato nelle carte fu completato – se puntualizziamo l’ipotesi della studiosa inglese – dal miniatore napoletano con l’aiuto di un collaboratore25 Notevole è, per esempio, l’affinità, già rilevata ancora una volta da de la Mare, tra le iniziali vegetali presenti nelle pagine incipitarie dei due manoscritti, eseguite in capitale epigrafica e poste entro una cornice modanata e contro un fondo colorato nel quale trovano spazio dei semplici motivi vegetali (al contrario, diverse, ma trascurabili perché alquanto generiche, sono le altre iniziali sparse nei volumi, nel primo caso ornate da semplici motivi bianchi – oggi grigi a causa
19 Lo scarto qualitativo riscontrabile nella produzione artistica dell’autore è stato messo in rilievo, e spiegato ipotizzando l’esistenza di una bottega posta sotto la sua direzione, già in PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988, p. 1122.
20 Sul codice si veda ORIANI 2021, pp. 182-184, scheda n. 22
21 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.
22 Per una descrizione dello stemma ducale aragonese si veda ORIANI 2024a, p. 638.
23 ORIANI 2021, pp. 182-184, scheda n. 22.
24 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.
25 ORIANI 2021, pp. 182-184, scheda n. 22
dell’ossidazione della biacca – su fondo blu, rosso e verde, e nel secondo caso a bianchi girari)26 . Molto simili risultano, inoltre, i frontespizi architettonici posti alle stesse due carte, e improntati a una concezione assolutamente identica: entrambi sono infatti caratterizzati da una struttura formata da più livelli sovrapposti e arricchita da elementi dal sapore antiquario; tutti e due presentano una pagina illusionistica, recante il testo e l’iniziale ornata, affissa alla cornice della costruzione; entrambi sono abitati da putti impegnati a sostenere tabelle ed elementi araldici; tutti e due sono disposti su un piano erboso con un cielo azzurro sullo sfondo.
È importante ricordare che tali frontespizi rientrano, come accennato, in una tipologia decorativa tipica di Majorana, che fin dalla metà degli anni Settanta si andò misurando, insieme ad altri artisti napoletani, con la miniatura ‘all’antica’, nata a Padova negli anni CinquantaSessanta del XV secolo in seguito alla svolta antiquaria impressa alla pittura da Andrea Mantegna e diffusasi di lì a poco a Roma principalmente per tramite di Bartolomeo Sanvito e Gaspare da Padova27. Come osservato da Gennaro Toscano, Majorana si accostò al nuovo linguaggio artistico soprattutto attraverso i prototipi veneto-romani presenti nelle raccolte aragonesi – tra i quali spicca il manoscritto 836 della Biblioteca Històrica de la Universitat de València, contenente il De bello Iudaico di Flavio Giuseppe, miniato da Gaspare verso il 1470-1475 per Alfonso duca di Calabria28 – e giunse ben presto a padroneggiare pienamente il repertorio ornamentale da essi esibito29 – come provato dai suoi interventi (ispirati alle miniature del suddetto codice valenciano) nel manoscritto 153 del Fitzwilliam Museum di Cambridge, un libro d’ore ordinato da Filippo di Matteo Strozzi nel 147830, e in quello segnato 52 di nuovo dell’ateneo spagnolo, copia del De principe e De obœdientia di Giovanni Pontano richiesta da Alfonso nel 1475-148031 . Così, a partire grosso modo dal 1480, egli, accantonando gradualmente i racemi di derivazione tardogotica e i bianchi girari di stampo umanistico con cui aveva esordito all’incirca un decennio prima, utilizzò con crescente frequenza e in una varietà di modi il nuovo vocabolario ‘all’antica’32. Ciò gli assicurò senza dubbio una posizione di spicco negli ambienti dei bibliofili partenopei, perché il nuovo linguaggio di ispirazione antiquaria, ritenuto adatto a conferire ai volumi un’aria in linea con le opere degli autori della Classicità e dell’Umanesimo in essi solitamente contenute, fu molto richiesto dai committenti più facoltosi e raffinati dell’epoca. Fra coloro che più di frequente si rivolsero all’artista per far decorare i propri libri in questo stile così ricercato e ricco di implicazioni figurano, com ’è prevedibile, molti dei componenti della famiglia aragonese, a cominciare dal re Ferrante I, cui appartenne, per esempio, il manoscritto 758 dell’Universitat de València, contenente la Vita e le Favole di Esopo nella versione volgare di Giovanni Brancati e risalente al 148133, e da Alfonso duca di Calabria, proprietario, tra gli altri, dell’appena citato manoscritto 52 dell’istituto spagnolo.
Questo linguaggio godé, inoltre, di un’ampia fortuna presso tutta una serie di personaggi dell’entourage aragonese, i quali in non pochi casi seguirono intenzionalmente gli orientamenti estetici e imitarono le scelte artistiche dei regnanti. Fra costoro rientra a pieno titolo Andrea Matteo III, che, come anticipato, tra gli anni Ottanta e Novanta del Quattrocento si rivolse a Majorana per la decorazione non solo dei due codicetti trattati di sopra, ma anche di molti altri suoi libri. Tra questi ultimi si possono per esempio citare il Barb. lat. 154 della Biblioteca Apostolica Vaticana di Città del Vaticano, contenente il De rerum natura di Lucrezio e risalente
26 A.C. de la Mare, scheda n. 31, in ALEXANDER–DE LA MARE 1969, pp. 84-85.
27 IACOBINI–TOSCANO 2010, pp. 127-131, e TOSCANO 2024a, pp. 74-79.
28 Sul codice valenciano si veda ORIANI 2024a, pp. 503-507, scheda n. 74
29 TOSCANO 2007a, pp. 246-248. Cfr. anche GUERNELLI 2022, pp. 120-122.
30 Sul codice inglese si veda S. Panayotova, scheda n. 100, in THE CAMBRIDGE ILLUMINATIONS 2005, pp. 222-223.
31 Sul codice valenciano si veda ORIANI 2024a, pp. 405-409, scheda n. 51
32 TOSCANO 2007a, pp. 245-246.
33 Sul codice valenciano si veda M.C. Cabeza Sánchez-Albornoz, G. Toscano, scheda n. 31, in LA BIBLIOTECA
REALE DI NAPOLI 1998, pp. 586-587.
al 1485 circa34, la cui pagina d’incipit è ornata da un’iniziale istoriata con Venere e Marte e un frontespizio architettonico del tutto analogo a quelli presenti nei due volumi poc’anzi discussi (c. 1r), e il 6B delle Universitaire Bibliotheken di Leida, contenente l’Opera di Virgilio e risalente al 1485-149035, la cui prima pagina d’incipit è ornata da un’iniziale prismatica e un frontespizio architettonico che, aperto su un paesaggio con Titiro e Melibeo e posto in un ambiente naturale con Virgilio incoronato dalle Muse, dal punto di vista strutturale è leggermente più complesso rispetto agli altri due (c. 2r; Fig. 3). Si può altresì ricordare – anche perché esso è esemplato, alla pari dei due presentati nelle pagine precedenti, dal Salernitano – il 45 della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna, contenente l’Ab Urbe condita (Decas III) di Tito Livio e risalente al 1490 circa36, nella cui pagina d’incipit figurano invece un’iniziale istoriata con Annibale che, con il padre Amilcare, giura odio ai Romani e un ampio paesaggio archeologico (c. 1r). Questo terzo esempio è significativo soprattutto perché dimostra la ricettività del miniatore napoletano verso modelli artistici afferenti ancora una volta al filone della miniatura ‘all’antica’, ma più avanzati di quelli richiamati poco fa. Infatti, il paesaggio, che può essere senz’altro inteso come uno sviluppo dei semplici piani ricoperti di prato tipicamente impiegati per dare un contesto ai frontespizi architettonici, suggerisce, in virtù del rilievo assunto dalla natura e dell’inserimento, accanto a rocce e vegetazione, di rovine antiche, un accostamento alle vedute archeologiche messe a punto da Mantegna, artista che incontrò una fortuna notevole a Napoli in quella congiuntura37. È noto, d’altra parte, che Majorana si avvicinò molto alla lezione del pittore padovano, come dimostrano, a titolo di esempio, la Geografia e il Tolomeo da lui realizzati nel manoscritto Latino 10764 citato in apertura di questo scritto (cc. 1v-2r; Figg. 4-5), le cui figure sono viste di sotto in su e costruite mediante una linea decisa e a tratti dura, che conferisce loro una spiccata monumentalità38; inoltre, egli conobbe certamente le incisioni del grande maestro, con buona probabilità attraverso l’anonimo miniatore con cui si trovò a collaborare proprio in occasione dell’allestimento del codice parigino39 .
In questo particolare clima artistico si può collocare anche il terzo codice oggetto del presente contributo, e cioè il manoscritto Barb. lat. 127 della Biblioteca Apostolica Vaticana, contenente le Naturales quæstiones di Seneca40. Questo volume merita un’attenzione particolare, perché, sebbene ricondotto ormai già da qualche tempo alla committenza dell’Acquaviva41, è passato pressoché inosservato agli studiosi, essendo stato citato unicamente da D’Urso in una nota di un recente contributo42. Tale scarsa notorietà è, in realtà, sorprendente, perché il codice è un prodotto di lusso assai notevole, di livello ben superiore a quello dei due volumetti trattati di sopra, i quali sono invece caratterizzati, come detto, da una certa corsività. Lo dimostra, al di
34 Sul codice vaticano si veda LES MANUSCRITS CLASSIQUES LATINS 1975, pp. 187-188. L’attribuzione delle miniature è avanzata da A Putaturo Murano, scheda n. 30, in CODICI MINIATI 1995, pp 96-101
35 Sul codice leidense si veda H. Timmer (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 3, in CASSEE 1985, p. 159.
36 Sul codice viennese si veda HERMANN 1933, pp. 68-71, scheda n. 36. L’attribuzione delle miniature è avanzata da DE MARINIS 1947-1952, I (1952), p. 153, n 18
37 TOSCANO 2008, pp. 79-85.
38 D’URSO 2007, pp. 127-133.
39 Questo anonimo miniatore riprese l’incisione con la Zuffa degli dèi marini di Mantegna nell’allegorico Ratto di Europa che nel manoscritto francese in questione precede le dieci carte geografiche del continente europeo (cc. 236v-237r). Cfr. F. Avril, scheda n. 156, in DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, p. 177. Sulla stampa si veda L. Aldovini, scheda n. III.17A-B, in ANDREA MANTEGNA 2019, pp. 172-173. In maniera analoga, Majorana riprese l’incisione con la Deposizione nel sepolcro anch’essa di Mantegna nella scena con lo stesso soggetto che apre l’Officium Passionis Iesu Christi nel manoscritto I.B.26 della Biblioteca Nazionale di Napoli (c. 155r), un libro d’ore confezionato per Pascasio Diaz Garlon, conte di Alife, nel 1490 circa (cfr. D’URSO 2007, pp. 133-137). Sulla stampa si veda L. Aldovini, scheda n. V.9, in ANDREA MANTEGNA 2019, pp. 233-234. Sul codice napoletano si veda F. Cacciapuoti, scheda n. 28, in LIBRI A CORTE 1997, pp. 126-128.
40 Sul codice si veda LES MANUSCRITS CLASSIQUES LATINS 1975, p. 160.
41 MARUCCHI 1964, pp. 33-34.
42 D’URSO 2023a, p. 79, nota 17
là della scrittura, che è un’ariosa ed elegante antiqua di mano di un copista non ancora identificato (responsabile anche di integrazioni e lezioni alternative marginali), soprattutto la decorazione, imperniata, se tralasciamo le iniziali ornate sparse nel volume, su una pagina incipitaria con un’iniziale figurata e una cornice riempita da motivi antiquari e vegetali (c. 1r; Fig. 6). Il testo, privo di rubriche, si apre, infatti, con una bellissima iniziale, la cui la lettera (Q), costituita da un festone vegetale e contenente nell’occhiello un altarolo e una lira, è posta in un riquadro dal fondo blu e rosso con puntini dorati. Tutt’intorno corre, poi, la cornice, delimitata a sua volta da sottili modanature e riempita nei margini laterali da candelabre – formate da bracieri, cornucopie, strumenti musicali, quali lire e flauti di Pan, e vasi di vario tipo –, nel margine superiore da motivi vegetali e in quello inferiore da altri motivi vegetali, con al centro un piccolo gioiello e ai lati due grandi tondi contenenti ciascuno uno stemma del ‘tipo Acquaviva d’Aragona’. Nel complesso, la pagina è caratterizzata da uno spiccato gusto da orafo, evidente tanto nella prevalenza dell’oro, che domina a livello cromatico e risalta specialmente contro il fondo rosso con piccoli inserti blu e verdi e puntini anch’essi dorati, quanto nell’aspetto quasi metallico, ottenuto mediante raffinate lumeggiature gialle, che distingue i vari elementi, quelli vegetali inclusi. L’opera può essere ascritta con sicurezza a Majorana e datata al 1490-1500 circa, dal momento che si riscontrano somiglianze notevoli, a livello generale e di singoli dettagli, con altre opere da lui realizzate in quel periodo e per l’Acquaviva in persona. Tra queste ultime si possono ricordare almeno la pagina d’incipit del manoscritto C.F.3.7 della Biblioteca dei Girolamini di Napoli (c. 2r; Fig. 7), che contiene l’Opera di Apuleio43, e quella del manoscritto
C.F.3.4 della stessa biblioteca napoletana (c. 5r; Fig. 8), che contiene invece l’In Aristotelis Physica paraphrasis di Temistio nella traduzione latina e con il Commentarium di Ermolao Barbaro il Giovane44 . Pur non essendo caratterizzata né da un frontespizio architettonico né da un paesaggio archeologico, questa realizzazione rientra anch’essa nel genere della miniatura ‘all’antica’, perché la cornice vegetale è arricchita, come si è visto, in senso antiquario e preziosistico, secondo una formula che rivela l’aggiornamento di Majorana su altri modelli. Questi ultimi possono essere identificati, come intuito da Antonella Putaturo Murano in relazione al suddetto manoscritto C.F.3.4 dei Girolamini45, con le opere di Giovanni Todeschino46, artista bergamasco di formazione veneta attivo nella città partenopea, al servizio degli Aragonesi, dal 1487 circa in avanti47. Fra i lavori di Todeschino probabilmente più influenti per Majorana, che per giunta in qualche occasione si trovò a collaborare direttamente con il collega settentrionale48, si può per esempio ricordare il manoscritto Latino 8016 della Bibliothèque nationale de France, contenente i Metamorphoseon libri XV di Ovidio, richiesto dal cardinale Giovanni d’Aragona nel 1485 circa49 , la cui pagina d’incipit presenta una cornice vegetale che per carattere e impostazione è assai vicina
43 Sul codice napoletano si vedano A. Putaturo Murano (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 31, in CODICI MINIATI 1995, pp. 101-104, e L. Oriani, scheda n. 47, in BIBLIOTECA ORATORIANA 2025.
44 Sul codice napoletano si vedano A. Putaturo Murano (cui risale l’attribuzione delle miniature), scheda n. 30, in CODICI MINIATI 1995, pp. 96-101, e M. Illiano, E. Perna, scheda n. 46, in BIBLIOTECA ORATORIANA 2025.
45 A. Putaturo Murano, scheda n. 30, in CODICI MINIATI 1995, pp. 96-101
46 Sul miniatore si vedano UGUCCIONI 2001 e D’URSO 2004, ma soprattutto D’URSO 2007
47 Ivi, pp. 147-148.
48 A oggi si conoscono due codici che dimostrano la collaborazione tra questi artisti. Il primo è il manoscritto M.1052 della Pierpont Morgan Library di New York, un libro d’ore realizzato per un ignoto personaggio nel 1483. Su di esso si vedano G.T. Clark, scheda n. 54, in ITALIAN MANUSCRIPT PAINTING 1984, pp.n.nn., e, per la decorazione – completata con il concorso di Nardo Rapicano –, TOSCANO 2007b, p. 355. Il secondo è il manoscritto Latino 2231(1-3) della Bibliothèque nationale de France, una copia dei Moralia in Iob di Gregorio Magno confezionata per il cardinale Giovanni d’Aragona nel 1485. Su di esso si vedano F. Avril, scheda n. 146, in DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, pp. 166-167, HAFFNER 1997, pp. 302-307, scheda n. 28, e, per la decorazione – iniziata da Gaspare da Padova –, D’URSO 2007, pp. 109-112.
49 Sul codice parigino si vedano F. Avril, scheda n. 147, in DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984, pp. 167168, HAFFNER 1997, pp. 231-236, scheda n. 14, e, per la decorazione, D’URSO 2007, pp. 96-99.
a quella in questione (c. 1r), sebbene più abbondante di dettagli antiquari (si osservino soprattutto i tondi con Profili di imperatori romani) e superiore per ricercatezza formale (si notino, in particolare, la rifinitura delle foglie di acanto e il fondo reso a tratteggio). Insistere su quest’altra componente del linguaggio artistico di Majorana è fondamentale non solo per spiegare l’arricchimento delle soluzioni ornamentali da lui proposte nei libri decorati in tale fase, ma anche per comprendere le ragioni della sua fortuna presso l’Acquaviva. Costui fu, infatti, sempre oltremodo attento a dotare la propria biblioteca di libri caratterizzati, oltre che da testi corretti e affidabili, da un pregio materiale notevole e da una decorazione aggiornata sul piano del gusto50, arrivando addirittura in non pochi casi a prendere parte in prima persona all’allestimento dei volumi mediante l’elaborazione dei programmi o la scelta dei modelli iconografici: ne è esempio, di nuovo, il manoscritto C.F.3.4 dei Girolamini, nella cui pagina d’incipit figura un’illustrazione con la personificazione della Natura derivante da quella realizzata da Gaspare da Padova in un perduto codice della Naturalis historia di Plinio il Vecchio destinato al cardinale d’Aragona51. Per questa ragione, il duca d’Atri si rivolse in svariate occasioni a Majorana, che, fra gli artisti attivi nello scriptorium aragonese di Castel Nuovo (considerando a parte Todeschino, titolare, in virtù della sua eccezionale maestria, delle commesse più prestigiose provenienti dai regnanti), fu senza dubbio – come si è appena visto – il più abile nell’aggiornarsi professionalmente, giungendo a mettere a disposizione della committenza un’ampia gamma di soluzioni ornamentali ispirate all’Antico e ad adattarsi con grande versatilità alle varie richieste e sollecitazioni.
In conclusione, i tre manoscritti presentati e ricondotti ad Andrea Matteo III in questo articolo non solo ampliano, portandola a 46 unità materialmente note, la consistenza della biblioteca da lui allestita fra Napoli e i suoi feudi abruzzesi e pugliesi all’incirca tra l’ultimo quarto del XV secolo e il primo quarto del XVI secolo52, ma ne confermano il carattere aristocratico e l’ispirazione umanistica, perché si inseriscono in maniera armoniosa, sul piano della materialità e su quello dei contenuti, in mezzo a tutti gli altri. In primo luogo, tali codici ribadiscono la preferenza accordata dall’Acquaviva ai manoscritti di lusso, di grande e di piccolo formato così come di notevole e di più modesto pregio, andando, in ogni caso, a costituire un’ulteriore e
50 BIANCA 1985, pp. 164, 166, e PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988, p. 1127.
51 D’URSO 2020, pp. 221-222. Tale modello fu inoltre ripreso da Majorana nell’iniziale istoriata nella pagina d’incipit del manoscritto Phil. gr. 2 della Österreichische Nationalbibliothek di Vienna (c. 1r), contenente la Physica e altre opere di Aristotele, realizzato nel 1496 ancora per il duca d’Atri e miniato dal maestro con la collaborazione di un artista di cultura prossima a Reginaldo Pirano (cfr. ivi, pp. 222-223). Sul codice viennese si vedano HERMANN 1933, pp. 60-68, scheda n. 35, e J.J.G. Alexander, scheda n. 53, in THE PAINTED PAGE 1994, p. 126.
52 Ai tre manoscritti discussi in questo contributo ne vanno aggiunti: 35 elencati in D’URSO 2020, pp. 228-229, dove si cita anche un incunabolo (ivi, p. 227); un manoscritto ricordato in IL DE VIRTUTE MORALI 2022, p. 47; quattro ricordati in D’URSO 2023a, p. 79, nota 17, dove si cita similmente pure un incunabolo (ibidem); e un manoscritto reso noto in ORIANI 2024b, p. 134, per un totale di 46 unità. Al contrario, certamente da espungere dai libri di Andrea Matteo III è un codice assegnatogli in DE MARINIS 1956, p. 4, n 2, dove viene ripreso un errore di RICCI 1935-1940, II (1937), p. 2324, n 59, in cui l’autore riteneva del ‘tipo Acquaviva’ lo stemma posto in un volume contenente i Commentaria tria de primo bello Punico di Leonardo Bruni all’epoca nella collezione di Cortland Field Bishop, stemma che è, in realtà, diverso, perché, stando alla descrizione fornita dal bibliografo inglese, è d’azzurro al leone d’oro (e non d’oro al leone azzurro). Da escludere è, inoltre, un codice ricondotto al colto feudatario meridionale ancora in DE MARINIS 1956, p. 4, n 9, e cioè il manoscritto Ashburnham 1041 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, contenente la Corographia di Pomponio Mela, il quale, come da comunicazione scritta dell’istituto (6 giugno 2024), presenta «uno stemma con due leoni rampanti e tre palle» che, diversamente da quanto ritenuto dallo studioso napoletano, non ha nulla a che fare con l’Acquaviva. Similmente, come osservato in ZANATO 2017, p. 46, nota 1 (cfr. SICILIANI 2017, pp. 71-75), va escluso anche il manoscritto King’s 322 della British Library di Londra, contenente un anonimo Canzoniere, collegato al condottiero in WARNER–GILSON 1921, III, p. 58. Dubbia, a causa delle rasure eseguite in corrispondenza degli stemmi nell’apparato decorativo –peraltro già rilevate in PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988, p. 1107, nota 11 –, è, infine, l’appartenenza ad Andrea Matteo III del manoscritto Urb. lat. 1380 della Biblioteca Apostolica Vaticana, contenente il De virtute morali di Plutarco nella traduzione latina realizzata dal duca d’Atri in persona, proposta in DE MARINIS 1956, p. 4, n 7.
significativa testimonianza dell’impegno da lui profuso nella costruzione della sua biblioteca53 . Poiché miniati da Majorana (anche con l’aiuto di collaboratori), essi avvalorano l’ipotesi di una speciale predilezione del duca d’Atri, particolarmente viva fino al 1500 circa, per questo artista54 , che fu coinvolto nella decorazione, tra manoscritti e incunaboli al momento conosciuti, di ben diciotto dei suoi volumi (cfr. APPENDICE). In secondo luogo, questi codici riaffermano l’interesse di Andrea Matteo III tanto per gli scrittori classici, dai poeti, come Marziale, ai filosofi, come Seneca, quanto per gli autori a lui contemporanei, come Pontano, andando così a porsi quali nuove e preziose tessere nel mosaico, dalla vocazione tutta umanistica55, della sua straordinaria collezione, concepita come uno strumento fondamentale per sostenere i suoi studia humanitatis e vista come un attributo determinante per dimostrare il suo prestigio sociale e politico56. In aggiunta, poiché nel caso del codice vaticano il responsabile dei notabilia inseriti a margine in una scrittura ora corsiva e ora al tratto in sanguigna fu proprio l’Acquaviva (cc. 11r, 18r, 21v, 22r, 25r, 26r, 29r, 29v, 30v) – si confronti, per esempio, il notabile a c. 29v con quello a c. 111r del suddetto codice C.F.3.7 dei Girolamini, parte di una serie di annotazioni a lui ricondotta da Bianca57 –, è certo che egli lesse e studiò le Naturales quæstiones senechiane e, in particolare, il libro dedicato ai fulmini e ai tuoni (il secondo dei sette). Se da un lato ciò conferma il profondo interesse dell’Acquaviva per la filosofia naturale, attestato, su tutti, dal manoscritto Phil. gr. 2 della Österreichische Nationalbibliothek, contenente la Physica e altre opere di Aristotele e risalente al 149658, dall’altro rafforza la sua immagine di condottiero umanista, dedito tanto all’esercizio delle armi quanto al culto delle lettere e personalmente convinto, come dichiarato nella prefazione della traduzione del De virtute morali di Plutarco da lui realizzata, della superiorità di queste ultime, autentica e privilegiata fonte di ispirazione per condurre un’esistenza virtuosa59 .
53 BIANCA 1985, pp. 161-162, 164-166.
54 D’URSO 2020, pp. 221, 224.
55 BIANCA 1985, pp. 167-170.
56 ABBAMONTE 2023, pp. 532-533, 536-538. Sul valore del modello della biblioteca umanistica nel XV secolo si vedano CHATELAIN 2024, pp. 230-232, e TOSCANO 2024b, pp. 235, 239-240.
57 BIANCA 1985, pp. 165 (nota 33), 170.
58 Sul codice viennese si rimanda alla nota 51 di questo scritto.
59 IL DE VIRTUTE MORALI 2022, pp. 20-22.
APPENDICE I
Elenco dei manoscritti miniati da Cristoforo Majorana per Andrea Matteo III Acquaviva:
1. Berlino, Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Ham. 466, Onosandro, De optimo imperatore, volgarizzamento di Crisostomo Colonna (1490 circa);
2. Besançon, Bibliothèque d’Étude et de Conservation - Archives Municipales, 842, Sallustio, De coniuratione Catilinae, De bello Iugurthino (1490 circa);
3. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 127, Seneca, Naturales quæstiones (1490-1500);
4. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 154, Lucrezio, De rerum natura (1485 circa);
5. Leida, Universitaire Bibliotheken, 6B, Virgilio, Opera (1485-1490);
6. Londra, British Library, Harley 5221, Frontino, De re militari (1480-1485);
7. Madrid, Biblioteca Nacional de España, 23145, Marziale, Epigrammaton libri XII (14851490);
8. Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, Gr. 119 = α. P. 5.9, Plutarco, Moralia (1490-1500);
9. Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, C.F.3.4, Temistio, In Aristotelis Physica paraphrasis, traduzione latina e Commentarium di Ermolao Barbaro il Giovane (1490-1500);
10. Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, C.F.3.7, Apuleio, Opera (1490-1500);
11. Napoli, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, II.A.35, Liturgica ad usum ecclesiarum Italo-Graecarum (1500);
12. Napoli, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, VIII.F.41, Excerpta ex legibus Platonis (1490-1500);
13. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Latino 10764, Tolomeo, Geographia, traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia (in collaborazione con un miniatore di cultura veneto-romana, 1490 circa);
14. Ubicazione ignota (già Londra, Sotheby’s, 1985), Giovanni Pontano, De fortitudine (1485-1490);
15. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 45, Tito Livio, Ab Urbe condita (Decas III) (1490 circa);
16. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Hist. gr. 2, Senofonte, Cyropædia, traduzione latina di Poggio Bracciolini (in collaborazione con Nardo Rapicano, 1500 circa);
17. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Phil. gr. 2, Aristotele, Physica, De generatione et corruptione, De anima (in collaborazione con un artista di cultura prossima a Reginaldo Pirano, 1496).
APPENDICE II
Elenco degli incunaboli miniati da Cristoforo Majorana per Andrea Matteo III Acquaviva:
1. Parigi, Bibliothèque nationale de France, Rés. Vélins 1917, Giovanni Pontano, De obœdientia (edizione Napoli, Mattia Moravo, 25 ottobre 1490).
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 1: Giovanni Pontano e bottega di Cristoforo Majorana, De fortitudine, c. 1r. Ubicazione ignota, già Londra, Sotheby’s, 1985 (in Western Manuscripts and Miniatures […], catalogo dell’asta di Sotheby’s (Londra 25 giugno 1985), Londra 1985, lotto 83, pp.n.nn., su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte)
Studi di Memofonte 34/2025
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 2: Marziale e bottega di Cristoforo Majorana, Epigrammaton libri XII, Mss/23145, c. 1r. Madrid, Biblioteca Nacional de España. Foto: © Biblioteca Nacional de España
Fig. 3: Virgilio e Cristoforo Majorana, Opera, Ms. 6B, c. 2r Leida, Universitaire Bibliotheken. Foto: © Universitaire Bibliotheken Leiden
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 4: Tolomeo e Cristoforo Majorana, Geographia, traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia, Ms. Latino 10764, c. 1v. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Foto: © Bibliothèque nationale de France
Fig. 5: Tolomeo e Cristoforo Majorana, Geographia, traduzione latina di Iacopo Angeli da Scarperia, Ms. Latino 10764, c. 2r. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Foto: © Bibliothèque nationale de France
Fig. 6: Seneca e Cristoforo Majorana, Naturales quæstiones, Ms. Barb. lat. 127, c. 1r Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Foto: © [2024] Biblioteca Apostolica Vaticana –per concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 7: Apuleio e Cristoforo Majorana, Opera, Ms. C.F.3.7, c. 2r. Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini Foto: su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini
8: Temistio e Cristoforo Majorana, In Aristotelis Physica paraphrasis, traduzione latina e Commentarium di Ermolao Barbaro il Giovane, Ms. C.F.3.4, c. 5r Napoli, Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini Foto: su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini
Studi di Memofonte 34/2025
Fig.
BIBLIOGRAFIA
ABBAMONTE 2023
G. ABBAMONTE, The Libraries of Humanists and of the Elites, in A Companion to the Renaissance in Southern Italy (1350-1600), a cura di B. de Divitiis, Leida - Boston 2023, pp. 530-562.
ACQUAVIVA D’ARAGONA 1960
Acquaviva d’Aragona Andrea Matteo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, I, Roma 1960, pp. 185-187.
ALEXANDER–DE LA MARE 1969
J.J.G. ALEXANDER, A.C. DE LA MARE, The Italian Manuscripts in the Library of Major J.R. Abbey, Londra 1969.
ANDREA MANTEGNA 2019
Andrea Mantegna Rivivere l’antico, costruire il moderno, catalogo della mostra, a cura di S. Bandera, H. Burns, V. Farinella, Venezia 2019.
A SELECTION OF PRECIOUS MANUSCRIPTS 1950
A Selection of Precious Manuscripts, Historic Documents, and Rare Books, the Majority from the Renowned Collection of Sir Thomas Phillipps, bt. (1792-1872), messa in vendita da William H. Robinson Ltd., Londra 1950.
BIANCA 1985
C. BIANCA, La biblioteca di Andrea Matteo Acquaviva, in Gli Acquaviva d’Aragona Duchi di Atri e Conti di S. Flaviano, atti del sesto convegno (Teramo 1983), I-III, Teramo 1985-1989, I (1985), pp. 159-173.
BIBLIOTECA ORATORIANA 2025
Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli. Catalogo dei manoscritti (secc. XI-XV) redatto dagli allievi della Scuola di alta formazione “A. Varvaro”, a cura di F. Autiero, S. Gorla, coordinamento scientifico di M. Cursi, A. Mazzucchi, Roma - Padova 2025 (in corso di stampa).
CASSEE 1985
E. CASSEE, La miniatura italiana in Olanda. Risultati di ricerche nella collezione della Biblioteca dell’Università di Leida, in La miniatura italiana tra Gotico e Rinascimento, atti del II Congresso di Storia della Miniatura Italiana (Cortona 24-26 settembre 1982), a cura di E. Sesti, I-II, Firenze 1985, I, pp. 155-174.
CHATELAIN 2024
J.-M. CHATELAIN, La bibliothèque humaniste et la magnificence des princes, in L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024, pp. 227-233.
CODICI MINIATI 1995
Codici miniati della Biblioteca Oratoriana dei Girolamini di Napoli, catalogo della mostra, a cura di A. Putaturo Murano, A. Perriccioli Saggese, presentazione di G. Ferrara, introduzione di F. Bologna, Napoli 1995.
DE MARINIS 1947-1952
T. DE MARINIS, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona, I-IV, Milano 1947-1952.
DE MARINIS 1956
T. DE MARINIS, Un manoscritto di Tolomeo fatto per Andrea Matteo Acquaviva e Isabella Piccolomini, Verona 1956.
DE MARINIS 1969
T. DE MARINIS, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona. Supplemento, I-II, col concorso di D Bloch, C Astruc, J Monfrin, appendice di J Ruysschaert, Verona 1969.
DIX SIÈCLES D’ENLUMINURE ITALIENNE 1984
Dix siècles d’enluminure italienne (VIe-XVIe siècles), catalogo della mostra, a cura di Y. Załuska, F. Avril et alii, indice e bibliografia messi a punto da C. Rabel, Parigi 1984.
DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI MINIATORI ITALIANI 2004
Dizionario Biografico dei Miniatori Italiani. Secoli IX-XVI, a cura di M. Bollati, prefazione di M. Boskovits, Milano 2004.
D’URSO 2004
T. D’URSO, Giovanni Todeschino, in DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI MINIATORI ITALIANI 2004, pp. 302-305.
D’URSO 2007
T. D’URSO, Giovanni Todeschino. La miniatura ‘all’antica’ tra Venezia, Napoli e Tours, presentazione di A. Perriccioli Saggese, Napoli 2007.
D’URSO 2014
T. D’URSO, Oltre la “Biblioteca dei re d’Aragona”: aggiunte all’attività tarda di Cristoforo Majorana, in Il codice miniato in Europa. Libri per la chiesa, per la città, per la corte, atti del convegno della Società Internazionale di Storia della Miniatura (Padova 2-4 dicembre 2010), a cura di G. Mariani Canova, A. Perriccioli Saggese, Padova 2014, pp. 601-614.
D’URSO 2019
T. D’URSO, La raccolta libraria di Federico d’Aragona: sulle tracce dei manoscritti miniati, in Biblioteche Medievali d’Italia, atti del convegno (Caserta 2016), a cura di M. Bassetti, D. Solvi, Firenze 2019, pp. 121-129.
D’URSO 2020
T. D’URSO, I libri miniati di Andrea Matteo III Acquaviva, in Principi e corti nel Rinascimento meridionale I Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli, incontro internazionale di studi (Fondi 15-17 novembre 2018), a cura di F. Delle Donne, G. Pesiri, Roma 2020, pp. 217-229.
D’URSO 2021
T. D’URSO, Un nuovo codice miniato da Cristoforo Majorana (Berlino, Staatsbibliothek zu BerlinPreussischer Kulturbesitz, Ms. Ham. 466), in Finis coronat opus. Saggi in onore di Rosanna Cioffi, a cura di G. Brevetti, A. Di Benedetto et alii, Todi 2021, pp. 35-38.
D’URSO 2023a
T. D’URSO, La biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva da Hermann Julius Hermann ad oggi, «Rivista di Storia della Miniatura», XXVII, 2023, pp. 72-80.
D’URSO 2023b
T. D’URSO, Una nuova tessera per l’attività di Cristoforo Majorana e la biblioteca di Andrea Matteo III Acquaviva, in The Art of the Renaissance Book. Tributes in Honor of Lilian Armstrong, a cura di I. Andreoli, H.K. Szépe, Turnhout 2023, pp. 207-223.
FIGLIUOLO 2015
B. FIGLIUOLO, Pontano Giovanni, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXIV, Roma 2015, pp. 729-740.
GUERNELLI 2018
D. GUERNELLI, Al servizio della corte aragonese di Napoli: un catalogo e nuove attribuzioni per Cristoforo Majorana, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXXX, 2018, pp. 299-323.
GUERNELLI 2022
D. GUERNELLI, «De lavore anticho con espitelli et altre lavore de fogliagi facti allantica»: codici di Cristoforo Majorana in Biblioteca Vaticana, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, XXVII, a cura di M.G. Critelli, Città del Vaticano 2022, pp. 113-152.
HAFFNER 1997
T. HAFFNER, Die Bibliothek des Kardinals Giovanni d’Aragona (1456-1485). Illuminierte Handschriften und Inkunabeln für einen humanistischen Bibliophilen zwischen Neapel und Rom, Wiesbaden 1997.
HERMANN 1898
H.J. HERMANN, Miniaturhandschriften aus der Bibliothek des Herzogs Andrea Matteo III. Acquaviva, «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses», XIX, 1898, pp. 147-216 (edizione italiana in H.J. Hermann, Manoscritti miniati dalla biblioteca del duca Andrea Matteo III Acquaviva d’Aragona, a cura e introduzione di C. Lavarra, Galatina 2013, pp. 57-159).
HERMANN 1933
H.J. HERMANN, Die Handschriften und Inkunabeln der italienischen Renaissance, IV. Unteritalien: Neapel, Abruzzen, Apulien und Calabrien Anhang: Nachahmungen italienischer Miniaturhandschriften, Lipsia 1933.
IACOBINI–TOSCANO 2010
A. IACOBINI, G. TOSCANO, «More graeco, more latino». Gaspare da Padova e la miniatura all’antica, in Mantegna e Roma. L’artista davanti all’antico, atti del convegno (Roma 8-10 febbraio 2007), a cura di T. Calvano, C. Cieri Via, L. Ventura, Roma 2010, pp. 125-190.
IL DE VIRTUTE MORALI 2022
Il De virtute morali di Plutarco nella versione latina di Andrea Matteo Acquaviva d’Aragona, a cura di C. Lavarra, C. Corfiati, Galatina 2022.
ITALIAN MANUSCRIPT PAINTING 1984
Italian Manuscript Painting 1300-1550, catalogo della mostra, New York 1984.
LA BIBLIOTECA REALE DI NAPOLI 1998
La Biblioteca Reale di Napoli al tempo della dinastia aragonese / La Biblioteca Reale de Nápoles en tiempos de la dinastía aragonesa, catalogo della mostra, a cura di G. Toscano, Valencia 1998.
LES MANUSCRITS CLASSIQUES LATINS 1975
Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, I. Fonds Archivio San Pietro à Ottoboni, a cura di E. Pellegrin, J. Fohlen et alii, Parigi 1975.
LIBRI A CORTE 1997
Libri a corte. Testi e immagini nella Napoli aragonese, catalogo della mostra, Napoli 1997.
L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024
L’invention de la Renaissance. L’humaniste, le prince et l’artiste, catalogo della mostra, a cura di J.-M. Chatelain, G. Toscano, Parigi 2024.
MARUCCHI 1964
A. MARUCCHI, Stemmi di possessori di manoscritti conservati nella Biblioteca Vaticana, in Mélanges Eugène Tisserant, VII Bibliothèque Vaticane. Deuxième partie, Città del Vaticano 1964, pp. 29-95.
MONTI SABIA 1962-1963
L.MONTI SABIA, Un ritrovato epigramma del Pontano e l’editio princeps del De fortitudine-De principe, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Napoli», X, 1962-1963, pp. 235-246.
ORIANI 2021
L. ORIANI, La biblioteca di Alfonso d’Aragona e Ippolita Maria Sforza, duchi di Calabria. Per una ricostruzione delle collezioni librarie di Castel Capuano a Napoli, tesi di Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 2021.
ORIANI 2024a
L. ORIANI, La biblioteca di Alfonso d’Aragona e Ippolita Maria Sforza, duchi di Calabria, Napoli 2024.
ORIANI 2024b
L. ORIANI, Sulla cerchia del Maestro del retablo di Bolea: il manoscritto Vat. lat. 8691 della Biblioteca Apostolica Vaticana, «Rivista di Storia della Miniatura», XXVIII, 2024, pp. 134-144
PUTATURO MURANO–PERRICCIOLI SAGGESE–LOCCI 1988
A. PUTATURO MURANO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, A. LOCCI, Reginaldo Pirano da Monopoli e i miniatori attivi per Andrea Matteo III Acquaviva, in Monopoli nell’età del Rinascimento, atti del convegno internazionale di studio (Monopoli 22-24 marzo 1985), a cura di D. Cofano, I-III, Monopoli 1988, III, pp. 1103-1168.
RICCI 1935-1940
S. DE RICCI, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, con la collaborazione di W.J. Wilson, I-III, New York 1935-1940.
SAPIENZA 2006
V. SAPIENZA, Majorana Cristoforo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXVII, Roma 2006, pp. 644-646.
SICILIANI 2017
M.A. SICILIANI, Annotazioni codicologiche e paleografiche sul ms. London, British Library, King’s 322, in Un canzoniere d’amore del XV secolo (London, British Library, ms King’s 322). Un codice acquaviviano?, a cura di C. Lavarra, F. Tateo, Galatina 2017, pp. 57-75.
SODANO 2012
G. SODANO, Da baroni del Regno a Grandi di Spagna. Gli Acquaviva d’Atri: vita aristocratica e ambizioni politiche (secoli XV-XVIII), Napoli 2012.
THE CAMBRIDGE ILLUMINATIONS 2005
The Cambridge Illuminations. Ten Centuries of Book Production in the Medieval West, catalogo della mostra, a cura di P. Binski, S. Panayotova, Londra 2005.
THE PAINTED PAGE 1994
The Painted Page. Italian Renaissance Book Illumination 1450-1550, catalogo della mostra, a cura di J.J.G. Alexander, Monaco di Baviera - New York 1994.
TOSCANO 2004
G. TOSCANO, Majorana Cristoforo, in DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI MINIATORI ITALIANI 2004, pp. 718-721.
TOSCANO 2007a
G. TOSCANO, Christoforo Majorana e la miniatura all’antica: a proposito di qualche manoscritto conservato a Cambridge, in The Cambridge Illuminations. The Conference Papers, atti del convegno (Cambridge 810 dicembre 2005), a cura di S. Panayotova, Londra 2007, pp. 245-254.
TOSCANO 2007b
G. TOSCANO, Pour Nardo Rapicano enlumineur : le Missel d’Alfonso Strozzi de la Bibliothèque universitaire de Leipzig, in Quand la peinture était dans les livres. Mélanges en l’honneur de François Avril, a cura di M. Hofmann, E. König, C. Zöhl, Turnhout 2007, pp. 352-365.
TOSCANO 2008
G. TOSCANO, Da lui cominciò ad rinovarsi la antiquità: per la fortuna di Andrea Mantegna a Napoli, in «Napoli è tutto il mondo». Neapolitan Art and Culture from Humanism to the Enlightenment, atti del convegno internazionale (Roma 19-21 giugno 2003), a cura di L. Pestilli, I.D Rowland, S. Schütze, Pisa - Roma 2008, pp. 79-97.
TOSCANO 2024a
G. TOSCANO, Le manuscrit italien, in L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024, pp. 69-81.
TOSCANO 2024b
G. TOSCANO, Le modèle humaniste de la bibliothèque au service de la gloire des princes, in L’INVENTION DE LA RENAISSANCE 2024, pp. 235-241.
UGUCCIONI 2001
A. UGUCCIONI, Giovanni di Gioacchino, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LVI, Roma 2001, pp. 53-55.
WARNER–GILSON 1921
G.F. WARNER, J.P. GILSON, Catalogue of Western Manuscripts in the Old Royal and King’s Collections, I-IV, Londra 1921.
WESTERN MANUSCRIPTS AND MINIATURES 1985
Western Manuscripts and Miniatures […], catalogo dell’asta di Sotheby’ s (Londra 25 giugno 1985), Londra 1985.
ZANATO 2017
T. ZANATO, Anonimo del «Canzoniere per Zucarina», in Atlante dei canzonieri in volgare del Quattrocento, a cura di A. Comboni, T. Zanato, Firenze 2017, pp. 46-51.
Studi di Memofonte 34/2025
ABSTRACT
In questo articolo si restituiscono ad Andrea Matteo III Acquaviva, duca d’Atri e conte di Conversano, tre manoscritti le cui miniature furono realizzate da Cristoforo Majorana tra gli anni Ottanta e Novanta del XV secolo. Si tratta di codici tuttora poco noti agli studiosi, oggi conservati rispettivamente in una collezione privata (ultima vendita: Londra, Sotheby’s, 1985), a Madrid (Biblioteca Nacional de España, 23145) e a Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 127). Attraverso la discussione dell’apparato decorativo in essi presente, in questo scritto si approfondiscono soprattutto i rapporti, ben attestati anche da altri volumi, tra il condottiero abruzzese e l’artista napoletano, da inquadrare nel contesto della fortuna della miniatura ‘all’antica’ nella Napoli aragonese sullo scorcio del Quattrocento.
This article presents three manuscripts the miniatures of which were realized by Cristoforo Majorana between the 1480s and 1490s for Andrea Matteo III Acquaviva, duke of Atri and count of Conversano. These codices are still little known to scholars and are nowadays housed respectively in a private collection (last sale: London, Sotheby’s, 1985), in Madrid (Biblioteca Nacional de España, 23145) and in the Vatican City (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 127). By discussing the decoration they feature, this paper especially explores the relationship, well documented by several other volumes, between the Abruzzese condottiero and the Neapolitan artist, which is to be framed in the context of the fortune of ‘all’antica’ style illumination in late fifteenth-century Aragonese Naples.
TRA MOBILI E IMMOBILI: LA MADONNA PAZZI E ALTRE OPERE DI FAMIGLIA
«Se Lei leggesse il Bocchi e il Cinelli […] e le guide di questa città fino ai principi del secolo presente, e confrontasse gli uni e le altre con le attuali, sono certo che ne avrebbe una stretta al cuore». Così ammoniva un anonimo giornalista nel 1885, in un dialogo fittizio col direttore di un noto periodico fiorentino1. Sulla scorta delle opere di cui faceva l’elenco, la polemica non era certo inedita, di fronte a un patrimonio culturale che andava disperdendosi sul mercato antiquario da oltre mezzo secolo.
A non dare pace allo scrittore era infatti il confronto – ormai irresistibile e morboso – con la guidistica antica: panoramica di cui non rimaneva più che il lacrimevole ricordo, come quello lasciato da Francesco Bocchi e Giovanni Cinelli con Le bellezze della città di Firenze (1591 e 1677).
A breve un’altra opera d’arte, pur essa individuata nella guida e appena venduta all’estero, avrebbe potuto aggiungersi al necrologio. Dalla sua riscoperta nel 1886, se della cosiddetta Madonna Pazzi si è scritto senza tregua2, sulla provenienza da cui trae il nome non è stato aggiunto nulla: svantaggio di un’opera che, seppure subito inserita tra i massimi esempi di Donatello nel rilievo stiacciato, dispone di un materiale documentario tanto suggestivo quanto scarno (Fig. 1).
Conviene a tal proposito ripercorrere le ragioni che hanno legato il bassorilievo alla famiglia Pazzi, a cominciare dalla monografia sullo scultore edita da Camillo Jacopo Cavallucci (1886), che per primo ne diede notizia, offrendone pure un’illustrazione (Fig. 2). Proprietà in quel tempo dell’oscuro carabiniere e collezionista Raffaele Lamponi -Leopardi, fu Cavallucci a indicarne la provenienza da un palazzo della famiglia, allora non più esistente giacché demolito «per fabbricarvi la sede della Banca Nazio nale». Tale notizia permise all’autore di fare un fugace ma imperdibile collegamento, sostenendo che l’opera era persino segnalata nella guida de Le bellezze3. Pur senza citarne nemmeno una virgola, decisiva fu la rievocazione di quel passo, in cui si narrava della
Per il presente articolo devo molto a coloro che, di fronte a persistenti richieste, hanno spesso agevolato l’accesso ai documenti, facendomi consultare l’inconsultabile: in particolare Fabio D’Angelo, Elisabetta Bettio, Daniela Fattori, Francesca Roggi e Silvia Sinibaldi (Archivio di Stato di Firenze), Stefano Tasselli (Archivio Storico Eredità Bardini), Simona Pasquinucci (Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine), Michaela Hussein-Wiedemann (Zentralarchiv di Berlino), Tiziana Dassi e Silvia Franz (Arch ivio Storico dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano), Oliva Rucellai (Archivio Rucellai di Firenze) e Alessandra Torrigiani Malaspina (Archivio Torrigiani-Malaspina). Sono inoltre grato al durevole sostegno di Marc Bormand, Alison Luchs, Beatrice Paolozzi Strozzi e Neville Rowley negli ultimi anni; alle puntuali ma preziose indicazioni fornitemi lungo la ricerca da Lorenz Böninger, Lorenzo Fabbri e Richard Goldthwaite; all’amicizia di Federica Carta, Davide Civettini, Leonardo Lenzini e Tommaso Mozzati che ne hanno tollerato gli aggiornamenti; e alla sollecitudine di Francesco Caglioti che ne ha tollerato la chirurgica revisione. Ringrazio infine Lynn Catterson, con cui non ho spesso condiviso le idee, ma sempre trovato una premurosa complicità. Tutte le date seguono lo stile comune.
1 ANONIMO 1885, p. 33.
2 Si veda la sterminata bibliografia pazientemente raccolta da Neville Rowley per la scheda digitale dell’opera nell’OnlineDatenbank der Sammlungen der Staatlichen Museen zu Berlin (https://recherche.smb.museum/detail/871363 <13 marzo 2025>). Per ultimo: ROWLEY 2022, pp. 20-22.
3 «Varie opere ricorda il Vasari scolpite da Donatello per più cittadini fiorentini, e fra questi i Pazzi, per il giardino dei quali avrebbe fatto un ‘bellissimo vaso che gettava acqua’, ed oltre di questo è registrato dal Bocchi il bassorilievo di una Vergine col Santo Bambino in braccio. Vasca e Madonna fortunatamente ancora in Firenze, ove sarebbe desiderabile che andassero ad arricchire il Museo Nazionale, in cui, già da tempo, sono depositate la porta del giardino, che la tradizione attribuisce a Donatello, e la vasca che il Vasari ricorda assieme a quella fatta per la famiglia Medici, oggi nella R. villa di Castello. Della Madonna – che stette sempre nel giardino dei Pazzi (finché questo assieme al palazzo non fu distrutto per fabbricarvi la sede della Banca Nazionale) – sono lieto di poter presentare
Casa di Francesco Pazzi, nella quale è una bellissima Vergine di basso rilievo in marmo di mano di Donatello: è il bambino Giesù a sedere sopra un guanciale, e con la destra la Vergine il sostiene mentr’egli con la sinistra alzata regge i lembi del velo ch e dal capo della Madonna pendono. È vaga in ogni sua parte, ed i panneggiamenti sono bellissimi; esprime la Vergine l’affetto verso il figliuolo con grand’arte, ed è tale che nelle divise seguite tra Pazzino <e Alessandro> la prese Alessandro padre di Francesco per scudi 500, secondo la stima che ne fu fatta4
Grazie alla presenza della Madonna in un antico palazzo dei Pazzi nell’Ottocento e alla sua identificazione con l’opera descritta due secoli prima in casa di un presunto esponente di quella famiglia, Cavallucci piantò i due cardini della storia collezionistica del bassorilievo. Ulteriori precisazioni sarebbero comparse dopo che l’opera fu consegnata in vendita da LamponiLeopardi all’antiquario Stefano Bardini nel gennaio del 1886, e acquistata il mese successivo da Wilhelm Bode per conto dei Musei Reali di Berlino5. Sollecitando maggiori notizie in merito alla sua nuova acquisizione, Bode ricevette dall’antiquario le ultime informazioni utili, ricavate indubbiamente dallo stesso Lamponi-Leopardi, benché la corrispondenza tra i due non ne abbia conservato traccia6. Oltre a parafrasare quanto già riportato da Cavallucci, Bardini indicò come antica collocazione la cappella privata del succitato palazzo; nonché, come successiva collocazione, una residenza di campagna dove si era trasferita la proprietaria, ricordata come «la vecchia Pazzi», la di cui morte aveva permesso a Lamponi-Leopardi di acquistare l’opera7 . Raccolto dunque tutto ciò che poteva per la propria pubblicazione, Bode fece (con minimi errori) un ultimo riepilogo, senza alcuna aggiunta se non che l’ultima proprietaria era un’«anziana» marchesa Pazzi8 .
Con apporti diversi ma mai discordanti tra loro, Cavallucci, Bardini e Bode sono di fatto i tre soli testimoni che costituiscono la tradizione storica dell’opera. Nella fattispecie, quindi, alla
una bella riproduzione xilografica, tratta dalla fotografia del marmo, posseduto attualmente dal conte LamponiLeopardi, distinto e intelligentissimo amatore di cose di arte, il quale, con la squisita gentilezza che lo distingue, mi permise di accrescere il valore artistico di questa pubblicazione pubblicando un prezioso documento inedito da riferirsi alla gioventù di Donatello» (CAVALLUCCI 1886 [stampato nel dicembre 1885], pp. 31-32).
4 BOCCHI/CINELLI 1677, pp. 369-370. Stando all’articolazione della frase, è d’obbligo qui ripristinare l’omissione prevista in origine dalla preposizione «tra», altrimenti inspiegabile a meno di correggerla in «con»: refusi che, in ambo i casi, tradiscono una vicenda patrimoniale sulla quale Cinelli appare chiaramente istruito, per cui si veda infra, p. 34.
5 Per la quietanza di pagamento dell’acconto (5000 lire) pagato da Bardini a Lamponi -Leopardi si veda ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.9 (Lamponi-Leopardi a Bardini, 20 gennaio 1886). Per l’acquisto di Bode si veda ASEB, Corrispondenza, 1886, 1, Corr.I.B.1 (Bode a Bardini, 14 febbraio 1886).
6 Negli scambi tra Bardini e Lamponi-Leopardi intercorre un silenzio dal 3-4 febbraio (ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.5) al 2 giugno 1886 (ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.13), periodo in cui vengono inoltrate le richieste di Bode: si veda infra, note 12 e 32.
7 «La Madonna del Donatello di Casa Pazzi era nella Cappella della Casa Pazzi in Borgo degli Albizi la quale corrispondeva in Via dell’Oriuolo. Venuta la Capitale in Firenze, la Banca Nazionale del nuovo Regno d’Italia comprò la Casa Pazzi e vi fabbricò l’a ttuale Palazzo per uso della Banca. In quella occasione la vecchia Pazzi trasferì la sua abitazione in campagna e fra le molte cose portò la Madonna e là rimase fino alla sua morte, dopo la quale dagli eredi fatta venire in Firenze e fatta stimare fu giudicata una porcheria e del valore di L. 200 e da essi venduta al Capitano Lamponi con molto piacere per 1000 lire» (ASEB, Copialettere, 2, cc 373-374, Bardini a Bode, 26 aprile 1886).
8 «Sowohl der Brunnen wie das Madonnenrelief befanden sich ursprünglich im alten Palazzo Pazzi; jener wird schon von Vasari im Garten neben dem Palast, dieses von Bocchi in der Hauskapelle erwähnt. Erst als Palast und Garten dem Neubau der Banca Nazionale w eichen mussten, wurde der Brunnen leihweise im Hof des Bargello ausgestellt und das Madonnenrelief zunächst bei Seite geschafft, bis es im Anfange des vorigen Jahres, nach dem Tode der alten Marchesa Pazzi, von den Erben an einen jener in Italien nicht sel tenen Signori [ scil. LamponiLeopardi], die unter dem Titel eines Liebhabers den Händler und Makler machen, verkauft wurde» ( BODE 1886, p. 203). È evidente come Bode stesse, se non travisando i fatti, quantomeno confondendo le loro fonti: benché la presenza della fontana nel giardino dei Pazzi fosse ricavata correttamente da Vasari, quella della Madonna nella cappella privata non era certo ricavata dalle Bellezze, ma da Bardini, ovvero l’«ersten und teuersten Händlers Italiens» di cui Bode stava accortamente tacendo il nome (ivi, p. 204).
denominazione di Madonna Pazzi corrispondono due piste di ricerca distinte ma possibilmente convergenti: capire se l’opera di Berlino sia quella descritta presso un esponente Pazzi nel Seicento (come hanno sostenuto i seguaci di Cavallucci) e se sia appartenuta alla medesima famiglia nell’Ottocento (come voleva la dichiarazione di Bardini).
A tenerle entrambe in stallo è stata paradossalmente la tradizione stessa. Come presagito dall’anonimo giornalista, una prima «stretta al cuore» venne proprio con la rilettura della guida di Cinelli, che, oltre a essere diventata la fonte scritta più antica, diventò anche fonte di un insopportabile dilemma iconografico. Che nell’opera berlinese la Vergine sostenesse il figlio con la mano sinistra (anziché destra) e che sotto a lui non comparisse nulla (tanto meno un guanciale) costrinse infatti presto a stemperare l’identificazione con l’opera descritta ne Le bellezze: un disagio che riconobbe lo stesso Bode (1888) e che già permise ad August Schmarsow di cassare qualsiasi nesso tra il marmo di Berlino e quello di Cinelli (1889)9. Su questa questione, sarà tuttavia opportuno tornare in un secondo momento, valutandola con cognizione di causa a fine articolo. In merito alle informazioni rimanenti, il fatto che a rilasciarle fosse uno come Bardini non dissipò certamente il clima di sfiducia, gettando semmai nell’imbarazzo l’intera vicenda. Non a caso, infatti, si è più volte sospettato che la provenienza Pazzi fosse stata inventata dall’antiquario allo scopo di dare all’opera un aggancio proficuo con la celebre guida 10 . Di fronte ai dubbi che incombevano sull’ammissibilità delle testimonianze, la critica ha scelto un cauto riparo, preferendo diffidare di una storia collezionistica troppo incerta. Con ciò ha però anche clamorosamente rinunciato a verificarne il contenuto. Ancora di recente, se l’operosità dell’antiquario nella compravendita del bassorilievo ha dato lo spunto per tornare su queste aporie, sono stati nuovamente tralasciati i pochi indizi rilevanti per venirne a capo 11. Così, mentre i presunti luoghi antichi di conservazione continuavano a sfuggire a un’indagine topografica, anche i presunti proprietari continuavano a sfuggire a una ricognizione genealogica. A tali disattenzioni si vuole perciò qui rimediare, anzitutto esaminando quanto riporta propriamente la tradizione, passandolo poi al vaglio di alcuni rinvenimenti documentari utili al caso.
Immobili e proprietari (secoli XV-XIX)
Già con Bode, la provenienza da una «casa Pazzi» (che la letteratura ha spesso alterato in un più solenne quanto ingannevole «palazzo») ha creato alcuni fraintendimenti con l’attuale Palazzo Pazzi Quaratesi, la storica dimora posta sul canto di Via del Proconsolo e Borgo degli Albizi, proprietà dell’infausto Jacopo ai tempi della congiura del 1478 12. Come tuttavia presagiva lo scempio fatto sullo stemma robbiano del palazzo (Fig. 3)13, ogni rapporto tra i Pazzi e l’immobile si spezzò in quell’anno 1478 per non più riallacciarsi, poiché nessuno di loro vi avrebbe mai rimesso piede14. Frutto quindi di una toponomastica equivoca e delle caotiche vicende
9 BESCHREIBUNG 1888, pp 15-16, n. 39; SCHMARSOW 1889, p. 206.
10 Si vedano GRASSI 1958, p. 64, n. 38 («[…] l’informazione del Bode sulla provenienza della così detta Madonna Pazzi non è diretta»), e i più perentori giudizi di JANSON 1957, II, p. 44 («[Bode’s] information about its origin evidently came from the dealer and is thus not wholly trustworthy, in the absence of any disinterested eyewitness reports on the panel in situ »), e di AVERY 1991, p. 35, n. 16 («Può darsi che la notizia della provenienza sia stata inventata per creare una connessione fra quest’opera e il rilievo menzionato dal Bocchi Cinelli»).
11 CATTERSON 2020.
12 «So che codesto [marmo] viene dalla famiglia Pazzi; ma non so se era in città nell’antico Palazzo Pazzi o piutosto in una Villa fuori di Firenze» (ASEB, Corrispondenza, 1886, 1, Corr.I.B.7, Bode a Bardini, 3 marzo 1886, di cui si veda la risposta supra, nota 7).
13 Su questo tondo, acquistato nel 1899 da Umberto Serristori per il suo palazzo d’Oltrarno, e gli interventi subiti in antico a seguito della condanna dell’araldica familiare, ci proponiamo di ritornare in altra sede.
14 Dopo la confisca, il palazzo venne venduto al cardinale di Rouen, Guillaume d’Estouteville (ASFi, Notarile antecosimiano, 9635 [Giovanni di Marco da Romena], cc. 264r [3 luglio 1479], 265v [12 luglio 1479]). Ereditato dai figli Girolamo e Agostino (ASFi, Notarile antecosimiano, 13186 [Jacopo di Martino Martini], c. 30r [23 gennaio 1483]),
immobiliari relative alla famiglia, questa contraddizione ha portato a escludere qualsiasi loro abitazione per la provenienza della Madonna berlinese, insabbiando proprio la strada che le fonti già note avevano aperto15.
Se è vero, dopotutto, che il bassorilievo venne ricondotto a Borgo degli Albizi, tutti –Cavallucci, Bardini o Bode che siano – furono unanimi nel riferirsi al palazzo che era stato recentemente demolito per far spazio alla nuova sede della Banca Nazionale (1865-1869)16
Questo edificio si trova tutt’oggi a metà della strada, fiancheggiato a levante da un passaggio a volta (detta ‘dei Ciechi’) che immette in una piccola corte (oggi Piazza dei Pazzi): uno spazio attorno al quale già nel Quattrocento incontriamo esclusivamente membri della famiglia, quali Andrea di Guglielmino, Ghinozzo di Luigi e i figli di Poldo di Geri17 – salvo due proprietà dei Tanagli e una dell’ospedale di Santa Maria Nuova (cfr. APPENDICE)18
Nonostante la quantità di beni ancora in regime di alienazione nel 1495, e segnalati nella Decima repubblicana dai fratelli Guglielmo e Giovanni dopo il loro richiamo a Firenze l’anno precedente, l’unico immobile riscattato in città fu precisamente quello sito nell’area dove sarebbe sorta la Banca19. A consentirne un quadro storico-edilizio, grazie all’indicazione dei notai roganti, è la portata fiscale del 1458, aggiornata con quella del 149520. Entro questo progetto immobiliare proseguito per tre generazioni, costante e organica appare la politica familiare di acquisti e accorpamenti esercitata attorno alla corte: a cominciare con l’acquisto della proprietà di
fu poi venduto a Franceschetto Cybo, figlio di papa Innocenzo VIII (ASR, Collegio dei Notai Capitolini, 176 [Camillo di Antonio Benimbene], cc. 590v [20 gennaio 1488]). Da lì all’acquisto da parte dell’INPS in era fascista, i passaggi di proprietà sono i seguenti: ASFi, Decima repubblicana, 31 (1495), cc. 685r, 686v, 687v (Franceschetto Cybo); Decima granducale, 3648, cc. 217v-218r (Lorenzo di Franceschetto Cybo, 1546-1574); 3646, cc. 169v-170r (Alberigo di Lorenzo Cybo, 1574-1593); 3617, cc. 492v-493r (Lorenzo di Carlo Strozzi, 1593-1609); 3616, cc. 342v-343r (Carlo, Alessandro, Leone, Filippo, Ottavio, Alfonso e Orazio di Lorenzo Strozzi, 1609-1618); 3619, c. 303 (Carlo di Lorenzo Strozzi, 1618-1623), c. 22 (Alessandro di Carlo Strozzi, 1623-1628); 3620, c. 279 (Marietta di Lorenzo Strozzi, 16281645), c. 174 (Lorenzo di Lorenzo Strozzi, 1645-1660), c. 203 (Idem, 1660-1671); 3657, c. 35 (Alessandra vedova di Lorenzo Strozzi, 1671-1673); 3619, c. 283 (eredità di Lorenzo di Lorenzo Strozzi, 1673-1674); 3620, c. 60 (Giovambattista di Lorenzo Strozzi, 1674-1681), c. 211 (Lorenzo-Francesco di Giovanbattista Strozzi, 1681-1714); 3621, c. 141 (Idem, 1714-1742), c. 283 (Filippo e Ferdinando di Lorenzo-Francesco Strozzi, 1742-1760); 3562, cc. 426, 486 (Niccolò di Giovanfrancesco Quaratesi, 1760-1776); Catasto lorenese, 11, pp. 4715-4717 (Idem, 1776); 18, c. 1222 (Idem, 1776-1779); 19, c. 1535 (Giovanfrancesco, Pietro e Luigi di Niccolò Quaratesi, 1779-1814); 29, c. 4135 (Giovanfrancesco di Niccolò Quaratesi, 1814-1832); 150, c. 4937 (Idem, 1832-1837); Catasto generale toscano, Firenze, Campioni, 23, C.5075 (Idem, 1832-1837); 20, C.4454 (Niccolò di Luigi Quaratesi, 1837-1843); Suppl. (serie I), 9, C.2588, 2589, 2590 (Idem, 1843); C.2666 (Ferdinand von Rast, 1843-1867); 48, C.14297 (Adolph di Ferdinand von Rast, 18671870); 58, C.17392 (Fondazione baronale De Rast, 1870); Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze, Atti del catasto fabbricati, Partitari del Comune di Firenze, 12, part. 2090 (Idem, 1870-1907); 77, part. 17326 (Eugenio Genazzani, 1907-1913); 147, part. 35481 (Banca Toscana, 1913-1929); 159, part. 38590 (Eadem, 1929-1931); 299, part. 65213 (Eadem, 1931-1932); 314, part. 67945 (Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali, 1932-1933); 337, part. 71981 (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, 1933-1940).
15 CATTERSON 2020, pp. 518-522, 536.
16 Per il cantiere si veda SGARANO 2018, pp. 65-72, 87-89.
17 ASFi, Catasto, 80 (1427), c. 586r (Andrea di Guglielmino Pazzi); 81 (1427), c. 23v (Alamanno e Geri di Poldo Pazzi); 80 (1427), c. 370v (Ghinozzo di Luigi Pazzi).
18 ASFi, Catasto, 80 (1427), c. 152v (Bernardo e Giovanni di Filippo Tanagli). Di più difficile identificazione è la casa di Santa Maria Nuova, a cui sembra tuttavia corrispondere la «casa in detta via [Borgo degli Albizi], a 1° via, a 2° messer Rinaldo degli Albizi, a 3° redi <di> Francesco [scil. Filippo?] Tanagli» (ASFi, Catasto, 185 [1427], c. 685v, Santa Maria Nuova).
19 ASFi, Decima repubblicana, 32 (1495), c. 67r (Guglielmo e Giovanni di Antonio Pazzi). Per il decreto di reintegrazione dei due fratelli si vedano ASFi, Signori e Collegi, Deliberazioni, 96, c. 92r (13 novembre 1494), nonché la provvisione in cui si concesse «a epsi Pazi le loro arme, dove fussino state capse, rifarle et riporle come erano innanzi […] et più possino etiamdio recup<er>are qualunche loro beni immobili» svenduti ai creditori abusivi (ASFi, Provvisioni, registri, 185, c. 53r [25 gennaio 1495]).
20 ASFi, Catasto, 830 (1458), c. 671r (figli di Antonio di Andrea Pazzi); Decima repubblicana, 32 (1495), c. 71v (Guglielmo e Giovanni di Antonio Pazzi).
Bernardo Guadagni da parte di Andrea nel 143521; nucleo a cui il figlio Antonio aggiunse prima la casa adiacente degli Spadini (già Infangati) nel 144022, poi le case del cugino Geri e di Santa Maria Nuova (già Guadagni) nel 144823; per concludersi con la casa dei Da Lutiano (già Infangati) acquistate da Guglielmo di Antonio nel 147624.
In linea con le condanne che colpirono questo ramo dei Pazzi25, la domus magna di Borgo degli Albizi fu incamerata, battuta all’asta e aggiudicata a Carlo Borromei nel 148026. Di questo scomodo parente, riaffiorava così il delicato rapporto con la famiglia, già risalente al 1477, quando una modifica legislativa caldeggiata da Lorenzo de’ Medici gli permise di arrogarsi l’eredità dello zio Giovanni Borromei, escludendo dalla successione l’unica figlia di costui, Beatrice27
Oltre al matrimonio che univa Giovanni Pazzi con la stessa Beatrice (1463) e di cui si conserva un fantasmagorico interno di coperchio di cassone (Fig. 4)28, altrettanto provvidenziale per il destino della casa dovette essere quello di Guglielmo con Bianca de’ Medici, sorella del Magnifico (1459). Senza congetturare oltremodo sulle motivazioni che spinsero Borromei all’acquisto, rimane comunque lecito chiedersi se ad agevolare il recupero dell’immobile non sia stato questo doppio legame filomediceo rimasto latente con le mogli, entrambe lì presenti al tempo della congiura, se non anche durante l’esilio dei mariti29
21 ASFi, Catasto, 626 (1442), c. 193r (Antonio di Andrea Pazzi). Per l’acquisto in seguito all’esilio di Bernardo di Vieri Guadagni nel 1434 si veda ASFi, CPGNR, 70, cc. 43v (19 maggio 1435), 48r (1° giugno 1435), 50r (5 giugno 1435), 52r (15 giugno 1435).
22 ASFi, Catasto, 626 (1442), cc. 193r (Antonio di Andrea Pazzi), 563r (figli di Spadino di Niccolò Spadini).
23 Per l’acquisto delle case di Geri si veda ASFi, Notarile antecosimiano, 690 (Angelo di Piero da Terranuova), cc. 31r-32r (24 maggio 1448); per la casa di Santa Maria Nuova, acquistata dall’ospedale dopo l’esilio di Bernardo di Vieri Guadagni, si veda ASFi, Notarile antecosimiano, 19346 (Matteo di Domenico Sofferoni), cc. 14r-15r (12 giugno 1448), e ASFi, Catasto, 844, c. 1v (gonf. Chiavi).
24 Per l’acquisto in seguito all’esilio di Michelangelo di Zanobi da Lutiano nel 1471 si veda ASFi, CPGNR, 65, c. 172r (29 gennaio 1472), e ASFi, Notarile antecosimiano, 236 (Giovambattista d’Albizo Albizi), c. 153r (29 aprile 1476).
25 Per la sentenza che colpì il ramo di Andrea di Guglielmino si veda ASFi, Provvisioni, registri, 169, cc. 24v-26r (23 maggio 1478, trascritta in FABRONI 1784, pp. 111-115). Nella fattispecie, le condanne si applicarono ai nipoti, poiché unici superstiti: Guglielmo e Giovanni furono confinati in perpetuo con i loro figli entro le cinque e le venti miglia da Firenze (ASFi, Atti del Podestà, 5160, c. 75r-v [28 aprile 1478], trascritto in POLIZIANO/PEROSA 1958, pp. 83-86). Giovanni fu poi condannato in perpetuo alle Stinche (ASFi, Atti del Podestà, 5160, c. 77r-v [7 maggio 1478]) e da lì tradotto nella prigione di Volterra, dove la pena venne commutata in esilio fuori dall’Italia per vent’anni (ASFi, OGBR, 61, cc. 29r-v [13 aprile 1482], 38v [22 aprile 1482]). Guglielmo, per non aver rispettato il confino, fu invece dichiarato ribelle con consecutiva confisca dei beni (ASFi, OGBR, 54, c. 48r-v [18 dicembre 1479]), sebbene la domus magna fosse già stata incorporata dal fisco, poiché intestata anche al terzo fratello Francesco, precedentemente giustiziato e dichiarato ribelle (ASFi, Notarile antecosimiano, 9635 [Giovanni di Marco da Romena], c. 256r [2 gennaio 1479]).
26 ASFi, Balìe, 38, cc. 26v, 28r, 34v. La data avanzata dell’acquisto, registrato il 10 ottobre 1480 (c. 26v), spiega perché l’immobile risultava ancora assente nella portata di Borromei per quell’anno (ASFi, Catasto, 1023 [1480], cc. 252r-256r), così come risultava assente il suo nome nelle portate dei confinanti (ASFi, Catasto, 1023 [1480], cc. 53r [Alessandro e Giovanni di Guglielmo Cortigiani], 432r [Girolamo di Francesco della Rosa-Gherardini]; 1024 [1480], c. 94r [Mauro e Benedetto di Roberto Adimari]).
27 Sulle vicende successorie del patrimonio di Giovanni Borromei e la fatidica lex de testamentis si vedano FABBRI 2019 e KUEHN 2020.
28 Per la tavola (Bloomington, Indiana Eskenazi Museum of Art, inv. 75.37) si veda D.L. Krohn, scheda n. 58a, in ART AND LOVE 2008, pp. 134-136, e LURATI 2012. La coppia di cassoni da cui proviene è registrata nell’apografo del libro di bottega di Apollonio di Giovanni e Marco del Buono (cfr. BNCF, Magl., Cl. XXXVII, 305, c. 64r, trascritto in CALLMANN 1974, Appendice I, p. 81).
29 La loro presenza è confermata in ASFi, Catasto, 927 (1469), c. 495r (figli di Antonio di Andrea Pazzi). Benché il campione redatto nel maggio del 1495 non riporti le bocche (ASFi, Decima repubblicana, 32 [1495], cc. 67r-73v [Guglielmo e Giovanni di Antonio Pazzi]), va data per scontata la presenza delle mogli anche in quella data, poiché ancora vive. Considerata infatti la morte di Giovanni lo stesso anno in Avignone (ASFi, Grascia, Morti, 190, c. 249r [5 luglio 1495]), la morte di Beatrice va riconosciuta in quella di «Monna Bice vedova, riposta in San Marcho» (ASFi, Grascia, Morti, 190, c. 254r [1° marzo 1496]), come suggerisce anche l’atto di restituzione della dote al figlio Raffaele redatto il mese seguente e gentilmente segnalatomi da Lorenzo Fabbri (ASFi, Arte dei Giudici e Notai o Proconsolo, 277, c. 16r-v [11 aprile 1496]); per la morte di Bianca si veda ASFi, Grascia, Morti, 190, c. 317v (20 luglio 1505).
Malgrado la difficoltà di restituire le planimetrie sulla base delle denunce catastali, delineare l’assetto di questa casa non è del tutto superfluo. Rimasta pressoché immutata, essa coincide infatti con la mappa particellare eseguita congiuntamente all’im pianto del Catasto Generale Toscano negli anni Trenta dell’Ottocento (Fig. 5) – momento in cui le particelle corrispondenti risultavano intestate ai fratelli Gaetano-Guglielmo e Girolamo Pazzi30
Mediante i rimandi vicendevoli fatti dalle denunce fiscali, la ricostruzione dei passaggi di proprietà dimostra allora il mantenimento ininterrotto dell’immobile nella discendenza agnatizia del ramo dal Quattro all’Ottocento, confermando pertanto la perman enza dei Pazzi in quella precisa casa da cui il bassorilievo berlinese sarebbe stato dichiarato infine proveniente 31
Sulla scia di questi stessi documenti che valicano il Settecento, riemerge così anche l’identità della misteriosa «marchesa» ricordata da Bode, poiché alla morte di GaetanoGuglielmo (1859) fu sua moglie Eleonora, figlia del marchese Pietro Torrigiani, a ereditare il palazzo fino alla vendita alla Banca Nazionale (1865): un’identificazione sulla quale convergono peraltro alcuni scambi tra Bardini e Bode relativi al suo decesso32
Ricordata per una bellezza che spiazzò persino Stendhal e per una travagliata liaison con Vincenzo Salvagnoli ultimamente messa in luce33, con la marchesa Eleonora si aprono alcuni squarci filantropici degni di nota, come il lascito testamentario per il compimento della facciata di Santa Maria del Fiore – di cui rimane memore lo scudo partito con le armi Pazzi e Torrigiani sovrastante la bifora prospiciente il campanile (Fig. 6) – o quello per il restauro del tetto della Cappella Pazzi in Santa Croce, in conformità con le volontà del marito defunto 34. A tali lasciti si aggiunge la grande Galatea di Luca Giordano, depositata agli Uffizi contestualmente alla vendita del palazzo, e ceduta al museo nel 1897 dall’ultima figlia superstite (Fig. 7)35 .
30 ASFi, Catasto generale toscano, Mappe, Firenze, 67; Catasto generale toscano, Tavole indicative, Firenze, 3, c. 139r, sub nn. 24, 24bis e 25.
31 Dal 1495 alla vendita del 1865, i passaggi di proprietà sono i seguenti: ASFi, Decima repubblicana, 32 (1495), cc. 67r, 73r (Guglielmo e Giovanni di Antonio); Decima granducale, 3648, cc. 19v, 22r (Jacopo e Francesco di Antonio, 1532-1560) insieme a 3647, cc. 414r, 417r (Giovanni, Guglielmo e Cosimo di Alessandro, 1532-1560); 3647, cc. 502v-503r (Giovanni di Alessandro, 1560-1564) insieme a 3646, cc. 533v-534r (Cosimo di Alessandro, 1560-1594); 3648, cc. 281v-282r (Lorenzo, Pazzino, Raffaele e Francesco di Cosimo, 1594-1597); 3647, cc. 120v-121r (Francesco di Cosimo, 1597-1619); 3651, c. 13 (Idem, 1619); 3650, c. 20 (Alessandro e Pazzino di Francesco, 16191653), c. 51 (Alessandro di Francesco, 1653-1658); 3651, c. 56 (Francesco, Angelo, Antonio, Filippo e Guglielmo di Alessandro, 1658-1699), c. 71 (Francesco di Alessandro, 1699-1714); 3653, c. 141 (Idem , 1714-1719), c. 258 (Andrea, Giovanni-Cosimo e Angelo di Francesco, 1719-1726), c. 295 (Giovanni-Cosimo e Angelo di Francesco, 1726-1746), c. 374 (Giovanni-Cosimo di Francesco, 1746-1774), c. 488 (Francesco-Alamanno e Andrea-Pazzino di Giovanni-Cosimo, 1774-1776); Catasto lorenese, 7, pp. 2846-2850 (Idem, 1776); 16, c. 664 (Idem, 1776-1782); 20, c. 1748 (Francesco-Alamanno di Giovanni-Cosimo, 1782-1808); 27, c. 3733 (Idem, 1808-1822); 32, c. 4822 (Idem, 1822), c. 4824 (Gaetano-Guglielmo e Girolamo di Francesco-Alamanno, 1822-1832); 148, c. 4519 (Idem, 18321848); Catasto generale toscano, Firenze, Campioni, 21, C.4655 ( Idem, 1832-1848); Suppl. (serie I), 17, C.5101 (Gaetano-Guglielmo di Francesco-Alamanno, 1848-1851); 20, C.5994 (Idem, 1851-1860); 35, C.10448 (Eleonora Torrigiani-Pazzi, 1860-1865); 43, C.12815 (Banca Nazionale, 1865-1875).
32 «[…] la vecchia Pazzi, morta 2 anni sono, era l’ ultima del nome Pazzi?» (ASEB, Corrispondenza, 1886, 1, Corr.I.B.16 [Bode a Bardini, 1° agosto 1886]). Si veda anche infra, nota 39.
33 Per i ricordi di Stendhal (in La vie de Henry Brulard e Rome, Naples et Florence) si veda BOTTACIN 2005, p. 171, nota 83. Per la relazione con Salvagnoli si vedano CONTINI 2004 e BELLUCCI 2008, pp. 139-159.
34 Si vedano le disposizioni testamentarie in ASFi, Notarile postunitario, atti originali, 6041 (Pellegrino Niccoli), fasc. 3248 (28 aprile 1881). Documenti riguardanti i due legati di 10.000 lire ciascuno si trovano anche in AOSMF, serie XIII, 1, 99, ins. 6, e AOSC, reg. 77, fasc. Restauro cappella Pazzi, ins. Legato della fu Marchesa Eleonora Torrigiani vedova De Pazzi. Per il testamento di Gaetano-Guglielmo si veda ASFi, Notarile moderno, Testamenti segreti pubblicati, 40, fasc. 35 (Luca Piccioli, 9 marzo 1846).
35 Per l’acquisto si veda ASGF, 1897, Galleria degli Uffizi, fasc. 6. Sebbene il deposito del 1865 non sia specificamente documentato, se ne scorgono richiami in queste stesse carte (ASGF, 1897, Galleria degli Uffizi, fasc. 6, docc. 2, 4, 7). A indurre le Gallerie all’acquisto (tanto da avvalersi del diritto di prelazione) fu la richiesta degli eredi Pazzi di recuperare il dipinto in seguito a una proposta avuta da Domenico Magno: agente tanto palese di Bardini da spingere le Gallerie a «far giudizio che questi è il vero acquirente, [nel margine:] come già lo fu della vasca di Donatello di proprietà de’ suddetti eredi che pure era stata depositata nel Museo Nazionale» (ASGF, 1897,
Sempre alla marchesa riconducono infine le vicende della fontana del Metropolitan Museum of Art di New York oggi attribuita ad Antonio Rossellino con l’aiuto di Benedetto da Maiano: non a caso segnalata nel giardino di Guglielmo Pazzi nel Memoriale di Albertini (1510), prima di essere segnalata di nuovo da Le bellezze presso un ramo collaterale, in seguito a una momentanea suddivisione dello stesso giardino (Fig. 8)36. In occasione della Mostra del Medio Evo allestita nel fatidico anno 1865, fu la marchesa a depositarla «sua vita natural durante» al Bargello37 – probabilmente già mutila del suo fusto centrale, oggi disperso ma brevemente ricomparso al suo fianco per l’Esposizione donatelliana del 1887, quando fu prestato dall’artistaantiquario Fosco Tricca38
Dopo la morte della marchesa non meraviglia dunque trovare Bardini prontamente impegnato già con questa fontana in operazioni di compravendita, a cui rimandano i vani tentativi per allettare Bode, nonché la decisione degli eredi di cessarne il deposito al Bargello39 Giunta nelle mani dell’antiquario, fu presentata all’Exposition Universelle di Parigi (1900), prima di essere inserita nel Catalogo degli oggetti di sommo pregio per la tutela del patrimonio che ne bloccava l’esportazione dall’Italia40. Fu soltanto con l’allentamento di tali restrizioni che la fontana poté essere spedita a Parigi nell’estate del 1912, previe sfiancanti trattative con l’antiquario Jacques Seligmann, mediante il quale raggiunse lo sfarzoso appartamento dei coniugi Blumenthal a New York e, con il loro lascito, il Metropolitan Museum of Art (1941)41.
Galleria degli Uffizi, fasc. 6, doc. 2 [Enrico Ridolfi, direttore delle Gallerie, a Emanuele Gianturco, ministro della Pubblica Istruzione, 3 giugno 1897]).
36 ALBERTINI 1510, c. 4r; BOCCHI/CINELLI 1677, p. 368. Sull’ambiguità semantica del passo di Albertini, sanata su un apografo che ristabilisce l’appartenenza della fontana ai Pazzi anziché ai Medici, si veda CAGLIOTI 2000, I, p. 377, nota 87. Per la più ampia trattazione dei problemi formali della fontana Pazzi, anche in rapporto a quella medicea, si veda CAGLIOTI 2003. Per la proprietà della fontana a partire dal Seicento si vedano ASFi, Famiglie, Pazzi, 126 (Filza IV. Liti, querele, accuse ecc.), fasc. L 119 (Questione sulla divisione della casa di Borgo degli Albizzi fra i fratelli Lorenzo e Francesco di Cosimo de’ Pazzi ), p.n.n., nonché un atto redatto dopo la morte di Gaetano-Guglielmo in cui si proibisce la vendita del «palazzo con giardino annessi, compresa la tazza di Donatello esistente nel giardino» (ASFi, Notarile postunitario, atti originali, 5386 [Egidio Fabbrichesi], p.n.n. [20 giugno 1860]).
37 Due esemplari dell’atto di deposito si trovano in AB, filza 6, fasc. 254 ( Mostra Centenario di Dante 1865 ), scheda di deposito n. 5 (5 novembre 1865), e ASGF, 1890, Gallerie e Musei, fasc. 91 (5 novembre 1865), in cui l’opera viene descritta come «1 tazza di marmo bianco con suo imbasamento decorata nella parte esterna con bassirilievi di putti intrecciati con ornati, ritenuta opera di Donatello. Nella parte superiore del suddetto imbasamento vi si vedono tre stemmi della famiglia Pazzi».
38 ESPOSIZIONE DONATELLIANA 1887, p. 45. Sulla base dei reperti, un’illustrazione ricostitutiva era già stata proposta da Ettore Sampaolo nel 1883, per cui si veda GENTILINI 1994, pp. 183 (fig. 128), 186. È tuttavia possibile che, avvantaggiandosi dello smantellamento immobiliare, l’asporto del fusto fosse già avvenuto nel 1865, come suggerisce la descrizione del resto dell’opera nell’atto di deposito (si veda supra, nota 37). Al momento del prestito di Tricca, è comunque chiaro come se ne fosse persa memoria certa, considerato il legame ipotetico istituito allora con la fontana: «Un nodo in marmo supposto far parte della tazza di Donatello esistente nel R. Museo Nazionale in Firenze» (AB, cartella 5 [Calchi e mostra donatelliana], ricevuta di prestito n. 5 [19 aprile 1887]; il corsivo nella citazione è mio).
39 «È morta la Marchesa Pazzi e ora si potrà comprare la vasca di Donatello che è al Bargello, prego rispondermi in proposito» (SMB-ZA, IV-NL Bode, I, fasc. 7 [Bardini a Bode, 1° gennaio 1885]); «Richiamo la Sua attenzione sopra la vasca di Donatello appartenente agli eredi Pazzi che trovasi nel Bargello, con i quali eredi ho fatto un contratto per vendergliela e la propongo a Lei prima che ad altri» (SMB-ZA, IV-NL Bode, II, fasc. 2 [Bardini a Bode, 31 marzo 1888]). Per la rimozione dal cortile del Bargello si veda ASGF, 1890, Gallerie e Musei, fasc. 91 (8 luglio 1890).
40 Del passaggio parigino rimangono la richiesta di esportazione in ASGF, 1900, Ufficio Esportazione, fasc. 3 (9, 18 giugno 1900), e due scatti dell’allestimento editi in COLLECTION BARDINI 1902, pp.n.nn. Va quindi corretta la confusione di Fabriczy, che segnalava la vendita della vasca in Inghilterra nel 1890 (FABRICZY 1891, p. 24, nota 44). Per il divieto di esportazione si veda CATALOGO 1903, p. 5679 (31 dicembre 1903), con relative disposizioni previste dalla legge 242 (27 giugno 1903; cfr. LEGGI E DECRETI 1903). Al termine dei due anni stabiliti per il blocco, la legge venne poi annualmente prorogata quattro volte (25 giugno 1905 [L. 260], 30 dicembre 1906 [L. 642], 14 luglio 1907 [L. 500], 2 luglio 1908 [L. 396]).
41 Su questo triangolo, durato dal gennaio 1911 all’agosto 1912, si veda AMCF, Fondo Bardini, Corrispondenza B, 1911, c. 55; Corrispondenza S, 1911, cc. 638-644; Corrispondenza S, 1912, c. 58, e ASEB, Copialettere, 30, cc. 458, 482, 492, 499500; 31, cc. 28-29; 32, cc. 165, 169, 184-186, 235, 244, 252, 269-270, 362, 369, 371-373, 402, 419. Si veda inoltre la licenza di esportazione in Ufficio Esportazione di Firenze, Licenze di Esportazione di Oggetti d’Arte Antica, 1912, ins. 1 (1° luglio
Richiudendo lo scorcio collezionistico apertosi con la marchesa Eleonora, si richiudono anche i risvolti della tradizione ottocentesca. Lungo la linea spazio-temporale che la casa Pazzi dispiega per cinque secoli, rimarrebbe quindi da appuntare l’ultima notizia vagante, giunta autonomamente con Le bellezze quando segnalavano in casa di un tale «Francesco» la presenza di un bassorilievo di marmo raffigurante una Madonna col Bambino.
Per capire quanta aderenza possa trovare il resoconto della guida con la situazione immobiliare fin qui esaminata, occorre ricordare i due momenti redazionali che contraddistinguono il testo. Nonostante la pionieristica edizione di Francesco Bocchi (1591), a fare da manuale fu infatti la seconda (1677), in cui il testo cinquecentesco, trapiantato in corsivo, venne abbondantemente accresciuto con le aggiunte di Giovanni Cinelli, inserite in tondo. Mantenendo così intatti i rapporti genetici, tale espediente tipografico, seppure accessorio, non è innocuo, poiché è esso a indicarci che Bocchi in casa di Francesco Pazzi non entrò mai.
Slittando quasi di un secolo, questo minuto accorgimento posticipa i termini cronologici entro i quali individuare il legittimo esponente, vieppiù grazie agli indizi circostanziali forniti da Cinelli, stando al quale il bassorilievo era disceso per divisa patrimoniale tra un «Pazzino» e un «Alessandro», padre del nostro Francesco. Tali discriminanti consentono allora di isolare una volta per tutte il Francesco (1649-1719) figlio di Alessandro e nipote ex fratre di Pazzino42 . Ma soprattutto di ravvisare il suo nome tra i proprietari del palazzo di Borgo degli Albizi 43 .
Appurato quindi che la casa di Francesco Pazzi in cui Cinelli descriveva un bassorilievo donatelliano è la stessa che pervenne poi fino alla proprietaria del bassorilievo berlinese, è possibile sottoporre queste premesse a un’ultima verifica, di natura inversa, in modo da vedere cosa davvero contenevano le mura di quel palazzo, e se la corrispondenza sia altrettanto valida per le due opere.
Mobili e inventari (secoli XVII-XIX)
Opache circostanze avvolgono la storia dell’archivio Pazzi-Saminiati. Custodito per secoli in una stanza sovrastante la sagrestia della cappella dei Pazzi in Santa Croce, la richiesta di sgombero fatta dai frati nel 1923 rappresentò sicuramente un innesco fatale per l’integrità del fondo44. In meno di un ventennio, misteriose operazioni di smistamento portarono infatti alla manomissione e alla dispersione dei registri, come si evince dalle poche scritture amministrative relative ai nuclei acquistati dall’Archivio di Stato di Firenze e dall’Università Bocconi di Milano 45
1912). Oltre a COLLECTION BLUMENTHAL 1926-1930, II (1926), tav. LXVIII, suggestivi scatti d’interno che mostrano la fontana sono conservati alla Thomas J. Watson Library, Rare Books, coll. B1683771, nn. 6, 8, 10, 12.
42 LITTA 1851, tav. X, le cui date vanno spesso sanate con quelle più accurate dell’albero genealogico edito in GROPPI 1990, quando non direttamente con quelle dei registri dei battesimi, delle sepolture o delle Tratte.
43 Si veda supra, nota 31.
44 AOSC, Libro verbali. Adunanze della Deputazione, p. 19 (12 marzo 1923).
45 Sebbene una piccola parte del fondo fosse già stata acquistata dalla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze per conto del Museo Horne nel novembre 1930, l’archivio familiare venne propriamente scisso da Cosimo di Pazzino Pazzi nel 1939, vendendo la metà più cospicua come carta da macero a Francesco Puccini (rappresentante della cartiera Donzelli). Avutane notizia, il Ministero vincolò il fondo (gennaio 1940), ingiungendo il deposito di ambo i nuclei presso l’Archivio di Stato di Firenze, in attesa che lo Stato procedesse all’acquisto. Dopo un ultimo acquisto parziale per il Museo Horne (aprile e marzo 1940), il nucleo rimasto nella cappella raggiunse quindi l’archivio fiorentino (marzo 1941). Il nucleo della cartiera, a seguito della rinuncia dello Stato, fu venduto da Puccini al professor Brunetto Fanelli e rivenduto all’archivio bocconiano (giugno 1941), che acquistò infine anche la parte custodita al Museo Horne (maggio 1953). Per queste vicende si vedano ASABTos, Archivi di Famiglia e Persona, Privati extraregionali vari [O-R], fasc. Archivio Pazzi-Sanminiati-Strozzi, e ASBOC, Buste AB, 103/2.5.2 (Archivio Samminiati Pazzi Strozzi). Ulteriori asportazioni avvenute in parallelo sono comunque dimostrate dalla presenza di alcune carte del fondo sul mercato antiquario.
A dispetto del più studiato e consistente nucleo lombardo, tra le 272 unità rimaste a soqquadro e in attesa d’indicizzazione a Firenze sussiste un volume di cartapecora bianca contenente una raccolta d’inventari redatti tra il 1610 e il 172446 . Estranei all’arco cronologico segnato in costola al registro in cui sono collocati, questi inventari aprono un’inaspettata panoramica trasversale, non solo perché si riferiscono a due degli immobili Pazzi sui quattro ricordati nell’itinerario di Cinelli, ma perché consentono, abbracciando tre generazioni, di ricavarne lo spaccato coevo a Cinelli stesso. Salvo per gli inventari di Alamanno di Girolamo (1648-1735) e Luigi di Cosimo (1629-1700), confluiti per via ereditaria nell’archivio Rucellai47 , è dunque possibile perlustrare, quasi in simultanea con l’autore de Le bellezze, sia la casa dei fratelli Lorenzo, Francesco e Clemente di Cosimo48 , sia quella del nostro Francesco di Alessandro 49
Lineare ma ristretta, la visuale offerta da questa raccolta non consente ovviamente un ragguaglio sistematico per ogni bene, tale da seguirne gli spostamenti o le permanenze all’interno degli spazi domestici da un passaggio di eredità all’altro. Da questi spaccati patrimoniali, insieme agli apporti collaterali emergono altrettanti silenzi, sintomi di vendite o dislocamenti, se non insolubili ‘vizi’ formali – quali semplificazioni o raggruppamenti in nuovi insiemi –, riscontrabili in alcune entrate non più testualmente concordi tra loro, ma non per questo diverse nella sostanza.
Ferme restando, insomma, le limitazioni inerenti a questa tipologia documentaria, non può passare inosservata la presenza di una «Madonna di basso rilievo» segnalata alla morte del padre Alessandro (1658) e di cui spicca soprattutto la stima sbalorditiva di 70 fiorini (pari a quasi 500 lire), tanto da farne il bene più quotato del palazzo50 . A confermarne l’eccezionalità, è proprio un documento preliminare alle divise con il fratello Pazzino, nel quale l’opera, già da entrambi riconosciuta di Donatello, veniva espressamente mantenuta indivisa ancora nel 1653, in attesa degli assegnamenti definitivi sui quali verrà correttamente informato Cinelli 51 . A liti concluse, infatti, il bassorilievo sarà doverosamente rinvenuto tra i beni di Francesco (1720), individuabile nel «quadro di marmo, éntrovi la Madonna con Gesù bambino con adornamento tutto intagliato e dorato»52 .
46 ASFi, Famiglie, Pazzi, 144 (Conti e ricevute dal 1867 al 1868), fasc. Inventari della Casa
47 AR, serie III (Patrimoni diversi), n. 15, ins. 16, cc. 77r-86r (beni di Girolamo di Piero, 24 settembre 1649); ins. 22, cc. 112r-119v (Idem, 30 giugno 1653); ins. 60, cc. 343r-363v (beni di Luigi di Cosimo, 19 maggio 1700). Per questi due altri rami della famiglia si veda LITTA 1851, rispettivamente tavv. V e IV (con l’errato sdoppiamento di Luigi a tav. X).
48 Per i beni del palazzo di Firenze si veda ASFi, Famiglie, Pazzi, 144 (Conti e ricevute dal 1867 al 1868), fasc. Inventari della Casa, cc. 106r-110r (beni di Cosimo di Lorenzo, 11 luglio 1657).
49 Per i beni del palazzo di Firenze si veda ASFi, Famiglie, Pazzi, 144 (Conti e ricevute dal 1867 al 1868), fasc. Inventari della Casa, cc. 128r-130r (beni consegnati ad Alessandro di Francesco dalla suocera Caterina Dassi, 6 agosto 1649, 7 settembre 1650, 24 maggio 1651, 11 settembre 1653), 96r-97r (beni di Alessandro di Francesco, 17 settembre 1658), 82r-v (beni di Francesco di Alessandro ricevuti dalla madre Lucrezia Dassi, agosto 1675), 66r-67v (beni di Francesco di Alessandro e fratelli, 31 ottobre 1695), 28r-37v (beni di Francesco di Alessandro, 8 gennaio 1720), pp. 1-7 (beni degli eredi di Francesco di Alessandro, 20 novembre 1723).
50 ASFi, Famiglie, Pazzi, 144 (Conti e ricevute dal 1867 al 1868), fasc. Inventari della Casa, c. 96v (beni di Alessandro di Francesco, 17 settembre 1658). Il bassorilievo ricomparirà tra i beni lasciati dalla vedova Lucrezia Dassi ai figli (cfr. ASFi, Famiglie, Pazzi, 109 [Amministrazione interna. Filza VI], fasc. S 294, p.n.n. [8 novembre 1674]). Merita inoltre sottolineare la curiosa somiglianza tra la cifra della stima inventariale del 1658, equivalente a lire 490, e quella riportata da Cinelli di scudi 500, possibilmente frutto di un arrotondamento e di una svista di valuta (per la base 1 fiorino = 7 lire nel Seicento, si veda GOLDTHWAITE 2009, tav. A.1, p. 613).
51 «Appresso diachiarorno, e dichiarano, detti Sig.ri fratelli de’ Pazzi come fra di loro resta in comune, e per indivisa, un’immagine della santissima Vergine in marmo di basso rilievo, di mano, come dissero concordemente, del Donatello. La qual’imagine, convennero, e convengono, che per detto Sig. capitano Alessandro si deva consegnare al Sig. Giannozzo Dondori lor amico comune, per tenersi e conservarsi dal medesimo Sig. Dondori a dispositione d’ambi detti Sig.ri fratelli de’ Pazzi, e fin tanto che tra di loro in qualsivoglia modo si aggiustino in questo capo ancora» (ASFi, Famiglie, Pazzi, 107 [Amministrazione interna. Filza IV], fasc. S 188 [Contratto di divise in fra Pazzino e Sig. Alessandro], pp. 142-143 [17 ottobre 1653]).
52 ASFi, Famiglie, Pazzi, 144 (Conti e ricevute dal 1867 al 1868), fasc. Inventari della Casa, c. 32r-v (beni di Francesco di Alessandro, 8 gennaio 1720).
Sebbene il periodo ricoperto dalla raccolta non consenta alcun riscontro per le generazioni successive, la lacuna viene sanata da un altro registro del fondo, contenente l’inventario steso dopo la morte di Giovanni-Cosimo di Francesco (1773), in cui l’opera ricompare più ampiamente descritta come «un quadro di marmo bianco intagliato a basso rilievo, guasto, con ornamento antico intagliato e dorato, rappresenta una Madonna col bambino, per tradizione dicesi di Donatello», suggestivamente ubicato nella cappella di casa 53. Un’ultima, stringata ricorrenza giunge dopo la morte del figlio Francesco-Alamanno (1821), padre del GaetanoGuglielmo che ne ereditò i beni (insieme al fratello Girolamo 54), fra i quali «un basso rilievo di marmo esprimente una Madonna con Gesù Bambino in collo, rotto in vari luoghi, e restaurato, sembra di Donatello, marcato di N° 42», il cui valore è ancora una volta ribadito dalla stima di oltre 133 lire (Fig. 9)55
Per quanto esile, costante è il filo che ricollega queste voci inventariali tra loro nei minimi termini, sia sul fronte locativo, tematico, materiale e tecnico, sia su quello valutativo indicato dalle stime. Tale collegamento è inoltre avvalorato dal fatto che le entrate soggette a questi comuni denominatori sono sempre e soltanto rappresentate da un’unica occorrenza all’interno di ogni singolo inventario, a scanso, dunque, di un doppione presente sincronicamente in palazzo.
Premesso dunque che l’opera che ricorre nella casa di Borgo degli Albizi dal Sei all’Ottocento è una sola – e quindi l’unica cui Cinelli poteva riferirsi in quel lasso di tempo –, sono le due ultime voci a suggerirne la corrispondenza con il marmo di Berlino.
Né sul retro né sui lati del bassorilievo compare oggi alcun numero d’inventario antico (Fig. 10)56. Ma la sua narrata provenienza dalla «Cappella della Casa Pazzi» e le molteplici fratture rilevabili nel marmo trovano una singolare coincidenza con quel bassorilievo precisamente inventariato nella cappella, così «guasto» da presentarsi «rotto in vari luoghi» – voce, quest’ultima, in cui si prospetta anche l’adeguamento alla stima di 200 lire, fatta con debita rivalutazione prima di vendere l’opera a Lamponi -Leopardi57.
Nello stesso inventario merita inoltre segnalare il «cassone da corredo rappresentante il Trionfo di David» insieme a un altro «rappresentante la caduta di Golia assai più danneggiato», entrambi creduti di Benedetto del Ghirlandaio e riconducibili a due tavole attribuite a Pesellino oggi a Londra (Figg. 11-12)58: due opere la cui provenienza Pazzi era stata finora solo tramandata sulla
53 ASFi, Famiglie, Pazzi, 100 (Filza di biglietti. N° 3), p.n.n. (beni di Giovanni-Cosimo di Francesco, 13 novembre 1773). Seppure frammentario, questo inventario è l’unico a presentare un dettato inequivocabile per questa opera rispetto alla sua versione completa (cfr. ASFi, Famiglie, Pazzi, 78 [Filza I. Sponsali, testamenti], fasc. N 27 [Pazzi. Testamento, codicilli ecc. del Commendatore Giovanni Cosimo de Pazzi], c. 38r [beni di Giovanni-Cosimo di Francesco, 13 novembre 1773]).
54 Benché i due fratelli rimanessero entrambi proprietari per indiviso del palazzo (si veda supra, nota 30), solo Gaetano-Guglielmo vi mantenne domicilio, per cui si vedano un chirografo in ASFi, Famiglie, Pazzi, 220 ( Sommario in copia delle divise patrimoniali De’ Pazzi -De’ Pazzi, 1821-1850), fasc. 32 (Chirografi e copie di chirografi ), allegato B (28 gennaio 1822), e un ristretto delle disposizioni prese dopo la morte del padre al fasc. 5 (23 dicembre 1826).
55 ASFi, Notarile moderno, atti originali, 16706 (Luigi Meucci), p.n.n. (beni di Francesco-Alamanno di GiovanniCosimo, ottobre 1821), sub n. 1205. L’effettiva stesura dell’inventario del palazzo (registrato il 12 luglio 1822) va collocata entro lo scadere del mese successivo alla morte di Francesco-Alamanno (20 settembre 1821), poiché vi compaiono ancora i beni che sarebbero stati rimossi dal palazzo e riportati nel fasc. Nota della mobilia che è stata levata in questo dì 30 ottobre 1821 , presente in ASFi, Famiglie, Pazzi, 128 ( Affari diversi del Sig. Cavaliere Guglielmo ). L’unica opera a superare la stima del bassorilievo (133 lire, 6 soldi, 8 denari) è la Galatea di Luca Giordano (400 lire).
56 Sono grato per la conferma a Bodo Buczynski che ha restaurato l’opera nel 2009.
57 Viene quindi da sfatare una volta per tutte l’informazione infondata secondo la quale l’opera sarebbe arrivata a Berlino frantumata in quattordici pezzi a seguito del trasporto (LISTA 2003, p. 54, ripresa da V. Krahn, scheda n. VIII.5, in LE PRINTEMPS DE LA RENAISSANCE 2013, p. 432). Attribuendo sempre le fratture a un trasferimento, più cauto rimase POPE-HENNESSY 1993, p. 254 («there is no means of establishing whether this damage occurred when it was removed from the wall in the Palazzo Pazzi prior to its transport to Berlin or when it was transferred to the Palazzo Pazzi from whatever site it originally occupied »), che contava quindici frammenti. Per la stima si veda supra, nota 7.
58 ASFi, Notarile moderno, atti originali, 16706 (Luigi Meucci), p.n.n. (beni di Francesco-Alamanno di GiovanniCosimo, ottobre 1821), sub nn. 1157 e 1158. Si veda inoltre AMES-LEWIS 2000, p. 194.
base della presunta acquisizione presso questa famiglia da parte di Luigi Torrigiani, ma che si rafforza tanto più considerando che la sorella di Torrigiani era appunto la marchesa Eleonora Pazzi59
Furono infine sempre le mura dello stesso palazzo a ospitare per qualche decennio il busto di Antonio Rossellino raffigurante Giovanni Chellini (Fig. 13), lì acquistato dal futuro Victoria & Albert Museum nel 1860, in occasione della vendita successoria avvenuta dopo la morte di Gaetano-Guglielmo l’anno precedente60. Già segnalato nel testamento del nipote erede di Chellini, Bartolomeo di Bartolomeo Saminiati (1438-1506), e in due inventari cinquecenteschi del ramo, il busto giungerà fino alla vedova di Ascanio di Francesco, Margherita della Gherardesca (1699-1778)61. Sancendo con la sua morte il completo passaggio del patrimonio Saminiati ai Pazzi, già in atto dagli anni Sessanta del Settecento, l’opera ricomparirà nell’inventario di divise di Francesco -Alamanno Pazzi (1781)62, per poi essere continuamente segnalata nel palazzo dalle guide ottocentesche63
Con l’ultimo rinvenimento inventariale del palazzo di Borgo degli Albizi prima della sua demolizione, si esauriscono le tracce che ricollegano il bassorilievo ai padroni di casa. Inutile si rivela purtroppo l’inventario redatto dopo la morte della marchesa Eleonora nel 1884, nonostante vi compaiano, oltre ai beni della casa in Borgo Pinti, pure quelli della villa di Arcetri 64 , ovvero quell’«abitazione in campagna» dove, a detta di Bardini, il bassorilievo venne trasferito nel 1865, restandovi fino alla morte della proprietaria 65 .
59 Nonostante il passaggio dai Pazzi ai Torrigiani sia ancora da indagare (in questo caso agevolato forse dalla morte di Gaetano-Guglielmo nel 1859), interessante diventa la svista di SCHUBRING 1915-1923, I (1915), pp 278-279, nn. 264-265, quando, ipotizzando per i due cassoni una provenienza Pazzi già nel Quattrocento, identificò la sposa raffigurata nel Trionfo con una «Eleonora Pazzi» stranamente consona con la marchesa da cui proveniva l’opera, e da cui provenne senz’altro anche il qui pro quo. I cassoni (già segnalati in collezione Torrigiani da CROWE–CAVALCASELLE 1864-1866, II (1864), pp. 366-367) compariranno poi nell’inventario steso dopo la morte del marchese Luigi (ATM, Torrigiani, 506, fasc. 1, p.n.n. [beni di Luigi di Pietro Torrigiani, 14 aprile 1869], sub nn. 50 e 52, per cui si veda la trascrizione completa in CATALUCCI 2014, pp. 137-143). Per la compravendita dei due cassoni (insieme ad altre opere della collezione Torrigiani) da parte di Bardini si veda BUDD–CATTERSON 2023. 60 ROBINSON 1862, pp 29-30, n. 7671, e LIGHTBOWN 1962-1963(1963), p. 15 e nota 1.
61 Per il testamento di Bartolomeo (già segnalato in GROPPI 1990, p. 34, nota 66) si veda ASBOC, Saminiati-Pazzi, reg. 844, ins. 10, c. 4v (9 marzo 1506), in cui si disponeva che «la testa del marmo di maestro Giovanni si habbi a tenere in decta casa [di Cosimo di Bartolomeo]». Per i due inventari si vedano le carte sciolte nel reg. 1056 (Inventari delle ville, e case di Firenze): il primo, molto frammentario, segnala «una testa di mastro Giovanni» insieme a «una di Simone» (probabilmente il figlio di Bartolomeo di Bartolomeo); l’altro, che segnala il busto di Giovanni Chellini con lo stesso dettato, riconosce invece nel secondo busto «una testa di Bartolomeo [di Bartolomeo]» (beni di Francesco di Simone, s.d.). Per l’inventario di Margherita della Gherardesca si veda ASFi, Famiglie, Pazzi, 149 (Affari Sanminiati, Ghelardesca, Strozzi e Pazzi), fasc. Atti dell’inventario solenne dell’eredità Samminiati, p.n.n. (10 novembre 1778), sub n. 102. 62 ASFi, Famiglie, Pazzi, 155 (Filza II. Imprestiti, mutui, depositi, disdette ecc. ), p.n.n. (beni di Francesco-Alamanno di Giovanni-Cosimo, 7 settembre 1781), sub n. 181: «Quattro mensole colorite, e dorate con tre busti di marmo, che uno di Giovanni Chellini». Più laconico sarà l’inventario redatto alla sua morte, nel quale il busto rimane tuttavia reperibile all’interno della stessa stanza, nelle « Quattro basi di legno tinte a marmo, e in parte dorate, sopra le quali quattro busti, che tre di marmo, e uno di terra cotta» (ASFi, Notarile moderno, atti originali, 16706 [Luigi Meucci], p.n.n. [beni di Francesco-Alamanno di Giovanni-Cosimo, ottobre 1821], sub n. 367).
63 LIGHTBOWN 1962-1963(1963), pp. 16-17; THOUAR 1841: «Una tazza con piedistallo, scult. – Un busto in marmo» (ivi, p. 447); «Galatea» (ivi, p. 450). Se l’indice a fine volume raccoglieva già le tre opere in una generica casa Pazzi «in Borgo degli Albizzi» (ivi, p. 608), la conferma che si trattasse di una sola e stessa casa è data dalla guida GUIDA DI FIRENZE 1852: «Nel Palazzo Pazzi (N° 441), sono meritevoli di osservazione lo stemma della famiglia Pazzi, scolpito sulla facciata, la porta del giardino sulla Via dell’Orivolo, la fontana di granito nel giardino stesso, un busto in marmo di Donatello, e una Galatea dipinta da Luca Giordano» (ivi, p. 94). Come ulteriore indizio a favore di tale identificazione va aggiunto che, contestualmente alla partenza del busto Chellini per Londra nel 1860, nella revisione fatta lo stesso anno alla guida scompare definitivamente dal palazzo proprio il «busto in marmo» fin qui sempre ricordato dalle edizioni precedenti (1852, 18542, 1858 3), cfr. GUIDA DI FIRENZE 1860, p. 134 (con il civico erroneamente segnalato come «841»).
64 Per l’inventario si veda ASFi, Notarile postunitario, atti originali, 6041 (Pellegrino Niccoli), fasc. 3260 (7, 8, 12, 16, 19, 30 gennaio 1885 [Borgo Pinti]; 20 marzo 1885 [Villa Montebello, Arcetri]).
65 Si veda supra, nota 7. La casa di Borgo Pinti fu acquistata nel 1866 (ASFi, Catasto generale toscano, Firenze, Suppl. [serie I], 38, C.11270; 46, C.13787), la villa di Arcetri nel 1859 (ASFi, Aggiornamento del catasto, Arroti di
Un’occhiata alla tempistica dei documenti induce però anche ad accettare questo silenzio, in quanto la travagliata inventariazione in Borgo Pinti, estesasi fino a tutto gennaio 1885, rimandò di conseguenza quella ad Arcetri al 20 marzo. Stando alla notizia giunta dall’antiquario nemmeno sette settimane dopo – da cui si evince che Lamponi-Leopardi aveva già visto e acquistato il bassorilievo, avviato le trattative per la sua rivendita e predisposto la sua formatura in gesso66 –, diventa allora predominante l’ipotesi che il marmo abbia lasciato Arcetri prima della stesura. Pur sfuggendo all’ultimo inventario di famiglia, e in attesa di documenti che ne definiscano il percorso nel Quattro e Cinquecento, la Madonna di Berlino ricevette dai Pazzi, se non il nome dei suoi committenti, quantomeno quello dei suoi custodi più duraturi: un dato di fatto che si staglia nella trama patrimoniale qui ripercorsa, alla quale si riallaccia ogni singola testimonianza rilasciata s ul marmo nell’Ottocento.
A fronte di tali circostanze, non rimane dunque che sdrammatizzare il divario iconografico, accennato nell’introduzione, tra la nostra opera e quella descritta da Cinelli. Nel rovesciamento speculare delle mani della Vergine affiora (oltre che un falso problema 67) un banale refuso ecfrastico, attribuibile all’ossessiva tendenza a contraddistinguere sinistra e destra, di cui il bassorilievo non fu d’altronde l’unica vittima 68. Esito collaterale ma sintomatico di un’esperienza che non veniva sempre appuntata in loco, ma in buona parte affidata poi alla memoria, e ai suoi inganni.
Con questa stessa ottica va altresì riconsiderato l’avvistamento del guanciale, causato da una cattiva lettura dei panneggiamenti, come già suggeriva Pope-Hennessy69, se non dal vertiginoso scorcio della mano sinistra della Vergine, tale da spiegare perché l’unica sua mano che il forestiero riuscì a individuare fu proprio e solo la destra.
Con buona pace di queste sviste, suona quasi premonitorio il disappunto di LamponiLeopardi quando, a ricezione del saldo di 13.113 lire, fece superstiziosamente presente a Bardini quanta sfortuna potevano arrecare quei numeri 70. Malgrado i dissensi che da lì a poco avrebbe infatti provocato la tradizione storica della Madonna Pazzi , i suoi testimoni si rifacevano a una vicenda familiare articolatissima, per quanto a loro sfuggente: una vicenda sulla quale difficilmente Cavallucci, Bardini e Bode si sarebbero dimostrati così concordi, se non attingendo dal vero.
voltura, Galluzzo, 27, arroto n. 65 ), andando poi in eredità ai nipoti De’ Rossi nel 1885 ( ASFi, Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Firenze, Atti del catasto fabbricati, Volture del Comune poi Distretto di Firenze, 1885, 4, arroto n. 782 ).
66 «Per ora nulla di nuovo. Dal Lamponi avrò il gesso, e il marmo non lo cede a meno di 50.000, <avrò> il gesso a condizione di rinviarlo, ma Ella troverà il modo di ritenerlo» (ASEB, Copialettere, 1, c. 480 [Bardini a Bode, 7 maggio 1885]).
67 Nella fattispecie, il reato di Cinelli sta nell’aver formulato una mezza verità più che un controsenso, dal momento che va riconosciuto che la mano con cui «la Vergine il sostiene» (cfr. supra, p. 27) è per forza anche la destra (seppure non soltanto).
68 Si veda l’inversione fatta da Cinelli per i due affreschi laterali con le Nozze di Cana e la Cena in Emmaus nel refettorio di Santo Spirito (BOCCHI/CINELLI 1677, pp. 150-151).
69 POPE-HENNESSY 1976, p. 172, nota 4.
70 «Non debbo nasconderle che i due 13 che si riscontrano nelle somme ricevute, temo che mi portino jettatura (rida pure) e per questo sarebbe stato meglio mi avesse mandato sue 14.000» (ASEB, Corrispondenza, 1886, 3, Corr.III.L.a.26 [Lamponi-Leopardi a Bardini, 22 settembre 1886]).
205/0#/ %&)&< &);&-
$"$!#.!:/ %&)36 &;&+-
205/0#/ %&)+) &;<'-
D28/4/ %&;(+ &;3;71208.98/ %&;(' &;)'-
4#.51/
!"##$%$&'$%(&)&%'$ %&663 &'),-
!"#$#
%&'() &'+,.!./0/12 %&'(3 &'')-
$"$!#.!:#0/ ,&--$
20>1.2 %@AB&36( &));$#/=200# %&)3, &),;-
2!.9920>1/ %&)')*@AB&;3(-
$#/=200# %&;&( &;+)-
!/1.0C/ %&;;& &+<3-
8/9#:/ %&;', &+;<-
4#.1/ %&)&+ &)+)-
71208.98/ %&)); &)6'-
D28/4/ %&)<3 &)6'-
8/9#:/ %&;&) &;,)-
2!.9920>1/ %&+&) &+;'71208.98/ %&;;, &+&,-
42CC#0/ %&+&+ &+6'-
!/1.0C/ %&+)< &+')71208.98/ %&+)+ &+6,8!.:.05. %&+), &+6'-
$#/=200# 8/9#:/ %&6(+ &66371208.98/ %&+), &6&,$#1/!2:/ %&6'6 &')'-
71208.98/*2!2:200/ %&6;) &'<&-
$2.520/*$"$!#.!:/ %&6'< &';,-
29820#/ %&+6' &6;'-
:21#2B82::#!!2 %&6<' &6+<-
$"$!#.!:/ %&'<6 &'6,:2>>2!.02 %&'<3 &''<2>1#202 %&'<+ &')3=#55/1#2 %&'<; &'63-
71208.98/ %&+)( &6(<29820#/ *&+$'$&!$ %&;,' &+'3⚭ &')' ⚭ &6;& ⚭ &'<<
42CC#0/ %&')' &,(&-
8/9#:/ %&'6+ &,;(-
01"&2%#$3$&4&$22%#$3$5&3"&'-$*,,-&.-//% 4&"3614&%7414&8$&("2$93$"
!$9<&=5&>%?"6433%@& '-$*,,-&.-//%@&=+-- A"@&B+@/CB)CD@/ A2@& 2"12%<& E413$?%@&E%84 GHI4H2@&$?J<&/=<& !%6%5&K&L6""63$AM4&GHI44?&NH&E413$?@&LOH376H14?I"223H?9&H?8&GHI4H2&(P1&EQN"?6$?$IAM4&RH?I6&,& S?6T4&U%$96
!"#$%&$%&'()*+*,"( )+,-.-/
Fig. 2: Xilografia della Madonna Pazzi (in Camillo Jacopo Cavallucci, Vita ed opere del Donatello, MilanoNapoli - Pisa 1886, p. 33)
Fig. 3: Luca e Andrea della Robbia, tondo con l’arme Pazzi, 1460 ca, 160 cm (diametro), terracotta invetriata (con inserti lignei non originali) Firenze, Palazzo Serristori. Foto: © Fabio Gaffo
Fig. 4: Apollonio di Giovanni, interno di coperchio di cassone con le armi Pazzi e Borromei, 1463, 53,7x182,9 cm, tempera su tavola. Bloomington, Eskenazi Museum of Art, inv. 75.37. Foto: © Eskenazi Museum of Art / Kevin Montague
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 6: Scudo con l’arme Pazzi-Torrigiani, 1881 ca, marmo. Firenze, Santa Maria del Fiore (facciata sud). Foto: © Opera di Santa Maria del Fiore / Alberto Conti
Fig. 7: Luca Giordano, Trionfo di Galatea, 1675 ca, 262x305 cm, olio su tela. Firenze, Palazzo Pitti, inv. 1890, n. 2218. Foto: © Serge Domingie & Marco Rabatti / LA COLLECTION
Fig. 8: Antonio Rossellino e Benedetto da Maiano, Fontana Pazzi, 1470 ca, 115,6(altezza)x169,5(diametro) cm, marmo. New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 41.190.471. Foto: © The Metropolitan Museum of Art, New York (lascito di George Blumenthal, 1941)
Studi di Memofonte 34/2025
Studi di Memofonte
Fig. 9: Notarile moderno, atti originali, 16706 (Luigi Meucci), p.n.n. (beni di Francesco-Alamanno di Giovanni-Cosimo Pazzi, ottobre 1821) Firenze, Archivio di Stato Foto: © Fabio Gaffo
!"#$%&'()($*$(%%&'()(+$)#$!"#$%%"&'"(() *$#),"*$&-*"*$.($/#%(0)(#
9(0:$;7+$<&=#,*))&>$!"#$%%"&'"(() ?"*,"&@>$;266 A#>$32>8B34BC>8$A%>$%#"%&:$D*")(=&>$D&.* FGH*G%>$(=I:$8;:$ 9&,&+$J$K,##,)(AL*$FGH**=$MG$D*")(=>$ KNG)-,G"*=H#%%)G=0$G=.$FGH*G%$/O"$DPM#=,(=(HAL*$QG=H,$5$ R=,S*$T&(0,
*+,#)&#)&!-.$/$%+- 4256768
!$01&223&!4"56786%&9787::$5%;& !"*-%(&$%&./0%$&(&1*2%/ <(4%5=7&>$&6"88%57?;&2)/-&6";&)/;/@2AB;-&6C;&=7CD74"&8E&="F%:"1& G%5>4";&H"=$%5":&'"::74I;&$5F1&J/AB1& !%=%3&K&LM7&H"=$%5":&'"::74I;&G%5>4"&<"6NE$8="="&6%:&8%8=705%&>7::OP4=&!E5>&7& >$F748$&:"86$=$&=78="C75="4$ ;&-...?
!$01&2-3&!4"56786%&9787::$5%;& 3-%*,+*&$%&./0%$ <(4%5=7&>$&6"88%57?;&2)/-&6";&)+;+@2AA&6C;&=7CD74"&8E&="F%:"1& G%5>4";&H"=$%5":&'"::74I;&$5F1&J/*.1&
!%=%3&K&LM7&H"=$%5":&'"::74I;&G%5>4"&<"6NE$8="="&6%:&8%8=705%&>7::OP4=&!E5>&7& >$F748$&:"86$=$&=78="C75="4$ ;&-...?
Fig. 13: Antonio Rossellino, Busto di Giovanni Chellini, 1456, 51,1x57,6x29,6 cm, marmo. Londra, Victoria & Albert Museum, inv. 7671-1861. Foto: © Victoria and Albert Museum, Londra
APPENDICE
Proposta ricostitutiva dei passaggi di proprietà attorno alla corte dei Pazzi durante il Quattrocento (fonte: catasti del 1427, 1442, 1458, 1480, Decima repubblicana del 1495)
DI CATELLINO INFANGATI
DI VIERI GUADAGNI
BORGODEGLIALBIZI
GIOVANNI
BERNARDO
ANTONIO
OTTAVIANO
RINALDO DI MASO ALBIZI
EREDI DI GIOVANNI DI JACOPO BUONAFÉ e GIOVANNI DI RINIERI BUONAFÉ (Albergo della Corona)
1442
SANTA MARIA NUOVA
ANTONIO DI ANDREA PAZZI
ALAMANNO e GERI DI POLDO PAZZI
ANTONIO DI ANDREA PAZZI
LUIGI e TEGLIAIO DI GHINOZZO PAZZI
ZANOBI DI LANCILLOTTO DA LUTIANO
ALAMANNO e GERI DI POLDO PAZZI
BORGODEGLIALBIZI CORTE
ANTONIO DI ANDREA PAZZI BERNARDO e GIOVANNI DI FILIPPO TANAGLI
SANTA MARIA NUOVA
GEROZZO DI PIERO GERINI
LEONARDO DI ANDREA BOCCHI
1458
ANTONIO DI GIOVANNI CARSIDONI, GUGLIELMO DI GHERARDO CORTIGIANI, MAURO DI ROBERTO ADIMARI e GIOVANNI DI RINIERI BUONAFÉ (Albergo della Corona)
ZANOBI DI LANCILLOTTO DA LUTIANO
GUGLIELMO, GIOVANNI e FRANCESCO DI ANTONIO PAZZI
BORGODEGLIALBIZI CORTE
GUGLIELMO, GIOVANNI e FRANCESCO DI ANTONIO PAZZI
EREDI DI BERNARDO e GIOVANNI DI FILIPPO TANAGLI
LUCANTONIO DI NICCOLÒ ALBIZI
LUIGI e TEGLIAIO DI GHINOZZO PAZZI
ANDREA DI GEROZZO GERINI
LORENZO DI LEONARDO BOCCHI
LUCANTONIO DI NICCOLÒ ALBIZI
SANTA MARIA NUOVA
1480
DI LEONARDO BOCCHI ALESSANDRO e GIOVANNI DI GUGLIELMO CORTIGIANI
FRANCESCO DI LUIGI PAZZI
e BENEDETTO DI ROBERTO ADIMARI
DI GEROZZO GERINI GIROLAMO DI FRANCESCO DELLA
DI BERNARDO TANAGLI GIROLAMO DI FRANCESCO PAZZI
GHERARDINI
PROPRIETÀ PAZZI ALIENATE DAL 1478
CORSINI
MAURO DI ROBERTO ADIMARI ALESSANDRO DI GUGLIELMO CORTIGIANI
GIROLAMO DI FRANCESCO DELLA ROSA GHERARDINI
1495 GUGLIELMO e GIOVANNI DI ANTONIO PAZZI
DI GHINOZZO PAZZI
PROPRIETÀ PAZZI ALIENATE DAL 1478
PROPRIETÀ PAZZI ALIENATE DAL 1478, RISCATTATE NEL 1495
ABBREVIAZIONI
AB Firenze, Archivio del Bargello
AMCF Firenze, Archivio dei Musei Civici Fiorentini
AOSC Firenze, Archivio dell’Opera di Santa Croce
AOSMF Firenze, Archivio dell’Opera di Santa Maria del Fiore
AR Firenze, Archivio Rucellai
ATM Pisa, Archivio Torrigiani-Malaspina
ASABTos Firenze, Archivio della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana
ASBOC Milano, Archivio Storico dell’Università Commerciale Luigi Bocconi
ASEB Firenze, Archivio Storico Eredità Bardini
ASGF Firenze, Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine
ASFi Firenze, Archivio di Stato
CPGNR Capitani di Parte Guelfa, Numeri Rossi
OGBR Otto di Guardia e Balìa della Repubblica
ASR Roma, Archivio di Stato
BNCF Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale
SMB-ZA Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, Zentralarchiv
BIBLIOGRAFIA
ALBERTINI 1510
F. ALBERTINI, Memoriale di molte statue et picture sono nella inclyta ciptà di Florentia […], Firenze 1510.
AMES-LEWIS 2000
F. AMES-LEWIS, Francesco Pesellino’s “Story of David” Panels in the National Gallery, London , «Biuletyn Historii Sztuki», LXII, 2000, pp. 189-203.
ANONIMO 1885
ANONIMO, Dialogo fra il Direttore e Uno dei Tanti , «Il Nuovo Osservatore Fiorentino», 1o marzo 1885, pp. 33-35.
ART AND LOVE 2008
Art and Love in Renaissance Italy, catalogo della mostra, a cura di A. Bayer, New York - New Haven - London 2008.
AVERY 1991
C. AVERY, Donatello. Catalogo completo delle opere , Firenze 1991.
BELLUCCI 2008
F. BELLUCCI, Donne e ceti fra romanticismo toscano e italiano. Le corrispondenti di penna con Vincenzo ed Antonio Salvagnoli, prefazione di S. Soldani, Pisa 2008.
BESCHREIBUNG 1888
Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epoche, a cura di W. Bode, H. von Tschudi, Berlino 1888.
BOCCHI/CINELLI 1677
G. BOCCHI, Le bellezze della città di Firenze […] (1591), testo ampliato e accresciuto da G. CINELLI, Firenze 1677.
BODE 1886
W. BODE, Neue Erwerbungen für die Abteilung der christlichen Plastik in den Königlichen Museen […], «Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstsammlungen», VII, 1886, pp. 203-214.
BOTTACIN 2005
A. BOTTACIN, Stendhal e Firenze (1811-1841), nota introduttiva di V. Del Litto, Moncalieri 2005.
BUDD–CATTERSON 2023
D.M. BUDD, L. CATTERSON, The Torrigiani Affair, in Italy for Sale. Alternative Objects – Alternative Markets, a cura di D.M. Budd, L. Catterson, Leida - Boston 2023, pp. 73-166.
CAGLIOTI 2000
F. CAGLIOTI, Donatello e i Medici. Storia del David e della Giuditta, I-II, Firenze 2000.
CAGLIOTI 2003
F. CAGLIOTI, Dal giardino mediceo di Via Larga: la fontana marmorea in cima allo Scalone del Moro , in Palazzo Pitti. La reggia rivelata, catalogo della mostra, a cura di G. Capecchi, A. Fara et alii, Firenze 2003, pp. 164-183.
e immobili: la Madonna Pazzi e altre opere
CALLMANN 1974
E. CALLMANN, Apollonio di Giovanni, Oxford 1974.
CATALOGO 1903
Catalogo degli oggetti di sommo pregio per la storia o per l’arte, appartenenti a privati, pubblicato a termini dell’art. 1° della legge 27 giugno 1903, n. 242 , «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 3 1 dicembre 1903, pp. 5678-5686.
CATALUCCI 2014
V. CATALUCCI, La famiglia Del Nero di Firenze: proprietà, patrimonio e collezioni. Il Palazzo Del Nero (oggi Torrigiani in piazza dei Mozzi). IIa parte, «Studi di Storia dell’Arte», XXV, 2014, pp. 109-144.
CATTERSON 2020
L. CATTERSON, Art Market, Social Network and Contamination: Bardini, Bode and the Madonna Pazzi Puzzle, in Florence, Berlin and Beyond: Late Nineteenth -Century Art Markets and Their Social Networks , a cura di L. Catterson, Leida - Boston 2020, pp. 498-552.
CAVALLUCCI 1886
C.J. CAVALLUCCI, Vita ed opere del Donatello […], Milano - Napoli - Pisa 1886.
COLLECTION BARDINI 1902
Catalogue des objets d’art antiques, du Moyen Âge et de la Renaissance provenant de la Collection Bardini de Florence, catalogo dell’asta di Christie (Londra 27 maggio 1902 e giorni seguenti), Parigi 1902.
COLLECTION BLUMENTHAL 1926-1930
Catalogue of the Collection of George and Florence Blumenthal , compilato da S. Rubinstein-Bloch, I-VI, Parigi 1926-1930.
CONTINI 2004
A. CONTINI, Tre donne, in Il Risorgimento nazionale di Vincenzo Salvagnoli. Politica, cultura giuridica ed economica nella Toscana dell’Ottocento, atti del convegno (Empoli - Firenze 29-30 novembre 2002) e atti della giornata di presentazione dell’ Inventario dell’Archivio Salvagnoli Marchetti (Empoli 5 marzo 2002), a cura di E. Insabato, S. Terreni, Ospedaletto 2004, pp. 405-424.
CROWE–CAVALCASELLE 1864-1866
J.A. CROWE–G.B. CAVALCASELLE, A New History of Painting in Italy from the Second to the Sixteenth Century […], I-III, Londra 1864-1866
ESPOSIZIONE DONATELLIANA 1887
Esposizione donatelliana nel R. Museo Nazionale in Firenze. V centenario di Donatello, catalogo della mostra, Firenze 1887.
FABBRI 2019
L. FABBRI, Women’s Rights According to Lorenzo de’ Medici: The Borromei -Pazzi Dispute and the Lex de testamentis, in The Art and Language of Power in Renaissance Florence: Essays for Alison Brown , atti del simposio (Prato 9-10 dicembre 2015), a cura di A.R. Bloch, C. James, C. Russell, Toronto 2019, pp. 91-115.
FABRICZY 1891
C. DE FABRICZY, Il Libro di Antonio Billi e le sue copie nella Biblioteca Nazionale di Firenze, Firenze 1891.
FABRONI 1784
A. FABRONI, Laurentii Medicis Magnifici vita , II. Adnotationes et monumenta ad Laurentii Medicis Magnifici vitam pertinentia , Pisa 1784.
GENTILINI 1994
G. GENTILINI, Fonti e tabernacoli … pile, pilastri e sepolture: arredi marmorei della bottega dei da Maiano , in Giuliano e la bottega dei da Maiano , atti del convegno internazionale di studi (Fiesole 13-15 giugno 1991), a cura di D. Lamberini, M. Lotti, R. Lunardi, Firenze 1994, pp. 182-195.
GOLDTHWAITE 2009
R.A. GOLDTHWAITE, The Economy of Renaissance Florence, Baltimora 2009.
GRASSI 1958
L. GRASSI, Tutta la scultura di Donatello, Milano 1958.
GROPPI 1990
S. GROPPI, L’archivio Saminiati-Pazzi, Milano 1990.
GUIDA DI FIRENZE 1852
Guida di Firenze e suoi contorni […], edita da A. Bettini, Firenze 1852.
GUIDA DI FIRENZE 1860
Guida di Firenze e suoi contorni […], edita da A. Bettini, Firenze 1860 (quarta edizione; edizione originale GUIDA DI FIRENZE 1852).
JANSON 1957
H.W. JANSON, The Sculpture of Donatello, I-II, Princeton 1957.
KUEHN 2020
T. KUEHN, Lorenzo de’ Medici and Inheritance Law in Florence , «Renaissance Studies», XXXIV, 2020, pp. [243]-259.
LEGGI E DECRETI 1903
Leggi e decreti [Legge n. 242], «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 27 giugno 1903, pp. 2745-2746.
LE PRINTEMPS DE LA RENAISSANCE 2013
Le Printemps de la Renaissance La sculpture et les arts à Florence 1400-1460, catalogo della mostra, a cura di M. Bormand, B. Paolozzi Strozzi, Parigi - Milano 2013.
LIGHTBOWN 1962-1963(1963)
R.W. LIGHTBOWN, Il busto di Giovanni Chellini al Museo Victoria & Albert di Londra, «Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato», n.s., XXVI, 35, 1962-1963(1963), pp. 15-24.
LISTA 2003
G. LISTA, Medardo Rosso. Scultura e fotografia, Milano 2003.
LITTA 1851
P. LITTA, Famiglie celebri italiane, LXXII. Pazzi di Firenze, Milano 1851.
LURATI 2012
P. LURATI, «In Firenze non si fe’ mai simile festa ». A proposito del cassone di Apollonio di Giovanni con scena di giostra alla Yale University Art Gallery, «Annali di Storia di Firenze», VII, 2012, pp. 35-71.
POLIZIANO/PEROSA 1958
A. POLIZIANO, Della congiura dei Pazzi (Coniurationis commentarium), a cura di A. PEROSA, Padova 1958.
POPE-HENNESSY 1976
J. POPE-HENNESSY, The Madonna Reliefs of Donatello, «Apollo», CIII, 1976, pp. 172-191.
POPE-HENNESSY 1993
J. POPE-HENNESSY, Donatello Sculptor, New York 1993.
ROBINSON 1862
J.C. ROBINSON, Italian Sculpture of the Middle Ages and Period of the Revival of Art […], Londra 1862.
ROWLEY 2022
N. ROWLEY, Donatello berlinese, Roma 2022.
SCHMARSOW 1889
A. SCHMARSOW, [Recensione di] […] Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epoche; bearbeitet von Wilh. Bode und Hugo v. Tschudi […], «Repertorium für Kunstwissenschaft», XII, 1889, pp. 203-211.
SCHUBRING 1915-1923
P. SCHUBRING, Cassoni. Truhen und Truhenbilder der italienischen Frührenaissance . Ein Beitrag zur Profanmalerei im Quattrocento, I-II, Lipsia 1915-1923.
SGARANO 2018
A. SGARANO, La Banca Nazionale nel Regno d’Italia a Firenze , Firenze 2018.
THOUAR 1841
P. THOUAR, Notizie e guida di Firenze e de’ suoi contorni , Firenze 1841.
ABSTRACT
Nel 1886, dallo storico dell’arte che ne presentò la riscoperta (Camillo Cavallucci), all’antiquario che ne orchestrò la compravendita (Stefano Bardini), fino al curatore che ne fece l’acquisto (Wilhelm Bode), la provenienza della cosiddetta Madonna Pazzi di Donatello viene sancita da tre uniche testimonianze, fragili quanto irrinunciabili. Da quell’anno, tuttavia, le presunte anomalie provocate da questa storia collezionistica e gli argomenti ad hominem nei confronti dell’antiquario che la promosse hanno avvolto la provenienza Pazzi di un dubbio insolubile. Una questione sulla quale la critica non è mai riuscita a deliberare – ma di cui non ha stranamente neppure cercato di verificare l’attendibilità.
Prendendo in esame i pochi elementi costitutivi di questa tradizione storica, il contributo intende quindi valutare gli indizi che hanno (nel bene e nel male) ricollegato il marmo berlinese alla famiglia Pazzi. Sulla base di riscontri catastali e ricognizioni genealogiche, ma anche degli inventari rinvenuti nel fondo Pazzi di Firenze e nelle carte notarili, si ricompone così un’organica vicenda patrimoniale, alla luce della quale diventa possibile appurare ogni singola testimonianza, scagionandola da qualsiasi errore o falsità.
In 1886, from the art historian who disclosed its rediscovery (Camillo Cavallucci), to the dealer who arranged its sale (Stefano Bardini), and to the curator who acquired it (Wilhelm Bode), the known provenance of Donatello’s Madonna Pazzi is set down through three faint yet momentous statements. However, since that year, the alleged inconsistencies within the resulting narrative, and the ad hominem arguments against the dealer who upheld it, have sown insurmountable doubt about the Pazzi provenance. As a c onsequence, scholars have resigned from resolving this matter, but oddly without ever making an attempt to test its validity.
By evaluating the scant evidence on which the historical tradition was shaped, this paper aims at assessing the cues that have (for better or worse) tied the Berlin marble to the Pazzi family. Based on cadastral and genealogical scrutiny, as well as family inventories discovered in both the Pazzi archival collection in Florence and in notarial papers, the organic patrimonial picture that emerges ultimately demonstrates that each statement was based in truth, rather than mistakes or mendacity.
ALFONSO LOMBARDI, PIETRO BEMBO E I RITRATTI PERDUTI
DI CAMILLA GONZAGA E PIETRO POMPONAZZI
In apertura della Vita dedicata ad Alfonso Lombardi, Giorgio Vasari afferma che alla fama dello scultore avevano fatto da volano «infiniti ritratti di naturale in medagliette piccole», realizzati in stucco e cera. Nell’elenco dei «molti signori e gentiluomini» effigiati da Cittadella, che comprende Carlo V, Clemente VII, Andrea Doria e Ippolito de’ Medici, il biografo include Pietro Bembo1 .
Dopo le prove pubbliche dell’Ercole e dei Funerali della Vergine, lo scultore ferrarese vide schiudersi a Bologna occasioni di confronto con il mondo intellettuale e con committenti di rango. Particolare interesse riveste la presenza di Alfonso all’interno della corte riunita attorno a Camilla Gonzaga, e animata dal poeta modenese Francesco Maria Molza2. Alla cerchia di Camilla si unì, dalle ultime settimane di marzo ai primi di maggio 1524, Pietro Bembo, amico di Molza dai tempi della Roma leonina3 .
Diretto nella città pontificia con la copia manoscritta delle Prose da presentare a Clemente VII, alla notizia della pestilenza che imperversava a Roma l’umanista veneziano arrestò il proprio viaggio a Bologna. Bembo indugiò volentieri in città prima di rientrare a Padova, ammaliato dalla signora Gonzaga e dalla vita intellettuale della sua piccola corte4 , espressione di un modello di socialità di cui era stato protagonista tra Urbino, Roma e l’entroterra padovano.
Dopo la partenza da Bologna, Pietro intrattenne scambi epistolari con Camilla5 e con Molza: di quest’ultimo carteggio rimangono due missive e un sonetto per ognuno dei corrispondenti6. Le lettere sono cadenzate fra giugno e settembre 1524 e testimoniano come già avvenuta la conoscenza tra il letterato e Alfonso Lombardi.
1 VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 1966-1987, IV (1976), p. 407. Nel racconto delle Vite, il paradigma del talento di Alfonso è affidato al celebre episodio del ritratto «rubato» a Carlo V, per cui si rimanda a CALOGERO 2022, I, pp. 82-83. La contingenza cronologica oggetto di questo studio è ricostruita ivi, I, pp. 19-21. Per i ritratti in cera e stucco ivi, pp. 147-149.
2 Per Camilla Gonzaga da Porto si vedano PIGNATTI 2018; CALOGERO 2022, in cui si ricostruisce il rapporto tra l’ambiente animato da Camilla e dalla sorella Isabella e la commissione delle sculture per la facciata di San Petronio; e infra. La recentissima edizione critica dei carmi molziani curata da Pignatti (MOLZA/PIGNATTI 2024) è venuta a surrogare la raccolta di Pierantonio Serassi (MOLZA/SERASSI 1747-1754). Per la biografia del poeta si vedano, oltre alla ricca nota biografica di Serassi nell’edizione citata, BARBIERI 1998 e 2014; lo scritto di R. Sodano in MOLZA/SCORSONE–SODANO 1999, pp. 108-140; PIGNATTI 2011.
3 CIAN 1885, p. 26. Per l’amicizia tra i due intellettuali si vedano DANZI 1986, pp. 541-542, e G. Bodon, «Omnis generis antiquitatis refertum» Qualche considerazione sul musæum di Pietro Bembo, in BODON 2005, pp. 51-67 (in particolare le pp. 57-58). Sulla presenza di Molza nell’entourage di Raffaello si rimanda a PERINI 1995(1996) L’affetto che legava Molza al veneziano è ricordato anche da Benedetto Varchi, nell’orazione funebre per Bembo pronunciata davanti all’Accademia Fiorentina (DIVERSE ORATIONI 1561, c. 56v). Va infine ricordato come, in un passaggio della Felsina Pittrice, Malvasia inserisse Molza nell’elenco degli «ingegni […] grandi […] e purgati» responsabili dell’iconografia delle Stanze Vaticane (MALVASIA 1678, I, p. 471).
4 In una lettera del 29 luglio 1524 scritta da Padova a Galasso Ariosto, Bembo, rammaricandosi di non aver incontrato a Bologna il fratello di Ludovico, affermava: «Se io del vostro venire a Bologna avessi inteso prima, che io ne fossi partito, v’avrei voluto aspettare in ogni modo, né mi sarebbe stata la dimora nojevole» I rapporti tra Galasso, Molza e Pietro Bembo sono stati ricostruiti in FRAGNITO 1994, in particolare p. 70.
5 BEMBO 1810, pp. 85-87; CALOGERO 2022, I, p. 19, nota 77.
6 MOLZA/PIGNATTI 2024, II, pp. 1133-1135: La bella donna, ch’io sospiro e canto. Nel commento sono riportate la risposta poetica di Bembo e stralci del carteggio riguardante Camilla. Molza dedicò alla Gonzaga alcuni sonetti, segnalati da PIGNATTI 2018, pp. 387-388, e in MOLZA/PIGNATTI 2024, II, come i nn. 149, 159, 198, 344, 361362. Sullo scambio poetico si vedano anche CIAN 1885, p. 30, nota 3; SCHERILLO 1888, pp. 136-137, nota 3; BIANCHI 1992, p. 262.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
Delle missive indirizzate da Bembo a Molza non si è mai persa la traccia, mentre quelle di Molza, pubblicate nel 1560 tra le Lettere da diversi […] a Mons. Pietro Bembo, rimasero sconosciute a Pierantonio Serassi che, nel Settecento, curò l’edizione dei materiali molziani, dove figurano soltanto i due sonetti e le lettere di Pietro. Le carte del modenese sono state reintegrate nell’epistolario molziano da Andrea Barbieri7
Nel corso della corrispondenza, impostata su un tono amichevole e sottilmente ironico, Bembo chiude i propri messaggi con i saluti rivolti a Camilla e agli amici lasciati a Bologna. Ricorrono i nomi di Galasso Ariosto e di un Alfonso, identificato finora, per una sorta di simmetria, con Alfonso Ariosto8
Montando in sequenza lo scambio epistolare con l’inclusione delle due lettere di Molza è però possibile, come si mostra di seguito, riconoscere Lombardi nel «nostro M. Alfonso» a cui Bembo rinnova più volte l’invito alla villa di Santa Maria in Non.
La corrispondenza prende avvio con una lettera di Molza datata 25 giugno 1524. Dopo aver ragguagliato l’umanista sulla disposizione d’animo di Camilla nei suoi confronti, Molza chiude confermando una prossima visita a Padova, compimento (come ricorda lo stesso Bembo in un messaggio successivo) di una promessa fattagli durante le settimane bolognesi: «Intanto io mi sforzerò insieme con M. Alfonso nostro, lo quale io aspetto di giorno in giorno che ritorni da Faenza, di venire a ritrovare V. S. a cui bacio le mani con quella riverenza ch’io posso maggiore»9 .
Un’iscrizione ottocentesca riferiva al 1524 la realizzazione del gruppo con La Vergine, il Bambino, san Giovanni Battista e san Giovanni Evangelista per l’oratorio faentino di San Giovanni Battista: la testimonianza di Molza conferma e precisa la datazione dell’opera, indirizzando l’identificazione di «M. Alfonso» verso lo scultore10. Il 29 luglio Bembo rinnovava con calore l’invito: «Se verrete, come dite, col nostro M. Alfonso a stare alcun giorno in questo mio nascondimento, e villetta, mi farete singolare piacere, della qual cosa vi prego grandemente»11 . Il 13 agosto Molza era però costretto a scusarsi con Bembo per la mancata visita: le commissioni ricevute da Alfonso trattenevano i due amici a Bologna. Per la prima volta, anzi, la possibilità che lo scultore partecipasse alla spedizione verso il buen retiro dell’umanista veniva garbatamente messa in dubbio: «Io spero di vedere in breve V. S. et forse in compagnia di M. Alfonso s’egli sarà isviluppato d’alcuni suoi lavori che gli ha presi di novo, fra tanto le bacio humilmente le mani»12. Tra i lavori «presi di novo» andrà incluso il rilievo con Mosè che toglie la corona al faraone per lo stipite della porta sinistra della basilica di San Petronio13
L’estate scivolava via e la visita padovana di Lombardi diventava sempre meno praticabile. Il 1° settembre Bembo rimbrottava scherzosamente Molza per non aver dato seguito all’impegno preso a suo tempo, annunciando un nuovo soggiorno bolognese nell’ottobre successivo e dicendosi certo di trovare in città anche il poeta, invischiato nella passione per Camilla Gonzaga:
7 Le lettere scritte da Molza a Bembo (pubblicate in DELLE LETTERE 1560, pp. 58-59, e in BARBIERI 2014, pp. 54-56) sono sfuggite nella pubblicazione CALOGERO 2022, I, p. 19, nota 77. Sul carattere del carteggio molziano si rimanda a FERRONI 2018, p. 296.
8 Così in CIAN 1885, p. 26, MUTINI 1988 e nel profilo biografico di R. Sodano in MOLZA/SCORSONE-SODANO 1999, p. 120. Nello stesso 1524 Ludovico Ariosto inseriva il nome di Molza nella sua VII Satira, v. 128.
9 BARBIERI 2014, p. 55.
10 Il gruppo è conservato nella Pinacoteca Civica faentina. Per l’iscrizione, ARGNANI 1881, pp. 3-4. Sull’opera si vedano GRAMACCINI 1980, pp. 35-37; FARANDA 1999, pp. 54-55; CALOGERO 2022, I, pp. 221-224, e CALOGERO 2023. Il soggiorno faentino pose tra l’altro Lombardi a stretto contatto con il mondo dei ceramisti, aggiornatissimi sui motivi raffaelleschi.
11 BARBIERI 2014, p. 55.
12 Ivi, p. 56.
13 SINIGALLIESI 1999, p. 23; CALOGERO 2020, p. 21. Il soggetto del rilievo petroniano fu successivamente modificato in Mosè che porta alla bocca i carboni ardenti
Studi di Memofonte 34/2025
Io m’avveggo che in vano v’ho insieme con M. Alfonso aspettato. Ora non mi rimarrò di ciò ingannato, che non v’aspetterò più. Anzi vi perdono io tutta questa ingiuria, che mi fate di non attenermi la promessa; perciocché io comprendo, che buonissima cagione ve ne ritiene. […] State sano, e salutatemi M. Alfonso, e M. Filippo Maria de’ Rossi14
Il rapporto, finora documentato dal solo riferimento vasariano, tra Alfonso Lombardi e Pietro Bembo risulta insomma già avviato all’inizio dell’estate 1524. È da credere che, durante il soggiorno a Bologna, l’umanista avesse avuto occasione di conoscere il talento di Lombardi, e che magari avesse già ottenuto dallo scultore la miniatura del proprio volto. Si può anche ipotizzare che Bembo desiderasse veder tradotto il microritratto in un’opera di maggior impegno come una medaglia, e che sollecitasse per questo la presenza in villa dell’artista15. La centralità del ritratto, surrogato del conforto umano e intellettuale procurato dal rapporto amicale, era stata messa a fuoco da Bembo all’altezza degli Asolani, in abbinamento con un’impresa che condensasse l’essenza individuale dell’effigiato16. La medaglia, coltivata con dedizione dall’umanista, risultava perfettamente calzante come sostituzione della viva presenza, soprattutto se il ritratto poteva essere colto dal vero da un artista abilissimo come Lombardi.
Davide Gasparotto segnalava, in una lettera indirizzata da Pietro a Vittoria Colonna nel 1532, il riferimento a una medaglia di cui l’umanista non era rimasto soddisfatto («non mi rassomiglia quanto potrebbe»), collegandola dubitativamente a un intervento di Alfonso, reso opaco dalla scarsa qualità della traduzione in bronzo17. Nella stessa missiva, Pietro precisava con qualche irritazione che la medaglia «m’è fin questo dì stata indugiata a fornirsi, e poi è suta fornita non bene»18. E chissà se la scarsa attenzione di Alfonso Lombardi rispetto all’urgenza dell’illustre interlocutore che affiora nel carteggio tra Bembo e Molza (coerente peraltro con il profilo vasariano dell’artista) non si sia prolungata nel tempo ben oltre i mesi documentati dall’intreccio delle lettere.
Resta impossibile, per ora, sapere se lo scultore ferrarese fosse effettivamente responsabile della medaglia che aveva deluso Bembo, né ci è noto quando e se l’artista sia stato ospite a Padova. In ogni caso, è difficile immaginare che Cittadella, per quanto, a detta di Vasari, instabile e vanesio, si sia lasciato sfuggire la possibilità di coltivare il rapporto con una figura cardine nell’orizzonte culturale del tempo, committente generoso e «sopra tutti gl’altri uomini dell’età nostra eccellentissimo»19 .
Dieci anni prima, alla corte di Leone X, Raffaello aveva definito forma e ambizioni del ritratto attraverso il confronto con le riflessioni sviluppate da Pietro Bembo tra Urbino e Roma20. Il significato di quella congiuntura, da cui era scaturito un capolavoro come il doppio ritratto di Navagero e Beazzano, poté in qualche misura rinnovarsi a Bologna nella primavera del 1524. Il confronto con Bembo avrà rappresentato per Alfonso Lombardi un catalizzatore di stimoli fondamentali, nel momento in cui la fama ormai raggiunta poneva lo scultore di
14 BARBIERI 2014, p. 57.
15 CALOGERO 2022, I, pp. 20-21, 32: l’autore ritiene invece che il ritratto di Bembo menzionato da Vasari possa essere datato al 1530, quando Bembo, Molza e Lombardi si ritrovarono a Bologna in occasione dell’incoronazione di Carlo V.
16 BOLZONI 2013a, pp. 306-308.
17 GASPAROTTO 1996(1998), p. 188. Sullo stesso tema si veda D. Gasparotto, schede nn. 23-27, in VITTORIA COLONNA 2005, pp. 91-93. Sull’argomento si rimanda anche a MAZZUCHELLI 1753-1763, II, t. 2 (1760), p. 754 e note; MIDDELDORF 1980 e 1981; COGGIOLA 1914-1915, pp. 480-481, nota 4. In una lettera del 1533 da Roma a Federico II Gonzaga, Alfonso Lombardi menzionava varie medaglie in stucco (tra cui una di Molza), prevedendo la possibilità di farne «gettare in metallo» alcune (cit. in BRAGHIROLLI 1874-1876, p. 108)
18 GASPAROTTO 1996(1998), p. 188. L’insoddisfazione nei confronti della stessa medaglia si trova anche in una lettera del 1535 scritta da Pietro a don Onorato Fascitello (ibidem)
19 VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 1966-1987, III (1971), p. 324; ROMANI 2013. In FARINELLA 2015 è ricostruito il contesto ferrarese in cui avvenne la formazione di Lombardi, aperto ai contributi raffaelleschi che il rapporto dello scultore con Molza e Bembo potrà aver approfondito.
20 AGOSTI 2003, in particolare le pp. 59-61; BOLZONI 2013b.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
fronte a nuove complessità e ambizioni espressive, in parallelo al prender piede del linguaggio raffaellesco a Bologna e sulla spinta della formulazione che del rapporto tra antico e modernità aveva dato, nelle Prose, lo stesso Bembo21 .
Realizzate in materiali diversi, sui crinali opposti della descrizione naturalistica e della stilizzazione idealizzante, le ‘teste’ costituirono la base su cui si consolidarono negli anni successivi la reputazione di Lombardi e il suo ruolo nella rinascita del busto-ritratto lapideo. Il legame con l’ambiente animato da Bembo e da Molza avrà sospinto l’aggiornamento del linguaggio di Alfonso, oggetto della mostra monografica del 2020, in un contesto certamente appartato ma non per questo meno significativo22. Per questa via privilegiata lo scultore poté assorbire ben prima del trasferimento a Roma, nel 1533, alcuni elementi della svolta classicista che si registra, ad esempio, nel Salvatore oggi in collezione privata, la cui ideazione si è fissata al 152423. Nello stesso anno, la commissione delle formelle per il portale petroniano poneva Alfonso a confronto con la scultura in pietra. Frequentata controvoglia da Lombardi, secondo il racconto delle Vite, quest’ultima fu tuttavia, da lì in poi, la sua occupazione prevalente24
Per mettere meglio a fuoco gli indirizzi formali che Alfonso Lombardi attraversò in quel momento di svolta si propone qui una ricognizione attorno a due opere oggi perdute dello scultore: il ritratto di Camilla Gonzaga e quello di Pietro Pomponazzi. I busti furono realizzati nella nebulosa intellettuale che gravitava intorno a Camilla ed Ercole Gonzaga, all’avanguardia sui fatti e sulle idee che animavano la cultura artistica italiana, particolarmente sensibile (negli anni di circolazione del testo di Filostrato) al rapporto tra parola e immagine.
L’indagine pone in evidenza le traiettorie intellettuali che videro la maturazione del pensiero di Cittadella sul significato e sulla forma del ritratto in relazione ai diversi materiali della scultura, in un orizzonte problematico ampio e allineato ai dibattiti in corso nelle corti italiane. Quell’esperienza fu inoltre per Lombardi la chiave di volta su cui l’artista impostò, qualche anno dopo, i rapporti con Federico II Gonzaga e Ippolito de’ Medici.
Figura chiave per documentare artisti e committenti nella Bologna di quegli anni è Girolamo Pandolfi da Casio, di cui è nota l’ammirazione per Lombardi. Nel Libro Intitulato Cronica Ove si tratta di Epitaphii, di Amore, e di Virtute25, Casio offre informazioni di prima mano, pur se frammentarie, sulle due opere perdute di Alfonso Lombardi.
21 Per un riepilogo si vedano GIULIO II E RAFFAELLO 2022 e GINZBURG 2021(2023)
22 ALFONSO LOMBARDI 2020. Sul ruolo di Bembo si veda anche RICCÒMINI 2008, pp. 45-46.
23 LUCIDI 2018, pp. 115-129; D. Lucidi, scheda n. 17, in ALFONSO LOMBARDI 2020, pp 137-139; CALOGERO 2020, pp. 18-19. Lo scultore visitò Roma per la prima volta nel 1533, al seguito di Ippolito de’ Medici (cfr. REBECCHINI 2010, pp. 251-259). Fu Molza a inoltrare allo scultore l’invito del cardinale a unirsi alla propria corte, come risulta dal carteggio di Lombardi pubblicato in BRAGHIROLLI 1874-1876, p. 105. Il ruolo quasi di mentore svolto da Molza nei confronti dello scultore si cristallizza nei mesi oggetto di questo scritto. La mediazione di Molza consentì a Cittadella di compiere un percorso di assimilazione del lessico raffaellesco la cui eccezionalità va letta sullo sfondo delle considerazioni dedicate da Vasari agli artisti attivi a Bologna in quegli anni (cfr. in particolare la Vita di Bartolomeo da Bagnacavallo e d’altri pittori romagnuoli, in VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 19661987, IV (1976), p. 493, e FAIETTI 2012).
24 VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 1966-1987, IV (1976), p. 409: secondo il biografo, Lombardi si sarebbe dedicato all’arte «più per piacere e per una certa vanagloria che per voglia di mettersi a scarpellare sassi», ma «non si contentando della gloria e utile che gli veniva dal fare opere di terra, di cera e di stucco, si mise a lavorar di marmo, et acquistò tanto in alcune cose di non molta importanza ch’e’ fece, che gli fu dato a lavorare in San Michele in Bosco fuori di Bologna la sepoltura di Ramazzotto, la quale gli acquistò grandissimo onore e fama» (ivi, p. 408). L’inventario delle suppellettili e delle sculture presenti nel laboratorio bolognese di Alfonso al momento della morte dà conto del gran numero di opere in marmo (si veda GAYE 1840, pp. 247-249). Sui materiali della scultura di Lombardi il riferimento è a CALOGERO 2022. 25 CASIO DE’ MEDICI 1529. Anche il busto del Redentore, modellato da Lombardi per la chiesa servita di San Giuseppe, fu ricordato da Casio nelle Vite de’ Santi (si veda LUCIDI 2018, pp. 115-129). La ricostruzione della cronologia della Cronica si trova in CAVICCHI 1915, pp. 17-19; sul fronteggiarsi di poesia e pittura nelle rime di Girolamo Casio si veda PERINI FOLESANI 2020. Per la figura di Pandolfi si vedano SASSU 1996, pp. 169-171, e QUAQUARELLI 2014. Un riferimento a entrambi i ritratti presi in esame si trova in AGOSTI 1998, p. 183, nota 12
Studi di Memofonte 34/2025
Il ritratto di Camilla Gonzaga
Camilla apparteneva al ramo dei Gonzaga di Novellara e sposò il conte vicentino Alessandro da Porto26. Perduto il marito nel 1518, la giovane soggiornò con la madre presso la corte mantovana. Ignorando la volontà dei fratelli che la volevano monaca, Camilla si trasferì a Bologna presso la sorella Isabella, vedova del conte Camillo Pepoli, che per qualche tempo era stato segretario del duca di Ferrara27. Nelle parole di Casio, legatissimo alla casa Gonzaga, le due signore, protettrici delle arti e ispirate dalla vivace raffinatezza della corte mantovana (con cui mantennero sempre un rapporto vivo anche per tramite di Ercole Gonzaga, allora studente a Bologna), avevano trasformato il «Pepolo tugurio»28 in un ricetto di grazia e virtù29 . Perno della cerchia di Palazzo Pepoli era Francesco Maria Molza, punto di riferimento per i Gonzaga fin da quando, nel 1511, il giovanissimo marchese Federico aveva soggiornato a Bologna sotto la sua tutela, mentre Giulio II assediava Mirandola30. Abbandonata Roma dopo una pugnalata ricevuta per questioni di gelosia che lo aveva ridotto in fin di vita, Molza si trattenne a Bologna dal 1522 al 152531. Qui allacciò un’amicizia con Ercole Gonzaga, giovane
26 Era figlia di Giampietro Gonzaga (il cui epitaffio si trova in CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 18r) e Caterina Torelli, e sorella di Pirro, diversamente da quanto affermato in AGOSTI 2005, p. 148. In aggiunta al profilo redatto in PIGNATTI 2018 (in particolare le pp. 381-383), sullo stato matrimoniale di Camilla si vedano DA PORTO/ BRESSAN 1857, p. 12, nota 3, e FRANZONI 1990, pp. 302-303. L’illustre famiglia Da Porto annoverava amici e corrispondenti di Pietro Bembo tra cui Luigi, dedicatario post mortem di un sonetto dell’umanista. È possibile che Camilla, definita «la poetessa» in DAVOLIO 1833, p. 19, conoscesse Bembo prima del suo soggiorno a Bologna (cfr. CIAN 1885, p. 27).
27 Il 18 dicembre 1522 Camilla Gonzaga da Porto scriveva a Isabella d’Este, informandola del suo arrivo a Bologna presso la sorella, raccomandandosi alla «signiora marchesana di Mantua» e rinnovandole la sua «servitù», pur nelle tribolazioni – «la mia malla [sic] sorte» e «li miei afanni [sic]» – della vedovanza (Mantova, Archivio di Stato (ASMn), Archivio Gonzaga (AG), busta 1149, c. 454r). In una seconda missiva a Isabella d’Este datata al 15 luglio 1524 la marchesa, informata della pestilenza che infuriava a Roma, aveva rimandato un viaggio alla volta dell’Urbe, e la conseguente sosta bolognese. Camilla, plaudendo alla «laudabile mutatione» nel progetto di viaggio, rinnovava la sua ospitalità a Isabella: «pur accadendo che sua ill.ma s.ria faccia quel viagio fra alquanti giorni come la dice no lassarò pregarla recordarse servirsi ancora di me come per sua humanità la si degnava fare andandogli al presente» (ASMn, AG, busta 1150, c. 460r). In entrambe le missive, ai saluti di Camilla si aggiungono quelli di Isabella Gonzaga Pepoli. A gennaio 1525 le signore risultano presenti a Bologna e ricevono per lettera gli omaggi di Bembo. Nel febbraio successivo la marchesa di Mantova transitò per Bologna alla volta di Roma, dove giunse il 2 marzo. Camilla si unì al suo seguito e approdò nell’Urbe. Il 25 agosto 1525 la sola Isabella rinnovava alla marchesa di Mantova l’invito a «farmi gratia voler alogiare in casa mia» durante un nuovo passaggio da Bologna (ASMn, AG, busta 1151, c. 249r). A Roma, nel 1534 Ippolito de’ Medici si innamorò di Camilla Gonzaga. Una lettera indirizzata a Isabella d’Este che racconta la gelosia del cardinale nei confronti della dama si trova in BARBIERI 2014, p. 75. In PIGNATTI 2019 sono pubblicati i testamenti e l’inventario della casa romana di Camilla.
28 Traggo la definizione della dimora pepolesca dal primo sonetto de La Gonzaga (n. 187, c. 81v, v. 1), su cui mi soffermerò nelle pagine che seguono.
29 Uno degli Epitaphii di Casio è dedicato alla memoria del conte Camillo Pepoli, morto nel 1516: «A la consorte sua disse, Isabella / s’io parto, nel tuo ventre un Camil resta / figliuol concetto a ben felice stella / fa che già mai non ti dimostri mesta / che ’l nochier si conosce in la procella / bianca la fe’ mantien, negra la vesta»; in CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 19r-v. Il sonetto viene ripreso in apertura de La Gonzaga, la sequenza poetica che ragguaglia sulla commissione e la realizzazione del busto di Camilla Gonzaga, a c. 82r Nel corpo della Cronica di Girolamo Casio, la raccolta viene introdotta da un’antiporta che racchiude la dedica a Ercole Gonzaga (ivi, c. 81r: «LA GONZAGA del Casio al Cardinale di Mantoa. Sonetti capitoli et canzoni amorose»). I testi poetici si scalano a partire da c. 81v Sul Pepoli cfr. R. Dodi, Note biografiche e tavole genealogiche della famiglia Pepoli, in PEPOLI 2018, p. 189. Per il rapporto di Casio con Isabella d’Este si veda LUZIO–RENIER/ALBONICO 2005, ad indicem. A documentare l’ambiente ad altissima densità gonzaghesca di Palazzo Pepoli va ricordato come, nel 1530, Federico II Gonzaga coinvolgesse Francesco Primaticcio e Tiziano nella realizzazione del ritratto di Cornelia Malaspina, damigella di Isabella Gonzaga Pepoli (cfr. ROMANI 2016 e CALOGERO 2022, I, p. 19, nota 74).
30 LUZIO 1886b, p. 516. Il 10 dicembre 1510 Molza, da Bologna, comunicava a Isabella d’Este di aver incontrato Federico Gonzaga, assicurandole il suo «maggior desiderio [ ] di obedirla et gratificarla» (ASMn, AG, busta 1147, c. 345r). A Elisabetta Gonzaga erano dedicate le COLLETTANEE 1504, che avevano segnato l’esordio poetico di Molza.
31 Per il periodo bolognese di Francesco Maria si vedano BARBIERI 1998, pp. 127-129, e PIGNATTI 2011, pp. 453-454.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
vescovo (e di lì a poco cardinale) di Mantova, che durò per sempre, e conobbe Camilla, fiamma di un amore modulato tra echi petrarcheschi, passione autentica e aspirazioni di matrice neoplatonica32 .
La presenza simultanea di Molza e Lombardi nel cenacolo di Palazzo Pepoli metteva in atto un confronto serrato fra arti figurative e parola poetica, che si specificava nella commissione del busto. Il tema assumeva singolare attualità anche alla luce del manoscritto delle Prose della volgar lingua, certamente discusso durante il soggiorno di Pietro Bembo e, del resto, già circolante33
La traduzione letteraria delle opere figurative e il ‘paragone’ fra pittura e scultura occuparono uno spazio di primo piano nell’attività poetica di Molza. La prossimità del poeta al progetto di rilievo architettonico della Roma antica che aveva impegnato gli ultimi anni di Raffaello, centro tematico del carme composto in morte dell’artista urbinate, si arricchì, nel periodo in cui Molza frequentò la corte di Ippolito de’ Medici, di riflessioni ad ampio spettro sulla cultura artistica del tempo34. Come riconoscimento di un rapporto per nulla episodico del poeta con le arti figurative, la Disputa della maggioranza delle arti di Benedetto Varchi attribuiva valore di indirizzo ad alcuni versi delle Stanze sopra il ritratto di Giulia Gonzaga, concepite dal modenese nel 153235. Dal canto suo, nella Giuntina, Vasari inseriva il nome del poeta tra quelli dei commensali che discussero, alla corte di Alessandro Farnese, il progetto delle Vite, documentandone anche il rapporto di amicizia con Sebastiano del Piombo e Perin del Vaga36 . La commissione a Cittadella del busto di Camilla Gonzaga segnò per Molza uno snodo fondamentale tra le esperienze maturate negli anni di Leone X, di cui il poeta stesso era testimonianza vivente, e lo sviluppo di cui il letterato fu protagonista attraverso i cenacoli che animarono la Roma del quarto decennio, presso i quali egli accreditò lo stesso Alfonso Lombardi. Per questa ragione, un’indagine sull’opera è utile a ricostruire da un lato un passaggio chiave per la messa a fuoco, da parte di Molza, di un pensiero organico sui rapporti fra le arti (e resta a tal proposito particolarmente grave la perdita dei testi che, stando alla testimonianza di Girolamo Casio, il poeta compose sul busto), tratteggiando d’altro canto l’ambiente in cui venne a maturazione l’aggiornamento stilistico di Alfonso Lombardi.
La realizzazione del ritratto di Camilla e il dibattito che la accompagnò sono documentati dai componimenti della raccolta poetica intitolata La Gonzaga, inclusa nella Cronica di Girolamo Casio37
Come testimonia un sonetto di Casio che dà voce ad Alfonso Lombardi, fu Francesco Maria Molza a commissionare il busto («Molza, per sodisfar al tuo desio»)38. La circostanza è rilevante per definire la datazione dell’opera, considerando che il poeta modenese lasciò
32 D. Chiodo, “E viva amore e muoia soldo”: il magistero molziano alla corte di Ippolito de’ Medici, in CHIODO 2013, pp. 6370, in particolare p. 64. Sulla frequentazione tra Ercole Gonzaga e le due sorelle si veda CALOGERO 2022, I, p. 20. Il pensiero di Molza sulla cultura artistica del suo tempo si arricchì in un ambiente denso di suggestioni mantovane e ferraresi, come avveniva in parallelo per Paolo Giovio (cfr. AGOSTI 2008, pp. 73-76)
33 BOLZONI 2008; CARRARA 2019, pp. 248-249; GINZBURG 2021(2023). Per la declinazione del tema nella cerchia di Raffaello si rimanda a FAIETTI 2016.
34 Il carme composto in morte di Raffaello si trova in SHEARMAN 2003, pp. 656-659. Molza entrò nella famiglia di Ippolito nel 1529. Per i due componimenti dedicati dal poeta, nei primi anni Trenta, ad altrettante opere di Tiziano si veda ONGHI 2021.
35 VARCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 41. Le cinquanta Stanze sopra il ritratto di Giulia Gonzaga sono riprodotte in MOLZA/SERASSI 1747-1754, I (1747), pp. 135-147. A Molza sono attribuite per errore anche le stanze che Gandolfo Porrino dedicò alla stessa opera. Per la presenza di Molza nelle Lezzioni si veda BOLZONI 2008, pp. 568-581. Su Varchi cfr. CARRARA 2019, pp. 252-254. A Roma, Ippolito chiese a Alfonso Lombardi di ‘rubare’ un ritratto a Giulia Gonzaga, riluttante rispetto alle sedute con Sebastiano del Piombo (cfr. BRAGHIROLLI 18741876, p. 108, e REBECCHINI 2010, p. 253).
36 VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 1966-1987, V (1984), p. 147; ivi, VI (1987), p. 389; GINZBURG 2007, pp. 151-152.
37 Su La Gonzaga si vedano COLASANTI 1904, p. 202, e CAVICCHI 1915, pp. 17-19, 26-30.
38 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 84v, v. 1.
Studi di Memofonte 34/2025
Bologna nella primavera 1525, recandosi a Roma con in tasca la lettera commendatizia rivolta da Ercole Gonzaga alla madre. Poco prima, anche Camilla si era trasferita a Roma al seguito di Isabella d’Este39. Nell’avvio de La Gonzaga (che assume la forma di ragguaglio indirizzato a Ercole Gonzaga) Girolamo Casio dichiara che il ritratto di Camilla fu realizzato durante l’estate: mi sembra pertanto ragionevole ipotizzare che Alfonso Lombardi l’abbia eseguito nei mesi estivi del 1524, in contiguità temporale con il soggiorno di Pietro Bembo a Bologna40 Dei numerosi sonetti di argomento amoroso che compongono La Gonzaga, soltanto i primi (nn. 187-200) ripercorrono i «memorandi casi intervenuti» durante la realizzazione del ritratto di Camilla41. Il busto della dama risulta incorporato come motivo poetico in altri versi, ma la sezione più significativa della sequenza di sonetti è indubbiamente quella iniziale, scandita dagli scambi tra Lombardi, Molza e Casio.
Impiegando un’immagine posta nel punto medio tra l’invenzione mantegnesca e quella vaticana di Raffaello (alla cui memoria la Cronica di Pandolfi dedica un sonetto e un tetrastico), Girolamo Casio definisce Palazzo Pepoli un secondo Parnaso, «verde, piano et vago monte» dove Apollo onora i poeti «col suo aloro» presso la fonte Castalia42
Nel Pepolo tugurio altro Parnaso renovata l’antica età de l’oro ivi posto han le nove Muse il coro ivi si pasce il bel caval Pegaso.
39 PIGNATTI 2018, pp. 385-386. Al viaggio della dama allude uno dei sonetti di Molza a lei dedicati (cfr. MOLZA/PIGNATTI 2024, II, p. 1443, vv. 10-11).
40 CALOGERO 2022, I, p. 20, fissa la realizzazione del busto al 1525. A supporto della datazione al 1524 va però anche rilevato che Casio, dedicando La Gonzaga a Ercole, richiama l’assenza del giovane da Bologna per le vacanze dovute alla sospensione estiva delle lezioni. Nel giugno 1525 il figlio di Isabella rientrò sì a Mantova, ma lo fece afflitto per la morte, nel mese di maggio di quell’anno, del suo maestro Pietro Pomponazzi. Al grave lutto che aveva colpito il giovane Gonzaga non viene fatto cenno nelle parole di Casio: «La Gonzaga allo illustrissimo et reverendiss[imo] monsignore Hercole Gonzaga marchese, et di Mantoa eletto reverendissimo MDXXV. Poi che questa prossima passata estade (per li suoi intemperati giorni) si fecero le usate vacationi del Studio, et che Vostra Illustriss[ima] et Reverendiss[ima] Signoria dalla Inclita, Dotta et opulente Cità [sic] Bologna stette absente» (CASIO DE’ MEDICI 1529, cc. 81v-83r).
41 Riepilogo di seguito la struttura della raccolta per la sola parte riguardante l’elaborazione del ritratto di Camilla (CASIO DE’ MEDICI 1529, cc. 81v-85v), riportando il numero progressivo dei sonetti, l’incipit e, laddove presente, il titolo tra virgolette:
187. Nel Pepolo tugurio
188. Di Apol pel canto et pel corsier di Marte (epitaffio di Camillo Pepoli, n.d.a.)
189. «Della signora Camilla» (anacrostico di Camilla Gonzaga, n.d.a.)
190. In Isabella in cui bontà si posa (anacrostico di Isabella Gonzaga, n.d.a.)
191. «Alli lettori»
192. «Alli lettori»
193. «Per la imagine»
194. «Il Casio al Molza»
195. «Il Casio al Molza» (anacrostico di Francesco Maria Molza, n.d.a.)
196. «Ad Alphonso»
197. «Alphonso al Molza»
198. «Il Molza ad Alphonso»
199. «Il Casio ad Alphonso»
200. «Amore a Natura»
I sonetti nn. 194 e 196-200, con l’aggiunta del componimento Chi di marmo vedrà questo bel volto, sono stati riprodotti in DAMIANAKI ROMANO 1998, pp. 387-392 PIGNATTI 2018, p. 386, ha riprodotto il n. 193. Per la sequenza poetica si veda anche CALOGERO 2022, II, pp. 91-94. Il componimento introduttivo e l’anacrostico di Camilla Gonzaga (nn. 187 e 189) discussi di seguito non sono stati ripubblicati.
42 Il sonetto Nel Pepolo tugurio, che apre La Gonzaga, è in CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 81v I componimenti di Casio dedicati a Raffaello si trovano alla c. 46v della Cronica (CASIO DE’ MEDICI 1529) e in SHEARMAN 2003, pp. 806807. Su questo tema cfr. PERINI 1995(1996), pp. 116-117, e, sul possibile precoce rapporto tra il Sanzio e la città felsinea, PERINI FOLESANI 2021
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
Le Grazie et le Vertuti ivi in un vaso hanno lo albergo lor, ivi restoro porge Febo a’ poeti col suo aloro ivi il tempo non può fortuna o caso.
Per il suo verde, piano et vago monte van due Diane, anzi la luna e il sole, con sue Gonzaghe ninfe sempre a fronte.
Queste son due, e sono uniche et sole, queste le guardie fanno al sacro fonte ove ancor del suo entrar Atteon si dole.
L’equivalenza tra Palazzo Pepoli e il Parnaso ricorre anche nella lettera scritta da Bembo a Molza il 1° settembre 1524: «Piacemi che siate stato in Bologna per lo continuo […] perché siate a Febo, e alle nove sorelle così caro»43. Va anche ricordato che il «caval Pegaso» del verso 4 fu un simbolo di Pietro Bembo, scelto da Benvenuto Cellini per la medaglia dedicata all’umanista44 . Introdotto il clima classicizzante che ispirava il cenacolo intellettuale, Girolamo Casio presentava l’opera realizzata dal «novo Phidia Alphonso», motivo centrale della raccolta: «Et oltra questo si è per il novo Phidia Alphonso scultore ritratta la diva effigie della illustrissima contessa signora Camilla, figliuola alla felice recordatione dello illustrissimo signor Gioampietro Gonzaga conte di Novellara»45 .
Dilatando lo spunto dei versi che Petrarca aveva dedicato al ritratto di Laura dipinto da Simone Martini46, i sonetti iniziali de La Gonzaga hanno per oggetto il confronto fra Molza, committente dell’effigie, e Alfonso Lombardi, che l’aveva eseguita «in bianco marmo»47. Nel rispecchiarsi e nel sovrapporsi di immagini e parole, la «humana, anci divina poesia» di Molza «ha fatto essere più eccelsa la scultura, et convenevolmente (come dice Horatio) pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas» 48. La citazione oraziana, pur applicata a uno scultore, indirizzava l’opera d’arte verso una libertà tutta intellettuale, non strettamente vincolata alla riproduzione del dato di natura, e diventava forse ancor più suggestiva alla luce della conoscenza diretta, da parte di Casio, dei pensieri sviluppati in merito da Leonardo49 La pari dignità fra poeta e artista è ribadita dal sonetto dedicato alla Imagine (n. 193), dove i «dui spirti […] eccelsi e divi» – Francesco Maria Molza e Alfonso Lombardi –contribuiscono in egual misura all’eternità della «Gonzaga Fama»50 Nel campo del ritratto, l’equivalenza tra poesia e pittura tracciava come orizzonte per l’artista la possibilità di esprimere di un soggetto, secondo Bembo, i «mores animique habitudinem»51. Accesa dalla figura prestigiosa del veneziano, la corte di Camilla Gonzaga
43 MOLZA/SERASSI 1747-1754, II (1750), p. 156.
44 D. Gasparotto, schede nn. 23-27, in VITTORIA COLONNA 2005, pp. 92-93.
45 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 81v
46 Rispettivamente i nn. LXXVII e LXXVIII del Canzoniere petrarchesco. Cfr. BOLZONI 2008, pp. 31-47, e WALTER–ZAPPERI 2006, pp. 17-20.
47 «Molza, per sodisfar al tuo desio / con ogni industria, forza ingegno et arte / oprato ho in bianco marmo de intagliarte / quella che te di te posto ha in oblio» (CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 84v).
48 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 82r.
49 Ibidem; COLLARETA 1988, pp. 570-573. Per la rilevanza del tema nelle Immagini di Filostrato Maggiore nell’ambiente gonzaghesco e per lo stesso Molza si veda MAFFEI 1991.
50 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 84r, v. 10. La divinizzazione di Alfonso è ribadita al v. 14 del sonetto Amore a Natura (cfr. ivi, p. 85v).
51 AGOSTI 2003, p. 60; BOLZONI 2013a, pp. 300 e sgg.
potrà avere fornito a Lombardi motivi rilevanti per la maturazione del proprio lessico formale, le cui premesse si inscrivevano nel naturalismo della tradizione emiliana.
Lo scambio fra il poeta-committente e lo scultore, che Casio mette in scena ne La Gonzaga attraverso l’alternarsi dialogico dei sonetti, innesca una vicenda in cui, secondo uno schema consueto, l’arte vince la natura e fonda la propria eternità sulla parola52. La struttura dialogica rende La Gonzaga un testo originale, pur nel limitato valore poetico dei versi, cui fa da sfondo la corte di Palazzo Pepoli, animata dall’aspirazione a una «perfezion de l’arte» moderna e antica insieme, espressione di valori comuni alle Prose della volgar lingua53
Il sonetto anacrostico di Camilla Gonzaga proietta nell’eternità la fama di Lombardi54. Il talento dell’artefice è esaltato dal materiale lapideo con cui il busto fu realizzato. Sul filo della cronologia, il ritratto di Camilla Gonzaga può essere stato una delle prime opere lavorate in pietra da Alfonso: il dato mi pare rilevante, all’interno del quadro di orientamento classicista che La Gonzaga consente di tratteggiare55
Nello stesso 1524 Sabba da Castiglione (formatosi nella Milano dove erano moneta corrente le considerazioni di Leonardo sulla plastica, ed estimatore di Guido Mazzoni56) affermava di preferire i lavori «di terra» del ferrarese, che meglio esprimevano la sua «maniera dolce et dilettevole», riconoscendo comunque l’artista come «eccellente et ingegnoso» anche nel marmo57. Quasi sul crinale tra i due materiali, tra 1522 e 1524 Alfonso Lombardi eseguì per Castel Bolognese la Visitazione e il San Girolamo. Vasari ricorda quelle sculture come «di stucco», definizione che consuona con quella dei «profeti, un d’ogni banda di tera cotta, finto di marmor» registrati da Pietro Lamo nella chiesa bolognese del Baraccano58. La riflessione condotta sui caratteri e sulle ambizioni della statuaria nella cerchia di Camilla Gonzaga avrà supportato l’artista nel passaggio dall’imitazione del marmo alle qualità specifiche della scultura ‘per via di levare’ . Il sonetto per Camilla pone in rima la «petra», il marmo, con la «cetra» di Molza (vv. 10 e 12), entrambe capaci di proiettare il nome di Lombardi oltre il tempo, in una consonanza di intenzioni espressive:
Della Signora Camilla
Corre la fama già per ogni parte Alphonso, che fatto hai una figura molto più viva che non se Natura in cui si vede il saper tuo de l’arte.
52 Per la presenza di questo tema nella poesia di Molza si veda BIANCHI 1992, p. 264. Sulla polarità eternità/morte e sui tratti idealizzanti dei ritratti di Girolamo Casio si vedano RAMA 1983; CAPRARA 2000; QUATTRINI 2021(2022).
53 La citazione riportata è tratta da BEMBO/DIONISOTTI 1966, III, I, p. 92.
54 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 82v
55 Sul tema del ritratto in pietra si veda BOLZONI 2008, pp. 24-26.
56 AGOSTI 2008, pp. 54-57.
57 CASTIGLIONE 1554, p. 51r. Qui Alfonso è definito «eccellente et ingegnoso in figure in marmo, ma più di terra, la cui maniera dolce et dilettevole communalmente piace a ogni buon gusto». Per Sabba, lo scultore realizzò il San Girolamo oggi alla Pinacoteca di Faenza (menzionato a p. 53r), su cui si veda A. Giannotti, scheda n. 22, in ALFONSO LOMBARDI 2020, pp. 156-158. Alla coroplastica, ma forse anche all’origine del ritratto, secondo il resoconto pliniano, fa riferimento il sigillo che rappresenta il vasaio Butades di Sicione, impresso sulla veste del San Girolamo, con cui Lombardi marcava la propria corrispondenza. Il sostegno di Sabba da Castiglione potrà inoltre aver sospinto l’accreditamento dello scultore presso la cerchia gonzaghesca.
58 LAMO/PIGOZZI 1996, p. 59. Anche Vasari ricorda: «Alla Madonna del Baracane fece il medesimo due Angeli di stucco» e le «cose pur di stucco a Castel Bolognese» (VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 1966-1987, IV (1976), pp. 408-409). Le sculture, in seguito policromate, sono oggi nella chiesa di San Petronio a Castel Bolognese (cfr. FARANDA 1999; L. Annibali, schede nn. 12-13, in L’ETERNO E IL TEMPO 2018, pp. 351-352. Sul tema si veda CALOGERO 2022(2023))
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
La penna poi che vergarà le carte lontano a chi sarà da tal scultura accompagnata da immortal scrittura gli farà noto, et sien tue lodi sparte.
O che gloria immortal, o che gran nome natura acquistarà con questa petra zià nota al Ciel per sue bellezze dive.
A tutto il mondo il Molza con sua cetra Gonzaga canta, e il Casio in questo scrive ai capi versi Camilla e il cognome.
Il percorso tratteggiato dai sonetti de La Gonzaga recupera temi ricorrenti nel punto d’incontro fra arti e lettere – l’eccellenza dell’artefice, il potere evocativo della scultura, la celebrazione della bellezza oltre il tempo – affidando però in modo originale alla facoltà spirituale dell’amore il compito di determinare la forma dell’opera d’arte. Da questa cornice ricca di sollecitazioni idealizzanti scaturisce infatti la modalità per nulla scontata secondo cui il busto di Camilla poteva definirsi somigliante al modello59 :
Ad Alfonso
Se cerchi Alfonso la Gonzaga diva scolpire in questo sasso al naturale per far la fama tua sempre immortale, et che di lei non sia questa età priva,
apri del Molza il cor, in cui lei viva amor già la scolpì con l’aureo strale per beltà fatta a le celesti uguale di cui convien che ogni poeta scriva.
Se col martello e col saper de l’arte brami viva tenerla sempre in terra, et egli con sua voce, inchiostro e carte,
la Parca che gli umani assalta e atterra sol di Camilla avrà la mortal parte, ché alla fama non può morte far guerra
Lo scultore si impegnava insomma a esemplare il ritratto non sull’aspetto esteriore, ma sull’immagine celeste di Camilla, scolpita da Amore nel cuore di Molza (vv. 5-8)60. Il motivo è desunto dal sonetto CLV del Canzoniere petrarchesco61 :
Quel dolce pianto mi depinse Amore, anzi scolpìo, e que’ detti soavi mi scrisse entro un diamante in mezzo al core
59 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 84v; DAMIANAKI ROMANO 1998, p. 389.
60 Viene in mente l’osservazione contenuta in una lettera che Giulio Romano scrisse nel 1538 da Bologna a Federico II, che definiva i ritratti in terra di Lombardi come più somiglianti al modello rispetto a quelli in marmo, cfr. GIULIO ROMANO 1992, II, pp. 756-757.
61 Vv. 9-11. I versi di Petrarca sono accostati dalla seconda Lezzione di Varchi a quelli stralciati dalle Stanze sopra il ritratto di Giulia Gonzaga di Molza (cfr. VARCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 40)
Forzando uno schema nei rapporti fra poeta-committente e artista al cui consolidamento aveva contribuito in modo significativo Bernardo Bembo62, a Lombardi si chiedeva di duplicare la forma ideale della donna presente nel cuore dell’amante, traducendo nel marmo una metafora poetica e ponendosi sullo stesso piano della divinità d’amore.
Il concetto, diffuso in ambito raffaellesco, secondo cui Amore rivela, dell’amata, qualità che neppure il più grande artista potrebbe cogliere63 portò Alfonso a confrontarsi con un’immagine dell’anima. L’effigie di Camilla veniva così sottratta al ruolo – consueto, nella stilizzazione petrarchesca – di ricettacolo dei sospiri e delle «perpetue lacrime» dell’innamorato64. L’elaborazione del ritratto consentiva alla scultura e al suo artefice di rendere trasparente il cuore dell’amante, aprendo allo sguardo la sua anima e mettendo in luce la perfezione che essa conteneva65. In questo senso specifico, la statuaria poteva richiamare la presenza viva della persona effigiata, motivo qualificante della scultura nelle discussioni del Cortegiano
Francesco Maria Molza, promotore a Bologna del gioco intellettuale che approfondiva lo schema mutuato da Petrarca, rivestiva in quegli anni un ruolo di punta nella comunità intellettuale. In tal senso si possono leggere l’omaggio lusinghiero che si trova nel sonetto indirizzatogli da Casio ne La Gonzaga, e la segnalazione del poeta come modello possibile della nuova letteratura nei Ricordi di Agnolo Firenzuola66 .
A sostegno del ruolo decisivo rivestito da Molza nel definire codici e temi nel cenacolo riunito presso il «Pepolo tugurio», va ricordata l’autorità in materia amorosa attribuita al poeta dalle Novelle di Matteo Bandello e dal Dialogo d’amore di Sperone Speroni, dove il modenese introduce una digressione impegnata a flettere verso orizzonti spirituali l’amore sensuale67 . L’amicizia fra Speroni e Molza, come pure quella tra Bandello e il poeta, risale agli anni oggetto di questo studio. I dialoghi bolognesi di Speroni tratteggiano in controluce la ricchezza di spunti che Molza poté sottoporre alla riflessione di Alfonso Lombardi con la commissione del ritratto.
Per Molza, ogni pensiero sulle arti muoveva dalla conoscenza della statuaria antica, e si affinò successivamente, a Roma, nella sodalitas dei ‘virtuosi’, attraverso la presenza di Michelangelo68 . Nel 1532, dieci anni dopo l’inizio del soggiorno bolognese, Molza fu testimone dell’incursione buonarrotiana nel campo del ritratto. Indotto dalla bellezza di Tommaso de’ Cavalieri ad affrontare un genere a lui alieno, Michelangelo alimentò una
62 WALTER–ZAPPERI 2006, pp. 31-44; BOLZONI 2013a.
63 FAIETTI 2016, p. 42, ma va ricordato anche il riferimento alla virtù «ristretta al cor» e al ruolo guida assunto da Amore nel guidare la mano dell’artista del sonetto molziano Per formar Zeusi una beltade eletta, per il quale si veda MOLZA/PIGNATTI 2024, II, p. 1210.
64 Il riferimento è alle parole di sant’Agostino nel Secretum petrarchesco (III, 115). Sull’amore come veicolo per l’emersione delle più alte qualità dell’anima e sull’impegno della pittura nel riprodurle si vedano BOLZONI 2008, pp. 11-12, FAIETTI 2016, p. 42, e Cinquant’anni di poesia su Raffaello e di Raffaello (1506-1556), antologia a cura di D. Da Pieve, P. Nardoni, con selezione dei testi di M. Faietti, in RAFFAELLO 2016, p. 53.
65 Il tema era stato sviluppato negli Asolani; si rimanda in proposito a BOLZONI 2010 e 2013a, pp. 303-304.
66 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 84r. Al v. 5, l’iperbolico sonetto di Casio si indirizza a Molza dichiarando che «Cato, Tullio e Maron in te si serra». Per l’omaggio rivolto a Molza da Agnolo Firenzuola si veda ROMEI 1983, pp. 108, 116.
67 Il dialogo apre la editio princeps di SPERONI 1542. Per il ruolo di Molza nel Dialogo d’amore, che include fra i protagonisti Benedetto Varchi, si veda D. Chiodo, “E viva amore e muoia soldo”: il magistero molziano alla corte di Ippolito de’ Medici, in CHIODO 2013, pp. 64-65. Una lettera indirizzata a Molza da Varchi nel 1537 testimonia che «messer Sprone […] è tutto di vostra signoria e molto a quella si raccomanda» (cit. in BARBIERI 2014, p. 114) Intorno ad argomenti amorosi si dipana anche la novella che Matteo Bandello dedica «al mag. e dotto m Francesco Maria Molza», rievocando anche le discussioni intrattenute a Bologna con il poeta (BANDELLO 1554, I, dittico I, 50, c. 331v)
68 La collezione di Molza è stata ricostruita in essenza da VAGENHEIM 2017 sulla base di un documento in cui Pirro Ligorio, in rapporto col poeta nei mesi estremi della sua malattia, esprimeva ammirazione incondizionata per le sue conoscenze antiquarie – Molza è infatti l’unico poeta moderno inserito nelle Antichità di Roma. Per l’Accademia della Virtù cfr. GINZBURG 2007.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
riflessione critica che aveva, per Molza, radici lontane. Di lì a poco, il poeta modenese si trovò ad argomentare la scelta di Sebastiano del Piombo quale unico artista capace di dare visibilità all’essenza spirituale di Giulia Gonzaga in virtù delle qualità scultoree che l’artista veneziano era in grado di infondere alla pittura. Le Stanze dedicate al ritratto della dama segnarono in seguito un punto di partenza per la riflessione sviluppata da Benedetto Varchi intorno alla «maggioranza delle arti»69
In una singolare sfida al tempo e alla morte, il ritratto in pietra (o, nel caso di Giulia Gonzaga, il dipinto capace di far proprie le caratteristiche della pietra) fissava le qualità interiori dell’amata esaltandone la dimensione celeste, e accompagnava l’osservatore, nelle parole che il Cortegiano faceva dire a Pietro Bembo, sulla «divina strada amorosa»70
Alla luce della riflessione formale compiuta da Lombardi durante l’elaborazione del busto di Camilla Gonzaga, le ragioni dello scarto di stile rilevabile tra le opere fittili e le sculture lapidee dell’artista assumono motivazioni forse non riconducibili soltanto alla predilezione del ferrarese per la coroplastica71. Il tratto sintetico che caratterizza le opere in pietra ancora esistenti, alternativo al naturalismo della plastica emiliana, fa rimpiangere la scomparsa del busto di Camilla scolpito da Alfonso, e l’impossibilità di misurare la risposta data dall’artista alle sollecitazioni che egli poté assorbire nelle sale di Palazzo Pepoli.
Il ritratto di Pietro Pomponazzi
Segmento centrale della Cronica di Girolamo Casio sono gli epitaffi commissionati da Ercole Gonzaga dopo la morte di Pietro Pomponazzi, maestro del giovane, avvenuta a Bologna il 18 maggio 152572. La serie di componimenti precede, nella scansione della Cronica di Pandolfi, la ben più corposa Gonzaga, e dà voce all’autore, al figlio di Isabella d’Este e al suo maestro, che osserva dall’aldilà il lutto dell’ateneo e del proprio allievo.
Il rapporto di Ercole Gonzaga con il filosofo, centrale nei versi di Casio, è documentato dal carteggio tra il giovane, sua madre Isabella e il mentore Vincenzo di Preti, cui si aggiungono alcune missive dello stesso Pomponazzi73. Ercole, giunto a Bologna diciassettenne nel dicembre 1522, affiancava alle lezioni le «conversazioni honorevolissime de ogni sorte de persone, maxime de litterati, quali dal Sr. mio sono adorati non che amati», nel cui numero sono da annoverare Girolamo Casio e Francesco Maria Molza74
69 Per le Stanze si veda MOLZA/SERASSI 1747-1754, I (1747), pp. 135-147. Varchi ottenne da Annibal Caro, nel marzo 1533, una copia del componimento, che fu anche commentato da Pietro Bembo con una serie di note oggi perdute (cfr. BARBIERI 2014, p. 41)
70 CASTIGLIONE/QUONDAM–LONGO 2000, IV, LXII, p. 440. Il ritratto femminile svolto alla maniera veneziana, attraverso ricchi impasti cromatici, diventava invece per Molza correlato visibile della sensualità (si veda in proposito ONGHI 2021, pp. 97-101). L’interpretazione metaforica dell’aspetto materiale dell’opera d’arte raggiunge il proprio vertice nel sonetto Da la più ricca vena il più pregiato (MOLZA/PIGNATTI 2024, II, pp. 904-905), dedicato al ritratto di Faustina Mancina dipinto da Giulio Clovio per il cardinale Alessandro Farnese. Un riferimento al componimento si trova in WALTER–ZAPPERI 2006, p. 94.
71 LUCIDI 2018, pp. 84-85.
72 La sequenza si trova in CASIO DE’ MEDICI 1529, cc. 57r-62r: «Havendomi V. Illustriss. et Reveren. Signoria commesso, che per la morte de lo eccelso philosopho et divo theologo maestro Pietro Pomponazo [sic] mantovano, cognominato il Peretto, felsineo cathedrante et di essa almo precetor, componga lo epitaphio» (ivi, p. 57r). La vicenda del ritratto di Pietro Pomponazzi è trattata da CALOGERO 2022, I, pp. 21-22.
73 LUZIO 1886a; MANTOVA 1962, pp. 273-292; MURPHY 2007, pp. 5-14; LUZIO–RENIER/ALBONICO 2005, pp. 65-72; CALOGERO 2022, I, pp. 21-22. Va ricordata la solidarietà portata da Bembo a Pomponazzi quando, nel 1516, il De anima aveva suscitato la reazione di Leone X (cfr. DANZI 2006, p. 114). Negli anni bolognesi, Ercole Gonzaga inaugurò una corrispondenza in latino con Pietro Bembo.
74 LUZIO 1886a, p. 376: la citazione è tratta da una lettera del 12 dicembre 1522 indirizzata da Vincenzo di Preti a Isabella d’Este.
Studi di Memofonte 34/2025
Le poesie di Pandolfi si impegnano a celebrare, con qualche cautela, il pensiero e l’insegnamento del filosofo, collocandone tra i beati l’esistenza oltremondana e allontanando l’ombra del suicidio dalle circostanze della morte. In chiusura della sequenza pomponazziana, i versi danno notizia, con un tetrastico, della realizzazione da parte di Alfonso Lombardi di un ritratto di Pomponazzi75 :
Per lo ritratto suo fatto dallo eccelso Alfonso scultore
Dil Pomponazzo mantovan Peretto felsineo cathedrante è il simulacro qual dava ad Aristotile et al sacro Thoma aquinate il proprio almo intelletto.
La commissione dell’opera giunse ad Alfonso da parte di Ercole Gonzaga, destinatario della serie poetica e tanto devoto a Pomponazzi da utilizzare, a partire dalla primavera 1524, quando il filosofo si ritirò dall’insegnamento per l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, un sigillo con il profilo del maestro (Fig. 1). È lecito chiedersi se la silhouette di Pomponazzi inclusa nel sigillo non debba essere ricondotta alla mano dello scultore ferrarese76. In ogni caso non mancavano a Ercole occasioni di contatto col mondo degli artisti: il 10 gennaio 1523 Vincenzo di Preti informava Isabella che
Domani se comincia qui a far nothomia d’uno di quei due che hoggi sono stati appichati per ladri, dove concorreranno tutti quesi scolari artisti, perché è cosa che si fa rare volte et molto utile alla professione loro: durerà diece o dodice giorni, nel qual tempo il Sr. mio ha ditto volere andare a vedere due o tre volte, andandogli anchor Mons. Pyrrho Gonzaga qual altre volte gli è stato77
Il rapporto di committenza tra Lombardi e il figlio di Isabella d’Este si colloca nella rete di contatti di matrice gonzaghesca tessuta dallo scultore a Bologna, al cui interno maturò anche lo scambio con Federico II, documentato a partire dal 1529. Centrate ancora sul ritratto, con la commissione delle effigi degli imperatori per la Sala delle Teste, le richieste di Gonzaga ebbero come fuoco principale l’apparato scultoreo del sepolcro del padre Francesco, che Lombardi non portò a termine78
75 CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 61v. La realizzazione dell’opera fu segnalata da Gaetano Milanesi in VASARI/MILANESI 1878-1881, V (1880), p. 92, nota 3, e successivamente in COLASANTI 1904, p. 202, e in AGOSTI 1998, pp. 173-174 e note 14-17. Il valore consolatorio dell’opera realizzata da Cittadella, che doveva costituire un surrogato della presenza di Pomponazzi, è confermato dai versi che precedono immediatamente il tetrastico (CASIO DE’ MEDICI 1529, c. 61v, vv. 7-10): «Sfoga mio acerbo pianto, o dira Morte / ch’io veda quel Peretto più per tempo / che le mie rime e ’l cor tenea già lieto, / per lo ritratto suo fatto dallo eccelso Alfonso scultore». In questa ottica, la somiglianza al modello diventava cruciale.
76 Riproduco il sigillo presente in ASMn, AG, busta 1150, c. 261v, la prima missiva che lo riporta, datata 10 giugno 1524. Il sigillo, pubblicato in MANTOVA 1962, tav. 15, è ricordato da LUZIO 1886a, p. 386. Nel 1528 Ercole commissionò un secondo sigillo a Benvenuto Cellini, per il quale si vedano PORTIOLI 1881c e BROWN 1991, fig. 11. Pochi giorni prima della morte di Pomponazzi, il 15 maggio 1525, Ercole Gonzaga aveva inviato al fratello maggiore alcune «teste antiche» (LUZIO 1886a, p. 385): chissà se Lombardi poté studiarle. La ricostruzione degli ultimi mesi di vita di Pomponazzi si trova in CIAN 1887, p. 15.
77 LUZIO 1886a, p. 381.
78 La corrispondenza fra Lombardi e Federico Gonzaga è stata pubblicata da BRAGHIROLLI 1874-1876; cfr. anche GRAMACCINI 1980, pp. 66-70. Per il progetto raffaellesco della tomba di Francesco Gonzaga cfr. PERINI 1995(1996), pp. 121-127; CALOGERO 2022, I, pp. 135-142; per la Sala delle Teste si veda AGOSTI–FARINELLA 1992. Il prestigio della committenza gonzaghesca spingeva Lodovici ad accostare il nome di Lombardi a quelli di Raffaello e Michelangelo; il passaggio di LODOVICI 1535 è anche in SHEARMAN 2003, p. 887.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
Dopo la scomparsa di Pomponazzi, Ercole rientrò a Mantova. Qui provvide alla sepoltura del maestro e patrocinò, secondo la testimonianza di Paolo Giovio, ripresa da Saverio Bettinelli, la realizzazione di un monumento in sua memoria nella chiesa di San Francesco, «con statua, ed iscrizione onorevole»79 È verosimile che la commissione del «simulacro» a Lombardi fosse orientata fin da subito a fornire un modello per l’effigie inclusa nel monumento: la citazione dell’opera nel contesto dei componimenti in morte del filosofo proietta il lavoro di Cittadella in ambito funerario.
Due anni prima che, nel 1799, la tomba di Pomponazzi in San Francesco venisse manomessa dalle truppe francesi, Francesco Tonelli ne descriveva con precisione l’aspetto80 :
essendo morto il Pomponazzi in Bologna, il detto Cardinal Ercole onorollo con far trasportare il di lui cadavero dal luogo in cui cessò di vivere, sino a Mantova, e con farlo porre in una cappella del tempio di San Francesco grande nel monimento sepolcrale della famiglia di esso Pomponazzi, aggiuntavi nel muro laterale una statua di bronzo che ancor oggigiorno lo rappresenta vestito da filosofo il qual siede con una mano al mento, con un libro aperto nell’altra, e con la seguente iscrizione sotto il piede destro: Obiit anno salutis M. D. MDXXIV [sic] mense Maii. / Mantua clara mihi genitrix fuit, et breve corpus / quod dederat natura mihi, me turba PERETTUM / dixit: naturae scrutatus sum intima cuncta.
L’intervento patrocinato da Ercole accostò al monumento della famiglia Pomponazzi, già esistente, l’effigie bronzea a figura intera del filosofo in meditazione, collocata in una nicchia e corredata di un’iscrizione che valorizzava la fisionomia di ‘Peretto’. La riconoscibilità dell’effigiato risultava cruciale per l’omaggio reso da Gonzaga al proprio maestro. Le capacità virtuosistiche di Alfonso Lombardi nel ritrarre in creta, che nel caso di Pomponazzi potevano aver avuto come base un calco funebre, potrebbero aver fatto del «simulacro» ricordato da Casio il punto di partenza indispensabile per la memoria del filosofo.
Che il ritratto eseguito da Lombardi abbia fornito il modello per la scultura inserita nel mausoleo è suggerito in via indiretta dalla corrispondenza settecentesca tra lo storico mantovano Leopoldo Camillo Volta e Giovan Battista Giovio, discendente dello storico. Volta, prefetto della Biblioteca Teresiana e del Museo di Antichità, visitata la raccolta comasca, chiedeva il permesso di far eseguire una copia su tela del ritratto di Pomponazzi, definito «conforme» alla scultura del sepolcro mantovano81 :
Nel mio passaggio per Como, avendo avuto l’onore di conoscere personalmente V. S. Ill.ma, e insieme di ammirare la di lei bellissima collezione di ritratti, mi fece ardito di chiederle il permesso di aver copia di quello di Pomponazzi, non essendomi avvenuto giammai in altro più bello e più somigliante di esso, perché conforme alla statua di bronzo che si osserva in questa chiesa di San Francesco, dov’è sepolto quel celebre filosofo.
79 La citazione è in BETTINELLI 1774, p. 144. Secondo Bettinelli la statua di Pomponazzi era «non sì perfetta, com’è la testa del Mantegna» in Sant’Andrea (ibidem). Per la dispersione del monumento funebre si veda INTRA 1882, p. 301. 80 TONELLI 1797, pp. VII-VIII. Notizie sul sepolcro si trovano anche in BETTINELLI 1774, p. 144, e FIORENTINO 1868, p. 68. Ciò che resta della tomba di Pietro Pomponazzi fu ricomposto nel 1804 sulla parete della Cappella Cantelmi nella basilica di Sant’Andrea, sormontato dal busto di Giovanni Pomponazzi «in abiti frateschi», in origine collocato di fronte al ritratto del filosofo: TONELLI 1797, p. LIII. La descrizione del monumento funebre si può integrare con la testimonianza della Cronaca univerale di Federico Amadei, risalente alla prima metà del Settecento: «una statua di bronzo che il rappresenta in atteggiamento di chi siede, con mano poggiata al mento, tenendo nella destra un libro aperto per istudiarvi sopra attentamente» (AMADEI 1954-1957, II (1955), p. 496).
81 Stralcio dalla lettera di Volta a Giovan Battista Giovio, datata 28 settembre 1786, riprodotta integralmente da KLINGER 2002, p. 154. Su Leopoldo Camillo Volta cfr. SCIFONI 1849.
Studi di Memofonte 34/2025
Il ritratto del Musæum gioviano era copia di un’effigie di Pomponazzi appartenente a Ercole Gonzaga che Paolo Giovio, allievo del filosofo a Padova e informato sul monumento patrocinato dal Gonzaga82, aveva chiesto per la propria collezione.
Scrivendo a Benedetto Capilupi il 20 ottobre 1545, il cardinale di Mantova descriveva in questi termini la sollecitazione giuntagli dallo storico comasco: «Quanto alli ritratti che desidera mons. Giovio vi dico che ho il Perotto [sic] naturalissimo et bisogna farne cavar da quello un simile, che altramente non mi priverei della memoria di quell’huomo che fu mio maestro» Il cardinale incaricò della copia Fermo Ghisoni, essendo Giulio Romano troppo impegnato «a disegni et fabriche» per accollarsi la realizzazione della tela83. L’inventario dei dipinti presenti nella collezione di Ercole Gonzaga includeva due ritratti di Pomponazzi, registrati come «uno del Pomponazo et uno del Peretto»84. Nel pubblicare il documento, Clifford Malcom Brown ipotizzava che una delle due effigi fosse a figura intera come la scultura del sepolcro.
L’opera inviata da Ercole Gonzaga a Paolo Giovio è dispersa85, ma ne resta un’eco nella copia seicentesca fatta eseguire da Federigo Borromeo oggi alla Biblioteca Ambrosiana (Fig. 2). Del dipinto appartenuto al Musæum esiste anche una derivazione a Ferrara, nel palazzo di Renata di Francia, attribuita a un anonimo pittore ferrarese, dove i tratti di Pomponazzi sono riconoscibili, pur se ammorbiditi86. Della tela conservata all’Ambrosiana colpisce la restituzione schietta, per nulla ingentilita, dell’aspetto di Pomponazzi, che evoca la descrizione ostile di Matteo Bandello:
Era il Peretto un omicciuolo molto picciolo, con un viso che nel vero aveva piú del giudeo che del cristiano, e vestiva anco ad una certa foggia che teneva piú del rabbi che del filosofo, e andava sempre raso e toso; parlava anco in certo modo che pareva un giudeo tedesco che volesse imparar a parlar italiano87 .
Del tutto simile è anche il ritratto tracciato con pochi, precisissimi tratti, da Paolo Giovio nel medaglione biografico dedicato al filosofo, che era stato suo maestro a Padova: «Erat pusilla admodum, sed quadrata corporis statura, capite nulla ex parte enormi, vel insulso, utpote oculis ad omnes animi habitus aptissime paratis, et intensis»88 .
82 Così Paolo Giovio nel medaglione biografico di Pomponazzi: «relatusque inde Mantuam, nobile sepulchrum Herculis Gonzaga Cardinalis, erga civem et magistratum liberali pietate promeruit» (GIOVIO 1577, p. 135). La biografia comparve nella prima edizione dell’opera, GIOVIO 1546. La registrazione gioviana coincide con quella dei Diari di Marin Sanudo: “Il corpo dil quale heri fu mandato a Mantova senza pompa alcuna et ivi si faranno le exequie solennissime, così ha voluto lo illustre signor Hercule fratello dil marchese di Mantova che è qui et era suo scolaro, non ha mancato in cosa niuna per aitarlo” (cit. in LUZIO 1887, p. 31).
83 Per la lettera di Ercole Gonzaga cfr. KLINGER 2002, pp. 153-154.
84 BROWN 1991, p. 216.
85 L’11 gennaio 1547 Paolo Giovio dava notizia della realizzazione della copia al vescovo di Fano: «si degni farmi grazia d’un suo ritratto in tela, per metterlo con tanti altri al mio Museo; poi che ’l Sig. Cardinale di Mantova non mi mandò, come gli domandai, questo tal ritratto […] havendo con singolar cortesia mandati quelli del Peretto, et del Carmelita» (GIOVIO/DOMENICHI 1560, p. 25).
86 Per il ritratto dell’Ambrosiana cfr. D. Tolomelli, scheda n. 853 (Pietro Pomponazzi), in PINACOTECA
AMBROSIANA 2007, pp. 342-343; JONES 1997, p. 325. Sul dipinto, attribuito a un pittore ignoto e già presente nelle raccolte ambrosiane nel 1661, si legge l’iscrizione «PERETTVS MANTVANVS». Per il dipinto ferrarese, corredato dell’iscrizione «PETRVS POMPONATIVS», si veda VISCONTI 1950, p. 46.
87 BANDELLO 1554, III, dittico I, cc. [130v]-132r: Il Peretto mantovano essendo in Modena, è dalle Donne per giudeo beffato, per la sua poca & abietta presenza (novella XXXVIII). Pomponazzi compare come personaggio della «Novella sesta» di Francesco Maria Molza: SÖDERHJELM 1914, pp. 56, 59. Sui rapporti tra Molza e Bandello, presente a Bologna in quel torno di anni, si vedano BARBIERI 1998, p. 127, e BARBIERI 2014, p. 21.
88 GIOVIO 1577, pp. 134-135. Del tutto simile è il ritratto che di Pomponazzi tracciò Luca Gaurico (cit. in GABOTTO 1892, p. 20).
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
L’incisività della tela ambrosiana lascia immaginare in filigrana le caratteristiche tanto del «Perotto naturalissimo» di Ercole Gonzaga quanto del ritratto bronzeo del sepolcro a cui esso risultava «conforme», secondo la definizione di Camillo Volta. È ragionevole ritenere che a capo di questa famiglia di effigi si trovasse l’opera di Lombardi, certamente in grado di riprodurre con efficacia l’aspetto di un individuo tanto singolare.
A proposito della sepoltura di Pomponazzi va anche registrata la testimonianza di Carlo d’Arco, che riferiva la realizzazione del ritratto bronzeo a un misterioso
Alfonso da Mantova che fece di bronzo la statua rappresentante Pietro Pomponazzo, la quale fu collocata nella chiesa di San Francesco e ricordata con molta lode dagli scrittori. A noi non è conceduto discorrere del merito di questa statua, perché sul finire del secolo trascorso andò miseramente distrutta89
D’Arco fissava la nascita di «Alfonso da Mantova» al 1509, nonostante ne riportasse la morte, su base documentaria, il 17 aprile 1599 «de anni 80». Anche rettificando la data di nascita, gli estremi biografici non si conciliano con un monumento la cui elaborazione prese avvio nel 1525, dopo la traslazione del corpo di Pomponazzi. Nella sua lunga carriera, aggiungeva d’Arco, «può credersi che [Alfonso da Mantova] abbia pur eseguiti altri lavori dei quali, andati poi guasti e perduti, per incuria cittadina non se ne sia tenuta punto memoria»90. La figura dell’artista diventa così evanescente, e spinge piuttosto a chiedersi se la sua evocazione non sia da leggersi come spia del collegamento tra il nome di Cittadella e l’effigie funeraria di Pomponazzi.
Resta fuori da questa genealogia di ritratti pomponazziani l’incisione eseguita da Tobias Stimmer per l’edizione degli Elogia stampata a Basilea da Pietro Perna (1577, Fig. 3). Tutt’altro che «toso», il profilo risulta lontano dalle caratteristiche del filosofo che si ritrovano puntualmente riprodotte tanto nel sigillo di Ercole Gonzaga quanto nella medaglia siglata da Bartolommeo Melioli e inclusa nel Museum Mazzuchellianum (Fig. 4)91. Il ritratto inciso da Stimmer ricalca vagamente i tratti somatici di Pomponazzi, risolvendone però in maniera incongrua la capigliatura e il copricapo: il profilo risulta in sostanza spurio e comunque non utilizzabile come modello per il bronzo del sepolcro mantovano.
Dal prototipo della tela ambrosiana (e gioviana) deriva invece l’incisione inclusa dal francese Claude Pernet nelle Illustrissimorum, omnique virtutis, et scientiarum laude præstantissimorum virorum icones, una raccolta di ritratti dovuti a incisori diversi, in parte derivata dall’iconoteca di Giovio, che riunisce le effigi di ecclesiastici e umanisti, e che fu dedicata nel 1625 a Filippo Colonna (Fig. 5)92. L’incisione, nitida e accurata, indugia sulle caratteristiche del volto e dell’epidermide, e dà risalto alla vivacità dello sguardo, gli «oculis […] intensis» ricordati da Giovio.
A oltre trent’anni di distanza dalla morte di ‘Peretto’, verso il 1557, Fermo Ghisoni (o forse Ippolito Costa) dipinse un secondo ritratto di Pomponazzi, incluso in veste di san Domenico all’interno della tavola con la Deposizione con il cardinale Ercole Gonzaga, oggi nella
89 D’ARCO 1857, I, libro III, pp. 85 (e nota 3), 86 (nota 1).
90 Ibidem
91 Bartolommeo Melioli morì nel 1514. Cfr. GAETANI 1761-1763, I (1761), tav. XXXIX, IV e pp. 173-174 Della medaglia discute anche PORTIOLI 1881a e 1881b. Di una diversa medaglia di Pomponazzi, firmata «magistro B. M. fac.», dà notizia ARMAND 1883-1887, III (1887), p. 194. Per il profilo di Pietro Perna, stampatore degli Elogia gioviani, si veda PERINI 2002.
92 PERNET 1625. La serie comprende 63 ritratti. Il ritratto di Pomponazzi reca l’iscrizione «Petrus Po(m)ponatius – 26», 104x80 mm. Su Claude Pernet (1585-1650), incisore e intagliatore, e sulla pubblicazione delle Icones, si vedano FIRPO 1954 e BATTIFOGLIA 2015, p. 169.
Studi di Memofonte 34/2025
chiesa mantovana di Sant’Egidio (Fig. 6)93. Chissà se la scultura del mausoleo mantovano non possa aver fatto da modello al pittore. L’opera riaffermava comunque, quasi in articulo mortis, l’affetto di Ercole per il maestro, mentre la scritta in ebraico sul sepolcro richiamava un tema legato all’anima, centrale nella speculazione di Pomponazzi94
Secondo i rapporti qui ricostruiti, il dipinto dell’Ambrosiana e l’incisione del volume di Claude Pernet consentirebbero di immaginare almeno in essenza il volto del «simulacro» eseguito da Alfonso Lombardi per Ercole Gonzaga. Le fattezze del filosofo dovevano esservi descritte con la verità tagliente, ‘naturalissima’, che aveva reso celebre l’artista ferrarese. L’eccezionale caratterizzazione del viso e il senso di viva presenza di Pomponazzi, insieme all’attenzione per le pieghe e le imperfezioni della pelle leggibili nella tela milanese e nell’incisione, fanno venire in mente una tipologia affine a quella del Giuseppe d’Arimatea nel Compianto realizzato da Lombardi per le monache di Santa Margherita a Bologna (Fig. 7). Assorto in una meditazione che evoca quella del ‘Peretto’ in bronzo del mausoleo mantovano, il Giuseppe d’Arimatea della cattedrale bolognese induce a sospettare che un unico pensiero aleggi dietro alle due figure95
La divaricazione tra sublimazione di matrice neoplatonica e aderenza alla natura innescata dai ritratti di Camilla Gonzaga e di Pietro Pomponazzi, la dialettica tra definizione di un canone di valore universale e riproduzione fedele dei tratti individuali, tra la tensione verso un modello ideale e la spregiudicata aderenza all’aspetto delle cose che Alfonso Lombardi ebbe occasione di tradurre in concrete scelte espressive trovano, singolare consonanza con alcuni nuclei tematici del Dialogo delle lingue di Sperone Speroni.
Allievo di Pomponazzi e collega a Bologna di Ercole Gonzaga, Speroni ambientava nella città felsinea un dibattito sulla lingua che dava corpo alle due opzioni divergenti proprio attraverso i personaggi di Bembo e Pomponazzi, in un contrasto prossimo a quello attraversato da Alfonso Lombardi nei mesi che hanno costituito l’oggetto di questo scritto96 .
Nel Dialogo speroniano, alla via propugnata da Bembo di una regola «generalissima e universale» che eleggeva, nel campo dello stile, «le più pure, le più monde, le più chiare sempre, le più belle e più grate voce»97, si opponeva l’intercalare vivacemente mantovano, polemicamente moderno e aderente alle cose con cui Pomponazzi punteggiava il latino delle proprie lezioni. Per bocca di ‘Peretto’, Speroni avvertiva anzi che ogni ritratto, «quantunque fatto d’artificiosissimo dipintore, non può essere del tutto simile alla idea»98 E chissà se Lombardi avrebbe sottoscritto questo pensiero, mentre sperimentava nelle proprie opere la via difficile fra terra e cielo.
93 Sul dipinto si vedano BROWN 1991, p. 206; MURPHY 2007, pp. 245-247; GRASSI 1993. Ringrazio don Andrea Luppi per il supporto nel reperire l’immagine del dipinto.
94 BROWN 1991, p. 225, nota 21. L’iscrizione in ebraico fa riferimento al Primo libro di Samuele (25, 29): «la tua anima […] sarà conservata nello scrigno della vita presso il Signore tuo Dio».
95 Sul Compianto si rimanda a LUCIDI 2018, p. 72. CAPRARA 2002, pp. 147-152, ha proposto per il gruppo oggi in Cattedrale una datazione al 1523, condivisa da CALOGERO 2022, I, p. 105. Per un corto circuito davvero affascinante, la citazione del libro di Samuele inclusa nella Deposizione con il cardinale Ercole Gonzaga (cfr. supra, nota 94), in cui compaiono insieme Pietro Pomponazzi e il cardinale di Mantova, fa riferimento – in un’iscrizione che si legge sul dipinto – alla «Pietra del sepolcro di Rabbi Yosef, figlio di Mattatia», cioè Giuseppe d’Arimatea.
96 Il dialogo fu pubblicato a Venezia nel 1542. Si vedano anche le riflessioni in proposito di RICCÒMINI 2008, pp. 45-47.
97 BEMBO/DIONISOTTI 1966, II, IV, p. 51
98 SPERONI/POZZI 1978, p. 622.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
Fig. 1: Alfonso Lombardi (?), Sigillo di Ercole Gonzaga con l’effigie di Pietro Pomponazzi, 10 giugno 1524 ASMn, AG, busta 1150, c. 261v. © Archivio di Stato di Mantova
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 2: Artista del XVII secolo, Perettus Mantuanus (Ritratto di Pietro Pomponazzi). Milano, Biblioteca Ambrosiana. © Veneranda Biblioteca Ambrosiana / Mondadori Portfolio
Fig. 3: Tobias Stimmer, Pietro Pomponazzi, in Paolo Giovio, Elogia virorum literis illustrium […], Basilea 1577, p. 134
Fig. 4: Bartolommeo Melioli, Medaglia di Pietro Pomponazzi, in P.A. Gaetani, Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doctrina præstantium, quæ apud Jo. Mariam comitem Mazzuchellum Brixiæ servantur […], I-II, Venezia 1761-1763, I (1761), tav. XXXIX, IV
Studi di Memofonte 34/2025
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
Fig. 5: Claude Pernet, Petrus Po[m]ponatius -26, in Illustrissimorum, omnique virtutis, et scientiarum laude præstantissimorum virorum icones […], Roma 1625. © The Trustees of the British Museum
Fig. 6: Ippolito Costa (o Fermo Ghisoni), Deposizione con il cardinale Ercole Gonzaga (particolare), 1557 ca. Mantova, chiesa di Sant’Egidio
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 7: Alfonso Lombardi, Giuseppe d’Arimatea, (particolare del Compianto sul Cristo morto), 1523 ca. Bologna, cattedrale di San Pietro. © Arcidiocesi di Bologna
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
BIBLIOGRAFIA
AGOSTI 2003
B. AGOSTI, Intorno alla ‘Vita’ gioviana di Raffaello, «Prospettiva», 110-111, 2003, pp. 58-69.
AGOSTI 2008
B. AGOSTI, Paolo Giovio. Uno storico lombardo nella cultura artistica del Cinquecento, Firenze 2008.
AGOSTI 1998
G. AGOSTI, Qualcosa su e di e intorno a Giulio Romano, in Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro, I, numero monografico di «Prospettiva», 91-92, 1998, pp. 171-185, 7.
AGOSTI 2005
G. AGOSTI, Su Mantegna I, Milano 2005.
AGOSTI–FARINELLA 1992
G. AGOSTI, V. FARINELLA, La Stanza delle teste, in Il giardino di San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo, catalogo della mostra, a cura di P. Barocchi, Cinisello Balsamo 1992, pp. 97-106.
ALFONSO LOMBARDI 2020
Alfonso Lombardi. Il colore e il rilievo. Un dialogo tra le arti a Bologna nel segno di Raffaello, catalogo della mostra, a cura di M. Calogero, A. Giannotti, [Rimini] 2020.
AMADEI 1954-1957
F. AMADEI, Cronaca universale di Mantova, I-V, Mantova 1954-1957.
ARGNANI 1881
F. ARGNANI, La Pinacoteca comunale di Faenza descritta […], Faenza 1881.
ARMAND 1883-1887
A. ARMAND, Les médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles, I-III, Parigi 1883-1887.
BANDELLO 1554
M. BANDELLO, Novelle, I-III, Lucca 1554.
BARBIERI 1998
A. BARBIERI, Biografia di Francesco Maria Molza dalle lettere, estratto di «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», XII, 1998, pp. 117-153.
BARBIERI 2014
A. BARBIERI, Il Molza. La sua vita e le sue lettere, Padova 2014
BATTIFOGLIA 2015
S. BATTIFOGLIA, Intagliatori francesi a Roma nel Seicento: un crocifisso inedito di Claude Pernet (16241625), in Scultura lignea: contributi per una storia tecnica, a cura di E. Lauro, N. Macchioni, volume speciale di «Rivista d’Arte», s. V, L, 2015, pp. 167-175.
Studi di Memofonte 34/2025
BEMBO 1810
P. BEMBO, Opere […], VIII. Lettere […] a principesse e signore, ed altre gentili donne scritte, Milano 1810.
BEMBO/DIONISOTTI 1966
P. BEMBO, Prose della volgar lingua, a cura di C. DIONISOTTI, Torino 1966.
BETTINELLI 1774
S. BETTINELLI, Delle lettere e delle arti mantovane discorsi due accademici ed annotazioni, Mantova 1774.
BIANCHI 1992
S. BIANCHI, Petrarca rivisitato. Il motivo delle «sei visioni» in una canzone di Francesco Maria Molza, «Lettere Italiane», XLIV, 1992, pp. 261-268.
BODON 2005
G. BODON, Veneranda Antiquitas. Studi sull’eredità dell’antico nella Rinascenza veneta, BernaBerlino - Bruxelles - Francoforte sul Meno - New York - Oxford - Vienna 2005.
BOLZONI 2008
L. BOLZONI, Poesia e ritratto nel Rinascimento, testi a cura di F. Pich, Bari 2008.
BOLZONI 2010
L. BOLZONI, Il cuore di cristallo. Ragionamenti d’amore, poesia e ritratto nel Rinascimento, Torino 2010.
BOLZONI 2013a
L. BOLZONI, Gli Asolani e il fascino del ritratto, in Pietro Bembo e le arti, atti del seminario internazionale (Vicenza 24-26 febbraio 2011), a cura di G. Beltramini, H. Burns, D. Gasparotto, Venezia 2013, pp. 285-308.
BOLZONI 2013b
L. BOLZONI, I ritratti e la comunità degli amici fra Venezia, Firenze e Roma, in PIETRO BEMBO 2013, pp. 210-217.
BRAGHIROLLI 1874-1876
W. BRAGHIROLLI, Alfonso Cittadella, scultore del secolo XVI, «Atti e Memorie della Reale Accademia Virgiliana», V, 1874-1876, pp. 77-132.
BROWN 1991
C.M. BROWN, Paintings in the Collection of Cardinal Ercole Gonzaga: After Michelangelo’s Vittoria Colonna Drawings and by Bronzino, Giulio Romano, Fermo Ghisoni, Parmigianino, Sofonisba Anguissola, Titian and Tintoretto, in Giulio Romano, atti del convegno internazionale di studi Giulio Romano e l’espansione europea del Rinascimento (Mantova 1°-5 ottobre 1989), a cura di O. Baracchi Giovanardi, Mantova 1991, pp. 203-226.
CALOGERO 2020
M. CALOGERO, Alfonso Lombardi, da Ferrara ai giorni dell’incoronazione. Un dialogo fra le arti, in ALFONSO LOMBARDI 2020, pp. 7-25.
CALOGERO 2022
M. CALOGERO, Alfonso Lombardi (1497 ca.-1537) e i materiali della scultura, tesi di Dottorato, I-II, Scuola Normale Superiore di Pisa, 2022.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
CALOGERO 2022(2023)
M. CALOGERO, Appunti per lo stucco “de marmoro” a Bologna nei primi decenni del Cinquecento (con un’ipotesi su Baldassarre Peruzzi), in Lo stucco nell’età della Maniera: cantieri, maestranze, modelli, a cura di A. Giannotti, S. Quagliaroli et alii, volume speciale di «Bollettino d’Arte», 2022(2023), pp. 25-34.
CALOGERO 2023
M. CALOGERO, La scultura nella prima metà del Cinquecento, in Il Cinquecento. Parte seconda, a cura di A. Tambini, in appendice Resti e testimonianze pittoriche del XVI secolo a Faenza di M. Vitali, Faenza 2023, pp. 206-227.
CAPRARA 2000
F. CAPRARA, Girolamo Casio e il ritratto a Bologna, fra religione, moda e letteratura, «Il Carrobbio», XXVI, 2000, pp. 61-82.
CAPRARA 2002
F. CAPRARA, «De uno monasterio de monache lascivo reformato al ben vivere per el Rosario». Alfonso Lombardi e Parmigianino in Santa Margherita, in Vita artistica nel monastero femminile. Exempla, a cura di V. Fortunati, Bologna 2002, pp. 147-167.
CARRARA 2019
E. CARRARA, Il tema del Paragone delle Arti da Leonardo a Benedetto Varchi, in Nodi, vincoli e groppi leonardeschi. Études sur Léonard de Vinci, atti della giornata di studi (Parigi 22 gennaio 2018), a cura di F. Dubard de Gaillarbois, O. Chiquet, Parigi 2019, pp. 241-256.
CASIO DE’ MEDICI 1529
G. CASIO DE’ MEDICI, Libro intitulato Cronica Ove si tratta di Epitaphii, di Amore, e di Virtute, [Bologna] [1529].
CASTIGLIONE/QUONDAM–LONGO 2000
B. CASTIGLIONE, Il Libro del Cortegiano (1528), introduzione di A. QUONDAM, note di N. LONGO, [Milano] 2000 (nona edizione; edizione originale 1990).
CASTIGLIONE 1554
S. DA CASTIGLIONE, Ricordi, overo ammaestramenti […] ne quali con prudenti, e christiani discorsi si ragiona di tutte le materie honorate, che si ricercano a un vero gentil’huomo […], Venezia 1554.
CAVICCHI 1915
F. CAVICCHI, Girolamo da Casio (1464-1533), «Giornale Storico della Letteratura Italiana», LXVI, 196-197, 1915, pp. 1-51
CHIODO 2013
D. CHIODO, Più che le stelle in cielo. Poeti nell’Italia del Cinquecento, Manziana 2013.
CIAN 1885
V. CIAN, Un decennio della vita di M. Pietro Bembo (1521-1531). Appunti biografici e saggio di studi sul Bembo. Con appendice di documenti inediti, Torino 1885.
CIAN 1887
[V. CIAN], Nuovi documenti su Pietro Pomponazzi, Venezia 1887.
COGGIOLA 1914-1915
G. COGGIOLA, Per l’iconografia di Pietro Bembo. Nota (con due tavole di ritratti), «Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Parte seconda», LXXIV, 1914-1915, pp. 473-514.
COLASANTI 1904
A COLASANTI, Gli artisti nella poesia del Rinascimento. Fonti poetiche per la storia dell’arte italiana, «Repertorium für Kunstwissenschaft», XXVII, 1904, pp. 193-220.
COLLARETA 1988
M. COLLARETA, Le «arti sorelle». Teoria e pratica del «paragone», in La pittura in Italia. Il Cinquecento, a cura di G. Briganti, I-II, Milano 1988, II, pp. 569-580
COLLETTANEE 1504
Collettanee grece, latine, e vulgari […], a cura di G.F. Achillini, con la vita di Serafino Aquilano scritta da V. Calmeta, Bologna 1504.
DAMIANAKI ROMANO 1998
C. DAMIANAKI ROMANO, «Come se fussi viva e pura». Ritrattistica e lirica cortigiana tra Quattro e Cinquecento, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LX, 1998, pp. 349-394.
DANZI 1986
M. DANZI, Il Raffaello del Molza e un nuovo codice di rime cinquecentesche, «Rivista di Letteratura Italiana», IV, 3, 1986, pp. 537-559.
DANZI 2006
M. DANZI, Da Padova a Roma all’Europa: collezionismo artistico, biblioteche e relazioni intellettuali in casa Bembo, in Del modo di insegnar presiedendo senza campanello. Studi in ricordo di Giulia Gianella, a cura di F. Beltraminelli, Bellinzona 2006, pp. 95-115.
DA PORTO/BRESSAN 1857
L. DA PORTO, Lettere storiche (1509-1528), a cura di B. BRESSAN, con l’aggiunta della novella di Giulietta e Romeo dello stesso autore e due lettere critiche di G. Todeschini, Firenze 1857.
D’ARCO 1857
C. D’ARCO, Delle arti e degli artefici di Mantova. Notizie raccolte ed illustrate con disegni e con documenti, I-II, Mantova 1857.
DAVOLIO 1833
V. DAVOLIO, Memorie storiche della contea di Novellara e dei Gonzaghi che vi dominarono, Milano 1833.
DELLE LETTERE 1560
Delle lettere da diversi re, et principi, et cardinali, et altri huomini dotti a Mons. Pietro Bembo scritte, a cura di F. Sansovino, Venezia 1560.
DIVERSE ORATIONI 1561
Diverse orationi volgarmente scritte da molti huomini illustri de tempi nostri. Nelle quali si contengono ragionamenti convenevoli a principi, a senatori, a capitani, & ad ogni altra qualità di persone […], a cura di F. Sansovino, Venezia 1561.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
FAIETTI 2012
M. FAIETTI, Vasari, maestro Amico e i pittori con «il capo pieno di superbia e di fumo», «Annali Aretini», XX, 2012, pp. 51-74, VII-IX.
FAIETTI 2016
M. FAIETTI, Raffaello, poeta mutolo, in RAFFAELLO 2016, pp. 24-45.
FARANDA 1999
F. FARANDA, Alfonso Lombardi. Il restauro delle sculture in cotto di Castel Bolognese, saggio introduttivo di D. Sinigalliesi, Castel Bolognese 1999.
FARINELLA 2015
V. FARINELLA, Alfonso I d’Este. Le immagini e il potere. Da Ercole de’ Roberti a Michelangelo, con la Cronistoria biografica di Alfonso I d’Este di M. Menegatti e Il Pulcher visus di Scipione Balbo a cura di G. Bacci, Roma 2015.
FERRONI 2018
G. FERRONI, «Sempre di natura pigro e negligentissimo nello scrivere». Le lettere di Francesco Maria Molza, in Epistolari dal Due al Seicento. Modelli, questioni ecdotiche, edizioni, cantieri aperti (Quaderni di Gargnano; 2), atti del XVI Convegno Internazionale di Letteratura Italiana ‘Gennaro Barbarisi’ (Gargnano del Garda 29 settembre - 1° ottobre 2014), a cura di C. Berra, P. Borsa et alii, Milano 2018, pp. [285]-314 (disponibile on-line https://riviste.unimi.it/index.php/quadernidigargnano/article/view/10882/pdf).
FIORENTINO 1868
F. FIORENTINO, Pietro Pomponazzi. Studi storici su la scuola bolognese e padovana del secolo XVI, Firenze 1868.
FIRPO 1954
L. FIRPO, Un ritratto sconosciuto di Francesco Guicciardini, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXXXI, 393, 1954, pp. 70-74
FRAGNITO 1994
G. FRAGNITO, Un eretico alla corte di Ferrara: Galasso Ariosto, in Alla corte degli Estensi. Filosofia, arte e cultura a Ferrara nei secoli XV e XVI, atti del convegno internazionale di studi (Ferrara 5-7 marzo 1992), a cura di M. Bertozzi, Ferrara 1994, pp. [65]-89.
FRANZONI 1990
C. FRANZONI, Le raccolte del Theatro di Ombrone e il viaggio in Oriente del pittore: le Epistole di Giovanni Filoteo Achillini, «Rivista di Letteratura Italiana», VIII, 2, 1990, pp. [287]-335
GABOTTO 1892
F. GABOTTO, Alcuni appunti per la cronologia della vita dell’astrologo Luca Gaurico, Napoli 1892.
GAETANI 1761-1763
P.A. GAETANI, Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doctrina præstantium, quæ apud Jo. Mariam comitem Mazzuchellum Brixiæ servantur […], I-II, Venezia 1761-1763.
GASPAROTTO 1996(1998)
D. GASPAROTTO, La barba di Pietro Bembo, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa Classe di Lettere e Filosofia. Quaderni», s. IV, 1-2, 1996(1998), pp. 183-206.
GAYE 1840
J.W. GAYE, Carteggio inedito di artisti dei secoli XIV, XV, XVI, II 1500-1557, Firenze 1840.
GINZBURG 2007
S. GINZBURG, Filologia e storia dell’arte. Il ruolo di Vincenzio Borghini nella genesi della Torrentiniana, in Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, atti delle giornate di studio (Pisa 30 settembre - 1° ottobre 2004), a cura di E. Carrara, S. Ginzburg, Pisa 2007, pp. [147]-203.
GINZBURG 2021(2023)
S. GINZBURG, Arti e lettere nell’orizzonte della nuova filologia. Sul proemio al III libro delle Prose di Bembo, in Pietro Bembo: dalle «città senza pari» alla corte papale, a cura di G. Donina, M. Grosso, numero monografico di «Horti Hesperidum», 2, 2021(2023), pp. [9]-54 (disponibile on-line https://www.horti-hesperidum.com/hh/horti-hesperidum-2021-2-2/).
GIOVIO 1546
P. GIOVIO, Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita. Quæ in musæo Ioviano Comi spectantur […], appendice con la vita di papa Adriano, Venezia 1546.
GIOVIO 1577
P. GIOVIO, Elogia virorum literis illustrium […], Basilea 1577 (edizione originale GIOVIO 1546).
GIOVIO/DOMENICHI 1560
P. GIOVIO, Lettere volgari […], a cura di L. DOMENICHI, Venezia 1560.
GIULIO II E RAFFAELLO 2022
Giulio II e Raffaello. Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna, catalogo della mostra, a cura di D. Benati, M.L. Pacelli, E. Rossoni, Cinisello Balsamo 2022.
GIULIO ROMANO 1992
Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie, a cura di D. Ferrari, introduzione di A. Belluzzi, III, Roma 1992.
GRAMACCINI 1980
N. GRAMACCINI, Alfonso Lombardi, Francoforte sul Meno - Berna 1980.
GRASSI 1993
M.G GRASSI, La Deposizione con il cardinale Ercole Gonzaga in S. Egidio a Mantova, «Civiltà Mantovana», XXVIII, 8, 1993, pp. 45-61.
INTRA 1882
G.B. INTRA, La Basilica di S. Andrea in Mantova, «Archivio Storico Lombardo», IX, 1882, pp. [289]-303.
JONES 1997
P.M. JONES, Federico Borromeo e l’Ambrosiana. Arte e riforma cattolica nel XVII secolo a Milano, Milano 1997.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
KLINGER 2002
L.S. KLINGER, The Portrait Collection of Paolo Giovio, Ann Arbor 2002.
LAMO/PIGOZZI 1996
P. LAMO, Graticola di Bologna (1560), a cura di M. PIGOZZI, Bologna 1996 (prima pubblicazione 1884).
L’ETERNO E IL TEMPO 2018
L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio, catalogo della mostra, a cura di A. Paolucci, A. Bacchi et alii, Cinisello Balsamo 2018
LODOVICI 1535
F. DE LODOVICI, Triomphi di Carlo, Venezia 1535.
LUCIDI 2018
D. LUCIDI, Alfonso Lombardi e il Salvator Mundi, introduzione di A. Natali, Firenze 2018
LUZIO 1886a
A. LUZIO, Ercole Gonzaga allo studio di Bologna, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», VIII, 1886, pp. [374]-386.
LUZIO 1886b
A. LUZIO, Federico Gonzaga, ostaggio della corte di Giulio II, «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», IX, 1886, pp. 509-582.
LUZIO–RENIER/ALBONICO 2005
A. LUZIO, R. RENIER, La coltura e le relazioni letterarie di Isabella d’Este Gonzaga (1899-1903), a cura di S. ALBONICO, introduzione di G. Agosti, indici e apparati a cura di A. Della Casa, Milano 2005.
MAFFEI 1991
S. MAFFEI, La σοφια del pittore e del poeta nel proemio delle Imagines di Filostrato Maggiore, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, XXI, 1991, pp. [591]-621.
MALVASIA 1678
C.C. MALVASIA, Felsina Pittrice. Vite de pittori bolognesi, I-II, Bologna 1678.
MANTOVA 1962
Mantova. La storia, le lettere, le arti, II. Le lettere, t. 2. L’esperienza umanistica, l’età umanistica, l’età isabelliana, autunno del Rinascimento mantovano, a cura di E. Faccioli, prefazione di L. Caretti, Mantova 1962.
MAZZUCHELLI 1753-1763
G MAZZUCHELLI, Gli scrittori d’Italia, cioè notizie storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani, I-II, tt. 6, Brescia 1753-1763.
MIDDELDORF 1979-1981
U. MIDDELDORF, Raccolta di scritti, That is Collected Writings, I-III, Firenze 1979-1981.
Studi di Memofonte 34/2025
MIDDELDORF 1980
U. MIDDELDORF, Una proposta per Alfonso Lombardi, in MIDDELDORF 1979-1981, II (1980), pp. 361-368 (edizione originale in La medaglia d’arte, atti del primo convegno internazionale di studio (Udine 10-12 ottobre 1970), Udine 1973, pp. 20-28)
MIDDELDORF 1981
U. MIDDELDORF, Zu einigen Medaillen der italienischen Renaissance, in MIDDELDORF 1979-1981, III (1981), pp. 171-172 (edizione originale in Festschrift Wolfgang Braunfels, a cura di F. Piel, J. Traeger, Tubinga 1977, pp. 263-265).
MOLZA/PIGNATTI 2024
F.M. MOLZA, Rime, edizione critica e commento a cura di F. PIGNATTI, I-II, Milano 2024
MOLZA/SCORSONE–SODANO 1999
F.M. MOLZA, Elegiae et alia, testo e note a cura di M. SCORSONE, R. SODANO, Torino 1999.
MOLZA/SERASSI 1747-1754
F.M. MOLZA, Delle poesie volgari e latine, corrette, illustrate e accresciute con la vita dell’autore scritta da P. SERASSI, I-III, Bergamo 1747-1754.
MURPHY 2007
P.V. MURPHY, Ruling Peacefully: Cardinal Ercole Gonzaga and Patrician Reform in Sixteenth-Century Italy, Washington 2007.
MUTINI 1988
C. MUTINI, Della Casa Giovanni, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, XXXVI, Roma 1988, pp. 699-719
(disponibile on-line https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-della-casa_(DizionarioBiografico)/).
ONGHI 2021
E ONGHI, Versi tizianeschi di Francesco Maria Molza, «La Diana. Rivista semestrale della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università degli Studi di Siena», 1, 2021, pp. 93-105 (disponibile on-line https://riviste.fupress.net/index.php/diana/article/view/2569/1705)
PEPOLI 2018
Pepoli. Storia, genealogia, iconografia, a cura di G. Malvezzi Campeggi, introduzione di M Fanti, Bologna 2018.
PERINI 1995(1996)
G. PERINI, Raffaello e l’Antico: alcune precisazioni, «Bollettino d’Arte», 89-90, 1995(1996), pp. 111144.
PERINI 2002
L. PERINI, La vita e i tempi di Pietro Perna, Roma 2002.
PERINI FOLESANI 2020
G. PERINI FOLESANI, Pittura e poesia, arti sorelle nella Bologna rinascimentale e barocca, «Letteraura e Arte», XVIII, 2020, pp. 67-80.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
PERINI FOLESANI 2021
G. PERINI FOLESANI, Raffaello a Bologna, Raffaello e Bologna, in Raffaello. Mito e percezione, a cura di D. Benati, S. Cavicchioli et alii, Bologna 2021, pp. 33-47.
PERNET 1625
C. PERNET, Illustrissimorum, omnique virtutis, et scientiarum laude præstantissimorum virorum icones […], Roma 1625.
PIETRO BEMBO 2013
Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra, a cura di G. Beltramini, D. Gasparotto, A. Tura, Venezia 2013.
PIGNATTI 2011
F. PIGNATTI, Molza Francesco Maria, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXV, Roma 2011, pp. 451-461 (disponibile on-line https://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-maria-molza_(Dizionario-Biografico)/).
PIGNATTI 2018
F. PIGNATTI, Per Camilla Gonzaga di Novellara, in Donne Gonzaga a Corte. Reti istituzionali, pratiche culturali e affari di governo, atti del convegno internazionale (Mantova 21-24 settembre 2016), a cura di C. Continisio, R. Tamalio, Roma 2018, pp. 381-403.
PIGNATTI 2019
F. PIGNATTI, I testamenti e l’inventario dei beni della casa romana di Camilla Gonzaga di Novellara (1495-1567 circa), «Civiltà Mantovana», LIV, 148, 2019, pp. 56-105.
PINACOTECA AMBROSIANA 2007
Pinacoteca Ambrosiana, III. Dipinti dalla metà del Seicento alla fine del Settecentp. Ritratti, a cura di L. Caramel, S. Coppa, Milano 2007.
PORTIOLI 1881a
A. PORTIOLI, Il ritratto di Pietro Pomponazzo, «Il Mendico», I, 13, 1881, pp. 7-9.
PORTIOLI 1881b
A. PORTIOLI, Il ritratto di Pietro Pomponazzo, «Il Mendico», I, 17, 1881, pp. 4-5.
PORTIOLI 1881c
A. PORTIOLI, I sigilli del cardinale Ercole Gonzaga, «Archivio Storico Lombardo», VIII, 1881, pp. 64-67.
QUAQUARELLI 2014
L. QUAQUARELLI, Pandolfi Girolamo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXX, Roma 2014, pp. 711-714 (disponibile on-line https://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-pandolfi_(DizionarioBiografico)/).
QUATTRINI 2021(2022)
C. QUATTRINI, “Ricordasi assai chi ben serve e tace”. L’Allegoria di Girolamo Casio di Boltraffio sotto un’altra luce, «Nuovi Studi», XXVI, 2021(2022), pp. 67-77, tavv. XIII-XIV, 109-113.
RAFFAELLO 2016
Raffaello. La poesia del volto. Opere dalle Gallerie degli Uffizi e da altre collezioni italiane, catalogo della mostra, a cura di M. Faietti, V. Markova et alii, sotto la direzione scientifica di E.D. Schmidt, Mosca 2016
RAMA 1983
E. RAMA, Un tentativo di rilettura della ritrattistica di Boltraffio fra Quattrocento e Cinquecento, in Umanesimo problemi aperti 5, atti del convegno (Milano - Varenna 3-9 settembre 1980), numero monografico di «Arte Lombarda», n.s., 64, 1983, pp. 79-92.
REBECCHINI 2010
G. REBECCHINI, «Un altro Lorenzo». Ippolito de’ Medici tra Firenze e Roma (1511-1535), Venezia 2010.
RICCÒMINI 2008
E. RICCÒMINI, Antiraphael. Tre contrasti circa la lingua italiana dell’arte, in Amico Aspertini 14741552. Artista bizzarro nell’età di Dürer e Raffaello, catalogo della mostra, a cura di A. Emiliani, D. Scaglietti Kelescian, Cinisello Balsamo 2008, pp. 45-51.
ROMANI 2013
V. ROMANI, Pietro Bembo tra cultura figurativa cortigiana e “maniera moderna”, in PIETRO BEMBO 2013, pp. 32-47.
ROMANI 2016
V. ROMANI, Primaticcio Francesco, detto il Bologna, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXV, Roma 2016, pp. 379-385 (disponibile on-line https://www.treccani.it/enciclopedia/primaticcio-francesco-detto-ilbologna_(Dizionario-Biografico)/).
ROMEI 1983
D. ROMEI, La “maniera” romana di Agnolo Firenzuola (dicembre 1524 - maggio 1525), Firenze 1983.
SASSU 1996
G. SASSU, Alcune riflessioni sui forestieri a Bologna nella prima metà del Cinquecento, in LAMO/PIGOZZI 1996, pp. 159-197.
SCHERILLO 1888
M. SCHERILLO, Un vero amore del Sannazaro, «Giornale Storico della Letteratura Italiana», XI, 1888, pp [131]-155.
SCIFONI 1849
F. SCIFONI, Volta Leopoldo-Camillo, voce in Dizionario biografico universale […], V, Firenze 1849, pp. 654-655.
SHEARMAN 2003
J. SHEARMAN, Raphael in Early Modern Sources, I. 1483-1602, New Haven - Londra 2003.
SINIGALLIESI 1999
D. SINIGALLIESI, Alfonso Lombardi (1497c.-1537), in FARANDA 1999, pp. 13-28.
Alfonso Lombardi, Pietro Bembo e i ritratti perduti di Camilla Gonzaga e Pietro Pomponazzi
SÖDERHJELM 1914
W. SÖDERHJELM, Les nouvelles de F. M. Molza, «Neuphilologische Mitteilungen», XVI, 1914, pp. [43]-64.
SPERONI 1542
S. SPERONI, I dialogi, Venezia 1542.
SPERONI/POZZI 1978
S. SPERONI, Dialogo delle lingue (1542), in Trattatisti del Cinquecento, I, a cura di M. POZZI, Milano - Napoli 1978, pp. [585]-635.
TONELLI 1797
F. TONELLI, Il Pomponazzi vindicato in lettera […], Guastalla 1797.
VAGENHEIM 2017
G. VAGENHEIM, Antiquari e letterati nell’accademia degli Sdegnati: il sodalizio di Pirro Ligorio e Francesco Maria Molza, in Intrecci virtuosi. Letterati, artisti e accademie tra Cinque e Seicento, a cura di C. Chiummo, A. Geremicca, P. Tosini, Roma 2017, pp. [91]-100.
VARCHI/BAROCCHI 1960-1962
B. VARCHI, Lezione nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura (1549), in Trattati d’arte del Cinquecento fra Manierismo e Controriforma, a cura di P. BAROCCHI, I-III, Bari 1960-1962, I, pp. 3-91.
VASARI/BETTARINI–BAROCCHI 1966-1987
G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. BETTARINI, commento secolare a cura di P. BAROCCHI, I-VI, Firenze 1966-1987.
VASARI/MILANESI 1878-1881
G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architettori, con nuove annotazioni e commenti di G. MILANESI, I-VII, Firenze 1878-1881
VISCONTI 1950
A VISCONTI, La storia dell’Università di Ferrara (1391-1950), Bologna 1950.
VITTORIA COLONNA 2005
Vittoria Colonna e Michelangelo, catalogo della mostra, a cura di P. Ragionieri, Firenze 2005.
WALTER–ZAPPERI 2006
I. WALTER, R. ZAPPERI, Il ritratto dell’amata. Storie d’amore da Petrarca a Tiziano, Roma 2006.
ABSTRACT
Il saggio ricostruisce un episodio poco esplorato nella biografia artistica di Alfonso Lombardi, soffermandosi sul suo rapporto con Pietro Bembo e su due ritratti oggi perduti: quello di Camilla Gonzaga e quello di Pietro Pomponazzi, realizzati a Bologna tra il 1524 e il 1525. La corrispondenza tra Bembo e Francesco Maria Molza consente di identificare lo scultore nel «M. Alfonso» citato nelle lettere, fissando alla primavera del 1524 un termine ante quem per l’inizio del rapporto tra lo scultore e l’umanista. In questo contesto si colloca la commissione del ritratto in marmo di Camilla Gonzaga da parte di Molza, celebrato nei sonetti della raccolta La Gonzaga di Girolamo Pandolfi da Casio. L’opera assume un significato simbolico, legato al modello poetico di Petrarca. Il busto – tra i primi lavori in pietra dello scultore – rappresenta un laboratorio espressivo attraversato da suggestioni classiciste, e segna una svolta nel linguaggio che l’artista andava elaborando in quegli anni. La seconda parte dell’indagine riguarda il «simulacro» di Pomponazzi, commissionato da Ercole Gonzaga in memoria del proprio maestro, e verosimilmente modellato in terracotta. L’opera potrebbe aver ispirato la statua bronzea del sepolcro mantovano che accolse le spoglie del filosofo, morto a Bologna nel 1525. Del monumento, disperso alla fine del Settecento, resta una traccia in una tela conservata alla Biblioteca Ambrosiana, che riprende un originale appartenuto a Paolo Giovio, a sua volta desunto da un prototipo appartenuto a Ercole Gonzaga. Il dipinto mostra un realismo schietto, vicino a modelli di Lombardi come il Giuseppe d’Arimatea del Compianto, oggi nella Cattedrale di Bologna. Il confronto tra i due busti riflette le sollecitazioni formali e concettuali affrontate dallo scultore, in un momento segnato dal dibattito sulla lingua letteraria e dall’influenza crescente del modello raffaellesco sulla cultura artistica bolognese.
The essay reconstructs a little-explored episode in the artistic biography of Alfonso Lombardi, focusing on his relationship with Pietro Bembo and on two now-lost portraits: one of Camilla Gonzaga and one of Pietro Pomponazzi, both executed in Bologna between 1524 and 1525. The correspondence between Bembo and Francesco Maria Molza makes it possible to identify the sculptor as the «M. Alfonso» mentioned in the letters, establishing spring 1524 as a terminus ante quem for the beginning of the relationship between the sculptor and the humanist. Within this context falls the commission of the marble portrait of Camilla Gonzaga by Molza, celebrated in the sonnets of La Gonzaga, a collection by Girolamo Pandolfi da Casio. The work assumes a symbolic significance, shaped by the Petrarchan poetic model. The bust one of Lombardi’s earliest works in stone serves as a space for expressive experimentation, marked by classicist influences, and signals a turning point in the artistic language he was developing during those years. The second part of the investigation focuses on the «simulacro» (simulacrum) of Pomponazzi, commissioned by Ercole Gonzaga in memory of his former tutor and likely modelled in terracotta. This work may have inspired the bronze statue in the Mantuan tomb that housed the philosopher’s remains, following his death in Bologna in 1525. Though the monument was lost at the end of the 18th century, a trace survives in a painting now held at the Biblioteca Ambrosiana, which reproduces an original once owned by Paolo Giovio, itself based on a prototype that had belonged to Ercole Gonzaga. The portrait displays a raw realism, akin to models by Lombardi such as the Joseph of Arimathea from the Lamentation group, now in Bologna Cathedral. The comparison between the two busts reflects the formal and conceptual stimuli encountered by the sculptor at a time marked by the debate over literary language and by the growing influence of the Raphael-inspired idiom on Bolognese artistic culture.
UNA PROPOSTA PER UN RITRATTO DELLA CANTANTE D’OPERA ANNA MARIA SARDELLI
Fra i ritratti senza identità della Pinacoteca del Museo Nazionale di Palazzo Mansi, a Lucca, quello attualmente noto come «Ritratto di gentildonna ignota, di Niccolò Cassana» (inv. 107, Fig. 1) pone una sfida in più, per la presenza di ridipinture tanto estese da far dubitare di osservare l’immagine integra e fedele all’originale. In simili condizioni, anche l’analisi iconografica rischia di risultare imprecisa, e con essa l’ancoraggio alle descrizioni antiche – già solitamente avare di dettagli –, a fronte di una catena di indizi pur all’apparenza attendibili. Ciò premesso, l’esame della documentazione d’archivio e di restauro conservata fra Archivio di Stato di Firenze, Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine e Archivio di Palazzo Mansi ha prodotto risultati rilevanti: dal risarcimento virtuale di alcune lacune è stato possibile ricostruire l’intera storia collezionistica del quadro, e da questa rintracciare l’identità smarrita della protagonista, corrispondente alla cantante d’opera Anna Maria Sardelli (documentata dal 1642 al 1659). I dati sulla provenienza e l’attendibilità del soggetto hanno indotto a rivedere l’attribuzione, riportandola alla cerchia del ritrattista Justus (Giusto) Suttermans (Anversa, 1597 - Firenze, 1681).
Dalla provenienza all’ipotesi identificativa
Come gran parte dei dipinti della Pinacoteca di Palazzo Mansi, anche il Ritratto di gentildonna ignota è pervenuto a Lucca a seguito della decisione di Leopoldo II d’Asburgo Lorena (1797-1870) di dotare il Palazzo Ducale della città – residenza granducale dal 1847 – di una galleria aperta al pubblico, inaugurata il 26 settembre 18531. Il trasferimento da Firenze a Lucca avvenne intorno al 16 luglio 1853, secondo la data riportata sul Mandato di uscita della Guardaroba Generale2 , ripetuta sull’aggiornamento dell’inventario del palazzo lucchese3. Dal Mandato si deduce la precedente collocazione nella Guardaroba Generale di Palazzo Vecchio, dov’è riconoscibile nel primo dei «Due [quadri] in tela da B. 1 ¼ e B. 1 dipintovi dalla scuola di Giusto Sustermans in uno ritratto di femmina, e nell’altro giovane con berretto in testa [… numero vecchio] 5828»4 . All’arrivo nella nuova destinazione il ritratto femminile fu segnato col numero d’inventario 13248, distinto dal 13249 del ritratto maschile, tutt’oggi visibile sul retro insieme al vecchio 5828 (da cui la certezza della corrispondenza)5. Sempre dal retro si deduce l’identità del pendant, corrispondente al Ritratto di Francesco Maria Suttermans come Paride di Giusto Suttermans (Lucca,
Per la complessità del caso di studio, la rarità dei ritratti femminili di cantanti e attrici del XVII secolo e l’abbondanza di documentazione, questa comunicazione anticipa una parte dei risultati emersi dal progetto di catalogazione della Pinacoteca del Museo Nazionale di Palazzo Mansi, tuttora in corso. Un ringraziamento va alle istituzioni coinvolte: la Direzione Regionale Musei Nazionali Toscana e Musei Nazionali di Lucca, IMT Alti Studi Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
1 Sulla costituzione e data di apertura della Pinacoteca – documentata al 1853 e non al 1847 o al 1861, come riportato in letteratura – si veda E. Pellegrini, Problemi di provenienza. La quadreria fiorentina di Palazzo Mansi e la politica culturale di Leopoldo II di Lorena, in PELLEGRINI 2023, pp. 89-135.
2 Firenze, Archivio di Stato (d’ora in avanti ASFi), Imperiale e Real Corte (d’ora in avanti IRC) 5000, c.n.n., Mandato 169. Una registrazione analoga è in ASFi, IRC 3379, c.n.n., Giustificazione 187.
3 ASFi, IRC 4996, c. 121s
4 ASFi, IRC 5000, c.n.n., Mandato 169.
5 Le risorse limitate del museo non hanno consentito la movimentazione del quadro, e pertanto questo e tutti i dati ricavati dal retro sono desunti da uno scatto fotografico (b/n) presso la Fototeca della Soprintendenza di Pisa (SBAAASPI57009016), allora competente sul patrimonio lucchese.
Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli
Museo Nazionale di Palazzo Mansi, inv. 99; Fig. 2)6. Tale corrispondenza è cruciale per ricostruire la storia collezionistica del ritratto femminile: l’unione col ‘ritratto di Francesco/Paride’ è infatti di molto precedente al 1853, e dalla migliore riconoscibilità del ritratto maschile è risultata ripercorribile la storia di quello femminile, dalle prime occorrenze nel tardo XVII secolo fino al passaggio a Lucca.
Il primo documento utile è l’inventario dei dipinti della Guardaroba del 1850, propedeutico alla formazione della galleria lucchese: il ritratto femminile corrisponde qui al numero 28 ed è segnato col numero 5828 (lo stesso di sopra); è descritto come un «Ritratto di dama con vezzo di perle e gioiello al collo. Ha nella destra una carta. Tela della stessa mano dell’antecedente», ossia del «Ritratto di Francesco Suttermans di mano di Giusto Suttermans suo padre»7. In chiusura è riportata la postilla: «Nel telajo si legge: De[l] Conte Francesco di Federigo Montauto»8. È questa un’indicazione del massimo interesse, sulla quale si tornerà in seguito. Restando ora sugli inventari, le prime tracce del ‘ritratto di Francesco/Paride’ col suo pendant femminile emergono dalle collezioni del gran principe Ferdinando de’ Medici (16631713): nell’inventario di Palazzo Pitti del 1698, subito dopo il ritratto del giovane Suttermans è elencato «Un quadro in tela dipintovj di mano di Giusto Suttermanni[sic] il ritratto dell’Anna M[ari]a Sardellj mez[z]a figura al naturale con penne nere in testa alto B. 1 ¼ largo B. 1 con adornamento dorato, s[egna]to [numero] 216»9. Si tratta della prima identificazione del soggetto che, come si vedrà, ritornerà in tutte le descrizioni successive, fino alle soglie del XIX secolo. Nello stesso ordine sequenziale i due ritratti compaiono nell’inventario della quadreria di Ferdinando del 1701-171010, in quello del 171311 e in quello, sempre del palazzo di residenza, del 176112; le descrizioni corrispondono parola per parola alla voce del 1698. Qualcosa cambia nell’inventario successivo del 1771; qui i ritratti sono per la prima volta uniti nella stessa voce (non più elencati in sequenza) e dotati dello stesso numero d’inventario; vi leggiamo:
Due quadri in tela alti B. 1 1/5 larghi B. 1 c[irc]a dipintovi di mano di Giusto Suttermanni[sic] ritratti fino a mezza vita, che in uno d’Anna M[ari]a Sardelli, con manto turchino alle spalle, carte di musica nella destra, vezzo di perle al collo, e capelli neri inanellati, che li cadono al seno; e l’altro d’un figlio di detto autore, rappresentato in Paride, con berretto foderato di pelliccie in testa, capelli lunghi, e pomo in mano; con adornamenti la maggior parte intagliati, e tutti dirati, segnati di n. vec[chi]o 20 e 23, e nuovo n. 46813
Il successivo inventario del 1782 – il cosiddetto ‘inventario parlante’ di Palazzo Pitti – ne mostra graficamente l’esposizione a pendant in una sala del piano terreno (oggi del Tesoro dei Granduchi) (Fig. 3); le sagome corrispondono ai numeri 1 – «Ritratto d’Anna Sardelli, di M[esse]r Giusto» – e 6 – «Ritratto del figlio di M[esse]r Giusto, di M[esse]r Giusto» – dell’elenco a fronte (pagina sinistra)14. È possibile che entro questa data i dipinti ricevessero le nuove cornici, identiche, con le quali sarebbero giunti a Lucca molti decenni dopo, a seguito di un piccolo
6 Su questo dipinto si vedano S. Meloni Trkulja, scheda n. VI.8, in AL SERVIZIO DEL GRANDUCA 1980, p. 39, e CHIARINI 1992, p. 94, tav. 79. L’immagine del retro è reperibile nella citata Fototeca della Soprintendenza di Pisa (SBAAASPI57093034).
7 Firenze, Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine (d’ora in avanti ASGF), Conservazione dei Monumenti d’Arte dei Regi Palazzi e Ville, XIII, ins. 4, c. 7949v.
8 Ibidem
9 ASFi, Guardaroba Medicea (d’ora in avanti GM) 1067, c. 21r L’occorrenza è già segnalata in CHIARINI 1975a, pp. 75, 95, nota 100, ma non è identificata col quadro in esame.
10 ASFi, GM 1185, I, p. 375, nn. 215 (Francesco-Paride) e 216 (Anna Maria Sardelli)
11 ASFi, GM 1222, c. 19r, nn. 215 e 216.
12 ASFi, GM Appendice 94, c. 26r-v, nn. 20 (Anna Maria Sardelli) e 23 (Francesco-Paride).
13 ASFi, IRC 4678, c. 256v
14 Firenze, Biblioteca Riccardiana, Man. Ricc. 4211, cc. 97v-98r (tav. 91).
Studi di Memofonte 34/2025
restauro (licenziato il 14 luglio 1852)15. È d’uopo precisare che la cornice originale è attualmente visibile solo sul ritratto di Francesco/Paride mentre quella identica del pendant è stata trasferita su un altro ritratto femminile della Pinacoteca, di Gentildonna ignota (inv. 103), chiaramente di miglior qualità e per questo – nonché per un’affinità d’esecuzione – ritenuto a Lucca meglio accostabile al ritratto maschile. Lo scambio è confermato dalla presenza del numero 12183 sul retro di inv. 103, che corrisponde al numero d’inventario del ritratto qui in esame dal momento del trasferimento in Palazzo Ducale. Infine, tornando agli inventari, nel 1791-1792, la coppia di ritratti Francesco/Paride-Sardelli ritornava nella stessa posizione del 1771, con la stessa descrizione16; lasceranno Palazzo Pitti per il deposito della Guardaroba Generale qualche tempo dopo, forse nel primo decennio del nuovo secolo, durante la dominazione borbonica17. Qui sarebbero stati rintracciati nel 1850 e, come visto, selezionati insieme per entrare nel catalogo dell’istituenda galleria lucchese.
Tutta la documentazione antica è concorde nell’identificare il ritratto-pendant di Francesco/Paride con quello di Anna Maria Sardelli, e nella voce inventariale del 1771 – la più dettagliata – il «manto turchino sulle spalle», il «vezzo di perle al collo» e i «capelli neri inanellati, che li cadono al seno» corrispondono perfettamente all’abito e all’acconciatura della donna. Restano però due ostacoli, impossibili da non considerare al fine della piena corrispondenza con la catena inventariale: l’oggetto bianco stretto dal soggetto manca dei caratteri tipici – spartito, note o testi – delle «carte di musica»; inoltre, nessuna traccia è visibile, a occhio nudo, delle «piume nere in testa», indicate fra 1698 e 1761 (ma non dal 1771 in avanti). Si tratta di due dettagli sostanziali ma che, con ogni evidenza, insistono proprio sulle zone peggio conservate della pittura originale: l’oggetto bianco – chiaramente un foglio, non un fazzoletto – presenta tracce molto abrase di pigmento nero, e per la sua funzione di attributo, dovrà aver accolto segni o caratteri ‘identificativi’ del soggetto, andati perduti; similmente, la parte alta dell’acconciatura è coperta da uno spesso strato di nero bituminoso. Il sospetto della scomparsa dei dettagli indicati negli inventari è forte ma, fortunatamente, alcune note di restauro risalenti al biennio 1951-1952 (di Marco Gazzi)18 consentono non solo di accertarlo, ma anche di risarcire, almeno virtualmente, una parte delle perdite. In quell’occasione risultano rimosse varie ridipinture, fra cui (si specifica) quelle «al cappello che era stato ingrandito (aumentato da una penna)». È questa la conferma dell’esistenza delle «piume nere in testa» che, come prevedibile, costituivano parte dell’ornamento di un cappello. La presenza di alcuni tocchi di pennello bianco-argenteo sulla fronte (Fig. 4) diventa interpretabile come ciò che resta della spilla metallica cui in origine era attaccata «la penna» (ossia la/le piuma/e). Un’altra informazione interessante riguarda la ridipintura della «parte superiore della mano risultante completamente mancante»19; è la conferma di un intervento esteso su un’area limitrofa al foglio, che probabilmente era già compromesso in precedenza.
La corrispondenza dell’effigie con la catena di descrizioni inventarili è dunque evidente e risulta rafforzata dall’analisi del quadro in relazione alla biografia di Anna Maria Sardelli.
Anna Maria Sardelli: dalla biografia al ritratto
Di origini romane (non se ne conosce la data di nascita, né di morte), Anna Maria Sardelli è documentata a più riprese tra Roma, Firenze e Venezia dal 1642 al 1659, spesso col soprannome
15 I pagamenti si conservano in ASFi, IRC 4123, Mandato 370.
16 ASFi, IRC 4682, I, c. 148r, n. 1625; segue l’indicazione del numero vecchio 468 e del numero nuovo 1084
17 La data esatta di tale spostamento non è finora emersa, ma nel periodo indicato sono compresi vari passaggi di opere da quest’ala di Palazzo Pitti alla Guardaroba.
18 Lucca, Archivio di Palazzo Mansi (d’ora in poi APM), Restauri, Lu 1239-1276; 213/11.
19 Ibidem
Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli
di ‘Campaspe’, dal ruolo recitato a Venezia nel 1650 nell’Alessandro vincitor di se stesso, su libretto di Francesco Sbarra, gentiluomo lucchese, e musiche di Antonio Cesti20. Stando alle fonti disponibili, Sardelli fu una vera ‘diva’ del suo tempo, contesa da principi e impresari teatrali di mezza Italia e assai chiacchierata per gli innumerevoli amanti – più o meno tollerati dallo sposo Carlo Ventura del Nero (fiorentino?) – che le valsero la fama di ‘virtuosa’ (nel canto) e ‘puttana’ (nella vita). A Firenze fu protetta da tutti i principi di Casa Medici ma in particolare da Mattias (1613-1667) e Giovan Carlo (1611-1663), e proprio dai carteggi di questi ultimi, editi di recente da Sara Mamone, emerge il grosso delle informazioni sul suo conto21. Le prime risalgono al 1642, quando una «Signora Anna Maria[,] già destinata a Vostra Altezza Serenissima [cioè Mattias]», fu veduta a Venezia da Michele Grasseschi – musico, maestro di canto e talent scout del principe22 – venendogli caldamente raccomandata («Dico che assaissimo mi piace, sì di aspetto come di voce e buona disposizione e trillo et è da fare ogni riuscita sì che se Vostra Altezza la piglierà farà buona elezione»)23. Negli ultimi mesi del 1648 Anna Maria è ancora a Roma, ma, pizzicata nel letto del giovanissimo ‘Cardinale Maldacchino’ (Francesco Maidalchini)24 , fu costretta ad allontanarsene, portandosi a Firenze. Qui la ritroviamo nel 1649, iscritta nel ruolo dei provvisionati del principe Mattias. Agli esordi dell’anno seguente è nuovamente in viaggio per Venezia, costretta da un ‘affare’ che aveva smosso una parte della diplomazia medicea. La vicenda è nota25 e può rievocarsi in sintesi: dopo aver accolto l’invito dell’abate Vittorio Grimani a recitare a Venezia nella stagione del 1650, Anna Maria tentò di sottrarsi all’impegno, riferendo di essere prossima a rinchiudersi in convento per mutare vita. Dietro tale risoluzione vi erano il suo primo protettore (e forse amante) fiorentino, il marchese Francesco Guicciardini, e l’abate Ottonelli, sempre in cerca di anime peccatrici da convertire trionfalmente. Allarmato dalle perdite finanziare e dal danno di reputazione, Grimani scrisse al principe Mattias che, temendo a sua volta di perdere la stima di uno dei principali procacciatori di opere e artisti per il teatro fiorentino, non esitò a coinvolgere i fratelli e lo stesso granduca per forzare Anna Maria a mutare (o comunque a sospendere) la pia risoluzione. L’unico alleato della cantante rimase Guicciardini, che in un estremo tentativo di trattenerla a Firenze, tentò di accelerare le pratiche della monacazione; scrisse così a Mattias di aver già «fatto venire a posta il suo marito di Roma; […] fatto le funzioni di divorzio, renunzia e l’altro all’Arcivescovado»26 ; ciononostante, gli interessi dei principi prevalsero e così, agli esordi del 1650, Anna Maria è già a Venezia. Qui, per due stagioni, da Campaspe a Cleopatra ne Il Cesare amante, la ‘diva Sardelli’ riscosse un successo dopo l’altro e, accantonati i propositi monastici, riprese a far parlare di sé, soprattutto per le energie profuse fuori dalle scene, ma con conseguenze altrettanto ‘drammatiche’. Un avviso da Venezia del 16 febbraio 1652 riportava a Firenze che, nel giro di poche settimane, «l’Anna Maria Campaspe» era scampata a «un’archibugiata» mentre si intratteneva con un nobile di casa Vendramin e, poco dopo, ad altri due colpi di fendente sferratile al petto e al fianco da un uomo mascherato27. Viva, ma terrorizzata, Anna Maria fuggì da Venezia e fece rientro a Firenze, dove l’accolse il cardinale Giovan Carlo de’ Medici. La storia successiva è nuovamente un’altalena di successi e scandali, con una terza aggressione subita nel 1654; l’indiziato (poi prosciolto) fu stavolta Ferdinando Tacca, ‘ingegnere’ al Teatro della Pergola. Una notizia poco nota è la presenza di Anna Maria a Lucca nello stesso 1654: mentre nel palazzo dei Borghi si recitava l’Alessandro Vincitor di se stesso del lucchese Sbarra, con soli attori
20 La biografia tracciata di seguito si basa in gran parte sui seguenti studi: BIANCONI–WALKER 1975, in particolare pp. 440-444; MAMONE 2003, pp. XLIV-LIV e Carteggio; MAMONE 2013, Carteggio ad indicem
21 Si veda la bibliografia alla nota precedente.
22 Cfr. MAMONE 2003, p. XLIV.
23 Cfr. MAMONE 2013, p. 46, n. 75.
24 Ivi, p. 241, n. 504.
25 Per una ricostruzione dettagliata, si rimanda alle pagine introduttive in MAMONE 2003, pp. XLIV-LIV.
26 ASFi, Mediceo del Principato (d’ora in avanti MdP) 5446, c. 117r-v; già citata in MAMONE 2013, p. 287, n. 604.
27 Su entrambi gli eventi si veda BIANCONI–WALKER 1975, p. 443.
uomini e le scenografie di Girolamo Scaglia, Anna Maria risulta in città perché denunciata al locale Magistrato dei Segretari, rea di essersi fatta nuovamente «apprezzare in privato [per] le sue poco virtuose fatiche», venendo bandita dallo Stato di Lucca per i successivi tre anni28. Al biennio 1658-1659 risalgono le ultime notizie, rintracciabili nei carteggi del cardinale Carlo de’ Medici; l’interesse è sulla vita amorosa della donna, e così se ne tratteggia l’ultimo ménage: «La Signora Anna Maria che era Dama del Signor Carlo Ventura del Nero, oggi innamorata del Bonsi, che sta con il Signor Duca Salviati, e il mondo crede che al Signor Duca non dispiaccia la sua conversazione»29
Veri o presunti gli amori, è indubbio che Anna Maria Sardelli godesse a Firenze di grande popolarità e che fosse carezzata da tutti gli esponenti della famiglia granducale. La presenza di un suo ritratto nelle raccolte del gran principe Ferdinando – degno erede del mecenatismo spettacolare degli avi paterni30 – è pertanto comprensibile e indubbiamente compatibile col soggetto del ritratto di Palazzo Mansi. La donna indossa una veste di seta rossa, composta da un busto allungato a punta e da un gonnellone del medesimo tessuto. Dall’ampia scollatura fuoriesce una camicia di lino bianco, impreziosita da un bordo drappeggiato e apparentemente orlato di merletto (impoverito dalla consunzione della pittura); la camicia fuoriesce abbondante anche all’altezza del braccio sinistro e del polso destro, sotto un mantello azzurro che gira dietro le spalle, adagiandosi sulle braccia. La scollatura è arricchita da un velo semitrasparente, arricciato e fermato al centro da una spilla di perle e pietre preziose, con l’attaccagnolo decorato da un fiocco rosso. Altri gioielli sono visibili al collo: un giro di perle bianche e, sotto, un laccetto nero con un piccolo pendente argentato, simile a un monile. Nell’insieme l’abbigliamento è databile tra il quinto e l’ottavo decennio del XVII secolo, come dimostra il confronto con numerosi ritratti di dame del tempo, a cominciare da quelli di Vittoria della Rovere (1622-1694), granduchessa di Toscana dal 1637 e ‘première dame’ fino alla morte31. Curioso è anche il dettaglio del cordoncino nero da cui pende il ciondolo argentato, che si ritrova in altre effigi fiorentine, sia nella forma semplice, priva di pendente – come, ad esempio, nelle dame in vesti allegoriche di Giovanni Martinelli (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Feroni)32 –, sia arrichito da gioielli analoghi. Un confronto seducente si rintraccia in un Ritratto di gentildonna con partitura, noto in due versioni assai simili (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi, inv. 1890, n. 2871, Fig. 5; USA, collezione privata, già Christie’s 2005), pubblicate di recente da Lisa Goldenberg Stoppato: l’identità della donna resta misteriosa ma la proposta di riconoscerne l’effigie di una giovane ‘musica’ (una cantante e/o suonatrice) della granduchessa Vittoria della Rovere, derivata da un originale perduto di Giusto Suttermans, è a mio avviso più che condivisibile33. Oltre che nel pendente – raddoppiato nel ritratto di ‘musica’ – le somiglianze col ritratto di Palazzo Mansi si estendono alla foggia e ai colori dell’abito (solo più adorno di ricami e perle nella ‘musica’) e all’acconciatura, in entrambi i casi ispirata al modello di Vittoria della Rovere. Altre affinità ancora si riconoscono nell’impaginato dei ritratti: le figure sono tagliate sotto il busto e colte in lieve scorcio, col capo ruotato e lo sguardo diretto allo spettatore. L’unica differenza è nella soluzione delle mani: mentre nel ritratto di ‘musica’ compaiono entrambe per srotolare uno
28 L’episodio è noto unicamente attraverso MEMORIE E DOCUMENTI 1914, t. 1, pp. 148-151.
29 ASFi, MdP 5469, cc. 542r-543v (cit. in MAMONE 2013, p. 655, n. 1325)
30 Sul tema, SPINELLI 2010
31 Per un profilo biografico si veda MODESTI 2020, con bibliografia. Uno studio accurato e ben documentato del guardaroba della Granduchessa è reperibile in MODESTI 2018 e 2020, pp. 114-128. Per un quadro completo dei ritratti di Vittoria, LANGEDIJK 1981-1987, II (1983), pp. 1475-1511, e ivi, III (1987), pp. 1553-1554; più di recente, SASO 2020(2021)
32 Cfr. BELLESI 2011. Altri confronti suggestivi si rintracciano nelle raffigurazioni di donne dell’epica moderna (Armida e Isabella), come quelle dipinte da Girolamo Frilli Croci e Giovanni Montini. Per tutti si veda L’ARME E GLI AMORI 2001, pp. 79, 195.
33 GOLDENBERG STOPPATO 2018, pp. 56-58, figg. 7 e 8; più in generale sui ritratti di Suttermans, GOLDENBERG STOPPATO 2006, con bibliografia precedente.
Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli
spartito, in quello di Palazzo Mansi ne è raffigurata solo una, reggente un attributo simile, un foglio (sebbene malconcio).
Dalle somiglianze fin qui elencate, l’identificazione della Gentildonna ignota di Palazzo Mansi con Anna Maria Sardelli, cantante d’opera inserita nei circoli della corte fiorentina alla metà del Seicento, risulta a mio avviso vieppiù sostenibile.
La provenienza Montauto e il ritorno all’ambito di Giusto Suttermans
I registri della Guardaroba Medicea non hanno restituito finora la data esatta dell’ingresso dell’opera ma, mentre la prima citazione a Palazzo Pitti risale al 1698, non v’è dubbio che l’esecuzione risalga a molti anni prima. Un ante quem compatibile con lo stile del ritratto si ricava, indirettamente, da un’iscrizione già ricordata in apertura – «De[l] Conte Francesco di Federigo Montauto» – ancora visibile nel 1850 sul retro dell’opera e fortunatamente trascritta dal redattore dell’inventario coevo34. Francesco Barbolani di Montauto (1610-1666), detto «il conte moro», nato da Federigo di Francesco e da Camilla di Giovanni Rossi dei conti di San Secondo35, fu l’ultimo esponente del suo ramo. Eletto Cavaliere di Santo Stefano nel 1636, fu un uomo di fiducia della famiglia granducale e dal 1656 si fregiò del titolo di Cameriere Segreto del cardinale Giovan Carlo de’ Medici. La presenza nei ruoli di corte negli anni esatti in cui Giovan Carlo accolse a Firenze Anna Maria Sardelli, sostenendone la carriera, rende verosimile la commissione del ritratto da parte di questo personaggio e dunque il passaggio alle raccolte medicee. Ma non è tutto: Francesco Montauto fu certamente in contatto diretto con la ‘diva Sardelli’, come provato da una missiva della donna indirizzata al cardinale Medici il 27 aprile 1652; siamo all’indomani dei due attentati veneziani e Anna Maria scrive:
[…] tutta confusa e impaurita tremo e vivo afflittissima e perciò ho dato ferma risoluzione e stabilito proponimento di venirmene in tutti i modi a Fiorenza, perché quest’aria è troppo nociva per me e tanto maggiormente mi confermo in questo proposito, quanto che anco Vostra Altezza benignamente per il Signor Conte Montauto mi ha fatto scrivere, che mi consiglia amichevolmente per mio bene che me ne torni36
La lettera prosegue con la richiesta di danaro per mettersi in viaggio: la stessa Anna Maria suggerisce al cardinale di consegnarlo «al Signor Conte Monte Auto, che sarà ben datto, che lui si piglierà cura di farmelo pervenire»37. È evidente che il Conte conoscesse bene Anna Maria e che questa lo considerasse un intermediario degno di fiducia. Da tali acquisizioni discendono almeno due considerazioni cruciali: se il primo proprietario del dipinto fu effettivamente il conte Francesco Montauto, la data di morte di questi, il 1666, diventa l’ante quem obbligato dell’esecuzione dell’opera, e ciò sembra a mio giudizio riscontrare adeguatamente con le caratteristiche formali e iconografiche del quadro. Da ciò discende però l’impossibilità di riferirlo al pittore veneziano (di origini liguri) Niccolò Cassana (Venezia, 1659 - Londra, 1713)38 , cui l’assegnano – talvolta dubitativamente, ma senza eccezioni – inventari, cataloghi e contributi critici posteriori al trasferimento del quadro a Lucca, per l’evidente incompatibilità con l’anagrafe del pittore.
34 ASGF, Conservazione dei Monumenti d’Arte dei Regi Palazzi e Ville, XIII, ins. 4, c. 7949v
35 Per le informazioni su Francesco Barbolani (1610-1664) cfr. https://www.archivistorici.com/it/archivi/47/famiglia <10 giugno 2025>
36 ASFi, MdP 5319, cc. 47r-48v; già citata in MAMONE 2003, pp. 173-174, n. 353.
37 Ibidem.
38 Sul pittore si vedano FOGOLARI 1937; ZAVA BOCCAZZI 1984 e 1999; RUGGERI 1996; PROFETI 2007; GOLDENBERG STOPPATO 2019(2020)
Studi di Memofonte 34/2025
Il riferimento più antico a Niccolò Cassana risale al 1861 e si rintraccia nel primo inventario della galleria di Palazzo Ducale39. Evidentemente, l’attribuzione alla «Scuola di Giusto Suttermans» (1853) non aveva convinto i conoscitori locali, forse per il confronto problematico con gli altri dipinti della pinacoteca attribuiti a Suttermans – i ritratti di Maria Maddalena d’Austria (inv. 133), del Cardinal Leopoldo de’ Medici (inv. 101), del Cardinal Giovan Carlo (inv. 98), di Vittoria della Rovere col principe Cosimo (inv. 39, quest’ultimo in realtà una copia di Filippo Latini dall’originale di Giusto)40 –, tutti appartenenti alla categoria del ritratto ufficiale e dunque lontani dalla libertà di disegno e di tocco del nostro. Certamente insufficiente era allora la conoscenza delle oscillazioni stilistiche di Suttermans fra ritratti principeschi e soggetti di rango inferiore, e ancora le differenze tra quadri eseguiti nell’arco di molti decenni (gli oltre sessant’anni al servizio dei Medici)41. Un segnale chiaro proviene, ancora una volta, dal confronto col ritratto-pendant di Francesco-Paride, oggi fra i capisaldi del catalogo di Suttermans: sebbene nel 1871 fosse identificato correttamente col figlio del pittore, e dunque attribuito a Giusto42, la singolarità rispetto ai ritratti di principi e cardinali trasse in inganno Placido Campetti, che scelse di presentarlo come Ritratto di giovane di Rembrandt van Rijn nel catalogo della Pinacoteca del 190943 Complice un qualche timore per la diminutio insita nella categoria ‘scuola di’ – leggibile fra le righe degli aggiustamenti attributivi di Sebastiano Onestini del 187144 –, la ricerca di una nuova paternità dovette sembrare inevitabile e ricadere sul ritrattista veneto Niccolò Cassana, destinatario di una certa fortuna in terra lucchese. Dagli studi di Franca Zava Boccazzi sappiamo che almeno due ritratti femminili del pittore erano giunti a Lucca nel primo decennio del Settecento, acquistati dal collezionista lucchese Stefano Conti († 1739) per l’arredo della sua galleria45. Altri ritratti potevano essere noti; eppure, anche ignorando gli esatti termini di paragone usati al tempo, il catalogo attualmente noto di Cassana genera non poche perplessità sull’attribuzione. Cominciando da quelli di formato simile – i nobili cacciatori della corte medicea (Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1890, nn. 547, 550), la Lodovica Dea come cuoca (ivi, inv. 1890, n. 7571), l’Autoritratto degli Uffizi (ivi, inv. 1890, n. 9612), i vari ritratti in collezione privata pubblicati da Franca Zava Boccazzi46 –, tutti dimostrano un’apertura spaziale, una libertà di movimento delle figure, una vivezza di sguardo e una matericità di tocco francamente inconciliabili col nostro dipinto; simili considerazioni valgono per i ritratti più ufficiali come quelli del Gran principe Ferdinando (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, inv. 1890, n. 5448) e della consorte Violante Beatrice di Baviera (Firenze, Museo Stibbert, inv. 4131), superiori per tenuta pittorica anche al netto della sofferenza della nostra pittura. L’attribuzione a Cassana sembra pertanto fragile ma non è mai stata realmente discussa nella letteratura sul quadro.
Dopo il catalogo del 1909, la si ritrova nello studio di Gino Fogolari sul carteggio di Cassana col gran principe Ferdinando47; nelle successive guide di Lucca di Pietro Lazzarini
39 APM, Inventario 1861, p.n.n., n. 45.
40 Cfr. L. Goldenberg Stoppato, scheda n. 22, in NEL SEGNO DEI MEDICI 2015, pp. 118-119.
41 Sul tema cfr. GOLDENBERG STOPPATO 2006.
42 ONESTINI 1871, p.n.n., n 28
43 CAMPETTI 1909, p. 70, n. 176.
44 ONESTINI 1871, pp.n.nn
45 ZAVA BOCCAZZI 1990. L’interesse di questa raccolta, costituita in prevalenza da pittura veneta ed emiliana, aveva già richiamato l’attenzione di Francis Haskell (cfr. HASKELL 1956 e 1966, pp. 350-354). Nei decenni successivi e dopo lo studio fondamentale di Zava Boccazzi, nuove precisazioni e identificazioni di opere sono state pubblicate da BETTI 1997 e 2003(2005); PASIAN 2010(2011); BETTI 2019; FUMAGALLI 2022, pp. 144-147. I tempi e i modi della dispersione non sono noti ma per molte delle opere rintracciate è stata appurata la presenza a Lucca, in collezioni private, per buona parte del XIX secolo.
46 ZAVA BOCCAZZI 1999.
47 FOGOLARI 1937, p. 156.
(1937)48 e Isa Belli Barsali (1953 e 1970)49; nella scheda ministeriale dell’opera del 1977 redatta da Roberto Paolo Ciardi50, nella quale l’attribuzione è ribadita «sia pure con qualche perplessità», ma ancorata al XVIII secolo sulla base (si legge) di un «abito tipicamente settecentesco», che non appare condivisibile; infine nella tesi di dottorato di Franco Paliaga sui rapporti fra gli ‘ultimi Medici’ e Venezia: Paliaga ribadisce l’attribuzione a Cassana, a Niccolò o, in alternativa, al fratello minore Giovanni Agostino (1658-1720), ma senza distinzioni di stile fra i due51
L’unica voce fuori dal coro risale al 1975, quando Marco Chiarini, pubblicando gli inventari dell’eredità del gran principe Ferdinando, propose l’accostamento del ritratto lucchese al «quadro in tela alto br. 1 ¼, largo br 1 soldi 1, dipintovi di mano di Giusto Suttermans una donna giovine vestita di nero, con maniche trinciate, con collana di perle pendente al petto»52
L’incongruenza del colore della veste, delle «maniche trinciate» e della «collana di perle pendente al petto» fu presto rilevata da Ciardi (1977)53, ed è certo confermabile. Tuttavia l’errore identificativo non cancella il merito di Chiarini di aver giudicato compatibile il ritratto con un dipinto attribuito storicamente a Giusto Suttermans; un giudizio contestato in passato54, ma che in questa sede appare degno di nuova considerazione, alla luce dei caratteri formali e sulla scia dell’identificazione proposta col ritratto di Anna Maria Sardelli, attribuito in antico a Giusto Suttermans. Diversamente dai ritratti di Cassana, la nostra effigie dimostra un attaccamento ancora forte alle formule della ritrattistica femminile della metà del Seicento. Il ritratto di ‘musica’ della corte fiorentina, copiato da un originale di Suttermans, rimane a mio avviso il confronto più convincente, ma altri se ne potrebbero aggiungere, prelevati dalla vasta iconografia di Vittoria della Rovere – ad esempio, quelli nelle vesti di Liberalità (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, inv. 1890, n. 4297) e Sant’Orsola (Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, inv. 1890, n. 5169) – o anche la poco maggiore Gentildonna di casa Almeni (Firenze, Gallerie degli Uffizi, depositi (Palazzo degli Uffizi), inv. 1890, n. 2760); tutti dotati della stessa compostezza d’atteggiamento e muta serenità di sguardo della ‘diva Sardelli’.
Se l’ambito di produzione è quello del ritrattista ufficiale della corte fiorentina, più complicato è stabilire l’autografia, per i segni di sofferenza della pittura che ostacolano una valutazione obiettiva del livello qualitativo. Nel solco di Suttermans e in particolare della produzione degli anni Sessanta si pone l’attenuata levigatura delle superfici, specie negli incarnati, con una pennellata più sciolta, particolarmente libera nei dettagli dei tessuti, ma senza i virtuosismi materici sperimentati dall’artista nei ritratti meno ufficiali già nei decenni precedenti (un esempio su tutti, l’Elia da Zia, pilota della Galera Capitana, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, inv. 1912, n. 119)55. Confronti pertinenti giungono dalle effigi dei figli di Cosimo III dipinte a cavallo del 167056, al limite dell’ante quem stabilito dalla supposta provenienza Montauto († 1666), e non troppo oltre il biennio 1658-1659, in cui si esauriscono le notizie su Anna Maria Sardelli. Non si può escludere, a questo proposito, che il ritratto riproduca un originale eseguito negli anni Cinquanta, con la cui iconografia sarebbe perfettamente compatibile, e in questo l’intervento dei collaboratori del maestro potrebbe
48 LAZZARINI 1937, p. 54, n. 7.
49 BELLI 1953, p. 132, inv. 107; BELLI BARSALI 1970, p. 98, inv. 99.
50 CIARDI 1977 Il contributo è confluito senza modifiche nel Catalogo Generale dei Beni Culturali, consultabile in rete all’indirizzo https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0900067703 <27 maggio 2025>
51 PALIAGA 2012-2013, pp. 193, 211, nota 13.
52 CHIARINI 1975b, pp. 83, 105, nota 231bis
53 CIARDI 1977
54 Fra le argomentazioni di Ciardi si legge, senza possibilità di equivoco: «niente di questo ritratto può ricordare il Sustermans» (ibidem).
55 Cfr. GOLDENBERG STOPPATO 2006, p. 47.
56 Ivi, pp. 58-63
57 ASFi, GM 1185, I, pp. 67-75
58 Ivi, p. 375, n. 216
Studi di Memofonte 34/2025 acquistare verosimiglianza. Al netto di ciò, resta sostenibile la restituzione all’ambito di Giusto Suttermans, sulla base dei confronti iconografici e per le tracce documentarie rinvenute. In conclusione, non si può non avvertire dell’esistenza di un documento che, se nulla prova, certo contrasta con l’attribuzione a Cassana: si tratta del già citato inventario delle raccolte del gran principe Ferdinando del 1701-1710, ordinato per pittori, dove le opere di Cassana sono elencate con precisione degna della contemporaneità della fonte57, ma nessuna traccia vi è del quadro, che è al contrario riconoscibile nelle pagine di Suttermans58
Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli
Fig. 1: Ambito di Giusto Suttermans, Ritratto di Anna Maria Sardelli (già Niccolò Cassana, Ritratto di gentildonna ignota), 1655-1666 ca, 72x57 cm, olio su tela Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Pinacoteca, inv. 107. Su concessione del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Nazionali Toscana
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 2: Giusto Suttermans, Ritratto di Francesco Maria Suttermans come Paride, 1662, 73x57 cm, olio su tela. Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Pinacoteca, inv. 99. Su concessione del Ministero della Cultura – Direzione regionale Musei Nazionali Toscana
Una proposta per un ritratto della cantante d’opera Anna Maria Sardelli
Fig. 3: Man. Ricc. 4211, cc. 97v-98r (tav. 91). Firenze, Biblioteca Riccardiana. Su concessione del Ministero della Cultura – Biblioteca Riccardiana
Fig. 4: Ambito di Giusto Suttermans, Ritratto di Anna Maria Sardelli (particolare con le tracce di un oggetto metallico sull’acconciatura, possibilmente la spilla del cappello), 1655-1666 ca, 72x57 cm, olio su tela. Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Pinacoteca, inv. 107 Foto dell’autore
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 5: Copia da Giusto Suttermans, Ritratto di gentildonna con partitura, XVII secolo, 75x62 cm, olio su tela Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi, inv. 1890, n. 2871 Su concessione del Ministero della Cultura –Gallerie degli Uffizi
Maria Sardelli
BIBLIOGRAFIA
AL SERVIZIO DEL GRANDUCA 1980
Al servizio del Granduca. Ricognizione di cento immagini della gente di corte, catalogo della mostra, a cura di S. Meloni Trkulja, Firenze 1980.
BELLESI 2011
S. BELLESI, I quadri allegorici, in Giovanni Martinelli da Montevarchi pittore in Firenze, a cura di L. Canonici, Firenze 2011, pp. 49-75
BELLI 1953
I. BELLI, Guida di Lucca, Lucca 1953
BELLI BARSALI 1970
I. BELLI BARSALI, Guida di Lucca, Lucca 1970 (seconda edizione interamente rifatta; edizione originale BELLI 1953)
BETTI 1997
P. BETTI, La collezione di Stefano Conti: un Lazzarini e due Carlevarijs ritrovati, «Antichità Viva», XXXVI, 1, 1997, pp. 38-43.
BETTI 2003(2005)
P. BETTI, Nuovi ritrovamenti per la Galleria Conti di Lucca, «Arte Veneta», LX, 2003(2005), pp. 112129.
BETTI 2019
P. BETTI, Antonio Balestra, Giuseppe Maria Crespi e suo figlio Luigi per Lucca, «Ricche Minere», VI, 12, 2019, pp. 97-105.
BIANCONI–WALKER 1975
L. BIANCONI, T. WALKER, Dalla Finta Pazza alla Veremonda: storie di Febiarmonici, in Studi in onore di Nino Pirrotta, a cura di L. Bianconi, F.A. Gallo et alii, numero monografico di «Rivista Italiana di Musicologia», X, 1975, pp. [379]-454.
CAMPETTI 1909
P. CAMPETTI, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Lucca (nel Palazzo Ducale), Lucca 1909.
CHIARINI 1975a
M. CHIARINI, I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana, «Paragone. Arte», XXVI, 301, 1975, pp. 57-98.
CHIARINI 1975b
M. CHIARINI, I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana (continuazione), «Paragone. Arte», XXVI, 303, 1975, pp. 75-108.
CHIARINI 1992
M. CHIARINI, Aggiunte a ‘I quadri della collezione del Principe Ferdinando di Toscana’, «Paragone. Arte», XLIII, 505-507, 1992, pp. 92-100.
CIARDI 1977
R.P. CIARDI, Cassana Nicoletto (attribuito), Ritratto di dama, scheda OA 0900067703, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, 1977
FOGOLARI 1937
G. FOGOLARI, Lettere pittoriche del Gran Principe Ferdinando di Toscana a Niccolò Cassana (1698-1709), «Rivista del R. Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte», VI, 1937, pp. [145]-186.
FUMAGALLI 2022
E. FUMAGALLI, Lettere d’artista e lettere artistiche nell’Autografoteca Campori: una prima ricognizione e due casi di studio fiorentini, in Collezionare autografi. La raccolta di Giuseppe Campori, a cura di M. Al Kalak, E. Fumagalli, Firenze 2022, pp. 143-156.
GOLDENBERG STOPPATO 2006
L. GOLDENBERG STOPPATO, Un granduca e il suo ritrattista. Cosimo III de’ Medici e la “stanza de’ quadri” di Giusto Suttermans, catalogo della mostra, Livorno 2006.
GOLDENBERG STOPPATO 2018
L. GOLDENBERG STOPPATO, Le “musiche” delle granduchesse e i loro ritratti, in Con dolce forza. Donne nell’universo musicale del Cinque e Seicento, catalogo della mostra, a cura di L. Donati, Firenze 2018, pp. 45-63.
GOLDENBERG STOPPATO 2019(2020)
L. GOLDENBERG STOPPATO, Appunti su Antonio Franchi e Niccolò Cassana in margine alla mostra dei Lanzi, «Bollettino. Amici di Palazzo Pitti», 2019(2020), pp. 64-85.
HASKELL 1956
F. HASKELL, Stefano Conti, Patron of Canaletto and Others, «The Burlington Magazine», XCVIII, 642, 1956, pp. 296-301
HASKELL 1966
F. HASKELL, Mecenati e pittori. Studio sui rapporti tra arte e società italiana nell’età barocca, Firenze 1966 (edizione originale Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque, Londra 1963)
LANGEDIJK 1981-1987
K. LANGEDIJK, The Portraits of the Medici, 15th-18th Centuries, I-III, Firenze 1981-1987.
L’ARME E GLI AMORI 2001
L’arme e gli amori. La poesia di Ariosto, Tasso e Guarini nell’arte fiorentina del Seicento, catalogo della mostra, a cura di E. Fumagalli, M. Rossi, R. Spinelli, Livorno 2001.
LAZZARINI 1937
P. LAZZARINI, Lucca e dintorni. Guida storico-artistico-religiosa, Lucca 1937.
MAMONE 2003
S. MAMONE, Serenissimi fratelli principi impresari. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei. Carteggi di Giovan Carlo de’ Medici e di Desiderio Montemagni suo segretario (1628-1664), trascrizione in collaborazione con A. Evangelista, Firenze 2003.
Maria Sardelli
MAMONE 2013
S. MAMONE, Mattias de’ Medici serenissimo mecenate dei virtuosi. Notizie di spettacolo nei carteggi medicei. Carteggio di Mattias de’ Medici (1629-1667), Firenze 2013.
MEMORIE E DOCUMENTI 1914
Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, XIV Spettacoli lucchesi nei secoli XVII-XIX, di A. Pellegrini, tt. 2, Lucca 1914.
MODESTI 2018
A. MODESTI, “Nelle mode le più novelle”. The Latest Fashion Trends (Textiles, Clothing and Luxury Fabrics) at the Court of Grand Duchess Vittoria della Rovere de’ Medici of Tuscany, in Telling Objects. Contextualizing the Role of the Consort in Early Modern Europe, a cura di J. Bepler, S. Norrhem, Wiesbaden 2018, pp. [107]-129.
MODESTI 2020
A. MODESTI, Women’s Patronage and Gendered Cultural Networks in Early Modern Europe. Vittoria della Rovere, Grand Duchess of Tuscany, New York - Londra 2020.
NEL SEGNO DEI MEDICI 2015
Nel segno dei Medici. Tesori sacri della devozione granducale, catalogo della mostra, a cura di M. Bietti, R. Gennaioli, E. Nardinocchi, Livorno 2015.
ONESTINI 1871
S. ONESTINI, Elenco dei quadri che sono attualmente disponibili per formare la Pinacoteca provinciale della città di Lucca [1871], in appendice a I. Pizzi, La pinacoteca di Lucca (1874-1948), Lucca 1980, pp.n.nn.
PALIAGA 2012-2013
F. PALIAGA, Dalla Laguna all’Arno. Cosimo III, il Gran Principe Ferdinando de’ Medici e il collezionismo dei dipinti veneziani a Firenze tra Sei e Settecento, tesi di Dottorato in Storia e Tutela dei Beni Culturali, Università degli Studi di Udine, A.A. 2012-2013.
PASIAN 2010(2011)
A. PASIAN, Antonio Bellucci per Stefano Conti: la Santa Rosalia allo specchio ritrovata, «AFAT. Arte in Friuli Arte a Trieste», XXIX, 2010(2011), pp. 347-349.
PELLEGRINI 2023
E. PELLEGRINI, Studi sul collezionismo a Lucca. Dall’Età moderna all’Unità, Lucca 2023.
PROFETI 2007
C. PROFETI, Note in margine al Museo della Natura Morta di Poggio a Caiano: ma quel Cassana è Suttermans?, «Commentari d’Arte», XIII, 38, 2007, pp. 83-90.
RUGGERI 1996
U. RUGGERI, Nuove opere di Niccolò Cassana, «Arte|Documento», X, 1996, pp. 77-82.
SASO 2020(2021)
J. SASO, I ritratti di Vittoria della Rovere, granduchessa di Toscana: un programma di autorappresentazione principesca, «Accademia Raffaello. Atti e Studi», XIX, 1-2, 2020(2021), pp. 97-164.
SPINELLI 2010
L. SPINELLI, Il principe in fuga e la principessa straniera. Vita e teatro alla corte di Ferdinando de’ Medici e Violante di Baviera (1675-1731), Firenze 2010.
ZAVA BOCCAZZI 1984
F. ZAVA BOCCAZZI, Contributo alla ritrattistica di Nicolò Cassana, «Arte Veneta», XXXVIII, 1984, pp. 97-105.
ZAVA BOCCAZZI 1990
F. ZAVA BOCCAZZI, I veneti della Galleria Conti di Lucca (1704-1707), «Saggi e Memorie di Storia dell’Arte», XVII, 1990, pp. 107-152, 313-321.
ZAVA BOCCAZZI 1999
F. ZAVA BOCCAZZI, “Istantanee familiari” di Nicolò Cassana, «Arte|Documento», XIII, 1999, pp. 228-235.
Maria Sardelli
ABSTRACT
Attraverso la ricostruzione dettagliata della storia collezionistica e il recupero di alcuni dati iconografici perduti – reso possibile dall’analisi di note di restauro del 1951-1952 – il Ritratto di gentildonna ignota esposto nella Pinacoteca del Museo Nazionale di Palazzo Mansi, a Lucca, sembra finalmente identificabile con la celebre cantante d’opera Anna Maria Sardelli (documentata dal 1642 al 1659), ritratta probabilmente a Firenze entro il 1666. Con le sue parti mancanti, il dipinto risulta ben riconoscibile negli inventari delle collezioni del gran principe Ferdinando de’ Medici (1673-1713), con una provenienza più antica dalla raccolta del conte Francesco Montauto († 1666), secondo una nota veduta sul telaio dell’opera nel 1850 (trascritta in un inventario coevo). L’analisi stilistica, congiunta alle informazioni sulla provenienza, induce a spostare la paternità del quadro dal veneziano Niccolò Cassana (1659-1714) – cui fu attribuito a partire dal 1861 – all’ambito del ritrattista della corte medicea, il fiammingo Giusto Suttermans (1597-1681).
This article focuses on a Portrait of an Unknown Lady in the Pinacoteca del Museo Nazionale di Palazzo Mansi, in Lucca. Through a detailed reconstruction of the provenance history and the recovery of some lost iconographic data retrieved from restoration notes dating 1951-1952 it seems finally identifiable as the famous opera singer Anna Maria Sardelli (documented from 1642 to 1659), probably portrayed in Florence within 1666. With its missing parts, the work is recognizable in the inventories of the collections of the Grand Prince Ferdinando de’ Medici (1673-1713), with an older provenance from the collection of Count Francesco Montauto († 1666), according to a note seen on the back of the painting in 1850 and transcribed in a coeval inventory. The stylistic analysis, combined with the information on the provenance, leads to shifting its authorship from the Venetian Niccolò Cassana (1659-1714) to whom it was attributed in 1861 to the circle of the portraitist of the Medici court, the Flemish Giusto Suttermans (1597-1681).
FRANCESCO FURINI E VINCENZO MANNOZZI: CUIQUESUUM
Problemi d’identità
In occasione della mostra Un’altra bellezza. Francesco Furini, organizzata a Palazzo Pitti nel 2007, a fronte dell’«oltraggiosa larghezza» con cui quel nome veniva (e viene tuttora) speso in repertori e cataloghi di vendite, Roberto Contini auspicava che vedesse la luce quanto prima un riepilogo «piuttosto restrizionista che necessariamente liberale» del corpus dell’artista1. I tempi sono maturi per rispondere all’appello, anche se forse non nella direzione ivi intesa delle copie o reinterpretazioni corsive. Occorre invece andare al cuore dell’immaginario furiniano, per come viene comunemente recepito dagli studiosi di Seicento fiorentino, e avviare un’operazione chirurgica che, sebbene possa esser accolta con comprensibile riluttanza, risulta improcrastinabile per restituire a Furini un corpo integro, e, al contempo, un corpo nuovo al suo ‘scolaro’ Vincenzo Mannozzi (1600-1658). Parimenti si presenterà un’inaspettata soluzione al quesito posto da Contini riguardo all’ultima fase della carriera di Francesco: a differenza di altri momenti in cui egli aveva manifestato un continuo e meditato aggiornamento sulle varie esperienze via via incontrate (la statuaria antica, il caravaggismo di Manfredi e Baburen, la pittura emiliana, il classicismo di Vouet), questa apparirebbe invece una «conquista interna» che «non dipende da curiosità per l’altro, per il nuovo: hybris? stanchezza? eppure il conio (dopo il 1640) della sua parzialmente modificata umanità di maschere dall’occhio gonfio, lacrimoso e ovalizzato unita a una più brusca geometrizzazione dei cartacei panneggi (Circe a Lucca) parlano di un artista teso a una sua evoluzione»2. Ma – vedremo – non si trattò affatto dell’avvitamento dell’ultimo Furini in una maniera autoreferenziale, poiché buona parte delle opere in questione furono realizzate anche diversi anni dopo la sua morte da Vincenzo Mannozzi, in uno stile artificialmente furiniano. In queste pagine proporremo infatti di togliere al primo alcuni dipinti, anche assai rilevanti, per assegnarli al secondo sulla scorta di notizie d’archivio e col sostegno dei dati stilistici e dell’esame dei disegni.
Il profilo critico di Vincenzo Mannozzi potrà in tal modo essere compreso nella sua interezza, ritrovando finalmente un’identità compiuta quale sino a oggi si è faticato a riconoscere, nonostante qualche sporadico tentativo. Tale incomprensione di fondo è dipesa largamente dal fatto che Filippo Baldinucci – la fonte principale circa le vite e l’attività dei pittori fiorentini del XVII secolo – non dedicò a Vincenzo una biografia autonoma ma si limitò a rammentarlo soltanto in calce alle notizie di Furini, di cui sarebbe stato «condiscepolo nella scuola del Passignano» per poi divenirne «scolaro» al pari di Giacinto Botti e Giovan Battista
Questo articolo costituisce l’approfondimento di alcune intuizioni emerse nello svolgimento di un assegno di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa, incentrato sullo studio e sulla catalogazione del patrimonio storico-artistico del Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia, di cui ho usufruito tra il 2023 e il 2024. Desidero ringraziare Francesco Caglioti, responsabile scientifico del progetto, e Monica Preti, direttrice di Pistoia Musei, per gli stimoli e l’incoraggiamento offertimi; quindi, per il generoso supporto, Gaia Ravalli, mia collega in quell’anno, assieme a Monia Manescalchi e Giandonato Tartarelli del Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica della Scuola Normale Superiore diretto da Flavio Fergonzi, e il personale di Pistoia Musei. Sono inoltre grato a vario titolo a Luisa Berretti, Duccio Conti Caponi, Micaela Cascella, Andrea De Marchi, Patrizia Di Cataldo, Pasquale Focarile, Lorenzo Gnocchi, Giovanni Pagliarulo, Annamaria Petrioli Tofani, Susi Piovanelli, Giovanni Serafini, Fabio Sottili e Riccardo Spinelli, Cristina Tuci, e, per l’aiuto prestatomi nelle ricerche, a Simona Pasquinucci e Francesca Moschi dell’Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine, ad Angelo Tartuferi e Barbara Pini per l’accesso ai Depositi di San Salvi, nonché al personale del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, dell’Archivio di Stato e del Kunsthistorisches Institut di Firenze. Tutti i disegni e i dipinti dei musei statali italiani sono riprodotti su gentile concessione del MiC; le opere di Pistoia fotografate da Giandonato Tartarelli per gentile concessione dell’Archivio Patrimonio Artistico di Intesa Sanpaolo.
1 CONTINI 2007, p. 105.
2 Ibidem
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Naldini, rispetto ai quali, però, «stette alquanto più nella […] maniera» di Francesco3. Pur relegandolo nelle fila dei maestri non meritevoli di resoconti puntuali, Baldinucci conosceva e probabilmente apprezzava le capacità disegnative di Vincenzo, se, stilando la consistenza della collezione del cardinal Leopoldo nel 1673, contava ben ventinove suoi fogli4, di autografia sicura perché ragionevolmente arrivati dall’artista medesimo (che per il principe aveva lavorato almeno dal 16515, dipingendo tra l’altro quattro grandi tele, come diremo più avanti). Si tratta di un numero ragguardevole a cui se ne aggiunsero altri quindici, nel 1699, arrivati da una collezione altrettanto raffinata come quella di Apollonio Bassetti6. Ma, nonostante l’attendibilità e il prestigio delle provenienze, col passare del tempo i fogli persero l’originaria attribuzione poiché Mannozzi era divenuto frattanto niente più che un nome senza quadri, e alcuni di essi furono riassegnati ad artisti più blasonati o dal catalogo pittorico almeno in parte noto, come appunto Furini o anche Lorenzo Lippi7
L’attività di Mannozzi pittore ha cominciato a riemergere soltanto dopo gli affondi archivistici condotti da Evelina Borea tra il 1975 e il 19778, che riportarono alla luce un primo nucleo di opere certe, tutte circoscrivibili fra la metà degli anni Trenta e la metà degli anni Quaranta, ovvero i quadri per don Lorenzo de’ Medici: il Ratto di Proserpina su pietra di paragone9 e le tele con Ila col vaso (Fig. 1)10 e Orlando che libera Isabella dalla grotta dei malandrini (Fig. 2)11. A queste, a partire dagli anni Ottanta, sono stati aggiunti molti altri dipinti su base attributiva –invero assai disomogenei tra loro12 – e, per contro, soltanto due identificabili in opere menzionate negli inventari medicei: l’Olimpia abbandonata da Bireno listata nel 1646 nella raccolta di Giovan Carlo de’ Medici, di cui si conserva agli Uffizi una versione forse di bottega (Fig. 3)13 , e La Verità scopre la Menzogna (Fig. 4)14, censita nelle collezioni di Vittoria della Rovere alla fine del Seicento (ossia più di trent’anni dopo la morte di Vincenzo), la quale, benché priva di un puntello cronologico certo, è stata a ragione creduta appartenere alla fase più avanzata della sua carriera15. Quest’ultimo quadro, assieme al modelletto in collezione Pratesi, ha costituito il fulcro
3 BALDINUCCI/RANALLI–BAROCCHI 1974-1975, IV (s.d.), p. 643.
4 FILETI MAZZA 2009, pp. 226, 232.
5 E. Borea, Vincenzo Mannozzi, in LA QUADRERIA 1977, p. 51; MASCALCHI 1986; BELLESI 2007; SPINELLI 2023, pp. 34-37.
6 Sulla quale si vedano PETRIOLI TOFANI 2020a e 2020b, in particolare pp. 80-81 per i disegni di Mannozzi.
7 Ad esempio, i nn. 1185 F e 1186 F, registrati come di Lippi (il secondo, poi, spostato temporaneamente a Simone Pignoni): cfr. GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI 1991-2005, II (2005), pp 102-103
8 BOREA 1975, pp. 28 e sgg.; E Borea, Vincenzo Mannozzi, in LA QUADRERIA 1977, p. 51.
9 Olio su pietra di paragone, 43,5x59 cm; Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi, inv. 1890, n. 4973. L’opera fu eseguita a pendant di un Incendio di Troia di misure identiche e su analogo supporto, di Stefano della Bella. Cfr. BOREA 1975, p. 28; E. Borea, scheda n. 27, in LA QUADRERIA 1977, p. 53; SPINELLI 2023, p. 31.
10 Olio su tela, 65x48 cm; Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi, inv. 1890, n. 2801. Cfr. BOREA 1975, p. 29; E. Borea, scheda n. 26, in LA QUADRERIA 1977, p. 52; MASCALCHI 1986, p. 111; SPINELLI 2023, pp. 28-31.
11 Olio su tela, 232x345 cm; Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi, inv. 1890, n. 7832. Cfr. BOREA 1975, p. 28; E. Borea, scheda n. 28, in LA QUADRERIA 1977, pp. 54-55; F. Baldassari, scheda n. 11, in FLORENCE AU GRAND SIÈCLE 2011, pp. 68-69; SPINELLI 2023, pp. 30-32.
12 MASCALCHI 1986, p. 112; CANTELLI 1983, p. 104; BELLESI 2007, p. 128; BALDASSARI 2009, pp. 502-503; BELLESI 2009, I, p. 189; CANTELLI 2009, I, pp. 134-135; per un riepilogo, SPINELLI 2023, passim
13 Identificata inizialmente in un olio su tela (170x227 cm) allora in collezione privata da R. Maffeis, scheda n. 75, in L’ARME E GLI AMORI 2001, p. 206, donato nel 2002 agli Uffizi (cfr. anche SPINELLI 2023, p. 32), secondo S. Bellesi, scheda n. 23 (Giovanni Martinelli, Olimpia abbandonata da Bireno), in LUCE E OMBRA 2005, p. 68, l’opera appartenuta al Medici sarebbe da riconoscere nella versione di misure lievemente differenti (174x210 cm) del Museo Statale di Archangelskoe, presso Mosca, che MARKOVA 2004 aveva pubblicato come replica del dipinto fiorentino.
14 Olio su tela, 265x205 cm; Cerreto Guidi, Museo della Caccia e del Territorio, inv. Bardini, n. 75. L’opera –appartenuta a Vittoria della Rovere, ereditata dal figlio Francesco Maria de’ Medici e alienata alla di lui morte nel 1711 – fu acquistata da Stefano Bardini in un tempo imprecisato; entrata nella sua raccolta, è stata riconosciuta da M. Scalini, scheda n. 13, in RIFLESSI DI UNA GALLERIA 2001, pp. 42-43, in virtù del confronto col modelletto pittorico di collezione Pratesi che R. Spinelli, scheda n. 31, in PITTURE FIORENTINE 1987, pp. 91-94, aveva reso noto collegandolo ai documenti relativi alla tela medicea e ai disegni preparatori, identificati da PETRIOLI TOFANI 1979, pp. 76-77.
15 BELLESI 2007, p. 128; SPINELLI 2023, p. 27.
della recente esposizione monografica in occasione della quale Riccardo Spinelli ha fornito un importante riepilogo della fortuna critica di Mannozzi sino a oggi16
Se guardiamo alle sole pitture documentate, si intuisce subito che la definizione di «scolaro» di Furini, fornita da Baldinucci, debba essere quantomeno problematizzata: non soltanto perché Vincenzo era più anziano del collega di quattro anni, ma anche e soprattutto perché nella sua prima attività per don Lorenzo e Giovan Carlo non emerge alcun debito nei confronti di Francesco. La citazione (peraltro non puntuale) del gruppo furiniano dell’Ila e le ninfe, del 1633, appartenuto ad Agnolo Galli17, nel vaso istoriato retto dall’Ila mannozziano per don Lorenzo, è di carattere puramente iconografico e non coinvolge lo stile di questo dipinto né degli altri, dove Vincenzo si mostra disinteressato allo sfumato di origine leonardesca che fu la cifra precipua di Furini, e appare piuttosto incline a un grafismo insistito – lo si veda esemplarmente nei panneggi, nel profilo anatomico e nelle onde come disegnate dell’Olimpia –che richiama il parzialmente omonimo Giovanni Mannozzi, da San Giovanni Valdarno18. Né mancano altri riferimenti (le figure maschili dell’Orlando, a mio parere, sono memori di certi aguzzini di Fabrizio Boschi19), ma nessuno in chiave realmente furiniana. È soltanto nella più tarda Verità che le riprese da Francesco sono evidenti, tanto nel reimpiego della sinuosa figura femminile di spalle quanto nella maggiore fusione pittorica d’insieme, seppure non manchino ulteriori rimandi alle composizioni più fragorosamente barocche di Pietro da Cortona e del Volterrano.
La reale traiettoria percorsa da Mannozzi fra questi estremi può adesso ricomporsi grazie all’individuazione di alcune opere che – a differenza di quelle arbitrariamente attribuite – hanno una relazione certa o con i rammentati disegni del GDSU o con i nuovi e decisivi riscontri archivistici rinvenuti da Spinelli, o, nel migliore dei casi, con gli uni e gli altri.
Più che «scolaro» diretto di Furini, Mannozzi ci apparirà allora un artista capace e, in un certo senso, smaliziato che dopo la morte del collega volle farsi aperto imitatore della sua maniera: l’intento, a tutta evidenza, era quello di proseguire su una linea apprezzata dai collezionisti fiorentini alla metà del secolo, il che, rimanendo inevasa la domanda sul mercato, gli avrebbe garantito un sicuro successo. Del resto, non va dimenticato che la sua attività principale – quella che lo aveva reso caro ai Medici, facendogliene guadagnare la fiducia – era, ancor prima che di pittore in proprio, di consulente negli acquisti sulle varie piazze d’Italia20 Non c’è dubbio, quindi, che sapesse intercettare come pochi il gusto dei committenti
Casus belli
La novità più eclatante, che deflagra nel cuore dell’«eterno femminino furiniano»21, riguarda la tela con Agar e l’angelo (Fig. 5) che Piero Bigongiari rese nota attribuendola a Francesco nel 1971 (oggi conservata, assieme al resto della sua collezione, a Pistoia presso il Museo dell’Antico
16 SPINELLI 2023.
17 Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina, inv. 1890, n. 3562; cfr. R. Maffeis, scheda n. 15, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 178-181 (con bibliografia precedente).
18 Si confronti ad esempio il profilo proteso in avanti della mannozziana Olimpia con quelli di Aurora o di una Baccante nei celebri affreschi su stuoie circolari, di Giovanni, oggi agli Uffizi. Si vedano da ultimo S. Benassai, scheda n. 7, in “BIZZARRO E CAPRICCIOSO UMORE” 2023, pp. 92-101, e scheda n. 12, ivi, pp. 108-111.
19 Come quelli del disperso Martirio di sant’Andrea già nella chiesa delle Stabilite in Via della Scala e poi in San Felice a Ema, del 1626-1627 circa, su cui si veda SPINELLI 2001(2002).
20 Da diversi documenti si evince che, per trattare acquisti per conto del granduca Ferdinando II e dei fratelli Giovan Carlo, Leopoldo e Mattias, Mannozzi fu a Bologna, Modena e Parma nel 1649; di nuovo a Modena nel 1650; tra il 1650 e il 1651, e poi ancora nel 1654, a Venezia (si veda COLLEZIONISMO MEDICEO 2005, t. 1, pp. 134135; ivi, t. 2, pp. 758-759; COLLEZIONISMO MEDICEO 2007, t. 1, pp. 151 (nota 528), 186, 462-464, 474-476, 548549; si veda anche FUMAGALLI 2013, p. 37, nota 25).
21 Secondo l’ironica eppur azzeccata definizione di CONTINI 2007, p. 105.
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Palazzo dei Vescovi22) e che, benché taciuta dalle fonti antiche, divenne immediatamente un punto fermo del catalogo dell’artista allora in via di definizione23. Lo studioso vi ravvisava il vertice di quella «eccedente bellezza» – forzando la celebre espressione di Baldinucci – che assurgeva a filtro interpretativo di tutta l’attività di Furini e del suo «universo, sì, aperto, ma pronto a chiudersi come un azzurro mallo minerale sul gheriglio delle figure teneramente sgusciate»24. In questa lettura che tanto peso ha avuto per la critica successiva – anche relativamente alla «sensualità» cui indirizzava il seno nudo, tanto sfacciato da esser coperto da una camicetta posticcia nel XIX secolo25 – ciò che Bigongiari non poteva allora sapere è che l’Agar non è un capolavoro di Furini, trattandosi di un’opera documentata di Mannozzi. Per giustificare questa diminutio, che sulle prime può far storcere il naso, chiediamo al lettore la pazienza di riannodare i fili della storia. Com’è noto, Bigongiari aveva acquistato l’Agar (160x139 cm) assieme alla tela di dimensioni prossime (ma non identiche: 175,5x136 cm) di Simone Pignoni, David e Abigail26; qualche tempo dopo, Giuseppe Cantelli avrebbe informato che l’acquisto era stato condotto dietro una sua segnalazione, e che alle due tele, provenienti dalla famiglia Pazzi, se ne accompagnava un’altra di formato maggiore (181x227 cm), Loth e le figlie, da lui inizialmente attribuita a Orazio Fidani e poi spostata allo stesso Pignoni27. Stante la quasi perfetta corrispondenza delle dimensioni e delle spettacolari cornici, tuttora in essere, fu inevitabile concludere che almeno l’Agar e l’angelo e il David e Abigail fossero stati dipinti a pendant, con l’inevitabile ante quem della morte di Furini e dunque entro il 1645-1646.
Successivamente è stato reso noto che le tele Pazzi provenivano, ab antiquo, dagli Strozzi28 È merito recente di Spinelli aver precisato su base archivistica che fu il senatore Lorenzo di Lorenzo Strozzi (1596-1671) a commissionare a Simone Pignoni le sue due tele, in tempi decisamente più avanzati rispetto alla morte di Furini: Loth e le figlie nel 1648, David e Abigail addirittura nel 1658-165929. Nello spoglio dei documenti, Spinelli affermava però di non aver rinvenuto pagamenti a Furini, supponendo che l’Agar potesse essere arrivata in un secondo momento – magari da un ramo collaterale della famiglia, che ebbe effettivamente una storia complessa di riunificazioni di linee diverse – ma, contestualmente, segnalava che il soggetto doveva riuscire gradito a Lorenzo Strozzi, se costui fra il 1652 e il 1653 si fece dipingere da Vincenzo Mannozzi «un quadro a olio fatto di sua mano entrovi un’Agar nel deserto quando gli appariva l’Angelo, e gli mostrò la fonte», la cui cornice fu dorata nel 1654 da Camillo Baracchi30 . Nonostante le misure perfettamente coincidenti con quelle rammentate dai documenti («alto braccia 2.15, largo 2.8» ovvero 160,49x140,06 cm), l’acclarato ‘pedigree’ furiniano della tela
22 Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, inv. ISP_021397.
23 BIGONGIARI 1974; la critica successiva ha accolto unanimamente Agar e l’angelo tra i capolavori di Furini, pur con lievi divergenze sulla datazione, generalmente indicata nella fase finale dell’artista e dunque fra il 1640 e il 1646, con una maggiore preponderanza per gli anni estremi della sua vita. La bibliografia è sterminata e mi limito a segnalare i contributi di GREGORI 1974, p. 222; CANTELLI 1980, pp. 165-166; G. Cantelli, scheda n. 1.138, in IL SEICENTO FIORENTINO 1986, vol. Pittura, p. 280; BALDASSARI 2004, p. 128, scheda n. 23; MAFFEIS 2003(2004), pp. 142-143; R. Maffeis, scheda n. 35, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 224-225; R. Spinelli, Francesco Furini, Agar e l’angelo, in IN FABULA 2022, pp. 171-176.
24 BIGONGIARI 1974, p. 58; cfr. BALDINUCCI/RANALLI–BAROCCHI 1974-1975, IV (s.d.), p. 639.
25 G. Cantelli, scheda n. 1.138, in IL SEICENTO FIORENTINO 1986, vol. Pittura, pp. 280-281.
26 Anch’essa oggi a Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, inv. ISP_021415.
27 CANTELLI 1974, p. 23; G. Cantelli, scheda n. 1.138 (Agar e l’angelo), in IL SEICENTO FIORENTINO 1986, vol. Pittura, p. 280, e scheda n. 1.238 (David e Abigail), ivi, p. 428; R. Contini, scheda n. 32 (Loth e le figlie), in PITTURE FIORENTINE 1987, pp. 95-97.
28 BALDASSARI 2004, p. 128, scheda n. 23, e ivi, pp. 172-174, scheda n. 43; la provenienza Strozzi è confermata da una scritta a pennello su un tassello del telaio originale del quadro di Pignoni, inserito nel telaio di restauro, a mia scienza mai riportata dalla critica: «Del Sig. Senator Strozzi».
29 SPINELLI 2022, pp. 217-218; R. Spinelli, Simone Pignoni, David e Abigail, in IN FABULA 2022, pp. 196-197.
30 Il saldo finale di 57 scudi, del 10 ottobre 1653, segue un primo stanziamento, nel settembre 1652, per la tela e l’azzurro: ASFi, Carte Strozziane, V, 338, cc. 343, 372, 391; SPINELLI 2022, p. 217; R. Spinelli, Simone Pignoni, David e Abigail, in IN FABULA 2022, pp. 197-198; SPINELLI 2023, pp. 46-47.
Studi di Memofonte 34/2025
Bigongiari ha impedito di concludere che essa è in realtà l’opera dipinta da Vincenzo Mannozzi, e che di conseguenza non è mai esistita alcuna Agar di mano di Furini, il cui nome pur prestigioso non compare mai negli inventari antichi di casa Strozzi31 . Concedendo però che possa tacciarsi come un argumentum e silentio, sarà opportuno addurre ulteriori conferme alla luce del dibattito sui disegni contesi tra Mannozzi e Furini. Poco dopo l’emersione dell’Agar, Giuseppe Cantelli pubblicava nel 1972 il foglio 1198 F degli Uffizi (Fig. 6), ritenendolo autografo di Francesco e propedeutico – assieme agli studi delle due braccia e di un piede tracciati sul recto e sul verso del 9719 F (Figg. 7-8) – alla Maddalena oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna32. In realtà, come rilevato da Rodolfo Maffeis, esso appare «compositivamente assai più affine all’Agar che non ad alcuna Maddalena furiniana ad oggi nota», specie se immaginiamo la figura con le gambe coperte e con un orcio al posto del teschio33 ; lo studioso tuttavia preferiva lasciare in sospeso l’attribuzione di questo e dell’altro foglio tra Furini e Mannozzi, al quale erano stati avvicinati nel 2005 da Annamaria Petrioli Tofani, che ne ricordava l’appartenenza al nucleo arrivato ab antiquo nelle collezioni medicee sotto il nome di Vincenzo e
31 Diversamente, in alcuni inventari settecenteschi rimase memoria dei nomi di altri artefici attivi per il senatore Strozzi, come Simone Pignoni, Cecco Bravo, Giacinto Gimignani e altri (sulla loro attività documentata, si veda SPINELLI 2022, pp. 215-219). Credo possibile, a questo proposito, che il nome del più quotato Pignoni abbia inglobato per attrazione anche le opere di Mannozzi, almeno nel caso delle scene bibliche già Bigongiari. Non sono in grado di stabilire quando il gruppo delle tre tele – ricordiamolo, composto da un dipinto un poco maggiore (Loth) e due pressoché uguali (Agar e Abigail), aventi cornici di simile fattura, dorate e con gola nera – passò ai Pazzi, anche se ciò avvenne probabilmente prima del 1810 giacché non furono censite tra i dipinti Strozzi che Vittorio Sampieri stimò in quell’anno (cfr. infra, nota 51). Ritengo però plausibile identificarle nel nucleo a tutta evidenza unitario di «n° 3 quadri grandi, che due più piccoli et uno grande con diverse figure con ornamento nero, e dorato», registrati ai primi del 1719 sotto il numero cumulativo «28», nella «Sala» del palazzo fiorentino, tra i beni dell’appena defunto balì Filippo Francesco (1628-1719), figlio del senatore Lorenzo (ASFi, Carte Strozziane, V, 1431, ins. Inventario delle masserizie ritrovate nel Palazzo dei Signori Strozzi attenenti all’Eredità dell’Illustrissimo Signor Cavaliere Filippo Vincenzo Strozzi, c. n.n.). Nello stesso inventario, inoltre, sotto il numero «18» nel «Salotto Grande», viene ricordato «un quadro mezzano, con n° 3 figure con ornamento nero e dorato», che propongo di identificare nella Preghiera di Tobia e Sara dipinta nel 1646-1647 da Cecco Bravo, di misure inferiori al Loth di Pignoni (122x180 cm ca) nel quale compariva infatti anche la figura di una inserviente, come attesta l’incisione trattane da Carlo Lasinio per l’Etruria Pittrice (SPINELLI 2022, pp. 216-217). I beni del balì Filippo furono ereditati dal nipote Lorenzo Francesco (16741742), il quale, avendo sposato nel 1698 Maria Teresa del ramo romano degli Strozzi (da cui trasse il marchesato di Forano e il ducato di Bagnolo), si trovò a riunire in sé le due linee dinastiche che sino a quel momento si erano divise la proprietà del palazzo edificato nel XV secolo da Filippo Strozzi (su tale frazionamento, poi ricomposto, si vedano GUERRIERI BORSOI 2004, in particolare pp. 36-42, e GUERRIERI BORSOI 2004(2005); MANIKOWSKI 1991 e 2017; FOCARILE 2019, in particolare pp. 55-65). Appena entrato in possesso dei beni dello zio, Lorenzo Francesco dovette operare alcuni spostamenti all’interno del palazzo, separando (almeno temporaneamente) il Loth dagli altri due quadri per accoppiarlo con un altro dipinto, come sembra di capire da un inventario redatto poco dopo, nell’aprile del 1719: nella «Arcova» furono posizionati «dui quadri di braccia 3 ¾ alti braccia 3 con ornamento tocco d’oro e nero, entrovi Istorie dissero opera del Botti [aggiuntovi a penna rossa: di Francesco Botti]», appunto il Loth di Pignoni e forse, se le misure fossero state prese in base al primo, il Tobia di Cecco Bravo, mentre nella «Guardaroba Grande», in attesa di una disposizione definitiva, furono ricoverati «due detti [quadri] di braccia 2 1/3, con adornamento dorato e nero, entrovi Istorie [aggiuntovi a penna rossa: del Pignoni]» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1431, ins. Inventario generale di tutto quello che si trova nel Palazzo di Firenze dell’Ill:mo et Ecc:mo Sig. Duca Lorenzo Francesco Strozzi principe di Forano, cc. 33, 49). Dieci anni più tardi la situazione era ulteriormente cambiata: il Loth e il temporaneo compagno facevano coppia nel «Salone del Trucco» e, da Francesco Botti, eran stati ricondotti al maestro Pignoni («due quadri di braccia 4 con ornamento nero e dorato, con rabeschi, entrovi Istorie si dicono del Pignoni»); mentre l’Agar e l’Abigail si trovavano nella «Camera delle visite» e, a questa data, il nero originario delle gole delle loro cornici era stato coperto da una vernice gialla (come ha confermato il recente restauro di quella dell’Agar: cfr. L. Castelli, Francesco Furini, Agar e l’angelo. Il restauro, in IN FABULA 2022, pp. 177-179): «due quadri braccia 2 in circa di larghezza, con cornici gialle, e dorate, entrovi Istorie, si dice del Pignoni» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1435, ins. Inventario generale di tutte le masserizie, arredi e mobili di qualunque sorte esistenti nel Palazzo di Firenze, cc. 61, 65).
32 G. Cantelli, schede nn. 15-16, in DISEGNI DI FRANCESCO FURINI 1972, pp. 29-30.
33 MAFFEIS 2003(2004), p. 155, nota 25; cfr. anche quanto osservato dallo stesso studioso nella scheda n. 32, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 218-220, e nella scheda n. 35, ivi, p. 224.
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
che li collegava al foglio 1186 F (rimasto censito sotto lo stesso nome: Fig. 11)34, una sorta di bozzetto a sanguigna con acquerellature, raffigurante la Maddalena nel deserto35 La proposta di Petrioli Tofani, accolta cautamente da Catherine Monbeig Goguel36, è stata confermata da Anna Forlani Tempesti37, che ha collegato gli studi sul verso del n. 1198 F (Fig. 9) – che già Maffeis aveva intuito esser preparatorio per una fanciulla in una scena di Loth e le figlie38 – al foglio 1185 F (Fig. 33)39, raffigurante appunto quell’episodio, di proporzioni e stile assai analoghi alla Maddalena del foglio 1186 F. Per queste ragioni, sembra ben plausibile che entrambi i modelletti grafici vadano messi in rapporto a due delle quattro tele dipinte da Mannozzi a Leopoldo de’ Medici, ovvero la «Maddalena nel deserto che diace in terra, coperta con panno azzurro e rivolta al Cielo di dove viene un raggio di splendore nella grotta» e il «Loth quando le figlie lo imbriacarono», censiti nel 1675 assieme a un Martirio di san Sebastiano e a un Alessandro e la famiglia di Dario, tutti aventi le misure di 3 braccia e 2/3 per 2 braccia e 7/8 (circa 214x168 cm)40
Restituita a Mannozzi la paternità dei disegni 1198 F e 9719 F recto e verso, si fa agevole riconsiderare una Maddalena dei Depositi delle Gallerie Fiorentine (Fig. 12) resa nota da Maffeis41, che ne evidenziava i rapporti tanto con quei fogli quanto con l’Agar Bigongiari, supponendola una versione lavorata dalla bottega di Furini. In verità – benché non si possa identificare nella Maddalena mannozziana appartenuta a Leopoldo, stanti le misure sensibilmente inferiori (176,2x134 cm) – la qualità che s’intuisce nelle pur precarie condizioni conservative e la provenienza medicea, attestata dai numeri inventariali a tergo42, suggeriscono che si tratti di un altro esemplare autografo di Vincenzo, con le sole varianti della caviglia destra, qui ravvicinata e anzi premuta contro la coscia, e del piede visto di profilo: soluzioni, queste, che ricordano non poco l’Olimpia abbandonata da Bireno dipinta per Giovan Carlo prima del 1646. Una datazione ancora entro lo scadere degli anni Quaranta, quando l’influsso furiniano non si era ancora imposto come esclusivo, è forse confermata dalla stilizzazione quasi elettrica dei capelli ondulati che fasciano i fianchi della Maddalena, così simili, come immaginazione, ai fiotti di spuma del mare nell’Olimpia, o alle fiamme spiritate dell’Orlando che libera Isabella Quando dunque, nel 1653, Mannozzi si trovò a dipingere l’Agar per Lorenzo Strozzi, poté ampiamente ricorrere alle pose anatomiche delle sue precedenti Maddalene e gli bastò mettere a punto lo svolgimento della veste sulle gambe della donna. Non stupisce, allora, trovare studiato
34 In GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI 1991-2005, II (2005), pp. 108-109, n. 1198 F, Petrioli Tofani lo censisce sotto Francesco Furini segnalando però la precedente attestazione a Vincenzo Mannozzi; la stessa studiosa, in una nota manoscritta sul cartone di montaggio del foglio, precisa: «V. Mannozzi, per la Maddalena di cui al n. 1186 F».
35 Ivi, p. 103, n. 1186 F: matita rossa e acquerello rosso su carta, 144x135 mm. Già E. Borea, Vincenzo Mannozzi, in LA QUADRERIA 1977, p. 51, aveva ipotizzato che il foglio fosse legato alla Maddalena appartenuta a Leopoldo de’ Medici
36 MONBEIG GOGUEL 2007, pp. 82-83.
37 FORLANI TEMPESTI 2009, pp. 69-70; il collegamento tra quadro mediceo e disegno è ribadito da SPINELLI 2023, pp. 37, 51, nota 60.
38 R. Maffeis, scheda n. 32, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, p. 220. Una ripresa del braccio e della mano che regge il manico del versatoio si trova nel foglio GDSU, n. 18262 F (Fig. 10), matita rossa su carta, 90x220 mm, già appartenuto a Bassetti (cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 80-81).
39 Matita rossa, acquerello rosso, lievi tracce di biacca su carta, 194x173 mm Cfr GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI 1991-2005, II (2005), pp. 102-103, n. 1185 F.
40 ASFi, Guardaroba medicea 826, Inventario dei mobili e masserizie dell’Eredità del Serenissimo e Reverendissimo Cardinale Leopoldo de’ Medici, cc. 78r-79r, nn. 387, 391, 395, 399: cfr. BOREA 1975, p. 38, nota 53; MASCALCHI 1986, p. 112; SPINELLI 2023, p. 37, che ne segnala il trasferimento nel 1695 nella villa di Poggio a Caiano, nella camera da letto del gran principe Ferdinando. Già E. Borea, Vincenzo Mannozzi, in LA QUADRERIA 1977, p. 51, aveva ipotizzato che il foglio 1186 F fosse legato alla Maddalena appartenuta a Leopoldo. In un inventario precedente (Firenze, Biblioteca Riccardiana, ms. 2443), la tela con Alessandro e la famiglia di Dario è interpretata, forse per fraintendimento del compilatore, come una Agar e l’angelo
41 R. Maffeis, scheda n. 35, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, p. 224.
42 Riportati sulla tela di rifodero, a pennello rosso: «1181», «1016»; su un pezzo di tela applicato al telaio di restauro, a pennello nero: «6038» barrato, «620(?)»; in un cartoncino applicato al telaio di restauro, iscrizione settecentesca a penna: «Una S:a M:a Maddalena Penit[ente] al Naturale di mano del Furino originale / n° 1016».
Studi di Memofonte 34/2025
tale dettaglio proprio in uno dei fogli da sempre censiti sotto il nome di Vincenzo al GDSU, il 7304 F (Figg. 13-14)43. Qualcosa di analogo avvenne forse per la figura dell’angelo. Il foglio 7143 F recto44 presenta il busto fasciato da una veste di un personaggio in piedi, non esattamente collimante con quello della tela Bigongiari: esso poteva riferirsi al protagonista di un dipinto non ancora riemerso (il David o l’Alessandro dell’altra tela per Leopoldo?), ma fu probabilmente riutilizzato con qualche variante per la posa ancheggiante – da manierismo nordico – del messo divino, combinandovi in basso le gambe panneggiate, studiate puntualmente nel foglio 7141 F (Figg. 15-16)45
La restituzione a Mannozzi del dipinto Bigongiari – il lettore lo avrà già intuito – porta con sé una serie di conseguenze impressionanti: venuta meno l’opera che aveva fatto da catalizzatore per l’attribuzione di non pochi quadri, va da sé che anche questi debbano essere ridiscussi.
Pitture nere da Furini a Mannozzi
Altre correzioni attributive vengono suggerite dai documenti Strozzi rinvenuti da Spinelli, dai quali traspare una certa frequentazione tra il committente e l’artista, certo facilitata da Leopoldo de’ Medici, di cui il senatore Lorenzo era allora maestro di camera: tra l’aprile del 1649, quando lo Strozzi registrò un pagamento generico a Mannozzi, e prima dell’esecuzione dell’Agar si situa infatti un episodio che li vide coinvolti tutti e tre. Stando alle fonti, in occasione della festa in onore di san Zanobi organizzata dall’Accademia della Crusca, e ospitata dallo Strozzi (accademico col nome di Travasato) il 20 giugno 1652 nel cortile del palazzo fiorentino, alla presenza dei principi medicei46, nell’arcata centrale del loggiato di ponente campeggiava – quale fulcro dell’apparato progettato da Alfonso Parigi – proprio una «immagine di S. Zanobi, con la mitria e il pastorale, mezza figura; opera di Vincenzio Mannozzi per disegno e bontà di colorito eccellentemente condotta»47, «nobil regalo fatto all’Accademia dalla pietà e liberalità del Serenissimo Candido»48, ovvero Leopoldo stesso.
Il comune servizio alla corte medicea spiega dunque l’assiduità delle commissioni di Lorenzo Strozzi a Mannozzi, il quale, dopo l’Agar, nel marzo 1655 gli licenziò «2 quadri a olio che uno d’una Circe alto braccia 2.3.8 e 1.14, l’altro di 2 fate che temperano una spada alto braccia 2 1/5 e 1.14.6»49. Ancora in Palazzo Strozzi per tutto il Settecento50, i dipinti vennero stimati nel 1810 da Vittorio Sampieri con una attribuzione alla «scuola del Forino»51. I loro
43 Matita rossa su carta, 155x200 mm; proveniente dalla raccolta di Bassetti. Cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 80-81.
44 Matita rossa su carta, 340x230 mm; anch’esso già appartenuto a Bassetti. Cfr. ibidem
45 Matita rossa su carta, 185x125 mm; anch’esso già appartenuto a Bassetti. Cfr. ibidem
46 Si vedano le deliberazioni dell’Accademia e le descrizioni della festa riportate in DI UNA PUBBLICA ADUNANZA 1880, pp. 14-17, 21-31; sulla pala del Travasato, si veda CIARDI–TONGIORGI TOMASI 1983, pp. 314-315, 467, 523.
47 DI UNA PUBBLICA ADUNANZA 1880, p. 24.
48 Ivi, p. 15.
49 ASFi, Carte Strozziane, V, 338, c. 412; SPINELLI 2022, p. 218; SPINELLI 2023, p. 53, nota 81.
50 Credo che le opere vadano riconosciute nei «due detti [quadri] di braccia 2 con rapporti su le cantonate, e nel mezzo tutti dorati, e fondo nero, entrovi Sante [aggiunto a penna rossa: sono del Botti]», conservati nell’aprile 1719 nella «Guardaroba Grande» del palazzo (ASFi, Carte Strozziane, V, 1431, ins. Inventario generale di tutto quello che si trova nel Palazzo di Firenze dell’Ill:mo et Ecc:mo Sig. Duca Lorenzo Francesco Strozzi principe di Forano, cc. 32-33). Non stupisca il fraintendimento dei soggetti, che infatti dieci anni dopo vengono interpretati in maniera più dubbiosa e censiti nella «Camera delle visite» (di nuovo con un cambio di colore nella gola delle cornici: cfr. supra, nota 31): «due quadri di braccia 2 in circa con rapporti sulle cantonate e nel mezzo dorati, con gole gialle, entrovi in uno una Femmina con vaso in mano, e nell’altro una figura con sciabola, e bilancia» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1435, ins. Inventario generale di tutte le masserizie, arredi e mobili di qualunque sorte esistenti nel Palazzo di Firenze, c. 64).
51 «Un detto [quadro] rappresentante due Donne una nuda, e l’altra in atto di vuotar acqua sopra una spada infuocata della scuola del Forino: 4.2», «un detto [quadro] rappresentante una Donna nuda con Tazza in mano della scuola del Forino: 4.2», entrambi conservati nel «Salotto parato di rosso ove pranzano l’inverno» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1434, fasc. Inventario e Stima fatta da me infrascritto Vittorio Sampieri dei quadri, e cornici, esistenti nel Palazzo dei Signori
Studi di Memofonte 34/2025
Grassi
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
soggetti ricordano immediatamente quelli a tema negromantico, replicati in più versioni, di opere sinora assegnate a Francesco, che dovranno esser restituite a Mannozzi financo nell’elaborazione iconografica, giacché, quando acquistava delle repliche, il senatore Lorenzo lo esplicitava nella voce del pagamento: nel luglio 1645, ad esempio, pagò quattro scudi «a Orazio Fidani pittore per pittura e tela d’un ritratto del Granduca in ottagono copia di Giusto»52 , derivato cioè da un originale di Suttermans. La precisione di Strozzi permette inoltre di chiudere una volta per tutte la questione della corretta interpretazione di quei soggetti: la Circe è davvero la maga omerica, e non una generica ‘sibilla’53; e nell’altro dipinto, talora creduto un’allegoria positiva della Temperanza54, le «fate» stanno dedicando le loro arti sulla lama, ancora in fase di forgiatura e priva dell’elsa, e non sulla bacchetta55, cosicché può essere accettato come titolo convenzionale quello di Streghe che conferiscono poteri a una spada56 . Accordare a Mannozzi l’invenzione delle tele negromantiche risolve inoltre non poche difficoltà che esse avevan riservato agli studiosi di Furini, al di là delle discordanze sulla piena accettazione al suo pennello della Circe di Palazzo Mansi a Lucca. Di esse infatti – di per sé degli hapax legomena nella produzione di Furini, ben pratico invece del mito antico e delle allegorie morali – non c’è traccia alcuna nella biografia scritta da Baldinucci (tantomeno in quella dell’allievo Domenico Peruzzi, che si interrompe piuttosto presto) né negli inventari seicenteschi delle collezioni dei Medici o di altre nobili famiglie fiorentine; ma, soprattutto, sono sostanzialmente incompatibili con la cronologia della vita di Furini. Se infatti è stato spesso e a ragione osservato che l’immaginazione della Circe si imparenta agli ‘stregozzi’ di Salvator Rosa, è però vero che il napoletano diede avvio a quel filone soltanto nell’ultima parte del suo soggiorno fiorentino, e precisamente verso il 1646, quando dipinse per Carlo De’ Rossi la sua prima Stregoneria (oggi alla National Gallery di Londra)57: una datazione approssimativa, che si basa su una menzione non necessariamente esatta ad annuum, offerta dallo stesso Rosa in una lettera all’amico Giovan Battista Ricciardi del 15 dicembre 1666, dove scrive che «sono hormai vent’anni ch’io lo feci»58. A ogni modo è chiaro che Furini, morendo nell’agosto del 1646 dopo un breve soggiorno a Roma nell’inverno precedente, non fece in tempo a sviluppare – forse, addirittura, nemmeno a conoscere – il filone appena inaugurato da Rosa. Poté invece farlo
fratelli Strozzi in ordine al chirografo de’ 24 aprile 1810, c.n.n., sotto i nn. 28 e 34). Su Sampieri, intendente e ‘restauratore’ presso la Galleria di Firenze tra Sette e Ottocento, si veda INCERPI 2014.
52 ASFi, Carte Strozziane, V, 338, c. 161.
53 La tela di Palazzo Mansi a Lucca – su cui si veda più avanti – è indicata come Sibilla da STANGHELLINI 1914, p. 44, seguito da MAFFEIS 2003(2004), p. 143; come Circe è invece intesa dubitativamente da TOESCA 1950, p. 20, quindi convintamente – fra gli altri – da CANTELLI 1983, p. 89, MOREL 2004, p. 316, COSI 2007(2008), p. 187, TCHEKHOFF 2020, pp. 14-16. Diversamente, DEL BRAVO 2005, p. 79, aveva ipotizzato che l’immagine, solo apparentemente una Circe, fosse un’allegoria della Bellezza caduca.
54 Così, circa la tela di Ponce su cui si veda più avanti, aveva ipotizzato J.L. Nissman, scheda n. 37, in FLORENTINE BAROQUE ART 1969, pp. 42-43, seguito da HELD–TAYLOR–CARDER 1984, pp. 118-119, COSI 2007(2008), pp. 183184, e, in parte, da DEL BRAVO 2005, p. 80.
55 Così BELLESI 1997, pp. 51-54, scheda n. 1, interpreta la tela già Bigongiari (su cui si veda più avanti).
56 Coniugando l’ipotesi di MOREL 2004, pp. 316-317, desunta dal rituale esoterico descritto nel De ceremoniis attribuito a Cornelio Agrippa, e quella di M. Gabriele, Francesco Furini (e bottega), Maghe temprano la spada di un cavaliere, in IN FABULA 2022, pp. 151-153, che ricorda la forgiatura di spade magiche nella letteratura cavalleresca dei secoli XV e XVI.
57 Londra, National Gallery, inv. NG6491.
58 Salvator Rosa, da Roma, a Giovan Battista Ricciardi, in Pisa, 15 dicembre 1666, cit. in ROSA/FESTA–BORRELLI 2003, pp. 356-357, scheda n. 335. Sul quadro di De’ Rossi, si veda VOLPI 2014, p. 476, scheda n. 157. Per affinità con questo dipinto, all’anno 1646 sono stati solitamente datati anche i versi dell’ode La strega, che Rosa avrebbe composto per esser messi in musica da Pietro Antonio Cesti; ma l’attribuzione al pittore di questo testo è piuttosto tarda e non documentata (cfr. REGEL–GRAF 2007, pp. 255-259). Come osservato da S. Ebert-Schifferer, scheda n. 42, in SALVATOR ROSA 2008, pp. 170-171, «sarà cauto non datare l’ode al 1646 e non cercarvi un parallelo cronologico con le rappresentazioni di incantesimi di Rosa»; similmente, FUMAGALLI 2007, p. 74, sottolineava la necessità di «rivedere con cautela» il consolidato riferimento al periodo fiorentino per la produzione negromantica di Rosa.
Studi di Memofonte 34/2025
Mannozzi, magari stimolato da alcuni amici in comune o committenti di Furini e Rosa, che in Firenze avevano dato vita alla cosiddetta Accademia dei Percossi: come ad esempio Francesco Cordini, collezionista e mercante che, con l’assenso dello stesso Rosa, non di rado faceva copiare opere del napoletano (talvolta con l’aggiunta di ritocchi per mano di qualche maestro) per meglio rivenderle59. Sembra ragionevole dunque che Mannozzi abbia elaborato i propri quadri sulla scia del favore incontrato dai temi negromantici sulla scena fiorentina tra la fine del quinto e il sesto decennio: periodo in cui si collocano i «quattro tondi […] entrovi stregonerie» dipinti da Rosa per il marchese Filippo Niccolini, oggi a Cleveland60, la Scena di stregoneria di Alessandro Rosi, forse appartenuta ai Ginori e attualmente in collezione Koelliker61, e l’«Incantesimo con diverse figure» eseguito da Rosa per Bartolomeo Corsini, ancora oggi nella raccolta fiorentina dei suoi discendenti, documentato al 165562
Stanti le misure riportate con esattezza nei documenti (corrispondenti a circa 128,40x100,65 cm), le Streghe che conferiscono poteri a una spada appartenute al senatore Strozzi sono da riconoscere senza difficoltà nel quadro attribuito a Furini oggi conservato nel Museo di Ponce in Portorico (128,70x100,60 cm; Fig. 17)63, mentre la versione acquistata da Piero Bigongiari e oggi a Pistoia ha misure lievemente differenti (133x99 cm; Fig. 18)64 e una qualità un poco inferiore, che induce a ritenerla una replica con intervento della bottega. La torsione della strega vista di spalle rielabora un’idea furiniana: ma non tanto la ninfa vista da tergo nell’Ila quanto piuttosto, ribaltandola, una delle Tre Grazie già presso don Lorenzo de’ Medici e oggi a San Pietroburgo65, a cui Mannozzi aveva guardato anche per una delle figlie del Loth per Leopoldo (Figg. 9-10).
L’identificazione della Circe già Strozzi (circa 127,40x99,21 cm, stando ai documenti) è invece più complicata, anche per il maggior numero di esemplari noti. Fra questi vanno subito esclusi una copia comparsa anche recentemente sul mercato (131x104 cm)66, forse un poco più tarda, e la celebre versione lucchese (Fig. 19), sia perché avente dimensioni incompatibili (146,5x106,5 cm) sia perché nel 1738 risulta censita tra i beni del granduca Gian Gastone de’ Medici67. Penso peraltro che, sebbene sia creduta un originale furiniano da buona parte della
59 Cfr. Salvator Rosa, da Roma, a Giovan Battista Ricciardi, in Pisa, del 10 marzo 1651, cit. in ROSA/FESTA–BORRELLI 2003, pp. 92-93, scheda n. 86.
60 Cleveland, Museum of Art, inv. 1977.37.1-4. Quanto alla datazione dei tondi, sicuramente eseguiti prima del 1657, anno in cui sono registrati nella raccolta di Niccolini (cfr. SPINELLI 2011, p. 97), VOLPI 2014, pp. 456-457, schede nn. 126-129, propende per una cronologia piuttosto precoce, sul 1642-1644 circa, mentre FABBRI 2010, passim, suggerisce che l’interesse negromantico di Rosa possa esser stato alimentato da esperienze e fatti di cronaca avvenuti in Toscana, in luoghi frequentati da lui e dai suoi committenti (Pisa, Volterra e soprattutto Camugliano, che Filippo Niccolini aveva ottenuto in feudo nel 1637) tra il 1646 e il 1647. Sul sito internet del Museo di Cleveland la datazione riportata è 1645-1649 circa.
61 Il dipinto è datato intorno alla metà del settimo decennio da BELLESI 1997, pp. 58-61, scheda n. 3; cfr. anche S. Bellesi, scheda n. 97, in SALVATOR ROSA 2008, p. 266.
62 FUMAGALLI 2007, pp. 74, 131, nota 194; S. Ebert-Schifferer, scheda n. 44, in SALVATOR ROSA 2008, p. 174; VOLPI 2014, p. 504, scheda n. 190.
63 Ponce, Museo de Arte, inv. 66.0598; sul dipinto, si veda supra, nota 54.
64 Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, inv. ISP_021398; sul dipinto, oltre a quanto segnalato supra nelle note 55 e 56, si veda anche BALDASSARI 2004, p. 130, scheda n. 25
65 San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, inv. 5560; sul dipinto, si veda R. Maffeis, scheda n. 17, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 184-187 (con bibliografia precedente).
66 Londra, Sotheby’s, 8 aprile 1981, lotto 46; Firenze, Pandolfini, 16 novembre 2022, lotto 34; ultimamente a Torino, presso Arcuti Fine Arts. CANTELLI 2010, p. 153, scheda n. 99b, ritiene questa Circe una «copia eseguita nella bottega di Furini con solo qualche parziale intervento del maestro».
67 Compare infatti in una lista di «robe per servizio del Casino da San Marco, quali sono di proprietà, e d’acquisto del Serenissimo Gran Duca Giovan Gastone», redatta il 15 luglio 1738, rinvenuta da LAURI 2023, pp. 130-131, 438, doc. IV, n. 91: «un simile alto braccia 2 ½ larbo braccia 1 5/6 dipintovi una femmina rappresentante Circe con panno bianco, e azzurro, che svolazza, che con la mano dritta tiene una tazza dorata, e con il braccio sinistro tiene un vaso dorato, che posa sopra una base di pietra, e in mano la verga, con libro, e un mortaro da una parte» (ASFi, Guardaroba medicea. Appendice, 22, Affari diversi, f. 297). Le misure sono compatibili con la tela di Palazzo
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
critica68, si tratti di una copia (come suggerisce l’espediente invero sbrigativo di ampliare il fondo neutro verso l’altro, evidentemente per andare incontro alle esigenze di formato del committente) eseguita da un pittore dotato, ma non necessariamente appartenente all’entourage di Furini e Mannozzi. La cifra più sincera appare il panneggio azzurro, il cui accartocciamento insistito, ora soffice e ora croccante, mi sembra spingere in direzione di Alessandro Rosi, che potrebbe aver copiato un originale di Mannozzi dopo il 1660, in accordo con i comuni e già rammentati interessi per il filone negromantico.
A questo punto, le versioni più autentiche della Circe paiono essere quella delle Gallerie Fiorentine (131x99,3 cm; Fig. 20), essa pure appartenuta a Gian Gastone69 ma bisognosa di un restauro che la liberi dalle vernici ingiallite, e quella del Musée des Vosges a Épinal (131x102,5 cm; Fig. 21)70, purtroppo drasticamente impoverita da incaute ripuliture. Al netto della cautela richiesta dalle condizioni conservative, è tuttavia possibile che siano entrambe autografe di Mannozzi, seppur licenziate a diverse altezze cronologiche. La prima sembra risalire alla fine degli anni Quaranta, in quanto la fattura appuntita delle dita e il trattamento come disegnato della fisionomia – rielaborata su quella della Poesia nel lunettone furiniano con Lorenzo il Magnifico fra i poeti e i filosofi dell’Accademia di Careggi nel Salone di Palazzo Pitti – nonché i solchi ritmici e lineari del lembo chiaro sulla coscia, come onde increspate, trovano consonanze con dipinti della prima fase quali l’Ila e l’Olimpia. La versione di Épinal, maggiormente sfumata, dovrebbe invece datarsi alla metà degli anni Cinquanta, cioè al tempo della più immersiva mìmesi furiniana, giacché il volto patetico, con l’apertura esasperata della bocca, e gli occhi velati d’umido ricordano davvero da vicino l’Agar del 1653.
Se le misure non perfettamente coincidenti non consentono di concludere che la Circe di Épinal sia quella Strozzi, ciò che più importa ai fini del nostro ragionamento è che la formulazione iconografica del prototipo spetti a Mannozzi. È pur vero che, a monte della composizione, sta l’Andromeda di Furini (Fig. 22)71, da cui la Circe riprende la postura dell’anatomia giunonica, la conformazione dei seni e dell’ombelico sottolineati dal chiaroscuro, la posa del braccio sinistro; ma, come al solito, Vincenzo dovette servirsene a guisa di canovaccio su cui apporre modifiche di propria invenzione, come si evince dall’esame dei disegni. A suffragio della presunta paternità furiniana, alla composizione della Circe erano stati accostati alcuni fogli autografi di Francesco (GDSU, nn. 1144 F, 1146 F e 9714 F)72, per i quali invece sarà opportuno mantenere l’annotazione ottocentesca, condivisa da Elena Toesca e inizialmente anche da Cantelli, che li voleva preparatori per una Artemisia73 , o forse una Sofonisba: dipinto a oggi non pervenutoci, ma di cui rimane traccia in una copia mediocre e probabilmente ridotta
Mansi a Lucca (inv. 73), giunta in quella sede entro l’agosto del 1853 dalle raccolte granducali fiorentine (cfr. PELLEGRINI 2021, pp. 18-23)
68 Ma non da tutta: già MAFFEIS 2003(2004), pp. 143-144, aveva rifiutato l’autografia furiniana, messa in dubbio pure da STANGHELLINI 1914, p. 44.
69 Firenze, Archivio Storico delle Gallerie Fiorentine, inv. 1890, n. 8035. Un dipinto «alto braccia 2 1/3 largo braccia 1 ¾ dipintovi una Circe con il torso tutto nudo, e panno bianco, e turchino da basso, che nella destra tiene una tazza, e con la sinistra tiene la verga, e abbraccia un vaso dorato, quale posa sopra una base, e dall’altra un libro, ed altro senza adornamento», segnato a tergo con la sigla «GG» che compare sul retro della tela delle Gallerie Fiorentine, è registrato in una «nota di quadri […] di proprietà del Serenissimo Gran Duca Giovan Gastone Primo» inviati alla Villa dell’Ambrogiana dalla sorella Anna Maria Luisa de’ Medici (ASFi, Guardaroba medicea. Appendice, 22, Affari diversi, f. 376): cfr. LAURI 2023, pp. 90, 428, doc. IX, n. 428.
70 MAFFEIS 2003(2004), p. 143, ritiene questa versione l’unica veramente furiniana; diversamente, CANTELLI 2010, p. 153, scheda n. 99a (con le misure errate di 100x80 cm), non la ritiene del tutto autografa di Furini a causa dello stato di conservazione.
71 San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage, inv. 6715; cfr. R. Maffeis, scheda n. 25, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 202-205 (con bibliografia precedente).
72 MAFFEIS 2003(2004), p. 144; CANTELLI 2010, p. 153, schede nn. 99a-99b.
73 Così TOESCA 1950, p. 20, e G. Cantelli, schede nn. 39-42, in DISEGNI DI FRANCESCO FURINI 1972, pp. 42-43.
nel formato, passata sul mercato qualche tempo fa (Figg. 23-25)74. A ben guardare, in effetti, l’ambientazione lussuosa, sottolineata dal cuscino ai piedi della donna nel disegno 1146 F, e lo sguardo dolente, pateticamente rivolto verso l’alto, tanto nel foglio 1144 F quanto nella copia pittorica, nulla spartiscono con lo scenario lugubre e con l’aria maliziosa della strega omerica. È piuttosto da credere che il perduto dipinto di Furini sia servito a Vincenzo da spunto per elaborare la propria immagine, e riflettere sulla posa del braccio e della mano destra che sostiene la tazza: tale dettaglio è infatti studiato nel verso del foglio 7139 F75, che reca la scritta seicentesca «Mannozzi» al pari di altri fogli autografi. Qui, i volumi del polso e dell’avambraccio appaiono ancora sottili e affusolati, per poi divenire nelle versioni pittoriche, anche per via della differente angolatura dell’arto, un poco più grandi; ma – come in tutte le redazioni della Circe – la mano mostra una scalatura delle dita inversa rispetto a quella messa a punto da Furini nel 9704 F (Figg. 26-28). Lo svolazzo frastagliato sulla sinistra, invece, trova corrispondenze eloquenti in certi disegni in cui Vincenzo si sofferma con minuzia sulle molteplici ‘ammaccature’ dei panni: si veda, in particolare, l’effetto di uno studio dell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma76, che mi permetto di ruotare di 90° (Figg. 29-30).
Su tale sostrato furiniano, infine, Mannozzi applicò alcuni lemmi propri del repertorio scabro di Salvator Rosa, quali i rampicanti selvaggi dietro le Streghe e, nella Circe, il libro stracciato con le pagine stropicciate o gli elementi architettonici sbreccati, come la base su cui poggia il vaso e la lesena scanalata e rudentata sullo sfondo. Un simile gusto per le rovine, raro in Furini, nutre invece molte idee mannozziane: lo troviamo ad esempio nel disegno con Il Tempo che scopre la Verità (GDSU, n. 1196 F; Fig. 31), dove sullo sfondo son rilievi a carattere bacchico77, nella Verità di Cerreto Guidi e negli studi a essa preparatori (Fig. 32), e – mancando all’appello le quattro tele dipinte per Leopoldo de’ Medici – nei fogli propedeutici, come il già rammentato n. 1185 F per il Loth (Fig. 33) e il n. 1195 F (Fig. 34)78 da mettere in probabile relazione col «S. Bastiano nudo legato all’albero, rappresentato moribondo, figura intera con panno azzurro e paonazzo che copre le parti virili, con armatura da una parte, e da lontano si vedono edifizij, e rovine»79. Per la posa arcuata del San Sebastiano – la cui anatomia superiore è indagata più dettagliatamente nel 7138 F80 – Mannozzi trasse ispirazione, come di consueto, da un’opera di Furini, e precisamente dal Martirio di una santa della National Gallery of Ireland di Dublino (Fig. 35)81 .
Altri dipinti
La composizione licenziata a Leopoldo fu probabilmente riproposta da Mannozzi in un dipinto per il suo maestro di camera: ancora dai documenti rinvenuti da Spinelli, infatti, apprendiamo che tra il novembre e il dicembre 1656 il senatore Lorenzo Strozzi ebbe un Martirio di san Sebastiano di piccolo formato (1.1.4 braccia x 17.4 soldi, ovvero circa 62,25x50,44 cm) assieme a
74 Sotheby’s, Londra, 19 aprile 2005, lotto 203.
75 Matita rossa su carta, 260x300 mm; il foglio proviene dalla raccolta di Bassetti Cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 80-81.
76 Fondo Corsini, inv. D-FC124958; matita rossa su carta, 305x200 mm.
77 Matita rossa su carta, 184x180 mm; cfr. GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI 1991-2005, II (2005), pp. 107-108, n. 1196 F.
78 Matita rossa su carta, 240x189 mm; cfr. GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI 1991-2005, II (2005), p. 107, n. 1195 F. Già E. Borea, Vincenzo Mannozzi, in LA QUADRERIA 1977, p. 51, aveva avvicinato questo foglio (e il n. 7138 F) al San Sebastiano appartenuto a Leopoldo.
79 ASFi, Guardaroba medicea 826, Inventario dei mobili e masserizie dell’Eredità del Serenissimo e Reverendissimo Cardinale Leopoldo de’ Medici, c. 78r, n. 387.
80 Matita rossa su carta, 252x400 mm; proveniente dalla collezione di Bassetti. Cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 80-81.
81 Inv. NGI.1716; olio su tela, 41,5x34,5 cm; si tratta probabilmente di un’operina appartenuta alla famiglia Vitelli. Cfr. CANTELLI 2010, p. 118, scheda n. 38.
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
un più grande «San Giovanni nudo nel diserto alto braccia 2.11, largo braccia 2.18» (corrispondenti a circa 148,80x169,10 cm)82
Le misure più contenute del primo dipinto si spiegano forse con la sua destinazione alla villa di Colombaia, dove è registrato nel 1671, alla morte dello Strozzi83, e poi ancora alla metà del Settecento84 L’altro dipinto veniva invece censito nel 1671 nel palazzo fiorentino85, dove risultava ancora nel 172986; se non è certo che sia stato trasferito per qualche tempo nella villa di Bagnolo, presso Montemurlo, dove forse è ricordato nel 1742 assieme a un San Girolamo nel deserto87, nel 1810 il «quadro rappresentante S. Giovanni» era sicuramente di nuovo a Firenze e veniva giudicato da Vittorio Sampieri come della «scuola del Forino», al pari della Circe e delle Streghe che conferiscono poteri a una spada, ma con una maggiore valutazione economica88. In palazzo fu visto ancora nel 1842 da Federigo Fantozzi, che lo attribuiva con certezza a Furini89 Il persistente riferimento furiniano, la notazione che il Battista fosse «nudo» e «con l’agnello» e infine il rapporto fra altezza e larghezza della tela spingono a riconoscere l’opera pagata a Mannozzi nel 1656 nel bel San Giovanni Battista nel deserto di collezione privata (Fig. 36), reso noto – purtroppo senza poterne indicare le misure esatte ma segnalandone comunque il «formato grande» – da Giuseppe Cantelli, che lo attribuiva a Furini90. La composizione si ispira effettivamente a un’idea furiniana, testimoniata dal foglio 9705 F recto degli Uffizi, indubitabilmente autografo, dove sono delicatamente studiate a matita rossa e nera le gambe di una figura sdraiata, che, negli schizzi vergati nella parte superiore, s’intende essere una Maddalena in meditazione (Fig. 37)91. Da questa immagine deriva il foglio 9699 F, a matita nera e biacca su carta preparata azzurra, in cui il personaggio – qui maschile – è colto nel gesto di abbracciare quello che, nella trasposizione pittorica, sarà l’agnello (Fig. 38): creduto anch’esso di Furini92, mi chiedo invece se, in virtù del tratto più spesso, non sia una rielaborazione di Mannozzi propedeutica al quadro Strozzi. La tela, del resto, mostra una condotta larga e generosa, assai diversa dalla stesura per velature di Francesco e prossima invece a quella dell’Agar Bigongiari, con la quale si imparenta pure per l’accentuazione patetica delle palpebre inclinate e della bocca semiaperta, trasfigurata in una silhouette; anche le ammaccature della cascata del
82 ASFi, Carte Strozziane, V, 338, c. 449; SPINELLI 2022, p. 218.
83 «un quadro alto un braccio e ½ e largo braccia 1 1/8 con adornamento tutto intagliato, e dorato, entrovi un San Bastiano [con la cornice misurava dunque 87,54x65,65 cm circa]» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1430, fasc. N° 14. Inventario delle Masserizie della Villa di Colombaia, e di Firenze, autentico del 1671, c. 172).
84 «un quadro alto braccia 1 1/3 incirca, e largo braccia 1 ¼ con adornamento tutto intagliato, e dorato, entrovi S. Bastiano frecciato» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1433, Inventario fatto alla morte di S.E. il Sig. Principe di Forano D. Lorenzo Francesco Strozzi 18 gennaio 1742, c. 119v).
85 «un quadro alto braccia 2 ½ e lungo braccia 3 con adornamento intagliato, e dorato, con fondo nero, entrovi un S. Giovanni nel deserto» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1430, fasc. N° 14. Inventario delle Masserizie della Villa di Colombaia, e di Firenze, autentico del 1671, c. 188v).
86 «un quadro lungo braccia 3 in circa con ornamento nero e intagli dorati, e rapporti simili, entrovi S. Giovanni con l’Agnello» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1435, ins. Inventario generale di tutte le masserizie, arredi e mobili di qualunque sorte esistenti nel Palazzo di Firenze, c. 71).
87 «un quadro grande lungo braccia 3 in circa, e alto braccia 2 con l’effigie di S. Girolamo nel deserto, e con adornamento nero, filettato, e rabescato d’oro. Un quadro simile con l’effigie di S. Giovanni Battista nel deserto» (ASFi, Carte Strozziane, V, 1433, Inventario fatto alla morte di S.E. il Sig. Principe di Forano D. Lorenzo Francesco Strozzi 18 gennaio 1742, c. 207r).
88 ASFi, Carte Strozziane, V, 1434, fasc. Inventario e Stima fatta da me infrascritto Vittorio Sampieri dei quadri, e cornici, esistenti nel Palazzo dei Signori fratelli Strozzi in ordine al chirografo de’ 24 aprile 1810, sotto il n. 106, nello «Scrittoio».
89 «II Stanza. S. Giovanni nel deserto, del Furino» (FANTOZZI 1842, p. 579).
90 CANTELLI 1983, p. 89 e tav. 452; CANTELLI 2010, p. 142, scheda n. 82; cfr. anche MONBEIG GOGUEL 2007, p. 69. Del dipinto esiste una replica (174x210 cm), anch’essa attribuita a Furini e già sul mercato antiquario russo (cfr. MARKOVA 2004, pp. 53-54), quindi presso Napoleon’s Fine Art, West Palm Beach, 3 marzo 2020, lotto 111, di qualità un poco inferiore.
91 G. Cantelli, scheda n. 36, in DISEGNI DI FRANCESCO FURINI 1972, p. 40.
92 G. Cantelli, scheda n. 35, ibidem; MONBEIG GOGUEL 2007, p. 69.
panno rivelano numerose assonanze con dettagli omologhi studiati in grafica da Vincenzo, ad esempio i fogli 9688 F e 9689 F degli Uffizi (Figg. 39-40).
I disegni mannozziani conservati a Firenze meriterebbero un’analisi dettagliata, da condurre in un contributo apposito; qui ci limitiamo a segnalare qualche prima osservazione. Tra gli studi di panneggio, il foglio 7140 F93 risulta propedeutico al tendaggio scostato dell’Olimpia (Figg. 41-42), mentre il 7144 F recto94 va forse collegato alla porzione di camicia bianca sul seno della Menzogna nella Verità di Cerreto Guidi. Sul verso di questo foglio compare inoltre, con un tratto quasi impercettibile, un fondale architettonico scorciato, a guisa di esedra scandita da lesene e nicchie, con una terrazza superiore schermata da balaustra e, a sinistra, una colonna su cui è avvolto un tendaggio: un impaginato non troppo distante da quello sullo sfondo di una Betsabea al bagno (Fig. 43), già riferita a Furini da Cantelli95. La fattura svelta e in qualche luogo abbreviata, da bozzetto, trova a mio avviso un confronto eloquente con quella del modelletto della Verità in collezione Pratesi (Fig. 44)96
Interessanti sono anche gli studi per due mani giunte a dita intrecciate, che Mannozzi indagò nel foglio 7145 F (Fig. 45)97 e sul verso del 7306 F (Fig. 46)98, prima della definitiva messa a punto sul recto del 7307 F (Fig. 47)99: la leziosa soluzione del mignolino levato all’insù non lascia dubbi sul fatto che siano propedeutici alla mimica di una dolente Ghismonda, oggi nei Depositi delle Gallerie degli Uffizi (Fig. 48)100, replicata pure in formato ovale e con un’espressione più risentita in una tela passata recentemente sul mercato (Fig. 49) con la corretta attribuzione a Vincenzo Mannozzi101. Dalla stessa composizione deriva anche una piccola Maddalena su rame (Fig. 50)102, vicina, nel tono maggiormente caricato, ai modi di Sebastiano Mazzoni (come del resto la già rammentata Betsabea). Procedendo su questa strada, dall’esame dei disegni potranno emergere ulteriori precisazioni e riconoscimenti. È il caso, ad esempio, del verso del foglio 7142 F (Fig. 51)103 , dov’è indagato il panneggio sulle gambe piegate di una figura adagiata a terra, con la doppia ripresa di un particolare. Si tratta a mio avviso dello studio per la veste azzurra della Maddalena già in collezione Pratesi e attualmente presso Conti Caponi, attribuita da Cantelli a Furini (Fig. 52)104. Il disegno anatomico delle mani e dei piedi, caratterizzati da lunghe falangi, la stesura ricca e compatta delle campiture del carnato e del mantello e quella invece sciolta e briosa che definisce la superficie scabra del teschio rivelano influssi assai diversi, ben oltre Furini, come Volterrano, Salvator Rosa e Giovan Battista Vanni.
93 Matita rossa su carta, 150x270 mm; proveniente dalla raccolta di Bassetti. Cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 81-80.
94 Matita rossa su carta, 285x205 mm; anch’esso appartenuto a Bassetti. Cfr. ibidem
95 CANTELLI 2009, I, p. 113, e ivi, II, tav. XXXVIII; CANTELLI 2010, pp. 151-152, scheda n. 96.
96 Reso noto da R. Spinelli, scheda n. 31, in PITTURE FIORENTINE 1987, pp. 91-94; cfr. anche SPINELLI 2023, p. 27.
97 Matita rossa su carta, 250x185 mm; proveniente dalla raccolta di Bassetti. Cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 81-80.
98 Matita rossa su carta, 195x250 mm; anch’esso appartenuto a Bassetti. Cfr. ibidem
99 Matita rossa su carta, 200x265 mm; sul verso è uno studio per il piede destro della Verità di Cerreto Guidi. Anche questo foglio proviene dalla collezione Bassetti Cfr. ibidem
100 Inv. 1890, n. 6953; olio su tela, 69x55,6 cm.
101 Già Vercelli, Meeting Art, 22 maggio 2022, lotto 458.
102 Firenze, Palazzo del Capitolo Metropolitano Fiorentino, Archivio, sala della Biblioteca; olio su rame, 13x11 cm; attribuzione a Mannozzi formulata correttamente da M. Palmeri nella scheda OA 0900746316 (2011) (https://dati.beniculturali.it/lodview-arco/resource/HistoricOrArtisticProperty/0900746316.html <3 giugno 2025>).
103 Matita rossa, 408x257 mm; sul recto compare uno studio per una figura anziana (forse il Tempo della composizione indagata nel foglio 1196 F), pubblicato da S. Mascalchi, scheda n. 2.219, in IL SEICENTO FIORENTINO 1986, vol. Disegno, pp. 258-259; anche SPINELLI 2023, p. 54, nota 89.
104 Olio su tela, 157x164,5 cm; cfr. CANTELLI 2010, p. 138, scheda n. 71.
Studi di Memofonte 34/2025
Grassi
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique
suum
Conclusioni (provvisorie) e nuove prospettive
Molto altro resta da chiarire e molti quadri sono ancora da ritrovare, ma la direzione sembra tracciata. Quando i risarcimenti alla fase matura di Mannozzi saranno in numero sufficiente da poter riconoscere con maggior sicurezza la sua mano nel mare magnum delle opere più o meno furiniane, si potrà infine azzardare qualche attribuzione ancorché non suffragata da disegni o da documenti. A titolo esemplificativo, un’ipotesi di lavoro percorribile può essere la singolare Assunzione della Vergine in Santa Maria Assunta a Santomato (Fig. 53), già attribuita a Furini105 per osmosi dall’Agar Bigongiari, di cui riprende la fisionomia insistita, gli occhi dalle palpebre pesanti, il ghigno della bocca quasi da maschera tragica. Sarà da tentare altresì qualche identificazione nel campo della ritrattistica, cui Vincenzo dovette dedicarsi almeno saltuariamente a giudicare dall’intenso Ritratto di giovinetto vergato su un foglio già in collezione Bassetti (Fig. 54)106, che, nella sodezza regolare dell’ovale, pare tradire qualche debito verso le morfologie care ai fratelli Cesare e Vincenzo Dandini.
Quanto a Furini, lo sfoltimento del suo catalogo per come è stato costruito sino a oggi non rappresenta certo un depotenziamento bensì un notevole incremento nella direzione di una più intellegibile coerenza stilistica. Inoltre, adesso che dal suo corpus son tolte alcune immagini di nudità conturbante – giacché l’Agar Bigongiari offre apertamente il petto, a differenza della Maddalena Pucci che comprime i seni tra le braccia; e la discinta Circe fissa lo spettatore in sfida, mentre Andromeda china lo sguardo mesta e un poco vergognosa –, si riduce alquanto l’appropriatezza del continuo riferimento, di taluni critici, alla categoria di un erotismo ambiguo e quasi ossessivo, per un pittore che era anche sacerdote. A una doverosa rilettura da parte degli specialisti, ormai inevitabile, speriamo di aver contribuito con queste pagine.
105 L’attribuzione a Furini, avanzata da CONTINI 1986, p. 66, e ribadita dallo stesso nella scheda n. 1.137, in IL SEICENTO FIORENTINO 1986, vol. Pittura, p. 279, è stata rifiutata da CANTELLI 2010, pp. 136-137, scheda n. 68, secondo il quale l’opera sarebbe il prodotto «di uno dei mestieranti della bottega del Furini, forse il Pogni, che continuarono a lungo, dopo la morte del maestro, a dipingere opere di sua imitazione». Come ha suggerito DEL BRAVO 2005, pp. 83, 88-89, nota 70 (seguito da MAFFEIS 2007, p. 31), la mimica a braccia aperte e lo sguardo rivolto in alto della Vergine caratterizzano tipologicamente il soggetto come una Assunzione, più che come una Immacolata Concezione (in cui solitamente Maria si presenta a capo chino e in atteggiamento raccolto): se pure è vero che ai suoi piedi è lo spicchio di luna (consueto attributo dell’Immacolata), esso va considerato in rapporto al contesto aurorale originato dal sole nascente all’orizzonte. La combinazione di tali elementi celesti traduce, a mio avviso, il versetto 6,9 del Cantico dei Cantici («Quae est ista, quae ascendit sicut aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol…»), adoperato come antifona nelle ore liturgiche della solennità dell’Assunzione. È possibile pertanto che la tela sia stata dipinta appositamente per l’altare maggiore della vecchia pieve di Santa Maria Assunta di Santomato, che sorgeva non lontano dall’attuale chiesa (questa, che ha ripreso la dedicazione dell’altra, afferiva all’antico monastero di San Tommaso). Poco dopo la metà del XVII secolo l’edificio fu interessato da alcuni lavori di ristrutturazione, che risultano non del tutto terminati nel 1673: se prima del 1582 all’altare maggiore stava una «tabula cum crucifixo», nel Settecento vi era una «tavola in tela con l’immagine della Santissima Vergine Assunta» (PAGNINI 2013, pp. 98-100), ragionevolmente l’opera in esame, che Mannozzi potrebbe aver dipinto poco prima di morire nel 1658.
106 GDSU, n. 1199 F; già in collezione Bassetti. Cfr. PETRIOLI TOFANI 2020b, pp. 80-81.
Fig. 1: Vincenzo Mannozzi, Ila col vaso Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, Depositi
Fig. 2: Vincenzo Mannozzi, Orlando che libera Isabella dalla grotta dei malandrini. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, Galleria Palatina e Appartamenti Reali, Depositi
Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco
Fig. 3: Da Vincenzo Mannozzi, Olimpia abbandonata da Bireno. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi
Fig. 4: Vincenzo Mannozzi, La Verità scopre la Menzogna. Cerreto Guidi (FI), Museo della Caccia e del Territorio
Fig. 5: Vincenzo Mannozzi, Agar e l’angelo. Collezione Intesa San PaoloPistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, in comodato
Fig. 6: Vincenzo Mannozzi, Studio per una Maddalena. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Alessandro Grassi
Furini e Vincenzo Mannozzi:
Fig. 7: Vincenzo Mannozzi, Studi per il braccio destro e il piede destro di una Maddalena. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 8: Vincenzo Mannozzi, Studio per il braccio sinistro di una Maddalena Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Francesco
cuique suum
9: Vincenzo Mannozzi, Studio per una figlia di Loth. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
10: Vincenzo Mannozzi, Studio per il braccio di una figlia di Loth. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig.
Fig.
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 11: Vincenzo Mannozzi, Maddalena nel deserto. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Alessandro Grassi
Fig. 12: Vincenzo Mannozzi, Maddalena. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
13: Vincenzo Mannozzi, Agar e l’angelo (particolare). Collezione Intesa San Paolo - Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, in comodato
Fig. 14: Vincenzo Mannozzi, Studio di gambe inginocchiate e panneggiate. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Studi di Memofonte 34/2025
Fig.
Fig. 15: Vincenzo Mannozzi, Agar e l’angelo (particolare). Collezione Intesa San PaoloPistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, in comodato
Fig. 16: Vincenzo Mannozzi, Studio di gambe panneggiate (particolare). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 17: Vincenzo Mannozzi, Streghe che conferiscono poteri a una spada. Ponce, Museo de Arte
Fig. 18: Vincenzo Mannozzi e bottega, Streghe che conferiscono poteri a una spada Collezione Intesa San Paolo - Pistoia, Antico Palazzo dei Vescovi, in comodato
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco
Studi di Memofonte 34/2025
Alessandro Grassi
Fig. 19: Alessandro Rosi (?) da Vincenzo Mannozzi, Circe. Lucca, Museo di Palazzo Mansi
Fig. 20: Vincenzo Mannozzi, Circe. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Archivio Storico
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 21: Vincenzo Mannozzi, Circe. Épinal, Musée des Vosges
Fig. 22: Francesco Furini, Andromeda. San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage
23: Francesco Furini, Artemisia (o Sofonisba). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig.
Fig. 24: Francesco Furini, Artemisia (o Sofonisba). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 25: Anonimo da Francesco Furini, Artemisia (o Sofonisba). Mercato antiquario
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 26: Francesco Furini, Studi delle mani di Artemisia (o Sofonisba). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
28: Vincenzo Mannozzi, Circe (particolare). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Archivio Storico
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 27: Vincenzo Mannozzi, Studio della mano destra di Circe. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig.
Alessandro Grassi
Fig. 29: Vincenzo Mannozzi, Circe (particolare). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Archivio Storico
Fig. 30: Vincenzo Mannozzi, Studio di panneggio. Roma, Istituto Nazionale per la Grafica
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 31: Vincenzo Mannozzi, Il Tempo che scopre la Verità. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Alessandro Grassi
Fig. 32: Vincenzo Mannozzi, La Verità scopre la Menzogna. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 33: Vincenzo Mannozzi, Loth e le figlie. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 34: Vincenzo Mannozzi, Martirio di san Sebastiano. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 35: Francesco Furini, Martirio di una santa. Dublino, National Gallery of Ireland
Alessandro Grassi
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 36: Vincenzo Mannozzi, San Giovanni Battista nel deserto. Collezione privata
Fig. 37: Francesco Furini, Studi di gambe distese. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 40: Vincenzo Mannozzi, Studio di panneggio. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 38: Vincenzo Mannozzi, Studio per san Giovanni Battista. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 39: Vincenzo Mannozzi, San Giovanni Battista nel deserto (particolare). Collezione privata
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 41: Vincenzo Mannozzi, Studi di panneggio. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 42: Vincenzo Mannozzi, Olimpia abbandonata da Bireno (particolare). Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi
Alessandro Grassi
Fig. 43: Vincenzo Mannozzi, Betsabea al bagno. Collezione privata
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 44: Vincenzo Mannozzi, La Verità scopre la Menzogna. Collezione Pratesi
Fig. 47: Vincenzo Mannozzi, Studio di mani giunte e di tre piedi. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 45: Vincenzo Mannozzi, Studio di mani giunte. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 46: Vincenzo Mannozzi, Studio di mani giunte e di un ginocchio panneggiato. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
Fig. 48: Vincenzo Mannozzi, Ghismonda. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Depositi
Fig. 49: Vincenzo Mannozzi, Ghismonda. Mercato antiquario
Fig. 50: Vincenzo Mannozzi, Maddalena. Ubicazione ignota
Alessandro Grassi
Fig. 51: Vincenzo Mannozzi, Studio di gambe panneggiate. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
Fig. 52: Vincenzo Mannozzi, Maddalena. Firenze, Galleria Conti Caponi
Vincenzo
Studi di Memofonte 34/2025
Francesco Furini e
Mannozzi: cuique suum
Fig. 53: Vincenzo Mannozzi (?), Assunzione della Vergine. Santomato (PT), Santa Maria Assunta
Fig. 54: Vincenzo Mannozzi, Ritratto di giovinetto. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe
BIBLIOGRAFIA
BALDASSARI 2004
F. BALDASSARI, La collezione Piero ed Elena Bigongiari. Il Seicento fiorentino tra “favola” e dramma, Milano 2004.
BALDASSARI 2009
F. BALDASSARI, La pittura del Seicento a Firenze. Indice degli artisti e delle loro opere, [Milano] 2009.
BALDINUCCI/RANALLI–BAROCCHI 1974-1975
F. BALDINUCCI, Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua […] (1681-1728), con nuove annotazioni e supplementi per cura di F. RANALLI (1845-1847), Appendice con nota critica e supplementi per cura di P. BAROCCHI, I-VII, Firenze 1974-1975.
BELLESI 1997
S. BELLESI, Diavolerie, magie e incantesimi nella pittura barocca fiorentina, introduzione di F. Cracolici, Firenze 1997.
BELLESI 2007
S.BELLESI, Mannozzi Vincenzo, voce in Dizionario Biografico degli Italiani, LXIX, Roma 2007, pp. 126-129.
BELLESI 2009
S. BELLESI, Catalogo dei pittori fiorentini del ’600 e ’700. Biografie e opere, I-III, Firenze 2009.
BIGONGIARI 1974
P. BIGONGIARI, L’«eccedente bellezza» in un’opera inedita del Furini, in P. Bigongiari, Il caso e il caos, I. Il Seicento fiorentino tra Galileo e il «recitar cantando», Milano 1974, pp. 54-63 (edizione originale in «Arte Illustrata», IV, 45-46, 1971, pp. 35-41).
“BIZZARRO E CAPRICCIOSO UMORE” 2023
“Bizzarro e capriccioso umore”. Giovanni da San Giovanni pittore senza regola alla corte medicea, catalogo della mostra, a cura di S. Benassai, C. Gnoni Mavarelli, V. Zucchi, Firenze 2023.
BOREA 1975
E. BOREA, Dipinti alla Petraia per don Lorenzo de’ Medici: Stefano della Bella, Vincenzo Mannozzi, il Volterrano, i Dandini e altri, «Prospettiva», 2, 1975, pp. 24-39.
CANTELLI 1974
G. CANTELLI, Per Simone Pignoni, «Antichità Viva», XIII, 2, 1974, pp. 18-31.
CANTELLI 1980
G. CANTELLI, Mitologia sacra e profana e le sue eroine nella pittura fiorentina della prima metà del Seicento (I), «Paradigma», 3, 1982, pp. 147-169.
CANTELLI 1983
G. CANTELLI, Repertorio della pittura fiorentina del Seicento, Fiesole 1983.
CANTELLI 2009
G. CANTELLI, Repertorio della pittura fiorentina del Seicento. Aggiornamento, I-II, Pontedera 2009.
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
CANTELLI 2010
G. CANTELLI, Francesco Furini e i furiniani, Pontedera 2010.
CIARDI–TONGIORGI TOMASI 1983
R.P. CIARDI, L. TONGIORGI TOMASI, Le pale della Crusca. Cultura e simbologia, Firenze 1983.
COLLEZIONISMO MEDICEO 2005
Collezionismo mediceo e storia artistica, II. Il cardinale Carlo, Maria Maddalena, Don Lorenzo, Ferdinando II, Vittoria della Rovere 1621-1666, a cura di P. Barocchi, G. Gaeta Bertelà, tt. 3, Firenze 2005
COLLEZIONISMO MEDICEO 2007
Collezionismo mediceo e storia artistica, III. Il cardinale Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo 1628-1667, a cura di P. Barocchi, G. Gaeta Bertelà, tt. 2, Firenze 2007.
CONTINI 1986
R. CONTINI, Apocrifi bilivertiani, e altro, «Paradigma», 7, 1986, pp. 53-69.
CONTINI 2007
R. CONTINI, «Paradiso di amene delizie»: Furini e gli altri, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 93-105.
COSI 2007(2008)
S. COSI, Proposte di interpretazione per Francesco Furini, «Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo. Annali», VIII, 2007(2008), pp. 179-207.
DEL BRAVO 2005
C. DEL BRAVO, Francesco Furini, prete e pittore, «Artista», XVII, 2005, pp. 76-89.
DISEGNI DI FRANCESCO FURINI 1972
Disegni di Francesco Furini e del suo ambiente, catalogo della mostra, a cura di G. Cantelli, Firenze 1972.
DI UNA PUBBLICA ADUNANZA 1880
Di una pubblica adunanza tenuta dagli Accademici della Crusca nel cortile del Palazzo Grande degli Strozzi in Firenze, a cura di G. Palagi, Firenze 1880.
FABBRI 2010
S. FABBRI, Inquisizione, esorcismi e caccia alle streghe a Pisa alla metà del Seicento. Genesi e collezionismo delle Stregonerie di Salvator Rosa, in Salvator Rosa e il suo tempo 1615-1673, atti del convegno internazionale di studi (Roma 12-13 gennaio 2009), a cura di S. Ebert-Schifferer, H. Langdon, C. Volpi, Roma 2010, pp. 159-168.
FANTOZZI 1842
F.FANTOZZI, Nuova guida ovvero descrizione storico-artistico-critica della città e contorni di Firenze, Firenze 1842.
FILETI MAZZA 2009
M. FILETI MAZZA, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Inventario generale delle stampe, II. Storia di una collezione dai libri di disegni e stampe di Leopoldo de’ Medici all’Età moderna, Firenze 2009.
FLORENCE AU GRAND SIÈCLE 2011
Florence au grand siècle entre peinture et littérature, catalogo della mostra, a cura di E. Fumagalli, M. Rossi, Cinisello Balsamo 2011.
FLORENTINE BAROQUE ART 1969
Florentine Baroque Art from American Collections, catalogo della mostra, a cura di J.L. Nissman, introduzione di H. Hibbard, New York 1969.
FOCARILE 2019
P. FOCARILE, Allestimenti di ritratti e narrative storico genealogiche nei palazzi fiorentini, ca. 1650-1750, prefazione di C.M. Sicca, Torino 2019 (disponibile on-line https://www.fondazione1563.it/pdf/CdSP_F1563_5.2_Focarile.pdf)
FORLANI TEMPESTI 2009
A. FORLANI TEMPESTI, Intorno al Furini: osservazioni sui disegni, «Paragone. Arte», LX, 715-717, 2009, pp. 67-78.
FUMAGALLI 2007
E. FUMAGALLI, Napoli a Firenze nel Seicento, in «Filosofico umore» e «maravigliosa speditezza». Pittura napoletana del Seicento dalle collezioni medicee, catalogo della mostra, a cura di E. Fumagalli, Firenze 2007, pp. 27-135.
FUMAGALLI 2013
E. FUMAGALLI, Dipinti e pittori tra Modena e Firenze negli anni di Francesco I, in Modena barocca. Opere e artisti alla corte di Francesco I d’Este (1629-1658), a cura di S. Casciu, S. Cavicchioli, E. Fumagalli, Firenze 2013, pp. 24-38.
GABINETTO DISEGNI E STAMPE DEGLI UFFIZI 1991-2005
Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Inventario. Disegni di figura, a cura di A. Petrioli Tofani, I-II, Firenze 1991-2005.
GREGORI 1974
M. GREGORI, A Cross-Section of Florentine Seicento Painting: The Piero Bigongiari Collection, «Apollo», C, 151, 1974, pp. 218-229.
GUERRIERI BORSOI 2004
M.B. GUERRIERI BORSOI, Gli Strozzi di Roma. Mecenati e collezionisti nel Sei e Settecento, Roma 2004.
GUERRIERI BORSOI 2004(2005)
M.B. GUERRIERI BORSOI, Il collezionismo di Giovan Battista Strozzi, marchese di Forano, a Firenze nel primo Seicento, «Bollettino d’Arte», LXXXIX, 130, 2004(2005), pp. 85-98.
HELD–TAYLOR–CARDER 1984
J.S. HELD, R. TAYLOR, J.N. CARDER, Museo de Arte de Ponce. Fundación Luis A. Ferré. Catalogue. Paintings and Sculpture of the European and American Schools, Ponce 1984.
IL SEICENTO FIORENTINO 1986
Il Seicento fiorentino. Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo III, catalogo della mostra, a cura di G. Guidi, D. Marcucci, I-III, Firenze [1986].
INCERPI 2014
G. INCERPI, Tommaso Puccini e Vittorio Sampieri. Nascita del “sistema” di conservazione dei dipinti nelle Gallerie fiorentine, in Tommaso Puccini nel bicentenario della morte 1811-2011, [Pistoia] [2014], pp. [63]-74.
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
IN FABULA 2022
In fabula. Capolavori restaurati della collezione Bigongiari, catalogo della mostra, a cura di M. Preti, A. Bertini, Pistoia 2022.
LA QUADRERIA 1977
La Quadreria di Don Lorenzo de’ Medici, catalogo della mostra, a cura di E. Borea, con la collaborazione di A.M. Petrioli Tofani per i disegni e le stampe e di K. Langedijk per i ritratti di Lorenzo de’ Medici, Firenze 1977.
L’ARME E GLI AMORI 2001
L’arme e gli amori. La poesia di Ariosto, Tasso e Guarini nell’arte fiorentina del Seicento, catalogo della mostra, a cura di E. Fumagalli, M. Rossi, R. Spinelli, Livorno 2001.
LAURI 2023
D. LAURI, Gian Gastone de’ Medici (1671-1737), ultimo Granduca: committenza, inclinazioni del gusto, relazioni artistiche, tesi di Dottorato in Storia dell’Arte, Università di Roma Sapienza, 2023.
LUCE E OMBRA 2005
Luce e ombra. Caravaggismo e naturalismo nella pittura toscana del Seicento, catalogo della mostra, a cura di P. Carofano, Pisa 2005.
MAFFEIS 2003(2004)
R. MAFFEIS, Le “pitture nere” di Francesco Furini, «Proporzioni», n.s., IV, 2003(2004), pp. 136-159.
MAFFEIS 2007
R.MAFFEIS, La Camera della Luna. Storia di Francesco Furini, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 21-63.
MANIKOWSKI 1991
A. MANIKOWSKI, Il ritratto di un Palazzo dall’interno: gli Strozzi nel Seicento, in Palazzo Strozzi metà millennio 1489-1989, atti del convegno di studi (Firenze 3-6 luglio 1989), a cura di D. Lamberini, Roma 1991, pp. 38-47.
MANIKOWSKI 2017
A. MANIKOWSKI, The Society of Elite Consumption. Lorenzo Strozzi’s Aristocratic Enterprise in Seventeenth-Century Tuscany, Varsavia 2017 (edizione originale Toskańskie przedsiębiorstwo arystokratyczne w XVII wieku. Społeczeństwo elitarnej konsumpcji, Varsavia 1991)
MARKOVA 2004
V. MARKOVA, Un capolavoro sconosciuto di Francesco Furini e un’altra aggiunta al suo catalogo, «Paragone. Arte», LV, 649, 2004, pp. 50-55.
MASCALCHI 1986
S. MASCALCHI, Vincenzo Mannozzi, in IL SEICENTO FIORENTINO 1986, vol. Biografie, pp. 111-112.
MONBEIG GOGUEL 2007
C. MONBEIG GOGUEL, Francesco Furini dans le prisme du dessin, in UN’ALTRA BELLEZZA 2007, pp. 65-91.
MOREL 2004
P. MOREL, La figure de la magicienne de l’Orlando furioso à l’art florentin entre Cinquecento et Seicento, in L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Florence, II. Dynasty, Court and
Imagery, atti del convegno internazionale (Firenze 27-29 giugno 2001), a cura di M. Rossi, F. Gioffredi Superbi, Firenze 2004, pp. 297-325.
PAGNINI 2013
M.C. PAGNINI, Atto Fabroni e il fratello Niccolò tra mecenatismo artistico e identità spirituale familiare. Note a margine, in Atto Fabroni e il Crocifisso di Sant’Ignazio. Storia, restauro e documenti, a cura di A. Agostini, M.C. Pagnini, Firenze 2013, pp. 85-100.
PELLEGRINI 2021
E. PELLEGRINI, Firenze altrove. Su un caso di restituzione tra “Ancien Régime” e Unità, in Arte e guerra. Storia dal Risorgimento all’età contemporanea, atti del convegno (Padova 3-5 febbraio 2020), a cura di C. Bajamonte, M. Nezzo, Padova 2021, pp. 17-28.
PETRIOLI TOFANI 1979
A. PETRIOLI TOFANI, [Recensione di] Ch. Thiem, Florentiner Zeichner des Frübarock […], «Prospettiva», 19, 1979, pp. 74-88.
PETRIOLI TOFANI 2020a
A. PETRIOLI TOFANI, Apollonio Bassetti collezionista di disegni, in Per Filippo Baldinucci. Storiografia e collezionismo a Firenze nel secondo Seicento, atti della giornata di studi (Firenze 16 gennaio 2020), a cura di E. Fumagalli, M. Rossi, E. Struhal, Firenze 2020, pp. 115-140.
PETRIOLI TOFANI 2020b
A. PETRIOLI TOFANI, La collezione di Apollonio Bassetti al Gabinetto Disegni degli Uffizi, «Imagines», 3, 2020, pp. 9-99 (disponibile on-line https://www.uffizi.it/magazine-imagines/imagines-3)
PITTURE FIORENTINE 1987
Pitture fiorentine del Seicento, catalogo della mostra, presentazione di G. Briganti, epilogo di G. Cantelli, Firenze 1987.
REGEL–GRAF 2007
W. REGEL, G. GRAF, Rosa und die Musik, in hoc gerühmt, fast vergessen, neu gesehen Der italienische Maler und Poet Salvator Rosa. Studien zur Neubewertung, a cura di W. Regel, H. Köhler, Würzburg 2007, pp. 223-267
RIFLESSI DI UNA GALLERIA 2001
Riflessi di una Galleria. Dipinti dell’Eredità Bardini, catalogo della mostra, a cura di M. Scalini, I. Taddei, Livorno 2001.
ROSA/FESTA–BORRELLI 2003
S. ROSA, Lettere, raccolte da L. FESTA, edizione a cura di G.G. BORRELLI, [Bologna] 2003.
SALVATOR ROSA 2008
Salvator Rosa tra mito e magia, catalogo della mostra, Napoli 2008.
SPINELLI 2001(2002)
R. SPINELLI, Di un disperso Martirio di Sant’Andrea di Fabrizio Boschi ritrovato (e nuovamente scomparso), «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XLV, 2001(2002), pp. [313]-318.
Francesco Furini e Vincenzo Mannozzi: cuique suum
SPINELLI 2011
R. SPINELLI, Documenti artistici dall’archivio Niccolini di Camugliano, II Pittura del Seicento e grande decorazione nel collezionismo e nel mecenatismo di Filippo di Giovanni (Firenze, 1586-1666), «Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato», LXXXIX, 78, 2011, pp. 71-112.
SPINELLI 2022
R. SPINELLI, Documenti artistici dalle ‘Carte strozziane’ nell’Archivio di Stato di Firenze, «Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato», C, 89, 2022, pp. 199-231.
SPINELLI 2023
R. SPINELLI, Vincenzo Mannozzi (Firenze 1600-1658): da Firenze al Museo storico della Caccia e del Territorio di Cerreto Guidi, in La Verità che scopre la Menzogna di Vincenzo Mannozzi da Palazzo Pitti a Cerreto Guidi, catalogo della mostra, a cura di R. Spinelli, Firenze 2023, pp. 21-54.
STANGHELLINI 1914
A. STANGHELLINI, Francesco Furini, pittore, Siena 1914.
TCHEKHOFF 2020
P. TCHEKHOFF, Magie amoureuse et sorcières tentatrices dans l’art italien moderne, in Perspectives de recherche III, a cura di M. Hochmann, numero monografico di «ArtItalies», 26, 2020, pp. 6-21.
TOESCA 1950
E. TOESCA, Francesco Furini, Roma 1950.
UN’ALTRA BELLEZZA 2007
Un’altra bellezza. Francesco Furini, catalogo della mostra, a cura di M. Gregori, R. Maffeis, Firenze 2007.
VOLPI 2014
C. VOLPI, Salvator Rosa (1615-1673) “pittore famoso”, Roma 2014.
ABSTRACT
Lo studio offre una rilettura del rapporto tra la fase matura di Francesco Furini e la produzione del poco noto Vincenzo Mannozzi, dopo la morte del primo nel 1646. Sulla base di riscontri documentari e con il supporto dei disegni autografi di Mannozzi, è possibile riconsiderare il corpus sinora accettato di Furini ed espungerne alcune opere, tanto significative quanto problematiche, come l’Agar e l’angelo già in collezione Bigongiari e le varie versioni della Circe, per restituirle a Mannozzi stesso. Se dunque da una parte il catalogo di Furini guadagna in coerenza interna, dall’altra si delinea un vero e proprio risarcimento a Mannozzi, il quale – anche in virtù della mìmesi furiniana, ma non solo – fu assai richiesto dal patriziato fiorentino del Seicento e da alcuni esponenti dei Medici.
The study offers a reconsideration of the relationship between Francesco Furini’s late period and the production of the little-known Vincenzo Mannozzi, after the former’s death in 1646. On the basis of documentary evidence and Mannozzi’s autograph drawings, it is possible to reexamine Furini’s hitherto accepted corpus and to exclude some works, so significant as they are troubling, such as the Agar and the Angel, formerly in the Bigongiari collection, and the various versions of Circe, in order to return them to Mannozzi himself. Thus, if on the one hand Furini’s catalogue gains in internal coherence, on the other hand a proper restoration is set up for Mannozzi, who also because of the imitation of Furini’s style, but not only was highly appreciated by the seventeenth-century Florentine patriciate and by some members of the Medici family.
« DES PASTELS QUI FONT PRESQUE LE MEME EFFET QUE LA PEINTURE… ».
DESSINER, OU PEINDRE AU PASTEL ?
LES FRONTIÈRES D’UNE PRATIQUE EN FRANCE AU XVIIIE SIÈCLE
Dans un contexte de rivalité entre la peinture et le dessin pour établir la hiérarchie entre les deux, ce dernier était perçu au fil des siècles de différentes manières : un outil d’aide à la définition d’une pensée en évolution, une expression du génie de l’artiste, ou encore le fondement de l’art même1, comme en témoigne par exemple la subdivision, en cinq catégories, opérée par Antoine-Joseph Dezailler d’Argenville (pensées, desseins arrêtés, études, académies, cartons)2. Si cet antagonisme se présente sous différentes formes – la plus célèbre étant la querelle du dessin et du coloris3 –, l’appréciation pour le dessin en soi se développe au XVIIIe siècle sans qu’il soit expression d’un processus de création, mais plutôt comme manifestation de la délectation de l’artiste. Ces dessins, aboutis ou encore en devenir, étaient fortement recherchés par les collectionneurs, amateurs ou connaisseurs, qui les admiraient non seulement comme une œuvre d’art mais également comme un outil pour l’étude de la manière avec laquelle un artiste créait une œuvre4 . Cette relation particulière avec la peinture est également visible pour l’art du pastel. Cette technique était utilisée d’abord en qualité de medium, comme les autres techniques sèches, afin de donner une structure chromatique aux esquisses5. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, nous assistons à un changement – le plus marquant esthétiquement – quand le pastel commence à être employé au-delà de cette fonction d’instrument, afin d’en faire le medium unique d’une œuvre d’art à part entière, finie, à admirer et à conserver6. Ce développement, perceptible dans le domaine de la pratique artistique, s’accompagne d’une littérature –notamment en France – à la fois techniques et théoriques, sur l’art du pastel. S’instaure alors un débat sur la nature même de cette technique qui concerne à la fois les sphères esthétiques, théoriques et pratiques7. Ces écrits, essentiellement des traités mais aussi des articles parus dans la presse, ou des livrets des Salons, ainsi que des dictionnaires, forment la scène où cette discussion se déploie et contribuent à l’affirmation d’un terme (pastel) propice à une ambiguïté terminologique. Il ne s’agit pas de la simple distinction entre l’instrument – le bâtonnet – et l’œuvre peinte, tous deux désignés par le même terme, mais, des différentes manières qui sont adoptées pour définir le pastel au tournant du XVIIe siècle, soit comme un dessin, soit comme une peinture. Cette antinomie théorique apparait notamment dans les dictionnaires et encyclopédies français.
L’une des premières définitions est donnée par Antoine Furetière (1619-1688) dont le Dictionaire universel est publié en 1690 :
Cet article est une version revue et augmentée d’une communication présentée lors du colloque Le pastel : regards croisés sur une technique singulière (Paris, INHA, 16 octobre 2017).
1 Pour une histoire du dessin pendant la première modernité voir MEDER/AMES 1978 ; ROLAND MICHEL 1987 ; TORDELLA 2009 et 2012.
2 DEZALLIER D’ARGENVILLE 1745-1752, p. XVII ; TORDELLA 2012, pp. 42-48.
3 Sur la querelle du dessin et du coloris voir RUBENS CONTRE POUSSIN 2004 et MICHEL 2005.
4 ROLAND MICHEL 1987, pp. 10-11, et pp. 243-253 pour un panorama des ventes et collectionneurs en France.
5 Nous attirons l’attention du lecteur sur la difficulté de pouvoir distinguer à l’œil nu l’emploi du pastel de celui des pierres reconstituées ou crayons. À ce problème – qui nécessiterait des examens techniques – s’ajoute la question (toujours irrésolue) de la définition du terme pastel par la critique contemporaine. Sur ces thématiques voir BURNS 1994 ; TOWNSEND 1998 ; BURNS 2002 et 2007, pp. 1-16 ; NOVA 2008(2010).
6 Pour une histoire du pastel voir BURNS 2007 ; BURNS–SAUNIER 2014 ; JEFFARES 2008.
7 Sur les différentes typologies de discours sur l’art en France au XVIIIe siècle voir LICHTENSTEIN 2015, en particulier pp. 31-36.
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
Pastel : s.m. (L’s se prononce) Pâte faite de plusieurs couleurs gommées & broyées ensemble, ou separément, dont on fait toutes sortes de crayons pour peindre sur le papier, ou le parchemin. Il y a des Peintres qui reüssissent merveilleusement à faire des portraits en pastel […]8
Si ici l’auteur fait référence à la pratique de peindre à pastel, Le Dictionnaire de l’Académie françoise (1694) précise :
Pastel. L’S se prononce. Sorte de crayon fait d’un peu de plastre destrempé avec de l’eau de gomme, & où on mesle diverses couleurs selon le besoin qu’on en a. On fait des pastels de toutes sortes de couleurs. Dessiner au pastel. On appelle aussi, Pastel, Ce qui est peint avec le pastel […]9 .
Cette définition marque plutôt une distinction entre les deux fonctions de cet instrument, qui renvoie à un positionnement théorique du dessin par rapport à la peinture : on dessine à pastel mais l’œuvre d’art en soi accomplie est une peinture à pastel. Il faudra attendre la quatrième édition (1762) du Dictionnaire pour trouver les deux verbes, peindre et dessiner à pastel, comme deux pratiques bien distinctes10 .
Ce positionnement, ainsi que la séparation des deux fonctions, se retrouve aussi en parcourant l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers où les allusions au pastel sont multiples. Claude-Henry Watelet (1718-1786) dans la définition du terme « Dessein », qui « est une des parties essentielles de la Peinture »11, souligne le caractère de support chromatique que le pastel peut avoir, comme pour les autres techniques sèches12. Toutefois, Louis de Jaucourt (1704-1780) dans son commentaire du terme « Pastel », qui semble être tiré du Dictionnaire portatif des beaux-arts de Jacques Lacombe (1752) spécifie qu’il s’agit d’une forme de peinture :
Pastel, peinture au, (Peinture mod.) c’est une peinture où les crayons font l’office des pinceaux ; or le mot de pastel qu’on a donné à cette sorte de peinture, vient de ce que les crayons dont on se sert sont faits avec des pâtes de différentes couleurs. […] Le plus grand usage que l’on tire du pastel, est de faire des portraits. […] Aussi a - t - on vû long - tems avec peine, que cette agréable peinture, qui ne tient aux tableaux que par la ténuité de ses parties, fût sujetye à s’affoiblir & à se dégrader par divers accidens inévitables13
La dimension du dessin est donc écartée de cette définition. Cette position intellectuelle est d’ailleurs commune aux deux traités sur l’art du pastel qui ont été publiés au XVIIIe siècle, dont les titres – Traité de la peinture à pastel – sont explicites. Bien que huit décennies les séparent, le premier a été annexé à l’édition de 1708 du Traité de la peinture en mignature attribué à Claude Boutet, alors que le deuxième est publié par Paul-Romain Chaperon (1732-1793) en 1788, les deux auteurs se retrouvent dans la volonté d’affirmer qu’il s’agit d’une peinture. Alors que Boutet spécifie que « […] la Peinture au Pastel se nommoit ainsi, à cause qu’elle se pratique avec des crayons faits de Pâtes de divers couleurs […] »14, Chaperon lui n’hésite pas à en faire une peinture15. La vision de Philippe de la Hire (1640-1718) est diamétralement opposée : il sépare nettement en deux sections son Traité de la pratique de la peinture (1730), en situant donc le pastel
8 FURETIÈRE 1690, III, ad vocem
9 LE DICTIONNAIRE DE L’ACADEMIE FRANÇOISE 1694, II, ad vocem
10 DICTIONNAIRE DE L’ACADEMIE FRANÇOISE 1762, II, ad vocem. Les éditions de 1718 et de 1740 n’apportent aucun changement.
11 WATELET 1754, p. 889.
12 « Les pastels, même de différentes couleurs, servent à indiquer les tons qu’on a remarqués dans la nature » (ivi, p. 891).
13 JAUCOURT 1765, pp. 153-154.
14 BOUTET 1708, p. 149
15 CHAPERON 1788, p. 9.
Studi di Memofonte 34/2025
parmi les types de dessin, probablement à cause de la nature du medium très semblable aux pierres et aux crayons16
À partir du milieu du XVIIIe siècle, plusieurs textes illustrent une évolution de la perception de l’art du pastel. Dans le Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure (1757) Antoine-Joseph Pernéty (1716-1796) positionne ainsi le pastel entre le domaine du dessin et celui de la peinture. Dans la préface il affirme :
La Peinture en pastel n’est proprement qu’une espece de dessein estompé qui représente les couleurs naturelles des objets avec des crayons de différentes couleurs qu’on appelle Pastels. […] Cette sorte de Peinture s’exécute sur du papier collé sur une toile ou sur de la peau de mouton bien tendue […]17
Il indique par ailleurs – dans l’entrée « pastel » – qu ’il s’agit d’ une « Peinture où les crayons font l’office des couleurs broyées & le doigt l’office des pinceaux »18. Une voie médiane est suivie aussi par Charles-Antoine Jombert (1712-1784) dans la réédition en 1766 de l’ouvrage de Roger de Piles Les premiers éléments de peinture pratique, enrichis de figures de proportions mesurées sur l’antique, dessinées et gravées par J-B Corneille, peintre de l’Académie Royale, bien qu ’il y a une contradiction entre le premier chapitre (De la peinture en general) et le deuxième (Du dessin) :
La peinture au pastel […] tient le milieu entre le dessein et la peinture. Ainsi que le dessein, elle se pratique avec des crayons ; comme la peinture, elle donne à chaque objet la couleur qui lui est propre : c ’est ce qui fait qu’on dit également, dessiner au pastel, & peindre au pastel. […] Enfin quoiqu’on fasse de fort beaux portraits & des figures entieres avec des pastels ou crayons de différentes couleurs, qui font presque le même effet que la peinture, néanmoins on ne peut gueres appeler ce travail qu’un dessein colorié, ou un dessein au pastel19 .
Le pastel constitue donc une dimension esthétique en soi qui touche à la fois à l’univers du dessin et à celui de la peinture20, concept qui est rappelée vers la fin du XVIIIe siècle dans deux ouvrages dirigés par Claude-Henry Watelet et Pierre-Charles Levesque (1736-1812), le volume Beaux-Arts de l’Encyclopédie méthodique et le Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure. À l’intérieur du premier nous pouvons lire que le pastel est une « sorte de peinture, dont le nom est dérivé du mot pâte […] », que l’« on peint au pastel avec des couleurs mises en poudre […] », mais que finalement « la peinture au pastel a beaucoup de rapport avec le dessin à l’estompe […] »21 .
La porosité entre ces deux sphères est à nouveau observable dans les mots de Jean-BaptisteClaude Robin (1734-1818), dans le Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure (1792) :
Si l’on ne considéroit comme peinture que celle qui s’opère avec le pinceau, le pastel en seroit exclu, & regardé comme un simple dessin ; mais il suffit que le résultat de l’ouvrage montre une imitation de la nature, par le moyen de matières colorées pour tenir rang dans les manières de peindre22
16 « Il y a encore une espece de dessein qui represente les couleurs naturelles, mais seulement avec des craïons de couleur qu’on appelle Pastels » (LA HIRE 1730, p. 662). Il faut souligner que la publication est posthume et qu’il s’agit d’un discours prononcé en 1709 à l’Académie des Sciences. Sur La Hire voir PINAULT 1988 et PHILIPPE DE LA HIRE 2013.
17 PERNETY 1757, pp CXXVI-CXXVII
18 Ivi, p. 444.
19 PILES/JOMBERT 1766, pp. 19 et 33.
20 TORDELLA 2009, p. 108. Voir également MASSE 2022, qui souligne l’intermédialité du pastel et l’analyse en tant que médium à travers la littérature artistique française du XVIIIe siècle.
21 WATELET–LÉVESQUE 1791, p. 708
22 ROBIN 1792, pp. 651-652
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
Il semble alors que l’association au domaine de la peinture ou à celui du dessin ne soit pas purement aléatoire, mais qu’il y a bien une distinction entre la fonction et l’objet, donc entre l’action de dessiner et le produit final de cette action. Lorsque les pastels sont utilisés pour colorer sans que l’œuvre soit terminée, alors on dessine, mais dès que l’œuvre est accomplie alors elle est définie comme une peinture. Dans le même temps, positionner le pastel – entendu comme l’œuvre – entre la dimension de la peinture et celle du dessin signifie également lui donner un statut propre, distinct, qui doit être légitimé et expliqué. L’expression employé par Robin – « tenir rang » – cache en soi une hiérarchie implicite, ancrée dans le modus cogitandi académique : le pastel pourrait donc aspirer à être considéré comme une peinture.
Ce système hiérarchisé est d’ailleurs souligné dans la structure de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, où les artistes, d’abord agrées, sont ensuite reçus avec un titre qui en précisait leur spécialité23. Le premier artiste spécialisé dans l’art du pastel à intégrer l’Académie est Nicolas Dumonstier (1612-1667), directement reçu le 31 mars 1663, présente le 4 janvier 1665, comme morceau de réception un portrait au pastel24. Le 28 juin 1698, Joseph Vivien se présente à l’Académie pour être reçu et se voit confier le 5 juillet la réalisation de « portraicts de Monsieur Girardon et de Monsieur Coysevaux, auxquels il mettra à chascun une glace »25 avant d’être reçu le 30 juillet 170126. Il est notable que, dès avant sa réception, il est déjà qualifié de « Peintre en portraiets de pastèle »27 : l’Académie ne créée alors pas une catégorie nouvelle, mais institutionnalise sa profession. L’accent mis sur le medium – et non pas sur le fait d’être portraitiste – est une formule qui est réitérée par exemple lors de l’agrément, puis de la réception, de Maurice-Quentin de La Tour28. Les textes produits dans le contexte de l’Académie, font également de l’art du pastel un genre : Alexis Loir est ainsi « agréé dans ce genre »29 en 1746, alors qu’en 1750, lors d’une des conférences mensuelles de l’Académie de Peinture et Sculpture, Jean-Baptiste Massé parle du pastel en qualité d’ un « nouveau genre » dans lequel les artistes peuvent se lancer30 . Éloigner le pastel du domaine du dessin, justifierait-il son appartenance au domaine de la peinture ? Ou plutôt, le pastel aurait-il acquis un statut autonome qui lui permettrait d’être un des deux objets d’ un nouveau paragone avec la peinture ? Toutefois, après la réception de De la Tour, l’Académie décida de demander de portraits à l’huile comme morceau de réception des artistes pastellistes31. Ce renversement de l’attention – portée désormais sur le portrait plutôt que sur le pastel – cache en réalité un développement du discours, perceptible à la lecture des textes, autour de cette technique, qui se voit mise en parallèle avec la peinture à l’huile. C’est probablement avec les paroles de Roger de Piles que cette mise en parallèle commence à prendre forme vers la fin du XVIIe siècle : Rien n’est plus commode que cette sorte de Peinture car outre qu’elle n’a point la sujession de l’huile, & qu’on la prend & laisse quand on veut, & selon le temps qui reste à y employer, le travail en est encore plus commode, parce que l’on peut faire avec les differens crayons ce que l’on fait
23 Sur l’histoire et le fonctionnement de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture voir MICHEL 2012.
24 PROCÈS-VERBAUX DE L’ACADEMIE ROYALE 1875-1892, I (1875), pp. 219 et 276 ; LECOEUR 2006, p. 212.
25 PROCÈS-VERBAUX DE L’ACADEMIE ROYALE 1875-1892, III (1880), pp. 236 et 238.
26 Ivi, pp. 319-320.
27 Ivi, p. 236.
28 « Quentin de La Tour, Peintre de portraits en pastel, aïant fait aporter de ses ouvrages, l’Académie, après avoir pris les voix à l’ordinaire reconnu sa capacité, a agréé sa présentation, et incessament la Compagnie luy donnera les sujets des portraits qu’il doit faire pour sa réception » (ivi, V, p. 205). « Le Sieur Maurice-Quentin de La Tour, Agréé, natif de S. Quentin, Peintre en pastel, a présenté à l’assemblée le portrait de M. Restout […] » (ivi, VI, p. 35). La littérature sur de La Tour est vaste ; nous renvoyons par synthèse à DEBRIE–SALMON 2000 et JEFFARES 2022.
29 PROCÈS-VERBAUX DE L’ACADÉMIE ROYALE 1875-1892, VI (1885), p. 28.
30 Conférence du 4 avril 1750, Examen pour connaître ses dispositions. Voir CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE ROYALE 2006-2015, V (2012), t. 2, pp. 466-486, et en particulier sur le pastel voir p. 482.
31 MICHEL 2012, p. 104 ; CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE ROYALE 2006-2015, V (2012), t. 2, p. 482.
Studi di Memofonte 34/2025
avec les Pinceaux & le maniement des uns fait le même effet que celui des autres ; on touche & on adoucit selon qu’on veut faire paroître d’esprit dans son ouvrage ou qu’on le veut finir32 .
Le théoricien met ici l’accent sur la facilité et la commodité d’utilisation de la technique à pastel, topos qui sera repris quelques années plus tard dans le Traité de la peinture en mignature attribué à Claude Boutet33 Ces caractères sont définis comme spécifiques à la peinture au pastel par plusieurs auteurs, parmi lesquels Philippe de La Hire, Antoine-Joseph Pernety, Jacques Lacombe dans son dictionnaire ou encore dans l’Encyclopédie34 . Mais ces traits spécifiques semblent servir à rabaisser le pastel face à la technique à l’huile. L’abbé Le Blanc participe de ce mouvement en soulignant la question de la facilité :
Quant aux discours que la jalousie fait tenir à plusieurs Artistes qui prétendent que le Pastel est beaucoup plus facile que l’huile, il s’en faut beaucoup que la chose soit vraie du pastel tel que M. de la Tour le traite. Les essais de quelques-uns de ceux qui ont voulu l’imiter leur ont assez mal réussi pour avoir dû les faire changer d’opinion. En tout genre il est aisé de faire communément, le difficile est d’exceller35
La difficulté réside essentiellement dans l’idée de perfection qui est complexe à atteindre. La possibilité offerte par le pastel de quitter et reprendre le travail autant de fois que nécessaire36 devient par exemple pour De la Tour la cause de l’impossibilité d’accéder à l’excellence. Les mots d’Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken van Zuylen (1740-1805)37, à propos de son portrait exécuté par De La Tour, auprès duquel elle prit des leçons, en témoignent. Les mots du maître sont eux aussi connus :
Toujour occupé de perfections en tout genre, et par conséquent du bonheur du genre humain, je m ’oublie comme un âtome dans l’espace de l’univers. Je devrois être dégouté de ce zèle de perfection, puisqu’il m’a fait gâter tant d’ouvrages. […] Bonne leçon pour vous, Mademoiselle, qui courez cette carrière. Si vous n’avez pas l’ambition de trop bien faire, je vous estimeray bien heureuse de vous être procuré un aussi agréable amusement sans qu’il vous soit aussi pénible qu’il me l’a été38
Le parallèle avec la peinture à l’huile ne se réduit pas à la seule dimension pratique mais prend également en compte les sphères visuelles et théoriques. Plusieurs sources en effet font référence à la vivacité des couleurs, à la douceur, à la grâce ou encore à la force comme points de comparaison.
Au début du XVIIIe siècle, les paroles de Florent Le Comte en offrent déjà un exemple : dans le chapitre Description des peintures, sculptures et estampes exposées dans la Grande Galerie du Louvre
32 PILES 1684, pp. 91-92.
33 « La Peinture au Pastel n’a guère moins de Partisans que la Miniature, parce qu’outre la commodité qu’on a, comme la Mignature, de la prendre et de la laisser quand on veut […] d’ailleurs ayant la même liberté, & une facilité aussi grande dans le travail […] » (BOUTET 1708, pp. 149-150).
34 « Ce travail est commode en ce qu’on le quitte & on le reprend quant on veut sans aucun appareil, & on le retouche aussi & on le finit tant qu’on veut, car on peut effacer facilement les endroits dont on n’est pas entierement satisfait avec un peu de mie de pain » (LA HIRE 1730, p. 663) ; « Ce travail est d’ailleurs commode en ce qu’on le quitte & on le reprend quand on veut, sans aucun appareil : on le retouche & on le finit à sa volonté » (PERNETY 1757, p. CXXVI) ; voir aussi JAUCOURT 1765, pp. 153-154, et LACOMBE 1752, ad vocem
35 LE BLANC 1747, pp. 88-89.
36 Christian Michel souligne que ce caractère est une qualité car la rapidité d’exécution était considérée comme une vertu au XVIIIe siècle. Cf. MICHEL 2018, p. 29.
37 « Mon portrait de la Tour a été admirable, […] tous les jours nous pension que ce serait la dernière séance, il n’y avait qu’un rien à ajouter aux yeux. Mais ce rien ne voulait pas venir, on cherchait, on retouchait […] » (GODET 1906, I, p. 123).
38 LA TOUR 1863, pp. 15-16. Sur la correspondance de l’artiste voir aussi LA TOUR/GUIFFREY–TOURNEUX 1885.
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
Plusieurs peintres de nos jours, tels que MM. de la Tour, Roslin, Lundberg, Perronneau, &c. ont porté cette sorte de peinture à un très haut degré de perfection, leurs portraits au pastel ne cedent en rien aux tableau peints à huile, soit pour la vérité avec laquelle ils ont rendu la nature, soit pour la force & la vivacité des couleurs41
Dans les mêmes années Jean-Étienne Liotard, un des plus célèbres pastellistes, s’insère dans ce débat en soulignant que « la peinture à pastel pour la beauté, la vivacité, la fraicheur et la légereté des teintes, est plus belle que quelque peinture que ce soit »42
Bien que certains textes se contentent de rester sur les caractères proprement visuels, d’autres les utilisent comme fondement pour porter le discours sur le plan théorique en faisant correspondre l’idée du rendu naturel avec la question de l’imitation de la nature. Roger de Piles considère que le manque de vigueur du naturel, tel que la peinture à l’huile peut atteindre, serait une imperfection43 Bien que selon les règles de l’Académie, la ressemblance soit l’un des critères fondamentaux pour juger d’un portrait, l’évaluation pour les portraits au pastel se faisait aussi par rapport à la peinture à l’huile. Ce débat se déroule, au-delà des dictionnaires et traités, aussi dans les écrits produits lors des Salons44. Les expositions annuelles de l’Académie royale de peinture et de sculpture offrent en effet un cadre propice – de par la disposition particulière des œuvres d’art – pour une comparaison entre les portraits à l’huile et ceux au pastel. Le court commentaire publié dans le livret, attribué à Pierre Estève, du Salon de 1753, souligne ainsi comment les pastels de De la Tour attirent tout l’attention aux dépends des œuvres à l’huile45 Quant à La Font de Saint-Yenne, il condamne la présence trop insistante des pastels et souligne la primauté de l’huile :
Le nombre des peintres a pastel est infini. Mais il est bien à craindre que la facilité et la célérité de ces fragiles craions ne fassent négliger l’huile beaucoup plus lente à la vérité, mais infiniment plus savante et incomparable pour durée. […] Je commencerai par les portraits à l’huile fort au dessus
39 LE COMTE 1699-1700, III (1700), p. 266.
40 ADAMCZAK 2014, p. 176.
41 PILES/JOMBERT 1766, p. 283. Plusieurs textes, écrits à l’occasion des Salons, se penchent sur ces questions. Nous renvoyons à l’anthologie proposée par N. Jeffares qui prend en compte le troisième quart du XVIIIe siècle :
JEFFARES 2008
42 LIOTARD 1762, p. 186. Sur l’artiste voir ROETHLISBERGER–LOCHE 2008.
43 « pour ceux dont la pratique dans le Coloris n’est pas excellente, rien n’est plus dangereux que le Pastel, lequel ne peut imiter ainsi que fait la Peinture à huile la force la vigueur du naturel, & c’est sans doute à cause de cette imperfection, qu’on dit indifféremment dessiner au Pastel & peindre au Pastel » (PILES 1684, p. 96). Aussi Claude Boutet était du même avis : « Cette peinture est propre particulièrement pour faire des Portraits, on peut les faire aussi grands que Nature, mais ordinairement on ne les fait que la moitié aussi grands, ce qui réüssit mieux, parce que ne pouvant pas donner autant de force & de vivacité qu’à la Peinture à huile, il se trouve que l’objet étant plus petit que Nature, en demande moins aussi, parce qu’alors on le suppose un peu éloigné » (BOUTET 1708, pp. 150-151).
44 Parfois nous pouvons trouver ces enjeux exprimés dans des articles, comme celui d’un auteur anonyme qui écrit en 1745 dans la revue hebdomadaire « Jugements sur quelques ouvrages nouveaux » que le pastel présenté par Nattier au Salon « surpasse tout ceux qu’il a fait à l’huile » (« Jugements sur quelques ouvrages nouveaux », 24 septembre 1745, p. 291, cité dans ADAMCZAK 2014, p. 178).
45 « Malgré ce reproche, on ne peut se défendre de reconnoître dans le pastel de ce Maître une fraîcheur qui efface tout ce qui est à l’huile » ([P. Estève], Lettre à un ami sur l’exposition des tableaux, faite dans le grand Sallon du Louvre le 25 août 1753, s.l. [1753], p. 15, cité dans JEFFARES 2008, p. 6, http://www.pastellists.com/Misc/Exhibitions_1751_75.pdf, p. 6, <8 mai 2025>).
Studi di Memofonte 34/2025 (1700), l’auteur fait une comparaison entre les portraits historiés de Joseph Vivien et les tableaux à l’huile contemporains, en soulignant comment ses pastels ont atteint « la même grâce, la même force, la même naïveté et la délicatesse »39 des œuvres peintes40. Si Roger de Piles ne se prononce pas sur cet aspect, la réédition de 1766 sous la direction de Charles-Antoine Jombert (17121784) rajoute :
des pastels soit par la sience et la difficulté du succès, soit par la solidité de leur durée qui ne sauroit être comparée aux beautés volatiles des craions46 .
Paul-Romain Chaperon, le plus éloquent quant à ce paragone, écrit dans son traité de 1788 :
La Peinture au pastel seroit donc généralement préférée, surtout pour le portrait, où l’on est souvent obligé d’opérer à différentes reprises […]. Aucun autre n’approche autant de la nature. Aucun ne produit des tons si vrais. C’est de la chair, c’est Flore, c’est l’Aurore. S’il n’a pas quelquesfois autant de force que la Peinture à l’huile, c’est moins sa faute que celle de la main qui l’employe. Non que je prétende inviter à quitter le pinceau pour le pastel. Mais combien d’occasion où l’on trouveroit de l’avantage à le substituer à la Peinture à l’huile plutôt que la détrempe47 .
La question de l’imitation de la nature sera aussi abordée par d’autres critiques. Jacques Lacombe affirme dans le Dictionnaire encyclopédique (1792) la supériorité absolue du pastel sur l’huile pour la vivacité, la fraicheur et l’éclat du coloris ainsi que pour l’imitation de la nature48. En 1792 également, Watelet et Levesque déclarent que la peinture à pastel « ne parôit pas pouvoir se prêter à tous les genres : mais elle est sans reproche, dans les genres auxquels elle convient »49 , c ’est-à-dire dans le genre du portrait50 . Alors que pendant tout le XVIIIe siècle les voix prenant position sur la prééminence de l’une ou de l’autre technique se multiplient, vers 1750 la notion de velouté fait son apparition dans les textes qui parlent du pastel. Ainsi en 1757 Pernety écrit :
On ne fait gueres usage de cette sorte de Peinture [p. cxxviii] que pour les portraits ; l’espece de velouté que forme cette poussiere est plus propre que toute autre peinture à représenter les étoffes, & le moëlleux avec la fraicheur des carnations ; la couleur en paroît plus vraie ; mais pour réussir parfaitement, il faut être extrêment habile51
La question du velouté, comme élément fondamental dans le processus d’appréciation du pastel, permet de dévier l’attention de toutes les qualités en commun avec la peinture à l’huile –douceur, force, coloris, etc. – et fondements de la comparaison. Le velouté devient ainsi la clé – car ne s’appliquant pas à la technique à l’huile – pour faire sortir le pastel de ce paragone en lui donnant alors ce statut tant recherché.
46 LA FONTDE SAINT-YENNE 1747,pp. 28 et104.Unautre passage peu élogieux sur lespastelsestlisible dans LACOMBE 1753, p. 26 (cité aussi dans JEFFARES 2008, p. 7, http://www.pastellists.com/Misc/Exhibitions_1751_75.pdf <8 mai 2025>)
47 CHAPERON 1788, pp. 10 et 13
48 LACOMBE 1792, p. 771.
49 WATELET–LÉVESQUE 1791, p. 708.
50 Sur le portrait dessiné en France au XVIIIe siècle voir le chapitre de synthèse de PRAT 2017, pp. 214-253.
51 PERNETY 1757, p. CXXVIII
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
BIBLIOGRAPHIE
ADAMCZAK 2014
A. ADAMCZAK, Présence du pastel au Salon : étude sur l’émergence d’un art, dans Le Salon de l’Académie royale de peinture et de sculpture. Archéologie d’une institution, actes de la conférence (Québec septembre 2012), sous la direction de I. Pachet, Paris 2014, pp. 173-194.
BOUTET 1708
[C. BOUTET], Traité de la peinture en mignature. Pour apprendre aisément à peindre sans maître […], La Haye 1708.
BURNS 1994
T. BURNS, Chalk or Pastel? The Use of Coloured Media in Early Drawings, «The Paper Conservator», XVIII, 1994, pp. 49-56.
BURNS 2002
T. BURNS, Distinguishing Between Chalk and Pastel in Early Drawings, dans The Broad Spectrum. Studies in the Materials, Techniques, and Conservation of Color on Paper, actes de la conférence (Chicago octobre 1999), éd. par H.K. Stratis, B. Salvesen, Londres 2002, pp. 12-16
BURNS 2007
T. BURNS, The Invention of Pastel Painting, Londres 2007.
BURNS–SAUNIER 2014
T. BURNS, P. SAUNIER, L’Art du pastel, Paris 2014.
CHAPERON 1788
P.-R. CHAPERON, Traité de la peinture au pastel, du secret d’en composer les crayons, & des moyens de le fixer ; avec l’indication d’un grand nombre de nouvelles substances propres à la peinture à l’huile, & les moyens de prévenir l’altération des couleurs, Paris 1788.
CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE ROYALE 2006-2015
Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, edition critique integrale sous la direction de J. Lichtenstein, C. Michel, I-VI, tt. 12, Paris 2006-2015.
DEBRIE–SALMON 2000
C. DEBRIE, X. SALMON, Maurice-Quentin de La Tour. Prince des pastellistes, Paris 2000.
DEZALLIER D’ARGENVILLE 1745-1752
[A.-J. DEZALLIER D’ARGENVILLE], Abregé de la vie des plus fameux peintres, avec leurs portraits gravés en taille-douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques réflexions sur leurs caractéres, et la maniere de connoître les desseins des grands maîtres, I-III, Paris 1745-1752.
DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE 1762
Dictionnaire de l’Académie françoise. Quatriéme édition, I-II, Paris 1762.
FURETIÈRE 1690
A. FURETIÈRE, Dictionaire universel, contenant generalement tous les mots françois tant vieux que modernes, & les termes de touts les sciences et des arts [ ], I-III, La Haye - Rotterdam 1690.
Studi di Memofonte 34/2025
GODET 1906
P. GODET, Madame de Charrière et ses amis d’apres de nombreux documents inédits (1740-1805), avec portraits, vues, autographes, etc., I-II, Genève 1906.
JAUCOURT 1765
L. DE JAUCOURT, Pastel, entrée dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, éd. par D. Diderot, J.-B.L.R. d’Alembert, XII, Paris 1765, pp. 153-154.
JEFFARES 2008
N. JEFFARES, Dictionary of Pastellists Before 1800, édition en ligne, mise à jour régulièrement (http://www.pastellists.com/).
JEFFARES 2022
N. JEFFARES, Maurice-Quentin de La Tour, 2022 (disponible en ligne http://www.pastellists.com/Misc/Jeffares_LaTour_2022ed.pdf).
LACOMBE 1752
J. LACOMBE, Dictionnaire portatif des beaux-arts, ou Abregé de ce qui concerne l’architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie & la musique […], Paris 1752.
LACOMBE 1753
[J. LACOMBE], Le Salon, en vers et en prose ou jugement des ouvrages exposées au Louvre en 1753, s.l. [1753].
LACOMBE 1792
[J. LACOMBE], Dictionnaire encyclopédique des amusemens des sciences mathématiques et physiques, des procédés curieux des arts, des tours récréatifs et subtils de la magie blanche, et des découvertes ingénieuses et variées de l’industrie […], Paris 1792.
LA FONT DE SAINT-YENNE 1747
[É. LA FONT DE SAINT-YENNE], Réflexions sur quelques causes de l’état présent de la peinture en France. Avec un examen des principaux ouvrages exposés au Louvre le mois d’août 1746, La Haye 1747.
LA HIRE 1730
P. DE LA HIRE, Traité de la pratique de la peinture, dans Mémoires de l’Académie Royale des Sciences depuis 1666 jusqu’à 1699, I-XIII, tt. 11, Paris 1729-1734, IX (1730), pp. [635]-730.
LA TOUR 1863
M.-Q. DE LA TOUR, Lettre à mademoiselle de Zuylen sur la pratique du pastel, dans Le Cabinet de l’amateur. Années 1861 et 1862, [éd. par] E. Piot, Paris 1863, pp. 14-16
LA TOUR/GUIFFREY–TOURNEUX 1885
M.-Q. DE LA TOUR, Correspondance inédite […], publiés par J. GUIFFREY, M. TOURNEUX, Paris 1885.
LE BLANC 1747
[J.-B. LE BLANC], Lettre sur l’exposition des ouvrages de peinture, sculpture, etc. de l’année 1747. Et en général sur l’utilité de ces sortes d’expositions […], s.l. 1747.
LECOEUR 2006
D. LECOEUR, Daniel Dumonstier 1574-1646, préface par H. Zerner, Paris 2006.
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
LE COMTE 1699-1700
F. LE COMTE, Cabinet des singularitez d’architecture, peinture, sculpture, et graveure, ou Introduction à la connoissance des plus beaux arts, figurés sous les tableaux, les statües, & les estampes […], I-III, Paris 1699-1700.
LE DICTIONNAIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE 1694
Le Dictionnaire de l’Académie françoise, dédié au Roy, I-II, Paris 1694.
LICHTENSTEIN 2015
J. LICHTENSTEIN, L’argument de l’ignorant Le tournant esthétique au milieu du XVIIIe siècle en France, Dijon 2015.
LIOTARD 1762
J.E. LIOTARD, Explication des différens jugemens sur la peinture, «Mercure de France», 11, 1762, pp. 173-190.
MASSE 2022
I. MASSE, Médium du portrait, portrait du médium : les spécificités du pastel dans les discours sur l’art au XVIIIe siècle, «Word & Image», XXXVIII, 2022, pp. 265-277.
MEDER/AMES 1978
J. MEDER, The Mastery of Drawings, traduit et révisé par W. AMES, I-II, New York 1978 (édition originale Die Handzeichnung: ihre Technik und Entwicklung, Vienne 1919).
MICHEL 2005
C. MICHEL, Y a-t-il eu une querelle du rubénisme à l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture ?, dans Le rubénisme en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, actes du colloque international organisé par le Centre de Recherches en Histoire de l’Art pour l’Europe du Nord - ARTES (Lille 1er-2 avril 2004), éd. par M.-C. Heck, Turnhout 2005, pp. 159-171.
MICHEL 2012
C. MICHEL, L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1648-1793) La naissance de l’École Française, Genève 2012.
MICHEL 2018
C. MICHEL, Le statut du pastel dans la France du XVIIIe siècle, dans Pastels du 16e au 21e siècle, catalogue de l’exposition, sous la direction de S. Wuhrmann, A. Couvreur, Lausanne 2018, pp. 29-31.
NOVA 2008(2010)
A. NOVA, Pietre naturali, gessi colorati, pastelli e il problema del ritratto, dans Le tecniche del disegno rinascimentale: dai materiali allo stile, actes du colloque international (Florence 22-23 septembre 2008), éd. par M. Faietti, L. Melli, A. Nova, numéro monographique de «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», LII, 2008[2010], pp. 158-175.
PERNETY 1757
A.J. PERNETY, Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure […], Paris 1757.
PHILIPPE DE LA HIRE 2013
Philippe de La Hire 1640-1718, entre architecture et sciences, actes du colloque (Paris 24-26 juin 2010), sous la direction de A. Becchi, H. Rousteau-Chambon, J. Sakarovitch, Paris 2013.
PILES 1684
[R. DE PILES], Les premiers elemens de la peinture pratique […], Paris 1684.
PILES/JOMBERT 1766
R. DE PILES, Éléments de peinture pratique, nouvelle édition entierement refondue, & augmentée considérablement par C -A. JOMBERT, Amsterdam - Leipzig 1766 (édition originale PILES 1684)
PINAULT 1988
M. PINAULT, Note sur Philippe de La Hyre, dans Laurent de La Hire (1606-1656). L’homme et l’œuvre, catalogue de l’exposition, éd. par P. Rosenberg, J. Thuillier, Genève 1988, pp. 76-80.
PRAT 2017
L.-A. PRAT, Le dessin français au XVIIIe siècle, Paris 2017.
PROCÈS-VERBAUX DE L’ACADÉMIE ROYALE 1875-1892
Procès-verbaux de l’Académie Royale de peinture et de sculpture 1648-1793, éd. par A. de Montaiglon, IX, Paris 1875-1892.
ROBIN 1792
J.B.C. ROBIN, Peinture, entrée dans Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, [éd. par] C.H. Watelet, P.-C. Lévesque, IV, Paris 1792, pp. 635-671.
ROETHLISBERGER–LOCHE 2008
M. ROETHLISBERGER, R.LOCHE, Liotard. Catalogue, sources et correspondance, I-II, Doornspijk 2008.
ROLAND MICHEL 1987
M. ROLAND MICHEL, Le dessin français au XVIIIe siècle, Fribourg - Paris 1987.
RUBENS CONTRE POUSSIN 2004
Rubens contre Poussin. La querelle du coloris dans la peinture française à la fin du XVIIe siècle, catalogue de l’exposition, sous la direction de E. Delapierre, [Gand] 2004.
TORDELLA 2009
P.G. TORDELLA, La linea del disegno. Teoria e tecnica dal Trecento al Seicento, Milan 2009.
TORDELLA 2012
P.G. TORDELLA, Il disegno nell’Europa del Settecento. Regioni teoriche, ragioni critiche, Florence 2012.
TOWNSEND 1998
J.H. TOWNSEND, Analysis of Pastel and Chalk Materials, «The Paper Conservator», XXII, 1998, pp. 21-28.
WATELET 1754
C.H. WATELET, Dessein, entrée dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, éd. par D. Diderot, J.-B.L.R. d’Alembert, IV, Paris 1754, pp. 889-891.
WATELET–LÉVESQUE 1791
[C.H. WATELET, P.C. LÉVESQUE], Pastel, entrée dans Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts, I-III, Paris 1788-1805, II (1791), pp. 708-718.
« Des pastels qui font presque le même effet que la peinture… ». Dessiner, ou peindre au pastel ? Les frontières d’une pratique en France au XVIIIe siècle
ABSTRACT
Attraverso l’analisi delle fonti di letteratura artistica francese, questo contributo intende indagare lo statuto del pastello del XVII e XVIII secolo. Il dibattito instauratosi in questo periodo, su articoli, libretti di Salon, dizionari e trattati, permette infatti di riflettere su una duplice dicotomia, sia materiale (olio e pastello) sia estetica (pittura e disegno).
Through the analysis of French art literature sources, this contribution aims to investigate the status of pastel in the 17th and 18th centuries. The debate established during this period, in articles, Salon booklets, dictionaries and treatises, allows us to reflect on a dual dichotomy, both material (oil and pastel) and aesthetic (painting and drawing).
Studi di Memofonte 34/2025
INCONTRI IN GALLERIA BORGHESE: IL MUSEO E GLI ARTISTI NEL PRIMO DOPOGUERRA
Rientrato a Roma nel 1944 a pochi mesi dall’arrivo degli alleati, Giorgio de Chirico scrisse una serie di ricordi ricchi di aneddoti e di stralci della sua vita nella capitale tra il 1919 e il 1925, offrendo la più vivida descrizione e il più sentito omaggio che un artista del Novecento ci abbia mai lasciato della Galleria Borghese e della sua collezione:
Mentre durava la mia mostra personale alla galleria di Bragaglia, avevo cominciato a frequentare i musei. Avevo una particolare simpatia per il museo di Villa Borghese ove rimanevo profondamente impressionato, tanto dei quadri che vi erano custoditi, quanto della classica bellezza degli alberi e delle piante in mezzo a cui il museo sorge. Fu al museo di Villa Borghese, una mattina, davanti ad un quadro di Tiziano, che ebbi la rivelazione della grande pittura: vidi nella sala come delle lingue di fuoco, e fuori, per gli spazii del cielo tutto chiaro sulla città, rimbombò un clangore solenne ed echeggiò un suono di trombe annuncianti una resurrezione. Capii che qualche cosa di enorme avveniva in me. Fino allora nei musei, in Italia, in Francia, in Germania, avevo guardato i quadri e li avevo visti come li vedono tutti: li avevo visti solo come delle immagini Naturalmente quello che allora mi fu rivelato al museo di Villa Borghese non era che un principio; in seguito, con lo studio, il lavoro, la meditazione, ho compiuto progressi giganteschi1 .
L’episodio di questa «rivelazione della grande pittura», avvenuto in una mattina del 1919, è stato più volte raccontato e studiato come un punto di svolta all’interno della carriera del pittore, da lui stesso paragonato quasi a una rinascita personale2. Ciò è giustificato dal fatto che lo stesso artista sottolineò come le visite in Galleria non rappresentassero un’esperienza fugace, bensì un approfondito processo di studio e di ripensamento incentrato sulla conoscenza delle opere degli antichi maestri. Tra i tanti capolavori De Chirico decise di realizzare la copia di un ritratto:
Avevo deciso di copiare al Museo di Villa Borghese un quadro di Lorenzo Lotto. Prima non avevo mai fatto copie nei musei; parlai del mio progetto a colleghi e ad amici e tutti più o meno benevolmente, sorrisero sotto i baffi; io però […] mi misi all’opera. Non fu molto facile cominciare, poiché non avevo né diplomi, né licenze, assolutamente nessun titolo di studio e ci voleva il permesso della direzione del museo. Per fortuna Spadini, che conosceva il direttore, professor Cantalamessa, mi accompagnò da lui. Il professore Cantalamessa era un signore molto anziano; sorrise anche lui all’idea che un ‘futurista’ volesse fare delle copie di quadri antichi […] ma poi […] divenne molto gentile e mi accompagnò nelle sale del museo illustrandomi le opere. […] Ci fermammo davanti al quadro di Lorenzo Lotto che io volevo copiare e che raffigurava un gentiluomo barbuto e vestito di nero3 .
La presente ricerca è stata condotta nell’ambito del PRIN 2022, codice 2022PEL788, titolo La Galleria Borghese e i suoi pubblici, 1888-1938, finanziato dall’Unione Europea-Next Generation EU, Missione 4 Componente 1, CUP E53D23014060006, principal investigator Lucia Simonato, Unità della Scuola Normale Superiore. Il PRIN si è svolto in collaborazione scientifica con la Galleria Borghese (direttrice Francesca Cappelletti).
1 DE CHIRICO 1945, pp. 43-45. Nonostante De Chirico pubblicasse nel 1945 i suoi ricordi romani mettendo come intervallo di tempo trascorso nella capitale quello tra il 1918 e il 1925, dopo la Prima guerra mondiale il pittore si era trasferito a Roma il 1° gennaio 1919 Cfr. la Cronologia, in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, p. 2756
2 «Era l’estate del 1919. A Roma faceva un gran caldo; soffiava sull’Urbe un vento infocato, uno di quei venti che vengono dall’Africa. Il giorno in cui nacqui là ove sorgeva l’antica Jolcos un vento simile soffiava sulla città degli Argonauti» (ibidem).
3 Ibidem
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
Il racconto di De Chirico ben illustra le modalità attraverso le quali egli riuscì a conoscere, anche grazie alla mediazione del pittore fiorentino Armando Spadini, l’allora direttore della Galleria Borghese Giulio Cantalamessa. Due artisti molto diversi tra loro come Spadini e De Chirico mostravano un comune interesse per la Galleria e la sua collezione. Inoltre, per Cantalamessa, ricevere la richiesta di copiare un dipinto rinascimentale da parte di un pittore ‘d’avanguardia’ doveva risultare un fatto quanto mai curioso.
L’obiettivo di questo studio è rimettere al centro dell’analisi il museo come luogo di incontri e formazione per gli artisti4. De Chirico si andò infatti a inserire nel solco di una consolidata tradizione di artisti e copisti che frequentavano la Galleria Borghese negli anni del primo dopoguerra. Inoltre, insieme a lui, altri artisti gravitarono attorno alla Galleria negli stessi anni e addirittura negli stessi giorni. Se infatti De Chirico menzionava Armando Spadini come suo accompagnatore e persona con la quale si intratteneva nel periodo in cui copiava il ritratto di Lorenzo Lotto5, è noto che fu proprio nelle sale del museo che egli incontrò per la prima volta anche Giorgio Morandi. Mentre ciò accadeva, nello stesso lasso di tempo un altro artista, Virgilio Guidi, nella sala a fianco a quella della ‘grande rivelazione’ di De Chirico davanti a Tiziano, veniva profondamente influenzato da un altro capolavoro della Galleria, la Danae di Correggio, di cui stava realizzando una copia in scala reale.
La collezione Borghese e gli artisti: le opere più ammirate e copiate
Per Giorgio de Chirico fu Tiziano il primo e vero oggetto di quel disvelamento della grande pittura del passato. In questo senso, il giudizio e l’esperienza del pittore si devono sicuramente collocare all’interno della lunga tradizione di interessamento nei confronti delle opere di Tiziano al museo Borghese. Tra esse spiccava Amor sacro e Amor profano (Fig. 1), all’epoca uno dei capolavori più considerati e apprezzati della Pinacoteca, tanto da divenire il motivo principale della contesa legale tra il principe Borghese e lo Stato prima della statalizzazione della collezione nel 19016. Uno scambio di lettere risalente al 1887 tra l’allora conservatore e futuro direttore Giovanni Piancastelli e il pittore tedesco Augusto Wolf, specializzato in copie dall’antico, ci descrive una situazione che rimase invariata fino agli anni del primo dopoguerra: a Wolf venne infatti ripetutamente negata la possibilità di copiare e studiare l’opera di Tiziano a causa dell’eccessivo numero di richieste7. In effetti, il dipinto era divenuto vera meta di pellegrinaggio artistico sin dal XIX secolo. Invece, copiare quello che all’epoca era denominato Ritratto di
4 La ricca e vasta bibliografia su De Chirico ha ampiamente confermato l’importanza del suo incontro con la Galleria Borghese, individuando in questo frangente il punto di svolta all’interno del processo creativo che portò il pittore dagli anni della Metafisica a quelli del ‘ritorno al mestiere’. Sono gli stessi anni in cui l’artista assumerà un ruolo di rilievo all’interno della rivista «Valori Plastici» esprimendo un nuovo concetto di pittura legato alla tradizione degli antichi e il suo ideale di pictor classicus. Si vedano specialmente i contributi di Fabio Benzi sulla carriera di De Chirico al tempo di Valori Plastici: BENZI 2002a, 2002b, 2019
5 «Mentre copiavo il quadro di Lorenzo Lotto vedevo spesso Spadini che veniva al museo e con lui parlavo della pittura antica. Spadini era un uomo pieno di temperamento, normale ed intelligente, che sentiva ed amava profondamente la pittura; egli non aveva nulla di comune con la maggior parte dei pittori di oggi che hanno un solo difetto ma grosso: quello di essere qualunque cosa fuorché dei pittori. I quadri di Spadini non mi sono mai piaciuti; ma nessuna pittura fatta oggi mi può piacere» (DE CHIRICO 1945, pp. 50-51).
6 BARBERINI 1984
7 Nell’Archivio Borghese conservato presso l’Archivio Apostolico Vaticano si trova molta documentazione riguardante la richiesta di copiare opere appartenenti alla collezione Borghese nonché di permessi per dipingere all’interno della villa pinciana. Tra questi si vedano le numerose missive inoltrate da Augusto Wolf in merito alla possibilità di studiare le opere di Tiziano: Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano (d’ora in poi AAV), Archivio Borghese, 433, Permessi per copiare 1886-1891, in particolare f. 665.
Studi di Memofonte 34/2025
gentiluomo di Lorenzo Lotto (Fig. 2)8 si configurava senz’altro come una scelta più eccentrica e inusuale, trattandosi di un dipinto fra quelli meno considerati dagli artisti. De Chirico l’aveva probabilmente notato contestualmente alla sua visita alla sala di Tiziano, in quanto sappiamo che le due opere erano collocate all’epoca vicine, forse sulla stessa parete9
Dalle parole di De Chirico si evince che non fosse per nulla semplice entrare in Galleria Borghese per copiare opere della collezione senza opportune qualificazioni. La documentazione archivistica ci rivela però una numerosa quantità di accessi al museo proprio per copiare le opere, soprattutto in formati più piccoli rispetto agli originali. Si nota anche un interesse specifico per singoli dettagli10. Nelle richieste precedenti la statalizzazione della collezione e in quelle successive, si evidenzia infatti un interesse costante verso lo stesso tipo di particolari, come ad esempio la coppia di putti presenti nella Danae di Correggio, o singole figure nei quadri di Tiziano11 Del resto, anche De Chirico porterà a compimento la sua personale interpretazione del quadro di Lorenzo Lotto concentrandosi soltanto sul volto del personaggio rappresentato (Fig. 3).
La richiesta specifica di copia, principalmente per scopi commerciali, era soprattutto appannaggio di pittori copisti di professione, tra i quali si può notare un elevato numero di donne, che rinnovavano di anno in anno il proprio permesso chiedendo di poter cambiare opera a cui dedicarsi. D’altro canto, gli artisti più interessati allo studio e all’opportunità di permanere liberamente all’interno della Galleria chiedevano, prima del 1901, un permesso per dipingere negli orari di chiusura della villa, optando invece per la formula dell’accesso libero da quando la Galleria divenne museo nazionale12. All’interno della documentazione esaminata compaiono anche le richieste di accesso libero di Spadini e De Chirico, datate rispettivamente 15 e 20 luglio 1919, fatto che conferma la vicinanza dei due artisti in quel periodo e l’affidabilità del racconto dechirichiano13. Dalla documentazione conservata nell’Archivio della Galleria relativa agli anni del primo dopoguerra si può evincere che fossero pochi i pittori affermati a richiedere il permesso di copia, rispetto invece alle domande dei copisti di professione e degli studenti ancora in formazione. Tra essi ricordiamo un ventenne Fausto Pirandello, il quale, iscritto alla scuola d’arte, chiedeva nel gennaio del 1923 di poter copiare Venere che benda Amore di Tiziano14. Proprio in questo senso bisogna forse intendere le parole di De Chirico relative alla difficoltà di accesso al museo, e si comprende maggiormente la perplessità di Giulio Cantalamessa riguardo al fatto che un artista affermato, per di più un ‘futurista’, un artista d’avanguardia, volesse fare una richiesta di copia.
La Galleria veniva quindi assiduamente frequentata dagli artisti dell’epoca e, soprattutto dopo gli anni tragici della Prima guerra mondiale, era molto sentito il desiderio da parte dei pittori, anche tra quelli più affermati, di poter dipingere all’interno del museo15. A conferma di ciò, si può leggere la lettera del dicembre 1918 della pittrice toscana Vittoria Morelli – amica
8 L’opera è stata a lungo considerata autoritratto del pittore. Oggi alcuni studi propongono che il personaggio raffigurato possa essere il conte Mercurio Bua. Cfr. https://www.collezionegalleriaborghese.it/opere/ritratto-diuomo-mercurio-bua <18 luglio 2025>.
9 Seppure non si possiedano fotografie dell’allestimento che gli artisti potevano vedere negli anni successivi al primo conflitto mondiale, l’assetto delle sale si può con efficacia ricostruire tramite una dettagliata descrizione di Adolfo Venturi pubblicata come dispensa didattica per i suoi studenti nel 1921. Cfr. VENTURI 1921.
10 Si vedano le seguenti segnature: AAV, Archivio Borghese, 433, Permessi per copiare 1886-1891; 434, Permessi per copiare 1890-1901, in particolare f. 455. Inoltre, presso la Galleria Borghese, si vedano le segnature: Roma, Archivio della Galleria Borghese (d’ora in poi AGB), Serie 16, Richieste riproduzioni opere d’arte, Richieste riproduzioni opere d’arte 1909-1931, busta 1.
11 Si rimanda alle segnature di cui sopra.
12 AAV, Archivio Borghese, 1062-1066, Permessi per dipingere a Villa Pinciana 1878-1894; AGB, Serie 24, Tasse d’ingresso, Tasse d’ingresso 1908-1929, busta 2.
13 AGB, Serie 24, Tasse d’ingresso, Tasse d’ingresso 1908-1929, busta 2.
14 AGB, Serie 16, Richieste riproduzioni opere d’arte, Richieste riproduzioni opere d’arte 1909-1931, busta 1.
15 Come sottolineato da Lucia Simonato, Roberto Longhi sosteneva che anche i futuristi andassero «di nascosto alla Galleria Borghese» negli anni precedenti la Prima guerra mondiale. Cfr SIMONATO 2018, pp. 246-247.
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
degli artisti residenti a Villa Strohl Fern, tra cui Carlo Socrate – indirizzata a Fillide Giorgi, anche lei pittrice nonché moglie dello scrittore Arrigo Levasti: «Sa che ho cominciato a copiare alla Galleria Borghese? Copio un Veronese, una Venere con amore e satiro. Sa chi ho trovato a copiare là dentro? Spadini!! Anche Socrate copia un quadrone!»16. In una missiva precedente inviata ad Arrigo Levasti la pittrice si dichiarava entusiasta per aver sbloccato, dopo alcune difficoltà, la richiesta di permesso per copiare: «Sembra finalmente che si siano spuntate molte difficoltà per le copie in galleria e che potremo ottenere il permesso tanto per Villa Borghese come per la Pinacoteca Vaticana»17. L’aneddoto raccontato da Vittoria Morelli ci conferma ancora una volta la fama riscossa dalle opere venete del Rinascimento nonché la presenza, in qualità di copiste, di molte donne nella vita quotidiana della Galleria, ma anche la frequenza assidua di noti pittori attivi all’epoca nella capitale.
Tra gli artisti menzionati nella testimonianza della pittrice si riscontra di nuovo Spadini, che viene ad assumere un ruolo centrale all’interno della cerchia degli artisti romani per il suo rapporto privilegiato con la Galleria, alla quale avvicinò probabilmente sia De Chirico che Virgilio Guidi. Spadini avrebbe poi nel 1920 ottenuto in affitto dal Comune di Roma uno studio presso l’Uccelliera di Villa Borghese, a pochi passi dal museo18 . Nel parco della villa il pittore realizzò numerose vedute e paesaggi, sebbene risulti difficile scorgere traccia della seppur sicura conoscenza delle opere della collezione Borghese all’interno della sua produzione19. Nonostante ciò, è riportato che realizzò una copia da Tiziano quasi al naturale, di cui non si menziona la data esatta20 . Lo stretto legame dell’artista fiorentino con il museo e con la direzione, prolungatosi negli anni, risulta però ulteriormente attestato da una disposizione ministeriale, a seguito della quale al funerale del pittore nel 1925 fu proprio la Galleria Borghese, a nome dello Stato, a fornire un aiuto economico alla famiglia21. Lo studio dell’Uccelliera, alla morte del marito, venne concesso dalla vedova dell’artista proprio a Virgilio Guidi, che era stato uno dei pittori a lui più vicini22 .
A partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento si erano diffuse anche numerose riproduzioni fotografiche dei dipinti e delle sculture della Galleria Borghese23, così come di numerosi dettagli, in particolare dei capolavori più richiesti, fra cui proprio Amor sacro e Amor profano di Tiziano. Di questo era divenuta celebre e apprezzata, seppur costosa, una stampa a carbone in scala reale realizzata da Domenico Anderson, lodata anche da Vittorio Alinari24. Molti studi, schizzi e copie degli artisti – in particolare di quelli che dall’estero giungevano a Roma, tappa di un viaggio più lungo – dovevano essere realizzati in studio basandosi sulle fotografie comprate in loco, piuttosto che dal vero nelle sale della Galleria. Ma anche gli artisti attivi a Roma fecero largo uso delle fotografie come oggetto di studio. Tale pratica fu aspramente contestata, tra gli altri, dal pittore Mario Bacchelli (anch’egli amico e allievo di Spadini), che in uno scritto inedito si lamentava dell’impossibilità di comprendere l’arte attraverso la sua trasposizione fotografica rischiando di ingannare artisti e storici dell’arte25. Bacchelli, collaboratore della rivista «La Ronda» e di «Valori
16 Vita, opere, fortuna critica, in CARLO SOCRATE 1988, pp. 146-147
17 Ivi, p. 146.
18 Cfr. il Regesto, in MATITTI–FAGIOLO DELL’ARCO 1994, p. 33
19 Adolfo Venturi, nel suo libro su Armando Spadini, riconosce in lui un continuatore della tradizione pittorica veneta e di Correggio. Cfr. A. Venturi, Armando Spadini, in ARMANDO SPADINI 1927, pp. VI, XIX.
20 «Il disegno non fu un esercizio, avendone fatto quanto gli era necessario per molti anni: mentre fu un esercizio profondo la copia dei maestri antichi che lo porto in una primavera alla Galleria Borghese a copiare quasi al naturale L’amore sacro e profano di Tiziano» (DISEGNI DI ARMANDO SPADINI 1946, p.n.n.).
21 AGB, Serie 22, Nucleo Antico, Carte dei direttori Piancastelli, Cantalamessa, Bertini Calosso 1902-1936, busta 1; FAGIOLO DELL’ARCO 1995
22 MARANGON 1998, p. 20
23 AAV, Archivio Borghese, 433, Permessi per copiare 1886-1891; 434, Permessi per copiare 1890-1901
24 ALINARI 1900, p. 223.
25 Roma, ANIMI (Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia), Archivio La Ronda, Serie 1. Bozze e manoscritti, 1918-1922, fasc. 25. Bozze e manoscritti vari non stampati, 1919-1922.
Studi di Memofonte 34/2025
Plastici», esprimeva un giudizio probabilmente condiviso anche dagli altri artisti gravitanti attorno a quella cerchia, che in questo periodo si riscoprivano frequentatori dei musei.
De Chirico, la Galleria Borghese, gli anni di Valori Plastici e la copia dall’antico
A fine luglio 1919 De Chirico era ancora impegnato a lavorare nelle sale di Galleria Borghese, e dalle lettere di quei giorni si evince che continuava a mantenere un buon rapporto con Armando Spadini26. Nel carteggio parla dei mesi estivi di quell’anno come un periodo di lavoro impegnativo e incessante27. In questo lasso di tempo, il confronto con gli antichi non deve essere passato solo attraverso la riflessione sul Gentiluomo di Lorenzo Lotto, ma anche tramite un generale studio della collezione della Galleria: il riferimento a opere specifiche ritornerà infatti negli scritti del pittore nel corso degli anni successivi28. Del resto, ad Antonia Bolognesi egli parlò di «copie dei quadri antichi», espressione dietro la quale si potevano celare anche studi, schizzi e disegni, che però non ci sono pervenuti29. Nel 1973, l’artista raccontò in un’intervista che a Roma aveva realizzato una copia di un dettaglio di Amor sacro e Amor profano di Tiziano30 . Si possono inoltre cogliere riferimenti puntuali alla Galleria anche all’interno della produzione letteraria degli anni romani del pittore, come alcuni suoi testi programmatici pubblicati sulle riviste dell’epoca, prima fra tutte «Valori Plastici» Qui diede alle stampe nel 1921 una delle più profonde meditazioni condotte sulla pittura del passato, ovvero La mania del Seicento, dove la Galleria pinciana viene evocata per la sua collezione caravaggesca, da cui emerge un’aspra critica al maestro lombardo:
Caravaggio è il pittore che gl’inneggiatori al Seicento tiran in ballo più spesso e volentieri, cercando di trovare nella sua pittura una giustificazione all’esagerato panegirico che fanno di quella dei suoi più o meno contemporanei. A noi non sembra che il Caravaggio meriti tante lodi; in un secolo in cui il senso del mestiere non era totalmente perduto come lo è oggi, non è un miracolo vedere nascere dei quadri come quelli lasciatici da Michelangelo Merisi […] basta guardare quelle quattro tele della galleria Borghese, con quel San Girolamo microcefalo, e quel San Giovanni e quel Davide decollatore, che potrebbero anche essere firmati: Léon Bonnat31
La valutazione sulla pittura di Caravaggio e più in generale del Seicento nell’ambiente artistico italiano di quegli anni non era certo univoca, così come non lo era quella nei confronti degli artisti contemporanei che venivano associati, per ispirazione e influenza, al secolo del Barocco32
26 In una lettera del 28 luglio 1919 a Antonia Bolognesi, l’artista scrive: «Nel mio lavoro sono anche aiutato dal tempo che si è rinfrescato; così che mi affatico meno a lavorare nelle ore pomeridiane durante le quali faccio delle copie dei quadri antichi, nel museo di Villa Borghese» (DE CHIRICO/PONTIGGIA 2018, p. 247). Inoltre, il giorno successivo, si confida con Olga Signorelli: «L’idillio con Spadini fila a gonfie vele» (ibidem). Il fondamentale carteggio del 1919 tra De Chirico, a Roma, e Antonia Bolognesi, rimasta a Ferrara, è pubblicato anche in BOLOGNESI 2015
27 Nella stessa lettera di cui sopra, indirizzata a Olga Signorelli, De Chirico scrive: «Sono preso da una vera febbre di lavoro e dall’inquietudine e la volontà di migliorare» (DE CHIRICO/PONTIGGIA 2018, p. 247).
28 De Chirico, nei suoi scritti, non spenderà parole di riguardo per la Caccia di Diana di Domenichino, davanti alla quale dichiara di aver sentito «orrore e compassione», né per le tele di Jacopo Bassano: «pitture che, inquinate dall’uso del blu di Prussia, hanno ormai assunto l’aspetto di paesaggi polari a mezzanotte» (DE CHIRICO 2023b, pp. 319-320).
29 DE CHIRICO/PONTIGGIA 2018, p. 247
30 Intervista a Giorgio de Chirico a cura di Franco Simongini andata in onda il 3 aprile 1974 e pubblicata in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 2371-2387 (cfr. in particolare p. 2386)
31 DE CHIRICO 1921, p. 62. Il riferimento a Léon Bonnat in senso dispregiativo era probabilmente dovuto all’uso frequente del fondo scuro da parte del pittore francese, nonché al suo essere rappresentante di un certo accademismo tardo-ottocentesco. Nel 1919 De Chirico stava rivolgendo il suo interesse anche verso Gustave Courbet, al quale dedicherà poi una monografia nel 1925 nelle edizioni di «Valori Plastici» (cfr. DE CHIRICO 1925).
32 La bibliografia sul tema è molto vasta; si rimanda in particolare ai seguenti contributi: MAZZOCCA 1975; NOVECENTO SEDOTTO 2010; SIMONATO 2018; MOURE CECCHINI 2022
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
Tra questi figurava spesso lo stesso Armando Spadini33 . È però indubbio che, nonostante la netta critica espressa da De Chirico su «Valori Plastici», negli stessi anni egli si interessasse alla natura morta del XVII-XVIII secolo, della quale si può trovare un’eco, ad esempio, nella Natura morta con le zucche, che portò a termine proprio nel 1919 e che presenta similitudini con esempi sei-settecenteschi come la Natura morta di Pietro Navarra, oggi conservata presso i Musei Vaticani34. Se una completa rivalutazione di Caravaggio e delle sue opere alla Galleria Borghese avverrà solo successivamente35, è però probabile che De Chirico fosse interessato già nel 1919 all’opera di Rubens, pittore che diverrà un riferimento importante nella sua carriera36. In tal senso si può forse cogliere un omaggio al rubensiano Compianto su Cristo morto del museo Borghese (Fig. 4)37 in particolare nella disarticolazione del braccio della Pietà scultorea realizzata negli anni Quaranta e oggi conservata al museo udinese di Casa Cavazzini (Fig. 5).
Già Maurizio Fagiolo dell’Arco metteva in relazione diretta la copia realizzata da De Chirico in Galleria Borghese del volto dell’uomo barbuto di Lorenzo Lotto – nonché il coevo studio della ritrattistica rinascimentale e barocca – con la produzione di autoritratti che l’artista avrebbe portato avanti negli anni successivi38. Del resto, non era certo casuale la scelta di copiare il ritratto di un pittore quale Lotto, la cui opera è densa di significati e di rappresentazioni allegoriche e simboliche, ricordate dallo stesso De Chirico nelle memorie relativamente alla presenza di san Giorgio e il drago all’interno dell’opera della Galleria Borghese39. Tale scelta sembra in effetti preludere a quel clima di autorappresentazione come pictor classicus che verrà portato a trattazione teorica nel celebre ‘manifesto’ del «ritorno al mestiere», pubblicato sempre su «Valori Plastici» alla fine dello stesso anno40. L’opera di Lotto forse colpì De Chirico anche per motivi iconografici e autobiografici, vista l’appartenenza del padre all’Ordine di San Giorgio e la fascinazione che il motivo di san Giorgio e il drago ebbero nel corso della sua carriera41 . In ogni caso, la copia del Lotto Borghese costituì solo l’inizio di una pratica che l’artista portò avanti per il resto della sua vita. Copiare le opere del passato, studiando nel dettaglio anche le tecniche di realizzazione, occupò infatti una parte importante della sua continua sperimentazione artistica e affermazione come pittore. Il 1919, in tal senso, costituì un anno di svolta42. Nel 1920 egli realizzerà anche una copia de La Muta di Raffaello, conservata presso la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, e, tre anni dopo, sempre da Raffaello copierà La
33 È lo stesso fratello di De Chirico, Alberto Savinio, ad associare al colore e alla stesura pittorica seicentesca la pittura di Spadini. Cfr. SAVINIO 1922, p. 209.
34 Solo un anno dopo, però, nel recensire una mostra di Ardengo Soffici a Firenze, il pittore criticò fortemente il ricorso al genere della natura morta da parte dei pittori moderni. Cfr. DE CHIRICO 1920
35 Contrariamente a De Chirico, nel 1919 Giuseppe Raimondi aveva pubblicato un testo su Caravaggio ne «La Ronda» che doveva aver anche influenzato Giorgio Morandi, interessato in quegli stessi anni al grande maestro lombardo. Cfr MARANGON 2001
36 Il fascino di De Chirico per Rubens era già stato sottolineato da Maurizio Fagiolo dell’Arco dopo una visita postuma all’atelier del pittore, nel 1985. Di per sé, ciò costituisce davvero un fatto significativo ed eccentrico rispetto a tutti gli altri artisti, che leggeranno nel Seicento solo la linea apprezzata da Roberto Longhi (Caravaggio, Poussin e Velasquez). Cfr. PILLON 1991, p. 17.
37 M. Massimo, scheda n. V.1 (Peter Paul Rubens, Compianto sul Cristo morto), in IL TOCCO DI PIGMALIONE 2023, pp 154-155.
38 FAGIOLO DELL’ARCO 1984
39 «Ci fermammo davanti al quadro di Lorenzo Lotto che io volevo copiare e che raffigurava un gentiluomo barbuto e vestito di nero. Il professore Cantalamessa mi disse che quel gentiluomo si doveva chiamare Giorgio, perché dietro, nel fondo, si vedeva un san Giorgio a cavallo nell’atto di trafiggere con la sua lancia il drago» (DE CHIRICO 1945, p. 50).
40 Si vedano in merito VACANTI 2006 e DE CHIRICO 1919
41 «Mio padre che durante tutto quel triste periodo si era prodigato con ogni mezzo per salvare il materiale della ferrovia, dopo che i turchi si furono ritirati, fu decorato con l’ordine di San Giorgio per l’intervento personale del re Giorgio di Grecia» (DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, p. 1272).
42 Cfr. I d’après dai grandi maestri, in DE CHIRICO E IL MUSEO 2008, pp. 83-100
Studi di Memofonte 34/2025
Gravida di Palazzo Pitti43. Queste ulteriori prove di copia dall’antico confermano l’interesse del pittore per il ritratto cinquecentesco, che accomuna tutte le opere citate. Al di là del motivo dello studio e della copia, le sale della Galleria diventarono per gli artisti un vero e proprio luogo di incontro sociale e di confronto sulla rispettiva ricerca artistica. Per quanto riguarda la permanenza di De Chirico nel museo Borghese, si evince dal carteggio e dalle testimonianze dell’epoca che fu proprio in Galleria che conobbe Giorgio Morandi, il quale gli fu presentato nel 1919 da Giuseppe Raimondi44. Non risulta possibile ricostruire nel dettaglio la natura e le caratteristiche di questo incontro. Grazie a una lettera inviata da De Chirico ad Ardengo Soffici si è però a conoscenza dell’ottima impressione che il primo ebbe di Morandi, motivo per il quale raccomandava fortemente all’amico di conoscerlo45. Non sembra però che i loro percorsi, incrociatisi fisicamente tra le mura del museo Borghese, portassero a una comunione di intenti o a una visione pienamente condivisa della collezione del museo e della pittura del passato. D’altronde, la distanza tra i due artisti appare maggiore rispetto alle caratteristiche in comune anche nella stessa ‘fase metafisica’, da loro percorsa separatamente negli anni precedenti con esiti profondamente diversi. Si può però affermare che anche Morandi si mostrò sicuramente interessato alla riscoperta degli antichi maestri, il che si può spiegare anche dalla vicinanza all’ambiente di Valori Plastici e dall’influenza di Vincenzo Cardarelli e degli intellettuali de «La Ronda»46 . Un secondo incontro che sicuramente si svolse in Galleria è raccontato dallo stesso De Chirico, il quale ricorda di aver rivisto lì Felice Carena:
Da molti anni conoscevo Felice Carena. Lo ricordo a Roma, dopo la prima guerra, quando io copiavo opere di Maestri antichi al Museo di Villa Borghese. Ci s’incontrava sovente e si parlava di pittura; anche Lui amava e studiava i Maestri antichi. Poi lo rividi a Firenze, nella sua Villa di San Domenico e finalmente a Venezia47 .
Possiamo supporre che queste conversazioni «di pittura» fossero anch’esse avvenute in quei giorni del 1919, sebbene non venga menzionata una data precisa. Un interesse comune nei confronti della pittura veneta del Rinascimento e di Tiziano si può sicuramente riscontrare in alcune delle opere più note di Carena degli anni del primo dopoguerra, tra cui La quiete del 1921 (Fig. 6)48. Per tale motivo, un incontro fra De Chirico e Carena nella sala della Galleria Borghese dedicata ai pittori veneti ci ricorda a maggior ragione la fortuna riscossa proprio da quelle opere del museo, tra cui senza alcun dubbio i capolavori di Tiziano.
Come già accennato, oltre all’incontro con Carena e Morandi, De Chirico stabilì un rapporto costante con Armando Spadini che andava ben al di là del contesto della Galleria. Ma questa relazione di amicizia non bastò a risparmiare il pittore fiorentino dalle pesanti critiche dechirichiane49 . Tuttavia De Chirico in quegli anni spendeva, su Spadini, parole soprattutto
43 FAGIOLO DELL’ARCO 1980, pp. 48-50.
44 DE CHIRICO/PONTIGGIA 2018, p. 253. L’incontro avvenne probabilmente nei primi giorni di agosto, in quanto in una lettera del 15 di quel mese Giuseppe Raimondi chiede all’amico Morandi un riscontro sull’incontro con De Chirico. Cfr. MORANDI/GIUDICI 2004, p. 18.
45 DE CHIRICO/PONTIGGIA 2018, p. 253.
46 Nelle lettere di quei mesi del 1919 Morandi menziona un interesse per Orazio Gentileschi, Caravaggio (del Bacco fiorentino richiede una riproduzione fotografica), oltre che per Masaccio e Paolo Uccello; nonché una visita agli Uffizi, avvenuta probabilmente subito dopo l’incontro con De Chirico in Galleria Borghese. Cfr. MORANDI/GIUDICI 2004, pp. 17-21.
47 DE CHIRICO 2023d.
48 Esposto alla Biennale di Venezia del 1926, il dipinto è oggi conservato alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza. Cfr. XVA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE 1926, p. 30.
49 «Spadini era un uomo pieno di temperamento, normale ed intelligente, che sentiva ed amava profondamente la pittura; egli non aveva nulla di comune con la maggior parte dei pittori di oggi che hanno un solo difetto ma grosso;
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
positive, chiamandolo, nello stesso 1919, ‘Renoir italiano’50 e dedicandogli, nel momento della morte prematura, un ricordo affettuoso e un omaggio alla carriera, per la quale si sarebbe augurato «ben altro destino»51 .
Virgilio Guidi e la Danae di Correggio
«Guidi conobbe de Chirico alla Galleria Borghese: mentre egli faceva una copia della Danae del Correggio, de Chirico lavorava nella stanza attigua intorno a due grandi ritratti di scuola veneziana; si avvicinò a de Chirico e si misero a conversare»52 . Il mercante d’arte Giorgio Zamberlan, che conosceva bene entrambi i pittori, racconta che De Chirico e Guidi si conobbero proprio alla Galleria Borghese. L’anno esatto di questo incontro non è menzionato e nell’Archivio della Galleria non si trovano riscontri al riguardo. Sia la bibliografia che i ricordi di Guidi risultano difformi53. Lo stesso pittore romano, infatti, in un’intervista del 1944 affermò: «Nel ’21 copio la Danae del Correggio. Copiava anche de Chirico. Sotto l’influenza del Correggio faccio la seconda Madre che si leva esposta nel ’22 a Venezia»54. Nonostante ciò, la menzione al fatto che Guidi lavorasse alla Danae proprio mentre De Chirico era impegnato nella sala attigua a copiare Lorenzo Lotto dovrebbe costituire una prova significativa del fatto che gli eventi in questione siano da far risalire alla stessa estate del 1919. Nel corso di tale periodo la Galleria fu molto frequentata da alcuni degli artisti più affermati dell’epoca, oltre che da figure emergenti del panorama romano. La presenza di De Chirico e Guidi all’interno del museo fu però motivata da ragioni sostanzialmente diverse. Se il primo si rivelò mosso da un desiderio di formazione personale e di ritorno a un confronto con l’arte del passato, condotto attraverso una copia di studio, alla base della scelta di Guidi vi furono essenzialmente motivi economici e di sussistenza. Più volte ricorre infatti, nel racconto biografico del pittore, il ricordo agli anni difficili del primo dopoguerra: «nel 1919 [ ] Avevo lasciato l’impiego di disegnatore al Genio Civile di Roma e non avevo soldi per pagarmi le modelle: allora, di nascosto da mio padre, facevo posare mia madre e le mie sorelle. La vita era dura»55. Fu probabilmente per questo motivo che Guidi scelse di copiare proprio la Danae di Correggio (Fig. 7), la quale era una delle opere della collezione Borghese – così come Amor sacro e Amor profano di Tiziano – che aveva goduto di più lunga fama da decenni. Visto l’alto numero di richieste di copie, spesso del solo dettaglio dei putti in basso a destra, la Danae doveva rappresentare per il pittore in precarie condizioni economiche la scelta vincente per una vendita sicura. Un’altra caratteristica che differenzia la copia dechirichiana di Lorenzo Lotto dall’opera di Guidi, oggi in collezione privata (Fig. 8), è il fatto che l’artista romano realizzò una versione della Danae assai fedele all’originale, rispettando nel dettaglio anche le dimensioni del quadro di Correggio. Ciò porta a credere o che il giovane artista avesse richiesto un permesso apposito –
quello di essere qualunque cosa fuorché pittori. I quadri di Spadini non mi sono mai piaciuti; ma nessuna pittura fatta oggi mi può piacere» (DE CHIRICO 1945, pp. 50-51).
50 «Il secondo onesto è Armando Spadini, questo Renoir dell’Italia, oggi poco più che trentenne, è già in pieno possesso di tutti i suoi mezzi d’espressione; ottimo disegnatore, colorista pieno di passione, con una sottile parabola di malinconico lirismo, esso è uno dei pochissimi pittori italiani che in questa prima metà del XX secolo lasceranno opere durature» (DE CHIRICO 2023a, p. 203).
51 DE CHIRICO 2023c
52 ZAMBERLAN 1955 (ritaglio stampa in Venezia, Archivio Storico delle Arti Contemporanee (d’ora in poi ASAC), Serie Arti Visive, Artisti, 18955, Virgilio Guidi)
53 Sia Silvio Branzi che Umbro Apollonio e Fabio Benzi riportano come data della Danae il 1921, probabilmente sulla scorta di un’indicazione di Virgilio Guidi stesso. Nonostante ciò, dalle evidenze qui considerate e seguendo il catalogo ragionato del pittore si propende a collocare la copia da Correggio nell’estate del 1919. Si vedano in proposito BRANZI 1965, p. 15; BENZI 1987; scheda 1918-1919 2, in BIZZOTTO–MARANGON–TONIATO 1998, I, p. 86.
54 CINTI 1943 (ritaglio stampa in ASAC, Serie Arti Visive, Artisti, 18955, Virgilio Guidi)
55 FABIANI 1972 (ritaglio stampa in ASAC, Serie Arti Visive, Artisti, 18955, Virgilio Guidi)
Studi di Memofonte 34/2025
oggi perduto o non ancora rintracciato all’interno della documentazione – o che si trattasse di una realizzazione su commissione56. Il formato totalmente conforme a quello correggesco permise addirittura alla Galleria Borghese di usufruire della copia di Guidi per sostituire la Danae durante la Seconda guerra mondiale57 Fu forse l’amicizia intima con Spadini, da cui ereditò lo studio all’Uccelliera nel 1925, che portò Guidi proprio alla Galleria Borghese58. Da una lettera indirizzata a Maurizio Calvesi dallo storico dell’arte Toni Toniato (genero del pittore) in occasione dell’esposizione dell’opera di Guidi nel 1984 alla mostra Arte allo Specchio (organizzata nel contesto della XLI Biennale di Venezia), si può comprendere però come la Danae, pur nel rispetto dell’originale, presentasse comunque caratteristiche proprie che avrebbero formato in futuro l’arte del pittore:
mi preme dirle però che l’opera in oggetto è in senso stretto una ‘copia’, eseguita direttamente nella Sala della Galleria Borghese, lavorando accanto allo stesso de Chirico, impegnato contemporaneamente a dipingere la copia di un altro illustre modello. In quella occasione le scelte diverse di questi due grandi artisti potrebbero spiegare molti dei loro sviluppi futuri. In ogni caso, la ‘copia’ guidiana resta più che una esplicita ‘citazione’, e tanto meno un ‘esercizio’ di perizia accademica. Pur nella evidente rassomiglianza è già possibile cogliere un ‘clima’ del tutto guidiano specie nel senso più frazionato e diffuso della luce ed insieme nell’unità mentale della sua costruzione plastica. Incredibili poi certe minime inesattezze anatomiche, rintracciabili nelle altre figure di nudi femminili, sia precedenti che posteriori a quella date della ‘copia’, ovviamente più maturi ed originali. [Mi fa piacere] segnalare la sua impronta anche in un ‘lavoro’ che per un certo periodo sostituì l’originale, durante la guerra59
Ciò che indubbiamente accomunò i due artisti fu l’impatto che l’opera studiata e copiata in Galleria Borghese ebbe sulle rispettive carriere e sullo sviluppo della loro pittura in quegli anni. Sia Guidi stesso che la critica hanno constatato infatti che la copia da Correggio fu l’inizio di una riflessione sulla luce e sulla disposizione delle figure nello spazio che avrebbe avuto un impatto immediato sulla pittura dell’artista romano60. Ciò si può sicuramente notare nell’importante opera che Guidi presentò alla Biennale di Venezia del 1922, la citata Madre che si leva (Fig. 9). Qui si rivela infatti la lezione correggesca, in particolare nella figura femminile al centro della composizione, nonché nel trattamento dei volumi e della luce sull’incarnato. Si coglie inoltre una diretta citazione nella donna che si accinge ad alzarsi dal letto, nonché nello scorcio della finestra in alto a sinistra. In una prima versione dell’opera, Madre con bimbo,
56 L’amico pittore Nino Bertoletti gli aveva consigliato una copia dall’antico proprio per la facilità di ‘piazzarla’ sul mercato. Cfr. MARANGON 1998, p. 17. Molto probabilmente, però, nel 1971 l’opera era di proprietà della figlia Vittoria Guidi, se si può definire affidabile la testimonianza di Pietro Fraccalini, che afferma di aver visto una copia di Virgilio Guidi da un quadro di Correggio molto fedele all’originale, seppur con alcuni dettagli resi in maniera più sintetica. Cfr. FRACCALINI 1971 (ritaglio stampa in ASAC, Serie Arti Visive, Artisti, 18955, Virgilio Guidi). Nel 1984, l’opera risultava invece proprietà di una collezionista romana, Luigina Calisi. Cfr. ASAC, Serie Arti Visive, Esposizioni biennali, mostre storiche e speciali, retrospettive e personali, 397, Arte allo Specchio, lista dei prestatori, 1984.
57 Purtroppo, non si è ancora riscontrata nessuna documentazione a tale proposito all’interno dell’Archivio Borghese, ancora in fase di studio. Per un approfondimento riguardo alla Galleria Borghese durante gli anni del conflitto mondiale si veda PAOLINI 2022
58 Rimane il fatto che anch’egli, come De Chirico e Morandi, era vicino all’ambiente gravitante attorno alle riviste romane, a Cardarelli e a Broglio: «In quel tempo era a Roma Armando Spadini, il quale mi stimava e in un certo senso io lo stimavo perché, in qualunque modo lo si pigli, non era un mediocre. Ma vedere affinità nella mia pittura di allora con quella di Spadini significa non avere capito che in Spadini era la luce naturalistica e in me un sentimento della luce che s’alternava tra la luce meridiana dei toscani del ’400 e la luce un po’ greve del Cinquecentismo o Seicentismo inoltrato di Roma. Sono stato vicino ai promotori dei Valori Plastici o, meglio, a lato, ma per me quello era un moto troppo teorico. In realtà non mi sentiva e non ero apparentato a nessuno» (SIMONGINI s.d., ritaglio stampa in ASAC, Serie Arti Visive, Artisti, 18955, Virgilio Guidi)
59 ASAC, Serie Arti Visive, Esposizioni biennali, mostre storiche e speciali, retrospettive e personali, 396, lettera di Toni Toniato a Maurizio Calvesi, 6 maggio 1984.
60 Si vedano ARNOVA 1937, pp. 16-17, e F Gualdoni, Virgilio Guidi, in VIRGILIO GUIDI 2002, p. 8
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
presentata alla Biennale precedente, nel 1920, lo studio su Correggio è ancora poco ravvisabile. Ciò induce a pensare che Guidi rifletté sul modello dell’opera Borghese aggiornando la composizione del proprio dipinto, la cui prima versione l’aveva lasciato insoddisfatto, tanto da tagliare in seguito egli stesso parte della tela, oggi quindi perduta nel suo aspetto originale61. È inoltre interessante notare che la ‘figura che si leva’ diventerà proprio dal 1920 in poi un’iconografia tipica dell’autore, che la trasferirà anche nei quadri più astratti successivi, mantenendo in un certo senso sotto traccia il modello correggesco nel corso della sua carriera (Fig. 10)62
Tra le opere che venivano considerate come modello fondante di una nuova pratica pittorica e di un ‘ritorno all’ordine’ non spiccava però solo la pittura rinascimentale veneta, ma iniziava a diffondersi anche una maggiore attenzione nei confronti di alcuni artisti di ascendenza caravaggesca, alla quale lo stesso Virgilio Guidi non rimase indifferente. Del resto, Fernanda Wittgens, nella presentazione della sala dedicata al pittore alla Biennale di Venezia del 1954, affermò un fatto storico comune anche ad altri artisti coevi:
Nell’iniziale periodo romano dell’artista, assistiamo ad un fatto di eccezione: il superamento dell’Impressionismo imperativo categorico per i rivoluzionari del Novecento – è raggiunto con un processo pittorico puro che prescinde dai modi correnti, futuristi, cubisti e metafisici. Guidi […] reagisce al post-impressionismo spadiniano imperante nell’arte ufficiale di Roma, con una sintesi di spazio e luce che ha un’antica ascendenza nelle esperienze del caravaggismo riformato di Orazio Gentileschi e dei suoi eredi: gli intimisti olandesi. La Donna delle uova, la Natività sono autentiche pitture di valori, ed esercitano, sul nostro spirito, la suggestione di tutte le opere novissime che recano il sigillo arcano di una tradizione63
In conclusione, gli intensi intrecci di artisti che attraversavano le sale della Galleria Borghese negli anni del primo dopoguerra ci restituiscono l’immagine di un museo che era diventato, all’altezza del 1919, una tappa imprescindibile per gli autori contemporanei, soprattutto per la ricchezza delle sue opere, dai veneti, a Caravaggio, a Rubens.
61 CINTI 1943 (ritaglio stampa in ASAC, Serie Arti Visive, Artisti, 18955, Virgilio Guidi).
62 VIRGILIO GUIDI 1991
63 WITTGENS 1954, p. 87.
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 1: Tiziano Vecellio, Amor sacro e Amor profano , 15151516, 118x278 cm, olio su tela. Roma, Galleria Borghese, inv. 147. Foto: © Galleria Borghese
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
Fig. 2: Lorenzo Lotto, Ritratto di uomo, 1530 ca, 118x105 cm, olio su tela. Roma, Galleria Borghese, inv. 185. Foto: © Galleria Borghese
Fig. 3: Giorgio de Chirico, Copia da Ritratto di uomo di Lorenzo Lotto, 1919, olio su tela Collocazione ignota (in F. Benzi, Giorgio de Chirico. La vita e l’opera, Milano 2019, p. 235)
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 4: Peter Paul Rubens, Compianto su Cristo morto, 1601-1602, 180x136 cm, olio su tela. Roma, Galleria Borghese, inv. 411. Foto: © Galleria Borghese
Fig. 5: Giorgio de Chirico, Pietà, 1940 ca, altezza 28 cm, terracotta policroma. Udine, Casa Cavazzini Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Foto: © Casa Cavazzini Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (Udine) / ERPAC Archivio Fotografico
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 6: Felice Carena, La quiete, 1921, 150x181 cm, olio su tela. Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, inv. 249. Foto: © PatER/Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi
Fig. 7: Antonio Allegri detto il Correggio, Danae, 1530-1531, 158x189 cm, olio su tela. Roma, Galleria Borghese, inv. 125. Foto: © Galleria Borghese
Fig. 8: Virgilio Guidi, Copia da Danae di Correggio, 1919 ca, 159x191 cm, olio su tela. Collezione privata. Foto: © Farsetti Arte
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 9: Virgilio Guidi, Madre che si leva, 1921, 181x151 cm, olio su tela. Collezione privata. Foto: © Archivio della Scuola Romana
Fig. 10: Virgilio Guidi, Figure nello spazio, 1947, 70x89 cm, olio su tela. Modena, Museo Civico, inv. Ser. 27. Foto: © Museo Civico di Modena
BIBLIOGRAFIA
XVA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE 1926
XVa Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1926.
ALINARI 1900
V. ALINARI, La fotografia all’Esposizione di Parigi, «Bullettino della Società Fotografica Italiana», XII, 1900, pp. 213-230.
ARMANDO SPADINI 1927
Armando Spadini, con uno studio di A. Venturi, catalogo dell’opera a cura di E. Cecchi, Milano 1927.
ARNOVA 1937
N. ARNOVA, Virgilio Guidi, New York 1937.
BARBERINI 1984
G. BARBERINI, “È nota a tutti la rovina economica che ha colpito il Principe ” 1887 - 1902: il passaggio allo Stato della Galleria Borghese, in Arte e politica artistica in Italia agli albori dello Stato unitario, numero monografico di «Ricerche di Storia dell’Arte», 23, 1984, pp. 33-44.
BENZI 1987
F. BENZI, Guidi e Roma, in Virgilio Guidi 1912-1948, catalogo della mostra, a cura di V. Sgarbi, F. Benzi, T. Toniato, Milano 1987, pp. 13-18.
BENZI 2002a
F. BENZI, Il carteggio de Chirico-Signorelli e gli esordi classicisti del pittore (1918-1919), «Metafisica», 1-2, 2002, pp. [161]-172 (disponibile on-line https://fondazionedechirico.org/wp-content/uploads/2019/06/161-172Metafisica-12-F.Benzi_.pdf).
BENZI 2002b
F. BENZI, Il carteggio de Chirico-Signorelli e gli esordi classicisti del pittore, in Nulla sine tragœdia gloria. L’opera di Giorgio de Chirico attraverso la storiografia contemporanea, atti del convegno europeo di studi (Roma 15-16 ottobre 1999), a cura di C. Crescentini, Firenze 2002, pp. 112-129.
BENZI 2019
F. BENZI, Giorgio de Chirico. La vita e l’opera, Milano 2019.
BIZZOTTO–MARANGON–TONIATO 1998
F. BIZZOTTO, D. MARANGON, T. TONIATO, Virgilio Guidi. Catalogo generale dei dipinti, I-III, Milano 1998.
BOLOGNESI 2015
E. BOLOGNESI, Alceste: una storia d’amore ferrarese. Giorgio de Chirico e Antonia Bolognesi, Falciano 2015
BRANZI 1965
S. BRANZI, Virgilio Guidi, [Ancona] 1965.
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
CARLO SOCRATE 1988
Carlo Socrate. Opere dal 1910 al 1946, catalogo della mostra, a cura di M. Quesada, Roma 1988
CINTI 1943
I. CINTI, Intervista a Virgilio Guidi, «Il Gazzettino», 11 maggio 1943
DE CHIRICO 1919
G. DE CHIRICO, Il ritorno al mestiere, «Valori Plastici», I, 11-12, 1919, pp. 15-19 (ripubblicato in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 187-192).
DE CHIRICO 1920
G. DE CHIRICO, La mostra personale di Ardengo Soffici a Firenze, «Il Convegno», I, 6, 1920, pp. 53-58 (ripubblicato in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 252-256).
DE CHIRICO 1921
G. DE CHIRICO, La mania del Seicento, «Valori Plastici», III, 1921, pp. 60-62 (ripubblicato in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 298-302).
DE CHIRICO 1925
G. DE CHIRICO, Courbet, Roma 1925
DE CHIRICO 1945
G. DE CHIRICO, 1918-1925 Ricordi di Roma, Roma 1945 (ripubblicato in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 985-1010).
DE CHIRICO 2023a
G. DE CHIRICO, La Galleria d’Arte Moderna a Roma (1919), in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 201-207.
DE CHIRICO 2023b
G. DE CHIRICO, Il monomaco parla (1922), in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, pp. 317-322.
DE CHIRICO 2023c
G. DE CHIRICO, Armando Spadini (1925), in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, p. 349.
DE CHIRICO 2023d
G. DE CHIRICO, Felice Carena (1966), in DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023, p. 1852.
DE CHIRICO/CORTELLESSA–D’ANGELOSANTE–PICOZZA 2023
G. DE CHIRICO, Scritti 1910-1978 Romanzi, poesie, scritti teorici, critici, tecnici e interviste, a cura di A. CORTELLESSA, S. D’ANGELOSANTE, P. PICOZZA, Milano 2023.
DE CHIRICO E IL MUSEO 2008
De Chirico e il museo, catalogo della mostra, a cura di M. Ursino, Milano 2008.
DE CHIRICO/PONTIGGIA 2018
G. DE CHIRICO, Lettere 1909-1929, a cura di E. PONTIGGIA, Cinisello Balsamo 2018.
DISEGNI DI ARMANDO SPADINI 1946
Disegni di Armando Spadini, presentazione di O. Vergani, Milano 1946.
FABIANI 1972
E. FABIANI, Vivrò finché non mi stanco, intervista a Virgilio Guidi, «Gente», 2 settembre 1972.
FAGIOLO DELL’ARCO 1980
M. FAGIOLO DELL’ARCO, Giorgio de Chirico. Il tempo di “Valori plastici” 1918/1922, Roma 1980.
FAGIOLO DELL’ARCO 1984
M. FAGIOLO DELL’ARCO, De Chirico al tempo di “Valori Plastici”. Note iconografiche, documenti inediti, in Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, I-II, Milano 1984, II, pp. 916-923.
FAGIOLO DELL’ARCO 1995
M. FAGIOLO DELL’ARCO, I funerali di Spadini: la fine di un mondo, in Armando Spadini 1883-1925. Tra Ottocento e Avanguardia, catalogo della mostra, a cura di M. Fagiolo dell’Arco, Milano 1995, pp. 174-181.
FRACCALINI 1971
P. FRACCALINI, Virgilio Guidi a Bologna, bilancio di una vita dedicata all’arte, «La Gazzetta di Mantova», 19 novembre 1971
IL TOCCO DI PIGMALIONE 2023
Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma, catalogo della mostra, a cura di F. Cappelletti, L. Simonato, [Roma] - Milano 2023.
MARANGON 1998
D. MARANGON, Il periodo romano, in BIZZOTTO–MARANGON–TONIATO 1998, I, pp. 11-25.
MARANGON 2001
D. MARANGON, Guidi e La Ronda, in Virgilio Guidi, atti del seminario (Venezia 29 novembre 2000), a cura di G. Dal Canton, Venezia [2001], pp. 41-54.
MATITTI–FAGIOLO DELL’ARCO 1994
F. MATITTI, M. FAGIOLO DELL’ARCO, Armando Spadini Al tempo di “Valori Plastici” 1918-1925, catalogo della mostra, a cura di F. Mattiti, M. Fagiolo dell’Arco, Roma 1994.
MAZZOCCA 1975
F. MAZZOCCA, La mostra fiorentina del 1922 e la polemica sul Seicento, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, V, 1975, pp. 837-901.
MORANDI/GIUDICI 2004
G. MORANDI, Lettere, a cura di L. GIUDICI, con uno scritto di R. Longhi, Milano 2004.
MOURE CECCHINI 2022
L. MOURE CECCHINI, Baroquemania: Italian Visual Culture and the Construction of National Identity 1898-1945, Manchester 2022.
Incontri in Galleria Borghese: il museo e gli artisti nel primo dopoguerra
NOVECENTO SEDOTTO 2010
Novecento sedotto. Il fascino del Seicento tra le due guerre, catalogo della mostra, a cura di A. Mazzanti, L. Mannini, V. Gensini, Firenze 2010.
PAOLINI 2022
C. PAOLINI, Aldo de Rinaldis e la Galleria Borghese, in Arte liberata. Capolavori salvati dalla guerra 1937/1947, catalogo della mostra, a cura di L. Gallo, R. Morselli, Milano 2022, pp. 256-265.
PILLON 1991
G. PILLON, De Chirico e il fascino di Rubens, Roma 1991.
SAVINIO 1922
A. SAVINIO, Armando Spadini, in La Fiorentina Primaverile, catalogo della mostra, Roma 1922, pp. 209-210.
SIMONATO 2018
L. SIMONATO, Bernini scultore. Il difficile dialogo con la modernità, Milano 2018.
SIMONGINI s.d.
F. SIMONGINI, Virgilio Guidi: un figlio del secolo che ha rimesso tutto in gioco, «Il Tempo», [s.d.].
VACANTI 2006
S. VACANTI, Giorgio de Chirico e il “ritorno al mestiere”. L’importanza della formazione artistica tra Atene e Monaco, «Metafisica», 5-6, 2006, pp. 404-432 (disponibile on-line https://fondazionedechirico.org/wp-content/uploads/2019/06/404-432Metafisica-56-S.Vacanti.pdf).
VENTURI 1921
A. VENTURI, Guida alle Gallerie di Roma. (Per i suoi allievi di storia dell’arte), a cura della Corporazione Universitaria Romana, Roma 1921.
VIRGILIO GUIDI 1991
Virgilio Guidi, catalogo della mostra, a cura di M. Rosci, Milano 1991.
VIRGILIO GUIDI 2002
Virgilio Guidi. I colori della luce, catalogo della mostra, a cura di F. Gualdoni, E. Di Martino, T. Toniato, Cortina d’Ampezzo 2002.
WITTGENS 1954
F. WITTGENS, Virgilio Guidi, in XXVII Biennale di Venezia, catalogo della mostra, Venezia 1954, pp. 87-89.
ZAMBERLAN 1955
G. ZAMBERLAN, Il commerciante in camera. Ricordi di un mercante di quadri, «Il Mondo», 19 luglio 1955.
ABSTRACT
La Galleria Borghese nel primo dopoguerra venne ad assumere un ruolo centrale come luogo di formazione, incontro e scambio tra artisti. Attraverso le esperienze di Giorgio de Chirico, Virgilio Guidi, Armando Spadini e Giorgio Morandi si può capire come il museo romano abbia rappresentato un fondamentale punto di riferimento per lo studio degli antichi maestri. De Chirico, in particolare, raccontò di una ‘grande rivelazione’ davanti a un dipinto di Tiziano, episodio che segnò una svolta nella sua carriera. Questo evento, accompagnato dalla decisione di copiare il Ritratto di gentiluomo di Lorenzo Lotto, riflette il profondo interesse del pittore per l’arte del passato, da cui trasse ispirazione per il suo percorso artistico.
Nello stesso periodo la Galleria Borghese fu frequentata anche da altri artisti, che realizzarono diverse copie dei dipinti della collezione. Tra questi, Virgilio Guidi dipinse una versione, fedele all’originale, della Danae di Correggio. In questo caso si avverte come le copie non costituissero solo un oggetto di vendita e sicuro guadagno economico, ma soprattutto occasioni di riflessione e formazione personale sull’arte del passato. Infine, l’analisi dei rapporti tra gli artisti e le opere della Galleria evidenzia l’importanza del museo come spazio di dialogo e confronto che influenzò profondamente l’arte italiana del XX secolo.
In the first post-World War period, the Galleria Borghese assumed a central role as a place for artistic training, interaction, and exchange among artists. Through the experiences of Giorgio de Chirico, Virgilio Guidi, Armando Spadini, and Giorgio Morandi, it becomes evident that the Roman museum served as a fundamental reference for the study of old masters. De Chirico, in particular, spoke of a ‘great revelation’ in front of a painting by Titian, an episode that marked a turning point in his career. This event, coupled with his decision to copy Lorenzo Lotto’ s Portrait of a Gentleman, reflects the painter’s profound interest in the art of the past, which greatly influenced his artistic journey.
During the same period the Galleria Borghese was also frequented by other artists, who produced various copies of the collection’s paintings. Among them, Virgilio Guidi painted a faithful version of Correggio’ s Danae. In this context, it is evident that copies were not merely objects for sale and a secure economic gain, but above all valuable opportunities for personal reflection and learning about historical art. Finally, the analysis of the relationships between artists and the Galleria’s works highlights the importance of the museum as a space for dialogue and exchange that profoundly influenced twentieth-century Italian art.
LA DISMISSIONE DELLA «VILLA REALE» DI CASTELLO
DALLA CORONA ALLO STATO ITALIANO.
DINAMICHE POLITICHE, ECONOMICHE E CULTURALI DI UNA TRANSIZIONE
PATRIMONIALE ALL’INDOMANI DELLA GRANDE GUERRA (1919-1928)
Nel 1938 usciva, per la collana Itinerari dei musei e monumenti d’Italia, la guida a cura di Arturo Jahn Rusconi dedicata alle Ville Medicee1 . Il critico d’arte prendeva in esame quei palazzi e giardini storici di Firenze o limitrofi alla città che, da circa un ventennio, erano stati ceduti dalla Reale Casa allo Stato in base ai RR.DD. 1792 e 2578 del 19192. Entrambi i provvedimenti erano stati considerati come una ricompensa «per i sacrifici fatti da tutti in battaglia per il bene supremo della nazione»3, come sottolineava il presidente del Consiglio dei Ministri Francesco Saverio Nitti, l’11 settembre 1919, leggendo la lettera di Vittorio Emanuele III indirizzata alla Camera dei Deputati il 21 agosto dello stesso anno4
L’agile guida di Rusconi, la cui breve narrazione era accompagnata da un ricco corredo iconografico di 79 immagini (Fig. 1), introduceva il lettore alla scoperta delle Ville di Petraia, Poggio a Caiano e dei Giardini di Boboli e Castello, tralasciando per queste ultime le rispettive residenze. Se Palazzo Pitti e in particolare le sue collezioni erano state già ampiamente illustrate in tre numeri precedenti della stessa collana5, la Villa di Castello non solo aveva perso il proprio status di residenza reale ma, all’indomani del primo conflitto bellico, il giardino era stato dichiarato monumento nazionale, mentre il pregevole edificio architettonico di epoca rinascimentale aveva cambiato destinazione d’uso.
La maggior parte degli ambienti era stata adibita ad aule scolastiche: «solo alcune sale –ricordava Rusconi – sono rimaste, e sono destinate ad ospitare la mostra storica del giardino italiano che si sta attualmente ordinando»6. L’accenno alludeva ai lavori, mai portati a termine, di allestimento delle opere che alcuni anni prima erano state esposte in occasione della prima mostra storica sul giardino italiano tenutasi nel 1931 a Palazzo Vecchio a cura di Ugo Ojetti7 .
Se vogliamo quindi scoprire quale fosse il volto della Villa di Castello prima della guerra e approfondire lo studio delle collezioni ospitate all’interno delle sale, dobbiamo affidarci in primo luogo agli ultimi inventari storici redatti nel 1911 dal Ministero della Real Casa, che
Si ringrazia il personale dell’Archivio Centrale dello Stato, dell’Archivio Storico delle Gallerie degli Uffizi e della Biblioteca Medicea Laurenziana. Il saggio è stato in parte presentato da chi scrive in occasione del convegno internazionale A Princely Education. Cosimo III de’ Medici’s travels through the Netherlands: global ambitions and local contexts (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte, Accademia della Crusca, 6-8 novembre 2019), a cura di A. Cattaneo, S. Corbellini, M.W. Kwakkelstein.
1 JAHN RUSCONI 1938.
2 Il R.D. 1792 del 3 ottobre 1919 regolamentava le modificazioni alla dotazione della Corona e al riordinamento del patrimonio artistico nazionale. Il successivo (n. 2578), datato 31 dicembre, distingueva quali fra questi beni dovessero essere riconsegnati al demanio e quali sarebbero stati ceduti all’Opera Nazionale dei Combattenti, nello specifico le rendite produttive.
3 FAILLA–GORIA 2017, p. 73.
4 Cfr. anche FAILLA 2015 e 2018, pp. 36-53.
5 Più precisamente TARCHIANI 1934; JAHN RUSCONI 1934 e 1935
6 JAHN RUSCONI 1938, p. 9.
7 MOSTRA DEL GIARDINO ITALIANO 1931. Tra queste opere si conservavano anche gli otto celebri modellini, veri e propri diorami, esposti nel Salone dei Cinquecento che dovevano raccontare l’evoluzione del giardino all’italiana dalle origini classiche fino all’Ottocento romantico. Con l’abbandono del progetto museografico, i materiali della mostra, tra cui i celebri diorami, furono in parte trasferiti alla Villa medicea della Petraia dove si conservano tuttora.
fotografano la consistenza, la distribuzione e la destinazione d’uso nei diversi ambienti delle opere d’arte e dei ricchi apparati di arredo che vi erano esposti8
Inoltre, è possibile affiancare agli inventari alcuni strumenti bibliografici, tra cui ad esempio il primo volume del celebre testo Palazzi e ville reali d’Italia, curato da Michele De Benedetti insieme ai Fratelli Alinari (Fig. 2), uscito proprio nel 1911 con l’intento di far conoscere questa «maraviglia di edifici, di raccolte d’arte e di bellezze naturali […] sconosciuta», come sottolineava Corrado Ricci nella prefazione9. Oltre a evocare le celebri pitture andate perdute di Pontormo e di Allori, De Benedetti si soffermava sulla decorazione pittorica superstite del Volterrano nella sala soprannominata all’epoca della ‘guardia degli Staffieri’ e sul prezioso arredamento risalente ancora agli anni di Firenze Capitale, quando a Castello erano confluiti mobili, oggetti preziosi, porcellane, tappeti e tessuti pregiati provenienti dagli ex Stati preunitari, soprattutto da Modena, Lucca, Siena e Livorno10. Tra i capolavori che l’autore segnala all’attenzione del lettore si annoverano: la collezione di nature morte di Bartolomeo Bimbi, da lui attribuita erroneamente al periodo di Cosimo II, ospitata nel salone principale; tre pannelli dipinti di epoca trecentesca non identificati; una Sacra Famiglia attribuita alla scuola di Filippo Lippi; quattro piccoli bassorilievi in terracotta settecenteschi raffiguranti le allegorie delle stagioni; un ritratto del bibliotecario di Cosimo III Antonio Magliabechi; infine, una «interessante raccolta di quadretti di scuola russa dei secoli XV e XVI rappresentanti immagini religiose»11 che soltanto qualche anno prima, nel 1906, nella seconda edizione della guida I dintorni di Firenze, Guido Carocci aveva segnalato come opere non particolarmente significative, «dono forse di qualche sovrano alla corte Toscana»12 .
Questa raccolta di opere d’arte e di arredi, a distanza di qualche anno a causa dello scoppio della Prima guerra mondiale, andrà incontro a vicende che ne comprometteranno l’integrità anche sotto il profilo conservativo. Tra il 1915 e il 1920, infatti, anche la Villa medicea di Castello (unico edificio a Firenze) viene scelta fra quelle residenze che avrebbero dovuto testimoniare il concreto contributo e l’impegno della famiglia reale alla causa della Grande Guerra, così come il Quirinale, la Casina di Caccia di Stupinigi e la Villa Margherita.
La decisione di trasformare la Villa di Castello in un ospedale militare, escludendo le altre residenze di corte fiorentine, probabilmente venne presa sulla base di più fattori. In primo luogo, potrebbe essere stata valutata in modo vantaggioso la sua posizione strategica, abbastanza vicina al centro storico fiorentino e alle principali vie di comunicazione per Bologna e, più in generale, verso l’Italia settentrionale. Inoltre, rispetto agli ambienti più monumentali di Palazzo Pitti, nell’opinione pubblica locale era ancora molto diffusa fra i cittadini fiorentini, ma soprattutto tra gli abitanti del quartiere di Castello, l’immagine della villa come buen ritiro dove i reali erano soliti rifugiarsi lontano dai palazzi ufficiali e dagli impegni istituzionali di corte. Nella sua guida aggiornata del 1906, Carocci le affidava ancora l’appellativo di «Villa Reale» prescelta dai sovrani durante un soggiorno a Firenze, in ricordo del quale i cittadini del quartiere avevano provveduto a far realizzare nel 1904 «un elegante monumento alla memoria di Re Umberto che sposo di Margherita di Savoja aveva fatto sosta a questa villa prima del suo solenne ingresso in Firenze»13
8 Firenze, Archivio Storico delle Gallerie degli Uffizi (d’ora in poi ASGU), Inventario Oggetti d’Arte della Real Villa di Castello, 1911; ASGU, Inventario mobili Real Villa di Castello, 1911.
9 RICCI 1911, in particolare p. 11.
10 Per un più ampio inquadramento storico sugli allestimenti avvenuti nelle residenze reali toscane negli anni di Firenze capitale si vedano COLLE 2015, e RUSSO 2017, a cui si rimanda per la bibliografia specifica di riferimento. Sulle vicende storiche, relative in particolare al periodo mediceo, della Villa di Castello rimane ancora fondamentale il volume di ACIDINI–GALLETTI 1992, in particolare pp. 13-65.
11 DE BENEDETTI 1911, pp. 181-185.
12 CAROCCI 1906, p. 288.
13 Si tratta del busto in bronzo opera di Odo Franceschi collocato di fronte all’ingresso principale nel piazzale antistante la villa. Il busto si conserva ancora oggi all’interno della Villa di Castello, attualmente affidata in gestione all’Accademia della Crusca. Cfr. ibidem
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928) 193
Studi di Memofonte 34/2025
Come avvenne anche altrove, il cambiamento di destinazione d’uso comportò non poche conseguenze sul piano architettonico e conservativo: basti pensare all’adeguamento delle sale in luoghi di ricovero per ospitare i malati e i feriti di guerra e al trasferimento di tutti gli arredi in alcune stanze, adattate a depositi di fortuna senza criteri di ordinamento particolari.
I mobili della Real Villa di Castello – osservava il Direttore provinciale della Real Casa in occasione di un sopralluogo – sono sparsi in diversi locali, dal pianterreno alle soffitte. In un locale al pianterreno sono riuniti, in parte, i mobili che non vennero dati in uso allo Ospedale come in parte ve ne sono in un salone al primo piano e nelle soffitte14
Una situazione caotica che sembra aggravarsi con la devoluzione dei beni della Corona allo Stato all’indomani della promulgazione dei regi decreti del 1919. Entrambi i provvedimenti legislativi andavano a toccare interessi patrimoniali importanti fomentando a livello nazionale lo scontro politico fra chi considerava questa operazione una straordinaria opportunità di arricchimento per le casse dello Stato gravemente impoverite dopo i sacrifici della guerra, elogiando il gesto magnanimo del sovrano, e chi invece non esitava a esprimere piena condanna, intravedendo una complessa manovra immobiliare architettata per liberare la Real Casa dai passivi accumulati negli anni per la gestione di un simile patrimonio15
Maggiore preoccupazione, con l’inevitabile strascico di polemiche riportato dalle principali testate locali e nazionali, sembra destare il destino a cui sarebbero andati incontro i molti arredi delle residenze di corte, tra cui anche quelli presenti nelle sale monumentali di Palazzo Pitti, che rischiavano di essere dispersi, trafugati o distribuiti fra varie sedi istituzionali, come sottolineava un articolo apparso sul quotidiano «L’Azione» nel 1922.
I vandalismi compiuti a Firenze nel 1864 e a Roma nel 1870 nella furia di adattare edifici storici ad uffici si sono rinnovati quando la burocrazia ha potuto mettere le mani sulle regge italiane, adattare ambienti, saccheggiare mobili e arazzi. Ecco il male, a cui urge porre riparo finché è ancora possibile. Tornino o non tornino al re i palazzi su cui le vecchie dinastie hanno lasciato un’orma non ingloriosa, quel che preme è che essi siano considerati quali esemplari preziosi di una storia e di un’arte passata che vanno tenuti un po’ meglio a disposizione del pubblico, un po’ meno alla mercé della burocrazia civile o, peggio, militare16 .
I nove verbali redatti per la ‘retrocessione’ della Villa di Castello, a partire dal 20 febbraio 1920 fino al 27 ottobre 1924, permettono solo in parte di comprendere il complesso iter burocratico innescato dai regi decreti17. Maggiori elementi emergono dal fitto scambio di relazioni, comunicazioni private e istituzionali, che copre un arco temporale di circa un decennio (dal 1919 al 1928), conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma. I documenti, ritrovati da chi scrive e rimasti finora inediti negli studi dedicati alla Villa medicea di Castello e alle vicende del suo patrimonio storico-artistico, gettano nuova luce su una fase storica ancora poco indagata, oltre a essere un ’importante testimonianza. In particolare, dalla lettura delle carte è possibile ricostruire i rapporti intercorsi tra il Ministero della Real Casa per il tramite dell’Ufficio Provinciale di Firenze (poi trasformato in Ufficio dei Beni già appartenenti alla Corona), il Ministero delle Finanze (in particolare la Direzione Generale del Demanio in qualità di ente
14 Il direttore provinciale della Real Casa al Ministero della Real Casa, Firenze, 8 novembre 1920, in Archivio Centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 417, fasc. 1.
15 Per ulteriori riferimenti si veda FAILLA 2018, in particolare pp. 36-39.
16 PALAZZI E VILLE REALI 1922. A questo riguardo, la rassegna stampa dell’epoca è piuttosto ricca; si vedano a titolo di esempio LO SGOMBERO DI PALAZZO PITTI 1921; OLTRE IL PORTONE 1921; OJETTI 1921a; TINTI 1921; GARBASSO 1922.
17 L’incartamento è conservato in ASGU, busta Affari Generali, Posizione 12 (nn. 1-28), 1921, fasc. 7 Tenute di Castello e Petraia
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
proprietario) e il Ministero dell’Istruzione Pubblica, che, in base ai regi decreti, avrebbe assunto la responsabilità della gestione dei beni di interesse storico-artistico della Corona, avvalendosi non solo dell’aiuto delle Soprintendenze sparse sul territorio – per Firenze quella delle Regie Gallerie guidata da Giovanni Poggi –, ma anche del Sottosegretariato di Stato alle Antichità e Belle Arti, presieduto da Giovanni Rosadi e appositamente istituito dal Ministero per seguire a livello nazionale tutte le fasi riguardanti la devoluzione.
Per quanto riguarda la destinazione della villa, furono numerosi gli enti e le istituzioni, anche privati, che fecero richiesta del suo utilizzo non appena terminate le operazioni di sgombero dell’ospedale militare. Quando era ancora in corso l’iter parlamentare sullo stralcio e la restituzione al demanio delle residenze in dotazione alla Corona, già il 24 maggio 1919 un imprenditore fiorentino chiedeva la possibilità di utilizzare la Villa di Castello per la sua industria italiana di giocattoli, impiegando come operai quegli stessi militari resi invalidi dalla guerra18 Qualche giorno dopo, il 21 maggio, è la volta del Patronato delle Famiglie degli Orfani di Guerra: la loro richiesta sarà perorata mesi dopo, il 28 gennaio 1920, anche dal Ministero della Guerra con lo scopo di poter prolungare la permanenza dei militari per trasformare in modo definitivo la residenza di Castello in ospedale per gli orfani19. In contrapposizione a queste continue richieste, frutto di interessi che entravano in conflitto con le reali necessità conservative del patrimonio storico-artistico, la Società Leonardo da Vinci (fondata nel 1902 a Firenze), tra i cui iscritti c’erano numerosi esponenti dell’arte e della cultura locali20, intervenne già il 26 settembre 1919 con una lettera in cui metteva in guardia il Ministero della Real Casa sui rischi che avrebbe potuto incorrere, suggerendo una serie di proposte per la destinazione delle ville e dei palazzi fiorentini donati dalla Casa Reale alla Nazione e chiedendo che «il Giardino di Castello, il salone di Poggio a Caiano cogli affreschi del Pontormo e di Andrea del Sarto, il cortile della Petraja cogli affreschi del Volterrano si mantengano con le debite norme, al pubblico godimento»21 . Il riferimento al solo Giardino monumentale di Castello anticipa quanto verrà sancito nel decreto presidenziale del 30 aprile 1920 n. 882, apparso sulla «Gazzetta Ufficiale» il 16 giugno dello stesso anno (n. 141), in cui si faceva riferimento, non solo ai beni retrocessi della Corona che sarebbero transitati dal Demanio al Sottosegretariato di Stato alle Antichità e Belle Arti, ma anche alla destinazione per ciascuno di essi. Se Palazzo Pitti, con il Giardino di Boboli, doveva diventare una sorta di museo delle arti applicate, le Scuderie Reali erano state assegnate alla Scuola di Arti Decorative; Villa La Petraia avrebbe mantenuto il suo status di monumento nazionale, mentre la Villa medicea di Castello sarebbe stata ceduta al Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi di Guerra, venendo incontro a una richiesta già trasmessa qualche mese prima dallo stesso Comitato all’attenzione del ministro della Real Casa, il 28 febbraio 1920.
18 La fabbrica si sarebbe chiamata «Industria italiana del giocattolo O. Pasini & C.» Si veda la lettera di Oddone Pasini al Ministero della Real Casa, Firenze, 24 maggio 1919, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1866-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 416, fasc. 1 Dotazione Corona.
19 In sostituzione della richiesta avanzata in precedenza, che proponeva la costituzione dell’Ospedale Militare Centrale di Firenze, si veda la lettera del ministro della Guerra al ministro della Real Casa, Roma, 28 gennaio 1920, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1866-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 412, fasc. 9. Si veda anche la richiesta del ministro della Real Casa al Patronato delle Famiglie degli Orfani dei Morti in Guerra, Roma, 21 maggio 1919, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1866-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 416, fasc. 1 Dotazione Corona. La nota del ministro della Real Casa anticipa la richiesta del Patronato inviata da Firenze, 15 maggio 1922, ibidem
20 Sulla storia della Società leonardiana si vedano ORVIETO/MAGGI 2007 e LA SOCIETÀ “LEONARDO DA VINCI” 1917.
21 Lettera della Società Leonardo da Vinci, a firma del presidente Antonio Garbasso e del segretario Piero Noselli, al ministro della Real Casa, Firenze, 26 settembre 1919, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1866-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 416, fasc. 1 Dotazione Corona
Studi di Memofonte 34/2025
Avendo questo ministero d’accordo con quello della P.I. riconosciuto che il Comitato fiorentino per l’assistenza ai ciechi di guerra, cui con decreto presidenziale 30 aprile u.s. è stata assegnata in uso la Villa di Castello, ha la disponibilità permanente dei mezzi necessari per sostenere gli oneri ricadenti sulla Villa predetta, compresi della manutenzione e del pagamento delle imposte, che ha legalmente deliberata l’iscrizione in bilancio delle somme all’uopo occorrenti e che infine, i locali assegnati non sono eccedenti al fine specifico che il Comitato si propone, occorre far luogo alla consegna al detto Comitato della Villa suindicata22
A questa data occorre far risalire la cesura, mai più risanata, tra la villa e il suo giardino. Mentre quest’ultimo avrebbe continuato a mantenere il suo carattere monumentale sotto il controllo della Soprintendenza e del Ministero dell’Istruzione Pubblica, la residenza si avviava verso un destino completamente differente23 .
La dismissione della residenza reale innescò inevitabilmente un’accelerazione del processo sia di riassegnazione del complesso monumentale al nuovo istituto sia di dispersione dei suoi preziosi arredi. Tuttavia, due anni più tardi il Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi di Guerra decise di rinunciare alla sede prestigiosa per i costi eccessivi che avrebbe comportato la sistemazione dei locali abbandonati in una condizione che era stata ritenuta «deplorevole» per lo stato in cui si trovavano i pavimenti e le pareti dei numerosi quartieri dopo l’occupazione militare24
Per comprendere quali fossero le condizioni conservative in cui versavano dopo sei anni di occupazione militare, è possibile fare riferimento alla relazione compilata il 30 maggio 1921 dal direttore provinciale della Real Casa per il ministro. Mentre per le opere e gli oggetti d’arte più preziosi, che sarebbero stati trasferiti di lì a breve dalla Soprintendenza a Firenze, era stato individuato un ambiente chiuso situato al primo piano, separato con un divisore in legno dalla zona occupata dai militari, per gli altri arredi, di uso comune ma altrettanto preziosi, come i tappeti e le porcellane, la forte umidità, la polvere e le condizioni poco igieniche in cui erano stati ammassati avevano provocato gravi danni e alimentato la proliferazione dei tarli.
Molti mobili, ad esempio, si presentavano con le impiallacciature distaccate o alcune parti completamente ammuffite; altri ancora erano stati giudicati irrecuperabili perché ormai ridotti in frammenti.
[…] Intanto i mobili giacciono da molti anni nelle stesse condizioni in cui erano quando vi furono trasportati ed ammassati senza che ne fosse possibile né la manutenzione, né la pulizia con quanto danno è facile immaginare. Di essi, come si è detto, una parte è in un locale a pianterreno, locale umido e con poca aria. Fin dalla mia prima visita a quella R. Villa rilevai questo stato di cose e detti disposizioni perché almeno nelle giornate di sole venisse aperto il locale ed arieggiato. Tali disposizioni non vennero osservate ed in una recente gita colà contestai che specialmente gli effetti letterecci sono in via di continuo deperimento. […] Per mio discarico informo codesto Ministero dello stato di cose e aggiungo che i danni potranno andare crescendo se i locali ed i mobili
22 Estratto della lettera del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, all’Intendenza di Finanza di Firenze, Roma, 30 dicembre 1920, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (18291951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 417, fasc. 2.
23 Nel corso degli anni successivi, la Soprintendenza ai Monumenti di Firenze continuò a ribadire l’importanza di considerare l’unità della villa con il suo giardino, come emerge in una nota della Direzione Provinciale della Real Casa al Ministero della Real Casa, Firenze, 21 febbraio 1921: «[…] La consegna, secondo intese stabilite fra il Soprintendente ai Monumenti ed il Presidente del Comitato rifletterà la Villa, propriamente detta, il parco e il Giardino che, secondo il predetto Soprintendente, formano un tutto inscindibile, verranno lasciati al libero transito e passeggio dell’ente concessionario finché duri la concessione d’uso della Villa […]» (ibidem)
24 Come segnalato dal Comitato Fiorentino per l’Assistenza ai Ciechi di Guerra al Ministero della Real Casa, Firenze, 6 novembre 1920, ibidem. Per la rinuncia alla sede della Villa di Castello si veda la nota trasmessa dal Ministero delle Finanze al Ministero della Real Casa, Roma, 14 febbraio 1922, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1866-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 416, fasc. 1 Dotazione Corona
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
rimarranno nelle stesse condizioni in cui vennero lasciati dall’Autorità militare, in attesa di una soluzione che non giunge mai25 .
A questi danni occorreva sommare anche quelli causati dai militari durante la loro permanenza, come riferiva il verbale del 3 gennaio 1922 compilato sempre dall’Amministrazione Provinciale della Real Casa in cui si accennava non solo al modo frettoloso e poco attento con cui vennero sgomberati gli ambienti, ma anche agli atti vandalici e ai furti commessi dai soldati26 :
Ritengo che in massima gli ammanchi, specie per i mobili e i rami, ottoni e ferri, possano attribuirsi prima di tutto alla fretta e al modo disordinato ed illogico con cui venne effettuato lo sgombero di quella parte della Villa che fu ceduta all’Autorità militare per l’impianto dell’Ospedale, poi agli atti vandalici e ai furti quasi certamente commessi dai soldati in detto ospedale ricoverati, i quali, a quanto viene asserito ora dal Riparbelli si sarebbero anche dolosamente introdotti in locali della Villa non assegnati all’Ospedale militare, cosa che non fu fatto alcun rapporto, a suo tempo, a questa direzione, e le cui conseguenze si potranno constatare soltanto in occasione dell’attuale ricognizione. È infine da tenere in non poco conto che, come ora soltanto viene riferito, per molteplici ragioni di servizio dell’ospedale militare, persone estranee avevano continuamente occasione di introdursi, permanere e uscire dalla Villa con imballaggi, panieri ed altri oggetti in cui si poteva eventualmente nascondere materiale da trafugare27
A fronte di questa situazione, l’Ufficio Provinciale della Real Casa, pertanto, in accordo con il Sottosegretariato di Stato alle Antichità e Belle Arti, si adoperò fin da subito per cercare di salvaguardare il patrimonio degli arredi e delle suppellettili. Il 14 settembre 1921, l’Ufficio Provinciale riuscì a distribuire gli arredi all’interno della villa così da facilitare le operazioni della Commissione interministeriale, appositamente incaricata nel 1920 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di effettuare di lì a breve un sopralluogo e di redigere un elenco che sarebbe servito ad arredare i nuovi uffici del Ministero dell’Interno, della Camera dei Deputati o delle ambasciate del Ministero degli Esteri28 .
25 Comunicazione della Direzione Provinciale della Real Casa in Firenze al Ministero della Real Casa, Firenze, 30 maggio 1921, ibidem
26 Tra quelli più significativi bisogna annoverare ad esempio la scomparsa, il 26 agosto 1919, di uno degli uccelli cinquecenteschi in bronzo che ornavano la celebre Grotta degli animali Sulla vicenda si veda MOZZO 2018, in particolare p. 76.
27 Amministrazione già della Real Casa per conto del Demanio in Firenze al Ministero della Real Casa, Consegna temporanea delle ville al Guardia Caccia Scelta Prioreschi Umberto, Firenze, 3 gennaio 1922, in ACS, Real Casa (18291951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1866-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 416, fasc. 1 Dotazione Corona. Si veda anche la nota dell’Amministrazione già della Real Casa per conto del Demanio in Firenze al Ministero della Real Casa, Firenze, 7 ottobre 1921, che denunciava la scomparsa di un dipinto, inventariato con il n. 543 nell’Inventario degli Oggetti d’arte, raffigurante un presepe: «Di esso è stata rinvenuta soltanto la cornice. Il custode Riparbelli interrogato in proposito ha dichiarato quanto appresso: Il sottoscritto riguardo al dipinto mancante alla Villa di Castello dichiara di essersene accorto insieme al deceduto Assistente Custode sig. Cavallo Ambrogio il quale manifestò di farne regolare rapporto a codesta Onorevole Amministrazione. Dichiara pure che durante la permanenza dell’Ospedale Militare nel fare il consueto giro d’ispezione mattinale ebbe a constatare l’apertura completa (mediante sbarramento) della porta d’ingresso del salone al primo piano ove era conservato gli oggetti d’arte di ciò ne fece rapporto al defunto sig. Cavallo – fu dopo questo fatto che trovarono la cornice senza il dipinto» (ibidem).
28 Comunicazione dell’Amministrazione già della Real Casa per conto del Demanio in Firenze al Ministero della Real Casa, Firenze, 14 settembre 1921, ibidem. La Commissione interministeriale, istituita per volere della Presidenza del Consiglio, era composta da Guido Albertelli per la Camera dei Deputati, Enrico Bovio per il Ministero degli Esteri, Paolo Donati per il Ministero dell’Interno, Roberto Papini per il Ministero dell’Istruzione Pubblica, Glauco Lombardi incaricato per conto delle province di Parma e Piacenza. In base alla residenza in cui avveniva il sopralluogo a livello nazionale, la Commissione era formata di volta in volta da un rappresentante locale del Ministero della Real Casa Cfr la nota dattiloscritta della Direzione Generale del Demanio alle Intendenze di Finanza, Roma, 16 settembre 1920, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 462, fasc. 11.
Studi di Memofonte 34/2025
Al fine di guidare il lavoro dei commissari e di fornire degli strumenti di valutazione che potessero impedire lo smembramento di arredi complessi o in serie, una nota della Direzione Generale del Demanio, trasmessa il 14 febbraio 1921, precisava che sarebbero stati esclusi quegli oggetti che presentavano uno «spiccato valore artistico od interesse storico locale»29, ma anche:
[…] quelli ritenuti necessari a mantenere al palazzo nel quale si trovano un arredamento decoroso ed adeguato alla sua attuale destinazione […] e quelli che, sebbene non abbiano un vero pregio artistico, siano tuttavia troppo appariscenti per addirsi alla serietà dei pubblici uffici ovvero, per la loro fragilità e deperibilità, non siano adatti all’uso pratico quotidiano mentre, come oggetto di mero ornamento, possono, senza deteriorarsi, conferire durevolmente decoro agli ambienti ai quali furono predestinati […]30 .
Anche se il sopralluogo della Commissione a Castello venne effettuato solo l’11 settembre 192131 , la situazione era rimasta immutata, così come il trasporto dei beni storico-artistici a Firenze, mentre continuavano ad arrivare richieste per lo spostamento degli arredi in altre sedi. Il 21 novembre 1921, ad esempio, una nota dell’Amministrazione già della Real Casa di Firenze riferiva sull’incontro con il segretario generale della colonia di Eritrea, Alberto Pollera, per la scelta di alcuni mobili da destinare agli uffici di rappresentanza32 . Tale quadro assume tinte ancora più confuse se guardiamo al verbale redatto il 26 novembre 1922 dall’Ufficio Provinciale della Real Casa in cui si evidenziava come una parte degli arredi si trovasse abusivamente nelle abitazioni dei cosiddetti assegnatari che occupavano alcuni locali pertinenti alla villa, un’altra fosse stata chiusa in un magazzino a Palazzo Pitti, un’altra ancora temporaneamente trasferita dalla Soprintendenza delle Regie Gallerie per arredare l’Appartamento del Sovrano in alcuni quartieri di Palazzo Pitti33 .
A fronte di una situazione così complessa che esponeva le opere a continui rischi di dispersione, appare quanto mai giustificabile l’intervento del direttore della Biblioteca Laurenziana, Guido Biagi, in merito alla possibilità di trasferire a Firenze presso il proprio istituto l’importante serie delle carte geografiche acquistate da Cosimo III nella seconda metà del Seicento in Olanda e ospitate a Castello almeno fin dalla seconda metà del XVIII secolo34. La richiesta muoveva dalla necessità di evitare che la preziosa raccolta potesse disperdersi o essere venduta all’estero. Una relazione del 2 ottobre 1920 scritta dal bibliotecario conservatore della Laurenziana, Enrico Rostagno, dietro indicazione del direttore, rispondeva al sottosegretario alle Antichità e Belle Arti, che aveva interpellato Biagi chiedendogli una valutazione in merito all’opportunità o meno di effettuare uno scambio proposto il 17 settembre a Roma dal bibliotecario della Universiteitsbibliotheek di Amsterdam, Frederik Caspar Wieder, fra alcuni oggetti antichi (dei portolani e un mappamondo) e due fra gli esemplari più importanti della celebre serie delle carte geografiche di Castello: la Pianta di Manhattan e la Carta Manatus, rispettivamente le più antiche rappresentazioni dell’Isola di Manhattan e della città di New York (Fig. 3)35
29 Nota della Direzione Generale del Demanio indirizzata all’Intendenza di Finanza, al Sottosegretariato di Stato per le Antichità e Belle Arti, ai componenti della Commissione interministeriale, Roma, 14 febbraio 1921, ibidem
30 Ibidem
31 Come attesta la comunicazione della Direzione Regionale della Real Casa al Ministero della Real Casa, Firenze, 13 settembre 1912, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (18291951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 412, fasc. 7.
32 Ibidem. Alberto Pollera (Lucca, 3 dicembre 1873 - Asmara, 5 agosto 1939) è stato una figura di primo piano della politica coloniale italiana.
33 Diciassette mobili erano stati abusivamente prelevati dal personale della villa e consegnati solo in un secondo momento non a Castello ma a Palazzo Pitti, dove erano stati chiusi in un magazzino. Altri tredici erano stati scelti arbitrariamente dalla Soprintendenza delle Gallerie per l’arredamento dell’Appartamento del Sovrano a Palazzo Pitti.
34 Sulla collezione delle carte si veda SGUARDI GLOBALI 2019.
35 Cfr. la richiesta di Giovanni Rosadi a Guido Biagi, Roma, 17 settembre 1920, in Archivio Biblioteca Medicea Laurenziana (d’ora in poi BML), Acquisti e Doni, A4b (1920-1930). Sulla vicenda si veda anche FANTONI 2019.
La relazione elogiava «l’oculata prudenza» con cui il Sottosegretariato era riuscito a «subdorare l’inganno» che avrebbe compromesso l’integrità della collezione, impedendo l’estradizione dai confini nazionali e riuscendo così a sottrarla alle mire di studiosi senza scrupoli. Parafrasando una celebre citazione dal secondo libro dell’Eneide virgiliana, Rostagno concludeva con la frase: «Timeo […] Batavos et dona ferentes!»36
L’episodio testimonia la scrupolosità dell’operato del Sottosegretariato che agiva sul territorio a livello nazionale non solo per il tramite delle Soprintendenze ma probabilmente anche grazie al supporto di una rete capillare di conoscenze e frequentazioni comuni. Come Biagi, anche Rosadi infatti era un membro della Società fiorentina Leonardo da Vinci, che conduceva da tempo una battaglia contro la dispersione dei beni retrocessi dalla Corona. Inoltre, la necessità di salvaguardare l’integrità della collezione rispondeva a quelle indicazioni comunicate ai propri uffici periferici dal ministro della Real Casa, il 20 settembre 1920, raccogliendo una precisa istanza del collega dell’Istruzione Pubblica37. Si chiedeva cioè di identificare alcune tipologie di collezioni e raccolte, presenti tra le regge italiane, da salvaguardare nella loro integrità per facilitare i lavori della Commissione interministeriale incaricata della selezione degli arredi. A corredo, il documento elencava a titolo esemplificativo alcune raccolte tra cui anche le «preziose stampe geografiche di porti e città antiche americane» della Villa medicea di Castello38 .
La consegna delle carte alla Laurenziana, avvenuta il 1° aprile 1921 a Castello alla presenza di Biagi e di alcuni funzionari dello Stato in rappresentanza del Demanio, del Ministero della Real Casa e della Soprintendenza delle Regie Gallerie, avrebbe contribuito ad arricchire il fondo di Cosimo III ivi già esistente, anche se avvenne nella forma solo di un deposito temporaneo e non di una vera e propria cessione al patrimonio bibliografico. Di conseguenza la tutela della raccolta continuò a essere esercitata dalla Soprintendenza delle Regie Gallerie, così come ancora oggi è affidata alle Gallerie degli Uffizi.
Il caso offerto dalle carte geografiche di Castello, iscritte nell’inventario del 1911 degli Oggetti d’Arte della Real Casa, considerate quindi a tutti gli effetti delle opere di importanza storico-artistica, non ha rappresentato un unicum39 .
36 La frase allude all’esortazione pronunciata da Laooconte per convincere i Troiani a non accogliere il celebre cavallo di Troia: «Timeo Danaos et dona ferentes». «È chiaro che il sig. Wieder, – sottolineava Rostagno – saputo della cessione delle Ville Reali e del divisato smembramento di tutte le pregevoli collezioni che vi si contengono, è calato in Italia ed a Roma facendo assegnamento sulle sue commendatizie e sulla bonarietà delle nostre Amministrazioni. Ma sono lieto di rilevare dalla stessa lettera dell’E.V. che l’oculata prudenza di chi presiede tanto degnamente alla amministrazione delle Belle Arti aveva subdorato l’inganno, onde con tanto facile bonomia» (minuta della relazione di Enrico Rostagno, sottoscritta da Guido Biagi, Firenze, 2 ottobre 1920, in BML, Acquisti e Doni, A4b (1920-1930))
37 «Nell’intento di facilitare il lavoro della Commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio per la scelta dei mobili dei Real Palazzi da destinarsi all’addobbo dei vari palazzi ed uffici dello Stato, sarebbe opportuno avere notizie circa quelle serie o quei fornimenti di mobilio o d’altra suppellettile che per qualsiasi ragione si trovino ora divisi o smembrati nelle varie residenze reali. E ciò allo scopo di reintegrare serie e fornimenti, di proporre eventuali cambi a codesto Ministero fra gli oggetti che vengono ceduti allo Stato e quelli che rimangono a far parte della Dotazione della Corona» (comunicazione del Ministero dell’Istruzione Pubblica al Ministero della Real Casa, Roma, 16 settembre 1920, in ACS Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (18291951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 462, fasc. 11)
38 «Quanto alla Real Villa di Castello si invita la S.V. a porre mente alle stanze di soggetti cinesi, napoletani, alle preziose stampe geografiche di porti e città antiche americane, di castelli austriaci, di personaggi della corte di Lorena etc. Infine nelle mirabili serie dei quadri di fiori e frutti, che si completano con altri analoghe di altre reggie» (minuta del ministro della Real Casa alle Direzioni Provinciali della Real Casa, Roma, 20 settembre 1920, ibidem)
39 Basti citare ad esempio la consegna, autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, di alcuni oggetti cinesi appartenenti a Palazzo Pitti al Museo Storico-Etnografico di Roma a seguito di una richiesta del suo direttore Luigi Pigorini. Sulla vicenda si veda l’incartamento conservato in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 412, fasc. 6.
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928) 199
Studi di Memofonte 34/2025
Tra le opere appartenenti alla Villa di Castello che subirono le conseguenze della sdemanializzazione, occorre citare anche il bassorilievo in terracotta policroma attribuito alla mano di Agostino di Duccio raffigurante una Madonna con Bambino circondata da angeli (Fig. 4)40 . Anche quest’opera dal 1915 si trovava custodita in uno dei depositi allestiti per fare posto all’ospedale militare. Già nota alla storiografia artistica, spetta a Claudio Gamba il merito di averla segnalata all’attenzione degli studiosi fin dal 1903, in un articolo apparso sulla rivista lombarda «Rassegna d’Arte» dal titolo Due opere d’arte nella R. Villa di Castello. Come è risaputo, lo studioso l’aveva identificata erroneamente come una rara testimonianza delle capacità espressive del maestro fiorentino nel lavorare lo stucco, e rivendicava il merito di averne rintracciato la provenienza dalla vicina Villa La Petraia, consultando un inventario granducale del 1598. Data la sua importanza, ne proponeva già allora un trasferimento presso le collezioni museali del Bargello per colmare la lacuna di opere appartenenti alla produzione dello scultore fiorentino41
In seguito, il bassorilievo venne menzionato anche nella storia dell’arte venturiana, nel volume uscito nel 1908 sulla scultura quattrocentesca42 ; più tardi, nel 1911, ne parlò De Benedetti, ma anche nel 1921 Ugo Ojetti accennò a uno «squisito stucco» nella prefazione al libro I palazzi e le ville che non sono più del re43 . Una citazione quest’ultima che sembrava tradire la presenza dell’opera ancora a Castello. Di fatto il prezioso rilievo era stato già trasferito al Museo del Bargello, come rivela la lettura del verbale di consegna che due anni prima, il 16 giugno 1919, ne aveva siglato la cessione alla presenza dei referenti delle Amministrazioni della Real Casa, del Demanio e del Ministero dell’Istruzione Pubblica44 . Il trasferimento, che era stato già ampiamente caldeggiato fin dal 1904 dal direttore del museo Igino Benvenuto Supino a incremento delle collezioni fiorentine45, ottenendo però il diniego della Direzione Provinciale della Real Casa favorevole a preservare l’opera in situ46, venne reiterato nel 1907 dal successivo direttore del Bargello, Giovanni Poggi, con la motivazione che il rilievo sarebbe stato maggiormente apprezzato in una sala del museo piuttosto che nella sua sede di origine:
Ella farebbe cosa di cui tutti gli studiosi le sarebbero riconoscenti. Non è che la villa di Castello sia sede inadatta a contenere lo stucco di Agostino né che sia difficile accedere, per chi voglia ammirarlo. Ma come ella facilmente comprende, quell’opera d’arte aumenterebbe di valore quando fosse possibile esporla colle altre dello stesso tempo47
40 Per la bibliografia sul rilievo di Agostino di Duccio cfr. BELLOSI 2001, in particolare p. 329. Si veda anche F. Caglioti, scheda n. 150 (Agostino di Duccio, Madonna col Bambino e quattro angeli), in EREDITÀ DEL MAGNIFICO 1992, pp. 168-170.
41 GAMBA 1903.
42 VENTURI 1908, p. 404.
43 I PALAZZI E LE VILLE 1921, p. 147.
44 Il verbale recava le firme dell’ingegner Stramucci in rappresentanza della Real Casa, dell’ingegner Rusconi per il Demanio e di Guglielmo Vivaldi, direttore del Bargello, per conto del Ministero dell’Istruzione Pubblica. Cfr. la copia dattiloscritta del Processo Verbale di dismissione della Real Casa al Demanio e di contemporanea consegna dal R. Demanio alla Direzione del R. Museo Nazionale in Firenze (Palazzo Bargello) di uno stucco di proprietà demaniale rappresentante la Madonna col Figlio ed angeli, opera di Agostino di Duccio, il quale stucco cessa di far parte del Corredo mobiliare in uso alla Corona (Lista Civile) e passa ad aumentare la raccolta degli oggetti di proprietà demaniale esistente presso il suddetto Museo, in ACS, Real Casa (1829-1951), Casa Civile di S.M. il Re e Ministero della Real Casa (1829-1951), Divisione III/ Amministrazione (1865-1951), Carteggio sedi reali retrocesse 1920-1946, busta 417, fasc. Madonna di Duccio – Retrocessione allo Stato
45 Comunicazione di Igino Benvenuto Supino al direttore della Real Casa, Firenze, 2 maggio 1904, ibidem
46 «A tale domanda il Ministero non intende dover aderire sia per non andare incontro alle responsabilità cui la rimozione del pregevole oggetto potrebbe per qualche accidentalità dare luogo, sia perché la R. Villa di Castello è sede punto […] adatta al prezioso lavoro» (nota del ministro dell’Istruzione Pubblica alla Direzione Provinciale della Real Casa, Roma, 22 maggio 1904, ibidem)
47 Lettera di Giovanni Poggi al Ministero della Real Casa, Firenze, 30 dicembre 1907, ibidem
L’idea di considerare la Villa di Castello un luogo poco consono a ospitare opere così rilevanti, che rischiavano di rimanere celate allo sguardo degli studiosi e degli appassionati, si rafforzò soltanto all’indomani della conclusione del primo conflitto bellico, quando ormai la residenza di corte aveva mutato la sua originaria destinazione d’uso. Il 20 aprile 1918 il Ministero dell’Istruzione Pubblica trasmetteva al Dicastero della Real Casa la sua terza istanza, invocando la consegna dell’opera al fine di evitare che venisse ricollocata nella sua «stanzetta dove prima si trovava»48
Il caso del bassorilievo di Agostino di Duccio, così come la vicenda delle carte geografiche ora alla Laurenziana, risentono dei radicali cambiamenti subiti dalla villa nel giro di pochissimi anni. Di lì a breve, per effetto delle conseguenze innescate dai processi di retrocessione e riconfigurazione della residenza di corte, gli arredi e gli oggetti d’arte sarebbero andati dispersi, perdendo quei legami con il contesto di provenienza che nel corso dei secoli si erano via via sedimentati caratterizzando l’immagine identitaria della Villa medicea di Castello con il suo storico giardino.
48 Comunicazione del ministro dell’Istruzione Pubblica al Ministero della Real Casa, Roma 20 aprile 1918, ibidem
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928) 201
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 1: Frontespizio di A. Jahn Rusconi, Le Ville Medicee. Boboli-Castello-Petraia e Poggio a Caiano
(Itinerari dei musei e monumenti d’Italia; 64), Roma 1938
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
Fig. 2: Veduta del giardino della Villa medicea di Castello (in M. De Benedetti, Palazzi e ville reali d’Italia, I. Roma e Firenze, con prefazione di C. Ricci, Firenze 1911, p. 182)
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 3: Johannes Vingboons (attribuito a), Afbeeldinge van de Stadt Amsterdam in Nieuw Neederlandt, post 1660, 66,5x52,1 cm, disegno a penna acquerellato su carta telata. Carte di Castello 18 in Biblioteca Medicea Laurenziana
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
Studi di Memofonte 34/2025
Fig. 4: Agostino di Duccio, Madonna con Bambino circondata da angeli, 1465-1468, 83x79 cm, rilievo in terracotta policroma. Firenze, Musei Nazionali del Bargello
BIBLIOGRAFIA
ACIDINI–GALLETTI 1992
C. ACIDINI, G. GALLETTI, Le ville e i giardini di Castello e Petraia a Firenze, Ospedaletto 1992.
BELLOSI 2001
L. BELLOSI, Tre sculture di Agostino di Duccio, in Opere e giorni. Studi su mille anni di arte europea dedicati a Max Seidel / Werke und Tage. Tausend Jahre europäischer Kunstgeschichte – Studien zu Ehren von Max Seidel, a cura di K. Bergdolt, G. Bonsanti, Venezia 2001, pp. 321-330.
CAROCCI 1906
G. CAROCCI, I dintorni di Firenze, I. Sulla destra dell’Arno, Firenze 1906 (edizione originale I dintorni di Firenze. Nuova guida illustrazione storico-artistica, Firenze 1881)
COLLE 2015
E. COLLE, Gusto sabaudo: decorazione e arredi nelle residenze di Vittorio Emanuele II, in Firenze Capitale 1865-2015. I doni e le collezioni del Re, catalogo della mostra, a cura di S. Condemi, Firenze[Livorno] 2015, pp. 72-83.
DE BENEDETTI 1911
M.DE BENEDETTI, Palazzi e ville reali d’Italia, I Roma e Firenze, con prefazione di C. Ricci, Firenze 1911.
EREDITÀ DEL MAGNIFICO 1992
Eredità del Magnifico 1492-1992, catalogo della mostra, a cura di G.G. Bertelà, B. Paolozzi Strozzi, Firenze 1992, pp. 168-170.
FAILLA 2015
M.B. FAILLA, Ospedali e caserme a Moncalieri e Stupinigi: le residenze sabaude e il patrimonio della Real Casa negli anni della Grande Guerra, in La Certosa di Calci nella Grande Guerra. Riuso e tutela tra Pisa e l’Italia, catalogo della mostra, a cura di A. Gioli, Firenze 2015, pp. [169]-180.
FAILLA 2018
M.B.FAILLA, Ambientazioni e “gusto modernissimo”. Musei a Torino negli anni tra le due guerre, Firenze 2018.
FAILLA–GORIA 2017
M.B. FAILLA, C. GORIA, Dalla Corona allo Stato. La dismissione delle residenze reali e il riordinamento del patrimonio artistico nazionale, in Dalle Regge d’Italia. Tesori e simboli della regalità sabauda, catalogo della mostra, a cura di S. Ghisotti, A. Merlotti, Genova 2017, pp. 73-77.
FANTONI 2019
A.R. FANTONI, Le Carte di Castello nella Biblioteca Medicea Laurenziana, in SGUARDI GLOBALI 2019, pp. 43-51.
GAMBA 1903
C. GAMBA, Due opere d’arte nella R. Villa di Castello, «Rassegna d’Arte», III, 1903, pp. [81]-83.
GARBASSO 1922
A. GARBASSO, Altre voci di protesta contro la spoliazione di Palazzo Pitti, «Il Nuovo della Sera», 3 gennaio 1922.
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
I PALAZZI E LE VILLE 1921
I palazzi e le ville che non sono più del re, [a cura di] G. De Abate, prefazione di U. Ojetti, Milano 1921.
JAHN RUSCONI 1934
A. JAHN RUSCONI, La Galleria d’Arte Moderna a Firenze (Itinerari dei musei e monumenti d’Italia; 35), Roma 1934.
JAHN RUSCONI 1935
A.JAHN RUSCONI, Il Museo degli Argenti in Firenze (Itinerari dei musei e monumenti d’Italia; 42), Roma 1935
JAHN RUSCONI 1938
A. JAHN RUSCONI, Le Ville Medicee. Boboli-Castello-Petraia e Poggio a Caiano (Itinerari dei musei e monumenti d’Italia; 64), Roma 1938.
LA SOCIETÀ “LEONARDO DA VINCI” 1917
La Società “Leonardo da Vinci” e la tutela dei monumenti durante la guerra, Firenze 1917.
LO SGOMBERO DI PALAZZO PITTI 1921
CIP., Lo sgombero di Palazzo Pitti ed una questione di dignità, «Il Nuovo Giornale», 27 ottobre 1921.
MOSTRA DEL GIARDINO ITALIANO 1931
Mostra del giardino italiano, catalogo della mostra, prefazione di A. Lensi, U. Ojetti, Firenze 1931.
MOZZO 2018
M. MOZZO, La decorazione della Grotta degli Animali: note sulle vicende conservative dall’epoca sabauda ad oggi, in Il Rinascimento delle grotte. Natura, arte e architettura fra Italia e Francia nel Cinquecento, atti del convegno internazionale di studi (Firenze 22 febbraio 2018), a cura di E. Ferretti, S. Frommel et alii, numero monografico di «Opus Incertum», n.s., IV, 2018, pp. 74-[81] (disponibile on-line https://oajournals.fupress.net/index.php/oi/article/view/7941/7939).
OJETTI 1921a
U. OJETTI, Una piccola rivoluzione in un gran palazzo, «Corriere della Sera», 24 dicembre 1921
OLTRE IL PORTONE 1921
CIP , Oltre il portone di Palazzo Pitti, «Il Nuovo Giornale», 13 dicembre 1921
ORVIETO/MAGGI 2007
A. ORVIETO, Storia e cronaca della «Leonardo» (1952), a cura di N. MAGGI, Firenze 2007.
PALAZZI E VILLE REALI 1922
A., Palazzi e Ville Reali, «L’Azione», 13-14 novembre 1922
RICCI 1911
C. RICCI, Prefazione, in DE BENEDETTI 1911, pp. 9-11.
RUSSO 2017
M. RUSSO, Firenze Capitale: lo spostamento degli arredi tra i palazzi di residenza reali in Toscana durante i primi anni del Regno d’Italia, «Contesti d’Arte», I, 1, 2017, pp. 155-167 (disponibile on-line https://www.memofonte.it/home/files/pdf/CONTESTI_I_2017_RUSSO.pdf).
SGUARDI GLOBALI 2019
Sguardi globali. Mappe olandesi, spagnole e portoghesi nelle collezioni del granduca Cosimo III de’ Medici, catalogo della mostra, [a cura di] A. Cattaneo, S. Corbellini, Lisbona - Firenze 2019.
TARCHIANI 1934
N. TARCHIANI, La R. Galleria Pitti in Firenze (Itinerari dei musei e monumenti d’Italia; 41), Roma 1934
TINTI 1921
M. TINTI, La Reggia che muore, «Il Resto del Carlino», 4 dicembre 1921
VENTURI 1908
A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, VI. La scultura del Quattrocento, Milano 1908.
Marco Mozzo
La dismissione della «Villa Reale» di Castello dalla Corona allo Stato italiano. Dinamiche politiche, economiche e culturali di una transizione patrimoniale all’indomani della Grande Guerra (1919-1928)
ABSTRACT
Il saggio intende far luce su un periodo ancora poco studiato della storia della Villa medicea di Castello. Grazie all’analisi dei documenti inediti ritrovati presso l’Archivio Centrale dello Stato, è possibile ripercorrere le principali dinamiche politiche, economiche e sociali che hanno determinato l’alienazione di una delle principali residenze di corte fiorentine dei Savoia per effetto dei provvedimenti legislativi introdotti dallo Stato italiano nel 1919. Con la dismissione della residenza di corte, il saggio affronta anche la questione complessa della dispersione del suo patrimonio storico-artistico.
The present essay aims to shed light on an understudied period in the history of the Medici Villa of Castello. Through the analysis of previously unpublished documents from the Central State Archive, it is possible to retrace the main political, economic, and social dynamics that led to the transfer of one of the House of Savoy’s main Florentine court residences. This transfer was the result of legislative measures introduced by the Italian State in 1919. The essay also tackles the intricate issue of the dissemination of the residence’s historical and artistic heritage.
BREVE ARGOMENTAZIONE SULL’IDEALECLASSICONEL PENSIERO DI CESARE GNUDI
Le Biennali d’Arte Antica di Bologna, tenutesi presso il Palazzo dell’Archiginnasio a partire dal 1954, sono state il frutto forse più alto o per lo meno più completo1 del programma di riabilitazione, recupero e, poi, valorizzazione del patrimonio artistico condotto nel capoluogo emiliano da Cesare Gnudi (Ozzano dell’Emilia, 9 luglio 1910 - Bologna, 19 gennaio 1981). Già dal momento della chiamata alle armi, avvenuta nel 1942, Gnudi si era impegnato attivamente nel tentativo di preservare i beni artistici della propria città. La paura della devastazione causata dalla guerra lo aveva spinto a cercare diverse vie per ottenere finti congedi che gli permettessero di occuparsi della protezione e dello spostamento (quando possibile) delle opere2 . Quest’idea di un dovere morale e civile che lo lega alla cultura e alla tradizione artistica del paese rimane in Gnudi anche negli anni successivi alla liberazione dell’Italia3 , ragione per cui in più occasioni rifiutò la possibilità di una carriera accademica in favore di quella amministrativa, fino a diventare finalmente soprintendente di Bologna nel 19524 . Ottenuto l’incarico, si mobilitò immediatamente per ridare splendore all’arte e alle collezioni della città con l’ammodernamento della Pinacoteca nel 1953 e con l’avviamento dei lavori per le già citate Biennali l’anno seguente. Una lettera inviata da Gnudi a «The Burlington Magazine» alla fine della V Biennale del 1962, L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio, e pubblicata nel 1963 funziona da esplicito manifesto di intenti per questo progetto:
Our experiences lead us to believe that an increasing maturity is perceptible in the attitude of the general public, in the sense of a willingness to seek a deeper understanding of works of art and the problems to which they give rise: so much so that it seems clear that there need be no incompatibility between (on the one hand) such an exhibition’s impact on a wide public in both arousing, and nourishing, its interest, and (on the other hand) the respect for those strict critical and art-historical standards in its organization which may seem professionally desirable. Indeed it would appear that these two aspects are not merely reconcilable, but indivisible and complementary5
Questo articolo nasce nell’ambito del progetto Antico/Moderno parte del Programma di Alti Studi sull’Età e la Cultura del Barocco della Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e, nello specifico, nella ricerca sul concetto di ideale classico curata da Michela di Macco e Silvia Ginzburg, confluita nel volume LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021 Data la complessità dell’argomento, l’obiettivo di questo sintetico intervento non è quello di esaurirne ogni aspetto ma di dare degli spunti per la rielaborazione di alcune problematiche di critica novecentesca. La natura di questo studio ha richiesto una lettura e un’analisi piuttosto vaste degli scritti di e su Cesare Gnudi che, per ragioni di chiarezza e concretezza, saranno, in più occasioni, riportate direttamente a testo, creando una sorta di frammentaria antologia.
1 Sull’importanza dell’impresa delle Biennali bolognesi, in quanto momento di ricerca e divulgazione, strutturato e programmatico, si veda FERRETTI 2019.
2 Per le indicazioni biografiche di Cesare Gnudi si è fatto riferimento ai seguenti testi: LA CASA DI CESARE GNUDI 1986; ROVINETTI 1981; TRIGLIA 1994.
3 In questo va tenuto presente il particolare ruolo antifascista di Bologna. Sulla doppia identità, intellettuale e politica, di Gnudi si veda MANSUELLI 1983.
4 Le ragioni di questa scelta sono ben spiegate da Gnudi stesso in una lettera, della quale non ci è noto il destinatario, pubblicata nel volume che raccoglie gli interventi del Colloquio Cesare Gnudi tenutosi a Bologna dal 3 al 5 aprile del 1986: BERTI ARNOALDI 1993, pp. 8-9.
5 GNUDI 1963.
Gnudi ritiene che, essendo il pubblico disponibile e pronto come dimostrato dai numeri e dalle reazioni del visitatore ordinario6 , è compito dello storico dell’arte organizzare mostre stimolanti e limpide, che non vuol dire semplici e banali o peggio ancora «shapeless and over-full»7 . Il visitatore ha bisogno, a detta di Gnudi, che lo storico dell’arte gli pulisca il terreno dagli elementi superflui e colmi le lacune rendendo lineare il percorso espositivo che deve possedere «a certain unity, to be in some sense a living reality with a structure and nature of its own»8 La distinzione tra banalizzazione e semplificazione è stato un concetto fondante per la realizzazione delle Biennali bolognesi, in particolare per quella del 1962:
From the start, it seemed to us far from easy to bring out and make understandable a theme at one and the same time so complicated and so nebulous – the nature of which was obviously hostile to any simplified, schematic explanation. Our task was to try to rediscover the common ground, within an epoch as many-sided and full of conflict as the Seicento, between artists of very varied character and origins who were nevertheless attracted in different ways – as if by the pull of a magnetic pole through the ever-changing flux of the contemporary artistic scene – by a classical ideal which provided an inspiration for their progress amid the contradictions and perplexities on an age which was no longer ‘classical’. In so far as we were successful in throwing into relief the essence of the historical tendency in question (even its romantic undercurrents!) and making its vitality and significance clearer, this was only because our carefully considered choice of works laid the stress on its most characteristic and artistically successful manifestations; thus enabling it to be visualized as one of the motive forces of the Seicento, parallel to those others – no less genuine and fruitful – of the naturalism of a Caravaggio or the baroque of a Bernini or a Cortona. As it turned out, our intentions appeared evident enough to the vast majority of thoughtful visitors (with the exception of one or two instances of misunderstanding, owing to conclusions reached in excessive haste): those intentions were not of course to lay a claim on behalf of the ‘classic’ tendency to a more exalted artistic status that its contemporary alternatives, or (even less) to set it up as an exemplar which was still valid, but to clarify its nature and origins, and to illustrate it in its inter-relationships, its developments and its transformations. Our aim seemed the more justifiable in that, in present-day Italy, this particular tendency has been more neglected and misunderstood than the others, despite the fact that its heritage is so clearly reflected in the artistic culture of Europe down to the nineteenth century and beyond. Hence the attempt in our city […] to re-create the ‘climate’ compounded of the very varied aspirations of the time towards a classical ideal9
Lo scopo principe della serie di mostre dell’Archiginnasio evoca, se non addirittura prende le mosse dai concetti esposti da Roberto Longhi quasi due decenni prima nella prolusione al corso di Storia dell’arte da lui tenuto tra il 1934 e il 1935 presso l’Università di Bologna10 Nonostante si trattasse di un corso sul Trecento, Longhi sfruttò l’occasione per ridare luce a una pittura – e il riferimento è esclusivamente a questa forma d’arte figurativa11 –, quella bolognese, che era «ormai l’unico Lazzaro dimenticato nella tomba»12 Il medesimo proposito risorge nell’immediato dopoguerra con la politica culturale democristiana e viene accolto a braccia
6 «Our total of paying visitors reached the figure of 73,873, working out at the gratifyingly high daily average of 1,040. The number of visitors exceeded by about 6,000 that attained by the ‘Mostra di Guido Reni’, which had hitherto boasted the highest figure in the series» (ivi, p. 127)
7 Ibidem
8 Ibidem
9 Ibidem
10 Cfr. LONGHI 1974. Il testo era stato originariamente pubblicato in «L’Archiginnasio» (LONGHI 1935) e ristampato in «Paragone. Arte» (LONGHI 1962). Cfr. MILOZZI 2021, p. 78.
11 Ben noto è il disinteresse di Longhi per la scultura e in particolare modo per quella seicentesca.
12 LONGHI 1974, p. 192.
aperte da un uomo certamente non vicino a Longhi ma dallo spiccato senso del dovere e dal forte attaccamento alla patria e al suo patrimonio artistico quale Cesare Gnudi era13 Prima di entrare nel merito delle Biennali d’Arte Antica, è opportuno soffermarsi sulle conseguenze che gli anni della Seconda guerra mondiale hanno avuto sul pensiero dello studioso bolognese tramite la rilettura di due articoli che egli scrisse sullo stesso tema, prima e dopo il conflitto: Note sullo stile di Guido Cagnacci del 1937 e Una fantasia interrotta I ‘quadroni’ del Cagnacci del 1951 ma edito nel 195414 Per quanto venga approfondita e rivista con una diversa maturità, l’opinione che Gnudi ha su Cagnacci non varia particolarmente; ma alcuni dettagli rivelano comunque le novità del suo pensiero. Prima fra tutte a tradire il cambiamento è la forma stessa della scrittura: nel 1937 la retorica è ricercata, non mancano alcuni arcaismi sia lessicali che di struttura e i concetti si esplicano tramite una certa dose di liricità. Non raggiunge la qualità longhiana ma essa è chiaramente il suo modello, come confermano i continui riferimenti diretti a temi di interesse dello studioso piemontese, tra cui, il più importante, Orazio Gentileschi, con citazione esplicita del Gentileschi, padre e figlia15 Tutto questo si perde nell’articolo del 1954: la forma è semplificata e chiara e, sebbene resti qualche rapido riferimento al pittore toscano, così come a Borgianni e a Caravaggio, manca ogni diretta ripresa di Longhi e addirittura si raggiunge il culmine con un breve paragrafo di esaltazione di Bernini16 . Ancor più esplicita è la variazione nel giudizio su Guido Reni. Nel primo articolo descrive un Reni dalla «poetica idealistica» che «appare subito […] più artificiale, più involuto, più ‘secentesco’»17 , e continua, soffermandosi sull’analisi dello stile reniano:
L’intenzione di correggere, di abbellire il vero, che era, dichiarata, nel suo programma artistico, si risolse troppo spesso nella sua immediata applicazione; conferendo alle sue opere quell’impronta di raffinata maestria, di ricercato artificio che fece di lui, insieme al Marino, uno dei caratteristici esponenti del suo tempo. In genere questo pseudo-idealismo che il Reni ebbe il merito di rappresentare nel modo più tipico, scoperto e significativo, fu il filone più ammirato, ma artisticamente più negativo, della pittura secentesca: esso non era che una contraffazione, una camuffatura dell’edonismo, caratteristica e piaga morale del secolo; e il dichiarato ellenismo del Reni non aveva altra origine: mezzo per la confezione della piacevole immagine. E infatti proprio nella corrente di impostazione teorica contraria, quella dei cosiddetti ‘naturalisti’, si trovano le forze morali ed artistiche più vive del secolo. In questo senso il caravaggismo poté rappresentare in quanto ‘naturalismo’ un antidoto morale e una chiarificazione estetica. Non fu l’idealista Reni, ma il Caravaggio ‘naturalista’ di programma, che, scavando in sé stesso e non correndo dietro a una effimera parvenza di bellezza, giunse al vero classicismo formale, senza bisogno di correggere
13 Non vanno in ogni caso dimenticate, in quanto anch’esse momenti di questa battaglia, due mostre importanti: la Mostra celebrativa di Giuseppe M. Crespi del 1948, per la quale Fernando Ghedini, autore della breve introduzione in catalogo, scrisse: «la conoscenza del Crespi, caro un tempo, sopratutto, al cuore dei petroniani, si farà più profonda e sentita in tutti gli italiani che meglio ne apprezzeranno le doti di eccellente pittore» (GHEDINI 1948); e quella totalmente longhiana, e più studiata, sul Trecento bolognese del 1950. Di questo precedente erano ovviamente coscienti i membri del Comitato delle Biennali, come spiega Andrea Emiliani: «un grande ritorno del ‘gusto dei bolognesi’ al quale Gnudi diede inizio già nel 1954 con il primo Guido Reni; ma al quale si può segnare un avvio con la piccola esposizione di Crespi del ’48 e anche con la stupenda mostra della Pittura del Trecento Bolognese che Longhi aveva organizzato, nel 1950, proprio dentro la Pinacoteca Nazionale di Bologna» (EMILIANI 1993, p. 378).
14 GNUDI 1937 e 1954b.
15 LONGHI 1961, in particolare si veda Gentileschi, padre e figlia (1916), pp. 220-283.
16 GNUDI 1954b, p. 47.
17 In quest’occasione Gnudi riporta un passaggio dell’Adone di Marino avvicinandolo a un commento di Benedetto Croce: «Non si potrebbe accostare ad una immagine reniana queste strofe del Marino? (Adone I, 113): Un rossor dal candor non ben distinto/ varia le guance e le confonde e mesce./ Il ligustro di propora è dipinto,/ là dove manca l’un, l’altro s’accresce./ Or vinto il giglo è dal rosa, or vinto/ l’ostro appar da l’avorio, or fugge, or esce./ A la neve colà la fiamma cede,/ qui la grana col latte in un si vede. È l’esatto equivalente delle ben dosate alchimie del Reni, alle cui opere spesso si potrebbero applicare le parole con cui il Croce critica queste espressioni del Marino: ‘incapacità di generare l’immagine dal sentimento’ nonostante ‘la sapienza grafica e descrittiva’» (GNUDI 1954b, p. 36)
Studi di Memofonte 34/2025
argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi
la realtà, prendendo anzi a modello, perché no?, anche il brutto naturale, non avendo questo nulla a che fare con il bello artistico, con lo stile.
Caravaggio raggiunge il «vero classicismo formale», mentre Reni camuffa il proprio edonismo e il proprio ellenismo tramite «questo pseudo-idealismo»: niente di più distante dal pensiero fondante che muove il progetto delle Biennali bolognesi. L’allontanamento dalle idee del 1937 è reso esplicito in una nota dell’articolo successivo:
In un mio vecchio articolo su Cagnacci […] nel mostrare il suo incontro con la poetica reniana, identificavo nella sopravvivenza e nella vitalità di quelle esperienze caravaggesche il punto di differenziazione fra lo stile delle sue opere più alte e quelle del Reni. Su questi punti e sulla interpretazione che diedi dello stile di Cagnacci ancora oggi sostanzialmente convengo; mentre fra la poesia del Cagnacci e la non-poesia del Reni, in conseguenza della schematica svalutazione del Reni come pittore artificioso e accademico; mentre mi appare oggi evidente che anche e specialmente per il Reni, il quale resta, come ben videro i contemporanei, la più grande figura del Seicento bolognese, gli aspetti tipici e i consueti pericoli del gusto dell’epoca vanno considerati in una dialettica assai più complessa, all’interno di un procedimento creativo che, muovendosi dietro a quel gusto, talvolta ne resta limitato, ma più spesso lo supera e lo trasforma in espressione di alta e raffinata poesia.
La causa del capovolgimento del giudizio su Reni non è semplicemente il rifiuto del metodo longhiano, dettato dalla nota differenza tra i due nella presa di posizione durante il regime fascista, ma un rinnovamento spirituale e morale più completo. Lo stesso Gnudi ripensa a quegli anni di attivismo politico e culturale, dall’ingresso in Giustizia e Libertà nel 1934 fino alla liberazione della città di Bologna il 19 aprile 1945, in questi termini: «per noi fu la salvezza e la rigenerazione spirituale in una vita nuova»18 .
Cesare Gnudi aveva a lungo e attivamente lottato contro il fascismo a fianco di Carlo Ludovico Ragghianti, e così, per evitare il carcere, era stato costretto a rifugiarsi a Firenze con la madre Rosa durante l’ultimo anno e mezzo di guerra, dal settembre 1943 al 25 aprile 1945, giorno in cui rientrò a Bologna per dedicarsi alla propria città: «certo venne il momento in cui diventò necessità impellente dare interi se stessi alla lotta antifascista e alla resistenza. E solo dopo la liberazione ripresi i miei studi e l’opera di ricostruzione del patrimonio artistico»19 . Fu in questo contesto che avviò il riallestimento, sia architettonico che didattico, della Pinacoteca di Bologna, coadiuvato da Leone Pancaldi, allora non ancora laureato ma già braccio attivo nella manifestazione delle idee del direttore20 , e il progetto delle Biennali d’Arte Antica. La motivazione cardine che spinse Gnudi a occuparsi con tanta dedizione agli spazi espositivi bolognesi, sia permanenti che temporanei, è ben spiegata da Giulio Carlo Argan in una descrizione dell’amico ricca e affettuosa, presentata in occasione del già citato premio dell’Archiginnasio d’oro:
una concezione così agile e moderna della tutela del patrimonio artistico è indubbiamente il prodotto di una lucida mentalità scientifica. Gnudi ha capito che non si può proteggere il patrimonio artistico se il pubblico se ne disinteressa, e per interessare il pubblico sono necessarie manifestazioni non soltanto di grande prestigio, ma intrinsecamente problematiche. Si è opposto alle impostazioni spettacolari, imponendo invece il criterio della dimostrazione scientifica21 .
18 La citazione proviene dal discorso di ringraziamento per l’Archiginnasio d’oro, premio conferitogli il 18 maggio 1973: IL RINGRAZIAMENTO DI CESARE GNUDI 1973, p. 20.
19 Ivi, p. 21.
20 MANTOVANI 1995-1996(1996); COVA 2008; PARISI 2021b.
21 IL DISCORSO DI GIULIO CARLO ARGAN 1973, p. 14.
Studi di Memofonte 34/2025
Torna quindi la questione, già esplicitata da Gnudi nella lettera a «The Burlington Magazine» del 1963, dell’importanza del rapporto con il pubblico e dell’impegno nella realizzazione di manifestazioni artistiche che fuggano il banale e la superficialità. L’approccio di Gnudi alla storia dell’arte ha, ovviamente, origini crociane esplicite e ben individuabili nell’introduzione al suo Giotto del 1959, che si apre proprio con una citazione da Croce22 In questa introduzione, riprendendo metodo e concetti degli studi del filosofo su Dante, Gnudi ci dona la chiave di lettura del proprio pensiero:
è soltanto la sintesi stessa, dalla sintesi illuminante operata dalla poesia, che si può risalire agli elementi ideali preesistenti che l’hanno generata. Ed è sempre così, d’altra parte, operando dal di dentro, partendo dalla realtà poetica, quale ci si presenta, e solo da essa guidati risalendo agli elementi che l’hanno prodotta, che si può fare opera di esegesi storica veramente interna al problema espressivo e capace di chiarirlo, e non esterna a esso e arbitraria23
Non è lo studio delle fonti, della cronologia, delle attribuzioni e dei dati documentari a permettere la comprensione degli artisti e del loro tempo, ma la loro «poetica». L’analisi della «poesia» dell’artista e la sua comprensione, tenendo presente il concetto di «unità dell’arte» e di coincidenza tra intuizione ed espressione, è il punto di partenza per la ricostruzione storica. Questo, in Gnudi, vale da Giotto fino a Giorgio Morandi, passando per Guido Reni24 . Ed è proprio tramite quest’ultimo che si possono chiarire alcuni momenti cardine del pensiero dello storico.
Nell’ottica del restauro, della conservazione e, quindi, della valorizzazione del patrimonio artistico in senso lato25 nascono le Biennali d’Arte Antica con la prima esposizione dedicata a Guido Reni. La scelta di cominciare con un tema monografico e, nello specifico, con Reni, e non con i Carracci come avrebbe voluto Francesco Arcangeli26 , è stata ponderata, necessaria e, con il senno del poi, intelligente. Gnudi voleva avviare un ciclo di mostre che coinvolgesse annualmente il pubblico ordinario nel complesso dibattito sul concetto di classicismo seicentesco, e per fare ciò decise di iniziare con un nome al tempo già universalmente noto e attraente. L’intento è esplicito:
The fact that the title of the Exhibition [of 1962] struck a somewhat sophisticated note, lacking the simple popular appeal of a familiar name (an asset which Guido Reni possessed, and possesses, at Bologna), and that it nevertheless achieved the notable popular success which yourself very reasonably regarded as problematical on that account, may call for some explanatory comment27
22 «Gli antecedenti della Commedia si ritroveranno guardando alla generale condizione degli spiriti al tempo di Dante e in Italia, e riportandosi a quel periodo dell’ultimo medioevo, in cui la civiltà moderna cresceva in tutte le sue forme e pur tuttavia al concezione medievale del mondo non era tramontata […] Il divino e l’umano, il cielo e la terra, il trascendente e l’immanente si vedevano, in quel tempo, mescolarsi e alternarsi e combattersi ed equilibrarsi, come due forze in uno stesso campo […] Trascendenza e immanenza si affermarono entrambe in lui con sommo vigore […] E queste due forze gagliarde e parimente sincere sono da dire il precedente vero e la materia del poema […] Per tale materia, Dante si lega all’età sua e insieme la produce e costituisce» (GNUDI 1959, p. 9; CROCE 1921, pp. 50-52)
23 GNUDI 1959, p. 10.
24 IL DISCORSO DI GIULIO CARLO ARGAN 1973.
25 Concetto per noi oggi forse più scontato di quello che non era a quelle date quando, da una parte, il fervore muoveva le imprese del giovane Istituto Centrale per il Restauro ma, dall’altra, i rinati colori delle opere pulite turbavano il pubblico. Lionello Venturi, in una recensione alla seconda Biennale, scrive che la gente sentiva la mancanza del «buio delle cappelle, lo sporco delle vecchie vernici e la luce delle candele per darsi l’illusione di antichi valori che non esistono» (VENTURI 1959).
26 PEPPER 1988, p. 37.
27 GNUDI 1963, p. 126. La scelta deriva anche dal già citato capovolgimento di opinione su Reni che Gnudi ebbe tra il 1937 e il 1951.
Breve argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi
La fama di Guido Reni ha quindi avuto un ruolo decisivo nella scelta del pittore come soggetto della prima mostra ma, dietro a questo aspetto pratico, si mascherano motivazioni concettuali più concrete, limpidamente descritte nel saggio del curatore che introduce il catalogo28 . Reni è per eccellenza il pittore del «culto della Bellezza», colui che incarna il classicismo razionalistico, il modello del rapporto dialettico tra arte figurativa e letteratura che tanto stava a cuore a Gnudi29 e per il quale riprende nuovamente Croce:
gioverà alla più retta definizione della figura di Reni, alla più retta comprensione della sua poesia, l’approfondito studio che in questi ultimi anni da parte del Croce e sulla sua scia è stato fatto dei rapporti fra poesia e letteratura: studio che fornisce uno strumento prezioso per penetrare nell’interno del processo creativo di un artista così chiaramente ed eminentemente letterato come il Reni. È il tal modo che si potrà chiarire il duplice, ma non contraddittorio rapporto che la sua poetica idealista e classicista, in lui come in pochi altri dominante ed esclusiva, ha con il suo raffinato lavoro letterario e con la sua fantasia30
Ecco che appaiono già nell’introduzione alla prima mostra, quasi come un manifesto d’intenti, i tre termini chiave delle Biennali: «poetica», ‘ideale’ e ‘classicismo’. Vorrei tenere fermo questo punto per tornarci dopo una breve riflessione sulla mostra del 1962: L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio
Seppure non prevista nel primissimo programma e nello statuto redatto alla fondazione del Comitato nel 1953, l’idea di una mostra trasversale, in origine dedicata esclusivamente al paesaggio e in corso di progettazione sempre più ampia, era già in gestazione dalla fine dell’anno successivo31 La V Biennale32 è quindi una summa, una rielaborazione di alcuni nodi venuti al pettine negli anni precedenti: era necessario «approfondire la conoscenza di un settore ampio e importante del Seicento pittorico, la cui comprensione appariva ancora gravemente ostacolata e impedita da persistenti pregiudizi ed errori di prospettiva storica»33
Una lettera scritta da Cesare Gnudi a Wart Arslan del 9 aprile 1962, quindi piuttosto vicina all’inaugurazione della mostra avvenuta il giorno 8 settembre dello stesso anno, riporta il titolo scelto per la V Biennale: «Classicismo del Seicento»34 . Il passaggio da classicismo del Seicento a ideale classico non è cosa di poco conto35 . La ragione è rintracciabile sia, ovviamente, in Bellori ma anche, ancora una volta, in Benedetto Croce. Esplicito su questo punto è stato Andrea Emiliani: «Ideale classico inteso come ideale non classicismo, perché non è una totalità è una tendenza»36 . Non è più, quindi, il classicismo di Denis Mahon, che sicuramente era alle origini di questo progetto, bensì una rielaborazione delle sue idee portata avanti dall’intero Comitato della mostra37 ,
28 GNUDI 1954a.
29 Di cui dà magistrale esempio più di vent’anni dopo nell’Ariosto e le arti figurative (GNUDI 1986, in particolare si veda Ariosto e le arti figurative (1975), pp. 119-160)
30 GNUDI 1954a, p. 15.
31 Non è infatti menzionata nel verbale del Comitato tecnico permanente del 19 dicembre 1954 (cfr. COSMI 2021, p. 89), ma dagli scambi epistolari tra Gnudi, Germain Bazin e Charles Sterling (entrambi curatori delle collezioni del Louvre) si evince già un primo ragionamento sul tema del paesaggio classico (cfr. FORMOSO 2021, p. 102).
32 La IV si era allontanata dal tema portante: Mostra dell’Etruria padana e della città di Spina (1960).
33 GNUDI 1962, p. 3.
34 Lettera del 9 aprile 1962 (Milano, Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco, ARS C 978)
35 Almeno dal 1956 circolava l’idea di una mostra sul classicismo che ha variato più volte forma prima di diventare, all’ultimo, L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio Cfr. FORMOSO 2021
36 Alcune informazioni, tra cui quest’ultima, riportate nel testo sono state tratte da una lunga chiacchierata con Andrea Emiliani che, insieme a Giulia Spoltore, ho avuto modo di incontrare, tramite l’aiuto di Michela di Macco nell’ambito del menzionato progetto della Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, a Bologna il 26 novembre 2015. Da ora indicata come Intervista ad A. Emiliani, 26 novembre 2015.
37 Cfr. Intervista ad A. Emiliani, 26 novembre 2015. «Le Biennali d’Arte Antica erano un comitato. […] In genere c’era molta attenzione reciproca, quando parlavo […] il mio pensiero aveva molta presenza» (ibidem) Ovviamente il ruolo di Mahon era particolarmente importante, basti pensare che originariamente Gnudi aveva sperato di poter
Studi di Memofonte 34/2025
composto da, in ordine alfabetico, Francesco Arcangeli, Stefano Bottari, Gian Carlo Cavalli, Andrea Emiliani, Cesare Gnudi, Michael Kitson, Amalia Mezzetti, lo stesso Mahon e Carlo Volpe. Non è mia intenzione entrare nel merito delle singole opere esposte38 , anche perché ormai è chiaro che gran parte degli studi su di esse sia stato frutto di un compromesso di idee e opinioni, oltre che di possibilità, e non delle singole direttive di Gnudi e Mahon: alla definizione della mostra contribuirono scambi con studiosi stranieri e prestatori39 Al contrario, nasce dal pensiero di Gnudi il motore che attiva questa ricerca, ed è su questo che mi preme riflettere: cosa vuol dire classico per Cesare Gnudi? Il termine classico, spesso significativamente posto tra virgolette, è presente in tutti gli scritti dello studioso dal dopoguerra in poi.
Nonostante si dichiari in diverse occasioni laico, la sua famiglia era molto religiosa ed è possibile che i due soprammenzionati anni passati a Firenze con la madre Rosa abbiano avuto un ruolo nei suoi importanti cambiamenti. Dagli scritti, tra i quali il già citato articolo su Guido Cagnacci del 1951, si legge chiaramente la nascita di un nuovo Gnudi, forse non propriamente religioso ma sicuramente più spirituale40 Come scrive nell’introduzione del catalogo del 1962, arrivati a queste date, ritiene necessario «riacquisire, per l’arricchimento spirituale di tutti, questi grandi valori poetici di cui sempre si riscopre, insieme alla validità, l’inevitabile ‘attualità’ che è di tutti i veri valori»41 : lo ritiene necessario e lavora affinché avvenga per la società, per Bologna e per sé stesso in primis. Gnudi ragionava – forse proprio in conseguenza a una meditazione sopra l’articolo del 1937 su Cagnacci – senza discriminazioni di gusto, anzi prendendo in considerazione e illuminando tutta «la stratificazione complessa, la dialettica interna della cultura figurativa, la poesia», per usare le parole del suo amico Argan42 . È anche per questo motivo che sente la necessità di lavorare sul concetto di classicismo che è, ai suoi occhi, fuori dalla storia, come chiarito da Natalino Sapegno, il quale ne sottolinea la differenza dai ‘concetti-etichetta’ come gotico, manierismo e barocco che sono identificabili in una cronologia e che hanno una loro topografia. Il classicismo di Gnudi è «una etichetta di carattere generale, astorico: come immagine ideale o come manifesto polemico di un certo modo di operare artistico. È tanto generico da finire coll’identificarsi in qualche modo con il concetto stesso dell’arte e della poesia»43 . Piuttosto vicino a quanto detto finora appare, seppur più concreto, Germain Bazin nella prefazione al
esporre a Bologna parte delle opere già presentate a Londra dallo studioso inglese nel 1955 (cfr. ARTISTS IN 17TH CENTURY ROME 1955 e GUMIERO 2021b, p. 117)
38 Per le quali rimando a CURTI 2021, GUMIERO 2021a, BRUNETTI 2021 e PARISI 2021a.
39 Spesso condotti da Mahon in esclusiva: «Io ho viaggiato per il mondo a spese di Denis Mahon. […] Mahon era una chiave, un chiavistello, siccome conosceva tutto il mondo, era un chiavistello di ingresso. […] Noi di qui da Bologna così come ci eravamo mossi ti immagini io, un ragazzo che veniva da Urbino, cosa avevo a che fare con la National Gallery di Londra?» (Intervista ad A. Emiliani, 26 novembre 2015).
40 Per la cui formazione ha sicuramente un ruolo anche Benedetto Croce: «Un mondo esterno, di contro o sopra lo spirito, non esiste né per l’uomo artista né per l’uomo in qualsiasi altra delle sue forme e determinazioni; e solo esistono sentimenti e volizioni e rappresentazioni e pensieri, e questa è la cerchia stessa della realtà, dell’unica realtà, che è spiritualità» (CROCE 1920, in particolare si veda L’arte della creazione e la creazione come fare (1918), pp. 151-160, soprattutto p. 153).
41 GNUDI 1962, p. 4.
42 IL DISCORSO DI GIULIO CARLO ARGAN 1973, p. 16. Su questa capacità di Gnudi vorrei riportare un commento che Andrea Emiliani scrisse per il Colloquio Cesare Gnudi tenutosi nel 1986: «Gnudi vedeva nelle vicende più grandi dell’arte italiana, dall’oreficeria ottoniano-carolingia alla scultura romanica e gotica, dalla pittura delle origini a Giotto e infine a Raffaello, Annibale Carracci e a Poussin, disegnarsi un gigantesco orizzonte storico, eloquente e drammatico, denso di chiaroscuro che era in lui un riflesso soltanto di un palcoscenico interiore sul quale –sull’esempio di Burckhardt e di Croce stesso – si muovevano i giganti del progresso dell’umanità» (EMILIANI 1993, p. 376). È, inoltre, interessante in questo contesto, un’affermazione di Gnudi del 1962: «Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che il giudizio critico deve esercitarsi […] al di fuori di ogni preferenza di gusto e partecipazione di tendenza, nella cognizione esatta e nella comprensione oggettiva della situazione storica in cui l’artista si è formato, in cui si è inserito, nella ascoltazione aderente, diretta, libera da ogni schermo o pregiudizio, del suo messaggio poetico» (GNUDI 1962, pp. 4-5).
43 SAPEGNO 1993, p. 15.
Breve argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi
catalogo della V Biennale, in cui si sente di dover sottolineare il proprio disaccordo con quanti considerino classicismo e barocco due opposti, con una serie di esempi di coesistenza di queste due poetiche, partendo da Bernini fino, andando a ritroso, all’antico. Bazin è più concreto perché meno filosofico ma anche perché entra nel merito di alcune caratteristiche specifiche del classicismo per difenderlo dall’ombra di accademismo sotto la quale era stato posto44 Lo stesso ragionamento sulle coesistenze, Gnudi lo applica a tutti i momenti artistici che affronta. Trattando il tema dell’arte federiciana, individua la presenza stilistica e culturale di un fantasma classico ma utilizza un termine molto interessante: ‘dati’ L’arte federiciana e la cultura in cui essa si innesta operano su diversi dati: romano, bizantino, tardoantico e classico, ed è la compartecipazione di questi dati che le conferisce unicità45 Inoltre, classicismo non vuol dire copiare dall’antico, e questo è molto chiaro nel momento in cui Gnudi si trova a dovere comprendere la differenza fra Nicola Pisano e Arnolfo di Cambio. Per Nicola, l’antico è sorgente di profondi rinnovamenti poetici ma ancora troppo spesso appare come un esempio assoluto per cui dà origine a copie. Per Arnolfo è diverso. Per esempio, il cavallo inginocchiato al centro della scena della Resurrezione di Napoleone Orsini nell’Arca di San Domenico a Bologna è stato individuato da Gnudi come di mano di Arnolfo e messo in rapporto da Angiola Maria Romanini con il Sarcofago delle Amazzoni del Palazzo Ducale di Mantova, dandoci un preciso modello per misurare il classicismo arnolfiano. Il cavallo conserva solo il tracciato del contorno, ma è una rielaborazione in forma gotica e quindi inedita: l’antico smette di essere un modello e diventa uno strumento46 . Stesso tipo di analisi, rimanendo nelle medesime date ma cambiando geografia, si scorge nel saggio sul jubé di Bourges47 nel quale Gnudi chiarisce un punto chiave del proprio pensiero:
Il romanico è, ancora, la continuazione di tutto il lungo processo di evoluzione, dalle sue fonti classiche, del linguaggio medioevale. Il gotico è possibilità di ritorno, con distacco, con distanza di osservazione allo spirito e alle forme della classicità riaffiorata nelle sue forme precedenti il punto in cui essa si era versata nella civiltà medioevale: e ciò per il ricrearsi di condizioni spirituali che recuperano alcuni essenziali aspetti della spiritualità classica48 .
Questo distacco che permette il riaffiorare della classicità e che distingue il gotico dal romanico è lo stesso che segna il passaggio dal Cinquecento al Seicento. Esiste però una netta differenza tra la classicità gotica e quella seicentesca:
i riferimenti all’antico [nel gotico] sono così sempre meno echi di un mondo scomparso (e quasi irrecuperabile), sempre più consonanza, affinità elettiva in una visione della realtà sempre più vicina a quella che nel mondo classico aveva trovato la sua perfetta espressione formale. Perciò quella della scultura gotica, naturalmente, interiormente classica, diviene la più grande e vitale esperienza classica compiuta nel Medioevo. È quella del gotico, soprattutto, una classicità insita nel nascere e nel fiorire delle forme, più che una classicità [come quella seicentesca] di contenuti letterari e di pensiero49 .
44 «En fait on a confondu la classique avec ce qui en découle, mais qui est son contraire plus que le baroque: l’académisme. Certes, le classicisme se plie à des règles, mais qu’il a créés, tandis que l’académisme se conforme a des règles héritées. On ne dira jamais assez que le classicisme a pour fondement la nature, et s’il en fait la quête à travers l’antique, c’est parce que pour les hommes de ce temps, l’antique était devenue une seconde nature» (BAZIN 1962, p. XVI). Carlo Ludovico Ragghianti, in un articolo scritto su «L’Espresso» parla proprio di «‘jumelage’ critico tra Germain Bazin e Cesare Gnudi» (RAGGHIANTI 1962).
45 Cfr. GNUDI 1978, p. 6.
46 ROMANINI 1993, p. 24
47 GNUDI 1982, pp. 21-54.
48 Ivi, p. 46.
49 Ivi, p. 47.
Studi di Memofonte 34/2025
Quest’idea nobile del «ricrearsi di condizioni spirituali» che permettono la ripresa della «spiritualità classica» torna continuamente nel pensiero di Gnudi, dal dopoguerra fino alla morte, anche quando affronta i temi più disparati. Nell’Ariosto e le arti figurative del 1974, riferendosi al Furioso, scrive forse una delle più rappresentative definizioni di questo concetto:
così che spesso e sempre più, come in Raffaello, i suoi fantasmi poetici dovettero prender vita nel ricordo diretto delle sculture classiche, specie quando si trattò di dare forma a un ideale di bellezza che con quello classico venne sempre a combaciare: […] in forme che accolgono sempre più ricco l’apporto della cultura classica, lo studio diretto della scultura ellenistica e romana, non già come elemento esteriore di cultura, ma come nutrimento profondo della fantasia50 .
Cercando di arrivare a un punto, per Gnudi classica è tutta quell’arte che tende a qualcosa di alto passando per regole razionali e rigorose nell’invenzione ma flessibili nella creazione. L’alto può essere Dio, come nel gotico, o la Bellezza assoluta, come nel Seicento. La Bellezza non è nella realtà ma è un ideale al di sopra dell’essere umano. Lo studio dell’antico, tanto quanto quello della natura, eseguito in rapporto dialettico con la letteratura, è un mezzo per raggiungerlo51 . Niente di più diverso di quanto scritto nell’emblematico articolo su Cagnacci del 1937 (riprendo qui parte di una citazione già riportata):
non fu l’idealista Reni, ma il Caravaggio ‘naturalista’ di programma, che, scavando in sé stesso e non correndo dietro a una effimera parvenza di bellezza, giunse al vero classicismo formale, senza bisogno di correggere la realtà, prendendo anzi a modello, perché no?, anche il brutto naturale, non avendo questo nulla a che fare con il bello artistico, con lo stile.
Così si spiega anche la scelta, che non poteva essere solo politica, di cominciare le Biennali d’Arte Antica con Guido Reni. Per Gnudi, a partire almeno dal 1951, la caratteristica costante di Reni, nelle sue variazioni stilistiche, è proprio il tendere a un ideale di bellezza che raggiunge l’apice nella Strage degli Innocenti, individuata, infatti, come unica opera reniana per la mostra L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio (1962)52 :
l’arte di Guido è la prima netta ed esclusiva polarizzazione, nel secolo, verso quella ‘stella fissa’, verso quel punto magnetico, che è la poetica dell’Idea53: verso quel culto della Bellezza, che investe tutte le facoltà spirituali, tutto il sentimento dell’artista, che in Guido assume il carattere di un quasi ostinato rigore da far presentire, per molti aspetti, quello del Poussin. […] Reni più fermamente teso verso quell’ideale di bellezza che non contrastò come limite, ma anzi resse e condusse come luce e forza costante tutto il suo cammino54
L’origine di questa idea di classicismo potrebbe essere rintracciabile, oltre che in Croce, in un approccio antropologico alla storia dell’arte che sarà presente anche nel pensiero di Arcangeli e più in generale diffuso nella Bologna degli anni Cinquanta e Sessanta Di tale approccio ha dato un’immagine Andrea Emiliani nella chiacchierata del 26 novembre:
50 GNUDI 1986, si veda soprattutto Ariosto e le arti figurative (1975), pp. 119-160, in particolare p. 128.
51 Prova di quest’affermazione sono diversi scritti di Gnudi, tra i quali riporto solo alcuni passi di GNUDI 1962 per pertinenza con il tema prepostomi: «Un loro ideale classico, che agì […] come polo d’attrazione e come richiamo, come norma e legge di un’arte volta alla ricerca della verità e della bellezza» (ivi, p. 3); «l’opera d’arte conserva vivo il riflesso, non meno che della riflessione teorica, di questa riflessione culturale e letteraria che ad essa si accompagna» (ivi, p. 11); «L’estetica del classicismo e dell’Idea nasce dunque, nel Seicento, reagendo contro l’astrazione formalistica, e costantemente rivendica, poi, il valore della verità e della natura aprendosi nel tempo stesso, nello studio della classicità e dell’antico, ad un vasto respiro umanistico» (ivi, p. 12).
52 MORSELLI 2021, pp. 61-62.
53 Sarebbe necessario aprire una parentesi sull’Idea di Bellori ma credo che questo intervento, che vuole essere un breve spunto, si stia già dilungando troppo.
54 GNUDI 1962, pp. 14-15. Sul ruolo di Poussin nella V Biennale bolognese si veda FORMOSO 2021, pp. 102-105.
Arcangeli era un grande scrittore, un grande scrittore critico. Lui diceva che la storia non esisteva, aveva perfettamente ragione. Era in realtà di scuola […] spazio-temporale, non esiste la storia, non esiste la geografia, esiste il luogo e il modo. Sono solo le ceneri del crocianesimo che specialmente in Francia sono molto presenti, soprattutto in Francia nella geografia, la scuola di Marc Bloch e Lucièn Fèvre. […] Questo è un metodo che sommariamente si può chiamare antropologico. Che poi la città di Bologna sia una città di piena antropologia lo diceva Arcangeli stesso. […] Parlava di pensiero antropologico, pensiero del modo e del luogo. Non abbiamo altre capacità di leggere il telaio storico55 .
Non va dimenticato però che Gnudi è stato allievo di Igino Benvenuto Supino e grande amico di Giulio Carlo Argan, perciò, per quanto sia riuscito a elaborare un pensiero libero da ancore storiche e geografiche, sentiva la necessità di definire storicamente questo ideale classico da lui stesso messo in campo e che si differenzia dal classicismo individuabile anche negli artisti barocchi o nei neoveneti; ed era questo il tema principale di discussione con Arcangeli: «Gnudi non giungeva alla demolizione dello storicismo, questo ad Arcangeli invece dava un grande fastidio e glielo diceva»56 . In compenso, questa concretizzazione dei concetti astratti ha portato a una delle grandi intuizioni di Gnudi. L’approccio seicentesco al classicismo è un passaggio cardine della storia culturale che apre una nuova via all’Europa – e da qua la compresenza nella mostra del 1962 di artisti italiani e stranieri – poiché nasce un nuovo modo di fare arte, riflessivo, razionale, risultato di un flusso continuo di scambio tra artisti e teorici, tra letteratura e figurativo. Fiorisce per la prima volta un modello di classicismo che verrà ripreso ogni qual volta si senta il desiderio di fare un’arte che tenda alla Bellezza ideale. Per Gnudi è in questo momento che nasce la storia della civiltà artistica moderna:
Da quel momento, e ancor oggi, ogni ritorno alla classicità non può essere che interiore conquista. Sempre più accidentato e difficile si fa il cammino dell’Idea. Ma la fiaccola di questo ideale e razionale equilibrio, di armonia, di ordine, da Poussin viene consegnata all’arte moderna; e la raccoglierà Ingres, la raccoglierà Cézanne agli albori della civiltà artistica contemporanea, e, come termine, come elemento indispensabile fra i tanti della sua incessante sperimentazione, la raccoglierà Picasso; e tutti coloro che continuano a sentire il valore profondo di questo eterno richiamo alla grandezza della classicità, del mito, dell’Idea57
Cesare Gnudi plasma un pensiero in contrapposizione a quello, diffuso e comunemente accettato nella prima metà del Novecento, di Heinrich Wölfflin, criticando la struttura per categorie, la periodizzazione schematica – Rinascimento come sinonimo di classico, Seicento come sinonimo di barocco – e l’antitesi tra barocco e classicismo. Tant’è che non usa il termine manierismo, né affronta il tema, perché non sente il bisogno di una cesura tra Rinascimento e Seicento. Lui lavorava sulle opere e sugli esseri umani, cercando di evitare – nonostante a oggi sia una delle cause della diffusione della categoria classicismo – di muoversi per mezzo di sovrastrutture ed etichette. Riesce a fare crollare le teorie storicistiche di Wölfflin senza scadere nella metastoria. Bella è l’immagine che ci lascia Jacques Thuillier dello studioso bolognese:
Cette époque de l’après-guerre aimait les grands systèmes, marxisme ou freudisme, et faisait ses délices des idées générales, fussent-elles vieilles de cinquante ou quatre-vingts ans. Précisément, en histoire de l’art, où les systèmes sont rares, se complétait et se refermait un jeu de conceptualisation qu ’il fallait ou accepter, au prix de graves sacrifices, ou rejeter entièrement, non sans inconvénients divers. C’est à ce moment qu ’intervinrent le sourire, la finesse et l’efficacité de Cesare Gnudi58
55 Intervista ad A. Emiliani, 26 novembre 2015.
56 Ibidem.
57 GNUDI 1962, p. 36.
58 THUILLIER 1993, pp. 255-256.
Studi di Memofonte 34/2025
La ragione di questo breve intervento sta nella nebbia di fraintendimenti e riletture che ha alterato la nostra percezione del pensiero di Gnudi e che si è formata attorno a lui quando ancora era in vita. Sono stati per primi i suoi stessi contemporanei a non comprendere in diverse occasioni il fulcro delle sue idee e del suo metodo, trasformando «l’alta ispirazione che s’accompagna alla tensione della mente e del sentimento verso quell’ideale di bellezza»59 in un concetto fattuale applicabile alle singole opere. Il pensiero e il linguaggio di Gnudi, al pari di quelli longhiani, non vanno parafrasati – cosa che ho cercato di fare il meno possibile –, vanno presi come sono e accettati o rifiutati senza ulteriori ricami. In quanto diafani e aerei, i concetti da lui elaborati non vanno maneggiati e adattati a un contesto di studi empirici.
Uno dei più eclatanti fraintendimenti contestuali è quello che trapela dalla recensione di George Isarlo della mostra L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio pubblicata il giorno 9 ottobre 1962 sul giornale da lui diretto «Combat-Art» In questo lungo articolo Isarlo si interroga sulla realtà dell’esistenza del paesaggio classico e questa è la risposta che si è dato dopo avere visto la mostra curata da Gnudi:
le mot ‘classique’ nous permet de distinguer les peintures qui s’inspirent de la sculpture grécoromaine. Il s’agit, forcément, de figures, car il n’existe pas de paysage proprement dit dans la sculpture. Et puisque, à part quelques décorations, il ne nous est rien parvenu de la peinture grécoromaine, il me paraît difficile de parler du paysage classique. En réalité nous appelons ainsi tout paysage orné d’accessoires gréco-romains (architectures débris de colonnes, figures imitant les poses des staute antiques, etc.)
e prosegue sfociando in uno schematismo senza precedenti:
composez une nature morte avec ces mêmes accessoires de la sculpture gréco-romaine et vous obtiendrez ainsi une nature morte ‘classique’. Ou bien, portaiturez les modèles dans des poses imitant les statues: vous y créerez le portrait classique. Il s’agit donc des accessoires seulement, mais ces dernier ne changent nullement les différentes branches de la Peinture – Paysage, Histoire, Portrait, Nature Morte, etc. – qui, indépendamment de ces accessoires, évolueront normalement60 .
Forse meno esagerate, ma di certo ugualmente impressionanti, sono le distorsioni del suo pensiero fatte dalle persone a lui più vicine. Tra i vari, spicca un commento di Argan del 1986 sulla scelta del titolo della V Biennale:
Perché ideale classico? Perché questo ideale classico, questo classicismo del Seicento, sorge e si determina precisamente quando non c’è più un rapporto diretto di ricerca di analisi e di studio tra chi esercita la professione di artista e quella cultura classica che veniva considerata il fondamento necessario di qualsiasi attività artistica. Ideale del classicismo perché non esisteva più l’esperienza storica del classico. Ideale del classicismo perché l’antichità non era più considerata un periodo storico con tutti i suoi drammi, con i drammi che sono propri di un periodo storico, ma veniva considerata un ideale e un principio di autorità61 .
Il passaggio da ideale classico a idealizzazione del classico è certamente causa di molta confusione. L’altra figura che prende un grosso abbaglio è Ragghianti, in questo caso sul metodo applicato da Gnudi per l’organizzazione delle mostre: egli, nella sua recensione alla mostra del 1962 pubblicata su «L’Espresso», non capisce in toto gli intenti dell’amico e compagno politico perché
59 GNUDI 1962, p. 11.
60 ISARLO 1962.
61 ARGAN 1993, p. 120.
Breve argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi
imposta la critica proprio su uno dei punti chiariti nella già menzionata lettera pubblicata su «The Burlington Magazine» nel 196362 , ovvero la differenza fra semplificazione e banalizzazione:
Il tema, cioè il proposito della mostra, è semplificato all’estremo: far vedere come nasce e come agisce l’ideale classico nella pittura del seicento, e nel suo seno il paesaggio. Una dimostrazione, anzi una dimostrazione per eccesso, tenuta su d’un piano di specialismo geloso e, quasi, esotico, certo così separato, e su una materia, poi, tanto satura di cultura, di storia, di dottrina, di scuola da togliere ogni possibilità di sostituire, in poche righe, una ricostruzione storica e giudizi critici e di motivarli adeguatamente63
Forse quest’incomprensione nasce anche da un disaccordo di contenuto. Ragghianti era infatti contrario all’idea dell’esistenza di uno spirito classico che si trasmette dal XVII secolo fino a oggi, mentre riteneva si potesse leggere il Seicento come un momento storicamente ben definito in cui esiste un classicismo accademico, prima italiano e poi francese, che produce opere che riprendono puntualmente l’antico greco e romano.
Ovviamente Gnudi è stato anche, in diverse occasioni, capito e seguito, come in un interessante articolo di Luigi Grassi su un disegno di Guido Reni, articolo di soli due anni successivo alla I Biennale e in cui l’autore accorda proprio alla mostra il merito di avere fatto capire che in un unico artista possono coesistere due o più stili e modelli d’ispirazione64 .
Probabilmente una delle cause principali dei fraintendimenti è nella scelta del termine classicismo, che sarebbe forse utile sostituire con umanesimo, idea che prende spunto dal discorso di Giulio Carlo Argan tenuto in occasione dell’assegnazione dell’Archiginnasio d’oro a Cesare Gnudi:
Non avrebbe fatto quello che ha fatto se non fosse l’uomo che è: un esempio, un modello di umanità perfetta. Dò alla parola umanità, humanitas, il senso preciso che aveva al principio del Quattrocento, all’alba di quella cultura che si chiama appunto umanistica, e di cui Gnudi è stato e rimane uno dei più convinti, fedeli e, purtroppo, ultimi assertori: una cultura che non ammetteva cesure tra il pensiero speculativo e l’azione pratica, tra l’amore di Maddalena e l’ufficio di Marta, e per cui non v’era impegno politico che non nascesse dalla esperienza storica né esperienza storica che non portasse, imperativamente, all’azione politica. E come per quei primi umanisti la civiltà era anzitutto la civitas e la città il luogo steso della storia e della politica, così per Gnudi Bologna è stata, più ancora che il centro dei ricordi e degli affetti, la fonte e la ragione di un’altra, virile vocazione civili, e cioè culturale e politica ad un tempo. Per questo, pur essendo studioso di prestigio internazionale, egli ha devotamente, attivamente dedicato la vita a conservare Bologna65 .
Gnudi stesso usa in un’occasione il termine umanesimo, rifacendosi all’«humanisme gothique» di Focillon, per descrivere la nascita di una «nuova intuizione estetica» che lega l’uomo tramite la poesia al ‘mondo ideale’66 . In conclusione, spero sia apparso chiaro che non è mia intenzione entrare nel merito del valore delle idee e del metodo di Cesare Gnudi, quanto ricostruire le radici dimenticate sulle quali si sono erette le Biennali d’Arte Antica di Bologna a partire dal 1954, poiché temo che oggi abbiamo meno coscienza delle problematiche connesse a questi temi di quanto non ne avessero al tempo. Per questo chiudo riportando l’eloquente citazione in apertura del saggio di Gnudi nel catalogo de L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio del 1962 tratta da Pascal: «Que l’homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté; qu’il éloigne sa vue des objets bas qui l’environnent».
62 GNUDI 1963.
63 RAGGHIANTI 1962.
64 GRASSI 1956, p. 16.
65 IL DISCORSO DI GIULIO CARLO ARGAN 1973, p. 11.
66 GNUDI 1982, p. 47.
Studi di Memofonte 34/2025
BIBLIOGRAFIA
ARGAN 1993
G.C. ARGAN, Classicismo: Rinascimento, in IL CLASSICISMO 1993, pp. 119-124.
ARTISTS IN 17TH CENTURY ROME 1955
Artists in 17th Century Rome. A Loan Exhibition to Save Gosfield Hall for the Nation as a Residential Nursing Home with Hospital Wards for the Elderly Sick and Infirm of Limited Means, catalogo della mostra, a cura di D. Mahon, D. Sutton, Londra 1955.
BAZIN 1962
G. BAZIN, Prefazione, in L’IDEALE CLASSICO 1962, pp. XV-XVIII.
BERTI ARNOALDI VELI 1993
F. BERTI ARNOALDI VELI, Introduzione, in IL CLASSICISMO 1993, pp. 7-10.
BRUNETTI 2021
V. BRUNETTI, Alessandro Algardi, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 126130.
COSMI 2021
A COSMI, Il Seicento emiliano 1959, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 8898.
COVA 2008
P. COVA, Leone Pancaldi e le Biennali d’Arte Antica, «Annuario della Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte dell’Università di Bologna», VII, 2008, pp. 173-182.
CROCE 1920
B. CROCE, Saggi filosofici, V. Nuovi saggi di estetica, Bari 1920.
CROCE 1921
B. CROCE, Scritti di storia letteraria e politica, XVII. La poesia di Dante, Bari 1921.
CURTI 2021
B. CURTI, Il paesaggio “ideale” e Nicolas Poussin nella mostra del 1962, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 106-114.
EMILIANI 1993
A. EMILIANI, Conclusione, in IL CLASSICISMO 1993, pp. 373-379.
FERRETTI 2019
M. FERRETTI, Da Guido Reni a Guercino: le mostre bolognesi dal 1954 al 1968, in Fortuna del Barocco in Italia. Le grandi mostre del Novecento, atti del convegno (Torino 28-29 novembre 2016), a cura di M. di Macco, G. Dardanello, Genova 2019, pp. 177-195 (disponibile on-line https://www.fondazione1563.it/wp-content/uploads/2022/01/Fortunadel-Barocco-in-Italia-Sagep-Fondazione-1563-2019.pdf)
Breve argomentazione sull’Ideale classico nel pensiero di Cesare Gnudi
FORMOSO 2021
M. FORMOSO, Genesi della mostra del 1962, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 99-105.
GHEDINI 1948
F. GHEDINI, Introduzione, in Mostra celebrativa di Giuseppe M. Crespi, catalogo della mostra, a cura di F. Arcangeli, C. Gnudi, prefazione di R. Longhi, Bologna 1948, p. 9.
GNUDI 1937
C. GNUDI, Note sullo stile di Guido Cagnacci, «Bologna Rivista Mensile del Comune», XV, 2-3, 1937, pp. 34-39
GNUDI 1954a
C. GNUDI, Introduzione, in Mostra di Guido Reni. Catalogo critico, catalogo della mostra, a cura di G. Cavalli, con la collaborazione di A. Emiliani, L. Puglioli Mandelli, Bologna 1954, pp. 13-44.
GNUDI 1954b
C. GNUDI, Una fantasia interrotta. I ‘quadroni’ del Cagnacci (1951), «Critica d’Arte», s. III, I, 1, 1954, pp. 33-48.
GNUDI 1959
C. GNUDI, Giotto, Milano 1959.
GNUDI 1962
C. GNUDI, Saggio introduzione, in L’IDEALE CLASSICO 1962, pp. 3-37.
GNUDI 1963
C. GNUDI, ‘The Classical Ideal’ at Bologna (1962), «The Burlington Magazine», CV, 720, 1963, pp. 126-127.
GNUDI 1978
C. GNUDI, Considerazioni sul gotico francese, l’arte imperiale e la formazione di Nicola Pisano, in Federico II e l’arte del Duecento italiano, atti della III Settimana di Studi di Storia dell’Arte Medievale dell’Università di Roma (Roma 15-20 maggio 1978), a cura di A.M. Romanini, I-II, Galatina 1978, I, pp. 1-17.
GNUDI 1982
C. GNUDI, L’arte gotica in Francia e in Italia, Torino 1982.
GNUDI 1986
C. GNUDI, L’Ideale classico. Saggi sulla tradizione classica nella pittura del Cinquecento e del Seicento, Bologna 1986.
GRASSI 1956
L. GRASSI, Un disegno di Guido Reni, «Paragone. Arte», VII, 81, 1956, pp. 13-20.
GUMIERO 2021a
E. GUMIERO, La quinta Biennale d’Arte Antica: riflessioni sull’allestimento dei dipinti, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 171-175.
GUMIERO 2021b
E. GUMIERO, Momenti del classicismo a Roma: la sezione antologica della quinta Biennale d’Arte Antica, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 115-122.
IL CLASSICISMO 1993
Il Classicismo. Medioevo, Rinascimento, Barocco, atti del Colloquio Cesare Gnudi (Bologna 3-5 aprile 1986), a cura di E. de Luca, Bologna 1993.
IL DISCORSO DI GIULIO CARLO ARGAN 1973
Il discorso di Giulio Carlo Argan, in L’ARCHIGINNASIO D’ORO 1973, pp. 11-17.
IL RINGRAZIAMENTO DI CESARE GNUDI 1973
Il ringraziamento di Cesare Gnudi, in L’ARCHIGINNASIO D’ORO 1973, pp. 19-25.
ISARLO 1962
G. ISARLO, Expositions à Bologne, à Trévise, à Varese. Paysage classique-Cima-Morazzone, «CombatArt», 8 ottobre 1962.
LA CASA DI CESARE GNUDI 1986
La casa di Cesare Gnudi, a cura di F. Berti Arnoaldi Veli, Bologna 1986.
L’ARCHIGINNASIO D’ORO 1973
L’Archiginnasio d’oro a Cesare Gnudi, numero monografico di «Bologna. Documenti del Comune», 6, 1973.
LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021
La tradizione dell’“Ideale classico” nelle arti figurative dal Seicento al Novecento, a cura di M. di Macco, S. Ginzburg, Genova 2021 (disponibile on-line https://www.fondazione1563.it/pdf/F1563_Ideale-Classico_MaccoGinsburg.pdf)
L’IDEALE CLASSICO 1962
L’Ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio, catalogo della mostra, prefazione di G. Bazin, saggio introduttivo di C. Gnudi, Bologna 1962 (seconda edizione riveduta e corretta).
LONGHI 1935
R. LONGHI, Momenti della pittura bolognese, «L’Archiginnasio», XXX, 1-3, 1935, pp. 111-135.
LONGHI 1961
R. LONGHI, Scritti giovanili 1912-1922, t. 1. Piero e la pittura veneziana; caravaggeschi; pittori futuristi; Boccioni scultore; la Mostra seicentesca del 1922, etc., Firenze 1961 (fa parte di Edizione delle opere complete di Roberto Longhi, I-XIV, tt. 18, Firenze 1956-2000).
LONGHI 1962
R. LONGHI, Momenti della pittura bolognese (dai Carracci a Morandi), «Paragone. Arte», XIII, 155, 1962, pp. 44-52.
LONGHI 1974
R. LONGHI, Momenti della pittura bolognese, in R. Longhi, Da Cimabue a Morandi, saggi di storia della pittura italiana a cura di G. Contini, Milano 1974, pp. 191-217 (edizione originale LONGHI 1935).
MANSUELLI 1983
G.A. MANSUELLI, Cesare Gnudi, «Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna Atti e Memorie», n.s., XXXIII, 1983, pp. 1-8.
MANTOVANI 1995-1996(1996)
M MANTOVANI, Leone Pancaldi (Bologna, 1915-1995), «Accademia Clementina. Atti e Memorie», 35-36, 1995-1996(1996), pp. 339-341.
MILOZZI 2021
A. MILOZZI, L’impronta di Longhi, l’emergere di Mahon nella mostra dei Carracci, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 78-87
MORSELLI 2021
R. MORSELLI, Una certa idea di Reni, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 6166.
PARISI 2021a
C. PARISI, Duquesnoy, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 131-135.
PARISI 2021b
C. PARISI, Leone Pancaldi e la luce, in LA TRADIZIONE DELL’“IDEALE CLASSICO” 2021, pp. 187189.
PEPPER 1988
D.S. PEPPER, Guido Reni, Cesare Gnudi e la prima Biennale, «Accademia Clementina. Atti e Memorie», 22, 1988, pp. 37-42.
RAGGHIANTI 1962
C.L. RAGGHIANTI, Cercavano la verità nei paesaggi, «L’Espresso», 7 ottobre 1962.
ROMANINI 1993
A.M. ROMANINI, Cesare Gnudi e il Classicismo medievale, in IL CLASSICISMO 1993, pp. 23-34.
ROVINETTI 1981
A. ROVINETTI, Cesare Gnudi (Bologna 1910-1981), Bologna 1981.
SAPEGNO 1993
N. SAPEGNO, Cesare Gnudi e il concetto di Classicismo, in IL CLASSICISMO 1993, pp. 15-20.
THUILLIER 1993
J. THUILLIER, Classicismo barocco Cesare Gnudi et le problème du Seicento, in IL CLASSICISMO 1993, pp. 253-258.
TRIGLIA 1994
P.P. TRIGLIA, Cesare Gnudi storico dell’arte, tesi di Laurea in Storia dell’Arte, Università degli Studi di Pisa, A.A. 1993-1994.
VENTURI 1959
L. VENTURI, Gli eredi dei Carracci, «L’Espresso», 5 luglio 1959.
ABSTRACT
L’articolo ha l’intento di riaprire alcune strade della critica d’arte novecentesca per recuperare idee e teorie storico-artistiche oggi dimenticate ma ancora in grado di dare il proprio apporto alle riflessioni sui grandi temi della ricerca sul Seicento italiano ed europeo. Si ripropone, quindi, di ragionare sul concetto di ideale classico e sulla cosiddetta etichetta di classicismo all’interno del pensiero dello storico dell’arte, soprintendente e direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna Cesare Gnudi. L’analisi muove i propri passi dalle Biennali d’Arte Antica, progettate e organizzate dallo stesso Gnudi nel capoluogo emiliano durante i decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, per poi cercarne le radici e i frutti in un’antologica riesamina della produzione scritta dello studioso e della sua fortuna nelle ricerche di altri intellettuali a lui vicini.
The article aims to reopen some topics of twentieth-century art criticism to recover historicalartistic ideas and theories that are now forgotten but still capable of giving their contribution to reflections on the major themes of research on the Italian and European seventeenth-century art. The author therefore intends to think about the concept of the classical ideal and the so-called label of classicism within the thought of Cesare Gnudi, art historian, superintendent, and director of the Pinacoteca Nazionale of Bologna. The analysis moves its steps from the Biennali d’Arte Antica, which Gnudi planned and organized in the Emilian capital during the decades following the Second World War, and then seeks their roots and results in an anthological re-examination of the scholar’s written production and of his reception in the research of other intellectuals close to him.