

TrasformAzioni





La presente pubblicazione è suddivisa in due sezioni principali: la prima dedicata alla narrazione del progetto, la seconda invece presenta un breve manuale pratico rivolto a chi opera nel settore. L’obiettivo del report é dunque quello di condividere l’esperienza realizzata mettendo in luce i punti di forza, e le difficoltà riscontrate e proporre strategie orientate a rendere le piccole e medie realtà teatrali più accessibili, stimolando l’attenzione delle politiche culturali e sociali e la creazione di una rete.
Crediti
Un progetto di Idra Teatro 2023-2024
In partenariato con UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sede Brescia
Con la collaborazione di Alessandro Tampieri
Con il sostegno di Fondazione Comunità Brescia, Bando Cultura 2023
Fotografie: Lisa Carminati e archivio Idra Teatro
Report di progetto e “10 buone pratiche per un teatro accessibile” a cura di Alessandro Tampieri






1. PREMESSA
Dall’indagine a seguito del progetto europeo ‘Europe Beyond Access’ (2020-2022), si è evidenziato quanto poco sia stato fatto per rendere lo spettacolo accessibile ai soggetti con disabilità. La Lombardia ha iniziato a occuparsi del tema solo nel 2021 con la prima conferenza organizzata per sensibilizzare il settore dello spettacolo, rivelando un panorama molto frammentato e lasciato alle singole iniziative, spesso appannaggio delle fondazioni liriche con maggiori possibilità economiche. Ne è emersa un’ampia zona oscura di medie o piccole realtà, che ancora non avevano avviato alcuna strategia in merito alle diverse esigenze legate alla disabilita, soprattutto per l’impossibilità di sostenerne i costi particolarmente onerosi.
Il progetto TrasformAzioni nasce dunque nel 2023 sulla base di quanto emerso in questa analisi, per sviluppare strategie e modelli d’innovazione in grado di rendere i piccoli e medi teatri luoghi più accessibili negli spazi, nella programmazione e nella comunicazione, lungo un arco temporale di quattro anni per potersi focalizzare ogni anno su una specifica forma di disabilità: quella sensoriale visiva, quella sensoriale uditiva e infine quella cognitiva.
Fondamentale per avviare questa fase pilota è stata la co-progettazione che ha visto la partecipazione attiva di diverse figure in grado di mettere in campo la specificità delle proprie esperienze, al servizio di una rete di partenariato e collaborazione.
Capofila del progetto è stato IDRA Teatro, con sede presso il centro per le nuove culture MO.CA. nel cuore della città di Brescia. Una realtà radicata sul territorio dal 1998 e riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la sua mission di formazione, produzione e ospitalità di spettacoli di teatro contemporaneo, in costante dialogo con la comunità di riferimento, e le diverse professionalità dello spettacolo dal vivo.
Partner di progetto in questo primo anno dedicato alla disabilità visiva è stata la sezione locale a Brescia di UICI Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con la sua funzione di rappresentanza e tutela delle persone associate e la finalità di solidarietà sociale tramite i diversi servizi offerti. A questa partnership si è aggiunta la collaborazione con l’attore e regista Alessandro Tampieri, coinvolto come consulente esterno nella prima fase progettuale e come parte integrante del lavoro in tutta la fase attuativa, per la sua esperienza come esperto in cultura e comunicazione dell’accessibilità, con particolare riferimento al contesto della disabilità visiva.
Tre le linee guida seguite per strutturare il progetto:
1. Mappatura dei bisogni e delle esigenze di soggetti ciechi e ipovedenti;
2. Studio di azioni mirate a un maggior coinvolgimento delle persone con disabilità che le vedesse coinvolte come parte attiva e non solo utenti finali relegate in ruolo di fruizione passiva;
3. Sensibilizzare il settore teatrale e aprirsi alle richieste di nuovi pubblici, sulla base di un modello sostenibile e replicabile, da poter condividere in futuro.
Beneficiari primari sono stati dunque i soggetti con disabilità visiva residenti a Brescia e provincia, con un target diretto rappresentato dalla stessa cittadinanza e un target indiretto rappresentato da operatrici e operatori del settore.
Per questo è stato importante agire sempre su un doppio binario che da un lato tenesse presenti l’esigenze e le aspettative della persone cieche e ipovedenti e dall’altro il mondo di addette e addetti ai lavori. Da qui la scelta di intraprendere una serie di azioni mirate a 360° per agire sull’accessibilità da più fronti, sviluppando un percorso che dal focus group, potesse proseguire nel laboratorio, fino alla partecipazione al festival con lo spettacolo audiodescritto, la tavola rotonda dove illustrare il percorso intrapreso e la stesura di questo e-book, come strumento concreto di diffusione dei risultati raggiunti e condivisione dell’esperienza maturata.
Nel contesto storico in cui viviamo dove i muri le fortezze si ergono a difesa di una fantomatica identità, da ormai qualche anno mi riecheggiavano in testa queste parole senza sapere chi le avesse pronunciate: Non fare caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini. Mi sono sempre sembrate rappresentative per descrivere l'attitudine con cui noi contemporanei guardiamo la diversità e tanto più affrontando la questione spinosa del diritto alla partecipazione della vita sociale delle persone disabili. Il contesto è cambiato: prima le persone disabili erano pressoché invisibili. Ora invece si fanno sentire, hanno gli strumenti per rivendicare una loro posizione ed è per questo che noi lavoratori dello spettacolo non possiamo non ascoltare queste parole per trovare soluzioni comuni - certamente non facili- e partecipare a questa rivoluzione culturale dove il disegno di una linea diventa possibilità di scoperte e ringrazio Frida Kahlo per aver trovato queste parole che si incarnano in una vita esemplare.
“
Davide D’Antonio
Direttore Artistico Idra Teatro e Wonderland Festival

2. IL FOCUS GROUP
La prima fase effettiva del progetto avviato nel 2024 è stata la pianificazione a inizio febbraio di un focus group come momento di analisi concreta dei bisogni della comunità di riferimento, organizzato su due giornate a fasce orarie diverse - venerdì pomeriggio e sabato mattina - per garantire una più ampia partecipazione, facendo scegliere alle persone interessate il giorno e l’orario preferiti. Tale accorgimento ha permesso l’adesione di 25 tra persone cieche e ipovedenti della provincia di Brescia, arrivate da sole o accompagnate, cui è stato dato appuntamento alla sede UICI con un invito basato su tre semplici domande:
Ti piacerebbe esplorare un teatro?
Ti piacerebbe cimentarti in un laboratorio teatrale?
Ti piacerebbe scoprire uno spettacolo nuovo?
Se hai risposto almeno un sì, ti aspettiamo per parlarne insieme.

La scelta strategica di un luogo familiare e il contesto da chiacchierata informale con tanto di momento aperitivo per un brindisi finale, hanno consentito di sondare esigenze e aspettative anche molto diverse tra loro. Punto di partenza è stata una domanda volutamente molto generale per non influenzare le risposte e vedere cosa nasceva spontaneamente. All’input ‘La prima cosa che vi viene in mente quando sentite la parola teatro’ sono emerse reazioni che andavano da ‘emozionante, coinvolgente, spettacolare’ via via fino a ‘noioso, finto, inaccessibile.’
La discussione è proseguita con un secondo stimolo che consentisse di entrare più nello specifico. Simulando che avessero vinto un biglietto per andare a teatro, abbiamo sondato le varie possibilità che si aprivano. Anche in questo caso sono derivati riscontri diversi in linea con un gruppo eterogeneo per anagrafica ed esperienze pregresse, nonché per bisogni individuali ben distinti. Le risposte sono spaziate dalla gioia, alla curiosità, alla perplessità, fino alle questioni più pratiche che avrebbero dovuto affrontare: con chi vado, come ci arrivo, chi mi accompagna, cosa mi metto, dove vado a mangiare dopo, cosa danno, quanto costa? ecc ecc.
Questo ha permesso a IDRA di far conoscere meglio la propria progettualità e alle persone presenti le proprie aspettative.
Ne è emersa una comune non frequentazione del teatro contemporaneo dovuta a svariati fattori, quali scarsa conoscenza, timore di un repertorio astratto o pesante, mancanze di proposte mirate. Cosa che non ha fatto che confermare i dati per cui gli spettacoli accessibili cui avevano partecipato erano essenzialmente opere liriche e musical, scelte che avevano creato un loro gusto di pubblico alla ricerca di generi musicali, spesso brillanti o d’intrattenimento e in alternativa prosa dialettale. Nello stesso tempo è stato ben evidente anche il loro interesse a trarre vantaggio dall’opportunità che veniva offerta, sulla spinta di diverse motivazioni: curiosità, voglia di mettersi in gioco, arricchimento personale, non ultimo lo spirito di condivisione con altre persone della stessa comunità.
Desideri che si sono manifestati nella richiesta sia di una programmazione più accessibile, sia di un laboratorio che potesse incontrare il loro interesse insieme pratico e teorico, non solo di andare a teatro ma anche di fare teatro con un ruolo da protagonista.
3. IL TEATRO
Secondo momento del progetto è stato aprire le porte della sede di IDRA per un pomeriggio d’inizio aprile, con lo stesso clima di incontro informale seguito da un aperitivo conclusivo. Questa fase ha avuto due finalità principali. Da un lato fare conoscere concretamente il teatro come spazio fisico, dall’altro entrare ancora meglio nel cuore del progetto che nel frattempo stava prendendo corpo.
Una prima parte dell’incontro ha visto dunque l’esplorazione dei luoghi.
Grazie a un plastico dello storico palazzo MO.CA. e a una planimetria in rilievo della città è stato possibile localizzare meglio la posizione per rendere più autonomi i futuri spostamenti - per questa prima volta il gruppo aveva infatti organizzato due meeting point per arrivare insieme - e percorrere così gli spazi attraverso le mani ancora prima che con i piedi. Fondamentale in questa prima sessione è stato il riscontro da parte della persona referente dell’UICI dell’accoglienza ricevuta e la segnalazione di eventuali barriere od ostacoli fisici. L’obiettivo duplice era infatti rendere più familiare per il gruppo la visita in un luogo nuovo e al contempo capire quanto il teatro fosse accessibile o meno. È stato così importante prendersi il tempo necessario per vagliare le singole esperienze, dalle problematiche sul come arrivare, a come spostarsi al suo interno, l’ubicazione dei bagni, le sedute, l’illuminazione fino alla gestione di cani guida, sedie a rotelle, oltre a un feedback sull’aiuto avuto dallo staff.
La seconda parte dell’incontro si è invece concentrata sulla presentazione del laboratorio teatrale che rispetto al focus group aveva assunto una maggiore definizione e chiarezza. Importante è stato infatti ascoltare e valutare le diverse risposte ricevute in febbraio e individuare un gruppo di soggetti maggiormente interessati a proseguire, numero fisiologicamente ridimensionato come prevedibile, ma sempre di entità rilevante. All’incontro di aprile erano infatti presenti 15 tra persone cieche e ipovedenti con eventuali accompagnatrici e accompagnatori. Sulla base delle indicazioni ottenute dal primo monitoraggio e a seguito di una più attenta valutazione, si è cosi optato per rimodulare l’idea iniziale del progetto nella struttura della fase formativa, passando da 2 percorsi brevi di 5 incontri l’uno, a un unico percorso estensivo in 10 incontri, che potesse coniugare la parte del fare più dinamica con la parte più teorica del sapere, incorporando quegli elementi utili per la lettura della scena contemporanea all’interno di pratiche teatrali più interattive.




4. IL LABORATORIO
Ad aprile il progetto è così entrato nel vivo con l’inizio del laboratorio, pensato in accordo con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Brescia, come strumento propedeutico all’espressività teatrale e allo stesso tempo come mezzo per avvicinare un futuro pubblico al teatro contemporaneo pressoché sconosciuto, nell’ottica di un’azione strategica di audience development.
I 10 incontri affidati ad Alessandro Tampieri sono stati programmati con cadenza bisettimanale in orario pomeridiano tra la primavera e l’autunno, sospendendoli nei mesi di luglio e agosto per la pausa estiva.
Sede del laboratorio è stato lo stesso teatro di IDRA o in alternativa altre sale prove presenti sempre a MO.CA. con incontri rigorosamente in presenza. Si è così vinta facilmente la ritrosia iniziale di alcune persone iscritte a voler frequentare da remoto in caso di assenza o a riascoltare le lezioni registrate. È stata invece evidente da subito la valenza non soltanto didattica ma anche sociale dello stare insieme dal vivo, sia per una maggiore coesione, sia per la tipologia di lavoro proposto, basata sull’esperienza sia individuale sia collettiva.
Tre le linee guida che si sono seguite nell’organizzazione del programma di studio, avendo avuto chiaro fin dall’inizio che non si sarebbe lavorato a un copione specifico per una messa in scena finale, ma si sarebbe optato per diverse tecniche introduttive ai molteplici linguaggi teatrali.
Una parte delle lezioni è stata così dedicata all’improvvisazione su situazioni o temi dati, fase fondamentale per rompere il ghiaccio e premettere a tutti gli elementi del gruppo di partecipare nonostante il differente bagaglio di esperienze maturate in precedenza. Un altro momento è stato riservato ai meccanismi dello storytelling trovando nella narrazione una modalità molto congeniale a un insieme di soggetti che con il raccontare storie poteva facilmente ovviare alla disabilità visiva. Un’ultima sezione del lavoro è stata poi rivolta a una pratica più fisica, compatibilmente a tutte le difficoltà che l’attività corporea comporta, da quella anagrafica a quelle legate ai differenti residui visivi o alla totale assenza della vista.
Nonostante queste apparenti barriere, ogni partecipante ha potuto cimentarsi con gli esercizi proposti sulla base delle proprie possibilità, sperimentando in una chiave più teatrale l’esplorazione dello spazio, la scoperta del proprio corpo e di quelli altrui, l’attivazione di quegli elementi sensoriali alternativi alla vista, così preziosi per l’espressività attoriale.
La combinazione di vari fattori quali un calendario d’incontri cadenzati con regolarità senza però una frequenza troppo fitta o rigida, la mancanza di preoccupazione per l’andata in scena a tutti i costi, la curiosità per il lavoro proposto, il clima di lavoro rilassato ecc ecc ha agito da collante per un gruppo che si è stabilizzato a 12 persone iscritte e partecipi, creando un ponte, non solamente temporale, che le ha portate fino a novembre con l’edizione 2024 del festival Wonderland.
Gli incontri stimolavano il cervello a inventare, a cercare e lavorare percorsi/connessioni nuove, cercando di uscire dai canoni/schemi che si seguono abitualmente, che sono più semplici ma limitano la fantasia. All’inizio non è semplice e ti costringe a reinventarti, soprattutto se la tua personalità è razionale e non ha l’istintività come dote innata.
Daniele Partecipante al laboratorio “

5. IL PRE-FESTIVAL
Con la fine del laboratorio e l’avvicinarsi dell’inizio del festival è stato quindi utile trovare un ulteriore momento di confronto con UICI per affinare strumenti e strategie in grado di garantire una maggiore accessibilità da più prospettive, in quella reciprocità che fin dall’inizio ha garantito un costante dialogo di scambio e mutuo arricchimento.
Il monitoraggio delle eventuali problematiche riscontrate nei mesi precedenti e l’esperienza maturata nell’accoglienza e gestione dei soggetti con disabilita visiva, sono stati oggetto di un’attenta valutazione da parte della persona referente per l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per poter elaborare le linee guida da trasmettere allo staff di volontarie e volontari, che avrebbero accompagnato il pubblico durante il festival. È stato così importante passare in rassegna la modalità di approccio, sia verbale sia fisico, nel relazionarsi a persone cieche e ipovedenti, raccontando l’origine e lo sviluppo del progetto e rispondendo a eventuali dubbi e curiosità. Pratica estremamente efficace proposta durante l’incontro di formazione è stato l’esercizio di role playing svolto a coppie, con simulazione della cecità, in una camminata a occhi a chiusi, sotto la guida di un’altra persona sconosciuta. Questa attività ha permesso in maniera chiara e diretta di sperimentare le barriere e gli impedimenti che incontra chi vede poco o non vede nulla, ma soprattutto la condizione emotiva e psicologica di dovere stabilire un immediato rapporto di fiducia tra chi guida e chi segue.
Oltre alla formazione del personale a contatto diretto col pubblico, si è poi proceduto alla verifica della comunicazione del festival con particolare attenzione al sito di Wonderland e alla biglietteria on line. Il web designer del festival e il tecnico di riferimento UICI hanno avuto modo di confrontarsi sulle scelte da intraprendere che conciliassero la grafica voluta dalla direzione artistica, i parametri di fruibilità di un sito secondo le norme vigenti sull’accessibilità, le tecnologie e le app di nuova generazione utilizzate dai soggetti con disabilità visiva per accedere alla navigazione. Fermo restando, come era ben evidente a tutte le parti coinvolte, che alcuni soggetti più refrattari al mondo digitale sarebbero dovuti essere raggiunti e sollecitati in altro modo, per quanto riguarda la divulgazione del programma, la prenotazione e l’acquisto dei biglietti. Ancora una volta la collaborazione con UICI si è dimostrata un punto di riferimento indispensabile, per l’azione capillare di informazione e di contatto diretto nella rete di tutte le persone afferenti all’Unione.
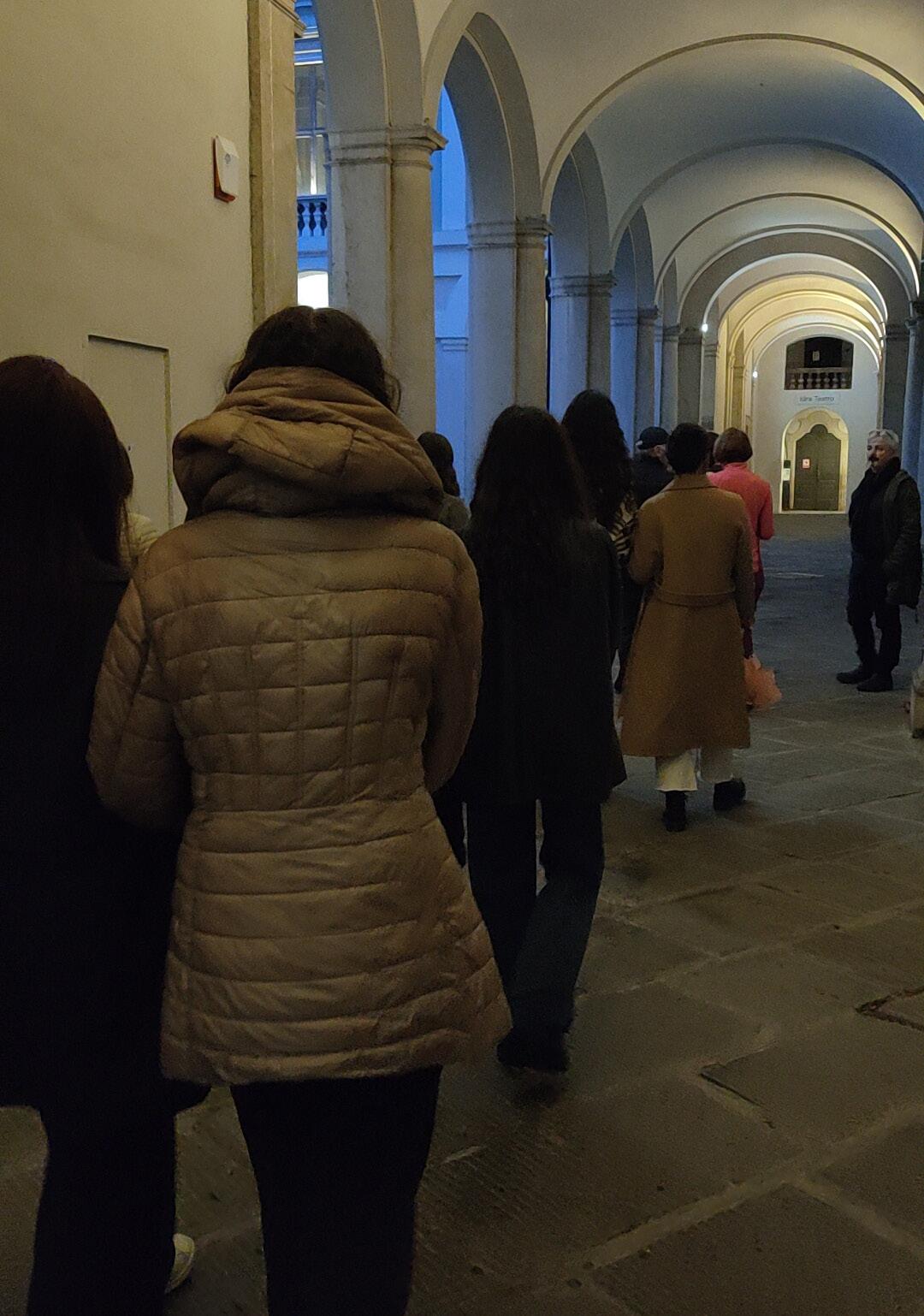
6. LO SPETTACOLO
Una volta cominciato il festival si è poi deciso di rendere uno dei titoli in programma completamente accessibile alle persone con disabilità visiva, proponendo tutte le opzioni al momento previste per lo spettacolo dal vivo: tour tattile, audiointroduzione e audiodescrizone.
La valutazione è avvenuta esaminando le possibili variabili e incrociando i diversi punti di vista che tenessero conto del maggior numero di fattori: dalle caratteristiche dello spettacolo in merito all’esito di una buona audiodescrizione - ricordiamo che tutto sulla carta può essere audiodescritto ma senza dubbio alcuni titoli o regie si prestano più di altri a una buona resa - alle questioni logistiche quali l’assetto dello spazio teatrale e la postazione per l’audiodescrittore, la disponibilità della compagnia per il tour tattile, la proposta di generi che potessero incontrare il gusto di un nuovo pubblico ecc ecc. Si è così deciso in accordo con la direzione artistica di selezionare quattro titoli che avessero le caratteristiche richieste da presentare e vagliare insieme al gruppo, che alle considerazioni artistiche e tecniche ha potuto aggiungere le proprie esigenze: interesse personale, comodità di giorno e orario, conoscenza della sala. Luogo dello spettacolo non era infatti la sede di IDRA ma il Sant’Afra di cui si era opportunamente verificata l’accessibilità degli spazi, teatro che per altro il gruppo già conosceva.
La scelta finale è così ricaduta su ‘Cenerentola’ di Zaches Teatro, che riusciva a soddisfare tutte le voci sopra elencate. Un lavoro ispirato alla tradizione orale e a due delle versioni scritte della famosissima favolaquella dei fratelli Grimm e ‘La Gatta Cenerentola’ di Basile - che presentava una storia nota e adatta a un pubblico di tutte le età, rivisitata però dai linguaggio contemporaneo, con una commistione di teatro danza e teatro di figura decisamente innovativa e una regia dall’impatto visivo di forte suggestione, particolarmente stimolante ad essere audiodescritta. Si è per tanto organizzato il tour tattile prima della replica che ha permesso a 7 persone cieche e ipovedenti di visitare il palco, soffermandosi soprattutto sui pupazzi, elementi cardine dell’allestimento.
L’esplorazione della scena è stata abbinata a un incontro con Luana Gramegna, regista e coreografa, che con generosità ha voluto essere presente per raccontare al meglio le scelte artistiche, il lavoro drammaturgico, la ricerca delle fonti, la studio sulla musica e il movimento, l’interazione tra interpreti e marionette. Per lo spettacolo, le persone cieche e ipovedenti presenti sono salite di numero a 10, con eventuali accompagnatrici o accompagnatori, cui era stata riservata una speciale offerta di biglietti gratuiti e ridotti pensata appositamente per questa utenza.

Chi non era presente al tour tattile ha potuto comunque usufruire dell’audiointroduzione per contestualizzare la storia e le note di regia, così come chi era presente ha potuto approfondire quanto già sperimentato durante la visita. Nel corso della replica si è poi realizzata in diretta l’audiodescrizione vera e propria, apprezzata all’unanimità dalle persone presenti, considerando anche qualche operatrice e operatore del settore e lo staff della compagnia stessa che con grande interesse e curiosità ha espresso la richiesta di ascoltarla tramite gli appositi auricolari.

Wonderland è stato come una cerimonia di nozze, ovvero non un arrivo ma una partenza di una lunga vita prospera e felice, questo vi auguro e mi auguro di vivere tale esperienza per decenni
Lorendana, Partecipante
7. IL CONVEGNO
Momento conclusivo del progetto è stata l’organizzazione di una tavola rotonda in occasione di Wonderland Festival, dove presentare i risultati raggiunti e raccontare l’esperienza maturata, tramite l’analisi delle difficoltà incontrate e delle strategie adottate. Realizzato in collaborazione con C.Re.S.Co e Centro Studi Socialis, l’incontro è stato aperto alla cittadinanza anche se mirava principalmente a stimolare un momento di scambio tra le professionalità del settore spettacolo. 30 le persone partecipanti che attivamente si sono confrontate su questioni cruciali quali il ruolo del digitale, il rapporto tra artisti e artiste in residenza e comunità ospitanti e, per l’appunto, l’accessibilità teatrale.

Presenti nel panel dedicato alla disabilità, Stefania Dolcini per la progettazione e comunicazione di IDRA Teatro, Monica Taffi referente UICI e Alessandro Tampieri, che ha guidato la discussione partendo da due considerazioni iniziali di fondamentale importanza nell’approccio all’accessibilità. La prima è l’importanza di passare dall’ottica dell’inclusione a quella della condivisione, sostituendo pratiche che trovano l’intervento dei soggetti con disabilità solo alla fine del processo, con azioni co-progettate e partecipate che li coinvolgano fin dall’inizio in un dialogo alla pari. La seconda è l’efficacia per entrambe le parti in causa di uscire dalla semplice prospettiva di dare una risposta ai bisogni, per abbracciare quella più ampia di nutrire il desiderio e le aspettative di una nuova comunità da conquistare. Non è un caso che la cornice generale del convegno avesse l’emblematico titolo ‘I non pubblici’ e in questa visione ci piace pensare che le persone cieche e ipovedenti siano un nonancora pubblico, pronte ad essere appassionate se coinvolte e sollecitate nella maniera giusta. Il teatro non è infatti solo un luogo fisico in cui basta ovviare alle barriere fisiche per risolvere l’accessibilità. È innanzi tutto un luogo della mente e dello spirito che necessita ben più di una rampa se alcuni gradini ostacolano il passaggio, dovendo invogliare a salire quella scala fino al punto di ritornarci altre volte.
La presenza di alcune delle persone iscritte al laboratorio o presenti allo spettacolo, venute per prendere parte al convegno in un confronto con addette e addetti ai lavori, è stata così la dimostrazione di come far incontrare due mondi attorno allo stesso tavolo non solo sia possibile, ma sia doveroso e necessario per una cultura e un teatro realmente accessibili. 10 le parole chiave scelte per descrivere il progetto in una narrazione interattiva che ha visto la partecipazione attiva del pubblico presente, cui è stata letteralmente data l’ultima parola, con la richiesta di uno spunto per la decima keyword volutamente lasciata in sospeso. A riprova di come TrasformAzioni sia sia ancora un progetto aperto, in divenire, e di quanto - più che mai per l’accessibilità - sia fondamentale entrare in una dimensione di dialogo, senza la pretesa di avere tutte le risposte pronte, ma sapendo stimolare le domande giuste, nell’ascolto e nel confronto.



Ciò che ho subito percepito è stata la voglia di conoscerci e la disponibilità a venire incontro alle nostre esigenze, dall’accompagnamento in teatro, dove si sono svolte quasi tutte le lezioni, al nostro posizionamento sul palco
La cosa chi mi ha colpita maggiormente è stata la partecipazione di persone che normalmente aderiscono poco o niente alle iniziative della nostra Sezione, un po’ perché abitano distanti dall’Unione e faticano a trovare chi li accompagni, un po’ perché poco interessati
Monica Taffi
Responsabile ipovedenti , UICI Brescia
8. RISULTATI
Al termine di un percorso durato quasi un anno, si è infine proceduto alla fase di valutazione da parte delle persone partecipanti. Monitoraggio che si è aggiunto all’analisi qualitativa e quantitativa presente in tutte le fasi, con una verifica costante al termine di ogni tappa e un riscontro puntuale da parte di UICI.
Il formulario finale consegnato a chi ha partecipato alle diverse fasi, è stato dunque un’occasione per ripercorrere i singoli momenti, nell’ottica di un bilancio a posteriori. Tutte le voci prese in considerazionedall’accoglienza, agli spazi, alla comunicazione, alle attività propostesono state valutate con un rating fra 4 e 5, laddove 5 era il massimo del punteggio. Un risultato significativo in termini di accessibilità e audience engagement, considerando il punto di partenza di un’utenza non abituata al teatro contemporaneo, diffidente per difficoltà di tipo logistico, a volte per scelte inadeguate nella programmazione o per pregiudizio verso un genere poco conosciuto. Nell’arco di questo primo anno è stato dunque possibile ribaltare i dati iniziali, avendo generato curiosità e interesse verso un nuovo linguaggio artistico.
Dalle risposte al questionario è emerso infatti il desiderio di un maggiore coinvolgimento in attività quali reading, incontri tematici, concerti proposti nell’arco dei mesi precedenti al festival, che non presentano particolari difficoltà in termini di accessibilità, ma consolidano la frequentazione viva del teatro. E insieme è stata evidente la volontà di proseguire il percorso formativo in un laboratorio ancora più strutturato con tanto di esito finale aperto alla cittadinanza, nella disponibilità quasi unanime a versare una quota di partecipazione individuale, a fronte di un percorso che per tutto il primo anno era stato interamente gratuito.

9. SVILUPPI FUTURI
Si apre dunque la sfida per continuare il percorso intrapreso e attivare strumenti e servizi sostenibili. In questa direzione è dunque fondamentale stringere alleanze con diversi soggetti della società civile, dalle associazioni di settore alle professionalità dello spettacolo, con uno scambio di pratiche e modelli condivisi, all’interno di una rete che possa favorire un’economia di scala dai costi generali ottimizzati.
Coinvolgere quindi tutte le professionalità in campo dalla direzione di teatri, festival e compagnie, ai circuiti di distribuzione, come pure tutte le categorie artistiche. È infatti innegabile che questo percorso non comporta solo un adattamento delle forme spettacolari per una fruizione diversa ma anche un nuovo modo di pensare lo spettacolo, che tenga a mente le caratteristiche di una pluralità di pubblici, portando avanti politiche più accessibili e creando un effetto moltiplicatore in grado di espandere i risultati di un progetto pilota.
Possiamo riassumere nei seguenti punti delle proposte per la creazione di un modello accessibile per i piccoli/medi teatri:
• Diffusione e condivisione di esperienze tra operatori e realtà teatrali e sociali. Nello specifico la diffusione del vademecum “10 buone pratiche per un teatro accessibile” per stimolare altre imprese culturali piccole e medie ad intraprendere azioni rivolte all’accessibilitá per persone cieche ed ipovedenti, rimodulando gli strumenti forniti in rapporto alle proprie necessità.
• Realizzazione di azioni di mediazione artistica specifiche per persone cieche e ipovedenti coinvolgendo direttamente le associazioni e che partano dai bisogno dei beneficiari diretti in un percorso bottom up e non di imposizione dettato dalle organizzazioni. In questa direzione è fondamentale capire quindi le aspettative, le conoscenze previe e gli interessi del gruppo per fare delle proposte coerenti e in sintonia.
• Stimolare l’economia di scala cercando modalità in cui i soggetti teatrali possano consorziarsi e creando una rete di luoghi della cultura che commissionano ad artisti e artiste uno o più strumenti di accessibilità dello spettacolo.
Riguardo invece la necessitá di finanziamenti e sostenibilitá economica dei processi di accessibilitá risulta primario trovare formule che permettano armonizzare i finanziamenti pubblici / privati e individuare linee di finanziamento chiare, continuative e trasparenti. Nella stessa direzione, risulta necessario stimolare le organizzazioni teatrali insieme ad artisti e artiste, a presentare nei bandi nazionali la problematica della partecipazione delle persone con disabilità alle attivitá teatrali (ad esempio Bandi SIAE).
Prendere parte al progetto per rendere il teatro un luogo più accessibile e inclusivo è stata un’esperienza straordinaria.
L’iniziativa non solo ha valorizzato il teatro come spazio di espressione culturale e sociale, ma ha dimostrato come la collaborazione possa abbattere barriere invisibili ma reali per molte persone con disabilità visiva.
Grazie a soluzioni innovative, come l’organizzazione di focus group inclusivi, laboratori e il supporto dell’audiodescrizione è stato creato un ambiente in cui ogni spettatore può vivere l’emozione dello spettacolo al massimo delle sue potenzialità, ma, più di tutto, ha preso vita un dialogo e un confronto che ha coinvolto direttamente le persone con disabilità visiva nella progettazione e nelle decisioni. Il teatro non è solo uno spazio fisico: è un luogo di incontro, di sogni e di inclusione. Questo progetto è un esempio concreto di come possiamo costruire insieme una società che riconosce il diritto di ogni persona a partecipare alla vita culturale. Siamo orgogliosi di aver contribuito a un’iniziativa che non solo ha aperto nuove porte, ma ha dimostrato che l’arte è davvero per tutti.
Sandra Inverardi Presidente UICI Brescia
In questa sezione dell’e-book sono riportate alcune pratiche derivate dalla nostra esperienza. Non si tratta di regole ferree o riflessioni di natura accademica, ma di osservazioni emerse nel corso della prima tappa di un progetto, che per sua natura è costantemente in trasformazione.
Ritenendo che una fase importante per dare continuità all’accessibilità culturale sia la condivisione dei percorsi intrapresi in una rete di scambio e dialogo reciproco con altre realtà, vogliamo diffondere questo breve decalogo da intendersi come un pratico vademecum, pronto per essere integrato e migliorato da esperienze future

1. LINGUAGGIO
Fin dalla stesura di un progetto o dalla compilazione di un bando è importante fare attenzione alle parole che si scelgono. Il mondo dell’accessibilità non è un’astratta teoria per speculazioni linguistiche ma è uno strumento concreto per coinvolgere un target sempre più ampio. Occorre tenere ben presente che dietro a ogni parola ci sono persone con una sensibilità da rispettare. Per questo anche in Italia stanno prendendo sempre più piede figure esperte nella cultura e nella comunicazione della disabilità, che possono facilmente fare da supervisione alle diverse proposte a partire dalle scelte lessicali. Espressioni come ‘portatore di handicap’ o ‘diversamente abile’ sono ormai ritenute inappropriate. Analogamente locuzioni come ‘non udente’ o ‘non vedente’ - un tempo ritenute politicamente corrette - finiscono con l’identificare un individuo per alterità. In caso di dubbio è sempre buona cosa chiedere alle persone direttamente interessate come è meglio rivolgersi loro. Nella maggior parte dei casi scoprirete che termini come ‘cieco/a' o ‘sordo/a’ sono di gran lunga preferiti rispetto a più complessi giri di parole.
2. CALENDARIO
Quando si organizza un’attività per un gruppo di persone cieche o ipovedenti è bene considerare con attenzione la gestione dell’agenda da programmare. Alcune di loro necessitano di essere accompagnate, altre dipendono dal trasporto pubblico. È molto probabile che molte siano lontane dalla sede dell’incontro, se non addirittura residenti in comuni limitrofi. Oltre al fatto che per tutte queste variabili, i tempi di spostamento saranno verosimilmente più lunghi. Prima di fissare un giorno e un orario, è sempre opportuno sondare le preferenze delle persone interessate, soprattutto se si parla di organizzare appuntamenti in orario serale o giornate festive. Sarà impossibile venire incontro a tutte le singole esigenze, ma si avrà di sicuro una chiara indicazione di massima, da tenere in conto nella gestione del calendario.
3. ACCOGLIENZA
Quando si ricevono persone cieche e ipovedenti in uno spazio nuovo è buona prassi cercare di metterle a loro agio. È utile che lo staff preposto all’accoglienza si presenti subito col proprio nome scandito in maniera chiara. Solitamente in teatro ci si dà del tu, a meno che non si ci si trovi davanti a una persona anziana. In quel caso si potrà dire ‘mi dia pure del tu’ e aspettare se la persona in risposta fa altrettanto o preferisce mantenere il lei. Per non creare un imbarazzo iniziale, meglio evitare di dare la mano, ma se l’altra persona ce la porge, allora ricambiare va benissimo. Allo stesso modo, quando si guida una persona con disabilità visiva, meglio evitare di toccarla direttamente. Piuttosto offrire il proprio aiuto con frasi del tipo ‘se serve posso dare il braccio o la spalla.’ Solitamente è buona norma che chi guida stia davanti così da segnalare già col proprio corpo intralci e direzioni. Non serve descrivere visivamente tutto quello che si attraversa. Poche parole ma precise sono sempre l’ideale. Riferimenti vaghi (di qua, di là) sono poco utili. Meglio dare direzioni chiare (dritto, destra, sinistra), segnalando ostacoli (curva, scala, rampa, gradino) specificando all’occorrenza numeri o misure (due gradini, una rampa piccola, un gradino alto).
4. ILLUMINAZIONE
Contrariamente a quanto si possa pensare, quando si lavora con la disabilità visiva, la questione dell’illuminazione può davvero essere un fattore dirimente. Se per le persone cieche dalla nascita, la luce è una variabile irrilevante, per quelle ipovedenti diventa invece una questione di grande importanza. Non si tratta infatti di un gruppo con caratteristiche omogenee. La degenerazione della vista è qualcosa di estremamente soggettivo e mutevole. Non solo il residuo visivo cambia da un individuo all’altro, ma varia anche per la stessa persona nel corso degli anni, trattandosi spesso di una condizione non stazionaria. Per questo è molto utile verificare a tale riguardo le esigenze di chi vuole partecipare alle attività proposte e predisporre un ambiente adeguato. La situazione ideale sarebbe poter lavorare in uno spazio dove le luci si riescono a diversificare, creando zone di maggiore o minore luminosità, con la possibilità di graduare l’intensità delle fonti luminose.
5. COMUNICAZIONE
Comunicare è un fattore fondamentale nel settore culturale. A maggior ragione quando si parla di disabilità sensoriale. Nel nostro gruppo per facilitare lo scambio di informazioni si è deciso di comune accordo con le persone che avrebbero partecipato al laboratorio di creare una chat su whatsapp, applicazione con cui avevano già dimestichezza. Diverso è stato raggiungere il resto della comunità sia per promuovere il progetto, sia per tenerla aggiornata sulle attività annuali e sul festival. Indispensabile è stato il supporto dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che si è fatta tramite con un prezioso passaparola nella rete di contatti dei loro associati e delle loro associate. Ciononostante è d’obbligo che il sito, primo biglietto da visita di un teatro o di una compagnia, sia reso accessibile secondo gli standard europei. Spesso non serve stravolgere l’impostazione dell’editing. Il linguaggio html consente già ai vari screen reader di evidenziare il testo con contrasto cromatico e dimensioni più leggibili, di esplicitare le immagini con apposite didascalie separandole dagli elementi grafici o di essere decodificato da un sintetizzatore vocale. È comunque fondamentale rivolgersi a una persona professionista, che abbia competenze aggiornate nelle tecnologie e nelle normative relative all’accessibilità.
6. BIGLIETTERIA
Non c’è scelta meno appropriata che assegnare alle persone con disabilità visiva posti casuali o addirittura con visibilità ridotta. Se per le persone cieche l’attribuzione di una seduta o di un’altra può non fare differenza, la cosa non vale per il loro accompagnatore o la loro accompagnatrice. Oltre al fatto che laddove è possibile, conviene sempre riservare posti facilmente raggiungibili, senza troppi ostacoli, tenendo in conto l’eventuale ingombro del bastone e/o del cane guida. Ancora maggiore attenzione meritano le persone ipovedenti. Se è vero che ognuna di loro ha esigenze diverse, occorre poter verificare caso per caso a quale distanza preferiscono stare rispetto alla scena e alle fonti luminose. Sarà dunque importante che la modalità di acquisto dei biglietti sia chiara e semplice, con un sito aggiornato e accessibile. Ottimo sarebbe avere la mediazione di qualche referente che si prenda in carico l’elenco delle singole richieste. E sicuramente la possibilità di una prenotazione telefonica con cui interpellare il personale addetto alla prevendita potrebbe essere di grande aiuto, soprattutto le prime volte che si prenota in un teatro nuovo. Parlarsi direttamente renderà più semplice fare incontrare le caratteristiche della sala con le specifiche esigenze di chi acquista il biglietto.
7. PROGRAMMAZIONE
Ragionare insieme sulle attività da programmare è un momento importante nel percorso di condivisione. Per questo è utile un focus group iniziale per capire le aspettative e l’interesse della comunità di riferimento. Questa fase diventa ancora più utile nella scelta degli spettacoli da audiodescrivere. Non dimentichiamo che spesso si ci sta rivolgendo a un pubblico ancora da conquistare. Molte delle persone con disabilità visiva, possono avere già fruito di spettacoli teatrali con o anche senza auidodescrizione. Ma è molto probabile che si sia trattato di spettacoli musicali, opere liriche o un genere leggero di intrattenimento. Difficilmente sarà un’utenza già preparata ai linguaggi e ai temi del teatro contemporaneo, del teatro fisico e della danza. La scelta dei titoli giusti da proporre dovrà dunque tenere conto di svariati fattori. che incontrino la linea della direzione artistica da un lato, le indicazioni di chi dovrà audiodescrivere da un altro e il gusto del pubblico da un altro lato ancora. Non è una questione di sola accessibilità per ridurre le barriere a chi non può vedere. Si tratta innanzi tutto di un’educazione agli spettatori e alle spettatrici da appassionare con scelte mirate e graduali, perché la loro non resti una bella esperienza isolata, ma siano stimolate nella loro curiosità e nella loro voglia di ritornare in futuro.
8. INCONTRO COMPAGNIA
L’audiodescrizione può essere fatta anche senza un tour tattile prima dello spettacolo. Tuttavia riteniamo che questa pratica sia di gran lunga preferibile per garantire un’accessibilità a 360 gradi. Non solo portare un gruppo di persone cieche e ipovedenti a esplorare il palco è un’esperienza di grande arricchimento, che offre loro la possibilità di sperimentare le dimensioni della spazio, la grandezza degli elementi scenografici, le caratteristiche dei materiali usati, le particolarità di oggetti e costumi. Ma diventa anche un momento di incontro con la compagnia che costituisce un valore aggiunto di grandissima importanza per entrambe le parti. Poter conoscere le maestranze dietro le quinte o confrontarsi con il cast che si sta preparando ad andare in scena è un modo concreto per far avvicinare il pubblico ai mestieri del teatro. Ma insieme diventa anche un modo per avvicinare gli addetti ai lavori al mondo dell’accessibilità, di cui ancora nel nostro paese si sa molto poco. Per questo è importante considerare questa pratica come un ponte che va in una doppia direzione e favorire nei 15-20 minuti, da concordare in base alla disponibilità del personale artistico e tecnico, quel prezioso momento di scambio al contempo umano e professionale.
9. AURICOLARI
L’audiodescrizione è uno strumento utile per rendere accessibile soprattutto quei generi teatrali che puntano sulla componente visiva e la commistione dei linguaggi. Essa consiste di una parte introduttiva da trasmettere prima dello spettacolo o in alternativa caricare sul sito come traccia audio, in cui fornire a chi ascolta una sintesi del classico programma di sala con crediti, sinossi e note di regia, che andrà integrata con tutti quegli elementi descrittivi relativi ad allestimento, scenografie, luci, costumi, trucco e parrucco. A questa segue l’audiodescrizione vera e propria, che avverrà durante lo spettacolo, con una serie di indicazioni sull’azione scenica che esplicitano quello che succede sul palco tra una battuta e l’altra. Questa parte potrà essere registrata o in diretta. La seconda modalità è di gran lunga preferibile soprattutto per il teatro di prosa in cui il ritmo del parlato può variare da una sera all’altra, in base all’interazione con il pubblico e all’energia che si crea in ciascuna replica. In ogni modo, a parte quei casi in cui la voce diventa elemento integrante della regia e viene amplificata per tutto il pubblico, l’ascolto dell’audiodescrizione è una pratica dalla fruizione individuale grazie agli appositi auricolari consegnati all’entrata. Ce ne sono di varie tipologie, da preferire quelli di facile utilizzo, che andranno già attivati e sintonizzati prima dello spettacolo. Sarà comunque opportuno avere qualcuno dello staff tecnico pronto a risolvere eventuali problemi di mal funzionamento. Decisamente meglio scegliere quelli con un auricolare solo. Le cuffie doppie, perfette per le proposte di teatro immersivo, rischierebbero di dare troppa importanza alla voce narrante lasciando in secondo piano quello che succede sulla scena. Molte cuffie sono ormai wireless. In questo caso assicurarsi che le batterie siano cariche e se il cursore luminoso che segnala l’accensione arreca disturbo al resto del pubblico, basterà coprilo con un po’ di nastro isolante, una volta verificata la corretta ricezione.
10. RISCONTRO
All termine di ogni percorso che sia un laboratorio, un festival o una rassegna è consigliabile trovare un momento per avere un riscontro su quanto proposto. A maggior ragione se la condivisione è avvenuta fin dall’inizio e le persone cieche e ipovedenti sono state coinvolte nella fase di progettazione, analogamente dovranno sentirsi partecipi nel feedback finale, tenendo conto che è proprio la loro esperienza concreta a diventare uno strumento prezioso per migliorare il grado di accessibilità. Occorre dunque valutare come formulare nella maniera più semplice ed efficace un eventuale questionario e soprattutto attraverso quali canali diffonderlo. Anche in questo caso si ritorna ai principii di una comunicazione chiara e accessibile. Qualunque sia la scelta, form on line, modulo cartaceo, mail, whatsapp, messaggi vocali ecc ecc sarà utile verificarla con una figura di riferimento che possa testarne la praticità. È importante che anche in quest’ultima fase, nessuna persona si senta esclusa, non solo dagli ostacoli legati alla disabilità visiva, ma anche da una eventuale scarsa padronanza della tecnologia. Non dimentichiamo che la degenerazione della vista è spesso legata all’avanzare dell’età. Per questo è un buona prassi ricordare che al momento un’alta percentuale delle persone cieche e ipovedenti non è nativa digitale e non va discriminata sulla base di un fattore anagrafico.
