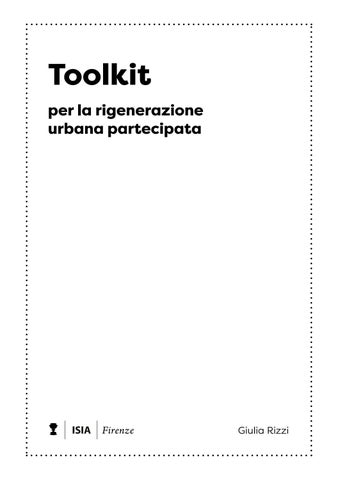Toolkit per la rigenerazione urbana partecipata
Giulia Rizzi
2 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA Indice Introduzione Approccio partecipativo e user-centered Le fasi del design thinking La co-progettazione Timeline Strumenti Bibliografia e sitografia 4 6 8 10 12 14 45
Introduzione
Negli ultimi cinquant’anni le città sono state oggetto di un profondo cambiamento spaziale, assumendo nuove conformazioni rispetto al passato e ridefinendo i loro caratteri specifici urbani. Diversi fattori hanno contribuito all’accelerazione del processo di svuotamento delle città, lasciando dietro di sè i cosidetti vuoti urbani: delle porzioni di terreno all’interno delle città che nel corso degli anni sono diventate obsolete e quindi abbandonate. Per tale motivazione è necessario prendere atto che una crescita esplosiva delle città non è più sostenibile perché comporta solamente la dispersione di servizi e risorse e un continuo aumento del consumo di suolo. È necessario quindi risanare queste ferite, colmare questi vuoti che sono causa di degrado e dequalificazione della città, spesso rischiosi per la salute e per gli ecosistemi. Infatti questi luoghi abbandonati all’interno delle città oltre all’aspetto problematico, possiedono grandi potenzialità e costituiscono un’occasione di ripensamento della città e di sviluppo locale sulla base di nuovi obiettivi, in particolare obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il tema della riqualificazione urbana di queste aree abbandonate è da tempo preso in considerazione da istituzioni pubbliche e soggetti privati
che negli anni hanno realizzato alcuni interventi di recupero che spesso però sono stati progettati con lo scopo di dare una nuova immagine al panorama urbano e di conseguenza non sempre coerenti con le esigenze del tessuto sociale locale. Questo fenomeno ha lasciato irrisolte molte questioni riguardanti l’effettiva qualità degli spazi urbani delle città e, in molte circostanze, l’incompletezza di imponenti programmi di rigenerazione, lasciando i luoghi oggetto di tali operazioni in un’ambiguità ancora più marcata.
È necessario quindi l’utilizzo di nuove metodologie per l’attivazione di processi di trasformazione del tessuto urbano che inevitabilmente devono confrontarsi con le esigenze del tessuto sociale locale.
La rigenerazione, non è solo una limitazione del consumo di suolo, ma è riconsiderare le dinamiche di sviluppo urbano, fondate sulla sostenibilità, riconoscendo le risorse possedute dalle comunità e valorizzandole nel quadro di un nuovo scenario urbano. Questa visione di rigenerazione volta alla sostenibilità e all’individuazione della domanda sociale, implica lo sviluppo di una nuova metodologia di analisi dei sistemi urbani e delle dinamiche sociali, volta all’innovazione sociale e al coinvolgimento
della cittadinanza nel processo progettuale. Questa visione reclama un ripensamento delle relazioni tra istituzioni e società, cercando un punto d’incontro con il governo pubblico delle trasformazioni urbane, implicando in primo luogo il riconoscimento delle capacità della società di trattare efficacemente problemi collettivi piuttosto che l’imposizione dall’alto di modelli di intervento, di conseguenza la co-progettazione e la co-creazione piuttosto che solamente l’ascolto.
In definitiva, ai Comuni alle prese con l’elaborazione di un nuovo Piano urbanistico, e in particolare a chi opera in urbanistica, è necessario fornire gli strumenti adeguati per poter attuare processi partecipati di rigenerazione urbana e gestire complesse fasi partecipative che includono tutti gli stakeholder coinvolti in questo processo.
Per tali ragioni viene proposto un toolkit, rivolto alle istituzioni pubbliche, sulla rigenerazione urbana partecipata, con l’intenzione di aprire nuovi sguardi al loro interno e condurle verso processi di rigenerazione urbana centrati sull’innovazione sociale e quindi individuando nuove forme di partecipazione che rendano quanto più possibile inclusivo il processo decisionale. All’interno di questo processo è fondamentale contrastare le dinamiche che causano disgregazione, per questo è necessario ricreare delle relazioni
socio-spaziali che mirino a ricucire il tessuto urbano e sociale. Vengono coinvolti all’interno di un processo di rigenerazione tutti coloro che hanno un interesse per il territorio, spesso però gli interessi sono differenti e per questo è necessario trovare un punto d’incontro tra le parti. L’intero iter, dall’individuazione delle esigenze alla decisione circa la fattibilità del progetto, fa parte di un processo nel quale, a vari livelli e con differenti responsabilità, devono necessariamente partecipare tutti gli attori interessati, per arrivare alla sua forma finale che ha tante più possibilità di successo quanto più è basata su un progetto realmente condiviso.
Il
Descrive i vantaggi di questo approccio, le linee guida e tutte le fasi che compongono il processo di rigenerazione urbana, dalla coprogettazione alla co-creazione, fornendo gli strumenti per metterlo in atto. È stato realizzato in forma di pdf interattivo per essere maggiormente navigabile e poter fruire di contenuti multimediali.
4 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
INTRODUZIONE 5
toolkit vuole essere un vademecum, ovvero un compendio di informazioni riguardanti il processo partecipativo per la rigenerazione urbana, da poter replicare in diversi scenari.
Approccio
partecipativo e user-centerd
L’user-centered design è un approccio partecipativo che si basa sul coinvolgimento degli utenti all’interno di processi volti alla progettazione di sistemi, servizi o prodotti1. Nel caso della rigenerazione urbana, questo approccio ha l’obiettivo di migliorare la comprensione delle esigenze degli utenti, guidare la progettazione secondo i loro bisogni e ricucire il tessuto sociale creando un senso di comunità.
di ciò che è stato sviluppato traducendosi in un alto livello di soddisfazione ed una più facile integrazione con l’ambiente circostante. Ci sono tre livelli di coinvolgimento dell’utente2:
1. Progettare per l’utente: qui l’utente è visto come una fonte di informazioni quindi utilizzando tecniche come interviste, questionari, e osservazione, il progettista raccoglie informazioni ritenute necessario per lo sviluppo del progetto;
Maggiore è il coinvolgimento dell’utente nella processo di progettazione, maggiore è la probabilità che ciò che è progettato sia adatto al contesto ed ai suoi scopi, permettendo un risultato finale più efficace ed efficiente.
Inoltre il coinvolgimento degli utenti nel processo progettuale crea un senso di appartenenza
2. Progettare con l’utente: il progettista propone soluzioni e le presenta agli utenti che possano valutare e costruire opinioni.
Questo tipo di coinvolgimento può essere raggiunto attraverso le stesse tecniche utilizzate nel livello precedente, aggiungendo il test di usabilità.
3. Progettare attraverso l’utente: l’utente è attivamente coinvolto e prende parte al processo progettuale per la realizzazione di prodotti che andrà ad utilizzare. L’utente ha potere decisionale sul progetto, sono utilizzate tecniche
di scambio di esperienze e di generazione di idee. Si richiede un maggiore sforzo su pianificazione, organizzazione ed esecuzione rispetto ai livelli precedenti.
Oltre ad essere user-centerd l’approccio deve essere partecipativo. È necessario specificarlo perchè in alcuni aspetti il primo differisce dal secondo, come ad esempio la figura dell’utente che non viene considerato come un vero e proprio membro della squadra ma è sempre rappresentato dal designer3. La partecipazione è intesa come la possibilità di raccogliere il contributo attivo di diversi attori durante un processo progettuale e quindi la possbilità di questi ultimi di interagire nello sviluppo del progetto. Quindi possiamo dire che la progettazione partecipativa prevede un totale coinvolgimento dell’utente che diventa membro attivo della squadra ed è strutturarta affinchè quest’ultimo possa essere coinvolto in ogni fase del percorso progettuale dando il
proprio contributo.
Quali sono quindi i vantaggi di un approccio partecipativo e usercentered? Sicuramente una migliore orientamento del processo di progettazione, maggiore soddisfazione degli utenti, la creazione di un senso di comunità tra gli attori coinvolti e maggiore probabilità di riuscita del progetto (ovvero che rispetti i reali bisogni sociali).
Perché non è utilizzato in ogni progetto d’interesse pubblico? Perché il fattore che ostacola maggiormente la diffusione della partecipazione all’interno del processo progettuale è il fatto che ci sono vari approcci, strumenti e tecniche tra cui scegliere, per questo è stato ideato il toolkit: guidare le istituzioni pubbliche all’interno del processo di rigenerazione partecipata.
1 SCARIOT C., HEEMANNA A., PADOVANI S., Understanding the collaborative-participatory desi gn, University of Paraná, Brezil, 2012.
2 CYBIS W., BETIOL A. H., FAUST R., Ergonomia e Usabilidade, conhecimentos, métodos e aplicações, Novatec Editora LTDA, São Paulo, 2007.
6 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
PARTECIPATIVO E USER-CENTERED 7
APPROCCIO
3 SANDERS E., STAPPERS P J Co creation and the new landscapes of design, 2008.
Le fasi del design thinking
Il design thinking è una metodologia che si articola in diverse fasi che scandiscono i momenti della progettazione, che a loro volta comprendono una serie di attività basate sul design che promuovono la collaborazione necessaria per risolvere i problemi in modi incentrati sull’uomo. Parliamo quindi di design thinking perchè é una metodologia che fonde insieme gli approcci descritti nel paragrafo precedente. Il design thinking si articola in diverse fasi che scandiscono i momenti della progettazione. Ci sono diverse scuole di pensiero riguardanti l’articolazione delle sue fasi di progettazione e in questo toolkit seguiremo la metodologia a doppio diamante del Design Council (fig. 1).
1. Discover
La prima fase è quella della sco perta che mira a raccogliere un gran numero di informazioni. Que sta fase divergente comprende l’acquisizione e la catalogazione dei dati permettendo di avvicinarsi al contesto e raccogliere una mol titudine di influenze e di idee. La mentalità è sempre orientata all’utilizzatore analizzando i com portamenti, i bisogni e le percezio ni degli utenti.
2. Define
Questa seconda fase possiamo considerarla come un filtro. Le informazioni raccolte vengono analizzate e selezionate in base alle scoperte fatte in precedenza, si definiscono con maggior accu ratezza i bisogni e si fanno ipotesi per risolverli. La fase di definizione si conclude con l’individuazione e la pianificazione precisa della dire zione che il progetto assumerà, per questo è considerata convergente.
Develop
Dopo aver individuato le linee guida del progetto, ci si trova in una fase divergente. Attraverso diversi strumenti si procede a sviluppare e testare sul campo le diverse soluzioni ipotizzate.
Deliver
Il progetto viene raffinato in base ai feedback ricevuti nella fase precedente, raggiungendo la sua forma finale.
In questo modello di innovazione l’elemento differenziale è la capacità di guardare oltre. Il risultato è solo la punta di un processo strutturato e più profondo di quanto solitamente siamo abituati a pensare.
DISCOVER
Acquisizione e catalogazione dei dati
Fattibilità delle proposte
DEFINE Filtraggio dei dati raccolti e selezione
DEVELOP
Sviluppo delle bozze
DELIVER Definizione del concept
Revisione del concept fase divergente fase convergente
fig. 1 Design thinking: modello a doppio diamante elaborato dal Design Council.
8 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
LE FASI DEL DESIGN THINKING 9
La co-progettazione
10 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA 11
È possibile cliccare su ogni voce per essere rimandati alla sua descrizione.
Individuazione del vuoto
2. Definizione
Personas Journey map Brainstorming Confronto tra brainstorming Triangolazione dei dati
Individuazione del vuoto urbano
3. Sviluppo e rilascio
Analisi vincoli e sviluppo proposta Prototipazione e condivisione
Analisi feedback e soluzione Individuazione del vuoto urbano
4.
Implementazione
Priorità Chi coinvolgere Realizzazione Individuazione del vuoto urbano
12 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
Timeline
1. Ricerca
Stakeholder map Immersione Esperienze analoghe Questionario Interviste Focus group Workshop
TIMELINE 13
Sfida Obiettivi Pubblico
14 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA TOOLKIT PER
RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA 15
LA
Gli strumenti
STRUMENTI- La sfida, gli obiettivi, il pubblico 17
0. La sfida, gli obiettivi, il pubblico
Individuazione della sfida, definizione degli obiettivi e del pubblico si trovano raccolti nello stesso paragrafo perché sono strettamente connessi all’interno di un processo iterativo (fig. 2). Per prima cosa è necessario definire una prima bozza della sfida di progetto, successivamente individuare gli obiettivi del progetto per poi andare a ridefinire meglio la sfida. Grazie a questo si andrà ad individuare il pubblico per cui si intende progettare e di conseguenza a definire quanto ampio o ristretto sia l’ambito della sfida progettuale.
2. Prova ad inquadrare questa sfida con una domanda: es. Come possiamo dare una seconda vita ad un luogo dismesso considerando i bisogni dei cittadini?
3. Indica il risultato principale che stai cercando di ottenere: es. Rigenerare un’area secondo i bisogni del pubblico.
Sfida Obiettivi Pubblico
4. Annota gli aspetti importanti del contesto o dei vincoli che devi considerare: es. Rispettare la biodiversità del luogo quindi una progettazione sostenibile. L’uomo al centro del progetto quindi approccio partecipativo e human-centered.
fig. 2 Processo iterativo
0.1 La sfida
Per individuare correttamente la sfida ecco la traccia di domande da seguire:
1. Qual è il problema che stai cercando di risolvere? es. L’area Pelagos è stata recentemente riqualificata ma ci sono ancora molte aree dismesse e abbandonate che impediscono di sfruttare le potenzialità del territorio ed offrire servizi che soddisfano i bisogni dei cittadini.
5. Quali sono alcune possibili soluzioni alla tua domanda di progettazione?
es. Coinvolgere i cittadini nel progetto, riappropriarsi e rivivere gli spazi, riprogettare le aree dismesse.
A questo punto bisogna scrivere la prima bozza della sfida progettuale: una frase breve e facile da ricordare che rappresenti il problema che si vuole risolvere risolvere. es. Coinvolgere i cittadini nella rigenerazione di un vuoto urbano.
16 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
0.2 Gli Obiettivi
Dopo aver definito la bozza della sfida di progettazione è il momento di individuare gli obiettivi. Per farlo bisogna munirsi di post-it e scrivere su ognuno quali possono essere gli impatti del progetto ed organizzarli in una scala verticale: i cambiamenti più a lungo termine, significativi e difficili da raggiungere più in alto mentre i cambiamenti più immediati, diretti e facili da ottenere più in basso.
18 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
CAMBIAMENTI Breve termine
Lungo termine
Incolla qui i tuoi post-it
STRUMENTI- La sfida, gli obiettivi, il pubblico
19
Dopo aver ordinato i post-it è necessario definire la scala d’impatto del progetto, ovvero la sua influenza. Questo perché i cambiamenti a lungo termine sono strettamente legati a quelli più immediati, anzi spesso sono proprio questi, i piccoli cambiamenti, che diventano il fulcro della sfida di design. La definizione della scala d’impatto serve a guidare la sfida di progettazione ed aiuta a rimanere concentrati sugli obiettivi. Successivamente bisogna riflettere sul cambiamento sociale duraturo del progetto, qualcosa a cui il design potrà contribuire nel tempo. Questo è l’impatto a lungo termine e per identificarlo bisogna considerare i post-it più vicini alla cima della scala. Compila i seguenti campi in relazioni ai post-it creati nella pagina precedente.
Il cambiamento sociale duraturo a cui vorrei contribuire è:
Il risultato più a breve termine che ci dice che la soluzione sta funzionando è:
La sfida, gli obiettivi, il pubblico 21
0.3 Il pubblico
I cambiamenti chiave che devono avvenire per arrivarci sono:
Questo cambiamento Per questo pubblico
A questo punto avrai definito anche il pubblico, ovvero a chi si rivolge la sfida, chi saranno i potenziali utenti.
Quindi grazie all’individuazione degli obiettivi, della loro scala d’impatto e del pubblico ora è il momento di riformulare la sfida di design: es.Riappropriarsi e rivivere le aree verdi dismesse della città attraverso un percorso partecipativo.
20 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI-
1. Ricerca
1.1 Stakeholder map
A questo punto, dopo aver individuato l’oggetto della rigenerazione urbana, è necessario analizzarne il contesto e capire chi sono gli stakeholder che verranno coinvolti nel progetto. Per capire il grado di coinvolgimento che avrà ognuno di loro basterà inserirli nella Stakeholder map considerando la loro influenza e il loro interesse nei confronti del progetto.
1.2 Immersioni
Le immersioni servono per trascorrere del tempo con le persone per cui si sta progettando. Bisogna osservare il più possibile e annotare esattamente ciò che si vede e si ascolta. Sono delle occasioni per osservare il contesto da vicino e i comportamenti delle persone che con interagiscono con esso. È consigliato svolgerne più di una ed in diversi momenti della giornata in modo da poterne confrontare i risultati. Scattate fotografie e prendete degli appunti
Immersione 1
Data: Ora:
Tienili aggiornati su tutto ciò che succede
Gestisci al meglio il loro coinvolgimento in tutte le fasi di lavoro
Comunica in modo regolare
Trova soluzioni alle loro esigenze, anticipa le loro domande
INFLUENZA DEGLI STAKEHOLDER
22 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
INTERESSE DEGLI STAKEHOLDER
+ + -
STRUMENTI- Ricerca 23
Immersione 2
Data: Ora:
Dopo aver osservato il contesto e le persone avrete fatto le vostre scoperte (findings).
Ad esempio se avete osservato che la maggior parte delle persone non si sofferma nell’area il vostro finding sarà: La maggior parte delle persone non sosta nell’area ma è solo di passaggio.
Finding 1:
Finding 2: Finding 3 : Finding 4: Finding 5:
Finding 6:
24 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Ricerca 25
1.3 Esperienze analoghe
Per avere una nuova prospettiva di ricerca è importante spostare l’attenzione su un altri contesti analoghi a quello di progetto. Le esperienze analoghe servono per trarre ispirazione da quello che già funziona e riproporlo in un altro contesto, per migliorarlo, quindi applicarlo alla sfida di progettazione a cui si sta lavorando. Scegliete due o tre contesti analoghi e trascrivete qui i vostri findings.
Esperienza analoga 1
Luogo: Scoperte:
Esperienza analoga 1 Luogo: Scoperte:
26 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Ricerca 27
1.4 Questionario di reclutamento
Il questionario di reclutamento serve per individuare determinate tipologie di utente per condurre delle interviste. Prima di tutto è necessario stabilire quali sono queste tipologie, per saperne di più puoi consultare qui Extremes and mainstreams del design kit di IDEO. A questo punto è necessario preparare il questionario, per farlo puoi seguire questa struttura:
- Messaggio introduttivo che spiega qual è l’intento della ricerca.
- Domande di screening: parametri demografici.
- Domande di screening: parametri attitudinali.
- Altre domande
- Conclusione in cui si invitano gli utenti a lasciare un recapito se disposti ad essere intervistati e, se previsto, il compenso che riceveranno in cambio. Inoltre per fare in modo che le persone interessate rimangano sempre aggiornate sul progetto potrete creare una mail list (chiedendo loro un contatto) oppure invitarli a seguire la vostra pagina social.
Per maggiori dettagli riguardo alla struttura del questionario puoi consultare la sezione dedicata del kit di designers italia. A questo punto dovrai decidere il canale di distribuzione per il questionario che potranno essere canali interni, i tuoi social oppure ad esempio gruppi facebook del luogo.
1.5 Interviste
Le interviste agli utenti sono fondamentali in questa fase perché essendo sessioni individuali di ricerca sul campo, forniscono preziosi dati qualitativi. Il design incentrato sull’uomo significa proprio questo: arrivare alle persone per cui si sta progettando e ascoltare le loro parole. Per questo è importante fare delle domande che vadano in profondità, orientate a capire le motivazioni e i bisogni espressi o inespressi della persona intervistata. A questo punto è necessario preparare una traccia per supportare lo svolgimento della conversazione ma ricordati che in relazione alle risposte che riceverai potrebbe essere utile porre ulteriori domande. Per preparare la traccia puoi consulatare il kit di Designers italia. Troverai una guida alla conduzione dell’intervista, la liberatoria per il consenso e i il trattameno dei dati che dovrai far firmare all’intervistato qualora tu voglia registrarlo (se condurrai l’intervista da solo è consigliabile, altrimenti se sarai in team a qualcuno verrà affidato il compito della documentazione scritta).
Concluse le interviste dovrai estrapolarne degli insight, ovvero delle rivelazioni. Per farlo dovrai assegnare ad ogni intervistato un colore e riportare su post-it (dello stesso colore) le informazioni più utili estrapolate dalle interviste. Raccogli tutti i post-it insieme e dividili per affinità tematica e dai un nome ad ognuna di queste. All’interno di ogni tematica potrai trovare informazioni molto simili e da qui estrapolare gli insight seguendo questa struttura:
igienici
Ricorda: l’obiettivo del questionario è selezionare un campione per ogni tipologia di utente scelto tra quelli volontari per le interviste ma puoi approfittarne anche per raccogliere preziosi dati riguardo abitudini, bisogni, motivazioni e frustrazioni dei cittadini.
28 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Ricerca 29
Insight
Chi? Che cosa fa? Perché? Insight 2 Chi? Che cosa fa? Perché? Insight 3 Chi? Che cosa fa? Perché?
1
I cittadini sostano nell’area per un tempo limitato non sono presenti servizi
1.6 Focus group
Il focus group è un’ intervista di gruppo che non si limita a fare domande e ricevere risposte ma coinvolge i partecipanti in attività pratiche che mirano ad esplorare in modo approfondito le opinioni, i bisogni e i comportamenti di un gruppo di persone (come ad esempio un’asscoiazione). Per questa sessione di lavoro proponiamo 4 attività da svolgere che andiamo a vedere nel dattaglio:
a. Giornale fotografico
Questa attività è utilizzata per capire meglio il contesto di una persona, le persone che la circondano, le dinamiche comunitarie e il viaggio attraverso il modo in cui utilizza un prodotto o servizio. L’attività necessita di una settimana per essere svolta quindi si consiglia di avvisare per tempo il gruppo di persone coinvolto. Ogni partecipante scatterà delle fotografie in relazione a dei temi proposti (es. un’attività che vorresti svolgere in un altro modo, un momento della giornata in cui sei soddisfatto ecc.) e le caricherà su una cartella condivisa. La sessione del focus group inizierà con l’interpretazione di queste fotografie. Grazie al giornale fotografico sarai in grado di estrapolare degli insight in base alle ripetizioni che si presentano.
b. Disegnalo! ll disegno è un ottimo modo per imparare dalle persone per cui si sta progettando, che sia uno schizzo veloce, un grafico o una sequenza temporale permette di superare le barriere linguistiche e tenere un registro della ricerca. Il disegno può anche aiutare le persone ad organizzare i loro pensieri visivamente e in generale stimolare idee e conversazioni in un modo diverso dal parlare. Per maggiori informazioni riguardo questa attività puoi consultare la sezione apposita del designkit di IDEO. L’attività consiste nel proporre una parola che deve essere illustrata e successivamente spiegata da ognuno al resto della comunità. L’obiettivo è raccogliere tutte le risposte per capire quali significati la collettività dà a quella parola. Ad esmpio di può creare man mano un brainstorming con tutti i significati che emergono durante le spiegazioni dei disegni.
1: Insight 2: Insight 3: Insight 4: Insight 5:
30 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Ricerca 31
insight
Crea qui
tuo brainstorming
il
Parola scelta
c. Card sorting
L’ordinamento delle carte aiuta a scoprire i modelli mentali degli utenti per una migliore architettura delle informazioni. In questa attività i partecipanti vengono divisi in piccoli gruppi e ad ognuno viene chiesto di organizzare le carte secondo una gerarchia d’importanza, trovando tra di loro un punto di incontro. Le carte sono 12, su ognuna sono raffigurati elementi che favoriscono la rigenerazione urbana (arredi urbani, attività, servizi), tranne una che è vuota e dev’essere completata dal gruppo e inserita nella scala gerarchica. Qui puoi stampare e ritagliare le tue carte. Lo scopo dell’attività è capire quali sono le necessità della collettività, quindi sarà necessario fare una media di tutte le scale gerarchiche per produrne una finale.
1.7 Workshop
Il workshop di co-progettazione è una sessione di lavoro di gruppo, in cui diversi attori, potenziali utenti del servizio, vengono invitati a discutere le criticità esistenti e individuare insieme delle possibili soluzioni, seguendo un percorso guidato. Si possono coinvolgere le persone intervistate ed i partecipanti del focus group oppure altri cittadini. Si consiglia inoltre, se possibile, di svolgere il workshop negli spazi oggetto di ricerca per una migliore osservazione del contesto.
I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi di lavoro che saranno mantenuti durante tutto il workshop.
Per il gruppo sono molto importanti
Mentre invece ritengono meno importanti
La prima attività che si propone e quella della creazione delle personas ognuna delle quali rappresenta una tipologia di utente differente per cui si ipotizzano caratteri personali come aspirazioni, frustrazioni e necessità. In un secondo momento per ogni persona creata si andrà ad eleaborare una journey map che descrive l’esperienza dell’utente nell’interazione con il luogo.
Per entrambe le attività si possono trovare delle schede pronte da stampare nel kit di Designers Italia qui: - Schede Personas - Schede Journey map
A questo punto ogni gruppo sarà in grado di individuare delle soluzioni alla necessità emerse dalle personas, le scriverà quindi su dei post-it. L’attività finale consiste in una presentazione dei risultati da un portavoce per gruppo e dalle soluzioni individuate che verranno raggruppate tutte insieme in un brinstorming comune.
In un secondo momento sarà opportuno riprendere in mano il brainstorming e raggruppare i post-it per affinità tematiche dando un nome ad ognuna, in questo modo sarà più semplice visualizzare i risultati.
32 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Ricerca 33
2. Definizione
Arrivati a questo punto del percorso progettuale è necessario creare delle personas sulla base dei dati raccolti finora e relative journey map per poter costruire un brainstorming delle possibili soluzioni progettuali e confrontarlo con il brainstorming realizzato dai partecipanti del workshop.
2.1 Personas
Le personas rappresentano visivamente un gruppo di persone con caratteristiche comuni (bisogni, aspirazioni, comportamenti), aiutando a comprendere i diversi punti di vista dei diversi gruppi di stakeholder ed immedesimarsi. Le personas aiutano a mantenere il focus sul gruppo di utenti per cui si sta progettando ed evitare di progettare per se stessi. Per costruirle è necessario partire dai dati raccolti durante le interviste svolte ai volontari e riprendere in mano i post-it colorati e divisi per affinità che si erano creati nel paragrafo 1.5. A questo punto identifica le categorie di stakeholder da rappresentare ( es. lo studente, il genitore, il lavoratore ecc.) e per ognuno di loro identifica dei pattern, cioè i comportamenti, interessi, bisogni che ricorrono rispetto al tema del progetto. Per farlo puoi utilizzare lo strumento attribute matrix.
Questo strumento si costruisce definendo una caratteristica o un comportamento emerso dalle interviste e dal questionario e ponendo i suoi estremi ai margini di un’asse. Una volta preparato lo scheletro, composto da una serie di assi posti l’uno sotto l’altro, si posizionano i diversi utenti intervistati su ogni asse in relazione a quanto emerso da interviste e questionario. Ricordati di rendere visibile la corrispondenza con la persona intervistata, in questo modo sarà più facile far emergere i pattern.
A questo punto per costruire le personas utilizza i modelli forniti nel kit di designers italia.
Ricorda di assegnare ad ogni persona un aggettivo che cominci con la stessa iniziale del nome (es. Silvia - Socievole), in questo modo sarà più facile ricordarli.
Strumento attribute matrix
1: Anna, 25
1 giovane anziano
34 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Definizione 35
2.2 Journey map
La journey map è strettamente correlata ad una persona costruita, si riferisce quindi ad un gruppo di persone con caratteristiche comuni ed è utilizzata per mappare l’esperienza di interazione con l’area interessata. Quindi riprendi in mano le schede delle personas create poco prima e utilizza il kit di designers italia per creare le journey map di ognuno.
2.3
Brainstorming
Grazie alle journey map create puoi individuare quali sono le criticità dell’area su cui stai indagando riscontrate da ogni persona ed ipotizzare delle possibili soluzioni raccogliendole in un brainstorming. Queste soluzioni dovrai poi raccoglierle per affinità tematica e dare ad ognuno un nome.
2.4 Confronto tra brainstorming
A questo punto è necessario confrontare il brainstorming appena ottenuto con quello elaborato dai partecipanti del workshop al paragrafo 1.7. Questo confronto permette di trovare le corrispondenze fra i due e capire cosa sia davvero utile a soddisfare i bisogni delle persone. Riporta le informazioni principali emerse dal confronto:
36 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
Scrivi qui le soluzioni individuate STRUMENTI- Definizione 37
2.4 Triangolazione dei dati
Arrivati a questo punto, oltre al match tra brainstorming, bisogna considerare anche gli insight emersi dalla triangolazione dei dati, quindi delle criticità esistenti che potremmo non aver ancora considerato. Si chiama triangolazione dei dati perchè se uno stesso dato emerge in tre situazioni differenti (per esempio durante l’immersione, dal questionario e dalle interviste) possiamo considerarlo come valido quindi estrapolare un insight ed evidenziare una mancanza. Ripercorri tutti i risultati ottenuti durante il percorso e prova individuare delle triangolazioni.
Insight Situazioni
Le persone non sostano nell’area perchè sprovvista di sufficienti sedute all’ombra ma lo potrebbero fare se ci fossero.
Questionario Immerisoni Interviste
3. Sviluppo e rilascio
3.1 Analisi vincoli e sviluppo proposta
Ora è il momento di considerare i vincoli progettuali derivanti dal contesto dell’area oggetto di rigenerazione e dal piano urbanistico della città. Una volta individuati questi vincoli sarà più semplice capire cosa progettare. Sviluppate quindi la vostra proposta di progetto utilizzando la pianta dell’area ed indicando le vostre soluzioni per rigenerarla. Non c’è bisogno di andare troppo nel dettaglio perché questa è solamente una bozza che andrà ad essere ultimata dopo aver chiesto feedback al pubblico.
3.2 Prototipazione e condivisione
Dopo aver sviluppato la bozza di progetto è il momento di prototiparla e testare se le soluzioni proposte funzionano! Per farlo potrai organizzare un incontro in cui presenterai la tua bozza agli stakeholder, esporrai le motivazioni che ti hanno portato a questa configurazione e raccoglierai i loro feedback. Potresti organizzare un incontro sul campo e fornire loro la pianta che hai sviluppato in formato cartaceo in modo che possano esplorare l’area e trarne le loro considerazioni. Inoltre potresti fornire loro delle domande guida per valutare la tua bozza di progetto: 1. Quale servizio è il più utile? Perché? 2. Quale meno utile? Perché? 3. Cosa manca? A chi sarebbe utile? 4. Cosa cambieresti?
In aggiunta all’incontro potresti realizzare un breve questionario (ad esempio un google form), utilizzando sempre la stessa traccia di domande, dove alleghi la tua proposta di progetto. Condividi il questionario sui canali social che ritieni più opportuni e raccogli le risposte degli utenti.
38 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
39
STRUMENTI- Sviluppo e rilascio
3.3 Analisi feedback e soluzione
Ora che hai raccolto i feedback dall’incontro e dal questionario incrocia i risultati e scrivi qui le tue scoperte:
4. Implementazione
4.1 Priorità
Ora che hai sviluppato il progetto per la rigenerazione urbana della tua area è necessario valutare le priorità di progettazione ovvero una scala di fattibilità delle soluzioni proposte. Dovrai quindi valutare cosa realizzare prima e cosa dopo e potrai farlo in base alle esigenze che sono emerse con maggior forza durante il percorso progettuale.
Alla luce di queste scoperte modifica la tua bozza di progetto in modo che le soluzioni si conformino maggiormente ai bisogni degli stakeholder e avrai finalmente il tuo progetto per la rigenerazione urbana.
40 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
STRUMENTI- Implementazione 41
Dopo
REALIZZAZIONE
Prima
4.2 Chi coinvolgere
Definite le priorità di realizzazione bisogna capire chi coinvolgere nella realizzazione di questa prima soluzione progettuale. Per farlo ridefinisci la mappa degli stakeholder in relazione a questo primo progetto che dovrà essere realizzato, considerando quindi tutte le parti interessate (potenziali utenti, associazioni locali, proprietari del suolo, produttori locali ecc.). Grazie a questo riuscirai a individuare chi coinvolgere nella fase di realizzazione.
4.3 Realizzazione
4.2.1
Incontro indroduttivo
Adesso che hai definito anche chi coinvolgere bisogna passare alla fase operativa: la realizzazione. Prima di arrivare al laboratorio di cocreazione è importante coinvolgere gli stakeholder selezionati in un incontro introduttivo per spiegare loro cosa si intende realizzare nel dettaglio e in che modo saranno coinvolti. Inoltre, in relazione a quello che sarà la finalità del laboratorio, sarebbe opportuno dettagliare le fasi di lavorazione ed introdurre i materiali che si andranno ad utilizzare, in questo modo l’incontro avrà anche uno scopo istruttivo. Per farlo puoi organizzare una presentazione che ti serivirà da supporto. Puoi trovare un esempio nel kit di Designers Italia. Potresti inoltre coinvolgere nella presentazione alcuni esperti del settore che parteciperanno al laboratorio co-struttivo.
Segui a grandi linee questa scaletta per organizzare la tua presentazione:
Tienili aggiornati su tutto ciò che succede
Gestisci al meglio il loro coinvolgimento in tutte le fasi di lavoro
- Copertina con il nome del progetto - Perché siamo qui - Obiettivi dell’incontro introduttivo e obiettivi del laboratorio - Approfondimento del progetto - Attori coinvolti - Dettagli tecnici di realizzazione - Organizzazione del laboratorio
4.2.3 Laboratorio di co-creazione
Comunica in modo regolare
Trova soluzioni alle loro esigenze, anticipa le loro domande
L’ultima fase del processo di rigenerazione urbana partecipata è la realizzazione degli elementi ideati durante il percorso progettuale. Organizza quindi un laboratorio (che potrà svilupparsi anche in diverse giornate) per creare insieme ai partecipanti una o più soluzioni di quelle emerse nel paragrafo 4.1 come prioritarie.
Potresti dividere i partecipanti in gruppi a seconda delle fasi di lavorazione o dei progetti da realizzare.
Coinvolgi professionisti locali nelle fasi di lavorazione in modo che possano condividere le loro competenze ed invita altri stakeholder (forse quelli già coinvolti nelle fasi precedenti?) ad imparare nuove tecniche e rigenerare insieme l’area!
42 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
INTERESSE DEGLI STAKEHOLDER
STRUMENTI- Implementazione 43
INFLUENZA DEGLI STAKEHOLDER
+ +
Bibliografia e sitografia
Ora che il primo progetto per la rigenerazione urbana è stato realizzato ritorna al paragrafo 4.1, scegli il progetto successivo e ripeti l’iter di realizzazione appena concluso!
SCARIOT C., HEEMANNA A., PADOVANI S., Understanding the collaborati ve-participatory design, University of Paraná, Brezil, 2012.
CYBIS W., BETIOL A. H., FAUST R., Ergonomia e Usabilidade, conhecimentos, métodos e aplicações, Novatec Editora LTDA, São Paulo, 2007.
SANDERS E., STAPPERS P. J. Co creation and the new landscapes of desi gn, 2008.
https://designers.italia.it/kit/ https://www.designkit.org/methods https://servicedesigntools.org/tools
https://diytoolkit.org/tools/ https://www.designcouncil.org.uk
44 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 45
Appunti
47
46 TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA TOOLKIT PER LA RIGENERAZIONE URBANA PARTECIPATA