NEL SINDACATO 1949-1969

e Materiale per la formazione Uff. formazione FLM Milano Consiglio di Fabbrica n. 57 - Giugno 1978 - Anno VI
LETTURE
Redazione: Piazza Umanitaria n. 5 - tel. 54.68.020/1/3/4, Milano.
Direttore responsabile: Walter Galbusera.
Direttori: Donato Di Meo, Renato Luceti, Piergiorgio Tiboni.
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 344 del 28 settembre 1971.
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 3°.

NEL SINDACATO 1949-1969 LETTURE

Materiale per la formazione
Uff. formazione FLM Milano

Presentazione dell'Ufficio Formazione provinciale FLM
L'Ufficio Formazione Provinciale è impegnato, in collaborazione con il collettivo BCD, da alcuni mesi, nella realizzazione di una serie di dispense sulla storia del sindacato (1944-1969).
Le difficoltà presenti nella stesura di simili materiali, che oltre ad avere una impostazione particolarmente attenta alla destinazione degli stessi, corsi di base per delegati prevalentemente neo-eletti, vengono proposti come un esempio di ricerca e di approfondimento unitari, richiedono tempi di realizzazione purtroppo non brevi.
Attualmente è disponibile la prima dispensa che "copre" il periodo 1944-1948 ed è a buon punto la definizione della seconda.
Si è pensato quindi di coprire temporaneamente il vuoto presente nei materiali per la formazione di base per il periodo 1949-1969 proponendo una serie di letture raccolte in questo numero di Consiglio di Fabbrica.

Scegliendo questi materiali non ci si è tanto preoccupati di evitare le caratterizzazioni quanto di renderle trasparenti, riservando l'approccio unitario alle varie tematiche alla stesura delle dispense già programmate.
Uff. Formazione Provinciale F.L.M. MILANO
3
Le conquiste dei sindacati dell'epoca dell'operaio -massa
Occorre superare un'interpretazione agiografica del sindacato unito nel dopoguerra e considerare i grossi limiti di partecipazione e democrazia che ebbe quell'esperienza. L'ideologia industrialista nel sindacalismo cattolico e il produttivismo della Cgil. Le ipotesi schematiche sulla stagnazione. Lo spartiacque del 1960 e il graduale superamento di una visione meramente contrattualistica dei rapporti del sindacato con lo Stato e le istituzioni.
di Bruno Trentin
Il 1960 rappresenta lo spartiacque della storia del movimento sindacale in questi trenta anni, dopo la scissione del 1948. Data da allora una svolta profonda nei contenuti dell'azione sindacale e, non casualmente, dei rapporti tra le organizzazioni nate dalla scissione: prende avvio la ripresa del discorso unitario.
Forse oggi, alla luce della evoluzione del sindacato italiano, si pone l'opportunità di una riflessione più approfondita, meno passionale, delle vicende del 1947-48. La storiografia e i giudizi politici hanno posto l'accento molto spesso sui danni che la scissione aveva provocato, su ciò che aveva lacerato e distrutto rispetto a un patrimonio che, sia pure rapidamente, si era accumulato nel movimento sindacale dal primo anteguerra. E non va assolutamente sottovalutato questo patrimonio e l'enorme potenzialità politica che il sindacato unitario rappresentava: il suo atto di nascita derivava, infatti, non solo da un accordo tra i partiti, ma dallo spirito e dalla volontà che animava le forze della Resistenza. Di qui la carica interna del Patto di Roma, che si presentava allora come una intelaiatura idonea allo sviluppo di una esperienza unitaria e che, soprattutto per merito di Di Vittorio, sfuggiva agli schemi, forse privilegiati da altri, del sindacato unico e istituzionalizzato in partenza.

Ma, sottolineato che lo sviluppo di una concreta esperienza di massa di tipo unitario avrebbe permesso al sindacato sorto dalla guerra di liberazione di dispiegare delle potenzialità che abbiamo recuperato solo in questi ultimi anni, non bisogna oscurare i limiti profondi che caratterizzavano il sindacato unitario nel dopoguerra. Bisogna superare interpretazioni agiografiche. In quel sindacato, per le sue strutture interne e per i meccanismi di formazione delle decisioni, risultava fortemente limitato il momento della partecipazione e della democrazia nella formazione di un orientamento autonomo. La logica delle correnti rappresentava il vero e unico spazio di democrazia all'interno del sindacato e il confronto non solo culturale, ma ideale e politico, veniva così ridotto soltanto a mediazione e a contrattazione. Questo dato non caratterizzava solo i rapporti all'interno dei gruppi dirigenti e non si manifestava solo sulle grandi scelte e sulle grandi sintesi politiche, ma si ritrovava a tutti i livelli della direzione sindacale unitaria, comprese le strutture di fabbrica. Per il periodo che va dalla liberazione alla scissione difficilmente si può parlare di momenti reali, autentici, di democrazia di base, in grado cioè di contribuire alla elaborazione culturale e politica di una strategia autonoma del sindacato.
Nel movimento sindacale del dgpoguerra sono coesistite, in fondo, sino al '48, delle anime profondamente diverse, che
hanno trovato fra loro dei momenti di composizione nella gestione pratica della Cgil, ma che non si sono mai cimentate fino in fondo in una esperienza di elaborazione politica e culturale comune. Un'anima era rappresentata dal sindacalismo cattolico, che esprimeva una sua ideologia sia pure in modo ancora confuso e oscillante. Da una parte vi era la preoccupazione non meramente strumentale di marcare un forte coliateralismo con le forze di governo e con le strutture del potere statale che stavano instaurandosi; questa tendenza troverà con l'appropriazione di una dottrina americana un'accentuazione, e non verrà affatto contraddetta da una visione che prefigurava una politica sindacale fondata sulla ricerca a priori di uno spazio privilegiato di potere: con il controllo degli strumenti che possono consentire il monopolio della rappresentanza della manodopera, dal collocamento pubblico e privato alla formazione professionale, all'assistenza. Un segno della rilevanza di questa concezione può ritrovarsi nell'attenzione che, sin dal loro sorgere, le Acli daranno al proprio ruolo di patronato di assistenza. Dall'altro lato si manifesta la preoccupazione di governare secondo parametri aziendali la politica salariale: non siamo ancora, come di lì a qualche anno, sul terreno della subordinazione teorizzata del salario alla produttività aziendale, ma comunque su quello di una azione moderata secondo le esigenze delle imprese. Secondo questa visione il sindacato assume un ruolo di sostegno alla politica di ricostruzione anche per quanto riguarda la sua componente finanziaria, cioè la politica deflazionistica.
Vi era, invece, nella Cgil un filone di antica tradizione, presente prima e dopo la scissione sindacale, col quale, in quel periodo, la componente cattolica non si è mai confrontata sino in fondo. Questo filone si espresse in gran parte attraverso le scelte della Cgil nella battaglia per la ricostruzione. Da un lato esse puntavano alla ricerca di una struttura salariale e di condizioni di occupazione, diremmo oggi, minimamente egualitarie: vi era cioè una azione insistente di unificazione fra Nord e Sud con una politica salariale perequativa, attraverso ad esempio, gli assegni familiari e la scala mobile, pagando però il prezzo di una marcata sottovalutazione dei problemi specifici del rapporto di lavoro nella grande impresa. Dall'altro lato essa si esprimeva in un impegno generale per affermare un potere di controllo del sindacato sulle scelte produttive, sia nelle campagne, sia nell'industria dove avvenivano i primi processi di ristrutturazione. Nell'esperienza dei consigli di gestione si sono infatti impegnati i migliori quadri della Cgil, mentre la liquidazione dei consigli di gestione vide sostanzialmente indifferente o neutrale la componente cattolica.
Nell'arco dei pochi anni che precedettero la scissione, dunque, mancarono le condizioni di vita democratica interna che avrebbero potuto consentire l'avvio di un confronto tra diverse esperienze, anche pratiche, e coesistettero quindi all'interno del
Da: "Rinascita" n. 28 - 15 luglio 1977
4
sindacato diverse concezioni sindacali di grande portata. Dopo la scissione queste concezioni si sono meglio precisate, anche perché, l'una e l'altra, ma soprattutto quella cattolica, hanno ricercato a posteriori una più coerente dignità ideologica. Ed è emblematico che il cammino non più parallelo ma antagonistico delle due componenti si sia manifestato intorno alla proposta del Piano del lavoro: la Cgil si impegnò nella battaglia per la difesa dell'industria, per la salvezza del posto di lavoro, per nuove opere pubbliche, per la terra e la riforma agraria, anche con forme nuove di lotta, autogestite dai lavoratori. La componente cattolica dal canto suo imboccò tutt'altra strada scontando, allora, la perdita di alcuni "valori" che erano presenti, ad esempio, nel movimento delle leghe bianche prima del fascismo. Divenendo Cisl, essa puntò sul sindacalismo aziendale, sulla realtà produttiva delle singole imprese e sui lavoratori dipendenti là dove c'erano, relegando molto sullo sfondo i problemi "politici" dello sviluppo, delle riforme, del Mezzogiorno e così via. E' la scelta dell'azienda come centro produttore, come entità garante della democrazia e della stabilità del "sistema", dell'azienda come centro fondamentale di decisioni rispetto al quale l'unico interlocutore deve divenire il sindacato. E' la fase delle relazioni umane, dei comitati di produttività nei quali la Cisl si impegna in prima persona, della politica salariale rapportata agli incrementi di Produttività.
In questo periodo si precisano le due grandi tradizioni presenti nel movimento operaio. Quella cattolica in particolare, e successivamente in qualche misura anche quella socialdemocratica, si rifanno al pragmatismo americano, e ciò consente loro di cogliere meglio lo specifico del mondo industriale in trasformazione, anche se questa nuova connotazione del sindacalismo interclassista sconta l'oscuramento di una tematica che era presente nella tradizione cristiana del sindacato, quella del controllo dal basso, del rapporto fra l'uomo e l'organizzazione della produzione, cioè della liberazione dell'uomo.
Questi diversi approcci alla concezione del sindacato coincidono con due analisi della società che risultano anch'esse profondamente marcate proprio dalla scissione e dalla rottura politica del dopoguerra.
Luna è quella dell'industrialismo, che scommette tutte le sue carte sul ruolo egemone dell'industria moderna e dei suoi sistemi di organizzazione del lavoro, come luogo di creazione e di crescita di un sindacato inteso come associazione chiusa, capace di garantire determinati privilegi ai suoi aderenti e di esercitare una funzione monopolistica nella tutela della manodopera occupata, e piuttosto disimpegnato invece sui problemi della macroeconomia, dello sviluppo economico. Si sale insomma su un autobus in corsa, ma soltanto al Nord e in alcune zone del Sud. L'altra, quella del sindacato che si richiama all'unità di classe, è la linea fondata su una ideologia produttivistica, di piena utilizzazione delle risorse umane e materiali in alternativa all'immobilismo e al parassitismo della società italiana: una visione che era però fortemente limitata da un'analisi invecchiata e schematica del capitalismo italiano e, Più in generale, del capitalismo nell'epoca contemporanea. L'analisi dello sviluppo industriale era ancora fondata sullo schema dell'equivalenza tra monopolio e stagnazione e quindi sull'ipotesi di un capitalismo italiano capace di esprimere un suo Modello di espansione. Al contrario un modello, sia pure distorto, c'era, e avrebbe determinato profonde contraddizioni nel tessuto sociale del paese.
Queste due analisi hanno sorretto il sindacalismo italiano in quegli anni, anche in grandissime battaglie, come quella per il Piano del lavoro. Ma l'una aveva il limite di sottovalutare il carattere fondamentalmente contraddittorio dello sviluppo industriale e capitalistico; l'altra invece ipotizzava una tendenza immobilistica, di stagnazione del capitalismo industriale, alla quale bisognava contrapporre una proposta di sviluppo alternativa, nella quale gli elementi di riforma e di mutamenti qualitativi negli indirizzi di politica industriale erano necessariamente oscurati.
2.
La crisi di queste tendenze e il rimescolamento delle carte comincia con il '55; con la sconfitta della Cgil che, paradossalmente, rappresentò per il sindacato una occasione di liberazione di vecchi schemi e di catarsi. Dopo di allora cominciano a gettarsi le basi per un'analisi più comune e più aderente alla realtà dello sviluppo industriale italiano e si ha la riscoperta,

non tanto della fabbrica, ma dei processi di ristrutturazione che stanno sconvolgendo l'assetto industriale ed economico del paese, nelle grandi, nelle medie e nelle piccole aziende. Senza dubbio la Cgil riassume in modo nuovo rispetto al passato la dimensione dell'azienda, individuando in primo luogo il profondo mutamento delle strutture organizzative dell'assetto industriale e dei rapporti tra grande e piccola azienda e in secondo luogo i nuovi elementi di contraddizione introdotti dai poli di industrializzazione nel tessuto economico e sociale del Mezzogiorno. Si prende piena coscienza dei problemi della qualità dello sviluppo, della condizione operaia e dell'occupazione.
Nella Cisl avviene un processo in qualche modo convergente anche se di altro segno. Con la vittoria in alcune grandi fabbriche, comincia la crisi della sua ideologia industrialista. In quegli stessi anni scompaiono senza colpo ferire i comitati di produttività e la politica delle relazioni umane. La Cisl vince in fabbrica, ma si trova a dover fare i conti con la ristrutturazione capitalistica e con la necessità di una elaborazione autonoma del sindacato, nel momento in cui le formule di crescita salariale collegate al parametro della produttività aziendale o le teorie sul risparmio contrattuale rivelano tutta la loro fragilità. Passa poco tempo insomma, e non è una coincidenza, tra la sconfitta della Cgil alla Fiat e la scissione della Cisl alla Fiat stessa.
In questa fase entrano in crisi due analisi della società, due nozioni sostanzialmente ideologiche della classe operaia e del processo di trasformazione. Il riavvicinamento si impone, invece, sui problemi della condizione operaia, su un terreno sostanzialmente nuovo per ambedue le organizzazioni: quello della condizione di lavoro in senso lato, e, quindi, del rapporto sindacato-società e fabbrica-classe. Negli anni 1955, '56, '57 la Cgil rivede un atteggiamento che lasciava alla contrattazione aziendale solo uno spazio integrativo e marginale e riconosce l'esigenza di un collegamento permanente del sindacato con le sue strutture di classe nella fabbrica. La Cisl, contemporaneamente, di fronte alle contraddizioni che derivavano dalla sua affermazione in alcune grandi fabbriche — Fiat, Montecatini, Pirelli, ecc. — comincia a prendere le distanze dalle commissioni interne e rivaluta il ruolo del sindacato provinciale e nazionale come soggetti contrattuali. Questa evoluzione giungerà sino al rovesciamento delle posizioni originarie della Cisl e della Cgil, allorquando proprio la Cisl, nel timore di una nuova forma di sindacalismo aziendalistico, resisterà alle ipotesi di una struttura sindacale aziendale dotata di potere contrattuale.
Il '55 segna dunque una tappa fondamentale nella storia del sindacato dopo l'anno della scissione. E' una data che va rivalutata come un grosso momento di riflessione collettiva nella Cgil e anche nel partito comunista; allo stesso tempo segna l'apice della Cisl ma anche l'avvio di un ripensamento profondo.
3.
La terza data determinante nella storia del sindacato è, come si è già detto, quella del '60, anche se il movimento sindacale vi è arrivato impreparato. Il luglio del '60 porta già il segno del peso che hanno assunto nelle lotte sociali le nuove generazioni, e particolarmente quelle emigrate, del ruolo fondamentale che esse svolgono già all'interno del processo produttivo e, nei fatti, all'interno del movimento operaio. In quegli anni, mentre il sindacato, faticosamente, si avvicina a una nuova dimensione della realtà produttiva e ricerca, partendo dalla fabbrica, un nuovo rapporto con la società e il paese, avviene il fatto imprevisto; i protagonisti cambiano. Vi è un mutamento radicale di generazioni nell'operaio-massa.
E' un fenomeno determinante in particolare per la Cgil che prevaleva tra quegli operai specializzati e qualificati che sono stati falcidiati dalla politica repressiva e di riassunzioni selezionate condotta dal padrone. Il problema del nuovo operaio-massa coinvolge comunque tutte le organizzazioni sindacali e viene fuori dai vicoli di Genova nel luglio '60. Questa nuova figura sociale è stata colta in particolare per la sua valenza antifascista, ma è stato sottovalutato ciò che più a fondo essa esprimeva e rappresentava. Non è un caso che proprio nel '60 si ha una prima drammatica rottura nel movimento sindacale, all'Alfa Romeo, sulle questioni dell'orario di lavoro e dei tempi alla catena di montaggio. Avviene una spaccatura tra sindacati, ma anche tra generazioni: gli operai più giovani, generalmente immigrati rifiutano un accordo di puro indennizzo salariale.
E' a questo punto che si delinea una svolta anche nel processo unitario del movimento sindacale: i sindacati tentano di
5
ricostituire un tessuto organizzativo e una linea politica fondati non solo su un'analisi rinnovata dei processi produttivi ma su una nuova capacità propositiva delle strutture di base, partendo dal dato del nuovo protagonista delle lotte, il giovane operaio-massa, generalmente di origine meridionale.
La lotta degli elettromeccanici milanesi avviene in quel periodo e si ha con quella lotta, caratterizzata da una rivendicazione di riduzione dell'orario di lavoro, la prima vera rottura di un immobilismo sindacale che durava praticamente dal '54. Con estrema rapidità cOminciano a bruciarsi i tempi e le tappe: la Cisl porta a compimento il suo mutamento. Nel '55 la Cisl vince alla Fiat contro la Cgil; nel '62, solo sette anni dopo, la Cisl sciopera alla Fiat con la Cgil e contro la Uil e il Sida (il sindacato nato dalla sua scissione) per respingere un accordo separato. E nella Uil si avvia, proprio nel vivo di un duro scontro all'interno del movimento sindacale, una dialettica nuova e la ricerca di una nuova collocazione.
Da quel momento sul nodo fabbrica-società, si recuperano e si intrecciano, come non era successo nel dopoguerra, esperienze e valori dei due grandi filoni del movimento sindacale italiano: quello socialista in senso lato e quello cattolico. Intorno alla tematica della condizione di lavoro si ripropone il problema del potere del sindacato, e proprio sui problemi della condizione di lavoro, e non soltanto sul salario, si costruisce la riscossa sindacale.
Le lotte contrattuali del 1962-65 si incentrano, infatti, sul diritto alla contrattazione articolata, particolarmente in ordine ai sistemi di cottimo e non possono non tradursi in una prova di potere. Il sindacato (e questa volta la Cgil, la Cisl e la Uil insieme), con il nuovo ruolo assunto dalla contrattazione nazionale, si conferma organizzazione di tutta la classe, ma nell'azienda si fa carico della tutela delle condizioni di lavoro attraverso una contrattazione articolata che, nel '63, assume come punto di riferimento il sistema di cottimo. Sulla tematica del lavoro alienato si ricostruiscono dunque le basi unitarie dell'azione del sindacato; ma si prende, al tempo stesso, coscienza della impossibilità di superare le condizioni strutturali dell'alienazione operaia in fabbrica senza rimettere in discussione i meccanismi di formazione delle decisioni nella società, la politica economica dello Stato, la organizzazione del territorio, la strategia dei grandi gruppi economici. Su questo terreno si sono posti i problemi della democrazia interna e delle nuove forme, unitarie, di organizzazioni del consenso all'interno del sindacato. E si è avuto, sul quel terreno, anche il recupero di alcuni valori originari dei due grandi filoni del movimento sindacale italiano. La Cisl, ad esempio ritrova interesse e impegno sui temi dell'uomo, dell'individuo e della comunità; ma in generale tutti recuperano gli obiettivi del potere e del controllo dal basso che caratterizzavano l'esperienza dei consigli di gestione e del Piano del lavoro, ma che erano stati fortemente limitati, nell'ottica della Cgil, da un'ipotesi di stagnazione del capitalismo italiano.

Questa ipotesi da un lato, per quanto riguarda la fabbrica, aveva in qualche modo rinchiuso il più forte sindacato italiano nella lotta al "supersfruttamento" (così veniva chiamato) come un'"aberrazione" scindibile dal processo produttivo in atto, e nella sottovalutazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro che si stavano socializzando in quella fase; dall'altro lato, quella ipotesi impedì di cogliere i termini nuovi in cui si poneva la questione meridionale, che si continuava a identificare con l'abbandono di un'area da parte di un capitalismo industriale sostanzialmente immobile. Di qui la difesa disperata da parte della Cgil di ogni posto di lavoro, di ogni pezzo di industria: di ogni miniera, di ogni torbiera, di ogni piccola seteria con la coscienza sincera di chi difendeva non solo un posto di lavoro ma un pezzo di struttura produttiva, insostituibile. (Intanto si stava raddoppiando Mirafiori e si stava costruendo Rivalta).
Dal '62 si ha il salto, si avvia un processo di riscoperta della fabbrica e della società. Questo processo verrà accelerato nel '68-69, quando la seconda generazione dei giovani "operaimassa" entra in campo. Ma è nel '62 che inizia la lunga marcia di avvicinamento alla società e alle istituzioni, tuttora in corso. Essa nasce da un crogiuolo dove cominciano a fondersi le diverse esperienze del sindacalismo italiano. Si tratta di una lunga marcia perché per un lungo periodo la nuova esperienza unitaria permane ancora racchiusa in una visione soprattutto aziendale. La fabbrica viene considerata, infatti, come una prima trincea da occupare e a partire dalla quale proiettarsi verso l'esterno.
I limiti di questa concezione si scontano già nel '66, quando la crisi economica rimette in discussione un rapporto farraginoso e burocratico tra sindacato e programmazione, mentre le lotte rivendicative all'interno delle fabbriche scontano il rischio di un loro isolamento. Allora il raccordo con la società viene riscoperto attraverso la politica delle riforme, che è stata però intesa, per un certo periodo, prevalentemente come un prolungamento della tutela sociale del lavoratore occupato. Le pensioni, le zone salariali, gli assegni familiari, la riforma sanitaria, la stessa politica della casa vengono vissuti in larga misura come obiettivi volti innanzitutto al miglioramento della condizione del lavoratore dipendente e non ancora consapevolmente come obiettivi politici, come parti di una politica economica generale che determini un nuovo uso delle risorse e spostamenti dei rapporti di potere nelle istituzioni e nella società. In quegli anni, e fino al '70, il sindacato non si fa quindi carico di una necessaria politica delle alleanze e nemmeno in misura adeguata del problema dell'agricoltura come uno dei nodi per risolvere il problema del Mezzogiorno.
Scontando successivamente i limiti di una strategia meramente contrattuale che privilegia il potere esecutivo quale gestore di una politica di riforme, il sindacato si troverà a fare i conti con le questioni essenziali delle istituzioni, del ruolo dei partiti, della riforma dello Stato. E cosi il movimento sindacale tende oggi a riscoprire una dimensione nuova della sua autonomia. L'autonomia della classe si realizza certamente di fronte alle scelte padronali individuando nuovi strumenti di democrazia e di partecipazione interna, tali da garantire essi stessi con la loro capacità di elaborazione e di iniziativa questa autonomia, ma essa si realizza anche con la proposta di un progetto complessivo, non più settoriale, che muti la società e che richiede per realizzarsi una concezione nuova, originale, del rapporto con lo Stato e le istituzioni.
Questa è la tematica oggi sul tappeto per tutto il movimento sindacale. E' la prima volta che si pone questa tematica comune: non vi sono né precedenti né paragoni possibili, sia nella storia del sindacato italiano che nelle esperienze di altri sindacati. Siamo al superamento di una visione puramente contrattualistica dei rapporti con lo Stato e le istituzioni. Il che non vuole dire certo passare da una sorta di collaborazione istituzionale, ma l'assunzione dell'obiettivo della riforma dello Stato come parte necessaria di una strategia di sviluppo e di trasformazione della società.
Fare i conti con i problemi dello Stato e della sua riforma, delle alleanze, fare i conti con questa nuova ottica, con i problemi del controllo dell'economia e della gestione dell'impresa richiede una autonomia culturale che il sindacato ancora non ha in misura sufficiente. Il sindacato italiano rappresenta un fatto nuovo, che è però ancora una potenzialità. Rimangono aperti pericoli di riflusso, sia per le opposizioni interne ed esterne sia per i limiti più diffusi che permangono nella sua elaborazione di massa e nella sua stessa democrazia interna; ma questa potenzialità segna con la sua stessa esistenza il superamento, almeno nei loro connotati originari, dei due filoni del sindacalismo che si contrapposero con la scissione del 1948.
6
I difficili anni cinquanta
11 9 gennaio 1950, a Modena, sei lavoratori delle Fonderie Riunite vengono uccisi dalla polizia di Scelba perché protestano contro la serrata della fabbrica effettuata dal padrone. Adolfo Orsi, un'industriale che si è 'fatto' durante il fascismo. Con questo episodio, drammatico e significativo, iniziano gli anni '50.

Il clima poliziesco creato a Modena ed in tutta l'Emilia rispondeva in quegli anni ad una precisa scelta politica imposta dal governo De Gasperi-Scelba. L'Emilia, notoriamente regione 'rossa', era stata definita: "il Messico d'Italia" e per reprimere le eventuali sommosse e gli scioperi erano stati mandati nei capoluoghi emiliani i funzionari più duri del ministero degli Interni. In un anno vennero effettuate in Emilia undici serrate di stabilimenti industriali: oltre duemila lavoratori furono le vittime di questa politica padronale. Nelle campagne 3.500 braccianti vennero imprigionati per aver effettuato 'scioperi alla rovescia'.
Se questa era la situazione nelle campagne, non meno drammatica era quella delle industrie. Decine di fabbriche effettuarono licenziamenti in massa: i disoccupati superarono i due milioni. Esemplare in questo periodo è la vicenda delle officine Reggiane di Reggio Emilia: una fabbrica che venne smobilitata nel 1951 nonostante l'occupazione effettuata dai lavoratori e durata un anno. Vennero colpite in questo periodo soprattutto le fabbriche a capitale pubblico (come erano appunto le Reggiane) secondo un preciso "piano" del governo tendente a favorire la ripresa dell'industria privata.
Le lotte disperate degli operai dell'Ansaldo, della Breda, delle Reggiane, del Pignone, e di tanti altri stabilimenti medi e Piccoli, testimoniano del fatto che la ripresa, in Italia, avvenne senza che il padronato salvaguardasse minimamente i livelli occupazionali, ma soprattutto, senza che il sindacato avesse alcun potere per la tutela di questi livelli. Nel 1951, per uno sciopero proclamato dalla Cgil contro la venuta di Eisenhower In Italia, numerosi lavoratori che avevano partecipato alla manifestazione furono licenziati. Sono gli anni, questi, dei licenziamenti a catena per motivi politici: i rappresentanti delle Commissioni interne vengono colpiti fra i primi.
La restaurazione capitalista, la disoccupazione e la contrapposizione fra i vari sindacati sono i tre elementi fondamentali che determinano la condizione di estrema debolezza della classe oPeraia. Fin dal 1949 il Parlamento aveva votato una legge che attribuiva al collocamento natura di funzione pubblica: di fatto si venne a privare il sindacato di uno strumento essenziale per la tutela dei diritti dei lavoratori.
Ma le lotte coraggiose che i lavoratori effettuarono nelle fabbriche minacciate di chiusura, se da un lato testimoniano l'importanza fondamentale della fabbrica come punto di partenza per la contrapposizione alla restaurazione capitalistica, d'altra parte sottolineano che la lotta di fabbrica in quegli anni non vive una reale dimensione sindacale; di un sindacato cioè effettivamente operante al suo interno.
Il Processo di sviluppo economico che prende l'avvio negli anni 90 in Italia si svolge senza o quasi la partecipazione del sindacato nella fabbrica; più che di "conquiste" della classe
operaia, in quel periodo si può piuttosto parlare di "elargizioni" concesse dal padronato, chiaramente in chiave paternalistica: premiando i 'buoni' e castigando i 'cattivi'. Questo fenomeno, come si legge dalle interviste di base, contenute in questo capitolo, fu presente in quasi tutte le fabbriche, e si fece particolarmente vistoso alla FIAT di Torino. L'8 maggio 1953 veniva firmato dalla Cgil, Cisl e Uil il nuovo accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne. L'accordo istituiva le Commissioni interne negli stabilimenti con più di quaranta dipendenti e riconosceva alla Commissione interna funzioni consultive circa i regolamenti interni: le ferie, l'orario, i nuovi metodi di retribuzione. La Commissione interna inoltre poteva formulare proposte circa il perfezionamento dei metodi di lavoro e l'istituto previdenziale all'interno delle aziende, ma non aveva competenza in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, compito esclusivo delle organizzazioni sindacali. Il contratto collettivo di lavoro ha vigore solo per quelle aziende che aderiscono alla Confindustria. Ne deriva che in moltissime aziende minori il padronato impedirà non solo la formazione delle Commissioni interne ma si rifiuterà anche di applicare il contratto di lavoro.
La scissione sindacale ha indebolito il potere dei lavoratori all'interno della fabbrica ed ha ancora più legato le tre organizzazioni sindacali: Cgil, Cisl e Uil, ai rispettivi partiti. In conseguenza di questo rapporto più stretto tra sindacato e partito, il sindacato in quegli anni non considera più la fabbrica come punto di partenza delle lotte operaie, ma tende solo a imporre delle direttive provenienti dall'alto. La crisi delle Commissioni interne è riconosciuta da tutte le organizzazioni sindacali. In alcune aziende le Commissioni interne non sostengono più le istanze dei lavoratori, si limitano ad avallare decisioni che provengono dalle Confederazioni. Si è parlato più volte, riferendosi a quegli anni, di una direzione sindacale ispirata continuamente a motivazioni politiche più generali del Paese. Una divaricazione quindi, fra istanza politica e interessi economici, che arriva fino al punto di svuotare di significato, nelle fabbriche, l'unico strumento atto a portare avanti le rivendicazioni operaie. Come ha scritto Aris Accornero: "(...) Dagli operai delle grandi fabbriche e il movimento operaio sembra attendersi un congenito e intransigente ascetismo, che li porti sempre a privilegiare l'impegno politico e a mortificare quindi le tentazioni economiche".
Solo circa il 30% delle piccole e medie aziende ha la Commissione interna. Nella provincia di Torino, per esempio, su 6.353 aziende con più di 50 dipendenti, solo 321 hanno la Commissione interna.
La Cgil cercò in quegli anni di rilanciare il ruolo del sindacato attraverso un programma economico nazionale: il Piano del lavoro, proposto al Congresso di Genova del 1949 e formulato successivamente in un convegno tenuto a Roma nel febbraio 1950. Il Piano del lavoro può anche essere considerato il primo tentativo di prefigurare una politica armonica di sviluppo nel nostro Paese. La Cgil in particolare proponeva la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la costituzione di un Ente nazionale di bonifica per le irrigazioni e le trasformazioni fondiarie, col compito di promuovere lo sviluppo dell'agri-
a Da:
!1 a
Marisa Malfatti, Riccardo Tortora "Il cammino dell'unità" - Bari 1976
7
coltura e di dare avvio alla riforma agraria; la costituzione di un Ente nazionale per l'edilizia popolare; la realizzazione di un vasto programma di opere pubbliche (strade, acquedotti, ecc.).
Il Piano tentava di sottrarre il Paese al processo di restaurazione già in atto, processo che favoriva nettamente l'industria privata e i grandi monopoli.
Ma il Piano fu boicottato, ignorato dalla direzione politica democristiana. Il governo De Gasperi effettuò in quegli anni la riforma fondiaria, ma non certamente nei termini espressi dal Piano del lavoro, che prevedeva l'eliminazione radicale del latifondo; mentre la riforma agraria di quegli anni fu solo uno "stralcio". Nel maggio del 1952, in una conferenza tenuta al Teatro Rasi di Ravenna, Luciano Romagnoli rilevava che: Esistono in Italia circa 4 milioni e mezzo di famiglie di lavoratori della terra, di braccianti, di compartecipanti, di salariati fissi, di mezzadri, piccoli fittavoli che non possiedono terra o ne hanno quote assolutamente piccole e d'altro lato contro questi 4 milioni e mezzo di famiglie senza terra, assetate di terra, di pane e di lavoro, stanno poche decine di migliaia di famiglie (circa 24-25 mila famiglie) che possiedono oltre dieci milioni di ettari di terra. Ecco il problema di fondo delle campagne italiane che è urgente risolvere. E' chiaro che fino a che non si comincerà sul serio a soddisfare la fame di terra e di lavoro di 4 milioni e mezzo di famiglie senza terra, espropriando le grandi estensioni di terra di proprietà di queste 24-25 mila famiglie, il problema agrario in Italia non sarà seriamente avviato a soluzione (...).
Intanto nelle fabbriche la condizione operaia peggiorava e lo sfruttamento aumentava. Le basi di quello che verrà definito il "miracolo economico" italiano poggiano proprio sul persistere in Italia dei salari più bassi di tutta Europa e nella difesa, ostinata e pervicace, da parte di una classe padronale con idee chiuse e ristrette dei propri privilegi. Di fronte alla trasformazione dei processi produttivi che in quegli anni avveniva all'interno delle aziende il sindacato fu colto impreparato.
(...) In quegli anni del dopoguerra — scrive ancora Accornero — durante grandi battaglie come quelle contro l'attentato a Togliatti, il 'generale peste', la 'legge truffa', la 'Comunità Europea di difesa', nelle quali gli operai mettevano una carica di ribaltamento che le organizzazioni operaie incanalavano entro obiettivi più graduali di cambiamento, l'unica cosa che pareva non potesse cambiare era l'organizzazione del lavoro nell'impresa capitalista.
Nell'inverno 1952-53 le tre Confederazioni furono coinvolte nella lotta contro la cosiddetta 'legge truffa', proposta da De Gasperi. La legge favoriva quel gruppo di partiti alleati che avesse raggiunto il 50% dei voti, con un aumento in percentuale di seggi parlamentari. Era chiaramente una manovra effettuata dalle destre maggioritarie per ottenere una stabilità governativa più solida. La Cgil organizzò contro la legge truffa una serie di agitazioni: il 19 gennaio 1953 proclamò uno sciopero generale, ed un secondo venne indetto, sempre dalla sola Cgil, il 29 marzo. L'azione combinata della Cgil e dei partiti della sinistra riuscì a bloccare la 'legge truffa'; nelle elezioni del 7 giugno 1953 l'elettorato italiano subì un sensibile spostamento verso gli schieramenti di sinistra.
La sconfitta della 'legge truffa' indusse il padronato a intensificare l'offensiva contro la Cgil in fabbrica. I licenziamenti e le pressioni aumentarono: il risultato di queste pressioni, che in non poche fabbriche — alla FIAT innanzitutto — arrivarono fino al terrorismo ed alle intimida'zioni, fu che nel marzo 1955, alla FIAT, per la prima volta nelle elezioni della Commissione interna, la Fiom-Cgil perde la maggioranza. Questo avvenimento fu molto sottolineato dalla stampa di destra che lo evidenziò come una sconfitta del socialcomunismo e l'avvio di quel sindacalismo di tipo aziendale europeo, che accettava la "collaborazione" col padronato e di cui, in quegli anni, si faceva portavoce la Cisl. Questa sconfitta segnò anche un momento di grande riflessione da parte della Cgil e portò alla famosa autocritica di Di Vittorio, al Direttivo confederale dell'aprile 1955. La Cgil riconosceva di aver sottovalutato in quegli anni i mutamenti di produzione avvenuti nelle aziende, soprattutto per quanto riguardava l'organizzazione del lavoro e la struttura dei salari. Questi cambiamenti ponevano problemi nuovi al lavoratore e soprattutto evidenziavano l'esigenza di poter aprire il contratto nazionale a un'integrazione aziendale. Si prefigurava cioè la necessità dell'ingresso del sindacato direttamente come agente contrattuale nella fabbrica, al di là dei contratti nazionali.
Bisogna aggiungere, a proposito della sconfitta della Fiom alla FIAT in quegli anni che in essa si inserì pure la vertenza per il conglobamento che praticamente mise 'fuorilegge' tutte le altre vertenze che si erano aperte nelle fabbriche, cosa che non giovò al morale di classe. La vertenza del 'conglobamento' (1952-1954) segnò il momento di massima divisione fra le tre Confederazioni e sottolineò, emblematicamente, lo scollegamento esistente fra le Confederazioni e la realtà nella fabbrica. Questa vertenza, proposta dalle confederazioni, consisteva nella richiesta di 'conglobare' nella paga-base l'assegno di caro-vita e le altre indennità minori, nonché nella richiesta di aumenti salariali.
Le tre Confederazioni non si accordarono nemmeno sull'entità dell'aumento salariale da richiedere e quando finalmente arrivarono al tavolo delle trattative e la Confindustria dichiarò che gli aumenti non erano accettabili, solo la Cgil si ritirò, lasciando la Cisl e la Uil a trattare separatamente. Nel giugno del '54 la Cisl e la Uil firmarono l'accordo separato con un aumento salariale inferiore al 5%. Il senso di sfiducia e di stanchezza che provocò nei lavoratori la definizione della vertenza sul conglobamento, ebbe il suo peso indubbio nella sconfitta della Fiom alla FIAT. Ma non per questo si devono sottovalutare la pressione esercitata sugli operai in quegli anni perché non votassero Fiom e le manovre aziendali per orientare le elezioni.
Scrive Marco Vais:
(...) Un'altra grave forma di pressione sulle elezioni di commissione interna in quegli anni è costituita dal frazionamento dei seggi elettorali, operati in modo da ridurre il numero delle schede scrutinate volta per volta a rendere palese l'orientamento di gruppi esattamente individuati di lavoratori. La riduzione del personale avverrà poi, reparto per reparto, secondo le indicazioni del voto.
Nei più grossi stabilimenti di Napoli e del napoletano, ad esempio, i seggi erano aumentati da 5 a 8, da 1 a 5, da 4 a 8. Dove prima venivano scrutinate 400-500 schede sé ne scrutinavano meno di 200. Nelle fabbriche di Milano si passava da 7 a 17, da 8 a 25, da 5 a 9, da 7 a 43. In uno stabilimento della Breda si scrutinavano 100 voti per volta. In una miniera del grossetano si passava da 1 seggio a 5, con 74 elettori ciascuno. Coli tali illecite pressioni si sono svolte e si svolgono le elezioni delle Commissioni interne.
L'Inchiesta parlamentare del 1956 sulle condizioni di vita degli operai nelle fabbriche, mise in luce tutti questi abusi. Denunciò anche le manovre clientelari messe in atto massicciamente per l'assunzione degli operai e il fatto che si facessero discriminazioni precise per i lavoratori socialisti e comunisti. Intanto lo sviluppo industriale di quegli anni aveva introdotto il lavoro 'a catena', che obbligava gli operai a dei ritmi sempre più stressanti. Negli anni '50-55 la produzione aumentò del 95%, ma non altrettanto proporzionata fu la crescita dei posti-lavoro; i disoccupati rimasero sempre due milioni; le ore di lavoro effettuate dal singolo operaio crebbero invece del 6%. Egualmente irrilevante fu l'aumento salariale, che variava prevalentemente per l'aumento di indennità di contingenza mentre i salari reali rimanevano pressoché stazionari: dal 1948 al 1956 variarono solo del 6%.

La nuova organizzazione del lavoro consiste, in alcune delle maggiori aziende, nell'introduzione della Job Evaluation, importata dagli Stati Uniti. Questo sistema di valutazione del lavoro operaio prevede un'incredibile frantumazione di categorie e di livelli, differenziando le paghe operaie in modo tale da rendere più difficile, all'interno di una stessa industria, l'individuazione di obiettivi di lotta con finalità eguali per tutti. Questo fatto (oltre alla divisione sindacale) aumentò il distacco fra lavoratori. A sua volta il sindacato, lacerato da problemi politici contrapposti, per alcuni anni non seppe dare risposta a questi problemi della fabbrica.
I fatti di Ungheria, esplosi nell'ottobre 1956, non fecero altro che acuire le tensioni già esistenti fra le varie Confederazioni. L'8 ottobre di quello stesso anno, a Torino, i rappresentanti della Cisl e della Uil annunziarono che nelle trattative con l'azienda si sarebbero rifiutati di sedere a fianco dei sindacalisti Cgil. La stessa 'questione morale' fu sollevata dalla Cisl e dalla Uil nazionali. L'episodio di Ungheria fu strumentalizzato a tutti i livelli.
Ma nonostante queste contrapposizioni, alla fine degli anni '50 il sindacato si avviava lentamente ad uscire dalle sue contraddizioni; man mano che si faceva strada nelle tre Confederazio-
8
ni — sia pure partendo da diverse premesse — l'esigenza di una contrattualistica diversa, che si articolasse anche a livello aziendale. La Cisl che propose per prima la contrattazione aziendale, vedeva in essa un mezzo per stringere un rapporto più diretto e dipendente fra produttività del lavoro e salario operaio, perseguendo con ciò la linea della "collaborazione aziendale" già posta in atto dai sindacati americani.
La Cgil invece, arrivò alla contrattazione aziendale in ritardo e cominciò a considerarla positivamente dopo l'autocritica di Di Vittorio. La sua politica in quegli anni, era stata volutamente orientata fuori della fabbrica, alla ricerca di obiettivi comuni di lotta in cui la classe operaia potesse riconoscersi; quindi, per un certo periodo, temette che la contrattazione aziendale trasformasse la classe operaia in uno strumento docile, manovrabile, legato ai sistemi di produzione ed al padronato, non più disposta — in definitiva — a lottare sui grandi temi di carattere nazionale.
Ma questa visione fu abbandonata, man mano che le esigenze Poste dal nuovo sviluppo produttivo si facevano più pressanti e le sue conseguenze drammatiche. La Cgil arrivò alla contrattazione articolata partendo dalle condizioni dei lavoratori in fabbrica (leggere le interviste con Boni (Cgil) e Beretta (Cisl) contenute in questo capitolo).
Scrive Agostino Novella, in un articolo pubblicato su "Rinascita" nel giugno 1957:
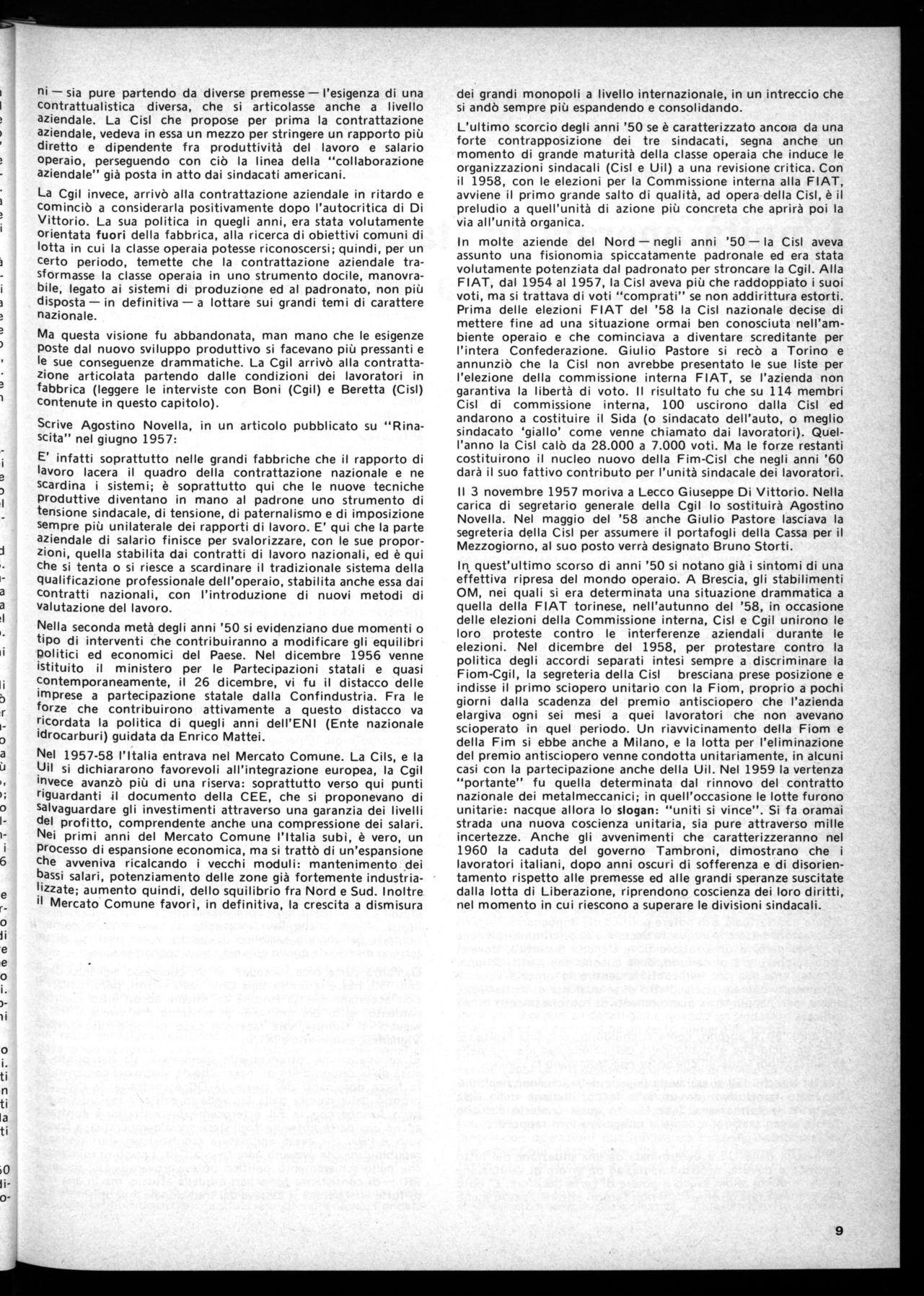
E' infatti soprattutto nelle grandi fabbriche che il rapporto di lavoro lacera il quadro della contrattazione nazionale e ne scardina i sistemi; è soprattutto qui che le nuove tecniche produttive diventano in mano al padrone uno strumento di tensione sindacale, di tensione, di paternalismo e di imposizione sempre più unilaterale dei rapporti di lavoro. E' qui che la parte aziendale di salario finisce per svalorizzare, con le sue proporzioni, quella stabilita dai contratti di lavoro nazionali, ed è qui che si tenta o si riesce a scardinare il tradizionale sistema della qualificazione professionale dell'operaio, stabilita anche essa dai a contratti nazionali, con l'introduzione di nuovi metodi di a valutazione del lavoro.
Nella seconda metà degli anni '50 si evidenziano due momenti o tipo di interventi che contribuiranno a modificare gli equilibri Politici ed economici del Paese. Nel dicembre 1956 venne istituito il ministero per le Partecipazioni statali e quasi contemporaneamente, il 26 dicembre, vi fu il distacco delle imprese a partecipazione statale dalla Confindustria. Fra le forze che contribuirono attivamente a questo distacco va ricordata la politica di quegli anni dell'ENI (Ente nazionale idrocarburi) guidata da Enrico Mattei.
Nel 1957-58 l'Italia entrava nel Mercato Comune. La Cils, e la Uil si dichiararono favorevoli all'integrazione europea, la Cgil invece avanzò più di una riserva: soprattutto verso qui punti riguardanti il documento della CEE, che si proponevano di o salvaguardare gli investimenti attraverso una garanzia dei livelli del profitto, comprendente anche una compressione dei salari.
Nei primi anni del Mercato Comune l'Italia subì, è vero, un processo di espansione economica, ma si trattò di un'espansione 6 che avveniva ricalcando i vecchi moduli: mantenimento dei bassi salari, potenziamento delle zone già fortemente industrializzate; aumento quindi, dello squilibrio fra Nord e Sud. Inoltre Mercato Comune favorì, in definitiva, la crescita a dismisura
dei grandi monopoli a livello internazionale, in un intreccio che si andò sempre più espandendo e consolidando.
L'ultimo scorcio degli anni '50 se è caratterizzato ancora da una forte contrapposizione dei tre sindacati, segna anche un momento di grande maturità della classe operaia che induce le organizzazioni sindacali (Cisl e Uil) a una revisione critica. Con il 1958, con le elezioni per la Commissione interna alla FIAT, avviene il primo grande salto di qualità, ad opera della Cisi, è il preludio a quell'unità di azione più concreta che aprirà poi la via all'unità organica.
In molte aziende del Nord — negli anni '50 — la Cisl aveva assunto una fisionomia spiccatamente padronale ed era stata volutamente potenziata dal padronato per stroncare la Cgil. Alla FIAT, dal 1954 al 1957, la Cisl aveva più che raddoppiato i suoi voti, ma si trattava di voti "comprati" se non addirittura estorti. Prima delle elezioni FIAT del '58 la Cisl nazionale decise di mettere fine ad una situazione ormai ben conosciuta nell'ambiente operaio e che cominciava a diventare screditante per l'intera Confederazione. Giulio Pastore si recò a Torino e annunziò che la Cisl non avrebbe presentato le sue liste per l'elezione della commissione interna FIAT, se l'azienda non garantiva la libertà di voto. Il risultato fu che su 114 membri Cisl di commissione interna, 100 uscirono dalla Cisl ed andarono a costituire il Sida (o sindacato dell'auto, o meglio sindacato 'giallo' come venne chiamato dai lavoratori). Quell'anno la Cisl calò da 28.000 a 7.000 voti. Ma le forze restanti costituirono il nucleo nuovo della Fim-Cisl che negli anni '60 darà il suo fattivo contributo per l'unità sindacale dei lavoratori. Il 3 novembre 1957 moriva a Lecco Giuseppe Di Vittorio. Nella carica di segretario generale della Cgil lo sostituirà Agostino Novella. Nel maggio del '58 anche Giulio Pastore lasciava la segreteria della Cisl per assumere il portafogli della Cassa per il Mezzogiorno, al suo posto verrà designato Bruno Storti. In quest'ultimo scorso di anni '50 si notano già i sintomi di una effettiva ripresa del mondo operaio. A Brescia, gli stabilimenti OM, nei quali si era determinata una situazione drammatica a quella della FIAT torinese, nell'autunno del '58, in occasione delle elezioni della Commissione interna, Cisl e Cgil unirono le loro proteste contro le interferenze aziendali durante le elezioni. Nel dicembre del 1958, per protestare contro la politica degli accordi separati intesi sempre a discriminare la Fiom-Cgil, la segreteria della Cisl bresciana prese posizione e indisse il primo sciopero unitario con la Fiom, proprio a pochi giorni dalla scadenza del premio antisciopero che l'azienda elargiva ogni sei mesi a quei lavoratori che non avevano scioperato in quel periodo. Un riavvicinamento della Fiom e della Fim si ebbe anche a Milano, e la lotta per l'eliminazione del premio antisciopero venne condotta unitariamente, in alcuni casi con la partecipazione anche della Uil. Nel 1959 la vertenza "portante" fu quella determinata dal rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici; in quell'occasione le lotte furono unitarie: nacque allora lo slogan: "uniti si vince". Si fa oramai strada una nuova coscienza unitaria, sia pure attraverso mille incertezze. Anche gli avvenimenti che caratterizzeranno nel 1960 la caduta del governo Tambroni, dimostrano che i lavoratori italiani, dopo anni oscuri di sofferenza e di disorientamento rispetto alle premesse ed alle grandi speranze suscitate dalla lotta di Liberazione, riprendono coscienza dei loro diritti, nel momento in cui riescono a superare le divisioni sindacali.
li r a u
ti n ti la ti 9
Da: "Lezioni di storia del movimento operaio" a cura di Alceo Riosa - Bari 1974
 Gino Giugni
Gino Giugni
L'unità operaia in Italia dagli anni cinquanta agli anni sessanta
Mi sembra opportuno per esaminare l'argomento assumere due punti di riferimento che ci serviranno per mettere ordine nelle vicende, peraltro abbastanza lineari, degli anni '50. I punti di riferimento li potremmo individuare nel tema dell'unità sindacale, che dovrà esser letto per questi anni soprattutto 'in negativo', e nell'argomento degli sviluppi della struttura e dei sistemi di contrattazione che cominceranno, dopo gli eventi bellici ed il quinquennio '45-50, a delinearsi ed a darsi una fisionomia precisa. I due temi si collocano in un rapporto temporale abbastanza preciso; si può dire che l'espressione convenzionale "anni '50" coincida con una reale periodizzazione storica: in effetti quello tra il '50 ed il '60 è un periodo molto ben marcato e delineato e, non tanto all'inizio, quanto nell'ultimo anno, ci troviamo di fronte ad una svolta: il '60 segna veramente la fine di un ciclo e l'inizio di un altro. Possiamo quindi isolare abbastanza bene questo periodo e cercare di vedere come in esso si muovano dei motivi di fondo che saranno poi presenti nelle vicende successive del movimento sindacale in Italia.
In questo decennio assistiamo ad un fenomeno di consolidamento molto importante, di cui viviamo ancora le conseguenze; un consolidamento organizzativo, che è la formazione dei tre grandi sindacati protagonisti del decennio seguente, ed un consolidamento della struttura di contrattazione, che verrà molto cambiata negli anni successivi, ma di cui resteranno intatte alcune linee portanti. Basta guardare alla situazione francese per vedere come lì manchi una struttura contrattuale, mentre nell'Italia degli anni '50, si definisce un aspetto del nostro sistema sindacale: la contrattazione, pur con difetti e limiti che si cercherà successivamente di superare. Ma il dato di fatto importante è che la contrattazione diventa un elemento stabile del sistema sociale del paese.
Questi sono i lati positivi di un decennio che, troppo spesso, viene presentato in chiave assolutamente negativa, commettendo, a mio avviso, un errore storico. E' un decennio molto pesante per il movimento operaio, che tocca il livello minimo di potere contrattuale e di potere politico del dopoguerra; tuttavia è provato il fatto che in questo decennio di discriminazioni, che si svolge però in un contesto dove c'è una dialettica, dove ci sono scioperi, c'è pluralismo, dove ci sono due partiti d'opposizione, che alla fin dei conti fa sentire la propria voce, il movimento operaio lascia dietro di sé qualcosa di sostanzioso, come, per l'appunto, i due momenti di consolidamento prima indicati.
Gli anni '50 si aprono, come si chiudono, con una svolta. Si apre un ciclo che è quello della definizione dell'identità delle organizzazioni sindacali che ancor oggi dominano la scena.
Tra il '48 ed il '50 si era avuta la serie delle scissioni; nel '50 si ha l'atto conclusivo: da un lato la costituzione della Cisl, dall'altro la formazione della Uil. In quale contesto nascono queste organizzazioni e come si pongono i loro rapporti con la sopravvissuta Cgil?
La nascita della Uil è determinata da una situazione del tutto specifica e dovuta, probabilmente, ad un errore di valutazione da parte di chi allora aveva il potere di certe decisioni. E' noto che a questa fase gli americani non furono estranei, per lo meno
i sindacati americani: fu una direttiva presa in altra sede, in altro paese, quella che portò alla fusione tra i raggruppamenti socialdemocratico e repubblicano, che si erano costituiti nella Fil (Federazione italiana del lavoro), e la "Libera Cgil", nata dalla scissione cattolica della Cgil, per creare la Cisl. Questa fusione fu voluta, quasi imposta, perché repubblicani e socialdemocratici non erano affatto unanimi e compatti nell'accettare questa decisione che li poneva, in sostanza, in balia di una maggioranza cattolica nell'ambito della "libera Cgil". La volontà americana era quella di avere, attraverso la presenza socialdemocratica e repubblicana, un tipo di sindacato che non avesse caratteristiche confessionali. Questo tipo di sindacato, infatti, in America, oltre ad essere malvisto, non è capito perché del tutto estraneo alla tradizione di quel paese. Gli americani ritenevano che il nuovo sindacato avrebbe avuto una migliore collocazione nel quadro internazionale, superando i limiti che derivavano alla "Libera Cgil" dalla definizione di organizzazione confessionale e cattolica.
D'altra parte, se è vero che nell'ambiente cattolico vi era una volontà egemonica nei confronti degli altri gruppi (il tentativo cioè di attirarli, in un quadro integralistico, in un unico sindacato e poi, in pratica, sottoporli al controllo DC) e altresì vero che anche nella DC si muovevano forze nuove — che ebbero notevole importanza negli anni successivi — che miravano, con l'unione di forze non cattoliche, ad avere l'avallo al tentativo di sprovincializzare il mondo cattolico. Fu la grande novità della Cisl dopo il '55-60; il tentativo, cioè, di portare i lavoratori cattolici ad essere presenti in una organizzazione capace di fare un discorso che non si forma nella cultura superata delle parrocchie, ma in uno studio critico dei problemi della società industriale.
Questa iniziativa nasce quindi in un contesto di iniziative varie e contraddittorie: volontà integralistiche e volontà di superamento che portano allo stesso risultato, pressioni americane, rifiuto da parte della maggioranza dei repubblicani e dei socialdemocratici di inserirsi in quest'organizzazione a maggioranza cattolica e, forse, anche loro incapacità di comprendere come i rapporti col mondo cattolico dovessero essere posti su di un terreno diverso da quello competitivo e concorrenziale.
Dall'altra parte cosa succede? In un congresso agli inizi degli anni '50, nasce la nuova sigla Cisl. Vasti settori, però, della Fil non accettano questa fusione e, insieme ad un altro raggruppamento, esito dei momenti di scissione che viveva il PSI, i seguaci di Romita, che facevano capo nel sindacato a Italo Viglianesi, danno vita alla Uil.
E' un'operazione estremamente spericolata, sia dal punto di vista della disponibilità di mezzi, che da quello del consenso tra le forze dominanti del paese: la DC è contraria; la Cisl, che proprio dalla nascita della Uil vede smentita la ragion d'essere della fusione con la Fil è ferocemente contraria; è contraria anche una parte notevole degli stessi socialdemocratici; a favore solo il PRI, che aveva addirittura espulso i segretari sindacali repubblicani che avevano aderito alta Cisl. I punti di solidarietà che nello schieramento politico poteva trovare la Uil erano: il PRI — di consistenza forse pari a quella attuale, ma in una fase di forte crisi perché si passava dal tradizionale mazzinismo verso
10
quella nuova formula che sarebbe stata rappresentata da La Malfa — e una parte dei saragattiani.
L'organizzazione nacque quindi con pochi quadri, pochi mezzi, in un'atmosfera avventuristica e si trovò poi ad affrontare l'enorme difficoltà derivante dal mancato riconoscimento internazionale. L'organizzazione internazionale dei sindacati "liberi", costituitasi da una scissione dalla Federazione sindacale mondiale, riconosceva la Cisl, ma non la Uil. E la Uil vivrà di vita grama per un paio d'anni, finché non otterrà il riconoscimento e, attraverso questo, i finanziamenti indispensabili per la vita di un sindacato.
In questo periodo l'organizzazione sindacale in Italia è in gran Parte sovvenzionata dall'estero perché non esiste un sistema di ritenute contributive sul salario; in origine funzionavano i collettori di fabbrica, ma, nell'atmosfera repressiva che si delinea dopo il '50, i collettori scompaiono, i mezzi autonomi di sostentamento vengono meno e le organizzazioni attingono a mezzi che vengono dall'estero. II risanamento del sindacato dal Punto di vista finanziario è un fenomeno che si verificherà dopo il '60.
Nel '50 emerge quindi la triade Cgil-Cisl-Uil, solo che non è una situazione di pacifica alleanza come quella attuale o come quella che, anche prima della federazione unitaria, vedeva il consolidamento dell'unità d'azione. Nel '50 i tre sindacati sono l'un contro l'altro armati. La Cgil contesta la genuinità sindacale della Cisl accusata di essere al servizio dei padroni, clericale, priva delle caratteristiche delle organizzazioni sindacali — e negargli l'identità sindacale è la condanna più grave che si possa fare ad un sindacato — , dall'altra parte la Cisl, afferma che la Cgil è venduta a Mosca e, siccome è al servizio di una potenza straniera che vuol dominare l'Italia, non è un vero sindacato. In mezzo, la fragile struttura della Uil che prende botte dagli uni e dagli altri e reagisce proclamandosi come l'unico vero sindacato Perché non è legato né alla potenza straniera vaticana, né alla Potenza sovietica. Si vanno in realtà accentuando i legami con la Potenza americana e, da una posizione iniziale di equidistanza, la Uil rapidamente approda ad uno schieramento molto ben definito nel quadro della guerra fredda: si arriva ad una sostanziale identificazione della sua linea di politica estera con quella socialdemocratica, cioè con una linea fondamentalmente filoamericana, anche molto più di quella DC.
In questa fase i rapporti interconfederali sono difficili. Si verifica però una costante che poi reggerà abbastanza nel tempo: mentre la lotta è violenta e senza esclusione di colpi a livello di organizzazione capillare e di prese di posizione generali, sul piano della contrattazione i rapporti tendono ad essere, se non unitari, per lo meno ad unificarsi in qualche fase; Probabilmente la funzione catalizzatrice di questa unificazione di comportamenti, per cui molti contratti vengono firmati da tutte e tre le organizzazioni, la esercitano, stranamente, i datori di lavoro che, alla fine dei conti, hanno bisogno di firmare i contratti nazionali con sindacati rappresentativi e quindi desiderano che tutti si siedano al tavolo delle trattative.
Potremmo dire che è la Confindustria che salva quel minimo di unità che vi è nel tessuto dei rapporti contrattuali. Infatti in una situazione di basso potere contrattuale, e di violenta polemica tra i sindacati, la Confindustria avrebbe potuto fare operazioni di divisione o di esclusione, che molto probabilmente sarebbero riuscite; anzi, se la Confindustria, a quell'epoca, avesse voluto far saltare il sistema contrattuale, e rifiutare di fare contratti nazionali, forse in molti settori ci sarebbe anche riuscita. Ma non volle farlo, perché aveva abbracciato una linea che tendeva a utilizzàre la contrattazione nazionale come strumento di alleggerimento delle tensioni, di pace sociale. L'obiettivo non era certo la divisione del potere con i lavoratori perché, ciò che la Confindustria accettava era soltanto quel contratto nazionale, che alla fin dei conti, così come era stipulato, a quell'epoca, era un fatto abbastanza burocratico, e molto poco partecipativo, dava poco potere ai lavoratori e si limitava ad elargire benefici soprattutto economici ad ogni scadenza contrattuale. Comunque, questo contesto si mantiene in piedi nonostante l'ondata avversa che va sempre più investendo il movimento operaio e che viene avvertita fondamentalmente ed essenzialmente a livello di rapporti di fabbrica. E' qui che il peso della scissione veramente incombe, e qui che i comportamenti polemici tra i sindacati si fanno più acuti, ed è qui che il padronato gioca la carta della divisione che invece, sul piano nazionale, gioca soltanto episodicamente.
A livello di fabbrica, vi è una situazione che è abbastanza nota nei suoi termini essenziali: la situazione di repressione, l'ondata
di rappresaglie, di licenziamenti, di discriminazioni, fu un fatto vero degli anni '50, soprattutto in alcune unità produttive, e acquistò caratteri clamorosi alla FIAT, che fu all'avanguardia in questo tipo di politica; ma in maniera più sottile la politica discriminatoria venne giocata un po' dappertutto.

Quindi non vi è nulla di inesatto in certe cronache se non forse il modo di porgere alcuni episodi, gli eventi, e l'interpretazione che ne viene spesso data è troppa semplicistica, troppo romantica. Questo padronato "malvagio" nel 1950 trova una classe lavoratrice debole, perché le elezioni del 18 aprile '48 sono andate male, al potere è andata la DC; ecco allora che questo padronato sfrutta la situazione, e inizia un'ondata di repressioni antisindacali, e in sostanza il sindacato viene posto in ginocchio: un'interpretazione di questo tipo, che pure era abbastanza corrente anche a quell'epoca, ma che ad esempio il sindacato che fu più colpito da questa repressione, la Cgil, non accettò in termini così banali, ci porta poi a costruire la storia in questa chiave di aggrediti e aggressori, vittime e tiranni. Ma non è questo il modo giusto per fare storia.
In verità, se questo si verificò, è perché in Italia, nel piccolo mondo della fabbrica, di tutte le fabbriche, si riprodusse in sostanza la situazione di tensione internazionale che era propria della guerra fredda. Se non ci fosse stata una situazione di questo tipo, anche in una fase politica avversa, cioè seguita dal trionfo dell'altra classe, la classe lavoratrice non sarabbe stata colpita così duramente, soprattutto perché il sindacato e l'attività sindacale in Italia avevano già ottenuto una certa fase di consenso generale (anche la Costituzione riconosceva il sindacato). Non eravamo negli Stati Uniti degli anni '20, quando ci fu proprio un'ondata antisindacale che usò tutti gli strumenti, ed ebbe successo grazie anche al fatto che né la legge né l'opinione pubblica maggioritaria avevano minimamente accettato l'organizzazione sindacale, che, anzi, veniva percepita chiaramente come un fattore di sfida a certi miti essenziali fondamentali della vita americana, come quello della proprietà privata e quello dell'individualismo.
In Italia, dopo il '45, non si poteva pensare che un fenomeno di carattere repressivo come quello che si ebbe negli anni '50 si sarebbe potuto produrre, se, appunto negli anni '50, non si fosse scontata questa tragedia internazionale che è stata la guerra fredda, nella maniera brutale con cui si è ripercossa nei nostri rapporti di fabbrica. E sostanzialmente ciò vuol dire che tutte le operazioni antisindacali di quegli anni erano operazioni che non avevano come obiettivo di fondo e primario il sindacato ma i comunisti e i socialisti allora ancora legati dal patto di 'unità d'azione.
Dall'esterno arrivavano pressioni: "non trattate con i sindacati contaminati dai comunisti" (si pensi all'episodio della produzione di commesse belliche, di cui era stato minacciato il ritiro ove gli operai avessero manifestato a maggioranza un'adesione alla Cgil).
Cosi tutte queste pressioni si dirigevano contro un avversario che non era nemmeno a casa nostra, era fuori, era appunto l'avversario proprio della contesa tra i due blocchi, tra le due potenze dominanti. In questa situazione cosa accadeva? I sindacati non comunisti ottennero una posizione di privilegio: soprattutto nei primi 5 anni, Cisl e Uil emersero come sindacati vezzeggiati e favoriti sia dal governo sia — e questo è l'aspetto più negativo — dal padronato, o meglio da un certo padronato. Il discorso quindi della non genuinità di questi sindacati, della loro tendenziale capacità collusiva, cioè di coincidenza di interessi nei confronti del padrone, non è privo di giustificazioni. Tuttavia, come sempre è accaduto storicamente in tutti i fenomeni in cui si sono avuti momenti di contaminazione tra l'interesse dei padroni e l'interesse dei lavoratori, al limite anche per i veri e propri sindacati gialli, quando un sindacato acquista una certa consistenza ed ha un certo numero di iscritti, anche se qualcuno lo ha voluto o cerca di conservarlo tale non riesce a rimanere perché esiste, perché potenzialmente è un avversario, perché i suoi iscritti desiderano una linea di condotta, un'azione politica che non sia vantaggiosa per i problemi ma per loro, e cioè per i lavoratori. Quindi man mano che questi sindacati acquistano consistenza, sicurezza, si garantiscono i mezzi finanziari per sopravvivere e allargano la sfera degli iscritti (anche con operazioni discutibilissime come la collaborazione alle assunzioni discriminate che Cisl e Uil hanno fatto ripetutamente), si trovano a gestire il malcontento di questi, e diventano sindacati veri. Così, soprattutto dopo il 1955 vediamo che la linea di comportamento di questi due sindacati si va facendo sempre più polemica, contestatrice. Ho assistito
11
personalmente a momenti di delusione da parte di rappresentanti del padronato: come mai questi discorsi duri li fa la Cisl? proprio la Cisl che dovrebbe andare d'accordo con noi? quei tali rivelavano dunque l'incapacità di capire questa nuova realtà che andava emergendo proprio nella misura in cui Cisl e Uil erano divenuti sindacati dotati di una cerfa forza, e quindi capaci di esprimere e gestire un certo tipo di forza contestatrice e di malcontento che si sprigionava dalla classe lavoratrice. D'altra parte che questo avvenisse è anche dovuto a un altro fattore: l'azione repressiva, una volta che si scatena, non va per il sottile, comincia a colpire i comunisti della Cgil, per dirigersi poi contro i socialisti (anzi non si fa distinzione tra i primi e i secondi data l'esistenza durante gli anni in esame dell'unità d'azione tra socialisti e comunisti) e infine per colpire anche gli altri settori. Se qualche sindacalista, qualche organizzatore operaio Cisl o Uil fa la voce grossa, si fa realmente sentire dentro la commissione interna, viene immediatamente individuato come elemento pericoloso e, in un quadro di politica che è fondamentalmente discriminatoria, prima o poi ne paga le conseguenze.
Ecco che allora si prende coscienza, da parte di questi sindacati, che una politica di discriminazione, a lungo termine, è una politica di cui pagano le spese tutti i sindacati, anche quelli che in apparenza, possono essere favoriti dalla discriminazione.
Tuttavia la discriminazione c'è stata, in un momento in cui ha trovato una larga giustificazione politica e ideologica anche abbastanza esplicita da parte di questi due sindacati; perché il discorso sull'isolamento della Cgil è stato fatto senza peli sulla lingua, proprio in maniera aperta, e molte volte, da parte della Cisl e della Uil si pretendeva che il padronato trattasse solo con loro e non con la Cgil. Pretesa non sempre soddisfatta dal padronato perché, essendo la Cgil l'organizzazione più forte, era l'unica che poteva poi realmente dare l'ordine di cessare uno sciopero. Quindi, a un certo punto, al padronato interessava che alla trattativa non fosse estraneo questo elemento di forza che era la Cgil. Nel periodo del governo Scelba, nel 1954, il periodo più nero da questo punto di vista, in sostanza questa politica di completo isolamento della Cgil acquistò una discreta consistenza, tanto è vero che si manifestarono allora i due avvenimenti più clamorosi: il primo fu l'andamento delle elezioni alla commissione interna della FIAT, che diedero il segno della svolta in corso, della crisi della Cgil. Ma proprio questa crisi determinò però immediatamente, all'interno della Confederazione, l'avvio di un discorso critico molto rapido, nutrito di elementi e idee nuove, destinato a portare celermente l'organizzazione a riassumere l'iniziativa negli anni successivi. Per il momento però il colpo fu durissimo: alle elezioni del 1954 la Fiom, che aveva sempre avuto la maggioranza nella commissione interna della FIAT, si trovò ridotta di circa un terzo, e questa situazione si consolidò negli anni successivi.
In realtà fra le ragioni della stanchezza della classe operaia, c'era il rifiuto di un certo tipo di contaminazione tra azione sindacale e azione politica, in cui si vedeva l'azione politica ma non si vedeva l'azione sindacale.
Agli scioperi contro la Nato, contro l'arrivo del generale Ridgway, a quello della guerra di Corea, gli operai non avevano aderito, perché non capivano più questo tipo di azione, che non andava neanche in parallelo con una lotta sindacale su temi veramente importanti per la classe operaia, e inoltre la Cgil, prendendo un atteggiamento che emerse con chiarezza e diede l'avvio ad un ripensamento critico, era ferma su certe posizioni di strategia globale: lotta per gli aumenti generalizzati, per esempio, lotta per l'occupazione, piano del lavoro. Tutte queste lotte però non parlavano agli operai il linguaggio dei problemi di ogni giorno, anzi tendevano a parlare un linguaggio troppo diverso, a volte falsato rispetto alle questioni che i lavoratori erano costretti ad affrontare.
Gli operai ormai avevano sempre più chiari davanti i problemi del cottimo, i problemi della razionalizzazione, i problemi dei ritmi di lavoro, la riorganizzazione produttiva, e ancora si parlava soprattutto di licenziamenti, di ristrutturazione. Accadevano anche queste cose, accadevano a Genova con le continue ristrutturazioni nelle aziende a partecipazione statale. Ma anche a Torino gli operai della FIAT avevano di fronte problemi completamente diversi: cominciavano le prime avvisaglie dell'immigrazione, non c'era una vera e propria minaccia di disoccupazione, ché anzi la FIAT si espandeva, e si espandeva con moduli tecnico-organizzativi completamente nuovi, che ponevano problemi di fronte a cui il sindacato era rimasto muto. Le forme rappresentative erano quelle della commissione
interna, con tutte le sue tare e l'incapacità di esprimere realmente l'interesse dei lavoratori, anche perché, a quell'epoca, la commissione interna risultava formata in maniera lottizzata, cioè una fetta della commissione interna andava alla Cgil, con ripartizione tra comunisti e socialisti, un'altra alla Cisl e un'altra alla Uil, e i momenti di scelta fondamentali erano estranei alla vita di fabbrica.
Proprio questo fu il tema fondamentale, che dominò il dibattito sindacale negli anni successivi, cioè l'estraneizzazione del sindacato dalla fabbrica, non soltanto perché ne era stato cacciato fuori, ma perché aveva scelto una linea politica che non era quella giusta, che non rispecchiava i problemi nuovi di un paese in cui si intravedeva ancora la minaccia della disoccupazione, del pauperismo, e che invece si avviava verso il boom. Erano gli anni in cui, anche a spese dei lavoratori, si sarebbe verificato a breve distanza il miracolo italiano, l'industrializzazione: si pensi al passaggio del 1957, con la sua svolta storica, quando il numero degli addetti all'agricoltura per la prima volta passa in secondo piano rispetto al numero degli addetti all'industria. L'Italia che era un paese prevalentemente agricolo prima del 1957, diventa, in termini statistici, un paese industriale dopo quell'anno.
Ora tutto questo, nei discorsi dei sindacati, non c'era, c'era solo un padronato perverso che addirittura, si diceva, era malthusiano, perché non voleva aumentare la produzione. In realtà, quel padronato incrementava notevolmente la produzione provocando quel salto qualitativo degli anni '50 che ha portato l'Italia ad essere un paese col modello di sviluppo sbagliato, ma comunque a un livello di sviluppo incomparabilmente diverso da quello di prima degli anni '50. Ora ci fu un insieme di errori e di azioni, che vennero poi scontati in modo clamoroso nell'episodio FIAT, ma con questo ce ne furono molti altri, perché il crollo delle commissioni interne, il crollo della Cgi si ripetè in molte fabbriche, anche se non in moltissime. Molti pensavano che si stesse ridimensionando il panorama sindacale: non è vero, in realtà questi furono degli episodi abbastanza limitati, il ridimensionamento ci fu, ma restò sempre in posizione maggioritaria la Cgil. Dal 70% passò al 55-58% nelle commissioni interne, ma restò sempre il primo sindacato, e ad un certo punto, dopo il '56-57 i rapporti di forza si stabilizzarono. In realtà le tre confederazioni sono quelle che sono, non si rubano più gli iscritti, attingono in modo diseguale alla riserva dei nuovi iscritti, dei nuovi lavoratori, ma in complesso i rapporti di forza si mantengono tra di loro abbastanza equilibrati, mentre fino alla seconda metà degli anni '50, tra i fenomeni tipici è anche questa corsa a portarsi via gli iscritti, che è l'espressione di una situazione caratterizzata da rivalità e da accesa competitività.
L'altro fatto importante del 1954 fu probabilmente (anche se qui il discorso non è stato mai fatto a fondo, né è stato fatto quello che occorreva: un esame accurato dei documenti e delle testimonianze) il controllo collettivo sul conglobamento con l'isolamento della Cgil; in questo caso l'isolamento riesce, qui Cgil e Uil realizzano quell'obiettivo di fondo che si erano proposte, cioè di essere le sole interlocutrici contrattuali della Confindustria; però quello che non si capisce è perché, poco dopo l'inizio della trattativa per il conglobamento, la Cgil se ne va; probabilmente se ne va per un calcolo tattico sbagliato, e cioè nella convinzione che le trattative non sarebbero continuate, assente la Cgil, e assente per ragioni di dissenso sulla linea contrattuale.
Una cosa del genere riuscirà qualche anno dopo, ma nel 1954, la tattica seguita dalla Cgil fallisce miseramente, perché Cisl e Uil accelerano i tempi, giungono ad un accordo, che nel complesso non è del tutto negativo, anche se non fornisce sostanziosi elementi di conquista ai lavoratori, contiene un nucleo di innovazioni di notevole importanza da cui la Cgil, per sua volontà in sostanza si trova tagliata fuori. L'accordo inizialmente doveva essere solo tecnico, in primo luogo di conglobamento nella paga base, della quantità innumerevole di punti di contingenza che erano scattati dopo il 1947 (con l'inflazione che c'era stata, la paga dell'operaio era per meno della metà paga base e per il resto contingenze e ammennicoli vari) in secondo luogo razionalizzazione del sistema retributivo che fino al '54 era estremamente complicato, e diseguale da zona a zona (se non si fosse fatto l'accordo del conglobamento nel '54, l'accordo sulle gabbie salariali del '69 non ci sarebbe potuto essere, perché questa è la prima e lontana premessa dell'avvento di un salario unico nazionale realizzato nel 1969). Ora questo accordo doveva essere un accordo tecnico; in

12
sostanza però, quando si fanno queste operazioni di conglobamento, ci sono sempre costi aggiuntivi, e vantaggi aggiuntivi qualche volta, quindi la trattativa fu difficilissima proprio per questa ragione. Il livello di accordo che venne raggiunto fu un livello basso, quello in cui prevaleva l'aspetto tecnico dell'operazione. Però l'accordo, nella misura in cui rinviava in sede applicativa di categoria, rappresentò il momento in cui la contrattazione di categoria, che era stata tenuta in frigorifero fino allora, comincia a funzionare. Fino allora, in pratica, era Prevalso il metodo dell'accordo interconfederale, i contratti di categoria rinnovati riguardavano soprattutto la parte normativa, non salariale, e se non si tocca la parte salariale i contratti non possono essere vitali. Del resto anche nella parte normativa c'erano poche innovazioni.
Nel 1954 dunque avviene il passaggio di consegne alla competenza delle categorie, perché è l'accordo che restituisce alle categorie il compito di negoziare i salari, che è fondamentale se si vuol dare alle categorie una ragion d'essere, una possibilità di esistere e di crescere come organizzazioni di categoria.
In questa fase fondamentale quindi la Cgil è tagliata fuori Perché, l'accordo interconfederale è firmato dalle sole Cisl e Uil. Ora, il fatto che la Cgil ne fosse fuori, significò agli occhi dei lavoratori che essa era realmente isolata.
Nel 1954 si tocca cosi il punto più basso, e diciamo pure che il punto è basso per tutti. Questa forza della Cisl e della Uil, sulla linea della politica dell'isolamento dell'avversario, è una forza apparente perché in realtà non viene mutuata dai lavoratori, ma viene da un'investitura della controparte e dietro questa del governo che chiaramente crea le premesse per un sindacalismo protetto da parte della struttura pubblica, procedendo ad escludere la Cgil da istituzioni di carattere rappresentativo. E' significativa, ad esempio, la presenza delle sole Cisl e Uil nell'Organizzazione internazionale del lavoro, che si è protratta fino a poco tempo fa. L'interesse del padronato è per cosi dire interpretato dal governo, ma non sono alcuni padroni che decidono questa linea, è in realtà la situazione politica che domina e che fa sì che ogni organizzazione dove vi siano maggioranze comuniste venga attaccata duramente a tutti i livelli, in qualche caso, probabilmente, senza che questo corrisponda a un vero e reale interesse del padronato.

Il padronato quell'interesse lo realizza estendendo l'area della Politica discriminatoria, facendo in modo che Cisl e Uil non riescano neanch'esse a funzionare come strumenti di tutela dei lavoratori, cioè in pratica, tendendo ad acquistare sempre maggiore libertà, con una situazione di graduale esclusione di tutti i sindacati. Quindi la situazione è questa: nelle grandi aziende, dove i sindacati sono presenti, si favoriscono i due cosiddetti democratici a danno del terzo; in quelle dove i sindacati non ci sono, nelle aziende nuove e così via, si cerca di non averne, al massimo si concede la commissione interna, dissociata dai sindacati, senza rapporti con quest'ultim i, fatta di operai dirigenti improvvisati, senza un'esperienza, facili vittime di trappole predisposte dalla direzione del personale, dal Padrone, quindi una situazione in cui viene sempre più a emergere una prevalenza della forza padronale su quella dei lavoratori; avendo ottenuto l'avallo del grande accordo del conglobamento retributivo del '54, fatto con l'esclusione della Cgil, questo modello tende allora a riprodursi nelle aziende, ed ecco spiegata la frequenza con cui vengono fatti accordi con Cisl e Uil senza che intervenga la Cgil, la frequenza con cui addirittura si arriva al punto di negoziare con spicchi della Commissione interna, la "negoziazione a spicchio" come si diceva allora, si prendono cioè solo i rappresentanti della Cisl e della Uil e si tratta solo con quelli, lasciando fuori la Cgil. Accade poi, che si consolidi la formula che ha funzionato fino al '66-67, che è quella di fare trattative formali con tutti, e poi negoziare sottobanco con qualcuno, per porre qualcun altro di fronte a un accordo in pratica già fatto. Allora cosa accade? Che dopo la lezione del 1954 e del conglobamento, la Cgil firma, per paura di farsi tagliare fuori, qualsiasi accordo, purché contenga miglioramenti, e ormai dopo il '55 la situazione comincia a cambiare, gli accordi devono contenere qualche miglioramento effettivo, anche perché la situazione economica del paese è veramente migliorata; allora, purché ci siano queste basi minime, la Cgil firma, perché in questo modo non si esclude, resta inserita nel contesto contrattuale, ed è questa una valutazione politica intelligente. Anche se porta ogni tanto a qualche amarezza, a contestazioni serpeggianti, però è quella che permette alla Cgil di mantenersi a galla, e il difficile era appunto questo.
Con il '54 si intravedono alcune novità, nel senso che incominciano a intravedersi rapporti di miglior vicinato. Per esempio, la contestazione della natura sindacale degli altri sindacati comincia a venir meno; ci si è accorti che la Cisl è un sindacato autentico, anche se non nella sua totalità, e gradatamente si prende coscienza che in Italia si è verificato un fatto nuovo di proporzioni storiche, vistose, cioè che il mondo cattolico ha espresso nel proprio ambito un'organizzazione di lavoratori che nel suo comportamento sindacale, non si ispira ai principi cattolici, alla dottrina sociale cristiana. Questa svolta viene preparata all'interno della Cisl da alcune leve nuove, che per l'appunto avevano visto dall'inizio l'incontro con i partiti laici come una garanzia per avviare un discorso che superasse le frontiere del provincialismo culturale cattolico.
Questo centro di formazione di idee nuove è fondamentalmente la Scuola della Cisl di Firenze, dove vengono soprattutto nella prima fase raccolti vari elementi, almeno prima che si innestasse un fattore burocratico nella direzione della scuola: si tratta di elementi di varia provenienza, alcuni dall'Università, elementi anche socialisti, c'è tutta una leva nuova di economisti che vengono a parlare un linguaggio nuovo, quello dell'economia moderna, che in Italia non era affatto conosciuto.
Si formano quindi quadri nuovi, si crea in questo ambiente una volontà di carattere nuovo, che io ritengo di fondamentale importanza per la storia della nostra classe operaia, e cioè che i lavoratori cattolici non sono più vittime di una ideologia interclassista di collaborazione di classe che nel corpo di Cristo vuole ricomporre i dissensi di fondo tra padroni e operai, ma, a un certo momento, acquisiscono coscienza della loro identità operaia, e la volontà di battersi per un destino di classe, come si chiarisce poi ulteriormente negli ultimi anni.
Dopo il '55 cominciano a delinearsi questi aspetti, la polemica con la Cgil si mantiene molto dura, si continua a qualificarla come il sindacato che non può essere sindacato perché asservito a Mosca; nel 1956, avvengono però fatti abbastanza importanti: rapporto Kruscev, destalinizzazione, rivolta in Ungheria. In Italia ci sono ripercussioni molto profonde e, nell'ambito della Cgil acquisisce una consistenza molto netta e marcata la corrente socialista che comincia a condizionare alcune scelte: per esempio la Cgil non si può più permettere, in politica estera, delle scelte in assoluta coincidenza con quelle sovietiche, perché la corrente socialista non lo vuole. Non lo vuole probabilmente neanche l'altra, alla quale fa comodo che la corrente socialista non lo voglia, e quindi la Cgil acquista una maggiore autonomia nel campo della politica estera, e, dall'altra parte, non la si può più accusare di identificarsi con uno dei blocchi; infine, anche questo tipo di polemica si attenua e si marcia verso una ricomposizione tendenziale di un orientamento di carattere unitario. Un orientamento c'era sempre stato, per certi aspetti, e si riassumeva in una formula che aveva abbastanza funzionato, anche nella prima metà degli anni '50, che era "marciare separati ma colpire uniti". C'era già qualcosa di unitario in quest'idea: gli scioperi venivano magari indetti separatamente, magari organizzati con modalità diverse, ma l'obiettivo era lo stesso, e occorreva colpire l'avversario unitariamente; questa era la formula di Pastore, che gli permetteva di compiere certe azioni sindacali che da solo non avrebbe potuto fare, poiché occorreva la solidarietà degli altri sindacati. Era in sostanza, la formula dell'unità d'azione nella sua espressione più scarnificata, ridotta all'essenziale, al minimo. Passata questa fase l'unità d'azione diviene sempre più una costante di comportamento, e tra l'altro, gli stessi rinnovi contrattuali nazionali rimettono in gioco la Cgil; il contratto dei metalmeccanici del '56 ha come firmataria la Cgil, e così tutti i contratti successivi.
Certo sono trattative inficiate dal sistema del doppio tavolo, si tratta da un lato con alcuni e dall'altro lato non si tratta con la Cgil e la si mette spesso davanti al fatto compiuto, però l'apparato formale della contrattazione unitaria è salvo e, ripeto, uno dei punti fondamentali in questa fase è il consolidamento di una struttura contrattuale nazionale di cui tutti i sindacati siano partecipi, si crea cioè e si consolida il modello di trattative per contratti nazionali, esclusivamente nazionali, che si fanno ogni due-tre anni, da parte di tre organizzazioni che sono Cgil, Cisl, Uil.
C'è da aggiungere e da porre in evidenza come in questi anni nasce, proprio sul terreno della critica al sistema di contrattazione, l'argomento della contrattazione aziendale, e questo argomento prima divide ancora di più i sindacati, poi li unisce verso un obiettivo che non viene raggiunto negli anni '50. L'azione per la contrattazione a livello aziendale è inconclu-
13
dente nei risultati, raggiunti poi nel decennio successivo, ma è tuttavia importante perché è motivo di un ampio dibattito politico-sindacale.
E' noto che il discorso sulla contrattazione aziendale partì dalla Cisl nel 1952, e la Cgil lo accolse molto male, definendolo un tipo di contrattazione a beneficio del padrone perché avrebbe spezzato i legami di solidarietà di classe. Però nel 1955 è lo stesso Di Vittorio a riconoscere la necessità che alla contrattazione nazionale venga affiancato un tipo di contrattazione aziendale a livello di fabbrica e che si costituiscano organizzazioni a livello di fabbrica.

Direi che in questa discussione sulla contrattazione aziendale si prepara il terreno per la convergenza di Cgil, Cisl e Uil sul piano della politica contrattuale, cosa che non si era verificata nel '50.
Vorrei concludere ricordando un episodio, che tutto sommato potremmo assumere proprio come l'indice della nuova svolta: nel dicembre 1959 si fondono I'llva e la Cornigliano per creare l'Italsider; in questa occasione vi era necessità di estendere, a tutti gli operai del gruppo, il sistema retributivo, la Job Evaluation, che era applicato alla Cornigliano. Non era stato negoziato dai sindacati, c'era una tacita intesa con la Cisl, che era molto forte perché alla Cornigliano avevano disinvoltamente assunto gli operai infilandogli in tasca la tessera della Cisl.
Questo fu nel dicembre: ora, quale linea di condotta adotta la direzione, che era ancora la vecchia direzione dell'Ilva, società estremamente arretrata in materia di politica del personale?
Quella della trattativa con la Cisl e con la Uil, e fa una intesa comunicata alla stampa, in base alla quale le due parti concordano per estendere a tutti i lavoratori il piano di Job Evaluation con certi benefici. Immediatamente, negli stabili-
menti interessati, che non sono evidentemente Cornigliano, ma soprattutto Bagnoli e Piombino, si scatena uno sciopero indetto dalla Cgil. Questa volta lo sciopero riesce, cioè questa volta il tentativo di isolare la Cgil su una costante di comportamento che era tipica della siderurgia a partecipazione statale, non riesce più, perché la Cgil riesce a mantenere uno sciopero abbastanza lungo contro l'accordo separato concluso con le altre due organizzazioni. Questa volta la Cgil non cerca un mezzo qualunque per affiancarsi alle altre, ma si rivolge ai lavoratori, per acquisire il riconoscimento di trattare, a livello d'azienda, a pieno titolo di parità con le altre organizzazioni. A seguito di questo sciopero il potere decisionale sulle linee della politica sindacale della direzione aziendale passa nelle mani del gruppo genovese, più moderno, e si apre una trattativa con Fiom, Fim e Uilm. E' in fondo la prima trattativa a livello di azienda e non a caso viene aperta con tutte e tre le organizzazioni, e non è una trattativa su due tavoli, ma in cui la Fiom agisce in condizioni di piena uguaglianza con le altre organizzazioni (1). Questo è l'inizio di una svolta in cui la Cgil e la Fiom pagavano in fondo anch'esse un costo, nel senso che, pur non gradendo la Job Evaluation, l'accettano in una forma negoziata, a patto di rientrare nel vivo del controllo dei rapporti contrattuali che in quelle aziende fino allora erano rimaste monopolio delle altre organizzazioni. Questo avviene proprio agli inizi degli anni '60.
(1) Allora il segretario della FIOM era Luciano Lama, mentre FIM e UILM appartenevano ancora alla vecchia gestione; infatti questa operazione non fu per nulla gradita alla FIM e alla UILM che protestarono e affermarono che l'Italsider (perche ormai era già l'Italsider) aveva compiuto questa operazione non discriminatoria perché aveva contatti commerciali con l'Unione Sovietica, la quale aveva imposto il riconoscimento della FIOM, accusa realmente incredibile data la non accentuata sensibilità che l'Unione Sovietica ha per questo genere di cose.
14
Da:
Marisa Malfatti, Riccardo Tortora "Il cammino dell'unità" - Bari 1976
La ripresa (1960 -1969)
A Milano, dal 2 al 7 aprile del 1960 si tenne il V congresso nazionale della Cgil.
I temi e i problemi venuti a maturazione alla fine del decennio Precedente furono ampiamente dibattuti dal Congresso. L'unità d'azione fra le tre confederazioni sindacali fu sottolineata dalla relazione di Agostino Novella come una pregiudiziale per poter risolvere i nuovi problemi che si ponevano al sindacato, sia sul terreno delle lotte salariali e su quello per l'occupazione, sia per la difesa dei diritti sindacali e per un corretto sviluppo economico. Il V congresso della Cgil si inaugura in un clima nuovo, crisi dei governi di centro, voluti dalla DC, e una certa congiuntura favorevole che sarà denominata "miracolo economico".
In materia di strategia sindacale il V Congresso compie la scelta della lotta articolata aziendale, necessaria per contrapporsi a una politica padronale sempre più complessa orientandosi verso nuove forme di organizzazione produttive.
Qualche mese dopo il Congresso il paese è nuovamente turbato dalla costituzione di un nuovo governo DC formato da Tambroni con l'appoggio determinante dei fascisti.
11 fatto è molto grave. Gli onorevoli Novella e Santi, a nome della Cgil dichiarano:
La soluzione che è stata data al problema del governo, in evidente contraddizione con la volontà popolare, significa via libera all'azione dei gruppi di pressione del grande capitale e di tutta la destra economica. L'accettazione dei voti fascisti come base di maggioranza è una offesa allo spirito della Resistenza e sottolinea la sempre maggiore subordinazione della politica del governo ai gruppi più retrivi del padronato italiano, i quali sono obiettivamente incoraggiati a portare l'attacco alle conquiste sociali e democratiche dei lavoratori italiani, ai loro diritti e alle loro libertà sindacali.
Il governo "demo-fascista" di Tambroni durerà quattro mesi. Quattro mesi di lotte, di dimostrazioni, di manifestazioni di Piazza: il governo Tambroni urta con la realtà del paese che va rapidamente mutando; urta anche con gli indirizzi della Cisl che Pure moderatamente sta uscendo dalla concezione di "sindacato di comodo" e sta rivendicando la sua autonomia.
Nel luglio del 1960 cade definitivamente il governo Tambroni. La scintilla che fa scoppiare la "grande rivolta", dalla Sicilia all'Emilia, contro l'autoritarismo di Tambroni, è data dal Congresso che il MSI, provocatoriamente, vuole organizzare a Genova e del quale Tambroni si rende garante coi fucili dei suoi poliziotti. La rivolta è immediata: a Reggio Emilia cinque lavoratori vengono uccisi nella piazza; 1'8 luglio la Cgil proclama uno sciopero generale senza l'adezione della Cisl e della Uil. Lo sciopero è unanime. A Palermo, a Catania a Licata, cadono altri lavoratori, ma la polizia non può reprimere il moto che divampa in tutto il paese, appoggiato anche dagli studenti che scendono nelle piazze portandosi dietro la rabbia repressa per problemi irrisolti. Il 19 luglio Tambroni si dimette. La DC dopo un lungo travaglio interno è costretta a costituire un primo governo Fanfani con l'appoggio esterno dei socialisti.

Si apre una nuova fase nella vita politica del paese che porterà ai
governi di centro-sinistra, il primo dei quali inaugurato da Moro nel 1962. Gli anni successivi, però, dimostreranno tutti i limiti e le contraddizioni di questa nuova formula di governo, nella misura in cui le riforme non saranno attuate e i piani di programmazione economica salteranno.
Tuttavia l'esperienza di centro-sinistra, che ha abbandonato il centrismo, contribuisce ad aprire per i lavoratori una 'nuova fase' dello sviluppo del movimento sindacale, un nuovo livello di scontro politico. La Cisl dibatte al suo interno sempre più il tema dell'autonomia del sindacato dai partiti, e le modalità per l'attuazione di tale richiesta. Un grande ruolo avrà in questo dibattito la Fim, uscita rinnovata certamente dalle lotte del '58 alla FIAT.
Nel primo periodo (gli anni '50) la Fim coincide praticamente con la Cisl e ne segue l'impostazione di fondo. Il secondo ('60-'61 fino al 1966-67) è un periodo di crisi o di passaggio, di crisi del modello originario della Cisl soprattutto nella sua attuazione confederale, di passaggio verso un nuovo modello di azione e di organizzazione sindacali. Questo periodo intermedio, forse il più importante per comprendere la natura e l'evoluzione della Fim, si traduce spesso nell'attuazione pratica di principi di fondo rimasti lettera morta all'interno della confederazione o nel tentativo di affrancamento delle ipotesi più qualificanti dell'esperienza della Cisl dal disegno di integrazione della classe operaia in cui erano inserite. Il terzo periodo, quello che stiamo vivendo tuttora, è quello della realizzazione, in chiave sempre più unitaria, di un nuovo sindacato radicalmente distante dal modello originario della Cisl, (G. Cella, B. Manghi, P. Piva, Un sindacato italiano degli anni sessanta, De Donato, Bari 1972).
Il primo successo unitario del sindacato si registrò nel settore elettromeccanico nel dicembre del 1960. La categoria era scesa in lotta per correggere con un accordo integrativo il contratto firmato l'anno prima. Il 1° dicembre vi fu una prima grandiosa manifestazione unitaria in piazza Duomo a Milano; centomila lavoratori del settore scesero in piazza.
Il 10 dicembre i sindacati firmarono il primo accordo con l'Intersind il cui contenuto fu fortemente innovativo: si affermava il diritto del sindacato di effettuare accordi integrativi; di fatto per la prima volta veniva accettata la contrattazione articolata. Inoltre — fatto molto importante — si determinò la rottura fra fronte privato e fronte pubblico (l'Assolombarda, che raggruppa le aziende private del settore, era ancora su posizioni di rifiuto).
Successivamente, per diminuire le resistenze dell'Assolombarda, i tre sindacati provinciali indissero una manifestazione particolarmente significativa: il giorno di Natale gli operai si riunirono di nuovo in piazza del Duomo; la manifestazione riuscì pienamente, nonostante la mancata adesione della Fim-Cisl nazionale. Un altro sciopero segui il 27 dicembre, ma tutto questo non bastava a piegare l'Assalombarda; tuttavia le aziende del settore privato nei mesi successivi capitolarono ad una ad una e accordarono i miglioramenti richiesti.
Fu nel 1961 che si cominciarono però a valutare i primi positivi risultati delle lotte effettuate per ottenere la contrattazione
15
aziendale. In questo anno si rinnovarono 34 contratti; si ottennero notevoli miglioramenti in riferimento ai vari aspetti del rapporto di lavoro e ai diritti sindacali. Gli aumenti salariali variarono dal 7% al 12% e venne esteso il riconoscimento degli scatti di anzianità, nella misura dell'1,50% ogni biennio, per gli operai in numerosi contratti.
Le lotte per ottenere il riconoscimento della contrattazione integrativa furono condotte nelle aziende metalmeccaniche, in quelle del settore chimico, tessile e petroiiero. Il sindacato cominciò ad essere più presente in azienda ed a collegarsi meglio alle nuove realtà produttive.
Il ministro del Lavoro onorevole Sullo, di fronte alle proteste degli industriali che si opponevano alla contrattazione articolata affermò che non esisteva incompatibilità fra il Contratto Nazionale di categoria e gli accordi aziendali, sottolineando l'esigenza di riformare l'assetto contrattuale. La lotta continuò in tutta Italia dando vita a forti manifestazioni: a Milano, a Napoli, a Trieste, a Palermo, ci furono una serie di arresti.
Nel 1962 le lotte continuarono con più forza. Scesero in agitazione quasi tutte le categorie, a cominciare da quella dei braccianti. Scioperarono per il rinnovo dei contratti i chimici del settore gomma, i conservieri, i poligrafici, i cartai. Scioperarono per integrare gli accordi i tessili, gli edili, i calzaturieri. E, intanto, era ancora aperta la vertenza dei metalmeccanici, il cui contratto scadeva in ottobre. I metalmeccanici cominciarono le loro agitazioni fin dall'inizio dell'anno: a Torino e a Milano. Alla terza dichiarazione di sciopero, dopo anni di silenzio e di repressioni risponderà anche la FIAT di Torino: un successo sindacale importante. Il 5 luglio i sindacati firmarono un accordo preliminare con l'Intersind e l'Asap. L'accordo riconosceva la legittimità, accanto alla contrattazione nazionale di categoria, di quella articolata, azienda per azienda.
Ma la vertenza rimase aperta nel settore privato, con uno sciopero di 72 ore proclamato per il 7, il 9 e il 10 luglio. Fu in questa occasione che la Uil firmò con la FIAT un accordo separato assieme al SIDA (il sindacato padronale dell'auto), ma l'accordo sarà violentemente respinto dagli stessi lavoratori il giorno successivo. Si arriverà ai drammatici scontri di Piazza Statuto a Milano che, tuttavia, segneranno una data importante per il rinnovamento della Uil. Le testimonianze di quei giorni che abbiamo raccolto in questo capitolo ci danno l'esatta "portata" del significato che assunsero i fatti di piazza Statuto all'interno della Uil.
Il 2 ottobre i sindacati firmarono con l'Intersind un altro importante accordo: si riconosceva la legittimità della contrattazione aziendale in merito ai cottimi, alle lavorazioni a catena, ai premi di produzione.
II 3 ottobre FIAT e Olivetti firmarono con i sindacati un 'protocollo' di accordo separato sul futuro rinnovo. Questo documento servirà come base per avviare le trattative nelle singole aziende. Il 5 ottobre, a Milano, i metalmeccanici organizzarono la "marcia silenziosa" di protesta contro il padronato che si rifiutava di chiudere definitivamente le vertenze. Ma si dovrà arrivare al febbraio 1963 ed a uno sciopero generale compatto di tutti i lavoratori dell'Industria, per chiudere la vertenza. Dopo 9 anni, per la prima volta, le tre Confederazioni proclamavano uno sciopero generale unitario. L'accordo che i metalmeccanici firmarono riconosceva la legittimità della contrattazione articolata.
Nel luglio del '63 cominciò la lotta contrattuale degli edili, il cui risultato fu: aumenti del 23% e il principio del salario annuo garantito. A Roma, per cercare in ogni modo di evitare questo contratto, gli impresari avevano effettuato numerose serrate e si dovrà arrivare agli scontri di Piazza Venezia perché i costruttori siano costretti a cedere.
Il "miracolo economico", non sorretto da un organico sviluppo economico che coinvolgesse le contraddizioni storiche del Paese, fu seguito da una fase congiunturale sfavorevole. I prezzi cominciarono a salire nel corso del 1963 e gli industriali denunciarono gli aumenti salariali ottenuti dai lavoratori come la causa prima del ristagno della produzione industriale: infatti con il '64 si registrò un calo della produzione e degli investimenti. Le autorità monetarie effettuarono una stretta creditizia che si ripercosse sui livelli dell'occupazione.
Il contratto dei chimici si chiuderà con un accordo separato sottoscritto da Cisl e Uil: la congiuntura economica negativa influisce sull'unità d'azione delle tre confederazioni. Agnelli in questo periodo effettuò la "serrata tecnologica" che bloccò per
quasi un mese tutta l'industria dell'auto e in agosto minacciò 10.000 licenziamenti. Il governo Moro era in crisi: fu l'estate dei complotti eversivi della destra neo-fascista.
Nel 1964 e 1965 si registrò un calo pauroso nell'occupazione. Furono perduti 100.000 posti nel settore metalmeccanico, 150.000 in quello edile e 60.000 nel settore tessile. Le agitazioni di quegli anni hanno come obiettivo la difesa del posto di lavoro. In questo clima nel marzo '65, la Cgil tenne a Bologna il suo VI congresso nazionale.
Il riflusso economico lasciava aperti nel Paese numerosi problemi ed accentuava gli squilibri: si evidenziava più che mai la necessità di un'azione programmatica che definisse le linee di sviluppo economico. Il Piano quinquennale di sviluppo proposto dal Governo, era in quei mesi al centro delle discussioni e sarà anche il tema fondamentale del Congresso della Cgil.
La relazione di Novella mise in evidenza il pericolo che ii Piano governativo, non modificato in profondità, avrebbe potuto trasformarsi in un ulteriore elemento di assecondamento alla politica dei grandi monopoli. (Nel 1967 la Cgil farà astenere i propri deputati presenti in Parlamento dal votare il Piano economico quinquennale).
La Cisl tenne il suo Congresso nell'aprile del '65: ne uscì fuori una linea di appoggio al Piano economico. Ma successivamente i sindacati si opposero alle linee del Piano, il quale metteva in' evidenza due opposte tendenze: da un lato la necessità, affermata sia dal mondo imprenditoriale che da numerose personalità politiche, di imporre la cosi detta "politica dei redditi", che agganciava la dinamica salariale alle variazioni della produttività; dall'altro l'opposizione dei sindacati che rivendicavano l'autonomia e l'articolazione contrattuale a vari livelli. La "politica dei redditi" era sostenuta in modo particolare dalla Confindustria che di fatto non aveva mai accettato la contrattazione articolata e che in questo modo tentava di riportare la contrattazione su una rigida struttura centralizzata.
Nel 1966 la Confindustria, in occasione del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, ribadì il rifiuto della contrattazione articolata. In quei mesi su proposta della Cisl, le tre Confederazioni avevano dato inizio a incontri unitari, per definire quello che venne chiamato "l'accordo-quadro". Ma le categorie impegnate nei rinnovi contrattuali rifiutarono energicamente l'"accordo-quadro", che sembrò tradursi in un tentativo di regolamentazione della contrattazione articolata subordinato all'obiettivo del Piano economico di vanificare l'articolazione contrattuale.

I vantaggi conquistati agli inizi degli anni '60 dalla classe operaia provocarono una organizzazione del lavoro più rigida, che va interpretata come risposta padronale alla spinta operaia di quegli anni. Per riequilibrare i margini di profitto, infatti, il padronato aumentò i ritmi di lavoro; e i benefici salariali, conquistati nei contratti del '62 e '63, furono erosi dalla crescita dei prezzi negli anni successivi il boom economico. Nel '66, i contratti furono più modesti e meno vantaggiosi.
La condizione operaia in fabbrica si fece ancora più intollerabile. Si accentuò la tendenza, nelle grandi aziende, di affidare i lavori più pesanti e più gravosi ad una manovalanza dequalificata che aveva appena lasciato i lavori dei campi ed era emigrata verso il triangolo industriale. Il 1968 si fondò su queste premesse: la delusione crescente della classe operaia e l'emergenza di nuovi fenomeni sociali e produttivi (esodo, inurbamento, meccanismi di razionalizzazione del ciclo produttivo).
Il 1968 — dunque — è l'anno della svolta, l'anno della ripresa del movimento popolare. In questo anno riprendono molte lotte aziendali: per l'aumento delle pensioni, contro le gabbie salariali che ancora dividono il paese in zone di serie A, B, C, e così via... in virtù delle quali gli operai non hanno un salario unificato.
Nel marzo alla FIAT scioperano 100.000 lavoratori per l'orario e per i cottimi. Non sfuggì a nessuno il valore politico del successo. A Valdagno gli operai tessili abbattono nella piazza la statua del padrone: il conte Marzotto, che è il simbolo della tracotanza del padronato ed è l'emblema di un miracolo economico costruito con il supersfruttamento.
Le interviste che pubblichiamo in questo capitolo con gruppi di operai testimoniano del clima di quei mesi e della passione che tutti i lavoratori, indistintamente misero in quelle lotte; ma testimoniano altresì del mutato rapporto con il padronato. L'anno si chiude con 3.870 accordi aziendali raggiunti. Ma si chiude pure con un'altra grande vittoria: l'abbattimento delle
16
gabbie salariali nell'industria pubblica. L'Intersind è obbligata a firmare l'accordo che appunto prevede l'abbattimento delle zone salariali nel Paese.
Nello stesso anno in Francia eslode il "maggio studentesco" che si estende in tutti i paesi dell'Europa occidentale, e in Italia assumerà caratteri di massa e contenuti politici che segneranno fortemente lo sviluppo democratico del Paese. La Cgil raccoglie questo potenziale di democrazia e di partecipazione che è stato preceduto da una fase di grandi lotte contadine e operaie.
In seguito Luciano Lama così scriverà sulla primavera studentesca in Italia:
Non l'esaltazione della contestazione in tutti i suoi contenuti e anche nelle sue illusioni, nei suoi infantilismi, ecc., ma i dati di fondo — che sono poi quelli che contavano e contano — dicono che questo elemento essenziale di rinnovamento insito in un fenomeno così dissacrante come quello della contestazione, aveva una sua validità era essenziale. Questo elemento è diventato importante non solo tra gli studenti, fra i giovani delle fabbriche, ma ha puntato anche al rinnovamento della vita Politica in Italia, nel rapporto fra partiti e masse, tra partiti e opinione pubblica, dando coscienza di un problema che prima sfuggiva: il problema di che cosa dev'essere la democrazia in un Paese come il nostra
Ma sull'autunno sindacale giocarono anche altri fattori oltre quelli prima descritti. Influirono soprattutto i risultati contrattuali degli anni '66 e '67 che erano stati insoddisfacenti. In alcune fabbriche i lavoratori rifiutarono i contratti considerati riduttivi in base ai nuovi rapporti di forza. Inoltre nel 1966 vi era stato l'accordo fra Confindustria e sindacati per il rinnovo delle Commissioni interne, prolungato per due anni. Ma le Commissioni interne—il cui accordo era stato raggiunto nel '66 — erano oramai uno strumento inadeguato rispetto alle nuove istanze della fabbrica; ne conseguì uno stato di insofferenza da parte della classe che porterà, fra il '67 e il '68, alla creazione di organismi diversi i Consigli di fabbrica e i delegati di reparto, che nascono prima in forma autonoma e successivamente saranno inseriti nella struttura sindacale. l delegati di reparto risolsero a livello di base la contrapposizione fra sigle sindacali. Infatti i lavoratori di una stessa linea di montaggio esprimevano le loro istanze per mezzo del "delegato ' senza più guardare a quale sindacato egli appartenesse o di quale partito fosse. I Consigli di fabbrica infine, portarono l'istanza del sindacato sul luogo di lavoro superando le divisioni Politiche. Questi organismi seguiranno dall'interno della fabbrica tutti i problemi dell'organizzazione del lavoro per cercare di ottenere la compatibilità tra la nuova organizzazione del lavoro e le esigenze della classe operaia.
Gli anni '60 furono caratterizzati da massicci fenomeni di "fuga" dei contadini dalle campagne che andavano ad ingrossare le fila dei disoccupati o dei sottoccupati o della manovalanza comune nelle città del nord.
Questi cittadini di 'serie b' vivevano urbanizzati in agglomerati urbani fatiscienti, sorti ai margini delle città, o relegati nei centri storici, in abitazioni malsane, insicure, abbandonate. (o lasciate appositamente "abbandonate" in attesa del momento buono per una operazione speculativa a vasto raggio). Questi emigrati — che il mancato sviluppo industriale nell'agricoltura h9 cacciato dalle loro case — portano con sé una carica disperata di rabbia che influirà moltissimo nelle lotte operaie del '68.
L'agricoltura negli anni '60 si scontra con questo tipo di logica di sviluppo: la "restaurazione" capitalistica aveva visto una compenetrazione sempre più stretta fra capitale statale e la grande agraria a danno di uno sviluppo equilibrato. Gli enti di riforma agraria altro non furono, infatti, che degli strumenti del capitalismo monopolistico dello Stato messi a loro servizio.

L'entrata dell'Italia nel MEC, alla fine degli anni '50, accentuò queste linee di sviluppo che si enucleavano intorno alla creazione dei monopoli. Prima conseguenza dell'entrata dell'Italia nel MEC fu la diminuzione del prezzo del grano che Provocò conseguenze disastrose nei piccoli e medi proprietari. Inoltre la Corte costituzionale abolì la sentenza sull'imponibile di mano d'opera, che aveva assicurato ai braccianti una qualche continuità di lavoro e, contemporaneamente, in quei mesi, i coltivatori diretti si videro triplicati gli oneri retributivi della mutua rispetto all'anno precedente.
!I monopolio tendeva a realizzare una politica "produttivistica" Identificata nel massimo profitto a danno della popolazione contadina e del piccolo proprietario. Alle soglie degli anni '60 il
movimento contadino sviluppò ampie lotte per rivendicare l'imponibile, il collocamento, il miglioramento delle condizioni di lavoro dei braccianti e per difendere la "giusta causa".
Alla Conferenza nazionale dell'agricoltura, tenuta a Roma nel giugno 1961, Luciano Romagnoli dichiarò:
(...) Già nel dibattito, come del resto nelle comunicazioni preparatorie della conferenza e nel dibattito delle commissioni, si sono scontrate due linee di pensiero e di azione opposte, che non vale la pena di cercare di comporre perché inconciliabili, ma che conviene chiarire a fondo. L'una sostiene che per tale ammodernamento conviene far perno sulla grande azienda e sulla grande proprietà in nome della sua efficienza, in nome della sua produttività, della sua competitività. (...) Attorno a queste aziende può esistere una fascia di aziende contadine, anzi si dice con una definizione equivoca, di imprese familiari a più lenta evoluzione (evoluzione di decenni, si è detto ieri) però in posizione subalterna rispetto alla grande azienda. Le altre aziende contadine marginali, è stato detto chiaramente, vanno liquidate; ed anzi per impedirne la creazione di nuove bisogna stabilire restrizioni legislative che hanno il sapore arcaico delle stesse che presiedono la sopravvivenza di quel tipico rudere feudale che è il "maso chiuso".
Non ci si dice il prezzo di questa operazione, che è un prezzo che noi conosciamo già o almeno conosciamo in parte, e conosciamo avendolo pagato. Il prezzo, intanto, è che lo sviluppo che viene così proposto, ammesso che di sviluppo si tratti, non è di tutta l'agricoltura, ma di una parte dell'agricoltura, sulla base di un criterio selettivo, che è di classe, proprio perché ci si propone di fare perno sulla grande azienda, sulla grande proprietà, anche se poi questo criterio viene coperto da false motivazioni agrotecniche (le terre buone, le terre che hanno vocazione agraria, quelle che non l'hanno e così via, come se non fosse vero che ogni suolo ha una sua vocazione utile).
Sviluppo quindi di una parte dell'agricoltura a danno di un'altra parte. Sviluppo disuguale che corrisponde agli analoghi criteri di classe della borghesia industriale, specie monopolistica. Le conseguenze sono a danno di popolazioni di intere zone, non solo per le popolazioni agricole, dove tutta l'economia degrada, sia nella città che nella campagna. E quindi la fuga, l'esodo tumultuoso e scomposto che nasce dalla degradazione e dalla miseria e che, come è stato sottolineato anche da pregevoli studi fornitici dal comitato preparatorio della conferenza, è l'opposto di una ordinata ridistribuzione delle forze del lavoro.
Si è calcolato che in quegli stessi anni i coloni e gli affittuari pagavano ancora oltre 150 miliardi annui alla rendita fondiaria e nel contempo erano costantemente impoveriti dal peso che su di essi esercitava il mercato monopolistico. Il bracciante agricolo era retribuito con un salario inferiore al 50% rispetto al salario operaio.
Il persistere di vaste aree di arretratezza e di sottosviluppo non venne considerato come uno dei fattori determinanti che impedivano al Paese una equilibrata espansione produttiva ed economica. Si sottovalutò cioè quali problemi e quali squilibri questa errata politica agricola stava provocando e si affermò l'illusione che le così dette "contraddizioni del sistema" potessero essere riassorbite dall'espansione capitalista.
Anche il Partito socialista, in quegli anni di centro-sinistra, accentrò tutta la sua attenzione sul piano di sviluppo economico con particolare riferimento all'industria; nel Sud invece abbracciò la tesi delle così dette "aree di sviluppo": come quelle dell'Italsider di Taranto. Sorsero le così dette "cattedrali nel deserto", che vennero impiantate in zone depresse, sfruttando la manovalanza disponibile a minor prezzo, ma senza collegarsi su tutto il territorio circostante a una serie di industrie indotte, tali da risollevare effettivamente l'intera economia locale.
Nel 1963 una legge (la "327") dette a quei contadini che avevano lavorato un certo numero di anni sul fondo effettuando continue migliorie, la possibilità di divenire proprietari della terra. La legge si riferiva ai contratti miglioratari in uso nel Lazio, ma presto fu rivendicata da migliaie di contadini in tutta Italia. Gli agrari opposero una resistenza tenace e si rifiutarono categoricamente di applicarla, denunciando i coloni (che pretendevano di attuarla) per appropriazione indebita aggravata. La lotta si espresse con scontri aperti e in ribellioni violente da parte dei contadini. Fu in questo clima che l'anno seguente, si inserì la legge sui patti agrari che per tutti quei contratti colonici in cui il concedente avesse ceduto solo il nudo terreno,
17
e il contadino avesse invece provveduto all'impianto, prevedeva una più equa ripartizione dei prodotti a favore di quest'ultimo. I patti agrari furono sostenuti dalla Federbraccianti-Cgil, anche se lo stesso Partito comunista ne sottolineò ed evidenziò i limiti. In sostanza i patti riproponevano rapporti di lavoro di tipo arcaico; mentre una vera riforma agraria doveva presupporre il superamento della mezzadria ed una più equa ripartizione delle terre a favore dei piccoli proprietari. Non di rado in quel periodo accadde che il mezzadro, volendo far valere i propri diritti, ricorresse al tribunale; e la storia di quegli anni, nel sud in particolare, è piena di processi trascinati per anni ed infine insabbiati da più di un giudice compiacente nei confronti del padronato agricolo.
In questi anni la Federbraccianti analizzò a fondo la composizione della popolazione contadina e riuscì a definire un fronte di lotta unico che aveva come obiettivo centrale un peso sempre maggiore del lavoratore nell'impresa e la progressiva riduzione della rendita fondiaria. In questo fronte unitario conversero anche i braccianti, per conquistare un salario annuo garantito ed una regolamentazione dei rapporti di lavoro. Contemporaneamente le tre organizzazioni sindacali cercavano faticosamente punti d'incontro per impostare le lotte in maniera unitaria. Queste lotte si concluderanno nel 1969, con la conquista dei capitolati colonici. Tutti i coloni finalmente avranno diritto ad una contrattazione e non dovranno più discutere singolarmente col padrone i termini dei contratti di lavoro. Le scelte produttive diventeranno collettive, così pure le forme di lotta saranno più organizzate e non si ridurranno più alla lotta generica di piazza.
Ma le lotte delle campagne, se paragonate a quelle che negli
stessi anni venivano portate avanti nelle fabbriche, sottolineavano una volta di più il divario esistente fra sviluppo agricolo (in cui ancora sussistevano contratti iniqui ed in cui il padrone si muoveva ancora in una logica tipicamente feudale) e sviluppo industriale. Questo divario, che tuttora permane e che è una delle cause fondamentali dello squilibrio economico italiano, fu evidenziato tragicamente dai fatti di Avola, nel dicembre 1968. La risposta che il Paese diede a questo ennesimo episodio di violenza fu unanime, Cgil, Cisl, Uil proclamarono uno sciopero unitario generale e contemporaneamente chiesero il disarmo delle forze di polizia nelle vertenze sindacali.
Avola fu l'ultimo atto di una lunga catena di eccidi perpetrati contro il movimento dei lavoratori. Avola chiude il 1968, e apre un altro capitolo nella storia del movimento sindacale che inizia con le lotte per i rinnovi contrattuali del 1969 (I autunno caldo"). Ma i fatti di Avola danno ai lavoratori la certezza che per ottenere un generale rinnovamento delle condizioni di vita delle classi più povere, contro lo sfruttamento e la monetizzazione della salute, bisogna modificare sostanzialmente l'assetto socio-politico del Paese. Modifica che non può avvenire senza il concorso di tutti i lavoratori e di tutte le aree produttive del Paese facendo scomparire definitivamente le zone depresse.
Avola non fece che sottolineare il fatto che fra le riforme più urgenti che il Paese doveva affrontare c'era quella dell'agricoltura e quella dello sviluppo economico del mezzogiorno: riforme che non potevano più aspettare; riforme che avrebbero consentito (e consentiranno) al Paese un coerente sviluppo sociale, economico, politico nell'ambito di una più salda democrazia.

18
Luciano Lama
Impegno della CGIL per lo sviluppo e l'unità del sindacato in Italia
La Cgil delle origini
Si è accusato il nostro movimento, soprattutto nei primi anni, per gli anni dell'unità fino al 1948, più che dopo, di aver Peccato di verticismo e di burocratismo.
Ebbene, nel 1945 io ero Segretario della Camera del lavoro di Forlì, una Camera del lavoro nata con la liberazione della città da parte dei partigiani diretti dal Comitato di liberazione nazionale composto dai partiti antifascisti. Noi aprimmo la sede della Camera del lavoro sfondando le porte dei sindacati fascisti e da quel momento cominciammo ad organizzare la gente che veniva. A che cosa si organizzava quella gente? A Forlì la maggior parte erano disoccupati, perché le fabbriche erano distrutte e quella è una regione d'Italia sulla quale la guerra è Passata a tappeto. Erano disoccupati e volevano andare a lavorare presso i cantieri della AMG, i cantieri delle forze militari alleate, che era l'unica fonte di lavoro per lunghi mesi, a parte le campagne, dove c'erano le mine su decine di migliaia di ettari del territorio agricolo.

Che cosa facemmo noi? Davamo una tessera provvisoria della Camera del lavoro (neanche si chiamava ancora Camera confederale) e nel giro di 6 mesi organizzammo 115.000 lavoratori. Chi li aveva portati a questa adesione? C'era verticismo, c'era democrazia, c'era burocratismo? Quelli vennero alla Camera del lavoro e non si iscrivevano alle singole categorie, perché non sapevano a quale categoria avrebbero potuto appartenere, ma si iscrivevano alla Camera del lavoro.
In quelle condizioni oggettive, l'adesione di quelle 115.000 Persone fu spontanea, perché noi non li andavamo a prendere a casa. Da che cosa erano spinti a venire al sindacato? Erano spinti al sindacato dall'orientamento che esprimevano, allora, le forze democratiche antifasciste, così come erano e per ciò che esse avevano rappresentato per la liberazione della mia terra; ed il sindacato era inteso da loro, dai lavoratori, come una espressione di quelle forze. Avevano ragione, avevano torto? Queste sottili disquisizioni che andiamo facendo da tanto tempo sui problemi dell'autonomia non esistevano proprio come pensiero, come intuizione, poiché non c'erano questi problemi allora sul tappeto.
Ora, id non voglio fare del determinismo storico a buon mercato, voglio dire però che fu così che nacque quella organizzazione della quale io sono ora un testimone e così nacque quella organizzazione in gran parte dell'Italia del Nord e del Sud.
Nel Sud la situazione era diversa, ma anche lì le cose erano tali da condizionare in modo molto serio la nascita di un sindacato unitario nel nostro Paese, poiché non c'è dubbio che in numerose regioni del Mezzogiorno il sindacalismo fascista sopravvisse in vari modi e per un po' di tempo alla Liberazione e alla caduta del fascismo.
Noi, allora, avevamo questa grande massa di lavoratori organizzati senza una struttura di categoria che venne, ripeto, dopo, anche a distanza di molti mesi e di qualche anno. In tutto c'erano solo 3 o 4 sindacati organizzati, poi, tutti gli altri lavoratori stavano nei sindacati veri — così li chiamavamo — che Si occupavano di moltissime cose, da quelle a cui faceva cenno
Bonaccini, ieri, ad altre tutte rispettabili, ma molto diverse le une dalle altre.
Il movimento sindacale, dopo la Liberazione, per molta parte del nostro territorio è nato così, e, quindi, sarebbe difficile cercare in esso, ai suoi primordi, una organizzazione molto razionale sul terreno delle strutture, capace di garantire un metodo di democrazia partecipata del tipo di quella che, oggi, noi abbiamo sperimentato, ma che allora non esisteva neanche come aspirazione.
Da Forlì, allora avevamo dei rapporti frequentissimi con Roma e chiedevamo i "lumi" a Roma. lo ricordo — e Lizzadri può essere testimone di quel periodo — che noi scrivevamo molte lettere; poi, quando le linee telefoniche cominciarono a funzionare, cominciammo a telefonare frequentemente per avere indicazioni, orientamenti sul cosa fare, sul come fare e, da parte dei compagni della Segreteria della Cgil ci veniva sempre l'indicazione: "fate, fate voi". Questo dicevano: cioè non c'era da parte del gruppo dirigente della Confederazione, in nessuna delle sue componenti per la verità, la tendenza a requisire poteri, ma al contrario, prevaleya. piuttosto l'orientamento a lasciar fare, anche perché quel fenomeno, quel processo che stava avvenendo era senza precedenti nella storia del nostro Paese, per cui si trattava di strutturare un organismo che doveva crescere anche secondo una sua logica, una sua legge, una sua capacità di divenire e di diventare adulto.
In quelle condizioni, noi abbiamo commesso certamente moltissimi errori, tra cui una contrattazione limitata nei risultati. Ma questo è ovvio, poiché l'incontro tra le parti si faceva in una Italia distrutta, dove non c'erano beni di consumo, e dove alla gente interessava molto di più che avere delle "amlire", avere la garanzia di una distribuzione di generi di prima necessità (fossero essi zucchero farina o pasta), avere il tesseramento e il contingentamento, con il mercato nero che infuriava.
C'è poi un altro discorso da tenere presente: e cioè la natura delle nostre convinzioni di allora. lo, per esempio, pensavo che l'evoluzione delle cose sarebbe stata diversa nel nostro Paese — mi riferisco ai miei pensieri del '45 del '46 e del '47. Pensavo che sarebbe stata diversa nel senso della velocità dei cambiamenti. Le nostre aspirazioni, le ragioni per le quali noi avevamo partecipato alla guerra di Liberazione avevano lasciato in noi un sedimento di fede dura a morire, una fede di mutamenti rapidi, e in capovolgimenti per la quale, percorsa metà della strada, si trattava di fare quell'altro piccolo passo per poi risolvere tutti i problemi.
In questo c'era, allora, davvero un grave fatto di immaturità. Pensavamo che bastasse liquidare il fascismo e liquidare lo sfruttamento per chiudere la fase storica precedente. Invece, non era così.
Da questo punto di vista, ripeto, non bisogna credere che questo modo di vedere le cose non abbia influito in quel periodo, perché esso ha influito sia sulle scelte concrete, che nel formare un certo tipo di quadri e nel farli come essi sono poi diventati.
Da: "I 30 anni della CGIL" - Roma 1975
D D a
3 3 19
Il Piano del lavoro
Perciò, sotto questo aspetto, sono convinto che il Piano del lavoro sia stata una intuizione felice, generosa, ma certamente non l'indicazione di un nuovo modello di sviluppo. Intanto esso non aveva neanche questa ambizione di essere un nuovo modello, nel senso che diamo oggi a queste parole; in più, la debolezza fondamentale del Piano del lavoro, ragionando sul Piano e non sul quadro generale nel quale esso si collocava, fu la seguente: fu che, in effetti, ad esso sfuggiva completamente l'industria e il Nord. Il Piano del lavoro, per certe regioni del Mezzogiorno, fu un piano esaltante di mobilitazione, di lotta e anche di conquista di risultati parziali, ma il Nord venne tagliato fuori completamente da quella esperienza.
In realtà, forse anche perché il processo di riorganizzazione e di ristrutturazione industriale era già molto avanzato al momento in cui fu lanciato il Piano del lavoro tra la fine del '49 e l'inizio del '50, ci si trovava già con una discrasia nei tempi che non assumeva i problemi di una funzione dell'industria (parlo della classe operaia del Nord) come forza essenziale per una trasformazione del Paese. Il Piano del lavoro, per questa ragione, oltre che per altre che riguardano il suo modo di essere e i suoi contenuti relativi a questo o quel settore, non poteva passare, e non passò, anche per le ragioni di carattere generale e cioè per quello che era allora il quadro politico nel quale questa proposta fu avanzata e questa lotta portata innanzi. Non si può, però, liquidare con questo solo discorso il Piano del lavoro, perché esso ha introdotto nella esperienza della Cgil e nel suo modo di vedere i problemi anche sindacali, in senso stretto, un fatto importante: l'esigenza che il sindacato intervenga nell'economia non soltanto sul versante della divisione del reddito, ma anche su quello della produzione del reddito. Questo dato che è stato, allora, tipico della Cgil, noi ce lo siamo portato avanti, in qualche caso con meno fortuna, in qualche caso in modo più esplicitamente presente, in qualche caso in modo meno presente, fino ad oggi, ed in questo sta il rapporto ideale tra quella esperienza, quella sconfitta, se la vogliamo chiamare così, di allora e le politiche che stiamo portando avanti oggi, dopo l'8° Congresso, con la nostra lotta per le riforme, per lo sviluppo delle basi produttive del Paese, per il Mezzogiorno, per l'agricoltura.
Tale continuità, in particolare, esprime pienamente il modo originale di essere della Cgil e del sindacato italiano rispetto ai movimenti sindacali degli altri paesi capitalistici. Un modo di essere, questo, che se pure è passato attraverso ritardi e difetti, assicura un ruolo e una funzione nazionale al nostro sindacato e alle sue politiche.
I ritardi e le autocritiche
Una critica che è stata rivolta alla nostra azione si riferisce alla politica aziendale ed alle autocritiche, da quella famosa di Di Vittorio nel 1955, alle altre che poi molti di noi hanno avuto occasione di fare, in sede di correzione di un errore che avevamo certamente commesso.
Permettetemi, anche qui, di offrire una mia personale esperienza. Al Congresso di Genova del 1949 presentai un rapporto, che era ad un tempo una apertura ed una chiusura: era un'apertura nel senso che si proponeva attraverso i Comitati degli attivisti, di creare una propaggine del sindacato nella fabbrica avvertendo i pericoli, e con molta forza, credo, per allora, dell'aziendalismo, delle politiche corporative, di una atomizzazione delle forze di classe all'interno della fabbrica. Questa preoccupazione era giusta, il modo di risolverla era sbagliato. Oggi possiamo dirlo, questo, perché l'esperienza di oggi ci dice che ci sono sistemi, mezzi e strumenti adeguati ad affrontare positivamente questo problema. Però, ripeto, oggi: tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70. Quale era la situazione del 1949 e degli anni che seguirono il '49 fino al '55, '56, '57? Allora, chi faceva la politica aziendalistica c'era, perché ne faceva una sua bandiera: era la Cisl a portare avanti nei fatti quella politica.

Ma se noi riandiamo al fatto che la maggioranza degli accordi aziendali che si fecero in quel periodo, furono accordi separati non perché la Cgil non li voleva firmare, ma perché essa era tenuta fuori dalla contrattazione, gran parte di questa critica che ci viene mossa perderebbe allora di fondamento. In definitiva, quindi, credo che noi abbiamo avuto dei ritardi gravi nell'acquisire i mutamenti che si erano verificati e che permettevano di avere come movimento sindacale un altro tipo di presenza e di forza contrattuale nella fabbrica, sconfiggendo
quei pericoli di aziendalismo e di isolamento aziendale delle masse lavoratrici; ma credo anche che se abbiamo ritardato troppo verso tale scelta, in questo modo ci siamo assicurati meglio contro un pericolo che, invece, è sempre presente e tuttora incombe sul movimento sindacale.
Noi in Italia, è noto, abbiamo la giungla retributiva, e questo, credo che conveniamo tutti, è un male da sconfiggere. Però, in Italia, a differenza di altri Paesi, su questa giungla retributiva non si è costruito un sistema di aristocrazie operaie; ma perché questo è avvenuto? lo dico che questo è avvenuto anche perché la nostra preoccupazione, se volete, eccessiva, almeno in un determinato periodo, ha però impresso al movimento sindacale italiano, alle masse lavoratrici la nozione di un pericolo che altrove non è stato considerato come un pericolo, ma come una conquista che, poi, ha condizionato la natura dei sindacati in altri Paesi capitalistici a differenza dell'Italia.
Non sono tra quelli che dicono che in Italia non esistono, o non sono esistite negli ultimi anni le basi oggettive per la creazione di una aristocrazia operaia, perché questo non è vero, dico però, che non si è costituita l'ideologia di massa di una aristocrazia operaia in Italia. Anche qui, valutando quel difetto, quegli errori, quei ritardi che sono certamente da considerare tali, dobbiamo vedere tutte e due le facce della medaglia, perché non esiste una medaglia con una faccia sola, in questo caso c'è anche una faccia non ripugnante.
Un altro problema sollevato negli interventi riguarda i ritardi avuti dalla Cgil, circa le Commissioni interne e l'articolo 39. Vais ne ha parlato e, secondo me, il discorso lo ha portato avanti fino ad un certo punto. Ma c'è un interrogativo alla fine di quel discorso che bisogna pur porsi, ed è questo: fra le forze presenti in campo, la Cgil è stata una delle forze che, avendo acquisito e avendo compreso le possibilità di un cambiamento in meglio, si è collocata fra quelle che spingevano, o fra quelle che resistevano rispetto alla sostituzione delle Commissioni interne con altre strutture democraticamente più adeguate e rappresentative della partecipazione dei lavoratori? E, per quanto riguarda l'articolo 39, la Cgil ha capito rapidamente che questo era un articolo fatto per l'unità di una determinata situazione e con una certa concezione o ha invece ritenuto che nelle nuove condizioni, l'insistere, su una posizione puramente costituzionalistica in senso formale poteva significare soltanto aggiungere elementi di divisione ad una divisione che si voleva superare?
Questa, allora, è una critica che si deve fare, secondo me, alla Cgil, anche scontando i termini di una comprensione verso il ritardo che vi è stato. Per un certo periodo noi non siamo stati un fattore di spinta, ma di resistenza all'adeguamento anche rispetto alle modifiche che si erano già verificate, in buona misura, nella realtà concreta.
Così i ritardi ci sono stati sui problemi dell'imponibile di mano d'opera, sulla contrattazione aziendale e sulla strutturazione efficace delle categorie: su questo sono d'accordo. Bisogna però collocare questi giudizi, che secondo me sono esatti, nel momento e nella realtà nella quale questi errori venivano commessi. E questo non per giustificarli, ma per capirli e per meglio comprenderli.
La Cgil sindacato unitario di classe
A questo punto, desidero, però, mettere in luce alcune delle caratteristiche che a me paiono essenziali e storiche della Cgil: una è questa del suo carattere unitario di classe. Le Camere del lavoro, nella storia del movimento sindacale italiano, sono una peculiarità che non esiste altrove e che condiziona il modo di essere del sindacato in Italia; le Camere del lavoro e i disposti statutari tradizionali che partono da questa realtà — ai Congressi: 50% delegati orizzontali, 50% delegati verticali — rappresentano una cosa che esiste soltanto in Italia. In qualsiasi parte del mondo, i delegati sono i delegati delle categorie. Punto e basta. Si va ad un Congresso del TUC e là ci sono i 2 milioni di organizzati al sindacato dei metalmeccanici britannico; i voti li porta il Segretario generale. Chi vota? Vota lui per tutti con un buon esempio di partecipazione, di democrazia e di rispetto delle minoranze. Lo stesso è per i sindacati degli altri Paesi: se andate in Germania federale è la stessa cosa, in Francia è la stessa cosa, anche nella CGT è la stessa cosa. Soltanto noi abbiamo questa caratteristica, ed io dico che questa è una splendida caratteristica perché adegua il carattere organizzativo e strutturale del movimento e del sindacato ad una nozione di classe reale, dal momento che noi siamo convinti che i
20
problemi, prima ancora che della emancipazione, dell'autonomia della classe, non si risolvono tutti dentro la fabbrica, non si risolvono in scontri morbidi o duri (poco importa da questo punto di vista) tra lavoratori e padroni dello stesso settore o della stessa fabbrica.
Dunque, la struttura della Cgil rispecchia questo suo modo di intendere in termini di coerenza anche formale il carattere di classe ed unitario del movimento. L'unionismo è agli antipodi della nostra concezione, e qui ci sono certamente delle ragioni che varrebbe la pena di indagare, che stanno anche nella storia — qualcuno l'ha ricordata — di certe nostre regioni meridionali; anche il peso che ha avuto per un certo periodo della storia sindacale d'Italia la concezione anarcosindacalista, non c'e dubbio, che ha avuto un ruolo importante nel determinare questo aspetto del nostro modo di essere.
Ci sono, poi, dei dati strutturali che hanno pesato e che pesano: ad esempio il dato strutturale della disoccupazione. In Italia, un sindacato che non faccia una politica per i disoccupati e che non li consideri parte di sé stesso è, necessariamente, un sindacato non unitario e non di classe. Queste discussioni intorno a questo problema non sono cominciate adesso e neanche con il Piano del lavoro perché nel movimento sindacale italiano la discussione relativa alla posizione sindacale dei disoccupati c'è stata anche nella vecchia Confederazione generale del lavoro. C'è poi un altro dato caratteristico del nostro sindacato che, anche questo, è peculiare: la presenza del sindacalismo agricolo, che ha avuto una grandissima influenza nel plasmare questo modo di essere della Confederazione del lavoro, come organizzazione globale della classe e non settoriale.
Ci sono stati infine gli squilibri territoriali, c'è stata la forte coscienza politica, soprattutto in questo dopoguerra che, certamente ha agito fortemente, caricando di questi contenuti di classe ed unitari la nostra Confederazione. Inoltre, io sono convinto che l'autonomia è concepibile soltanto Per un sindacato che abbia questi connotati, e che altrimenti non ci può essere che o la subordinazione al sistema o la subordinazione ai partiti politici.
I lavoratori, vedete, sono divisi ideologicamente anche altrove; non è affatto vero che in Gran Bretagna siccome c'è un solo sindacato che si chiama TUO con più di 10 milioni di organizzati, tutti i lavoratori sono laburisti. Non è affatto vero. E' vero invece che i laburisti qualche volta vincono e qualche volta perdono sul piano del rapporto con i lavoratori, e che fra gli elettori conservatori e liberali, ci sono anche, certamente, molti lavoratori organizzati al TUC. lo credo che si possa dire la stessa cosa per la Germania federale relativamente alla DGB, una grande organizzazione unitaria anche essa.
In verità, questi sindacati non chiamano i lavoratori a trasformare la società; questo è il punto decisivo! E siccome non li chiamano a trasformare la società, ma li chiamano a conquistare dei contratti e dei salari, l'unità sindacale in quelle zone, con quel tipo di sindacati, è più facile. Non perché i lavoratori ripeto, non siano ideologicamente divisi e non abbiano ciascuno la propria propensione politica — anche negli Stati Uniti è la stessa cosa — ma perché il sindacato, in definitiva, è un servizio che serve ad un determinato scopo, che non incide sulla struttura di classe e sul modo di essere della società, che non si Pone il struttura. problema di realizzare dei mutamenti profondi della
li carattere classista della Cgil consiste in questo. Ecco perché noi non abbiamo molto bisogno di parlare di classe ad "ogni Pie' sospinto"; la nostra natura ci ha fatti così e così siamo e non mi pare che abbiamo perduto mai questa caratteristica, neanche nei momenti più difficili della nostra storia.
L'impegno riformatore e le alleanze
Un'altra delle caratteristiche essenziali della nostra organizzazione, come giustamente è stato detto, è quella che riguarda il suo sforzo e il suo impegno per elaborare una politica generale, una politica riformatrice, appunto, sul piano delle strutture e della società, e di cercare di collegare alle forze di classe altre forze sociali. Ecco un punto sul quale io ho inteso, anche in questa riunione, osservazioni critiche: "smodate alleanze", ha detto Giugni. Le alleanze possono essere giuste o sbagliate, ma smodate, no, secondo me. Perché? Perché qui si tratta di sapere, ripeto, sempre dove vogliamo andare. E bisogna rispondere a questa domanda. Se noi ci proponessimo soltanto una

visione essenzialmente od unicamente contrattualistica della nostra funzione, di strappare buoni contratti, i migliori contratti, allora potremmo anche farne a meno. Non a caso ci sono le concezioni che si ispirano a questo: c'è chi è convinto, per esempio, che per strappare un buon contratto negli autoferrotranvieri bisogna premere in ogni modo sulla gente perché questo fa diventare quella lotta un fatto emergente nella società in modo tale che, alla fine, il risultato si ottiene senza preoccuparsi delle rotture determinate da quell'azione sociale, rotture che non si rimarginano mai di per sé.
A chi ha questa concezione del sindacato, ripeto, le alleanze possono sembrare sempre smodate. La verità è che noi, invece, cerchiamo di coagulare attorno a questo disegno ed a questa forza di classe che ha questi obiettivi di trasformazione sociale altre forze che possono essere indotte, condotte a condividere, almeno in parte, questi obiettivi, per realizzare quel tal rapporto di forza che ci permetta di ottenere dei risultati anche in questo campo, nel campo delle strutture, delle riforme e non soltanto in quello del puro contratto.
La politica, quindi, della raccolta delle forze attorno alla classe per conquistare dei mutamenti nella società è la politica che abbiamo scelto. Anche qui si può sbagliare, intendiamoci bene; certo, si possono commettere degli errori per difetto e, credo, che siano quelli che, in generale, negli ultimi periodi abbiamo commesso; se ne possono commettere però anche in eccesso. Però sicuramente la negazione o la noncuranza di questo problema, che noi troppo spesso riscontriamo in altre organizzazioni, specie nella Cisl, è un indebolimento oggettivo della capacità del movimento sindacale di realizzare gli obiettivi più avanzati sul piano delle strutture e della società, che esso si propone. Una cosa singolare al riguardo è che proprio quelle forze all'interno della Cisl, che sul piano degli obiettivi di trasformazione della società si dichiarano più disposte e lo sono a portare avanti l'azione e la lotta, quando si tratta poi di cercare di creare il rapporto di forza necessario per vincere quella lotta, allora, assumono un atteggiamento di tipo aristocratico rispetto al lavoro da fare e ai rapporti da intrecciare con altre forze sociali le quali, appunto con la loro presenza, possono agevolare il raggiungimento di obiettivi che in questa materia sono sempre così ardui e difficili da raggiungere.
Voglio, a questo punto, fare un'altra considerazione che è importante per definire la natura della Cgil. La Cgil non ha considerato e non ritiene che in un Paese come l'Italia, con la Costituzione che ha, con le forze di massa organizzate che ha, e con gli squilibri che la caratterizzano, lo Stato, il governo debbano essere, necessariamente, un comitato di affari del grande capitale. Questa è una cosa molto importante. lo ricordo a questo proposito — permettetemi, anche qui, una piccola notazione autobiografica, anche perché io non voglio dare altro a questo discorso se non il carattere di un intervento personale in un dibattito — un incontro che facemmo a Mosca nel 1959, alla vigilia di un Congresso della Cgil con il povero Novella e ricordo lo sforzo e l'impegno ideale, che Novella mise nel sostenere questa tesi che io ho, pocanzi brevissimamente sunteggiato, ma che non era affatto acquisita e che non è acquisita neanche oggi, da buona parte del movimento operaio rivoluzionario comunista, sia di altri Paesi capitalistici che di Paesi socialisti. Cioè noi riteniamo che, tenuto conto del rapporto di forze che esiste e della natura dello schieramento di classe che c'è in Italia e della capacità di lotta che sono in grado di esprimere le forze operaie del nostro Paese; tenuto conto anche del carattere della Costituzione che sta alla base del nostro ordinamento, noi non riteniamo che sia inevitabile in ogni condizione il fatto che il governo debba essere un puro meccanismo di gestione degli affari del capitale o del grande capitale.
Guardate che questo dato ha influito potentemente nel determinare gli orientamenti nostri e del movimento sindacale in rapporto ai governi, e anche in rapporto alle politiche che si sono portate avanti nel nostro Paese e nel dare ai lavoratori una carica di fiducia su degli obiettivi di trasformazione della società che non comportano necessariamente o automaticamente il rovesciamento delle cose esistenti.
I nostri programmi di riforma, i nostri programmi per una nuova economia nascono da qui, anche perché se non si crede in questo, tutto diventa, al massimo, propaganda, addestramento. Ma non è questo l'orientamento della Cgil, e non lo è da lungo tempo. lo ho voluto apposta ricordare quell'incontro che avemmo con Novella a Mosca per sottolineare come il disaccordo che allora si registrò non ci fece cambiare la nostra
21
convinzione, la quale oggi resta più che mai consolidata dall'esperienza concreta della nostra azione. Mi pare, d'altra parte, che la realtà ci dia ragione, anche se è vero, come diceva Boni, che è mancato in questi anni, in grande misura, un interlocutore a questo tipo di politica promossa dal movimento sindacale: ma la mancanza di un interlocutore non significa che questa politica sia sbagliata, né che questa politica non possa essere in tempi lunghi una politica vincente.
La democrazia quale fondamento dell'unità sindacale lo vorrei trattare un ultimo argomento: l'impegno di direzione, il rapporto vertice-base, quello tra partecipazione e democrazia. lo credo che noi abbiamo fatto e facciamo un giusto sforzo per combattere lo spontaneismo, e che perciò dobbiamo continuare a farlo perché democrazia è una cosa, assenza di orientamento e di direzione è tutt'altra cosa. Naturalmente, si tratta di fare in modo che la direzione cominci effettivamente dal delegato di fabbrica che non si deve staccare dai suoi compagni e che deve essere capace di esprimere l'orientamento dei suoi compagni che lavorano insieme a lui nel gruppo omogeneo. Questa responsabilità di direzione che sta a tutti i livelli del movimento sindacale deve essere esercitata perché noi non siamo una struttura che assiste, che coordina, con il significato letterale della parola, ci sforziamo invece di essere una forza che stimola, che dirige, che mobilita le masse. Non gestiamo il movimento, ma cerchiamo di farlo protagonista sulla base di una idea razionale della sua funzione in questa società, di farlo protagonista di un cambiamento di questa società.
Questi risultati non si ottengono senza la partecipazione e la democrazia, ma non si ottengono neanche senza una scelta di direzione.
Ho inteso, nelle parole di un compagno, un accento critico che non ho capito, rispetto al fatto che in un certo periodo della sua storia la Cgil avrebbe quasi abdicato alla sua autonomia perché avrebbe partecipato, insieme con le forze politiche, all'azione antifascista. Ebbene, io dico che, su questo terreno, noi non abbiamo nessuna autonomia da difendere. Per noi fascismo significa antisindacato, e non soltanto antidemocrazia e antiliberalità; esso è la negazione di quello che siamo, e nell'impegno antifascista, nella lotta antifascista, ripeto, noi non abbiamo nessuna autonomia di difendere, e ci leghiamo invece a tutti quelli che sono antifascisti e che vogliono battersi perché il fascismo non prevalga di nuovo nel nostro Paese o non sottoponga il nostro Paese a delle prove drammatiche quali in questi giorni cominciano a verificarsi. Possiamo aver fatto qualche sciopero politico di troppo, come diceva ieri Bonaccini; certamente non abbiamo fatto nessuno sciopero antifascista di troppo.
lo credo che questi siano alcuni dei connotati essenziali della nostra organizzazione, sui quali noi dobbiamo lavorare per riuscire a caratterizzare, sempre più, il processo unitario. Ci sono stati dei cambiamenti molto importanti nelle altre organizzazioni; qui non si è parlato delle altre organizzazioni e quindi è difficile parlare di questi connotati che sono cambiati, ma c'è qualcuno che vi ha fatto riferimento.

La Cisl, nella sua maggioranza, ha abbandonato in verità gli orientamenti solidaristici del cattolicesimo preconciliare, ed oggi, nei fatti, aderisce ad una concezione classista del movimento. Questo è un cambiamento qualitativo verificatosi nell'ultimo periodo, che è stato certamente agevolato — non dico promosso o determinato, ma certamente agevolato — dall'esperienza che abbiamo compiuto, dalla battaglia che abbiamo fatto ed anche dal fatto che la Cgil, come tale, su questi punti essenziali e nodali del suo modo di essere non abbia mai fatto compromessi.
Noi dobbiamo portare avanti questa politica unitaria e andare all'unità sindacale, traguardo che per noi non è un fatto da raccontare su un libro di storia, ma una conquista da realizzare per far si che i lavoratori dispongano in Italia di una forza organizzata non solo sul piano sociale, ma anche sul piano politico e capace di cambiare le cose sempre in funzione di quell'obiettivo di trasformazione della società sul quale prima ho insistito.
Qui, viene fuori la questione dell'autonomia. lo credo che noi abbiamo un grado abbastanza elevato di autonomia. Sono anche d'accordo con quei compagni — Boni insiste molto su questo argomento, e credo che abbia ragione — che ritengono che con la unità cresce l'autonomia, e non cala; il discorso dell'autonomia non può diventare un'arma puntata contro l'unità, come invece vi è pericolo che sia nelle posizioni di qualche dirigente e di qualche organizzazione, secondo cui non essendovi autonomia nella organizzazione, e non potendosi senza l'autonomia fare l'unità, l'unità non si può fare.
Questo discorso l'abbiamo inteso tante volte ed è un discorso inaccettabile: l'unità non si può fare con chi? Con coloro con i quali si sta insieme da 30 anni, l'unità si è fatta e si mantiene. Non si capisce, allora, perché quella tale mancanza di autonomia che non condiziona l'unità con i partners, che si afferma non essere autonomi, quella tale unità non si possa realizzare su una scala generale.
Certo è che il lavoratore è uno, come il dirigente è uno; ed il problema dell'autonomia non sarà mai risolto, una volta per sempre, in via definitiva. L'autonomia infatti è una conquista che ogni giorno deve essere ripetuta ed io so che dire queste parole significa non rendere le cose più facili: ma io non voglio ingannarmi, né ingannare, e noi non abbiamo il diritto, su una cosa così seria, di ingannare alcuno e, tanto meno, di ingannare noi stessi.
L'autonomia, per quello che essa significa nella realtà, non può essere chiusa in uno schema di comportamenti dettati una volta per sempre. Si può mettere in uno schema l'incompatibilità, si può mettere in uno schema lo scioglimento formale delle correnti, si può mettere in uno schema che i dirigenti sindacali non possono essere candidati alle elezioni; si possono fare queste cose e noi le abbiamo fatte. Ma, se l'autonomia deve significare, come può significare soltanto, la capacità del sindacato di trarre dalla propria esperienza, dal proprio lavoro, dagli orientamenti che emanano dalla sua stessa azione, le sue scelte senza farle venire dal di fuori e, se nello stesso tempo, autonomia non può significare tagliare i ponti fra un militante che vuole essere organizzato e, magari, il dirigente sindacale, con la forza politica, con l'ideologia, con la fede politica che anima, se autonomia vuol dire questo, non è possibile imprigionarla, allora, in uno schema di comportamenti predeterminati, validi una volta per sempre, perché non c'è nessuno schema che possa rispondere a questo tipo di problemi.
Eppure, in queste condizioni, noi dobbiamo fare l'unità. Anche questo è uno dei problemi, in parte da risolvere. Ne abbiamo molti, ma ciò che conta, io credo, è essenzialmente la qualità del sindacato, il suo ruolo e la sua capacità di essere, il più possibile, aderente a questo suo ruolo ed a questa sua qualità nella considerazione di tutte le debolezze, i difetti e le lacune, che certamente nella vita del sindacato e della Cgil ci sono stati e nella speranza che nel futuro ce ne siano di meno che nel passato.
Ho esaltato la Cgil, in questo modo? Si, certo l'ho esaltata. L'ho esaltata perché la nostra vita di 30 anni è stata, anche per noi, la vita della Cgil. La Cgil ci ha fatti come siamo, così come siamo; la sua storia è anche la nostra storia, e nessuno, io credo, potrebbe parlare male della propria storia.
22
Un sindacato italiano negli anni sessanta - La FIM -CISL dalla associazione alla classe - Bari 1972

1) Autonomia e ruolo del sindacato nel sistema
L'autonomia del sindacato, le strategie ad essa connesse e le pratiche di applicazione più o meno coerenti con le scelte di fondo o le dichiarazioni di principio, costituiscono certamente un osservatorio privilegiato per riuscire a cogliere le caratteristiche originarie di una organizzazione sindacale, la portata Politica della sua azione, l'evoluzione della sua effettiva collocazione nel sistema economico-sociale. Compiere delle scelte in tema di autonomia è sempre, per un sindacato, un modo indiretto per definire il proprio ruolo nella società, per esprimersi nei confronti dei rapporti fra politica ed economia, per vincolare o meno le proprie linee rivendicative alla divisione del lavoro esistente fra partiti e sindacati, per identificarsi nel quadro istituzionale del sistema o per respingerlo.
Questo punto di osservazione diventa ancor più importante in un ambiente come quello italiano, caratterizzato da una forte conflittualità politica e dalla presenza di una pluralità di partiti che più o meno legittimamente si richiamano alle classi Popolari. In questo ambiente il problema dell'autonomia ha costituito per decenni un nodo molto difficile da sciogliere anche per le componenti sindacali più naturalmente autonome (i sindacati delle categorie industriali), più innovative, più aggressive sul piano rivendicativo.
Una cosa,è certa: il problema dell'autonomia non si è tradotto solo in esercizi intellettuali o in confronti fra i diversi statuti, esso è stato anche un terreno reale di scontro politico. In primo luogo, fra le diverse centrali sindacali, nel periodo che potremmo definire del "pluralismo guerreggiato" (gli anni '50) come in quello delle sperimentazioni unitarie (1966-69) fino all'attuale Periodo di costruzione dell'unità sindacale organica. In secondo luogo, per le diverse centrali al loro interno, sia pure su differenti linee di divisione e di dibattito.
Nella Cisl il dibattito sull'autonomia e sulle sue pratiche d'attuazione si articolava lungo la discriminante del moderatismo. Fin dall'inizio le componenti più autonome della confederazione hanno coinciso con quelle federazioni industriali o organizzazioni territoriali più avanzate sul piano rivendicativo, sul piano della democrazia interna, sul piano dei rapporti unitari.
Nella Cgil il dibattito ha coinvolto invece più ampi problemi di carattere politico-partitico e forse anche per questo ha avuto all'interno della confederazione uno svolgimento meno vivace, meno esplicito che nella Cisl. Nella Cgil, la discriminante fra le diverse posizioni si è rivelata più complessa e non è passata tanto per linee di carattere immediatamente sindacale, quanto sulle diverse concezioni dei rapporti fra azione politica e azione sindacale.
Quale il ruolo giocato dalla FIM nella impostazione e nella risoluzione di questi problemi? Su questo, come sugli altri aspetti che esamineremo più avanti, è possibile individuare, nella breve storia della federazione, tre periodi tipici identificanti altrettante fasi di sviluppo nella concezione e nella prassi. Nel primo periodo (gli anni '50) la FIM coincide praticamente con la Cisl e ne segue l'impostazione di fondo. Il secondo ('60-'61 fino al 1966-67) è un periodo di crisi o di passaggio, di
crisi del modello originario della Cisl soprattutto nella sua attuazione confederale, di passaggio verso un nuovo modello di azione e di organizzazione sindacali. Questo periodo intermedio, forse il più importante per comprendere la natura e l'evoluzione della FIM, si traduce spesso nella attuazione pratica di principi di fondo rimasti lettera morta all'interno della confederazione o nel tentativo di affrancamento delle ipotesi più qualificanti dell'esperienza della Cisl dal disegno di integrazione della classe operaia in cui erano inserite. Il terzo periodo, quello che stiamo vivendo tutora, è quello della realizzazione, in chiave sempre più unitaria, di un "nuovo sindacato" radicalmente distantb dal modello originario della Cisl. Occorre dunque, per descrivere ed interpretare gli sviluppi successivi, delineare brevemente la posizione della Cisl degli anni '50 in tema di autonomia del sindacato e sul conseguente ruolo nel sistema. Alla fondazione della Cisl, dopo la scissione del 1948, presiede una intuizione (se così possiamo chiamarla) che trovò larga conferma negli anni successivi: l'avere colto la reale possibilità di spazio, nel movimento sindacale italiano sorto dalle distruzioni della guerra e tra la stessa classe operaia, per una grande centrale sindacale moderata. L'anticomunismo diventava il suggello ideologico di fondo di questa operazione, il cui successo sembrava anche garantito dalla collocazione dell'Italia nell'area occidentale, nella dominante logica della guerra fredda.
Questa grande operazione moderata si svolgeva, peraltro, all'insegna di indubbi elementi di novità. Non ci si riferiva tanto ai vecchi modelli cristiano-sociali o a soluzioni di facile collaborazionismo di classe, si puntava piuttosto alla costituzione di un sindacato "moderno", "avanzato", "efficiente", che facesse della contrattazione o della competizione conflittuale fra imprenditori e forza-lavoro il centro della sua azione e del suo modo di porsi nella società. L'ambizione era quella di costruire un sindacato moderato e integrato sul piano politico generale, ma non rinunciatario sul piano contrattuale anche se la sua azione rivendicativa avrebbe dovuto esplicarsi nell'ambito dei vincoli di efficienza, di produttività, ecc. per garantire lo sviluppo "equilibrato" del sistema economico.
Un sindacato di questo tipo avrebbe dovuto essere autonomo dai padroni, dallo Stato e dai partiti politici, definendosi rigidamente a-ideologico. Completa era l'accettazione del quadro sociale esistente, del sistema capitalistico, della logica dell'organizzazione del lavoro industriale. Il comunismo era respinto come ideologia tipica dei paesi industrialmente arretrati e l'adesione alla società capitalistica (definita nei termini ideali di "società pluralista", mai curandosi di stabilire quanto esistesse in pratica di questo pluralismo) veniva giustificata o con ragioni di tipo sociologico o data addirittura per scontata. Che cosa è accaduto di queste impostazioni di fondo? La prima ambizione doveva in gran parte fallire, come conseguenza del prevalere della moderazione sul piano politico e dei vincoli assunti per l'azione rivendicativa sulla incisività e sulla ampiezza della conflittualità e del potere rivendicativo.
Lo stesso si può dire della seconda ambizione, quella relativa alla costruzione di un sindacato autonomo e a-ideologico. Fallimento dovuto soprattutto all'equivoco su cui si reggeva
Cella / Manghi / Piva
23
questo disegno: l'equivoco di considerare non ideologiche ma "scientifiche" l'opposizione al comunismo e l'adesione alla società capitalistica. Sulla base di questo equivoco, i gruppi dirigenti confederali sono riusciti per anni a fare passare il sostanziale collateralismo con la Democrazia cristiana e con i governi centristi come una deroga temporanea alla scelta dell'autonomia e non come quello che in realtà era: non solo l'abbandono dei principi di fondo ma la prova concreta del moderatismo originario della confederazione.
Questo il quadro con il quale la FIM si è più o meno identificata nel corso degli anni '50. All'inizio degli anni '60, in un ambiente reso dinamico da una congiuntura economica favorevole senza precedenti e da lotte operaie che fanno dimenticare gli anni delle sconfitte, la FIM parzialmente rinnovata negli uomini e nelle strutture comincia a differenziarsi da questo quadro. Una differenziazione che si farà, nel corso del decennio, sempre più pronunciata arrivando in alcuni momenti (le prime sperimentazioni unitarie, il Congresso confederale del 1969, ecc.) fino al limite drammatico della rottura.
Si può dire che in questo periodo la FIM raccolga le ambizioni fallite della Cisl tentando di realizzarle. La condizione per questa realizzazione è stata una profonda trasformazione nella federazione, trasformazione non sempre indolore e preceduta da mutamenti radicali nelle linee rivendicative e nella conduzione politica di alcuni sindacati provinciali delle zone più industrializzate (Milano, Brescia, ecc.). Questo periodo di rinnovamento ha il suo primo punto d'arrivo nell'Assemblea organizzativa di Novara dell'ottobre 1964: a questa data ormai esistono ben più che delle premesse per la costruzione di un sindacato industriale non rinunciatario, combattivo sul piano rivendicativo, incisivo nella sua prassi contrattuale. Questo sindacato già esiste ed opera almeno nelle zone industrialmente più avanzate.
I princìpi fondamentali in tema di autonomia e le loro attuazioni pratiche come l'incompatibilità si trasformano da ornamenti formali del "patrimonio" dell'organizzazione e da strumenti per la polemica contro le altre centrali sindacali in rivendicazioni concrete all'interno della confederazione. Per anni la FIM condurrà una battaglia insistente per l'attuazione delle incompatibilità dopo averle fin dal 1962 stabilite al proprio interno. Ma sotto l'obiettivo dell'incompatibilità occorre fin da allora leggere anche la lotta al moderatismo della dirigenza confederale e di altre strutture della Cisl, e l'esigenza di affrancarsi definitivamente da un partito responsabile da sempre della gestione moderata del potere politico.
La visione della società e dei rapporti con il sistema politico ed economico resta comunque non antagonistica nei confronti della società capitalistica e non molto difforme da quella originaria della Cisl anche se viene notevolmente attenuata la polemica anticomunista (introducendo delle distinzioni "giovannee" fra ideologia e militanti) e se alcuni presupposti dati per scontati dalla confederazione, come il carattere pluralistico della società italiana, si trasformano in obiettivi. L'autonomia dai partiti politici è vista ancora, per il momento, in chiave non competitiva verso di essi.
Resta ora da stabilire come da questa fase intermedia la FIM giunga alle posizioni di questi ultimi anni: quelle tipiche di un sindacato antagonista verso il sistema e l'organizzazione del lavoro e autonomo dai partiti politici in modo competitivo. La nostra tesi, anche se può essere accusata di notevoli forzature, è la seguente: la FIM è diventata dopo il 1968 il sindacato più direttamente "politico" (se intendiamo con l'aggettivo "politico" definire un comportamento di contestazione verso le strutture di potere e verso i tradizionali rapporti fra partito e sindacato) proprio per aver attuato fino in fondo, negli anni precedenti, il modello trade-unionista nel senso migliore del termine.
L'aver realizzato nei fatti, nella quotidiana prassi di azione rivendicativa quello che la Cisl per anni aveva relegato alla predicazione dei corsi di formazione o alle decisioni dei consigli generali "storici", e cioè l'associazione, il sindacato in fabbrica, la contrattazione articolata, l'autonomia, ha permesso di instaurare legami solidi, senza mediazioni partitiche o ideologiche, con la classe operaia, quei legami che avrebbero sempre di più accreditato l'importanza del ruolo della FIM all'interno del movimento operaio.
Ancora una volta l'ambizione originaria della Cisl (la costituzione di un sindacato integrato sul piano politico-sociale ma combattivo sul piano rivendicativo) è destinata a fallire sia pure
per ragioni opposte a quelle descritte in precedenza. Mentre per la Cisl degli anni '50 è la prima componente (il generale moderatismo) ad imporsi sulla seconda (la conflittualità e l'incisività rivendicativa), nella FIM degli anni '60 è questa ultima a imporsi sulla prima rendendo necessario un profondo rinnovamento degli atteggiamenti politico-sociali del sindacato. Da questo rinnovamento, sull'onda del ciclo di lotte iniziatesi nel 1968-69, nascerà la scelta anti-capitalistica di fondo e l'apporto della FIM al processo di costruzione del sindacato unitario.
2) La politica organizzativa
Se le scelte in tema di autonomia costituiscono un indicatore del modo di collocarsi del sindacato nella società, del suo atteggiamento verso il sistema economico ed i vincoli da esso imposti, della sua visione dei rapporti con le forze politiche, le scelte di politica organizzativa possono fornirci un quadro adeguato non solo di ciò che il sindacato è nella sua prassi quotidiana ma anche di quello che decide di essere in rapporto alla classe operaia ed alla tradizione del movimento sindacale nel suo insieme.
Anche per quanto attiene all'evoluzione delle scelte e delle realizzazioni in tema di politica organizzativa è possibile individuare, nella storia della FIM, tre periodi tipici; praticamente gli stessi che abbiamo prima descritto parlando dell'autonomia del sindacato. In effetti questi periodi tipici con le connesse fasi di svolta e di mutamento sono tali per la FIM nel suo complesso e per l'insieme delle sue politiche ed è solo per comodità di esposizione e per identificare più chiaramente le linee di sviluppo che separiamo in questa sede le scelte in tema di autonomia da quelle di politica organizzativa e queste da quelle di politica contrattuale.
Nel primo periodo (anni '50) la FIM si identifica con la Cisl ed è pienamente coinvolta nella sua politica organizzativa. Sono questi soprattutto gli anni della elaborazione di un mcdello organizzativo profondamente innovatore della tradizione sindacale italiana; l'applicazione pratica di questa elaborazione avverrà solo negli anni successivi. Nel secondo periodo (dall'inizio degli anni '60 fino al 1968-69) il rafforzarsi e il rinnovarsi della federazione si traducono in intensi sforzi organizzativi rivolti appunto alla realizzazione su scala sempre più estesa ed in modo sempre più conseguente del modello organizzativo proposto dalla Cisl. Il terzo periodo comprende gli anni dell'ultimo ciclo di lotte e rappresenta un significativo momento di "apertura" dell'organizzazione alle nuove istanze espresse dalla base e di risposta alla crisi delle tradizionali formule organizzative, travolte proprio da queste nuove esigenze di partecipazione; un momento, insomma, di de-strutturazione e di ri-strutturazione su nuovi fondamenti.

E' certo che, per quanto riguarda i rapporti con la Cisl, le svolte organizzative attuate in questi periodi non hanno provocato i contrasti drammatici che hanno fatto corona immancabilmente, invece, al dibattito sulla autonomia e sulle sperimentazioni unitarie. Ma è altrettanto certo che, in ultima istanza, è proprio sul terreno organizzativo che si può misurare oggi la massima distanza delle realizzazione della FIM dal modello originario della Cisl e soprattutto dalle sue ragioni politiche.
Questo modello originario si presentava sulla scena sindacale dall'inizio degli anni '50 con indubbie caratteristiche di innovazione. A quei tempi si trovò anche una formula (rivelatasi sempre più una "scatola vuota", buona per contenuti molto divergenti) per definire questa novità: il sindacato-associazione, con chiari intenti polemici nei confronti della tradizione sindacale italiana identificata con sindacato-movimento.
La prima conseguenza di questa impostazione organizzativa fu la sostituzione degli iscritti alla classe come punto di riferimento del sindacato e della sua azione rivendicativa. L'iscritto (il "socio" come veniva definito nelle interpretazioni più osservanti) diventava l'oggetto-soggetto della politica organizzativa, costituendo un diaframma fra l'organizzazione e la più ampia realtà di classe.
La tradizione del movimento operaio italiano veniva praticamente respinta come tipica di un ambiente arretrato dal punto di vista economico-sociale, come troppo ideologizzata e scarsamente autonoma. La tradizione viene sostituita con la concezione, con il "patrimonio" dell'associazione, da ciò
24
l'estrema importanza affidata, nella pratica organizzativa, alla formazione dei quadri.
La struttura organizzativa generale si presentava come una confederazione di sindacati fondata sull'autogoverno delle categorie. Con questa scelta si respingeva, ovviamente, il modello storico del sindacalismo britannico (i sindacati di mestiere) ma anche quello dell'esperienza sindacale italiana, imperniata sul ruolo dominante delle strutture territoriali (Camere del lavoro e confederazioni). L'esperienza a cui si riferiva era piuttosto quella nord-americana del CIO (2) in particolare.
Queste impostazioni originarie della Cisl prevedevano, infine, la realizzazione di strutture associative di base del sindacato direttamente sui luoghi di lavoro le (SAS (3)) in concorrenzacollaborazione se non in alternativa alle Commissioni interne, la struttura che costituiva da quarant'anni l'unica forma di rappresentanza operaia a livello aziendale.
Con tali scelte innovative si voleva favorire il superamento di due limiti "storici" dell'esperienza sindacale nel nostro paese: la scarsa dinamicità contrattuale e l'assenza di strutture direttamente sindacali sui luoghi di lavoro. Il primo limite si traduceva, fino ai primi anni '50, in un accentramento a livello interconfederale della contrattazione; in seguito (almeno per tutto il decennio) nel prevalere dei contratti nazionali di categoria e nello scarsissimo peso della contrattazione ai livelli inferiori. Il secondo limite (effetto ma anche causa del primo) faceva sì che le Commissioni interne si trovassero ad avere il monopolio dell'attività sindacale a livello aziendale; di qui i pericoli di aziendalismo e di integrazione, di burocratizzazione e di mancato ricambio dei quadri, ecc.
Questi limiti hanno, peraltro, mostrato una ben maggiore consistenza di quanto si era ipotizzato all'inizio del decennio, retroagendo così, anche in presenza del moderatismo di fondo della Cisl, sulla portata quantitativa e qualitativa delle innovazioni organizzative previste. Per rendere sostanziali queste ultime e soprattutto l'autonomia delle categorie e la realizzazione delle sezioni di fabbrica occorreva un sistema di relazioni industriali molto più dinamico di quello dominante negli anni '50, di quello "permesso" da un ambiente nel quale la classe Operaia era in posizione di netto svantaggio sul mercato del lavoro, la Cisl non aveva alcun interesse a trarre le conseguenze rivendicative concrete delle sue scelte organizzative, la Cgil era incapace di mediare da un punto di vista di classe queste scelte utilizzandole criticamente nel movimento.
La portata innovativa di queste scelte fu perciò, nella pratica sindacale, molto ridotta. L'autonomia delle categorie, soprattutto a livello provinciale rimase sulla carta per tutti gli anni '50 e il ruolo della confederazione, un ruolo non solo di "coordinamento" ma anche di controllo accentrato delle deviazioni dalla linea ufficiale, restò ben più ampio di quanto si era iPotizzato e bene inserito nella tradizione italiana di predominio delle confederazioni. Non molte furono le SAS concretamente realizzate e comunque tutte inserite, a livello teorico e pratico, in una visione assai riduttiva dei loro compiti, senza nessuna attribuzione di dirette responsabilità contrattuali. La formazione cadeva dall'alto, "a pioggia", senza nessuna possibilità di Partecipazione "associativa" degli iscritti, e diffondeva temi tecnici privi di alcun rapporto critico o temi economici laudativi degli effetti positivi dello sviluppo nel quadro della società "Pluralista". Anche la democrazia interna procedeva a cascata, lasciando ben pochi margini di dissenso.
Questa portata innovativa fu, con molte minori incertezze e con maggiore coerenza, realizzata concretamente dalla FIM negli anni '60. All'inizio del nuovo decennio cominciarono a venire meno i due elementi che avevano fortemente condizionato la Politica organizzativa della confederazione: il moderatismo sul Piano rivendicativo e la limitatezza qualitativa-quantitativa dell'attività contrattuale.
II rinnovamento della federazione passa attraverso ingenti sforzi di ricostruzione organizzativa. Si punta alle creazioni di forti sindacati provinciali e sulla diffusione delle SAS mantenendo viva la polemica nei confronti delle Commissioni interne. Il quadro di fondo entro il quale tutto questo si colloca è, Peraltro, ancora quello originario della confederazione: non ci si rivolge alla classe ma agli iscritti, si limitano i poteri delle sezioni aziendali alla partecipazione alle trattative e alla gestione degli accordi, ecc. Ma il quadro complessivo è reso più dinamico, meno chiuso, dal rilancio della pratica rivendicativa a livello nazionale e aziendale sia pure entro gli schemi mortifi-
canti delle clausole di tregua e di rinvio, e dalle prime significative esperienze unitarie. Il tutto verso l'obiettivo di costruzione di un "sindacato forte, efficiente, democratico"; dovrà passare ancora qualche anno ed aprirsi un nuovo ciclo di lotte prima di giungere agli obiettivi post 1968: la costruzione di un "sindacato unitario, di classe, aperto, consiliare".
La FIM rivendica pienamente all'interno della confederazione il diritto all'autonomia e all'autogoverno delle categorie, ovvero lo spazio per la sperimentazione e per la realizzazione concreta del "patrimonio" dell'associazione. Mai come nel periodo 1965-1968 i rapporti fra FIM e confederazione furono così tesi, le politiche così divergenti, i momenti di netta divisione così numerosi (sulle proposte di accordo-quadro, sull'accordo delle pensioni, ecc.). Era l'affrancamento delle categorie industriali da una leadership confederale che ritrovava la propria legittimazione, oltre che nel collateralismo con la Democrazia cristiana, nelle categorie del pubblico impiego e dei lavoratori agricoli, nelle organizzazioni territoriali del Centro e del Sud. Zone e categorie nelle quali la pratica organizzativa e rivendicativa era pesantemente condizionata dalle strutture del sottogoverno, dagli atteggiamenti filo-padronali, dalla generale arretratezza dei rapporti politico-sociali.
Se un appunto può essere fatto oggi a questo atteggiamento della FIM, non riguarda certo l'asprezza della contrapposizione alla confederazione; una tale lotta politica andava condotta senza compromessi e la radicalità ha giovato all'emergere faticoso del "sindacato nuovo" dal tessuto dominante del moderatismo. Le critiche possono essere piuttosto rivolte a quel prevalente interesse di categoria che condusse la FIM in quegli anni ad un relativo isolamento all'interno stesso delle forze della nuova Cisl (le categorie industriali e le unioni del Nord). In tal senso la FIM non ha assunto un vero e proprio ruolo di leadership di queste forze, ha coperto piuttosto un ruolo di esempio fidando nella diffusione della sua esperienza. Forse maggiore attenzione andava rivolta ai processi di crescita delle altre categorie, processi che andavano anche provocati con la polemica diretta, e alla ricerca di strategie di alleanze sul piano rivendicativo. E' l'attenzione che la FIM ha mostrato in questi ultimi anni e che mostra tuttora.
Questi sforzi di rinnovamento organizzativo non avrebbero avuto successo se non fossero stati accompagnati da una vasta attività formativa e da una efficace politica dei quadri. Con la prima si cerca di uscire dagli ambiti angusti della formazione impartita dalla confederazione, proponendo al dibattito temi di più ampio contenuto politico. Con la seconda si puntava soprattutto alla costituzione di un corpo di operatori sindacali che fosse in grado di gestire il nuovo sindacato, di guidare le lotte aziendali, di assumere insomma, un ruolo effettivo di dirigente. Si può dire che questa figura, e non solo il suo nome (come è noto nella Cgil si è chiamata sempre funzionario) sia una invenzione della FIM e della nuova Cisl. Un ruolo non di semplice esecutore: non solo un "servizio" per i lavoratori ma anche un militante accanto ad altri militanti.
Se la scelta di puntare ampiamente su questa figura può aver provocato alcuni scompensi (un certo spontaneismo nelle politiche rivendicative, difficoltà di coordinamento delle diverse zone, e altri) è certo che gli aspetti positivi sono stati molto più rilevanti: possibilità di fare crescere quadri di fabbrica e di inserirli immediatamente nel lavoro del sindacato in posizioni di responsabilità, progressivo affermarsi dell'autonomia delle strutture di lega o di zona, costituzione di spazi di mediazione sempre meno burocratici e sempre più politici agli inevitabili contrasti fra base e vertice.
Ma è negli sforzi di creazione delle SAS che è possibile cogliere insieme aì caratteri più significativi i limiti della politica organizzativa degli anni '60. Sono questi per la FIM anni di grande interesse per la fabbrica e per le strutture sindacali in esse operanti; le SAS diventano il simbolo di questo rinnovato interesse e insieme l'obiettivo più prezioso di tutti gli sforzi organizzativi. Come dicevamo, sono però ancora concepite in modo riduttivo e si stenta ad affidar loro diretti compiti contrattuali. Esiste una profonda contraddizione fra lo spazio loro attribuito nel modello associativo della federazione e i loro ridotti compiti rivendicativi.
Congress of Industrial Organizations, l'organizzazione che raggruppava tutti i maggiori sindacati industriali, nata nel 1936 dalla scissione dell'AFL (American Federation of Labor). Sezione aziendale sindacale.

25
Al contrario di quanto accade nella Cgil dove, dopo la svolta del V Congresso (1960) e degli anni immediatamente successivi, alle ampie funzioni attribuite alle Sezioni aziendali nelle elaborazioni teoriche non corrisponde un pari sforzo organizzativo per realizzarle. E' certo che la FIM, in alcune grandi fabbriche del Nord, ha buona parte delle poche Sezioni sindacali veramente funzionanti, ma è altrettanto certo che la nuova struttura stenterà a diffondersi, a imporsi non solo sul piano associativo ma anche su quello rivendicativo. Le Commissioni interne ed i sindacati provinciali manterranno quasi tutti i compiti contrattuali.
Gli anni immediatamente precedenti al 1968 vedranno un progressivo allargarsi dei compiti delle SAS, ma nel momento in cui l'ampiezza e la dinamicità della contrattazione aziendale dovrebbero creare il terreno alla loro diffusione, esse saranno letteralmente "saltate" non solo dalle tendenze del movimento ma anche dalla stessa politica organizzativa del sindacato.
Le SAS si apriranno e nel momento stesso cominceranno ad essere assorbite dalle nuove strutture: sarà uno degli indici del passaggio dall'associazione alla classe. Le Sezioni aziendali, pensate in fondo in una visione associazionistica e moralistica della "partecipazione per la partecipazione", si ritroveranno inadeguate in un periodo nel quale prevale la "partecipazione per la lotta".
Il nuovo ciclo di lotte segnerà una profonda ristrutturazione del sindacato con il sorgere dei delegati e dei consigli. Questo processo, realizzando nei fatti, alla base, il sindacato nuovo ed unito, favorirà grandemente I cammino dei metalmeccanici verso l'unità, rendendolo irreversibile. La FIM era in grado di accettare e di favorire il processo della ristrutturazione di base in quanto, se la sua politica organizzativa si mostrava per molti versi ormai superata, essa aveva, peraltro, contribuito a creare dei solidi rapporti con la base, un interesse estremo per i problemi di fabbrica, una disponibilità ad affrontare i delicati problemi della democrazia interna e della rotazione delle cariche. Il nuovo rapporto instaurato con la classe, senza mediazioni esterne al sindacato, rendeva più facile il superamento delle vecchie strutture.
L'associazione era ormai superata, ma è indubbio che con il nuovo ciclo di lotte le esigenze di partecipazione della base esprimeranno componenti sempre più "associative", sia pure in modi sostanziali e non formali ed entro strutture aperte, e sempre meno aspetti tipici del rapporto passivo fra organizzazione e "mobilitati". Una fase per la FIM era dunque chiusa; restavano però da spendere nel sindacato unitario una forte sensibilità politica per questo tipo di problemi e una notevole pratica di applicazione di questa sensibilità.
3) La politica rivendicativa
Per quanto riguarda le scelte di politica rivendicativa può risultare più difficile tracciare dei periodi di evoluzione interna alla Cisl ed alla FIM (anche se collegati con l'evoluzione del movimento sindacale nel suo complesso), in quanto queste scelte dipendono, molto più delle precedenti (in tema di autonomia e di politica organizzativa) da variabili "esterne" al sindacato: dall'andamento complessivo del sistema economico, dalla situazione del settore industriale in particolare, dai conflitti interni alla classe capitalistica, dalle politiche economiche del governo e delle altre istituzioni.
Sarebbe però semplicistico attribuire alle scelte di politica rivendicativa un mero ruolo dipendente nei confronti delle variabili economico-strutturali, un ruolo esclusivo di risposta verso di esse. Alcune scelte rivendicative determinano a loro volta un certo andamento del sistema economico; per questo, in ogni tentativo di ricostruzione delle vicende contrattuali, non va trascurato il momento della "produzione" di una certa linea rivendicativa internamente a una determinata organizzazione sindacale.
I periodi delineati per gli aspetti già presi in considerazione sono significativi anche per la politica contrattuale della FIM; sarà opportuno peraltro su quest'ultimo aspetto identificare con maggiore precisione alcune componenti costanti nell'atteggiamento della federazione, facendole precedere da una rapida descrizione del quadro politico-rivendicativo ereditato dalla Cisl degli anni '50.
Nella visione della Cisl di quegli anni la contrattazione costituiva il centro, l'essenza di tutta l'attività del sindacato, il quale, praticamente, in essa si esauriva. Questa scelta di fondo,
non priva di caratterizzazioni ideologiche (si vedano i riferimenti continui alla società "pluralista", dove i gruppi liberamente competono, contrattano, si accordano), si costituiva in alternativa ad ogni altro tipo di intervento sui problemi del lavoro dipendente: in particolar modo di quello legislativo. La contrattazione avrebbe dovuto prevedere una articolazione a livello aziendale non solo per aderire maggiormente alle diverse realtà produttive ma per garantire uno sviluppo equilibrato del sistema economico.
Nel complesso vi era una piena accettazione di tutti i vincoli di efficienza e produttività; la contrattazione avrebbe dovuto sottostare agli imperativi dello sviluppo economico considerato sempre in modo tecnico e neutrale. La politica salariale doveva subordinarsi agli incrementi di produttività realizzati, sia pure non di quelli a livello generale nel sistema ma a livello settoriale o delle singole aziende. I contenuti di tipo normativo avevano uno spazio notevole, ma vi era un pieno riconoscimento del ruolo e delle prerogative imprenditoriali, e dunque non si praticava in nessun caso un'ottica di "contestazione" delle strutture aziendali.
L'ambizione (è il caso di usare tale termine anche in questo caso) era quella di arrivare alla realizzazione di un sistema di relazioni industriali estremamente elaborato e articolato che, senza nessun intervento legislativo, attraverso una adeguata rete di rinvii ai diversi livelli negoziali garantisse non solo un andamento dinamico della contrattazione ma anche un equilibrato ed armonico sviluppo economico nella necessaria "pace sociale". Lo sciopero viene considerato come una "azione straordinaria" da intraprendere dopo aver esperito le vie permesse dai vari strumenti di regolazione (non obbligatoria) del conflitto: arbitrato, conciliazione, comitati misti, ecc. Negli anni '60 questa impostazione giungerà a prevedere opportune "armonizzazioni" fra azione rivendicativa e piano economico e a proporre un "accordo quadro" che avrebbe dovuto regolare per via contrattuale tutti questi vincoli, questi rinvii, ecc. Abbiamo già descritto nelle pagine precedenti le implicazioni ideologiche di queste scelte di politica rivendicativa e le loro premesse e conseguenze sul piano organizzativo. Ricorderemo solo come il moderatismo di fondo della confederazione e i vincoli accettati o addirittura ipotizzati nello svolgimento dell'attività negoziale non permettevano l'esprimersi reale della indubbia portata innovativa di alcune componenti di questa impostazione rivendicativa, prima fra tutte la contrattazione articolata. La situazione economica degli anni '50 non favoriva, inoltre, alcuna pratica innovatica di grande significato nel campo delle relazioni industriali.
Il quadro delle relazioni industriali in questo decennio riflette sia queste contraddizioni interne al movimento sindacale (e non solo nella Cisl ma anche nella Cgil, incapace di innovare radicalmente la propria prassi rivendicativa nonostante il riconoscimento, fin dal 1955, della necessità di sostanziali cambiamenti) sia la posizione di relativa debolezza della classe operaia nel sistema economico-politico.
Fino al 1954 la contrattazione avrà luogo pressoché esclusivamente a livello interconfederale con un conseguente forte contenimento degli incrementi salariali; dopo questa data la situazione cambierà e le federazioni di categoria acquisteranno la prerogativa effettiva di contrattare a livello nazionale, ma le articolazioni a livello aziendale saranno solo un fatto sporadico e notevolmente compromesso dalla pratica degli accordi separati.
E' possibile individuare nella politica rivendicativa della FIM degli anni '60 delle componenti costanti, dei punti particolari di attenzione e di impegno organizzativo che assumeranno tuttavia forme, accenti, significati politici, diversi al variare della situazione economica, della composizione prevalente di classe, delle caratteristiche della base organizzata e delle sue concrete possibilità di partecipazione e di decisione nelle strutture del sindacato, della portata delle sperimentazioni unitarie.
Queste componenti costanti possono essere identificate nelle seguenti:
A) Privilegio della contrattazione su ogni altro strumento di intervento in tema di rapporti di lavoro.
Questo atteggiamento passa dal contrattualismo rigido ed esclusivo dei primi anni del decennio, di stretta osservanza Cisl, alle posizioni più sfumate del 1965-66 quando si comincia ad affrontare il tema dell'intervento legislativo e della legislazione di sostegno all'attività contrattuale. Il privilegio concesso alla

26
contrattazione (il pan-contrattualismo come diranno molti critici) resta comunque una caratteristica di fondo della FIM, anche se nel corso del decennio l'attività contrattuale sarà concepita e portata avanti sempre più come strumento di controllo-contestazione, in taluni casi addirittura sostitutivo di una carente iniziativa delle forze politiche, e sempre meno come strumento di competizione equilibrato e codificato.
II luogo ottimale per lo svolgimento dell'attività contrattuale è considerato il livello aziendale.
E' certo che la FIM in tutto il corso della sua esperienza non ha mai avuto incertezze riguardo all'estrema importanza del livello aziendale nell'attività contrattuale, incertezze così comuni invece, sia pure con accenti diversi, all'interno di altri sindacati e soprattutto della Cgil. L'azione a livello aziendale viene condotta inizialmente nell'ottica dell"'articolazione", aderendo così non solo all'impostazione originaria della Cisl ma anche alla struttura contrattuale dominante nella prima metà del decennio; in seguito assumerà sempre più un carattere autonomo, e in • alcuni casi di anticipazione, rispetto alla contrattazione nazionale.
Prima dell'avvio dell'ultimo ciclo di lotte, trovarono un certo spazio nella FIM, come in buona parte della Cisl, discorsi relativi alla trasformazione della struttura contrattuale italiana allora ancora dominante (contratti nazionali con articolazioni a livello aziendale) attraverso l'introduzione di contratti aziendali integrali, sostitutivi di ogni altra regolamentazione, sul modello nord-americano. Questi discorsi non ebbero tuttavia un grosso seguito e non trovarono nessuna applicazione pratica. Da questo Punto di vista, è certo che fu salutare la posizione critica della FIOM con il suo ruolo di difesa "storica" della contrattazione nazionale.
Forte caratterizzazione politica della azione e della partecipazione dal basso, dell'impegno rivendicativo nella fabbrica. L'azione a livello aziendale non è privilegiata solo per quanto attiene agli aspetti tecnico-contrattuali; essa conquista, nella visione e nella pratica della FIM, sempre più ampi significati Politici. Una progressiva caratterizzazione politica necessaria per un sindacato che, affrancandosi dal moderatismo originario, Puntando prevalentemente sull'incisività della propria azione rivendicativa e sulla capacità organizzativa, intende affermare senza la mediazione di partiti o di legami tradizionali con la Classe operaia un proprio autonomo ruolo politico.
Si Passerà da una posizione che individua questi significati Politici soprattutto nella "crescita" associativa degli iscritti e nel miglioramento della qualità della sindacalizzazione, a una Posizione che esalta l'impegno a livello aziendale in quanto azione nel centro motorio della società capitalistica, azione che unisce al massimo di incisività, il massimo di potere della base in lotta e che permette il superamento di ogni distinzione fra azione economica e azione politica. E' una scoperta progressiva della centralità politica della fabbrica, che procede fianco a fianco, anche se in lieve ritardo, a quella riscoperta della fabbrica che, negli anni '60, si diffonde nella sinistra del socialismo europeo e nelle sue espressioni sindacali (si pensi, per I Italia, al gruppo di "Quaderni Rossi" e agli ambienti della Cgil di cui sono stati espressione dirigenti come Vittorio Foa e Sergio Garavini).
Tendenza a intervenire nel vivo dell'organizzazione azien- dale.
Questa :tendenza si manifesta inizialmente in modo tecnicoProduttivistico (sia pure in chiave conflittuale), negli ultimi anni in forme di critica-contestazione della organizzazione capitalistica del lavoro. Quello che vi è in comune fra queste posizioni così diverse come portata politica, è la volontà di collegarsi alla realtà tecnico-organizzativa delle aziende per concretizzare e rendere dinamico l'impegno rivendicativo, per trasformarlo in una azione di controllo.
Da questo punto di vista nessuno contesterà meglio il cottimo, sia politicamente che tecnicamente, di chi per anni l'ha contrattato rendendolo più rimunerativo, più legato alle mansioni concrete, ecc. Nessuno avvertirà di più la necessità di esprimere rivendicazioni alternative ai criteri padronali di Produttività, di chi aveva fatto di quest'ultima un mito "neutrale", un terreno di conflitto ma anche di incontro con la controparte, contrattando per anni i premi di produzione collegati ai cosiddetti "parametri obiettivi". Nessuno comprenderà meglio le ragioni di crisi del sistema di qualifiche, di chi
aveva percorso fino in fondo la strada dell"'oggettivazione" della qualifica nella mansione, contrattando e sollecitando l'introduzione dei piani di job evaluation.
Privilegio dei contenuti normativi rispetto a quelli puramente salariali.
Nella FIM le rivendicazioni di tipo normativo sono state considerate, in ogni caso, qualitativamente superiori a quelle salariali. Non sono mai state presenti elaborazioni che facessero del salario il nucleo centrale dell'azione di classe. Tutto ciò ha forse fatto trascurare le caratterizzazioni tipicamente economiche del conflitto fra capitale e lavoro, ma ha, in compenso, preservato dai rischi dell'economicismo volgare, ricorrente in modo ciclico in tutte le componenti del movimento operaio. L'attenzione della FIM per questo tipo di rivendicazioni, pur rimanendo costante si è accentrata su contenuti diversi. Se, negli anni che vanno dal 1963 al 1966, i "diritti sindacali" sono stati al centro di tutte le impostazioni rivendicative (era il momento di affermare la presenza del sindacato in fabbrica), dopo questo periodo i contenuti più direttamente connessi alla condizione di lavoro (revisioni delle classificazioni, parità normativa, ecc.) hanno avuto la prevalenza. Nel primo periodo, nell'ottica del "rafforzamento dell'associazione", si sollevò nella federazione il problema della stipulazione dei contratti per i soli iscritti (in chiaro riferimento alle esperienze trade-unioniste in tema di "privilegi sindacali"), peraltro, nonostante l'autorevolezza di alcuni dirigenti sostenitori di questa tesi e l'ammissibilità della stessa nella tradizione "associativa" della Cisl, questi discorsi trovarono scarso seguito e nessuna rilevante applicazione concreta.
Disponibilità a individuare i problemi rivendicativi di gruppi particolari di lavoratori.
Questa disponibilità si è tradotta nella "scoperta" di gruppi come gli impiegati (in tutto il corso del decennio) o gli operai comuni (nell'ultimo ciclo di lotte), e di prassi rivendicative conseguenti. Per quanto riguarda gli impiegati, questa scoperta ha favorito il superamento, sia pure parziale, del circolo chiuso in cui si dibatteva il problema della sindacalizzazione di questi gruppi di lavoratori: scarsa partecipazione alle lotte — abbandono in sede di trattativa dei contenuti rivendicativi interessanti la forza lavoro impiegatizia — conseguente impossibilità di sindacalizzazione.
L'attenzione per questi problemi può essere stata facilitata, all'inizio, dall'assenza nella FIM di una consolidata ed omogenea visione di classe; è indubbio però che ha permesso la comprensione delle trasformazioni qualitative della forzalavoro. L'affermarsi progressivo di una visione di classe, favorita anche da una pratica unitaria sempre più intensa con la Fiom-Cgil, se ha portato la FIM a una maggiore valutazione delle omogeneità insite nella condizione lavorativa, non ha impedito tuttavia di mantenere questa disponibilità e questa duttilità rivendicativa. Nel corso delle lotte degli ultimi anni tutto ciò ha permesso alla FIM di cogliere adeguatamente il significato politico emergente dalla nuova combattività rivendicativa di gruppi come quello degli operai comuni.
Rifiuto di ogni forma di centralizzazione e di coordinamento forzato della attività contrattuale.
Durante tutti questi anni la FIM non ha mai rinunciato alla propria autonomia rivendicativa in nome del coordinamento più meno forzato, della necessità di rendere più regolamentare ed equilibrate le relazioni industriali nel nostro paese, ecc. Questa "deviazione" dal modello originario della Cisl, si tradusse sul piano politico nella decisiva avversione alle proposte di accordo-quadro avanzate con particolare insistenza dalla confederazione attorno alla metà del decennio e non sgradite alla Confindustria. Opposizione che diede un contributo non indifferente (unendosi all'altrettanto deciso no della Cgil) al fallimento di questa proposta di blocco sostanziale dell'autonomia rivendicativa.
In seguito non sono però mancate alla FIM, da parte di vari settori (partitici e sindacali) del movimento operaio, accuse più meno velate relative alla scarsa considerazione dimostrata dalla federazione nei confronti dei problemi più generali del sistema economico. Accuse, insomma, di operaismo (un'altra delle eresie di cui i meccanici Cisl sono stati tacciati). Critiche che non hanno tenuto conto di come la FIM, da questo punto di vista, proprio per la sua autonomia e per il tipo di rapporti instaurato fra organizzazione e classe, non potesse che essere un

n a a e
27
sindacato "operaista", se con questo termine si intende definire un sindacato che esprime direttamente ed esclusivamente le esigenze della propria base organizzata. Ed è allora da dimostrare se questo ruolo, pur nei suoi evidenti limiti politici, non abbia avuto un effetto positivo in un movimento operaio troppo spesso alla ricerca della mediazione, fra i diversi interessi particolari, fra il particolare e il generale, fra classe operaia e classe media, fra l'economico ed il politico, fra la prospettiva a breve e quella a lungo termine, ecc. ecc. Una ricerca che non si traduce sempre in linee politiche, ma che sfocia talvolta nella ricerca della mediazione per la mediazione.
Applicazione di metodi di lotta e di conduzione delle vertenze innovativi nella tradizionale prassi sindacale. La natura "associativa" originaria della FIM ha indubbiamente favorito la ricerca e l'applicazione di metodi di lotta che, come gli scioperi articolati o a singhiozzo, innovavano una prassi di azione sindacale troppo ancorata a metodi di lotta generali e indifferenziati. In questa direzione l'esempio delle migliori esperienze trade-unioniste nei paesi a capitalismo avanzato ha insegnato non poco alla FIM. Si pensi anche alla tradizione diffusa nella nostra esperienza di sospendere le agitazioni nel corso delle trattative che, saltata nella prassi sindacale unitaria dei metalmeccanici del 1969 in avanti, fu dalla FIM contestata fin dal contratto del 1966 causando una breve, ma significativa, rottura con la FIOM.
Rifiuto della tradizionale divisione dei compiti fra confederazioni e sindacati di categoria.
Questo rifiuto, manifestatosi all'inizio in forma negativa (il momento dell'affrancamento dalla matrice originaria della Cisl), ha progressivamente assunto un senso positivo traducendosi non solo nell'interessamento diretto della federazione su temi considerati tipici delle strutture orizzontali (i problemi dell'ambiente, della assistenza e della sicurezza sociale, ecc.) ma anche nella scelta della autonomia di giudizio e di comportamento nei confronti delle decisioni confederali (si pensi al primo accordo sulle pensioni, siglato dalla Cisl e respinto dalla FIM, che partecipò in molte province a scioperi unitari con gli altri sindacati metalmeccanici).
Questo atteggiamento nei confronti delle strutture orizzontali contribuì non poco alla modificazione di quei rapporti di sostanziale subordinazione dei sindacati di categoria alle strutture orizzontali che, così tipici della tradizione sindacale italiana, si erano andati rafforzando nel corso degli anni '50 (in anni nei quali la forza contrattuale autonoma delle categorie era molto debole) ma continuavano a mantenersi, sia pure come residuo, anche nel corso del decennio '60. Esso inoltre, permise ai meccanici l'apertura a temi di portata politica più generale, rimasti per anni monopolio del moderatismo della confederazione; si pensi infatti a temi come: il giudizio sulla società capitalistica, il problema della pace nel mondo, ecc.
Aver messo in luce queste componenti costanti negli atteggiamenti e nei comportamenti rivendicativi della FIM, non vuol dire certo aver delineato delle linee precise di evoluzione, ma solo aver individuato gli spazi entro i quali è variata l'esperienza della federazione. D'altra parte su molti aspetti è piuttosto difficile parlare di evoluzione, è più esatto parlare di salti, di bruschi mutamenti. Non si è voluto dunque razionalizzare ex post questi salti e questi mutamenti, ma solo esprimere una tesi sull'esperienza rivendicativa della FIM degli anni '60: una progressiva sperimentazione di alcuni temi, la presa di coscienza del significato politico di obiettivi considerati in precedenza in modo tecnico e neutrale, l'assunzione di nuovi e più qualificati obiettivi sulla base di questa sperimentazione e di questa presa di coscienza o sulla base dei solidi ed immediati rapporti instaurati con la classe operaia. Questa tesi, crediamo, permette di comprendere, senza ricorrere a facili stereotipi od etichette, la particolarità dell'esperienza della FIM nelle diverse fasi delle
relazioni industriali del decennio trascorso ed il significato e la portata del suo contributo alla costruzione del sindacato unitario.
Occorre, però, per chiarire maggiormente questa tesi, descrivere brevemente il ruolo giocato dalla FIM nel corso del ciclo di lotte iniziatosi nel 1968-69. E' infatti su questa "esplosione" di combattività operaia e sulle sue influenze verso i comportamenti della FIM che sono più diffuse interpretazioni inesatte o semplicistiche, inesatte come quelle che si rifanno ai vecchi modelli del "sindacalismo rivoluzionario", semplicistiche come quelle che interpretano la FIM come il "sindacato degli operai comuni".
All'inizio di questo periodo di lotte una serie di elementi relativi al sistema politico (crisi definitiva del centro-sinistra e della programmazione), al sistema politico-culturale (la contestazione studentesca, la critica diffusa verso la scienza e la tecnologia), al sistema economico (la favorevole congiuntura e l'affermarsi di un modello di sviluppo trainato dalle grandi aziende a produzione di massa), alla composizione di classe (la presenza consolidata di una forza-lavoro comune con caratteristiche di giovane età e di provenienza non settentrionale-industriale), al mercato del lavoro (situazione di relativo maggior potere I dell'offerta) agisce in un momento nel quale la FIM si trova ad aver portato fino in fondo (o, meglio, fino al concretamente realizzabile) il proprio modello rivendicativo ed associativo.
Da una parte è dunque possibile, in una nuova situazione economica e politica, cogliere tutti i limiti politico-rivendicativi di questo modello, dall'altra, pur con tutti questi limiti, esso fornisce una ottima disponibilità all'interpretazione del nuovo emergente da una azione di classe, senza mediazioni esterne di carattere ideologico od organizzativo.
Da questo punto di vista la FIM è stata il sindacato degli operai comuni non tanto, almeno all'inizio, per una diversa composizione della base organizzata rispetto alle altre federazioni metalmeccaniche, quanto per la maggiore possibilità di espressione e di partecipazione concessa a questi gruppi operai ed alle loro istanze rivendicative dalle strutture organizzative della FIM, autonome non solo in senso formale ma anche sostanziale. Le indicazioni ugualitarie, la contestazione alla linea rivendicativa tradizionale sui cottimi e sulle qualifiche, la lotta contro l'organizzazione capitalistica del lavoro saranno recepite dalla FIM e costituiranno la base per la nuova politicizzazione che essa andava ricercando. La posizione di autonomia all'interno del movimento operaio renderà più facile la comprensione non solo della crisi della tradizionale divisione del lavoro fra partito e sindacato ma anche della necessità di dare direttamente uno sbocco politico positivo a delle esigenze di classe da troppo tempo o represse all'interno di un'ottica sindacale meramente difensiva o relegate nell'attesa di una società futura. Da queste indicazioni e da questa comprensione è possibile trarre il significato politico dell'apporto della FIM al processo di unità di classe.
Processo che è andato progressivamente maturando nel corso del decennio '60 passando dalle prime (e coraggiose) sperimentazioni unitarie del 1960-1963, al periodo intermedio dell'unità d'azione e degli interminabili dibattiti sulle possibilità . 1 di realizzazione della unità organica, fino alla fase attuale di costruzione del sindacato unitario come risposta delle organizzazioni di classe a un'unità sindacale che già esiste alla base, nelle fabbriche, attraverso strutture unitarie per essenza come i Consigli. Processo nel quale la FIM ha sempre creduto e con il quale essa è cresciuta in tutti questi anni. Il suo apporto all'unità è misurabile solo sulla base di quanto essa vi ha coinvolto: tutta la propria esperienza. E' stato detto che la FIM di oggi non ha padri, non ha tradizioni: forse è vero, ma una cosa è certa; il significato politico dell'esperienza della FIM (per quello che essa è stata) sul piano dell'autonomia, della politica organizzativa, della politica rivendicativa, avrà un futuro nel sindacato unitario.

28
Piero Craveri
Sindacato e istituzioni
Venti anni fa, qualcuno certamente se lo ricorderà, i socialisti si e avviarono al giro di boa del centro-sinistra masticando un ri vecchio distico teorico, che già da un secolo travaglia tutta la vicenda del movimento operaio italiano e europeo, quello di riforma o rivoluzione. Venti anni dopo, usciti dalla leggenda, ii nella prassi della nostra vita sociale e politica vediamo affermati due contradditori metodi di lotta politica: neocorporativismo e terrorismo.
ii e a o a e o n o e e il à
Accanto ad essi brancolano come fantasmi due diversi modelli Ideali agitati da parti opposte, in modo più o meno fraudolento: neoliberismo e neo-riformismo.
Alcuni fatti sono troppo noti per essere qui riassunti. Altri restano ignoti, mancano soprattutto le riflessioni adeguate. Certo è che quel po' di tradizione statuale europea di origine unitaria, che per anni era sopravvissuto, fu come ingoiata nel tessuto connettivo della nuova Repubblica. Credo infatti vada tenuto presente che quando parliamo di Stato, o meglio vociferiamo intorno allo Stato, come in queste ultime settimane, ci riferiamo in primo luogo allo Stato liberale europeo, modello secolo XIX. In secondo luogo a quella decisiva modifica di esso, che prese la sua forma definitiva a seguito della grande crisi, negli anni '30, dopo lunga incubazione, che è lo Stato pluriclasse democratico di massa.
Questo modello di stato, come è noto, ha implicato un mutamento profondo dei rapporti tra stato e mercato, in Particolare una modifica dell'intervento dello stato sulla domanda effettiva nelle sue variabili dell'investimento e del consumo. Per quel che ci interessa, rovesciato così il postulato del rapporto inversamente proporzionale tra salario reale e occupazione, divennero possibili politiche di crescita del salario nominale, compatibili con obiettivi di piena occupazione. L'azione sindacale da fattore esogeno, frizionale del sistema di equilibrio neoclassico, diveniva elemento funzionale del nuovo modello politico economico. Il sindacato entrava così a far Parte integrante del sistema istituzionale con un suo ruolo socio-economico definito. Il diritto al lavoro, che costituiva il principio costituzionale del nuovo modello di stato, anche se formulato esclusivamente al livello di costituzione materiale, operava quindi, non tanto come principio giuridico, ma come Postulato politico attraverso questa nuova interazione tra Stato, capitale e sindacato.
Questa interazione si fondava su tre regole:
a) l'intervento diretto dello Stato e del sindacato viene attuato nella sfera della distribuzione e non in quella della produzione; ciò implicava il pieno riconoscimento del potere autonomo del Management, principio che si affermava sia nei sistemi privatistici puri sia in quelli misti, in cui la regola dell'intangibilità della proprietà privata dei mezzi di produzione veniva integrata con una teoria unitaria dell'impresa;
b) attuata così la convivenza fra diritto al lavoro e diritto alla giusta retribuzione da un lato, e libertà di impresa dall'altro, determinato in quest'ambito il ruolo istituzionale del sindacato, si operava nel contempo una modifica sostanziale dei sistemi Politici.
L'istituzionalizzazione del ruolo del sindacato si accompagnava
all'assunzione nel sistema politico dei partiti del movimento operaio con partiti di governo. Il modello delle politiche di patto sociale, che non è di oggi, ma ha cinquant'anni di esperienze nei paesi a capitalismo maturo, nasce e si sviluppa su questo fondamento politico. Il patto sociale implica che lo Stato vi svolga un ruolo centrale. Perciò i suoi soggetti istituzionali, a sinistra, sono stati sempre insieme il partito e il sindacato. Il partito come partito di governo e del sindacato, il sindacato come sindacato del partito. Ma il soggetto primario del patto sociale è il partito. Il patto sociale è un patto politico-costituzionale, anzi è per eccellenza un patto costituzionale del moderno stato pluriclasse democratico di massa (come e perché questo patto sia mancato all'atto della costituzione del nostro ordinamento repubblicano e non si sia verificato nel trentennio successivo si potrà dedurre da quanto segue);
c) l'alternanza da regola formale si trasformava in principio sostanziale della democrazia rappresentativa. Ma davvero crediamo, per un insipiente eccesso di formalismo costituzionale o per una implicita riserva di stampo bolscevico-staliniano, che il principio dell'alternanza è sempre stata la regola aurea della democrazia rappresentativa, che il suo modello storico è stato quello del liberalismo inglese del sec. XIX, la contrapposizione tra Whigs e Thirues, tra liberale e conservatori? Una cosa è l'alternanza in uno stato monoclassista, un altro in uno stato pluriclassista. Una cosa è l'egemonia di una classe (la borghesia il proletariato) in uno stato monoclassista, un'altra cosa è in uno stato pluriclassista. Alternanza e egemonia sono poi ancora principi diversi. L'alternanza democratica ha implicato finora la convivenza di due garanzie politico-costituzionali: l'irreversibilità di politiche volte alla concreta realizzazione del diritto al lavoro e la libertà di impresa, con i connessi poteri e diritti proprietari. L'egemonia implica sempre e comunque l'assolutizzazione di uno di questi due principi. E' l'inverso del patto costituzionale.

Negli anni '30 non tutti i paesi europei approdarono a questo modello di stato. L'Inghilterra ci arrivò definitivamente nel dopoguerra col governo di Lord Attlee, la Francia fallì l'esperienza del Fronte Popolare, essa rimane a tutt'oggi uno stato democratico pluriclasse ad egemonia borghese, la Spagna ebbe la guerra civile, la Germania e l'Italia, misero a punto un'altra soluzione, quella del corporativismo fascista. Il caso della Germania richiede altre riflessioni.
Il fascismo italiano mise a punto, con notevole perizia istituzionale e politica, uno stato pluriclasse non democratico ad egemonia borghese.
Esso poggiava infatti su un rapporto privilegiato tra Stato e capitale, con il sindacato relegato a una funzione meramente amministrativa. I corollari di questo schema sono noti. Ricordiamo tre conseguenze, che segnano differenze strutturali profonde rispetto al modello democratico a cui abbiamo accennato: riduzione dei salari monetari, livelli di occupazione garantiti attraverso la separatezza del mercato del lavoro agricolo da quello industriale, stagnazione economica.
L'ordinamento dello Stato repubblicano, che succedeva a quello fascista, affidava al sindacato il ruolo istituzionale di contraente
la Relazione tenuta
o e ii iio ie 3i
al convegno di "Fabbrica Aperta" - Roma, 11 maggio 1978
/i a e 31 li 3a ii 31 e d
a 29
salariale. Ma, a livello della costituzione materiale, l'originario schema fascista fu assicurato, rompendo ogni rapporto politico-istituzionale tra Stato e sindacato. Ne sono derivati, almeno fino alla metà degli anni '60, due modelli di azione sindacale, che per comodità denomineremo Cgil e Cisl. Nella Uil può forse trovarsi l'embrione di un diverso modello. Esso non ha tuttavia mai preso forma definitiva. Questa impotentia partoriendi è certamente connessa al rapporto della Uil con il movimento socialista e i partiti di democrazia laica, formazioni politiche tutte, nel nostro sistema politico, sostanzialmente subalterne alle due forze maggiori, DC e PCI.

Modello Cgil
Lo analizziamo attraverso due relazioni: sindacato-classe operaia e sindacato-Stato nella prima il modello è perseguito (tuttora, anche se il "neo" implica tutta una serie di variabili) è neoleninista; nella seconda il modello è democratico.
Quanto al modello neoleninista ci sono aspetti troppo noti per essere qui tratteggiati: cinghia, accentramento contrattuale, prevalenza dell'organizzazione orizzontale, del quadro militante, centralismo democratico. Ci riferiamo solo ad un aspetto più propriamente ideologico-politico che certamente caratterizzò la Cgil degli anni '50 e che tutt'ora ha il suo peso. L'essenza neoleninista del modello Cgil sta nel postulare il sindacato e il partito come organizzazioni della classe e in quanto tale momento di separatezza tra classe e Stato. La classe si organizza anzi si manifesta come classe, fuori dallo Stato attraverso il partito e il sindacato. Saranno poi il partito e il sindacato a rappresentare la classe nello Stato. Ciò implica il principio ideologico e politico del monopolio della rappresentanza di classe da parte del partito e del sindacato. Principio diverso dalle organizzazioni che si dichiarano di classe, in quanto rappresentano una parte o la totalità della classe organizzata, ma non fondano questa rappresentanza su un postulato ideologico-politico, ma sul consenso di massa all'organizzazione, iscrizioni, partecipazione, adesione all'azione programmata dall'associazione sindacale.
PCI e Cgil scandiscono così il momento della separatezza della classe dallo Stato. L'unicità del loro mandato rappresentativo le abilita a un rapporto di scontro o di collaborazione con lo Stato, presieduto dal principio del primato della politica come, non a caso, di recente alcuni pubblicisti comunisti detti erroneamente operaisti, hanno teorizzato.
Veniamo così all'altro termine relazionale, il rapporto sindacato-Stato. Rapporto dominato anch'esso dal postulato del primato della politica. Si è detto che il suo modello è stato sostanzialmente democratico. In un'eccezione precisa però.
Quella di una costante ricerca di intese unitarie con le altre forze sindacali e politiche ai fini di un riflesso del partito e del sindacato nel quadro delle istituzioni pubbliche di governo, come organizzazioni rappresentative della classe.
Qui riscontriamo motivi di affinità profonda con il modello dello Stato pluriclasse democratico di massa, che abbiamo sommariamente descritto, e con il ruolo svolto per la sua realizzazione dai movimenti operai di ispirazione laburista e socialdemocratica, ma anche profonde differenze. Come si è accennato, in altri paesi il movimento operaio ha espresso forze politiche che non erano solo portatrici dell'esigenza e necessità di essere forze di governo ai fini della convivenza civile e dell'ordine sociale, ma anche di un nuovo modello di Stato, di una nuova politica economica volta ad obiettivi di piena occupazione.
Questa domanda politica ha implicato la trasformazione dello stesso equilibrio istituzionale, l'introduzione di nuove garanzie costituzionali, oltre al mantenimento di quelle più antiche, con la pura e semplice modifica del sistema politico e con essa l'accettazione e la conferma di tutte le regole esistenti del gioco. Dei comunisti italiani, per quanto possa sembrare un paradosso, sappiamo poco. Al di là dei commenti giorno per giorno o di alcuni sommari e generalissimi metri di giudizio, quali le analisi in profondità sulla politica economica, delle istituzioni, del lavoro?
Qui solo un'osservazione ulteriore. I comunisti non hanno mai operato per un processo di transizione nel capitalismo, che è stato il contributo storico delle socialdemocrazie. Dire che non hanno neppure operato per una transizione al socialismo è una ragione poco rassicurante.
E' certo comunque che tra i modelli possibili di Stato, a cui si poteva far riferimento il realismo comunista ha scelto lo Stato e il sistema economico così quali essi sono, al culmine della loro putrefazione neocorporativa, in omaggio al principio che pone prima il problema dell'accesso al potere e poi quello della gestione politica.
Ma l'incontro con lo Stato clientelare, neocorporativo, non è il prodotto di una fatalità storica che vede il ritorno dei comunisti nell'area di governo,. solo dopo trent'anni di malgoverno democristiano. La degenerazione di questo Stato e di questa nostra società, è stata consapevolmente vissuta dai comunisti (come anche dai socialisti) sui banchi -della opposizione. Togliatti più di una volta ne fece oggetto di denuncia, sottolineò la continuità di essa con i presupposti strutturali costruiti dal fascismo negli anni '30. Ma diversamente da Gramsci, e bisognerebbe incominciare a confrontare Togliatti a Gramsci, egli concepì questa degenerazione come il terreno storicamente necessario di incontro dei comunisti con le altre forze politiche.
La disgregazione dello Stato ed il suo trapasso in un sistema di potere della DC, esalta il partito comunista come forza politica e sociale diversa, esterna allo Stato, ma proprio per questo capace di portare un supporto indispensabile allo Stato. Così il "compromesso storico" come incontro tra il PCI e la DC+Stato si configura come una pseudo-teoria dello Stato.
Questa è l'illusione di molti democratici liberali e socialisti. Questo è il timore, non gratuito, di molti conservatori e progressisti, e cioè che per questa via passi l'egemonia politica dei comunisti nello Stato, per non essere ipocriti, sulla DC.
Modello Cisl
In breve, poiché anche qui tutte le caratteristiche politico-sindacali sono note, una sola osservazione. E' sempre mancata alla Cisl una concezione dello Stato. Di qui una totale subordinazione del modello Cisl al sistema di potere democristiano. Ricordiamo di quest'ultimo soltanto il metodo della stratificazione del consenso, attraverso la divisione microstrutturale dei poteri, la mediazione politica che ne derivava come mediazione degli interessi particolari, e il conseguente concetto di iniziativa politica, non come individuazione dell'interesse generale, ma come somma di interessi particolari. Tutte analisi note. Conosciuti e analizzati anche gli effetti sull'apparato istituzionale, sulle strutture finanziarie, sul mercato del lavoro, sul sistema dei redditi. Negli anni delle vacche grasse, o meglio pasciute, si è venuta creando in Italia una costellazione di spazi di contrattazione tra loro distinti. Tra i soggetti contraenti c'è stato anche il sindacato. Non vogliamo ridurre il contrattualismo Cisl a questa filosofia neocorporativa, anche se in alcuni settori di quell'organizzazione tale è stata e non altro.
Vogliamo sottolineare che il contrattualismo, nella sua accezione migliore, quella tradeunionistica, presuppone per essere un metodo corretto di dinamica sociale, un sistema di garanzie politiche ed economiche che sono venute a mancare nel contesto italiano, e che un'organizzazione come la Cisl non ha mai veramente assunto come necessarie.
Se il metodo della Cgil è stato quello della separatezza, quello della Cisl è stato quello dell'identificazione col sistema politico, se l'obiettivo della Cgil è stato quello della egemonia di classe, come egemonia comunista, quello della Cisl è stato quello del pluralismo sociale, come rafforzamento istituzionale degli spazi di contrattazione particolare.
Vero è anche che la Cisl è stata l'organizzazione sindacale che ha vissuto più drammaticamente i grandi traumi dell'ultimo decennio. La sua filosofia politica originaria era troppo legata alla fenomenologia del potere propria dell'integralismo cattolico, per evolvere compiutamente in una concezione nuova dello Stato e del sistema economico e sociale.
Ma le grandi lotte sociali dal '69 in poi hanno determinato fratture non più rimarginabili nel vecchio sistema di mediazione interclassista. Su queste fratture il PCI ha costruito il volano della sua irresistibile ascesa, facendo del sindacato la valvola del suo potere separato nella società.
La Cisl si è trovata via via ad approfondire la sua logica degli spazi distinti. Ed è emersa all'interno di essa una variante logica tramutando uno di questi spazi distinti quello del settore produttivo in spazio generale di contrattazione, o meglio in sede
30
di uno scontro generale e politico, non più circoscritto o circoscrivibile nelle maglie di una strategia interclassista o neocorporativa ha determinato una frattura insanabile nella vecchia filosofia della Cisl senza peraltro crearne una nuova. La strategia sociale senza una corrispondente strategia politica è destinata alla sconfitta. Questo nel medio termine è più vero che non l'inverso. Tutte le obiezioni che da sinistra si fanno al PCI in questo senso lo vedono dunque per il momento vincente, Perché quella comunista è una strategia politica. Oltre ai profondi legami con la DC e il mondo cattolico che ancora determinano il collateralismo della Cisl, si intende così come essa vede il suo riferimento politico nell'orbita DC come una necessità vitale di sopravvivenza e ciò in assenza di un referente socialista, che è, per naturale destinazione e fede di molti, il problema drammatico della Uil.
Quindi per concludere ancora un cenno è necessario sulla DC. Come si è accennato l'integralismo che è stata la vera essenza del partito cattolico, e che si è espresso attraverso la sua identificazione con lo Stato, ha trovato il suo metodo di azione Politica, attraverso la stratificazione sociale e istituzionale degli interessi sociali, così da svuotare la società delle due spinte conflittuali, la lotta politica di quella dialettica che la rap, senta e compone in sintesi generale, l'integralismo cattolico dunque, ha perso la sua egemonia sociale e politica nell'ultimo decennio, in presenza di due fattori: la conflittualità sociale e l'emergenza politica del PCI.
II fattore primario non esorcizzabile è stata la conflittualità sociale; il fattore derivato è stato di rafforzamento politico del PCI. L'attuale equilibrio politico ruota tutto, come è noto, sulla necessità del blocco moderato cattolico di mettere in contraddizione tra loro due fattori.
Il PCI e la Cgil come struttura politica di controllo della conflittualità sociale.
Siamo così però fuori dal vecchio schema integralista. Quanto successe agli inizi degli anni '60 al PSI fu indubbiamente diverso. L'ingresso dei socialisti nell'area di governo non comporta nessuna possibilità di controllo nuovo sulla conflittualità sociale e per essa, allora, sull'organizzazione sindacale.
Fu un'operazione tutta politica che servì alla DC per allargare il suo metodo della stratificazione del consenso a fasce sociologicamente più larghe e articolate, conformemente ai mutamenti strutturali intercorsi negli anni '50. Il PSI così cadde, anche questo è noto, nella rete dell'interclassismo democristiano. Diverso, indubbiamente, oggi, il rapporto col PCI. Basti un data. Allora la DC non aveva bisogno del consenso sindacale, ne aveva semmai bisogno il PSI per mandare avanti una linea alternativa di governo all'interno della nuova maggioranza. E né la Cgil né la Cisl gliela diedero. Ora la DC ha bisogno del consenso sindacale. Ha bisogno in primo luogo del consenso della Cgil, e questa glielo dà, conformemente alla linea del PCI. Cosi il collateralismo della Cisl rispetto alle fasi precedenti della sua storia, ha uno spazio materiale più ristretto, quello di conservare aree di presenza organizzata nel mondo del lavoro,

non comunista, operando di volta in volta una divaricazione tra consenso sociale e politico di contro all'omogeneità di comportamento della Cgil.
Non vogliamo prefigurare qui dei futuri possibili scenari. Però nutriamo la convinzione che la strategia morotea, quella dell'unità delle forze democratiche, che in questi giorni ci viene continuamente proposta come la formula sociale d'un nuovo giuramento di Pontida, fosse necessariamente una dimensione tattica e non strategica, a differenza di come aveva a suo tempo concepito il rapporto con il PSI. Questa volta c'è in giuoco un problema di egemonia politica, che del resto è il problema di tutte le grandi coalizioni, non delle piccole, che se mai pongono problemi di condizionamenti più o meno efficaci.
Questo conclarato equilibrio politico presuppone una lotta sorda, senza quartiere, che già si gioca nelle retrovie, e che non ha per oggetto l'affermazione di un nuovo modello di Stato, ma semplicemente il potere dello Stato.
Ora tutto questo realismo che impernia e soffoca la lotta politica produce questo paradosso, che senza un modello nuovo di Stato, senza una strategia nuova di politica economica, l'obiettivo dell'egemonia politica dello Stato da parte della DC e del PCI è privo di sbocchi e di soluzioni politiche possibili, perché il potere dello Stato sulla società si impoverisce giorno per giorno, si approfondisce sempre più una voragine tra lo Stato, la classe politica e la società che né l'integralismo cattolico, né l'egemonia comunista, in sé e per sé, come puri metodi dell'agire politico, possono colmare. Credere che la solidarietà contro il terrorismo sia un cemento costruttivo è poi il paradosso ultimo. Se ci si pensa bene vuoi dire credere che il terrorismo è un male necessario all'equilibrio politico. Ma è anche vero che se dall'equilibrio si passasse allo scontro sarebbe subito un nuovo drammatico '40 dagli esiti imprevedibili. Insomma, la cruda realtà è che siamo in presenza di un equilibrio politico, necessario, ma assolutamente non sufficiente e che di per sé non prefigura nessuno sbocco politico auspicabile.
Come militanti in partiti e organizzazioni, che per semplificare chiamo intermedie, sappiamo che strappi bruschi, impennate impulsive, non sono possibili. In realtà la logica della grande coalizione non offre alcuno spazio alle forze intermedie all'interno del quadro politico.
Occorre dunque muoversi e lavorare su un altro terreno che è quello del rapporto tra Stato e società, sfuggendo alle tentazioni facili, che non sono consentite, di rottura del quadro politico e sindacale, e nel contempo evitando la totale paralisi dell'iniziativa sociale e politica.
Con una copertura come la DC si potrebbe anche giocare alla Cisl. Ma comunque è un gioco che non porta lontano. Non siamo più negli anni post '69 quando tutti gli spazi sembravano aperti, o almeno l'illusione che lo fossero, era plausibile.
Per muoversi, con efficacia e distinguendosi dagli altri, occorre oggi una forte qualificazione dell'iniziativa sindacale e politica, che riesca a ristabilire un nesso tra le istituzioni politiche e la società.
3 a a a e e a o Ei e o :a )o le o e! ili :a -e le
31
Sindacato e democrazia
Lo stato e i termini attuali dell'autonomia sindacale
I ruoli e gli spazi delle organizzazioni della società civile
Il valore della solidarietà democratica per l'uscita dalla crisi e per la caduta delle pregiudiziali anticomuniste

Il rapporto con le istituzioni e i partiti
Con questa tavola rotonda, Rinascita intende dare inizio a un dibattito e a un'indagine che avranno per oggetto la nuova e più complessa "stagione" sindacale che si va profilando con l'autunno. Negli ultimi tempi, diverse componenti del movimento unitario, hanno riproposto i temi dell'autonomia e dell'unità del sindacato, dei rapporti con le forze politiche e col governo, nonché questioni ancor più generali inerenti alle forme della democrazia e dello Stato, alla luce della novità costituita da una maggioranza parlamentare che per la prima volta dopo trent'anni comprende i partiti più rappresentativi della classe operaia. In un confronto quasi sempre a distanza, la discussione ha assunto assai spesso caratteri "ideologici"— come del resto è avvenuto nel dibattito tra le forze politiche — e qualche volta ha dato forse l'impressione di un dialogo tra sordi. Ci è sembrato perciò utile invitare attorno ad
Rinascita — In quali termini si pone oggi la questione dell'autonomia del sindacato? Il rapporto sindacati-governo può forse essere per principio considerato in termini conflittuali, ovvero in termini contrattuali? E' giusto questo? L'esperienza, nella storia nei diversi paesi, dimostra che una politica progressista non può mai essere attuata senza il concorso dei sindacati, che rappresentano le più potenti organizzazioni di massa di tutte le società moderne. Quale risposta dà a questo problema l'esperienza del sindacato italiano, che rappresenta, in fondo, una terza via tra la subordinazione del sindacato al partito nei paesi socialisti, e il rapporto organico di collateralismo e anche di subordinazione tra sindacato e partito nelle grandi socialdemocrazie?
un tavolo quattro fra i maggiori leaders del movimento sindacale, per discutere gli stessi temi nella forma più diretta e costruttiva. Ne emergono, ci sembra essenziali punti di convergenza, insieme a dissensi o comunque a problemi che richiedono ulteriore approfondimento.
Unanime è il riconoscimento che l'attuale quadro politico costituisce anche per l'iniziativa sindacale una base più avanzata, dalla quale occorre partire per andare ulteriormente avanti contrastando ogni velleità di ritorni al passato. Sulle linee e i modi per andare avanti, e in particolare sul ruolo del sindacato nella lotta per rinnovare e trasformare la società e lo Stato, il discorso resta aperto e resta aperto il confronto tra posizioni diverse.
Siamo convinti, d'altra parte, che, se la discussione sulle varie "vie della transizione" rappresenta lo sfondo necessario,
Trentin — Abbiamo tutti più volte sottolineato l'originalità dell'esperienza del movimento sindacale italiano nel contesto europeo e la prova particolarmente difficile alla quale in questa fase politica è sottoposta l'autonomia del sindacato. Parlo di originalità perché per una serie di ragioni storiche e organizzative il sindacato italiano, nel momento in cui cercava di configurare le basi per una sua unità anche organica, è stato portato a definire la sua autonomia nei confronti delle forze politiche e delle istituzioni in forme molto diverse da quelle che appartengono alla tradizione del movimento operaio dell'occidente e anche del mondo anglosassone. In Italia non si è avuto solo il rifiuto della cinghia di trasmissione o dei vari collateralismi, ma anche della divi-
uno degli elementi decisivi per impedire un arretramento rispetto all'attuale quadro politico e per creare anzi la condizione di un suo nuovo sviluppo, sarà costituito dal peso e dalle forme che l'iniziativa sindacale verrà assumendo nei prossimi mesi, sia in rapporto all'esigenza di introdurre elementi di programmazione democratica nel processo economico, sia in rapporto all'evoluzione della situazione politica. Proprio per questo l'iniziativa di Rinascita proseguirà nelle prossime settimane cercando anche di mettere a fuoco i temi più specifici della stagione contrattuale ormai prossima, le novità in atto nelle politiche e nelle strutture del sindacato, i nessi tra l'azione sindacale e le scelte di uno sviluppo economico programmato. Oltre al contributo di dirigenti sindacali e politici, solleciteremo la partecipazione al dibattito e all'indagine di operai, tecnici, delegati e consigli di fabbrica.
sione dei compiti e delle competenze tra sindacati e partiti. Tra le ragioni che hanno determinato questa originalità mi sembra rilevante la presenza di più partiti che hanno un'influenza più o meno grande nel movimento operaio. E mi sembra che vadano anche molto valorizzate le esperienze di dieci anni fa, quelle che hanno determinato l'atteggiamento di non-delega del sindacato sui problemi di fondo della politica economica, della trasformazione della società e della riforma dello Stato. Per questo in Italia non si instaura quel rapporto sindacato-partito che vediamo in altri paesi dell'occidente, a seconda che al governo ci sia il partito vicino al movimento operaio o no. Non voglio indicare il nostro come un modello ideale del sin-
Tavola rotonda con Benvenuto, Carniti, Marianetti e Trentin
Giorgio Benvenuto, segretario generale della Uil
Pierre Carniti, segretario generale aggiunto della Cisl
Agostino Marianetti, segretario generale aggiunto della Cgil
Bruno Trentin, segretario confederale della Cgil
32
dacato, ma è certo che è un modello distinto dagli altri che conosciamo. Questo è il primo dato da considerare. Il secondo è quello costituito da un quadro Politico nel quale confluiscono, con responsabilità diverse, i vari partiti che hanno un'influenza nel mondo del lavoro. Quindi questo nostro sindacato, che non costruisce la sua autonomia sulla divisione dei compiti e sulla neutralità, ma su una sua elaborazione autonoma di politica economica, si trova a fare i conti con un'esperienza che in modo diverso si è già verificata in paesi come la Germania, la Gran Bretagna, la Svezia. Per l'autonomia, come l'abbiamo concepita, siamo a una prova della verità. lo ritengo che un sindacato che non delega ad altri la gestione dei grandi problemi del paese è Portato a superare un modello rigidamente contrattuale, anche tenendo conto che i soggetti di decisione sono molteplici. Mi pare invece inevitabilmente conflittuale l'approccio del sindacato con il governo e le istituzioni per cercare di ottenere dei risultati sulla base dei suoi orientamenti. Non voglio dire con questo che il conflitto è un dato di principio, ma che è un dato potenziale dal momento che il sindacato tende a far valere i suoi obiettivi col supporto delle forze che rappresenta, e quindi esercitando un rapporto di forza, con lo sciopero o meno. Certo lo strumento del sindacato non è il voto.
C'è anzi da tutelare questo rapporto conflittuale, non solo in nome, diciamo, della "terza via" del sindacato italiano, Ma della stessa democrazia. Voglio dire che non mi scandalizzo se si ricorre anche allo sciopero contro una legge del Parlamento. Ciò non può essere interpretato come un atto contro le istituzioni. Certo, C'è un fatto nuovo: c'è una maggioranza che non è nemica del sindacato, nella quale anzi vi sono forze amiche del sindacato, ma il sindacato non può cambiare il suo atteggiamento.

Carniti — Infatti: secondo alcuni il sindacato non dovrebbe scioperare contro gli atti di determinate maggioranze. Naturalmente, poi, non si dice proprio così, ma più pudicamente che il sindacato non Può andare contro le decisioni del Parlamento.
Trentin — lo non credo che se si sciopera contro una legge si possa parlare di leso Parlamento, come non credo che un contrasto anche aspro con l'esecutivo voglia dire mettere in discussione il ruolo istituzionale, di sintesi, che spetta al Potere esecutivo. Questo è il modo di vedere il problema, senza sottacerne le grandissime difficoltà. Va prevista e scontata la possibilità di conflitti, tanto più difficili e complessi, quanto più si accetti la regola che nessuna forza può rappresentare da sola gli interessi generali della classe e della società.
Non è facile muoversi in uno schema nuovo rispetto a quelli, in fondo più
rassicuranti, nei quali si è mossa finora tutta la storia del movimento sindacale. La capacità del sindacato di attenersi a questo schema, evitando sul serio quelli esistenti e consolidati, si misura dalla sua capacità di privilegiare, direi, i contenuti: cioè di rappresentare un momento di pressione e di vigilanza critica sui contenuti discriminanti di una esperienza politica e di governo. Per il sindacato italiano è essenziale il nesso tra quadro politico e contenuti della politica di governo: non vi è un prima e un dopo, perché si rischierebbe o di privilegiare un certo quadro politico, a prescindere dai suoi contenuti programmatici, o, al contrario, di diventare paradossalmente una forza preminentemente critica del quadro politico, invece che suscitatrice di nuovi contenuti.
Benvenuto — Anch'io penso che l'autonomia si ponga nei termini degli ultimi dieci anni e che debba rispondere a tre problemi: quello della capacità del sindacato di avere una sua proposta; quello del modo col quale questa proposta viene definita; quello del modo col quale questa proposta viene gestita e attuata. E come si realizza l'autonomia? con la capacità di non essere solo il rappresentante di posizioni protestatarie, di non fare una politica rivendicativa di rimessa, ma al contrario di avere un proprio disegno complessivo e di confrontarlo con le forze politiche e le altre forze che sono all'interno della società. L'importanza dell'Eur mi sembra proprio questa: di avere abbandonato una pratica contrattuale del rapporto col governo, e di avere presentato il sindacato con una sua proposta capace di partecipare alla realizzazione di una politica progressista. E vengo al modo in cui si realizzano e si gestiscono queste proposte del sindacato. Mi sembra che l'autonomia debba fondarsi in gran parte sulla democrazia interna al sindacato, sulla possibilità di contribuire e di contare che hanno i lavoratori. Ecco, mi pare che quando si parla di caduta di autonomia, ci si debba riferire alla caduta dei processi di partecipazione. Il dibattito che prima passava attraverso le tre organizzazioni e coinvolgeva i lavoratori, oggi è sempre più un dibattito fra le tre confederazioni e sempre meno con caratteristiche unitarie. Oggi noi dobbiamo cercare le soluzioni e non, come a volte c'è la tendenza, il colpevole. L'autonomia è legata al modo con cui si realizza la partecipazione, e cioè a un dibattito nel quale le posizioni di organizzazione non siano tanto forti da essere paralizzanti. Secondo me è infatti avvenuto che, dopo aver costruito il sindacato dei consigli, si sono andati via via privilegiando i confronti centralizzati, provocando una caduta dell'autonomia. Infine: come si gestisce la proposta del sindacato? La partecipazione non significa esclusione di una conflittualità. Nel passato il rapporto tra sindacato e quadro politico ha avuto dei momenti di grande complessità, oggi ci troviamo in una
situazione nuova e corriamo il rischio di trovarci come i sindacati in Germania, o Gran Bretagna, o Svezia. Abbiamo una maggioranza sterminata, che presenta dei rischi totalizzanti. E' una maggioranza che il sindacato ha voluto, ma esiste il problema sollevato da Carniti, e cioè che una nostra posizione contro il governo finisca per essere indicata come un atto contro il Parlamento. Penso alla legge Scotti sulla scala mobile, all'esperienza per me drammatica del dopo 2 dicembre, quando fare o non fare lo sciopero generale significava un pronunciamento del sindacato sul quadro politico. Questo è un nodo che va sciolto. lo credo che la conflittualità del sindacato sia legata alla sua autonomia, e che anche in presenza di un quadro politico come l'attuale il sindacato continui ad avere i suoi spazi di lotta, compreso lo sciopero generale. Nel momento in cui il sindacato cerca di realizzare la sua proposta deve misurarsi con le altre forze, non autolimitarsi nella sua azione. Sia chiaro: non dico che l'autonomia coincide con la conflittualità, anzi con un governo come questo la conflittualità dovrebbe ridursi, però il sindacato deve continuare a esercitare la sua funzione con gli strumenti che gli sono propri. Anche perché il livello di mediazione che c'è nel quadro politico, proprio per le caratteristiche della maggioranza attuale, corra il rischio molte volte di essere in contraddizione con il livello di mediazione che c'è nel sindacato: questo è più avanzato rispetto a quello. Non possiamo accettare il dilemma che se il sindacato dice "no", è destabilizzatore, e se dice "sì", perde la sua autonomia.
Carniti — Si può essere tentati di definire su un piano ideologico questioni come quelle dell'autonomia del sindacato e del suo rapporto con i partiti e le istituzioni. A me pare più utile invece considerare che l'autonomia non può mai essere definita una volta per tutte, anche perché sindacati, partiti e istituzioni mutano con il mutare delle condizioni storiche e politiche. lo non so se l'esperienza del sindacato italiano rappresenti una terza via, vi sono certamente connotati originali: il rapporto sindacato-partito è da noi più complesso rispetto agli schemi semplificati degli altri paesi come quelli citati. Noi dobbiamo certamente essere attenti a quanto avviene in Europa, ma dobbiamo poi adattare le risposte alla specificità del caso italiano. L'autonomia del sindacato riflette la specificità della condizione politica dei diversi paesi. Credo tuttavia che possono essere individuati alcuni cardini sul terreno della ricerca dell'autonomia del sindacato in Italia e che possono anche costituire dei parametri di valutazione. Si tratta innanzitutto, come diceva Benvenuto, di stabilire un nesso stretto tra autonomia e democrazia nel sindacato: credo che l'autonomia è tanto più consolidata quanto più è estesa la partecipazione al suo interno. La democrazia negli ultimi
33
tempi è regredita e, così, anche l'autonomia ha avuto degli scricchiolii.
Rinascita — Ma perché è diminuita questa democrazia?
Carniti — C'è stato anche un certo fastidio nel sindacato per questa estensione della democrazia, dopo la grande stagione del '68-'69. La democrazia è più faticosa e quindi anche più fastidiosa, rende tutto più complicato. Si sono avuti atteggiamenti un po' troppo liquidatori con l'esperienza del passato, si è considerata una certa fase della storia del movimento sindacale come una sorta di ubriacatura, così si sono liquidati non solo gli errori commessi, ma anche i dati positivi della ricerca di un più elevato livello di democrazia interna e di un rapporto diverso sindacato-lavoratori, che è la condizione per un rapporto autonomo tra sindacato e forze politiche. In secondo luogo non vi è, secondo me, un rapporto logico e cronologico tra autonomia e unità sindacale, come a volte si è invece cercato di dire. Se è vero che senza autonomia non si può fare l'unità è anche vero il contrario: siccome l'esperienza sindacale italiana è stata essenzialmente un'esperienza di divisione indotta dalle forze politiche, la consapevolezza del fallimento delle cinghie di trasmissione o dei collateralismi ha prodotto uno sforzo di elaborazione che non andrebbe sottovalutato e che anzi corrisponde alla specificità del caso italiano.

L'autonomia è stata messa alla prova non solo dalla caduta della democrazia interna e della partecipazione, ma anche perché l'allargamento della maggioranza ha accresciuto difficoltà e rigidità per il sindacato. Mi riferisco alle questioni che sollevava Trentin. Vi sono dei pericoli e li indico perché costituiscono una minaccia non solo per il sindacato, ma per il consolidamento della democrazia nella società. Parlo della tendenza a giudicare irrispettosi, irriguardosi, gli atteggiamenti del sindacato che rifiutano certe soluzioni legislative e si orientano su misure di lotta. Questo clima di insofferenza ha portato anche a tentazioni di intervento legislativo in materie proprie del sindacato, a tentazioni crescenti di invadere l'autonomia contrattuale delle parti sociali, al di là del merito delle singole questioni. Non so se vi sia una volontà deliberata o inconsapevole di andare a una sovrapposizione dell'ordinamento statuale sugli altri ordinamenti della società civile: questo implica però che alla mediazione politica si sostituisce la mediazione giuridica e quindi anche le proposte politiche dei partiti, quelle del confronto o dell'alternativa o del compromesso storico, mutano in questo contesto la loro natura.
Quello che noi conosciamo in Italia non è l'unico tipo di democrazia possibile ma se si alternano gli equilibri di potere immaginati dalla Costituzione, e non voglio considerare le prospettive totalitarie, si va
incontro comunque a una messa in causa della democrazia nata dalla Resistenza e si aprono problemi nuovi che possono essere risolti con soluzioni progressive o anche regressive. Ora, queste tendenze mettono alla prova un sindacato come quello italiano che fa politica e che rifiuta la divisione dei compiti e lo spingono a una condizione di subalternità. Questa è la situazione in Italia. Se si alterano le regole del gioco si possono creare anche condizioni migliori, ma possono però emergere pericoli di regresso rispetto alle conquiste democratiche sin qui realizzate.
Rinascita — Quali regole del gioco?
Carniti — Penso ad esempio alle tentazioni di regolamentare lo sciopero per legge o di trasformare in legge le norme di autoregolamentazione del sindacato, ai tentativi di svuotare la contrattazione...
Trentin — ...o quelli di regolamentare il controllo sindacale sugli investimenti.
Carniti — Ma io non dico che ci sia un disegno deliberato, bensì che si rischia di andare all'integrazione di tutti gli ordinamenti nell'ordinamento statale. Questo metterebbe in causa il pluralismo, all'interno della società, che non è solo fatto di opzioni politiche, ma anche di ordinamenti. Verrebbe impoverito il livello di democrazia che si è realizzato in trent'anni con le lotte del movimento operaio.
Marianetti — Siamo d'accordo che il conflitto non è un metro di misura dell'autonomia, e quando si parla di negoziato si dice una cosa ancora più imperfetta sul rapporto tra sindacati e governo. L'evocazione del contratto come modo di essere di questo rapporto non regge. Debbo invece dire che nel rapporto più generale con le istituzioni vi è oggi un'evoluzione di tipo sia conflittuale che cooperativo più marcato che nel passato. Noi abbiamo avuto un decentramento dello Stato e su questa strada vi è il rischio però che non vi sia un uguale decentramento dei poteri reali. Si possono articolare le istituzioni, ma non è detto che si articoli il potere. Tuttavia se avvenisse, come noi vogliamo, una diffusione reale dei poteri fra le varie istituzioni, come è auspicabile, diventerebbe inevitabile il carattere più cooperativo che conflittuale dell'azione del sindacato.
E veniamo al modo in cui la nostra autonomia può manifestarsi, non in rapporto al padronato, ma con la società politica, le istituzioni, il governo. Bisognerebbe tentare di fare un discorso un po' nuovo. Si dice: l'autonomia del sindacato è caduta perché è caduta la partecipazione, la democrazia interna; questo è un fatto, ma perché? A me non convincono le spiegazioni soggettive, tutte interne al sindacato. Ci sono invece delle cause oggettive, e una di queste è la caduta della prospettiva unitaria. E' evidente che tanto più la Federazione di-
venta una sede di mediazione tra forze che non si avvicinano, ma anzi tendono sempre più a caratterizzarsi, tanto più la mediazione stessa tende a concentrarsi in pochissime persone.
Carniti — La Federazione si è costruita non sull'idea della mediazione, ma del compromesso e le conseguenze di cui tu parli erano inevitabili.
Trentin — L'ipotesi di Marianetti dà un rilievo tale ai gruppi dirigenti da accentuare il soggettivismo della spiegazione.
Marianetti — Noi abbiamo costruito un' esperienza e un modello di partecipazione che definiva una sorta di autosufficienza della democrazia interna al sindacato. E' questo il punto al quale voglio arrivare. Noi abbiamo vissuto una grande stagione di democrazia, ma bisogna pur riconoscere che la partecipazione in una fase tutta rivendicativa è relativamente semplice rispetto a una fase assai più difficile, come quella che stiamo vivendo. Secondo me non può esistere un modello di democrazia nel sindacato che realizzi la partecipazione, se non si identificano analoghi modelli di partecipazione nella società. Insomma, per incidere e per contare sulle politiche economiche non basta avere delle strutture democratiche nel sindacato: il problema è se nella società civile e nello Stato vi sono livelli di partecipazione che diano potere.
Carniti — Questo ragionamento è reversibile: il sindacato non è credibile nella sua battaglia per estendere la democrazia se non sa prefigurare al suo interno strumenti di partecipazione.
Marianetti — Questo è del tutto ovvio, ma voglio dire che, se non riusciamo a imporre un metodo di programmazione fondato su un nuovo reticolato di sedi di controllo, noi potremmo avere, per assurdo, il massimo della democrazia nel sindacato, e quindi di autonomia, ma anche una scarsa influenza sugli obiettivi della programmazione. In questo senso non condivido un accenno di Trentin sui rischi dell'interferenza legislativa sulle materie negoziali e quindi anche di sedi e di strumenti istituzionalizzati di controllo, ad esempio, sulla politica degli investimenti. Non penso che si tratti della stessa cosa.
Trentin — E' una cosa molto diversa dal tipo di autonomia che abbiamo cercato di costruire.
Marianetti — Per me si tratta solo di una premessa per un discorso su una partecipazione che conti.
Trentin — No, è un discorso che ci porta a confluire in un modello che conosciamo da cinquant'anni.
Marianetti — Per me è una premessa decisiva. Non penso che abbiamo compiuto
34
tutta la nostra elaborazione sulla questione di un sindacato che voglia incidere sui processi generali della società.

Carniti — Nella nozione di autonomia vi è un elemento discriminante, ed è quello di impedire che lo Stato si espanda nella e sulla società civile. Se questo avvenisse l'autonomia del sindacato si ridurrebbe.
Marianetti — Sono d'accordo con te, ma io non condivido una nozione di democrazia che si riduce a un conflitto, quando c'è, tra un ordinamento democratico dello Stato e società civile e sottovaluta, o ignora, la presenza di istituzioni nella società civile che consentano la partecipazione effettiva dei lavoratori. Secondo me le questioni legate a una gestione democratica della economia e ai problemi dell'impresa, alle sedi di controllo e di Partecipazione nell'impresa, appartengono a una linea di sviluppo della democrazia e anche dell'autonomia del sindacato. Non il contrario.
Trentin — Queste questioni vanno risolte in forme che non hanno precedenti in nessun altro paese. Non sono a conoscenza che ci sia mai stato uno sciopero in Germania sui poteri della cogestione. Mentre da noi abbiamo bene o male costruito un'esperienza di massa sul controllo degli investimenti.
Marianetti — Esatto, ma i risultati non sono stati decisivi. Non credo che in una discussione di questo genere ci debbano essere dei tabù ideologici. Ma voglio affrontare un'altra questione: abbiamo Parlato dell'autonomia intesa come rapporto tra sindacato e partiti, tra sindacato e governi, come se non riguardasse il sindacato ciò che succede nel sistema Politico. E' un discorso difficile da affrontare perché ci si tira dietro l'accusa di voler favorire una qualche formula politica. Ora io voglio dire che un sindacato che voglia cambiare l'assetto economico e sociale non può essere indifferente al fatto che si perpetui un'egemonia politica, o che a questa egemonia si sostituisca una compartecipazione di tutti perché tutto rimanga come è. Al di là delle Preferenze politiche di ciascuno si tratta di sapere qual è la spinta dinamica all'interno di un sistema democratico e, secondo me, questa spinta è nei possibili ricambi nella direzione politica del paese. II sindacato può rimanere indifferente di fronte a questo problema? Il sindacato deve concorrere a creare le condizioni Perché il ricambio avvenga, partendo dalla legittimazione di tutte le forze democratiche a governare. Questa questione c'entra con l'autonomia. Quella del sindacato italiano è un'esperienza originale, ma non una terza via, è invece in rapporto con la seconda via. Noi abbiamo qualche parentela con le esperienze del movimento operaio nell'EuroPa capitalistica. Stiamo cercando un'esperienza diversa da quella degli altri paesi, Ma il nostro retroterra di finalità, di
ispirazioni e di valori ci fa essere vicini alle esperienze europee.
Trentin — Continuo a essere convinto dell'originalità dell'esperienza italiana. Il che non vuol dire che questa esperienza sia figlia della situazione italiana, ma che ne è stata fortemente condizionata. Qui non ha riscontro il modello lassalliano del partito unico e del sindacato unico, che è dominante in occidente, ci sono invece sindacati con diversa matrice politica e ideologica, e più partiti che hanno un peso rilevante nella classe operaia e nel mondo del lavoro. Sono convinto che in Italia vi sia effettivamente un'esperienza originale, e questo non vuol dire che non dobbiamo saper valutare le altre esperienze europee. lo non so se si tratti di una terza via, ma constato che la nostra è una concezione dell'autonomia in cui il sindacato fa politica, e con il sindacato altre forze che possono rappresentare nella società di transizione una pluralità di centri di elaborazione politica a parità di diritto.
Insisto sul fatto che l'originalità nostra non è nel superamento della cinghia di trasmissione, ma nel rifiuto della divisione dei compiti fra sindacato e partito. Troviamo riflessioni di questo tipo nel movimento sindacale francese, o britannico, o tedesco? lo credo di sì: quindi non dobbiamo temere di essere provinciali se riteniamo che la particolarità e la drammaticità della situazione italiana ci abbiano portato prima di altri ad elaborare e costruire ipotesi di autonomia che riguardano non il sindacato ma la democrazia. Se invece prevalesse l'ipotesi che stiamo attraversando una transizione da un modello un po' sottosviluppato ai modelli già assestati in occidente, allora molte cose di cui parliamo dovrebbero cambiare. Perché si tratterebbe di una specie di ritorno all'ovile, a una funzione del sindacato più tradizionale. In questo caso, sì, il primato della politica spetterebbe esclusivamente al partito politico, mentre il sindacato diventerebbe il garante della democrazia economica. Su questo terreno credo che dobbiamo una grossa risposta al problema della democrazia in questa fase della transizione. Molto spesso si tendono a fare delle caricature sullo Stato autoritario, contro il quale ci si difenderebbe con una società civile lasciata libera a se stessa; d'altro canto si nega semplicemente che esista questa transizione che ha in sé, invece, una carica autoritaria. Sono problemi che in Italia possono apparire offuscati, ma che riguardano tutti gli Stati moderni, tutti i paesi capitalistici. Dove passa il vero pericolo di autoritarismo? Proprio nella gestione della società e dell'economia della transizione, in una corporativizzazione della società non solo indotta dalla crisi, ma dalla burocrazia dello Stato. Per questa burocrazia i soggetti politici, come la classe operaia, non possono esistere, sono delle astrazioni. Esistono dei gruppi di interesse che
si mediano, e per questo lo Stato moderno produce corporativizzazione e segmentazione della società. La democrazia si afferma non solo nelle salvaguardie individuali, ma in nuove forme di protagonismo che favoriscono aggregazioni, contro le frammentazioni determinate dallo Stato moderno. Questo non avviene attraverso un'istituzione, ma attraverso la pluralità dei soggetti politici, fra i quali i sindacati.
Marianetti — Su questa base non c'è dissenso.
Trentin — Il dissenso è nel fatto che è autonomo il sindacato che fa politica e che questa è una tendenza di fondo che per ora non ha riscontro in altri paesi occidentali. Il superamento della divisione dei compiti è il dato che contraddistingue il processo di autonomia di cui parliamo. E io trovo che certe forme di regolamentazione, ad esempio del controllo degli investimenti, rientrino nel processo di corporativizzazione indotto dallo Stato, di cui parlavo. Il pericolo, infatti, è quello di riconfinare il controllo degli investimenti nell'ambito di una sola azienda, di segmentare quello che invece è un processo aggregativo; di non affrontare il problema di fondo delle Sedi, anche nuove, del rapporto fra sindacato e programmazione, fra sindacato e istituzioni. Ora, su questo ci sono modelli diversi: uno che delega a un giudice l'arbitrato per sapere se un'impresa è stata fedele nel comunicare i bilanci, e rinchiude in un conflitto fra lavoratori e azienda il problema della strategia dello sviluppo economico, l'altro che porta fuori questo confronto, con le pubbliche istituzioni locali, regionali, nazionali. Questa seconda ipotesi prefigura il superamento della divisione dei compiti, non si può parlare cioè di democrazia politica e di democrazia economica come elementi separati. lo sono convinto che la classe operaia organizzata nel sindacato non potrà essere protagonista di un controllo di masse se non è anche protagonista del progetto di società attraverso una pluralità di soggetti politici. Sono anch'io convinto che l'autonomia si afferma con la democrazia interna al sindacato. Perché questa democrazia è in crisi? C'è, io credo, una crisi dei gruppi dirigenti a tutti i livelli, che è dovuta in buona parte alla caduta del disegno unitario. Ma c'è soprattutto la difficoltà dovuta all'impatto con il nuovo quadro politico, che tende a sostituire la mediazione alla ricerca, indubbiamente rischiosa, del confronto a livello di base. Non ci sono i buoni e i cattivi, dunque, ma il pericolo è che questo ci porti alla paralisi. E' del tutto vero che un sindacato che fa politica introduce un nuovo connotato alla democrazia del paese e alla possibile trasformazione dello Stato, ma a quel punto non può ignorare le implicazioni delle sue scelte sul quadro politico. Non mi scandalizzo se uno sciopero determina la crisi, ma è certo che quel sindacato non
e D a a 3
35
può pretendere di essere un soggetto politico a metà: anche fatti del genere possono cristallizzare le posizioni all'interno del sindacato e indebolire la sua vita democratica.
Benvenuto — L'originalità del sindacato italiano: certo non ha nessuna parentela con l'esperienza sindacale dell'est. Qualche parentela, purtroppo assai limitata e provvisoria, semmai si è avuta con quello che avvenne in Cecoslovacchia, penso al sindacato dei consigli. Certamente ci sono dei collegamenti maggiori con le esperienze dei paesi europei, che non abbiamo mai considerato, io credo, con la dovuta attenzione. Credo comunque che il nostro patrimonio abbia una sua originalità e che in altri paesi europei si cominci a fare i conti con i problemi che noi affrontiamo.
Il modello sindacato-partito delle esperienze socialdemocratiche per noi è improponibile, perché da noi non c'è un partito che rappresenta tutti i lavoratori, ma abbiamo più partiti che organizzano i lavoratori e abbiamo, poi l'esperienza tutta particolare del mondo cattolico. La scelta europea, che io sostengo, non significa dunque sposare i modelli che troviamo nei diversi paesi. Detto questo, mi sembra che noi dobbiamo temere lo Stato che si sostituisce al sindacato, ma non possiamo mettere sullo stesso piano l'iniziativa legislativa che interferisce in materie proprie del sindacato, con una legislazione di sostegno delle conquiste sindacali.
Trentin — Ma guarda, io non dico di temere che una legge assuma certe posizioni del sindacato, come la legge Scotti, sulla quale vi è stato un disaccordo sul metodo, ma che si regolamenti quello che deve essere un confronto libero tra le parti. E questo è il caso di una eventuale legge che regolamenti il controllo sindacale sugli investimenti.
Marianetti — Ma perché è da temere?
Carniti — Intanto perché deve prevedere necessariamente delle sanzioni.
Benvenuto — Noi dobbiamo avere tutte le preoccupazioni necessarie verso leggi che si sostituiscano al sindacato. Ma una legge che contenga anche delle sanzioni, e dia però più forza contrattuale al sindacato non mi scandalizza. Lo statuto dei lavoratori prevede delle sanzioni, ma lo abbiamo voluto noi.
Trentin—Lo statuto tutela dei diritti individuali.
Marianetti -- La filosofia dello statuto è a sostegno delle prerogative del sindacato.
Benvenuto — Mi sembra che siamo tutti d'accordo che se una legge, ad esempio, facesse proprie le norme di autoregolamentazione dello sciopero decise dal sindacato sarebbe estremamente grave, ma
una legge che ampliasse Io statuto dei lavoratori, riconoscesse al sindacato diritti di contrattazione, io non la vedo come una sovrapposizione dell'intervento dello Stato sulle prerogative del sindacato. Mentre mi rimane la preoccupazione per una tendenza che non è solo quella dell'intervento legislativo, bensì di un intervento delle forze politiche per far passare un loro accordo rispetto alle posizioni del sindacato.

Torniamo al problema della divisione dei compiti. Mi pare che oggi nel dibattito all'interno della sinistra si tenda a riproporre questa divisione. E' un problema sul quale va fatta chiarezza. Credo che la lotta sindacale di questi anni abbia avuto effetti positivi, in particolare facendo cadere la pregiudiziale anticomunista. La spinta sindacale ha anche messo in crisi un sistema di governo. Solo che il nuovo ruolo assunto dal PCI pone dei problemi a tutti noi, nel rapporto sindacato-partiti, e ripropone la questione dell'autonomia.
Credo, cioè, che rispetto al passato, con le sinistre o i comunisti all'opposizione, oggi si è ristretto lo spazio del sindacato: oggi, appunto, ci si pone il problema se con la nostra conflittualità mettiamo in discussione o meno il quadro politico. Qui ci si pone un problema di una maggiore partecipazione e di un maggiore potere del sindacato e anche di un decentramento istituzionale che renda effettivo il potere del sindacato.
Rinascita — A che cosa ti riferisci quando dici che la presenza del partito comunista nella maggioranza pone dei problemi?
Benvenuto — Dobbiamo fare i conti con un sindacato che opera in una situazione politica dove c'è un accordo tra molti partiti.
Carniti — E' rimasta soltanto un'opposizione di tipo eversivo.
Benvenuto — L'iniziativa del sindacato pone dei problemi sul quadro politico. Ora, siccome non facciamo il discorso sul quadro politico ottimale perché non ci porterebbe lontano, io credo che la strada migliore sia quella di puntare ai contenuti. La caduta della pregiudiziale non può insomma significare una diminuzione del ruolo del sindacato.
Carniti — lo non credo che ci siano due modelli di esperienze sindacali, e comunque quello dei paesi socialisti non è assolutamente confrontabile con gli altri dal momento che il sindacato è un ramo dell'amministrazione. Inoltre, c'è una grande diversità anche nelle esperienze dei paesi industrializzati: c'è semmai una correlazione di condizioni politiche. lo non vedo, come sembra a Marianetti, una tendenza del sindacato italiano verso modelli nord-europei e nemmeno che il problema dell'autonomia, in termini di superamento della divisione dei compiti, come diceva Trentin, si ponga ora agli
altri paesi. In realtà l'autonomia dipende dalle situazioni politiche e dalle istituzioni delle diverse società.
Voglio dire che l'avvicendamento delle forze politiche alla direzione del paese, se esiste in teoria, è precluso nella pratica, ed è quindi obbligata la ricerca dell'avvicinamento tra le forze politiche. Allora io mi chiedo se alla lunga la nostra non rischi di diventare una democrazia speciale, proprio per questo blocco tra le forze politiche, e, senza sottovalutare o tacere che la politica di solidarietà l'abbiamo voluta anche noi, io credo che i problemi di difesa della democrazia e dei diversi ruoli di tutte le istituzioni all'interno delta società, compreso il sindacato, hanno una loro peculiarità che è diversa dai contesti politici di altri paesi occidentali.
Marianetti — Il rischio alla fine è di avere una democrazia politica senza una democrazia economica.
Carniti — lo voglio solo rimarcare un elemento di specificità nella ricerca dell'autonomia da parte del movimento sindacale italiano, che è connaturato alla specificità della condizione politica italiana. Quindi mi pare che pensare a convergenze con altre esperienze sindacali sia una forzatura.
Marianetti — lo non vado assolutamente alla ricerca di modelli, ma a questa questione rispondo così: che all'interno del sindacalismo dell'Europa occidentale vi è un'omogeneità del contesto dei sistemi politici in cui il sindacato opera. lo pongo il problema di sviluppare le condizioni per cui il sindacato non sia autonomo e impotente, ma agisca in uno scenario di articolazione delle istituzioni tale da renderlo oltre che autonomo anche con un potere reale. La caduta della partecipazione che abbiamo avuto negli scorsi anni è dovuta anche al fatto che i lavoratori non hanno trovato strumenti idonei di partecipazione rispetto alle grandi questioni che il sindacato intende oggi affrontare e che sono connesse alla crisi e ai suoi sbocchi. lo vedo il pericolo che si arrivi a una crisi di ingovernabilità se non si forniscono le sedi di partecipazione e di responsabilizzazione rispetto alla domanda che esprimono i vari gruppi sociali: se non c'è questa risposta emergono i pericoli di corporativizzazione di cui parlava Trentin e che indubbiamente sono presenti nelle società industrializzate. La possibilità di superare la crisi sta in uno sviluppo diversó e nuovo della democrazia che non si esaurisce né all'interno del sindacato, né all'interno dello Stato, ma anche in forme di democrazia economica. Non pongo dunque una questione di una definizione giuridica dei compiti del sindacato, ma di una istituzionalizzazione, perché no? , di certe prerogative del sindacato. In questo senso dobbiamo riflettere su che cos'è oggi l'impresa
PI va aL Ti ch CC M as lo ra SV sii dc fa cc di Pe cc te sc Ti m q( ci di M st cF T. se ni re e M T al d si al q ir
zi
ri si C 36
li
e
e e e i D a e a a a
Pubblica, l'ordinamento dell'impresa privata, le partecipazioni statali, le aziende autonome dello Stato.
Trentin — Che differenza c'è tra quello che dici e la legislazione di sostegno alla contrattazione?
Marianetti — Non credo che siano cose assolutamente distinte, possono avere una loro complementarità. C'è stato o no un rapporto fra lo statuto dei lavoratori e lo sviluppo delle prerogative negoziali del sindacato? lo penso che c'è stato. Allora dobbiamo prendere in considerazione il fatto che alcune prerogative conquistate contrattualmente hanno incontrato delle difficoltà ad essere uno strumento della Partecipazione di massa. D'altra parte al Congresso della Cgil si è parlato di mettere allo studio ipotesi di legislazione di sostegno.
Trentin — lo mi sono espresso assolutamente contro ipotesi del genere. Del resto qualcuno ha tirato fuori norme di partecipazione a livello europeo senza sentire non dico un iscritto, ma neanche un dirigente del sindacato.
Marianetti — Su questo hai ragione. Ma io sto ponendo apertamente un problema che mi pare di dover discutere.
Trentin — C'è un punto che voglio capire: se consideri che la partecipazione sostenuta dalla legislazione abbia un rapporto reale, stretto, con i problemi della società e della democrazia politica.
Marianetti — Certamente.
Trentin — Se è cosi, prenderemo tutti atto che la legislazione interrompe questo rapporto, perché chiama un giudice a decidere se è giusto investire in un posto Piuttosto che in un altro.

Marianetti — Allora non c'è un dissenso sulle intenzioni, ma sui modi. lo dico che l'approccio che propongo è possibile, almeno come ricerca. lo ritengo che su questo piano l'esperienza contrattuale è incompiuta. Non nego l'originalità italiana, ma un movimento operaio internazionale esiste o no? E perché le altre esperienze non debbono indurci a delle riflessioni? Volevo anche dire che non sono d'accórdo con un'osservazione di Carniti, che mi dà il senso della rasse-
gnazione — altro che della difesa del superamento dei compiti tra sindacato e partito! — quando di fatto afferma che il sindacato, il sindacato che fa politica, mette una sordina sui principali nodi politici. E infatti Carniti dice: preso atto che in questo paese non è possibile l'avvicendamento delle forze al governo...
Carniti — Sostengo esattamente il contrario. L'alternanza non c'è stata anche per responsabilità della sinistra, ma oggi vi sono potenzialità nuove determinate in larga parte dalle lotte del sindacato per la caduta delle pregiudiziali e per una legittimazione che riteneva giusta. Suscitare nuove potenzialità politiche e necessarie alla strategia del sindacato. Sta di fatto, però, che il sindacato difficilmente può realizzare i cambiamenti che vuole con un sistema politico cosi rigido; e sta di fatto che questo quadro politico oggi non è modificabile.
Marianetti — lo ti chiedo se sarebbe scandaloso se in qualche documento il sindacato desse una valutazione autonoma sul fatto che non esistono vincoli internazionali, né questioni di idoneità democratiche che rendano impossibili ipotesi di avvicendamento. lo non lo troverei scandaloso, lo riterrei anzi una prova di autonomia, fermo restando che questa è una democrazia dove decidono gli elettori.
Carniti — Ma questo significherebbe avallare da parte del sindacato delle ipotesi politiche: è come se si chiedesse una solidarietà rispetto, non so, all'alternativa e al compromesso storico. Questo non significa protestare contro le discriminazioni. Non capisco perché su delle ipotesi politiche, del tutto legittime, debba pronunciarsi il sindacato. Sono questioni sulle quali il sindacato non deve dividersi.
Marianetti — Non dico che il sindacato debba sposare un'ipotesi politica. lo dico che questo sindacato è interessato al fatto che questo sistema politico non sia speciale, come del resto dicevi, non sia l'unico fra i sistemi democratici nel quale è impedito un pluralismo nella funzione di governo.
Carniti — Ma è possibile oggi una soluzione diversa da quella della solidarietà democratica?
Marianetti — L'autonomia del sindacato non si misura su quello che è possibile o meno, ma sulla sua intenzione di contribuire a creare le condizioni per quello che ritiene essere il meglio.
Carniti — Non si tratta di pronunciarsi su modelli possibili di democrazia politica sui quali siamo tutti d'accordo. Tu chiedi che il sindacato si pronunci, oggi, sull'alternanza. La mia opinione è che su questo c'è un giudizio politico diverso tra di noi. lo parlo delle condizioni in Italia, oggi, nel '78. Il prossimo anno ne riparleremo. Se oggi cambiasse il quadro generale di riferimento, se una delle grandi forze politiche fosse mandata all'opposizione sarebbe uno sfacelo.
Marianetti — Non lo so, suppongo di si. Prendo atto che non sono riuscito a spiegarmi: tutti avvertono i rischi che una maggioranza vasta condizioni il sindacato. E allora? Abbiamo lavorato per un governo di emergenza, ma siamo in una fase di transizione in cui sono in discussione i problemi della democrazia: io ne concludo che lo sbocco dell'emergenza non può essere sul piano politico il tipo di assetto che esiste oggi. E non parlo di formule di governo. Da questa affermazione che ne deriva? Ne deriva ad esempio che se qualcuno sostiene che alcune forze non possono governare, noi rispondiamo che come sindacato la pensiamo diversamente.
Carniti — Tu dici che il sindacato deve lavorare per l'alternanza. Io dico invece che in una situazione nella quale siamo costretti a ricercare una risposta di solidarietà per far fronte all'emergenza, dobbiamo fare in modo di rafforzare l'autonomia. E autonomia significa rifiuto della divisione dei compiti e della subordinazione. Riconosco questo quadro politico come necessario, ma non mi faccio paralizzare dal dilemma sulla stabilità o meno del quadro politico rispetto alle scelte del sindacato.
Trentin — E' importante capire il rapporto tra democrazia, quadro politico, ruolo del sindacato. Il compromesso storico: se esclude una dialettica profonda di schieramenti politici è una cosa, ma se mette invece, come io credo, in moto una dialettica tra le forze politiche io ci ritrovo un nuovo elemento di vitalità democratica.
37

Indice
Presentazione dell'Ufficio Formazione provinciale FLM
B. TRENTIN
Le conquiste dei sindacati dell'epoca dell'operaio-massa
M. MALFATTI - R. TORTORA
I difficili anni cinquanta
G. GIUGNI
L'unità operaia in Italia dagli anni cinquanta agli anni sessanta
M. MALFATTI - R. TORTORA
La ripresa (1960-1969)

L. LAMA
Impegno della CGIL per lo sviluppo e l'unità del sindacato in Italia
CELLA - MANGHI - PIVA
Un sindacato italiano negli anni sessanta - La FIM-CISL dalla associazione alla classe
P. CRAVERI
Sindacato e istituzioni
TAVOLA ROTONDA CON BENVENUTO, CARNITI, MARIANETTI, TRENTIN
Sindacato e democrazia
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
39
3
4
7
10
15
19
23
29
32

i











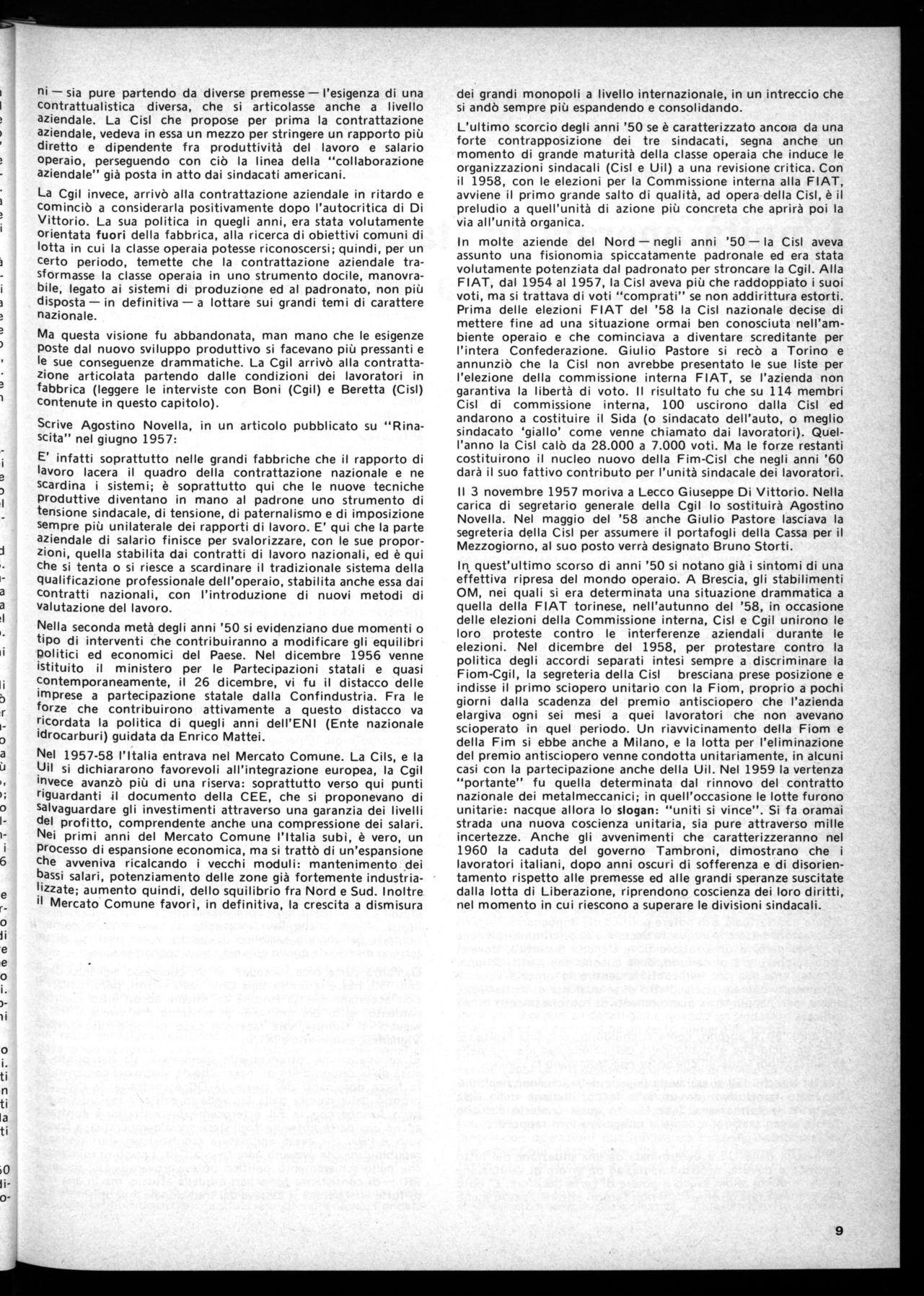
 Gino Giugni
Gino Giugni





























