DA CHE PARTE STA LA VIOLENZA?
— Troppo spesso si prende spunto da dei fatti concreti, appellandosi al rispetto della legalità e al senso dell'ordine, per mistificare la « realtà vera » delle cose e per tacciare di violenza delle persone o dei gruppi di persone che invece stanno solo lottando per il rispetto dei propri ed altrui diritti contro i trasgressori della « legge della giustizia ».

E' bene allora cercare di vedere insieme in che tipo di realtà viviamo per potere avere poi gli strumenti per giudicare criticamente ogni evento che accade senza cadere nell'ambiguità o peggio nell'errore.
— Ouesto è un mondo dove il divario tra paesi sottosviluppati e paesi ricchi continua ad aumentare, dove mi ci fu un numero così alto di persone al mondo a patire la fame, i 2/3 (2,5 miliardi) soffrono di sottoalimentazione o di cattiva nutrizione, alcuni anche nei paesi meno sviluppati vivono nell'opulenza e dissipano beni. Non ci sono scuse demografiche a ciò perché dal '65 la popolazione è aumentata dell'1,5%, la produzione alimentare del 3%.
La causa principale di mesta situazione è il neo colonialismo che impone ai paesi del 3° mondo dei prezzi irrisori per le materie prime che compera, contro prezzi altissimi per le attrezzature che gli vende. Così invece di aiuto al « terzo mondo » da parte dei paesi ricchi diventa un aiuto dei paesi poveri ai paesi ricchi.
Ogni anno vengono spesi 200 miliardi di dollari per armamenti, ma solo 12 per l'aiuto ai paesi sotto-
sviluppati.
— In questo contesto si inseriscono come espressione più raffinata del capitalismo le imprese multinazionali: vedi Esso, Shell, B.P., Fiat, Pirelli, Montedison, Snia, Superbox, IBM (detentrice del monopolio mondiale dei calcolatori).
Queste controllano forti capitali di altre aziende, Istituti finanziari, Banche, giornali. Esse sono dei conglomerati che collegano imperi i quali tendono a controllare il potere politico e militare, tecnico e culturale, i mezzi di informazione sociale, stampa, radio TV. Questi ultimi diventan oi trasmettitori delI aideologia dominante, cioè la loro, con la quale riescono a perpetuare il consenso del popolo.
Tutto ciò fa sì che gruppi sempre più ristretti dispongano di un SOMMARIO
Da che parte sta la violenza ?
Diritto di sciopero
assai ampio potere decisionale e dí azione che gioca un ruolo fondamentale nel processo di proletarizzazione e sottoproletarizzazione dei paesi poveri e delle zone povere dei paesi ricchi.
Forse tra pochi anni avremo poche grandi imprese che controllano tutto il mondo; queste sono le previsioni di esperti economisti. Non solo ma questo porta ad un totale svuotamento della democrazia nei paesi in quanto il governo ed i parlamentari che vengono « liberamente » scelti ed ai Guaii affidiamo la nostra delega di fatto non contano niente. La vita democratica diventa una farsa. L'umanità una massa di manovra.
— Scendendo troviamo nelle fabbriche una condizione di disumanizzazione e di sfruttamento dell'uomo. esse sono imoerniate su una oraanizzazione del lavoro che vieta all'uomo di esprimersi e di realizzarsi. Questa è basata sulla divisione del lavoro (parcellizzazione, standardizzazione, ritmi. aumenti di merito, mansioni) che è una imposizione di chi detiene il potere verso 'Duelli che sono sottomessi ed è funzionale alla conservazione del privilegio.
-
Solo i vertici possono decidere cioè pochi, è questa obbedienza non partecipazione, costringendo l'uomo ad un ruolo subalterno nel quale si trova incapace ad esorimere il proprio potenziale creativo umano, favorendo inoltre il determinarsi di falsi valori (mali l'ideologia della carriera, della competizione, dell'efficienza. che portano ad assumere un atteggiamento aggressivo nei confronti degli al-
Disaffezione dal lavoro
Il Vietnam ha vinto
tri, impedendo l'instaurarsi di un rapporto sincero, autentico.
Tutto ciò dimostra come questo mondo, questa società moderna sia di per sè impregnata di violenza e come questa vada denunciata a livello di questa struttura, di questa cultura.
Niente si salva, tutte le istituzioni sono violente: la famiglia dove i genitori sono psicologicamente violenti nei confronti dei figli perché a loro volta hanno ricevuto una educazione repressiva, perché scaricano su di loro le frustrazioni di tutti i giorni, perché li vogliono forgiare entro i limiti dei loro schemi mentali, perché a volte sono costretti per ragioni di lavoro a trascurarli. a delegare la responsabilità della loro formazione a delle istituzioni che oggi sono anche loro violente e in fondo ancora congeniali al perpetuarsi della ideologia dominante.
La scuola dove, con il metodo di insegnamento e con la selezione del voto tra l'altro supportato dal consenso dei genitori, si insegna al bambino ad essere individualista e aggressivo, ad essere efficente, a far carriera. a sentirsi diverso dagli altri col risultato di far suscitare nei Più bravi sentimenti di superiorità tendenti ad emarginare i meno bravi, i ouali a loro volta si sentono repressi e tendono a rinchiudersi o ad assumere reazioni negative.
L'individuo stesso diventa violento in conseguenza degli impulsi aggressivi la cuí espressione è favorita da tali istituzioni economiche e sociali. E LA RESPONSABILITA' E' DI HA IL POTFRF E NFI FATTI GESTISCE_ QUESTA SOCIETA' E NE MODELLA LA STRUTTURA.
— in questa situazione diventa facile per chi è detentore di potere e di privilegio (Per altro non sancito da nessun diritto naturale, ma che la legge, quella legge fatta ancora dagli stessi detentori d iprivilegio, ben salvaguarda e difende, vedi codice Rocco fascista), considerare violenti coloro i quali per rivendicare i propri ed altrui diritti più elementari di sopravvivenza, quali un salario più adeguato, condizioni più giuste, sono costretti ad entrare in quella
che il padrone considera la sua proprietà, per far sentire di più le loro istanze, e magari un vetro scappa rotto.
Diventa facile considerare violenza la collera dei poveri che costretti da condizioni di oppressione e di miseria alzano la voce per farsi sentire. Vengono considerati violenti coloro che chiedono il diritto di potersi riunire per discutere dei loro problemi. Mentre non è considerato violento quel padrone che froda il salario agli operai, che denuncia i lavoratori, che di fatto col suo rifiuto a trattare in un rinnovo contrattuale mette in atto tutto un clima ed un sistema di provocazione e di tensione. Che trasgredisce la legge sugli straordinari, che fa aumentare la disoccupazione, che produce a scopo di profitto strumenti che vengono poi usati per scopi bellici ed in guerre genocide da quel governo col quale si sono strette. forti alleanze economiche, che nei fatti insieme agli altri padroni si dimostra insensibile ai problemi angosciosi dell'umanità che soffre.
Vi sono dunque tante forme di violenza che creano le condizioni perchè gli uomini siano violenti: le situazioni di profonda ingiustizia e di disuguaglianza, tali da provocare difficoltà o imoossibilità alla soddisfazione dei bisogni fondamentali, l'umiliare le facoltà vitali dell'uomo, (creatività. fantasia, facoltà di scelta...) il distruggere la salute fisica e mentale. il manipolare le coscienze condizionando le scelte umane attraverso i mezzi di comunicazione di massa, la scuola, una certa orwiizzazione del lavoro imperniata sulla divisione e S,1ali au-nenti discriminati ecc. TUTTO QUESTO E' VIOLENZA.
— E' chiaro che in questa situazione non si pone il problema del12 violenza o non violenza. Il problema è sto'-'co prima ancora che etico o relinioso oerchè la violenza esiste già. è già nelle cose, viene nià fatta da qualcuno. La scelta da fare non più tra auella violenta e nuella non violenta. ma tra la violenza degli uni e quella degli altri. Non è più di scegliere se ammettere la lotta di classe o meno nerrhe le classi esistono già. LA gen TA nA FARE E' DA CHE PARTE SCHIERARCI.
Violento diventa allora non tanto colui che difendendosi contesta il sistema imperniato sulla violenza,
ma soprattutto colui che lo accetta e lo difende, o colui che per paura di sporcarsi le mani, se ne tira fuori finendo per diventare complice di una violenza già in atto.
Non è quindi un problema di VIOLENZA ma di GIUSTIZIA e la giustizia sta dalla parte dei poveri, dei più deboli, di quelli che vivono in condizioni di dipendenza di bisogno. Oggi questi sono la « CLASSE OPERAIA ».
La classe nella quale si scaricano con maggior violenza tutti i processi di disumanizzazione e che avendo preso coscienza di questo, mira a cambiare i rapporti per liberare tutti gli uomini, andando ad incidere alla radice dei processi del sistema produttivo che è generatore di violenza.
— La lotta di classe non è perciò odio contro qualcuno, ma lotta contro strutture violente e contro coloro che essendo schierati dalla parte di queste strutture, ne diventano complici della loro conservazione, per liberare l'uomo da questa condizione di assoggettamento affinchè possa realizzare se stesso, i suoi bisogni materiali, le sue aspirazioni umane e spirituali più profonde. E' quindi una espressione genuina di amore perchè risponde ad una esigenza vera di LIBERAZIONE.

Diritto di sciopero e diritto di picchettaggio

Valerio Onida - Professore di Diritto Pubblico all'Università di Sassari.
Innanzitutto occorre porre correttamente il problema della legalità delle forme di lotta della classe operaia. Non esiste una legalità soltanto, vale a dire una sola interpretazione neutra e oggettiva della legge.
Il punto fondamentale a cui agganciarsi è tuttavia rappresentato dalla Costituzione, la quale, pur essendo frutto di un compromesso politieo, fa notevoli aperture e favorisce una interpretazione dinamica della legge.
Ló sciopero, con la Costituzione, viene introdotto tra i proce• dimenti della legalità e tra i meccanismi costituzionali dello Stato. Non è più considerato un attentato alla tranquillità degli abbienti (Calamandrei, 1952).
Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero non risolve però tutti i problemi. A partire dalla Costituzione si aprono molte strade (la C. non dà risposta su tutte le questioni inerenti al diritto di sciopero): ciò spiega perchè si può arrivare ad interpretazioni opposte.
La Costituzione, riconoscendo il diritto di sciopero, ammette che non ci debba essere una composi-
zione autoritativa degli interessi, e lascia uno spazio di autoregolamentazione da parte delle forze sociali interessate. Lo sciopero costituisce infatti una forma di autotutela collettiva di interessi.
Da questo punto di vista lo sciopero può collocarsi tra i diritti fondamentali di libertà assieme ad altri tradizionali (diritto di parola, di riunione, ecc.), ma come diritto collettivo e non individuale. Entro certi limiti (ad esempio il rispetto della dignità della persona) la Costituzione appare infatti ispirata a un criterio di prevalenza degli interessi collettivi rispetto a quelli individuali (art. 2).
Quindi lo sciopero non può essere considerato un diritto dei singoli a « starsene a casa », ma deve essere considerato come un diritto ad una azione collettiva di lotta della classe operaia per mutare l'assetto socio-economico e i rapporti di forza esistenti.
Rispetto ai limiti al diritto di sciopero va considerato che il limite ad un diritto costituzionale può derivare esclusivamente da un altro bene protetto dalla Costituzione. Tra i beni protetti dalla Costituzione vi è poi una graduazione: occorre cioè fare una scelta di priorità. Qui si apre un ampio Campo di scelte interpretative, fat-
te dal legislatore o dal giudice, alle quali non si può non riconoscere anche in questo secondo caso, se non si vuole mistificare, la natura di scelte politiche.
Per le cose dette — e in base ai princìpi di interpretazione della Costituzione generalmente accettati (ad esempio: i beni economici sono meno importanti dei diritti personali), Io sciopero (diritto fondamentale di libertà e collettivo) prevale sui redditi economici (interesse del datore di lavoro al profitto, interesse alla continuità della produzione, ecc.), e può prevalere su certi interessi individuali.
Quanto al crumiraggio, esso non riceve una valutazione positiva dalla Costituzione. Innanzitutto non è specificamente protetto. Non si può richiamare a questo riguardo il « diritto al lavoro » di ogni cittadino previsto dall'art. 4. Infatti qui il diritto al lavoro, in collegamento con il secondo comma dell'art. 3 (« è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... che... impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese ») è inteso come dovere per la società organizzata a favorire la creazione di po-
DOMAMI SUoPeR0 SE S1D ftICIZI IL CAPO MI PQENDE Di MIRA FlN e-I-K1 PE9D` DEVO DECiDERlf ENTRo AoworwASFC-u6 MESTI 3CIOPYRi cc" PREAVviSo HI SEN8RAga•-., UN INUTILE 5 ADiSt10—.sti di lavoro per tutti. In altre parole, sotto questo profilo, è la disoccupazione che rappresenta una violazione all'articolo 4, e non certo le azioni che impediscono il crumiraggio.
Nè si può richiamare l'art. 39 (« L'organizzazione sindacale è libera... »), configurandosi la libertà sindacale in termini di valutazioni collettive e non già individuali; vale a dire, come diritto per i lavoratori di organizzarsi collettivamente.
Nè infine si può richiamare l'art. 40 (diritto di sciopero): il crumiraggio, lungi dal costituire l'esercizio di un diritto costituzionale, rappresenta piuttosto la rinuncia
all'esercizio di un diritto costituzionale. E siccome si tratta di un diritto « funzionale » (cioè finalizzato al mutamento dei rapporti sociali ed economici attraverso la lotta sindacale) non è concepibile un suo esercizio « negativo », come invece è possibile per altri diritti di libertà di non manifestare il proprio pensiero, di non associarsi.
II crumiraggio in sostanza si configura come un comportamento individuale che tende a contrapporsi ad un'azione collettiva diretta al conseguimento di obiettivi collettivi in funzione dei quali la Costituzione protegge lo sciopero. .
Di qui la valutazione negativa sul crumiraggio implicita nella Co-
stituzione.
Sotto questo profilo il crumiraggio presenta una qualche analogia con la condotta antisindacale, quale la creazione da parte padronale di un sindacato di comodo, tanto più se si ha variazione delle mansioni durante lo sciopero (ad esempio, il direttore di banca che sostituisce il cassiere in sciopero).

Da quanto detto, in conclusione, appare evidente che il picchettaggio — in quanto modalità di organizzazione dello sciopero che cerca di evitare un danno collettivo derivante dal crumiraggio individuale — è dunque del tutto legittimo.
Una vorta un Cavallo strucchione ch'ogni tanto cascava pe' strada scioperò pe' costringe er Padrone a passaje più fieno e più biada; ma er Padrone s'accorse der tiro e pensò de pijasse un crumiro.
Chiamò er Mulo, ma er Mulo rispose: — Me dispiace, ma proprio nun posso; se Dio guardi je faccio ste cose li cavalli me sarteno addosso... — Er Padrone, pe' mette un riparo,fu costretto a ricorre ar Somaro.
LE BESTIE E ER PADRONE
Nun pò stà che tradisca un compagno: disse er Ciuccio — so' amico der Mulo, e purlo, come lui, se nun magno, tiro carci, m'impunto e rinculo... Come vòi che nun sia solidale se ciavemo l'istesso ideale?
Chiama l'Omo, e sta' certo che quello fa er crumiro co' vera passione; per un sòrdo se venne er fratello, pe' du' sòrdi va dietro ar padrone, finchè un giorno tradisce e rinnega er fratello, er padrone e la Lega.
(Trilussa)
POESIA DEDICATA Al CRUMIRIDisaffezione dal lavoro
Si è parlato molto ultimamente e si continua ancora a scrivere fiumi di parole a proposito ed a sproposito, il più delle volte, intorno all'assenteismo ed alla disaffezione dal lavoro. Credo sia opportuno ritornare ancora su questo problema così sentito ed importante per la classe padronale tanto che lo stesso presidente Leone così sensibile ai mugugni ed alle piangine del padrone se ne è fatto carico e non ha perso occasione nella sua benedizione televisiva di fine anno al « Popolo » per dare una benedizione particolare, tramite una accusa pesante, a quei lavoratori che durante l'anno fanno tante assenze dal lavoro affinché iniziassero il nuovo anno con propositi dí occuparsi un po' meno della loro salute ed un po' più di quella dei padroni, salute economica s'intende.
Ma lasciamo a parte le ironie alle quali siamo provocati dalle affermazioni dei padroni. per cercare di affrontare invece la questione seriamente come essa merita.
I VERI AMMALATI SONO LA FABBRICA E LA SOCIETA'
Credo sia necessario ancora sottolineare come è stato affermato più volte e come del resto viene messo in evidenza anche dalle statistiche e dagli studi fatti appositamente (veddi dati ISRIL, rapporti clinica del lavoro di Milano, statistiche INAIL) che l'indice di assenteismo non è poi aumentato come i padroni vogliono far credere e come al fenomeno ci siano delle motivazioni pienamente giustificate. Infatti vengono messe in evidenza le cause vere: l'aumento delle malattie professionali, che non sto ad elencare, degli infortuni. la presenza di agenti nocivi nell'ambiente di lavoro, il continuo aumento di malattie psichiche, in altre parole le condizioni di malattia vera in cui si trova la fabbrica e la società in senso lato, che sta pian piano distruggendo l'uomo.
Bastano questi pochi dati ricavati da un'indagine conoscitiva
svolta dalla Commissione Industria e Commercio della Camera sulla situazione dell'industria degli elettrodomestici per confermare la veridicità di quanto affermato sopra.
Infatti in uno stabilimento di Co negliano Veneto dove si è svolta la ricerca su 1200 operai si è constatato che (vedi « Sole 24 ore 28-7-1972):

il 40% è afflitto da esaurimento nervoso;
il 22% soffre di insonnia; più del 50% ha dichiarato aver perduto la voglia di divertirsi;
il 17% denuncia disturbi della sfera sessuale.
L'aspetto più allarmante è che il peso della linea di montaggio è maggiormente sentito dai giovani per i quali il salto dalla famiglia alla vita di fabbrica è insopportabile al punto da costringerli a licenziarsi.
Sempre dalle stesse statistiche si può arrivare ad altre considerazioni; si può notare che i gruppi che presentano tassi di assenteismo più elevati e più bassi sono sempre gli stessi e ciò induce a ritenere che deve essere messo in relazione con alcune caratteristiche strutturali dei settori in cui si manifesta. Oppure che le assenze tendono ad aumentare là dove c'è una percentuale elevata di manodopera femminile e minorile occupata.
Questo dimostra la insufficienza delle condizioni della donna al di fuori della fabbrica, cioè la carenza dei necessari servizi sociali (asili nido, trasporti, strutture scolastiche e così via, oltre alla condizione di subordinazione a cui è relegato il ruolo della donna ancora oggi.
ALIENAZIONE E SPERSONALIZZ/3ZIONE
Tuttavia esiste un margine di assenteismo che non è malattia vera e propria m aè disaffezione dal lavoro e che la classe operaia non deve nascondere perché reale. Ma esiste un altro tipo di « disaffezione » se così si può chiamare che non può essere disgiunta
dalla prima, è un sintomo molto grave dal punto di vista della realizzazione umana perché porta a frustrazioni e alienazione, e della quale i padroni sembra non si preoccupino perchè non arriva agli estremi della astensione dal lavoro e perchè probabilmente è più controllabile un lavoratore alienato di uno integro ed autonomo nelle sue capacità intellettuali e di scelta. E' la dissociazione che esiste tra l'uomo e il lavoro che sta svolgendo, che inizia quando ci si accorge più o meno coscientemente del non senso di quello che si fa, della illusione di essere creatori della propria attività; anzi questa viene rapinata e strumentalizzata per fini alle cui decisioni il lavoratore non è in nessun modo partecipe.
Chi ricorda il film « La classe operaia va in Paradiso » ricorda anche come l'azione dell'operaio protagonista fosse rivolta al pezzo cioè alla realizzazione del cottimo ma la sua aspirazione interiore era rivolta verso il « culo della ragazza «. Questo lo "si pub riscontrare anche in IBM tra noi lavoratori, non ci realizziamo e non ci identifichiamo in Quello che facciamo, tuttavia lavoriamo. ma con il nostro pensiero in tutt'altre direzioni.
E qui scatta tutto un meccanismo di evasione e di falsa compensazione al di fuori del lavoro; vedi barzellette e materiale pornografico circolante, oppure la trasposizione della propria realizzazione sul piano religioso mediante un ripiegamento di tipo intimistico privo di alcun valore perché non imperniato su una fede che passa attraverso l'analisi degli eventi storici, oppure la trasposizione della realizzazione al di fuori della fabbrica nella famiglia, nella società, negli hobby, nel possesso di beni materiali (casa, macchina, ecc.).
Dov'è la creatività del lavoro, l'estrinsecazione delle nostre migliori capacità interiori per una nostra promozione umana e sociale; questo è il modo migliore per distruuggere quello che di buono abbiamo dentro!
Naturalmente questa dissociazione lavoro-pensiero non è una CONTINUA IN
causa ma un effetto, è un modo di reagire al sistema competitivo a cui siamo sottoposti in fabbrica; alla concentrazione per il controllo delle macchine per gli operai soprattutto dove esistono catene di montaggio o ritmi prefissati, al ritmo intensivo e di stress psicologico di tutta la giornata lavorativa, ed infine alla mancanza di un senso a quello che si fa in relazione ai propri bisogni specifici ed all easpírazioni ad una maturazione personale al fine di tentare di recuperare parzialmente la propria autonomia e dignità umana.
Questa esperienza dissociativa che l'uomo vive in fabbrica e che non gli permette di vivere una dimensione globale di creatività e di espressione di vita è di per sè aia significativo anche se non sufficiente per mettere in evidenza le perversioni di questo tipo di organizzazione del lavoro.
Riscontriamo auindi in auanto descritto sinora due motivi fondamentali della disaffezione:
Disaffezione come conseguenza della perdita di professionalità e di creatività del lavoro e quindi impossibilità di esprimersi da parte dell'uomo.
Disaffezione dovuta a motivi di appartenenza, di mancanza di identificazione con quelli che sono i fini dell'azienda e perciò i valori proposti alle cui scelte il lavoratore non è chiamato a partecipare. Anzi, per il raggiungimento dei fini dell'azienda. si fa leva arbitrariamente sugli aspetti meno nobili del-
la personalità umana, quali egoismo, carrierismo, desiderio di consumismo imposto occultamente, indifferenza verso sè stessi e quindi verso gli altri (quelli che ci stanno vicino e tutti quelli che vivono in condizioni peggiori delle nostre), sfiducia nell'uomo, perché si dice che gli uomini sono tutti egoisti senza però vedere il perchè.
LA SCIENZA E LA TECNICA NON SONO NEUTRALI
Ma per mettere in evidenza meglio il fenomeno disaffezione, è necessario fare una analisi di tutta l'attuale organizzazione del lavoro e risalire alle cause presenti e remote mettendo in evidenza anche le contraddizioni intrinseche che si manifestano.

Occorrerà allora rifarsi a quella che è la divisione del lavoro nell'attuale organizzazione aziendale e al processo di spinta alla divisione che è stato attuato in fabbrica oggi; divisione del lavoro che apparentemente sembra un fatto solo tecnico e auindi una necessità di migliore efficienza organizzativa, ma che in realtà è anche un fatto altamente politico perchè il committente della scienza e della tecnica e quindi dell'organizzazione, che oggi è il Capitale (padrone), ha anche le possibilità oggettive di cestire come vuole la forza lavoro. E la saprà gestire in misura tanto maggiore quanto maggiormente riuscirà a creare dei meccanismi di divisione tra i lavoratori, meccanismi che con la divisione del lavoro, riesce a creare perfettamente. Vedi esempio IBM con le
píù di mille mansioni sempre più in via di parcellízzazione e dequalificazione.
Il processo di spinta alla divisione inizia essenzialmente con il passaggio dalla industria a basso quantitativo di produzione alla industria della produzione in serie di elevati quantitativi.
Questo avviene perchè c'è un mercato di massa che dà la possiblità di smerciare beni a grandi masse. Si introducono le catene di montaggio e si rende necessario razionalizzare per ridurre i costi. ecco allora l'applicazione del Taylorismo con la spinta alla divisione ed alla parcellizzazione delle mansioni. Vediamo oggi che il lavoro qualificato si riduce semnre di più in quanto è entrato all'interno della macchina, e rimane sempre di più ai margini della 'Produzione (manutenzione e qualche altro servizio).
La deaualificazione non si ferma al mondo operaio ma si estende nel settore impiegatizio ed anche nei settori fuori della fabbrica. perchè c'è l'esigenza di pianificare, standardizzare e controllare sempre più il lavoro.
Va sottolineato come í tentativi della job rotation, dell'arricchimento delle mansioni, già attuato in IBM, o il nuovo modo di fare l'automobile (Volvo - Svezia) non abbia portato a nessun mutamento e quindi non sia lo sbocco di salvezza perchè il problema sta a monte e cioè nell'estraneità del lavoratore alle decisioni, alle scelte dell'azienda e ai fini della produzione.
pON Si Puo'ANIARE AVAPITi ALL'INFINITO A sFwerAkE gimIM SENZA SAPERE iVEANCidE 0116 Co5A Si garm..Tutto questo non è un fatto neutrale ma porta ad una modifica sostanziale dell'applicazione del concetto di gerarchia. La figura del capo diventa sempre meno guida tecnica, colui che conosce meglio il lavoro, colui che ne sa di più per trasformarsi e diventare sempre più una figura di controllo della forza del lavoro, una guida politica, colui che da più affidamento nel trasmettere la ideologia che sta alla base delle politiche aziendali.
L'UOMO VIENE EMARGINATO
Questo processo di divisione e dequalificazione nella fabbrica dà luogo a delle conseguenze che hanno una enorme influenza sul piano umano, sociale e culturale.
Vediamo infatti il crearsi di tanti livelli di mansione con l'assegnazione ad ognuno di essi di una fascia salariale, si verificano allora tra i vari livelli delle disuguaglianze salariali enormi che poi rimangono stabili perchè chi viene inserito nei livelli più bassi, dovendo svolgere un lavoro stupido, semplice, in realtà ha poche possibilità di imparare e migliorare per poter passàre a mansioni più qualificate.
Siccome oggi nella società il lavoro identifica l'uomo e diventa il parametro con cui giudicare l'altro, cioè se fa un lavoro manuale, intellettuale, ben remunerato o po-
co remunerato (per l'IBM operaio, impiegato Junior esperto, professional, professional senior, capo, dirigente ecc.), ne consegue una stratificazione degli uomini non solo a livello dei ruoli e delle competenze tecniche ma anche a livello della dignità, della responsabilità del potere, della libertà.
Un'altra conseguenza per l'uomo che fa un lavoro standardizzato, parcellizzato, monotono, controllato è l'impossibilità di esprimersi nel lavoro stesso.
Diceva Adam Smith: « L'uomo che passi l'intera vita ad eseguire poche e semplici mansioni non ha alcuna possibilità di esercitare la propria intelligenza, di solito egli diviene tanto stupido quanto è possibile a un rssere umano: l'uniformità della sua vita stazionaria intacca per forza di cose anche il coraggio del suo spirito, intacca sinanco le energie del suo corpo e lo rende incapace di sniegare con perseveranza la sua forza al di fuori di quella specifica occupazione alla quale è stato abituato. In ogni società industriale e civile è necessario che i poveri lavorino, ossia che le grandi masse del poi nolo si riducano in queste condizioni ». (A. Smith in « Ricchezza delle nazioni »).
Questa diventa allora non una tecnica oraanizzativa ma di sfruttamento dell'uopo; solo pochi possono decidere, cioè i vertici, agli altri viene chiesta obbedienza tramite un'organizzazione rigida, privandola di tutto il potenziale creativo degli uomini che più o meno con-
sapevolmente accettano di rinchiudersi in un mondo di rasseghazione privo di rischi e di lotta.
CONSUMARE AL DI LA' DEL BISOGNO
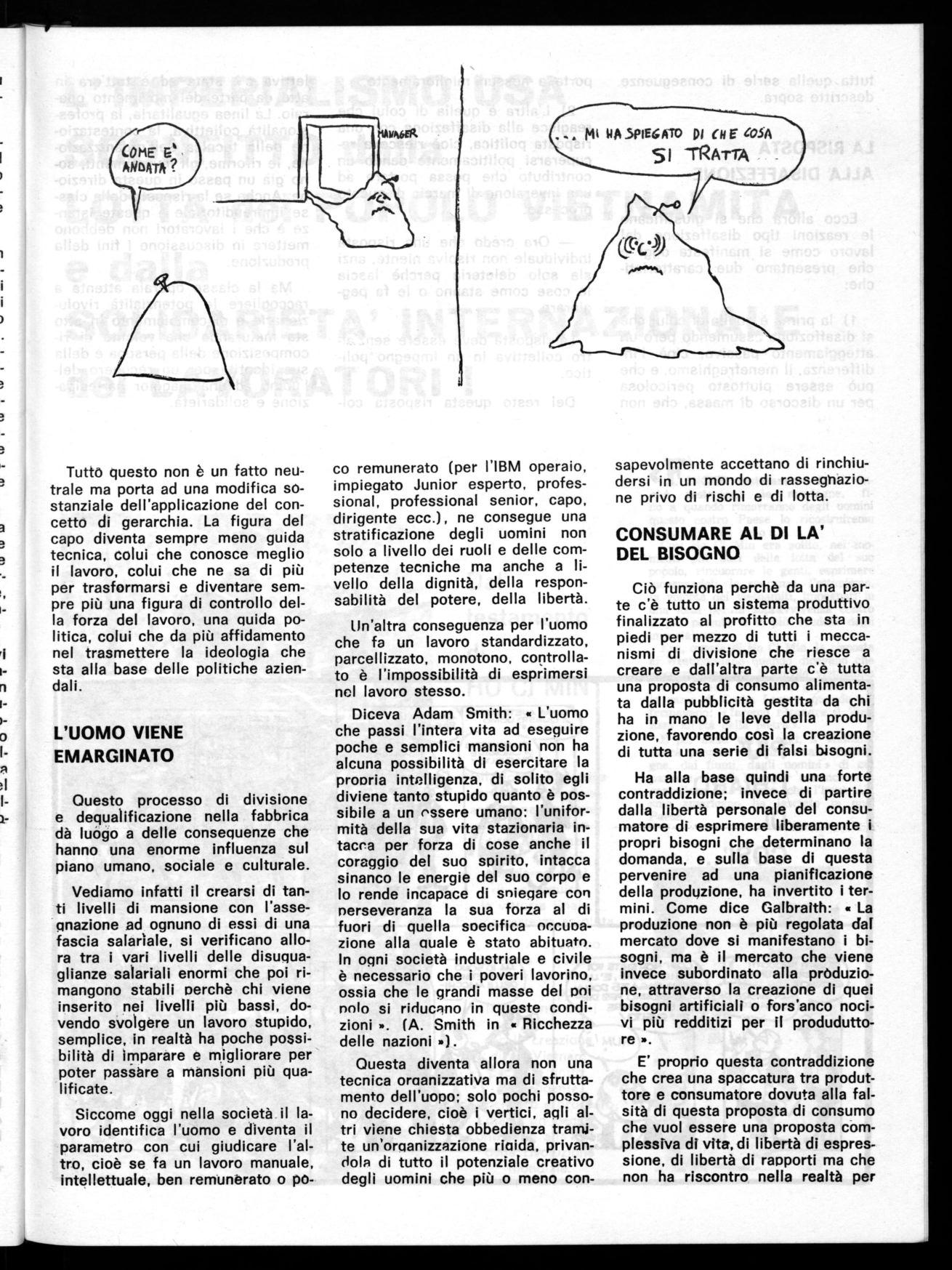
Ciò funziona perchè da una parte c'è tutto un sistema produttivo finalizzato al profitto che sta in piedi per mezzo di tutti i meccanismi di divisione che riesce a creare e dall'altra parte c'è tutta una proposta di consumo alimentata dalla pubblicità gestita da chi ha in mano le leve della produzione, favorendo così la creazione di tutta una serie di falsi bisogni.
Ha alla base quindi una forte contraddizione; invece di partire dalla libertà personale del consumatore di esprimere liberamente i propri bisogni che determinano la domanda, e sulla base di questa pervenire ad una pianificazione della produzione, ha invertito i termini. Come dice Galbraith: « La produzione non è più regolata dar mercato dove si manifestano i bisogni, ma è il mercato che viene invece subordinato alla pròduzione, attraverso la creazione di quei bisogni artificiali o fors'anco nocivi più redditizi per il produduttore ».
E' proprio questa contraddizione che crea una spaccatura tra produttore e consumatore dovuta alla falsità di questa proposta di consumo che vuol essere una proposta complesgva di vita, di libertà di espressione, di libertà di rapporti ma che non ha riscontro nella realtà per
tutta quella serie di conseguenze porta a nessun miglioramento. descritte sopra.
LA RISPOSTA ALLA DISAFFEZIONE
Ecco allora che si giustificano le reazioni tipo disaffezione dal lavoro come si manifesta oggi e che presentano due caratteristiche:
1) la prima è quella di colui che si disaffeziona cssumendo però un atteggiamento passivo, cioè l'indifferenza, il menefreghismo, e che può essere piuttosto pericolosa per un discorso di massa, che non
2) L'altra è quella di colui che reagisce alla disaffezione con una risposta politica, cioè riesce a recuperarsi politicamente dando un contributo che possa portare ad una inversione di marcia di questo processo.
— Ora credo che una risposta individuale non risolva niente, anzi sia solo deleteria perchè lascia le cose come stanno o le fa peggiorare.
La risposta deve essere senz'altro collettiva in un impegno politico.
Del resto questa risposta col-
lettiva c'è stata ed è tutt'ora in atto da parte del movimento operaio. La linea egualitaria, la professionalità collettiva, la contestazione della tecnica dell'organizzazione, le riforme, gli investimenti, sono già un passo in questa direzione. Anche se la risposta della classe imprenditoriale a queste istanze è che i lavoratori non debbono mettere in discussione i fini della produzione.
Ma la classe operaia attenta a raccogliere le potenzialità rivoluzionarie e di cambiamento in atto sta maturando una volontà di ricomposizione della persona e della sua identità per un recupero dell'uomo ad una maggior partecipazione e solidarietà.

SCONFITTO dalla
LOTTA del POPOLO VIETNAMITA e dalla

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE dei LAVORATORI !
FINCHE' resteranno i fiumi, finchè resteranno le montagne, fino a quando rimarranno degli uomini questo nostro Paese lo ricostruiremo dieci volte più bello ».
Così Ho Ci Min era solito, nei momenti più duri della lotta del suo popolo, rincuorare le genti, esprimere incarnandoli, la speranza, l'ottimismo, la volontà dei vietnamiti, impegnati in una lotta per .1a sopravvivenza contro il più potente e il più crudele degli Era, questa di Ho Ci Min, la risposta ai Westmoreland quando dicevano che « occorre segnare il popolo vietnamita per degli anni interi ›, ai generali della razza di Curtis Lemay, quando affermavano: « faremo ritornare il Vietnam all'età della pietra ».
Nella lotta patriottica contro l'aggressione americana, dovremo in verità subire altre sofferenze e altri sacrifici, ma siamo certi di conseguire la vittoria finale. E' una certezza assoluta. (...) Il mio ultimo desiderio è questo: tutto il partito, tutto il popolo, strettamente uniti si battano per la creazione di un Vietnam pacifico, unito, indipendente, democratico.e prospero, diano un degno contributo alla causa della rivoluzione mondiale.
E per molti versi, oggi, il Vietnam, dovrà proprio ripartire «dalle montagne, dai fiumi, dagli uomini » di cui parlava Ho Ci Min per cominciare a cancellare il « segno » che l'imperialismo americano ha lasciato in quel Paese.

