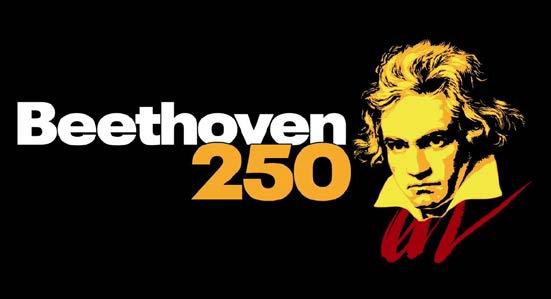11 minute read
1770-2020 - Omaggio a Beethoven per i suoi primi 250 anni
Vita, stile e testimonianze di un grande compositore
Non ci sarà purtroppo possibile rendergli omaggio come avremmo voluto, ma nel dicembre 1770, quindi 250 anni fa, veniva alla luce uno dei titani (forse il più grande, ma ammetto candidamente una netta e spudorata preferenza) della musica colta europea, Ludwig van Beethoven. Contemporaneo e lettore di Immanuel Kant, Wolfgang Goethe e Friedrich Schiller, Beethoven incarna la nuova figura del compositore moderno: con lui l’espressione dell’interiorità dell’artista e delle sue dolorose vicende esistenziali viene in primo piano. Col suo lavoro, la nuova coscienza storica e morale che aderisce ai grandi ideali di libertà e giustizia emersi dalla Rivoluzione francese investe la creazione musicale. Nella potente novità della concezione della sua musica si avverte il passaggio epocale tra Settecento e Ottocento. Parliamo inoltre di uno dei primi artisti pienamente consapevoli della grandezza della propria arte, poco disposto a compromessi e piaggerie nei confronti di nobili e potenti. Ludwig van Beethoven nacque a Bonn, in Germania, nel 1770. La sua famiglia aveva origini fiamminghe, essendosi suo nonno trasferito dalle Fiandre (ove il contrappunto la faceva da padrone pochi secoli prima) intorno al 1730, entrando come strumentista nella cappella arcivescovile. Suo figlio Johann, padre di Ludwig, era stato tenore nella stessa cappella. Lo studio del pianoforte, dell’organo e della composizione con l’organista di corte Christian Gottlob Neefe garantì al giovane Ludwig una buona formazione musicale. Beethoven ebbe inoltre la fortuna di essere introdotto in casa del consigliere di corte von Breuning, e di essere assunto come organista, nel 1784, dal nuovo elettore Maximilian Franz, il quale, promotore di idee aperte e illuminate, aveva ampliato l’orizzonte culturale della città, fondando anche un’università presso la quale Beethoven frequentò alcune lezioni di filosofia. Da Bonn Beethoven intraprese alcuni viaggi a Vienna, ove si stabilì definitivamente nel 1792, e dove studiò con Franz Joseph Haydn, Johann Georg Albrechtsberger e col compositore della corte imperiale Antonio Salieri. Sostenuto dagli ambienti aristocratici, che ne ammiravano per lo più il talento di improvvisatore al pianoforte, tollerando spesso le sue asprezze caratteriali, ebbe tra i maggiori mecenati il principe Karl von Lichnowsky, al quale egli dedicò la famosa sonata per pianoforte detta Patetica (1799), e il conte Andreas Razumowsky, che mantenne a sue spese un quartetto d’archi, mettendolo a
Advertisement
disposizione del compositore. A questo primo periodo viennese risalgono lavori orchestrali quali la Prima (1799-1800) e la Seconda sinfonia (1800-02), le prime Sonate per pianoforte, i Trii per archi op. 9 (1796-98), i Quartetti per archi op. 18 (1798), i primi tre Concerti per pianoforte e orchestra (1798, 1801, 1802). Queste opere, che pur contengono in nuce elementi originali e innovativi, sono ancora vicine al mondo espressivo settecentesco, quello di Haydn e Mozart. Nel frattempo però, sul finire del secolo, si stavano manifestando i primi sintomi di quella che sarebbe stata la malattia che poi l’avrebbe tormentato: la sordità. L’impatto, anche emotivo, fu pesantissimo; la sordità totale sopraggiunse nel 1819, costringendolo a comunicare solo attraverso del “quaderni di conversazione” (che sono però per noi posteri una grande fonte di informazioni). Beethoven fu anche uno dei primi a esprimere, per iscritto e con una prosa che risente pienamente del periodo romantico in cui viveva (parliamo sempre di Romanticismo tedesco, ovviamente) considerazioni sull’arte e sulla vita. Di grande impatto è quindi il Testamento di Heiligestadt, che prende il nome dalla dimora di campagna vicino a Vienna, dove fu redatto nel 1802. Le parole del compositore, pur nella drammaticità della situazione, lasciano intravvedere la reazione energica e quasi “Eroica” dell’uomo di fronte alle avversità del destino, e il dolore al quale egli oppone una volontà di superamento (per aspera ad astra). Vi si legge anche quale deve essere la nuova funzione dell’arta: non più solo quella di piacevole intrattenimento, ma di espressione dell’interiorità dell’artista e della moralità dell’uomo. Dopo il Testamento di Heiligestadt si accentuarono gli elementi innovativi e gli scostamenti dalla tradizione; la Terza sinfonia detta Eroica (1802-04) venne composta sull’onda dell’entusiasmo per gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità espressi dalla Rivoluzione francese. In un primo tempo il compositore aveva dedicato la sinfonia, “composta per festeggiare il sovvenire di un grande uomo”, a Napoleone Bonaparte; la dedica venne però rabbiosamente tolta quando Napoleone, nel 1804, si fece incoronare imperatore, tradendo lo spirito rivoluzionario (Beethoven non fu l’unico a sentirsi tradito dal generale corso: anche Ugo Foscolo riflette nell’opera epistolare Ultime lettere di Jacopo Ortis la delusione per il trattato di Campoformio e per la deriva presa dal Bonaparte). Nella Quinta e nella Sesta sinfonia emergono ulteriormente le nuove idee musicali, attraverso l’energia della Quinta (col celeberrimo incipit) e la serena cantabilità della Sesta (detta Pastorale), in cui Beethoven presenta un altissimo esempio di quella che poi sarà la musica “a programma”, che si ispira a un programma extramusicale. In questo caso, il compositore tradusse in suoni i sentimenti suscitati dalla contemplazione della natura, un fondamentale tema d’ispirazione del Romanticismo. Nell’ultimo decennio di vita, lo stile di Beethoven si indirizzò verso un nuovo mondo sonoro: all’eroismo energico della produzione precedente si sostituì un abbandono al flusso del sentimento, secondo una sensibilità ormai pienamente romantica; questa evoluzione si coglie chiaramente nelle ultime cinque Sonate per pianoforte, scritte tra il 1816 e il 1822, in cui la forma tradizionale tende a dissolversi. Ciò avviene anche negli ultimi Quartetti per archi, composti tra il 1822 e il 1826. Le soluzioni formali e musicali, che prevedono un forte recupero del contrappunto, rivelano un’originalità e modernità che tuttavia parte del pubblico dell’epoca non fu in grado di comprendere. Pur dovendo necessariamente abbreviare per necessità di sintesi, e non potendo analizzare ogni lavoro, non si può non menzionare, all’interno della meno famosa ma non meno bella Settima sinfonia, il secondo movimento, un Allegretto caratterizzato da un dolente incedere e da piccoli barlumi di speranza, metafora dell’esistenza umana. L’ultima sinfonia, la Nona (1822-24), è caratterizzata dall’inserimento dell’Inno alla gioia di Friedrich Schiller; il coro celebra la tensione di tutta l’umanità verso la fratellanza universale, tramite un messaggio di solidarietà morale e di libertà. Gli ultimi anni (Beethoven si spense nel 1827) furono ancora fecondi e pieni di progetti; la sua produzione è vastissima, e attraversa tutti i generi musicali che all’epoca venivano praticati: non solo sinfonie, quartetti, cantate, ma anche musica per pianoforte, musica da camera, messe e oratori, musiche di scena e un’unica opera, il Fidelio. Non basterebbe un volume per parlare del suo stile musicale, della sua evoluzione, del suo carattere impaziente, leggendario almeno quanto lui. Molto si potrebbe ricavare approfondendo le sue idee politiche, i suoi interessi culturali, la sua personalità non facile, forse influenzata dalla famiglia (molto si è scritto sul carattere violento del padre); non si sposò mai, ma questo non vuol dire che non ebbe passioni. Non ebbe figli, ma cercò, pur commettendo errori, di essere una guida per il nipote… È forse meglio lasciare che sia lui a parlare in prima persona, nei testi riportati nelle prossime pagine. Segue poi un approfondimento sul contributo della musica di Beethoven alla settima arte: il cinema! Paola Magnaghi
La voce di Beethoven
dal testamento per i fratelli Carl e [Johann] Beethoven, 6 ottobre 1802