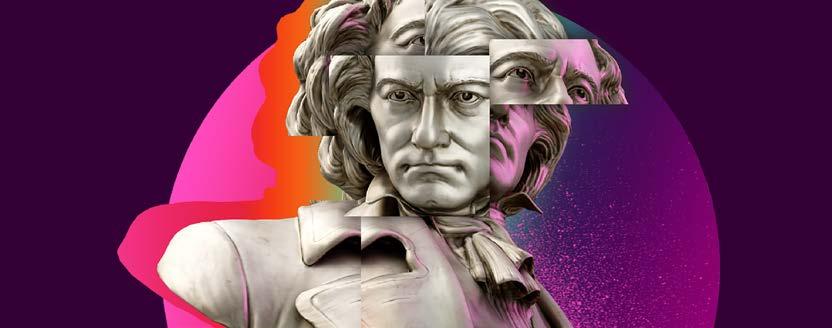6 minute read
Classica o popolare... è sempre musica!
Articolo di Gianni Rainoldi
L’inizio della contaminazione tra la musica seria e la musica popolare si può far coincidere col Romanticismo.
Advertisement
Proprio i musicisti romantici iniziarono a fare aperto riferimento alla musica popolare, citando nelle loro composizioni vere o presunte canzoni popolari.
Mendelssohn, per esempio, nella famosissima Sinfonia op. 90 in la maggiore conosciuta come Italiana cita in maniera diffusa temi popolareschi; nei suoi Lieder ohne Worte (canzoni senza parole) compone brani di intenzione vagamente popolare: per esempio, le cosiddette “barcarole” sono intese come il genere di melodie cantate dai gondolieri veneziani (il loro nome tedesco è Venetianisches Gondellied, ovvero “canto da gondola veneziano”).
Sempre Mendelssohn indica nelle sue opere precisi riferimenti a realtà geografiche, specie con riferimento alla Scozia, come nella meravigliosa Sinfonia op. 56 in la minore nota come Scozzese o nel brano Fingal’s Cave (la grotta di Fingal).

Felix Mendelssohn - Fingal's Cave
https://www.youtube.com/watch?v=zcogD-hHEYs

Felix Mendelssohn - Venetianisches Gondellied
https://www.youtube.com/watch?v=DTqPJ2_ZAQ8
Altri compositori della prima fase del Romanticismo, nell’alveo del nazionalismo che fa parte del pensiero romantico e anche nella ricerca di una maggior libertà formale, si sono richiamati a melodie o a ritmi con un chiaro riferimento alla propria patria: è il caso di Chopin, che compose numerose mazurke, danze tipiche del proprio Paese, e diverse polonaises (polacche), brani con andamento solenne di evidente origine. Le polonaises peraltro erano brani già entrati nell’uso della musica seria da molti anni (se ne ricordano numerose composte da Johann Sebastian Bach, la più famosa delle quali è forse quella contenuta nella Overture BWV 1067). In Chopin è evidente il costante richiamo alla musica popolare del proprio Paese, la Polonia.

Frédéric Chopin - Polonaise da Op. 44
https://www.youtube.com/watch?v=ehm_kDU563Q

Johann Sebastian Bach - Polonaise da Overture BWV 1067
https://www.youtube.com/watch?v=z0ftSQ7N7e0
Analogamente altri artisti romantici hanno composto brani con riferimenti popolari. Procedendo in ordine rigorosamente cronologico, Liszt (nato nel 1811, mentre Chopin era del 1810) compose numerosi brani di ispirazione e riferimento popolare, con riferimento alla propria patria d’origine, l’Ungheria (anche se Liszt era di formazione tedesca e non ungherese, e si esprimeva in tedesco), tra cui danze di origini ungheresi come le csárdás e soprattutto le famosissime Rapsodie ungheresi. Nelle sue opere pianistiche, spesso improntate a un virtuosismo trascendentale, non mancano poi citazioni di ritmi popolari stranieri (come la tarantella).

Franz Liszt - Rapsodie ungheresi
https://www.youtube.com/watch?v=I9AK1alrIHA
Il riferimento popolare è stato presente anche nei compositori della “seconda fase” del Romanticismo, che in un modo o nell’altro hanno pagato il proprio obolo alla musica popolare.
Brahms, fra l’altro, con le famosissime Danze Ungheresi; Dvořák, il quale, oltre ad aver evocato nelle sue composizioni ritmi della sua patria d’origine, nella Sinfonia in mi minore op. 95 “Dal nuovo mondo” ha dato ingresso finalmente alla musica popolare americana, con la citazione nel primo movimento dello spiritual Swing Low Sweet Chariot e con l’inserimento nel secondo movimento di un tema inventato dal compositore che si richiama allo spiritual (tant’è che in seguito per la melodia di tale brano furono scritti dei testi e fu chiamato Goin’ Home).

Johannes Brahms - Danze ungheresi
https://www.youtube.com/watch?v=QAMxkietiik
Čajkovskij ancora, oltre a composizioni di tono russo e di palese ispirazione nazionalistica e patriottica, nelle quali vengono citati brani della tradizione nazionale, ha al suo attivo il famosissimo Capriccio italiano nel quale parafrasa e rielabora alcuni brani regionali nostrani. Tra i contemporanei di Čajkovskij, Grieg costruì il proprio stile sulla base del folklore norvegese, componendo brani ispirati alla musica del suo Paese e trascrizioni armonizzate di melodie popolari, riuscendo a realizzare uno stile personale e riconoscibile sul quale fondò il proprio successo. Medesimo discorso va fatto per il finlandese di lingua svedese Sibelius che, non diversamente da Grieg, svolse la propria attività creativa attraverso la ricerca di melodie fortemente caratterizzate sotto il profilo nazionale.
Non si deve peraltro dimenticare l’opera di Mahler, che si servì di materiale popolare delle origini più disparate, a partire da melodie klezmer fino a temi e melodie della tradizione boema e austriaca.
Va detto comunque che tutti questi musicisti si servirono di melodie popolari come materiale tematico da rielaborare liberamente, armonizzandolo e modificandolo. Il riferimento popolare veniva utilizzato come mero pretesto creativo, come ispirazione ritmica o armonica, mentre il procedimento di rielaborazione e armonizzazione rimaneva sempre nell’ambito della forma classica, della musica “colta”.
La musica popolare non assumeva alcuna dignità autonoma, rimanendo confinata alla tradizione orale del popolo. Un profondo cambiamento, una vera e propria svolta nella gestione della musica popolare si verificò all’inizio del XX secolo.
Ravel per esempio ricorse sempre più spesso nelle proprie Mélodies, ovvero nelle opere da camera per voce solista con accompagnamento strumentale, a trascrizioni particolarmente fedeli di melodie di provenienza etnica: le Deux mélodies ebraïques tra le quali è contenuto il Kaddisch ebraico, per voce e pianoforte; alcune melodie popolari greche, nel ciclo Cinq mélodies populaires grecques; addirittura i ritmi e le melodie del Madagascar, nel ciclo vocale con accompagnamento di piccolo gruppo da camera, nelle Chansons Madécasses.

Maurice Ravel - Deux mélodies ebraiques
https://www.youtube.com/watch?v=EOQlbvwFar0

Maurice Ravel - Chansons Madécasses
https://www.youtube.com/watch?v=k5Txcx_030o
La ricerca vera e propria, con criteri scientifici, sulla musica popolare, fu compiuta per la prima volta (avvalendosi anche di strumenti tecnologici per la registrazione) dai compositori ungheresi Béla Bartók e Zoltán Kodály, per i quali forse fu coniato il termine “etnomusicologo”.
Il primo in particolare compì un’accurata ricerca della musica dell’Europa orientale, trascrivendo in maniera estremamente rispettosa degli originali numerosissime melodie popolari, per pianoforte solo, per voce e pianoforte e per coro. L’opera di Kodály, sebbene meno celebrata, è sotto il profilo della ricerca etnomusicologica forse altrettanto importante di quella di Bartók.
Contemporaneamente a Bartók una ricerca analoga veniva compiuta, in Brasile, da Heitor Villa-Lobos, la cui formazione era da autodidatta. Egli compì fin dal 1905 viaggi nel Nord-Est del Brasile e in Amazzonia per la ricerca sulla musica indigena, che utilizzò in tutto il corso della propria opera.
Nella enumerazione dei compositori di musica che hanno svolto ricerche sulla musica etnica non si può dimenticare il ceco Leóš Janáček, di poco più anziano dei compositori appena citati, vero e proprio etnomusicologo ante litteram, che dopo una lunga ricerca sulla musica folkloristica del proprio Paese nel 1894 organizzò la sezione musicale morava alla Mostra etnografica di Praga e nel 1901 curò l’edizione di una raccolta di oltre duemila canti moravi.
Con questo può ritenersi concluso questo breve excursus riguardante la scoperta della musica popolare da parte dei musicisti classici, e la progressiva liberazione della musica popolare dalle sovrastrutture formali tipiche della musica classica.
La successiva riscoperta della musica folkloristica è avvenuta poi, grazie alla diffusione di supporti per la musica registrata, senza la necessità di mediazioni o, più esattamente, di elaborazioni per gli strumenti e i mezzi espressivi tipici della musica accademica (posto che comunque, per l’ascoltatore, ogni esecuzione o interpretazione rappresenta una mediazione).
È possibile da qualche tempo a questa parte, per chi ne sia appassionato, ascoltare la musica proveniente da ogni luogo del mondo eseguita sugli strumenti originali, quelli realmente utilizzati nella loro esecuzione da parte del “popolo”.
Fonte: Stefano Cambi, Il centralismo della musica seria, la federazione della musica popolare