EMANUELE CANONICI
Viaggio nelle meraviglie del sapere dimenticato
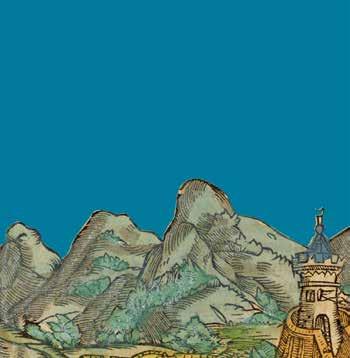
con l’introduzione di Filippo La Porta e un contributo di Gianfranco Bondioni
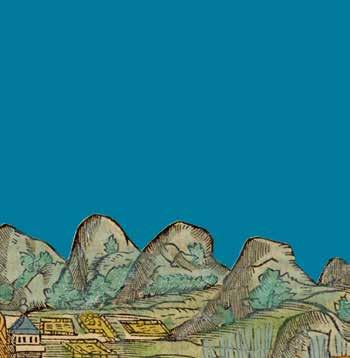








EMANUELE CANONICI
Viaggio nelle meraviglie del sapere dimenticato
con l’introduzione di Filippo La Porta e un contributo di Gianfranco Bondioni
Il piacere di apprendere


Dedico questo libello a mio padre Gian Gabriele, storico libraio ed editore, che mi ha trasmesso la passione e il piacere per la ricerca, stimolando in me fin da bambino la curiosità. La sua passione contagiosa per i libri e le stampe antiche per me è stata un vero nutrimento, luce per una mente aperta e per un nuovo Umanesimo.
Responsabile di progetto e coordinamento Manuela Lori
Redazione Maria Stefania Bruno
Coordinamento redazionale Marco Mauri
Art director Enrica Bologni
Cartine Studio Aguilar
Progetto grafico e Impaginazione Quadri_Folio, Torino
Copertina Quadri_Folio, Torino
Referenze iconografiche: Archivio Principato; Archivio G.Bondioni; Archivio E.Canonici; Courtesy of Sandow Birk and Catharine Clark Gallery, San Francisco; G.Capitano; Eugene a; SailKo/Wikimedia commons.
Prima edizione: 2024
Printed in Italy © 2024 – Proprietà letteraria riservata.
È vietata la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art.68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n.633. le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico ocommerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali) corso di Porta Romana, 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org. L’editore fornisce, per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti o nel sito www.gruppoeli.it- materiali e link a siti di esclusivamente per fini didattici terze parti o perché indicati e consigliati da altri siti tradizionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.
Casa Editrice G. Principato
Via G.B. Fauché 10 20154 Milano sito web: http://www.gruppoeli.it e-mail: info@gruppoeli.it
Segnalazione di errori
La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali. La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a: Servizio clienti Principato- e-mail: info@gruppoeli.it
Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division – Loreto – Trevi 24.85.141.0P
Prefazione
Questo libello vuole essere un piccolo contributo rivolto alle ragazze e i ragazzi, ma anche alle docenti e ai docenti, per affrontare alcuni temi storico-filosoficoletterari che spesso non vengono trattati o per mancanza di tempo o forse perché non proprio attinenti ad un “canone” istituzionale�
Essendo rivolto in particolare a giovani lettrici e lettori, il testo è stato concepito come un vero e proprio viaggio esplorativo e indagatorio, un sentiero nella ricerca, che possa suscitare curiosità, offrire spunti e potenziare la capacità critica e l’interesse alla scoperta dei temi suggeriti, non con le pretese di una trattazione di saggistica complessa, ma con l’intento di porre domande, aprire un sentiero, provare a guardare da un altro punto di vista Non è dunque un libello che possa offrire risposte, ma certamente mi auguro che aiuti a porre domande, il motore della conoscenza�
La direzione è quella di iniziare a offrire alcuni elementi di riferimento per un possibile itinerario storicofilosofico-letterario che attraversi luoghi letterari poco o affatto conosciuti con la passione della curiosità, della leggerezza e del piacere�
Con questa ipotesi di viaggio, attraverso tracce e suggestioni culturali e narrative, le docenti e i docenti, in un rapporto scambievole con le ragazze e i ragazzi, potranno occuparsi di contenuti atti a stimolare e a consolidare la ricerca storico-letteraria, ma anche etico-filosofica, per condividere i principi di un’educazione volta al rispetto di tutte le culture, di tutte le fedi e di qualsiasi essere umano che si affidi all’accoglienza delle differenze, costruendo insieme una dimensione che
possa trasvolare i confini (non solo fisici, ogni limitazione al sapere lo è) con il fine di giungere a una visione di Pax Mediterranea e, perché no, mondiale�
Per onestà intellettuale e con la mia solita trasparenza, questo lavoro non ha nessuna velleità di ricerca scientifica, in quanto vuole, scegliendo di usare un tono colloquiale, rivolgersi a una platea di giovani lettrici e lettori con l’intento di stimolare curiosità e domande utili alla formazione civile degli stessi grazie alla guida responsabile del docente�
Mi scuso con tutti coloro che si aspettavano qualcosa di diverso e ringrazio di cuore tutte le autrici e tutti gli autori delle fonti citate, senza le quali questo libello non sarebbe stato possibile; rimango a disposizione di tutti gli aventi diritto
La bibliografia presente alla fine del libro potrà essere un canale di approfondimento per tutti coloro che fossero interessati ad analizzare i temi proposti
Fatte queste brevi note per enunciare gli intenti della narrazione, non mi resta che augurarvi buon viaggio!
Emanuele
Introduzione
di Filippo La Porta
Quello che ci accingiamo a leggere è un libro “militante”, sia pure scritto con piglio lieve e con l’affabilità della conversazione� L’autore non è uno studioso ma un lettore colto, appassionato e non privo di rigore che per ragioni professionali ha qualche dimestichezza con i ragazzi� L’intento è quello di rivolgersi a studentesse e studenti che si affacciano allo studio della letteratura nel triennio superiore (e ai loro docenti) per provare a immettere la storia viva della cultura – ricostruita con scrupolo documentario – nell’agone delle battaglie civili del nostro tempo e toglierla da qualsiasi polveroso museo� Un esempio per tutti: i libri li bruciavano, assai prima dei nazisti, i protocristiani, i Barbari, gli Arabi…� Una lunga schiera di piromani nemici del sapere� Conoscere meglio questa vicenda educa le nuove generazioni a una critica ancora più convinta dell’intolleranza e dell’oscurantismo�
Viva Babele
Motivo ispiratore di queste pagine è che le “radici” dell’Europa – argomento su cui oggi si fa spesso una retorica vuota – sono innumerevoli e spesso nascoste, poiché la nostra cultura consiste in una varietà e pluralità di apporti Ogni orizzonte multiculturale e multietnico va sbattuto contro le anguste paranoie della cosiddetta “sostituzione etnica”: ciascun essere umano è un mosaico, un patchwork dove i pezzi “etnici” si sostituiscono continuamente� Ancora una volta ci soccorre l’autorità di Dante, così presente nel saggio� Nel De vulgari eloquentia Dante enuncia la teoria della lingua data
da Dio ad Adamo (l’ebraico), in seguito differenziatasi a causa della costruzione della Torre di Babele, e dunque di un peccato di tracotanza degli uomini�
Nella Commedia invece viene superato questo pregiudizio teologico, peraltro molto discusso dai padri della Chiesa: le lingue si divisero prima di Babele semplicemente perché l’essere umano tende naturalmente alla mutevolezza, e anzi ha il piacere di mutare, di variare, di rinnovare�
In questa prospettiva Babele può anche apparire come un dono e una benedizione Assodato che, beninteso, gli uomini si intendono tra loro in virtù della ragione comune: perciò hanno tutti la facoltà di parlare (al contrario degli animali, e anche degli angeli, che sono trasparenti gli uni agli altri), ed essa viene prima della grammatica e di ogni convenzione linguistica�
Leggiamo i versi del Paradiso (Dante si rivolge ad Adamo):
La lingua ch’io parlai fu tutta spenta / innanzi che a l’ovra inconsummabile / fosse la gente di Nembrot attenta, / ché nullo effetto mai razionabile / per lo piacer umano che rinnovella / seguendoli cielo, sempre fu durabile� / Opera naturale è ch’uom favella / ma, così o così natura lascia / poi fare a voi, secondo che v’abbella�
Paradiso, XXVI�
Dunque: Dante, pur immerso nella cultura medievale, non era un pensatore monistico, non credeva metafisicamente nella reductio ad unum Anzi, aveva un senso molto forte della varietà naturale, della cangiante molteplicità, come di un valore� Sapeva bene che la realtà umana è quanto mai mutevole, instabile e soprattutto varia�
Il Libro della scala
Già nelle prime pagine di questo saggio si orchestra una tipica scena del delitto, rivolgendo innumerevoli domande al lettore intorno al viaggio che sta per compiere Ma
soprattutto l’indagine sull’anello mancante, il Libro della Scala poi ritrovato, che spiegherebbe l’influenza araba, e anzi arabo-persiana, su Dante è svolta come in un giallo storico� Dante era a conoscenza dell’opera non tanto perché gliene aveva parlato il maestro Brunetto Latini (che aveva trascorso un periodo di studi a Toledo), ma probabilmente perché ne aveva letto una versione in latino donata nel 1313 da un frate al convento domenicano di Bologna, gli anni in cui Dante aveva dimorato nella città (una copia però misteriosamente scomparsa!)� E si potrebbe anche fantasticare, in termini di noir a tinte esoteriche, sulla figura dell’abate Miguel Asìn Palacios, autore del fondamentale tomo su Dante e l’Islam del 1919 (tradotto da noi tardissimo!), che dimostra analogie e somiglianze tra l’immaginario dantesco e quello islamico (il viaggio notturno nell’oltretomba, le pene dei peccatori, l’ascensione di Maometto al cielo…): professore e sacerdote, studioso dell’induismo e dell’alchimia, basterebbe vedere una sua qualsiasi fotografia per avvertire tutta l’energia irradiante del suo viso, e intravedere la mente visionaria di un mistico Chissà che non si fosse esercitato in qualche segreto esperimento alchemico alla ricerca della Pietra Filosofale?
Splendori e miserie dell’Occidente
L’Occidente ne ha combinate di tutti i colori: una dozzina di crociate, genocidi, conquiste coloniali, eretici bruciati sul rogo, tratta degli schiavi su larga scala, due guerre mondiali� In verità, nella storia umana sovente le parti in gioco hanno responsabilità ed efferatezze simili (la tratta degli schiavi l’hanno cominciata prima i mercanti arabi), però noi europei abbiamo praticato tutto ciò su larga scala, abbiamo perfezionato l’orrore grazie alla nostra straordinaria tecnologia E anzi, proprio perché abbiamo perso l’innocenza e siamo andati fino in fondo all’orrore – come ci ricorda Kurz nel Cuore di tenebra di Conrad – abbiamo anche sviluppato gli anticorpi per potercene liberare�
Nessuna civiltà ha saputo criticare sé stessa in modo così radicale come la civiltà europea � Come peraltro riconosce lo storico Franco Cardini, pur simpatizzando esplicitamente per l’Oriente e il Medioevo�
A proposito di una tentazione etnocentrica, cui pure siamo esposti, può essere però utile ripassare un ragionamento che vent’anni fa svolse Amartya Sen (Le radici della democrazia, 2003, disponibile in Rete)�
La democrazia è un bene prezioso, ma – ci avverte il saggista indiano, Nobel per l’economia nel 1998 – non è monopolio esclusivo dell’Occidente� E anzi ci informa che in Cina, in India, in Corea, in Africa, nel mondo arabo, ci sono state epoche in cui prevaleva il rispetto per le libertà fondamentali e per la diversità, e in cui si governava solo attraverso il consenso Cita l’esperienza di Nelson Mandela giovane nelle assemblee locali “democratiche” legate a una società tribale, poi in India almeno il re Ashoka e quel re mogul Akbar che proprio l’anno (1600) in cui Giordano Bruno venne bruciato vivo dal Sant’Uffizio a Campo de’Fiori a Roma svolse un elogio della tolleranza A ciò si aggiunga che il filosofo ebreo spagnolo Maimonide nel XII secolo scappò da un’Europa intollerante per trovare rifugio alla corte di Saladino, che Dante aveva messo nel limbo (una cosa che pure andrebbe ricordata nell’attuale conflitto medio-orientale!)�
Giusto il rilievo di Sen Possiamo solo concludere che, fermo restando il contributo di ogni civiltà del pianeta alla grande idea di democrazia, solo in Europa si è sentita l’esigenza di scriverne meticolosamente le regole: il rivoluzionario seicentesco Cromwell, non immune da tentazioni autoritarie, fu però costretto a promulgare una Costituzione scritta, da cui lui stesso era vincolato�
Non possiamo non dirci lucreziani L’ultimo capitolo del saggio è dedicato alla scoperta del De rerum natura da parte di Poggio Bracciolini nel
1417, in un’abbazia benedettina tedesca, capitolo fondamentale di una storia delle radici europee: quell’opera ha influenzato una schiera sterminata di autori, da Montagne a Einstein�
C’è un punto soprattutto che collega direttamente il vasto poema lucreziano alla modernità, e invece confligge con la visione medievale (dantesca): nel mondo non ci sono scopi ma solo creazione e distruzione governate dal caso� E forse non possiamo non dirci lucreziani � Resta solo il punto controverso che riguarda il libero arbitrio�
Lucrezio pensava che tutto dipendesse dalla caduta degli atomi (o “semi delle cose”), eterni e invisibili, che deviando dalle loro traiettorie si scontrano, ricombinandosi in nuove forme Dunque siamo di fatto tutti trasportati, eterodiretti� In realtà però gli esseri umani possono a loro volta muoversi nello spazio e cambiare direzione Possiamo sempre decidere di restare un po’ in disparte, di tirarci indietro, come osserva Stephen Greenblatt in un saggio su Bracciolini, Il manoscritto (2012) La libertà si esercita dunque essenzialmente come nonagire, non-partecipare, non-esserci� Il “vivere nascosti” epicureo�
Elogio della leggerezza
Il ponte del capello, che a Dante proviene dalla Visione di Alberico, a sua volta debitrice verso l’Oriente, si restringe via via come un capello, come la lama affilata di un rasoio: per poterlo superare occorre essere leggeri del peccato� In che senso?
Nessuna delle Lezioni americane di Italo Calvino è stata fraintesa come quella più nota, relativa alla leggerezza� Non l’invito a una esistenza extralight , impalpabile, sciolta da ogni vincolo e dovere morale, refrattaria al tragico e in sintonia con lo spirito dei tempi� Piuttosto con essa Calvino intende soprattutto il volo dell’immaginazione letteraria, la fantasia inesauribile del poetafilosofo, le sue invenzioni da contrapporre alla pesan-
tezza del mondo, alla realtà pietrificata� Ma non è neanche questa l’accezione di leggerezza che riguarda Dante e il Libro della Scala � In ogni verso della Divina commedia, un’opera scritta non per gli studiosi ma per ogni lettore, Dante ci rivolge l’appello a una conversione, alla possibilità di “convertirsi” alla vita nuova, che è soprattutto una vita “leggera”� Romano Guardini, teologo e finissimo dantista, scrive: «un pensiero profondo nella Commedia assimila il male alla pesantezza� Diventare cattivi significa pesare�» Già, si sprofonda verso il basso, proprio perché chi non dà realtà agli altri poi la realtà la trattiene tutta in sé, in eccesso, e diventa intollerabilmente pesante�
Il peccato più grave per Dante, ma anche per l’Islam e le religioni orientali, resta la superbia, quell’amore esclusivo di sé che coincide oggi con il narcisismo diffuso nella nostra società � Mentre la salvezza è legata alla capacità di ridimensionare il proprio io, le sue pretese, e insomma di farsi “pusilli” (piccoli), come fece san Francesco, per poter superare il ponte e non cadere nel nero fiume turbinoso
Capitolo 1 Le domande per il viaggio
Come per tutti i viaggi, di certo per ciascuno di noi c’è un motivo diverso per intraprendere un viaggio�
Se pensiamo al viaggio delle vacanze, ognuno seleziona un luogo, a seconda dei propri interessi, delle proprie curiosità, delle proprie aspettative e anche delle proprie fantasie
Anche per proporti questo viaggio insieme mi sono calato nel ruolo di un tour operator e partendo da una serie di domande o curiosità ho voluto sottotitolare “quello che non ti hanno mai detto”, ovvero viaggio alla scoperta di una civiltà letteraria volutamente dimenticata
Il “volutamente” è una mia interpretazione, quindi non tenerne conto, ma ne riparliamo poi quando rientrerai da questo viaggio
E allora diamo spazio alle domande o alle curiosità che generano il viaggio�
1. A breve intraprenderai lo studio della letteratura italiana con l’analisi dei primi documenti in volgare, come quello del 976 d�C�, detto “lascito di Capua”�
La domanda sorge spontanea: ma che cosa è successo in questi misteriosi cinquecento anni che trascorrono quasi nell’oblio dal crollo dell’Impero romano d’Occidente (nel 476 d�C�)?
Che cosa succede alla cultura di Roma e delle città dell’esteso Impero romano dopo le invasioni barbariche?
Che cosa succede alle scuole, alle biblioteche ma anche ai magistri o docenti dell’epoca?
2. Chi raccoglie l’eredità e la memoria delle biblioteche e delle scuole disperse o distrutte o semplicemente chiuse in quel periodo di disordine generale? Ma soprattutto dove e perché? E ancora: chi raccoglie i papiri, i rotoli, le pergamene, i codici? E chi li brucia e perché?
3. È possibile che dopo la caduta dell’Impero romano d’Occidente, il Mediterraneo o mare nostrum , come lo definivano i Romani, torni ad essere “romano” prima solo con le crociate dall’anno 1000 in avanti, poi con Genova, Venezia, Pisa, Amalfi, repubbliche marinare dal 1200 al 1500? Ma dal 476 d�C� al 1000, le navi che solcavano il Mediterraneo di chi erano?
4. Chi è Gherardo da Cremona? E che ci fa a Toledo in Spagna? E chi è Brunetto Latini, ma soprattutto che ci fa anche lui a Toledo nel 1260? E la lontanissima Baghdad che cosa ha a che fare con noi?
5. Chi sterminò la retroguardia di Carlo Magno provocando la morte del paladino Orlando al passo di Roncisvalle? Gli Arabi o i Vichinghi o chi altri? E quanto tempo passa tra il fatto storico (15 agosto del 778) e la scrittura della Chanson de Roland ? dieci, venti, cinquanta o cento anni?
6. Che cos’è lo zajal o zejel, cioè la poesia strofica in arabo parlato, e che cosa c’entra con il laudario di Jacopone da Todi?
7. Dante Alighieri scrive la Divina Commedia nel 1300, ma l’opera è una sua pura invenzione letteraria o si ispira a qualche fonte non citata? E facendo fantapolitica potrebbe essere la stessa opera un tentativo politico di restaurazione della Chiesa attraverso Dante?
8. Chi sono i Mozarabi? Che cosa sono gli hadith e che c’entrano con Dante? Che cosa è il mi raj o mi’rag del VI e VII secolo d � C � ? Che cosa rappresenta il
