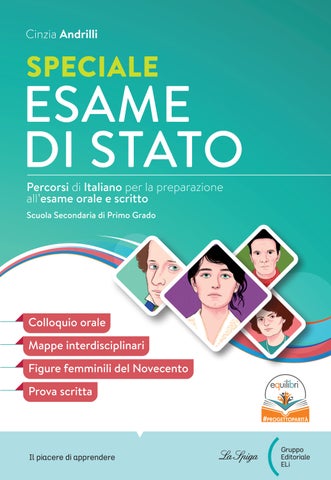2 minute read
PREMESSA
La Letteratura: un confronto impietoso col presente
Siamo negli anni della narrazione multimediale e la sfida è quella di coinvolgere gli alunni, a partire dal primo ciclo di istruzione, nello studio della letteratura; è sicuramente un discorso complesso ma l’obiettivo reale è far capire agli studenti che nella letteratura si sta parlando di loro, è qualcosa che li riguarda come uomo e donna, come persona. Uno degli scopi principali dei testi letterari è l’educazione ai sentimenti, alla riflessione, alla tolleranza, alla formazione del senso critico e civile. Senza la letteratura il mondo vivrebbe nella barbarie. La prima educazione è l’educazione alla bellezza: l’uomo è l’unica creatura in grado di cogliere la bellezza che ci circonda; dobbiamo scommettere sul potere della bellezza che conquista e avvince e se non si insegna agli studenti a coltivare la propria anima, la propria interiorità, non riusciremo mai a farli appassionare alla letteratura.
L’insegnamento della letteratura dovrebbe guardare al presente e studiarla non dovrebbe significare solo imparare date, figure retoriche, vita, opere di un autore e leggere i testi. Esistono insegnanti appassionati capaci di conquistare l’attenzione degli studenti, al di là dei programmi ministeriali, ed esistono studenti entusiasti, curiosi, partecipativi, propositivi. Nelle scuole oggi c’è un problema di tempo, di direttive e di programmi curricolari. Al di là di ogni premessa, pare esserci un problema generalizzato nell’insegnamento della letteratura che affonda le sue radici in anni e anni di norme didattiche e tecnicismi presenti in tanti manuali infarciti di commenti pedanti ed esercizi meccanici. Sicuramente la conoscenza dell’insieme di formule o norme è utile, se non fondamentale, per un corretto studio dei testi letterari; ma il problema sorge quando tutto questo diventa la priorità rispetto al portare nel presente le autrici e gli autori. Un immobilismo che dovrebbe aprirsi al cambiamento per entrare nel mondo dei ragazzi e interessarli alla letteratura, non con l’imposizione ma con l’attrazione, la fascinazione. La scelta di inserire determinati autori dell’Ottocento e del Novecento
La scelta di inserire determinati autori dell’Ottocento e del Novecento rientra nel rispetto di un canone letterario la cui oggettività altro non è che il prodotto di una selezione avvenuta nel tempo. Una scelta che appartiene a una tradizione atavica, che spesso docenti e dirigenti temono di sovvertire o modificare, come se venisse toccata la sacralità di un qualcosa di intoccabile. Gli stessi autori del Novecento a stento vengono menzionati o affrontati, se non in pochi casi. La contemporaneità praticamente non è pervenuta.
Il Novecento, in particolare, è ricco di donne scrittrici e donne poetesse che hanno svelato la propria interiorità, difeso i loro diritti quando nessuno ne parlava, vissuto e raccontato la guerra come nessuno mai; eppure le uniche donne considerate degne di entrare nel canone sono state Elsa Morante e Natalia Ginzburg. Mentre altre, da Sibilla Aleramo ad Alda Merini, sono rimaste figure impalpabili, fantasmi indegni di entrare nel pantheon dei grandi autori. Senza togliere spazio agli autori imprescindibili, forse letture diverse, meno canoniche, più attuali e vicine al mondo dei ragazzi, potrebbero stimolarli maggiormente. Magari alcuni mostri sacri potrebbero essere trattati diversamente.
Cinzia Andrilli