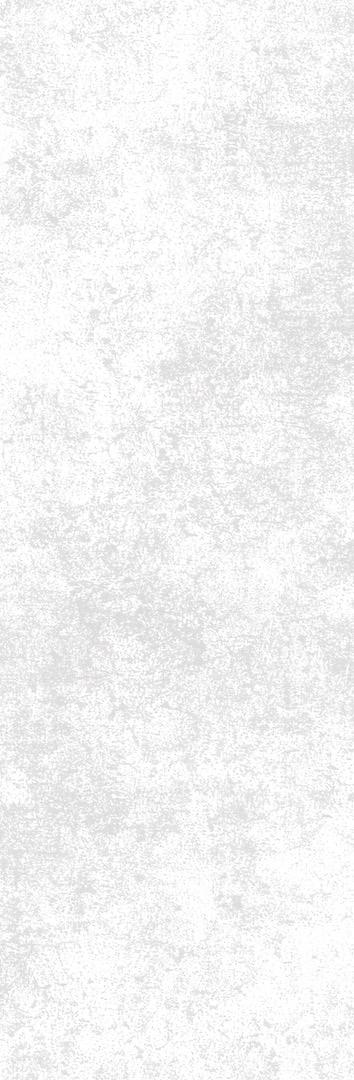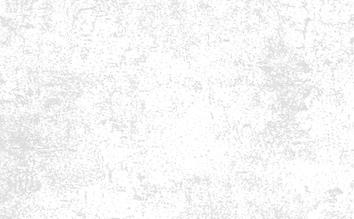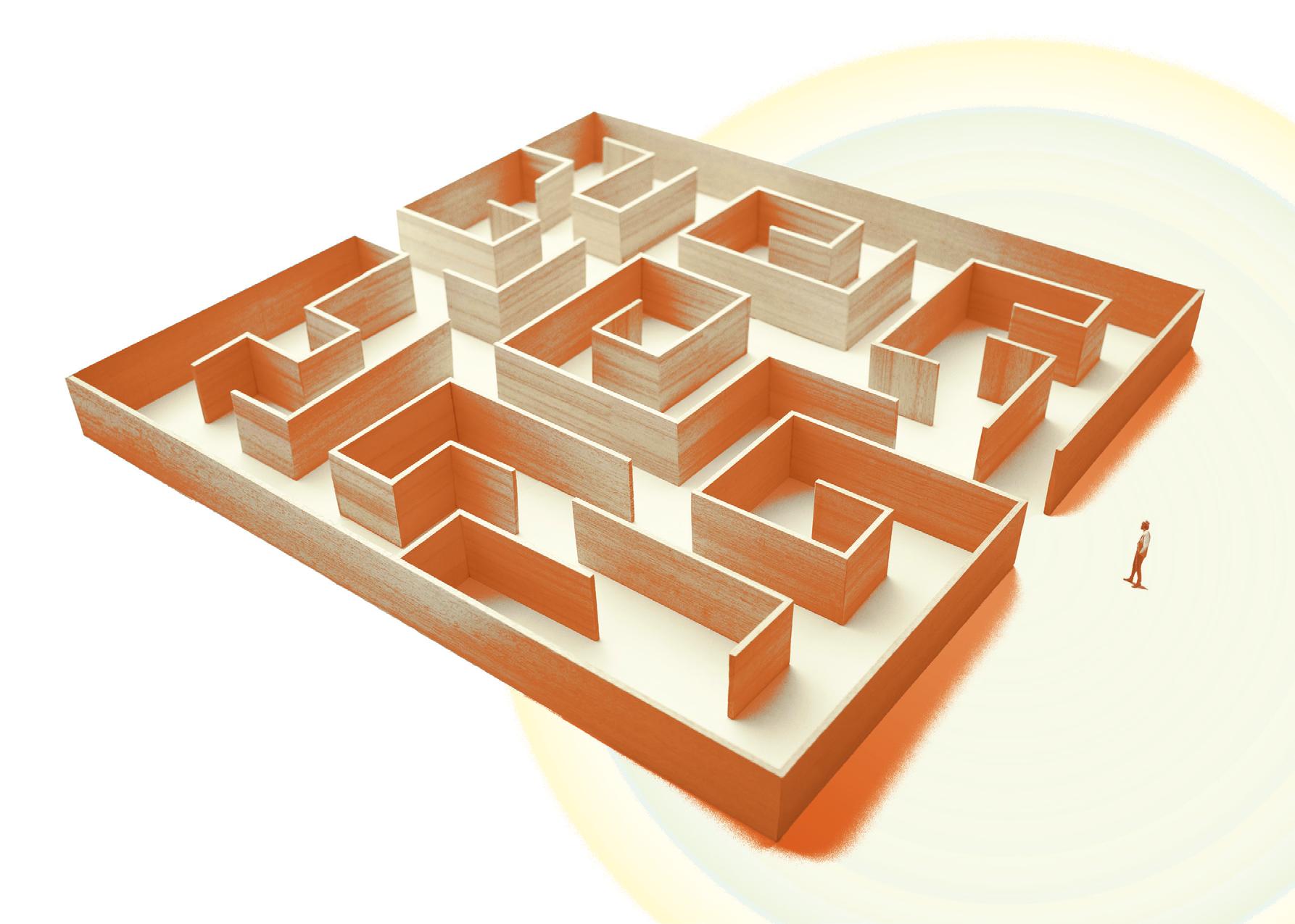

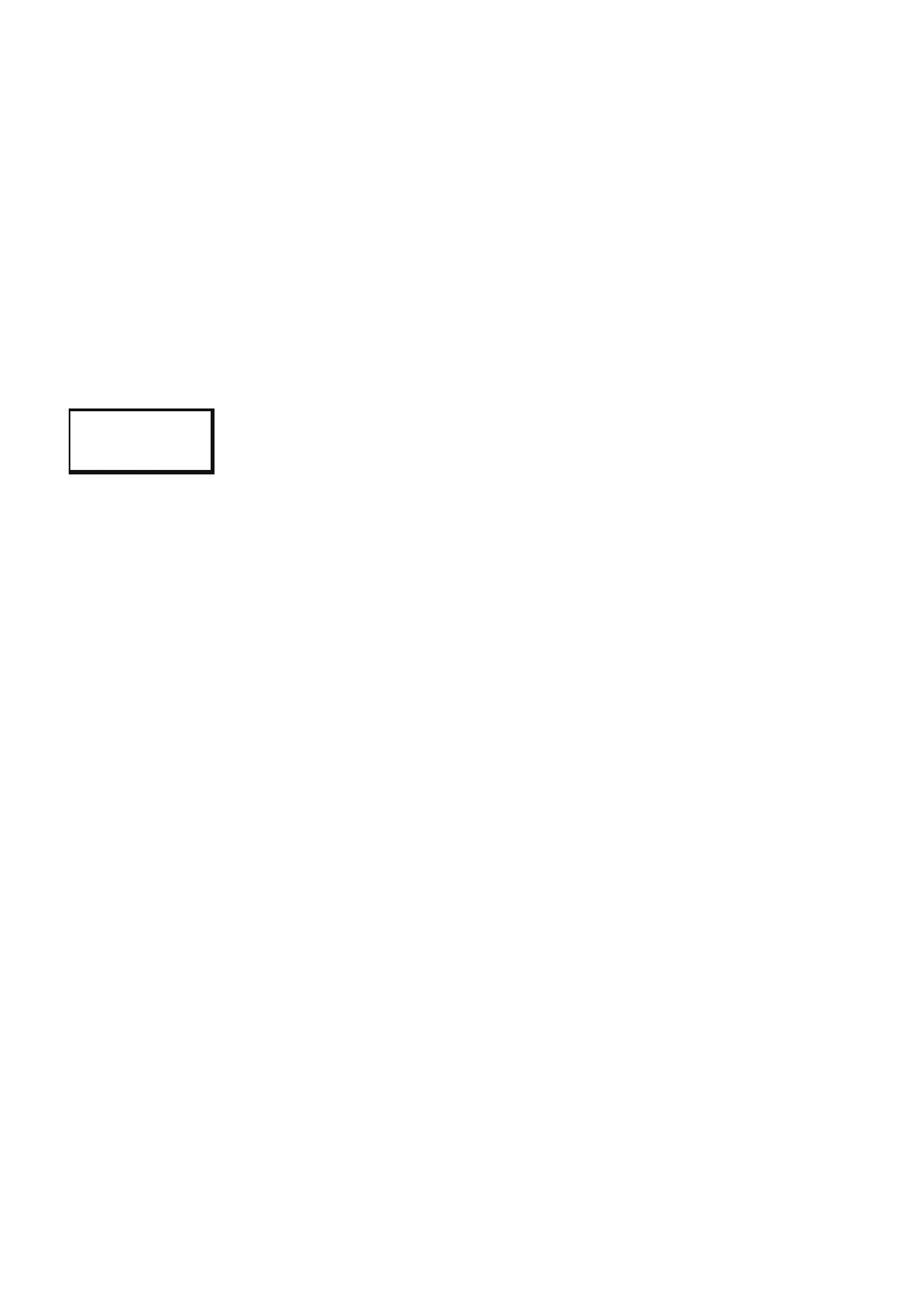
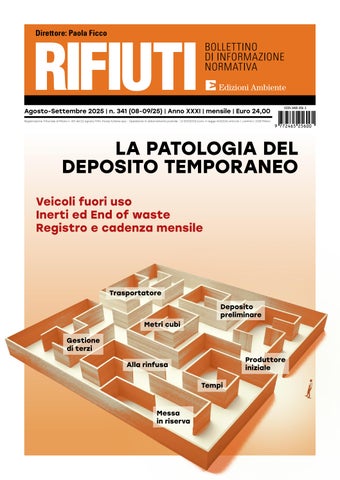
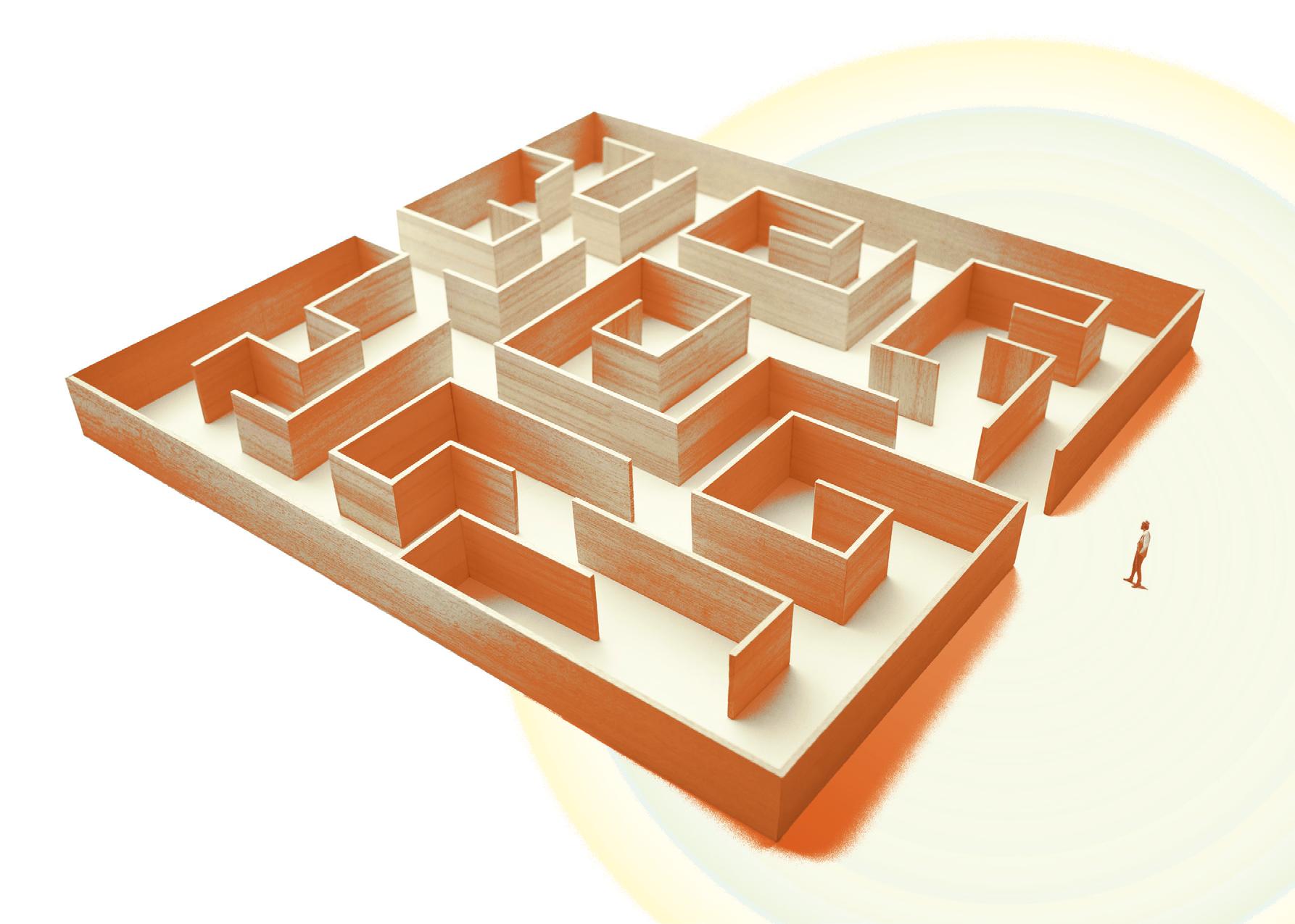

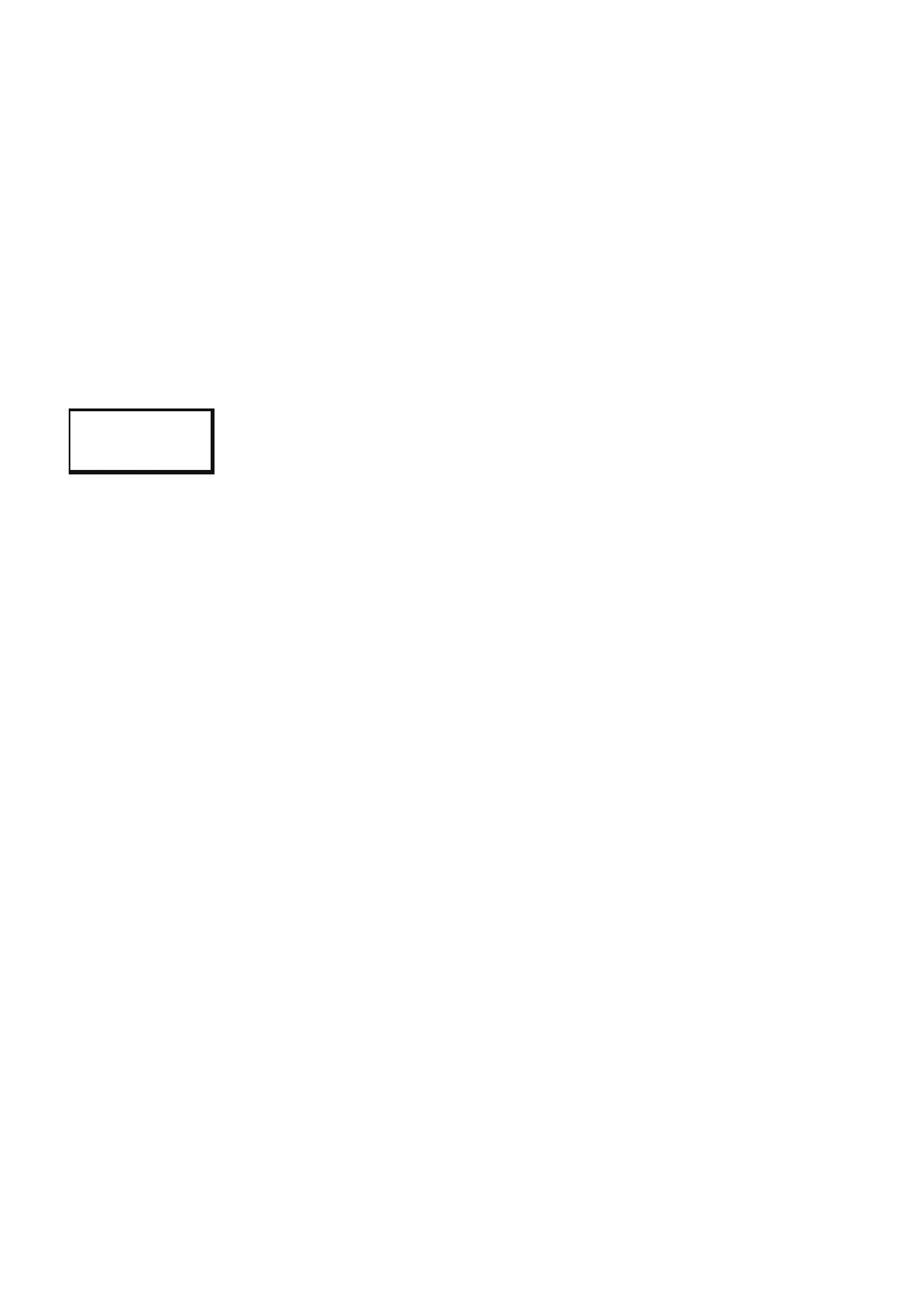
Direttore responsabile e Coordinamento Normativa Reteambiente.it
Paola Ficco
Direttore responsabile Reteambiente.it
Vincenzo Dragani
Redazione normativa
Simona Faccioli
Costanza Kenda
Alessandro Geremei
Irene Manca
Francesco Petrucci
Maria Letizia Signorini
Editing
Claudio Colucci
Relazioni esterne e istituzionali
Anna Re
Umberto Catanzaro
Progetto grafico
Roberto Gurdo
Impaginazione
Giordano Galli
Hanno collaborato
Francesco Cinti
Pasquale Fimiani
Alessandro Geremei
Costanza Kenda
Federica Lusito
Irene Manca
Italia Pepe
Francesco Petrucci
Gabriele Taddia
Elisabetta Torzuoli
Best practice
Sun RAEE
Il presente numero è stato chiuso in Redazione il 27 agosto 2025
Finito di stampare nel mese di settembre 2025 presso Lazzati Industria Grafica srl Casorate Sempione (Va)
Le opinioni sono espresse a titolo personale, impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle Istituzioni o agli Enti di loro appartenenza né alla Rivista.
Limitazioni di responsabilità. Il contenuto dei documenti non ha carattere di ufficialità; per gli atti degli Enti pubblici, sia italiani che stranieri, l’unico testo facente fede è esclusivamente quello riportato sulle pubblicazioni ufficiali (come, ad esempio, la Gazzetta Ufficiale dell’Ue o della Repubblica Italiana, i Bollettini delle Regioni, i siti informatici delle Amministrazioni pubbliche deputati alla pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi ex articolo 32, legge 69/2009).
di coordinamento dell’attività di ReteAmbiente Srl
Rivista Rifiuti – Attività di formazione – Area normativa ReteAmbiente.it
Presidente:
Paola Ficco (Giurista ambientale, avvocato in Roma, giornalista pubblicista, docente universitario, Direttore responsabile della Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa”)
Componenti:
Francesco Bicciato (Executive Director Forum per la Finanza Sostenibile)
Tommaso Campanile (Presidente CONOE)
Marco Casini (Università degli Studi di Roma La Sapienza)
Massimo Centemero (Direttore generale CIC – Consorzio Italiano Compostatori)
Maurizio De Paolis (past Direttore Servizio Massimario e Ruolo Generale del Consiglio di Stato)
Pasquale De Stefanis (Past Enea – Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile)
Vincenzo Dragani (Direttore responsabile “Reteambiente – Osservatorio di normativa ambientale”)
Simona Faccioli (Redazione normativa Reteambiente)
ReteAmbiente Srl
Viale Sabotino 24 20135 Milano tel. 02.45487277
redazione@rivistarifiuti.it marketing@reteambiente.it quesiti@rivistarifiuti.it www.rivistarifiuti.it
ISSN 2465-2563
Numero di iscrizione ROC 33667
© copyright 1994-2025
ReteAmbiente Srl
Viale Sabotino 24 20135 Milano
Tutti i contenuti sono coperti dal diritto d’autore e i diritti sono riservati. È vietato qualunque uso e/o riproduzione, anche parziale, dei testi senza il consenso scritto dell’Editore, ricevuto tramite Pec.
Questa rivista è stampata su carta certificata FSC®.
Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Luigi Fimiani (avvocato in Roma)
Barbara Gatto (Direttore operativo CONOE)
Franco Gerardini (Regione Abruzzo – Servizio gestione rifiuti)
Alessandro Geremei (Redazione normativa Reteambiente)
Costanza Kenda (Redazione normativa Reteambiente)
Rosanna Laraia (Microbiologa, già Responsabile del Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti e l’economia circolare di Ispra)
Marco Marcatili (Responsabile Sviluppo Nomisma)
Massimo Medugno (Direttore generale Assocarta, Confindustria)
Loredana Musmeci (Chimico – Esperto ambientale)
Alessandro Muzi (Ingegnere, past Direttore smaltimento finale AMA Roma)
Maria Letizia Nepi (Direttore generale Erion Care)
Stefania Pallotta (Responsabile Unità Legalità e ambiente Città metropolitana di Venezia)
Francesco Petrucci (Redazione normativa Reteambiente)
Michelangelo Prenna (avvocato – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Arera)
Claudio Rispoli (Chimico – Consulente ADR)
Daniele Salvatori (Economista e Giurista ambientale –Istruttore direttivo di Arpae Emilia Romagna)
Andrea Sconocchia (ARPA Umbria, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni)
Gabriele Taddia (avvocato in Ferrara)
di Paola Ficco
“Overtourism” e “Il turismo che non paga” : un anglicismo e un libro per ricordare l’occasione mancata di perdersi senza mai sentirsi fuori rotta
“Overtourism”: il fenomeno che reca con sé l’apparente e allettante promessa di prosperità e vivacità ma che si rivela sempre più come la grave piaga moderna per i territori che ne sono invasi. Un’ulcera contemporanea che si snoda tra le pagine della realtà, delineando scenari di bellezza ferita e di identità svanite. Città d’arte, borghi sospesi nel tempo e isole remote assalite dal fastidio dei trolley rotolanti: il battito metallico che soffoca il respiro antico della pietra e del mare.
E poi le strade, prima solitarie, ora sono fiumi umani che scorrono senza sosta, trascinando l’effimero: mappe digitali che cancellano la geografia del cuore, bastoni per selfie eretti come scettri in un regno dove l’apparenza si impone sulla memoria. E domande, domande ovunque, sussurrate o gridate, tutte ridotte all’essenziale: “Dove si mangia bene al costo minore?”.
Così, la realtà si sfoglia come una mappa consunta, e del viaggio autentico rimane l’ombra sciatta e sbiadita di un’eco che si perde tra la folla.
Le conseguenze ambientali dell’ “overtourism” possono essere significative; si pensa al degrado degli ecosistemi naturali più fragili; all’inquinamento dovuto al maggior volume di rifiuti prodotti; al consumo eccessivo di risorse come acqua ed energia in aree dove sono già scarse; al disturbo della fauna selvatica e all’apporto che l’incremento dei trasporti aerei e terrestri, con l’emissione di gas serra, fornisce al cambiamento climatico.
Affrontare l’ “overtourism” richiede politiche di gestione sostenibile del turismo e una maggiore consapevolezza dei viaggiatori.
“Il turismo che non paga” (di Cristina Nadotti – Edizioni Ambiente, Milano 2025) si interroga su cosa accade quando una città diventa “d’arte”, un paese “borgo autentico” e una spiaggia “località instagrammabile”. Cosa succede al territorio e a chi lo abita quando i luoghi diventano turistici? Che impatto ha tutto questo sul patrimonio ambientale e culturale? Del resto, il turismo è la più contraddittoria delle industrie contemporanee. Da opportunità di sviluppo a predazione il passo è breve, dipende dai punti di vista. Il Saggio affronta questo tema con lucidità spietata. L’Autrice scava sotto la patina dorata delle statistiche economiche per rivelare il costo nascosto del turismo sfrenato: perdita di autenticità, erosione di risorse locali, gentrificazione che esilia i residenti storici. Il luogo si trasforma in vuoto palcoscenico, scenografia per selfie e itinerario preconfezionato.
E gli abitanti sono i nuovi perdenti della storia, i nuovi invisibili; aggrediti dal dolore silenzioso di chi non riconosce più la propria geografia, perdendosi in uno straniante luna park.
In un mondo dove le città si affollano come pagine ingiallite da troppe dita che le toccano, il turismo si srotola come un racconto di eccessi e disarmonie. Ma se osserviamo da un’angolazione diversa, forse scorgiamo una geometria latente: una proporzione simmetrica che attende di essere tracciata tra il viaggiatore e il luogo. “Il turismo che non paga” non è solo un titolo, ma è anche un invito sottile a riconsiderare il viaggio non come sequenza di tappe, ma come trama di attese e silenzi.
Immaginare di camminare non per conquistare spazi, ma per ascoltare il respiro delle strade, il sussurro delle pietre che narrano storie dimenticate. Viaggiare diventa allora non un accumulo di timbri sul passaporto, ma una raccolta di emozioni sospese, di incontri che si adagiano nell’anima come frammenti di un mosaico incompiuto. E nel farlo, senza disturbare troppo chi incontriamo lungo il cammino, scopriamo che la bellezza autentica vive proprio lì, in un angolo nascosto, dove ci si può perdere senza mai sentirsi fuori rotta.
Paola Ficco
Procedimenti autorizzativi “caso per caso” di impianti di recupero inerti. Esperienze e prospettive pag. 9 di Francesco Cinti La patologia del deposito temporaneo
La delega al Governo per recepire gli ultimi provvedimenti europei sui rifiuti Legge 13 giugno 2025, n. 91 – Stralcio
Pannelli fotovoltaici, adesione ai sistemi collettivi va comunicata al Gse entro il 30 settembre 2025
Veicoli fuori uso, senza bonifica sono rifiuti pericolosi Corte di Cassazione – Sentenza 7 aprile 2025, n. 13282
La giurisprudenza
a cura di Costanza Kenda e della Redazione normativa di Reteambiente
Focus rifiuti e sanzioni amministrative
Estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative. Procedure a confronto
a cura di Italia Pepe

“caso
di Francesco Cinti
Responsabile Green Deal e transizione ecologica Arpa Umbria
ABSTRACT
Il Dl 77/2021 ha introdotto un parere obbligatorio e vincolante dell’Agen zia Regionale per la Protezione Am bientale territorialmente competente “caso per caso” per tutti gli impian ti di recupero inerti soggetti alle au torizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e Aia.
Con l’approvazione del Dm 152/2022 e il successivo Dm 127/2024 in tema di End of waste di inerti, il rilascio del pa rere “caso per caso” è diventato resi duale ad impianti che trattano rifiuti inerti non previsti dal Dm o che produ cono Eow destinati a scopi differenti.
Premessa
L’economia circolare è un modello di pro duzione e consumo volto all’uso efficiente delle risorse e al mantenimento circolare del loro flusso minimizzando gli scarti e massimizzando il recupero, il riutilizzo e il riciclo. Uno dei settori cardine dell’econo mia circolare e del riciclo di rifiuti è quello dei rifiuti inerti ed in particolare dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione.
Dal Rapporto Rifiuti Speciali Ispra 2024 si evince come in media ogni anno in Italia vengono prodotti più di 48 milioni di ton nellate di rifiuti minerali della costruzio ne e della demolizione, ed il 78% di tali rifiuti viene sottoposto a preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre forme di re cupero di materia.
Dal 2021 il Legislatore italiano ha apportato numerose modifiche alla disciplina del riciclo dei rifiuti inerti che hanno comportato continui cambiamenti, anche sostanziali, mettendo a dura prova tutti gli addetti ai lavori: l’industria del riciclo, i consulenti ambientali e, non da ultima, la Pubblica amministrazione.
L’introduzione del parere obbligatorio e vincolante di Ispra o di Arpa Il primo importante “scossone” è sta to dato dal Dl 77/2021, convertito con legge 108/2021, il quale ha introdotto il pa rere obbligatorio e vincolante dell’Ispra o dell’Agenzia Regionale per la Protezio ne Ambientale territorialmente competen te, nell’ambito delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Ti tolo III‑ bis, Parte seconda, Dlgs 152/2006 (Autorizzazioni integrate ambientali –Aia) per lo svolgimento delle operazioni di recupero, rilasciate o rinnovate “caso per caso” secondo il comma 3 dell’artico lo 184‑ ter, ovvero in mancanza di crite ri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 184‑ter (regolamenti comuni tari o decreti ministeriali per la cessazio ne della qualifica di rifiuto).
Il parere è finalizzato alla valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184‑ter e dei criteri dettagliati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Tenuto conto che non esiste un regolamen to europeo sul recupero dei rifiuti inerti e che nel 2021 non era presente alcun De creto ministeriale, tutti gli impianti di re cupero inerti soggetti alle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e Aia era no sottoposti al rilascio del parere obbli gatorio e vincolante da parte delle Arpa.
L’aggiornamento delle Linee guida Snpa e i riferimenti tecnici
Alla luce dell’introduzione dell’obbligo del parere obbligatorio e vincolante, Il Siste ma Nazionale per la Protezione Ambienta le (Snpa), in soli sei mesi, ha aggiornato le “Linee guida per l’applicazione della disci plina End of waste (Eow) di cui all’artico lo 184‑ter comma 3‑ter del Dlgs 152/2006”.
Lo scopo della revisione è stato quello di fornire un sistema comune ed omoge neo a livello nazionale per la valutazione istruttoria ai fini del rilascio del pare re “caso per caso”. Le modifiche delle Li nee guida si sono incentrate sul capitolo 4 “Criteri condivisi per la redazione del pa rere tecnico”.
All’interno del capitolo, particolare im portanza riveste la Tabella 4.1, che sinte tizza gli aspetti da analizzare in fase di istruttoria tecnica per la predisposizione
del parere tecnico Eow “caso per caso”. In particolare, nella tabella sono definiti:
• i contenuti minimi dell’istanza da parte del proponente;
• la modalità di valutazione di ciascuna delle quattro condizioni e dei cinque cri teri dell’articolo 184‑ter ;
• gli elementi minimi da includere nel pa rere tecnico da parte delle Arpa.
Dalle Linee guida è possibile dedurre qua li siano i riferimenti tecnici e ambienta li ai fini della predisposizione del parere.
I Dm 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 che di sciplinano le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti sono fra i principa li riferimenti normativi ai fini del rilascio delle autorizzazioni “caso per caso”.
Tuttavia, vista l’evoluzione tecnologica dei processi di recupero progredita negli ulti mi 27 anni e trattandosi di norme ormai datate, le Linee guida indicano altri possi bili riferimenti tecnici e ambientali.
Oltre alle normative europee e ai regolamenti nazionali specifici, le norme tecniche di prodotto europee/nazionali o internazionali costituiscono un riferimento tecnico comunemente utilizzato in tutti i pareri Eow “caso per caso”.
Sono inoltre importanti riferimenti tecni ci le norme o le Linee guida redatte da al cune Regioni, ad esempio le linee guida per la gestione delle scorie nere e bianche di acciaieria a forno elettrico e le linee guida sulla gestione delle terre di fonde ria redatte dalla Regione Lombardia. Un ulteriore riferimento si può trovare, per processi di recupero analoghi, anche nelle autorizzazioni rilasciate nel territo rio nazionale. Ai fini del rilascio del pare re, le Agenzie Regionali possono accedere alla raccolta di autorizzazioni “caso per caso” disponibili nel Registro Naziona le delle Autorizzazioni al Recupero (RE cer), istituito ai sensi del comma 3‑septies dell’articolo 184‑ter, Dlgs 152/2006.
Nel 2021, dunque agli albori dell’introdu zione del parere “caso per caso”, i princi pali riferimenti tecnici, per gli impianti di recupero rifiuti inerti, sono stati: • quelli di cui alla tipologia 7.1, Dm 5 feb braio 1998;
• la bozza del Dm di recupero inerti che poi sarebbe diventata il futuro Dm 152/2022,
Non esiste un regolamento europeo sul recupero dei rifiuti inerti
già all’epoca consultabile nel sito del Mini stero dell’Ambiente (Figura 1).
La maggior parte degli impianti di recu pero rifiuti inerti ha fatto istanza di au torizzazione “caso per caso” riferendosi al primo, quindi prevedendo la produ zione di Eow conformi all’Allegato C del la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.
Nella Circolare, tuttavia, si rileva il non perfetto allineamento con i limiti dei pa rametri previsti nelle norme Uni ai fi ni della marcatura Ce del prodotto. Oltre a ciò, la Circolare riporta parametri ri conducibili alla frazione estranea, ad esempio materiali deperibili, non corri spondenti ai costituenti della medesima frazione previsti dalla norma Uni (mate riali flottanti).
I gestori più lungimiranti degli impianti hanno invece fatto istanza “caso per caso” riferendosi alla bozza di quello che sarebbe poi diventato il Dm 152/2022, prevedendo quindi la produzione di Eow con requisiti tecnico‑prestazionali conformi alle norme ivi riportate, ai fini della marcatura Ce e della verifica dell’idoneità tecnica del prodotto.
Il Dm 152/2022 e la gestione della problematica sul sistema di gestione della qualità
Con la successiva approvazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152, il rilascio del pare re “caso per caso” è diventato residuale, li mitato ai soli casi in cui l’impianto operi in parziale o totale difformità del Decre to medesimo; nello specifico, nell’eventua lità l’impianto ricicli rifiuti non elencati dal Decreto, preveda sistemi di trattamen to diversi o la produzione di Eow destina ti a scopi differenti da quelli definiti dal provvedimento (Figura 2).
La principale problematica del Dm 152/2022 risiedeva nel fatto che l’impianto doveva essere dotato di un sistema di gestione della qualità certificato conforme alla Uni En Iso 9001 e che Accredia non aveva ancora fornito le specifiche tecniche ai fini di tale certificazione.
Di conseguenza, molte aziende presentava no istanze “caso per caso” solo perché non
in grado di dotarsi della certificazione del sistema di qualità richiesta dal Decreto.
Alcune Regioni italiane hanno gesti to la criticità rilasciando autorizzazio ni “caso per caso” ad impianti conformi al Dm 152/2022 prescrivendo un termine per la certificazione del sistema qualità (di fatto congelando l’operatività dell’im pianto fino al conseguimento della certi ficazione); in altri casi, invece, alcuni Enti di certificazione hanno rilasciato attesta zioni dei sistemi di qualità anche senza le specifiche di Accredia, sulla base della ve rifica di conformità delle procedure im plementate dalla ditta con il Dm 152/2022.
Il Dm 127/2024
Fortunatamente l’ostacolo è stato supera to con l’approvazione del Decreto 28 giu gno 2024, n. 127 attualmente vigente che, per gli impianti di recupero inerti, ha tolto l’obbligo di dotarsi della indicata certifica zione. Il comma 2, articolo 1, Dm 127/2024 definisce quali sono le due casistiche per le quali un impianto di recupero inerti è soggetto al rilascio o al rinnovo delle auto rizzazioni “caso per caso”: • la prima, quando le operazioni di re cupero, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono svolte in tutto o in parte su rifiuti non elencati nell’Allega to 1, Tabella 1, punti 1 e 2 del Decreto; • la seconda, quando l’impianto produce Eow destinati a scopi specifici differen ti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4.
Quindi, un impianto di recupero rifiu ti inerti, che tratta anche un solo codice Eer non previsto dal Dm o che produce un Eow destinato a scopi differenti, oggi è soggetto ad autorizzazione “caso per ca so” ed è quindi necessario il parere obbli gatorio e vincolante da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente (Figura 3).
Il Dm 127/2024 rimane comunque uno dei principali riferimenti tecnici ai fini di autorizzazioni “caso per caso” di impianti di recupero rifiuti inerti, e la Tipologia 7.1 del Dm 5 febbraio 1998 e la relativa Circolare sono ormai da considerarsi superate.
L’articolo 7, Dm 127/2024, istituisce un si stema di monitoraggio con la possibilità di effettuare un’ulteriore revisione dei crite ri per la cessazione della qualifica di rifiu to del Dm stesso.
Il Dm 127/2024 ha tolto l’obbligo della certificazione del sistema di qualità
Figura 1 – Pareri “caso per caso” di impianti recupero inerti dopo introduzione Dl 77/2021
Il Dl 77/2021 introduce la procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi End of waste caso per caso
2021
Rilascio del parere “caso per caso” di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e Aia di tutti gli impianti di recupero rifiuti inerti.
Dm 5 febbraio 1998: Allegato C della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
Bozza Dm 152/2022
Idoneità tecnica ai sensi delle Uni
Figura 2 – Pareri “caso per caso” di impianti recupero inerti dopo approvazione Dm 152/2022
Il Dl 77/2021 introduce la procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi End of waste caso per caso
Dm 152/2022
1º Dm recupero inerti
2021 2022
Rilascio del parere “caso per caso” di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e Aia di impianti di recupero rifiuti inerti in parziale o totale difformità del Dm 152/2022.
Rifiuti non elencati
Scopi specifici differenti
Assenza Iso 9001
Figura 3 – Pareri “caso per caso” di impianti recupero inerti dopo approvazione Dm 127/2024
Il Dl 77/2021 introduce la procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi End of waste caso per caso
Dm 152/2022
1º Dm recupero inerti
Dm 127/2024
2º Dm recupero inerti
2021 2022 2024
Rilascio del parere “caso per caso” di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e Aia di impianti di recupero rifiuti inerti in parziale o totale difformità del Dm 127/2024.
Rifiuti non elencati
Scopi specifici differenti
I dati di monitoraggio attraverso il REcer e il tavolo di confronto con tutti gli stakehol ders, già convocato dal Ministero dell’Am biente e della sicurezza energetica (Mase) pochi giorni dopo la pubblicazione del De creto, ci diranno se in futuro avremo ulte riori modifiche.
Le modifiche auspicabili
Tra le modifiche auspicabili, si annovera la necessità di esplicitare la casistica del parere “caso per caso” anche nell’even tualità l’impianto operi con un processo
di lavorazione differente da quello pre visto dal Dm 127/2024 e il dipanamento della questione dei requisiti tecnico‑pre stazionali e relativa marcatura Ce degli aggregati recuperati destinati ai ripristi ni ambientali.
Ci si aspetta, infine, dal Legislatore un ul teriore sforzo nel trovare un equilibrio tra la logica del Decreto che verifica il possesso dei requisiti per ogni lotto sta tico di aggerato recuperato e quella del la marcatura Ce del prodotto che applica una logica – di fatto – dinamica.

di Pasquale Fimiani
Avvocato generale presso la Corte di Cassazione
ABSTRACT
La giurisprudenza penale ha tracciato nel tempo un quadro delle situazioni patologiche, di carattere oggettivo e soggettivo, che determinano l’illiceità del deposito temporaneo, incentran do le proprie decisioni sulla necessi tà che esso avvenga nel luogo di pro duzione ad opera del produttore di ri fiuti, principi dai quali può desumersi la preclusione per l’affidamento del deposito temporaneo a soggetti di versi senza specifica autorizzazione, poiché questi svolgerebbero attività di gestione di rifiuti prodotti da ter zi, ipotesi da escludersi nei soli casi di mero utilizzo da parte del produtto re di lavoratori di altre imprese trami te le figure del contratto di sommini strazione o del distacco.
Giurisprudenza penale e deposito temporaneo: quadro generale
Il deposito temporaneo dei rifiuti, discipli nato dal combinato disposto degli artico li 183, lettera bb) e 185‑ bis, Dlgs 152/2006, costituisce un istituto di carattere eccezio nale e di stretta applicazione, in quanto prevede stringenti condizioni temporanee, quantitative e qualitative che escludono l’obbligo di autorizzazione (articolo 208, comma 17, Dlgs 152/2006) la cui sussistenza è onere del produttore provare. 1
Il giudice penale può verificare la sussisten za di tali condizioni, acquisendo le neces sarie informazioni quantitativo‑temporali sull’attività dell’azienda, “desumibili anche dai registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria, anche per i depositi tempora nei”, 2 oltre che dai formulari.
1. Ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 15680/2010, n. 17184/2016, n. 19957/2017, n. 48334/2017, n. 46699/2018, n. 49674/2018, n. 24989/2020, n. 1131/2021, n. 35410/2021, n. 14030/2022, n. 15450/2023 e n. 39599/2024.
2. Cass. pen., sez. III, n. 13808/2001 cit., in cui, peral tro, si precisa che “in presenza di un provvedimento di sequestro dei rifiuti per violazione dell’articolo 51 del Dlgs 22/1997, il giudice del riesame non può verifi care la sussistenza delle condizioni richieste dall’ar
La giurisprudenza inquadra l’inosser vanza delle regole del deposito tempo raneo nel reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall’articolo 256, com ma 2, Dlgs 152/2006, ritenendolo di natura permanente perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” pro dromico alla fase di gestione, con la conse guenza che l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’articolo 185‑ bis inte gra una condotta la cui antigiuridicità ces sa sino allo smaltimento o al recupero (o con il sequestro). 3
Peraltro, se di regola, quando i rifiuti so no depositati dal produttore presso il sito aziendale senza rispettare le condizioni per il deposito temporaneo, si è in presenza di un deposito incontrollato, è ben possibile che la condotta si manifesti concretamente 4 in modo tale da essere qualificata, a secon da dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), 5 come “mes sa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), 6 come “abban dono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero), come “stoccaggio” (in quanto autonoma at tività di smaltimento), 7 o come “discarica abusiva” (nell’ipotesi di abbandono reitera to nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi). 8
La distinzione, rispetto alle prime quattro ipotesi, appare peraltro di carattere più teorico, che pratico, stante l’identità di sanzione, 9 mentre rileva nei rapporti con la discarica abusiva, stante la maggiore gravità della pena prevista per essa dal comma 3 dell’articolo 256, Dlgs 152/2006.
ticolo 6 lettera m) del Dlgs citato per qualificare un deposito come temporaneo, dovendosi limitare a ve rificare la esistenza del fumus del reato ipotizzato” Ciò in quanto “in tema di gestione dei rifiuti, la di sciplina di cui al Dlgs 22/1997 si applica anche allor ché lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenga ad opera dell’impresa che li ha prodotti e negli stes si luoghi di produzione” (sez. III, n. 14762/2002).
3. Soluzione del resto seguita ripetutamente dal la giurisprudenza (ex plurimis, si veda Cass. pen., sez. III, n. 9168/1997, n. 31128/2001, n. 20780/2002, n. 9057/2003, n. 10662/2004, n. 37879/2004, n. 2033/2006, n. 9851/2009, n. 35540/2010, n. 15540/2023, n. 18917/2023, n. 30062/2024 e n. 30929/2024).
4. Ex plurimis, Cass. pen., sez. I, n. 40718/2018 nonché sez. III, n. 39544/2006, n. 20468/2007, n. 19883/2009, n. 49911/2009, n. 11270/2010, n. 44516/2019, n. 5417/2020 e n. 24989/2020 (a tali decisioni si rinvia per ulteriori riferimenti giuri sprudenziali).
Nel configurare la responsabilità penale la giurisprudenza ha tracciato un quadro del le situazioni patologiche, di carattere ogget tivo e soggettivo, che determinano l’illiceità della condotta.
Sul primo versante ha tratto una serie di conseguenze di sistema dalla regola dell’ar ticolo 185‑ bis , comma 1, Dlgs 152/2006, secondo cui il deposito temporaneo è con sentito senza autorizzazione solo se effettua to “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svol ge l’attività che ha determinato la produzio ne dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci”.
Diverse sono poi le decisioni che definisco no le condizioni di operatività del comma 2 dell’articolo 185‑ bis, Dlgs 152/2006, nella parte in cui prevede cadenze temporali e quantitativi di riferimento, l’obbligo di ef fettuare il deposito temporaneo per catego rie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. Per quanto infine riguarda le patologie di carattere soggettivo, le decisioni della giuri sprudenza si incentrano, nell’esaminare le varie fattispecie, sulla riferibilità dell’isti tuto al solo produttore dei rifiuti nel luogo di produzione, con esclusione di situazioni in cui tale corrispondenza venga a mancare.
Le patologie di carattere oggettivo: luogo di produzione, trasporto e movimentazione
In linea generale, il deposito temporaneo, quale istituto eccezionale, può essere uti
5. Per alcune fattispecie, si veda Cass. pen., sez. III, n. 21024/2004, n. 6764/2006 e n. 15659/2014.
6. Per una fattispecie, si veda Cass. pen., sez. III, n. 21576/2004.
7. Ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 4364/2022 e n. 5297/2022. Costituisce stoccaggio anche il depo sito di rifiuti utilizzando, seppure per un tempo limitato, continuativamente la stessa area, allocan dovi altri rifiuti una volta rimossi quelli preceden temente depositati (sez. III, n. 42426/2021).
8. A titolo esemplificativo, si veda Cass. pen., sez. III, n. 3377/2000, con riferimento alla “macroscopica ec cedenza dei quantitativi di scorie accumulati rispet to a quelli periodicamente rimossi, appare del tutto logico ritenere che non più di deposito, controllato o meno si tratti, ma di vero e proprio abbandono si stematico e, quindi, di discarica” (conformi, ex plu rimis , n. 7140/2000, n. 6766/2006, n. 23792/2007, n. 11258/2010, n. 36979/2011 e n. 6985/2014).
9. Come rilevano anche Cass. pen., sez. III, n. 2033/2006 e n. 15659/2014.
Le situazioni patologiche che determinano l’illiceità del deposito temporaneo sono di carattere sia oggettivo sia soggettivo
lizzato solo da parte del produttore (prima rio) dei rifiuti, nel luogo di produzione, con esclusione di tutte le ipotesi di trasferimen to degli stessi in altri siti aziendali od ex tra‑aziendali. 10
Pertanto, “quando i rifiuti non vengono rag gruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso si ha vero e proprio stoc caggio (…) e non deposito temporaneo, per il quale è richiesto che i rifiuti siano raggrup pati nel luogo di produzione e non altrove” 11 Per questa ragione, non rientrano nel con cetto di deposito temporaneo le c.d. “eco piazzole” o “isole ecologiche”, definite quali centri di raccolta dall’articolo 183, comma 1, lettera mm), Dlgs 152/2006 (v. paragrafo che segue), né le attività di deposito di rifiuti prodotti da terzi, in quanto l’istituto riguar da il solo accumulo temporaneo dei rifiuti presso il loro produttore. 12
Parimenti, il cassone collocato sulla pubbli ca via non è un luogo idoneo a configurare un deposito temporaneo prima della raccol ta dei rifiuti edili contenuti (e quindi, se non autorizzato, è stoccaggio illecito di rifiuti). 13 Il deposito temporaneo è incompatibile con il concetto di trasporto, che rientra invece nella piena fase di gestione.
Va però distinta l’attività di “movimentazio ne” da quella di “trasporto” dei rifiuti. La prima (si veda articolo 193, comma 11, Dlgs 152/2006: “la movimentazione dei rifiu ti esclusivamente all’interno di aree priva te non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non ne cessita di formulario di identificazione” ) non necessita di alcuna autorizzazione e si svolge all’interno del sito aziendale ai fini del deposito temporaneo, mentre la secon da rientra nel novero della “gestione” ai
10. Cass. pen., sez. III, n. 23792/2007 ha precisato che non si può parlare di deposito temporaneo se i rifiuti provengono da luogo diverso da quello di produzione.
11. Cass. pen., sez. III, n. 17819/2012. Conforme sez. III, n. 5916/2015, con riferimento ad una fat tispecie in cui il deposito era frutto dell’inter vento diretto di una società ed era eseguito in un’area distinta rispetto a quella ove i rifiuti era no prodotti verso la quale gli stessi erano con feriti attraverso l’intervento della detta società, che li prelevava da bordo nave e li trasferiva sulla terraferma ove, peraltro, gli stessi erano oggetto di successiva lavorazione – consisten te principalmente nella loro cernita in funzione delle varie tipologie di rifiuto presenti – a cura di una ulteriore ditta a ciò incaricata dalla pre cedente.
12. Cass. pen., sez. III, n. 41692/2014.
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006 ed è oggetto di specifica au torizzazione in quanto tale, con la conse guenza che solo dopo l’inizio del deposito temporaneo comincia la gestione dei rifiuti in senso tecnico e l’obbligo di rispettarne re gole e prescrizioni. 14
Peraltro, assume rilievo penale pure la movimentazione dei rifiuti che, pur aven do avuto inizio in aree private, sia obiet tivamente finalizzata al loro trasporto all’esterno delle stesse, essendo il regime di esenzione accordato soltanto al trasporto di rifiuti veicolati all’interno di aree private ai fini di una loro diversa sistemazione. 15
Occorre poi accedere ad una nozione “funzionale” del luogo di produzione, nel senso che tale definizione riguarda non soltanto il luogo in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello nella disponibilità dell’impresa funzionalmente collegato a quello di produzione. 16
Tale collegamento è stato ravvisato per “qualsiasi area delimitata facente parte del complesso aziendale, [inclusa] l’area esterna al piazzale aziendale, ma recintata ed acces sibile solo da essa” 17 e, in una prospettiva ancor più ampia, nel caso di “contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell’impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato”, in quanto “con sente di estendere al secondo, ove funzional mente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposi to temporaneo” 18
Si è precisato altresì che, ad integrare la nozione di collegamento funzionale ai fi ni del deposito temporaneo, concorre non
13. Cass. pen., sez. III, n. 42610/2024.
14. Cass. pen., sez. III, n. 17460/2012 (la Corte, nella fattispecie, ha escluso la decorrenza della gestio ne dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l’inizio del deposito temporaneo, sia perché nulla era dato sa pere circa l’effettiva osservanza delle prescrizio ni imposte dalla legge per considerare legittima detta forma di deposito, sia perché non vi era stata movimentazione all’interno di uno stesso compen dio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione).
15. Cass. pen., sez. III, n. 13817/2021 (che richiama sez. III, n. 5312/2008 e n. 40860/2010).
16. Ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 45447/2008, n. 28204/2011, n. 37843/2014, n. 38676/2014 e n. 16441/2017.
17. Cass. pen., sez. III, n. 7459/2008.
18. Cass. pen., sez. III, n. 35622/2007.
Deposito temporaneo solo nel luogo di produzione e senza trasporto
soltanto dal punto di vista spaziale la con tiguità dell’area a tal fine utilizzata ri spetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento ur banistico e dell’assenza di una sua auto noma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata. 19
Al fine di individuare la disciplina applica bile, è necessario che il giudice valuti, ade guatamente e congruamente motivando il suo convincimento in proposito, verificando se luogo di produzione e luogo di deposito si ano a disposizione della stessa impresa e se il secondo possa ritenersi funzionalmente collegato al primo, tenendo anche conto del le caratteristiche del caso concreto. 20
Tale disponibilità può configurarsi anche se l’area dove viene effettuato il deposito temporaneo sia di proprietà di terzi (dispo nibile, evidentemente, sulla base di speci fiche previsioni contrattuali), ma, non per questo, il depositante, una volta collocato il materiale può disinteressarsi della sorte del medesimo, in quanto “se il deposito pre lude per legge all’avviamento del materiale alle operazioni di recupero e di smaltimen to, è necessario che il requisito del raggrup pamento per categorie omogenee sussista inizialmente e permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a ca rico di chi il deposito effettui curare che det to requisito venga costantemente rispettato, senza per questo addossare al depositante inadempienze altrui” 21
Segue: cadenze temporali e quantitativi di riferimento
Per quanto riguarda le ulteriori condizio ni di liceità del deposito temporaneo, la giurisprudenza si è appuntata sulle pre visioni del comma 2 dell’articolo 185‑ bis, Dlgs 152/2006, ed in particolare: • sulla lettera b), secondo cui “i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore
19. Cass. pen., sez. III, n. 4181/2018, n. 49674/2018 e n. 8498/2021.
20. Cass. pen., sez. III, n. 45447/2008, che, in tale prospettiva, ha ritenuto insufficiente, per esclu dere un deposito temporaneo, la circostanza che i rifiuti venissero spostati, all’interno della stessa area oggetto di lottizzazione, da una zona in via di costruzione ad altra già costruita.
21. Cass. pen., sez. III, n. 46711/2013, in una fatti specie in cui l’imputata aveva raggruppato il le gname proveniente dallo smantellamento del proprio stabilimento nello spiazzo di proprietà
dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti peri colosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”; • sulla la lettera c), secondo cui “i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel ri spetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle nor me che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”.
Per quanto riguarda il primo punto, al fine del calcolo dei metri cubi, va tenuto conto degli spazi vuoti esistenti fra i diversi cor pi, spazi ovviamente irregolari e diversi a seconda dei materiali, in quanto “ciò che la legge individua è l’ingombro dei materia li abbandonati e non la quantità di materia che li compone” 22
Va poi ricordata la definizione di cui all’articolo 2, lettera g) del Dlgs 36/2003, da cui si ricava che, superato il limite di un anno, il deposito temporaneo viene ad essere inquadrato nella nozione di discarica.
Quanto poi all’applicabilità della lettera c), sono state fatte due precisazioni. La prima è che la cernita non costituisce at tività di raggruppamento, ma di gestione, secondo la definizione di cui all’articolo 183, lettera n), Dlgs 152/2006, per cui “è evidente che se è già stata fatta una cernita dei rifiu ti non può parlarsi di deposito temporaneo ma già di “gestione” dei rifiuti (e, in parti colare, se si tratta di operazioni finalizza te al recupero, a quelle di cui alla lettera R12 dell’Allegato C), il che significa che il raggrup pamento secondo categorie omogenee di ri fiuti deve avvenire nel luogo ove si effettua il deposito temporaneo, e non prima” 23 Quanto al significato della locuzione “ca tegorie omogenee”, queste, secondo l’inter
di un terzo, attiguo allo stabilimento, e con il suo consenso (la decisione precisa che “la nozione di deposito di rifiuti anche solo temporaneo implica, a differenza di quella dell’abbandono, ed in virtù della sua finalizzazione ad una gestione degli stessi, una attività connotata necessariamente da un control lo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi permanga, nell’arco temporale richiesto, secondo le modalità di legge” ).
22. Cass. pen., sez. III, n. 6266/2010. 23. Cass. pen., sez. III, n. 20841/2024.
Per il calcolo dei metri cubi rileva l’ingombro dei materiali
pretazione della S.C., non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all’articolo 184 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costitu iscono specificazione secondo una precisa individuazione tecnica (connotata da appo sito codice Cer), sì che anche l’omogeneità delle stesse deve essere verificata nei mede simi termini. 24
Tale interpretazione, del resto, è in linea con quanto affermato dalla Corte di Giu stizia 25 che, nell’affermare la compati bilità con la Direttiva 75/442/Cee e con la Decisione della Commissione 3 mag gio 2000, 2000/532/Ce della commistione, da parte del produttore di rifiuti, di rifiuti ri conducibili a codici diversi dell’elenco al legato alla Decisione 2000/532 al momento del loro deposito temporaneo prima della loro raccolta nel luogo in cui sono prodot ti, ha precisato che “gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure che obbligano il produttore di rifiuti alla cernita e al depo sito separato dei rifiuti al momento del lo ro deposito temporaneo, prima della loro raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, uti lizzando a tal fine i codici di detto elen co, qualora ritengano che siffatte misure siano necessarie per raggiungere gli obietti vi fissati dall’articolo 4, primo comma, della Direttiva 75/442, quale modificata dal Rego lamento 1882/2003”.
Pertanto, esula dal concetto di deposito temporaneo il deposito od accumulo “alla rinfusa”, cioè di rifiuti eterogenei ammassati in maniera del tutto asistematica, attività sufficiente ai fini della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti, senza che rilevi la parziale riciclabilità del materiale depositato. 26
24. Cass. pen., sez. III, n. 11492/2015, che rileva co me il principio sia stato implicitamente afferma to anche con riguardo alla categoria dei fanghi da trattamento (sez. III, n. 21774/2007) o dei vei coli fuori uso (sez. III, n. 40945/2010). Senza inter venire sul rapporto tra la nozione di categoria ed i codici, sez. III, n. 14557/2007 ha escluso la pre senza di categorie omogenee nel caso di deposito di materiali consistenti in residui di produzione vari (cascami di fibre tessili, ovatta, resti di im ballaggi in plastica, etc.) in attesa di essere ven duti a terzi.
25. Corte di Giustizia, sez. II, 11 dicembre 2008, causa C‑387/07, Mi.Ver.
26. Ex plurimis, Cass. pen., sez. III, n. 15593/2011, n. 15659/2014, n. 5916/2015, n. 44631/2016, n. 17184/2016, n. 41524/2017, n. 45739/2017, n. 40778/2019 e n. 35410/2021.
27. Principi valorizzati anche da Cass. pen., sez. I, n. 40718/2018.
Rafforza tale conclusione l’affermazione che il deposito temporaneo, pur esulando dall’attività di gestione dei rifiuti, in quan to costituisce una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, “è comunque sog getto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, 27 con la conseguenza che è necessario che i rifiuti siano conservati con modalità adeguate allo scopo, 28 è vietato il divieto di miscelazione ed è obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico”. 29
Le patologie di carattere soggettivo e la necessaria riferibilità del deposito temporaneo al produttore dei rifiuti Giova ribadire che, al fine di non stravolge re la collocazione sistematica del deposito temporaneo, la cui introduzione è stata sem pre giustificata dalla necessità, per il pro duttore materiale dei rifiuti, di raggrupparli prima di avviarli a recupero o smaltimento, deve ritenersi che, dovendo il deposito tem poraneo comunque precedere la fase di rac colta e trasporto dei rifiuti, 30 è al luogo di materiale produzione del rifiuto che occorre fare riferimento.
Tale riferimento perimetra l’applicabilità dell’istituto non solo sotto il profilo oggetti vo e spaziale, ma anche sotto quello sogget tivo, nel senso di consentirne l’applicabilità alle sole attività svolte direttamente dal pro duttore.
Pertanto, nel caso di deposito di rifiuti pro venienti da terzi – e quindi non accumulati dal produttore nel luogo di produzione – non può parlarsi di deposito incontrollato, ma si è in presenza di stoccaggio o messa in riser va non autorizzati. 31
Parimenti, va escluso che il produttore pos sa affidare a terzi la gestione del deposito temporaneo, poiché tale attività, inevitabil
28. Cass. pen., sez. III, n. 41692/2014, che ha escluso la configurabilità del deposito temporaneo in una fattispecie in cui “dall’ingente quantitativo di rifiu ti fuoriusciva percolato che confluiva nelle griglie di raccolta del capannone nonché odore intenso e nau seabondo”.
29. Cass. pen., sez. III, n. 39544/2006.
30. Si veda Cass. pen., sez. III, n. 8113/2003 che, ri guardo alle attività di spazzamento delle strade con sistematico scarico dei rifiuti, ha escluso la configurabilità del deposito temporaneo quando i rifiuti vengano raggruppati dopo la loro raccolta e trasportati in luogo diverso.
31. Cass. pen., sez. III, n. 34411/2005, con riferi mento all’attività di un carrozziere che raccoglie va olio esausto presso terzi o lo prelevava dalle carcasse depositate presso il suo sito produttivo, poiché in entrambi i casi il rifiuto non veniva pro dotto dalla sua attività.
Esclusa la gestione del proprio deposito temporaneo da parte di terzi
mente, deve qualificarsi come gestione di rifiuti prodotti da terzi.
Non a caso, la possibilità di cedere a terzi la gestione del deposito temporaneo (e quin di di ampliare la posizione di garanzia ti pica del produttore), introdotta nel 2006, fu abrogata nel 2008. In particolare:
• il 29 aprile 2006 entrava in vigore il Dlgs 152/2006 che, al suo articolo 208, com ma 17, recava la seguente previsione “La medesima esclusione opera anche quando l’attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti. Il conferimento di rifiuti da par te del produttore all’affidatario del deposi to temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all’articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del pro duttore che dell’affidatario del deposito tem poraneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore”;
• il 13 febbraio 2008 entrava in vigo re il Dlgs 4/2008 (primo correttivo al “Co dice ambientale”) che al suo articolo 2, comma 29‑ ter, lettera c) dispone che “al comma 17 sono soppresse le parole da ‘la medesima esclusione’ fino alla fine”
Il riallineamento ai principi generali, del resto, appare in linea con il principio di stretta interpretazione del deposito tempo raneo, affermato non solo dalla giurispru denza nazionale, ma anche dalla Corte di Giustizia Ce fin dal 1999. 32
Se l’affidamento a terzi della gestione del deposito temporaneo dei rifiuti generati dalla produzione è incompatibile con la
struttura essenziale dell’istituto, possono però ammettersi forme negoziali che includono nell’organizzazione del produttore il personale che materialmente si occupa di tale attività.
Appare praticabile il contratto di sommi nistrazione di lavoro, definito dall’artico lo 30 del Dlgs 81/2015 33 come “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione au torizzata, ai sensi del Dlgs 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più la voratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore” 34 Od ancora, l’istituto del distacco previsto dall’articolo 30 del Dlgs 276/2003 (che “si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone tem poraneamente uno o più lavoratori a dispo sizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa” ). 35
In questi casi, infatti, il lavoratore entra nell’organizzazione del produttore, il qua le resta l’unico autore e gestore del deposi to temporaneo.
Lo stesso risultato, di contro, non si rag giunge con il contratto di appalto in quan to, secondo l’articolo 1655, C.c., con esso “una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio ri schio, il compimento di un’opera o di un ser vizio verso un corrispettivo in danaro”, con la conseguenza che tratto distintivo dell’i stituto è l’autonomia dell’appaltatore, e non la sua inclusione nell’organizzazione del committente. 36
Ammesso il contratto di somministrazione e il distacco ma non l’appalto
32. Si veda Corte di Giustizia, sez. IV, 5 otto bre 1999, cause riunite C‑175/98 e C‑177/98: “in quanto deroga a norme che mirano a conseguire obiettivi di una fondamentale rilevanza, quali la protezione dell’ambiente e della salute, la nozione di ‘deposito temporaneo’ deve interpretarsi in mo do restrittivo”
33. In continuità normativa con il previgente arti colo 20 del Dlgs 276/2003.
34. L’inclusione nella struttura del produttore dei rifiuti nel caso di ricorso trova conferma nel principio per il quale “la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavora tore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull’utilizzatore, quale sogget to che inserisce il lavoratore nella propria struttu ra imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa” (Cass. civ., sez. III, n. 31889/2019).
35. L’interesse può fondarsi su varie ragioni, qua li, ad esempio, “l’incremento della polivalenza pro fessionale individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea, nell’attesa della ri presa produttiva, al fine di non disperdere il patri monio professionale di ciascun dipendente” (Cass. civ., sez. lav., n. 18959/2020).
36. Come afferma Cass. civ., sez. lav., n. 15557/2019: “l’appalto di opere o servizi espleta to con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della ‘organizzazione dei mez zi necessari da parte dell’appaltatore’, previsto dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interven ti dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’ap paltatore”
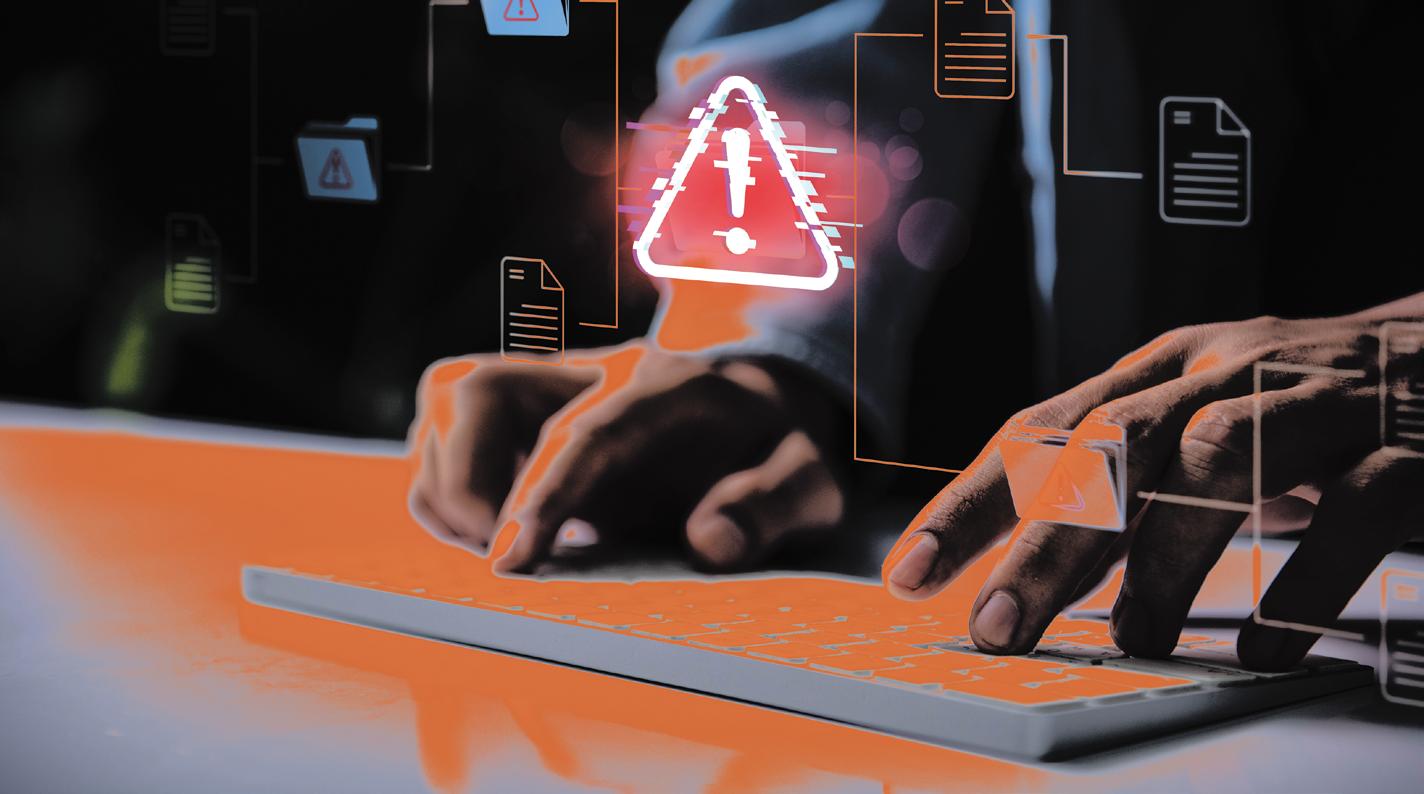
di Gabriele Taddia
Avvocato in Ferrara
ABSTRACT
Ai fini della configurabilità della re sponsabilità da reato degli Enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di or ganizzazione o la loro inefficace at tuazione, essendo necessaria la dimo strazione, per l’appunto, della “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli auto ri del reato. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con sen tenza 25 giugno 2024, n. 31665.
Premessa
La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza 25 giugno 2024, n. 31665 è tornata ad occuparsi di un tema di estrema rilevan za nell’ambito della responsabilità ammi nistrativa degli Enti per fatti dipendenti da reato, e lo ha fatto in modo estremamente efficace e condivisibile ribadendo, da un la to, un principio che nella giurisprudenza di legittimità si sta ormai consolidando, e cioè la necessità (ai fini della condanna) che l’ac cusa provi in giudizio la colpa di organizza zione dell’ente indipendentemente dal fatto che lo stesso si sia o meno dotato un model lo di organizzazione e gestione, sfuggendo così alla tentazione di costituire una inac cettabile responsabilità oggettiva dell’ente seppur in un campo ibrido come quello del la responsabilità ex Dlgs 231/2001 che, come ormai assodato, costituisce un modello mi sto fra penale e amministrativo.
Il secondo principio enunciato dalla sen tenza è forse anche più interessante ed innovativo: infatti, viene stabilito che la violazione sporadica delle prescrizioni del modello (o di qualunque atto organiz zativo di cui è dotata l’azienda), pur com messa da un soggetto apicale in modo non fraudolento ma comunque non conosciu
to all’organo amministrativo della società, non consente di attribuire all’ente una col pa di organizzazione che pur sarebbe di per sé ammissibile.
Si tratta di un principio sostanzialmente nuovo nel campo della responsabilità degli Enti per fatti dipendenti da reato, che impone sempre più all’accusa di dover dimostrare in concreto (finalmente) non solo il fatto di reato, ma anche la prevedibilità e prevenibilità da parte dell’ente, indipendentemente – si ripete – dalla presenza o meno del modello organizzativo.
Il fatto e la vicenda processuale
In estrema sintesi, il fatto storico da cui prende le mosse la sentenza riguarda la violazione di norme relative alla sicurez za sui luoghi di lavoro, ma ciò non rende la questione meno interessante anche in campo ambientale, poiché i principi enun ciati sono applicabili in via generale.
Agli imputati veniva contestato di non aver provveduto a predisporre idonee procedure per assicurare la sicurezza dei lavoratori nel corso di trasferimenti (all’e stero) in zone estremamente pericolose a causa della presenza di una forte instabi lità politica.
E, purtroppo, è accaduto che nel corso di un trasferimento alcuni lavoratori venis sero sequestrati e di seguito uccisi nel cor so di un conflitto a fuoco con malviventi della zona. Alla società datrice di lavoro veniva pertanto contestata l’omessa pre visione di protocolli di sicurezza adegua ti e, per questo motivo, oltre al delegato in materia di sicurezza (che ha separatamen te richiesto applicazione della pena ex ar ticolo 444, C.p.p.) veniva condannato l’ente ex Dlgs 231/2001.
La difesa della società proponeva ricor so per cassazione, rappresentando che era stato ampiamente dimostrato nel corso del giudizio di merito che l’azienda aveva in realtà protocolli ben rodati per il tra sferimento del proprio personale in zone pericolose e che gli stessi erano stati viola ti dal delegato in materia di sicurezza sen za che il c.d.a. fosse a conoscenza di tale violazione, e – date le dimensioni rilevan ti della società – nemmeno sarebbe sta to possibile che l’organo amministrativo fosse concretamente in grado di conoscere di volta in volta le modalità organizzative dei trasferimenti.
L’accoglimento dei motivi di ricorso
La Corte di Cassazione accoglie tali motivi di ricorso, argomentando in modo molto convincente e tale da allontanare – final mente – la responsabilità ex Dlgs 231/2001 da una inaccettabile responsabilità og gettiva alla quale, in un passato molto re cente, parte della giurisprudenza si era orientata.
In primo luogo, la sentenza precisa un ele mento giuridico e fattuale imprescindibi le: per la valutazione della responsabilità dell’ente, il tema non è se le procedure fosse ro contenute nel documento di valutazione dei rischi (o nel Mog, possiamo aggiungere), ma se vi fosse un’organizzazione azienda le nota e conosciuta al personale tesa a fron teggiare i rischi all’incolumità degli operai nei loro spostamenti. E tali disposizioni vengono ritenute anche nella sentenza im pugnata come esistenti note al soggetto dele gato, agli stessi lavoratori e solo per la prima volta in quella specifica occasione disattese.
L’errore logico compiuto dalla sentenza è dunque quello di desumere la responsa bilità dell’ente semplicemente dallo spora dico comportamento tenuto da una figura apicale senza indagare sulla reale portata dell’organizzazione dell’ente stesso. D’al tronde, è la stessa sentenza della Corte di Appello che riconosce che il comporta mento del delegato in materia di sicurez za che aveva posto in essere la violazione dei protocolli aziendali fosse occasionale e non prevedibile dai vertici societari.
“Sul punto la Corte territoriale, nell’af fermare la responsabilità ai sensi del le legge 231/2001 della [società], non pare operare un corretto governo della più re cente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che, al fine di evitare che la re sponsabilità dell’ente sia formalisticamen te e automaticamente dedotta, in base a schemi logico‑presuntivi che richiamano il paradigma della responsabilità oggetti va, dal fatto che un reato è stato commesso nell’ambito dell’organizzazione societaria, ha ancora più esplicitamente ribadito (ri spetto a quanto già comunque affermato in precedenza) la necessità che l’accertamen to della responsabilità dell’ente segua un percorso di natura sostanziale (lo stesso in effetti applicato dalla sentenza impugnata nella prima parte della motivazione, che ha portato all’assoluzione dei componenti del c.d.a.) che, a somiglianza di quanto accade
La rilevanza dello sporadico comportamento della figura apicale
nel campo della responsabilità delle perso ne fisiche e indipendentemente dalla for male presenza di un modello organizzativo efficace e correttamente implementato, ac certi l’esistenza in concreto di una ‘colpa di organizzazione’ rispetto alla quale il rea to che è stato commesso si ponga in stretto ed univoco rapporto di derivazione causa le. Si tratta, cioè, proprio di quegli elementi di cui, nel caso di specie, la sentenza impu gnata, trattando della responsabilità delle persone fisiche, ha escluso l’esistenza”.
Il principio posto dalla Corte è totalmen te condivisibile: su questa specifica linea si è attestata anche la recentissima sez. IV, n. 21704 del 28 marzo 2023, nella cui mo tivazione si legge che: “La responsabilità da reato degli Enti rappresenta un model lo di responsabilità che, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello ammi nistrativo, ha finito con il configurare un tertium genus, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza e i criteri d’impu tazione oggettiva di essa (sez. U., n. 38343 del 24 aprile 2014, E., Rv. 261112). Inoltre, il legislatore ha previsto specifici criteri di imputazione di tale responsabilità, l’in teresse o il vantaggio di cui all’articolo 5 del Dlgs 231 del 2001), che sono alternati vi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del re ato, apprezzabile ex ante, cioè al momen to della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggetti vo, il secondo ha connotazione essenzial mente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dall’illecito (sez. U., n. 38343/2014, cit., Rv. 261114). Tuttavia, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in rela zione a reati colposi di evento in violazio ne della normativa antinfortunistica, il S.C. ha precisato che la ‘colpa di organizzazio ne’ deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall’i nottemperanza da parte dell’ente dell’ob bligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la com missione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto col lettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (sez. U, n. 38343/2014, cit., Rv. 261113)”
Se così non fosse verrebbe svuotata di contenuto la previsione normativa che
ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell’ente anche i reati colposi (come molti di quelli ambientali).
Nel caso di specie, la violazione dei proto colli non è avvenuta in modo occulto ma si è esplicitata in una violazione frontale e diretta delle prescrizioni, commessa in modo palese e non occulto. “Ritenuto so lo il primo atto ad escludere la responsa bilità dell’ente, si è peraltro chiarito, in via interpretativa, che i citati criteri di imputa zione oggettiva vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento, in con formità alla diversa conformazione dell’il lecito, essendo possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istan ze funzionali a strategie dell’ente. A mag gior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente (in motiva zione, sez. U. n. 38343 del 2014, cit.)”.
Continua la Corte precisando che “peral tro, ai fini della configurabilità della re sponsabilità da reato degli Enti, non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo ne cessaria la dimostrazione, per l’appunto, della ‘colpa di organizzazione’, che carat terizza la tipicità dell’illecito amministrati vo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato (sez. 4, n. 18413 del 15 febbraio 2022, C.G.V., Rv. 283247‑01). Nell’affermare tale principio, peraltro, si è spiegato in moti vazione (richiamando sez. 4, n. 32899 del 8 gennaio 2021, C., sul disastro ferrovia rio di Viareggio) che la struttura dell’ille cito addebitato all’ente incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale tra reo ed ente e quella teleolo gica tra reato ed ente hanno la funzione di rafforzare il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere at tribuito a quest’ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell’organizza zione, ma per fini estranei agli scopi di que sta. Ciò consente di dire, dunque, che l’ente risponde per fatto proprio e che per scon giurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una ‘colpa di or ganizzazione’ dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
Necessaria la dimostrazione della ‘colpa di organizzazione’, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo
Dunque, a riscontro di un tale deficit or ganizzativo a consentire l’imputazio ne all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo, spetta all’accu sa dimostrare l’esistenza dell’illecito pe nale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e che essa ha agito nell’interesse del se condo, previa individuazione di preci si canali che colleghino l’azione dell’uno all’interesse dell’altro (in motivazione, sez. 6, n. 27735 del 18 febbraio 2010, S., Rv. 247666).
Impeccabile interpretazione da parte della Corte di Cassazione Si tratta di una interpretazione che, in sostanza, attribuisce al requisito della “colpa di organizzazione” dell’ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, cioè di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.
Essa va dimostrata dall’accusa e l’ente può dimostrarne l’assenza, gli elementi costi tutivi dell’illecito essendo rappresenta ti dalla sopra descritta immedesimazione organica “rafforzata”, ma anche dalla ca renza di un adeguato modello organizza tivo, oltre che dal reato presupposto e dal nesso causale tra i due (in motivazione, sez. 4, n. 18413 del 15 febbraio 2022, cit.).
In questa prospettiva, è chiaro che anche l’illecito amministrativo da reato dell’en te deve rispondere ad un giudizio di colpevolezza della persona giuridica, po nendosi come espressione di un suo fatto proprio e colpevole.
Come del resto previsto dalla relazio ne ministeriale di accompagnamento al Dlgs 231/2001, “il reato dovrà costituire an che espressione della politica aziendale o
quanto meno derivare da una colpa di or ganizzazione”.
Ma cosa si intende per colpa di organizza zione?
La Cassazione (sez. III penale, 31 genna io 2024) ha già avuto modo di precisare che al fine di scongiurare imputazioni di responsabilità amministrativa da reato a titolo meramente oggettivo – è necessario che “sussista la c.d. colpa di organizzazio ne dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi ido nei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
Dunque, in una normativa complessa, e piena di inaccettabili contraddizioni come quella del Dlgs 231/2001, la Cassazione inizia – finalmente – a fissare dei principi che tendono ad allontanare l’impianto normativo dalla tentazione dell’imputazione per responsabilità oggettiva dell’ente.
Tale assunto della Cassazione diviene pre zioso anche in campo ambientale, laddove i reati presupposto puniti a titolo di col pa e non di dolo sono la maggioranza, uno fra tutti la gestione illecita di rifiuti, nella quale la colpa della persona fisica è spes so quasi impossibile da evitare, mentre in presenza di procedure e modelli organiz zativi efficaci e rodati sarà ben possibile una difesa dell’ente che punti a dimostra re che, pur in presenza di una organizza zione efficace, la violazione da parte della persona fisica non era prevedibile e nem meno prevenibile.
È, pertanto, necessario che le aziende prov vedano alla predisposizione di procedure efficaci e conosciute dai propri dipendenti, con frequenti verifiche del corretto funzio namento di tali procedure; solo così sarà possibile approntare una difesa dell’ente che abbia buone possibilità di successo.
Di seguito la rubrica dedicata alle Best Practice. Le pagine sono dedicate a Imprese, Associazioni, Consorzi e altri Enti che propongono le proprie esperienze nel quadro della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare.
Sono casi emblematici di innovazione e di buone pratiche che tracciano gli elementi di un impegno concreto nel difficile equilibrio tra compliance e sostenibilità.
per informazioni e contatti: marketing@reteambiente.it
di Diego Arbizzoni, Head of Sales Re Open
Il fotovoltaico è ormai una colonna portante del sistema energetico italiano: quasi 40 GW di potenza installata e milioni di moduli in funzione testimoniano una diffusione di questa tecnologia. Questo successo, però, pone una questione inevitabile: cosa accade quando i pannelli raggiungono il termine della loro vita utile?
Un modulo solare non è eterno. Dopo venti o trent’anni di esercizio – o talvolta anche prima, per guasti o eventi atmosferici – diventa un rifiuto speciale. La normativa italiana lo classifica come RAEE fotovoltaici (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), imponendo obblighi precisi di raccolta, trattamento e recupero. Gestire correttamente questi rifiuti significa non solo ridurre i rischi ambientali, ma anche recuperare materiali preziosi e ridare valore a ciò che altrimenti diventerebbe scarto.
Un pannello fotovoltaico con tecnologia cristallina è costituito per la maggior parte da vetro e alluminio, a cui si aggiungono silicio, rame, argento e vari polimeri che fungono da leganti e strati protettivi. Se consideriamo che solo i moduli installati con il Conto Energia tra il 2007 e il 2015 pesano complessivamente oltre un milione di tonnellate, è evidente che ci troviamo di fronte a un flusso consistente di materiali che nei prossimi anni dovrà essere gestito con grande attenzione.
Questi numeri rendono chiara la posta in gioco: i pannelli a fine vita possono essere una risorsa per l’industria, oppure un problema ambientale. La differenza dipenderà dalla capacità di costruire una filiera efficiente di raccolta, trattamento e riciclo.
La tecnologia di riciclo dei moduli è relativamente giovane, ma si sta evolvendo rapidamente. Oggi i principali approcci si possono sintetizzare in quattro modalità operative:
1. Triturazione meccanica
I moduli vengono frantumati, con o senza rimozione preliminare della cornice e della junction box. È un sistema veloce e adatto a grandi volumi, ma produce frazioni miste e poco pure, difficili da reimpiegare senza ulteriori lavorazioni.
2. Abrasioni selettive Alcuni impianti adottano linee che asportano progressivamente lo strato di vetro, generando polvere di silicio e residui di backsheet. Si ottengono materiali più puliti e meglio valorizzabili, ma a scapito della produttività: i tempi di trattamento sono lunghi e i costi elevati. 3. Processi ibridi Esistono soluzioni intermedie, in cui i moduli vengono “grattati” superficialmente per rimuovere la parte vitrea, lasciando un sandwich di celle ed EVA da avviare ad altri impianti. Questo approccio ha il vantaggio della rapidità, ma dipende da filiere esterne per completare il recupero.
4. Preparazione al riutilizzo Prima ancora del riciclo, si può
prolungare la vita utile dei moduli ancora funzionanti. In appositi centri autorizzati i pannelli vengono testati e, se idonei, possono essere reinstallati, spesso in mercati emergenti. È un’opzione sostenibile, ma il suo sviluppo è frenato da incertezze normative e dalla scarsa tracciabilità della filiera di riuso (mercati di destino dei moduli).
Alcuni componenti sono facilmente valorizzabili: l’alluminio delle cornici, il rame dei cavi, trovano facilmente sbocchi nell’industria metallurgica. Più complessa è la gestione del vetro, che rappresenta circa il 70% di un modulo.
Il problema è duplice: da un lato, la contaminazione con silicio e polimeri rende il vetro meno puro; dall’altro, i volumi disponibili sono modesti se confrontati con quelli del riciclo tradizionale (in Italia ogni anno si riciclano 2,4 milioni di tonnellate di vetro, contro le 25-30 mila tonnellate provenienti dai pannelli). Questo squilibrio rende difficile integrare stabilmente il vetro fotovoltaico nelle filiere già operative.
Un ulteriore fronte aperto è il recupero dei materiali “nobili” come silicio e argento. Questi elementi hanno un valore economico alto, ma estrarli in forma pura è complesso e richiede processi avanzati che ancora faticano a raggiungere un equilibrio tra costi e benefici.
Le soluzioni tecniche non possono essere scollegate dal
modo in cui i moduli vengono progettati. I pannelli di ultima generazione hanno strutture più complesse – ad esempio con doppio vetro o celle più sottili – che migliorano l’efficienza ma rendono più difficile il recupero dei materiali.
Qui entra in gioco l’ecodesign, cioè la progettazione orientata al fine vita. Prevedere sistemi di assemblaggio che permettano un più facile disassemblaggio potrebbe semplificare enormemente il lavoro degli impianti di riciclo. È un approccio che richiede collaborazione tra produttori, riciclatori e istituzioni, ma che può ridurre drasticamente i costi e gli impatti ambientali nel lungo periodo.
Oltre alla tecnologia, c’è un aspetto molto concreto: come raccogliere e trasportare i moduli a fine vita. Diversamente dagli elettrodomestici, i pannelli non si trovano concentrati nei centri urbani, ma sparsi in tetti di aree industriali e in impianti a terra in zone rurali. Questo significa che la logistica è più complessa e costosa: servono mezzi specializzati, personale formato e una pianificazione capace di raggiungere anche luoghi remoti. Senza un’organizzazione efficiente, il rischio è che i costi di trasporto annullino i benefici del riciclo.
Negli ultimi anni, l’attenzione istituzionale è cresciuta. Fondi nazionali ed europei, tra cui il PNRR, stanno sostenendo la creazione di impianti specifici per il trattamento dei moduli fotovoltaici. Parallelamente, consorzi e operatori stanno sperimentando nuove linee di riciclo. Ma la sfida non è solo tecnologica: serve un quadro regolatorio stabile, che favorisca la nascita di mercati per le materie prime seconde, incentivi l’innovazione e garantisca tracciabilità e trasparenza lungo tutta la filiera.

I moduli fotovoltaici a fine vita non possono essere visti come un problema, ma come un tassello essenziale della transizione ecologica. Recuperare in modo efficiente
vetro, metalli e silicio significa ridurre lo sfruttamento di nuove risorse, contenere gli impatti ambientali e creare opportunità economiche e occupazionali.
Sun RAEE nasce come primo sistema collettivo interamente dedicato alla filiera dei RAEE fotovoltaici, fondato sull’esperienza concreta e la gestione ad oggi di migliaia di tonnellate di moduli, inverter e componenti derivanti da interventi di revamping. Frutto della collaborazione tra attori qualificati del settore fotovoltaico e dei rifiuti, garantisce una gestione centralizzata e conforme alla normativa ambientale. Tra i suoi punti di forza, il Trust ad hoc: uno strumento finanziario flessibile e sicuro, costruito su misura in base alle esigenze dei proprietari di impianti incentivati in Conto Energia, che tutela gli obblighi di trattamento dei moduli fotovoltaici secondo le direttive del GSE. Grazie alla società di servizi Re Open, questo modello innovativo assicura trasparenza, efficienza e specializzazione esclusiva nel settore fotovoltaico, offrendo al mercato un interlocutore affidabile per una gestione sostenibile e integrata dei RAEE fotovoltaici.
di Francesco Petrucci
Redazione normativa Reteambiente
Legge 13 giugno 2025,
(Guri 25 giugno 2025 n. 145)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea –
Legge di delegazione europea 2024
La legge 13 giugno 2025, n. 91 contiene le disposizioni che autorizzano il Governo a ema nare uno o più decreti legisla tivi per recepire nell’ordina mento nazionale le ultime di rettive europee approvate. Il Parlamento ha indicato all’E secutivo una serie di “crite ri direttivi”, cioè le condizioni cui attenersi nell’attuazione nazionale del diritto europeo. Sono inoltre dettate norme per adeguare alcuni regola menti europei. Questi, pur es sendo immediatamente ap plicabili sul territorio italiano, hanno bisogno di essere inte grati e accompagnati da spe cifiche disposizioni nazionali. Tra i provvedimenti europei che il Consiglio dei Ministri è chia mato ad attuare molti riguar dano la gestione dei rifiuti. Li riepiloghiamo di seguito.
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l’attuazione degli atti dell’Unione europea (omissis)
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee (omissis)
Articolo 8
Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/ Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Raee 1. Nell’esercizio della delega per il rece pimento della direttiva (Ue) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, ol tre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicem bre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riordinare la disciplina nazionale re lativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (Ue) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiu ti originati da pannelli fotovoltaici, di cui
Argomento e glossa
I Raee fotovoltaici
all’articolo 1, punti 2) e 3), della diretti va (Ue) 2024/884; b) adeguare la disciplina relativa al finan ziamento della gestione dei rifiuti origi nati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovol taici alle disposizioni di cui all’articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (Ue) 2024/884, anche in considerazione di quanto dispo sto dall’articolo 14, paragrafo 2, della di rettiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall’articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (Ue) 2024/884, relati vi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori de gli impianti di trattamento, senza preve dere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel ri spetto dei principi di semplificazione e di gitalizzazione degli obblighi informativi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del pa rere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago sto 1997, n. 281.
3. Dall’attuazione del presente artico lo non devono derivare nuovi o maggio ri oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve dono all’adempimento dei compiti deri vanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le gislazione vigente.
La disposizione contiene la delega al recepimento della Direttiva 2024/884/Ue. Ta le provvedimento ha eliminato dalla normativa europea sui rifiuti elettronici
(Raee) l’applicazione retroattiva della responsabilità estesa del produttore delle apparecchiature elettroniche (Aee) conformandosi alla sentenza della Corte di Giusti zia Ue 25 gennaio 2022, causa C‑181/20.
In particolare, la Direttiva del 2024 ha modificato la Diret tiva 2012/19/Ue stabilendo che i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovol taici spettano al produttore dei pannelli solo con riferimen to ai prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 (data di entrata in vigore della Direttiva 2012/19/Ue).
Peraltro, si ricorda che il Dlgs 49/2014 (recante la discipli na dei rifiuti elettronici) si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (compresi i pannelli fotovol taici) dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto (cioè dal 12 aprile 2014).
Un’altra modifica della Direttiva europea del 2024 alla normativa del 2012 ha disposto che il regime di responsa
Articolo 9
Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/ Ce e 2009/123/Ce 1. Nell’esercizio della delega per il rece pimento della direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi gene rali di cui all’articolo 32 della legge 24 di cembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al Titolo VI‑ bis del Libro secondo del Codice penale e alla legisla zione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena at tuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (Ue) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizio ne dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsio ne di sanzioni effettive, dissuasive e pro porzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all’artico lo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’ar ticolo 32, comma 1, lettera d), della leg ge 24 dicembre 2012, n. 234; b) prevedere per le persone giuridiche, ai
Argomento e glossa
bilità estesa del produttore (Epr) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche aggiunte al campo di applica zione della Direttiva 2012/19/Ue il 15 agosto 2018 si ap plica a quelle immesse sul mercato dopo tale data (in cui è cessato il periodo transitorio previsto dalla Diretti va 2012/19/Ue).
Pertanto, tra i criteri di cui il Consiglio dei Ministri dovrà tenere conto nel recepire la Direttiva Raee c’è quello più generale di provvedere al riordino della disciplina na zionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita prove nienti sia dalle famiglie che dalle imprese.
Il Governo provvederà anche ad adeguare la disciplina del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da altre apparecchiature elettroniche allineandola alle al tre novità introdotte dalla Direttiva 2024/884/Ue come quelle sull’informazione agli utilizzatori e agli impianti di trattamento.
La Direttiva europea va recepita entro il 9 ottobre 2025.
sensi dell’articolo 7 della direttiva (Ue) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzio nate in relazione alla responsabilità di cui all’articolo 6 della medesima diret tiva, anche apportando modifiche al de creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; c) apportare alla normativa naziona le vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della diretti va (Ue) 2024/1203, in materia di con gelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizio nale, di strumenti investigativi e di coo perazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della me desima direttiva; d) prevedere adeguati meccanismi di co ordinamento e cooperazione tra le Au torità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei rea ti ambientali, anche adottando eventua li disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effet ti indicati dall’articolo 19 della diretti va (Ue) 2024/1203; e) provvedere, anche attraverso la pre visione di regolamenti o atti ammini strativi, all’adozione delle disposizioni
I nuovi reati ambientali introdotti dall’Unione europea
La disposizione delega il Governo a recepire la Diretti va 2024/1203/Ue sulla tutela penale dell’ambiente. Il provvedimento europeo stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni (non solo penali) al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente.
necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della diretti va (Ue) 2024/1203, in relazione all’ela borazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambien tali e in relazione al sistema di registra zione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli arti coli 3 e 4 della direttiva medesima; f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell’ordinamen to interno, anche attraverso l’abrogazio ne delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (Ue) 2024/1203, al fine di armonizzare il qua dro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finali tà della direttiva medesima, anche in re lazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pub blicazione di informazioni e accesso al la giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione.
2. Dall’attuazione del presente artico lo non devono derivare nuovi o maggio ri oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provve dono all’adempimento dei compiti deri vanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nel confermare i principi fondanti il meccanismo di tu tela introdotto dalla Direttiva 2008/99/Ce, la nuova disci plina prevede da un lato norme di maggiore dettaglio per l’applicazione dei principi in questione (introducendo an che misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale), dall’altro estende il cam po di applicazione della tutela penale a nuove tipologie di
reati ambientali o inasprisce le pene per comportamenti illeciti già presenti.
Tra i criteri direttivi l’indicazione al Governo di appor tare modifiche al Codice penale e alle altre pertinenti normative per dare piena attuazione alla Direttiva eu ropea.
L’attenzione è anche alla disciplina della responsabili tà amministrativa delle persone giuridiche. Sono infat ti stati introdotti dalla disciplina europea del 2024 nuovi “reati‑presupposto” che, se commessi dal manager o di pendente dell’azienda a vantaggio della stessa, compor tano per l’Ente conseguenze sanzionatorie.
Tra le nuove fattispecie si segnalano quelle legate al commercio illegale di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi, le violazioni gravi della
Articolo 10
Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/ Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti 1. Nell’esercizio della delega per il recepi mento della direttiva (Ue) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicem bre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le qua li condurre i procedimenti di autorizza zione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei control li, nel rispetto della disciplina dell’Unio ne europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Mi nistero dell’ambiente e della sicurez za energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall’articolo 3, paragrafo 5, della diretti va (Ue) 2024/1785; b) introdurre, sia per gli allevamen ti, sia per altre categorie di installazio ni, la possibilità, prevista dall’articolo 6 della direttiva 2010/75/Ue del Parlamen to europeo e del Consiglio, del 24 novem bre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i proce dimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale con una presa d’atto di conformità, modi ficando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando
legislazione in materia di sostanze chimiche e l’esauri mento delle risorse idriche.
Dovrà essere dunque modificato il Dlgs 231/2001 che re ca la disciplina italiana in materia di responsabilità am ministrativa delle società per i reati degli amministratori o dipendenti.
Il Governo dovrà anche elaborare e pubblicare entro il 21 maggio 2027 la Strategia nazionale in materia di con trasto ai reati ambientali.
La Direttiva 2024/1203/Ue deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.
Per un quadro della disciplina Ue si rimanda all’interven to di Pasquale Fimiani “La nuova Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente: un primo sguardo d’insieme” pub blicato sul numero 331 (ottobre 2024) di questa Rivista.
la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo; c) assicurare l’efficace partecipazione dell’Italia alle attività di scambio di in formazioni tecniche previste dalla diret tiva (Ue) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (Incite), previsto dall’articolo 27‑ bis della direttiva 2010/75/Ue; d) assicurare che la singola autorizza zione contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo di un elevato livello di pro tezione della salute umana e dell’ambien te nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala lo cale, individuando a tal fine le procedu re e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorren ti, da porre a carico dei gestori median te le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribui re efficacemente all’individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condi zionare l’esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni inte grate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedi mento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fa se decisoria dei soli soggetti aventi tito lo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri infor mativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la defi nizione o l’aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall’autoriz zazione;
f) chiarire come le disposizioni vigen ti in materia di risarcimento e indenniz
zo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che de termina un danno sanitario, ove neces sario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente di sciplina dell’Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico ti tolato ad accertare la violazione e intro ducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso; g) riordinare le disposizioni legislati ve e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l’autoriz zazione integrata ambientale – Ippc, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all’articolo 29‑ se xies , comma 9‑ quinquies , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le pro cedure autorizzative riguardanti inter venti che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche dispo nibili di riferimento, nonché le com petenze del tavolo di coordinamento previsto dall’articolo 29‑ quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di inter pello ambientale; h) prevedere sanzioni effettive, dissuasi ve e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivan ti dalla direttiva (Ue) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), del la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introdu cendo altresì strumenti deflativi del con tenzioso, quali la diffida ad adempiere; i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fi ne di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l’a brogazione delle disposizioni incompa tibili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
Argomento e glossa
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025‑2027, nell’am bito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripar tire” dello stato di previsione del Mini stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente uti
Il riordino delle disposizioni sulla prevenzione delle emissioni degli impianti industriali – Le Bat per le discariche
La disposizione delega il Governo all’attuazione della Di rettiva 2024/1785/Ue, che ha effettuato il restyling della storica disciplina sulle emissioni industriali recata dalla Direttiva 2010/75/Ue.
L’aggiornamento inciderà sulla Parte II del Dlgs 152/2006 recante la disciplina dell’autorizzazione integrata am bientale (Aia), provvedimento necessario per la costru zione e l’esercizio di una vasta tipologia di impianti e stabilimenti soggetti alla normativa sulle emissioni in dustriali.
Tra i criteri direttivi per il Governo c’è l’obbligo di intro durre la possibilità di stabilire per gli allevamenti, ma anche per altre installazioni, una serie di requisiti vin colanti da rispettare per l’impresa in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell’auto rizzazione integrata ambientale con una “presa d’atto di conformità” (a tali vincoli). Restano ferme le procedure di riesame e controllo dell’autorizzazione.
Nel recepire la Direttiva europea il Governo dovrà prov vedere a riordinare le procedure per il rilascio dell’au torizzazione integrata ambientale in coerenza con la disciplina sul procedimento amministrativo. In partico lare, nella fase decisoria andranno coinvolti solo i sogget ti che hanno titolo a esprimere atti di assenso necessari all’interno della Conferenza di servizi.
L’aggiornamento della disciplina alleggerisce la buro crazia per le imprese: la procedura di autorizzazione sa rà meno onerosa e più snella, ed entro il 2035 gli Stati
(omissis)
Capo III
Deleghe al Governo per l’attuazione di regolamenti europei (omissis)
Articolo 27
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (Ce) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (Moca), di cui al regolamento Ue
lizzando l’accantonamento relativo al Mi nistero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
4. Dall’attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggio ri oneri a carico della finanza pubblica.
dovranno introdurre un sistema di autorizzazione elet tronica.
La normativa europea introduce la possibilità per i citta dini che hanno subito danni alla salute di agire per ave re un indennizzo dalle Autorità responsabili di violazioni della Direttiva. Il Governo dovrà verificare la coerenza delle norme italiane con queste novità e introdurre even tuali correttivi per consentirne l’applicazione.
Infine, si ricorda che la nuova Direttiva 2024/1785/Ue apre alle migliori tecniche disponibili (cd. “Bat”, acroni mo dall’inglese Best available techniques) per le discari che di rifiuti.
Come è noto, la Direttiva sulle emissioni industriali as segna alla Commissione europea il compito di approvare delle norme tecniche da rispettare per la prevenzione e la riduzione delle emissioni di determinati inquinanti de gli impianti. Le cosiddette conclusioni sulle migliori tec niche disponibili (Bat). Le Bat sono approvate ad hoc per singoli settori produttivi e relative installazioni. E sono tenute in considerazione in sede di rilascio dell’autorizza zione integrata ambientale richiesta dall’impresa. Secondo quanto previsto dalle nuove norme europee, alle discariche di rifiuti (anche a quelle già soggette alle rego le della Direttiva 2010/75/Ue) saranno applicate le “mi gliori tecniche disponibili” che verranno approvate dalla Commissione europea.
Attualmente invece i requisiti della Direttiva 1999/31/Ce sulle discariche sono considerati “Bat” ai sensi della Di rettiva sulle emissioni industriali.
Le nuove regole Ue dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 1º luglio 2026.
2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017
1. Il Governo è delegato ad adottare, en tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle dispo sizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (Ue) 2022/1616 della Com missione, del 15 settembre 2022.
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’artico lo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri diretti vi specifici: a) semplificare e migliorare le mo dalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamen to (Ue) 2022/1616 e del regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;
b) istituire un sistema di banca di dati na zionale, da adeguare ai sistemi informati ci previsti a livello europeo; c) determinare tariffe, per l’attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli ali menti (Moca), di cui al regolamento (Ue) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione de gli operatori che effettuano i relativi con trolli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (Ue) 2022/1616; d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del rego lamento (Ue) 2022/1616 mediante la pre visione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
e) destinare i proventi derivanti dal le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenzia mento dell’attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
Argomento e glossa
3. Dall’attuazione del presente artico lo non devono derivare nuovi o maggio ri oneri a carico della finanza pubblica. L’amministrazione interessata provvede
I prodotti fatti con la plastica riciclata che vengono a contatto con il cibo
La disposizione delega il Governo ad adeguare l’or dinamento interno alle disposizioni del Regolamen to 2022/1616/Ue che disciplina le regole per immettere in commercio materiali e oggetti di plastica riciclata desti nata a venire in contatto con gli alimenti. Il provvedimento è un Regolamento europeo, non una Direttiva. Pertanto, è già in vigore nell’ordinamento italiano. Tuttavia, sono necessari alcuni interventi per meglio integrare la disciplina europea con le regole na zionali.
Tra i criteri cui dovrà attenersi il Governo nello scrivere le norme figurano quelli di: migliorare le modalità di no tifica e controllo degli impianti di riciclo; determinare le
(omissis)
Articolo 29
Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/Ce e il regolamento (Ue) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/Ce
1. Il Governo è delegato ad adottare, en tro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de creti legislativi per l’adeguamento del la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2023/1542 del Parla mento europeo e del Consiglio, del 12 lu glio 2023.
2. Nell’esercizio della delega di cui al com ma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’artico lo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri diretti vi specifici:
a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, rici clo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (Ue) 2023/1542;
b) adeguare lo schema di responsabi lità estesa del produttore alle nuove di sposizioni previste dal regolamento (Ue) 2023/1542, disciplinando i sistemi collet tivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di ri conoscimento degli stessi;
c) prevedere forme di garanzia finanzia ria per la gestione del fine vita dei pro dotti;
d) regolamentare le attività di gestione
agli adempimenti derivanti dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanzia rie disponibili a legislazione vigente.
tariffe per l’attività di controllo su prodotti e materiali; ridefinire il sistema sanzionatorio, destinando i proven ti delle sanzioni amministrative pecuniarie al migliora mento e potenziamento dell’attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
Dovranno anche essere introdotte disposizioni per deter minare le tariffe (a carico delle imprese) previste per le attività di controllo dell’Autorità pubblica su materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.
Per una disamina del Regolamento europeo del 2022 sia consentito il rimando a Francesco Petrucci, “Aggior nate le regole sulla plastica riciclata a contatto con gli alimenti” pubblicato sul numero 312 (gennaio 2023) di questa Rivista.
del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destina zione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relati vi rifiuti;
e) prevedere modalità per il conferimen to dei rifiuti di batterie, nonché per le re lative operazioni di raccolta;
f) individuare un’autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (Ue) 2023/1542, e definire le modalità organiz zative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rende re efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;
g) adeguare la disciplina relativa al re gistro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previ ste dal regolamento (Ue) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
h) individuare gli organismi di valutazio ne della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (Ue) 2023/1542, nel rispet to della competenza esclusiva in mate ria di prevenzione incendi del Ministero dell’interno, per il tramite del Diparti mento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposi zioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legi slativo 12 ottobre 2022, n. 157; l) prevedere misure volte ad assicura
re il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l’individuazione, la prevenzione e la ge stione dei rischi effettivi e potenziali legati all’approvvigionamento, alla la vorazione e all’immissione in commer cio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garanti scano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimen sione aziendale;
m) adeguare il sistema sanzionatorio vi gente, attraverso la previsione di sanzio ni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazio ni delle disposizioni del regolamento (Ue) 2023/1542;
n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il lo ro ciclo di vita;
o) prevedere disposizioni in tema di pro venti e tariffe per le attività connes se all’attuazione del regolamento (Ue) 2023/1542, determinate sulla base del co sto effettivo del servizio, nonché dei ter mini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione;
p) aggiornare gli allegati al decreto legi slativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in mate ria di vigilanza del mercato previste dal regolamento.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Confe renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall’attuazione del presente artico lo non devono derivare nuovi o maggio ri oneri a carico della finanza pubblica.
Argomento e glossa
Le amministrazioni interessate provve dono all’adempimento dei compiti deri vanti dall’esercizio della delega di cui al
I nuovi obblighi per i produttori di batterie e per la gestione dei relativi rifiuti
La norma contiene la delega al Governo per l’adeguamen to dell’ordinamento nazionale al Regolamento sulle bat terie e i relativi rifiuti 2023/1542/Ue. Il Regolamento ha sostituito la storica Direttiva 2006/66/Ce.
Le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano in tutta l’Unione europea dal 18 febbraio 2024. Fanno ecce zione le norme sui rifiuti delle batterie che sono operati ve dal 18 agosto 2025.
Anche in questo caso, come visto sopra, il nuovo Regola mento sulle batterie è in vigore in tutta l’Unione europea e non ha quindi bisogno di un “recepimento” nel diritto italiano. Ma occorre intervenire per eliminare dalle nor me nazionali elementi obsoleti o introdurre specificazio ni e adattamenti.
Ricordiamo che la Direttiva del 2006 era stata recepi ta con il Dlgs 188/2008. Tale provvedimento dovrà esse re modificato dal Governo, a ciò delegato dall’articolo in commento, per adeguarlo alle novità europee.
Sottoposte alla nuova disciplina tutte le batterie, com prese quelle per veicoli elettrici, quelle industriali, per avviamento, illuminazione e accensione (utilizzate prin cipalmente per veicoli e macchinari) e le batterie per mezzi leggeri di trasporto (come biciclette, motorini e sco oter elettrici).
Per i produttori scatterà l’obbligo di prevedere una di chiarazione e un’etichetta obbligatori sull’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici, le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (ad esempio per scooter elet trici e biciclette). Sono comprese le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kW/h, che sa ranno anche dotate di un “passaporto” digitale del pro dotto (contiene tutta la “storia” del bene e dei materiali con cui è fatto).
Il Regolamento prevede ambiziosi obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie e livelli minimi da raggiungere in me rito ai materiali recuperati. Così come sono introdotte
Allegato A
(articolo 1, comma 1) (omissis)
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le gislazione vigente.
maggiori restrizioni sul contenuto di mercurio, cadmio e piombo in alcuni tipi di batterie. Questi limiti si aggiun gono a quelli presenti nel Regolamento Reach e nella di sciplina sui veicoli fuori uso.
Il Governo, nell’implementare il Regolamento europeo nel diritto nazionale, dovrà ridefinire gli obiettivi di rac colta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dall’Europa.
L’Esecutivo italiano dovrà, inoltre, prevedere misure vol te ad assicurare il rispetto da parte dei produttori degli obblighi in materia di dovere di diligenza (due diligence) in materia di prevenzione dei rischi derivanti dalla cate na di approvvigionamento dei materiali con cui fabbrica no le batterie.
A questo proposito è in fase avanzata di approvazione una proposta di Regolamento europeo che farebbe slitta re al 2027 gli obblighi in materia di due diligence. Senza interventi correttivi le imprese sarebbero tenute a osser vare le disposizioni in materia dal 18 agosto 2025.
Saranno adeguate le regole sulla responsabilità estesa del produttore (Epr) disciplinando i sistemi collettivi e indi viduali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto‑tipo e delle modalità di rico noscimento degli stessi da parte del Ministero. Pertanto, sarà modificata la attuale disciplina Epr per le batterie.
Nelle disposizioni future emanate dal Governo saranno anche previste forme di garanzia finanziaria per la ge stione del fine vita dei prodotti, definite le attività di ge stione del prodotto, e quelle di trattamento dei relativi rifiuti. Saranno disciplinati il conferimento dei rifiuti di batterie e le relative operazioni di raccolta.
Di particolare interesse, infine, la disposizione che obbli ga il Governo a prevedere dei criteri ambientali minimi (cd. Cam) da inserire nei bandi di gara pubblici per l’ap provvigionamento di batterie o prodotti in cui sono in corporate.
Pannelli fotovoltaici, adesione ai sistemi collettivi va comunicata al Gse entro il 30 settembre 2025
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Decreto direttoriale 12 marzo 2025, n. 45
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 13 marzo 2025)
Approvazione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli incentivati”
Direzione generale economia circolare e bonifiche
Il Direttore generale
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e del la tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni e i compiti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizza zione del Governo, a norma dell’artico lo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 35 che ha isti tuito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché la legge 17 lu glio 2006, n. 233, che ha conferito la nuova denominazione Ministero dell’am biente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordi namento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto‑legge n. 22 del 1º mar zo 2021, convertito con modificazioni dal la legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di rior dino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l’altro, viene istituito il Mi nistero della transizione ecologica che ha riunito le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia precedentemente ripartite tra altri Dicasteri;
Visto il Dpcm n. 128 del 29 luglio 2021, avente ad oggetto il regolamento di orga nizzazione del Ministero della transizio ne ecologica, pubblicato in Guri n. 228 del 23 settembre 2021 e registrato dalla Cor te dei conti al n. 2763 in data 14 settem bre 2021;
Visto il decreto‑legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l’articolo 4 che prevede, tra l’altro, che il Ministero della transizio ne ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurez za energetica;
Visto il Dpcm n. 180 del 30 ottobre 2023, pubblicato in Guri n. 286 del 7 dicem bre 2023, recante il “Regolamento con cernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della tran sizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Dpcm n. 128/2021, come mo dificato dal Dpcm n. 180/2023, il Dipar timento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di li vello dirigenziale generale:
• Direzione generale economia circolare e bonifiche (Ecb);
• Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (Ussa);
• Direzione generale valutazioni ambien tali (Va);
• Direzione generale sostenibilità dei pro dotti e dei consumi (Spc);
Visto il decreto del Ministro dell’ambien te e della sicurezza energetica 12 genna io 2024, n. 17, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di li vello dirigenziale non generale del Mi nistero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 al n. 242; Visto il Dm del 14 marzo 2024, n. 100, di
approvazione della direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2024, registrato al la Corte dei conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;
Visto il decreto del Ministro dell’am biente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2025, n. 26, con il quale è stato adottato l’ “Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della si curezza energetica per l’anno 2025 e il triennio 2025 – 2027”, ammesso alla re gistrazione dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2025 al n. 329;
Visto il Piao 2025/2027 approvato con de creto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n.36 del 3 febbra io 2025;
Visto il decreto legislativo 29 dicem bre 2003, n. 387 recante l’attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promo zione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel merca to interno dell’elettricità;
Vista la direttiva 2009/28/Ce del Par lamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante l’attuazione della diretti va 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;
Visto il decreto del Ministro dello svilup po economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2011 (Incentiva zione della produzione di energia elettri ca da impianti solari fotovoltaici);
Visto il decreto del Ministro dello svilup po economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo rio e del mare del 5 luglio 2012 (Attuazio ne dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazio ne della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici);
Vista la direttiva 2008/98/Ce del Parla mento europeo e del Consiglio del 19 no vembre 2008 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni che (Raee);
Vista la direttiva (Ue) 2018/849 del Par lamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica le diretti ve 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/Ce relativa a pile e accumula tori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
Vista la direttiva (Ue) 2024/884 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 13 mar zo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/ Ue sui rifiuti di apparecchiature elettri che ed elettroniche (Raee); Vista la direttiva 2018/851/Ue del Par lamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la diretti va 2008/98/Ce relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia am bientale”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante l’attuazione della diretti va 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchia ture elettriche ed elettroniche (Raee); Visto il decreto legislativo 3 settem bre 2020, n. 116, recante l’attuazione del la direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 settem bre 2020, n. 118 recante l’attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (Ue) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/Ce re lative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiu ti di apparecchiature elettriche ed elet troniche;
Visto l’articolo 1, comma 1, lettera c) del suddetto decreto legislativo 3 settem bre 2020, n. 118 che ha introdotto nel de creto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, l’articolo 24‑ bis (Razionalizzazione del le disposizioni per i Raee da fotovoltaico); Visto il decreto‑legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dal la legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha disposto con l’articolo 19, comma 1, let tere a), b) e c) la modifica dell’artico lo 24‑ bis , comma 1 e dell’articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 mar zo 2014, n. 49;
Vista, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 40, comma 3, del decre to legislativo 14 marzo 2014, n. 49 con cui si prevede che il gestore dei Servizi energetici, previa approvazione del Mi nistero dell’ambiente e della sicurezza energetica, definisca “il metodo di cal colo della quota da trattenere e le rela tive modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fo tovoltaici”;
Visto il decreto direttoriale n. 54 dell’8 agosto 2022 della Direzione gene rale economia circolare del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energeti ca che ha approvato le “istruzioni opera tive per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”; Visto il decreto‑legge 29 dicembre 2022, n. 198 (legge di conversione 24 febbra io 2023, n. 14) che ha fissato al 30 giu gno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli “impianti fo
tovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio ne gli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia”, possono comuni care la scelta di partecipare a un sistema collettivo al gestore dei Servizi energetici e al sistema collettivo medesimo nonché inviare a quest’ultimo la relativa docu mentazione di adesione;
Visto il decreto‑legge 24 febbraio 2023, n. 13 (legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41) che ha previsto la possibilità di rateizzare, in cinque anni, la quota da versare al sistema collettivo in caso di adesione ai sensi del decreto legislativo n. 118/2020;
Visto il decreto‑legge 10 maggio 2023, n. 51 (legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87) che ha spostato al 30 giugno 2024 “il termine entro il quale i soggetti re sponsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al gestore dei Servizi energetici e al siste ma collettivo medesimo nonché inviare a quest’ultimo la relativa documentazio ne di adesione”;
Visto l’aggiornamento alle “istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” ap portato dal gestore dei Servizi energeti ci in data 26 ottobre 2023 in recepimento delle sopra citate novità introdotte dal la legge 21 aprile 2023, n. 41 e dalla leg ge 3 luglio 2023, n. 87; Visto il decreto‑legge 9 dicembre 2023, n. 181 (legge di conversione 2 febbra io 2024, n. 11), che ha raddoppiato la som ma che il gestore dei Servizi energetici trattiene dai meccanismi incentivanti ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del decre to legislativo 14 marzo 2014, n. 49; Visto il decreto‑legge 25 giugno 2024, n. 84 (legge di conversione 8 agosto 2024, n. 115) che ha ulteriormente spostato al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comuni care la scelta di partecipare a un sistema collettivo, ed ha disposto che “a decor rere dal 1º gennaio 2025, il Gse prevede, nell’ambito delle istruzioni operative, due finestre temporali annuali di dura ta pari a sessanta giorni, entro le quali i soggetti responsabili possano comunica re allo stesso Gse la scelta di partecipare a un sistema collettivo”; Visto il Dpcm del 31 maggio 2024, regi strato dalla Corte dei conti in data 1º lu glio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore generale della Direzione gene rale economia circolare e bonifiche (Ecb); Considerata la necessità del gestore dei Servizi energetici di provvedere alla ri definizione del “metodo di calcolo della quota da trattenere e delle relative moda lità operative a garanzia della totale ge
stione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici”, in virtù delle citate novità normative in tervenute a seguito dell’aggiornamento alle “istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” apportato dallo stesso gesto re dei Servizi energetici in data 26 otto bre 2023; Vista la comunicazione trasmessa dal gestore dei Servizi energetici alla com petente Direzione generale del Mini stero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 31 ottobre 2024 acqui sita agli atti con prot.n. 199669, ripor tante in allegato la nuova versione delle “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incen tivati”, che recepisce le novità normati ve introdotte; Tenuto conto della comunicazione ef fettuata dal gestore dei Servizi energe tici alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicu rezza energetica, acquisita agli atti con prot.n. 23532 del 7 febbraio 2025, con cui vengono forniti chiarimenti in me rito all’aggiornamento delle “istruzio ni operative per la gestione del fine vita
dei moduli fotovoltaici incentivati” uni tamente alla versione definitiva delle ci tate istruzioni;
Tenuto conto dell’istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurez za energetica;
Tenuto conto che la versione delle “istru zioni Operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici” include, in conformità al decreto legislativo 14 mar zo 2014, n. 49, obblighi differenti per i soggetti responsabili degli impianti foto voltaici incentivati rispetto a quelli dei produttori di apparecchiature elettri che ed elettroniche (Aee) previsti all’ar ticolo 8 del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Decreta
Articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 è approvato il documento “Istruzioni ope rative per la gestione del fine vita dei mo duli fotovoltaici incentivati”, contenente il metodo di calcolo della quota da trat
tenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiu ti da pannelli fotovoltaici, ridefinito dal gestore Servizi energetici, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
1. Per l’anno 2025, l’operatività del le due finestre annuali, di cui all’artico lo 24‑ bis, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ricade per la pri ma finestra nel periodo 1º aprile 2025 –31 maggio 2025 e per la seconda finestra nel periodo 1º luglio 2025 – 30 settem bre 2025.
Gli allegati sono reperibili in normativa Rifiuti in www.reteambiente.it al seguente link
https://lc.cx/SeeR53
di Alessandro Geremei
Redazione normativa Reteambiente
Il meccanismo per garantire il “fine vita” dei pannelli foto voltaici incentivati dal “Con to Energia” è stato modifica to dal Legislatore, nel corso dell’ultimo biennio, al fine di promuovere la partecipazio ne dei soggetti responsabili degli impianti ai Sistemi Col lettivi (cd. “opzione”), a sca pito dell’originario sistema che prevede un trattenimen to degli incentivi da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse). A partire dall’aumento della quota di incentivi trat tenuta da parte dal Gesto re e dal nuovo calendario per aderire, in qualsiasi momen to, alla “opzione”. Le nuove istruzioni operative, appro vate nel marzo 2025 dal Ma se, forniscono i dettagli per l’applicazione delle indicazio ni del Parlamento. E provano a “razionalizzare” anche le in dicazioni da seguire nel ca so di revamping degli impianti (totale o rilevante).
Premessa
Con un Comunicato del 1º luglio 2025, ri portato a pagina 48, il Gestore dei ser vizi energetici (Gse) ricorda che, fino al 30 settembre 2025, i soggetti respon sabili degli impianti fotovoltaici in centivati in “Conto Energia” 1 possono comunicare l’avvenuta adesione ai Si stemi Collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroni che (Raee) fotovoltaici.
È la seconda finestra temporale messa a disposizione degli operatori nel 2025 per aderire alla cd. “opzione”, introdot ta nel 2020, che consente di evitare il trattenimento di una quota (nel frat tempo raddoppiata) degli incentivi da parte del Gse, a garanzia del corretto “fine vita” degli impianti. Durante la prima (1º aprile‑30 maggio 2025) sono state trasmesse 1.346 istanze di adesio ne riguardanti oltre 800.000 moduli.
La garanzia per il corretto smaltimento dei moduli incentivati
I moduli fotovoltaici sono stati inclusi tra i Raee dal Dlgs 49/2014, e obblighi per la corretta gestione del loro fine vita sono stati posti (anche) a carico del detentore. 2 In particolare, per gli impianti incenti vati con il “Conto Energia”, il Legislatore ha affidato al Gse il compito di trattenere parte degli incentivi e di restituirli solo dopo aver accertato il corretto adempi mento degli obblighi di gestione dei Raee. I soggetti responsabili possono presta re, in alternativa al trattenimento delle quote, un’apposita garanzia finanziaria per la gestione dei Raee mediante la par tecipazione a un sistema collettivo (cd. “opzione”).
1. Il “Conto Energia” è il meccanismo di in centivazione della produzione di energia da impianti fotovoltaici entrati in eserci zio tra il 2006 e il 2013 (quindi prima che il Dlgs 49/2014 stabilisse l’obbligatorietà del versamento del contributo ambientale anche per tali Raee), mediante convenzio ni stipulate tra i proprietari degli impianti e il Gse di durata mediamente ventennale. Le convenzioni non sono più attivabili dal 6 luglio 2013, data in cui è stato raggiunto il tetto prefissato di costo cumulato degli in centivi (6,7 miliardi di euro).
2. Si veda l’Intervento “La gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici”, a firma di Francesco Petrucci, pubblicato sul n. 217 di maggio 2014 di questa Rivista.
3. Per un’analisi del quadro normativo ag giornato al gennaio 2023 sia consentito ri mandare al commento “Raee fotovoltaici, le nuove istruzioni operative per gli impian ti incentivati con il ‘Conto Energia’”, pub blicato sul n. 312 di gennaio 2023 di questa Rivista.
Il favor per l’“opzione”
Nel biennio 2023‑2024 3 è stata introdot ta la possibilità di rateizzare la quota da versare al sistema collettivo (leg ge 41/2023); è stata “raddoppiata” la quota trattenuta dal Gse rispetto alla garanzia versata al sistema collettivo (legge 11/2024); 4 il termine ultimo per l’adesione alla “opzione” è stato ripetu tamente prorogato infine al 31 dicem bre 2024; 5 sono state infine introdotte, dal 2025, due finestre temporali an nuali (di 60 giorni) per comunicare la decisione di partecipare a un sistema collettivo (legge 115/2024). Al Gse sono stati affidati compiti di monitoraggio e vigilanza.
Le nuove istruzioni operative
Le “Istruzioni operative per la gestio ne del fine vita dei moduli incentivati” aggiornate dal Gse sono state approva te con Dd Mase 12 marzo 2025, n. 45. 6
La maggiorazione della quota trattenu ta dal Gse (20 €/modulo), 7 raddoppiata rispetto al costo di adesione al sistema collettivo (10 €/modulo), viene applica ta ai moduli professionali adeguando il piano di trattenimento nelle annua lità residue.
Per tutte le comunicazioni va utiliz zato l’applicativo Siad. Semplificata la restituzione delle quote per i moduli domestici (non può essere più richiesta “altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento” ) e professio nali (niente più certificato di avvenuto trattamento/recupero). Scompare an che l’obbligo di attestare le condizioni equivalenti per i trattamenti all’estero. Trattenimenti “cautelativi” nel caso di dubbi sui numeri.
4. Misura evidentemente volta alla “pro mozione dell’utilizzo diretto dei servizi of ferti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei Raee”, secondo il Dossier di approfondimento sul disegno di legge A.C. 1606‑A – poi approvato come legge 11/2024 –pubblicato sul sito della Camera dei Deputa ti il 24 gennaio 2024.
5. Al 31 dicembre 2022 dal Dd 45/2025, al 30 giugno 2023 dalla legge 14/2023 di con versione del Dl 198/2022, al 30 giugno 2024 dalla legge 87/2023 di conversione del Dl 41/2023 e al 30 dicembre 2024 dalla leg ge 116/2024 di conversione del Dl 84/2024.
6. Sesta versione delle istruzioni operative pubblicate per la prima volta nel dicembre 2015. La precedente versione è stata pubbli cata sul sito del Gse il 26 ottobre 2023.
7. E non più “10 €/pannello” come previ sto dalle precedenti istruzioni operative. La medesima sostituzione – del sostantivo “pannello” con quello di “modulo” – si ripe te in svariate disposizioni delle nuove istru zioni operative.
Vengono rivisti tempi e modi per l’a desione alla “opzione”. Dal 2026, le fi nestre temporali utili si apriranno a febbraio‑marzo e giugno‑luglio. Il Gse interrompe il trattenimento delle quote nei confronti dei soggetti che aderisco no alla “opzione” e restituisce le quo te già trattenute: entro 180 giorni dalla chiusura della finestra temporale utiliz zata per i moduli professionali; nell’an no successivo per quelli domestici.
Si applicano le disposizioni relative a “costituzione e gestione amministrati va e finanziaria del Trust” contenute nel Disciplinare tecnico Gse del 1º di
8. Secondo le precedenti istruzioni del Gse, erano invece da ritenersi “integralmen te superate”. In occasione del webinar or ganizzato dal Gse in collaborazione con il Mite per illustrare le novità del 2022, tut
cembre 2012 (per gli impianti del IV e V “Conto Energia”). 8
Razionalizzazione del revamping
Deroghe possibili al trattenimento del le quote:
a) esenzione per il revamping “totale” dei moduli installati, domestici e pro fessionali; b) rimodulazione per il revamping “rile vante” (ex “parziale”) di almeno la metà dei moduli professionali installati.
Se i moduli vengono ritirati e sostituiti in garanzia, bisogna verificare se quel
tavia, era già stato sottolineato che le par ti del “Disciplinare tecnico” relative alla costituzione e alla gestione amministra tivo‑finanziaria del trust non fossero da considerarsi superate. Il webinar è vi
li installati provengono da una di scor ta tecnica immessa sul mercato ante Dlgs 49/2014, nel qual caso il processo di trattenimento delle quote prosegue. Altrimenti, si interrompe, e il Gse resti tuisce le quote già trattenute entro 120 giorni dalla valutazione amministrati va dell’intervento.
Vengono definiti ex novo i requisiti ri chiesti per l’esonero dal trattenimento delle quote riferito a moduli “corretta mente funzionanti” venduti all’estero. Consentita anche la rimodulazione.
sionabile sul portale YouTube al seguen te indirizzo: https://www.youtube.com/ watch?v=OOSMHfVTuGo
Con Decreto direttoriale 23 maggio 2025 il Ministero dell’In terno definisce le modalità operative per consentire alle unioni di Comuni e alle comu nità montane di accedere ai contributi per i servizi gestiti in forma associata nel 2025 (co me il servizio rifiuti).
Si tratta del contributo sta tale previsto a favore dei Co muni e delle comunità mon tane che svolgono in forma associata alcune funzioni co munali. E che viene determi nato in base al servizio ero gato oltre che, per le unioni di Comuni, in base alla popola zione e al numero di Enti loca li partecipanti.
Gli Enti che intendono ottene re il contributo devono invia re le certificazioni sulle spese sostenute per i servizi confe riti in gestione associata tra mite l’apposito sistema tele matico accessibile dal sito in ternet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del MinInterno (http://finanzalo cale.interno.it/apps/tbel.php/ login/verify).
Le certificazioni vanno presen tate entro le ore 24 del 30 set tembre 2025. (I.M.)
Ministero dell’interno Decreto direttoriale 23 maggio 2025 (Guri 4 giugno 2025 n. 127)
Approvazione della modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2025, del contributo erariale alle unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata
Il Direttore centrale per la finanza locale Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con il decreto legi slativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista l’intesa n. 936 del 1º marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unifi cata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’asso ciazionismo comunale, dove tra l’altro, all’articolo 8, è riservata al Ministero dell’interno la gestione delle risorse per l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato; Vista l’ulteriore intesa numero 22 del 6 marzo 2025, con la quale è stato concor dato, per l’anno 2025, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministe ro dell’interno; Considerato che per l’anno 2025, con l’in tesa numero 21 del 6 marzo 2025, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti Regioni: Ligu ria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia‑Romagna, Puglia, Piemonte, Lom bardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna; Visto che l’articolo 7 della citata inte sa n. 936/2006, prevede che nei territori delle Regioni che non sono individua te, nell’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle ri sorse statali, si applicano, in via sussi diaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell’interno 1º settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del
Ministro dell’interno 1º ottobre 2004, n. 289; Visto l’articolo 2, comma 6, del richiama to decreto ministeriale n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell’anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stes se o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle Comu nità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di Comuni e le Comunità mon tane trasmettono la richiesta di contri buto, unitamente alla certificazione di cui all’articolo 5, comma 1, del medesi mo decreto, per l’attribuzione del con tributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno; Visto l’articolo 5 del citato decreto mini steriale, il quale prevede che le unioni di Comuni e le Comunità montane svolgen ti l’esercizio associato di funzioni comu nali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti; Visto in particolare il comma 1 dell’arti colo 5, in forza del quale, in sede di pri ma istituzione delle unioni, di variazione del numero dei Comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del nume ro dei servizi, ed in sede di primo con ferimento in forma associata di servizi comunali alle Comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i Co muni interessati inviano attraverso le unioni di Comuni e le Comunità monta ne, entro il termine di cui all’articolo 2,
comma 6, apposita certificazione, al fine di ottenere il contributo statale; Considerato che in particolare il comma 2 dell’articolo 5 demanda ad apposito de creto del Ministero dell’interno la defi nizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 5; Visto il comma 5 dell’articolo 5, secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideter minato ogni triennio sulla base dei da ti relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercita ti in forma associata attestate dalle unio ni di Comuni e dalle Comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2; Rilevato l’obbligo di acquisire i dati ri chiesti nelle disposizioni normative ri chiamate;
Viste le disposizioni in materia di dema terializzazione delle procedure ammini strative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizza zione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recan te norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra zioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consi ste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natu ra prettamente gestionale;
Decreta:
Articolo 1
Enti destinatari della misura finanziaria
1. Sono legittimati alla richiesta per l’ot tenimento del contributo le unioni di Co muni e le Comunità montane.
Articolo 2
Modalità di certificazione
1. È approvata la modalità di certifica zione presente sul Sistema certificazio ni Enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.it/ apps/tbel.php/login/verify – relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle Comunità monta ne per i servizi gestiti in forma associata nell’anno 2025.
Articolo 3
Quantificazione del contributo
1. La quantificazione del contributo era riale che deriva dai fondi erariali stan ziati e dal numero degli Enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante ripar to del fondo stesso secondo il criterio pro porzionale.
Articolo 4
Modalità e termini di trasmissione 1. Per la validità della comunicazione, le
unioni di Comuni e le Comunità monta ne, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all’articolo 2 entro il termine perentorio, a pena di decaden za, delle ore 24,00 del 30 settembre 2025.
Articolo 5
Istruzioni e specifiche
1. La certificazione dovrà essere compila ta con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizio ne di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio fi nanziario.
2. La certificazione eventualmente tra smessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valida ai fini del corretto adempimento di cui all’articolo 4.
3. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione già tra smessa telematicamente comporta la non validità della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all’ar ticolo 4.
4. È facoltà delle unioni di Comuni e del le Comunità montane che avessero ne cessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque en tro i termini di trasmissione fissati all’ar ticolo 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nel la Gazzetta ufficiale della Repubblica ita liana.
Roma, 23 maggio 2025
I veicoli fuori uso che non ven gono bonificati dei liquidi o di altre componenti inquinanti, come la batteria e l’olio moto re, sono rifiuti speciali perico losi ai sensi del Codice ambien tale (Dlgs 152/2006). E lo sono indipendentemente dal fatto che siano muniti di targa. Ne consegue che colui che ge stisce senza autorizzazione veicoli fuori uso ancora dota ti di materiali inquinanti, nel la specie smaltendo abusiva mente il veicolo su un’area di proprietà comunale, è punito per il reato previsto dall’arti colo 256, comma 1, lettera b) del Dlgs 152/2006. (I.M.)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
la Corte Suprema di Cassazione
Sezione terza penale
ha pronunciato la seguente
Sentenza sul ricorso proposto da: N. (omissis) avverso la sentenza del 5 aprile 2024 del Tribunale di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugna to e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere (omissis); letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu ratore generale (omissis), che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 5 aprile 2024, il Tri bunale di Cagliari ha dichiarato N. col pevole del reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 152 del 2006, per avere, in qualità di esecutore materiale, effettuato gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione e, segnatamente, per aver smaltito un vei colo di proprietà di un terzo e nella di sponibilità dell’imputato, depositandolo in un’area sita in località (omissis) di pro prietà comunale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ap pello, riqualificato in ricorso per cassa zione, l’interessato a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazio ne ex articolo 173, disp. att., Codice di pro cedura penale.
2.1. Deduce, con il primo motivo, l’erro neità della sentenza in ordine al reato perché il fatto non sussiste.
In sintesi, la difesa dell’imputato, pro ponendo erroneamente appello avver so sentenza inappellabile ex articolo 593, comma 3, Codice di procedura pena le, dopo aver descritto la cronistoria del processo penale e richiamato le fonti
probatorie, sostiene che la sentenza im pugnata sarebbe palesemente errata. An zitutto, perché non sarebbe emersa una prova documentale certa della “can nibalizzazione” del veicolo ad opera dell’imputato. Sostiene che il testimone, proprietario del veicolo che sarebbe sta to abusivamente gestito da parte dell’im putato, dopo aver inizialmente negato di esserne proprietario, solo a seguito di contestazioni da parte del pubblico mi nistero avrebbe cambiato versione e ammesso il fatto, affermando di aver por tato il veicolo a riparare presso l’autof ficina in cui l’attuale imputato lavorava e di essersi rivolto a lui per un preventi vo. Il teste aveva riferito di aver porta to il veicolo presso l’autofficina ma che, reputando il costo della riparazione an tieconomico, aveva deciso di abbando nare l’auto sul posto anche su proposta dello stesso imputato, avendolo fatto per ché quest’ultimo gli avrebbe prospettato l’ipotesi di ricavarne pezzi da rivendere, anche se tuttavia l’autovettura era stata rinvenuta integra dalla polizia munici pale. Si tratterebbe peraltro di dichiara zioni rese su contestazione del pubblico ministero, sulla cui attendibilità vi è dub bio da parte del difensore.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, l’er roneità della sentenza in ordine al rea to perché l’imputato non lo ha commesso. In sintesi, la difesa sostiene l’assenza dell’elemento psicologico del reato, in quanto osserva che, se l’imputato avesse davvero voluto riciclare i pezzi del veico lo di proprietà altrui e smaltire il restan te, non avrebbe lasciato integro il numero di telaio. Il Giudice non avrebbe inoltre tenuto conto che, ove l’imputato avesse effettivamente deciso di smaltire l’auto vettura mettendo da parte i pezzi riutiliz zabili, certamente non l’avrebbe lasciata in bella vista per tutto quel lasso di tem po, ciò in considerazione del fatto che l’of ficina in cui lavorava come dipendente era adiacente ad un campo rom pieno di carcasse d’auto e, quindi, facile preda di “cannibalizzazione” da parte di coloro che vi risiedevano.
2.3. Chiede, con il terzo motivo, l’assolu
zione ai sensi dell’articolo 131‑ bis Codice penale per particolare tenuità o occasio nalità del fatto.
In sintesi, si osserva che, avendo il Giudi ce riconosciuto le circostanze attenuan ti generiche essendo l’imputato un mero dipendente nell’officina, e considerato che si trattava di fatto assolutamente oc casionale, l’episodio avrebbe potuto es sere ricondotto all’articolo 131‑ bis Codice penale.
2.4. Chiede, infine, con il quarto ed ulti mo motivo, la riduzione della pena pecu niaria.
In sintesi, la difesa ritiene eccessivo il trattamento sanzionatorio in quanto, es sendo egli un lavoratore dipendente con un reddito mensile modesto, il paga mento dell’ammenda ascritta inflittagli comporterebbe un notevole disagio eco nomico in capo al medesimo.
3. In data 31 gennaio 2025, il Procurato re generale presso questa Corte ha de positato la propria requisitoria scritta, chiedendo a questa Corte dichiararsi l’i nammissibilità del ricorso.
In particolare, ritiene il Pg che il primo e il secondo motivo di ricorso sono en trambi inammissibili, perché contengo no censure attinenti a profili di merito e che fuoriescono dal perimetro del giu dizio di legittimità in quanto tese a pro spettare una diversa e più favorevole ricostruzione del fatto. Il ragionamento con cui il Giudice di primo grado ha ri tenuto sussistente l’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato è basato sull’apprezzamento degli elementi emer si in fase di indagine, in particolare le dichiarazioni testimoniali acquisite in fase di istruttoria dibattimentale, ed è esente da censure in termini di logicità, coerenza e contraddittorietà, e pertanto immune da errori giuridici rilevabili in questa sede. Il terzo ed il quarto motivo sono poi ge nerici, e quindi inammissibili. Entrambi i motivi si limitano, infatti, a sanziona re in modo generico, rispettivamente, il mancato riconoscimento della partico lare tenuità del fatto e l’eccessività della pena pecuniaria. Il ricorrente lamenta ge nericamente l’eccessività della pena pe cuniaria, omettendo di confrontarsi con il rilievo che la pena è stata comminata in misura inferiore al minimo edittale, per effetto della concessione delle atte nuanti generiche. La doglianza con cui si deduce la mancata applicazione dell’ar ticolo 131‑ bis C.p. è anch’essa da respin gere, in quanto l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non pu nibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazio ne implicita (Sezione 5, n. 24780 del 8 mar zo 2017, Rv. 270033‑01). Nel caso di specie il Tribunale di Cagliari ha effettuato una
“valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie con creta” (Sezioni Unite, n. 13681 del 25 feb braio 2016, T., Rv. 266590‑01), sulla base della quale ha ritenuto di escludere l’ap plicazione dell’articolo 131‑ bis in ragione della pericolosità dei rifiuti, ma di con cedere le attenuanti generiche alla luce della limitata portata offensiva della con dotta, trattandosi di una sola automobile, in ossequio ai principi delineati dalla giu risprudenza di legittimità in materia di non punibilità del fatto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso, trattato cartolarmente in as senza di richieste di discussione orale, è inammissibile.
2. Preliminarmente, occorre osservare che il reato di attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata ex artico lo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006, è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da due milaseicento euro a ventiseimila euro, dunque con pena detentiva alternativa a pena pecuniaria. Nel caso di specie, l’imputato è stato con dannato alla sola pena dell’ammenda. Pertanto, avendo la sentenza inflitto la sola pena dell’ammenda, la difesa non era legittimata a proporre appello, poi ché si tratta di sentenza inappellabile se condo quanto stabilito dall’articolo 593, comma 3, C.p.p., introdotto dall’artico lo 34, comma 1, lettera a), del Dlgs 10 ot tobre 2022, n. 150, il quale stabilisce che “sono in ogni caso inappellabili le senten ze di condanna per le quali è stata appli cata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento re lative a reati puniti con la sola pena pecu niaria o con pena alternativa”.
A ciò va aggiunto che i motivi di ricor so proposti sono tutti articolati in fatto, poiché rivolti al giudizio di merito, os sia l’appello, che, tuttavia, non è previsto dalla legge.
In base a tali considerazioni, i motivi so no, di per sé, inammissibili perché propo sti fuori dai casi consentiti ex articolo 606 Codice di procedura penale.
3. Ciò premesso, il primo motivo è inam missibile anche per manifesta infonda tezza.
A prescindere dalla considerazione se condo cui l’impugnazione, di per sé, de ve essere considerata inammissibile, in relazione al primo motivo, invero, la dife sa contesta la sentenza, ritenendola erro nea e sostenendo la mancata sussistenza del fatto.
3.1. Secondo quanto, invece, corretta mente affermato dal Giudice di primo grado, il reato contestato risulta piena mente integrato. Infatti, questa Corte (Se
zione 3, n. 35134 del 10/09/2009, non mas.) ha affermato che integra gli estremi del reato di cui all’articolo 256, comma 1, let tera b) del Dlgs 152/2006, la condotta del soggetto che abbia abbandonato o depo sitato in modo incontrollato veicoli a fine vita, quindi, fuori uso, essendo tali veico li, ancorché muniti di targa, qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bo nificati mediante la eliminazione dei ma teriali inquinanti.
3.2. I veicoli fuori uso sono classifica ti come rifiuti pericolosi (Codice Cer/Eer 160104) sia ai sensi del Dlgs 22 del 1997 che del vigente Dlgs 152 del 2006, allor ché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinan ti. Peraltro, vanno qualificati come vei coli fuori uso e pertanto rifiuti, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del Dlgs 24 giugno 2003, n. 209, i veicoli a fi ne vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero ab bia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Inoltre, affinché un veicolo dismesso pos sa considerarsi rifiuto pericoloso è neces sario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre compo nenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il Codice Cer/Eer 16.01.06.
In generale, un autoveicolo contiene ele menti e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (ad es. combustibile, bat teria, olio motore, liquidi refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata trami te operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezza ture per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche. Una vol ta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.
3.3. Nel caso di specie, il veicolo era do tato di tutti i liquidi e componenti di fabbrica, alcuni dei quali inquinan ti e inquadrabili nella disciplina del Dlgs 209/2003.
Come anticipato, i liquidi ed altre com ponenti di un veicolo a motore – come ad esempio combustile, batteria, olio motore, sospensioni idrauliche, olio dell’impian to frenante, liquidi refrigeranti o antige lo, detergenti per i cristalli – richiedono, per essere rimossi, operazioni oggettiva mente complesse, le quali comportano non soltanto la previa selezione dei sin goli elementi da eliminare, ma anche la disponibilità di particolari attrezzature per lo smontaggio. Si tratta, inoltre, di at tività che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il ri spetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fi ne di evitare danni alle persone o alle co se – requisiti del tutto mancanti nel caso
di specie. Tali interventi di bonifica risul tano ancor più complessi quando le con dizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di dan ni ingenti alla carrozzeria a seguito di si nistro stradale, rendono meno agevoli le operazioni di movimentazione e di smon taggio delle singole componenti. Inoltre, una volta rimossi, i liquidi e le componen ti non più utilizzabili vanno pure trattati come rifiuti e sono, pertanto, soggetti al la disciplina prevista per la loro gestio ne, cosicché attività quali, ad esempio, il deposito, il trasporto, o lo smaltimento ri chiedono specifici titoli abilitativi e do vrebbero risultare comunque tracciabili (Sezione 3, n. 11030 del 5 febbraio 2005, A, Rv. 263248‑01).
3.4. In aggiunta, l’imputato era consape vole di aver ricevuto un veicolo quale ri fiuto, avendo consentito al proprietario di prelevare la targa e i documenti per procedere alla cancellazione dal Pra e, inoltre, la stessa attività di demolizione e recupero di parti di veicoli rientra nel la nozione di gestione e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 ed è specificamente disci plinata dal Dlgs 24 giugno 2003 n. 209. Per tali motivi, il reato risulta integrato e il motivo inammissibile.
4. Anche il secondo motivo è inammissi bile.
In sintesi, la difesa sostiene erroneamen te la mancanza della coscienza e volon tà dell’imputato di riciclare l’autovettura. Ed infatti, la circostanza di aver ricevuto l’auto dal proprietario proponendogli di lasciarla in officina per estrarvi dei pezzi di ricambio, in quanto era antieconomica ripararla, integra una condotta colpevo
le di disfarsi del rifiuto, atteso che la rice zione da parte del proprietario del mezzo per “cannibalizzarlo” senza poi segui re la procedura prevista dal Dlgs 209 del 2003 per lo smaltimento dei veicoli fuori uso, integra all’evidenza l’elemento psico logico del reato contestato, punibile a ti tolo di colpa.
5. Il terzo motivo è parimenti inammis sibile.
Attraverso la disposizione di cui all’arti colo 131‑ bis Codice penale, il legislatore ha privato alcune fattispecie di reato, in dividuate sulla base di un criterio quan titativo, del loro disvalore non già in astratto, ma soltanto all’esito di una va lutazione giudiziale “personalistica”, do vendosi avere riguardo alla particolare tenuità del fatto, articolata in due “indi ci‑requisiti” che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pe ricolo, e la non abitualità del comporta mento. Il nuovo istituto non individua quindi un ulteriore elemento costituti vo del fatto, bensì un limite negativo alla sua punibilità, che non può prescindere poi da un accertamento nel merito. Così configurato, lo stesso, secondo cate gorie di consolidata elaborazione giuri sprudenziale, non costituisce oggetto di contestazione o di prova negativa da par te dell’Accusa, essendo invece onere della difesa allegare la sussistenza dei relati vi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sezione 2, n. 32989 del 10 aprile 2015, L., Rv. 264223‑01). Nel caso di specie, tale onere non risul ta soddisfatto, non avendo, la difesa, al legato alcuno specifico elemento idoneo a ritenere sussistente la particolare tenu ità del fatto.
6. Infine, non si sottrae al giudizio di inammissibilità nemmeno il quarto mo tivo.
Infatti, premesso che tale richiesta è ar ticolata in fatto, essendo diretta al Giu dice di appello, occorre osservare che i Giudici hanno dato correttamente con to dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 133 Codice penale ai fini del la determinazione del trattamento san zionatorio.
Inoltre, essendo la pena inflitta inferio re al medio edittale, è sufficiente richia mare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel caso in cui venga irroga ta una pena al di sotto della media edit tale, non risulta necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del Giudice, essendo sufficiente il richia mo al criterio di adeguatezza della pe na, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 Codice penale (Se zione 2, n. 36104 del 27 aprile 2017, M., Rv. 271243).
7. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
Dichiara inammissibile il ricorso e con danna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu ro tremila in favore della Cassa delle am mende. Così deciso il 20 marzo 2025.
Depositato in cancelleria il 7 aprile 2025
di Federica Lusito
Dottoressa in giurisprudenza a indirizzo diritto penale dell’ambiente
ABSTRACT
Con la sentenza 7 aprile 2025, n 13282, la III sezione penale della Cassazione ha confer mato la condanna per gestio ne non autorizzata di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006, ri tenendo responsabile anche il mero esecutore materia le. L’imputato aveva smalti to un veicolo, ancora integro ma non più utilizzato, depo sitandolo su suolo comunale.
La Corte ha qualificato l’au to come rifiuto speciale pe ricoloso per la presenza di li quidi e componenti inquinanti, prescindendo dalla sua appa rente integrità. Estendendo il concetto di “gestione” anche all’abbandono e ampliando i soggetti attivi del reato, la sentenza evidenzia una ten denza giurisprudenziale all’al largamento dell’ambito pena le, con implicazioni sui principi di tassatività e legalità. La sentenza arricchisce il già vasto quadro giurispruden ziale di legittimità finora de lineato e sussunto in schema (nelle sue principali pronunce) in calce al commento.
Premessa
Con la sentenza 7 aprile 2025, n. 13282, la III sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di gestione di rifiuti non autorizzata da parte del me ro esecutore materiale. L’imputato è sta to condannato all’ammenda per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lette ra a), 1 Dlgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) per aver smaltito un veico lo di proprietà di un terzo e nella dispo nibilità dell’imputato, depositandolo in un’area di proprietà comunale.
Il fatto e la vicenda processuale
In data 5 aprile 2024, il Tribunale di Ca gliari condannava l’imputato in qualità di esecutore materiale del reato di gestio ne non autorizzata di rifiuti. Da quanto si apprende dalla sentenza di legittimità, la vicenda trae origine dalla testimonianza del proprietario del veicolo oggetto di ge stione abusiva, il quale riferisce di aver portato lo stesso veicolo a riparare pres so l’autofficina in cui l’imputato lavorava al fine di ottenere un prospetto di pre ventivo per le lavorazioni necessarie. In esito al preventivo, ritenendo antiecono mica la riparazione, decise di abbando nare l’auto all’autofficina su proposta del lavoratore, il quale gli avrebbe prospetta to l’ipotesi di ricavarne i pezzi da riven dere. L’auto è stata, poi, ritrovata integra. L’imputato, in esito alla sentenza del Tri bunale di Cagliari, proponeva appello, riqualificato in ricorso per cassazione: avendo la sentenza inflitto la sola pena dell’ammenda, la difesa non era legitti mata a proporre appello in quanto trat tasi di sentenza inappellabile ai sensi dell’articolo 593, comma 3, C.p.p. 2 La Suprema Corte, dichiarando inam missibili tutti i motivi di ricorso, nella sentenza in parola, si pone in linea di continuità con quella che è una posizio ne che sembra ormai consolidata.
Tuttavia, non è difficile scorgere quan to le maglie della sanzione penale in
1. Attività di gestione di rifiuti non autoriz zata.
“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’ar ticolo 29‑quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed in termediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comu nicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiu ti non pericolosi; b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento eu
campo ambientale si siano allargate sempre di più, fino a ricomprendervi an che i casi limite tra la sanzione ammi nistrativa e la risposta punitiva penale. Infatti, nell’interpretazione giurispru denziale dei casi di illeciti amministra tivi ovvero di contravvenzioni di cui al Dlgs 152/2006, il punto di discrimen , spe cie per ciò che riguarda l’attività senza autorizzazione o inosservanza delle pre scrizioni, è il tipo di attività posta in es sere e la tipologia di rifiuto, più che la qualifica del soggetto. 3
La sentenza individua il soggetto attivo della fattispecie di cui all’articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 anche nel mero esecutore materiale, ampliando in maniera estensiva la figura dell’im prenditore richiesta dalla norma. È in fatti pacifico che la soggettività ristretta che caratterizza la fattispecie contrav venzionale in parola include anche colui che eserciti di fatto l’attività, di qualsi asi tipo. Per “soggettività ristretta” si intende quella caratteristica per cui al cune norme incriminatrici possono es sere integrate solo da taluni soggetti dotati di una particolare qualifica.
La fattispecie in parola è stata al centro di un annoso dibattito giurisprudenzia le in merito alla qualifica di reato pro prio o comune. All’orientamento per cui costituirebbe reato proprio, cioè a soggettività ristretta, si è contrappo sto – e costituisce orientamento mag gioritario – quello per cui l’articolo 256, Dlgs 152/2006 è una ipotesi di reato co mune, potendo essere posto in essere anche da chi non svolge attività impren ditoriale, purché la condotta non sia connotata da assoluta occasionalità. 4
Individuato il soggetto attivo, quindi, il tema oggetto del caso in esame riguarda l’attività di gestione ovvero di abbando no di rifiuti perpetrata dal mero lavora
ro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in mo do incontrollato i rifiuti ovvero li immetto no nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 (…)”.
2. Come sostituito dall’articolo 34, comma 1, lettera a), Dlgs 10 ottobre 2022, n. 150.
3. Si veda giurisprudenza in calce alla pre sente nota a sentenza.
4. Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2023, dep. 8 giugno 2023, n. 24676; Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 2021, n. 4770.
tore. Ciò posto, la Suprema Corte ritiene che si configuri la gestione abusiva –cioè senza alcuna autorizzazione – di ri fiuti speciali pericolosi.
Guardando alla condotta, la sentenza in commento qualifica l’attività del lavora tore in quella di “gestione non autoriz zata di rifiuti pericolosi” anche prima che sia posta in essere qualsiasi attività di “cannibalizzazione” dell’auto. Per tale motivo, la Terza Sezione sembra oscilla re tra la condotta di gestione e la con dotta di abbandono di cui al comma 2 dell’articolo 256, Dlgs 152/2006. Infatti, vengono riferite all’ambito di applica zione della gestione di cui al comma 1 anche le condotte di abbandono o depo sito incontrollato di rifiuti, pur essendo due condotte ontologicamente incompa tibili con l’attività propria di gestione e già sanzionate specificamente dal com ma 2 dell’articolo 256, qualora poste in essere dall’imprenditore, e dall’artico lo 255, Dlgs 152/2006 (Abbandono di ri fiuti), qualora perpetrate dal privato. Sintomo del fenomeno di interpretazio ne estensiva del comma 1 della contrav venzione in commento.
L’auto rinvenuta integra, munita anco ra di targa, comprensiva dei liquidi e degli elementi essenziali al suo funzio namento (combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti), ancorché a fine vita, secondo la Corte, costituisce rifiuto speciale pericoloso e perciò è og getto materiale della fattispecie puni ta penalmente ai sensi dell’articolo 256, Dlgs 152/2006.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. pen., sez. III, 20 dicembre 2011, n. 6667
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio per cui, per qualificare un veicolo “fuori uso” e, quindi, “rifiuto speciale”, è inin fluente la permanenza o meno della tar ga, rilevando la sussistenza di tutti gli elementi indicativi di una volontà di ab bandono da parte del proprietario non ché l’inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria. 5
Quanto all’accertamento giudizia le con riguardo al veicolo fuori uso, la pronuncia in esame si pone in linea di continuità con un consolidato approdo giurisprudenziale che aveva stabilito il seguente principio di diritto: in te ma di gestione di rifiuti, la natura di ri fiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamen ti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti pe ricolose. 6
A prescindere dalla qualificazione del la condotta, la sentenza, sulla nozione di “auto fuori uso”, sembra presumere, cer tamente in via relativa, la pericolosità di tale oggetto propria dell’articolo 256, Dlgs 152/2006, rispetto alla sanzione am ministrativa di cui all’articolo 29‑ quat tuordecies, Dlgs 152/2006 (Sanzioni).
Dal quadro finora delineato si desume che, oltre alla specifica attività di ge stione o abbandono ovvero sulla posi zione qualificata del soggetto attivo, la
20 febbraio 2012
Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2015, n. 11030 16 marzo 2015
5. Si veda Cass. pen., sez. III, 20 dicem bre 2011, dep. 20 febbraio 2012, n. 6667; Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2024, dep. 22 ot tobre 2024, n. 38811; Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2022, dep. 21 giugno 2022, n. 23845.
Corte di Cassazione sembra allargare le maglie della sanzione punitiva pe nale fondando tale ampliamento anche sulla pericolosità del rifiuto, forzando la lettera della norma di cui all’artico lo 256, Dlgs 152/2006. Infatti, la giuri sprudenza è ormai assestata, come si è già data evidenza, nel ritenere il veico lo, ancorché integro, quale rifiuto spe ciale pericoloso, o meno, a seconda che contenga, o non contenga, i liquidi di refrigerazione, olio motore, combusti bile, batterie al piombo. In caso positi vo il veicolo fuori uso, sebbene integro, è catalogato con il codice Cer 16 01 04*; in caso contrario è catalogato con il co dice Cer 16 01 06.
La qualificazione del rifiuto come pe ricoloso comporta evidenti conseguen ze sul piano sanzionatorio laddove la lettera a) dell’articolo 256, con riguar do ai rifiuti non pericolosi, prevede la pena alternativa dell’arresto o dell’am menda; invece, la lettera b) della norma, con riguardo ai rifiuti pericolosi, preve de la sanzione cumulativa dell’arresto e dell’ammenda.
In conclusione, lo sforzo di interpreta zione estensiva della giurisprudenza di legittimità si giustifica per i beni tutela ti dalla normativa speciale, quali la sa lute e la sicurezza pubblica, senz’altro meritevoli di efficaci presidi di tutela ambientale. D’altra parte, è bene sem pre bilanciare tale esigenza con i princi pi fondamentali della sanzione penale di determinatezza, tassatività ed extrema ratio della risposta punitiva.
Per qualificare un veicolo “fuori uso” e, quindi, “rifiuto speciale” è ininfluente la permanenza o meno della targa, rilevando tutti gli elementi indicativi di una volontà di ab bandono da parte del proprietario nonché l’inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria.
In tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericolo so di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accer tamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad al cuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o del le altre componenti pericolose.
(segue)
6. Si veda Cass. pen., sez. III, 5 febbra io 2015, dep. 16 marzo 2015, n. 11030; Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 2022, dep. 30 mar zo 2022, n. 11603; Cass. pen., sez. III, 13 feb braio 2020, dep. 16 luglio 2020, n. 21153;
Cass. pen., sez III, 23 novembre 2023, dep. 30 gennaio 2024, n. 3729.
(segue)
Sentenza
Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2020, n. 21153
Cass. pen., sez. III, 26 gennaio 2022, n. 11603
Data deposito
16 luglio 2020
30 marzo 2022
Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2022, n. 23845
Cass. pen., sez III, 23 novembre 2023, n. 3729
Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2024, n. 38811
21 giugno 2022
Massima
La natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata al la rimozione dei liquidi o delle altre componenti pericolose.
La natura di “rifiuti” è correttamente desunta dalla quanti tà, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, os sia veicoli semidistrutti e completamente inutilizzati, pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi – quali batterie, parti elettriche, pneumati ci, contenitori di oli – il tutto in stato di abbandono, senza al cuna protezione ed esposto alle intemperie.
Per quanto attiene alla individuazione della natura dei ri fiuti, rilevante anche ai fini dell’individuazione dei presidi di sicurezza da assicurare, è fuori discussione che oli esau sti e liquidi di batterie costituiscono rifiuti pericolosi.
30 gennaio 2024 Sono qualificati come rifiuti speciali pericolosi i veicoli fuo ri uso e i loro componenti.
22 ottobre 2024
Al fine di qualificare correttamente il veicolo fuori uso, ri sulta pacifico dedurre che il discrimen per assegnare agli stessi veicoli a motore in disuso la natura di rifiuti pericolo si o meno sia la presenza o l’assenza di liquidi o altre com ponenti pericolose.
Tutte le sentenze sono reperibili in www.reteambiente.it “normativa rifiuti”
A cura di Costanza Kenda e della Redazione normativa Reteambiente
Tutte le sentenze elencate in sintesi in questa pagina sono presenti per intero e massi mate nell’Area “Normativa rifiuti” in www.reteambiente.it, riservata agli abbonati.
Consiglio di Stato, sezione quarta
Sentenza 11 luglio 2025, n. 6062
Con riferimento al campo di applicazione dell’End of waste, il comma 3 dell’artico lo 184‑ter, Dlgs 152/2006 prevede espressamente la possibilità di individuare “ca so per caso”, non solo con decreti ministeriali generali, ma nell’ambito dell’Aia, e quindi da parte della Regione, i criteri in base ai quali il materiale trattato in un dato impianto perde la qualità di rifiuto; questa previsione, non essendo stata mo dificata, si deve quindi considerare vigente dal 3 novembre 2011 ad oggi.
Consiglio di Stato, sezione quarta
Sentenza 23 giugno 2025, n. 5466
Se alla scadenza del termine di validità della Via non è stato realizzato l’intero progetto di completamento della discarica, pur essendo stato avviato il conferi mento dei rifiuti, la Valutazione d’impatto ambientale va reiterata.
Corte di Cassazione, sezione sesta penale
Sentenza 23 giugno 2025, n. 23329
Viene specificato che per profitto “di grande rilevanza”, a cui conseguono sanzio ni interdittive ulteriori, si intende quando questo supera il mero dato oggettivo del denaro ottenuto e si estende a elementi soggettivi derivanti dalla attività crimino sa. Ad esempio, il maggiore “potere” acquisito sul mercato nei confronti di clienti e fornitori. O la cresciuta autorevolezza verso gli istituti bancari.
Consiglio di Stato, sezione sesta
Sentenza 14 maggio 2025, n. 4133
Le Autorità portuali non hanno l’obbligo di coinvolgere i Sindaci nell’adozione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti delle navi, che possono anche non essere coe renti con il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
Raee, adesione
sistemi collettivi
Sul tema, si veda anche D.d. 12 marzo 2025, n. 45 a pag. 34 e il commento di A. Geremei a pag. 37.
(Pubblicato sul sito del Gse il 1º luglio 2025)
la seconda finestra temporale per aderire ai sistemi collettivi
Si ricorda che da oggi 1º luglio 2025 fi no al 30 settembre 2025 sarà possibile co municare al Gse l’avvenuta adesione ai Sistemi Collettivi di gestione dei Raee fo tovoltaici da parte dei Soggetti Respon sabili degli impianti fotovoltaici in Conto energia.
La richiesta di adesione a un Sistema Collettivo deve essere trasmessa al Gse esclusivamente tramite l’applicativo Siad, utilizzando il questionario “Raee – Mo dello di adesione a un Sistema Collettivo”, disponibile nell’Area Clienti.
Se il Soggetto Responsabile invia, duran te una delle finestre temporali previste, la richiesta di adesione a un Sistema Col lettivo mentre il processo di trattenimen to delle quote a garanzia è già iniziato, il
Gse interromperà il trattenimento e resti tuirà tutte le quote trattenute fino a quel momento.
Durante la prima finestra temporale 1º aprile 2025‑30 maggio 2025 sono sta te trasmesse 1.346 istanze di adesione ai Sistemi Collettivi, per un totale di circa 840.000 moduli garantiti. I risultati com plessivi sono riportati nell’apposito cru scotto di monitoraggio.
Per promuovere la massima diffusione della disciplina dei Raee fotovoltaici, il Gse ha aggiornato la brochure informati va che illustra, in particolare, le modalità e gli adempimenti per garantire la cor retta gestione del fine vita dei moduli fo tovoltaici incentivati in Conto energia e l’adesione a uno dei Sistemi Collettivi.

Le opinioni presenti nelle risposte ai quesiti, al pari di tutte le altre presenti nella Rivista, sono espresse a titolo personale.
Esse impegnano esclusivamente gli Autori e non sono riferibili né alle istituzioni, né agli enti di appartenenza, né alla Rivista.
La Rivista RIFIUTI pubblica le risposte fornite dai suoi Esperti ai quesiti posti dai Lettori. Le risposte sono a pagamento. L’entità viene valutata caso per caso ma, ovviamente, è quasi simbolica poiché il servizio fornito riserva un dovuto trattamento di favore agli Abbonati alla Rivista (sia cartacea che on line).
La rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti.
La pubblicazione è riservata solo a quesiti ritenuti, a insindacabile giudizio dei Curatori della Rubrica, di valenza generale. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
cura di Paola Ficco
Risponde Paola Ficco
1681. Deposito temporaneo: i criteri sono due e non vanno confusi
Deposito temporaneo con tre diversi codici Eer; considerato che il deposito temporaneo deve considerarsi un unicum, qualora per uno di tali codici Eer si superi il limite dei 30 mc di rifiuto non pericoloso, e quindi scatti l’obbligo dell’allontanamento entro i tre mesi, questo vale per tutti i rifiuti/codici Eer di quel deposito temporaneo? Oppure l’obbligo scatta solo per quello che ha superato il limite?
Il deposito temporaneo prima della raccolta è disciplinato quanto alla sua definizione dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 e, quanto alle sue regole operative, dall’articolo 185‑ bis, del medesimo Dlgs 152/2006. La fonte argomentativa, dunque, risiede in tale seconda disposizione, in cui le quantità sono declinate nella interezza del deposito e non con riferimento al singolo codice Eer (la singola categoria omogenea). Il che trova conferma testuale nel comma 2 dell’indicato articolo 185‑ bis, quando alla lettera b) è stabilito che la scelta della cadenza trimestrale può essere operata “quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi”, dove il termine “complessivamente” non lascia spazio a dubbi. Pertanto, la quantità massima del totale dei rifiuti posti in deposito temporaneo è pari a 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi + 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In assenza di rifiuti pericolosi, i 30 metri cubi sono tutti dedicati ai rifiuti non pericolosi. Il criterio della “complessività” dispiega le sue ragioni anche nella locuzione immediatamente successiva, quando si legge che “In ogni caso, allorché il
quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno” Infatti, il riferimento al “predetto limite all’anno” comprende, ad ogni evidenza, la quantità calcolata complessivamente, e non per singolo codice Eer. Questa opzione, dunque, può essere esercitata dal produttore dei rifiuti entro un anno dalla loro produzione. In genere si tratta di una scelta operata dai piccoli produttori.
Tuttavia, la scelta del produttore dei rifiuti può anche essere operata in omaggio al criterio trimestrale per il quale i rifiuti possono essere posti in deposito temporaneo “indipendentemente dalle quantità in deposito” a condizione che vengano avviati a recupero/ smaltimento entro e non oltre tre mesi dalla data di produzione. Quindi, il criterio qualitativo, in questo caso, non è un problema, e si tratta di una scelta che viene operata, in genere, dai grandi produttori. Né si pone il problema dei 30 metri cubi (complessivamente inteso). In ogni caso, l’inizio del computo del tempo combinato con la quantità si misura in base ai registri di carico e scarico.
La norma indicata prevede infatti due modalità alternative tra loro di condurre il deposito temporaneo e a scelta del produttore dei rifiuti:
• la prima , il deposito non può superare i tre mesi, a prescindere dalle quantità in deposito. In questo caso il limite di 30 metri cubi non è contemplato. L’importante è che entro i tre mesi dal giorno della loro produzione vengano avviati tutti quelli prodotti entro i tre mesi da quando il deposito è iniziato a recupero/smaltimento. Quindi, l’obbligo di allontanamento scatta entro i tre mesi per tutti i rifiuti che sono stati prodotti (indicati sul registro) dal primo giorno di quei tre mesi e via via nei giorni successivi.
Esempio:
– produzione rifiuto A il 10 gennaio 2025
> avvio a R/D entro il 10 aprile 2025; – produzione rifiuto B l’11 gennaio 2025
> avvio a R/D entro l’11 aprile 2025;
– produzione rifiuto C il 12 gennaio 2025
> avvio a R/D entro il 12 aprile 2025.
• la seconda , il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge “complessivamente” i 30 metri cubi (di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi). Il produttore dei rifiuti ha tempo fino a un anno dal giorno della loro produzione per poterli avviare tutti a recupero/smaltimento.
Quindi, l’obbligo di allontanamento scatta entro un anno per tutti i rifiuti che sono stati prodotti (indicati sul registro) dal primo giorno di quell’anno e via via nei giorni successivi.
Esempio:
– produzione rifiuto A il 10 gennaio 2025
> avvio a R/D entro il 10 gennaio 2026;
– produzione rifiuto B l’11 gennaio 2025
> avvio a R/D entro l’11 gennaio 2026;
– produzione rifiuto C il 12 gennaio 2025
> avvio a R/D entro il 12 gennaio 2026.
Per rifiuti che sono prodotti
• dopo un anno o dopo i tre mesi, o
• da momenti successivi all’inizio dei tre mesi o dell’anno, inizia ovviamente un nuovo computo di tempo per i tre mesi o per l’anno.
Nel caso di cui è quesito, però, i due criteri paiono confondersi. Perché il limite di 30 metri cubi deve essere osservato entro il termine massimo di un anno dalla data di produzione; il limite dei tre mesi, invece, come indicato, non patisce limiti quantitativi.
In ogni caso, ove il Richiedente:
• abbia superato i tre mesi di giacenza ma non i 30 metri cubi (anche nella composizione 20 metri cubi + 10 metri cubi indicata), ha tempo un anno dalla data di loro produzione (annotazione sul registro di carico e scarico) per avviarli a recupero/smaltimento. In questo caso, la giacenza riguarda tutti i rifiuti “complessivamente” presenti in deposito temporaneo e non riguarda il singolo codice Eer;
• abbia superato i 30 metri cubi di rifiuti non pericolosi (anche nella composizione di 20 metri cubi + 10 metri cubi indicata) ma non i tre mesi, ha tempo tre mesi dalla data di loro produzione (annotazione sul registro di carico e scarico) per avviarli a recupero/ smaltimento (“indipendentemente dalle quantità in deposito” ).
Per considerazioni relative alla patologia del deposito temporaneo si veda P. Fimiani in questa Rivista a pag. 14
1682. Recupero metalli, sì alla sorveglianza radiometrica se prevista in autorizzazione
Siamo un’azienda con Autorizzazione unica ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 che effettua raccolta, trattamento e bonifica di contenitori industriali in ferro e termoplastici con codici Eer 15.01.02, 15.01.04, 15.01.06, 15.01.10. In fase di rinnovo autorizzativo è stata inserita una prescrizione di attuazione di procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal Dlgs 101/2020. Trattandosi di rifiuti da imballaggio, dobbiamo ottemperare a questa prescrizione per il materiale in entrata?
Le Linee guida Snpa 51/2024 affermano che la sorveglianza radiometrica va osservata se nel titolo autorizzativo sono presenti prescrizioni dettate al riguardo. La sorveglianza radiometrica è l’insieme delle azioni che un’azienda è obbligata a svolgere per individuare sorgenti o materiali radiocontaminati che possono finire impropriamente tra i materiali trattati, e la gestione dei materiali contaminati che si sono eventualmente trovati.
L’articolo 72, Dlgs 101/2020, come riscritto dal Dl 17/2022, convertito dalla legge 34/2022, obbliga alla sorveglianza radiometrica i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta. Sono obbligati anche i soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo, e viene disposta su specifica richiesta delle Autorità competenti. L’obbligo non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
Il Dl 17/2022 cit. ha anche sostituito integralmente l’Allegato XIX al Dlgs 101/2020 ora intitolato “Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica”. L’articolo 1, comma 1, lettera h) di tale novellato Allegato XIX, Dlgs 101/2020 definisce i “materiali metallici di risulta” come i “rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o
di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell’ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche”
Secondo quanto affermato nelle Linee guida Snpa 51/2024, per una serie di soggetti non sussiste “in senso stretto, l’obbligo della sorveglianza radiometrica”, e precisamente:
• soggetti che esercitano attività di manutenzione macchine, mezzi ed attrezzature e che nel corso di tali attività producono rifiuti metallici (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);
• chi esegue esclusivamente demolizione di automobili;
• chi esercita solo attività di cernita, separazione, selezione su rifiuti di varia natura – ad esempio chi seleziona plastica da raccolta differenziata (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);
• chi gestisce impianti di compostaggio (anche se effettuano cernita del materiale in ingresso);
• soggetti che gestiscono impianti di spazzamento terre o di riciclo plastica che separano il materiale metallico dal rifiuto in ingresso;
• chi esercita attività di raccolta di Raee senza trattamento;
• chi recupera e tratta parti di Raee.
Le Linee guida Snpa 51/2024, a pag. 11, affermano che sono soggette alla sorveglianza radiometrica le “aziende in Aia (…), in Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (ex articolo 208) ed impianti autorizzati in procedura semplificata (ex articoli 214 e 216) che trattano rifiuti, e nei cui atti autorizzativi è prescritta la sorveglianza radiometrica nel rispetto, ad esempio, di quanto previsto dalle Bat (vedi inceneritori, termovalorizzatori in Aia)” Pertanto, in ordine all’autorizzazione ex articolo 208, tali Linee guida affermano che la sorveglianza radiometrica va osservata se nel titolo autorizzativo sono presenti prescrizioni dettate al riguardo, come riferito nel caso di cui è quesito.
1683. Registro carico e scarico, il computo dei termini non segue il criterio “ex numero”
Con l’entrata in vigore del RENTRI i registri sono digitali. Come associazione teniamo i registri per conto delle imprese associate con delega ai sensi dell’ar-
ticolo 190, comma 7, Dlgs 152/2006. Lo facciamo con specifico software interoperabile con il RENTRI e il file XML del registro che ne garantisce l’immodificabilità (file che viene inviato in conservazione e al RENTRI), traccia, data, ora e nome del soggetto delegato che esegue le registrazioni.
Le annotazioni con cadenza mensile come vanno eseguite? Alla fine di ogni mese, es. 31 luglio 2025 tutti i carichi di quel mese?
I primi giorni del mese successivo a quello di comunicazione da parte dell’impresa dei dati: es. scheda con le produzioni di luglio trasmessa dall’azienda entro il 31 luglio, può essere registrata entro i primi giorni del mese di agosto con produzione al 31 luglio? O alla data di registrazione, cioè ad esempio il 5 agosto?
In sintesi: cosa si intende per cadenza mensile?
Ai sensi dell’articolo 190, comma 7, Dlgs 152/2006, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con
cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.
Il sistema della computazione civile non è “ex numero”, bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Infatti, in ordine alla “cadenza mensile”, l’articolo 155, comma 2, C.p.c. (cui si riferisce anche l’articolo 2963, C.c., in tema di prescrizione) stabilisce che “per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune”. Pertanto, non si contano i singoli giorni che compongono il mese, ma solo il mese o l’anno di per sé considerati. Ad esempio, se il termine è di un anno, scade lo stesso giorno dell’anno successivo (2 febbraio 2025‑2 febbraio 2026).
Nel caso del termine a mesi, vige lo stesso principio, per cui non si conta il numero di giorni che compongono il mese (30 o 31) né che febbraio ha 28 giorni. Ad
esempio, se un termine inizia il 10 febbraio, la scadenza sarà il 10 marzo. Se invece il termine inizia il 31 gennaio, la scadenza sarà il 28 (o il 29) febbraio. Inoltre, l’articolo 155, comma 3 stabilisce che, se il termine scade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Quindi, le annotazioni con cadenza mensile vanno eseguite alla fine di ogni mese relativamente alla data iniziale, che è quella di produzione del rifiuto da parte dell’impresa; pertanto, si ha che:
• il 30 luglio è termine finale per l’associazione per annotare i rifiuti prodotti dall’associato il 30 giugno;
• il 30 agosto è termine finale per l’associazione per annotare i rifiuti prodotti dall’associato il 30 luglio;
• il 31 agosto è termine finale per l’associazione per annotare i rifiuti prodotti dall’associato il 31 luglio;
• il 30 settembre è termine finale per l’associazione per annotare i rifiuti prodotti dall’associato il 31 agosto; ecc.
Pertanto, quando si registrano i rifiuti del 30 luglio entro il 30 agosto, come indicato nell’esempio, poiché si usa un software e il registro è digitale, le registrazioni vanno fatte il 30 agosto con data 30 luglio.
Errata corrige:
Nella risposta al quesito n. 1657, in questa Rivista n. 338 (5/2025), la frase “Come si evince dalla lettura del riportato articolo 193, comma 15, Dlgs 152/2006, questo distingue le due fattispecie operative di tra sbordo e di sosta tecnica” è sostituita dalle seguente:
“Come si evince dalla lettura del riportato articolo 193, comma 15, Dlgs 152/2006, questo distingue le due fat tispecie operative di stazionamento in configurazio ne di trasporto e di sosta tecnica per il trasbordo” Ci scusiamo con i Lettori.

L’interpello ambientale è uno strumento introdotto dall’arti colo 27 del Dl 77/2021, che ag giunge l’articolo 3‑septies al Dlgs 152/2006. Si tratta di una consulenza giuridica sulle nor mative ambientali statali, non classificabile come interpello ordinario o probatorio.
Possono presentare istanze Regioni, Province, Città metro politane, Comuni, Associazio ni di categoria rappresentate nel Cnel, Associazioni di pro tezione ambientale a caratte re nazionale e quelle presen ti in almeno cinque Regioni. Le risposte vengono pubblicate online entro 90 giorni dalla ri chiesta e forniscono criteri in terpretativi per le amministra zioni pubbliche in materia am bientale.
Le indicazioni fornite non so stituiscono gli atti di consenso previsti dalla normativa vigen te e non influiscono sulle sca denze o sui termini di prescri zione delle norme ambientali.
Per comprendere il valore, l’ef ficacia e la spendibilità di una risposta ad interpello, si rinvia all’intervento di P. Fimiani L’in terpello ambientale, pubbli cato sul numero 303 (3/22) di questa Rivista.
Tutta la normativa è reperibile in “Normativa rifiuti” www.reteambiente.it e visibile agli abbonati al servizio.
A cura di Elisabetta Torzuoli
Avvocato in Siena – Elenco speciale
Richiedente: Città di Roma Metropolitana – Prot. 0058077 del 27 marzo 2025
Nota MASE: 0138506 del 22 luglio 2025
Domanda (sintesi)
1) Se, sulla base delle disposizioni di cui al Dm 127/2024, non sia più possibile effettuare direttamente il recupero ambientale (R10) del rifiuto individuato dal codice Eer 170504, ma se lo stesso debba necessariamente essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al predetto decreto; 2) se, sulla base del Dm 5 febbraio 1998, che non prevede l’operazione R5 per la tipologia 7.31-bis ai fini dell’utilizzo in recuperi ambientali, il rifiuto con codice Eer 170504 possa essere autorizzato all’operazione R5 in procedura semplificata ex articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006 solamente per l’industria della ceramica e dei laterizi e per la formazione di rilevamenti e sottofondi stradali. Conseguentemente, se per l’utilizzo nei recuperi ambientali e per gli altri utilizzi previsti dal Dm 127/2024, invece, la produzione di aggregato recuperato dal rifiuto con codice Eer 170504 debba essere autorizzata in procedura ordinaria ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006.
Il Ministero, ripercorso il quadro normativo, acquisito il parere Ispra il 9 giu gno 2025, afferma che, per la produzione di aggregato da impiegare in interven ti di recupero ambientale, il relativo impianto deve essere autorizzato, ai sensi del Dm 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208, Dlgs 152/2006, mentre il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31 bis, Dm 5 febbraio 1998, segue la procedura sempli ficata di cui agli articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006.
In particolare, con riguardo al primo quesito, il Ministero rinvia all’Allegato 1, sub allegato 1, tipologia 7.31 bis, Dm 5 febbraio 1998 in materia di procedure sem plificate per i rifiuti non pericolosi, che prevede diverse attività di recupero dei ri fiuti classificati con il codice Eer 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’a gricoltura o dell’ecologia, subordinando lo stesso all’esecuzione del test di cessio ne sul rifiuto secondo il metodo di cui all’Allegato 3, oltreché a quanto stabilito dall’articolo 5 sulle condizioni dei rifiuti da sottoporre a recupero ambientale, per accedere alle procedure semplificate; il recupero di cui al Dm 127/2024 presuppo ne, invece, la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Pertanto, il Ministero non ritiene ammissibile quanto sostenuto nell’istanza (ossia che il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato Eer 170504, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessa zione della qualifica di rifiuto, ai sensi del Dm 127/2024), poiché non coerente al quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del pro dotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of waste. Tan to vale anche per evadere il secondo dei quesiti posti.
Nota di commento
Il Ministero evade l’interpello e ribadisce, in maniera netta, la differente ratio che governa le regolamentazioni evocate, complementari tra loro.
Col Dm 127/2024 la materia cessa la qualità di rifiuto e, così trasformata, divie ne un prodotto impiegabile in riempimenti e colmate. Col Dm 5 febbraio 1998, in vece, il materiale continua ad essere rifiuto sino alla destinazione; la cava è perciò autorizzata all’impiego di rifiuti. La differenza è sostanziale.
Normativa e prassi di riferimento
• Articolo 184 ter, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
• Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine mine rale, ai sensi dell’articolo 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
• Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
Richiedente: Amici della Terra Onlus – Prot. 0041292 del 5 marzo 2025
Nota MASE: 0121740 del 26 giugno 2025
Domanda (sintesi)
Chiarimenti interpretativi in merito alla normativa applicabile al digestato prodotto presso alcuni impianti che introducono nel digestore, insieme ai materiali previsti dal Dm 5046/2016, anche altre sostanze, segnatamente biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti (End of waste) ai sensi dell’articolo 184 -ter, Dlgs 152/2006. In particolare: se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come End of waste per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’articolo 208, Dlgs 152/2006 e conforme alla norma Uni 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal Dm 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’articolo 184 -bis del medesimo decreto.
Il Ministero, ripercorsa la normativa di settore (articolo 184‑ bis, Dlgs 152/2006 e Dm 5046/2016), acquisiti i pareri di Ispra (nota prot. 20 maggio 205, n. 95657) e del Ministero dell’agricoltura e della sicurezza alimentare e delle foreste (nota prot. 24 giugno 2025, n. 119470), riporta il disposto di cui all’articolo 24, lettera a), Dm cit, secondo cui “il digestato è originato da impianti di digestio ne anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusiva mente con materiali e sostanze di cui all’articolo 22, comma 1”, tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizza to al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari”, descrit ta nell’istanza. Per l’effetto, il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’interpello, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV, Dm 5046/2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.
Nota di commento
La risposta al quesito è mutuata dall’esame letterale del Dm 5046/2016 che, in ot temperanza all’articolo 184‑ bis, Dlgs 152/2006, prevede le misure per stabilire cri teri quali‑quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o prodotti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, sulla base delle condizio ni pre‑individuate dalla richiamata disposizione del Dlgs 152/2006. L’articolo 22, Dm cit, dettaglia le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da im pianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica possa con siderarsi sottoprodotto. In particolare, vengono elencati tutti i tipi di materiali e tutte le tipologie di sostanze utilizzabili, da soli o in miscela tra di loro, per la pro duzione del digestato.
Normativa e prassi di riferimento
• Articolo 184‑ bis, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152;
• Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concer to con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Mi nistro della salute 25 febbraio 2016, n. 5046.
* Tutta la normativa e la giurisprudenza indicate sono reperibili in “Normativa Rifiuti” Osservatorio di normativa ambientale www.reteambiente.it
* Si veda anche la sezione “Interpelli” in https://www.rivistarifiuti.it/

La Rubrica si propone di aggior nare mensilmente il Lettore sul le novità regionali più rilevan ti in materia di rifiuti. I singoli provvedimenti sono pubblica ti in Reteambiente – Osserva torio di normativa ambienta le (www.reteambiente.it Area “Normativa sui rifiuti”) e visibili agli abbonati al servizio.
A cura di Francesco Petrucci e della Redazione normativa Reteambiente
Abruzzo
Lr 29 maggio 2025, n. 17 (Bur 4 giugno 2025 n. 22)
Modifiche alla Lr 45/2007 recante norme per la gestione integrata dei rifiuti. Di sposizioni in materia di Piano regionale di gestione dei rifiuti.
Calabria
Ordinanza Presidente Giunta regionale 10 giugno 2025, n. 1 (Bur 10 giugno 2025 n. 112)
Misure di prevenzione per la sicurezza dei lavoratori del settore dell’igiene am bientale che operano all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole –Modificata dalla ordinanza del Presidente della Regione 13 giugno 2025, n. 2.
Dgr 16 giugno 2025, n. 371 (Bur 30 giugno 2025 n. 44)
Riconoscimento dei ristori in relazione al rifiuto conferito presso il Termovaloriz zatore di Acerra ex articolo 38 della Lr 26 maggio 2016, n. 14.
Decreto dirigenziale 9 giugno 2025, n. 4 (Bur 16 giugno 2025 n. 40)
Piano delle ispezioni negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Seveso III) di soglia inferiore.
Determinazione dirigenziale 11 giugno 2025, n. 11093
(Bur 2 luglio 2025 n. 174)
Sottoprodotti denominati “Sabbie di lavorazione dei pomodori” e “Sassi di lavora zione dei pomodori” – Approvazione scheda tecnica.
Decreto dirigenziale 11 giugno 2025, n. 666 (Gurs 4 luglio 2025 n. 30)
Approvazione del Piano regionale integrato dei controlli Reach‑Clp e Biocidi an no 2025.
Lr 6 giugno 2025, n. 28 (Bur 9 giugno 2025 n. 35)
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2025 – Modifiche alle disposi zioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Lr 10/2010 per al linearle alle ultime novità della disciplina nazionale.

ABSTRACT
La legge 68/2015, nel rafforzare la tutela penale dell’ambiente, ha introdotto un procedimen to che consente di estingue re alcune fattispecie di reati ambientali di natura contrav venzionale, tramite l’adempi mento alle prescrizioni impar tite dall’organo accertato re, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa. La contestazione di una violazio ne amministrativa prevista dal Dlgs 152/2006 deve avere luo go ai sensi dell’articolo 14 del la legge 689/1981, ove è possibi le, in via immediata, e ammet te al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della san zione prevista per la violazione commessa o, se più favorevo le e qualora sia stabilito il mini mo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. A differenza di quanto acca de nella procedura di estinzio ne delle contravvenzioni, nella contestazione delle violazioni amministrative si viene imme diatamente ammessi a paga re un importo liberatorio senza preliminarmente verificare che gli effetti della violazione siano cessati, ovvero che il trasgres sore intenda porvi rimedio ed in quali modi.
Estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative Procedure a confronto
A cura di Italia Pepe
Direttore Generale Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
Contravvenzioni e sanzioni amministrative, principi comuni La legge 68/2015, nel rafforzare la tute la penale dell’ambiente, prevedendo al cune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, ha introdotto una nuova procedura di estinzione di alcuni reati ambientali – di minore gravità – in serendo, all’interno del Dlgs 152/2006, la Parte VI‑ bis: è stato quindi introdotto un procedimento che consente di estingue re alcune fattispecie di reati ambienta li di natura contravvenzionale, tramite l’adempimento alle prescrizioni imparti te dall’organo accertatore, oltre al paga mento di una sanzione amministrativa.
In sostanza, è venuta a generarsi la pos sibilità di una sorta di “depenalizzazio ne” in cui ha acquisito rilievo in modo del tutto determinante l’intervento del trasgressore tale da rimuovere gli effet ti delle contravvenzioni attraverso l’a dempimento alle prescrizioni impartite, conseguentemente al quale dovrà prov vedere al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda.
Sin da subito questa riforma ha mostra to principi comuni all’estinzione delle violazioni amministrative, anch’esse di sciplinate dal Dlgs 152/2006 a fronte del mancato rispetto di norme ambientali ed il cui procedimento osserva i dispo sti di cui alla legge 689/1981; anche per queste, infatti, e come meglio oltre ar ticolato, può assumere rilievo l’opera prestata dal trasgressore per l’elimina zione delle cause di violazione, oltreché il pagamento della somma ingiunta che estingue ogni pendenza in capo al tra sgressore.
Occorre poi dare evidenza al fatto che benché le prescrizioni incidano sui pro cedimenti penali in termini di estin zione, ciò non significa che queste sostituiscano i provvedimenti ammini strativi quali ad esempio le ordinanze sindacali o le diffide assunte dalle Au
torità competenti, poiché differenti so no gli effetti giuridici; questi ultimi, infatti, producono effetti sul piano am ministrativo e sono propedeutici all’e manazione di ulteriori atti, come ad esempio la sospensione o la revoca di un’autorizzazione.
Allo stesso modo la contestazione di una violazione amministrativa, ai sensi del la legge 689/1981, impone alle Autorità competenti comunque l’assunzione dei relativi provvedimenti amministrati vi, come sopraccitati, in virtù del fatto che l’ingiunzione della sanzione ammi nistrativa ha la finalità preliminare di punire il trasgressore per l’illecito ac certato, oltreché evitare che questi reiteri, attraverso una corretta quanti ficazione della somma ingiunta tale da costituire idoneo deterrente, mentre i corrispondenti provvedimenti ammini strativi, da assumersi contestualmente al verbale di accertamento di trasgres sione, quali ad esempio diffida, so spensione o revoca dell’autorizzazione, hanno lo scopo di “accompagnare” il trasgressore nel porre rimedio al fatto illecito rilevato indicando le azioni da assumere nei termini adeguati cono sciute le cause dei comportamenti, con l’evidente circostanza di rappresentare un momento di ulteriore interlocuzione e confronto con l’Autorità competente.
La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale Il presupposto per l’applicazione della procedura di estinzione dei reati, ai sen si dell’articolo 318‑ bis , primo comma, Dlgs 152/2006, è che non abbiano cagio nato danno o pericolo di danno concreto ed attuale alle risorse ambientali urba nistiche e paesaggistiche protette, cosic ché lo scopo della procedura è quello di risolvere situazioni che hanno caratteri stiche di pericolo intrinseche e non legate alla probabilità concreta che effetti nega tivi si producano; ne discende che la posi
zione che è prevalsa da parte delle varie Procure italiane è quella di applicare la procedura alle contravvenzioni i cui ef fetti possono essere rimossi, adempiendo appunto alle prescrizioni, di talché il pre giudizio ambientale può essere rimediato attivando delle misure che producano ta le effetto e che rientrano comunque nella facoltà del contravventore.
Da tutto ciò consegue che, qualora la condotta generi danni o pericoli di dan ni concreti ed attuali irreversibili, o dif ficilmente eliminabili, non vi possono essere prescrizioni che consentano il ri pristino, mentre, qualora la condotta positiva ripristini, in tempi ragionevo li, lo stato antecedente, allora impartire le prescrizioni acquisisce un significato.
Valutare la possibile rimozione degli effetti negativi che si siano prodotti in conseguenza del reato commesso signi fica anzitutto verificare che si possa procedere facilmente ed in breve ter mine e garantire il ripristino dello sta to dei luoghi; deve pertanto trattarsi di effetti completamente reversibili, con l’evidente esclusione dall’applicazione della procedura estintiva di tutte quelle situazioni che possano evolvere con pro babilità ed in poco tempo in ipotesi di danno alle matrici ambientali.
L’articolo 300 del Dlgs 152/2006 definisce il danno come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile diretto o indi retto di una risorsa naturale o dell’utilità che questa assicura, con la conseguen za che vi saranno reati che produrran no effetti sull’ambiente e che si potranno eliminare con la procedura estintiva ed altri invece che produrranno un danno, ed in quanto tali non potranno giovare di alcuna procedura se non affrontare le sorti del giudizio penale.
Fra l’altro è giusto il caso di segnalare che la procedura estintiva non è con dizione di procedibilità dell’azione pe nale; a ben vedere, infatti, gli organi di polizia giudiziaria che accertano i rea ti hanno la piena discrezionalità per va lutare – in modo concreto e attuale – la sussistenza del danno o del pericolo di danno e pur tuttavia, dalle esperienze accumulate sin dall’entrata in vigore della legge 68/2015, si è definitivamen te sancito che il contravventore che non abbia beneficiato, per cause a lui non imputabili, della procedura estintiva può chiedere all’organo di vigilanza/po
lizia giudiziaria, nella fase delle indagi ni penali, di esservi ammesso, potendo peraltro avanzarne istanza in sede giu diziaria purché prima dell’apertura del dibattimento.
In ogni momento, infatti, il giudice ha il potere di sindacare sulla correttezza dell’operato dell’organo di vigilanza ve rificando la sussistenza dei presupposti delle condizioni che consentano al con travventore di beneficiare del meccani smo estintivo del reato.
Procedura di estinzione delle contravvenzioni: il verbale di prescrizioni
L’organo che si appresta all’accertamen to di un reato dovrà, di volta in volta, nella notizia dello stesso, dare adegua ta motivazione in virtù della quale non si ritenga applicabile la procedura di estinzione delle contravvenzioni, poi ché, contrariamente, l’applicazione po trebbe emergere dai fatti rilevando una negligenza dello stesso organo.
La valutazione dell’applicabilità del la procedura in questione che compete all’organo accertatore deve concerne re esclusivamente l’ambiente, e dunque l’assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambien tali; qualora, infatti, l’organo accertato re dovesse rilevare che il trasgressore reitera la medesima contravvenzione, ciò non può tuttavia escludere a priori l’applicazione della procedura di estin zione, rimanendo però inteso che, trat tandosi di aspetto che denota l’indole del contravventore (che compete all’Au torità giudiziaria!) e non l’ambiente, oc correrà rivolgersi al pubblico ministero per ricevere eventuali differenti indica zioni a procedere, al fine di mostrare as soluta rigorosità nella valutazione della sommatoria degli eventi.
All’organo di vigilanza spetta l’assun zione del verbale di prescrizioni, che in quanto tale deve intendersi quale atto tipico di polizia giudiziaria e pertanto non può essere impugnato né avanti al Tar, né con ricorso straordinario al Pre sidente della Repubblica, poiché infatti non è imputabile ad un organo ammi nistrativo.
Una volta elaborata la prescrizione – e ancora prima di essere impartita – que sta deve essere asseverata tecnicamente
dall’ente specializzato competente per materia, e anche tale processo non ne muta comunque la sua natura. L’asseve razione, come oltre meglio argomenta to, ha infatti la funzione di validazione tecnico‑amministrativa del contenuto delle prescrizioni senza modificarne la natura penale, e ciò poiché il presuppo sto dell’atto con cui vengono impartite le prescrizioni è appunto l’accertamento di un reato, e pertanto il verbale stesso non può che intendersi quale fase di un pro cedimento penale.
Per meglio elaborare il contenuto di una prescrizione occorre averne a mente la relativa finalità:
a) eliminare la contravvenzione; b) estinguere il reato; c) eliminare gli effetti del reato.
Si riportano, nel seguito, a titolo esem plificativo, i disposti dell’articolo 256, nonché la formulazione di una ipotetica prescrizione da attribuire al fine di av viare la procedura di estinzione.
Ai sensi dell’articolo 256 (Attività di ge stione di rifiuti non autorizzata), com ma 5, “Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, 1 effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, let tera b)” (arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi).
In tali casi l’organo accertatore può im porre – per mezzo del verbale di prescri zioni – di interrompere immediatamente la miscelazione dei rifiuti, attribuendo un termine fra 3 e 5 giorni, ovvero di ge stire i rifiuti miscelati affidandoli a trat tamento da parte di soggetto autorizzato in relazione alle caratteristiche della mi scela ottenuta, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 187, comma 3; 2 in tal caso, il termine entro il quale prov vedere potrebbe essere ricompreso tra 30 e 60 giorni.
Alcune contravvenzioni punisco no invece l’esercizio di un’attività in mancanza di un’autorizzazione a pre scindere dal verificarsi di un danno o pericolo di danno concreto ed attuale. Si pensi ad esempio ai disposti di cui all’articolo 137 comma 1: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29‑quat tuordecies, comma 1, chiunque apra o co munque effettui nuovi scarichi di acque
1. Articolo, 187 comma 1: “È vietato misce lare rifiuti pericolosi aventi differenti ca ratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La misce
lazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”
2. Articolo 187, comma 3: “Fatta salva l’appli cazione delle sanzioni specifiche ed in partico
lare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è te nuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4”
reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantene re detti scarichi dopo che l’autorizzazio ne sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro”.
Si tratta quindi di esempi di contrav venzioni di pericolo astratto o di ti po formale, ovvero tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per l’ambiente. In questi casi, per orien tamento prevalente, sono ammissibili prescrizioni volte alla richiesta ed ot tenimento di titoli abilitativi assegnan do un termine congruo ed in linea con i relativi procedimenti amministrativi oltre che, nelle more della notifica del ti tolo abilitativo, all’assunzione di misu re idonee a garantire un livello di tutela ambientale che porti, ove necessario, anche all’interruzione dell’attività. È be ne segnalare come la procedura estinti va possa applicarsi anche alle ipotesi in cui, nel tempo che intercorre tra l’accer tamento del reato e la segnalazione in Procura, il trasgressore si sia già dota to dell’autorizzazione; in tal caso, infat ti, questi verrà ammesso direttamente al pagamento, senza l’attribuzione di al cuna prescrizione, pur non escludendo la verifica da parte dell’organo accerta tore circa il danno o pericolo di danno, poiché laddove esistenti, ovviamente, e come già più volte precisato, non si po trà essere ammessi alla procedura pur a fronte di un titolo abilitativo al cui man cato possesso sia stato posto rimedio.
Procedura di estinzione delle contravvenzioni: l’asseverazione Come già anticipato l’asseverazione, ri lasciata dagli enti preposti alla tute la ambientale, è un’attività tecnica che non richiede attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria e serve a validare ap punto tecnicamente ed amministrativa mente le prescrizioni.
L’asseverazione impone la verifica del la pertinenza ed efficacia delle prescri zioni, la coerenza con le finalità delle prescrizioni medesime (che sono appun to quelle di rimuovere il reato e far ces sare situazioni di pericolo), di verificare la congruità dei tempi assegnati per l’ot temperamento della prescrizione e che siano stati dettati criteri precisi che ga rantiscano l’osservanza di quanto pre scritto, che non potrà che corrispondere alle norme tecniche di settore. Ne di scende che sia oltremodo consigliabile, seppur non obbligatorio, un coordina
mento tra l’organo di vigilanza e l’ente asseveratore – anche in fase di indivi duazione delle prescrizioni – poiché il ruolo di quest’ultimo impone la conva lida, piuttosto che la modifica, della pre scrizione quanto alla congruità, ovvero al termine.
Per quanto poi l’asseverazione appaia una fase fondamentale della procedu ra di estinzione, tuttavia, non sempre questa è obbligatoria. Si pensi ad esem pio ai casi in cui siano state impartite prescrizioni formali (come quella circa l’istanza e l’ottenimento di un titolo abi litativo) che non comportano valutazio ni tecniche, o a prescrizioni “standard”, ovvero quando ad avere impartito la prescrizione è proprio l’organo tecnico specializzato.
Procedura di estinzione delle contravvenzioni: verifica delle prescrizioni ed ammissione al pagamento Una volta che l’organo di vigilanza ha verificato l’avvenuto ottemperamen to nei termini assegnati e secondo le condizioni stabilite, si potrà essere ammessi al pagamento ai sensi dell’arti colo 318‑ quater, comma 2, Dlgs 152/2006: “Quando risulta l’ottemperamento del la prescrizione, l’organo accertatore am mette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad un quarto del mas simo dell’ammenda stabilita per la con travvenzione commessa”
Il pagamento nei termini previsti è con dizione essenziale ai fini della con clusione positiva della procedura di estinzione dei reati. Sia che avvenga sia che non abbia seguito, la polizia giudi ziaria è tenuta comunque a riferire alla relativa procura: “entro 120 giorni dal la scadenza del termine fissato nella pre scrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento del la prescrizione nonché l’eventuale paga mento della predetta somma”
Procedimento amministrativo sanzionatorio: le fasi
La contestazione di una violazione am ministrativa prevista dal Dlgs 152/2006 deve avere luogo ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/1981, ove è possibile, in via immediata sia nei confronti del tra sgressore che della persona obbligata in solido al pagamento della somma dovu ta per la violazione stessa; ove impos sibile, il verbale di trasgressione andrà
notificato agli interessati entro il termi ne di 90 giorni dall’accertamento.
La contestazione della violazione, eccet to che per determinate fattispecie pun tualmente disciplinate, come quella degli scarichi, 3 ammette al pagamento di una somma in misura ridotta pari al la terza parte del massimo della sanzio ne prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabi lito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, ol tre alle spese del procedimento. Il paga mento deve avere luogo nel termine di 60 giorni dalla contestazione immedia ta o, se questa non vi è stata, dalla noti ficazione degli estremi della violazione.
Il trasgressore può decidere di non av valersi del pagamento liberatorio ed in tal caso, nel termine di 30 giorni dalla contestazione della violazione, potrà tra smettere all’Autorità competente scritti e documenti e chiedere di essere sentito; quest’ultima, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, esaminati i documenti inviati e gli argomenti espo sti negli scritti difensivi, se ritiene fon dato l’accertamento, assume ordinanza con cui ingiunge la somma dovuta per la violazione all’autore della stessa e alle persone che vi sono obbligate so lidalmente. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica zione di quest’ultimo provvedimento.
La somma ingiunta, a differenza di quanto stabilito per la procedura di estinzione delle contravvenzioni, non è già determinata dalla legge ma viene definita dall’Autorità competente, in via discrezionale, pur sulla base di precisi criteri indicati all’articolo 11 della leg ge 689/1981:
a) gravità della violazione: risulta per l’intenzionalità dimostrata dall’autore per il danno cagionato e per le speciali circostanze in cui il comportamento si è attuato, di modo che non venga commi nata una sanzione identica per compor tamenti che hanno un’obiettiva rilevanza negativa diversa;
b) opera svolta dall’agente per l’elimina zione o attenuazione delle conseguenze della violazione: tale criterio non richie de l’effettiva eliminazione o attenuazio ne delle conseguenze della violazione, ma assume di contro rilievo l’attività di rav vedimento compiuta dal trasgressore per sonalmente o per suo incarico da terzi; c) personalità del trasgressore: i prece denti soggettivi possono continuare ad
essere considerati motivo di diversifica zione della sanzione, e fra questi il com portamento anteriore, contemporaneo o successivo del trasgressore, nonché le sue qualità sociali e morali, il grado di istruzione e di capacità intellettiva; d) condizioni economiche del trasgres sore: queste non potranno costituire motivo di discriminazione, e pertanto l’importo della sanzione può essere au mentato se, in dipendenza delle abbienti condizioni del destinatario, essa non as sumesse alcun valore afflittivo.
I criteri utili alla definizione della som ma da ingiungere, come sopra indicati, fanno emergere un importante elemen to di distinzione fra le due procedure: l’e stinzione delle contravvenzioni impone l’ottemperamento delle prescrizioni im partite dall’organo di vigilanza, che han no, come ampiamente argomentato, la finalità di eliminare gli effetti del reato, e pertanto il trasgressore deve render si parte attiva e rimediare al pregiudi zio ambientale attraverso l’assunzione di provvedimenti tecnici; di contro, nel procedimento amministrativo sanzio natorio, per la definizione della somma da ingiungere con ordinanza di ingiun zione rileva esclusivamente la volontà di ravvedimento ovvero, deve essere mani festo che il trasgressore abbia inteso atti varsi al fine di riparare alle conseguenze della propria azione o omissione.
Violazioni amministrative pecuniarie ed estinzione delle contravvenzioni: procedure a confronto A differenza di quanto accade nel la procedura di estinzione delle con travvenzioni, nella contestazione delle violazioni amministrative in materia ambientale, come disciplinate dalla leg ge 689/1981, si viene immediatamente ammessi a pagare un importo liberato rio senza preliminarmente verificare
che gli effetti della violazione siano ces sati, ovvero che il trasgressore intenda porvi rimedio ed in quali modi.
L’oblazione, qualora pagata nei termi ni imposti, consente la definizione im mediata di ogni pendenza nei confronti dell’Autorità competente, senza addirit tura che in futuro se ne possa tenere conto in occasione della valutazione di una possibile recidività. Il procedimen to sanzionatorio viene definito allo stato dei fatti senza che si sviluppi al riguar do un’apposita istruttoria che porti ad una valutazione della gravità del fat to illecito, dell’opera prestata dal tra sgressore per l’eliminazione delle cause di violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, tutti criteri questi cui in vece dovrà ricorrersi, come anticipato, nel caso di quantificazione della som ma da ingiungere nell’ipotesi di manca to pagamento, appunto, dell’oblazione. Il pagamento in misura ridotta previe ne pertanto l’accertamento della viola zione che opererebbe con l’ordinanza di ingiunzione e si traduce in una concilia zione fra le parti, avendo una funzione transattiva tale da estinguere il potere sanzionatorio dell’ufficio.
In entrambi i casi, tuttavia, sia nella procedura di estinzione delle contrav venzioni, che nella definizione dei pro cedimenti amministrativi sanzionatori, il pagamento della somma comminata – aldilà delle fasi differenti in cui de ve avere luogo a seconda della proce dura in essere – costituisce condizione essenziale per l’archiviazione degli ille citi accertati: nella procedura di estin zione delle contravvenzioni, qualora non abbia luogo il pagamento se ne do vrà riferire al Pm e si darà luogo al procedimento penale che sino a quel momento non aveva avuto corso; nella definizione dei procedimenti per viola
zioni amministrative, invece, il mancato pagamento vedrà un rincaro della som ma ingiunta, che verrà coattivamen te recuperata e comporterà l’aumento di un decimo per ogni semestre a parti re dal momento in cui la somma è dive nuta esigibile per mezzo della notifica dell’ordinanza di ingiunzione.
In entrambe le procedure, nell’ipotesi di concorso di persone, il pagamento del la sanzione pecuniaria, rappresentando aspetto di carattere realmente punitivo, ricade su tutti i concorrenti in virtù del principio per cui la responsabilità penale è personale, e allo stesso modo l’archivia zione dei procedimenti si genera chiunque sia il soggetto che provvede al pagamento (ad esempio l’obbligato solidale).
Vi è poi da segnalare, quanto alla pro cedura di estinzione delle contravven zioni, che numerose sono le procure che invitano ad applicare il principio di so lidarietà sia per l’ottemperamento che per il pagamento, cosicché, anche nell’i potesi in cui vengano posti in essere esclusivamente da un soggetto, questa sua azione libera tutti gli altri coinvolti. L’obiettivo è quello, infatti, di elimina re l’illecito attraverso la doppia pretesa amministrativa (prescrizione e paga mento), che fa appunto venire meno la pretesa punitiva dello Stato.
E pur tuttavia la maggior parte del le procure aderisce al principio del la responsabilità penale personale per cui sostiene che l’adempimento del la prescrizione da parte di un soggetto coinvolto giova a tutti gli altri, ma il pa gamento potrà avere effetto estintivo so lo nei confronti di coloro che vi abbiano dato seguito; principio questo che, co me anticipato, aderisce perfettamente a quanto accade nell’ambito del procedi mento amministrativo sanzionatorio ex legge 689/1981.
Rivista Rifiuti online
Nel sito della Rivista Rifiuti gli abbonati accedono ai singoli numeri in formato impaginato e possono consultare e stampare separatamente ogni parte di interesse. Tutte le norme citate sono linkate ai relativi provvedimenti. La Rivista è disponibile immediatamente dal primo giorno del mese.
Rivista Rifiuti online + Rivista su carta
In questa formula gli abbonati hanno accesso alla versione online e ricevono la Rivista su carta, combinando tutti i servizi e i vantaggi delle due formule. La Rivista su carta è in formato cm 21x29,7, con stampa a colori. Il numero di pagine può variare in modo consistente da mese a mese: dalle 70 pagine dei numeri più contenuti fino a più di 200 pagine per i numeri speciali. La spedizione avviene per posta ordinaria (consegna: circa 15 gg).
Rivista Rifiuti online + Normativa Rifiuti
Gli abbonati hanno accesso alla versione online della Rivista e possono consultare tutti i provvedimenti contenuti nell’area Normativa Rifiuti in reteambiente.it
Normativa Rifiuti contiene provvedimenti della normativa Ue, nazionale e regionale, vigenti e in corso di approvazione, specifici in materia di rifiuti e di Albo gestori ambientali. Accompagnati da approfondimenti e Dossier, giurisprudenza, prassi e documentazione complementare, nonché correlati agli altri documenti complementari. I testi dei provvedimenti consolidati sono aggiornati in tempo reale, con modifiche a vista.
Rivista Rifiuti online + Rivista su carta + Normativa Rifiuti
È la formula di abbonamento più completa. Offre l’accesso a tutti i servizi online e ai numeri stampati, fornendo così il supporto più efficace ed essenziale al lavoro di analisi e interpretazione svolta dalla Rivista.
Nuovo servizio riservato agli abbonati alla Rivista online
L’interpello è uno strumento giuridico che consente a determinati soggetti di presentare al Ministero dell’Ambiente istanze di ordine generale volte a chiarire l’applicazione della normativa ambientale. In questa sezione vengono presentati e raccolti i principali interpelli in materia di rifiuti, con i link alla normativa di riferimento e completi dell’intera documentazione originale.
Gli abbonamenti possono essere effettuati nel sito rivistarifiuti.it, nelle varie formule disponibili
Rivista Rifiuti online
Rivista Rifiuti online + Rivista su carta
Rivista Rifiuti online + Normativa Rifiuti
Rivista Rifiuti online + Rivista su carta + Normativa Rifiuti
Interpelli sui rifiuti*
* Riservato agli abbonati a Rifiuti online
Servizio clienti
Luisa Baldino (Rivista Rifiuti) tel. 02 45487277
mail luisa.baldino@reteambiente.it
Listino valido fino al 31/12/2025
Nadia Meazza (Servizi online) tel. 02 45487378 mail nadia.meazza@reteambiente.it
l’acquisto di più di un abbonamento del Network ReteAmbiente si ha diritto a uno sconto del 10% sul prezzo totale.
Normativa ambientale Ue/Nazionale (esclusi Rifiuti e Albo Gestori) . 310,00 € (iva compresa)
Normativa ambientale Regionale (esclusi Rifiuti e Albo Gestori) . . . 250,00 € (iva
Normativa Rifiuti (Ue/nazionale e regionale)*
Adempimenti e scadenze ambientali
* È incluso il tema Albo gestori ambientali
380,00 € (iva compresa)
300,00 € (iva
Osservatorio di normativa energetica (Ue/nazionale) 310,00 € (iva compresa) con Vademecum autorizzazioni
Normativa energetica regionale 310,00 € (iva compresa)
* Prezzo per singolo dossier
Rifiuti
Rivista Rifiuti online .
Rivista Rifiuti online + Rivista su carta
Rivista Rifiuti online + Normativa Rifiuti
180,00 € (iva compresa)
324,00 € (iva
€ (iva
Rivista Rifiuti online + Rivista su carta + Normativa Rifiuti 704,00 € (iva compresa)
Interpelli sui rifiuti*
* Riservato agli abbonati a Rifiuti online
Servizio clienti
Luisa Baldino (Rivista Rifiuti) tel. 02 45487277 mail luisa.baldino@reteambiente.it
€ (iva compresa)
Listino valido fino al 31/12/2025
Nadia Meazza (Servizi online) tel. 02 45487378 mail nadia.meazza@reteambiente.it
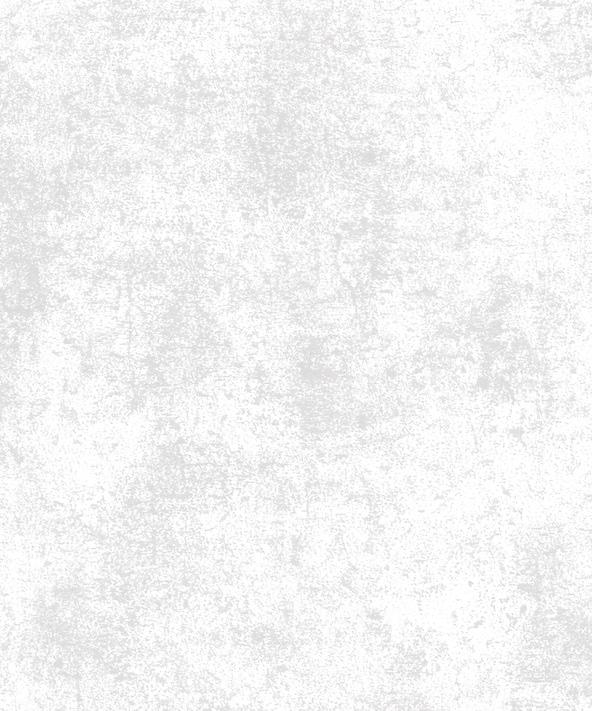
Le ultime novità spiegate in diretta dai nostri esperti attraverso gli strumenti del sistema integrato di ReteAmbiente.
Evento gratuito online Terza
http://bit.ly/47Pp2LN

24 settembre 15:00 – 16:00
Su zoom