UNIVERSITA’ IUAV VENEZIA
Corso di laurea magistrale
Architettura per il nuovo e per l’antico
Anno Accademico 2016/2017
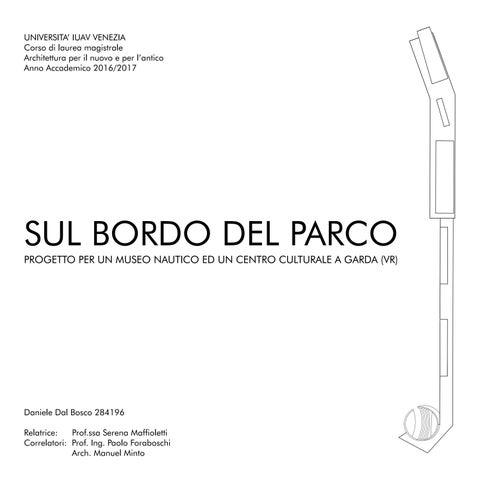
UNIVERSITA’ IUAV VENEZIA
Corso di laurea magistrale
Architettura per il nuovo e per l’antico
Anno Accademico 2016/2017
PROGETTO PER UN MUSEO NAUTICO ED UN CENTRO CULTURALE A GARDA (VR)
Daniele Dal Bosco 284196
Relatrice: Prof.ssa Serena Maffioletti
Correlatori: Prof. Ing. Paolo Foraboschi
Arch. Manuel Minto






I più antichi ritrovamenti nell’area corrispondente all’attuale territorio del Comune di Garda riguardano una necropoli risalente al periodo tra l’età del bronzo e l’età del ferro, nel cosiddetto periodo “protoveneto” (II millennio a.c.). Se tralasciamo le prime, frammentarie e incerte testimonianze di epoca romana su un villaggio presente nella zona, possiamo concentrare la nostra attenzione su alcuni documenti di epoca medievale che certificano l’esistenza di un’entità politica.
Il nome Garda compare per la prima volta in un’opera intitolata “ Cosmografia ” compilata da un anonimo monaco ravennate nel 670 d.c. al cui interno erano descritti gli itinerari che congiungevano le principali città dell’Impero Romano.
“ … parimenti in alta (Italia) non lontano dalle Alpi si trovano due città, Sirmione e Garda e presso di esse un grandissimo lago chiamato Benàco ”.
Garda deriva dall’antico germanico “ Warta ” che significa guardia, fortezza, rocca. Questa è solo una delle tante parole di origine longobarda che troviamo nella zona, infatti, dopo la caduta dell’impero romano l’Italia settentrionale fu invasa dai Longobardi che dominarono per circa due secoli (568-774 d.c.), influenzando molti aspetti della vita quotidiana tra cui la toponomastica di alcuni paesi ed alcuni nomi propri di persona.
I documenti più antichi parlano di Garda come di un baluardo imprendibile e di un centro
politico che estendeva la sua giurisdizione su un vasto territorio che si estendeva dal lago alla riva orientale dell’Adige: la sua importanza fu tale da imporre il cambiamento del nome latino del lago Benacùs in lago di Garda. Quest’area ebbe particolare importanza anche sotto i successivi dominatori Franchi (776-888 d.c.) tanto da restare separata dal restante territorio veronese rimanendo un distretto autonomo.
Intorno all’anno 1000 l’imperatore Ottone decretò la distruzione di Garda e della Rocca, verosimilmente tale scempio non fu mai attuato poiché in documentazioni di poco successive il borgo viene citato come fiorente centro di una signoria detta “Giudicaria del lago” governata da ufficiali tedeschi residenti nella zona. Nel 1193 si registra la cessione del territorio soggetto alla Rocca di Garda al Comune di Verona ad opera dell’Imperatore di Germania Enrico IV. In questo periodo si inizia a parlare di “ Garda plana “: i castelli gradualmente perdono la loro funzione e la loro autorità mentre città e villaggi si circondano di mura, adottano i primi statuti e iniziano ad assumere funzioni politiche. Assistiamo al passaggio dal feudalesimo all’età comunale. Nel secolo successivo la Rocca fu oggetto di numerose dispute tra le famiglie veronesi fino al definitivo sopravvento degli Scaligeri che per tutto il 1300 controllarono Verona e la zona del lago fino al 18 giugno
1387 quando furono sconfitti
dai Visconti grazie all’ausilio delle prime armi da fuoco, così come testimoniato da una lapide celebrativa.
Nel 1405 i veneziani insediavano il loro dominio su Verona e il suo territorio. L’autorità della Serenissima sul lago era rappresentata dal “Capitano del lago” eletto ogni tre anni, coadiuvato dal “Consiglio della gardesana dell’acqua” una sorta di federazione fra comuni con compiti consultivi. Garda fu anche sede di un “Vicariato” un’antica amministrazione comunale che durerà fino a Napoleone. In questo periodo viene creata la corporazione degli antichi originari formata da famiglie di pescatori che acquistarono il diritto esclusivo di pesca sul lago.
Durante il XV secolo il territorio di Garda fu più volte terreno di battaglia e di saccheggi, anche ad opera dei terribili Lanzichenecchi che nel 1526, durante la loro calata su Roma,
non persero occasione di depredare ferocemente tutti i paesi rimasi fedeli a Venezia. E’ di questo periodo la costruzione della villa Guarienti a punta San Vigilio e della Loggia in fianco al comune attribuite alla scuola del Sanmicheli, operativo a Verona nell’ultimo periodo della sua vita.
Con l’arrivo della peste nel 1630 la popolazione di Garda, già provata dalle scorrerie dei Lanzichenecchi diretti a Mantova, si ridusse di circa due terzi. Anche nel XVIII secolo le scorribande degli eserciti coinvolti nelle Guerre di Successione non fecero che aggravare le già precarie condizioni degli abitanti di Garda, colpevolmente lasciati soli governo veneto concentrato a difendere le città di Verona.
Napoleone nel 1796 vinti gli austriaci in Piemonte ed in Lombardia si avvicinò ai territori sotto il dominio della Repubblica Veneta (che in queste guerre era rimasta neutrale): conquistò

Verona e la difese dai ripetuti tentativi degli Austriaci di riconquistarla.
Il grande imperatore francese ebbe il merito di rinnovare le strutture politico/amministrative locali, rese obbligatoria la scuola elementare e per garantire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle città decise di spostare i cimiteri fuori dai centri abitati.
Dopo la pace di Campoformio Venezia finisce sotto il dominio degli Austriaci dando origine al Regno Lombardo – Veneto governato dal Vicerè in nome dell’imperatore d’Austria che si spese molto per perseguitare i collaboratori di Napoleone e reprimere anche in modo violento il nascente sentimento di “ italianità ”.
L’avvento dell’era industriale fece sentire i suoi benefici effetti anche sul Lago di Garda: nel 1824 la “ società milanese per la navigazione a vapore nei laghi ”, voluta da un gruppo di banchieri del capoluogo
lombardo avvio un progetto di costruzione di alcuni battelli e nel 1827 il battello a vapore divenne una delle maggiori attrazioni del lago. Per oltre un secolo, i battelli sopperirono alla mancanza di importanti vie di comunicazioni terrestri navigando prevalentemente sulla linea nord-sud collegando Peschiera del Garda a Riva del Garda, gli unici paesi che erano dotati delle prime linee ferroviarie. Fu così che il turismo mittel-europeo scoprì le bellezze paesaggistiche del lago nonché le doti curative delle acque termali particolarmente indicate nella cura delle malattie polmonari molto diffuse alla fine dell’800.
Durante le Guerre d’Indipendenza il Lago di Garda cambierà più volte “padrone” e più volte segnerà il confine tra l’Impero Austriaco e Regno d’Italia. Nel 1889 venne inaugurata la linea ferroviaria VeronaCaprino Veronese, nel 1904 il tronco Affi-Garda, nel 1908

vide le stampe la “ Guida spirituale alle osterie italiane da Verona a Capri ” di Hans Barth che descriveva in modo molto lusinghiero alcune osterie di Garda: in conseguenza di tutto ciò l’attività turistica della zona ricevette un notevole impulso nonostante la riluttanza dei pescatori della zona interessati a preservare il loro luogo di lavoro.
Tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, a seguito del parziale interramento del porto vecchio, vengono realizzati la piazza principale, il nuovo porto e si assiste ad un generale ampliamento dello spazio. Nel 1914 iniziarono gli studi per la creazione di un’arteria stradale di collegamento tra i maggiori centri abitati, ma la Prima Guerra Mondiale interrompe ogni iniziativa; bisognerà attendere gli anni ’30 per vedere in funzione una strada che assolva a questo scopo. Luogo di impegno militare dopo la ritirata di Caporetto per soldati
francesi e italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale Garda è residenza per numerosi soldati tedeschi che insieme a Mussolini cercarono un‘ultima resistenza armata contro gli Alleati.

Per poter progettare uno spazio per l’esposizione della cultura nautica del lago di Garda è necessario conoscere le varie tipologie di mezzi tuttora usati e capirne la storia e lo sviluppo.
Per una lunghissima serie di secoli, il lago di Garda è stato una grande e comoda via commerciale, sulla quale passavano uomini e merci in un traffico incessante, che costituiva il vero flusso vitale di tutta la regione gardesana.
L’orografia delle sponde del Garda, la positura e forma sono i principali fattori dello sviluppo della navigazione lacuale e può dividersi in due facies : una dalle rive pianeggianti, sabbiose e lievemente digradanti e l’altra caratterizzata da rocce a strapiombo che proibiscono il passaggio via terra lungo le rive. Il Garda giace in parallelo all’Adige e il lago mette in comunicazione l’economia della pianura e della montagna.
Una serie di reperti aiutano a supporre dettagli sulla navigazione preistorica e la diffusione dei traffici nell’area gardesana.
Grazie alle epigrafi trovate si conferma l’esistenza di traffici nautici con la possibilità di arrivo di imbarcazioni anche da paesi lontani come il phaselus di Catullo, un battello marino, atto per affrontare la navigazione mediterranea di cabotaggio e alle “ganzare o canzage”, imbarcazioni lunghe e ufficiali usate per la sorveglianza delle acque.
Le prime canoe venivano
utilizzate nell’età preistorica per spostarsi da una popolazione all’altra e vasselli, barche grosse con vele quadrate utilizzate dai corsari del lago.
Legata ad un episodio di guerra, quella che fece seguito alla Lega di Cambrai, va ascritta la causa dell’affondamento nel lago di Garda di una fusta veneziana (simile alla galea, ma di dimensioni inferiori). La scoperta ufficiale avvenne nell’estate del 1962, quando si riuscì a localizzare il relitto che giace ad una profondità compresa tra i 24 ed i 27 metri su un fondale fangoso, circa 500 metri dal porto moderno di Lazise.
Lo scafo conservato risulta per una lunghezza dì trenta metri ed una larghezza massima di tre metri e mezzo, presenta una giacitura doppiamente inclinata, sono perfettamente leggibili molti dei principali elementi costitutivi dell’ossatura della nave.
Il fondale del lago, in questo punto fangoso, l’ambiente freddo e buio e la conseguente scarsa attività biologica, hanno permesso la conservazione in buono stato di parte dello scafo di questa nave da guerra d’epoca rinascimentale.
Gli scambi tra i vari paesi si avevano anche grazie a mezzi tradizionali, ma con l’avvento del vapore molte cose cambiarono.
Nel 1824, sotto il dominio austriaco venne costruito il primo battello a vapore in legno, “l’Arciduca Ranieri”.
Successivamente la flotta andò ad ampliarsi anche grazie alla fondazione di nuove società
per i trasporti e l’affidamento di alcune tratte alla società ferroviaria che poteva così unire le stazioni di Peschiera del Garda e Riva del Garda, gli unici due paesi con la rete ferroviaria. Col passare degli anni iniziarono a navigare i piroscafi a ruota e le motonavi più recenti con il motore diesel.
TRADIZIONE GARDENSE:
Le tipologie di barche sul Lago di Garda si dividono in due grandi famiglie: nella zona veronese (sud) si possono trovare barche, barchettoni, gondole, battelli e nel Sommolago (nord), bragozzi, bisse e bissoni.
Le differenze tra queste due categorie, non particolarmente evidenti sono dovute principalmente alla qualità delle correnti, più forti a nord rispetto alla zona meridionale del lago.
Le imbarcazioni che oggi navigano sulle acque del Garda sono innumerevoli e tutte con stile diverso, la barca vera e propria è limitata all’uso della pesca, tutte in vetroresina e tutte simili, l’unica cosa che è stata conservata è lo stile dello scafo e la sistemazione degli interni.
- BARCA DA PESCA , limitata a tale scopo, fondo ampio e piatto, per facilitare i movimenti dei pescatori e permettere loro di trascorrere a bordo le notti di pesca, estrema manovrabilità e dotate di un paio di remi.
- BARCHETTONI/BARCHETTI , barca da pesca con fondo piatto e due punte rialzate che ospitavano tre, quattro pescatori.
- GONDOLA : si presume che le prime siano approdate sul Garda dopo le armate veneziane. Imbarcazioni usate come rappresentanza vista la loro scarsa affidabilità sull’onda del lago, più agitato rispetto una laguna veneta.
Le gondole veneziane sono adatte ad un trasporto tranquillo, manovrabili e veloci. Sono barche lunghe, piatte e sottili con bordo basso, lunghe 11 metri con forma/scafo asimmetrica/o, il lato sinistro più largo del destro, rematori in piedi verso prua.
La denominazione gondola veniva assegnata alle imbarcazioni che avessero le estremità arricciate ed oltre a soddisfare il gusto estetico era un mezzo di trasporto per passeggiate e spostamenti.
Lo scafo venne adattato alla navigazione sul Garda, aumentando le fiancate e la larghezza trasformandolo in un mezzo di lavoro per la pesca.
Vennero rinforzate le “astil” (aste di prua e poppa) agevolando il trasporto delle “remàt” grandi e pesanti reti, il rematore scese dalla posizione di equilibrio stabilendosi sul pagliolato.
- GONDOLA PIANA , dalla gondola viene tolta sia la poppa che la prua, alleggerendola e snellendola. Una barca di uso universale sul Lago.
- GONDOLA PIANA SIGNORILE , due/quattro remi, addobbata a festa, utilizzata in occasioni speciali e adibita ad uso turistico.
- GONDOLA DA CARICO , un’imbarcazione che portava fino a 100-150 quintali, con la poppa arrotondata, rientrante e un timone ricurvo che ne segue
linea.
- BRAGOZZO , barca da pesca in legno, con prua e poppa tondeggianti, con alberi e vele per avere la capacità di navigare sottovela mantenendo la rotta grazie al grande timone. Tozza con fondo piatto, solida ed economica, facilmente manovrabile.
- BISSA , (biscia), lunga barca, stretta con priorità nella velocità, fondo piatto, lunga 10,50m, e larga 0,65 con 35 ordinate, un fasciame non più longitudinale ma coperto da tre fogli di compensato marino, composta da quattro rematori e quattro scalmieri (il punto dove il remo ruota e si appoggia in manovra), oggi ridimensionata, più tozza e corta per la pesca.
- BISSA DA REGATA , medesime caratteristiche ma utilizzata nelle regate ovvero gare di velocità tra imbarcazioni a vela, remi o motore, sul Garda dal 1548.
- BISSONE , imbarcazione veneziana da parata a otto remi, per feste e regate. Molto più grandi, pesanti e tozzi rispetto alle bisse, a fondo piatto, due prue, pensata per quattro rematori. Lunga 6 mt, larghi oltre 1,60 mt, portata da 1 a 3 tonnellate, fasciame longitudinale con tutte e quattro le sciamane in legno,
- SANDOLINO DE PALUDE , un’imbarcazione stretta e lunga, a fondo piatto con poppa e prua aguzze, remo a pala doppia, facile da costruire, da condurre, per due persone. Naviga in acque basse tra canneti, infatti “sandalo” indica ogni cosa che possa galleggiare.
- MÈSA BARCA (mezza barca) Ha le stesse possibilità di portata della gondola da carico, ma più economica nella costruzione e più veloce in acqua. Per le molteplici forme e qualità nautiche rappresentò per il lago di Garda il mezzo prioritario.
- BURCELA (piccolo burcio) imbarcazione di circa 8-10 metri, molto solida, atta a portare carichi pesanti.
- VELA , le prime imbarcazioni venivano realizzate con pezzi di vecchie tele usata per mantenere la rotta e sfruttare il vento.
Si distinguono in “derive”, piccole barche, sotto i 5-6 metri, senza cabina e senza chiglia, per uso sportivo o brevi escursioni e “barche a chiglia” con chiglia appesantita (o bulbo) per una permanenza più prolungata e navigazioni di ampio raggio; canotto a vela, veloce e particolarmente robusto.
- IL BURCHIO , una barca a fondo piatto a remi, a vela o trainata dall’alzaia (fune per trainare battelli controcorrente) per navigare sui fiumi, canali e lagune. E’ dedicato al trasporto di materiale vario con forme dello scafo molto semplici, solidità, facilità di costruzione, prua e poppa semplici, pratici ed albero abbattibile.
- PEOTA DA CARICO , una barca semplice di medie dimensioni, a remi o vela usata nella laguna veneta, massicce e molto solide, capienti e utilizzate per trasporto di materiali pesanti e ingombranti.
- BARCHETTA CON IL FELZE , dotata di una sovrastruttura a volta di botte per sostenere
un tessuto che riparasse dalle intemperie e da occhi indiscreti.
- CANOTTO , più piccolo del barchetto, con solo una prora, una bassa chiglia lungo la lunghezza dello scafo per maggiore stabilità, 6 m di lunghezza, usato per la pesca costiera.
Trattandosi di mezzi prevalentemente in legno ed a contatto con l’acqua la scelta del materiale è molto importante.
Il legno per il fondo e i bordi erano larice e abete, mentre il gelso, legno duro e più facile da sagomare, veniva usato per le ordinate (corbe), i dritti e ruote di prua o poppa; infine il rovere, meno nodoso, usato per lavori più fini.
Il sistema per costruire una barca è conosciuto come tre di spade, ossia un tavolato piatto centrale composto da più assi, e due fiancate laterali, semplice, maneggevole ed economico.
I metodi di costruzione erano a barca dritta o rovesciata, il procedimento era analogo.
Si iniziava dal fondo piatto, con assi tenute assieme da traversine, i due dritti di prua e poppa, un’ordinata maestra e due ordinate chiamate quarti, dividendo lo scafo in quattro.
Più tardi si applicò l’ordinata maestra chiamate “a seste”, dividendo lo scafo in sei, agevolando la piegatura delle assi.
Col tempo alcuni accorgimenti finiranno per essere agiunti, come la “colomba”, un travetto posto al centro del fondo della barca per mantenere stabilità di rotta e proteggere il fondo da sassi appuntiti.
La chiglia venne usata più tardi nei primi scafi costruiti su ordinate tondeggianti.

L’area di progetto che ho scelto è conseguenza delle molte modificazioni subite nel xx secolo.
Il lago ha un’importanza particolare, non solo per il valore paesaggistico, ma anche per l’atmosfera ed i giochi di luce che va a creare regalando scenari sempre mutevole e mai banali.
Un ulteriore particolarità è dovuta alla presenza del piccolo torrente, la Gusa, che per un buon periodo dell’anno sembra quasi dipendere dal lago e non viceversa. Nel corso degli anni, soprattutto per le vecchie generazioni era sentito quasi come un confine tra il borgo (zona più antica) e il paese più recente. Naturalmente col passare degli anni questo non diventa più un limite ma una possibilità da sfruttare.
Il grande polmone verde è nato dopo la dismissione della ferrovia e la successiva demolizione
della stazione. Che ha portato nei decenni successivi alla costruzione della sala congressi dell’Architetto Cecchini, uno dei pochi esempi di architettura contemporanea nel centro di Garda, ed il teatro all’aperto all’inizio del parco. La ferrovia ha avuto una grande importanza nella storia locale del paese, dando uno sbocco sul lago a Verona. Importanza anche dal punto di vista dell’impatto sul territorio che ne rimane segnato da tutti questi binari paralleli e un sistema di scambi. Un altro elemento è la presenza di un piccolo porto turistico vicino alla stazione per un breve periodo, poi spostato nella zona del nuovo porto.
L’attuale grande passeggiata è una lastricatura della strada originaria che attraversava il paese e che recentemente è stata spostata fuori dal centro abitato. Allo stato attuale è sbilanciata verso il lago creando dei timidi sentieri all’interno del parco, che d’estate risulta essere un

ottimo ristoro dal sole cocente. Questo sbilanciamento fa sì che la sezione di questo grande lungolago rimanga continua non permettendo di definire i limiti del centro e non dando alternative valide alla strada sul retro. Infatti manca una connessione diretta ed isolata tra il Parco e la piazza del Comune che possa considerarsi un percorso più introverso e veloce rispetto alla passeggiata in riva al lago. Nel punto in cui la passeggiata incontra la foce del torrente, si trova il Parco della Rimembranza, zona che dovrebbe ricordare i caduti della prima guerra mondiale, ma che in realtà non presenta lapidi nè nessun elemento commemorativo che lo possa far capire e trasformi un piccolo giardino con delle sedute in uno spazio dove poter dedicare un pensiero ai nostri avi.
L’edificio di Cecchini, edificio di pregevole qualità architettonica, nasce come edificio a ponte sul torrente Gusa, in modo
da connettere l’edificio del Comune con il parco e posizionando la sala congressi nel punto panoramicamente più caratteristico, sull’acqua. Per motivi prettamente finanziari l’edificio è stato modificato e realizzato nell’attuale forma, limitando il tutto alla creazione di uffici e di una sala congressi per 360 persone. L’edificio presenta un fronte principale rivolto verso il parco, il che consente l’uso del vetro. Nel corso degli anni l’edificio sta perdendo un po’ la sua funzione, sia per lo sviluppo di centri congressi più grandi e flessibili che per la sua posizione, scomoda, nascosta e fuori da ogni logica di percorsi. Il teatro all’aperto, piccola struttura lapidea, risulta, pur se a pochi metri dal centro, in una posizione periferica che ne limita l’utilizzo. Il tutto anche per la presenza di un parcheggio molto vicino che disturba visivamente e acusticamente l’atmosfera scenografica della sua posizione. L’edificio residenziale

prospicente la sala congressi, costruito negli anni ’60, allo stato attuale si presenta a un tale livello di degrado sia funzionale che strutturale che ha portato il Comune a pensare ad un cantiere di demolizione.
L’edificio dell’attuale comune (da non confondere con la sede storica vicina, ora piccola sede della biblioteca) edificato negli anni 30, subisce diverse modificazioni per contenere prima le scuole e attualmente la sede “monumentale” del comune. L’edificio al fianco est del Comune è stato edificato negli anni Quaranta del Novecento, ma nel corso del Secolo ha subito diverse modificazioni, che ne hanno alterato la volumetrie e le forometrie in più fasi e allo stato attuale si presenta con una struttura metallica che ha alterato quasi definitivamente le memorie dell’edificio rendendolo un corpo anonimo nel disegno del fronte della piazza, rendendo
possibile una sua rimozione. La sede storica del Comune, edificato sul finire dell’Ottocento, attualmente ospita la biblioteca comunale, ma la sede non riesce a rispondere alle necessità di cui la funzione avrebbe bisogno. All’ultimo livello dell’edificio sono situati alcuni uffici del Comune connessi all’edificio vicino grazie ad una passerella.

Partendo dalle problematiche rilevate nell’area, l’idea alla base del progetto è quella di creare un edificio che possa mettersi in relazione con il parco, diventandone il bordo naturale, rivalorizzando tutta l’area, tuttora poco sfruttata. Il nuovo edificio, nella parte meridionale di un piano, presenta un fronte articolato da volumi vetrati verso il parco (contenenti la nuova biblioteca ed una caffetteria) e chiuso verso la strada sul retro , crea un dialogo con il teatrino esistente che ne diventa punto di partenza visivo, e del percorso sopraelevato sulla copertura.
Questo elemento cambia registro in corrispondenza del torrente Gusa, diventando un elemento molto importante, che rielabora la figura della banchina e la trasforma in un acquedotto romano contemporaneo che connette la piazza del comune alla sala congressi e consente una vista inusuale verso il lago grazie alla terrazza in copertura. Questa struttura, in calcestruzzo con inerti colorati diventa importante anche nella gestione dei percorsi, una nuova porta urbana per il paese di Garda. I percorsi principali, quello lungo il torrente Gusa e l’asse che collega la passeggiata verso Bardolino e la piazza si incrociano proprio in posizione baricentrica.
Questo nodo, a cui si affacciano lo spazio espositivo polivalente (verso la piazza del comune) e l’accesso al museo nautico, un volume vetrato appeso alla imponente struttura, che
diventa nel suo lato meridionale la conclusione del percorso sopraelevato proveniente dal teatrino.
Lo spazio espositivo, dedicato alla navigazione sul Garda è una grande sala sviluppata principalmente in una direzione, e per poter creare punti di vista alternativi sulle barche oltre che poter contenere delle barche a vela diventa a doppia altezza alle due estremità, ottenendo così due volumi sul piano della terrazza.
Anche la materialità usata per il rivestimento, il multistrato marino, vuole richiamare il tema nautico.
Un volume, quello a sud, regolare contente tutti i servizi di risalita; mentre l’altro a nord si spinge verso la piazza diventandone parte importante del prospetto. Parte fondamentale del progetto, rimane il parco che grazie allo creazione di una serie di grandi vasche verdi crea una serie di spazi più intimi e più adatti per il semplice riposarsi e godere il paesaggio lacustre. Un operazione del genere coinvolge infine anche la sala congressi, che col passare degli anni necessitava di una struttura più flessibile e degli spazi per piccoli ricevimenti/caffetteria. Il tutto è stato risolto con un nuovo volume nella parte verso il lago per ospitare una nuova sala di medie dimensioni, un foyer di ingresso e una spazio per la caffetteria.

Museo nautico (950 mq- 3 livelli)
Bar/cafe (125 mq + 90 mq congressi)
Biblioteca - sala principale (170 mq)
Percorsi esterni all’aperto (1000 mq)
Spazio espositivo polivalente (110 mq)
Foyer
Sala congressi flessibile
Servizi igienici
Spazi per il personale
Vani tecnici
Percorsi principali













1 Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante (8mm); Massetto pendenza in calcestruzzo alleggerito (100 mm); Isolante in xps (100 mm); Barriera vapore in polietilene (2 mm); Lamiera grecata collaborante; Struttura per controsoffittatura con finitura in multistrato marino (12 mm).
2 Pavimento in multistrato marino (12 mm); Massetto per posa parquet (20 mm); Anticalpestio (1 mm); Massetto alleggerito per impianti (100 mm); Solaio in calcestruzzo a pannelli (300 mm); Trave con soluzione mista calcestruzzo e profili in acciaio HEA 500 (dimensione finita 800 x 500mm); Struttura per controsoffittatura con finitura in multistrato marino (12 mm).
3 Pavimento sopraaelevato in legno di teak (12 mm); Struttura lignea per posa pavimentazione a clip (sp. 30 mm); Guaina bituminosa doppia impermeabilizzante (4 mm); Massetto pendenza in calcestruzzo alleggerito (100 mm); Barriera vapore in polietilene (2mm); Solaio in calcestruzzo a pannelli (300 mm); Controsoffitto in pannelli di cemento fibrorinforzato finitura calcestruzzo (12 mm).
4 Pavimento in multistrato marino (12 mm); Massetto per posa parquet (20 mm); Massetto alleggerito per impianti (100 mm); Lamiera grecata collaborante; Struttura per controsoffittatura con finitura in multistrato marino (12 mm).
5 Pavimentazione in pietra (20 mm); Massetto per posa pavimenti (20 mm); Massetto per impianti (100 mm); Isolante in xps (100 mm); Guaina bituminosa (4 mm); Massetto in calcestruzzo (50 mm); Vespaio aerato (30mm)
6 Vetrocamera isolante 66.2/24/6/16/4 con inserto in metallo Okatech metallgewebe;
7 Pannello per facciate in cemento fibrorinforzato 3000 x 900 finitura calcestruzzo (12 mm); Intercapedine per ventilazione (50 mm); Isolante in xps (120 mm); Muratura di tamponamento in laterizio forato (250 mm); Intonaco interno (15 mm)



1 Pavimento sopraaelevato in legno di teak (12 mm); Struttura lignea per posa pavimentazione a clip (sp. 30 mm); Guaina bituminosa doppia impermeabilizzante (8 mm); Massetto pendenza in calcestruzzo alleggerito (100 mm); Barriera vapore in polietilene (2mm); Solaio in calcestruzzo a pannelli (300 mm); Controsoffitto in acquapanel outdoor (12,5 mm).
0,70
2 Pavimentazione in listelli di multitstrato marino (20 mm); Struttura per pavimento sopraelevato; Massetto per impianti (100 mm); Isolante in xps (100 mm); Guaina bituminosa (4 mm); Massetto in calcestruzzo (50 mm); Vespaio aerato (30mm).
3 Vetrocamera isolante 66.2/24/6/16/4 con inserto in metallo Okatech metallgewebe.
4 Pannello per facciate in cemento fibrorinforzato 3000 x 900 finitura calcestruzzo (12 mm); Intercapedine per ventilazione (50 mm); Isolante in xps (120 mm); Muratura di tamponamento in laterizio forato (250 mm); Intonaco interno (15 mm).




Butturini F., Il Garda, un lago per tutte le stagioni, Padova, La linea, 1987; Cambiè G.M., Uomini e merci. La navigazione sul lago di Garda , Verona, Edizioni scaligere, 1988; Capulli M., Le navi della Serenissima. La galea di Lazise, Venezia, Marsilio, 2013; Mazza I., Monese L., Ragnolini M., Garda ieri e oggi, Verona, Corev, 1980; Ogliari F., La navigazione sui laghi italiani. Lago di Garda, Milano , Cavallotti, 1987; Ragnolini M., Storia di una comunità. Garda. Dalle origini al 1630, Garda, Comune di Garda, 1991; Ragnolini M., Guida di Garda, Verona, Tipolitografia La Grafica, 1996; Schwarz Scavaortz S.; Barche nel tramonto. La barca gardesana dalla gondola al bragozzo, Verona, Cierre grafica, 2010; Vedovelli G., Barche e vele del lago di Garda, Sommacampagna, Cierre edizioni promoprint, 2009;