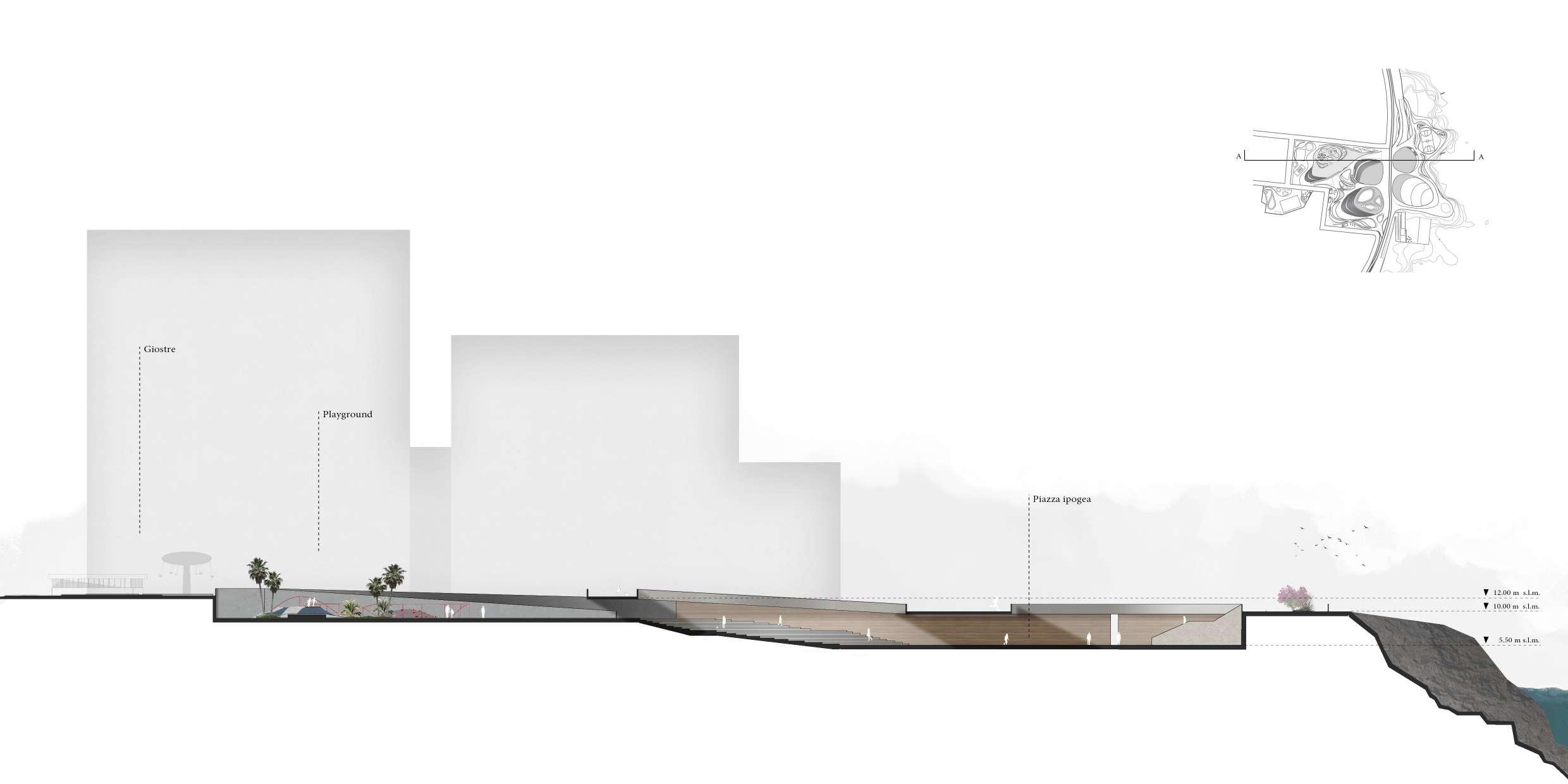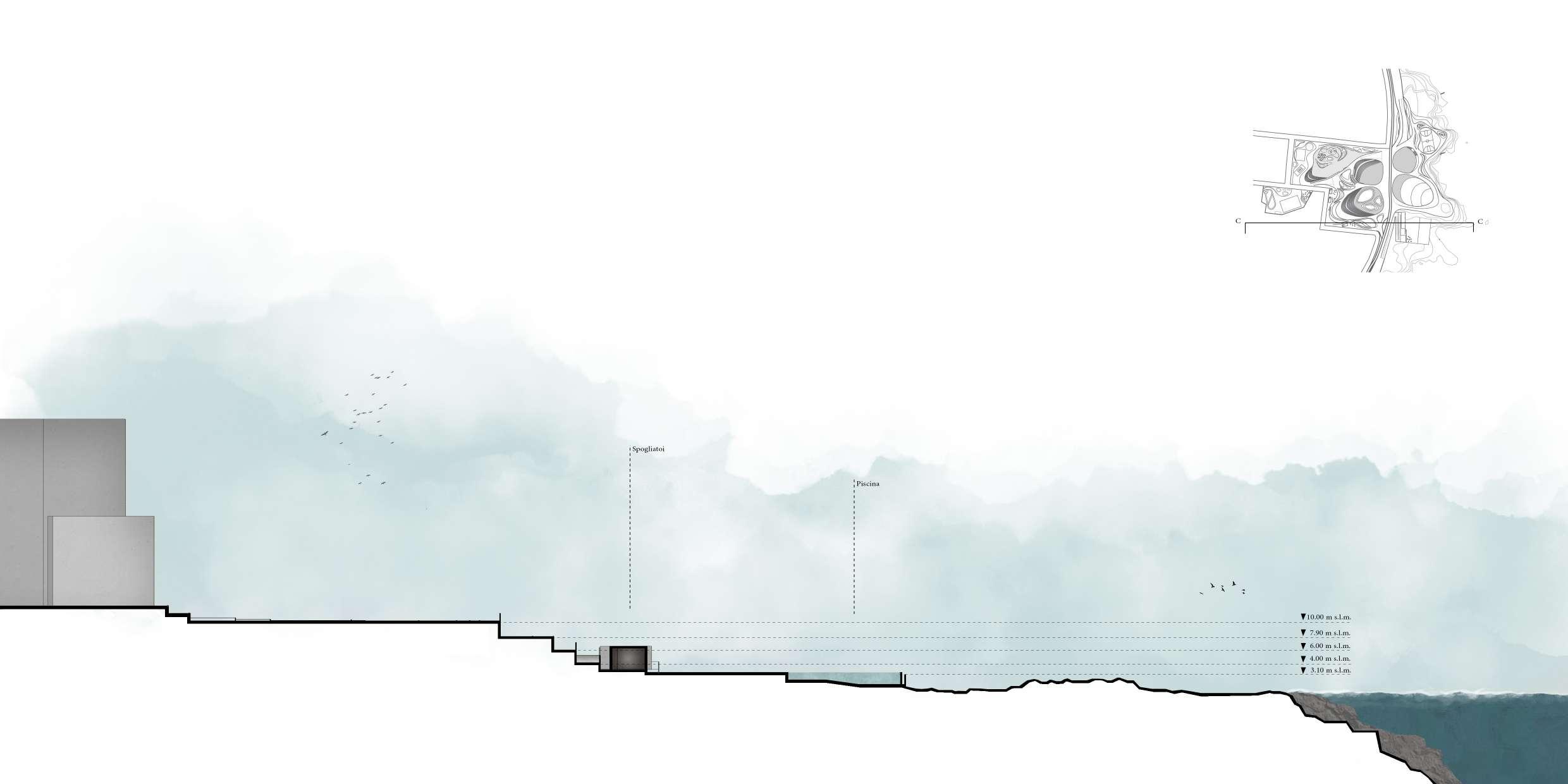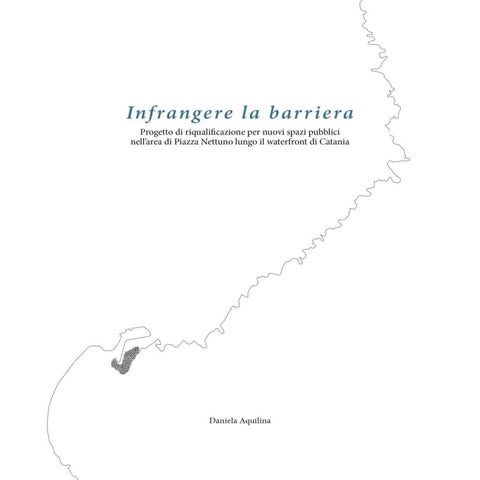Università degli studi di Catania

Dipartimento di ingegneria Civile ed Architettura (DICAR)
Corso di laurea in Ingegneria Edile – Architettura
Progetto di riqualificazione per nuovi spazi pubblici nell’area di Piazza Nettuno lungo il waterfront di Catania
Anno accademico 2019/2020
Relatore: Prof. Ing. Sebastiano D’Urso
Laureanda: Daniela Aquilina
Parte I - Il Waterfront
1_Premessa
Il lavoro di tesi svolto si pone l’obiettivo di affrontare la tematica del waterfront catanese, oggetto di ampi dibattiti, attraverso l’elaborazione di una proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di uno spazio pubblico, multifunzionale, da realizzarsi mediante la riqualificazione del litorale roccioso del Lungomare di Catania e con particolare attenzione ci si vuole soffermare sull’area di Piazza Nettuno, considerato un punto nevralgico del litorale catanese, con la finalità di conferirgli un nuovo assetto funzionale ed estetico.
Questo lavoro si sviluppa secondo tre fasi, la prima della quali, una fase introduttiva, analizza e studia il concetto di waterfront e la sua evoluzione nel corso del tempo, effettuando una rassegna di casi esemplificativi di tale concetto, una seconda fase, quella conoscitiva, la quale si concentra dapprima sull’intero litorale roccioso, analizzandone i diversi aspetti circa la mobilità, l’accessibilità e il sistema del verde, il sistema delle attrazioni e degli eventi.
A partire da un inquadramento a scala vasta che inquadra la città di Catania e l’area di progetto all’interno del proprio territorio, segue una ricostruzione storica di come la città ha negato il dialogo con il mare nel corso dei decenni, analizzandone il sistema antropico, il sistema naturale e costiero, al fine di evidenziare i rapporti tra la realtà urbana e quella fronte mare.
Con l’ultima fase, quella progettuale, si propone un intervento volto a ricostruire un vero e proprio dialogo, favorendo la dimensione del cittadino e del suo contatto diretto con il mare. La fase di progetto perciò si sviluppa a partire da un nuovo sistema di mobilità, teso a favorire la dimensione naturalistica, paesaggistica e pedonale, seguito poi dallo sviluppo di un masterplan generale dell’area di studio e un’elaborazione progettuale.
2_L’uomo e l’acqua
Elemento essenziale della storia e della natura, l’acqua, ha assunto diverse connotazioni nel suo incontro con l’uomo, divenendo risorsa, fonte di ricchezza, fonte di vita, la base dell’economia e del trasporto, ma rappresentando anche la fonte di divertimento e svago. Ha da sempre influenzato la vita dell’uomo, costituendo l’elemento fondamentale per lo sviluppo economico e culturale di tutte le popolazioni. Nel corso dei secoli l’uomo ha intessuto stretti rapporti con questo elemento ma differenti per epoca e geografia. Il suo valore simbolico è stato trasmetto dalla storia, dalle religioni, dalla mitologia e dalla letteratura, dove sorgenti, fiumi e piogge sono associati alla fertilità. All’elemento dell’acqua si lega peraltro una dimensione mistica, fatta di simbolismi e di riti di purificazione che sfociano nell’atto del battesimo. L’acqua assume così un ruolo terapeutico e si concretizza nelle sorgenti, negli specchi d’acqua e nelle fontane da sempre presenti nella cultura architettonica dell’uomo sino ai nostri giorni. Tuttavia, da elemento mistico, legato alla sfera della ritualità, esso diventa materia di studio acquisendone valore laico, ed è importante sottolineare come nella storia dell’uomo e delle civiltà l’acqua costituisca l’elemento fondante di ogni attività umana: corsi d’acqua e canali sono stati i primi luoghi intorno ai quali è nata la civiltà, divenendo garanzia di vita e possibilità di sostentamento e comunicazione, di difesa, di risorsa e di trasporto. Le aree del lungomare e del lungofiume hanno da sempre rappresentato un luogo privilegiato per l’insediamento dell’uomo: molte delle città storiche più importanti sono state fondate in posizione strategica sulle principali rotte per il commercio e l’approvvigionamento di merci. Agli albori della società industriale settecentesca, assistiamo tuttavia ad un mutamento del rapporto tra città e acqua, all’avvento della ferrovia si rendono superflui i trasporti fluviali e ha inizio il processo di rottura delle
relazioni dirette con i fiumi. Ne emerge tuttavia, per tutto l’Ottocento, uno stretto interesse dell’acqua legato allo svago e al tempo libero: ai margini del tessuto urbano, tra la campagna e la città, una folla brulicante di persone popola le rive godendosi l’aria aperta e il contatto con la natura. Si pensa ad una sponda brulicante di persone ed è subito immediato il richiamo alle opere di Georges Seurat.
Criticoèperciòilmomentoincuisiperdeilcontattoconlanaturaelosiricerca al di fuori dell’ambito urbano, poiché è proprio la sua espansione sempre crescente che ha determinato la perdita e la cancellazione di tutte le tracce di naturalità esistenti al suo interno. Dunque l’acqua perde definitivamente il valore essenziale di elemento di relazione tra città e paesaggio.
I primi decenni del Novecento segnano infatti tale processo di rottura: la quasi totalità di attività ed usi che caratterizzano i paesaggi urbani sull’acqua, vengono sostituiti da intense attività industriali che contraddistinguono l’avvio della società moderna, una società sempre più tesa alla produzione e allo sfruttamento del territorio e delle sue risorse, allo sviluppo di nuove vie di comunicazione stradale e ferrovie a discapito delle aree fronte mare Spesso infatti, tali aree vengono trasformate in infrastrutture per lo scorrimento veloce, numerosi sono i casi delle città che vedono i propri litorali chiusi da linee ferroviarie, precludendo ogni contatto, fisico e visivo, del fronte mare al cittadino. Il processo di urbanizzazione ha reso la fascia costiera estranea ed ostile, e anche quando si è tentato di avvicinare l’uomo al mare, sono state attuate metodologie inadeguate, corrompendo l’integrità del paesaggio e spesso avvalendosi di cementificazioni inopportune.
Esemplificativo è il caso del lungomare e della zona portuale di Catania, la quale vede il proprio litorale precluso dalla linea ferroviaria, da una rete stradale a veloce scorrimento e a gran parte del fronte lavico cementato, comportando così una grave perdita del valore paesaggistico che le colate laviche conferiscono al litorale catanese.
Il Waterfront
La ricerca effettuata propone una riflessione su un tema emergente che interessa le realtà urbane sviluppatesi lungo zone costiere, fiumi, canali, e che sifocalizzasulleopportunitàchetaliareediconfinepossonooffrire.Talizone, lungo le quali la linea di costa incontra la città, sono definite “waterfront” e con tale termine, che letteralmente si traduce in “fronte d’acqua” si intende waterfront perciò quella porzione di tessuto della città che si pone a contatto conl’acqua,chesiaessadolce,salataosalmastra,edèilluogoincuiavvengono e si scontrano numerosi processi di riqualificazione urbana. Esso rappresenta l’interfaccia acqua – città e offre una ampia potenzialità di sviluppo non preclusa alla singola zona bensì per un’area molto più vasta. Il waterfront dunque, funge da cerniera e costituisce uno spazio di sovrapposizione tra la sfera urbana e il sistema marino, in cui funzioni ed usi si intersecano, dando origine ad un sistema singolare. Si presenta come un vero e proprio spazio di interconnessione eterogeneo, all’interno del quale si incontrano i diversi flussi materiali ed immateriali che fanno riferimento alle molteplici attività presenti nell’area.
La città del XXI secolo, è un sistema complesso e stratificato, assume configurazioni aperte e spesso indefinite. Essa può essere letta come un sistema di frammenti, di relazioni, forme d’uso e di compresenze diversificate, dove passato e contemporaneità convivono e l’evoluzione del tessuto urbano avviene per integrazione, sostituzione e connessione spesso su aree dismesse e su vuoti urbani. Il cambiamento ha interessato anche relazioni tra la città e il porto generando il fenomeno urbano contemporaneo del “waterfront redevelopment” altresì conosciuto come “waterfront regeneration”, che ha prodotto ampi dibattiti ed episodi di notevole interesse. I waterfront interagiscono con il paesaggio contemporaneo secondo metodi
innovativi, capaci di sfruttarne le opportunità per generare nuove economie e dinamiche nell’ambito dello sviluppo territoriale. Si tratta di luoghi in costante evoluzione, di cui risorse e opportunità permettono di suscitare nuove rappresentazioni nell’immaginario e diventare progetto, generando nuove forme urbane, nuove relazioni, connessioni, nuovi paesaggi e nuove dinamiche sociali e di mercato, infine nuove forme di identità.
Il waterfront appare dunque come una realtà urbana complessa, un luogo scenografico di grande visibilità e di grande impatto: l’interazione tra due sistemi diversi, quello dell’acqua e della terra, esercita da sempre un’attrazione particolare da un punto di vista sociale, culturale e paesaggistico e allo stesso tempo ne emerge la sua ricchezza in termini di risorse e potenzialità.
Nella città contemporanea che muta, l’interfaccia acqua – terra è letta come un’area di transizione in costante evoluzione, afferendo ad una nuova centralitàurbanacheconiugailnuovoconlepreesistenzesecondounrapporto di equilibrio. I waterfront si fanno portatori dell’identità urbana, diventano landmarks in continua trasformazione e riconoscibili nell’evoluzione storica degli insediamenti, e diventano essi stessi, catalizzatori dinamici di attività, eventi ed economie, in grado di trasformare l’intera città e non limitatamente al perimetro costiero.
Rappresentano il luogo dell’espressione del mutamento, dello sviluppo e dell’evoluzione e si traduce concretamente in metodi e strumenti del progetto urbano e dell’architettura, ma allo stesso tempo è il luogo della conservazione della memoria e di tutela del patrimonio storico, costituendo esso stesso l’identità del luogo, in quanto risultato di un processo di sedimentazione.
Numerose sono le esperienze in cui è stato affidato al waterfront il valore trainante nella prospettiva dello sviluppo urbano e territoriale, affrontati attraverso un approccio strategico multidisciplinare di riqualificazione e ne hanno determinato una riconquista delle zone che s’affacciano sui fronti
d’acqua. La storia urbana degli ultimi decenni ha portato all’attenzione le vicende di questa porzione di tessuto, divenendo tema nevralgico di progettazione urbana e delle politiche di trasformazione e riqualificazione dei tessuti urbani della città contemporanea, riconoscendone il ruolo di elemento strutturale.
Inoltre, in Europa le dinamiche di trasformazione devono far fronte alla necessità di conservazione del patrimonio materiale e immateriale dei waterfront urbani, richiedendo quindi, sperimentazioni progettuali che però si confrontino con analisi sulla sensibilità, sui rischi e sui valori ambientali e paesaggistici.
Dal punto di vista delle dinamiche di trasformazione urbana, i waterfront rappresentano perciò una delle declinazioni più feconde in cui si può investire in termini di valorizzazione della cultura locale, del suo sviluppo economico e identitario. Sono luoghi ibridi e densi di risorse, opportunità, aspirazioni e ambizioni della città.
Si attinge infine al «Manifesto per le città creative» (Carta 2007) dal quale emergono sette principi che declinano l’azione creativa volta all’innovazione urbana. - Principio di identità, ossia il riconoscimento dell’identità culturale, sociale, funzionale ed economica; - Principio di attivazione economica;
- Principio di potenzialità, identificando i waterfront urbani come luoghi in cui esiste un dislivello tra i bisogni percepiti rispetto alle attuali funzioni e dunque riconoscendovi un potenziale di trasformazione inespressa;
- Principio di dinamicità, secondo il quale il waterfront non è che un’intersezione di diversi flussi;
- Principio di interazione, secondo il quale il waterfront è riconosciuto come ambiente capace di accogliere la diversità e la varietà, e di diventare luogo di scambio;
- Principio di multisettorialità;
- Principio di perturbazione, ossia il dinamismo culturale sociale ed economico che il waterfront è in grado di generare deve avere un potente riverberosuitessutiurbani,nonlimitatoallasingolafasciaportualeecostiera.
Storia ed evoluzione del concetto di waterfront
Il rapporto tra le città costiere e il mare è molto complesso e nel corso dei secoli, ha subito notevoli trasformazioni, in linea con la diversa prospettiva che si ha avuto nel tempo nel modo di concepire e vivere il mare. Esso infatti, col mutare degli equilibri politici e delle condizioni sociali e culturali, ha acquisito via via nuove sfaccettature fino a diventare una nuova via per lo sviluppo.
La presenza di fiumi e di mari ha storicamente svolto un ruolo di calamita di attrazione per la nascita dei primi insediamenti urbani, i quali sono sorti laddove fosse possibile reperire e usufruire dell’acqua come risorsa, in ogni forma in cui essa si presentasse. L’acqua infatti, rappresentava una forma di sostentamento, una forma di ostacolo per la difesa, un mezzo di trasporto e commercio. Il fronte mare del passato, pertanto, non si limita ad essere solamente un affaccio sull’acqua, ma costituisce un luogo polifunzionale in cui si concentrano numerose attività, la cui presenza ha permesso di definire tali luoghi come ambienti ricchi di caratteristiche singolari e di identità locali, che vanno a costituire poi i piccoli borghi marinari che ancora oggi sopravvivono.
Fino al Cinquecento, viene concepito infatti come un punto di vulnerabilità, da cui bisognava difendersi e per il quale era necessario ergere cinte murarie. È il caso dei Bastioni di Catania, fortificazioni distribuite lungo le mura di Carlo V, in seguito distrutte dalle devastazioni che colpiscono la città di fine Seicento, la colata lavica del 1669 e il terremoto del 1693. Il mutato clima post Seicentesco permette l’innesco di nuovi equilibri e di nuove condizioni politiche che portano al ridimensionamento delle esigenze difensive. Il fronte mare diventa il luogo in cui si concretizza l’ascesa della borghesia legata al commercio, le tracce di tale manifestazione sono
rinvenibili nelle città di Napoli, Reggio Calabria o Messina, nella quale, tra il 1622 e il 1625, viene eretta la Palazzata.
Sulla fascia costiera di Messina, viene costruito un vero e proprio anfiteatro marittimo, un unico grande palazzo alto quattro piani e lungo quasi un chilometro e mezzo, il quale si collega alla città retrostante mediante diciotto porte aperte. La palazzata è espressione della borghesia commerciale in ascesa, la quale manifesta mediante la monumentalità di tale architettura, la propria ricchezza, creando uno spazio pubblico inedito fronte mare.
La tendenza dei centri urbani ad aprirsi verso il mare si accentua con l’avvento del Settecento, fenomeno principalmente legato all’affermazione di nuovi valori estetici, orientati prevalentemente al paesaggio. Si assiste infatti alla diffusione del nuovo gusto del pittoresco, alimentata sicuramente dalle correnti artistiche del tempo. Emerge perciò la riscoperta di scorci, di bellezze panoramiche e dalla suggestione che ne deriva dal rapporto tra l’ambiente costruito e quello naturale, e si approda ad una nuova chiave interpretativa della realtà volta alla sua estetizzazione. Si assiste ad un rinnovato senso estetico che si esplica in una nuova visione urbana che predilige spazi aperti. Ed è proprio in questo periodo che nascono i primi spazi organizzati sul bordo dell’acqua.
ApartiredalXIXsecolo,conl’avventodellerivoluzioniindustriali,ilrapporto tra la città e il mare subisce un radicale cambiamento, nell’ambito del quale molti dei fronti marittimi si trasformano in vere e proprie aree industriali, nelle quali i porti, in continua espansione, diventano progressivamente aree di separazione tra la terra e il mare, compromettendo ogni contatto diretto. L’avvio della società industriale ha dunque portato ad un travalicamento di quel limite di sostenibilità che caratterizzava l’equilibrio preesistente tra uomo e natura costituendo una totale cesura.
La clarissima Città di Catania Patria di S.ta Agatha Verg. Et Mar., Nicola Van Aelst, Roma 1592
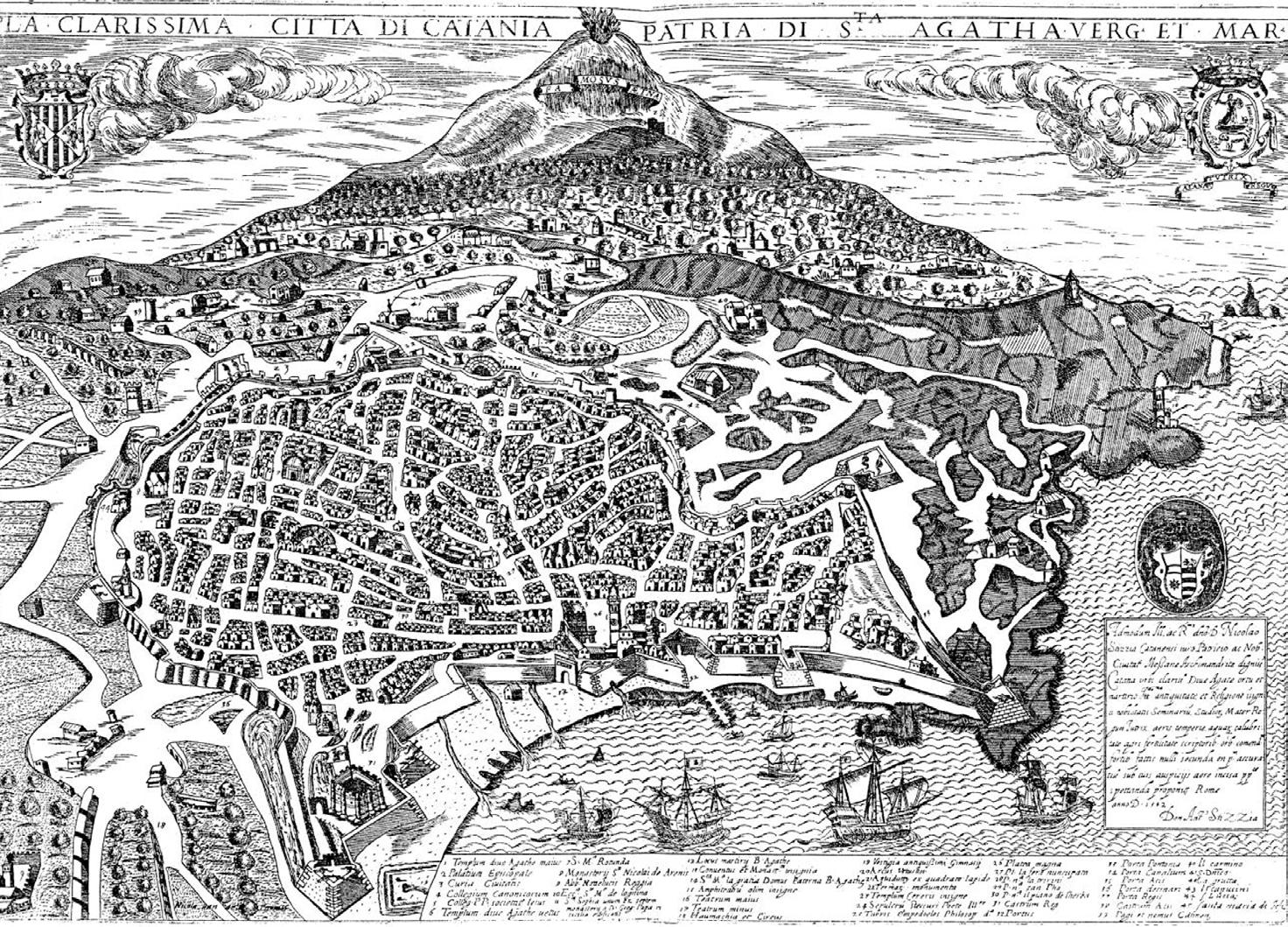
Le aree costiere della città, infatti, a causa di mutamenti tecnici, economici e sociali, hanno subito intense trasformazioni volte all’insediamento delle infrastrutture portuali e di trasporto. La crescita delle zone portuali ha determinato un sempre maggiore distacco tra mare e città a causa della costruzione di banchine, magazzini, silos, riempimenti a mare, ma anche opere di infrastrutture ferroviarie e stradali necessarie alla movimentazione delle merci.
Mentre la linea di costa subisce radicali modifiche, l’accesso al fronte mare viene progressivamente e definitivamente negato, impedendone anche la percezione visiva.
L’altra tendenza dell’800 era quella di trasformare il confine tra la città e il mare, in uno spazio ben strutturato e attrezzato, di creare una passeggiata a mare. Sorgono le prime strutture balneari, semplici e smontabili, quali le cabine, ma ben presto verranno sostituite da strutture edilizie vere e proprie. Il confine terra-mare si connotava così, sempre più come uno margine ben caratterizzato da infrastrutture turistiche, attrezzature e servizi, che risponde ad esigenze funzionali di diversa natura- difesa della costa, organizzazione di attività portuali, fruizione del mare – e tenta, al tempo stesso, di conferire un carattere ben preciso a questo singolare ambito urbano, sviluppandosi generalmente per fasce parallele, poste tra l’arenile e la cortina degli edifici, e dando vita ad una sequenza di fasce specializzate e multifunzionali.
L’inizio del XX secolo porterà ad una vera e propria rottura con il mare. Si osserva uno sovrasfruttamento del territorio, da parte dell’uomo il quale ricopre le coste per la loro posizione strategica: infatti insediare gli stabilimenti industriali lungo la fascia litoranea significava risparmiare sui costi del traporto dallo stabilimento al porto. Ne segue dunque, un
processo invasivo di fenomeni di cementificazione del territorio litoraneo compromettendone il paesaggio naturale e costiero e avviandosi verso un processo di deterioramento progressivo.
Solo dopo il secondo dopoguerra, si assiste ai primi tentativi di legare la città al mare, infatti, nell’ambito della ricostruzione post bellica dei porti, ne emerge il tentativo di superare il senso di estraneità tra i due mondi ormai separati. Le cause che hanno condotto questa tendenza sono da ricercarsi innanzitutto nelle nuove esigenze commerciali.

Infatti, con la rapida espansione commerciale e industriale e con il cambiamento delle esigenze legate alla logistica, che richiedono bacini portuali sempre più ampi e dotati di funzionalità tecniche maggiormente efficienti per la movimentazione di navi di dimensioni sempre maggiori, spazi e strutture più adeguati alle nuove attività portuali e alle nuove tecnologie di trasporto, i porti diventano oggetto di grandi trasformazioni funzionale con il conseguente trasferimento degli stessi in ampi siti, generalmente nelle zone periferiche delle città e accessibili da reti autostradali mentre le vecchie aree portuali risultano così obsolete.
La presenza di ferrovie e il sistema stradale ha costituito una vera e propria rottura tra il centro urbano e il waterfront e ne ha impedito qualsivoglia tipo di relazione tra i due ambiti.

A tali problematiche si aggiunge una maggiore coscienza ambientale e la volontà di migliorare la qualità estetica – paesaggistica di queste aree urbane con il conseguente focus sul lungomare, dando via a fenomeni di waterfront regeneration.
Nell’ambito litoraneo, la scarsa pianificazione dei collegamenti infrastrutturali ha comportato inoltre. un rallentamento dell’economia locale e impedendo il corretto uso dei litorali dando vita a problemi di diverso tipo legati all’ambiente, all’inquinamento e al consumo sregolato del suolo.
Processi di riappropriazione del fronte acqua
Il fronte mare passa dall’esser considerato una semplice linea di confine tra l’acqua e la terra ad una fonte di innumerevoli opportunità in termini di funzione pubblica, commerciale e ricreativa. Non più considerato dunque, come una semplice passeggiata attrezzata tipica di ottocentesca memoria, come può essere il caso di Barcellona o di Salerno, piuttosto si erge a vero e proprio landmark della città, assume un ruolo fondamentale per lo sviluppo urbano, ne diviene il fulcro, capace di innescare processi di rinnovamento che coinvolgono l’intero contesto urbano. Non più considerato mera linea di demarcazione tra acqua e terra, bensì una porzione di territorio che si fa portatrice di identità e centralità, che esalta il mare e il dialogo che esso ha con l’uomo.
Si procede perciò con l’obiettivo di ottenere una maggiore accessibilità, attraverso l’abbattimento di barriere fisiche e visive, quali infrastrutture, ferrovie, strade, recinzioni che si interpongono tra la costa e il centro urbano.
Emblematico è, infatti, il caso della città di Catania. Lafruibilitàègarantitaattraversolapedonalizzazioneditaliaree,favorendone lo sviluppo di spazi pubblici e attrezzature e servizi per lo sport, il tempo libero, la cultura e la socializzazione.
Altro obiettivo di cui si fanno carico tali progetti di riqualificazione consiste nella valorizzazione di spazi marginali o in disuso, rendendo produttivi tali spazi portuali attraverso azioni di recupero e riconversione. Si tratta dunque di trasformazioni volte a generare nuovi spazi collettivi qualificati che integrano la presenza dell’acqua, la quale spesso diviene elemento fondante dello spazio stesso e rappresenta un valore inestimabile di tali progetti.
Ha così inizio il processo di rigenerazione e di risanamento delle aree costiere in cui la domanda di accessibilità e il desiderio di riappropriazione dello spazio pubblico si concretizzano in una serie di operazioni di grande interesse.
A partire dagli anni 60- ’70, si rende più pressante l’esigenza di superare la barriera cementata del porto per poter avviare la riconquista del mare, attraverso il recupero delle aree portuali dismesse e degradate, nel tentativo di dare una seconda vita a queste aree, e costituendo per le città, un’occasione di riscatto.
Si distinguono tre stagioni di trasformazione dei fronte acqua nelle città portuali.
Il processo di rivitalizzazione dei waterfront è un fenomeno che affonda le sue radici in USA negli anni ’60, e vede in seguito una rapida diffusione nel resto del mondo tale da condurre alla definizione di una nuova tipologia di intervento urbano che è proprio quello del “waterfront redevelopment”. Boston, Baltimora e San Francisco si annoverano tra le prime esperienze urbane pionieristiche di rigenerazione, dove sono state privilegiate tipologie di progetti puntuali che prevedono la realizzazione di singole strutture quali hotel, strutture turistiche, aree direzionali, centri culturali o di intrattenimento.
Segue una seconda stagione, collocabile tra gli anni ’70 e ’80, nella quale in città come Sydney, Londra e Toronto, viene favorito lo sviluppo del settore terziario e immobiliari.
Emblematica è anche l’esperienza di San Francisco, dove all’inizio degli anni ’80 si mette in atto la prima importante opera di rivitalizzazione del waterfront volta a riconvertire un’ampia zona portuale in disuso.
Infine, nella terza e ultima stagione, che collochiamo a partire dagli anni ’90,
Vista aerea dell’area portuale di San Francisco

la rigenerazione costiera diventa oggetto di interesse anche in Europa, in città come Oslo, Rotterdam, Barcellona, Bilbao, Londra e Genova. Spesso si sfruttano i finanziamenti legati a grandi eventi espostivi, come nel caso di Bilbao o di Genova, per costruire nuovi poli attrattivi come centri divertimento, museali o multifunzionali.
Significativo è stato il caso di Genova e della darsena, che ha avuto la finalità di creare un polo di attrazione a livello internazionale. Il processo di rigenerazione è stato favorito da tre importanti occasioni di finanziamento quali, le celebrazioni Colombiane del 1992, il G8 tenutosi a Genova nel 2001 e Genova Capitale della Cultura Europea nel 2004. Il suo è stato uno sviluppo avvenuto per fasi, con l’inserimento di elementi di attrattività culturali e turistici, quali l’Acquario, la Bolla, il Museo del Mare, il Bigo.
Anche Barcellona, in occasione dei Giochi Olimpici del 1992, ha avuto l’occasione di creare nuovi accessi all’acqua e quindi, consentire la realizzazione di nuovi spazi pubblici. È stata riqualificata l’area del Porto Vecchio con la realizzazione di Piazza della Dogana, aperta verso il mare sulla quale confluiscono i viali alberati della Rambla de Flores, connettendo così il centro storico al mare.
Altri casi significativi sono Valencia (America’s Cup nel 2007), Saragozza (Expo 2008), Lisbona (Expo 1998 e Parco delle Nazioni 1993), Liverpool (Città Marittima Mercantile Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO dal 2004).
Nell’ultimo ventennio, le città del Sud Europa, Barcellona, Bilbao, Valencia, Lisbona e Saragozza, si sono distinte nell’ambito della rigenerazione delle aree urbane, oggi invece, si può affermare che siano le città nordiche ad essersi assunte il ruolo trainante, città come Oslo, Copenaghen, Helsinki, Reyjyavik, Amburgo.
Di grande rilievo è la Global Conference on the Urban Future (Urban 21), svoltasi nel 2000 a Berlino, durante la quale si è affrontato il tema della rigenerazione urbana a partire dalla riqualificazione dei waterfront. Ne emergono principi secondo i quali sono stati fissati i punti che definiscono questa tipologia di intervento, in termini di spazio pubblico, partecipazione, identità del luogo, rispetto del passato. Il processo di rigenerazione dei fronte acqua urbani, secondo tali principi, ha quindi trasformato in opportunità la situazione di criticità relativa alla presenza di ampie aree dismesse o degradate in prossimità dell’acqua e la necessità di giungere ad una nuova identità e destinazione d’uso. Si manifesta la volontà di avviare azioni sinergiche ed integrate volte sia a risolvere le criticità ambientali, sia alla valorizzazione del patrimonio, sia a ristabilire un rinnovato rapporto tra l’acqua e il territorio.
I dieci principi per lo sviluppo sostenibile dei waterfront urbani:
1. Garantire qualità ambientale: la qualità dell’acqua in un sistema di corsi d’acqua, fiumi, laghi e mari è un pre-requisito per qualsiasi intervento di waterfront regeneration;
2. Integrare il waterfront al contesto urbano esistente: i nuovi interventi devono essere concepiti come parte integrante della città esistente e del territorio, contribuendo allo sviluppo locale, e in tal senso l’acqua è parte del paesaggio e dovrebbe essere utilizzata per funzioni specifiche quali il trasporto, il tempo libero, la dimensione estetica;
3. Preservare l’identità storico-culturale: l’acqua è intesa come elemento fondante del paesaggio e della sua storia. La tutela del passato è un elemento importante del recupero;
4. Assicurare un mix di funzioni ed usi: valorizzare la presenza dell’acqua attraversounavarietàdifunzioniculturali,ricreative,didattiche,commerciali e insediative;
5. Garantire fruibilità dei luoghi: l’accessibilità di tali luoghi deve essere
garantita a livello visivo e fisico, ad ogni classe di utenza;
6. Favorire partnership pubblico-private: i nuovi programmi di sviluppo per i waterfront devono essere proposti secondo tale ottica;
7. Partecipazione pubblica;
8. Adottare una prospettiva a lungo termine;
9. Pianificare in modo aperto e flessibile alla trasformazione, concependo il processo di rivitalizzazione come un processo continuo;
10. Confrontarsi con le esperienze internazionali e favorire gli scambi culturali.
Dall’analisi di questi dieci punti si evince l’importanza che il waterfront assume nei confronti del territorio urbano in quanto portatore di identità.
Risulta inoltre, evidente una rinnovata sensibilità verso tematiche ambientali, sociali e l’importanza dello scambio di esperienze e conoscenze.
Esso deve costituire per la città un motore di sviluppo e un punto di vantaggio e non deve porsi come entità a contrasto che mina l’integrità del tessuto stesso, e deve in tal senso diramarsi al suo interno, in modo tale da creare flussi continui tra il mare e la città secondo una crescita sinergica Una mancata integrazione del waterfront comporterebbe invece la formazione di un sistema in antitesi, in cui i due elementi mancano di una relazione biunivoca e che tutt’al più si concentra solo sul waterfront comportando un impoverimento del resto della città.
Si tratta, dunque, di una riconfigurazione di tipo funzionale, morfologico e identitario di queste porzioni di tessuto urbano, costituenti dei vuoti urbani, la quale si basa su un approccio strategico che mira al recupero della memoria storica e identitaria del luogo mediante la conservazione di antiche strutture e l’innesto di nuove funzioni. Intervenire su queste aree significa riorganizzare le loro forme e funzioni attraverso la
ricucitura dei tessuti urbani mediante aree residenziali, commerciali, culturali e aree destinate a parchi e giardini e l’intero sistema dovrà poi esserebencollegatomediantelariorganizzazionedellamobilitàurbana.
Nel panorama generale delle città d’acqua, pertanto, il waterfront redevelopment non consiste più nella semplice realizzazione di parchi di waterfront, ma questa tipologia di intervento si sta spingendo verso la realizzazione di vere e proprie aree attrattive, ricreative, svuotate delle loro vecchie funzioni, e rese più accessibili e più attraenti.


Effetto Bilbao
La città di Bilbao nasce come un centro mercantile nel Medioevo, e durante l’800 basa la propria economia sull’industria metallurgica, navale e sulle attività estrattive. Negli anni ’80 si assiste ad una migrazione da parte della popolazione dalla riva del fiume Nevriòn verso l’area metropolitana della città di Bilbao, ciò a causa di una trasformazione del sistema produttivo dovuto alla fine delle politiche protezionistiche, con la conseguente nascita di una profonda crisi.
Dopo la seguente crisi, e soprattutto dopo la successiva piena del fiume che inonda la città nel 1983, si punta alla ricostruzione di una nuova immagine per la città e soprattutto alla ripresa economica.
In questi anni, la città diviene oggetto di risanamento e vive un periodo di rinascita grazie al sistema metropolitano progettato da Norman Foster, al sistema infrastrutturale di Santiago Calatrava e soprattutto, alla presenza del museo Guggenheim di Frank O. Gehry.
La città vede pertanto trasformato il proprio panorama urbano. Vengono attuate diverse politiche volte alla rigenerazione sociale e ambientale, ed è in questi anni, in particolare nel 1992, che viene costituita la società Bilbao Ria 2000, con il compito di conferire usi urbanistici a zone urbane degradate e avviare diversi programmi di sviluppo, e in particolar modo concentrandosi sulle aree industriali dismesse.
Successivamente all’inaugurazione del museo nel 1997, l’intera regione basca rifiorisce, segnando l’inizio di un significativo processo di rigenerazione urbana, sociale e culturale, a seguito del quale si è largamente diffuso il fenomeno conosciuto come “effetto Bilbao”.
A Bilbao è stato applicato un modello di rigenerazione innovativo, risultato di una pianificazione integrata dell’intera area metropolitana basato su: potenziamento infrastrutturale, sostenibilità economica, attenzione a
tematiche paesaggistiche, partenariato pubblico e privato.
La progettazione del nuovo porto industriale alla foce del fiume Nevrion consente lo spostamento delle attività portuali e la rivitalizzazione della riva sinistra del fiume, e la realizzazione di un grande collettori fognario ha consentito il disinquinamento delle acque fluviali.
Le vecchie aree industriali dismesse lungo il fiume Nerviòn sono diventate poli per l’innovazione, per il turismo e per la cultura.
È proprio la costruzione del Guggenheim, tra il 1993 e il 1997, che segna la prima tappa di un importante sviluppo dell’intera area di Abandoibarra, a sud del fiume Nerviòn. L’edificio del Guggenheim Museum si erge a edificio simbolo di una città, dal gusto accattivante e dalla forma riconoscibile, identificativa, ne diventa un vero e proprio landmark.

I diversi interventi si concentrano proprio negli spazi pubblici a diretto contatto con il fiume e questo ha permesso di interrogarsi circa il dialogo da instaurare con l’elemento liquido, il quale, viene concepito come nuovo asse di connessione tramite la costruzione di nuovi attraversamenti trasversali.
Il caso di Bilbao rappresenta pertanto, l’esempio di rigenerazione del riverfront, che ha comportato la reinvenzione dell’intera città.
 Guggenheim Museum, Bilbao
Guggenheim Museum, Bilbao
Eventi recenti
Nell’ultimo decennio si assiste ad una ulteriore progresso nella riqualificazione dei fronti acqua, con una maggiore consapevolezza nel reinserimento della dimensione paesaggistica nell’ambito del sistema urbano, in particolar modo, basata sulla condizione di fruizione da parte della popolazione stessa, sulla gestione e la costruzione di infrastrutture verdi per la protezione da esondazioni fluviali e inondazioni marittime.
Basti pensare al progetto della Dry Line, un’idea sviluppata appositamente per New York, un progetto che mira a salvare l’isola di Manhattan da inondazioni costiere e uragani sempre più frequenti. La proposta prevede la creazione di una barriera verde lunga 16 chilometri, situata a ridosso della linea costiera e rialzata rispetto al livello del mare, nella quale potranno essere ospitati spazi pedonali, piste ciclabili, nuovi locali commerciali, ricreativi e culturali. Il nome del progetto deriva dall’assonanza con la High Line, parco lineare realizzato sul tracciato ferroviario dismesso e la Low Line, il parco underground, attualmente in fase di costruzione. Il progetto è costituito da una cintura a forma di U che avvolge la Lower Manhattan con una serie di interventi paesaggistici e si configura come un parco naturale immediatamente confinante con i grattacieli di Manhattan, che in caso di inondazione è adibito all’assorbimento dell’acqua.
Il Brooklyn Bridge Park è situato su una vasta area lineare che si estende per due chilometri sulla riva dell’East River e comprende sei moli del vecchio porto di New York. Il tratto costiero post industriale è stato radicalmente trasformato in un parco connettore tra la città e l’acqua, uno spazio che accoglie una vasta gamma di attività, tra cui parchi gioco, campi sportivi e aree polifunzionali.
Progetto del Brooklyn Bridge Park

Contesto europeo
In Europa negli ultimi decenni si annoverano numerosi e importanti interventi che mirano alla riqualificazione urbana dei bordi sull’acqua delle città.
Tante città europee, negli ultimi anni, hanno sperimentato, con varie procedure e progetti, il rilancio verso una nuova immagine di creatività Ogni caso è singolare in quanto ogni città gode di una propria identità e di caratteristiche uniche.
A Siviglia, è stato l’evento dell’Expo del 1992, ad innescare i cambiamenti radicali che la città ha vissuto negli ultimi anni.
La città di Madrid, nel 2011, vede completato il progetto di ricucitura urbana tra due parti di città, dove è proprio il fiume che viene concepito come elemento chiave di tale connessione: il fiume viene restituito alla città, l’autostrada viene interrata e viene realizzato un parco pensile che s’affaccia sul fiume.

Si tratta di un progetto dello studio West 8, che prevede l’interramento di 43 chilometri di autostrada in modo tale da restituire il corso del fiume alla città, e il nuovo paesaggio polifunzionale, con percorsi pedonali e piste ciclabili al posto dell’autostrada, lungo il fiume Rio Manzanares.
A Lione, le aree lungo il fiume Rodano, sono state trasformate dallo studio In Situ Architectes Paysagistes: cinque chilometri di corsie ad alta velocità lungo il fiume sono state rivoluzionate radicalmente per dare vita ad aree dedicate alla pesca, aree relax, noleggio biciclette.
3_Letteratura dei waterfront contemporanei
Nell’ambito del panorama europeo, la Spagna, è da considerarsi pioniera nel campo delle politiche per la rigenerazione costiera. Si sceglie pertanto, di focalizzare l’attenzione sugli interventi effettuati a Barcellona, in quanto emblematici ed esemplificativi di un modus operandi divenuto poi un modello.
Il caso di Barcellona
L’esperienza di Barcellona, con la riconquista del suo fronte marittimo, è diventata emblematica nelle tendenze attuali per la riqualificazione dei fronti marittimi. Il modello spagnolo si basa su una serie di interventi facenti riferimento ad una strategia di sviluppo a lungo termine, e oggi si configura come uno degli esempi cardine del waterfront redevelpment.
La storia Barcellona sorge su un’ampia fascia litoranea che si estende per diversi chilometri tra il fiume Besòs a Oriente, e quello del Llobregat, a Occidente. La città, ha sempre avuto un forte legame con il mare, poi consolidatosi con la costruzione del nuovo porto, nel 1477, costruito sugli arenili, presso il quali sorgerà poi la Barceloneta. Essa si afferma nel contesto del Mediterraneo come uno dei porti più importanti e centro di scambio commerciale. Quello che in questo periodo, costituisce la Barceloneta, ossia un ampio spazio vuoto, successivamente costituirà il luogo dell’espansione della città, nella quale sorgerà la Plaza de Palau, uno spazio aperto sul mare, ossia il primo tentativo di spostare il baricentro cittadino dal centro in direzione della costa
Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, la città vive un periodo di sviluppo, favorito dalla costruzione della prima linea ferroviaria spagnola. Questo è il periodo in cui sorgono i primi stabilimenti balneari ottocenteschi, ma è anche in questo contesto che si ha un progressivo degrado del fronte marittimo.
Negli anni ’70, molti sono i siti e gli insediamenti che vengono dismessi, ritenuti ormai obsoleti, con il conseguente degrado del fronte mare della città.
Allo stesso tempo vengono smantellati anche gli storici stabilimenti balneari al fine di consentire l’accesso pubblico e gratuito alla spiaggia.
Fatto di rilievo è proprio la scadenza delle concessioni e la restituzione del carattere pubblico al demanio, coincidente con la gran trasformazione di Barcellona in occasione delle Olimpiadi del 1992. Prima di allora, la città era totalmente separata dal mare anche se furono attuati vani tentativi di apertura.
Con quest’evento di importanza mondiale, vengono finalmente forniti alla città gli strumenti ma soprattutto i finanziamenti per intraprendere un processo di recupero dei suoli del demanio pubblico lungo la costa e la riqualificazione del fronte mare.
A metà degli anni ’80, Barcellona vive un vero e proprio periodo di trasformazione, passando da città industriale a capitale del turismo europeo e divenendo oggetto di una profonda azione di rinnovamento urbano che ben presto è diventata, su scala mondiale, un riferimento operativo ed un esempio di come, il progetto architettonico, può essere uno strumento per la definizione di una rinnovata identità urbana e una nuova consapevolezza dell’abitare metropolitano.
La città infatti, si riappropria del proprio patrimonio costiero grazie alle opere di riqualificazione del waterfront e alla realizzazione dei parchi urbani.
Moll de Fusta
Prima di esse, tuttavia, è rilevante citare l’intervento di apertura verso il mare elaborato da Manuel de Solà Morales per Moll de Fusta: si tratta di un’elaborazione progettuale di uno spazio pubblico, un luogo di incontro e di relazione tra il contesto urbano e quello marino.
Il progetto di Manuel de Solà Morales, per Moll de Fusta di Barcellona 1983-1987 può essere considerato il primo intervento di all’apertura verso il mare. Si vuole rendere progettare uno spazio pubblico tentando di rendere compatibile all’attraversamento una via a scorrimento veloce e progettare dunque,unluogodiincontrotralacittàeilmare,questofupossibilemediante la realizzazione di una sezione trasversale a gradinata volta ad incanalare il traffico in un tunnel semiinterrato e tentando di restituire la quota della strada al cittadino, rendendo l’area adatta al transito e alla sosta pedonale. Questo intervento segna infatti il primo momento di riconquista del mare Successivamente la capitale catalana, sfrutterà due grandi eventi per poter avviare un lungo processo di rigenerazione. La prima stagione pertanto si apre con il primo evento, l’occasione cardine che dà avvio a questo lungo processo trasformativo, rappresentata dalle Olimpiadi del 1992, che offre alla città grandi opportunità di rigenerazione, migliorando infatti, l’accesso all’acqua, la percorribilità pedonale e permettendo il raggiungimento di altissimi livelli qualitativi di vita. Viene avviata la rigenerazione del quartiere Poblenou, allora un’area prettamente industriale. Questo intervento si incardina in un contesto dove era già in atto un notevole cambiamento urbano, in termini di funzionalità legame con il contesto, integrazione sociale e equilibrio tra la tradizione e l’innovazione. Si procede perciò, con una rilocalizzazione delle strutture portuali lungo il fiume Liobregat, liberando la costa.


La Villa Olimpica
Le Olimpiadi del 1992 rappresentano l’occasione per trasformare quella che costituiva una zona prettamente industriale, sede di manifatture chimiche, farmaceutiche, metallurgiche e anticamente, una zona destinata alla lavorazione del cotone. Negli anni ’70, con la crisi industriale, molte sono le fabbriche costrette a chiudere e a lasciare che la zona diventasse sempre più degradata. Il recupero di quest’area inizia proprio con la realizzazione del Villaggio Olimpico nella zona di Nuova icarìa, un quartiere che avrebbe dovutoospitareresidenze,hotel,ufficieattrezzaturesportive.Larealizzazione di questi interventi diventa espediente per avviare la sistemazione della costa e la sua dotazione infrastrutturale, l’interramento della linea ferroviaria e la costruzione di una strada costiera, la Ronda Litoral. Qui sorge il Porto Olimpico: inizialmente fu pensato di costruire una piazza d’acqua, non prevedendone il carattere portuale, tuttavia il progetto mutò in un vero e proprio porto turistico. Dopo le Olimpiadi, il porto si evolve in uno spazio ludico – ricreativo denso di attività e locali. La villa Olimpica viene realizzata con l’intento di agganciarsi alla vecchia maglia articolata dal Cerdà, si opera dunque, mediante una sorta di “ricucitura”, secondo una maglia che riprende quella ottocentesca ma che al contempo si adatta alle nuove esigenze.

Port Vell
Quello di Port Vell, rappresenta uno degli interventi cardine di questo processo: si dà avvio alla rivitalizzazione del waterfront del quartiere marinaro di Barceloneta, in particolare proprio del Port Vell, l’antico porto della città al confine con l’estremità della Rambla, il quale subisce un processo di riconversione, e quello che un tempo era caratterizzato dalla vita di porto e dai mercati del pesce, è oggi un’area multisettoriale

Si pensa alla riqualificazione del porto antico sulla base del modello delle prime città americane, con cinema, acquari, locali, a discapito, tuttavia, dell’immagine storica della città. Viene rielaborato un efficace sistema di pedonalizzazione che collega Placa Catalunya lungo le Ramblas con il Port Vell. Il recupero del waterfront è legato allo spostamento delle attività portuali più a sud, lungo la costa: attraverso il recupero del porto vecchio Barcellona ha avviato un grande processo di trasformazione urbana, e nel corso di un ventennio si è espansa verso Nord per circa 10 km, diventando così una complessa infrastruttura su cui poggia l’intera città.
Il Port Vell non è stato del tutto sradicato dalla sua originaria natura, è infatti mantenuta una zona adibita alla pesca, che prende il nome della Torre del Rellotge, e ad un piccolo mercato del pesce. Permangono gli antichi arsenali medievali, le Drassanes Reials, testimone dell’antica potenza della marina catalana.
Rambla de Mar
Un altro intervento su cui ci si vuole soffermare è quello riguardante la costruzione della Rambla de Mar, ossia una passerella di legno, che nasce dalla Placa de Colom, estremità della Ramblas.
La Rambla de Mar, il cui nome vuole suggerire la continuità della Rambla, come una estensione sul mare, si presenta come una passerella, costituita da un percorso principale centrale, ai cui lati si trovano panchine e divisori per favorire la sosta degli utenti. Nasce con l’intento di connettere il centro storico alle acque del porto permettendo, quindi, un flusso continuo.

Explanada del Forum
Conclusasi l’avventura olimpica, la seconda stagione è invece segnata da un altro grande evento, quello del Forum delle Culture del 2004, con il quale si traccia una nuova direttrice di espansione, la zona orientale della città. Fino agli anni ’90, la Avenida Diagonal, infatti, rappresentava una arteria lunga quasi 10 km che tuttavia era priva di un proprio sbocco a mare, bensì si perdevainun’areadegradata.ÈagliinizideglianniDuemila,che,all’estremità orientale di questa arteria, si progetta un insediamento residenziale sul mare. Nel contesto del Forum delle Culture del 2004, il progetto dell’Explanada del Fòrum viene assegnato a Josè Antonio Martinez Lapena e Elìas Torres Tur, ed ha permesso la sistemazione dell’area posta all’estremità orientale dell’Avenida Diagonal: grandi piazze e spazi pubblici, connessi con rampe e terrazzamenti ad un porto sportivo e ad un parco litorale. Il Forum delle Culture rappresentò dunque, l’occasione per poter avviare il recupero di questa zona degradata del fronte mare. Intorno a questo spazio si innestano una serie di edifici adibiti a diverse funzioni. Si erge, a simbolo di questa zona, un edificio triangolare, il Museu Blau, progettato da Herzog & De Meuron.
L’Explanade rappresenta una grande area – filtro tra la città e il mare, caratterizzata da una pergola Fotovoltaica di 400 mq, la quale produce ombra ed energia.
Planimetria di progetto dell’area del Forum




Il caso di Lione
Lione si sviluppa presso la confluenza del Saone e del Rodano. Nell’ambito internazionale, Lione si afferma tra le città interessate da sperimentazioni di pianificazione territoriale e progettazione urbana a partire dagli anni ’80. La città si afferma come modello di qualità per la riqualificazione dello spazio pubblico e soprattutto per il rinnovato rapporto città-natura. Il processo vede la rigenerazione di spazi aperti e del sistema del verde, il miglioramento della mobilità pubblica e privata e l’aumento delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.
A partire degli anni ‘90, l’area metropolitana di Lione cerca di riconquistare i suoi fiumi attraverso grandi progetti di urbanistica. I progetti s’inseriscono in una strategia d’insieme e sono basati su una nuova relazione tra natura, paesaggio, e città. Si tratta di una pianificazione strategica inaugurata dal Grand Lyon attravers la quale superare l’inefficacia della tradizionale visione territoriale tipica dei piani urbanistici.
Nel 1992 viene definito il piano strategico “Lyon 2000”, articolato secondo diversi piani tematici: il Plan Presqu’île, sulla rivitalizzazione del centro storico, il Plan Lumière, sulla creazione di un nuovo sistema di illuminazione della città, il Plan Couleurs, sulla riqualificazione di alcuni quartieri attraverso piani del colore, lo Schèma d’amènagement des espace publics, sullarifunzionalizzazionedeglispazipubblici,IlplanVert, sullasalvaguardia e della valorizzazione delle aree verdi, il Plan Bleu, sulla sistemazione dei margini fluviali del Saone e del Rodano, fino alla loro confluenza.
Inparticolarmodo,ilPlanBleu,ossiailpianodeglispaziblu,hacomeobiettivo il recupero del rapporto tra la città e i suoi due fiumi e la rigenerazione delle sue rive, mediante l’individuazione di una serie di interventi di progettazione di spazi verdi di qualità, nuove connessioni ciclopedonali, spazi attrezzati per
lo sport, e delle strategie volte a migliorare la navigabilità dei fiumi mediante banchine, imbarcaderi, rampe d’accesso.
Il Rodano e la Saône presentano fisionomie differenti: il Rodano è un corso d’ acqua alpino con forte declività, e la Saône, invece, è un fiume di pianura, con bassa declività. Di conseguenza sono state adottate due tipi percorrenze delle rive: presso la sponda del Saone, sono adibiti spazi per la pedonalità, mentre la riva sinistra del Rodano è accostata da piste ciclabili.
Citè Internationale
All’estremità nord – orientale di Lione, la Cité Internationale, rappresenta uno dei primi progetti che ha introdotto la politica di trasformazione della città, configurandosi come una nuova parte di città e si estende linearmente tra l’ottocentesco Parc de la Tête d’Or e il Rhône.
Sul lato opposto del boulevard urbain, sorgono gli edifici progettati da Renzo piano, che con le loro coperture in vetro richiamano le serre tipiche ottocentesche. Si tratta di un nuovo complesso della Cité Internationale, che ospita un ampio sistema di attività culturali e congressuali, residenze e uffici, e costituisce un importante punto di accesso nella città dall’esterno.
Il progetto si presenta come il connubio tra architettura e natura un sistema di edifici residenziali, culturali commerciali che si fonde con ampi spazi verdi e permette di ricucire il rapporto tra il parco e il fiume, secondo una logica compositiva che si articola per fasce parallele, a seguire l’andamento del fiume.

Les Berges du Rhone
Avviato nel 2005, il progetto, facente parte di un più ampio piano di riqualificazione della città di Lione, prevede la riappropriazione dei fiumi e del sistema naturale e un vasto intervento di risistemazione della riva sinistra che si snoda per la lunghezza di cinque chilometri dal Parc de la Tête d’Or e il parco di Gerland, prolungando verso sud la rete dei percorsi definiti da Michel Corajoud nel sito della Citè Internationale. L’obiettivo è quello di restituire alla fascia contigua all’acqua, dapprima asfaltata e adibita alla sosta carrabile, il ruolo di elemento di connessione degli spazi della città, ed espediente per dotare i quartieri limitrofi di un sistema di passeggiate ciclopedonali e di ambiti pubblici estrani dal flusso delle automobili. A tal scopo, sono stati realizzati parcheggi sotterranei.
L’intervento sul fiume Rhône, su progetto dell’architetto paesaggista Annie Tardivon, si articola secondo una successione di spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero per un’estensione di cinque chilometri lungo la sponda del fiume.
Nel progetto, dunque, le sponde del fiume diventano parte integrande della città, e si trasformano in un sistema di piazza continua che dà affaccio sul fiume, dove si alternano percorsi pedonali, ciclabili, spazi ricreativi, strutture per le attività sportive, spazi per l’incontro, specchi d’acqua, giocando sulle diversità di materiale e di vegetazione.
I tratti posti all’estremità della promenade, mostrano una maggiore connotazione naturale, in cui gli interventi si limitano alla pavimentazione del percorso, la realizzazione di rampe, gradonate di collegamento e pontili per la pesca, e l’accurata scelta della vegetazione fluviale. I tratti centrali, invece, assumono connotazioni urbane, dove il trattamento degli spazi si fa più incisivo.
I percorsi lungo il fiume terminano nel quartiere di Gerland, polo economico ed urbano della città. L’area ospita il Parc de Gerland, terzo polmone verde di Lione, dopo il Parc de la Tête d’Or e il Parc des Hauteurs, si pone come il è frutto della riconversione di 80 ettari di aree industriali dismesse, e della loro riconnessione con le sponde del Rhône.
Il progetto del paesaggista Michel Corajoud, si basa sulla volontà di unire le diverse modalità di utilizzo quella di luogo di passeggio e quella di centro per lo sport. E vuole integrare le attrezzature sportive esistenti (tra cui lo Stadio di Tony Garnier) con le nuove strutture e i nuovi spazi per lo sport e il tempo libero.
La realizzazione del sito si articola in due fasi.
La prima fase a cavallo tra il ’90 e il 2000, riguarda l’area settentrionale, ha riguardato la sistemazione di un’area di circa 20 ettari, originariamente occupata dai mattatoi comunali e da stabilimenti petrolchimici, in cui si oppone alla frammentarietà delle architetture, la continuità di un vasto prato verde di forma triangolare che raccorda l’interno del parco con la sponda del Rodano, con boschetti radi tali da mantenere libera la visuale sul fiume, mentre a nord-est si trova un giardino che costeggia il viale d’accesso ai nuovi insediamenti dell’Universitè Lyon I.
Tra il parco e il giardino si estende la promenade plantée, con la sua grande varietà di specie erbacee e arbustive, il cui intento è quello di giocare sulle diverse trame vegetali che variano in funzione del tempo.
Si ha poi una seconda fase, che si concentra sulla parte terminate di avenue Jean Jaurés, a fianco degli insediamenti sportivi. L’area si articola in tre diverse fasce, una prima fascia di aree verdi destinate ad accogliere attività all’aperto, una seconda fascia adibite a giardino e attraversata da un canale, e un’ultima fascia, contigua alle precedenti e prospiciente l’avenue, si struttura come una sequenza di aree per il gioco e giardini.


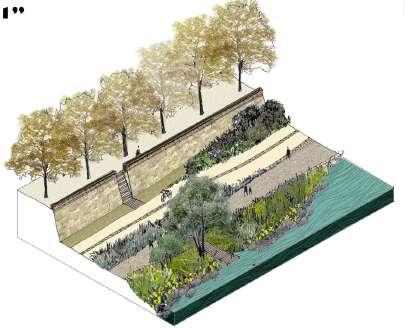
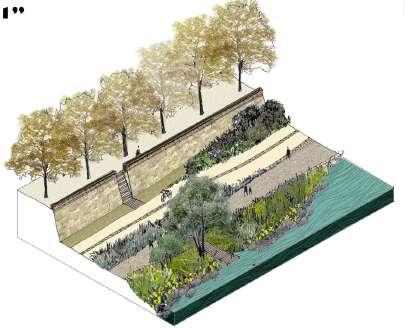
Vista del lato sinistro del Rhone, adibito a percheggio, prima dell’intervento
Vista del lato sinistro del Rhone, a livello del Avenue Leclerc, dopo l’intervento


La Confluence
Costituisce uno dei migliori esempi di riqualificazione quello del distretto de “La Confluence”, un’area di ben 150 ettari collocata alla confluenza dei due fiumi Rhône e Saône, precedentemente occupata da stabilimenti industriali che, dal 2003 è stata oggetto di un’intensa trasformazione, per dare impulso alla creazione di un nuovo quartiere.

Alla base di tale trasformazione, vengono definiti gli obiettivi da perseguire: -La liberazione del sito dai fasci infrastrutturali e ferroviari; -La ripresa di una struttura insediativa dai forti connotati urbani, quale quella per isolati, che caratterizza il centro cittadino, resa però più permeabile dalla presenza pervasiva di percorsi e spazi aperti; -L’applicazione di una concezione di continuum paesaggistico e la riconquista delle rive dei fiumi.
La rigenerazione del paesaggio industriale dismesso è affidata all’architetto Oriol Bohigas, la cui proposta si estende per un ampio arco temporale, e prevede l’interramento di fasci stradali e ferroviari che hanno comportato la separazione di tale area dal resto della città per poter avviare la realizzazione di nuove connessioni pedonali tra i due fiumi, dapprima impedite, ed una radicale rigenerazione del sito con realizzazione di aree con funzioni residenziali, commerciali, culturali, di servizio, in un contesto con spazi aperti ed aree verdi di alta qualità.
La riconnessione funzionale e spaziale è affidata all’architetto F. Grether e al paesaggistaM.Desvigne,allaqualesiaggiungeanchelarealizzazionediservizi e attrezzature di livello urbano. Si vuole sottolineare il carattere processuale dell’intervento, il quale garantisce un conettivo verde che si evolve durante la realizzazione dell’intervento, occupando con orti, promenades e allestimenti
La Concluence
vegetazionali provvisori gli spazi in attesa di trasformazione. La volontà è quindi quella di costruire un paesaggio intermedio tale da accompagnare il processo di trasformazione dell’area mediante frammenti verdi provvisori.
Il masterplan di Grether e Desvigne propone una strategia fondata su un processo evolutivo basato su principi di valorizzazione del paesaggio, della natura dei luoghi, sulla prevalenza della mobilità sostenibile che privilegia l’uso della bicicletta, e infine, sull’uso dell’acqua, tramite la quale si vuole rafforzare il rapporto tra la città e il fiume e rimane elemento centrale dell’intero processo.
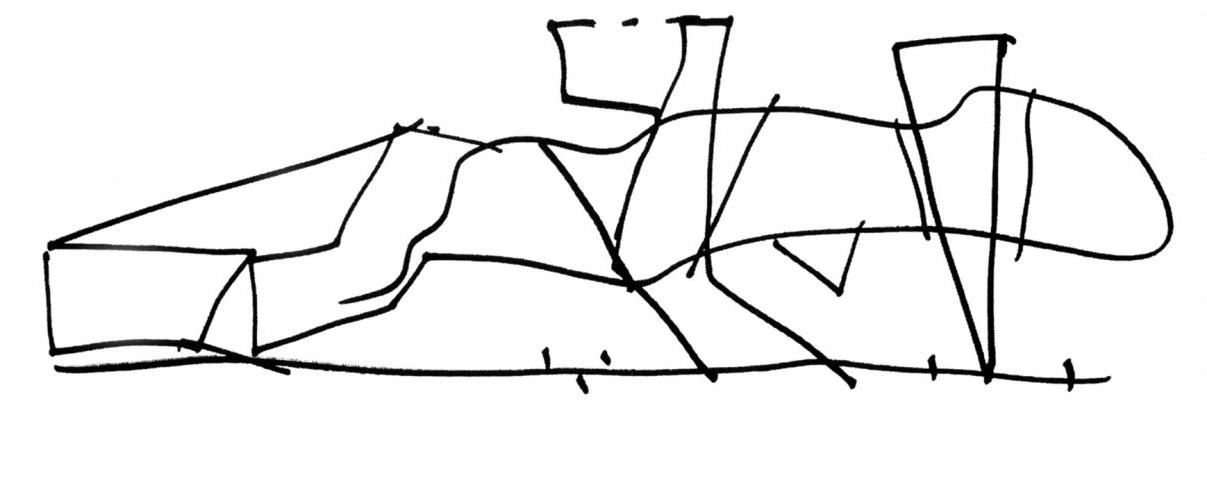
Questalogicad’insiemebensiadattaconlaricercataeccezionalitàdegliedifici, mirata a connotare il nuovo distretto come un luogo di sperimentazione dell’architetturacontemporanea,infatti,lungoilfiumesitrovanoedificicome la nuova sede Euronews, la Sucrière della Biennale d’arte contemporanea, il Padiglione Dogane, Gli uffici Dark Point. Sulla punta sud dell’area, alla confluenza tra i due fiumi, si erge il nuovo Musée des Confluences, progettato dallo studio viennese Coop Himmelb(l) au. Questo edificio si staglia sul paesaggio come un insieme di volumi che si compenetrano, tra acciaio, vetro e cemento.
 Schizzo, del Musée des Confluences
Schizzo, del Musée des Confluences
4_Riferimenti progettuali
Sono differenti gli approcci che si possono adottare nel progetto di un contesto naturale costiero, nel quale si può decidere di intervenire superando il limite “terreno” e valicando quella soglia terra – mare per dare vita a strutture artificiali sul mare, oppure di intervenire adeguandosi e adagiandosi letteralmente al contesto, il fine è tuttavia comune: quello di dare luogo ad uno spazio ricreativo, dedicato al tempo libero e allo svago e allo stesso tempo riparato.
Siindividuanodegliesempichebenesplicanolaprimatipologiadiintervento, che si occupa di creare delle vere e proprie estensioni sul mare, che esprimono l’azione e la direzione dell’uomo verso il mare e la sua conseguente invasione. In seguito si individueranno quelle tipologie di intervento che mirano ad un progetto che non vuole emergere dal contesto, una tipologia di intervento che fa riferimento alle piscine naturali scavate dall’azione persistente del mare, un approccio che si basa sulla volontà di agire nella linea esatta del margine.
Le estensioni sul mare Copenaghen Harbour Bath/ BIG

Lo studio di architettura BIG, si è occupato di dare un luogo ricreativo al waterfront di Copenaghen. La città infatti, sta assistendo ad una trasformazione che vede il proprio porto passare da area industriale a centro culturale e sociale e questo progetto è esemplificativo di questo processo. L’obiettivo è quello di estendere il parco circostante oltre il limite calpestabile, assolvendo a quelle funzioni sociali e alle esigenze in termini di accessibilità e sicurezza. Si tratta dunque di un vero e proprio “terrazzamento” sull’acqua, che ospita al suo interno, ben tre vasche, una di 50 metri una per bambini e una per le immersioni, e due saune, e che assolve la funzione di portare l’acqua nel suo uso ricreativo in città, dando luogo ad uno spazio dedicato allo svago, al relax, all’intrattenimento ma anche all’incontro e all’interazione sociale.

The Kalvebod Waves / JDS
Con l’apertura delle Kalvebod Waves nel porto di Copenaghen, una parte centrale del porto è finalmente resa accessibile e attrattiva per il pubblico. Questo nuovo spazio pubblico sull’acqua conferisce al porto una nuova dimensione in termini di spazio ricreazionale collocato al centro della città: lo scopo è riconnettere il centro cittadino con il proprio porto e creare una sorta di continuità urbana rivitalizzando una storica area industriale. Nell’elaborazione del progetto, gli architetti si concentrano su un aspetto importante,cheèquellodiindividuare,nellanuovastruttura,unorientamento ottimale affinché sin dai primi raggi estivi, le piscine godano di una adeguata esposizione: le ombre lunghe proiettate dagli edifici adiacenti ombreggiano quasi permanentemente il tratto di lungofiume oggetto dell’intervento.

A seguito di uno studio sul percorso di tali ombre, sono state individuate sull’acqua due principali aree soleggiate, presso cui sono collocati gli spazi di sosta sull’acqua.
Sono state disegnate lunghe passerelle sul mare, che accolgono spazi di sosta e di belvedere, con punti che si alzano di quota sormontando aree chiuse destinate ad attività acquatiche di diverso tipo. Si vuole dunque permeare il luogo con una vocazione al divertimento che richiama pubblico semplicemente per fare il bagno, prendere il sole o godersi la vista del canale dalle panchine, ma anche per praticare sport come il kayak. L’andamento sinuoso delle banchine di Kalvebod waves ha lo scopo di diversificare la funzionalità di quest’area, offrendo anche lunghi coperti come quello che ospita il club di canoa. Il complesso è costituito da un molo fluttuante, dal quale cittadini e visitatori possono godere della vista sul porto da diversi livelli.
Spreebrucke è un chiaro esempio del riuso e del riciclo nelle sue differenti declinazioni. Si tratta di un progetto facente parte di una iniziativa promossa dallaorganizzazioneCityArtproject,ilBerlinCityCouncileHeikeCahterina Muller nel 2003, ponendosi come obiettivo il rafforzamento delle relazioni sociali e culturali tra la città e il fiume, basato sull’idea di creare un vero e proprio ponte capace di creare una connessione tra la natura e la città. In tal senso il progetto si pone come il ponte che crea un legame tra i cittadini e il fiume Spree, fino ad ora sfondo dello sviluppo industriale della città e ridotto ad un bassissimo livello igienico.
Il fiume assume perciò una nuova immagine: quella di un posto di incontro e comunicazione. Si vuole suscitare una nuova consapevolezza del fiume e delle sue qualità: infatti come una goccia di acqua pulita, afferma lo stesso architetto, il progetto annuncia la possibilità di nuotare nel fiume, risollevandosi dalla sua immagine tradizionale.

Le piscine del mare
Molteplici sono gli esempi di piscine costruite ai margini costieri, che esplicano la volontà di antropizzare un luogo totalmente naturale e di renderlo un posto accessibile e più sicuro a tutti. Si tratta dunque di fondere insieme naturale e artificiale, adattando la necessità di svago allo sfondo naturale senza intaccarne in maniera totalizzante il contesto.
Le rocce, la sabbia il mare permangono comunque come elementi principali e da valorizzare, si prediligono costruzioni quasi mimetiche, che poco contrastino con l’ambiente naturale, prevalgono a strutture balneari visibili che si impongono sul contesto.
Swimming Pool / Fernando Menis
La piscina naturale dell’oceano Atlantico di Fernando Menis, costruita nel 1993, si trova a sud dell’isola di Tenerife (Canarie). La piscina di Menis è un richiamo all’azione naturale del mare che, scavando nella roccia, genera queste piscine.

Costruita in cemento e rivestita in pietra locale, dalla forma circolare, e dà affaccio diretto sull’Atlantico, si innesta nel contesto come un volume cementizio che si riempie e si rinnova con l’acqua dell’Oceano, esempio di un’architettura a basso costo: l’impatto sul paesaggio è minimo in termini di imposizione dell’architettura stessa sul contesto. Per la sua costruzione inoltre, è stato fatto riferimento al calendario delle maree per determinare i livelli dell’acqua di bassa e alta marea. Col passare del tempo, l’acqua ha eroso la roccia e vi si sono insediati licheni e alghe, tali da generare sempre più una stretta contaminazione della natura sull’artificio.
Vida della piscina
Pianta e sezione della piscina naturale di Fernando Menis
Carpa Oliveira, Colectivo Urbano
Carpa Oliveira / Colectivo Urbano
Viene costruita nel 1915, lungo la Olas Atlas Beac nei pressi del centro storico di Mazatlan (Messico), tuttavia l’esposizione alle intemperie e un urugano la devasta conducendola all’abbandono. Nel 2015, l’anno in cui lo studio di architettura Collettivo Urbano avvia un progetto di recupero del luogo, al fine di ripristinare le funzioni originarie. Il progetto prevede l’integrazione di un nuovo elemento, lo scivolo a spirale, un elemento definito come un “playful element”, capace di promuovere la riattivazione sociale dell’area.



Le piscine delle Maree / Alvaro Siza
Il complesso di piscine Leça, dell’architetto portoghese Alvaro Siza, si trova sulla costa settentrionale di Matosinhos, una piccola città a nord di Porto ed è stato costruito nel 1960.

Si tratta di un sistema balneare comprensivo di spogliatoi, un cafè e due piscine d’acqua salata, di cui una per adulti e una per bambini.
Giungendo da fuori la struttura non risulta visibile, poiché è collocata al di fuori della vista: il complesso risulta infatti abbassato rispetto alla quota della strada, ed è proprio grazie a questo espediente che Siza promuove una disconnessione totale tra le piscine e l’infrastruttura stradale della città, collegato e accessibile mediante un sistema di rampe parallele alla carreggiata.
Solo provenendo dal mare o dalla spiaggia è possibile scorgere il sistema di volumi, che costeggia la strada ma che ne risulta del tutto nascosto.
Duplice è la motivazione di tale scelta formale: la prima, quella di non voler minare la visibilità dell’oceano dalla strada, e la seconda, quella di disconnettere un posto naturale dal contesto urbanizzato.
Il progetto inoltre rappresenta la sintesi formale di un programma architettonico ben preciso: un progetto dalle forme semplici, a tratti confondibile, per grana e per colore, con le rocce della scogliera a cui fa da sfondo, il cui scopo è quello di ricavare uno spazio intermedio tra l’antico centro abitato e l’Atlantico, costituito da una serie di terrazzamenti e di piscine, riparato dai suoni provenienti dalla strada e che funga da connessione tra l’oceano e la terra.
Il complesso architettonico dunque, si insedia nel luogo in maniera del tutto graduale, parallelamente al percorso di chi vi si addentra, che viene dolcemente guidato da setti murari in calcestruzzo a faccia vista, seguendo un percorso sensoriale, in cui la vista cede lentamente il predominio della cognizione agli altri sensi, al suono dell’oceano che in crescendo si sente
Vista aerea della Piscina delle Maree
attraversando i camerini. L’accesso alle piscine è permesso mediante una rampa in cemento, parallela alla strada, che lungo il percorso, dà accesso agli spogliatoi e alle docce. Addentrandosi, mentre i muri, in calcestruzzo faccia a vista, oscurano lentamente la visuale dell’oceano, si avverte sempre di più il suono del mare Si gioca volutamente sulla prevalenza del senso dell’udito su quello della vista. Il programma architettonico si sviluppa secondo una lineare concatenazione di ambienti, puntualmente adattata alle variazioni di quota della costa Si ottiene così progressivo dipanarsi di episodi spaziali, raccordati da un percorso obbligato che lentamente conduce a mare. La struttura inoltre, non si impone con le sue forme nel contesto naturale della spiaggia, a tratti un po’ rocciosa e un po’ sabbiosa, poiché la volontà dell’architetto è quella di non intaccare l’ambiente naturale, bensì di preservarlo e valorizzarlo, e questa scelta si sintetizza tanto nella scelta dei materiali quanto nella composizione formale della struttura stessa tale da risultare semplice ma ricercata, sviluppandosi secondo una sequenza di piattaforme,dispaziapertiedispazicoperti,delimitatidasettiincalcestruzzo che individuano il percorso da compiere per arrivare alle piscine.
In ogni scelta di Siza si evince la volontà di non violare l’Oceano e il suo ambiente, diversamente prova a far sì che il suo progetto diventi parte di esso: la scelta del materiale che si riversa su un cemento duro, grezzo, che si mimetizza con il paesaggio, per colore e consistenza, la scelta di creare un senso di continuità facendo sì che la linea dell’oceano e quella della piscina sembrino coincidenti, ricreando dunque una connessione visiva dei due orizzonti, che peraltro sembra essere perseguita anche attraverso i tetti verde rame che si confondono con il colore dell’acqua.
Il volume degli spogliatoi e dei bagni è posto ad un livello intermedio, fungendo da elemento di congiunzione e transizione dei due contesti. Particolare attenzione è stata posta anche nel preservare gran parte delle
Vista della piscina per adulti

formazioni rocciose esistenti. Le piscine, infatti, si adagiano in maniera naturale sul litorale roccioso senza determinare una perimetrazione netta. Si giunge ad una sorta di fusione tra l’elemento artificiale in cemento e l’elemento naturale roccioso, permettendo così la riconciliazione tra natura e architettura, nel puro rispetto per la fascia costiera rocciosa. Nessun limite chiaro imposto dall’architetto tra artificiale e naturale nella sistemazione della scogliera. Le rocce penetrano il cemento delle piattaforme, le sabbie sfumano i bordi dei terrazzamenti. Nella piscina per adulti, i muri sprofondano nel mare e si fondono con la formazione roccioso, a perseguire quel senso di continuità, senza confini e transizioni, di paesaggio ininterrotto. La piscina per bambini invece, risulta maggiormente protetta, posta più all’interno e delimitata da un basso muro curvilineo di cemento a spezzare l’insieme delle forme rettilinea dei restanti volumi.

Vista della piscina minore

Parte II - Il Waterfront di Catania
Catania si affaccia sul mare per uno sviluppo totale di 15 km, su una costa che risulta diversificata. Si passa infatti, a partire da Sud, dalla spiaggia, determinata dai depositi sabbiosi continentali e marini, alla scogliera, nella fascia costiera Nord, determinata dalle diverse colate laviche.
In prossimità della stazione ferroviaria sono ancora esistenti i resti delle canne fumarie, a testimonianza della storica vicenda legata allo zolfo e alle sue raffinerie che hanno reso Catania protagonista nell’ambito dell’attività industriale di fine Ottocento.
Frutto di un rapporto diversificato nel tempo, il rapporto col mare si esplica dunque secondo una varia composizione di tipi edilizi, quali case terrane per i pescatori, ville, strutture per la balneazione, depositi e strutture ferroviarie. Questa diversificazione nel tempo ha condotto ad una condizione di scarsa fruibilità dell’area in termini fisici e percettivi, determinando una barriera tra il mare e l’entroterra. L’area litoranea caratterizzata dalla presenza della scogliera lavica, si estende a partire dal porto di Catania, fino a Cannizzaro per uno sviluppo di circa 8 km, e si presenta secondo una morfologia frastagliata, con cavità e anfratti prodotti dall’ininterrotta opera di erosione da parte del mare. Un tratto di due chilometri circa della fascia, compresa tra il Porto fino a Piazza Europa, è occupato dal sistema ferroviario che la separa nettamente dalla città, un altro tratto di due chilometri circa è occupato dall’area portuale e altrettanti due chilometri dipartono da Piazza Europa fino al
Porticciolo di Ognina, costituendo il Lungomare di Catania, la cui costa si assesta su quote comprese tra gli otto e gli undici metri di altezza dal mare.
In prossimità dei tre porti, il Porto Rossi, il porto di S. Giovanni e il Porto di Ognina, vi è un cambio di topografia per il quale la città raggiunge la quota del mare. I due borghi marinari, quello di S. Giovanni Li Cuti e quello di Ognina, seguono l’assetto del terreno, e si distaccano dalla città: il primo segue un abbassamento di quota pur costeggiando la strada principale, via Ruggero di Lauria, il secondo invece, viene precluso dalla presenza del ponte stradale, che passa al di sopra della piazza di Ognina, dividendo percettivamente il borgo di Ognina. Nell’area di Ognina, in corrispondenza del Porto Ulisse, che sorge presso una insenatura naturale, si trovano due spiagge, di cui una localizzata davanti la Chiesa Santa Maria di Ognina, ed utilizzato come banchina, mentre la seconda, localizzata più a Nord. All’estremità sud dell’area individuata del lungomare di Catania, vi è un’altra spiaggia storica, all’interno del borgo di S. Giovanni Li Cuti, di sabbia “nera” di origine vulcanica. Di notevole rilevanza naturalista sono i prodotti dei fenomeni erosivi marini quali per l’appunto grotte, archi e faraglioni di cui si parlerà in maniera più specifica nei paragrafi successivi dedicati alla morfologia costiera del Lungomare.
Individuazione della circoscrizione di pertinenza
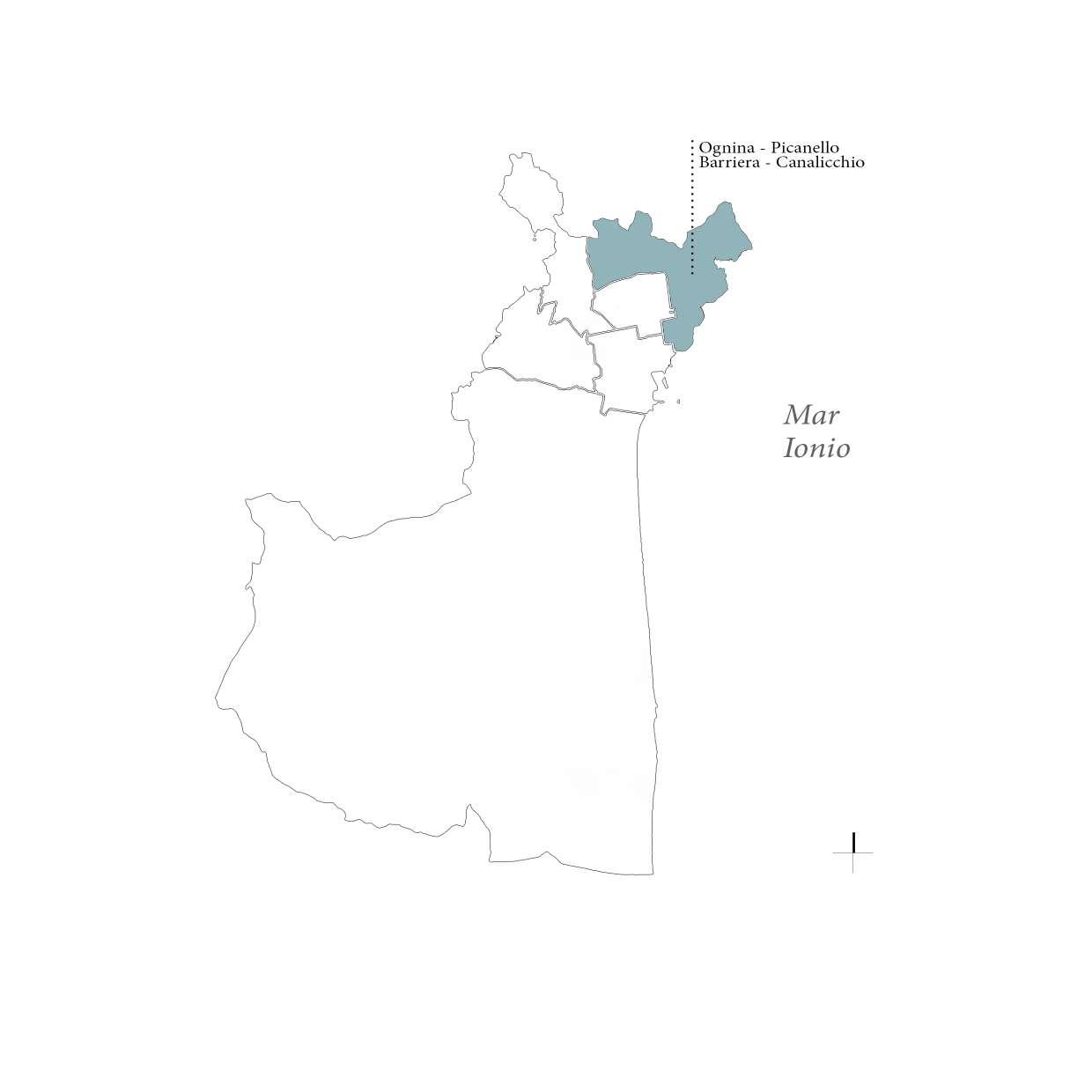
5_Lungomare di Catania

Inquadramento storico
Catania è una città di mare, e con esso vive un rapporto di simbiosi. È una città che ha fondato su questo rapporto il proprio carattere identitario, e ne ha fatto uno degli elementi fondativi, uno dei fattori che ha contribuito da definire la città nei suoi caratteri dominanti.
Il porto, costruito tra il 1600 e il 1800, diviene la manifestazione fisica di questo rapporto, e la sua realizzazione si rende necessaria a seguito della distruzione del vecchio porto dovuta all’evento devastante della colata lavica del 1381, la cui conseguenza fu un avanzamento della linea di costa di alcune centinaia di metri.
È negli anni della ricostruzione post terremoto del 1693, che il ruolo del porto passa in secondo piano, in favore di una nuova infrastruttura: la ferrovia. Con il suo avvento, la logica prevalente fu quella di utilizzare le aree facilmente accessibile, ossia quella costa, andando a determinare la cesura che di fatto ha portato all’allontanamento della città dal mare.
Individuazione dell’area di studio
Cenni urbanistici e il rapporto con il quartiere di Ognina
Il quartiere di Ognina comprende una porzione di territorio urbano di differenti origini ma in gran parte costituitasi nel XIX secolo a partire da quattro nuclei principali, da ricercarsi nei sobborghi di Ognina, Picanello, Barriera e Canalicchio.

Il borgo di Ognina si afferma come realtà a sé stante a causa della sua conformazione di piccolo golfo presso il quale si sono insediati i pescatori dello Jonio.
L’insenatura presso il quale sorge il borgo, è di natura vulcanica, infatti sono le eruzioni del Rotolo e del Crocifisso, risalenti al 6 Agosto del 1381, a determinarne l’attuale morfologia.
Prima delle grandi eruzioni, tuttavia, il borgo si presentava come un villaggio di marinai, e per lungo tempo ha assunto la conformazione di luogo adibito al transito delle merci, che dal suo grande porto noto in tutto il Mediterraneo come Porto di Ulisse, partiva o arrivava via mare, per avviarsi in tutti i paesi del mondo antico, ogni tipo di merce. A tutti gli effetti, la “baia di Lognina” era il porto di Catania e già ai tempi di Plinio il Vecchio (79 d.C) veniva indicato col nome di “porto di Ulisse”.
Per secoli esso rappresentò un punto di intenso traffico commerciale tra l’Europa e il Medio Oriente; con maggiore incremento durante il periodo di dominio romano che, in quel tempo, rappresentava gran parte del mondo civile. Ed è per questo che l’intera costa, che da Letojanni si estende fino alla Playa, trovandosi in una delle principali vie marittime di comunicazione del mondo greco-romano, è ricca di leggende pagane raccontate nell’Odissea da Omero.
Nei pressi della spiaggia di Ognina, sorgeva un tempietto dedicato ad Athena di Lognina, poiché la mitologia tramandava che essa avesse insegnato la navigazione agli uomini, successivamente viene sostituita dalla Madonna di Lognina, per la quale viene edificato il suo Santuario, l’attuale Parrocchia Santa Maria di Ognina.
Il susseguirsi di calamità, scatenatesi su Catania, ha portato alla cancellazione del disegno del tessuto, e nello specifico caso di Ognina, il terremoto e il maremoto del 1693 hanno cancellato ogni traccia di quella che doveva essere la precedente situazione. Dopo il terremoto, la ricostruzione di Catania viene affidata al Duca di Camastra, il quale base il piano di ricostruzione della città su un programma che seguiva nuove direttrici e tracciava la struttura della città secondo un impianto di assi ortogonali.
Si realizzano i primi collegamenti stradali, con botteghe e attività lungo i margini, comportando la formazione di piccoli nuclei abitativi.
Il nucleo di Ognina, comincia perciò ad assumere l’aspetto di borgo marinaro.
Fino all’800 viene considerato il limite ultimo del perimetro nord della città.
Fino al XIX pertanto mantiene la sua caratteristica di borgo autonomo, separato dalla restante città, tuttavia, è lo sviluppo dell’industria dello zolfo a comportare un significativo cambiamento nella struttura territoriale della Sicilia Orientale, cambiamento che ha coinvolto in maniera radicale anche il piccolo borgo marinaro.

Con la costruzione della ferrovia viene abbandonata la vecchia strada che collegava ad Ognina, oggi nota come Via Vecchia Ognina, per un nuovo percorso più vicino alla ferrovia e alle industrie: nell’arco temporale che va dal 1830 al 1835, viene realizzata la via Messina, strada che collegava la zona delle raffinerie.
La via Messina dunque, si scosta dalla via Vecchia Ognina, ripercorrendola fino a Piazza Santa Maria della Guardia, e prosegue fino alla via del Rotolo secondo un percorso rettilineo, fino a giungere alla zona del golfo di porto
Ulisse e per poi proseguire verso i paesi limitrofi della costa.
Successivamente, nel 1866, viene realizzata la tratta ferroviaria Messina –Catania, la quale comporta la necessità di tagliare in due il borgo, il quale, nello stesso periodo, vede procedere l’edificazione lungo le strade che collegavano in borgo alla città, fino ad integrarlo totalmente.
Nel periodo di fine Ottocento, si ha un impulso maggiore nello sviluppo della città che va a determinare una trasformazione nella struttura della stessa, e la sua espansione nelle zone suburbani, quali le zone di Cibali, Barriera, Picanello e Ognina.
Si tratta di aree prive di alcuno schema di pianificazione che si sviluppano per iniziativa privata. L’espansione spontanea di queste aree determina la nascita delle ville suburbane, prossime al mare: sono le case di villeggiature delle famiglie benestanti, e tra queste figurano le ville di Ognina, caratterizzate peraltro da una varietà di tipi edilizi, a testimonianza della compresenza delle differenti classi sociali insediate nel borgo.
È anche in questi anni, che sorge la piazza Mancini battaglia, la cui realizzazione si deve alla famiglia Mancini Battaglia.
Nel 1888, il piano del Cusa – Gentile, piano volto al risanamento del centro storicodellacittàdiCatania,prevedeinoltrel’ampliamentoel’urbanizzazione dei territori di collegamento tra la città e i suoi sobborghi, questo comprende anche lo sviluppo dell’area comprendente Picanello e Ognina. Nei primi del Novecento si assiste alla nascita dei primi lidi di balneazione lungo tutto il litorale, a partire dalla stazione sino ad Ognina: per iniziativa del barone Paolo Castorina, nascono, accanto all’attuale terrazza Balsamo i bagni pubblici “Porto Ulisse” e, nella costa dell’Armisi più a sud della Stazione
Ferroviaria, lo Stabilimento Balneare della famiglia Longombardo. Con la pubblicazione del bando di concorso del piano regolatore nel 1931, Ognina viene indicata come area d’espansione della città.

Infatti, la linea politica generale era quella volta all’ampliamento urbanistico e al risanamento delle aree centrali urbane. Per la città di Catania, questi sono gli anni in cui scontare una crescita disorganica, disorganizzata e periferica e il continuo aumento del degrado che segnava determinate zone del centro, tra cui S. Berillo, S. Cristoforo, Redentore, ma anche zone esterne, quali Borgo, Barriera e Cibali.
Si delinea nel Novecento una sempre più crescente domanda di nuovi spazi, che prende forza nelle successive ipotesi di PRG: nelle ipotesi del 1934 i temi della crescita urbana e dell’espansione diventano catalizzatori di tutte le attenzioni che mettono in secondo piano il rapporto della città col mare ridotto ormai al tema dello spostamento della linea ferroviarIa verso ovest e quello della bonifica dei terreni alluvionali della Plaja.

Il progetto di Piccinato prevedeva tre elementi principali: un inquadramento territoriale generale, un disegno delle zonizzazioni di espansione, configurate secondo un sistema di viabilità principale e secondaria, e infine, una definizione tipologica delle strutture edilizie principali.
Particolare attenzione viene posta nella cura delle nuove espansioni litoranee: si evince la strategia complessiva che si vuole adottare per strutturare il tessuto urbano di Catania, prevalentemente incentrata sullo spostamento della struttura ferroviaria, dalla fascia litoranea verso nord, così da liberare il lungomare, per collocare la nuova stazione centrale in posizione baricentrica rispetto alle zone d’espansione della città, quindi verso il sistema collinare.
In tal modo si vuole tentare di restituire la fascia costiera ad una funzione prevalentemente pubblica.
Nell’ambito della proposta, vengono dunque individuate le aree a sud della città per i nuovi grandi impianti litoranei e per gli impianti industriali e produttivi.
Negli anni Quaranta la città si mantiene sprovvista di un piano regolatore, sarà nei successivi anni Cinquanta – Sessanta, che, con la forte crescita demografica dovuta all’inurbamento dalle campagne, si assiste ad una significativa tendenza insediativa, la quale trova conferme nei programmi d’attuazione del PRG, secondo i quali vengono considerati prioritari quelli volti alla realizzazione del nuovo quartiere residenziale lungo la costa e la nuova circonvallazione.
Questi sono dunque, gli anni che segnano radicalmente l’intera area, compresa tra Corso Italia e Ognina, individuata dal Piccinato come area di elevata densità edilizia.
Il PRG infatti, ne ridisegna la struttura urbana, individuando aree di destinazione scolastica e aree destinate al verde pubblico, ma anche aree di destinazione ad attività balneari nella zona a ridosso del golfo, giungendo così alla cancellazione dell’antico borgo di Ognina.
Negli anni Settanta, con l’aumento del traffico veicolare, si rende necessaria la realizzazione di uno svincolo su due direzioni, uno verso Messina e uno di ritorno per Catania. Tuttavia, quello che si realizza è uno svincolo dalla pendenza troppo ripida.
Viene realizzato il cavalcavia, soprastante il Borgo, programmato per costituire un’importante struttura viaria di un moderno quartiere della città, con l’inconveniente però, di interrompere la continuità fisica e visiva del Borgo di Ognina.
Nella seconda metà degli anni ’90, la città rinnova il suo rapporto con il mare a seguito del dibattito circa l’elaborazione del PRG, nell’ambito del quale emerge una nuova consapevolezza e una nuova sensibilità che la città comincia ad esprimere in vista degli effetti negativi dell’espansione incontrollata, con la conseguente perdita di quei caratteri identitari. Così, nell’ambito dell’elaborazione del Piano Cervellati, viene ridefinito un nuovo rapporto tra il mare e la città lungo l’intero sviluppo della linea di costa del
territorio comunale, diventando uno dei punti principali, e proponendo dunque diverse ipotesi di uso della fascia costiera. Con lo Schema di Massima del 1998 si trova nuova conferma del rinnovato rapporto tra la città e il mare, da considerarsi “il fondamento del nuovo edificio urbanistico”. Vengono così definiti cinque ampi comprensori mediante i quali viene suddivisa la fascia costiera del territorio comunale: il comprensorio della costa dell’Oasi del Simeto, nel quale emergono esigenze di tutela naturalistica e ambientale, quello della Plaja e del suo entroterra, con la ristrutturazione delle aree destinate alla balneazione e con il recupero ambientale mediante rimboschimento, quello del faro Biscari e piazza Alcalà, quello tra il Porto e piazza Europa, volto al recupero della fruizione delle scogliere e con particolare attenzione per il sistema ferroviario, e infine quello tra piazza Europa e Cannizzaro, per la fruizione collettiva per la balneazione e per usi principalmente legati al tempo libero, interessando prevalentemente la modifica del viale Ruggero di Lauria convertendolo da asse viario di attraversamento a lungo – scogliera da sud fino alla Piazza Nettuno e provvedendo alla rivalorizzazione della aree pubbliche e dei due borghi storici, S. Giovanni Li Cuti e Ognina con il suo Porto di Ulisse.
Il “Programma del waterfront urbano di Catania”
Il programma del waterfront urbano di levante viene elaborato nel 2004 dalla Direzione urbanistica del Comune, con la collaborazione di Oriol Bohigas e dello studio MBM Arquitectes di Barcellona. L’intento è quello di rimodellare l’intero sistema urbano costiero ponendo le basi per una riorganizzazione dell’assetto infrastrutturale, a partire dall’area costiera che va da Piazza Europa sino al Porto di Ognina.
Il punto di partenza del progetto Bohigas è l’eliminazione della linea ferrata che separa la città dal mare, con l’interramento della stessa, includendovi la stazione ferroviaria, per mezzo della quale si vuole applicare una strategia di
recupero degli spazi aperti antistanti il mare. La Piazza Giovanni XXIII diventa uno dei cardini del nuovo assetto viario tramite l’innesto con le vie Archimede e Viale della Libertà e ne consente il collegamento veloce con il centro.
Il progetto prevede che Viale Africa venga rifondato come passeggiata a mare con traffico limitato, con marciapiedi larghi, presenza di verde, e strutture abitative basse a monte del tracciato. Mentre una nuova arteria, in fase di ultimazione, Via Alcide De Gasperi, costituisce l’alternativa di collegamento in senso sud con la circonvallazione ed il borgo di Ognina. Si vuole ripristinare un rapporto più funzionale con gli altri borghi marinari.
Il progetto si fonda sull’idea del waterfront, concepito come un’estensione della città verso il mare: i tessuti urbani giungono sino alla linea di costa come a segnare un prolungamento sul mare, e ciò è permesso attraverso la riqualificazione di alcuni assi viari di collegamento, alcuni dei quali già esistenti,comeviadelRotolo,lungoiqualisonostaticollocatedellevolumetrie
“simbolo”, a costituire l’accesso rappresentativo della zona litoranea. La città dunque si estende sul territorio seguendo la morfologia della costa e diventando anch’essa elemento paesaggistico della scogliera. L’intervento prevede l’inserimento di numerosi spazi attrezzati per attività legate al tempo libero, alternati alla presenza di volumetrie poste lungo i collegamenti principali, che diventeranno gli assi infrastrutturali e funzionali di connessione tra fascia urbana costiera e aree urbane più interne. L’idea progettuale è quella di trasferire la viabilità pesante ad ovest, su Via Alcide De Gasperi, strada già prevista nel Piano Regolatore del Piccinato negli anni ’60, tuttavia mai realizzata. Si rende possibile l’appalto del primo tratto tra Ognina e il Rotolo, per il futuro interramento della stazione ferroviarie e il riutilizzo delle aree liberate dai binari.
L’approccio di Bohigas verte su interventi singoli, che caratterizzano le diverse aree del waterfront: a partire da Sud, un intervento su Via VI Aprile, la ristrutturazione di un vecchio edificio all’interno del Porto, la ristrutturazione della vecchia dogana, e un intervento a carattere turistico sull’area di Faro Biscari. A Nord invece, sono previsti i seguenti interventi: l’abbattimento del ponte di Ognina, la riqualificazione del Porto di Ognina, la viabilità tra via del Rotolo ed Ognina (realizzato al 90%), il collegamento con via Alcide De Gasperi e più in generale la mobilità dell’intera area al fine di rendere a viabilità ridotta o pedonale Viale Ruggero di Lauria, finalizzata anche all’abbattimento del ponte davanti la Chiesa di Ognina. È inoltre previsto un parcheggio interrato nella zona di Piazza Europa, oggi realizzato. L’elaborazione progettuale di Bohigas, prevede inoltre, di sfruttare il dislivello sui 10 – 12 metri tra via de Gasperi e Viale Artale Alagona, per realizzare parcheggi ma anche attività culturali e ricreative, al fine di rendere più attrattivo il fronte mare.
Progetto urbano definitivo del tratto costiero compreso tra piazza Europa e Ognina
L’elaborazione progettuale dello studio MBM prevede dunque la ricucitura di questi borghi con la città. Per quanto concerne la viabilità, le modifiche prevedono che la via De Gasperi si sviluppi ad un livello superiore, tra i 14 m e 16 m dal livello del mare, raccordandosi alle quote degli edifici esistenti, e che sia costituita da due carreggiate di 7 m (ognuna per un senso di circolazione) e lungo il suo viluppo a partire da Piazza Europa ad Ognina, si inseriscano due carreggiate ausiliari di 6 m. In prossimità di S. Giovanni Li Cuti, la via Alcide de Gasperi è tangente al viale Ruggero di Lauria, tuttavia vi è una differenza di livello tra le due strade, sfruttata per collegarvi il parcheggio e diverse attività commerciali.
La via Alcide de Gasperi è così raccordata al Viale Ruggero di Lauria mediante
due rotatorie, una in corrispondenza di via del Rotolo e una più a Nord, cui convergono i due assi che fungono da collegamento tra la strada a monte e quella costiera.
Questi due assi, perpendicolari allo sviluppo costiero, sono dunque costituiti da una sezione stradale di 21 m, due carreggiate di 6 m l’una, e separate da un alberato di 5 m. Si viene a delineare un ordine costituito dai due assi perpendicolari alla costa, in particolare via del Rotolo assume un ruolo centrale nella riconfigurazione della nuova zona.
Nel medesimo ambito sono inoltre previste due torri, costituenti una sorta di “porta” della città sul mare, e un ampio giardino retrostante, inoltre, si prevede la creazione di un sistema di isolati, per un totale di cinque isolati organizzati a corte con patii interni in cui sono pensati dei giardini. Sono previsti inoltre, una scuola, nuove infrastrutture sportive e un parco urbano. Lungo lo sviluppo del lungomare si prevede un sistema di chioschi e pergole destinati a caffetterie, ristoranti e servizi per il tempo libero.
Da piazza Europa ad Ognina viene definito un sistema di spazi pubblici, ognuno con caratteristiche peculiari.
Nel borgo di S. Giovanni Li Cuti è prevista una passeggiata tra le case e i balneari, che segue l’andamento del terreno e dunque passando da una quota di 8 metri ad una di 3, e scandita da un sistema di pergole ad enfatizzare la forma radiale della costa.
L’intenzione è quella di creare permeabilità tra la città e il borgo risolvendo la differenza di quota che sussiste tra le due. Si è pensato dunque, ad un sistema articolato su tre livelli. Il primo livello è quello della via de Gasperi, il livello intermedio è costituito dal parcheggio interrato e le attività commerciali che costituiscono una vera e propria facciata urbana di via Ruggero di Lauria definendone il fronte, e infine, il livello del borgo, accessibile mediante una strada di raccordo dalla forte pendenza, e il cui fronte mare si sviluppa
parallelamente alla strada ed è scandito dalle cinque pergole di cui sopra
Il lungomare, nel suo intero sviluppo di 5 km, viene concepito come un’estensione verso il mare della città che si adagia sulla costa, divenendo un elemento paesaggistico, ma al contempo finalizzato ad ospitare spazi per la contemplazione, lo sport, il gioco e attività legate al tempo libero, come manifestazioni ed eventi, costituendo una passeggiata alberata e riservata al pedone.
La piazza Nettuno viene ridisegnata e l’ampio tratto di lungomare che si estende davanti le torri costituisce la quinta delle torri verso il mare.
Le torri infatti, si ergono su un ampio spazio pubblico, organizzato con giardini, specchi d’acqua e percorsi. Nella parte retrostante alle torri è stato pensato l’accesso al parcheggio sotterrano, corrispondente ai giardini.
Un altro giardino è stato pensato e collocato laddove oggi sorge L’istituto Nautico mentre in corrispondenza di via De Gasperi, si è pensato ad un parco urbano e al lato di quest’ultimo un parco sportivo, dotato di piscina, campo da tennis e spogliatoi.
All’estremità nord del lungomare, il sistema Ognina – Battaglia, con il porto Ulisse, è concepito come un unico spazio urbano in cui convivono molteplici attività: quelle dei pescatori locali, le attività nautiche e sportive, l’ormeggio delle imbarcazioni.
La scala ridotta del borgo di Ognina è un invito alla contemplazione del mare, della pesca e delle attività legate alla vita associativa lungo la strada e all’appropriazione dello spazio pubblico come luogo di scambio e di incontro.
La Piazza di Ognina viene riorganizzata secondo la configurazione di piazza centrale del borgo e nella sua relazione con il mare, e viene raccordata alla Piazza Mancini Battaglia, per mezzo di una passeggiata bordo – mare che segue l’estensione dei moli del porto.
La piazza Mancini Battaglia viene ridefinita per recuperare la sua
connotazione di piazza urbana al di là delle due rampe di collegamento con la circonvallazione, riprogettate proprio per abbassarne la quota, in quanto dapprima progettate secondo una pendenza molto ripida. Qui la piazza si presenta con un doppio ordine di palme, una zona pavimentata che termina con una gradonata di raccordo tale da creare una seduta sul fronte mare.
Il sistema dei parcheggi pensato dallo studio MBM Arquitectes, sfrutta le differenze di quote e si articola in più aree puntuali, come per esempio a S.
Giovanni Li Cuti e piazza Mancini Battaglia, oppure in grandi spazi verdi, in corrispondenza dei quali sono presenti parcheggi sotterranei, come in via del Rotolo.
La città di Catania infatti, è invasa da auto parcheggiate in modo caotico su piazze, marciapiedi e spazi pedonali. L’obiettivo è quello di promuovere la realizzazione di numerosi parcheggi così da svuotare le strade e incentivare l’uso di trasporti pubblici urbani ed extra urbani. Oltre al sistema di parcheggi sotterranei, sono definiti parcheggi di superficie per brevi soste dislocati lungo la via de Gasperi, in Piazza del Tricolore, in corrispondenza del molo del Porto Ulisse e infine in prossimità della stazione del treno Ognina.
In conclusione, il progetto elaborato dallo studio MBM Arquitectes presenta il primo passo verso la riqualificazione della fascia nord costiera di Catania, trattando con maggiore precisione le aree del lungomare, le piazze, gli spazi pubblici e persino l’arredo urbano, come la pavimentazione, i chioschi l’illuminazione.
Progetto urbano del tratto costiero compreso tra piazza Europa e Ognina 2003 - 2004

Morfologia del territorio
L’attuale assetto geomorfologico di Catania, costruita alle falde dell’Etna, è il risultato di diversi processi, tra cui particolare importanza hanno gli eventi vulcanici e sismici che hanno sconvolto la città nel corso della sua storia Le eruzioni vulcaniche sin da sempre provocato mutamenti morfologici che hanno man mano modellato il territorio modificandone la linea costiera. Catania è stata prevalentemente costruita su colate laviche, le quali si sono consolidate su tessuti urbani preesistenti e ne hanno formato la base del suo territorio.
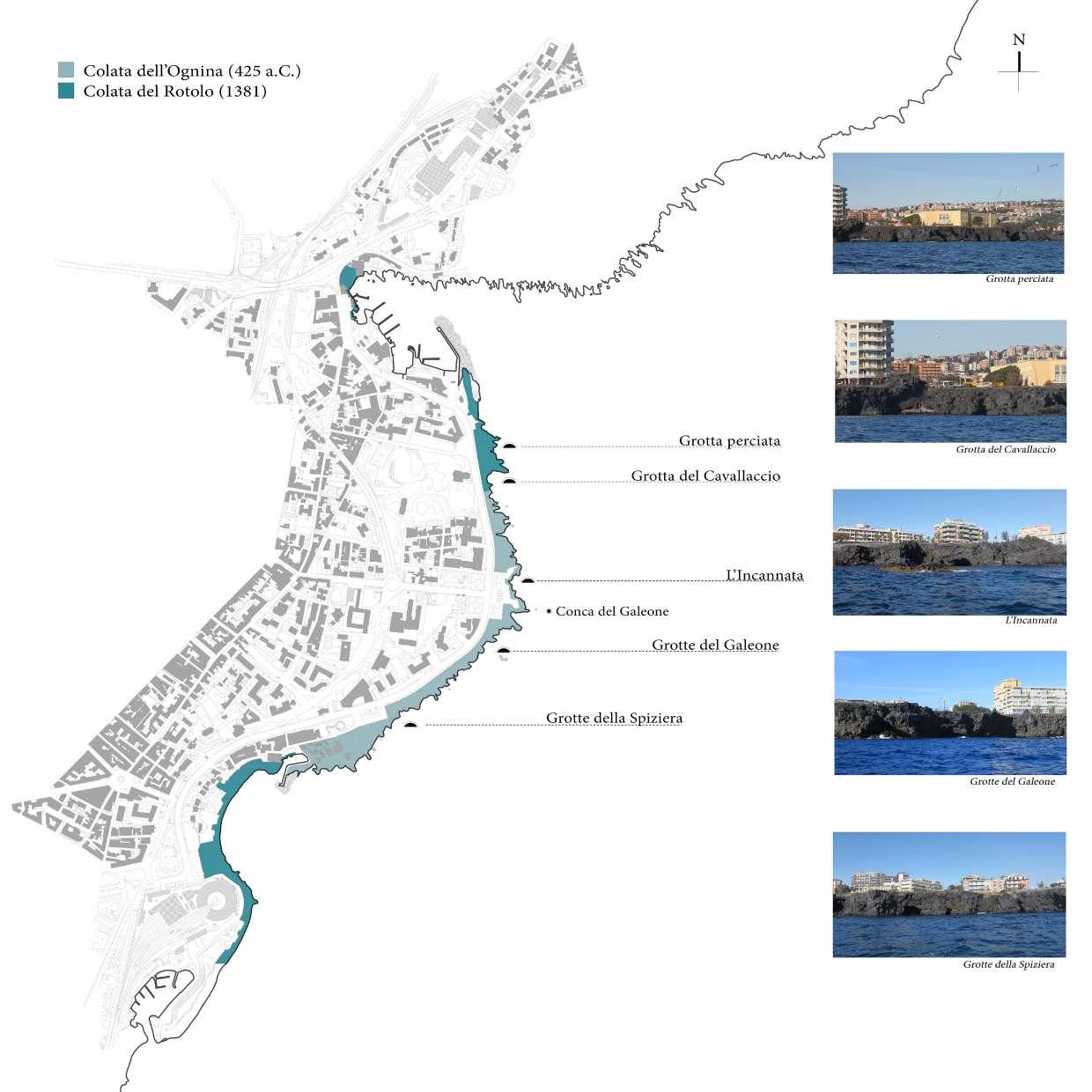
L’attività vulcanica ha provocato notevoli trasformazioni del territorio, infatti precedentemente alle prime colate laviche, la linea di costa era spostata molto più ad ovest.
Le prime colate storiche sono quelle di “Santa Sofia” e quella dell’Armisi”, le quali si sono spinte in direzione est sul mare ionico andando a conformare la scogliera dell’Armisi, mentre con le colate del “Longona”, si ha la prima trasformazione del litorale con la formazione di un’ampia insenatura, dove viene localizzato l’antico porto. Nel 1381 si ha la colata del “Rotolo” e successivamente quella de “Crocifisso”. Queste due colate sono quelle che vanno a conformare l’attuale fisionomia della costa di Ognina: le colate hanno completamente seppellito l’insenatura e si sono riversate sul mare dando origine alle scogliere nere che costituiscono il perimetro frastagliato, ricco di archi e grotte. Invece, le colate successive sono quelle del 1669 che si riversano in direzione sud, intorno al Castello Ursino, costruito allora come baluardo in riva al mare.
Nell’ambito costiero catanese, sono rilevanti le seguenti colate laviche: quella di Ognina, risalente al 425 a.C. e quella del Rotolo, risalente al 1381.
morfologica - Le Grotte
Colata dell’Ognina (425 a.C.)
Queste lave hanno costituito la scogliera lunga 1,5 km e alta fino a 10 metri tra Ognina e il Golfo di Guardia, e sono conosciute come le lave di Ognina. L’evento eruttivo, storicamente collocabile nel 425 a.C., viene raccontato da Tucidide, Strabone e Pindaro. Si decide di dare credito alla versione tucididea dell’evento, e alla sua data, anche se è più verosimile il fatto che tale colata sia in realtà il frutto di più eruzioni le cui lave abbiano seguito all’incirca lo stesso percorso.
La lava occupa parte del litorale del golfo di Ognina e risulta ricoperta quasi interamente da altre colate sopravvenute negli anni successivi. Una caratteristica di queste lave è quella di presentare una morfologia a corde, ben visibile dal lungomare di Catania.
Colata del Rotolo (1381)
Viene descritta da Simone da Lentini, nel suo Chronicon: la lava giunge fino al mare riversandosi nelle piccole baie di Ognina e Guardia, dopo aver invaso i quartieri odierni di Barriera, Canalicchio, Picanello e Guardia – Ognina. Nel passato si erano distinte due fasi eruttive: la prima era quella del Crocifisso mentre la seconda del Rotolo.
Le grotte
LascoglierafrastagliatadelLungomareoffreunprofiloriccodigrotte,anfratti ed archi, che sono nascosti alla vista di chi vi passeggia. Alcune di queste grotte sono visibili solo dal mare, altre è possibile scorgerle più facilmente.
“A Spiziera” (La Speziera)
Partendo dall’estremità sud del Lungomare, immediatamente dopo il porticciolo di S. Giovanni Licuti, e in corrispondenza della Piazza del Tricolore, si può scorgere questo grosso scoglio denominato “scugghiazzu”, accanto al quale sono presenti tre grotte, da cui il nome “Spiziera” per la presenza di una piccola fabbrica di prodotti medicinali.
“U Jaliuni” (Il Galeone)
Proseguendo la passeggiata in direzione nord, poco prima di giungere in Piazza Nettuno, si trova un frangente, “La punta del Galeone” seguito più a nord da una conca, detta “conca del Galeone”, il cui nome deriva dai naufragi di diversi galeoni avvenuti nel passato nel medesimo punto
“L’incannatu” (L’Incannata)
Lasciato il frangente del Galeone, immediatamente dopo, si può scorgere invece L’Incannata: si tratta di una piccola cala ai piedi di un grande costone di roccia, il cui nome deriva dall’usanza dei pescatori catanesi di creare delle particolari trappole per poter impedire la fuga ai cefali presenti in quella zona. Le trappole erano costituite da una doppia rete, una detta “tònira” che veniva disposta verticalmente, l’altra invece veniva distesa orizzontalmente e mantenuta a galla. In tal maniera si sfruttava la conformazione della cala per riuscire nell’intento.
“U
Cavaddazzu” (Il Cavallaccio)
Come accade per molti luoghi di Catania, anche questa grotta si lega alla leggenda di un fantasma, di cui circolavano notizie vaghe, e che manteneva lontani i visitatori.
“A Rutta Pirciata” (La grotta forata) La punta di Santa Maria
Vista dal mare della grotta “perciata”

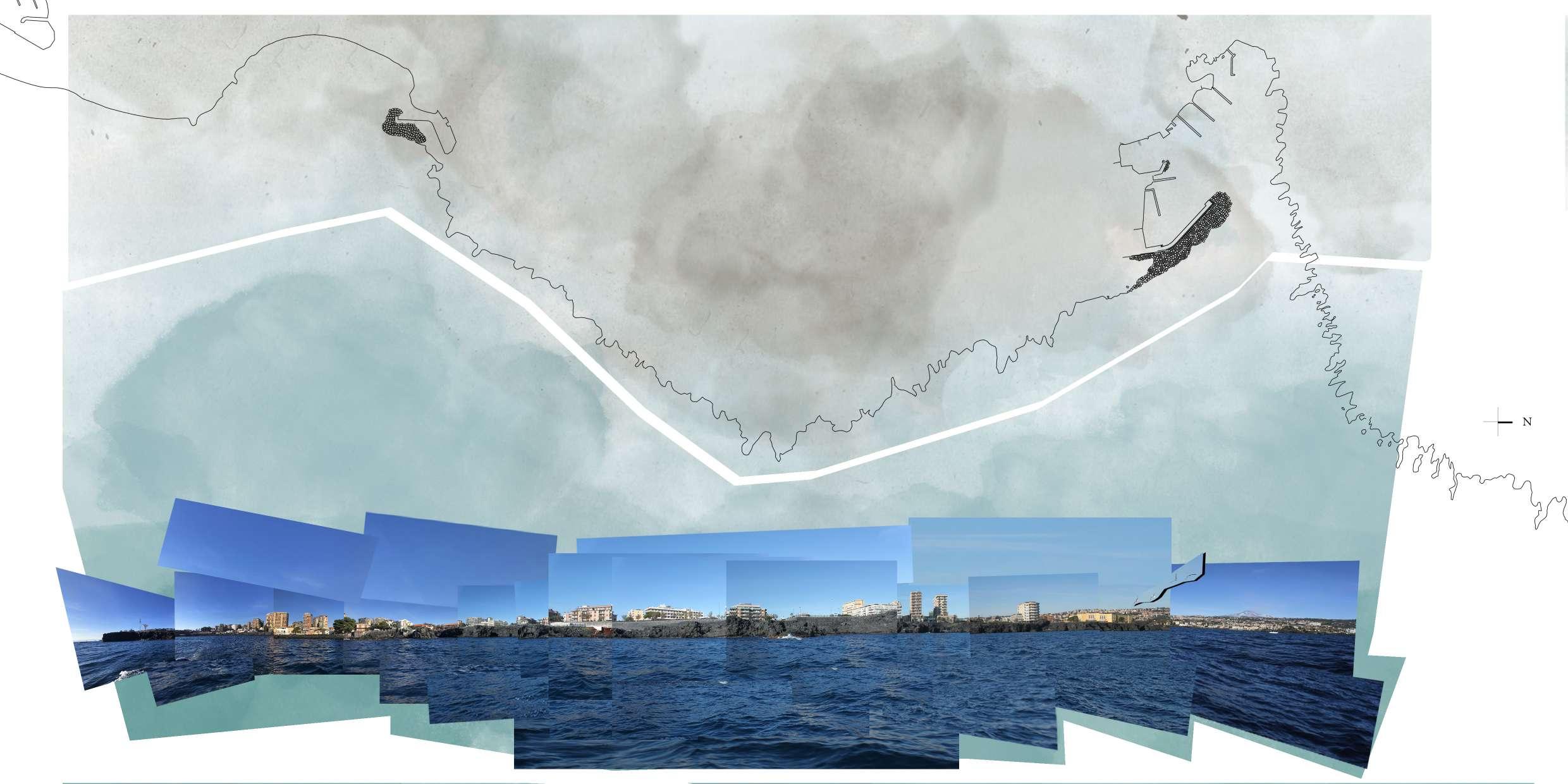
Sistema della mobilità
Nei paragrafi precedenti, si è parlato della storia urbanistica di Catania, e si è visto come l’intero litorale sia stato frequentemente oggetto di studio. Il caso del lungomare presenta oggi delle serie criticità: quella che dovrebbe essere una passeggiata interamente rivolta al cittadino, è contrariamente una strada statale (SS114) che costeggia l’intero perimetro costiero e si configura come una sorta di prolungamento della circonvallazione, è un’arteria litoranea urbana che riceve il traffico veicolare pendolare proveniente da Cannizzaro e da Acicastello.
A partire da Piazza Europa, la SS114 prende il nome di Viale Ruggero di Lauria e fiancheggia il tratto sud del Lungomare di Catania fino a Piazza Nettuno, mentre prende il nome di viale Artale Alagona, dalla piazza stessa fino ad immettersi in Viale Ulisse, che si sviluppa lungo l’asse Ovest – Est. Essa presenta due carreggiate con ciascuna doppio senso di marcia, per una sezione stradale di 14 m in totale.
Viale Alcide De Gasperi e la strada statale SS114 sono connesse da diverse strade secondarie, tuttavia tra queste è significativo il collegamento di via del Rotolo, che si innesta perpendicolarmente in Viale Ruggero di Lauria in corrispondenza di Piazza Nettuno e con la sua rotatoria, connette il perimetro costiero a Via Messina e via Galatioto, due arterie stradali interne, ma con un unico senso di marcia, che connettono Ognina – Guardia alla circonvallazione di Catania.

La SS114 è costeggiata da una pista ciclabile, che parte in corrispondenza di piazza Europa e segue l’intero tratto del Lungomare per 2 km circa, interrompendosi bruscamente immediatamente dopo la piazza Mancini Battaglia per immettersi all’imbocco della circonvallazione. Presenta superfici regolari, senza asperità dovute a botole dei sottoservizi a garantire
Sistemi lineari - Mobilità carrabile
la sicurezza dei ciclisti. Presenta anch’essa due corsie per senso di marcia protette da un cordolo e verniciate con colori antiscivolo, ciascuna larga 1.25 m. È inoltre definita una pista di larghezza 1 m per il running. La zona è inoltre servita da linee di trasporto pubblico, che collegano il territorio comunale con il comune di Aci Castello e la frazione di Aci Trezza
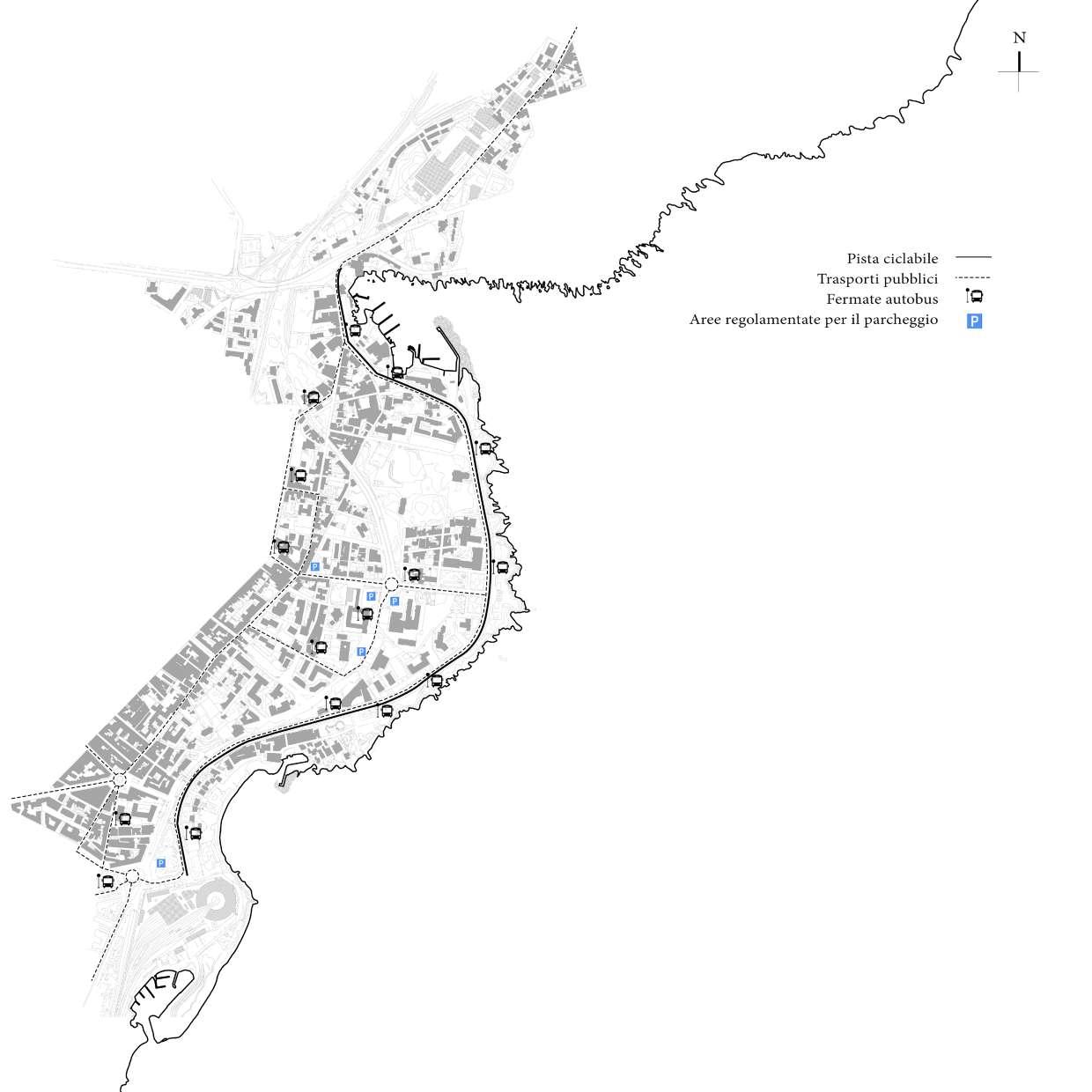
Per quanto concerne la viabilità pedonale, è presente un lungo marciapiede sul lato destro del viale, intervallato da un sistema di piazze, a partire da piazza Europa, passando per Piazza del Tricolore, per Piazza Nettuno, per arrivare infine alla piazza Mancini Battaglia. Il lato sinistro dell’intero sviluppo invece, presenta un marciapiede di estensione ridotta, e inoltre, costeggiato da posteggi di superficie.
Sistemi lineari - Mobilità pubblica e ciclabile
Relazioni esistenti
Dall’analisi effettuata sull’uso del suolo di una porzione di tessuto del quartiere di Ognina – Picanello, è possibile distinguere due aree, la prima delle quali, individuata ad ovest di via Alcide De Gasperi, si sviluppa longitudinalmente lungo l’asse Nord-Sud, e si presenta prevalentemente come una zona omogenea a carattere prevalentemente residenziale e misto, nella quale la maggior parte degli edifici residenziali presenta il piano terra adibito ad uso commerciale. Ad est della via Alcide De Gasperi, il tessuto si presenta già secondo una morfologia più irregolare, e data la vicinanza con il litorale, la gran parte di edifici e tessuti misti presenta il piano terra adibito ad uso commerciale e prevalentemente legato ad attività marittime. Questa caratteristica è per lo più riscontrabile nei due borghi, posizionati alle estremità del tessuto in analisi: la porzione Sud - Est dell’area analizzata coincide con il borgo di San Giovanni Li Cuti, dove il carattere è in prevalenza residenziale o misto con presenza di edifici isolati, mentre la porzione Nord – Est coincide con il borgo di Ognina, anche qui con prevalenza residenziale o mista, e in particolare le attività commerciali presenti si legano alle attività di pesca che caratterizzano il borgo. In prossimità della zona centrale, corrispondente a Piazza Nettuno, è possibile distinguere un’ampia zona di verde incolto. Lungo l’intero litorale, si sviluppa un’area eterogenea, con edifici di tipo specialistico, legati alle attività marittime: lidi, attività commerciali legate alla pesca e agli sport acquatici, l’Istituto Tecnico Nautico Duca degli Abruzzi, attività di ristorazione e attività portuali. Inoltre, si susseguono diverse piazze, spazi pubblici e aree adibite a verde di cui si farà una specifica analisi nei paragrafi successivi. È presente dunque, una varietà nell’uso del suolo che rende evidente l’influenza del mare sull’attività insediativa della zona.
Uso del suolo

Vengono individuate le relazioni che l’uomo ha instaurato con il litorale roccioso: a partire dal sistema della balneazione, dai solarium pubblici ai lidi, alle aree dedicate al divertimento e allo svago, tra giostre, paninerie ambulanti, il campo da basket e l’area fitness, la costa si configura come un sistema di interazioni e attività tutte interamente dedicate al relax e al tempo libero.


Analisi delle problematiche
Mobilità
Le criticità che affliggono il litorale sono principalmente legate alla mobilità.
Tale criticità sussiste tutt’oggi e nonostante nel corso dei decenni siano state pensate delle alternative, la presenza di una strada a scorrimento veloce continua a frapporsi tra il mare e il cittadino, impedendone qualsivoglia accesso.
Dapprima, con il piano di Piccinato, e a seguire il progetto di Bohigas, si era previsto l’uso quasi esclusivo di via Alcide de Gasperi per la mobilità pesante, tuttavia, il tratto si interrompe bruscamente senza essere mai stato completato e dunque mai connesso al Viale Ulisse.
Via Ruggero di Lauria, oltre a presentarsi come un tratto ad alto scorrimento, presentaancheproblematichecircalacongestionedeltraffico,particolarmente rilevante negli snodi principali: all’imbocco della circonvallazione (Viale Ulisse), in direzione Cannizzaro. L’area localizzata peraltro, si presenta come il fulcro di svariate attività: essa si trova infatti, in prossimità del porticciolo, laddove sono presenti le strutture del Circolo di Canoa ma anche la banchina dove ormeggiano innumerevoli imbarcazioni, mentre sul fronte opposto sono presenti numerose attività di ristorazione e commerciali. La zona è pertanto facilmente congestionabile, e sicuramente aggravata dalla presenza di posteggi non regolarizzati. L’intenso traffico veicolare, la sua velocità e l’ampiezza eccessiva della sezione stradale e l’elevato rischio di incidenti dovuti all’alta velocità risultano compromettenti quella che dovrebbe essere la naturale funzione di un litorale, ossia quello di una lenta e rigenerativa passeggiata tra la costa e il mare.
Accessibilità e degrado
Soffermandosi sulle problematiche che affliggono l’intera area, possiamo subito ricondurci al problema generale della mancata accessibilità al mare.
Si è visto nei paragrafi precedenti, come Catania, nel corso della storia, abbia negato ai suoi cittadini qualsivoglia dialogo con il mare, se non lasciando alla libera fruizione tratti di limitata estensione che identifichiamo nella spiaggia nera di origine vulcanica di S. Giovanni Li Cuti, nei pochi tratti accessibili della scogliera del lungomare e, per quanto riguarda la zona della Plaja, sono presenti lidi e spiagge libere. La spiaggetta di Ognina non è resa fruibile a causa dell’ingombro delle molteplici imbarcazioni le quali ostacolano la balneazione.
Sono realizzati due solarium nella stagione estiva, che permettono di accedere al mare, rispettivamente ad Ognina e in corrispondenza di Piazza Europa.
La balneazione non è tuttavia l’unico problema riferito all’accessibilità del mare.
Illungomareinfatti,siconfiguracomeunsempliceaffacciochepocovalorizza la sua scogliera dall’alto valore paesaggistico, l’accesso al mare è negato da una recinzione che si frappone tra il visitatore e la scogliera, limitandolo alla semplice visuale.
Da questa considerazione perciò sorge spontanea la volontà di ricucire e riconnettere quel legame tanto agognato quanto ostacolato, tra la città e il suo mare.
Dimensione del pedone
La funzione del litorale roccioso catanese risulta perciò quella di un collegamento stradale, nell’ambito del quale al pedone viene destinato uno stretto marciapiede a ridosso della scogliera da cui può solamente godere della vista.
Spazi pubblici lungo la costa
Si è osservato in precedenza un sistema di diverse piazze e spazi pubblici che costeggia il litorale. Tra questi figurano diverse piazze, la prima delle quali, a partire da Sud, Piazza Europa, che segna il nodo iniziale in cui si incardinano tre arterie importanti, quali Corso Italia, Viale Africa e Viale Ruggero di Lauria. A seguire, lungo viale Ruggero di Lauria, s’innesta abbassandosi di quota, il borgo di San Giovanni Li Cuti, il quale si presenta per lo più come un’appendice all’arteria stradale, e si ricongiunge ad essa mediante la piazza del Tricolore, che fa, dunque, da spazio di connessione tra l’estremità Nord del borgo e Viale Ruggero di Lauria. Proseguendo in direzione Nord, si taglia il sistema di piazze costituenti Piazza Nettuno, si passa per il largo che costituisce la punta est del Viale Artale Alagona, dal quale diparte il molo, e infine, passando al di sopra del borgo di Ognina attraverso il cavalcavia si giunge all’estremità Nord del litorale corrispondente a Piazza Mancini Battaglia.
Segue pertanto un’analisi di questi spazi pubblici secondo diverse categorie.
A tal fine vengono presi in considerazione elementi di confort che rendono lo spazio pubblico vivibile, accessibile e attrattivo, elementi legati alle attività sociali che permettono la frequentazione e la permanenza nei luoghi da parte di una utenza diversificata (famiglie, anziani, giovani, disabili, bambini), elementi legati alle attività di ristorazione nelle diverse forme, dalle attività fisse alle attività ambulanti tipiche della zona, elementi legati al valore storico del luogo e infine, elementi che esplicano il rapporto che il luogo instaura con l’acqua, diretto o indiretto, naturale o artificiale, o del tutto assente o negato.
Analisi degli spazi pubblici lungo la costa

Piazza Europa
Comfort
Una parte della piazza è stata recentemente riqualificata e si configura secondo un sistema di due livelli: un livello corrispondente alla quota del terreno e un livello interrato. Entrambi i livelli presentano aree di seduta, zone d’ombra, aree adibite a verde organizzato.
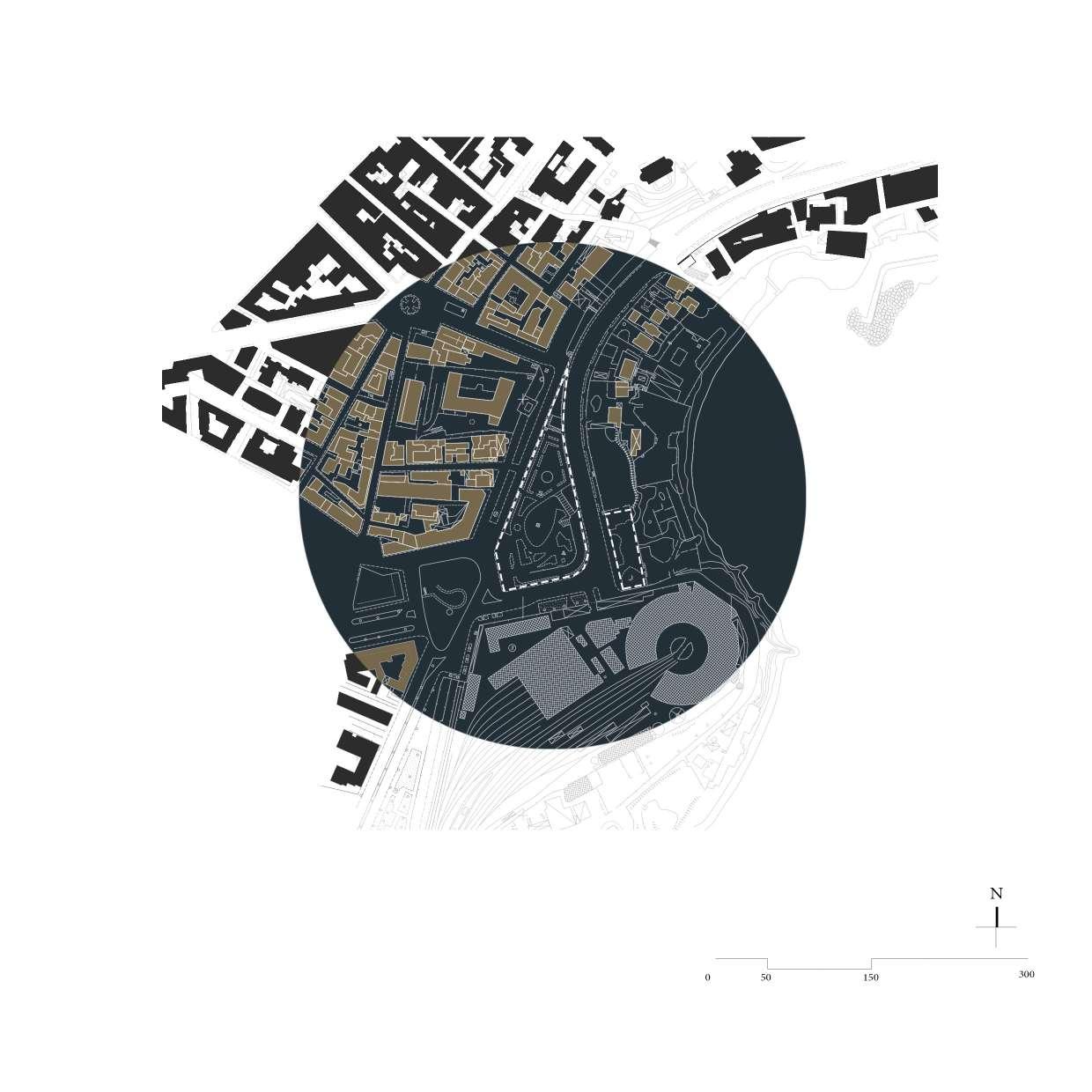
Attività sociali
La piazza, al livello corrispondente alla quota del terreno, ospita un giardino organizzato in fasce e alternato a sedute lineari che si sviluppano in direzione delle vetrate di affaccio sul mare, diventando luogo di ritrovo per giovani. Il livello interrato invece accoglie diverse tipologie di spazi, destinati ad ospitare laboratori, attività didattiche, ludiche e commerciali.
Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
In corrispondenza del piano interrato, sono presenti numerosi locali, bar e ristoranti che rendono il luogo frequentato nelle ore prevalentemente serali e notturne.
A dividere la parte nuova dalla parte vecchia di Piazza Europa, è la garitta militare spagnola, costruita come torre di avvistamento su uno sperone di roccia lavica, tra il 1552 e il 1574 sotto il regno di Carlo V,
La piazza instaura un rapporto indiretto con il mare tramite un affaccio vetrato.
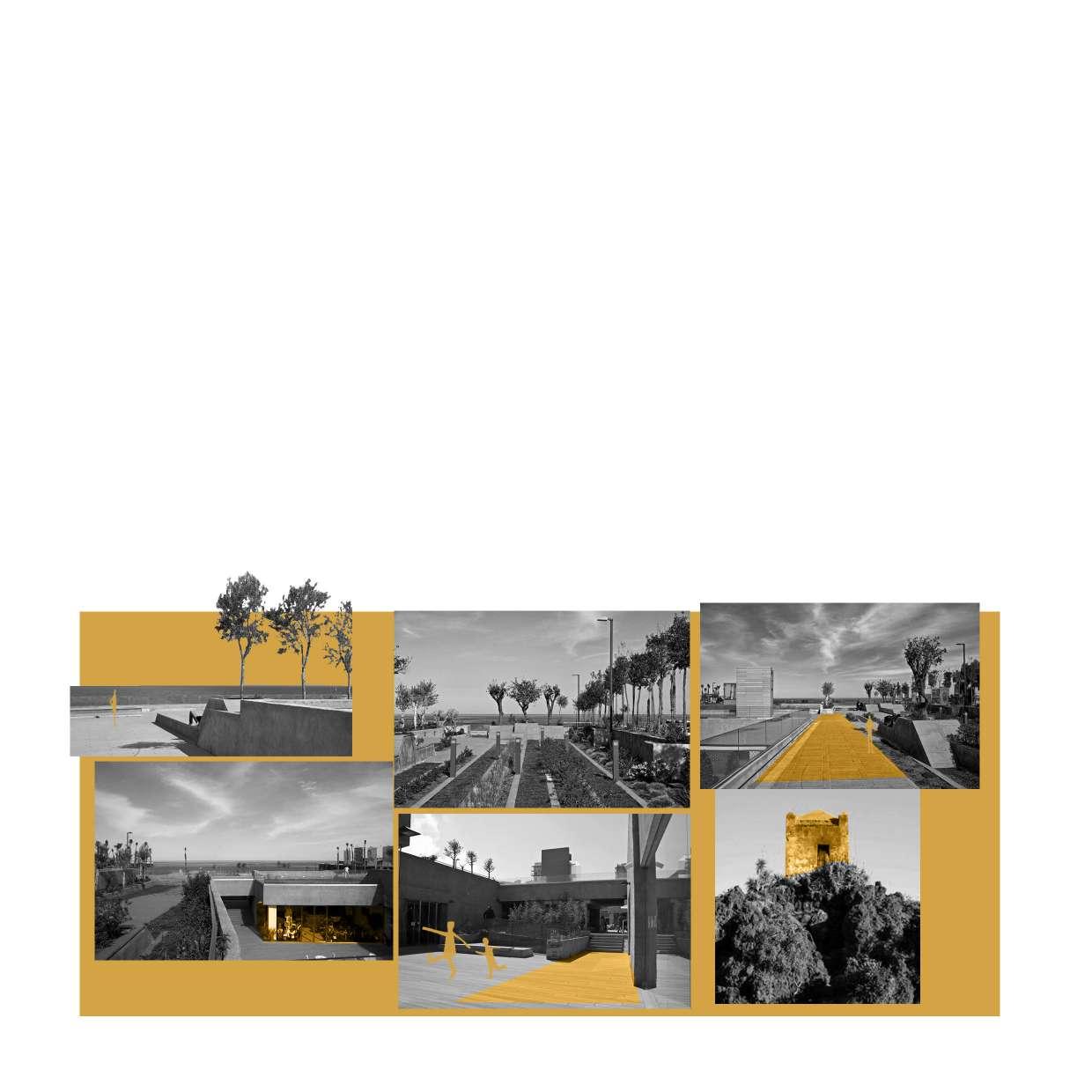
Comfort
Diverse panchine e fontanelle sono dislocate lungo la discesa costituente la stradina principale del borgo di San Giovanni Li Cuti. Inoltre il Borgo offre altre sedute e spazi di sosta nella piazza principale che si affaccia direttamente sul molo.
Attività sociali Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
L’attività principale in cui si identifica il luogo è quello della balneazione, non necessariamente limitata al periodo estivo: la spiaggia di San Giovanni Li Cuti si presenta come un luogo di incontro e di relax per giovani, per famiglie e per anziani.
Lungo la strada principale del borgo sono dislocati diversi locali e ristoranti che rendono la zona frequentata, con maggiore intensità nel periodo estivo - primaverile.
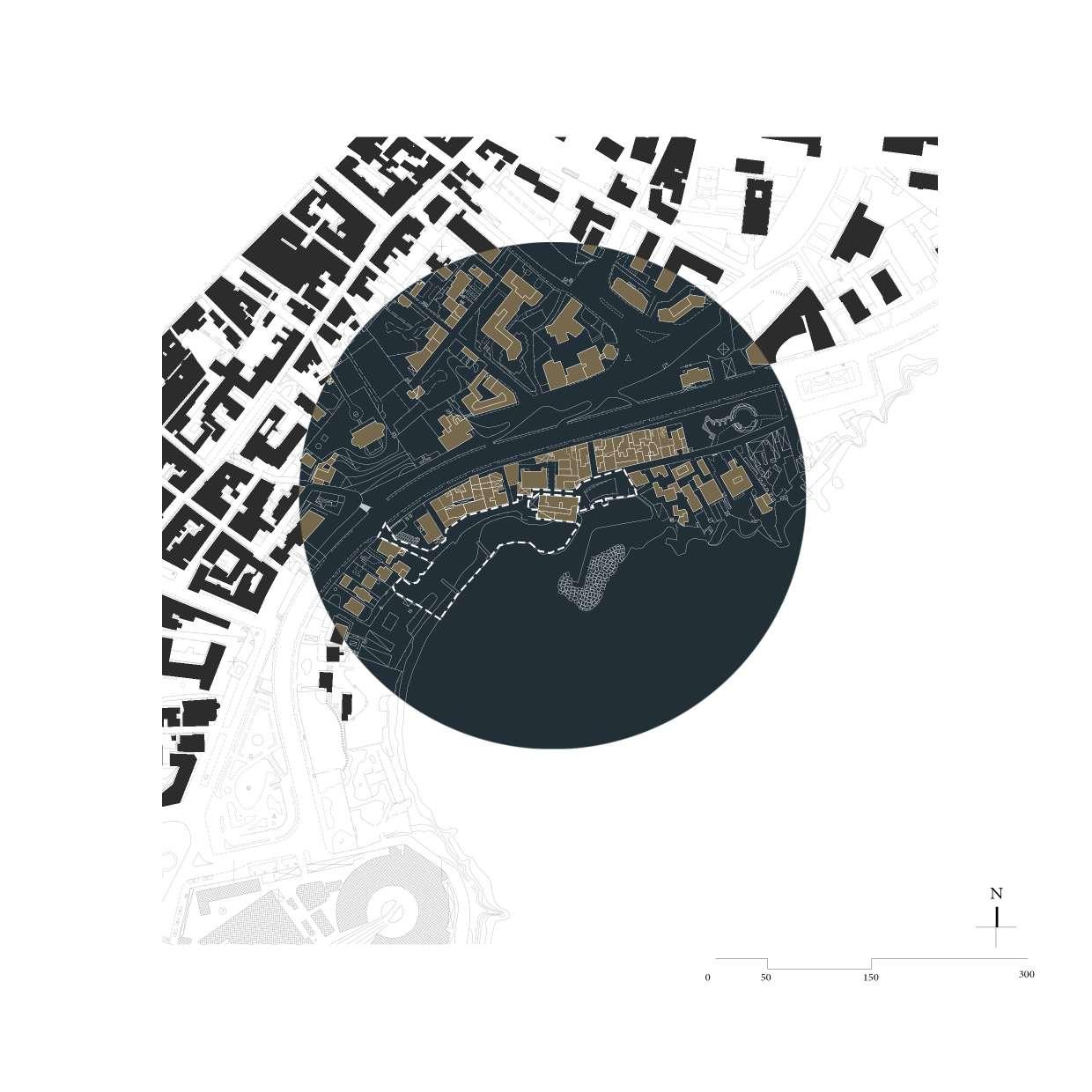
Elevato è il valore storico di cui si fa carico la borgata, proprio grazie alla spiaggia di San Giovanni Li Cuti, in quanto la componente marittima della città stessa si identifica nella sua spiaggia nera.
Il contatto è di tipo diretto.
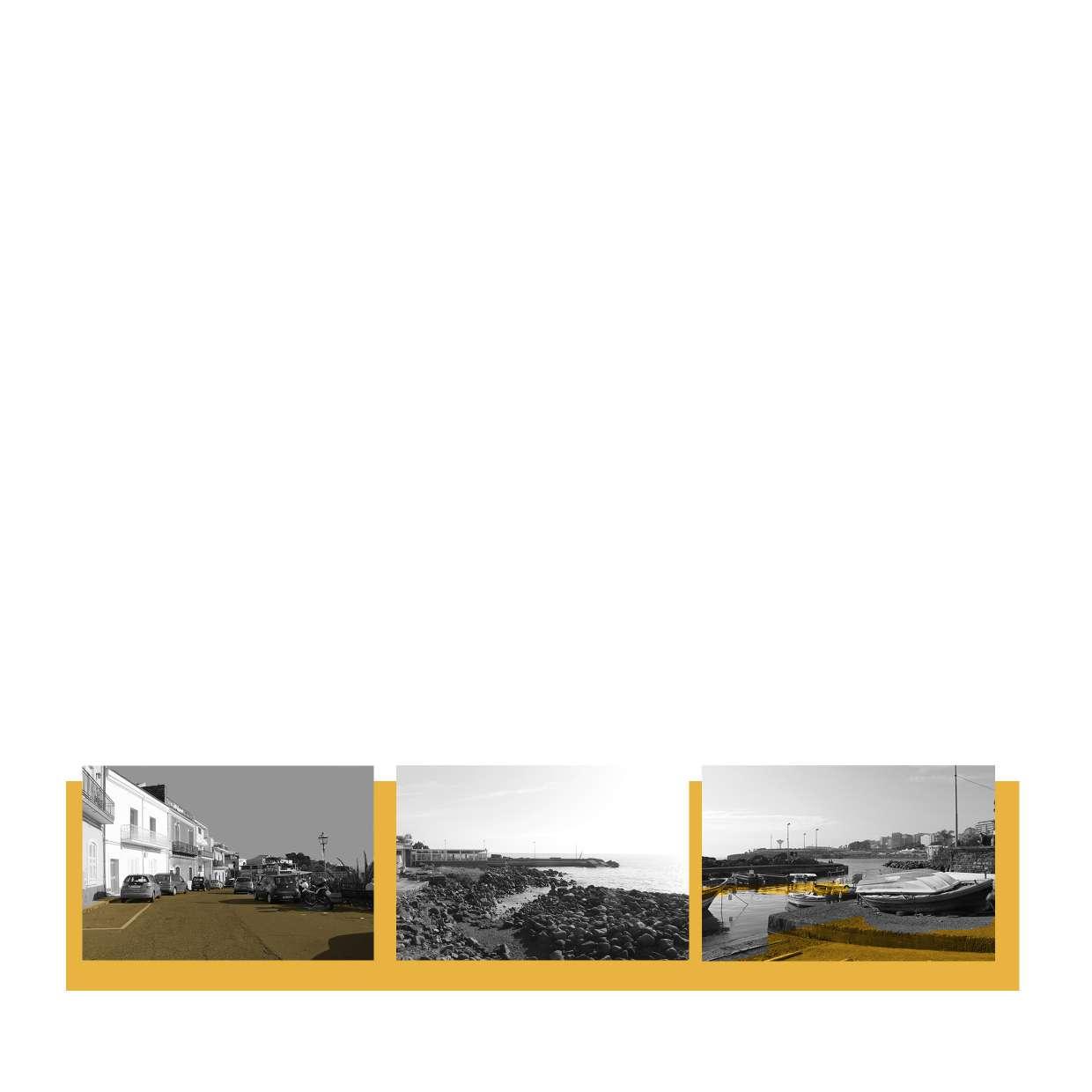
Piazza del Tricolore
Comfort
La piazza si presenta spoglia di qualsiasi arredo urbano. Sono presenti aree verdi relativamente ampie in proporzione all’area analizzata. Questo luogo si presenta come una “piazza” poco frequentata e utilizzata poichè adibita a parcheggio.
Attività sociali
Il Monumento ai Caduti non è solo un monumento, bensì accoglie al suo interno uno spazio espositivo, mentre nella corte interna è presente un anfiteatro. L’esterno del Monumento è ricorrentemente soggetto ad atti di vandalismo che rendono poco fruibile lo spazio esterno, tuttavia è spesso utilizzato come luogo di ritrovo per giovani e per praticanti di sport di strada.
Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
Tipici di questo spazio sono le gelaterie e le paninerie ambulanti, che portano la piazza, ad abbandonare la funzione di luogo di passaggio e divenire luogo di sosta.
IlMonumentoaiCaduticonferiscevalorestoricoeartisticoallapiazzadelTricolore:essoèun’operainstiledecostruttivista realizzato dall’architetto catanese Giuseppe Marino. Soprannominato “Vortice”, l’obiettivo dell’architetto fu quello di rappresentare il vortice che si viene a creare a seguito della deflagrazione di una bomba.
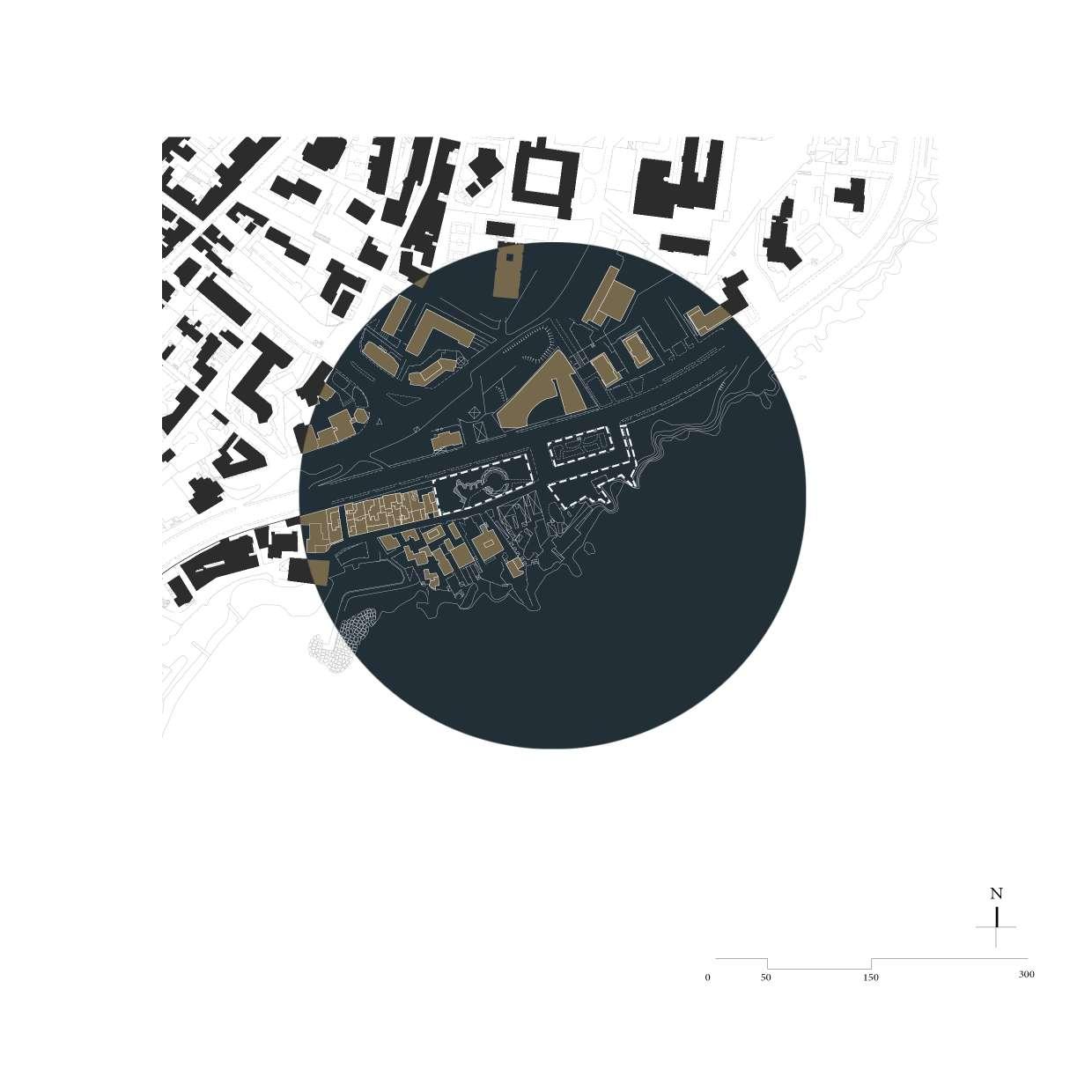
Contatto parziale indiretto: semplice affaccio sul mare, parzialmente negato a causa dei diversi dissesti presenti.

Piazza Nettuno
Comfort
La piazza si divide in due ampie zone, quella a destra di Viale Ruggero di Lauria, e quella alla sua sinistra: la prima priva di alberature che raffrescano la zona ma dotata di ampie aiuole, di zone attrezzate per lo sport e un campo da basket. La seconda invece, si compone di ulteriori tre piazze, due delle quali dotate di poche sedute ma ampie zone di verde, una terza invece presenta delle zone d’ombra grazie alla presenza degli alberi.
Attività sociali
La piazza si configura come il luogo di incontro per eccellenza per le diverse tipologie di utenze: famiglie, giovani, anziani e sportivi. Principale luogo di ritrovo, svago e relax nell’ambito del litorale catanese grazie alla presenza delle giostre, del campo da basket, e delle paninerie ambulanti presenti che diventano l’attrazione principale nelle ore pomeridiane e serali per l’intero periodo annuale e in particolar modo nel periodo estivo.


Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
Tipici di questo spazio pubblico sono le paninerie ambulanti, che costituiscono una delle peculiarità dello street food catanese, e una delle attrazioni della zona.
Nessun particolare valore storico.
Contatto parziale indiretto: si tratta di un semplice affaccio sul mare, e anche in tal caso si presenta parzialmente negato a causa dei diversi dissesti presenti.
Comfort
Un ampio spiazzo si affaccia sul mare e dà accesso ad una piccola piazzetta dotata di panchine prima di accedere al molo.
Attività sociali
Costituisce uno dei punti finali della passeggiata del Lungomare: si può scegliere se proseguire lungo il Viale, oppure se procedere lungo il molo.
Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
Questo spazio è caratterizzato dalla compresenza di locali, bar e paninerie ambulanti che richiamano le diverse utenze nelle diverse ore del giorno.
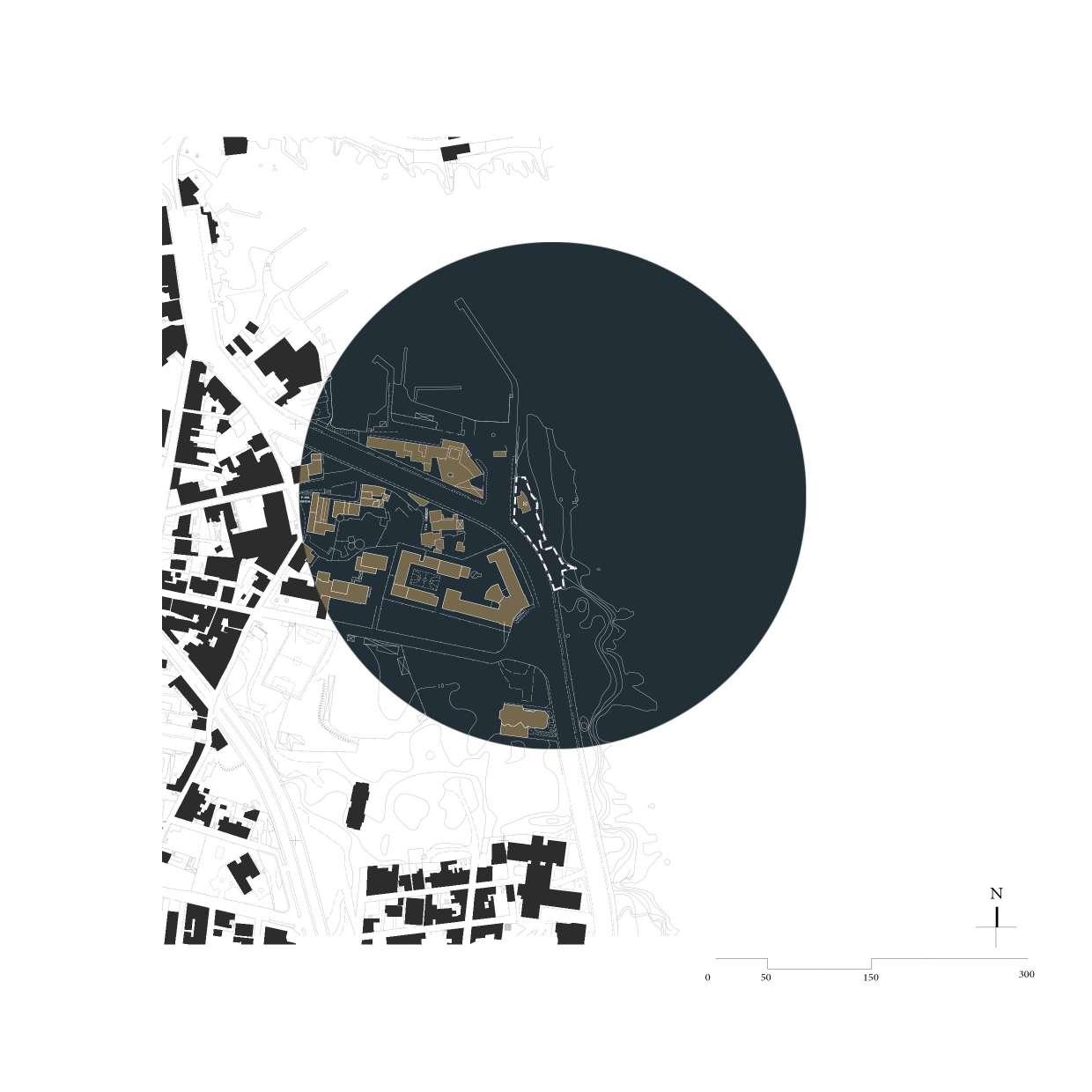
Anche questo spazio ospita una delle torri difensive costruite sotto il regno di Carlo V, posta al centro della piazza.
La piazza si configura come un affaccio sul mare ma con la sua piazza attrezzata posta ad una quota inferiore sembra volersi avvicinare al livello del mare. Inoltre dalla medesima area è possibile accedere all’area portuale.
Nella stagione estiva viene costruito il “Solarium” di Ognina che permette un accesso facilitato al mare.

Borgo di Ognina

Comfort
Lo spazio non presenta particolare attenzione per elementi di arredo urbano se non poche sedute.
Attività sociali
Insieme a piazza Mancini Battaglia, questo spazio si presenta per lo più come uno spazio adibito al passeggio, alla sosta e alla contemplazione.
Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
Il borgo di Ognina è ricco di botteghe, negozi e attività gastronomiche che rendono tale luogo l’attrazione finale della passeggiata lungo il litorale catanese roccioso.
Il valore storico dela borgata di Ognina si lega al mito di Ulisse che, sin dalla stesura del poema Il Ciclope di Euripide, si vuole sbarcasse lungo la frastagliata costa catanese. Inoltre di importante rilievo è la torre che costeggia la Chiesa di Ognina, datata al XIV-XV secolo, la cui funzione dovette essere probabilmente di carattere militare
Il borgo vive con l’acqua un rapporto di simbiosi, tutte le attività presenti si legano infatti alla presenza del mare a partire dalle attività di pesca, alle rimesse per le imbarcazioni, alle botteghe, ai ristoranti presenti fino alle attività ludicosportive praticate nell’area.

Comfort
Questo spazio pubblico non si configura come una vera e propria piazza, bensì come un allargamento della strada invaso dal parcheggio abusivo, e spesso congestionato dall’intenso traffico. La piazza si affaccia inoltre sui moli del porticciolo turistico e lo stesso parapetto costituisce una seduta continua da cui osservare il porticciolo.
Attività sociali
Insieme al borgo di Ognina, questo spazio si presenta per lo più come uno spazio adibito alla sosta e alla contemplazione, ma anche un punto di ritrovo data la presenta di rinomati locali e ristoranti.


Servizi e ristorazione Valore storico e/o monumentale Rapporto con l’acqua
Diversi ristoranti, locali e bar si affacciano sulla piazza, tuttavia l’affaccio di questi ultimi non è diretto sulla piazza stessa perchè la strada ad alta velocità e l’elevato traffico disgiungono e tagliano le due aree.
La piazza non presenta particolari elementi di valore storico, artistico o monumentale.
Il rapporto di questo spazio pubblico con l’acqua si esplica in due modi: il primo è quello legato alle imbarcazioni che ormeggiano nei moli del porticciolo, il secondo è quello legato allo sport e in particolare alla canoa.
A Nord della piazza, si può accedere ad una spiaggia di piccola estensione che tuttavia non viene utilizzata per la balneazione a causa delle numerose imbarcazioni.
6_Piazza Nettuno
Piazza Nettuno non è semplicemente una piazza, non un semplice spazio pubblico, essa rappresenta il luogo di incontro tra il mare e la città, ma anche il luogo dello sport all’aria aperta, il luogo dell’incontro multietnico, il luogo dello svago con le sue storiche giostre e uno dei luoghi dello street food catanese con le sue peculiari paninerie ambulanti, i cosìdetti “camion dei panini”. Sono tutte peculiarità che fanno di quest’area il fulcro della passeggiata al lungomare e allo stesso tempo sono la manifestazione del modus vivendi del cittadino che abita e vive la città.
Un ampio spazio aperto, che si affaccia sul mare, un luogo di incontro per giovani, anziani e bambini, che trovano in questo ampio spazio di 14000 metri quadri circa, il loro svago: dalle giostre al campo di basket e all’area fitness, dai chioschi alle paninerie ambulanti.
L’area oggi risulta parzialmente fruibile, poiché molte sono le zone chiuse e recintate, prevalentemente le zone di affaccio sul mare, che risultano pericolanti a causa di smottamenti e per lavori di consolidamento mai avviati. L’affaccio sul mare nella zona centrale della piazza presenta un dislivello di 10 metri circa, e l’idea che suggerisce è quella di una terrazza sul mare, al contrario invece della restante passeggiata del lungomare lungo la quale questo dislivello risulta più graduale ed eterogeneo.
Vista dal mare di Piazza Nettuno

Questo ampio sistema di piazze accoglie un’area dedicata allo sport ad est, in cui si trovano un campo da basket e una piccola area attrezzata per lo sport oggi riqualificata con prato sintetico, mentre nella zona ovest, al di là del viale Artale Alagona, si trovano due piazze simmetriche prive di una propria identità e destinate a verde, un’ulteriore piazza attrezzata, e infine, a costituire da quinta della scena, il sistema delle giostre il cui profilo svetta sullo sfondo. Nel complesso questo spazio pubblico risulta frammentario, separato da Viale Artale Alagona, strada ad alto scorrimento, e da via del Rotolo, e le singole piazze di cui si compone appaiono interamente sconnesse tra di loro. La piazza attualmente risulta priva di una propria identità ma mostra la sua vocazione a divenire uno spazio dedicato allosport, allo svago e al tempo libero.
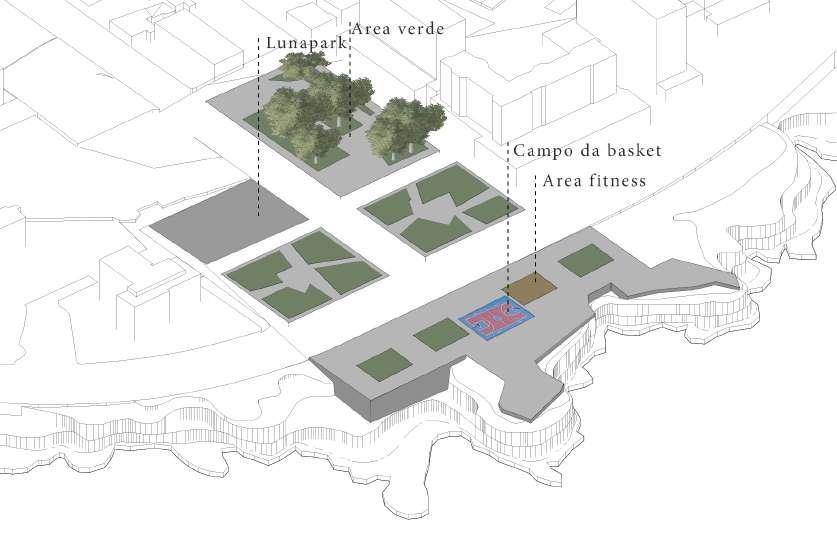
Elementi di interesse e di attrazione Gli spazi intorno Piazza Nettuno ospitano diverse attività legate all’intrattenimento e al tempo libero. Il filo conduttore è infatti quello del gioco, che unisce ogni componente della piazza. L’identità della stessa, peraltro, si fonda prevalentemente sull’immagine delle sue giostre.
Le giostre di Ognina, infatti, fondate nel 1965 e oggi conosciute con il nome di “NettunoPark”,costituisconoatuttiglieffetti,unodeglielementidiprincipale attrazione presenti nell’area e sono situate in via Del Rotolo, rappresentando un polo identitario per i Catanesi. Esse pertanto costituiscono un punto di ritrovo e di svago per giovani e per famiglie, e un punto di riferimento della vita catanese.
Un secondo elemento peculiare di questo spazio pubblico, e non solo, sono le attività ambulanti: di particolare rilievo sono infatti le paninerie, espressione della cultura culinaria catanese di strada.
Il panino è infatti da considerarsi uno dei cibi tipici di strada catanese, con l’espressione “cibo di strada” si fa riferimento ai cibi preparati e venduti da bancarelle, furgoni e banchetti che si collocano direttamente in strada. La città di Catania, e in particolare diversi punti della costa catanese sono caratterizzati dalla presenza di questi furgoncini.
Spesso la piazza ospita manifestazioni ed eventi, sfruttando l’ampio spazio a disposizione. Uno di questi, a cadenza mensile è proprio il cosiddetto “Lungomare liberato”, l’evento per cui la città ogni prima domenica del mese chiude il lungo viale per poterlo occasionalmente restituire nella sua interezza ai cittadini.
Si tratta di un evento che attira molti visitatori, i quali si recano nella zona per partecipare alla manifestazione, che si presenta anche come un’occasione per incentivare l’uso di mezzi sostenibili quali la metropolitana, le bici elettriche e i pattini. È un evento in cui si rende il Lungomare libero dal suo consueto traffico e dallo smog, e permette ai cittadini di godere della vista del mare.
Analisi delle problematiche
Degrado diffuso

Nonostante la recente opera di riqualificazione avviata, una situazione di degrado ben più radicato continua ad affliggere l’intero sviluppo del Lungomare: la pavimentazione sconnessa è stata sostituita, è stato ripristinato il campo da basket e sostituiti i vecchi tabelloni e canestri, le aiuole laterali sono state inverdite, il percorso vita è stato reso più accessibile con l’inserimento di un prato sintetico più adatto per l’esercizio fisico, ma nonostante ciò, la piazza risulta in gran parte interdetta a causa dell’elevato pericolo di crollo della scogliera, segnalata peraltro come zona a rischio di frana di elevata intensità.
In tal modo ci si priva perciò di uno spazio esteso che potrebbe essere ampiamente sfruttato e rivalorizzato, oltre che portare allo snaturamento del valore paesaggistico di cui gode l’intera zona, ossia quello della scogliera lavica.
Il dialogo negato con il mare Uno spazio pubblico prospiciente sul mare, ma che con esso non ha nessun contatto. Dissesti, dislivelli e sbarramenti hanno reso il mare un semplice sfondo della piazza, rendendolo dunque irraggiungibile.


Le attività commerciali ambulanti Unitamente alle criticità relative all’inteso traffico, si aggiungono anche le diverse e numerose attività ambulanti che si concentrano per lo più lungo la via del Rotolo, contribuendo sicuramente al congestionamento delle strade.

Parte III - Infrangere la barriera di Piazza Nettuno
7_ La nuova soglia
Il concept
L’immagine che il lungomare di Catania ci restituisce è quella di una barriera che nega ai suoi visitatori ogni accesso al mare. I due borghi marinari, posti alle estremità della passeggiata del litorale, costituiscono le uniche soglie che consentono l’accesso al mare e il contatto diretto con esso: queste due soglie costituiscono gli unici punti, agevolati dalla naturale morfologia del territorio, nei quali il visitatore può finalmente giungere al mare.
La barriera si infrange e diventa soglia laddove la naturale pendenza del terreno accompagna il visitatore sino a giungere a livello del mare.
La seguente elaborazione progettuale pone come base di partenza l’obiettivo di instaurare un dialogo con il mare, un dialogo che negli ultimi decenni è stato negato: il lungomare infatti non è che un affaccio sul Mediterraneo, dove l’uomo si limita ad osservare dal mare, distante, senza poterlo mai raggiungere.
Lo spazio pubblico come barriera
Piazza Nettuno si configura come il luogo della cesura, della separazione tra la terra e il mare, e a contribuire a tale funzione sono l’infrastruttura, l’elevato dislivello, la scarsa accessibilità, le recinzioni.
Le soglie attuali
Da barriera a soglia
Il dislivello costante che intercorre l’uomo dal mare si ponecomebarrieraedostacolo al suo raggiungimento.
Le soglie, in cui è permesso un contatto, sono poche e sono individuabili nei due borghi marinari di Ognina e di San Giovanni Li Cuti.
La nuova soglia
La barriera può diventare soglia, punto di ingresso. Può diventare un luogo di passaggio per l’uomo e per l’acqua.
Piazza Nettuno può dunque, diventare la nuova soglia, ed è proprio attraverso il processo di corrosione che l’elemento separatore, che è l’acqua, si evolve ad elemento unificatore.
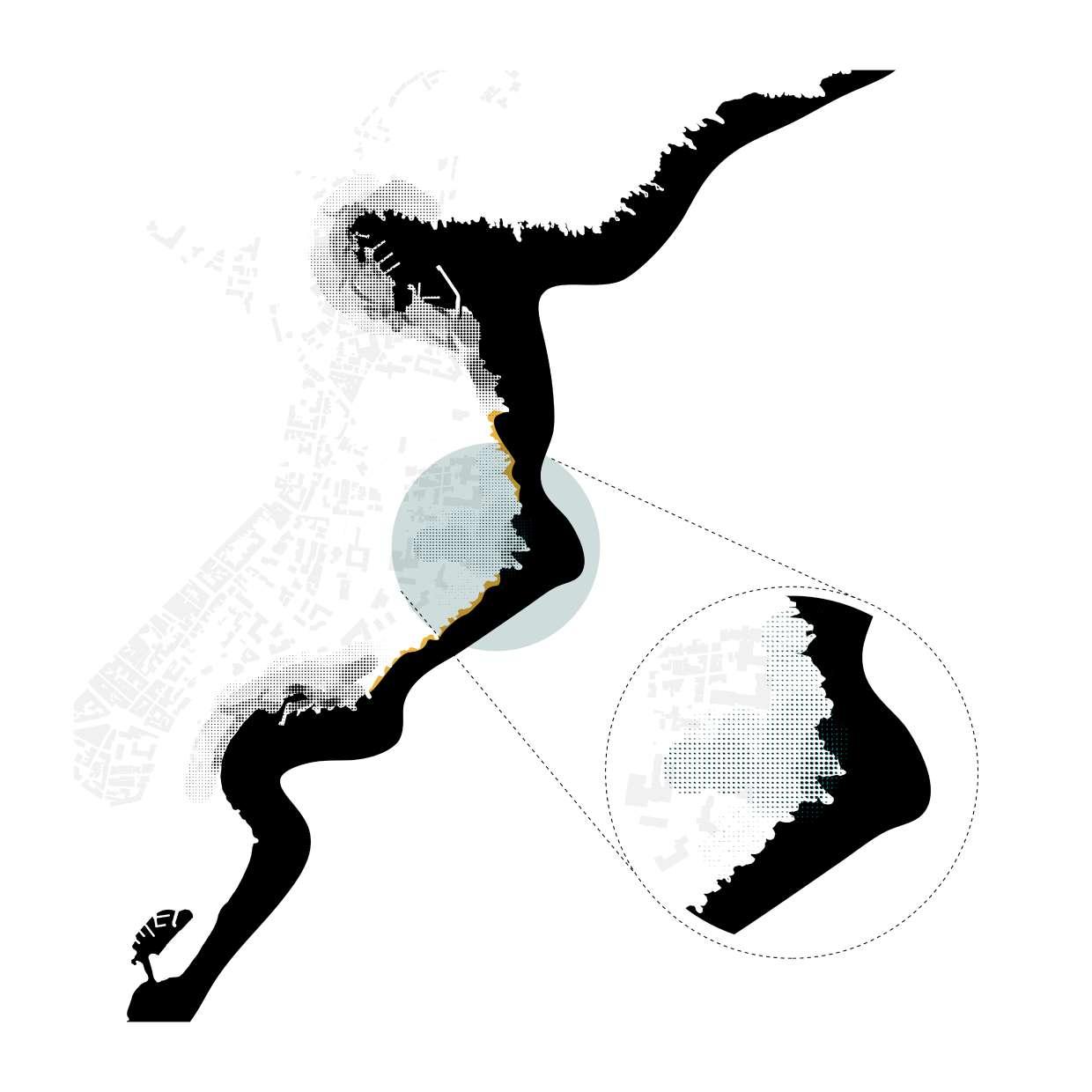
Piazza Nettuno
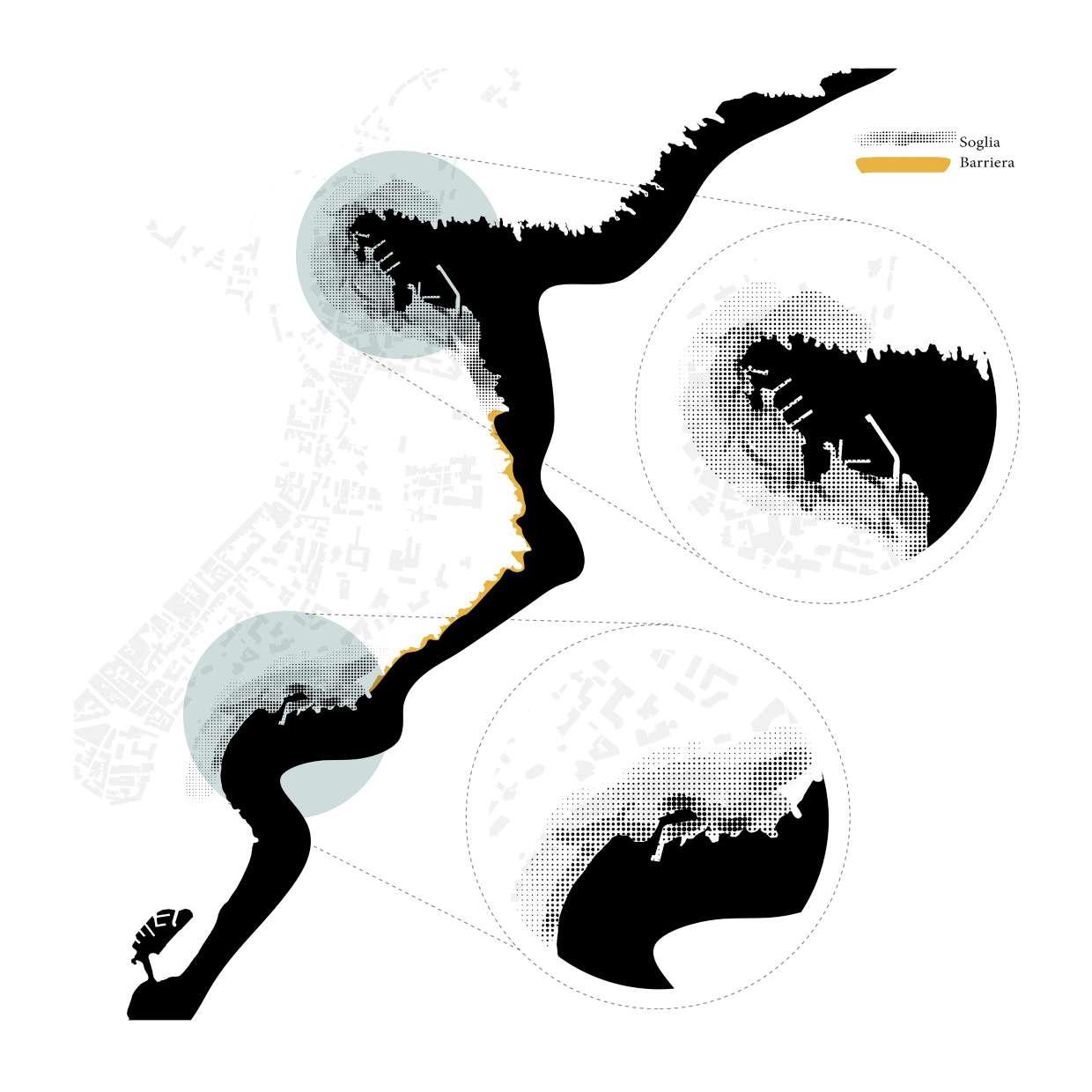
Soglia e barriera
La soglia di San Giovanni Li Cuti
La soglia di Ognina
Fase 1_L’acqua penetra e corrode la roccia
Fase 2_L’acqua ha generato gli spazi e definito i luoghi del suo passaggio
Fase 3_L’acqua è solo di passaggio, vi sono tuttavia dei punti in cui essa permane
Fase 4_ Si definiscono i contorni e i percorsi
L’erosione della barriera
Appare dunque chiaro l’intento di ripristinare questo rapporto perduto con il mare e di avviare un processo di valorizzazione del ruolo che ha l’acqua all’internodellospaziopubblico. Talevalorizzazionesitraducedunque,nella volontà di portare in senso letterale il mare in città, applicando un’inversione di metodologia che generalmente vede l’uomo protendersi verso il mare.
Ci si pone l’obiettivo di infrangere questa barriera anche laddove il dislivello elevato e gli svariati dissesti non lo permettono. Il fine, pertanto, non è quello di estendersi verso il mare e protendersi per poterlo raggiungere, sarà tuttavia il mare stesso ad entrare in città, sfruttando idealmente quella che è la naturale porosità della roccia lavica, e si farà strada dentro di essa, creerà dei cunicoli, dei fori, degli scavi e la sua salinità la corroderà generando degli spazi vivibili: sarà così riconsegnato al mare il ruolo di nuovo protagonista nell’ambito dello spazio pubblico catanese lungo il litorale roccioso.
L’erosione è il processo naturale cui la roccia è soggetta ed è esso stesso il principio generatore di questo progetto, che permette la riconquista fisica e visiva del mare.
Si evidenzia infatti il naturale processo erosivo che il mare esercita sul litorale roccioso, e da qui l’idea di volerne accentuare l’azione trasformativa. L’azione erosiva del mare si fa essa stessa generatrice del progetto, permettendo all’acqua di penetrare la roccia, farsi strada dentro di essa, creare dei pozzi di acqua, corrodendo e lentamente scavando, dando vita ad un intreccio caotico e disordinato.
L’erosione è dunque, il principio generatore del progetto.
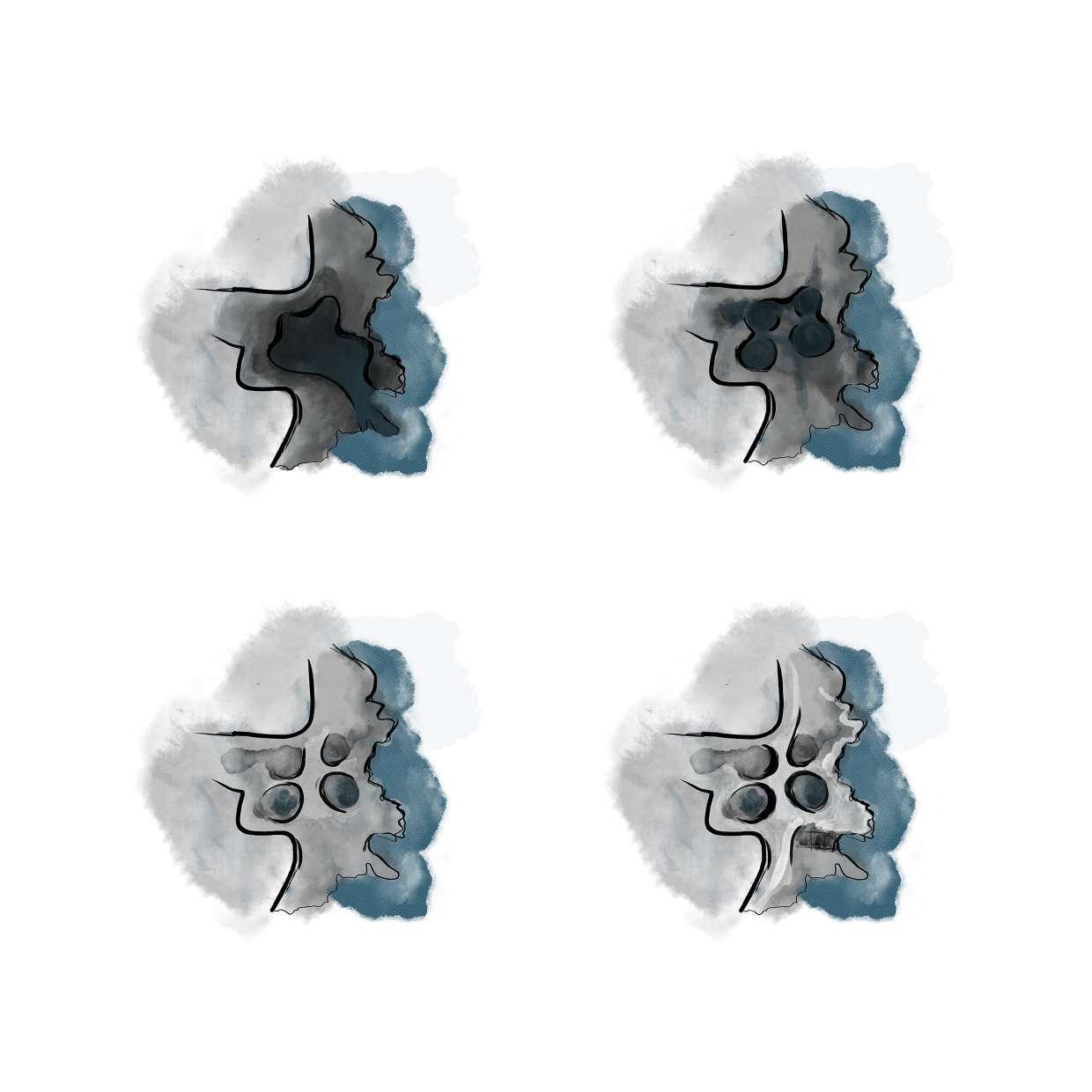
La nuova viabilità
Sulla base delle analisi svolte nella più ampia area lungo il litorale roccioso e in una più dettagliata area corrispondente all’area di Piazza Nettuno, si è giunti a quella che sembra essere la soluzione agevole che possa permettere a questo spazio pubblico di perdere la connotazione di luogo di cesura.
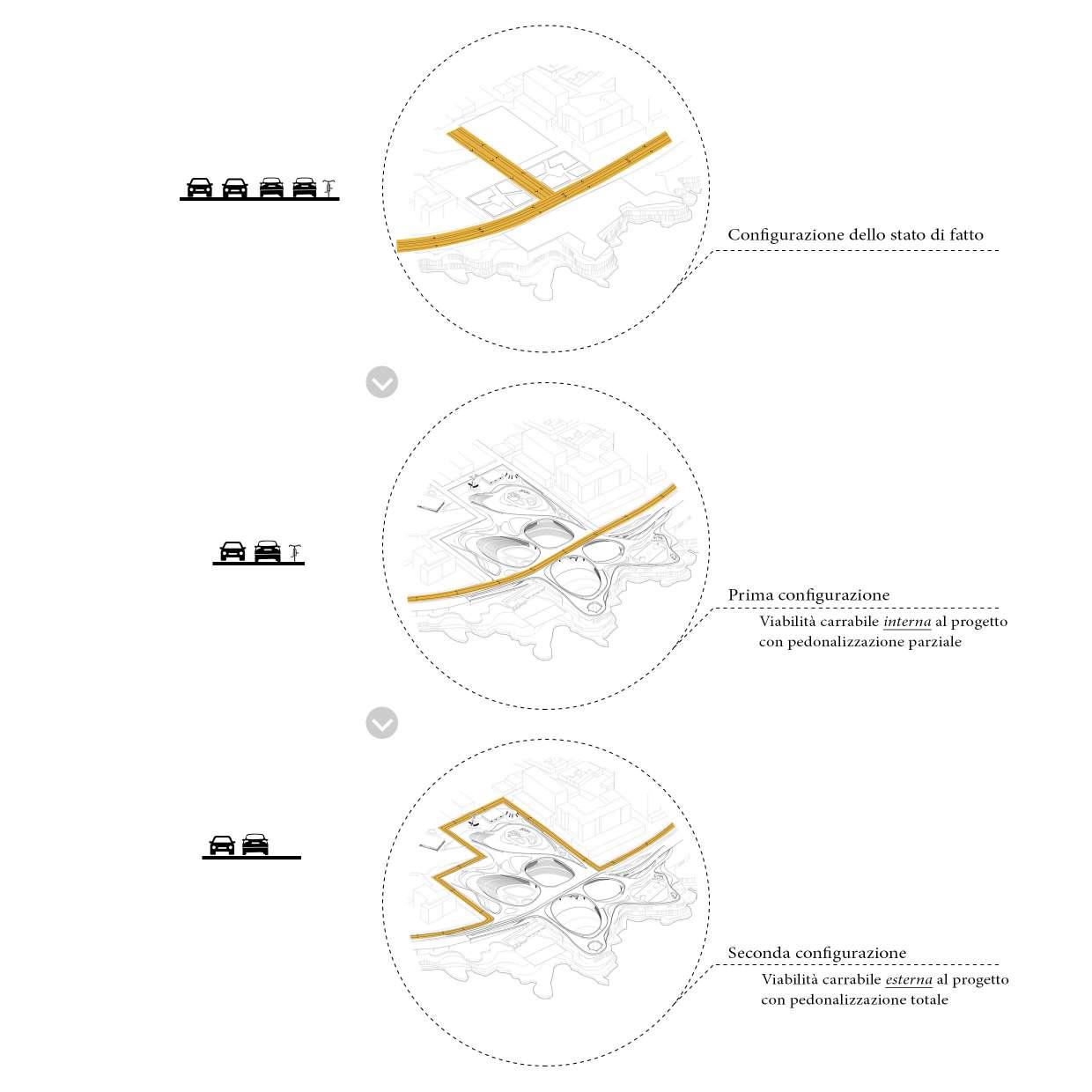
Si è infatti detto che uno dei motivi per cui esso si presenta in tali condizioni è proprio riconducibile alla presenza di una strada a scorrimento veloce che funge da collegamento principale interquartiere.
Il progetto vede una parziale ripedonalizzazione del lungomare con il conseguente spostamento dell’intenso traffico veicolare da Viale Ruggero di Lauria a Viale Alcide De Gasperi, scelta che si pone come completamento di quelle che erano le previsioni precedenti.
Si è tuttavia scelto di non pedonalizzare completamente il litorale ma, operando sulla riduzione della sezione stradale, si è scelto di declassare Viale Ruggero di Lauria e Viale Artale Alagona a strade con una corsia per senso di marcia, riducendo la sezione stradale da 10 m a 6 m, così da destinare una più ampia porzione al passeggio e al verde stradale.
L’esigenza di connettere l’uomo al mare e al paesaggio naturale diventa il motivo promotore del progetto e si traduce in un nuovo spazio in cui è la dimensione naturale e quella umana a prevalere su quella dell’infrastruttura.
Il lungomare non è più solo un collegamento stradale.

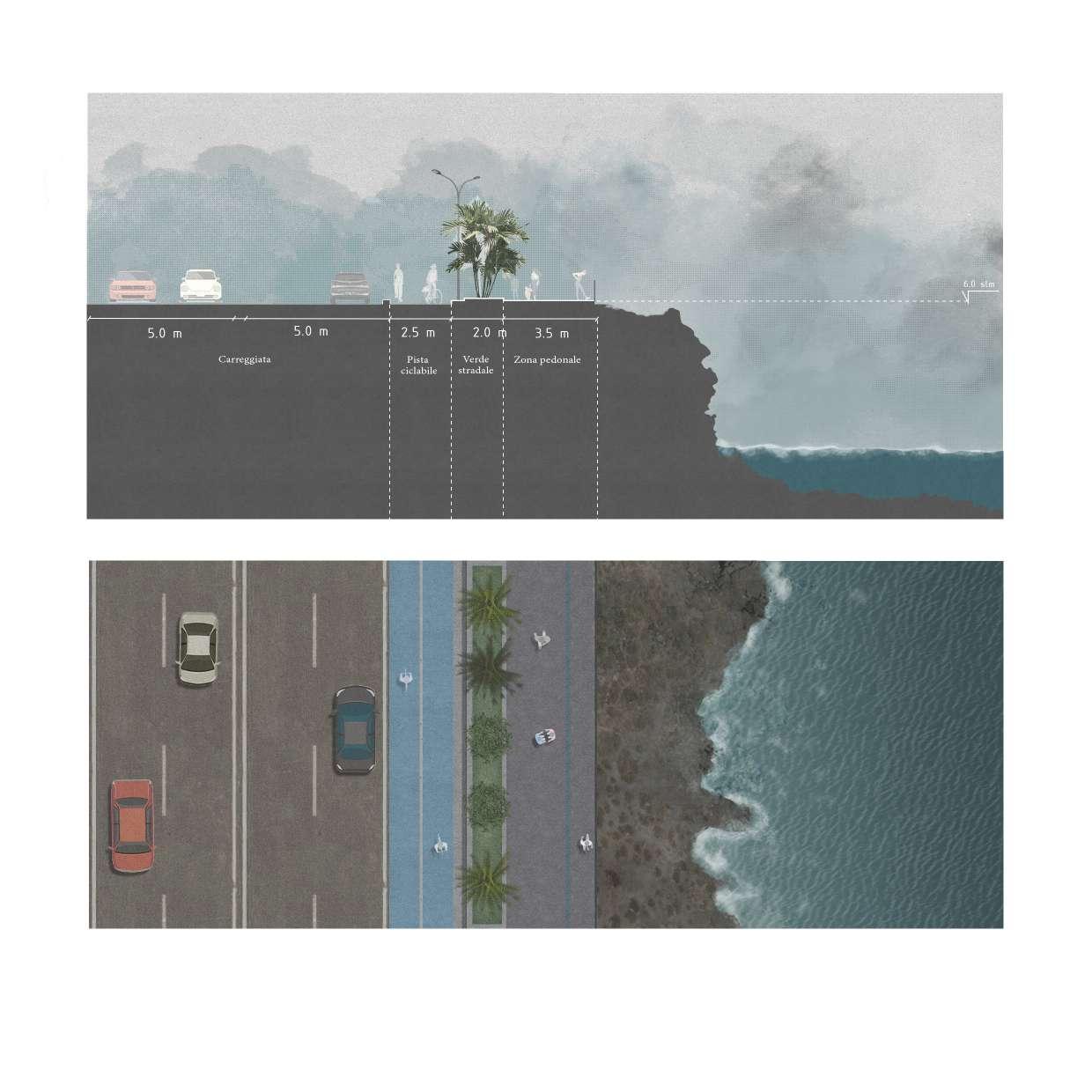
Alla base dello sviluppo del concept del progetto vi è proprio la considerazione svolta circa la viabilità: sono state pensate due possibili configurazioni della viabilità passante per l’area di progetto, senza che quest’ultimo subisca modifiche sostanziali.

Una prima configurazione, meno invasiva e radicale, si pone quindi come il primo step dell’elaborazione progettuale, e vede il passaggio di una strada dallapiùridottasezionestradale,lungol’areadiprogetto,eseguel’andamento della strada originaria, la SS114.
Una seconda configurazione, più radicale, segue come secondo step del progetto, e vede una modifica più invasiva della viabilità, la quale viene spostata lungo il perimetro dell’area, al fine di pedonalizzare totalmente la zona centrale.
Sezione stradale di progetto
Elementi esistenti
Svolto uno studio dell’area di progetto, e delle relazioni che intercorrono con il quartiere, sono stati individuati i principali elementi esistenti che costituiranno la base di partenza per l’intera elaborazione progettuale.
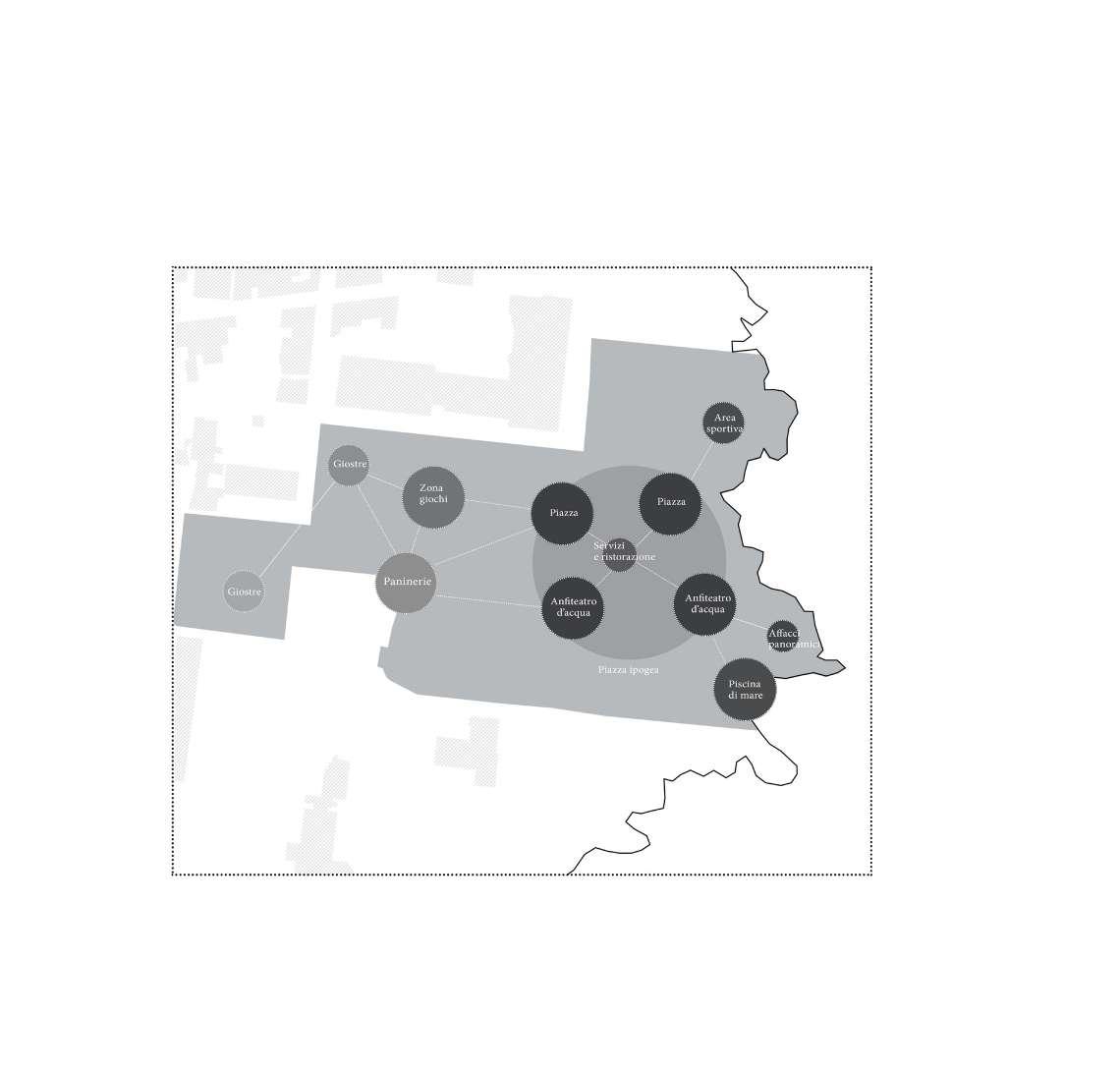
Gli elementi principali che configurano Piazza Nettuno sono pertanto le giostre, lo sport e il cibo di strada delle paninerie ambulanti.
Le giostre sono parte integrante della piazza e per questo motivo appare subito chiaro l’intento di volerle inglobare nel progetto e di valorizzarle. Esse, unitamente alle differenti attività commerciali ambulanti, costituiscono la principale fonte di economia del luogo.
Le paninerie infatti, sono da sempre, simbolo dello street food catanese e costituiscono un importante richiamo del luogo.
Infine il campo da basket, come si è già visto, costituisce anch’esso, un elemento di forte richiamo del luogo.
Alla luce di ciò, tali elementi, non vengono ignorati né estirpati, bensì ricollocati nell’ambito del progetto così da poter essere valorizzati.
Vienedefinitounprogrammafunzionalechepermettedicapireladislocazione delle diverse funzioni presenti nel progetto, che vede centralmente la collocazione di una grande piazza ipogea che ingloba dentro sè quattro grandi ambienti. Da queste aree sono accessibili tutte le funzioni e le zone che costituiscono il perimetro dell’area di progetto: gradonate, scalinate e rampe sono infatti poste a collegamento dei diversi luoghi permettendo un flusso continuo e generando così uno spazio connesso e continuo.
Il progetto
Il progetto di riqualificazione di piazza Nettuno si basa sullo scavo di livelli posti a quote differenti.
L’Area di piazza Nettuno, infatti, si presenta composta da frammenti di spazio separati da via del Rotolo e viale Artale Alagona.

La separazione fisica è accentuata dalla carenza di un’unione funzionale che permetta agli spazi di ritrovare la loro identità di luoghi di aggregazione.
Il progetto cerca dunque, di rispondere a queste esigenze: si vuole giungere pertanto alla riconquista del mare mediante una soluzione progettuale basata sulla continuità funzionale e fisica di uno spazio ricreativo e attrattivo.
Attraverso lo scavo, si vuole pertanto dar vita al processo di erosione che l’acqua provoca alla roccia per così generare un sistema di spazi pubblici, tra loro connessi al fine di dare un senso di continuità e di ottenere un unico ampio spazio.
Ma che spazio si vuole generare? Incuriosire è la chiave del progetto. Attivare i processi di uso e frequentazione del luogo che nascono dalla curiosità.
Il progetto deve instillare la curiosità nel visitatore, il quale si addentra in questo spazio pubblico ed è incentivato alla sua permanenza.
La nuova piazza infatti si articola secondo un sistema di dislivelli, compresi tra la quota +5.5 m s.l.m. e la quota +10.0 s.l.m.
Si passa infatti da un’unica ampia area scavata, posta a +5.5 m s.l.m. e collocata in posizione centrale all’area di progetto e prospiciente il mare, la quale si riconnette alla quota 10.00 m s.l.m. in direzione Ovest. Essa infatti si addentra gradualmente al tessuto urbano e si ricongiunge ad esso attraverso due ampie gradonate ellittiche: la prima si riconnette in maniera diretta alla quota della strada (+10.00 m s.l.m.) ed è collocata nella parte più a Sud dell’area di progetto, mentre la seconda, si riconnette alla quota della strada
(+12.00 m s.l.m.) attraverso una seconda piazza, di dimensioni minori, posta su quota intermedia (+9.00 m s.l.m).
La piazza è inoltre accessibile mediante due ampie e lunghe rampe che tagliano longitudinalmente l’area di progetto, una posta a nord e una a sud che connettono rispettivamente viale Artale Alagona e viale Ruggero di Lauria con la piazza.
La conquista fisica del mare avviene proprio in questi grandi spazi ricavati nella roccia: gli ambienti sono infatti raffrescati da quattro grandi vasche di acqua salata.
La conquista visiva del mare è invece raggiunta attraverso degli specifici punti panoramici collocati in diverse zone del progetto.
Un primo punto panoramico è costituito da un vero e proprio affaccio, raggiungibile mediante una rampa che segue il perimetro della vasca d’acqua posta a est, la quale conduce il visitatore a questo “balcone” sul mare, accessibile mediante due squarci effettuati sulla roccia. Queste due aperture sul mare sono anche degli scorci che da una visuale lontana, anche da una quota inferiore, permettono di intravedere il mare.
Unsecondopuntopanoramicoèinvececostituitodallapasserellasopraelevata che congiunge come due lembi, i due spazi antistanti, posti rispettivamente a Nord e Sud - Ovest, a livello della strada.
In particolar modo questa si trova in corrispondenza della seconda gradonata che congiunge le due piazze, quella maggiore e quella minore, e offre una doppia visuale: da questo punto è possibile apprezzare sul versante Ovest il parco dedicato interamente alle giostre e al playground per i bambini, mentre sul versante Sud-Est si può ottenere una visione globale dei quattro ampi scavi.
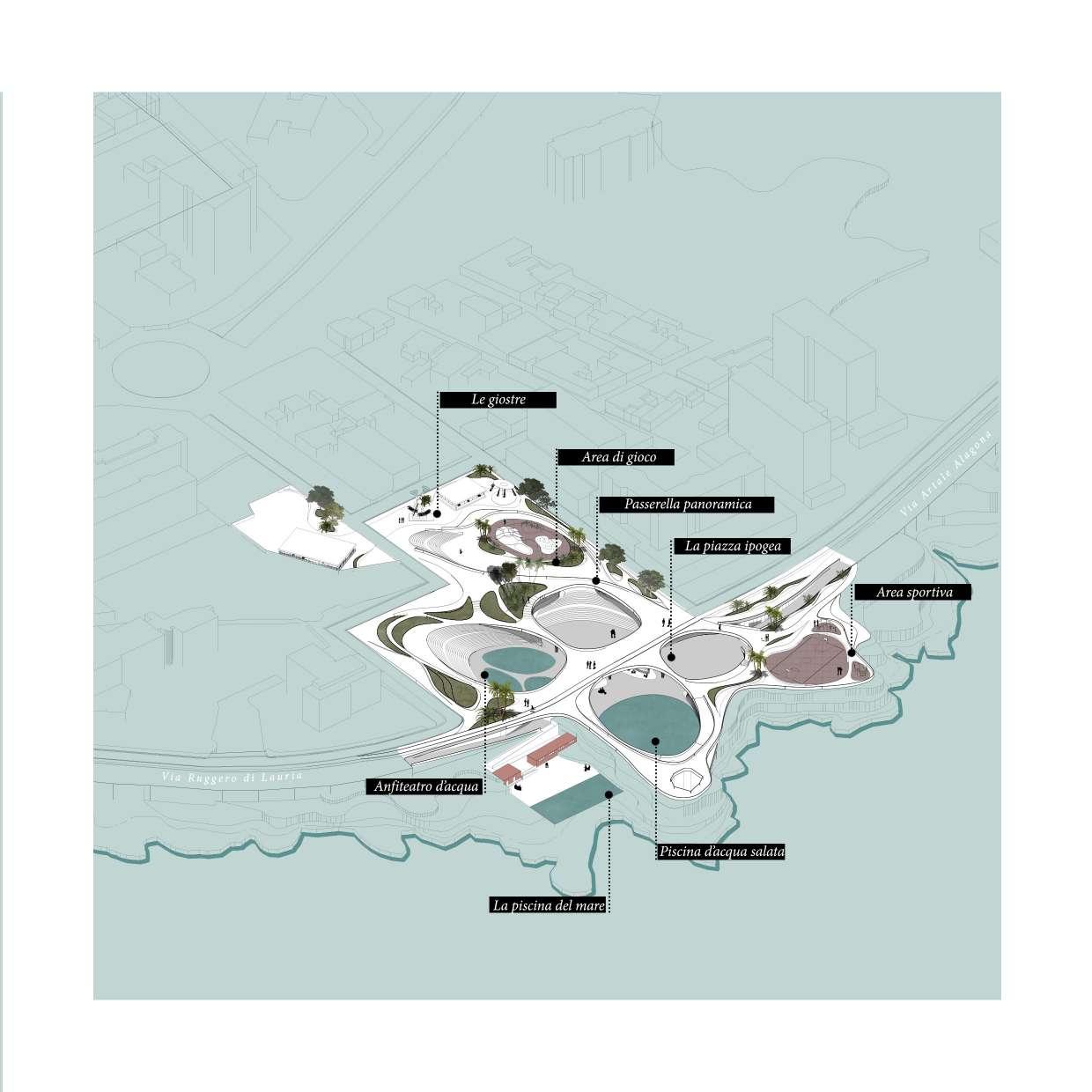
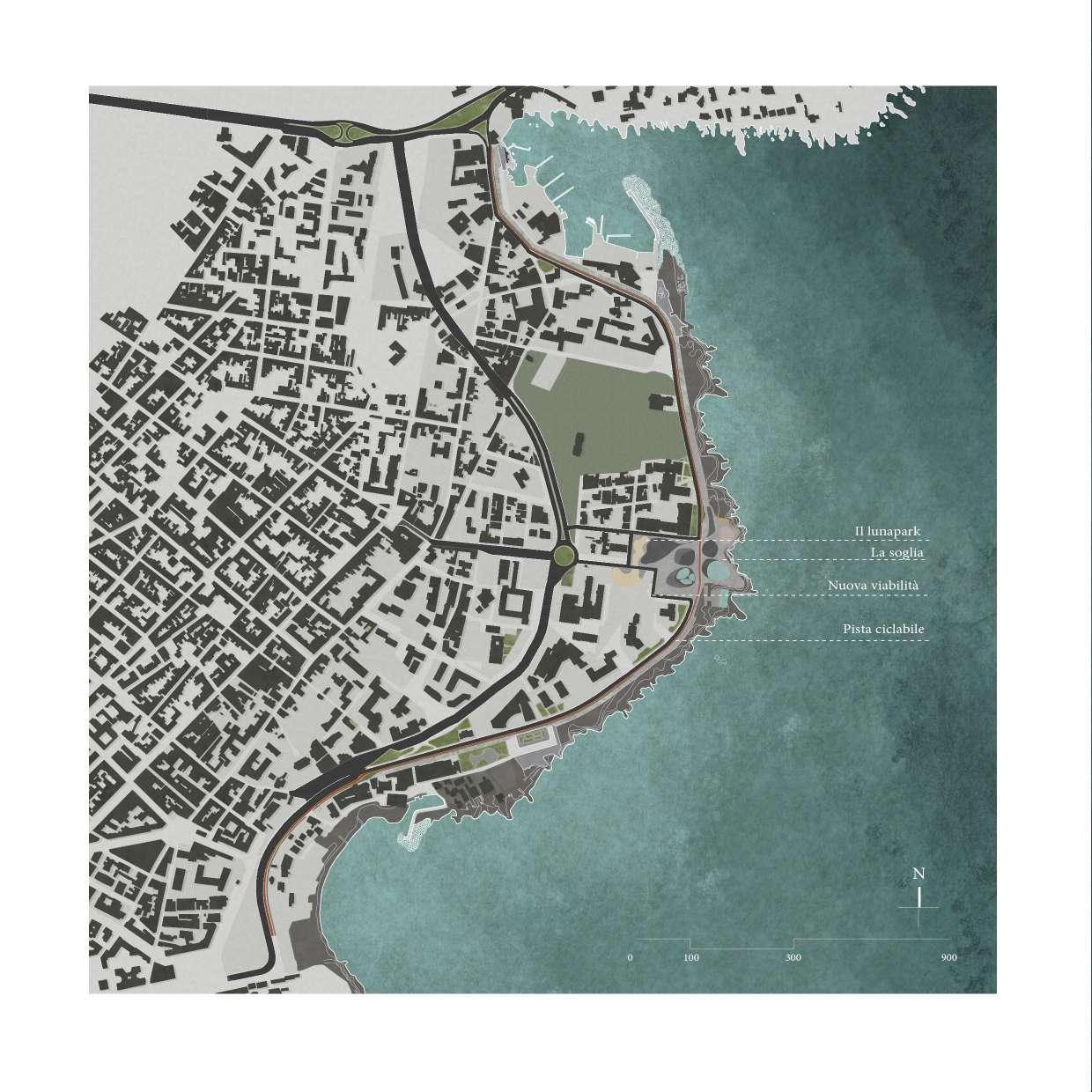

Quelli che dall’esterno appaiono come quattro ampi scavi in realtà costituiscono un unico grande spazio, sormontato da passerelle che dividono otticamente lo spazio nei quattro ambienti sopracitati e connettono le diverse aree del livello 0.
Poste centralmente alla piazza, sono due strutture con scheletro in cemento armato, le quali costituiscono il perno dell’ampia piazza e che contribuiscono alla divisione ottica della stessa nelle quattro aree.
Si tratta di un progetto a scala urbana, di uno spazio aperto, un luogo dello stare che vuole mediare il rapporto tra la terra e l’acqua. Il progetto è volto ad esaltare e rafforzare il margine, in un gioco di sottrazione rispetto alla terra operato dall’acqua stessa, la quale secondo un processo continuo, corrode la roccia porosa.

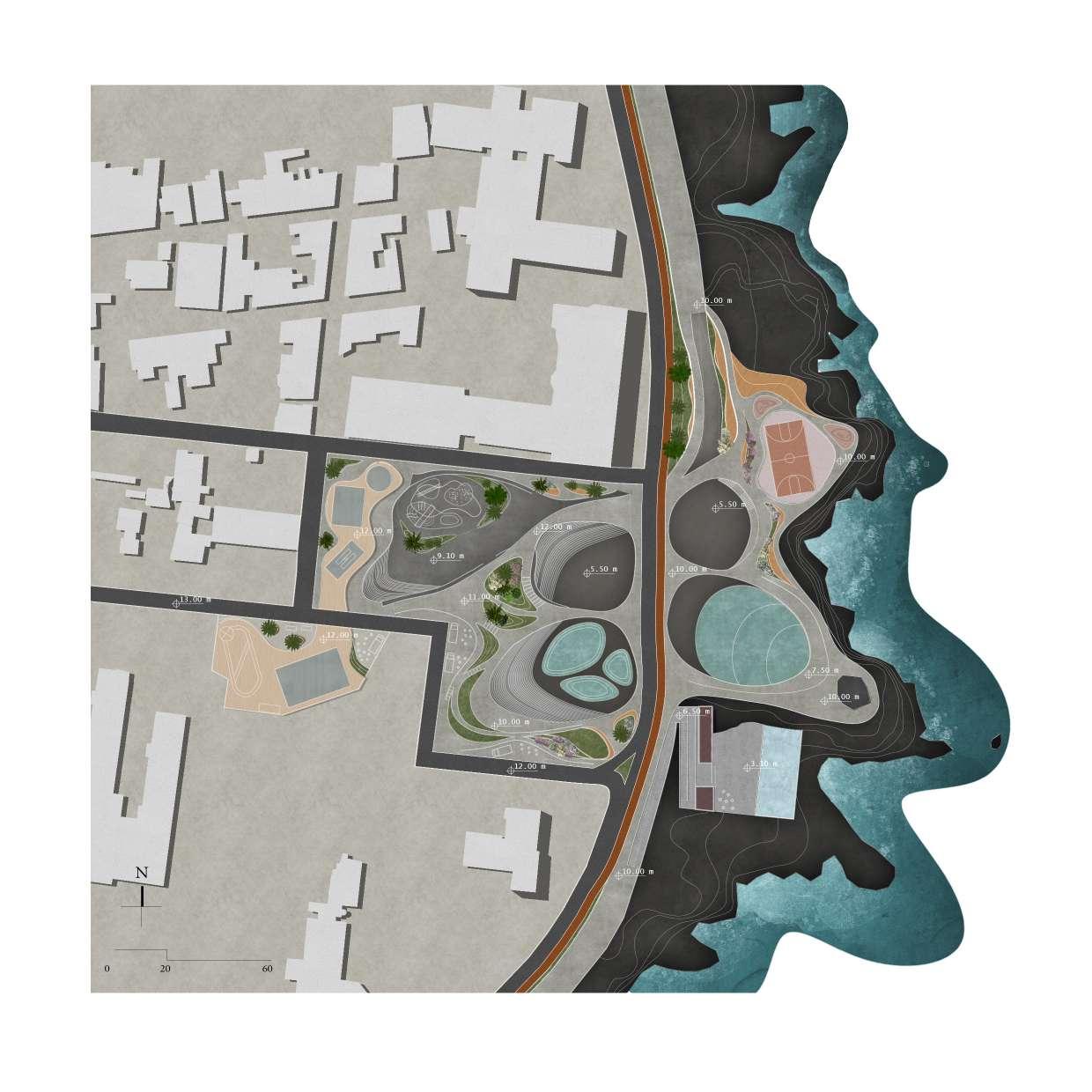

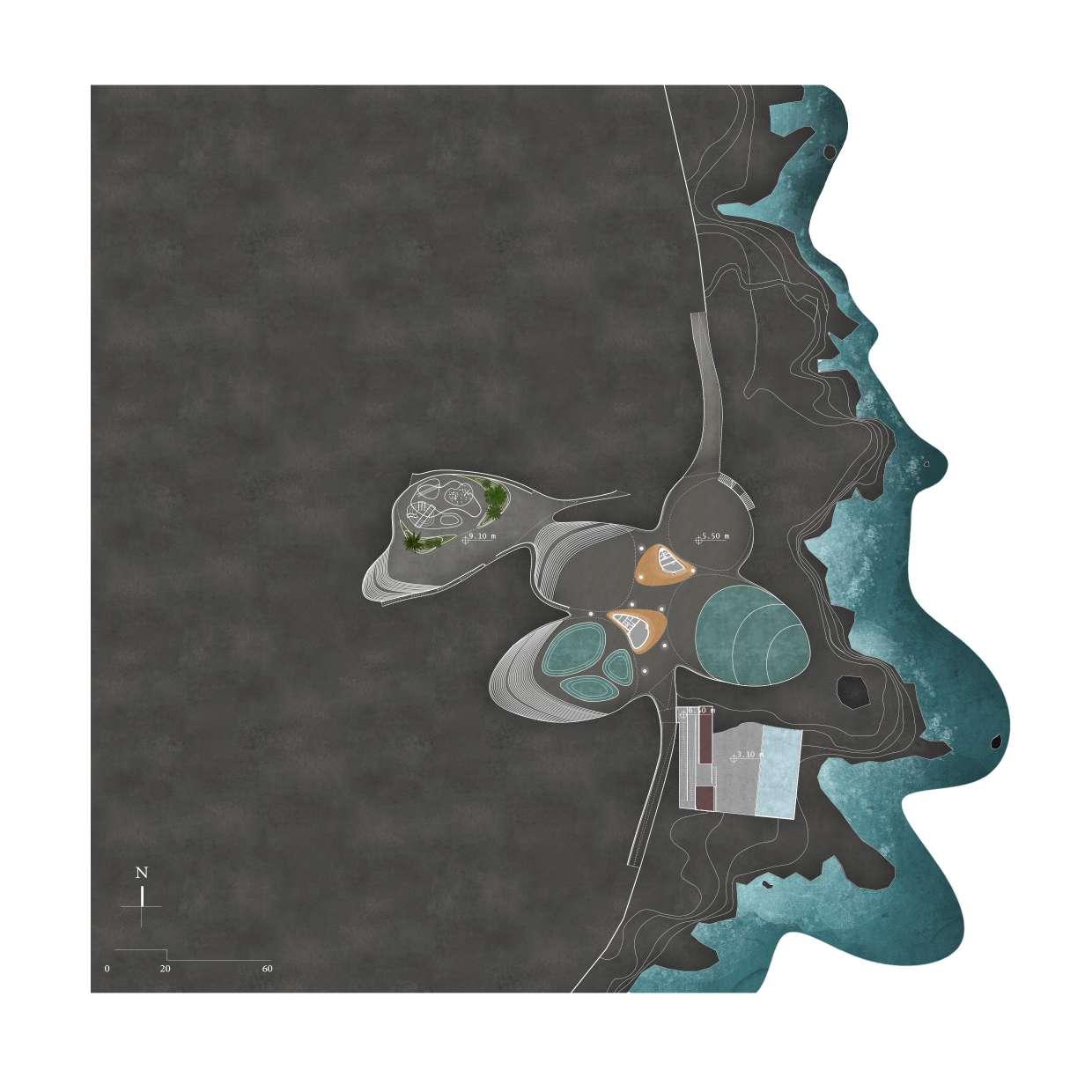

Le funzioni
Scelto di mantenere gli elementi esistenti, quali le giostre, le paninerie e il campo da basket, si è pensato dunque ad ulteriori funzioni. Le funzioni presenti sono riconducibili a due grandi categorie: l’acqua e l’uomo.
L’acqua
L’acqua diventa infatti protagonista di questo nuovo spazio pubblico e in particolar modo è l’acqua del mare che penetra lo spazio nelle sue diverse forme: acqua liquida e acqua nebulizzata. Prendono il nome di “anfiteatro d’acqua”, le quattro vasche di acqua di mare presenti nell’ampia piazza scavata nella roccia: queste ultime non solo costituiscono lo sfondo per questo nuovo spazio pubblico, ma contribuiscono a rendere ancora più ampio uno spazio di per sé vasto, più luminoso grazie ai suoi giochi di luce e diventano essi stessi punti di interazione e fonte di gioco, oltre che a contribuire al raffrescamento naturale dell’ambiente.

Una prima vasca d’acqua si compone di 3 piccole vasche dalle forme organiche e dalla profondità di 50 cm, e sono circondate come un vero e proprio anfiteatro, da una gradonata ellittica, sulle quali è possibile soffermarsi e sedersi per godere della vista.
Dal medesimo punto è possibile scorgere la seconda unica grande vasca, che invece, presenta una profondità crescente raggiungendo la profondità di 1 m.
Il rapporto con l’acqua
Render dell’Anfiteatro d’acqua”

Render dell’affaccio sulla vasca d’acqua salata

La “Piscina del mare”, è invece raggiungibile mediante un sistema di rampe che si adagia sulla roccia dalla ridotta pendenza, e che mediante un accesso laterale, risolve il dislivello presente tra la quota della strada e quello del mare, permettendone dunque l’accesso alla piscina e anche al mare, e il raggiungimento della quota di 3.10 m sul livello del mare. Questo spazio è ricavato da quello che originariamente costituiva un’alta terrazza affacciata sul mare, alta 10 metri e che inglobava la costa rocciosa.

Si è dunque pensato di smantellare questa zona per poter riportare alla luce l’originario andamento delle curve di livello e di conseguenza adagiarvi la nuova struttura balneare.
Le rampe infatti seguono un andamento parallelo alla strada, e conducono gradualmente dapprima al locale degli spogliatoi, in seguito al bar e infine alla piattaforma in calcestruzzo, da cui è possibile continuare il cammino tra le rocce e poter accedere al mare oppure usufruire della piscina di acqua salata.
I volumi si presentano come incastonati nella roccia, in calcestruzzo faccia vista e non compromettono la visuale del mare al visitatore che scende dalle rampe di accesso.
Si tratta infatti di un esplicito richiamo alle “Piscine delle Maree” di Alvaro Siza: anche qui alla base del progetto si pone la volontà di non invadere in maniera radicale l’ambiente naturale della costa rocciosa ma di adattarsi e quasi mimetizzarsi nella colata lavica, senza dunque, impedire la visuale del mare, ma piuttosto volto ad incorniciarla.
Zoom - La piscina del mare
Pianta della struttura balneare
Render della “Piscina del mare”


Sezione AA 1:300
Render della “Piscina del mare”
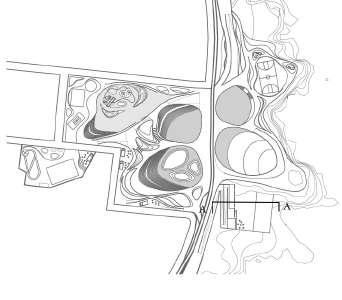

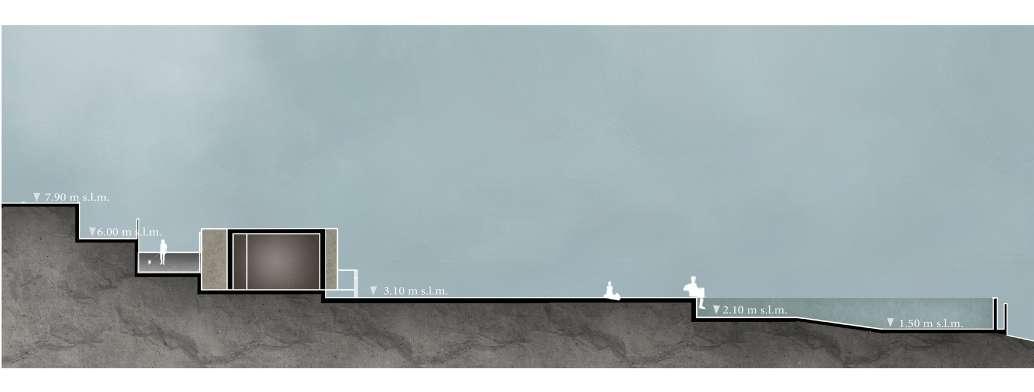
Il rapporto con l’uomo
L’area sportiva
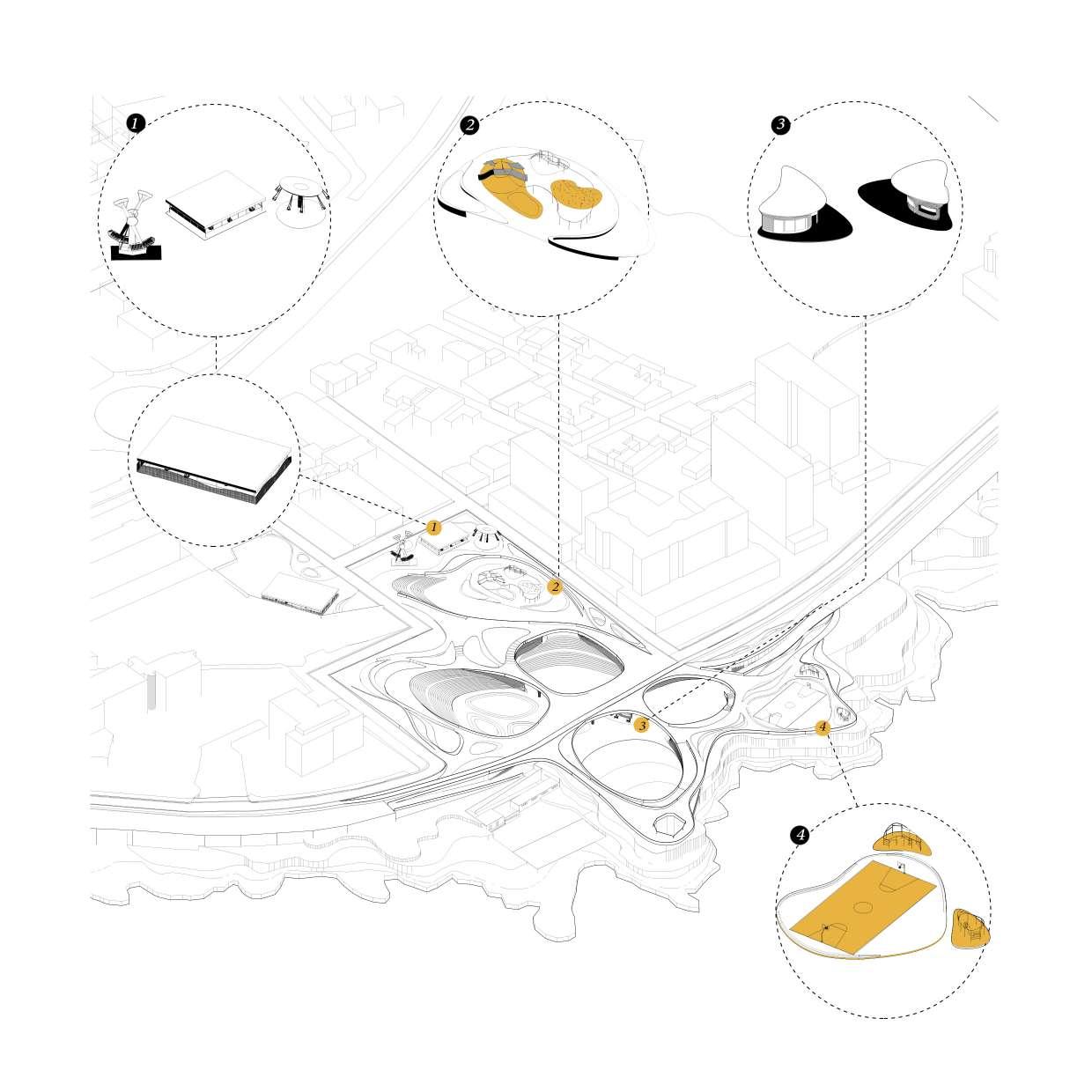
L’uomo
La seconda grande categoria è quella relativa all’uomo e alla sua interazione con il luogo.
La funzione prima di questo spazio pubblico è quella dello svago: dall’interazione dell’uomo con il luogo nascono il gioco e lo sport e si traducono nell’area giochi destinata ai bambini, nell’area fitness destinata agli sportivi che sono soliti frequentare il luogo, e ai due locali, un chiosco e un lounge bar, presenti a livello -1, che possano incentivare ancora di più la frequentazione diurna e notturna di questo spazio pubblico.
La prima area è quella del gioco dedicati ai bambini. Piazza Nettuno infatti non prevede un vero e proprio spazio dedicato al gioco dei bambini se non con le sole giostre. Si è dunque pensato ad una vera e propria “oasi” di gioco, racchiusa da grandi aree verdi dalle forme organiche che ospitano una vegetazione rigogliosa di palme di altezza varia e arbusti di origine mediterranea, a generare ombra e raffrescare la zona. Le stesse aiuole costituiscono delle lunghe sedute di calcestruzzo. Si compone di diversi elementi di gioco: dai classici scivoli all’arrampicata, dalla sabbiera ad una scaletta in acciaio. Tutti gli elementi sono attraversati letteralmente da una struttura tubolare curva, che costituisce elemento di collegamento dei giochi e inoltre, in corrispondenza della scaletta in acciaio, questo tubolare presenta un sistema di nebulizzazione dell’acqua.


La seconda area è quella dello sport, posta a nord in un’area d’affaccio sulla costa e comprende un campo da basket e due piccole aree dedicate allo street workout, dotate di sbarre per ogni tipologia di esercizio. L’area è invece delimitata da tre lunghe sedute ricurve, le quali racchiudono la zona centrale del campo da basket che per materiali spicca dal resto: infatti per delimitare questa zona è stato utilizzato un apposito rivestimento in resina.. +10

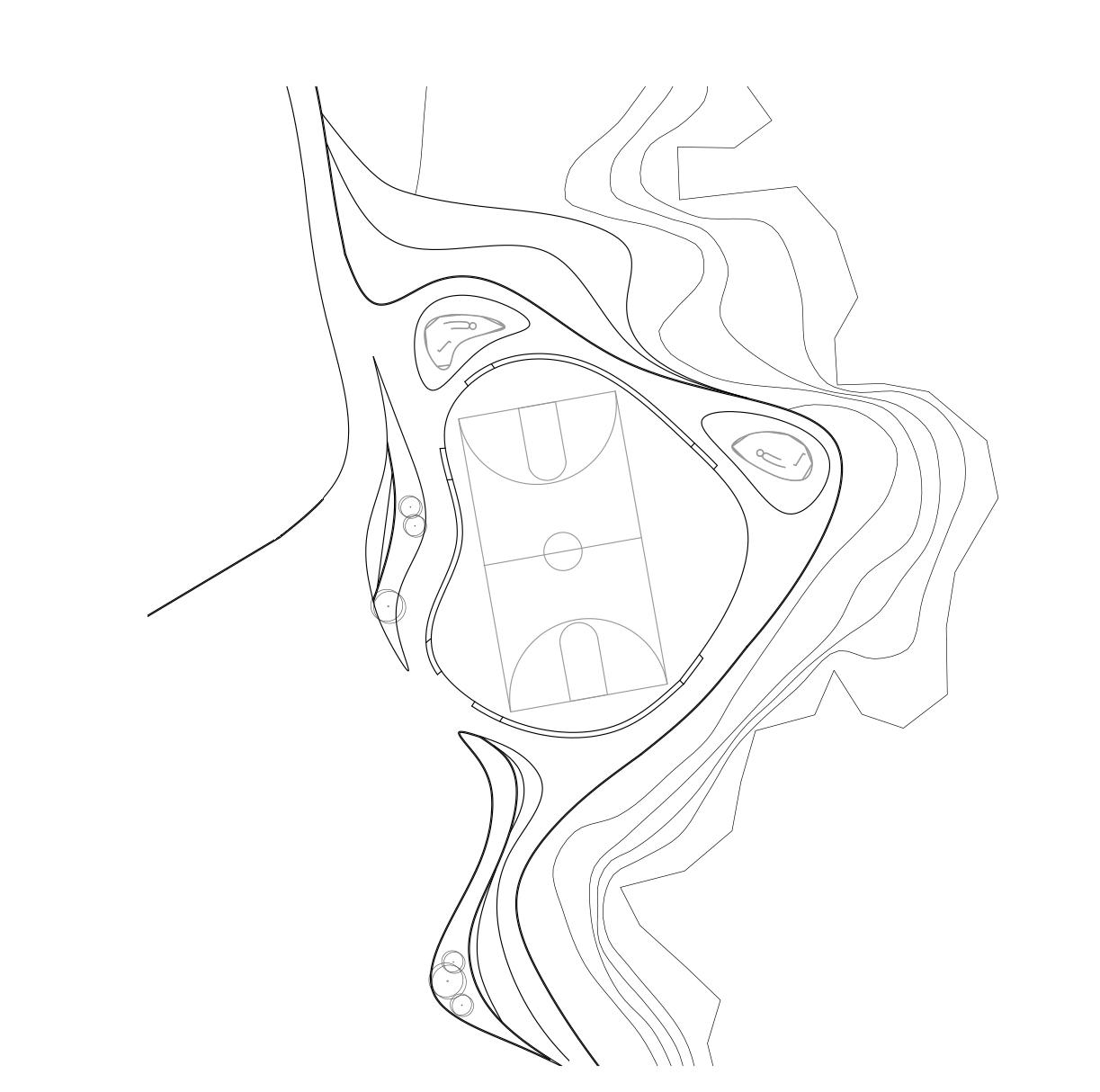
Vista dell’area sportiva


Infine, l’ultima area interessata è quella dei locali: sono stati collocati a livello -1, posti come perno centrale della grande piazza interrata, con la finalità di rendere frequentata e viva una zona, che, soprattutto per quanto concerne le ore serali, potrebbe risultare poco sicura.

 Pianta dei locali
Pianta dei locali


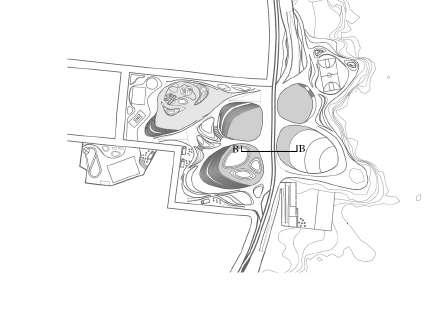

Vegetazione di progetto Le essenze