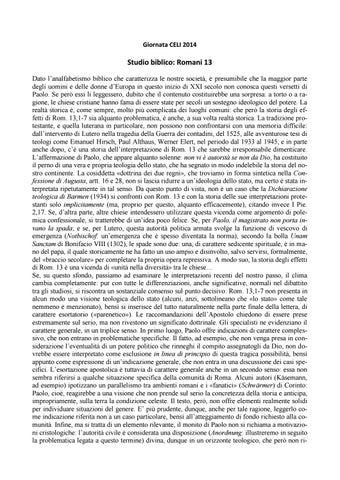Giornata CELI 2014
Studio biblico: Romani 13 Dato l’analfabetismo biblico che caratterizza le nostre società, è presumibile che la maggior parte degli uomini e delle donne d’Europa in questo inizio di XXI secolo non conosca questi versetti di Paolo. Se però essi li leggessero, dubito che il contenuto costituirebbe una sorpresa: a torto o a ragione, le chiese cristiane hanno fama di essere state per secoli un sostegno ideologico del potere. La realtà storica è, come sempre, molto più complicata dei luoghi comuni: che però la storia degli effetti di Rom. 13,1-7 sia alquanto problematica, è anche, a sua volta realtà storica. La tradizione protestante, e quella luterana in particolare, non possono non confrontarsi con una memoria difficile: dall’intervento di Lutero nella tragedia della Guerra dei contadini, del 1525, alle avventurose tesi di teologi come Emanuel Hirsch, Paul Althaus, Werner Elert, nel periodo dal 1933 al 1945, e in parte anche dopo, c’è una storia dell’interpretazione di Rom. 13 che sarebbe irresponsabile dimenticare. L’affermazione di Paolo, che appare alquanto solenne: non vi è autorità se non da Dio, ha costituito il perno di una vera e propria teologia dello stato, che ha segnato in modo indelebile la storia del nostro continente. La cosiddetta «dottrina dei due regni», che troviamo in forma sintetica nella Confessione di Augusta, artt. 16 e 28, non si lascia ridurre a un’ideologia dello stato, ma certo è stata interpretata ripetutamente in tal senso. Da questo punto di vista, non è un caso che la Dichiarazione teologica di Barmen (1934) si confronti con Rom. 13 e con la storia delle sue interpretazioni protestanti solo implicitamente (ma, proprio per questo, alquanto efficacemente), citando invece I Pie. 2,17. Se, d’altra parte, altre chiese intendessero utilizzare questa vicenda come argomento di polemica confessionale, si tratterebbe di un’idea poco felice. Se, per Paolo, il magistrato non porta invano la spada; e se, per Lutero, questa autorità politica armata svolge la funzione di vescovo di emergenza (Notbischof: un’emergenza che è spesso diventata la norma), secondo la bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII (1302), le spade sono due: una, di carattere sedicente spirituale, è in mano del papa, il quale storicamente ne ha fatto un uso ampio e disinvolto, salvo servirsi, formalmente, del «braccio secolare» per completare la propria opera repressiva. A modo suo, la storia degli effetti di Rom. 13 è una vicenda di «unità nella diversità» tra le chiese… Se, su questo sfondo, passiamo ad esaminare le interpretazioni recenti del nostro passo, il clima cambia completamente: pur con tutte le differenziazioni, anche significative, normali nel dibattito tra gli studiosi, si riscontra un sostanziale consenso sul punto decisivo: Rom. 13,1-7 non presenta in alcun modo una visione teologica dello stato (alcuni, anzi, sottolineano che «lo stato» come tale nemmeno è menzionato), bensì si inserisce del tutto naturalmente nella parte finale della lettera, di carattere esortatorio («parenetico»). Le raccomandazioni dell’Apostolo chiedono di essere prese estremamente sul serio, ma non rivestono un significato dottrinale. Gli specialisti ne evidenziano il carattere generale, in un triplice senso. In primo luogo, Paolo offre indicazioni di carattere complessivo, che non entrano in problematiche specifiche. Il fatto, ad esempio, che non venga presa in considerazione l’eventualità di un potere politico che rinneghi il compito assegnatogli da Dio, non dovrebbe essere interpretato come esclusione in linea di principio di questa tragica possibilità, bensì appunto come espressione di un’indicazione generale, che non entra in una discussione dei casi specifici. L’esortazione apostolica è tuttavia di carattere generale anche in un secondo senso: essa non sembra riferirsi a qualche situazione specifica della comunità di Roma. Alcuni autori (Käsemann, ad esempio) ipotizzano un parallelismo tra ambienti romani e i «fanatici» (Schwärmer) di Corinto: Paolo, cioè, reagirebbe a una visione che non prende sul serio la concretezza della storia e anticipa, impropriamente, sulla terra la condizione celeste. Il testo, però, non offre elementi realmente solidi per individuare situazioni del genere. E’ più prudente, dunque, anche per tale ragione, leggerlo come indicazione riferita non a un caso particolare, bensì all’atteggiamento di fondo richiesto alla comunità. Infine, ma si tratta di un elemento rilevante, il monito di Paolo non si richiama a motivazioni cristologiche: l’autorità civile è considerata una disposizione (Anordnung: illustreremo in seguito la problematica legata a questo termine) divina, dunque in un orizzonte teologico, che però non ri-