1.1.4Situazione economica delle singole aziende
La valutazione della situazione economica delle aziende si fonda sui risultati della Centrale analisi di Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Non soltanto i diversi dati concernenti il reddito, bensì, ad esempio, anche gli indicatori sulla stabilità finanziaria forniscono informazioni importanti in merito alla situazione economica delle aziende. Gli indicatori figurano dettagliatamente nella tabella in allegato. Nelle pagine seguenti ne vengono trattati approfonditamente alcuni.
Adeguamenti metodologici 2007

Quest’anno la Centrale analisi ha introdotto due tipi di adeguamenti metodologici. Essi riguardano il passaggio dal conto reddito lordo al conto prestazione lorda nonché i costi del commercio dei contingenti lattieri.
–Passaggio dal conto reddito lordo al conto prestazione lorda: il reddito lordo è un parametro economico in disuso che riporta le entrate rettificate in base agli acquisti di animali. Nel calcolo della prestazione lorda gli acquisti di animali non vengono registrati in negativo, bensì aggiunti alla lista dei costi. I valori delle rubriche prestazione lorda, spese materiali e costi di terzi variano in funzione dei costi legati agli acquisti di animali. Non è tuttavia possibile procedere a tali adeguamenti poiché non si dispone delle informazioni dettagliate per gli anni prima del 2003.
–Riclassificazione dei costi del commercio dei contingenti lattieri: secondo la nuova definizione, tali costi non vengono più considerati come spese materiali derivate dalla detenzione di animali. I costi legati all’acquisto di un contingente figurano come ammortamenti alla rubrica spese strutturali, che, proprio come le spese materiali derivate dalla detenzione di animali, rientrano nella categoria delle spese materiali. I costi derivati dalla presa in affitto di un contingente figurano per la prima volta alla rubrica canoni d’affitto che fa parte della cosiddetta categoria delle spese materiali 2 (costi del personale, interessi).
Per rendere possibile il confronto con gli anni precedenti, è stato necessario adeguare i dati relativi agli anni 2003–2005. Tali adeguamenti non hanno ripercussioni sull’ammontare del reddito agricolo né su quello del profitto del lavoro.
■■■■■■■■■■■■■■■■
Terminologia e metodi, pagina A59
51 1.1 ECONOMIA 1
■ Il reddito agricolo 2006 è diminuito rispetto al 2003/05
Reddito e indicatori economico-aziendali
Andamento dei redditi delle aziende agricole: media di tutte le regioni
Nel 2006 la prestazione lorda derivata dalla produzione agricola è rimasta praticamente costante rispetto alla media degli anni 2003/05 (+0,5%) e all’anno prima (–0,2%). Rispetto al triennio precedente i pagamenti diretti per azienda sono aumentati del 4,8 per cento. L'incremento rispetto al 2005 è stato del 2,6 per cento. Ciò è riconducile alla crescita dell’azienda in termini di superficie nonché allo sviluppo della detenzione di vacche madri.
Nel 2006 i costi di terzi sono stati del 2,9 per cento superiori al livello del triennio 2003/05. Rispetto al 2005 si registra un aumento dello 0,5 per cento. In particolare sono aumentati i costi per foraggi concentrati per bovini, altri foraggi, edifici, personale, interessi passivi e costi generali d’esercizio. Sono invece diminuiti i costi per l’acquisto di animali in seguito al calo dei prezzi dei suinetti.
Il reddito agricolo è il risultato della differenza fra prestazione lorda e costi di terzi. Esso indennizza da un lato il lavoro della manodopera familiare pari mediamente a 1,24 unità e dall’altro il capitale proprio investito nell’azienda pari mediamente a 411'000 franchi. Nel 2006 il reddito agricolo risultava del 2,5 per cento al di sotto del valore registrato nel 2005 e del 6,5 per cento inferiore al valore medio degli anni 2003/05.
Tabelle 17–26, pagine A16–A26
1990/9220052006 20032004 fr. per azienda Reddito extraagricolo Reddito agricolo Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 16 264 62 822 1,39 ULAFUnità di lavoro annuale della famiglia 21 557 60 472 1,25 22 172 54 274 1,24 22 939 52 915 1,24 21 210 55 029 1,24 52 1.1 ECONOMIA 1
Nel 2006, rispetto agli anni 2003/05, il reddito agricolo ha subito una flessione nella regione di pianura e in quella collinare pari rispettivamente all’8 e al 7,4 per cento; nella regione di montagna si è registrato un calo pari al 2,1 per cento. Il reddito extraagricolo ha segnato un incremento in tutte le regioni, ma soprattutto in quella di pianura (+6,9%), seguita dalle regioni collinare (+2,8%) e di montagna (+7,8%). Nella regione di montagna il reddito globale è leggermente aumentato (+1,1%), mentre nella regione collinare (–4,3%) e in quella di pianura (–4,5%) è diminuito.
Reddito delle aziende agricole secondo le regioni
Nel 2006 la quota di pagamenti diretti rispetto alla prestazione lorda era del 16,4 per cento nella regione di pianura, del 22,9 per cento in quella collinare e del 36,3 per cento in quella di montagna. Rispetto al 2003/05 la quota nella regione di pianura e in quella di collinare è aumentata lievemente, mentre è leggermente diminuita nella regione di montagna.
Reddito per regioneUnità1990/9220032004200520062003/05–2006 % Regione di pianura Superficie agricola utileha16,6619,7920,0720,6421,024,2 Unità di lavoro della famigliaULAF1,361,191,211,191,19–0,6 Reddito agricolofr.73 79464 12972 61562 69661 132–8,0 Reddito extraagricolofr.16 42920 64220 53221 53122 3396,9 Reddito globalefr.90 22384 77193 14684 22783 471–4,5 Regione collinare Superficie agricola utileha15,3018,4818,5218,9218,881,3 Unità di lavoro della famigliaULAF1,401,261,231,231,22–1.6 Reddito agricolofr.59 83851 44254 74249 62748 114–7,4 Reddito extraagricolofr.14 54421 67122 16723 27723 0002,8 Reddito globalefr.74 38273 11476 90972 90471 114–4,3 Regione di montagna Superficie agricola utileha15,7618,6018,6319,0919,664,7 Unità di lavoro della famigliaULAF1,421,311,331,341,330,3 Reddito agricolofr.45 54143 92146 10944 80743 980–2,1 Reddito extraagricolofr.17 85321 66222 64522 15123 8797,8 Reddito globalefr.63 39465 58368 75466 95867 8581,1
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 53 1.1 ECONOMIA 1
Tabelle 17–20, pagine A16–A19
La situazione relativa al reddito negli undici tipi di azienda (indirizzi di produzione) è indicatrice di differenze ragguardevoli.
Reddito delle aziende agricole secondo i tipi di azienda – 2004/06
Tipo di aziendaSuperficie Unità di Reddito Reddito Reddito agricola utilelavoro della agricoloextraagricologlobale famiglia haULAFfr.fr.fr.
Nella media degli anni 2004/06 le aziende attive nei settori colture speciali, campicoltura nonché determinate aziende combinate (latte commerciale/campicoltura, trasformazione) hanno realizzato il reddito agricolo più elevato. Queste aziende, assieme alle aziende del tipo «Aziende combinate, vacche madri», hanno ottenuto parimenti il reddito globale più alto. Il reddito agricolo e il reddito globale più bassi sono stati rilevati nelle aziende dei tipi «Equini/ovini/caprini» e «Altro bestiame bovino». Le aziende specializzate del tipo «Latte commerciale» hanno fatto segnare valori medi. I loro risultati inerenti a tutte le categorie di reddito sono risultati al di sotto della media.
Media di tutte le aziende19,691,2455 88722 22378 110 Campicoltura23,000,9763 02329 60292 625 Colture speciali12,951,2867 89120 33088 221 Latte commerciale19,791,3253 25218 73871 990 Vacche madri19,411,1444 59832 88477 482 Altro bestiame bovino16,831,2437 35127 01564 366 Equini/ovini/caprini13,191,1726 72539 06365 788 Trasformazione11,641,2154 39527 98082 374 Aziende combinate, latte commerciale/campicoltura26,501,2770 26715 22485 490 Aziende combinate, vacche madri23,001,0753 59632 20485 800 Aziende combinate, trasformazione19,851,2568 10516 96585 070 Aziende combinate, altre21,931,2358 49122 14480 636 Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
54 1.1 ECONOMIA 1
Tabelle 21a–21b, pagine A20–A21
■ Profitto del lavoro –2006
Il profitto del lavoro conseguito dalle aziende agricole (reddito agricolo meno interessi per il capitale proprio investito nell’azienda) remunera il lavoro della manodopera famigliare non salariata. Il profitto del lavoro registrato nel 2006 per unità di lavoro della famiglia (valore mediano) è cresciuto del 6,3 per cento rispetto alla media del triennio 2003/05. Rispetto al 2005 si è invece registrato un calo del 4,1 per cento. Profitto del lavoro e reddito agricolo sono quindi diminuiti in ugual misura negli ultimi tre anni. Dal confronto con il 2005 risulta tuttavia che il profitto del lavoro ha fatto registrare un calo maggiore rispetto al reddito agricolo. Ciò è dovuto all’aumento degli interessi (interessi delle obbligazioni della Confederazione più elevati).
Il profitto del lavoro per unità di lavoro della famiglia ha seguito un andamento molto diverso a dipendenza della regione. Mediamente esso è stato decisamente più elevato nella regione di pianura che in quella di montagna. Divari notevoli si registrano anche per quanto concerne i quartili. Nel periodo 2004/06 nella regione di pianura, il profitto del lavoro nel primo quartile è stato pari al 22,3 per cento e nel quarto quartile al 202,6 per cento del valore medio di tutte le aziende della regione. La varianza è stata simile nella regione collinare (18,3% e 196,3%) e ancora più marcata in quella di montagna (9,8% e 207,5%).
Profitto del lavoro delle aziende agricole – 2004/06, per regioni e quartili

Profitto del lavoro 1 in fr. per ULAF 2 Valore
1L’interesse del capitale proprio corrisponde al tasso d’interesse medio delle obbligazioni della Confederazione. 2004: 2,73%, 2005 2,11%; 2006: 2,50% 2Unità di lavoro annuale della famiglia: base 280 giorni di lavoro
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Valori
mediano RegioneI quartileII quartileIII quartileIV quartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Regione di pianura43 08710 12834 39852 24791 841 Regione collinare32 5546 18925 44239 46466 498 Regione di montagna25 5712 66119 47032 18656 514
medi
Tabelle 22–25, pagine A22–A25
55 1.1 ECONOMIA 1
■ Stabilità finanziaria
Nel 2004/06 nella regione di pianura e in quella collinare il quarto quartile delle aziende agricole ha superato il livello di salario lordo annuale della rimanente popolazione rispettivamente di circa 23'000 e 3'000 franchi. Nel periodo considerato nella regione di montagna il quarto quartile ha mancato di poco il livello del rispettivo salario comparabile. Rispetto al periodo 2003/05 la regione di pianura è stata la sola a migliorare leggermente la sua situazione in termini relativi.
Salario comparabile – 2004/06, per regioni
Va tenuto in considerazione che le economie domestiche agricole non dispongono soltanto del profitto del lavoro per il proprio sostentamento. Il loro reddito globale, compreso quello non agricolo, è notevolmente maggiore del profitto del lavoro.
La quota del capitale di terzi rispetto al capitale globale indica il grado d’indebitamento dell’impresa. Se questo dato viene combinato con l’entità della formazione del capitale proprio, è possibile esprimere considerazioni in merito alla sopportabilità di un debito. Dal profilo finanziario un’azienda permanentemente confrontata con una quota elevata di capitale di terzi e una formazione del capitale proprio negativa non è in grado di sopravvivere.
Sulla base di queste considerazioni, le aziende sono state classificate in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa.
Classificazione delle aziende in quattro gruppi con stabilità finanziaria diversa
Aziende con … Quota di capitali di terzi Bassa (<50%)Elevata (>50%)
Formazione di positiva... una situazione... un’autonomia financapitale proprio buonaziaria limitata negativa... un reddito ... una situazione finaninsufficienteziaria preoccupante
Fonte: De Rosa
RegioneSalario comparabile 1 fr. per anno Regione di pianura68 953 Regione collinare63 281 Regione di montagna58 150
1Valore mediano dei salari lordi annui di tutte le persone impiegate nel secondario e nel terziario.
Fonti: UST, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
1.1 ECONOMIA 1 56
Dalla valutazione della stabilità finanziaria delle aziende scaturisce un quadro analogo per tutte le regioni. Il 40–44 per cento delle aziende ha una buona situazione finanziaria. Nel 34–36 per cento circa dei casi la situazione è considerata problematica (aziende con formazione del capitale proprio negativa). La media del triennio 2004/06 segna dunque un peggioramento generalizzato in tutte le regioni rispetto al 2003/05.
Valutazione della stabilità finanziaria 2004/06: per regioni

Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna Quota di aziende Situazione finanziaria preoccupante Reddito insufficiente Autonomia finanziaria limitata Situazione finanziaria buona Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 18 18 22 42 18 17 25 40 14 20 23 44 1.1 ECONOMIA 1 57
■ Formazione di capitale proprio, investimenti e quota di capitali di terzi
Rispetto al 2003/05 gli investimenti effettuati nel 2006 dalle aziende di riferimento di ART sono scesi del 4,5 per cento. Si è registrato anche un calo per quanto riguarda il cash flow (–5,5%). Il rapporto fra cash flow e investimenti si è quindi contratto dell’1,5 per cento. La situazione relativa alla formazione di capitale proprio (reddito globale meno consumo privato) è decisamente peggiorata rispetto al periodo di riferimento (–42,8%), mentre la quota di capitale di terzi è leggermente cresciuta (+3,8%). Il motivo di tale incremento è dato dal fatto che il capitale di terzi è cresciuto maggiormente rispetto al capitale proprio. Per quanto riguarda il capitale di terzi, sono infatti aumentati in modo particolare i crediti ipotecari e il capitale di terzi a medio e lungo termine.
Evoluzione della formazione del capitale proprio, degli investimenti e della quota di capitali di terzi
1Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti sovvenzioni e disinvestimenti
2
fra cash flow (formazione del capitale proprio più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo) e investimenti
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

Caratteristica1990/9220032004200520062003/05–2006 % Formazione di capitale propriofr.19 51313 34315 5909 4937 325–42,8 Investimenti 1 fr.46 91447 58051 26147 33646 524–4,5 Rapporto cash flow – investimenti 2 %9595918890–1,5 Quota di capitale di terzi%43434443453,8
Rapporto
1.1 ECONOMIA 1 58
Con quale grado d’efficienza l’agricoltura fornisce prestazioni multifunzionali?
In virtù dell’articolo 104 della Costituzione, la Confederazione deve provvedere affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale e a garantire un’occupazione decentrata del territorio. Dall’inizio degli anni ’90, si parla, a tal proposito, della multifunzionalità dell’agricoltura. Uno studio presentato nella primavera 2007, curato da 4hm AG e dal centro di ricerche di business metrics dell’Università di San Gallo, mostra che i compiti multifunzionali fissati nell’articolo della Costituzione hanno una grande valenza per la popolazione. Parallelamente, le aziende efficienti possono raggiungere un reddito adeguato a condizione che queste prestazioni siano fornite.
Da alcuni anni l’OCSE si occupa attivamente delle prestazioni multifunzionali dell’agricoltura. Un tema importante è la cosiddetta «jointness», ovvero il tipo e l’intensità del legame tra la produzione di derrate alimentari e le prestazioni multifunzionali, alla luce della quale acquista grande valenza anche l’efficienza delle capacità multifunzionali dell’agricoltura. Nel quadro di un progetto dell’OCSE incentrato su tale tema, l’UFAG ha commissionato una ricerca per trattarne i vari aspetti. Dopo una breve introduzione della tematica, di seguito, vengono illustrati i principali risultati di questa ricerca.
Il termine multifunzionalità è riconosciuto internazionalmente nella misura in cui vengono accettati strumenti di indennizzo delle prestazioni multifunzionali. In Svizzera è mediante i pagamenti diretti che vengono indennizzate le prestazioni multifunzionali dell’agricoltura fissate ai sensi della Costituzione.
L’OCSE ha analizzato il concetto della multifunzionalità dal profilo economico-teorico, traendo conclusioni per l’impostazione di provvedimenti di natura politica. Uno dei punti chiave per definire provvedimenti di natura politica efficaci è il grado di jointness, ovvero la portata del legame tra la produzione di beni e le prestazioni multifunzionali. Esso viene definito attraverso il principio delle economie di scopo (economies of scope). A tal fine i costi della produzione congiunta vengono confrontati con quelli di prestazioni alternative. Vengono stimati i costi che sarebbero generati se tutte le attuali prestazioni multifunzionali dell’agricoltura (p.es. cura del paesaggio) non fossero più fornite in maniera congiunta alla produzione agricola, bensì da altri fornitori (p.es. giardinieri paesaggisti). Secondo l’OCSE si parla di economie di scopo se la produzione congiunta è economicamente più conveniente della produzione separata di beni agricoli e prestazioni multifunzionali. In tal caso la produzione congiunta e il rispettivo sostegno all’agricoltura sono efficienti e anche economicamente opportuni.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.1 ECONOMIA 1 59
■ Multifunzionalità e jointness
La valutazione della jointness nel quadro dell’agricoltura svizzera è particolarmente interessante al fine di impiegare in modo efficiente i fondi federali. La difficoltà sta nelle complesse relazioni tra l’agricoltura e le prestazioni pubbliche, ma anche tra le diverse prestazioni. L’agricoltura fornisce parallelamente diverse prestazioni multifunzionali interagenti e difficilmente separabili le une dalle altre. Un primo passo nell’analisi di problemi complessi risiede nella suddivisione in sottoaspetti e nell’analisi separata di questi sottoproblemi. A tal proposito sono utili le conoscenze, di seguito riportate, emerse dagli studi sulla jointness tra agricoltura e paesaggio, sviluppo rurale, nonché sicurezza alimentare quali basi per una valutazione sovrasettoriale dell’efficienza della fornitura di prestazioni multifunzionali da parte dell’agricoltura.
Lo studio di Robert Huber (PFZ) fornisce una stima dei costi, alle condizioni del mercato mondiale, relativi alla cura del paesaggio non da parte dell’agricoltura nella regione del lago di Greifen. Questo studio fornisce spunti per la valutazione della jointness tra agricoltura e paesaggio. L’analisi verteva sulla funzione estetica del paesaggio, che è correlato all’agricoltura attraverso il tipo di gestione dei terreni e gli elementi paesaggistici quali alberi e siepi.
I costi per una cura del paesaggio alternativa sono costituiti, da un lato, dai costi per la cura delle superfici (sfalcio e pacciamatura) e la valorizzazione della biomassa ottenuta, dall’altro dai costi per la conservazione della varietà del paesaggio e per gli elementi paesaggistici (alberi e siepi). I costi si riferiscono tuttavia soltanto alle superfici che non vengono impiegate per l’avvicendamento delle colture. In tal modo si assicura che i costi di fornitura alternativa per la cura del paesaggio colturale non si mescolino con l’obiettivo della garanzia dell’approvvigionamento della popolazione.
Dai calcoli effettuati è emerso che i costi annui per la fornitura alternativa della cura del paesaggio nella regione del lago di Greifen ammontano a 8,5 milioni di franchi circa. Con tale importo si assicurerebbe la cura di una superficie pari a 3'580 ettari, pari al 43 per cento della superficie totale della regione presa in esame. I costi per la cura degli elementi paesaggistici rappresentano soltanto un quinto dei costi totali, mentre quelli per la cura delle superfici rappresentano poco meno di un quarto. I costi di valorizzazione della biomassa, pari ad oltre il 55 per cento, fanno registrare la quota più alta rispetto ai costi di fornitura di prestazioni alternative.
I costi della cura del paesaggio non congiunta alla produzione agricola nella regione di pianura svizzera dipendono essenzialmente dal modo in cui viene valorizzata la biomassa. Il fatto che l’agricoltura disponga di vantaggi legati ai costi relativi alla cura del paesaggio dipende dalla misura in cui essa può utilizzare le superfici ai prezzi del mercato mondiale e dal modo in cui sviluppa i metodi tecnici di valorizzazione di forniture alternative.

1.1 ECONOMIA 1 60
■ Jointness tra agricoltura e paesaggio nella regione di pianura
Lo studio di Christian Flury, Gianluca Giuliani e Simon Buchli (Flury&Giuliani GmbH) verteva da un lato sulla valenza dell’agricoltura dal profilo dell’occupazione e del valore, dall’altro sul confronto tra i costi per l’attuale sostegno dell’agricoltura e quelli per la creazione di possibilità occupazionali alternative. Nello studio sono state prese in considerazione quattro regioni di montagna della Svizzera orientale (GR, GL): Sernftal, Poschiavo, Safiental e Albula.
Spiegazione della terminologia
Valore aggiunto: incremento di valore che si verifica nell’ambito della produzione o della trasformazione di un bene. Se si compra un bene per 1 franco e lo si rivende, trasformato, per 1.50 franchi, si ha un valore aggiunto di 0.50 franchi.
Effetto sul valore aggiunto: effetto moltiplicatore relativo al valore aggiunto. Indica quale influsso ha un franco prodotto nell’agricoltura sul flusso medio degli altri settori economici.
Effetto sull’occupazione: effetto moltiplicatore relativo all’occupazione. Indica quale influsso ha un posto di lavoro nell’agricoltura attraverso le interconnessioni economiche sui posti di lavoro degli altri settori economici.
Nelle quattro regioni prese in esame il 14–72 per cento delle persone occupate e il 7–49 per cento del valore aggiunto sono direttamente o indirettamente vincolati all’agricoltura. Il contributo dell’agricoltura è alto soprattutto nelle regioni a vocazione agricola e le ripercussioni negative indirette diminuiscono in maniera inversamente proporzionale alla quota dell’agricoltura di una regione. Le possibilità di ottenere prestazioni preliminari, beni d’investimento e di consumo in regioni con un’economia poco differenziata sono limitate e pertanto l’effetto sull’occupazione e sul valore aggiunto esercitato dall’agricoltura negli altri settori economici è esiguo.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.1 ECONOMIA 1 61
■ Jointness tra agricoltura e sviluppo rurale nella regione di montagna
■ Jointness tra agricoltura e sicurezza alimentare
Valenza dal profilo economico-regionale dell’agricoltura nelle quattro regioni prese in esame
Effetto indiretto sull'occupazione del primario Persone direttamente occupate nel primario Effetto indiretto sul valore aggiunto del primario Valore aggiunto diretto del primario
L’effetto sull’occupazione esercitato dall’agricoltura, attraverso il sostegno vincolato alla produzione e i pagamenti generali, genera costi che variano a seconda della regione da un minimo di 35'000 ad un massimo di 55'000 franchi per equivalente a tempo pieno. Per quanto riguarda l’effetto sul valore aggiunto, i costi oscillano tra 0.52 e 0.73 franchi per franco di valore aggiunto. I costi sono elevati soprattutto nelle regioni a vocazione agricola e ciò è riconducibile al minor valor aggiunto dell’agricoltura e al minor effetto moltiplicatore in relazione a occupazione e valore aggiunto.
Un andamento analogo si osserva per i costi delle possibilità occupazionali alternative. Nelle regioni a vocazione agricola, alle attuali condizioni quadro, è praticamente impossibile trovare e mantenere un impiego nel secondario e nel terziario siccome i costi superano il valore aggiunto realizzabile. Ciò significa che in queste regioni si può parlare di economie di scopo in relazione allo sviluppo rurale poiché il sostegno dell’agricoltura presenta dei vantaggi rispetto alle forniture alternative. Nelle regioni (grandi) che hanno un’economia diversificata o a vocazione turistica si potrebbero creare possibilità occupazionali alternative a costi più bassi rispetto al primario.
Lo studio sul contributo dell’agricoltura alla sicurezza alimentare è stato pubblicato dal prof. Pius Hättenschwiler (Università di Friburgo) e Christian Flury (Flury&Giuliani GmbH). È stato fatto un paragone tra l’attuale garanzia dell’approvvigionamento in situazioni di crisi e quella data da una produzione indigena alle condizioni del mercato mondiale, ovvero da un’agricoltura senza alcun sostegno.
Quota rispetto all'occupazione e al valore aggiunto regionali in %
Sernftal 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Puschlav
1.1 ECONOMIA 1 62
Fonte:
Flury & Giuliani GmbH
Safiental Albula
In Svizzera la strategia di sicurezza alimentare è impostata in maniera da poter garantire il completo approvvigionamento della popolazione nei primi sei mesi di crisi. In questo periodo devono poter essere adottati provvedimenti per gestire la crisi. La strategia tiene conto di vari rischi e sviluppi entro e oltre i confini europei oppure delle ripercussioni di cambiamenti globali. Uno scenario medio di crisi standard parte dal presupposto che la metà della superficie agricola utile non sia più disponibile, che il commercio estero sia limitato al 50 per cento dei normali contatti commerciali e che le scorte obbligatorie nei primi sei mesi debbano essere usate per l’approvvigionamento della popolazione.
Esperti dell’Amministrazione, di organizzazioni agricole e di produttori nonché degli ambienti scientifici hanno effettuato una stima dei volumi di produzione dell’agricoltura svizzera alle condizioni del mercato mondiale. Tutti si attendono un calo compreso tra il 50 e il 70 per cento dell’utilizzo delle superfici, il quale, nel caso della campicoltura, potrebbe essere ancor più sensibile. Si stima una diminuzione del 25–40 per cento degli effettivi di animali, che nella peggiore delle ipotesi potrebbe toccare addirittura il 75 per cento. Per ottimizzare e valutare la sicurezza alimentare è stato impiegato il Modello Decision Support System (DSS), un supporto decisionale disponibile in Svizzera. Il DSS è stato sviluppato dal Dipartimento di informatica dell’Università di Friburgo (DIUF) quale supporto decisionale strategico e operativo per l’ottimizzazione della sicurezza alimentare in Svizzera.
Dai calcoli effettuati è emerso che in uno scenario di crisi come quello appena illustrato i volumi di produzione stimati non possono di fatto garantire l’approvvigionamento alimentare a medio e lungo termine. In uno scenario medio di crisi, invece, l’attuale produzione indigena e il relativo potenziale produttivo permettono di garantire la sicurezza alimentare in modo durevole.
Nell’ottica di crisi di approvvigionamento di breve durata è di per sé possibile scorporare la sicurezza alimentare dalla produzione agricola. Riducendo sostanzialmente la produzione indigena, gli alimenti necessari all’approvvigionamento della popolazione potrebbero comunque essere forniti (scorte obbligatorie). Tuttavia, ciò potrebbe determinare l’aumento sostanziale dei costi legati alla tenuta delle scorte obbligatorie imposta dallo Stato. A medio e lungo termine, non è invece possibile prescindere dal legame fra produzione indigena e sicurezza alimentare. In caso di lunghi periodi di crisi, assicurare le capacità di produzione e di trasformazione nonché la disponibilità dei mezzi di produzione necessari risulta fondamentale per poter convertire ed estendere la produzione. Per quanto riguarda le capacità di produzione, ciò implica la tutela delle superfici agricole in quanto potenziale produttivo nonché la conservazione del capitale rappresentato dai macchinari e dagli edifici. Benché non sarebbe indispensabile mantenere la produzione ai livelli odierni, limitare la produzione indigena equivarrebbe a ridurre le capacità di trasformazione. In situazioni di crisi sarebbe quasi impensabile ripristinare tali capacità in poco tempo e di conseguenza garantire l’approvvigionamento della popolazione.

1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.1 ECONOMIA 1 63
In linea di massima, si potrebbe anche immaginare di scorporare capacità di produzione e produzione stessa, affidandosi a provvedimenti alternativi. Quest’eventualità non è tuttavia stata oggetto di questo studio. Non è quindi dato saper se mantenere o meno le capacità produttive determini una reale differenza sul piano dei costi. Non sono state espresse considerazioni di alcun tipo riguardo all’efficienza dell’attuale sistema di sicurezza alimentare rispetto a un sistema alternativo alle condizioni del mercato mondiale. Mantenere il potenziale produttivo dell’agricoltura è comunque determinante, dal momento che, in situazione di crisi, non è possibile garantire un approvvigionamento della produzione a lungo termine sulla base di una produzione ai prezzi del mercato mondiale.
Nell’ambito di tali studi, è stata effettuata una distinzione fra economie di scopo e singole prestazioni multifunzionali, successivamente analizzate senza tenere conto della loro interconnessione. I risultati indicano che scorporare le diverse prestazioni potrebbe rivelarsi vantaggioso dal punto di vista economico. Nella realtà, però, l’agricoltura fornisce nel contempo varie prestazioni multifunzionali interconnesse. Con la produzione di derrate alimentari, ad esempio, essa contribuisce alla garanzia dell’approvvigionamento nonché alla diversificazione del paesaggio. Nelle regioni a vocazione agricola viene inoltre fornito un contributo allo sviluppo rurale. La fornitura delle prestazioni multifunzionali sotto forma di pacchetto costituisce un elemento centrale della multifunzionalità dell’agricoltura. Nelle ricerche svolte per conto dell’OCSE, non sono però state effettuate analisi in questo senso. Ne consegue che, sulla base dei risultati delle singole osservazioni, non è quindi possibile stabilire in che misura l’attuale sostegno alla sicurezza dell’intero pacchetto di prestazioni multifunzionali sia realmente valido. Il presente studio sottolinea tuttavia come, pur dipendendo dal tipo di prestazione specifica, nella maggior parte dei casi il grado di jointness potrebbe essere molto elevato.
64 1.1 ECONOMIA 1
■ Conclusioni tratte dagli studi
1.2 Aspetti sociali
Il resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura si suddivide nei tre ambiti seguenti:

–reddito globale e consumo privato delle economie domestiche agricole; –rilevamento di tematiche sociali importanti; –studi su aspetti sociali.
Nel presente rapporto agricolo vengono illustrati il reddito e il consumo delle economie domestiche agricole in base all’analisi centralizzata dei dati contabili di Agroscope Reckenholz-Tänikon ART. Nell’ambito del resoconto sulle componenti determinanti per fotografare la situazione sociale vengono illustrati i risultati della valutazione particolare sul tema «Lavoro e formazione professionale». Lo studio di quest’anno approfondisce le questioni relative ai «Rapporti fra città e campagna» in ambito agricolo.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 65
1.2.1Reddito e consumo
Reddito e consumo sono due indicatori importanti per valutare la situazione delle famiglie contadine sul piano sociale. Nella dimensione economica della sostenibilità, l’aspetto del reddito è interessante soprattutto come indicatore per appurare la produttività delle aziende. Nella dimensione sociale l’accento è posto sulla situazione reddituale delle economie domestiche agricole. Per tale motivo nell’analisi viene preso in considerazione anche il reddito extraagricolo delle famiglie contadine. Vengono analizzati sia il reddito globale che l’evoluzione del consumo privato.
Nel 2004/06, il reddito globale, formato dal reddito agricolo e extraagricolo, ha registrato valori medi tra i 67'900 e gli 86'900 franchi per economia domestica a seconda della regione. Il reddito globale delle economie domestiche della regione di montagna corrispondeva al 78 per cento circa di quello delle economie domestiche della regione di pianura. Con un reddito extraagricolo medio che variava dai 21'500 ai 22'900 franchi, le famiglie contadine hanno avuto una fonte di reddito supplementare importante, che per le economie domestiche nella regione di pianura rappresentava il 25 per cento del reddito globale, mentre costituiva rispettivamente il 31 e il 34 per cento del reddito globale per le economie domestiche della regione collinare e per quelle della regione di montagna. Nel caso delle economie domestiche della regione di montagna si registra il reddito extraagricolo più alto, pari a 22'900 franchi.
Reddito globale e consumo privato per azienda a seconda della regione – 2004/06
Fonte: Centrale analisi, Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
In tutte le regioni la formazione del capitale proprio, ossia la parte del reddito globale non consumata, costituisce in media il 13 per cento circa del reddito globale. Il consumo privato si situa al di sopra del valore del reddito agricolo. Rispetto al volume del reddito globale, il consumo privato ha registrato i valori assoluti più elevati nelle economie domestiche della regione di pianura e i valori assoluti più bassi in quelle della regione di montagna.
Nel 2006 il reddito globale medio per economia domestica è stato pari a 75'900 franchi, segnando una flessione rispetto agli anni 2003/05 (78'200). Il consumo privato per economia domestica, invece, è aumentato di 3'100 franchi rispetto al 2003/05 raggiungendo i 68'500 franchi.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Reddito globale e consumo privato
In fr. Consumo privato Reddito extraagricolo Reddito agricolo
Regione di pianuraRegione collinareRegione di montagna
0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 66
1 Quartile in base al profitto del lavoro per unità di manodopera familiare
2 Unità di consumo = membro della famiglia d’età superiore a 16 anni che partecipa al consumo annuo della famiglia

Fonte: Centrale analisi Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Il reddito globale per unità di consumo delle economie domestiche del primo quartile ha raggiunto il 42 per cento di quello delle economie domestiche del quarto quartile. Per quanto concerne il consumo privato la differenza fra il primo e il quarto quartile è decisamente più contenuta: il consumo privato delle economie domestiche del primo quartile è stato pari al 68 per cento di quello delle economie domestiche del quarto quartile.
Nel 2004/06, nelle aziende del primo quartile il reddito globale per unità di consumo non ha coperto il consumo delle famiglie. La formazione del capitale proprio è stata negativa. Se tali aziende continueranno ad attingere alla sostanza dell’azienda per lungo tempo, presto o tardi dovranno cessare l’attività. Negli altri quartili il consumo privato è stato inferiore al reddito globale: nelle aziende del secondo quartile rappresentava il 95 per cento del reddito globale, nelle aziende del terzo e quarto quartile rispettivamente l’83 e il 71 per cento.
Nel 2006 il reddito globale per unità di consumo ha segnato un aumento rispetto agli anni 2003/05 che ha interessato tutti i quartili, sebbene il reddito globale medio per economia domestica abbia segnato una battuta d’arresto rispetto al triennio precedente. Ciò è riconducibile al fatto che nel 2006 il numero delle unità di consumo era più basso rispetto al 2003/05 e il calo del reddito globale è stato compensato dalla diminuzione delle unità di consumo. Nello stesso anno il consumo privato di tutti i quartili ha segnato un incremento rispetto alla media degli anni 2003/05.
Reddito globale e consumo privato per unità di consumo per quartile 1 –2004/06 PrimoSecondoTerzoQuartoTutte le quartilequartilequartilequartileaziende Reddito globale per UC 2 (fr.)14 78918 91723 82934 92522 995 Consumo privato per UC (fr.)16 95817 93619 85824 82719 841
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 67
1.2.2Formazione professionale e lavoro
La formazione professionale e il lavoro sono componenti importanti nella vita di un individuo e ne determinano la situazione sociale. Nell’ambito del resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura, questi elementi costituiscono dunque uno dei temi principali oggetto di rilevamento quinquennale sulla base di indagini rappresentative.
La rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), effettuata annualmente dall’Ufficio federale di statistica, permette di esprimere considerazioni sulla situazione di chi ha un lavoro, di coloro che non esercitano un’attività lucrativa e dei disoccupati. Vengono rilevati dati concernenti le condizioni di lavoro, la situazione famigliare e quella abitativa. Nell’ambito della rilevazione viene contattata una persona in qualità di rappresentante dell’economia domestica. Ogni anno vengono contattate telefonicamente persone scelte a caso dall’elenco telefonico (48'000 nel 2006). L’insieme di base di riferimento della RIFOS è rappresentato dalla popolazione residente di età superiore a 15 anni. Sulla base dell’esito di tale sondaggio sono estrapolati dati per l’intera popolazione.
I risultati importanti per il resoconto sugli aspetti sociali nell’agricoltura sono elencati nelle seguenti sezioni «Situazione famigliare e abitativa» e «Formazione professionale e situazione lavorativa». Le cifre corrispondono ai dati RIFOS 2006. Viene confrontata la situazione delle cinque categorie di lavoratori di seguito elencate:
–Lavoratori indipendenti nell’agricoltura (308 uomini e 178 donne);
–Lavoratori indipendenti nell’artigianato/industria (1'048 uomini e 160 donne);
–Altri lavoratori indipendenti (1'298 uomini e 1'430 donne);
–Lavoratori dipendenti nell’agricoltura (73 uomini e 35 donne);
–Altri lavoratori dipendenti (12'066 uomini e 11'347 donne);
Per lavoratori s’intende chi, nella settimana precedente il sondaggio, ha svolto un lavoro retribuito per almeno un’ora o chi, in qualità di membro della famiglia, ha lavorato gratuitamente nell’azienda famigliare. Nella categoria «lavoratori indipendenti nell’agricoltura»possono essere incluse anche le mogli che collaborano nell’azienda. I campioni di lavoratori dipendenti del settore primario sono molto esigui e pertanto i dati percentuali estrapolati per questa categoria sono statisticamente poco affidabili e i paragoni con le altre categorie vanno interpretati con la dovuta cautela. Per tale ragione nel presente rapporto non vengono espresse considerazioni particolari al riguardo.
I risultati relativi alla valutazione speciale RIFOS 2001 sono stati pubblicati per la prima volta nel Rapporto agricolo 2002. Nella presente edizione, nella sezione «Formazione professionale e situazione lavorativa» i dati relativi agli uomini e quelli relativi alle donne sono esposti separatamente. Gli indicatori del 2002 «tempo dedicato complessivamente ai lavori domestici e alla famiglia» e «soddisfazione in merito alle condizioni di lavoro» derivano da un modulo supplementare della RIFOS, che non si è ritenuto opportuno riprendere nel 2006. Nella presente edizione non compare più neanche l’indicatore «lavoro serale e notturno», mentre sono stati introdotti per la prima volta i dati concernenti la «custodia dei figli» nonché la «formazione più alta terminata». Le variazioni e gli sviluppi riscontrati fra il 2001 e il 2006 sono puntualmente menzionati nel testo.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 68
■ La rilevazione delle forze di lavoro in Svizzera quale base
■ Situazione famigliare e abitativa
In questa sezione vengono illustrati i dati relativi agli indicatori «età delle persone occupate», «numero di persone e di vani per economia domestica», «condizioni di proprietà» nonché «custodia dei figli», introdotto quest’anno.
Età delle persone occupate
Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria
Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1
Altri lavoratori dip.
In % 06040100 20 80
15–39 anni 55–64 anni
40–54 anni 65+ anni
Da questi dati emerge che, fra i «lavoratori indipendenti nell’agricoltura», la percentuale dei lavoratori attivi di età superiore a 65 anni, pari al 15 per cento, è il doppio delle percentuali registrate per le altre due categorie di lavoratori indipendenti. Tra gli agricoltori indipendenti inoltre, la quota dei lavoratori di età inferiore a 55 anni è più esigua rispetto agli impiegati agricoli. Sempre in questa categoria, rispetto al 2001 nel 2006 la percentuale delle persone attive di età superiore a 65 anni risulta ancora una volta superiore alle altre categorie, sebbene la tendenza sia al ribasso.
Numero di persone nell'economia domestica
In % 06040100 20 80
Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria
Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.
1 persona
3–4 persone
2 persone
5 o più
Circa un terzo dei «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» vive in economie domestiche composte da cinque o più persone. La differenza con le altre categorie professionali è notevole; negli altri casi, infatti, tale quota risulta pari al 10 per cento (impiegati agricoli esclusi). D’altro canto, solo il 5 per cento degli agricoltori indipendenti vive in un’economia domestica formata da una singola persona, mentre per gli altri gruppi la percentuale sale al 15 per cento.
Fonte: UST
1 Dati statisticamente poco affidabili
Fonte: UST
1 Dati statisticamente poco affidabili
persone
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 69
Numero di vani per economia domestica *
Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.
1
Fonte: UST
Vista la dimensione dell’economia domestica, i lavoratori indipendenti del primario vivono in alloggi con molti vani. Il 70 per cento circa vive in case o appartamenti con cinque o più vani. Le altre categorie non rispecchiano questa tendenza; ad esempio, solo un terzo circa degli altri lavoratori dipendenti vive in grandi alloggi.
Condizioni di proprietà
Lavoratori indip. agricoltura Lavoratori indip. artigianato/industria Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.
1 Dati statisticamente poco affidabili
(Com-) proprietario Altro (p.es. appartamento di servizio)
Locatario appartamento (cooperative incluse), casa
Per quanto concerne le condizioni di proprietà, emerge che più dell’80 per cento dei «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» è proprietario o comproprietario e solo meno del 10 per cento locatario. Quasi il 60 per cento degli altri due gruppi di lavoratori indipendenti è proprietario, mentre fra i lavoratori dipendenti tale percentuale si eleva al 40 per cento circa. Negli ultimi cinque anni, fra i «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» la quota dei proprietari è leggermente cresciuta.
 * Cucina e bagno esclusi
* Cucina e bagno esclusi
1–2
4 vani 3 vani 5 o più vani
Dati statisticamente poco affidabili
vani
In % 06040100 20 80
Fonte: UST
In % 06040100 20 80 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 70
■ Formazione professionale e situazione lavorativa
Custodia dei figli
Lavoratori indip. agricoltura
Lavoratori indip. artigianato/industria
Altri lavoratori indip. Lavoratori dip. agricoltura 1 Altri lavoratori dip.
Custodia dei figli esterna alla famiglia
Custodia dei figli interna alla famiglia
I dati relativi a questo indicatore tengono conto esclusivamente delle economie domestiche con figli di età inferiore ai 15 anni. La percentuale degli interpellati che affida i figli a persone al di fuori della cerchia famigliare si situa fra il 20 e il 40 per cento per tutte le categorie. La quota più bassa si registra fra gli agricoltori indipendenti (23%).
Nelle pagine seguenti vengono illustrati i dati relativi agli indicatori «formazione professionale e attività svolta», «formazione più alta terminata» (nuovo), «frequenza di corsi di perfezionamento», «ore di lavoro settimanali», «lavoro al fine settimana» e «numero di giorni di ferie». Viene operata una distinzione fra i dati che riguardano gli uomini e quelli che riguardano le donne.
Formazione professionale e attività svolta
Lavoratori indipendenti agricoltura
Lavoratori indipendenti artigianato/industria
Altri lavoratori indipendenti
Lavoratori dipendenti agricoltura 1
Altri lavoratori dipendenti
Professione svolta = prima professione appresa
Professione svolta = diversa dalla prima prof. appresa Nessuna professione appresa
Fonte: UST
1 Dati statisticamente poco affidabili
In % 06040100 20 80
Fonte: UST
1 Dati statisticamente poco affidabili
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In % 06040100 20 80
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 71
I dati relativi alla categoria «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» evidenziano enormi differenze fra i sessi. Gli uomini svolgono la prima attività appresa nella misura del 77 per cento (percentuale in assoluto più elevata rispetto alle altre categorie), mentre nel caso delle donne tale quota raggiunge appena il 20 per cento. Un quarto di esse ammette inoltre di non aver appreso alcuna professione, rispetto al 10 per cento circa degli uomini. In generale, la percentuale di donne non qualificate è superiore a quella degli uomini. Negli ultimi cinque anni, tali cifre non hanno subito variazioni di rilievo. Il numero degli uomini e delle donne che lavorano nell’agricoltura da indipendenti senza aver appreso alcun tipo di professione è leggermente diminuito.
Formazione più alta terminata
Lavoratori indipendenti agricoltura

Lavoratori indipendenti artigianato/industria
Altri lavoratori indipendenti Lavoratori dipendenti agricoltura 1
Altri lavoratori dipendenti
Scuola dell'obbligo
Tirocinio professionale (formazione empirica inclusa)
Maturità e scuole professionali a tempo pieno (scuole di diploma incluse)
Università/politecnico e formazione professionale superiore (scuole universitarie professionali incluse)
1 Dati statisticamente poco affidabili
Fonte: UST
Per quanto riguarda il grado di formazione, spicca in particolare la quota di lavoratori indipendenti uomini con un diploma universitario o con una formazione professionale superiore (più del 50%). La maggior parte degli agricoltori indipendenti (60%), invece, dichiara di aver completato un tirocinio professionale. Anche nel caso di questo indicatore, la differenza fra i sessi è notevole. Da questi dati emerge infatti che gli uomini possono vantare un grado di formazione più alto delle donne.
06040100 20 80
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In % 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 72
Frequenza
perfezionamento (negli ultimi 12 mesi)
06040100 20 80
Lavoratori indipendenti agricoltura
Lavoratori indipendenti artigianato/industria
Altri lavoratori indipendenti
Lavoratori dipendenti agricoltura 1
Altri lavoratori dipendenti
Per «corsi di perfezionamento» s’intendono esclusivamente le varie forme di perfezionamento professionale. Per quanto concerne le tre categorie di lavoratori indipendenti, i risultati parlano chiaro: nei dodici mesi precedenti il sondaggio il 20 per cento circa degli interpellati ha frequentato almeno un corso di perfezionamento, ad eccezione delle lavoratrici indipendenti nell’ambito agricolo la cui quota sfiora appena il 10 per cento. Al contrario, più di un quarto delle donne impiegate in altri settori afferma di aver investito nel proprio perfezionamento professionale. Nel 2001, la percentuale delle lavoratrici indipendenti nell’agricoltura che riconoscevano di frequentare almeno un corso all’anno si situava al 18 per cento. Fatta eccezione per il 2006 (9%), negli ultimi cinque anni tale quota si è stabilizzata al 15 per cento.
Ore di lavoro settimanali * 06040100 20
Lavoratori indipendenti agricoltura
Lavoratori indipendenti artigianato/industria
Altri lavoratori indipendenti
Lavoratori dipendenti agricoltura 1
Altri lavoratori dipendenti
1–19 20–39 40–49 50 ed oltre
Fonte:
UST 1 Dati statisticamente poco affidabili Nessuno Almeno uno
di corsi di
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In %
Fonte: UST
* Lavoro svolto normalmente in ore settimanali 1 Dati statisticamente poco affidabili
80
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In % 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 73
1 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 74
Per quanto riguarda le ore di lavoro settimanali, vengono conteggiate esclusivamente quelle dedicate all’attività lucrativa (fonte principale di reddito). I lavori domestici non entrano in linea di conto. Il totale delle ore di lavoro è alto nel caso degli agricoltori indipendenti. Quasi i tre quarti di essi infatti lavorano generalmente più di 50 ore alla settimana. Anche in questo caso, i dati evidenziano una grande differenza fra uomini e donne: in generale gli uomini lavorano più delle donne, anche se spesso ciò è riconducibile al fatto che esse non lavorano a tempo pieno. I «lavoratori indipendenti nell’agricoltura» uomini lavorano più a lungo rispetto al passato. Cinque anni fa, infatti, la percentuale di coloro che accumulavano più di 50 ore alla settimana si attestava ancora attorno al 60 per cento. Nello stesso arco di tempo è invece diminuita la quota degli altri lavoratori indipendenti uomini con più di 50 ore settimanali al loro attivo (artigiani: dal 47% nel 2001 al 38% nel 2006, altri lavoratori indipendenti: dal 46 al 42%).
al fine settimana In %
Mai Talvolta di sabato o domenica (gratuitamente o contro retribuzione) Generalmente di sabato o di domenica Generalmente di sabato e di domenica Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Nella categoria dei lavoratori indipendenti nell’agricoltura, il 2 per cento degli uomini e il 13 per cento delle donne dichiara di non lavorare mai durante il fine settimana. Per quanto concerne le altre due categorie di indipendenti, tale percentuale varia tra il 35 (uomini) e il 39 (donne) per cento nei «lavoratori del settore artigianato e industria» e tra il 23 (uomini) e il 45 (donne) per cento negli «altri lavoratori indipendenti». Oltre il 70 per cento degli uomini e il 60 per cento delle donne che lavorano nell’agricoltura come indipendenti ammettono di lavorare spesso anche al sabato e alla domenica.

Fonte: UST
Lavoro
06040100 20 80 Lavoratori indipendenti agricoltura Lavoratori indipendenti artigianato/industria Altri lavoratori indipendenti Lavoratori dipendenti agricoltura
1 Dati statisticamente poco affidabili Altri lavoratori dipendenti
■ Conclusioni
Numero di giorni di ferie
Lavoratori indipendenti agricoltura
Lavoratori indipendenti artigianato/industria
Altri lavoratori indipendenti
Lavoratori dipendenti agricoltura 1
Altri lavoratori dipendenti
06040100 20 80
Per semplificare il conteggio dei giorni di ferie, vengono presi in considerazione solo i lavoratori a tempo pieno. Con una media di circa 7 giorni l’anno sono i lavoratori indipendenti del primario a fare meno giorni di ferie. La cifra sale a 19 e 21 giorni rispettivamente per i lavoratori indipendenti del settore artigianato e industria e per gli altri lavoratori indipendenti. Gli altri lavoratori dipendenti dispongono, in media, di 25 giorni di ferie l’anno. Contrariamente agli altri lavoratori indipendenti, quelli del primario, segnatamente gli allevatori di bestiame da reddito, non possono semplicemente chiudere temporaneamente l’azienda. Negli ultimi cinque anni, la percentuale degli agricoltori indipendenti che non si concedono neppure un giorno di ferie è costantemente diminuita, mentre il numero medio di giorni di ferie è salito da sei a sette.
Come già evidenziato cinque anni or sono, le differenze più marcate fra gli agricoltori e le altre categorie di lavoratori riguardano i giorni di ferie e il lavoro al fine settimana. Nel 2006, i primi hanno fatto in media solo 7 giorni di ferie, mentre i lavoratori delle altre categorie 19 giorni o più. La quota degli agricoltori che non si concedono neppure un giorno di ferie è leggermente scesa (2001: 26%; 2006: 21%). Gli agricoltori che dichiarano di non lavorare mai durante il fine settimana sono solo il 2 per cento (uomini) e il 13 per cento (donne); per quanto riguarda le altre categorie, invece, tali valori variano dal 23 al 56 per cento. Degno di nota è pure il divario fra il totale delle ore di lavoro settimanali. Nel 2006 quasi i tre quarti dei lavoratori indipendenti del primario uomini hanno accumulato generalmente più di 50 ore alla settimana (nel 2001 erano il 60%); tra i lavoratori indipendenti, invece, questa percentuale si aggira attorno al 40 per cento. Sebbene oggi, rispetto a cinque anni fa, gli agricoltori indipendenti lavorino di più, vi è stato un lieve aumento del numero dei giorni di ferie. È confermata la tendenza del 2001 che vede la quota di lavoratori che svolgono la prima professione appresa (77%) e che dispongono di un tirocinio professionale quale più alto grado di formazione (58%) raggiungere la percentuale più elevata. Dai dati relativi al tempo di lavoro e alla formazione emergono chiare differenze fra i sessi: le donne hanno un grado di formazione generalmente più basso e svolgono più frequentemente impieghi a tempo parziale rispetto ai colleghi uomini.
Fonte: UST
1 Dati statisticamente poco affidabili
0 1–10 11–25 26 ed oltre
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne In %
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 75
■ Vendita diretta, in fattoria e cesti di prodotti tipici
1.2.3Rapporti fra città e campagna
L’agricoltura svizzera contribuisce in diversi modi e luoghi alla promozione dei rapporti fra città e campagna. Le iniziative quali la vendita diretta, la vendita in fattoria, i cesti di prodotti tipici assortiti, i «contratti di vicinato», il programma «Scuola in fattoria» e Agro-image, il servizio agricolo, l’offerta di innumerevoli compiti di assistenza, il brunch del 1° agosto e altre manifestazioni analoghe nonché il successo dell’agriturismo, favorisconola reciproca conoscenza tra i due mondi. Quest’anno, nel resoconto sugli aspetti sociali in ambito agricolo vengono esaminati più da vicino le varie proposte fatte dall’agricoltura nell’ottica dell’avvicinamento fra città e campagna.
La vendita diretta, su semplici scaffali o in locali dell’azienda appositamente allestiti, di frutta, verdura, cereali, formaggio, latte, carne o persino legna da ardere, costituisce una valida alternativa al supermercato.
La cura e la fidelizzazione della clientela è molto importante nel mercato della vendita diretta, dal momento che il successo dell’attività dipende in gran parte dalla relazione personale instaurata con il cliente. Tra le varie iniziative di fidelizzazione della clientela figurano le porte aperte e gli «incontri in fattoria», momenti che mirano a far conoscere la vita della fattoria e a risvegliare l’interesse per i prodotti della terra. Molto spesso, infatti, chi acquista i prodotti direttamente in fattoria vuole sapere da dove vengono.
I cesti di prodotti nostrani di tutte le regioni della Svizzera rivelano la dedizione e l’amore dei contadini per le loro specialità e sono un regalo particolarmente gradito.
L’elenco dei commercianti diretti e di prodotti di nicchia nell’ambito agricolo è disponibile sul sito www.bauernbieten.ch.
■ Contratti di vicinato
Il concetto di contratto di vicinato (agriculture contractuelle de proximité) nasce in Giappone circa 40 anni fa quando abitanti delle città decidono di concludere contratti con i contadini, per acquistare i loro prodotti a un prezzo pattuito. Oggi, in Giappone sono diversi milioni le persone che hanno adottato questo sistema, chiamato «Teikei». Negli Stati Uniti, invece, questa pratica è conosciuta come «Community supported agricolture».
Su questa scia, anche in Svizzera, a seconda della struttura dell’azienda e della domanda dei consumatori vengono offerti prodotti quali carne, frutta, verdura o anche prodotti lavorati. Le cooperative agricole forniscono il quantitativo settimanale dei propri prodotti ai clienti situati prevalentemente in aree urbane, i quali non solo pagano il prezzo convenuto in precedenza ma partecipano anche all’attività delle aziende. Questa forma di collaborazione implica un confronto concreto e attivo con l’agricoltura e favorisce la comprensione e la solidarietà fra gente di città e di campagna.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 76
La seguente tabella elenca i progetti elaborati nell’ottica dei contratti di vicinato in Svizzera. Alcune aziende qui non menzionate, come la Brüglingerhof di Basilea, offrono abbonamenti abbinati all’acquisto di verdura o di frutta. Questi abbonamenti non hanno tuttavia niente a che vedere con la sopraccitata collaborazione.
Progetti relativi ai contratti di vicinato per la promozione dei rapporti tra città e campagna
NomeRegione Anno di Numero Prodotti Fornitura Bio / PER Contatti fonda- di persone zioneimpiegate
Le Jardin des Charrotons GE 2007 80 4,5 sett. Bio charrotons@hotmail.com
Les Vergers d’EpicureGE2007205irregolareBiowww.vergers-epicure.ch
Prodotti forniti
1. Prodotti che si possono immagazzinare (patate, lenticchie, cereali, ecc.)
2. Prodotti lavorati (succo di frutta, aceto, ecc.)
3. Vini
4. Frutta
5. Verdura
6. Latticini
7. Prodotti carnei
PER:Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
Bio:Agricoltura biologica
Fonti: Uniterre, UFAG
Uniterre offre una piattaforma che riunisce le persone interessate a partecipare a uno scambio di esperienze e di opinioni: www.uniterre.ch (agriculture contractuelle de proximité)
Les Jardins de Cocagne GE 1978 400 1,2,4,5 sett. Bio www.cocagne.ch La Clef des champs JU 1980 130 1,4,5,6,7 sett. Bio www.clef-des-champs.ch BirsmattehofBL1980300sett. Biowww.birsmattehof.ch L’Affaire TourneRêve GE 2003 1 300 1,2,4,5,7 2 / anno Bio / PERwww.affairetournereve.ch Le lopin bleu NE 2005 360 1,2,3,6,71 / anno Bio / PERwww.lopinbleu.ch L’Agrihotte VD 2005 150 1,2,4,5,7 2 / anno Bio / PERwww.lagrihotte.ch L’Abbaye de Fontaine-AndréNE 2005401,4,5sett. Bio www.fontaine-andre.ch Les cueillettes de Landecy GE 2006 50 4,5 Fai da teBio www.cueillettes.org Les ares et vous GE 2006 60 1,2,4,5 sett. Bio t.descombes@infomaniak.ch Le Panier à 4 pattes GE 2006 100 1,2,3,4,5,7 2 / anno PERwww.paniera4pattes.ch Le Jardin Potager VD 2006 240 1,4,5 sett. Bio www.lejardinpotager.ch La ferme du Taulard VD 2006 50 4,5 sett. PERwww.marchepaysan.ch Saveurs de Saison JU 2006 50 1,2,3,4,5,6,7 1 / anno Bio www.saveurs-de-saisons.ch Femmes Solidaires VD 2006 30 4 2 / mese PERnicolepletscher@yahoo.fr Notre panier Bio FR 2006 140 1,2,3,4,5,6,7 6 / anno Bio g.hasinger@bio-conseil.ch Lumière des Champs VD 2007 ? 4,5 sett. ? www.lumiere-des-champs.ch Les Jardins du FlonVD2007501,2,4,533 / annoPER / Biowww.lesjardinsduflon.ch
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 77
■ Scuola in fattoria e Agro-Image
Le fattorie sono luoghi di apprendimento ideali poiché offrono agli scolari un contesto creativo e globale. Le varie materie, dalle lingue alla matematica e persino l’economia domestica, trovano riscontro nella vita di tutti i giorni. Il programma Scuola in fattoria (SIF) prepara i piccoli alla vita. I corsi pratici destano la curiosità degli scolari per l’ambiente e l’interazione fra uomo, suolo, acqua, aria, piante e animali. Inoltre, i lavori pratici svolti in comune a stretto contatto con la natura stimolano le competenze individuali e sociali.
Le aziende svizzere che partecipano a quest’iniziativa sono circa 500, per più di 20'000 scolari che ogni anno frequentano la scuola della fattoria per uno o più giorni. Maggiori informazioni possono essere ottenute sul sito www.schub.ch.
Agro-Image: l’agricoltura fa scuola. Giovani agricoltori offrono lezioni gratuite agli allievi di scuola media superiore, scuole professionali e licei, trasmettendo loro le conoscenze sull’agricoltura e la produzione di derrate alimentari. I corsi sono adattati alle esigenze scolastiche, degli allievi nonché della pratica agricola.
Nel 2006, i collaboratori di Agro-Image hanno tenuto all’incirca 270 corsi. Quasi la metà delle classi proveniva dai Cantoni di Berna e Soletta e un terzo dalla Svizzera romanda. Per ulteriori informazioni: www.agro-image.ch.
■ Servizio agricolo
Istituito nel 1946, il servizio agricolo permette ai giovani in età compresa fra i 14 e i 25 anni, per lo più svizzeri ma anche provenienti da altri Paesi dell’UE, volontari o scolari, di svolgere per un breve periodo un’attività pratica che consente loro di farsi un’idea dell’agricoltura.
Gli aiutanti agricoltori coadiuvano le famiglie contadine nello svolgimento delle mansioni quotidiane e imparano a conoscere la vita in fattoria. Con questa iniziativa si intende gettare un ponte fra città e campagna, fra regioni linguistiche diverse nonché fra consumatore e produttore. Ogni anno quasi 3'000 giovani e 1'200 famiglie contadine partecipano al progetto. Per ulteriori informazioni: www.landdienst.ch.
■ Compiti di assistenza
Alle persone che cercano un’abitazione a titolo provvisorio o stabile, viene offerta la possibilità di vivere e lavorare nell’ambito dell’agricoltura, sia in casa che nell’azienda. Le aziende agricole in cui la struttura famigliare è ritenuta solida, i pasti sono consumati in comune, le attività giornaliere sono regolari e i rapporti interpersonali vengono costantemente curati rappresentano una buona alternativa alla realtà domestica. Ancora oggi però, questa soluzione viene sfruttata relativamente poco. Occuparsi di bambini e adolescenti difficili, di disabili o anziani risulta molto impegnativo e tutta la famiglia deve farsi carico di questa responsabilità.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 78
Le varie possibilità di assistenza possono essere suddivise nelle seguenti categorie:
–Età: bambini, adolescenti, adulti, anziani;
–Esigenze: presa a carico durante il giorno, pranzo, educazione e sostegno, riabilitazione, assistenza a persone con disturbi psichici, cura di disabili.
–Situazione temporale: centro diurno adibito a diversi scopi. Mensa, madre diurna, asilo nido, gruppi gioco all’aperto, ippoterapia, soggiorni per disabili e giovani con difficoltà famigliari, assistenza a medio o lungo termine, sostegno e cura.
Per ulteriori informazioni: www.agridea.ch (Para-agricoltura/assistenza nella fattoria).
Il 1° agosto 2007, le famiglie contadine svizzere hanno aperto le porte alla popolazione per la quindicesima volta. Quasi 420 famiglie di tutte le regioni della Svizzera hanno accolto 200'000 ospiti. Il brunch è un’occasione per avvicinare la gente di città alla realtà agricola, promuovendo nel contempo la comprensione e la simpatia reciproche.

Con una spesa compresa tra i 18 e i 30 franchi, ognuno ha quindi la possibilità di gustare formaggio, pane, burro, marmellata, latte, carne, frutta e altri specialità fatte in casa o della regione. È un momento privilegiato in cui ci si lascia sorprendere dalla provenienza, dalla qualità e dalla bontà dei prodotti indigeni e nel contempo ci si rende conto di quanto lavoro e fatica stiano dietro a tutto ciò.
Per informazioni più dettagliate e per ottenere la lista delle aziende partecipanti, vedasi il sito www.brunch.ch.
La visita alla stalla è un’iniziativa coordinata a livello nazionale. Il 21 aprile 2007, più di 200 aziende agricole svizzere hanno infatti aperto le porte delle loro stalle, consentendo ai consumatori di entrare in un mondo a loro sempre più sconosciuto. Per ulteriori informazioni: www.stallvisite.ch.
In molti casi, le aziende agricole mettono a disposizione spazi per seminari, feste e riunioni aziendali e offrono attività quali trekking, labirinti nei campi di mais, swin-golf, wellness eccetera. Per quel che concerne l’attuazione di tali offerte, l’agricoltura trae numerosi vantaggi dalla revisione della legge sulla pianificazione del territorio.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.2 ASPETTI SOCIALI 1 79
■ Brunch del 1° agosto e altre manifestazioni analoghe
■ Agriturismo
Tranquillità e relax, ospitalità sincera, appartamenti di vacanza accoglienti e curati oppure camere, ostelli o capanne di montagna. Le vacanze in una fattoria svizzera sono sempre un’esperienza piacevole.
Le circa 250 aziende che partecipano al progetto «Vacanze in fattoria» sono presenti su tutto il territorio nazionale, le attività che vi si tengono sono certificate e la qualità dell’offerta è garantita. Per ulteriori informazioni: www.bauernhof-ferien.ch. Voglia di vacanze in un’azienda bio? Sul sito www.bioterra.ch figurano le possibilità di pernottamento. Offerte di pernottamento a prezzi vantaggiosi per entrare per un attimo nella realtà della fattoria: ecco quindi la «Schlaf in Stroh», ovvero «dormire sulla paglia». Ulteriori informazioni sul sito www.schlaf-im-stroh.com.
■ Conclusioni
Il contributo dell’agricoltura alla promozione dei rapporti fra città e campagna è molteplice: vendita diretta, in fattoria, cesti di prodotti genuini, contratti di vicinato, scuola in fattoria e Agro-Image, servizio agricolo, compiti di assistenza, brunch del 1° agosto e visita alle stalle, agriturismo eccetera.
Questa ampia gamma di offerte per una maggiore comprensione tra città e campagna implica un ruolo attivo da parte delle famiglie contadine e invita gli abitanti delle aree urbane a confrontarsi con la realtà dell’agricoltura e la vita di campagna. Nel caso dei contratti di vicinato invece, anche i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente.
In ambito sociale, l’assistenza prestata nel quadro di aziende agricole permette di sgravare i servizi sociali e gli istituti cittadini. L’esempio di Eggiwil (Rapporto agricolo 2001), mostra come bambini e adolescenti a rischio abbiano avuto la possibilità di ritrovare il calore di una casa presso alcune famiglie contadine dell’Emmental. La collaborazione fra città e campagna si rivela dunque molto vantaggiosa, sia per i bambini che per gli adolescenti. La ricerca di spazi in cui poter offrire questa assistenza è tuttora in atto, poiché si è convinti che in questo ambito il potenziale dell’agricoltura possa essere ulteriormente sfruttato.
1.2 ASPETTI SOCIALI 1 80
Nel presente rapporto agricolo accanto a dati fondamentali inerenti all’utilizzo del suolo e ai mezzi di produzione, per la seconda volta dopo il 2003, vengono illustrati approfonditamente aspetti correlati ai temi clima, energia e aria.

Per quanto attiene alla tematica del clima, viene esaminato l’andamento delle emissioni di gas a effetto serra (anidride carbonica, metano, protossido d’azoto e gas sintetici) in Svizzera nonché la rispettiva quota riconducibile all’agricoltura. Inoltre, viene discusso l’impatto del cambiamento climatico globale sulla realtà svizzera e in particolare sul primario. Infine, vengono illustrate le possibili misure che l’agricoltura svizzera può adottare per adeguarsi al mutamento delle condizioni climatiche (innalzamento delle temperature, variazione delle precipitazioni, ecc.).
Nel capitolo dedicato all’energia viene dato particolare risalto al consumo energetico, presentando, inoltre, determinati risultati dello studio «Ecobilancio di prodotti energetici».
Oltre che delle emissioni dirette di polveri fini (particolato primario), ad esempio la fuliggine diesel generata dai veicoli agricoli, il primario è responsabile delle emissioni di gas precursori di particolato secondario. Sulla scorta di uno studio su modelli viene esaminata approfonditamente la correlazione tra ammoniaca (NH3) e particolato secondario.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■
1.3Ecologia ed etologia
1.3.1Ecologia
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 81
Uso del suolo e mezzi di produzione
Andamento
della quota di superficie gestita in modo rispettoso dell'ambiente In % della SAU Gestione rispettosa dell'ambiente 1 Di cui bio Fonte: UFAG 1 1993–1998: PI + Bio; dal 1999: PER 1993199419951996199719981999200020012002 0 100 80 60 40 20 90 70 50 30 10 20052006 2004 2003 Andamento della superficie di compensazione ecologica 1 1993199419951996199719981999200020012002200320052006 2004 In 1 000 ha Regione di montagna Regione di pianura Fonte: UFAG 1 Senza alberi da frutta ad alto fusto nei campi, prima del 1999 soltanto per superfici di compensazione ecologica aventi diritto a contributi 0 140 120 100 80 60 40 20 Andamento dell'effettivo di animali 1990199619971998199920002001200220052006 2004 2003 In 1 000 UBG 1 Altri Suini Bovini Fonte: UST 1 UBG: unità di bestiame grosso 0 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 82

Andamento del consumo di concimi minerali In 1 000 t Azoto (N)Fosfato (P2O5) Fonte: USC 1990/9219941996199820002002 19931995199719992001 0 80 70 60 50 30 40 20 10 20032005 2004 2006 Andamento del consumo di alimenti concentrati per animali 1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320052006 (provv.) 2004 In 1 000 t Altri CH Panelli di semi oleosi CH Cereali da foraggio CH Trasformazione di alimenti importati per animali Alimenti importati per animali Fonte: USC 0 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 83

Andamento delle vendite di prodotti fitosanitari 199119921993199419951996199719981999200020012002200320042006 2005 In t di principio attivo Fungicidi, battericidi, prodotti per la concia delle sementi Erbicidi Insetticidi, acaricidi Regolatori della crescita Rodenticidi Fonte: Società svizzera dell'industria chimica 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 84
■ Emissioni di gas a effetto serra in Svizzera
Clima
Per clima s’intende l’insieme delle condizioni atmosferiche che caratterizzano una determinata regione. La temperatura è un parametro importante per descriverlo. La temperatura terrestre dipende dall’effetto serra. L’intensità dell’effetto serra vitale viene determinata dalla naturale presenza nell’atmosfera di vapore acqueo (H2O), anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido d’azoto (N2O) e altri gas. Negli ultimi decenni l’attività umana ha provocato una continua crescita delle emissioni dei cosiddetti gas a effetto serra, alla base del surriscaldamento della superficie e dell’atmosfera terrestri e dei conseguenti cambiamenti del ciclo dell’acqua. Questi ultimi hanno assunto una portata tanto allarmante da suggerire un vero e proprio cambiamento climatico globale. In futuro si imporrà una sfida a livello internazionale, con l’obiettivo di attuare provvedimenti finalizzati sia ad arginare il problema del cambiamento climatico sia ad adeguarsi al mutamento delle condizioni climatiche.
Per certi aspetti, l’agricoltura è direttamente responsabile del surriscaldamento globale a causa delle emissioni di gas a effetto serra che provoca (soprattutto metano e protossido d’azoto). Nel 2005 la Svizzera ha ratificato il Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997, impegnandosi a ridurre, entro il periodo 2008–2012, le emissioni di gas a effetto serra nella misura dell’8 per cento rispetto al 1990, l’anno di riferimento del Protocollo di Kyoto. A tal riguardo nelle pagine seguenti verrà illustrato l’andamento dei gas a effetto serra agricoli. Per altri aspetti, invece, il progressivo cambiamento climatico incide sempre più sulla realtà svizzera e in particolar modo sull’agricoltura. Le conseguenze e le possibili strategie d’adeguamento al cambiamento climatico vengono illustrate nel capitolo intitolato «Cambiamento climatico nella Svizzera entro il 2050».
Per gas a effetto serra s’intende l’insieme delle sostanze gassose che contribuiscono all’effetto serra. Possono essere d’origine naturale o generati dall’attività umana, cui è riconducibile gran parte dell’aumento registrato per alcuni di questi gas. I gas citati dal Protocollo di Kyoto sono: anidride carbonica, metano, protossido d’azoto e gas sintetici (HFC, PFC e SF6). Per agevolare il confronto, tutti i valori dei gas relativi al potenziale di surriscaldamento globale sono espressi in CO2 equivalente (CO2eq.): 1 kg di metano e 1 kg di protossido d’azoto equivalgono rispettivamente a 21 e 310 kg di anidride carbonica. È importante prendere conoscenza di questa equivalenza. Un animale da reddito assume una quantità di anidride carbonica fissata nel foraggio, la quale durante il processo di digestione viene scissa in metano, un gas a maggior impatto climatico.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 85
L’elevata quota dell’agricoltura rispetto alla totalità delle emissioni di metano in Svizzera (quasi 80%) è riconducibile alla fermentazione che avviene durante la digestione all’interno del rumine e allo stoccaggio di concimi aziendali. Pressoché dello stesso ordine di grandezza è la quota dell’agricoltura rispetto alle emissioni totali di protossido d’azoto (75% circa). In questo caso le emissioni sono riconducibili alla gestione dei concimi aziendali e allo sfruttamento agricolo del suolo. Nel caso delle emissioni di protossido d’azoto dal suolo vengono considerate le emissioni dirette dalla superficie agricola utile (sulla scorta dell’immissione di azoto attraverso i concimi minerali e aziendali, l’incorporazione nel terreno dei resti del raccolto e le leguminose che fissano l’azoto, nonché della coltivazione di suoli organici) e dalla detenzione di animali (pascolo) nonché le emissioni indirette non generate dalla superficie agricola utile. Queste ultime provengono da altre fonti, quando i composti azotati vengono trasportati mediante volatilizzazione (ammoniaca e ossidi d’azoto), erosione o dilavamento, accumulandosi altrove.
La quota dell’agricoltura rispetto alla totalità delle emissioni di metano e protossido d’azoto in Svizzera è considerevole. Tuttavia, nel complesso, le emissioni di gas a effetto serra riconducibili all’agricoltura espresse in CO2 eq. rappresentano soltanto il 9,8 per cento rispetto alle emissioni totali svizzere. Considerando la necessità di ridurre le emissioni totali dell’8 per cento entro il 2008–2012 e in maniera massiccia entro il 2050, la politica di riduzione della Svizzera non deve trascurare le emissioni di gas a effetto serra provocate dal primario, nonostante la loro percentuale sia relativamente bassa.

Principali gas a effetto serra in Svizzera – 2005 CO2 Metano 6,6 (79)6,1 (75,1) 1,7 85,7 (1,4)* Protossido d'azotoGas sintetici In % CO 2 eq.
Fonte: UFAM
Emissioni di gas a effetto serra Quota dell'agricoltura 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 86
( ): Quota in % dell'agricoltura per ciascun gas a effetto serra ( )*: Quota in % dell'agricoltura e della silvicoltura nell'emissione di CO2
■ Emissioni di gas a effetto serra secondo le fonti
Secondo il metodo IPCC, nel 2005 la Svizzera ha emesso 53,5 milioni di tonnellate circa di CO2 eq. La principale fonte sono i trasporti, con una quota pari al 30 per cento. Economie domestiche e industria sono responsabili rispettivamente del 20 per cento circa delle emissioni. L’agricoltura occupa il quarto posto, con una quota del 10 per cento circa, che include le emissioni di metano e di protossido d’azoto ma non le emissioni dirette di anidride carbonica provocate ad esempio dai tubi di scappamento delle macchine agricole e forestali. Secondo il metodo IPCC esse, infatti, non vengono classificate specificatamente in ambito agricolo. Se, invece, le emissioni dirette di anidride carbonica provocate dall’uso di veicoli agricoli e forestali nonché dall’essiccazione del fieno venissero conteggiate insieme a quelle di metano e protossido d’azoto, la quota dell’agricoltura per il 2005 salirebbe all’11,2 per cento.
Le emissioni di gas a effetto serra non dovute al consumo di energia dell’agricoltura (senza emissioni dirette di anidride carbonica) sono riconducibili alla detenzione di bestiame (43% circa, digestione), allo sfruttamento agricolo del suolo (39% circa) e alla gestione di concimi aziendali (17% circa).
Emissioni di gas a effetto serra, secondo le fonti – 2005 Totale 53,64 mio. t CO2 equivalente
Il calo delle emissioni di metano nel primario è correlato al calo costante dal 1990 dell’effettivo di bestiame. La riduzione delle emissioni di protossido d’azoto è riconducibile, da un lato, alla diminuzione dell’effettivo di animali e, dall’altro, dal minor uso di concimi minerali azotati. In controtendenza rispetto alla diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’agricoltura (metano + protossido d’azoto + anidride carbonica), le emissioni lorde registrate in Svizzera nel 2005 hanno segnato un aumento rispetto al 1990.
Trasporti 29,2% Economie domest. 22,3% Fonte:
Agricoltura 9,8% Servizi 10,3% Rifiuti 5,5% Industria 21,5% Essicazione
veicoli agricoli e forestali 1,4% Terreni agricoli 39,2% Gestione concimi aziendali 17,2% Altro 0,2% Detenzione animali da reddito 43,4%
UFAM
del fieno nonché
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 87
■ Metano e protossido d’azoto provenienti
Andamento delle emissioni di gas a effetto serra
Emissioni lorde Svizzera N2O agricoltura Effettivo
CH4 agricoltura Obiettivo Kyoto (emissioni lorde)
L’agricoltura svizzera, con una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari al 10,9 per cento tra il 1990 e il 2004, rientra nella media internazionale. Dall’andamento delle emissioni di gas a effetto serra dell’agricoltura di alcuni Paesi scelti emergono notevoli differenze. In Germania la riduzione delle emissioni agricole ha raggiunto il 18,3 per cento, mentre in Nuova Zelanda si è registrato un aumento del 14,9 per cento. Anche i dati relativi alla quota dall’agricoltura rispetto alle emissioni totali di gas a effetto serra nel 2004 si rivelano particolarmente eterogenei. In Francia si registra una quota superiore al 17 per cento che si contrappone al 2 per cento del Giappone. La Svizzera, con una quota del 9,9 per cento, si posiziona a metà della graduatoria.
Andamento delle emissioni di metano e di protossido d'azoto provocate dall'agricoltura nei Paesi selezionati
Quota dell'agricoltura rispetto al totale dei gas a effetto serra – 2004
Fonte: United Nations Framework Convention on Climate Change
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005 Indice 1990 = 100 Fonti: UFAM, USC 75 105 100 95 90 85 80
di bovini
Germania Giappone Austria Svizzera Francia Italia
Australia
Zelanda –18,3 –14,9 –13,8 –10,9 –10,5 –6,8 0,1 2,2 14,9 –30–20–10 60 01020304050 In %
dal 1990 al 2004
USA
Nuova
Variazione
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 88
dall’agricoltura nel confronto internazionale
■ Rapporto sul clima dell’IPCC–2007
Che sia in atto un cambiamento climatico, il quale continuerà anche in futuro, è ormai un dato di fatto. I Rapporti 2001 e 2007 a cura dell’Integovernmental Panel on Climate Change (IPCC) corroborano scientificamente le ipotesi che circolavano ormai da anni. Con oltre il 90 per cento di probabilità l’innalzamento della temperatura media globale è da imputare essenzialmente ai gas a effetto serra generati dall’attività umana. Non farà soltanto più caldo, bensì assisteremo più di frequente ad eventi estremi.
Dal punto di vista globale, nel XX secolo la temperatura media ha registrato un aumento di 0,6°C circa. Nello stesso periodo in Svizzera la temperatura media ha subito un’impennata. Nella Svizzera romanda, tedesca e italiana l’innalzamento delle temperature è stato pari rispettivamente a 1,6, 1,3 e 1,0°C. Anche il XXI secolo vedrà crescere i livelli di surriscaldamento. In base al Rapporto 2007 dell’IPCC, entro il 2100 la temperatura media globale registrerà un innalzamento tra 1,1 e 6,4°C (confronto con la media del periodo 1980–1999). Entro il 2050 v’è da attendersi un rialzo della temperatura tra 0,8 e 2,4°C rispetto al 1990. L’ampia forbice dei valori è dovuta ai diversi modelli climatici e alle previsioni relative alle emissioni, che tengono conto di vari sviluppi plausibili a livello demografico, economico e tecnologico.
■ Cambiamento climatico in Svizzera entro il 2050
L’organo consultivo per le questioni legate al cambiamento climatico (OcCC), che formula raccomandazioni su clima e cambiamento climatico all’attenzione della politica e dell’amministrazione svizzere, ha pubblicato un rapporto in tedesco intitolato «Klimaänderung und die Schweiz 2050». In esso sono raccolte le più recenti conoscenze scientifiche sulle conseguenze del cambiamento climatico in Svizzera.
Al fine di tracciare il profilo della futura evoluzione del clima e delle rispettive conseguenze in Svizzera, è stato allestito uno scenario climatico regionale. Dai risultati emergono i seguenti cambiamenti.
Entro il 2050 la Svizzera dovrà far fronte ad un aumento delle temperature autunnali, invernali e primaverili di 2°C rispetto al 1990 (intervallo d’incertezza di 1–5°C) e di 3°C per quelle estive. Si verificherà, inoltre, un aumento delle precipitazioni invernali pari al 10 per cento e una diminuzione di quelle estive del 20 per cento. Di conseguenza in estate si intensificheranno le ondate di caldo come pure, probabilmente, i periodi di siccità. Al contrario è attesa una diminuzione delle ondate di freddo nel periodo invernale.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 89
Sulla scorta di tali risultati sono state analizzate le conseguenze del cambiamento climatico sull’ecosistema nazionale, sull’agricoltura, sull’economia, sulla sanità, sul settore energetico, sul turismo, sulle infrastrutture, sulle aree urbane e sulle assicurazioni.
Osservazione: un valore pari a 0,5 equivale ad una diminuzione del 50% mentre un valore pari a 1,25 ad un aumento del 25% rispetto alle condizioni attuali. Le linee orizzontali indicano la stima media (mediane). Con il 95% di probabilità, la variazione delle temperature e delle precipitazioni resterà nelle colonne colorate.
Variazione delle temperature medie Nord delle AlpiSud delle Alpi Variazione delle temperature (°C) Fonte: OcCC
InvernoPrimaveraEstate Stagione Autunno 0 6,0 7,0 8,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 203020502070 Variazione delle temperature (°C) InvernoPrimaveraEstate Stagione Autunno 0 6,0 7,0 8,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 0,9 0,4 1,0 0,4 1,8 0,5 1,1 3,4 3,3 3,5 3,8 7,0 1,9 0,9 0,8 0,6 2,6 1,4 1,4 4,7 2,7 4,74,8 5,2 1,7 3,0 2,5 2,6 1,2 1,11,1 2,1 1,7 1,8 1,7 1,8 0,9 0,4 0,9 0,4 1,9 0,6 1,1 3,0 3,3 3,6 4,0 7,1 2,1 0,9 0,8 0,6 2,6 1,5 1,5 4,9 2,8 4,5 4,7 5,3 1,7 3,1 2,6 2,5 1,2 1,1 1,2 2,2 203020502070 Variazione delle precipitazioni medie Nord delle AlpiSud delle Alpi Variazione delle precipitazioni (%) InvernoPrimaveraEstate Stagione Autunno 0,50 0,66 0,80 0,90 1,00 1,10 1,25 1,50 203020502070 Variazione delle precipitazioni (%) InvernoPrimaveraEstate Stagione Autunno 1,11 1,08 1,05 0,990,99 1,0 1,0 1,04 0,94 1,0 0,92 0,97 1,21 1,1 1,0 0,77 0,91 0,59 0,990,99 0,89 0,82 0,97 0,91 0,69 0,93 0,83 1,3 1,13 1,0 0,8 0,91 1,11 0,85 0,86 0,94 1,13 1,11 1,03 0,96 0,94 0,98 1,0 1,06 0,91 1,02 0,93 0,98 1,26 1,05 1,04 0,74 0,92 0,51 1,011,01 0,85 0,97 0,9 0,64 0,94 0,81 1,42 1,07 1,06 0,81 0,95 1,16 0,780,78 0,86 0,96 203020502070 0,50 0,66 0,80 0,90 1,00 1,10 1,25 1,50 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 90
■ Conseguenze del cambiamento climatico sull’agricoltura svizzera
In seguito al protrarsi del periodo di vegetazione, presupposta una sufficiente disponibilità d’acqua e di sostanze nutritive, aumenteranno la produzione dei prati e la resa dei raccolti di diverse colture agricole. Inoltre, l’inizio anticipato del periodo di vegetazione in foraggicoltura si tradurrà in un aumento della sicurezza di resa, poiché si potrà procedere al primo sfalcio già a inizio primavera. Di conseguenza, anche la produzione animale ne trarrà vantaggio potendo contare su una maggiore offerta di foraggi indigeni.
Parallelamente, tuttavia, si dovrà far fronte all’aumento di malerbe e piante che prediligono le temperature calde, come le piante erbacee d’origine subtropicale, che possiedono bassi valori nutritivi per gli animali. L’innalzamento delle temperature e il prolungarsi dei periodi caldi determineranno anche l’insorgere di problemi legati a insetti e organismi nocivi. È possibile che insetti quali piralide del mais, diabrotica del mais, criocera del frumento, afidi e dorifora della patata si svilupperanno e si propagheranno più rapidamente. La maggior durata del periodo caldo farà sì che in una stagione gli organismi nocivi potranno sviluppare 2–3 generazioni (piralide del mais) contro le attuali 1–2 generazioni. Se finora alcuni organismi nocivi hanno provocato danni soltanto ogni tre anni (melolonte), in futuro aumenterà la frequenza con cui si ripresenteranno gli attacchi. Con inverni meno rigidi, gli afidi che svernano in fase adulta lasceranno prima i luoghi di svernamento per migrare sulle colture. L’insorgenza di patogeni fungini e batterici è leggermente più complessa. A seconda del sistema ospite/patogeno il cambiamento climatico avrà un impatto sulle popolazioni positivo, negativo o neutrale. Inverni e primavere più miti favoriranno l’insorgenza di ruggine bruna e ruggine gialla, oidio e elmintosporosi di cereali e mais, mentre le estati calde e piuttosto secche determineranno un calo delle malattie che si diffondono in condizioni di elevata umidità, quali septoriosi e fusariosi della spiga del frumento.

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 91
■ Conclusioni
Problematico è l’aumento dei periodi di afa e siccità. Uno studio di Calanca (2006) mostra che alle attuali condizioni climatiche l’Altipiano svizzero sarà colpito da siccità ogni 6–7 estati. Le previsioni legate alle variazioni delle temperature e delle precipitazioni (entro il 2050 +2°C e calo delle precipitazioni estive del 20% circa) non fanno che sottolineare l’elevato rischio di siccità estiva. Occorre quindi tener presente che si registreranno siccità estive mediamente ogni 2–3 anni. Il perdurare, per settimane, di situazioni critiche dal punto di vista del bilancio idrico dei terreni potrà causare perdite di resa delle nostre colture. Di conseguenza in molte aree crescerà pure il bisogno d’irrigazione, anche se l’inizio anticipato del periodo di vegetazione potrebbe mitigare la situazione. A gravare ulteriormente sulla questione dell’irrigazione è il fatto che, in seguito all’innalzamento del limite dell’innevamento e allo scioglimento di minor quantità di neve, la portata estiva dei corsi d’acqua diminuirà a causa dell’evaporazione e il livello della falda freatica si potrà abbassare. Parallelamente si attende, tuttavia, un aumento delle precipitazioni abbondanti. Ciò determinerà altresì un maggior rischio di erosione del suolo.
Pertanto per l’agricoltura s’impongono provvedimenti per un’irrigazione efficace, cosicché in estate non debbano essere ulteriormente ridotte le già scarse riserve idriche. Inoltre deve essere appurato il potenziale di alcune colture, prendendo in considerazione l’uso di colture e varietà alternative più adeguate alle condizioni climatiche. Per ripartire meglio il rischio di raccolti scarsi sarebbe opportuna una strategia di diversificazione con l’obiettivo di ampliare la gamma di colture. In tal modo si potrebbe far fronte anche alla minaccia di attacchi parassitari, che con tutta probabilità saranno più numerosi.
Un aumento delle temperature inferiore a 2–3°C avrà effetti positivi sulla produzione di derrate alimentari dell’agricoltura svizzera, a condizione che la disponibilità d’acqua e di sostanze nutritive sia sufficiente. Tuttavia, i vantaggi di un moderato innalzamento delle temperature saranno tangibili soltanto se saranno attuati provvedimenti per assicurare la disponibilità di acqua e di sostanze nutritive nonché adeguamenti nei metodi di coltivazione.
Naturalmente nel caso di un surriscaldamento superiore a 2–3°C gli svantaggi prevarrebbero certamente. L’aumento del tasso di evaporazione e di traspirazione nonché il calo delle precipitazioni nel periodo di vegetazione accentuerebbero ancor più la penuria d’acqua. Per i cereali e le leguminose a granelli si andrebbe incontro a perdite di raccolto dovute all’accelerazione dello sviluppo delle piante.
Le emissioni di gas a effetto serra riconducibili all’agricoltura sono pari all’11,2 per cento circa delle emissioni totali di gas a effetto serra in Svizzera. Nel caso delle emissioni correlate al primario si tratta essenzialmente di emissioni di metano e protossido d’azoto, riconducibili alla detenzione di bestiame e alla campicoltura. In agricoltura vi è un certo potenziale tecnico di riduzione delle emissioni di metano e protossido d’azoto. Tuttavia le emissioni sono vincolate al sistema e la riduzione della produzione di derrate alimentari all’interno del Paese determina soltanto uno spostamento delle emissioni all’estero.
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 92
D’altro canto l’agricoltura svizzera viene anche influenzata dal cambiamento climatico. Le scoperte nel campo delle scienze naturali mostrano, infatti, che a differenza di quanto è il caso in altre regioni del globo la produzione agricola svizzera beneficerà di una crescita delle rese, perlomeno considerando un moderato innalzamento delle temperature entro il 2050. Affinché ciò accada, sono necessari adeguamenti sostanziali, quali ad esempio la garanzia di un approvvigionamento idrico sufficiente, la selezione di varietà più adatte alle condizioni climatiche, eccetera. Dopo il 2050, tuttavia, anche per il bene dell’agricoltura svizzera sarà indispensabile ridurre le emissioni di gas a effetto serra attuando una politica climatica globale. L’evoluzione che segnerà la seconda metà del XXI secolo è decisamente vincolata alle misure di riduzione delle emissioni che verranno adottate a breve e medio termine. Le conseguenze di un’evoluzione dettata da un atteggiamento «business as usual», ovvero privilegiando le ragioni economiche, inciderebbero considerevolmente a livello internazionale, anche nel settore primario, dove si imporrebbero adeguamenti determinanti per la sicurezza alimentare della popolazione mondiale.
Soprattutto i Paesi poveri in via di sviluppo dovranno far fronte a gravi conseguenze pur non disponendo di sufficienti possibilità finanziarie e tecniche per attuare gli adeguamenti necessari.

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 93
Energia
Il consumo energetico totale della Svizzera è in costante aumento. Nel settore agricolo, dal 1990 vi è stato un notevole calo dell’impiego di energia. Tuttavia ciò non ha avuto effetti sul consumo energetico nazionale, considerata la quota esigua dell’agricoltura rispetto al consumo energetico totale. Data la crescente consapevolezza delle conseguenze climatiche legate al consumo di energia fossile, è aumentata l’attenzione rivolta alle fonti di energia alternative. Ciò chiama in causa anche l’agricoltura con la produzione di energia dalla biomassa. Questa tematica è affrontata nei capitoli seguenti in riferimento allo studio «Ecobilancio di prodotti energetici».
L’uso di energia nell’agricoltura è dato dall’impiego diretto (diesel per il funzionamento delle macchine) e indiretto. Quest’ultimo comprende il fabbisogno energetico per la fabbricazione, l’impiego e la manutenzione di macchinari e mezzi di produzione, la cosiddetta energia grigia.
Il consumo totale viene calcolato sommando il consumo di energia diretta e indiretta dell’agricoltura. A tal fine ci si avvale del metodo dell’ecobilancio, nel cui ambito vengono valutati i volumi di sostanze e di energia nonché tutte le emissioni nocive e i carichi ambientali correlati. Per definizione, sulla scorta dell’ecobilancio non è possibile, tuttavia, trarre conclusioni in merito ai fattori socio-economici. Altre limitazioni si hanno a seconda del prodotto, della base dei dati e del contesto di valutazione.
Secondo Rossier (2000), per il calcolo del consumo energetico dell’agricoltura i dati relativi alla produzione vengono moltiplicati con coefficienti che danno il tenore energetico diretto e indiretto di un prodotto o di un’attività. Le cifre risultanti vengono sommate per ottenere il consumo energetico dell’agricoltura svizzera. Questo sistema considera unicamente la produzione primaria agricola. Nel caso della produzione lattiera, ad esempio, non viene tenuto conto della trasformazione in formaggio. Non vengono nemmeno presi in considerazione il materiale di condizionamento, il trasporto e la lavorazione di beni di consumo agricoli, le attività non agricole (agriturismo) e i consumi energetici per ovviare a eventuali danni ambientali (carico di nitrati nelle acque sotterranee).
L’efficienza energetica viene calcolata dividendo l’energia digeribile contenuta nei prodotti alimentari prodotti all’interno del Paese per il consumo energetico.

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 94
■ Energia nell’agricoltura svizzera
■ Stabilizzazione del consumo di energia
Andamento del consumo agricolo di energia da fonti non rinnovabili
1970808590919293949596
Il consumo energetico nell’agricoltura ha cominciato a stabilizzarsi a partire dagli anni ’90. Circa la metà del fabbisogno energetico agricolo è riconducibile all’uso diretto di energia (soprattutto diesel, benzina e olio combustibile) e corrente elettrica. L’altra metà è riconducibile all’energia grigia. Il 70 per cento circa di questa energia è contenuto in edifici e macchinari e il 30 per cento (15 per cento dell’energia totale) in mezzi di produzione quali concimi, pesticidi, sementi e alimenti per animali importati.
Andamento dell'energia impiegata e dell'energia nei prodotti agricoli
1970808590919293949596
A) Energia nei prodotti agricoli (MJ/ha)
B) Energia per la produzione (MJ/ha)
energetica (A/B)
979899000102030405 MJ/ha Pesticidi Alimenti importati
Sementi importate Concimi
Anno
per animali
Carburanti Elettricità Macchine Edifici 0 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Fonte: Agridea
979899000102030405 MJ/ha
Anno
Efficienza
0 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 E. prodotti agr./E. produzione 0,60 0,40 0,50 0,30 0,20 0,10 0 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 95
Fonte: Agridea
Tra il 1970 e il 1990 l’efficienza energetica ha segnato un’involuzione, in particolare a causa dell’incremento del consumo di energia. Da ciò si desume che l’energia alimentare correlata ai prodotti del raccolto è stata prodotta in misura maggiore con energia fornita da terzi. Questa tendenza negativa si è interrotta negli anni ’90 e l’efficienza energetica ha iniziato a stabilizzarsi. Negli ultimi anni, tuttavia, non si è registrato alcun miglioramento.
La presa di coscienza dell’assottigliamento delle fonti di energia fossile e della problematica legata al cambiamento climatico ha creato maggior interesse nei confronti dell’impiego di fonti di energia rinnovabile. Nei trasporti stradali, i carburanti ottenuti da biomassa (bioetanolo, biometanolo, biodiesel e biogas) sono attualmente le principali forme di energia rinnovabile. Nel dibattito pubblico a favore dei carburanti ottenuti da biomassa (biocarburanti) viene spesso sottolineato il fatto che, a differenza dei combustibili fossili, non pongono problemi dal profilo ecologico e la loro produzione offre pure una nuova opportunità all’agricoltura. Considerato che, in Svizzera così come a livello internazionale, il margine di ampliamento della superficie agricola utile è limitato (cfr. Rapporto agricolo 2006, capitolo 1.3), va tenuto presente che aumentando le superfici destinate alla coltivazione di biomassa agricola per la produzione energetica si potrebbe generare una situazione di conflitto d’interessi con la produzione di derrate alimentari, la biodiversità e le superfici forestali. Inoltre, il potenziale di coltivazione varia notevolmente a seconda del Paese. Nel Rapporto agricolo 2006 (pag. 146 segg.) sono stati allestiti i calcoli relativi alla Svizzera, dai quali si evince che il potenziale per la produzione di energia da materie prime rinnovabili coltivate nel nostro Paese è limitato.
L’efficienza energetica e la riduzione mirata delle emissioni di gas a effetto serra non sono gli unici criteri per la valutazione ecologica globale di carburanti alternativi. Nello studio «Ecobilancio di prodotti energetici» sono stati valutati gli effetti ambientali dell’intera filiera di produzione, allestendo un ecobilancio dei biocarburanti impiegati in Svizzera (periodo di riferimento 2004). È stato fatto un confronto tra le fonti d’energia rinnovabili ottenute dalla produzione Svizzera e quelle ottenute dalla produzione estera, tuttavia considerando sempre la Svizzera come area d’utilizzo dell’energia. Al fine della valutazione dell’ecobilancio totale nello studio è stato impiegato anche il metodo della scarsità ecologica (UBP 06), la cui unità di misura è costituita dai punti di carico ambientale. Questo metodo di valutazione esamina la differenza tra conseguenze ambientali quali, ad esempio, potenziale di smog in estate, sovraconcimazione o ecotossicità rispetto ai valori limite svizzeri.
Percentualmente, alle nostre latitudini la coltivazione agricola risulta la principale fonte di carichi ambientali riconducibili all’impiego di macchinari, concimi e/o pesticidi nonché di emissioni dirette. Nel caso dell’agricoltura praticata nelle aree tropicali gli elevati carichi ambientali sono dovuti essenzialmente alle perdite di biodiversità e all’inquinamento atmosferico dovuti a incendi nonché alla tossicità dei pesticidi, alcuni dei quali vietati in Svizzera. A differenza dei prodotti agricoli, il trattamento dei rifiuti e del materiale di scarto non richiede alcun consumo di energia e ciò incide in modo molto positivo sul bilancio totale.
■ Ecobilancio di carburanti
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 96
■ Carichi ambientali lungo la filiera di produzione
Carico ambientale di biocarburanti rispetto ai combustibili fossili
100% metil-estere colza CH
Biodiesel (rifiuti+ coltura)
Alcool (coltura)
Metano (rifiuti+scarti)
Fossile
100% X-metil-estere olio di palma MY
100% X-metil-estere olio di soia US
100% X-metil-estere olio di soia BR
100% X-metil-estere olio commestibile usato CH
Etanolo erba CH
Etanolo patate CH
Etanolo barbabietola da zucchero CH
Etanolo legno CH
Etanolo segale UE
Etanolo mais US
Etanolo canna da zucchero BR
Metano liquame
Metano liquame+co-substrato
Metano liquame, processi ottimizzati
Metano liquame+co-substrato, processi ottimizzati
Metano rifiuti biologici
Metano fanghi di depurazione
Diesel, a basso tenore di zolfo EURO3
Benzina, a basso tenore di zolfo EURO3 Gas naturale, EURO3
La trasformazione in carburanti ha un impatto ambientale minore rispetto alla coltivazione agricola. Particolarmente basso è il carico ambientale riconducibile all’estrazione di olio e all’esterificazione in biodiesel. Il maggior impatto ambientale è quello generato dalla produzione di metano da rifiuti biogeni. Ciò è dovuto alle emissioni di metano e protossido d’azoto generate dalla seconda fermentazione del digestato e alla possibilità di una perdita di metano, dovuta ad esempio a falle durante la trasformazione della biomassa in metano.
Il trasporto di carburante dall’area di produzione ai distributori ha un ruolo secondario, se il trasporto intercontinentale avviene via navi petroliere o oleodotti.
L’impatto ambientale collegato all’uso di veicoli è sensibilmente maggiore e ciò è dovuto al fatto che viene maggiormente utilizzato combustibile fossile anziché biocarburanti a scarsa emissione di CO2
Nello studio sono state considerate anche la costruzione e la manutenzione di strade e veicoli (infrastruttura). Tuttavia tutti i casi osservati riguardavano il medesimo tipo di veicolo con stesso chilometraggio e quindi la quota è la stessa per tutte le varianti.
Infrastruttura Coltivazione Trasformazione Trasporto Uso dei veicoli 0 0200400600 Punti di carico ambientale 8001000 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 97
Fonte: Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR)
Dall’analisi dei vari carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili è emersa mediamente una riduzione di un terzo delle emissioni di gas a effetto serra, anche se la coltivazione e la trasformazione possono determinare altri carichi ambientali.
La metà circa dei 26 biocarburanti analizzati rende possibile una riduzione delle emissioni del 50 per cento circa; 5 di essi sono ottenuti da rifiuti. La riduzione più marcata si segnala per i biocarburanti ottenuti dal liquame cui seguono biodiesel da olio commestibile usato, metanolo e metano nonché bioetanolo da biomassa indigena (erba, legna, barbabietola da zucchero o siero di latte), canna da zucchero brasiliana e sorgo zuccherino cinese. Nel caso di 9 carburanti è osservabile una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra superiore al 30 per cento. Ciò interessa anche la produzione di biodiesel da diversi prodotti agricoli (olio di soia USA, olio di palma Malesia, olio di colza Svizzera).
Il fatto che nella valutazione dell’impatto ambientale venga considerato il carico ambientale totale modifica il quadro rispetto alla valutazione esclusiva del potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Ciò è visibile in riferimento alla produzione di bioetanolo dalla canna da zucchero brasiliana. Spesso le superfici coltivate a canna da zucchero sono ottenute bruciando estese aree di foresta oppure prima del raccolto vengono bruciate le foglie secche. Questo modo di trasformare aree di foresta in campi coltivati provoca un’enorme dispersione dell’anidride carbonica incamerata dalle piante. Inoltre, cresce sensibilmente anche l’inquinamento atmosferico per via delle polveri fini e dello smog così come l’indicatore ambientale relativo al potenziale di smog in estate. Ciò comporta una valutazione negativa della coltivazione di canna da zucchero destinata alla produzione di energia, benché la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili sia superiore al 50 per cento.
Emissioni di gas a effetto serra e carico ambientale globale 0204060
■ Riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra vs. carico ambientale
Emissioni di gas a effetto serra in %
Carico ambientale globale (UBP 06) in % Metano Da materie prime
dei materiali
di ricerca (LPMR) 0 200 100 300 400 500 600 Etanolo Da materiale di scarto XME Segale, UE Patate, CH Mais, US Erba Legna (etanolo) Soia, BR
Colza, CH Palma da olio, MY Liquame+ co-substrato ott. Liquame Rifiuti biologici Fanghi di depurazione Gas naturale Diesel a basso tenore di zolfo
basso tenore di zolfo
da zucchero, BR Liquame+ co-substrato Liquame ott. Barbabietola da zucchero, CH Fossile Olio commestibile usato 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 98
80100120
Fonte: Laboratorio federale di prova
e
Soia, US
Benzina a
Canna
Per poter classificare gli effetti delle emissioni di gas a effetto serra e del carico ambientale globale la benzina è stata scelta come riferimento al 100 per cento per entrambe le dimensioni. I carburanti inferiori al 100 per cento in entrambe le dimensioni hanno dato valori più bassi per quanto riguarda sia le emissioni di gas a effetto serra sia il carico ambientale globale. Nel complesso emerge che tra i carburanti a minor tasso di emissioni e carico ambientale rispetto alla benzina, i migliori sono quelli ottenuti da rifiuti e materiale di scarto. Ciò è dovuto, da un lato, al fatto che vengono eliminati i carichi elevati legati alla preparazione delle materie prime e, dall’altro, che possono essere ridotte le emissioni nell’ambiente derivanti dal trattamento dei rifiuti, quali l’inquinamento delle acque di scolo con siero di latte o emissioni di metano dovute alla concimazione con liquame non fermentato. Il potenziale volume di produzione di biocarburanti considerate queste filiere di produzione è molto contenuto (meno dell’1% del quantitativo di diesel attualmente consumato in Svizzera).

Relativamente buono risulta il bioetanolo ottenuto dalle barbabietole da zucchero. Grazie alle elevate rese di coltivazione, al basso tenore di fibra delle piante rispetto alla canna da zucchero e all’elevata densità energetica della barbabietola (maggior tenore di saccarosio), le fasi di produzione a valle della coltivazione sono meno intensive in termini di consumo energetico rispetto alla produzione di bioetanolo dalla canna da zucchero brasiliana. Il rischio di costipamento del suolo correlato al raccolto non incide nella valutazione ecologica globale, poiché il carico del suolo nell’arco dell’intero periodo di vegetazione è considerato buono. La situazione è diversa per quanta riguarda i prodotti a bassa resa di combustibile per unità di superficie (p.es. coltivazione di colza, mais e soia). Le emissioni di protossido d’azoto provocate dall’impiego di concimi minerali e dalla lavorazione meccanica, nonché l’uso di erbicidi e pesticidi pesano negativamente sulla valutazione globale.
Particolarmente negativa è la valutazione della produzione di bioetanolo da patate svizzere e da segale europea. L’elevato carico della produzione da patate svizzere è riconducibile al considerevole impatto del dilavamento di sostanze nutritive. I valori molto negativi della produzione da segale europea possono essere motivati dalla bassa resa media dei raccolti.
Migliorando la coltivazione agricola (innanzitutto anche nel caso delle materie prime estere) si potrebbe migliorare anche il bilancio ecologico globale della produzione energetica da materie prime rinnovabili. Dal profilo delle colture si deve mirare ad ottimizzare il rapporto tra resa energetica e basso carico ambientale. Tale obiettivo può essere raggiunto con una scelta idonea delle varietà e dell’avvicendamento delle colture.
Un fattore critico della coltivazione di materie prime agricole per la produzione energetica è la concorrenza con altri impieghi (derrate alimentari, legname per energia, edilizia e industria cartiera). Il disboscamento di foreste vergini per la coltivazione di materie prime agricole destinate alla produzione di energia può causare anche emissioni di anidride carbonica.
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 99
■ Conclusioni
Il presente studio mostra che la maggior parte dei biocarburanti determina una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, benché per quanto riguarda diversi altri indicatori ambientali la coltivazione e la produzione di questi carburanti facciano registrare carichi più elevati rispetto alla benzina.
La scoperta fondamentale di questo studio è che nel caso dei biocarburanti la maggior parte dei carichi ambientali è causata dalla coltivazione agricola. Dal profilo della produzione agricola la resa delle superfici e il rispettivo rapporto con l’impiego di energia (concimi minerali, lavorazione meccanica, ecc.) rappresenta un criterio decisivo in grado di influenzare la valutazione globale.

1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 100
■ Emissioni di fuliggine diesel provenienti dall’agricoltura
Aria
Gli elevati carichi di polveri fini registrati tra gennaio e metà febbraio 2006 a Nord delle Alpi hanno aperto un acceso dibattito pubblico. Le emissioni di ammoniaca (gas precursore di particolato secondario), causate per oltre il 90 per cento dall’agricoltura, sono state indicate come la causa principale dell’inquinamento da polveri fini. Pertanto la loro riduzione è sembrata un provvedimento indicato per contenere i carichi di polveri fini.
Le polveri fini, o particolato, sono una miscela di particelle di polvere microscopiche con un diametro aerodinamico inferiore a 10 micrometri, ecco perché vengono anche indicate come PM10 (particulate matter). La composizione del particolato è complessa. Il particolato primario, che può avere effetti più o meno nocivi per la salute, è generato direttamente dai processi di combustione, dall’abrasione meccanica o dal risollevamento di sostanze naturali già depositate (p.es. polline). Una fonte importante di particolato primario è la fuliggine dei gas di scarico dei motori diesel.
Il particolato secondario si forma invece nell’aria a partire da precursori gassosi quali anidride solforosa (SO2), ossidi d’azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti organici volatili (COV). Esso costituisce una parte importante delle polveri fini, in quanto ammonta ad un terzo/metà di esse.
Le discussioni scatenate dagli elevati carichi di polveri fini rilevati ad inizio 2006 hanno chiamato fortemente in causa il primario, settore in cui, secondo i dati utilizzati dall’UFAM, i macchinari impiegati generano 1'100 tonnellate di fuliggine diesel nociva per la salute.
L’agricoltura ha criticato i calcoli di riferimento. Sulla scorta di una nuova valutazione è emerso che nel 2005 i macchinari agricoli hanno emesso soltanto 400 tonnellate di fuliggine diesel. Il notevole scarto tra i risultati delle due valutazioni è riconducibile all’adeguamento di diversi fattori alla base del modello. Da un lato i fattori di emissione (quantità di fuliggine diesel emessa in g/potenza motore) sono stati ridotti di quasi la metà sulla scorta dei miglioramenti tecnici apportati ai motori, dall’altro la durata media d’uso annuale dei macchinari agricoli è stata ridotta di un terzo in Svizzera.
Al momento non è dato sapere la quota percentuale dei macchinari agricoli rispetto alle emissioni totali di fuliggine diesel. Prima devono essere approntati i calcoli relativi alle altre categorie di fuoristrada (emissioni di veicoli diversi da quelli per il normale traffico su strada, come p.es. macchine edili, industria, silvicoltura, navi).
1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 101
■ Ammoniaca e particolato secondario
L’industria, l’artigianato, i trasporti e le economie domestiche generano anidride solforosa (SO2) e ossidi d’azoto (NOx) che nell’aria si trasformano in acido nitrico e acido solforico. L’ammoniaca (NH3), prodotta in gran parte dall’agricoltura, neutralizza nell’aria questi acidi sotto forma di sali di nitrato d’ammonio e solfato d’ammonio che si legano a particelle già esistenti o ne formano delle nuove. Considerato che per la formazione di particelle è necessaria l’ammoniaca, ridurne la concentrazione sembrerebbe la misura più indicata al fine di diminuire il particolato secondario. Uno studio su modelli a cura di Agroscope Reckenholz-Tänikon ART mostra tuttavia che non esiste un rapporto diretto tra riduzione di emissioni di NH3 e riduzione del particolato, poiché la variazione delle quantità di particolato dipende dal rapporto tra ammoniaca e acidi reagenti. A seconda della quantità degli acidi, infatti, la reazione del particolato alla variazione della concentrazione di ammoniaca può essere più o meno marcata. Questo rapporto particolarmente delicato può essere inoltre influenzato da altri fattori quali temperatura e umidità.
Diminuzione media della massa di particolato inorganico a dipendenza delle diverse riduzioni di emissioni
■ Conclusioni
I risultati dello studio mostrano che una riduzione delle attuali emissioni di ammoniaca nella misura del 10 per cento determinerebbe una diminuzione del particolato pari soltanto allo 0,5 per cento. Se le emissioni di ammoniaca venissero dimezzate v’è da attendersi un calo medio della massa di particolato inorganico del 10 per cento. Dato che il particolato inorganico rappresenta soltanto la metà circa delle polveri fini, ciò corrisponde ad una riduzione delle PM10 pari al 5 per cento circa. Ciò è tipico di una situazione di eccedenza di ammoniaca. Soltanto a seguito di una consistente riduzione delle emissioni di ammoniaca si ha una reazione dei quantitativi di particolato e l’efficacia è maggiore se s’intensifica la portata delle riduzioni.
I risultati mostrano che un’eventuale riduzione delle emissioni di ammoniaca contribuisce soltanto in parte al calo delle polveri fini. Dato il complesso equilibrio tra i precursori che entrano in gioco, una riduzione globale di ammoniaca, ossidi d’azoto e zolfo avrebbe un impatto maggiore sulla diminuzione del particolato secondario. È tuttavia un dato di fatto che ci si debba adoperare al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca in vista di una diminuzione del carico di azoto in ecosistemi sensibili.
Riduzione aerosol inorganici in % Estate Inverno Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART 010305070 20 Riduzione emissioni NH3 in % 406080 0 50 40 30 20 10 60 70 80 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 102
Partecipazione ai programmi URA e SSRA
Nel quadro dei pagamenti diretti agli agricoltori, mediante i programmi «uscita regolare all'aperto» (URA) e «sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» (SSRA) la Confederazione promuove la detenzione degli animali da reddito agricoli rispettosa delle loro esigenze. Il programma URA disciplina in particolare l’uscita degli animali al pascolo o nel parchetto all’aperto oppure nello spazio esterno coperto per quanto concerne il pollame. Il programma SSRA prevede soprattutto condizioni di natura qualitativa concernenti le singole aree delle stalle ad aree multiple nelle quali gli animali possono muoversi liberamente. La partecipazione a questi programmi è facoltativa. Le cifre riportate di seguito si riferiscono all'insieme delle aziende che beneficiano di pagamenti diretti, vale a dire a tutti gli animali da reddito che vi sono detenuti.
Dall’introduzione dell’URA (1993) e dei SSRA (1996), la partecipazione ad entrambi i programmi è in costante aumento. Nel 2006 le aziende che hanno partecipato ai programmi URA e SSRA sono state rispettivamente 38'000 e 18'300.

■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1.3.2Etologia
Tabelle 38–39, pagine A42–A43
1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 103
Andamento della partecipazione ai programmi URA e SSRA
Tra il 1996 e il 2006 la quota degli animali da reddito detenuti secondo le condizioni URA è cresciuta dal 19 al 71 per cento. Nello stesso periodo, per il programma SSRA si è registrato un incremento della quota dal 9 al 41 per cento. Questi valori sono una media delle quattro categorie di animali da reddito (bovini, altri animali che consumano foraggio grezzo, suini e pollame).
Andamento della partecipazione al programma URA, secondo le categorie di animali da reddito
Osservando la partecipazione al programma URA, differenziandola per categorie di animali da reddito, emerge che tra il 1996 e il 2006 l'incremento per i bovini e gli altri animali che consumano foraggio grezzo è stato notevole. La quota è infatti passata dal 20 a rispettivamente il 73 e l'81 per cento. Per i suini vi è stata una crescita della partecipazione dal 5 per cento al 60 per cento.
Quota di UBG in % URASSRA Fonte: UFAG 1996199719981999 0 60 70 80 50 40 30 20 10 2000 2001 200220032004 2005 2006
Quota di UBG in % Fonte: UFAG Bovini
SuiniPollame 199619971998199920012002 2000 0 70 80 90 50 60 40 30 20 10 20032004 2005 2006 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 104
Altri animali che consumano foraggio grezzo
L'andamento della partecipazione per il pollame da reddito è caratterizzato da due evoluzioni molto differenziate per le galline ovaiole e i polli da ingrasso. Se da un lato la partecipazione per le galline ovaiole è aumentata costantemente fino al 2006 (2006: 65%), quella per i polli da ingrasso ha smesso di crescere nel 1999 (42%), quando ha ripreso a diminuire per attestarsi al di sotto del 9 per cento nel 2006. Ciò è riconducibile all'introduzione della durata minima di ingrasso dei polli di 56 giorni. La durata d'ingrasso decisamente maggiore rispetto alla produzione convenzionale comporta un aumento dei costi di produzione e, di riflesso, un rincaro del prezzo di mercato. Di conseguenza vi è stato un calo della domanda di polli URA.

Andamento della partecipazione al programma SSRA, secondo le categorie di animali da reddito
Da una distinzione della partecipazione al programma SSRA per gruppi di animali da reddito emerge che tra il 1996 e il 2006 per quanto riguarda i bovini e gli altri animali che consumano foraggio grezzo gli aumenti sono stati di gran lunga più contenuti rispetto a quelli registrati in riferimento all'URA. Le quote sono infatti aumentate dal 10 per cento al 32 per cento. Ciò è riconducibile soprattutto al fatto che nella maggior parte dei casi gli investimenti sono molto elevati (stabulazione libera) e pertanto vengono fatti di regola al momento di un investimento sostitutivo.
Per i suini il programma SSRA è stato introdotto soltanto nel 1997. La partecipazione è stata analoga a quella rilevata nel quadro del programma URA. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che le label esistenti per i suini partono dal presupposto che gli animali siano stati detenuti nel quadro di programmi URA e SSRA.
L'impennata della partecipazione del pollame al programma SSRA (2006: 84%) è in gran parte dovuta al successo sul mercato di un marchio nel quadro del quale gli allevatori si impegnano per la detenzione di ovaiole e di polli da ingrasso particolarmente rispettosa delle loro esigenze.
Quota di UBG in % Fonte: UFAG Bovini Altri animali che consumano foraggio grezzo SuiniPollame 1996199719981999200120022003200420052006 2000 0 80 90 50 60 70 40 30 20 10 1.RUOLOESITUAZIONEDELL’AGRICOLTURA 1.3 ECOLOGIA ED ETOLOGIA 1 105
106 1

107 2
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. Provvedimenti di politica agricola
I provvedimenti di politica agricola si suddividono in tre ambiti:
– Produzione e smercio: in questo ambito i provvedimenti si traducono in valide condizioni quadro per la produzione e lo smercio delle derrate alimentari. Le uscite della Confederazione per produzione e smercio diminuiscono costantemente. Nel 2006 ammontavano a 606 milioni di franchi, ossia oltre 1 miliardo di franchi in meno rispetto alla riforma agraria del 1990/92.
– Pagamenti diretti: si tratta di pagamenti che indennizzano le prestazioni fornite nell’interesse della collettività come la cura del paesaggio, la salvaguardia delle basi vitali naturali e il contributo per l’occupazione decentrata del territorio nonché le prestazioni ecologiche particolari. I prezzi delle derrate alimentari non comprendono tali prestazioni data l’assenza di un mercato corrispettivo. Mediante i pagamenti diretti lo Stato assicura che l’agricoltura fornisca prestazioni a favore della collettività.
– Miglioramento delle basi: con tali misure la Confederazione promuove e sostiene una produzione di derrate alimentari rispettosa dell’ambiente, sicura e efficiente. Nella fattispecie trattasi di provvedimenti volti a migliorare le strutture nonché di misure nei settori della ricerca, della consulenza, delle materie ausiliarie dell’agricoltura, della protezione dei vegetali e delle varietà.
108 2. PROVVEDIMENTI DI POLITICA AGRICOLA 2
2.1 Produzione e smercio
Conformemente all’articolo 7 LAgr, che fissa gli obiettivi della produzione e dello smercio di prodotti agricoli, l’agricoltura è tenuta a produrre in modo sostenibile e poco costoso e a conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. Per raggiungere tali obiettivi, la Confederazione può adottare misure che riguardano i settori: qualità, promozione dello smercio e caratterizzazione, importazione ed esportazione, economia lattiera, produzione animale, produzione vegetale e vitivinicoltura.

Nel 2006, alla promozione della produzione e dello smercio sono stati accordati 606 milioni di franchi. Rispetto all’anno precedente si è registrata una diminuzione delle uscite di 71 milioni di franchi (–10,5%). La riduzione dei mezzi finanziari alla promozione dello smercio è il risultato di una modifica del termine di pagamento degli acconti e dei saldi delle prestazioni. L’importo necessario alla promozione dello smercio, tuttavia, non varia rispetto al passato e resta sui 54 milioni di franchi.
Uscite per produzione e smercio
Il trasferimento di fondi dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti determina una progressiva diminuzione dei mezzi finanziari destinati alla produzione e allo smercio.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Conto 2006Preventivo 2007 Ambito di spesaImportoQuotaImportoQuota mio. fr.%mio. fr.% Promozione dello smercio325,3549,6 Economia lattiera44373,136665,5 Produzione animale193,1234,1 Produzione vegetale (compresa la viticoltura)11218,511620,8 Totale606100559100
dello Stato, UFAG
Fonti: Conto
finanziari
Prospettiva
■ Mezzi
2006 ■
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 109 2
Tabelle 27–30, pagine A27–A29
■ Estensione delle misure di solidarietà
2.1.1 Strumenti sovrasettoriali
Organizzazioni di produttori e di categoria
In virtù degli articoli 8 e 9 LAgr, il Consiglio federale può dichiarare vincolanti misure per il miglioramento della qualità, la promozione dello smercio e l’adeguamento dell’offerta alla domanda decise da organizzazioni di produttori e di categoria. Dal 2002 il Consiglio federale ha più volte esteso ai non membri le misure di solidarietà di un’organizzazione; nella maggior parte dei casi si è trattato del finanziamento del marketing per prodotti agricoli. Questo strumento consente di far fronte in maniera efficace al problema legato alle imprese che approfittano di misure di solidarietà pur non applicandole né finanziandole. Nel 2006 e nel 2007 il Consiglio federale ha esteso ai non membri le misure convenute da tre organizzazioni di produttori (Unione svizzera dei contadini, Produttori Svizzeri di Latte e GalloSuisse) e da quattro associazioni di categoria (Interprofession du Gruyère, Interprofession du Vacherin fribourgeois, Emmentaler Switzerland e Sbrinz GmbH).
Le estensioni vigenti decadono il 31 dicembre 2007. Sei organizzazioni hanno presentato al Consiglio federale una domanda di rinnovo dell’estensione che le concerne. Come prescritto dalla legge, le domande sono state pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) per dare ai non membri delle organizzazioni la possibilità di esprimere il proprio parere nel quadro della procedura di consultazione. Una volta trattate dall’UFAG, le domande sono state trasmesse al Consiglio federale unitamente a un preavviso. Il Consiglio federale è tenuto a emettere una decisione entro la fine dell’anno.
■ Modifica d’ordinanza nel quadro della PA 2011
Nel quadro della PA 2011 il Parlamento ha approvato la modifica dell’articolo 9 LAgr, per garantire la continuità dei provvedimenti per la promozione dello smercio ed il miglioramento della qualità. Ciò consente di prolungare, a seguito di un riesame, le misure di solidarietà laddove le organizzazioni ne facciano domanda. Tuttavia, il Parlamento ha previsto che l’estensione di misure di solidarietà per l’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze di mercato sia da attuare soltanto in situazioni straordinarie non vincolate a questioni di natura strutturale. L’ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori sarà adeguata con effetto al 1° gennaio 2008 per tener conto di tali decisioni.
In base alla prassi adottata dal Consiglio federale dal 2002, l’estensione viene concessa indistintamente per un periodo di due anni. Siccome il Parlamento non voleva dare a priori una limitazione temporale alle misure di solidarietà, è possibile estenderle per più di due anni. Il disegno d’ordinanza inviato in consultazione prevedeva una durata di estensione di quattro anni al massimo per i provvedimenti di promozione dello smercio e di miglioramento della qualità. Nel caso dei provvedimenti di gestione dell’offerta, invece, è stato proposto di mantenere la validità di due anni. Entrambe le proposte di modifica sono state approvate.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 110
Una maggiore durata dell’estensione comporta una semplificazione amministrativa sia per le organizzazioni coinvolte sia per gli uffici federali. Le organizzazioni, alle quali il Consiglio federale ha assicurato un’estensione delle misure di solidarietà, devono consegnare un rapporto annuo al Dipartimento federale dell’economia sull’esecuzione e l’efficacia delle misure. Il Consiglio federale può revocare l’estensione in qualsiasi momento laddove vengano constatate irregolarità.

2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 111 2
■ Evoluzione della preferenza accordata ai prodotti agricoli svizzeri
Promozione dello smercio
I consumatori svizzeri sono attenti all’origine dei prodotti? Nel gennaio 2007 è stato condotto il quinto sondaggio su questo tema che ha interessato la Svizzera tedesca e francofona. Le domande spaziavano dall’atteggiamento nei confronti dell’agricoltura svizzera e dei sui prodotti, alle esigenze poste alla produzione rispetto all’estero, passando per la disponibilità a pagare di più per determinati prodotti.
Per diversi prodotti gli interpellati hanno risposto a domande quali «fa attenzione all’origine?» e «preferisce i prodotti svizzeri?». Le risposte hanno permesso di mettere a fuoco l’atteggiamento dei consumatori verso l’agricoltura svizzera tracciandone l’evoluzione nel tempo.
Preferenza accordata a prodotti svizzeri rispetto a quelli esteri
Uova (463)
Carne (salumi esclusi) (467)
Formaggio (479)
Vino (374)
Latte e latticini freschi (478)
Miele (345)
Verdura (475)
Frutta/bacche (473)
Salumi (433)
Patate (460)
Funghi (358)
Olio commestibile (441)
Prodotti a base di cereali (487)
Succhi di frutta (420)
Prodotti a base di patate (358) Fiori recisi (319)
Piante in vaso (226)
Le uova figuravano in testa alla graduatoria fin dal primo sondaggio svolto nel 1998. Dai risultati si evince che la preferenza per le uova svizzere è legata ancora al divieto di allevamento in batteria. I consumatori sembrano essere maggiormente attenti all’origine degli alimenti animali che a quella degli alimenti vegetali. L’importanza dell’origine appare minore per i prodotti di genere non alimentare quali fiori recisi o piante in vaso. Da ciò si evince che per quanto riguarda le derrate alimentari non soltanto la vicinanza, bensì anche sicurezza, qualità e fiducia hanno una valenza particolare.
sempre/quasi
talvolta mai perlopiù raramente non so/nessuna risposta 0 10 20 30 40 50 In % degli interpellati 60 70 80 90 100 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 112
Fonte: DemoScope 2007
sempre
Tabella 27, pagina A27
Con soddisfazione si osserva che i consumatori riconoscono che gli agricoltori svizzeri sono tenuti a produrre secondo esigenze ben più severe di quelle estere. Questo è quanto affermato dall’82 per cento degli interpellati. Inoltre, il 64 per cento ritiene che l’agricoltura svizzera meriti fiducia e il 26 per cento che sia piuttosto affidabile. L’immagine dell’agricoltura svizzera presso i consumatori è, quindi, molto buona.
Esigenze poste alla produzione più elevate in Svizzera che all’estero
Assolutamente falso 3%
Piuttosto falso 9%
Piuttosto vero 44%
Non so 6%
Assolutamente vero 38%
Fonte: DemoScope 2007
Un’altra domanda chiave è se la convenienza di prezzo sia un motivo per optare per altri prodotti nonostante la buona immagine della produzione svizzera. Il 40 per cento circa degli interpellati non è disposto a pagare di più per i prodotti svizzeri. Al contrario, il 50 per cento circa è pronto a pagare di più, anche se su quanto di più le opinioni divergono.
La scelta di un’identità comune permette di consolidare al meglio la fiducia dei consumatori. In tal modo il messaggio legato alla prestazione particolare dell’agricoltura svizzera sarà recepito dal grande pubblico. Molto è già stato fatto a questo proposito. Dal 2009 l’agricoltura svizzera si doterà di un’identità comune nella comunicazione senza rinunciare alle diverse peculiarità legate alla prestazione o al mittente.

2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 113 2
■ Ordinanza montagna/alpe
Politica della qualità e caratterizzazione
In data 8 novembre 2006 il Consiglio federale ha varato l’ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati.
L’ordinanza del Consiglio federale persegue tre obiettivi. Offre alle aziende uno strumento per la differenziazione e la segmentazione dell’offerta, protegge i produttori e gli addetti alla trasformazione dalla concorrenza sleale e fornisce ai consumatori la garanzia della provenienza di un prodotto dalla regione di montagna o da quella alpestre. L’ordinanza rispecchia la volontà del Consiglio federale di promuovere la creazione di valore aggiunto e lo sviluppo rurale soprattutto nella regione di montagna.
L’ordinanza montagna/alpe disciplina in maniera chiara le condizioni per impiegare queste designazioni; tutte le aziende che desiderano caratterizzare in questa maniera i loro prodotti svizzeri devono rispettarle. Le disposizioni fungono da incentivo per i produttori e per gli addetti alla trasformazione nonché alla distribuzione a definire il legame tra la provenienza dei loro prodotti e la regione di montagna o d’estivazione, il che un tempo era reso difficile per la mancanza di una chiara definizione. Chi ha già fatto corretto uso di queste designazioni, sarà tutelato, in futuro, dalla concorrenza sleale. Data la liberalizzazione dei mercati agricoli e la soppressione del contingentamento lattiero prevista per il 2009, le regioni di montagna hanno tutto l’interesse nel poter differenziare i loro prodotti alle condizioni migliori. Le richieste delle aziende all’UFAG, in particolare quelle concernenti la certificazione, rispecchiano questo interesse. Sul fronte della distribuzione, nel febbraio 2007, la Coop ha lanciato una linea di prodotti di montagna con il marchio «Pro Montagna». Il secondo grande distributore svizzero ha quindi ampliato la sua offerta di prodotti di montagna nei punti vendita raggiungendo la Migros che un anno prima aveva lanciato il marchio di latticini «Heidi».
Criteri per l’utilizzo dei termini «montagna» e «alpe»
Il termine «montagna» può essere impiegato soltanto per prodotti agricoli provenienti dalla regione di montagna e per prodotti agricoli trasformati le cui materie prime provengono dalla regione di montagna e vengono trasformate in detta regione o in un Comune confinante. Con l’estensione ai Comuni confinanti vengono incluse le aziende di trasformazione che soprattutto per le condizioni topografiche sono state installate nella regione di pianura nelle immediate vicinanze della regione di montagna (v. cartina 1).
Per i prodotti le cui materie prime provengono dalla regione di montagna senza tuttavia essere trasformate in detta regione o in un Comune confinante, può essere indicata l’origine delle materie prime. Questa eccezione al principio precedentemente descritto va essenzialmente a favore dei prodotti industriali (p.es. yogurt «con latte di montagna»). Non è applicabile ai formaggi per i quali continua a vigere un disciplinamento ferreo. Il latte deve essere assolutamente prodotto nella regione di montagna ed essere trasformato in formaggio nella regione di montagna ampliata o in un Comune confinante. Questa norma rispecchia l’attuale prassi nel settore caseario.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 114
Il termine «alpe» può essere impiegato soltanto per prodotti agricoli provenienti dalla regione d’estivazione e per prodotti agricoli trasformati le cui materie prime provengono dalla regione d’estivazione, dove sono anche trasformate.
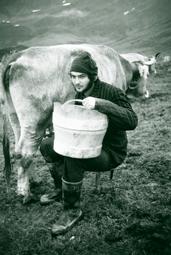
Ordinanza montagna/alpe – Aree di produzione e di trasformazione Prodotti di montagna
Regione d’estivazione e zone di montagna I–IV Comuni parzialmente ubicati nella regione di montagna e alpestre
Ordinanza montagna/alpe – Aree di produzione e di trasformazione Prodotti d’alpe
Regione d’estivazione
©Copyright GG25: Swisstopo/2005 Fonte: UFAG, 2006
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 115 2
©Copyright GG25: Swisstopo/2005 Fonte: UFAG, 2006
■ Stato attuale del registro
DOP/IGP
Con decisione datata 26 settembre 2006 il Tribunale federale ha respinto i ricorsi di tre organizzazioni estere (due francesi e una tedesca) contro la registrazione dell’Emmentaler. Le organizzazioni ricorrenti avevano impugnato la decisione della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell’economia (REKO/EVD) che non ha riconosciuto loro la legittimità a ricorrere siccome non potevano far valere alcun interesse degno di protezione sul territorio svizzero. Con la DOP Emmentaler sale a 15 il numero dei prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati iscritti nel registro DOP/IGP, nel quale figurano ben 9 formaggi. Nel 2006 all’UFAG sono state presentate altre tre domande di registrazione. Si tratta delle DOP Assenzio e Jambon de la borne nonché dell’IGP Longeole. Inoltre, l’organizzazione di categoria «Interprofession de la charcuterie AOC» ha presentato un nuovo elenco degli obblighi per il Boutefas. In particolare viene richiesto di ampliare l’area geografica al Cantone Friburgo per uniformare l’area di produzione dei suini con quella del Jambon de la borne. Attualmente è in corso l’esame di 3 domande di iscrizione DOP (Büscium da cavra, Sauerkäse/Bloderkäse e Tomme vaudoise) e di 4 domande di iscrizione IGP (St. Galler Bratwurst, Appenzeller Pantli, Appenzeller Siedwurst e Appenzeller Mostbröckli). Per quanto concerne la domanda di registrazione della DOP Bois du Jura, inoltrata nel 2004, si deve attendere la modifica della legge sulle foreste, che dovrebbe consentire di estendere la protezione DOP a un prodotto silvicolo. Proseguono, inoltre, l’esame e la procedura relativi a 6 domande di modifica dell’elenco degli obblighi che riguardano: Vacherin Mont-d'Or (DOP), Berner Alpkäse (DOP), Saucisson Neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise (IGP), Saucisson vaudois (IGP), Saucisse aux choux vaudoise (IGP) e Tête de Moine, Fromage de Bellelay (DOP).
Per quanto concerne le domande di iscrizione delle DOP Damassine e Poire à Botzi è in corso la procedura d’opposizione mentre il fascicolo Raclette è pendente dinanzi al Tribunale federale.

2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 116
NumeroNumerott
Formaggio
L’EtivazDOP721378366OIC
EmmentalerDOP2 91321300OIC/SQS
GruyèreDOP2 53024528 14827 700OIC
SbrinzDOP479311 3141 608Procert
Tête de MoineDOP29371 7912 064OIC
Formaggio d’alpe TicineseDOP3333135180OIC
Vacherin FribourgeoisDOP4208300OIC
Vacherin Mont-d’OrDOP24212555543OIC
Berner AlpkäseDOP549151 020OIC
Prodotti carnei
Carne secca dei GrigioniIGP39994983Procert
Saucisse d’AjoieIGP105762OIC
Carne secca del ValleseIGP21396361OIC
Saucisse neuchâteloise / Saucisson neuchâtelois IGP18123147OIC
Saucisson vaudoisIGP42650650OIC
Saucisse aux choux vaudoiseIGP42450612OIC
Bevande contenenti alcol di distillazione
Eau-de-vie de poire du ValaisDOP2684 OIC
Abricotine
Altri prodotti
DOP1423OIC
Rheintaler RibelDOP2423033Procert
Cardon épineux genevoisDOP927463Procert
Pane di segale vallesanoDOP4565480738OIC
Zafferano di MundDOP150,000910,00052OIC
Fonte: UFAG
Registro DOP/IGP al 31 dicembre 2006
Denominazione Protezione Aziende agricole Aziende (trasformazione/ lavorazione) Volume di produzione certificato 2005 Volume di produzione certificato 2006 Enti di certificazione 98 824 litri alcol al 100% 93 000 litri alcol al 100% 28 756 litri alcol al 100% 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 117 2
■ Modifiche delle basi legali e nell’esecuzione delle norme d’importazione
Strumenti del commercio estero
Continua il processo di semplificazione delle norme d’importazione scaturito dall’ulteriore sviluppo della politica agricola e dagli accordi bilaterali di libero scambio. Nel giugno 2007 sono entrati in vigore gli accordi di libero scambio con l’UE che interessano il formaggio. Ad inizio 2007 si è tenuta l’ultima vendita all’asta dei quantitativi rimanenti dei contingenti doganali di formaggio esenti da dazio. In alcuni casi i quantitativi messi all’asta hanno superato di molto la domanda. Inoltre, è stato deciso che per le importazioni di formaggio saranno mantenuti sia l’obbligo del permesso sia le tasse amministrative fintanto che l’UE continuerà ad applicare una procedura di licenza che prevede una cauzione. Il rimanente contingente doganale nel quadro dell’OMC, ovvero quello per il formaggio fontal, viene mantenuto sebbene amministrato mediante la procedura in base all’ordine di entrata delle domande di sdoganamento alla frontiera.
Nel settore della carne, dal 2007, tutte le quote di contingente doganale vengono vendute all’asta, ad eccezione del 10 per cento dei contingenti di carne di pecora e di manzo. I contingenti doganali parziali di animai della specie equina sono stati raggruppati in un unico contingente le cui quote sono assegnate in base all’ordine di entrata delle dichiarazioni doganali alla frontiera. L’attuale stato d’utilizzo dei contingenti doganaliassegnati in base a tale criterio può essere consultato sul sito Internet dell’Amministrazione federale delle dogane (www.ezv.admin.ch > Informazioni doganali per le ditte > Contingenti doganali).
Per il contingente doganale di verdure congelate il periodo di riferimento determinante per il calcolo delle quote di contingente è stato adeguato cosicché queste ultime possano essere assegnate definitivamente già prima dell’inizio dell’anno civile (periodo di contingentamento). In collaborazione con le associazioni di categoria interessate, è stata abolita la gestione di singole varietà di verdura fresca oppure si è optato per l’amministrazione combinata di più prodotti. Da inizio 2008 verrà soppressa l’assegnazione di quantitativi minimi per evitare che vengano creati abusivamente diritti d’importazione.
Per limitare le differenze di prezzo con l’estero, si è proceduto ad un adeguamento dei dazi e dei supplementi; ad esempio nel 2006, a tal fine, sono stati abbassati i prezzi soglia per i foraggi proteici importati. Per migliorare la competitività della produzione animale indigena e per garantire la differenza di prezzo tra cereali panificabili e foraggieri, nel 2007 i prezzi soglia e le aliquote di dazio per i cereali panificabili sono stati ridotti di 3 franchi al quintale.
Per la maggior parte dei prodotti agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo più poveri le aliquote di dazio, comprese quelle fuori contingente doganale, sono state azzerate. Per dettagli sulle modifiche dell’ordinanza sulle preferenze tariffali si rinvia al capitolo 3.1 alla parte «Sviluppi internazionali».
I dettagli sui provvedimenti tariffali, segnatamente sulla pubblicazione dell’attribuzione e dell’utilizzo dei contingenti doganali nel 2006, sono illustrati nel rispettivo rapporto del 14 febbraio 2007 a cura del Consiglio federale. La documentazione può essere consultata sul sito Internet dell’UFAG sotto «Temi > Importazione ed esportazione».
118 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2
Accanto alla legislazione agricola anche il nuovo diritto doganale, entrato in vigore il 1° maggio 2007, costituisce una condizione quadro importante per l’avvenire del commercio transfrontaliero di prodotti agricoli. Si riportano di seguito le disposizioni che rivestono un particolare significato per l’agricoltura.
Traffico di perfezionamento attivo (art. 12 LD)
La procedura doganale applicata al traffico di perfezionamento attivo (TPA) consente di importare in Svizzera, ed in seguito riesportare, merci o materie prime estere per la lavorazione o la trasformazione sotto concessione di una riduzione dei tributi doganali o di una franchigia doganale. La competenza decisionale spetta all’Amministrazione federale delle dogane, la quale può negare la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale soltanto se ciò va contro interessi pubblici preponderanti (sicurezza delle derrate alimentari, metodi di produzione vietati in Svizzera o protezione dagli inganni). Com’è stato il caso finora, per i prodotti agricoli e le materie prime agricole, il TPA è autorizzato soltanto quando i prodotti indigeni equivalenti non sono disponibili in quantità sufficienti o se per tali prodotti lo svantaggio a livello di prezzo della materia prima non può venir compensato.
Contrariamente alla prassi finora applicata, per il TPA di prodotti agricoli, di norma, viene autorizzato il regime di equivalenza e soltanto in casi eccezionali viene prescritto il regime d’identità (identità della merce). Nel regime di equivalenza le merci da riesportare non devono essere necessariamente quelle importate per la lavorazione o la trasformazione, bensì si può trattare di altre merci che però devono avere la stessa quantità e la medesima qualità e natura. Quindi le merci importate possono essere sostituite da merci indigene. Nel regime d’identità, invece, ciò non è consentito.
Si deroga al principio dell’equivalenza quando l’azienda di trasformazione non può garantire in modo credibile il quantitativo, le caratteristiche e la qualità delle merci riesportate o quando il traffico di perfezionamento, nel caso di merci le cui aliquote di dazio variano stagionalmente, potrebbe comportare problemi sul mercato. In questi casi viene applicato il regime d’identità.
Traffico di perfezionamento passivo (art. 13 LD)
La procedura del traffico di perfezionamento passivo (TPP) è disciplinata separatamente nella nuova legge sulle dogane e consente di trasferire materie prime indigene per la lavorazione o la trasformazione in territorio estero sotto concessione di una riduzione dei tributi doganali o di una franchigia doganale in caso di reimportazione. Dal punto di vista economico il TPP rispecchia il TPA.
Per i prodotti agricoli e le materie prime agricole temporaneamente esportate in vista di una trasformazione, l’Amministrazione delle dogane autorizza il TPP, durante un periodo di transizione fino al 2011, soltanto se in tal modo non si pregiudicano importanti interessi economici all’interno del Paese.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 119 2
Prodotti agricoli (art. 15 LD)

L’articolo in questione disciplina la procedura per la gestione delle scorte di frutta e verdura fresche durante la fase di passaggio da un periodo libero a uno amministrato. L’obiettivo è quello di evitare che durante la fase libera si importi un quantitativo di merci eccessivo all’aliquota di dazio del contingente che, dopo l’inizio del periodo amministrato, viene immesso sul mercato. Per le scorte ancora disponibili occorre presentare una nuova dichiarazione doganale. Non deve obbligatoriamente essere versata l’aliquota di dazio fuori contingente in quanto il dichiarante ha la possibilità, a determinate condizioni, di far computare le merci su quote di contingente doganale assegnategli. Inoltre, vengono tollerate le scorte che coprono il fabbisogno di due giorni, tenendo conto delle correnti condizioni di mercato.
Traffico nella zona di confine (art. 43 LD)
Il traffico nella zona di confine è finalizzato a regolamentare soprattutto la gestione agricola delle superfici nella zona di confine. Per zona di confine, rispetto a Germania, Francia e Italia, finora s’intendeva la zona radiale. Essa comprendeva l’area nazionale ed estera all’interno di un raggio di 10 chilometri a partire dall’ufficio doganale più vicino. Con l’Austria si è concordato di definire la zona di confine come una zona parallela equivalente a una fascia di territorio di 10 chilometri di profondità lungo il confine doganale con tale Stato.
In virtù della nuova legge sulle dogane, la zona di confine rispetto a tutti i Paesi confinanti corrisponde alla zona parallela. Ciò significa che le fasce di territorio di 10 chilometri di profondità lungo tutto il confine nazionale soggiacciono al disciplinamento del traffico nella zona di confine.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 120
■ Prospettiva
Nel pacchetto di riforma PA 2011, per i provvedimenti di protezione alla frontiera è previsto un ulteriore processo di liberalizzazione e semplificazione. Dal 2009 i contingenti doganali parziali di burro e latte intero in polvere saranno attribuiti mediante vendita all’asta e non più in base alla prestazione fornita all’interno del Paese. Le ordinanze contenenti soltanto disposizioni d’esecuzione saranno abrogate e integrate, se del caso, nell’ordinanza sulle importazioni agricole. Inoltre, vi è da presumere che le condizioni quadro del commercio estero muteranno portando ad un’ulteriore apertura del mercato.
■ Amministrazione dei contingenti doganali attraverso una nuova applicazione informatica
La realizzazione della nuova applicazione informatica KIC (contingenti, import, controlling) risale al maggio 2007. Essa viene utilizzata per la ripartizione dei contingenti doganali in base a diversi metodi d’assegnazione, per la fatturazione delle tasse e dei prezzi d’offerta nonché per il monitoraggio delle importazioni, in particolare per quanto concerne le clausole di salvaguardia speciali. KIC è il nucleo di diverse applicazioni informatiche nell’ambito dell’amministrazione dei contingenti doganali. L’applicazione integra, da un lato, i dati degli utenti dell’UFAG, dall’altro i dati sulle importazioni dell’Amministrazione federale delle dogane. Quest’ultima, dal canto suo, registra elettronicamente gli sdoganamenti attraverso l’applicazione e-dec, verifica i dati relativi al permesso generale d’importazione (PGI) con l’applicazione e-quota e vigila sul rispetto delle quote individuali di contingenti doganali. KIC riceve altri dati via Internet. Grazie all’applicazione Vendita all’asta elettronica i titolari di PGI possono inviare elettronicamente le proprie offerte per una vendita all’asta. Mediante AEV14online, invece, possono registrare direttamente attraverso un accesso sicuro ad Internet gli accordi di utilizzazione di quote di contingente doganale conclusi con altri aventi diritto a quote di contingente doganale. I dati registrati elettronicamente vengono trasmessi a KIC e possono essere ulteriormente elaborati. I dati relativi alle quote individuali di contingente doganale e gli aggiornamenti vengono trasmessi da KIC all’Amministrazione federale delle dogane, o più precisamente all’applicazione e-quota per poter monitorare l’utilizzo dei contingenti doganali e le quote individuali.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 121 2
Interazione delle applicazioni informatiche nell’amministrazione dei contingenti doganali
Clienti, titolari di PGI
ricevono informazioni via fax, e-mail e Internet o inviano informazioni a Internet (p.es. moduli on-line)
UFIT
Fax-GatewayE-Mail-GatewayInternet
notificano importazioni (sdoganamento elettronico)
ricevono riscontro se il n. PGI è valido e se dispongono di una QCD sufficiente
AFD/DGD
e-dece-quota
pagamento prezzo d’offerta, tasse
forniscono indicazioni sull’indirizzo e comunicano eventuali cambiamenti
Applicazioni interne all’UFAG: contabilità finanze gestione rubrica indirizzi gestione degli affari e archiviazione
Stampante
ricevono informazioni e decisioni in merito a QCD via posta
Legenda: Clienti, titolari di PGI: titolari di un permesso generale d’importazione, dichiaranti
AFD / DGD: Direzione generale dell’Amministrazione federale delle dogane
registrano accordi di utilizzazione di QCD via accesso sicuro ad Internet
AEV14online
presentano offerte via collegamento sicuro ad Internet
Vendita all’asta elettronica
UFIT: Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione e-dec ed e-quota: sistema elettronico di imposizione doganale e applicazione EED per l’amministrazione dei contingenti doganali dell’AFD AEV14online: applicazione Internet per la registrazione di accordi di utilizzazione di quote di contingente doganale giusta l’art. 14 OIAgr Vendita all’asta elettronica: applicazione Internet per la registrazione di offerte per vendite all’asta di contingenti doganali QCD: quote di contingente doganale
Fonte: UFAG
KIC UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 122
Anche nell’anno oggetto del rapporto continuano i successi legati all’entrata in vigore, il 1° febbraio 2005, della versione rivista del Protocollo n. 2 concernente l’accordo di libero scambio tra Svizzera e CE del 1972.
Il volume delle esportazioni svizzere verso l’UE ha segnato un rialzo del 30 per cento mentre la cifra d’affari è cresciuta del 29 per cento. L’incremento più massiccio è quello registrato dalle esportazioni di bevande analcoliche come quelle a base di latte che sono triplicate raggiungendo le 240'000 tonnellate. Va tuttavia sottolineato che queste esportazioni nel 2005 sono rientrate soltanto parzialmente nell’ambito di applicazione del Protocollo n. 2. Altrettanto marcato è stato l’aumento segnato dalle esportazioni di birra (oltre 200%), cioccolato e altre preparazioni alimentari (+10%).
Tra i prodotti le cui importazioni hanno segnato una vera e propria impennata si segnalano: yogurt aromatizzato (raddoppiate a 3'700 t), alcool etilico (+80% a 44'300 t), bevande analcoliche comprese quelle a base di latte (+ 20% a 77'600 t), cioccolato e altri prodotti contenenti cacao (+10%).
Grazie alla cessione di 10 milioni di franchi dal preventivo agricolo, l’importo dei mezzi a disposizione, pari a 90 milioni di franchi, per la compensazione delle differenze di prezzo delle materie prime non è variato rispetto al 2005. Inoltre ci si è avvalsi dei contributi su base volontaria dei produttori lattieri, un provvedimento lanciato l’anno precedente. Essi, infatti, non erano stati esauriti e di conseguenza quel che rimaneva è stato impiegato nell’anno oggetto del rapporto. Un effetto positivo sulle esportazioni è stato esercitato anche dalla riduzione della differenza tra i prezzi praticati in Svizzera e quelli dell’UE per le materie prime più importanti (latticini e prodotti cerealicoli). La compensazione dei prezzi della farina panificabile e del latte scremato in polvere ha potuto essere ridotta di oltre il 10 per cento.
■ Importazioni
Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli trasformati 1000 t EsportazioniImportazioni Fonti: AFD, UFAG 2004 0 1000 1200 800 600 400 200 2005 2006 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2 123
ed esportazioni di prodotti trasformati
Gli effetti del nuovo disciplinamento del mercato zuccheriero dell’UE costituiscono una sfida notevole (v. capitolo 2.1.4). La soluzione del doppio zero per lo zucchero muove da un allineamento dei prezzi dello zucchero nell’UE e in Svizzera. La riduzione delle superfici destinate alla produzione di zucchero e il calo di resa nell’UE hanno determinato non soltanto un massiccio rincaro delle esportazioni dell’UE verso la Svizzera, bensì anche la loro diminuzione. Per poter raggiungere anche in futuro l’obiettivo di un allineamento dei prezzi di mercato dello zucchero in Svizzera e nell’UE, in collaborazione con gli zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld, la Federazione svizzera delle industrie alimentari FIAL, il mulino per zucchero di Rupperswil e gli importatori, è stato messo a punto un sistema per il calcolo del dazio sullo zucchero. Esso risulta particolarmente difficoltoso perché il calo dei quantitativi di zucchero provenienti dall’UE viene compensato sempre più con importazioni da Paesi in via di sviluppo e di recente industrializzazione. Paesi quali Brasile e Tailandia offrono una qualità accettabile e all’importazione in Svizzera beneficiano di un dazio preferenziale pari a 22 franchi al quintale di zucchero. I costi per la raffinazione dello zucchero sono più bassi rispetto al dazio preferenziale concesso. Il sistema di calcolo dei dazi deve pertanto essere ulteriormente perfezionato per poter rispettare gli impegni assunti con il Protocollo n. 2.
fr.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 180 115 1991/922004 115 2003 90 2006 90 2005 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 124
Evoluzione dei contributi all'esportazione per prodotti trasformati mio.
Fonti: AFD, UFAG
Misure 2006/07
2.1.2Economia lattiera
Nel 2006 il mercato lattiero si è evoluto in maniera soddisfacente. Nell’anno oggetto del rapporto le forniture di latte sono lievemente aumentate. È cresciuta la produzione di formaggio, di specialità a base di latte (quali dessert) e di panna. Al contrario sono lievemente diminuiti i volumi di produzione di burro, yogurt e latte in polvere. Rispetto all’anno precedente si è registrata una flessione delle esportazioni di formaggio, cui si è contrapposta una lieve crescita delle esportazioni di panna.
ProdottoFormaggioBurroLatte Latte Latte di consumo, scrematoin polverepanna, prodotti
1Solo per determinati scopi d'utilizzazione
2Solo in caso di rinuncia all'importazione
3Solo per esportazioni in Paesi al di fuori dell'UE e differenziato per tipo di formaggio
4Escluso il latte di consumo
Rispetto al 2005 il prezzo medio alla produzione del latte è diminuito di 0,6 centesimi al chilogrammo fissandosi a circa 71,8 centesimi al chilogrammo. Il prezzo del latte biologico è diminuito di 1,6 centesimi toccando gli 80,2 centesimi al chilogrammo. Il calo in questo segmento è stato quindi più sensibile rispetto a quello registrato per il latte convenzionale.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
base
Misura Protezione alla frontiera ■■■■■ Supplementi ■ Aiuti all'interno del Paese ■ 1 ■ 1 ■ 2 Aiuti all'esportazione ■ 3 ■■ 4
a
di latte fresco
Fonte: UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 125 2
Le misure di sostegno sotto forma di supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati continuano ad essere destinate in primo luogo al settore caseario. Nel 2006 le uscite della Confederazione a favore dell'economia lattiera sono lievemente diminuite. Secondo il preventivo, l'importo disponibile era di 31,5 milioni di franchi inferiore a quello dell'anno precedente (–6,6%).

Totale 442,7 mio. fr.
Aiuti all'esportazione 7%
Aiuti all'interno del Paese 14%
Amministrazione 1%
Supplementi 78%
Per il sostegno del prezzo nel settore lattiero sono stati stanziati complessivamente 442,7 milioni di franchi, di cui 352,3 milioni a favore del formaggio (79,6%). Il settore del burro ha assorbito 24,9 milioni di franchi (5,6%), quello del latte in polvere e di altri latticini 60,0 milioni di franchi (13,6%). I costi amministrativi sono stati pari a 5,6 milioni di franchi. Essi corrispondono all'1,2 per cento del preventivo per l'economia lattiera.
■ Mezzi finanziari 2006
Tabella 28, pagina A28 Ripartizione dei mezzi – 2006
Fonte: UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 126
2
Contingentamento lattiero
Nell'anno lattiero 2005/06 i produttori che commercializzavano latte erano 30'163. Rispetto all'anno 2000/01 il numero di produttori è diminuito di 7'919 unità, ossia del 20,8 per cento. Nell’anno lattiero 2005/06 il contingente medio è aumentato del 5,0 per cento a 100'761 chilogrammi. Il contingente medio nella regione di pianura si è attestato su 121'510 chilogrammi (+6'296 kg), quello nella regione di montagna si è fissato su 74'486 chilogrammi (+4,6%). Dall’anno lattiero 1999/2000 il contingente medio nella regione di pianura è cresciuto di quasi 33'175 chilogrammi (37,6%), quello nella regione di montagna di 16'080 chilogrammi (27,5%).
Dati statistici E
■ PRODUZIONE
Alla vigilia dell'abbandono anticipato del contingentamento lattiero i trasferimenti non definitivi (locazione) hanno sensibilmente perso terreno rispetto ai trasferimenti definitivi (acquisto). Nell’anno lattiero 2005/06, 7'447 produttori (+18%) hanno acquistato un contingente mentre 4'629 produttori (–47,6%) lo hanno preso in locazione. Il quantitativo trasferito giusta l'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il contingentamento della produzione lattiera (OCL; RS 916.350.1) ha raggiunto 271 milioni di chilogrammi che equivalgono all’8,9 per cento del contingente di base. Rispetto all'anno precedente il volume dei contingenti affittati è diminuito di 66,4 milioni di chilogrammi (–46%), quello dei contingenti acquistati è aumentato di 29,6 milioni di chilogrammi, raggiungendo quota 192,1 milioni di chilogrammi (+18%).
Nell'anno lattiero 2005/06 il quantitativo di contingenti locati è ammontato a circa 353 milioni di chilogrammi. Dall'introduzione del commercio di contingenti, nell'anno lattiero 1999, circa 783 milioni di chilogrammi sono stati acquisiti definitivamente. Nell'anno lattiero 2005/06 un quantitativo di 1,136 milioni di tonnellate, ossia il 37 per cento del contingente di base, risultava utilizzato da altri produttori a seguito di trasferimenti di contingente non vincolati alla superficie.
SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
127
I servizi di amministrazione del contingentamento lattiero hanno dovuto allestire un conteggio finale per i produttori che sono usciti dal contingentamento lattiero il 1° maggio 2006 onde calcolare la tassa sull’intero quantitativo eccedente il contingente. La tassa sulle sovraforniture ammontava a 10 centesimi il chilogrammo per le eccedenze di latte commercializzato fino a 5'000 chilogrammi e a 60 centesimi il chilogrammo per le altre sovraforniture. La tassa per le aziende d’estivazione è pari a 10 centesimi il chilogrammo. L’importo totale delle tasse versate dai 12'995 produttori usciti anticipatamente dal contingentamento al 1° maggio 2006 è stato di 6,1 milioni di franchi. Le eccedenze sono risultate pari a 58,1 milioni di chilogrammi circa. Per l’anno lattiero in oggetto i produttori ancora assoggettati al contingentamento hanno dovuto versare tasse per un totale di 4,3 milioni di franchi. Le sovraforniture hanno raggiunto i 19,7 milioni di chilogrammi. Le eccedenze delle sole aziende d’estivazione sono risultate pari a 15 milioni di chilogrammi di latte ovvero a oltre tre quarti della sovrafornitura totale. 2.1
■ Abbandono anticipato del contingentamento lattiero
Con il consenso dell’UFAG, le organizzazioni, i cui produttori hanno abbandonato anticipatamente il contingentamento lattiero il 1° maggio 2006, possono commercializzare un quantitativo supplementare di latte in virtù degli articoli 12 e 20 dell’ordinanza sull’abbandono anticipato del contingentamento lattiero (OACL; RS 916.350.4). L’UFAG non dà il suo consenso se il quantitativo supplementare richiesto serve unicamente a soppiantare la concorrenza svizzera sul mercato nazionale. Pertanto vengono autorizzati in primo luogo i progetti relativi alle esportazioni. I progetti all’interno del Paese sono considerati a condizione che i prodotti fabbricati con il quantitativo supplementare siano innovativi e richiedano determinati standard qualitativi per il latte. In ogni caso deve essere comprovato il bisogno del quantitativo supplementare da commercializzare.
Delle 27 organizzazioni uscite dal contingentamento lattiero, 24 sono ricorse a questa possibilità nel primo anno dopo l’abbandono.
Domande di quantitativo supplementare – 2006/07
NumeroQuantitativo (mio. kg.)
Domande inoltrate103130,8
Da organizzazioni di produttori (OP)757,5
Da organizzazioni di produttori-valorizzatore (OPV)1773,3
Domande accolte9577,6
Progetti d’esportazione8172,9
Progetti all’interno del Paese143,3
Domande respinte5(30,4)
Domande in sospeso36,2
Fonte: UFAG
Affinché l’UFAG possa osservare e controllare l’iter dei vari progetti relativi ai quantitativi supplementari, le organizzazioni e i valorizzatori gli presentano un rapporto trimestrale contenente i dati relativi all’esportazione e alla vendita dei rispettivi prodotti. In tal modo viene garantito che il mercato indigeno non sia sovraccaricato dal latte proveniente da progetti relativi ai quantitativi supplementari o che non vengano accolte domande per proseguire progetti dai risultati carenti. Inoltre, trascorso il terzo trimestre, l’UFAG, in collaborazione con le organizzazioni e i valorizzatori responsabili, esegue anche una verifica a campione più accurata sullo stato dei singoli progetti.
All’UFAG sono pervenute domande di abbandono anticipato del contingentamento lattiero al 1° maggio 2007 da parte di 7 organizzazioni. Si tratta soltanto di organizzazioni di produttori-valorizzatore (OPV). Eccezion fatta per l’OPV Laiteries Réunies Genève, sono tutte organizzazioni piccole che non raggiungono il quantitativo minimo richiesto di 20 milioni di chilogrammi. Siccome i valorizzatori interessati rivestono, tuttavia, una certa valenza regionale in termini di valore aggiunto legato alla produzione lattiera e all’offerta di posti di lavoro, le domande hanno potuto essere accolte in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 OACL.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 128
■ Progetto Admin Milch 2006
Nell’anno lattiero precedente 134 produttori hanno cambiato organizzazione, principalmente per affiliarsi ad una nuova OPV. Alle organizzazioni già esistenti si sono uniti altri produttori. Il numero dei produttori fuori contingente, quindi, è passato da 21'929 a 23'849 e la rispettiva quota dal 63 al 72 per cento. Il quantitativo di latte fornito dalle 34 organizzazioni fuori contingente rispetto al potenziale di produzione nazionale di 3,11 milioni di tonnellate (escl. contingenti supplementari e quantitativi supplementari) è aumentato a 2,58 milioni di tonnellate passando dal 75 all’83 per cento.
Organizzazioni fuori contingentamento al 1° maggio 2007
ProduttoriQuantitativo di base (provv.) (stato 22.03.2007)
Nel complesso, la possibilità di abbandonare anticipatamente il contingentamento lattiero costituisce una valida preparazione alla fase successiva all’abolizione del contingentamento lattiero prevista per il 30 aprile 2009. Nel primo anno di transizione per alcune organizzazioni fuori contingentamento si è imposta una ristrutturazione in vista delle sfide future. Inoltre, la concessione di quantitativi supplementari ha scatenato tra i partner di mercato un notevole dinamismo spesso basato su progetti innovativi.
Il progetto Admin Milch 2006 è finalizzato alla creazione di una piattaforma di valutazione di tutti i dati sul latte trasparente e uniforme. In tal modo l’UFAG intende soddisfare al meglio le proprie esigenze attuali e future legate alla valutazione dei dati sul latte. La piattaforma di valutazione non deve restare uno strumento fine a se stesso, bensì deve essere messa a servizio dell’intero settore tenendo in considerazione anche le esigenze degli altri interessati. Sarà possibile impostare la piattaforma coinvolgendo anche parti esterne all’Amministrazione, seguendo il modello del partenariato pubblico privato. La piattaforma di valutazione deve poter essere sviluppata e perfezionata in una rete globale dei dati agricoli.
A tal fine è stata data una notevole importanza alla definizione delle esigenze in seno all’Ufficio federale e al settore. Sulla scorta di sondaggi è stato allestito un inventario dei dati e delle statistiche sul latte impiegati nell’Amministrazione federale e nelle stazioni di ricerca agronomica (Agroscope). Parallelamente è stata rilevata l’esigenza futura di dati sul latte e le condizioni poste ad una piattaforma di valutazione uniforme.
OPVNumeromio. kg OPV Laiteries Réunies Genève14320 741 237 OPV Pro Milch Ost8910 578 502 OPV Aletsch-Goms271 464 975 OPV Käsereimilch677 046 808 OPV Freiamt476 009 887 OPV Napfbergland745 421 211 OPV Altendorf161 095 545
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 129 2
Dal sondaggio è emerso che attualmente presso l’UFAG i dati sul latte vengono impiegati per diversi scopi. In particolare servono da base per
–decisioni strategiche nella politica agricola e di commercio estero; –compiti esecutivi e sostegno all’esecuzione nell’ambito di orientamento e sostegno della produzione, pagamenti diretti, miglioramenti strutturali, promozione dello smercio, commercio estero e controlli in virtù del diritto sulle derrate alimentari; –confronti tra Paesi in campo scientifico nonché per ricerca e consulenza.
I dati sul latte attualmente disponibili dovranno continuare ad esserlo anche in futuro. Tuttavia le esigenze tendono a cambiare data la liberalizzazione del mercato lattiero. Con la progressiva abolizione delle misure di orientamento e sostegno della produzione prevista per i prossimi tre –sei anni, i dati sul latte non saranno praticamente più impiegati in questo campo. Tuttavia, i dati su produzione e valorizzazione continueranno ad essere impiegati nella stessa misura in altri ambiti. I dati su contenuti, qualità e mercato così come quelli sul confronto internazionale acquisiranno maggior importanza. Considerando soprattutto la liberalizzazione del mercato lattiero, la crescente valenza del commercio estero e lo sviluppo di misure di promozione della qualità e dello smercio sarà auspicata e richiesta una migliore trasparenza del mercato.
Sostegno del mercato mediante supplementi ed aiuti
Nel 2006 gli strumenti per il sostegno del mercato, in linea di massima, non sono stati oggetto di modifiche di rilievo. Al contrario, in seguito alla già citata riduzione del sostegno pari a 31,5 milioni di franchi, i supplementi e gli aiuti hanno dovuto essere adeguati con effetto al 1° gennaio 2007.
Dal 1° gennaio 2007 il supplemento per il latte trasformato in formaggio ammonta a 15 centesimi il chilogrammo di latte trasformato in formaggio (–3 ct./kg) e quello per il foraggiamento senza insilati a 3 centesimi (–1 ct./kg). Gli aiuti all’esportazione di formaggio in Paesi diversi da quelli dell’UE hanno subito una riduzione tra i 20 e i 60 centesimi il chilogrammo. In virtù dell’articolo 12 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, gli aiuti all’esportazione a favore dei latticini ammontano a 16 centesimi per equivalente-composizione. Tale aliquota è stata ridotta di 11 centesimi. Con effetto al 1° gennaio 2007 l’aliquota per il burro in confezioni da 1 chilo, in panetti, è stata ridotta di 1.20 franchi al chilogrammo a 40 centesimi e quella per il burro in confezioni da 1 chilo, in lastre, di 1.29 franchi al chilogrammo a 51 centesimi. Anche l’aliquota per il burro in confezioni superiori a 1 chilo è stata ridotta di 1.29 franchi al chilogrammo a 80 centesimi. Stessa evoluzione per le aliquote per il burro disidratato, il grasso del latte nel gelato commestibile e il latte scremato, nonché per il latte intero in polvere e il latte condensato.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 130
2.1.3 Produzione animale

A fine 2006, l’Unità ESB ha tracciato un bilancio molto positivo dei suoi sei anni di attività. Da diversi anni si osserva una netta diminuzione dei casi di ESB. Con l’unità ESB è stato possibile non soltanto uniformare la prassi relativa alle misure contro l’ESB, bensì anche dimostrare con chiarezza quanto sia utile un servizio federale per Cantoni ed imprese. Da inizio 2007 è operativa un’altra unità nazionale, l’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) che garantisce il sostegno ai Cantoni e la sicurezza delle derrate alimentari in base al motto «dalla forca alla forchetta». l’UFAL si occupa della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari.
Le misure varate dal Consiglio federale il 20 febbraio e il 29 settembre 2006 per far fronte all’emergenza dell’influenza aviaria hanno permesso di rafforzare la fiducia nei prodotti avicoli. La misura principale prevedeva il divieto di uscita all’aperto dei volatili (polli, tacchini, faraone, pernici, fagiani, quaglie, anatre, oche, struzzi e altri ratiti). Dal 15 ottobre 2006 al 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha limitato tale divieto alle aree dove il rischio di insorgenza del virus è maggiore, ovvero attorno ai laghi o lungo i grandi corsi d’acqua dell’Altipiano svizzero.
L’influenza aviaria ha provocato un calo del 7,6 per cento del consumo pro capite di carne di pollame nonché una diminuzione del 10,8 per cento dell’effettivo di pollame da ingrasso. Per compensare le perdite subite dai produttori, il Consiglio federale ha deciso di mantenere per il 2006 lo stesso livello dei pagamenti diretti (SSRA/URA) dell’anno precedente.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 131 2
Dazi e contingenti doganali rappresentano i principali strumenti di protezione della produzione di carne indigena. Vengono pure concessi aiuti per il sostegno del mercato della carne e delle uova nonché per la promozione dell’esportazione di animali da allevamento e da reddito. Visti il notevole livello della domanda sul mercato della carne e il calo dell'offerta indigena, nel 2006 non sono state necessarie azioni di immagazzinamento di carne bovina. Si è inoltre potuto rinunciare allo sgombero del mercato nei macelli per gli animali delle specie bovina, suina ed equina.
Dal 1° gennaio 2007 l’UFAG stanzia contributi d’infrastruttura per gli apparecchi e le attrezzature dei mercati pubblici nelle regioni di montagna. Questi contributi (a fondo perso) sono validi soltanto per provvedimenti collettivi e sono limitati ad un massimo di 50'000 franchi a progetto. Ne hanno diritto soltanto le persone giuridiche, le comunità di persone, i Cantoni ed i Comuni, escludendo i privati.
Provvedimenti – 2006 Animale/ProdottoBoviniVitelliSuiniEquiniOviniCapriniPollameUova Provvedimento Protezione alla frontiera ■■■■■■■■ Sgombero del mercato sui mercati pubblici ■■■ Sgombero del mercato nei macelli ■■■■■ Azioni d’immagazzinamento ■■■ Azioni di vendita a prezzo ridotto ■■■ Contributi agli investimenti per la costruzione di stalle ■ Azioni di spezzatura e di commercializzazione ■ Contributi per la valorizzazione della lana di pecora ■ Aiuti all’esportazione di animali da allevamento e da reddito ■■■■ Effettivi massimi ■■■■ Banca dati sul traffico di animali ■■■■■
Fonte: UFAG
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 132
■ Mezzi finanziari 2006
Dei 24,4 milioni di franchi di mezzi finanziari della Confederazione iscritti nel preventivo per misure nel settore della produzione animale ne sono stati utilizzati soltanto 18,8. Queste minori uscite sono riconducibili alla buona situazione sul mercato della carne di manzo, della carne di vitello e delle uova. Da un lato si è resa necessaria soltanto quasi la metà degli interventi sul mercato e dall'altro non sono stati utilizzati appieno gli aiuti all'esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito. Nel quadro del controllo del traffico di animali, sono stati spesi 8,8 milioni di franchi per l’accordo di prestazione per la gestione della banca dati sul traffico di animali (BDTA). È stato nuovamente possibile adempiere le disposizioni della legge sulle epizoozie secondo cui i costi d’esercizio della BDTA vanno coperti mediante le tasse imposte ai detentori di animali. Grazie al miglioramento della qualità dei dati della BDTA e al costante adeguamento dell’infrastruttura e del software oggi è possibile creare sinergie efficaci tra la BDTA e i suoi partner pubblici e privati.
Ripartizione dei mezzi – 2006
Totale 18,8 mio. fr.
Contributi per la valorizzazione della lana di pecora 4%
Accordi di prestazione Proviande 36%
Contributi per azioni di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto per la carne bovina e di vitello 16%
■ Bestiame da macello e carne: accordi di prestazione
Contributi a sostegno della produzione indigena di uova 17%
Contributi per l'esportazione di bestiame da allevamento e da reddito 27%
Fonte: Conto dello Stato
In virtù dell'articolo 51 LAgr, dal 1° gennaio 2000 l'UFAG ha delegato a Proviande diversi compiti in relazione al mercato del bestiame da macello e della carne. I mandati e l’indennità finanziaria corrisposta a Proviande sono disciplinati in due accordi di prestazione che scadono a fine 2007, anno in cui i compiti saranno oggetto di un nuovo concorso pubblico.
1.Classificazione neutrale della qualità
Nei macelli di grandi dimensioni la qualità degli animali macellati deve essere classificata da un servizio neutrale; attualmente ciò compete a Proviande. Alla fine dell’anno oggetto del rapporto, il servizio di Proviande aveva provveduto alla classificazione della qualità presso 34 aziende. Sono stati classificati l’86 per cento degli animali macellati della specie suina, l'86 per cento di tutti gli animali della specie bovina e il 63 per cento di tutti gli animali della specie ovina. Nell’ambito di CH-TAX sono aumentate le contestazioni sulla classificazione della qualità rispetto all’anno precedente. Per 5'847 carcasse contestate delle specie bovina, ovina ed equina è stata effettuata una nuova perizia da parte degli esperti, la quale nel 41 per cento dei casi (2'403 carcasse) ha portato ad una classificazione diversa dalla precedente. Nonostante l’aumento delle contestazioni, è diminuita la quota relativa degli esiti rettificati della classificazione della qualità. Ciò va a riprova del maggior livello di competenza degli esperti.
Tabella 29, pagina A28 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 133 2
– 2006
La determinazione della muscolatura e del tessuto grasso di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina avviene otticamente. Esistono cinque classi di muscolatura: C = molto bene in carne, H = bene in carne, T = muscolatura media, A = scarnato, X = molto scarnato. Anche per la valutazione del tessuto grasso ci si avvale di cinque classi. Dalla classificazione, il 22 per cento delle vacche è risultato scarnato e il 21 per cento molto scarnato. Rispetto al 2005 la percentuale degli animali scarnati è diminuita di un punto mentre sempre di un punto è aumentata quella degli animali molto scarnati. Le due tendenze opposte potrebbero essere dovute alla polarizzazione del mercato del bestiame da macello che vede contrapporsi razze da carne da un lato e razze da latte dall’altro. Si è riconfermata la tendenza al rialzo per quanto riguarda la muscolatura dei torelli osservata gli scorsi anni. Quasi tutti gli animali controllati sono risultati da mediamente a molto bene in carne. La metà degli agnelli controllati presentava una muscolatura media mentre oltre un terzo risultava bene in carne.
2.Sorveglianza dei mercati pubblici nonché organizzazione dei provvedimenti tesi a sgravare il mercato
Le organizzazioni contadine e/o i servizi cantonali hanno organizzato nell’arco dell’anno mercati pubblici di animali delle specie bovina e ovina. Rispetto al 2005, il numero dei mercati di bestiame grosso e di vitelli è diminuito, tuttavia sono aumentati gli animali presentati sui mercati e venduti all’asta (vitelli 29,3% e bestiame grosso
3,3%). La nuova ripartizione dei contingenti doganali (il 10% delle quote del contingente doganale di carne di animali della specie bovina e suina è assegnato in base ad una prestazione all’interno del Paese) spiega il motivo del rinnovato interesse per l’acquisto di animali sui mercati pubblici. 2'336 capi presentati sui mercati (3,1% del totale degli animali) non sono stati acquistati su base volontaria, Questi animali sono stati assegnati da Proviande ai macelli e alle ditte commerciali che sottostanno all’obbligo di ritiro. Per loro Proviande applica i prezzi solitamente praticati sul mercato. Nel quadro dello sgombero del mercato, ai macelli sono stati assegnati 6'114 capretti, ovvero 1'538 in meno rispetto all’anno scorso.
In %
Distribuzione delle carcasse in funzione delle classi
Fonte: Proviande
C = molto bene in carne H = bene in carne T = muscolatura media A = scarnato X = molto scarnato
VaccheTorelliVitelli Classe di muscolatura Agnelli Capretti 0 70 50 60 40 30 20 10 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 134
C H T A X
■ Registrazione e controllo delle domande di quote di contingente doganale
Cifre inerenti ai mercati pubblici sorvegliati – 2006
CaratteristicaUnitàVitelliBestiameAnimali della grossospecie ovina
Mercati pubblici sorvegliatiNumero393834329
Animali presentati, venduti all’astaCapi31 72262 70374 210
Quota degli animali presentati
rispetto alle macellazioni%121728
Animali assegnati
(sgombero del mercato)Capi02862 336
Fonte: Proviande
Proviande designa, per ogni anno civile, i mercati pubblici per animali delle specie bovina e ovina. La designazione avviene d’intesa con i Cantoni e le organizzazioni contadine e necessita del consenso dell’UFAG. Prima dell’inizio dell’anno civile Proviande allestisce un programma annuale in cui figurano i mercati pubblici designati. Tale programma indica in particolare le piazze e i giorni dei singoli mercati nonché le categorie di animali che possono esservi presentate. Dal 1° gennaio 2007 quali mercati pubblici possono essere designati soltanto i mercati sui quali tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno civile precedente sono stati presentati e venduti all’asta almeno 50 animali. Un mercato pubblico può comprendere anche due mercati che, sommati, raggiungono il quantitativo minimo di 50 animali, se hanno luogo nella stessa regione e durante la stessa mezza giornata e se sono sorvegliati dagli stessi impiegati dell’organizzazione incaricata. Queste disposizioni sono applicabili ai nuovi mercati soltanto a partire dal terzo anno civile.
Per il congelamento di carne di vitello e la riduzione del prezzo della carne bovina l'UFAG ha versato rispettivamente 2,4 e 0,6 milioni di franchi. In primavera 101 macelli e ditte commerciali hanno congelato 583 tonnellate di carne di vitello che sono state nuovamente immesse sul mercato entro la fine del 2006. Inoltre sono stati ridotti i prezzi di 255 tonnellate di carne di manzo (quarti anteriori) per la trasformazione e di 730 tonnellate di muscoli di manzo per la produzione di carne secca.
Dal 2007 soltanto il 10 per cento delle quote di contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina (esclusi i muscoli di manzo) e di animali della specie ovina viene assegnato in funzione di una prestazione all’interno del Paese. Sulla scorta delle prestazioni all’interno del Paese fornite durante il periodo di riferimento (dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006), nel 2007 l’UFAG ha concesso, mediante decisione, quote di contingente doganale a 114 persone fisiche e giuridiche. A 97 persone sono state assegnate quote per carne di animali della specie bovina (esclusi i muscoli di manzo) e a 22 quote per carne di animali della specie ovina.

2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 135 2
■ Vendita all’asta di carne
Previa valutazione della situazione del mercato e consultazione del consiglio d’amministrazione di Proviande, l’UFAG fissa i quantitativi che possono essere importati per un determinato periodo. La carne bovina e quella suina in mezzene possono essere importate in un lasso di tempo pari a quattro settimane mentre la carne ovina, caprina e equina, nonché la carne di pollame e le frattaglie possono essere importate per un trimestre. Se sono adempiuti determinati presupposti, è possibile ridurre o prolungare i periodi d'importazione. I quantitativi che possono essere importati di insaccati, specialità a base di carne e carne di animali abbattuti secondo prescrizioni rituali sono stabiliti dal Consiglio federale nell’ordinanza sull’importazione di prodotti agricoli. Nel periodo di contingentamento 2006 l’UFAG ha messo all’asta il 100 per cento dei contingenti per l’importazione di insaccati, di specialità a base di carne e di carne di animali abbattuti secondo prescrizioni rituali nonché il 66 per cento di tutti gli altri contingenti per l’importazione di carne.
■ Rapporto del Consiglio federale sulle conseguenze della vendita all’asta di contingenti doganali d’importazione di carne per il 2005
Dal rapporto redatto per dar seguito al Postulato Walter (postulato 05.3883 del Consigliere nazionale Hansjörg Walter UDC, TG) emerge che la prima fase del passaggio dalla prestazione all’interno del Paese al sistema della vendita all’asta dei contingenti doganali d’importazione di carne non ha avuto conseguenze negative sui prezzi alla produzione del bestiame da macello. La formazione dei prezzi ha seguito l’evoluzione di domanda ed offerta. La crescente partecipazione delle aziende alla vendita all’asta dei contingenti ha rafforzato la competitività all’importazione, cosicché, ad esempio, il margine lordo trasformazione-distribuzione realizzato sulla carne di manzo e di maiale è diminuito. Rispetto al 2005 è salito il numero degli offerenti che sono ricorsi alla vendita all’asta elettronica. Quasi il 90 per cento dei partecipanti, infatti, ha presentato le proprie offerte via Internet. Nel 2006 198 imprese hanno partecipato all'asta di carne di animali delle specie bovina, ovina, suina, equina e caprina nonché di carne di pollame e frattaglie. Dato che, di norma, una ditta presenta una sola offerta che raggruppa però quelle di un gran numero di piccole imprese, il numero effettivo di partecipanti è maggiore. L’analisi dei partecipanti mostra quanto segue: 79 attori non erano titolari di quote di contingente sulla base di una prestazione all’interno del Paese; 68 attori erano già titolari di quote assegnate in base alla prestazione all’interno del Paese e 51 ditte hanno approfittato della vendita all’asta aggiudicandosi prodotti per cui non erano titolari di quote di contingente in base al vecchio sistema. Nel 2006 il numero di titolari di quote di contingente doganale di carne di pollame che hanno partecipato alla vendita all’asta è più che triplicato (98) rispetto a quello delle ditte con una prestazione all’interno del Paese (30). Con la vendita all’asta di due terzi dei volumi d’importazione il mercato della carne importata si è fatto più dinamico e competitivo senza conseguenze sul livello dei prezzi.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 136
Risultati delle vendite all’asta – 2006 ProdottoQuantitativi Numero medio dei Prezzo medio messi all’astapartecipanti d’aggiudicazione
Le vendite all’asta di tutte le categorie di carne effettuate per il periodo di contingentamento 2006 hanno fruttato 122,8 milioni di franchi alla Cassa federale. Carne di pollame, lombi/High-Quality-Beef e carne ovina hanno raggiunto una quota del 70 per cento. Nel suo messaggio del 29 maggio 2002 relativo all’ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007, FF n. 29 2002, pag. 4299), il Consiglio federale stimava che le nuove entrate a favore della Cassa federale nel 2006 sarebbero state pari a 100 milioni di franchi. La stima non teneva conto dei contingenti di salumi e delle specialità a base di carne, già completamente venduti all’asta dal 1999. Questi prodotti hanno fruttato entrate per un totale di 15,4 milioni di franchi.
Unitàkg lordiNumerofr./kg lordi Carne di pollame24 420 000661,61 Carne ovina4 158 000503,62 Carne suina in mezzene 3 382 500260,39 Carne equina3 382 500170,98 Lombi/High-Quality-Beef2 706 0006711,72 Carne di vacca da salumeria1 204 500292,36 Carcasse di vacche destinate alla trasformazione (con ossi)1 518 000170,80 Muscoli di manzo772 2003211,21 Carne di vitello709 500334,65 Lingue528 00070,02 Muselli di bovini198 00070,03 Fegato di vitello79 200110,08 Carne caprina237 600191,09 Carne bovina (kasher)258 45050,62 Carne bovina (halal)300 00040,56 Carne ovina (kasher)20 00030,41 Carne ovina (halal)100 00040,71 Prosciutto essiccato all’aria dall’UE1 100 000647,36 Carne secca essiccata all’aria dall’UE220 000447,38 Prosciutto cotto e in scatola71 500226,95 Conserve a base di carne di manzo770 000120,44 Salumi dall’Italia2 856 000581,67 Salumi dalla Francia125 00082,61 Salumi dalla Germania103 00061,63 Salumi dall’Ungheria64 00030,25
Fonte: UFAG
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 137 2
■ Uova: provvedimenti a sostegno della produzione indigena e misure di valorizzazione
Il 30 settembre 2006 è stato soppresso il sostegno di investimenti per la trasformazione e la costruzione di pollai particolarmente rispettosi degli animali. Nell’arco di quasi cinque anni è stato attribuito un contributo di 600 franchi per UBG a promozione della detenzione rispettosa degli animali. I fondi erano destinati esclusivamente a pollai per la produzione di uova per i quali non venivano concessi crediti d’investimento. Complessivamente sono stati stanziati 3,2 milioni franchi a un totale di 127 aziende.
Contributi per investimenti
2002–2006
La domanda di uova indigene cala specialmente dopo Pasqua e durante i mesi estivi. Onde attutire le ripercussioni delle fluttuazioni stagionali, dopo aver sentito le cerchie interessate l'UFAG ha messo a disposizione un importo massimo di 2,37 milioni di franchi per il finanziamento di misure di valorizzazione. Le azioni di spezzatura svolte dai fabbricanti di prodotti di uova hanno interessato 19 milioni di uova indigene in esubero. Tali azioni sono state sostenute mediante il versamento di un contributo di 9 centesimi per uovo di cui è comprovata la spezzatura. Le azioni di riduzioni di prezzo, di cui approfittano i consumatori, hanno interessato 13,2 milioni di uova. Il contributo concesso agli offerenti è stato pari a 5 centesimi per uovo. Alle azioni di spezzatura e di riduzione del prezzo hanno partecipato rispettivamente 14 e 9 aziende. L'UFAG ha verificato l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di azioni di spezzatura e di riduzione del prezzo, eseguendo sopralluoghi e controlli dei documenti probatori.
■ Cavalli da reddito e per la pratica di sport: vendita all’asta del contingente doganale
Nell’anno oggetto del rapporto l’UFAG ha pubblicato e venduto all’asta per l’ultima volta il contingente doganale di animali della specie equina (esclusi riproduttori, asini, muli e bardotti). I due bandi comprendevano ciascuno 1'461 capi. Ad ogni vendita all'asta le ditte commerciali sono state circa 200. Il prezzo medio d'aggiudicazione è stato di 354 franchi per cavallo da reddito e per la pratica di sport. Il ricavo totale a favore della Cassa generale della Confederazione è stato di oltre 1 milione di franchi. Dal 1° gennaio 2007 il contingente doganale di animali della specie equina pari a 3'322 capi viene assegnato dall’Amministrazione federale delle dogane mediante procedura in base all’ordine d’entrata alla frontiera della dichiarazione doganale.
■ Controllo del traffico di animali ed eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
La banca dati sul traffico di animali (BDTA) è gestita da Identitas AG in virtù di un mandato. Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore un nuovo accordo di prestazione con questa ditta. Da allora una parte dell’infrastruttura federale è passata alla ditta gerente della BDTA. Le nuove disposizioni contrattuali per la gestione della BDTA sono risultate efficaci. Resta un imperativo: vigilare affinché vengano rispettate. Il 1° aprile 2006 è divenuta operativa la banca dati sul controllo delle carni. Grazie a questa piattaforma gestita da Identitas AG i servizi cantonali di veterinaria dispongono di uno strumento efficace per il controllo della qualità delle carcasse.
ParametriCostruzioneTrasformazione Pollai per ovaioleNumero4953 Effettivo medio per pollaioCapi4 4204 881 Totale per ovaiolefr.1 299 6481 552 215 Pollai per gallinelleNumero916 Effettivo medio per pollaioCapi5 2115 129 Totale per gallinellefr.112 560196 961
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 138
Provvedimenti – 2006
2.1.4Produzione vegetale
Nell’anno oggetto del rapporto non vi sono state variazioni di rilievo per quanto concerne le misure volte a garantire la produzione indigena. Il sostegno statale si è limitato essenzialmente alla protezione alla frontiera, la quale ha subito una riduzione nel settore degli alimenti proteici per animali. Siccome le componenti e gli scopi d’utilizzo degli alimenti composti per animali variano fortemente comportando anche notevoli differenze di prezzo, è stato introdotto un nuovo strumento per il calcolo delle aliquote di dazio, che, adesso, avviene in base alle componenti della ricetta standard.
1A dipendenza dello scopo di utilizzo o della voce di tariffa non vi è imposizione doganale o vengono applicati dazi ridotti
2Riguarda solo una parte del quantitativo raccolto (somministrazione allo stato fresco ed essiccazione di patate, riserva di mercato per i concentrati di frutta a granelli)
3Patate: solo per i prodotti di patate a scopo alimentare / sementi: solo per le patate da semina / frutta: solo per le ciliegie da conserva trasformate e diversi prodotti di frutta a granelli

4Riguarda solo determinate colture
Fonte: UFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Protezione alla frontiera 1 ■■■■■■■■ Contributi di trasformazione ■■ 2 ■■ 2 ■ 2 Contributi di coltivazione ■■■ Contributi all’esportazione 3 ■■■
per la riconversione e per l’impianto di colture innovative 4 ■■
Provvedimento
Contributi
Coltura Cereali Leguminose a granelli Semi oleosi Patate Barbabietole da zucchero Sementi Verdura, fiori recisi, vitivinicoltura Frutta 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 139 2
Nell’anno oggetto del rapporto, rispetto al 2005, i mezzi finanziari destinati al sostegno del mercato sono diminuiti passando da 125 a 112 milioni di franchi. Anche le uscite per i contributi di trasformazione e di valorizzazione sono notevolmente calate. Al contrario a seguito dell’estensione delle superfici coltivate a semi oleosi, le uscite per i contributi di coltivazione sono aumentate di 1,9 milioni di franchi. I contributi all’esportazione non hanno subito variazioni di rilievo.
I mezzi finanziari stanziati per la campicoltura sono diminuiti di 13 milioni di franchi rispetto all’anno precedente. Tale calo è riconducibile essenzialmente al taglio dei mezzi impiegati per la valorizzazione delle barbabietole da zucchero, che sono passati da 35,6 milioni di franchi (raccolto 2004) a 28,8 milioni (raccolto 2005). Le maggiori uscite per i semi oleosi sono riconducibili all’estensione delle superfici ad aliquote invariate nonché all’aumento dei contributi di trasformazione. Nell’anno oggetto del rapporto sono lievemente diminuiti i mezzi finanziari stanziati per le patate mentre sono aumentati quelli destinati alle leguminose a granelli. I fondi per le materie prime rinnovabili (MPR) e per la produzione di sementi non hanno subito alcuna variazione rispetto all’anno precedente.
 ■ Mezzi finanziari
■ Mezzi finanziari
Contributi alla trasformazione e alla valorizzazione 48%
Ripartizione dei mezzi – 2006
Contributi di coltivazione 41%
Fonte: Conto dello Stato
Contributi all'esportazione 8%
Totale 112 mio. fr.
Diversi 3%
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 140
Tabella 30, pagina A29
Ripartizione dei mezzi finanziari secondo le colture
Barbabietole da zucchero 1
Patate
Leguminose a granelli Semi oleosi (compr. MPR)
Materie prime rinnovabili (escl. semi oleosi)
Produzione di sementi
Frutta
Vitivinicoltura 2
mio. fr.
5 10 1520354045
0253050
2004 2005 2006
1 2005: 28,5 mio. fr. per il raccolto 2004 e 17,5 mio. fr. per il raccolto 2005; 2006: 11,3 mio. fr. per il raccolto 2005 e 18,3 mio. fr. per il raccolto 2006
2 Dal 2004 esclusa la promozione dello smercio
Uscite per la valorizzazione della frutta – 2006
Esportazione di altra frutta a granelli 4%
Esportazione di ciliegie 3%
Valorizzazione indigena di mele e pere 8%
Misure di adeguamento al mercato di frutta e verdura (riconversione frutta) 5%
Esportazione di concentrato di succo di pera 13%
Esportazione di concentrato di succo di mela 66%
Altro 1%
Nel complesso, le uscite per la valorizzazione della frutta sono state pari a 10,4 milioni di franchi. A causa dello scarso raccolto dell’anno precedente sono diminuiti i volumi d’esportazione di concentrato di succo di mela e di pera. Per tale motivo i fondi destinati all’esportazione sono stati ridotti di 6 milioni di franchi circa.
Fonte: Conto dello Stato
Fonte: UFAG
Totale 10,4 mio. fr.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 141
■ Provvedimenti alla frontiera
Colture campicole
Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la riduzione di 2 franchi il quintale dei prezzi soglia degli alimenti proteici per animali. I prezzi soglia sono prezzi fissati dal Consiglio federale che corrispondono al prezzo mirato d’importazione. Servono per stabilizzare i prezzi alla produzione. Quello dei panelli di soia è stato fissato a 50 franchi il quintale. Per i panelli di soia, che hanno prezzi più bassi, viene applicato un dazio alla frontiera per allineare il prezzo d’importazione a quello soglia. Sempre dal 1° luglio 2006 l’aliquota di dazio degli alimenti composti viene calcolata in base alle aliquote di dazio applicate alle diverse componenti di una ricetta standard e a un supplemento che verrà concesso fino al 2011. Nel novembre 2006 il Consiglio federale ha disposto, con effetto al 1° luglio 2007, una riduzione di 3 franchi il quintale dei prezzi soglia degli alimenti per animali ed anche dell’aliquota di dazio del contingente dei cereali panificabili. In pratica il prezzo soglia dell’orzo passa da 43 a 40 franchi il quintale, mentre l’aliquota di dazio del contingente dei cereali panificabili viene fissata a 23,30 franchi il quintale. Parallelamente il DFE ha deciso di ridurre il supplemento concesso per gli alimenti composti da 4 a 2 franchi il quintale.
■ Semi oleosi: evoluzione dei contributi di coltivazione e di trasformazione
Gli oli ed i grassi vegetali hanno una quota d’importazione molto elevata. Attraverso dazi fissi le oscillazioni dei prezzi internazionali vengono traslate direttamente sui prezzi dei semi oleosi praticati in Svizzera. Va inoltre aggiunto che i tributi doganali si differenziano notevolmente a seconda dello scopo d’utilizzo della merce. Per ottenere una compensazione dei prezzi all’interno del Paese, la Confederazione versa contributi di trasformazione. Tale sostegno statale per i semi oleosi (colza, girasole e soia) e per le MPR ha subito notevoli variazioni negli ultimi anni.
Prima dell’entrata in vigore, nel 1999, della nuova LAgr, la Confederazione stanziava premi di coltivazione per l’orientamento della produzione. I premi allora stanziati per le MPR ammontavano a 3'000 franchi l’ettaro. La Confederazione garantiva il ritiro di semi oleosi a prezzi prestabiliti. L’Ufficio federale pagava ai produttori la differenza tra i prezzi di costo (costi di ritiro e liquidazione) degli oleifici ed i prezzi stabiliti.
Con l’entrata in vigore della nuova LAgr, il sostegno nel settore dei semi oleosi è cambiato. La garanzia del prezzo è stata abolita. Colza, soia, girasole e canapa tessile ricevono un sostegno indipendentemente dall’utilizzo mediante un contributo di coltivazione pari a 1'500 franchi. A sostegno della trasformazione dei semi oleosi sono stati stanziati contributi agli stabilimenti dove l’olio è ricavato mediante pressatura con minori rese rispetto a quelli in cui l’olio viene ottenuto mediante estrazione. Inoltre la trasformazione di MPR è stata sostenuta nell’ambito di impianti pilota e di dimostrazione riconosciuti. Essi servono per testare scientificamente nuovi sistemi e consentono di valutare in modo scientifico un’eventuale introduzione sul mercato. Il raccolto di colza indigena ha un’elevata qualità e pertanto, se necessario, i gestori di impianti pilota e di dimostrazione possono destinare la colza indigena garantita contrattualmente alla produzione di olio commestibile importandone altra per le loro attività. Nel 2001 è stato deciso che gli impianti pilota e di dimostrazione che cedono colza indigena per la produzione di olio commestibile hanno diritto a contributi per il corrispettivo quantitativo di colza importata.
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 142
■ Evoluzione dei contributi di trasformazione per i semi oleosi
Con la chiusura, nel 2000, dello stabilimento per l’estrazione d’olio Sais di Horn, non vi era più motivo di mantenere i contributi di compensazione delle rese. Da gennaio 2002 questi mezzi finanziari sono stati accorpati a quelli per la riduzione del prezzo delle MPR a formare un unico contributo di trasformazione per un importo massimo di 8,5 milioni di franchi per i semi oleosi. Gli impianti pilota e di dimostrazione riconosciuti si sono visti stanziare un sostegno pari a 20 franchi, che dal 2003 è salito a 30 franchi per quintale di semi oleosi trasformati. Nel 2004 il sostegno statale è stato esteso alla promozione della produzione di sementi di soia.
Dal 2002, tra l’UFAG e l’organizzazione di categoria per i cereali, le piante oleaginose e le piante proteiche (swiss granum) esiste un accordo di prestazione. La swiss granum è incaricata di assegnare i contributi federali annui per la trasformazione di semi oleosi. L’organizzazione di categoria s’impegna a impiegare i contributi federali per ottimizzare la creazione di valore aggiunto, trasformare in maniera efficiente i semi oleosi indigeni e assicurare la produzione di sementi indigene di soia.
dei contributi di

Con il raccolto del 2005 (importazioni di MPR incl.) è stato raggiunto il picco massimo dei volumi di trasformazione di semi oleosi (81'858 t). Nel 2006 si è registrata una flessione dei quantitativi trasformati che sono riscesi a 78'315 tonnellate.
Ogni anno l’organizzazione di categoria swiss granum fissa i nuovi contributi di trasformazione. Quello per la trasformazione di semi oleosi ammonta al massimo a 35 franchi il quintale. Quello per la trasformazione di MPR in impianti pilota e di dimostrazione per la colza importata nel quadro della compensazione del raccolto va calcolato in modo che il prezzo di costo della merce importata non sia superiore a quello della colza indigena oggetto di riduzione di prezzo.
Evoluzione
trasformazione per i semi oleosi 20022003200420052006 In t In mio. fr. Fonti: UFAG, swiss granum 0 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 10 8 6 4 2 Quantitativo trasformato Contributi 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 143
Per il raccolto 2006 swiss granum ha stanziato contributi di trasformazione ad un totale di 15 aziende dei settori: olio commestibile (5), MPR (3), derrate alimentari –soia (3), alimenti per animali (3) e sementi (1). I settori e i processi aventi diritto a contributi non hanno subito cambiamenti dal raccolto 2004. La maggior parte dei mezzi finanziari viene destinata al settore dell’olio commestibile, seguito da MPR e alimenti per animali. La produzione di sementi di soia e la fabbricazione di tofu non hanno particolare incidenza finanziaria. Per il raccolto 2007 sono stati aumentati i contributi di trasformazione per colza e girasole. L’obiettivo è far arrivare ai produttori di semi oleosi i mezzi approntati dalla Confederazione in maniera possibilmente rapida ed evitando che si creino riserve.
Contributi di trasformazione dei raccolti 2004–2007
SettoreSemi oleosi2004200520062007 fr./tfr./tfr./tfr./t
Olio commestibile,
Impianti P&D MPRColza350.00270.00270.00280.00
Fonte: swiss granum
Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale, rispettivamente nella sessione invernale 2006 e nel marzo 2007, hanno deciso di sopprimere il mandato di prestazione per i semi oleosi. Il Parlamento ha accolto la proposta del Consiglio federale e del DFE. Pertanto il raccolto 2008 sarà l’ultimo ad avere diritto a contributi.
Il settore cerealicolo, finora, ha sempre beneficiato di una notevole protezione alla frontiera e di conseguenza è stato caratterizzato da forti differenze di prezzo rispetto ai Paesi confinanti. Dal 2001 sono stati ridotti i prezzi soglia dei cereali foraggieri, l’aliquota di dazio del contingente dei cereali panificabili e l’imposizione doganale per gli alimenti composti per animali. Tali cambiamenti hanno reso necessario un intervento sul dazio della farina. Il 16 maggio 2007 il Consiglio federale ha disposto, con effetto al 1° luglio 2008, una riduzione delle aliquote di dazio del contingente della maggior parte dei prodotti. Dagli attuali 143–148 franchi il quintale si passerà a 65 franchi il quintale. Questo adeguamento del dazio sulla farina alla riduzione dell’imposizione doganale dei cereali panificabili eviterà l’eccessivo inasprirsi della concorrenza nel commercio di cereali foraggieri, alimenti composti, cerali panificabili e farina. In un secondo tempo, il 1° luglio 2009, è prevista la riduzione dei prezzi soglia e dell’aliquota di dazio del contingente dei cereali panificabili.
soiaColza75.0027.5027.5040.00 Produzione di derrateGirasole120.0072.5072.5085.00 alimentariGirasole alto oleico120.0052.5052.5065.00 Soia270.00180.00180.00180.00
di alimenti per animaliSoia240.00150.00150.00150.00
di sementiSoia250.00180.00180.00180.00
Produzione
Fabbricazione
2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 144
■ Prospettiva
■ Contributi di riconversione per i vigneti

Colture speciali
Prendendo spunto dai cambiamenti in atto sul fronte dei consumi di vino e dalla crescente pressione concorrenziale determinata dalla fusione dei contingenti d’importazione di vini bianchi e rossi, nel suo messaggio del 29 maggio 2002 sulla PA 2007 il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le superfici coltivate a Chasselas e Müller-Thurgau dovevano essere ridotte di 500–1000 ettari. Pertanto ha disposto una serie di misure limitate al 2011 per estirpare le viti e reimpiantare tali vigneti optando per altre specialità di uve bianche e rosse.
I contributi di riconversione vengono concessi soltanto per i vigneti di almeno 500 metri quadri. Il trattamento delle domande e il calcolo dei contributi federali in funzione della pendenza e del terrazzamento spetta ai Cantoni che partecipano al programma di riconversione. Questi ultimi devono inoltre fissare una resa massima ridotta di 0,1 chilogrammi al metro quadro per Chasselas e Müller-Thurgau.
■ Bilancio intermedio
Il grafico illustra i contributi di riconversione concessi dal 2003 al 2006. Già nel primo anno (2003) oltre 1'000 aziende di diversi Cantoni si sono annunciate per la riconversione di vigneti. I mezzi finanziari approntati dalla Confederazione, pari a 3,5 milioni di franchi, hanno tuttavia consentito di prendere in considerazione soltanto 855 aziende per un totale di 204 ettari di vigneti. Per tale motivo, oltre al programma federale sono stati stanziati aiuti di riconversione cantonali (Ginevra: 19 ha; Vallese: 45 ha). Nel 2004 è stato possibile entrare nel merito di tutte le richieste. Al programma di riconversione hanno preso parte 577 aziende per un totale di 119 ettari. Ciò sottolinea il consenso riscosso nel settore vitivinicolo da questo tipo di contributi. Oltre al programma federale, nel Cantone di Ginevra è stata riconvertita una superficie viticola pari a 7 ettari. Nel biennio 2005–2006 sono andati consolidandosi il numero delle aziende partecipanti al programma (454 e 475) e l’area di riconversione (83 e 82 ha). Anche in questo periodo il Cantone di Ginevra ha stanziato finanziamenti complementari per la riconversione di 13 e 8 ettari.
Aziende Riconversione di vigneti mediante contributi federali e iniziative cantonali 2003200420052006 Superfici Ct. GE Superfici Ct. VS Superfici Confederazione Fonte: UFAG 0 300 200 100 In ha 204 45 19 119 7 83 13 82 8 Numero 0 900 600 700 800 500 400 300 100 200 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 145
■ Cambiamento nell’assortimento delle varietà di vitigni
Nel 2006 l’area di riconversione interessata dal programma federale ammontava complessivamente a 488 ettari di vigneti precedentemente messi a Chasselas e MüllerThurgau. A tale superficie si aggiungono altri 92 ettari riconvertiti grazie a cosiddette iniziative cantonali. La riconversione dei vigneti finora attuata rispecchia l’obiettivo prefissato.
Il grafico mostra l’evoluzione delle principali varietà coltivate dal 1996. Fino al 2002 i vigneti di Chasselas e Müller-Thurgau raggiungevano i 5'742 ettari circa, ovvero l’82 per cento delle superfici coltivate a vitigni bianchi in Svizzera. Nel caso del Chasselas, già prima del 2002 era andato delineandosi un calo dell’1–2 per cento. Questa tendenza si è accentuata nel 2003, raggiungendo il 6,5 per cento, per poi attenuarsi nuovamente toccando il 4,2 per cento nel 2004/05 e il 3,2 per cento nel 2006. La stesso andamento si è osservato per il Müller-Thurgau, anche se complessivamente ha interessato una superficie meno estesa. Tra il 1998 e il 2002 il calo annuo delle superfici coltivate è stato pari all’1–3 per cento; nel 2003 si è accentuato raggiungendo il 7,5 per cento, per poi attenuarsi nuovamente fissandosi attorno al 3 per cento l’anno. Nel 2006 l’area totale dei vigneti di Chasselas e Müller-Thurgau era pari a 4'777 ettari, ovvero il 75 per cento delle superfici coltivate a vitigni bianchi in Svizzera.
Di questa evoluzione hanno beneficiato soprattutto i vitigni rossi, quali ad esempio Gamaret (+91 ha), Merlot (+51 ha) e Garanoir (+44 ha), ma anche alcune specialità di uve bianche quali Petite Arvine (+29 ha) e Sauvignon Blanc (+18 ha). Il processo di riconversione ha determinato anche un cambiamento, nel 2005, ai vertici della classifica dei vitigni bianchi più diffusi in Svizzera. Il Chasselas, infatti, ha lasciato il primo posto al Blauburgunder (Pinot Noir).
Evoluzione varietà di vite selezionate in Svizzera
19961997199819992000200120022003200420052006
■ Prospettiva
Grazie ai contributi di riconversione è stato possibile ridurre le eccedenze strutturali dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau, rafforzando, parallelamente, l’offerta di altri vini richiesti dal mercato. Mediante tali provvedimenti è stato inoltre possibile stabilizzare il prezzo di mercato del vino Chasselas a un livello soddisfacente per i produttori. Il Cantone Vallese ha annunciato che dal 2007 non attuerà più provvedimenti di riconversione.
In ha Chasselas Blauburgunder/Pinot N. Gamay Fonte: UFAG Specialità uve rosse Specialità uve bianche Müller-Thurgau 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2.1 PRODUZIONE E SMERCIO 2 146
2.2 Pagamenti diretti
I pagamenti diretti sono uno degli elementi principali della politica agricola. Essi indennizzano le prestazioni richieste dalla società. Si distingue fra pagamenti diretti generali e pagamenti diretti ecologici.
Uscite per i pagamenti diretti 2000–2006
Ambito di spesa2000200120022003200420052006 mio. fr.
Pagamenti diretti generali1 8041 9291 9951 9991 9942 0002 007
Pagamenti diretti ecologici361413452477495507518
Riduzioni23172117182026
Totale2 1422 3252 4262 4592 4702 4862 500
Avvertenza: Non è possibile effettuare un paragone diretto con i dati del Conto dello Stato. I valori indicati nella parte 2.2. «Pagamenti diretti» si riferiscono all’intero anno di contribuzione, mentre il Conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile.
Fonte: UFAG

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 147
■ Indennizzo di prestazioni a favore della collettività
2.2.1Importanza dei pagamenti diretti
Le prestazioni dell’agricoltura a favore della collettività vengono indennizzate tramite i pagamenti diretti generali. Tra questi rientrano i contributi di superficie e quelli per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Questi contributi sono finalizzati a garantire la gestione e la cura della superficie agricola utile. Nella regione collinare e in quella di montagna i gestori percepiscono inoltre contributi di declività e contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. Tali provvedimenti consentono di tenere in considerazione le difficoltà di gestione con le quali sono confrontati coloro che operano in queste regioni. I pagamenti diretti (esclusi i contributi d’estivazione) sono concessi soltanto agli agricoltori che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER).
■ Indennizzo di prestazioni ecologiche particolari
I pagamenti diretti ecologici costituiscono un incentivo a fornire prestazioni ecologiche particolari. Tra questi rientrano i contributi per la compensazione ecologica, per la qualità ecologica, d'estivazione e per la protezione delle acque nonché i contributi etologici per la detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze. Mediante questi contributi vengono promosse con incentivi economici le prestazioni dell’agricoltura che vanno oltre le esigenze in ambito legislativo e la PER. S'intende tra l'altro conservare e aumentare la biodiversità nelle regioni agricole, incentivare la detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze, ridimensionare l'uso di concimi e prodotti fitosanitari, ridurre il carico di nitrati e fosforo nei corsi d'acqua e gestire in modo sostenibile la regione d'estivazione.

■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 148
■ Importanza economica dei pagamenti diretti nel
Nel 2006 i pagamenti diretti corrispondevano al 72 per cento delle uscite dell’UFAG. Il 61 per cento dei pagamenti diretti è andato a beneficio delle regioni di montagna e collinare.
Non è possibile effettuare un paragone diretto con i dati del Conto dello Stato. I valori indicati nella parte 2.2 «Pagamenti diretti» si riferiscono all’intero anno di contribuzione, mentre il Conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile. Le riduzioni si riferiscono alle deduzioni dovute alle limitazioni e alle sanzioni giuridiche e
Pagamenti diretti – 2006 Tipo di contributoTotaleRegione di Regione Regione di pianuracollinaremontagna 1 000 fr. Pagamenti diretti generali2 007 181749 822515 294730 685 Contributi di superficie1 319 103653 275325 471340 357 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo301 21389 52077 905133 788 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione281 2584 63978 648197 972 Contributi di declività generali94 2272 38933 27058 568 Contributi di declività per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate11 380 Pagamenti diretti ecologici518 211207 192115 95697 097 Contributi ecologici420 245207 192115 95697 097 Contributi per la compensazione ecologica126 97673 40331 97821 595 Contributi giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE)30 2569 6428 52912 086 Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza (produzione estensiva)31 09421 8068 599690 Contributi per l’agricoltura biologica28 6728 8805 79913 993 Contributi per la detenzione di animali da reddito agricoli particolarmente rispettosa delle loro esigenze203 24793 46261 05148 734 Contributi d’estivazione91 696 Contributi per la protezione delle acque6 270 Riduzioni25 820 Totale pagamenti diretti2 499 572957 014631 250827 782 Pagamenti diretti per azienda44 89740 48641 73048 958 Avvertenza:
UFAG
amministrative. Fonte:
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 149 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
2006
■ Esigenze poste per l’ottenimento di pagamenti diretti
Quota dei pagamenti diretti rispetto al reddito lordo delle aziende di riferimento, per regione – 2006
CaratteristicaUnitàTotaleRegioneRegioneRegione
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART

L'importo dei pagamenti diretti versato per ettaro lievita proporzionalmente al grado di difficoltà gestionali con cui sono confrontate le regioni collinare e di montagna. Visto che nelle regioni più elevate vengono conseguiti redditi meno consistenti, la quota di pagamenti diretti rispetto al reddito lordo aumenta.
Per avere diritto ai pagamenti diretti i gestori devono adempiere una serie di esigenze. Tra queste rientrano condizioni di natura generale come la forma giuridica, il domicilio di diritto civile, eccetera, ma anche criteri strutturali e sociali come ad esempio il volume di lavoro minimo, l’età del gestore, il reddito e la sostanza. A ciò si aggiungono condizioni specifiche di carattere ecologico in base al principio della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate. Le esigenze poste dalla PER comprendono: un bilancio di concimazione equilibrato, una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica, un avvicendamento disciplinato delle colture, una protezione adeguata del suolo, un’utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari e una detenzione degli animali da reddito agricoli rispettosa delle loro esigenze. Lacune in materia delle prescrizioni determinanti comportano riduzioni o il diniego dei pagamenti diretti.
di
AziendeNumero3 2711 491957823 SAU in Øha20,0721,0218,8819,66 Pagamenti diretti generalifr.38 48632 31637 26849 995 Contributi ecologici ed etologicifr.7 9998 8838 1176 405 Totale pagamenti direttifr.46 48441 19945 38656 400 Reddito lordofr.226 795272 530209 031168 145 Quota dei pagamenti diretti sul reddito lordo%20,515,121,733,5
di pianuracollinaremontagna
Tabelle 41a–42, pagine A46–A49
150 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2
■ Sistema d’informazione sulla politica agricola
La maggior parte dei dati statistici sui pagamenti diretti proviene dalla banca dati sviluppata dall’UFAG, denominata AGIS/SIPA (sistema d’informazione sulla politica agricola). In questo sistema affluiscono i dati delle rilevazioni annuali delle strutture effettuate dai Cantoni e i dati sui versamenti (superfici ed effettivi di bestiame che hanno beneficiato dei contributi e rispettivi importi) per tutti i tipi di pagamenti diretti (provvedimenti). La banca dati serve in primo luogo per assicurare un controllo, sul piano amministrativo, degli importi versati dai Cantoni ai gestori. Il sistema consente, inoltre, di allestire statistiche di carattere generale sui pagamenti diretti. Grazie alla ricchezza d’informazioni e all’efficacia delle applicazioni informatiche è possibile fornire delucidazioni su un gran numero di aspetti inerenti alla politica agricola.
Delle 61'304 aziende, al di sopra del limite di rilevazione federale e registrate nel 2006 nell’AGIS/SIPA, 55'673 hanno ottenuto pagamenti diretti.
■ Effetti delle graduazioni e delle limitazioni
Graduazioni e limitazioni si ripercuotono sulla ripartizione dei pagamenti diretti. Tra le limitazioni rientrano i limiti di reddito e di sostanza nonché il contributo massimo per unità standard di manodopera (USM), mentre le graduazioni si riferiscono alla riduzione progressiva dei contributi in base a superfici ed animali.
Effetti delle limitazioni dei pagamenti diretti – 2006
LimitazioneAziende Riduzione Quota rispetto Quota rispetto interessateal contributo all’importo totale delle aziende dei pagamenti interessatediretti
Fonte:
Le limitazioni hanno determinato riduzioni dei pagamenti diretti pari a 11,7 milioni di franchi circa, di cui 10,9 milioni di franchi riconducibili a riduzioni dovute al superamento dei limiti di reddito e sostanza. Rispetto all’anno precedente si registra un aumento sia del numero delle aziende interessate sia dell’importo delle riduzioni.
Numerofr.%% per USM410828 4115,510,03 a causa del reddito1 0366 080 21711,670,24 a causa della sostanza2404 781 82362,590,19 Totale11 690 4510,43
UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 151 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA
Effetti della graduazione dei contributi in funzione della superficie o del numero di animali – 2006
ProvvedimentoAziende Superficie/ Riduzione Quota rispetto Quota rispetto interessateeffettivo al contributo all'importo di animalidelle aziendedei pagamenti per aziendadiretti
Le graduazioni previste dall’ordinanza sui pagamenti diretti hanno interessato complessivamente 9'299 aziende. Nella maggior parte dei casi sono state applicate deduzioni per diversi provvedimenti. Le riduzioni ammontano complessivamente a 39,7 milioni di franchi circa. Commisurate a tutti i pagamenti diretti, i quali sono graduati, rappresentano una quota dell'1,6 per cento circa. La riduzione progressiva dei contributi si ripercuote in modo massiccio soprattutto sui contributi di superficie. In questi casi le graduazioni interessano oltre 7'600 aziende (circa il 13,7% delle aziende che beneficiano di pagamenti diretti). Delle aziende che percepiscono contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo 308 si sono viste ridurre i contributi, in quanto altre limitazioni specifiche previste nell’ambito di questo provvedimento, come il limite di promozione e la deduzione per il latte commercializzato, espletano i loro effetti prima della graduazione dei pagamenti diretti. Le riduzioni dei contributi hanno interessato anche i pagamenti diretti ecologici. Ad esempio, circa 3'475 aziende (esclusi doppi versamenti) hanno subito riduzioni del 10,6 per cento (SSRA) e dell’8,5 per cento (URA) dei pagamenti diretti per la detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze (URA e SSRA), mentre 812 aziende dedite all’agricoltura biologica hanno dovuto sopportare riduzioni del 7,4 per cento.
Numeroha o UBGfr.%% Contributi di superficie7 63642,232 915 5307,61,32 Contributi per la detenzione
animali
reddito che consumano foraggio grezzo30858,6880 4355,80,04 Contributi di declività generali8834,340 6553,20,00 Contributi di declività per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate132,420841,90,00 Contributi per la compensazione ecologica3038,892 9549,10,00 Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza (produzione estensiva)4736,635 4615,10,00 Contributi per l’agricoltura biologica81240,3629 9047,40,03 Contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali2 13468,62 012 70410,60,08 Contributi per l’uscita regolare all’aperto3 14565,13 088 8898,50,12 Totale9 299 1 39 698 6167,71,59 1Esclusi doppi versamenti Fonte: UFAG
di
da
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 152
■ Esecuzione e controllo
Conformemente all’articolo 66 dell’ordinanza sui pagamenti diretti, il controllo in relazione alla PER è delegato ai Cantoni. Per l’esecuzione essi ricorrono a organizzazioni accreditate che garantiscono controlli obiettivi e imparziali. I Cantoni verificano, per campionatura, l’attività di controllo esercitata da tali organizzazioni. Le aziende dedite all’agricoltura biologica aventi diritto a pagamenti diretti, oltre agli oneri relativi all’agricoltura biologica, devono adempiere le condizioni poste dalla PER e detenere gli animali da reddito in base alle esigenze poste dal programma URA. Ogni anno tali aziende vengono controllate da un ente di certificazione accreditato. I Cantoni vigilano sul corretto svolgimento di questi controlli. L’articolo 66 capoverso 4 dell’ordinanza sui pagamenti diretti precisa i criteri in base ai quali i Cantoni o le organizzazioni alle quali essi si sono rivolti devono controllare le aziende.
I controlli devono riguardare: –tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti; –tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei controlli dell’anno precedente e –almeno il 30 per cento delle altre aziende scelte a caso.
In caso di lacune relative al principio della PER i contributi vengono ridotti in base a criteri uniformi. La Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura ha emanato le rispettive direttive.
■ Controlli eseguiti e riduzioni dei contributi nel 2006
Nel 2006 le aziende aventi diritto a contributi ammontavano a 55'673, di cui 29'330 (52,7%) sono state sottoposte a controllo in merito al rispetto della PER da parte dei Cantoni rispettivamente dai competenti servizi di controllo. A causa di lacune relative ai principi della PER, 1'917 aziende (3,4% delle aziende controllate) hanno subito una riduzione dei contributi.
In virtù dell’ordinanza sull’agricoltura biologica tutte le aziende dedite all’agricoltura biologica devono essere controllate su base annuale. Il 4,4 per cento di esse si è visto ridurre i contributi a causa di lacune.
Nell’ambito dei programmi SSRA e URA, in media, è stato controllato rispettivamente il 25,3 e il 45,1 per cento delle aziende aventi diritto a contributi. Non sono compresi i controlli svolti nel quadro dei controlli PER. Pertanto la percentuale effettiva è più alta. Nel quadro dei programmi SSRA e URA le aziende che hanno subito riduzioni dei pagamenti diretti sono state rispettivamente lo 0,9 e l’1,9 per cento.
Complessivamente sono state constatate oltre 6'061 lacune, che hanno comportato riduzioni di contributi pari a 8,5 milioni di franchi circa.
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 153
Registrazioni lacunose, detenzione degli animali da reddito non rispettosa delle loro esigenze, altri motivi (mancata attuazione delle analisi del suolo, test sui trattamenti scaduti), bilancio di concimazione non equilibrato, fasce tampone e inerbite insufficienti, selezione e utilizzazione di prodotti fitosanitari, notifica tardiva, quota di SCE non commisurata alla SAU.
Elementi diversi da quelli elencati (altra utilizzazione, epoca dello sfalcio e provvedimenti di cura non rispettati), utilizzazione troppo precoce o non autorizzata, indicazioni non veritiere sul numero di alberi, malerbe, indicazioni non veritiere sulle superfici, concimazione non autorizzata, notifica tardiva e protezione delle piante.
Notifica tardiva, raccolto finalizzato all’estrazione di granelli effettuato prima della piena maturazione, impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati.
Elementi diversi da quelli elencati (infrazione delle prescrizioni in materia di foraggiamento, aziende gestite per passatempo non conformi alle prescrizioni in materia di agricoltura biologica, detenzione di animali, protezione delle acque, registrazioni, ecc.), impiego di concimi e prodotti fitosanitari non autorizzati nell’agricoltura biologica, notifica tardiva, indicazioni non veritiere.
Elementi diversi da quelli elencati (lettiere inadeguate), notifica tardiva, mancanza di un sistema di stabulazione ad aree multiple, detenzione non conforme alle prescrizioni di alcuni animali della medesima categoria, area di riposo insufficiente, indicazioni non veritiere, illuminazione delle stalle insufficiente.
Elementi diversi da quelli elencati (mancato raggiungimento della durata minima d’ingrasso, area di riposo con fessure o perforazioni, inadempienza delle prescrizioni sulla protezione degli animali, superficie di pascolo troppo piccola, entrata tardiva), giorni d’uscita insufficienti, notifica tardiva, registrazioni lacunose, detenzione non conforme alle prescrizioni di alcuni animali della medesima categoria, indicazioni non veritiere, parchetto insufficiente.
Carico inferiore o superiore a quello usuale, gestione dei pascoli inadeguata, utilizzo di superfici non destinate al pascolo, infrazioni di prescrizioni rilevanti per l'agricoltura, notifica tardiva, spandimento di concimi non autorizzati, altri elementi (superamento contingente lattiero), indicazioni non veritiere sull’effettivo di animali, documentazione incompleta, manutenzione inadeguata degli edifici, ostacoli ai controlli, indicazioni non veritiere sulla durata d’estivazione, dati incompleti, impiego di erbicidi non autorizzati, recidive.
Ricapitolazione delle riduzioni di contributi – 2006 CategoriaAziende Aziende Aziende RiduzioniMotivi principali aventi diritto controllatesoggette a contributia riduzioni NumeroNumeroNumerofr. PER55 67329 3301 9172 660 778 SCE 52 728-923790 976 Produzione 16 4145 5195547 957 estensiva Bio 6 2606 394280330 455 SSRA 38 8899 828366348 187 URA 37 97817 143707686 025 Estivazione7 3368746701 545 255 Fonte: Rapporti cantonali concernenti i controlli e le sanzioni
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 154
Tabelle 43a–43b, pagine A50–A51
Ricapitolazione delle riduzioni di contributi – 2006
CategoriaAziende Aziende Aziende RiduzioniMotivi principali aventi diritto controllatesoggette a contributia riduzioni
Indicazioni non veritiere sulle superfici e sull’effettivo di animali, altri elementi (indicazioni non veritiere sulla PER, quota di manodopera propria dell’azienda <50%, notifica tardiva della (non) partecipazione ad un programma, ostacoli ai controlli), indicazioni non veritiere sull’azienda o sul gestore come pure sull’estivazione.
Nessuna indicazione possibile
Nessuna indicazione possibile
Nessuna indicazione possibile

NumeroNumeroNumerofr. Dati di base--8511 477 021 Protezione delle --235580 736 acque Protezione della --238 599 natura e del paesaggio Protezione --3424 374 dell’ambiente Totale--6 061 8 500 363
Fonte: Rapporti cantonali concernenti i controlli e le sanzioni
Tabelle 43a–43b, pagine A50–A51
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 155
In virtù dell’allegato 6.4 dell’ordinanza sui pagamenti diretti, in casi particolari i servizi fitosanitari cantonali possono concedere autorizzazioni speciali. Nel 2006 per 4'968 ettari di SAU sono state rilasciate 2'176 autorizzazioni speciali. Analogamente agli anni precedenti, nella maggior parte dei casi sono stati autorizzati trattamenti contro romice e ranuncolacee sui prati naturali.
Autorizzazioni speciali rilasciate nel settore fitosanitario – 2006
ProdottoAutorizzazioniSuperficie
Numero di % di tutte ha% della aziendele aziendesuperficie totale interessata
Applicazione di prodotti fitosanitari durante il periodo di divieto di trattamento vigente d'inverno663,02214,5
Uso di insetticidi e granulati contro i nematodi35016,01 08521,8
Cereali: lotta contro la criocera del frumento 1 1416,53988,0
Colza: lotta contro l'altica 00,000,0
Patate: lotta contro la dorifora 1 10,120,1
Leguminose, girasole, tabacco: lotta contro gli afidi00,000,0 Lotta contro altri parassiti in ambito campicolo130,6240,5
Terreni permanentemente inerbiti: trattamento delle superfici1 53070,33 15063,3
1Trattamenti con prodotti diversi da quelli che figurano nelle istruzioni della Conferenza dei Servizi fitosanitari cantonali
2 Autorizzazioni speciali rilasciate per provvedimenti fitosanitari che non figurano nelle direttive specifiche riconosciute
3 La maggior parte delle autorizzazioni speciali rilasciate per il settore frutticolo riguarda un prodotto autorizzato nel corso dell'anno di coltivazione
Fonte: UFAG
Frutticoltura 2,3 743,4861,7 Viticoltura 2 10,120,1 Totale2
Orticoltura 2 00,000,0
1761004 968100
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 156
■ Autorizzazioni speciali nel settore della protezione fitosanitaria
■ Obiettivo: gestione globale delle superfici
Pagamenti diretti generali
Contributi di superficie
Mediante i contributi di superficie vengono indennizzate le prestazioni a favore della collettività come la protezione e la cura del paesaggio colturale, l’assicurazione della produzione di derrate alimentari e la conservazione delle basi esistenziali naturali. Nel 2001 tali contributi sono stati integrati con un contributo supplementare per i terreni coltivi aperti e per le colture perenni.
Aliquote 2006fr./ha 1
– fino a 30 ha1 200
– da 30 a 60 ha900

– da 60 a 90 ha600
– oltre 90 ha0
1Il contributo supplementare per i terreni coltivi aperti e le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro all’anno e soggiace alla graduazione delle superfici
Nel caso di superfici gestite per tradizione familiare nella zona economica estera le aliquote dei pagamenti diretti legati alle superfici sono ridotte del 25 per cento. Dal 1984 nella zona economica estera vengono gestiti complessivamente circa 5'000 ettari. Le aziende svizzere che attualmente acquistano o prendono in affitto superfici nella zona economica estera non ricevono pagamenti diretti.
■■■■■■■■■■■■■■■■
2.2.2
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 157
Tabelle 32a–32b, pagine A31–A32
Contributi di superficie – 2006 (compreso il contributo supplementare)
Il contributo supplementare è stato concesso per 275'777 ettari di terreni coltivi e 18'545 ettari di colture perenni.
La riduzione dei contributi ha interessato l’8,4 per cento della SAU. In media, per ettaro viene versato un contributo di superficie di 1'281 franchi (compr. il contributo supplementare). Le aziende con una superficie fino a 10 ettari gestiscono complessivamente l’8,7 per cento della SAU. Soltanto l’1,4 per cento delle aziende dispone di una superficie superiore ai 60 ettari. Tali aziende gestiscono il 5,6 per cento della SAU totale.
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna Superficieha479 979261 430288 9131 030 322 AziendeNumero23 52415 08416 89455 502 Superficie per aziendaha20,417,317,118,6 Contributo per aziendafr.27 77121 57720 14723 767 Totale contributi1 000 fr.653 275325 471340 3571 319 103 Totale contributi 20051 000 fr.652 743326 778340 0741 319 595 Fonte: UFAG
aziende
della SAU
le classi di dimensioni – 2006 Fonte: UFAG Classe di dimensioni in ha Aziende SAU < 30 60 < SAU < 90 30 < SAU < 60 SAU > 90 30 302020100 Ripartizione in % 20 1030 >90 60–90 30–60 20–30 15–20 10–15 5–10 <5 1,81,90,6 21,4 27,5 16,6 13,6 7,3 13,3 1,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 21,0 17,7 20,3 17,8 1,4 6,4 Aziende in %SAU in % 8,4 0,3 0,2 1,2 1,81,90,6 0,40,40,3 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 158
Ripartizione delle
e
secondo
■ Utilizzazione delle superfici inerbite
Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo
Questo provvedimento è finalizzato a mantenere la competitività della produzione di carne mediante foraggio grezzo e nel contempo a garantire, attraverso la gestione, la cura delle superfici nel nostro Paese a vocazione pastorizia.

I contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo vengono concessi a favore degli animali tenuti nella rispettiva azienda durante il foraggiamento invernale (periodo di riferimento: 1° gennaio fino al giorno di riferimento dell’anno di contribuzione). Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo si intendono quelli delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. I contributi vengono versati in funzione delle superfici permanentemente inerbite e dei prati artificiali. Le diverse categorie di animali vengono convertite in unità di bestiame grosso che consumano foraggio grezzo (UBGFG) e sono limitate per ettaro. La limitazione è graduata in funzione delle zone.
Limitazione della promozioneUBGFG/ha
–zona campicola, zona intermedia ampliata e zona intermedia2,0
–zona collinare1,6
–zona di montagna I1,4
–zona di montagna II1,1
–zona di montagna III0,9
–zona di montagna IV0,8
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 159
Le UBGFG sono suddivise in due gruppi di contribuzione. Per gli animali delle specie bovina ed equina, i bisonti, le capre lattifere e le pecore lattifere vengono versati 900 franchi per UBGFG, mentre a favore delle altre capre e pecore nonché di cervi, lama e alpaca l’importo dei contributi scende a 400 franchi per UBGFG.
Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo – 2006 CaratteristicaUnitàRegione
Nel 2006, per ogni 4'400 chilogrammi di latte fornito nell’anno precedente i produttori di latte commerciale hanno subito la detrazione di una UBGFG dall’effettivo avente diritto ai contributi.
Contributi ad aziende con e senza latte commercializzato – 2006
CaratteristicaUnitàAziende Aziende con latte senza latte commercializzato commercializzato
02419 452
Animali per aziendaUBGFG24,713,8
Deduzione per la limitazione dei contributi in base alla superficie inerbitaUBGFG1,31,3
Deduzione per il latteUBGFG16,60,0
Animali che danno diritto ai contributiUBGFG6,812,6
Contributi per aziendafr.6 02610 521
Fonte: UFAG
Le aziende che commercializzano latte ricevono contributi UBGFG decurtati di 4'500 franchi circa rispetto a quelle che non producono latte commercializzato, ma approfittano del sostegno del mercato previsto nel settore dell’economia lattiera (p.es. supplemento per il latte trasformato in formaggio).
Regione di
pianuracollinaremontagna UBGFG che danno diritto ai contributiNumero104 49791 256159 204354 958 AziendeNumero10 22410 25714 99535 476 UBGFG per azienda che danno diritto ai contributiNumero10,28,910,610,0 Contributi per aziendafr.8 7567 5958 9228 491 Totale contributi1 000 fr.89 52077 905133 788301 213 Totale contributi 20051 000 fr.84 58875 287132 093291 967 Fonte: UFAG
di Regione
Totale
AziendeNumero16
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 160
Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione
■
Indennizzo
delle difficoltà di produzione
Mediante questi contributi vengono compensate le condizioni difficili di produzione con le quali sono confrontati i detentori di animali nella regione di montagna e nella zona collinare. Contrariamente ai contributi generali per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, volti in primo luogo a promuovere lo sfruttamento e la cura dei pascoli, questa misura persegue anche obiettivi sociali, strutturali e di politica d’insediamento. Le categorie di animali sussidiabili sono le stesse di quelle che beneficiano dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. I contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione vengono concessi per un massimo di 20 UBGFG per azienda.
Aliquote per UBGFG – 2006fr./UBG
– zona collinare260
– zona di montagna

I440
III930
190
– zona di montagna II690 – zona di montagna
– zona di montagna IV1
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 161
Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianura 1 collinaremontagna
UBGFG
1Aziende che gestiscono una parte della superficie nella regione di montagna e in quella collinare
Nel 2006 è continuata la diminuzione dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione. Rispetto all’anno precedente il mutamento strutturale in corso e la limitazione a 20 UBGFG per azienda hanno comportato una diminuzione di 1 milione di franchi circa dei contributi versati. Per le UBGFG aventi diritto ai contributi si registra un calo di 746 unità. Stessa tendenza per le aziende aventi diritto ai contributi che hanno segnato una diminuzione di 352 unità.
Ripartizione degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo in condizioni difficili di produzione, secondo la classe di dimensioni – 2006
Nell'anno di contribuzione 2006, il 68 per cento circa dell'effettivo di UBGFG si trovava presso aziende aventi diritto ai contributi, interessate dal limite. In queste aziende la quota di UBGFG senza contributi è stata del 35 per cento.
che danno diritto ai contributiNumero52 168226 880239 580518 629 AziendeNumero2 91014 24316 23833 391
Contributi
Totale contributi1
972281
Totale contributi
615282
UBGFG per aziendaNumero17,915,914,815,5
per aziendafr.1 5945 52212 1928 423
000 fr.4 63978 648197
258
20051 000 fr. 4 49679 109198
220
Fonte: UFAG
<5 5–10 10–15 15–20 20–30 30–45 45–90 >90
Classe di dimensioni in UBGFG Aziende (in 100) Animali (in 1000) con contributi Animali (in 1000) senza contributi 100 10050500 0 Numero 50100150200250 8 40 68 103 16635 9065 3955 54 54 23 59 83 43 17 38 1 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 162
Fonte: UFAG
■ Contributi di declività generali per l’indennizzo delle condizioni difficili di gestione delle superfici
Contributi di declività
Mediante i contributi di declività generali vengono indennizzate le difficoltà connesse alla gestione delle superfici declive nelle regioni di collina e di montagna. Tali contributi sono versati soltanto per prati, terreni da strame e superfici coltive. I prati devono essere falciati almeno una volta l’anno mentre i terreni da strame ogni uno fino a tre anni. Le zone declive sono suddivise in due categorie.
Aliquote 2006fr./ha – 18–35 per cento di declività370 – oltre 35 per cento di declività510
Contributi per le superfici declive – 2006
con superfici nella regione di montagna o in quella collinare
Aziende con contributi di declività – 2006
Totale 564 331 ha
<18% 61%
Fonte: UFAG
L’entità delle superfici notificate varia leggermente di anno in anno. Ciò dipende dalle condizioni climatiche che esercitano un influsso sul tipo di gestione (estensione maggiore o minore dei pascoli o dei prati da sfalcio).
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianura 1 collinaremontagna Superfici aventi diritto ai contributi: –18–35 per cento di declivitàha4 55864 92273 650143 131 –oltre 35 per cento di declivitàha1 37718 14061 46080 976 Totaleha5 93583 062135 110224 107 AziendeNumero2 08513 48615 69731 268 Contributo per aziendafr.1 1462 4673 7313 014 Totale contributi1 000 fr.2 38933 27058 56894 227 Totale contributi 20051 000 fr.2 31733 46058 99194 768 1Aziende
Fonte: UFAG
Declività
Declività
25% Declività >35% 14%
18–35%
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 163
■ Contributi di declività per i vigneti finalizzati alla conservazione dei vigneti nelle zone in forte pendenza e terrazzate
Mediante questi contributi di declività s’intende conservare i vigneti situati nelle zone in forte pendenza e terrazzate. Per tenere in considerazione le condizioni dei vigneti degni di essere sostenuti finanziariamente, si distingue tra vigneti in pendenza e in forte pendenza da un canto e vigneti terrazzati retti da muri di sostegno dall’altro. I contributi per i vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate vengono concessi soltanto a favore delle superfici con una declività di oltre il 30 per cento. Le aliquote di contribuzione non sono in funzione delle zone.
Aliquote 2006fr./ha – superfici con una declività del 30 fino al 50%1 500 – superfici con una declività di oltre il 50%3 000 – superfici in zone terrazzate5 000
Contributi per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate – 2006
La quota di vigneti aventi diritto ai contributi in zone in forte pendenza e terrazzate rispetto alla superficie totale messa a vigna ammonta al 29 per cento circa, mentre la quota di aziende rispetto all’insieme delle aziende dedite alla viticoltura è del 49 per cento.
Innovazioni nel 2007
Con decreto datato 8 novembre 2006, in seguito alle misure di risparmio, il Consiglio federale ha disposto con effetto al 1° gennaio 2007 una riduzione di 50 franchi del contributo di superficie, il quale ammonta a 1'150 franchi. Parallelamente, al fine di attutire le ripercussioni del calo del prezzo soglia di cereali e alimenti proteici per animali è stato aumentato il contributo supplementare per i terreni coltivi aperti e le colture perenni da 400 a 450 franchi l’ettaro.
Unità Superfici aventi
ai contributi in totaleha3 727 Superfici con una pendenza dal 30 fino al 50% ha1 876 Superfici con una pendenza superiore al 50%ha344 Superfici terrazzateha1 507 Numero di aziendeNumero2 909 Superficie per aziendaha1,3 Contributo per aziendafr.3 912 Totale contributi 1 000 fr.11 380 Totale contributi 20051 000 fr.11 056 Fonte: UFAG
diritto
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 164
2.2.3Pagamenti diretti ecologici
Contributi ecologici
Mediante i contributi ecologici vengono indennizzate prestazioni ecologiche particolari che soggiacciono a condizioni più severe rispetto a quelle previste nel quadro della PER. Ai gestori vengono offerti programmi con partecipazione facoltativa. I programmi sono indipendenti gli uni dagli altri e i contributi possono venir cumulati.

■■■■■■■■■■■■■■■■
UFAG Totale 420,2 mio. fr. Compensazione ecologica 30% Produzione estensiva
URA 37% SSRA 12% Agricoltura biologica
OQE 7% 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 165
Tabelle 33a–33b, pagine A33–A34 Ripartizione dei contributi ecologici tra i vari programmi – 2006
Fonte:
7%
7%
■ Prati sfruttati in modo estensivo
Compensazione ecologica
Attraverso la compensazione ecologica s’intende conservare e se possibile ampliare nuovamente lo spazio vitale della fauna e della flora indigene nelle regioni a vocazione agricola. La compensazione ecologica contribuisce pure alla conservazione delle strutture e degli elementi paesaggistici tipici. Determinati elementi della compensazione ecologica fruiscono dei contributi e possono nel contempo venir tenuti in considerazione per la compensazione ecologica obbligatoria nel quadro della PER, mentre altri non sono computabili al fine della PER.
Elementi della compensazione ecologica con e senza contributi
Elementi computabili per la PER Elementi computabili per la PER con contributi senza contributi Prati sfruttati in modo estensivoPascoli sfruttati in modo estensivo Prati sfruttati in modo poco intensivoPascoli boschivi Terreni da strameAlberi indigeni, isolati o in viali alberati Siepi, boschetti campestri e rivieraschiFossati umidi, stagni, pozze Maggesi fioritiSuperfici ruderali, cumuli di pietra, affioramenti rocciosi Maggesi da rotazioneMuri a secco Fasce di colture estensiveSentieri e accessi naturali non consolidati Alberi da frutto ad alto fusto nei campiSuperfici viticole con elevata biodiversità
Altre superfici di compensazione ecologica sulla SAU definite dai servizi cantonali preposti alla protezione della natura
Le superfici non devono essere concimate, devono esistere per sei anni ed essere falciate al più presto tra metà giugno e metà luglio a dipendenza della zona. Lo sfalcio tardivo assicura la completa maturazione dei semi e promuove la biodiversità attraverso l’inseminazione naturale. Inoltre, invertebrati, uccelli che nidificano al suolo e mammiferi di piccola taglia dispongono di un periodo di tempo sufficiente per riprodursi.
I contributi per prati sfruttati in modo estensivo, terreni da strame, siepi, boschetti campestri e rivieraschi sono disciplinati in maniera uniforme e sono calcolati in base alla zona in cui si trova la superficie. Negli ultimi anni la quota di prati sfruttati in modo estensivo è costantemente aumentata.
Aliquote 2006fr./ha
– zona campicola e zone intermedie1 500
– zona collinare1 200
– zone di montagna I e II700
– zone di montagna III e IV450
Tabelle 34a–34d, pagine A35–A38
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 166
■ Terreni da strame
Contributi per prati sfruttati in modo estensivo – 2006
■ Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
Per terreni da strame s’intendono le superfici inerbite gestite in modo estensivo in luoghi bagnati o umidi. Il prodotto dello sfalcio, effettuato di regola in autunno o in inverno, viene utilizzato come lettiera.
Contributi per terreni da strame – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
Per siepi e boschetti campestri o rivieraschi s’intendono siepi basse, arbustive e arboree, siepi frangivento, gruppi di alberi, scarpate boscate e boschetti rivieraschi a forma di siepe. Le superfici devono essere gestite e curate correttamente per sei anni consecutivi.
Contributi per siepi nonché boschetti campestri e rivieraschi – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione
pianuracollinaremontagna AziendeNumero19 0969 94010 20539 241 Superficieha27 04811 13016 82955 007 Superficie per aziendaha1,421,121,651,40 Contributo per aziendafr.2 0731 1428681 524 Totale contributi1 000 fr.39 59511 3498 85359 797 Totale contributi 20051 000 fr.38 38110 9388 11657 434 Fonte: UFAG
di Totale
AziendeNumero1 8911 9503 1637 004 Superficieha1 8831 5403 6397 062 Superficie per aziendaha1,000,791,151,01 Contributo per aziendafr.1 459765726935 Totale contributi1 000 fr.2 7601 4922 2966 548 Totale contributi 20051 000 fr.2 7471 4852 2426 474 Fonte: UFAG
AziendeNumero5 7723 0541 29010 116 Superficieha1 4077933092 508 Superficie per aziendaha0,240,260,240,25 Contributo per aziendafr.360269159307 Totale contributi1 000 fr.2 0808212053 106 Totale contributi 20051 000 fr.2 0437982003 041 Fonte: UFAG
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 167
■
Sui prati sfruttati in modo poco intensivo è autorizzato spandere quantitativi molto limitati di letame o composta. Per la gestione si applicano le stesse prescrizioni vigenti per i prati sfruttati in modo estensivo.
Aliquote 2006fr./ha
– zona campicola fino a zona collinare650
– zone di montagna I e II450
– zone di montagna III e IV300
Contributi per prati sfruttati in modo poco intensivo – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
■
Per maggesi fioriti s’intendono le fasce pluriennali, seminate con sementi di erbe selvatiche indigene, non concimate, di almeno 3 metri di larghezza. I maggesi fioriti sono finalizzati alla protezione delle erbe selvatiche minacciate. Essi rappresentano un habitat e una fonte di nutrimento ideali anche per insetti e piccoli esseri viventi. Offrono rifugio pure a lepri ed uccelli. Per i maggesi fioriti vengono versati 3'000 franchi per ettaro. I contributi vengono applicati per superfici della zona campicola fino alla zona collinare compresa.
Contributi per maggesi fioriti – 2006
Superficieha6
Contributo
Totale contributi1 000 fr.3 9113 6106 12013 641 Totale contributi 20051 000 fr.4 2043 8086 36514 378 Fonte: UFAG
AziendeNumero6 8987 2379 42323 558
1036 53918 05130 693 Superficie per aziendaha0,880,901,921,30
per aziendafr.567499649579
Regione
pianuracollinaremontagna1 AziendeNumero2 03439232 429 Superficieha1 96033622 298 Superficie per aziendaha0,960,860,600,95 Contributo per aziendafr.2 8902 5731 8102 837 Totale contributi1 000 fr.5 8771 00956 891 Totale contributi 20051 000 fr.5 9391 013106 961
CaratteristicaUnitàRegione di Regione
di Totale
1Trattasi di aziende che gestiscono superfici nella regione collinare o di pianura
Fonte: UFAG
Prati sfruttati
intensivo
in modo poco
Maggesi fioriti 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 168
■ Maggesi da rotazione
Per maggesi da rotazione si intendono le superfici che per uno o due anni vengono seminate con sementi di erbe campicole indigene, non concimate e che misurano almeno 6 metri di larghezza e 20 are. Essi fungono da habitat ideale per uccelli che nidificano al suolo, lepri e insetti. In zone idonee è consentito anche l’inerbimento spontaneo. Per i maggesi da rotazione nella zona campicola fino alla zona collinare compresa vengono stanziati 2'500 franchi per ettaro.
Contributi per maggesi da rotazione – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna1 AziendeNumero5161011618
■ Fasce di colture estensive in campicoltura
Le fasce di colture estensive rappresentano uno spazio vitale ideale per la flora campicola collaterale. Per fasce di colture estensive in campicoltura si intendono le fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo, larghe almeno 3 e al massimo 12 metri, coltivate a cereali, colza, girasoli, piselli proteici, favette e soia ma non a granturco. In tutte le zone viene versato un contributo uniforme di 1'500 franchi l’ettaro.
Contributi per le fasce di colture estensive – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna1
AziendeNumero6024084
Superficieha327039
Superficie per aziendaha0,530,300,000,47
Contributo per aziendafr.7994570701
Totale contributi1 000 fr.4811059
Totale contributi 20051 000 fr.6710077
Superficieha6701281799 Superficie per aziendaha1,301,271,001,29 Contributo per aziendafr.3 2473 1712 5003 233 Totale contributi1 000 fr.1 67532031 998 Totale contributi 20051 000 fr.1 87535532 233
1Trattasi di
aziende che gestiscono superfici nella regione collinare o di montagna, che tuttavia gestiscono una parte delle loro superfici nella regione di pianura
Fonte: UFAG
1Trattasi di aziende che gestiscono superfici nella regione collinare o di pianura
Fonte: UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 169
■ Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Vengono concessi contributi per alberi da frutto a nocciolo e a granelli ad alto fusto che non fanno parte di frutteti nonché per i castagni e per i noci in selve curate. Vengono stanziati 15 franchi per albero notificato.
Contributi per alberi da frutto ad alto fusto nei campi – 2006 CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
■ Ricapitolazione sulle superfici di compensazione ecologica nel 2006
Maggesi da rotazione 0,8%
Fasce di colture estensive 0,0% Maggesi fioriti 2,3%
Prati sfruttati in modo poco intensivo 31,2%
Boschetti campestri e rivieraschi 2,5%
1 Esclusi gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi
Prati sfruttati in modo estensivo 55,9%
Terreni da strame 7,2%
Fonte: UFAG
Ripartizione delle superfici di compensazione ecologica per regioni – 2006
Regione di Regione Regione di pianuracollinaremontagna ha% dellaha% dellaha% della
0485,3711 1304,1716 8295,74
Prati sfruttati in modo poco intensivo6 1031,216 5392,4518 0516,16
Terreni da strame1 8830,371 5400,583 6391,24
Siepi e boschetti campestri e rivieraschi1 4070,287930,303090,11 Maggesi fioriti1 9600,393360,1320,00
Maggesi da rotazione6700,131280,0510,00
Fasce di colture estensive320,0170,0000,00 Totale39 1027,7720
AziendeNumero16 45012 3665 42334 239 Alberiha1 163 919891 132274 2092 329 260 Alberi per aziendaha70,7572,0650,5668,03 Contributo per aziendafr.1 0611 0817581 020 Totale contributi1 000 fr.17 45513 3674 11334 935 Totale contributi 20051 000 fr.17 71813 5904 11835 426 Fonte: UFAG
ElementiSAUSAUSAU Prati sfruttati
estensivo27
in modo
4747,6638 83013,24
Fonte: UFAG
Composizione delle superfici di compensazione ecologica1 2006
Totale 98 406 ha
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 170
Ordinanza sulla qualità ecologica
Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, SCE di qualità biologica superiore e l'interconnessione di SCE sulla SAU. Le esigenze che devono essere adempiute dalle superfici per poter beneficiare dei contributi giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE) sono fissate dai Cantoni. La Confederazione verifica quanto stabilito dai Cantoni sulla base di esigenze minime. Se le esigenze cantonali corrispondono alle esigenze minime della Confederazione e la partecipazione finanziaria regionale è garantita, la Confederazione accorda aiuti finanziari per i contributi versati dai Cantoni agli agricoltori. A dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, l'aiuto finanziario varia dal 70 al 90 per cento dei contributi computabili. Il 10–30 per cento rimanente deve essere corrisposto da terzi (Cantone, Comune, privati, enti). I contributi per la qualità biologica e per l'interconnessione sono cumulabili. L'ordinanza si basa su principi quali volontarietà, incentivi finanziari e considerazione delle differenze regionali per quanto riguarda la biodiversità.
Aliquote computabili
Aliquote 2006fr. – qualità biologica500.–/ha – qualità biologica degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi20.–/albero – interconnessione500.–/ha
Una SCE contribuisce a conservare e a favorire la varietà naturale delle specie se presenta determinate piante indicatrici e caratteristiche strutturali e/o se è ubicata in un luogo interessante dal profilo ecologico. Nell'ambito della qualità ecologica il singolo gestore di una SCE può annunciarsi direttamente, mentre per quanto riguarda l'interconnessione di SCE è necessario un progetto che interessi almeno un'unità agricola ed ecologica.

2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 171
Contributi1 giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica – 2006
di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
1 Riduzioni, rimborsi e pagamenti suppletivi esclusi
2 Conversione degli alberi ad alto fusto (1 albero = 1 ara) Fonte:
Contributi1 per la qualità biologica e l'interconnessione – 2006 CaratteristicaUnitàQualità
1
sfruttati in modo estensivo, prati sfruttati in modo poco intensivo, terreni da strame
AziendeNumero9 6927 8569 41226 960 Superficie 2 ha14 52912 24322 40049 172 Superficie 2 per aziendaha1,501,562,381,82 Contributo per aziendafr.9951 0861 2841 122 Totale contributi1 000 fr.9 6428 52912 08630 256 Totale contributi 20051 000 fr.8 8028 13310 50727 442
CaratteristicaUnitàRegione
UFAG
Solo
connessionelogica
2
AziendeNumero9 73212 3887 177 Superficieha12 47911 57911 190 Contributi1000 fr.4 7704 5778 646 Siepi e boschetti campestri e rivieraschi AziendeNumero5192 5061 037 Superficieha110473255 Contributi1000 fr.43209204 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi AziendeNumero3 7308 4573 719 AlberiCapi223 157288 079194 649 Contributi1000 fr.3 5971 1424 009 Altri elementi AziendeNumero-6 360Superficieha-6 027Contributi1000 fr.-3 068-
inter-Qualità biobiologica
e interconnessione
Prati
Riduzioni,
rimborsi e pagamenti suppletivi esclusi 2 Programmi unificati Fonte: UFAG
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 172
Tabella 35, pagina A39
compensazione ecologica
l’OQE (compr. gli alberi ad alto fusto) 0 1–5 6–10 11–20 >20 Estivazione in % della SAU
Superfici di
con qualità giusta
Valori per Comune
Fonte: UFAG GG25 ©swisstopo
gli alberi ad alto fusto) 0 1–5 6–10 11–20 >20 Estivazione in % della SAU
Superfici di compensazione ecologica con interconnessione giusta l’OQE (compr.
Valori per Comune 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 173
Fonte: UFAG GG25 ©Swisstopo
Produzione estensiva di cereali e colza
Mediante questo provvedimento s’intende promuovere la coltivazione di cereali e colza senza ricorrere a regolatori della crescita, fungicidi, stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali e insetticidi. Il contributo per ettaro ammonta a 400 franchi.
Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza – 2006

di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna AziendeNumero9 9535 79866316 414 Superficieha54 81421 5341 72578 074 Superficie per aziendaha5,513,712,604,76 Contributo per aziendafr.2 1911 4831 0411 894 Totale contributi1 000 fr.21 8068 59969031 094 Totale contributi 20051 000 fr.22 0498 71175631 516 Fonte: UFAG Composizione della superficie estensiva – 2006 Cereali panificabili 53% Colza 6% Cereali da foraggio 41% Fonte: UFAG Totale 78 074 ha
CaratteristicaUnitàRegione
174 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2
Tabella 36, pagina A40
Agricoltura biologica
A complemento del maggior ricavo che può essere ottenuto sul mercato, la Confederazione promuove l’agricoltura biologica come forma di produzione particolarmente rispettosa dell’ambiente. Per poter beneficiare dei contributi i gestori devono rispettare, sull’insieme delle superfici dell’azienda, le esigenze dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Vi sono eccezioni relative alla gestione sull’intero territorio aziendale per quanto riguarda la viticoltura e la frutticoltura.
Gli agricoltori rinunciano totalmente all'utilizzo di materie ausiliarie ottenute mediante sintesi chimica come concimi commerciali o pesticidi. Ciò consente di risparmiare energia e di proteggere l'acqua, l'aria e il suolo. Per l’agricoltore è quindi particolarmente importante tenere in considerazione i cicli e i processi naturali. Questo metodo di coltivazione risulta essere più efficiente per quanto riguarda la gestione delle risorse disponibili. Ciò è un indicatore importante della sostenibilità del sistema di produzione. La rinuncia all'uso di erbicidi favorisce lo sviluppo di un gran numero di erbe accessorie. Una flora ricca è fonte di nutrimento per un numero maggiore di piccoli esseri viventi. Ciò contribuisce a migliorare la «dieta» dei vertebrati predatori come il carabide e crea i presupposti per una lotta naturale contro gli organismi nocivi. La presenza massiccia di vegetali, animali e microrganismi irrobustisce l'ecosistema.
Grazie a concimi organici, metodi di gestione rispettosi del suolo e alla rinuncia a prodotti fitosanitari l'agricoltura biologica favorisce la diffusione e la varietà degli organismi presenti nel suolo. L'attività biologica influisce positivamente sulla fertilità del suolo. Aumenta il tenore in humus, migliora la struttura del suolo e diminuisce il rischio d'erosione.
Per raggiungere un equilibrio ottimale fra piante, suolo, animali e uomo all'interno dell'azienda, nell'agricoltura biologica ci si premura che i cicli di nutrienti siano chiusi. Ciò è possibile vincolando l'allevamento di animali alla base foraggiera propria dell'azienda. La coltivazione di leguminose aumenta il tenore di azoto nel suolo. I concimi aziendali e il materiale organico risultante dalla semina a sovescio e dal raccolto garantiscono un adeguato approvvigionamento delle piante in nutrienti, grazie anche all'operato dei microrganismi presenti nel suolo.
Nel settore dell'allevamento di bestiame da reddito devono essere adempiute le esigenze URA. Esse rappresentano le esigenze minime per la detenzione di animali nel quadro dell'agricoltura biologica. È pure vietato l’impiego a scopo preventivo di alimenti medicati per animali. Il fatto che venga utilizzato prevalentemente foraggio prodotto nell'azienda garantisce una produttività adeguata e il benessere degli animali. In caso di necessità viene data la preferenza a metodi terapeutici naturali.
Nel 2006 l’agricoltura biologica veniva praticata sul 10,9 per cento dell’intera SAU.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 175
per l’agricoltura biologica – 2006
Quota della superficie gestita biologicamente, per regione – 2006

Aliquote 2006fr./ha – colture speciali1 200 – superficie coltiva
speciali800 – superfici inerbite e
strame200
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna AziendeNumero1 1911 4243 6456 260 Superficieha21 93523 75170 017115 703 Superficie per aziendaha18,4216,6819,2118,48 Contributo per aziendafr.7 4564 0723 8394 580 Totale contributi1 000 fr.8 8805 79913 99328 672 Totale contributi 20051 000 fr.8 7285 86914 00428 601 Fonte: UFAG
aperta senza colture
terreni da
Contributi
Tabella 33a, pagina A33
Regione di pianura 19% Regione di montagna 60% Fonte: UFAG Totale 115 703 ha Regione collinare 21% 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 176
■ Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA)
Detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze
In questo ambito rientrano i programmi SSRA e URA illustrati di seguito (cfr. pure la parte 1.3.2).
Viene promossa la detenzione di animali in sistemi di stabulazione che rispondono a requisiti il cui livello è di gran lunga superiore a quanto prescritto dalla legislazione in materia di protezione degli animali.
Aliquote
– animali della specie bovina senza vitelli, capre, conigli90 – suini155 – ovaiole, pollastrelle e galletti, galline e galli da allevamento, pulcini280 – polli da ingrasso e tacchini180
Contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) – 2006
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna
■ Uscita regolare all’aperto (URA)
Viene promossa l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito. Per uscita regolare all’aperto si intende l’uscita al pascolo, in un parchetto all’aperto o in uno spazio esterno coperto che risponde alle esigenze degli animali ai sensi dell’ordinanza URA.
–animali delle specie bovina ed equina, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli180
2006fr./UBG
AziendeNumero8 7755 7223 84318 340 UBGNumero250 779129 31964 931445 028 UBG per aziendaNumero28,5822,6016,9024,27 Contributo per aziendafr.3 2312 5721 7382 713 Totale contributi1 000 fr.28 35014 7186 68149 749 Totale contributi 20051 000 fr.26 91913 9846 18647 089 Fonte: UFAG
Aliquote 2006fr./UBG
–suini155 –pollame280
Tabella 37, pagina A41
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 177
■ Gestione sostenibile delle regioni d'estivazione
Contributi per l’uscita regolare all’aperto (URA) – 2006
Contributi d’estivazione
Mediante i contributi d’estivazione s’intende garantire la gestione e la cura dei vasti pascoli d’estivazione nelle Alpi, nelle Prealpi e nel Giura. La regione d’estivazione viene gestita e curata con circa 300'000 UBG. Il carico di bestiame viene definito secondo i principi di una gestione sostenibile. Si parla del cosiddetto carico usuale. Partendo dal carico usuale, i contributi vengono versati in base al carico normale (CN). Per CN si intende l’estivazione di una UBG durante 100 giorni.
Aliquote 2006fr. –per UBG di vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere (estivazione di 56–100 giorni)300 –per CN di ovini, eccettuate le pecore lattifere – in caso di sorveglianza permanente300 – per pascoli da rotazione 220 – per altri pascoli120 –per CN di altri animali che consumano foraggio grezzo300
Contributi d’estivazione – 2006
CaratteristicaContributiAziendeUBG o CN 1 000 fr.NumeroNumero Vacche, capre lattifere e pecore lattifere15 8952 07453 036 Ovini , eccettuate le pecore lattifere4 96795524 535
Altri animali che consumano foraggio
grezzo70 8336 724236 300
Totale91 6967 336 1
Totale 200591 6107 387 1
1Questa cifra indica il totale delle aziende d’estivazione aventi diritto a contributi (senza doppi versamenti)
Fonte: UFAG
CaratteristicaUnitàRegione di Regione Regione di Totale pianuracollinaremontagna AziendeNumero13 99811 23112 77138 000 UBGNumero375 682263 353235 204874 239 UBG per aziendaNumero26,8423,4518,4223,01 Contributo per aziendafr.4 6524 1253 2934 039 Totale contributi1 000 fr.65 11246 33342 053153 498 Totale contributi 20051 000 fr.62 78145 11640 781148 678 Fonte: UFAG
Tabella 39, pagina A43
2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 178
Tabelle 40a–40b, pagine A44–A45
Dal 2003 vengono stanziati contributi d’estivazione per ovini (escluse le pecore lattifere) in maniera differenziata a seconda del sistema di pascolo. Con contributi più elevati per pascoli da rotazione e sorveglianza permanente vengono indennizzati i costi maggiori, da un lato, e dall’altro, analogamente ai contributi ecologici, viene incentivata un’estivazione sostenibile del bestiame ovino. Vi è una sorveglianza permanente se la conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto giornalmente ai luoghi di pascolo stabiliti dal pastore stesso. Vi è un pascolo da rotazione se il pascolo avviene, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.
Estivazione di ovini secondo il sistema di pascolo – 2006
Evoluzione dell’estivazione 2000–2006: aziende, animali estivati in carichi normali, per categoria di animali
Sistema di pascoloAziendeAnimali con Contributi contributi NumeroCN1 000 fr. Sorveglianza permanente947 8512 340 Pascoli da rotazione1985 1951 139 Altri pascoli64210 3651 243 Combinazione di sistemi di pascolo211 124245 Totale95524 5354 967 Totale 200597524 6444 847 Fonte: UFAG
Anno2000200120022003200420052006 Categoria di animaliUnità Vacche Aziende4 9614 7124 6004 4904 3534 3014 259 lattifereCarichi 118 793118 021116 900116 679111 123112 858110 070 Vacche madri Aziende1 2801 1601 2271 3541 4341 5121 592 e nutriciCarichi13 85414 48615 71517 94918 90421 22722 662 AltrobestiameAziende6 6846 4536 5036 4256 3586 3196 332 bovinoCarichi 134 457129 217127 946126 910121 169120 421118 060 Animali della Aziende1 1321 0861 0751 0841 0631 0791 056 specie equinaCarichi4 6524 3154 3644 3404 3474 5154 558 OviniAziende1 1731 1451 1041 1501 1111 0761 053 Carichi29 67826 17224 71026 63325 81326 85626 086 CapriniAziende1 7001 6231 6671 6691 6571 6481 615 Carichi5 1655 2145 4345 6625 6645 9775 857 Altri animali Aziende22289277241240236225 estivati Carichi60899764735541496497 1 carico = 1 UBG * durata / 100 Fonte: UFAG 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 179
Contributi per la protezione delle acque
Fin dal 1999 mediante l’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque la Confederazione può promuovere i provvedimenti presi dal settore agricolo per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze nelle acque superficiali e sotterranee. Il gruppo di lavoro Nitrato della Confederazione si occupa dell’attuazione a livello nazionale. Il gruppo di lavoro è diretto dall’UFAG. Oltre all’UFAG, del gruppo di lavoro fanno parte rappresentanti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Conferenza dei direttori degli uffici per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CDA), della Conferenza degli uffici dell’agricoltura della Svizzera (KOLAS) e della centrale di consulenza AGRIDEA. L’accento del programma è posto sulla riduzione del carico di nitrato nell’acqua potabile e del carico di fosforo nelle acque superficiali in regioni nelle quali la PER, l’agricoltura biologica, divieti e precetti nonché i programmi facoltativi promossi dalla Confederazione (produzione estensiva, compensazione ecologica) non sono sufficienti.
Nel 2006 erano in corso d’attuazione 22 progetti: 18 progetti relativi ai nitrati, 3 relativi al fosforo e 1 progetto sui prodotti fitosanitari. I 3 progetti relativi al fosforo attuati nel laghi dell’Altipiano e 4 progetti relativi ai nitrati sono nella seconda fase di progetto. Sono in corso di allestimento circa 13 nuovi progetti, tra cui 1 progetto sui prodotti fitosanitari nel Cantone di Ginevra.
In virtù dell’ordinanza sulla protezione delle acque, i Cantoni sono tenuti a designare un settore d’alimentazione per le captazioni di acque superficiali e sotterranee nonché a ordinare provvedimenti di risanamento qualora la qualità dell’acqua fosse insufficiente. Questi provvedimenti possono comportare limitazioni significative rispetto allo stato della tecnica per quanto concerne l’utilizzazione del suolo nonché perdite finanziarie insopportabili per le aziende. I contributi ai costi concessi dalla Confederazione ammontano all’80 per cento per gli adeguamenti strutturali e al 50 per cento per i provvedimenti di gestione.
Nel 2006 sono stati stanziati circa 6,3 milioni di franchi.

2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 180
■ Prevenzione del convogliamento e del dilavamento di sostanze
Ricapitolazione dei progetti – 2006
Durata prevista SostanzaComprensorio Totale costi Contributi Comunedel progettodel progettoprevisti2006
CantoneRegione,
Annohafr.fr. AGBaldingen2004–2009Nitrati69281 40024 797 AGBirrfeld2002–2007Nitrati8131 909 500162 837 AGWohlenschwil2001–2009Nitrati62547 69652 249 FRAvry-sur-Matran2000–2011 1 Nitrati37405 73927 133 FRCourgevaux2003–2008Nitrati27164 83818 516 FRDomdidier2004–2009Nitrati30195 58825 413 FRFétigny2004–2009Nitrati631 526 110106 612 FRLurtigen2005–2010Nitrati2861 218 964417 818 FRMiddes2000–2012 1 Nitrati45369 85323 543 FRSalvenach2005 2 Nitrati13.5202 334161 868 LULago di Baldegg2000–2010 1 Fosforo5 60018 800 7821 597 274 LULago di Sempach2005–2010 1 Fosforo4 90517 577 4551 377 540 LU/AGLago di Hallwil2001–2006 1 Fosforo3 7864 283 732981 202 SHKlettgau2001–2007Nitrati3571 866 870186 437 SOGäu I2000–2008 1 Nitrati6582 220 050200 769 SOGäu II2003–2008Nitrati8501 217 040149 556 VDBavois2005–2010Nitrati5178 98518 109 VDBofflens2005–2010Nitrati112580 10073 246 VDBoiron / Morges2005–2010Prodotti fitosanitari2 2501 313 100258 106 VDMorand / Montricher2000–2007Nitrati3911 572 848348 893 VDThierrens1999–2011 1 Nitrati17333 57022 113 ZHBaltenswil2000–2008 1 Nitrati e prodotti 130712 00035 511 fitosanitari Totale 57 478 5546 269 542 Totale 2005 6 152 390 1 Proroghe decretate 2 Progetto nel quadro di un raggruppamento terreni con contributo unico Fonte: UFAG 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2 181
Progetto Chrummenlanden, Klettgau Ct. SH
Il progetto relativo ai nitrati Chrummenlanden nel Cantone di Sciaffusa è stato lanciato nel 2001. Interessa 520 ettari con un totale di 357 ettari di SAU. I valori relativi ai nitrati all’inizio del progetto superavano i 40 mg/l. Passando dalla campicoltura ai prati sfruttati in modo estensivo e ai maggesi fioriti, impiantando fasce tampone, lavorando il terreno senza aratura e attuando altre misure è stata raggiunto, e superato, l’obiettivo intermedio di una riduzione a 35 mg/l. Le precipitazioni in parte forti e continuate del 2006 hanno determinato un maggior dilavamento di nitrati, come chiaramente evidenziato dall’andamento della curva relativa ai nitrati. Tuttavia, alla fine del 2006 nella captazione della falda freatica Chrummenlanden il valore relativo ai nitrati si aggirava attorno a 26 mg/l!
Nel 2007 inizia la seconda fase di progetto. L’obiettivo è di raggiungere entro il 2012 un valore permanentemente al di sotto del valore fissato ai sensi dell’ordinanza sulla protezione delle acque pari a 25 mg di nitrato per litro di acqua potabile.
Andamento della curva relativa ai nitrati del progetto Chrummenlanden da marzo 2001 a dicembre 2006
NO 3 mg/l Sorgente di Widen Pompa Chrummenlanden Captazione della
Inizio pompaggio
Ufficio dell’agricoltura del Canton Sciaffusa 75 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Apr.01 Lugl.01 Ott.01 Gen..02 Apr.02 Lugl.02 Ott.02 Gen.03 Apr.03 Lugl.03 Ott.03 Gen.04 Apr.04 Lugl.04 Ott.04 Gen.05 Apr.05 Lugl.05 Ott.05 Gen.06 Apr.06 Lugl.06 Ott.06 Gen.01 182 2.2 PAGAMENTI DIRETTI 2
falda freatica Neukirch Muzzel
Fonte:
2.3Miglioramento delle basi
Mediante i provvedimenti denominati «Miglioramento delle basi» viene promossa e sostenuta la produzione di derrate alimentari rispettosa dell’ambiente ed efficiente nonché incoraggiato lo svolgimento dei compiti multifunzionali.
Aiuti finanziari per il miglioramento delle basi
Provvedimento200520062007 mio. fr.
Contributi per i miglioramenti strutturali85107 1 107 1
Crediti di investimento686966
Aiuti per la conduzione aziendale226
Aiuti per la riqualificazione0,10,22
Consulenza e contributi per la ricerca242323
Lotta alle malattie delle piante e agli organismi nocivi323

Produzione vegetale e allevamento232223
Totale205,1225,2230
1Risanamento dei danni provocati dal maltempo 2005 incluso
Gli obiettivi dei provvedimenti nel campo del miglioramento delle basi sono: –rafforzamento della competitività attraverso la riduzione dei costi di produzione; –promozione sostenibile delle aree rurali; –strutture aziendali moderne e superfici agricole utili ben accessibili; –produzione efficiente e rispettosa dell’ambiente; –varietà possibilmente resistenti e ad alto rendimento nonché prodotti di alta qualità; –protezione della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente; –diversità genetica.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fonte: UFAG
183 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
2.3.1Miglioramenti strutturali e misure sociali collaterali
Miglioramenti strutturali
I provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali consentono di migliorare le condizioni di vita ed economiche nelle aree rurali. Ciò riguarda in particolare la regione di montagna e le regioni periferiche. Il raggiungimento degli obiettivi ecologici, di protezione degli animali e di pianificazione del territorio, quali la rinaturalizzazione dei piccoli corsi d’acqua, l’interconnessione di biotopi e lo sviluppo di sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, consente di tutelare gli interessi della collettività.
Gli aiuti agli investimenti sostengono le infrastrutture agricole e rendono possibile l’adeguamento delle aziende ai cambiamenti delle condizioni quadro. Mediante la riduzione dei costi di produzione e la promozione dello sviluppo ecologico viene migliorata la competitività di un’agricoltura dedita alla produzione sostenibile. Anche in altri Paesi, in particolare nell’UE, gli aiuti agli investimenti rientrano tra i principali provvedimenti volti a promuovere le aree rurali.

Gli aiuti agli investimenti vengono concessi quali incentivi all’autosostegno a favore di provvedimenti individuali o collettivi. Sono disponibili due strumenti: –contributi (a fondo perso) con partecipazione dei Cantoni, prevalentemente per provvedimenti collettivi; –crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interessi, prevalentemente per provvedimenti individuali.
Parole come zone a scarso potenziale, maggese alpino, spopolamento progressivo, mutamento strutturale o scomparsa del servizio pubblico caratterizzano il dibattito sul futuro delle aree rurali. Nelle regioni periferiche in particolare, l’agricoltura e la selvicoltura costituiscono, insieme all’artigianato e al turismo, i pilastri dell’attività economica. Per poter affrontare le sfide future è indispensabile che una maggiore cooperazione fra questi settori sia considerata prioritaria. Integrando i diversi ambiti è possibile migliorare il potenziale di creazione di valore aggiunto disponibile e sviluppare nuovi campi di attività. I vari strumenti di politica agricola sostengono gli sforzi profusi in questo senso con gli incentivi all’autosostegno.
Dal primo gennaio 2007 è possibile promuovere tramite contributi i progetti per lo sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali che coinvolgono prevalentemente il primario. Tali progetti prevedono provvedimenti per creare un valore aggiunto nell’agricoltura e mirano a rafforzare la cooperazione intersettoriale fra l’agricoltura e i settori vicini, segnatamente l’artigianato, il turismo, l’economia del legno e la selvicoltura. I progetti in questione possono anche comportare provvedimenti basati su aspetti di natura ecologica, sociale o culturale per la realizzazione di interessi pubblici. I provvedimenti devono essere armonizzati nel quadro di una strategia globale e coordinati con lo sviluppo regionale e la pianificazione del territorio. Le esperienze acquisite dal 2004 nell’ambito dei due progetti pilota nei Cantoni Ticino (Brontallo) e Vallese (Val d’Hérens) hanno fornito indicazioni fondamentali per
■■■■■■■■■■■■■■■■■
184 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Nuovi impulsi per le aree rurali
■ Mezzi finanziari per i contributi
l’elaborazione delle disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (OMSt; RS 913.1) entrate in vigore nel 2007. In futuro, per i progetti a carattere regionale sarà possibile concedere contributi a favore dell’accompagnamento specializzato (coaching) dall’idea fino alla fase di realizzazione del progetto, nel quadro di un accertamento preliminare (maggiori informazioni sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Sviluppo delle aree rurali).
Nel 2006 per le bonifiche fondiarie, le costruzioni agricole e il risanamento dei danni causati dal maltempo nel 2005 sono stati erogati contributi per un totale di 107,5 milioni di franchi. L’UFAG ha approvato nuovi progetti con contributi federali per un importo complessivo di 111,4 milioni di franchi. Il volume degli investimenti è stato di 421 milioni di franchi. L’ammontare dei contributi federali relativi ai progetti approvati non è identico all’importo iscritto nella rubrica del preventivo «Miglioramenti strutturali agricoli», in quanto l’assicurazione di un contributo e il relativo versamento avvengono soltanto eccezionalmente nello stesso anno. Per un progetto approvato viene spesso assicurata soltanto una tranche di credito.
Costruzione di strade agricole
Acquedotti
Danni alluvionali e altri provvedimenti del genio civile
Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo
Altri provvedimenti nel settore delle costruzioni rurali
L’ammontare dei contributi federali versati nel 2006 è stato del 25 per cento superiore all’anno precedente. Tale aumento dei fondi è riconducibile alla necessità di ripristinare i danni provocati dal maltempo nel 2005.
Contributi
Ricomposizioni particellari (compr. le infrastrutture)
Tabelle 44–45, pagina A52
della Confederazione – 2006
mio. fr. Regione di pianura Regione collinare Regione di montagna 0515102035 30 25404550 Fonte: UFAG 17,0 13,5 9,2 44,8 26,5 0,5 69% 10% 21% 185 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2
Contributi della Confederazione alle bonifiche fondarie e agli edifici rurali 1997–2006
Nel 2006 i Cantoni hanno concesso crediti d’investimento per un ammontare complessivo di 282,9 milioni di franchi da destinare a 1'963 casi. L’82,9 per cento di tale importo è stato riservato al finanziamento di provvedimenti individuali mentre il 17,1 per cento al sostegno di provvedimenti collettivi. A favore dei progetti collettivi nella regione di montagna possono venir concessi anche crediti di transizione, ossia crediti di costruzione con una decorrenza di tre anni al massimo.
I crediti per i provvedimenti individuali hanno riguardato principalmente l’aiuto iniziale così come la costruzione e la trasformazione di edifici d’abitazione nonché di edifici rurali. Vengono rimborsati mediamente sull’arco di 13,6 anni. Per i provvedimenti di diversificazione sono stati concessi 2,6 milioni di franchi da destinare a 31 casi.
Nel settore dei provvedimenti collettivi sono stati sostenuti finanziariamente soprattutto bonifiche fondiarie, acquisto in comune di macchine e veicoli nonché provvedimenti nel settore edile (edifici ed installazioni per l’economia lattiera nonché per la lavorazione, lo stoccaggio e lo smercio di prodotti agricoli).
Nel 2006 la Confederazione ha assegnato ai Cantoni nuovi mezzi finanziari pari a 68,5 milioni di franchi. Essi, unitamente agli importi costantemente rimborsati, vengono utilizzati per la concessione di nuovi crediti. Il Fonds de roulement, istituito nel 1963, comprende 2,15 miliardi di franchi.
Crediti d’investimento 2006 CasiImportoQuota Numeromio. fr.% Provvedimenti individuali1 783234,582,9 Provvedimenti collettivi, crediti di costruzione esclusi12917,76,3 Crediti di costruzione5130,710,8 Totale1 963282,9100
UFAG
Fonte:
■ Mezzi finanziari per i crediti d’investimento
1990/92199719981999200020012002200320042006 2005 mio. fr. Fonte: UFAG 0 20 40 60 80 100 120 140 119827575871029010294,5107,5 85
186 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Tabelle 46–47, pagine A53–A54
Crediti
1

d'investimento
categorie di provvedimenti, crediti di costruzione
– 2006 Aiuto iniziale Acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario Provvedimenti collettivi 1 Diversificazione Edifici d'abitazione Edifici rurali mio. fr. Regione di pianura Regione collinare Regione di montagna 78,7 020406080100120 4,9 Bonifiche fondiarie 2,7 15,0 2,6 46,3 102,1 Fonte: UFAG
secondo le
esclusi
26% 47% 27% 187 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Acquisto in comune dell'inventario, aiuto iniziale per le organizzazioni contadine di solidarietà, lavorazione e stoccaggio di prodotti agricoli
■ Aiuti per la conduzione aziendale
Misure sociali collaterali
Gli aiuti per la conduzione aziendale sono concessi sotto forma di mutui esenti da interessi e servono ad evitare o a far fronte a ristrettezze finanziarie temporanee non imputabili al gestore. Gli effetti degli aiuti per la conduzione aziendale corrispondono a quelli dello sdebitamento indiretto della singola azienda.
Nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale nel 2006 sono stati concessi mutui per un importo totale di circa 18,3 milioni di franchi a favore di 141 casi. L’importo del mutuo medio è stato di 130'521 franchi e viene rimborsato in 13,6 anni.
Mutui nel quadro dell’aiuto per la conduzione aziendale – 2006
DisposizioneCasiImporto Numeromio. fr.
Rifinanziamento di debiti esistenti10014,8 Superamento di una difficoltà finanziaria eccezionale413,6
Totale14118,4
Fonte: UFAG
Nel 2006 ai Cantoni sono stati assegnati 2,25 milioni di franchi. Tali fondi sono vincolati a una prestazione adeguata da parte del Cantone che a dipendenza della sua capacità finanziaria varia dal 20 all’80 per cento della quota federale. I nuovi mezzi finanziari della Confederazione e dei Cantoni, unitamente agli importi costantemente rimborsati, vengono utilizzati per concedere nuovi mutui. Il Fonds de roulement, istituito nel 1963 con nuovi mezzi finanziari della Confederazione e importi rimborsati, ammonta, unitamente alle quote dei Cantoni, a 209 milioni di franchi circa.
■ Aiuti per la riqualificazione
Gli aiuti per la riqualificazione agevolano la conversione ad una professione non agricola delle persone indipendenti attive nel settore primario. Tale misura comprende contributi ai costi di riqualificazione e di sostentamento per capiazienda che non hanno ancora compiuto il 52esimo anno di età. La concessione di un aiuto per la riqualificazione presuppone l’abbandono dell’azienda agricola. Nel 2006 sono stati prospettati complessivamente 808'861 franchi da destinare a 7 casi. Queste sette aziende sono state affittate a lungo termine. La durata della riqualificazione varia, a seconda della formazione, da 1 a 3 anni. Nell’insieme, sono stati versati 222'350 franchi degli aiuti per la riqualificazione assicurati l’anno precedente, a sette richiedenti.
188 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■
Esperienze relative al maltempo 2005
Le forti alluvioni verificatesi tra il 21 e il 23 agosto 2005 hanno provocato danni ingenti in 17 Cantoni per un totale di 3 miliardi di franchi. Oltre ai danni assicurati nel settore privato, nel settore pubblico si sono registrati sinistri per più di 500 milioni di franchi, di cui 72 milioni destinati ai lavori di ripristino nel settore dell’agricoltura eseguiti prevalentemente sulle infrastrutture e finanziati mediante i contributi federali per gli anni 2005, 2006 e 2007 pari a 42 milioni di franchi.
Questo evento ha dato origine a vari progetti da attuare in tempi brevi. Nonostante dopo un tale avvenimento regni il caos, è innanzitutto necessario procedere al ripristino dei danni alluvionali in loco. Occorre inoltre rivolgersi a esperti con conoscenze specifiche riguardanti le condizioni locali. Appena possibile, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a fornire ai servizi interessati le informazioni concernenti il rilevamento dei danni, la procedura, il diritto ai contributi e i contributi di sostegno.
I progetti di ripristino a seguito dei danni provocati dal maltempo devono tenere debitamente conto di tutti gli interessi, ovvero di quelli dell’agricoltura e dell’economia alpestre, del fabbisogno di spazio dei corsi d’acqua, della protezione contro le piene o della protezione delle zone golenali. Occorre occuparsi tempestivamente dei corapporti a livello cantonale e federale, degli oneri pubblici e della loro pubblicazione nonché di un eventuale esame dell’impatto sull’ambiente. Nelle situazioni di conflitto la molteplicità di interessi può causare ritardi. Per questo motivo, dev’essere elaborato un progetto che sappia raccogliere il necessario consenso. Per quel che concerne il finanziamento si deve procedere in modo pragmatico, decidendo in modo tempestivo e lineare riguardo alla competenza dei vari settori specifici per i contributi pubblici. Se necessario i progetti devono essere chiaramente ripartiti.
Il ripristino delle strade agricole figura raramente nella lista delle priorità, dal momento che per prima cosa è necessario ristabilire i collegamenti sugli assi principali (strade cantonali e linee ferroviarie) nonché ricostruire gli insediamenti colpiti. Risulta d’altronde impossibile occuparsi di tutto allo stesso tempo. Le decisioni in materia di coordinamento dei lavori spettano al Cantone. Un sopralluogo destinato a tutti gli interessati (organizzazioni pubbliche e private, comuni, Cantone e Confederazione) ed effettuato in tempo utile consente di risparmiare tempo per la pianificazione e la realizzazione dei progetti. La fase di costruzione è tra l’altro determinante per l’avvio di nuovi provvedimenti. Autorizzando l’inizio anticipato dei lavori è possibile privilegiare il rapido ripristino della funzionalità degli impianti.

2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 189 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Molteplicità di interessi
■ Gestione moderna dei rischi

Le opere di ripristino a seguito dei danni alluvionali devono osservare i principi della gestione moderna dei rischi. Prima di prendere provvedimenti di ricostruzione onerosi, è necessario determinare con chiarezza l’origine dei danni e cercare di arrivare a una soluzione adeguata a lungo termine. Devono essere inoltre valutate le conseguenze che un altro evento di questo tipo potrebbe avere. Un regolamento collaterale di utilizzazione in materia di pianificazione del territorio e una gestione che riduca i rischi permettono già di prevenire un certo numero di danni. Le misure di protezione d’oggetto e le arginature non rappresentano l’unica soluzione possibile. I progetti di ampliamento in vista di una maggiore sicurezza non devono inoltre essere considerati un tabù. Poiché l’esame e la concretizzazione dei principi della gestione moderna dei rischi necessitano di tempo, dovrebbero essere stanziati crediti pluriennali per la gestione dei danni, nell’interesse di una soluzione durevole.
Gli strumenti a disposizione, come le ricomposizioni particellari o le migliorie integrali, aiutano a trovare soluzioni adeguate e permettono già oggi di applicare le misure legate alla gestione integrale dei rischi, come ad esempio l’approntamento di terreni per l’edificazione di opere di protezione, gli ampliamenti dei corsi d’acqua o le aree d’inondazione.
190 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Migliore utilizzazione degli edifici
Revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio: nuove opportunità per l’agricoltura
La «piccola» revisione della legge sulla pianificazione del territorio attuata dal Parlamento accresce le possibilità di sfruttamento degli edifici esistenti al di fuori delle zone edificabili e l’importanza delle attività accessorie non agricole nelle aziende. A determinate condizioni, possono essere approvate nuove forme di aziende accessorie in cui può essere impiegato personale specializzato, sono possibili ampliamenti modesti degli edifici e possono essere costruiti impianti conformi alla zona per la produzione di energia dalla biomassa.
Tenuto conto dei forti cambiamenti strutturali cui è confrontata l’agricoltura, le esperienze fatte con il diritto pianificatorio in vigore dal 2000 hanno messo in evidenza diverse lacune in questo settore. Per questo motivo, il Consiglio federale ha elaborato un messaggio con lo scopo di realizzare quanto prima le modifiche urgenti, nell’interesse dell’agricoltura. Nel contempo, si tiene anche conto del fatto che la realtà sociale ha subito profonde modifiche. Per prima cosa si tratta di migliorare lo sfruttamento degli edifici esistenti al di fuori della zona edificabile. Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha licenziato le modifiche di legge, entrate successivamente in vigore a metà 2007, trascorso il termine di referendum.
■ Riconoscimento delle attività non agricole
Le attività non agricole che hanno un legame materiale stretto con l’attività agricola vengono privilegiate rispetto al diritto vigente. Tra queste figurano offerte quali «dormire sulla paglia», i pernottamenti nella fattoria o le offerte socio-terapeutiche in cui la vita nella fattoria è un elemento centrale della terapia.
Per quel che riguarda il riconoscimento di tali attività sono introdotti i seguenti miglioramenti:
–l’avvio di questo genere di attività accessorie è possibile anche per le aziende agricole la cui esistenza non dipende da un reddito supplementare;
–nei casi in cui non vi è sufficiente spazio per esercitare l’attività accessoria sono permessi anche ampliamenti moderati dell’infrastruttura;
–può essere assunto personale impiegato esclusivamente nell’azienda accessoria, per quanto il lavoro prestato in questo settore sia comunque svolto principalmente dalla famiglia responsabile della gestione dell’azienda agricola.
Per evitare distorsioni della concorrenza, le aziende accessorie non agricole devono soddisfare le stesse esigenze legali e le stesse condizioni quadro applicate alle aziende commerciali equivalenti situate nelle zone edificabili.
191 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Maggiori possibilità di sfruttamento
A determinate condizioni, anche gli edifici e gli impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa possono essere considerati conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura nonché con l’azienda del luogo.
È possibile sfruttare meglio gli edifici esistenti non più utilizzati per l’agricoltura per scopi abitativi non agricoli o per la tenuta di animali a scopo di hobby e rispettosa della specie.
Nei casi in cui le modifiche proposte dovessero entrare in conflitto con le concezioni globali di pianificazione territoriale dei Cantoni, questi ultimi sono autorizzati a emanare disposizioni limitative in materia di costruzioni nelle zone non edificabili.
192 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
2.3.2 Sistema delle conoscenze agricole
Il sistema delle conoscenze agricole comprende tutti gli attori coinvolti nel processo di sviluppo, divulgazione e applicazione delle conoscenze nel settore agricolo. Trattasi, in particolare, di tutte le istituzioni nei campi di ricerca, formazione professionale e consulenza. Anche associazioni, organizzazioni di categoria, stampa specializzata ed imprese private svolgono un ruolo essenziale in questo sistema. Non meno importante la funzione dei contadini stessi con le loro cognizioni tecniche. Anche l’esperienza assume una valenza particolare in quanto permette di far buon uso di conoscenze prettamente scientifiche applicandole nella pratica in maniera efficace e proficua. Basi scientifiche ed esperienza non derivano da un’unica fonte e non confluiscono nemmeno in un unico campo d’applicazione, bensì creano una rete di sinergie tra i vari attori del sistema delle conoscenze.
In Svizzera ricerca agronomica, formazione professionale e consulenza sono in gran parte finanziate pubblicamente. Pertanto le conoscenze, per quanto possibile, devono coprire un ampio spettro d’applicazione ed avere la massima efficacia.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
193 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Ricerca
Agroscope con le tre stazioni di ricerca, Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Agroscope Liebefeld-Posieux ALP e Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, è il centro di competenze per la ricerca e lo sviluppo dell’UFAG. Oltre ad attività prettamente di ricerca, Agroscope svolge mandati esecutivi e di controllo onde garantire in Svizzera la produzione di derrate alimentari sicure e di alta qualità. Ricerca ed esecuzione sono al servizio di una svariata clientela, che non comprende soltanto il settore primario, bensì anche quelli a monte e a valle, l’industria di trasformazione, i consumatori e, considerati i beni pubblici prodotti dall’agricoltura, l’intera società.
Per concetto di ricerca s’intende l’impostazione strategica. I documenti elaborati a questo proposito servono ad informare gli attori interessati e coinvolti nonché a sostenere il coordinamento della ricerca; rappresentano, quindi, uno strumento di pianificazione e legittimazione delle attività di ricerca. Nel quadro del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2008–2011, l’UFAG è stato incaricato di elaborare un concetto di ricerca per l’agricoltura. Si tratta, in pratica, del concetto di ricerca di Agroscope per il triennio 2008–2011, in cui vengono fissati gli obiettivi strategici. Il documento è stato elaborato in collaborazione con il Consiglio di ricerca agronomica e Agroscope, sulla scorta di un’analisi di contesto, di un’analisi delle esigenze dei clienti di Agroscope e del profilo dei punti di forza/di debolezza delle stazioni di ricerca.
L’attività principale di Agroscope continuerà ad essere lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di produzione agricoli, anche se questo campo d’attività verrà ridimensionato. Verranno potenziati, invece, i settori trasversali «agricoltura-ambiente» e «basi decisionali per la gestione dell’azienda» nonché i campi d’attività «salute e benessere degli animali» e, soprattutto, «qualità e sicurezza dei prodotti nonché relativi effetti sulla salute dell’uomo». Infine, la portata della ricerca nell’ambito «sostegno dell’operato dello Stato» non subirà variazioni.
Sebbene i singoli ambiti di ricerca saranno rivisti, i sei obiettivi strategici di ricerca, fissati per il periodo 2004–2007, non cambieranno, in particolare i tre attinenti alla sostenibilità, visto che questo tema non ha perso la sua valenza restando un punto cardine per lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale. Inoltre, il perseguimento di questi obiettivi garantirà il perfezionamento coerente delle competenze delle stazioni di ricerca. Gli obiettivi di sostenibilità sono orientati verso un settore agricolo efficiente dal profilo economico, rispettoso degli imperativi ecologici ed etologici nonché socialmente sostenibile. Per quanto concerne i tre obiettivi di processo: diagnosi precoce, ricerca di sistema orientata ai problemi nonché comunicazione e gestione delle conoscenze, soltanto gli ultimi due sono stati ulteriormente sviluppati. La ricerca, quindi, si concentrerà maggiormente sui sistemi, favorendo lo scambio delle conoscenze anziché il trasferimento univoco.
194 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Concetto e obiettivi di ricerca
Obiettivi strategici di Agroscope per il periodo 2008–2011
Obiettivi di sostenibilità
1.Settore agricolo efficiente dal profilo economico. La ricerca mira a promuovere la competitività, riducendo i costi legati alla produzione attraverso innovazioni dal profilo organizzativo, biologico e tecnico, nonché la sicurezza e la qualità delle derrate alimentari a prezzi di mercato corretti.
2.Settore agricolo rispettoso degli imperativi ecologici ed etologici. La ricerca mira a conservare e a gestire in modo sostenibile le risorse naturali quali suolo, acqua, aria, paesaggio e biodiversità nonché a potenziare l’efficienza energetica e delle risorse. È tesa ad approfondire le conoscenze sulle correlazioni tra ecosistemi, la detenzione degli animali nel rispetto delle loro esigenze ed il loro benessere.
3.Settore agricolo socialmente sostenibile. La ricerca sviluppa strumenti di valutazione dei provvedimenti di politica agricola che tengano conto della situazione del reddito, della dinamica delle strutture e degli effetti sulle aree rurali.
Obiettivi di processo
1.Diagnosi precoce. La ricerca appronta le conoscenze necessarie al riconoscimento e alla valutazione degli sviluppi futuri, soprattutto nei settori: mercati, salute ed alimentazione, standard qualitativi ed ecologici, flusso delle merci e abitudini di consumo, cambiamenti climatici, energia e materie prime nonché nuove tecnologie.
2.Ricerca di sistema orientata ai problemi. La ricerca è volta ad una valutazione d’insieme del sistema che interessi aspetti legati a sicurezza e qualità, lungo l’intera catena alimentare, dalla forca alla forchetta, e all’impatto ambientale dell’attività agricola. Nell’ambito della ricerca di sistema viene creata una rete tra le varie discipline specifiche (approccio interdisciplinare) coinvolgendo i clienti di Agroscope nella pianificazione della ricerca e nell’applicazione dei risultati (approccio transdisciplinare).
3.Comunicazione e gestione delle conoscenze. I risultati della ricerca sono messi a disposizione degli utenti in modo da soddisfare le esigenze dei clienti. La ricerca è trasparente e dialoga con il grande pubblico attraverso i mezzi di comunicazione.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 195 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Programmi di ricerca
Per fornire risposte a domande tanto complesse quanto importanti si rendono necessari un approccio inter-transdisciplinare ed una mentalità sistemica. È quindi opportuno definire dei programmi di ricerca, vale a dire dei progetti di ricerca nell’ambito dei quali diversi attori interagiscono coordinando le proprie attività al servizio di un obiettivo comune.
Negli anni 2008–2011, Agroscope si concentrerà su tre programmi di ricerca interdisciplinari negli ambiti: sistemi di produzione vegetale competitivi nella regione di pianura (ProfiCrops), qualità e sicurezza dei prodotti, salute e alimentazione (NutriScope), nonché realizzazione ed accompagnamento di sistemi di produzione all’avanguardia nelle regioni di montagna (AgriMontana). Le peculiarità di questi programmi di ricerca sono: una durata limitata, obiettivi ben definiti, un’impostazione interdisciplinare e la cooperazione con i clienti che beneficiano e usano direttamente i risultati della ricerca. Attraverso la creazione di reti, le competenze fondamentali delle singole stazioni di ricerca, ed anche al di fuori di Agroscope, saranno raggruppate per trattare i temi in modo centralizzato.


ProfiCrops si pone l’obiettivo di assicurare il futuro della produzione vegetale svizzera in un contesto di progressiva liberalizzazione del mercato e di rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti autoctoni. In collaborazione con i partner andrà creato un maggior valore aggiunto per i prodotti innovativi lungo tutta la catena, andranno messe a punto nuove tecnologie e sviluppate conoscenze innovative dal profilo economico-aziendale.

NutriScope mira ad ottimizzare i parametri decisivi per qualità, sicurezza e salute lungo tutta la catena alimentare. Questo programma di ricerca è volto alla promozione di un’alimentazione sana per salvaguardare la salute dei cittadini ed, inoltre, al rafforzamento della competitività dei prodotti alimentari svizzeri nonché della fiducia dei consumatori nei confronti della catena alimentare.
Nell’ambito del programma AgriMontana vengono effettuate l’analisi e la valutazione delle conseguenze economiche, sociali ed ecologiche dei diversi sistemi di gestione nelle regioni di montagna tenendo conto del mutamento delle condizioni quadro e delle strutture. Considerando i dibattiti politici, il programma contribuisce ad una politica regionale e settoriale coordinata ed elabora le conoscenze necessarie per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali.
Accanto a questi tre programmi di ricerca interdisciplinari, durante il triennio 2008–2011, sarà mantenuta la piattaforma informativa «Profi-Lait – Per una produzione lattiera competitiva in Svizzera». L’obiettivo di Profi-Lait è creare una rete che colleghi gli attori del settore della produzione lattiera fornendo informazioni aggiornate provenienti da pratica, ricerca e consulenza affinché ne sia fatto ampio uso sul campo. Agroscope è un partner importante di Profi-Lait in quanto fornisce i risultati della ricerca. Le competenze e le attività fondamentali di Agroscope vengono completate dalla ricerca incentrata sulla produzione lattiera condotta nel quadro di Profit-Lait, che si affianca ai tre programmi di ricerca, ProfiCrops, NutriScope e AgriMontana.

196 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
La ricerca è stata esplicitamente esclusa dal divieto di coltivare piante transgeniche, in vigore fino al 2010 (moratoria sugli OGM). La ricerca deve approfittare di questo lasso di tempo per intensificare le sue attività al fine di approfondire le conoscenze in merito ai rischi e ai vantaggi delle colture transgeniche. In tal modo, grazie alla ricerca, l’agricoltura svizzera, i consumatori e gli elettori saranno più informati su questo tema, in vista del voto previsto per il 2009/2010 con il quale verrà deciso se sopprimere, prorogare o modificare la moratoria.
Agroscope, naturalmente, fornirà la sua collaborazione nel quadro del progetto nazionale di ricerca PNR 59, date le conoscenze specifiche che possiede in materia di biosicurezza nel settore agricolo. Agroscope, in collaborazione con diversi partner in ambito universitario, partecipa al progetto «Konsortium-Weizen.ch» nel cui ambito sono previsti esperimenti con grano geneticamente modificato.
Il mandato assegnato alla ricerca gode di ampio consenso. In virtù del mandato di prestazione assegnatogli dal Consiglio federale, Agroscope è esplicitamente tenuto a condurre ricerche nel campo della biosicurezza delle piante transgeniche. Interventi politici chiedono l’esecuzione di esperimenti sul campo. L’Unione svizzera dei contadini (USC) vuole che siano svolte analisi sui rischi e sulle opportunità legate all’ingegneria genetica.
Concentrandosi su varietà di grano geneticamente modificato, che possiede una maggiore resistenza alla malattia fungina oidio, più comunemente noto come mal bianco, verranno condotti esperimenti sul campo al fine di analizzare le interazioni tra colture transgeniche e ambiente. L’obiettivo è di accertare: (1) quale effetto ha la resistenza all’oidio in pieno campo, (2) se il grano geneticamente modificato ha un effetto sugli organismi del suolo (micorizie, batteri e lombrichi, insetti, millepiedi), (3) se e in quale misura il grano geneticamente modificato può essere ibridato, (4) se e in quale modo reagiscono i vari insetti quando entrano in contatto con il grano geneticamente modificato, (5) come si comporta il grano geneticamente modificato rispetto a quello convenzionale, (6) se e come influiscono le manipolazioni genetiche sulle piante impiegate per la sperimentazione.
Mediante l’emissione sperimentale è possibile riprodurre le condizioni pratiche (preparazione delle sementi, semina, cura, raccolta, pulizia di tutti gli strumenti/attrezzi utilizzati, ecc.) di una separazione tra colture convenzionali e geneticamente modificate. In un altro progetto Agroscope analizzerà i costi della coesistenza di colture transgeniche e convenzionali (analisi costi-profitti).
La procedura step by step (prima coltivazione in laboratorio e serra, poi nell’area di vegetazione al coperto ed infine in pieno campo) consente di accertare i rischi ad ogni livello. Viene analizzato il possibile effetto del grano geneticamente modificato sugli organismi del suolo (micro-macrorganismi) e le rispettive funzioni. Le nuove scoperte consentiranno di comprendere meglio questi processi e grazie a studi pluriennali sarà possibile pronunciarsi in merito alle eventuali conseguenze a lungo termine sugli organismi del suolo. Grazie a questi esperimenti potrà essere condotta un’analisi costiprofitti fondata sui fatti, in grado di dimostrare se in futuro l’ingegneria genetica in Svizzera andrà considerata ancora una possibile alternativa.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 197 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Ricerca nel settore dell’ingegneria genetica
Nel perseguire i propri obiettivi d’efficacia, le stazioni di ricerca non perdono mai di vista le esigenze e la soddisfazione dei clienti. Per tale motivo, nel 2006, l’UFAG ha svolto un sondaggio scritto tra i clienti di Agroscope, nell’ambito del quale 1'712 agricoltori hanno dato il loro parere in merito alla chiarezza delle informazioni ottenute da Agroscope e dai divulgatori di sapere dei settori a valle nonché alla loro utilità pratica. Questi due attributi hanno ottenuto una valutazione buona o addirittura molto buona. In particolare, delle prestazioni offerte da Agroscope si sono detti più soddisfatti gli agricoltori dediti alla produzione vegetale, segnatamente alle colture speciali, rispetto a quelli nel settore della produzione animale. Nel complesso, gli agricoltori si sono dimostrati molto interessati alle nuove conoscenze e particolarmente convinti del fatto che la ricerca è importante per il futuro dell’agricoltura svizzera. Tuttavia, si auspicano che venga rafforzato il legame tra ricerca e pratica. Dai risultati del sondaggio sono emersi elementi importanti per l’impostazione dei programmi di lavoro e del concetto di comunicazione di Agroscope, che contribuiscono a promuovere lo scambio di conoscenze tra le stazioni di ricerca e i loro clienti.

198 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ La ricerca è importante per il futuro dell’agricoltura
■ Detenzione di equini nelle aziende agricole
Istituto nazionale di allevamento equino
Un gruppo di lavoro, diretto dall’Istituto nazionale di allevamento equino e composto da rappresentanti del settore equino, ha pubblicato un rapporto sull’importanza del cavallo in Svizzera. Lo studio, che succede all’ultimo datato 1987, rivela diversi aspetti sorprendenti.
Nell’ultimo ventennio, in Svizzera, si è registrato un forte aumento dell’effettivo di animali della specie equina (cavalli, pony, cavallini, asini, muli e bardotti). Il loro numero è passato da 55'500 a 85'000 capi, segnando un incremento del 53,1 per cento. Attualmente l’85 per cento degli equini è detenuto in aziende agricole, circa metà delle quali situate nella zona prealpina e delle zone di montagna. Il numero di aziende agricole che detengono equini, 13'000 nel 2005, è stabile da circa dieci anni. Ogni azienda detiene mediamente 5,5 capi. Sono soprattutto le grandi aziende agricole che hanno fatto registrare l’aumento degli effettivi. La superficie agricola utile a disposizione per ciascun equino è pari in media a 1,1 ettari. La superficie destinata all’uscita all’aperto e a una parte del foraggiamento (pascolo) varia da 90'000 a 100'000 ettari, di cui 78'000–88'000 ettari nella zona agricola.
■ Utilizzo dei cavalli
L’attuale effettivo di equini è composto per metà da circa 22'000 pony, cavallini e altri equini nonché da 21'000 cavalli delle Franches-Montagnes, mentre l’altra metà comprende cavalli mezzo sangue e puro sangue. In gran parte i cavalli vengono impiegati per attività svolte nel tempo libero (equitazione e gite in carrozza, turismo, manifestazioni folcloristiche, ecc.). Soltanto il 10 per cento dei cavalli partecipa regolarmente a competizioni ippiche. Tra i fattori che hanno determinato l’aumento dell’effettivo di equini, può essere citata la popolarità di cui godono le attività equestri nel tempo libero. Nessun segnale fa pensare che la crescente passione per i cavalli, soprattutto delle ragazze, sia soltanto una moda passeggera. L’effettivo totale di equini dovrebbe, quindi, continuare a crescere.
Andamento dell'effettivo di equini 198819932005 In ambito agricolo In ambito non agricolo Fonte: UST 0 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Numero
199 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Aspetti finanziari e posti di lavoro
I contributi federali e cantonali stanziati a favore dell’allevamento equino toccano i 3,5 milioni di franchi l’anno. L’Istituto nazionale di allevamento equino ha un fabbisogno finanziario netto pari a 5,6 milioni di franchi, mentre le attività militari costano 3,5 milioni.

La cifra d’affari annua del settore equino viene stimata a 1,58 miliardi di franchi. Due terzi (1,03 mia. fr.) delle entrate provengono da prestazioni fornite ai proprietari di cavalli, in particolare pensione per equini, insegnamento e prestazione di servizi. Le entrate realizzate dalle aziende agricole ammontano a 500 milioni di franchi circa. Nel complesso il settore equino crea 10'400 posti di lavoro (a tempo pieno) nei settori dell’agricoltura, della formazione, della cura dei cavalli, dell’ippoterapia, dell’artigianato e del commercio.
■ La formazione dei detentori di equini deve essere approfondita
La graduale scomparsa delle truppe del treno e il ridimensionamento della parte dedicata ai cavalli nella formazione agricola compromettono il trasferimento delle conoscenze in materia di detenzione e cura degli equini. Soltanto un terzo dei detentori di equini possiede le necessarie conoscenze specifiche in materia. Prima dell’introduzione della formazione Equigarde® da parte dell’Istituto nazionale di allevamento equino, non esisteva alcuna formazione continua e completa in materia di allevamento e detenzione di equini. Tutti gli attori del settore sono concordi nell’affermare che il miglioramento sostenibile della detenzione degli equini in Svizzera passa attraverso l’approfondimento della formazione.
■ Impatto sulle aree rurali
L’allevamento e la detenzione di equini contribuiscono alla diversificazione dell’attività agricola e alla promozione della qualità di vita nelle aree rurali. Questa diversificazione consente di sfruttare maggiormente le infrastrutture (pensione per cavalli) e le superfici inerbite (consumo di foraggio grezzo). L’ulteriore sviluppo della detenzione di equini nelle aziende agricole dipende, tuttavia, dai futuri adeguamenti strutturali dell’agricoltura e dalla revisione della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
200 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Nuovo accordo di prestazione con AGRIDEA
Consulenza
Le centrali ed i servizi di consulenza fondono le conoscenze prettamente scientifiche ed il sapere legato all’esperienza, affinché le innovazioni trovino un’applicazione pratica, rapida ed efficace. La consulenza diretta viene curata essenzialmente dai servizi cantonali di consulenza e in ambiti specifici anche da organizzazioni attive a livello nazionale. Le due centrali di consulenza di AGRIDEA svolgono un’attività di supporto.
Uscite della Confederazione per la consulenza – 2006
DestinatarioImporto mio. fr.
Servizi cantonali di consulenza agricola8,5 Servizi cantonali di consulenza in economia domestica rurale0,7 Servizi di consulenza speciali delle organizzazioni agricole0,8
AGRIDEA (centrali di consulenza di Losanna e Lindau)8,0 Totale18,0
Nella primavera del 2007, UFAG e AGRIDEA hanno sottoscritto il nuovo accordo di prestazione per gli anni 2008–2011. AGRIDEA è un’associazione per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali. Gestisce le due centrali di consulenza AGRIDEA Losanna e AGRIDEA Lindau, le quali, in prima linea, forniscono assistenza ai servizi di consulenza agricola e di consulenza in economia domestica rurale, pur offrendo servizi anche a tutti gli attori che ricoprono il ruolo di divulgatori nella diffusione delle conoscenze in ambito agricolo e dello sviluppo delle aree rurali. Il mandato di base comprende le cinque prestazioni elencate di seguito.
Fonte: Conto dello Stato
201 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
PrestazioniDescrizione delle prestazioni più importanti Acquisizione delle basi e sviluppo di metodi
Le esigenze di consulenza sono note e possono essere soddisfatte in maniera flessibile attraverso un’ampia competenza. Sono disponibili metodi sperimentati e basi di dati aggiornate. Laddove non ancora disponibili, vengono rilevati e stimati i dati relativi alla pratica.
Introduzione, qualifica e formazione continua del personale addetto alla consulenza
Informazione, documentazione, materiale didattico, informatica
AGRIDEA offre un ampio programma di introduzione e perfezionamento professionale, adattato in funzione delle esigenze dei divulgatori. Promuove la qualifica del personale addetto alla consulenza.
Al personale addetto alla consulenza viene messa a disposizione una vasta offerta di documenti informativi, documentazione e materiale didattico nelle sfere di competenza, segnatamente per quanto riguarda la gestione delle imprese e il governo dell’economia domestica. Ciò è concepito in modo da poter essere applicato direttamente nelle aziende contadine. I prodotti software di AGRIDEA devono, in primo luogo, aumentare la capacità del personale addetto alla consulenza di adempiere le proprie funzioni.
Supporto diretto a servizi di consulenza, categorie e regioni
Reti di coordinamento
■ Conseguenze della NPC
AGRIDEA mette a disposizione, su richiesta, conoscenze specifiche e la capacità di operare nella soluzione di problemi. Supporta progetti nella fase iniziale che rientrano nell’interesse pubblico.
Su richiesta o d’intesa con i responsabili o i partecipanti, AGRIDEA assume, all’interno del sistema delle conoscenze, le funzioni di rete.
Dal 2008 la Confederazione concederà alle centrali di consulenza un contributo annuo pari a 9,5 milioni di franchi, che andrà a coprire il 50 per cento circa dei costi d’esercizio. I costi residui verranno coperti attraverso le entrate provenienti dal mandato di base (3 mio. fr.), le quote sociali (0,2 mio. fr.) e i mandati complementari (5,6 mio. fr.).
Ad inizio 2008 è prevista l’entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Ciò inciderà notevolmente sulla consulenza. Infatti, sarà soppresso l’aiuto finanziario a favore dei servizi cantonali fornito dalla Confederazione (sgravio delle finanze federali per un importo pari a 9,2 mio. fr.), anche se quest’ultima si assumerà le quote sociali dei Cantoni (onere per la Confederazione pari a 1,5 mio. fr.). Se intendono mantenere inalterata la gestione dell’attività di consulenza, i servizi cantonali di consulenza devono compensare i contributi federali soppressi attraverso un incremento dei contributi cantonali, un aumento delle entrate o tagli ai costi. D’altro canto AGRIDEA ha dovuto adeguare la propria organizzazione affinché i Cantoni, che sono i suoi principali clienti, rimangano vincolati all’associazione in qualità di membri.
202 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
Formazione professionale
La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore il 1° gennaio 2004, tiene conto dell’importante cambiamento nel mondo professionale e del lavoro e ha lo scopo di promuovere vie diverse di formazione professionale, nonché una permeabilità il più grande possibile nel sistema di formazione professionale e di istruzione. Invece dell’attuale sistema di contributi in funzione dei costi, a partire dal 2008 verrà introdotto un sistema di importi forfetari che implica, dal punto di vista finanziario, una maggiore collaborazione tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (OML). L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) sostiene la formazione professionale agricola con un importo annuo di circa 10 milioni di franchi.

La riforma della formazione professionale di base delle professioni agricole ed equestri è giunta alla fase conclusiva. I lavori di redazione delle ordinanze e dei relativi piani di formazione sono stati portati a termine all’inizio dell’anno e hanno superato con successo l’esame di consistenza didattica e pedagogica richiesto dall’UFFT. I testi di seguito elencati sono stati inviati in consultazione nella primavera 2007.
–Ordinanza concernente la formazione professionale di base del campo professionale dell’agricoltura e dei suoi prodotti, nella quale sono descritte le prescrizioni in materia di formazione per agricoltori, ivi compresa la specializzazione in agricoltura biologica, avicoltori, orticoltori, frutticoltori, tecnici del vino e viticoltori, nonché i rispettivi piani di formazione.
–Ordinanza concernente la formazione professionale di base per le figure professionali nel campo equestre ad indirizzo «cura dei cavalli», «monta classica», «monta western», «tölt e ambio veloce», «corsa» nonché rispettivo piano di formazione. –Ordinanza concernente la formazione professionale di base dei custodi di cavalli e rispettivo piano di formazione.
Le associazioni professionali, le organizzazioni del mondo del lavoro (AgriAliForm per il campo professionale dell’agricoltura e l’OML per le professioni equestri), i responsabili cantonali della formazione professionale, diverse associazioni regionali e nazionali, nonché vari uffici federali si sono espressi su questi testi. I risultati della consultazione verranno tenuti in considerazione per l’elaborazione delle versioni finali di ordinanze e piani di formazione da mettere in vigore il 1° gennaio 2008.
I lavori della commissione di riforma responsabile dell’introduzione di una formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica in ambito agricolo avanzano come previsto. I primi cicli di formazione dovrebbero poter cominciare nell’autunno 2009.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 203 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Formazione professionale di base
Per eseguire un esame professionale federale o un esame professionale superiore, le rispettive organizzazioni del mondo del lavoro formano un organo responsabile. I regolamenti d’esame disciplinano le condizioni di ammissione all’esame, i programmi di formazione, la procedura di qualificazione, gli attestati e i titoli di formazione. Essi soggiacciono all’approvazione da parte dell’UFFT. AgriAliForm è responsabile dell'organizzazione e della vigilanza degli esami professionali superiori.
I regolamenti dell'esame federale di professione e dell'esame professionale federale superiore quale agricoltore sono stati rivisti. I primi attestati professionali basati sul nuovo regolamento d'esame verranno concessi a partire da giugno 2007. Il primo esame finale e la prima verifica della formazione modulare in relazione agli esami professionali superiori in base al nuovo regolamento d'esame avranno luogo nel 2008.
204 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
■ Esame federale di professione ed esame professionale federale superiore quale agricoltore
■ Cause della presenza di residui multipli
2.3.3 Mezzi di produzione
Prodotti fitosanitari: residui multipli nelle derrate alimentari
Il dibattito sulla valenza dei residui multipli di prodotti fitosanitari è d’attualità. I residui multipli sono la conseguenza dell’applicazione, contemporaneamente o a scaglioni, di diversi prodotti fitosanitari ad elevata selettività. Oggigiorno, questo tipo di prodotti fitosanitari è diventato una colonna portante della buona pratica agricola.
Oltre a una serie di misure quali l’avvicendamento disciplinato delle colture, l’impiego di piante resistenti, procedure che consentono di salvaguardare gli organismi utili, l’attuale pratica agricola della produzione sostenibile prevede l’impiego mirato di prodotti fitosanitari ad elevata selettività. Soltanto impiegando mezzi così specifici è possibile rispettare le esigenze ecologiche. Tra queste rientrano la conservazione o la promozione della biodiversità degli ecosistemi agricoli nonché le strategie di prevenzione della formazione di resistenze. A ciò è strettamente vincolato l’impiego di prodotti fitosanitari ad azione specifica con diversi meccanismi d’efficacia. A seconda della situazione devono essere applicati contemporaneamente diversi prodotti fitosanitari. La combinazione di diversi principi in un prodotto può determinare un ampliamento dello spettro d’efficacia o un miglioramento degli effetti e di conseguenza una riduzione delle dosi d’applicazione nonché, in ultima analisi, dei possibili residui. I progressi tecnici nell’analisi dei residui così come l’attuale sviluppo di nuovi sistemi di gestione della qualità da parte del settore alimentare hanno fatto sì che la presenza di residui multipli venga tenuta sotto stretta osservazione.
■ Attuale valutazione dei residui
In virtù della legislazione in materia di derrate alimentari, i residui possono essere presenti negli o sugli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili. L’applicazione concreta di questi requisiti è resa possibile attraverso la determinazione di concentrazioni massime (valori di tolleranza, valori soglia) nell’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23). Il presupposto per fissare un limite a norma di legge è la valutazione tossicologica di ogni singolo principio attivo. In tal modo il limite viene stabilito cosicché i residui non comportino alcun rischio per la salute dei consumatori, garantendo l’ineccepibilità delle derrate alimentari dal tal profilo. Il secondo requisito comporta una riduzione dei residui. La base quantitativa affinché i residui rimangano ad un livello tecnicamente indispensabile è costituita dagli esperimenti con applicazioni conformi alla pratica. La buona pratica agricola evita il superamento di queste concentrazioni massime.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 205 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
L’attuale criterio applicato anche a livello internazionale si basa sulla valutazione dei singoli principi come precedentemente illustrato. Questa modalità di valutazione dei residui multipli è suffragata dai risultati di diverse analisi. Da studi su combinazioni di principi attivi non sono emersi elementi che provino che i residui multipli di prodotti fitosanitari quale conseguenza di effetti combinati inattesi possano rappresentare un rischio per la salute. Tuttavia, a livello internazionale l’attività di ricerca si sta concentrando sui meccanismi degli effetti combinati di sostanze chimiche al fine di ampliare le basi per la valutazione dei residui multipli e di ottimizzare i metodi di valutazione. Il servizio d’omologazione dei prodotti fitosanitari dell’UFAG, sull’onda degli sforzi profusi a livello internazionale, provvederà ad aggiornare il metodo di valutazione alla luce delle nuove conoscenze.
Importazioni parallele di prodotti fitosanitari
Nel 1998, in occasione del dibattito sulla nuova legge sull’agricoltura, il Parlamento ha introdotto la possibilità di autorizzare le importazioni parallele di prodotti fitosanitari. Nel quadro della modifica dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari in base alle nuove prescrizioni di legge, nel 1999 sono state fissate le norme dettagliate a riguardo, mettendo a punto un elenco dei prodotti fitosanitari di cui è autorizzata l’importazione parallela. Da allora tale elenco è tenuto costantemente aggiornato. Attualmente contiene circa 680 prodotti esteri con 88 formulazioni diverse. Con l’entrata in vigore, nell’agosto 2005, del nuovo diritto sui prodotti chimici e del testo rivisto dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161), la procedura ha potuto essere razionalizzata nonché semplificata notevolmente.
Prodotti esteri pubblicati recentemente
Nello stesso periodo, dall’elenco hanno dovuto essere stralciati circa 160 prodotti esteri fuori commercio o non più conformi alle condizioni imposte dalla legge.
AnnoNumero 2000295 200374 20049 2005318 2006148
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 206
Alimenti per animali
Il 1° gennaio 2006 sono entrati in vigore i criteri del controllo autonomo e gli obblighi ad esso correlati di cui all’articolo 20e dell’ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (RS 916.307). Conformemente a tale articolo: «Chiunque produce, trasporta, immagazzina o mette in commercio alimenti per animali, deve disporre di una procedura scritta basata sui principi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)».

Questa modifica è servita ad allineare le norme elvetiche al diritto internazionale, ma soprattutto a garantire la massima sicurezza degli alimenti. Infatti viene introdotto un criterio di controllo indispensabile lungo tutta la catena alimentare, dalla forca alla forchetta, che di conseguenza interessa anche gli alimenti per animali.
I principi HACCP costituiscono un approccio sistematico e preventivo per la garanzia della sicurezza delle derrate alimentari. Sono uno strumento per la rilevazione dei rischi e l’attuazione di un sistema di controllo che si fonda sulla prevenzione piuttosto che sull’esame del prodotto finito. Pertanto è importante conoscere l’intero processo di fabbricazione di un alimento per animali, dalle materie prime alla fornitura dell’alimento composto per animali.
Di norma si muove da tre possibili tipi di rischio: –biologico (p.es. micotossine, batteri, virus, parassiti, ecc.); –chimico (p.es. disinfettanti, allergeni, nitrati, ecc.); –fisico (p.es. frammenti di metallo, vetro, corpi estranei).
I principi HACCP per evitare i diversi rischi possono essere riassunti come segue: –identificare i rischi per la sicurezza degli alimenti per animali;
–identificare i punti critici che devono essere oggetto di un controllo per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a un livello accettabile;
–stabilire, ai punti critici, i limiti accettabili per la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei rischi identificati;
–sorvegliare i punti critici;
–fissare in anticipo le misure correttive da adottare qualora la sorveglianza evidenzi che un punto critico non è sotto controllo; –verificare periodicamente la completezza e l’efficacia delle misure di cui sopra; –allestire una documentazione relativa all’attuazione di tutti i provvedimenti, da tenere costantemente aggiornata.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 207
■ Perché i principi HACCP?
■ Applicazione pratica
Gli attori del settore degli alimenti per animali sono tenuti ad applicare i principi HACCP. A tal riguardo il legislatore ha previsto due possibilità: –avvalersi di una propria procedura HACCP; –avvalersi di una guida di buona pratica.
Questa guida fondata sui già citati principi HACCP è stata elaborata dalle organizzazioni professionali interessate – agricoltori, mugnai, importatori – ed approvata dall’UFAG.
Essa semplifica l’applicazione pratica della procedura HACCP. Anche gli agricoltori che producono alimenti per animali per il consumo proprio sono tenuti ad applicare il metodo HACCP o la guida di buona pratica laddove vengano impiegati additivi.
■ Controllo
Il sistema HACCP è, per definizione, un controllo autonomo. Il produttore, che applica il metodo HACCP o si avvale di una guida di buona pratica, deve fissare i controlli che intende svolgere ed aggiornare costantemente il suo sistema. In quanto attore del settore, è l’unico garante della sicurezza del suo prodotto.
A livello nazionale, è l’unità «Controllo degli alimenti per animali» di Agroscope Liebefeld-Posieux ALP ad essere incaricata del controllo del commercio di alimenti per animali nonché dell’omologazione delle nuove sostanze per l’alimentazione animale. Nel quadro dei controlli ufficiali anche gli ispettori devono appurare l’applicazione del sistema HACCP o della guida di buona pratica. Nel 2006 hanno ricevuto una formazione mirata a tal proposito.
Chi importa, mette in commercio o produce alimenti per animali è assoggettato al controllo di ALP. Sono inclusi anche gli agricoltori che impiegano additivi per i quali è previsto un limite massimo in virtù del libro sugli alimenti per animali. Gli altri agricoltori sottostanno ai controlli previsti nell’ambito dei pagamenti diretti.
Piante di vite
La base per una vitivinicoltura produttiva nonché orientata alle esigenze di mercato ed ecologiche è costituita da materiale vegetale qualitativamente ineccepibile di varietà adeguate alle condizioni climatiche regionali e adatte alle condizioni del mercato interno. I vitivinicoltori fissano standard elevati per le piantine di vite, siccome queste, così come altri elementi importanti della tecnica di produzione, hanno un influsso decisivo sul successo economico.
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
208
■ Disposizioni armonizzate
L’esigenza di standard qualitativi elevati ed uniformi per le piante di vite così come la volontà politica di tutelarne gli acquirenti, hanno fatto sì che lo Stato, dal 1° luglio 1999, abbia emanato disposizioni per regolamentare in maniera armonizzata i vari settori dalla selezione alla messa in commercio di materiale vegetale. In seguito all’apertura dei mercati e ai crescenti rapporti internazionali della Svizzera in questo settore, le disposizioni vengono costantemente allineate nel quadro degli accordi bilaterali con l’obiettivo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio con l’UE. In vista del reciproco riconoscimento, è stata abrogata l’ordinanza che fissava le esigenze in materia di produzione e messa in commercio di piante di vite ed emanata una nuova ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3), entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Oltre alle disposizioni vigenti dal 1999 relative al riconoscimento (certificazione) di materiale di moltiplicazione, la nuova ordinanza disciplina la produzione di materiale standard.
■ Sicurezza della qualità nella moltiplicazione
La moltiplicazione di piante di vite certificate è facoltativa ed avviene in base ad uno schema di moltiplicazione ben definito, che fissa il numero di generazioni del nucleo di conservazione, in cui viene garantita la selezione conservatrice, fino alle pianticelle di vite innestate. Per ogni categoria, la legislazione in materia di sementi contiene le disposizioni concrete relative alla provenienza delle materie prime, alle esigenze poste al suolo, alle ispezioni sul campo nonché le esigenze poste alla commercializzazione, tra cui quelle relative al condizionamento e all’etichettatura.
Nel 2006, in Svizzera è stato prodotto materiale vegetale da 65 vivai di viti omologati. In 26 casi trattasi di produttori attivi nel campo della certificazione. Nei mesi di agosto e settembre avvengono i controlli sulle particelle, in occasione dei quali viene effettuata un’ispezione visiva delle piante per individuare eventuali sintomi di malattie. Nel caso delle particelle destinate alla produzione di materiale vegetale certificato, a seconda della categoria, vengono effettuati anche prelievi fogliari, sistematicamente o per campionatura, da utilizzare per il test ELISA. Ciò significa che oltre ad attuare un controllo mirato ad identificare gli organismi di quarantena filossera della vite e flavescenza dorata, nelle colture devono essere svolte ispezioni per rivelare l’eventuale presenza di sintomi della degenerazione infettiva della vite, dell’accartocciamento fogliare della vite nonché della malattia del legno nero. Questi controlli vengono eseguiti da controllori di Vitiplant su mandato della Confederazione.
Se gli esiti dei controlli fitosanitari e di quelli fissati in base al diritto sulle sementi sono soddisfacenti, le piante di vite possono essere commercializzate e, una volta entrato in vigore questo campo d’applicazione nel quadro dell’accordo bilaterale con l’UE, anche esportate senza ulteriori oneri.

2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
209
Organismi geneticamente modificati negli alimenti per animali
L’importazione di alimenti per animali contenenti o ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) ha registrato un ulteriore notevole calo. Nel 2006 la quota di alimenti per animali contenenti OGM non ha superato lo 0,02 per cento del volume totale delle importazioni di alimenti per animali. Dal 1° gennaio 2003 le disposizioni del diritto sugli alimenti per animali sono state estese anche agli alimenti per animali da compagnia. Trascorso il periodo transitorio, dal 2005 essi sono soggetti agli stessi controlli effettuati sugli alimenti per animali da reddito. Il livello di dichiarazione degli OGM negli alimenti per animali da compagnia non è ancora paragonabile a quello nel settore degli alimenti per animali da reddito (cfr. tabella).
Alimenti per animali contenenti OGM notificati alla dogana all’importazione
AnnoVolume totale alimenti Alimenti per animali con- Alimenti per animali conper animali importatitenenti OGM notificatitenenti OGM notificati
Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alimenti per animali da reddito a cura di Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
AnnoCampioni prelevati Indicazioni Campioni prelevati Indicazioni dalla doganaerrateda ALP da prodotti errate all’importazionesul mercato
Analisi sulla presenza di componenti OGM negli alimenti per animali da compagnia a cura di Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
AnnoAlimenti per animali Indicazioni da compagnia controllatierrate
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2
in tin tin % 2002318 0682 5630,8 2003412 1636880,2 2004383 5952 1010,55 2005356 1494020,11 2006373 228600,02 Fonti: UFAG, DGD
NumeroNumeroNumeroNumero 20025402033 20038102670 20046122285 20053002503 20067903000 Fonte: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
NumeroNumero 20052074 200623010 Fonte: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP 210
■ Prima conferenza internazionale della FAO sulle risorse zoogenetiche

2.3.4Allevamento di animali
In Svizzera la razze elvetiche hanno una valenza considerevole e godono pertanto di un adeguato sostegno da parte di Confederazione, Cantoni e organizzazioni di allevamento. Alla luce di ciò, la Svizzera si è dichiarata disposta ad ospitare la Prima conferenza tecnica internazionale della FAO sulle risorse zoogenetiche. L'organizzazione della conferenza, svoltasi ad Interlaken nel settembre 2007, è stata affidata all'UFAG.
Da anni la FAO si impegna, a livello mondiale, nella sensibilizzazione sull'importanza delle risorse zoogenetiche in relazione alla sicurezza alimentare, coinvolgendo gli Stati membri in un processo costante di conservazione e di impiego sostenibile delle molteplici razze di animali da reddito agricoli. La conferenza, alla quale hanno partecipato rappresentanti provenienti da oltre 160 Paesi, era finalizzata ad emanare un rapporto sullo stato mondiale delle risorse zoogenetiche e a fissare gli elementi chiave della strategia per la conservazione e l'impiego sostenibile di tali risorse.
A margine dei negoziati, i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere l'agricoltura svizzera e in particolare le razze autoctone di animali da reddito. Per tale motivo, oltre ad escursioni è stata allestita l'esposizione «Biodiversità, alimentazione e cultura – Alla scoperta della varietà di animali da reddito». Mediante questa esposizione aperta anche al pubblico si è voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, mettendo in evidenza la correlazione tra razze di animali da reddito, sicurezza alimentare e cultura nonché illustrando gli effetti della diversità. La possibilità di osservare le diverse razze svizzere pascolare liberamente entro recinti appositamente allestiti nonché di consumare i prodotti da essi ottenuti o di scoprire determinati aspetti culturali ad essi legati ha rappresentato un'occasione unica, per le razze autoctone, di farsi conoscere dal vasto pubblico.
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
211
Tabella 51, pagina A57
■ Inseminazione artificiale nel bestiame bovino
La nuova normativa sull'inseminazione artificiale rappresenta un ulteriore passo verso la liberalizzazione della legislazione svizzera sull'allevamento di animali. Finora, per la produzione, l'immagazzinamento e la vendita di sperma di toro era necessario disporre di un permesso dell'UFAG che veniva concesso unicamente ad organizzazioni d'inseminazione elvetiche detentrici di tori allevati in Svizzera, le quali, attraverso il prelievo e la vendita di sperma, contribuiscono al mantenimento di un allevamento bovino indigeno indipendente. La vendita di sperma da parte di commercianti senza una propria organizzazione di inseminazione non era consentita. Questa restrizione è stata abrogata sulla scorta di una decisione del Tribunale federale. Per l'importazione di sperma di toro effettuata al di fuori del contingente doganale non è più necessario disporre di un permesso. L'importazione nel quadro del contingente doganale rimane invece una prerogativa delle organizzazioni di inseminazione operanti in Svizzera.
2.3 MIGLIORAMENTO DELLE BASI 2 212
2.4 Sezione Ispettorato delle finanze
Il programma delle ispezioni dell’Ispettorato delle finanze è elaborato sulla base delle analisi dei rischi in seno alla Sezione, di valori empirici e di una pianificazione pluriennale. Al fine di evitare doppioni, lacune e sovrapposizioni nel programma di verifica, esso viene concertato e allineato al programma del Controllo federale delle finanze.
Ispettorato delle finanze
Nell’anno oggetto del rapporto sono state eseguite le seguenti revisioni: –revisioni esterne all’UFAG presso sei beneficiari di prestazioni o di contributi e rispettivi incaricati; –analisi e rapporto sulla situazione dei 22 Cantoni visitati negli ultimi quattro anni; –revisione interna all’UFAG in una sezione specifica; –verifica periodica dei giustificativi presso l’UFAG e le Stazioni di ricerca; –una revisione finanziaria presso l’Istituto nazionale di allevamento equino; –quattro revisioni delle chiusure contabili presso beneficiari di contributi e una verifica dell’efficacia nel campo della ricerca; –una verifica speciale su incarico del direttore; –follow-up di revisioni concluse.
Tutte le ispezioni sono state eseguite in base agli standard per la pratica professionale dell’Institute of Internal Auditors (IIA) nonché dell’Associazione svizzera di revisione interna (ASRI) e sono state sottoposte a una verifica interna sull’assicurazione della qualità.
Le verifiche della struttura e dell’efficacia del sistema dei pagamenti diretti in sei Cantoni hanno costituito una linea prioritaria delle attività di verifica. In generale i sistemi di controllo interni (SCI) dei Cantoni sono organizzati in maniera razionale, anche se esiste ancora un potenziale di perfezionamento. In particolare andrebbe svolta un’attività di sorveglianza anche sulle attività assegnate all’esterno. Dalle verifiche finanziarie è emerso che nel complesso i processi sono organizzati in modo mirato. Il rischio di pagamenti ingiustificati è ritenuto esiguo.
Un altro elemento fondamentale dell’attività di verifica è costituito dalla stima e dall’analisi della situazione del sistema dei pagamenti diretti sulla scorta delle informazioni raccolte dalle ispezioni effettuate negli ultimi quattro anni in 22 Cantoni nonché dalle revisioni condotte in tre Cantoni dal Controllo federale delle finanze. Il SCI per il versamento dei pagamenti diretti funziona in maniera ragguardevole. L’impostazione dei vari processi consente con grande probabilità di evitare abusi. Ai Cantoni deve essere riconosciuto il grande impegno profuso per la corretta applicazione delle disposizioni legali. Sono state espresse valutazioni negative per mancanza di distacco nei controlli, lacune nell’organizzazione interna, incompletezza della documentazione relativa ai processi essenziali o insufficiente trasparenza dei rapporti di controllo.
2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 2.4 SEZIONE ISPETTORATO DELLE FINANZE 2 213 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Rendiconto sull’anno oggetto del rapporto
■ Follow-up
Le revisioni all'interno dell'UFAG prevedono una verifica indipendente e sistematica dell'organizzazione del lavoro e delle attività in seno all'unità organizzativa. L'accento è posto sulla struttura e sull’organizzazione del lavoro di una sezione. Un elemento importante è pure la verifica SCI. L’attenzione non viene focalizzata soltanto sulle discrepanze tra stato attuale e stato auspicato, bensì anche sulle cause. I risultati delle verifiche sono stati in prevalenza positivi. Nella maggior parte dei casi gli strumenti di gestione e di controllo applicati sono risultati adeguati.
La revisione finanziaria in seno all’UFAG ha comportato una revisione di fine esercizio e due verifiche parziali ad intervalli periodici. Sulla scorta dell’esame a campione di voci selezionate è stato possibile confermare la regolarità e la correttezza delle spese sostenute. La gestione contabile in seno all’UFAG avviene in maniera regolare, nel rispetto dei principi della contabilità. Anche la revisione finanziaria effettuata presso l’Istituto nazionale di allevamento equino ha dato esito positivo.
In tutti i casi le revisioni delle chiusure contabili hanno dato risultati positivi. La struttura SCI è ritenuta sufficiente. Nel caso di un’organizzazione partner sono state mosse alcune critiche sul fatto che è stato particolarmente dispendioso accertare le spese rispetto al preventivo. Per un eventuale mantenimento dell’accordo di prestazione con l’UFAG è necessario introdurre un metodo di calcolo dei costi più trasparente. Per quanto riguarda un’altra organizzazione si è giunti alla conclusione che i fondi federali finora concessi non sono stati destinati completamente ai produttori, bensì sono stati utilizzati per costituire riserve e accantonamenti consistenti. Di conseguenza è stato raccomandato di rivalutare a breve termine l’importo dei pagamenti per questo mandato di prestazione.
Nel dicembre 2005 si è venuti a sapere che un’organizzazione partner ha dovuto far fronte a notevoli problemi finanziari. Per appurare se la crisi coinvolgesse anche fondi federali, l’Ispettorato delle finanze, su incarico del direttore, ha effettuato una prima valutazione in loco. La situazione di crisi è stata determinata essenzialmente dal lancio in contemporanea di diversi progetti che hanno comportato costi decisamente superiori a quanto preventivato, dalla mancanza di strumenti di gestione e di controllo adeguati nonché dalle uscite legate ai progetti, risultate sproporzionate rispetto alle entrate. È stata pertanto effettuata una verifica accurata del corretto impiego dei fondi federali, in seguito alla quale, è stato possibile accertare che il 96 per cento dei fondi federali approntati è stato utilizzato come disposto. Sulla scorta di questi risultati il 4 per cento dei fondi non è stato versato.
Nell'ambito del follow-up, si è verificato lo stato di attuazione delle raccomandazioni in sospeso sulla base di sette revisioni effettuate presso le sezioni interessate. È stato possibile stabilire che l’84 per cento delle raccomandazioni è stato attuato. Lo stato di attuazione delle raccomandazioni ancora pendenti sarà nuovamente verificato nel corso dell’anno.
2.4 SEZIONE ISPETTORATO DELLE FINANZE 2 214
■ Attività
Servizio d’ispezione Controlli sul campo
Il servizio d’ispezione Controlli sul campo effettua controlli in tutti gli ambiti della legislazione agricola relativamente alla produzione e allo smercio per i servizi dell’UFAG. Nel 2006 sono stati effettuati 409 controlli. Le verifiche hanno riguardato i seguenti settori: –latte e latticini: 327 controlli; –frutta, verdura e fiori recisi: 41 controlli; –carne e uova: 27 controlli; –campicoltura e foraggicoltura: 7 controlli; –viticoltura, misure di riconversione: 7 controlli.
I controlli dei quantitativi nel settore lattiero in relazione a supplementi e/o aiuti (sostegno del prezzo del latte) e/o tasse (contingentamento lattiero) sono stati svolti secondo la norma internazionale EN 45004 (ISO/IEC 17020, organismo d’ispezione accreditato tipo B). Per gli altri ambiti di controllo sono state utilizzate le stesse norme di qualità.
La scelta delle aziende da controllare nel settore latte e latticini è stata effettuata sulla scorta di un’analisi dei rischi periodicamente aggiornata e di un mandato globale annuale concordato con la competente sezione. Nell’anno oggetto del rapporto, 1'146 aziende aventi diritto ad aiuti hanno ricevuto supplementi e aiuti all’interno del Paese per un totale di 433 milioni di franchi. Di queste aziende, 327 (28,5%) sono state sottoposte al controllo. In 131 aziende sono state rilevate lacune mentre 15 aziende hanno dovuto subire conseguenze finanziarie sotto forma di rimborsi o versamenti suppletivi.
Nell’ambito dei controlli a domicilio relativi a frutta e verdura fresche, nel 29 per cento dei controlli effettuati sono state rilevate irregolarità che hanno comportato misure amministrative.
Nel settore della carne, per la prima volta, è stata controllata la prestazione all’interno del Paese conformemente alla vigente ordinanza. I risultati mostrano che per oltre la metà delle aziende controllate sono state constatate discrepanze per quanto riguarda l’effettivo di animali dichiarato nella domanda e quello realmente detenuto. I rapporti di controllo sono stati trasmessi alla competente sezione per l’ulteriore disbrigo.
Per quanto concerne i controlli negli altri settori non vi sono osservazioni di rilievo.
■ Infrazioni
Gli accertamenti, le inchieste e le indagini concernenti infrazioni della legislazione agricola vengono effettuati in collaborazione con autorità d’inchiesta federali e cantonali con organizzazioni private e altri servizi di assistenza giuridica. Nell’anno oggetto del rapporto sono stati aperti nove casi nell’ambito del contingentamento lattiero. Sei di questi sono stati trasmessi alla competente sezione per l’ulteriore disbrigo mentre tre sono ancora in elaborazione.
di controllo nell’anno oggetto del rapporto
2.4 SEZIONE ISPETTORATO DELLE FINANZE 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 215
■ Rallentamento del ritmo di trasformazione
2.5Evoluzione della politica agricola
Dall’inizio degli anni ’90 è in atto il processo di riforma a tappe della politica agricola. I prezzi delle materie prime agricole vengono progressivamente allineati al livello dei prezzi praticati all’estero e le prestazioni fornite nell’interesse della collettività vengono indennizzate in modo mirato mediante pagamenti diretti. La Politica agricola 2011 s’inserisce in maniera ottimale in tale processo. Essa mira a potenziare la competitività, riducendo ulteriormente il sostegno al mercato vincolato alla produzione e aumentando, per contro, i pagamenti diretti. Rispetto al passato, l’agricoltura svizzera è maggiormente esposta alla concorrenza internazionale e deve adeguarsi a queste nuove condizioni quadro.
I tappa: art. 31a e 31b vecchia LAgr
■ Introduzione di pagamenti diretti non vincolati alla produzione
■ Riduzione dei prezzi
■ Incentivo per prestazioni ecologiche particolari (p.es. biodiversità)
■ Riduzione della protezione alla frontiera (OMC)
II tappa: PA 2002
■ Abolizione delle garanzie di prezzo e di smercio
■ Liquidazione Butyra e Unione svizzera del formaggio
■ Creazione di un vincolo tra pagamenti diretti e prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
III tappa: PA 2007
■ Smantellamento contingent. lattiero
■ Vendita all’asta dei contingenti per l’importazione di carne
■ Misure sociali collaterali
IV tappa: PA 2011
■ Trasformazione del sostegno al mercato in pagamenti diretti
■ Abolizione dei sussidi all’esportazione
■ Incentivo alla creazione di valore aggiunto in aree rurali
93949596979899000102030405060708091011
Il 5 ottobre 2007, il Parlamento ha concluso i dibattiti sul messaggio riguardante l’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011). Le modifiche della LAgr e il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2008–2011 sono stati licenziati già nella sessione estiva 2007. Non è stato tuttavia raggiunto il numero di firme necessario per il referendum contro la modifica della legge sull’agricoltura. Il 1° gennaio 2008 dovrebbero entrare in vigore le modifiche della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura e della LAgr. Nel contempo entrerà in vigore anche il primo pacchetto di ordinanze sull’attuazione della Politica agricola 2011. Le modifiche del diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo, della legge sulle derrate alimentari e della legge sulle epizoozie passeranno in giudicato presumibilmente nella seconda metà del 2008.
In linea di massima il Parlamento ha approvato i punti cardine della Politica agricola 2011. I mezzi finanziari attualmente destinati al sostegno dei prezzi saranno ridotti e i sussidi all’esportazione completamente aboliti. Rispetto alla proposta del Consiglio federale il passaggio di fondi dal sostegno al mercato ai pagamenti diretti sarà più contenuto. La riduzione dei dazi per cereali e foraggi è stata approvata da entrambe le Camere. In deroga al messaggio del Consiglio federale il Parlamento ha licenziato le modifiche degli articoli della LAgr elencati di seguito.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
2.5 EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA 2 216
Promozione mirata dell’apicoltura: per quanto riguarda l’apicoltura nella LAgr vigono ora esplicitamente le disposizioni economiche generali, i provvedimenti concernenti ricerca e consulenza, la promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali e le misure preventive relative alla protezione dei vegetali e ai mezzi di produzione.
– Caratterizzazione dei prodotti svizzeri: per le campagne di promozione dello smercio per cui è previsto un sostegno finanziario è obbligatorio impiegare i simboli definiti dalla Confederazione.
– Gestione sull’intero territorio aziendale secondo il metodo di produzione biologica: nel messaggio il Consiglio federale ha proposto di poter autorizzare eccezioni ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologica e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate. Le eccezioni non rimangono limitate soltanto alle colture perenni.
– Nessuna protezione per la trasformazione di alimenti per animali: ai sensi di legge viene stabilito esplicitamente che le aliquote di dazio per gli alimenti per animali non devono contenere alcun elemento di protezione industriale. Il Consiglio federale ha già deciso la graduale riduzione di questi elementi.
– Nessuna vendita all’asta dei contingenti doganali di patate: l’assegnazione agli importatori di quote del contingente doganale parziale di patate continuerà ad avvenire in base alla prestazione all’interno del Paese.
– Autorizzazione di importazioni parallele: i mezzi di produzione e i beni d’investimento agricoli protetti da brevetto possono essere importati se sono stati messi in commercio all’estero dal titolare del brevetto.
– Supplementi per il latte più elevati: i mezzi finanziari relativi al supplemento per il latte trasformato in formaggio saranno aumentati di circa la metà. Fino al 2011 sarà mantenuta l’aliquota di 15 centesimi il chilogrammo sempre tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti effettivamente stanziati. Il supplemento per foraggiamento senza insilati sarà mantenuto sull’attuale livello di 3 centesimi il chilogrammo fino al 2011. Anche in tal caso si dovrà sempre tener conto dell’evoluzione dei quantitativi e dei crediti stanziati.
– Valorizzazione della lana di pecora: i contributi per la valorizzazione della lana di pecora indigena non vengono soppressi.
– Graduazione dei pagamenti diretti: la riduzione graduata dei pagamenti diretti a partire da un determinato numero di animali e da una data superficie viene mantenuta. Nel quadro della Politica agricola 2007 il Parlamento ne aveva deciso l’abolizione, che adesso viene revocata.
Aiuti agli investimenti per le piccole aziende commerciali nella regione di montagna: gli aiuti agli investimenti possono essere concessi non solo alle singole aziende agricole, alle costruzioni e agli impianti collettivi, bensì anche alle piccole aziende commerciali nella regione di montagna, a condizione che trasformino e commercializzino prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto. Le aziende puramente commerciali non vanno sostenute. Pertanto, per poter ricevere contributi e crediti d’investimento, le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.
–
–
2.5 EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 217
Nella determinazione dei tre limiti di spesa agricoli i mezzi finanziari hanno subito un aumento pari complessivamente a 150 milioni di franchi, da ripartire sul periodo 2009–2011. In funzione delle decisioni, il sostegno al mercato correlato ai supplementi per il latte viene ridotto in maniera più contenuta. Lo stesso accade per i contributi di coltivazione nella campicoltura. Ciò va a favore della produzione di semi oleosi, leguminose a granelli, sementi e piante da fibra.
Dati il maggior sostegno lattiero e i minori pagamenti diretti i contributi per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo non possono essere uniformati. I contributi per le vacche da latte commerciale vengono fissati a un livello più basso sfruttando i crediti stanziati.
L’ammontare dei mezzi finanziari per i miglioramenti strutturali è stato ripreso dal Parlamento nel decreto federale così come figura nel messaggio. Rispetto ai limiti di spesa 2004–2007 questi fondi hanno subito un taglio pari a un terzo.
Limite di spesa agricolo per il periodo 2008–2011
MessaggioDecreto federale del Differenza CF5 giugno 2007 Miglioramenti
Una parte considerevole dell’attuazione della politica agricola, segnatamente la riduzione del sostegno vincolato alla produzione e la trasformazione dei relativi mezzi in pagamenti diretti, sarà trasposta a livello d’ordinanza, come previsto, soltanto a partire dal 2009. Per tale motivo, le disposizioni esecutive relative alla Politica agricola 2011 sono state suddivise in due pacchetti d’ordinanze. Per quanto riguarda il primo pacchetto, l’UFAG ha avviato un’indagine conoscitiva rivolta a Cantoni e cerchie interessate nell’estate 2007. Questo pacchetto contiene principalmente le modifiche d’ordinanza con effetto al 1° gennaio 2008. Il secondo pacchetto contiene, invece, le aliquote dei pagamenti diretti dopo il trasferimento di fondi e sarà licenziato dal Consiglio federale nell’estate 2008.
strutturali7197190 Produzione e smercio1 5291 886357 Pagamenti diretti11 25111 044–207
49913 649150
Totale13
2.5 EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA 2 218
■ Quadro finanziario 2008–2011 lievemente aumentato
■ Revisione ridotta del diritto fondiario rurale e degli affitti agricoli
Per promuovere l’evoluzione strutturale nell’agricoltura, la dimensione minima di un’azienda agricola viene aumentata da 0,75 a 1,0 USM. L’aumento determina una riduzione del numero delle aziende che possono essere riprese al valore di reddito in seno alla famiglia e in seguito gestite parallelamente all’esercizio di un’altra attività professionale. Il terreno giunge sul mercato fondiario e degli affitti e la mobilità fondiaria aumenta. Nel messaggio il Consiglio federale proponeva un aumento a 1,25 USM.
Le particelle in zone edificabili vengono escluse dal diritto sull’affitto. I limiti di prezzo per i fondi agricoli e il limite d’aggravio nel diritto fondiario rurale così come il controllo dei canoni d’affitto per i fondi individuali nel diritto sull’affitto agricolo vengono mantenuti. Ai Cantoni è stata data la possibilità di aumentare il limite di prezzo per i fondi agricoli dal 105 al 115 per cento del prezzo medio degli ultimi cinque anni.
■ Tutti i progetti approvati
Non si sono incontrate particolari resistenze nel corso dei dibattiti sulle altre modifiche di legge. Il Parlamento ha approvato a grande maggioranza l’abolizione del limite di reddito relativamente agli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti con il parallelo aumento delle aliquote per gli assegni per i figli. Le modifiche delle leggi sulle derrate alimentari e sulle epizoozie hanno permesso di creare le basi per disciplinare meglio a livello d’ordinanza le disposizioni equivalenti in materia d’igiene.
■ Condizioni quadro per l’evoluzione della politica agricola
L’evoluzione della politica agricola dipende da numerosi fattori di politica interna ed esterna. Un fattore di politica interna è stato fissato nel quadro dei dibattiti sulla Politica agricola 2011. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare, entro il 2009, un rapporto sull’ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (Mozione 06.3635 CET-CS). In particolare vanno considerati i seguenti aspetti:
–evoluzione di altri sistemi di pagamenti diretti (UE) e delle condizioni quadro internazionali (OMC, Accordo agricolo con l’UE);
–idoneità dell’indennizzo di prestazioni non commerciali richieste dall’agricoltura; –utilizzo, per quanto possibile mirato, dei fondi in vista dell’effetto perseguito (p.es. produttività, ecologia, benessere degli animali, occupazione decentrata del territorio, garanzia dei redditi);
–possibilità d’incentivare le aziende affinché ottengano risultati superiori agli standard (p.es. biodiversità); –criteri d’ottenimento (azienda, superficie, unità di bestiame, lavoro); –esecuzione dai costi contenuti e credibile.
Mediante l’ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti s’intende offrire all’agricoltura un quadro stabile che le consenta di continuare ad adempiere il mandato costituzionale assegnatole. A tal fine si muove dalle esistenti basi costituzionali.
2.5 EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA 2 2.PROVVEDIMENTIDIPOLITICAAGRICOLA 219
I fattori determinanti sul piano della politica estera sono la possibile conclusione di un accordo OMC, gli accordi di libero scambio presenti e futuri nonché l’ulteriore sviluppo degli accordi agricoli bilaterali (clausola evolutiva) o di un eventuale accordo di libero scambio nel settore agricolo con l’UE.
Base costituzionale (art. 104 Cost.)
Attuazione PA 2007
Elaborazione e dibattito parlamentare PA 2011
Attuazione PA 2011
Rapporto PDEvoluzione PA
Accordo libero scambio agr. con l’UE (ALSA) colloqui espl., negoziati e lex
Attuazione ALSA
Attuazione decisione OMC Negoziati OMC e lex OMC
Accordi bilaterali I e II (Accordo agricolo, Protocollo 2)
Diversi accordi di libero scambio
200420052006200720082009201020112012
2.5 EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA 2 220
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3. Aspetti internazionali

3
221
L’ampliamento delle relazioni commerciali internazionali riguarda vieppiù l’agricoltura. Essa, infatti, è stata inglobata nella normativa internazionale dell’OMC. Dal punto di vista della concentrazione geografica del commercio agricolo, gli accordi con l’UE e la progressiva integrazione nel panorama europeo rivestono un notevole significato per la Svizzera.
Al fine di mantenere ed ampliare le proprie possibilità di esportazione, la Svizzera necessita di un accesso ai mercati esteri possibilmente libero. Inoltre, essa si impegna notevolmente a livello internazionale affinché gli accordi internazionali tengano maggiormente in considerazione la multifunzionalità dell’agricoltura.
Il Rapporto agricolo tiene conto di questi sviluppi sul piano internazionale, trattandone gli aspetti principali nel terzo capitolo.
–La parte 3.1 contiene informazioni sullo stato attuale nel fascicolo Europa, sui negoziati dell’OMC, sugli accordi di libero scambio, in seno all’OCSE e alla FAO.
–Nella parte 3.2 vengono effettuati confronti sul piano internazionale. Nel presente rapporto viene approfondito il tema dell’aumento dei prezzi delle materie prime, data la sua attualità.
3. ASPETTI INTERNAZIONALI 3 222
3.1 Sviluppi sul piano internazionale
Oltre al processo di adeguamento permanente all’interno del Paese, la progressiva globalizzazione dell’economia rappresenta la sfida più importante per l’agricoltura svizzera.

–L’aumento dei prezzi delle materie prime – riconducibile tra l’altro alla crescita del consumo nei grandi Paesi di recente industrializzazione quali Cina ed India nonché alle nuove possibilità di utilizzo soprattutto come biocarburanti – ha determinato un’inversione della tendenza strutturale, in atto da decenni, al ribasso dei prezzi di produzione, quantomeno temporaneamente. Le conseguenze a lungo termine di questa evoluzione, soddisfacente dal profilo dei produttori, sono tuttavia difficilmente stimabili.
–Nell’anno oggetto del rapporto, le riforme attuate nella Politica agricola comune del nostro principale partner commerciale, l’UE, hanno riguardato essenzialmente i disciplinamenti dei mercati di zucchero, frutta e verdura. Ad esse si aggiungono le proposte di riforma nel settore vinicolo a conferma della tendenza al disaccoppiamento e alla semplificazione.
–Negli accordi bilaterali del 1999 tra Svizzera e UE, quasi tutti i settori sono stati interessati da adeguamenti ai nuovi standard e alle più recenti politiche. Il 1° giugno 2007 è stato totalmente liberalizzato il commercio caseario come sancito da questi accordi, anche se fino a fine 2007 saranno mantenute ancora alcune limitazioni amministrative.
■■■■■■■■■■■■■■■■■
3.ASPETTIINTERNAZIONALI 3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 223
–Nel presente capitolo viene innanzitutto illustrato il progetto lanciato all’inizio del 2006 di «Accordo di libero scambio con l’UE nel settore agroalimentare». Dai lavori preliminari emerge che un accordo di questo tipo potenzierebbe immediatamente la competitività sul piano internazionale del settore alimentare. La maggiore pressione dei prezzi sulle aziende e sulle imprese svizzere nel settore agroalimentare potrebbe essere compensata, almeno parzialmente, concentrandosi su strutture e metodi di produzione più efficienti così come sfruttando il libero accesso al mercato interno europeo. Creando pari opportunità rispetto alla concorrenza dell’UE gli agricoltori svizzeri disporrebbero di prospettive chiare su cui impostare le proprie decisioni d’investimento a lungo termine. Entro fine gennaio 2008 il Consigliofederale deciderà se avviare negoziati su un accordo di libero scambio in base ai numerosi studi ed accertamenti preliminari e tenendo conto degli sviluppi a livello europeo e politico-commerciale.

–Nemmeno la stagnazione dei negoziati OMC è in grado, ormai, di arrestare il processo di riduzione della protezione alla frontiera. Gli accordi di libero scambio siglati tra numerosi Paesi impongono anche alla Svizzera di concludere accordi commerciali bilaterali e regionali, onde prender parte al commercio mondiale in costante crescita e godere dei risvolti positivi di tale evoluzione globale. Questa situazione coinvolge necessariamente anche l’agricoltura.
–L’esenzione da dazio in vigore dal 1° aprile per i prodotti agricoli dai Paesi in via di sviluppo più poveri non avrà ripercussioni dirette sui volumi d’importazione, molto esigui, da questi Paesi. Nonostante ciò anche in questo frangente, per motivi legati all’evoluzione politica, è stata attuata una significativa apertura delle frontiere.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 224
■ Risultati delle analisi esplorative
Accordo di libero scambio con l’UE nel settore agroalimentare (ALSA)
Dalla consultazione, in Svizzera, delle cerchie interessate e dai sondaggi presso la Commissione UE è scaturito un interesse di massima nei confronti di ulteriori accertamenti in vista di una liberalizzazione degli scambi nel settore agroalimentare tra Svizzera e UE (ALSA). Sulla scorta di questo risultato, nel giugno 2006, il Consiglio federale ha incaricato il DFE e il DFAE di avviare colloqui esplorativi con l'UE e di svolgere parallelamente un'analisi approfondita delle ripercussioni sul piano economico-finanziario di un simile accordo. I risultati finora ottenuti, di cui il Consiglio federale ha preso conoscenza il 4 luglio 2007, confermano l’interesse di massima dell’UE, la fattibilità dal profilo tecnico e i vantaggi per tutta l’economia di un eventuale ALSA. Le durevoli ricadute sul prodotto interno lordo (PIL) e sul potere d’acquisto dei consumatori come pure il miglioramento della competitività dell’intero settore agroalimentare potrebbero compensare rapidamente ed in maniera sensibile i temporanei costi d’adeguamento.
Un eventuale ALSA è ragionevole laddove, oltre a coinvolgere l’intera filiera di produzione alimentare (ovvero l’agricoltura nonché i settori a monte e a valle), non vengono eliminati soltanto gli ostacoli al commercio tariffali (dazi, contingenti doganali), bensì anche quelli non tariffali. Con tale approccio s’intende garantire non soltanto l’accesso al vicino mercato UE ad alto potere d’acquisto, bensì anche un margine di risparmio sull’acquisto di mezzi di produzione agricoli e beni d’investimento.
Dalle indagini esplorative con la Commissione UE è emerso un quadro ben definito dei possibili valori di riferimento di un eventuale ALSA. In linea di principio l’UE accetta l’approccio della Svizzera secondo cui gli eventuali negoziati dovranno tener conto degli ostacoli al commercio di natura tariffale e non a tutti i livelli della filiera di produzione alimentare. Per quanto riguarda dazi e contingenti doganali sono possibili fasi transitorie con la progressiva riduzione per tutti o determinati prodotti. L’eliminazione degli ostacoli al commercio non tariffali può avvenire mediante il reciproco riconoscimento dell’equivalenza delle prescrizioni legali o mediante la ripresa da parte della Svizzera dell’acquis communautaire ovvero dell’insieme delle norme europee rilevanti. In entrambi i casi non dovrebbero porsi difficoltà materiali di fondo, poiché il livello di regolamentazione in Svizzera e nell’UE è comparabile e dovrebbero essere possibili deroghe nei settori sensibili (OGM, protezione degli animali). L’introduzione della libera circolazione delle merci e l’adeguamento della legislazione presupporrebbero il coinvolgimento della Svizzera nei processi e negli organi dell’UE per l’analisi dei rischi e la presa di decisioni in relazione ai provvedimenti rilevanti nei settori della sanità, dell’ambiente e della protezione dei consumatori.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 225 3.ASPETTIINTERNAZIONALI
■ Consultazione delle cerchie interessate in Svizzera
Nel 2006 il progetto di un ALSA di ampia portata è stato discusso con le cerchie interessate (Cantoni, autorità, associazioni, organizzazioni di categoria e imprese). È emerso un interesse di fondo a portare avanti questo progetto. L’ampio approccio proposto ha ottenuto largo consenso.
Le opportunità per l’agricoltura e l’industria di trasformazione si concentrano in particolare sull’esportazione di specialità nei settori caseario, della carne e vinicolo. Inoltre, l'economia agroalimentare potrebbe riconquistare le quote di mercato perse a causa del turismo degli acquisti. Le associazioni economiche si attendono risvolti positivi sull’economia in termini di produttività e competitività. Decisivo sarà che anche i consumatori possano beneficiare del calo dei prezzi.
Il rischio più grosso sembra essere il maggiore livello di costi in Svizzera, che un eventuale ALSA contribuirebbe a ridurre soltanto in parte. Ne conseguirebbe che non si potrebbe ovviare completamente agli scompensi dal profilo dei prezzi attraverso corrispettive riduzioni dei costi. In tutto il settore agroalimentare si verificherebbero, quindi, forti pressioni su stipendi e posti di lavoro. Le conquiste in campo ecologico ed etologico (ambiente e allevamento) così come gli standard nell’informazione dei consumatori dovrebbero essere conservati.
Nel quadro dei lavori commissionati nel giugno 2006 dal Consiglio federale è stato portato avanti l’intenso dialogo con le organizzazioni di categoria e le imprese interessate, che dal canto loro auspicano principalmente una situazione di pari opportunità rispetto alla concorrenza europea in condizioni di libero scambio.
■ Effetti economici
Parallelamente alle indagini esplorative è stata svolta un’analisi delle conseguenze economiche di un eventuale ALSA sulla base di un modello d’equilibrio economico. I risultati dell’analisi mostrano, tra l’altro, che il PIL segnerebbe un aumento durevole di almeno lo 0,5 per cento ossia di circa 2 miliardi di franchi l’anno. Ciò può essere spiegato da due effetti economici complementari.
1.Con il libero scambio con l’UE i prezzi al dettaglio dei generi alimentari in Svizzera subirebbero un notevole calo. Ciò potenzierebbe immediatamente la competitività sul piano internazionale dei settori direttamente interessati, segnatamente l’industria alimentare e il turismo. I consumatori beneficerebbero della diminuzione dei costi di sostentamento e di conseguenza crescerebbe il reale potere d’acquisto delle economie domestiche. Ciò comporterebbe un aumento della domanda in tutti i settori economici (effetto sulla domanda).
2.La maggiore pressione sul fronte dei prezzi indurrebbe le aziende e le imprese svizzere del settore agroalimentare a attuare adeguamenti e tagli dei costi. A tal fine occorrerebbe da un lato concentrarsi su strutture e metodi di produzione più efficienti (p.es. specializzazione nella coltivazione e nella fabbricazione di prodotti ad elevato valore aggiunto, miglior impiego di edifici, impianti e macchinari, processi ottimizzati, aziende più grandi, maggiore cooperazione, ecc.) e, dall’altro, sfruttare il margine di manovra creato dal libero accesso al mercato interno europeo nel campo della produzione e dello smercio. Ciò comporterebbe un incremento della produttività del settore agroalimentare (effetto sull’offerta)
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 226
Per l’agricoltura e l’industria alimentare svizzere l’ALSA garantirebbe il libero accesso al mercato interno europeo, contrariamente a una riduzione generale dei dazi nel quadro dell’OMC, la quale comporterebbe migliori possibilità di accesso al mercato soltanto a determinate condizioni. In tal modo le aziende competitive avrebbero l’opportunità di compensare, perlomeno in parte, le riduzioni di prezzo all’interno del Paese ampliando le possibilità di smercio all’estero. Le quote di mercato andate perse a livello nazionale potrebbero essere riacquisite e ne potrebbero essere conquistate delle nuove all’estero. Creando pari opportunità rispetto alla concorrenza dell’UE gli agricoltori svizzeri disporrebbero di prospettive chiare su cui impostare le proprie decisioni d’investimento a lungo termine.
Nonostante ciò l’ALSA porrebbe l’agricoltura svizzera di fronte a sfide impegnative. L’apertura del mercato determinerebbe una perdita di reddito nel primario la cui portata effettiva dipende, in particolare, dai seguenti fattori: sfruttamento del potenziale d’esportazione, difesa efficace delle quote di mercato in Svizzera, portata delle riduzioni dei costi, aumento della produttività e riacquisizione delle quote di mercato perse a causa del turismo degli acquisti.
Studi di singole associazioni di categoria sulle conseguenze di un eventuale ALSA
Heiko Bergmann e Urs Fueglistaller (KMU-HSG), 2007. «Auswirkungen eines Agrarfreihandelsabkommen CH-EU auf die Produktion und den Grosshandel von Tafeläpfeln, Lagerkarotten und Rispentomaten in der Schweiz»
–Nell’UE i prezzi di vendita dei prodotti presi in esame sono inferiori del 50 per cento circa a quelli praticati in CH.
–L’ALSA non determinerebbe una riduzione degli elevati costi di manodopera, macchinari, infrastrutture, trasporti, condizionamento ed energia.
–Costo unitario del lavoro decisivo! CH: elevati costi legati al personale + piccole strutture di produzione.
–UE: i produttori ricevono aiuti agli investimenti attraverso associazioni di produttori, CH: i produttori ricevono un sostegno in base alla superficie comparativamente più alto.
–I prodotti presi in esame sono commodities (il prezzo è più importante della qualità nella scelta dell’acquisto).
–Valore aggiunto possibile puntando su gusto, freschezza, salute, vicinanza al consumatore.
–Scarse opportunità d’esportazione poiché esistono poche possibilità di differenziazione.
Heiko Bergmann e Urs Fueglistaller (KMU-HSG), 2006. «Auswirkungen eines Agrarfreihandelsabkommen CH-EU auf die mittelgrossen Betriebe der Gemüse-, Kartoffel- und Ölsaatenverarbeitung»
–Nell’UE il livello dei prezzi dei prodotti presi in esame è nettamente inferiore a quello in CH. –Rispetto all’UE i costi di trasformazione in CH sono nettamente più alti (manodopera ed elettricità più care, no economies of scale).
–I prodotti presi in esame sono commodities (il prezzo è più importante della qualità nella scelta dell’acquisto). –Opportunità per le specialità, ma non per i prodotti di massa.
Bernard Lehmann (PFZ) e Hans-Georg Christiansen (Christiansen Unternehmensberatung), 2007. «Staatliche Unterstützung zugunsten der milchverarbeitenden Industrie in Deutschland und der Schweiz»
–L’industria di trasformazione europea beneficia di sostegni statali che non esistono in CH.
–Principalmente aiuti agli investimenti, fino al 50 per cento dei costi d’investimento.
–Sostegni specifici per ubicazione e imprese (princip. PMI).
–Il comportamento delle imprese per quanto riguarda gli investimenti, tuttavia, è più influenzato dall’evoluzione di mercato che dagli strumenti di promozione statali.
–I sostegni hanno un ruolo importante per la competitività delle piccole imprese.
3.ASPETTIINTERNAZIONALI 3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 227
Se venisse attuato un ALSA, il settore agroalimentare svizzero dovrebbe adeguarsi a nuove condizioni quadro. Mantenendo l’attuale livello dei pagamenti diretti, per garantire uno sviluppo agricolo socialmente sostenibile dovrebbero essere concessi aiuti a tempo determinato per agevolare tale adeguamento. Tali misure andrebbero impostate in maniera da non limitare l’autonomia decisionale del capoazienda e promuovere il mutamento strutturale onde creare per le aziende rimaste sul mercato condizioni ottimali per uno sviluppo sostenibile.

Viste le circostanze, il 4 luglio il Consiglio federale ha incaricato i Dipartimenti responsabili di portare a termine le indagini esplorative per definire il quadro di un ALSA e di elaborare un concetto relativo alla portata, all’impostazione e al finanziamento di misure collaterali. In base a ciò, entro fine gennaio 2008 il Consiglio federale deciderà se avviare negoziati su un accordo di libero scambio tenendo conto degli sviluppi a livello europeo e politico-commerciale.
Accordi di libero scambio con Paesi al di fuori dell’UE
La Svizzera è un Paese dall’economia ad orientamento fortemente internazionale. Ciò è quanto confermato dal saldo commerciale 2006, che indica un volume d’esportazione di 177 miliardi di franchi circa, contro i 166 miliardi di franchi circa del volume d’importazione. Gli scambi commerciali di beni e servizi così come gli investimenti internazionali risultano quindi determinanti per la prosperità della Svizzera; ecco perché un obiettivo importante della sua politica economica estera è il costante miglioramento dell’accesso ai mercati esteri. Il modo migliore per raggiungere tale obiettivo è rappresentato da un approccio nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
L’esito dei negoziati del Doha Round nel quadro dell’OMC appare tuttavia incerto. Per incrementare la liberalizzazione degli scambi, molti Paesi hanno quindi iniziato a concludere simultaneamente accordi bilaterali o multilaterali, regionali o interregionali. Negli ultimi anni, i nostri principali concorrenti sui mercati internazionali, l’UE in particolare, hanno continuamente ampliato la propria rete di accordi di libero scambio. La Svizzera si avvale degli accordi di libero scambio quale mezzo per garantire alle proprie imprese un accesso ai mercati internazionali quanto meno pari a quello di cui beneficiano i suoi principali concorrenti. Soltanto così è possibile rafforzare la competitività e la prosperità della piazza economica svizzera.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 228
■ Misure collaterali
La strategia di politica economica estera del Consiglio federale stabilisce quattro criteri per la scelta di un eventuale partner di libero scambio:
1.rilevanza economica effettiva e potenziale dell’eventuale partner;
2.portata delle discriminazioni esistenti o possibili che scaturirebbero da accordi di libero scambio tra l’eventuale partner e importanti concorrenti della Svizzera;
3.volontà dell’eventuale partner di negoziare e possibilità di riuscita;
4.considerazioni di natura politica (p.es. i benefici che si trarrebbero, a livello di stabilità e sviluppi economici, dalla conclusione di un accordo di libero scambio con un eventuale partner e più in generale la coerenza con gli obiettivi della politica estera della Svizzera).
Dal 1960 la Svizzera fa parte dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che tra i suoi membri conta Islanda, Norvegia e Principato del Liechtenstein. Accanto alla Convenzione AELS, ad oggi sono stati conclusi oltre 17 accordi di libero scambio nell’ambito dell’AELS. Islanda, Norvegia e Principato del Liechtenstein sono anche membri dello Spazio Economico Europeo (SEE), cui nel 1992 la Svizzera non ha aderito.
Gli Stati AELS, normalmente, negoziano congiuntamente i loro accordi di libero scambio. Tuttavia, ogni Paese ha la possibilità di siglare accordi al di fuori dell’AELS. A titolo d’esempio, la Svizzera, nel 1995, ha concluso un accordo bilaterale con le Isole Faroe e attualmente, in seguito ad uno studio congiunto di fattibilità, ne sta negoziando un altro con il Giappone, uno dei suoi principali partner commerciali.
I primi accordi risalenti agli anni ’90 sono stati siglati con Paesi dell’Europa orientale, oggi membri dell’UE, e con Turchia, Croazia e Macedonia. L’obiettivo principale del processo di Barcellona dell’UE è la creazione, entro il 2010, di una zona di libero scambio euro-mediterranea per dare impulso economico all’intero bacino mediterraneo. Ciò ha indotto la Svizzera a cercare nuovi accordi con Paesi del bacino mediterraneo quali Marocco, Tunisia, Egitto, Libano, Israele, Autorità palestinese e Giordania.
Con il crescente aumento del numero di accordi di libero scambio interregionali, la Svizzera ha iniziato ad estendere la propria politica di libero scambio a potenziali partner oltreoceano.
3.ASPETTIINTERNAZIONALI 3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 229
■ Accordi di libero scambio della Svizzera
–Alla fine degli anni ’90 sono stati avviati negoziati con il Canada, che tuttavia sono stati a lungo in situazione di stallo a causa di problemi insormontabili tra Canada e Norvegia, partner della Svizzera nell’AELS, nel settore della costruzione navale. Soltanto nel gennaio 2007 si è giunti con successo alla conclusione delle trattative. L’accordo dovrebbe essere siglato entro breve ed entrare in vigore prima della fine del 2007. Sempre per quanto riguarda il continente americano, sono stati successivamente firmati accordi con il Messico (2001) e il Cile (2002). Nel maggio 2007 sono state altresì intraprese le trattative per un accordo con Colombia e Perù. Sono state concluse convenzioni di collaborazione con l’obiettivo di negoziare in futuro un accordo di libero scambio con i membri del Mercosur (Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Venezuela). Nel 2005 in seguito ad indagini esplorative, l’ipotesi di negoziare un eventuale ampio accordo bilaterale di libero scambio tra Svizzera e USA è apparsa manifestatamene infondata.
–Negli ultimi due anni, la piazza economica asiatica ha fatto registrare una crescita enorme e è diventata un mercato di sbocco sempre più importante per i Paesi industrializzati occidentali. Finora gli Stati AELS hanno concluso accordi con Singapore e Corea del Sud. Sono in corso negoziati con la Tailandia e con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (CGC: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Oman). È altresì prevista l’apertura di negoziati con India, Indonesia, Malesia e Cina.
–Per quanto riguarda il continente africano, l’anno scorso è stato siglato un accordo con gli Stati della SACU (Unione doganale dell’Africa australe che comprende Africa del Sud, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland), il quale entrerà presumibilmente in vigore nel secondo semestre del 2007.
Gli accordi di libero scambio conclusi con partner dell’Europa orientale e del bacino mediterraneo (cosiddetti accordi «di prima generazione») contenevano per lo più disposizioni sulla libera circolazione delle merci e sulla protezione della proprietà intellettuale. In primo luogo venivano reciprocamente ridotti o aboliti i dazi doganali (industria) ed eliminati gli ostacoli al commercio. Le concessioni concordate nel quadro di scambi di lettere o accordi bilaterali relativamente a prodotti agricoli non trasformati avevano tutte una portata limitata.
Gli accordi conclusi con Messico, Cile, Singapore e Corea del Sud sono di ampia portata (cosiddetti accordi di «seconda generazione»), poiché oltre alla circolazione delle merci e alla protezione della proprietà intellettuale includono di norma anche impegni sostanziali in ambito di servizi, investimenti e mercati pubblici.
Gli accordi AELS con Paesi terzi non membri dell’UE sono praticamente tutti accordi asimmetrici a favore dei Paesi partner. Gli Stati AELS applicano già dazi doganali bassi nel settore industriale e concedono l’accesso al mercato a dazio zero per tutti i beni industriali a partire dall’entrata in vigore dell’accordo. A loro volta i Paesi partner concedono una graduale riduzione dei dazi doganali su diversi anni. La maggior parte dei 13 accordi di libero scambio attualmente esistenti è stata conclusa con Paesi in via di sviluppo o con Paesi di recente industrializzazione, quasi tutti esportatori di prodotti agricoli (Messico, Cile, Paesi del bacino mediterraneo, ecc.). Pertanto, il successo nella conclusione di un accordo dipende essenzialmente dalle concessioni nel settore agricolo che gli Stati AELS sono disposti a fare.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 230
■ Contenuto degli accordi di libero scambio
Le concessioni tariffali in ambito agricolo si basano in primo luogo sugli interessi d’esportazione di entrambi i partner. Ciò significa che vengono negoziate concessioni «su misura». Per quanto riguarda i prodotti sensibili per l’agricoltura svizzera viene garantito che la Svizzera possa perseguire la sua politica agricola in piena autonomia senza essere limitata da accordi di libero scambio con Paesi terzi. Nella maggior parte dei casi finora si è trattato di definire, per mezzo di accordi bilaterali, le riduzioni tariffali concesse autonomamente nel quadro del sistema di preferenze tariffali generalizzate per i Paesi in via di sviluppo (PVS). Ulteriori agevolazioni di accesso vengono concesse in maniera molto restrittiva e nel caso di prodotti rilevanti dal profilo della politica agricola vengono imposte limitazioni quantitative o stagionali. Gli interessi offensivi della Svizzera sono spesso puntati sui prodotti sensibili dei suoi Paesi partner (latte, carne, verdura e frutta) nonché sui prodotti agricoli trasformati. Nonostante ciò la Svizzera ha spesso potuto negoziare concessioni reciproche soprattutto per specialità quali formaggio o carne secca.
Da anni l’interesse di fondo per la protezione delle indicazioni geografiche induce in molti casi a avviare negoziati poiché in tal modo può essere dato risalto in maniera credibile alla particolarità dei prodotti agricoli. La Svizzera è una ferma sostenitrice dell’estensione di questa protezione nel quadro dell’accordo dell’OMC attraverso i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) a tutti i prodotti agricoli e pertanto cerca di integrare questo aspetto fondamentale per l’agricoltura anche nei negoziati con Paesi terzi, rafforzando indirettamente la propria posizione nel quadro dell’OMC.
Gli accordi di libero scambio nell’ambito dell’AELS con i partner non membri dell’UE concernono attualmente il 7 per cento circa delle esportazioni della Svizzera. Osservando gli sviluppi statistici si constata che il commercio estero della Svizzera con partner di accordi di libero scambio presenta tassi di crescita decisamente superiori a quelli del commercio con Paesi con cui non sono stati siglati accordi. Secondo i dati statistici sul commercio estero, nel periodo 1992–2002, il commercio globale della Svizzera (somma di importazioni ed esportazioni) ha segnato una crescita del 3 per cento l’anno circa, mentre gli scambi con i partner di accordi di libero scambio, nei primi quattro anni dall’entrata in vigore degli accordi, hanno registrato in media un aumento annuale del 10 per cento circa.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 231
■ Effetti economici
Accordi di libero scambio con Paesi non membri dell’UE con esempi di concessioni accordate in ambito agricolo (stato giugno 2007)
PaeseEntrata in vigoreEsempi di concessioni specifiche Esempi di concessioni specifiche accordate dalla Svizzera ai Paesi partner accordate dai Paesi partner alla Svizzera
EgittoSottoscritto in data
27.1.2007
Cile1.2.2004
Isole Faroe1.3.1995
Israele1.1.1993
Giordania1.1.2002
CanadaNegoziati conclusi
Croazia1.1.2002
Libano1.1.2007
Contingente reciproco di formaggio, latte in polvere, miele per la trasformazione industriale, fiori recisi, patate (contingente), uva da tavola (contingente), olio d’oliva (contingente), pesche e pesche noci (contingente)
Uva da tavola, nocciole, olio d’oliva
Concessioni AELS
Nessuna concessione supplementare Carne di pollame, uva da tavola, olio d’oliva, succhi di frutta (senza zucchero aggiunto)
Grano duro, carne equina, sperma di toro, contingente a dazio zero per alimenti per cani e gatti
Sconti per formaggio, miele, kiwi, farina di malto, olio d’oliva, minestre, salse
Latte in polvere, contingente di formaggio, pectina e pectinati
Bestiame da allevamento, carne secca, sperma di toro
Accesso al mercato a dazio zero per tutti i prodotti agricoli, ad eccezione di poche voci di tariffa
Prodotti agricoli trasformati
Bestiame da allevamento, latte in polvere, formaggio a pasta dura e semidura, caffè torrefatto, preparazioni foraggiere
Formaggio a pasta dura e semidura, carne bovina, sperma di toro, preparazioni foraggiere
Bestiame da allevamento, contingenti di latte in polvere e formaggio, preparazioni alimentari e alcool etilico
Marocco1.1.1998
Macedonia1.1.2001
Messico1.7.2001
Carne ovina e caprina, frattaglie, carne di pollame, formaggio fresco, piante ornamentali vive, fiori recisi, alberi di natale, uva da tavola (contingente), olio d’oliva, insaccati, conserve di carne Fiori recisi, pomodori, verdure varie, olio d’oliva, verdure pronte, conserve di verdura, noci, succhi di frutta
Conserve di verdura (miscele), succhi di frutta
Uova esenti da patogeni, miele per la trasformazione industriale, banane, uva da tavola, caffè crudo e torrefatto, succhi vegetali, pectina, succhi di frutta, birra, liquori, acquavite
Bestiame da allevamento, latte in polvere, formaggio, sperma di toro, caffè torrefatto, essenze/estratti di caffè e tè, preparazioni foraggiere
Formaggio, conserve di frutta, essenze/estratti di caffè e tè, preparazioni foraggiere
Bestiame da allevamento, contingente di formaggio, essenze/estratti di caffè e tè
Bestiame da allevamento, sperma di toro, pectina e pectinati, essenze/estratti di caffè e tè, minestre, salse, preparazioni alimentari, alcool etilico, liquori e acquavite, preparazioni foraggiere
Autorità 1.7.1999
palestinese
SACU Sottoscritto in data
Unione doganale 1.7.2006
dell’Africa australe
Miele, uva da tavola, agrumi, patate, olive, olio d’oliva
Latte in polvere, formaggio, caffè torrefatto, marmellate, conserve di frutta
Singapore1.1.2003
SPG più carni fresche, refrigerate o congelate (contingente), carne secca (Biltong), contingente di formaggio a pasta dura e semidura, miele per la trasformazione industriale, nocciole, uva da tavola, caseina, albume d’uovo Orchidee speciali
Bestiame da allevamento, carne secca, contingenti di formaggio a pasta dura e semidura, frutta in polvere, conserve di verdura, essenze/estratti di caffè e tè, preparazioni foraggiere, sigari, sigarette, tabacco pronto all’uso
Accesso al mercato a dazio zero per tutti i prodotti agricoli
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 232
Accordi di libero scambio con Paesi non membri dell’UE con esempi di concessioni accordate in ambito agricolo (stato giugno 2007)
PaeseEntrata in vigoreEsempi di concessioni specifiche Esempi di concessioni specifiche accordate dalla Svizzera ai Paesi partner accordate dai Paesi partner alla Svizzera Corea del Sud1.9.2006
Conserve di verdura (Kimchi), bevande fermentate di riso («Cheong ju», «Yak ju», «Tak ju», «Makkoli»)
Tunisia1.6.2005
Turchia1.4.1992

Carne di selvaggina, struzzo, cammello, patate, olio d’oliva (contingente)
Fegato di pollame, fiori recisi, succhi di frutta, raki, olio d’oliva
Bestiame da allevamento, carne secca, contingenti di formaggio, sperma di toro, vino, preparazioni foraggiere, sigarette Latte in polvere, formaggio fuso, marmellate, conserve di frutta, essenze/estratti di caffè e tè, preparazioni foraggiere Prodotti agricoli trasformati
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 233
Accordo agricolo Svizzera–UE
Il Comitato misto per gli accordi agricoli tra Svizzera e UE si è riunito per la sesta volta l’8 dicembre 2006. La riunione si è svolta a Bruxelles sotto la presidenza della Commissione UE. Per la prima volta ha partecipato anche una delegazione del Liechtenstein in qualità di osservatrice. La Svizzera e la Commissione UE avevano già approvato la richiesta del Principato del Liechtenstein di aderire all’accordo agricolo bilaterale.

Dopo ulteriori lavori tecnici preliminari, il 2 maggio 2007 ha potuto essere concordata, in linea di massima, la prima grande revisione dell’accordo agricolo sotto forma di agreed minutes. Si tratta essenzialmente di modifiche e aggiornamenti degli allegati 1 e 2 per concessioni tariffali reciproche nonché 4–9 per disposizioni tecnico-commerciali. Le modifiche degli allegati 1 e 2 interessano i contingenti doganali in seguito all’entrata nell’UE di Romania e Bulgaria il 1° gennaio 2007 come pure alla comunitarizzazione di contingenti doganali bilaterali per gli insaccati. Le modifiche degli allegati 4–9 sono, invece, adeguamenti puramente tecnici. Nell’allegato 4 è stata apportata una semplificazione amministrativa secondo cui gli Stati devono comunicare soltanto su richiesta gli indirizzi dei servizi competenti per il rilascio del passaporto delle piante. Nel quadro del reciproco riconoscimento delle disposizioni in materia di igiene in relazione agli alimenti per animali si è reso necessario un adeguamento delle due appendici dell’allegato 5. L’allegato 6 è stato modificato con l’allestimento di un catalogo comune delle sementi per il reciproco riconoscimento delle varietà di sementi. Gli allegati 7 e 8 sono stati adeguati al nuovo contesto giuridico e completati con la lista dei vini e delle bevande contenenti alcol di distillazione dell’UE-27; infine nell’allegato 9 è stata apportata una semplificazione amministrativa abolendo l’attestato di controllo per i prodotti biologici (anche per prodotti da Paesi terzi). Dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale, il 27 giugno 2007, dell’impiego a titolo provvisorio di queste concessioni tariffali, il Parlamento dovrebbe approvarle in via definitiva nella primavera 2008. Inoltre è stato deciso di formulare l’articolo 11 dell’accordo agricolo in modo che in futuro il Comitato misto possa approvare le modifiche degli allegati 3–10 di natura non tariffale, senza decreto del Consiglio UE, accelerando quindi il processo d’adeguamento. Sul fronte dell’UE tutte queste modifiche devono essere ancora ratificate dal Consiglio dei ministri.
L’allegato 3 dell’accordo agricolo sancisce la completa liberalizzazione del commercio caseario tra Svizzera e UE a decorrere dal 1° giugno 2007. Per motivi amministrativi, la procedura di licenza concernente le importazioni nell’UE potrà essere soppressa presumibilmente soltanto a partire dal 1° gennaio 2008. Quale regolamentazione transitoria, è stata concordata, a partire dal 1° giugno 2007, una riduzione da parte della Commissione UE della cauzione per i formaggi svizzeri da 10 a 1 euro il quintale. Una volta abolita la procedura di licenza la Svizzera annullerà la tassa di scarico pari a 5 franchi per consegna e anche il permesso generale d’importazione (quale misura amministrativa per il controllo statistico delle importazioni di formaggio). In seguito ai commercianti di formaggio sarà richiesto solo il certificato d'origine.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 234
■ Libero commercio di formaggio
■ Negoziati sulle DOP
Nell'atto finale degli accordi bilaterali I le parti confermano il loro intento di estendere la protezione delle denominazioni di origine già vigente per vino e bevande contenenti alcol di distillazione anche ad altri prodotti agricoli e derrate alimentari. Ciò con l’obiettivo di raggiungere un riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Già nel giugno 2005 il Consiglio federale aveva assegnato un mandato negoziale a tal fine, facendosi garante di un reciproco riconoscimento globale delle denominazioni di origine protette sulla scorta di apposite liste e ponendo l’accento in particolare sulle denominazioni dei formaggi. Una volta che il Consiglio UE avrà approvato un mandato per questi negoziati, nel luglio 2007 potrà iniziare la fase negoziale vera e propria.
Politica agricola comune dell’UE
■ Stato di salute 2008
I concetti principali proposti dalla Commissione europea nel quadro dello «Stato di salute» della Politica agricola comune (PAC), previsto per il 2008, sono: più disaccoppiamento dei pagamenti diretti, semplificazione del regime di pagamento unico per azienda, più modulazione obbligatoria, lavori preliminari in vista dell’abolizione delle quote latte, prevista per il 2015, opzioni di gestione delle crisi che dovrebbero sostituire l’intervento pubblico.
–Semplificazione del regime di pagamento unico per azienda (RPU): abolizione dell’incentivo di 45 euro l’ettaro per le coltivazioni ad uso energetico, del pagamento unico per azienda previsto specificatamente per la messa a riposo, nonché degli altri sostegni soggetti a specifiche condizioni cosicché gli attuali quattro diversi tipi di incentivi potrebbero infine ridursi a uno solo.
–Limite inferiore dei pagamenti unici per azienda: introduzione di una soglia minima per la corresponsione del pagamento unico per azienda, quale importo minimo per singola azienda, oppure innalzamento dell’attuale soglia di una superficie minima di 0,3 ettari necessari per fare domanda.
–Modulazione obbligatoria (riduzione degli aiuti diretti a favore di provvedimenti agroambientali): incremento del tasso di modulazione obbligatoria dall’attuale 5 per cento (nel 2008) al 6 per cento nel 2009, al 7 per cento nel 2010, eccetera, fino ad arrivare al 10 per cento dal 2013 in poi.
–Più disaccoppiamento dei pagamenti diretti: abolizione dell’opzione di pagamento accoppiato del 25 per cento per i seminativi, usato unicamente in Francia e Spagna. Per altri comparti possibilità di mantenere un accoppiamento del 100 per cento per l’incentivo previsto per le vacche lattifere, ove non vi fossero altre misure onde evitare la scomparsa di questa forma di produzione in talune regioni. Più a lungo termine la Commissione europea ritiene assolutamente necessario abbandonare il modello di pagamento unico per azienda basato su valori di riferimento storici, per arrivare ad un modello regionale, con il pagamento di una tariffa fissa per ettaro in ogni regione, come già in atto in Germania, Inghilterra e Finlandia. È tuttavia del tutto fuori questione pensare di arrivare alla stessa somma in euro per ogni ettaro di superficie agricola dell’UE.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 235
–Strumenti di gestione del mercato:
–soppressione a lungo termine del concetto di intervento pubblico, abolizione formale dell’intervento per la carne di maiale, che non viene più usato da oltre 30 anni. Le tempistiche dell’abolizione degli interventi pubblici, secondo la Commissione europea, dipendono dall’attuazione di strumenti alternativi per la gestione delle crisi quali l’assicurazione del raccolto o fondi di solidarietà.
–Abolizione della percentuale del 10 per cento di messa a riposo obbligatoria e quindi della restrizione della produzione per uso non alimentare (1 milione di tonnellate di farina di soia equivalenti) concordato con gli USA nell’accordo di Blair con la Camera dei Rappresentanti, mantenimento della messa a riposo volontaria.
–Nessuna proroga del sistema delle quote latte ad oltre il 2014/15 e ricerca di misure tese a realizzare una sorta di «atterraggio morbido» attraverso, ad esempio, una graduale riduzione della tassa supplementare o incrementando gradualmente le quote stesse. Introduzione di misure di sostegno attraverso programmi di sviluppo delle aree rurali o prelievo fino al 10 per cento del credito finanziario nazionale o regionale destinato al pagamento unico per azienda onde sostenere l’attività di produttori delle aree più svantaggiate e di montagna.
–Nessuna proroga a lungo termine del sistema delle quote relative alla fecola di patate, già prorogato per due anni.
Le proposte di riforma concernenti vino, zucchero, frutta e verdura saranno trattate più avanti.
Dopo il primo esame del Bilancio comunitario del 2008 il Consiglio dei ministri dell’UE ha proceduto ad una riduzione dei pagamenti diretti e dei provvedimenti agricoli pari all’1,7 per cento rispetto al Bilancio 2007, mentre ha aumentato dell’1,6 per cento i provvedimenti a sostegno dello sviluppo rurale. Il bilancio globale (agricolo e extraagricolo) è cresciuto del 3,4 per cento e rappresenta lo 0,95 per cento del prodotto interno lordo dell’UE. Nel 2007 la quota della PAC rispetto al bilancio globale dell’UE ha toccato il 46 per cento, facendo registrare un sensibile calo rispetto al passato (anni ’90: 60%, anni ’80: 70%). La quota delle uscite in ambito agricolo potrebbe ulteriormente diminuire fino a toccare, dal 2008 in poi, un minimo storico, posizionandosi dietro le varie forme di sostegno strutturale, in particolare a favore delle aree sfavorite dell’UE. Per il 2013 si stima una quota del 42 per cento, di cui il 9 per cento per lo sviluppo rurale. Per maggiori informazioni: http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/ l34004.htm e http://europa.eu/scadplus/leg/it/s27000.htm.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 236
■ Bilancio
■ Semplificazione della Politica agricola comune
L’11 giugno i ministri dell’agricoltura dell’UE hanno raggiunto un accordo politico unanime su una proposta di riforma della Commissione intesa a realizzare un’unica organizzazione comune dei mercati (OM) per tutti i prodotti agricoli che sostituirà le attuali 21 OM. Questa iniziativa è un passo importante nell’attuale processo di semplificazione della PAC nell’interesse di agricoltori, autorità e imprese del settore agricolo. La realizzazione di un’unica OM contribuisce a snellire le disposizioni giuridiche creando maggior trasparenza così da rendere i provvedimenti più facilmente accessibili. Essa rappresenta la semplificazione tecnica più significativa finora raggiunta dalla PAC. Non deve essere considerata un tentativo ufficioso di riforma della politica. Con l’OM unica sarà abrogata una cinquantina di atti normativi del Consiglio e gli oltre 650 articoli delle vigenti legislazioni saranno ridotti soltanto a 200.
■ Riforma dell’organizzazione comune del mercato dell’ortofrutta
Il 12 giugno 2007 i ministri dell’agricoltura dell’UE hanno dato il loro consenso unanime alla riforma dell’organizzazione comune del mercato dell’ortofrutta (http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2007/com2007-_0017it01.pdf).Il 1°gennaio 2008l’organizzazione del mercato applicata dal 1996 sarà abbandonata. Essa, infatti, non rappresentava più i principi della riforma della PAC, soprattutto per quanto concerne gli aiuti alla produzione e alla trasformazione vincolati alla produzione per pomodori, agrumi, pere, pesche noci, pesche, fichi secchi, prugne ed uva secche. Attraverso la riforma questi pagamenti saranno disaccoppiati dalla produzione.
Organizzazioni di produttori
L’adesione a organizzazioni di produttori (OP) sarà incoraggiata erogando finanziamenti comunitari supplementari. Nei nuovi Stati membri il tasso di cofinanziamento conunitario sarà del 60 per cento anziché del 50 per cento. I produttori possono aderire a OP diverse per ogni singolo prodotto. Ciò aumenta la flessibilità delle OP. Gli Stati membri e le OP elaboreranno programmi operativi basati su una strategia nazionale. Le risorse di bilancio per le PO ammontano a 700 milioni di euro circa e verranno aumentate annualmente di 50 milioni di euro.
Gestione delle crisi
Sarà organizzata dalle OP (per il 50% a carico del bilancio comunitario). Per gestire le crisi si farà ricorso a strumenti quali la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta degli ortofrutticoli, misure pubblicitarie e di comunicazione in caso di crisi del mercato, iniziative di formazione e perfezionamento, assicurazione del raccolto e copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi comuni d’investimento. I ritiri dal mercato effettuati dalle OP saranno cofinanziati in ragione del 50 per cento. La Comunità si accollerà il 100 per cento delle spese per i ritiri finalizzati alla distribuzione gratuita alle scuole e ad altri istituti. L’aiuto comunitario alle OP resterà limitato al 4,1 per cento del valore totale della produzione commercializzata, ma questo massimale potrà aumentare al 4,6 per cento purché le eccedenze siano utilizzate soltanto per la gestione delle crisi.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 237
Integrazione dell’ortofrutta nel regime di pagamento unico
La superficie coltivata a ortofrutticoli potrà beneficiare dei diritti all’aiuto nell’ambito del regime di aiuti disaccoppiati vigente in altri comparti agricoli. Tutti gli aiuti esistenti a favore degli ortofrutticoli trasformati saranno disaccoppiati e verranno aumentati i massimali di bilancio nazionali del RPU. L’importo totale che verrà trasferito al RPU ammonta a circa 800 milioni di euro.
Misure ambientali
L’integrazione dell’ortofrutta nel RPU implica l’obbligo di rispettare la condizionalità (ossia norme ambientali e relative alla protezione dei consumatori) per tutti i beneficiari di pagamenti diretti. Le OP dovranno inoltre destinare almeno il 10 per cento della spesa di ciascun programma operativo a interventi ambientali. La produzione biologica beneficerà di un tasso di cofinanziamento comunitario del 60 per cento in ciascun programma operativo.
Incoraggiare un maggiore consumo
Le OP potranno inserire la promozione del consumo di ortofrutticoli nei loro programmi operativi. Per incoraggiare il consumo di frutta e verdura dei bambini e ragazzi in età scolare il tasso di cofinanziamento comunitario salirà al 60 per cento. A tal fine sarà destinato uno stanziamento supplementare di 6 milioni di euro nell’ambito del regolamento generale sulla promozione. Una dotazione di 8 milioni di euro sarà inoltre prevista per la distribuzione gratuita di ortofrutticoli a scuole, ospedali ed enti caritativi.
Pagamento transitorio per i frutti rossi
Per consentire ai produttori di lamponi e fragole destinati alla trasformazione di adeguarsi alle condizioni del mercato, verrà loro erogato un pagamento diretto transitorio di 230 euro l’ettaro per un massimo di cinque anni e per un determinato numero di ettari. Gli Stati membri possono versare un’integrazione nazionale, a condizione che il totale non superi i 400 euro l’ettaro.
Pagamento disaccoppiato per gli ortofrutticoli nei Paesi RPUS
Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) potranno introdurre un pagamento disaccoppiato a favore dei produttori storici di ortofrutticoli. Entro il 1° novembre 2007 essi dovranno decidere l’importo da detrarre dalla dotazione riservata al RPUS per coprire tale pagamento e definire i criteri per la sua concessione.

Riforma dell’organizzazione del mercato vitivinicolo
La prima organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata introdotta nel 1970 e da allora è stata più volte modificata. Dati i profondi cambiamenti nelle strutture di produzione e smercio come pure nelle tendenze di consumo, gli strumenti dell’OM in vigore dal 1998 non erano più adeguati per sostenere i produttori vitivinicoli europei dinanzi all’acuirsi delle sfide sul mercato internazionale. Viste le circostanze, il 4 luglio 2007 la Commissione UE ha presentato una proposta di riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/ com2007_372_it.pdf). I principali aspetti della riforma interessano i provvedimenti illustrati di seguito; tuttavia, date le controversie scaturite dalle discussioni, essi non sono stati ancora decisi in via definitiva.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 238
Misure regolamentari rinnovate, snellite e semplificate
Vengono abolite le misure di sostegno al mercato dispendiose e non conformi ai principi dell’OMC, in particolare: distillazione di crisi, sostegno a favore dei sottoprodotti della distillazione, distillazione di alcol per usi commestibili e dei vino ottenuti da varietà a doppia classificazione, aiuto al magazzinaggio privato, restrizioni all’esportazione e aiuto relativo ai mosti destinati all’arricchimento.
Divieto d’utilizzare lo zucchero per l’arricchimento
L’aiuto destinato alla produzione di vino di mosto concentrato e rettificato sarà abolito e parallelamente sarà istituito il divieto di utilizzare lo zucchero per l’arricchimento. Pertanto l’arricchimento potrà essere ottenuto esclusivamente con mosto di uve concentrato e rettificato (p.es. osmosi inversa).
Regime di pagamento unico per azienda e regime d’estirpazione
Per ridurre il potenziale produttivo e quale misura collaterale per la soppressione delle misure relative alla distillazione, viene versato un premio di estirpazione per l’abbandono definitivo dei vigneti. In tal modo sarà possibile espiantare una superficie pari a 200'000 ettari circa. La superficie agricola precedentemente coperta dai vigneti, dopo l’estirpazione, sarà ammessa a beneficiare del regime di pagamento unico per azienda.
Divieto di nuovi impianti
Tenendo conto del fatto che il regime d’estirpazione richiede un certo tempo per dare i primi frutti, il divieto di nuovi impianti sarà mantenuto fino al 2013, data a partire dalla quale sarà tuttavia necessario levarlo definitivamente per permettere ai produttori competitivi di adeguarsi liberamente alle condizioni del mercato.
Pratiche enologiche
La competenza di approvare le nuove pratiche enologiche o modificare quelle esistenti passa alla Commissione UE affinché le pratiche enologiche autorizzate dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) possano essere riprese in maniera rapida. La vinificazione da mosti e vini importati rimane vietata.
Confezione ed etichettatura
I vini a indicazione geografica vanno suddivisi in due sottocategorie: vini ad indicazione geografica protetta e vini a denominazione di origine protetta. Per i vini senza indicazione geografica (vini da tavola) va data la possibilità di indicare sull’etichetta il vitigno e l’annata.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 239
La riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, entrata in vigore il 1° luglio 2006, è finalizzata a garantire la sostenibilità della produzione europea di zucchero. La creazione di un fondo di ristrutturazione destinato ad incoraggiare i produttori di zucchero non competitivi ad abbandonare, il taglio del 36 per cento del prezzo minimo garantito dello zucchero e una compensazione parziale disaccoppiata a favore degli agricoltori rappresentano i principali elementi della riforma che mira ad una riduzione della produzione pari a 6 milioni di tonnellate entro il 2010, puntando sugli zuccherifici produttivi. Dall’inizio della riforma per le esportazioni di zucchero è stato fissato un limite di 1,374 milioni di tonnellate l’anno. In passato i volumi d’esportazione raggiungevano mediamente i 4,6 milioni di tonnellate.
Nel biennio 2006/07, primo anno della prevista riduzione del prezzo, nel quadro del regime di riconversione i produttori hanno rinunciato a quote per un totale di 1,5 milioni di tonnellate circa. Nel secondo anno 2007/08 le quote cui i produttori hanno rinunciato sono state pari soltanto a 0,7 milioni di tonnellate. La graduale riduzione prevista per i prezzi dello zucchero non ha ancora avuto effetti sui produttori di barbabietole e quelli sugli addetti alla trasformazione sono stati modesti. Muovendo dall’eccedenza stimata a 4 milioni di tonnellate nell’anno 2007/08, nel marzo 2007 la Commissione ha deciso di ritirare dal mercato 2 milioni di tonnellate circa di zucchero. Ciascuna impresa deve provvedere a proprie spese allo stoccaggio di un quantitativo di zucchero equivalente all’uso della percentuale stabilita sulla propria produzione di zucchero entro quota. I quantitativi ritirati dal mercato vanno computati alla produzione dell’esercizio successivo.
Siccome la riduzione delle quote non è stata sufficiente per stabilizzare il mercato, per l’anno 2008/09 i produttori di zucchero riceveranno un pagamento supplementare di 237.50 euro per tonnellata di quota restituita. Il taglio della produzione è ripartito tra gli Stati membri secondo una ponderazione equilibrata che tiene conto dei coefficienti di riduzione tradizionalmente applicati. Al termine del periodo di ristrutturazione entro il 2010 la produzione europea potrà, se necessario, essere adeguata con una riduzione lineare delle quote decisa dalla Commissione.
La convenzione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) sarà mantenuta nella forma originale fino a settembre 2009. A partire da ottobre 2009 fino al 2015 i Paesi ACP potranno importare nell’UE un massimo di 3,5 tonnellate di zucchero a dazio zero. Con l’entrata in vigore della terza fase, a partire dal 2015 è prevista l’importazione di zucchero dai Paesi ACP senza dazi né quote.
Il settore lattiero riveste una grande importanza per l’UE. È il primo tra i settori a prodotto unico, con una quota del 14 per cento circa rispetto alla produzione agricola totale. Tutti gli Stati membri dell’UE, senza eccezioni, producono latte anche se con enormi variazioni rispetto alle dimensioni e alle strutture delle aziende agricole.
Il regime delle quote latte, introdotto nel 1984, era finalizzato, da un lato, alla limitazione della produzione lattiera e, dall’altro, alla stabilizzazione dei prezzi dei latticini. Come emerso con il passare degli anni, il successo in termini di economia di mercato è stato piuttosto scarso. Non si è raggiunto un equilibrio di mercato. Nonostante il regime vigente, il mercato lattiero fino a poco tempo fa faceva segnare notevoli eccedenze che, altamente sovvenzionate, venivano vendute sul mercato mondiale.
■ Riforma del mercato dello zucchero
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 240
■ Fine del regime delle quote latte
Il livello dei prezzi dell’UE, inoltre, è decisamente superiore a quello del mercato mondiale.
I sostenitori dell’abolizione delle quote latte auspicano in particolare un mutamento strutturale verso forme aziendali più efficienti.
A sfavore del mantenimento di questo regime parlano anche le necessarie misure di risparmio per consolidare il bilancio a livello europeo e nazionale, che si ripercuotono anche sulla PAC con una pressione economica verso una riforma. Viste le attuali circostanze si può giungere alla conclusione che le quote vanno abolite. Alcuni Paesi quali Svezia, Danimarca, Olanda o Regno Unito si dichiarano a favore dell’abrogazione del regime delle quote latte. Senza una proposta di mantenimento da parte della Commissione UE esso decadrà con l’anno lattiero 2014/15.
OMC
Dopo che, nel settembre 2006, i negoziati del Doha Round erano stati temporaneamente sospesi, i delegati di Stati Uniti, Unione europea, Brasile e India, che compongono il gruppo del G4, hanno ripreso i negoziati a Ginevra. A fine giugno 2007 a Potsdam, in Germania, si è tenuto un vertice ministeriale che segna uno sforzo decisivo per la fissazione delle modalità da parte dei presidenti dei gruppi negoziali agricoltura e prodotti industriali (di seguito «NAMA»). Tuttavia i ministri di Brasile e India hanno abbandonato anticipatamente i negoziati sostenendo che non sono state fatte proposte significative in relazione al fascicolo agricolo. A loro volta USA e UE hanno sottolineato l’irremovibilità delle controparti nelle trattative NAMA.
Ciononostante, i presidenti dei due gruppi negoziali hanno redatto due documenti concernenti le modalità, i cui contenuti rispecchiano quanto discusso a Ginevra e Potsdam. I parametri chiave testimoniano l’equilibrio che deve essere creato tra le formule concernenti la riduzione del sostegno interno e l’accesso al mercato. Se gli USA concordano nel tagliare in modo più sensibile le proprie sovvenzioni agricole, devono essere ridotti proporzionalmente anche gli elevati dazi agricoli (73%) dell’UE e degli altri Paesi d’importazione (tra cui i membri del G10 e la Svizzera). Il testo agricolo è prova di grandi ambizioni, soprattutto per quando attiene all’accesso del mercato (66–73% per la fascia di dazio superiore) e prevede maggiore flessibilità soltanto nel comparto dei prodotti sensibili da compensare con contingenti d’importazione supplementari. Un primo esame a grandi linee dei documenti ha avuto luogo a luglio al momento della pubblicazione. Le trattative vere e proprie potrebbero essere riprese dopo la pausa estiva a settembre. Gli ultimi mesi dell’anno saranno utili per capire se i membri saranno in grado di concludere entro breve i negoziati di Doha. Se non ci sarà la dovuta volontà, i negoziati subiranno una nuova interruzione e saranno ripresi soltanto nel 2009.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 241
USA
I protagonisti del Doha Round criticano la politica agricola nazionale degli Stati Uniti ed in particolare gli elevati sussidi agricoli. La revisione prevista per quest’anno è seguita con grande interesse dai membri dell’OMC. Il Farm Bill del 2002 (the Farm Security and Rural Investment Act) scade a fine settembre 2007. La proposta di revisione del Governo americano (United States Department of Agriculture – USDA) è stata presentata alla Camera dei Rappresentanti. Il disegno dell’USDA prevede soltanto modifiche puntuali dei contenuti, mantenendo intatta l’attuale struttura del sostegno interno. Si è stimato che le risorse di bilancio necessarie per la riforma superano quelle previste in caso di mantenimento del Farm Bill del 2002. L’USDA ha reso noto che attualmente si tratta di attuare la completa armonizzazione con le condizioni dell’Uruguay Round e che il disegno di legge non rappresenta una posizione negoziale per il Doha Round; tuttavia potrebbe venir adeguato nel caso i negoziati approdassero a dei risultati.

Dopo la votazione alla Camera dei Rappresentanti, il 27 luglio 2007, non rimane molto delle riforme tentennanti proposte dal Governo. Lo stato attuale del Farm Bill 2007 (Farm, Nutrition and Bioenergy Act of 2007) può essere riassunto come segue.
–Le sovvenzioni vengono adeguate in modo da escludere dagli aiuti il gruppo dei destinatari più abbienti. L’USDA aveva proposto di ridurre la soglia triennale di 2,5 milioni di dollari a 200'000 dollari l’anno. La Camera dei Rappresentanti ha fissato il tetto massimo a 1 milione di dollari l’anno.
–Essa, inoltre, si è opposta al taglio dei prezzi garantiti per i prestiti di assistenza al mercato (loan deficiency payments) e li ha parzialmente aumentati. L’OMC classifica tale provvedimento nella scatola ambra siccome ha per oggetto aiuti che soggiacciono a determinati limiti, in grado di generare distorsioni nella produzione e nel commercio. Nel caso in cui il Doha Round giunga a dei risultati, i prezzi saranno presumibilmente ridotti.
–Gli aiuti diretti vengono mantenuti invariati.
–Il sostegno di programmi volti a proteggere l’ambiente viene rafforzato e viene promosso l’impiego di fonti d’energia rinnovabili, in particolare di biocarburanti.
–Il sistema di pagamenti anticiclici basato sul prezzo viene sostituito con un sistema basato sulla cifra d’affari (questo provvedimento potrebbe essere classificato dall’OMC nella scatola blu, ovvero nella categoria di aiuti vincolati all’impegno di limitare la produzione). Secondo l’USDA questa nuova base va intesa come una sorta di rete di sicurezza in quanto consente di mantenere il sostegno anche in caso di aumento dei prezzi e di diminuzione dei rendimenti. La Camera dei Rappresentanti ha approvato questa modifica pur lasciando ai produttori la scelta di applicare il vecchio sistema.
–I programmi sociali vengono ampliati, in particolare gli aiuti alimentari. Nell’ultimo Farm Bill gli aiuti alimentari rappresentavano il 54 per cento del bilancio. Comprendono l’aiuto interno (che costituisce la maggior parte del bilancio) e quello internazionale. L’aiuto interno contempla, ad esempio, i buoni per acquistare cibo per la popolazione a reddito basso (food stamp program), un programma alimentare per i bambini, eccetera. La legge prescrive che i prodotti per gli aiuti alimentari devono provenire dagli USA.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 242
■ Nuovo Farm Bill per gli Stati Uniti?
■ Merci dai Paesi più poveri esentate da dazi e contingenti doganali
–Un’innovazione di rilievo introdotta dalla Camera dei Rappresentanti è l’obbligo di introdurre le denominazioni di origine per carne, frutta e verdura.
Il contenuto materiale delle riforme è stato offuscato dall’aumento delle imposte per le imprese estere operanti negli USA, introdotto nel Farm Bill dal democratico Lloyd Doggett. Questo provvedimento è stato inserito per compensare l’aumento dei programmi sociali. Questa correlazione ha scatenato un’accesa discussione sul Farm Bill creando una frattura tra democratici e repubblicani.
Il sostegno interno non è stato allineato alle norme OMC. A tal proposito il dimissionario ministro dell’agricoltura Mike Johanns ha reso noto che intende sensibilizzare i presidenti del comitato agricolo al Senato in merito alla necessità di un Farm Bill maggiormente armonizzato con le norme OMC.
Nel settembre 2007, la versione del Farm Bill varata dalla Camera dei Rappresentanti è stata presentata al Senato dove ha subito numerosi cambiamenti. L’impostazione che il Senato intende adottare è ancora incerta. La nuova legge entrerà presumibilmente in vigore nel 2008.
Paesi meno sviluppati
Il decreto federale provvisorio del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo è stato abrogato dalla legge federale (legge sulle preferenze tariffali) emanata dal Parlamento a fine 2006 e entrata in vigore il 1° marzo 2007.
In virtù della legge sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza sulle preferenze tariffali. Tale modifica è entrata in vigore il 1° aprile 2007. L’obiettivo principale di queste disposizioni esecutive è dare al sistema svizzero di preferenze tariffali generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo (PVS) un’impostazione maggiormente incentrata sulle necessità dei Paesi meno sviluppati (LeastDeveloped Countries, LDC). A questi Paesi sono equiparati i Paesi che hanno aderito all’iniziativa internazionale per la cancellazione del debito dei Paesi poveri fortemente indebitati (Highly Indebted Poor Countries, Paesi HIPC). Ai Paesi LDC e HIPC, dal 1° aprile 2007, è accordata l’esenzione da dazi e contingenti doganali per l’importazione in Svizzera di merci con prova dell’origine. Temporaneamente esclusi da queste disposizioni sono le rotture di riso a scopo foraggiero (completa abolizione del dazio al 1° settembre 2009) e lo zucchero di canna o di barbabietola (completa abolizione al 1° luglio 2009). In tal modo viene concessa la liberalizzazione di questi prodotti in linea con l’applicazione delle rispettive preferenze tariffali dell’UE.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 243
Questo provvedimento fa della Svizzera uno dei primi Paesi ad applicare la concessione accordata in occasione della Conferenza dei ministri dell’OMC di Hong Kong nel 2005 in merito ad un accesso al mercato libero da dazi e contingenti doganali per i Paesi più poveri. Il Consiglio federale, inoltre, ha attuato la terza ed ultima tappa dell’iniziativa a dazio zero, decisa nel 2001. Da allora le importazioni dai Paesi LDC sono più che raddoppiate e nel 2006 hanno superato dell’80 per cento il livello del 2005. Ciononostante rappresentano soltanto lo 0,21 per cento (375,1 mio. fr.) delle importazioni totali.
In virtù dell’articolo 2 capoverso 2 della legge sulle preferenze tariffali, se l’applicazione di preferenze tariffali esplica effetti che rischiano di pregiudicare interessi economici svizzeri, oppure dovesse perturbare considerevolmente i flussi commerciali, il Consiglio federale può modificare o sospendere le preferenze tariffali. Le crescenti importazioni di zucchero cristallizzato a dazio preferenziale PVS stavano pregiudicando la cosiddetta soluzione a doppio zero per lo zucchero nel quadro del Protocollo. II relativo all’Accordo di libero scambio del 1972 tra Svizzera e CE e di conseguenza il Consiglio federale, il 4 luglio, ha deciso di sospendere questa preferenza tariffale dal 1° settembre al 31 dicembre 2007. Le importazioni di zucchero dai Paesi in via di sviluppo più poveri non sono interessate da questa misura. Entro fine 2007 il DFE appurerà se sia ancora necessario concedere preferenze tariffali alla luce delle mutate condizioni quadro (indicatore: importazioni di zucchero cristallizzato dai Paesi in via di sviluppo all’aliquota NPF) e in caso affermativo in che modo esse possano essere concesse nel pieno rispetto di convenzioni e contratti internazionali.

Anche l’ordinanza sulle preferenze tariffali prevede che le agevolazioni in determinati casi possano essere sospese o modificate a breve termine, ad esempio se un Paese beneficiario non garantisce la collaborazione amministrativa per il controllo della prova dell’origine o per la lotta contro le pratiche fraudolente. Inoltre il DFE può fare ricorso a una clausola preferenziale per un periodo di tre mesi (art. 8). Per valutare se sia il caso vanno considerati determinati criteri. Tra essi rientra l’aumento inconsueto dei volumi d’importazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la crescita dell’offerta interna e la stagnazione della domanda interna. A questo proposito i dati relativi alle importazioni di prodotti agricoli originari di Paesi LDC e HIPC vengono costantemente monitorati. Non appena si tocca la soglia di uno sviluppo inconsueto dei volumi d’importazione, si avvia un’analisi approfondita delle condizioni del mercato. Finora al riguardo non v’è stata alcuna necessità d’intervento.
L’ordinanza sulle preferenze tariffali consente di escludere le merci dai Paesi in via di sviluppo più progrediti (graduazione) dal trattamento preferenziale se ciò va sensibilmente a scapito delle merci provenienti da altri Paesi in via di sviluppo. A partire da inizio 2008, ad esempio, lo zucchero di canna e di barbabietola sarà escluso dalle norme preferenziali. Ciò anche perché la concessione di agevolazioni tariffali per questo prodotto sarebbe in contraddizione con l’impostazione auspicata del sistema di preferenze tariffali generalizzate maggiormente incentrata sui Paesi più poveri.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 244
OCSE
L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nell’ultimo anno si è occupata di numerosi temi che rivestono una particolare valenza per la politica agricola svizzera come pure per la sua evoluzione.
–Nell’ambito di un seminario OCSE, studiosi di numerosi Paesi hanno affrontato il tema della cosiddetta jointness, ovvero di come la produzione agricola sia vincolata a prestazioni multifunzionali (cfr. il capitolo 1.1.4). Tutti hanno concordato sul fatto che almeno in molti casi si può parlare di jointness, anche se a livelli diversi, e che le analisi in merito devono continuare.
–Sono stati portati a termine studi condotti sull’arco di diversi anni sul tema targeting efficace. In questo ambito, i lavori si sono concentrati essenzialmente sulla struttura da dare agli strumenti della politica agricola per raggiungere gli obiettivi politici nella maniera più efficiente. L’OCSE è giunta alla conclusione che un provvedimento politico può essere efficace soltanto se mirato e se gli obiettivi sono misurabili nonché definiti in maniera chiara e semplice.
–Le compensazioni da parte dello Stato nel quadro di riforme agrarie diventano un’opzione politica se la riforma e l’adeguamento strutturale creano una situazione di squilibrio. I lavori dell’OCSE indicano diverse strategie di riforma illustrando chi va compensato durante una riforma agraria, come e quando, al fine di poter concludere con successo il processo di riforma.
–Le raccomandazioni politiche per la riduzione dei costi delle transazioni suscitano particolare interesse. Come nel caso del targeting efficace, al fine di una riduzione dei costi, l’OCSE raccomanda di fissare obiettivi politici chiari, precisi e misurabili, di assicurare trasparenza a tutti i livelli e di potenziare l’efficienza dell’amministrazione.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 245
■ Conferenza tecnica internazionale sulle risorse zoogenetiche nel settore agroalimentare
Dal 3 al 7 settembre 2007, l’UFAG, in collaborazione con la FAO, ha organizzato la prima Conferenza tecnica internazionale sulle risorse zoogenetiche nel settore agroalimentare. La conferenza, tenutasi ad Interlaken, si è svolta sotto la presidenza del Direttore dell’UFAG. Vi hanno partecipato oltre 300 ospiti da tutto il mondo, in rappresentanza dei Governi, delle organizzazioni internazionali e della società civile.

La conferenza si è snodata attorno a tre punti fondamentali: il forum scientifico sulle risorse zoogenetiche, tenutosi il 2 settembre sotto la presidenza di Fritz Schneider, vicedirettore della Scuola universitaria svizzera di agronomia, la presentazione del Rapporto sullo stato mondiale delle risorse zoogenetiche nel settore agroalimentare e l’adozione di un Piano d’azione globale per le risorse zoogenetiche, ovvero la Dichiarazione di Interlaken.
Accanto alla conferenza, l’UFAG ha organizzato anche un’esposizione sul tema «Biodiversità, alimentazione e cultura – scoprire la diversità degli animali da reddito», nell’ambito della quale 20 organizzazioni svizzere hanno presentato la loro attività e i loro prodotti. Sono state allestite un’esposizione all’aperto di animali e una mostra su tematiche correlate a biodiversità, alimentazione e cultura. L’obiettivo era mostrare perché è importante preservare la diversità delle razze di animali da reddito e mettere in evidenza le relazioni tra la biodiversità, la garanzia dell’approvvigionamento, l’offerta del mercato e gli aspetti culturali della vita quotidiana.
La conferenza mirava principalmente a creare un consenso sulle misure urgenti che devono essere adottate per la gestione sostenibile, lo sviluppo e la preservazione delle risorse zoogenetiche nonché a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse funzioni, sul valore e sull’importanza di queste risorse vitali.
■ Stato delle risorse zoogenetiche
Particolare interesse tra i partecipanti ha suscitato il Rapporto sullo stato mondiale delle risorse zoogenetiche per il settore agroalimentare. Il documento è stato elaborato dal Centro di coordinamento mondiale delle risorse zoogenetiche della FAO, nell’ambito di un lungo e coordinato processo di preparazione avviato nel 2001. È stato allestito sulla base dei 169 rapporti nazionali presentati dagli Stati membri, Svizzera inclusa, nonché di rapporti a cura di varie organizzazioni internazionali. Questi rapporti hanno illustrato lo stato e lo sviluppo delle risorse zoogenetiche, il contributo effettivo e potenziale degli animali da reddito nei settori alimentazione, agricoltura e sviluppo rurale nonché la condizione delle capacità disponibili a livello nazionale per la gestione di queste risorse. Hanno inoltre messo in evidenzia il contributo insostituibile delle varie razze da reddito dal profilo della sicurezza alimentare e dello sviluppo economico dei Paesi. Dalla documentazione è emerso altresì che le risorse zoogenetiche non sono sfruttate pienamente. Infine particolarmente preoccupante è risultata la riduzione della diversità genetica nei Paesi sia industrializzati che in via di sviluppo. Questa erosione genetica, le cui cause sono innumerevoli, potrebbe pregiudicare la capacità dei contadini di adeguarsi ai cambiamenti ambientali e socio-economici, in particolare all’evoluzione delle abitudini alimentari e ai desideri dei consumatori.
FAO
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 246
In occasione della conferenza è stata approvata la pubblicazione del Rapporto sullo stato delle risorse zoogenetiche quale studio di riferimento in questo campo. Esso fungerà da base per i provvedimenti futuri per una gestione sostenibile delle risorse zoogenetiche.
Il rapporto può essere scaricato al seguente indirizzo: http://www.#fao.#org/AG/ againfo/programmes/fr/genetics/ITC_docs.#html
In occasione della conferenza è stato adottato il Piano d’azione globale per le risorse zoogenetiche. Esso offre un quadro internazionale efficace e significativo a garanzia della gestione, dello sviluppo e della preservazione delle risorse zoogenetiche nel settore agroalimentare. Può contribuire, inoltre, agli sforzi volti alla sicurezza alimentare e alla lotta contro la povertà nel mondo.

Il Piano d’azione globale contempla le priorità strategiche che fissano gli interventi da attuare e che sono riassunte nei quattro punti principali di seguito elencati.
1. Caratterizzazione, rilevamento e monitoraggio di tendenze e rischi. Questo ambito comprende i provvedimenti tesi a garantire un concetto armonioso ed efficiente per la classificazione delle risorse zoogenetiche. Ciò costituisce un presupposto decisivo per la loro preservazione e gestione sostenibile.
2. Gestione sostenibile e sviluppo. Si tratta di provvedimenti volti a garantire la sostenibilità dei sistemi di produzione animale per la sicurezza alimentare e per lo sviluppo rurale.
3. Preservazione delle risorse zoogenetiche. Questo ambito comprende i provvedimenti necessari al fine di conservare la diversità genetica e l’integrità a favore delle generazioni presenti e future.
4. Politica, istituzioni e potenziamento delle capacità. I provvedimenti contemplati in questo ambito sono finalizzati a risolvere immediatamente i problemi principali correlati all’attuazione sulla base di uno sviluppo delle necessarie istituzioni e capacità usando un approccio coerente e sinergetico.
L’attuazione del Piano d’azione globale richiede investimenti strategici significativi a lungo termine nonché provvedimenti per rendere più dinamici i programmi regionali ed internazionali per le risorse zoogenetiche. Questo processo mira a promuovere e sostenere la partecipazione degli agricoltori, degli allevatori nomadi e di altri allevatori, delle comunità locali e residenti, delle organizzazioni e delle istituzioni nonché della società civile. A tal riguardo sarà decisiva la collaborazione sul piano regionale ed internazionale. L’attuazione del Piano d’azione globale viene monitorata e gestita dalla Commissione delle risorse zoogenetiche della FAO.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 247
■ Piano d’azione
■ Dichiarazione di Interlaken
La conferenza, tuttavia, muove dal fatto che l’attuazione del Piano d’azione globale per le risorse zoogenetiche compete essenzialmente ai Governi e che richiede centri di coordinamento nazionali efficienti. Ogni Paese fisserà le proprie priorità alla luce di quelle del Piano d’azione globale e delle proprie esigenze nel campo dello sviluppo del settore agroalimentare. La conferenza ha altresì sottolineato il ruolo fondamentale della FAO nel promuovere l’impegno dei Paesi per l’attuazione del Piano d’azione globale, in particolare nel fornire un sostegno ai Paesi in via di sviluppo e di transizione per la gestione di queste risorse.
La Conferenza si è conclusa con la sottoscrizione della Dichiarazione di Interlaken. Sulla base delle loro possibilità e risorse i partecipanti si sono impegnati a adottare le misure necessarie ad attuare il Piano d’azione globale onde garantire la gestione sostenibile, lo sviluppo e la preservazione delle risorse zoogenetiche nel settore agroalimentare con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e le condizioni alimentari della popolazione mondiale fornendo un contributo per lo sviluppo rurale.
3.1 SVILUPPI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 248
3.2Confronti sul piano internazionale
Il confronto tra i prezzi alla produzione e quelli al consumo di diversi Paesi dell’UE e della Svizzera presentato nelle precedenti edizioni del Rapporto agricolo era basato sull’evoluzione degli ultimi tre anni nonché sulla media di riferimento del triennio 1990/92. L’accento era posto sugli sviluppi di più ampio respiro. Non veniva tuttavia offerto un quadro della situazione attuale. Dal momento che quest’anno si è assistito a un aumento considerevole dei prezzi dei principali prodotti vegetali e del latte praticati sul mercato mondiale, la presente edizione del Rapporto agricolo vuole occuparsi proprio di questa tematica.
Il 2007 è stato caratterizzato dal notevole aumento a livello mondiale dei prezzi di diverse materie prime vegetali, latte in polvere e burro. Il prezzo al quintale del frumento, ad esempio, nell’arco di un anno è passato da 20 a 40 franchi circa. Sul mercato dell’orzo la tendenza è simile e anche i prezzi di mais e semi oleosi risultano più elevati rispetto a un anno fa. Il rincaro è stato ancor più significativo per quanto riguarda il latte in polvere e il burro. I prezzi al quintale di questi due prodotti sono saliti da 2,8 a 5,8 franchi nel caso del latte in polvere e da 2,1 a 4,4 franchi nel caso del burro. Gli incrementi di prezzo hanno avuto ripercussioni anche sul prezzo alla produzione del latte. In Germania e Austria, un chilo di latte è pagato 65 centesimi e in alcuni casi anche di più. A fine 2007 il valore medio europeo potrebbe attestarsi tra i 55 e i 60 centesimi.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
materie prime agricole 3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 249
■ Aumentano i prezzi delle
Evoluzione dei prezzi delle materie prime
Prezzi 2007 di frumento, orzo, mais da granella e latte in Svizzera nonché del latte in Germania: agosto 2007; prezzi 2007 della verdura: gennaio–settembre 2007. Verdura, Svizzera: franco grossista, prezzi indicativi; verdura, Germania: mercati all’ingrosso. Fonti: Ministero bavarese dell’agricoltura e delle foreste, USC, CSO, ASF, swiss granum, swisspatat, ZMP
Il massiccio rincaro dei prezzi sul mercato mondiale ha inciso solo marginalmente sull’agricoltura svizzera, in quanto i dazi doganali la proteggono dalla concorrenza internazionale. Benché le ripercussioni sulla situazione reddituale dei contadini svizzeri per il 2007 siano state minime, gli sviluppi internazionali hanno tuttavia contribuito a ridurre fortemente il divario tra i prezzi dei prodotti summenzionati. Mentre, solo un anno fa, in Svizzera i prezzi alla produzione dei principali prodotti campicoli quali frumento, orzo, semi oleosi o mais erano da due a tre volte superiori a quelli praticati nell’UE, oggi tale differenza è stata colmata e i prezzi dell’UE risultano superiori tutt’al più del 50 per cento. Secondo le previsioni, il mercato del latte potrebbe subire la stessa sorte. Negli scorsi anni le differenze di prezzo tra Svizzera e UE erano dell’ordine di 30 centesimi; alla fine del 2007 tale scalino potrebbe dimezzarsi fino a toccare quota 10–15 centesimi. Nell’arco di un anno, dunque, le materie prime svizzere hanno acquistato un ampio margine di competitività.
Sul fronte del mercato della carne la situazione è ben diversa, anche se non si escludono mutamenti nel corso dell’anno prossimo in particolar modo per quanto riguarda il pollame e la carne di maiale. Infatti, dal momento che i suini sono nutriti con foraggi concentrati, il prezzo di questo tipo di carne potrebbe risentire del netto rincaro registrato per i prodotti campicoli. Dato che i costi di foraggiamento degli animali incidono nella misura del 50 per cento sulla produzione di carne suina, i prezzi alla produzione in questo settore potrebbero subire un aumento fino al 25 per cento. Gli incrementi di prezzo permettono di evitare che molti produttori europei siano costretti a cessare l’attività. Attualmente la situazione appare già abbastanza critica, soprattutto in Germania.

ProdottiØ 2005Ø 20062007 (sett.) DCHDCHDCH Lattect./kg42.7372.4143.0271.8258.8272.67 Bestiame da macello Torelli, T3fr./kg PM4.477.974.798.444.728.91 Vitelli, T3fr./kg PM7.5113.208.0814.438.9614.36 Suinifr./kg PM2.234.022.373.852.434.00 Polli, classe Ifr./kg PV1.052.601.092.601.332.41 Cereali e semi oleosi Frumento, classe Ifr./100 kg14.9952.4218.2152.3739.8952.1 Orzofr./100 kg14.5142.2416.2641.8734.8436.62 Mais da granellafr./100 kg15.5642.2319.3942.8735.7241.02 Colzafr./100 kg29.8076.5035.7877.0052.7583.66 Sarchiate Patate da tavolafr./100 kg15.1446.6524.6651.4521.4245.6 Barbabietole da zuccherofr./100 kg7.5911.776.9111.496.5211.2 Verdura Carotefr./kg0.621.370.751.440.781.38 Pomodori tondifr./kg2.192.342.142.592.302.51 Lattuga cappucciofr./kg1.853.632.183.942.173.76 Cavolfiorefr./kg1.232.301.322.811.422.76
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 250
■ Ripercussioni sui prezzi al consumo
Fino al mese di settembre, in Europa il costo più elevato delle materie prime agricole ha avuto un certo impatto sui prezzi al consumo. Sono lievitati soprattutto i prezzi di burro e panna. I consumatori tedeschi, ad esempio, hanno visto il prezzo del burro aumentare nella misura del 60 per cento circa rispetto al 2006. Nello stesso arco di tempo, i prezzi di latte e latticini sono rincarati del 22 per cento. Al rialzo anche i prezzi di pollame, uova e frutta; sono invece diminuiti quelli di verdura e patate. In Germania, nel settembre di quest’anno l’esigenza di un paniere ponderato contenente prodotti freschi ha determinato un aumento dei prezzi pari al 6 per cento rispetto all’anno precedente. In Svizzera, invece, i prezzi al consumo hanno registrato soltanto un lieve aumento (+0,3% da gennaio a settembre 2007). Non è tuttavia impensabile che anche in Svizzera possano in futuro verificarsi adeguamenti di questo tipo su prodotti come pane, determinati latticini e pasta.
Variazione dei prezzi al consumo1 tra settembre 2006 e settembre 2007 in Germania
Prodotti freschi
Prodotti carnei e insaccati
In generale, le conseguenze dirette del rincaro delle materie prime sui prezzi al consumo variano a seconda del prodotto in questione. Nel caso del pane, il costo delle materie prime incide nella misura del 15 per cento sul prezzo totale. Ecco perché se il prezzo del frumento raddoppia, quello del pane sale del 15 per cento circa. Il prezzo di vendita del latte di consumo è invece aumentato proporzionalmente a quello alla produzione. Nel complesso, si può affermare che il prezzo delle materie prime rappresenta soltanto il 20 per cento del costo totale di un alimento. A titolo di esempio, un rincaro medio delle materie prime pari al 50 per cento corrisponderebbe a un aumento complessivo del 10 per cento sulle uscite legate alle derrate alimentari.
■ Fino a che punto sono sostenibili questi aumenti di prezzo?
Nel corso degli ultimi vent’anni, i mercati agricoli internazionali sono stati caratterizzati da costanti, seppur di breve durata, variazioni di prezzo verso l’alto. Per quanto riguarda i prodotti vegetali, esse erano riconducibili ai raccolti di gran lunga inferiori alla media. Oggi però le cose stanno diversamente. La produzione di frumento e cereali da foraggio, quali mais e orzo, nel 2007 potrebbe infatti risultare nettamente superiore al decennio precedente. Malgrado ciò, l’elevato rendimento non è in grado di coprire la domanda. Eccezion fatta per il 2004, questo stato di cose si protrae ormai dal 1999. Grazie alle grandi scorte a disposizione è stato a lungo possibile ovviare a tale scompenso e mantenere bassi i livelli dei prezzi. Nel 2006 le scorte si sono ridotte al 15 per cento del consumo annuo, una situazione che gli operatori del settore commer-
Fonte:
ZMP
1 Base: prodotti ZMP; prezzi al consumo ponderati in funzione dei quantitativi registrati nei rispettivi mesi dell'anno precedente
Uova Frutta Verdura Patate Latte
Olio commestibile Pane In % –205101520 –10–50 5,9 13,1 0,3 6,0 0,3 2,4 7,7 –0,6 –11,1 25 –15 22,1 –16,8
Carne Pollame
e latticini
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 251
■ Domanda
ciale definiscono critica. A livello internazionale, la soglia minima a garanzia di un approvvigionamento senza problemi è fissata per scorte pari al 17 per cento del consumo. Nella stagione 2007/08 in corso la superficie messa a cereali è stata ampliata di 15 milioni di ettari circa, tuttavia le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito un miglioramento della situazione relativa all’approvvigionamento. Il fatto che neppure il raccolto 2007 riesca a coprire la domanda e che di conseguenza le scorte stiano ulteriormente diminuendo, ha avuto una profonda incidenza sui prezzi dei cereali. Sul mercato lattiero la situazione è analoga. Dal 2004 i volumi di produzione lattiera sono stati costantemente inferiori alla domanda. Fino al 2007 è stato possibile compensare questo squilibrio attingendo alle scorte di burro e di latte scremato in polvere. L’esaurimento delle scorte e la conseguente scarsità di questi prodotti hanno determinato un netto incremento dei prezzi.
All’origine del rincaro dei prezzi non vi è dunque un evento sporadico, bensì una tendenza la cui portata è aumentata negli anni: la domanda è cresciuta a un ritmo più elevato rispetto all’offerta. L’evoluzione futura dei prezzi dipende da numerosi fattori legati sia alla domanda che all’offerta. Essi sono descritti dettagliatamente nei paragrafi seguenti.
L’andamento futuro della domanda di materie prime agricole è influenzato principalmente dai seguenti fattori.
–Crescita della popolazione mondiale: ogni anno la popolazione del pianeta aumenta di 70–80 milioni. Ciò significa che per poter nutrire sufficientemente l’intera umanità il quantitativo di calorie deve aumentare annualmente dell’1 per cento.
–Sviluppo economico: se i redditi aumentano, cresce anche la domanda di carne e latticini. Per incrementare la produzione di questi prodotti, è necessario destinare maggiori quantità di prodotti campicoli al foraggiamento degli animali, a scapito dell’impiego diretto nell’alimentazione umana. La produzione animale comporta una perdita di efficienza. Per ricavare una caloria dalla produzione animale occorre infatti impiegare da due a sette calorie di prodotti vegetali.
–Domanda di energia: negli ultimi anni i carburanti ottenuti da biomassa hanno acquisito un’importanza vieppiù maggiore. Essi contribuirebbero infatti a ridurre le emissioni di anidride carbonica nonché la dipendenza dalle importazioni di petrolio, soprattutto negli USA. I prodotti campicoli impiegati nella produzione di carburanti vanno a ridurre la disponibilità per l’alimentazione umana. Parte del materiale di scarto può comunque venir utilizzato come foraggio. Negli USA si prevede che, entro il 2010, un terzo del raccolto di mais sarà impiegato per la produzione di bioetanolo. In Germania, circa 2 dei 12 milioni di ettari di terreni coltivi sono già oggi adibiti alla produzione di energia.
1998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/08 Superficie coltiva (mio. ha)534515514516508517519521518533 Produzione (mio. t)1 4811 4641 4431 4751 4711 4701 6461 6001 5701 668 Consumo (mio. t)1 4491 4681 4681 4921 5071 5341 5891 6171 6351 676 Scorte (mio. t)445441416399336272329312247239 % scorte rispetto al consumo30,730,028,326,722,317,820,719,315,114,3 1 Riso escluso Fonte: United States Department of Agriculture
Evoluzione di domanda e offerta nel settore cerealicolo 1
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 252
Le tendenze di sviluppo generali lasciano presupporre un ulteriore aumento della domanda di materie prime per i prossimi 5 anni. Tuttavia, qualora i prezzi dovessero mantenersi elevati, si assisterà probabilmente a un’attenuazione dell’aumento.
L’offerta agricola dipende, da un lato, dalle condizioni quadro economiche e dall’altro dalla disponibilità delle risorse naturali.
–Condizioni quadro economiche: nell’ultimo cinquantennio le eccedenze strutturali relative alle materie prime agricole che si osservano sui mercati internazionali nonostante la fame nel mondo hanno determinato un costante calo dei prezzi alla produzione. Il progresso tecnico nella selezione vegetale e l’impiego di concimi minerali e prodotti fitosanitari sintetici hanno contribuito ad accrescere l’offerta. Tuttavia, grazie alle innovazioni tecniche ed ai continui adeguamenti strutturali gli agricoltori hanno potuto realizzare mezzi finanziari sufficienti per nuovi investimenti o investimenti sostitutivi e per il sostentamento, nonostante il calo dei prezzi alla produzione. Ciononostante negli ultimi anni la sopravvivenza economica è diventata sempre più difficile anche per le aziende efficienti. Il costante aumento dei costi si è contrapposto alla stagnazione, se non addirittura alla flessione, dei prezzi alla produzione e queste aziende non dispongono praticamente più di alcuna riserva di razionalizzazione. In Gran Bretagna, ad esempio, in questi ultimi anni i produttori non hanno più interesse a produrre e le quote latte restano inutilizzate.
–Risorse naturali: per la produzione agricola sono essenziali determinati presupposti, quali terreni fertili, sufficiente disponibilità di acqua e condizioni climatiche propizie. Anche le possibilità di fotosintesi limitano la produzione di ogni singola unità di superficie. Oltre un terzo delle terre emerse dell’intera superficie terrestre (14,8 mia. ha) è costituito da distese di ghiaccio e da altre superfici improduttive quali deserti e catene montuose (5,6 mia. ha). Poco meno di un terzo è ricoperto da foreste (4,2 mia. ha) e un terzo viene sfruttato a scopo agricolo (5,0 mia. ha), di cui 1,5 miliardi di ettari per colture campicole o perenni. Le superfici restanti sono terreni inerbiti e pascoli o steppa sfruttata in modo estensivo. Secondo la FAO sarebbe possibile sfruttare in modo intensivo a scopo agricolo un totale di 1,63 miliardi di ettari circa. Le riserve di superfici su cui la produzione può essere intensivizzata sono limitate. Negli ultimi anni vi è stato altresì un rallentamento dell’incremento delle rese sia nel settore della produzione vegetale che in quello della produzione animale. Nel complesso si presuppone che in diverse regioni il cambiamento climatico provocherà un inasprimento delle condizioni della produzione agricola.
A breve e medio termine l’offerta dipende dall’evoluzione dei prezzi alla produzione e dall’impatto del clima sui raccolti. Il rialzo dei prezzi alla produzione avrà un influsso positivo sugli investimenti e si assisterà ad un tendenziale aumento dell’offerta. Va osservato, tuttavia, che l’estensione delle superfici coltivate con un determinato prodotto può andare a scapito di altre coltivazioni. È sempre più difficile realizzare un’estensione generalizzata delle superfici e a fare le spese di questo stato di cose sono spesso le superfici che sarebbero importanti per la conservazione della biodiversità. Anche nei prossimi anni le condizioni meteorologiche rimarranno una componente critica. È possibile che tra un anno si registri un raccolto molto soddisfacente, analogamente al 2004, anno in cui il panorama internazionale era stato caratterizzato da condizioni buone. Nel complesso tuttavia appare più plausibile che i raccolti saranno pregiudicati dalle condizioni meteorologiche come è avvenuto negli ultimi anni.
3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 3.ASPETTIINTERNAZIONALI 253
■ Offerta
■
Conclusioni
Dall’analisi della domanda e dell’offerta si evince complessivamente che un aumento del livello dei prezzi è decisamente più probabile di un’eventuale diminuzione ai livelli minimi dell’ultimo decennio. Le possibilità di ampliare l’offerta contenendo i costi sono limitate in tutti i settori. Per allineare l’offerta alla domanda s’impongono sforzi considerevoli e incentivi sotto forma di prezzi adeguati. Un anno caratterizzato da condizioni meteorologiche propizie può mitigare la situazione, ma è altrettanto possibile che condizioni avverse scatenino una nuova e marcata impennata dei prezzi. Nel complesso si profilano quindi forti oscillazioni di prezzo, in quanto già in situazioni di lievi squilibri sui mercati agricoli si osservano tendenzialmente reazioni sproporzionate.
A lungo termine potrebbe essere determinante riuscire a mantenere le attuali superfici produttive e a gestirle in maniera sostenibile. Attualmente ciò non è sempre il caso. Da un lato la produzione intensiva causa notevoli problemi ambientali e il degrado dei migliori terreni agricoli; dall’altro, le aree a rendimento marginale vengono caricate di bestiame in maniera troppo intensiva accelerando il processo di desertificazione. I migliori terreni agricoli vanno persi anche a causa del continuo avanzamento dei centri urbani e della costruzione di infrastrutture.
Per garantire a lungo termine le risorse naturali quali basi della produzione di materie prime agricole non ci si può basare solo ed esclusivamente sulla concorrenza dal profilo dell’economia di mercato. La teoria neoclassica non prende in considerazione le risorse naturali. Concretamente ciò significa che dal profilo della formazione dei prezzi sul mercato non ha nessuna importanza se nell’ambito della produzione si tiene conto anche della preservazione a lungo termine delle risorse. È indispensabile fissare dei requisiti che garantiscano che i terreni siano sfruttati in maniera sostenibile. Le condizioni naturali sono tuttavia molto differenziate e pertanto questi requisiti non possono essere gli stessi a livello globale. Occorre piuttosto adeguarli alle realtà locali. Anche i costi di gestione variano sensibilmente, basti pensare alle differenze in suolo elvetico tra regioni di montagna e di pianura. Per poter garantire un approvvigionamento sostenibile a lungo termine vanno tuttavia mantenute produttive superfici dai costi di gestione molto variabili. È in base a ciò che vanno impostate le condizioni quadro. 3.2 CONFRONTI SUL PIANO INTERNAZIONALE 3 254
Collaborazione al Rapporto agricolo 2007
■ Direzione del progetto, Werner Harder
segreteria
■ Autori
Alessandro Rossi
Monique Bühlmann
■ Ruolo e situazione dell’agricoltura
L’agricoltura, parte integrante dell’economia
Alessandro Rossi
Mercati
Jacques Gerber, Simon Hasler, Katja Hinterberger, Stefan Rösch, Beat Ryser, Hans-Ulrich Tagmann
Situazione economica
Vinzenz Jung, Fabian Riesen
Aspetti sociali
Esther Grossenbacher
Ecologia ed etologia
Brigitte Decrausaz, Reto Burkard, Elvira Eberhard, Esther Grossenbacher
■ Provvedimenti di politica agricola
Produzione e smercio
Jacques Gerber
Strumenti sovrasettoriali
Friedrich Brand, Jean-Marc Chappuis, Emanuel Golder, Samuel Heger, Jacques Henchoz
Economia lattiera
Katja Hinterberger
Produzione animale
Simon Hasler
Produzione vegetale
Beat Ryser, Hans-Ulrich Tagmann
Pagamenti diretti
Thomas Maier, Daniel Meyer, Hugo Roggo, Olivier Roux, Beat Tschumi, Michael Weber, Conrad Widmer
255
Miglioramento delle basi
Miglioramenti strutturali e misure sociali collaterali
René Weber, Gustav Munz, Willi Riedo, Anton Stübi
Ricerca, Istituto di allevamento equino, consulenza, formazione professionale, CIEA
Anton Stöckli, Urs Gantner, Geneviève Gassmann, Markus Lötscher, Pierre-André Poncet
Mezzi di produzione
Lukas Barth, Elisabeth Bosshard, Jacques Clément, Markus Hardegger, Beat Schmitter
Allevamento di animali
Karin Wohlfender
Sezione Ispettorato delle finanze
Rolf Enggist
■ Aspetti internazionali
Sviluppi sul piano internazionale
Krisztina Bende, Friedrich Brand, Jean Girardin, Gisèle Jungo, Hubert Poffet, Fabian Riesen
Confronti sul piano internazionale
Werner Harder
■ Servizi di traduzione Italiano: Patrizia Singaram, Federica Steffanini, Simona Stückrad
Tedesco: Yvonne Arnold
Francese:Elisabeth Tschanz, Pierre-Yves Barrelet, Yvan Bourquard, Odile Derossi, Giovanna Mele, Magdalena Zajac
■ Internet Denise Kummer
■ Assistenza tecnica Hanspeter Leu, Peter Müller
3 256
ALLEGATO A1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Allegato Tabelle Strutture A2 Tabelle Mercati A4 Tabelle Risultati economici A14 Conto economico dell’agricoltura A14 Risultati d’esercizio A16 Tabelle Uscite della Confederazione A27 Uscite Produzione e smercio A27 Uscite Promozione dello smercio A27 Uscite Economia lattiera A28 Uscite Produzione animale A28 Uscite Produzione vegetale A29 Uscite Pagamenti diretti A30 Uscite Miglioramento delle basi A52 Uscite Agricoltura e alimentazione A58 Atti legislativi, Terminologia e metodi A59 Abbreviazioni A61 Bibliografia A63
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Strutture
Tabella 1
Evoluzione delle aziende agricole, della superficie agricola utile e delle unità di bestiame grosso
A2 ALLEGATO
ClassididimensioniinhaAziendeSuperficieagricolautileUnitàdibestiamegrosso disuperficieagricola utile199020002006199020002006199020002006 NumeroNumeroNumerohahahaNumeroNumeroNumero 0-16 6293 6092 8002 8951 3361 00082 55061 01659 400 1-313 1904 7623 90023 8288 8617 10034 46614 75313 700 3-58 2595 3933 90032 24321 34815 50042 47327 71420 600 5-1018 83313 14910 700141 40399 05680 900209 784127 361102 400 10-1518 92013 81211 500233 888171 817143 900341 563230 628191 000 15-2012 71011 1729 900218 771193 856172 000290 523247 517224 000 20-256 6777 2447 100147 772161 311157 200173 896191 057194 600 25-303 3644 4304 70091 271121 005128 40097 680130 901144 300 30-402 6744 1684 80090 726142 266163 10087 709142 628171 500 40-508751 5911 90038 67270 50184 20032 21461 91479 600 50-705079211 20028 84952 67270 20023 17242 70762 100 70-10012720930010 37117 02128 3007 41413 29023 600 >10050771007 80211 44413 4006 3158 0259 700 Totale928157053762800106849010724921065200142975912995121296500 Fonte: UST
Tabella 2 Evoluzione del numero di lavoratori nell'agricoltura CategoriaLavoratoriatempopienoLavoratoriatempoparzialeTotale 199020002006199020002006199020002006 CapiaziendaUomini62 72049 33943 50026 16925 38521 50088 88974 72465 000 Donne1 4565247002 4701 8222 6003 9262 3463 300 Altri membri della famigliaUomini21 7968 7498 90022 72918 21216 70044 52526 96125 600 Donne14 36714 28110 20065 77047 66542 60080 13761 94652 800 ManodoperafamiliareTotale10033972893633001171389308483400217477165977146700 Manodopera extrafamiliare, svizzeriUomini12 45310 8368 3002 9495 1253 50015 40215 96111 800 Donne3 2002 5921 8003 3044 1943 1006 5046 7864 900 Manodopera extrafamiliare, stranieriUomini10 9108 0617 2001 7583 4542 60012 66811 5159 800 Donne6631 6131 5008471 9412 0001 5103 5543 500 ManodoperaextrafamiliareTotale27226231021880088581471411200360843781630000 LavoratoriTotale127565959958210012599610779894600253561203793176700 Fonte: UST
Tabella 3
Lavoratori in aziende in settori a monte e a valle dell'agricoltura
1Quota corrispondente alla quota dell'agricoltura rispetto agli investimenti edili
2Quota corrispondente alla quota della popolazione rurale rispetto alla popolazione totale, stima sulla base del censimento della popolazione
3Quota corrispondente alla quota dei lavoratori agricoli rispetto al totale dei lavoratori, stima sulla base del censimento delle aziende
4Quota corrispondente alla quota delle aziende agricole rispetto al totale delle aziende, stima sulla base del censimento delle aziende
ALLEGATO A3
199820012005 Attività minerarie ed estrazione di pietre e terra 1 12511472 Fabbricazione di alimenti per animali da reddito2 1112 2731 928 Lavorazione e trasformazione del legno 1 920849557 Fabbricazione di concimi e composti azotati109176169 Fabbricazione di prodotti fitosanitari e altri prodotti agro-chimici3 2183 1011 744 Fabbricazione di saponi, detergenti, profumi e cosmetici 1 14614431 Fabbricazione di altri prodotti derivati da minerali non metallici 1 478435268 Produzione e lavorazione di metallo, fabbricazione di prodotti metallici 1 2 3892 298218 Fabbricazione di macchine agricole3 7283 6714 212 Approvvigionamento energetico ed idrico 1 593530380 Edilizia 1 7 0536 4664 485 Mediazione commerciale di prodotti di base, animali, materie prime tessili e semilavorati42970116 Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per animali 4 1953 9103 807 Commercio all'ingrosso di macchine ed attrezzature agricole2 7903 2482 848 Commercio al dettaglio di cereali, alimenti per animali e prodotti nazionali9881 2371 389 Trasporti terrestri, trasporto mediante condutture 1 2 1182 0221 432 Credito e assicurazione 2 5 9916 0135 187 Affitto di macchine agricole 12932 Servizi d'informazione 1 1 0131 484952 Ricerca e sviluppo 1 271320245 Fornitura di prestazioni di servizio per imprese 2 8 5269 3218 843 Amministrazione pubblica generale, opere sociali, economia 3 4 3443 9274 163 Scuole medie superiori e altre scuole d'insegnamento generale 2 554147 Scuole secondarie professionali 2 861822747 Università e formazione superiore 2 1 2021 2481 305 Veterinaria 3 2053 3943 794 Federazioni economiche e di datori di lavoro, organizzazioni professionali 4 1 0349471 008 Totalelavoratoriinaziendeinsettoriamonte579045807049978 Macellazione e lavorazione della carne11 03410 68310 966 Lavorazione del pesce 311235198 Lavorazione e conservazione di frutta e verdura3 3223 4362 641 Fabbricazione di grassi e oli animali e vegetali481410402 Lavorazione del latte 10 47410 0589 192 Mulini per la macina/pilatura, fabbricazione di amido e prodotti amidacei2 1201 8131 545 Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia21978100 Fabbricazione di pane e prodotti di panetteria8 3189 0669 370 Fabbricazione di prodotti di biscotteria2 2571 9231 858 Fabbricazione di zucchero 4493741 092 Fabbricazione di prodotti a base di cacao, cioccolata e dolciumi6 0185 9685 858 Fabbricazione di pasta 1 2481 4851 619 Lavorazione di tè e caffè 1 0531 1071 136 Fabbricazione di spezie e salse 1 3411 393689 Fabbricazione di alimenti omogeneizzati e dietetici578430439 Fabbricazione di altri alimenti non specificati altrove4 7024 3056 223 Fabbricazione di bevande 6 0685 9865 850 Lavorazione del tabacco 2 8262 6932 710 Lavorazione e cardatura della lana 745353 Lavorazione e pettinatura della lana 160417361 Lavorazione e filatura del lino 150Produzione di cuoio 10710072 Totalelavoratorinelcampodellalavorazioneedellafabbricazionediderratealimentari, bevandeealtriprodotti631756201362374 Mediazione commerciale di derrate alimentari, bevande e tabacchi20695178 Commercio all'ingrosso di fiori e piante1 8311 8451 616 Commercio all'ingrosso di animali vivi970845911 Commercio all'ingrosso di pellami, pellicce e cuoio195167146 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo411911 Commercio all'ingrosso di derrate alimentari, bevande e tabacchi32 79929 58530 320 Commercio al dettaglio di merci di varia tipologia, in primo luogo derrate alimentari81 12272 39564 852 Commercio al dettaglio di derrate alimentari, bevande e tabacchi45 83546 05344 955 Commercio al dettaglio di fiori e piante6 6377 0387 034 Totale lavoratori in mediazione commerciale, commercio all'ingrosso e al dettaglio169 636158 042150 023 Totalelavoratoriinaziendeinsettoriavalle232811220055212397 Totalelavoratoriinaziendeinsettoriamonte/avalle290715278125262375
Fonti: UST, USC, UFAG
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Mercati
A4 ALLEGATO
Tabella 4
Prodotto1990/9220042005200611990/92–2004/06 hahahaha% Cereali207292161753167689165659-20.4 Cerealipanificabili102840872818803980085-17.2 Frumento96 17383 16683 74475 835-15.9 Spelta2 1602 2492 4282 52911.2 Farro, piccola spelta 2 163165160 Segale4 4321 6801 6771 539-63.2 Miscele di cereali panificabili75232522-68.9 Cerealidaforaggio104453744727965085574-23.5 Frumento-2 5696 33415 003 Orzo59 69537 40137 68937 051-37.4 Avena10 4343 0282 9502 416-73.2 Miscele di cereali da foraggio2382582542314.1 Mais da granella25 73918 81620 61219 616-23.5 Triticale8 34712 40011 81111 25741.6 Leguminose2258492551785652132.5 Piselli da foraggio (proteici)2 1124 6004 8075 254131.4 Favette14624927229385.4 Lupini-7699105Sarchiate36385336093219831984-10.4 Patate (comprese quelle da semina)18 33313 33512 51011 973-31.2 Barbabietole da zucchero14 30818 62218 24818 73929.6 Barbabietole da foraggio (zuccherine e semizuccherine)3 7441 6521 4401 272-61.1 Semioleosi1820323217231432383028.5 Colza16 73015 75116 54917 402-1.0 Girasole-4 9455 0425 268 Soia1 4742 4951 5181 12516.2 Zucche per l'estrazione d'olio-263435Materieprimerinnovabili-127513061461Colza-1 0881 1021 286Girasole-364141Altre (kenaf, canapa, ecc.)-151163134Verdureinpienocampo82508813891488997.6 Maisverdeedasilo3820442433429384186911.0 Maggeseverdeefiorito319359232923100944.4 Altra superficie coltiva aperta8301 6861 7731 736108.6 Superficiecoltivaaperta311741281303286431284190-8.9 Pratiartificiali9443612447411910112050028.5 Altra superficie coltiva3 9773 0692 9683 627-19.0 Totalesuperficiecoltiva410154408846408500408317-0.4 Frutticoltura6 9146 7336 6726 636-3.4 Viticoltura14 91914 93714 90314 885-0.1 Miscanthus sinensis3238231-7 716.7 Prati naturali, pascoli638 900624 337625 432625 132-2.2 Altro utilizzo nonché strame e torba7 3949 4839 38010 23031.2 Superficieagricolautile1078600106457410651181065200-1.3
Superficie
agricola utile secondo le forme di utilizzazione
Fonti: viticoltura e frutticoltura: UFAG; altri prodotti: USC, UST
1 Dati provvisori 2 Registrazione separata dal 2002
1 Dati provvisori
2 Media degli anni 1990/93
3 Variazione 1990/93–2003/06
Fonti:
Latte e latticini: USC (1990–98), dal 1999 TSM
Carne: Proviande
Uova: Aviforum
Cereali, sarchiate e semi oleosi: USC
Frutta: Associazione svizzera frutta, Interprofession des fruits et légumes du Valais
Verdura: Centrale svizzera dell'orticoltura
Vino: UFAG, Cantoni
ALLEGATO A5 Tabella 5 Produzione ProdottoUnità1990/922004200520061990/92–2004/06 % Latteelatticini Latte di consumot549 810497 021488 412493 246-10.4 Pannat68 13363 92764 41664 743-5.5 Burrot38 76640 66440 27340 8454.7 Latte in polveret35 84451 04850 80448 37339.7 Formaggiot134 400162 397167 708172 91424.8 Carneeuova Carne di manzot PM130 710100 308100 024104 217-22.3 Carne di vitellot PM36 65633 67932 28931 588-11.3 Carne suinat PM266 360227 085236 165243 321-11.6 Carne ovinat PM5 0656 5966 1915 78822.3 Carne caprinat PM541488568525-2.5 Carne equinat PM1 2121 050941911-20.2 Pollamet peso di vendita20 73334 34133 36129 78156.7 Uova in gusciomio. di pezzi6386526576602.8 Cereali Grano tenerot546 733528 300521 400530 200 1 -3.7 Segalet22 97811 3009 4008 600 1 -57.5 Orzot341 774257 400231 200229 400 1 -30.0 Avenat52 80715 70015 30012 000 1 -72.9 Mais da granellat211 047180 900198 900151 100 1 -16.1 Triticalet43 94082 90068 40064 500 1 63.7 Altrit11 46912 50011 90011 800 1 5.2 Sarchiate Patatet750 000526 700485 000392 000 1 -37.6 Barbabietole da zuccherot925 8671 455 8001 409 4001 242 728 1 47.9 Semioleosi Colzat46 11455 30056 20053 300 1 19.1 Girasolet-13 49615 00013 600 1Altrit3 6587 4804 3003 380 1 38.1 Frutta(datavola) Melet91 503 2 100 755102 900102 8819.4 3 Peret-17 20716 25114 238Albicocchet3 407 2 4 6253 3554 555-1.8 3 Ciliegiet1 818 2 2 0261 5881 689-3.6 3 Prugnet2 837 2 2 9951 9982 382-6.6 3 Fragolet4 2635 7755 6955 40131.9 Verdure(fresche) Carotet49 16257 84455 92459 47217.5 Cipollet23 50532 35732 84426 76630.4 Sedano rapat8 5068 85210 7858 2039.1 Pomodorit21 83034 93132 03531 79850.8 Lattuga cappucciot18 82115 59015 66713 212-21.2 Cavolfioret8 3317 4416 4615 455-22.6 Cetriolit8 6089 3039 6699 94612.0 Vino Vino rossohl550 276606 909522 415539 7421.1 Vino biancohl764 525552 261478 988471 380-34.5
A6 ALLEGATO
6 Produzione di latticini Prodotto1990/922004200520061990/92–2004/06 tttt% Totaleformaggio13440016239716770817291424.8 Formaggio fresco4 38736 82239 78140 551790.2 Mozzarella-13 33714 81515 470Altro formaggio fresco-23 48524 96625 081Formaggio a pasta molle4 8126 7276 5656 77339.0 Tomme1 2492 1812 0341 98865.5 Formaggio a crosta fiorita, da semigrasso a grasso1 5731 3971 4551 488-8.0 Altro formaggio a pasta molle1 9903 1493 0753 29759.5 Formaggio a pasta semidura40 55647 87849 43349 56020.7 Appenzeller8 7258 3009 1888 662-0.1 Tilsiter7 7364 4534 1434 123-45.2 Formaggio da raclette9 89813 11713 20412 92932.2 Altro formaggio a pasta semidura14 19722 00822 89823 84661.4 Formaggio a pasta dura84 62970 16071 05075 105-14.8 Emmentaler56 58833 50432 18033 894-41.3 Gruyère22 46426 72027 52928 37122.6 Sbrinz4 6591 7161 5631 664-64.6 Altro formaggio a pasta dura9188 2209 77811 176959.3 Prodotti speciali 1 158108799275 713.3 Totaleprodottiabasedilattefresco6808227269017405357484748.5 Latte di consumo549 810497 021488 412493 246-10.4 Altri131 012229 880252 123255 22887.6 Totaleburro387664066440273408454.7 Burro speciale27 2004 2194 1924 355-84.4 Altro11 56636 44536 08136 490214.2 Totalepanna68133639276441664743-5.5 Totalelatteinpolvere3584451048508044837339.7 1 Formaggio di solo latte di pecora o di capra Fonti: USC (1990–98), dal 1999 TSM Tabella 7 Valorizzazione del latte commercializzato Prodotto1990/922004200520061990/92–2004/06 1000tlatte1000tlatte1000tlatte1000tlatte% Lattediconsumo549456448450-17.8 Lattetrasformato249027322755272810.0 in formaggio1 5311 3231 3721 403-10.8 in burro35649448146434.7 in panna430247251251-41.9 in altri latticini173668652611272.1 Totale30393187320331795.0 Fonti: USC (1990–98), dal 1999 TSM
Tabella
Tabella 8
Valorizzazione del raccolto della produzione vegetale
ALLEGATO A7
Prodotto1990/922004200520061990/92–2004/06 tttt% Patate Patate da tavola285 300162 800166 200160 200 1 -42.8 Patate destinate alla trasformazione114 700126 700133 200114 700 1 8.9 Patate da semina35 93327 50024 70023 600 1 -29.7 Somministrazione allo stato fresco agli animali225 967150 100134 00073 800 1 -47.2 Trasformazione in alimenti per animali146 90055 70021 50014 100 1 -79.3 Meleeperesvizzeredasidro (trasformazioneinstabilimentiartigianali)183006215682395768132917-30.73 Quantitativo di frutta da sidro per succo grezzo182 424 2 156 59795 651132 850-30.5 3 Sidro fresco da torchio10 477 2 9 5289 1669 679-6.0 3 Sidro per la fabbricazione di acquavite3 297 2 598162233-87.0 3 Succo concentrato165 263 2 145 56881 195115 597-31.7 3 Altri succhi (compreso l'aceto)3 387 2 9035 1287 3416.4 3 Frutta pigiata582 2 22611767-74.4 3 Fabbricazionedibevandecontenenti alcoldidistillazione di mele e pere svizzere40 255 2 17 18621 66811 104-51.3 3 di ciliegie e prugne svizzere23 474 2 13 32912 7268 065-44.9 3 Verduresvizzerefrescheperlafabbricazione diderratealimentari Verdure congelate26 06120 05924 10430 049-5.1 Verdure da conserva (fagiolini, piselli, carote parigine)19 77614 53214 35414 937-26.1 Crauti 8 0916 1235 5644 887-31.7 Rape1 535924898739-44.4 1
2
3 Variazione 1990/93–2003/06 Fonti: Patate: swisspatat Frutta da sidro: UFAG; bevande contenenti alcol di distillazione: Regia federale degli alcol Verdure per la trasformazione: Centrale svizzera dell'orticoltura
Dati provvisori
Media degli anni 1990/93
A8 ALLEGATO
Commercio estero Prodotto1990/922004200520061990/92–2004/06 tttt% Esporta-Importa-Esporta-Importa-Esporta-Importa-Esporta-Importa-Esporta-Importazionizionizionizionizionizionizionizionizionizioni Latteelatticini Latte 1923 0075722 64032623 05533523 9291 139.20.9 Yogurt1 1951717 0336937 3001 8776 9183 903771.512 591.8 Panna909251 3791 0124 2753 2104 0113 043254.49 472.1 Burro04 154598622 04154 5071 207.1-39.5 Latte in polvere8 1583 26615 61738116 97054512 69138485.0-86.6 Formaggio62 48327 32850 87531 46151 70931 91350 48730 892-18.315.0 Carne,uovaepesce Carne di manzo2807 8731 15910 1031 22312 6101 34614 450343.857.3 Carne di vitello09160377097201 208--7.0 Carne suina2881 95653413 49021610 0362558 98116.3454.0 Carne ovina56 48906 23206 07306 077-100.0-5.6 Carne caprina0403033902540331--23.6 Carne equina04 60004 21104 27804 748--4.1 Pollame1039 94247042 53372442 06441543 4135 263.36.8 Uova031 401127 0647028 3442928 912--10.5 Pesce, crostacei e molluschi62031 13217336 82015737 01124931 372-68.912.6 Cereali Frumento6232 134107279 90178202 62970257 2411 235.56.2 Segale03 05706 57802 7793008 754-97.5 Orzo43644 50411226 22517214 06812455 015-68.8-28.6 Avena13160 885144 007047 408054 976-99.9-19.9 Mais da granella19460 51235379 30553376 09617156 30481.516.6 Sarchiate Patate9 6958 7221 11938 35752520 2101 74357 325-88.4342.9 Zucchero40 882124 065271 611288 462302 485313 561284 086277 158599.7136.2 Semioleosi Semi oleosi489134 57049983 15560379 1271 11685 12351.1-38.7 Oli e grassi vegetali18 68057 7652 275105 1862 953110 9572 865123 16561.295.8 Frutta(fresche) Mele683 1 12 169 1 16321 34661110 62975910 00824.6 2 2.1 2 Pere491 1 11 803 1 2266 4803289 605788 482-64.0 2 -28.6 2 Albicocche226 1 10 578 1 106 34119 1281358 363-81.5 2 -24.3 2 Ciliegie256 1 1 062 1 51 094251 561221 860-94.5 2 26.7 2 Prugne e susine12 1 3 290 1 24 42116 313295 60312.5 2 65.8 2 Fragole15011 0234511 8967412 3846811 299-58.57.6 Uva2333 6911334 205636 71014032 676127.12.5 Agrumi161135 78038125 4365123 676351126 087-18.4-7.9 Banane8577 8962873 538574 2203174 068-74.8-5.1 Verdure(fresche) Carote711 710258 313705 87745 411-53.5282.0 Cipolle8623 444299 98163 40118 692-98.6113.7 Sedano rapa020608230970204-81.6 Pomodori40235 700939 5214140 3524841 194-91.913.0 Lattuga cappuccio373 95412 48002 394132 654-87.3-36.5 Cavolfiore119 98509 23118 58079 420-76.5-9.1 Cetrioli6517 479115 712316 113116 222-97.4-8.4 Vino Vino rosso (in hl)3 4991 494 2949 9131 360 28611 7711 348 27415 1251 287 362250.7-10.9 Vino bianco (in hl)7 59076 8358 540223 08911 651228 17511 129239 45937.5199.7 1 Media degli anni 1990/93 2 Variazione 1990/93–2003/06 Fonti: Latte e latticini, uova, cereali, sarchiate, semi oleosi, frutta, verdura e vino: DGD Zucchero: réservesuisse
Tabella 9
Commercio estero di formaggio
ALLEGATO A9
10
Tabella
Prodotto1990/922004200520061990/92–2004/06 tttt% Importazioni Formaggio fresco 1 4 1759 4159 2299 896127.9 Formaggio grattugiato 2 233748833804241.8 Formaggio fuso 3 2 2212 1922 1752 4081.7 Formaggio a crosta fiorita 4 2 2762 1512 0802 078-7.6 Formaggio a pasta molle 5 6 6285 6535 7835 700-13.8 Formaggio a pasta semidura 6 11 795 4 9174 8925 508 Formaggio a pasta dura 7 6 3856 9216 906 0.4 Totaleformaggioericotta2732831461319133330017.9 Esportazioni Formaggio fresco 1 28629845813 933.3 Formaggio grattugiato 2 10496881352.2 Formaggio fuso 3 8 2454 8954 6154 253-44.4 Formaggio a crosta fiorita 4 0313200 Formaggio a pasta molle 5 305406073741 584.2 Formaggio a pasta semidura 6 54 102 7 7338 9599 355 Formaggio a pasta dura 7 37 52237 12836 350 -15.6 Totaleformaggioericotta62483508755170950945-18.1 1 0406.1010, 0406.1020, 406.1090 2 0406.2010, 0406.2090 3 0406.3010, 0406.3090 4 0406.4010, 0406.4021, 0406.4029, 0406.4081, 0406.4089 5 0406.9011, 0406.9019 6 0406.9021, 0406.9031, 0406.9051, 0406.9091 7 0406.9039, 0406.9059, 0406.9060, 0406.9099 Fonte: DGD
A10 ALLEGATO Tabella 11 Consumo pro capite Prodotto1990/9220042005200611990/92–2004/06 kgkgkgkg% Latteelatticini Latte di consumo104.3780.9079.1079.10-23.6 Panna6.438.308.208.3028.5 Burro6.205.605.605.60-9.7 Formaggio16.9019.8019.7019.9017.2 Formaggio fresco3.466.106.406.4082.1 Formaggio a pasta molle1.831.801.701.80-3.6 Formaggio a pasta semidura5.655.705.605.60-0.3 Formaggio a pasta dura5.966.206.006.102.3 Carneeuova Carne di manzo13.7110.2310.3910.91-23.3 Carne di vitello4.253.543.433.35-19.1 Carne suina29.7324.8025.2025.66-15.2 Carne ovina1.421.471.401.36-0.7 Carne caprina0.120.100.090.10-19.4 Carne equina0.750.630.630.68-13.8 Pollame8.059.979.698.2715.7 Uova in guscio (pz.)199182185185-7.5 Cereali Pane e prodotti da forno50.7050.7051.0051.600.8 Sarchiate Patate e prodotti a base di patate44.1740.2643.6438.00-8.0 Zucchero (compr. zucchero nei prodotti trasformati)42.3756.8558.6056.9035.6 Semioleosi Oli e grassi vegetali12.8015.8516.0617.2027.9 Frutta(datavola) Mele15.26 2 16.4315.1314.94-1.7 3 Pere-3.163.423.02Albicocche2.04 2 1.481.671.70-25.6 3 Ciliegie0.39 2 0.420.420.476.4 3 Prugne e susine0.91 2 1.001.111.0619.5 3 Fragole2.242.382.412.224.3 Agrumi20.0916.9016.5816.75-16.7 Banane11.539.919.959.86-14.1 Verdure(fresche) Carote7.538.918.278.6414.3 Cipolle3.865.704.864.7232.0 Sedano rapa1.291.301.461.120.3 Pomodori8.4610.039.709.7216.0 Lattuga cappuccio3.372.452.432.13-30.7 Cavolfiore2.712.252.021.98-23.1 Cetrioli2.972.802.802.88-4.8 Vino Vino rosso (in l)31.9726.3325.5924.83-20.0 Vino bianco (in l)14.4711.7810.2110.81-24.4 Totale vino (in l)46.4438.1135.8035.64-21.4 1 Dati in parte provvisori 2 Media degli anni 1990/93 3 Variazione 1990/93–2003/06 Fonti: Latte e latticini, uova, sarchiate, cereali e semi oleosi: USC Carne: Proviande Frutta, verdura e vino: UFAG
1 Media degli anni 1990/93
2 Variazione 1990/93–2003/06
3 Prezzi franco macello, escl. suini da carne franco fattoria, GQ: gestione della qualità Carne Svizzera
4 Il prezzo non si applica alle eccedenze
Fonti:
Latte: UFAG
Bestiame da macello, pollame e uova: USC
Cereali, sarchiate e semi oleosi: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Frutta: Associazione svizzera frutta e Interprofession des fruits et légumes du Valais; trattasi di prezzi indicativi alla produzione definitivi
Verdura: Centrale svizzera dell'orticoltura; prezzi franco distributore all'ingrosso
ALLEGATO A11 Tabella 12 Prezzi alla produzione ProdottoUnità1990/922004200520061990/92–2004/06 % Latte Totale Svizzeract./kg104.9774.6372.4171.82-30.5 Latte trasformato in formaggio (solo dal 1999) ct./kg-73.8472.2171.65Latte biologico (solo dal 1999)ct./kg-85.4581.8180.24Bestiamedamacello3 Vacche T3fr./kg PM7.826.626.166.35-18.5 Giovani vacche T3fr./kg PM8.137.126.947.08-13.3 Torelli T3fr./kg PM9.288.177.978.44-11.7 Buoi T3fr./kg PM9.838.147.958.41-16.9 Manze T3fr./kg PM8.668.077.948.23-6.7 Vitelli T3fr./kg PM14.3912.6113.2014.43-6.8 Suini da carne, dal 2003 GQfr./kg PM5.834.544.023.85-29.0 Agnelli fino a 40 kg T3fr./kg PM15.4010.2110.3010.34-33.2 Pollameeuova Polli cl. I, franco fattoriafr./kg PV3.722.672.602.60-29.5 Uova da allevamento al suolo, a negozifr./100 pz.41.0236.0638.0839.92-7.3 Uova da allevamento in libertà, a negozifr./100 pz.46.2142.2442.0841.68-9.1 Cereali Frumentofr./100 kg99.3457.8452.4252.37-45.4 Segalefr./100 kg102.3643.9944.7844.66-56.5 Orzofr./100 kg70.2444.2642.2441.87-39.1 Avenafr./100 kg71.4044.6746.9747.73-34.9 Triticalefr./100 kg70.6944.9042.6641.83-39.0 Mais da granellafr./100 kg73.5443.3142.2342.87-41.8 Sarchiate Patatefr./100 kg38.5533.3834.3038.07-8.6 Barbabietole da zuccherofr./100 kg14.8411.8511.7711.49-21.1 Semioleosi Colzafr./100 kg203.6776.6076.8375.55-62.5 Girasolefr./100 kg-83.7482.0082.92Frutta Mele: Golden Delicious Ifr./kg1.12 1 1.06 4 1.01 4 0.97 4 -5.1 2 Mele: Maigold Ifr./kg1.35 1 1.21 4 0.90 4 0.90 4 -18.3 2 Pere: Conférencefr./kg1.33 1 0.98 4 1.09 4 1.23 4 -14.7 2 Albicocchefr./kg2.09 1 2.092.372.5317.1 2 Ciliegiefr./kg3.20 1 3.503.703.6010.9 2 Prugne: Fellenbergfr./kg1.40 1 1.552.052.0531.3 2 Fragolefr./kg4.775.605.005.2010.4 Verdure Carote (scorte)fr./kg1.091.261.381.4525.1 Cipolle (scorte)fr./kg0.891.190.971.6040.8 Sedano rapa (scorte)fr./kg1.622.442.322.4347.9 Pomotori rotondifr./kg2.422.372.342.590.6 Lattuga cappucciofr./kg2.373.433.633.9454.7 Cavolfiorefr./kg1.852.132.302.8130.5 Cetriolifr./kg1.662.192.152.3634.5
con carne label e convenzionale): UFAG
e prodotti di origine vegetale: UFAG, UST
A12 ALLEGATO Tabella 13 Prezzi al consumo ProdottoUnità1990/922004200520061990/92–2004/06 % Latteelatticini Latte intero, pastorizzato, imballatofr./l1.851.541.541.52-17.1 Latte drink, pastorizzato, imballatofr./l1.851.521.501.49-18.7 Latte scremato UHTfr./l-1.401.421.43Emmentalerfr./kg20.1519.9319.6319.21-2.8 Gruyèrefr./kg20.4020.5420.1919.97-0.8 Tilsiterfr./kg-17.3417.5916.80Camembert 45% (grasso s.s.)125 g-2.862.902.88Formaggio a pasta molle, a crosta fiorita150 g-3.673.683.64Mozzarella 45% (grasso s.s.)150 g-2.202.132.12Burro speciale200 g3.463.142.952.85-13.9 Il Burro (burro da cucina)250 g3.442.962.842.76-17.1 Panna intera, imballata 1⁄2 l-4.504.223.97Panna per caffè, imballata 1⁄2 l-2.412.342.27Yogurt, aromatizzato o alla frutta180 g0.890.680.660.65-25.1 Carnedimanzo Entrecôte, tagliatofr./kg48.3655.7455.7057.0516.1 Fettine, nocefr./kg37.5943.4242.8643.7515.3 Arrosto, spallafr./kg26.3428.5627.8928.167.1 Carne macinatafr./kg15.0017.0216.9517.2113.7 Carnedivitello Braciole, tagliatefr./kg35.3242.5844.1747.5326.7 Fettine, nocefr./kg32.5636.3636.3537.8413.2 Spezzatinofr./kg21.6731.4631.8633.5849.1 Carnesuina Braciole, tagliatefr./kg19.8820.4919.9219.640.7 Fettine, nocefr./kg24.4828.0025.7925.978.6 Arrosto, spallafr./kg18.4320.3419.5918.535.7 Spezzatino, spallafr./kg16.6919.6018.9718.4113.8 Carned'agnello,indigena,fresca Cosciotto senza osso femoralefr./kg26.3428.7228.7528.919.3 Braciole, tagliatefr./kg30.3237.0538.4641.6228.8 Prodotticarnei Prosciutto cotto di coscia, nello stampo, affettatofr./kg25.5631.1429.6729.7618.1 Salame indigeno I, affettatofr./100 g3.094.364.464.5143.8 Polli Indigeni, freschifr./kg8.419.019.129.569.7 Produzionevegetaleeprodottidioriginevegetale Farina biancafr./kg-1.441.391.38Pane bigiofr./500 g-1.371.371.26Pane semibiancofr./500 g-1.411.411.30Panini al latte / Michettefr./kg-10.5110.4910.66Cornettifr./kg-15.8216.2116.36Spaghettifr./500 g-1.141.101.06Patatefr./kg1.432.232.262.3158.5 Zucchero cristallizzatofr./kg1.651.591.651.832.4 Frutta(indigenaedestera) Mele: Golden Deliciousfr./kg3.15 1 4.043.824.0223.4 2 Perefr./kg3.25 1 3.763.563.9014.7 2 Albicocchefr./kg3.93 1 6.176.156.8061.6 2 Ciliegiefr./kg7.35 1 10.019.889.5830.7 2 Prugnefr./kg3.42 1 3.894.464.3324.5 2 Fragolefr./kg8.6910.5710.8311..9223.1 Verdure(perconsumofresco;indigeneedestere) Carote (scorte)fr./kg1.912.162.022.2011.3 Cipolle (scorte)fr./kg1.862.281.952.6623.5 Sedano rapa (scorte)fr./kg3.144.213.854.5734.1 Pomodori rotondifr./kg3.733.293.593.51-7.1 Lattuga cappucciofr./kg4.461.751.862.01-58.0 Cavolfiorefr./kg3.583.634.214.6716.5 Cetriolifr./kg2.803.904.101.8016.7 1 Media degli anni 1990/93 2 Variazione 1990/93–2003/06 Fonti: Latte, carne
Produzione vegetale
(paniere
Tabella 14
Grado di autoapprovvigionamento
1 Compresi prodotti della molitura e cereali panificabili germogliati, esclusi i panelli oleosi; le variazioni delle scorte non sono considerate
2 Compresi grano duro, avena commestibile, orzo commestibile e granoturco
3 Mele, pere, ciliegie, prugne, susine, albicocche e pesche
4 Quota della produzione indigena rispetto al peso della carne e dei prodotti carnei pronti per la vendita
5 Compresa la carne equina, caprina, di coniglio e la selvaggina, nonché pesci, crostacei e molluschi
6 Energia assimilabile in Joules, comprese le bevande alcoliche
7 Esclusi i prodotti di origine animale ottenuti a partire da alimenti per animali importati
8 Produzione indigena ai prezzi alla produzione, importazione ai prezzi della statistica sul commercio (franco frontiera, non sdoganati)
Fonte: USC
ALLEGATO A13
Prodotto1990/922003200420051990/92–2003/05 Percentualequantitativa:%%%%% Cereali panificabili 118789287-27.4 Cereali da foraggio 1 614975727.1 Totalecereali264466363-10.4 Patate commestibili101879591-9.9 Zucchero464450504.3 Grassi e oli vegetali22192222-4.5 Frutta 3 72647359-9.3 Verdura55515551-4.8 Latte di consumo 979899981.4 Burro 899797937.5 Formaggio 137113114117-16.3 Totalelatteelatticini110109108108-1.5 Carne di vitello 4 979898970.7 Carne bovina 4 93918886-5.0 Carne suina 4 99939394-5.7 Carne ovina 4 3942454412.0 Pollame 4 3745484927.9 Carnedituttiitipi4576706970-8.3 Uova e conserve di uova444746443.8 Percentualedienergiaalimentare6: Derrate alimentari di origine vegetale 43394543-1.6 Derrate alimentari di origine animale lorde 97959494-2.7 Totalederratealimentarilorde62566059-5.9 Totale derrate alimentari nette 7 58515554-8.0 Percentualeinvaloredeltotalederratealimentari872626463-12.5
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Risultati economici
Tabella 15
Produzione del settore primario ai prezzi alla produzione correnti, in 1 000 fr.
Tutti
risultati sono stati rivisti (cfr. allegato pagina A59)
1 Semidefinitivo, stato 11.09.2007
2 Dati provvisori, stato 11.09.2007
3 Stima, stato 11.09.2007
Le cifre vengono arrotondate per eccesso o difetto, per cui la somma delle componenti può divergere dal totale o dai saldi.Fonte: UST
A14 ALLEGATO
Prodotto1990/92200420051200621990/92–200732004/06–2004/062007 %% Produzionedibeniagricoli13325590996120994144879044339-28.99397766-0.8 Produzionevegetale6049831476591144656894132704-26.444905660.8 Cereali (compr. sementi)1 116 180492 768448 267439 799-58.8415 747-9.7 Frumento543 264281 024259 251267 876-50.4250 081-7.2 Orzo306 59199 06184 82885 166-70.777 525-13.6 Mais da granella153 80369 38868 89354 275-58.356 606-11.8 Altri cereali112 52243 29635 29532 481-67.131 535-14.8 Piante industriali261 444304 158284 733254 9447.6294 5444.7 Semi e frutti oleosi (compr. sementi)96 23097 10687 99787 503-5.692 4821.8 Piante proteiche (compr. sementi)10 28214 93314 34114 75342.714 085-4.0 Tabacco grezzo16 94519 91622 83017 30718.115 435-22.9 Barbabietole da zucchero136 590168 452154 747129 98910.6166 60510.3 Altre piante industriali1 3983 7514 8175 392233.05 93727.6 Piante foraggere1 953 8331 435 6011 347 9651 034 030-34.91 413 80211.1 Mais da foraggio200 132202 395171 391120 414-17.7177 0287.5 Sarchiate da foraggio31 76111 3859 1888 747-69.28 181-16.3 Altre piante foraggere1 721 9391 221 8211 167 386904 869-36.21 228 59311.9 Prodotti d'orticoltura e floricoltura1 246 2961 314 8931 269 7321 258 2822.81 281 5680.0 Verdura fresca387 355538 267530 192522 01836.9528 791-0.3 Piante e fiori858 941776 626739 540736 264-12.6752 7780.3 Patate (compr. patate da semina)276 669170 617177 114171 353-37.5170 928-1.2 Frutta704 397598 683496 360511 611-24.0494 247-7.7 Frutta fresca324 160353 250282 824301 297-3.6307 196-1.7 Uva380 237245 433213 536210 314-41.3187 051-16.2 Vino467 759426 461413 234431 593-9.4386 926-8.7 Altri prodotti di origine vegetale23 25322 73128 28331 09317.732 80519.9 Produzioneanimale7275760519529749487984911635-31.04907200-2.2 Bovini1 833 1621 211 3491 177 4321 218 829-34.41 225 4001.9 Suini1 533 2121 088 131975 330959 871-34.31 002 202-0.6 Equini15 0027 9695 0662 576-65.33 724-28.4 Ovini e caprini62 47154 84151 02946 689-18.642 982-15.5 Pollame177 154217 975205 507181 57013.8206 1912.2 Altri animali32 12913 59710 79310 498-63.810 249-11.9 Latte3 396 1492 414 1662 336 1952 306 596-30.72 233 773-5.0 Uova211 437177 526179 538176 351-15.9173 778-2.3 Altri prodotti di origine animale15 0449 7437 9088 655-41.78 9021.5 Produzionediprestazioniagricole425198655379638100624067-627801-1.8 Prestazioni agricole425 198618 020607 767616 12044.4624 1821.7 Locazione di contingenti lattieri037 35930 3337 946-3 619-85.6 Produzioneagricola1375078910616588100525869668405-26.510025567-0.9 Attivitàaccessorienonagricole(nonseparabili)359034278912294148310893-17.93106855.4 Trasformazione di prodotti agricoli276 878193 819193 502205 289-28.7202 7572.6 Altre attività accessorie non separabili (beni e servizi)82 15685 093100 646105 60418.2107 92711.1 Produzionedelsettoreprimario1410982310895500103467349979298-26.210336252-0.7
i
ALLEGATO A15 Tabella 16 Conto economico dell'agricoltura ai prezzi correnti, in 1 000 fr. Prodotto1990/92200420051200621990/92–200732004/06–2004/062007 %% Produzionedelsettoreagricolo1410982310895500103467349979298-26.210336252-0.7 Totaleprestazionipreliminari6866775650384762636126132955-8.364195681.9 Sementi e materiale vegetale346 578299 031303 775297 070-13.5296 100-1.3 Energia, lubrificanti334 759398 119432 847460 91628.6471 7769.6 Concimi e sostanze ammendanti250 334182 864183 940184 290-26.6188 6752.7 Prodotti fitosanitari e per la lotta agli organismi nocivi138 587125 684126 012126 488-9.0126 1070.0 Veterinario e medicamenti156 121170 046180 894195 44416.7196 8218.1 Alimenti per animali3 766 0312 877 5032 674 9502 487 026-28.82 759 3263.0 Manutenzione di macchine e apparecchiature353 840463 053462 322463 94030.9466 3300.7 Manutenzione di impianti agricoli119 521196 920188 790192 06761.1194 8001.1 Prestazioni di servizio agricole425 198655 379638 100624 06750.3627 801-1.8 Altri beni e servizi848 4861 004 491955 446992 63616.0975 246-0.9 Oneri bancari assoggettati127 321130 756116 535109 010-6.7116 586-1.8 Valoreaggiuntolorodaiprezziallaproduzione7243047439165340831223846343-43.33916684-4.6 Ammortamenti2 058 2542 098 4002 154 6152 163 6213.92 189 3722.4 Attrezzature1 023 5491 060 1161 076 8321 075 6244.61 067 101-0.4 Edifici947 711916 243954 453969 830-0.11 001 8975.8 Piantagioni83 44296 91897 61696 78416.497 4390.3 Altro3 55225 12325 71421 383577.722 935-4.7 Valoreaggiuntonettoaiprezziallaproduzione5184793229325319285071682722-62.01727312-12.2 Altre imposte sulla produzione43 355135 436140 742146 807225.2148 6405.4 Altre sovvenzioni (non vincolate ai prodotti)886 8542 607 2002 570 7702 658 900194.62 667 2222.1 Redditodeifattori6028292476501743585354194815-26.44245894-4.4 Costo della manodopera1 233 8401 218 5241 193 4221 242 644-1.31 237 4281.6 Eccedenzaaziendalenetta/redditoindipendente4794452354649331651132952170-32.83008466-6.6 Canoni d'affitto pagati192 569200 071200 829201 4024.3201 5340.4 Interessi pagati455 911191 349211 420218 037-54.6222 1467.4 Interessi riscossi64 03111 45710 94710 405-12 764Redditosettorialenetto44210003316653027638102543136-32.92597550-8.0 Tutti i risultati sono stati rivisti (cfr. allegato pagina A59) 1 Semidefinitivo, stato 11.09.2007 2 Dati provvisori, stato 11.09.2007 3 Stima, stato 11.09.2007 4 Nella bibliografia e nel metodo Eurostat viene indicato come utile aziendale netto Le cifre vengono arrotondate per eccesso o difetto, per cui la somma delle componenti può divergere dal totale o dai saldi.Fonte: UST
Tabella 17
Risultati d’esercizio: tutte le regioni
(Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF2946533356367043383332461-6.3 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990: 6.40%; 1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2003: 2.63%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
* Questi valori possono essere calcolati unicamente a partire dal 2003. Per il biennio 1990/92 tali informazioni non sono disponibili (cfr. testo).
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A16 ALLEGATO
CaratteristicaUnità1990/9220032004200520062003/05–2006 % Aziende di riferimentoNumero4 302 2 663 3 077 3 135 3 271 10.6 Aziende rappresentateNumero62 921 50 516 50 976 50 916 50 099 -1.4 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha16.06 19.10 19.25 19.75 20.07 3.6 Superficie coltiva apertaha4.90 4.76 4.84 5.16 5.24 6.5 Manodopera aziendaleULA1.88 1.62 1.63 1.63 1.63 0.2 di cui: manodopera familiareULAF1.39 1.24 1.25 1.24 1.24 -0.3 Totale vaccheNumero12.9 13.6 13.5 13.8 13.9 2.0 Totale animaliUBG23.2 22.9 23.1 23.4 23.7 2.4 Strutturadelcapitale Totale attivifr.606 321 749 781 771 195 777 034 797 522 4.1 di cui: attivo circolantefr.116 932 133 220 135 366 134 727 135 289 0.6 di cui: inventario vivofr.60 662 46 012 48 205 50 444 50 975 5.7 di cui: attivo immobilizzatofr.428 727 570 549 587 624 591 862 611 257 4.8 di cui: attivo aziendafr.558 933 702 760 726 323 733 817 753 830 4.6 Quota di capitale di terzi%43 43 44 43 45 3.8 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.19 808 10 383 11 028 8 694 10 283 2.5 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.*217 837 231 763 227 283 226 795 0.5 di cui: pagamenti direttifr.13 594 47 046 47 485 48 745 50 033 4.8 Spese materialifr.*137 035 144 409 145 550 146 039 2.6 Reddito aziendalefr.93 027 80 803 87 354 81 733 80 756 -3.1 Costi del personalefr.13 775 11 978 13 081 13 548 13 925 8.2 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.11 361 7 309 7 095 6 941 7 232 1.6 Canoni d'affittofr.5 069 6 487 6 706 6 970 6 684 -0.6 Costi di terzifr.*162 809 171 291 173 009 173 880 2.9 Reddito agricolofr.62 822 55 029 60 472 54 274 52 915 -6.5 Reddito extraagricolofr.16 264 21 210 21 557 22 172 22 939 6.0 Reddito totalefr.79 086 76 238 82 030 76 446 75 854 -3.0 Consumo privatofr.59 573 62 896 66 440 66 954 68 529 4.7 Formazione di capitale propriofr.19 513 13 343 15 590 9 493 7 325 -42.8 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.46 914 47 580 51 261 47 336 46 524 -4.5 Cash flow 3 fr,44 456 45 285 46 392 41 588 41 961 -5.5 Rapporto cash flow-investimenti 4 %95 95 91 88 90 -1.5 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %66 69 66 64 67 1.0 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %52 45 46 41 38 -13.6 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %26 23 25 21 22 -4.3 Aziende con reddito insufficiente 8 %10 17 14 20 21 23.5 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 15 14 17 19 23.9 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA49 473 49 903 53 720 50 282 49 459 -3.6 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha5 796 4 231 4 538 4 138 4 025 -6.4 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%16.7 11.5 12.0 11.1 10.7 -7.2 Redditività Redditività del capitale totale 10 %0.8 -2.3 -1.6 -2.5 -2.7 26.6 Redditività del capitale proprio 11 %-2.2 -5.9 -4.7 -6.2 -6.6 17.9 Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF3102535886396763668734492-7.8
Tabella 18
Risultati d’esercizio: regione di pianura*
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990: 6.40%; 1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2003: 2.63%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione di pianura: zona campicola più zone intermedie
** Questi valori possono essere calcolati unicamente a partire dal 2003. Per il biennio 1990/92 tali informazioni non sono disponibili (cfr. testo).
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ALLEGATO A17
CaratteristicaUnità1990/9220032004200520062003/05–2006 % Aziende di riferimentoNumero2 356 1 219 1 435 1 426 1 491 9.6 Aziende rappresentateNumero29 677 22 533 23 059 23 244 22 818 -0.6 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha16.66 19.79 20.07 20.64 21.02 4.2 Superficie coltiva apertaha8.34 8.77 8.88 9.38 9.62 6.8 Manodopera aziendaleULA2.05 1.68 1.70 1.68 1.71 1.4 di cui: manodopera familiareULAF1.36 1.19 1.21 1.19 1.19 -0.6 Totale vaccheNumero12.8 13.7 13.7 13.8 13.9 1.2 Totale animaliUBG22.9 23.7 24.0 24.0 24.0 0.4 Strutturadelcapitale Totale attivifr.706 406 849 670 866 584 873 507 902 017 4.5 di cui: attivo circolantefr.149 871 160 321 161 665 165 542 165 408 1.8 di cui: inventario vivofr.61 461 46 513 48 325 49 315 49 685 3.4 di cui: attivo immobilizzatofr.495 074 642 837 656 594 658 649 686 925 5.2 di cui: attivo aziendafr.642 757 793 919 814 884 819 652 850 932 5.1 Quota di capitale di terzi%41 43 44 42 45 4.7 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.23 633 11 760 12 331 9 830 11 638 2.9 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.**266 744 285 352 276 157 272 530 -1.3 di cui: pagamenti direttifr.7 248 40 265 41 563 42 994 44 741 7.5 Spese materialifr.**168 365 176 795 176 761 173 929 0.0 Reddito aziendalefr.115 056 98 379 108 557 99 396 98 600 -3.4 Costi del personalefr.20 784 16 905 18 517 19 255 19 872 9.0 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.13 463 8 717 8 450 8 006 8 457 0.8 Canoni d'affittofr.7 015 8 627 8 975 9 440 9 139 1.4 Costi di terzifr.**202 614 212 737 213 461 211 397 0.9 Reddito agricolofr.73 794 64 129 72 615 62 696 61 132 -8.0 Reddito extraagricolofr.16 429 20 642 20 532 21 531 22 339 6.9 Reddito totalefr.90 223 84 771 93 146 84 227 83 471 -4.5 Consumo privatofr.67 985 70 092 73 335 73 704 75 679 4.6 Formazione di capitale propriofr.22 238 14 679 19 811 10 523 7 792 -48.1 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.56 951 51 053 56 403 50 898 54 327 2.9 Cash flow 3 fr.52 079 51 149 54 643 46 840 45 705 -10.2 Rapporto cash flow-investimenti 4 %92 100 97 92 84 -12.8 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %64 68 66 62 63 -3.6 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %52 43 46 41 38 -12.3 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %24 23 27 20 21 -10.0 Aziende con reddito insufficiente 8 %12 18 13 21 21 21.2 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 16 15 18 20 22.4 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA56 050 58 433 63 865 59 256 57 637 -4.8 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha6 908 4 971 5 410 4 816 4 691 -7.4 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%17.9 12.4 13.3 12.1 11.6 -7.9 Redditività Redditività del capitale totale 10 %2.1 -1.0 -0.2 -1.4 -1.6 84.6 Redditività del capitale proprio 11 %0.0 -3.7 -2.2 -4.2 -4.7 39.6 Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF3692443948499164442541655-9.6 (Valore medio) Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF3618642602481554166539440-10.6 (Valore mediano)
Tabella 19
Risultati d’esercizio: regione collinare*
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990: 6.40%; 1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2003: 2.63%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione collinare: zona collinare e zona di montagna I
**Questi valori possono essere calcolati unicamente a partire dal 2003. Per il biennio 1990/92 tali informazioni non sono disponibili (cfr. testo).
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A18 ALLEGATO
CaratteristicaUnità1990/9220032004200520062003/05–2006 % Aziende di riferimentoNumero1 125 745 846 901 957 15.2 Aziende rappresentateNumero17 397 14 062 14 013 13 739 13 610 -2.4 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha15.30 18.48 18.52 18.92 18.88 1.3 Superficie coltiva apertaha3.08 2.82 2.77 3.05 2.98 3.5 Manodopera aziendaleULA1.81 1.58 1.54 1.55 1.53 -1.7 di cui: manodopera familiareULAF1.40 1.26 1.23 1.23 1.22 -1.6 Totale vaccheNumero14.4 15.0 15.1 15.5 15.6 2.6 Totale animaliUBG26.0 24.8 25.3 26.1 26.2 3.1 Strutturadelcapitale Totale attivifr.553 876 716 978 739 401 739 607 749 459 2.4 di cui: attivo circolantefr.95 672 117 869 118 553 115 250 113 742 -3.0 di cui: inventario vivofr.66 366 49 785 53 082 56 503 56 355 6.1 di cui: attivo immobilizzatofr.391 838 549 325 567 766 567 855 579 362 3.2 di cui: attivo aziendafr.516 933 674 799 698 926 705 879 713 054 2.9 Quota di capitale di terzi%46 45 46 46 47 2.9 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.17 271 9 549 10 213 7 983 9 359 1.2 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.**200 539 213 244 209 813 209 031 0.6 di cui: pagamenti direttifr.15 415 46 494 46 540 47 887 47 897 2.0 Spese materialifr.**126 659 135 541 136 468 137 667 3.6 Reddito aziendalefr.84 599 73 880 77 702 73 345 71 363 -4.8 Costi del personalefr.9 943 9 488 10 005 10 531 10 336 3.3 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.10 915 7 120 6 913 6 964 7 136 2.0 Canoni d'affittofr.3 903 5 830 6 042 6 224 5 777 -4.2 Costi di terzifr.**149 097 158 501 160 186 160 917 3.2 Reddito agricolofr.59 838 51 442 54 742 49 627 48 114 -7.4 Reddito extraagricolofr.14 544 21 671 22 167 23 277 23 000 2.8 Reddito totalefr.74 382 73 114 76 909 72 904 71 114 -4.3 Consumo privatofr.55 272 59 442 63 851 63 761 65 303 4.7 Formazione di capitale propriofr.19 110 13 672 13 058 9 143 5 811 -51.4 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.41 428 54 334 53 676 47 152 41 892 -19.0 Cash flow 3 fr.41 445 43 742 42 906 40 168 40 410 -4.4 Rapporto cash flow-investimenti 4 %100 81 80 85 96 17.1 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %68 69 66 67 68 1.0 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %50 44 45 40 35 -18.6 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %30 26 27 23 23 -9.2 Aziende con reddito insufficiente 8 %8 15 13 18 21 37.0 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 15 15 19 21 28.6 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA46 654 46 739 50 332 47 252 46 591 -3.2 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha5 533 3 999 4 195 3 876 3 779 -6.1 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%16.4 10.9 11.1 10.4 10.0 -7.4 Redditività Redditività del capitale totale 10 %0.4 -3.0 -2.3 -3.0 -3.2 15.7 Redditività del capitale proprio 11 %-3.3 -7.5 -6.1 -7.4 -8.0 14.3 Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF3033533209361973377831657-8.0
(Valore medio) Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF2952030811343603186531436-2.8 (Valore mediano)
Tabella 20
Risultati d’esercizio: regione di montagna*
(Valore medio) Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF2070724817253742685524483-4.7 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (1990: 6.40%; 1991: 6.23%; 1992: 6.42%; 2003: 2.63%; 2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione di montagna: zone di montagna II a IV
**Questi valori possono essere calcolati unicamente a partire dal 2003. Per il biennio 1990/92 tali informazioni non sono disponibili (cfr. testo).
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ALLEGATO A19
CaratteristicaUnità1990/9220032004200520062003/05–2006 % Aziende di riferimentoNumero821 699 796 808 823 7.2 Aziende rappresentateNumero15 847 13 921 13 904 13 933 13 671 -1.8 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha15.76 18.60 18.63 19.09 19.66 4.7 Superficie coltiva apertaha0.44 0.24 0.23 0.20 0.19 -14.9 Manodopera aziendaleULA1.63 1.55 1.59 1.61 1.60 1.1 di cui: manodopera familiareULAF1.42 1.31 1.33 1.34 1.33 0.3 Totale vaccheNumero11.4 11.9 11.8 11.9 12.2 2.8 Totale animaliUBG20.5 19.6 19.3 19.8 20.6 5.3 Strutturadelcapitale Totale attivifr.476 486 621 232 645 041 652 996 670 958 4.9 di cui: attivo circolantefr.78 573 104 862 108 694 102 525 106 471 1.1 di cui: inventario vivofr.52 902 41 392 43 089 46 354 47 772 9.5 di cui: attivo immobilizzatofr.345 011 474 979 493 257 504 118 516 715 5.3 di cui: attivo aziendafr.448 089 583 451 607 061 618 171 632 350 4.9 Quota di capitale di terzi%45 41 41 42 43 4.0 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.15 432 8 997 9 690 7 501 8 943 2.4 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.**156 150 161 553 162 977 168 145 4.9 di cui: pagamenti direttifr.23 476 58 581 58 257 59 185 60 993 4.0 Spese materialifr.**96 803 99 635 102 439 107 820 8.2 Reddito aziendalefr.61 026 59 347 61 918 60 539 60 325 -0.5 Costi del personalefr.4 860 6 518 7 168 7 002 7 571 9.8 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.7 918 5 221 5 029 5 143 5 284 3.0 Canoni d'affittofr.2 707 3 687 3 612 3 587 3 490 -3.8 Costi di terzifr.**112 228 115 444 118 170 124 165 7.7 Reddito agricolofr.45 541 43 921 46 109 44 807 43 980 -2.1 Reddito extraagricolofr.17 853 21 662 22 645 22 151 23 879 7.8 Reddito totalefr.63 394 65 583 68 754 66 958 67 858 1.1 Consumo privatofr.48 548 54 736 57 614 58 840 59 807 4.8 Formazione di capitale propriofr.14 846 10 847 11 140 8 118 8 052 -19.8 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.34 138 35 138 40 299 41 575 38 112 -2.3 Cash flow 3 fr.33 482 37 352 36 224 34 227 37 257 3.7 Rapporto cash flow-investimenti 4 %98 106 90 82 98 5.8 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %70 71 68 66 72 5.4 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %54 49 48 42 42 -9.4 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %26 20 22 23 23 6.2 Aziende con reddito insufficiente 8 %8 17 18 22 19 0.0 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %12 14 12 14 16 20.0 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA37 418 38 190 39 021 37 571 37 621 -1.7 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha3 874 3 191 3 323 3 171 3 069 -4.9 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%13.6 10.2 10.2 9.8 9.5 -5.6 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.3 -4.4 -4.1 -4.5 -4.6 6.2 Redditività del capitale proprio 11 %-7.4 -9.0 -8.5 -9.3 -9.5 6.3 Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF2120126631274652786126395-3.4
Tabella 21a
Risultati d’esercizio secondo i tipi di azienda* – 2004/06
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
ART
A20 ALLEGATO
ProduzionevegetaleDetenzionedianimali Mediadi CaratteristicaUnitàtutteleCampi-ColtureLatteVaccheAltri aziendecolturaspecialicommercialemadribovini Aziende di riferimentoNumero3 161 108 85 1 210 139 187 Aziende rappresentateNumero50 664 3 385 3 406 16 548 2 589 3 882 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.69 23.00 12.95 19.79 19.41 16.83 Superficie coltiva apertaha5.08 18.93 6.23 1.01 0.95 0.31 Mandopera aziendaleULA1.63 1.28 2.10 1.63 1.34 1.44 di cui: manodopera familiareULAF1.24 0.97 1.28 1.32 1.14 1.24 Totale vaccheNumero13.7 3.1 1.6 17.6 16.6 8.0 Totale animaliUBG23.4 6.3 2.6 24.6 18.9 15.7 Strutturadelcapitale Totale attivifr.781 917 741 747 864 089 730 461 734 877 603 025 di cui: attivo circolantefr.135 127 162 367 201 017 116 908 118 799 104 207 di cui: inventario vivofr.49 875 13 427 6 277 54 510 52 183 42 671 di cui: attivo immobilizzatofr.596 915 565 952 656 796 559 044 563 895 456 147 di cui: attivo aziendafr.737 990 684 556 810 683 691 353 688 052 560 328 Quota di capitale di terzi%44 40 42 44 45 42 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.10 002 9 852 11 233 9 375 9 092 7 929 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.228 614 218 474 271 693 193 412 161 545 149 644 di cui: pagamenti direttifr.48 754 46 280 26 316 49 702 64 299 59 835 Spese materialifr.145 332 130 193 149 708 118 155 100 774 99 124 Reddito aziendalefr.83 281 88 281 121 985 75 257 60 772 50 520 Costi del personalefr.13 518 9 979 39 245 9 566 6 048 5 809 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.7 089 6 633 8 409 6 220 6 772 4 456 Canoni d'affittofr.6 787 8 646 6 440 6 219 3 353 2 904 Costi di terzifr.172 727 155 451 203 802 140 160 116 947 112 294 Reddito agricolofr.55 887 63 023 67 891 53 252 44 598 37 351 Reddito extraagricolofr.22 223 29 602 20 330 18 738 32 884 27 015 Reddito totalefr.78 110 92 625 88 221 71 990 77 482 64 366 Consumo privatofr.67 308 82 594 78 383 61 532 64 695 57 165 Formazione di capitale propriofr.10 802 10 032 9 839 10 459 12 787 7 200 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.48 374 46 759 40 443 48 278 32 536 40 307 Cash flow 3 fr.43 314 38 313 42 697 41 236 39 981 31 601 Rapporto cash flow-investimenti 4 %90 81 111 86 127 79 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %66 61 61 67 74 63 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %42 42 39 44 42 43 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %23 18 24 22 30 19 Aziende con reddito insufficiente 8 %18 20 16 18 16 21 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %17 19 20 16 12 16 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA51 154 69 313 58 168 46 166 45 540 34 956 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 233 3 852 9 427 3 804 3 134 3 004 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%11.3 12.9 15.1 10.9 8.8 9.0 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.3 0.4 -1.2 -3.2 -2.7 -5.7 Redditività del capitale proprio 11 %-5.8 -1.0 -4.0 -7.5 -6.8 -11.3 Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF369525458444238332893128523683
(Valore medio)
* Nuova tipologia aziendale FAT99 Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon
Tabella 21b
Risultati d’esercizio secondo i tipi di azienda* – 2004/06
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
* Nuova tipologia aziendale FAT99 Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ALLEGATO A21
DetenzionedianimaliAziendecombinate MediadiEquini,Latte CaratteristicaUnitàtutteleovini,Trasforma-comm./VaccheTrasformaaziendecaprinizionecampicolt.madrizioneAltre Aziende di riferimentoNumero3 161 32 77 320 47 571 384 Aziende rappresentateNumero50 664 2 032 1 529 4 143 829 5 368 6 951 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.69 13.19 11.64 26.50 23.00 19.85 21.93 Superficie coltiva apertaha5.08 0.39 1.07 13.91 10.74 6.15 7.14 Mandopera aziendaleULA1.63 1.41 1.47 1.82 1.45 1.73 1.70 di cui: manodopera familiareULAF1.24 1.17 1.21 1.27 1.07 1.25 1.23 Totale vaccheNumero13.7 1.6 10.1 20.4 17.4 16.4 15.8 Totale animaliUBG23.4 14.4 46.2 27.7 20.2 42.0 25.9 Strutturadelcapitale Totale attivifr.781 917 517 987 949 201 866 275 895 483 958 820 840 147 di cui: attivo circolantefr.135 127 80 269 157 876 167 933 168 173 143 290 136 966 di cui: inventario vivofr.49 875 24 768 66 424 61 030 55 340 71 690 60 780 di cui: attivo immobilizzatofr.596 915 412 951 724 901 637 312 671 970 743 840 642 401 di cui: attivo aziendafr.737 990 487 397 869 019 822 953 847 291 920 505 796 578 Quota di capitale di terzi%44 56 50 40 45 45 44 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.10 002 5 091 10 800 11 880 11 163 12 191 10 760 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.228 614 121 565 335 466 276 674 229 033 355 495 246 574 di cui: pagamenti direttifr.48 754 43 151 33 314 49 980 66 267 47 345 49 994 Spese materialifr.145 332 80 795 256 952 168 833 144 357 253 061 155 123 Reddito aziendalefr.83 281 40 770 78 514 107 841 84 677 102 434 91 451 Costi del personalefr.13 518 5 769 9 656 18 101 14 580 17 615 16 149 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.7 089 6 383 11 163 7 192 8 320 9 089 7 860 Canoni d'affittofr.6 787 1 893 3 300 12 282 8 181 7 625 8 951 Costi di terzifr.172 727 94 840 281 071 206 408 175 437 287 390 188 082 Reddito agricolofr.55 887 26 725 54 395 70 267 53 596 68 105 58 491 Reddito extraagricolofr.22 223 39 063 27 980 15 224 32 204 16 965 22 144 Reddito totalefr.78 110 65 788 82 374 85 490 85 800 85 070 80 636 Consumo privatofr.67 308 60 488 68 066 72 963 74 739 72 047 68 708 Formazione di capitale propriofr.10 802 5 300 14 309 12 528 11 062 13 024 11 927 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.48 374 32 178 52 402 54 286 45 508 63 180 53 155 Cash flow 3 fr.43 314 25 914 59 211 47 740 47 204 57 632 46 550 Rapporto cash flow-investimenti 4 %90 93 114 89 117 91 88 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %66 74 71 63 66 67 65 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %42 32 40 44 39 40 40 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %23 31 25 20 25 24 25 Aziende con reddito insufficiente 8 %18 19 15 22 10 18 18 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %17 18 20 14 25 18 17 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA51 154 28 610 53 510 59 313 58 560 59 121 53 793 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 233 3 077 6 820 4 075 3 687 5 164 4 173 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%11.3 8.3 9.0 13.1 10.0 11.1 11.5 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.3 -7.7 -1.5 -1.1 -1.3 -0.6 -1.9 Redditività del capitale proprio 11 %-5.8 -21.1 -5.5 -3.4 -4.2 -2.9 -5.3 Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF37416162874118445924383704815338021 (Valore medio)
Tabella 22
Risultati d’esercizio per quartili: tutte le regioni – 2004/06
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF369526138267224275977504 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF34333 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A22 ALLEGATO
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero3 161 675 798 854 834 Aziende rappresentateNumero50 664 12 674 12 673 12 657 12 660 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.69 14.90 17.44 20.82 25.61 Superficie coltiva apertaha5.08 2.65 3.37 4.87 9.45 Manodopera aziendaleULA1.63 1.54 1.62 1.65 1.70 di cui: manodopera familiareULAF1.24 1.25 1.33 1.28 1.10 Totale vaccheNumero13.7 10.2 13.2 15.4 16.1 Totale animaliUBG23.4 18.4 20.9 25.5 28.7 Strutturadelcapitale Totale attivifr.781 917 706 697 701 009 799 552 920 601 di cui: attivo circolantefr.135 127 107 783 119 917 141 670 171 188 di cui: inventario vivofr.49 875 40 512 45 879 54 163 58 963 di cui: attivo immobilizzatofr.596 915 558 402 535 213 603 720 690 450 di cui: attivo aziendafr.737 990 666 604 665 093 752 418 868 022 Quota di capitale di terzi%44 45 43 42 45 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.10 002 8 893 9 132 10 559 11 426 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.228 614 161 021 191 419 239 518 322 612 di cui: pagamenti direttifr.48 754 40 787 45 595 50 422 58 226 Spese materialifr.145 332 123 040 125 546 147 896 184 894 Reddito aziendalefr.83 281 37 982 65 874 91 623 137 718 Costi del personalefr.13 518 10 555 9 765 12 251 21 507 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.7 089 6 888 6 271 6 696 8 503 Canoni d'affittofr.6 787 3 958 5 106 7 370 10 718 Costi di terzifr.172 727 144 441 146 689 174 213 225 622 Reddito agricolofr.55 887 16 580 44 731 65 305 96 990 Reddito extraagricolofr.22 223 33 663 20 273 17 366 17 577 Reddito totalefr.78 110 50 243 65 004 82 671 114 566 Consumo privatofr.67 308 57 548 61 541 68 804 81 355 Formazione di capitale propriofr.10 802 -7 304 3 463 13 867 33 212 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.48 374 45 579 38 144 46 153 63 631 Cash flow 3 fr.43 314 24 432 32 727 46 790 69 341 Rapporto cash flow-investimenti 4 %90 54 86 102 109 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %66 55 66 70 72 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %42 25 40 51 52 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %23 14 19 25 34 Aziende con reddito insufficiente 8 %18 34 21 12 5 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %17 27 20 12 8 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA51 154 24 630 40 573 55 521 81 175 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 233 2 555 3 778 4 403 5 386 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%11.3 5.7 9.9 12.2 15.9 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.3 -8.3 -5.1 -1.4 3.7 Redditività del capitale proprio 11 %-5.8 -17.0 -10.7 -4.0 5.1
Tabella 23
Risultati d’esercizio per quartili: regione di pianura* – 2004/06
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
* Regione di pianura: zona campicola e zone intermedieFonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ALLEGATO A23
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero1 451 327 376 377 371 Aziende rappresentateNumero23 040 5 781 5 778 5 728 5 753 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha20.57 16.07 18.36 20.69 27.20 Superficie coltiva apertaha9.29 6.51 7.31 8.84 14.53 Manodopera aziendaleULA1.70 1.65 1.68 1.69 1.76 di cui: manodopera familiareULAF1.20 1.23 1.28 1.20 1.06 Totale vaccheNumero13.8 11.3 13.8 14.6 15.5 Totale animaliUBG24.0 19.7 22.3 25.6 28.3 Strutturadelcapitale Totale attivifr.880 703 862 813 808 613 859 825 991 567 di cui: attivo circolantefr.164 205 138 813 151 605 172 070 194 583 di cui: inventario vivofr.49 108 41 886 47 214 51 108 56 263 di cui: attivo immobilizzatofr.667 389 682 114 609 794 636 647 740 720 di cui: attivo aziendafr.828 489 814 017 767 366 793 677 938 739 Quota di capitale di terzi%44 45 42 42 46 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.11 266 10 946 10 705 11 090 12 321 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.278 013 216 214 242 828 282 601 370 864 di cui: pagamenti direttifr.43 099 33 989 38 292 43 161 57 015 Spese materialifr.175 829 161 401 158 484 172 641 210 905 Reddito aziendalefr.102 184 54 813 84 344 109 960 159 958 Costi del personalefr.19 214 16 864 14 281 18 766 26 987 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.8 304 8 618 7 364 7 455 9 777 Canoni d'affittofr.9 185 5 834 7 793 9 973 13 163 Costi di terzifr.212 532 192 718 187 921 208 835 260 833 Reddito agricolofr.65 481 23 496 54 906 73 766 110 031 Reddito extraagricolofr.21 467 30 570 19 012 19 265 16 983 Reddito totalefr.86 948 54 066 73 918 93 032 127 014 Consumo privatofr.74 239 65 190 69 466 75 278 87 087 Formazione di capitale propriofr.12 709 -11 124 4 452 17 754 39 927 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.53 876 50 132 44 786 47 327 73 286 Cash flow 3 fr.49 062 26 664 38 543 53 603 77 606 Rapporto cash flow-investimenti 4 %91 54 86 115 106 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %64 50 64 70 71 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %42 20 41 52 54 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %22 14 18 24 34 Aziende con reddito insufficiente 8 %18 33 23 11 6 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 32 18 13 7 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULAF60 253 33 152 50 082 65 088 91 113 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha4 972 3 416 4 592 5 346 5 885 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%12.3 6.8 11.0 13.9 17.1 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-1.0 -6.5 -3.4 -0.2 5.0 Redditività del capitale proprio 11 %-3.7 -13.7 -7.7 -2.0 7.3
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF4533210128343985224791841 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF43087 (Valore mediano)
Tabella 24
Risultati d’esercizio per quartili: regione collinare* – 2004/06
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF338776189254423946466498 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF32554 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione collinare: zona collinare e zona di montagna I
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
A24 ALLEGATO
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero901 186 222 244 250 Aziende rappresentateNumero13 787 3 454 3 459 3 441 3 433 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha18.77 14.92 16.47 19.52 24.23 Superficie coltiva apertaha2.93 2.06 2.49 3.03 4.17 Manodopera aziendaleULA1.54 1.49 1.55 1.53 1.59 di cui: manodopera familiareULAF1.23 1.18 1.32 1.28 1.13 Totale vaccheNumero15.4 11.5 14.6 17.0 18.5 Totale animaliUBG25.9 20.8 23.5 27.0 32.2 Strutturadelcapitale Totale attivifr.742 822 696 964 679 027 734 725 861 258 di cui: attivo circolantefr.115 848 100 152 110 075 116 037 137 239 di cui: inventario vivofr.55 313 46 027 50 212 57 753 67 366 di cui: attivo immobilizzatofr.571 661 550 784 518 740 560 934 656 653 di cui: attivo aziendafr.705 953 660 623 643 908 705 753 814 184 Quota di capitale di terzi%46 49 44 45 47 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.9 185 8 088 8 739 9 431 10 489 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.210 696 164 301 182 119 215 317 281 583 di cui: pagamenti direttifr.47 442 39 223 42 818 48 377 59 440 Spese materialifr.136 559 126 482 121 363 135 064 163 544 Reddito aziendalefr.74 137 37 819 60 757 80 253 118 039 Costi del personalefr.10 290 10 742 7 531 7 792 15 128 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.7 004 7 387 6 212 6 513 7 909 Canoni d'affittofr.6 014 4 267 4 613 6 160 9 041 Costi di terzifr.159 868 148 878 139 719 155 529 195 622 Reddito agricolofr.50 828 15 423 42 400 59 788 85 961 Reddito extraagricolofr.22 815 34 191 21 919 16 527 18 581 Reddito totalefr.73 642 49 613 64 320 76 316 104 542 Consumo privatofr.64 305 55 655 60 889 64 600 76 166 Formazione di capitale propriofr.9 337 -6 041 3 430 11 716 28 375 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.47 573 50 561 37 835 42 524 59 394 Cash flow 3 fr.41 161 25 504 33 376 43 147 62 755 Rapporto cash flow-investimenti 4 %87 51 91 102 107 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %67 54 68 68 76 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %40 24 38 47 51 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %25 14 19 29 37 Aziende con reddito insufficiente 8 %17 30 21 13 4 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %18 32 23 11 8 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA48 058 25 391 39 145 52 268 74 049 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha3 950 2 543 3 695 4 109 4 874 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%10.5 5.7 9.4 11.4 14.5 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-2.8 -7.9 -5.5 -2.0 2.7 Redditività del capitale proprio 11 %-7.2 -18.0 -11.7 -5.4 3.3
Tabella 25
Risultati d’esercizio per quartili: regione di montagna* – 2004/06
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF272412661194703218656514 (Valore medio)
Profittodellavorodellamanodoperafamiliare12fr./ULAF25571 (Valore mediano)
1Applicazione del tasso medio d'interesse delle obbligazioni della Confederazione (2004: 2.73%; 2005: 2.11%; 2006: 2.50%)
2Investimenti lordi (senza prestazioni proprie) dedotti contributi e disinvestimenti
3Formazione di capitale proprio (senza prestazioni proprie per investimenti) più gli ammortamenti più/meno le variazioni delle scorte e dell'inventario vivo
4Rapporto tra cash flow e investimenti totali
5Quota di aziende con cash flow > investimenti totali
6Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio positiva
7Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio positiva
8Quota di capitali di terzi <50% e formazione di capitale proprio negativa
9Quota di capitali di terzi >50% e formazione di capitale proprio negativa
10Rapporto tra interessi passivi più utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse del capitale proprio e attivo dell'azienda
11Rapporto tra utile calcolatorio/perdita calcolatoria più interesse capitale proprio e capitale proprio dell'azienda
12Rapporto tra reddito agricolo meno interesse del capitale proprio dell'azienda e unità di lavoro annuale della famiglia (ULAF)
*Regione di montagna: zone di montagna II a IV
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ALLEGATO A25
Inbasealredditodellavoro CaratteristicaUnitàMediaIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Aziende di riferimentoNumero809 170 205 218 216 Aziende rappresentateNumero13 836 3 468 3 460 3 459 3 450 Strutturaaziendale Superficie agricola utileha19.13 13.88 16.13 20.12 26.42 Superficie coltiva apertaha0.21 0.08 0.13 0.18 0.43 Manodopera aziendaleULA1.60 1.48 1.63 1.63 1.67 di cui: manodopera familiareULAF1.33 1.29 1.43 1.36 1.24 Totale vaccheNumero11.9 8.6 10.5 13.0 15.7 Totale animaliUBG19.9 15.5 17.0 21.2 25.9 Strutturadelcapitale Totale attivifr.656 332 561 834 576 093 671 364 816 746 di cui: attivo circolantefr.105 897 76 764 98 817 112 393 135 789 di cui: inventario vivofr.45 738 35 179 39 669 48 885 59 287 di cui: attivo immobilizzatofr.504 697 449 891 437 607 510 086 621 670 di cui: attivo aziendafr.619 194 534 666 545 653 625 481 771 641 Quota di capitale di terzi%42 43 40 41 43 Interesse del capitale proprio dell'azienda 1 fr.8 711 7 485 7 864 8 797 10 708 Contoperditeeprofitti Prestazione lordafr.164 225 113 913 138 873 174 785 229 638 di cui: pagamenti direttifr.59 478 45 803 53 771 62 920 75 502 Spese materialifr.103 298 90 206 90 167 105 767 127 155 Reddito aziendalefr.60 927 23 707 48 707 69 018 102 484 Costi del personalefr.7 247 5 152 5 666 7 653 10 529 Interessi passivi, altri costi/ricavi finanziarifr.5 152 5 344 4 311 5 030 5 926 Canoni d'affittofr.3 563 2 272 3 046 3 885 5 054 Costi di terzifr.119 260 102 975 103 190 122 336 148 663 Reddito agricolofr.44 965 10 939 35 683 52 449 80 975 Reddito extraagricolofr.22 892 36 869 21 092 18 770 14 777 Reddito totalefr.67 857 47 807 56 775 71 220 95 752 Consumo privatofr.58 753 52 818 52 470 59 274 70 500 Formazione di capitale propriofr.9 103 -5 010 4 305 11 945 25 252 Investimentiefinanziamento Totale investimenti 2 fr.39 995 35 455 31 482 39 763 53 340 Cash flow 3 fr.35 903 21 928 27 702 38 627 55 443 Rapporto cash flow-investimenti 4 %90 62 92 99 105 Aziende con eccedenza di finanziamenti 5 %68 59 70 71 73 Stabilitàfinanziaria Aziende con una situazione finanziaria buona 6 %44 26 43 55 52 Aziende con autonomia finanziaria limitata 7 %23 14 19 22 35 Aziende con reddito insufficiente 8 %20 41 22 11 5 Aziende con una situazione finanziaria preoccupante 9 %14 20 16 12 8 Rapportoredditoaziendale-impiegodifattori Reddito aziendale per unità di manodoperafr./ULA38 071 16 046 29 882 42 385 61 490 Reddito aziendale per ettaro di superficie agricola utilefr./ha3 188 1 710 3 024 3 439 3 879 Rapporto reddito aziendale-attivi azienda%9.8 4.4 8.9 11.0 13.3 Redditività Redditività del capitale totale 10 %-4.4 -11.0 -7.9 -3.4 1.9 Redditività del capitale proprio 11 %-9.1 -21.1 -14.7 -7.3 2.0
Tabella 26 Risultati d'esercizio per regione, tipo di azienda e quartile: 1990/92–2004/06
UnitàAziendecombinate:Aziendecombinate:Aziendecombinate:Aziendecombinate: lattecommerciale/vacchemadritrasformazionealtre campicoltura
A26 ALLEGATO
UnitàTutteleaziendeRegionedipianuraRegionecollinareRegionedimontagna Redditoperregione1990/922004/061990/922004/061990/922004/061990/922004/06 Superficie agricola utileha16.06 19.69 16.66 20.57 15.30 18.77 15.76 19.13 Manodopera familiareULAF1.39 1.24 1.36 1.20 1.40 1.23 1.42 1.33 Reddito agricolofr.62 822 55 887 73 794 65 481 59 838 50 828 45 541 44 965 Reddito extraagricolofr.16 264 22 223 16 429 21 467 14 544 22 815 17 853 22 892 Reddito totalefr.79 086 78 110 90 223 86 948 74 382 73 642 63 394 67 857 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF3102536952369244533230335338772120127241 UnitàCampicolturaColturespecialiLattecommercialeVacchemadri Redditopertipodiazienda1990/922004/061990/922004/061990/922004/061990/922004/06 Superficie agricola utileha21.23 23.00 8.92 12.95 15.30 19.79 15.32 19.41 Manodopera familiareULAF1.08 0.97 1.29 1.28 1.42 1.32 1.20 1.14 Reddito agricolofr.60 284 63 023 67 184 67 891 53 923 53 252 36 627 44 598 Reddito extraagricolofr.26 928 29 602 21 555 20 330 16 044 18 738 33 558 32 884 Reddito totalefr.87 212 92 625 88 739 88 221 69 967 71 990 70 185 77 482 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF3437554584303344423826471332891734831285 UnitàAltriboviniEquini/ovini/capriniTrasformazione Redditopertipodiazienda1990/922004/061990/922004/061990/922004/06 Superficie agricola utileha14.20 16.83 Solo sette13.19 9.34 11.64 Manodopera familiareULAF1.37 1.24 aziende1.17 1.35 1.21 Reddito agricolofr.38 407 37 351 disponibili26 725 86 288 54 395 Reddito extraagricolofr.20 570 27 015 39 063 14 614 27 980 Reddito totalefr.58 977 64 366 65 788 100 902 82 374 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF1679323683182864818236173
Redditopertipodiazienda1990/922004/061990/922004/061990/922004/061990/922004/06 Superficie agricola utileha20.37 26.50 17.93 23.00 15.59 19.85 17.24 21.93 Manodopera familiareULAF1.45 1.27 1.24 1.07 1.40 1.25 1.43 1.23 Reddito agricolofr.75 368 70 267 51 161 53 596 84 363 68 105 66 705 58 491 Reddito extraagricolofr.11 802 15 224 20 475 32 204 12 032 16 965 15 000 22 144 Reddito totalefr.87 170 85 490 71 636 85 800 96 395 85 070 81 705 80 636 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF3642046108274563959242927445833273238642 UnitàIquartileIIquartileIIIquartileIVquartile (0–25%)(25–50%)(50–75%)(75–100%) Redditoperquartile(profittodellavoro)1990/922004/061990/922004/061990/922004/061990/922004/06 Superficie agricola utileha14.68 14.90 15.30 17.44 15.78 20.82 18.47 25.61 Manodopera familiareULAF1.36 1.25 1.49 1.33 1.42 1.28 1.27 1.10 Reddito agricolofr.26 883 16 580 52 294 44 731 69 198 65 305 102 975 96 990 Reddito extraagricolofr.27 789 33 663 14 629 20 273 12 064 17 366 10 557 17 577 Reddito totalefr.54 672 50 243 66 923 65 004 81 262 82 671 113 532 114 566 Profittodellavorodella manodoperafamigliarefr./ULAF43676138235922672236016427596266577504 Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
■■■■■■■■■■■■■■■■■ Tabelle Uscite della Confederazione
Uscite per produzione e smercio
ALLEGATO A27
Tabella 27 Promozione dello smercio Settori/SettoridiprodottidimercatoConsuntivo2005Consuntivo20061Preventivo2007 fr.fr.fr. Produzionelattiera269189502945019629628840 Formaggio, estero 2 20 572 00020 350 54722 528 040 Formaggio, Svizzera Latte e burro 3 6 346 9509 099 6497 100 800 Produzioneanimale526225048489865037437 Carne3 915 0003 814 7623 850 000 Uova703 000593 407629 289 Pesce12 50000 Animali vivi631 750440 817460 750 Miele 0097 398 Produzionevegetale1084592897486817869796 Verdura e funghi1 512 9051 811 5571 995 800 Frutta2 425 1492 119 3122 225 000 Cereali438 270423 862452 000 Patate700 625593 407630 000 Semi oleosi362 500362 500330 578 Piante ornamentali665 000423 862425 000 Vino4 555 2363 772 6811 621 418 Sementi186 243241 500190 000 Provvedimenticollettivi296817931133833286558 Provvedimentisovrasettoriali(Bio,PI)301216429519212953200 Pubblicherelazioni283425027342502701141 Conteggi finali ed impegni a lungo termine, piccoli progetti e sponsorizzazione61 000500 000922 424 Nazionale519027215334741752399396 Regionale129653323000002283705 Totale531992545564741754683101 1Chiusura dei conti definitiva ancora pendente in alcuni casi 2Dal 2005: formaggio, Svizzera ed estero 32004/05 Quote del consuntivo su più periodi Fonte: UFAG
Tabella 28
Uscite nel settore dell’economia lattiera
Tabella 29
Uscite nel settore della produzione animale
DenominazioneConsuntivo2005Consuntivo2006Preventivo2007 fr.fr.fr.
Indennitàaorganizzazioniprivateperilbestiamedamacelloelacarne714472667014716631020
Sostegnodelmercatodellacarne
Contributi alle azioni d'immagazzinamento di carne di vitelllo2
Contributi alle azioni di vendita a prezzo ridotto di muscoli di manzo241
Contributi alle azioni di vendita a prezzo ridotto di carne da banco per la trasformazione975
Sostegnodelmercatodelleuova
Azioni di spezzatura1
sul pollame conformi alla pratica582
Contributi d'investimento per la costruzione di pollai444
Aiutiperl'esportazionedibestiamedaallevamentoedareddito565820051386005940000
Contributiperlavalorizzazionedellalanadipecora800061803088792000
Conto
Stato, UFAG
A28 ALLEGATO
737 9442 373 840
23462 127
395486730232885940000
690587 321
822 9601 713
767660
Esperimenti
61654 704
263 Azioni di vendita a prezzo ridotto693
225
606750 858 301603731243463465000
Contributiperapparecchie/oattrezzaturedi mercatipubblicinellaregionedimontagna495000 Totale205738911879079323263020
Entratedeltrafficodianimali-2037745-2003702-9000000 AccordodiprestazioneIdentitasSA892570688822108910000
Provvedimenticontrol'ESB:eliminazionedegliscartidicarne365019393866491046530000
Fonti:
dello
DenominazioneConsuntivo2005Consuntivo2006Preventivo20071 fr.fr.fr. Sostegnodelmercato(supplementieaiuti) Supplemento per il latte trasformato in formaggio287 330 430296 979 460243 650 000 Supplemento per il foraggiamento senza insilati43 058 40844 591 50536 500 000 Aiuti all'interno del Paese a favore del burro61 560 30724 861 80925 800 000 Aiuti all'interno del Paese per latte scremato e latte in polvere40 104 85339 034 61333 300 000 Aiuti all'interno del Paese a favore del formaggio000 Aiuti all'esportazione a favore del formaggio10 706 02510 731 7007 200 000 Aiuti all'esportazione a favore di altri latticini25 571 47720 935 11314 900 000 468331500437134200361350000 Sostegnodelmercato(amministrazione) Commissioni di ricorso in materia di contingentamento lattiero59 49667 2420 Amministrazione contingent. lattiero e valorizzazione latte5 841 3335 540 1745 000 000 590082956074165000000 Totale474232329442741616366350000
Considerato il blocco dei crediti
Conto dello Stato, UFAG
1
Fonti:
Tabella 30
Uscite nel settore della produzione vegetale
1 Nel preventivo 2004 nella rubrica «Altre spese per beni e servizi» (3190.000)
2 Ex promozione della viticoltura
3 Promozione dello smercio di vino all'estero / Nel consuntivo 2003 sono contenuti i contributi di riconversione per il vino / Dal 2004 la promozione dello smercio è contenuta nella rubrica 3601.200
4 Esclusi i semi oleosi
5 Nel consuntivo 2005 sono stati versati 28,5 mio. fr. per il raccolto 2004 e 17,5 mio. fr. per il raccolto 2005, nel consuntivo 2006 sono stati versati 11,3 mio. fr. per il raccolto 2005 e 18,3 mio. fr. per il raccolto 2006
ALLEGATO A29
DenominazioneConsuntivo2004Consuntivo2005Consuntivo2006Preventivo2007 fr.fr.fr.fr. Contributinellacampicoltura43503727444131594629744144776611 Contributi di superficie per semi oleosi35 857 27936 245 11737 435 27336 916 011 Contributi di superficie per leguminose a granelli7 190 0817 704 3928 393 9547 425 000 Contributi di superficie per piante da fibra456 367463 650468 214435 600 Contributiditrasformazioneedivalorizzazione94298154779587306274818966568780 Trasformazione di barbabietole da zucchero 5 45 338 10745 982 00029 641 00026 037 000 Trasformazione di semi oleosi8 436 2502 577 5004 054 2004 158 000 Trasformazione di patate18 329 41716 260 74615 558 50015 642 000 Produzione di sementi3 730 7423 421 7203 126 1043 384 800 Valorizzazione di frutta18 463 6379 716 76310 368 38517 326 980 Trasformazione di MPR 4 00020 000 Promozionedellavitivinicoltura3931769312080028713903548160 Spese per beni e servizi 1 Controllo della vendemmia 2 935 7241 086 010882 4781 073 160 Misure di valorizzazione 3 Trasformazione dell'uva in prodotti analcolici Contributi di riconversione in vitivinicoltura2 996 0452 034 7901 988 9122 475 000 Totale141733649125492688111917020114893551
Fonti: Conto dello Stato, UFAG
Uscite nel settore dei pagamenti diretti
Tabella 31
Evoluzione dei pagamenti diretti
non è possibile fare un paragone diretti con i dati del Conto dello Stato. I valori relativi ai pagamenti diretti si riferiscono all'intero anno di contribuzione, mentre il conto dello Stato riporta le spese sostenute durante un anno civile. Le riduzioni indicano le deduzioni in ragione delle limitazioni e delle sanzioni giuridiche e amministrative. Fonte: UFAG
A30 ALLEGATO
2000200120022003200420052006 Tipodicontributo 1000fr.1000fr.1000fr.1000fr.1000fr.1000fr.1000fr. Pagamentidirettigenerali1803658192909419948381999091199391519996062007181 Contributi di superficie1 186 7701 303 8811 316 1831 317 9561 317 7731 319 5951 319 103 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo258 505268 272283 221287 692286 120291 967301 213 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione251 593250 255289 572287 289284 023282 220281 258 Contributi di declività generali96 71496 64395 81195 63095 30894 76894 227 Contributi di declività per vigneti in zone in forte pendenza e terrazzate10 07610 04310 05110 52410 69111 05611 380 Pagamentidirettiecologici361309412664452448476724494695506895518211 Contributiecologici278981329886359387381319398109409348420245 Contributi per la compensazione ecologica108 130118 417122 347124 927125 665126 023126 976 Contributi giusta l'ordinanza sulla qualità ecologica (OQE)--8 93414 63823 00727 44230 256 Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza33 39832 52631 93831 25530 82431 51631 094 Contributi per prati sfruttati in modo estensivo su superfici coltive di cui è cessata la gestione (disposizione transitoria fino a fine 2000)17 150 Contributi per l'agricoltura biologica12 18523 48825 48427 13527 96228 60128 672 Contributi per la detenzione di animali da reddito particolarmente rispettosa delle loro esigenze108 118155 455170 684183 363190 651195 767203 247 Contributid'estivazione81238805248956191381910669161091696 Contributiperlaprotezionedelleacque1090225435004024552159366270 Riduzioni22542167632114317138181202037825820 Totalepagamentidiretti2142425232499524261432458677247049024857582499572 Avvertenza:
Tabella 32a
Pagamenti diretti generali – 2006
ContributidisuperficieContributiperanimalidaredditocheconsumanoforaggiogrezzo
ALLEGATO A31
AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeUBGFGTotalecontributi Numerohafr.NumeroNumerofr. Cantone ZH3 53770 67594 767 1421 81317 75715 158 269 BE12 245188 168243 653 4718 16265 77057 337 352 LU4 95177 15097 325 7982 93326 78423 491 405 UR6386 6898 029 6485885 3784 501 473 SZ1 63124 03028 787 5381 42214 54812 250 748 OW6847 8299 402 5175803 7403 251 067 NW4876 0897 298 7103762 6522 241 325 GL4047 1898 613 8613863 8003 270 081 ZG55210 54913 005 5263723 3552 859 537 FR3 10474 96197 306 2561 83918 25515 981 952 SO1 38531 56441 093 4428619 0537 769 854 BL92821 28527 037 5276056 3195 429 267 SH56414 24019 634 8982322 7722 400 862 AR73711 95214 262 7845885 0064 225 906 AI5367 2458 674 6493602 5252 180 846 SG4 22271 59987 050 1383 10730 30025 694 042 GR2 60752 95062 905 0532 47735 67929 302 005 AG3 02658 47579 771 2641 50015 97113 608 680 TG2 59349 10765 461 7699028 2006 760 457 TI88413 07015 824 0746777 1385 413 998 VD3 894106 639144 145 4201 88923 80120 637 630 VS3 62236 20145 493 4672 18519 84914 441 950 NE90432 98438 310 4406418 3077 300 847 GE30410 50114 098 624991 4371 202 632 JU1 06339 18047 148 95888216 56014 500 578 Svizzera555021030322131910297435476354958301212763 Zona1 Pianura23 524479 979653 274 74210 224104 49789 519 822 Collina7 892142 576181 331 9464 88845 35738 649 091 ZM I7 192118 854144 139 0575 36945 89939 256 079 ZM II8 827156 395183 544 6057 14771 52061 714 827 ZM III5 31385 182101 039 8645 15557 66047 867 538 ZM IV2 75447 33655 772 7602 69330 02324 205 406 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Pagamenti diretti generali – 2006
DetenzionedianimaliinContributidideclivitàgeneraliContributidideclivitàpervigneti condizionidifficilidiproduzioneinzoneinfortependenzaeterrazzate
A32 ALLEGATO
Tabella 32b
TotaleTotaleTotale AziendeUBGFGcontributiAziendeSuperficiecontributiAziendeSuperficiecontributi NumeroNumerofr.Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH78212 9123 919 5057535 0242 067 647189184343 590 BE8 678128 76671 153 8578 06946 99719 705 70175101349 061 LU3 25151 06420 897 8093 20321 9959 187 438151830 750 UR6317 9106 857 0735894 7502 254 655323 060 SZ1 46722 34412 841 4551 42910 0954 311 993141326 055 OW65810 1515 815 0076294 6222 124 560112 500 NW4597 0793 716 0044413 8551 722 782000 GL3635 7434 241 2423603 3471 512 695127 650 ZG3636 1272 839 6873592 8321 186 18221915 FR1 76133 63012 349 4091 4627 1142 807 884181522 651 SO6039 9563 729 2215714 8211 846 040000 BL68510 8213 013 7266725 3902 103 217413764 670 SH1211 866307 390150959360 14512498163 240 AR73212 0436 964 0287325 9692 376 13551029 895 AI5288 3995 584 9405143 3871 411 271000 SG2 92948 55621 985 7902 85525 12610 464 43270100307 425 GR2 50838 92537 542 9632 45331 20213 649 171251840 830 AG1 08917 0073 404 9401 1397 4232 855 280144175299 880 TG1733 047944 1481501 166510 83181102155 355 TI6487 8566 389 6085463 1551 390 869179172355 275 VD1 26021 7609 278 9879625 6402 237 3864677502 596 415 VS2 18823 26720 998 7982 07012 1375 440 7211 3591 7866 322 271 NE75414 7048 806 0905843 5031 315 1605591173 480 GE153 167121 265395382 455 JU75914 6937 673 4415753 5941 383 884212 400 Svizzera3339151862928125828531268224107942273442909372711379823 Zona1 Pianura2 91052 1684 638 7472 0855 9352 389 1501 7862 4507 412 246 Collina7 309117 26230 086 9736 89236 91914 463 410219284712 144 ZM I6 934109 61948 560 5796 59446 14418 806 872195228666 039 ZM II8 251129 68688 430 6967 78960 83925 607 4355627082 391 570 ZM III5 25273 03267 530 7495 18546 78920 589 68310546160 185 ZM IV2 73536 86342 010 5412 72327 48212 370 794421137 639 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
ALLEGATO A33
Tabella 33a
Compensazioneecologica1Agricolturabiologica AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH3 5219 21013 058 4573506 9822 215 094 BE11 96018 71418 524 1851 36520 3574 946 487 LU4 9398 6509 780 7823094 9691 281 006 UR6351 220632 71164922184 990 SZ1 6063 3482 972 5051602 592521 730 OW6821 068888 0171942 427486 442 NW485940739 93072986199 968 GL3971 018628 997901 692336 094 ZG5531 6391 781 700831 470326 760 FR3 0186 5707 454 6111142 329812 629 SO1 3854 2255 299 6741153 117792 530 BL9283 4584 575 1301282 833767 267 SH5511 7412 662 57518487210 732 AR690862707 8751302 364471 269 AI468558401 7183147394 137 SG4 1868 2048 880 8534958 6951 890 031 GR2 58415 1066 314 4191 43831 1696 337 607 AG3 0127 68610 578 4142114 0401 467 962 TG2 5675 2517 512 0242284 1331 527 722 TI8221 6391 242 4611111 757422 671 VD3 6719 63912 519 0461342 9721 044 437 VS2 0644 8222 808 8282854 6861 263 718 NE6831 8291 649 654431 231302 415 GE2991 1421 929 76189775 268 JU1 0223 1593 431 314842 923693 375 Svizzera52728121699126975638626011570328672341 Zona2 Pianura22 58550 74173 402 8521 19121 9358 879 946 Collina7 80017 82821 614 51262210 9862 992 030 ZM I6 90311 55710 363 48280212 7652 807 065 ZM II7 85614 99710 667 5331 29523 1114 653 288 ZM III4 94713 6206 045 4931 39626 5505 335 413 ZM IV2 63712 9564 881 76795420 3554 004 599 1 Alberi da frutto ad alto fusto convertiti in are 2 Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Contributi ecologici – 2006
Contributi ecologici – 2006
A34 ALLEGATO
Tabella 33b
ProduzioneestensivaDetenzionedianimalidaredditoparticolarmente dicerealiecolzarispettosadelleloroesigenze AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeUBGTotalecontributi Numerohafr.NumeroNumerofr. Cantone ZH1 5236 4822 584 5872 13075 19511 303 838 BE4 76314 9645 985 1179 436248 08339 706 630 LU1 1703 4161 366 2883 944175 45326 110 149 UR0004376 9111 131 971 SZ15197 6961 11427 3384 402 893 OW1140048312 5931 977 607 NW0002787 9401 239 309 GL352 1083097 8851 303 308 ZG6615562 18840516 2702 407 454 FR1 2176 0832 431 6662 525113 62517 612 464 SO7333 7741 502 6911 07836 4625 540 236 BL6263 2131 262 04260023 5143 542 517 SH3222 457966 36226912 6221 793 272 AR00062617 0392 844 274 AI00044113 0052 247 598 SG282689270 4683 032109 91217 392 297 GR160513205 3602 32960 6459 467 496 AG1 5807 1022 838 0251 83771 24310 715 798 TG7933 0111 202 3201 77177 40711 501 117 TI66306122 30465313 4592 104 111 VD1 91316 3346 520 2552 17588 02013 172 545 VS100261102 8691 31619 8183 273 274 NE3502 6821 071 13269430 6404 662 792 GE2243 2541 255 157802 695394 118 JU5073 3531 335 33892751 4937 399 616 Svizzera164147807431094373388891319268203246684 Zona1 Pianura9 95354 81421 805 62814 670626 46193 461 723 Collina3 88515 0776 016 3735 929221 05033 944 180 ZM I1 9136 4572 582 4065 490171 62127 106 962 ZM II5761 617646 5906 536178 23428 762 095 ZM III709236 9924 11082 10613 441 894 ZM IV17166 3842 15439 7956 529 830 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Tabella 34a
Contributi per la compensazione ecologica – 2006
ALLEGATO A35
PratisfruttatiinmodoestensivoPratisfruttatiinmodopocointensivo AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH3 1334 9777 055 717852742470 937 BE7 9577 8127 918 9916 3765 3802 554 073 LU4 1764 0824 437 9961 6761 274634 858 UR402529255 055438523165 085 SZ1 1151 080785 409452327140 529 OW596646406 2291819541 126 NW390522330 12617913959 539 GL358735434 15215416863 723 ZG366383453 91522115984 949 FR1 9282 7133 556 6631 7912 4641 446 387 SO1 1952 3392 962 055498661375 038 BL7731 3611 628 416406495302 881 SH5191 1181 566 39311712682 181 AR387223161 177375234106 405 AI300221154 4131419241 545 SG2 9932 7863 043 5941 7021 170626 294 GR2 0906 7073 272 4422 2267 9852 448 758 AG2 5824 2475 763 609974806518 631 TG1 9862 0272 979 556847573369 996 TI535738613 599384634222 026 VD3 0745 3857 294 2081 1632 0201 050 718 VS8911 279848 3711 4882 871957 706 NE487898969 021344741345 370 GE2908541 280 7239117 178 JU7181 3471 625 2935641 003524 881 Svizzera392415500759797120235583069313640813 Zona1 Pianura19 09627 04839 595 4136 8986 1033 911 404 Collina5 6767 1688 427 2083 7093 5172 207 985 ZM I4 2643 9632 921 5253 5283 0221 401 529 ZM II4 9215 3273 598 1974 0494 8422 121 319 ZM III3 3246 1992 859 7063 1935 9641 819 543 ZM IV1 9605 3032 395 0712 1817 2442 179 033 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Contributi per la compensazione ecologica – 2006
A36 ALLEGATO
Tabella 34b
TerrenidastrameSiepi,boschetticampestrierivieraschi AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH1 1641 3641 859 551975190274 417 BE758569361 2352 127451485 936 LU538383335 446705137178 902 UR625948 21521421 SZ8731 225974 3125544 360 OW1548984 5163021 937 NW1199879 2972021 598 GL575238 0841321 164 ZG302537421 0742826664 380 FR925049 522791239319 610 SO422 17132393115 163 BL00027390108 636 SH1069 3452526893 831 AR269200141 82771107 106 AI221191133 74965128 561 SG1 7651 8131 546 9035317484 235 GR723114 9851913830 754 AG11488130 4891 156324423 145 TG17698140 417473100149 236 TI425051 8562978 586 VD13511889 3021 021360488 009 VS3475 8091723527 388 NE432 2821043735 976 GE446 1501153653 715 JU352321 672340130138 445 Svizzera7004706265482061011625083105510 Zona1 Pianura1 8911 8832 759 7025 7721 4072 080 378 Collina856689827 0791 962517621 725 ZM I1 094851665 1831 092275198 823 ZM II2 0942 6081 809 358944246173 854 ZM III802751359 5812775225 558 ZM IV267280127 30569115 173 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Tabella 34c
Contributi per la compensazione ecologica – 2006
ALLEGATO A37
MaggesifioritiMaggesidarotazione AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeSuperficieTotalecontributi Numerohafr.Numerohafr. Cantone ZH346256766 62492110275 925 BE295260781 3285762154 031 LU291441 910101230 450 UR000000 SZ000000 OW000000 NW000000 GL000000 ZG5925 650125 500 FR239244732 6374158145 697 SO6191272 856151333 275 BL147136407 6404964160 516 SH180164492 390223076 225 AR000000 AI000000 SG312573 183324 375 GR151442 2404923 050 AG399182546 870125138344 575 TG115108323 340263381 325 TI7926 46041946 575 VD3715611 684 08091121301 625 VS211443 200425 925 NE2837111 510131743 025 GE6595284 6404685211 450 JU7579234 920152254 725 Svizzera2429229868914786187991998269 Zona1 Pianura2 0341 9605 877 2625166701 675 452 Collina383333997 92698126315 519 ZM I9410 860324 798 ZM II325 430112 500 ZM III000000 ZM IV000000 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Contributi per la compensazione ecologica – 2006
A38 ALLEGATO
Tabella 34d
FascedicoltureestensiveincampicolturaAlberidafruttoadaltofustoneicampi AziendeSuperficieTotalecontributiAziendeAlberiTotalecontributi Numerohafr.NumeroNumerofr. Cantone ZH822 6252 461156 8932 352 660 BE24913 4918 187417 1196 255 100 LU211 6654 153274 6374 119 555 UR00023210 929163 935 SZ0001 00671 1931 067 895 OW00044823 614354 210 NW00033917 958269 370 GL0001386 12591 875 ZG00049048 425726 233 FR657 1101 83879 7991 196 985 SO522 7221 136102 4311 536 394 BL000878131 1381 967 041 SH311 20037922 734341 010 AR00033819 424291 360 AI000754 23063 450 SG323 2102 978233 2773 499 059 GR2040556332 119481 785 AG1433 8402 511189 8172 847 255 TG211 2302 113231 1753 466 924 TI00023818 222273 360 VD141421 3151 972105 9861 589 790 VS00082261 362920 430 NE0001769 498142 470 GE10751125 72285 830 JU00065655 433831 378 Svizzera84395888834239232926034935354 Zona1 Pianura603247 93216 4501 163 91917 455 309 Collina2168 6916 791547 2328 208 380 ZM I322 2655 575343 9005 158 500 ZM II0003 925197 1252 956 875 ZM III0001 24865 407981 105 ZM IV00025011 677175 185 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Tabella 35
Contributi per la qualità biologica e l'interconnessione – 2006
Soltantoqualitàbiologica1Soltantointerconnessione1QualitàbiologicaeContributifederali interconnessione1
ALLEGATO A39
AziendeSuperficieAziendeSuperficieAziendeSuperficieAziendeTotalecontributi NumerohaNumerohaNumerohaNumerofr. Cantone ZH6977271 5282 3127171 1222 0502 441 914 BE1 2777027 0718 2083 4703 1537 8327 157 975 LU1 7821 5257831 1955647622 5202 856 636 UR188249152253121245346447 115 SZ6515815497257301 4821 2741 965 037 OW2863575849112127370301 582 NW20720110583180364345363 353 GL18938739722538231215 440 ZG38473930382337405467 471 FR244257485963123133728714 859 SO329631464400371363 796 BL78852465945411 0126381 295 936 SH131102949883177203239 572 AR1951046849130152280204 876 AI8540203127194210328240 908 SG1 5862 0061 0131 3786957382 4892 423 164 GR 1 2782 3285751 0995711 3251 4552 648 663 AG2612465067065291 8277912 127 768 TG5043251 6851 5944473601 9011 626 696 TI1973164111527126231273 164 VD1 0421 36487254001 083718 230 VS41873410959000480598 545 NE2563168721300304203 745 GE242800002410 192 JU2534715620100281349 565 Svizzera125421482115616209609282133912696030256201 Zona Pianura4 0803 7546 2527 7342 5033 0419 6929 641 871 Collina1 7341 6232 2792 7901 6022 5334 0735 160 647 ZM I1 6371 7012 2032 3301 2311 2663 7833 368 068 ZM II2 2622 9662 3913 1211 8532 4744 6174 735 675 ZM III1 6162 5341 6802 9181 4082 4033 0664 204 026 ZM IV1 2132 2428112 0676851 6751 7293 145 915 1Alberi ad alto fusto convertiti in are Fonte: UFAG
Tabella 36
Contributi per la produzione estensiva di cereali e colza – 2006
A40 ALLEGATO
CerealipanificabiliCerealidaforaggioColzaTotale AziendeSuperficieAziendeSuperficieAziendeSuperficieTotalecontributi NumerohaNumerohaNumerohafr. Cantone ZH1 1864 3379381 8491432962 584 587 BE2 7107 1323 8147 4801833515 985 117 LU6511 3598781 7801402771 366 288 UR0000000 SZ111418007 696 OW001100400 NW0000000 GL0035002 108 ZG2354488451862 188 FR7673 2159382 586852822 431 666 SO5101 9565901 692631251 502 691 BL4171 5135231 585361141 262 042 SH3101 97313837448110966 362 AR0000000 AI0000000 SG892132244371940270 468 GR9226712824126205 360 AG1 3014 1681 1532 6471482862 838 025 TG6462 069460816731271 202 320 TI462182873315122 304 VD1 2588 5071 4385 5096892 3176 520 255 VS63186536816102 869 NE1547223311 743612171 071 132 GE1962 2082011 00410421 255 157 JU2811 4624291 790291011 335 338 Svizzera107014156012330317831738473031094373 Zona1 Pianura7 60633 4726 61717 5201 3723 82221 805 628 Collina2 3266 4223 2977 9622906936 016 373 ZM I6571 4741 7934 782702022 582 406 ZM II881685451 436613646 590 ZM III181962730036 992 ZM IV651611006 384 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Tabella 37
Contributi per la detenzione di animali particolarmente rispettosa delle loro esigenze – 2006
ALLEGATO A41
SistemidistabulazioneparticolarmenteUscitaregolareall'aperto rispettosideglianimali AziendeUBGTotalecontributiAziendeUBGTotalecontributi NumeroNumerofr.NumeroNumerofr. Cantone ZH1 18928 4603 002 1502 04846 7358 301 688 BE3 65469 0338 177 8479 282179 05031 528 783 LU2 63571 3468 578 7913 860104 10817 531 358 UR1111 292123 2534375 6191 008 718 SZ3796 776735 0501 10420 5623 667 843 OW2353 985435 6774738 6081 541 930 NW1472 851343 7732725 089895 536 GL871 501155 8703096 3851 147 438 ZG2206 248648 18939710 0231 759 265 FR1 37938 3984 328 2012 45175 22613 284 263 SO55412 4061 326 5221 04624 0564 213 714 BL3699 128978 32958514 3862 564 188 SH1976 587766 0732236 0341 027 199 AR1733 238383 25062613 8012 461 024 AI1563 391530 4834359 6141 717 115 SG1 32333 6213 902 7862 97776 29213 489 511 GR87716 6391 573 7152 32644 0067 893 781 AG1 15329 8643 427 9351 72441 3797 287 863 TG1 03431 6693 538 8991 68345 7387 962 218 TI1853 361304 92165010 0981 799 190 VD1 12631 9103 249 6622 10456 1109 922 883 VS2183 369345 2411 31116 4492 928 033 NE3169 356918 06568921 2843 744 727 GE33983100 894801 711293 224 JU59019 6181 873 25690831 8745 526 360 Svizzera183404450284974883238000874239153497852 Zona1 Pianura8 775250 77928 349 72513 998375 68265 111 998 Collina3 30879 5179 183 6025 791141 53424 760 578 ZM I2 41449 8025 534 6145 440121 81921 572 348 ZM II2 28941 9794 505 0616 509136 25524 257 034 ZM III1 03615 7331 508 6124 10866 37211 933 282 ZM IV5187 218667 2182 15432 5775 862 612 1Classificazione della superficie in base alla quota di SAU gestita dall'azienda in una zona Fonte: UFAG
Tabella 38
Partecipazione al programma SSRA – 2006
A42 ALLEGATO
Base1PartecipazioneSSRA CategoriedianimaliUBGAziendeUBGAziendeUBGAziende NumeroNumeroNumeroNumero%% Allevamento e reddito: Vacche lattifere603 39034 678164 9876 15427.317.7 Manze di oltre 1 anno136 55333 97044 3538 77432.525.8 Tori di oltre 1 anno5 6078 4992 0132 70435.931.8 Bestiame giovane, da 4 a 12 mesi, femmine32 43727 20110 3846 68032.024.6 Bestiame giovane, da 4 a 12 mesi, maschi1 9863 96626644913.411.3 Vacche madri e nutrici: Vacche madri e nutrici senza vitelli:79 0376 81266 0504 58483.667.3 Ingrasso: Manze, tori, buoi di oltre 4 mesi39 7077 17423 6682 87259.640.0 Totalebestiamebovino898716433003117201475634.734.1 Caprini9 3566 0902 82377030.212.6 Conigli6183 31727815645.04.7 Totalealtrianimalicheconsumanoforaggiogrezzo99738661310188631.110.2 Suini da allevamento di oltre 6 mesi e suinetti62 6204 57536 3631 82758.139.9 Rimonte fino a 6 mesi e suini da ingrasso101 5758 89165 3693 68564.441.4 Totalesuini16419510680101732451162.042.2 Galline e galli da allevamento8831 9543048134.44.1 Galline ovaiole18 41512 89614 8301 67780.513.0 Pulcini, galletti e pollastrelle2 7204742 03412774.826.8 Polli da ingrasso20 6421 01318 16878788.077.7 Tacchini2 2832402 20210196.442.1 Totalepollame449431453737537260283.517.9 Totaledituttelecategoriedianimali1117828467564540901832040.639.2 1 Aziende aventi diritto ai contributi (aziende che hanno ottenuto pagamenti diretti) Fonte: UFAG
Tabella 39
Partecipazione al programma URA – 2006
ai contributi (aziende che hanno ottenuto pagamenti diretti)
ALLEGATO A43
CategoriedianimaliUBGAziendeUBGAziendeUBGAziende NumeroNumeroNumeroNumero%% Allevamento e reddito: Vacche lattifere603 39034 678463 42024 38276.870.3 Manze di oltre 1 anno136 55333 97099 02922 71772.566.9 Tori di oltre 1 anno5 6078 4993 1154 73355.655.7 Bestiame giovane, da 4 a 12 mesi, femmine32 43727 20120 57416 86863.462.0 Bestiame giovane, da 4 a 12 mesi, maschi1 9863 9666301 27531.732.1 Vitelli da allevamento fino a 4 mesi25 54924 8406 9376 48527.226.1 Vacche madri e nutrici: Vacche madri e nutrici con vitelli:79 0376 81274 1345 80893.885.3 Ingrasso: Manze, tori, buoi di oltre 4 mesi39 7077 17418 9503 39747.747.4 Vitelli fino a 4 mesi3 9376 1278671 19822.019.6 Vitelli da ingrasso9 95115 7681 1871 62911.910.3 Totalebestiamebovino938152433006888423214573.474.2 Animali della specie equina34 95211 22829 3488 35684.074.4 Ovini39 7579 52332 6036 74882.070.9 Caprini9 3566 0906 6903 06771.550.4 Daini e cervi78621570617789.882.3 Bisonti177121721097.383.3 Conigli6183 317161742.65.2 Totalealtrianimalicheconsumanoforaggiogrezzo8564522694695341494581.265.9 Suini da allevamento di oltre 6 mesi e suinetti62 6204 57536 2031 90857.841.7 Rimonte fino a 6 mesi e suini da ingrasso101 5758 89161 8153 66360.941.2 Totalesuini1641951068098018458459.742.9 Galline e galli da allevamento8831 95411317312.88.9 Galline ovaiole18 41512 89612 0152 97565.223.1 Pulcini, galletti e pollastrelle2 7204745078918.618.8 Polli da ingrasso20 6421 0131 7671618.615.9 Tacchini2 2832402 19111996.049.6 Totalepollame449431453716593326636.922.5 Totaledituttelecategoriedianimali1232935500568729873797870.875.9 1 Aziende aventi
UFAG
Base1PartecipazioneURA
diritto
Fonte:
Contributi d'estivazione – 2006
CantonePecoreVacchemunte,pecoreAltrianimalicheconsumanoAziendeecontributi (escl.pecorelattifere)lattifereecaprelattifere1foraggiogrezzoTotale AziendeCaricoaventeAziendeUBGaventiAziendeCaricoaventeAziendeContributi dirittoaidirittoaidirittoai contributicontributicontributi
A44 ALLEGATO
Tabella 40a
NumeroCariconormaleNumeroUBGNumeroCariconormaleNumerofr. ZH000094719 141 183 BE1812 27350513 0991 57848 3501 68018 829 780 LU43317613382446 0002481 948 659 UR651 5052183 9322393 1353312 426 756 SZ486542712 7314249 7034533 877 362 OW21193557562428 2322582 730 691 NW19183131271274 1861331 327 372 GL1344351301126 6211202 117 190 ZG00138201861 164 FR47630481 05859422 5786247 200 187 SO1317592 46959 743 066 BL00001041510 124 629 SH00001100129 889 AR15283061122 378113806 620 AI8901041 4641391 8701451 004 995 SG401 1421334 35643216 6534446 535 797 GR1828 10638714 11187133 4441 00816 118 996 AG2140073789 114 891 TG0000276222 893 TI922 162824 1042084 6602653 025 139 VD266541732964832 76366110 077 611 VS1625 8291406 08642415 6125157 491 508 NE11174971504 3951551 382 089 GE11100016234 719 JU2103118311 605833 508 173 Totale955245352074530366724236300733691681359 1 Animali munti con una durata d'estivazione di 56–100 giorni Fonte: UFAG
Tabella 40b
Statistica sull'estivazione – 2006: aziende e carichi normali per Cantone
lattifereenutricibovini
ALLEGATO A45
CantoneVaccheVacchemadriAltriEquiniOviniCapriniAltri
AziendeDensitàAziendeDensitàAziendeDensitàAziendeDensitàAziendeDensitàAziendeDensitàAziendeDensità NumeroCNNumeroCNNumeroCNNumeroCNNumeroCNNumeroCNNumeroCN ZH001678336111001300 BE1 12526 0822562 3391 54225 1532429232022 821507812949 LU981 186626212433 762234751345415139 UR2203 735343391802 114129681 5846625700 SZ2743 092766754186 359451355466211026700 OW1974 384182522383 14122302523142492889 NW841 674192171221 88714131825323612074 GL1003 697242731112 274232815438415751147 ZG23400815510000000 FR3067 0158388958213 3828123955871126214316 SO912626447591 59513782122100 BL1346810260133001200 SH000019700000000 AR811 3293301101 0688131540461341 AI1161 544001371 30191410914397816 SG2747 063941 3014189 2064369432 12315723900 GR44513 5054708 23878217 2002377361997 6771521 17063 AG003557299002140000 TG000026200000000 TI1103 841515241361 05363226932 0741191 8518351 VD38813 4942103 57464314 274111273317696313400 VS33813 437861 2033495 575521291765 8197553700 NE54934383861452 7582312031113112 GE000000151840000 JU373 892341 163814 751311 42741013800 Totale425911007015922266263321180601056455810532608616155857225497 Un carico normale (CN) = 1 UBG * durata dell'estivazione / 100 Fonte: UFAG
Pagamenti diretti a livello aziendale1: per zone e classi di dimensione – 2006
diretti in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
1 I risultati si basano sui dati dell’analisi centralizzata di ART
2 Contributi d'estivazione, contributi di coltivazione, altri contributi
A46 ALLEGATO
Tabella 41a
ZonadipianuraZC CaratteristicaUnità10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Aziende di riferimentoNumero58050520822314248 Aziende rappresentateNumero8 3515 3633 1462 9571 487678 Superficie agricola utileha 15.3424.3436.6214.6524.2535.78 Pagamenti
Pagamentidirettigenerali,totalefr.243993752754073279024448959996 Contributi di superficiefr.20 51533 55448 71518 54431 82144 803 Contributi per animali che consumano foraggio grezzofr.3 1873 2144 5783 4135 2426 827 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.4514594554 1734 6044 979 Contributi di declivitàfr.2452993251 7722 8233 386 Contributiecologiciedetologici,totalefr.7358101561541572151208014826 Compensazione ecologicafr.2 4253 1915 3902 0643 5394 772 Produzione estensivafr.6801 0421 8096651 0211 801 Agricoltura biologicafr.4433291 004564895202 Contributi etologicifr.3 8115 5947 2123 9226 6268 050 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.31 75747 68369 48835 11656 56974 823 Prestazione lordafr.210 096298 413382 410180 266279 179336 730 Quota di PD giusta l'OPD rispetto alla prestazione lorda %15.116.018.219.520.322.2 Altri pagamenti diretti 2 fr.2 3223 1496 2612 0133 1375 174 Totale pagamenti diretti fr.34 07950 83275 74937 13059 70679 997 Quota totale di PD rispetto alla prestazione lorda%16.217.019.820.621.423.8
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabella 41b
Pagamenti diretti a livello aziendale1: per zone e classi di dimensione – 2006
1 I risultati si basano sui dati dell’analisi centralizzata di ART
2 Contributi d'estivazione, contributi di coltivazione, altri contributi
ALLEGATO A47
ZMIZMII CaratteristicaUnità10–2020–3030–5010–2020–3030–50 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU Aziende di riferimentoNumero2211296021014070 Aziende rappresentateNumero3 0711 3028262 9411 7791 042 Superficie agricola utileha 15.0824.0137.2815.1224.4937.41 Pagamenti diretti
Pagamentidirettigenerali,totalefr.340774919168362401235626371099 Contributi di superficiefr.18 44329 49445 35118 04929 10741 901 Contributi per animali che consumano foraggio grezzofr.4 6057 1279 5146 2449 24111 408 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.7 7418 6699 42812 09013 38613 826 Contributi di declivitàfr.3 2873 9024 0693 7414 5293 964 Contributiecologiciedetologici,totalefr.59729745125335534848611113 Compensazione ecologicafr.1 4382 1312 1911 2381 7041 843 Produzione estensivafr.1995091 4873155261 Agricoltura biologicafr.6369235028491 1351 943 Contributi etologicifr.3 6996 1838 3523 4165 5927 067 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.40 04858 93780 89545 65764 74982 212 Prestazione lordafr.159 457242 880313 801154 549206 773257 568 Quota di PD giusta l'OPD rispetto alla prestazione lorda %25.124.325.829.531.331.9 Altri pagamenti diretti 2 fr.1 7122 7164 8654 3674 9214 512 Totale pagamenti diretti fr.41 76061 65385 76150 02469 67086 724 Quota totale di PD rispetto alla prestazione lorda%26.225.427.332.433.733.7
in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
Tabella 41c
Pagamenti diretti a livello aziendale1: per zone e classi di dimensioni – 2006 ZMIIIZMIV
CaratteristicaUnità10–2020–3030–5010–2020–3030–503 haSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAUhaSAU
Pagamenti diretti in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
contributi di coltivazione, altri contributi
Fonte:
A48 ALLEGATO
Aziende di riferimentoNumero105643375257 Aziende rappresentateNumero1 4799175211 292393 Superficie agricola utileha 14.6024.1437.4214.7724.51
Pagamentidirettigenerali,totalefr.4729567192836715093572174 Contributi di superficiefr.17 59328 80641 88417 69029 386 Contributi per animali che consumano foraggio grezzofr.10 30913 77415 30010 37214 463 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.14 67518 28019 08717 62921 602 Contributi di declivitàfr.4 7196 3327 4015 2446 722 Contributiecologiciedetologici,totalefr.436276421035947949230 Compensazione ecologicafr.1 1301 5781 9651 3522 483 Produzione estensivafr.004500 Agricoltura biologicafr.7971 7172 5911 0572 740 Contributi etologicifr.2 4354 3475 7572 3864 007 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.51 65774 83494 03055 72981 404 Prestazione lordafr.127 301192 001230 708126 323196 628 Quota di PD giusta l'OPD rispetto alla prestazione lorda%40.639.040.844.141.4 Altri pagamenti diretti 2 fr.3 9165 3988 9045 2717 781 Totale pagamenti direttifr.55 57280 232102 93461 00089 185 Quota totale di PD rispetto alla prestazione lorda%43.741.844.648.345.4
I risultati si basano
2Contributi d'estivazione,
3 A causa dell'esiguità
1
sui dati dell’analisi centralizzata di ART
del campione non vengono forniti risultati
Reckenholz-Tänikon ART
Agroscope
Tabella 42
Pagamenti diretti a livello aziendale1: per regioni – 2006
in virtù della ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
1 I risultati si basano sui dati dell’analisi centralizzata di ART
2 Contributi d'estivazione, contributi di coltivazione, altri contributi Fonte: Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
ALLEGATO A49
CaratteristicaUnitàTutteleRegioneRegioneRegione aziendedipianuracollinaredimontagna Aziende di riferimentoNumero 3 2711 491957823 Aziende rappresentateNumero 50 09922 81813 61013 671 Superficie agricola utileha 20.0721.0218.8819.66 Pagamenti
Pagamentidirettigenerali,totalefr.38486323163726849995 Contributi di superficiefr.25 48228 24523 37122 973 Contributi per animali che consumano foraggio grezzofr.5 3813 3245 1449 050 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzionefr.5 5574116 05813 647 Contributi di declivitàfr.2 0663362 6954 325 Contributiecologiciedetologici,totalefr.7999888381176405 Compensazione ecologicafr.2 3253 0562 0891 341 Produzione estensivafr.62497561350 Agricoltura biologicafr.6724445631 161 Contributi etologicifr.4 3784 4084 8533 853 Totale pagamenti diretti giusta l'OPDfr.46 48441 19945 38656 400 Prestazione lordafr.226 795272 530209 031168 145 Quota di PD giusta l'OPD rispetto alla prestazione lorda%20.515.121.733.5 Pagamenti diretti per ettarofr./ha2 3171 9602 4042 869 Altri pagamenti diretti 2 fr.3 5493 5422 5124 593 Totale pagamenti direttifr.50 03344 74147 89760 993 Quota totale di PD rispetto alla prestazione lorda%22.116.422.936.3
diretti
Cantone Aziende aventi diritto ai PD (cifre Rapporto agricolo 2006)
PD
controllate in % di tutte le aziende aventi diritto ai
Detenzione
di concimazione equilibrato
adeguata di superfici di compensazione ecologica
tampone e di superficie inerbita
Se il numero di aziende controllate è superiore al numero di aziende aventi diritto ai PD significa che nel Cantone in questione vi sono più aziende notificate che aziende aventi diritto ai PD
A50 ALLEGATO
Tabella 43a
Numero%NumeroNumeroNumero ZH3 55956.672 017051811411288102260285 BE12 26931.443 8574148171394313131270 LU4 95548.522 404070132577301015132390 UR63937.40239028 20020001648 SZ1 63145.4974243828 301000377 OW68930.622110232 1000004075 NW48853.482610821 101000031 GL40457.18231045020001012 ZG55457.763201727 402002043 FR3 11038.071 1840113191451525334210 SO1 394101.081 40912414 216252158 BL933100.00933063007340124 SH56571.334030012 1047001034 AR73957.2442302312 111000442 AI54135.12190028101920000059 SG4 24151.312 17604313821510011149269 GR2 61375.551 974035106144300021183 AG3 038100.793 06235611165204292440334 TG2 60751.591 34530105291428872965288 TI89153.8748004372 00000028143 VD3 90662.492 44119302118261142190148 VS3 62955.392 010810222410423153206577 NE90844.934080011 204000724 GE30557.38175000110507519 JU1 06540.8543502452809000084 CH5567352.682933075866125322715224962741576233727
Controlli PER – 2006 Contestazioni
Aziende
Aziende
Notifica
Registrazioni Bilancio
Quota
Fasce
Avvicendamento
Protezione
Selezione
Fonte: AGIS/SIPA e rapporti cantonali concernenti i controlli e le sanzioni – 2006 Altro Totale
controllate
tardiva
degli animali da reddito rispettosa delle loro esigenze
disciplinato delle colture
adeguata del suolo
e utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle piante
contestazioni
Se il numero di aziende controllate è superiore al numero di aziende aventi diritto ai PD significa che nel Cantone in questione vi sono più aziende notificate che aziende aventi diritto ai PD
Fonte: AGIS/SIPA e rapporti cantonali concernenti i controlli e le sanzioni – 2006
ALLEGATO A51
Tabella 43b
%%Numero%%fr.fr. ZH8.0114.13992.784.911 563.52154 788 BE2.207.002702.207.00774.20209 033 LU7.8716.221392.815.781 952.04271 333 UR7.5120.08345.3214.23278.629 473 SZ4.7210.38573.497.684 260.74242 862 OW10.8935.55314.5014.6951716 027 NW6.3511.88102.053.839479 470 GL2.975.19122.975.191 239.5814 875 ZG7.7613.44132.354.062 717.6935 330 FR6.7517.742237.1718.832 420.40539 750 SO4.164.12584.164.121 65095 700 BL2.572.57242.572.571 041.5024 996 SH6.028.44325.667.94831.7226 615 AR5.689.93283.796.621 226.5734 344 AI10.9131.05356.4718.421 454.9150 922 SG6.3412.362696.3412.36520.07139 899 GR7.009.27873.334.411 054.1691 712 AG10.9910.911705.605.551 587.74269 915 TG11.0521.41742.845.501 109.8082 125 TI16.0529.79444.949.171 424.2862 668 VD3.796.061303.335.331 368.32177 881 VS15.9028.71381.051.891 456.2155 336 NE2.645.88101.102.45698.896 989 GE6.2310.86175.579.711 048.0417 817 JU7.8919.31131.222.991 609.0820 918 CH6.6912.71191793.616.541387.992660778
Controlli PER – 2006
Cantone Contestazioni per 100 aziende aventi diritto ai PD Contestazioni per 100 aziende controllate Aziende con riduzioni Aziende con riduzioni per 100 aziende aventi diritto ai PD Aziende con riduzioni per 100 aziende controllate Riduzione in fr. per azienda con riduzioni Totale riduzioni
Uscite nel settore del miglioramento delle basi
Tabella 44
Contributi versati ai Cantoni – 2006
Tabella 45
Contributi a progetti approvati, secondo i provvedimenti e le regioni – 2006
A52 ALLEGATO
CantoneBonifichefondiarieEdificiruraliTotalecontributi fr.fr.fr. ZH2 015 732311 9002 327 632 BE17 324 9635 249 50022 574 463 LU8 341 3131 407 9009 749 213 UR984 181231 0001 215 181 SZ2 851 091995 2003 846 291 OW2 332 210455 5002 787 710 NW2 879 044187 9333 066 977 GL198 37986 400284 779 ZG505 167371 500876 667 FR3 872 2352 674 8006 547 035 SO1 511 566729 9002 241 466 BL398 591432 300830 891 SH174 36937 900212 269 AR245 163646 000891 163 AI419 873759 1001 178 973 SG4 090 5512 004 1006 094 651 GR15 818 2193 481 40019 299 619 AG1 240 500450 8001 691 300 TG72 650177 200249 850 TI2 704 002234 2002 938 202 VD6 406 7421 474 1007 880 842 VS3 344 576844 5004 189 076 NE739 0001 686 0002 425 000 GE108 958108 958 JU2 693 1601 161 5003 854 660 Diversi111 371111 371 Totale8138360626090633107474239 Fonte: UFAG
ProvvedimentiContributiCosti complessivi RegioneRegioneRegioneTotaleTotale dipianuracollinaredimontagna 1000fr. Bonifichefondiarie Ricomposizioni particellari (infrastrutture incluse)5 6752 5198 76116 95444 841 Costruzione di strade agricole1 9943 1778 29513 46650 887 Altri impianti di trasporto 9191308 Provvedimenti volti a conservare e migliorare il bilancio idrico del suolo2 5535091 1624 22415 187 Acquedotti461 7477 4259 21838 265 Approvvigionamento elettrico1701282981 277 Ripristino e consolidamento 1 4746 59230 07437 14071 578 Acquisto dei dati di base3263261 033 Ripristino periodico4003801 9392 72014 764 Totaleintermedio11467150935787584436238140 Edificirurali Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo7 91617 83525 751170 872 Edifici alpestri 7687686 148 Edifici collettivi per lavorazione, stoccaggio e smercio405764815 494 Totaleintermedio83211867826999182515 Totale114672341476554111435420655
Fonte: UFAG
1Danni provocati dal maltempo inclusi
Tabella 46
Crediti d'investimento accordati dai Cantoni – 2006
ALLEGATO A53
CantoneBonifichefondiarieEdificiruraliTotale ProvvedimenticollettiviP.collettiviP.individuali CreditidicostruzioneCreditid'investimentoCreditid'investimentoCreditid'investimento Numero1000fr.Numero1000fr.Numero1000fr.Numero1000fr.Numero1000fr. ZH1100212611316 67211616 898 BE1411 840183373533741 43035554 088 LU3910218931 06919223 10120025 268 UR2360161 700182 060 SZ102 7562672445 896569 324 OW42 0501190273 332325 572 NW2136121 352141 488 GL 131 193131 193 ZG 253 565253 565 FR889291 49016426 78818129 170 SO11432390164416 464457 061 BL1586352384 659455 069 SH1155181 674191 829 AR 333 109333 109 AI157222 311232 368 SG890416821 33217622 236 GR149 67752088711 30110621 186 AG2609912 83710112 897 TG 7010 2277010 227 TI13001291103847811910 VD1400445 11014218 50318724 013 VS436542 137161 552244 054 NE12 30071 338355 584439 222 GE1232680971 041 JU12205262578 649639 131 Totale51307362527091041501717832345181963282980 Fonte: UFAG
Tabella 47
Crediti d'investimento secondo le categorie di provvedimenti – 2006 (senza crediti di costruzione)
CantoneAiutoAcquistoDiversi-EdificiEdificiProvvedi-LavorazioneBonificheTotale inizialedell'aziendaficazioned'abita-ruralimentiestoccaggiofondiarie dapartezionecollettivi1diprodotti dell'affittuarioagricoli
A54 ALLEGATO
1000fr. ZH4 8305952 1809 06712610016 898 BE14 95869444411 40713 9277358342 248 LU8 199420726 6657 74530076918924 358 UR7208201601 700 SZ1 650401 5252 6816726 568 OW1 8604501 0221903 522 NW6902354271361 488 GL7244691 193 ZG1 140613002 0643 565 FR7 5301 4054 65513 19894954189229 170 SO1 680711 1953 519643906 918 BL1 8603303722 097352585 069 SH330741001 1701551 829 AR1 0808761 1533 109 AI4203124061 173572 368 SG8 485720864 5097 53254136322 236 GR3 1942 4665 64120811 509 AG4 6502181 8606 1096012 897 TG2 4903701 4055 96210 227 TI5628014210329610 VD6 8401052 2529 3063 7671 34323 613 VS480603706422 070673654 054 NE1 6507164942 7249973416 922 GE4202001892321 041 JU3 5702801107133 9762622209 131 Totale7872648772562462581020951036646512709252244 1Acquisto dell'inventario,
Fonte: UFAG
aiuto iniziale per le organizzazioni contadine di solidarietà
Tabella 48
Mutui accordati dai Cantoni nel quadro dell'aiuto alla conduzione aziendale – 2006 (quote federali e cantonali)
ALLEGATO A55
CantoneNumeroImportoPersingolocasoDurataammortamento 1000fr.1000fr.anni ZH6 73012213 BE11 1 54514014 LU24 3 88616219 UR SZ7 82111713 OW1 15015017 NW2 1809016 GL2 27013515 ZG FR6 1 04017310 SO6 1 05617615 BL2 30015017 SH1 10010010 AR5 57311511 AI2 170859 SG9 97810915 GR5 4809619 AG3 31010314 TG3 3601208 TI2 35918017 VD9 2 22624715 VS8 85110615 NE3 32010711 GE JU24 1 699718 Totale14118403 Media13114 Fonte: UFAG
dei contributi
49b Ricapitolazione dei crediti d'investimeno e dei mutui per l'aiuto alla conduzione aziendale
A56 ALLEGATO Tabella
Ricapitolazione
ProvvedimentiProgettiapprovatiin1000fr. 200420052006 Contributi8345286631111435 Ricomposizioni particellari (infrastrutture incluse)20 40216 64816 954 Costruzione di strade agricole13 16717 25113 466 Acquedotti 9 8319 7759 218 Altri provvedimenti del genio civile (maltempo incluso)12 30916 51244 798 Edifici rurali per animali che consumano foraggio grezzo26 18925 13726 519 Altri provvedimenti nel settore delle costruzioni rurali1 5541 308481 Fonte: UFAG
ProvvedimentiCreditiaccordatiin1000fr. 200420052006 Creditid'investimento1286007293956252244 Aiuto iniziale 80 47776 03978 726 Acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario3 8096 7034 877 Diversificazione 2 1094 3572 562 Edifici d'abitazione 53 83455 25546 258 Edifici rurali 119 444125 573102 095 Provvedimenti collettivi / lavorazione, stoccaggio e smercio di prodotti agricoli23 01721 43315 017 Bonifiche fondiarie, crediti di costruzione esclusi3 3174 5962 709 Mutuiperlaconduzioneaziendale1311751659218403 1Accordati dal Cantone Fonte: UFAG
49a
Tabella
Tabella 50
Aiuti per la riqualificazione – 2006 CantoneContributiprospettatiContributiversati1
1Da importi prospettati l'anno precedente
Tabella 51
Aiuti finanziari all'allevamento di animali – 2006
GeneredianimalieprovvedimentiContributoAnimaliiscrittialLGOrganizzazioni diallevamento fr.Numero
del libro genealogico2 660 000
funzionali del latte e della carne10 302 000
della conformazione681 000
del libro genealogico579 000 Esami funzionali del latte250 000
1 Puledri identificati Fonti: Conto dello Stato / Organizzazioni di allevamento
ALLEGATO A57
Numerofr.Numerofr. ZH BE2 170 5264 80 900 LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO 2 95 800 BL SH AR AI SG GR1 120 050 AG TG1 153 000 TI VD3 365 285 VS 1 45 650 NE GE JU Totale78088617222350
Fonte: UFAG
Bovini1364300053510910
Apprezzamento
Equini10640004440124 Suini1694000158572 Ovini1097000841466
Tenuta
Esami
Capreepecorelattifere829000291394 Tenuta
Conservazionedellerazzesvizzere8070007 Totale19134000
Uscite della Confederazione per agricoltura e alimentazione, in 1 000 fr.
Osservazione: il Conto dello Stato 1999 rappresenta la base per la ripartizione dei mezzi finanziari fra i singoli ambiti di spesa. Le uscite per la valorizzazione delle patate e della frutta o quelle dell'amministrazione dei cereali 1990/92, ad esempio, figurano come uscite dell'UFAG. All'epoca esistevano ancora conti separati. Per tale motivo le cifre relative al 1990/92 non sono identiche a quelle figuranti nel Conto dello Stato. Quelle successive sono nuovamente comparabili. L'aumento delle spese di amministrazione è riconducibile in primo luogo al fatto che alcune prestazioni, come ad esempio quelle per le Casse pensioni, non sono più riportate in un'unica rubrica del Conto dello Stato, bensì ripartite fra i singoli Uffici.
Fonte: Conto dello Stato
A58 ALLEGATO
52
Tabella
Ambitodispesa1990/922004200520061990/92–2004/06 % UsciteUFAG269944235436133439972348127429.2 Creditiquadro-34317953318501 Produzioneesmercio1684994731419676975605644-60.2 Promozione dello smercio63 67456 67631 796 Economia lattiera1 127 273503 513474 232442 742-58.0 Produzione animale133 90222 49920 57418 791-84.6 Produzione vegetale423 819141 734125 493112 316-70.1 Pagamentidiretti772258249834824640002553000224.4 Pagamenti diretti generali758 3322 023 0001 989 0001 989 000163.8 Pagamenti diretti ecologici13 926475 348475 000564 0003 524.7 Miglioramentodellebasi1858362020281775262008064.1 Miglioramenti strutturali133 87994 50885 026107 474-28.5 Crediti d'investimento27 13676 46368 00068 500161.6 Aiuti per la conduzione aziendale9528 8141 5882 250343.0 Produzione vegetale e animale23 86922 24322 82122 372-5.8 Aldifuorideicreditiquadro-111818121472121822 Amministrazione33 42952 06549 21749 18650.0 Consulenza e contributi per la ricerca21 47623 64123 84423 42810.1 Lotta alle malattie delle piante e ai fitofagi1 4491 7092 9831 66146.1 Controllo del traffico degli animali/smaltimento scarti di carne-34 40345 42847 547Altreuscite348163358193330821312420-4.1 Contributi d'esportazione per prodotti agricoli trasformati93 867114 90090 00090 0004.7 Assegni familiari nell'agricoltura77 99677 80076 80076 100-1.4 Stazioni di ricerca agronomica96 431121 487120 063116 53723.8 Istituto nazionale di allevamento equino6 8437 7607 6697 47211.6 Altre73 02636 24636 28922 311-56.7 Totaleagricolturaealimentazione304760539018063770793379369425.4
Terminologia e metodi
Atti legislativi
Gli atti legislativi possono essere consultati sul sito Internet seguente: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00103/index.html?lang=it
Terminologia e metodi
Conto economico dell’agricoltura – revisione parziale 2007
Il conto economico dell’agricoltura (CEA) viene allestito annualmente dall’Ufficio federale di statistica (UST), in collaborazione con la Segreteria dell’Unione svizzera dei contadini (USC). Le principali modifiche nel quadro della revisione parziale 2007 sono state dettate, da un lato, da adeguamenti di natura metodologica attuati nei conti nazionali e a livello internazionale (Eurostat), dall’altro, dalla volontà di tener più specificatamente conto delle realtà agricole svizzere. La revisione ha interessato tutte le sequenze di dati (1985–2007) al fine di garantire come in passato la comparabilità nel tempo dei risultati CEA. Le modifiche più salienti e le loro ripercussioni sui risultati precedentemente pubblicati sono illustrate di seguito. Rispetto al vecchio metodo il reddito da impresa netto è inferiore di oltre 36 milioni di franchi alla media degli anni 2002/04.
Introduzione dei servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) e degli interessi ricevuti dai depositanti
Per servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM, dall’inglese FISIM financial intermediation services indirectly mesured) s’intende la parte degli interessi passivi che indennizza la banca per suo il servizio in relazione alla concessione di un credito. Finora questa parte rientrava negli interessi passivi. Adesso i SIFIM vengono dedotti e registrati separatamente nei consumi intermedi. La logica inversa è applicata agli interessi ricevuti dai depositanti che sono maggiorati di un teoretico indennizzo della prestazione della banca la cui contropartita è dedotta dai consumi intermedi. Questi adeguamenti non hanno alcuna ripercussione sul reddito da impresa netto.
Investimenti fissi lordi in animali da reddito
Gli investimenti fissi lordi in animali da reddito sono dati dalla differenza tra le acquisizioni (rinnovo del bestiame) e le c essioni (macellazioni, p.es. di vacche). Finora tutte le variazioni di effettivo erano valutate allo stesso modo. Adesso il rinnovo degli animali è valutato ad un prezzo più alto rispetto a quello degli animali riformati. Questa modifica incide sulla produzione animale aumentandone leggermente il valore.
Attivi immobilizzati e ammortamenti
Finora si partiva dal presupposto che tutti gli attivi di una stessa categoria (edifici, attrezzature, impianti) messi in esercizio in un dato momento avessero la stessa durata d’utilizzo. Adesso la valutazione tiene maggiormente conto delle condizioni reali in base a cui la durata d’utilizzo di attivi della stessa categoria può variare anche sensibilmente. Sono stati inoltre adeguati i tassi d’ammortamento, finora lineari, onde meglio prendere in considerazione il fatto che il tasso d’invecchiamento di un attivo è più pronunciato all’inizio che alla fine. Soltanto gli impianti continueranno ad essere ammortizzati in maniera lineare. Questa modifica si ripercuote soprattutto sugli edifici il cui ammortamento è più elevato sull’arco del periodo osservato.
Produzione e consumo di foraggio
Il fulcro della revisione è l’adeguamento del calcolo del consumo foraggiero. L’aumento del fabbisogno nutritivo per vacca induce una correzione verso l’alto della produzione e del consumo di foraggio.
ALLEGATO A59 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Atti legislativi,
Altre revisioni
Sono state effettuate altre modifiche di portata limitata, che incidono soltanto marginalmente sui risultati in generale e, nello specifico, sul reddito da impresa netto. Si cita, in particolare, la semplificazione del calcolo dell’onere dell’imposta sul valore aggiunto dell’agricoltura, con la registrazione soltanto del saldo. In linea generale, le aziende agricole pagano più IVA sui loro acquisti rispetto a quanto possono fatturarne sulla loro cifra d’affari e ciò crea una sottocompensazione che viene registrata nelle «altre imposte sulla produzione».
Terminologia e metodi possono essere consultati sul sito Internet seguente: – http://www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00103/index.html?lang=it
A60 ALLEGATO
Organizzazioni/Istituzioni
ACWStazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil ACW
AFDAmministrazione federale delle dogane, Berna
AgrideaSviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali
ALPStazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux ALP
ARTStazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon ART
DFEDipartimento federale dell’economia, Berna
DGDDirezione generale delle dogane, Berna
FAOOrganizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma
IEAIstituto di economia agraria, Zurigo
IRABLIstituto di ricerche dell’agricoltura biologica, Frick
OCSEOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, Parigi
OMCOrganizzazione mondiale del commercio, Ginevra
PFZPolitecnico federale, Zurigo
PSLProduttori svizzeri di latte, Berna
secoSegretariato di Stato all’economia, Berna
TSMFiduciaria Latte Sagl, Berna
UEUnione europea
UFAEUfficio federale per l’approvvigionamento economico del paese, Berna
UFAGUfficio federale dell’agricoltura, Berna
UFAMUfficio federale dell’ambiente, Berna
UFASUfficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
UFFTUfficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Berna
UFSUfficio federale di statistica, Neuchâtel
UFSPUfficio federale della sanità pubblica, Berna
UFVUfficio federale di veterinaria, Berna
USCUnione svizzera dei contadini, Brugg
USTUfficio federale di statistica, Neuchâtel
ZMPZentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft Sagl, Bonn
Unità di misura
cts.centesimo fr.franco
haettaro = 10'000 m2 hora
hlettolitro
kcalchilocalorie
kgchilogrammo
kmchilometro llitro
mmetro
m2 metro quadrato
m3 metro cubo
mia.miliardo
ALLEGATO A61 ■■■■■■■■■■■■■■■■■
Abbreviazioni
mio.milione
pz. pezzi
qquintale = 100 kg
ttonnellata
%per cento
Ømedia
Terminologia/Denominazioni
ADCAliquota di dazio del contingente
ADFCAliquota di dazio fuori contingente
AGIS/SIPAServizio d’informazione sulla politica agricola
AIAssicurazione invalidità
AVSAssicurazione vecchiaia e superstiti
ca.circa
cfr.confronta
CO2 Anidride carbonica
compr.compreso
DOPDenominazioni di origine protette
ESBEncefalopatia spongiforme dei bovini («Malattia della mucca pazza»)
IGPIndicazioni geografiche protette
IPGIndennità per la perdita di guadagno
IVAImposta sul valore aggiunto
LAgrLegge sull’agricoltura
MPRMaterie prime rinnovabili
NAzoto
OGMOrganismi geneticamente modificati
PFosforo
PACPolitica agricola comune dell’UE
PERProva che le esigenze ecologiche sono rispettate
p.es.per esempio
PIProduzione integrata
PMPeso alla macellazione
PTPProdotti per il trattamento delle piante
PVPeso vivo
risp.rispettivamente
SAUSuperficie agricola utile
SCESuperficie di compensazione ecologica
SSRASistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
UBGUnità di bestiame grosso
UBGFGUnità di bestiame grosso foraggio grezzo
ULAUnità di lavoro annuale
ULAFUnità di lavoro annuale della famiglia
UMUnità di manodopera
UMSUnità di manodopera standard
URAUscita regolare all’aperto
ZM I, II, ..Zona di montagna
Rinvio all’allegato (p.es. tabelle)
A62 ALLEGATO
AGRIDEA, comunicato personale.
Bergmann H., Fueglistaller U., 2006. Auswirkungen eines Agrarfreihandelsabkommen CH-EU auf die mittelgrossen Betriebe der Gemüse-, Kartoffel- und Ölsaatenverarbeitung.
Istituto svizzero per le piccole e medie imprese (KMU-HSG), Università di San Gallo.
Bergmann H., Fueglistaller U., 2007.
Auswirkungen eines Agrarfreihandelsabkommen CH-EU auf die Produktion und den Grosshandel von Tafeläpfeln, Lagerkarotten und Rispentomaten in der Schweiz.
Istituto svizzero per le piccole e medie imprese (KMU-HSG), Università di San Gallo.
Calanca P., 2006.
Climate change and drought occurrence in the Alpine region: how severe are becoming the extremes?
Global Planetary Change, 57, 1–2, 151–160.
Flury C., Buchli S. e Giuliani, G. 2007. Evaluation of jointness between agriculture and rural development. OCSE Parigi.
Hättenschwiler P. e Flury C. 2007.
Evaluation of Agriculture's Contribution to Food Security. OCSE Parigi.
Huber R. 2007.
De-linked cost of rural landscape maintenance: A case study from Swiss lowlands. OCSE Parigi.
Hüglin C., Gerhig R., Baltensberger U., Gysel M., Monn C. and Vonmont H., 2005. Chemical characeterisation of PM2.5, PM10 and coarse particles at urban, near-city and rural sites in Switzerland. Atmospheric Environment, 39 (4), 637–651.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2001.
Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2001.
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007.
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, U.K.
ALLEGATO A63 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ Bibliografia
Lehmann B., Christiansen H.-G., 2007. Staatliche Unterstützung zugunsten der milchverarbeitenden Industrie in Deutschland und der Schweiz. Institut für Umweltentscheidungen, Politecnico federale di Zurigo.
Organo consultivo sui cambiamenti climatici (OcCC), 2007. Klimaänderung und die Schweiz 2050 – Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Berna.
Rossier D., 2000.
Vereinfachte Beurteilung der potenziellen Umweltwirkungen der schweizerischen Landwirtschaft. Studio condotto nell’ambito del progetto «Zentrale Auswertung und Ökobilanzierung».
Spirig C., Neftel A., 2006.
Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft und Feinstaub.
Agrarforschung, 13 (9), 392–397.
Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), diverse edizioni. Rapporto agricolo 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006.
Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP, oggi UFAM), 2005.
Switzerland’s Fourth National Communication under the UNFCCC. First National Communication under the Kyoto Protocol to the UNFCCC.
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), 2006.
Switzerland's Greenhouse Gas Inventory 1990–2004. National Inventory Report.
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), 2004.
Kenngrössen zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Schweiz (1990–2002)
Ufficio federale di statistica (UST).
Unione svizzera dei contadini (USC), diverse edizioni. Statistische Erhebungen und Schätzungen über Landwirtschaft und Ernährung, Brugg.
Zah R., Böni H., Gauch M., Hischier R., Lehmann M. und Wäger P., 2007. Ökobilanz von Energieprodukten: Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR).
A64 ALLEGATO


 Direttore dell’Ufficio federale dell‘agricoltura
Direttore dell’Ufficio federale dell‘agricoltura



























 * Cucina e bagno esclusi
* Cucina e bagno esclusi


















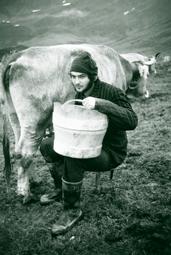







 ■ Mezzi finanziari
■ Mezzi finanziari










































