





NUMERI ARRETRATI
Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it
Il costo di ciascun arretrato è 15,00 €
SCARICA LA APP DAGLI STORE DIGITALI



Per leggere la rivista sul tuo dispositivo se sei abbonato o per acquistarla in digitale (anche arretrati) a 2,99 €

per te 12 numeri a soli 85,00€*
Invece di 118,80€
www.abbonamenti.it/cosmo
Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da BFC Space Srl. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www. abbonamenti.it/cga

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
» Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/cosmo
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero 02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
DAL SITO, ANCHE
REGALARE
ABBONAMENTO

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia. Cognome
I MIEI DATI
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
rilascio nego il consenso per le attività di profilazione
Da questo mese Cosmo cambia formato. Pur mantenendo la qualità e la quantità dei contenuti, oltre all’eleganza della veste gra ca, le sue dimensioni siche si sono un po’ ridotte. Gli scopi dell’operazione? Aumentare la maneggevolezza e la trasportabilità della rivista. Ma anche risparmiare sui costi della carta per aumentare la tiratura e consentire una maggiore di usione della rivista. Evitando allo stesso tempo gli sprechi, per dare anche noi un piccolo contributo alla gestione delle risorse naturali del nostro pianeta. Chi si interessa di astronomia non può che interessarsi alle sorti della Terra e soprattutto a quelle dell’umanità. Perché non crediamo che al nostro pianeta importi molto essere disabitato e inquinato o viceversa. Deve invece importare molto a chi ha cuore le sorti dei suoi abitanti e della conoscenza accumulata dalla specie umana. Conoscenza che verrà certamente accresciuta grazie al telescopio spaziale Euclid dell’Agenzia spaziale europea, sulla rampa di lancio questo mese: ne parliamo di usamente nelle prime pagine di questo numero, con una intervista all’astronomo Roberto Scaramella, curata da Corrado Ruscica. Euclid è uno strumento innovativo che prende il nome dal grande geometra classico perché si propone di studiare la geometria dell’Universo, con la speranza di fate un po’ di luce sull’oscurità. Nel vero senso della parola, dato che fra i suoi obiettivi principali c’è il saperne di più sulla materia oscura e sull’energia oscura, i due più grandi enigmi dell’astro sica e della cosmologia contemporanea. Anche Euclid, come tanti altri telescopi di ultima generazione, imbarca tanta, tantissima Italia a bordo, un vanto per il nostro Paese. Pur continuando a ritenere che i con ni e le barriere stabiliti dagli uomini sul nostro pianeta, di qualsiasi natura siano, lascino il tempo che trovano, specialmente se vengono inseriti nella vastità dell’Universo. Buona lettura e buona fruizione di questo nuovo formato di Cosmo.
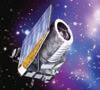 DI WALTER RIVA
DI WALTER RIVA
ANNO 5 - NUMERO 41 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019
CASA EDITRICE BFC SPACE
Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com
DIRETTORE RESPONSABILE
Walter Riva riva@bfcmedia.com
DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com
HANNO COLLABORATO
Gabriella Bernardi, Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Matteo Cerri, Giordano Cevolani, Giuseppe Donatiello, Aldo Ferruggia, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Piero Mazza, Corrado Ruscica.
GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com
PUBBLICITÀ Newton Winston info@bfcspace.com
ABBONAMENTI
Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia
ARRETRATI
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it
STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com


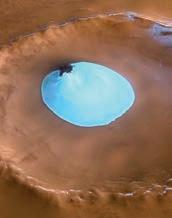
IN COPERTINA: la missione Euclid in assetto operativo, ra gurata con una rappresentazione del cosmic web, il reticolo di gas e di materia oscura che costituisce la struttura portante dell’Universo.
NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR
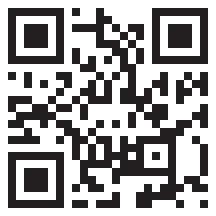
ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/
LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF
Inquadra




36
42
48
Nei mesi scorsi abbiamo annunciato su queste pagine il progetto di un viaggio in Messico per assistere alla Great North American Eclipse, la grandeeclisse totale di Sole dell’8 aprile 2024

Tutti gli articoli già pubblicati sono raccolti alla pagina bit.ly/3ZFdeVg del sito Bfcspace.com, dove si trova anche il modulo di iscrizione (individuale) al viaggio, che comprende la richiesta di versamento di un anticipo di 1000,00 euro sul totale della quota del viaggio, ssata in 4850,00 euro a testa. Al modulo si può accedere anche direttamente al link bit.ly/3C7VSGx. Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto e all’osservatorio sono operati da un pullman riservato e sono compresi nella quota del viaggio. Ulteriori dettagli sul viaggio saranno forniti nei prossimi numeri di Cosmo e potranno essere richiesti scrivendo a eclisse2024@ bfcspace.com.
Si prega di a rettarsi per le iscrizioni (entro e non oltre il prossimo 15 settembre), perché i posti sono limitati e occorre de nire le prenotazioni alberghiere con molto anticipo. Venite con Cosmo a osservare la Grande Eclisse Nordamericana!
» Il percorso dell’eclisse dell’8 aprile 2024 nelle regioni nord-occidentali del Messico. Le linee diagonali rosse delimitano la fascia della totalità, la linea blu è quella centrale, che corrisponde alla durata massima.
PROGRAMMA DEL VIAGGIO (5-12 APRILE 2024)
5 aprile: partenza da Milano-Malpensa (intorno ore 12) con Fly Free Airways per l’aeroporto di Torreòn (Messico), con 1-2 scali intermedi.
6 aprile: arrivo a Torreòn e alloggio dei partecipanti in Albergo 4 stelle in città con trattamento di pensione completa.
7 aprile: visita della città di Torreòn con una guida locale.

8 aprile: trasferimento all’Osservatorio astronomico di Nazas (25 km da Torreòn) per l’osservazione dell’eclisse (massimo alle 12h 18m locali).
9 e 10 aprile: escursioni naturalistiche nei dintorni di Torreòn e in serata osservazioni astronomiche guidate all’Osservatorio di Nazas, con strumenti forniti dall’organizzazione.
11 aprile: partenza dall’aeroporto di Torreòn con Fly Free Airways per il ritorno, con 1-2 scali intermedi.
12 aprile: arrivo a Milano-Malpensa.




WEBB TROVA VAPORE ACQUEO SULLA SUPER-TERRA GLIESE 486 B
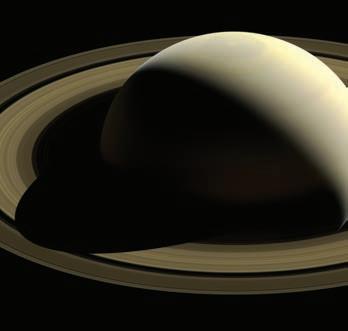
2
3 UN GRANDE ATLANTE FOTOGRAFICO DI VIVAI STELLARI
5 UN QUASAR CHE BRILLA COME 100 MILA MILIARDI DI SOLI
4 L’ANELLO MANCANTE DEI BUCHI NERI
VEGA C LANCERÀ IL SATELLITE SPAZZINO EUROPEO
6
7 RINVIATA LA MISSIONE EUROPEA PER URANO 8
Mentre ci dedichiamo a ricerche sempre più ra nate e profonde tra i sistemi extrasolari, il buon vecchio Sistema solare ci riserva ancora delle sorprese. Un protagonista eccezionale è questa volta Saturno, che rivela la presenza di decine di nuove lune.
Nel 1655 è stata scoperta Titano, la prima luna di Saturno, e sono occorsi 368 anni per scoprirne altre 82. Negli ultimi anni abbiamo assistito al continuo avvicendamento al vertice della classi ca tra Saturno e Giove per numero di lune. Quest’ultimo sembrava ben piazzato in testa, ma il suo record è crollato grazie a una recente ricerca che ha portato all’annuncio di ben 62 nuovi satelliti di Saturno, portando il totale a 145 lune
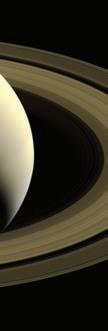
Un gruppo guidato da Edward Ashton, un giovane borsista presso l’Institute of Astronomy & Astrophysics di Taiwan, ha utilizzato una tecnica di imaging per identi care i nuovi satelliti.
La loro bassissima luminosità richiede lunghe esposizioni, ma le lune planetarie si spostano durante l’esposizione, rischiando di perdersi nel fondo di rumore strumentale. Allora i ricercatori hanno ripreso lunghe serie d’immagini abbastanza brevi da impedire ai potenziali satelliti di produrre delle tracce; hanno quindi calcolato le possibili posizioni dei nuovi oggetti e impilato le immagini, per migliorare il rapporto segnale/ rumore delle candidate lune.
TUTTA PRIVATA VERSO LA ISS
BLUE MOON, IL LANDER LUNARE PER ARTEMIS V 9 AX-2, LA SECONDA MISSIONE
Il team ha elaborato immagini acquisite dal Canada-France-Hawaii Telescope tra il 2019 e il 2021. Sin dalle prime osservazioni, sono emersi vari candidati poi seguiti durante le osservazioni successive, con magnitudini no alla 26,3, corrispondente a oggetti di circa 2,5 chilometri di diametro. Tutte le nuove lune sono “irregolari”, cioè oggetti catturati molto tempo fa, con orbite ampie, ellittiche e inclinate rispetto alle lune regolari formatesi insieme al pianeta. Per il momento Giove si attesta a 95 lune, ma c’è da scommettere che applicando la stessa tecnica, tra qualche tempo riprenderà la competizione tra i due giganti.
Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3qdyxk3 G.D.
Nuove immagini scattate dal rover Perseverance della Nasa mostrano i segni di quello che un tempo doveva essere un fiume impetuoso che scorreva su Marte, in un ambiente occupato da una miriade di corsi d’acqua che sfociavano nel cratere Jezero, l’area che il rover sta esplorando.
L’attenzione è concentrata su un ammasso di roccia sedimentaria alto 250 metri e caratterizzato da strati curvilinei che potrebbero essere i resti degli argini di un fiume che si sono spostati nel tempo, trasformati in roccia e levigati dal vento (vedi in figura la collina di Pinestand).
I ricercatori stanno anche “guardando” sotto la superficie marziana con il radar Rimfax di Perseverance. La comprensione di questi ambienti è un passaggio fondamentale nella ricerca di segni di un’antica vita microbica che potrebbe essersi preservata nella roccia marziana.
Nel frattempo, il rover cinese Zhurong ha scoperto tracce “recenti” di acqua in un’altra regione del Pianeta rosso: si tratta di caratteristiche morfologiche trovate su alcune dune di sabbia, con età compresa tra 0,4 e 1,4 milioni di anni, che forniscono una prova della presenza di acqua liquida anche alle basse latitudini (vedi anche l’articolo a pag. 22). Adesso la domanda è se queste condizioni abbiano permesso lo sviluppo di forme di vita, nel passato o perfino nell’epoca presente.
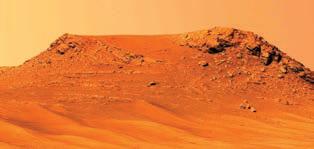
Inquadra il QR per il video della Chinese Academy of Sciences dedicato a questa scoperta.

Il telescopio spaziale James Webb conferma le capacità di indagare i pianeti extrasolari e le loro atmosfere (vedi l’articolo di C. Guaita su Cosmo n. 40), grazie allo spettro dell’esopianeta roccioso Gj486 b, la cui analisi mostra la presenza di vapore acqueo. Durante i transiti di Gj486 b sulla sua stella, la luce stellare ltra attraverso i gas che costituiscono l’atmosfera planetaria, imprimendo delle “impronte digitali” che permettono agli astronomi di decodi carne la composizione. Il segnale raccolto potrebbe provenire da un’atmosfera planetaria ricca di acqua, ma anche da macchie stellari “fredde” sulla stella ospite, una nana rossa Se verrà confermata da future osservazioni spettroscopiche del Webb, che cercheranno di discriminare tra l’origine planetaria e quella stellare del vapore d’acqua, questa sarà la prima atmosfera individuata attorno a un esopianeta roccioso. Gj486 b è circa il 30% più grande della Terra e tre volte più massiccio; orbita attorno alla sua stella in poco meno di 1,5 giorni, con un’orbita sincrona e molto ravvicinata e presenta una temperatura super ciale di circa 430 °C
Le nane rosse sono stelle molto attive e rilasciano radiazioni ultraviolette e raggi X che possono distruggere le atmosfere planetarie. Perciò, se veramente Gj486 b possiede un’atmosfera, si dovrà immaginare che venga costantemente rifornita da vulcani che emettono vapore dall’interno del pianeta.

Grazie al Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (Vista) dell’Eso, un gruppo di astronomi ha realizzato Visions, un vasto atlante infrarosso di cinque vivai stellari nel cielo meridionale. Le immagini sono state ottenute componendo a mosaico oltre un milione di singoli scatti, ripresi nell’arco di cinque anni nelle costellazioni di Orione, O uco, Camaleonte, Corona Australe ( gura) e Lupo. Distando meno di 1500 anni luce, tali regioni sono anche molto estese nel cielo e per questo è stato utile il campo di vista della Vircam, pari a circa tre lune piene.

Questi mosaici permettono agli astronomi di penetrare l’interno delle nubi dove stanno nascendo nuove stelle, un processo conosciuto a grandi linee, ma ancora sfuggente in alcuni passaggi importanti. Le immagini infrarosse vanno a integrare quelle ottiche realizzate dalla missione Gaia dell’Esa, che non è in grado di osservare dentro le nubi di gas e polveri. Così come altri sondaggi, anche Visions è a disposizione della comunità di astronomi e o rirà materiale di studio per molti anni. Gli stessi dati forniranno indicazioni per osservazioni più mirate con i grandi telescopi del futuro, come l’Extremely Large Telescope dell’Eso.
Vedi la news completa su Bfcspace.com al link bit.ly/3OIEfVj e inquadra il QR per un video di Media-Inaf dedicato a questa spettacolare campagna osservativa.

Un gruppo di ricercatori ha sfruttato i dati raccolti dal satellite Gaia dell’Esa e altri ottenuti dal telescopio spaziale Hubble per studiare un’enorme massa oscura situata al centro di M4, un ammasso globulare situato a circa 7200 anni luce di distanza nella costellazione dello Scorpione (in figura ripreso da Hubble). L’oggetto individuato nell’ammasso è 800 volte più massiccio del Sole e potrebbe essere un “buco nero di massa intermedia”. Gli astronomi stanno dando la caccia a questi buchi neri da oltre due decenni. La maggior parte di quelli noti sono resti di stelle giganti esplose come supernovae, con masse fino a cento volte quella solare, oppure gli oggetti supermassicci annidati nei nuclei di grandi galassie, con masse che possono arrivare a miliardi di volte quella del Sole. I buchi neri di massa intermedia (Imbh) sarebbero quindi l’”anello mancante” tra queste due tipologie. “Nel prossimo futuro”, afferma Luigi Bedin, ricercatore all’Inaf di Padova e co-autore della ricerca, “avremo modo di caratterizzare meglio questo eccesso di massa, grazie a nuove osservazioni dell’ammasso M4 eseguite dal telescopio James Webb”. Inquadra il QR per un viaggio virtuale verso M4 con un video dell’Eso.

Un team di astronomi ha puntato al cuore di un potentissimo quasar con strumenti ottici da terra e con satelliti per raggi X e gamma dallo spazio, per osservare cosa accade all’interno di questa “sorgenti quasi stellari” e come interagisce con l’ambiente circostante.

Si tratta di J1144, ospite di una galassia situata a 9,6 miliardi di anni luce dalla Terra, tra le costellazioni del Centauro e dell’Idra. Tra gli oggetti più brillanti e distanti dell’Universo conosciuto, i quasar sembrano alimentati dalla violenta caduta di materia verso un buco nero supermassiccio, un fenomeno estremo e inarrestabile che produce la loro prodigiosa luminosità. J1144 è 100mila miliardi di volte più luminoso del Sole, mentre la sua temperatura è 60mila volte maggiore di quella della superficie solare. La massa del buco nero al centro del quasar è 10 miliardi di volte quella del Sole e cresce di circa 100 masse solari all’anno.
Una caratteristica di questa sorgente è la variabilità della radiazione che emette, con periodicità dell’ordine dei giorni nei raggi X. Le osservazioni hanno mostrato che mentre una parte del gas viene inghiottita dal buco nero, un’altra è espulsa sotto forma di potenti correnti che introducono enormi quantità di energia nella galassia ospite. Le indagini continuano e J1144 potrebbe rivelare presto altre sorprese.

Sarà il lanciatore europeo Vega C, costruito in Italia da Avio, a portare in orbita la prima missione attiva di rimozione di detriti spaziali ClearSpace-1, che attraverso un robot spazzino di 700 chilogrammi catturerà e farà uscire dall’orbita un relitto spaziale di 112 kg dell’Agenzia spaziale europea (Esa).
Il lancio della missione è previsto dallo spazioporto europeo nella Guyana francese a partire dalla seconda metà del 2026 Lo stabilisce il contratto siglato da Arianespace e ClearSpace.
Il detrito spaziale che verrà rimosso dall’orbita è una parte della piattaforma lancia satelliti di un vecchio razzo Vega, lasciato in un’orbita di “smaltimento graduale”, in ottemperanza alle normative sulla mitigazione dei detriti spaziali, durante il secondo volo di Vega nel 2013.
Il detrito spaziale, con una massa simile a quella di un piccolo satellite, ha una forma semplice che consentirà di dimostrare le tecnologie del veicolo spaziale e del suo quartetto di bracci robotici, aprendo così la strada a missioni più impegnative con più catture per volo. La missione ClearSpace-1 rappresenta “un punto di svolta nell’industria spaziale, poiché abbiamo urgente bisogno di apportare soluzioni a un problema fondamentale: stiamo introducendo oggetti nello spazio più velocemente di quanto non vengano rimossi” - precisa Luc Piguet, amministratore delegato e co-fondatore della startup svizzera ClearSpace.

È stata rinviata al 2031 la missione Uranus Path nder, prima missione dell’Agenzia spaziale europea, in cooperazione con la Nasa, diretta verso Urano. L’arrivo al penultimo pianeta del Sistema solare è previsto per il 2043. Il programma è partito nel 2010, e il lancio era inizialmente programmato per il 2025.

E sarà sempre un razzo vettore Atlas V statunitense a inviare nello spazio la sonda che dovrà e ettuare alcuni y-by con Venere, con la Terra e Saturno, prima di raggiungere il suo obiettivo.
La conferma è giunta da ricercatori dell’Esa durante il convegno internazionale Space Exploration che si è tenuto dal 10 al 12 maggio scorso al Politecnico di Torino. Finora l’unica missione ad aver raggiunto Urano è stata la celebre Voyager 2, nel gennaio 1986, nel corso del suo storico Grand tour del Sistema solare.
La sonda della Nasa, che fece una sorta di transito, e ettuò misurazioni importanti e rivelò la rotazione del pianeta sul proprio asse, ma la nuova missione Esa-Nasa studierà a lungo il campo gravitazionale e il campo magnetico del pianeta, e per svolgere questi compiti avrà a bordo so sticate camere a largo campo, spettrometri nell’infrarosso, magnetometri, apparati di radio scienza e rilevatori di plasma. A.L.
La Nasa ha selezionato il lander Blue Moon di Blue Origin per portare gli astronauti sulla Luna a partire dalla missione Artemis V Probabilmente il lander verrà lanciato a bordo di un razzo New Glenn, ovvero il successore del New Shepard per lanci sub-orbitali di Blue Origin. Il contratto prevede che l’azienda di Je Bezos compia un allunaggio senza equipaggio prima di e ettuare la missione con astronauti, che al momento è in programma per il 2029

A salire a bordo del lander saranno solo due dei quattro astronauti della missione, perché gli altri due rimarranno a bordo del Gateway, la stazione spaziale lunare ancora in fase di sviluppo. Raggiunta la super cie selenica, gli astronauti eseguiranno esperimenti scienti ci per circa una settimana, avvicinando la realizzazione di una base lunare permanente e lo sbarco su Marte. Blue Origin si unisce quindi a SpaceX, che ha già ottenuto il contratto per Artemis III e IV con una versione della sua navicella Starship opportunamente modi cata. Dopo queste prime missioni, la Nasa alternerà l’utilizzo di Blue Moon e Starship, secondo la politica degli ultimi anni: far competere le aziende contraenti per stimolare l’avanzamento tecnologico e l’abbassamento dei costi. Inoltre, nel caso in cui uno dei due sistemi di allunaggio dovesse rivelarsi fallace, ci sarebbe l’altro pronto a sostituirlo.
Il 21 maggio è stata lanciata la capsula Crew Dragon con a bordo i quattro astronauti della missione Ax-2 di Axiom Space. Il giorno successivo la capsula ha attraccato alla Stazione spaziale internazionale (Iss), dove la comandante Peggy Whitson, ex astronauta Nasa ora passata ad Axiom Space, che detiene il record americano di permanenza in orbita, ha consegnato ai compagni una spilla dell’Association of Space Explorers, che distingue chiunque abbia orbitato attorno alla Terra. Il pilota e privato cittadino statunitense John Sho ner ha ricevuto la numero 598, lo specialista di missione Ali AlQarni la 599 e la sua collega Rayyanah Barnawi la 600, diventando la prima donna araba nello spazio.

AlQarni e Barnawi non hanno “pagato il biglietto” personalmente, perché sono sulla
Iss per lavoro: sono astronauti professionisti alla loro prima missione, pagata ad Axiom dall’agenzia spaziale dell’Arabia Saudita. Intanto, Axiom ha compiuto un altro passo verso il suo obiettivo a lungo termine: la realizzazione di una stazione spaziale privata
Nei prossimi anni verrà lanciato il primo modulo, che andrà ad attraccare alla Iss per usarne i sistemi di supporto vitale. Qui comincerà a essere utilizzato dagli astronauti Axiom. Dopo che altri moduli si saranno aggiunti al segmento di Axiom, questo diventerà autonomo e si staccherà dalla Iss per diventare una stazione indipendente.
D.L.
A COLLOQUIO CON
ROBERTO SCARAMELLA
SULLA MISSIONE
CHE INDAGHERÀ
LE ENIGMATICHE
MATERIA OSCURA
ED ENERGIA OSCURA
» A sinistra: Rendering di Euclid in assetto operativo. Uno schermo rivolto verso il Sole protegge la sonda, i cui strumenti si trovano sul fondo del tubo ottico. Alla base, una rappresentazione del cosmic web, il reticolo di gas e di materia oscura che costituisce la struttura portante dell’Universo.
Euclid è una missione di classe media che fa parte del programma Cosmic Vision dell’Agenzia spaziale europea (Esa). Il satellite è in partenza dalla base di Cape Canaveral dove si prevede il lancio nel corso del mese di luglio con un razzo Falcon 9 di SpaceX.
Il nuovo osservatorio spaziale è stato concepito per studiare con un’accuratezza senza precedenti la storia evolutiva dell’Universo nel corso degli ultimi dieci miliardi di anni e per tentare di rispondere ad alcune questioni di sica fondamentale e cosmologia sulla natura e proprietà dell’energia oscura e della materia oscura e sulla formazione delle strutture cosmiche.
Euclid osserverà miliardi di oggetti distribuiti su varie distanze cosmiche, coprendo un’area di cielo equivalente a più del 30% della sfera celeste
La missione durerà sei anni, durante i quali Euclid produrrà mezzo milione di immagini ottiche e infrarosse, centinaia di milioni di spettri e diverse decine di petabyte di dati.
L’Euclid Consortium (EC), che oggi comprende oltre 1500 scienziati di 14 nazioni europee e alcuni istituti canadesi, giapponesi e statunitensi (tramite la Nasa), ha inizialmente proposto la missione, ha costruito gli strumenti e si occuperà dalla riduzione dei dati e delle analisi scienti che iniziali. Cosmo ha raggiunto Roberto Scaramella, astronomo ordinario presso l’Osservatorio di Roma (Inaf), Euclid Survey Scientist e capo dell’Euclid Consortium Survey Group (Ecsurv).
Partendo dalla tesi di laurea all’Università La Sapienza di Roma e da quella di dottorato di ricerca alla Sissa di Trieste, mi sono sempre occupato di cosmologia. Verso il 2008 seppi dell’idea di colleghi francesi di proporre al loro Centro nazionale di studi spaziali (Cnes) una missione dedicata a misure di lenti gravitazionali deboli (weak lensing, WL), chiamata Dune (Dark Universe Explorer). Il WL misura la distorsione gravitazionale delle immagini di galassie distanti dovuta alle disomogeneità della materia interposta lungo la linea di vista. Questo allo scopo di determinare la distribuzione della materia oscura e la misura delle caratteristiche di crescita delle strutture cosmiche, per veri care l’esistenza dell’energia oscura o la presenza di deviazioni dagli e etti gravitazionali previsti dalla Relatività generale. L’idea era di fare una missione medio-piccola, guidata (e pagata per metà) dalla Francia, con l’aiuto di tre partner europei. Mi misi in contatto a riguardo e organizzai un primo incontro dei proponenti francesi con la comunità italiana dei molti


interessati per poi proporre all’Agenzia spaziale italiana (Asi) la partecipazione dell’Italia. In seguito, il Cnes scelse di fare un altro tipo di missione e si dovette cambiare contesto.
Successivamente, fu proposta all’Esa una versione più grande e complessa di Dune nell’ambito del programma

Cosmic Vision, riunendo parecchie nazioni europee con un principal investigator (PI) francese, A. Refregier
(Commissariat à l’énergie atomique), e un co-PI per ciascuna delle altre nazioni proponenti (il sottoscritto per l’Italia). All’Esa arrivarono una ventina di proposte diverse e in competizione tra loro, tra le quali una molto a ne come scopo scienti co, ma che usava un metodo diverso rispetto al WL, incentrato sulla spettroscopia a bassa dispersione. Questa proposta, chiamata Space (SPectroscopic All-sky

Cosmic Explorer), era inizialmente guidata da M. Robberto (Space Telescope Science Institute) e A. Cimatti (Università di Bologna) e poi dal solo Cimatti. Durante il periodo di selezione, si studiò la possibilità di unire Dune e Space in una unica missione, sfruttando le parti in comune tra i due strumenti. Da questa fusione, giudicata tecnicamente possibile e vantaggiosa, è nato Euclid. Il progetto fu selezionato per diventare la seconda missione di classe media del programma Cosmic Vision dell’Esa con approvazione nel 2012. La parte degli istituti scienti ci fu inizialmente guidata da A. Refregier e in seguito da Y. Mellier (Institute d’Astrophysique Paris), che coordina l’EC da oltre dieci anni.
Da allora c’è stato un grande lavoro che partendo dalla progettazione ha incluso la realizzazione e il test di tutte le componenti del satellite. L’Esa dirige la missione e fornisce tutto tranne gli strumenti e il segmento di analisi dati a terra. La costruzione della parte principale del satellite è stata a data alla liale italiana di ales Alenia Space a Torino, lo specchio e il modulo per il payload ad Airbus di Tolosa.

L’Asi, insieme a Inaf e Infn, ha guidato il team industriale che ha progettato e realizzato i contributi italiani agli strumenti, capeggiato da OHB Italia, in collaborazione con SAB Aerospace e Temis. La costruzione degli strumenti e la parte di analisi dati sono stati a dati all’EC, che oggi comprende tredici nazioni europee.

La Nasa è entrata a far parte della missione tramite la fornitura dei rivelatori infrarossi, mentre Canada e Giappone garantiranno la fornitura di dati ottenuti con telescopi da terra, complementari a quelli che si otterranno con le misure dallo spazio. Personalmente ricopro parecchi ruoli nella missione, alla quale lavoro da una dozzina di anni. Insieme a Cimatti rappresento l’Italia nel Board del Consorzio (le nazioni con i principali contributi hanno due membri, le altre uno). Sono, inoltre, membro dell’Euclid Science Team (Est) come survey scientist, mentre Cimatti è l’altro
membro italiano come esperto di spettroscopia.
Sempre per EC partecipo a diversi gruppi di lavoro. Il compito più gravoso è stato quello di survey scientist di EC e di leader del gruppo Ecsurv. Questo lavoro ha portato alla formulazione della survey per la missione, cioè a de nire tutti i puntamenti del satellite per l’intera durata della sua attività, nel rispetto dei numerosi vincoli tecnici e scienti ci, ottimizzandone la resa scienti ca.
Lo scopo della missione ha origine nella cosmologia, con la peculiarità di osservare dallo spazio una grandissima area di cielo: l’obiettivo è coprire oltre 14mila gradi quadrati della sfera celeste, l’area migliore per osservazioni extragalattiche, ottenendo dati in
quantità tali da ottenere risposte statisticamente signi cative. Nella survey ci si aspetta di avere dati per alcuni miliardi di galassie.
Dagli anni 30 del secolo scorso esiste il problema della materia oscura, cioè l’osservazione di fenomeni spiegabili con la presenza di massa gravitante che però non emette né assorbe luce. Dalla ne del secolo scorso, inoltre, è stata osservata la accelerazione dell’espansione dell’Universo. Questa accelerazione (oltre a far vincere il Premio Nobel ai suoi scopritori) ha fatto emergere la necessità di capire il meccanismo che causa questo fenomeno, al momento spiegabile tramite la presenza di una costante cosmologica, o con la presenza di un campo quantistico (energia oscura) o ancora modi cando le equazioni della relatività generale a grandissime distanze.
Adesso è cruciale fare il passo successivo rispetto alle misure geometriche, per esempio quelle della relazione luminosità-distanza relativa alle supernovae che hanno evidenziato l’accelerazione dell’espansione cosmica. Per questo scopo vanno fatte misure degli aspetti dinamici, ovvero del modo (e cienza e velocità) in cui si formano le strutture cosmiche (galassie, ammassi di galassie e lamenti) che crescono a partire dalle piccole uttuazioni di densità rivelate da misure del fondo cosmico di microonde (Cosmic Microwave Background), quando l’Universo aveva un’età di poco inferiore ai 400mila anni.
I processi di formazione delle strutture, infatti, cambiano a seconda delle equazioni di evoluzione dell’Universo. Quindi, utilizzando un insieme di dati signi cativo, si potrà discriminare
tra i vari modelli di evoluzione, selezionando quelli che forniscono come risultato una geometria ed evoluzione delle strutture compatibili con le osservazioni. In questo aspetto Euclid appare unico, potendo diminuire grandemente l’attuale incertezza sui parametri cruciali dei diversi modelli..
L’Italia è la seconda nazione, dopo la Francia, per i contributi alla costruzione del satellite e degli strumenti e per la partecipazione alle attività scienti che e del segmento di terra, con il lavoro di decine di scienziati e ingegneri. Gli anni-uomo di lavoro complessivo impiegati a oggi in EC da parte italiana ammontano a circa 720, eseguiti da circa 300 membri attivi.
Quindi, con il grande sostegno di Asi (B. Negri, responsabile del Volo umano e sperimentazione scienti ca, M. Salatti, program manager per strumenti Euclid ed E. Tommasi, program manager di Euclid) e poi di Inaf (Istituto nazionale di astro sica), di Infn (Istituto nazionale di sica nucleare, tramite L. Stanco) e di molte Università, l’Italia è molto impegnata e presente in tutti i campi: responsabilità del sistema di controllo, acquisizione ed elaborazione dei dati del fotometro-spettrometro infrarosso Nisp (partecipazione coordinata da L. Valenziano, Inaf-Oas); responsabilità dell’elettronica della camera per immagini nel visibile Vis (partecipazione coordinata da A. Di Giorgio, Inaf-Ifsi); responsabilità delle survey (coordinata da R. Scaramella, Inaf-Oar); responsabilità globale del
segmento di terra (coordinato da A. Zacchei, Inaf-Oats).
Il centro dati italiano è sotto la responsabilità di M. Frailis (Inaf-Oats) e le relative attività industriali sono state a date da Asi alla ditta Altec. L. Guzzo (Università di Milano) è uno dei quattro membri principali del gruppo di coordinamento scienti co. A questo si aggiungono importanti presenze nel coordinamento dei singoli gruppi scienti ci e del segmento di terra.
La peculiarità di Euclid è che le risposte ai grandi temi cosmologici vengono cercate tramite due metodi diversi e complementari.
Il primo metodo è la misura del raggruppamento delle galassie (clustering) tra i redshift 1 e 3, tramite spettroscopia nel vicino infrarosso. Il secondo è la misura delle caratteristiche del WL tramite tomogra a, cioè studiando il WL in “fette” di Universo a distanze crescenti, dove le distanze delle galassie (misurate dal loro redshift) sono stimate tramite bande fotometriche. Queste stime di redshift sono meno precise delle misure spettroscopiche, ma il metodo consente di studiare in modo complementare oggetti molto più deboli e numerosi di quelli per cui è possibile ottenere la spettroscopia.
Per il WL si usano le immagini di Euclid prese in una larga banda del visibile e per i photo-z si considerano le bande infrarosse di Euclid in combinazione con i dati ottici presi mediante telescopi da terra.
La complementarità dei metodi e del tipo di dati aiuterà a diminuire le
conseguenze di e etti sistematici sui risultati (biases), grazie alla diversità degli stessi presenti in entrambi i metodi utilizzati. Un grande problema di questo tipo di analisi statistiche, infatti, è dato dal controllare e mitigare la presenza di questi errori non casuali. Gli strumenti a bordo producono tre tipi di dati. Il Vis fornisce le immagini ottiche estremamente dettagliate (risoluzione con pixel di 0,1 secondi d’arco) necessarie all’analisi del WL. Il Nisp ha due modalità di operazione nel vicino infrarosso: lavora sia come imager (fotometria in tre bande per la stima dei redshift, con pixel di 0,3 secondi d’arco) che come spettroscopio senza fessura (slitless) a bassa risoluzione per la misura dei redshift tramite righe di emissione delle galassie. In ogni puntamento del satellite, entrambi gli strumenti osservano la stessa area di cielo, il Vis nel visibile e il Nisp nel vicino infrarosso.
Il satellite verrà situato nel punto lagrangiano L2 del sistema Sole-Terra, dove opererà per sei anni, ma questo periodo comprenderà anche i circa due anni necessari alle calibrazioni degli strumenti e all’osservazione di campi più profondi della wide survey, per la caratterizzazione statistica delle diverse sorgenti che saranno studiate e per l’individuazione di possibili e etti sistematici.
Le deep survey saranno eseguite su
*CORRADO RUSCICA
HA STUDIATO ASTRONOMIA
ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
E DI MILANO E GIORNALISMO
SCIENTIFICO ALL’UNIVERSITÀ
DI FERRARA, HA COLLABORATO
CON GIORNALI ON LINE
ED È AUTORE DI TESTI DI
DIVULGAZIONE ASTRONOMICA.
tre campi profondi (deep elds) pari a 53 gradi quadrati (20 per il campo North, 10 per il campo Fornax e 23 per il campo South) a una profondità limite di due magnitudini maggiore della wide survey. Verranno anche studiati alcuni campi ausiliari osservati dal telescopio spaziale Hubble. In ne, alcuni mesi saranno dedicati a osservazioni non inerenti lo scopo principale della missione. Questi campi profondi saranno unici nel panorama dell’infrarosso, per area e profondità, e sono stati scelti con l’intento di massimizzare i risultati scienti ci che possono essere ottenuti tramite altri strumenti spaziali e terrestri. Per esempio, per l’Euclid Deep Field South c’è già un accordo con il telescopio Vera Rubin (ancora in preparazione) per la copertura dello stesso campo a ussi ottici molto bassi, per massimizzare le sinergie dei due esperimenti. Tutti i dati che verranno man mano raccolti saranno resi pubblici per la comunità scienti ca in tre parti a intervalli regolari: prima
2500 gradi quadrati, poi altri 5000 e in ne la restante area osservata. Per motivi di stabilità termica, il satellite deve osservare rimanendo sempre quasi ortogonale al Sole, quindi in un dato giorno potrà osservare una striscia circolare di cielo. Le osservazioni saranno realizzate con il metodo step and stare, coprendo un’area di cielo di mezzo grado quadrato, poi puntando l’area adiacente e così via no a coprire un enorme mosaico sulla volta celeste.
COME COLLABORERÀ
EUCLID CON ALTRI
STRUMENTI TERRESTRI E SPAZIALI?
I dati fotometrici da terra sono necessari ai redshift fotometrici e per questo ci si avvale di dati esistenti, allo scambio di dati o a campagne osservative di centinaia di notti di osservazione fatte ad hoc per Euclid
In questo ambito ci sono la survey Union nel cielo nord, una survey del telescopio Subaru, la survey Des e
quelle che verranno fatte dal Vera Rubin, più il campo profondo Euclid Deep Field South.
I dati di Euclid saranno utili anche per osservazioni multifrequenza che vedono coinvolti gli strumenti radio Lofar, Alma, Meerkat+ e Ska per la banda radio, eRosita per la banda X e Planck per il fondo di radiazione cosmica.

Gli stessi dati aiuteranno per la scelta di oggetti da studiare in modo approfondito con il Jwst e l’E-elt (ancora in costruzione), per la ricerca di controparti di onde gravitazionali individuate dall’Einstein Telescope Così, diversi campi dell’astronomia bene ceranno dei dati di Euclid per decine di anni.
Lo scopo principale è studiare il modello standard cosmologico, per capire l’origine dell’accelerazione dell’espansione cosmica e per decidere se possiamo porre vincoli sulle proprietà della materia oscura e sulla massa dei neutrini. Inoltre, si vuole indagare l’isotropia dell’Universo, identi care eventuali oggetti cosmici peculiari e ricavare informazioni sui lamenti cosmici e sull’evoluzione delle galassie
A questi quesiti di carattere fondamentale si aggiungono innumerevoli temi astro sici (chiamati Legacy Science per distinguerli dai principali che caratterizzano la missione). In ne, c’è sempre da aspettarsi l’inaspettato, che magari potrebbe causare una crisi negli attuali modelli cosmologici, di portata tale da richiedere la de nizione di un nuovo modello di Universo.
PREZIOSA OPPORTUNITÀ PER TUTTI GLI AMANTI DELLO SPAZIO
CON COSMO N. 34


ESATTA REPLICA DELL’ORIGINALE REALIZZATA IN ALLUMINIO FORMATO 28X19,5 CM PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA MISSIONE

DISPONIBILE SU BFCSTORE.COM (bit.ly/41Fv5w4)

A 20,00 EURO (SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE)
Le notizie che provengono da Marte continuano a riempire le pagine delle news. Il rover cinese Zhurong, attivo dal maggio 2021 all’estremità meridionale di Utopia Planitia, ha trovato rocce che denunciano la presenza di acqua liquida nella zona equatoriale del pianeta un milione di anni fa. Non è la prima volta che sentiamo parlare di acqua su Marte, ma in genere viene trovata sotto forma di ghiaccio ad alte latitudini, dove la regione bianca in corrispondenza dei poli cambia dimensioni con le stagioni marziane, che sono lunghe il doppio delle nostre. In più, la sonda Mars Express dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ha rivelato la presenza di laghi sotterranei a un paio di chilometri di profondità in prossimità del Polo sud. In parallelo, il monitoraggio continuo della super cie del pianeta da parte delle sonde in orbita permette di vedere quando cambia qualcosa, così su diverse pareti scoscese sono stati scoperti coni di deiezione imputati ad acqua liquida che è zampillata fuori dalla super cie a seguito della fusione di ghiaccio sotterraneo e che è rapidamente
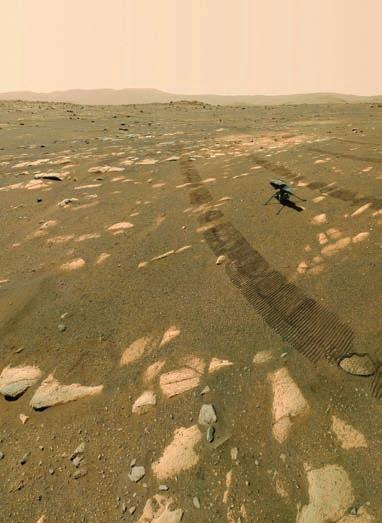
dilavata prima di evaporare a causa della bassissima pressione atmosferica del pianeta. Zhurong ha fatto anche un’indagine geologica sulla super cie delle dune, trovando croste e crepe nella sabbia compattata che mostrano la presenza di acqua salata. Potrebbe trattarsi di neve che si è fusa, nonostante le basse temperature, proprio grazie alla presenza di sali nella sabbia; l’acqua è poi evaporata, formando le strutture osservate. Dato che le dune hanno un’età tra 0,4 e 1,4 milioni di anni, si tratta di acqua “recente” a basse latitudini. Recentemente, i ri ettori sono stati puntati anche sulla piccola luna Deimos, le cui foto ad alta risoluzione, ottenute dalla sonda Hope degli Emirati Arabi, hanno rivelato una composizione molto simile a quella di Marte, dimostrando che è veramente “ glia” del Pianeta rosso (vedi l’articolo a pag. 42).
UN TESTIMONE D’ECCEZIONE
Continua a fare notizia Ingenuity, il piccolo elicottero sceso su Marte tutto ripiegato sotto il rover Perseverance nel febbraio 2021. Ingenuity
» Un selfie del rover Perseverance insieme con il drone-elicottero Ingenuity. Inquadra il QR per un video del volo n. 51 del drone marziano (22 aprile 2023).


doveva essere una prova tecnologica e ci si aspettava che avrebbe portato a termine cinque voli. Invece, le prestazioni del piccolo drone stanno superando ogni più rosea speranza e i suoi voli hanno già superato quota 50.

Intanto, Perseverance, dopo avere depositato in punti prestabiliti i tubi sigillati contenenti i campioni raccolti nora, ha ripreso una nuova campagna di ricerca e raccolta di altri campioni che dovranno aspettare una prossima missione per essere raccolti e portati sulla Terra. Non sarà facile, perché bisognerà disporre di un mezzo (rover o elicottero) che li recuperi e li introduca in un razzo che li porterà in orbita marziana, dove ci sarà una sonda ad aspettarli per intraprendere il viaggio di ritorno verso Terra.
Chi è interessato a questa missione (e non solo) può leggere Le s de di Marte. Storie di esplorazione di un pianeta di cile, un libro scritto da Paolo Ferri, di recente pubblicazione. Ferri è un esperto con una lunghissima carriera in Esa, che sa tutto sulle missioni marziane In questa sua opera racconta come si progettano le missioni e di come i piani originali a volte cambino per adattarsi ai problemi incontrati, alle nuove tecnologie o ai mutati assetti geopolitici.
Il lo conduttore del libro è l’attività svolta da Ferri all’Esoc (European Space Operations Center) dell’Esa, dove non vengono costruiti gli strumenti, ma ci si dedica alla progettazione del software necessario a farli funzionare e a evitare che si mettano nei guai, oltre a calcolare le traiettorie delle sonde. La storia inizia con il fallimento
del lancio dei quattro satelliti della missione Cluster, che ha spinto un giovane Ferri alquanto demoralizzato a lavorare sul segmento di terra della missione Rosetta diretta verso la cometa 67P/ChuryumovGerasimenko.
Quando l’Esa ha deciso di progettare
la sua prima missione planetaria alla volta di Marte, si è pensato di riutilizzare tutto quello che era stato fatto per Rosetta, così da contenere i costi e velocizzare i tempi. Perciò, quando si cercava un responsabile per il segmento di terra di Mars Express, è stato suggerito a Ferri


di fare domanda per la posizione. Inizialmente ha ri utato, per non abbondonare Rosetta che si stava avvicinando al lancio. Ma il razzo Ariane 5 ha avuto un malfunzionamento e il lancio della sonda cometaria è stato rimandato per indagare le cause. Così Rosetta è stata “superata” da Mars Express, mentre Ferri, ormai capo divisione, è diventato responsabile di entrambe le missioni.
Lanciata nel 2003, Mars Express si è rivelata una missione capricciosa, che spesso si blocca ed entra in safe mode, quando il software di bordo rivela qualcosa di insolito. Ogni volta
bisogna intervenire per farlo ripartire, ma la missione è arrivata a Marte ed è un grande e longevo successo, visto che dopo vent’anni è ancora in attività.
Nel frattempo, già si progettava un’altra missione marziana, ExoMars Ferri racconta come la missione sia stata divisa in due fasi, la prima con il Tgo (Trace Gas Orbiter, per cercare tracce di metano nell’atmosfera) e il modulo di discesa Schiaparelli; la seconda con un rover fornito di una trivella capace di perforare il suolo
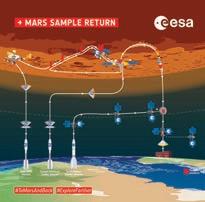
no a 2 metri di profondità. A questo punto, sono entrate in gioco vicende internazionali, con la Nasa che doveva essere partner, ma poi si è ritirata. Allora è stato negoziato un accordo con la Roscomos russa, che ha fornito i razzi Proton per il lancio e il modulo di atterraggio per il rover, insieme ad altri strumenti.
Il lancio dell’orbiter nel 2016 è stato fonte di molte preoccupazioni per Ferri (diventato capo del dipartimento delle operazioni), che temeva l’insu cienza dei test di preparazione. I timori si sono rivelati infondati e la sonda si è comporta bene, meglio di Mars Express. I problemi non sono mancati, ma sono stati brillantemente risolti. Prima della frenata per l’inserimento in orbita marziana, è stato rilasciato il lander Schiaparelli che doveva continuare da solo la sua traiettoria. L’arrivo a Marte è stato per Ferri un momento di cile, perché alle preoccupazioni per la buona riuscita delle manovre si sono sommate quelle personali, collegate al grave stato di salute del padre. Intanto, mentre l’orbiter non ha avuto problemi a inserirsi in orbita marziana, il lander purtroppo si è schiantato al suolo.
Proprio a Ferri, che aveva sempre avuto dubbi sulle possibilità di successo di Schiaparelli, è toccato il compito di dare informazioni alla stampa su questo insuccesso. Poi si è preparato a partire per l’Italia, ma purtroppo suo padre è mancato. Nel frattempo, il Tgo svolgeva alla perfezione le manovre di aerobraking, sfruttando la tenue atmosfera marziana per modi care l’orbita. Pur tenendo molto impegnato il gruppo di Esoc che lo seguiva, ha compiuto un lavoro egregio. A questo
punto, bisognava lavorare al rover che avrebbe dovuto essere lanciato nel 2018. Purtroppo, il programma non era pronto e si è rimandato il tutto alla nestra di lancio del 2020, che però è stata resa impraticabile dalla pandemia, che ha impedito
ai gruppi di lavoro di riunirsi per portare avanti il programma. Peccato, perché, per onorare il centenario della nascita di Rosalind Franklin, la celebre scienziata i cui lavori hanno contribuito alla scoperta della struttura del Dna, l’Esa aveva deciso di dedicarle il rover marziano. Ci si è quindi preparati per il 2022 (le nestre di lancio per Marte si aprono circa ogni due anni), e questa volta sembrava che tutto fosse pronto, ma la guerra in Ucraina ha fatto saltare i piani di lancio da Baikonur, insieme a tutta la collaborazione di Esa con Roscosmos. Un vero peccato, forse evitabile, visto che la Nasa ha continuato a collaborare con l’agenzia russa per la Stazione spaziale internazionale. Ferri, come tutti i “marziani europei”, ha cercato di correre ai ripari, ma ormai occorre riprogettare tutta la missione, il cui lancio è slittato (per ora) al 2028.
Nell’attesa che riparta ExoMars, Ferri sta seguendo il progetto Mars sample return, pensato per andare a recuperare dei campioni di suolo da Marte. È una s da che vede gli sforzi congiunti di Nasa ed Esa, ma anche in questo caso il progetto si è evoluto nel corso degli anni.
Le sfide di Marte. Storie di esplorazione di un pianeta di cile è un volume di Paolo Ferri edito nel 2023 a Milano da Ra

Composto da 280 pagine formato 14x 22,5 cm, è in vendita nelle librerie al prezzo di € 22,00. Leggi liberamente le prime 43 pagine del libro su Google books al link bit.ly/42PVqbx
Deciso, cancellato e poi reinventato, adesso intende realizzare il primo passo con la raccolta dei campioni da parte di Perseverance che ne ha depositati un certo numero, ma che continuerà a raccoglierne, con l’idea di consegnarli alla missione che scenderà su Marte per poi ripartire e trasferirli in orbita marziana alla sonda Esa responsabile per il ritorno a casa nel 2031. Un progetto complesso di cui ci auguriamo il funzionamento, perché è solo analizzando i campioni a terra che capiremo qualcosa di più sull’evoluzione del nostro vicino planetario.
Le s de di Marte è un libro ideale per apprezzare quanto sia complesso raggiungere il Pianeta rosso, ma anche per rendersi conto di come è organizzata l’Agenzia spaziale europea. Si capisce come le missioni vengono proposte e come vengono approvate, come nella realizzazione di hardware e software si debba sempre tenere conto delle pressioni degli stati membri, mentre si cerca di minimizzare i rischi, utilizzando tecnologie molto provate e sicure. Ferri fa notare come questo approccio sia diverso da quello delle agenzie private, che accettano maggiori rischi per essere più veloci. In fondo è tutta una questione di decidere quanti rischi si possono accettare. È anche questa una s da.
*PATRIZIA CARAVEO
È DIRIGENTE DI RICERCA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)
E LAVORA ALL’ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI MILANO.
Abbiamo dedicato molte pagine del numero di giugno di Cosmo all’altra metà dello spazio, a partire dalla celebrazione del sessantesimo anniversario del volo della prima donna spaziale, Valentina Tereshkova.
Recentemente questa metà è diventata un po’ più italiana, un altro sogno diventato realtà. Grazie a passione, ducia nei propri mezzi e caparbietà.
È l’unico modo per superare selezioni di cili, che vedono migliaia di candidati in corsa per pochi posti. È stato così anche per Anthea Comellini, classe 1992, di Chiari, in provincia di Brescia.
Ha superato 22.500 aspiranti astronauti, provenienti da tutta Europa. È passata attraverso sei fasi di test durissimi. Ed è stata selezionata dall’Agenzia spaziale europea, nell’ultimo team di astronauti europei presentati a Parigi lo scorso novembre. È una dei 17 nuovi astronauti europei (cinque in carriera, undici membri di riserva e un astronauta con disabilità) del prossimo futuro. Anthea è stata selezionata tra i membri di riserva, è l’unica donna italiana; oltre a lei, è stato selezionato anche Andrea Patassa (vedi Cosmo n. 39).
Abbiamo intervistato Anthea in collegamento da Cannes, dove c’è la sede francese di ales Alenia Space.
Non ancora, è presto. Prima o poi verremo integrati assieme al resto del Corpo astronauti Esa, inizialmente assieme ai cinque astronauti selezionati anche loro con la “classe 2022”, che hanno già iniziato il basic training per le prossime missioni.


CHE SIETE
LA GENERAZIONE DELLA LUNA…
In e etti, quando voleremo, i viaggi Terra-Luna dovrebbero svolgersi a un ritmo più o meno regolare; sarebbe meraviglioso partecipare a una missione lunare, ma al momento non ci penso troppo. Vi sono molti altri step da superare. Iniziare a integrarsi con gli astronauti, imparare ancora tante cose.
Sono cresciuta nell’era dei voli dello Space Shuttle, che tanto mi hanno appassionato. E poi ovviamente della Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma mi sono documentata molto sulle missioni Apollo, incredibili. Sarebbe fantastico vivere le esperienze di quegli astronauti. E poi la Luna

potrebbe essere la base intermedia per l’esplorazione dello spazio profondo, e quindi anche di Marte.
Sono ingegnere specializzato per i sistemi di guida, controllo e navigazione di satelliti. In particolare, per i sistemi automatici di rendezvous e aggancio tra satelliti e veicoli spaziali. Sono apparati molto simili a quelli che abbiamo utilizzato con il cargo Atv (Automated Transfer Vehicle), che per cinque volte ha raggiunto e agganciato la Iss. Mi occupo anche dei nuovi metodi per inviare nello spazio satelliti in grado di catturare quelli abbandonati che vagano in orbita bassa. Ce ne sono ormai troppi, e il metodo per non peggiorare la situazione è
progettare satelliti che già in fase di sviluppo siano predisposti alla dismissione. Se si tratta di satelliti in orbita geostazionaria, a 36mila chilometri dalla Terra, si usa un motore in grado di portarli a una quota più distante. Se si trovano in orbita bassa, devono essere raggiunti da satelliti dotati di meccanismi di aggancio, che li recuperano e li fanno deorbitare no a raggiungere gli strati atmosferici. Si possono deorbitare satelliti di qualsiasi dimensione. Quelli “grandi” devono essere deorbitati in modo da precipitare su una regione precisa dell’oceano Paci co, per minimizzare il rischio di collisione con cose e persone. Quelli piccoli, invece, bruciano interamente in atmosfera e quindi possono rientrare dovunque. Alcuni satelliti sono già in grado di e ettuare
il rientro in maniera autonoma, come il satellite Swot (Surface Water and Ocean Topography), di cui ales Alenia Space è prime contractor, lanciato a dicembre 2022. Mi occupo anche di rendez-vous spaziali per veicoli che richiedono un rifornimento in orbita o per il recupero di satelliti in panne. Un compito che anni fa era compito degli Space Shuttle, ma con le navette spaziali si era dimostrato troppo dispendioso e richiedeva l’intervento diretto degli astronauti. Anche se in molti casi era necessario, come per la manutenzione del telescopio spaziale Hubble, che ha richiesto cinque missioni di servicing. Con attività extraveicolari complesse e anche pericolose per gli stessi astronauti. Ora, grazie all’avvento di sistemi robotici, si potranno e ettuare queste attività a costi ridotti e senza esporre a rischi gli equipaggi umani.

Certamente! Ed è una delle ragioni per cui mi sono candidata e ora sono vicina a realizzare questo mio sogno, che coltivo sin da bambina. Superare le selezioni è stato bello, appassionante e s dante. Non sono partita con l’idea dover essere selezionata a tutti i costi. Molti test ti mettono davvero alla prova. E non è tutto, perché le centrifughe e i voli in zero-g fanno parte del training vero e proprio prima di una missione.
I test sono durati più di un anno. Durante la prima fase, siamo passati in circa 1300. Dovevamo superare test psicometrici: test della memoria, della velocità di percezione, della
coordinazione occhio-mano, per citarne alcuni. Siamo rimasti in circa 400, poi tutti a Colonia, al Centro di addestramento astronauti dell’Esa, per ulteriori test sulla personalità e psicologici e qui siamo scesi a un centinaio. Dopo ulteriori e complessi test psicologici, siamo rimasti in circa 50 per un colloquio classico di lavoro con personale dell’Esa. Obiettivo: valutare le motivazioni personali. Da qui siamo stati scelti in meno di 30 e abbiamo avuto un colloquio nale con il direttore generale. In ne, siamo stati selezionati in 17.
UN BREVETTO DI VOLO?
Non era obbligatorio. Chi già è pilota di professione lo aveva inserito nel proprio curriculum.
Io un brevetto di volo ce l’ho. L’ho preso in Francia dove mi sono trasferita già dal 2015 per ragioni di studio, e ho avuto l’opportunità di prenderlo quasi gratuitamente, grazie all’università francese Isae-SupAero.
A mie spese solo il carburante. Altra esperienza fantastica, volare è davvero meraviglioso.
IN COSA CONSISTE
LA SELEZIONE DEGLI ASTRONAUTI “DI RISERVA”?
È un metodo che l’Esa ha avviato per prepararsi al futuro. Le imprese spaziali saranno sempre più numerose e il corpo di riserva serve per essere “pronti” nel caso che si manifestino nuove opportunità di volo, cosa che non è così improbabile, soprattutto in questo clima di grande interesse per la ricerca in microgravità in orbita bassa e con l’avvento di “attori” commerciali. I “riservisti” non sono mai stati intesi come backup su una missione. Questo è un ruolo
*ANTONIO LO CAMPO
È UN GIORNALISTA SCIENTIFICO
FREELANCE SPECIALIZZATO
PER IL SETTORE AEROSPAZIALE
E COLLABORA CON QUOTIDIANI
E PERIODICI NAZIONALI. PER “COSMO” CURA LA SEZIONE SPAZIO.
assicurato da un astronauta della stessa classe che si sta addestrando nello stesso periodo. Quindi il concetto del riservista è quello di avere una scorta pronta per le nuove occasioni.

ARRIVI DAL BRESCIANO, DOVE STANNO NASCENDO STARTUP SPAZIALI.
COSA NE PENSI?
Sono aziende molto competitive, che realizzano progetti molto interessanti. Sia ales Alenia Space che l’Esa o rono molte belle opportunità per i giovani talenti; quindi, potrà esservi spazio per loro nelle grandi industrie e nelle agenzie. E le startup sono una nuova realtà che si a anca alle grandi industrie. E assieme alle medie e piccole imprese, creano un ecosistema ben funzionante, quello de nito ora come New space economy.

QUALI SONO STATE LE TUE MOTIVAZIONI, PER DIVENTARE INGEGNERE IN CAMPO SPAZIALE?
Non ci sono ambiti in cui una ragazza come me non può eccellere. Siamo in grado di fare tutto, se abbiamo la passione a motivarci. E le mie scelte sono state motivate dalla passione, ma anche per le loro implicazioni positive sulla società. Noi andiamo nello spazio per osservare la Terra, per conoscerla meglio, per monitorare il cambiamento climatico, l’atmosfera, per studiare come evolve l’ecosistema terrestre, per permettere teleassistenza a zone più remote. Grazie ai sistemi satellitari di osservazione, telecomunicazione e navigazione riusciamo a intervenire per situazioni di emergenza gravi, come i disastri naturali.
Anthea Comellini ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria spaziale al Politecnico di Milano nel 2017. Nello stesso anno ha conseguito il Diplôme d’Ingénieur nell’ambito di un programma di doppia laurea con la French Grande école of engineering Isae-SupAero di Tolosa, in Francia, e ha completato un master in Elaborazione di immagini e di segnali e controllo avanzato presso l’Università di Paris-Saclay, in Francia. Ha conseguito il dottorato in Navigazione autonoma per rendez-vous nello spazio presso Isae-SupAero in collaborazione con Thales Alenia Space a Cannes e Tolosa, in Francia, nel 2021. Durante il dottorato, ha trascorso sei mesi come ricercatrice in visita nel laboratorio di robotica mobile e sistemi autonomi del Polytechnique Montréal, in Canada. Dal 2021 al 2022 ha lavorato come Ingegnere delle dinamiche di volo per la determinazione dell’orbita nelle missioni interplanetarie con il Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc) dell’Esa a Darmstadt, in Germania, dove ha condotto operazioni di navigazione nello spazio profondo in missioni come BepiColombo, Gaia, Mars Express e Trace Gas Orbiter. Dal 2022, lavora come ingegnere Gnc (Guidance, Navigation, and Control) e Aocs (Attitude and Orbit Control System) nel reparto di Ricerca e sviluppo di Thales Alenia Space a
in Francia (figura).
DA ESPERTA
DI RENDEZ-VOUS SPAZIALI, SAI DELLA STORIA
DI “MISTER RENDEZ-VOUS”?
Sì, è il mitico Buzz Aldrin, pilota del modulo lunare dell’Apollo 11. Parlava continuamente di rendez-vous
e di agganci nello spazio, già materia della sua tesi di laurea e poi di specializzazione durante l’inizio della sua carriera alla Nasa.
Spero che il fatto di essere una Miss Rendez-vous mi porti realmente fortuna, come è capitato a Buzz.

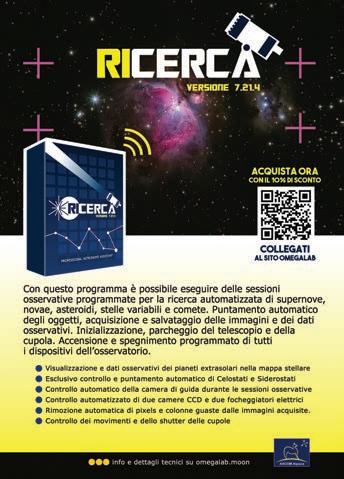
EXTRATERRESTRI RICHIEDONO NUOVE ATTENZIONI
E COMPETENZE IN CAMPO MEDICO
Con il procedere del Programma Artemis e gli ambiziosi obiettivi di colonizzazione delle aree più prossime del Sistema solare, alla biomedicina spaziale è richiesta un’accelerazione signi cativa, per aumentare le competenze sia pratiche che teoriche. In questo ambito si inserisce il cammino dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) nel settore delle scienze della vita, che ha compiuto un passo importante nello scorso mese di marzo con un workshop svolto presso la sede dell’Asi, dal titolo: “Biomedicina spaziale per le future missioni di esplorazione umana dello spazio: a call to action”.
Al centro di questo interesse vi è la Stazione spaziale internazionale, un laboratorio unico che no al 2030 consentirà di sperimentare le contromisure alle problematiche della permanenza spaziale senza ricorrere ai cosiddetti “analoghi terrestri”. Per il nostro Paese sarà necessario sfruttare al massimo questa risorsa, cosa che Asi già si sta apprestando a fare grazie a un bando dedicato. La visione di medio
termine vede nella Luna il necessario passaggio intermedio. Le di coltà della missione appaiono evidenti: occorrerà sviluppare sistemi biorigenerativi per conservare l’habitat umano, sistemi di radioprotezione sia per gli equipaggi umani sia per le apparecchiature elettroniche, ma soprattutto sarà necessario compiere grandi passi avanti nella biomedicina spaziale. La stessa gura dell’astronauta cambierà, come detto da Roberto Vittori nel suo intervento di chiusura del workshop: si passerà da piloti di provenienza aeronautica a squadre di specialisti in diversi settori, le cui abilità saranno necessarie sulla super cie lunare. Sarà quindi richiesto di gestire vari domini d’intervento, e la biomedicina spaziale dovrà adattarsi ad a rontare nuove s de. Da un lato, ci sarà personale sulla super cie lunare prima, e marziana poi, che dovrà a rontare la di coltà della vita su altri corpi celesti. Marte, per esempio ha livelli di radiazioni settecento volte maggiori rispetto alla Terra, una temperatura che oscilla tra -140 °C e i 20 °C, con un’atmosfera irrespirabile e una gravità uguale al 38% di quella terrestre. Dall’altro lato ci sarà personale che potrà restare
in orbita per un tempo maggiore di quanto accaduto nora, spesso lontano dalla protezione o erta dal campo magnetico terrestre. In questo scenario, la medicina diventerà un supporto fondamentale.
Negli ultimi decenni la medicina spaziale non si è evoluta con la stessa velocità delle altre discipline spaziali. Molti aspetti dell’adattamento allo spazio sono ancora il frutto di inferenze e ettuate sulla base di studi condotti in analoghi terrestri che, per quanto ben eseguiti, non possono sostituire la sperimentazione sul campo. Anche la di coltà di condurre studi sugli animali nello spazio ha contribuito a rallentare la crescita delle conoscenze nel settore della siologia dell’adattamento spaziale, ma sarà necessario a rontare questo settore di studi con progetti ambiziosi per preparare adeguatamente le future missioni. Dal punto di vista strategico, questo tipo di ricerca diventerà un asset importante per il paese che riuscirà per primo a de nire i protocolli migliori di permanenza nello spazio e le contromisure più e caci.
È ancora molto quello che non sappiamo; per esempio, se la vita possa essere concepita nello spazio, se una gravidanza possa essere portata a termine, se può avvenire una nascita e come si può sviluppare un essere umano nello spazio.
L’uso di modelli animali sarà necessario per preparare adeguatamente gli equipaggi umani: la costruzione di uno stabulario spaziale per poter ottenere e studiare specie native dello spazio potrà fornire una marcia in più al Paese che per primo lo svilupperà. Asi si sta già interessando al problema, per esempio con il progetto Ovospace, presentato al workshop da Valeria Fedeli, condotto dall’Agenzia in collaborazione con il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università di Roma La Sapienza ed eseguito in volo da Samantha Cristoforetti, che si propone di studiare l’adattamento delle cellule ovariche alle condizioni di microgravità.
Ora che Asi ha provveduto al rinnovo delle sue cariche apicali, inclusa la presidenza, ci auguriamo che il ruolo delle scienze della vita spaziali possa essere potenziato nei programmi di ricerca dell’Agenzia. La comunità scienti ca ha risposto con entusiasmo alla chiamata di Asi e sarebbe un peccato se questa forza propulsiva venisse meno. Molte sono le azioni che si possono intraprendere per sostenere questo rinato a ato: per esempio, sarebbe opportuna la formazione di una società scienti ca dedicata alla biomedicina spaziale, che possa essere casa di tutti i ricercatori italiani del settore; oppure, con più ambizione, si potrebbe pensare a un Istituto nazionale di biomedicina spaziale che possa avere le adeguate risorse e possibilità per diventare una frontiera della ricerca nel settore. Un modello simile a quello dell’Istituto italiano di tecnologia potrebbe essere una soluzione adeguata.

Anche la didattica non andrebbe trascurata, promuovendo la nascita di master di medicina spaziale. La leadership nella corsa allo spazio vede oggi la Cina in grande accelerazione, mentre gli Stati Uniti sembrano volersi a dare alle imprese private per cercare di difendere il proprio primato. In questo scenario, l’acquisizione di un posto in prima la nel settore della biomedicina spaziale da parte del nostro Paese ci permetterebbe di conservare un ruolo signi cativo nella corsa alle risorse che lo spazio porterà, sia in termini di tecnologia, sia in termini di risorse. Il futuro della tecnologia si costruisce con il presente della scienza.

Nel volgere di pochi anni è profondamente cambiata la visione del Gruppo Locale di galassie a cui appartiene anche la Via Lattea. È apparso sempre più evidente che il nostro quartiere cosmico è tutt’altro che un semplice aggregato di galassie circondate da satelliti, ma è invece un ambiente molto dinamico e in continua evoluzione. Sempre più consistenti sono emerse le tracce di antiche fusioni con altre galassie, sia per la galassia di Andromeda (M31) sia per la Via Lattea, e gli indizi delle interazioni reciproche tra le due grandi galassie. Invece, la piccola galassia spirale del Triangolo (M33) sembra che stia entrando per la prima volta nel Gruppo Locale; quindi, non avrebbe mai interagito con M31, contrariamente a quanto si riteneva in passato. Altrettanto le due Nubi di Magellano, alle quali ci si riferisce spesso come satelliti della Via Lattea, sembrano siano al primo arrivo nel nostro ambiente galattico e non avrebbero ancora completato neanche un’orbita.
Le Nubi di Magellano non sono solo degli oggetti spettacolari da osservare nel cielo australe; sono anche interessanti per gli studiosi, perché abbastanza inconsueti nella struttura dei gruppi di galassie. Solo una piccola frazione tra le galassie simili alla Via Lattea possiede due compagne così massicce. La coppia di piccole galassie è anche colta in un momento storico particolare, poiché ha superato in tempi relativamente recenti il pericentro dell’orbita galattica (il punto più vicino al nucleo della Via Lattea) e pertanto risultano ben visibili le conseguenze di tale passaggio. Lo stato delle conoscenze delle nostre due vicine galattiche è stato recentemente sottoposto a una corposa revisione da parte di Eugene Vasiliev dell’Institute of Astronomy di Cambridge. Prima di entrare nella regione d’in uenza della Via Lattea, la Grande Nube di Magellano (LMC) era una discreta galassia spirale barrata. Gli e etti mareali hanno distorto i

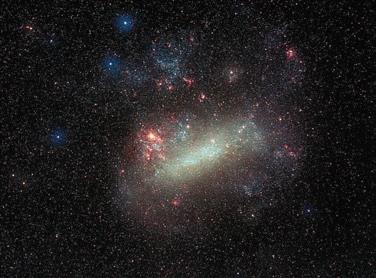
suoi bracci e risucchiato materia che è andata a formare un lungo usso di gas, detto Corrente Magellanica (Magellanic Stream).
Della galassia originaria rimangono la barra centrale e un cenno di bracci. Le conseguenze dinamiche
dell’incontro con la Via Lattea sono ben rilevabili nei dati osservativi, come evidenti perturbazioni nelle popolazioni stellari e nella distribuzione delle nubi di gas. Alcune di queste perturbazioni sono registrabili anche con mezzi
amatoriali, grazie a fotogra e “profonde”, eseguite con normali teleobiettivi. Gli e etti delle perturbazioni sono stati monitorati con precisone analizzando i dati ottenuti dal satellite astrometrico Gaia dell’Agenzia spaziale europea.

L’altissima qualità raggiunta da questi dati ha permesso di ricostruire in 3D l’alone galattico e rilevare così gli e etti dell’interazione con la LMC, che ha una massa compresa tra il 10 e 20 per cento della Via Lattea. Gli e etti più poderosi dell’incontro sono più evidenti lungo la congiungente tra la LMC e la Via Lattea e meno nel disco della nostra Galassia. L’alone galattico ha subito invece una netta deformazione e altrettanto l’alone di materia oscura che circonda la Via Lattea. Gli e etti dell’incontro sono ben visibili sulla LMC e sulla SMC, mentre sono meno evidenti
sulla nostra Galassia, poiché il nostro punto di vista interno al disco galattico non ne favorisce l’osservazione. Nonostante il perfezionamento delle misure, permane ancora molta incertezza sul periodo orbitale della LMC e nella distanza dell’apocentro. Tale incertezza è in gran parte dovuta al fatto che l’orbita della LMC è appena marginalmente legata alla Via Lattea. Anzi, secondo alcuni modelli, entrambe le Nubi, dopo aver raggiunto la minima distanza, si allontaneranno inde nitamente, compiendo in pratica solo un y-by della Via Lattea.
Tali destini dipendono fortemente dalla massa della nostra Galassia e da come è distribuita. Gli indizi a favore dello scenario di un primo passaggio sono però meno forti ora di quanto non fossero 15 anni fa, poiché la velocità tangenziale della LMC sembra leggermente più bassa di quanto misurato in precedenza e forse su ciente da ritenere la Grande Nube catturata in un’orbita allungata, con periodo maggiore di cinque miliardi di anni. Se la Via Lattea fosse più massiccia di quanto è oggi stimato, la LMC si troverebbe attualmente al suo secondo passaggio al pericentro.
Le simulazioni indicano che entro circa 100mila anni luce dal centro della Via Lattea (dove risiede il buco nero supermassiccio Sagittarius A*) gli e etti delle perturbazioni causate delle Nubi di Magellano non sono evidenti. Invece, le stelle e il gas presenti nell’alone galattico subiscono perturbazioni abbastanza intense da modi care le forme e le cinematiche di queste regioni.
L’attrazione della Via Lattea sulla Grande Nube ha come prima conseguenza una riduzione del suo periodo orbitale. Perfezionare la conoscenza dell’orbita passata del grande compagno galattico servirà per conoscere quella futura e il suo destino. Le simulazioni dovranno riprodurre la situazione attuale con accuratezza elevata per poter formulare previsioni sulla evoluzione futura, un obiettivo molto di cile da ottenere. Simulazioni più accurate potranno avvalersi nel prossimo futuro di dati migliori sui traccianti cinematici nell’alone che potranno

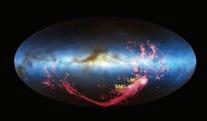
Le Nubi di Magellano sono due piccole galassie irregolari, attuali compagne della Via Lattea. Sono visibili a occhio nudo nel cielo notturno dell’emisfero sud, e prendono il nome dal navigatore Ferdinando Magellano, poiché furono descritte nel resoconto della spedizione da lui guidata, pubblicato nel 1524.
La Grande Nube (Large Magellanic Cloud, LMC) si osserva nelle costellazioni australi del Dorado e della Mensa, dista circa 157mila anni luce e si estende per 14 mila anni luce. La Piccola Nube di Magellano (Small Magellanic Cloud, SMC), situata 20° più a ovest, nella costellazione del Tucano, dista circa 197mila anni luce e si estende per 2900 anni luce.
Entrambe le galassie sono collegate fra di loro e con la Via Lattea da un lungo ponte di idrogeno neutro e stelle, la Corrente Magellanica; un secondo flusso di materia, il Ponte Magellanico, collega le due Nubi.
La Grande Nube ospita la più grande nebulosa di usa del Gruppo Locale, la Nebulosa Tarantola, in cui è in atto una intensa attività di formazione stellare, oltre a ospitare il resto della supernova SN 1987a, la più vicina osservata negli ultimi 300 anni. Per gli aggiornamenti sulle Grandi Nubi, vedi il sito Bfcspace.com (scrivi Magellano nella finestra di ricerca).
essere rivelati da apposite surveys astrometriche.
Molto probabilmente, le due Nubi di Magellano continueranno a orbitare attorno alla Via Lattea, no a fondersi con essa entro un paio di miliardi di anni. Queste fusioni produrranno dei cambiamenti importanti nelle caratteristiche della Via Lattea, come il consistente aumento di massa dell’alone stellare e della sua metallicità, ovvero l’abbondanza di elementi pesanti.


La fusione con le Nubi di Magellano sarà il preludio all’incontro più importante con l’altra grande galassia del Gruppo Locale, cioè M31, che avverrà tra circa quattro miliardi di anni. Gli e etti dell’avvicinamento, tuttavia, cominceranno a essere percepibili ben prima, con la creazione di ussi di marea tra i due oggetti. Anzi, secondo alcuni studi, queste interazioni sono (molto debolmente) già iniziate. Non sarà comunque uno scontro diretto. ma un balletto cosmico, che porterà le due galassie a fondersi in una sola grande galassia tra 6-7 miliardi di anni, quando la nostra stella e il nostro pianeta saranno un lontano ricordo. Ma il nome è già pronto: da Milky Way (Via Lattea) e Andromeda deriverà Milkomeda. Le intelligenze che ci saranno (se ci saranno) si godranno lo spettacolo.
*GIUSEPPE DONATIELLO RESPONSABILE DELLA SEZIONE PROFONDO CIELO/UAI, È ATTIVO NELLO STUDIO DEI FLUSSI STELLARI IN GRUPPI RICERCA INTERNAZIONALI. HA SCOPERTO SEI GALASSIE NANE VICINE, QUATTRO DELLE QUALI PORTANO IL SUO NOME.

Asaph Hall nacque nel 1829 ad Annapolis, nel Connecticut, ma rimase orfano di padre a soli 13 anni e fu costretto a lavorare come garzone in una falegnameria per mantenersi agli studi. Riuscì comunque a iscriversi al New York Central College di McGrawville, per intraprendere i suoi studi preferiti, quelli di matematica.
E in quel College prese ripetizioni dall’insegnante tedesca Angeline Stickney (1830-1892), quasi sua coetanea. La comune passione per la matematica li avvicinò al punto che si sposarono nel 1856.
Angelina rinunciò alla sua carriera accademica, cercando però di aiutare quella del marito. Fu lei a contattare J. Gills, capitano della marina americana, per convincerlo ad assumere Asaph come assistente astronomo presso il Naval Observatory (Usno) di Washington. Un anno dopo, nel 1863, Asaph fu nominato
professore e nel 1875 ricevette la responsabilità del telescopio dell’Usno da 66 cm, che all’epoca era il più grande rifrattore del mondo.
Con questo strumento, in occasione della grande opposizione di Marte del 1877, Hall si dedicò a un suo sogno: quello di rintracciare satelliti attorno a Marte, una ricerca nella quale avevano fallito molti suoi più famosi colleghi.
La scoperta dei satelliti avvenne tra il 10 e il 17 agosto 1877 e importante fu il contributo della moglie Angeline. Nonostante condizioni atmosferiche pessime, il 10 agosto Asaph aveva intravisto un piccolo oggetto di magnitudine 12,8 a 1,8 secondi d’arco dal pianeta. Decise di tentare una riconferma la notte successiva, ma il tempo inclemente stava per fargli abbandonare le osservazioni.

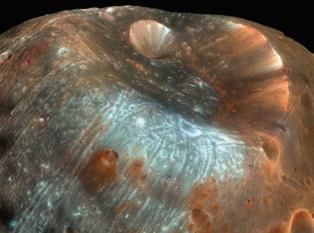

Angeline però lo convinse a insistere, nella speranza di una schiarita. Che arrivò alle 2.30 di notte, permettendo ad Hall di individuare il satellite poco a nord di Marte. Per la conferma si dovette attendere no al 16 agosto, quando fu chiaro che il piccolo oggetto, che poi sarebbe stato chiamato Deimos, era davvero un satellite, che si muoveva assieme a Marte. Ulteriori osservazioni nella notte seguente portarono alla scoperta di un secondo satellite più interno,
poi chiamato Phobos (mag. 11,6 a 24,6 secondi d’arco dal pianeta). I nomi delle due lune furono proposti dal chimico inglese Henry Madan (1838–1901), e richiamano quelli dei gli di Ares, Phobos (“paura”) e Deimos (“terrore”), che secondo la mitologia greca accompagnavano in battaglia il dio della guerra, l’equivalente greco del dio romano Marte. Nei decenni successivi, lo stesso rifrattore dell’Usno e il rifrattore Lick da 91,4 cm condussero
importanti campagne per de nire i parametri orbitali dei due satelliti. Entrambi rivoluzionano sincroni e diretti sul piano equatoriale di Marte: Deimos in 30 ore alla distanza di 23.460 km e Phobos in 7,65 ore a 9375 km. Phobos è pericolosamente prossimo all’atmosfera marziana, che per attrito ne fa decadere lentamente l’orbita; in circa 50 milioni di anni raggiungerà il limite di Roche di 5400 km e questo sarà l’inizio della sua distruzione mareale, con la probabile formazione di un anello di detriti attorno a Marte. Ulteriori piccoli satelliti di dimensioni superiori a 100 metri sono stati cercati ed esclusi dal telescopio spaziale Hubble nei primi anni 2000.

Per determinare le dimensioni e le caratteristiche morfologiche e geologiche dei due satelliti, è stato necessario aspettare i sorvoli ravvicinati da parte di sonde spaziali. Il Viking 1 scrutò Phobos da 80 km all’inizio di febbraio 1977, mentre Mars Express è passato a 45 km il 29 dicembre 2013. Deimos venne s orato dal Viking 2 da 30 km il 15 ottobre 1977. Questi passaggi hanno permesso di de nire le loro dimensioni: 26,8 × 22,4 × 18,4 km per Phobos e 15 × 12,2 × 10,4 km per Deimos.
Dalle latitudini equatoriali della super cie di Marte, Phobos allo zenit presenta un diametro angolare di 12,3’ (un terzo della nostra Luna) e una magnitudine apparente pari a -3,9. Deimos presenta un diametro di circa 2’ e una magnitudine massima pari a -0,1. Siccome il diametro angolare del Sole visto da Marte è di circa 21’, non possono veri carsi
eclissi totali di Sole sul Pianeta rosso. Dall’equatore è però possibile osservare veloci transiti di Phobos quasi ogni giorno (durata di circa 30 secondi).
Deimos, invece, transita sul disco solare in media una volta al mese, in circa 1,5 minuti.
I yby spaziali stretti hanno fornito anche la massa e l’albedo dei satelliti marziani. La massa, dedotta dalle perturbazioni orbitali delle navicelle coinvolte, ha permesso di risalire alle rispettive densità, che sono risultate molto basse: 1,87 g/cm3 per Phobos e 1,47 g/cm3 per Deimos. Molto bassa è anche, per entrambi, l’albedo (circa 0,07), dovuta a un colore super ciale molto scuro.
Densità e albedo così bassi sono tipici degli asteroidi di tipo C e D e questo ha fatto pensare che i satelliti di Marte fossero asteroidi catturati dalla Fascia principale. Ma la bassa densità potrebbe anche indicare una struttura interna ricca di zone vuote, tipica degli oggetti rubble pile (“mucchio di sassi”): potrebbe allora trattarsi di aggregazioni in orbita marziana di frammenti prima dispersi, provenienti da un grosso impatto avvenuto sulla super cie di Marte. Un indizio di questa struttura sono i molti impatti che Phobos è riuscito a sopportare senza disgregarsi: un centinaio di crateri più larghi di 1 km e addirittura uno di ben 8 km, che è stato dedicato alla moglie di Hall.

In de nitiva, sono asteroidi catturati o “ gli” violenti del Pianeta rosso? Per distinguere tra le due possibilità, occorrono indagini spettroscopiche molto ra nate, come quelle e ettuate solo di recente, grazie alla missione Emm (Emirates Mars Mission) svolta dall’orbiter marziano Hope, lanciato il 19 luglio 2020 ed entrato il 9 febbraio 2021 in un’orbita marziana di 20mila x 43mila km, percorsa in 55 ore.
I risultati di questa missione sono stati presentati al recente congresso internazionale Egu 2023 a Vienna. Una delle informazioni più interessanti riguarda le prime analisi
spettroscopiche ad alta risoluzione di Deimos, che ne dimostrerebbero un’origine “marziana”.
Gli strumenti principali di Hope sono la camera multispettrale Exi (Emirates eXprolation Imager, UV 245-275 nm, UV 305-335 nm, Vis 400-625 nm), lo spettrometro infrarosso Emirs (Emirates Mars Infrared Spectrometer, 6-100 micron) e lo spettrometro ultravioletto Emus (Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer, 100-170 nm).
La missione primaria di Hope si è conclusa a febbraio 2023, dopo un anno (marziano) di osservazioni atmosferiche e climatiche, con a bordo ancora una buona riserva di combustibile. La somiglianza tra la distanza orbitale di Deimos e il perigeo marziano di Hope ha suggerito di tentare un avvicinamento spinto con Deimos, in particolare con l’emisfero illuminato opposto

a Marte, inaccessibile alla maggior parte delle altre missioni marziane. Così, a partire da agosto 2022, sono state e ettuate delle correzioni orbitali che hanno portato Hope a s orare Deimos il 10 marzo 2023 da soli 107 km.
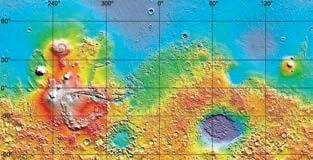
La camera Exi ha realizzato spettacolari riprese dell’emisfero di Deimos opposto a Marte con una risoluzione di 10 metri, mentre la camera Emirs, osservando tra 7 e 50 micron, ha rivelato una composizione molto simile tra Deimos e Phobos, di natura fondamentalmente basaltica. È stato strategico il risultato dello spettrometro Emus nell’UV lontano, dove Deimos ha mostrato uno spettro indistinguibile da quello dalla luce solare ri essa, quindi praticamente piatto. Se Deimos fosse un asteroide di tipo D (sono corpi scuri, ricchi di materiali carboniosi e provenienti forse dalla fascia di Kuiper), lo spettro
nel lontano UV dovrebbe presentare assorbimenti importanti al di sotto dei 200 nm.
I satelliti di Marte, quindi, sarebbero costituiti da materiale basaltico marziano riassemblatosi in orbita dopo un violento impatto, cosa che giusti cherebbe anche la loro bassa densità. Forse c’è un collegamento con il grande impatto primordiale che avrebbe colpito l’emisfero nord di Marte, creando l’infossatura della Vastitas Borealis, successivamente riempita dall’antico oceano boreale.

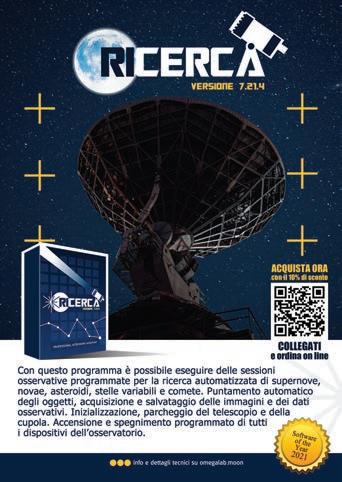
Le colonie lunari diventeranno presto realtà e si dovrà pensare ad attività sportive per tenere in forma i coloni. Non sarà comunque una novità, perché c’è un precedente illustre. Il 6 febbraio 1971 Alan Shepard, comandante della missione Apollo 14, oltre a detenere già il titolo di primo astronauta statunitense, conquistò un nuovo record: fu il primo sportivo a esibirsi con la mazza da golf sulla Luna.
Poco prima di abbandonare il satellite terrestre, al termine di una faticosa raccolta di rocce lunari, Shepard estrasse da una tasca della tuta la testa di una mazza da golf numero sei (il “ferro” solitamente impiegato per coprire medie distanze) e la ssò all’estremità di un’asta pieghevole destinata al prelievo di campioni rocciosi.
Subito dopo tirò fuori una pallina e la lasciò cadere al suolo iniziando a oscillare l’improvvisata mazza da golf,
impugnata con una sola mano perché gli ingombranti guanti impedivano di usarla normalmente, ma il colpo così sferrato sollevò soltanto molta polvere e l’ironia del collega Edgar Mitchell che si era fermato a guardarlo. Poco o nulla scoraggiato da quell’iniziale fallimento, prelevò dalla tasca un’altra pallina e riprese il movimento oscillatorio, il cosiddetto swing, con maggiore convinzione. Questa volta il colpo andò a segno e in assenza di aria, con una forza di gravità molto inferiore rispetto a quella terrestre, la vanagloria dello sportivo prese il sopravvento, portandolo a esclamare “miglia e miglia e miglia” mentre osservava il lento volo della pallina.
L’astro sico americano Ethan Siegel, esperto giocatore di golf, calcolò che nelle migliori condizioni una pallina sulla Luna si potrebbe lanciare a quasi quattro chilometri di distanza, con un tempo di volo superiore al minuto. Usando una mano sola e con poca precisione, come ammise molti anni dopo lo stesso Shepard in una intervista, la pallina volò per
poche centinaia di metri prima di toccare il suolo vicino ad altri oggetti abbandonati poi sulla Luna.
L’idea di andare a giocare a golf sulla Luna, tutt’altro che improvvisata, prese forma diversi mesi prima, quando Bob Hope visitò il quartiere generale della Nasa a Houston, per preparare una trasmissione televisiva che avrebbe coinvolto anche alcuni astronauti, e in quella occasione il comico era stato legato a un dispositivo che simulava la minore gravità lunare.
Hope portava sempre con sé una mazza da golf e guardandolo Shepard si rese conto che il modo migliore di divulgare le singolari condizioni di minore gravità presenti sul satellite terrestre, in modo da raggiungere una platea molto vasta, consisteva nel mostrare il volo di una pallina da golf. Così l’astronauta chiese per tempo a un artigiano locale di creare la testa in alluminio della mazza da golf, quindi la portò alla divisione servizi tecnici della Nasa per adattarla all’asta
» In senso orario: l’equipaggio della missione lunare Apollo 14 (31 gennaio - 9 febbraio 1971): da sinistra Edgar Mitchell (pilota del modulo lunare), Alan Shepard (comandante), e Stuart Roosa (pilota del modulo di comando).

Alan Shepard assembla alcuni attrezzi impiegati sulla Luna. Inquadra il QR per il video originale della sua impresa sportiva extraterrestre.


L’astronauta Alan Shepard (1923-1998) fotografato nel 1996 con la mazza da golf pieghevole usata per giocare sulla Luna.

pieghevole destinata alla raccolta dei campioni di rocce lunari. L’attrezzatura sportiva salì a bordo con discrezione e il consenso dell’ingegnere Robert Gilruth, primo direttore del Manned Spacecraft Center della Nasa, convinto solo dopo molta insistenza da parte di Shepard: il fallimento e la tragedia s orata con l’Apollo 13 avevano portato a livelli molto bassi il senso dell’umorismo all’interno dell’Agenzia. Le condizioni concordate prevedevano che l’esibizione fuori programma doveva svolgersi solo al termine della seconda e ultima escursione, ma a condizione che ogni altro aspetto della missione si fosse concluso con successo.
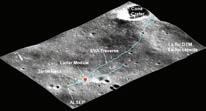
Il peso del “ferro 6” e delle palline rientrava nelle 5 libbre (2,27 kg) di equipaggiamento personale consentito a ogni astronauta nel modulo di comando e nella mezza libbra ciascuno che Shepard e Mitchell potevano portare nel modulo lunare Antares.
LE SETTE VITE DI SHEPARD
Risolti chirurgicamente nel 1968 i problemi all’orecchio interno che lo avevano reso inidoneo al volo, Shepard aveva lasciato l’incarico a lungo ricoperto di Comandante dell’U cio Astronauti per assumere, all’età di 47 anni, la guida della terza missione di allunaggio umano. La passeggiata del secondo giorno fu dedicata a raggiungere il bordo del Cone Crater, principale obiettivo scienti co della missione, dove raccogliere campioni di rocce espulse da un antico vulcano. Spingendo un carrello pieno di attrezzi, i due astronauti a rontarono il chilometro circa che li separava dalla meta, aiutandosi lungo la strada con i riferimenti - grandi massi e piccoli crateri - memorizzati studiando le mappe fotogra che dell’area. Avvicinandosi al punto stabilito, però, il pendio diventava sempre più ripido, come rivelava anche il monitoraggio dei parametri vitali di Shepard: quando il suo cuore raggiunse i 140 battiti al minuto,
i medici della Nasa gli intimarono di riprendere ato e procedere alla raccolta dei campioni senza andare oltre. La discesa fu più agevole e quando raggiunsero il modulo lunare, i due astronauti sistemarono le rocce raccolte negli appositi compartimenti per tornare da Stuart Roosa, che era rimasto ad aspettarli in orbita sul modulo di comando. Poco prima di salire la scaletta, però, Shepard allestì rapidamente l’esibizione a lungo piani cata: regolò la telecamera per assicurarsi di essere inquadrato; quindi, raggiunse l’improvvisata piazzola di partenza e tirò fuori dalle tasche tutto il necessario. Sorprendendo anche il compagno Mitchell, che era all’oscuro delle sue intenzioni, avvertì i controllori della missione a Houston che si apprestava a tentare il colpo detto “trappola di sabbia”, quello che si esegue quando la pallina nisce in un avvallamento privo di erba. Pochi minuti dopo, grazie a pochi tiri piuttosto approssimativi, il suo nome entrò nella storia del golf. Nel 1976 il cantante Bing Crosby convinse Shepard a donare la sua singolare mazza al Golf Association Museum del New Jersey; mentre quella conservata al Museo Nazionale dell’Aria e dello Spazio di Washington, invece, è una replica dell’originale. Giocando a golf sulla Luna, Shepard aveva apposto un “marchio” molto personale alla missione e ancora oggi rivela la sorprendente “freschezza” dell’astronauta più anziano del programma Apollo.

Dopo il grande successo ottenuto nelle 6 tappe del 2022, continua anche nel 2023, con ben 9 tappe, il viaggio di Forbes dedicato alla scoperta delle PMI, spina dorsale dell’Italia che cresce.

Un’occasione per confrontarsi su temi quali sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, welfare, accesso al credito e per creare relazioni professionali. Il progetto è rivolto a imprenditori e manager che gestiscono PMI del territorio e alle grandi aziende che vogliono mettersi in contatto con loro.








SCOPRI DI PIÙ: www.eventi.forbes.it/smallgiants/


DUE APPUNTAMENTI TRA IL NOSTRO SATELLITE NATURALE E LA BRILLANTE “RIVALE DI MARTE” NELLO SCORPIONE
Tra i vari fenomeni celesti del mese di luglio, vi sono le congiunzioni della Luna con la stella Antares che si veri cano sabato 1 e venerdì 28. Una congiunzione della Luna con una stella luminosa non è un evento raro e con la stessa stella deve necessariamente veri carsi a distanza di un mese siderale (27,3 giorni), ma spesso tale evento avviene in orari molto scomodi, con gli astri situati sotto l’orizzonte, in pieno giorno o –ancora – con una distanza di diversi gradi.
Nulla di tutto questo si veri ca il 28, quando si ha la congiunzione di luglio più stretta fra la Luna e Antares. Inoltre, in questa circostanza l’evento è nelle ore serali, mentre in quello del giorno 1 è alle 10 del mattino. Il 28 luglio, nell’ora della congiunzione, la Luna si trova proiettata nella costellazione dello
Scorpione a 380mila chilometri dalla Terra. È una distanza un po’ inferiore alla media, perché la Luna si sta avvicinando al perigeo, che raggiungerà la mattina del 2 agosto.
Di conseguenza, il Plenilunio di 12 ore prima darà luogo a una tipica “superluna”.
La minima distanza tra la Luna e Antares sarà di soli 0,5°; un valore
» La fotogenica regione di Rho Ophiuchi-Antares. La Alfa dello Scorpione è la stella più brillante in basso, immersa nella nebulosità giallastra (Telescope Live).

davvero molto ridotto. Per l’Italia, questa distanza minima si veri ca alle ore 19 di Tempo legale estivo, quindi solo un paio d’ore prima che la stella inizi a essere visibile a occhio nudo. La Luna, invece, essendo in fase gibbosa e sorgendo verso le 17, è già visibile al momento della massima vicinanza.
Se si utilizza uno strumento anche piccolo (come un rifrattore da 60 mm di diametro), dopo aver inquadrato la Luna, basta scrutare più in basso, a una distanza inferiore al
diametro lunare, per riuscire a vedere Antares. Ma la stella è molto bassa sull’orizzonte e le foschie potrebbero impedirne la visione. La visibilità di Antares, quando il cielo è ancora chiaro, è facilitata dall’adozione di un ltro arancione o rosso, che scurisce l’azzurro del cielo ma non la luce della stella, che è di questa tonalità.
UNA DOPPIA DIFFICILE
Antares (Anti-Ares, la “rivale di Marte”, per via del suo colore) è una stella supergigante rossa, con un
diametro circa 850 volte maggiore di quello solare, situata a una distanza di circa 600 anni luce nella costellazione dello Scorpione. È la stella principale di questa costellazione, e per questo catalogata come Alfa Scorpii, ed è una stella doppia.
La duplicità di Antares venne scoperta durante un’occultazione lunare osservata il 13 aprile del 1819 a Vienna da Johann Tobias Burg Durante la fase di emersione dal bordo non illuminato della Luna, Burg vide dapprima una stella che

stimò di magnitudine 6,7. Circa 5 secondi dopo apparve la stella di prima magnitudine. Burg interpretò questo evento come una prova che Antares fosse una stella doppia, con la componente più debole normalmente soverchiata dalla brillante primaria. È una fortuna che Antares B sia posizionata quasi esattamente a ovest rispetto alla principale, così l’intervallo di tempo dell’emersione fra le due stelle è il massimo possibile per un’occultazione “frontale”, cioè tale per cui il bordo lunare risulti perpendicolare alla direzione che unisce le due stelle. Va tenuto conto che la Luna si sposta sulla sfera celeste a una velocità di 1 secondo d’arco in circa due secondi di tempo. Essere posizionata a ovest vuole anche dire che nella comune visione telescopica, cioè con l’immagine rovesciata di 180°, la secondaria si vede a sinistra. Grazie al contrasto di colori (arancione carico la primaria e verdastra la secondaria), Antares è senza dubbio una delle stelle doppie più belle da contemplare. Ma non è facile da separare, anche se teoricamente già nelle potenzialità di un buon rifrattore da 11 cm di diametro. Robert Burnham Jr riporta che la trovava “abbastanza facile” con il rifrattore da 18 cm dell’Osservatorio Lowell, ma aggiungeva (sottolineandolo)
“quando l’aria è tranquilla”. In e etti, un buon seeing è determinante per riuscire a scorgere la compagna, che non è così debole come ritenevano i suoi primi osservatori. Le misure moderne indicano una magnitudine di 5,5; quindi Antares è solo 60-70 volte più luminosa. Ma per chi osserva dall’Italia (soprattutto da quella
settentrionale), la declinazione negativa di questa coppia (–26°26’) è tale da non renderla visibile, in certe regioni, a più di 18-19 gradi sopra l’orizzonte.
La possibilità di osservare Antares alta sull’orizzonte è determinante per separarla, come prova il fatto che chi scrive non è riuscito a vedere la compagna con un rifrattore da 13 cm a 191x da una latitudine di +45° (ma l’ha vista bene dallo stesso sito con un rifrattore da 42 cm), mentre D. Ballereau dal Senegal (a una latitudine di +15°) ha a ermato di esserci riuscito con un rifrattore di soli 7,5 cm a 140x.
Le due stelle sono separate attualmente (2023) da 2,50”, con magnitudini di 1,0 e 5,5. Però Antares è anche una stella variabile; la sua luminosità varia in genere fra 0,86 e 1,1 magnitudini, ma in passato è stato segnalato un minimo di 1,8.
Oltre che a seguire l’evento direttamente, vale la pena di riprenderlo fotogra camente. Bisogna utilizzare focali corte, in quanto quelle elevate – e ancor più quelle telescopiche – fanno perdere la bellezza dovuta alla vicinanza dei due astri. Inoltre, una focale corta, grazie alla bassa altezza dei due astri sull’orizzonte, permette di includere nell’inquadratura un paesaggio terrestre, che contribuisce
*WALTER FERRERI SI È OCCUPATO DI RICERCA SCIENTIFICA, DI TELESCOPI E DI ASTROFOTOGRAFIA PRESSO L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO. NEL 1977 HA FONDATO LA RIVISTA ORIONE
notevolmente alla bellezza dell’immagine. Per “focali corte” intendiamo quelle da 50 mm sul formato pieno (24x36mm) o sui 30 mm sul APS-C e in proporzioni minori sui formati ancora più ridotti, come quelli delle fotocamere bridge o compatte. Per l’esposizione, in linea di massima va bene utilizzare quella impostata dagli automatismi, sottraendo 2 stop. Molto però dipende dalla luminosità dello sfondo. Con il digitale non c’è problema a retti care o correggere un’immagine insoddisfacente, dal momento che il risultato è subito visibile. Comunque, anche se si ottiene subito un’immagine che si ritiene buona, conviene eseguirne altre in sovra e sottoesposizione, poiché una ripresa soddisfacente come posa potrebbe poi rivelarsi carente in qualche altro aspetto. Conviene anche utilizzare focali maggiori, da teleobiettivi moderati, come quelli da 100 a 200 mm nel formato pieno. Come per l’osservazione diretta, anche in quella fotogra ca è possibile avvalersi di ltri, ma è bene limitarsi a quelli gialli-arancioni e alle fasi in cui il cielo è ancora piuttosto chiaro, quando è incluso anche il paesaggio terrestre, per non avere un’alterazione profonda delle tonalità. Invece, se non è incluso il panorama terrestre, l’alterazione cromatica è meno (o per nulla) sgradevole. In ogni caso, è bene procedere con diverse prove.
Una coppia di fotogra e ottenute a distanza di tempo l’una dall’altra può mettere in evidenza il movimento della Luna e dare un senso di profondità. In pratica, con due di
queste immagini si può ricavare una foto stereoscopica. Non è necessario attendere molto tra una foto e la successiva: è su ciente un quarto d’ora. Questo intervallo è condizionato dalla focale utilizzata: con le focali minori è bene attendere almeno una mezz’ora, che si riduce a dieci minuti o meno con le focali maggiori.

Siccome si deve riprodurre la visione binoculare dei nostri occhi, che si ha dalla distanza della visione distinta (25 cm) no a circa 200 metri, le


tolleranze sono piuttosto ampie. Ma la visione tridimensionale più piacevole e naturale si ottiene per oggetti posti tra 1 e 10 metri. Dato che la distanza media tra le pupille umane vale 65 mm, si ha che alla distanza media di 5 metri l’angolo è pari a 65/5000 = 0,013 radianti, che corrispondono a circa 0,7 gradi. Considerando i limiti di 1 e 10 metri, si ottengono rispettivamente circa 4 e 0,4 gradi.
Questi valori angolari hanno un senso solo se sono riferiti a obiettivi di
focale “normale”, come quelli da 50 mm nel formato pieno (ricordiamo che viene considerato obiettivo “normale” quello che ha una focale identica alla lunghezza della diagonale del sensore). Se si utilizzano obiettivi di focale diversa, occorre variare l’angolo secondo la relazione: focale obiettivo normale / focale obiettivo impiegato.
Per esempio, con obiettivo da 200 mm sul formato 24x36 si ha 50:200 = 0,25. Allora invece di 0,7°, occorre uno spostamento di circa 0,2°.

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Blue Financial Communication S.p.A. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www.abbonamenti.it/cga
Invece di 58,80€
*24,90€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 29,90€ (IVA inclusa) invece di 58,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP
BRESCIA Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero
02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Sì, mi abbono a FORBES per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 58%. Pagherò 24,90€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 29,90€ IVA inclusa) invece di 58,80€.O erta Valida solo per l’Italia.




Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa
Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, con sede in Via Melchiorre Gioia 5520124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà e ettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@ bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti. it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto rilascionego il consenso per le attività di profilazione

» Il cielo visibile da Roma alle 01h 00m TC a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia.


Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 00h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
il 3 alle 13h 38m
il 10 alle 3h 47m
il 17 alle 20h 31m
il 26 alle 0h 06m
il 1° agosto alle 20h 31m
l'8 agosto alle 12h 28m
Massime librazioni in latitudine
il 4 alle 21h - visibile
il Polo nord
il 18 alle 6h - visibile
il Polo sud
il 1° agosto alle 3h - visibile
il Polo nord
Massime librazioni in longitudine
l'11 alle 8h - visibile il lembo occidentale
il 27 alle 11h - visibile il lembo orientale
l'8 agosto alle 8h - visibile
il lembo occidentale
Perigeo
360.149 km il 5 alle 0h 25m
Apogeo
406.289 km il 20
alle 8h 56mm
Perigeo
357.311 km il 2 agosto
alle 7h 52m
Dopo aver raggiunto la massima declinazione boreale, il Sole inizia la lenta discesa verso l'equatore: il 21 esce dai Gemelli ed entra nel Cancro. L'arco diurno percorso dall'astro si accorcia progressivamente, ma la diminuzione nelle ore di luce nel corso del mese rimane contenuta tra 36 minuti (meridione) e 55 minuti (settentrione). Il giorno 6 alle 22:06 è alla massima distanza dalla Terra (afelio a 1,01668 UA).
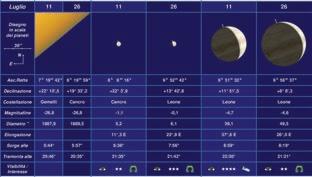
È in congiunzione superiore con il Sole il giorno 1 ed è quindi inosservabile fino al 7, quando riappare, tra le luci del tramonto, sull’orizzonte nord-occidentale. Il 10 si sposta nel Cancro, ma il suo veloce moto diretto lo porta, il giorno 21, nel Leone, dove il 26 supera Venere, 5°,3 più a nord. Il 29 è protagonista di una stretta congiunzione con Regolo (Alfa Leonis), 7' a sud.
Il lungo periodo di visibilità serale del pianeta è al termine. Inizialmente visibile subito dopo il tramonto nelle vicinanze di Marte, dal quale il giorno 1 lo separano 3°,6, il 16 raggiunge la minima distanza da Regolo (Alfa Leonis), portandosi 3°,5 a ovest, ma il suo movimento diretto è sempre più lento e il 21 è stazionario. La distanza che lo divide dal Sole tende a diminuire rapidamente e dopo essere stato superato da Mercurio il giorno 26, pochi giorni dopo scompare tra le luci del crepuscolo.
Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese. La mappa, in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.

MARTE
È visibile al tramonto tra le stelle del Leone, preceduto di alcuni gradi da Venere, dal quale tende progressivamente ad allontanarsi; la sua visibilità è in lenta diminuzione e nella seconda decade la sua calata anticipa il termine del crepuscolo. Il 10 è in congiunzione con Regolo, 42' a nord di Alfa Leonis; il 13 è invece il giorno del Solstizio Estivo per il pianeta.
GIOVE
È visibile nella seconda parte della notte nell’Ariete, 6° a ovest della stella di 5a magnitudine Sigma Arietis, alla quale va lentamente avvicinandosi. La sua visibilità è in costante crescita: a metà mese il pianeta sorge prima della mezzanotte locale.
E emeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate.
Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra). Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
Le stelline (da 1 a 5) misurano l’interesse dell'osservazione.

Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.
SATURNO
È visibile per buona parte della notte nelle vicinanze della stella di 5a magnitudine Sigma Aquarii All’inizio sorge meno di un’ora dopo il termine del crepuscolo serale, ma già a metà mese leva tra le ultime luci del tramonto e alla fine si alza al termine del crepuscolo nautico.
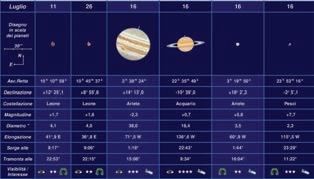
URANO
È visibile nella seconda parte della notte 2°,5 a sud-est di Delta Arietis, di magnitudine +4,3, dove si sposta animato da lento moto diretto. È preceduto, una decina di gradi a occidente, da Giove. Negli ultimi giorni del mese la levata del pianeta anticipa la mezzanotte locale.
NETTUNO È visibile per buona parte della notte 4°,6 a sud-est della stella di 4a magnitudine Lamba Piscium; il giorno 1 è stazionario in Ascensione Retta, poi assume il moto retrogrado che caratterizza il periodo dell’opposizione al Sole. A fine mese sorge al termine del crepuscolo serale.
Ancora una volta il transito della Luna quasi completamente illuminata dal Sole tra le stelle dello Scorpione produce delle belle configurazioni, meritevoli di attenzione.
Nelle ore che precedono l’alba, mentre la caratteristica figura della costellazione va adagiandosi sull’orizzonte sud-occidentale, la Luna gibbosa crescente transita nello spazio compreso tra le “chele” dello Scorpione, avvicinandosi ad Antares (Alfa Scorpii), con cui sarà in congiunzione in Ascensione Retta, 1°,1 a nord, nel corso della giornata. Le osservazioni verranno interrotte dalla discesa sotto l’orizzonte, approssimativamente all’inizio del crepuscolo astronomico, del nostro satellite naturale (vedi l’articolo di W. Ferreri a pag. 52).
All’inizio del mese la luminosa coppia formata da Venere e Marte, che da alcuni mesi anima il cielo serale, raggiunge la minima separazione apparente di 3°,6; una manciata di gradi a est è visibile Regolo (Alfa Leonis), alla quale i due vanno avvicinandosi.
Nei giorni che seguono, la distanza che li separa torna ad aumentare: il veloce moto diretto di Venere va rallentando, consentendo a Marte di distanziare nuovamente Venere, mentre quest’ultimo si abbassa sull’orizzonte fino a scomparire, negli ultimi giorni del mese, tra le luci del crepuscolo.
Nel disegno sono riportate le posizioni dei due pianeti tra le stelle del Leone alle 22:10 di Tempo Civile del 1° luglio, al termine del crepuscolo nautico.
DUE STELLE NEL SAGITTARIO

La notte tra il 2 e il 3 luglio la Luna Piena occulta, a poche ore di distanza l’una dall’altra, due stelle della costellazione del Sagittario: SAO 186328 e SAO 186594, rispettivamente di magnitudine +4,6 e +6,1.
Entrambi gli eventi sono visibili da tutto il Paese, ma risultano di di cile osservazione a causa dell’elevata luminosità del disco lunare completamente illuminato dal Sole. Le fasi iniziali del primo, con la scomparsa della stella SAO 186328 dietro un quasi impercettibile lembo lunare oscuro tra le 21:24 (CA) e le 21:46 (TS), si verificano con il cielo ancora rischiarato dalle luci del tramonto. La stella riappare sul bordo illuminato dal Sole dopo le 22:18 (AO e MI) tra le ultime luci del crepuscolo. L’occultazione di SAO 186594, la cui osservazione è resa maggiormente di coltosa dalla non elevata luminosità della stella, ha invece inizio tra le 2:04 (AO) e le 2:20 (LE), mentre la riapparizione è prevista tra le 3:07 (AO) e le 3:30 (LE), quando per le regioni orientali vanno accendendosi le primissime luci dell’alba.
Nelle ore che precedono l’alba è possibile seguire il progressivo avvicinamento della Luna gibbosa calante a Saturno: la congiunzione tra i due, con il nostro satellite naturale 3°,4 a sud del pianeta inanellato, si verifica poco prima del levar del Sole, con il cielo ormai completamente chiaro. La migliore configurazione osservabile è quella che si concretizza all’inizio del crepuscolo nautico, alle 4:30 circa, con la Luna 3°,7 “sotto” Saturno ed entrambi in prossimità del meridiano.
Per l’intero mese di luglio il pianetino (15) Eunomia risulta su cientemente luminoso da poter essere seguito con l’aiuto di un binocolo, ma individuarlo non è impresa facile, in quanto si trova nel Sagittario, una delle zone celesti più densamente popolate di deboli stelle. In opposizione al Sole il giorno 7, quando raggiunge la magnitudine visuale +8,8, (15) Eunomia è rintracciabile inizialmente meno di 1° a ovest di Psi Sagittarii, di magnitudine +4,9, dalla quale va progressivamente allontanandosi. Nelle prime ore del giorno 12 transita poco più di 7’ a sud della stella SAO 187599, di magnitudine +5,6. Nei giorni seguenti, grazie al moto retrogrado da cui è animato, passa alcuni primi a nord di altre due stelle di 6a e 7a magnitudine, mentre la notte tra il 18 e 19 luglio è in congiunzione con Nunki (Sigma Sagittarii), 1°,6 a nord. Altre due congiunzioni di rilievo sono quella con 26 Sagittarii, alcuni primi a nord della quale transita il 2 agosto, e quella con l’ammasso globulare M22, 33’ a nord-est del quale (15) Eunomia viene a trovarsi la notte tra l’8 e il 9 agosto. Nella mappa sono ra gurate tutte le stelle più luminose della magnitudine +10,5.
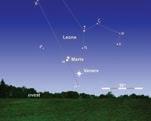

Dopo il tramonto del Sole, sull’orizzonte occidentale spicca la presenza, a una decina di gradi d’altezza, di una spettacolare ma e mera coppia di astri di simile luminosità ma tonalità contrastanti: si tratta di Marte, di magnitudine +1,7, e Regolo (Alfa Leonis), di magnitudine +1,4, preceduti, alcuni gradi a ponente, dalla luminosissima scintilla di Venere. La sera del 9 luglio il Pianeta rosso, animato da moto diretto, è visibile 50’ a nord-ovest della stella, con cui è in congiunzione in Ascensione Retta, 42’ più a nord, nella tarda mattinata del giorno 10. La minima separazione angolare di 39’ viene raggiunta nelle ore serali, poco prima della calata del Sole.
La sera seguente Marte si è spostato 55’ “sopra” Regolo, da cui andrà progressivamente allontanandosi con il trascorrere dei giorni. Nel disegno è ra gurata la configurazione osservabile sopra l’orizzonte occidentale alle 22:00 TC del 10 luglio, alcuni minuti prima del termine del crepuscolo nautico.
Nelle ore che precedono il sorgere del Sole, nel cielo orientale si va alzando la costellazione zodiacale dell’Ariete, tra le cui stelle è possibile ammirare Giove, facilmente riconoscibile per la sua luminosità, seguito una dozzina di gradi a levante da Urano, individuabile solo con l’aiuto di un binocolo.

Nei giorni compresi tra l’11 e il 13 luglio i due pianeti vengono a ancati dalla falce calante della Luna, che viene a trovarsi in congiunzione con Giove, 1°,3 a nord del pianeta, la sera dell’11, alcune ore prima della loro levata dall’orizzonte nord-orientale, e con il debole Urano nelle ore serali del 12.
Nessuna delle congiunzioni è direttamente visibile dal nostro Paese; le migliori configurazioni osservabili, ra gurate nel disegno, si realizzano alle 2:30 TC delle date indicate, un’ora prima dell’inizio del crepuscolo astronomico.
Un’ora circa dopo il tramonto del Sole, con le luci del crepuscolo ancora molto pronunciate, una manciata di gradi sopra l’orizzonte occidentale è possibile ammirare Venere, pressoché stazionario, 3°,5 a est di Regolo, mentre 3°,7 a est di Alfa Leonis è presente Marte. Appena sopra la linea dell’orizzonte, se le condizioni di visibilità sono favorevoli, è possibile cogliere Mercurio, che nella seconda parte del mese emergerà progressivamente dalle luci del crepuscolo.
Tra la seconda e la terza decade di luglio, poco dopo la calata del Sole sull’orizzonte occidentale va formandosi una spettacolare parata di pianeti, costituita da Marte (che continua a resistere al luminoso richiamo del crepuscolo serale), Venere (che il 21 arresta il suo movimento diretto per poi abbassarsi rapidamente sull’orizzonte e scomparire, prima della fine del mese, nel chiarore solare) e Mercurio, che invece va emergendo dalle luci vespertine per un’apparizione serale non particolarmente favorevole.
Il trio viene raggiunto e superato, nell’arco di alcune sere, dalla falce crescente della Luna: visibile appena sopra l’orizzonte, 7° a est di Mercurio, la sera del 18, il 19 luglio si è già spostata 3°,7 “sopra” il pianeta. Dopo una congiunzione, non osservabile direttamente, 7°,5 a nord di Venere la mattina del 20, la sera dello stesso giorno la si può ammirare 7° a nord del pianeta e 3° a nord di Regolo. È inosservabile anche la congiunzione con Marte delle prime ore del 21, 6° a est del quale la ritroviamo invece nelle ore serali.
Le configurazioni celesti rappresentate nel disegno sono quelle osservabili alle 21:20 TC dei giorni indicati, in presenza delle luci del tramonto, ancora intense.

Ormai sempre più vicino all’orizzonte occidentale, Venere è al termine della lunga apparizione serale iniziata lo scorso dicembre. La sera del 24 il pianeta viene a ancato, 6°,5 a “destra”, da Mercurio che invece sta emergendo dalle luci del crepuscolo per raggiungere, negli ultimi giorni di luglio, la massima visibilità serale della corrente apparizione. Grazie al veloce movimento diretto, Mercurio supera Venere, transitando oltre 5° a nord di quest’ultimo, e si dirige verso Regolo, con cui è protagonista di una spettacolare congiunzione, purtroppo non direttamente osservabile, nelle prime ore del 29 luglio, quando transita 7’ a sud di Alfa Leonis. È comunque possibile tentare di osservare la coppia MercurioRegolo, separati da 17’, la sera del 28, poco dopo il tramonto del Sole. Da notare la presenza di Marte, una decina di gradi a oriente.
Al termine del crepuscolo civile, quando il cielo è ancora notevolmente rischiarato dalle luci del tramonto, sopra l’orizzonte meridionale, in prossimità del meridiano, è visibile l’intera figura dello Scorpione, con la rossa scintilla di Antares accompagnata, 1° a levante, dalla Luna in fase gibbosa crescente.
La distanza apparente tra il nostro satellite naturale e Alfa Scorpii va progressivamente aumentando dopo la congiunzione in Ascensione Retta, con i due astri separati da appena 30’, verificatasi nel tardo pomeriggio, con il Sole ancora sopra l’orizzonte e il cielo illuminato a giorno.

Nel disegno la configurazione che è possibile ammirare alle 21:45 TC, al termine del crepuscolo nautico (vedi a pag. 52).
Nelle ultime notti del mese risulta attivo lo sciame meteorico delle Delta Aquaridi sud. Si tratta di uno sciame non particolarmente ricco, con valori dello Zhr (il tasso orario di attività con il radiante allo zenit) intorno a 25, le cui meteore sono spesso di debole luminosità; il massimo di attività è previsto per le ore serali del 30, ma il numero di meteore osservabili si dovrebbe mantenere relativamente costante dal giorno 28 sino a fine mese.
A causa della posizione in cielo del radiante, visualmente lo sciame o re il meglio di sé agli osservatori delle regioni meridionali: le migliori condizioni per l’osservazione si verificano nella seconda parte della notte, nel breve intervallo di tempo tra il tramonto della Luna e la comparsa delle prime luci dell’alba (vedi l’articolo di G. Cevolani a pag. 70).
NELLA PRIMA DECADE DI AGOSTO CI ATTENDONO
• 1 AGOSTO: SUPERLUNA DELLO STORIONE O DEL GRANO (DIAMETRO DISCO LUNARE: 33' 24",7)
•3 AGOSTO: LUNA E SATURNO DI SERA
•5 AGOSTO: OCCULTAZIONE DI 27 PISCIUM
•8-9 AGOSTO: LUNA, GIOVE E URANO PRIMA DELL’ALBA
•9 AGOSTO: LUNA E PLEIADI ALL’ALBA
•10 AGOSTO: MERCURIO ALLA MASSIMA ELONGAZIONE ORIENTALE DI 27°,4
I testi completi dei fenomeni sul prossimo numero di Cosmo e sul sito bfcspace.com
*TIZIANO MAGNI
ESPERTO DI MECCANICA CELESTE, ELABORA LE PREVISIONI DI FENOMENI ASTRONOMICI CON SOFTWARE APPOSITAMENTE REALIZZATI (WWW.TIZIANOMAGNI.IT).
Durante la prima settimana del mese possiamo ammirare una bella costellazione zodiacale che transita esattamente in meridiano verso le 23: lo Scorpione. Copre circa 500 gradi quadrati di cielo ed è interamente ubicata nell’emisfero australe, dato che la sua parte più settentrionale si ferma poco al di sotto di 8 gradi di declinazione negativa. È attraversata dall’eclittica per non più di 6 gradi, così il Sole rimane entro i suoi con ni per meno di una settimana (in genere dal 23 al 29 novembre), prima di far ingresso nell’O uco. L’asterismo principale rappresenta abbastanza fedelmente il pericoloso aracnide da cui prende il nome, anche se a partire dal III secolo a.C. (almeno secondo Flammarion) le chele sono state “asportate” per formare la contigua costellazione della Bilancia, di per sé estranea allo Zodiaco, essendo l’unica delle dodici costellazioni zodiacali che non rappresenta un essere vivente.
Non è facile osservare interamente lo Scorpione dall’Italia settentrionale: le due stelle più basse, Eta e eta, pur essendo abbastanza luminose (sono rispettivamente di 3ª e 2ª grandezza), si trovano a una declinazione di -43°. Pertanto, a meno di non disporre di un sito completamente libero e buio in meridiano, è di cile scorgerle dalle brume che spesso si addensano all’orizzonte. Chi scrive è riuscito a osservarle solo da un sito sulle Alpi Apuane, meta di astro li della Versilia, con il sud che puntava direttamente verso il mare. Antares (Alfa Scorpii) è una delle stelle più note del cielo, che tuttavia si colloca solo al 15º posto fra gli astri di 1ª grandezza. È situata poco al di sotto dell’eclittica, a una declinazione appena inferiore a -26° e culmina bassa sull’orizzonte. È comunque inconfondibile per il suo colore arancione che
sin dai tempi più remoti le è valso il nome di “rivale di Marte” (vedi l’articolo di Walter Ferreri a pag. 52). Meno noto è invece il nome arabo Calb al-Akrab, che signi ca “il cuore dello Scorpione”, lo stesso nome con cui era nota ai Romani (Cor Scorpii). È una stella supergigante con un diametro di quasi un miliardo e 200 milioni di chilometri. Se fosse situata al posto del Sole, arriverebbe a inglobare i pianeti no a Marte! Giove sarebbe salvo, ma dal pianeta gigante la stella apparirebbe di proporzioni mostruose: una sfera di fuoco accecante dal diametro apparente di 75 gradi. E malgrado la mole, Antares possiede una massa appena 15 volte maggiore di quella del Sole, il che comporta una densità media bassissima di questa stella. Lambda (Shaula, ossia il “pungiglione”), di magnitudine 1,6, è la seconda stella più brillante dello Scorpione; è una gigante azzurra distante circa 700 anni luce e 8600 volte più luminosa del Sole. Forma una coppia larga con la Ypsilon, anch’essa azzurra e situata 35’ a WSW. Al terzo posto c’è la eta, di magnitudine 1,9; questa è bianca, mille volte più brillante del Sole e distante 270 anni luce. Proseguendo in ordine di luminosità, troviamo la Epsilon, una gigante arancione di magnitudine 2,3, distante 65 anni luce e 40 volte più brillante del Sole. Per ultima osserviamo la Delta, situata poco più a nord di Antares
» In alto: la mappa della costellazione dello Scorpione (Perseus). Sotto: il rendering della visione di Antares e compagna da un eventuale pianeta del sistema (da confrontare con una vera foto come quella a pag, 56).


e quindi a una declinazione abbordabile. Può essere considerata una parente stretta di Lambda, poiché è una gigante azzurra di classe spettrale B0 e di magnitudine 2,4; si trova a una distanza di 400 anni luce ed è 1350 volte più brillante del Sole. È curioso notare che, a parte la Alfa, l’ordine di luminosità delle stelle dello Scorpione in relazione alle lettere greche è alquanto caotico!
UNA DOPPIA LARGA
E UN PAIO DI GLOBULARI
Un grado a SSE dalla stella Beta c’è la coppia Omega1 e Omega2, distanti fra loro circa 15’ e quindi facilmente separabili anche a occhio nudo; è però consigliabile un buon binocolo per osservarle. Con uno strumento di grandi dimensioni (come un 20×80), si possono coglierne i colori: la prima è bluastra, mentre la seconda è ambrata. Nello Scorpione sono presenti due ammassi globulari appartenenti al catalogo di Messier. Il più brillante e famoso è M4, scoperto da De Chéseaux nel 1746; Messier nel 1764 lo descrive come un “ammasso di piccolissime stelle; con un telescopio più piccolo appare più simile a una nebulosa”.
Descrizione interessante, se pensiamo
ai piccoli strumenti con i quali operava l’astronomo francese; in e etti, M4 è forse l’unico globulare risolvibile almeno parzialmente in stelle con un binocolo 20×80. Questo ammasso manca di un nucleo brillante; al suo posto si nota, già al binocolo, una piccola stringa che corre da nord a sud; questa curiosa conformazione aveva gettato dubbi sulla sua reale natura, anche se è ormai accertato che non si tratta di un ammasso aperto.
È uno dei globulari più grandi che si conoscono, con un’estensione apparente poco superiore ai 20’. Sono stati determinati magnitudine e colore di oltre 600 stelle di M4, fra le quali sono note una quarantina di variabili. Nel 1987 è stata persino scoperta una pulsar (la prima in un globulare), con un periodo di circa 3 millisecondi. Nell’agosto del 1995, il telescopio spaziale Hubble è riuscito a fotografarvi alcune nane bianche e in base a questa osservazione la sua distanza è stata stabilita in 7000 anni luce, che fa di questo ammasso globulare il più vicino a noi. Poco meno di 4 gradi a NNW di M4 si trova M80, un ammasso globulare più piccolo e meno appariscente; rappresenta una genuina scoperta
di Messier avvenuta nel 1781, e da questi descritto come simile al nucleo di una cometa. Si può rintracciare in un binocolo 10x50 a metà strada tra Antares e Beta Scorpii Osservato in un piccolo telescopio presenta un nucleo di aspetto quasi stellare, ma per notare anche una lieve screziatura dell’alone occorre uno strumento di almeno 25 cm di diametro a 150x-200x.
William Herschel, il più grande visualista di tutti i tempi, aveva formulato un’ipotesi curiosa sulle nebulose oscure, nonché sulla struttura della Via Lattea: egli riteneva che la gravità costringesse le stelle ad addensarsi in gruppi che col tempo diventavano sempre più densi ed estesi. La sua ipotesi scaturiva dall’osservazione di alcuni ammassi, fra cui M4, situati ai bordi di vaste zone virtualmente priva di stelle, come se queste fossero state risucchiate per formare gli ammassi. Secondo questa ipotesi, durante il processo potevano talvolta formarsi alcune piccole condensazioni secondarie.
Fra queste, ce n’è una osservabile
con un telescopio anche modesto, un grado a nord-est di M4. Si tratta di NGC 6144, che conviene osservare ad alti ingrandimenti per tenere Antares fuori dal campo visivo. È un piccolo ammasso globulare, con diametro di circa 4’ e poco concentrato; in telescopi

da 30 o 40 cm appare nemente screziato e parzialmente risolto, con una decina di componenti disposte irregolarmente, ma che forse non appartengono all’ammasso; fra queste ve n’è una brillante al margine occidentale.
L’astronomia ha fatto enormi
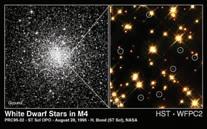
progressi dai tempi di Herschel; oggi sappiamo che le zone scure della Via Lattea non sono vuote, ma vere e proprie cortine fumogene che nascondono la vista di stelle comunque presenti. Sappiamo inoltre che gli ammassi aperti non continuano a crescere per e etto della gravità, ma che avviene proprio il contrario, cioè tendono a disgregarsi con il tempo.
E gli ammassi globulari non sono diventati tali in tempi recenti, ma hanno assunto la loro forma nelle prime fasi di vita della Galassia. Le conoscenze scienti che continuano a evolvere e anche molte di quelle che oggi diamo per certe potrebbero essere riviste in un futuro più o meno lontano.

Il primo importante appuntamento estivo con le “stelle cadenti” è con lo sciame delle Delta Aquaridi, che si sovrappongono in parte alle più famose Perseidi, creando qualche di coltà quando si tratta di distinguere la loro appartenenza.
Anche se poco note, queste meteore sono annoverate tra i dieci sciami principali, dato che non di rado regalano piccole “piogge” di stelle cadenti.
È tuttavia uno strano sciame, che si suddivide in due componenti: una meridionale, dette Delta Aquaridi Sud, e una settentrionale, le Delta Aquaridi Nord. Le più attive e interessanti sono le prime, attive dal 12 luglio di ogni anno, con il picco verso la ne del mese di luglio. Le Delta Aquaridi Nord interessano più o meno lo stesso periodo, dal 15 luglio al 25 agosto.
La “cometa madre” di queste meteore, la 96P/Machholz, appartiene a un complesso cometario che comprende otto sciami meteorici, due gruppi di comete (Marsden e Kracht) e almeno un asteroide (2003 EH1). Tutti questi sciami e comete sembrano condividere un’origine comune, anche se con il tempo si sono leggermente discostate nelle loro orbite attorno al Sole. Ma qui arriva un’altra stranezza delle Delta Aquaridi: è l’unico sciame di meteore generato da una cometa che forse ha origini extrasolari. L’orbita peculiare che porta la 96P/Machholz vicino al Sole ha suggerito agli studiosi che si tratti di un oggetto proveniente da un altro sistema stellare. Ma cominciamo dalle sue meteore.
La costellazione dell’Acquario si trova in direzione sud-est, tra il Capricorno e i Pesci. Il radiante dello sciame (il punto da cui sembrano provenire le

meteore) è vicino alla stella Delta Aquarii, la terza più luminosa della sua costellazione. Nel mese di luglio sorge a metà serata, culmina alle 2 del mattino ed è bassa nel cielo all’alba. Come le Eta Aquaridi, lo sciame di meteore generato dalla cometa di Halley e visibile nella prima parte di maggio, anche le Delta Aquaridi favoriscono l’emisfero australe, ma sono visibili anche alle latitudini medio-basse dell’emisfero boreale e sono quindi preferite le nostre regioni meridionali.

La velocità relativamente bassa delle Delta Aquaridi rispetto ad altri sciami (come Perseidi e Leonidi), le rende meno luminose. Un cielo scuro e senza Luna è essenziale per osservarle, dopo aver abituato gli occhi al buio per molti minuti. Solo il 5-10 per cento delle Delta Aquaridi lascia treni persistenti con scie luminose di gas ionizzato che durano pochi secondi
dopo che la meteora è passata. È consigliabile osservare le meteore da ne luglio a inizio agosto, da metà sera all’alba. È previsto un picco di 15-20 meteore per ora per il 30 luglio alle ore 20, ma la Luna Piena cade alle 20h 32m del 1° agosto e disturba la visione. Occorre quindi appro ttare delle mattine senza Luna a ne luglio, per osservare le Delta Aquaridi (e le prime Perseidi). In genere, si vedono meteore di entrambi gli sciami no a metà agosto, perché sono attivi per diverse settimane.
Per attribuire correttamente l’appartenenza di una meteora al suo sciame, occorre determinare il radiante da cui proviene.
Se si tracciano le Delta Aquaridi all’indietro, queste sembrano irradiarsi da un punto situato nella costellazione dell’Acquario, nel cielo meridionale. Invece, le Perseidi
si irradiano dalla costellazione di Perseo, che si sposta alta nel cielo settentrionale. In pratica, osservando da mezzanotte in poi, le meteore che provengono da nord-est o da nord sono Perseidi, mentre quelle che arrivano da sud sono Delta Aquaridi. Nel caso più fortunato, si potrebbe addirittura vederne qualcuna incrociarsi!
LA MADRE
DELLE DELTA AQUARIDI
Quest’anno, la cometa 96P/ Machholz si è molto avvicinata al Sole, giungendo al perielio il 31 gennaio. La cometa ha un nucleo di 6 km e orbita attorno al Sole ogni 5,3 anni. La sua distanza del perielio è di 18 milioni di chilometri, tre volte più piccola di quella a cui orbita Mercurio. La 96P/Machholz non è nuova a questi passaggi “acrobatici” nei pressi del Sole, dato che è almeno la quinta volta che li compie da quando è stata scoperta nel 1986. Avvicinamenti così spinti producono continue modi cazioni di forma e inclinazione dell’orbita, con il risultato che la cometa ha seminato polveri e gas in tutto il Sistema solare interno. Si valuta che il materiale responsabile delle Delta Aquaridi abbia lasciato il nucleo della cometa circa 20mila anni fa. Poiché il nucleo della 96P/Machholz possiede dimensioni notevoli, resiste ai passaggi ravvicinati con il Sole, liberando grandi quantità di materiale cometario che forma le sue spettacolari code.
La peculiare orbita che porta la cometa così vicino al Sole suggerisce che si tratti di un oggetto proveniente da un altro sistema stellare, dal quale potrebbe essere stata espulsa a causa
Il radar si è rivelato un potente mezzo per osservare l’attività e la struttura degli sciami meteorici; la sua utilità è dovuta soprattutto alla capacità che hanno i meteoroidi di ionizzare l’aria mentre cadono in atmosfera.
Il radar ha il vantaggio di poter operare di giorno e di notte e di poter identificare e caratterizzare un corpo che entra nel suo cono di azione, dalla morfologia dell’eco registrato e dalla sua durata e ampiezza. Gli atomi liberati per ablazione dal meteoroide collidono con molecole e atomi dell’aria, provocando un aumento della temperatura, un’eccitazione luminosa e la ionizzazione degli atomi espulsi.
Per un meteoroide di velocità pari a 40 km/s (come quella delle Delta Aquaridi), la frazione di energia trasformata in luce è due millesimi e quella in ionizzazione è meno di un millesimo. Così, un meteoroide di 0,1 grammi ha un’energia cinetica iniziale di 80mila joule (come un’automobile che viaggia a 45 km/h). Di questa energia, 160 joule si trasformano in luce, producendo la “stella cadente”, e 80 joule vengono spesi nella ionizzazione di miliardi di miliardi di atomi, che producono altrettanti elettroni liberi. Gli echi radar provenienti da complessi meteorici di tipo cometario hanno generalmente morfologie diverse tra di loro, per ampiezza e tempi di decadimento. Elevate ampiezze comportano maggiori densità elettroniche dei meteoroidi in fase di ionizzazione e quindi maggiori masse, con densità più alte delle scie ionizzate. Da queste osservazioni è possibile comprendere come gli echi generati dalla materia interplanetaria di tipo asteroidale (come quelli delle Geminidi), derivano da corpi più compatti e più densi rispetto a quelli degli sciami di origine cometaria (come le Perseidi).
Grazie ai radar, si può studiare la struttura degli sciami meteorici e la loro evoluzione in relazione alla vita dei loro corpi progenitori. Si distinguono quattro stadi nell’evoluzione di uno sciame. Il primo è caratterizzato da una breve attività, che ha un andamento dipendente dalla posizione del corpo progenitore (come le Leonidi, associate alla cometa Tempel-Tuttle). Nel secondo stadio, la corrente delle particelle si estende lungo tutta l’orbita della cometa: la sezione del flusso è ristretta e con un radiante ben definito (come nelle Perseidi).
Il terzo stadio presenta un’attività abbastanza pronunciata, con un radiante più disperso: è il caso delle Delta Aquaridi, le cui polveri che osserviamo hanno migliaia di anni. Nel quarto stadio, la corrente di particelle è più di usa a causa dell’influenza sempre maggiore di forze dispersive. Il corpo progenitore non genera più meteoroidi, poiché si è ridotto solo alla parte più compatta del nucleo, come è il caso di 3200 Phaeton, l’asteroide progenitore delle Geminidi. A questo punto lo sciame transita lentamente alla fase di meteore sporadiche, con il radiante non più localizzabile con precisione nel cielo.
In figura, l’osservatorio astronomico di Modra, in Slovacchia. L’impianto comprende un sistema di tracciamento delle meteore che lavora in collaborazione con analoghe stazioni radar installate a Bologna e a Lecce.

dell’interazione gravitazionale con un grande pianeta. E dopo aver vagato a lungo nello spazio sarebbe stata deviata verso il Sistema solare interno da un passaggio ravvicinato a Giove, iniziando così a orbitare attorno al Sole.
A sostenere questa ipotesi c’è anche la composizione chimica della 96P/ Machholz. Uno studio ha messo a confronto 150 comete, stabilendo che questa cometa ha un contenuto di cianogeno molto più basso delle altre e anche un basso contenuto di carbonio. Il cianogeno, un gas tossico

costituito da atomi di carbonio e azoto, è una rma tipica delle comete che orbitano attorno al Sole. D’altra parte, la sua presenza anche nella chioma della 2I/Borisov, la prima cometa interstellare accertata, conferma che anche comete di altri sistemi stellari hanno una chimica e una composizione simili alle nostre. E che pertanto sono originate da meccanismi simili.

Se ulteriori studi confermeranno la natura aliena della 96P/Machholz, questa sarebbe il terzo oggetto interstellare osservato dopo l’asteroide 1I/Oumuamua e la cometa 2I/Borisov, e il primo stabilitosi nel nostro sistema. Un po’ diverso ma non troppo rispetto agli altri oggetti che ciclicamente tornano a splendere nei nostri cieli. E regalandoci la
visione di una materia interstellare che cade nella nostra atmosfera, quando osserviamo una Delta Aquaride in una notte d’estate.




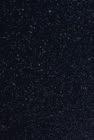








La selenocromatica è un particolare approccio alla fotogra a lunare che sposta l’attenzione dall’estetica all’approfondimento scienti co. Lo scopo della sua versione più avanzata, la 2.0, è permettere una lettura immediata delle immagini a colori della Luna. A questo ne un apposito team ha sviluppato speci che metodiche di acquisizione ed elaborazione delle immagini, un linguaggio apposito e una particolare cronologia lunare, oltre a nuovi metodi analitici.
L’obiettivo della selenocromatica è la conoscenza del nostro satellite naturale e in questo si di erenzia dalla tecnica della Mineral Moon, il cui ne è puramente estetico (vedi la rubrica Cosmo kid su Cosmo n. 34). Infatti, dalla sua nascita, nei primi mesi del 2021, la selenocromatica ha cercato di mettere in correlazione i colori della Luna con i minerali di cui è composta: il nostro satellite è solo apparentemente sbiadito e il suo grigiore non deriva dall’assenza di colore, ma dalla somma di tutti i colori dello spettro. Ogni singolo minerale lunare ri ette a modo suo la luce solare, selezionando un colore che dipende dalla sua composizione chimica. Così, se sovra-saturiamo opportunamente le immagini lunari, è possibile ottenere informazioni abbastanza precise sulla composizione delle rocce e sull’evoluzione della Luna stessa. Non stupisce quindi che n dall’inizio si sia ricercata
l’a dabilità dei dati raccolti, nonostante la variabilità della risposta della crosta lunare: la radiazione solare interagisce con l’estrema varietà dei suoli, producendo un gran ventaglio di tinte, anche a causa della curvatura della super cie. Questo genera variazioni cromatiche nelle zone in ombra, nei pressi del terminatore e in aree di elevata albedo (per e etto prospettico) nei pressi dell’orizzonte del disco lunare e delle cuspidi. Si deve tenere conto poi della “maturazione” del suolo lunare, che deriva dalla sua duratura esposizione agli impatti, al vento solare e all’ambiente spaziale riducente, tre elementi che modi cano il cromatismo della crosta, rendendola più scura. Anche la craterizzazione in uisce notevolmente sul colore della super cie lunare, grazie alla contaminazione dei suoli di tipo orizzontale (materiali espulsi a distanza) e verticale (materiali riportati in super cie dalla profondità).
In base a tutti questi criteri, un team del Gruppo Astro li William Herschel (Gawh) di Torino ha individuato e codi cato le tecniche di acquisizione più adatte a garantire la maggiore quantità d’informazione. Per evitare che la forte variabilità cromatica fornisca dei colori fake, ci si è a dati al metodo dell’esaltazione cromatica controllata (Cce): le riprese vengono elaborate in maniera rigorosa (coerenza interna) e devono fornire risultati in accordo con dei riferimenti cromatici della crosta lunare (coerenza
I Le tinte nette provengono da evento recente e tutte le raggiere colorate devono essere considerate neocromatiche; lo stesso vale per i DHC (Dark Halo Craters).
II Le tinte sbiadite sono dovute a strati piatti meso-cromatici (“pianure chiare”) che coprono lo strato di criptomare più scuro (mescolando dal basso).
III Le tinte anortositiche ocra sono tipiche di aree dal forte rimaneggiamento, altopiani degradati e craterizzati (paleocromatiche).
IV I colori guida sono il grigio/ocra dell’anortosite, il blu, il rosso/marrone e l’azzurro; gli altri colori derivano dal mescolamento di colori guida in zone di contaminazione o per diversa incidenza della luce: terminatore e orizzonte talora rivelano materiali sottostanti.
V Nelle zone PKT (Procellarum Kreep Terrane), nei Mari Nubium, Serenitatis e Frigorisorientale possiamo considerare il blu dei basalti esposti come neocromatico e il rosso come mesocromatico.
VI Basalti marini al di fuori delle aree PKT possono essere ritenuti nel complesso come meso-cromatici, soprattutto se coperti dai raggi di crateri eratosteniani; particolarmente complessa è la valutazione di Mare Humorum e Mare Tranquillitatis (verifica geo-cromatica obbligatoria); considerare meso-cromatici (tipicamente imbriani) tutti gli strati ripescati da livelli sottostanti a quelli esposti, normalmente apprezzabili negli ejecta dei crateri medio-grandi o per modifica cromatica dal basso per microcraterizzazione
VII Gli strati vulcanici e piroclastici vanno dal giallo/arancione/rosso scuro alle sfumature bluastre/violacee.
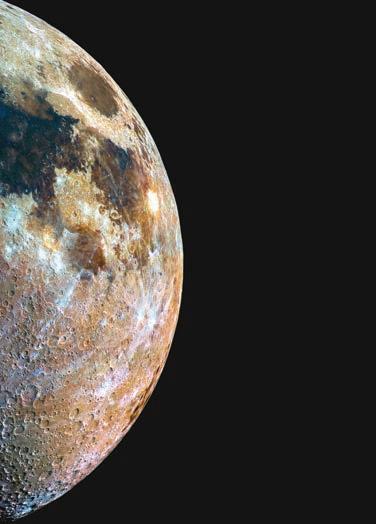
esterna). Solo rispettandoli possiamo darci di ciò che vediamo. Questi “reperi” sono individuati grazie alla veri ca statistico-comparativa di immagini amatoriali e professionali. L’Atlante dei reperi selenocromatici
derivato da questi studi elenca le formazioni cromatiche di cui siamo ragionevolmente sicuri ed è consultabile alla pagina selenocromatica nel sito del Gawh (www.gawh.it). Poste le basi di
a dabilità dei dati acquisiti, si è potuto standardizzare l’aspetto delle immagini e passare all’analisi dei colori, correlandoli alla storia della Luna ed entrando così nella versione 2.0 della selenocromatica. In particolare, per le immagini ottenute si è pensato a un preciso format: una cornice nera di almeno 100 pixel e una InfoBar, che comprende la sigla “Si” (Selenochromatic image), tre cerchi colorati che garantiscono la fedeltà dei colori nella trasmissione, una serie di dati che ne quanti cano l’a dabilità (Mineral Score) e ne de niscono il procedimento di elaborazione (camera di acquisizione, ltri ecc.).
La scienti cità dell’analisi di una Si è basata su due metodi analitici: il primo, detto geo-cromatico, è più complesso (tre fasi) ma anche più preciso: consiste nella correlazione dei colori della Si con le formazioni geologiche della mappa Uggmm (Uni ed Global Geologic Map of the Moon) della Nasa. Il secondo metodo, detto strati-cromatico, si basa sulla correlazione tra la stratigra a lunare e una cronologia sempli cata. L’applicazione di questo metodo ha il vantaggio di permettere a chi legge una Si la ricostruzione immediata degli eventi nel loro ordine corretto, senza utilizzare mappe geologiche.
I più comuni minerali lunari sono cromaticamente suddivisibili in due tipologie maggiori: i minerali dei Mari lunari e quelli delle highlands, le terre. Queste ultime sono composte da soprattutto da anortosite e sono caratterizzate da una maggiore omogeneità minerale rispetto ai Mari: l’anortosite è costituita da un 95% di

plagioclasio e da un 5% di pirosseni, olivina, rocce magnesiache, minerali dalla risultante colorazione grigio-ocra. I Mari sono le aree più scure della Luna, in quanto presentano livelli maggiori di biossido di titanio e di ossido ferroso rispetto alle terre. L’ilmenite è la causa dei tipici colori dei Mari lunari, con sfumature dovute alla diversa concentrazione relativa di
titanio e ferro. Tralasciando quindi i minerali sostanzialmente ubiquitari, saranno l’anortosite color ocra e l’ilmenite ricca di titanio (sfumature viola, blu, verdi) o di ferro (marrone, rosso, arancione) a creare quasi tutti i contrasti cromatici della super cie lunare.
Sulla scena selenocromatica recitano un ruolo importante i Crateri con
Aloni Azzurri (AHC), con raggiere celesti (talora di colore verde acqua), sempre associate a un’elevata albedo: sono ejecta, fondi craterici e aloni d’impatto dei crateri più giovani. Si trovano anche aloni scuri, di colore caldo o freddo: sono i cossiddetti DHC (Dark Halo Craters), “buchi” relativamente piccoli (2-5 km) nel suolo lunare con intorno un anello scuro che spicca in un contesto più chiaro. Una parte minore origina da fenomeni vulcanici, mentre la maggioranza deriva da meteoriti che hanno “bucato” gli strati più super ciali, riportando in super cie materiali prelevati da strati profondi e scuri. Una particolare e più rara variante di crateri colorati sono i RHC (Red Halo Craters), dotati di piccole raggiere e aloni rossastri.
Vi sono poi i Red Spot, formazioni cromatiche e geologiche di origine vulcanica. Quelli strutturati in “domi” sono caratterizzati da un colore che va dal rosato al rosso mattone, passando per l’arancione, talora confusi per contaminazione con i basalti marini circostanti.

Il vulcanesimo lunare si manifesta anche in numerose zone piroclastiche, aree scure dalle sfumature composite (viola, blu, verde e granata scuro), intriganti dal punto di vista mineralogra co.
La relazione tra i colori e il tempo è stata riassunta in sette leggi selenocromatiche (vedi il riquadro).
La prima tiene conto dell’immane rimescolamento a cui è sottoposta la crosta lunare: le strutture geologiche più antiche sono anche quelle completamente sbiadite. Quando
risultano colorate, lo sono grazie alla contaminazione da formazioni più recenti. Per converso avremo colori nitidi da eventi recenti.
Guidati dai colori, piuttosto che seguire il timing lunare u ciale diviso in cinque periodi (pre-Nectariano, Nectariano, Imbriano, Eratosteniano e Copernicano) si preferisce dividere la storia della Luna in tre eoni, in base alla comparsa dei vari colori e della loro “purezza” o contaminazione.
L’eone Paleo-cromatico (da 3,85 a 4,3 miliardi di anni fa) fornisce, seppure contaminati, i più antichi colori che possiamo apprezzare sulla crosta lunare, i basalti di antichissimi Mari ormai sepolti. Nell’eone Mesocromatico (da 2,3 a 3,85 miliardi di anni fa) compare la maggior parte dei basalti marini e quindi la maggior parte dei colori della Luna, con un certo grado di contaminazione.
L’eone Neo-cromatico (da 2,3 miliardi di anni fa a oggi) è caratterizzato dall’azzurro dei cristalli generati dal calore degli impatti. Altre volte sono visibili strati diversamente colorati,
sollevati da strati profondi dall’impatto o generati dalla distruzione del meteorite coinvolto, ma si tratta in ogni caso di tinte nitide, correlate all’evento della formazione del cratere (colori propri).
N Strato neo-cromatico (da 2,3 Ga ad oggi)
M Strato meso-cromatico (da 2,3 a 3,85 Ga)
P Strato paleo-cromatico (da 3,85 a 4,3 Ga)

X livello di età composita o non definita; se in rosso indica un sito vulcanico/ piroclastico
>
> copertura orizzontale di materiali (ejecta, raggi, materiali e usivi) miscelazione prevalentemente verticale (contaminazione dal basso per microcraterizzazione) o trasparenza di materiali di livelli inferiori (terminatore, orizzonte)
n: una lettera minuscola seguita da due punti prima di una formula significa che l’evento causale ha una diversa età dei materiali esposti; sono consentite solo le lettere “n:” e “m:”
2 i numeri segnalano quanti livelli della stessa età e composizione sono sovrapposti.
La nostra analisi si trasferisce su mappe (geo-cromatiche o strati-cromatiche) con una speci ca simbologia. Per i metodi e i ni selenocromatici abbiamo dovuto elaborare speci ci criteri e linguaggi ma procediamo in modalità aperta, seppure coordinata dal Gawh per garantire coerenza. Siamo quindi disponibili a contributi e suggerimenti su ogni aspetto della nostra attività, dalle tecniche di acquisizione alla lettura delle immagini, no agli originali progetti di catalogazione che stanno per iniziare. Invitiamo quindi ogni astro lo interessato a contattarci all’indirizzo info@gawh.net, per partecipare a questo lavoro.
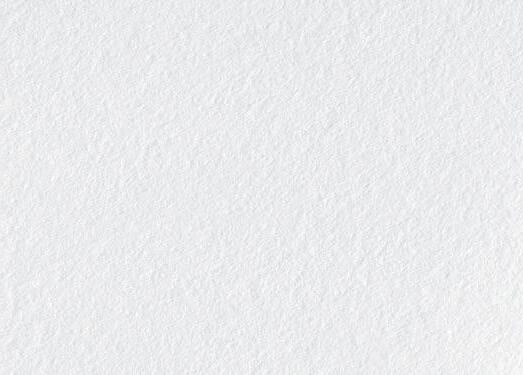

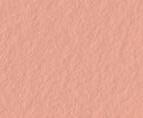





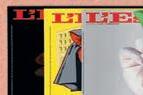
CARICATE LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE SU BFCSPACE.COM
LA REDAZIONE SCEGLIERÀ LE MIGLIORI PER “LE VOSTRE STELLE”
SONO TAGGATE DA UNA STELLA LE FOTO CHE HANNO VINTO LE NOSTRE SFIDE SOCIAL INQUADRA IL QR PER VISITARE LA GALLERY DELLE FOTO

NEBULOSE GUM 14 E GUM 15 NELLE VELE
Riprese dal Cile il 15/04/2023
Telescopio T5 (RH 200 f/2) del servizio in remoto Chilescope (vedi Cosmo n. 40).
Gum 14 e Gum 15 sono due nebulose a emissione che appartengono al Vela Molecular Ridge, un complesso molecolare ricco di stelle giovani e calde.

Albireo (Beta Cygni) ripresa da Ferrara il 04/05/2023

Telescopio Konus 200/1000 mm su montatura EQ6R Pro
Camera QHY 168c con filtro SvBony UV/IR-cut
Tubo guida 60/240 mm con Barlow 2x e Asi 290 Mini
Pose: 24x60 s, elaborate con App, Pixinsight, Photoshop
Autore: Massimo Di Fusco, Ferrara.
Gruppo di galassie appartenenti all’Ammasso della Vergine, riprese
da Manduria (TA) il 22/04/2023
Telescopio Sharpstar 94 Edph ridotto a 410 mm f/4,4 su montatura
Sky-Watcher EQ6R Pro

Camera ZWO ASI 294 MC Pro con ltro Optolong L-Pro
Guida con ZWO ASI 120 Mini
Pose: 74x300 s, elaborate con Pixinsight, Photoshop
Autore: Giacomo Pro’, Torricella (TA).

Ripresi da Taormina-Mazzarò (ME) il 25/04/2023
Fotocamera Canon Eos R5 con obiettivo Canon RF zoom 15-35 mm a 15 mm f/5 su cavalletto Manfrotto
Pose: 1352x8 s, intervallate da 4 s a 6400 ISO, elaborate con Lightroom, Sequator, Photoshop.
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.
Riprese da Civitavecchia il 23/04/2023
Fotocamera Nikon Z9 con obiettivo
Nikon 300 mm f/2,3 VR
Somma di due pose: ¼ s a f/4 1600 ISO per la congiunzione; 4 s a f/4, 800 ISO per l’albero.

Autore: Marco Meniero, Civitavecchia (RM).

Ripreso da Siracusa il 24/04/2023
Telescopio Lunt LS60THaDS60PT/B1200 su montatura iOptron Cem 70G
Camera Point Grey Grasshopper3 GS3-U3-28S4M
Elaborazione con AutoStakkert, ImPPG, Photoshop.
Autore: Salvo Lauricella, Siracusa.
Inquadra il QR per una animazione delle macchie visibili il 5 maggio.
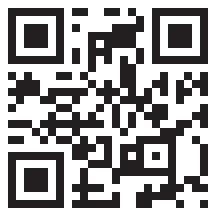

Ripresa da Pozzallo (RG) il 05/05/2023
Fotocamera Canon Eos R con obiettivo Canon EF 200 mm f/2,8 a f/8 su cavalletto Manfrotto
Pose 11 x 1/60 s (intervallate da 3 minuti) a 800 ISO, elaborate con Lightroom e Photoshop.
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.
Resto di supernova ripreso da Modena il 02/02/2023

Telescopio APM SD Apo 140 mm f/4,6 su montatura iOptron GEM 45
Camera ZWO ASI 533MC Pro con filtri Optolong L-Ultimate (3 nm) Optolong UV IR cut, Optolong L-eXtreme (7 nm)
Guida con ZWO ASI 220-290 MM Mini e ZWO OAG-L
Pose 127x600 s + 41x60 s (colori stelle), elaborate con Astro Pixel Processor, PS 2022, Topaz Denoise, Starnet v2, Siril-1.
Autore: Andrea Arbizzi, Modena.

Ripresa il 03/11/2022 con fotocamera Canon 6D e obiettivo Sigma 150-600 mm a 300 mm.
La nebulosa (distante circa 1000 anni luce) appare come una amma che sembra emergere dal cratere di sud-est. Il cratere è stato ripreso con il chiarore della Luna, mentre la nebulosa è stata ripresa dopo il tramonto lunare.
Pose: 240 s a f/5,6, 400 ISO per il paesaggio terrestre, 1 s a f/5,6, 25.600 ISO per le nuvole, 31x40 s a f/5,6, 3200 ISO per il cielo.
Autore: Dario Giannobile, Siracusa.
AL PLANETARIO DI MARINA DI CARRARA E NON SOLO
Il Gruppo Astro li Massesi (Gam), in prima linea nella divulgazione della scienza, non va in vacanza. Anche nei mesi estivi, i soci del Gam, animati da una forte passione per gli astri, organizzano per il pubblico di adulti e bambini, di esperti e semplici curiosi del cielo, tanti eventi dedicati alla scoperta dell’a ascinante mondo dell’astronomia in varie località nella provincia di MassaCarrara, in Toscana. Spettacoli nel planetario, formidabile strumento di simulazione del cielo, e osservazioni all’oculare di telescopi sono i principali “ingredienti” delle serate astronomiche a cura del Gam, delegazione territoriale dell’Unione Astro li Italiani (Uai), come ci spiega il presidente Pietro Baru etti, con il quale vogliamo anche ripercorrere alcuni momenti cruciali della storia associativa.
La nostra associazione nasce per opera di quattro giovani amici che abitavano in una frazione di Massa, nello spazio di nemmeno un chilometro quadrato, esattamente 50 anni fa, nel 1973, in un periodo in cui l’interesse per l’astronomia era forse più di uso di adesso e senza dubbio coltivato con meno “distrazioni”. L’associazione è attiva nel campo della divulgazione dell’astronomia e delle discipline scienti che a essa collegate e nel campo della ricerca astronomica amatoriale. Le prime attività di osservazione e di studio dei corpi celesti sono state svolte in collaborazione con il Gruppo italiano RV Tauri (Girvt) e con il Gruppo europeo di osservazione stellare (Geos).
Purtroppo, non abbiamo mai avuto una sede di nostra proprietà, ma nel corso degli anni siamo passati da locali
privati, messi a disposizione da soci, ad aule scolastiche, concesse in comodato gratuito. In questo periodo teniamo riunioni telematiche presso il Planetario “A. Masani” di Marina di Carrara o a casa di uno dei nostri soci. Nella sede associativa teniamo i nostri registri, libri, riviste e gli strumenti astronomici che usiamo durante gli eventi aperti al pubblico. Le riunioni telematiche, introdotte durante la pandemia, si sono rivelate uno strumento molto utile per rimanere in contatto con soci, vecchi e nuovi, disseminati in Italia e in centri di ricerca europei.
Terremo le nostre lezioni con cadenza settimanale al Planetario di Marina di Carrara - che gestiamo, in convenzione, dal 2006 - e serate astronomiche, osservative e no, su richiesta di enti pubblici e privati. Le location variano da stabilimenti balneari a rifugi sulle Alpi Apuane, da agriturismi a piazze e castelli nei dintorni di Massa. Invitiamo tutte le persone interessate a partecipare ai nostri eventi a consultare il sito web (www.astro limassesi.it) e le pagine Facebook del Gam e del Planetario.
Apriamo al pubblico le porte del planetario tutti i venerdì sera per o rire eventi dal format molto originale. Invece di svolgere la classica lezione sui movimenti del cielo e sul riconoscimento delle costellazioni, o riamo un incontro articolato in tre step.
Si parte con l’illustrazione di un tema astronomico, a scelta tra quelli selezionati in tanti anni di attività. Parliamo di circa cento argomenti, tra cui: L’astronomia col binocolo, L’astronomia al cinema, Buchi Neri, Quasar e GRB, Leopardi
» A sinistra: il logo del Gruppo Astrofili Massesi. Sotto: la serata astronomica a cura del Gam presso un agriturismo della provincia di Massa-Carrara. In basso: l’inizio dell’eclisse solare del 21 agosto 2017 ripresa dai soci del Gam in Colorado.


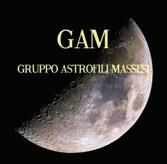
e Pascoli: due poeti appassionati del cielo. A questa parte segue la classica osservazione dei moti del Sole e del cielo nel corso dell’anno. Mostriamo anche il cielo ad altre latitudini, in presenza di visitatori stranieri. L’incontro si chiude con l’osservazione all’aperto, a occhio nudo o con un vecchio Celestron da 8”, meteo permettendo. In tutte le nostre attività cerchiamo di coinvolgere il maggior numero possibile di soci per garantire una formazione continua e nell’ottica di un ricambio generazionale.
O riamo alle scuole di ogni ordine e grado visite al planetario. Nell’arco dell’anno, circa cinquanta gruppi di studenti hanno l’opportunità di visitare il planetario con i nostri esperti. Svolgiamo inoltre, su richiesta delle scuole del territorio, altre tipologie di attività didattiche. Di recente ci siamo recati in un Liceo scienti co della Lunigiana dotato di un newtoniano da 20 cm acquistato anni fa, per illustrare a docenti e studenti il funzionamento del telescopio. Abbiamo svolto un breve

corso di astronomia e una lezione pratica sul campo per circa venti persone interessate a far “rivivere” il loro piccolo tesoro.
L’attività di ricerca astronomica si è ridotta negli anni ed è attualmente incentrata sull’osservazione di occultazioni asteroidali, un settore in cui l’astro lo può dare ancora un contributo signi cativo per la comunità scienti ca. Parliamo di questo ambito di studi, in modo particolareggiato, nel volume Piccoli mondi antichi della collana di libri I manualidel cielo della Uai. Il volume raccoglie gli articoli dedicati al tema delle occultazioni asteroidali pubblicati sulla rivista Astronomia della Uai dal 2014 al 2020, proponendoli in una veste rinnovata e ampliata, con l’aggiunta di capitoli inediti. Molti nostri soci sono ricercatori professionisti: dopo la laurea, hanno preso il dottorato in astronomia e astro sica e ora svolgono il proprio lavoro presso Osservatori astronomici in Italia e all’estero. Ci fa piacere
segnalare la grande prevalenza di donne fra questi ricercatori.
QUALI EVENTI DELLA STORIA ASSOCIATIVA RICORDA CON MAGGIORE ENTUSIASMO?
Posso citare il Congresso nazionale della Uai del 1999 organizzato a Massa e le due “spedizioni” per eclissi totali di Sole: la prima nel 1999 con un pullman che ci portò ad assistere all’eclisse in una campagna nei pressi di Reims, in Francia, e la seconda nel 2017 negli Stati Uniti. Sono indimenticabili anche le disavventure con la fauna notturna in occasione dei campi estivi del Geos organizzati per due anni in una collina della Lunigiana, le soddisfazioni per le foto di soci selezionate dalla Nasa come Apod (Astronomy Picture of the day), gli incontri all’alba per vedere la cometa Neowise dalla spiaggia o da un rifugio.
QUALI SONO I VOSTRI PROGETTI PER IL FUTURO?
Vogliamo continuare sul cammino che pratichiamo da anni e - se ci saranno le condizioni - realizzare un Osservatorio astronomico, anche se ci scoraggia l’inquinamento luminoso che domina tutta la zona di costa del Nord-ovest della Toscana e che rende poco appetibili anche le Apuane più vicine a noi. Un altro impegno sarà quello di trovare nuove leve, in grado di animare il gruppo e a ancare i nostri soci più anziani.




Segnalate eventi, mostre, star party a stroppa@bfcmedia.com
ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA CONFERMA
DEGLI EVENTI SUI SITI INDICATI
AMELIA (TR)
IL CIELO COME MAESTRO
DAL 12 AL 15 LUGLIO
Al Planetario di Amelia torna la Scuola estiva di didattica dell’astronomia; quattro intense giornate per gli appassionati di cosmologia, astrofotogra a, archeoastronomia e astrobiologia, con relatori d’eccezione. bit.ly/43dk8CP
LASCO DI PICIO, MONTE ROMANO (VT)
XII STAR PARTY DEL CENTRO ITALIA
DAL 21 AL 23 LUGLIO
Evento a cura del Gruppo Astro li Galileo Galilei di Tarquinia, per osservare e fotografare le bellezze del cosmo. Molto spazio sarà dedicato all’astronomia pratica e alla divulgazione. bit.ly/3MLQ3or
ROCCA DI PAPA (RM)
ASTROINCONTRO “STELLE AL PLANETARIO”
21 LUGLIO, ORE 20.45



Evento per tutti cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia: spettacolo multimediale nel Planetario, visita guidata al Parco astronomico “Livio Gratton” e osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio.
bit.ly/3MnXCjR



GUARCINO (FR)
SCUOLA ESTIVA DI ASTRONOMIA
DAL 24 AL 26 LUGLIO Organizzata dall’Associazione Tuscolana di Astronomia, è aperta a docenti, divulgatori scienti ci, operatori di osservatori astronomici e planetari per apprendere le tecniche di didattica e divulgazione scienti ca. bit.ly/3MnXUar
VERONA
LUNA IN PIAZZA BRA
27 LUGLIO, ORE 21.00



Serata astronomica dedicata alla scoperta e all’osservazione al telescopio della Luna, a cura del Circolo Astro li Veronesi. bit.ly/3K8fOwk
LIGNAN, NUS (AO)
SPETTACOLI AL PLANETARIO DAL MARTEDÌ AL SABATO
ORE 16.00 E 18.00



Spettacolo “Polaris” al Planetario per i più piccoli, alla scoperta dei pianeti del Sistema solare, e “Il grande ume del cielo” per tutti, dedicato a costellazioni e fenomeni celesti visibili nella stagione estiva. bit.ly/3R5BhrD
SALERNO
GALACTIC PARK
22 LUGLIO
Secondo appuntamento del 2023 di Galactic Park, il festival dedicato a tutti gli appassionati di astro sica, astronomia ed esplorazione spaziale, con eventi, laboratori e spettacoli. bit.ly/3Iv6mna
CAMPOFELICE, LUCOLI (AQ)
STAR PARTY DI CAMPO FELICE
DAL 14 AL 16 LUGLIO
Evento a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia presso il Rifugio Alantino, tre giorni sotto il cielo stellato e alla scoperta del Parco naturale regionale del Sirente-Velino. bit.ly/3WlLSmA
BARI
SPETTACOLI AL PLANETARIO TUTTI I WEEK-END
Presso il Planetario, con cupola di 15 metri di diametro, l’Associazione culturale Andromeda o re spettacoli di astronomia, spettacoli di teatro-scienza e laboratori per scoprire le meraviglie del cosmo. bit.ly/3pv1AvZ

CAGLIARI, EDIZIONI CONDAGHES, 2023
PAGINE 280 CON FOTO E ILLUSTRAZIONI B/N
FORMATO 17 X 24 CM
PREZZO € 25.00
Si potrebbe considerare la Sardegna un museo a cielo aperto? Probabilmente sì, considerando i circa 8000 nuraghi conosciuti, anche se solo una frazione di essi attende il riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. Non tutti questi antichi monumenti sono citati nel testo di Atzeni e Garau, il cui scopo non è enciclopedico. Ogni sito che viene citato (in totale sono una trentina) è corredato da fotogra e, planimetrie, dati e misure e ettuate in loco dagli stessi autori, nonché dalle conclusioni che hanno a che fare con l’astronomia. Perché lo scopo degli autori è di stabilire un report delle Nuove scoperte e analisi, come recita il sottotitolo dell’opera, annotando i fenomeni astronomici che si veri cano all’interno di questi siti in particolari momenti dell’anno, come gli equinozi o i solstizi. Questi siti sono studiati da tempo dagli archeologi, ma solo recentemente anche da studiosi di altre discipline, che hanno notato particolarità legate non solo alle loro imponenti strutture, ma anche ai loro orientamenti.
ANNALISA DOMINONI E BENEDETTO QUAQUARO
MILANO, IL SAGGIATORE, 2023
PAGINE 199
FORMATO 14,5 X 21,5 CM
PREZZO € 16,00
Come sarà abitare nello spazio? Alle soglie della colonizzazione spaziale, occorre porsi questa domanda, che costituisce il sottotitolo di un’opera molto istruttiva, perché cerca di vedere con occhi diversi ambienti e problemi che pensiamo di conoscere bene. L’esercizio preliminare alla progettazione delle città dell’universo viene proposto da Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro, due architetti che lavorano alla Scuola del Design del Politecnico di Milano e hanno collaborato con l’Agenzia spaziale europea per progettare gli interni dei moduli del Gateway lunare, la stazione spaziale che orbiterà intorno alla Luna, ma anche le architetture destinate alle future colonie lunari e marziane.
Dalla lettura si scopre che i primi a occuparsi del comfort delle navicelle spaziali furono i sovietici, grazie a Galina Balosova. Si impara come si possono usare luce e colori per allargare spazi angusti, permettendo a ciascuno di ritagliarsi un angolino su misura, dato che l’architettura deve preoccuparsi anche del benessere dei viaggiatori spaziali. Si capisce che occorre pensare
Sì, perché queste strutture archeologiche non sono posizionate a caso, ma sono orientate astronomicamente, come dimostrano le misure riportate nel testo. Quindi, è ancora più interessante visitarli in occasioni dei fenomeni che avvengono in determinati giorni dell’anno. In particolare, gli autori si so ermano sui fenomeni luminosi, in cui i fasci di luce che attraversano aperture opportunamente posizionate creano particolari proiezioni luminose all’interno delle strutture stesse. Alessandro Atzeni e Sandro Garau sono soci fondatori del Gruppo Ricerche Sardegna, un gruppo che si propone di osservare i siti archeologici della loro terra, dai circoli di pietre ai menhir, dai sepolcri megalitici alle muraglie e dai pozzi sacri ai nuraghi, per la salvaguardia e valorizzazione che passa anche attraverso il legame astronomico. A corollario del testo vi sono una mappa del territorio e una tabella del censimento e ettuato dagli autori della ricerca.
Gabriella Bernardigli ambienti in modo che siano funzionali, ma anche gradevoli, ricordando che gli astronauti vivono in situazioni di stress continuo. È un problema tutt’altro che semplice e a lungo considerato di secondaria importanza, a fronte delle richieste legate alla sicurezza. Oggi, anche grazie al “turismo spaziale”, il design è entrato nella progettazione delle capsule, che sono diventate più confortevoli.
Esplorare l’architettura degli ambienti spaziali è un problema affascinante, perché il corpo umano privo di peso fluttua nell’aria, assumendo una posizione neutra. Nello spazio non esistono il sopra e il sotto, cambia la percezione di odori e sapori e perfino i vestiti devono essere ripensati.
E una volta arrivati a destinazione, si apre il capitolo delle abitazioni sugli altri pianeti, dove si scoprono progetti che sembrano usciti da un libro di fantascienza, come le dimore fatte con il micelio dei funghi.
Patrizia Caraveo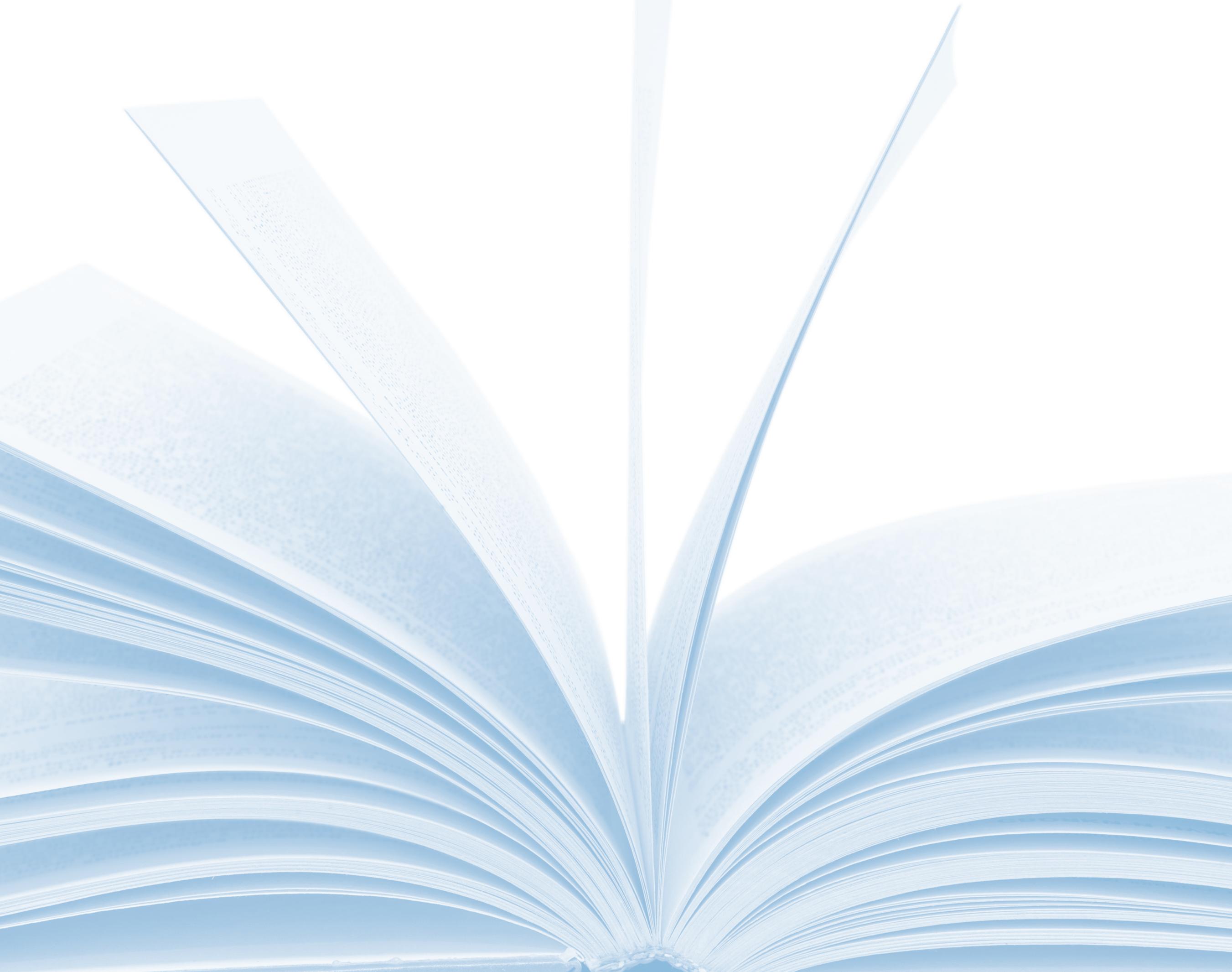
OFFERTA DEDICATA AI LETTORI DI COSMO
Acquista 6 libri a scelta dalla lista al prezzo di 60 euro, spese di spedizione incluse.
La ricerca amatoriale delle supernovae

Giancarlo Cortini, Stefano Moretti
Super-occhi per scrutare il cielo
Walter Ferreri, Piero Stroppa
I pianeti e la vita
Cesare Guaita
I giganti con gli anelli
Cesare Guaita
Alla ricerca della vita nel Sistema Solare
Cesare Guaita
Oltre Messier
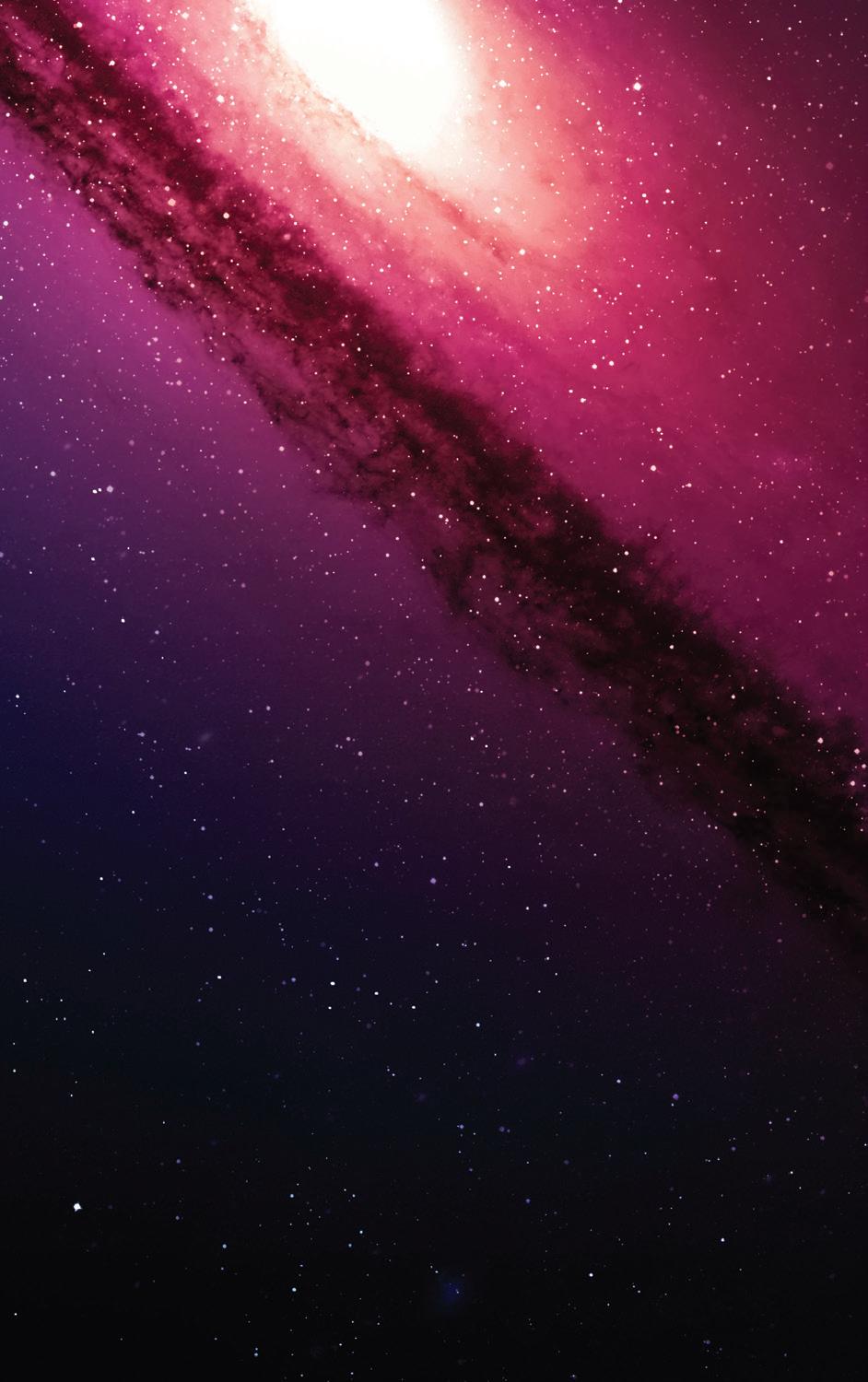
Enrico Moltisanti
I grandi astrofili Gabriele Vanin
La Luna
Walter Ferreri
In viaggio nel Sistema Solare
Francesco Biafore
Come funziona l'Universo
Heather Couper, Nigel Henbest
Come fotografare il cielo
Walter Ferreri
L'osservazione dei pianeti
Walter Ferreri
Cento meraviglie celesti Gabriele Vanin
Effettua l’ordine comodamente su BFC Store (bfcstore.com): acquistando il coupon “I best seller di Cosmo” riceverai un’email di conferma, rispondendo alla quale potrai indicare i titoli scelti.

ASTRONOMIA / COSMOLOGIA / SPAZIO
OSSERVATORI / STRUMENTI / ASTROFOTOGRAFIA INTERVISTE IN STUDIO E SERVIZI

DA UN’IDEA DI FRANCO CAPPIELLO CONDOTTO DA WALTER RIVA PRESENTA ADRIANA LALA
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA UNIONE ASTROFILI ITALIANI
TUTTE LE 12 PUNTATE DISPONIBILI SU BFCVIDEO.COM
