VALENTINA TERESHKOVA
L’ALTRA METÀ DELLO SPAZIO
TUTTI GLI ESOPIANETI DEL WEBB
IL PROGETTO SHARA
IL CIELO DEL MESE


VALENTINA TERESHKOVA
TUTTI GLI ESOPIANETI DEL WEBB
IL PROGETTO SHARA
IL CIELO DEL MESE

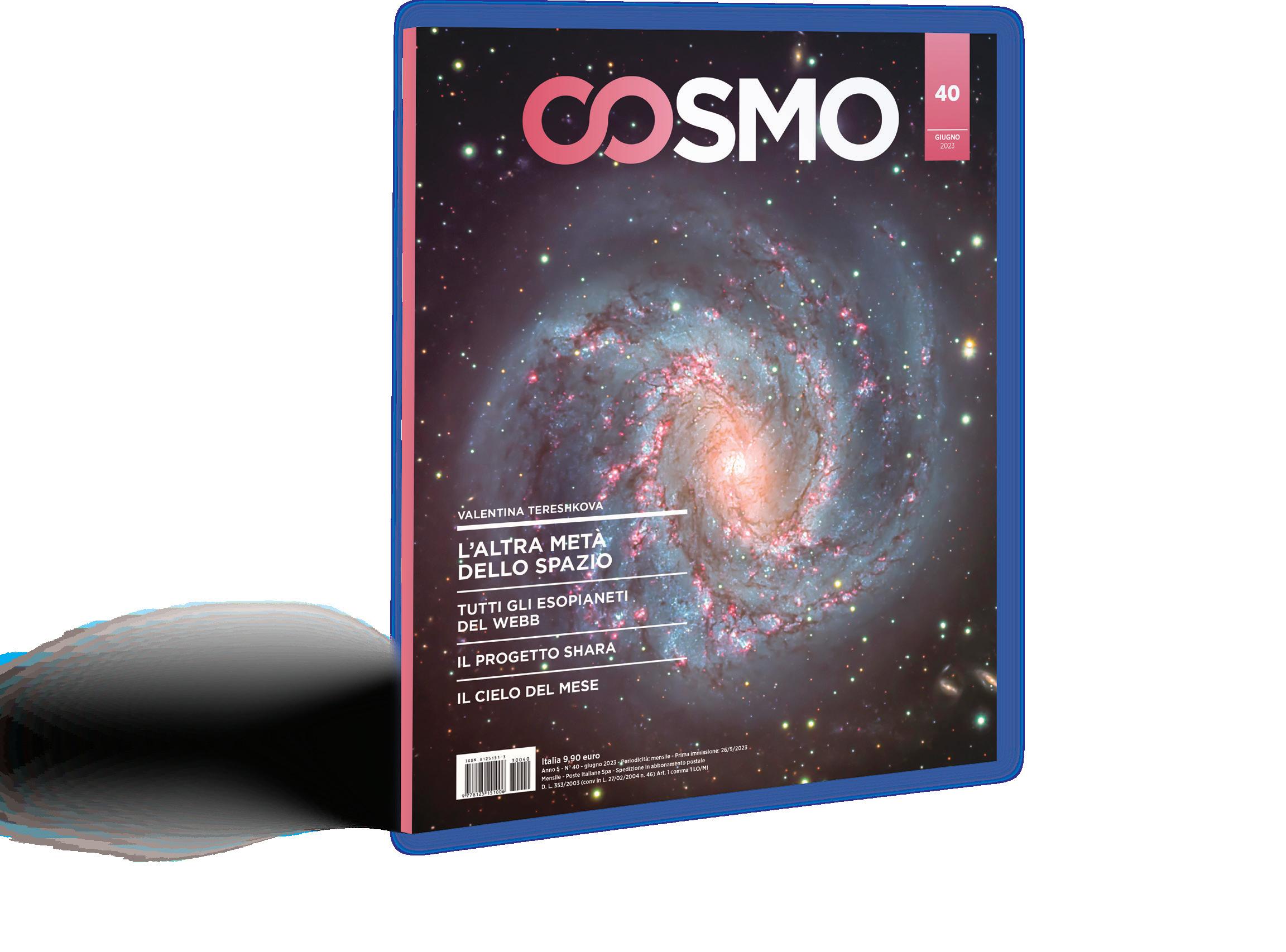

NUMERI ARRETRATI Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it
Il costo di ciascun arretrato è
*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
Invece di 118,80€



Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

Cognome

Indirizzo N° Prov.
Tel.
Nome CAP Città
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
rilascio nego il consenso per le attività di profilazione

Aun anno e mezzo dal lancio del James Webb Space Telescope, partito il giorno di Natale del 2021, a più di un anno dalla rst light (13 febbraio 2022) e a poco meno di un anno dal rilascio delle prime immagini (12 luglio 2022), possiamo azzardare un primo bilancio. Il sito Alive Universe Today (bit.ly/3I4B32m) sta raccogliendo le immagini più signi cative dell’epopea del nuovo occhio spaziale. Fra esse spiccano quelle riprese a partire dall’inizio della sua attività scienti ca, dopo essere entrato in orbita attorno al punto lagrangiano L2. È una sequenza impressionante. Come hanno già mostrato le primissime immagini, quelle di use lo scorso luglio tramite la conferenza stampa dalla Casa Bianca alla presenza del presidente Usa Joe Biden, colpisce soprattutto la straordinaria varietà degli oggetti ripresi: si va dai campi di galassie alle nebulose, dai pianeti di casa nostra a quelli extrasolari, no alle immagini dell’impatto della sonda Dart sul piccolo asteroide Dimorphos. E una grande sorpresa sembra già celarsi dietro le quinte, in particolare grazie alle riprese più profonde. Sembra, infatti, che le primissime galassie fossero troppe o troppo luminose rispetto a quanto previsto dagli astronomi, con una abbondanza inattesa di quelle a forma di disco. Vedremo se ciò condurrà a una rivoluzione nei modelli di formazione galattica.
Anche Cosmo sta seguendo le grandi gesta del James Webb. Nei due numeri precedenti abbiamo esaltato la sua capacità di riprendere nell’infrarosso i pianeti del Sistema solare e i suoi corpi minori. In questo numero, sempre a rma di Cesare Guaita, ci dedichiamo invece alle incredibili capacità del nuovo telescopio spaziale nel catturare gli spettri delle atmosfere degli esopianeti.Senza dimenticare le news che in ogni numero descrivono l’avanzamento delle sue scoperte. Ed è fuor di dubbio che continueremo a seguire il Webb anche in futuro, con la grandissima attenzione che si è meritato in questo anno di immagini mozza ato.

ANNO 5 - NUMERO 40 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019
CASA EDITRICE BFC SPACE
Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI
Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com
DIRETTORE RESPONSABILE Walter Riva riva@bfcmedia.com
DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com
HANNO COLLABORATO
Gabriella Bernardi, Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Massimo De Fusco, Giuseppe Donatiello, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Piero Mazza, Gianluca Ranzini, Alessandro Ravagnin, Andrea Simoncelli, Anita Maria Vena.

GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com
PUBBLICITÀ Newton Winston info@bfcspace.com
ABBONAMENTI
Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia
ARRETRATI
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it
STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com

IN COPERTINA: La galassia M83 nella costellazione dell’Idra, ripresa in remoto dal Progetto Shara.

NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/
LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF
SPAZIO
14 COVER STORY VALENTINA TERESKHOVA
20“RIPARTIREI ANCHE DOMANI… PER MARTE”
24 ASTRONAUTICA L’ALTRA METÀ DELLO SPAZIO

28 IL COSMO DI MALERBA IL FESTIVAL DELLO SPAZIO 2023
CIELO
50 FENOMENO DEL MESE LA MASSIMA ELONGAZIONE ORIENTALE DI VENERE
54 CIELO DEL MESE
62 OSSERVAZIONI UN PASTORE DEL CIELO A GUARDIA DEI SETTE BUOI
66 L’ORA DI ASTRONOMIA L’EVAPORAZIONE DEI BUCHI NERI
UNIVERSO
30 TEMA DEL MESE
TUTTI GLI ESOPIANETI DEL WEBB
36 RADIOASTRONOMIA

FAST RADIO BURST
40 CIELO E TERRA
UN TEMPO PER OGNI PIANETA

44 PERSONAGGI
HERMANN OBERTH, E LA FANTASCIENZA DIVENNE REALTÀ
70 CITIZEN SCIENCE CLASSIFICARE LE STELLE VARIABILI
76 ASTROFOTOGRAFIA IL PROGETTO SHARA

82 LE VOSTRE STELLE
88 UAI INFORMA ASSOCIAZIONE CASCINESE ASTROFILI
92 PLANETARI PLANIT 2023: UN’OCCASIONE SPECIALE
94 EVENTI SOTTO IL CIELO
96 RECENSIONI
Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni, podcast, gallery).

PSYCHE: LANCIO CONFERMATO A OTTOBRE
8
9 IL LANDER HAKUTO-R SI SCHIANTA SULLA LUNA
LA CINA PRIVATA IN ORBITA CON PROPELLENTE LIQUIDO
10

Da oggi è possibile sorvolare virtualmente la super cie di Marte, osservandola nei minimi dettagli, grazie al Global CTX Mosaic of Mars, un’immagine interattiva che permette a tutti – scienziati o semplici curiosi – di esplorare nel dettaglio il Pianeta rosso, sorvolando scogliere, crateri da impatto e tracce di polvere sulla super cie. Sviluppato nei laboratori del Caltech in California, il mosaico marziano si basa su oltre 110mila fotogra e scattate dalle tre fotocamere del Mars Reconnaissance Orbiter (Mro) della Nasa ed è l’immagine globale a più alta risoluzione (25 metri quadrati di super cie per pixel) del Pianeta rosso mai creata, per un totale di 5,7 terapixel Mentre la High-Resolution Imaging Science Experiment fornisce immagini a colori di elementi della super cie piccoli come un tavolo da pranzo, la Context Camera (Ctx) fornisce immagini in bianco e nero, dando una visione più ampia del terreno intorno a questi elementi. La terza fotocamera è la Mars Color Imager, che produce una mappa delle condizioni climatiche globali giornaliere, con una risoluzione spaziale più bassa delle altre due. Il mosaico ha richiesto sei anni e decine di migliaia di ore di lavoro per comporre il puzzle. A questo scopo è stato sviluppato un algoritmo in grado di abbinare le immagini in base alle caratteristiche catturate. Ma i tecnici hanno dovuto comporre manualmente 13mila immagini che l’algoritmo non riusciva ad abbinare. E sono rimaste delle zone vuote, che rappresentano parti di Marte non riprese dalle fotocamere di Mro, oppure aree oscurate da nubi o polvere. Nonostante la complessità di questo strumento, chiunque può liberamente accedervi al link bit.ly/3oZ2ELO e usarlo, magari per accompagnare il rover Perseverance nell’esplorazione del cratere Jezero (vedi gura in alto), oppure per visitare Olympus Mons, il vulcano più alto del Sistema solare, grazie anche alla aggiunta dei dati topogra ci della missione Mars Global Surveyor, sempre della Nasa.


La missione Solar Orbiter dell’Agenzia spaziale europea, frutto della collaborazione con la Nasa e del contributo dell’Agenzia spaziale italiana, potrebbe essere a un passo dal risolvere il paradosso della corona solare, che vede la parte più esterna dell’atmosfera del Sole raggiungere temperature fino a circa 2 milioni di gradi, molto più elevate rispetto ai circa 5500 °C che caratterizzano la sua superficie.

Nel marzo dell’anno scorso, quando la sonda era ancora a metà della distanza Terra-Sole, il suo Extreme Ultraviolet Imager (Eui) ha ripreso immagini ad altissima risoluzione del Sole per indagare il fenomeno della riconnessione magnetica, la repentina riconfigurazione delle linee del campo magnetico che si aggrovigliano come degli elastici, accumulando energia e rilasciandola poi verso gli strati superiori dell’atmosfera.
Le immagini di Eui hanno dimostrato che la riconnessione magnetica avviene in modo costante su piccola scala, producendo dei blob di materia che vengono lanciati a circa 80 km/s verso l’alto. Questo flusso costante di energia può spiegare il riscaldamento eccezionale della corona. L’obiettivo dei ricercatori è ora quello di osservare la dinamicità magnetica a una risoluzione ancora più elevata, in occasione dei prossimi avvicinamenti della sonda al Sole. L’ultimo passaggio ravvicinato di Solar Orbiter è avvenuto il 10 aprile scorso, quando la sonda si trovava ad appena il 29% della distanza tra la Terra e il Sole. Inquadra il QR per un video del fenomeno osservato da Solar Orbiter
Non basta l’appartenenza di un esopianeta alla “zona abitabile” della sua stella per garantirne l’abitabilità da parte di forme di vita. La vita è molto esigente e richiede anche altre condizioni, come la presenza di un campo magnetico che possa schermare le pericolose radiazioni provenienti dallo spazio. Proprio come avviene sulla Terra.

YZ Ceti b, un pianeta roccioso in orbita intorno a una stella distante 12 anni luce da noi, sembra soddisfare questa richiesta. Scoperto nel 2017, è un esopianeta di tipo terrestre che orbita attorno a una stella di tipo M in soli due giorni. Sebastian Pineda e Jackie Villadsen hanno puntato verso YZ Ceti b la schiera di radiotelescopi del Very Large Array. Analizzando i dati raccolti, i ricercatori hanno scoperto la presenza di segnali radio che sono la probabile spia della presenza di un campo magnetico intorno al pianeta.
Le onde radio emesse dagli esopianeti sono rilevabili anche su lunghe distanze, ma devono essere molto intense. In genere arrivano da pianeti grandi almeno come Giove, ma nel caso di YZ Ceti b la vicinanza alla stella potrebbe innescato l’emissione di onde radio, grazie all’attraversamento del materiale stellare da parte del campo magnetico del pianeta.
YZ Ceti b non è comunque “abitabile”, essendo troppo vicino alla sua stella, ma lo studio del suo campo magnetico è un precedente interessante e offre lo spunto per un nuovo campo d’indagine, quello del clima spaziale extrasolare
Arp 220 è un oggetto dell’Atlante delle galassie peculiari compilato dall’astronomo Halton Arp, situato a 250 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Serpente. Ed è uno degli eventi più spettacolari dell’Universo: una gigantesca collisione tra due galassie, iniziata circa 700 milioni di anni fa e ora ripresa nell’infrarosso dagli strumenti del telescopio spaziale James Webb
La stragrande maggioranza della produzione totale di energia di Arp 220 avviene proprio nell’infrarosso, caratteristica che le vale l’appartenenza al gruppo delle “galassie ultra-luminose nell’infrarosso” (Ulirg). La sua luminosità nell’infrarosso è pari a quella di oltre tremila miliardi di soli, superata solo dai quasar più luminosi (anch’essi generati da scontri tra galassie).
La collisione delle due galassie ha innescato un’ondata di formazione stellare (starburst) che ha portato alla comparsa di circa 200 ammassi stellari in una regione densa e polverosa di circa 5000 anni luce di diametro, al cui interno sono stati individuati 100 resti di supernove e una quantità di gas uguale a quella presente all’interno di tutta la Via Lattea. Le osservazioni con il Chandra X-ray Observatory hanno rivelato la presenza di un buco nero supermassiccio in ciascuno dei due nuclei originari.

Nell’immagine si notano le deboli code di marea presenti alla periferia dell’oggetto, costituite da stelle e gas, prodotte dall’interazione gravitazionale tra le galassie. Inquadra il QR per un video di AsiTV dedicato ad Arp 220.

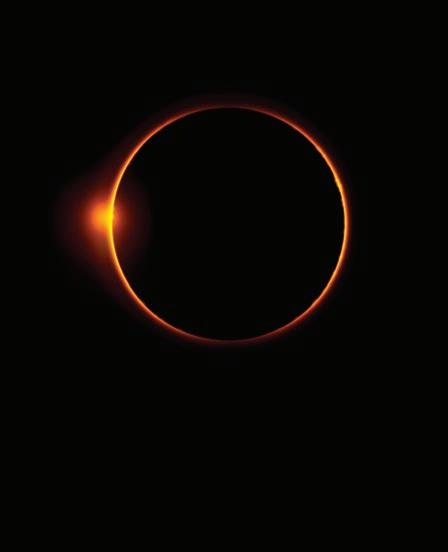
Il buco nero supermassiccio (Smbh) della galassia M87 è ancora al centro dell’attenzione. Di questo oggetto, nel 2019, fu presentata la prima immagine radio, ottenuta attraverso tecniche interferometriche dall’Event Horizon Telescope. Di recente, quella immagine ha subito un nuovo trattamento, utilizzando tecniche di intelligenza arti ciale, diventando più nitida rispetto alla prima versione.
Ora abbiamo anche la ripresa simultanea dell’ombra del buco e della parte iniziale del potente getto relativistico prodotto dal mostro celeste. Grazie al Global Millimeter Vlbi Array, una schiera di radiotelescopi in Europa e Nord America, alle antenne dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array in Cile e del Greenland Telescope, che hanno formato un radiotelescopio virtuale grande quanto l’intera Terra.

Ogni grande galassia ospita nel suo centro un Smbh; quello di M87, a 55 milioni di anni luce da noi, ha l’asse di rotazione quasi esattamente lungo la nostra direzione di vista e questo permette di osservare frontalmente l’orizzonte degli eventi e la base del getto collimato che erutta dal disco di accrescimento.
La stessa rete di radiotelescopi punta adesso a osservare altri buchi neri utilizzando di erenti lunghezze d’onda, per rivelare dettagli sempre più ni in tali strutture. Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3LgPfWK

La Piramide di Cheope è la più antica delle “sette meraviglie” del mondo classico e l’unica ancora quasi intatta, ma la tecnica utilizzata per costruirla rimane un mistero. Sicuramente, deve avere una struttura interna per scaricare i pesi e stabilizzarla, ma tutto questo è inaccessibile: le uniche cavità interne note sono quelle raggiungibili dall’esterno e percorse dai visitatori. Perciò è nato il progetto ScanPyramids, che sfrutta il usso di muoni, particelle di alta energia prodotte dall’interazione dei raggi cosmici con gli atomi dell’atmosfera. I muoni vengono assorbiti dal materiale che incontrano e l’e etto è tanto più grande quanto maggiore è lo spessore del materiale. Disponendo lungo i corridoi accessibili dei rivelatori di muoni forniti dall’Università di Nagoya e dal Cea di Paris Saclay, è stata stimata la quantità di materiale che separa i rivelatori dall’esterno. Così, si è evidenziata la presenza di un’area vuota lunga una decina di metri che si trova sopra una struttura ben visibile sul lato nord della piramide, forse un’antica porta.
La misura del usso dei muoni può servire anche per monitorare i movimenti della lava all’interno dei vulcani. Il telescopio Astri, costruito dall’Istituto nazionale di astro sica sulle pendici dell’Etna per studiare i raggi gamma di altissima energia di origine celeste, potrebbe fare anche una muonogra a del vulcano, aprendo orizzonti “cosmici” alla vulcanologia. Inquadra il QR per un video sulle radiogra e muoniche.





Dopo mesi di dichiarazioni contrastanti, e in alcuni casi minacciose, alimentate dalle tensioni politiche dovute all’invasione dell’Ucraina, il governo della Federazione Russa ha u cializzato l’estensione al 2028 della sua partecipazione alla Stazione spaziale internazionale (Iss): lo ha fatto con una lettera del capo di Roscosmos, Juri Borisov, il nuovo numero uno dell’agenzia russa dai toni decisamente più pacati e collaborativi rispetto al predecessore.
Il documento è stato inviato all’amministratore della Nasa Bill Nelson, al capo dell’Esa Josef Aschbacher, al presidente della Csa Lisa Campbell e al ministro giapponese Keiko Nagaoka, come riferisce Roscosmos.
Il programma Iss è il progetto internazionale più grande e di maggior successo nel campo dello spazio - sottolinea il numero uno di Roscosmos - e sono lieto che un laboratorio così unico continuerà il suo lavoro e contribuirà alla realizzazione delle idee più audaci dell’umanità nell’esplorazione dello spazio”. Un anno fa, dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina, l’agenzia spaziale aveva dichiarato che la partecipazione era garantita no al 2024 e che, nel caso di revoca, la Russia avrebbe dato un adeguato preavviso ai partner. Nei mesi scorsi Borisov aveva annunciato che la collaborazione sarebbe potuta continuare no al 2028, almeno no alla messa in orbita della futura stazione spaziale russa Ross ( gura). Nasa ed Esa hanno deciso di recente di prolungare l’operatività della Iss no al 2030.

Nel centro per l’addestramento degli astronauti di Houston, in Texas, ha aperto le porte al pubblico l’habitat Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog) della Nasa, stampato in 3D e costruito per simulare l’ambiente marziano il più realisticamente possibile. A partire da questo mese di giugno, Chapea ospita una missione della durata di un anno, nella quale quattro volontari, non astronauti di professione, aiuteranno la Nasa a prepararsi per l’esplorazione umana di Marte, il prossimo grande passo dopo il ritorno dell’uomo sulla Luna grazie alle missioni Artemis Durante la simulazione, i membri dell’equipaggio svolgeranno diversi tipi di attività, tra cui nte passeggiate marziane, operazioni robotiche, attività di manutenzione, esercizio sico e coltivazione del raccolto. Le passeggiate verranno e ettuate in una speciale area dell’habitat di circa 365 metri quadrati, che è stata riempita con sabbia rossa per simulare il paesaggio marziano (vedi gura). Il laboratorio include anche gli alloggi, una cucina e aree dedicate per attività mediche, ricreative, sport, lavoro e crescita delle colture, nonché un’area di lavoro tecnica e due bagni. La missione sarà la prima di una serie di tre esperimenti già in programma, tutti della durata di un anno: il secondo e il terzo sono previsti rispettivamente per il 2025 e il 2026. A.L.
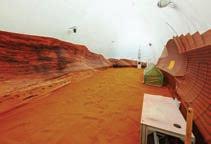
La Nasa ha confermato che la sonda Psyche partirà entro la ne del 2023 con alcune modi che alla traiettoria per sfruttare l’e etto della onda gravitazionale o erta da Marte. Questo permetterà l’avvicinamento all’asteroide metallico (16) Psyche, anche se in un punto diverso dell’orbita, rispetto a quanto inizialmente programmato, a causa dei cambiamenti nelle tempistiche di lancio. Gli asteroidi sono al centro di una vasta campagna di osservazioni e studio sia per motivi scienti ci legati alle origini e all’evoluzione del Sistema solare, sia per evitare eventi catastro ci che potrebbero colpire la Terra. La Nasa ha confermato che la nestra di lancio della missione si aprirà il 5 ottobre e si chiuderà il 25 dello stesso mese. La traiettoria prevede un yby di Marte con l’arrivo in orbita intorno all’asteroide metallico per l’agosto del 2029
La durata della missione sarà di 26 mesi, che verranno sfruttati per raccogliere dati da diverse altitudini. Con il nuovo piano di volo, ci potrebbe essere una migliore gestione dei propulsori elettrici e dell’utilizzo del propellente, così da consentire una missione di maggiore e cacia. Modi cando il periodo di lancio, è stato modi cato anche il periodo del primo ingresso in orbita e questo ha previsto di rivedere anche alcune operazioni.

Dopo un viaggio di 5 mesi e una corretta inserzione in orbita, il lander Hakuto-R della missione M1 ha impattato la Luna Tutto si è svolto normalmente nché, durante la discesa verso la super cie, gli ingegneri dell’azienda giapponese ispace hanno notato che le stime del carburante residuo stavano raggiungendo il valore minimo. Poco dopo, la velocità di discesa è aumentata e sono state perse le comunicazioni con il lander, che in tutta probabilità si è schiantato sulla super cie del nostro satellite. Assieme alla missione di ispace niscono, senza essere mai davvero iniziate, anche le missioni del piccolo rover Rashid dell’agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti e del Transformable Lunar Robot della Jaxa, entrambi a bordo di Hakuto-R. Un brutto nale per la prima missione privata verso la Luna, che però ha visto tanti successi per un’azienda al suo volo spaziale inaugurale. Fortunatamente per lei, ispace si è tutelata con la compagnia giapponese Mitsui Sumitomo Insurance, sussidiaria di MS&AD, nel primo caso di assicurazione della Lunar Economy. Questo non ha evitato il crollo in borsa dell’azienda giapponese all’indomani della perdita del segnale col lander. Nonostante ciò, ispace continua a puntare alla Luna con le prossime due missioni programmate: la M2 nel 2024 e la M3 nel 2025.

In gura, un’eccezionale foto della macchia prodotta dall’eclisse solare del 20 aprile scorso sulla Terra, ripresa dalla sonda M1 prima del tentativo di allunaggio. D.L.
Per la prima volta un’azienda privata cinese è riuscita a lanciare con successo un razzo con propellenti liquidi. L’azienda pechinese Space Pioneer ha lanciato il razzo Tianlong-2 il 2 aprile, portando in orbita un piccolo satellite dimostrativo da 8 kg realizzato dalla Hunan Hangsheng Satellite Technology. Ma a bordo c’era anche una zavorra per simulare un pieno carico. Questo razzo, con 32,8 metri di altezza e 3,35 di diametro, può portare in orbita bassa ben due tonnellate

A ridimensionare l’impresa di Space Pioneer sono i tre motori del razzo, realizzati con stampa 3D e di produzione statale. L’azienda ha però dichiarato di voler produrre in autonomia questi motori e spera di raggiungere un ritmo di 50 all’anno. I motori potranno anche essere ripensati in una versione riutilizzabile, e questo sarebbe un balzo gigante per la Cina. Un’innovazione a cui sta lavorando anche i-space, azienda di Pechino da non confondere con l’omonima giapponese, che mira a diventare la SpaceX orientale.
Il successo di Space Pioneer rimane importante poiché nessun’altra startup aveva mai raggiunto l’orbita nel lancio inaugurale. Nemmeno la concorrente pechinese LandSpace nel 2018 con il razzo a propellente solido Zhuque-1. Ci aveva riprovato nel dicembre 2022 con Zhuque-2, il suo primo razzo a propellente liquido, ma ancora una volta senza successo. Ora però la Cina ha un nuovo razzo e la partita per il dominio dell’orbita bassa continua.

ESATTA REPLICA DELL’ORIGINALE REALIZZATA IN ALLUMINIO FORMATO 28X19,5 CM PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA MISSIONE

DISPONIBILE SU BFCSTORE.COM (bit.ly/41Fv5w4)

A 20,00 EURO (SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE)


Vengono spesso de nite come “L’altra metà del cielo”. Ma a buon diritto, possiamo anche de nirle come “L’altra metà dello spazio”. Le donne astronauta, infatti, sono grandi protagoniste dello scenario spaziale. Ed esattamente sessant’anni fa avvenne il primo, pionieristico passo orbitale di Valentina Tereshkova, datato 16 giugno 1963. Da allora, le missioni spaziali hanno visto una presenza crescente di donne astronauta e cosmonauta, provenienti da varie nazioni e ormai non più solo esclusiva di russe e americane. La prima della storia, però, è stata Valentina Vladimirovna, una donna straordinaria che oggi dimostra un entusiasmo per lo spazio pari a quello di sessant’anni fa.
DUE ANNI DOPO GAGARIN
» A sinistra: la cosmonauta russa Valentina Tereshkova. Inquadra il QR per un video di Asi TV dedicato alla prima donna nello spazio.
“Ecco la vera Miss Universo: è russa, e si chiama Valentina Tereshkova”. Questo è solo uno tra i tanti titoli apparsi sui giornali di tutto il mondo il 17 giugno 1963. Il giorno prima, una donna era entrata in orbita attorno al nostro pianeta a bordo di una navicella Vostok, come quella che già due anni prima aveva portato il primo uomo nello spazio, Jurij Gagarin. Valentina Tereshkova, 26 anni all’epoca della sua missione, divenne la prima donna a volare tra le stelle, scrivendo un altro primato nel libro della conquista dello spazio e della cosmonautica russa. Mentre gli americani archiviavano con successo il Progetto Mercury ed erano già proiettati al Programma Gemini, i russi preparavano un’altra impresa spettacolare, per concludere trionfalmente il loro Progetto Vostok (in russo “Oriente”), iniziato con la missione di Gagarin. La spettacolarità era data da due lanci Vostok nel giro di 24 ore e l’appuntamento in orbita, sia pure a distanza. Per dare ampia visibilità ai propri successi in campo spaziale e per raggiungere primati in anticipo sugli americani, i responsabili del programma spaziale russo

decisero di inviare in orbita una donna. Così, un razzo vettore Vostok salì nel cielo del Kazakhistan con in vetta la Vostok 6, che ospitava Valentina Tereshkova. Due giorni prima, con la Vostok 5, era partito Valerj Bikovskij, che dalla quota di 235 per 181 chilometri e durante il suo giro attorno alla Terra di 88 minuti, attendeva di intravvedere la Vostok 6 con a bordo la prima donna delle stelle.


Il primo gruppo di cinque cosmonaute era stato selezionato nel febbraio del 1962. L’obiettivo era di addestrare il gruppo per poi candidare una donna a un volo del Programma Vostok. Alle candidate
veniva richiesta grande esperienza come paracadutiste (si scoprirà anni dopo che al ritorno i cosmonauti non toccavano terra con la Vostok, ma si lanciavano con un seggiolino eiettabile), un’età non superiore ai 30 anni, un’altezza non superiore a 172 centimetri e un peso non superiore ai 70 chilogrammi.
Il responsabile del Corpo cosmonauti, Nikolaij Kamanin, aveva ottenuto il via libera per la selezione delle prime cosmonaute nell’ottobre 1961. Si candidarono in molte: poche erano però quelle con esperienze da pilota, ma erano decisamente di più le paracadutiste.
Nel febbraio 1962 le cinque candidate iniziarono l’addestramento presso Star City, nei pressi di Mosca, unendosi al gruppo che comprendeva cosmonauti già famosi, come Jurij Gagarin e German Titov, e vennero a date, per la preparazione speci ca alla Vostok, al Progettista capo del programma, Sergheij Korolev “Fu davvero entusiasmante,” - ci ha detto Valentina Tereshkova - “era come vivere un sogno. L’addestramento era duro, e comprendeva molte ore di ginnastica e preparazione sica, oltre che quella tecnica, ma eravamo giovani e piene d’entusiasmo. E, tutto sommato,

eravamo anche carine...” - dice sorridendo mentre commenta un lmato del 1962 che la ritrae in addestramento.
DELLE DUE VOSTOK
La missione spaziale di Valentina Tereshkova si svolse all’inizio con regolarità, ma qualche apprensione ci fu la sera del 16 giugno, quando

*ANTONIO LO CAMPO GIORNALISTA AEROSPAZIALE, SCRIVE PER QUOTIDIANI NAZIONALI
E PERIODICI, E PER “COSMO” CURA LA SEZIONE SPAZIO.
l’agenzia Tass informò che la Vostok 6 era uscita dall’orbita prevista. L’agenzia rassicurava che la situazione si sarebbe presto normalizzata e che non preoccupava più di tanto i tecnici a terra. Il giorno successivo, Radio Mosca annunciava che il doppio volo delle Vostok procedeva regolare; Valentina aveva riferito di aver trascorso bene il periodo di riposo in orbita, anche se il sonno non poteva certo essere lato liscio come se niente fosse...

Le due navicelle si incrociarono e i due cosmonauti comunicarono tra loro: “Ehi, gabbianella, mi
senti?” - era la voce di Bikovskij“Sì, perfettamente”. “Ogni tanto canticchiavo” - ci ha raccontato la Tereshkova - “un po’ per allentare la tensione, un po’ perché mi sentivo tutto sommato contenta e tranquilla”. A terra giungevano le immagini televisive in bianco e nero di use dal centro di Mosca, disturbate ma chiare. Si notava la barba sul volto di Bikovskij e il sorriso di Valentina, ripresa anche mentre si alimentava da un tubetto contenente cibo lio lizzato. I due cosmonauti e ettuarono anche il previsto lavoro scienti co, con riprese e osservazioni
Nel maggio del 1962, una delegazione sovietica che includeva anche German Titov andò in visita negli Stati Uniti, e nell’occasione fu invitata a una festa organizzata per celebrare il primo volo orbitale americano di John Glenn.
La delegazione si intrattenne con Glenn, il quale confidò loro che vedeva con grande entusiasmo la possibilità che una donna astronauta andasse in orbita, e accennò a Mercury 13, il programma americano che intendeva selezionare delle donne pilota statunitensi per una missione sulla capsula Mercury. Questo programma verrà poi cancellato (non senza polemiche da parte di gruppi di femministe americane, e non solo, vedi l’articolo a pag. 20), mentre i russi tornarono a casa sapendo che gli americani avrebbero potuto e ettuare un tentativo, e diedero quindi vigore alla loro iniziativa.
Le cinque candidate, tra le quali la Tereshkova, seguirono l’addestramento dei colleghi uomini: voli parabolici in assenza di peso, centrifughe, lanci con paracadute, prove di isolamento e studi sulla propulsione dei razzi e di ingegneria spaziale relativi al funzionamento della Vostok. Accumularono anche molte ore di volo sul caccia MIG-15 Uti, in quel periodo utilizzato per l’addestramento dei cosmonauti.
Delle cinque donne ne restarono solo tre: Valentina Tereshkova, Irina Solovyova (che sarà la sua riserva per la missione della Vostok 6), e Tatjana Kuznecova. La scelta per il volo cadrà poi sulla Tereshkova. Ma le altre (a cui se ne aggiunsero quattro) avrebbero continuato a far parte del gruppo di cosmonaute fino al 1969.
L’idea di Korolev (che morì nel 1966) era di organizzare una missione tutta al femminile, con tre cosmonaute a bordo di una Vostok o di una Sojuz. Ma la gara spaziale, la corsa alla Luna e i ritardi causati dal primo, tragico volo della Sojuz fecero arrestare il programma. La successiva selezione sarebbe avvenuta solo alla
fine degli anni Settanta, per inviare cosmonaute sui laboratori orbitanti Saljut
della volta celeste, del Sole e di alcune regioni del nostro pianeta. Bikovskij, in particolare, lavorò su problemi riguardanti l’orientamento orbitale della sua Vostok 5, in vista delle missioni del successivo Programma Voskhod. Fino a quel momento, infatti, le capsule venivano guidate da terra tramite sistemi radar, ottici e radio, mentre per le imprese successive le navicelle avrebbero dovuto orientarsi autonomamente. Con questo doppio volo orbitale, i russi macinavano nuovi record di permanenza in orbita: Bikovskij concluse il suo volo dopo 119 ore, la Tereshkova dopo 71. Rientrarono entrambi il 19 giugno, in buone condizioni di salute. Valentina atterrò dopo 48 giri attorno alla Terra nella steppa kazaka, lanciandosi con il seggiolino eiettabile da una quota di circa 7000 metri, mentre la capsula impattava al suolo in un’area disabitata. La cosmonauta toccò terra con il suo paracadute presso alcune cascine.
Un’anziana contadina, vestita di nero, si avvicinò, dopo che Valentina si era liberata a fatica dal seggiolino eiettabile e dai cordoni del paracadute, e un po’ disorientata dalla scena, le chiese “Sta bene?” “Ha bisogno di aiuto?”. Poi, dopo aver capito che la donna arrivava dallo spazio, domandò: “Senta, ma lei che è stata lassù, ha incontrato Dio?”. “Mah…” - rispose Valentina - “per la verità no, ma è possibile che io abbia percorso un tragitto che non me l’ha fatto incrociare. Chissà, può essere che mi abbia accompagnato per terminare sana e salva la mia missione...”. E la contadina o rì a Valentina pane e latte, in segno di benvenuto.

» In alto:un’immagine recente di Valentina Tereshkova.


A sinistra: Valentina dopo un atterraggio con il paracadute durante l’addestramento per il suo volo spaziale.
A destra: insieme al marito, il cosmonauta Andriyan Nikolayev, e alla loro figlia Alena.

Valentina Tereshkova è nata nel 1937 in un villaggio della regione di Yaroslav. Durante gli anni della Seconda guerra mondiale, ancora bambina, aveva perso il padre, trattorista di un kolkhoz. Dopo aver lavorato in una fabbrica di pneumatici e in uno stabilimento tessile, nel 1962 aveva intrapreso la carriera politica su scala regionale.
Appassionata di paracadutismo, dal 1959 al 1963 aveva e ettuato 126 lanci col paracadute da aerei in quota. Entrata nel corpo dei cosmonauti, le fu conferito il grado di sottotenente. La Guerra fredda e la gara spaziale tra le due potenze vivevano in quel periodo le fasi più calde. Ma oggi Valentina Tereshkova mostra orgogliosa le immagini storiche della sua missione e parla del presente e del futuro della conquista spaziale con grande entusiasmo.
L’abbiamo incontrata in occasione di Bergamo Scienza, l’annuale manifestazione dedicata alla ricerca e alla divulgazione scienti ca, organizzata dal Comune e dalla Provincia di Bergamo. Insieme a mille altre ragazze aveva partecipato alle dure selezioni per diventare una cosmonauta e alla ne era stata lei a eseguire il primo volo di una donna tra le stelle.
Vedendo le immagini degli astronauti russi e americani insieme sulla Stazione spaziale internazionale, commenta: “Che invidia, come vorrei andarci anch’io lassù, su quegli spazi così ampi a godermi di nuovo la cosa più bella
che abbia mai visto nora, e cioè la Terra dallo spazio. Qualcosa di incredibile, che te la fa amare ancora di più”. E così comincia l’intervista, con una domanda molto intrigante.
“La mia missione doveva durare solo un giorno. Ma mi promisero che, se tutto si fosse svolto con regolarità, il mio volo sarebbe durato per altre 48 ore. E le cose in e etti andarono così.
A un certo punto mi accorsi, assieme al centro di controllo a terra, che la navicella si stava un po’ alla volta allontanando. Seguiva cioè un’orbita un po’ esterna, che tendeva ad allontanarsi dalla traiettoria nominale prevista. Ma grazie al continuo scambio di dati con il centro di terra, riuscimmo a risolvere il problema e tutto andò bene. Il volo della “gabbianella”, come mi chiamava il responsabile tecnico del programma, Sergheij Korolev (e nome in codice per le comunicazioni radio alla missione), poteva così proseguire con regolarità. Comunque, non ebbi paura, per due motivi. Uno perché non ne avevo il tempo: l’ansia di risolvere il problema superava anche la paura. L’altro, è che un cosmonauta (anche quelli di oggi) viene addestrato a gestire le situazioni e a non farsi prendere dal panico. Questo genere
di emozione non potrebbe che complicare ulteriormente le cose. Tutto sommato, sopportai bene il volo. La mia, pur essendo solo la sesta missione orbitale russa, era una missione con diversi risvolti scienti ci, che puntavano a capire sempre meglio come si sarebbe comportato un uomo - o una donna nel mio caso - durante una missione spaziale. Alcuni test dovevano veri care la regolarità del sonno e avevo una serie di sensori attaccati alla pelle, che dopo tre giorni quasi entrarono nella cute, e lasciandomi dei segni che si notano nelle immagini dopo l’atterraggio. Era davvero curioso dormire con le braccia che penzolavano a mezz’aria, ma ricordai l’esperienza di German Titov sulla Vostok 2 e misi le mani nella cintura mentre dormivo. Non ho fatto sogni, o perlomeno non ricordo nulla, ma avevo appetito, questo sì: avevo una dieta variata, ma pur sempre nei tubetti, e verso la ne del volo cominciai a desiderare un po’ di tradizionale cibo terrestre”.
TEMPO, PER RIVEDERE UNA
DONNA NELLO SPAZIO?
“Il programma spaziale russo ha sempre messo in primo piano, n dagli inizi, la presenza di donne nelle sue missioni, tanto che si era persino deciso di piani care una missione spaziale solo al femminile. L’idea era stata di Korolev, il regista di quei grandi successi nello spazio, che ci aiutò tantissimo a prepararci a quelle imprese, sia dal lato umano che da quello tecnico. Ma dopo la mia missione, che concluse il programma Vostok, ci furono solo due missioni della Voskhod e poi il primo

volo della nuova navicella Sojuz, che si concluse tragicamente con la morte di Komarov. Per questo il programma della Sojuz fu ritardato e fu data priorità ad altre missioni. Nel frattempo, anche per raggiunti limiti d’età, noi lasciammo il programma e subentrarono nuove cosmonaute, come Svetlana Savitskaja, che prese parte alla missione sul laboratorio Saljut nel 1982”.
Dopo la missione, Valentina Tereshkova lasciò il programma spaziale per dedicarsi al ruolo di mamma (“Ma poi sono tornata per addestrare nuovi cosmonauti” - precisa). Già un anno dopo la missione nacque la sua unica glia Alena, e il papà (e marito della Tereskhova all’epoca) era il cosmonauta Adrijan Nikolaijev
In molti dissero che la prima bimba concepita da due soggetti già stati nello spazio avrebbe potuto nascere con chissà quali misteriosi problemi.
E invece... “Mia glia oggi ha 50 anni e sta benissimo, ed è lei stessa mamma di due bimbe, ormai ragazze” - dice la prima cosmonauta“non solo, ma è lei che si occupa della salute degli altri, perché è anche un bravo medico...”.
“Sì, se potessi, ripartirei anche domani… per Marte. Studio e osservo da tempo questo pianeta, e credo sia importante esplorarlo con missioni di astronauti.
La sua super cie è ricca di minerali, sotto di essa è possibile raccogliere molte risorse ed è possibile trovare forme di vita. È un pianeta davvero a ascinante. Anche se in fondo qualsiasi astronauta, ne sono certa, ha sempre nostalgia e voglia di tornare sulla Terra, la nostra vera casa e l’unico angolo del Sistema solare dove è possibile vivere. E sempre dallo spazio si sta lavorando, e molto altro ancora si potrà fare, per controllare e intervenire sulle problematiche del nostro pianeta”.









Entra nel network editoriale che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Scannerizza il QR code e partecipa al contest!

La prima fu Valentina Tereshkova, che durante il suo volo spaziale nel 1963 so rì terribilmente di mal di spazio. Stette così male che non riuscì a portare a termine i compiti che le erano stati a dati. Ritornò a terra in condizioni pietose, nonostante dal suo racconto tutto questo non emerga (vedi l’intervista a pag, 20). La foto ricordo alla ne della sua impresa venne fatta dopo un passaggio in ospedale e un lavoro di pulizia generale. Questi problemi, che al tempo avrebbero o uscato l’immagine della scienza sovietica, vennero taciuti al pubblico, ma il nume tutelare della cosmonautica russa, Sergei Korolev, disse che con le donne aveva chiuso. In e etti, dovettero passare 19 anni prima di vedere un’altra donna nello spazio, Svetlana Savitskaija
Non che alla Nasa le cose andassero meglio, diciamo che non si ponevano nemmeno il problema: negli anni 60 l’idea di scegliere gli astronauti tra i piloti collaudatori delle varie armi dell’esercito americano aveva automaticamente escluso le donne. Non mancavano aviatrici coraggiose ed esperte, però mancava la volontà di riconoscere e valorizzare le loro capacità.
Notevoli sforzi, purtroppo niti nel nulla, furono fatti tra il 1960 e il 1962 da un gruppo di 13 donne pilota, che Martha Ackmann descrive nel libro Mercury 13. La vera storia di tredici donne e del sogno di volare nello spazio (edizioni Springer).
Tutto era iniziato dall’incontro di Randy Lovelace, il capo del team medico che esaminava i candidati astronauti, con Jerrie Cobb, un’aviatrice di tutto rispetto.

Dopo avere visto il comportamento di tanti uomini, Lovelace si chiedeva come avrebbero reagito le donne davanti alle stesse prove. Queste prove vennero condotte nel suo ospedale su un gruppo di 13 donne di età inferiore ai 35 anni e con più di 1000 ore di volo. E bastò un articolo dedicato da Life a questa iniziativa per sommergere la Nasa di autocandidature, alle quali però venne risposto “grazie, non ci interessa”. Una delle 13 aviatrici, Jane Hart, era moglie di un senatore democratico (e madre di otto gli) ed ebbe l’idea di andare per vie politiche. Prima incontrarono il vicepresidente Lyndon Johnson,
che non si dimostrò sensibile alle loro istanze, poi ottennero una audizione parlamentare per discutere di possibili discriminazioni messe in atto dalla Nasa nella selezione degli astronauti. Finì con un buco nell’acqua e la Nasa dichiarò che aprire alle donne lo spazio non “era una priorità”.
La situazione cambiò nel 1976, quando nel bando per il reclutamento di nuovi astronauti venne introdotta
la gura dello “specialista di missione” che richiedeva solo una preparazione scienti ca: non occorreva essere un pilota collaudatore per fare la domanda. Finalmente, anche le donne potevano aspirare alla carriera di astronauta e furono in 1000 a farsi avanti, su un totale di 8370 domande.

Sally Ride lavorava all’Università di Stanford e lesse l’annuncio sullo Stanford Daily. Fece la domanda, fu selezionata e andò in orbita nel 1983 sullo Space Shuttle, vent’anni dopo Valentina.

Da allora, la percentuale di donne spaziali è in lento ma continuo aumento. Finora, hanno volato 71 donne su un totale di oltre 600 viaggiatori spaziali. Sono ancora percentuali lontane dalla metà, ma bisogna riconoscere che le azioni più decise per incrementare e valorizzare la componente femminile nel gruppo degli astronauti sono targate Nasa. Le altre agenzie spaziali sono meno attente, a cominciare da quella russa che, dopo il primato di Valentina, presenta una percentuale veramente bassa di cosmonaute. Alla Nasa, invece, nelle ultime selezioni delle nuove classi, si è arrivati alla quasi parità tra uomini e donne. Attualmente, il corpo astronauti Nasa conta 16 donne e 25 uomini. L’attenzione dell’agenzia americana alla parità traspare anche dalla scelta degli astronauti che parteciperanno alla missione Artemis per il ritorno alla Luna: la squadra è formata da nove uomini e nove donne. Dopo tutto, l’impegno della Nasa è di portare

primo uomo non bianco. Anche l’Agenzia spaziale europea (Esa) che ha appena chiuso un bando per la selezione di nuovi astronauti, ha dichiarato che farà attenzione a o rire uguali opportunità a uomini e donne e cercherà di considerare anche candidati disabili, purché questo non precluda la possibilità di essere operativi in orbita. È un passo importantissimo nella strada dell’inclusività, ricordando che all’inizio dell’era spaziale i candidati astronauti dovevano avere dei sici perfetti, non era ammesso il minimo difetto.
Nel bando dell’Esa, il primo dopo quello del 2009 che portò alla selezione di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, si dice che verranno considerate anche candidature di persone di bassa statura o con problemi agli arti inferiori. Dopo tutto, nello spazio le gambe si usano poco.
Tuttavia, l’Esa non potrà dire di avere introdotto la categoria dei parastronauti. La prima astronauta disabile ha fatto parte dell’equipaggio di Inspiration4, che, dal 16 al 18 settembre 2021, ha volato su una navicella Crew Dragon, la prima a non avere a bordo astronauti ma solo passeggeri. A orchestrare il tutto è stato il miliardario (lui stesso pilota) Jared Isaacman, che ha comperato il volo e ha messo in palio due
dei quattro posti disponibili, per dimostrare che non occorre essere miliardari per coronare il sogno di viaggiare nello spazio. Un posto è andato a Sian Proctor vincitrice di una gara di creatività spaziale via Twitter, mentre un altro è stato assegnato a Christopher Sembroski, grazie a una lotteria organizzata per raccogliere fondi destinati all’ospedale oncologico pediatrico St. Jude a Memphis. Sian è una donna afro-americana che aveva più volte tentato di partecipare alla selezione degli astronauti Nasa senza successo. Quando aveva ormai perso le speranze, ha partecipato a una gara organizzata da Isaacman per promuovere la sua compagnia Shift4Payments attraverso video centrati su progetti di imprenditorialità spaziale. Sian ha vinto e così ha coronato il sogno di andare nello spazio. Christopher aveva donato 50 dollari all’ospedale, ma non ha vinto la lotteria. La fortuna ha però baciato un suo amico che ha poi rinunciato al giretto nello spazio, cedendo il posto a Christopher.
Nel volo c’era anche Hayley Arceneaux che proprio nell’ospedale St. Jude era stata curata per un cancro alle ossa che le aveva attaccato la gamba sinistra dove una protesi metallica ha sostituito parte delle ossa malate. A 29 anni, Hayley è stata la più giovane astronauta americana, ma non entrerà nel Guinness dei primati, dato che Valentina Tereshkova ha
volato a 26 anni. Sarà piuttosto la sua disabilità a darle visibilità, perché è la prova vivente che lo spazio è proprio per tutti. Nell’ottobre 2021, si è registrato un altro primato femminile, quando la Stazione spaziale internazionale (Iss) ha ospitato Julia Peresild, la prima attrice cha ha girato alcune scene di un lm in orbita, insieme all’attore/ regista Klim Shipenko. Julia è stata la seconda donna non astronauta a visitare la Iss, dopo Anousheh Ansari, imprenditrice iranianaamericana e prima turista spaziale nel 2006.
Finora le donne hanno viaggiato in orbita terrestre, e la prima che si allontanerà per arrivare a circumnavigare la Luna sarà Christina Koch, selezionata come specialista di missione per Artemis II. È la donna che ha passato il più lungo periodo continuo nella Iss, 328 giorni. Dove è stata protagonista della prima attività extraveicolare (Eva) solo al femminile, insieme alla collega Jessica Meir, che ha sei Eva al suo attivo. Alle donne che sono andate in orbita vogliamo aggiungere anche quelle che hanno fatto un volo suborbitale. Al momento sono cinque quelle che hanno passato qualche minuto in microgravità. Tra loro ricordiamo Wally Funk, una delle 13 pilote che tentarono inutilmente di farsi considerare dalla Nasa. Il 20 luglio 2021 Wally è stata invitata da Je Bezos a far parte dell’equipaggio del primo lancio turistico di Blue Origin. Aveva aspettato 60 anni per uttuare senza peso e la sua soddisfazione è tutta contenuta nel bellissimo sorriso.

APPUNTAMENTO CON L’ESPLORAZIONE SPAZIALE A BUSALLA DAL 28 GIUGNO AL 2 LUGLIO
Il Festival dello Spazio di Busalla torna anche quest’anno, dal 28 giugno al 2 luglio. Sarà la settima edizione, che per il 2023 avrà come tema Abitare lo spazio
Il nocciolo del programma scienti co ruota attorno al “ritorno alla Luna per restare”, prendendo alla lettera l’impegno dell’Amministrazione americana e della Nasa, al quale molti Paesi hanno aderito, Italia compresa. E cercherà di farlo in modo accessibile, intrigante, seguendo la traccia della ricerca scienti ca, ma anche le prospettive fantascienti che più ragionevoli, fedele ai programmi istituzionali e industriali che sono in corso e che coinvolgono gli impegni nazionali e internazionali del nostro Paese.
La prima domanda è “chi è la Luna, questa sconosciuta”, che viaggia regolarmente nel cielo, misteriosa ispiratrice di interpretazioni artistiche nella musica, nell’arte e nella poesia?
La Luna è una delle “singolarità astro siche” che rendono possibile la vita sulla Terra; la sua origine è ancora da chiarire, anche se i ricercatori propendono per l’ipotesi che sia il risultato di una straordinaria collisione astronomica. Satellite solitario della Terra, con la sua forza gravitazionale impone una costanza all’inclinazione dell’asse terrestre e un regolare succedersi delle stagioni, delle maree, del ciclo dell’acqua. La Terra in ritorno impone alla Luna la sincronizzazione del moto di rotazione e di rivoluzione, per
cui della Luna vediamo sempre la stessa faccia; il giorno e la notte lunari durano 14 giorni terresti. Questa circostanza rende complessa la tecnologia della sopravvivenza e la scelta del luogo di sbarco: contrariamente ai punti di sbarco delle missioni Apollo, la zona più favorevole a una base permanente sarà ai poli lunari, dove si spera di trovare acqua sotto forma di ghiaccio e dove si può immaginare una struttura - tipo torre Ei el - che riesca a ricevere i raggi del Sole in permanenza. Ci porteranno per mano in questa scoperta della Luna Enrico Flamini, già chief scientist dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), e Tommaso Ghidini, tecnologo dell’Agenzia spaziale europea (Esa), due care conoscenze del Festival.

LA PROSSIMA STAZIONE CISLUNARE
Abbiamo assistito nei mesi scorsi alla missione Artemis 1, che ha collaudato la nuova capsula Orion e il grande vettore Sls, l’impianto fondamentale del nuovo sistema di trasporto verso la Luna e ritorno. A bordo c’era Argomoon, il microsatellite italiano “paparazzo”, che ha fotografato l’impresa da vicino; al Festival ce ne parleranno ricercatori di Asi e di Argotec, l’azienda che lo ha realizzato, mentre gli ingegneri di ales Alenia Space, tra cui Maria Antonietta Perino, ci aggiorneranno sui piani ambiziosi per la realizzazione della stazione cislunare Lunar Gateway e del modulo abitativobase permanente Argonaut dell’Esa.
Il villaggio lunare che comincia a prendere forma nei piani
degli ingegneri e delle agenzie spaziali è già disponibile in formato ridotto nella collezione realizzata dalla Lego, che al Festival sarà il punto di incontro dei più piccoli, così come il modello funzionante del cannone acchiappa-detriti spaziali di Stam, che fa sempre scena quando opera e che è ormai parte del museo spaziale di Villa Borzino. Nella sessione dedicata alla space economy, il Festival organizzerà dei tavoli di discussione su temi di interesse per l’industria e in particolare per le Piccole e medie imprese (Pmi) e startup, con personaggi della Commissione Europea e dell’Esa attivi nella promozione di nuove iniziative d’impresa. Si parlerà di come in diverse aree d’Italia si stanno formando dei distretti di imprese, agevolati da investimenti nazionali e regionali che possono accelerare lo sviluppo e la crescita delle PMI spaziali associate. In particolare, il Festival vedrà il ritorno di Franco Ongaro, già direttore dell’Estec, nella sua nuova veste di chief technology officer di Leonardo; lo interrogheremo sulle eccellenze spaziali della più grande impresa tecnologica italiana, dall’elettro-ottica di Campi Bisenzio alla robotica di Nerviano, alla Cybersecurity di Genova, e come questa rete di eccellenze tecnologiche possa generare opportunità di impresa.

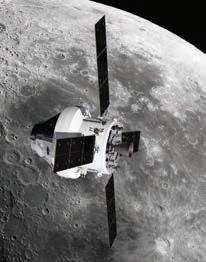
Il Festival dello spazio di Busalla non è un convegno scientifico dove si parla degli ultimi risultati di ricerche
specifiche tra addetti ai lavori. È invece un evento culturale di divulgazione scientifica, dove - grazie al contributo dei relatori e degli eventi collaterali - si vuole coinvolgere un pubblico vario, anche allargando l’angolo visuale ad altre discipline.
Così è impostato anche il concorso che il Festival organizza ogni anno in collaborazione con la Sisri (Scuola internazionale superiore di ricerca interdisciplinare), premiando il miglior elaborato su un tema spaziale diverso ogni anno per incoraggiare la contaminazione tra approcci diversi: scientifico, medico, legale, umanistico, filosofico.
L’esplorazione umana di ambienti extraterrestri pone molte domande inusuali, che vanno al di là della tecnica necessaria per affrontare un ambiente decisamente ostile; ma riguardano i ritorni economici e geopolitici di tali investimenti e le motivazioni profonde dell’essere umano, ovvero la sua insaziabile ricerca di conoscenza e di verità.
Per questo avremo tra i relatori Marco Aime, esploratore e illustre antropologo docente all’Università di Genova ecome è ormai consuetudine - don Giuseppe Tanzella-Nitti, astronomo e teologo presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma. Per aggiornamenti e programma dettagliato vedi www.festivaldellospazio.com

IL SUPERTELESCOPIO JWST
SI STA MOSTRANDO IDEALE
ANCHE PER LO STUDIO
DELLE ATMOSFERE EXTRASOLARI

Le potenzialità del telescopio spaziale James Webb (Jwst) si estendono su tutti i campi dimensionali dell’Universo. Nelle news di ogni numero di Cosmo pubblichiamo dei contributi che arrivano dal nuovo osservatorio e abbiamo già dedicato due articoli alle novità più inattese, quelle riguardanti il Sistema solare con “La riscoperta dell’Universo vicino” nel numero 38 di aprile e “Il Webb all’inseguimento dei corpi minori” nel numero 39 di maggio.
Il Webb si è già dimostrato eccellente anche per lo studio dei pianeti extrasolari e in queste pagine ci occupiamo proprio delle sue ricerche tra stelle e pianeti della nostra Galassia. La capacità di catturare la radiazione infrarossa fino a 28 micron rende agevole la ripresa di spettri delle atmosfere di pianeti in transito sulle rispettive stelle, per cercare righe di assorbimento atmosferico nella luce stellare che attraversa l’atmosfera del pianeta. Inoltre, la presenza di un coronografo in tre strumenti su quattro del Webb facilita la realizzazione di spettri anche su pianeti non in transito.
La prima osservazione coronografica del Webb è stata realizzata a metà luglio 2022 dalla camera Miri e a fine luglio 2022 dallo spettrometro NirSpec. Il target era un pianeta di circa 10 masse gioviane a 90 Unità astronomiche (UA, la distanza media Terra-Sole) dalla giovane stella HIP 65426 di due masse solari, situata a 385 anni luce nel Centauro.

Nonostante una temperatura stimata di circa 1200 °C, nel 2017 lo strumento Sphere al Very Large Telescope in Cile aveva scoperto delle bande dell’acqua. Con il Webb, il pianeta è risultato direttamente visibile e la sua massa è stata ssata in sette masse gioviane.
Dal punto di vista coronogra co, un sistema ideale per il Webb è la giovane stella HR 8799, di 1,5 masse solari a 129 a.l. in Pegaso. La stella è circondata da quattro pianeti gioviani visibili di piatto, a distanze comprese tra 16 e 71 UA. Il Webb la sta studiando da novembre 2022 e si attende che i risultati vengano u cializzati.

Nel frattempo, il Webb si è “esercitato” su VHS 1256b, un oggetto di 19 masse gioviane, di soli 150 milioni di anni e caldo (830 °C), a 150 UA da una coppia di nane brune di circa 100 masse gioviane, situate a 70 a.l. nel Corvo. Il 5 luglio 2022, gli strumenti NirSpec e Miri hanno osservato questo megapianeta, realizzando uno spettro da 1 a 29 micron che ha rivelato la presenza di acqua, monossido di carbonio, anidride carbonica e metano, mentre la Miri ha mostrato tra 8 e 11 micron la presenza di nuvole opache di composti a base di silicio, che si rimescolano di continuo, dato che VHS 1256b ruota in 22 ore, modi cando in maniera drammatica la sua luminosità. Il primo esemplare di esopianeti transitante scrutato dal Webb è stato Wasp-96b, un pianeta di taglia gioviana, in orbita circolare attorno a una stella di tipo solare a 1150 a.l. nella Fenice, che era stato scoperto nel 2013 dalla collaborazione Wide Angle Search for Planets, un

complesso di otto teleobiettivi da 200 mm situato sull’isola di La Palma alle Canarie. Il 21 giugno 2022 lo spettrometro canadese Niriss (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph) ha misurato la curva di luce del transito del pianeta davanti alla sua stella, osservando per 6,4 ore attorno al transito, con la ripresa di dati ogni 1,4 secondi.
La diminuzione di luce dell’1,5% rivela il transito di un pianeta 1,2 volte più largo di Giove, con una massa di 0,48 masse gioviane, già nota da misure prese a terra.
Si tratta di un pianeta gassoso, che ruota attorno alla sua stella in soli 3,5 giorni, a una distanza di soli 7,5 milioni di km, con una temperatura
super ciale vicina ai 500 °C. Lo spettrometro Niriss ha ottenuto uno spettro in transito (per di erenza tra lo spettro totale e quello della stella), in cui sono presenti tutte le bande fondamentali dell’acqua. Nell’ambito di una serie di ricerche esplorative lanciate dalla Transiting Exoplanet Community guidata da Natalie Batalha (leader della missione spaziale Kepler per la ricerca di esopianeti in transito), è stata selezionata una quindicina di esopianeti transitanti “caldi”, orbitanti attorno a nane rosse e in parte già studiati. Il primo tra questi è Wasp 39b, un gigante gassoso simile a Saturno, che rivoluziona in 4 giorni a soli 7 milioni di km da una
stella di 0,9 masse solari, situata a 700 anni luce nella Vergine. La minima distanza dalla sua stella fa sì che la temperatura di Wasp 39b sia di circa 800 °C. Un singolo transito è stato osservato dal NirSpec per 8 ore il 10 luglio e dal Niriss per 5 ore il 26 luglio 2022, rivelando la presenza di una serie di assorbimenti dell’acqua e una banda dell’anidride carbonica. Per la prima volta sono apparse anche una debole banda dell’anidride solforosa, prodotta per interazione fotometrica dello zolfo con la radiazione della stella centrale, e una banda del sodio. L’anidride carbonica si era manifestata anche nelle curve fotometriche del transito realizzate in una ventina di intervalli spettrali

alla ne di luglio 2022. Il massimo abbassamento della luce stellare durante il transito del pianeta si aveva a 4,3 micron, proprio in conseguenza dell’assorbimento dell’anidride carbonica.
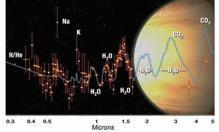
Anche le bande dell’acqua sono state individuate con queste modalità in altri due “Giovi caldi”: Wasp 18b (10 masse gioviane a 3 milioni di km da
una stella di tipo solare, distante 325 a.l. nella Fenice) e Wasp 43b (2 masse gioviane a 2,5 milioni di km da una nana rossa a 261 a.l. nel Sestante).
Una particolare attenzione è stata riservata ai pianeti transitanti di taglia terrestre. Il primo a essere scoperto
(dopo alcuni indizi raccolti dalla sonda Tess) è stato LHS 475b, che rivoluziona in 2 giorni attorno a una nana rossa di 0,28 raggi solari, situata a 41 a.l. nella costellazione dell’Ottante. Al NirSpec sono bastati due transiti all’inizio di settembre 2022 per confermare l’esistenza del pianeta e per realizzare la prima indagine spettrale. Questo pianeta è molto caldo, con una temperatura di circa 300 °C, alla quale concorrono la vicinanza dalla stella e un’atmosfera di anidride carbonica, che l’intensa radiazione della stella non è riuscita a disperdere. Se le osservazioni confermeranno questa interpretazione, siamo di fronte al primo esopianeta simile a Venere.
La curiosità maggiore delle prime osservazioni del Webb era riservata ai sette pianeti “terrestri” della nana rossa Trappist-1. La scoperta dei primi tre pianeti (b, c, d) di questo sistema risale all’autunno 2015, grazie al telescopio robotico Trappist (Transiting Planets and PlanestIsimals Small) da 60 cm, che un gruppo di ricerca dell’Università di Liegi ha collocato a La Silla nel giugno 2010. L’anno dopo il telescopio spaziale Spitzer scopriva altri quattro pianeti (e, f, g, h), portando a sette il numero totale.
Tutti questi pianeti transitano sulla loro stella e gli rivoluzionano vicinissimi (tra 1 e 9 milioni di km), con “anni’ che vanno da 1 a 20 giorni. Una situazione che induce dei probabili sincronismi rotazionerivoluzione che costringono uno degli emisferi di ogni pianeta a rimanere sempre rivolto verso la stella. Trappist-1 ha 500 milioni di anni, 0,08 masse solari, una temperatura

di 2300 °C ed è situata a 39 a.l. nell’Acquario. La cosa interessante è che quattro dei suoi pianeti si trovano nella fascia di abitabilità della stella, cioè in una regione dove la temperatura permetterebbe all’eventuale acqua di rimanere in forma liquida. Ma sono pianeti rocciosi come la Terra, o gassosi come Giove?
Per rispondere a questa domanda, bisogna conoscere le loro densità, che si ottengono dal rapporto tra masse e volumi. I volumi dei pianeti sono stati ricavati dalle intensità dei cali di luce, mentre le masse sono state calcolate in base ai Ttr (Transit Time Variation), ossia ai ritardi (o agli anticipi) sulla ripetitività dei cali di luce, indotti su ogni pianeta

dalla massa dei pianeti vicini. Si è così trovato che le masse dei pianeti “trappisti” vanno da 0,5 a 1,4 masse terrestri e questi dati, combinati con i rispettivi volumi, hanno mostrato che tutti i sette pianeti hanno una composizione rocciosa.
Per valutare le eventuali somiglianze con la Terra, era necessario indagare anche la presenza di atmosfere intorno a questi esopianeti, una ricerca a cui si è dedicato il Webb nei primi sei mesi di lavoro.
Sono stati già pubblicati i risultati relativi a Trappist-1b e 1c (i pianeti più vicini) e Trappist-1g (il pianeta “abitabile” più lontano). L’emissione
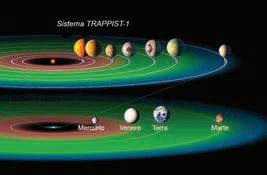
termica di Trappist-1b è stata calcolata dalla camera Miri, togliendo alla somma dell’energia della stella più pianeta l’energia della stella da sola in regime di “eclisse secondaria” (pianeta dietro la stella). Risulta una temperatura super ciale di 450 gradi, la stessa prevista in assenza di atmosfera. Una qualunque atmosfera, grazie ai moti convettivi indotti dal forte squilibrio termico tra l’emisfero oscuro e quello illuminato avrebbe fatto diminuire in maniera sensibile questa temperatura. Più complessa è la situazione di Trappist-1g. Il telescopio spaziale Hubble, sfruttando alcuni transiti nel 2016-2017, aveva escluso la presenza di una atmosfera molto estesa e questo dato è stato confermato anche dal Webb: ma il campo spettrale del NirSpec, molto più esteso di quello di Hubble, fa sospettare la presenza di un’atmosfera densa ed opaca, dominata da anidride carbonica e smog idrocarburici. Quindi, Trappist1g potrebbe essere simile a Titano o meglio alla Terra primordiale, data la giovanissima età della sua stella. Molte altre sorprese sono sicuramente racchiuse nei dati nora raccolti dal Webb, ma c’è estrema prudenza nelle dichiarazioni dei responsabili di queste ricerche. Però, Trappist-1 non potrà nascondere i suoi segreti ancora per molto.
*CESARE GUAITA LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL PLANETARIO DI MILANO.

IFast Radio Burst (Frb) sono fenomeni astro sici molto frequenti: si tratta di lampi di onde radio molto brillanti, che si presentano con durate di pochi millisecondi. La maggioranza delle rilevazioni di Frb è stata ottenuta grazie ai radiotelescopi e ha dimostrato una provenienza da distanze di miliardi di anni luce.

I primi Frb sono stati registrati nel 2007 da Duncan Lorimer e colleghi della West Virginia University, grazie al radiotelescopio di Parkes, in Australia. I segnali raccolti erano distribuiti in modo inconsueto: per prime venivano percepite le onde ad alta frequenza e dopo una frazione di secondo quelle a bassa frequenza, con un conseguente cambiamento di “colore”.
La caratteristica principale di questi lampi è che si manifestano anche 10mila volte al giorno: tenuto conto della distanza di origine, si può determinare che ognuno di essi è associato a un’energia strabiliante, confrontabile con quella prodotta dal Sole in un anno.
Le ipotesi sull’origine dei Frb sono molteplici. Questi lampi radio potrebbero essere generati da collisioni esplosive di coppie di stelle di neutroni o nane bianche, che liberano grandi quantità di energia.
David Champion, del Max-Planck-Institut per la radioastronomia, ha ipotizzato la presenza di due esplosioni (una da cui ci arrivano le onde ad alta frequenza, l’altra da cui giungono quelle a bassa), a seguito della rilevazione a Parkes di un Frb esploso due volte: poteva trattarsi del collasso di una stella estremamente massiccia conclusosi con la formazione di un buco nero, oppure dello starquake di una magnetar (magnetic star), in pratica un “terremoto stellare” che ha coinvolto l’intera struttura di una stella di neutroni dotata di un enorme campo magnetico.
I Frb potrebbero essere generati anche da potenti outburst (esplosioni) di pulsar, come propone Kiyoshi Masui, della University of British Columbia. Queste esplosioni libererebbero un’energia minore rispetto alle precedenti e sarebbero anche relativamente più vicine, a una distanza non superiore ai sei miliardi di anni luce.
Shrinivas Kulkarni, astro sico del California Institute of Technology, analizzando il segnale di un Frb registrato dal radiotelescopio di Arecibo, ha proposto in ne come origine una gigantesca esplosione di una magnetar in una densa regione di plasma magnetizzato.
I FRB PERIODICI AIUTANO A SVELARE IL MISTERO
Nel 2018, per la prima volta, è stato scoperto un Frb che si ripete periodicamente. Questa sorgente è stata trovata in Canada grazie al radiotelescopio Chime (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) e mostra un periodo di 16,35 giorni con questo schema: per quattro giorni emette uno o due burst ogni ora, poi “tace” per 12 giorni e quindi ripete il tutto.
Questo Frb proviene dalla periferia di una galassia a spirale situata a 500 milioni di anni luce di distanza, e quindi è possibile escludere che sia originato da un buco nero supermassiccio annidato nel nucleo galattico.
» Sopra: una stella di neutroni rotante altamente magnetizzata, una possibile fonte dei Fast Radio Burst
A destra: la drammatica sequenza di un pasto stellare a più riprese operato da un buco nero.
Successivamente, sono stati trovati altri Frb periodici (ormai sono più di cinquanta); in particolare, una campagna di osservazioni durata quattro anni presso l’Osservatorio Jodrell Bank dell’Università di Manchester, ha analizzato la periodicità del Frb 121102. Questa sorgente presenta ra che di burst radio per circa 90 giorni, seguite da silenzio radio per 67 giorni, con un periodo complessivo di 157 giorni. Questa scoperta suggerisce che i Frb siano collegati al movimento orbitale di una stella di neutroni o di un buco nero.
Però è necessario scoprire un maggior numero di Frb periodici, per poter dedurre con sicurezza la natura dei loro progenitori. Inoltre, lo studio di questi fenomeni così violenti e così lontani può fornire un metro per misurare le grandi
distanze cosmologiche e sondare più in profondità i vasti spazi tra le galassie, che possono essere regioni ricche di materia oscura o di energia oscura. E aiutare a comprendere le caratteristiche peculiari delle magnetar o del plasma intergalattico.

Brian Metzger, astro sico della Columbia University, ha elaborato un modello per cercare di rappresentare in modo appropriato e comprensibile i Frb. Il fenomeno è un ash della durata di pochi
millisecondi che con la sua potenza oscura temporaneamente l’emissione delle pulsar radio della nostra Galassia. Si tratta di esplosioni che avvengono nelle nubi di particelle e campi magnetici che circondano le magnetar. Queste stelle di neutroni magnetiche producono occasionalmente dei brillamenti che proiettano nello spazio elettroni, positroni e ioni, con velocità vicine a quella della luce. L’impatto di questa materia con il plasma circostante

» Sopra: il Frb 121102 è stato generato in una debolissima galassia nana distante 3 miliardi di anni luce nella costellazione dell’Auriga, qui ripresa dal telescopio Gemini Nord
Le osservazioni radio fanno supporre che l’evento sia associato a un buco nero supermassiccio o a una giovane stella di neutroni.
genera onde d’urto e intensi campi magnetici.
Ogni lampo contiene dei sotto-lampi che riducono la frequenza con il seguente meccanismo: 1) i fronti delle onde d’urto accumulano il gas mentre si espandono; 2) la massa di gas accumulata rallenta il fronte d’urto; 3) La radiazione emessa si sposta verso frequenze più basse per e etto Doppler. Questo meccanismo spiegherebbe la duplicità dei segnali e la di erenza di frequenza che manifestano.
Al centro della maggior parte delle galassie si trovano dei buchi neri supermassicci, molto di cili da individuare, nonostante abbiano masse pari anche a miliardi di masse solari. Talvolta vengono scoperti grazie a stelle che si avvicinano ad essi e vengono fatte a pezzi dalle forze mareali, formando dischi di detriti stellari di cui i buchi neri si nutrono. Durante questo processo, possono essere rilevate radiazioni su tutto lo spettro elettromagnetico, con esplosioni di radiazioni che durano mesi, no all’esaurimento del “pasto stellare”. Studi guidati dagli astronomi omas Wevers e
Il 28 aprile 2020, il radiotelescopio canadese Chime e lo statunitense Stare2 hanno rivelato un Frb trenta volte meno brillante di quelli extragalattici, ma proveniente dalla Via Lattea.

Allo stesso tempo e nella stessa direzione, diversi telescopi spaziali per le alte energie, tra cui l’europeo Integral, il cinese Hxmt e l’italiano Agile, avevano osservato un lampo all’estremo opposto dello spettro elettromagnetico, nei raggi gamma, permettendo di localizzare l’origine di questo evento in una magnetar scoperta alcuni anni prima nella costellazione della Volpetta, la SGR 1935+2154 (SGR sta per Soft Gamma Repeater). Vedi in figura, un’immagine artistica
Zhu Liu, in Germania e conclusi a gennaio 2023 hanno rivelato che molte stelle potrebbero sopravvivere al primo attacco di un grande buco nero e continuare le loro orbite per incontrare nuovamente il mostro celeste, provocando ash ricorrenti. Gli astronomi hanno trovato dei brillamenti di raggi X ripetuti in due galassie che ospitano buchi neri supermassicci a distanze rispettivamente di 900 milioni e 1 miliardo di anni luce.
Queste osservazioni, e ettuate grazie
al telescopio spaziale Xmm-Newton nel 2021 e nel 2022, hanno rilevato che il brillamento originale è stato seguito da ripetuti outburst ogni 223 giorni circa. Le similitudini con i Frb sono sorprendenti e fanno ipotizzare che in questi casi ci sia un’origine comune.
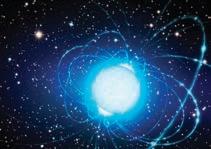
*ANITA MARIA VENA
STUDIA SCIENZE MATEMATICHE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO, AREA DI SPECIALIZZAZIONE ASTROFISICA.
COME GESTIRE GLI OROLOGI SULLA TERRA CHE RALLENTA E NELLE FUTURE COLONIE EXTRATERRESTRI

Per millenni, misurare il tempo è stato un compito dell’astronomia, dato che lo scandire dei giorni era legato alla rotazione della Terra (ovvero al moto apparente del Sole). L’unità di misura del tempo, in secondo, è stata inizialmente de nita come la 86.400esima parte della durata del giorno, suddiviso in 24 ore da 60 minuti ciascuna, dove ogni minuto è a sua volta composto da 60 secondi. Ma misurare in modo individuale il tempo non basta: se ci vogliamo dare un appuntamento, il mio tempo deve essere uguale al tuo, cioè i nostri orologi devono essere sincronizzati, e questo deve valere su tutta la Terra. Un compito tutt’altro che banale, che le varie nazioni avevano a rontato già nell’800, grazie ai laboratori di metrologia che erano dedicati, tra l’altro, anche alla misura del tempo.

Per essere sincronizzati, i laboratori devono essere coordinati a livello mondiale e questo è il compito del Bipm (Bureau International des Pois et Mesures) una istituzione intergovernativa, creata a Parigi nel 1875, che oggi conta 62 stati membri e 42 associati. Tutti devono lavorare in collaborazione, perché la misura del tempo, così come la de nizione di tutte le unità di misura, è quanto di più internazionale si possa immaginare. I membri del Bipm si incontrano ogni quattro anni in “Conferenze generali dei pesi e misure”, durante le quali vengono esaminate le nuove tecnologie per la de nizione e la misura delle unità. È stato così che, nel 1967, si è deciso di sostituire la rotazione della Terra
con le vibrazioni dell’atomo di cesio che sono diventate la base della scala atomica dei tempi. È questo orologio atomico super-preciso che determina il Tempo universale coordinato (UTC) che è utilizzato ovunque. Tuttavia, non possiamo dimenticare che viviamo sulla Terra e vorremmo che il tempo scandito dall’orologio atomico fosse allineato con la rotazione del nostro pianeta, cioè con il Tempo solare osservato, noto come UT1.
Purtroppo, per e etto della complessa interazione con la Luna, la rotazione della Terra accumula piccoli
ritardi rispetto all’orologio atomico. E proprio queste misure hanno potuto valutare in modo diretto il lievissimo ma continuo rallentamento del moto di rotazione terrestre. Per correggere questo sfasamento, nel 1972 è stato deciso di aggiungere all’UTC un secondo “saltellante” quando lo scarto arriva a 0,9 secondi. Da allora la procedura è stata ripetuta 27 volte, a intervalli irregolari e non prevedibili. Con l’eccezione del 1972, non è stato mai aggiunto più di un secondo all’anno ed è capitato che siano passati diversi anni tra un’aggiunta e la successiva.

Quando ho iniziato la mia carriera scienti ca e dovevo allineare i tempi di arrivo dei raggi gamma per tracciare le curve di luce delle pulsar, dovevo sempre controllare quando erano stati aggiunti i leap second che non venivano conteggiati dall’orologio atomico a bordo del satellite. Quarant’anni fa era solo una seccatura interna all’ambiente dei ricercatori, ma nell’attuale società digitale e interconnessa è un signi cativo aggravio del sistema informatico mondiale.
Oggi le transazioni commerciali si giocano sulle frazioni dei millisecondi ed è sempre più costoso inserire questo saltino nel computo del tempo.
I primi a lamentarsi sono stati giganti come Google e Meta, che temono il veri carsi di crash informatici. Considerate le tante critiche, si è iniziato a pensare se l’inserimento del secondo saltellante fosse veramente necessario. I militari americani che gestiscono il sistema satellitare GPS, per esempio, hanno già deciso di farne a meno.
Sul problema si è dibattuto a lungo: cambiare lo status quo deciso a livello mondiale non è semplice, ma la conferenza tenutasi a Parigi a novembre dell’anno scorso ha votato a maggioranza che, dal 2035, i secondi saltellanti non verranno più aggiunti e si dovrà trovare un altro metodo per sincronizzare la rotazione della Terra con le vibrazioni dell’atomo di cesio.
Le conseguenze di questa storica decisione non saranno neanche minimamente apprezzabili per la popolazione, ma la storia dei secondi
saltellanti è un esempio di come tutta l’umanità sia costantemente s data da un problema così immateriale, ma così importante, come la misura del tempo.
Il problema di questa misura è destinato a complicarsi di pari passo con la colonizzazione del Sistema solare. Quando saranno realizzati i primi insediamenti lunari, per esempio, bisognerà poter rispondere alla domanda “che ora è sulla Luna?”. Finora, le missioni lunari sono state “posizionate” usando segnali radio inviati da grandi antenne terrestri a orari prestabiliti. Ma, quando ci saranno dozzine di missioni operative, non ci saranno abbastanza risorse per posizionare on precisione ciascuna di esse. È un problema sottile ma fondamentale, perché qualsiasi sistema di posizionamento lavora sulle di erenze dei tempi di arrivo di segnali da diversi satelliti; quindi, bisogna che gli orologi dei satelliti siano sincronizzati. Ma sincronizzati con che cosa?
Finora si è usato l’UTC terrestre, ma la scelta potrebbe non essere priva di problemi. La teoria della relatività generale ci ricorda che il tempo scorre a una velocità diversa in presenza di campi gravitazionali
diversi; in pratica, un orologio va più lentamente in un campo gravitazionale più intenso. Dato che la Luna è meno massiva della Terra, il suo campo gravitazionale è più debole e allora per un osservatore terrestre un orologio lunare va più veloce. Il guadagno è di 56 microsecondi al giorno, e non è neanche costante in ogni punto della Luna. Se si decidesse di estendere l’UTC alla Luna, sarebbe necessario risincronizzare il tempo lunare a intervalli regolari. Nell’intervallo di tempo che separa due successive sincronizzazioni, farebbe fede un proto-orologio lunare, il lunar master clock. Questa scelta avrebbe il vantaggio di sempli care le interazioni con la Terra. In alternativa, si potrebbe de nire un “Tempo standard lunare” indipendente dall’UTC ma basato su almeno tre orologi di riferimento lunari, le cui misure sarebbero combinate per produrre l’”ora lunare”. Se si decidesse per questa soluzione, bisognerebbe discutere su dove sarebbe meglio posizionare gli orologi. Sulla super cie (con attenzione alla quota, perché anche questo è un parametro importante), oppure in orbita. Una volta risolti questi problemi, si potrà disporre di un’ora lunare che, pur non
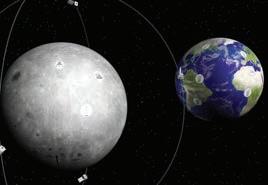
essendo correlata con il tempo terrestre, permetterebbe il corretto funzionamento della otta di satelliti che orbiterà intorno alla Luna per fornire servizi di navigazione e posizionamento. Si chiamerà Global satellite navigation system (Gnss) e, nei piani delle agenzie spaziali, dovrebbe essere operativo dal 2030.
L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha approvato il suo progetto di navigazione lunare Moonlight nella riunione ministeriale del novembre 2022, mentre la Nasa è partita con il Lunar Communications Relay and Navigation Systems a gennaio del 2023. Intendiamoci, il Gnss non ha bisogno di un tempo lunare per poter funzionare: l’UTC andrebbe benissimo, a patto che tutti i satelliti siano sincronizzati.
“Costruire” un tempo lunare servirà anche per prepararsi ad a rontare un problema analogo, quando inizierà la colonizzazione di Marte, dove sarebbe veramente di cile continuare a usare il tempo terrestre. Da un lato, la sincronizzazione sarebbe tutt’altro che banale, dall’altro sarebbe innaturale imporre un giorno di 24 ore su un pianeta che ha un periodo di rotazione di 24 ore e mezza (il “sol” marziano). Lo sanno bene i controllori a terra dei rover marziani, che devono continuamente spostare i loro turni, per tenere conto della mezz’ora da sommare ogni giorno al tempo terrestre. Morale, non lamentiamoci per le sottigliezze dei secondi saltellanti; quando ci sarà da gestire il Tempo Universale nel Sistema solare, sarà tutto molto più complicato.
Il razzo fantasticato cento anni fa da un tecnico visionario trovò abili divulgatori, tra ragazzi cresciuti nella Repubblica di Weimar, che alimentarono il sogno collettivo dell’esplorazione spaziale. Il mezzo di trasporto immaginato per raggiungere altri pianeti, però, trovò da principio nanziamenti solo per farne un temibile strumento bellico: sarà poi la corsa allo spazio, campo di confronto negli anni della Guerra fredda, a ricondurlo verso gli originari obiettivi, portando i primi astronauti sulla Luna. Tutte queste vicende ruotano attorno a un singolare personaggio, che ricordiamo in occasione dei cento anni trascorsi dalla pubblicazione della sua opera più feconda.
Nel giugno 1923 va in stampa Die Rakete zu den Planetenrdumen (“Il razzo nello spazio interplanetario”); un saggio nato come tesi di laurea, ri utata dai professori dell’Università di Monaco, che diventa un bestseller tra gli appassionati di un argomento considerato a quel tempo pura fantascienza.
Nonostante la molta matematica utilizzata, il libro in amma la fantasia dei più giovani, che nelle premesse leggono:
1) allo stato attuale della scienza e della tecnologia è possibile costruire macchine in grado di salire oltre i limiti dell’atmosfera terrestre; 2) con un ulteriore perfezionamento, riusciranno a lasciare il campo gravitazionale della Terra;
3) potranno trasportare in sicurezza gli esseri umani; 4) in
determinate condizioni economiche, la loro costruzione può anche diventare redditizia. A ermazioni visionarie, soprattutto l’ultima, che riescono nell’arco di pochi anni a far nascere la moderna missilistica.
L’autore della singolare opera, Hermann Julius Oberth, nato il 25 giugno 1894 a Hermannstadt (oggi Sibiu in Romania), coltiva dall’età di 11 anni un profondo interesse per i viaggi nello spazio. Passione iniziata quando la madre gli regala il romanzo Dalla Terra alla Luna di Jules Verne: le avventure descritte dallo scrittore francese lo spingono ad approfondirne gli aspetti tecnici.
Crescendo, si convince che l’idea del viaggio verso nuovi mondi possa uscire dal regno della fantasia per diventare realtà. Appena adolescente, studia la teoria della propulsione a getto e comprende che occorre accrescere il rapporto tra propellente e massa per aumentare la velocità del razzo: il carburante consumato in volo, però, progressivamente riduce questo rapporto e di conseguenza anche l’e cienza.
Studiando il modo di risolvere il problema, Oberth trova la soluzione suddividendo il razzo in più stadi: quando una sezione esaurisce il combustibile immagazzinato all’interno, diventando un peso morto, si stacca così da incrementare la velocità della parte rimanente ancora attiva.
Nel 1912 si iscrive all’Università di Monaco, per diventare un medico come il padre, ma lo scoppio della Prima guerra mondiale interrompe gli studi e lo porta a curare i feriti in una unità da campo dell’esercito austro-ungarico. Coglie
» Oberth e colleghi ripresi il 1° gennaio 1931 con un razzo che nelle intenzioni poteva portare la posta da Berlino a New York in 24 minuti raggiungendo i 100 km di quota.
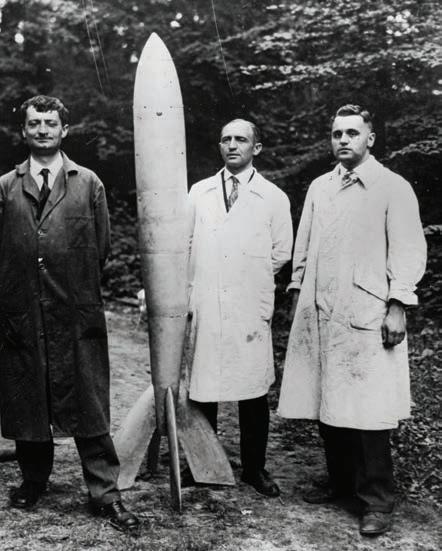
l’occasione per proporre ai superiori lo sviluppo di un missile a lunga gittata da impiegare come arma, ma l’idea viene bocciata perché è giudicata troppo balzana. La tragica esperienza militare si rivela utile per far scoprire a Oberth,

come dichiarato da lui stesso, “che probabilmente non sarei mai stato un buon medico”.
Nonostante si senta tedesco per lingua e cultura, con il passaggio della Transilvania alla Romania dopo la guerra, Oberth diventa uno straniero in Germania. Sposa Mathilda Hummel e torna a Monaco per completare gli studi, ma questa volta si iscrive alla facoltà di sica per assecondare le sue inclinazioni.
Nel 1922 presenta una tesi di laurea incentrata sui propulsori a razzo e sulla possibilità tecnica di realizzarli, ma - nonostante il rigore scienti co della trattazione - i professori la respingono, giudicandola per i temi trattati inadeguata, e così gli negano il dottorato. “Mi sono astenuto dallo scrivere un’altra tesi.” - scriverà Oberth - “Non importa, dimostrerò di essere in grado di diventare uno scienziato più grande di voi, anche senza il titolo di dottore”.
Così, rinuncia a completare gli studi universitari e rientra in Transilvania, dove inizia a insegnare matematica e sica nelle scuole superiori. Oberth decide di di ondere i contenuti della tesi respinta e dopo alcuni ri uti trova un editore di Monaco disposto a pubblicarla, ma a condizione che provveda lui a sostenerne le spese. Accetta le condizioni e suddivide il libro in tre parti: la prima contiene calcoli teorici, informazioni tecniche, principi di funzionamento e prestazioni dei razzi; la seconda riguarda la progettazione del Modello B, un razzo multi-stadio a propellente liquido per l’esplorazione dell’alta atmosfera, mentre la terza parte o re

una panoramica sul futuro della missilistica.
In merito ai possibili impieghi, suggerisce l’esecuzione di esperimenti in assenza di gravità, l’invio in orbita di telescopi per osservare gli altri corpi celesti così come la super cie terrestre, l’esplorazione dell’emisfero nascosto della Luna e le comunicazioni a grande distanza.
Il libro viene pubblicato nel giugno 1923 e la prima tiratura, nonostante le di coltà della trattazione tecnica, si esaurisce rapidamente: il saggio è accolto con favore dal pubblico, ma solleva le critiche del mondo accademico, che continua a giudicare una sciocchezza l’idea del viaggio spaziale.
Oberth contribuisce a rendere l’argomento molto popolare in Germania, ma la lettura del suo libro ispira altri che lo superano in abilità come divulgatori. Uno di questi è l’austriaco Max Valier, giornalista scienti co residente a Monaco, che l’anno seguente pubblica Der Vorstoss in der Weltenraum (“Guida verso lo spazio esterno”), con il quale raggiunge un pubblico ancora più vasto. Un altro sostenitore è lo studente Willy Ley, che vede nello spazio la prossima frontiera e a soli 19 anni inizia a promuovere l’idea di esplorarlo.
I “seguaci” di Oberth sono giovani, pieni di entusiasmo e disposti ad a rontare s de scienti che estreme: una decina di loro, tra i quali Willy Ley, si riunisce il 5 luglio 1927 nel retro di un ristorante a Breslavia per fondare la Società per i viaggi spaziali (Verein für Raumschi hart, VfR) che ha l’obiettivo di costruire razzi con le caratteristiche descritte da Oberth. I membri della VfR aumentano
rapidamente e già un paio di anni dopo se ne contano oltre ottocento, che o rono al loro ispiratore la carica di presidente.
Nell’autunno 1928 Oberth si reca a Berlino, dove il famoso regista Fritz Lang lo ha chiamato per a dargli l’incarico di consulente scienti co per un lm che ha messo in cantiere, dopo il grande successo di Metropolis. Nel nuovo lm si deve rappresentare il lancio di un razzo con equipaggio verso la Luna, perché è basato sulla novella Die Frau im Mond (“La donna sulla Luna”) scritta dalla moglie ead von Harbon.
Oberth è incaricato di disegnare i
modellini dell’astronave da usare nelle riprese e prende come riferimento il suo Modello B. Sovraintende alla costruzione della scenogra a negli studi della società di produzione Universum Film AG alla periferia di Berlino, sperando di trovare le risorse necessarie a proseguire le sue ricerche. Intravedendo il valore pubblicitario del lancio di un vero razzo, giusto in coincidenza con la prima proiezione del lm, la produzione decide di nanziare l’impresa. Oberth assume alcuni collaboratori e a ronta la costruzione del propulsore a combustibile liquido che in Germania nessuno era ancora riuscito a far funzionare in maniera controllata. Durante gli esperimenti, a riprova
delle di coltà incontrate nel rendere a dabile il motore, una forte esplosione lo ferisce a un occhio: oltre al grave infortunio, costi e ritardi crescono al punto da indurre il produttore ad abbandonare l’impresa. Il lm, proiettato a Berlino il 15 ottobre 1929, ottiene un grande successo di pubblico, mentre Oberth, deluso e completamente al verde, ritorna dalla famiglia.

Nella primavera seguente, mentre si trova nella sua casa a Medias in Romania, lo informano che l’Istituto per la chimica e la tecnologia ha messo a disposizione della VfR i mezzi per
assemblare e testare un razzo. Ritorna subito a Berlino e il 23 luglio 1930 si svolge con successo il collaudo del nuovo motore, che il direttore dell’Istituto nanziatore, nel suo rapporto u ciale, riassume così: “Ha funzionato senza incidenti per 90 secondi, consumando 6 kg di ossigeno liquido e 1 kg di benzina e fornendo una spinta costante di 7 [Newton]”.
Tra gli studenti dell’Università Tecnica di Berlino coinvolti negli esperimenti, è particolarmente attivo il diciottenne Wernher von Braun, destinato a superare il maestro. Riuscito nalmente a dimostrare la realizzabilità tecnica, Oberth lascia agli ingegneri il perfezionamento del motore e riprende il lavoro a scuola. Nel 1938 trasferisce la famiglia a Vienna e poi Dresda, dove insegna nei collegi tecnici: diventa cittadino tedesco e tre anni dopo lavora nello


stabilimento di Peenemünde, dove von Braun sviluppa i razzi V-2 come direttore tecnico del centro collaudi missilistici dell’esercito tedesco.

Terminata la guerra, entra con falso nome in Svizzera e qui, oltre a scrivere articoli per riviste tecniche, collabora dal 1949 con una fabbrica di razzi antiaereo presso Interlaken.
All’inizio del 1951 raggiunge La Spezia con il compito di sviluppare segretamente, per conto della Marina militare italiana, un razzo teleguidato al nitrato di ammonio: gli scarsi risultati ottenuti, però, portano dopo un paio di anni alla rescissione del contratto. Torna con la famiglia in Germania e nel 1955 parte per
Huntsville in Alabama, dove mette le sue capacità a disposizione di von Braun, sempre con il sogno di esplorare lo spazio. Diventa per un paio di anni consulente della compagnia aerospaziale Convair, ma poi decide di ritirarsi dal lavoro e torna in Germania.
Muore a Norimberga il 29 dicembre 1985, dopo avere visto molte delle intuizioni descritte nel suo libro diventare realtà, anche grazie all’allievo von Braun, progettista del gigantesco razzo Saturn V che ha portato gli astronauti sulla Luna. “Devo a Oberth non solo la stella polare della mia vita, ma anche il mio primo contatto con gli aspetti teorici e pratici della missilistica e del viaggio nello spazio” - ha detto von Braun - “Un posto d’onore dovrebbe essere riservato nella storia della scienza e della tecnologia ai suoi contributi rivoluzionari nel campo dell’astronautica”.

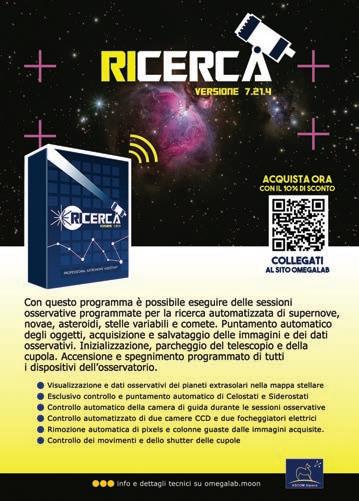
AI PRIMI DI QUESTO MESE OSSERVIAMO IL PIANETA PIÙ BRILLANTE IN UNA FAVOREVOLE APPARIZIONE SERALE
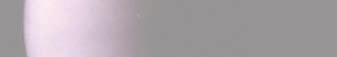
» Un’immagine di Venere ripresa nell’ultravioletto dal telescopio spaziale Hubble mentre il pianeta si trovava a 114 milioni di chilometri dalla Terra.


Domenica 4 giugno Venere raggiunge la massima distanza angolare dal Sole, arrivando ad allontanarsi no a 45,4° dalla nostra stella e rendendosi appariscente nel cielo serale a occidente poco dopo il tramonto del Sole.
Questa “elongazione” vede il brillante pianeta circa alla stessa declinazione del Sole, a quasi +23°, con il Sole proiettato nella costellazione del Toro, mentre Venere è appena all’interno del Cancro. Proprio il giorno della massima elongazione il Sole ha una declinazione di +22°26’, mentre quella di Venere è +22° 51’. Con una di erenza così minima, si può considerare che Venere tramonti dopo il Sole tanto tempo dopo quante sono le ore in Ascensione Retta di di erenza, ovvero in questa circostanza oltre le 3 ore. In tabella sono alcuni dati per il mese di giugno. I valori sono riferiti a 00h 00m di Tempo Universale; la distanza, in milioni di chilometri, è quella dalla Terra. Si noti che all’inizio del mese la declinazione di Venere è molto alta, anche se non come è stata a maggio, quando ha raggiunto +26°.
Il fenomeno è impreziosito dalla vicinanza di Marte, che il 2 giugno transita davanti all’ammasso del Presepe (M44, vedi a pag. 58). Purtroppo, ora Marte è solo di magnitudine 1,5 a causa della distanza dalla Terra di oltre 2 Unità Astronomiche. Tra l’altro, pochi giorni prima (il 29 maggio) si è avuta la massima elongazione ovest di Mercurio, con il piccolo pianeta proiettato nella costellazione dell’Ariete.
All’inizio dell’estate, il 21 giugno, vi sarà un bel quadretto celeste, con la falce lunare che passa in prossimità di Venere e Marte; peccato che quest’ultimo pianeta apparirà soltanto come una stellina. Però la distanza è su cientemente ridotta da riuscire ad averli tutti e tre nel campo di un binocolo.
» Il bacio tra Venere e Giove (meno luminoso) ripreso da Sorrento il 01/03/2023 sullo sfondo dell’isola di Capri con una fotocamera Nikon D5100 e obiettivo da 26 mm su cavalletto, posa di 1 secondo a 800 Iso (Nello Ruocco).

Fotogra camente sarà molto facile riprendere il fenomeno, anche se Marte sarà poco luminoso. Nei giorni della massima elongazione, la distanza tra Venere e la Terra è di circa 106 milioni di chilometri, che comporta un diametro angolare fra i 23” e i 24”, una fase in dicotomia e una magnitudine di -4. Anche se la luminosità non è proprio la massima, il valore è già così alto da renderne possibile l’individuazione a occhio nudo subito dopo il tramonto del Sole. Durante un’elongazione massima, il pianeta si presenta come la Luna al Primo quarto, ovvero dell’emisfero illuminato se ne vede metà e in tali condizioni anche un comune binocolo (tipo un 8x30), se fornisce immagini molto nitide, inizia a rivelarne la fase.
Con un diametro angolare oltre i 20”, è un piacere osservare Venere al telescopio, ma anche ai crepuscoli per una visione ottimale la sua luminosità è eccessiva se non si adotta un attenuatore. Per questo è molto consigliabile la sua osservazione diurna, preferibilmente con un ltro giallo o arancione (vedi il box a pag. 53).
Uno strumento di diametro contenuto, diciamo da 80 mm di diametro, è in grado di assicurare già ottime osservazioni del pianeta, in
» Venere tra Marte e i Gemelli alle ore 22 del 4 giugno sopra l’orizzonte occidentale (Stellarium).

quanto consente di e ettuare visioni interessanti con poteri nell’ordine dei 120x. Con un rifrattore acromatico da 90 mm a f/10, sono molto utili poteri fra 120x e 150x. Con strumenti più grandi, come possono essere quelli dai 100 ai 150 mm, molti osservatori hanno riportato dei segni sul suo manto nuvoloso. Con un buon rifrattore acromatico da 130 mm e un seeing
medio, per Venere l’ingrandimento ottimale è compreso fra 140x e 190x.
Ma spesso il pianeta si presenta senza dettagli, presentando un manto virtualmente uniforme con qualsiasi telescopio. In e etti, le eventuali ombreggiature sono deboli, di use e notoriamente di cili da percepire. Ciononostante, le prime a dabili
osservazioni di dettagli su Venere furono eseguite oltre tre secoli fa da Gian Domenico Cassini. Da allora, parecchi osservatori hanno segnalato la presenza di dettagli scuri che sembravano muoversi sul disco e nell’Ottocento divenne popolare l’idea che su Venere la durata del giorno fosse praticamente la stessa di quella della Terra.
La realtà è che i dettagli venusiani sono assai deboli e mal de niti; basti pensare che quel modello di onestà, pazienza e pure di abilità che fu Johann Schröter, osservò il pianeta per nove anni prima di convincersi di aver visto un dettaglio reale! Questo è un aspetto che non si può trascurare quando si considerano schizzi fatti da osservatori che usano piccoli telescopi con i quali registrano dettagli ogni volta che esaminano il pianeta… Comunque, come dimostrano parecchie riprese fotogra che, la situazione non è senza speranze. Sebbene il disco appaia spesso uniforme, al di là di una percettibile
PUNTARE VENERE DI GIORNO
caduta di luce presso il terminatore, nella maggior parte delle elongazioni si hanno delle ombreggiature credibili. Di queste, quelle viste più di frequente sono i cappucci sulle cuspidi, che possono apparire sia durante la fase gibbosa che quella di crescente. Si tratta di aree brillanti in prossimità dei poli del pianeta. Talvolta sono state riportate con un bordo scuro o collare, sebbene questo in luce visibile sia talvolta il risultato di un e etto di contrasto. Comunque, le immagini in luce ultravioletta realizzate dalle sonde confermano questi aspetti, come anche la posizione, poiché l’inclinazione dell’asse di rotazione è di solo poco superiore ai 2°. È possibile che in luce visibile i cappucci sulle cuspidi siano semplicemente un e etto ottico, ma diversi osservatori sostengono che il fatto di non essere sempre visibili deponga a favore della loro realtà, che è indiscutibile in luce ultravioletta. Nel passato ci sono stati molti
Per rintracciare Venere al telescopio nel cielo diurno, è su ciente conoscere la sua posizione rispetto al Sole.
È facile individuarlo anche con cerchi di puntamento molto approssimati come quelli presenti in una montatura EQ1. In questo caso, si punta dapprima il Sole (proiettandone l’immagine su uno schermo chiaro) e poi ci si sposta di tanti gradi quanti sono quelli che separano Venere dal Sole.
Anche se la montatura è puntata in direzione nord in modo approssimativo, un campo come quello che si ha con un oculare da 25 mm su un piccolo rifrattore 80/400 mm fa entrare il pianeta in campo dopo pochi tentativi.
tentativi infruttuosi per determinare il periodo di rotazione, che oggi sappiamo, grazie al radar, di avvenire in 243 giorni ed essere retrogrado. Con l’osservazione telescopica, neppure i pioneristici lavori in luce ultravioletta condotti nel secolo scorso agli osservatori di Monte Wilson e McDonald da Gerard Kuiper portarono a un corretto periodo di rotazione. Alcuni astro li, con osservazioni visuali, hanno segnalato la presenza di strisce analoghe a quelle registrate nelle fotogra e, dettagli del tutto invisibili alla maggioranza degli osservatori. Sotto questo aspetto, Venere appare molto “democratico” dal momento che qui anche i grandi osservatori del passato non sono giunti a determinazioni conclusive. Lowell riportò un imbarazzante groviglio di linee e Barnard, con il rifrattore da 91 cm di Lick, percepiva appena alcuni dettagli sfumati. Appositi esperimenti hanno dimostrato che gli occhi di alcune persone sono leggermente sensibili alla luce ultravioletta, mentre la maggioranza degli occhi risponde solo alla normale luce visibile dello spettro, dal rosso al blu. Chiaramente, anche deboli di erenze nella sensibilità visuale possono fare la di erenza, quando si osservano dettagli così elusivi come quelli venusiani. In queste circostanze un ltro azzurro-violetto è sempre di grande aiuto.
*WALTER FERRERI
SI È OCCUPATO DI RICERCA
SCIENTIFICA, DI TELESCOPI
E DI ASTROFOTOGRAFIA PRESSO
L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO

DI TORINO. NEL 1977 HA FONDATO
LA RIVISTA ORIONE.
» Il cielo visibile da Roma alle 01h 00m a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia.
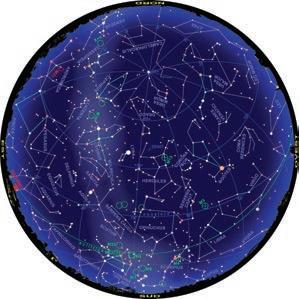

il 4 alle 5h 41m
il 10 alle 21h 31m
il 18 alle 6h 37m
il 26 alle 9h 49m
il 3 luglio alle 13h 38m
il 10 luglio alle 3h 47m
Massime librazioni in longitudine
il 1° alle 10h - visibile
il lembo orientale
il 14 alle 3h - visibile
il lembo occidentale
il 29 alle 8h - visibile
il lembo orientale
Massime librazioni in latitudine
il 7 alle 15h - visibile
il Polo nord
il 21 alle 4h - visibile
il Polo sud
il 4 luglio alle 21h - visibile
il Polo nord
Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 00h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
Perigeo 364.861 km il 7 alla 1h 06m
Apogeo 405.385 km il 22 alle 20h 30m
Perigeo 360.149 km il 5 luglio alle 0h 25m
SOLE
Il 21 giugno alle 16:57 si verifica il Solstizio
Estivo: il Sole raggiunge il punto più alto dell'eclittica, alla declinazione celeste di 23° 26' 18",4 nord. Nel calendario astronomico ciò rappresenta l'inizio dell'estate quando per l'emisfero nord del nostro pianeta l'insolazione raggiunge i massimi valori annuali. Il 22 si sposta nella costellazione dei Gemelli.

È visibile poco prima dell'alba fino al 24, ma quella attuale, con il pianeta che per tutta la prima decade sorge un’ora prima del Sole ed è preceduto di circa 15° dal più luminoso Giove, è l’apparizione meno favorevole dell’anno. Il giorno 6 si sposta dall’Ariete nel Toro e per le nostre latitudini raggiunge la massima altezza di 4°,4 sull’orizzonte orientale all'inizio del crepuscolo civile. Il 17 viene a ancato dalla falce calante della Luna, ma la sua altezza va diminuendo e nell’ultima parte del mese scompare tra le luci dell’alba.
VENERE
È l’oggetto più brillante visibile nelle prime ore serali, seguito a breve distanza da Marte. Il giorno 3 si sposta dai Gemelli nel Cancro e il 4 raggiunge la massima elongazione orientale di 45°,4. La sua altezza sull’orizzonte è però in diminuzione sin dall’inizio del mese e il pianeta anticipa sempre più l’istante del tramonto. Il 13 transita 34’ a nord del Presepe (M44), mentre il 26 entra nel Leone, avvicinandosi a Marte: la distanza che lo separa dal Pianeta rosso diminuirà fino a raggiungere il valore minimo di 3°,6 il prossimo 1° luglio.
Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese.
La mappa, in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.

MARTE
È visibile di sera, preceduto di una decina di gradi dal ben più luminoso Venere; la sua visibilità è in lenta ma costante diminuzione e a fine mese tramonta poco dopo il termine del crepuscolo astronomico. Inizialmente è nel Cancro che attraversa rapidamente: tra il 2 e il 3 giugno transita tra le stelle del Presepe, mentre la sera del 4 è in congiunzione con Delta Cancri, 1°,4 a nord della stella; il giorno 20 si sposta nel Leone.
E emeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate.
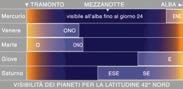
Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra). Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5
E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
Le stelline (da 1 a 5) misurano l’interesse dell'osservazione.
GIOVE
È visibile al mattino nell’Ariete: all’inizio sorge in presenza delle prime luci dell’alba seguito, 45 minuti più tardi, da Mercurio; la sua visibilità è però in progressivo miglioramento e dalla seconda decade la sua levata anticipa l’inizio del crepuscolo astronomico.
SATURNO
È visibile nella seconda parte della notte 1°,5 a est della stella Sigma Aquarii di 5a mag. Il lento moto diretto da cui è animato va rallentando e il 18 il pianeta è stazionario in Ascensione Retta, dopodiché assume moto retrogrado. A fine mese la sua levata segue di meno di un’ora il termine del crepuscolo.

Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.
URANO
Torna a essere osservabile al mattino il giorno 21, all’inizio con di coltà, ma la sua visibilità va migliorando e a fine mese la sua levata precede di 40 minuti la comparsa delle prime luci dell’alba; è rintracciabile un paio di gradi a sud-est della stella Delta Arietis di quarta magnitudine.
NETTUNO
È in quadratura con il Sole il giorno 19 e risulta visibile nella seconda parte della notte 1°,1 a nord-est di 20 Piscium e 1° a nord di 24 Piscium, rispettivamente di magnitudine +5,5 e +5,9. Il 1° luglio è stazionario, quindi assume moto retrogrado.
MARTE IN TRANSITO DAVANTI AL PRESEPE
Nei primi giorni del mese Marte raggiunge il Presepe e tra il 1° e il 3 giugno, negli istanti che seguono il termine del crepuscolo serale, è possibile seguire il transito del pianeta davanti alle regioni settentrionali dell’ammasso. Il pianeta è visibile senza di coltà anche a occhio nudo, ma per riuscire a scorgere l’ammasso e le stelle che lo compongono è consigliabile l’uso di un binocolo o di un telescopio a grande campo.
La sera del 2 giugno Marte transita poco più di 18’ a nord di Epsilon Cancri, la stella più luminosa del Presepe, di magnitudine +6,3. La sera seguente il pianeta si è spostato a oriente di M44, mentre il 4 è in congiunzione, 1°,4 più a nord, con la stella di 4a magnitudine Delta Cancri

Il disegno riporta le posizioni di Marte rispetto al Presepe e alle stelle della costellazione del Cancro alle 23:00 TC delle date indicate.
Nelle ore che seguono il tramonto a oriente del meridiano, è visibile l’inconfondibile figura dello Scorpione, tra le cui stelle spicca la luminosa presenza della Luna Piena. Meno di un grado “sotto” il nostro satellite naturale, è individuabile la rossa scintilla di Antares (Alfa Scorpii), con la quale la Luna viene a trovarsi in congiunzione in Ascensione Retta, 42’ a nord, mezz'ora prima della mezzanotte tra il 3 e il 4. La minima distanza apparente di 39’ viene raggiunta allo scoccare della mezzanotte.
Nella prima decade del mese Mercurio raggiunge la massima visibilità nella corrente apparizione mattutina che, causa la piccola inclinazione tra orizzonte ed eclittica, risulta essere la meno favorevole dell’anno. Nonostante il pianeta abbia raggiunto la massima elongazione occidentale dal Sole di 25° lo scorso 29 maggio, la sua levata precede di meno di un’ora quella del Sole.
L’altezza apparente di Mercurio all’inizio del crepuscolo civile e, di conseguenza, la visibilità mattutina del pianeta, raggiunge il valore massimo di 4°,4 la mattina del 6 giugno; una ventina di gradi più a ovest, un poco più alto sull’orizzonte, è ben visibile Giove.
Nel disegno è ra gurata la posizione dei due pianeti sull’orizzonte orientale alle 5:00 TC, all’inizio del crepuscolo civile.
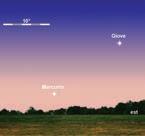
Alcuni gradi a ovest di Sabik (Eta Ophiuchi) e 6° a sud-est di Zeta Ophiuchi, entrambe di magnitudine +2,5, un binocolo consentirà di individuare il pianetino (11) Parthenope, in opposizione al Sole il giorno 6, quando raggiunge la magnitudine +9,5.

All’inizio il pianetino si trova meno di 2° a occidente di Eta Ophiuchi, dalla quale va allontanandosi, a causa del moto retrogrado da cui è animato, in direzione delle stelle di 4a magnitudine Chi e Phi Ophiuchi; con quest’ultima (11) Parthenope viene a trovarsi in congiunzione, 18’ a sud della stella, il prossimo 10 luglio. Nella mappa sono ra gurate tutte le stelle fino alla magnitudine +10,5 compresa.

Di mattina, nell’intervallo di tempo compreso tra la levata del nostro satellite naturale e le prime luci dell’alba, è possibile seguire il progressivo allontanamento dell’Ultimo quarto di Luna da Saturno: la congiunzione tra i due, con il nostro satellite 3°,7 a nord del pianeta inanellato, si è verificata nelle ore serali del giorno 9, quando entrambi i protagonisti si trovavano ancora ben al di sotto dell’orizzonte. La migliore condizione osservabile è quella che realizza dopo la 1:40 TC del 10 giugno, con Saturno poco meno di 4° sopra la Luna, appena levata dall’orizzonte sud-orientale.
Una decina di giorni dopo il transito di Marte, l’ammasso di stelle M44 fa da sfondo al passaggio di un secondo pianeta: la sera del 13 giugno è possibile ammirare la congiunzione relativamente ravvicinata tra il Presepe e Venere. Il pianeta, che si sposta di quasi 1° in 24 ore, non transita davanti all’ammasso ma 34’ a nord del centro geometrico di M44.
La notte tra il 14 e 15 giugno Venere transita 2° a nord di Delta Cancri, mentre nel tardo pomeriggio del 15 occulta la stella SAO 80426, di magnitudine +7,7; il fenomeno, pur essendo teoricamente visibile anche dall’Italia, si verifica nelle ore diurne ed è quindi inosservabile. Il disegno riporta le posizioni del pianeta rispetto al Presepe alle 23:00 TC delle date indicate.
A metà mese tra le luci dell’alba è ancora visibile, pur con di coltà sempre maggiore, l’elusivo Mercurio. Il pianeta è preceduto, quasi 30° a occidente, da Giove, che va progressivamente allontanandosi dalle luci dell’alba. Tra il 14 e il 17 giugno nella zona è visibile anche la Luna calante.

La mattina del 14 il nostro satellite naturale è protagonista insieme a Giove di una spettacolare configurazione celeste: la distanza che li separa è di poco più di 1° e diminuisce con il progredire dell’alba; la congiunzione in Ascensione Retta si verifica nelle ore diurne. Nei giorni seguenti la falce lunare si abbassa sull’orizzonte, assottigliandosi sempre più e la mattina del 17, solo 25 ore prima del Novilunio, tra le intense luci dell’alba è visibile, 5°,5 a “sinistra” di Mercurio, un sottilissimo falcetto lunare.

Il disegno ra gura le configurazioni celesti che è possibile ammirare all’inizio del crepuscolo civile, alle 5:00 TC, delle date indicate.
DI TIZIANO MAGNIDopo aver superato in momenti diversi l’ammasso del Presepe, la coppia costituita da Marte e Venere, che si muovono quasi di conserva a distanza di 4°,5 l’uno dall’altro, si sposta velocemente in direzione del Leone e di Regolo, la stella più brillante della costellazione. All’inizio dell’ultima decade del mese i due vengono superati dalla falce crescente della Luna, in transito 2°,8 a nord di Venere e, alcune ore più tardi, 3°,5 a nord di Marte il giorno 22. La “doppia congiunzione” non è purtroppo osservabile direttamente, poiché si verifica nelle ore diurne. Le migliori configurazioni osservabili, qui ra gurate, sono quelle che si realizzano al termine del crepuscolo serale, alle 23:00 TC del 21 giugno, con il nostro satellite naturale 4° a “destra” di Venere, e del giorno seguente, con la Luna spostatasi nel frattempo 4° a nord-est di Marte.
LUNA E SPICA DI SERA
Tra le ultime luci del crepuscolo serale del giorno 27, sull’orizzonte sud-occidentale è possibile ammirare l’estesa costellazione zodiacale della Vergine, nonché la congiunzione in Ascensione Retta tra la Luna gibbosa crescente e, 2°,1 a sud, Spica (Alfa Virginis).
Nelle ore seguenti il nostro satellite naturale si avvicinerà ancor più alla stella, fino a raggiungere la minima distanza angolare di 1°,8 intorno alla 1:00 TC, con la figura della Vergine che va lentamente calando sotto la linea dell’orizzonte.
MASSIMO DELLO SCIAME
DELLE BOOTIDI DI GIUGNO
Nelle ore che precedono l’alba dovrebbe raggiungere il massimo di attività lo sciame meteorico delle Bootidi di giugno, il cui periodo di visibilità si estende dal 22 giugno al 2 luglio; grazie all’elevata declinazione settentrionale il radiante è visibile per l’intera notte.

L’orbita attuale della cometa 7P/Pons-Winnecke, da cui derivano le Bootidi, non interseca quella della Terra ma risulta essere più esterna di 0,24 UA; le Bootidi osservate in diverse occasioni, le ultime delle quali si sono concretizzate nel 1998 e nel 2004 con valori dello Zhr (il tasso orario zenitale) fino a 100, derivano da nubi di particelle rilasciate nel passato, quando la cometa percorreva un’orbita di erente.
Per il 2023 non sono previsti incrementi di attività, ma grazie a condizioni di visibilità relativamente favorevoli (la Luna in fase gibbosa calante tramonta un paio di ore prima dell’inizio del crepuscolo astronomico) l’osservazione dello sciame è comunque consigliata, per cogliere possibili segni di attività.

NELLA PRIMA DECADE DI LUGLIO CI ATTENDONO
• 1 LUGLIO: LUNA A ANTARES PRIMA DELL’ALBA
•1 LUGLIO: VENERE E MARTE AL TRAMONTO
•2 LUGLIO: LA LUNA OCCULTA LA STELLA DI QUARTA MAGNITUDINESAO 186328 NEL SAGITTARIO
•7 LUGLIO: LUNA E SATURNO ALL’ALBA
•7 LUGLIO: (15) EUNOMIA, DI MAGNITUDINE +8,8, IN OPPOSIZIONE NEL SAGITTARIO
•10 LUGLIO: MARTE 42’ A NORD DI REGOLO, AL TRAMONTO
I testi completi dei fenomeni sul prossimo numero di Cosmo e sul sito bfcspace.com
*TIZIANO MAGNI ESPERTO DI MECCANICA CELESTE, ELABORA LE PREVISIONI DI FENOMENI ASTRONOMICI CON SOFTWARE APPOSITAMENTE REALIZZATI (WWW.TIZIANOMAGNI.IT).
Il Boote è una delle costellazioni più antiche; occupa oltre 900 gradi quadrati ed è molto sviluppata in declinazione, estendendosi con la sua forma di aquilone tra +7° e +55°. È usualmente conosciuta con questo nome, anche perché il suo vero signi cato è controverso e variamente interpretabile: pastore, bovaro, bifolco sono fra i nomi più comuni con cui viene tradotto il termine greco bootes
Virgilio lo de nisce “contadino”, ma dal momento che pastorizia e agricoltura si sono sviluppate parallelamente agli albori della civiltà, può darsi che il termine si riallacci tanto ai contadini, quanto alle tribù nomadi che guidavano gli animali durante la transumanza. Per i Latini, Bootes era il custode dei septem triones, i sette buoi simbolicamente rappresentati dalle sette stelle che costituiscono l’asterismo del Grande Carro. E così pure per i Greci. Ancora nel Medioevo veniva variamente ra gurato come
contadino con in mano una falce, oppure come un cacciatore con al guinzaglio i due cani da caccia che Hevelius introdurrà attorno al 1660 come costellazione a sé stante.
È doveroso, parlando del Boote, so ermarci innanzitutto su Arturo, una delle stelle più brillanti del cielo, preceduta solo da Sirio, da Canopo e dal sistema di Alfa Centauri (ma queste ultime due sono invisibili dalle nostre latitudini). Il nome, che deriva dal greco Arctûros, signi ca “guardiano dell’Orsa” e compare per la prima volta in un poema di Esiodo del VII secolo a.C.
C’è chi sostiene di essere riuscito a scorgerla a occhio nudo una ventina di minuti prima del tramonto, ma non è di cile da individuare anche in pieno giorno con un telescopio anche modesto, impresa riuscita ad alcuni astronomi già nel XVII secolo. Arturo è così brillante anche perché
si tratta di una stella relativamente vicina; la sua distanza ammonta infatti a 36 anni luce, un valore assai modesto su scala galattica. Se riuscissimo a fare un viaggio sino a un ipotetico pianeta in orbita attorno ad Arturo, vedremmo un cielo notturno simile a quello a noi familiare, salvo il fatto che il Sole sarebbe ridotto a un’insigni cante stellina di quinta grandezza. Si tratta comunque di una vicinanza temporanea: essendo una stella di Popolazione II, usualmente con nata nel nucleo e nell’alone galattico, Arturo percorre un’orbita piuttosto allungata che interseca il disco della Galassia nei nostri dintorni. Il suo transito si sta veri cando in modo abbastanza veloce e fra meno di mezzo milione di anni Arturo si sarà talmente allontanata da non essere più visibile a occhio nudo.
Arturo è una gigante rossa, cento volte più brillante del Sole; appartiene, cioè, a quelle stelle che, abbandonata da tempo la Sequenza
Principale, si stanno avviando verso una lunga agonia; la stessa cui andrà incontro il nostro Sole fra circa cinque miliardi di anni. Insieme ad Arturo, l’unica stella del Boote al di sotto della 3a grandezza è la Epsilon, una delle più belle doppie del cielo, tanto da essere soprannominata Pulcherrima (“Stupenda”) da Friedrich Struve, che la scoprì nel 1829, mentre in arabo era conosciuta come Izar (“velo” o “cintura”). È costituita da una gigante arancione e da una compagna bianca di 5ª grandezza, appartenente alla Sequenza Principale, situata a 2.6”
» A sinistra: la costellazione del Boote incastonata fra le confinanti costellazioni boreali.
Qui sopra: Arturo ripresa in un piccolo rirattore con campo di circa 1°; si noti l’assenza dei caratteristici baffi di diffrazione pro¬dotti dalla crociera del secondario di un riflettore.
verso nord. Il sistema si trova a 210 anni luce di distanza e la separazione e ettiva dei due astri ammonta a 185 Unità astronomiche, con un periodo di rivoluzione superiore ai 1000 anni. Le stelle Beta, Gamma e Delta, che formano la parte settentrionale dell’aquilone, sono di 3ª magnitudine: Beta è gialla, distante 218 anni luce e 350 volte più brillante del Sole; Gamma è bianca, distante 85 anni luce e 35 volte più brillante della nostra stella; Delta, di spettro identico alla Beta, è distante 115 anni luce e 45 volte più brillante del Sole.

In una edizione di e Geography of the Heavens, della metà del secolo XIX, gli autori E. Burritt e H. Mattison parlano di un gruppo nutrito di stelle che circondano Arturo e osservabile in un piccolo telescopio. Qualcosa in e etti si nota, ma sembra un raggruppamento casuale, grosso modo orientato da est a ovest e di dimensioni 3°x2°. Alcune di queste stelle appaiono al telescopio di una tinta tra il giallo e l’arancione, ma solo con un oculare grandangolare si riescono a

racchiudere tutte nello stesso campo. La soluzione migliore è quella di un buon binocolo da 80 mm, solidamente ancorato a uno stativo. Più simile a un piccolo ammasso aperto è invece quel piccolo asterismo situato circa 40’ a sud di Arturo, chiamato Picot 1, dal nome dell’astronomo francese
Fulbert Picot che l’aveva notato per primo; è costituito da sette stelline di magnitudini comprese tra la 9a e l’11a e disposte in un modo tale da meritarsi il soprannome di “Cappello
di Napoleone”. Lo segnaliamo per chi ama cacciare qualcosa di esotico e di poco conosciuto.
DUE INTERESSANTI
AMMASSI GLOBULARI
Non sarà forse eclatante come alcuni oggetti di Messier, ma NGC 5466 è un ammasso globulare che merita comunque di essere osservato. Nonostante abbia una bassa luminanza super ciale, è già visibile in un binocolo da 50 mm sotto un cielo molto buio e diviene
evidente in un rifrattore da 8-10 cm, nel quale appare come una debole macchiolina grigiastra con diametro di 5’. Occorre uno strumento di almeno 30 centimetri per individuare qualche dettaglio; a un centinaio di ingrandimenti si vede nemente screziato, mentre a 250x è possibile risolverlo, sia pure limitatamente alla zona periferica. Le stelline non sono di luminosità uniforme e non è presente una condensazione centrale apprezzabile.
Anche se situato nella con nante costellazione dei Cani da caccia (Canes Venatici), M3 tende a o uscare il precedente, per fama e per bellezza. È la prima scoperta u ciale di Charles Messier, avvenuta il 3 marzo 1764 e del quale ci ha lasciato la seguente descrizione: “Nebulosa scoperta tra Bootes e uno dei Cani da caccia di Hevelius; non contiene alcuna stella, il suo centro è brillante e la sua luce va scemando sensibilmente; essa è rotonda; con un bel cielo la si può vedere con un telescopio di un piede”.
Si tratta di un oggetto che alcuni astro li giudicano più a ascinante persino di M13. Alcuni osservatori dalla vista particolarmente acuta sono riusciti a scorgerlo a occhio nudo, ma l’ammasso richiede almeno un binocolo 10x50, con il quale lo si individua 11’ a NNW di una stellina di 8a grandezza, mentre un’altra stellina di 9,5 mag. si trova a
*PIERO MAZZA MUSICISTA DI PROFESSIONE, È UN APPASSIONATO VISUALISTA, CON MIGLIAIA DI OSSERVAZIONI DEEP SKY CONSULTABILI DAL SITO WWW.GALASSIERE.IT

ridosso del margine nord-occidentale. Conviene comunque gustarselo in un piccolo telescopio ed è su ciente uno strumento da 15 cm per risolverlo nelle regioni periferiche. Oltre a essere diversamente strutturato rispetto a NGC 5466, M3 appare brillante anche perché è distante 30mila anni luce, contro gli oltre 50mila del precedente.
La maggior parte degli oggetti deep-sky presenti nel Bootes sono galassie. Sono a ascinanti le cosiddette edge-on, ossia le galassie poste di taglio o quasi, fusi argentei che quando sono molto estesi, come nel caso di NGC 4565 nella Chioma di Berenice, sembrano tagliare a metà il campo oculare. NGC 5529, di 12a grandezza, non ha queste dimensioni, ma è molto bella osservata in telescopi da 30 o 40 cm ad almeno 200 ingrandimenti; è relativamente brillante, anche se con gradiente di luce molto basso, orientata da NE a SW per circa 5’. La galassia è molto distante, a 143 milioni di anni luce.

Circa 40’ a ENE si trova NGC 5557, una galassia di aspetto completamente diverso. Pur essendo di forma leggermente ellittica, visualmente appare rotonda, con un diametro di un paio di primi, compatta e con alto gradiente di luce. È un tipico oggetto
per telescopi da 10-15 cm, simile a un piccolo ammasso globulare irrisolto. Se si osserva in uno strumento superiore in ottime condizioni di trasparenza e seeing, è possibile scorgere, a oltre 200 ingrandimenti, una stellina a ridosso del nucleo, all’incirca verso sud.
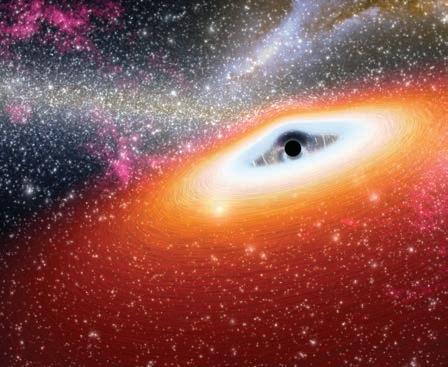
L’ORA DI ASTRONOMIA
Questa rubrica vuole avere una connotazione didattica, per stimolare i lettori ad approfondire l’indagine del cielo anche con gli strumenti della matematica e della fisica.
» Una rappresentazione artistica di un buco nero primordiale (Nasa/Jpl-Caltech).
Chi si ferma su queste pagine scopre che può arrivare a comprendere come funziona l’Universo, con l’aiuto di una semplice calcolatrice Domande, risposte e proposte riguardanti i problemi di calcolo astronomico possono essere inviate in redazione, all’indirizzo stroppa@bfcmedia.com
Tra i tanti oggetti che popolano l’Universo, i buchi neri sono quelli che attirano le maggiori attenzioni e curiosità, grazie alla loro natura del tutto straordinaria, che ha ispirato anche varie opere di fantascienza, nonostante la difficoltà di comprendere come sono fatti e come si comportano. Ricordiamo che il termine “buco nero” fu coniato dall’astrofisico John A. Wheeler nel 1967, per indicare un oggetto la cui forza di gravità è talmente intensa che nulla può sfuggirgli, nemmeno la luce. Ma l’espressione è un po’ ingannevole e riduttiva, perché questi oggetti celesti non sono né buchi, né neri. In ambito scientifico sono definiti, in modo meno colorito, delle “singolarità spazio-temporali”.

Ogni buco nero è circondato da una superficie sferica ideale, con il raggio uguale al raggio di Schwarzschild (che abbiamo imparato a calcolare nella puntata pubblicata su Cosmo n. 33): tutti i fenomeni che accadono all’esterno di questa sfera possono
essere osservati, mentre quelli al suo interno non sono accessibili. Nel caso in cui non ruota ed è privo di carica elettrica, un buco nero è costituito da questa regione sferica che ha al centro un punto (la “singolarità”), in cui è concentrata tutta la sua materiaenergia e dove le leggi fisiche a noi note cessano di essere applicabili. Poiché niente può superare la velocità della luce, radiazione e materia in caduta verso un buco nero sono “inghiottite” per sempre una volta superata la superficie di Schwarzschild, sfuggendo così a ogni osservazione diretta. Questa considerazione però tiene conto solo della teoria della relatività di Einstein. Se si considera la meccanica quantistica, si arriva a dare un altro “colpo” al termine buco nero.
Nel 1974, Stephen Hawking, sulla base della meccanica quantistica, dimostrò come i buchi neri non
siano completamente “neri”, dato che emettono un particolare tipo di radiazione, de nita “radiazione di Hawking”. Secondo la meccanica quantistica, dal vuoto si possono creare coppie di particelle virtuali (particellaantiparticella, come elettronepositrone) purché questo accada in un tempo molto breve. Il vuoto quantistico è in realtà pieno di particelle elementari, che vengono create dal nulla e rapidamente spariscono, annichilendosi ciascuna con la propria antiparticella. Se una coppia di particelle virtuali appare in prossimità dell’orizzonte degli eventi, una delle due può cadere oltre l’orizzonte, mentre l’altra può avere su ciente energia per fuggire via. Il risultato è l’apparizione di una particella, che ora non è più virtuale, ma reale, che per formarsi però ha bisogno di energia. Da dove viene questa energia? L’unica possibilità è che l’energia venga dal buco nero, che di conseguenza diminuisce l’energia e, per l’equivalenza massaenergia, anche la sua massa. In de nitiva, il buco nero emette particelle (la “radiazione di Hawking”), come per una lenta “evaporazione”. Man mano che la massa si riduce, la temperatura e la
potenza emessa aumentano, nché quello che resta del buco nero si dissolve in forma esplosiva.
Per calcolare il tempo (in secondi) necessario per l’evaporazione completa di un buco nero, si può usare la formula:
t = 10240 ϖ2 G2 M3 / h c4
Dove h è la costante di Planck (6,626 x 10−34 J·s), c è la velocità della luce (3 x 108 m/s), G è la costante di gravitazione universale (6,67 x 10−11 N·m2/kg2), ϖ è il “pi greco” (3,14) e M è la massa del buco nero (in chilogrammi).
Sostituendo nella formula i valori delle costanti ed esprimendo la massa del buco nero in masse solari (Ms = 2 x 1030 kg), si ottiene una versione sempli cata della formula, con il tempo espresso in anni:
t = 2,1 x 1067 x (M/Ms)3
Per un buco nero con una massa pari a quella del Sole (M/Ms = 1), sarebbero necessari circa 1067 anni per evaporare del tutto. Per un buco nero di 10 masse solari (M/Ms = 10) abbiamo: t = 2,1 x 1070 anni.
Quindi, per buchi neri di tipo stellare, il tempo di evaporazione è molto maggiore dell’età dell’Universo,
Ecco le soluzioni dei problemi proposti nella puntata precedente (“La danza dei buchi neri” di A. Simoncelli), pubblicata su Cosmo n. 35.
L’evento GW 190521 è stato prodotto dalla fusione di due buchi neri (66 masse solari uno e 85 l’altro) con la formazione di un buco nero di 142 masse solari.
Quindi sono 9 le masse solari convertite in energia da questa fusione ed emessa sotto forma di onde gravitazionali, per un totale di 1,62 x 1048 J.
pari a 13,8 miliardi di anni. Inoltre, l’intensità della radiazione di Hawking è molto debole; perciò, abbiamo poche speranze di osservare questa radiazione per buchi neri stellari. Pertanto, l’attenzione degli astro sici è rivolta verso i buchi neri primordiali, oggetti di piccola massa che si sarebbero originati subito dopo il Big Bang, in seguito a forti uttuazioni nelle concentrazioni locali di materia. Questi oggetti sono più promettenti, rispetto a quelli formati nel collasso stellare, come si vede dal calcolo del tempo di evaporazione per un oggetto di 1011 kg (= 5 x 10-20 Ms). Si ottiene un tempo di 2,6 miliardi di anni. Questo tempo è minore all’età dell’Universo e quindi potenzialmente osservabile. Nonostante non esistano ancora prove dell’esistenza dei buchi neri primordiali, molti astro sici continuano a sperare che in futuro si possa osservare la loro evaporazione per emissione della radiazione di Hawking, magari utilizzando i rivelatori di onde gravitazionali. La veri ca della previsione di Hawking consentirebbe un passo in avanti nella comprensione di questi bizzarri corpi celesti.
Per la prossima puntata, proviamo a calcolare il tempo di evaporazione di un buco nero di 30 masse solari.


Lanciata nel 2013, la missione astrometrica Gaia dell’Esa continua a raccogliere dati su milioni di sorgenti celesti. L’osservatorio, posto a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, con i suoi due telescopi e gli strumenti scienti ci al piano focale, prende quotidianamente precisissime misure di posizione, fotometria e spettroscopia di stelle appartenenti alla Via Lattea, oggetti extragalattici e corpi minori del Sistema solare.
Gaia sta raggiungendo i suoi obiettivi misurando ripetutamente posizioni, luminosità e movimento di tutti gli oggetti sino alla magnitudine 20 (circa 400mila volte più debole di quanto sia visibile a occhio nudo). Con questi dati, gli astronomi stanno costruendo la più precisa mappa 3D della nostra Galassia.
Gaia ha ottenuto nora dati per 1,8 miliardi di stelle con una precisione senza precedenti, ottenendo il più ricco catalogo sinora pubblicato. Nel 2022 è stato pubblicato il terzo catalogo di dati (Gaia DR3) che comprende 10,5 milioni di sorgenti variabili, identi cate mediante sistemi automatici e validati dal team di studio. Questo enorme censimento stellare sta fornendo i dati necessari per a rontare importanti questioni aperte relative all’origine, alla struttura e alla storia evolutiva della Via Lattea. Ora sappiamo che la nostra Galassia deve la sua rilevanza a ripetute fusioni con altre galassie più piccole. Tuttavia, il maggiore accrescimento in massa si deve a un importante evento occorso circa dieci miliardi di anni fa: la fusione con la galassia che è stata chiamata GaiaSausage-Enceladus (Gse). Grazie a Gaia sono stati identi cati gli echi di quell’evento nei moti peculiari delle
stelle e nella loro composizione. Gaia ha contribuito anche a conoscere meglio il Gruppo Locale di galassie, in particolare le Nubi di Magellano, la galassia di Andromeda (M31) e quella del Triangolo (M33). I dati delle loro stelle più luminose permettono di analizzare i moti reciproci e in rapporto alla nostra Galassia e consentono di formulare previsioni sull’interazione futura di queste grandi galassie. Ora abbiamo la conferma che la Via Lattea e M31 si stanno avvicinando e sono destinate a fondersi tra alcuni miliardi di anni.
GAIA VARI
I ricercatori che lavorano ai dati di Gaia non riescono a controllare tutte le sorgenti; perciò, chiedono l’aiuto degli appassionati per classi care le variabili in catalogo. Il sistema occhio/cervello è in grado di eseguire associazioni mentali ancora

di cili per i sistemi automatizzati e per l’intelligenza arti ciale. L’AI è ampiamente utilizzata per analizzare i dati di survey, ma spesso fallisce nel riconoscere oggetti non convenzionali, dove invece l’operatore umano riesce benissimo. E l’analisi dei dati visuali ha portato a scoperte importanti. Con Gaia, si parla di milioni di dati;
una quantità impegnativa anche per potenti computer e ancor di più per l’ispezione visiva limitata agli scienziati coinvolti nella missione. Non è così per un gruppo formato da migliaia di astro li: i volontari hanno mostrato di poter svolgere compiti anche molto impegnativi in ricerche di punta e per questo è stato lanciato il nuovo progetto di citizen science

chiamato
Partecipando a questo progetto, i volontari possono aiutare a classi care le sorgenti variabili registrate dal satellite. In particolare, l’attenzione è rivolta all’analisi delle curve di luce per comprendere meglio queste stelle, scoprirne di nuove e identi care eventuali sorgenti peculiari.
La storia dei progetti di citizen science è ricca di scoperte fatte dai volontari che grazie all’attenta ispezione delle immagini e gra ci hanno notato qualcosa di anomalo e interessante tra esopianeti, comete, oggetti extragalattici. Basta citare KIC 8462852, la “Stella di Boyajian” che mostra insoliti cali di luminosità anche del 20% in pochi giorni, trovati nei dati del telescopio spaziale Kepler della Nasa.
Tra molti altri oggetti, Gaia ha individuato dieci milioni di stelle variabili. Lo studio delle variazioni di luminosità è uno degli strumenti più importanti nell’indagine astro sica, perché consente di comprendere l’evoluzione e la struttura interna delle stelle, oltre all’eventuale presenza di esopianeti. La variabilità può essere infatti
intrinseca o estrinseca, a seconda della causa delle uttuazioni: la prima è dovuta a reali cambiamenti sici, come eruzioni o pulsazioni nella stella, mentre la seconda può essere causata, per esempio, dal transito di un suo pianeta.
L’analisi delle singole sorgenti non rientra negli scopi primari della missione Gaia, ma i volontari possono farlo per il piacere di contribuire alla scienza in modo semplice, grazie a un’interfaccia ben studiata e amichevole, ospitata sulla piattaforma Zooniverse (bit. ly/3M90N0d).
Di particolare interesse per questo progetto sono le variazioni nella luminosità di circa due miliardi di
sorgenti. Data l’enorme quantità di dati, il consorzio Gaia ha progettato una classi cazione automatizzata delle variabili, basata sulle proprietà delle classi di variabilità note. Questo ha permesso di identi care 25 tipi di variabili in Gaia DR3. Tuttavia, la classi cazione automatica non è un meccanismo perfetto e alcune sorgenti sono state classi cate in modo inesatto. La classi cazione umana è un importante meccanismo complementare che può migliorare il processo.
Dopo una veloce prova autonoma d’ingresso ben spiegata, il volontario può passare alla classi cazione delle curve di luce, i colori e altri parametri variabili nel tempo, senza nemmeno eseguire una registrazione. Tuttavia, registrandosi nella piattaforma si accede ad alcuni servizi riservati, tra

cui la possibilità di partecipare alle discussioni.
Partecipando a Gaia Vari, i volontari classi cano variabili, identi cano le classi errate, possono scoprire potenziali nuovi tipi di variabilità e aiutano ad addestrare gli algoritmi e a preparare il prossimo rilascio di dati, previsto per il 2025. Tale compito aiuta a scoprire dove i sistemi automatici falliscono nel processo di classi cazione. Inoltre, questa analisi potrà permettere di identi care oggetti interessanti e forse anche scoprire qualcosa di nuovo.
I promotori di Gaia Vari chiedono ai partecipanti di stabilire come cambia la luminosità, il periodo e il colore di possibili sistemi binari a eclisse (Ecl), pulsatori di tipo cefeide (Cep), pulsatori di tipo RR Lyrae (RR) e stelle variabili di lungo periodo (Lpv). Gaia osserva in varie bande passanti mediante ltri. La di erenza nei valori della luminosità dell’oggetto (magnitudine apparente) nella banda passante blu (BP) e rossa (RP) è chiamato indice di colore, correlato alla temperatura dell’oggetto: maggiore è il valore, più freddo è l’oggetto.
Inserendo in un gra co l’indice di colore e la magnitudine apparente, otteniamo un diagramma coloremagnitudine (CMD). Si possono inoltre tracciare i cambiamenti di colore e di magnitudine assoluta di un dato oggetto nel tempo. Tali modi che possono di erire tra le diverse classi di variabilità.
La gra ca di Gaia Vari è essenziale, ma non banale. Uno degli aspetti da notare è il tentativo di non

rendere la classi cazione astratta. Di ogni sorgente è visualizzato un numero identi cativo, mentre la rappresentazione della Via Lattea ne indica la posizione approssimativa rispetto alla sua struttura spirale con riferimento al Sistema solare. Due sottopannelli mostrano la Galassia frontalmente e di taglio con le coordinate galattiche e la scala delle distanze. Non è una mappatura precisissima, ma permette di farsi un’idea di dove si trovi la sorgente che in esame. Mentre procede la classi cazione, l’impressione è di saltellare qua e là lungo la Via Lattea. Una nestra di dialogo permette di avere informazioni aggiuntive sulla sorgente, anche in italiano. Al pari di altri progetti di citizen science, il partecipante può discutere con altri volontari o con i promotori, anche per segnalare eventuali oggetti anomali.

All’Esa sono duciosi che questo
progetto produrrà un maggiore coinvolgimento del pubblico con il mondo della ricerca e che l’apertura ai non specialisti non mancherà di fornire risultati.
“Gaia sta approfondendo la nostra comprensione dell’Universo, e sia gli astronomi professionisti sia quelli dilettanti sono rimasti stupiti dai risultati analizzati nora”, ha detto Pedro García Lario, community support scientist presso il Gaia Science Operations Center – “Ora abbiamo bisogno della comunità degli astronomi amatoriali per capire meglio come le stelle varino nel corso degli anni”.

 DI MASSIMO DE FUSCO E ALESSANDRO RAVAGNIN*
DI MASSIMO DE FUSCO E ALESSANDRO RAVAGNIN*
Durante il lockdown degli anni scorsi, un gruppo di astro li veneti (Alessandro Ravagnin, Andrea Bertocco e Christian Privitera), normalmente abituato a ritrovarsi insieme per fotografare il cielo, ha ideato un progetto di astrofotogra a condivisa, basato sulla ripresa degli stessi oggetti celesti in contemporanea, mantenendo però le distanze.
Combinando insieme le rispettive riprese, potevano sfruttare al massimo le rare serate di cielo adatto per l’astrofotogra a che si riescono ad avere nel Nord Italia. Così, i tre amici hanno organizzato la prima edizione del FotoniContest: un evento di osservazione condivisa con la propria strumentazione su un target comune. Le prime tre edizioni hanno visto come protagonisti oggetti molto fotografati dagli astro li amatoriali: la grande nebulosa di Orione, la galassia di Andromeda e il complesso nebulare del Cigno.
Per la quarta edizione (FotoniContest#4), a causa di condizioni meteo avverse, è nata l’idea di fare riprese condivise sfruttando i telescopi remoti. L’edizione si è conclusa con un successo di partecipazione e in termini di risultati, con la produzione di immagini della galassia M83 nella costellazione dell’Idra e dei “Draghi belligeranti” nella costellazione dell’Altare (NGC 6188).
Negli ultimi anni sono aumentate le installazioni di strumentazione astronomica connesse a internet e gestibili da remoto, localizzate in posti bui e remoti: dal Cile al deserto dello Utah in America, no alle Astrofarm in Namibia, con 300 giorni all’anno di cielo sereno. Un miraggio per chi vive in Italia! In queste installazioni sono disponibili sia telescopi di piccole dimensioni che telescopi di classe professionale. Il servizio che si è deciso di utilizzare per il FotoniContest#4 è ubicato a Rio Hurtado in Cile, a 1600 metri di quota, sotto uno dei cieli più bui e incontaminati del pianeta. Il sito mette a disposizione quattro telescopi: un Riccardi-Honders da 200 mm di diametro f/3, due Newton da 500 mm e un RitcheyChrétien da 1 metro. Tutti utilizzabili previa prenotazione e pagamento delle sessioni di astrofotogra a, con tari e orarie dipendenti dal diametro del telescopio.
Le cifre per accedere a questi telescopi sono abbastanza alte, a causa del costo della strumentazione e delle spese di manutenzione dell’osservatorio, che non è molto agevole, date le condizioni di isolamento del sito.
La trasferta cilena del FotoniContest è piaciuta così tanto che si è deciso di aprire un nuovo progetto, dedicato


all’astrofotogra a remota condivisa: a ottobre 2022 è nato così il Progetto ShaRA (Shared Remote Astrophotography), avviato da sette reduci dal FotoniContest#4, ai quali si sono poi aggiunti molti altri partecipanti. L’ingresso è libero e non è soggetto ad alcun vincolo. All’inizio di ogni progetto (generalmente a cadenza bimestrale), i partecipanti sono inviati a proporre un soggetto da riprendere; il coordinatore raccoglie le proposte, che vengono poi sottoposte a una votazione; il soggetto più votato viene selezionato come target. Si passa quindi alla raccolta fondi: ognuno è libero di partecipare e nanziare con la cifra desiderata (generalmente, dai 20 ai 60 euro).

Chiuso il budget, si programmano le sessioni di ripresa sulla piattaforma Chilescope (www.chilescope.com) decidendo il telescopio da utilizzare
e il campo inquadrato. Come prima cosa, si bloccano le ore disponibili in base al budget raccolto e si paga la quota, con un tempo minimo di utilizzo di 40 minuti. Si possono avere sconti in base alle fasi lunari: più ci si avvicina alla Luna piena, più alto è lo sconto.
In seguito, si a na il piano di riprese, che dipende dal target scelto: per le galassie si realizzano molte pose con un ltro di luminanza, più il completamento con i ltri RGB per la crominanza (contenuto colore), mentre per le nebulose si fanno riprese con ltri a banda stretta con banda passante per l’emissione dell’idrogeno ionizzato (H-alfa), ossigeno ionizzato (OIII) e zolfo ionizzato (SII).
Realizzate le pose, il coordinatore distribuisce ai partecipanti i le grezzi da elaborare, così ognuno procede con le proprie elaborazioni,
utilizzando i software preferiti. I risultati vengono spediti al coordinatore che li anonimizza e li condivide con il gruppo per l’ultima votazione. In base ai risultati delle votazioni, viene composta l’immagine nale, grazie a una formula che permette di fondere i singoli pixel dei vari contributi in base alla qualità degli stessi. Il risultato è un’immagine che prende quanto di meglio è stato ottenuto in ogni elaborato e media i difetti introdotti dai vari autori. Le discussioni si svolgono all’interno di un gruppo WhatsApp, mentre per le votazioni si utilizza Google Moduli, condividendo i risultati in chiaro, per garantire la trasparenza all’interno del gruppo. A processo concluso, viene condivisa la griglia con i voti assegnati dai singoli partecipanti alle foto degli altri (un partecipante non vota la sua foto).
LE PRIME EDIZIONI
La prima edizione del progetto ShaRA si è tenuta nell’ottobre del 2022 e la fase di selezione ha portato a un target iconico per gli amanti dell’astrofotogra a: i Pilastri della Creazione nel cuore della Nebulosa Aquila (M16), resi famosi da una foto del 1995 del telescopio spaziale Hubble e più recentemente dal nuovo James Webb. Per l’occasione è stato utilizzato il T1 da 1 metro di diametro e sono stati realizzati due pannelli con pose da 600 secondi, usando i ltri a banda stretta H-alfa, SII e OIII. I contributi di ogni partecipante possono essere visionati alla pagina bit.ly/3IRqwHk.
La seconda tornata di ShaRA, tenutasi a dicembre 2022, ci ha portato nell’emisfero australe, con la scelta delle nebulose NGC 2014

(chiamata Cosmic Reef perché ricorda un variopinto fondale marino) e NGC 2020 nella Grande Nube di Magellano. Anche in questo caso, è stato scelto il telescopio T1 con gli stessi ltri della sessione precedente, più quelli a banda larga RGB. La foto è stata pubblicata su Bfcspace. com; le elaborazioni si possono visionare alla pagina bit.ly/3BSL67r. Con l’inizio dell’anno nuovo è stato dato il via alla terza edizione di ShaRA, per la quale è stato scelto un oggetto nella costellazione australe della Fornace, la galassia NGC 1097, ribattezzata “Occhio di Horus” per la sua forma che ricorda il famoso simbolo della mitologia egizia. È stata ripresa ancora con il telescopio T1 e i ltri a banda larga L e RGB, aggiungendo qualche posa con il ltro H-alfa per catturare le zone di formazione stellare di cui è ricca questa galassia. Vedi la foto su Bfcspace.com (bit.ly/3F8A1kd) e le elaborazioni dei partecipanti alla pagina bit.ly/3F2KQV7. Il gruppo si sta a atando e molti altri progetti ShaRA seguiranno. Fintanto che nuvole e inquinamento luminoso ci impediranno di osservare il cielo, l’astrofotogra a remota rappresenterà un’ottima opportunità per continuare a praticare la nostra passione per l’osservazione del cosmo.
*MASSIMO DI FUSCO
È DOTTORE DI RICERCA IN CHIMICA, APPASSIONATO DI ASTRONOMIA
E ASTROFOTOGRAFO AMATORIALE ALESSANDRO RAVAGNIN
È INGEGNERE DELLE
TELECOMUNICAZIONI, IDEATORE E COORDINATORE DEL PROGETTO SHARA (ASTROTREX.WORDPRESS.COM).

Dopo il grande successo ottenuto nelle 6 tappe del 2022, continua anche nel 2023, con ben 9 tappe, il viaggio di Forbes dedicato alla scoperta delle PMI, spina dorsale dell’Italia che cresce.

Un’occasione per confrontarsi su temi quali sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, welfare, accesso al credito e per creare relazioni professionali. Il progetto è rivolto a imprenditori e manager che gestiscono PMI del territorio e alle grandi aziende che vogliono mettersi in contatto con loro. SCOPRI DI PIÙ: www.eventi.forbes.it/smallgiants/








CARICATE LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE SU BFCSPACE.COM
LA REDAZIONE SCEGLIERÀ LE MIGLIORI PER “LE VOSTRE STELLE”
SONO TAGGATE DA UNA STELLA LE FOTO CHE HANNO VINTO LE NOSTRE SFIDE SOCIAL INQUADRA IL QR PER VISITARE LA GALLERY DELLE FOTO

LA NEBULOSA PLANETARIA ABELL 21 NEI GEMELLI

Ripresa da Stigliano (MT), 18/03/2023
Telescopio Newton Gso 200/800 mm su montatura Sky-Watcher EQ 6R Pro
Camera Zwo Asi 294 MC Pro con filtro Optolong L-Ultimate
Guida con Zwo Asi 120 Mini
Pose 104 x 300 s, elaborate con Pixinsight e Photoshop
Autore: Giacomo Pro’, Torricella (TA).

Riprese da Punta di Mola (RG) il 23/03/2023
Fotocamera Canon Eos R con obiettivo Canon EF 200 mm f/2,8 a f/4,5 su cavalletto Manfrotto
Posa di 2,5 s a 1600 ISO, elaborata con Photoshop
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.

Ripresa da Modena il 22/03/2023
Telescopio Apm SD Apo 140 mm f/7 su montatura iOptron Gem 45
Camera Zwo Asi 533 MC Pro con ltro Optolong L-Pro
Guida con Zwo Asi 220 MM Mini e Zwo Oag-L
Pose 259 x 300 s, elaborate con Astro Pixel Processor, PS 2023, Topaz
Denoise, Starnet v2, Siril 1.
Autore: Andrea Arbizzi, Modena.

Ripresa da Sannicola (LE) il 15/03/2023
Telescopio Sv503 Svbony 102/714 mm su montatura HEQ5
Camera Qhy 294 con ltro Optolong L-Ultimate, guidata con Phd2
Pose 275 x 300 s, elaborate con PixInsight e Photoshop
Scoperta solo nel 1980, Puwe-1 è una delle più grandi “planetarie” visibili nei nostri cieli, con un diametro pari quasi alla Luna piena.
Autore: Lino Benz, Sannicola (LE).
RESTO DI SUPERNOVA SH2-224 IN AURIGA

Distante 14.700 anni luce, ripreso da Manduria (TA) dal 23/11 al 27/12/2022
Telescopio Sharpstar 94 Edph ridotto a 410 mm f/4,4, su montatura Sky-Watcher
EQ6R Pro
Camera Zwo Asi 294 MC Pro con ltro Optolong L-Ultimate
Guida con Zwo Asi 120 Mini
Pose: 83x900 s, più dark, at e dark at, elaborate con PixInsight, Photoshop
Autore: Giacomo Pro’, Torricella (TA).

Ripresa da Vecchiazzano-Forlì il 18/09/2022
Telescopio Sky-Watcher Newton 200/1000 mm su montatura Sky-Watcher EQ6R Pro
Camera Qhy 294c con ltro Optolong L-Enhance
Guida con acromatico 70/400 mm e camera Zwo Asi 224 con ltro Uv-Ir Cut Svbony
Pose 53 x 300 s, elaborate con Pixinsight e Photoshop
La Cocoon è una nebulosa a forma di bozzolo, distante circa 3300 anni luce, che circonda un piccolo ammasso stellare aperto (IC 5146).
Autore: Omar Cazzanti, Vecchiazzano–Forlì.
Accessibilità e inclusione sono le parole d’ordine dell’Associazione cascinese astro li (Aca), delegazione territoriale dell’Unione astro li italiani (Uai) della provincia di Pisa. Modelli tattili, testi in Braille per non vedenti, telescopi per l’osservazione del cielo in carrozzina e tanti altri strumenti di divulgazione inclusiva rappresentano gli “ingredienti” principali degli eventi organizzati dagli esperti dell’Associazione per raggiungere un vasto pubblico e per consentire a tutti di provare l’emozione della scoperta dell’Universo. L’attenzione al mondo della disabilità connota da sempre l’Associazione, come ci racconta il presidente dell’Aca Domenico Antonacci, astro lo e divulgatore di lunga data, onorato nel 2019 dall’assegnazione del suo nome a un asteroide di Fascia principale (84120 Antonacci) da parte degli studiosi e scopritori di asteroidi Maura Tombelli e Fabrizio Bernardi, per il suo pro cuo impegno nella divulgazione dell’astronomia.
L’Associazione cascinese astro li nasce il 28 settembre 2012 a Cascina (PI), con lo scopo di promuovere iniziative ed eventi socio-culturali dedicati all’astronomia, alla sica e alle altre scienze naturali. L’Associazione si propone in particolare di avvicinare alla cultura scienti ca bambini e adulti, creando occasioni di crescita, confronto, socialità e divertimento. Gli attuali consiglieri dell’Aca sono - oltre al presidente - Simone Pertici, Barbara Antonacci, Fausto
Rossi e Giuseppe Di Grazia. I soci iscritti ogni anno oscillano fra i 20 e i 30. L’astronomia è una materia che incuriosisce molti, ma che appassiona pochi. Richiede anche un certo impegno di tempo e in orari che non sono facili per nessuno, specie in inverno.
La sede associativa è collocata a Cascina (PI) in via Berretta 80, località San Lorenzo Alle Corti, all’interno di un centro parrocchiale molto frequentato dai giovani. La nostra sede si compone di una sala conferenze, di un terrazzo dove allestiamo gli strumenti di osservazione e di alcuni locali adibiti a magazzino. La strumentazione astronomica è rappresentata da un ri ettore SC 9,25”, un ri ettore Dobson da 300 mm, un rifrattore da 102 mm, un rifrattore da 150 mm, un rifrattore acromatico da 250 mm (in fase di assemblaggio), una camera CCD e una Canon 450 modi cata.
QUALI ATTIVITÀ OFFRITE AL PUBBLICO?
L’Associazione svolge un’intensa attività divulgativa che mira a coinvolgere il più vasto pubblico, anche di persone poco esperte, con l’obiettivo di promuovere la scienza e il metodo scienti co. O riamo al pubblico della provincia di Pisa, presso la nostra sede e in location sia pubbliche che private, diverse tipologie di attività: osservazioni ai telescopi, conferenze, eventi di divulgazione inclusiva, corsi di astronomia, anche per persone con disabilità e con
disturbo autistico, e percorsi museali di astronomia inclusiva.
L’Associazione si occupa di divulgazione inclusiva dal 2013, organizzando manifestazioni che prevedono il coinvolgimento di persone con disabilità, come i non vedenti, non udenti, persone con disabilità motoria e con disabilità
cognitiva. L’Aca fa parte del progetto “Divulgazione inclusiva” dell’Uai ed è stata pioniera nella promozione di attività rivolte ai disabili cognitivi con l’evento del 22 agosto 2018 a Quercianella (LI).
O riamo alle scuole di ogni ordine e grado una serie di attività didattiche, in linea con i programmi scolastici,
dedicate all’esplorazione di temi astronomici e all’osservazione del cielo con i nostri strumenti, anche in occasione di eventi astronomici particolari.
Per le scuole realizziamo inoltre esposizioni permanenti di astronomia inclusiva. Abbiamo, per esempio, inaugurato il 18 ottobre

2022 un percorso di astronomia, intitolato “L’Universo Inclusivo” composto da dieci pannelli didattici, installati in modo permanente all’interno dell’Istituto comprensivo “Gamerra” di Riglione (PI). Il percorso si compone anche di testi in
Braille per la lettura dei contenuti da parte dei non vedenti e sui pannelli è stato creato un QR-Code per rendere facilmente accessibili, tramite APP, i contenuti audio/video presenti sul sito web dell’Aca. Siamo molto sensibili al tema
Giovedì 8 giugno (ore 18:00): “Toccare e ascoltare il cosmo”, conferenza pubblica di astronomia dedicata ai non vedenti presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato” di Cascina (PI).
Venerdì 16 giugno: attività osservativa serale ai telescopi, accessibile ai non vedenti presso il campo volo di Collesalvetti (PI), in località Grecciano. Questi due eventi sono organizzati con la collaborazione dell’Unione italiana ciechi (Uici) di Pisa, nell’anno i cui si celebrano per l’Aca i dieci anni di attività divulgativa con i non vedenti.
Sabato 24 giugno (ore 10:00): visita guidata all’Osservatorio gravitazionale europeo (Ego) di Cascina (PI), organizzata dall’Aca in collaborazione con EgoVirgo. Un’occasione per parlare dell’importanza del metodo scientifico e per dire grazie ai medici e sanitari in prima linea durante il periodo di gestione della pandemia da Covid-19. Dopo la visita all’interferometro, sarà possibile osservare il Sole al telescopio messo a disposizione dagli astrofili dell’Aca.

Giovedì 29 giugno (ore 19:00): “Asteroid Day con Aca: meteoriti e detriti spaziali” presso la Cittadella Galileiana in Largo Renzo Spadoni a Pisa. Al termine dell’evento, rigorosamente inclusivo, saranno e ettuate osservazioni al telescopio.
dell’inquinamento luminoso, che a rontiamo durante le nostre conferenze. È fondamentale portare avanti la battaglia contro questa forma di inquinamento, sia per evitare sprechi energetici, sia per restituire a tutti il diritto di osservare il cielo sopra di noi, un cielo buio e ricco di stelle.
Stiamo lavorando alla realizzazione di due postazioni sse per i telescopi, con l’obiettivo di rendere più semplice e sistematica la nostra attività di astrofotogra a, che avrà anche scopi di ricerca. Vorremo riuscire a settare i nostri strumenti per ottenere il codice osservatorio del Minor Planet Center e poter svolgere la nostra parte nel campo della ricerca degli asteroidi pericolosi Nei prossimi mesi dovremo dedicarci anche al montaggio del rifrattore progettato da Luigi Righi, telescopio che ci è stato assegnato con una donazione (in buona parte) dal glio Marco. Siamo orgogliosi di potercene occupare e ci preme rendere omaggio a un appassionato astro lo come Luigi, che ormai guarda il cielo da sopra le nuvole, ma che ha lasciato materiale e strumenti che parlano tanto della sua passione. Inoltre, vogliamo impegnarci di più nell’ambito della divulgazione e della formazione, organizzando nuovi corsi di astronomia. Per maggiori informazioni sull’Aca, vedi il sito www.astro licascinesi.it

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Blue Financial Communication S.p.A. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www.abbonamenti.it/cga
Invece di 58,80€
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
*24,90€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 29,90€ (IVA inclusa) invece di 58,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP
BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO Chiama il numero
02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COUPON DI ABBONAMENTO SPECIALE
Sì, mi abbono a FORBES per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 58%. Pagherò 24,90€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 29,90€ IVA inclusa) invece di 58,80€.O erta Valida solo per l’Italia.






Cognome
Indirizzo
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, con sede in Via Melchiorre Gioia 5520124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà e ettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@ bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti. it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto
rilascionego il consenso per le attività di profilazione
Da venerdì 14 a domenica 16 aprile si è tenuto, al Planetario di Ravenna, il XXXVIII Meeting dei Planetari italiani. L’appuntamento annuale che raccoglie ogni anno non solo gli operatori di planetari, ma anche chi si occupa di didattica e divulgazione scienti ca, astro li, insegnanti e semplici appassionati delle scienze del cielo. A organizzarlo è stata PLANit, l’Associazione dei Planetari Italiani (www.planetari. org), insieme al Planetario di Ravenna e all’Arar, l’Associazione Ravennate Astro li Rheyta (www. arar.it). L’incontro di quest’anno ha visto una partecipazione senza precedenti, un segnale che i planetari raccolgono sempre più interesse e che chi vi lavora sente l’importanza di fare comunità, per collaborare e migliorare le proprie proposte verso il pubblico, che negli oltre 120 planetari italiani supera le 400mila presenze l’anno.

Il Planetario di Ravenna non ha un sistema di proiezione digitale a tutta cupola (fulldome), ma un proiettore optomeccanico di tipo
tradizionale sotto una cupola di 8 metri di diametro gestito dall’Arar, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. Ma se il digitale per una volta non l’ha fatta da padrone, l’attenzione si è spostata verso le diverse modalità per proporre l’astronomia al pubblico in modo sempre più accattivante e coinvolgente.
In questo senso va visto il workshop che si è tenuto nel pre-meeting del venerdì, il cui obiettivo è stato proprio il rapporto con il pubblico. Luca Perri, astro sico e noto divulgatore, con il suo intervento (Lo smarting up ci salverà dal dumbing down: si può essere chiari parlando di cose incomprensibili?) ha sottolineato i vari pregiudizi che possono essere presenti in una platea generale e i modi per a rontarli.
Mentre Graziano Garavini, attore e formatore, con il suo laboratorio su Spontaneità, narrazione creativa, gioco e rapporto con ilpubblico, ha cercato di mettere in luce “l’attore” che è sempre presente in chi parla in un planetario, anche dividendo i partecipanti in gruppi e invitandoli a improvvisare una mini-pièce teatrale di taglio astronomico.
Il sabato è stato interamente dedicato agli interventi dei partecipanti al convegno. Tra questi, segnaliamo la presentazione sull’originale interazione tra umani e robot svolta al Planetario di Lignan (AO) da Paolo Calcidese e le potenzialità di utilizzo dell’intelligenza arti ciale per produrre contenuti per planetari presentate da Dario Tiveron, presidente di PLANit. Nino Ragusi di Muggiò (MB) ha presentato un excursus sull’astronomia nelle opere d’arte, mentre l’architetto e curatrice Elisabeth Veermer ha portato i presenti nelle eccentricità della moda ispirate all’astronomia e alle missioni spaziali, dagli anni Sessanta a oggi; Laura Saba, della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze, ha invece presentato il suo libro Favole tra le Stelle, in cui rivisita miti antichi e propone nuove storie del cielo. Lo stesso giorno, le aziende produttrici di planetari presenti al meeting hanno illustrato le novità tecnologiche del settore e le più recenti realizzazioni, in Italia e all’estero. Sempre sabato si è tenuta anche una tavola rotonda, una
novità per il meeting. Il tema Come promuovere il proprio Planetario? ha esortato i presenti a condividere le proprie esperienze sul tema della promozione e del marketing, tra mezzi tradizionali (radio, carta stampata, manifesti) e digitali (sito web, social, newsletter).
La giornata si è conclusa con la premiazione del vincitore del Premio PLANit, giunto all’undicesima edizione, che riconosce il miglior video fulldome su un argomento di interesse scienti co. A vincerlo è stato Emanuele Balboni in rappresentanza di In ni.to, il Planetario con annesso museo dell’astronomia e dello spazio sulla collina di Pino Torinese, con il video La regata spaziale, che a breve sarà messo gratuitamente a disposizione dei soci di PLANit. La domenica mattina ha visto una serie di interventi sulle collaborazioni
esistenti tra PLANit e altre realtà, come l’Unione astro li italiani, rappresentata da Giorgio Bianciardi, insieme alla quale PLANit organizza alcune scuole estive di didattica dell’astronomia. Mentre la collaborazione con l’International Planetarium Society è stata descritta da Simonetta Ercoli, di Perugia. Importanti anche i progetti di Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) illustrati da Nicola Bernardo del Planetario di Ravenna.

Il programma delle tre giornate si è chiuso con l’Assemblea dei soci di PLANit, un momento fondamentale di confronto e di libera discussione, nel quale si è parlato del centenario dei planetari moderni, i cui festeggiamenti iniziano quest’anno, e delle diverse iniziative legate a questa scadenza (www.planetari.org/centenario-dei-
planetari). E anche della Giornata nazionale sull’inquinamento luminoso, nata nel 1993 con il patrocinio dell’Associazione Amici dei Planetari (oggi PLANit), e sull’opportunità di fonderla con la manifestazione M’illumino di Meno, senza però confondere il problema dell’inquinamento prodotto dalle luci arti ciali con quello dello spreco di energia. In ne, il presidente Dario Tiveron ha illustrato come sia stato ampliato il serbatoio di lmati fulldome gratuiti disponibili per i soci, e ha invitato i presenti a candidarsi per ospitare il meeting del prossimo anno.
*GIANLUCA RANZINI ASTROFISICO E GIORNALISTA, SI OCCUPA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E DI PLANETARI. È TRA I FONDATORI DI PLANIT, L’ASSOCIAZIONE DEI PLANETARI ITALIANI.
Segnalate eventi, mostre, star party a stroppa@bfcmedia.com
ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA CONFERMA DEGLI EVENTI SUI SITI INDICATI

MONZAMBANO (MN)
NUS (AO), LOCALITÀ LIGNAN
SPETTACOLI AL PLANETARIO SABATO, ORE 16:00 E 18:00
Il Planetario di Lignan o re al pubblico di adulti e bambini spettacoli dedicati alla scoperta del cielo del periodo e all’esplorazione di temi di forte rilevanza scienti ca. bit.ly/3R5BhrD
FESTIVAL DELL’ASTRONOMIA 9-11 GIUGNO
A Castellaro Lagusello si possono incontrare astronomi e astro li e scoprire la passione che anima la ricerca e la divulgazione scienti ca. Il Festival è organizzato dall’Istituto nazionale di astro sica, dal Comune e dalla Fondazione Città di Monzambano.
bit.ly/40yXrXP

VARESE
PORTE APERTE ALL’OSSERVATORIO
11 GIUGNO, DALLE 10:00 ALLE 16:00
Gli esperti della Società Astronomica “G.V. Schiaparelli” o rono al pubblico visite guidate all’Osservatorio, visite al giardino montano, laboratori didattici e l’osservazione del Sole. bit.ly/3mL5LGs
VERONA
LUNA IN PIAZZA BRA
27 GIUGNO, ORE 21:00






Il Circolo Astro li Veronesi o re al pubblico di adulti e bambini un evento dedicato alla scoperta e all’osservazione al telescopio della Luna. bit.ly/3K8fOwk
FAENZA (RA)
BINOCULAR CLASSROOM
15 GIUGNO ORE 21:30
Al Parco delle Ginestre, lezioni di astronomia pratica, osservando il cielo al binocolo, a cura del Gruppo Astro li Faenza. È necessaria la prenotazione. www.astrofaenza.it
FIRENZE MARGHERITA HACK E LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
6 GIUGNO, ORE 21:00
Conferenza sull’astronoma e divulgatrice scienti ca Margherita Hack, a cura di Emiliano Ricci presso l’Istituto “P. Calamandrei”. L’evento è organizzato dalla Società astronomica orentina. bit.ly/3oAp2KV
CASCINA (PI)
INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
CASCINESE ASTROFILI
8, 16, 24 E 29 GIUGNO
Conferenze pubbliche, attività osservative, visita all’Osservatorio gravitazionale europeo, partecipazione all’Asteroid day. Per i dettagli, vedi a pag. XX bit.ly/3KOHdE8
BACOLI (NA)
SUPERNOVAE E BUCHI NERI:
LE FABBRICHE DELLA LUCE
23 GIUGNO, ORE 20:00
Conferenza a cura di Massimo Della Valle, presso la Biblioteca “Plinio Il Vecchio” nel Parco Cerillo, abbinata all’osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio con i soci dell’Unione Astro li Napoletani. bit.ly/40h9gCs
SOVICILLE (SI)
VISITE ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
9 E 23 GIUGNO, ORE 21:30
Gli esperti dell’Unione Astro li Senesi aprono al pubblico le porte dell’Osservatorio astronomico provinciale di Montarrenti per o rire osservazioni guidate del cielo notturno ai telescopi. bit.ly/3AwPw3I
PISA
MOSTRA FOTOGRAFICA
“PER DESIDERIO”
FINO AL 17 GIUGNO
Nella Torre del Conte Ugolino uno spazio culturale con letture di poesie e conferenze pubbliche sul tema del cielo per un viaggio tra le immagini del cielo inteso in chiave artistica, poetica e scienti ca. desidus.org
NIGHT STAR & MOON WALK
24 GIUGNO, ORE 21:00








L’Associazione Tuscolana di Astronomia organizza, in collaborazione con il Parco regionale dei Castelli Romani, una passeggiata notturna nei dintorni del Parco astronomico “Livio Gratton”, per l’osservazione del cielo stellato a occhio nudo e al telescopio. bit.ly/3mNZQQX
BARI (BA)
SPETTACOLI AL PLANETARIO
OGNI WEEK-END
Gli esperti dell’Associazione culturale Andromeda conducono il pubblico alla scoperta dell’a ascinante mondo dell’astronomia attraverso spettacoli multimediali e laboratori. bit.ly/3pv1AvZ
MILANO, ADELPHI, 2023
PAGINE 144 CON ILLUSTRAZIONI A COLORI
FORMATO 10 X 17,5 CM
PREZZO € 14,00
Fino ad ora l’attenzione degli astro sici si è focalizzata sui buchi neri. Carlo Rovelli, invece, ha deciso di andare oltre, per scoprire che cosa c’è (o ci potrebbe essere) “dopo” un buco nero. Nel suo Buchi bianchi - Dentro l’orizzonte propone un viaggio concettuale ispirandosi ad altri viaggiatori che hanno s dato l’impossibile, a cominciare da Dante che viene citato spesso. Visto che si viaggerà in un territorio inesplorato, Rovelli si farà guidare dalle equazioni di Einstein, che conosce benissimo. Per aiutare a visualizzare concetti non banali, che espone in tono colloquiale e con un linguaggio semplice, Rovelli utilizza un imbuto lunghissimo e sempre più stretto. È questa per lui la migliore descrizione dell’interno del buco nero e compare decine di volte nel libro, perché è proprio percorrendo questo imbuto che il viaggiatore si avvicina, o pensa di avvicinarsi, alla singolarità, per scoprire che quello che cerca accade dopo e, per andare oltre, il tempo deve essere ribaltato. Non è un processo
AUGUSTO MULAS E MARCO SANNA
CAGLIARI, EDIZIONI CONDAGHES, 2013
PAGINE 95 CON ILLUSTRAZIONI B/N
FORMATO 15 X 21 CM
PREZZO € 9.00
E se rappresentassero le Pleiadi? È quello che avrà pensato l’archeologo Augusto Mulas a Torralba, in Sardegna, in una notte stellata. Questa visione riassume una precisa ipotesi: ogni singola stella del famoso asterismo, già noto nell’antichità da popolazioni sparse sull’intero globo, avrebbe come corrispondente un nuraghe presente nella piana di Torralba.
Le Pleiadi sono stelle che hanno accompagnato l’umanità nella vita di tutti i giorni, risultando utili indicatori per l’agricoltura, la transumanza o per la navigazione, ma non è nemmeno improbabile pensarle legate anche alla spiritualità dell’epoca nuragica.
Il lavoro è molto significativo, perché contribuisce a rafforzare l’ipotesi che i nuraghi siano monumenti di culto e legati al sacro, a scapito della tradizionale interpretazione di un utilizzo militare. Nel libro, quest’ultima interpretazione è messa in crisi dalla disposizione stessa dei monumenti, che non riesce a essere spiegata da alcun modello classico legato alla gestione del territorio.
banale, perché richiede una capriola gravitazionale e quantistica, ma è l’essenza alla base del “buco bianco”. Le equazioni di Einstein sono sempre le stesse, ma il tempo cambia di segno. Questo signi ca che, mentre dal buco nero nulla può uscire, dal buco bianco nulla può entrare perché c’è solo la via per uscire. Rovelli si entusiasma per questa descrizione, ma fa notare che tutto questo potrebbe essere sbagliato; è una precisazione che va a tutto merito della sua onestà intellettuale. Non conosco molti altri sici teorici disposti ad ammettere che il problema che studiano potrebbe essere sbagliato o irrilevante. Altrettanto veritiero è il racconto della soddisfazione che prova nel formulare un’idea che potrebbe essere interessante. Dopo tutto, i buchi bianchi sono una s da e quello che a ascina lo scienziato è la capacità di interrogarsi sul modo di unire la relatività generale e la sica quantistica.
Patrizia CaraveoLa lettura del volume, il cui sottotitolo è I Nuraghi e le Pleiadi, è piacevole anche per chi non si è mai interessato all’archeoastronomia, un filone multidisciplinare che ultimamente sta emergendo sempre più, con lavori sull’orientamento astronomico di tanti siti prestorici, come i monumenti del passato sardo.
Per riassumere, la stella più luminosa, Alcione, corrisponderebbe al nuraghe più bello e complesso, quello di Santu Antine, ma come si fa ad affermare con certezza che gli altri nuraghi raffigurino Maia, Elettra, Merope, Celeno, Taigete e Sterope?
Per rispondere, l’ingegnere Marco Sanna ha elaborato un’analisi probabilistica della corrispondenza tra la disposizione del gruppo dei nuraghi e le Pleiadi: il risultato fornisce un forte supporto all’ipotesi che non si tratti di una disposizione casuale, ma che i nuraghi ricalchino in terra le “sette sorelle” che si vedono oggi come allora in cielo. Il volume è oggi disponibile anche in lingua inglese.
Gabriella Bernardi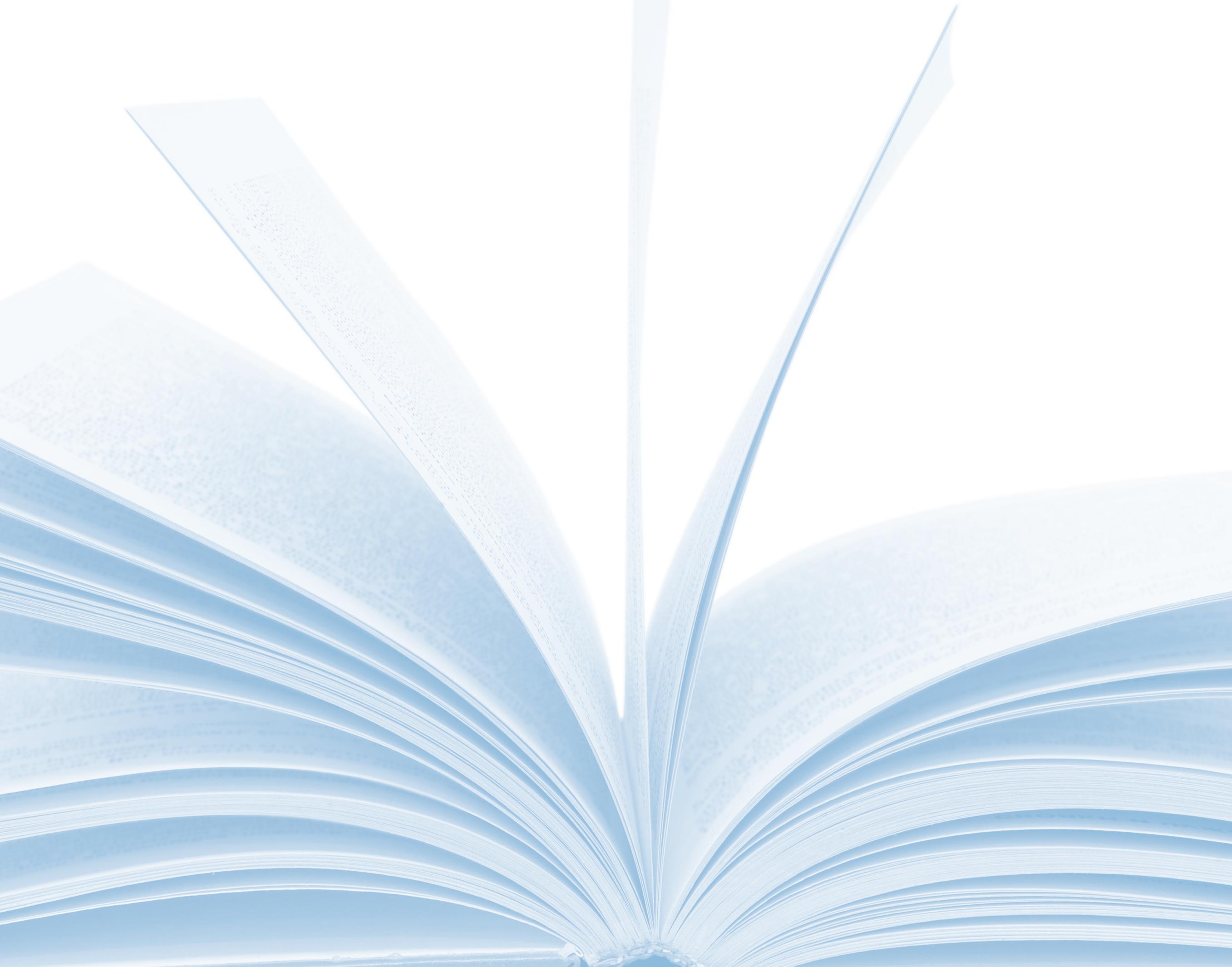
OFFERTA DEDICATA AI LETTORI DI COSMO
Acquista 6 libri a scelta dalla lista al prezzo di 60 euro, spese di spedizione incluse.
La ricerca amatoriale delle supernovae
Giancarlo Cortini, Stefano Moretti
Super-occhi per scrutare il cielo Walter Ferreri, Piero Stroppa
I pianeti e la vita Cesare Guaita
I giganti con gli anelli
Cesare Guaita
Alla ricerca della vita nel Sistema Solare
Cesare Guaita
Oltre Messier

Enrico Moltisanti
I grandi astrofili Gabriele Vanin
La Luna Walter Ferreri
In viaggio nel Sistema Solare Francesco Biafore
Come funziona l'Universo Heather Couper, Nigel Henbest

Come fotografare il cielo Walter Ferreri
L'osservazione dei pianeti Walter Ferreri
Cento meraviglie celesti Gabriele Vanin
Effettua l’ordine comodamente su BFC Store (bfcstore.com): acquistando il coupon “I best seller di Cosmo” riceverai un’email di conferma, rispondendo alla quale potrai indicare i titoli scelti.

ASTRONOMIA / COSMOLOGIA / SPAZIO
OSSERVATORI / STRUMENTI / ASTROFOTOGRAFIA INTERVISTE IN STUDIO E SERVIZI

DA UN’IDEA DI FRANCO CAPPIELLO CONDOTTO DA WALTER RIVA PRESENTA ADRIANA LALA
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA UNIONE ASTROFILI ITALIANI
TUTTE LE 12 PUNTATE DISPONIBILI SU BFCVIDEO.COM
