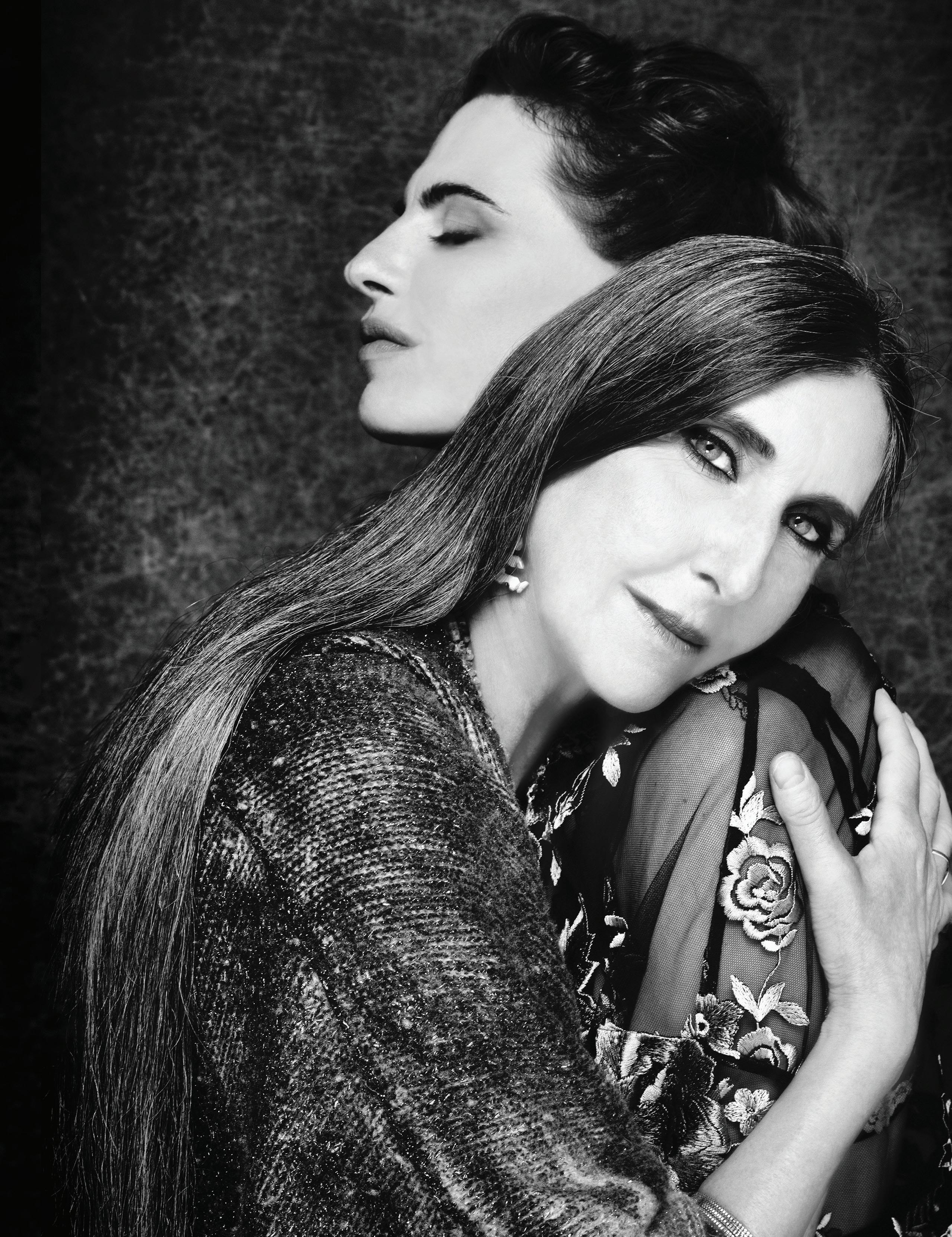LA PRIMA STAZIONE SPAZIALE USA

VERSO LA GRANDE ECLISSE IN MESSICO
PALLONI STRATOSFERICI
IL CIELO DEL MESE


VERSO LA GRANDE ECLISSE IN MESSICO
PALLONI STRATOSFERICI
IL CIELO DEL MESE

NUMERI ARRETRATI
Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it
Il costo di ciascun arretrato è
*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.

VERSIONE DIGITALE INCLUSA
Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/cosmo
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero 02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
DAL SITO, ANCHE PER REGALARE
UN ABBONAMENTO
Vai su BFCStore a bit.ly/3PJXDPd
Oppure inquadra il QR



Invece di 118,80€

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

I MIEI DATI
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto
rilascio nego il consenso per le attività di profilazione
Lo scorso 3 aprile la Nasa ha nalmente annunciato l’equipaggio di quattro astronauti (tre americani e un canadese, tre uomini e una donna) della missione Artemis II, che a ne 2024, o giù di lì, sorvoleranno la Luna, senza scendervi. I prescelti sono il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione ChristinaKoch e Jeremy Hansen. Nomi che, al momento, dicono poco o nulla al grande pubblico. La nostra memoria va piuttosto all’Apollo 8 e all’Apollo 10, che sorvolando la Luna, avvicinarono la discesa degli astronauti dell’Apollo 11 sul nostro satellite naturale e che prepararono, anche psicologicamente, l’umanità al fatto che lo sbarco su un altro corpo celeste era davvero imminente. Adesso, a più di 50 anni di distanza, probabilmente abbiamo bisogno della stessa iniezione di ottimismo verso il futuro. La sensazione, già espressa proprio in queste pagine, è che chi non segue da vicino le vicende spaziali non si renda conto di quanto sia prossimo il ritorno alla Luna, indipendentemente dal fatto che avvenga davvero a dicembre 2025 con la missione Artemis III, come è ancora schedulato nei programmi della Nasa, o che l’allunaggio ritardi di qualche mese o anche di un paio di anni. Ai quattro nuovi “moschettieri” di Artemis II spetta quindi un altro compito, che non sarà solo quello di eseguire al meglio il programma della loro missione, ma anche quello di coinvolgere le persone, di farle “innamorare” di loro e del loro lavoro, di far sì che i loro nomi diventino celebri, di annunciare forte e chiaro, in particolare a quei (mal contati) due terzi di uomini e donne che erano troppo giovani o non c’erano ancora 50 anni fa, che potranno (ri)vivere le emozioni dei loro padri e dei loro nonni nell’alzare gli occhi al cielo e nell’ammirare quel magni co corpo celeste, così lontano per ognuno di noi ma ormai così vicino per l’umanità.

ANNO 5 - NUMERO 39 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019
CASA EDITRICE BFC SPACE Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI
Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com
DIRETTORE RESPONSABILE Walter Riva riva@bfcmedia.com
DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com
HANNO COLLABORATO
Pia Bassi, Gianfranco Benegiamo, Gian Nicola Cabizza, Patrizia Caraveo, Giordano Cevolani, Laura Citernesi, Giuseppe Donatiello, Marco Sergio Erculiani, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Antonio Grandieri, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Piero Mazza, Marco Montagna.
GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com
PUBBLICITÀ
Roberta Zabotti info@bfcspace.com
ABBONAMENTI
Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia
ARRETRATI
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it
STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com
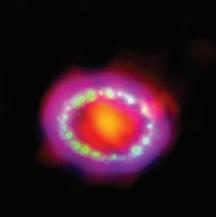

IN COPERTINA: Lo Skylab, prima stazione spaziale americana, in orbita terrestre nel 1973.

NEWSLETTER DI BFCSPACE
Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR
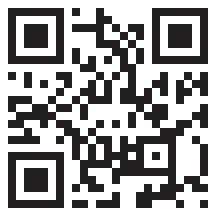
ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/
LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF
UNIVERSO
30 TEMA DEL MESE TRA CIELO E TERRA: I PALLONI STRATOSFERICI



36 SISTEMA SOLARE IL WEBB ALL’INSEGUIMENTO DEI CORPI MINORI
40 RICERCA ET SETI POST-DETECTION HUB
46 PERSONAGGI LA STRANA COPPIA CHE CI PORTÒ SULLA LUNA
Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni, podcast, gallery).
INSIEME A COSMO VERSO LA GREAT NORTH AMERICAN ECLIPSE
IL PROGRAMMA DEL VIAGGIO CHE CI PORTERÀ IN MESSICO IN APRILE 2024 PER UN APPUNTAMENTO ECCEZIONALE

Siamo entrati nella fase operativa del viaggio già annunciato sui numeri di gennaio e febbraio di quest’anno, si tratta del viaggio che Cosmo sta organizzando per volare in Messico ad assistere alla Great North American Eclipse, l’eclisse totale di Sole che si veri cherà l’8 aprile 2024. Partiremo dall’aeroporto di Milano Malpensa, possibilmente in un orario non problematico per chi viene da altre regioni, ma tutto dipenderà dall’operatività dei voli che è ancora da de nire. Faremo in modo che la partenza avvenga due o tre giorni prima dell’eclisse, così come il ritorno due o tre giorni dopo, per una durata complessiva del viaggio di 6-7 giorni con 5-6 pernottamenti. Il volo, dopo un cambio in una città europea, ci porterà a Città del Messico e successivamente a Torreòn, una città di 500mila abitanti nello stato messicano di Coahuila, circa 1000 km a nord della capitale.

Nella città di Torreòn avremo i pernottamenti in un hotel 4 stelle situato in zona centrale. Sarà organizzato un itinerario di visita alla città con una guida locale. Si partirà da Plaza de Armas, il cuore della vita sociale di Torreón, fondata poco più di un secolo fa e conosciuta anche come la Comarca Lagunera, poiché nelle sue origini il ume Nazas sfociava in una laguna. Visiteremo il Canal de la Perla, costituito da una serie di gallerie sotterranee nel centro della città, realizzate alla ne dell’800 come impianto di irrigazione che nel tempo cadde in disuso. Attualmente
è sede di esposizioni e di attività culturali. Troviamo quindi il Coliseo del Centenario, chiamato così perché è una replica del Colosseo di Roma, che costituisce il centro di intrattenimento più completo e all’avanguardia della regione Lagunera.
Una piccola escursione fuori città ci porterà al Cristo de las Noas, un’opera imponente, costruita a 220 metri sopra il livello della città e alta 22 metri. Proseguiremo per il Bosco Venustiano di Carranza, un’enorme area verde al cui interno si trova uno dei principali musei della città, il Museo Regional de La Laguna, con collezioni permanenti di archeologia regionale e Mesoamerica. Non mancherà una visita al pittoresco Mercado Juárez.
Visiteremo quindi il Planetario, un museo interattivo, con sale, laboratori e mostre, considerato uno dei migliori musei della scienza orientato all’astronomia, allo spazio e alla cura dell’ambiente in Messico.
Nei giorni prima e dopo l’eclisse saranno proposte delle escursioni in pullman, alcune comprese nel prezzo e altre facoltative. Una di queste è alle Dune di Bilbao, situate a 65 km da Torreón. Un deserto di sabbia ne prodotto dell’erosione degli elementi naturali, grazie al clima arido. La vegetazione e la fauna sono tipiche delle zone semidesertiche, con serpenti, falchi e coyote. A causa del clima, è consigliabile la visita molto presto la mattina oppure al tramonto. Un’altra escursione naturalistica potrebbe svolgersi al Parco Statale Cañón de Fernández, nella parte


nord-occidentale dello stato di Durango, oppure alla Riserva Ecologica Sierra y Cañón de Jimulco, una catena montuosa isolata che si erge sopra il deserto di Chihuahua a circa 45 km da Torreón.


Una meta delle escursioni sarà sicuramente l’Osservatorio Astronomico di Nazas, situato a
circa 25 km da Torreòn, curato dalla locale associazione astro li. Insieme agli astro li di Torreòn trascorreremo una serata osservativa, grazie anche a telescopi portati dall’Italia, sotto la guida dei nostri esperti.
Il clima arido dell’altopiano di Coahuila, l’assenza di inquinamento luminoso, l’altitudine di 1200 metri sul mare e la vicinanza al Tropico del Cancro (si trova alla latitudine di 25° N) promettono visioni stupende del
cielo, con la possibilità di addentrarsi in costellazioni australi invisibili dal nostro Paese. Lo spazio libero e protetto che circonda l’osservatorio è anche la location che è stata scelta per l’osservazione dell’eclisse, che inizierà alle ore 11 della mattina dell’8 aprile e raggiungerà la totalità alle 12h 18m, con una durata della totalità di quasi 4 minuti e mezzo (vedi la tabella per le tempistiche precise dell’evento). Il costo del viaggio, tutto compreso, si aggirerà intorno ai 4850 euro a persona. I posti sono limitati! Gli interessati al viaggio sono invitati a compilare il modulo con i propri dati al link bit.ly/3KhUdSH (o inquadrare il QR per accedervi direttamente) così da poter precisare i preventivi e organizzare prenotazioni e trasferte. Gli aggiornamenti e il programma dettagliato con i prezzi saranno pubblicati sui prossimi numeri di Cosmo e alla pagina bit.ly/3ZFdeVg del sito Bfcspace.com
*ANTONIO GRANDIERI LAUREATO IN ASTRONOMIA, HA INSEGNATO MATEMATICA E FISICA IN UN LICEO SCIENTIFICO; SI OCCUPA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E DI FOTOGRAFIA SOLARE.


IL PRIMO VOLO SUBORBITALE VIRGIN TUTTO ITALIANO 9
8

IN-ORBIT SERVICING ITALIANO 10
V883 Orionis è un disco di formazione planetaria che si trova a circa 1300 anni luce da noi nella costellazione di Orione. Quando una nube di gas e polvere collassa, forma una stella, intorno alla quale il materiale della nube si raccoglie in un disco. Nel corso di pochi milioni di anni, la materia nel disco si aggrega a formare comete, asteroidi e in ne pianeti. L’acqua è formata da un atomo di ossigeno e due di idrogeno. Ma un team di ricercatori del National Radio Astronomy Observatory (Usa), guidato da John J. Tobin, ha studiato la rara acqua “pesante” (HDO), in cui un atomo di idrogeno è sostituito dal deuterio, un isotopo dell’idrogeno. Poiché l’acqua semplice e quella pesante si formano in condizioni diverse, il loro rapporto può essere utilizzato per tracciare quando e dove l’acqua si è formata. Così, si è dimostrato che vi sono comete e asteroidi del Sistema solare in cui questo rapporto è simile a quello dell’acqua terrestre, suggerendo che le comete possono aver fornito acqua al nostro pianeta.

Nelle immagini del disco di V883 Orionis ( gura in alto) ottenute dai radiotelescopi Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) si vede la distribuzione spaziale dell’acqua (in arancione), della polvere (in verde) e del monossido di carbonio (in blu).
IL GIAPPONE SULLA LUNA
Il “viaggio dell’acqua” dalle nubi alle giovani stelle e dalle comete ai pianeti era già stato indagato, ma nora mancava il collegamento tra le giovani stelle e le comete. V883 Orionis è l’anello mancante: la composizione dell’acqua nel suo disco è simile a quella delle comete del Sistema solare e questo conferma che l’acqua si è formata miliardi di anni fa, prima del Sole, nello spazio interstellare. Ed è stata ereditata sia dalle comete che dalla Terra, relativamente immutata.Osservare l’acqua in questi ambienti è di cile, perché in genere si presenta in forma ghiacciata, ma il disco di V883 Orionis è insolitamente caldo e l’acqua è in forma gassosa. Così si è potuto rilevarla e valutarne la quantità, circa 1200 volte maggiore di quella contenuta in tutti gli oceani terrestri. Inquadra il QR per compiere un viaggio verso il sistema di V883 Orionis


Nella news di apertura viene valutata l’acqua come uno dei componenti fondamentali dell’Universo. Ma bisogna considerare anche la polvere, che è una parte integrante del funzionamento dell’Universo. Forma dei bozzoli che proteggono le stelle in formazione, si compatta per aiutare a formare pianeti e permette alle molecole di aggregarsi insieme, fino a formare i “mattoni della vita”.
Il Mid-Infrared Instrument (Miri) del telescopio spaziale James Webb ha ripreso la stella WR 124 a 15mila anni luce di distanza nella costellazione del Sagittario; è una stella “di Wolf-Rayet”, quindi al termine della sua vita e in procinto di esplodere come supernova. Nell’immagine ripresa in luce infrarossa si presenta incorniciata da uno spettacolare alone di gas e polvere, risultato di una serie di esplosioni cicliche, che precedono il botto finale.
WR 124 ha una massa pari a 30 volte quella del Sole e ne ha già perso un terzo nella sua vita corta e turbolenta, soffiando materiale via da sé. Lo studio di questo genere di stelle è utile per aiutare a comprendere un periodo cruciale nella storia primordiale dell’Universo, quando le stelle più antiche, con le loro esplosioni, hanno disseminato il cosmo con gli elementi pesanti forgiati nei loro nuclei, per donare materiali più variegati alle generazioni di stelle future. Come il Sole.
Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3ZhPK81
M.S.E.
Venere è coperto da una spessa coltre di nubi e l’unico modo per osservare dettagli superficiali è l’utilizzo del radar. Nei primi anni 90, la sonda Magellan della Nasa ha mappato quasi tutta la superficie del pianeta, mostrando la presenza di numerosi e giganteschi vulcani e una superficie modellata da imponenti eruzioni.
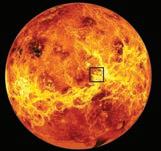
Non c’erano finora delle prove certe di eruzioni in atto su Venere. L’archivio delle immagini di Magellan è stato recentemente analizzato da Robert R. Herrick (Università dell’Alaska Fairbanks) e Scott Hensley (Jet Propulsion Laboratory) con delle tecniche differenti da quelle usate 30 anni fa.
Nella regione Atla (nel quadrato nero in figura) si trovano due dei vulcani più grandi del pianeta: Ozza e Maat Mons, strutture sospettate di vulcanismo attivo. I ricercatori hanno identificato una bocca vulcanica che ha cambiato forma durante le riprese di Magellan, segno di un riempimento con nuovo materiale, probabilmente dovuto a un lago di lava formatosi durante gli otto mesi trascorsi tra le due riprese. Sorprende una scoperta effettuata in dati vecchi di trent’anni fa, grazie solo all’utilizzo di nuove tecnologie di indagine. Chissà quante altre importanti informazioni sono sepolte in montagne di dati archiviati, che sono fruibili da chiunque, anche da astrofili, grazie a progetti di citizen science Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3ZintOB
G.D. 2

Anche su Urano, come su Venere, l’indagine su dati presi decine di anni fa consente ancora di eseguire nuove scoperte. Urano fu visitato dalla sonda Voyager 2 nel gennaio 1986. Con un sorvolo spettacolare, la sonda raccolse immagini dettagliate e una enorme quantità di dati.
Già nel 2022, l’astro lo Ian Regan, elaborando le immagini d’archivio, aveva notato un anello esterno che era sfuggito ai planetologi. Ora un gruppo di ricerca ha riesaminato i dati sulle radiazioni e il magnetismo nel sistema di Urano, trovando anomalie riconducibili alle lune Ariel e Miranda. I due satelliti potrebbero avere oceani interni sotto le loro spesse croste ghiacciate. Stanno infatti espellendo particelle di plasma nello spazio, come viene dimostrato dal rilevamento di particelle energetiche. Una fonte di
calore interna permetterebbe la produzione di pennacchi simili a quelli osservati su Europa nel sistema di Giove e su Encelado in quello di Saturno.
Le particelle scoperte formano una struttura toroidale molto vicina al pianeta, compresa tra Ariel e Miranda, che pertanto con nano le particelle nella struttura che, in caso contrario, tenderebbe a di ondersi nel sistema. Servono altri dati, ma la prospettiva ra orza l’ipotesi che le lune oceaniche siano numerose nel Sistema solare. Ambienti propizi alla comparsa di vita autoctona anche in posti lontani dalla “zona abitabile” del Sole (e magari anche di altre stelle). Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3LSEKLd
Il 6 dicembre 2020 la sonda giapponese Hayabusa-2 ha riportato sulla Terra 5,4 grammi di campioni raccolti sul piccolo asteroide Ryugu. In base alla analisi spettroscopiche, è stata trovata un’ampia gamma di composti organici, come amminoacidi di tipo racemico non proteico, acidi carbossilici, idrocarburi policiclici aromatici e azoto eterociclico. Avendo notato una analogia tra Ryugu e una classe di meteoriti in cui sono state trovate anche basi azotate, sono state cercate anche queste, ma con di coltà, a causa della esiguità del materiale a disposizione. Il risultato è stato il ritrovamento dell’uracile e della vitamina B3. L’uracile è una base azotata che forma i nucleotidi, i “mattoni” dell’acido nucleico Rna. Questi ritrovamenti nelle meteoriti avevano fatto sorgere il dubbio che si trattasse di contaminazioni dovuta all’esposizione all’ambiente terrestre. Ma Hayabusa-2 ha raccolto i campioni direttamente da Ryugu e li ha riportati sulla Terra in capsule sigillate, perciò si può escludere ogni contaminazione terrestre.
La scoperta dell’uracile nei campioni di Ryugu dà forza all’ipotesi che le basi azotate siano state portate sulla Terra primordiale da asteroidi carbonacei che avrebbero agito da “incubatori” di molecole prebiotiche. Quest’anno la missione Osiris-Rex della Nasa riporterà i campioni raccolti dall’asteroide Bennu, e uno studio comparato della composizione di questi asteroidi potrebbe fornire ulteriori conferme.

Ancora le polveri cosmiche. Non disperse nello spazio, ma piovute dal cielo sulla Terra. E che ci possono rivelare per no la presenza di forme di vita extraterrestre. Secondo uno studio condotto dal Dipartimento di Astronomia dell’Università di Tokyo, le collisioni tra oggetti celesti possono provocare l’espulsione di materiale che può essere rilevato anche a grandi distanze di tempo e di spazio. Queste polveri cosmiche possono essere analizzate per individuare la presenza di eventuali microrganismi che provengono da lontani sistemi planetari. Le distanze enormi e le radiazioni cosmiche riducono di molto le possibilità di conservare integro questo materiale. Ma circa 100mila granelli di dimensione superiore a 1 micrometro possono giungere sulla Terra ogni anno dallo spazio esterno al Sistema solare. Granelli che si possono ben conservare all’interno del ghiaccio in Antartide, dove sono recuperabili in modo relativamente semplice, perché si distinguono facilmente dal materiale terrestre; la di coltà sta nel distinguere il materiale extrasolare da quello che ha avuto origine nel nostro sistema planetario.

Un altro sistema è la raccolta di questo materiale nello spazio con l’aerogel, una sorta di schiuma solida leggerissima già utilizzata nel 2011 dalla la sonda Stardust della Nasa per raccogliere campioni di polvere della coda della cometa Wild 2 e riportarli a terra. In gura, campioni di polveri cosmiche individuate nella nostra atmosfera (Nasa).
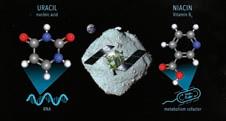




Non era un razzo alieno il primo asteroide interstellare che ha visitato il nostro sistema planetario nel 2017. Però nella sua traiettoria spiccatamente iperbolica c’entra qualcosa la propulsione a razzo, anche se si tratta di un fenomeno naturale.

Al tempo, si scoprì che dopo il perielio ‘Oumuamua (una sorta di sigaro con le dimensioni di 115 x 111 x 19 metri), stava misteriosamente accelerando, anziché rallentare, come dettato dalle leggi della gravitazione. La soluzione del mistero è arrivata grazie a Jennifer B. Bergner e Darryl Z. Seligman, che hanno spiegato questo comportamento con un degassamento di idrogeno molecolare
Durante il viaggio interstellare di ‘Oumuamua, per milioni o miliardi di anni, raggi cosmici ad alta energia sono penetrati nel suo corpo sino a decine di metri di profondità, e dal ghiaccio d’acqua hanno estratto l’idrogeno in forma gassosa, che è rimasto intrappolato in sacche all’interno del ghiaccio stesso. Quando è stato riscaldato, passando vicino al Sole, il ghiaccio ha rilasciato le bolle d’idrogeno, che hanno fornito a ‘Oumuamua la forza che spiega la sua accelerazione non gravitazionale.
Per una cometa di diversi chilometri di diametro, il degassamento sarebbe originato da un guscio molto sottile, con un e etto non rilevabile. Ma ‘Oumuamua è così piccolo, che il degassamento ha generato un e etto razzo evidente.
Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.
ly/3JMqQYk e inquadra il QR per un video di AsiTV dedicato a questa scoperta.
 G.D.
G.D.
L’idea di costruire un radiotelescopio sulla faccia nascosta della Luna inizia ancor prima dell’avvento dell’era delle imprese spaziali. Anche il Programma Seti e i progetti di radiotelescopi per inviare segnali radio nel cosmo hanno sempre considerato il lato nascosto del nostro satellite una collocazione ideale. Che però è ideale soprattutto per osservare e studiare l’Universo.
Come esperimento pilota parte il progetto LuSee-Night (Lunar Surface Electromagnetic Experiment), che avrà l’arduo compito di sbirciare nella cosiddetta “età buia” dell’Universo: il periodo del cosmo primordiale, tra 400mila e 400 milioni di anni dopo il Big Bang, precedente alla formazione delle prime stelle e galassie. Il telescopio, sviluppato da Dipartimento dell’Energia degli Stati

Uniti, Università della California a Berkeley e Nasa, sarà installato sulla faccia nascosta della Luna e il suo lancio a bordo di un veicolo robotico privato è previsto per la ne del 2025
Il lato nascosto del nostro satellite naturale è un ottimo posto per cercare i deboli segnali radio che potrebbero contenere indizi sul remoto passato dell’Universo, grazie al profondo silenzio radio che la Terra non può o rire. Il radiotelescopio, che sarà operativo per due anni, sarà una sorta di “esploratore”, pensato per aprire la strada a strumenti più ambiziosi. A.L.
Si svolgerà probabilmente entro l’anno la missione Virtute-1, di competenza dell’Aeronautica militare italiana (che quest’anno celebra il centenario) con il Cnr. Si svolgerà allo Spaceport America nello stato del New Mexico con lo spazioplano SpaceShipTwo della Virgin Atlantic Tutto ciò nonostante il recente fallimento della Virgin Orbit, sempre del Gruppo di Branson, che si occupava programma di invio in orbita dei velivoli spaziali. Procedono quindi (al momento) i progetti per i voli suborbitali. E questo volo fa seguito a un accordo stabilito tra l’Aeronautica militare e il Cnr del febbraio 2021.

L’obiettivo è quello di avviare il processo di avvicinamento a questa nuova forma di volo che avrà ri essi sia sul versante militare e scienti co sia su quello civile e turistico, ma anche industriale e strategico, visto l’interesse della Virgin a sfruttare in prospettiva lo spazioporto pugliese di Grottaglie
L’accordo del febbraio 2021 prevedeva l’e ettuazione del primo volo sub-orbitale nel corso dello stesso anno, ma i problemi tecnici legati allo sviluppo del velivolo lo hanno rinviato di due anni. Come previsto, servirà a condurre esperimenti multidisciplinari (quattro medici e otto tecnologici) in condizioni di microgravità. Tra le discipline coinvolte previste vi sono medicina, sica dei uidi, siologia e materiali avanzati. A.L.
Un dream team di aziende nostrane ha ricevuto dall’Agenzia spaziale italiana un contratto per lo sviluppo di una missione dimostrativa di In-Orbit Servicing (“assistenza orbitale”), che vedrà l’interazione in orbita terrestre fra due satelliti, un servicer attivo e un target passivo, come il rifornimento e la modi ca dell’orbita stessa.

Il contratto, del valore 235 milioni di euro, si inquadra nell’ambito del Pnrr e coinvolge ales Alenia Space, Avio, D-Orbit, Leonardo e Telespazio. Entro il mese di aprile 2026 queste aziende, in collaborazione con altre realtà industriali e accademiche, dovranno realizzare i due satelliti e dimostrare la capacità di e ettuare diverse attività in orbita. Queste attività vanno dall’ispezione al rifornimento, no alla modi ca dell’orbita del satellite target, e sono mirate a estendere la vita operativa di un satellite.
Tuttavia, anche la deorbitazione, cioè la discesa controllata di un satellite verso l’atmosfera terrestre, rientra nei servizi appetibili per gli operatori di satelliti e costellazioni. Questo perché ripulendo l’orbita terrestre dai pericoli rappresentati dai satelliti inattivi e dai “detriti spaziali”, si va a salvaguardare la durata vitale di tutti i satelliti. D.L.
Il lander lunare Hakuto-R M1 dell’azienda giapponese ispace ha raggiunto l’orbita lunare il 21 marzo. Era partito l’11 dicembre 2022 a bordo di un Falcon 9 ed era arrivato a circa 1,376 milioni di km dalla Terra, diventando la sonda privata più lontana di sempre. Questo lungo viaggio si è concluso con l’allunaggio nel cratere Atlas, programmato per ne aprile. Se tutto sarà andato come dovuto e le comunicazioni stabili, il lander, che misura 261 cm di lato per 226,7 cm di altezza, potrà rilasciare due importanti payload. Il primo è il piccolo rover Rashid ( gura) dell’agenzia spaziale degli Emirati arabi uniti, con solo 10 kg di peso, che ha a bordo diversi strumenti per studiare l’ambiente lunare. Il secondo è il Transformable Lunar Robot della Jaxa: una sfera di 8 cm di diametro, capace di cambiare forma, assumendo un assetto “da corsa” per esplorare il suolo selenico.

Hakuto-R M1 sarà incaricato di creare un ponte radio per le comunicazioni fra questi rover e la Terra, ma il lander ha anche un altro compito dimostrativo. Un meccanismo costruito in una gamba del lander ha la capacità di prelevare della regolite lunare e farla ricadere in uno dei piedi. Se le telecamere di bordo riusciranno a fotografare la regolite prelevata, questa verrà venduta alla Nasa per 5000 dollari, siglando così la prima transazione economica di un bene nello spazio.



OGNI VENERDÌ ALLE 22.00
ASTRONOMIA / COSMOLOGIA / SPAZIO
OSSERVATORI / STRUMENTI / ASTROFOTOGRAFIA INTERVISTE IN STUDIO E SERVIZI

DA UN’IDEA DI FRANCO CAPPIELLO CONDOTTO DA WALTER RIVA PRESENTA ADRIANA LALA
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA UNIONE ASTROFILI ITALIANI
SUI CANALI DI BFC VIDEO OPPURE IN STREAMING O IN DIFFERITA SU BFCVIDEO.COM
» Mentre lo Skylab partiva da Cape Kennedy il 14 maggio 1973, un razzo Saturn 1b era già in attesa su un’altra rampa di lancio a poca distanza per inviare in orbita il primo equipaggio

IL 14 MAGGIO 1973
L’ULTIMO LANCIO
DEL GLORIOSO
SATURNO V IMMETTEVA
IN ORBITA
LO STORICO
LABORATORIO
CELESTE
Intanto che ci interroghiamo sul destino della Stazione spaziale internazionale e sulle nuove stazioni spaziali, come quella cinese, e sui progetti di quelle future come il Gateway, celebriamo il cinquantesimo anniversario di uno storico inizio di questo genere di imprese.
Il 14 maggio 1973 un razzo Saturno V si sollevava dalla piattaforma 39-A del Centro Spaziale Kennedy, in Florida. Era l’ultimo lancio di questo glorioso razzo vettore progettato a Huntsville dall’equipe guidata da Wernher von Braun per spedire l’uomo verso la Luna. Questa volta, però, sopra i due stadi del razzo non c’era il terzo stadio con in cima l’Apollo, ma un cilindro nero a fasce verticali bianche, con un cono bianco collocato sopra di esso.
Si trattava dello Skylab, considerata (per i grandi spazi al suo interno) la prima stazione spaziale orbitante degli Stati Uniti, anche se forse è più corretto de nirla un grande laboratorio spaziale, o “celeste” come recitava il suo nome.
I sovietici avevano già in orbita da tre anni il laboratorio Saljut 1, che però era stato abitato sino ad allora da un solo equipaggio, poi perito con l’incidente della Sojuz 11, ma si trattava di un modulo-laboratorio di dimensioni molto inferiori rispetto allo Skylab.
UN LABORATORIO CON TELESCOPI INCORPORATI
Figlio del Programma Aap (Apollo Application Program), lo Skylab era stato ricavato da uno stadio S-IV B dei razzi Saturno V destinati alle tre ultime imprese lunari
Apollo che erano state cancellate dalla Nasa. Lo stadio venne privato di motori e serbatoi e fu trasformato in un’area abitabile piuttosto ampia; pesava 75 tonnellate, aveva una lunghezza di 36 metri e un volume di 331 metri cubi.
Lo Skylab era composto da quattro sezioni: il modulo di lavoro, che comprendeva la sezione di abitazione degli astronauti, lunga 14,7 metri con un diametro di 6,6 metri, e una

camera di compensazione, dotata di uno sportello per uscire nello spazio e contenente gli strumenti per il controllo operativo della stazione spaziale, lunga 5,4 metri con 1,7-3 metri di diametro.
In ne, vi era il modulo di aggancio, che recava all’estremità un sistema per il docking. Questa sezione conteneva anche gli strumenti per l’osservazione della Terra, un pannello di comando per pilotare i sei telescopi montati
sulla stazione, una fornace per la fusione dei materiali e una camera ad alto vuoto per sperimentare nuove tecniche di produzione industriale. Dopo il lancio, lo Skylab fu collocato in un’orbita quasi circolare a 435 chilometri di quota. Subito dopo l’immissione in orbita, si veri cò un guasto che fece dubitare sul proseguimento della missione: lo scudo contro le meteoriti, che doveva assolvere anche una funzione di
ri essione dei raggi solari per evitare il surriscaldamento del laboratorio orbitante, si staccò, distrusse un pannello a energia solare e ne danneggiò seriamente un altro. Dopo giorni di febbrili consultazioni, alla Nasa decisero di addestrare il primo equipaggio pronto a partire verso lo Skylab, in modo che potesse riparare il pannello danneggiato. Così, il 25 maggio partiva un vettore Saturno 1-B con a bordo il comandante Charles Conrad, il pilota Paul Weitz e l’astronautamedico Joe Kerwin per la prima missione con equipaggio, battezzata Skylab 2.

I tre astronauti furono lanciati con una capsula Apollo simile a quelle
inviate verso la Luna e in grado di agganciarsi allo Skylab. Dopo il loro ingresso nel laboratorio, gli astronauti si dedicarono a un’attività extraveicolare molto complessa, per stendere una sorta di parasole per ra reddare la stazione e riparare le celle solari danneggiate. Dopo diverse ore di lavoro, riuscirono a riportare lo Skylab in piena e cienza. La prima missione durò 28 giorni (per quell’epoca un record), inaugurando l’attività scienti ca sulla stazione. Dopo meno di un mese dal rientro della prima missione, il 28 luglio
1973 un altro Saturno 1-B portava una capsula Apollo in orbita verso lo Skylab. A bordo c’erano il comandante Alan Bean, il pilota Jack Lousma e l’astronautascienziato Owen Garriott, che
installarono un più e cace pannello parasole e iniziarono l’attività di osservazione di risorse terrestri e di protuberanze solari

Riuscirono a portare a termine tutti gli esperimenti in programma, nonostante il rischio di concludere anticipatamente la missione, a causa di un guasto ai motori d’assetto dell’Apollo che li aveva portati in orbita. A terra erano già pronti Vance Brand e Don Lind, che sarebbero andati a recuperare con una missione di soccorso i tre astronauti con un’altra Apollo, ma il guasto fu risolto e gli astronauti rientrarono a terra il 25 settembre, dopo 59 giorni e mezzo in orbita.
La terza e ultima missione (Skylab 4) partì il 16 novembre 1973 con tre astronauti, tutti al loro “battesimo spaziale”: il comandante Gerald Carr, il pilota William Pogue e il ricercatore Edward Gibson Durante i 171 giorni complessivi delle tre missioni, gli astronauti e ettuarono dieci “passeggiate spaziali” per un totale di oltre 42 ore, oltre a più di 2000 ore di attività scienti che. Molti esperimenti erano di natura medica, per studiare l’adattabilità umana a periodi prolungati di relativa assenza di gravità; altre attività erano legate allo studio del Sole dallo spazio e fu osservata anche la cometa Kohoutek. Tra le ricerche astronomiche più interessanti vi fu la prima osservazione dallo spazio di una grande eruzione solare con
Alcuni anni fa abbiamo incontrato a Torino l’ex astronauta Gerald Carr (deceduto nel 2020), durante una sua visita presso l’allora Aeritalia Gruppo Sistemi Spaziali (oggi Thales Alenia Space).
Sullo Skylab, Carr stabilì il record americano di permanenza in orbita per quell’epoca, 84 giorni “Sopportammo benissimo l’accelerazione della partenza” - diceva Carr – “La vita nello spazio è davvero esaltante. Siamo rimasti per tre mesi in condizioni di microgravità e il problema era soprattutto di avere cura del corpo, perché in tale ambiente comincia ad adattarsi alla relativa assenza di peso e ne risente soprattutto il sistema cardiovascolare. Vi sono inconvenienti anche per lo scheletro; quindi, ci si deve tenere molto in esercizio e lavorare sodo per mantenersi in buone condizioni fisiche; sullo Skylab


Mount.
L’archivio di informazioni raccolte dallo Skylab portò a 250 metri quadrati di fotogra e di risorse terrestri, 70 chilometri di registrazioni su nastro di dati scienti ci e circa 250mila immagini del Sole e di migliaia di soggetti astronomici.
Proprio il Sole che aveva così tanto studiato fu la causa della ne prematura dello Skylab. L’intensa attività solare dell’estate 1979 portò lo Skylab a perdere quota a causa di un rigon amento dell’atmosfera terrestre. Le misure e ettuate dai radar di terra decretarono che il laboratorio spaziale (orami privo di equipaggio) non poteva essere salvato e che sarebbe rientrato in atmosfera, disintegrandosi. I suoi frammenti più grandi, però, avrebbero resistito
c’era tanto spazio da permetterci vari movimenti ed esperimenti. Ne abbiamo fatti 60 e riguardavano le scienze biomediche, studi sul Sole per un totale di circa 350 ore, osservazioni della Terra, con i vulcani, l’oceanografia, la geologia, le risorse, la meteorologia... insomma eravamo molto inda arati”.
Tanto inda arati che avete improvvisato una sorta di sciopero spaziale: “Si, perché uno dei problemi maggiori nel nostro programma scientifico era rappresentato dall’eccessiva di coltà del programma stesso. Trascorrevamo molte ore a lavorare più intensamente di quanto previsto e dopo un mese ci rendemmo conto che, a causa della stanchezza accumulata, avremmo potuto commettere gravi errori. D’accordo con Houston, decidemmo di modificare il programma, per avere un po’ più di libertà personale;
all’impatto e sarebbero arrivati sulla super cie terrestre. Scattò un allarme mondiale che non si era mai veri cato dall’inizio dell’era spaziale. La Nasa si attivò per garantire un rientro sicuro nell’atmosfera e i suoi tecnici, in collaborazione con il Norad (North American Aerospace Defense Command), seguirono l’evoluzione dello Skylab, riuscendo a fargli eseguire delle manovre per ridurre le probabilità che i rottami nissero sulla terraferma. L’ultima orbita dello Skylab l’11 luglio 1979 si svolse quasi tutta sugli oceani; i suoi frammenti si distribuirono su una striscia sottile sopra l’Oceano Indiano e l’Australia Occidentale, fortunatamente in una zona poco abitata.
Il rientro dello Skylab ebbe ampia risonanza sui media, che diedero la notizia della morte di una mucca colpita dai rottami (unica vittima), e della multa comminata da una

cittadina australiana al governo Usa per avere gettato ri uti sul suo territorio. Un giornale, il San Francisco, o rì un premio di 10mila dollari a chi avesse per primo consegnato un pezzo dello Skylab ai suoi u ci. Il premio venne vinto da un ragazzo, Stan ornton, che aveva trovato dei rottami sul tetto della sua casa.
La perdita dello Skylab fu rilevante, perché il laboratorio spaziale avrebbe potuto essere ancora utilizzato per altre sperimentazioni, che furono invece rimandate ad altri progetti, prima con i laboratori orbitali sovietici Saljut, poi sulla stazione spaziale sovietica/russa Mir e in ne sulla Stazione spaziale internazionale attualmente operativa. Due copie dello Skylab sono esposte allo Smithsonian National Air and Space Museum di Washington e presso il Johnson Space Center di Houston nel Texas.

così, la produttività e l’e cienza del nostro lavoro aumentò di nuovo e subito”.
Quali sono state le di coltà che avete incontrato al rientro a Terra? – abbiamo chiesto al comandante di Skylab 4: “C’è stata qualche di coltà, ovviamente. Nei primi momenti a Terra mi sentivo appesantito e con una sensazione di fatica nei movimenti.
Ma dopo quattro ore cominciai a stare meglio e in dieci giorni tutte le funzioni fisiche ripresero normalmente.
I sovietici hanno dimostrato che l’uomo può restare nello spazio per 12 mesi”.
Colonnello dei Marines e astronauta dal 1966 al 1977, “Jerry” Carr era destinato a una missione lunare, l’Apollo 19: Carr sarebbe sceso sulla Luna con Fred Haise, mentre in orbita li avrebbe attesi William Pogue. Ma la missione fu annullata e Carr fu nominato
comandante (pur non avendo preso parte a precedenti voli spaziali) per la terza missione Skylab
“Non ho rimpianti, anzi! - diceva Carr – “L’esperienza sullo Skylab è stata eccezionale e vi sono giunto dopo quattro anni di preparazione per il programma lunare. Quella lezione di tre mesi in orbita è stata utile anche per i programmi attuali di stazioni spaziali permanenti e per progetti di nuove e avanzate cabine di pilotaggio per aerei civili e militari.
Il problema è sempre il medesimo; ridurre il carico di lavoro in modo che l’equipaggio non sia occupato anche dalle piccole cose, ma abbia tempo per pensare e compiere ricerche scientifico-tecnologiche con una certa tranquillità”.
In figura, Gerald Carr impegnato in un’attività extraveicolare durante la missione sullo Skylab
» Nella pagina a fianco: il primo equipaggio di salvataggio spaziale: Vance Brand e Don Lind. Per fortuna, la loro missione non fu necessaria. Sopra: l’Apollo Telescope Mount, l’osservatorio solare dello Skylab, composto da una serie di strumenti per osservare il Sole in lunghezze d’onda dai raggi X morbidi, all’ultravioletto e alla luce visibile. Sotto: la spettacolare eruzione solare ripresa il 19 dicembre 1973 dallo spettroeliografo dello Skylab nella luce dell’elio ionizzato (estremo ultravioletto). La protuberanza si innalzò di 588mla km dalla superficie solare.
PICCOLE ASTRONAVI A MISURA D’UOMO (E DI DONNA)
DA AXIOM SPACE PER GLI ASTRONAUTI DEL PROGETTO ARTEMIS
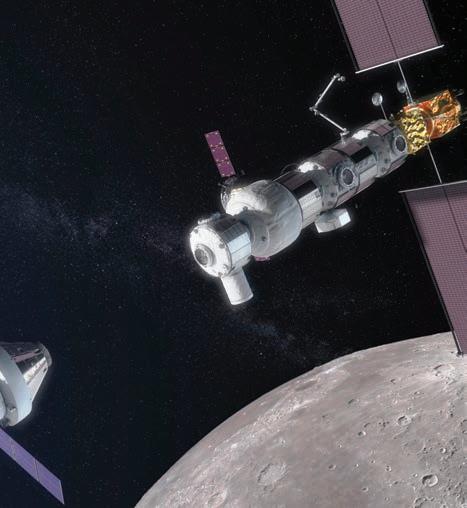
Le tute spaziali sono un abbigliamento iconico che evolve nel tempo, ma del quale a prima vista si coglie solo l’aspetto estetico, mentre sono un concentrato della migliore tecnologia esistente. Le prime tute spaziali non erano so sticate come quelle attuali ed erano state adattate sfruttando tecnologie già sviluppate per i voli di alta quota e per le immersioni in profondità.
Una tuta spaziale deve unire il comfort con la tecnologia all’avanguardia, in modo da garantire protezione e libertà di movimento agli astronauti, in considerazione dell’ambiente in cui devono operare. Per esempio, nelle prime tute spaziali, le protezioni contro i raggi cosmici e la temperatura non erano prese in considerazione, perché non erano ancora previste le attività extraveicolari (Eva, Extra vehicular acivity).
La storica competizione tra Russia e Stati Uniti ha consentito una crescita costante della tecnologia delle tute spaziali. Quelle statunitensi, pressurizzate a 0,3 bar (poco meno di un terzo di atmosfera), sono composte da quattro elementi, che vengono indossati in ordine dall’astronauta: pantaloni, giacca con maniche, casco e guanti. Quelle russe, pressurizzate a 0,56 bar (circa mezza atmosfera), sono costituite da un unico elemento semirigido, con un’apertura all’altezza della schiena, da cui l’astronauta si in la, e che viene chiusa da un collaboratore.
La tuta spaziale deve proteggere l’astronauta da fattori ostili come le radiazioni infrarosse e ultraviolette che nello spazio non sono ltrate dall’atmosfera, e dagli sbalzi della temperatura, che può oscillare fra -100 °C all’ombra e i +120 °C al sole. Inoltre, deve proteggere dal vuoto esterno, grazie alla pressurizzazione interna, che però non ricrea l’atmosfera terrestre a cui siamo abituati: ogni escursione spaziale equivale a una gita in alta montagna. Per tutte queste necessità, la tuta è composta da undici strati, ognuno con particolari caratteristiche, in base alla funzione cui è destinato (vedi il box a pag. 28).

Prima di ogni attività extraveicolare, un astronauta deve e ettuare un periodo di adattamento nel cosiddetto airlock, un compartimento a tenuta stagna per equilibrare la pressione prima e dopo ogni uscita, evitando le patologie da decompressione, come accade quando si va sott’acqua. Inoltre, deve respirare ossigeno puro per eliminare l’azoto presente nel corpo. Infatti, all’interno della tuta, a causa della bassa pressione, la concentrazione di ossigeno sarebbe del 6 per cento, troppo bassa per un essere umano.
La parte superiore della tuta è costituita dal casco in policarbonato rigido, che può resistere al calore e che garantisce una perfetta trasparenza. Internamente è rivestito da un liquido anti-appannamento. All’elmetto è applicata una visiera mobile, la Extravehicular Visor Assembly, fatta da due pannelli laterali e uno frontale, regolabile grazie a una coppia di manopole. La visiera è laminata con un sottile strato di oro, per proteggere la vista dell’astronauta dalla luce diretta solare e dal riverbero luminoso.
Il busto della tuta (Hard Upper Torso) è in bra di vetro e ad esso sono collegati gli altri componenti. I guanti sono molto importanti e sono meno spessi e più comodi di quanto si possa pensare. Esternamente sono rivestiti da uno strato in gomma per una migliore presa sugli oggetti, oltre ad avere ganci per appendere eventuali utensili. Le estremità delle dita sono dotate di un dispositivo di riscaldamento azionabile tramite un interruttore posizionato sul polso. I guanti sono il componente più soggetto a usura e questo può dar luogo anche a tagli o strappi pericolosi.
La parte inferiore della tuta è il Lower Torso Assembly, che comprende i gambali, con articolazioni mobili
delle ginocchia e delle caviglie, e gli stivali. I gambali sono dotati di fasce colorate, ssate con il velcro, per il riconoscimento dell’astronauta. Importanti accessori sono i contenitori per l’acqua potabile con capienza di 1-2 litri (In-suit Drink Bag), posti all’altezza del petto e dotati di un tubicino per consentire all’astronauta di bere. Abbiamo anche le lampade a batteria, posizionate lateralmente al casco, per illuminare le zone d’ombra, una telecamera, posta sul casco, attivabile dall’astronauta e collegata con la base mobile e con il centro di
» Yuri Gagarin con la tuta che indossava nel 1961 per il primo volo spaziale umano. Inquadra il QR per un video della prima “passeggiata spaziale”, compiuta il 18 marzo 1965 dal cosmonauta Aleksej Leonov.

controllo a terra, oltre a auricolari e microfoni, incorporati in una cu a di tessuto e collegati a due circuiti di alimentazione separati, per garantire il funzionamento anche in caso di guasto di uno di essi. In ne, un modulo di indicazione e controllo (Display and Control Module) è posizionato anteriormente all’altezza dell’addome per monitorare il corretto funzionamento della tuta. Grazie a uno specchietto montato sul polso, l’astronauta può controllare la temperatura, i parametri vitali, l’intensità delle radiazioni cosmiche e i livelli di ossigeno all’interno della tuta. Ma non dimentichiamo il pannolone, che serve per raccogliere le urine prodotte nelle lunghe ore di attività extraveicolare.

» Sopra: l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano ripreso il 15 novembre 2019 durante una attività all’esterno della Stazione spaziale internazionale per la riparazione del rivelatore di particelle cosmiche AMS.


A sinistra: L’astronauta Buzz Aldrin nella prima passeggiata lunare (Apollo 11, 1969).
A destra: la tuta AxEMU progettata da Axiom Space per le missioni lunari del Programma Artemis

Il primo e il secondo strato della tuta spaziale sono costituiti dal Liquid Cooling and Ventilation Garment (Lcvg), che serve per la termoregolazione del corpo. Si tratta di una specie di calzamaglia aderente alla pelle dell’astronauta, intrecciata con dei tubicini, all’interno dei quali scorre acqua fredda che conduce il calore lontano dal corpo. Nel primo strato è presente un tubo che assorbe l’aria espirata e la trasferisce nel backpack
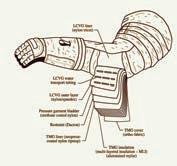
Il terzo strato è realizzato in nylon e serve per garantire la traspirazione, rivestito con gomma sintetica per mantenere la tenuta stagna. Il quarto strato, di poliestere, serve per mantenere stabile la pressione, evitando che la tuta si gonfi, diventando d’intralcio ai movimenti.
Il quinto strato funge da protezione contro calore, abrasioni e perforazioni dovute a micrometeoriti: questa funzione viene garantita dal mylar rivestito di alluminio, la stessa pellicola che si usa per i filtri solari dei telescopi.
Gli strati dal sesto al decimo sono una spessa barriera che garantisce un’alta resistenza al calore. Infine, l’undicesimo, chiamato Tmg, è costituito da una o due coperture in Goretex e serve per proteggere dall’impatto con micrometeoriti.
La massa delle tute per le passeggiate lunari delle missioni Apollo si aggiravano intorno ai 100 kg, mentre quelle per lo Space Shuttle superavano i 130 kg. Ogni tuta ha un costo che varia da 675mila a 1,25 milioni di euro. In passato ogni singolo pezzo era realizzato su misura per ogni astronauta, ma con l’aumentare del costo e della complessità dei materiali, le taglie sono state uniformate, per altezze degli astronauti comprese tra 167 e 187centimetri.
TUTE SPAZIALI AXIOM
Le tute che indosseranno i primi astronauti che si dirigeranno alla volta del Polo sud lunare con la missione Artemis III sono fornite da Axiom Space. Queste nuove tute spaziali consentiranno anche alle donne di camminare sulla Luna e apriranno nuove opportunità di
esplorare e fare scienza sul suolo lunare.
Si tratta delle AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), che saranno dotate delle tecnologie più avanzate per o rire una maggiore mobilità e essibilità nell’esplorazione dell’ambiente lunare e per garantire una maggiore sicurezza. Le nuove tute sono state progettate per adattarsi a una vasta gamma di membri degli equipaggi, coprendo almeno il 90 per cento della popolazione maschile e femminile degli Stati Uniti.
Il prototipo utilizza un materiale di copertura grigio scuro, ma sarà completamente bianca la versione nale che sarà indossata dagli astronauti sulla super cie lunare, per mantenerli al sicuro dalla polvere e dai raggi solari e rimanere freschi mentre lavoreranno nel duro ambiente lunare, con escursioni termiche estreme.
Le tute AxEMU sono composte
da due elementi singoli in modo che ogni astronauta possa essere autonomo nell’indossarle, in landosi da un’apertura posta nella parte posteriore. Il casco presenta una fascia luminosa sopra la bolla, per consentire una migliore visione e una videocamera HD a lato, per poter seguire l’astronauta durante le sue esplorazioni. Gli stivali saranno ben isolati per consentire agli astronauti di lavorare anche nelle condizioni estreme delle regioni sempre in ombra della Luna. L’azienda testerà queste nuove tute in un ambiente simile allo spazio prima della missione vera e propria. Attraverso il motore di sviluppo generato da Artemis, la Nasa aprirà la strada a una presenza lunare sostenibile a lungo termine per condurre delle esplorazioni approfondite del nostro satellite naturale e poter preparare le future missioni umane su Marte.





TRA CIELO E TERRA:
PIÙ IN ALTO DEGLI AEREI E PIÙ IN BASSO DEI SATELLITI, PER OSSERVARE E STUDIARE SUOLO, ARIA E SPAZIO
PIÙ IN ALTO DEGLI AEREI E PIÙ IN BASSO DEI SATELLITI, PER OSSERVARE E STUDIARE SUOLO, ARIA E SPAZIO

La saga del pallone cinese che ha messo in allarme gli Stati Uniti nel febbraio scorso (vedi il box), con tutti i suoi risvolti politici e militari, ci ha ricordato che ogni giorno vengono lanciati migliaia di palloni, la maggior parte dei quali è dedicata a studi meteorologici.
Sono 900 le stazioni meteo sparse per il mondo (molte anche nel nostro Paese) e una campagna di misurazione richiede almeno due lanci al giorno di palloni che devono salire no a circa 30 km di altezza, dove operano per poche ore, misurando temperatura, umidità e pressione.
I palloni meteo sono fatti di un sottile materiale biodegradabile; una volta esaurito il loro compito, esplodono e vengono persi, mentre gli strumenti, dotati di paracadute, tornano a terra e possono essere recuperati per un nuovo utilizzo. Dopo i palloni meteorologici, in termini di numerosità, vengono i palloni lanciati da associazioni amatoriali per portare ad alta quota piccoli trasmettitori radio, oppure per fare piccoli esperimenti (che poi vengono recuperati).

Un’alternativa ai lanci amatoriali di piccoli razzi, con gli stessi obiettivi (vedi Cosmo n. 31 e 32).
Una sola compagnia americana dice di avere lanciato più di mille palloni negli ultimi 15 anni. Sono piccoli e poco costosi e potrebbe appartenere a questa categoria un oggetto abbattuto recentemente sul lago Huron che ha richiesto ben due missili aria-aria, perché il primo aveva mancato il bersaglio.
Poi ci sono i palloni lanciati da compagnie private per fornire servizi di telecomunicazioni, come la connettività Internet in regioni remote. Il pallone, a di erenza di un satellite, può stare fermo in una certa posizione (vento permettendo) e questo sempli ca molto la gestione del servizio.
I palloni scienti ci, molto meno numerosi, sono molto più grandi: quando raggiungono la quota operativa, si espandono no a 80 metri di diametro, hanno un carico che si misura in tonnellate e sono fatti per resistere il più a lungo possibile alla quota di circa 37 km. Mentre i palloni meteorologici sono semplicemente rilasciati a mano, quelli che portano in quota strumenti astro sici richiedono un vero e proprio team di lancio. Bisogna riempire di gas elio nel pallone che si solleva ancora relativamente sgon o, mentre un carro gru tiene il suo carico sospeso a mezz’aria e lascia la presa allo strappo del pallone in salita. Non è una manovra facile, perché va eseguita con un tempismo perfetto.
UN PALLONE DAL BRASILE
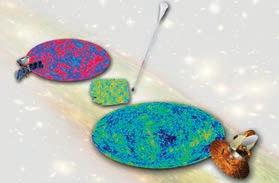
Essendomi sempre occupata di astro sica delle alte energie, ho avuto spesso a che fare con colleghi che costruivano strumenti da fare volare in pallone. Pur essendo una “spaziale”, ho anche partecipato alla campagna di lancio di un pallone dal Brasile: volevamo osservare l’emissione gamma della supernova che era esplosa nel febbraio del 1987 nella Grande Nube di Magellano e dovevamo portare il nostro rivelatore sopra la parte più densa dell’atmosfera grazie a un pallone. Sarebbe stato meglio disporre di uno strumento su satellite, ma avevamo dovuto tenere conto del fattore tempo, accoppiato al fattore costo. Costruire un satellite richiede molti anni (partendo dall’approvazione da parte di una agenzia spaziale,

» Le anisotropie della radiazione di fondo primordiale rivelate nel 2003 dall’esperimento Boomerang (Balloon Observations Of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics), a confronto con quelle misurate dai satelliti Cobe (sopra) e Wmap (sotto).

La saga del pallone cinese è iniziata il 1° febbraio 2023 con un oggetto sferico che brillava al sole nei cieli del Montana. Sollecitati dai video postati sui social, le autorità hanno inviato dei jet militari, dai quali è arrivata la conferma che si trattava di un pallone con appesa una “gondola” di grandi dimensioni, munita di pannelli solari, prevedibilmente per l’alimentazione delle sue strumentazioni.
Il pallone era a circa 20mila metri di quota, molto sopra la quota delle rotte degli aerei, e si muoveva trascinato dai venti. Il 3 febbraio era sopra il Kansas, poi ha sorvolato la South Carolina, per portarsi il giorno dopo sull’oceano Atlantico, dove è stato abbattuto (figura). La strumentazione di bordo, caduta in mare con un paracadute, è stata poi recuperata dalla Marina militare americana.
I militari americani (che l’avevano avvistato fin dal 30 gennaio, quando aveva sorvolato l’Alaska per poi passare sul Canada, prima di arrivare in Montana) non hanno avuto dubbi sulla provenienza del pallone: era una missione spia cinese.
Con una mossa inusuale, il governo cinese ha confermato che si trattava di un loro pallone stratosferico, precisando che era dedicato principalmente a studi meteorologici. Si sono anche dichiarati dispiaciuti che, a causa del forte vento, il pallone avesse deviato dalla rotta prevista e fosse entrato nello spazio aereo americano.

Più o meno in contemporanea, un altro pallone è stato avvistato nello spazio aereo del Costarica. Anche in quel caso il governo cinese ha ammesso che si trattava di un loro pallone meteorologico fuori rotta, una dichiarazione che induce a porsi domande sulle capacità di chi gestisce questi palloni così disobbedienti. Anche se il Pentagono ha rassicurato la popolazione sulla non pericolosità del pallone, chi ha visto questo oggetto si è sentito minacciato. Sembra che questa sia stata la reazione anche del presidente Biden, che avrebbe voluto dare subito l’ordine di abbattere l’intruso, ma è stato dissuaso dai consiglieri militari. Perché mai i cinesi dovevano mandare un visibilissimo pallone in missione di spionaggio? È vero che in Montana c’è una base con testate nucleari, ma non è segreta. Palloni di questo tipo sono stati avvistati sul Pacifico intorno alle Hawaii, dove possono cercare di captare le conversazioni tra basi militari, navi e aerei che pattugliano il Pacifico. Magari anche il pallone abbattuto aveva uno scopo del genere, stando a debita distanza dal territorio americano, ma è stato veramente spinto dal vento nella direzione sbagliata.
passando dalla progettazione no alla costruzione e al lancio), mentre noi sapevamo che la supernova avrebbe emesso le righe gamma (prodotte dal decadimento degli elementi sintetizzati nell’esplosione) per un tempo limitato, imposto dalla sica del decadimento.
Inoltre, bisognava cogliere l’attimo nel quale l’emissione gamma era ancora abbastanza intensa, mentre la nube di materiale in espansione si era abbastanza diradata da lasciar passare i fotoni gamma che, quando il gas è ancora abbastanza denso, vengono assorbiti. Sapevamo che le condizioni ottimali si sarebbero veri cate 9-10 mesi dopo l’esplosione, da qui la necessità di costruire uno strumento gamma in tutta fretta e portarlo sopra la parte più densa dell’atmosfera con un pallone. Questa scelta ha il vantaggio di essere molto più economica rispetto a uno strumento spaziale. Purtroppo, non abbiamo avuto fortuna, perché qualcosa non ha funzionato. Il nostro strumento - che avevamo chiamato Spegas, perché volevamo registrare lo spettro gamma di una supernova - è stato sganciato sopra la foresta del Pantanal. In un ambiente del genere, il recupero dello strumento non era dei più facili, tanto più che avevamo idee molto vaghe sulla sua posizione. Non sempre la sfortuna si accanisce contro i “pallonari”. Spesso va tutto per il verso giusto: il lancio avviene nel momento ottimale e il pallone sale con il suo carico no a raggiungere la quota prevista per operare gli strumenti, i venti si comportano bene e il volo segue la traiettoria prevista e per la quale vengono chieste tutte le
autorizzazioni, dal momento che questi oggetti attraversano lo spazio aereo di una o più nazioni. In particolare, sfruttando i vortici artici e antartici, è possibile organizzare voli di lunga durata che permettono di raccogliere molti dati. È così che lo strumento Boomerang, volando sopra l’Antartide, ha ottenuto la prima mappa dettagliata del rumore di fondo cosmico in una regione del cielo.
Nella famiglia dei palloni di grandi dimensioni, si aggiungeranno presto

quelli dotati di cabina pressurizzata, dedicati al turismo stratosferico. Nell’ambito di un progetto chiamato Open Universe, una società giapponese o re un giretto di un’ora a 25 km di altezza con una capsula pressurizzata che può ospitare due persone: il pilota e il passeggero, che pagherà l’equivalente di 175mila dollari.
*PATRIZIA CARAVEO
È DIRIGENTE DI RICERCA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) E LAVORA ALL’ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI MILANO.

Sarà un turismo spaziale più slow di quello o erto da Blue Origin o da Virgin Galactic (vedi Cosmo n. 30) e certamente è meno costoso, anche se la quota raggiunta è ben lontana dai 100 km che rappresentano la divisione convenzionale tra l’alta atmosfera e lo spazio. La società ha aperto le “iscrizioni”: i primi turisti in pallone saranno annunciati in ottobre e voleranno prima della ne di quest’anno.
Secondo Keisuke Iwaya, Ceo della startup Iwava Giken, sarà un turismo spaziale gentile ed ecologico, alla portata di (quasi) tutti.





SUGLI OGGETTI TRANS-NETTUNIANI E SULLE COMETE
Nel n. 38 di Cosmo (aprile 2023) abbiamo visto come il telescopio spaziale James Webb (Jwst) stia indagando pianeti e satelliti del Sistema solare. Magari con una certa sorpresa, perché molto lo immaginano intento a scrutare solo le profondità dell’Universo, alla ricerca delle galassie più lontane. Ma non abbiamo detto tutto, perché il Jwst sta indagando anche corpi più piccoli del nostro sistema planetario. Sia quelli situati al di là delle orbite dei pianeti più lontani, dove una folla di oggetti poco conosciuti attende di essere studiata nella vasta regione che precede il vero e proprio spazio interstellare, sia le comete più vicine, che si aggirano nella Fascia principale degli asteroidi.
Pablo Santos-Sanz è un ricercatore dell’Iaa (Istituto di Astronomia dell’Andalusia) che da anni si occupa delle possibili occultazioni stellari da parte di oggetti lontani come i Tno (oggetti trans-nettuniani della fascia asteroidale di Kuiper) e i Centauri (asteroidi ghiacciati situati tra le orbite di Saturno e Urano). Queste occultazioni stellari sono molto rare ma anche molto utili per determinare con precisione forma e dimensioni, oltre a individuare satelliti e addirittura anelli attorno a questi corpi lontanissimi. Le potenzialità del Jwst sono importanti in questo campo, ma
sono anche difficili da prevedere in maniera precisa, sia per certe indeterminazioni nel moto dei piccoli corpi coinvolti, sia per le piccole variazioni orbitali del grande telescopio spaziale attorno al punto lagrangiano L2, dove è posizionato in orbita solare, a 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra. Queste caratteristiche rientrano nella cosiddetta categoria dei ToO (Target of Opportunity), cioè degli eventi improvvisi, quindi indeterminati nei tempi, ma preziosi come opportunità di indagine.
GLI
Santos-Sanz ha recentemente presentato il risultato dello studio di 36 occultazioni di stelle prodotti da oggetti Tno e quattro da Centauri. Si tratta di fenomeni in cui questi oggetti hanno brevemente occultato debolissime stelle (fino alla magnitudine 20) del grande catalogo stellare Gaia DR3 prodotto dal satellite astrometrico Gaia.
Il primo di questi eventi si è verificato il 18 ottobre 2022, quando la camera infrarossa NirCam (Near-Infrared Camera) del Jwst ha seguito per 2,3 ore l’occultazione radente di una stella di magnitudine 15,7 da parte del centauro Chariklo (diametro di 250 km). I ricercatori si erano già attivati a metà agosto 2022, quando i calcoli indicavano un’occultazione completa da parte del Centauro. Poi si era scoperto che il corpo centrale avrebbe solo sfiorato la stella: una situazione
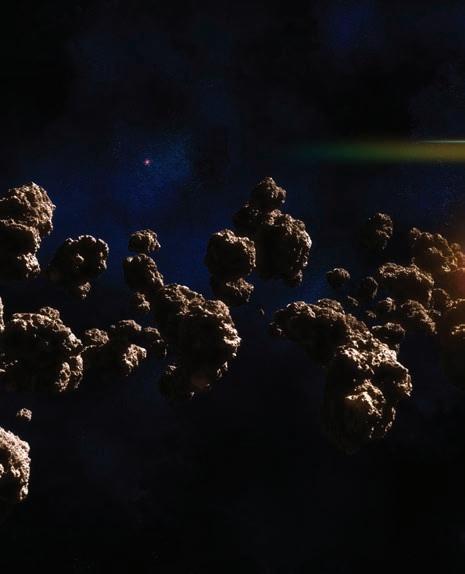

ottimale per la ricerca di eventuali anelli intorno a Chariklo.

Già il 3 giugno 2013, l’occultazione della stella Ucac4 248-108672 (magnitudine 12,4) nello Scorpione aveva suggerito la presenza di due anelli distanti da Chariklo circa 400 km. Con il Jwst, osservando a 1,5 e 3,2 micron (per massimizzare il usso della stella rispetto a quello del Centauro), si è avuta una spettacolare conferma della presenza degli anelli e della loro struttura, grazie alla ripresa di 14.826 immagini (una ogni 3,3 secondi). Il più interno, battezzato Oiapoque, si trova a 390 km dall’asteroide ed è largo 6 km. A 8 km di distanza si trova l’anello
più esterno, largo 3–4 km e battezzato Chuí. Il risultato è particolarmente interessante, perché non ha coinvolto il Centauro, ma solo le sue vicinanze. Un’altra occultazione è stata osservata il 21 marzo scorso e una prossima è prevista per il 26 agosto.
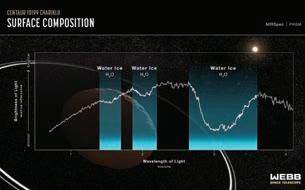
Il 31 ottobre 2022 lo spettrometro infrarosso NirSpec (Near Infrared Spectrometer) del Jwst ha implementato lo studio di Chariklo, realizzando alcuni spettri del materiale super ciale. Vi compaiono in maniera nitida le bande di assorbimento del ghiaccio cristallino e da questo si deduce che il ghiaccio amorfo super ciale deve aver subito molti episodi di riscaldamento,

verosimilmente legati a impatti esterni: fu forse uno di questi impatti a estirpare il materiale che ha poi dato origine agli anelli.
Lo stesso strumento ha indagato gli spettri di altri Tno, tra cui Haumea, Quaoar, Sedna. I risultati evidenziano due tipologie principali di oggetti: quelli con super cie ricca di ghiaccio in parte anche cristallino (rivelato da una banda a 1,65 micron) e quelli ricchi di materia organica (banda a 3,3-3,6 micron), anidride carbonica (banda a 4,27 micron), monossido di carbonio (banda a 4,7 micron), ma poveri di ghiaccio super ciale.
Il maggiore di quelli appartenenti alla prima categoria e studiati dal
Jwst è 2002 TX300, un oggetto di 900 km di diametro, che fa parte di una famiglia di corpi che sono probabilmente “ gli” del pianeta nano Haumea, mentre il maggiore fra quelli che appartengono alla seconda categoria è Sedna, con un diametro stimato di 1500 km.
Altri oggetti previlegiati dal Jwst sono le comete, che si prestano a diventare Target of Opportunity: un caso tipico
è stato quello di una cometa di nuova apparizione come la C/2022 E3 ZTF, la “Cometa di Neanderthal” osservata e fotografata anche da molti amatori
e alla quale abbiamo dedicato un lungo articolo nel n. 38 di Cosmo (aprile 2023).
Un caso speciale riguarda un progetto osservativo che il 20 agosto 2022 ha permesso al Jwst di ricavare uno spettro della cometa periodica P/238 Read, dotata di un nucleo di 0,6 km e un periodo orbitale di 5,6 anni. Si tratta di una rara cometa situata nella Fascia principale degli asteroidi (ce ne sono una ventina, denominate Mbc, Main Belt Comets), della quale non si conoscevano le caratteristiche compositive.
I risultati ottenuti dal NirSpec sono molto interessanti: questa cometa mostra un chiaro picco
dell’acqua (H2O, banda a 2,5-2,8 micron), mentre è assolutamente assente l’anidride carbonica (CO2) a 4,2 micron, laddove nelle comete “normali” il rapporto CO2/H2O è sempre attorno al 10 per cento. Da qui l’idea che la Read non sia una cometa arrivata dalla Fascia di Kuiper e poi catturata da Giove, ma che sia originaria della Fascia principale, dove la CO2 è notoriamente molto scarsa. Ad attivarla potrebbe essere stato un impatto esterno, come ci ha insegnato la missione Dart della Nasa, che dopo aver colpito il piccolo satellite Dimorphos dell’asteroide Didymos (evento ben documentato anche dal Jwst), ne ha suscitato una lunga coda persistente per mesi. Nell’ambito dello stesso progetto, il 25 agosto 2022 è stato registrato uno spettro della cometa P/22 Kop nella regione 0,6-5,3 micron, mentre si trovava a 2,2 Unità astronomiche dal Sole: risultavano ben evidenti le bande del vapor d’acqua, dell’anidride carbonica e dei materiali organici. Il 9 luglio 2022 la NirCam era riuscita per no a individuare il nucleo della cometa Hale-Bopp che presentava la magnitudine di 25,4 e si trovava alla distanza 46 Unità astronomiche. Il 6 ottobre il NirSpec ne ha preso anche lo spettro, individuando acqua e materia organica.
*CESARE GUAITA LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL PLANETARIO DI MILANO.

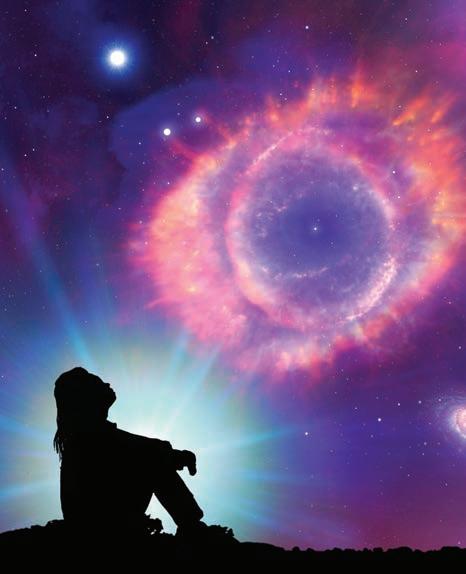
Con le sue opere visionarie Dalla Terra alla Luna (1865) e Intorno alla Luna (1870), il romanziere francese Jules Verne portava i suoi lettori in viaggio sul nostro satellite naturale già 150 anni fa, quando imprese del genere erano ritenute solo utopie, anche perché della Luna, in fondo, se ne sapeva ben poco.
La predilezione surrealistica di Verne era stata ispirata dall’amicizia con il celebre scienziato François Arago, che gli aveva lasciato idee e suggestioni utili, rielaborate secondo i consigli dell’astronomo Jules Jannsen e i calcoli del matematico Joseph Bertrand.

Una fantasia, quindi, ma corredata di nozioni scienti che impartite da scienziati dell’Accademia delle Scienze di Francia, a quel tempo la più prestigiosa al mondo. Nel 2005, in occasione del centenario della scomparsa del romanziere, è stato istituito l’Anno “Jules Verne” e gli è stato intitolato un cratere sulla Luna.
REALTÀ E UTOPIE CHE SI INTRECCIANO
A metà dicembre 2022 è stato ricordato il centenario della nascita di un altro visionario, Peter Kolosimo (pseudonimo di Pier Domenico Colosimo), che nello stesso anno 1969 del primo sbarco umano sulla Luna, si aggiudicava il Premio Bancarella con il suo libro più famoso, intitolato Non

è Terrestre. Proprio mentre le visioni di Verne diventavano realtà, veniva posta l’attenzione su una serie di misteri del passato che adombravano visite del nostro pianeta da parte di intelligenze extraterrestri, indagando piramidi senza nome, enigmatici gra ti rupestri, disegni enormi visibili solo dal cielo, leggende e miti molto simili che accomunano popolazioni lontane.

Laureato in lologia, Kolosimo li conosceva bene, quei miti. Da letterato, lo scrittore modenese era un maestro nel confondere i piani, sovvertire gli schemi e giocare con le percezioni del lettore, che rimaneva a ascinato, scoprendo realtà che neanche avrebbe immaginato, come una storia alternativa e parallela a quella più nota. Chi lo leggeva con attenzione, però, imparava a non

prenderlo troppo alla lettera. Lui stesso aveva rivelato in un’intervista che “i dischi volanti sono solo un espediente narrativo: ci sono cose sulla terra che non si possono spiegare se non tirando in ballo gli extraterrestri”.
Kolosimo è stato uno dei primi sostenitori di teorie pseudoscienti che e pseudostoriche, come quella che ipotizza la visita di civiltà extraterrestri in tempi remoti, che avrebbero preso contatto con le nostre antiche civiltà, come Sumeri, Ebrei, Egizi, Precolombiani. Teorie che si sono di use a partire dalla metà del XX secolo, collegate alla cosiddetta clipeologia, l’archeologia ufologica, che pretende di individuare tracce aliene in antiche rappresentazioni artistiche. Il nome deriva da clipeus (“scudo” in
latino), termine col quale (secondo i sostenitori di queste ipotesi) gli antichi romani indicavano le apparizioni di strani oggetti volanti. Un abile illusionista quindi, il nostro Kolosimo, i cui scritti vanno inquadrati nella narrativa utopica che – al contrario del romanzo scienti co di Verne – si basa più sul dato emozionale che su un serio confronto con dati scienti ci, datazioni accurate, lettura e interpretazione dei simboli calate nel contesto culturale e storico in cui sono stati rappresentati. Un sicuro merito l’ha avuto Kolosimo ed è stato quello di puntare l’attenzione su reperti archeologici misteriosi e “scomodi” e pertanto lasciati in disparte, ponendo nuovi interrogativi alla comunità scienti ca, con un linguaggio molto popolare, accessibile a tutti.
Il grande scienziato Stephen Hawking, nonostante il suo sostegno per un progetto dedicato alla ricerca della vita extraterrestre, aveva avvertito che la vita aliena potrebbe tentare di conquistare o colonizzare la Terra. Ma Jill Tarter, ex-direttore del Seti Institute (Search of Extraterestrial Intelligence), non condivide questo allarme. Se gli alieni fossero in grado di visitare la Terra, per Tarter ciò signi cherebbe che avrebbero capacità tecnologiche tanto so sticate da non aver bisogno di schiavi, cibo o altri pianeti e se proprio dovessero venire qui sarebbe semplicemente per esplorare. Oggi esistono progetti di difesa planetaria, anche stabiliti con le Nazioni Unite, per a rontare la minaccia rappresentata dagli impatti di asteroidi/comete sulla Terra, ma esistono solo timide iniziative per prepararci a rispondere a un segnale radio proveniente dallo spazio, o addirittura per ricevere ET se si presentasse di persona. L’interesse per questo problema è andato via via aumentando, con la scoperta dei pianeti extrasolari.
A ne 2022 il totale degli esopianeti confermati ammontava a 5235 in 3913 sistemi planetari diversi, mentre quelli ancora da confermare erano quasi il doppio. Per non parlare della ricerca di segni di vita presente e passata sui pianeti vicini a casa, come Marte e Venere e le lune che popolano il Sistema solare, come quelle gioviane verso le quali è in viaggio la sonda Juice (vedi Cosmo n. 37).
La ricerca dell’intelligenza extraterrestre, insieme alla ricerca per trovare anche semplici forme di vita, è diventata estremamente
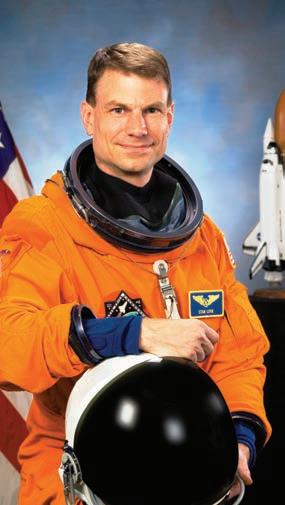
so sticata, aumentando le probabilità che potremmo imbatterci in segni di vita aliena nei prossimi decenni, e per questo non ci dobbiamo trovare impreparati.
Per questo motivo è stato istituito un nuovo centro di ricerca internazionale, il Seti Post-Detection Hub, ospitato dal Center for Global Law and Governance dell’Università St. Andrews, in Scozia, che coordinerà le competenze globali per preparare l’umanità a un tale evento, e per stabilire come dovremmo comportarci e come si dovranno di ondere le informazioni al pubblico riguardo a un rilevamento extraterrestre confermato.

Il Seti Post-Detection Hub fornisce per la prima volta un centro permanente per coordinare lo sviluppo di tutti gli aspetti del problema, coinvolgendo ampie comunità accademiche ed esperti di politica, per lavorare su argomenti che vanno dalla decifrazione dei messaggi e l’analisi
dei dati, allo sviluppo di protocolli normativi, diritto spaziale e strategie di impatto sociale.
DOVE SONO TUTTI QUANTI?
Ormai più di 70 anni fa, il sico premio Nobel Enrico Fermi si chiedeva “Se l’Universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti?”. Purtroppo, non abbiamo ancora una risposta: né avvistamenti lontani (segnali dallo spazio), né vicini, nonostante le fantasie clipeologiche alla Kolosimo o gli avvistamenti attuali di oggetti volanti non identi cati (Ufo). La stragrande maggioranza dei casi Ufo viene identi cata dalle indagini, mentre la modesta percentuale (1%) di casi irrisolti non signi ca che si tratta di astronavi aliene, ma semplicemente di casi per i quali non ci sono dati su cienti per una spiegazione. Da alcuni anni, inoltre, si preferisce classi care questi avvistamenti con il termine più generico Uap (“fenomeni aerei non identi cati”, vedi Cosmo n. 2), per indicare che in molti casi non si tratta neanche di oggetti, ma di semplici fenomeni luminosi (lampi, ri essi e così via).
È provocatoria la posizione dell’astronomo e astronauta americano Stanley G. Love (ha volato sullo Shuttle nel 2008), secondo il quale gli alieni esistono, ma non hanno ancora visitato la Terra per tre buoni motivi.
Come primo motivo, potremmo immaginare secondo Love una vita intelligente che non si preoccupa della tecnologia, che è a suo agio nel rimanere a casa propria e che non sente il bisogno di costruire astronavi. In sostanza, gli alieni non sarebbero interessati a farci visita. Un secondo motivo è che potrebbe esserci una vita intelligente che noi non riconosceremmo nemmeno come tale, come potrebbero esserlo delle barriere coralline abbastanza complesse da avere un proprio intelletto e in grado di comunicare attraverso impulsi codi cati di larve di pesce e uova di riccio di mare e di cui noi non ne avremmo idea. Le intelligenze aliene potrebbero essere molto più comuni di quanto pensiamo, ma non le riconosciamo perché sono profondamente diverse. Un terzo motivo è che una civiltà in possesso di una quantità di energia e di competenze tali da consentire di visitarci probabilmente non ha nulla a che fare con noi e si potrebbe immaginare un suo interesse per il genere umano solo di tipo scienti co, come noi siamo interessati ai formicai. Non aver visto alcun segno di vita intelligente - per dirla con Love - non signi ca negarne l’esistenza: l’assenza dell’evidenza non è l’evidenza dell’assenza. Ma tutte queste considerazioni sono un bagno di umiltà per il genere umano. Non ci rimane che continuare a cercare e a… tenerci







La collaborazione tra Walt Elias Disney e Wernher von Braun servì a promuovere quello sviluppo civile della missilistica che portò, il 29 luglio 1958, all’istituzione della National Aeronautics and Space Administration (Nasa). Due anni più tardi la Nasa aprì in Alabama un nuovo centro spaziale, il Marshall Space Flight Center, che a dò alla direzione di von Braun. E qui fu sviluppato il Saturn V, il razzo di enorme potenza che portò gli astronauti sulla Luna. Due personaggi, motivati da interessi molto diversi, si trovarono a collaborare insieme per promuovere l’apertura di una nuova frontiera: l’esplorazione dello spazio.
Negli anni 50 del secolo scorso, Walt Disney, il disegnatore e regista statunitense che era giunto al successo realizzando lm di animazione, giudicò opportuno diversi care la propria attività imprenditoriale e decise di costruire un grande parco divertimenti che si sarebbe chiamato Disneyland. Le principali aree tematiche scelte per il parco, denominate Fantasyland, Adventureland, Frontierland e Tomorrowland, avrebbero consentito ai visitatori di esplorare territori dedicati rispettivamente a personaggi di fantasia come Topolino, alle storie di avventura, all’epopea del Far West e alle anticipazioni del mondo futuro.
La scarsità del materiale disponibile per sviluppare quest’ultima area richiese un maggiore impegno creativo e pubblicitario, essendo lo spazio un settore relativamente nuovo, così la società del disegnatore americano decise di farlo attraverso la televisione, un mezzo di comunicazione in
» A destra: Walt Disney fotografato nel 1954 durante una visita al Redstone Arsenal in Alabama dove Wernher von Braun sviluppava nuovi razzi per l’esercito statunitense.
Sotto: una popolare serie di articoli sullo spazio, illustrati da Chesley Bonestell, fu pubblicata nel 1952 dalla rivista Collier’s e tra gli autori figurava anche Wernher von Braun.
rapida ascesa che si andava a ermando come il più potente nel condizionare l’opinione pubblica.
Disney decise di realizzare una serie televisiva, presentata in anteprima nell’ottobre 1954, incentrata sull’area Tomorrowland del parco in costruzione alla periferia di Los Angeles. Un gruppo di suoi collaboratori, guidato da Ward Kimball, sviluppò la sezione dedicata al “Mondo di domani” e nel farlo cercò di documentare in maniera scienti ca come inviare uomini nello spazio.
Su questo argomento Kimball aveva letto la


serie di articoli apparsa nel 1952 sulla rivista Collier’s e anni dopo ricordava che “gli articoli erano dei massimi esperti spaziali dell’epoca (Willy Ley, Heinz Haber e Wernher von Braun) e mi interessarono molto”. I lavori preparatori della Disney coinvolsero questi esperti tedeschi giunti negli Stati Uniti subito dopo la Seconda guerra mondiale, insieme a molti altri tecnici e scienziati coinvolti dalla operazione segreta Paperclip, con il compito di contribuire allo sviluppo dell’industria aerospaziale. I consulenti presero parte alle puntate di un’ora circa andate in onda con i titoli Man in Space e Man and the Moon, così come a quella programmata due anni dopo Mars and Beyond. La prima, trasmessa il 9 marzo 1955 dalla rete televisiva ABC, fu vista secondo alcune stime da oltre 40 milioni di americani e modi cò
DI GIANFRANCO BENEGIAMOprofondamente la loro idea di viaggio spaziale.
Tra gli spettatori c’era anche il presidente Dwight D. Eisenhower, che la mattina seguente telefonò a Disney: dopo essersi complimentato con lui per lo spettacolo, gli chiese una copia del lm da mostrare ai massimi funzionari del Pentagono. Le puntate della trasmissione resero pienamente consapevole il pubblico americano e i suoi rappresentanti politici che l’esplorazione spaziale era fattibile, ma soprattutto contribuirono a formare il consenso popolare necessario per nanziare la costosissima corsa alla Luna.
Disneyland aprì il 17 luglio 1955 e nella sezione Tomorroland o riva come principale attrattiva ai visitatori il razzo di linea per la Luna, il Moonliner sponsorizzato inizialmente dalla compagnia aerea Trans World Airlines (TWA), che costituiva la
struttura più imponente del parco, superando in altezza anche l’iconico Castello della Bella Addormentata.
WERNHER VON BRAUN INSEGUE I SOGNI FATTI DA RAGAZZO
Wernher von Braun aveva già da qualche tempo iniziato a promuovere le sue idee sulla colonizzazione dello spazio e sul modo di raggiungere Luna e Marte, proponendo articoli divulgativi per una rivista a grande tiratura come Collier’s L’iniziativa prese origine dalle crescenti di coltà incontrate dall’ingegnere tedesco nel concretizzare un programma missilistico civile, rivolto all’esplorazione del Sistema solare. Cosciente del fatto che in tal modo avrebbe raggiunto un pubblico ancora più vasto per di ondere i suoi progetti, si prestò volentieri a

collaborare alle trasmissioni televisive prodotte da Disney. La disponibilità fu forse la conseguenza di alcune decisioni, prese nel 1955 dal Governo statunitense, che assegnavano al gruppo di von Braun lo sviluppo dei soli missili a medio raggio d’azione per l’esercito, lasciando quelli balistici intercontinentali a lungo raggio all’aviazione e a dando alla Marina la messa in orbita di satelliti. Il sogno di von Braun nel dare inizio alla colonizzazione dello spazio sembrava irrealizzabile.
Fu così che von Braun si trovò a spiegare, in una trasmissione televisiva popolare, aiutato da modellini in scala e da e caci animazioni, il funzionamento dei razzi e gli e etti sull’uomo della permanenza nello spazio. Moto orbitale, forza gravitazionale, radiazioni e assenza di peso erano alcuni degli altri argomenti trattati nei lm diretti da Kimball. Unendo conoscenze tecniche e capacità narrativa, le trasmissioni riuscirono a descrivere in maniera semplice e
accattivante concetti come la forza di gravità, il funzionamento dei missili e l’utilità delle stazioni spaziali. Nella seconda puntata, intitolata “L’uomo e la Luna” e trasmessa quello stesso anno, von Braun appariva con un regolo calcolatore nel taschino, intento a spiegare come raggiungere la Luna usando una base spaziale, simile a una ciambella di diametro pari a circa 75 metri, con gli alloggi necessari a ospitare decine di persone e un reattore atomico per produrre elettricità. La base, situata in orbita attorno alla Terra, avrebbe fornito il trampolino di lancio ottimale per i razzi con equipaggio diretti verso la Luna e il pianeta Marte.
Molti anni dopo, nell’aprile 1965, preoccupato di dare continuità agli sviluppi futuri della missilistica, von Braun invitò Disney a visitare il Marshall Space Flight Center di Huntsville in Alabama, con la speranza di riaccendere in lui l’entusiasmo per l’esplorazione

spaziale. Avvicinandosi la conclusione degli impegni legati allo sviluppo del programma Apollo, sentiva il bisogno di dare una opportunità al suo sogno forse più grande: portare l’uomo anche su Marte.
Nell’intervista rilasciata in quella occasione a un giornalista del e Huntsville Times, il disegnatore disse: “Se posso aiutare con i miei programmi TV a svegliare le persone sul fatto che dobbiamo continuare a esplorare, lo farò”.
L’anno seguente Disney morì e ciò mise ne alla speranza di un nuovo lm per promuovere la permanenza dell’uomo nello spazio: le attrazioni di Tomorrowland, però, lasciarono un segno profondo nella cultura popolare americana. Nel dicembre 1968, quando gli astronauti della missione Apollo 8 orbitarono per la prima volta attorno alla Luna, molte delle anticipazioni tecniche date oltre un decennio prima dai programmi televisivi trovarono un puntuale riscontro. Proprio in quella occasione Kimball fu chiamato al telefono da von Braun che gli disse con il solito forte accento tedesco: “Beh, Ward stanno seguendo il nostro copione”. La diretta televisiva dello sbarco sulla luna dell’Apollo 11, proiettata pochi mesi dopo per gli ospiti di Tomorrowland, coronò il sogno condiviso da una strana coppia, Walt Disney e Wernher von Braun, accomunata dall’interesse per l’esplorazione spaziale.
*GIANFRANCO BENEGIAMO LAUREATO IN CHIMICA, NUTRE DA SEMPRE UN PROFONDO INTERESSE PER I MOLTEPLICI ASPETTI TECNICI E STORICI DELL’ASTRONOMIA.
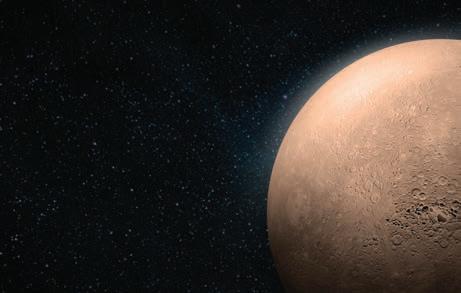
Il mese di maggio è caratterizzato da diversi fenomeni celesti, ma nessuno di essi emerge nettamente sugli altri. Per questo ci soffermiamo su due (modesti) spettacoli che saranno offerti dalla Luna e da Mercurio, ma separatamente: l’eclisse lunare di penombra di venerdì 5 maggio e la massima elongazione est di Mercurio di lunedì 29 maggio.
QUANDO L’ECLISSE SFIORA LA LUNA
Il 2023 è un anno particolarmente avaro di eclissi per l’Italia; delle quattro eclissi globali, solo le due di Luna sono visibili dal nostro Paese. E non sono di rilievo; di sola penombra quella del 5 maggio e con una parzialità minima quella del 28 ottobre. In tabella 1 sono riportati gli orari dell’eclisse, espressi in orario legale estivo.
La grandezza di questa eclisse è pari a 0,965. Ricordando che la “grandezza” è la parte del disco lunare immerso nella penombra, questo valore indica che quasi tutto il disco viene a trovarsi all’interno del cono di penombra. In questa circostanza la Luna è proiettata nella costellazione della Bilancia, poco a sud della stella Alfa (dove viene a trovarsi il Sole il 7-8 novembre). La Luna sorge mediamente in Italia alle ore 20; prima nelle regioni sud-orientali e dopo in quelle nord-occidentali. In nessuna regione l’eclisse sarà visibile integralmente, poiché anche dalla Puglia (la regione in cui la Luna sorge prima) la Luna è ancora sotto l’orizzonte all’inizio del fenomeno. Per non parlare delle zone più a nord-ovest, dove mediamente la Luna sorge alle 20h 40m. Inoltre, occorre considerare che spesso la Luna non si riesce a vedere appena sorta, non solo per le brume e le foschie che stazionano lungo l’orizzonte, ma anche per
» Un fotomontaggio “impossibile” di Luna e Mercurio. Con un raggio di 2440 km, il piccolo pianeta supera di poco la nostra Luna, che ha un raggio di 1737 km.

» In alto: Mercurio ripreso di giorno il 23/06/2022 con un telescopio SC 14’’ e camera ASI 290 MM più filtro IR 760 nm; 20mila pose elaborate con Autostakkert, Iris, Pipp, Photoshop Elements 12 (Raimondo Sedrani, Pordenone).
Qui sopra i tre tipi di eclisse lunare: quella di penombra, quella parziale e quella totale (3BMeteo).
la presenza di ostacoli. Solo durante la fase nale, cioè intorno alle 21, sarà un po’ alta sull’orizzonte. Verso le 20h 30m l’eclisse si presenta con una leggera ombreggiatura sulla parte nord-occidentale (in alto a sinistra) del disco lunare, come una specie di nebbia fuligginosa che investe tutta la Luna, ma che è più evidente nella regione del Mare Imbrium. Con il passare dei minuti, la parte più “nebbiosa” si riduce, spostandosi verso la parte destra (orientale) del disco. Questa minore luminosità di una parte del disco è evidente verso le 20h 45m, ma poi lo diviene sempre meno, no a quando, verso le 21, a occhio nudo non si riesce più a percepirla, mentre al binocolo si dovrebbe seguirla no alle 21h 15m (vedi anche a pag. 58).
Tutti i binocoli sono adatti a seguire questa eclisse; sono ottimi quelli luminosi come i 7x50 o 10x50, cioè che sviluppano 7 o 10 ingrandimenti e hanno obiettivi da 50 mm di diametro. Osservando con un telescopio, anche piccolo, è impressionante notare come sulla super cie lunare risulti scomparsa ogni ombra; l’illuminazione è estremamente piatta e non si nota alcun rilievo.
Durante l’eclisse di questo mese, la Luna non passa per il centro dell’ombra (altrimenti l’eclisse sarebbe totale-centrale), ma un po’ a sud. Di conseguenza, la parte più profondamente immersa nella penombra sarà quella a nord. Il fatto
che la porzione della Luna all’interno della penombra non risulti molto più debole dell’altra dipende dalla modesta di erenza in illuminazione, che mediamente è solo del 50%.
Nelle eclissi di questo tipo il disco lunare eclissato non mostra alcuna colorazione particolare, anche quando è immerso completamente nel cono di penombra.
Gli appassionati di fotogra a possono appro ttare per ottenere immagini del fenomeno. Riprendere foto alla Luna in eclisse di penombra è come farle alla normale Luna piena: si tratta di riprese molto semplici, che possono divenire anche molto suggestive con la Luna che sorge su uno sfondo coreogra co.

Lunedì 29 maggio Mercurio viene a trovarsi alla massima elongazione ovest, a ben 25° dal Sole. Una distanza notevole per Mercurio, ma stemperata dal fatto che il pianeta si trova a 9° a sud del Sole e quindi in posizione sfavorevole per l’osservazione. A tal punto che nel caso di cielo fosco o velato, le probabilità di vederlo scendono drasticamente.
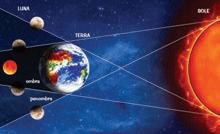
Per individuarlo (tentativo da fare solo in presenza di cielo limpido),
EVENTO ORA
La Luna inizia a entrare
nella penombra17h 14m
Fase massima19h 23m
Uscita dalla penombra21h 32m
conviene iniziare a scrutare il cielo un’ora prima del sorgere del Sole a nord-est, cioè verso le 4h 30m, dato che in quei giorni il Sole sorge mediamente in Italia intorno alle 5h 30m. È fondamentale disporre di un orizzonte sgombro; anche una piccola elevazione, come il pro lo di una collina lontana, ne può precludere la visibilità. In compenso, non c’è il rischio di confondere Mercurio con una stella, perché nella parte inferiore della costellazione dell’Ariete in cui si trova non vi sono stelle brillanti. Sarà preceduto dal più brillante Giove, che sorge alle 4h 30m circa.
Anche se il piccolo pianeta raggiunge la sua massima distanza angolare dal Sole nella mattinata del 29, presentando una magnitudine di +1 e
una falce come quella lunare al quarto giorno di lunazione ed estesa per 8”, si può tentare di scorgerlo già uno o due giorni prima e seguirlo per due o tre giorni dopo.

Più esattamente, a cavallo della massima elongazione, si hanno le condizioni riportate in tabella 2 (a 00h 00m di Tempo Universale, ovvero a 02h 00m dell’ora estiva in vigore in Italia). Per la fase si ricordi che 1,00 equivale al disco completamente illuminato; 0,50 equivale al quarto.
Anche questo fenomeno è interessante da documentare fotogra camente. È su ciente una comune fotocamera o addirittura un cellulare.
Ma occorre sottoesporre un po’ rispetto all’esposizione dell’automatismo, ad esempio di 2 o 3 stop, per far risaltare meglio il piccolo pianeta dal chiarore del cielo circostante. A questo scopo è utile adottare un ltro giallo o arancione. Il pianeta diviene più visibile se si utilizza un teleobiettivo o un piccolo telescopio. La foto telescopica lo renderà meglio visibile, ma di cilmente sarà in grado di mostrarne la fase (come la falce lunare), a causa della turbolenza che si ha quando il pianeta è basso sull’orizzonte. Alcuni astro li riescono, dopo un’elaborazione al computer di molte immagini, a produrre fotogra e del pianeta che mostrano per no dettagli sul disco, riprendendolo però quando è più alto in cielo, con strumenti molto performanti e con condizioni di seeing particolarmente favorevoli.

Clicca e sfoglia gratis

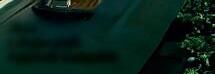




il giornale stampabile



» Il cielo visibile da Roma alle 01h 00m TC a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia.

il 5 alle 19h 34m
il 12 alle 16h 28m
il 19 alle 17h 53m
il 27 alle 17h 22m
il 4 giugno alle 5h 41m
il 10 giugno alle 21h 31m
Massime librazioni in longitudine
il 4 alle 23h - visibile
il lembo orientale
il 18 alle 22h - visibile
il lembo occidentale
il 1° giugno alle 10h - visibile
il lembo orientale
Massime librazioni in latitudine
l'11 alle 10h - visibile
il Polo nord
il 24 alle 23h - visibile

il Polo sud
il 7 giugno alle 15h - visibile
il Polo nord
Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 0h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
Perigeo
369.343 km l'11 alle 7h 05m
Apogeo
404.509 km il 26 alle 3h 38m
Perigeo
364.861 km il 7 giugno
alla 1h 06m
Prosegue la costante ascesa verso declinazioni boreali sempre più elevate: dai circa 15° dell’inizio del mese, sale fin quasi a raggiungere i 22° alla fine spostandosi, il giorno 14, dall’Ariete nel Toro. Si allunga, di conseguenza, l'arco diurno percorso dall'astro e aumentano ulteriormente le ore di luce, con un guadagno complessivo di 59 minuti.
MERCURIO
È in congiunzione inferiore con il Sole il giorno 2 ed è quindi inosservabile fino al 15, quando riappare tra le luci dell'alba. Le condizioni geometriche dell’apparizione sono però particolarmente sfavorevoli: il 29, quando raggiunge la massima elongazione occidentale di 24°,9, il pianeta sorge solo un’ora prima del Sole, con le luci dell’alba già intense. Il giorno 14 è stazionario quindi riprende moto diretto; il 14 è anche all'afelio.
Sempre più brillante, raggiunge la massima visibilità serale della corrente apparizione nella prima metà del mese, quando tramonta circa 3h 40m dopo il Sole e 1h 50m dopo la scomparsa delle ultime luci del crepuscolo. Il giorno 1 è in congiunzione con El Nath (Beta Tauri), 3° a sud; l'8 si sposta nei Gemelli, dove il 17 transita 43' a nord di Epsilon Geminorum mentre il 30 è in congiunzione con Polluce (Beta Geminorum), 4°,1 a sud.
Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese.

La mappa, in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.
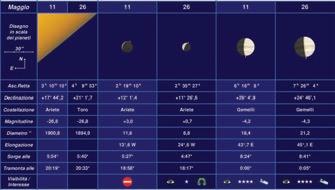
MARTE
È visibile nella prima parte della notte, preceduto di circa 20 gradi da Venere: alto sull’orizzonte occidentale nelle luci del crepuscolo serale, va progressivamente abbassandosi, tramontando approssimativamente a metà della notte. Grazie al suo veloce moto diretto, attraversa la costellazione dei Gemelli e la sera del 10 è in congiunzione con Polluce (Beta Geminorum), 5°,1 a sud; il 17 si sposta nella costellazione del Cancro, dirigendosi verso l’ammasso del Presepe.
E emeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate.
Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra). Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
Le stelline (da 1 a 5) misurano l’interesse dell'osservazione.
GIOVE
Riappare all’alba ai primi del mese, tra le stelle dei Pesci. La sua visibilità aumenta e nell’ultima decade di maggio sorge prima dell'inizio del crepuscolo nautico. Nella seconda parte del mese è accompagnato, pochi gradi a oriente, da Mercurio, che si sta allontanando angolarmente dal Sole. Il giorno 18 si sposta nell’Ariete.
SATURNO

È visibile al mattino nelle vicinanze della stella di 5a magnitudine Sigma Aquarii, con cui è in congiunzione stretta, 13' a sud, il giorno 4. la sua visibilità è in lento aumento e può essere osservato sull’orizzonte sud-orientale nelle ore che precedono l’alba; il 28 è in quadratura con il Sole.
URANO È in congiunzione superiore con il Sole il giorno 9 ed è quindi inosservabile per l’intero mese.
NETTUNO È visibile al mattino nella prima decade del mese tra le stelle dei Pesci.
Inizialmente osservabile
4°,5 a sud-est di Lambda Piscium (4a mag.) si sposta con lento moto diretto alcune decine di primi a nord-est di 20 Piscium, di magnitudine +5,5. A fine mese la sua levata anticipa di circa un’ora l’inizio del crepuscolo.
Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.

MARTE OCCULTA UNA STELLA NEI GEMELLI
Nelle ore serali è possibile assistere all’occultazione della stella TYC 1910-01431-1 di magnitudine +10 da parte di Marte, che invece appare di magnitudine +1,4.
L’esatto istante di inizio del fenomeno può variare di alcune decine di secondi a seconda della località d’osservazione a partire dalle 22:40 di Tempo Civile con la scomparsa dell’astro dietro il lembo oscuro del pianeta, di cui è evidente l’aspetto “gibboso”. La riapparizione sul bordo illuminato del disco di Marte si verifica dopo circa 3,5 minuti, per una durata massima, per l’Italia, di appena 220 secondi.
Le osservazioni si prospettano di cili per la grande di erenza (oltre 8 magnitudini) nelle luminosità apparenti dei due oggetti.
Il lento moto diretto da cui è animato ha portato Saturno ad avvicinarsi sempre più a Sigma Aquarii: nei primi giorni del mese il pianeta inanellato transita 12’ a sud della stella di magnitudine +4,8. La configurazione celeste che ne risulta è visibile senza di coltà appena prima dell’alba, quando i due protagonisti sono su cientemente alti sull’orizzonte sud-orientale. Osservazioni ripetute per alcuni giorni permetteranno di rilevare il variare della posizione del pianeta rispetto a Sigma Aquarii
Dalle ultime luci del tramonto fino ai primi bagliori dell’alba, il cielo notturno è dominato dalla luminosa presenza della Luna, quasi completamente Piena, in transito nell’estesa costellazione zodiacale della Vergine. Nelle ore comprese tra la calata del Sole e la discesa del nostro satellite naturale sotto l’orizzonte occidentale, tra le luci dell’alba che vanno intensificandosi, è possibile seguire il progressivo avvicinamento della Luna a Spica (Alfa Virginis).
La distanza apparente tra i due astri diminuisce dagli iniziali 5° fino a 2°,3 nell’istante della congiunzione in Ascensione Retta, che si verifica poco prima della loro scomparsa sotto la linea dell’orizzonte.
La sera del 5 maggio si verifica un’eclisse Parziale di Luna di sola penombra, visibile da Europa, Africa, Asia, Australia, oceano Indiano. Nell’istante del massimo, alle 19:23 Tempo Civile, il disco lunare risulta quasi totalmente immerso (quasi il 97% del proprio diametro) nella frazione meridionale del cono di penombra della Terra. Il fenomeno è teoricamente visibile, nelle sole fasi finali, anche dall'Italia: la Luna sorgerà già in piena eclisse tra le 19:45 (Lecce) e le 20:45 (Aosta), contemporaneamente alla calata del Sole. La presenza delle intense luci del tramonto e la bassa altezza sull’orizzonte renderanno però inosservabile l’uscita della Luna dalla penombra della Terra; l’eclisse terminerà alle 21:32 TC, con il cielo che nelle regioni centro-settentrionali è ancora rischiarato dalle luci del crepuscolo (vedi l’articolo di W. Ferreri a pag. 50).
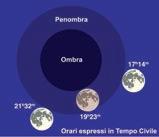
Nelle ore che precedono l’alba è osservabile lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi, il cui massimo di attività si verifica nelle ore serali del giorno 6. È uno sciame abbastanza ricco, con valori dello Zhr (il tasso orario di attività con il radiante allo Zenit) attorno a 65, ma dalle nostre latitudini è osservabile nelle sole ore mattutine e con qualche di coltà, a causa della bassa altezza sull’orizzonte del radiante; quest’anno le osservazioni saranno inoltre notevolmente disturbate dalla contemporanea presenza in cielo della Luna quasi completamente Piena.
Nelle ore che seguono il tramonto il cielo occidentale è dominato dalla luminosa coppia costituita da Venere e Marte, separati da una ventina di gradi, tra le stelle dei Gemelli.
Tra la prima e la seconda decade del mese il Pianeta rosso viene a trovarsi in congiunzione con Polluce (Beta Geminorum): la sera del 10 maggio Marte transita 5°,1 a sud della stella che è di tonalità paragonabile a quella del pianeta, ma più luminosa di 0,2 magnitudini. La minima separazione angolare di 5° tra il pianeta e Polluce viene raggiunta nelle prime ore del giorno 9.
Prosegue il veloce movimento di Venere che, dopo aver attraversato l’intera costellazione del Toro, nella prima decade del mese si sposta nei Gemelli e il giorno 17 è protagonista di una congiunzione relativamente ravvicinata con la stella di 3a magnitudine Epsilon Geminorum
La congiunzione in Ascensione Retta, con Venere 43’ a nord della stella, non è direttamente osservabile poiché si verifica nelle prime ore del giorno 17 e con il pianeta sotto l’orizzonte; ma è degna di nota la configurazione celeste che è possibile ammirare alle 23:00 del giorno 16, qui ra gurata, con Venere che ha quasi raggiunto la stella dalla quale dista 44’; la sera seguente il pianeta si è portato 1°,1 “sopra” Epsilon Geminorum

Alcuni gradi a nord di Gra as (Beta Scorpii), nella zona di cielo compresa tra il confine tra Ofiuco e Scorpione a oriente e la Bilancia a occidente, sono visibili quattro asteroidi relativamente luminosi: si tratta di (44) Nysa (mag. +10,3), (67) Asia (mag. +10,8), (45) Eugenia (mag. +10,9) e (423) Diotima (mag. +11,3) in opposizione al Sole tra il 17 e il 23 maggio. Degni di nota i transiti di (44) Nysa 20’ a sud di 48 Librae la notte tra il 23 e 24, quello di (45) Eugenia 10’ a nord di Psi Scorpii la mattina del 20 e la congiunzione in Ascensione Retta di (423) Diotima 1°,9 a nord di Beta Scorpii del 15 maggio. La mappa è completa fino alla magnitudine +11,0.

Le mattine del 17 e 18 maggio, all’inizio del crepuscolo civile, approssimativamente alle 5:15 TC, con il cielo notevolmente rischiarato dalle luci dell’alba, si concretizza una delle migliori occasioni per tentare di cogliere il duo composto da Giove e Mercurio, separati da poco più di 6°, mentre va progressivamente allontanandosi dalla luminosa presenza del Sole.
La mattina del 17 il nostro satellite naturale si trova 4°,8 a ovest di Giove, con il quale è in congiunzione nelle ore pomeridiane; il fenomeno, che non è direttamente osservabile dal nostro Paese, culmina con l’occultazione del pianeta.
Il giorno seguente la sottilissima falce calante della Luna si è spostata 8° a oriente di Giove, avvicinandosi all’orizzonte e a Mercurio, quest’ultimo rintracciabile, pur con qualche di coltà a causa della sua non elevata luminosità, 3°,6 a “destra” del nostro satellite.

Alcune suggestive configurazioni celesti risultano osservabili le sere tra il 22 e il 24 maggio, approssimativamente al termine del crepuscolo astronomico, quando la Luna si avvicina e infine supera la splendente “scintilla” di Venere e successivamente anche il più debole Marte. La sera del 22 una sottile falce di Luna è visibile 8° a ovest di Venere, con Marte oltre 15° a oriente. La sera seguente il nostro satellite naturale si è spostato 3°,3 a est di Venere, quasi a metà strada tra quest’ultimo e Polluce, dopo essere transitato, nelle ore diurne, 1°,9 a nord del pianeta; la congiunzione con Beta Geminorum, 2°,4 a sud di quest’ultima, si verifica invece nelle prime ore del 24 e non è direttamente osservabile. Il 24, subito dopo il tramonto del Sole, la Luna transita 3°,3 a nord di Marte, ma la distanza che la separa dal Pianeta rosso diminuisce ulteriormente fino a 3° alle 23;20 TC. La mattina successiva il nostro satellite raggiunge anche l’ammasso del Presepe, 2°,9 a nord del quale transita alle 5:41, quando entrambi sono già da tempo tramontati. Nel disegno le configurazioni osservabili alle 22:30 TC delle date indicate.
LUNA E REGOLO
A partire dal crepuscolo serale e per buona parte della notte è possibile seguire il lento avvicinamento della Luna, a meno di 24 ore dal Primo quarto, a Regolo; le osservazioni verranno però interrotte dalla discesa dei due astri sotto l’orizzonte occidentale alcune ore prima di poterne ammirare la reciproca congiunzione in Ascensione Retta.
La migliore configurazione osservabile è quella che si realizza intorno alla 1:30 TC, un paio d’ore prima dell’inizio del crepuscolo mattutino, con il nostro satellite naturale, ormai basso sull’orizzonte, 4°,2 a nord di Alfa Leonis
•
Il giorno 29 Mercurio raggiunge la massima elongazione occidentale di 24°,9 ma nonostante l’elevata distanza angolare dall’astro del giorno, il pianeta sorge solo un’ora prima del Sole e risulta osservabile con qualche di coltà. Una decina di gradi a ovest di Mercurio spicca la luminosa scintilla di Giove, che va progressivamente emergendo dalle luci del crepuscolo, mentre 8° a “sinistra” di Mercurio è presente anche Urano, inosservabile a causa della vicinanza angolare al Sole. Nel disegno è rappresentata la configurazione osservabile alle 4:55 TC, una decina di minuti prima dell’inizio del crepuscolo civile (vedi l’articolo di W. Ferreri a pag. 50).
NELLA PRIMA DECADE DI GIUGNO CI ATTENDONO
•3
•4
Due ore circa dopo il tramonto del Sole, con il cielo ancora debolmente illuminato dalle ultime luci del crepuscolo, sull’orizzonte occidentale è possibile ammirare Venere nelle vicinanze di Polluce: la sera del 29 il pianeta si trova alla minima distanza angolare dalla stella, 4° a sud di Beta Geminorum; la congiunzione in Ascensione Retta si verifica però solo la sera seguente. Una dozzina di gradi a est di Venere è visibile Marte, il cui moto diretto lo porta ad avvicinare rapidamente l’ammasso del Presepe, davanti al quale transiterà nei primi giorni del prossimo mese. Nel disegno sono indicate le posizioni dei due pianeti tra le stelle dei Gemelli e del Cancro alle 22:30 di Tempo Civile delle date indicate.
•6 GIUGNO: MASSIMA VISIBILITÀ MATTUTINA DI MERCURIO
•6 GIUGNO: (11) PARTHENOPE, DI MAGNITUDINE +9,5, IN OPPOSIZIONE AL SOLE NELL'OFIUCO
•10 GIUGNO: LUNA E SATURNO DI MATTINA

I testi completi dei fenomeni sul prossimo numero di Cosmo e sul sito bfcspace.com

Nel numero di giugno 2020 (vedi Cosmo n. 7) abbiamo presentato il Corvo, una piccola costellazione australe situata a sud della Vergine, facilmente identi cabile in un trapezio irregolare composto da stelle di terza

grandezza. Questa costellazione è associata a quella del Crater (in italiano “Coppa”), perché sono entrambe collegate al mito di Apollo. Questo mese ci dedichiamo proprio alla Coppa, una costellazione incastonata tra il Leone (a nord), il
Sestante (a NW), la Vergine (a NE), l’Idra a sud e il Corvo a est. Anche se più di cile da localizzare rispetto al Corvo, le stelle più luminose della Coppa fanno e ettivamente pensare a una coppa inclinata. Si tratta tuttavia di stelle deboli e
» Sopra: la mappa della costellazione della Coppa, con gli oggetti trattati nel testo; a fianco, la costellazione del Corvo. A sinistra: le galassie NGC 3513 e NGC 3511 (in basso) in un campo oculare di circa 20’; il nord è in basso come appare nella visione telescopica.

dato che la costellazione è situata al di sotto dell’equatore celeste, è opportuno osservarla da un sito buio di montagna, dove l’aria è tersa.
Alfa Crateris, nota col nome arabo di Alkes (“la Brocca”), è la stella più occidentale della costellazione; di colore giallo-arancio, è quasi 60 volte più brillante del Sole e dista 170 anni luce. Questi dati fanno capire che la stella si colloca al di sopra della Sequenza Principale e appartiene al ramo delle giganti. Beta, la stella più meridionale dell’asterismo, è 90 volte più luminosa del Sole e dista 260 anni luce. Essendo bianca, la maggior parte della sua luminosità cade nella regione del visibile; in termini tecnici, possiede una magnitudine assoluta “bolometrica” (cioè misurata su tutto lo spettro elettromagnetico) molto simile a quella ottica. Poco più brillante della Beta è la Gamma; anch’essa bianca, è una doppia situata praticamente al centro della costellazione. Non è una coppia facile da separare: una debole compagna di magnitudine 9,6 si trova a soli 5” verso est e occorre un elevato ingrandimento per distinguerla dal bagliore della stella principale. Uno strumento da 15 centimetri è su ciente, ma è preferibile un rifrattore da 10 cm, oppure uno Schmidt-Cassegrain, per evitare gli artefatti causati dalla crociera che regge il secondario.
*PIERO MAZZA MUSICISTA DI PROFESSIONE, È UN APPASSIONATO VISUALISTA, MIGLIAIA DI OSSERVAZIONI DEEP SKY CONSULTABILI DAL SITO WWW.GALASSIERE.IT
Gamma Crateris è 15 volte più brillante del Sole e dista 80 anni luce. La Delta Crateris, contrariamente alle aspettative, è la stella più brillante della costellazione, di colore giallo e di classe spettrale appena più avanzata del Sole; dista poco meno di 200 anni luce ed è 110 volte più brillante della nostra stella.
UNA COPPIA DI GALASSIE
Verso l’angolo sud-occidentale della costellazione, un paio di primi scarsi a WSW della Beta, si trovano NGC 3511 e NGC 3513, un’interessante coppia di galassie distanti circa 40
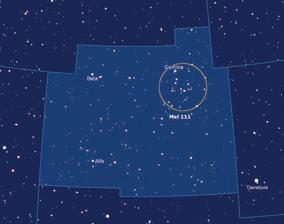
milioni di anni luce, separate da appena 11 primi d’arco e che quindi possono essere comprese nello stesso campo dell’oculare.
La prima è più brillante, grazie a una mezza magnitudine in meno e alla luminanza speci ca maggiore. Già facilmente visibile in uno strumento da 25 centimetri a un centinaio di ingrandimenti, diventa molto bella in un 40 cm. È molto di usa e orientata da est a ovest, di dimensioni 4’×1,5’, con un debole bulge esteso e poco contrastato sul disco. Le dimensioni della galassia sono delimitate da due stelline ai bordi est e ovest.
Anche la seconda è visibile senza problemi in un 25 cm, anche se più stemperata sul fondo cielo; in un 40 cm appare di usa e con basso gradiente di luce, rotonda con diametro di circa 2 primi e con lievi irregolarità di luce che appaiono solo a momenti all’interno; c’è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso est e un’altra di luminosità simile alla stessa distanza verso sud. È da osservare anche NGC 3887, una galassia già visibile in piccoli telescopi da 15-20 cm come un piccolo batu olo uniforme leggermente ovale e orientato da nord a sud. In strumenti dobsoniani da 40 cm e oltre appare nemente screziata e contrastata sul fondo cielo, di dimensioni 2,5’×2’ e con una tenue condensazione centrale. Una stellina molto debole si trova al bordo NNE e un’altra di luminosità simile subito a SE.
Può capitare che i nomi delle costellazioni si rifacciano a episodi realmente avvenuti in un passato lontano e che i racconti ispirati a questi episodi li abbiano poi coloriti con toni poetici. Tale è, per esempio, il caso della principessa egizia Berenice. Figlia di Maga, re di Cirene, e della glia del re di Siria Antioco I, Berenice nacque attorno al 265 a.C. ed ereditò il trono del padre nel 258. Nel 246 andò sposa a Tolomeo III Evergete, cui portò in dote la Cirenaica. Quando questi intraprese la guerra contro Seleuco, re di Siria, Berenice, come voto per il felice ritorno dello sposo, o rì ad Afrodite le sue lunghe trecce dorate, che depose nel tempio della dea a Zephyrium (presso l’odierna Mersin,
in Turchia). Ma il giorno dopo le chiome erano scomparse e spettò al matematico e astronomo di palazzo Conone di Samo placare l’ira della coppia regale, a ermando che la dea si era sentita così onorata del dono della sposa che aveva deciso di trasportarne le lunghe trecce in cielo, così che tutti potevano ammirarle: è la costellazione della Chioma di Berenice
Il poeta di corte Callimaco assecondò la fantasia dell’astronomo con la composizione di un’elegia dedicata alla fanciulla, che fu tradotta poi in latino da Catullo.
Denominato anche Collinder 256, Melotte 111 è uno dei più vasti ammassi aperti del cielo, preceduto soltanto dalle Iadi e da Collinder 285 (che però è particolarmente disperso e di cilmente riconoscibile: è costituito da cinque delle sette stelle del Grande Carro, più altre stelle nelle costellazioni adiacenti).
Questo oggetto cospicuo è situato a ridosso della stella Gamma Comae nella costellazione della Chioma di
Berenice e ha un’estensione di quasi 5 gradi, il che lo rende visibile un po’ a fatica in un binocolo 10x50 con campo apparente modesto; per contemplarlo nella sua interezza, è meglio utilizzare un piccolo binocolo grandangolare con 7-8 ingrandimenti.
L’ammasso fu catalogato per la prima volta da Tolomeo nel 138 d.C., ma non è stato incluso nel catalogo di Messier, né nel più voluminoso New General Catalogue (NGC), dato che la sua vera natura è stata dimostrata soltanto nel 1938 da Trumpler, che vi aveva identi cato 37 stelle sicamente legate. Prima di lui, l’astronomo inglese di origine belga Philibert Jacques Melotte (18801961) l’aveva incluso con il numero 111 nel suo catalogo del 1915, che comprendeva 245 ammassi aperti. L’appartenenza delle singole componenti all’ammasso si è potuta stabilire misurando il loro moto proprio; Melotte 111 si muove, infatti, quasi perpendicolarmente alla nostra linea di vista verso sudest, al ritmo di circa 2 centesimi di secondo d’arco all’anno, un valore molto piccolo ma misurabile con le
tecniche moderne. Pertanto, anche se i suoi componenti non presentano spostamenti Doppler nelle righe spettrali, grazie a questo debole moto proprio collettivo se ne è potuto stabilire il legame gravitazionale. Lo Sky Catalog 2000 fornisce per l’ammasso un’età di 400 milioni di anni, analoga a quella delle Pleiadi, mentre la sua distanza, determinata dalle misurazioni del satellite astrometrico Hipparcos e dedotta dal diagramma colore-magnitudine, è risultata essere poco superiore a 280 anni luce. Le componenti più brillanti, se escludiamo Gamma Comae, un astro arancione che però non ne fa parte, sono di quinta grandezza e si tratta per lo più di stelle bianco-azzurre di classe spettrale A. La magnitudine totale integrata dell’ammasso è 1,8, per cui è facilmente visibile a occhio nudo. Attenzione: Melotte 111 non va confuso con il cosiddetto Ammasso della Chioma, un vasto agglomerato di galassie molto distanti situato nella stessa costellazione, ma una decina di gradi a ENE dal centro dell’ammasso stellare aperto catalogato da Melotte.
Nella scorsa puntata avevamo avuto un primo assaggio di osservazione del cielo stellato a occhio nudo, provando a localizzare la stella Polare. Ora scopriremo insieme quali sono le principali costellazioni che possiamo ammirare nel corso delle diverse stagioni dell’anno.
OGNI STAGIONE HA LE SUE COSTELLAZIONI
Le costellazioni sono dei gruppi di stelle che sembrano formare delle gure in cielo e che appaiono vicine tra loro dalla nostra prospettiva, mentre in realtà possono essere distanti anche migliaia di anni luce le une dalle altre e non avere nessun legame reciproco.
Chi si è già so ermato ad ammirare il cielo stellato avrà notato come per esempio la cintura di Orione o le Pleiadi, ben visibili in inverno, siano assenti in estate. Nel corso dell’anno, infatti, a causa della rivoluzione della Terra intorno al Sole, si modi ca il panorama di stelle che è possibile osservare nelle ore notturne. Ogni stagione ha le sue costellazioni, e adesso vedremo insieme quelle più importanti, magari armandoci di un atlante del cielo per poterle riconoscere più facilmente.
IL CIELO PRIMAVERILE
Il cielo in primavera, così come in autunno, è più povero di stelle rispetto alle altre stagioni, in quanto stiamo osservando aree del cielo che si trovano al di fuori della nostra Galassia, la Via Lattea. Guardando verso nord, è facile riconoscere le sette stelle che formano il Grande Carro, una porzione della più debole ed estesa costellazione dell’Orsa Maggiore. Questa è una delle costellazioni “circumpolari”, ovvero quelle che non tramontano mai e che sono visibili per tutto l’anno dalle nostre latitudini. Altre due costellazioni circumpolari sono Cassiopea e l’Orsa Minore
Se prolunghiamo l’arco di stelle del Grande Carro, raggiungiamo Arturo, una splendida stella arancione appartenente alla costellazione di Boote, la quarta stella più luminosa del cielo. Questa costellazione ha una caratteristica forma ad aquilone. Al suo anco, si può ammirare la Corona Boreale, una cintura di stelle

molto vicine, il cui astro principale è Gemma. Proseguendo a sud di Arturo, si trova la costellazione della Vergine, la cui stella principale è Spica

Ora torniamo al Grande Carro, considerando di nuovo le due stelle che abbiamo usato per individuare la Polare. Se si prolunga lo stesso segmento immaginario, ma nella direzione opposta alla Polare, si arriva alla costellazione del Leone, la cui stella principale è Regolo Un’altra stella brillante di questa costellazione è Denebola, la coda del leone. Insieme ad Arturo e Spica, Denebola forma il cosiddetto Triangolo di primavera. A destra del Leone, poco appariscente sotto cieli inquinati, si trova la costellazione del Cancro, dalla caratteristica
forma a “Y” rovesciata, che ospita un magni co ammasso stellare aperto, M44, chiamato anche “Presepe”. Proseguendo nella stella direzione, si arriva alla costellazione dei Gemelli, dominata dalle stelle Castore e Polluce, dalle quali si diramano splendidi archi di stelle.
Con l’arrivo dell’estate, la Via Lattea domina il cielo: si tratta di una striscia formata da migliaia di stelle che culmina a sud, nel centro galattico, situato nella direzione della costellazione del Sagittario, una regione molto ricca di nebulose
Questa rubrica vuole rendere il cielo stellato accessibile a chiunque, con un linguaggio semplice ed esempi pratici. Tutti sono incuriositi dalle stelle, ma la pratica osservativa presenta delle barriere talvolta insormontabili. Posso dopo passo, partendo dalle basi e procedendo verso anche argomenti più avanzati, supereremo queste barriere e impareremo insieme a scrutare il cosmo. Le puntate precedenti:
1. Prima di osservare il cielo, Cosmo n. 31
2. Orientarsi nel cielo stellato, Cosmo n. 34
e ammassi stellari. In questa area del cielo si può notare una stella arancione e brillante: è Antares, la stella principale dello Scorpione Guardando sopra di noi, possiamo localizzare un’altra stella molto brillante, di colore bianco: è Vega, distante 25 anni luce dalla Terra e stella principale della costellazione della Lira, che possiede la forma di un piccolo parallelogramma ben riconoscibile nel cielo.

Muovendoci lungo la Via Lattea, possiamo ammirare una costellazione a forma di croce altrettanto ben riconoscibile: il Cigno, la cui stella principale è Deneb. Questa costellazione è attraversata in pieno dalla Via Lattea: se si punta un telescopio in qualsiasi angolo al suo interno, si possono osservare centinaia
di stelle e diversi ammassi stellari. Una terza stella brillante, a sud di Vega e Deneb, conclude il cosiddetto Triangolo Estivo: si tratta di Altair, la stella principale della costellazione dell’Aquila. Nonostante anche questa costellazione sia attraversata dalla Via Lattea, al telescopio mostra meno stelle, poiché questa regione è parzialmente schermata da nubi di polvere oscura che bloccano la luce visibile.
A poca distanza da Vega si può osservare la costellazione di Ercole, estesa ma poco appariscente, benché sia facile riconoscere il quadrilatero centrale a forma di trapezio, che ospita su un suo lato il celebre ammasso globulare M13
Chiudiamo la rassegna con due costellazioni, l’O uco e il Serpente.
Quest’ultima è divisa in due parti, la Testa del Serpente e la Coda del Serpente, con in mezzo l’O uco che a erra il rettile. L’O uco, noto come il tredicesimo segno zodiacale, è molto debole ma ricco di ammassi globulari.
Le giornate cominciano ad accorciarsi e le costellazioni estive lasciano progressivamente il passo a quelle autunnali. In alto nel cielo, risplendono due costellazioni legate tra di loro, Andromeda e Pegaso. La seconda è caratterizzata da un grande quadrato che la rende facilmente riconoscibile, mentre Andromeda è formata da due scie di stelle che si originano entrambe dalla stella Alpheratz e le conferiscono

Gli argomenti che a rontiamo in questa rubrica sono trattati in modo più esaustivo nel libro Il cielo sopra di noi, acquistabile in formato cartaceo o Kindle su Amazon. In questo volume sono trattati moltissimi argomenti, dalle prime nozioni sull’Universo alle prime osservazioni a occhio nudo, dalla scelta del primo telescopio ai consigli su come e cosa osservare nel cielo stellato. Sono presenti numerose mappe stellari con annotazioni per comprendere come localizzare gli oggetti celesti più interessanti.
la forma di una “A” allungata e schiacciata. Ai con ni della costellazione è presente la galassia di Andromeda (M31), l’unico oggetto extra-galattico visibile a occhio nudo. Andromeda e Pegaso sono legate da Alpheratz: è uno dei pochissimi casi in cui due costellazioni condividono una stella. A est di Pegaso e a sud di Cassiopea si osserva il Perseo. Questa costellazione ospita il radiante delle Perseidi, le
celebri “stelle cadenti” di agosto. Il Perseo ospita anche uno splendido ammasso stellare aperto doppio, identi cato dalle sigle NGC 869 e NGC 884. A sud di Andromeda troviamo due costellazioni, il Triangolo e l’Ariete. La prima è una costellazione molto piccola ma ben riconoscibile, e contiene la galassia del Triangolo (M33), la terza in ordine di grandezza del nostro Gruppo Locale di galassie, visibile sotto cieli bui anche con un semplice binocolo. L’Ariete è una costellazione zodiacale, anch’essa molto piccola e priva di stelle luminose.
Chiudiamo la rassegna con un’altra costellazione zodiacale, quella dei Pesci. Molto vasta, ma priva di stelle brillanti, richiede un cielo buio per essere apprezzata. I due archi di stelle di cui è composta sembrano avvolgere il quadrato di Pegaso a est e a sud e convergono insieme sulla stella binaria Alrisha, la principale della costellazione.

L’inverno è il momento migliore per osservare il cielo, grazie alla maggior durata del buio, e come nei mesi estivi, il suo cielo è dominato dalla Via Lattea.
Il re incontrastato del cielo invernale è Orione. Questa costellazione ha una forma inconfondibile di una clessidra e si trova a sud del Toro e dei Gemelli. Una delle sue caratteristiche più evidenti è la Cintura, formata dalle stelle Alnitak, Alnilam e Mintaka.
Più in alto si possono ammirare le spalle del cacciatore mitologico, formate dalle stelle Betelgeuse e Bellatrix. La prima è una “gigante rossa”, cento volte più grande del Sole, che è ormai giunta al termine della sua vita, e potrebbe esplodere entro qualche migliaio di anni, diventando una supernova. I piedi del cacciatore sono formati da Salph e da Rigel, una meravigliosa stella azzurra, la sesta più brillante
del cielo. Orione si trova in un braccio spettacolare della Via Lattea, ricchissimo di nebulose, e ospita la celebre Nebulosa di Orione (M42), probabilmente l’oggetto astronomico più osservato e fotografato.
A nord-est di Orione si trova la costellazione dei Gemelli. Le sue stelle principali, Castore e Polluce, sono ben riconoscibili nel cielo invernale. Mentre Polluce è una stella normalissima, Castore è un sistema formato da ben sei stelle, tenute insieme dalla reciproca gravità.
A nord-ovest di Orione si trova la costellazione del Toro, che ospita
diversi oggetti del cielo profondo, tra cui l’ammasso aperto delle Iadi e la nebulosaGranchio (M1), resto di una supernova esplosa nel 1054. Ma l’oggetto più famoso del Toro è l’ammasso aperto delle Pleiadi (M45), visibile a occhio nudo con una forma che ricorda un Piccolo Carro in miniatura.
In basso e a sinistra rispetto a Orione si trova il Cane Maggiore, che appartiene quasi interamente nell’emisfero australe. La sua stella principale, Sirio, è la più brillante di tutto il cielo stellato.
A sinistra di Orione e del Cane
Maggiore si trova una piccola costellazione, composta in pratica da sole due stelle: il Cane Minore, la cui stella principale Procione forma insieme a Betelgeuse e Sirio il Triangolo Invernale. Il nome Procione deriva dal greco e signi ca “Prima del cane”, poiché sorge prima della costellazione del Cane Maggiore.

CARICATE LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE SU BFCSPACE.COM
LA REDAZIONE SCEGLIERÀ LE MIGLIORI PER “LE VOSTRE STELLE”
SONO TAGGATE DA UNA STELLA LE FOTO CHE HANNO VINTO LE NOSTRE SFIDE SOCIAL INQUADRA IL QR PER VISITARE LA GALLERY DELLE FOTO


Ripreso dall’acquedotto delle Arcatelle, Tarquinia (VT), da marzo 2022 a marzo 2023, mediamente uno scatto ogni 15 giorni
Fotocamera Nikon Z9 impostata a 32 Iso e obiettivo Nikon Z 14-24 mm f/2,8 chiuso a f/22
Pose da 1/32.000 s a 1/8000 s in base alle condizioni del cielo
Panorama ripreso il 1° novembre 2022, ore 11:10 TU, somma di due riprese a 360° di 12 scatti ciascuno, una per il suolo e una per il cielo.
Elaborazione: Photoshop
Autore: Marco Meniero, Civitavecchia (RM).

Ripresa da La Spezia il 21/10/2022
Telescopio Sky-Watcher 72 ED su montatura Sky_Watcher HEQ5
Camera ZWO ASI 533 pro con filtri H-alfa, SII, OIII
Guida con camera ZWO ASI 120 mini
Pose: H-alfa 56x300 s; OIII 55x300 s, SII 54x300 s
Elaborazione con PixInsight, Deep Sky Stacker, Photoshop
Autore: Flavio Striano, La Spezia.

Ripresa da Cirica (RG) il 01/03/2023
Fotocamera Canon Eos R5 con obiettivo Sigma ART 50 mm f/1,4 a f/7,1 su cavalletto Manfrotto
Singola posa di 5 s a 6400 Iso elaborata con Photoshop
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.

LA CINTURA DI ORIONE SENZA STELLE
Nebulose di Orione, dalla Testa di Cavallo (a sinistra) alla Testa di Strega (a destra) riprese da Mari Ermi, Cabras (OR) il 10/02/2023
Obiettivo Samyang 85 mm f/1,4 su montatura Star Adventurer GTI
Camera ASI 294 MC PRO con ltro IDAS LPS P3
Guida con Svbony 120 mm f/4 e camera ASI 178 MC
Pose: 75x120 s a f/2,8 con gain 120, elaborate con PixInsight e Photoshop
Note: la versione starless della ripresa evidenzia la trama cosmica delle nebulose della regione.
Autore: Simone Lochi, Nurachi (OR).


Riprese da Modena il 15/01/2023
Telescopio APM SD Apo 140 mm f/4,6 su montatura iOptron Gem 45
Camera ZWO ASI 533 MC Pro con ltri Optolong L-Pro.
Guida con ASI 220 MM mini e ZWO OAG-L
Pose: L-Pro: 189x240 s, L-Ultimate (3 nm): 75x600 s, UV IR cut: 40x60 s
Elaborazione: Astro Pixel Processor, PS 2022, Starnet v2, Siril 1
Autore: Andrea Arbizzi, Modena.
Ripresa da Siracusa il 09/03/2023
Telescopio TecnoSky Apo Sld 130/910 mm su montatura iOptron Cem 70G
Camera ZWO ASI 174 MM con filtri Baader D-Erf 135 mm, DayStar Quark Chromosphere

Elaborazione: AutoStakkert, ImPPG, Photoshop
Autore: Salvo Lauricella, Siracusa.
NEBULOSA GABBIANO (GUM 2)

Ripresa da Ferrara il 14/01/2023
Telescopio SW ED 80 su montatura EQ6R Pro
Camera QHY 168c
Pose: Optolong L_eNhance 80x600 s, SvBony SII 7 nm 70x300 s, SvBony
UV/IR-cut 20x60 s
Elaborazione: APP, Pixinsight, Photoshop
Autore: Massimo Di Fusco e Lino Benz, Ferrara.
Resto di supernova distante 1900 anni luce, ripreso da La Spezia l’8/08/2022

Telescopio RC 6 Omegon su montatura Sky-Watcher HEQ5
Camera ZWO ASI 533 pro con ltro L-eNhance
Guida con ZWO ASI 120 mini
Pose: 74x300 s, elaborate con PixInsight, Deep Sky Stacker, Photoshop
Autore: Flavio Striano, La Spezia.


Dopo il grande successo ottenuto nelle 6 tappe del 2022, continua anche nel 2023, con ben 9 tappe, il viaggio di Forbes dedicato alla scoperta delle PMI, spina dorsale dell’Italia che cresce.


Un’occasione per confrontarsi su temi quali sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, welfare, accesso al credito e per creare relazioni professionali. Il progetto è rivolto a imprenditori e manager che gestiscono PMI del territorio e alle grandi aziende che vogliono mettersi in contatto con loro.






Il disco di Nebra è uno degli oggetti preistorici più interessanti trovati nel XX secolo. Tanto interessante da entrare a far parte, nel 2013, nel Programma “Memoria del mondo” dell’Unesco; una iniziativa fondata nel 1992 per preservare il patrimonio culturale mondiale.

Questo disco di bronzo di 32 cm di
diametro, spesso 4,5 cm al centro e 1,7 cm ai bordi e pesante circa 2 chilogrammi, ci rivela come osservavano il rmamento gli uomini dell’età del bronzo, grazie a preziosi intarsi dorati. Gli archeologi lo hanno datato intorno al 1600 a.C. (ma alcune valutazioni lo fanno risalire al 2100 a.C.) e lo hanno interpretato come una rappresentazione del cielo,
forse la più antica del mondo.
La sua storia è degna di un romanzo di avventure: inizia nel 1999 sul Mittelberg, una collina vicina alla città di Nebra, in Germania, quando viene portato alla luce insieme a due spade di bronzo da Henry Westphal e Mario Renner, due tombaroli che danneggiano il reperto, scambiato per uno scudo, e lo vendono a un
commerciante senza pensarci troppo. Inizia così il lungo viaggio del disco, che viene venduto più volte sul mercato, nché non nisce nelle mani di un archeologo professionista, Harald Meller, che riesce a risalire agli scopritori e a farli processare. Il fatto che il disco di Nebra sia stato inizialmente scambiato per uno scudo non deve sorprendere; infatti, ricorda lo scudo di Achille, forgiato dal dio Efesto, quello descritto così nell’Iliade (libro VIII):
“Ivi ei fece la terra, il mare, il cielo E il Sole infaticabile, e la tonda Luna, e gli astri diversi onde sfavilla Incoronata la celeste volta, E le Pleiadi, e l’Iadi,...”
Oggi il disco di Nebra si trova nel museo regionale della preistoria di Halle, sempre in Germania, dove si possono ammirare le sue forme dorate e i piccoli dischetti che lo adornano. Il
cerchio più grande è stato interpretato come il Sole o la Luna piena; mentre l’applicazione dorata a destra ha la forma della Luna crescente; ma potrebbe anche rappresentare il Sole e la Luna durante un’eclisse.


I cerchietti dorati ricordano le stelle; in particolare, un gruppo di sette cerchietti, a metà tra il cerchio grande e la Luna, potrebbe essere l’ammasso stellare delle Pleaidi, che nella mitologia greca erano le glie di Atlante e Pleione, le quali, dopo la morte delle Iadi, loro sorelle, si uccisero per divenire stelle. Nella mitologia greca ricorre spesso l’ascesa e la trasformazione di personaggi che dopo la morte vengono posti in cielo dal dio Giove, sotto forma di costellazioni. Il disco può essere interpretato come un calendario agricolo, dato che la levata eliaca delle Pleiadi indica l’inizio della stagione della semina. Per “levata eliaca” si intende il sorgere di un astro esattamente all’alba e prima del Sole.
Come ci ricorda Esiodo (Le opere e i giorni, Libro III):
“Quando sorgono le Pleiadi, glie di Atlante, incomincia la mietitura; l’aratura, invece, al loro tramonto. Queste sono nascoste per quaranta giorni e per altrettante notti; poi, inoltrandosi l’anno, esse appaiono appena che si a li la falce.”
In ne, gli archi dorati laterali (che in origine erano tre), sembrano rappresentare le curve dell’orizzonte in riferimento alla posizione del Sole al tramonto a Mittelberg, nei giorni dei solstizi e degli equinozi. Infatti, il tramonto rappresentato dall’arco dorato a destra coinciderebbe con la presenza della Luna crescente, che compare in cielo dopo la discesa dell’astro sotto l’orizzonte astronomico e viene quindi illuminata da quel lato. Se dalla collina del Mittelberg si posiziona il disco orizzontalmente, in modo che la linea immaginaria tra la parte superiore dell’arco sinistro e la parte inferiore dell’arco destro indichi la cima del monte Brocken (distante circa 80 km), abbiamo un calendario per l’anno solare. In e etti, osservando da Mittelberg, al solstizio d’estate il Sole tramonta proprio dietro il monte Brocken.
L’arco dorato sotto il disco grande è stato invece identi cato come la “barca solare”, un simbolo che ci porta nell’antico Egitto, dove il Sole era identi cato da divinità che percorrevano il cielo con una barca al mattino (la barca del Sole) e un’altra al tramonto (la barca della notte).
La bellezza dell’astronomia può essere espressa tramite ogni forma artistica. Bastano pochi elementi per realizzare
un disco di Nebra con i bambini: una sagoma rotonda e rigida, argilla bianca modellabile, una forma rotonda piccola, acqua, tempere color giallo ocra, verde smeraldo e turchese, uno smalto dorato, un mattarello, vernice trasparente base acqua e le estremità di una matita e di un compasso.
Lavoriamo il panetto di argilla con l’acqua per ammorbidirlo e in seguito stendiamolo, con l’aiuto di un mattarello, sul disco rigido. Eliminiamo i bordi fuori uscenti e usiamoli per ricavare il disco del Sole e la Luna crescente, da attaccare in seguito sul disco. Ricaviamo le stelle usando l’estremità del compasso e gli archi d’orizzonte con l’estremità tondeggiante della matita. A questo punto, è necessario far asciugare il disco di argilla ottenuto, sotto al Sole, prima di iniziare a dipingerlo. Per colorare gli elementi dorati del disco, possiamo mischiare il giallo dell’ocra insieme allo smalto dorato. Per colorare le parte restanti, basterà utilizzare le tempere color turchese e verde smeraldo. Facciamo nuovamente asciugare il disco colorato e in seguito ricopriamolo con una passata di vernice trasparente. Lasciamo asciugare all’aria tutta la notte.
Inquadra il QR per il video tutorial che spiega come realizzare il disco di Nebra con l’argilla modellabile.

Le Pleiadi sono un ammasso stellare aperto nella costellazione del Toro, costituito da centinaia di stelle legate tra di loro dalla gravitazione e nate dalla stessa nube interstellare e pertanto presentano età e composizioni chimiche simili. Sono stelle molto giovani, con una età di circa cento di milioni di anni, e quindi molto calde, sette delle quali sono visibili a occhio nudo e sembrano formare nel cielo un piccolo carro, simile a quello della costellazione dell’Orsa Maggiore.

Nelle notti autunnali è possibile individuarle alte nel cielo, in condizioni di cielo buio, a nord-ovest rispetto alla costellazione di Orione. Se vengono osservate con un piccolo telescopio rifrattore o un newtoniano, si presentano in tutto il loro splendore. Le stelle principali dell’ammasso portano i nomi delle “sette sorelle” e dei loro genitori: Alcyone, Atlante, Elettra, Maia, Merope, Taigete, Pleione, Celeno e Asterope
Le Pleiadi sono anche conosciute con la sigla M45 (Messier 45), poiché sono state registrate nel primo catalogo astronomico di oggetti non stellari compilato dall’astronomo francese Charles Messier
COSMO KID
*LAURA CITERNESI APPASSIONATA DI ASTRONOMIA, GESTISCE LA PAGINA FACEBOOK ASTRODOMINE E REALIZZA LABORATORI DI ASTRONOMIA PER BIMBI E RAGAZZI.
Cosmo Kid è una rubrica astronomica a misura di bambino. Con l’intento di avvicinare non solo i bimbi appassionati al cosmo, ma anche quelli che hanno il piacere di stupirsi e di porsi domande davanti al cielo stellato. Tramite il gioco e le immagini, mostriamo ciò che della volta celeste non si può vedere nell’immediato e o riamo spunti per un viaggio personale e fantastico dentro l’Universo. Ma Cosmo appartiene anche ai lettori, e così invitiamo appassionati, insegnanti, genitori a farsi avanti con suggerimenti o richieste, scrivendo a info@bfcmedia.com

OFFERTA DEDICATA AI LETTORI DI COSMO
Acquista 6 libri a scelta dalla lista al prezzo di 60 euro, spese di spedizione incluse.
La ricerca amatoriale delle supernovae

Giancarlo Cortini, Stefano Moretti
Super-occhi per scrutare il cielo Walter Ferreri, Piero Stroppa
I pianeti e la vita Cesare Guaita
I giganti con gli anelli Cesare Guaita
Alla ricerca della vita nel Sistema Solare Cesare Guaita
Oltre Messier Enrico Moltisanti
I grandi astrofili Gabriele Vanin
La Luna Walter Ferreri
In viaggio nel Sistema Solare Francesco Biafore
Come funziona l'Universo Heather Couper, Nigel Henbest






Come fotografare il cielo Walter Ferreri
L'osservazione dei pianeti Walter Ferreri
Cento meraviglie celesti Gabriele Vanin
E ettua l’ordine comodamente su BFC Store (bfcstore.com): acquistando il coupon “I best seller di Cosmo” riceverai un’email di conferma, rispondendo alla quale potrai indicare i titoli scelti.
Nelle Marche si va alla scoperta delle meraviglie del cielo con l’Associazione Astro li Alpha Gemini, delegazione territoriale dell’Unione astro li italiani (Uai). Animati da una grande passione per l’astronomia, gli astro li dell’associazione organizzano durante tutto l’anno, per il pubblico di adulti e bambini, eventi dedicati alla conoscenza e all’osservazione del cielo, a occhio nudo e all’oculare dei telescopi. Oltre 3000 persone prendono parte ogni anno alle iniziative di divulgazione astronomica dell’associazione, che rappresenta ormai un solido punto di riferimento culturale e formativo per l’intero territorio marchigiano. Parliamo con Giampaolo Butani, presidente dell’associazione, di tutte le attività e i progetti portati avanti con competenza ed entusiasmo.

ASTROFILI ALPHA GEMINI?
L’associazione si è costituita il 9 gennaio 1999, la notte del transito al meridiano di Alpha Gemini (Castore), a
Civitanova Marche (MC). L’associazione persegue, senza scopo di lucro, nalità di promozione della cultura e dell’astronomia, con la convinzione che la passione per il cielo e le competenze scienti che possano essere un valido contributo alla formazione e alla valorizzazione delle attitudini individuali.
Dopo aver trovato accoglienza in diversi plessi scolastici del territorio marchigiano, la nostra sede oggi si colloca in una piccola struttura a Civitanova Marche (MC), in via Contrada San Michele snc.
Questa struttura è adibita a sala riunioni e aula didattica ed è fornita di un telescopio a controllo remoto posizionato all’esterno, con il quale svolgiamo osservazioni e monitoraggio dell’attività solare usando ltri a luce bianca e H-alfa, osservazioni notturne della volta celeste per appassionati e semplici curiosi, e laboratori didattici per scolaresche di ogni ordine e grado. In futuro la nostra sede ospiterà anche un piccolo planetario.
L’associazione gestisce anche
l’Osservatorio astronomico
Elpidiense “Marco Bertini” sito a Castellano di Sant’ Elpidio a Mare a pochi chilometri da Civitanova, in un centro suburbano lontano dalla costa, posto su una collinetta a 150 metri sul livello del mare. L’osservatorio è equipaggiato con strumentazione a controllo remoto: Schmidt
Cassegrain 11”, rifrattore Meade HD 127 e Ritchey-Chrétien GSO
11”. Inoltre, dispone di un CPC 11”
Celestron e di un Dobson Meade da 16” per le attività itineranti.
Siamo aperti al pubblico tutti i lunedì con cielo sereno, per o rire l’osservazione guidata degli oggetti celesti al telescopio, e in occasione di eventi astronomici particolari. Organizziamo inoltre eventi divulgativi riservati alle scolaresche e alle associazioni di volontariato a carattere socio-culturale.
Appuntamenti diventati consuetudine per l’associazione
sono “I venerdì degli astro li”: incontri che si svolgono presso la nostra sede per favorire lo scambio di conoscenze per la crescita culturale individuale e di gruppo. Ogni anno proponiamo corsi di astronomia e astrofotogra a molto partecipati e periodicamente il gruppo di astrofotogra a si reca nei cieli bui dell’entroterra per realizzare foto professionali.
È inoltre consuetudine, dalla primavera all’autunno, organizzare nelle notti di Luna nuova degli Star Party in montagna, aperti a tutti gli appassionati, per osservazioni astronomiche sotto cieli bui. Tra gli eventi pubblici che organizziamo ogni anno, uno è particolarmente atteso da tutta la comunità: l’iniziativa “Passeggiando sotto le stelle” nel periodo delle Perseidi, una suggestiva serata nel buio della pista ciclabile che da Civitanova Porto va a Civitanova alta, dove postazioni di telescopi propongono osservazioni degli oggetti del cielo sotto la “pioggia” di stelle cadenti. La presenza sui social network, il passaparola, la qualità nell’accoglienza e la professionalità degli astro li dell’associazione hanno portato l’Osservatorio “Marco Bertini” a essere un punto di riferimento sia per l’utenza locale e delle altre province della regione sia - soprattutto nel periodo estivo - per i turisti residenziali o di passaggio. Negli ultimi anni è aumentato non solo il numero degli ospiti, ma anche quello delle persone appassionate di astri.

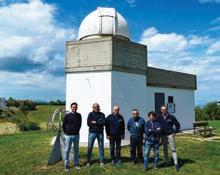
Molti ragazzi ci raggiungono con il proprio telescopio per approfondire le competenze nell’ambito dell’osservazione del cielo.
COSA OFFRITE ALLE SCOLARESCHE?
Ci rivolgiamo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e, con particolare attenzione, ai licei, a cui o riamo stage di orientamento con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro e corsi di astronomia che prevedono laboratori nalizzati all’utilizzo della strumentazione per osservazioni o riprese fotogra che degli oggetti del cielo, con misurazione di grandezze siche (come la misurazione della temperatura super ciale delle stelle mediante il metodo spettroscopico e la misurazione dei rilievi lunari con il metodo delle ombre).
Presso l’Osservatorio proponiamo visite guidate per osservazioni e riprese planetarie, con minicorsi di geogra a astronomica e orientamento alle costellazioni. Presso la nostra sede o riamo laboratori solari per l’osservazione delle macchie solari e
la misurazione dell’attività solare con l’apposita strumentazione.
É in fase di realizzazione una collaborazione di ricerca scienti ca nell’ambito della spettrofotometria con l’Ans Collaboration presso l’Osservatorio astronomico di Asiago.
L’inquinamento luminoso è una tematica molto sentita, dato che ci troviamo a operare, per la gran parte, sotto un cielo molto inquinato dalle luci delle città costiere. In ogni manifestazione cerchiamo di sensibilizzare gli ospiti riguardo a questa grave problematica. L’interlocuzione con le amministrazioni locali è di cile a causa della scarsa sensibilità al problema.
Ogni anno, in occasione della
L’Unione Astrofili Italiani:
•promuove l’attività astrofila e la conoscenza degli strumenti e delle tecniche osservative,
•è impegnata in prima linea nel trasferire ai più giovani la passione di scoprire l’Universo,
•coordina il contributo degli astrofili all’avanzamento della conoscenza astrofisica,
•valorizza la rete degli astrofili italiani al servizio della di usione della cultura astronomica e scientifica,
•tutela e valorizza l’ambiente-cielo.
Per conoscere le sue attività, i suoi progetti, le sue pubblicazioni, la sua di usione territoriale, per contatti e iscrizioni, vedi il sito www.uai.it
giornata “M’illumino di Meno”, proponiamo la manifestazione “Spegni le luci e accendi le Stelle”, una serata in cui l’amministrazione comunale spegne i lampioni nei pressi dell’Osservatorio per qualche ora. Riusciamo così a far comprendere al pubblico che con un piccolo gesto possiamo godere di un cielo che non siamo più abituati a osservare e, allo stesso tempo, possiamo realizzare un notevole risparmio energetico.

Tra i progetti futuri c’è la radioastronomia amatoriale Al momento stiamo realizzando un piccolo radiotelescopio a microonde per ascoltare radiosorgenti molto intense (Sole e Luna). L’obiettivo è quello di sviluppare gradualmente le competenze per “ascoltare” radiosorgenti più deboli, come le galassie, acquistando strumentazione sempre più adatta e specializzata.

Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Blue Financial Communication S.p.A. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www.abbonamenti.it/cga
Invece di 58,80€
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
*24,90€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 29,90€ (IVA inclusa) invece di 58,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP
BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO Chiama il numero
02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COUPON DI ABBONAMENTO SPECIALE
Sì, mi abbono a FORBES per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 58%. Pagherò 24,90€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 29,90€ IVA inclusa) invece di 58,80€.O erta Valida solo per l’Italia.





Cognome
Indirizzo
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, con sede in Via Melchiorre Gioia 5520124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà e ettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@ bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti. it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.

rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto rilascionego il consenso per le attività di profilazione

Sempre più spesso nei planetari si parla di tematiche di attualità. Pace, guerra, pari opportunità possono essere inserite con un accorto uso di riferimenti letterari, artistici e… astronomici. Ciò vale anche per argomenti in apparenza molto distanti da stelle e pianeti.Una decina di anni fa ero responsabile del Planetario de L’Unione Sarda a Cagliari e venne a trovarmi una delegazione del Gay Pride per chiedere se fosse possibile dedicare loro uno show al Planetario. Furono sorpresi quando risposi che il cielo stellato era ricco di spunti e riferimenti alle tematiche Lgbt e che quindi non sarebbe stato un problema. Negli incontri sotto la cupola di un planetario si fanno molti riferimenti alla mitologia classica su costellazioni, stelle e pianeti e se prestiamo attenzione ad alcune pagine delle Metamorfosi di Ovidio e delle Nozze di Cadmo e Armonia di Roberto Calasso, troviamo molti esempi che si possono presentare con un linguaggio lieve e misurato.
Possiamo iniziare da una regione del cielo che, per la sua importanza,
viene sempre descritta al planetario: il Polo nord celeste e le costellazioni circumpolari, visibili tutto l’anno.
L’Orsa Maggiore viene illustrata portando l’attenzione alle due stelle Dubhe e Merak, che consentono di individuare facilmente la stella Polare Il mito sull’Orsa è molto bello, e ci porta al tema dell’omosessualità. Narra della giovane e bella sacerdotessa del tempio di Artemide, Callisto, di

cui Giove si invaghì. Le sacerdotesse erano votate alla castità, ma resistere all’attenzione del re degli dei non era cosa da mortali. Quando la sventurata, durante la caccia, resta isolata, Giove le appare nelle sembianze di Artemide (transessualità?).
Sentiamo Ovidio: “O vergine, mia cara compagna, su che cime sei stata a cacciare?”. La fanciulla balza dalle verdi zolle e risponde: “Salute o Dea, che a
mio parere, anche se lui risente, sei più grande di Giove!”. Egli ride, divertito a sentirsi preferire a sé stesso, e la bacia in modo un po’ violento, non come dovrebbe fare una vergine. E mentre essa si accinge a raccontare in che bosco è andata a caccia, la blocca in un amplesso e così si rivela. Ovidio prosegue sulla scoperta della gravidanza e sulla punizione tremenda in itta alla povera Callisto dopo il parto: viene trasformata in un’orsa. Arcade, il glio, cresce, diventa a sua volta un cacciatore e il destino gli fa incontrare l’orsa, sua madre. Arcade, spaventato, sta per tra ggerla, ma a quel punto interviene Giove che trasporta i due in cielo: Callisto diventerà l’Orsa Maggiore e Arcade la stella Arturo (da Arcto lax, “colui che ama l’Orsa”), nella vicina costellazione del Boote.
La povera Callisto è sostanzialmente vittima di un tranello e di una violenza sessuale, ma nelle arti visive l’attenzione è sempre rivolta al primo contatto tra le due donne, al momento omosessuale, probabilmente per il fatto che questo gesto nel mondo classico non dava scandalo. In un planetario digitale si può dunque mostrare una breve galleria di questi capolavori dell’arte.
ZODIACALI
La descrizione dello Zodiaco e delle sue costellazioni è un altro tema tipico dei planetari. Prestiamo attenzione al Cancro: tra le due stelle Asellus Borealis e Asellus Australis c’è un ammasso stellare, il Presepe, noto n dall’antichità.

Le due stelle e il Presepe devono i loro nomi a una delle versioni del mito sulla battaglia nale in cui gli dèi
» Il gruppo scultoreo raffigurante Pan e Dafni ospitato presso gli Uffizi di Firenze. Inquadra il QR per una lezione sui miti del cielo senza pregiudizi sulla pagina Facebook di PLANit, l’Associazione dei Planetari Italiani.
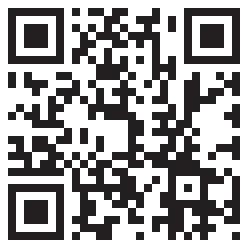
Olimpi scon ggono i Titani. Si narra che il dio Pan ne fosse il protagonista risolutivo: lanciando la carica con una sterminata mandria di asini e con il suo terribile urlo (che incuteva il “terrore di Pan” o “panico”), scompigliò le schiere dei Titani, favorendo la vittoria degli Olimpi. Giove portò in cielo due asinelli e diede loro una mangiatoia, in latino praesepe. Pan ebbe diversi amori omosessuali: il più noto è quello con Dafni, descritto spesso come un eromenos (un adolescente che aveva una relazione d’amore con un adulto). Anche per questo abbiamo una ricca documentazione di dipinti e sculture. E che dire di Ercole, alto nel cielo nelle notti estive? Nel mito si fa riferimento alle dodici fatiche, o al suo concepimento fraudolento operato da Giove ai danni di Alcmena e suo marito An trione. L’eroe ebbe diversi amori omosessuali: il più noto quello con Ila, che accompagnò Ercole anche nel viaggio degli Argonauti. E nel cielo estivo, non lontano da Ercole, abbiamo il Cigno, che nel mito è
Giove che si posa accanto a Leda per conquistarla. Non è necessario spendere molte parole: è su ciente ammirare il disegno, attribuito a Michelangelo, su Leda e il Cigno.
Oggi, nei planetari digitali, si può mostrare bene il moto di Mercurio (Ermes) attorno al Sole. Sappiamo molto sul pianeta grazie alle missioni interplanetarie Mariner 10 e Messenger, entrambe della Nasa. Nel mito, Ermes si innamorò del giovane Croco, che poi uccise accidentalmente giocando al lancio del disco.
Si può concludere con la Corona Boreale, in cielo tra Ercole e Arturo, che fu donata da Dioniso ad Arianna. Dioniso fu guidato verso l’Ade da Prosimno, che come compenso ebbe la promessa di giacere con Dioniso al suo ritorno dall’Ade. Ma, nel frattempo, Prosimno morì. Dioniso, per mantenere la promessa, tagliò un pezzo da un ramo di co, lo lavorò a forma di fallo e si auto-sodomizzò sulla tomba dell’amico. È la prima apparizione di un… sex toy. Lo show per il Gay Pride fu un gran successo. Raccomando ai planetaristi di cogliere l’occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite, che si celebra dal 2004 il 17 maggio di ogni anno.
Lo slogan è sempre lo stesso: “Lo spazio per tutti, tra gioco, scienza e fantascienza”. Dopo il successo della prima edizione, a ottobre del 2021, riparte lo Space Festival che si svolge dal 4 al 7 maggio a Torino, ideato e organizzato da Marco Berry, personaggio televisivo, un inizio di carriera come prestigiatore e illusionista, e in seguito conduttore di molti programmi TV, compresi alcuni di divulgazione scienti ca.
RIVOLTO A TUTTI
“Il nostro Festival è completamente gratuito” – spiega Berry – “ed è rivolto a tutti. Ecco perché si svolge in otto location diverse, a seconda del livello e delle caratteristiche di ciò che proponiamo. Molti eventi si svolgeranno anche contemporaneamente, perché saranno dedicati a un pubblico diverso, dagli specialisti di settore, sino ai semplici curiosi e ai bimbi. Quindi conferenze, tavole rotonde, ma anche mostre di modellismo e di oggetti spaziali, proiezioni di lm celebri, osservazioni astronomiche, corsi di volo, pilotaggio di droni e tanto altro ancora”.
Le sedi sono tra le più prestigiose del capoluogo piemontese: dal Politecnico alla Unione industriale (Amma), dalla “Pista” sulla tettoia del Lingotto (per le osservazioni del cielo con gruppi di astro li) al Planetario di Pino Torinese, dall’Aero Club tra Torino e Collegno, alla Pista del Lingotto, sino al Centro Spaziale di Altec. E con una postazione nella centralissima Piazza San Carlo
Il programma è ricco di appuntamenti. Si va dalle conferenze degli astronauti, e ve ne saranno tre di quelli italiani: Maurizio Cheli, già pilota collaudatore, mission specialist nella missione Shuttle STS-75 e oggi imprenditore nel settore tecnologico dell’aeronautica; Paolo Nespoli, astronauta dell’Esa, che ha trascorso

313 giorni in orbita in tre missioni tra il 2007 e il 2017; Walter Villadei in collagamento da Houston, dove si addestra per una delle prossime missioni Nasa e Space X destinate alla nuova stazione Axiom. E poi l’astro sica, con una conferenza di Massimo Robberto, tra i responsabili scienti ci del James Webb Space Telescope, che illustrerà le ultime meraviglie del cosmo riprese dal nuovo osservatorio spaziale. Vi sarà molta scienza, ma anche fantascienza, con proiezioni di lm come Interstellar e presentazioni del critico cinematogra co Steve Della Casa.
Anche in questa edizione vi sarà uno spazio dedicato alla divulgazione nelle scuole. Un progetto che coinvolge le scuole di tutti gli ordini e gradi, realizzando dei moduli didattici dedicati e con lezioni di esperti. Al Politecnico, nelle giornate del 5 e 6 maggio, le conferenzedibattito specialistiche saranno tre: una sulla space economy, una sul futuro dell’esplorazione lunare, e una sulle attività spaziali italiane con la presenza di esperti e dirigenti delle maggiori aziende italiane del settore.
Ancora prima, nella mattinata del 4 maggio, è in programma una tavola rotonda sul tema: “Donne nella scienza e nello spazio”, a cura di CreoStudios (che cura l’organizzazione dello Space Festival) e il supporto della Fondazione Segre Saranno presenti la vicerettrice del Politecnico Giovanna Mattiazzo,
l’astro sica Patrizia Caraveo, Maria Antonietta Perino di ales Alenia Space, Barbara Negri (Asi), e Fulvia Quagliotti (Distretto aerospaziale Piemonte).
Alla Pista del Lingotto sono in programma numerose presentazioni di libri ed è in programma una conferenza del divulgatore scienti co
Luca Perri
E mentre i droni progettati per volare sulla Luna, verranno testati in aree predisposte a cura di Giuseppe Santangelo (Ceo di Skypersonic), non sono esclusi momenti dedicati allo spettacolo e alle canzoni dedicate allo spazio (con qualche nome celebre della musica italiana), il tutto in una vera full-immersion di quattro giorni tra spazio e un po’ di fantascienza.

“La scelta di Torino” – dice Marco Berry – “è dovuta soprattutto al fatto che è la capitale dell’aeronautica e dello spazio in Italia, un aspetto spesso sconosciuto di questa città. L’obiettivo è anche quello di raccontare una delle migliori eccellenze della città e la sua forte vocazione allo spazio, con un ecosistema che coinvolge 300 aziende e poli di ricerca dell’aerospazio tra i più importanti al mondo. Capaci di a ermarsi come player mondiali del settore, come dimostrano gli attuali e futuri programmi, compreso quello del ritorno alla Luna, che sarà il focus dell’edizione 2023.
E speriamo anche questa volta, con un tema a ascinante, di essere attrattivi e divertenti. Vi aspettiamo quindi tutti a Torino dal 4 al 7 maggio!”.
Tutte le info, e il programma aggiornato si trovano sul sito www. spacefestival.it



Segnalate eventi, mostre, star party a stroppa@bfcmedia.com
ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA CONFERMA DEGLI EVENTI SUI SITI INDICATI


TORINO
SPACE FESTIVAL
DAL 4 AL 7 MAGGIO
Conferenze, presentazioni e spettacoli di astro sica e spazio per pubblico di ogni età, in otto location diverse della città (vedi a pag. 92). www.spacefestival.it
LOCALITÀ LIGNAN, NUS (AO)
SPETTACOLI AL PLANETARIO DI LIGNAN
TUTTI I SABATI, ORE 16:00 E 18:00
Il Planetario di Lignan o re al pubblico di adulti e bambini spettacoli multimediali sul cielo del periodo e su tematiche di forte rilevanza scienti ca e attualità. bit.ly/3R5BhrD
ROVERETO (TN)
IL CIELO IN UNA STANZA
TUTTE LE DOMENICHE, ORE 15:00



Gli esperti della Fondazione Museo Civico di Rovereto o rono spettacoli sotto la cupola del Planetario dedicati all’esplorazione dell’Universo bit.ly/3C2dLHW
SELVA DI PROGNO (VR)
VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO
27 MAGGIO, ORE 21:30

Visita guidata all’Osservatorio
“Parco della Lessinia” a cura degli Astro li Lessinia Orientale, con osservazione del cielo all’oculare del telescopio. bit.ly/42uiQ74
LA VITA OLTRE LA TERRA
5 MAGGIO, ORE 21:00
Lezione pubblica e gratuita sull’astrobiologia a cura di Guido Rocca. L’evento è organizzato dal Circolo Astro li Veronesi (via Filippo Brunelleschi 12). bit.ly/3K8fOwk

ASTROINCONTRO “STELLE AL PLANETARIO”

12 MAGGIO, ORE 20:45
Evento a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia, con spettacolo nel planetario, visita guidata al Parco Astronomico “Livio Gratton” e osservazione degli oggetti celesti a occhio nudo e al telescopio. bit.ly/42qWTp5
ROMA
SCUOLA DI ARCHEOASTRONOMIA
DAL 10 AL 12 MAGGIO
Corso di formazione organizzato presso il Museo Etrusco di Villa Giulia dalla Sezione “Storia e Archeoastronomia” dell’Unione astro li italiani (anche in modalità online). bit.ly/3WxfMTw


SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
IL VOLTO OSCURO DELL’UNIVERSO
20 MAGGIO, ORE 16:00
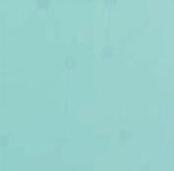
Conferenza sulla materia ed energia oscura a cura di Catalina Curceanu (Infn). L’evento è organizzato dalla Associazione Astronomica del Rubicone presso la Biblioteca “Antonio Baldini”. bit.ly/3AahGQL
BOLOGNA
OLTRE LO SPAZIO, OLTRE IL TEMPO FINO AL 28 MAGGIO
“Il sogno di Ulisse Aldrovandi”, un percorso espositivo tra arte, scienza ed esplorazione spaziale allestito presso il Centro Arti e Scienze Golinelli. ilsognodialdrovandi.it
BARI
SPETTACOLI AL PLANETARIO
TUTTI I WEEK-END
BACOLI (NA)
I NUMERI DELL’ASTRONOMIA


26 MAGGIO, ORE 20:00



Conferenza di Giuseppe Longo e osservazione del cielo al telescopio con i soci dell’Unione Astro li Napoletani, presso la Biblioteca
“Plinio Il Vecchio” nel Parco Cerillo. bit.ly/40h9gCs
Gli esperti dell’Associazione culturale Andromeda o rono spettacoli di astronomia, spettacoli di teatro-scienza e laboratori per scoprire le meraviglie dell’Universo. bit.ly/3pv1AvZ
TORINO, EINAUDI, 2022
PAGINE XIV-394
FORMATO 16 X 23,5 CM
PREZZO € 32,00
Fin dalla notte dei tempi, l’umanità si è confrontata con un problema così immateriale, ma così importante, come la misura del tempo. In e etti, oltre a misurare il uire del tempo, abbiamo sempre cercato di capire il suo signi cato profondo. È una s da sempre nuova e, nel corso dei secoli, mentre lo scorrere del tempo faceva aumentare le nostre competenze scienti che, è stata a rontata da loso , sici e matematici. Non si contano gli autori che hanno scritto libri a ascinanti sulla natura del tempo, cercando di chiarire perché questa variabile uisca sempre e solo in una direzione, mentre le leggi della sica potrebbero permettere anche il contrario.
Julian Barbour è un sico e losofo britannico, specializzato in teorie di gravità quantistica e in storia della scienza. In questo volume, sottotitolato Una nuova teoria del tempo, sfrutta la caratteristica bifronte del dio romano per immaginare dove, nell’Universo, il tempo possa scorrere nei due sensi. Se ci mettessimo nel punto di
GIORGIO CHINNICI
TORINO, CODICE EDIZIONI, 2023
PAGINE 167 CON ILLUSTRAZIONI B/N
FORMATO 14 X 21 CM
PREZZO € 18,00
Una grande avventura che dura da più di un secolo, nella quale si sono impegnate le menti più eccelse, per indagare un mistero grande come l’Universo. E che, curiosamente, ha richiesto di scoprire come funziona questo minuscolo componente su cui si fonda tutta la realtà che ci circonda. E di cui siamo fatti anche noi. Perché è sulla struttura del nucleo atomico che si poggia l’esistenza del carbonio, l’elemento alla base delle molecole organiche. In un agile volumetto alla portata di tutti, il fisico e ingegnere elettronico Giorgio Chinnici ci porta a scoprire i preziosi frutti che ci permettono di migliorare la nostra vita sulla Terra e al tempo stesso di esplorare l’Universo. Da questi frutti possiamo cercare di trarre energia “pulita” e di imparare a gestire le immense forze presenti nel nucleo, magari evitando di autodistruggerci con le bombe nucleari. Già molte sono le applicazioni benefiche del nucleare in molti campi, come la medicina e la produzione dell’energia, ma molti passi devono essere ancora compiuti, si pensi ai progetti di centrali per la produzione di energia
Giano vedremmo la “freccia del tempo” che si muove in entrambe le direzioni. In e etti, quella compiuta da Barbour è una ri essione profonda e articolata sul concetto di entropia, sviscerata in un corposo capitolo dedicato alla nascita della termodinamica. Barbour deve essere una persona che ama l’ordine e proprio non gli piace l’idea che l’Universo evolva verso una situazione di disordine sempre maggiore: lui preferisce pensare che l’Universo vada verso un futuro più complesso governato dall’entassia, una grandezza che diminuisce nel tempo. Questa interpretazione potrebbe piacere alla frazione della popolazione che viene sempre rimproverata perché disordinata. Pensate che bello rispondere che il caos della vostra scrivania è un esempio di complessità. Scherzi a parte, Julian Barbour è un veterano dell’esplorazione del concetto del tempo. E le sue idee, certo non convenzionali, sono tutt’altro che banali. Anzi, fanno pensare e rendono stimolante la lettura delle sue ri essioni.
da fusione e alla propulsione nucleare delle astronavi. Ma come ha fatto l’uomo a scoprire i segreti del nucleo? Ricordiamo che se un atomo fosse grande come un campo da calcio, il suo nucleo sarebbe come un seme di ciliegia al centro del campo… Tutto è iniziato con le osservazioni del fisico francese Antoine Henri Becquerel, che nel 1896 registrò una radiazione su una lastra fotografica, rivelando una potente attività interna all’atomo. Iniziava così una sequenza di studi che ha portato a svelare il meccanismo di funzionamento del Sole e delle stelle e alla realizzazione di strumentazioni complesse come il grande acceleratore al Cern di Ginevra, dove si riproducono eventi che si sono verificati alla nascita dell’Universo. E non finisce qui, perché dallo studio del nucleo è emerso uno “zoo” di particelle elementari che attende ancora di essere compreso e catalogato e per il quale si dovrà trovare una “nuova fisica”, per svelare quello che ancora non sappiamo e che non sappiamo di non sapere.
Pia Bassi