

COMINCIA OGGI IL TUO VIAGGIO NELL’UNIVERSO


NUMERI ARRETRATI Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it
Il costo di ciascun arretrato è
per te 12 numeri a soli 85,00€*
www.abbonamenti.it/cosmo
*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/cosmo
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a: DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero 02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
DAL SITO, ANCHE PER REGALARE UN ABBONAMENTO
Vai su BFCStore a bit.ly/3PJXDPd
Oppure inquadra il QR



Invece di 118,80€
COUPON DI ABBONAMENTO SPECIALE

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

I MIEI DATI
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto
rilascio nego il consenso per le attività di profilazione
Alla fine di febbraio una collaborazione internazionale ha presentato un documento al Copuos, il Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, proponendo la costituzione di un nuovo gruppo di esperti per proteggere i cieli bui e silenziosi. Il documento, che è stato approvato da Cile, Spagna, Slovacchia, Bulgaria, Repubblica Dominicana, Perù, Sudafrica, oltre che dall’Eso, dall’Unione Astronomica Internazionale (Iau) e dallo Square Kilometer Array Observatory (Skao), chiede con questo nuovo gruppo di esperti di monitorare l’impatto dei satelliti artificiali sulla ricerca astronomica e formula raccomandazioni per la sua mitigazione.
Praticamente lo stesso giorno, il sito Astrospace.it, specializzato in cronache spaziali, segnala che SpaceX ha lanciato la seconda generazione dei satelliti Starlink, nella loro versione “Mini”, ottimizzata per il lancio sul Falcon 9. Questi nuovi satelliti copriranno quattro volte più banda dei precedenti, e avranno prestazioni di propulsione e velocità di comunicazione doppie. Date le crescenti dimensioni, il problema della luminosità e del disturbo alle osservazioni astronomiche tornerà a farsi sentire, come e più di prima. Già adesso, le strisciate dei satelliti Starlink appaiono intaccare quasi il 5% delle riprese di Hubble, come evidenziato dal progetto Hubble Asteroid Hunter per la ricerca di asteroidi.
Pare di assistere, insomma, a un tira e molla fra scienza e tecnologia, due cavalli che, come quelli del Fedro di Platone, sembrano adesso divergere, mentre hanno spesso – e volentieri – cavalcato insieme le strade del progresso. In palio c’è il nostro futuro, quello della ricerca astronomica, quello delle comunicazioni sempre più globali, quello, in fondo, delle esigenze di sviluppo del mercato della space economy. Si troverà un compromesso accettabile dominato dalla ragione, come l’auriga che conduce la biga? Chissà se fra 50 anni l’umanità guarderà alla nostra epoca con quel misto di ammirazione e stupore che abbiamo noi quando pensiamo, per esempio, alle missioni Pioneer, celebrate in questo numero primaverile insieme agli sguardi che il telescopio James Webb ha dedicato all’Universo a noi più vicino, quello dei pianeti.

ANNO 5 - NUMERO 38 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019
CASA EDITRICE
BFC SPACE

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI
Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: Denis Masetti
CONSIGLIERE DELEGATO: Mirko Bertucci
CONSIGLIERE: Franco Cappiello
DIRETTORE RESPONSABILE Walter Riva riva@bfcmedia.com
DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com
HANNO COLLABORATO
Giovanni Bonini, Patrizia Caraveo, Giordano Cevolani, Giuseppe Donatiello, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Piero Mazza, Gianluca Ranzini.
GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com
PUBBLICITÀ Francesco Vannucci vannucci@bfcmedia.com
ABBONAMENTI
Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia
ARRETRATI
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it
STAMPA TEP Arti Grafiche Srl
Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com
IN COPERTINA: La cometa C/2022 E3 ZTF fotografata a gennaio da Jasna Maras in Croazia (Getty).

NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR


ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/
LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF
34


40
44
Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni,



UNA MISSIONE PER URANO 8
UNA MAREA DI GALASSIE LONTANE PER IL JAMES WEBB
7
Gli astrofisici sono alla ricerca del “pianeta gemello” della Terra (e circa ogni mese presumono di averne trovato uno nello zoo dei nuovi esopianeti).
Meno nota è la ricerca di una “galassia gemella” della Via Lattea, un’impresa che ha lo stesso fascino, aumentato dal fatto che non possiamo vedere la nostra Galassia dal di fuori. Un’occasione ce la fornisce il telescopio spaziale James Webb con questa immagine in cui possiamo vedere solo galassie lontanissime, di diversa natura e forma. Una marea galattica che vede in primo piano Leda 2046648, la grande spirale adagiata nella parte inferiore dell’immagine. Ripresa con un dettaglio sorprendente, se si considera che questa galassia, situata nella costellazione di Ercole, si trova a più di 1 miliardo di anni luce di distanza da noi, con una compagna più piccola appena sotto. La ripresa è stata realizzato dalla NirCam (Near-InfraRed Camera) del telescopio spaziale di Nasa, Esa e Csa, durante la campagna di messa in funzione di un altro strumento di bordo, lo spettrografo Niriss Lo scorso mese di gennaio Niriss aveva subito una anomalia, che aveva fatto temere gli scienziati, ma a fine mese lo strumento è tornato a operare efficientemente.

LA STAZIONE SPAZIALE SOTTO STRESS
SMILE, UN “SORRISO” EURO-CINESE 9
Leda 2046648 si mostra con un grande dettaglio, grazie al quale i ricercatori possono indagare le somiglianze con la Via Lattea, per rivelare magari qualcosa anche della nostra Galassia. Ma i veri target del James Webb sono le galassie ben più distanti: quelle dell’Universo primordiale che si trovano a più di 13 miliardi di anni luce di distanza, per avere una visione più profonda della storia del cosmo. Per guardare così indietro nel tempo, lo sguardo all’infrarosso del Webb è fondamentale, perché, la luce di queste galassie è virata verso l’estremità rossa dello spettro dal cosiddetto redshift, causato dall’espansione dell’Universo.
Dal confronto tra queste galassie antiche e lontane e quelle più vicine, gli astronomi comprenderanno l’evoluzione dei sistemi galattici nella storia dell’Universo.
LA PIÙ GRANDE MAPPA DEL CIELO
È la più grande mappa bidimensionale del cielo e copre quasi metà della volta celeste con oltre un miliardo di galassie.
La Legacy Imaging Survey del Desi (Dark Energy Spectroscopic Instrument) è un monumentale sondaggio del cielo che per sei anni ha visto coinvolti i telescopi del Kitt Peak National Observatory in Arizona e del Cerro Tololo Inter-American Observatory in Cile, gestiti dal NoirLab del Nsf statunitense. Il progetto è stato realizzato per studiare nel dettaglio la struttura dell’Universo e indagare le proprietà della materia oscura e della energia oscura. Le indagini hanno ripreso 14mila gradi quadrati del cielo visibile dall’emisfero settentrionale, raccogliendo un petabyte di dati e 100 milioni di ore di Cpu su uno dei computer più potenti del mondo presso il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Con l’aggiunta delle immagini del cielo australe, l’archivio Legacy Surveys supera ora i 20mila gradi quadrati della volta celeste.
Non sono solo gli scienziati a poter beneficiare di questi dati, perché questi sono pubblicamente disponibili e consentono a chiunque di svolgere ricerche anche di punta, accedendo Astro Data Archive al sito astroarchive.noirlab.edu.

In figura, l’ammasso di galassie Abell 3158, distante circa 825 milioni di anni luce. Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3IWlhYe

G.D.
GIOVANI STELLE IN POSA
NGC 346 è una regione di formazione stellare situata a circa 210mila anni luce di distanza nella Piccola Nube di Magellano (SMC), una galassia nana vicina alla Via Lattea.
Osservazioni condotte dal telescopio spaziale James Webb (Jwst) della Nasa hanno rivelato in questa “culla cosmica” la presenza di una consistente popolazione di giovani stelle e di strutture di gas e polveri mai osservate prima. Una scoperta che getta nuova luce sulla prima era della formazione stellare.
Gli autori dello studio hanno puntato l’attenzione sulla SMC, perché le basse percentuali di elementi pesanti presenti al suo interno assomigliano a quelle dell’Universo primordiale, durante l’epoca nota come “mezzogiorno cosmico”, circa 3,5 miliardi di anni dopo il Big Bang.
Grazie alla NirCam di Jwst, sono state individuate più di 33mila stelle in formazione all’interno di NGC 346, rivelando che ci sono quindi le condizioni ambientali per avere formazione stellare e planetaria, nonostante il basso contenuto di elementi pesanti. Le immagini mostrano anche una rete intricata di strutture gassose, con pennacchi costituiti da idrogeno molecolare (colore arancio in figura), con temperature di circa -200 °C, l’ambiente perfetto per la formazione di nuove stelle, e idrogeno ionizzato dal “vagito” delle nuove stelle (in colore rosa), la cui temperatura si aggira intorno ai 10mila gradi. Nonché grandi quantità di polveri, disponibili per la formazione di strutture planetarie

IL NUOVO PROGRAMMA TV PER TUTTI GLI AMANTI DEL CIELO


DAL 10 MARZO, OGNI VENERDÌ ALLE 22.00
ASTRONOMIA / COSMOLOGIA / SPAZIO OSSERVATORI / STRUMENTI / ASTROFOTOGRAFIA INTERVISTE IN STUDIO E SERVIZI
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA UNIONE ASTROFILI ITALIANI
DA UN’IDEA DI FRANCO CAPPIELLO CONDOTTO DA WALTER RIVA PRESENTA ADRIANA LALA

DODICI ANNI IN CINQUE SECONDI
Non è un’animazione, ma una sequenza d’immagini infrarosse che il Keck Observatory, alle Hawaii, ha ripreso a intervalli regolari per dodici anni (dal 2009 al 2021), osservando un sistema di quattro pianeti attorno a HR 8799, una giovane stella distante 133 anni luce da noi nella costellazione di Pegaso
La stella al centro, la cui luce saturerebbe la scena, è stata oscurata da un coronografo. Un altro accorgimento è stato l’impiego dell’ottica adattiva, per ridurre le distorsioni delle immagini dovute alla turbolenza atmosferica.
Dodici anni di lavoro per un time-lapse di cinque secondi che ci offre una vista “frontale” simile a quella che possiamo ottenere dai software planetari. I pianeti di HR 8799 sono quattro giganti gassosi, con masse che vanno dalle 5 alle 10 volte quella di Giove.


Il più vicino alla stella impiega 45 anni a completare un’orbita, mentre al più lontano (quasi immobile a sinistra), ne occorrono quasi 500.
Il segmento in basso indica la scala dell’immagine (20 Unità Astronomiche) e ci rivela che stiamo osservando un sistema planetario gigantesco, dove il pianeta più vicino alla stella ha un raggio orbitale circa venti volte maggiore di quello terrestre. Combinando le misure di tempo con quelle di distanza, si potrebbe eseguire un calcolo per verificare che questo sistema planetario rispetta la terza legge di Keplero. Inquadra il QR per vedere il time-lapse del sistema planetario di HR 8799
SEI GALASSIE IMPOSSIBILI
Risalgono a un’epoca in cui l’Universo aveva solo 600 milioni di anni, ma sono già talmente massicce da mettere in discussione gli attuali modelli cosmologici. Sono le sei galassie scoperte da un team internazionale di astronomi nelle immagini multibanda ottenute dalla Near Infrared Camera del telescopio spaziale James Webb Alcune di esse hanno masse superiori ai 10 miliardi di masse solari e una di esse sarebbe confrontabile con la Via Lattea, ma tutte risalgono a un’epoca in cui ci si attendeva di trovare oggetti giovani e piccoli in formazione, non certo galassie già “mature”. Se le conclusioni alle quali è giunto lo studio sono corrette, bisogna rivedere la teoria secondo cui nell’Universo primordiale le prime galassie sono nate come piccole nubi di stelle e polveri, che si sono gradualmente ingrandite e aggregate nel tempo.
E se quelle individuate non fossero in realtà galassie? I ricercatori si riferiscono a questi oggetti come a “candidate galassie”.
La possibilità che si tratti di qualcos‘altro c’è, ma si tratta di una possibilità remota. Un modo per confermare la scoperta del team consiste nell’ottenere gli spettri di questi oggetti. “Uno spettro ci dirà immediatamente se questi oggetti sono reali o meno”, afferma Joel Leja, uno dei ricercatori. “Ci mostrerà quanto sono grandi e quanto queste galassie sono lontane. E tutto ciò è alla portata del James Webb”.

5
LA METEORITE DI SAN VALENTINO
Dopo il ritrovamento della meteorite Cavezzo, avvenuto ai primi di gennaio del 2020 (bit.ly/3Sj7qOI), i calcoli eseguiti dagli esperti della rete Prisma hanno fatto nuovamente centro, stavolta indicando nella zona Nord di Matera quella della possibile caduta della “meteorite di San Valentino”.

Lo scorso 14 febbraio, verso le sette di sera, un luminoso bolide era stato osservato da numerosi testimoni solcare il cielo della Puglia e della Basilicata da nord-est, fra i quali tre “occhi” elettronici delle camere di Castellana Grotte, Tricase e Vasto, appartenenti alla rete Prisma, un network di una sessantina di camere sparse sul territorio italiano per un progetto di ricerca e di citizen science coordinato dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e sostenuto da Fondazione Crt (bit.ly/3Euigvq).
Grazie a queste informazioni, nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio era stato tracciato lo strewn field, cioè il campo di possibile caduta al suolo di frammenti del corpo celeste progenitore. Subito era scattato l’avviso ai mezzi di comunicazione e alla popolazione locale e nello stesso giorno sono stati recuperati dei frammenti precipitati sul balcone di una abitazione in una contrada alla periferia nord del capoluogo della Basilicata.
Finora sono stati trovati oltre 70 grammi in 12 frammenti principali e decine di frammenti più piccoli (Figura). Secondo i calcoli di Prisma, la meteorite è caduta verticalmente con una velocità di circa 300 chilometri orari. I frammenti sono stati consegnati a Carmelo Falco, rappresentante del Project Office della rete Prisma e associato Inaf, subito accorso in loco per coordinare le ricerche. Che sono continuate con vigore, alla ricerca di altri eventuali campioni sopravvissuti all’attraversamento dell’atmosfera. Il materiale recuperato verrà sottoposto ad analisi particolareggiate per determinare composizione chimica, mineralogia e caratteristiche petrografiche, utili alla classificazione della meteorite.
Ricordiamo che le meteoriti hanno attraversato quasi inalterate i circa 4,5 miliardi di anni dalla formazione del Sistema solare e ritrovarne una appena caduta aiuta gli scienziati a ricostruire le tappe che hanno portato alla formazione dei pianeti, Terra compresa. Il secondo ritrovamento in pochi anni di meteoriti “fresche” è una conferma dell’efficacia della rete Prisma nel reperire questo materiale così prezioso per la scienza.
Maggiori particolari e altre immagini su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3EwMrSE
UN TRANSITO DI MERCURIO DALLO SPAZIO
L’ultimo transito di Mercurio sul Sole si è verificato nel novembre del 2019 e per il prossimo dovremo attendere il 12 novembre 2032, ma la sonda Solar Orbiter dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e della Nasa ha anticipato i tempi e lo scorso 3 gennaio ha colto un passaggio di Mercurio sul disco solare e l’ha ripreso con i suoi strumenti (Figura). I transiti planetari sono utilizzati dagli astronomi per ottenere informazioni sia sui pianeti del Sistema solare che su quelli in orbita attorno ad altre stelle, molti dei quali vengono trovati proprio grazie ai loro transiti davanti alle rispettive stelle, che causa periodici indebolimenti delle loro luminosità. Dal 2026, il telescopio spaziale Plato (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) dell’Esa utilizzerà i transiti per cercare pianeti gemelli della Terra, mentre Ariel (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey), un’altra missione europea, dal 2029 studierà le atmosfere di un migliaio di esopianeti, sempre sfruttando i loro transiti. Il transito osservato da Solar Orbiter è stato invece utilizzato dai ricercatori per tarare gli strumenti di bordo del satellite europeo, in vista dei suoi prossimi avvicinamenti al Sole.



Inquadra il QR per un video del transito di Mercurio ripreso nell’ultravioletto dall’Extreme Ultraviolet Imager del Solar Orbiter

UNA MISSIONE PER URANO
Studiare il pianeta Urano ”da vicino” è uno dei prossimi obiettivi dell’esplorazione spaziale. A ribadirlo è Kathleen Mandt, planetologa dell’Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University, che sostiene che la Nasa dovrebbe inviare in tempi rapidi una sonda destinata solo ed esclusivamente al grande pianeta ghiacciato: “Anche se i pianeti che hanno un’atmosfera molto densa sono più difficili da analizzare, studiarli è indispensabile per capirne le caratteristiche, e dovremmo anche fare presto, visto che la prossima miglior finestra di lancio sarà nel 2032, quando l’allineamento tra Giove e la Terra permetterà di eseguire una fionda gravitazionale verso il pianeta”. E alla Nasa stanno valutando seriamente l’idea di partire con una Fase A avanzata del progetto di una sonda spaziale destinata al terzo pianeta più grande del Sistema solare. L’unico veicolo spaziale automatico ad aver osservato da vicino Urano è stata, sinora, la storica sonda Voyager 2, nel gennaio del 1986, come penultima tappa del suo Grand Tour nel Sistema solare, prima di raggiungere Nettuno nel 1989 ed entrare poi nel “mezzo interstellare”. Fu proprio grazie a Voyager 2 che si scoprì che una delle caratteristiche più interessanti di Urano è la sua inclinazione sull’asse di rotazione, che è di circa 98 gradi rispetto al piano dell’eclittica, tale per cui si muove quasi “rotolando” sulla sua orbita intorno al Sole.
ORGANIZZA UN GRANDE VIAGGIO PER ASSISTERE ALLA GREAT NORTH AMERICAN ECLIPSE



Insieme a un gruppo di esperti che terranno conferenze e osservazioni guidate del cielo. Programma del viaggio su Bfcspace.com/category/mexico-2024
I posti sono limitati! Invia la manifestazione di interesse a eclisse2024@bfcspace.com

SMILE, UN “SORRISO” EURO-CINESE
Presso il centro Estec dell’Agenzia spaziale europea (Esa) in Olanda, si sono tenuti i primi test d’integrazione della missione di eliofisica Smile (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) con l’adattatore del razzo italiano Vega-C. È la seconda missione scientifica sviluppata congiuntamente dall’Esa con la Cina, e programmata per il lancio nel 2025 dalla base di Kourou.

Un team cinese dell’Innovation Academy for Microsatellites ha svolto le prove su alcune parti del bus satellitare della missione. I test sono serviti per validare l’adattatore, i sistemi di aggancio e separazione dal Vega-C sui tre moduli spediti dall’agenzia cinese a fine anno 2022.
Questo evento rappresenta il primo incontro tra i team delle due agenzie da gennaio 2020, seguito in questi giorni da un nuovo incontro in Spagna, dove test simili verranno ripetuti con il modulo sviluppato da Airbus che ospita gli apparati scientifici. L’arrivo dei moduli cinesi in Olanda segna un piccolo record: è la prima volta che un satellite cinese viene integrato in buona parte con un lanciatore europeo.
Il programma della missione Smile è iniziato nel 2019, con l’obiettivo di studiare l’interazione del vento solare con la magnetosfera terrestre. Con una massa di 2200 kg, il satellite verrà posto in un’orbita ellittica intorno alla Terra che completerà in 40 ore un con apogeo di circa 120mila km. La missione primaria di Smile avrà una durata di tre anni.
LA STAZIONE SPAZIALE SOTTO STRESS
Dal 15 dicembre 2022 la situazione a bordo della Stazione spaziale internazionale ha continuato ad accumulare tensione a causa di problemi alle capsule per trasporto sia cargo che astronauti.
Tutto è cominciato quando a metà dicembre la navicella Soyuz MS-22 ha mostrato una perdita che è stata poi riconosciuta come liquido refrigerante.
La perdita è avvenuta da un foro di 0,8 mm causato dall’impatto con un micrometeorite o un piccolo detrito spaziale. Questo ha lasciato i due astronauti russi Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e lo statunitense Francisco Rubio senza un mezzo di emergenza per effettuare un rientro sicuro a Terra.
Il 12 febbraio anche la capsula cargo Progress MS-21 ha mostrato una fuga di liquido refrigerante, ma senza problemi diretti, dato che destino di queste capsule è quello di distruggersi al rientro in atmosfera.
La situazione si è distesa con l’attracco della Soyuz MS-23 il 27 febbraio, che significa avere un mezzo per evacuare la stazione in caso di necessità e per tornare a casa a settembre.
Quello stesso giorno il lancio della missione Crew-6 con una capsula Crew Dragon (figura) è stato fermato a due minuti dalla partenza e rimandato a marzo, per un problema ai serbatoi che ha portato i tecnici di SpaceX a fermare il countdown. Una giornata infelice per l’azienda di Elon Musk, che ha dovuto rimandare anche i lanci di due missioni Starlink, per problemi ambientali.



IN VIAGGIO VERSO LE STELLE
CINQUANT’ANNI FA IL LANCIO DI UNA DELLE SONDE
INTERPLANETARIE ORMAI DESTINATE ALLO SPAZIO PROFONDO

Attualmente, si trova a circa 105 Unità Astronomiche dalla Terra, pari a 15,7 miliardi di chilometri, e viaggia alla velocità di 11,4 chilometri al secondo verso le stelle. La sonda Pioneer 11 della Nasa di strada ne ha fatta molta, sin dal suo lancio avvenuto cinquant’anni fa, e ancora molta ne farà, essendo ormai diventata un veicolo interstellare.

Era il 6 aprile 1973, quando dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral un razzo vettore Atlas-Centaur si arrampicava nel cielo della Florida, per dare il via a una missione interplanetaria destinata a passare alla storia. La Pioneer 11 intraprendeva un viaggio ancora più esteso della sonda gemella Pioneer 10, lanciata poco più di un anno prima, ma con una rotta diversa, pur essendo i loro obiettivi planetari piuttosto simili. Lo stadio Centaur aveva immesso la sonda su un’orbita solare tra 1,0 e 6,12 Unità Astronomiche, inclinata in modo tale da farle raggiungere Giove direttamente, senza la necessità di una “fiondata gravitazionale” per raggiungere il gigante gassoso del Sistema solare.
UNA MISSIONE AMBIZIOSA
Grazie a questa traiettoria, quando Pioneer 11 sorvolò Giove il 3 dicembre 1974 a soli 42.500 chilometri, tre volte più da vicino di Pioneer 10, riuscì anche a fotografare per la prima volta le regioni polari del pianeta. Approfondì le osservazioni riguardanti anche le lune, e poi, utilizzando la forza gravitazionale del pianeta con un effetto fionda, si rilanciò verso la sua seconda meta, Saturno E ora viaggia oltre il Sistema solare, in direzione della costellazione dell’Aquila, che raggiungerà tra circa quattro milioni di anni.
Anche se Marte era diventata una meta privilegiata della Nasa (e del programma spaziale sovietico), al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) a Pasadena si guardava oltre, preparando l’esplorazione di altri pianeti. Era una sfida tecnologica e scientifica che l’ente spaziale americano aveva accettato di affrontare, utilizzando il Jpl come base dei programmi di esplorazione dello spazio profondo.
Le due sonde Pioneer erano basate sulla tecnologia e le caratteristiche di alcune delle sonde che avevano raggiunto Marte, ma rappresentavano una rivoluzione in campo tecnologico, poiché avrebbero dovuto superare difficoltà ambientali mai incontrate prima da un veicolo costruito dall’uomo.
L’idea era nata a metà degli anni 60 con il programma Planetary Grand Tour, che intendeva sfruttare un raro allineamento dei pianeti del Sistema solare esterno; missione che poi avrebbe compiuto la coppia delle sonde Voyager. Approvata dalla Nasa nel febbraio 1969, la missione delle due Pioneer doveva anticipare quella delle Voyager (poi lanciate nel 1977) con spettacolari sorvoli di Giove e Saturno.
Così, nel marzo 1972 e nell’aprile 1973 venivano lanciate le prime due sonde verso lo spazio profondo, per compiere il primo incontro ravvicinato con Giove e andare anche oltre. La doppia impresa rimarrà memorabile, aprendo la stagione dei lunghi viaggi spaziali. Le Pioneer erano alimentate per la prima volta da generatori nucleari a radioisotopi, perché si allontanavano troppo dal Sole e le celle solari sarebbero state inadeguate.
Un’altra “prima volta” era il superamento dell’orbita di Marte e l’attraversamento
della Fascia degli asteroidi, un territorio sconosciuto nel quale si temevano i rischi di collisione con la miriade di piccoli corpi che lo popolano.
Ma emergendo indenni dalla Fascia, a più di 400 milioni di chilometri dalla Terra, le due sonde dimostravano che questo pericolo era minore di quanto temuto.
La Pioneer 11, come la gemella Pioneer 10, reca a bordo una targa proposta dall’astrofisico Carl Sagan: una sorta di “messaggio in bottiglia” per eventuali esseri intelligenti che potrebbero venire in contatto con le due sonde (vedi a pag. 20).


LA SONDA E GLI APPARATI A BORDO
La Pioneer 11 era stata realizzata con dimensioni tali da poterla collocare nell’ogiva di 3 metri di diametro in vetta al razzo Atlas-Centaur. La parte più appariscente della sonda era l’antenna parabolica di 2,74 metri di diametro, grazie alla quale sono avvenute le comunicazioni con la Terra, sino al termine della missione, chiusa il 30 settembre 1995, quando la fonte energetica a radioisotopi si era esaurita, 22 anni dopo il lancio. Il corpo principale è un parallelepipedo a base esagonale, con lato di 72 centimetri, su cui sono
attaccate frontalmente le antenne e posteriormente i generatori atomici di energia elettrica e i propulsori per il controllo d’assetto.
La traiettoria della sonda era mantenuta per mezzo di un sensore stellare che inseguiva la stella Canopo, mentre altri due sensori erano puntati sul Sole. Il computer di bordo, basandosi sugli angoli relativi tra le direzioni programmate, calcolava la rotta, apportando le eventuali variazioni. Per mantenere un assetto costante, la Pioneer 11, così come la gemella, veniva fatta girare su sé stessa da tre piccoli razzi posti vicino al bordo dell’antenna
parabolica, che consentivano anche di eseguire le variazioni di direzione. La temperatura all’interno del veicolo spaziale era mantenuta costantemente tra -23 °C e +38 °C, per garantire il funzionamento degli strumenti di bordo nelle condizioni termiche estreme del viaggio cosmico. L’isolante termico usato nel compartimento degli strumenti è alluminio plastificato, mentre il riscaldamento era garantito da una “stufetta” al plutonio-238. La strumentazione scientifica principale era formata da un magnetometro per lo studio dei campi magnetici di Giove e Saturno,



PASADENA, ABBIAMO UN PROBLEMA
Poco dopo il lancio, la Pioneer 11 incontrò alcuni problemi, in particolare nel dispiegamento di uno dei due bracci contenenti l’Rtg, cioè la centralina atomica di bordo, che rimase solo parzialmente esteso, portando a un aumento di rotazione della sonda, per la conservazione del momento angolare. Successivamente, fallì uno dei componenti del sistema di trasmissione, subito sostituito dal suo backup
A metà marzo 1974 la sonda uscì intatta dalla Fascia degli asteroidi; durante la prima fase del viaggio, il Meteoroid detector della sonda aveva registrato venti impatti di piccole particelle, delle quali solo sei si erano verificati all’interno della Fascia degli asteroidi.
Il 19 aprile Pioneer 11 consumò 7,7 kg di propellente per un cambio di velocità totale che l’avrebbe immessa in una traiettoria molto più vicina a Giove che avrebbe prodotto anche un sorvolo polare, esponendosi però a un ambiente maggiormente carico di radiazioni. Il 18 novembre, la sonda iniziò a riprendere i primi dati scientifici, e il 4 dicembre transitò a 34mila chilometri da Giove

Il 1º settembre 1979 la Pioneer 11 raggiunse Saturno, passando nei pressi del pianeta degli anelli a soli 21mila chilometri.
da un rivelatore di radiazione cosmica e da una telecamera a scansione per le riprese fotografiche dei pianeti e dei loro satelliti. I segnali radio emessi dalla sonda venivano sfruttati anche per lo studio dei campi gravitazionali e delle atmosfere planetarie, sulla base delle perturbazioni ai segnali che si sono generate quando il veicolo spaziale si è avvicinato ai pianeti. Le due sonde Pioneer ci hanno rivelato per la prima volta, oltre alle caratteristiche dei due pianeti maggiori del Sistema solare, anche l’ambiente che li circonda, popolato di lune grandi e piccole che li fa apparire come dei sistemi planetari in miniatura.
Attualmente l’antenna della Pioneer 11 non risulta più allineata in direzione della Terra; non essendo possibile inviare comandi né riceverne, non si conosce l’attuale stato delle apparecchiature e non si sa se stia ancora trasmettendo dei segnali radio. Ma quella delle due sonde Pioneer resta comunque una delle missioni meglio riuscite. Nonostante abbia fatto uso di tecnologie degli anni 60, molte delle quali alla prima esperienza, ha raggiunto tutti i traguardi previsti dal programma.


IL MESSAGGIO IN BOTTIGLIA DELLE
PIONEER PLAQUE
A BORDO DELLE DUE MISSIONI PIONEER LE TARGHE
Una targa è per sempre. Soprattutto se è attaccata a missioni spaziali gloriose come le Pioneer 10 e 11. Stiamo parlando delle Pioneer Plaque, cioè le effigi figurative di alluminio anodizzato oro che vennero sistemate a bordo delle due missioni. Veri e propri “messaggi in bottiglia” per navigatori interstellari nell’oceano del cosmo, vennero pensate e realizzate nell’eventualità (veramente molto remota) che qualche essere intelligente le potesse intercettare e, quindi, tentare di decifrarle.
Fu il giornalista e conferenziere Eric Burgess, corrispondente scientifico del Christian Science Monitor, che seguiva per la testata i primi lanci delle missioni interplanetarie, a suggerire l’idea a Carl Sagan, noto astrofisico di fama mondiale e convinto sostenitore dell’idea che ci siano altri esseri intelligenti nella Via Lattea, al punto da figurare fra i fondatori del programma Seti per la ricerca di intelligenze extraterrestri.
Sagan fu entusiasta dell’idea e preparò la targa insieme a sua moglie Linda e a Frank Drake, altro grande personaggio dell’esobiologia, che sarebbe divenuto il papà della celebre equazione che permette di stimare il numero di civiltà intelligenti presenti nella nostra Galassia. La Nasa non si oppose, e le targhe furono fissate sui fronti dei supporti delle antenne delle due navicelle, in modo da proteggerle dall’erosione della polvere interstellare. L’alluminio è un materiale durevole, resistente alle intemperie e agli agenti chimici: se adeguatamente trattato, può mantenersi inalterato nel tempo.
IL MESSAGGIO: CHI SIAMO NOI
Un obiettivo affatto banale quello di realizzare in 23 cm di lato e 15 cm di altezza un messaggio che possa essere decodificato da altri esseri pensanti di cui non conosciamo nulla. A destra si misero le figure umane, un uomo e una donna nudi davanti a un disegno della navicella per dare un’idea delle dimensioni reciproche (criticati perché troppo rappresentativi della sola etnia “bianca” del genere umano).
Inevitabile ricorrere al simbolismo, sperando che altri esseri senzienti siano in grado di interpretare correttamente l’infografica finale. E allora ecco, in alto a sinistra, una rappresentazione schematica dell’interazione iperfine dell’inversione di spin dell’atomo di
idrogeno, l’elemento più abbondante nell’Universo, un’informazione che dovrebbe far parte del bagaglio di conoscenze di ogni civiltà evoluta. Al di sotto di questo simbolo, una piccola linea verticale rappresenta la cifra binaria 1. L’inversione di spin elettronico dell’idrogeno dallo stato up a quello down descrive anche una unità di lunghezza (la lunghezza d’onda di 21 cm della radiazione emessa da questo effetto), e una unità di tempo (la frequenza di 1420 MHz della radiazione, con periodo 0,7 ns). La radiazione appartiene alla banda delle microonde ed è largamente sfruttata in astronomia, in quanto può attraversare le polveri interstellari, che sono opache alla luce visibile. Queste due unità vengono poi usate per indicare le altre misure. Per esempio, tra i segni che indicano l’altezza della donna, si vede la rappresentazione binaria del numero 8 che, moltiplicato per 21 cm, dà il risultato di 168 cm.
E poi il saluto dell’uomo È molto improbabile che possa essere interpretato come un segno di pace, ma offre comunque informazioni sulla nostra anatomia, con il pollice opponibile in evidenza, una prerogativa quasi esclusiva della
specie umana e che permette al pollice di piegarsi in maniera tale da toccare tutte le dita della stessa mano.
INDICARE LA NOSTRA POSIZIONE
Dopo aver sperato di aver descritto chi siamo, ecco a sinistra la parte del messaggio che riguarda da dove veniamo. Quindici linee si diramano da una stessa origine: quattordici di esse indicano la posizione relativa di altrettante pulsar, accompagnate da un numero binario molto lungo, che rappresenta il loro periodo di pulsazione, usando come unità il periodo della radiazione a 21 cm. Poiché i periodi cambiano con il tempo, l’epoca del lancio può essere dedotta da questi valori. La lunghezza delle linee indica le distanze fra le pulsar e il Sole.
La quindicesima linea sulla placca si estende verso destra, dietro le figure umane, e indica la distanza del Sole dal centro della Via Lattea. Alla base delle targhe, una rappresentazione schematica del Sistema solare, con nove pianeti (Plutone compreso, il suo declassamento era ancora lontano).
Le targhe montate sulle due Pioneer sono identiche, sebbene la Pioneer
11 sia stata diretta anche verso Saturno dopo aver incontrato Giove (vedi l’articolo a pag. 22). Per questo particolare, la placca del Pioneer 11 ha una piccola imprecisione. Gli anelli di Saturno potrebbero dare un ulteriore suggerimento per identificare il Sistema solare, anche se oggi sappiamo che tutti i pianeti giganti del nostro sistema possiedono un sistema di anelli, cosa che era ignota quando la placca fu disegnata. Infine, il numero binario vicino ai pianeti mostra le distanze relative dal Sole; l’unità è 1/10 del raggio orbitale di Mercurio.
TUTTO CIÒ È COMPRENSIBILE?
Molti si sono chiesti se il messaggio portato dalle Pioneer – un esperimento di comunicazione che verrà poi ripetuto e ampliato con i Golden Records ospitati a bordo delle sonde Voyager – potesse essere comprensibile da chi lo avesse casualmente ricevuto.
Solo pochi scienziati umani a cui il messaggio fu mostrato furono in grado di decodificarlo esattamente e completamente. Qualche dubbio è quindi legittimo. Ogni tentativo di comunicazione rivolta all’esterno – anche verso ipotetici esseri extraterrestri – comprende obiettivi e problemi che sono anche propri della comunicazione interna. Quindi, se perfino noi stessi abbiamo difficoltà a decodificarlo correttamente, forse si poteva fare di meglio.
Le Pioneer Plaque, a prescindere dalla presunta efficacia del messaggio che recano, rappresentano comunque uno dei più pionieristici e coraggiosi tentativi di comunicazione con altri esseri intelligenti.

PIONEER 11
UNA MISSIONE VERAMENTE PIONIERISTICA
GLI OBIETTIVI SCIENTIFICI DI UNA SONDA CARICA DI PRIMATI CHE HA APERTO LA STRADA ALLE SUCCESSIVE ESPLORAZIONI
Per apprezzare gli obiettivi scientifici della missione Pioneer 11, occorre tornare indietro di oltre mezzo secolo e considerare quali erano le domande che gli scienziati si ponevano a proposito del mezzo interplanetario, della Fascia degli asteroidi e dei giganti gassosi.
Seguendo la sua traiettoria dalla Terra a Giove, la sonda avrebbe oltrepassato l’orbita di Marte, un pianeta già raggiunto da altre sonde, ma poi si sarebbe trovata in una terra incognita, la cui esplorazione era iniziata solo l’anno prima, grazie alla sonda gemella Pioneer 10. Dopo lo spazio interplanetario avrebbe attraversato la Fascia degli asteroidi, la cui popolazione era ancora poco nota, ma che si temeva potesse rappresentare un pericolo durante il passaggio della sonda, per poi avvicinarsi a Giove.
Pioneer 11 incontrò l’onda d’urto causata dall’interazione tra il campo magnetico del pianeta e il vento solare il 25 novembre 1974, poi continuò il suo viaggio verso Giove che avrebbe sorvolato a inizio dicembre 1974, avvicinandosi fino a circa 43mila km tra il 2 e 3 dicembre 1974 alla velocità di 171mila chilometri all’ora, un record per l’epoca.
polari del pianeta, per poi rivolgersi verso le sue lune, che furono immortalate da 200 scatti.
I parametri del passaggio ravvicinato erano stati proprio scelti per fare in modo che l’interazione gravitazionale della Pioneer 11 con Giove modificasse la direzione della velocità della sonda, per metterla in rotta verso Saturno, mai visitato fino ad allora.
VERSO SATURNO E OLTRE
Il 31 agosto 1979, a circa 1,5 milioni di km da Saturno, la sonda incontrò un disturbo del vento solare per effetto dell’onda d’urto prodotta dal campo magnetico del pianeta inanellato, che rivelava la sua importante presenza con questo biglietto di benvenuto.
In previsione dell’arrivo delle sonde Voyager (che erano state lanciate nel 1977 e a quell’epoca si trovavano già oltre Giove), venne deciso che Pioneer 11, nella sua traiettoria verso il punto di maggiore avvicinamento a circa 20mila km dalle nubi di
» Nella pagina a destra in alto:
una rappresentazione artistica “di taglio” degli anelli di Saturno. Il pioneristico attraversamento eseguito dalla Pioneer 11 ha dimostrato che la loro consistenza era ridotta e non pericolosa per le sonde.
Il flyby, tre volte più vicino di quello effettuata da Pioneer 10, avrebbe permesso di acquisire dati più accurati di Giove e di studiare le fasce di radiazione che, con il loro alto flusso di particelle, preoccupavano i progettisti delle successive missioni Voyager, che erano già in avanzato stato di preparazione. Durante il veloce flyby, Pioneer 11 fotografò la Grande macchia rossa e le regioni
Qui a fianco, una ripresa delle regioni polari di Giove effettuata dal Pioneer 11
Oggi siamo abituati da ben altre immagini, ma queste sono state le prime ottenute da vicino dei grandi pianeti.
A destra, la Grande macchia rossa di Giove ripresa da Pioneer 11



Saturno, attraversasse gli anelli del pianeta. Era la stessa traiettoria che avrebbero dovuto fare le due Voyager e alla Nasa volevano essere sicuri che il passaggio nella zona degli anelli, composti da granelli di ghiaccio e polvere, non fosse troppo pericoloso. La sonda Pioneer 11 fu quindi un vero pioniere per aprire la strada alle Voyager. La manovra dell’attraversamento degli anelli sarebbe stata poi ripetuta, il 30 giugno 2004, dalla sonda Cassini che, a differenza di Pioneer 11 e delle due Voyager, si doveva mettere in orbita intorno al pianeta. Per proteggere gli strumenti dagli urti
con la materia degli anelli, Cassini utilizzò come uno scudo la sua grande antenna, di fabbricazione italiana.
Tornando a Pioneer 11, il suo attraversamento degli anelli di Saturno ebbe luogo il 1° settembre 1979, ma la sonda non venne danneggiata, dimostrando che la materia degli anelli era sufficientemente dispersa da non costituire un ostacolo insormontabile. Durante il flyby, la sonda riprese 440 immagini, 20 delle quali avevano una risoluzione di 90 km. Grazie a queste riprese, si capì che l’atmosfera di Saturno è meno turbolenta di quella
di Giove e che il pianeta è composto soprattutto da idrogeno, a una temperatura media di circa 180 gradi sottozero. Utilizzando la velocità della sonda, fu possibile migliorare la misura delle masse di Saturno e dei suoi satelliti maggiori. Pioneer 11 scoprì anche un nuovo anello all’esterno dell’anello A, che fu chiamato anello F, e una nuova luna del pianeta. Le immagini del satellite Titano (con la risoluzione di 180 km) mostrarono la presenza di una grande macchia di colore arancione, con una temperatura di quasi -200 °C. Avendo esaurito i possibili appuntamenti planetari, Pioneer 11 si

lasciò alle spalle Saturno, dirigendosi verso l’esterno del Sistema solare, ma in una direzione opposta a quella seguita dalla Pioneer 10. Il 23 febbraio 1990 attraversò l’orbita di Nettuno, ma continuò a mandare dati fino a novembre 1995.
L’ANOMALIA DEI PIONEER
I dati raccolti dalle sonde Pioneer 11 sono stati fondamentali per il successo di tutte le missioni successive, a cominciare dalle due Voyager, anche se le immagini ottenute da queste ultime, di migliore risoluzione, hanno eclissato quelle “storiche”.
Tuttavia, le missioni Pioneer hanno continuato a fare parlare di sé per molto tempo dopo la fine della loro vita operativa, a causa di uno strano effetto, noto come anomalia dei Pioneer, che è stato un rompicapo per il personale del Jet Propulsion Laboratory che seguiva le traiettorie

delle due sonde. Le due Pioneer non si trovavano dove ci si aspettava che fossero. Se si misurava la posizione delle sonde e si calcolava dove si sarebbero trovate di lì a un anno, le posizioni effettive, derivate a partire dal tempo di transito dei segnali radio che venivano inviati dalle sonde in risposta a quelli mandati dai controllori a terra, risultavano spostate di circa 400 km. La discrepanza venne notata negli anni 80, quando le sonde erano già ben oltre le 20 Unità Astronomiche da noi (circa 3 miliardi di chilometri), a una distanza rispetto alla quale un “errore” di 400 km non era certo importante, ma era comunque degno di attenzione.
Sicuramente, non era dovuto a una causa che si era presentata una volta sola nella missione, perché il rallentamento cresceva con il passare del tempo a riprova che la sua causa continuava ad agire.
La ricerca della causa del rallentamento (circa 1 km/h su un periodo di 10 anni) divenne oggetto di studio nel 1994 per capire se fosse da imputare a qualche particolarità delle sonde, oppure a un sottile effetto di fisica fondamentale.
Tra i filoni della ricerca c’era quello legato alla struttura della sonda che procedeva ruotando su sé stessa mantenendo l’antenna puntata verso la Terra (e quindi verso il Sole), senza bisogno di accendere i motori per effettuare correzioni di rotta. In posizione opposta all’antenna, le sonde avevano una coppia di generatori a radioisotopi (Rtg) che fornivano energia grazie al calore generato dal decadimento radioattivo del plutonio e convertito in energia elettrica grazie all’effetto Seebeck. Si riconobbe che era il calore prodotto dai generatori, emesso in direzione opposta al Sole, il responsabile della leggerissima forza che frenava la sonda.
Le discussioni furono accese e solo nel 2012 venne accettata la spiegazione che riconduceva l’anomalia delle posizioni a una anomalia termica.
Questo effetto non era stato rilevato per altre sonde interplanetarie fornite di generatori Rtg, come le Voyager, perché queste non erano stabilizzate dalla rotazione e richiedevano frequenti aggiustamenti di rotta, di entità molto maggiori di qualsiasi anomalia radiativa. Ogni missione, insomma, è una storia a sé.
STARSHIP PRENDE IL VOLO
DOPO IL TEST ORBITALE, DECINE DI LANCI SENZA EQUIPAGGIO, I FLYBY LUNARI PRIVATI E INFINE
LO SBARCO SULLA LUNA

Dal lancio del prototipo SN 15 del 5 maggio 2021, non è più volato niente da Starbase, il complesso texano di SpaceX in cui vengono realizzati e da cui partiranno i sistemi di lancio Starship. Ora però tutti i test sono conclusi e quasi tutte le autorizzazioni ottenute. Il prossimo passo è il test di volo orbitale. Test che, alla pubblicazione di questo numero, potrebbe essere già avvenuto, in quanto Elon Musk ha parlato di marzo come prima data di lancio. Tuttavia, la sua azienda ci ha abituati a repentini cambi di ritmo e, nel campo dell’esplorazione spaziale, le incognite sono molte. Sicuramente, questo “test di lancio orbitale”, malgrado il nome, non prevede l’esecuzione di un’orbita intera. Secondo il programma di volo, la navicella Starship 24 uscirà dall’atmosfera, ma verrà fatta rientrare prima di aver compiuto un intero giro del mondo per ammarare a 100 km nord-ovest da Kauai, isola delle Hawaii. Il Booster 7 invece effettuerà uno splashdown a “soli” 30 km dalle coste texane su cui si trova Starbase. Una distanza comunque ragguardevole, se si considera che nessun booster Super Heavy si è finora sollevato dalla rampa di lancio.
GLI ULTIMI TEST
Sia booster che navicella sono già stati sottoposti a un’ampia campagna di test culminata col raggiungimento di due pietre miliari: il primo Wet Dress Rehearsal del sistema di lancio Starship al completo, e lo Static Fire Test del Booster 7

Nel primo caso, il 23 gennaio, la navicella Starship 24 e il Booster 7 sono stati impilati sulla rampa di lancio e sono stati caricati di metano e ossigeno liquidi. Il sistema di lancio, dell’altezza complessiva di circa 120 metri, è stato rifornito con più di 4500 tonnellate di carburante in un’ora e 15 minuti circa. Dopo la conclusione del test, gli operai di Starbase hanno rimosso la navicella e l’hanno trasferita al sito di costruzione per l’ultimazione dello scudo termico.
Nel frattempo, al Booster 7 venivano aggiunti i 33 motori Raptor che sono stati
» Sopra: il Wet dress rehearsal (test di carico del carburante) di Starship eseguito il 23 gennaio scorso. Sotto: un rendering della Starship HLS (Human Landing System) sulla Luna.


utilizzati durante lo Static Fire Test, avvenuto il 10 febbraio. Anche se un motore è stato spento dal team di controllo dopo aver rilevato dei valori anomali, e un altro è stato spento dal sistema di bordo, la spinta di 3600 tonnellate generata ha reso il Booster 7 il razzo più potente mai acceso e ha anche superato il record per numero di motori attivi in contemporanea, imbattuto dai tempi della prima corsa alla Luna e detenuto al razzo sovietico N1, che vantava ben 30 motori. Sotto sforzo è andato non solo il gigantesco booster, ma anche la stessa torre di lancio, che ha mostrato qualche segno di deterioramento dopo il test. Ma da SpaceX è arrivata la conferma che sia il booster, sia la torre non hanno subito danni integrali.
Durante il test orbitale, però, le cose
potrebbero complicarsi in quanto, come dichiarato da Elon Musk, durante lo Static Fire i motori erano solo al 50% della potenza.
VERSO LA LUNA
Nel frattempo, in stile SpaceX, proseguono in parallelo i lavori ad altre navicelle, come la Starship 26 Portata sul Pad A nella seconda metà di febbraio, questa navicella ha la peculiarità di essere “nuda”: mancano infatti il rivestimento termico, le quattro alette e persino la porta per la baia di carico.

Non ci sono ancora commenti ufficiali, ma, non potendo rientrare o portare carico, l’unico ruolo possibile per questa Starship è quello di serbatoio, un componente fondamentale per il programma Artemis. Infatti, a partire dalla
missione Artemis III, gli astronauti raggiungeranno la Luna a bordo della speciale Starship HLS, in grado di allunare e di riportare l’equipaggio in orbita lunare. Un lungo viaggio che rende necessario un rifornimento prima di lasciare l’orbita terrestre. Per fare ciò, saranno necessari diversi attracchi fra Starship mirati a rifornire la cosiddetta Starship Tanker, che a sua volta rifornirà la navicella diretta verso la Luna. Il ruolo della Starship 26 potrebbe quindi essere proprio quello di serbatoio orbitante per rifornire i mezzi con destinazione lunare e, in futuro, marziana. Le telecamere amatoriali che circondano Starbase non hanno catturato attracchi o meccanismi per il trasferimento di propellente connessi a Starship 26, ma ha senso che SpaceX dia priorità a una Starship Tanker, in quanto tutti i successivi voli orbitali di test potranno portare come payload il loro stesso carburante e raggiungere due obiettivi in contemporanea.
Al piatto c’è da aggiungere il contratto dimostrativo stipulato con la Nasa che premia l’azienda con 53 milioni di dollari per il trasferimento di 10 tonnellate di ossigeno liquido in orbita fra veicoli Starship Questa ipotesi è in linea anche con quanto dichiarato dalla presidente di SpaceX Gwynne Shotwell, ovvero che i voli di Starship verso la Luna arriveranno dopo l’esperienza maturata in decine di voli senza equipaggio. Questo comporta anche un calendario estremamente fitto a Starbase. La navicella Starship HLS con destinazione lunare dovrà essere pronta nel 2025, quindi in futuro dovremo aspettarci un lancio Starship a settimana.
I FLYBY LUNARI PRIVATI
I tempi si accorciano se come viaggio verso la Luna la Shotwell intende anche le missioni private che prevedono un flyby lunare. Al momento sono tre quelle in programma e tutte hanno a bordo un turista spaziale che è già stato in orbita.
La prima a partire dovrebbe essere la missione Polaris III dell’imprenditore Jared Isaacman, già fautore dell’impresa Inspiration4 del 2021 a bordo di una capsula
Crew Dragon, e che quindi ha già un rapporto preferenziale con SpaceX. Il programma Polaris si divide in tre missioni di cui le prime due spingeranno la navicella Crew Dragon ai suoi limiti, mentre la terza prevede un flyby della Luna a bordo di una navicella Starship

Un programma ambizioso che dovrà mantenere il ritmo di una missione l’anno, non scontato nemmeno per astronauti professionisti.
La missione privata annunciata da più tempo è però DearMoon dell’imprenditore giapponese
Yusaku Maezawa. Anche questa missione prevede un flyby lunare a bordo di una navicella Starship, con l’aggiunta di artisti e personalità varie per rendere il viaggio uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età e nazionalità. Anche durante il suo primo volo nel dicembre 2021, Maezawa aveva cercato una forte partecipazione del pubblico tramite i social media. Inoltre, l’altro sedile della capsula Sojuz affittato da Maezawa era stato riservato al suo assistente Yozo Hirano, con l’incarico di filmare e documentare la missione.
Il terzo volo Starship privato in programma è quello voluto dal primo astronauta commerciale, Dennis Tito, che nel 2001 visitò la Stazione spaziale internazionale. Assieme alla moglie Akiko e agli altri dieci che acquisteranno il biglietto, Tito farà
un giro attorno alla Luna, ma non è ancora chiara la tempistica della missione.
Nel frattempo, SpaceX dovrà testare anche la capacità di Starship HLS di allunare e ritornare in orbita.
Tuttavia, per il primo test, la Nasa ha chiesto solo la dimostrazione dell’atterraggio, non della possibilità di ripartire dalla superficie. È quindi possibile che la prima Starship a raggiungere la Luna verrà abbandonata lì e che ci saranno due Starship HLS dimostrative.
UN IMPRESSIONANTE RITMO DI LANCI
Per rispettare i suoi piani, a partire dalla seconda metà del 2023 SpaceX dovrà lanciare almeno una Starship alla settimana e accelerare ancora di più il ritmo nel 2024. In effetti, a dispetto della sua imponente statura, il sistema di lancio Starship è pensato per essere costruito e lanciato in tempi molto più rapidi rispetto a quelli dei razzi Falcon 9 Elon Musk parla di una produttività a pieno regime di un sistema Starship al giorno, ma c’è ancora da definire la logistica di lancio. Musk ha inoltre dichiarato che con Starship vuole ridurre il costo del trasporto in orbita bassa a meno di dieci dollari al chilogrammo. Un progetto visionario che ha incontrato ancora più scetticismo del solito. Tuttavia, anche con un parziale successo, il sogno di colonizzare la Luna e Marte non sarebbe più così lontano.
IL SOGNO DI ANDREA PATASSA
A COLLOQUIO CON IL NUOVO ASTRONAUTA ITALIANO, RECENTEMENTE SELEZIONATO DALL’ESA
“La mia generazione di astronauti è destinata a missioni lontano dalla Terra? È possibile, e sarebbe fantastico, ma anche in orbita terrestre sarebbe il coronamento di un sogno”.
Andrea Patassa è capitano e pilota dell’Aeronautica Militare Italiana, che quest’anno celebra il centenario dalla sua costituzione.
Andrea invece ha 31 anni, e la prima fase del suo sogno che si avvera è legata al 2022. Infatti, lo scorso novembre Andrea, assieme ad Altea Comellini, anch’essa ufficiale dell’Aeronautica, è tra i due unici italiani selezionati dall’Esa (Agenzia spaziale europea) nel gruppo dei nuovi astronauti europei. In una categoria che, in qualche modo, rappresenta una novità. Quella degli “astronauti di riserva”. Il che non significa che non siano astronauti a tutti gli effetti: “Facciamo parte di un team che dovrà essere sempre pronto a partire per lo spazio” –ci conferma Andrea – “E in seguito potremo essere inseriti nei ‘titolari’. Quindi è previsto che ci addestreremo come tutti gli altri astronauti, poiché, come alcune volte è capitato in passato, se un titolare per una qualsiasi ragione non potrà partire, dovremo essere pronti. E nel frattempo, faremo molta esperienza a terra, supportando le missioni dalle basi spaziali”.
“Oppure” – aggiunge – “a volte capita che alcuni astronauti, pur restando in servizio attivo,
» In alto a sinistra: il pilota dell’Aeronautica militare italiana Andrea Patassa, nuovo astronauta Esa.
Sotto: Altea Comellini, ufficiale dell’Aeronautica e nuova astronauta europea. A destra: Patassa e Comellini insieme a Luca Parmitano.
non fanno più addestramento, perché diventano una sorta di ambasciatori dello spazio a livello internazionale. A quel punto c’è bisogno di altri astronauti che subentrino subito”. In pratica, un po’ il percorso che seguono tutti i nuovi astronauti, e un po’ di tutte le agenzie spaziali: “Personalmente, anche se non vedo l’ora di poter partire per lo spazio, non ho fretta. Siamo giovani, abbiamo un bel futuro davanti e l’esperienza ci aiuterà a essere ancora più pronti per le prossime sfide spaziali”.
COME SI DIVENTA ASTRONAUTA
Andrea Patassa ha studiato scienze aeronautiche presso l’Università di Napoli Federico II, in Italia, e ha conseguito la laurea nel 2013, seguita da un master nel 2018. È diventato pilota dall’Aeronautica militare nel 2017. Nel 2022 è diventato pilota collaudatore sperimentale presso la la scuola di pilotaggio dell’Usaf presso la base aerea di Edwards in California. Dal 2010 ha preso parte a diversi corsi di sopravvivenza e salvataggio con l’Aeronautica militare italiana, che includono addestramento alla fuga subacquea e sopravvivenza e salvataggio in ambienti estremi. Ha alle spalle più di 1000 ore di volo su 30 diversi velivoli:
“Il mio sogno sin da bambino è sempre stato quello di diventare pilota d’aerei” – ci dice Andrea –“e ovviamente anche astronauta. Ora, infatti, in attesa di iniziare l’addestramento come astronauta, continuo a volare sugli aerei da caccia. Il mio preferito? Tutti, ma se devo sceglierne uno, certamente dico l’Eurofighter, una macchina straordinaria, un vero gioiello dell’aviazione militare”. Chiediamo ad Andrea come ha iniziato il percorso di preselezione: “Ho subito risposto al bando dell’Esa” – dice – “e da quel momento è iniziata una lunga sequela di e-mail, grazie alla quale ho capito che avevo qualche possibilità …”. Le prove più difficili?: “Quelle cognitive” – aggiunge Patassa – “sono dei test psicologici complessi ma allo stesso divertenti, come dei giochi. Che servono per capire quanto sei sveglio nell’intervenire su alcune azioni”. La centrifuga?: “Non l’abbiamo fatta, ma in ogni caso

non mi spaventa, perché l’ho già provata per diventare pilota. E in effetti è una bella prova, piuttosto estrema”. Durante le selezioni, Andrea racconta dell’incontro con gli astronauti già in servizio attivo: “Ho conosciuto Luca Parmitano, che era nella commissione di selezione. E anche Alexander Gerst. Persone eccezionali, avevo la sensazione che fossero dei fratelli maggiori” – dice –“Ero emozionato quando incontrai Luca, quasi non mi pareva vero, così come mi emoziona poter lavorare con lui in futuro. Oltretutto anche lui proviene dalla nostra Aeronautica, così come Samantha Cristoforetti”. Le missioni future? Ti candidi per la Luna?: “Ci penso, naturalmente. Sarebbe meraviglioso, ma preferisco fare un passo alla volta. Ora sono astronauta di riserva. Prossimo passo, astronauta titolare. E poi anche una missione in orbita terrestre, sulla Stazione spaziale internazionale, sarebbe davvero il coronamento di un sogno”.


L’UNIONE EUROPEA E LE NUOVE SFIDE PER LO SPAZIO
L’OBIETTIVO FINALE È RAGGIUNGERE LA SOVRANITÀ
“La guerra in Ucraina è stata una sveglia che ha rivelato l’importanza strategica dei sistemi spaziali nella difesa dell’UE, ma anche la loro vulnerabilità”. Così ha detto Joseph Borrel, Alto Rappresentante della politica europea di sicurezza e difesa, alla Conferenza annuale sulla politica europea per lo spazio tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 gennaio scorso. “L’avanzata delle forze armate russe il 24 febbraio 2022 è stata accompagnata da un cyber attacco sulla rete satellitare Viasat che ha creato scompiglio nelle reti di telecomunicazione in Ucraina, ma ha prodotto anche interruzioni di servizio sulla rete informatica della ditta tedesca Enercon, che gestisce centinaia di turbine a vento, che erogano più di 10 gigawatt in Europa Centrale. Sul lato positivo, sono proprio le comunicazioni e l’intelligence satellitare, in parte messe a disposizione all’Ucraina
dai paesi della Nato, che hanno consentito all’esercito ucraino di reggere l’attacco, alla popolazione di rimanere connessa con i suoi soldati e al Paese di rimanere connesso al mondo”.
UN ELEMENTO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA
Lo spazio è dunque diventato ancor più importante nella politica di sicurezza e difesa dell’Unione Europea. Un anno fa è stato approvato il documento base della strategia di difesa comune dell’UE, il cosiddetto Strategic Compass, e Borrel nel suo intervento ha anticipato la pubblicazione di un nuovo documento integrativo del suo gruppo Eeas (European External Action Service), dedicato alla dimensione spaziale della difesa. La miglior garanzia di robustezza e sostenibilità di un programma spaziale europeo si traduce infine nella disponibilità di una

industria capace di reggere la competizione internazionale, di disporre di tecnologie essenziali europee autonome, di innovare continuamente. A questi obiettivi è orientata la politica del Commissario all’industria Breton che lavora per un aggiornamento del tema spaziale con investimenti sui sistemi satellitari europei già esistenti – Galileo e Copernicus – e un’accelerazione nel programma Iris 2, la rete di telecomunicazioni satellitare supersicura, riservata soprattutto alle comunicazioni governative istituzionali.
L’obiettivo finale è la “sovranità europea” nell’ambito dei sistemi spaziali, che significa disponibilità di un apparato industriale solido e competitivo, fatto di “campioni mondiali”, ma anche di Pmi e startup innovative, di accesso sicuro alla componentistica necessaria, di lanciatori performanti.
La Commissione investe su ciascuno di questi punti. Per le startup, il
programma Cassini è in pieno svolgimento, mentre sul tema dell’accesso allo spazio, si fa strada nella politica della Commissione il sostegno anche ai piccoli lanciatori; ce ne sono parecchi in corso di sviluppo in Europa con investimenti pubblici e privati e la Commissione li incoraggerà, acquistando i primi lanci.

IN ATTESA DI UNA
NAVETTA EUROPEA PER ASTRONAUTI
Un argomento nuovo è brevemente emerso nei dibattiti della stessa Conferenza attorno alla capacità di trasporto di persone in orbita bassa (Leo). Gli astronauti europei raggiungono la Stazione spaziale internazionale come “passeggeri” a bordo di veicoli altrui. Così era
ai tempi dello Space Shuttle e poi della Sojuz; il servizio “taxi” agli astronauti europei era garantito da accordi intergovernativi. Non c’era altra ragione di portare persone nello spazio che per servire la Stazione.
Oggi il servizio taxi alla Stazione è assicurato dalla navetta Crew Dragon operata dalla società privata SpaceX Quando ci sarà in orbita quella moltitudine di stazioni e di servizi che gli analisti della space economy prevedono per i prossimi anni, potranno gli europei competere a parità di condizioni con i grandi del mondo, soprattutto Usa e Cina, senza un loro veicolo di trasporto abitato? Una risposta di “cambio di gioco” potrebbe venire allo Space Summit dell’Agenzia spaziale europea (Esa) previsto a novembre quest’anno.
Il direttore dell’Esa Aschbacher

ha informato che c’è al lavoro un gruppo di riflessione di intellettuali, scelti segretamente dall’Esa, campioni di esperienze e competenze le più diverse nei settori delle scienze umane - antropologia, filosofia, storia, giurisprudenza - che produrranno un rapporto per portare una proposta ben motivata sul tema allo Space Summit. È così possibile che rinasca un progetto europeo di capsula spaziale abitata, a lunga distanza dalla fine ingloriosa del progetto Hermes ormai più di 30 anni fa. Lo studio dovrebbe consentire anche di stimare i costi di un tale sviluppo; ciò che al momento si può dire è che le condizioni attuali sono piuttosto favorevoli, ma solo l’incontro di novembre potrà confermarlo.
*FRANCO MALERBA
È IL PRIMO ASTRONAUTA ITALIANO AD AVER VOLATO NELLO SPAZIO, NEL 1992. ORGANIZZA IL FESTIVAL DELLO SPAZIO DI BUSALLA (GE) ED È SOCIO FONDATORE DI START UP SPAZIALI.
LA RISCOPERTA DELL’
UNIVERSO VICINO
GRAZIE AL TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB STIAMO INDAGANDO L’UNIVERSO PIÙ LONTANO, MA ANCHE IL SISTEMA SOLARE…
Il telescopio spaziale James Webb (Jwst) ci ha subito affascinato con le sue riprese dell’Universo profondo e non manca di stupirci con osservazioni e scoperte di interesse cosmologico (vedi le Space news di questo numero). Ma i suoi strumenti non mancano di studiare anche l’ambiente più vicino a noi. E anche qui non mancano le sorprese.
L’OGGETTO PIÙ VICINO
Il 5 settembre 2022, sotto la guida di Geronimo Villanueva (Goddard Space Flight Center), sono state concesse sette ore al Jwst per osservare Marte. Trattandosi dell’oggetto più vicino (127 milioni di km) e luminoso (mag. = -0,5) osservato dal Jwst, l’osservazione è stata complessa per uno strumento studiato per riprendere oggetti debolissimi e lontanissimi. Per evitare la saturazione dei sensori, assieme alla naturale attenuazione dei filtri (per le immagini) o della fessura (per gli spettri), sono stati utilizzati i tempi di posa più brevi compatibili con la strumentazione (0,18 s).
La camera infrarossa NirCam ha ripreso l’emisfero di Marte centrato sulla Syrtis Major, dove si trovano il grande cratere Huygens (470 km) e il bacino Hellas (1930 km). Le immagini a 2,12 micron non sono molto diverse, sia come risoluzione che come differenze di albedo, da quelle ottiche riprese dal telescopio spaziale Hubble
Completamente diverso appare invece Marte a 4,3 micron, perché questa regione infrarossa è sensibile all’emissione termica: l’intensità è massima sulla Syrtis Major, dove il Sole batteva alla massima altezza, mentre l’emissione diminuisce a sud, vicino alla regione polare, e a nord, in piena stagione invernale. È interessante notare il calo di emissione infrarossa del bacino Hellas, che appare nettamente più scuro: non si tratta di temperature più basse, ma di assorbimento della radiazione da parte dell’atmosfera di anidride carbonica (CO2), che su Hellas, profondo 7 km, ha uno spessore superiore alla media.
L’atmosfera marziana è stata spettrografata nell’infrarosso dallo strumento NirSpec da 0,8 a
» Sopra: una ripresa di Giove con la NirCam del Jwst con filtri sensibili al metano a 2,12 micron (in arancio) e a 3,362 micron (in azzurro).

A sinistra: Marte ripreso dalla NirCam il 5 settembre 2022.

5,14 micron. Già a questo livello si possono individuare, oltre a molte bande della CO2, anche bande minori di monossido di carbonio e acqua. Il NirSpec doveva anche verificare la presenza di metano (CH4) nell’alta atmosfera, dove la sonda Trace Gas Orbiter non ha rilevato nulla, mentre il rover Curiosity ha misurato al suolo valori fino a 10 parti per miliardo. Al momento, la risposta di NirSpec è categorica: non c’è traccia di metano.
IN ATTESA DI PENETRARE LA GRS
Nell’ambito dei tredici progetti che sono stati assegnati ai primi cinque mesi (luglio-dicembre 2022) di osservazioni del Jwst, per rendere subito pubblici i risultati che dimostrano l’efficacia e le potenzialità del nuovo telescopio spaziale, sono state assegnate 45 ore per lo studio del sistema di Giove da parte di un team guidato da Imke de Pater (Università della California), La NirCam ha ripreso Giove per la prima volta il 28 giugno 2022 durante la messa a punto dello strumento, prima che iniziasse l’attività scientifica del Jwst. Quel giorno, Giove si trovava a 688 milioni di km e si muoveva a 46mila km/h, spostandosi tra le stelle a circa 0,2 secondi d’arco ogni minuto. Lo scopo primario di queste riprese era quello di testare la capacità di riprendere dettagli molto deboli in presenza di un oggetto molto luminoso e valutare le capacità di inseguimento del Jwst su un oggetto in “veloce” movimento relativo: per questo la posa è stata di 75 secondi. Sono state sovrapposte due pose infrarosse: una a 2,12 micron (falso
colore rosso) e l’altra a 3,32 micron (falso colore blu). Il filtro a 2,12 micron è sensibile all’emissione del metano e dello smog ad alta quota: appaiono in chiaro le regioni povere di metano quando sono situate a quote elevate, come nel caso della Grande macchia rossa (Grs) e di molti altri cicloni minori. Si vedono il sottilissimo anello polveroso di Giove e due piccoli satelliti collegati ad esso e che lo alimentano con la polvere che emettono: a destra Metis, uno dei “carabinieri” dell’anello principale assieme ad Adrastea, e a sinistra Thebe, il confinatore della parte più esterna ed espansa dell’anello gioviano, il cosiddetto “Velo”.
È visibile a sinistra (e talmente a fuoco da mostrare la figura di diffrazione) il satellite Europa, la cui ombra si vede come disco nero poco a sinistra della Grs. Che qui non appare rossa, in quanto è ripresa nell’infrarosso e riprodotta in falsi colori. La Grs sarà oggetto di una indagine speciale da parte della camera Miri, il cui campo spettrale arriva fino a 20 micron e potrà quindi penetrare in profondità e forse finalmente risolvere il mistero dei composti che conferiscono la colorazione rossa nelle immagini ottiche.
Giove è stato di nuovo osservato con la NirCam il 27 luglio 2022.

UN ASTEROIDE PER CASO
È un piccolo asteroide della Fascia principale, situato tra Marte e Giove. La sua scoperta è avvenuta per caso, nei dati ottenuti nella fase di calibrazione dello strumento Miri di Jwst che ha messo a fuoco l’asteroide (10920) 1998 BC1 per testare le prestazioni dei suoi filtri.
Durante l’analisi di questi dati, un team di ricerca del Max Planck Institute tedesco ha trovato un “intruso” nello stesso campo visivo. Il piccolo asteroide, in attesa di ulteriori osservazioni e per adesso ancora senza nome, è il più piccolo osservato finora dal Webb, con dimensioni simili a quelle del Colosseo, tra i 100 e i 200 metri di lunghezza (vedi in figura una illustrazione artistica).

Inquadra il QR per un video di Asi TV dedicato a questa scoperta.

Per quanto riguarda Europa, NirSpec ha fatto un’importante scoperta in corrispondenza della caotica Tara Regio sull’emisfero anteriore della luna. Qui nel 2017 Hubble aveva rilevato una forte emissione a 450 e 230 micron, indizio della presenza di cloruro di sodio degradato dalla radiazione cosmica. Nella stessa zona, NirSpec ha individuato un’intensa e insospettabile presenza di CO2 solida a 2,69 e 4,25 micron. Non sono però state rilevate tracce di emissioni di acqua dal Polo sud, che erano state intraviste alla fine del 2013 dallo spettrometro Stis di Hubble, a dimostrazione di un’attività probabilmente altalenante.
SPINGENDO LO SGUARDO VERSO SATURNO
Ai filtri precedenti è stata aggiunta una posa con un filtro a 3,624 micron e falso colore rosso, che evidenzia le attività aurorali su entrambi i poli del pianeta, essendo sensibile all’emissione aurorale tipica dello ione idrogenonio a circa 1000 km di altezza. Ben visibili l’anello e i due piccoli satelliti Adrastea (20 km a 129mila km da Giove) e Amaltea (250-150 km a 181mila km da Giove).
È da sottolineare che l’elaborazione
di queste immagini è stata eseguita da Judy Schmidt, un’astrofila californiana che da dieci anni si “diverte” a elaborare immagini di Hubble con la supervisione di Ricardo Hueso (Università spagnola dei Paesi Baschi).
Prolifica è stata anche l’azione del Jwst su due satelliti ghiacciati sospettati di attività geologica. Lo spettrometro NirSpec ha cercato tracce di attività emissiva da Europa e da Encelado il 4 ottobre 2022.
Titano ed Encelado sono i due satelliti più interessanti di Saturno. Titano (5149 km) è una specie di Terra primordiale, con la sua atmosfera di azoto, metano e idrocarburi. Si è conservato tale grazie alla sua gelida temperatura, ma possiede un’intensa meteorologia innescata da nubi e piogge di metano. Un programma osservativo del Jwst ha lo scopo di tenere sotto controllo l’atmosfera di questa luna. Le prime immagini ottenute il 4 novembre 2022 dalla NirCam sembrano promettenti: nella regione settentrionale, dove ha sede il
*CESARE GUAITA
LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL PLANETARIO DI MILANO.
grande lago di metano Kraken, sono stati individuati due grossi sistemi nuvolosi in movimento, confermati due giorni dopo dal telescopio Keck alle Hawaii. Il tutto in coerenza con l’aumentata evaporazione di metano innescata dall’estate boreale in atto. Diversa ma altrettanto sorprendente è la storia del piccolo Encelado (500 km), che fa da sorgente primaria per l’anomalo anello E di Saturno. NirSpec ha confermato l’emissione dal Polo sud di intensi getti di vapor d’acqua su una superficie ghiacciata, a dimostrazione di una attività persistente. Questi getti si estendono per oltre 10mila km, ossia almeno dieci volte di più di quanto era stato osservato dalla sonda Cassini
GLI ANELLI DI NETTUNO
Nell’ambito di un progetto gestito da K. Pontopidan (Space Telescope Science Institute), il 12 luglio 2022 è stata puntata la NirCam su Nettuno, a 2,7 miliardi di km di distanza: sono state realizzate impressionanti immagini sovrapponendo tre pose con i filtri F140M (falso colore blu), F210M (falso colore verde) e F460M (falso colore rosso).


Il disco di Nettuno appare blu nelle immagini ottiche per la presenza consistente di metano. Ma siccome il metano assorbe in infrarosso, le riprese della NirCam nostrano un disco abbastanza grigio, dove gli unici dettagli interessanti sono strisce di nuvole di alta quota, quindi emergenti dall’assorbimento del metano, sia nei dintorni del Polo sud del pianeta, sia attorno alla fascia equatoriale.
Il dettaglio più incredibile di queste immagini è la visione perfetta del sistema di anelli e bande di polvere
che circonda Nettuno sul piano equatoriale. Gli anelli erano stati intravisti nel 1989 dalla sonda Voyager 2, ma non erano mai stati ripresi nella loro interezza da Terra.
Nelle immagini Jwst si vedono anche sette dei 14 satelliti: Galatea, Naiad, Thalassa, Despina, Proteus, Larissa, e Tritone, la grande luna che rivoluzione in senso opposto alla rotazione del pianeta, forse in conseguenza di una cattura primordiale. Tritone, essendo

coperto di ghiaccio, riflette il 70% della luce solare e appare così brillante ai sensori della NirCam, da mostrare spettacolari raggi di diffrazione.
L’8 gennaio 2023 anche Urano è stato osservato (a media risoluzione) dalle camere NirCam e Miri. La NirCam ha ripreso parte dell’emisfero nord completamente offuscato da perturbazioni chiare, in conseguenza dell’incipiente stagione estiva. La Miri ha ripreso il pianeta
e gli anelli a 23,4 micron, quasi di piatto. Sono state riprese anche immagini ad alta risoluzione che sono in attesa di essere pubblicate. Tutte queste osservazioni, seppure preliminari, danno l’idea delle enormi potenzialità del Jwst anche verso lo studio dei pianeti extrasolari, un settore di ricerca nel quale sta già accumulando importati novità, degne di essere raccontate in un prossimo articolo.
UNIVERSI ARTIFICIALI
L’UMANITÀ POSSIEDE CONOSCENZE E TECNOLOGIE ANCORA LIMITATE, MA PUÒ VANTARE UNA FANTASIA SMISURATA
Molti scienziati sostengono che la vita sulla Terra non sia un’eccezione e che a dividerci da altre civiltà intelligenti siano soltanto problemi di comunicazione.
Uno studio dell’Università di Nottingham del 2020 suggeriva che dovrebbero esserci più di trenta civiltà aliene attive disseminate uniformemente nella Via Lattea, e comunicanti (Ceti, Communicating Extra-Terrestrial Intelligent civilisations), cioè che trasmettono onde radio nello spazio, come facciamo noi (vedi Cosmo n. 13).
Una stima che potrebbe essere estrapolata ad altre galassie in grado di ospitare civiltà tanto avanzate da essere in grado di sfruttare leggi della fisica che ancora non conosciamo. In effetti, malgrado i grandi successi ottenuti dalla “fisica moderna” a partire dall’inizio del XX secolo, abbiamo ancora dei modelli incompleti e perfino incompatibili della realtà. I fisici non sono ancora riusciti a operare una sintesi della meccanica quantistica e della relatività generale che porti a una teoria della “gravità quantistica”, capace di offrire una visione non contradditoria del mondo.
Esempi di situazioni in cui la gravità quantistica gioca un ruolo importante sono la struttura dello spazio
a piccolissima scala, le fasi finali dell’evaporazione di un buco nero, o le fasi iniziali della dinamica dell’Universo, subito dopo il Big Bang.
LA CREAZIONE DI UNIVERSI QUANTISTICI
Il mistero dei misteri è la provenienza del nostro Universo: che cosa c’era prima del Big Bang? Ci sono varie ipotesi che aspettano di essere sottoposte a verifica, o meglio che si trovi un modo per sottoporle a verifica. Sono stati elaborati modelli come quello di un Universo nato da una fluttuazione statistica del vuoto, o di un Universo ciclico, con ripetuti periodi di contrazione ed espansione, o addirittura emerso dal collasso della materia all’interno di un buco nero.
Ma nessuna di queste ipotesi è più paradossale di quella secondo la quale il nostro Universo sarebbe stato creato nel laboratorio di una civiltà tecnologica avanzata. Un’ipotesi da rigettare come pura fantasia antiscientifica, se non fosse che a sostenerla (a fine 2021) sia stato Avi Loeb, presidente del Board on Physics and Astronomy delle National Academies e direttore dell’Institute for Theory and Computation


RICERCA ET
DI GIORDANO CEVOLANI» A sinistra: l’illustrazione del concetto di gravità quantistica, come derivazione dalla relatività generale, dalla meccanica quantistica e da altre teorie (Future and Cosmos).


nell’Universo. Secondo i sostenitori di questo assunto, l’energia “positiva”, che è alla base della formazione della materia, sarebbe completamente compensata dall’energia “negativa”, rappresentata dalla gravità.
SCALE DI CIVILTÀ
L’astrofisico russo Nikolai Kardašëv propose negli anni 60 un’interessante scala di valori riguardo al progresso tecnologico di una civiltà, nella quale i progressi possono essere schematizzati tramite tre “livelli”: la civiltà di tipo I riesce a sfruttare tutta l’energia che arriva dalla stella intorno alla quale orbita il suo pianeta; quella di tipo II riesce a sfruttare tutta l’energia della stella, dunque anche quella che non raggiunge il pianeta; e quella di tipo III sfrutta tutta l’energia presente nella sua galassia.
presso l’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Loeb è anche l’autore di libri come Non siamo soli, in cui esamina i possibili indizi dell’esistenza di civiltà extraterrestri. Per Loeb, una civiltà avanzata potrebbe aver sviluppato una tecnologia in grado di creare un Universo dal nulla, attraverso il tunneling quantistico. Un fenomeno grazie al quale un oggetto quantistico può attraversare una barriera di potenziale anche se il suo livello di energia risulta inferiore al livello
minimo di energia richiesto per attraversare la barriera. Un risultato che richiede superpoteri tecnologici, ma che presuppone l’aver risolto il problema della gravità quantistica, arrivando così alla cosiddetta “Teoria del tutto”. Secondo Loeb, il sospetto che il nostro Universo possa essere stato creato artificialmente risiede in alcune delle sue caratteristiche principali, come la sua geometria “piatta” e un’energia netta pari a zero. Quest’ultima è una delle ipotesi più affascinanti riguardanti l’energia
Uno studio recente ha esaminato la potenzialità per gli esseri umani di raggiungere il livello I, prevedendo che si debbano attendere ancora 350 anni, quando l’umanità dovrebbe essere in grado di sfruttare appieno l’energia del Sole. In questo scenario, un professore di astrofisica dell’Università di Rochester, Adam Frank, suggerisce di fare un passo oltre i confini della realtà, chiedendosi se una civiltà tecnologica possa arrivare addirittura a modificare le leggi fisiche dell’Universo.
Superato questo limite, la scala di Kardašëv non sarebbe più adatta, in quanto a una civiltà del genere non interesserebbe più la raccolta di energia. Probabilmente, potrebbe crearla dal nulla.
E qui entra in gioco la “materia oscura”, l’inafferrabile materia la cui esistenza è stata appurata tramite
calcoli gravitazionali. Secondo l’astrofisico Caleb Scharf, questa materia potrebbe non essere di origine naturale, ma il risultato dell’opera di ingegneria di una civiltà avanzatissima. L’Universo, pervaso da radiazioni potentissime e scosso da onde d’urto prodotte da immani esplosioni, non sembra essere un posto molto adatto per la vita. Nella visione di Scharf, la materia
oscura potrebbe rappresentare una sorta di “assicurazione cosmica” progettata e realizzata a copertura di questi rischi.
Anche l’espansione dell’Universo potrebbe essere per Scharf l’opera di una civiltà intelligente. Una civiltà sufficientemente avanzata a livello tecnologico potrebbe aver avuto l’idea di far espandere l’Universo per evitarne la morte termica e quindi per sopravvivere in eterno. E questo richiama l’attenzione su un altro rompicapo della fisica contemporanea: l’energia oscura, che dovrebbe giustificare l’accelerazione dell’espansione dell’Universo,

rappresentando circa il 68,3% dell’Universo stesso, mentre il 26,8% sarebbe composto di materia oscura e alla materia ordinaria resterebbe un misero 4,9%.
IN ATTESA DI UNA “NUOVA FISICA”
Dietro la fisica classica e la fisica moderna c’è una realtà più profonda, meno disposta a seguire il filo del buon senso e meno accessibile agli esperimenti; un territorio sconfinato per le brillanti menti di fisici fondamentali, dalle quali ci aspettiamo il parto di una “nuova fisica”.
Per la nostra civiltà “ancora cosmologicamente sterile”, come la definisce Loeb, è inimmaginabile poter creare un altro mondo come quello che ci ha generati. Secondo lo scienziato, nella sua ipotetica scala di quattro classi che soppianta quella di Kardašëv, siamo confinati all’ultima classe (D), che rappresenta una civiltà che è in grado solo di distruggere il suo habitat naturale, come stiamo facendo sulla Terra con ottimi risultati. In questa scala, il livello più alto (A) compete a una civiltà in grado di ricreare condizioni cosmiche simili a quelle che hanno dato origine alla stessa civiltà e che riescono a creare degli universi “figli”. Dopo secoli di progressi scientifici e tecnologici, abbiamo scoperto di vivere in un Universo che per il 95 % ci risulta perfettamente sconosciuto. La nostra civiltà di cui siano tanto fieri è attualmente in grado solo di distruggere la culla in cui è nata. A questo punto, ci resta però una fantasia smisurata per immaginare nuove scoperte, nuovi progressi, nuove teorie, nuovi mondi.

MISURIAMO L’INQUINAMENTO LUMINOSO
IL PROGETTO “GLOBE AT NIGHT” DI CITIZEN SCIENCE RECLUTA VOLONTARI PER INDAGARE LA LUCE DEL CIELO

L’illuminazione artificiale rappresenta sicuramente la modifica più spettacolare e pervasiva che la nostra società abbia operato sull’ambiente a livello planetario.
La luce artificiale è una grande conquista, ma tendiamo a farne un uso eccessivo, dimenticandoci che tutte le forme di vita che si sono evolute sul pianeta Terra hanno bisogno del buio della notte. Avere le strade illuminate a giorno non fa abbassare la criminalità, ma le luci troppo brillanti si riflettono sulle superfici che illuminano e vengono diffuse dal pulviscolo e dall’aerosol presenti nell’atmosfera, creando aloni luminosi che sono straordinariamente efficaci a “spegnere” le stelle.
L’illuminazione sbagliata (diretta anche verso l’alto) ed eccessiva è uno spreco energetico che causa l’inquinamento luminoso, una forma di alterazione dell’ambiente naturale della quale siamo totalmente responsabili, anche se non ci facciamo grande attenzione.
RICONOSCERE LE CITTÀ DAL COLORE
La luce sprecata trasforma la superficie terrestre in uno spettacolo di grande bellezza che affascina gli astronauti della Stazione spaziale internazionale (Iss), che usano le luci per riconoscere le città che sorvolano di notte. Il colore dell’illuminazione varia da una parte all’altra del mondo: i giapponesi amano le lampade al mercurio che danno alle loro città un colore verdognolo.

Le città americane sono più giallastre, perché preferiscono le lampade al sodio. In Europa i sistemi convivono, con i centri storici più verdognoli e le parti esterne delle città, più recenti, dominate dal giallo, oppure bianche perché illuminate dai Led.
Le luci di Dubai sono decisamente bianche, a indicare che utilizzano esclusivamente i Led, che stanno conquistando mercato ovunque. Le città europee hanno struttura a raggiera, mentre quelle americane, così come le nuove città negli Emirati Arabi, sono squadrate con strade in direzione nord-sud ed est-ovest:
CIELO E TERRA DI
PATRIZIA CARAVEOuna versione moderna dei cardi e decumani degli accampamenti romani.
Fa eccezione Las Vegas. dove la celebre Strip, illuminata dalle enormi insegne dei casinò, disegna una brillante e coloratissima diagonale che gli astronauti dicono essere la macchia di luce più spettacolare del nostro pianeta. Sono stati prodotti video bellissimi per permettere a tutti di fare uno straordinario giro del mondo di notte, imparando a riconoscere le città sulla base della loro illuminazione.
L’inquinamento luminoso è subdolamente presente quasi ovunque, ma per avere idea della portata del problema e di come cambi nel tempo, occorre misurarlo su intervalli almeno decennali. Lo si può fare dall’alto, sfruttando di notte i satelliti di osservazione della Terra.
I satelliti meteorologici della Nasa e della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) sono stati utilizzati per produrre collage straordinari della Terra di notte, che si possono trovare in rete cercando
Earth at Night. Le foto, scattate alla mezzanotte locale in notti senza nuvole e senza Luna, sono utilissime per avere un’idea della situazione dell’inquinamento luminoso a livello globale.

In rete si trovano anche le foto fatte dagli astronauti dalla Iss. Sono immagini a più alta risoluzione che permettono di apprezzare molti più dettagli. Tutto quello che si vede è luce dispersa verso la volta celeste, assolutamente inutile ai fini dell’illuminazione: uno spreco scioccamente costoso che purtroppo, mediato su tutto il pianeta, aumenta del 2% all’anno.
IL PROGETTO GLOBE AT NIGHT
Per avere un’idea più locale della qualità del cielo, occorre lo sforzo di molti osservatori volontari, grazie all’iniziativa Globe at night. È un programma (già presentato nella nostra rubrica di Citizen science su Cosmo n. 4) che vuole aumentare il livello di consapevolezza dell’impatto dell’inquinamento luminoso,
» A sinistra: a mappa interattiva dell’inquinamento luminoso disponibile al sito nightearth.com. Inquadra il QR per una serie di riprese notturne delle città effettuate dalla Stazione spaziale internazionale. A destra: questo grafico illustra come la quantità di stelle visibili diminuisce all’aumentare dell’inquinamento luminoso. La scala numerica è simile a quella utilizzata dai partecipanti a Globe at Night.
chiedendo ai partecipanti di misurarlo con osservazioni a occhio nudo.
Prima di tutto occorre consultare il sito di Globe at night (bit.ly/3kzkfIf), che è disponibile in tutte le lingue, per capire quali sono i giorni giusti, dato che le misurazioni devono essere fatte nelle notti di Luna nuova, quando il cielo dovrebbe essere naturalmente buio.
Occorre anche controllare quale sia la costellazione da cercare nel cielo, e questo dipende dal momento dell’anno. Se la data è giusta e il cielo è sereno, bisogna uscire almeno un’ora dopo il tramonto e mettersi al lavoro. Non occorre essere esperti: basta abituarsi al buio prima di guardare in alto e cercare la costellazione che è stata suggerita (eventualmente seguendo le istruzioni). A questo punto, bisogna confrontare quello si vede con la mappa celeste visualizzata sullo schermo.
Lo scopo dell’esercizio è rendersi conto di quante stelle si riescono effettivamente a vedere, rispetto a quelle che dovrebbe essere visibili a
occhio nudo. Più stelle si vedono, migliore è la qualità del cielo. Al contrario, più alta è l’illuminazione parassita, meno stelle si riescono a vedere. La geolocalizzazione e l’orologio del cellulare risparmiano la fatica di inserire le coordinate locali e l’ora della misura. A questo punto, si deve solo inviare l’osservazione, che verrà inserita nella banca dati dell’inquinamento luminoso. È un esercizio semplice che permette di compilare una mappa dell’inquinamento luminoso dal basso nell’intervallo di frequenze alle quali è sensibile il nostro occhio. Ripetuto nel tempo, permette di seguire come evolve la situazione. In media, Globe at night può contare su 20mila misurazioni all’anno ottenute in giro per il mondo. Ovviamente, le misure sono a “macchia di leopardo”, con il maggior numero di rilevamenti eseguite in Europa e Stati Uniti. Ma l’Italia ha poche misurazioni e per questo occorre reclutare nuovi volontari per questa attività nel nostro Paese. Chi non riesce a farlo subito, non tema:
l’appuntamento si ripete con cadenza mensile (in effetti si tratta del mese lunare) nelle date che si trovano sul sito.
PER NON SPEGNERE LE STELLE
Utilizzando dieci anni di misurazioni, Globe at night ha prodotto un quadro molto poco rassicurante del crescere continuo dell’inquinamento luminoso misurato dal basso, che aumenta del 9,6% all’anno. È un dato veramente preoccupante, tanto più che risulta almeno quattro volte superiore all’aumento dell’illuminazione rivelata dal monitoraggio dall’alto, prodotto dai satelliti.

Come è possibile che misurando in due modi diversi la stessa quantità si arrivi a risultati così diversi?
Tutto sta nella sensibilità diversa degli strumenti che operano sui satelliti rispetto al nostro occhio.
Gli strumenti in orbita non sono sensibili alle lunghezze d’onda del blu-violetto, a differenza dell’occhio umano. La crescita dell’inquinamento
luminoso rivelato dai volontari è in gran parte dovuto alla diffusione dei Led, una tecnologia straordinaria che permette di produrre più luce a parità di consumo e che, quando vengono utilizzati Led a luce bianca, emette anche nel blu e nel violetto.
Erano stati in molti a sperare che l’introduzione dei Led avrebbe diminuito l’inquinamento luminoso, oltre alle spese per l’illuminazione. Invece, complice il basso costo di esercizio, vengono utilizzati Led troppo brillanti, che producono illuminazione inutile ed eccessiva, aumentando l’effetto alone.
Dai privati cittadini alle amministrazioni pubbliche, tutti devono resistere alla tentazione di montare lampade troppo brillanti e troppo bianche. Le lunghezze d’onda blu e violette sono quelle che disturbano maggiormente l’ecosistema e che influiscono di più sul nostro ritmo circadiano, perché interferiscono con la produzione di melatonina, l’ormone che regola il nostro ciclo sonno-veglia.
Per questo motivo, non bisognerebbe mai usare lampade con “temperatura di colore” superiore a 3000 gradi (un dato che si trova sulle confezioni).
Temperature più alte implicano emissione nel blu e violetto e conseguente inibizione della produzione di melatonina. Illuminare meglio è possibile. Scegliendo in modo oculato le luci, che devono essere direzionali (dirette solo verso il basso), intelligenti (accese solo al bisogno), del colore giusto (evitando la radiazione blu) e non eccessive, si può contribuire a preservare la biodiversità nell’ecosistema, a proteggere la nostra salute e a non spegnere le stelle.

MISTA E OCEANICA

Le eclissi non sono un fenomeno raro: ogni anno se ne verificano diverse, ma poche sono visibili da una stessa località. Questo è particolarmente vero per quelle di Sole, visibili solo da una parte limitata del globo terrestre. E così, mentre secondo le statistiche un’eclisse totale di Sole per la Terra nella sua globalità si verifica ogni 16-18 mesi, per una nazione come l’Italia le statistiche ne attribuiscono in media una al secolo. L’ultima ebbe luogo nel lontano 1961 e la prossima è prevista per il 2081! A rigore, sfiorerà l’Italia anche un’eclisse nel 2027, con la fascia della totalità di passaggio nelle nostre acque territoriali a sud dell’isola di Lampedusa. Questa rarità dipende dall’entità della superficie: più una nazione è ampia, più probabilità ha di avere un’eclisse. L’Italia, con i suoi 300 mila chilometri quadrati, costituisce solo 1/600 delle terre emerse e per questo sono rare le eclissi totali di Sole dalle quali è interessata. Ed è un vero peccato, perché un’eclisse totale di Sole è uno dei fenomeni astronomici più rilevanti e sicuramente il più coinvolgente: anche conoscendone la causa, è impossibile sottrarsi all’angoscia e al timore ancestrale da cui si è colti quando il disco della Luna copre integralmente quello del Sole. Per la Terra nella sua globalità le cose vanno meglio, anche se spesso le eclissi si verificano in regioni scarsamente accessibili; l’ultima eclisse totale di Sole, che ha interessato l’Antartide, si è verificata il 4 dicembre 2021 e la prossima, che sarà visibile dal Nord America, è attesa per l’8 aprile 2024.

Questa è l’eclisse per la quale Cosmo sta organizzando un viaggio che consentirà di osservarla nelle migliori condizioni, che si verificheranno nel nord-ovest del Messico (per informazioni, vedi bit.ly/3ZFdeVg).
IL PERCORSO DELL’ECLISSE
Quella del 20 aprile è un’eclisse piuttosto atipica, in quanto ha la particolarità di essere “mista”: un po’ totale e un po’ anulare. Questa condizione si verifica quando la distanza della Luna è tale che l’estremità del suo cono d’ombra lambisce appena la superficie terrestre e questo solo nelle regioni più prospicienti alla Luna.
L’eclisse, che è del tutto invisibile dall’Italia, inizia all’alba nell’Oceano Indiano meridionale come anulare, con Sole e Luna proiettati nella parte sud-occidentale della costellazione dell’Ariete. Ma già dopo poche centinaia di chilometri diviene totale. Poi, spostandosi verso nordest, la sottile striscia della totalità
lambisce la punta nord-occidentale dell’Australia, per raggiungere l’isola di Timor.
Qui, cioè intorno ai 10 gradi di latitudine sud, si ha la fase massima dell’eclisse, purtroppo con una durata molto breve, prevista in solo 1 minuto e 16 secondi. Questo è un fatto normale per le eclissi ibride, per le quali al centro della Terra il disco lunare non arriva neppure a eguagliare quello solare. Infatti, in questa occasione la Luna, a 375.600 km, ci sottende un diametro di 1908” contro i 1911” del Sole, dal quale distiamo 150,27 milioni di km.
Dopo Timor, la sottile striscia della totalità (larghezza massima di 49 km) tocca la Papua Occidentale per poi proseguire nell’Oceano Pacifico, dove torna a essere anulare per le ultime centinaia di chilometri del suo percorso.
La distanza dall’Italia dei luoghi dove l’eclisse è totale, la breve durata della fase clou del fenomeno e il suo percorso oceanico che si limita a lambire poche terre emerse, sono
FENOMENO DEL MESE
DI WALTER FERRERIfattori che hanno condizionato l’organizzazione di viaggi per seguirla, benché sia l’unica eclisse totale di Sole del 2023 (ce ne sarà un’altra il 14 ottobre, ma solo anulare). In effetti, per il viaggio organizzato da Cosmo si è preferito puntare sull’eclisse dell’aprile 2024 che è decisamente più favorevole, anche per motivi climatici.


UN’ECLISSE PERLATA
Le fasi da anulare a totale e viceversa sono caratterizzate da quelle in cui l’eclisse è “perlata”. Cosa vuol dire? Che tra le due condizioni si verifica quella in cui il disco della Luna copre esattamente quello del Sole. Ma, poiché il disco lunare è caratterizzato da rilievi e depressioni, ovvero non è una sfera liscia ma corrugata, ne consegue che attraverso queste irregolarità lascia passare i raggi solari, che si presentano come punti molto luminosi lungo tutta la circonferenza del disco. Questi punti sono chiamati “grani di Baily”, dal nome dell’astronomo inglese che li osservò e descrisse per primo nel 1836. È incredibile come anche da una minuscola porzione della superficie solare, resa visibile da una depressione lunare, fuoriesca una quantità di luce tale da provocare un forte illuminamento. Un celebre fenomeno di questo tipo si verificò vicino all’Italia nel 1966 e fu visibile soprattutto dalla Grecia. Chi avrà l’occasione di vedere la totalità potrà ammirare a fianco del Sole i due pianeti più brillanti: Venere e Giove. Il primo sarà molto più evidente, perché sette volte più luminoso di Giove, che, inoltre, sarà angolarmente più vicino al Sole. Più problematico sarà avvistare a occhio
» Sopra: la mappa dell’eclisse totale di Sole del 22 aprile. La linea di colore blu indica la fascia della totalità. Inquadra il QR per vedere una animazione dell’eclisse. A sinistra: il Sole tra Giove e Venere durante l’eclisse del 20 aprile (Stellarium).

LA PRIMA ECLISSE ITALIANA
La prima registrazione affidabile di un’eclisse totale di Sole vista da una regione italiana si riferisce a quella osservata in Sicilia il 15 agosto 310 a.C. ed è contenuta nella Biblioteca storica di Diodoro Siculo del primo secolo a.C. Raccontando la fuga da Siracusa del tiranno Agatocle, che forzò il blocco delle navi cartaginesi, Diodoro riferisce: “Raggiunsero la salvezza insperatamente sul far dell’alba. Il giorno successivo ci fu un’eclisse di Sole, nel corso della quale scese il buio più fitto e le stelle furono viste splendere per tutto il cielo.”

In realtà, in queste circostanze il cielo non diviene mai molto buio, soprattutto perché è illuminato dalle regioni circostanti il cono dell’eclisse.
una notevole oscurità, in quanto il cono d’ombra che raggiunge la superficie terrestre è molto ridotto; perciò, a non molti chilometri dal centro si incontra già il cielo circostante illuminato. Da una regione immensamente più ampia l’eclisse è visibile come parziale, dall’Antartide a tutta l’Australia, in Tasmania e in parte della Nuova Zelanda. E così anche in molti altri stati nella regione equatoriale e a nord dell’equatore come Indonesia, Malesia e più a nord fino a Taiwan e parte del Giappone. L’entità della porzione di disco solare eclissato dipende dalla distanza dalla fascia della totalità. Da Bali si vede oltre l’80% del disco eclissato, mentre dal Giappone meridionale la porzione scende a meno del 10%.
SEGUIRE E FOTOGRAFARE L’ECLISSE
Per seguire e fotografare un’eclisse, è sufficiente uno strumento compatto, come un piccolo rifrattore da 60-70 mm di diametro. La fotografia della corona, anche utilizzando una fotocamera a formato intero (24x36 mm) dà molta soddisfazione con strumenti dalle dimensioni contenute.
Come caso estremo, per registrare il fenomeno si può utilizzare anche solo una fotocamera bridge; molti di questi modelli hanno uno zoom così esteso da non far rimpiangere i piccoli telescopi.
nudo Mercurio, che in tale occasione sarà molto poco luminoso, con una magnitudine di 2,4, neppure al livello della stella Polare.
Per esperienza, durante le eclissi totali di Sole, a occhio nudo si riescono a
scorgere stelle solo fino alla prima magnitudine. Ma, ovviamente, molto dipende dall’acuità visiva dell’osservatore e dalla limpidezza del cielo. In ogni caso, durante questa eclisse non si dovrebbe raggiungere
In Italia, per un’eclisse parziale di Sole, dopo quella del 25 ottobre scorso, dovremo attendere il 29 marzo 2025, tra l’altro molto modesta per il disco solare appena intaccato dalla Luna e addirittura invisibile per le regioni più meridionali del nostro Paese. Andrà meglio con quelle seguenti del 12 agosto 2026 e del 2 agosto 2027; la prima di queste sarà totale anche alle Baleari, mentre per la seconda la totalità lambirà le nostre acque poco a sud di Lampedusa. In questi casi la percentuale del disco oscurato in Italia sarà altissima, ma allora varrà la pena di fare un viaggio per vederne la totalità.
*WALTER FERRERI SI È OCCUPATO DI RICERCA
SCIENTIFICA, DI TELESCOPI E DI ASTROFOTOGRAFIA PRESSO
L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO. NEL 1977 HA FONDATO LA RIVISTA ORIONE.
IL PLANISFERO CELESTE / APRILE
» Il cielo visibile da Roma alle 01h 00m TC a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia.

il SOLE
la LUNA

fenomeni LUNARI
il 6 alle 6h 34m
il 13 alle 11h 11m
il 20 alle 6h 12m
il 27 alle 23h 19m
il 5 maggio alle 19h 34m
Massime librazioni in longitudine
l'8 alle 10h - visibile
il lembo orientale
il 22 alle 0h - visibile
il lembo occidentale
il 4 maggio alle 23h - visibile
il lembo orientale
Massime librazioni in latitudine
il 14 alle 5h - visibile
il Polo nord
il 27 alle 16h - visibile
il Polo sud
l'11 maggio alle 10h - visibile
il Polo nord
Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 0h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
Perigeo 367.968 km il 16 alle 4h 23m
Apogeo 404.299 km il 28 alle 8h 43m
Perigeo 369.343 km l'11 maggio alle 7h 05m
CIELO DEL MESE
DI TIZIANO MAGNI
SOLE e PIANETI
SOLE
Dopo aver superato l'equatore celeste, il 19 si sposta dai Pesci nell’Ariete, scalando rapidamente il ramo ascendente dell'eclittica settentrionale: l'arco diurno tracciato dall'astro del giorno è sempre più esteso e le ore di luce aumentano nel corso del mese di 65 minuti per il meridione d'Italia, ma di quasi 100 per le estreme regioni settentrionali del Paese.
MERCURIO
È visibile al tramonto fino al 21 nella miglior apparizione serale dell’anno: sin dall’inizio del mese cala dopo il termine del crepuscolo nautico e risulta osservabile nelle migliori condizioni fino al 18, quando la sua luminosità diminuisce fino alla 1a magnitudine. Dal 7 al 15 tramonta dopo il termine del crepuscolo astronomico e il 12 raggiunge la massima elongazione est dal Sole di 19°,5. Inizialmente si trova nei Pesci, ma il giorno 3 entra nell’Ariete; il 21 è stazionario quindi assume moto retrogrado.
VENERE
Con la sua elevata luminosità domina l’orizzonte nordoccidentale nelle ore che seguono il tramonto. Il giorno 7 il suo veloce moto diretto lo porta dall’Ariete nel Toro, dove il 10 è in congiunzione con le Pleiadi, 2°,7 a sud dell’ammasso, e il 20 con Aldebaran (Alfa Tauri), 7°,5 a nord; il 17 è al perielio.
Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese.

La mappa, in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.

MARTE
È visibile per buona parte della notte nei Gemelli, che attraversa rapidamente, grazie al suo veloce moto diretto. Il 5 è in congiunzione con Mu Geminorum, 2°,8 a nord della stella di 3a magnitudine, il 14 è protagonista di una stretta congiunzione con Epsilon Geminorum, con un passaggio appena 9' a sud della stella; il 30 transita 2° a nord di Wasat (Delta Geminorum). La sua visibilità va gradualmente diminuendo e a fine mese tramonta mezz’ora circa dopo la mezzanotte locale.
Effemeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate. Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra).
Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
GIOVE
È visibile poco dopo il tramonto, profondamente immerso nelle intense luci del crepuscolo, solo nei primissimi giorni del mese, quindi viene rapidamente avvicinato dall’astro del giorno con il quale è in congiunzione superiore il giorno 12.
SATURNO
È visibile all'alba alcuni gradi a ovest della stella di 5a magnitudine Sigma Aquarii, alla quale va lentamente avvicinandosi. Nella seconda decade la sua levata precede la comparsa delle prime luci dell’alba e a fine mese anticipa di circa 40 minuti l’inizio del crepuscolo astronomico.
URANO
È marginalmente visibile di sera, nell’Ariete, fino al giorno 18, quando la sua calata arriva ad anticipare il termine del crepuscolo, divenendo inosservabile.
NETTUNO È inosservabile per l’intero mese a causa della vicinanza all’astro del giorno.

Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara.
Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.

FENOMENI del mese
1-2
LUNA E REGOLO
Il cielo notturno è dominato, dalla scomparsa degli ultimi bagliori del tramonto fino all’accendersi delle prime luci dell’alba, dalla luminosa presenza della Luna gibbosa crescente. Il nostro satellite naturale si muove nella costellazione zodiacale del Leone, avvicinandosi progressivamente a Regolo, con cui è in congiunzione alcune ore dopo la loro discesa sotto l’orizzonte occidentale. La migliore configurazione osservabile si concretizza alle 5:00 TC del 2 aprile, poco prima dell’inizio del crepuscolo astronomico, con la Luna meno di 6° a nord-ovest di Alfa Leonis ed entrambi ormai prossimi alla linea dell’orizzonte.

LUNA E SPICA DI SERA
Poco più di mezzora dopo la calata del Sole, con le luci del tramonto ancora evidenti, sull’orizzonte orientale è possibile assistere alla levata contemporanea della Luna Piena e della bianco-azzurra scintilla di Spica. La distanza apparente tra il nostro satellite naturale e Alfa Virginis raggiunge il minimo valore di 2°,7 poco dopo le 21:00 e precede di una ventina di minuti la congiunzione in Ascensione Retta, raffigurata nel disegno. La separazione andrà poi aumentando progressivamente con il trascorrere delle ore, superando i 4°,5 tra le luci all’alba, quando la costellazione della Vergine si va adagiando sull’orizzonte occidentale.
LUNA E ANTARES PRIMA DELL’ALBA - OCCULTAZIONE DI SIGMA SCORPII
Nelle ore che precedono l’alba, è osservabile in prossimità del meridiano la caratteristica figura zodiacale dello Scorpione, tra le cui stelle è in transito la Luna gibbosa calante, illuminata per l’84%. Il nostro satellite naturale va avvicinandosi ad Antares, con cui sarà in congiunzione in Ascensione Retta, 42’ a nord di Alfa Scorpii, nel corso della giornata.
Nella marcia di avvicinamento ad Antares, la Luna transita davanti alla stella Sigma Scorpii, di magnitudine +2,9, la cui scomparsa sul bordo lunare orientale illuminato dal Sole è osservabile tra le 4:50 (AO) e le 5:13 (CT e LE) di Tempo Civile, mentre la riapparizione da dietro il lembo lunare oscuro si verifica a partire dalle 5:51 (AO) con il cielo che va schiarendo, in misura maggiore per le regioni meridionali e orientali, per l’ormai imminente levata del Sole.

VENERE E PLEIADI DI SERA
Una bella configurazione celeste è quella visibile all’inizio della seconda decade del mese al termine del crepuscolo serale, quando Venere, animato da veloce moto diretto, transita 2°,7 a sud delle Pleiadi. Il movimento del pianeta è facilmente rilevabile anche a distanza di un solo giorno. Da notare la presenza, in prossimità dell’orizzonte, dell’elusivo Mercurio nei giorni di massima visibilità serale.
Il disegno raffigura l’orizzonte occidentale alle 21:20 TC del 10 aprile, un’ora e mezza circa dopo il tramonto del Sole.
16
LUNA E SATURNO ALL’ALBA
MARTE ED EPSILON GEMINORUM IN CONGIUNZIONE
Nelle ore che seguono il tramonto del Sole, alta sull’orizzonte occidentale è ben visibile la rossa scintilla di Marte che sta attraversando la costellazione dei Gemelli. La sera del 14 il pianeta è protagonista di una congiunzione particolarmente ravvicinata con Epsilon Geminorum (Mebsuta): Marte transita appena 9’ a sud della stella di 3a magnitudine. La minima distanza apparente viene raggiunta poco dopo la calata del Sole e con il cielo rischiarato dalle luci del tramonto, aumentando però solo marginalmente fino al termine del crepuscolo astronomico, quando il pianeta e la stella sono osservabili senza difficoltà.
Visibile all’alba, inizialmente con qualche difficoltà, in prossimità dell’orizzonte orientale, a partire dalla seconda decade di aprile Saturno sorge prima dell’inizio del crepuscolo astronomico. La mattina del 16 sopra l’orizzonte è presente anche la falce calante della Luna, transitata 4°,5 a sud del pianeta poco prima della loro levata; la migliore condizione osservabile si realizza tra le 5:00 e le 5:30 di Tempo Civile, con i due protagonisti bassi sull’orizzonte tra le luci dell’alba che vanno intensificandosi.


29 MAR - 18 APR
MERCURIO AL TRAMONTO
Per buona parte del mese il pianeta più interno del Sistema solare risulta osservabile con relativa facilità tra le luci del tramonto, in prossimità dell’orizzonte nord-occidentale, nella migliore apparizione serale dell’anno. Il giorno 12 raggiunge la massima elongazione orientale di 19°,5, ma il periodo di miglior visibilità si estende dal 29 marzo al 18 aprile, con Mercurio che cala dopo il termine del crepuscolo nautico. Solo negli ultimi giorni la sua luminosità, in rapida diminuzione, lo rende sempre più difficile da osservare.
Per poter ammirare il pianeta è indispensabile un cielo limpido e un orizzonte libero da ostacoli come raffigurato nel disegno, che mostra le posizioni del pianeta rispetto alla linea dell’orizzonte alla fine del crepuscolo nautico per tutto il periodo compreso tra il 29 marzo e il 23 aprile.
ECLISSI ANULARE-TOTALE DI SOLE
Inizia alle 3:34 del giorno 20 con il primo contatto tra il cono della penombra lunare e la superficie terrestre nell’Oceano Indiano un’eclissi ibrida anulare-totale di Sole, di magnitudine 1,013, visibile dall'Oceano Indiano meridionale, Antartide, Australia, Indonesia, Papua, Oceano Pacifico, ma non dall’Italia.

La parte anulare del fenomeno è ridotta alle sole fasi iniziali e finali, risultando invece prevalente quella totale; la fascia di totalità attraversa l'Oceano Indiano passando a nord dell’isola Kerguélen, lambisce le coste nord-occidentali dell’Australia Orientale, interessando il golfo di Exmouth quindi tocca l’isola di Timor, dove viene raggiunta la fase massima dell’eclissi con una durata della totalità di 1m 16s, per poi transitare sulla Papua occidentale e dirigersi infine nell’Oceano Pacifico, dove il fenomeno si concluderà alle 8:59 TC (vedi l’articolo di W. Ferreri a pag 48).
20-23
LUNA, VENERE E ALDEBARAN DI SERA
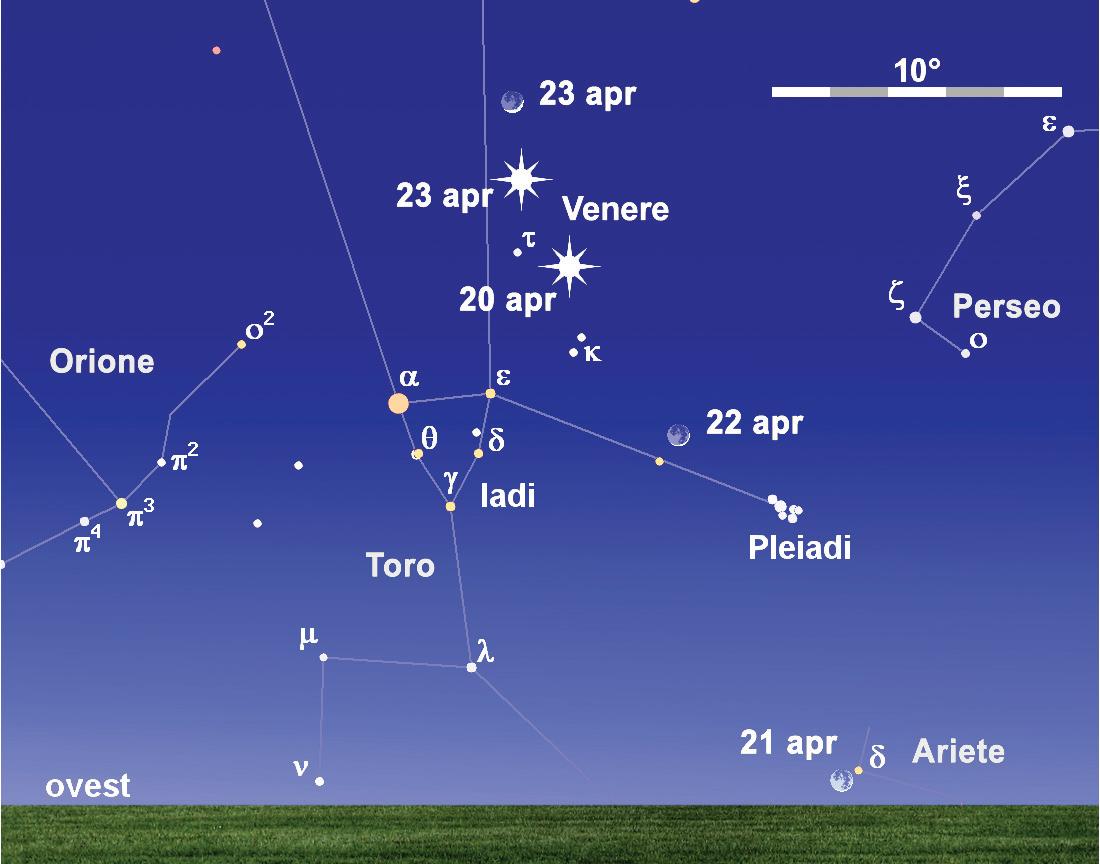
Prosegue il rapido transito di Venere tra le stelle del Toro che, dopo quella con le Pleiadi della prima parte del mese, la sera del 20 aprile è protagonista di un’ampia congiunzione con Aldebaran: il pianeta condivide con Alfa Tauri lo stesso valore dell’Ascensione Retta ma rispetto alla stella si trova 7°,5 più a nord.
Nei giorni seguenti la costellazione è interessata anche dal passaggio della falce crescente della Luna, con diverse congiunzioni di particolare interesse. La mattina del 22 il nostro satellite naturale è in congiunzione con le Pleiadi, 2°,6 a sud dell’ammasso; è poi il turno di Aldebaran, che il 23 viene superata poco meno di 8° più a nord: la congiunzione si verifica nelle ore diurne. Sempre il 23, nel primo pomeriggio, la falce lunare transita 1° a nord di Venere e nelle ore serali è possibile ammirarla 2°,8 “sopra” il pianeta. Il disegno mostra le diverse configurazioni celesti visibili alle 20:40 TC delle date indicate, approssimativamente al termine del crepuscolo serale.
MASSIMO DELLO SCIAME DELLE LIRIDI
Nella seconda parte del mese è attivo lo sciame meteorico delle Liridi, le cui particelle provengono dalla cometa C/1861 G1 (Thatcher), osservata in un solo passaggio e il cui periodo orbitale è di oltre 400 anni. Si tratta di uno sciame con un’attività moderata e che varia di anno in anno in maniera difficilmente prevedibile, con valori dello Zhr (il tasso orario di attività con il radiante allo zenit) compresi tra 14 e 23 ma che nel 1982 ha raggiunto, per un breve intervallo, le 90 meteore orarie. Il massimo dovrebbe verificarsi la mattina del giorno 23, in totale assenza di disturbo da parte della Luna: lo sciame dovrebbe produrre un numero significativo di meteore nelle ore che precedono l’alba.
25-26
CONGIUNZIONE LUNA-MARTE
Nelle ore che seguono il tramonto è possibile osservare una bella configurazione celeste con protagonisti Marte e la Luna: il nostro satellite naturale va lentamente avvicinandosi al Pianeta rosso, con cui viene a trovarsi in congiunzione in Ascensione Retta, ma 2°,4 più a nord, alle 4:47 TC del 26, alcune ore dopo la loro calata sotto l’orizzonte nord-occidentale.
La migliore configurazione osservabile è quella che si verifica poco prima del tramonto dei due astri, intorno alla 1:45 TC, con la falce crescente della Luna 3°,2 a “destra” di Marte. 30 APR - 4 MAG
OPPOSIZIONI DI (7) IRIS E (32) POMONA
Nell’ultima decade del mese è possibile osservare ben due pianetini nella stessa zona della costellazione zodiacale della Bilancia, in prossimità del confine con la Vergine.

Il più luminoso è (7) Iris, in opposizione il giorno 30 quando raggiunge la magnitudine +9,6, rintracciabile poco più di 7° a sud-ovest di Alfa Librae, di magnitudine +2,7. (32) Pomona è di magnitudine +10,4 all’opposizione al Sole del 4 maggio: il suo movimento retrogrado lo porta a transitare nelle immediate vicinanze della stessa Alfa Librae, 15’ a sud-ovest della quale è rintracciabile la notte tra il 25 e il 26 aprile; la mattina del 1° maggio è invece 12’ a sud di 5 Librae, di magnitudine +6,3.
Il disegno riporta tutte le stelle fino alla magnitudine +11.
I testi completi dei fenomeni sul prossimo numero di Cosmo e sul sito
UN GRAZIOSO FELINO FRA LE
STELLE
PASSEGGIAMO TRA LE STELLE DELLA LINCE ALLA RICERCA DELLO SCOMPARSO GATTO DEI CIELI
Dal momento che in cielo sono presenti molti animali, con tre costellazioni dedicate ai cani (il Cane Maggiore, il Cane Minore, i Cani da caccia), molti si chiedono perché manca invece una costellazione del Gatto
In effetti, tale costellazione esisteva sino a cent’anni fa ed è riportata nello storico atlante Uranographie di Johann Elert Bode, astronomo tedesco vissuto tra il XVIII e il XIX secolo. Era stato Joseph Jérôme de Lalande, grande amante dei gatti, a creare nel 1799 la simpatica costellazione, con una motivazione molto semplice, riportata dallo storico statunitense Richard Hinckley Allen (Star Names, Their Lore and Meaning): “C’erano già trentatré animali in cielo; io vi ho aggiunto il trentaquattresimo, il gatto”. E con un pizzico d’ironia aveva poi aggiunto: “Amo molto i gatti. Farò sì che questa figura felina compaia nella mappa stellare. Del resto, ho dedicato così tanta attenzione al cielo nella mia vita che ora, credo, posso permettermi di divertirmi un poco”.
Che fine ha fatto allora il Gatto, che compariva anche sul planisfero realizzato da Padre Secchi nel 1878, comodamente accucciato tra l’Idra e l’Antlia?
La costellazione è stata rimossa nel 1922 dall’Unione Astronomica
Internazionale, sotto la spinta del grande divulgatore Camille Flammarion, che evidentemente non nutriva simpatie per questa graziosa bestiola. Ne è rimasta solo un flebile traccia nella HD 85951, una stellina di 5a grandezza nell’Idra, che in onore della costellazione scomparsa è stata denominata Felis
DAL GATTO AL GATTONE
Scomparso il gatto, in cielo è tuttavia presente la Lince, che in fondo è un… gattone. È una costellazione alquanto estesa, soprattutto in declinazione, che copre 545 gradi quadrati. Fu creata attorno al 1660 da Hevelius, che la inserì
OSSERVAZIONI
» La mappa della costellazione della Lince riporta gli oggetti menzionati nel testo.
» Il lontanissimo ammasso globulare NGC 2419 in un’immagine del telescopio spaziale Hubble


nel suo Prodromus Astronomiae con l’intento di riempire i vuoti presenti fra alcune costellazioni maggiori. Essendo solo un “tappabuchi”, è mal riconoscibile, contrassegnata da stelle poco luminose. La si può individuare fra l’Orsa Maggiore, situata a nordest, l’Auriga a ovest e i Gemelli a sud-ovest.
La stella più brillante è la n. 40 della numerazione di Flamsteed, alla quale è stata assegnata la lettera Alfa, secondo la classificazione di Bayer. Alfa Lyncis è situata all’estremità sud-orientale della costellazione ed è una stella di 3ª grandezza di classe spettrale avanzata, che al binocolo
DI PIERO MAZZAmostra una colorazione rossastra. La sua distanza è di 220 anni luce ed è oltre 200 volte più brillante del Sole.
Segue al secondo posto la 38 Lyncis, di 4ª grandezza, una stella bianca distante 120 anni luce e 30 volte più brillante della nostra stella. Sempre di 4ª, ma un po’ più debole della precedente, è la 31 Lyncis, situata in posizione abbastanza centrale; è una gigante arancione di spettro K5, distante 390 anni luce e 230 volte più luminosa del Sole. Essendo visibile a occhio nudo con una certa facilità, costituisce un comodo riferimento nella ricerca
di oggetti deboli, se dalla parte sud-orientale dell’Orsa Maggiore desideriamo dirigerci verso l’Auriga e i Gemelli.
IL PROFONDO CIELO DELLA LINCE
NGC 2419, noto anche come Caldwell 25, è un ammasso globulare di 9a grandezza e quindi alla portata di un piccolo telescopio.
È situato a circa 300mila anni luce dal centro galattico ed è uno dei globulari più distanti osservabili con strumentazione amatoriale. La sua orbita sembra assimilabile a quella delle Nubi di Magellano, ma

è considerato comunque un oggetto della Via Lattea.
Con un’orbita così estesa, NGC 2419 impiega non meno di tre miliardi di anni per compiere un giro completo intorno alla nostra Galassia. In un riflettore da 20 cm di diametro appare rotondo con un diametro di un paio di primi, ma non è risolvibile in stelle neppure forzando gli ingrandimenti, come se fosse una piccola galassia ellittica; è allineato con due stelle brillanti di 7a grandezza ed equidistante da loro. In questa costellazione si trovano alcune galassie degne di nota. Una delle più appariscenti è NGC 2683, scoperta da William Herschel nel 1788 e denominata “Galassia Ufo” a causa della sua forma simile a un disco volante visto di taglio. Distante circa 25 milioni di anni luce, si osserva a ridosso del confine con il Cancro, dove si presenta come un fuso relativamente compatto e gradatamente più brillante verso l’interno. È facilmente osservabile in un 25 cm, con alto gradiente di luce, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 6’×1’ e con bulge diffuso. Appare leggermente arcuata, con la
concavità rivolta verso nord-ovest; tre deboli stelline quasi allineate da NW a SE attraversano la galassia verso l’estremità di nord-est.
NGC 2337 è stata scoperta nel 1877 da Édouard Stephan, direttore dell’Osservatorio di Marsiglia e scopritore del celebre Quintetto di galassie che porta il suo nome.
È una galassia nana irregolare di tipo magellanico, situata a una distanza di circa 20 milioni di anni luce.
Ha un diametro di circa 20mila anni luce e presenta segni di attività di formazione stellare, probabilmente a causa di passate interazioni gravitazionali con altre galassie.
Si trova al confine con l’Auriga e in un telescopio da 30 cm appare piuttosto debole, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60”×45”. Tre stelle brillanti, quasi allineate da nord a sud, si trovano a ovest della galassia.
Una galassia debole, ma molto interessante è IC 2233, scoperta nel 1894 dall’astronomo britannico Isaac Roberts. È una lama di luce orientata da nord a sud, di aspetto uniforme, che in visione distolta appare estesa per circa 4’; c’è una
stellina all’interno verso il bordo settentrionale. Oltre a essere debole persino in un telescopio da 40 cm, è anche disturbata da una stella doppia stretta, situata quasi a ridosso verso est, la cui componente più brillante è di decima grandezza. Assomiglia molto a NGC 100 nei Pesci, un’altra tipica galassia vista perfettamente di taglio.
NGC 2541 è un’altra galassia debole, con una luminanza superficiale molto bassa, scoperta da Herschel nel 1788 assieme ad altre componenti di un piccolo gruppo di galassie che fa capo a NGC 2841 nell’Orsa Maggiore. Si trova in mezzo a due stelline relativamente brillanti distanti poco meno di 4’ in direzione NNE-SSW. In un telescopio da 25 cm a un centinaio di ingrandimenti appare molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme e con un diametro che in visione distolta arriva a un paio di primi.
UNA DIAFANA BOLLA DI SAPONE
Chiudiamo con la nebulosa planetaria PK 164+31.1, situata nella parte alta della Lince, 6° a sud
dal confine dell’Orsa Maggiore, a una distanza di circa 1600 anni luce. Pur essendo debole ed estesa, diviene relativamente semplice da osservare in uno strumento da 25-30 cm con un filtro OIII. È stata scoperta nel 1939 da Rebecca B. Jones e Richard Emberson su una lastra fotografica acquisita con il rifrattore da 40 cm dell’osservatorio di Oak Ridge (Massachusetts). Per trovarla, conviene partire dalla 27 Lyncis e
spostarsi di 2,5 gradi verso NW. Come tutte le planetarie, ha una struttura e una forma dovute all’espansione del guscio di gas espulso da una stella morente.
Al centro si trova infatti una nana bianca, la cui intensa radiazione ultravioletta eccita e illumina l’involucro di gas, composto prevalentemente da idrogeno, con la presenza di ossigeno due volte ionizzato che può essere


pertanto selezionato dal filtro OIII. L’area centrale ha una forma circa rettangolare, mentre la nebulosa appare di forma circolare.
*PIERO MAZZA MUSICISTA DI PROFESSIONE, È UN APPASSIONATO VISUALISTA, CON MIGLIAIA DI OSSERVAZIONI DEEP SKY CONSULTABILI DAL SITO WWW.GALASSIERE.IT





LA COMETA DI

NEANDERTHAL
OSSERVAZIONI
Sono tantissime le immagini della C/2022 E3 ZTF pubblicate in rete, molte delle quali decisamente spettacolari. Fra queste, le Apod (Astronomy Picture Of the Day, bit.ly/3XHWUSb) dei giorni 9, 21, 27, 28 e 31 gennaio 2023: una delle quali ripresa da Dario Giannobile, collaboratore di Cosmo
E così ancora a febbraio, nei giorni 3, 7, 10 e 13, con l’avvicinamento della cometa al pianeta Marte, ripreso da un altro astrofilo italiano, Donato Lioce, e ancora il 21 febbraio e il 1° marzo.
Non dimentichiamo infine le foto realizzate dai lettori di Cosmo, pubblicate sul sito della rivista (bfcspace. com/?s=ztf). In particolare, inquadra il QR per un video realizzato da Graziano Ventre che mostra il movimento della cometa tra le stelle nella notte tra il 22 e il 23 gennaio.

Èstata soprannominata la “Cometa di Neanderthal”, perché il suo precedente passaggio al perielio risale a circa 50mila anni fa, quando questi ominidi non si erano ancora estinti. All’inizio del 2023 ha catalizzato l’interesse degli astrofili e del grande pubblico, con una serie di eventi organizzati per la sua osservazione nei giorni di massima visibilità.
La mia prima osservazione della C/2022 E3 ZTF, scoperta il 2 marzo 2022 nel corso della Zwicky Transient Facility, risale al mattino del 14 gennaio 2023, quando era già passata al perielio (il 12 gennaio, a 166 milioni di chilometri dal Sole) e si stava avvicinando alla Terra, nella costellazione di Bootes.
Ho utilizzato un binocolo gigante di fascia economica, dal generoso angolo di campo. I suoi 20 ingrandimenti e gli 80 mm di diametro mi hanno offerto una visione soddisfacente della cometa, nonostante la Luna fosse vicina all’Ultimo quarto. Ho montato lo strumento su un treppiede per videocamere, approfittando del fatto che in quel periodo buona parte dell’illuminazione pubblica veniva spenta a mezzanotte, così il cielo notturno era leggermente più buio del solito.
Osservando con il binocolone, la cometa era riconoscibile già alla prima occhiata. Era una macchia di luce un po’ elongata, più luminosa verso il falso nucleo, con un aspetto simile a quello di una stella leggermente sfocata. Il chiaro di Luna e l’inquinamento luminoso, enfatizzati dalla pupilla d’uscita di 4 mm, producevano uno scarso contrasto con il fondo cielo, che non permetteva di apprezzare i dettagli più deboli.
UNA COMETA CON TRE CODE
La visione della cometa faceva ben sperare per i giorni di massimo avvicinamento alla Terra, all’inizio di febbraio, con la possibilità di ammirare un bello spettacolo. Nei giorni seguenti, la Luna calante avrebbe dato sempre meno fastidio, mentre la cometa si sarebbe spostata verso declinazioni più settentrionali, fino a diventare circumpolare (alle nostre latitudini). La sera del 25 gennaio sono riuscito a osservare la ZTF da una zona collinare del Vicentino, impiegando un rifrattore acromatico a corta focale 80/400 (80 mm di diametro e 400 mm di focale). La cometa si trovava fra le due Orse e con il cercatore acromatico 6x30 mm si poteva riconoscere già al primo sguardo. In soli undici giorni la cometa aveva attraversato una discreta porzione di cielo e la sua luminosità era aumentata, restando però invisibile a occhio

OSSERVAZIONI
DI GIOVANNI BONINIL’ALTRA COMETA DI INIZIO 2023


nudo per via dell’inquinamento luminoso. Nelle riprese fotografiche esibiva una bella chioma di colore verde, dovuto alla presenza di carbonio in configurazione biatomica (C2).
Con gli oculari PL 17 mm (circa 23,5x) e KE 10 mm (40x), era ben visibile la forma allungata della chioma, con il falso nucleo dall’aspetto stellare. Pochi giorni prima era stata ripresa una disconnessione nella coda di gas, dovuta all’interazione con il vento solare prodotto da una Cme (Coronal Mass Ejection).
Nelle immagini riprese fra la seconda e la terza decade di gennaio, si può ammirare anche un’anticoda
prospettica. Così, in quei giorni, la cometa si è presentata con ben tre code: un vero spettacolo! Ho osservato ancora la ZTF la sera del 28 gennaio con il rifrattore 80/400. Dal giardino di casa, complici la Luna crescente (ormai al Primo quarto), l’inquinamento luminoso e un cielo non perfetto, la ricerca della cometa non si è rivelata agevole. Con gli oculari PL 17 mm e KE 10 mm era discretamente visibile e a 23,5x si poteva intuire l’inizio della coda. Si notava una condensazione del falso nucleo, dall’aspetto stellare, indice di un’attività particolarmente elevata, come testimoniato anche dalle due code (di gas e di polveri) e dall’anticoda prospettica, che nelle

riprese di quei giorni si estendevano per diversi gradi.
Il giorno dopo ho osservato la cometa con un rifrattore Apo da 90 mm di diametro, con oculari Ultra Wide Angle da 82 gradi di campo apparente (e focali di 24 mm e 14 mm).
Nonostante questo strumento avesse rispetto all’acromatico da 80 mm un solo centimetro di diametro in più, restituiva una immagine della cometa molto più appariscente.
UNA CONGIUNZIONE COMETARIA
Ho osservato ancora la cometa il 1° febbraio, quando si trovava alla minima distanza dalla Terra di 42 milioni di chilometri e
aveva raggiunto la costellazione della Giraffa. In quei giorni, la magnitudine della ZTF era stimata inferiore alla quinta: in alta montagna, se fossimo stati lontani dal Plenilunio, sarebbe stata visibile a occhio nudo.
Il 6 febbraio è transitata a breve distanza angolare dalla cometa C/2022 U2 Atlas, realizzando una rara “congiunzione cometaria”; un’occasione che è stata colta dagli astrofotografi più esperti. Il 7 febbraio, la ZTF si trovava nella costellazione di Auriga, altissima sui nostri orizzonti. Per osservarla meglio, mi sono recato in collina, sfruttando la sua visibilità nelle poche decine di minuti precedenti
al sorgere della Luna. Nonostante fosse ancora un oggetto molto interessante da ammirare con un piccolo telescopio, la sua luminosità si stava affievolendo, essendo ormai in allontanamento.

L’elevata altezza della cometa sull’orizzonte ha evidenziato i limiti delle montature altazimutali, quando si tratta di puntare corpi celesti prossimi allo zenit. Avevo in effetti montato il rifrattore 80/400 su un cavalletto fotografico di fascia economica. Per l’osservazione, ho utilizzato solo l’oculare PL 17 mm: l’elevato tempo di smorzamento delle vibrazioni sconsigliava l’uso dell’oculare KE 10 mm, che avrebbe prodotto 40x.

OSSERVAZIONI
DI GIOVANNI BONINI

Il 10 febbraio, la ZTF si trovava a poco più di due gradi da Marte, e questo affascinante quadretto celeste è stato ripreso da molti astrofotografi. La mia ultima osservazione della cometa risale al 12 febbraio, quando aveva ormai superato Marte e si stava dirigendo verso le Iadi, nella costellazione del Toro. Nel rifrattore 80/400 a 23,5x, erano ancora visibili la chioma, con il falso nucleo dall’aspetto stellare, e l’inizio della coda. Ma era ormai evidente il calo di visibilità, dovuto all’allontanamento.

UN BILANCIO FINALE
La ZTF non ha raggiunto la visibilità a occhio nudo, ma ha soddisfatto molte delle attese che abbiamo nei confronti dei passaggi
delle comete: ha mostrato ben separate la coda di gas e quella di polveri; ha regalato una bella anticoda prospettica; è diventata circumpolare (alle nostre latitudini); ha presentato una disconnessione nella coda di gas; è stata alla portata di un binocolo anche in presenza di moderato inquinamento luminoso; è stata protagonista di una rara congiunzione cometaria; è passata nei pressi di Marte e di alcune stelle brillanti, come Capella (in Auriga) e Aldebaran (nel Toro); è stata
osservabile quasi allo zenit, a elevate altezze sui nostri orizzonti.
Purtroppo, il chiaro di Luna ha impallidito il cielo proprio nel periodo di massima luminosità della cometa. Il passaggio della ZTF è stato comunque un’ennesima conferma di come i piccoli rifrattori a corta focale, acromatici o (meglio ancora) apocromatici, siano particolarmente indicati per l’osservazione visuale delle comete, soprattutto se abbinati a un oculare dal generoso campo visivo.
Non ci resta che salutare la C/2022 E3 ZTF, la “Cometa di Neanderthal”, augurandole di fare un buon viaggio verso il suo lontanissimo afelio, a 2800 Unità astronomiche dal Sole.
ALLA RICERCA DI
NUVOLE MARZIANE
LA NASA HA CHIESTO L’AIUTO DEI VOLONTARI PER IL PROGETTO CLOUDSPOTTING ON MARS
Marek Slipski è uno scienziato planetario che dopo essersi specializzato all’Università del Colorado sulle proprietà dell’atmosfera marziana, sotto la guida di Bruce Jakosky, ha iniziato alla fine del 2020 la sua tesi di dottorato al Jet Propulsion Laboratory della Nasa, con uno studio approfondito delle nubi presenti nell’alta atmosfera marziana e della loro distribuzione in funzione dell’altezza, delle stagioni e delle ore del giorno.
Si tratta delle cosiddette nubi mesosferiche, situate tra 50 e 80 km di quota, che vengono esaminate di preferenza dalle ore 3 del mattino alle 3 del pomeriggio. Si tratta certamente di nubi di vapor d’acqua, utili per capire sia la quantità di vapore presente a quelle altezze sia i meccanismi che ne favoriscono il trasporto. Ma sono abbondanti (data la gelida temperatura ambiente) anche le nubi di anidride carbonica,
che condensano a temperature inferiori a quelle dell’atmosfera marziana e sono quindi un ottimo tracciante delle variazioni di temperatura con l’altezza.
GRAZIE A MRO E ZOONIVERSE
Per il suo studio, Slipski ha deciso di sfruttare il grande archivio di dati raccolti in 16 anni dallo strumento Mcs (Mars Climatic Sounder) imbarcato sulla sonda Mro (Mars Reconnaissance Orbiter), collocata su un’orbita bassa (250 x 316 km) attorno a Marte, che percorre in 112 minuti. Il Mcs è uno strumento di 9 chilogrammi, costituito da due telescopi (A e B) da 4 cm aperti a f/1,7. Il telescopio A dispone di sei filtri infrarossi (da 1,6 a 22 micron), adatti a visualizzare l’anidride carbonica e il ghiaccio d’acqua; il telescopio B dispone di tre filtri nell’infrarosso più lontano (32-42 micron), adatti a visualizzare il vapor d’acqua e la polvere.
Mcs ha raccolto negli anni decine di migliaia di fenomeni nuvolosi e risulta impossibile esaminarli tutti con una semplice indagine visuale. Slipski ha messo a punto un algoritmo per eseguire questo compito in automatico.
Ma l’algoritmo fornisce risultati parziali e talvolta controversi, dato che nessuno strumento elettronico possiede la stessa affidabilità dell’occhio umano.
Un aiuto importante al lavoro di Slipski è arrivato da Armin
Kleinböhl, lo scienziato atmosferico che è il principale responsabile di Mcs. La Nasa aveva lanciato tra i suoi scienziati il programma Cssfp (Citizen Science Seed Funding Program), invitandoli a formulare dei progetti che potessero coinvolgere volontari appassionati di scienza (citizen scientist) in ricerche di argomento planetario e fisicobiologico.
Kleinböhl ne ha subito approfittato, presentando a fine 2021 il Mars
» A sinistra: le nuvole marziane riprese l’11 marzo 2018 dallo strumento Marci della sonda Mro.
Sopra: il satellite Phobos in transito sul sottile bordo dell’atmosfera marziana, ripreso il 4 marzo 2015 dalla sonda indiana Mom.


Sotto: strisce di cirri ripresi dal rover Curiosity nel cielo del cratere Gale il 30 marzo 2021. Inquadra il QR per una ripresa video di queste nuvole marziane.


Mesospheric Cloud, l’unico progetto di argomento planetario tra i nove che sono stati poi selezionati verso la metà del 2022.
A questo punto, sotto il nome di Cloudspotting on Mars, il progetto è stato caricato sulla piattaforma Zooniverse dedicata alla citizen science (bit.ly/3smGiCa).

ISTRUZIONI PER L’USO
Per indagare le nuvole di Marte, occorre individuare gli archi immersi nel “rumore di fondo” di ogni scansione eseguita da Mcs sul bordo marziano, che lo strumento realizza ogni due rivoluzioni, ossia per un tempo di circa 4 ore.


Le nubi mesosferiche si presentano come archi, perché appaiono basse quando lo strumento è lontano, si alzano progressivamente quando lo strumento si avvicina e poi si riabbassano quando lo strumento si allontana: la posizione vera della nube corrisponde quindi alla cima dei vari archi.
Un facile e intuitivo tutorial permette di impratichirsi, prima di essere aggiunti al folto gruppo dei volontari. Gli archi vengono fissati da un marker a croce fornito dal sistema. In ogni immagine del bordo marziano ci possono essere anche più archi che, nel caso in cui siano molto deboli, possono essere individuati aumentando gli ingrandimenti, oppure scegliendo una delle quattro versioni disponibili delle immagini a differente luminosità.
Inizialmente, Slipski e Kleinböhl hanno caricato quattro mesi e mezzo di immagini Msc, pensando che ci volessero almeno due mesi per analizzare questi dati. Invece, la risposta è andata al di là delle
previsioni: in sole due settimane i citizen scientists hanno esaminato più di 6000 immagini, realizzando più di 120mila classificazioni e individuando 3-4 nubi per ogni immagine.
Slipski e Kleinböhl non hanno esitato allora a incrementare il numero di immagini caricate. Alla fine di settembre 2022 avevano superato le 21mila immagini, corrispondenti a tutto il primo anno marziano (che va dal 9 dicembre 2007 al 21 maggio 2009): un mese dopo, quasi 5000
» Le nubi mesosferiche marziane appaiono basse quando Mcs è lontano, si alzano progressivamente quando Mcs è vicino, e si riabbassano quando Mcs si riallontana. Una nube appare quindi come un arco il cui culmine corrisponde all’altezza reale della nube stessa.
» Alcune immagini di Mcs presentano un singolo e nitido arco (sopra); altre presentano molti archi contemporaneamente (sotto). Dopo aver contrassegnato gli archi con il marker, il comando Done restituisce al sistema l’immagine esaminata.
volontari avevano esaminato oltre il 60% del materiale disponibile. C’è però ancora moltissimo lavoro da fare; pertanto, il progetto rimane aperto per un gran numero di nuovi volontari. Ma Slipski e Kleinböhl non pretendono l’aiuto per tutto il materiale disponibile: altri 2-3 anni marziani di lavoro esterno saranno sufficienti per realizzare, grazie alle tecnologie dell’intelligenza artificiale, algoritmi più raffinati ed efficaci dei precedenti per l’analisi automatica delle immagini.





STELLE LE VOSTRE
CARICATE LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE SU BFCSPACE.COM
LA REDAZIONE SCEGLIERÀ LE MIGLIORI PER “LE VOSTRE STELLE”
SONO TAGGATE DA UNA STELLA LE FOTO CHE HANNO VINTO LE NOSTRE SFIDE SOCIAL INQUADRA IL QR PER VISITARE LA GALLERY DELLE FOTO

L’OCCHIO DI HORUS
La galassia NGC 1097, distante 45 milioni di anni luce nella costellazione australe della Fornace, ripresa il 20/01/2023 in remoto dal Cile con un telescopio RC da 1 metro di diametro f/6,8. Maggiori dettagli al link bit.ly/41ewmek
Autore: team ShaRA.

LA COMETA ZTF IN ALLONTANAMENTO

Ripresa da Porto Ulisse - Ispica (RG) il 18/02/2023
Fotocamera Canon Eos RA con obiettivo Sigma Art 35 mm f/1,4 a f/3,2
Montatura iOptron Sky Guider Pro iPolar.
Filtro Optolong L-eNhance.
N. 61 pose da 50 s a 6400 Iso con dark, flat e dark flat. elaborate con Pixinsight, StarNetv2, Photoshop.
Nota: la cometa si trova circa a metà dell’immagine verso destra.
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.
IL SOLE IN H-ALFA

Ripreso da Siracusa il 04/02/2023
Telescopio Lunt LS60THa DS60 / B1200PT su montatura iOptron
CEM 70 G.
Camera PGR Grasshopper3 GS3-U3-28S4M
Elaborazione: AutoStakkert!3, ImPPG, Photoshop CC.
Autore: Salvo Lauricella, Siracusa.

IL GRANDE AMMASSO GLOBULARE DI ERCOLE (M13)

Ripreso da Ferrara il 30/01/2023.
Telescopio Konus 200/1000 mm su montatura EQ6R Pro.
Camera QHY 168C con filtro Svbony CLS.
Guida con cercatore 50/180 con Barlow 2x e ASI 224 MC.
Pose: 81x180 s, 20x5 s, 10x30 s, 5x60 s, elaborate con APP, Pixinsight, Photoshop.
Autore: Massimo Di Fusco, Ferrara.
NEBULOSA PLANETARIA WEINBERGER 1-10 NEL CIGNO

Ripresa da Gualdo Tadino (PG) il 12/09/2023
Telescopio GSO RC14 f/8 su montatura iOptron CEM 120 EC
Camera Moravian G3 16200 con filtri RGB, H-alfa, OIII, SII
Guida: Starlight Xpress Lodestar X2
Pose: H-alfa 8x1800 s, OIII 4x1800 s bin 2x2, 11 dark, 11 flat, 11 bias
Elaborazione: PixInsight
Autore: Francesco Ciavaglia, Gualdo Tadino (PG).
IL SOLE AL TRAMONTO

Ripreso da Arezzo l’11/11/2022 alle 16:36


Fotocamera Canon Power Shot SX 50 su cavalletto, obiettivo a F. 2400 mm f/6,5 (zoom digitale)
Posa di 1/60 s a 200 ISO con 5 filtri da 2 ND elaborata con Photoshop CS 5.
Autore: Aldo Luttini, Arezzo.
Diventa Podcaster de





Entra nel network editoriale che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Scannerizza il QR code e partecipa al contest!

LA NEBULOSA M78 IN ORIONE

Ripresa da Forca Canapine (AP) il 25/12/2022.
Rifrattore tripletto Apo Sky-Watcher Esprit 120/840 mm a f/7 su
montatura Sky-Watcher AZ EQ6 GT.
Camera QHY 168C (a -20°C) con filtri Idas LPS-D1.
Guida Lodestar su rifrattore Sky-Watcher 70/500 mm
Pose: 106x300 s elaborate con PixInsight, Photoshop CS 6.
Autore: Saverio Ferretti, Spinetoli (AP).
I BEST SELLER DELLA LETTERATURA ASTRONOMICA LIBRI

OFFERTA DEDICATA AI LETTORI DI COSMO
Acquista 6 libri a scelta dalla lista al prezzo di 60 euro, spese di spedizione incluse.
La ricerca amatoriale delle supernovae

Giancarlo Cortini, Stefano Moretti
Super-occhi per scrutare il cielo Walter Ferreri, Piero Stroppa
I pianeti e la vita Cesare Guaita
I giganti con gli anelli Cesare Guaita
Alla ricerca della vita nel Sistema Solare Cesare Guaita
Oltre Messier Enrico Moltisanti
I grandi astrofili Gabriele Vanin
La Luna Walter Ferreri
In viaggio nel Sistema Solare Francesco Biafore
Come funziona l'Universo Heather Couper, Nigel Henbest

Come fotografare il cielo Walter Ferreri
L'osservazione dei pianeti Walter Ferreri
Cento meraviglie celesti Gabriele Vanin
Effettua l’ordine comodamente su BFC Store (bfcstore.com): acquistando il coupon “I best seller di Cosmo” riceverai un’email di conferma, rispondendo alla quale potrai indicare i titoli scelti.
NEBULOSA ANIMA (LBN 673) IN CASSIOPEA

Ripresa Gualdo Tadino (PG) il 17/10/2022.
Telescopio GSO RC14 f/8 su montatura iOptron CEM 120 EC.
Camera Moravian G3 16200 con filtri L, R, G, B, HA, OIII, SII
Guida con Starlight Xpress Lodestar X2.
Pose: Hubble Palette R,G,B 4x300 s, H-alfa 8x1800 s, OIII 6x1800 s, SII
3x1200 s bin 2x2, 11 dark, 11 flat, 11 bias
Elaborazione: PixInsight.
Autore: Francesco Ciavaglia, Gualdo Tadino (PG).

Invece di 58,80€
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
*24,90€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 29,90€ (IVA inclusa) invece di 58,80€.
COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO Chiama il numero
02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
COUPON DI ABBONAMENTO SPECIALE
Sì, mi abbono a FORBES per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 58%. Pagherò 24,90€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 29,90€ IVA inclusa) invece di 58,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.


I MIEI DATI
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa
Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BLUE FINANCIAL COMMUNICATION con sede in Via Melchiorre Gioia 5520124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@ bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti. it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca. rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto rilascio nego il consenso per le attività di profilazione
I BIOMARCATORI NELLE ATMOSFERE DEGLI ESOPIANETI
Un obiettivo degli astronomi è trovare un pianeta gemello della Terra; fra i requisiti per il “gemellaggio”, c’è la presenza di un’atmosfera simile a quella terrestre che contenga innanzitutto ossigeno libero (cioè in forma molecolare, composta da due atomi). Il telescopio spaziale James Webb (Jwst) è in grado di rilevare questa molecola?
Anche l’Extremely Large Telescope (Elt), che l’European Southern Observatory sta costruendo sul Cerro Armazones, in Cile, con un diametro dello specchio primario di 39 metri (la prima luce è prevista per il 2027, figura) sarà usato nell’analisi dell’atmosfera degli esopianeti.

In che cosa Elt risulterà superiore al Jwst, dal momento che entrambi operano nel vicino e medio infrarosso?
Inquadra il QR per un video di presentazione di Elt.

L’ossigeno libero (O2) è un valido marcatore biologico, ma è debole, poiché può essere prodotto da processi non biologici. La rivelazione dell’ossigeno nelle atmosfere planetarie non sarebbe la prova dell’esistenza di attività biologica se, insieme a tale molecola non fossero trovati biomarcatori più forti La radiazione ultravioletta della stella, per esempio, può scomporre le molecole d’acqua nell’atmosfera, creando idrogeno atomico e ossigeno. L’idrogeno è abbastanza leggero da sfuggire nello spazio, perciò, grazie a questo processo, un esopianeta potrebbe esibire una densa atmosfera di ossigeno. Non tutti i biomarcatori sono esclusivi dell’attività biologica, quindi andranno cercate le firme spettrali di sostanze unicamente legate alla chimica biologica, almeno per come la conosciamo. Anche il concetto di vita non è univoco. Organismi con attività analoghe alle forme biologiche, basate sul carbonio, potrebbero non produrre prodotti di scarto riconoscibili come biomarcatori. In questa ricerca, c’è il rischio di essere condizionati dall’unica forma di vita che conosciamo.

Anche sulla Terra, nei primi miliardi di anni, le forme di vita unicellulari hanno prosperato nei mari senza produrre significativi tenori di ossigeno. Trovarne in quantità misurabili, sempre nell’ipotesi di forme viventi come quelle terrestri, significherebbe che quelle atmosfere ospitano una biosfera già molto evoluta. Quegli organismi hanno già conosciuto un evento come la “grande ossidazione”, adattandosi a un’atmosfera altrimenti letale.
Un esopianeta con un’atmosfera dotata di forti biomarcatori è nelle attuali possibilità tecnologiche. Sia il Jwst dallo spazio, sia Elt dal suolo, sono in grado di rivelare la presenza di ossigeno molecolare per via spettroscopica in pianeti non molto distanti. Nello specifico, alcuni astronomi propongono che il Jwst potrebbe cercare l’impronta dell’ossigeno mediante l’osservazione di una particolare banda spettroscopica a 6,4 micrometri (nel medio infrarosso), prodotta dalla collisione tra molecole, durante i transiti (figura). Questi assorbimenti potrebbero essere la caratteristica dell’O2 più rilevabile entro un raggio di 16 anni luce da noi, con lo strumento Miri del Jwst. Tuttavia, ciò non basterebbe per confermare l’origine biologica, a causa di una certa percentuale di falsi positivi. Elt consentirà di ottenere immagini dirette di esopianeti vicini, compresi quelli rocciosi nelle “zone abitabili” delle stelle. Grazie all’enorme potere di raccolta luce di Elt, gli astronomi potranno rilevare e caratterizzare le impronte chimiche delle atmosfere dei pianeti che sono in transito davanti alla loro stella, determinando perfino il clima, le stagioni e l’esistenza di forti biomarcatori. Misurazioni del genere sono state già eseguite per esopianeti giganti con telescopi della classe degli 8 metri, ma l’estensione di queste misure ai pianeti terrestri è alla portata di Elt. Se la vita analoga alla nostra è un fenomeno universale, come molti credono, la scoperta di un esopianeta con un’atmosfera con segni di attività biologica potrebbe essere imminente. Tutto questo è emozionante e possiamo considerarci dei privilegiati per vivere in tale momento storico.
IL 56º
DELL’UNIONE ASTROFILI ITALIANI CONGRESSO
APPUNTAMENTO A CUNEO DAL 5 AL 7 MAGGIO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ASTROFILI BISALTA
Dopo tre anni di sessioni remote, il Congresso dell’Unione astrofili italiani (Uai) torna a svolgersi in presenza. Sarà la Casa del Fiume di Cuneo, centro di educazione ambientale al servizio del territorio piemontese, a ospitare quest’anno - dal 5 al 7 maggio - il 56º Congresso dell’Uai: il più importante appuntamento degli appassionati di astronomia in Italia, dedicato all’aggiornamento, allo scambio di idee ed esperienze e alla definizione dei programmi di attività nei settori della divulgazione, della tecnica e della ricerca amatoriale astronomica.

L’edizione 2023 del Congresso si avvarrà del prezioso supporto organizzativo dell’Associazione Astrofili Bisalta, delegazione territoriale dell’Unione astrofili italiani della provincia di Cuneo.
“Il Congresso - spiega il presidente dell’Uai Luca Orrù - è ormai dal lontano 1968 il più atteso e privilegiato momento di incontro, condivisione e socializzazione di tutta la comunità degli astrofili, delle associazioni, degli osservatori, dei planetari e dei musei a tema astronomicoscientifico che si riconoscono nella Uai. Un fine settimana per fare il punto della situazione, promuovere attività e
condividere esperienze, offrire nuovi stimoli e anche per vivere momenti di grande divulgazione scientifica”. Parteciperanno all’irrinunciabile appuntamento scientifico congressisti afferenti alle oltre 60 delegazioni dell’Uai distribuite in maniera capillare sul territorio nazionale e tutti gli astrofili interessati a dare il proprio contributo ai lavori del Congresso.
DEFINIRE IL FUTURO DELL’ASTROFILIA IN ITALIA
Il Congresso prevede, in primo luogo, momenti di condivisione e discussione dei progetti realizzati nell’ambito dei vari settori di attività dell’Uai: divulgazione - anche in chiave inclusiva - delle scienze astronomiche, osservazione e studio degli oggetti celesti, monitoraggio e contrasto dell’inquinamento luminoso, promozione dell’uso della strumentazione astronomica e delle tecniche osservative e dell’astrofotografia più innovative.
Ma il Congresso, come sottolinea Orrù, sarà anche l’occasione per “riflettere sulle sfide e opportunità da affrontare, e quindi per definire le principali attività su cui concentrarsi nell’anno successivo; in sintesi, un incontro
in cui portare, con concretezza, le proprie esperienze, le proprie idee e la propria progettualità per definire assieme il futuro dell’astrofilia in Italia”.

In particolare, sono previste, nell’ambito del Congresso, sessioni di lavoro a cura delle tre Commissioni nazionali dell’Uai: la Commissione Outreach, articolata nelle Sezioni nazionali di didattica, divulgazione, storia e archeoastronomia, e divulgazione inclusiva, la Commissione Ricerca, suddivisa in dieci sezioni, e la Commissione Tecnica. Inoltre, novità di quest’anno, ci sarà una sessione dedicata al tema Astrofilia e territorio, a cura dei fiduciari dell’Uai.
Il Congresso darà, inoltre, l’opportunità di incontrarsi ai soci storici, membri del programma Redshift introdotto nel 2022 per premiare i soci con la maggiore anzianità di iscrizione. In particolare, un tavolo sarà riservato ai membri Redshift 5, con iscrizione continuata alla Uai da quaranta e più anni.
IL MOMENTO DEI PREMI
In occasione del Congresso, come da tradizione, verranno assegnati il premio “Gian Battista Lacchini”, il premio “Guido Ruggieri” e il premio “Stella al merito”. Il premio “Lacchini” è il più importante riconoscimento che l’Uai conferisce ad astronomi e astrofili di fama mondiale che, oltre a essere all’avanguardia nella ricerca astronomica e astrofisica, dedicano una parte rilevante delle proprie energie alla divulgazione dell’astronomia, attraverso la pubblicazione di libri,
la partecipazione a conferenze e a trasmissioni televisive. Il premio “Ruggieri” viene invece assegnato all’astrofilo più meritevole per specifiche attività di ricerca effettuate o per l’insieme delle attività realizzate nel corso della propria carriera astrofila. Il premio “Stella al merito” va ai soci dell’Uai che più si sono distinti nell’ambito delle attività divulgative e didattiche, per meriti organizzativi o per il sostegno alla crescita dell’associazione.
Nel corso del Congresso verrà decretato anche il vincitore del bando Astroiniziative 2023 riservato alle delegazioni dell’Uai. Il bando, con cadenza annuale, vuole sostenere le iniziative in ambito divulgativo e didattico, eventualmente anche incentrate su attività di ricerca amatoriale, allo scopo – da un lato – di diffondere l’astronomia e la scienza nella società, e – dall’altro – di incoraggiare la creatività e la progettualità delle delegazioni. L’Uai ha scelto di dedicare l’edizione 2023 del bando al tema dell’osservazione astronomica. Il Congresso sarà anche l’occasione per esporre i risultati del progetto “E (troppa) luce fu” realizzato dal Centro Astronomico
Neil Armstrong, vincitore del bando Astroiniziative 2022.
CONDIVIDERE LA PASSIONE
È prevista nell’ambito del Congresso anche la consueta assemblea dei soci. Non mancheranno infine le attività per il grande pubblico e le occasioni di incontro con le scuole del territorio, per diffondere la cultura astrofila e scientifica, come spiega Orrù: “Crediamo che l’astronomia, con il suo carico di storia millenaria e di fascino universale, sia lo strumento ideale per veicolare la cultura scientifica, ancora troppo poco diffusa nel nostro Paese, da valorizzare e accrescere”.
“Con il suo ricco programma di attività, il Congresso dell’Uai - conclude Orrù - si conferma anche quest’anno come la migliore occasione per condividere e approfondire la passione per l’osservazione del cielo e per la scienza, in un contesto di grande valore naturalistico”.
Il programma dettagliato del Congresso e le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito web dell’Uai, www.uai.it
IL CIELO
A CASA VOSTRA
I PLANETARI ITINERANTI, UNA REALTÀ IMPORTANTE E VERSATILE MA POCO CONOSCIUTA
Quando si pensa a un planetario, la mente va a una struttura mediogrande, collocata in un edificio, con in cima la classica cupola semisferica. Nel mondo dei planetari esistono però anche realtà meno conosciute ma altrettanto importanti e vivaci nelle loro attività, cioè i planetari itineranti. Si tratta di planetari sufficientemente piccoli da essere trasportabili da un luogo all’altro, con un’auto capiente o un piccolo furgone. Che, in pratica, possono portare il cielo stellato direttamente… a domicilio. I planetari itineranti sono composti da tre elementi principali. Il primo è il sistema di proiezione, che è quasi sempre digitale e realizzato con un singolo videoproiettore. Il secondo è la cupola, che - diversamente dai planetari tradizionali - non è rigida, bensì gonfiabile, come un igloo. Il terzo elemento è la ventola che serve a gonfiare la cupola e a mantenerla in pressione. Le sedie non servono: ci si accomoda per terra.
ALL’INIZIO FU LO STARLAB
La storia dei planetari itineranti inizia negli anni Settanta e in Italia i primi
arrivano una decina di anni dopo. “Io iniziai con un modello giapponese, l’EX-3 della Goto, acquistato nel 1987”, ricorda Loris Ramponi, uno dei pionieri dei planetari itineranti, oggi segretario di PLANit, l’Associazione dei planetari italiani. “Era un piccolo strumento opto-meccanico sferico, equipaggiato con una cupola di 3 metri di diametro che si apriva come un ombrello all’interno di una stanza, con qualche problema per ripararsi dalla luce esterna, che disturbava la proiezione. Due anni dopo visitai l’Exploratorium di San Francisco e vidi uno Starlab. Fu amore a prima vista, e convinsi l’associazione nella quale operavo ad acquistarne uno”. Lo Starlab, dell’azienda americana Learning Technologies Inc., è stato per molti anni l’asso dei planetari itineranti. Anch’esso aveva un proiettore opto-meccanico, che però non aveva forma sferica: la lampada interna proiettava il cielo stellato grazie a dei cilindri. Lo strumento era di utilizzo molto semplice, aveva certamente qualche limite ma anche una importante innovazione:
“I cilindri erano intercambiabili. Oltre a quello relativo al cielo
tradizionale, si poteva anche acquistare, per esempio, il cilindro con le costellazioni dei nativi americani”, spiega Ramponi. “E c’erano anche cilindri non astronomici, in particolare uno biologico, con l’immagine di una cellula, e uno sulla tettonica a zolle. Lo Starlab è stato il primo proiettore multidisciplinare della storia”. L’altra innovazione dello Starlab era la cupola gonfiabile, che “a riposo” si ripiegava e si metteva in un borsone, per trasportarla ovunque; poi si gonfiava sul luogo della proiezione, e garantiva una buona tenuta alla luce esterna. Qualche cupola Starlab d’annata, in Italia, circola ancora.

I SISTEMI DIGITALI
Dei loro cugini di cinquant’anni fa, i planetari portatili moderni conservano la cupola gonfiabile, ma sotto di essa si trovano sistemi di proiezione digitale. “Come per i planetari fissi, anche per quelli itineranti esistono due categorie: soluzioni amatoriali, realizzate assemblando componenti varie, e soluzioni commerciali progettate ad hoc”, precisa Dario Tiveron, presidente di PLANit.
“Nella prima ricadono quei sistemi che chi desidera farsi un planetario portatile in casa mette insieme acquistando in modo indipendente il proiettore, la lente che serve a mettere a fuoco l’immagine sulla cupola, e magari costruendo da sé i supporti per entrambi. Poi si utilizza un computer e in genere un software gratuito, come Stellarium, che supporta l’uscita fulldome”. Quelli della seconda categoria fanno parte del catalogo di tutte le principali aziende che realizzano anche planetari fissi di grandi
IL MEETING 2023 DI PLANIT
dimensioni. “Sono sistemi che vengono consegnati chiavi in mano, già ottimizzati per la massima resa e con un software nativo per i planetari digitali”. Come accade quindi anche per i planetari fissi, quelli “artigianali” nascono e vengono utilizzati principalmente da strutture (come associazioni o circoli astrofili) che intendono fare divulgazione “itinerante” ma hanno risorse economiche limitate; con alcune migliaia di euro è possibile mettere insieme un hardware dignitoso. Mentre i sistemi proposti
Il convegno annuale dell’Associazione dei planetari italiani si svolgerà al planetario di Ravenna da venerdì 14 a domenica 16 aprile. È la principale occasione di incontro e di discussione per i planetaristi, ma anche per insegnanti e tutti gli appassionati del cielo.
Da segnalare, il pomeriggio del venerdì, il workshop “Divulgazione scientifica e gestione del pubblico”, con la partecipazione di Luca Perri, astrofisico e divulgatore, e di Graziano Garavini, attore e formatore. Saranno presenti anche alcuni planetaristi “itineranti” che continuano a spostarsi ove richiesto con le loro cupole gonfiabili. Per informazioni vedi bit.ly/3Zi5icJ
dalle aziende sono in genere utilizzati da realtà più strutturate; per la parte hardware possono costare tra i 25mila e i 50mila euro.
CUPOLE E ATTIVITÀ
Poi è necessaria la cupola, per la quale ci si può rivolgere alle aziende di planetari, che ne distribuiscono diverse tipologie: una cupola di 6 metri di diametro (che può ospitare 30-40 persone) costa circa 20mila euro. “In rete si trovano anche cupole gonfiabili molto più economiche, ma bisogna andarci cauti”, precisa Tiveron. “Bisogna rispettare le normative di sicurezza previste dalla legge nel caso di luoghi al chiuso in cui c’è un pubblico. Le cupole gonfiabili devono quindi soddisfare criteri antincendio, di non tossicità e per l’evacuazione veloce. Le cupole a basso costo spesso non sono certificate secondo le nostre norme e non garantiscono questi requisiti”. Chi ha il desiderio di realizzare un planetario “casalingo”, o per la propria scuola o associazione, può rivolgersi a PLANit (www. planetari.org), i cui esperti potranno aiutare nella scelta. Se si vuole semplicemente noleggiare un planetario itinerante per un tempo limitato, per una scuola, una festa o un evento, una ricerca in rete permette di trovare diversi enti, no-profit o commerciali, in grado di “portare il cielo a casa vostra”.

EVENTI SOTTO IL CIELO DI APRILE
Segnalate eventi, mostre, star party a stroppa@bfcmedia.com
ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA CONFERMA DEGLI EVENTI SUI SITI INDICATI

CAMPO DEI FIORI, VARESE
MEETING CORPI MINORI UAI 1-2 APRILE
Organizzato presso l’Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” dalle Sezioni di Ricerca Comete, Meteore e Asteroidi dell’Unione Astrofili Italiani, è aperto a tutti gli interessati a questo campo dell’astronomia. bit.ly/3SfMFTO
ASTI
DALLA TERRA
ALLA LUNA E RITORNO?
FINO AL 23 APRILE
Mostra interdisciplinare sulla esplorazione della Luna presso il Magmax. Ingresso gratuito ma con prenotazione, scrivendo ad astimagmax@gmail.com bit.ly/3Q4NgXr
ROVERETO (TN)
IL CIELO IN UNA STANZA
TUTTE LE DOMENICHE, ORE 15:00 Sotto la cupola del planetario del Museo di Scienze e Archeologia di Rovereto si va alla scoperta delle meraviglie dell’Universo con gli esperti della Fondazione Museo Civico. bit.ly/3IDFdPh
VERONA
UNA FINESTRA SULL’UNIVERSO DELLE PARTICELLE ELEMENTARI
28 APRILE, ORE 21:00
Lezione pubblica sulla Fisica delle particelle elementari a cura di Luca Panizzi. Evento organizzato dal Circolo astrofili veronesi (via Brunelleschi 12). bit.ly/3K8fOwk
SOVICILLE (SI)
VISITE ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO PROVINCIALE
14 E 28 APRILE, ORE 21:30
L’Unione Astrofili Senesi offre al pubblico osservazioni guidate del cielo notturno ai telescopi presso l’Osservatorio astronomico di Montarrenti. bit.ly/3BsCgMM

BOLOGNA
OLTRE LO SPAZIO, OLTRE IL TEMPO
FINO AL 28 MAGGIO
“Il sogno di Ulisse Aldrovandi”, un percorso espositivo tra arte, scienza ed esplorazione spaziale allestito presso il Centro Arti e Scienze Golinelli ilsognodialdrovandi.it
RAVENNA (RA)
MEETING DEI PLANETARI ITALIANI
14-16 APRILE
l convegno dei planetari italiani organizzato da PLANit presso il Planetario di Ravenna, al quale sono invitati anche astrofili e insegnanti. bit.ly/3xCdJmQ
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
JWST: LA SUA STORIA

FINO ALLE PRIME IMMAGINI
28 APRILE, ORE 21:00
Conferenza divulgativa al Palazzo comunale dedicata al telescopio spaziale James Webb, a cura di Emanuele Cambiotti, evento organizzato dall’Associazione Astronomica del Rubicone. bit.ly/3AahGQL
ROCCA DI PAPA (RM)
LA FORMA DELLE GALASSIE

7 APRILE, ORE 20:45
Evento per tutti a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia, con conferenza sulle galassie, osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio, e visita guidata al Parco astronomico “Livio Gratton”. bit.ly/3EnTxcl
ROMA
FESTIVAL DELLE SCIENZE
DAL 18 AL 23 APRILE
All’Auditorium Parco della Musica, con il tema “Immaginari”, suddiviso in tre aree tematiche (Scenari, Ispirazioni, Visioni), il programma prevede conferenze, mostre, laboratori, eventi per famiglie. bit.ly/3kUUvWL
BARI
SPETTACOLI AL PLANETARIO
TUTTI I WEEK-END
Presso il planetario di Bari, con cupola di 15 metri di diametro, gli esperti dell’Associazione culturale Andromeda offrono al pubblico spettacoli di astronomia, spettacoli di teatro-scienza e laboratori. bit.ly/3pv1AvZ
NAPOLI
MOSTRE E SPETTACOLI NEL PLANETARIO DA MARTEDÌ A DOMENICA
Città della Scienza propone ad adulti e bambini spettacoli multimediali di astronomia nel planetario, la visita al ricco percorso espositivo e, durante il weekend e nei giorni festivi, attività laboratoriali. bit.ly/3CmkUmY
I NEURONI DI DIO
MARCO SALVATI
ROMA, CASTELVECCHI, 2023 PAGINE
120
PREZZO € 15.00
FORMATO 15 X 21 CM
Quando ho ricevuto una copia di questo libro, pensavo fosse un testo di astrofisica. Me lo suggeriva il nome dell’autore, Marco Salvati, un collega con il quale ho avuto spesso a che fare, perché entrambi ci siamo occupati di stelle di neutroni; poi lui era passato a studiare il comportamento delle galassie attive, con qualche puntatina anche sui lampi gamma. Inoltre, Marco è stato direttore dell’Osservatorio di Arcetri. Le mie aspettative erano corroborate dall’immagine in copertina dove spicca una bellissima galassia a spirale. Confesso di avere pensato: chissà se per Marco i neuroni di Dio sono le stelle di neutroni o i maxi- buchi neri che dominano il comportamento delle galassie attive. Dopo tutto, la metafora si poteva adattare a entrambe le classi di oggetti celesti. Invece, è bastato guardare l’indice, per capire che si tratta di un libro di fisica, nel quale un astrofisico riflette sui grandi temi che hanno agitato (e agitano) questa disciplina. L’autore inizia a ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo del concetto di

PICCOLI MONDI ANTICHI
PIETRO BARUFFETTI
UNIONE ASTROFILI ITALIANI
PAGINE 297 ILLUSTRATE A COLORI
FORMATO 17,5 X 25 CM
PREZZO € 10,00/25,00 (DIGITALE/CARTACEO)
L’Unione Astrofili Italiani (Uai) ha prodotto la collana intitolata I manuali del cielo che offre valide guide per l’osservazione e lo studio dei fenomeni astronomici. I volumi raccolgono le conoscenze astronomiche e le tecniche osservative accumulate negli anni dagli esperti dell’Uai, che ottengono dati indispensabili ai professionisti in molti campi dell’astronomia. Nel primo testo della collana, con il sottotitolo Storie e osservazioni di occultazioni asteroidali, troviamo gli articoli dedicati a questo tema sulla rivista Astronomia Uai dal 2014 al 2020, proposti in una veste rinnovata e ampliata, con l’aggiunta di capitoli inediti. Il libro è il frutto del lavoro del coordinatore delle osservazioni di occultazioni asteroidali Pietro Baruffetti e del Gruppo Astrofili Massesi. L’osservazione delle occultazioni asteroidali consiste nel seguire l’andamento luminoso di una stella davanti alla quale è previsto il passaggio di un asteroide. Quando avviene l’occultazione, si ha un quasi istantaneo calo di luminosità, seguito pochi secondi dopo da

relatività, passando da Galileo a Einstein, dalla relatività speciale a quella generale, per arrivare fino ai buchi neri. Ci sono capitoli sulla fisica quantistica, con il famoso paradosso del gatto di Schroedinger, che è contemporaneamente vivo e morto, sullo scorrere del tempo e sul concetto di riversibilità, sul multiverso, sull’inizio di tutto. Ricorre spesso il concetto di entanglement, dal quale l’autore è chiaramente affascinato. Nel capitolo finale, intitolato Dio esiste?, si dribbla elegantemente la questione religiosa vera e propria, proponendo una versione quantistica delle interazioni tra Dio e l’Universo basata sui “teoni”, ipotetiche particelle che dovrebbero trovare un loro spazio nel modello standard.
In definitiva, per capire il significato del titolo occorre arrivare alla fine del libro. Per scoprire che i “neuroni di Dio” siamo… noi. Proprio noi, esseri pensanti che siamo in grado di porci delle domande e di cercare delle risposte.
una risalita fino alla luminosità iniziale. Quando le postazioni da cui viene osservato l’evento sono numerose, si riescono a definire perfino la sagoma dell’oggetto e l’eventuale presenza di satelliti, “gareggiando” con i grandi telescopi professionali. In effetti, queste osservazioni sono eseguite anche dai professionisti, ma solo il numero di postazioni garantito dagli astrofili organizzati permette di catturare il numero di eventi necessari per ottenere il massimo delle informazioni.
Attraverso numerosi esempi, corredati anche da curiosità, aneddoti e informazioni storiche e mitologiche, il manuale mostra le potenzialità della ricerca amatoriale in questo settore, oltre ai possibili risultati e alle tecniche osservative e di elaborazione dei dati osservativi. Un settore, quello delle occultazioni asteroidali, sempre attivo e in continua evoluzione. Per le modalità di acquisto del volume, vedi il link bit.ly/3JLNVMy
Piero Stroppa





