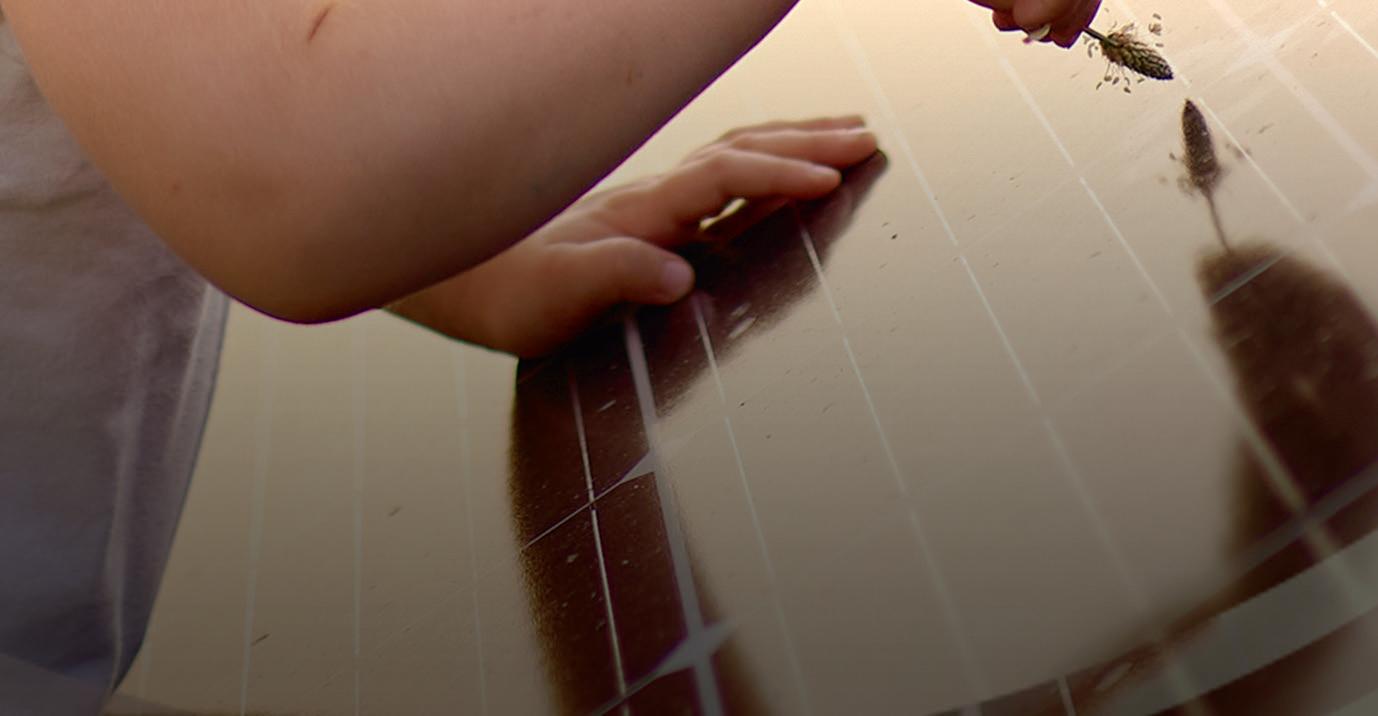UN CIELO SEMPRE PIÙ




NUMERI ARRETRATI Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it
Il costo di ciascun arretrato è
*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.
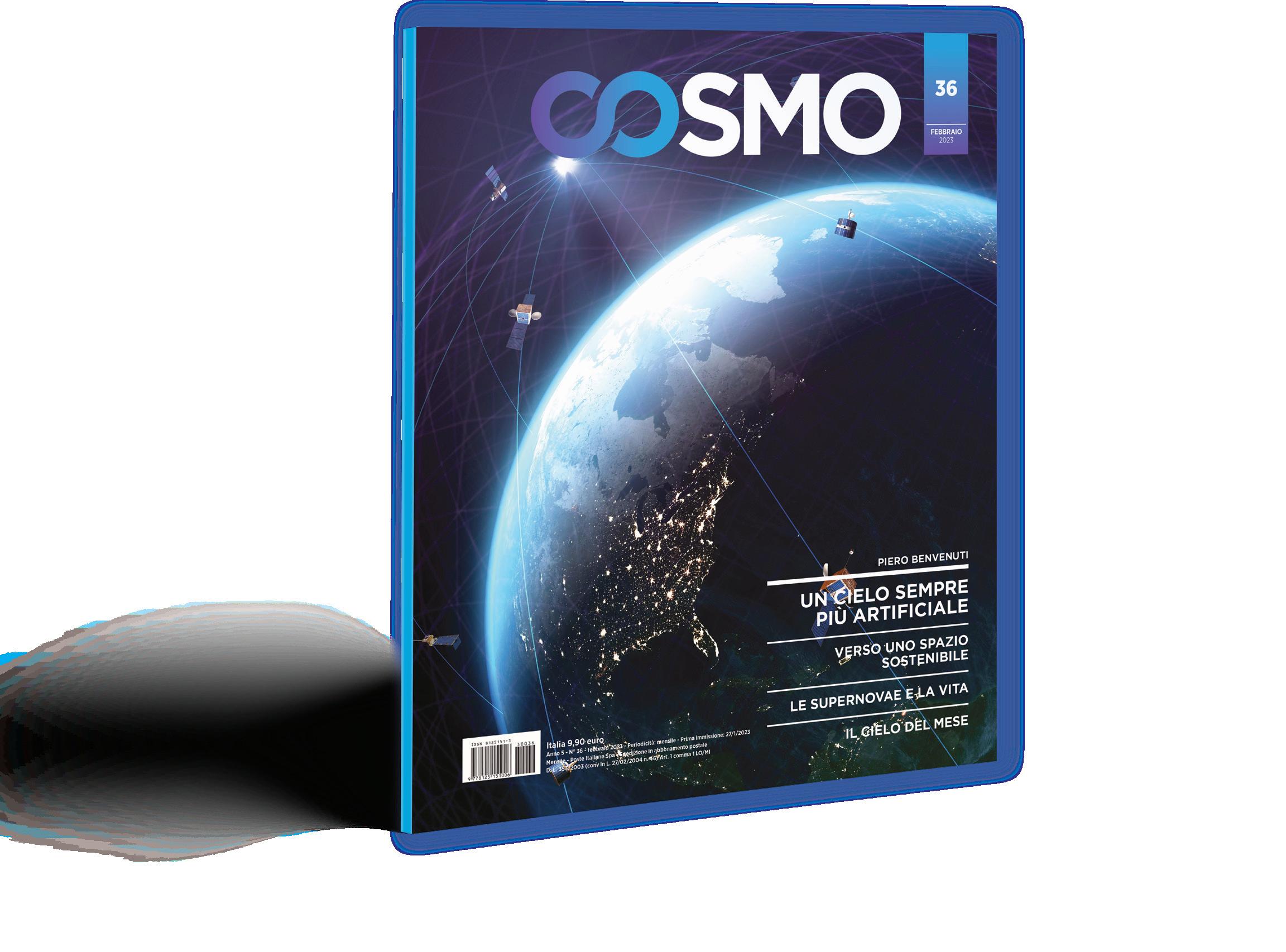
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/cosmo
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero 02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
DAL SITO, ANCHE PER REGALARE
UN ABBONAMENTO
Vai su BFCStore a bit.ly/3PJXDPd
Oppure inquadra il QR



Invece di 118,80€

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.

I MIEI DATI
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
rilascio nego il consenso per le attività di profilazione
In questo numero trovate alcuni articoli che parlano di supernovae, quelle immani esplosioni stellari tipiche di stelle evolute di grande massa che, grazie alle energie messe in campo dalla straordinarietà del fenomeno, riescono a realizzare il sogno dell’alchimista medievale di trasformare gli elementi chimici semplici in altri più pesanti e più preziosi, come l’oro, l’argento e il platino. Oggi l’astronomia multi-messaggera ci ha insegnato che la fonte primaria per l’origine di questi metalli, più che nelle esplosioni di supernovae, va ricercata nelle fusioni fra stelle di neutroni, ma per ottenere una stella di neutroni occorre proprio una supernova. Ogni anno nel mese di febbraio mi trovo a pensare alla supernova del 1987 (SN 1987A), che fu avvistata nella Grande Nube di Magellano la notte fra il 23 e il 24 febbraio di quell’anno. L’osservazione fu accompagnata dalla rilevazione di alcuni neutrini sia dall’apparato giapponese Kamiokande II, sia dal Liquid Scintillation Detector all’epoca in funzione nel laboratorio sotterraneo del Monte Bianco. Purtroppo, i dati di quest’ultimo esperimento non sono mai stati accettati dalla comunità scienti ca, ma i dubbi, a distanza di più di 35 anni, rimangono aperti. Così come rimane aperta la caccia al “resto di supernova” lasciato da quell’esplosione: un buco nero, una pulsar o una “semplice” stella di neutroni? Due ricerche indipendenti, alla ne del 2019, supportate dalle osservazioni eseguite dalle antenne dei radiotelescopi di Alma sulle Ande cilene, facevano propendere per quest’ultima ipotesi. Se fosse confermata, sarebbe la più giovane stella di neutroni mai trovata. Comunque sia, quello fu l’evento precursore dell’astronomia multi-messaggera, cioè un fenomeno osservato da strumenti di erenti e portato no a noi da “messaggeri” diversi: la luce e i neutrini. Se esplodesse oggi una stella così vicina a noi, ma comunque a distanza di sicurezza, sarebbe una vera fortuna per tutta la comunità scienti ca, attrezzata oggi molto meglio di quanto non fosse trentasei anni fa. Non ci resta che sperare, continuando a osservare il cielo.
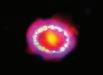
ANNO 5 - NUMERO 36 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019
CASA EDITRICE
BFC SPACE
Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI
Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: Denis Masetti
CONSIGLIERE DELEGATO: Mirko Bertucci
CONSIGLIERE: Franco Cappiello

DIRETTORE RESPONSABILE
Walter Riva riva@bfcmedia.com
DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com
HANNO COLLABORATO
Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Laura Citernesi, Giuseppe Donatiello, Marco Sergio Erculiani, Walter Ferreri, Azzurra Giordani, Antonio Grandieri, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Franco Malerba, Paolo Palma, Piero Mazza, Massimiliano Razzano, Volodymyr Usov, Graziano Ventre.
GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com
PUBBLICITÀ
Francesco Vannucci vannucci@bfcmedia.com
ABBONAMENTI
Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia
ARRETRATI
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it
STAMPA TEP Arti Grafiche Srl
Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA
Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com
IN COPERTINA: rendering di una rete globale di satelliti per telecomunicazioni.


NEWSLETTER DI BFCSPACE
Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR
ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/
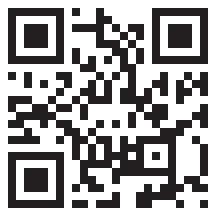
44

52

72

Inquadra con la fotocamera o con la App Scan

Mentre la Terra orbita intorno al Sole, la Luna orbita intorno alla Terra, e così può accadere, per la combinazione di questi moti orbitali, che questi tre corpi celesti vengano a trovarsi nella situazione particolare in cui la Luna si trovi allineata tra la Terra e il Sole. Più precisamente, molto vicino a uno dei suoi nodi, i punti in cui il piano dell’orbita lunare interseca il piano orbitale terrestre.
L’orbita lunare intorno alla Terra è un’ellisse il cui piano è inclinato di circa 5 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre; pertanto, la distanza tra la Luna e la Terra cambia tra un valore massimo, detto apogeo, e un valore minimo, il perigeo. Grazie alle dimensioni e alle distanze della Luna e del Sole dalla Terra, si veri ca che le dimensioni apparenti della Luna e del Sole siano praticamente le stesse, con piccole variazioni tra apogeo e perigeo.
Queste circostanze concorrono al veri carsi del fenomeno dell’eclisse di Sole. Un fenomeno unico nel
Sistema solare, perché altri pianeti hanno satelliti, ma le loro dimensioni angolari sono minori di quelle solari, e così dalle loro super ci si può assistere solo a un “transito”, come quando un satellite di Marte passa davanti al Sole. Oppure sono maggiori, producendo così una “occultazione”, come sarebbe un’eclisse di Sole provocata dalla Terra e osservata dalla Luna. Il cono d’ombra della Luna ha una lunghezza di circa 372mila km; pertanto, quando la Luna è al nodo e nei pressi del perigeo, la sua ombra s ora la Terra, determinando un’eclisse parziale di Sole. Se la Luna si trova più distante dalla Terra, l’ombra lunare non arriva sulla super cie terrestre, determinando un’eclisse anulare di Sole. Praticamente si ha un transito, che lascia scoperto un anello di Sole intorno alla Luna. Quando la Luna si trova esattamente sul nodo, allora il disco lunare copre completamente quello solare dando origine a un’eclisse totale di Sole.
La durata di un’eclisse totale dipende dalla distanza della Luna e può variare da qualche secondo a circa sette minuti e mezzo.
Durante un’eclisse totale di Sole si rendono visibili la cromosfera, le protuberanze e la corona solare Paradossalmente, le formazioni più interessanti e spettacolari della nostra stella si rendono facilmente visibili solo quando il suo disco si nasconde dietro la Luna, eliminando la luce abbagliante prodotta dalla fotosfera. Inoltre, dato che si veri ca un oscuramento anche del cielo, durante un’eclisse totale si rendono visibili le stelle più luminose e i pianeti Questo spettacolo eccezionale non si veri ca per gli altri tipi di eclisse, perché è garantito solo quando il disco solare è coperto al 100 per cento.
In ne, ci sono le eclissi ibride, come quella che si veri cherà il 20 aprile 2023 e sarà visibile in Indonesia, Australia e Papua Nuova Guinea, con la durata di 1 minuto e 16 secondi.
Un’eclisse ibrida è un raro tipo di eclisse solare che cambia il suo aspetto mentre l’ombra della Luna si sposta sulla super cie terrestre.
Più precisamente, un’eclisse ibrida si manifesta come un’eclisse anulare oppure un’eclissi totale, a seconda della posizione dell’osservatore lungo
il percorso centrale dell’eclisse. Infatti, durante questo genere di eclisse, la curvatura della Terra porta alcune aree del percorso dell’eclisse nell’ombra della Luna, producendo l’eclisse totale, mentre altre aree rimangono fuori dalla portata dell’ombra, provocando un’eclisse anulare.

L’eccezionalità della eclisse totale giusti ca l’interesse per organizzare un tour per la sua osservazione, anche se si tratta di viaggi in genere lunghi e costosi, ma solo se si ha un’alta probabilità di successo per l’osservazione e una buona disponibilità per trasporti e soggiorni.
Tutte condizioni che sono rispettate nel caso dell’eclisse dell’8 aprile 2024, se si prende in considerazione il passaggio dell’eclisse dal Messico, dove in quella stagione si ha una bassissima probabilità di copertura nuvolosa. Condizioni che non sono soddisfatte per l’eclisse di aprile 2023, sia per la logistica che per le condizioni climatiche previste.
Se analizziamo le eclissi totali di Sole dal 2023 al 2040 con una durata superiore ai 4 minuti, notiamo che sono solo tre:
- 8 aprile 2024, 4 min 28s (Messico, Stati Uniti Centrali, Canada)

- 2 agosto 2027, 6 min 23s (Marocco, Spagna, Algeria, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Yemen, Somalia)
- 22 luglio 2028, 5 min 10s (Australia, Nuova Zelanda) Successivamente, per osservare un’eclissi totale di Sole con una durata superiore ai 4 minuti, bisognerà attendere il 2042! Quindi, per i prossimi cinque anni vale la pena investire nell’organizzazione di un tour per osservare l’eclisse di Sole del 2024. La zona di visibilità di questa eclisse
» A sinistra: la cromosfera solare (in rosso) ripresa durante l’eclisse dell’11 agosto 1999, al di sopra della quale si innalzano brillamenti e protuberanze (Getty images).


Sopra: schema delle circostanze di un’eclisse totale di Sole. Inquadra il QR per vedere una animazione del passaggio dell’ombra dell’eclisse dell’8 aprile 2024 sulla superficie terrestre.
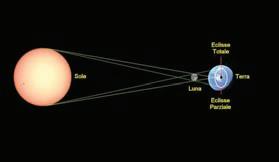
spazia dal Messico, agli Stati Uniti centrali, al Canada, ma la durata massima di 4 minuti e 28 secondi si avrà presso la cittadina di Nazas, nello stato di Durango, in Messico. Questa località ha potenzialmente le caratteristiche climatiche e ambientali migliori per l’osservabilità del fenomeno. Situata a un’altezza di circa 1250 metri slm, presenta un clima secco o steppico, con una temperatura media annuale di circa 21 °C. La copertura nuvolosa e le precipitazioni sono praticamente assenti nel mese di aprile, con temperature medie giornaliere che si aggirano sui 27-30 °C. Nei prossimi numeri di Cosmo entreremo nel dettaglio del progetto di viaggio in Messico per l’osservazione della Great North American Eclipse, che
de nirà il periodo scelto per il tour, la location per l’osservazione dell’eclisse e le condizioni climatiche e ambientali della regione. Elencheremo anche gli strumenti che avremo a disposizione per osservare questo fenomeno magico, al quale ci prepareremo adeguatamente nei giorni precedenti l’eclisse, con l’aiuto di una squadra di esperti. Invitiamo i lettori potenzialmente interessati al viaggio a comunicarlo all’indirizzo eclisse2024@bfcspace.com per ricevere informazioni più tempestive e personalizzate.
*ANTONIO GRANDIERI LAUREATO IN ASTRONOMIA, HA INSEGNATO MATEMATICA E FISICA AL LICEO SCIENTIFICO; SI OCCUPA DI DIVULGAZIONE E FOTOGRAFIA SOLARE.ORGANIZZA UN GRANDE VIAGGIO PER ASSISTERE ALLA GREAT NORTH AMERICAN ECLIPSE



Insieme a un gruppo di esperti che terranno conferenze e osservazioni guidate del cielo. Programma del viaggio su Bfcspace.com/category/mexico-2024
I posti sono limitati! Invia la manifestazione di interesse a eclisse2024@bfcspace.com


DANURI, UN ORBITER LUNARE COREANO
Quante volte abbiamo sentito annunciare che era stato “ricreato il Sole” in laboratorio? Che la stessa fonte di energia che fa funzionare la nostra stella sarebbe diventata presto una risorsa illimitata e non inquinante per tutta l’umanità?

L’ultimo di questi annunci è arrivato il 5 dicembre scorso dal Lawrence Livermore National Laboratory (Llnl), in California, dove è stata innescata una reazione di fusione nucleare controllata, in grado di produrre circa 1,5 volte la quantità d’energia immessa nel reattore.
La reazione è avvenuta in meno di un miliardesimo di secondo in una capsula sferica di 4 millimetri (vedi foto in alto), che racchiudeva deuterio e trizio, due isotopi dell’idrogeno. Attraverso appositi fori, 192 fasci laser hanno colpito l’interno del contenitore, generando dei raggi X che hanno compresso la capsula, no a ottenere la temperatura di 150 milioni di gradi che ha innescato la fusione.
LA PRIMA MISSIONE PRIVATA VERSO LA LUNA 8
Fornendo 0,57 kilowattora al bersaglio (ma sono occorsi 139 kWh per produrli…), sono stati ottenuti 0,88 kWh di energia di fusione: un guadagno netto, dunque, ma molto relativo.
Il plasma prodotto dal processo è stato “con nato” dagli stessi laser, un metodo diverso da quello utilizzato dal progetto europeo Iter, che è basato sul “con namento magnetico”. In e etti, la corsa alla fusione nucleare è anche una s da tra superpotenze. Il risultato americano arriva dieci mesi dopo un altro risultato notevole: la produzione di 16 kWh per cinque secondi da parte del reattore europeo Jet (Joint European Torus), in Gran Bretagna. Ma ci vorranno comunque ancora molti anni (forse decenni) per arrivare all’uso commerciale dell’energia da fusione. Ricordiamo in ne che questi studi non hanno solo nalità scienti che e tecnologiche, ma anche militari, come ha dichiarato la segretaria Usa all’energia Jennifer M. Granholm: “Il lavoro dei nostri scienziati ci aiuterà a risolvere i problemi più complessi e urgenti dell’umanità, come fornire energia pulita per combattere il cambiamento climatico e creare un deterrente senza e ettuare test nucleari”.
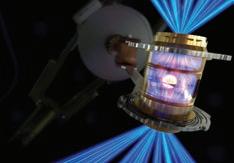
L’Agenzia spaziale europea ha recentemente pubblicato un’immagine ripresa dalla fotocamera per immagini stereo ad alta risoluzione della sonda Mars Express nella regione Ultimi Scopuli, vicino al Polo sud marziano. All’epoca dello scatto (maggio 2022), nell’emisfero australe era primavera, il ghiaccio cominciava a ritirarsi e molte dune scure facevano capolino attraverso il gelo.
Nell’immagine prodotta dalla sonda che quest’anno compie 20 anni di esplorazioni marziane, è inquadrato un grande cratere da impatto, il cui interno è striato da strati alternati di ghiaccio e sedimenti ni. Si pensa che la polvere scura provenga da antichi strati sepolti di materiale, che è stato eruttato da antichi vulcani. Questo materiale può essere trovato su tutto il pianeta, perché riesce a di ondersi facilmente grazie ai forti venti che so ano sul Pianeta rosso.
Completano la scena strati di nebbie, specialmente nella parte centrale dell’immagine. Durante l’inverno, ai poli di Marte si deposita ghiaccio di anidride carbonica, un fenomeno che interessa circa il 15 per cento dell’atmosfera marziana. Questo ghiaccio sublima in primavera, facendo aumentare la pressione atmosferica e generando forti venti. Così si crea un enorme scambio di materiale tra la super cie e l’atmosfera durante tutto l’anno marziano.

Lo studio degli esopianeti, oltre a fornirci una varietà esagerata di tipologie planetarie, al di là di quelle che no a pochi decenni fa conoscevamo nel nostro Sistema solare, ci consente di spaziare anche nel tempo: abbiamo scoperto esopianeti allo stato nascente, ancora avvolti dalla nebulosa stellare in cui si stanno formando, altri in età matura, altri invece prossimi alla loro ne.

Uno di questi ultimi è Kepler-1658b, che sta procedendo inesorabilmente verso l’inghiottimento stellare all’interno di un vecchio sistema planetario. Scoperto dal telescopio spaziale Kepler della Nasa, mostra un’orbita spiraleggiante e sempre più stretta attorno alla sua stella ospite, che si trova in una fase evolutiva avanzata. Curiosamente, Kepler-1658b è il primo esopianeta scoperto da Kepler, nel 2009, ma sono occorsi molti anni per confermare la sua esistenza. E il suo tracciamento, proseguito da terra all’Osservatorio Palomar e poi dallo spazio con il satellite Tess, ha rivelato il suo lento avvicinamento alla stella madre. Kepler-1658b ha massa e dimensioni simili a quelle di Giove, ma è caldissimo, essendo molto vicino alla sua stella, con un periodo orbitale di soli 3,8 giorni. Il motore di questa “attrazione fatale” è da ricercare nelle forze di marea, che sono in aumento, per via della espansione della vecchia stella madre, che sta entrando nella fase di “sub-gigante”. Forze che vengono dissipate all’interno del pianeta, contribuendo al suo riscaldamento.
Porta la rma di un giovanissimo ricercatore la scoperta di una stella variabile nella costellazione meridionale della Carena. Lorenzo Sassaro ha 16 anni, studia in un liceo di Valdagno (VI) e – da grande appassionato del cielo – frequenta il Marana Space Explorer Center (Marsec) di Marana di Crespadoro (VI), delegazione territoriale dell’Unione astro li italiani (Uai). E proprio sotto la guida degli esperti Ivo Peretto e Stefano Lora del Marsec, Lorenzo è riuscito a individuare la stella variabile, che è stata denominata MarSEC2_V2 Lorenzo ha studiato da casa gli oggetti celesti dell’emisfero australe, analizzando i dati pubblici di recenti survey, grazie al cosiddetto data-mining, per cercare le stelle variabili, dopo un tutoraggio curato da Stefano Lora. L’attività condotta da Lorenzo ha dato il suo primo frutto in tempi eccezionalmente brevi: la scoperta è stata sottoposta all’American Association Variable Stars Observers, l’ente internazionale per le stelle variabili, che l’ha approvata dopo i necessari controlli. La stella variabile MarSEC2_V2 si trova a 1480 anni luce di distanza, ha una temperatura di 10.800 gradi e varia la sua luminosità con un periodo di un giorno e mezzo. Questi dati suggeriscono che si tratta in realtà di una coppia di stelle che interagiscono. La scoperta incoraggia la Sezione “Stelle Variabili” della Uai nella sua opera di coinvolgimento di ragazzi che con passione si dedicano alla ricerca astronomica.
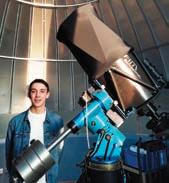

Dopo oltre 30 anni di ideazione, progettazione e test, il progetto Square kilometre array (Ska, il radiotelescopio da “un chilometro quadrato”) sta nalmente diventando una realtà. In Australia e in Sudafrica sono iniziati i lavori per quello che sarà il radiotelescopio più importante al mondo.

Ska è considerato uno degli sforzi scienti ci globali più ambiziosi del XXI secolo, coinvolgendo sedici Paesi in cinque continenti. L’Italia vanta una lunga tradizione nel campo della radioastronomia e tramite l’Istituto nazionale di astro sica (Inaf) è una delle prime nazioni ad aver preso parte al progetto. Grazie alla leadership dell’Inaf, tutta la comunità scienti ca italiana godrà di un coinvolgimento trasversale in Ska.
In Sudafrica verranno installate 133 antenne a parabola di 15 metri di diametro (a sinistra in gura), in aggiunta alle 64 antenne del telescopio MeerKat già esistenti, per captare segnali radio a media frequenza. L’Australia ospiterà un array di 131.072 antenne, ciascuna alta due metri e a forma di albero di Natale per segnali a bassa frequenza (a destra in gura).

Già dalla ne di questo decennio, gli scienziati di tutto il mondo useranno le antenne di Ska per rispondere a domande cruciali sulle prime fasi di vita dell’Universo e per svelare alcuni dei misteri più profondi dell’astro sica. Vedi la notizia completa su Bfcspace alla pagina bit.ly/3VGQmCi e inquadra il QR per un video di presentazione di Ska.
La Cina si prepara a realizzare sulla sua stazione spaziale Tiangong un sistema sperimentale di generazione e trasmissione di energia solare in vista del suo completamento nel 2028. Lo ha annunciato il progettista capo della stessa Tiangong, Yang Hong, nel corso di una presentazione alla China Space Conference
Il progetto è stato avviato con la China Academy of Space Technology, il più grande fornitore di navicelle e tecnologia spaziale cinese. La prima fase sarà quella del trasporto in orbita del materiale necessario, per mezzo di un vettore Long March 9 e della costruzione che sarà e ettuata attraverso il braccio meccanico della Tiangong. La seconda fase prevede che il modulo di generazione, conversione e trasmissione, una volta realizzato e spostatosi in orbita geostazionaria a 35.800 km dalla Terra, inizi la fase sperimentale di trasmissione nel 2028.
La terza fase, nel 2035, prevede la generazione di energia solare con una potenza di 10 megawatt, mentre con la quarta e ultima fase, nel 2050 si dovrebbe arrivare a 2 gigawatt, grazie a più impianti operativi. Vi è poi la struttura terrestre che dovrà ricevere e smistare l’energia prodotta nello spazio. Il primo tassello è l’antenna alta 75 metri realizzata dalla Xidian University ( gura). Le strutture di generazione che opereranno in orbita avranno dimensioni di 1000 per 100 metri, trasmettendo poi verso Terra l’energia prodotta attraverso fasci di microonde con lunghezza d’onda di 55 metri.
Il gigante del settore alberghiero Hilton Worldwide Holdings ha rmato un contratto per la progettazione di suite e altre strutture, per gli astronauti della stazione spaziale privata Starlab, attualmente in fase di sviluppo da parte di Nanoracks, Voyager Space Holdings e Lockheed Martin.

Questa partnership tra aziende spaziali e il settore alberghiero potrebbe costituire un primo passo verso la realizzazione di progetti di hotel orbitali, ipotesi a lungo accarezzata dai due settori. Nel dicembre 2021 erano stati annunciati i tre vincitori dei fondi del programma Commercial Leo Development della Nasa, nalizzato alla costruzione delle future stazioni spaziali commerciali.
La partnership con Hilton nasce da una relazione tra le due compagnie iniziata con l’esperimento “biscotti spaziali” del 2020 che ha coinvolto Nanoracks. In quella occasione, il nostro astronauta Luca Parmitano e l’astronauta della Nasa Christina Koch avevano cucinato i biscotti DoubleTree, con l’obiettivo di testare il forno sperimentale di Zero-g Kitchen, con un impasto pronto fornito dal marchio DoubleTree di Hilton.
Danuri, l’orbiter della Corea del Sud lanciato il 5 agosto 2022 a bordo di un Falcon 9, ha raggiunto l’orbita lunare e, prima della ne del 2022, ha portato a termine tutte le manovre per arrivare all’orbita necessaria per svolgere le sue attività. Il primo orbiter lunare coreano, chiamato anche Kplo (Korea Path nder Lunar Orbiter), misura 1,4 metri di diametro per un’altezza di 2,3 metri, mentre i suoi pannelli solari raggiungono un’estensione di 7,5 metri.
La traiettoria utilizzata da Danuri è stata adottata recentemente anche dalla sonda Capstone e dal lander giapponese Hakuto-R

M1. Si chiama Ballistic Lunar Transfer e permette di raggiungere l’orbita lunare utilizzando molto meno carburante, ma impiegando molto più tempo. Dopo quasi cinque mesi di viaggio, Danuri ha cominciato a mappare la topogra a lunare, utilizzando quattro strumenti scienti ci realizzati in patria. Secondo i programmi, la missione durerà solo per il 2023, ma il team di Kplo vorrebbe estenderla di un altro anno, sempre che le condizioni della sonda lo permettano.

Grazie a Danuri, l’agenzia spaziale sudcoreana Kari diventa la settima agenzia a raggiungere con successo l’orbita lunare dopo Russia, Usa, Giappone, Europa, Cina e India.

L’11 dicembre, dopo diversi rimandi, è stata lanciata con un Falcon 9 la missione M1 dell’azienda giapponese ispace. A bordo del razzo si trovava anche il cubesat Lunar Flashlight, arrivato in ritardo per il lancio di Artemis I. Secondo i piani di viaggio, il lander Hakuto-R M1 ha passato il primo mese di viaggio allontanandosi dalla Terra di circa 1,4 milioni di chilometri, diventando la sonda privata più lontana di sempre, e spenderà poi altri quattro mesi per spiraleggiare verso la Luna. Una volta sulla super cie, il lander da 2,3 metri di altezza per 2,6 metri di lato scaricherà il piccolo rover Rashid dell’agenzia spaziale emiratina e il Transformable Lunar Robot della giapponese Jaxa, una palla robotica da 8 centimetri di diametro, che esplorerà la super cie lunare grazie alla sua capacità di cambiare forma (vedi gura e inquadra il QR per un video dedicato alla missione).
Ma Hakuto-R M1 preleverà anche un po’ di materiale lunare, grazie a un meccanismo che farà cadere una manciata di regolite all’interno del piede del lander. Questo sarà il primo simbolico prelievo che in successive missioni potrebbe essere eseguito in modo più sostanzioso per essere venduto alla Nasa, in base a un contratto già siglato da ispace nell’ambito degli Artemis Accords.






» A sinistra: il rendering di una rete globale di connessioni per telecomunicazioni creata grazie a grandi costellazioni di satelliti artificiali.
Sopra: la ripresa del gruppo di galassie NGC 5353/4 realizzata al Lowell Observatory, in Arizona. Le linee diagonali sono scie di luce lasciate da satelliti Starlink che attraversano il campo visivo del telescopio.
Da qualche anno a questa parte, alzando lo sguardo al cielo, capita di osservare, oltre alle meravigliose costellazioni stellari, anche quelle dei satelliti arti ciali. Perlopiù si tratta di piccoli satelliti applicativi, in particolare per servizi di telecomunicazioni. Pertanto, non si tratta di costellazioni stellari e nemmeno di Ufo (come tante volte vengono segnalate dagli osservatori occasionali), dato che sono oggetti perfettamente identi cati.

Il più delle volte, si tratta di “collane” della costellazione Starlink, formata da una lunga serie di piccoli satelliti. Non è più una novità. Poiché da quando la miniaturizzazione ha reso anche i satelliti arti ciali sempre più piccoli, ma altrettanto funzionali, sono sempre più numerose le compagnie spaziali che ne inviano tanti, sino a centinaia in un colpo solo. Cioè, in un solo lancio con uno stesso razzo vettore.
L’esempio più noto è proprio quello della costellazione Starlink di SpaceX, che punta a inviare in pochi anni su orbite diverse attorno alla Terra sino a centinaia di migliaia di piccoli satelliti per varie applicazioni: telecomunicazioni, internet
sempre più veloce, TV digitale, telefonia mobile. Creando però non pochi problemi per le osservazioni astronomiche e le ricerche in campo astro sico, sia nell’astronomia ottica che nella radioastronomia, anche con i più potenti osservatori terrestri.
Da circa un anno, l’astro sico Piero Benvenuti dirige il nuovo Centro per la protezione del cielo buio e silenzioso dall’interferenza delle costellazioni satellitari, che ha due sedi, una negli Usa, a Tucson (Arizona), e una in Europa, a Manchester, in Gran Bretagna. “È il tentativo dell’Unione astronomica internazionale di “salvare” l’oscurità,
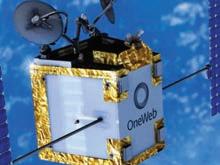

Piero Benvenuti è nato il 16 febbraio 1946 a Conegliano (Padova) e attualmente è professore emerito dell’Università di Padova. Dal 1977 al 1984 è stato ricercatore per l’osservatorio spaziale ultravioletto Iue (International Ultraviolet Explorer) in ambito Esa (Agenzia spaziale europea). Dal 1984 al 2003 è stato responsabile europeo all’Hubble Space Telescope Coordination Center presso la sede Esa a Garching, in Germania.
Nel 1986 è diventato professore ordinario presso l’Università di Cagliari, incarico che ha ricoperto fino al 2007, per il quale ha insegnato astrofisica delle alte energie, fisica del plasma spaziale e storia dell’astronomia. Dal 2003 al 2007 è stato presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), poi è diventato un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), posizione che ha tenuto 2007 al 2011.
Dal 2007 è professore ordinario nel Dipartimento di Fisica e Astronomia presso l’Università di Padova, dove insegna astrofisica delle alte energie, astronomia e storia dell’astronomia. Dal 2011 è anche consulente del Pontificio Consiglio della Cultura a Città del Vaticano. Da agosto 2012 a agosto 2015, è stato segretario generale aggiunto della Iau (International astronomical union), primo italiano a ricoprire questo ruolo, e in seguito è diventato segretario generale fino ad agosto 2018.
Nel novembre 2018, è stato nominato Commissario straordinario dell’ Asi dal Ministero della Ricerca Scientifica, prima della nomina dell’attuale presidente Asi, Giorgio Saccoccia.
e quindi la ricerca astronomica” –dice Benvenuti, che sta portando avanti una battaglia in difesa delle osservazioni astronomiche di terra, che rischiano di restare “o uscate” da queste costellazioni di migliaia di satelliti.
Professore emerito di astro sica dell’Università di Padova, una vita e una carriera dedicata a studiare il cosmo lavorando in osservatori astronomici terrestri e a missioni spaziali di grande rilevanza, a cominciare dal telescopio spaziale Hubble, che ha seguito nel suo ruolo di astro sico dell’Esa (l’agenzia spaziale europea), Benvenuti precisa: “Non siamo contrari ai satelliti per utilizzi vari, anzi. Ma a quelle costellazioni formate da migliaia

di questi piccoli corpi arti ciali, realizzate soprattutto da compagnie private, che rischiano di impedire nei prossimi anni la ricerca astronomica”. Cosmo lo ha intervistato in occasione del recente New Space Economy Forum, organizzato dalla Fondazione Amaldi insieme a Fiera di Roma.
Ormai si è partiti, ma è necessario contenere gli e etti negativi di questo continuo lancio di grappoli di centinaia di satelliti. Se arriveranno, come pare, a 100mila, saremo al limite. Superata questa soglia, sarà quasi impossibile evitare l’interferenza dei satelliti su qualsiasi
ricerca in campo astronomico da terra.
La costellazione che oggi risulta più problematica è la Starlink, progettata tre anni fa da Elon Musk, con SpaceX, che prevede un totale di 42 mila satelliti! Gli astronomi si sono preoccupati e hanno simulato l’impatto futuro sulle osservazioni, e il risultato è notevole. C’è una probabilità molto alta di transito di satelliti sulle immagini astronomiche, questo ne riduce il valore scienti co.
In e etti, non è solo un problema da parte di SpaceX. Internet globale e le telecomunicazioni sempre più avanzate interessano molte altre compagnie, come Amazon-Kuiper
e OneWeb, con obiettivi analoghi ma diversi cati rispetto a quelli di SpaceX. E anche Cina, India e Russia hanno in programma la realizzazione di simili costellazioni satellitari. In particolare, ne è prevista una, la Blue Walker 3 di Ast SpaceMobile, che prevede di mettere in orbita ripetitori per telefonia mobile di 64 metri quadrati. Questi avranno un potere ri ettente tale da produrre una luminosità simile a quella della stella Vega. Un prototipo è stato lanciato il 10 settembre 2022 e i suoi e etti letali si sono già visti nel cielo.
Abbiamo iniziato un dialogo diplomatico come Iau (International astronomical union), tramite le organizzazioni preposte, in particolare il Copuos (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) dell’Onu, che opera per l’uso paci co dello spazio e anche per avere regole che limitino l’impatto delle costellazioni. Grazie a questo lavoro di diplomazia, siamo riusciti a ottenere già un primo risultato importante: SpaceX ha cambiato il
Il 28 dicembre 2022 SpaceX ha lanciato dalla Space Force Station di Cape Canaveral i primi 54 satelliti Starlink di nuova generazione (Gen2), andando così a integrare la costellazione per l’Internet globale.

Si è trattato del sessantesimo lancio del 2022 per SpaceX, quasi raddoppiando i 31 lanci e ettuati nel 2021. I nuovi satelliti sono stati inseriti in una nuova orbita, a circa 530 chilometri di quota.
Oltre ad aumentare il tra co di rete e la velocità, i satelliti di Gen2 saranno in grado di fornire la connessione via satellite direttamente agli smartphone: un ulteriore passo verso l’obiettivo di SpaceX di fornire la copertura Internet in ogni angolo del pianeta.
Inquadra il QR per la ripresa del lancio.

rivestimento dei satelliti Starlink, e ha poi creato uno schermo per evitare che i pannelli solari brillino, ri ettendo la luce del Sole. Insomma, è già un primo, importante risultato. Ora stiamo preparando nuove azioni con il supporto di oltre venti delegazioni nazionali. Il prossimo incontro, di grande importanza, si terrà entro questo mese di febbraio. Abbiamo il supporto di molti, ma non è semplice ottenere il consenso di tutti…
Per questa discussione, spesso faccio l’esempio della plastica Un’invenzione eccezionale diventata un problema, perché non abbiamo pensato subito a regole di riciclo e smaltimento. La stessa cosa va fatta con i satelliti, che sono un’invenzione straordinaria e sono fondamentali per tante nostre attività. Però va trovato il modo di non intasare lo spazio, che già è popolato da migliaia di detriti spaziali grandi e piccoli, e ora con questi oggetti che limitano o possono persino annullare la ricerca astronomica.
RISULTATI DI HUBBLE, COSA POSSIAMO ATTENDERCI
DAL WEBB TELESCOPE?
Fortunatamente, i telescopi spaziali non sono disturbati dalle costellazioni satellitari!
Con il telescopio spaziale Hubble, abbiamo avuto trent’anni di scoperte straordinarie. E ora abbiamo il James Webb, che è davvero un miracolo tecnologico e ci darà sicuramente tanti risultati scienti ci, tenuto conto delle meraviglie che già ci o re, dopo solo pochi mesi di operatività. Hubble fu progettato appositamente per essere riparato e sottoposto
a manutenzione da parte degli astronauti, dato che è stato collocato in orbita a circa 600 chilometri dalla super cie terrestre. Il Webb si trova in una posizione più vantaggiosa, per le osservazioni, nel punto lagrangiano L-2, a un milione e mezzo di chilometri da noi, ma è impossibile da raggiungere e ha richiesto pertanto delle soluzioni molto più avanzate. Certamente, Hubble, grazie alle riparazioni e agli aggiornamenti e ettuati anche da parte di astronauti dell’Esa, per essere un progetto risalente agli anni Settanta, è stato anch’esso un miracolo tecnologico. Che, peraltro, funziona ancora!
ELON MUSK HA PROPOSTO

DI SALVARE HUBBLE CON
UNA DELLE SUE DRAGON
Hubble ha ormai terminato la sua vita operativa, ma è andato molto, molto oltre le aspettative, con le sue scoperte e immagini sensazionali. Recuperarlo per non farlo ricadere e distruggere in atmosfera è un’ottima idea. Sono davvero curioso di vedere come la navicella Dragon riuscirà a portarlo in un’orbita più alta e quindi a… “salvare il soldato Hubble”.
UNO DEGLI OBIETTIVI
DEL WEBB È LA RICERCA DI ESOPIANETI.
CREDE CHE VI SI POSSA
TROVARE LA VITA?
La possibilità che forme di vita analoghe a quelle che conosciamo sulla Terra si siano sviluppate in altri pianeti extrasolari è oggi un’ipotesi che, su basi scienti che, non si può escludere, anzi appare ogni giorno più plausibile. L’evoluzione unitaria del cosmo, come oggi la conosciamo, l’evoluzione chimica del
mezzo interstellare dal quale si sono formate stelle e pianeti, il numero continuamente crescente di sistemi planetari scoperti attorno a stelle di ogni tipo, sono tutti indizi che inducono a pensare che l’evoluzione biologica e per no l’emergere della coscienza possano essere ritenute delle caratteristiche proprie e globali dell’Universo stesso.
D’altra parte, vanno considerate, sempre su base scienti ca, le enormi distanze cosmiche che intercorrono tra i possibili pianeti extrasolari “abitati”, che si traducono in tempi lunghissimi, se teniamo conto del limite sico della velocità di propagazione di ogni tipo di
informazione, cioè la velocità della luce. Se a questo aggiungiamo la durata e mera del “fenomeno umano”, a confronto con i tempi scala dell’evoluzione cosmica, otteniamo che purtroppo è praticamente nulla la possibilità che si riesca a entrare in contatto, anche solo per una comunicazione a distanza, con le eventuali forme di vita cosciente presenti nell’Universo.
*ANTONIO LO CAMPO
GIORNALISTA AEROSPAZIALE, SCRIVE PER QUOTIDIANI NAZIONALI E PERIODICI, E PER “COSMO” CURA LA SEZIONE SPAZIO.
Sul numero di dicembre 2022 (Cosmo n. 34) abbiamo fatto il punto della situazione e passato in rassegna le prospettive del prossimo futuro per i rover lunari. In questo numero ci spingiamo più lontano ed esaminiamo come procede l’esplorazione robotica di Marte, nella paziente attesa della partenza di ExoMars, la travagliata missione europea per la quale si parla adesso del 2028.
Lo studio in situ della super cie di Marte è iniziato con le sonde gemelle Viking, discese in luoghi diversi del pianeta nel 1976. I Viking avevano a bordo quattro strumenti ispirati dal grande Carl Sagan e dedicati alla ricerca di tracce biologiche, anche inerti, nel suolo. Gli strumenti, che funzionarono alla perfezione, cercavano molecole organiche collegate a forme di vita basate su carbonio e acqua.
Utilizzando il braccio meccanico fornito di una paletta, i due lander riuscirono a raccogliere una piccola quantità del terreno sabbioso di fronte alla sonda e portarla dentro la sonda stessa per accurate analisi chimiche, basate sull’osservazione di eventuali reazioni quando il campione raccolto era posto in un ambiente umido o con nutrienti (portati da Terra).
Nessuno dei quattro esperimenti diede un risultato positivo. Forse uno di essi trovò qualcosa, ma si trattò di indicazioni molto indirette, che non furono in grado di fornire prove convincenti. Per mettere nella giusta prospettiva questo risultato basato sull’analisi di qualche cucchiaiata di sabbia raccolta in un paio di località scelte a caso sulla super cie di Marte, dobbiamo considerare che, se ripetessimo lo stesso esperimento sulla Terra in un deserto in alta quota, esposto alla radiazione ultravioletta, i risultati non sarebbero molti diversi.
Dopo i Viking, l’esplorazione in situ di Marte ha avuto una battuta d’arresto e si sono dovuti aspettare 20 anni per ricominciare con la sonda Path nder e il suo robottino mobile Sojourner, che ha dimostrato le potenzialità straordinarie o erte dagli spostamenti sulla super cie del pianeta.
» Un selfie di Curiosity a spasso per Marte.
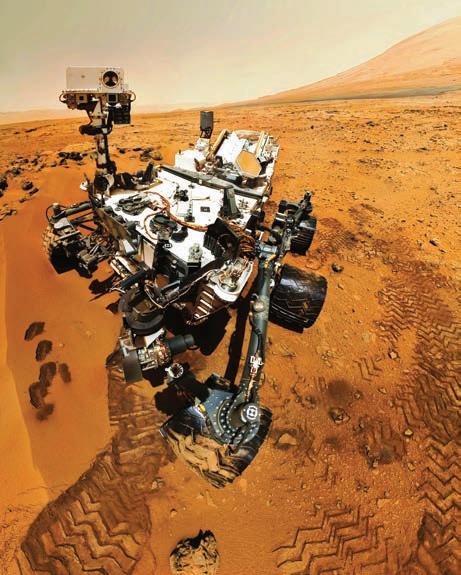
La mobilità marziana era la base della proposta presentata da Steve Squyres alla Nasa per costruire un rover molto più grande e complesso. La proposta venne accettata nel 2001, con la clausola di preparare due rover per sicurezza, in considerazione dei rischi degli “ammartaggi”. Iniziò così una corsa contro il tempo per arrivare alla “ nestra di lancio” di giugnoluglio 2003 per i Mars Exploration Rovers, che a seguito di un concorso tra gli studenti di tutte le scuole americane, sono stati battezzati Spirit e Opportunity.

Spirit è stato lanciato il 10 giugno 2003 ed è atterrato su Marte il 4 gennaio del 2004, mentre Opportunity è partito il 7 luglio 2003 ed è arrivato il 25 gennaio 2004. Al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) avevano attrezzato due sale di controllo su piani diversi e di colore diverso per cercare di evitare confusione ai team che dovevano lavorare in “tempo marziano”: la di erenza tra il giorno terrestre e il “sol” marziano fa spostare ogni giorno i turni di mezz’ora per poter utilizzare tutta la nestra di comunicazione per ricevere dati e inviare istruzioni ai rover che, pur potendo contare su un basilare sistema di guida autonoma, non possono essere lasciati soli. Le traversie della costruzione e del lancio dei due rover sono state raccontate da Steve Squyres nel libro Roving Mars, che è poi diventato anche un documentario Disney nel 2006.
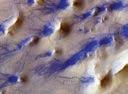
Spirit e Opportunity sono stati un successo straordinario per la Nasa: progettati per durare pochi mesi, hanno scorrazzato sulla sabbia

di

di Marte per anni. La durata della missione era stata calcolata supponendo che l’abbondante polvere marziana avrebbe ricoperto i pannelli solari, diminuendo le loro prestazioni e, quindi, l’energia disponibile per fare funzionare la strumentazione. Ma al Jpl non avevano tenuto conto dei dust devils, i mulinelli di sabbia che hanno spolverato i pannelli solari, ripristinando la produzione di energia. Le macchine fotogra che dei rover ne hanno immortalati moltissimi, realizzando delle sequenze
impressionanti, dato che questi mulinelli sono l’unica presenza animata nel paesaggio marziano. Spirit e Opportunity non avevano a bordo strumentazioni studiate speci camente per la ricerca della vita, e così non hanno fornito contributi interessanti al riguardo. Hanno però confermato l’evidenza
*PATRIZIA CARAVEO
È DIRIGENTE DI RICERCA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF) E LAVORA ALL’ISTITUTO DI ASTROFISICA SPAZIALE E FISICA COSMICA DI MILANO.
di un passato con acqua liquida sulla super cie di Marte, dimostrata dalla presenza di rocce sedimentarie e dalle piccole sferule bluastre di ematite che ricoprivano il luogo di atterraggio di Opportunity
Spirit ha smesso di rispondere nel 2010 e la sua missione è stata dichiarata conclusa nel 2011, mentre Opportunity ha continuato la sua esplorazione arrivando a oltre 5000 giorni di attività. Nell’estate del 2018, dopo avere percorso 45 km sulla super cie marziana, si è arreso alla durezza delle condizioni meteo

Good Night Oppy è un documentario dedicato alla missione di Opportunity che copre oltre due decadi di storia. Guardando il cambiamento dei protagonisti umani, si tocca con mano la durata di questa missione spaziale. In un’intervista rilasciata nel giugno 2003, in occasione del lancio dei rover, Steve Squyres è un bell’uomo dai capelli scuri che dichiara di avere già dedicato 16 anni al progetto. In una chiacchierata più recente, il piglio è sempre lo stesso, ma il look è decisamente ingrigito. Il tempo fa anche crescere le giovani generazioni: una studentessa di liceo, invitata al lancio nel 2003, è stata travolta dall’entusiasmo fino a diventare una scienziata marziana al Jpl.

Il documentario ripercorre la progettazione, la costruzione, i test, il lancio, le traversie del viaggio (quando una tempesta solare fa andare in tilt il computer di bordo e il software deve essere ricaricato), l’arrivo, i risultati ottenuti e i problemi a rontati durante gli anni di operazioni delle sonde che, con le camere di ripresa sul loro braccio robotico, hanno un’apparenza quasi animata, che ricorda il robottino protagonista del film Wall-E della Disney. È istruttivo vedere per esempio la squadra del Jpl che cerca di riprodurre le condizioni di Opportunity che si è insabbiato, per capire quale manovra fare per cercare di disincastrarlo.


I rover non avevano a bordo strumenti in grado di fornire immagini ad alta risoluzione, ma il documentario non lesina sugli e etti speciali, così realistici da far pensare che ci fosse qualcuno su Marte a filmare i rover. Chissà che cosa sarà possibile ottenere con i filmati ad alta risoluzione prodotti da Perseverance Inquadra il QR per un trailer del documentario (disponibile su Amazon Prime).
forse era rimasta troppo tempo senza energia e si era congelata. La missione è stata dichiarata conclusa all’inizio del 2019: per tutti gli appassionati è stato come perdere un vecchio amico, ormai per tutti “Oppy”.
mentre stava esplorando la valle della Perseveranza, il luogo giusto per terminare una missione storica. Quando, a giugno 2018, gli strumenti in orbita avevano fotografato un’enorme tempesta, si
era capito che Opportunity sarebbe stato colpito in pieno e i responsabili lo avevano messo in ibernazione, sperando di poterlo risvegliare alla ne della bufera. Ma la sonda non ha più risposto alle chiamate da Terra:
Il lavoro di esplorazione più recente è a dato alla strumentazione della nuova generazione di rover chiamati Mars Science Laboratory. Il primo, battezzato Curiosity, è sceso su Marte ad agosto 2012, mentre il più recente Perseverance è arrivato nel febbraio 2021. Entrambi hanno le dimensioni di un Suv e sono forniti di generatori di energia basati sul decadimento del plutonio, così possono funzionare indipendentemente dall’insolazione, a di erenza del piccolo Oppy. Curiosity ha recentemente raggiunto una zona ricca di sali, che lasciano presupporre un passato con acqua abbondante. Questa area era stata scoperta dal Mars Reconnaissance Orbiter ma ora il rover l’ha raggiunta per condurre esperimenti in situ. Curiosity ha percorso dall’inizio della sua missione circa 29 km in 3700 giorni di lavoro. Perseverance prosegue nella raccolta dei campioni marziani, accompagnato dal piccolo droneelicottero Ingenuity che ha compiuto alcuni piccoli voli dimostrativi, inaugurando l’era dell’esplorazione aerea sul Pianeta rosso. I campioni raccolti da Perseverance e depositati in apposite provette sulla super cie marziana saranno prelevati dalla missione congiunta Nasa-Esa Mars Sample Return (Msr) che partirà nel 2027 per trasportarli a Terra. Inquadra il QR per un video dedicato alla missione Msr.





Tra qualche rinvio nelle missioni di preparazione al lancio, qualche lancio avvenuto puntualmente, e rendez-vous planetari in perfetto sincronismo, l’esplorazione del Sistema solare è sempre in fermento. In attesa che anche gli astronauti possano tornare ai viaggi interplanetari con le missioni TerraLuna di Artemis, e in seguito con missioni destinate a Marte, i veicoli robotizzati che esplorano pianeti e lune sono sempre numerosi: al momento sono 52 le missioni di veicoli spaziali che operano oltre l’orbita terrestre, per un totale di 59 sonde automatiche (alcune missioni comprendono più di un satellite). Partiamo dalle missioni rinviate. Nel 2022 era previsto il lancio di Psyche, sonda della Nasa che ha perso la nestra di lancio, a causa di un software non completato nei tempi previsti. Il lancio è slittato all’autunno
del 2023. Sempre nel 2022, era previsto Janus, altro veicolo spaziale automatico della Nasa, così come Slim, dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa, che viene rinviato a causa dei ritardi accumulati da un altro progetto con cui doveva condividere il volo. Ma vediamo, passando da un corpo celeste all’altro, a che punto siamo con le missioni attualmente operative.
SULLA LUNA
La missione Artemis I, lo scorso novembre, ha sganciato undici minisatelliti, compreso l’unico europeo: ArgoMoon, dell’Asi, uno dei pochi che ha compiuto la missione con successo.
Il 15 novembre, un giorno prima della partenza del potente razzo Sls con la Orion di Artemis, era arrivata in orbita lunare Capstone della Nasa dopo molti mesi di viaggio, avendo seguito una traiettoria molto più lunga, ma a risparmio energetico, che ha richiesto
minore consumo di carburante. Un trittico di sonde lunari è stato lanciato in dicembre da un Falcon 9 di SpaceX verso la Luna, con un orbiter, un lander e dei mezzi di trasporto. L’orbiter è Lunar Flashlight, realizzato dal Jpl della Nasa; il lander M1 del programma Hakuto-R, è stato realizzato dall’azienda giapponese ispace, che porta a bordo un robot rotolante, e poi c’è il rover emiratino Rashid. Poi ci sono le missioni cinesi: Chang’e 5 è in orbita lunare con solo il modulo di servizio, mentre Chang’e 4 ha sempre il suo rover Yutu-2 sul lato nascosto della Luna e Queqiao in orbita a far da ripetitore al rover. In ne, ricordiamo Chandrayaan-2 (dell’Isro indiana) e Lro (della Nasa), due sonde che dall’orbita mappano la super cie lunare, oltre a emisArtemis (sempre della Nasa), che assieme alle P-1 e P-2 sta tracciando una mappa del campo magnetico in orbita lunare.
NEI PUNTI LAGRANGIANI
Ci sono due punti lagrangiani a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra che grazie a un equilibrio di forze gravitazionali favoriscono lo stazionamento in orbita per due ruoli scienti ci principali: dal punto L1 si osserva bene il Sole e i suoi e etti sulla Terra; dal punto L2 ci si lascia dietro questi due corpi luminosi e si punta allo studio del Sistema solare esterno, della Via Lattea e delle altre galassie. Il telescopio spaziale James Webb è

ormai nel pieno della sua missione operativa, in L-2, e continua a inviare immagini con dettagli senza precedenti che stanno rivoluzionando l’astro sica, come testimoniano le nostre Space News.
I satelliti Dscovr (Nasa/Noaa), Ace (Nasa) e Wind (Nasa) si trovano tutti nel punto L-1, dove raccolgono dati sull’attività solare, sul vento solare e sul suo impatto con la magnetosfera terrestre, insieme alla veterana SoHo (Nasa/Esa), in orbita dal 1995.
Attorno al punto L-2, oltre al James Webb, orbita anche Spektr-Rg, una missione delle agenzie spaziali di Germania e Russia, sulla quale, purtroppo, lo strumento principale, di fattura tedesca, è stato spento all’inizio della guerra russo-ucraina.
E poi c’è il satellite “mappatore stellare” Gaia (dell’Esa), lanciato nel 2013, che dopo aver e ettuato la scorsa estate il terzo rilascio completo dei dati scienti ci, è pronto per nuove indagini: recentemente ha consentito
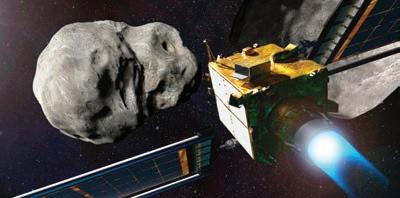
la scoperta del buco nero più vicino alla Terra, una delle due componenti del sistema Gaia Bh-1 (vedi le Space News di Cosmo n. 35)

La sonda BepiColombo dell’Esa procede nel suo viaggio: l’arrivo all’orbita operativa attorno a Mercurio è previsto nel 2025. Venere invece, è già sotto osservazione da più di sei anni, grazie alla sonda giapponese Akatsuki che è nella fase estesa della missione e proseguirà senza una scadenza ssata.
La Parker Solar Probe della Nasa, al 12° passaggio al perielio, ha s orato l’atmosfera solare a soli 8,5 milioni di chilometri dalla super cie.
A osservare il Sole vi sono altre due sonde, Solar Orbiter (Esa), che si avvicinerà sempre di più nel corso degli anni, diminuendo la distanza al perielio e aumentando l’inclinazione orbitale, e Stereo A Passando agli asteroidi, la sonda Dart della Nasa è la prima missione spaziale di difesa planetaria, che dopo aver colpito un asteroide lo scorso settembre per deviarne la traiettoria, continua nel suo viaggio nel Sistema solare. Osiris-Rex della Nasa ha già studiato e visitato l’asteroide Bennu, e sta per trasferire dei campioni sulla Terra. La consegna avverrà “in corsa”, poiché la sonda proseguirà oltre per arrivare a ne decennio a incontrare l’asteroide Apophis, in una nuova missione chiamata Osiris-Apex In ne, la nipponica Hayabusa 2 ha già completato la sua missione primaria, portando a Terra campioni dall’asteroide Ryugu e sta procedendo verso lo studio di altri due asteroidi, 2001 CC21 e 1998 KY26.
Anche sul Pianeta rosso fervono
le attività, sia in orbita che sulla super cie, come abbiamo già indagato su Cosmo n 34. E mentre l’orbiter Tianwen-1 prosegue la sua missione scienti ca, in Cina programmano già una missione marziana più ambiziosa, Tianwen-3, con prelievo di campioni dalla super cie e ritorno a Terra entro il 2031.

Per i veicoli che operano sulla super cie marziana, vedi l’articolo a pag. 22. Aggiungiamo solo che Zhurong, l’ultimo rover arrivato su Marte, con la missione cinese Tianwen-1, prima della fase di ibernazione (sbloccata a ne dicembre), era arrivato sino a 1350 metri di distanza in linea d’aria dal luogo di atterraggio.
La sonda Lucy della Nasa procede nella sua missione, nonostante qualche inconveniente tecnico e scienti co. Nel corso di una campagna osservativa di Polymele, uno degli asteroidi da visitare durante la missione, si è scoperto che l’asteroide (un “troiano” di Giove) è binario, per cui si aggiunge un nuovo corpo celeste agli obiettivi scienti ci. La Juno (della Nasa, con tecnologia e scienza italiana a bordo), ha sorvolato da vicino la vulcanica luna Io di Giove il 16 dicembre scorso. Strumenti permettendo, la sua missione è stata prolungata no al 2025. Ancora più lontano, abbiamo tre sonde attive: New Horizons (Nasa), che continua il suo viaggio in ibernazione a 58 unità astronomiche dalla Terra, e verso lo spazio interstellare le due leggendarie sonde Voyager 1 e Voyager 2, rispettivamente a 162 e 135 unità astronomiche.
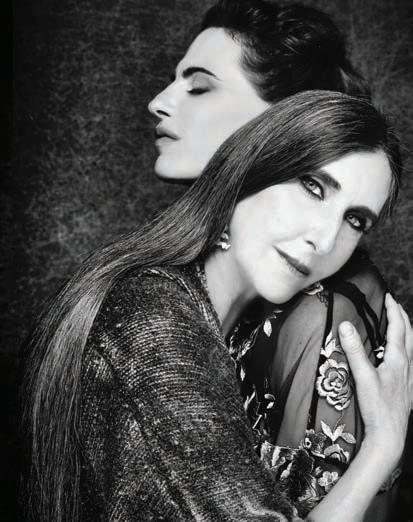

Oggi la logistica spaziale è un’attiva area di ricerca e sperimentazione che vuole rendere più e cace l’esplorazione e le operazioni commerciali. Invece di condurre una missione alla volta, com’è stato fatto in passato, stiamo iniziando a sviluppare intere campagne umane e robotiche che possano essere condotte in maniera più sostenibile. Per questo, è necessario essere consci dell’impatto della riusabilità, della multimodalità e della manutenzione orbitale. Nonché di nuovi standard per il trasporto merci che potrebbero giocare un ruolo signi cativo nel futuro della logistica spaziale.
Quando, negli anni 50, venne sviluppata la strategia di attuazione del neonato programma spaziale americano, la logistica era considerata uno degli elementi chiave. Con la transizione al programma Apollo,
invece, gli elementi legati alla logistica vennero abbandonati.
Ciò impedì lo sviluppo ordinato delle capacità di volo spaziale e la transizione a una più ampia imprenditorialità nello spazio. Il programma spaziale americano degli inizi era una proposta di esplorazione spaziale nalizzata a portare l’uomo oltre questo pianeta, ma che implicava lo sviluppo di alcuni ingredienti base: satelliti in orbita intorno alla Terra, per comprendere i requisiti tecnologici per operare in un ambiente ostile; voli orbitali con equipaggio, per determinare la capacità umana di esplorazione e sopravvivenza; astronavi riutilizzabili per viaggiare da e verso l’orbita terrestre, così da estendere i principi del volo atmosferico allo spazio e renderne le operazioni di routine; stazioni spaziali permanentemente abitate e infrastrutture orbitali critiche, come basi per le future esplorazioni della Luna e dei pianeti; esplorazione
umana della Luna, per creare basi e colonie permanenti; spedizioni con equipaggio verso Marte, con l’obiettivo di esplorarlo e, eventualmente, colonizzarlo. I voli umani rappresentavano il cuore logistico del programma, reso popolare allora da Wernher von Braun. Se questo programma fosse stato eseguito scrupolosamente, avrebbe reso disponibile sin dall’inizio un sistema di accesso allo spazio riutilizzabile, anticipando la presenza umana permanente in orbita alla metà degli anni 70. Avrebbe magari tardato l’esplorazione della Luna di circa una decade, o rendo però una possibilità di esplorare Marte negli anni 90. Tuttavia, questa visione venne abbandonata nel 1961, con la decisione del presidente Kennedy di saltare i progetti di astronavi riutilizzabili e di stazioni spaziali e procedere direttamente alla conquista della Luna.
Hans Mark, direttore dell’Ames Research Center della Nasa negli» Sopra: il rendering di un laboratorio orbitante autonomo, progettato per docking di veicoli spaziali anche automatici, come lo Space Rider dell’Esa. Sotto: rendering di un satellite “acchiappa-detriti”, dotato di meccanismi sofisticati di attracco che permetterà di recuperare satelliti abbandonati in orbita per inviarli a quote più sicure o per farli rientrare in atmosfera.

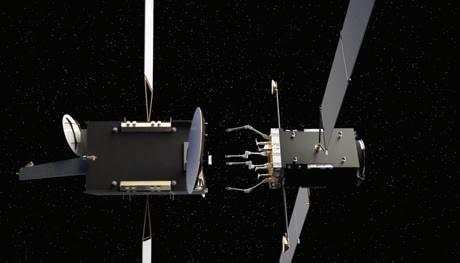
anni 60, aveva espresso un giudizio critico del programma Apollo.
“L’obiettivo del presidente Kennedy è stato debitamente raggiunto, — scrisse nel 1987 — ma abbiamo pagato un prezzo.
Il programma Apollo non ha avuto una logica eredità”. Secondo Mark, il programma Apollo era stato un binario morto, perché non aveva favorito lo sviluppo di capacità di volo spaziale che andassero al di là delle missioni lunari.

Settant’ anni dopo, con il programma Artemis, la Nasa prevede di far allunare la prima donna entro la decade, utilizzando tecnologie innovative per esplorare più super cie lunare di quanta ne sia mai stata battuta sinora. E, negli anni successivi, collaborerà con partner internazionali per portare avanti l’esplorazione in maniera sostenibile. Anche la stazione spaziale Gateway sarà un punto di svolta per la sostenibilità del programma,
diventando l’avamposto intorno alla Luna che supporterà le missioni scienti che e umane, la base futura della logistica verso lo spazio profondo. Verrà costruita con la cooperazione di aziende private e sarà un modello anche per le missioni future verso Marte.
E poi ci sono i 2,9 miliardi di dollari che la Nasa ha assegnato a Space X, che mandano un chiaro segnale di quanto e cienza e riusabilità siano diventati fondamentali per l’esplorazione spaziale. Questo contratto infatti garantirà l’utilizzo del sistema Starship come mezzo di trasporto verso il suolo lunare.
L’allunaggio più recente di un equipaggio risale alla missione Apollo 17 del 1972 (vedi Cosmo n. 34), ma con l’evoluzione tecnologica e i successi dell’ultimo decennio, la visione di una colonizzazione dello spazio si è lentamente risvegliata.
Oggi il manifesto della logistica spaziale sono i satelliti, con decine di migliaia di velivoli posizionati nell’“orbita bassa” (Low Earth Orbit). Enormi costellazioni di satelliti interconnessi tra loro che forniscono molteplici servizi (vedi la cover story a pag. 16).
E nello sforzo di mantenerne la viabilità economica, gli operatori riducono i costi di lancio e operativi. Come diretta conseguenza, l’entusiasmo verso il settore privato è aumentato; così, aziende come SpaceX e Blue Origin hanno proposto la realizzazione di enormi veicoli di lancio riutilizzabili, per trasportarne di più, a costi inferiori. Ma i grandi vettori sono e cienti solo se lanciano grandi carichi a
orbite basse. Se diventa necessario distribuire carichi in orbite diverse, o trasportarli all’estremità del pozzo gravitazionale, ovvero su orbite più distanti, come quelle geostazionarie o cislunari, va raggiunta una velocità di gran lunga più alta. In questo caso, l’utilizzo di razzi convenzionali implica che la percentuale di massa trasportabile scenda dal 5 per cento a meno dell’1 per cento. Inoltre, se il carico è di gran lunga inferiore alla capacità massima di un grande lanciatore, si devono utilizzare razzi di piccole o medie dimensioni, il cui costo, in proporzione al carico trasportato, è più alto.
Diventa indispensabile a darsi a trasporti multimodali, con vettori di grandi dimensioni, come le Starship o i New Glenn, che trasportino le merci in bassa orbita terrestre verso dei “rimorchiatori spaziali” che si occuperanno di portarli alle destinazioni nali.
È quello che sta avvenendo con compagnie come la D-Orbit, che
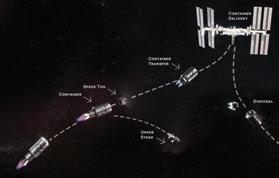
ha già lanciato sei volte il proprio veicolo di trasferimento orbitale (Otv), utilizzando anche razzi di erenti: raggiunta l’orbita iniziale, si sono occupati di portare i satelliti a bordo alle loro di erenti mete nali. La sostenibilità nello spazio non richiede solo il supporto ai veicoli spaziali, ma anche il mantenimento delle orbite libere da potenziali pericoli. È importante difendere il diritto all’accesso allo spazio per le generazioni future, evitando che le conseguenze della cosiddetta Sindrome di Kessler blocchino l’umanità sulla Terra per sempre. La startup svizzera ClearSpace è stata la prima azienda selezionata e nanziata dall’Esa per svolgere la prima missione di rimozione attiva di un rottame in orbita.
Si avvicina un’epoca in cui l’umanità diventerà una specie interplanetaria, espandendo le proprie attività a tutto il Sistema solare. Grandi aziende e startup stanno già lavorando per supportare l’industria al di là dei con ni terrestri. Ma che n’è del trasporto merci, il punto focale di qualsiasi sistema logistico? Bisogna
prima scendere sulla Terra per capire come siamo riusciti a costruire un intero ecosistema al riguardo. Kurs Orbital è una nuova azienda di supporto orbitale, impegnata nello sviluppo di un sistema di rimorchiatori e container che sfrutti la tecnologia di rendez-vous Kurs, responsabile di più del 65 per cento degli attracchi in orbita dal 1985. Un punto focale del suo progetto è la completa riusabilità del proprio rimorchiatore, così da sfruttarne i bene ci economici dove realmente contano. Con i suoi sensori, il sistema di attracco, l’avionica e le capacità di controllo, viene lanciato in orbita una volta sola, dove resta per tutta la durata della sua vita operativa. Senza gli stress e i rischi collegati a continui rientri e lanci orbitali.
Con le prossime stazioni spaziali private in via di sviluppo da aziende come Axiom, Blue Origin, Sierra Space, Lockheed Martin e Nanoracks, ci saranno abbondanti richieste per missioni di rifornimento nei prossimi dieci anni. Sarà davvero necessaria una soluzione e ciente in termini economici, qual è la proposta di Kurs Orbital.
Alla ne saranno la riusabilità, la multimodalità e la standardizzazione dei contenitori merci a portare lo sviluppo della logistica spaziale verso alti livelli di sostenibilità. Questa volta andremo nello spazio per rimanerci.
Lo scorso mese di dicembre è stata annunciata una nuova scoperta nell’ambito dell’a ascinante nuova frontiera dell’astronomia: la ricerca di pianeti extrasolari. Due pianeti che vengono considerati “fratelli della Terra”, poiché molto simili al nostro per dimensioni, e un po’ per caratteristiche, sono stati scoperti intorno alla stella GJ 1002, una nana con solo il 12 per cento della massa del nostro Sole, molto simile a Proxima Centauri, la stella a noi più vicina. Entrambi orbitano a una distanza dalla loro stella tale da mantenere l’acqua allo stato liquido e sarebbero quindi potenzialmente in grado di ospitare la vita. La scoperta di questo sistema esoplanetario, che si trova a soli 16 anni luce di distanza, in direzione della costellazione della Balena, si deve a un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Istituto spagnolo di astro sica delle Canarie, al quale hanno partecipato anche ricercatori dell’Istituto nazionale di astro sica (Inaf) e della Scuola Normale Superiore di Pisa.
Siamo dunque alla ricerca di un pianeta gemello con il nostro.
Ma la nostra Terra rimane un posto “molto speciale”. Sono sempre stato a ascinato dalla catena di eventi che hanno combaciato miracolosamente per far sì che sulla Terra si sia sviluppata la vita, dapprima con forme elementari, e poi come vita cosciente, capace di sopravvivere in ambienti diversi, di costruire relazioni attraverso la parola, di immaginare la matematica, di concepire il canto e la musica, di comprendere e imitare la natura con la tecnologia, di coltivare la bellezza. È di cile immaginare una ripetizione similare di tante circostanze e stimoli, a volte forse fortuiti o provvidenziali, che si sono incastrati perfettamente.
Ma certamente la scoperta di queste simil-Terre nella nostra Galassia, che stimola l’aspettativa di poter trovare forme di vita su altri pianeti, avvalora il celebre Paradosso di Fermi sugli ‘in niti mondi”. La stessa presenza dell’acqua, in gran quantità sul nostro pianeta, è la conferma della complessità di trovare vita. Proprio le nostre missioni spaziali di sonde robotizzate, e anche la scoperta degli stessi esopianeti, ci confermano quanto sia di cile trovare acqua nel Sistema solare, e oltre. Esistono, quindi, altre civiltà oltre alla nostra?
Ricordo una tavola rotonda con il cardinale Tonini, molti anni fa, dove si parlava dell’ipotesi di altre civiltà nel cosmo. Una signora pose la domanda: “se trovassimo altri esseri civilizzati, dovremmo battezzarli?”
Rispose il cardinale: “Oh glia mia, prima di prendere una decisione così importante, vediamo di incontrarli questi extraterrestri!”. In pratica, gli extraterrestri dobbiamo cercarli noi, in attesa che possano cercarci loro. Un posto ideale per entrare in contatto? La Luna potrebbe diventare la base ideale a nostra portata per ricevere segnali radio da eventuali civiltà extraterrestri collocando un radiotelescopio sul suo lato nascosto, protetto dall’inquinamento radio della Terra. Le di coltà pratiche da superare per una simile stazione sono molte, ma non insuperabili, e molti addetti ai lavori, da tempo ci stanno pensando seriamente. Il Seti (Search of Exta-Terrestrial Intelligence), passato da programma governativo a privato, al momento lo reputo un programma di ricerca serio per quanto riguarda l’ascolto dei segnali provenienti da altre eventuali forme di vita intelligente dall’Universo. È un programma che a ronta la tematica
con rigore scienti co. Purtroppo (o per fortuna) non abbiamo ancora risultati che convincono al 100 per 100. D’altra parte, abbiamo certezza solo di ciò che vediamo, tocchiamo e sperimentiamo. E non ci è stato ancora dato di incontrare intelligenze non provenienti dal nostro pianeta. Qualche volta medito sul tema, pensando che non credo che dovremmo aspettarci astronavi aliene in visita; semmai capteremmo segnali radio o radiotelevisivi, perché questo è il modo più semplice per di ondere messaggi nell’Universo.
Al di sotto di queste pretese è la ricerca di forme anche elementari di vita nell’Universo, che ritengo non solo possibile, ma probabile: la cerchiamo su Marte, a due passi da
noi; guriamoci se nel resto del cosmo non si è veri cata quella coincidenza in grado di sviluppare un sistema capace di riprodursi, sfruttando le risorse ambientali.
AVVISTAMENTO ALIENO
Molto spesso, durante le conferenze, mi chiedono: “Ha mai visto Ufo o cose simili, dai nestrini dello Shuttle, durante la sua missione?”. La mia risposta è che di cose strane se ne vedono molte, da quel panorama davvero particolare del cosmo. Ma niente Ufo. Forse la curiosità maggiore riguardò l’aver visto alcune “stelle cadenti”, che certamente appartenevano allo sciame delle Perseidi, dato che la missione si
svolgeva nella prima metà di agosto del 1992. Queste meteore si accendevano lando verso la Terra, con i bagliori intensi, estesi e di lunga durata di tempeste elettriche nell’atmosfera e lampi percepiti singolarmente negli occhi, dovuti alle radiazioni ionizzanti, che possono penetrare nel cranio e colpire la retina, provocando una sensazione simile a un ash. È certamente questo il mio più importante “avvistamento” registrato durante la mia missione.
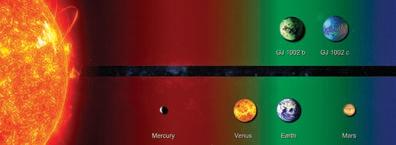

*FRANCO MALERBA
È IL PRIMO ASTRONAUTA ITALIANO AD AVER VOLATO NELLO SPAZIO, NEL 1992. ORGANIZZA IL FESTIVAL DELLO SPAZIO DI BUSALLA (GE) ED È SOCIO FONDATORE DI START UP SPAZIALI.







LE RADIAZIONI EMESSE
DALLE GRANDI ESPLOSIONI STELLARI
POTREBBERO NON ESSERE
SOLO FONTI DI PERICOLI
Quando in una grande stella viene meno l’equilibrio fra le reazioni nucleari e la gravità, essa esplode, liberandosi degli strati più esterni: si ha una “supernova”. Nonostante la loro grande potenza, sono poche le supernovae osservate a occhio nudo nel corso della storia. D’altra parte, se da lontano queste esplosioni possono apparire a ascinanti, da vicino potrebbero causare seri problemi. Fortunatamente, lo spazio è vasto e in gran parte vuoto, e le supernovae sono relativamente rare. Inoltre, per quanto ne sappiamo, la maggior parte dei pianeti presenti nell’Universo non supporta la vita, cosa che dovrebbe rendere queste esplosioni statisticamente innocue per gli esseri viventi. Tuttavia, un nuovo studio mostra come alcuni tipi di supernova abbiano una portata più estesa di quanto si pensasse prima e che potrebbero generare delle conseguenze letali per pianeti come il nostro.

Sono state trovati indizi che le supernovae abbiano in uenzato l’evoluzione della vita sul nostro pianeta. Nel 2018 è stato pubblicato lo studio di un’esplosione stellare avvenuta 2,6 milioni di anni fa a 160 anni luce di distanza da noi. Questa supernova avrebbe avuto un ruolo importante nell’estinzione della mega fauna marina del Pliocene. Circa un terzo delle grandi specie marine della Terra
in acque costiere poco profonde venne spazzato via. E non è stata l’unica. Nel corso degli ultimi 11 milioni di anni sono esplose una ventina di supernovae nell’associazione stellare OB Scorpius-Centaurus, alcune delle quali a 130 anni luce dalla Terra. Una di esse, esplosa circa due milioni di anni fa, ha prodotto radiazioni che hanno impattato così violentemente con la nostra atmosfera da danneggiare lo strato protettivo di ozono. Ci sono diversi tipi di supernovae.
Alcune hanno una portata molto più vasta e una durata molto maggiore di altre, come le supernovae a raggi X di tipo IIn. Quando esplode una supernova a raggi X, emette le stesse radiazioni delle altre, ma una parte di queste radiazioni interagisce con il mezzo circumstellare che circonda la stella, generando raggi X che possono essere letali no a 160 anni luce di distanza.
Queste supernovae emettono anche raggi cosmici, quindi corpuscolari,
che possono arrivare centinaia o migliaia di anni dopo le radiazioni elettromagnetiche. Se questo accade a distanze relativamente vicine al nostro pianeta, i raggi cosmici possono erodere lo strato di ozono e aumentare la radiazione muonica e UV che giunge sulla sua super cie. Secondo gli studi, se un’esplosione di supernova dovesse veri carsi entro circa 25 anni luce dalla Terra, il nostro pianeta probabilmente perderebbe la sua atmosfera e di conseguenza si estinguerebbero tutte le forme di vita.
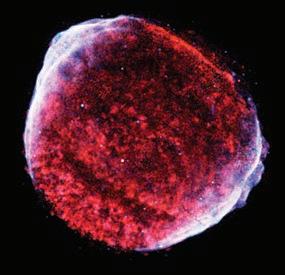
Facciamo una breve carrellata delle supernovae registrate in epoca pretelescopica e quindi particolarmente potenti, ricordando che dopo l’invenzione del telescopio, negli ultimi 400 anni, nessuna supernova è stata così luminosa da poter essere osservata a occhio nudo.
RCW 86: la più antica supernova registrata
Chissà che cosa avranno pensato gli astronomi cinesi del 185 d.C., quando videro apparire una strana “stella ospite” nel “Cancello meridionale”, un asterismo compreso tra Epsilon Centauri e Alfa Centauri “La dimensione era mezza stuoia di bambù. Mostrava vari colori e gradualmente diminuì”. Fu documentata in Cina, ma anche gli astronomi romani potrebbero avere assistito all’evento.
La generazione della supernova
RCW 86 è avvenuta dopo che una stella vicina ha scaricato enormi quantità della propria materia su una nana bianca. Ciò ha portato a una supernova di tipo Ia, esplosa a circa
8000 anni luce dalla Terra. L’onda d’urto ha riscaldato il gas interstellare circostante no alla temperatura di milioni di gradi.
G347.3-0.5: una guest star cinese Questa supernova apparve nel 393 d.C., con una luminosità che fu giudicata simile a quella di Giove. Anche Claudiano fa riferimento a una stella apparsa nei cieli nello stesso anno, ma il collegamento con la supernova G347.3-0.5 è di cile, perché non tornano la durata della sua permanenza nel cielo e la stima della luminosità.

SN 1006
Alla ne di aprile del 1006 apparve una stella incredibilmente luminosa nella costellazione del Lupo. Con una magnitudine stimata di -7,5, si rese visibile anche durante il giorno. Questo evento fu registrato in tutto il mondo: in Cina, Giappone, Iraq, Egitto, Europa e forse anche Nord America, dove un gra to trovato nel White Tank Regional Park dell’Arizona potrebbe rappresentare proprio questo evento.
La descrizione più completa è quella dell’astrologo egiziano Ali Bin Ridwan che, nel suo commentario al Tetrabiblos di Tolomeo scriveva che la stella si trovava bassa sull’orizzonte meridionale, circa tre volte più grande del disco di Venere e raggiunse circa un quarto della luminosità della Luna.
Gli scritti dei monaci dell’abbazia benedettina di San Gallo risultano concordi con queste osservazioni, con l’aggiunta che “in modo meraviglioso era a volte contratta, a volte di usa, e inoltre, a volte spenta”. Altre fonti indicano che la stella era abbastanza
brillante da proiettare ombre.
SN 1054: La Nebulosa Granchio
Il 4 luglio 1054 apparve una nuova stella nella costellazione del Toro. Inizialmente sembra che fosse più luminosa della Luna, per poi a evolirsi lentamente nel corso dei due anni successivi. Anche questo oggetto fu probabilmente visto in tutto il mondo. Alcune opere documentano l’evento, come i petrogli del Chaco Canyon National Park nel New Mexico e nella regione
circostante, anche se non tutti i ricercatori sono d’accordo con questa interpretazione.
Il resto di questa supernova è visibile ancora oggi anche con un modesto telescopio: è la Nebulosa Granchio (M1). Molto probabilmente si è formata da una supernova di tipo II, che si veri ca quando esplode una stella massiccia.
Ancora una volta, gli astronomi cinesi e giapponesi sono stati testimoni dell’esplosione di una stella avvenuta nell’anno 1181 e registrata come guest star. Le immagini del resto di questa supernova restituiscono oggi dettagli incredibili, in particolare grazie alle
» Il resto della SN 1604, la “supernova di Keplero” ripreso nella costellazione di Ofiuco, alla distanza di 16.300 a.l., da tre telescopi spaziali della Nasa: Chandra nei raggi X (in blu), Spitzer nell’infrarosso (in rosso), e Hubble nel visibile (in giallo).

riprese nella banda X eseguite dal satellite Chandra della Nasa. Al suo interno è stata individuata una stella di neutroni in rapida rotazione, una pulsar che spara getti di raggi X per miliardi di chilometri, creando anelli e vortici attorno alla stella.
SN 1572: La supernova di Tycho Nel 1572 apparve una supernova nella costellazione di Cassiopea. L’astronomo danese Tycho Brahe riportò l’osservazione di questo evento nell’opera De nova et nullius aevi memoria prius visa stella (“La stella nuova e mai vista prima nella vita o nella memoria di nessuno”), pubblicata nel 1573, mentre lavorava alla sua mappatura celeste, l’ultima prima dell’arrivo del telescopio. Secondo Brahe, la nuova stella
si trovava oltre la Luna. E aveva ragione: i cieli rivelavano di non essere immutabili come pretendeva l’astronomia classica. In Cina, la SN 1572 diede dei problemi al giovane imperatore Wanli della dinastia Ming, poiché la tradizione cosmologica cinese vedeva nella nuova stella un oscuro presagio e così l’imperatore venne invitato a considerare i suoi comportamenti scorretti.
SN 1604: La supernova di Keplero
La “supernova di Keplero” apparve nel 1604 nella costellazione di O uco e venne seguita nelle osservazioni per più di un anno. Porta il nome di Keplero perché l’astronomo parlò di questo evento nel libro De Stella nova in pede Serpentarii (“La nuova stella nel piede del Serpentario”).
La supernova fu segnalata anche in Cina e in altri paesi, poiché si rese visibile anche di giorno. Fu osservata a occhio nudo per diciotto mesi e al suo picco era più brillante di ogni altra stella del cielo, e anche di molti pianeti, grazie a una magnitudine apparente di -2,5. Ancora oggi, gli astronomi studiano il sorprendente resto di questa supernova.
Il Sistema solare si trova all’interno della cosiddetta “Bolla Locale”, una cavità scolpita nel mezzo interstellare del braccio galattico di Orione dalle multiple esplosioni di supernovae avvenute negli ultimi 10-20 milioni di anni.
Queste supernovae potrebbero davvero essere state parte integrante della storia del nostro pianeta. Infatti, su campioni oceanici risalenti a 2-3
milioni di anni fa è stata trovata la presenza di isotopi radioattivi non decaduti dell’isotopo ferro-60 che ha un tempo di dimezzamento di 2,6 milioni di anni. E le supernovae possono creare questo isotopo quando esplodono. Negli stessi campioni di crosta che contengono il ferro-60 è stato anche trovato il manganese-53, un altro isotopo radioattivo che dovrebbe essere decaduto e che, a di erenza del ferro-60, può essere prodotto soltanto dalle supernovae. Sebbene questi isotopi siano radioattivi, non rappresentano oggi una minaccia per la vita, grazie alla loro rarità, ma la loro presenza induce a pensare che la supernova che li ha creati fosse abbastanza vicina alla Terra e che al tempo dell’esplosione la radiazione che ha colpito la Terra doveva essere molto potente. Ma vediamo quali e etti possono avere le radiazioni prodotte dalle supernovae. Se riescono a indebolire lo strato di ozono dell’alta atmosfera terrestre, possono creare un varco per il passaggio di radiazioni ultraviolette in grado di causare mutazioni nel genoma degli esseri viventi. Questo processo non va considerato però solo in senso negativo, ricordando che la mutazione è il motore principale dell’evoluzione dei viventi. Un’accelerazione delle mutazioni genetiche potrebbe “rimescolare le carte” a favore del processo evolutivo. Gli studi continuano, sistemando a una a una le tessere di un enorme mosaico. L’astronomia, la biologia, la geologia, la chimica e la sica viaggiano su binari che si intrecciano in una trama complessa, per riuscire a de nire il nostro posto nell’Universo.

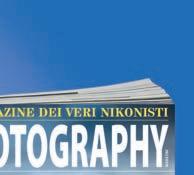










QUALI INDIZI POSSONO SUGGERIRICI DOVE PUNTARE I TELESCOPI PER OSSERVARE IN DIRETTA LA PROSSIMA ESPLOSIONE STELLARE
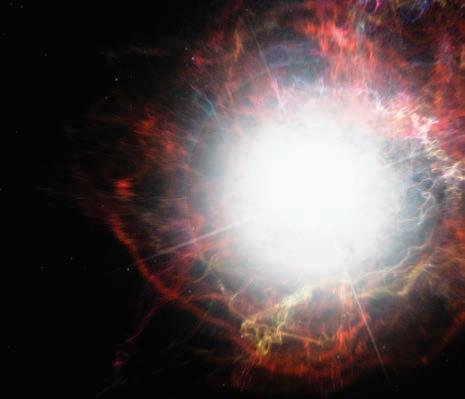
» Immagine artistica di una supergigante rossa in cui si vedono gli strati di polvere formarsi durante l’esplosione (Eso/M. Kornmesser).
Cosa succederebbe se alzando per caso gli occhi al cielo, magari di giorno, trovassimo una nuova stella che non avevamo mai visto? Come minimo resteremmo a bocca aperta e poi inizieremmo a chiederci cosa potrebbe essere quella nuova luce apparsa dal nulla.
Deve essere andata più o meno così in quella lontana estate del 1054, quasi mille anni fa, quando una nuova stella iniziò a brillare nella costellazione del Toro.
Le cronache degli astronomi cinesi ci parlano di questa “stella nuova” che apparve a luglio e rimase visibile in pieno giorno per più di due settimane (vedi l’articolo a pag. 38). Quel fenomeno, che oggi chiamiamo “supernova”, era l’ultimo, spettacolare atto della lunga vita di una stella. Un evento stupefacente e imprevedibile, che turbava l’apparente immutabilità dei cieli. Nei secoli successivi a quello straordinario evento astronomico, abbiamo osservato moltissime altre supernovae, purtroppo quasi tutte in altre galassie, studiandone in dettaglio le caratteristiche siche e costruendo ra nati modelli di queste colossali esplosioni.
Resta un aspetto che contribuisce a rendere le supernovae così a ascinanti, cioè la loro imprevedibilità. Anticipare dove e quando apparirà la prossima supernova è impossibile, ma forse possiamo raccogliere indizi importanti per capire quando una stella si avvia al suo nale esplosivo. Lo sostiene un gruppo di astronomi dell’Università di Liverpool e Montpellier, che in un recente lavoro di ricerca propone un metodo per identi care le stelle che stanno per diventare supernovae. Il lavoro si basa su nuove, so sticate simulazioni delle fasi nali della vita delle supergiganti rosse, studiandone in dettaglio come evolve la luminosità nella fase precedente al fenomeno di supernova. Grazie al nuovo lavoro, pubblicato sulle Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, gli scienziati potrebbero ora disporre di uno strumento per prevedere e quindi riuscire a osservare in tempo reale le supernovae, arrivando così a svelare nel dettaglio i meccanismi di queste straordinarie esplosioni stellari. Nelle loro simulazioni al computer, gli astronomi hanno mostrato cosa succede a queste stelle morenti durante la fase di supergigante rossa, rivelando un importante cambiamento nella luminosità della stella.

Il team di astronomi, coordinato da Benjamin Davis dell’Università John Moores di Liverpoool, si è concentrato proprio sulle fasi immediatamente precedenti l’esplosione. Nel lavoro si prende in considerazione una delle principali classi di supernovae, quelle di tipo IIp.
Gli astronomi suddividono le supernovae in due grandi classi, in base alle proprietà dei loro spettri e all’evoluzione della curva di luce nel tempo.

Le supernovae di tipo I non mostrano righe di assorbimento dell’idrogeno, che sono invece presenti in quelle di tipo II.
La presenza di righe di altri elementi, come il silicio, e la variazione di luminosità nel tempo permettono di suddividere queste tipologie in sottoclassi. Dalle osservazioni sappiamo che in quasi tutti i casi le supernovae sono prodotte dal collasso della stella e dalla successiva esplosione. Questo avviene per le stelle con una massa superiore a circa otto volte quella solare, dato che le stelle più piccole terminano la loro vita come nane bianche, come avverrà anche per il nostro Sole.
Si producono però anche supernovae (quelle di tipo Ia), in conseguenza del trasferimento di materia all’interno di un sistema binario composto da una nana bianca e da stella normale. Quando quest’ultima evolve, espandendosi e trasformandosi in gigante rossa, può trasferire il gas negli strati più esterni verso la nana bianca, che accrescendo materia può arrivare a superare il cosiddetto limite di Chandrasekhar diventando instabile e avviandosi su un cammino che può portarla a esplodere.
Per alcune dozzine di supernovae di tipo IIp esplose in galassie a distanza minori di 90 milioni di anni luce, è stato possibile identi care le stelle progenitrici, grazie alle immagini ad alta risoluzione ottenute in periodi che vanno da dieci anni no a un solo anno prima dell’esplosione. Le progenitrici identi cate sono risultate stelle molto luminose, almeno 10mila volte più del Sole, e con una classe spettrale di tipo M, suggerendo un’identi cazione con supergiganti rosse.

A partire da queste considerazioni, Davis e colleghi hanno compiuto una serie di so sticate simulazioni numeriche, per capire che cosa succede alle supernovae IIp durante questa fase di supergigante rossa, mostrando che la stella può diventare decisamente meno luminosa. Questa variazione sembrerebbe legata alla presenza di materiale circumstellare molto denso e che quindi assorbe la luce stellare.
Il ruolo del materiale circumstellare espulso dalla stella è diventato chiaro nel caso delle improvvise variazioni
di luminosità subite da Betelgeuse fra il 2019 e il 2020, probabilmente attribuibili proprio all’assorbimento da parte di materiale espulso violentemente dalla supergigante rossa. Una importante novità di questo lavoro è lo studio dei tempi tipici su cui si forma questo “bozzolo” di materia intorno alla stella, un aspetto nora non indagato a fondo. Secondo Davis, “Il materiale denso oscura quasi completamente la stella, rendendola cento volte più debole nella banda visibile dello spettro. Questo signi ca che, probabilmente,
il giorno prima dell’esplosione della stella, non siamo capaci di vederla”. Le conclusioni del lavoro sono in accordo con le immagini raccolte delle progenitrici, che si spingono no a circa un anno prima dell’esplosione. Secondo gli autori, questa è un’indicazione che il bozzolo si forma in tempi inferiori all’anno. “Finora siamo stati capaci di raccogliere osservazioni delle supernovae solo alcune ore dopo l’esplosione. Con questo sistema di allerta, possiamo essere pronti a osservarle in tempo reale, a puntare i nostri migliori telescopi sulle stelle progenitrici, e vederle andare in pezzi di fronte ai nostri occhi”. Decisamente un bel posto in prima la per ammirare lo straordinario spettacolo di una stella che esplode.

I MICROFOSSILI AIUTANO A RICOSTRUIRE I CICLI CLIMATICI COLLEGATI CON PERIODICITÀ ASTRONOMICHE

Da che cosa dipendono le grandi e lente variazioni climatiche cui è soggetta la Terra, con andamenti ciclici? Sono dovuti a cause interne o esterne? Non parliamo delle veloci e preoccupanti variazioni dell’ultimo secolo, la cui responsabilità è ben nota (e su cui torneremo nelle ultime righe), ma di quelle che hanno caratterizzato la lunga storia del nostro Pianeta.

Un indizio arriva dallo spazio ed è dato dai cicli di Milankovitch, periodicità astronomiche legate alla rotazione della Terra intorno al proprio asse e al suo moto orbitale intorno al Sole. Le cose si fanno subito complicate, perché per determinare queste periodicità bisogna tenere conto della variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre (tra 22,5° e 24,5°), della precessione degli equinozi e delle oscillazioni dell’ellitticità dell’orbita della Terra (da un minimo di 0,005 a un massimo di 0,06), a causa delle interazioni gravitazionali con Giove e Saturno. Ogni e etto ha un suo periodo. Il più “breve” è la precessione degli equinozi, con un ciclo di circa 26mila anni, poi viene la variabilità dell’inclinazione dell’asse terrestre, che si compie un 41mila anni, e in ne la variazione dell’ellitticità dell’orbita della Terra, che ha un periodo di 100mila anni, modulato da un secondo periodo di 400mila anni. L’astronomo serbo Milutin Milankovitch propose un secolo fa che queste periodicità giocassero un ruolo fondamentale nelle variazioni del clima terrestre, per esempio per spiegare l’alternarsi delle
glaciazioni. Visto che l’e etto con maggiori possibilità di in uenzare l’insolazione della super cie terrestre era quello collegato alla variazione dell’inclinazione dell’asse terrestre, Milankovitch si sarebbe aspettato che il fenomeno si presentasse ogni 40mila anni. Invece, lo studio delle “carote” di ghiaccio estratte da ghiacciai molto antichi (in Groenlandia e in Antartide) ha rivelato che le glaciazioni hanno una periodicità di circa 100mila anni, quindi collegata più alla variazione dell’ellitticità dell’orbita terrestre. Non è chiaro come la modesta variazione dell’ellitticità dell’orbita terrestre possa indurre cambiamenti così signi cativi nella temperatura del pianeta e si pensa che ci siano fenomeni di feedback in grado di ampli care tali variazioni. Potrebbe trattarsi di e etti di risonanza come quelli che si presentano nei sistemi non lineari e che sono stati studiati dal premio Nobel Giorgio Parisi, e etti in cui un “rumore” è in grado di ampli care un segnale di minore intensità e frequenza, invece che coprirlo.
Per esempio, si dovrebbe tenere conto dell’attività solare e delle sue variabilità in termini di luminosità e di intensità del campo magnetico, che possono interferire con il clima terrestre (vedi Cosmo n. 15). Variabilità che, a loro volta, possono essere modulate e ampli cate dalle
La memoria climatica della Terra è conservata molto bene nei resti nanofossili calcarei di microscopiche alghe fotosintetiche unicellulari appartenenti all’ordine dei Coccolitophorales. I loro discendenti sono i Coccolitoforidi, ancora parte integrante del toplancton e giocano un ruolo importante nel ciclo dello zolfo e del carbonio.
La caratteristica più saliente di queste alghe è la loro capacità di produrre i “coccoliti”, placchette calcaree con dimensioni dell’ordine del micron che funzionano come scudi scheletrici esterni. In genere, ce ne sono tra 10 e 30 incastrati tra loro a formare una “coccosfera” che avvolge la cellula. Alla morte della cellula, questi coccoliti precipitano e si depositano in fondo al mare, dove si fossilizzano. Le famose scogliere bianche di Dover, per esempio, sono formate da coccoliti fossili. Come tutti gli organismi viventi, il ciclo vitale di queste alghe (che esistono in plurime specie) dipende dalle condizioni del mare, come temperatura, acidità e salinità. Alcune specie prediligono acque più calde, altre acque più fredde. La stessa specie, inoltre, può raggiungere dimensioni diverse in condizioni diverse. Conoscendo il comportamento delle alghe
attuali, è possibile utilizzare quelle fossilizzate come indicatori climatici di epoche passate. I carotaggi del fondo oceanico, datati con il metodo del carbonio 14, consentono di ricostruire le condizioni di temperatura, acidità e salinità degli oceani, grazie alle caratteristiche dei coccoliti che troviamo in essi. Con l’aiuto dell’intelligenza arti ciale sono state studiate le dimensioni di 9 milioni di placchette fossilizzate, depositate nel corso di 2,8 milioni di anni in carote estratte dai fondali dell’oceano Indiano e del Paci co. La datazione ha prodotto risultati con una risoluzione di circa 2000 anni, mostrando che le dimensioni dei coccoliti del gruppo Noelarhabdaceae, il più facile da riconoscere, varia con cicli regolari della durata di 405mila anni.
I coccoliti più grandi appaiono subito dopo che la Terra raggiunge la massima eccentricità orbitale, mentre quelli più piccoli (che sono anche i più numerosi) hanno un andamento inverso. Un e etto che gli autori dello studio spiegano guardando al toplancton attuale, in quale presenta le maggiori di erenze alle latitudini medie, dove si veri cano le maggiori variazioni stagionali. Forse la periodicità nelle dimensioni dei coccoliti indica che nei momenti di maggiore ellitticità dell’orbita terrestre, si manifestano variazioni stagionali anche nelle zone equatoriali.
Si tratterebbe di un adattamento ai cambiamenti climatici, che forse potrebbe contribuire alle variazioni della temperatura sulla Terra attraverso il ciclo del carbonio che può essere sequestrato in quantità più o meno grande nei coccoliti. Va
tenuto presente che questi organismi sono responsabili della formazione di circa metà delle rocce calcaree (composte da carbonato di calcio) e quindi giocano un ruolo importante nella chimica degli oceani.
In de nitiva, le alghe non si adatterebbero al cambiamento climatico, ma ne sarebbero la causa.
I cicli astronomici avrebbero quindi degli e etti evolutivi che potrebbero modi care il ciclo del carbonio e spiegare perché la temperatura sulla Terra dipenda in modo così importante dalla ellitticità orbitale.
» Sopra: le tre ciclicità dell’orbita terrestre su cui si basa l’ipotesi dei cicli di Milankovitch.
Sotto: dimensioni dei coccoliti in due diverse ere geologiche: a sinistra nel Miocene (tra 23 e 5 milioni di anni fa) e a destra nel Pleistocene (tra 2,5 milioni e 10mila anni fa).



Ricordiamo che i cicli di Milankovitch agiscono su tempi scala di decine di migliaia di anni e pertanto non sono responsabili del “riscaldamento globale” che sta facendo cambiare il clima del nostro pianeta su scale dell’ordine delle decadi. Anzi, se guardiamo ai cicli astronomici, la nostra epoca dovrebbe collocarsi in un periodo di lieve decrescita dell’insolazione; pertanto, in assenza delle attività umane, dovremmo per no aspettarci un ra reddamento del clima globale.
L’ESPRESSO INIZIA
UNA NUOVA STORIA.

LE GUIDE DE L’ESPRESSO NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SU AMAZON.

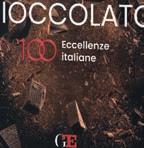




L’ESPRESSO. TUTTO CIÒ CHE ERA E TUTTO IL NUOVO CHE VERRÀ.




RICORDIAMO UN PIONIERE DELLA FOTOGRAFIA ASTRONOMICA A CENTO ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Rimanere orfano di padre, giusto qualche mese prima di venire al mondo, e trascorrere l’infanzia nella miseria, aggravata dal dilagare della Guerra civile americana: sembra la premessa di un romanzo d’appendice, anziché della biogra a di un grande astronomo, che vogliamo celebrare a cent’anni dalla scomparsa.
Edward Emerson Barnard nasce il 16 dicembre 1857 a Nashville nel Tennessee; la mamma, Elizabeth Jane Haywood, lo alleva da sola, insegnandogli a leggere e scrivere.
A nove anni, nella città ancora occupata dall’esercito nordista, inizia a lavorare in uno studio fotogra co. Come primo incarico, guida un grande apparato ottico sul Sole, per catturarne la luce necessaria all’ingrandimento dei ritratti su carta argentata di sensibilità ancora molto modesta. Crescendo, assume incarichi di maggiore responsabilità e acquisisce un’ampia esperienza delle tecniche fotogra che che più tardi utilizzerà in modo magistrale in un campo molto diverso.
Verso i 18 anni si trova tra le mani un libro di astronomia, ottenuto da un conoscente a garanzia di un piccolo prestito (mai restituito), dove alcune mappe stellari gli accendono l’interesse per il cielo. Utilizzando un piccolo telescopio, costruito assemblando lenti di recupero, si appassiona alla visione del cielo notturno e così acquista un rifrattore da 12,7 cm di diametro, che gli costerà ben otto mesi di salario.
Nel 1876 Nashville ospita la riunione annuale dell’American Association for the Advancement of Sciences
e in questa occasione Barnard si presenta al principale astronomo matematico americano, Simon Newcomb, chiedendogli quale lavoro utile potesse svolgere con il suo strumento. La risposta di Newcomb, “metti via quel telescopio e studia la matematica”, lo rende consapevole dei limiti imposti dalla mancanza di una solida istruzione scolastica. Il 6 maggio 1878 segue il transito di Mercurio davanti al Sole, rilevando i tempi dei contatti e contribuendo così, in un impegno condiviso con molti altri, a precisare la misura dell’Unità astronomica. Terminato il lavoro nello studio fotogra co, osserva regolarmente il cielo notturno, ma alla passione aggiunge anche la speranza di guadagnare i 200 dollari o erti in premio dall’uomo di a ari Hulbert Warner per ogni nuova cometa scoperta. Nel gennaio 1881 sposa Rhoda Calvert e il 17 settembre seguente individua una cometa mai osservata prima: in rapida successione ne trova altre quattro e incassa i premi, che lo aiutano a costruirsi una casa, che chiamerà per questo motivo Comet House. Il giovane dilettante cura nel 1883 una rubrica di astronomia del giornale Artisan, pubblicato due volte al mese a Nashville, e quello stesso anno gli amici gli o rono una borsa di studio alla Vanderbilt University di Nashville: nalmente può prepararsi alla professione di astronomo. Lasciare tutto per un magro compenso mensile è certamente un azzardo, ma la moglie lo incoraggia ad accettare l’o erta. Ospitato nel campus, Barnard si iscrive alla scuola di matematica e intanto cura il piccolo osservatorio della facoltà. Successivamente diventa insegnante

di astronomia pratica, mentre prosegue gli studi di matematica, sica e chimica.
Frequenta le lezioni durante il giorno e trascorre le notti a scrutare il cielo con un telescopio da 15 cm, che il 16 luglio 1884 gli permette di scoprire una cometa di breve periodo orbitale. Pubblica regolarmente i risultati ottenuti su riviste scienti che e quotidiani, spesso a scapito delle ore di sonno, conquistando però una certa notorietà.
Nel 1887 si laurea, scopre tre comete e riceve una proposta di lavoro dall’Osservatorio Lick in California. Non si lascia scappare l’occasione e attraversa il continente, attratto dall’idea di poter utilizzare il telescopio rifrattore più grande del mondo con i suoi 91,4 cm di diametro.
Inizialmente a anca la ricerca di nuove comete con l’osservazione dei pianeti, utilizzando uno strumento di apertura minore, ma il poco tempo concesso per lavorare al telescopio principale lo spinge ad a rontare discussioni sempre più accese con il direttore dell’Osservatorio. Esasperato, si rivolge ai Reggenti dell’Università della California, che accolgono le sue richieste. Così, a partire dall’agosto 1892 ottiene l’autorizzazione a usare, ogni venerdì sera, il grande strumento. E i risultati non tardano ad arrivare: il 9 settembre 1892 scopre il quinto satellite di Giove, battezzato Amaltea, dopo quasi tre secoli trascorsi da quando Galileo Galilei aveva scoperto le quattro “lune medicee”. Nello stesso periodo esegue
DI GIANFRANCO BENEGIAMO*straordinari disegni di Marte, giunto alla minima distanza dalla Terra, ma senza trovare traccia dei controversi canali osservati da Giovanni Schiaparelli e Percival Lowell.
La precedente esperienza lavorativa nel campo fotogra co entra sistematicamente nella nuova professione di Barnard a partire dall’agosto 1889, quando ricicla
un grande obiettivo da ritratti per eseguire fotogra e grandangolari della Via Lattea. Le immagini ottenute rivelano dettagli ancora sconosciuti: il suo interesse è attratto in particolare da vaste aree oscure, che inizialmente interpreta come regioni totalmente prive di stelle.
Il 13 ottobre 1892 scopre la prima cometa fotogra ca, ritrovata solo nel 2008 dall’astronomo italiano Andrea Boattini e oggi denominata 206P/Barnard-Boattini. Nel 1895

lascia Monte Hamilton per andare a lavorare nell’Osservatorio Yerkes dell’Università di Chicago, diretto da George Hale, dove procedono i lavori per la costruzione di un telescopio rifrattore ancora più grande di quello californiano.

Il 20 maggio 1897 trascorre la prima notte all’oculare del nuovo rifrattore, con apertura poco superiore al metro, e pochi giorni dopo il pavimento dell’osservatorio collassa, fortunatamente senza causare vittime. Impressionato dalla straordinaria abilità dimostrata durante le osservazioni e in camera oscura, Hale gli concede l’uso del grande strumento per due notti la settimana. Nemmeno un’ora di quel tempo prezioso va sprecata e il suo inarrestabile entusiasmo è presto
ricompensato con nuovi mezzi d’indagine.
Grazie al grande talento di Hale nel raccogliere nanziamenti, la ricca ereditiera Catherine Bruce acquista un telescopio fotogra co da 25 cm di apertura, che nel 1904 è sistemato a disposizione di Barnard nel parco di Yerkes. Pochi mesi dopo, però, la necessità di trovare cieli più trasparenti spinge Hale a trasferire la sede delle osservazioni sul Monte Wilson vicino a Pasadena, in California. Barnard lo segue con il telescopio fotogra co e qui trova le condizioni migliori per fotografare le regioni centrali della Via Lattea. Applicando ritmi frenetici di lavoro, riesce in otto mesi a impressionare centinaia di lastre fotogra che e ottiene immagini così ben de nite da

convincersi che le aree oscure sono probabilmente grandi nubi opache che si trovano davanti al fondo stellato.
Inoltre, confrontando le fotogra e riprese in una dozzina di anni, nel 1916 individua una stella nana rossa dotata di elevato moto proprio, seconda in distanza dopo il sistema di Alfa Centauri, che sarà poi chiamata “Stella di Barnard”. Partecipa poi alla spedizione diretta a Green River, Wyoming, per fotografare l’eclissi totale di Sole dell’8 giugno 1918 e nonostante la grande variabilità meteorologica riesce a riprendere una buona immagine della corona solare. Nel corso della carriera, realizza circa 3500 lastre fotogra che della Via Lattea a Yerkes e altre 500 a Monte Wilson: un lavoro fondamentale che gli consente di catalogare 349 nebulose oscure, indicate ancora oggi con numeri preceduti dalla iniziale del suo cognome.
Il 13 gennaio 1923 segue l’occultazione di Venere da parte della Luna e questa è la sua ultima osservazione documentata: la sera del 6 febbraio seguente muore e viene sepolto accanto alla moglie nel cimitero di Monte Olivet a Nashville. Poco prima aveva con dato alla nipote e assistente Mary Calvert: “Non m’importa di morire, ma sono dispiaciuto di non avere completato il mio lavoro”. Si riferiva alle innumerevoli lastre della Via Lattea che poi la nipote utilizzò per pubblicare nel 1927 un catalogo formato da vere fotogra e, per garantire alle immagini una qualità altrimenti irraggiungibile con le tecniche di stampa disponibili a quel tempo: A Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky Way

Tra i vari fenomeni celesti di questo mese, uno dei più appariscenti è il passaggio della Luna tra Venere e Giove, che si veri ca mercoledì 22 febbraio nella costellazione dei Pesci. La congiunzione più stretta si ha fra la Luna e Giove, ma anche quella con Venere è notevole. Però in quest’ultima la Luna è più vicina a Venere al mattino, con il Sole già sopra l’orizzonte e non è quindi osservabile, mentre è meglio osservabile la congiunzione con Giove, che avviene dopo il tramonto. La congiunzione con Venere si veri ca alle 7:26 (ora italiana), quando la Luna e il pianeta sono ancora sotto l’orizzonte; ma anche se fossero appena sorti, non sarebbero osservabili neppure con strumenti ottici, a causa delle foschie che stazionano sopra l’orizzonte e della luce del mattino. Utilizzando uno strumento, è possibile percepire la luce di Venere dalla tarda mattinata e soprattutto dopo il mezzogiorno. Allora, grazie alla forte luminosità speci ca di Venere, che equivale a quella di una stella di prima grandezza per secondo d’arco quadrato, con un cielo limpido anche un binocolo 8x30 riesce a stanare il pianeta nel cielo diurno. Meno facile è distinguere la sottile falce lunare, in quanto la sua luminosità speci ca è inferiore a quella di Venere. Filtri gialli o arancioni sono d’aiuto. Strumenti più potenti aumentano la possibilità di osservazione, ma fanno perdere la visione della congiunzione, in quanto non si hanno più entrambi gli astri nello stesso campo di vista. Più facile da osservare è la congiunzione della Luna con Giove, che si veri ca esattamente alle 23:56. A quell’ora i due astri
sono già tramontati dall’Italia, ma la congiunzione, che raggiunge una distanza minima di 1,6°, è già abbastanza stretta poco dopo il tramonto del Sole.
La visione migliore si ha fra le 18 e le 19, al termine del crepuscolo civile. Allora i due pianeti sono già visibili, insieme alla falce lunare. Un binocolo a grande campo (come uno da 8,5°) è in grado di mostrare tutto il quadretto celeste. L’osservazione telescopica mostra i tre astri più in dettaglio, ma uno alla volta. In questa occasione, Venere, distante 210 milioni di km, sottende un diametro di 12” e mostra un disco illuminato per l’87%. Giove, nonostante sia a ben 853 milioni di km, esibisce un generoso disco da 34”. Il periodo del crepuscolo è anche quello migliore per fotografare la scena con lo sfondo ancora chiaro.
Cioè quando il fondo cielo è già abbastanza buio da far risaltare tutti e tre i corpi celesti, ma non così scuro da produrre un contrasto eccessivo. Le foto di queste congiunzioni risultano ulteriormente abbellite se nel campo rientra anche un paesaggio terrestre; del resto, queste non sono foto con velleità scienti che, ma dalla notevole valenza estetica.
Molto dipende dalle condizioni atmosferiche; un cielo sereno e trasparente fornirà uno sfondo azzurro, mentre uno coperto darà una tonalità grigia. Le focali migliori per far rendere il quadretto celeste sono quelle che fanno distinguere bene i soggetti ma non al punto da distanziarli troppo, in modo che gli estremi siano ai bordi del campo.
Le focali migliori per il formato
APS-C si situano fra i 50 e i 100 mm. Un aspetto positivo di questa congiunzione è il contenuto divario di luminosità tra la Luna e i due pianeti. Infatti, la Luna è sotto forma di falce sottile, essendovi stato il Novilunio solo due giorni prima. Questo evita quanto accade di frequente, cioè che nelle immagini esposte correttamente per la Luna, gli altri astri risultino sottoesposti, mentre se esponiamo in modo ottimale per gli altri, la Luna risulta sovraesposta. In ogni caso, le attuali fotocamere digitali hanno dei sensori dalla grande “dinamica” (o latitudine di posa). Inoltre, i programmi di fotoritocco possono aiutare a bilanciare i forti divari in luminosità.
Una serie di fotogra e ottenute a distanza di tempo l’una dall’altra può mettere in evidenza il movimento della Luna e dare un senso di profondità. Infatti, con due di queste immagini si può ricavare una foto stereoscopica. Non è necessario attendere molto tra una foto e la successiva: grazie al moto lunare, è su ciente un quarto d’ora. Questo intervallo è condizionato dalla focale utilizzata; con le focali minori è bene attendere almeno una mezz’ora, che si riduce a dieci minuti o meno con le focali maggiori, quelle che a malapena contengono tutti e tre gli astri nel sensore.
Siccome si deve riprodurre la visione binoculare dei nostri occhi, che si ha dalla distanza della visione distinta (25 cm) no a circa 200 metri, le tolleranze sono piuttosto ampie. Ma a noi interessa una visione tridimensionale piacevole e naturale, che in genere si ottiene per oggetti
posti tra 1 e 5 metri. Dato che la distanza media tra le pupille umane vale 65 mm, si ha che alla distanza di 1 metro: 65/1000 = 0,065 radianti, cioè poco meno di 4 gradi, mentre a 5 metri abbiamo poco meno di 1 grado. Anche con spostamenti minori o maggiori si ha la sensazione della profondità, ma è meno percettibile nel primo caso, mentre è troppo forzata e arti ciosa nel secondo. Questi valori angolari hanno un senso solo se sono riferiti a obiettivi di focale normale,
come quelli da 30-35 mm nel formato APS-C o da 50 mm nel formato pieno (24x36).
Se si usano obiettivi di focale diversa, occorre variare l’angolo secondo il rapporto tra la focale dell’obiettivo normale e la focale dell’obiettivo impiegato. Per esempio, se si usa un 200 mm sul formato pieno, si ha 50/200 = 0,25, cioè occorre ridurre lo spostamento di quattro volte.
A rigore, l’obiettivo normale dovrebbe avere una focale identica
alla lunghezza della diagonale del sensore, ciò che non accade quasi mai, anche se le di erenze sono piccole e tollerabili per i nostri scopi. Per esempio, per il formato APS-C (23x15 mm), la focale risultante dovrebbe essere di 27 mm, mentre per quello pieno (24x36 mm) dovrebbe essere 43 mm.
Con focali telescopiche si possono ottenere ottime foto stereoscopiche anche della sola Luna, sfruttando il fenomeno delle librazioni, che a parità

di fase mostrano i dettagli lunari in posizioni un po’ diverse rispetto ai bordi, ma in questo caso le due foto devono essere scattate da una lunazione all’altra, ovvero a circa un mese di distanza (per le date precise delle librazioni massime, vedi la rubrica Cielo del Mese).

Un discorso analogo vale per i pianeti: Giove, meno luminoso di Venere, si presta molto bene allo scopo. In questo caso, però, si sfrutta il suo movimento tra le stelle e si deve riprende il pianeta a distanza di un numero di giorni tale da ottenere un buon e etto stereo in base alla focale utilizzata. Questa possibilità si estende a tutti i corpi celesti che mostrano uno spostamento sensibile tra le stelle di fondo. È importante che questi corpi non siano né troppo deboli né troppo luminosi, in modo da accordarsi armonicamente con lo sfondo stellato.
Ottenute le stampe delle fotogra e stereoscopiche, si presenta il problema di osservarle. L’ideale sarebbe servirsi di appositi stereovisori, che però non sono facilmente reperibili. Ma è possibile sostituirli con un paio di lenti da ingrandimento con potenza nell’ordine delle dieci diottrie. Al primo sguardo, è di cile notare la profondità, ma grazie al potere di accomodamento dell’occhio, quando si riesce a sovrapporre esattamente le due immagini, essa si rende improvvisamente visibile, con un e etto estremamente avvincente.

» Il cielo visibile da Roma alle ore 00h 00m TC a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia


il 5 alle 19h 28m
il 13 alle 17h 00m
il 20 alle 8h 05m
il 27 alle 9h 05m
il 7 marzo alle 13h 40m
Massime librazioni in latitudine
il 5 alle 2h
- visibile il Polo sud
il 18 alle 17h
- visibile il Polo nord
il 4 marzo alle 4h
- visibile il Polo sud
Massime librazioni in longitudine
il 13 alle 6h
- visibile il lembo orientale
il 25 alla 1h
- visibile il lembo occidentale
Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 0h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
Apogeo
406.476 km il 4 alle 9h 54m
Perigeo
358.267 km il 19 alle 10h 05m
Apogeo
405.889 km il 3 marzo alle 19h 00m
SOLE
Si sposta sempre più decisamente verso l'equatore celeste, passando dal Capricorno all’Acquario il giorno 16, a indicare la fine ormai prossima della stagione invernale. Si allunga l'arco diurno percorso dall’astro; di conseguenza, le ore di luce aumentano, nel corso del mese, di 72 minuti, quasi equamente distribuiti tra progressivo anticipo dell’alba e costante ritardo dell’istante del tramonto.
MERCURIO
È visibile all'alba fino al 25, ma dopo la prima decade il pianeta è osservabile con sempre maggiore di coltà, fino a scomparire tra le luci del crepuscolo negli ultimi giorni del mese. Il giorno 11 si sposta dal Sagittario nel Capricorno, mentre il 15 è all’afelio.
VENERE
È visibile di sera tra le stelle dell’Acquario dove si trova anche Nettuno, con il quale il giorno 15 è protagonista di una congiunzione ravvicinata, transitando appena 1’ a sud del pianeta. Il 16 si sposta nei Pesci, il 26 entra nella Balena, ma già il giorno seguente è di ritorno nei Pesci, avvicinandosi sempre più a Giove. A fine mese tramonta un’ora dopo il termine del crepuscolo serale.
Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese.
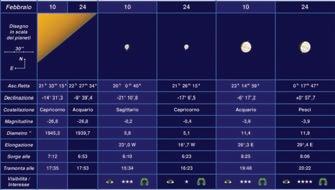
La mappa, in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.

MARTE È visibile per buona parte della notte nel Toro, dove il 5 è in congiunzione con Aldebaran (Alfa Tauri), 8°,2 a nord. La sua visibilità è in diminuzione: a metà mese il Pianeta rosso culmina al termine del crepuscolo serale e cala intorno alle 3:00 TC. In progressivo calo anche il diametro apparente, che nel corso della prima decade scende sotto i 10”.
GIOVE È visibile di sera nei Pesci, ma tra il 5 e il 19 febbraio si sposta nella Balena, circa 20° a nord di Alfa Ceti. La sua visibilità è in diminuzione: all’inizio tramonta 3 ore dopo le ultime luci del crepuscolo, ma a fine mese, quando viene avvicinato da Venere, solo un’ora dopo il termine del crepuscolo.
E emeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate. Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra).
Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati; l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.

SATURNO
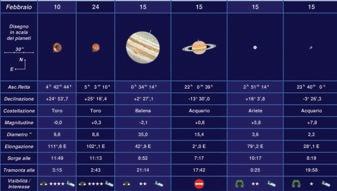
È nel Capricorno, dove risulta visibile subito dopo il tramonto del Sole fino al giorno 8, quando scompare tra le luci del crepuscolo; il 13 abbandona il Capricorno ed entra nell’Acquario, dove il 16 viene raggiunto dal Sole, con il quale è in congiunzione superiore.
URANO È visibile nella prima parte della notte 1°,5 a sud di Pi Arietis e 1° a nord-ovest di Sigma Arietis, entrambe di 5a magnitudine. Il giorno 4 è in quadratura con il Sole, mentre a fine mese tramonta circa mezzora prima della mezzanotte locale.
NETTUNO È osservabile subito dopo il tramonto nell’Acquario, poco più di 5° a sud di Lambda Piscium (4 mag.), seguito da Giove, circa 12° a est. Il 15 viene superato da Venere, in transito 1' a sud. La sua visibilità è in rapida diminuzione e nell’ultima decade scompare tra le luci del crepuscolo.
Come già anticipato lo scorso mese (vedi Cosmo n. 35), nella prima metà di febbraio dovrebbe essere visibile la cometa C/2022 E3 (ZTF), che potrebbe raggiungere la magnitudine +5,4 all’inizio del mese, quando si troverà alla minima distanza dalla Terra di 42 milioni di km; la cometa si dovrebbe mantenere più brillante della magnitudine +6 per tutta la prima decade. Dopo essere passata a una decina di gradi dal Polo nord celeste alla fine di gennaio, la cometa, grazie al veloce moto apparente sulla volta stellata, attraversa la costellazione circumpolare della Gira a, quindi transita 1° a ovest di Capella (Alfa Aurigae), la notte tra il 5 e 6 febbraio. Si dirige poi verso Marte e Aldebaran, che raggiungerà rispettivamente l’11 e il 15 febbraio. Nella mappa sono indicate le posizioni giornaliere della cometa alle ore 00:00 TC dal 1° febbraio al 1° marzo.
Il transito, nei primi giorni del mese, del disco lunare quasi completamente illuminato nella costellazione dei Gemelli produce alcune interessanti configurazioni celesti osservabili nelle prime ore serali. Il 3 febbraio, al termine del crepuscolo, il nostro satellite, illuminato al 96%, occulta la stella 76 Geminorum, di magnitudine +5,3; la scomparsa avviene dietro il lembo lunare oscuro a partire
dalle 19:15 (AO). La riapparizione si verifica sul bordo illuminato dal Sole tra le 20:14 (CT) e le 20:37 (TS), ma risulta ben più di cile da seguire. Quasi contemporaneamente, la Luna è in congiunzione in ascensione retta con Polluce, 2°,1 a sud di Beta Geminorum, ma è solo alla 1:00 TC del giorno 4 che viene a trovarsi esattamente “in linea” con Polluce e Castore. Il nostro satellite naturale andrà poi allontanandosi dai due “gemelli dioscuri”, varcando il confine con la costellazione del Cancro alle prime luci dell’alba.


Trascorsi alcuni giorni dal passaggio della Luna, la posizione di Marte tra le stelle del Toro è cambiata di alcuni gradi e il Pianeta rosso, animato da moto diretto, si è avvicinato ad Aldebaran (Alfa Tauri): la mattina del 5 febbraio i due astri, che mostrano una colorazione simile, sono in reciproca congiunzione, con Marte 8°,2 a nord e più luminoso della stella di circa una magnitudine.
Da notare, in prossimità di Capella, la luminosa Alfa dell’Auriga, la presenza della cometa C/2022 E3 (ZTF), probabilmente al limite della visibilità a occhio nudo.
Nel disegno la posizione di Marte tra le stelle del Toro, alto sull’orizzonte occidentale, alle 23:00 TC del giorno 5.
Tra le luci del tramonto che vanno a evolendosi, sull’orizzonte orientale si sta alzando la Luna pressoché Piena, alcuni gradi a sud della quale è possibile ammirare la bianco-azzurra scintilla di Regolo, la stella Alfa della costellazione zodiacale del Leone.
La congiunzione in Ascensione Retta tra la stella e il nostro satellite naturale si è verificata poco dopo la calata del Sole, con i due che devono ancora sorgere. La distanza che li separa diminuisce fino a raggiungere il valore minimo di 3°,9 poco dopo le 21:15, quindi torna ad aumentare, pur se marginalmente, e il 7 febbraio all’alba supera i 5°.
Per buona parte della notte il cielo è rischiarato dalla presenza della Luna, in fase gibbosa calante, in transito nell’estesa costellazione zodiacale della Vergine. Nelle ore comprese tra la levata del nostro satellite naturale, intorno alle 22:30 e la comparsa delle luci dell’alba, il cui chiarore porrà termine alle osservazioni, è possibile seguirne il progressivo avvicinamento a Spica (Alfa Virginis). La migliore configurazione osservabile è quella che è possibile ammirare la mattina dell’11 febbraio all’inizio del crepuscolo nautico, con i due astri separati da 2°,8, mentre la congiunzione in Ascensione Retta si verifica poco più tardi, intorno alle 7:00 TC alla levata del Sole.
A metà mese, dopo il tramonto del Sole, quando le luci del crepuscolo vanno spegnendosi, sull’orizzonte occidentale è possibile tentare l’osservazione di Nettuno, prima della sua prossima congiunzione superiore con l’astro del giorno. Nonostante le oggettive di coltà dovute alla debole luminosità
DI TIZIANO MAGNI(il pianeta è di magnitudine +8 e per essere individuato richiede l’utilizzo almeno di un binocolo), la presenza nelle sue immediate vicinanze della “lucidissima” Venere costituisce un ottimo punto di riferimento: i due pianeti si sono trovati in congiunzione nelle prime ore pomeridiane, con Venere, in veloce movimento diretto, in transito appena 1’ a sud di Nettuno.
Il giorno 22 al termine del crepuscolo serale, quando il cielo è ormai completamente buio, è possibile ammirare appena sopra l’orizzonte occidentale una sottile falce di Luna crescente, accompagnata, 4°,2 a ovest, dalla luminosa “scintilla” di Venere, con cui il nostro satellite naturale si è trovato in congiunzione, 3°,1 a sud del pianeta, nel corso della mattinata. Quattro gradi a nord-est spicca invece Giove - più debole ma sempre evidente - 1°,6 a sud del quale la Luna transiterà poco prima della mezzanotte, quando il trio sarà già da tempo sceso sotto la linea dell'orizzonte (vedi l'articolo di W. Ferreri a pag. 56). Nel disegno è ra gurata la bella configurazione celeste osservabile alle 19:15 TC, appena prima della scomparsa delle ultime luci serali.


Allo spegnersi degli ultimi bagliori del tramonto, 2°,5 a nord-ovest della mezzaluna crescente, un occhio attento riuscirà a cogliere la presenza di Alcyone e di alcune delle componenti più brillanti delle Pleiadi (M45), uno degli ammassi stellari tra i più conosciuti. Il nostro satellite naturale è transitato un paio di gradi a sud dell’ammasso nelle prime ore pomeridiane, mentre la minima separazione angolare è stata raggiunta poco dopo la calata del Sole sotto l’orizzonte.
Nelle ore che seguono, il disco lunare, illuminato al 45%, si avvicina progressivamente alla stella 32 Tauri, di magnitudine +5,6, e tra le 21:26 (AO) e le 21:40 (CT e LE) la stella scomparirà dietro il lembo lunare oscuro. L’occultazione terminerà tra le 22:35 (AO) e le 22:48 (CT) con la riapparizione dell’astro da dietro il bordo illuminato dal Sole.
Nel disegno è ra gurato il movimento apparente della Luna tra le stelle del Toro tra le 19:30 TC del 22 e le 00:30 del 23 febbraio.
Nel corso del mese è possibile osservare, con l’aiuto di un binocolo, il pianetino (40) Harmonia, in opposizione al Sole il giorno 27, quando raggiunge la magnitudine visuale +10,1. (40) Harmonia si trova nel Leone, nell’area compresa tra Regolo e Theta Leonis, di magnitudine +3,3, 4° a sud della quale il pianetino è rintracciabile nei primi giorni di febbraio.
Il movimento retrogrado in direzione di 52 Leonis porta l’asteroide a transitare 44’ a nord-est della stella di 5a magnitudine nei primi giorni di marzo. Un paio di gradi a sud di 52 Leonis risultano visibili numerose galassie, tra le quali la coppia di spirali barrate M95 e M96, rispettivamente di magnitudini +9,7 e +9,3, e l’ellittica M105, di magnitudine +9,5.
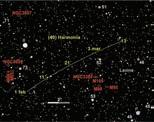

La mappa riporta tutte le stelle più luminose della magnitudine +11,0.
Dopo l’ampia congiunzione della prima parte del mese, il Pianeta rosso si allontana sempre più decisamente dalla luminosa Aldebaran (Alfa Tauri) e alla fine di febbraio la distanza che lo separa dalla stella raggiunge i 12°. Nelle ultime notti del mese l’ampia coppia di astri dalla colorazione rossastra viene raggiunta dal Primo quarto di Luna, in transito poco meno di 8° a nord di Aldebaran il pomeriggio del 27 e soltanto 16' a nord di Marte la mattina del 28; quest’ultima congiunzione, che si verifica dopo la discesa dei due astri sotto l’orizzonte nordoccidentale ed è inosservabile dall’Italia (la migliore configurazione che è possibile ammirare dal nostro Paese è quella che si ha poco dopo le 2:00, con la Luna bassa sull’orizzonte), produce un’occultazione visibile da parte dell’Islanda e della Scandinavia e dalle regioni artiche. Il disegno ra gura la configurazione celeste visibile alle 00:00 TC del giorno 28.
NELLA PRIMA DECADE DI MARZO CI ATTENDONO
• 1 MARZO: URANO IN CONGIUNZIONE CON SIGMA ARIETIS
•2-3 MARZO: CONGIUNZIONE STRETTA VENERE-GIOVE
•3 MARZO: LUNA E POLLUCE AL MATTINO
*
•4 MARZO: LUNA E PRESEPE AL MATTINO
•6 MARZO: LUNA IN CONGIUNZIONE CON REGOLO
•9 MARZO: MARTE IN CONGIUNZIONE CON EL NATH
I testi completi dei fenomeni sul prossimo numero di Cosmo e sul sito bfcspace.com
Acirca metà della stagione invernale possiamo ancora contare su notti molto lunghe per piani care le nostre osservazioni. Una volta gli astro li in attesa di una serata osservativa manifestavano i primi segni di brillazione quando iniziava a intravedersi la stella Polare: era arrivato il momento di allineare gli strumenti. Oggi è tutto meno emozionante, perché la maggioranza degli strumenti esegue l’allineamento in automatico sulle prime due stelle brillanti che appaiono in cielo, ma la Polare è ancora sfruttata da chi utilizza gli strumenti dobsoniani per controllare il centraggio delle ottiche, facilmente compromesso dal trasporto e montaggio. Quando appare la Polare, signi ca che il cielo è abbastanza scuro, con il Sole a una dozzina di gradi sotto l’orizzonte. È l’inizio del cosiddetto “crepuscolo nautico”, che serviva anticamente ai naviganti per “fare
il punto” con il sestante. Prima di questo momento, l’operazione non era possibile, perché con il cielo ancora chiaro, la Polare era invisibile; dopo diveniva arduo, perché con il cielo scuro era invece l’orizzonte a non essere più visibile. Oggi queste operazioni sono eseguite in automatico e con meno romanticismo grazie al sistema GPS. Convenzionalmente, si ritiene il cielo perfettamente buio quando il Sole si trova almeno a 18 gradi sotto l’orizzonte (“crepuscolo astronomico”), ma è già possibile iniziare visualmente le osservazioni, almeno dalla parte opposta del tramonto, circa 20 minuti prima di questo momento.
Alle 8 di sera, verso la metà di questo mese di febbraio 2023 non ci sarà la Luna e in meridiano possiamo ammirare Orione, la bellissima costellazione simbolo
dell’inverno. È particolarmente ricca di stelle brillanti, in quanto ne possiede sette più luminose della seconda grandezza. Inconfondibili, anche per il contrasto di colore già individuabile a occhio nudo, sono le due principali stelle situate ai vertici opposti del rettangolo di Orione: Betelgeuse (Alfa Orionis a NE) e Rigel (Beta Orionis a SW). La prima è una celebre gigante rossa che se si trovasse al posto del Sole, arriverebbe a lambire l’orbita di Giove. La sua luminosità oscilla tra le magnitudini 0,4 e 1,3, ma la variazione è irregolare e non è possibile predire quando si veri cherà un massimo o un minimo.
Conviene monitorarla costantemente, anche senza ausili ottici, grazie al confronto con Aldebaran (Alfa Tauri), di 0,8 mag., situata poco più di 20 gradi a NW. Anche quest’ultima è leggermente variabile, ma le sue oscillazioni sono molto modeste (circa 0,2 mag.).
» A sinistra: il cielo verso sud visto da una località del nord Italia alle 8 di sera attorno alla metà del mese. Le stelle sono riportate fino alla mag. 6; si noti il pianeta Marte (mag. 0), 9 gradi a nord di Aldebaran (Perseus). Sopra: il disco di Betelgeuse ripreso dall’astronomo Xavier Haubois all’Osservatorio di Parigi.

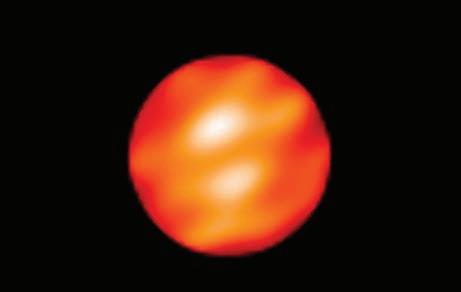
Facilita il compito il colore di Aldebaran, anch’esso rossoarancione. Questo può essere un ottimo esercizio per un principiante, dato che entrambe le stelle sono su cientemente brillanti da poter essere osservate anche da cieli cittadini. Rigel è invece una supergigante blu con una massa di quasi 20 masse solari.
A parte la piccola costellazione australe del Lupo, Orione possiede il maggior numero di stelle delle prime classi spettrali. D’altra parte, se è relativamente semplice imbattersi in stelle di classe B, è più raro incontrare quelle di classe O; ebbene, fra le poche di questa classe visibili a occhio nudo, vi sono Iota e Lambda Orionis, quest’ultima situata verso l’estremità nord e che forma un triangolino con Phi1 e Phi2. La Lambda è doppia, con una compagna di 6 mag., situata a soli 4 secondi dalla principale; non è di cile da vedere anche in un piccolo rifrattore, ma occorre un buon seeing. Lambda ha una temperatura super ciale altissima, di ben 47mila gradi! A questa temperatura la materia si trova allo stato di plasma, cioè un gas totalmente ionizzato.

Anche se abbiamo già osservato la Nebulosa di Orione mille volte, non trascuriamo di contemplare, da cieli bui, il bellissimo quadretto presente in questa regione di cielo, già emozionante in un binocolo 10x50 e spettacolare in un 20x80. È una zona decentrata rispetto alla Via Lattea invernale, dove la presenza di un gran numero di gemme di colore azzurro contrasta nettamente col nero del fondo. L’e etto è più evidente verso la parte meridionale del campo, nei pressi di Iota. M42 e M43, quest’ultima poco più che una sorta di pennacchio situato a nord della prima, appaiono piccole, ma perfettamente delineate e contrastate. Sempre al binocolo si può notare anche una debole fosforescenza in concomitanza della nebulosità di NGC 1973-75-77. In ne, è da notare l’ammasso aperto NGC 1981, situato a nord; appare povero e disperso in un telescopio, ma è interessante in un grande binocolo, pur non presentando alcuna traccia di nebulosità all’interno.
La Nebulosa di Orione è solo la parte più vistosa di un grande complesso
sistema nebulare, distante circa 1600 anni luce, che abbraccia praticamente l’intera costellazione; si trovano nebulose di tutti i tipi, a emissione, a ri essione e oscure.
La tenue lattescenza di M42 si intravede già a occhio nudo nelle serate molto limpide, ma altre richiedono un minimo di ausilio ottico, come un binocolo o un piccolo telescopio.

M78 è una piccola nebulosa di aspetto cometario, molto facile da trovare: se si parte dalle tre stelle brillanti allineate che formano la cintura di Orione (Delta, Epsilon e Zeta, da NW a SE), basta spostarsi ad angolo retto da Zeta verso NE per una distanza uguale e si arriva sul bersaglio. Passando dal binocolo al telescopio, ci troviamo di fronte a una vera e propria esplosione di oggetti notevoli. Un rifrattore da 10 cm permette già di risolvere il sistema di eta Orionis (il “Trapezio”), o di sdoppiare Rigel, che possiede una debole compagna di 7 mag. a 9 primi di distanza verso SSW. Come già detto, un’altra stella doppia è Lambda, la cui compagna è sbilanciata di due magnitudini.
Un autentico caleidoscopio si ottiene scandagliando lentamente tutta la zona nebulare con uno strumento di apertura via via crescente: così ci si accorge che M43 è separata dalla nebulosità principale e che M78, ben de nito e con una coppia di stelline nella parte più brillante, è a sua volta
una struttura complessa costituita da tenui sfumature, fra cui NGC 2071, la più vistosa, e NGC 2064, che richiede un telescopio di almeno 20 o 25 cm. Alcuni presunti appannamenti dell’oculare potrebbero non essere causati dall’umidità o da ri essi, ma rivelare piccole e deboli nebulose, per lo più a ri essione, attorno alle stelle che le illuminano. Una delle più evidenti è NGC 2023, poco più di 20 primi a sud della Nebulosa Fiamma (NGC 2024), relativamente semplice da osservare in piccoli telescopi, che ne mostrano la caratteristica diramazione scura. Conviene però forzare gli ingrandimenti per limitare i danni visivi indotti da Zeta Orionis, che sfavilla a solo una decina di primi verso ovest.
LA SFIDA DEL CAVALLO
In ne, ecco una s da per chi osserva con telescopi di almeno 30 o 40 cm: la nebulosa Testa di Cavallo Esistono diversi sistemi per scovarla, tra cui un ltro a banda passante strettissima come l’H-beta, che aiuta sicuramente, ma scurisce talmente il fondo cielo che occorre molta attenzione per individuarla. Si procede cosi: con un campo oculare non superiore ai 20-30 primi, si parte da NGC 2023 e ci si porta sulla stellina di magnitudine 7,5 situata 9’ a SSW. Un secondo riferimento è la stellina della stessa luminosità situata 13’ a SW. Queste due stelline costituiscono la base di un triangolo isoscele, al cui vertice rettangolo si trova la nebulosa. Ma non bisogna farsi illusioni, perché presenta un contrasto minimo rispetto a IC 434, la tenue nebulosa molto allungata da nord a sud che le fa da sfondo.
Non è un’impresa molto di cile costruire una postazione astronomica nel giardino di casa. La mia postazione è situata sul lago di Como, in località Scegola, sulle prime pendici che da Bellagio portano al passo del Ghisallo. Il cielo di questo sito è abbastanza buio e trasparente, paragonabile a quello dei 1000 metri di quota della Colma di Sormano, sempre in provincia di Como, dove è situato l’Osservatorio alle cui attività aderisco sin n dalla sua nascita, nel 1985. Una partecipazione ora più viva che mai, considerato che gli sforzi del team che lo gestisce, insieme al Comune di Sormano, sono concentrati nella costruzione di un Planetario e di un nuovo Osservatorio, grazie ai fondi elargiti dal progetto Interreg Italia-Svizzera “Astronetilo”.
Sono interessato a tutti gli aspetti dell’astronomia pratica, ma la mia vera passione sono le comete. Oltre alla classica attività fotogra ca, in tempi recenti la mia attenzione si
è spostata verso l’astrometria, cioè la determinazione delle coordinate astronomiche degli oggetti ripresi, per una loro identi cazione e per stabilirne la traiettoria celeste. Con l’aiuto dei soci Piero Sicoli, Augusto Testa e Francesco Manca, nel 2017 sono riuscito a ottenere per la postazione di Bellagio il codice internazionale L06, che mi ha consentito di battezzarla u cialmente come Postazione Astronomica Sormano2, Bellagio Via Lattea (L06)
Vi sono molti programmi per la riduzione astrometrica delle immagini CCD. Quello che utilizzo viene usato dalla maggior parte degli astro li ma anche da molti professionisti: è Astrometrica, un programma molto semplice, versatile e a dabile, sviluppato alcuni anni fa dall’austriaco Herbert Raab
Si può scaricare dalla pagina www. astrometrica.at ed è fruibile gratuitamente per 100 giorni, dopodiché viene richiesto un piccolo contributo. Nel sito di Raab si trovano tutte le informazioni al riguardo. Grazie al codice internazionale, ho potuto inviare le misure astrometriche al Minor
Planet Center (Mpc). Due pagine del sito di questo organismo internazionale (bit.ly/3NkObBK) sono dedicate rispettivamente alle comete e agli asteroidi di recentissima scoperta. La prima (Possible Comet Con rmation Page) raccoglie le posizioni di possibili nuove comete ancora da confermare; la seconda (Near Earth Object Con rmation Page) si occupa di nuovi asteroidi che possono avvicinarsi pericolosamente al nostro pianeta. La tipica sessione osservativa serale inizia dalla consultazione di queste due pagine, dalle quali vengono estratti gli oggetti che sono alla portata della mia strumentazione. Le variabili che limitano la scelta sono la magnitudine, la velocità angolare sulla volta celeste e l’errore di posizione, dovuto all’incertezza dell’e emeride. La mia prima strumentazione era composta da un Celestron C11 montato su una EQ6 Pro e accoppiato a una camera CCD Orion Parsec 8300M. Questo setup consentiva di raggiungere nelle belle nottate la 19a magnitudine e mi ha dato grandi soddisfazioni, come le prime menzioni nelle note u ciali del Mpc, le Mpec (Minor
» Sopra a sinistra: la cometa C/2021 A1 (Leonard) ripresa dalla Postazione Astronomica Bellagio il 03/12/2021 con un Newton 8” f/3,8, posa di 6’ s di Graziano Ventre ed Emanuele Valli.

Sopra a destra: la cometa C/2020 F3 (Neowise) ripresa sempre da Bellagio il 18/07/2020 con un telescopio ED 80 mm f/5.

Sotto: l’Osservatorio Astronomico di Sormano (CO).

da una specola di 2 x 2,50 metri e alta 2 metri, rifinita con perline di 2 cm. Sul tetto piatto di quest’ultima ho incollato un isolante di ardesia, impregnando poi il tutto con catramina. Per finire, ho coibentato e verniciato di bianco l’intero locale. Nella parte inferiore della costruzione ho montato quattro robuste ruote in nylon di buon diametro. Scorrendo su due binari, le ruote permettono la mobilità all’intero edificio. Ho quindi sistemato con precisione la colonna per lo strumento, fissandola direttamente nel calcestruzzo. La casetta svolge la funzione di riparo per le notti invernali e da “sala controllo”. Al suo interno si trova il PC che gestisce la montatura e tutta l’attrezzatura utile all’osservazione astronomica. Da una finestrella, posta su una delle pareti, si può tenere sotto controllo il telescopio. In tempi successivi ho installato un cavo di rete che collega direttamente il PC della postazione al PC di casa, per rendere ancora più comodo il lavoro osservativo.
Per ragioni pratiche e di sicurezza ho infine installato una telecamera a raggi infrarossi, che permette di seguire il telescopio nelle sue manovre di puntamento.
nel caso del NEO 2022 QN5, dove è stata superata la 21a magnitudine.
Perché costruire una postazione osservativa dietro casa, se si ha la possibilità di operare presso un Osservatorio come quello di Sormano?
Planet Electronic Circulars), grazie alla conferma di comete come la C/2021 A1 (Leonard), la prima del 2021, una delle più spettacolari degli ultimi anni, e la 2I/Borisov, la prima cometa di origine interstellare. Un salto di qualità si è veri cato nella primavera del 2021, quando ho sostituito la montatura EQ6 pro con la 10 Micron GM 2000 QCI e il telescopio C11 con il più performante Celestron C14 e la camera CCD con una Moravian G21600. Quest’ultima, con un picco di
e cienza quantica pari all’80%, posso montarla anche su un Vixen R200SS f/3,8 per sfruttare un campo più grande, indispensabile per la ripresa delle code cometarie.
È di grande utilità anche la nuova montatura, che consente di impostare i moti degli oggetti da osservare tramite pulsantiera o in remoto. Così si possono inseguire nei loro movimenti in cielo e impostare esposizioni fotogra che più lunghe, per aumentare il guadagno nella magnitudine limite accessibile. Come
In e etti, frequento con regolarità l’Osservatorio, ma una postazione in giardino o re impareggiabili vantaggi, se si ha la fortuna di abitare sotto un buon cielo. In primo luogo, agendo rapidamente, si possono sfruttare anche quei brevi momenti di sereno nei giorni in cui il cielo è soggetto a grande variabilità, ma soprattutto si può lavorare a qualsiasi ora, anche verso l’alba, stando seduti comodamente alla scrivania di casa. E poi, quando c’è la passione e la voglia di mettersi in gioco, la soddisfazione di raggiungere dei risultati ottenuti totalmente con le proprie mani è impagabile, tanto più se questi lavori sono utili alla comunità scienti ca. Ci sono in ne delle piccole grati cazioni che arrivano dall’esterno: fra queste, l’assegnazione del mio nome all’asteroide 22500 e la citazione dei miei lavori da parte di Denis Buczynski, responsabile della Sezione comete della British Astronomical Association. È avvenuto nel corso del meeting degli osservatori non professionisti, svoltosi a Elgin, in Scozia, il 10 settembre 2022.
*GRAZIANO VENTRE* È UN MEMBRO DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SORMANO E POSSIEDE UN OSSERVATORIO PERSONALE A BELLAGIO, DAL QUALE OTTIENE POSIZIONI ASTROMETRICHE DI COMETE.




OFFERTA DEDICATA AI LETTORI DI COSMO
Acquista 6 libri a scelta dalla lista al prezzo di 60 euro, spese di spedizione incluse.
La ricerca amatoriale delle supernovae
Giancarlo Cortini, Stefano Moretti
Super-occhi per scrutare il cielo Walter Ferreri, Piero Stroppa
I pianeti e la vita Cesare Guaita
I giganti con gli anelli Cesare Guaita
Alla ricerca della vita nel Sistema Solare Cesare Guaita
Oltre Messier Enrico Moltisanti
I grandi astrofili Gabriele Vanin
La Luna Walter Ferreri
In viaggio nel Sistema Solare Francesco Biafore
Come funziona l'Universo




Heather Couper, Nigel Henbest
Come fotografare il cielo Walter Ferreri

L'osservazione dei pianeti Walter Ferreri
Cento meraviglie celesti Gabriele Vanin
E ettua l’ordine comodamente su BFC Store (bfcstore.com): acquistando il coupon “I best seller di Cosmo” riceverai un’email di conferma, rispondendo alla quale potrai indicare i titoli scelti.
CARICATE LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE SU BFCSPACE.COM
LA REDAZIONE SCEGLIERÀ LE MIGLIORI PER “LE VOSTRE STELLE”
SONO TAGGATE DA UNA STELLA LE FOTO CHE HANNO VINTO LE NOSTRE SFIDE SOCIAL INQUADRA IL QR PER VISITARE LA GALLERY DELLE FOTO
LA LUNA IN UN MARE DI CIRRI

Ripresa da Bagheria (PA) il 18/09/2022
Fotocamera Nikon D3400 a f/14
Singolo scatto da1/320 s a 200 ISO, elaborato con Lightroom
Autore: Teresa Molinaro, Bagheria (PA).
IL CIELO SULLA COLATA LAVICA DELL’ETNA

Ripreso da Milo (CT) il 01/12/2022
Fotocamera Canon EOS R con obiettivo Canon RF zoom 15-35 mm a 29 mm f/4 su cavalletto Manfrotto
Posa di 10 secondi a 6400 ISO, elaborata con Photoshop.
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.
NEBULOSA “ELMETTO DI THOR” (NGC 2359)

Nel Cane Maggiore, ripresa da Modena il 20/11/2022
Telescopi APM Apo 140 f/4,6 su montatura iOptron Gem 45 e TecnoSky Apo 125 f/5,1 su iOptron Cem 40
Camera ZWO ASI 533 MC Pro
Filtri Optolong L-Ultimate (3 nm), UV IR cut e L-eXtreme
Guida ASI 290 MM Mini e ZWO OAG-L
Pose: 149x600 s e 40x30 s, elaborate con Astro Pixel Processor, PS 2022, Starnet v2, Topaz Denoise, Siril 1.
Autore: Andrea Arbizzi, Modena.
Nella Grande Nube di Magellano, ripresa dal Cile il 01/12/2022
Telescopio da 1 metro utilizzato da remoto
Pose: 19x600 s H-alfa, 21x600 s OIII, 3x600 s SII (bin2), 7x180 s RGB (bin 2)
NGC 2014 è una fucina di stelle che viene chiamata Cosmic Reef per la sua conformazione simile a un fondale marino ed è plasmata dal forte vento energetico di giovani stelle blu che illuminano il gas con luce ultravioletta. La ciambella blu (NGC 2020) è composta principalmente da idrogeno e ossigeno ionizzato risultato dall’espulsione degli strati esterni dell’enorme stella centrale di tipo Wolf-Rayet (WR71).

Autore: ShaRA Team (bit.ly/3BSL67r).
Inquadra il QR per una navigazione nel Cosmic Reef basata su immagini del telescopio spaziale Hubble.


Ripresa effettuata l’8/11/2022 da Tokyo con uno smartphone Honor 10 applicato all’oculare di un telescopio Vixen
Il pianeta è in basso, leggermente a sinistra.
Autore: Davide Lizzani, Tokyo (Giappone).

Ripresa da Costa dell’Ambra, Pachino (SR) il 15/10/2022
Telescopio SW Evostar 72ED su montatura SW EQM-35 Pro
Camera ZWO ASI 294 MC Pro con filtro Optolong L-Ultimate 2”
Guida Ultraguide 32 MKII Artesky e ZWO ASI 224 MC
Pose: 55x600 s, elaborate in HOO con PixInsight
Autore: Gaetano R. Cassarino, Catania.
I PILASTRI DELLA CREAZIONE NEL SERPENTE
Ripresi in remoto dall’Osservatorio El Sauce in Cile il 01/11/2022
Mosaico di due pannelli ripresi con telescopio Asa RC 1000 e camera FLI PL 16083 mediante il servizio Chilescope, in collaborazione con altri 13 astrofotografi.

Pose: SII 15x600 s, H-alfa 10x600 s, OIII 15x600 s, elaborate con App, PixInsight, PS
Autore: Massimo Di Fusco, Ferrara.
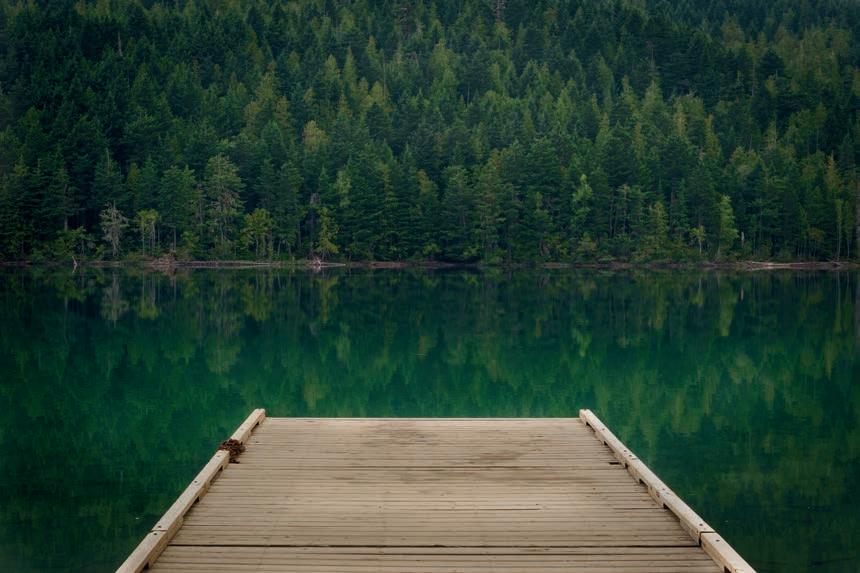



“Non può essere una sorpresa che il Grande Creatore abbia ritenuto conveniente diversi care le stelle con una tale varietà di tonalità. Al contrario, è pienamente coerente all’analogia di tutte le sue opere […], e l’aspetto di un prato orito nella sua esuberanza di tinte, ci preparerebbe naturalmente ad aspettarci qualcosa di simile negli estesi campi del cielo”. Così scriveva omas William Webb in Star Colours. Ed ecco in un solo sguardo le sfumature di tutte le stelle della volta celeste, di tutte quelle cioè visibili a occhio nudo dalle latitudini italiane entro la quinta magnitudine. Il cielo stellato nasconde un bellissimo segreto che si può rivelare attraverso un semplice mosaico: come tanti coriandoli lanciati in aria, i suoi astri sono tutti colorati, perché brillano di una sfumatura tutta propria, che dipende dalla temperatura della loro fotosfera. Questo segreto si tradisce già a occhio nudo attraverso gli astri più luminosi, come Betelgeuse, Antares e Arturo, alle cui sfumature, notate n dall’antichità, si sono ispirati anche dei miti; quelle delle altre stelle invece, si rivelano solo attraverso
un binocolo o un telescopio. Anche osservando con gli strumenti, però, si riscontrano di coltà, a causa della “tritanopia da piccolo campo”, ovvero l’incapacità dell’occhio di percepire il colore di un oggetto puntiforme. Così, n dal XIX secolo, gli esperti suggeriscono di mettere l’astro fuori fuoco o di “agitarlo” nel campo dell’oculare, perché spalmando la sua luce su una super cie maggiore, i colori che lo caratterizzano diventano più facilmente percepibili.
Negli ultimi anni dedicati all’osservazione dei colori stellari, ho cercato di fotografarli seguendo queste due tecniche visuali: la prima dedicata principalmente alle stelle visibili a occhio nudo; la seconda a quelle deboli e visibili solo al telescopio. Infatti, al telescopio è possibile osservare contemporaneamente il colore degli astri presenti nello stesso campo dell’oculare, ma fotografandoli è possibile vedere anche i colori di stelle che si trovano lontane tra loro nella volta celeste. Ho così collezionato le sfumature degli astri, soprattutto di quelli
visibili a occhio nudo; inizialmente circa 1300 stelle che una volta posizionate al posto giusto riuscivano a dare un’originale visione d’insieme sulle costellazioni e più in generale sulla distribuzione che questi colori hanno nella volta celeste. Un numero destinato a crescere, no a raggiungere tutti gli astri no alla magnitudine +5,5 Pur trattandosi di “semplici” immagini fuori fuoco, ho a nato la tecnica, preferendo sfuocare le stelle in relazione alla loro magnitudine. Per ottenere immagini più regolari, ho imparato ad aspettare il seeing migliore e a riprenderle solo quando non fossero basse all’orizzonte, perché il loro colore non fosse alterato dalla rifrazione atmosferica. Ho ripreso il colore di ogni singola stella con un semplice smartphone così come appare all’oculare di un ri ettore Dobson da 46 cm di diametro, a 285 ingrandimenti e con una sensibilità di 800 ISO Il risultato, come ogni foto e ogni mediazione, è sempre un velato tradimento; tuttavia, quelli immortalati sono comunque i colori reali delle singole stelle e ciò di cui chiunque può fare esperienza guardando attraverso l’oculare di un grande telescopio.
Il punto di arrivo di questo progetto è stata la realizzazione di un mosaico che permettesse di vedere tutte queste sfumature in un solo sguardo. Inizialmente, pensavo a un’immagine rettangolare, ma le cose sono cambiate una volta scelto il nome per presentarla. Ma come chiamare un mosaico dei colori di tutte le stelle?
Così, quando è sortito il termine Kaleidocosmo, ho ricostruito il mosaico in forma rotonda: come infatti attraverso un caleidoscopio è possibile vedere innumerevoli trasformazioni di forme colorate, così attraverso questo mosaico è possibile
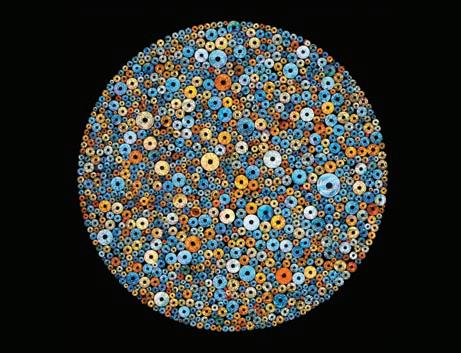
vedere le sfumature di colore delle stelle sotto forma di piccoli dischetti, rappresentati in scala secondo la loro magnitudine.
Un lavoro che richiama le ricerche di Benedetto Sestini e di William Sadler Franks, gli astronomi che tra il XIX e il XX secolo hanno osservato il colore di migliaia di stelle, ma che, in mancanza della fotogra a a colori, hanno potuto solo descrivere a parole e rappresentare con puntini colorati. Così, Kaleidocosmo porta a compimento un percorso scienti co e artistico iniziato quasi due secoli fa. Da allora, l’aspetto quasi monocromatico della volta celeste
che accompagnava l’umanità ha cominciato ad assumere le sembianze di un immenso prato orito, perché è divenuto sempre più chiaro che “ogni sfumatura che sboccia nei ori d’estate ammeggia nelle stelle della notte” ( Joel Dorman Steele, Fourteen Weeks in descriptive Astronomy, 1873).
E
I
E
Cosmo Kid approda tra le stelle, alla ricerca delle loro sfumature delicate e variopinte, che brillano e cambiano colore nella notte, grazie alla scintillazione prodotta dalla turbolenza atmosferica.
Le stelle nascono dal collasso delle parti più dense di grandi nubi molecolari che si compattano sotto il loro stesso peso. Così nascono le protostelle che, staccandosi dalla nube, continueranno a sottrarle materia, aumentando così la loro energia no ad accendere le reazioni nucleari e a diventare stelle a tutti gli e etti.
Tutto questo è avvenuto circa 4,6 miliardi di anni fa nella nostra regione di spazio, dove si è sviluppato il Sole, mentre dal resto della nube si sono in seguito formati tutti i corpi del Sistema solare, Terra compresa. Le stelle vengono classi cate principalmente attraverso la massa e la luminosità. E il colore?
Il colore delle stelle dipende dalla temperatura della loro super cie,

precisamente della fotosfera. Infatti, è proprio dalla fotosfera che le stelle emettono, sotto forma di luce visibile (e di altre radiazioni elettromagnetiche)
la loro energia prodotta nel nucleo. Per esempio, il Sole presenta un colore giallo e ha una temperatura super ciale di 5778 kelvin (5504 °C).
A un primo sguardo in cielo, le stelle ci appaiono tutte bianche, ma non è così: è bianca la stella Polare nell’Orsa Minore, ma è blu Alnitak in Orione, sono blu chiaro le Pleiadi, è azzurra Fomalhaut nel Pesce Australe, è giallo-arancio Arturo nel Boote, è bianco-gialla Alfa Centauri
nel Centauro ed è rosso-arancio Betelgeuse in Orione. Ma si tratta di deboli sfumature che solo nelle stelle più luminose sono evidenti a occhio nudo; negli altri casi i colori si distinguono solo osservando al telescopio o nelle riprese fotogra che. Al diminuire della temperatura super ciale, il colore delle stelle va dal blu al rosso: le stelle blu e bianche sono quelle più calde e in prima approssimazione anche le più giovani; le stelle rosse sono le più fredde e in genere anche le più “vecchie”. Il Sole appartiene a una classe intermedia con temperature comprese tra 5200 e 6200 kelvin. I colori cangianti che manifestano talvolta le stelle, quando le osserviamo vicino all’orizzonte in
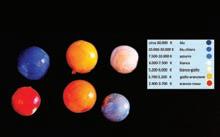
serate molto limpide, non dipendono da loro variazioni reali ma solo da e etti prodotti dalla nostra atmosfera, in modo imprevedibile.
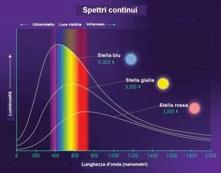
Nonostante la loro luminosità e i loro colori, le stelle vengono considerate dei corpi neri, oggetti ideali in grado di assorbire tutta l’energia incidente (nel caso delle stelle è quella che proviene dall’interno) e di riemetterla in un modo che dipende solo dalla loro temperatura.
Questa emissione può essere rappresentata in un gra co in funzione della lunghezza d’onda. Il risultato è una curva caratteristica, con un picco che dipende dalla temperatura della sorgente: più è alta la temperatura, più il picco
si sposta verso lunghezze d’onda minori, quindi dal rosso verso il violetto. Per esempio, il massimo della radiazione solare presenta un picco a una lunghezza d’onda intorno ai 500 nanometri, che corrisponde al colore giallo-verde (il nanometro è la miliardesima parte del metro).
Questa relazione tra la temperatura e il picco di emissione viene formulata dalla legge di Wien, grazie alla quale si può calcolare la temperatura di una stella in base alla lunghezza d’onda del suo picco di emissione. Un’esercitazione su questa legge è stata proposta nella rubrica L’Ora di astronomia pubblicata sul n. 6 di Cosmo
Nella rubrica di astrofotogra a vediamo (a pag. 84) come fotografare i colori delle stelle; qui proponiamo invece di riprodurre i colori degli astri attraverso tempere e pennelli. Occorrono anche delle palline di legno e un po’ di fantasia, per ottenere le tonalità apparenti degli astri: bianco, blu, blu chiaro, azzurro, gialloarancio bianco-giallo, rosso e arancio. Bisogna colorare le palline di legno e lasciarle asciugare all’aria.
Poi passare sopra il colore una bella pennellata di vernice trasparente a base acquosa. Dopo un’altra asciugatura, ecco un piccolo ammasso di stelle colorate!
Inquadra il QR per un video tutorial che spiega come realizzare i colori delle stelle.


CON UNA MOSTRA INTERDISCIPLINARE
Il cinquantesimo anniversario dell’ultimo sbarco lunare del Programma Apollo, quello della missione 17 del dicembre 1972, non è passato inosservato neanche nel nostro Paese. Oltre alla nostra iniziativa sul numero di dicembre, con allegata la riproduzione della targa applicata al modulo lunare con cui sbarcarono Cernan e Schmitt (vedi Cosmo n. 34), varie iniziative culturali dedicate alla Luna e alla nuova esplorazione lunare si sono svolte un po’ in tutta Italia. Segnaliamo tra queste la mostra dal titolo Dalla Terra alla Luna e ritorno?, che si tiene nel Museo Astense di Geologia, Mineralogia,
Arte mineraria e Cristallogra a (Magmax) di Asti, che resterà aperta al pubblico no al prossimo 23 aprile.
Spicca tra tutti gli oggetti esposti un campione (terrestre) di troctolite, una roccia magmatica intrusiva ritenuta il più importante fra i materiali lunari portati sulla Terra.
Gli astronauti delle sei missioni Apollo, che hanno raggiunto la super cie lunare tra il 1969 e il 1972, raccolsero complessivamente 2415 campioni, per un peso totale di 384 chilogrammi. Ricorda Massimo Umberto Tomalino, fondatore
del Magmax, e coordinatore della mostra: “Gli studi che derivarono soprattutto dall’osservazione della troctolite lunare, scoperta l’11 dicembre 1972 dall’unico astronauta-geologo Harrison “Jack” Schmitt dell’Apollo 17, portarono a conclusioni decisive, consentendo una più precisa datazione delle origini della Luna. Il campione mostrato proviene dalla collezione storica petrogra ca di James Gregory e fu prelevato in Cornovaglia intorno alla metà dell’Ottocento, quando questa roccia è stata caratterizzata per la prima volta sulla Terra. La mostra o re al visitatore l’esclusiva opportunità di ammirare la Luna da
un punto di vista geo-mineralogico. Oltre a un campione di polvere lunare (regolite), contenuto in una ala di vetro, sono esposti i campioni di rocce e minerali terrestri, esatti corrispondenti delle analoghe specie presenti sul nostro satellite e riportate sulla Terra dai dodici astronauti che hanno camminato sulla super cie lunare.
COME
» In alto: Il campione di troctolite terrestre, analogo della roccia trovata sulla Luna. A sinistra: le fialette contenenti polvere di regolite lunare e campioni di meteoriti lunari e marziane cadute sulla Terra.
Una vetrina rotante, organizzata su più livelli, corrispondenti a ciascuna delle missioni lunari Apollo, ospita una cinquantina di campioni esibiti come controtipi terrestri delle specie mineralogiche rinvenute nel materiale lunare portato a terra e analizzato nel mezzo secolo trascorso da quelle missioni. Un lavoro non ancora completato! Una seconda vetrina
La mostra Dalla Terra alla Luna e ritorno? si può visitare con ingresso gratuito, ma previa prenotazione, telefonando al 328 169 8691 o scrivendo all’indirizzo astimagmax@gmail.com. Altre informazioni su bit.ly/3Q4NgXr
della mostra è dedicata all’esibizione di memorabilia delle missioni Apollo.


Coerentemente con lo spirito interdisciplinare del Magmax, a corredo del materiale litologico sono esposti francobolli, cartoline postali, medaglie, gurine e documenti relativi alle missioni Apollo, messi insieme da Tomalino in circa cinquant’anni di ricerca. Di rilievo artistico e storico è la fotogra a originale Nasa, scattata dal comandante dell’Apollo 17 Eugene Cernan, che ritrae Harrison Schmitt mentre è intento a prelevare alcuni campioni lunari, durante la prima delle tre escursioni fuori dal modulo lunare Challenger. Il centro della vetrina è occupato da una serie di alette contenenti campioncini di asteroidi lunari e marziani caduti sul suolo terrestre. Curiose sono alcune cromolitogra e spagnole di inizio Novecento che ritraggono le illustrazioni a colori della prima edizione del romanzo Viaggio dalla Terra alla Luna di Jules Verne e una gurina-omaggio di ne Ottocento di una marca di cioccolato francese, che riporta l’immagine satirica di un capitalista intento a vendere le azioni di presunte miniere d’oro scavate sulla Luna. L’ultimo acquisto, entrato l’estate scorsa nella Torre Quartero, sede del Magmax, è un piccolo ma dettagliato mappamondo di latta dedicato alla Luna e alle esplorazioni no all’allunaggio del 1969. È invece legata all’adolescenza del fondatore del Magmax la mappa datata 1969 (e realizzata da Ibm Italia), entrata a casa Tomalino come inserto della rivista Epoca
L’Unione astro li italiani (Uai) - da oltre 50 anni il principale punto di riferimento culturale, organizzativo e motivazionale degli appassionati di astronomia - conferma anche nel 2023 il suo impegno per la promozione e di usione della cultura scienti ca e lancia numerose iniziative di divulgazione, didattica, ricerca amatoriale in ambito astronomico e di formazione specialistica, pubblicate nel Calendario Astro lo 2023, disponibile sul sito Uai, anche in formato Google Calendar, al link bit. ly/3WxfMTw

Le iniziative sono promosse e organizzate dall’Uai sia direttamente che tramite la rete delle sue oltre sessanta Delegazioni e relativi osservatori astronomici e planetari. Riportiamo di seguito tutte le iniziative in programma nel 2023. Tali appuntamenti verranno richiamati, di mese in mese, nella rubrica dedicata agli eventi.
Si parte lunedì 30 gennaio con l’evento - organizzato da EduInaf (Istituto nazionale di astro sica) con la collaborazione della Uai - dedicato
all’osservazione del cielo invernale e della cometa C/2002 E3 (ZTF).
FEBBRAIO
L’Uai organizza uno speciale evento in occasione dell’International Day of womenand girls in Science, che si celebra l’11 febbraio, e il meeting nazionale “La didattica dell’astronomia nella scuola italiana” nella giornata del 12 febbraio. Sarà il planetario di Ravenna a ospitare il meeting tematico a cura della Sezione Didattica dell’Uai.
MARZO
Nelle giornate del 17 e 18 marzo torna l’iniziativa di divulgazione e osservazione astronomica “Il cielo di primavera” che vede il coinvolgimento delle delegazioni territoriali dell’Uai.
APRILE
Dall’1 al 2 aprile si svolgerà a Varese presso l’Osservatorio astronomico “Giovanni Virginio Schiaparelli” il meeting “Corpi minori” a cura delle Sezioni Comete, Asteroidi e Meteore dell’Uai.
Dal 14 al 16 aprile si terrà il meeting dei planetari italiani organizzato da
PLANit (Associazione dei Planetari Italiani) a Ravenna.
Dal 17 al 21 aprile sono in programma eventi a cura delle delegazioni dell’Uai, indirizzati agli studenti e al pubblico adulto e dedicati all’osservazione delle costellazioni, con attenzione al tema dell’inquinamento luminoso, in occasione della International Dark Sky Week
MAGGIO
Da non perdere il 56° Congresso Nazionale dell’Uai: vero momento di incontro di tutta la comunità astro la, importante occasione per fare il punto della situazione, promuovere attività e condividere esperienze, per o rire nuovi stimoli e anche per vivere momenti di grande divulgazione scienti ca. Quest’anno il Congresso si svolgerà in Piemonte dal 5 al 7 maggio, con la collaborazione dell’Associazione Astro li Bisalta.
Dal 10 al 12 maggio è in programma a Roma e in modalità online la nuova edizione della prestigiosa Scuola di Archeoastronomia, rivolta a docenti, appassionati e cultori della materia.
GIUGNO
Il mese si apre con l’iniziativa di divulgazione e solidarietà “Stelle per tutti”: il 3 giugno le delegazioni dell’Uai organizzeranno in tutta Italia eventi osservativi accessibili anche alle persone con disabilità. Il 5 giugno è la volta dell’iniziativa di divulgazione astronomica e di educazione ambientale Save the pale blue dot, promossa e coordinata dalle delegazioni campane dell’Uai per sensibilizzare il pubblico riguardo ai gravi problemi ambientali del nostro pianeta e per invitarlo ad assumere comportamenti sostenibili. Il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, sono in programma eventi divulgativi in tutta Italia, aventi per tema le stagioni.
LUGLIO
Tornano le scuole estive di astronomia rivolte ai docenti, agli operatori di osservatori e planetari e a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze e competenze nell’ambito della didattica e della divulgazione astronomica. Le scuole, registrate sulla piattaforma So a del Miur, sono valide per l’aggiornamento professionale dei docenti.
AGOSTO
Dal 10 al 12 agosto tornano le “Notti delle stelle”, dedicate alla scoperta del famoso sciame meteorico delle Perseidi e abbinate all’iniziativa
enogastronomica “Calici di Stelle”. Il 30 agosto l’attenzione verrà puntata sulla Luna: nel corso di un evento online si parlerà del signi cato dei termini “Superluna” e “Luna blu”, sempre più usati dai media, delle recenti scoperte che riguardano la Luna e dei programmi di esplorazione del nostro satellite naturale.
SETTEMBRE
Dal 10 al 13 settembre si terrà a Roma il 1° Convegno nazionale di divulgazione dell’astronomia rivolto ad appassionati e professionisti del settore, per condividere esperienze e buone pratiche.
Il 23 e 24 settembre si svolgerà il meeting “Sole-Luna-Pianeti” dell’Uai presso l’Osservatorio astronomico di Campo Catino, a Guarcino (FR).
OTTOBRE
Dal 6 all’8 ottobre è in programma il meeting “Variabilità e Pianeti Extrasolari” nell’ambito del 30° Convegno Nazionale del Gruppo astronomia digitale (Gad).
Il 6 e 7 ottobre tornano in tutta Italia le “Notti dei giganti” dedicate alla scoperta e all’osservazione dei “giganti” del Sistema solare.
Il 21 ottobre i telescopi saranno puntati sulla Luna, in occasione della InternationalObserve the Moon Night.
Il 28 ottobre ancora protagonista la Luna, interessata da un’eclissi di penombra, che sarà visibile in Italia nella tarda serata.
Il 28 e 29 ottobre si terrà il Congresso Italiano di Radioastronomia Amatoriale, organizzato dalla Sezione Radioastronomia dell’Uai e dalla Italian Amateur Radio Astronomy (Iara).
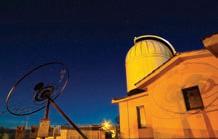
NOVEMBRE
Nelle giornate del 25 e 26 novembre torna il meeting “Profondo cielo” Uai, in programma quest’anno a Brindisi.
DICEMBRE
Chiude il ricco calendario di eventi l’iniziativa “Siamo tutti astronauti” organizzata dall’Uai il 16 dicembre, in occasione della “Giornata Nazionale dello Spazio”, per ripercorrere le più grandi imprese del passato, come il programma Apollo, e per scoprire gli attuali e futuri programmi di esplorazione spaziale.
Il calendario astro lo 2023 comprende anche gli Star Party, momenti di aggregazione e di promozione per eccellenza dell’attività astro la, sostenuti dalla Uai e organizzati da una o più delegazioni territoriali solitamente nei weekend di Luna Nuova della stagione estiva. Queste iniziative e i dettagli sulle scuole nazionali di astronomia saranno pubblicati nel corso dell’anno nella mappa delle Astroiniziative nella home page del sito Uai, insieme a tutti gli eventi a cura delle delegazioni territoriali dell’Uai.

Segnalate eventi, mostre, star party a stroppa@bfcmedia.com
ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA CONFERMA DEGLI EVENTI SUI SITI INDICATI


LIGNAN, NUS (AO
SPETTACOLI AL PLANETARIO
TUTTI I SABATI, ORE 16:00 E 18:00
Il Planetario di Lignan o re al pubblico di adulti e bambini spettacoli sulle meraviglie del cielo del periodo e su tematiche di forte rilevanza scienti ca e attualità. bit.ly/3R5BhrD
CASTELLO TESINO (TN)
VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DEL CELADO
2, 16 E 25 FEBBRAIO, ORE 21:00

Gli esperti dell’Unione astro li del Tesino e della Valsugana o rono al pubblico una conferenza su un tema astronomico, la visita guidata alla struttura e l’osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio. bit.ly/3Uoc5j3
SORMANO (CO)
VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO

5 FEBBRAIO, DALLE ORE 14:30



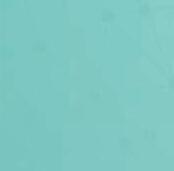

Visita guidata alla struttura situata alla Colma di Sormano, con osservazione al telescopio del Sole, durante il giorno, e della Luna e dei pianeti in orario serale. bit.ly/3G85mob
VERONA
LUNA IN PIAZZA BRA
26 FEBBRAIO, ORE 20:00
Il Circolo astro li veronesi o re al pubblico un evento divulgativo dedicato alla scoperta e all’osservazione della Luna all’oculare del telescopio. bit.ly/3K8fOwk
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
CLIMA E AMBIENTE
24 FEBBRAIO, ORE 21:00



Conferenza presso il Palazzo Comunale a cura di Elisa Palazzi. Evento organizzato dall’Associazione Astronomica del Rubicone. bit.ly/3AahGQL
RAVENNA
LA DIDATTICA DELL’ASTRONOMIA NELLA SCUOLA ITALIANA
12 FEBBRAIO





Meeting presso il Planetario di Ravenna, a cura della Sezione Didattica dell’Unione astro li italiani. Incontro aperto agli operatori della didattica, ai ricercatori e a tutti gli interessati. bit.ly/3WxfMTw
ROCCA DI PAPA (RM)
STELLE AL PLANETARIO
10 FEBBRAIO, ORE 20:45
Spettacolo nel planetario sul cielo di febbraio, visita guidata al Parco astronomico “Livio Gratton” e osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio, a cura dell’Associazione tuscolana di astronomia. bit.ly/3jlK6Cj
BARI
SPETTACOLI AL PLANETARIO
OGNI WEEK-END
Presso il planetario di Bari, con cupola di 15 metri di diametro, gli esperti dell’Associazione culturale Andromeda o rono al pubblico spettacoli di astronomia, spettacoli di teatro-scienza e laboratori. bit.ly/3pv1AvZ
NAPOLI
SHOW AL PLANETARIO
DA MARTEDÌ A DOMENICA
Il Planetario 3D di Città della Scienza propone al pubblico una serie di spettacoli per immergersi nel mondo dell’astronomia, abbinati alla visita alle aree espositive e ad attività laboratoriali. bit.ly/3 FwCv

CHIERI, GAIDANO&MATTA, 2021
PAGINE 178 CON FIGURE B/N E COLORE
FORMATO 15,5X22 CM
PREZZO € 17,00
“Caro Agostino, leggi questo libro” è l’invito di un’originale prefazione dello scrittore Dario Voltolini a questo libro, nella quale si rivolge idealmente a Sant’Agostino, che aveva a ermato di non sapere che cosa fosse il tempo. Perché un modo di conoscere è misurare, ed è proprio la storia lunga e controversa dei tentativi umani di misurare il tempo che viene trattata in queste pagine. Preceduto anche da una prefazione del giornalista scienti co Piero Bianucci, A errare il tempo ci accompagna in un viaggio nella storia e nell’astronomia lungo migliaia di anni, per scoprire come è nato e come si è evoluto il calendario, “meraviglioso anello di congiunzione tra il cielo e la terra”, dalla preistoria alle mitologie mesopotamiche, no alle concezioni moderne, derivate dalle rivoluzioni scienti che.
Il calendario nei secoli: origini, storia e prospettive recita il sottotitolo di questo lavoro di Walter Ferreri, già astronomo presso l’Osservatorio astronomico di Torino, dove troviamo, con un linguaggio alla portata di tutti, storie e curiosità del calendario che
usiamo tutti i giorni. Perché i mesi non hanno tutti la stessa durata? Perché i mesi dal decimo al dodicesimo hanno nomi che ricordano i numeri da 7 a 10? Perché il nostro secolo è iniziato nel 2001 e non nel 2000? “L’immagine mobile dell’eternità”, come de niva il tempo Pitagora, non è solo di cile da concepire, ma anche da misurare, come ci ricorda Ferreri attraverso le diverse de nizioni di anno (solare, tropico, anomalistico, vago…) e le diverse riforme del calendario che si sono succedute nei secoli.
Storia nita? No, perché ci sono diverse proposte per ulteriori riforme del calendario, per sistemarne alcuni difetti. Intanto, possiamo dilettarci a individuare il giorno della settimana di qualsiasi data con il “calendario perpetuo” riportato nelle ultime pagine del volume.
In de nitiva, che cosa concluderebbe Sant’Agostino dopo la lettura di questo libro? Per immaginarlo, dobbiamo innanzitutto leggerlo anche noi!
MARIA GIULIA ANDRETTA
ROMA, CAROCCI EDITORE, 2022
PAGINE 162
FORMATO 13X21 CM
PREZZO € 16,00
Prima di essere un obiettivo delle agenzie spaziali di tutto il mondo, Marte è stato una fonte di ispirazione per scrittori, sceneggiatori e registi che, fantasticando sulle scoperte degli astronomi, hanno creato una vasta gamma di civiltà extraterrestri. È una storia lunga e variegata, che ci viene raccontata in modo esauriente da Maria Giulia Andretta in questo volume, il cui sottotitolo è L’affascinante avventura del Pianeta rosso
Seguendo il filo delle scoperte scientifiche, l’autrice racconta come, a fine ’800, un fatale errore di traduzione dei “canali” di Marte abbia fatto nascere un ricco filone di racconti di fantascienza, alcuni dei quali hanno goduto di straordinario successo. È difficile non stupirsi del numero di libri che hanno trattato della vita su Marte, dei marziani e dei loro rapporti con i terrestri. I marziani facevano parte dell’immaginario collettivo e hanno goduto di grande popolarità. È molto interessante anche la cavalcata sulla filmografia marziana, con vere chicche storiche. Il fascino di Marte è rimasto con noi
anche quando le foto delle sonde hanno mostrato il vero volto del pianeta, che si è mostrato brullo, gelido, senza vegetazione e soprattutto… senza marziani. Mentre l’esplorazione si è sviluppata con missioni robotiche in orbita, seguite da lander e rover, sopravvissuti alla pericolosa manovra di atterraggio su Marte, i marziani sono tornati talvolta a far parlare di sé, con bufale come quella della presunta “faccia su Marte”, poi rivelatosi solo un curioso gioco di luci su una anonima collina. La fantascienza, intanto, si è evoluta verso scenari più realistici, con storie di colonizzazione e di sopravvivenza, magari con tentativi di terra-formazione per rendere il pianeta più accogliente, avviando dei processi che lo potrebbero portare a diventare più simile alla Terra. Ma questa non è solo fantasia; nei piani delle agenzie spaziali, Marte rimane sempre la nuova e prossima frontiera dell’esplorazione umana.
Patrizia CaraveoMILANO, CAIRO EDITORE, 2022 - PAGINE 272
FORMATO 14,2X21,6 CM PREZZO € 18,00
Non c’è dubbio che l’astronomia sia una grande passione. Lo sanno bene coloro che si sono avvicinati all’osservazione del cielo, in primis gli astro li, che sono i principali ambasciatori della scienza del cielo. In tutto il mondo gli appassionati all’astronomia contribuiscono a di ondere la conoscenza delle bellezze dell’Universo, con attività pratiche come serate osservative e con iniziative di vario tipo, che su Internet si sono tramutate in siti, blog e pagine sui social network
Ed è proprio dai curatori di uno di questi blog, Passione Astronomia (www.passioneastronomia.it) che nasce il volume che presentiamo, dove si propone un viaggio attraverso gli scon nati labirinti cosmici. Gli autori sono Pasquale D’Anna, fondatore e amministratore del portale, che insieme a Umberto Battino, Daniele Gasparri, Tommaso Nicolò e Livio Bordignon mantiene vivo il blog con contributi sempre nuovi. Come si fa a tradurre in un libro la passione per l’astronomia? La scelta degli autori è stata quella di mostrare un panorama sulle
conoscenze astronomiche attuali che fosse capace di incuriosire e di riassumere in maniera chiara i diversi temi. Il volume si apre con una parte introduttiva sulla storia dell’astronomia e continua con un excursus sulla vita delle stelle, per poi proseguire con una rassegna dei principali telescopi attualmente in funzione nel mondo. Il volume si conclude con due capitoli su temi di grande attualità, ovvero l’esplorazione spaziale e lo studio dei pianeti, da Marte no agli esopianeti più lontani.
La scelta di fornire un quadro generale delle conoscenze astronomiche è sicuramente interessante, in quanto stimola la curiosità dei lettori. Naturalmente, è impossibile concentrare in un solo volume l’incredibile mole di conoscenze che abbiamo sul cosmo, ma il volume riesce bene a fornire spunti sui vari temi che potranno poi essere successivamente approfonditi. Un libro scorrevole e chiaro, che riesce a trasmettere in modo semplice perché l’astronomia può essere così appassionante.
Massimiliano RazzanoCARLO DI LEO, ANTONIO LO CAMPO
ROMA, IBN EDITORE, 2022
PAGINE 162 - FORMATO 23,5X16 CM
PREZZO € 15,00
Questo illustratissimo volume inizia con una prestigiosa prefazione di Paolo Nespoli. Questo contributo di un celebre astronauta italiano significa avere una solida garanzia sull’affidabilità del libro, tanto più che Nespoli definisce gli autori “grandi conoscitori della storia dell’astronautica”. Dopo una breve introduzione, seguono quattro corposi capitoli, dieci tavole sulle missioni Apollo e un’estesa bibliografia e sitografia. Il primo capitolo (“Il programma Apollo e le prime missioni”) è dedicato agli inizi del programma che portò i primi uomini sulla Luna, dando molto risalto a Wernher von Braun e arrivando fino all’Apollo 14, considerata l’ultima delle missioni “scientifico-dimostrative”.
“In auto sulle montagne lunari” è il titolo del capitolo seguente, dove troviamo molte informazioni sul rover lunare. Apprendiamo anche come la missione Apollo 15 sia stata un’impresa temeraria e rischiosa, in quanto fu effettuata al limite delle possibilità sia degli uomini che delle macchine.
Il terzo capitolo si apre con la seconda missione scientifica (Apollo 16), che viene descritta in forma estremamente dettagliata nelle pagine molto fitte di questo libro, che ha una “gabbia” da 4100 battute a pagina. L’ultimo capitolo ci parla dell’Apollo 17, definita dagli autori la “missione dei record: Luna addio”. Anche questa missione è descritta nei minimi dettagli, iniziando fin dalla selezione degli astronauti. Questo capitolo termina con un paragrafo dedicato alle missioni 18, 19 e 20, inizialmente previste e prese in considerazione fino al 1969, ma poi cancellate.

In definitiva, un lavoro letteralmente impregnato di immagini (molte a colori), che contiene tantissime informazioni di difficile reperibilità in lingua italiana. Ringraziamo gli autori per averci messo a disposizione una pubblicazione davvero unica nel panorama editoriale italiano e a un prezzo molto competitivo per un lavoro autorevole così denso e completo.
Walter FerreriSu Cosmo parliamo spesso di buchi neri; nel n. 30 di luglio abbiamo dedicato il “Tema del mese” e la cover story all’“ombra” del buco nero centrale della Via Lattea; nel n. 33 di novembre la puntata della rubrica “L’Ora di astronomia” era dedicata al calcolo del raggio di Schwarzschild Ma questo non basta per rispondere alle domande provocatorie che spesso ci vengono poste. Vediamo in questa pagina come si può affrontare la questione posta nel titolo e sottotitolo di questa puntata di “Luoghi comuni”. Rispondiamo subito che dal punto di vista gravitazionale non accadrebbe proprio nulla. E non solo alla Terra, ma anche agli altri pianeti, compresi quelli più vicini al centro del Sistema solare: le loro orbite non sarebbero sconvolte e non verrebbero fagocitati dal Sole. Per capire questo, basta analizzare il campo gravitazionale generato da un corpo a simmetria sferica come il Sole o un buco nero. Dalla Relatività generale, sappiamo che quando una stella collassa in un buco nero, si producono due singolarità, cioè due punti in cui si ha un comportamento anomalo. La prima singolarità si ha al centro, a raggio zero, ma non è particolarmente interessante per noi. Quella che ci

interessa è l’altra singolarità, relativa al raggio di Schwarzschild, che definisce l’orizzonte degli eventi, cioè la distanza al di sotto della quale la velocità di fuga dal corpo supera la velocità della luce e quindi all’interno di tale orizzonte non ci si può allontanare dal corpo. Se le dimensioni del corpo sono inferiori a questo valore, tale raggio identifica il bordo del buco nero. All’esterno di questo raggio, il campo gravitazionale ha un andamento regolare e lo spazio-tempo si comporta in maniera standard. Non importa se il corpo generante è normale oppure collassato. Un corpo con la massa del nostro Sole ha un raggio di Schwarzschild pari a circa 3 km, mentre il raggio del Sole è di circa 700mila chilometri.
Quindi, qualunque pianeta del Sistema solare si trova ben al di fuori dell’eventuale orizzonte degli eventi di un buco nero con massa equivalente al Sole. Se si sostituisse il Sole con un buco nero equivalente, non ci sarebbe nessun effetto sulle orbite dei corpi del Sistema solare. Ovviamente, ci sarebbero degli altri effetti, perché i pianeti smetterebbero di ricevere luce e calore, ma sappiamo che questo è fisicamente impossibile, perché il Sole non ha la massa sufficiente per collassare in un buco nero, né è previsto che riesca ad acquisirla (dovrebbe scontrarsi con una stella di almeno 8-10 masse solari). Quindi, si tratta di un problema puramente teorico.