





NUMERI ARRETRATI
Rivolgiti all’e-mail arretrati@mondadori.it oppure al sito arretrati.pressdi.it
Il costo di ciascun arretrato è 15,00 €
SCARICA LA APP DAGLI STORE DIGITALI



Per leggere la rivista sul tuo dispositivo se sei abbonato o per acquistarla in digitale (anche arretrati) a 2,99 €
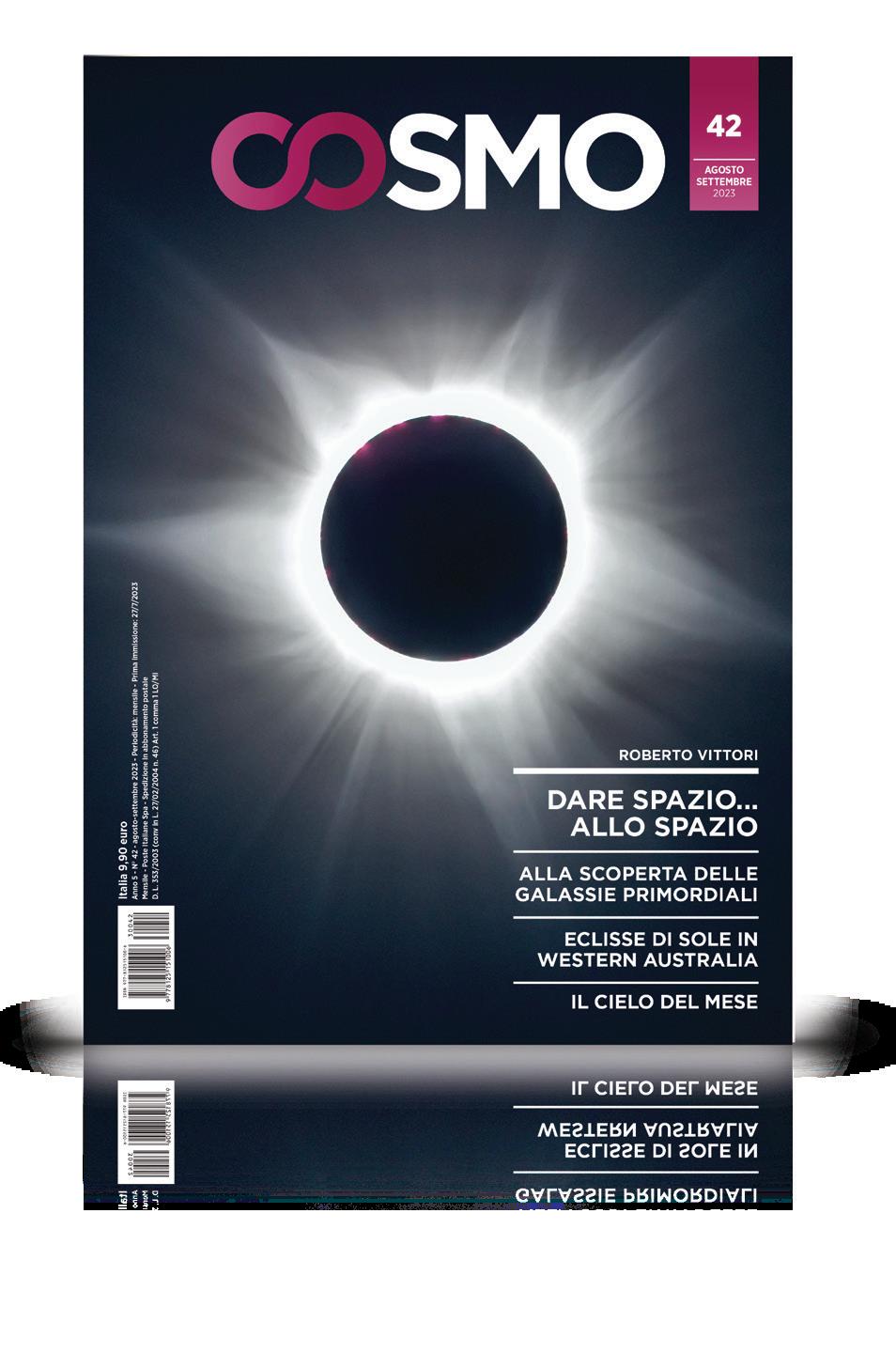
per te 12 numeri a soli 85,00€*
Invece di 118,80€
www.abbonamenti.it/cosmo
Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da BFC Space Srl. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www. abbonamenti.it/cga

*85,00€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 90€ (IVA inclusa) invece di 118,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
» Ti puoi abbonare con la CARTA DEL DOCENTE: tutte le istruzioni su www.abbonamenti.it/cartadeldocente

» COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/cosmo
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP BRESCIA Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero 02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
DAL SITO, ANCHE
REGALARE
ABBONAMENTO
su BFCStore

Sì, mi abbono a per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 28%. Pagherò 85,00€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 90,00€ IVA inclusa) invece di 118,80€. Offerta Valida solo per l’Italia.
I MIEI DATI
Cognome
Indirizzo
Tel.
Nome CAP Città
N° Prov.
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/cosmo
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BFC Space, con sede in Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti.it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.
rilascio nego il consenso per le attività di profilazione
In questo numero di 128 pagine - come è tradizione nei mesi di agosto e settembre – Cesare Guaita continua, come in un romanzo a puntate, a seguire le gesta del James Webb Space Telescope. Dopo averci presentato, nei mesi scorsi, le scoperte e ettuate nel Sistema solare e tra gli esopianeti, ora ci proietta ai con ni dell’Universo, proprio là da dove era iniziata, un anno fa, la dimostrazione della potenza del Webb con quella foto dell’ammasso di galassie Smacs 0723 presentata in diretta dalla Casa Bianca dal presidente Biden e dall’amministratore delegato della Nasa Bill Nelson. Come si legge nell’articolo, sembra che spingendo lo sguardo n quasi alle porte del Big Bang, oltre che galassie relativamente piccole e poco produttive in termini di formazione stellare – come è lecito attendersi da galassie tanto giovani – il Webb stia scoprendo anche galassie più strutturate, solo di poco successive alle precedenti, non compatibili con la forma e la massa delle galassiette primordiali, nemmeno se la loro evoluzione fosse avvenuta in maniera iper-accelerata. Un bel grattacapo, la cui soluzione potrebbe chiamare in causa la “materia oscura”.

In redazione stiamo però già pensando al ritorno all’usuale cadenza mensile, che riprenderemo a ottobre, convinti che sia questa la periodicità ottimale per fornire gli approfondimenti necessari alle notizie che si inseguono giornalmente sul web e sui social senza soluzione di continuità.
Eventi da seguire con assiduità saranno la missione della sonda Psyche, che inizierà in autunno il suo viaggio verso l’asteroide metallico 16 Psyche (il lancio è piani cato a inizio ottobre), e l’evoluzione della luminosità della cometa Tsuchinshan-Atlas che potrebbe – il condizionale è d’obbligo con le comete – garantire uno spettacolo eccezionale nei nostri cieli fra poco più di un anno, sempre che non le capiti qualcosa per strada. Noi la seguiremo pertanto mese per mese, facendo i dovuti scongiuri; sarebbe veramente l’ora di osservare una bella cometa a occhio nudo! Buona estate e arrivederci al numero di ottobre.
DI WALTER RIVAANNO 5 - NUMERO 42 mensile registrato presso il Tribunale di Milano al n° 137 del 6 giugno 2019
CASA EDITRICE BFC SPACE
Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano MI Tel. (+39) 02 30 32 111 - Fax (+39) 02 30 32 11 80 bfcspace.com
DIRETTORE RESPONSABILE
Walter Riva riva@bfcmedia.com
DIRETTORE EDITORIALE Piero Stroppa stroppa@bfcmedia.com
HANNO COLLABORATO
Salvatore Albano, Gianfranco Benegiamo, Patrizia Caraveo, Giordano Cevolani, Laura Citernesi, Giuseppe Donatiello, Marco Sergio Erculiani, Cesare Guaita, Walter Ferreri, Robert Galassi, Azzurra Giordani, Davide Lizzani, Antonio Lo Campo, Tiziano Magni, Piero Mazza, Marco Meniero, Marco Montagna, Dea Ortolani, Corrado Ruscica, Andrea Simoncelli.
GRAPHIC DESIGN Massimiliano Vecchio vecchio@bfcmedia.com
PUBBLICITÀ Newton Winston info@bfcspace.com
ABBONAMENTI
Direct Channel SpA c/o CMP Brescia BS Via Dalmazia 13, 25126 Brescia
ARRETRATI
Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia Srl arretrati.pressdi.it arretrati@mondadori.it
STAMPA TEP Arti Grafiche Srl Strada di Cortemaggiore, 50 - 29100 - Piacenza (PC) Tel. 0523.504918 - Fax. 0523.516045

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA Press-di Distribuzione stampa e multimedia srl via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano
SEGRETERIA DI REDAZIONE info@bfcspace.com
IN COPERTINA: La corona solare ripresa da Shivam Bansal durante l’eclisse totale del 20 aprile 2023 in Western Australia.
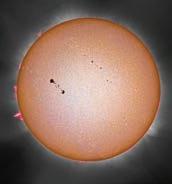
NEWSLETTER DI BFCSPACE Iscriviti per essere sempre aggiornato: bit.ly/3PyWCd1 oppure inquadra il QR
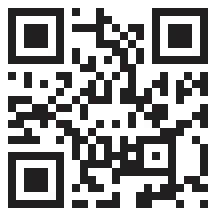

ASCOLTA I NOSTRI PODCAST bfcspace.com/category/podcast/
LE EDICOLE DI COSMO bit.ly/3YhHLrF
UNIVERSO


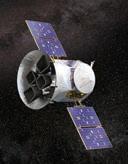
28
34
38
43

48
Inquadra con la fotocamera o con la App Scan del tuo smartphone o tablet i simboli QR che trovi in allegato agli articoli di questo numero per accedere a numerosi contenuti multimediali (video, simulazioni, animazioni,
LA FUSIONE CON ANDROMEDA È GIÀ INIZIATA
1
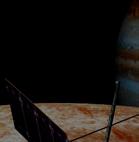
IL TERZO FLY-BY DI BEPICOLOMBO CON MERCURIO


3 ALBA E TRAMONTO SU MARTE
5
MATTONI DELLA VITA OVUNQUE 2
4 GALASSIE IN PICCHIATA NELL’AMMASSO DELLA CHIOMA
6 DRAGONFLY IN PARTENZA NEL 2027 VERSO TITANO


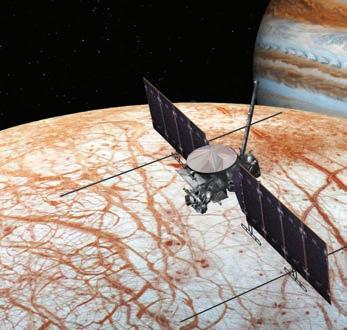
UNA BASE CINESE SULLA LUNA
7
IL MODULO DI SERVIZIO EUROPEO PER ARTEMIS II
8
UNA STARSHIP MODIFICATA PER IL PROSSIMO TEST
9
La campagna Message in a Bottle della Nasa invita le persone di tutto il mondo a rmare con il proprio nome una poesia scritta dalla poetessa statunitense Ada Limón (vedi foto sopra). Basta compilare il form al link bit.ly/3qJk27O e si riceverà via mail un messaggio di conferma della registrazione.
In Praise of Mystery: A Poem for Europa (il testo si può leggere e ascoltare al link bit.ly/461gZIn) è un poema che collega due mondi acquatici: la Terra, desiderosa di raggiungere e capire quali caratteristiche rendono “abitabile” un mondo, ed Europa, in attesa delle esplorazioni che facciano luce sui suoi segreti. La campagna è frutto di una collaborazione speciale, che unisce arte e scienza, della Nasa, della poetessa Limón e della Library of Congress.

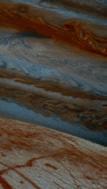
La poesia è incisa su una lastra di metallo al tantalio applicata alla sonda e viaggerà insieme ai nomi di tutti i rmatari, che saranno registrati su un microchip montato sulla navicella. La poesia e i nomi viaggeranno insieme, per miliardi di chilometri, nel viaggio che compirà la sonda Europa Clipper della Nasa verso il sistema di Giove.


La sonda verrà lanciata dal Kennedy Space Center della Nasa nell’ottobre 2024 ed entro il 2030 sarà in orbita attorno al pianeta gigante, poco tempo prima dell’arrivo della sonda europea Juice (vedi l’articolo a pag. 38). Durante la sua missione, che durerà diversi anni, Europa Clipper eseguirà 45 sorvoli di Europa ad altitudini comprese tra i 25 e i 2700 chilometri, raccogliendo misurazioni dettagliate per determinare se la luna possiede condizioni adatte alla vita nell’oceano nascosto sotto la crosta ghiacciata.
Ogni sorvolo coprirà un diverso settore di Europa, per ottenere in ne una mappa topogra ca globale della luna, che comprenderà una valutazione dello spessore del ghiaccio. Nei sorvoli a basse altitudini, Europa Clipper potrebbe anche attraversare i pennacchi di vapore acqueo che eruttano dai geyser ghiacciati della luna, per analizzare così il suo oceano dalla quota orbitale. Inquadra il QR per un video dedicato all’iniziativa Message in a Bottle.

La Via Lattea e la Galassia di Andromeda (M31) sono in avvicinamento reciproco e si ipotizza una fusione tra queste due grandi galassie fra quattro miliardi di anni. Un evento molto lontano ma che forse è già iniziato.

Nel nostro alone galattico sono state identificate più di 12mila stelle con velocità uguali o maggiori di 300 km/s. Sono stelle vecchie e a bassa metallicità; perciò, la loro origine potrebbe essere dovuta a episodi di cattura. Circa 500 di tali stelle esibiscono velocità anche maggiori di 1000 km/s e sono dette iperveloci (Hvs) (vedi anche a pag. 126).
Misure eseguite dal satellite astrometrico Gaia suggeriscono che siano di origine extragalattica, cioè espulse da galassie vicine e catturate dalla nostra. In particolare, una apposita simulazione gravitazionale ha dimostrato plausibile l’ipotesi che sia in corso un fenomeno di migrazione stellare tra M31 e la nostra Galassia, attualmente separate da 2,4 milioni di anni luce. E dato che anche dalla Via Lattea avvengono espulsioni stellari, è altrettanto probabile che M31 abbia catturato delle stelle partite dalla nostra Galassia.
Nessuna Hvs di sicura provenienza da M31 (vedi la foto di Omar Cazzanti) è stata ancora osservata, ma questo scenario è affascinante e indica una storia di interazione tra le due galassie più complessa di quanto creduto finora. Vedi la news completa su Bfcspace.com alla pagina bit.ly/3XoRFbx.
Da Encelado, satellite di Saturno, no alla costellazione del Perseo, rimbalzano le scoperte di “mattoni della vita”, della nostra vita, quella terrestre. Un team di ricercatori ha individuato il fosfato di sodio nell’oceano nascosto sotto la crosta ghiacciata di Encelado
Il composto si trova in quantità cento volte superiori a quelle degli oceani terrestri, rendendo la luna di Saturno uno degli obiettivi più promettenti per la ricerca diretta di forme di vita extraterrestre.
Il fosfato è stato trovato grazie alle analisi dei geyser di Encelado compiute dalla sonda Cassini. La missione si è conclusa nel 2017, ma i dati raccolti consentono ancora oggi di e ettuare nuove scoperte. I fosfati sono composti essenziali per la produzione del Dna e dell’Rna e di molte strutture biologiche degli organismi terrestri.
Da Encelado allo spazio profondo: grazie a spettri infrarossi ottenuti dall’osservatorio spaziale Spitzer (ormai dismesso) è stato individuato l’amminoacido triptofano nella nebulosa IC 348, una regione di formazione stellare che si trova a 1000 anni luce nel Perseo (vedi foto diAdam Block).

Il triptofano è uno dei 20 amminoacidi essenziali per la formazione di proteine, che sono la chiave per la vita sulla Terra. Gli amminoacidi non sono una novità nello spazio e si trovano comunemente nelle meteoriti: erano dunque presenti quando si è formato il Sistema solare. La nuova scoperta fa supporre che gli amminoacidi siano una presenza comune nelle regioni di formazione stellare, contribuendo alla chimica primitiva dei sistemi planetari.
In questa spettacolare composizione di immagini, il rover Curiosity ha catturato l’incredibile panorama che si staglia nella Marker Band Valley in due momenti diversi della giornata, all’alba e al tramonto. Sebbene i colori siano stati elaborati successivamente, le due immagini, scattate una alle 9.20 e l’altra alle 15.40 (ora locale di Marte), mostrano un’illuminazione completamente di erente. Curiosity si trova ai piedi del monte Sharp, 5 chilometri all’interno del cratere Gale, dove continua le sue esplorazioni. Qui il rover in precedenza aveva scoperto le prove che anticamente questa regione era occupata da un grande lago. La Marker Band (“banda marcatrice”) che individua la regione in cui si aggira attualmente Curiosity, è un termine che i geologi usano per riferirsi a un sottile strato di roccia molto distinto dagli altri. Lo strumento che appare nell’immagine (il cerchio bianco in basso a destra) è il Radiation Assessment Detector, un misuratore di radiazioni che aiuta gli scienziati a capire come proteggere i primi astronauti che saranno inviati sul Pianeta rosso dalle pericolose radiazioni cosmiche che arrivano sulla super cie, non essendo intercettate da un campo magnetico e da una spessa atmosfera come accade sulla Terra.
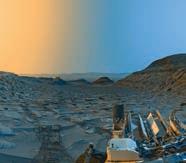

Nel periodo in cui vengono celebrate più che in ogni altro le “stelle cadenti” (in realtà frammenti di materiale interplanetario), grazie allo sciame delle Perseidi di agosto, (vedi a pag. 61), parliamo anche di vere e proprie stelle cadenti (vedi la news a pag. 6 e l’articolo a pag. 126). Ma esistono per no le “galassie cadenti”. In gura vediamo (nel riquadro) un gruppo di galassie che sta precipitando all’interno dell’ammasso di galassie della Chioma di Berenice, lasciandosi dietro un’enorme coda di gas surriscaldato. La scoperta è stata realizzata grazie all’osservatorio a raggi X Chandra della Nasa, che ha puntato i suoi strumenti verso il gruppo di galassie NGC 4839
Questo gruppo si trova vicino al bordo esterno dell’ammasso della Chioma, a circa 340 milioni di anni luce da noi, e si sta muovendo verso il centro di questo grande ammasso, “nuotando” in un mare di gas caldo che ha formato dietro le galassie una coda lunga 1,5 milioni di anni luce, pari a 15 volte il diametro della Via Lattea. I dati di Chandra hanno evidenziato anche la formazione di un’onda d’urto, simile al boom sonico di un jet supersonico, prodotta dall’enorme velocità di NGC 4839 che sta viaggiando a circa 4,8 milioni di chilometri all’ora verso l’ammasso di galassie. Vedi la news completa su Bfcspace alla pagina bit.ly/3ptCpxn
M.S.E.

Martedì 19 giugno la sonda BepiColombo dell’Agenzia spaziale europea (Esa) è arrivata no a un’altezza di circa 236 chilometri da Mercurio e questo è il terzo di sei passaggi ravvicinati del pianeta previsti da una missione che si sta svolgendo con precisione assoluta.
Il viaggio è ancora lungo e si attendono novità importanti per l’esplorazione del pianeta più vicino al Sole, che già ora, con questo spettacolare rendez-vous, ci ha regalato immagini di grande interesse.
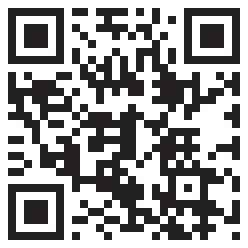
Le manovre di y-by sono fondamentali per disporre la sonda nelle condizioni necessarie per entrare in orbita attorno a Mercurio alla ne del 2025
La sonda è frutto della collaborazione dell’Esa con l’agenzia giapponese Jaxa e imbarca quattro strumenti scienti ci realizzati in Italia. Durante il y-by ha rilevato diversi crateri da impatto, compreso uno con diametro di 218 km ancora senza nome, che è stato battezzato Manley. Questa zona sarà interessante da esaminare quando inizierà la missione scienti ca della sonda, in quanto potrebbe essere composta dalla prima crosta del pianeta con materiale particolarmente scuro e poco ri ettente (forse ricco di carbonio).
In attesa dell’esplorazione vera e propria, per ottenere nuove immagini ravvicinate di Mercurio bisognerà aspettare il 5 settembre 2024. Vedi la news completa su Bfcspace,com alla pagina bit.ly/44iJTCn e inquadra il QR per il video del y-by.
Titano è una delle molte lune di Saturno, che per caratteristiche rappresenta molto più un pianeta che un satellite naturale. La conferma arrivò nel 2005 dalla piccola sonda di atterraggio Huygens, sganciata dalla sonda euro-americana Cassini. E quelle straordinarie immagini - anche se poche e non di eccelsa qualità – e i molti dati raccolti hanno subito avviato gli astronomi a proporre una nuova missione. Che si chiama Dragon y e verrà lanciata a giugno del 2027, per poi scendere su Titano nel 2034 – come confermato da un team di giovani ricercatori della Nasa e dell’Università Johns Hopkins, al convegno internazionale Space Exploration svoltosi lo scorso maggio al Politecnico di Torino. Un evento organizzato sotto le bandiere di Italia e Francia, le due nazioni che formano la ales Alenia Space, joint venture tra la francese ales e l’italiana Leonardo. Dragon y, che verrà lanciata da Cape Canaveral con un razzo Delta IV, è una missione che prevede un modulo di atterraggio con aerogiro. Quindi con un rotore tipo elicottero e ettuerà molti decolli e atterraggi dalla super cie per esplorarne le aree di maggiore interesse (e ora allo studio). Avrà l’ambizioso compito di valutare quanto Titano, un corpo celeste che ricorda molto la Terra primordiale (dove si stavano sviluppando le prime forme di vita), possa essere abitabile o perlomeno esplorabile e naturalmente studiarne la chimica prebiotica.
La Cina intende inviare i propri taikonauti sulla Luna per il 2030 e sono arrivate recentemente conferme e nuovi dettagli sui programmi, assai ambiziosi, di esplorazione umana che Pechino ha avviato per la super cie lunare.
Secondo quanto a ermato in un meeting dello scorso 29 maggio da Lin Xiqiang, vicedirettore della China Manned Space Agency, i primi taikonauti che toccheranno la super cie lunare saranno due e lo faranno per un soggiorno breve, di 6 ore. Questi saranno coadiuvati da un altro membro dell’equipaggio che rimarrà, invece, a bordo di un modulo di servizio in orbita lunare. La prima breve esplorazione è legata a un progetto di più vasto respiro, l’International Lunar Research Station (Ilrs).
Il progetto a guida cinese, che vede come primo e unico partner la Russia, mira a costruire una base lunare permanente, inizialmente robotizzata.

La base di ricerca verrà realizzata agli inizi degli anni 30, ma le prime missioni robotiche apripista verranno lanciate entro la ne dell’attuale decennio. “Questo include lo sviluppo di un razzo vettore con equipaggio di nuova generazione” – dice Lin – “il potente razzo Long March 10 (primo lancio nel 2027), un veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione, un lander lunare, una tuta lunare e altri prodotti per il volo spaziale. Sono in corso anche la costruzione di un nuovo sito di lancio e i test sulle relative strutture di lancio”.

La missione Artemis II riporterà degli astronauti in orbita lunare dopo oltre 50 anni di assenza umana. La data del lancio è fissata per non prima di novembre 2024, ma il modulo di servizio europeo Esm-2 che accompagnerà la capsula Orion fino alla Luna e ritorno è già stato consegnato alla Nasa (in figura, il motore principale del modulo). La nuova capsula Orion non è invece ancora ultimata, in quanto alcuni elementi devono essere recuperati dalla capsula che ha viaggiato nella missione Artemis I, un processo delicato che potrebbe causare dei ritardi sulla tabella di marcia.
Il modulo Esm-2, prodotto dall’Agenzia spaziale europea, ha il compito di spingere e orientare correttamente la capsula grazie ai suoi 33 motori, di alimentarla grazie ai suoi pannelli solari, di regolarne la temperatura e di immagazzinare aria e acqua.
Per assicurarsi che i quattro astronauti di Artemis II non abbiano problemi, durante il viaggio che li porterà fino a circa 9000 km oltre la Luna, raggiungendo così il nuovo record di distanza umana dalla Terra, il modulo di servizio verrà testato fino a fine anno per poi essere integrato alla navicella Orion e infine montato sulla cima del razzo Sls.

Dalle parole di Elon Musk, il prossimo test di volo di Starship potrebbe avvenire ad agosto. Questa volta Musk si aspetta una percentuale di successo più alta rispetto a quella di aprile, grazie alle migliorie eseguite. Il punto critico dello scorso test è stato la separazione fra navicella e booster, e proprio qui SpaceX ha apportato più modi che. Dal prossimo volo verrà testato l’hot staging, cioè il distacco tramite l’accensione dei motori della Starship. Questo aumenterà il carico utile del 10%, ma si deve implementare uno scudo nella parte superiore del booster, che nei piani a lungo termine dovrà essere riutilizzato. Anche la rampa di lancio verrà rinforzata con acciaio, cemento armato e un sistema di soppressione ad acqua. Alcune migliorie sono state e ettuate ai motori Raptor, alcuni dei quali non hanno dato ottime prestazioni nello scorso test. Entro ne anno gli investimenti totali in Starship supereranno i 3 milioni di dollari, ma se il progetto prenderà vita, il ritorno sarebbe assicurato. C’è infatti in gioco il lancio più economico di Starlink e altri satelliti di terze parti, l’utilizzo della navicella Starship come lander lunare per le missioni Artemis e non solo. La Nasa ha infatti rmato un accordo per fornire supporto scienti co e logistico a sette aziende statunitensi per la realizzazione di stazioni spaziali. Una di queste è proprio SpaceX, che vuole trasformare in ambiente abitativo la carenatura di Starship


“Il futuro dei voli spaziali sarà sempre più caratterizzato dai progetti delle società private. Lo spazio e l’aerospazio in generale si stanno dimostrando terreno fertile non solo per la scienza, per la ricerca e per la tecnologia, ma anche per opportunità di crescita industriale e commerciale. Ed è un futuro che è già iniziato”.
È più che una convinzione, ma una certezza, quella che esprime Roberto Vittori, generale di brigata aerea dell’Aeronautica militare italiana, e astronauta italiano dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. Il futuro, d’altra parte, è iniziato dopo la conclusione del Programma Shuttle, con una serie di progetti nanziati dalla Nasa, uno dei quali, quello della navicella Dragon di SpaceX, è ormai pienamente operativo dal 2020 e ha già portato in orbita con successo molti equipaggi con la Crew Dragon, così come andrà in orbita entro il 2023 la Starliner di Boeing, sempre con a bordo un equipaggio.
Oltre ai voli suborbitali di Virgin Galactic, non solo dedicati a voli turistici, ma anche per ricerche tecnologiche, come ha dimostrato proprio il recente volo Galactic-1 con a bordo tre u ciali dell’Aeronautica Militare Italiana.
Roberto Vittori ha preso parte a quella che era programmata come l’ultima missione del Programma Sts delle navette spaziali, volando sulla Endeavour nella missione Sts-134, nel maggio 2011, a cui però fu aggiunta una missione extra, la Sts-135, che resta così l’ultima del programma.
Dopo il suo volo sullo Shuttle, terza missione della sua carriera di astronauta dopo le precedenti spedizioni sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) con le navicelle Sojuz, Roberto Vittori ha rappresentato una sorta di “Ambasciatore astronauta italiano” presso l’Ambasciata italiana a Washington, con l’obiettivo, tra gli altri, di mantenere sempre viva la storica collaborazione tra Italia e Stati Uniti in campo spaziale:
“È una collaborazione di cui stiamo celebrando il 60° anniversario, dato che risale all’agosto 1963 il lancio di uno dei primi satelliti (suborbitali) realizzati dal nostro Centro di Ricerche Aerospaziali in seguito agli accordi di collaborazione tra Italia e Stati Uniti nell’ambito del Progetto
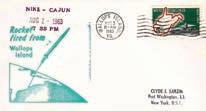
San Marco, grazie al professor Luigi Broglio, che fece dell’Italia uno dei primi paesi al mondo in grado di costruire e mettere in orbita un proprio satellite” - ci ricorda Roberto Vittori, che abbiamo incontrato presso Leonardo a Torino, dove si trovava per testare alcuni droni
sviluppati dalla startup Skypersonic.
“Lo spazio del futuro? Guarda anche e soprattutto a iniziative private e commerciali” - dice l’astronauta italiano - “Da quando il programma Shuttle è terminato, la Nasa ha iniziato a trasferire nanziamenti a iniziative esterne. Il progetto della Dragon di SpaceX ne è la dimostrazione, con i suoi tre voli già e ettuati in versione cargo alla Iss, che hanno funzionato e le ottime performance del Falcon Heavy, un razzo vettore ben più potente che mette assieme tre Falcon 9 e li fa rientrare tutti alla base, dimostrando grandi capacità di recupero. Anche Je Bezos, con i suoi vettori di Blue Origin è competitivo... è un nuovo mondo che si è a acciato alla corsa spaziale e ne è protagonista”.

La Crew Dragon prevede l’invio di un equipaggio di quattro o cinque astronauti per la Iss e ritorno a Terra: “È un programma ormai pienamente operativo, e con voli sia governativi che privati” - dice Vittori - “Questo progetto riassume le esigenze attuali: disporre di un veicolo di concezione semplice e a dabile.
La Dragon, infatti, è una capsula di tipo tradizionale, un ibrido tra Apollo e Sojuz, che a costi contenuti può fare n da subito la spola Terra-spazio. E che funziona però con nuove tecnologie”.
E per un nuovo shuttle? C’è da aspettare ancora? “In questo momento sì – risponde VittoriAlcuni progetti, come il Dream Chaser, che prevede una mininavetta, un po’ come doveva essere
la Hermes europea (poi annullata), richiedono tempo. Anche se il concetto dell’aeroplano spaziale resta sempre valido”.
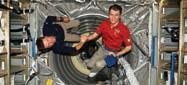
“Piuttosto” - aggiunge - “i primi velivoli spaziali potrebbero essere quelli di alcune società private, come già avvenuto con X-Core, che prevedono l’invio ad alta quota di velivoli tipo aero-razzi, tramite un velivolo atmosferico più grande che li porta ad alta quota; una volta sganciati dal velivolo principale, accendono i loro propulsori a razzo per raggiungere dapprima quote sub-orbitali, e in seguito quelle orbitali. In questo senso, il progetto del Dream Chaser di Sierra Nevada è competitivo”.
In Europa, la situazione è diversa, rispetto agli Usa: la partecipazione dei privati non ha coinvolgimenti diretti né in ambito dei voli umani, né in quello della robotica. Un percorso che si di erenzia nettamente dai nostri partner e dove non è prevedibile un cambio di direzione a breve. “L’aspetto innovativo dei nuovi progetti” - dice Vittori - “è l’anima commerciale che li distingue. Le nuove iniziative promettono anche nuovi posti di lavoro presso le società impegnate. Ed è un modello da esportare: per noi è interessante portarlo in Italia, nonostante il tessuto sociale e del lavoro sia diverso da quello americano”.
“E poi vi è una realtà altrettanto importante” - aggiunge - “Quella del turismo tra le stelle. I voli degli spazioplani di Richard Branson sono ormai una realtà e l’Italia fa parte integrante di questo progetto, con lo spazioporto di Grottaglie in Puglia e il centro di controllo in Altec a Torino. È turismo spaziale,
Nato nel 1964 a Viterbo, Roberto Vittori è sposato con Valeria Nardi e ha tre figli. Ama il calcio, la corsa, il nuoto e le buone letture. Nel 1989 si laurea presso l’Accademia aeronautica di Pozzuoli con una tesi in Scienze Politiche. Ha volato per circa 2000 ore su 40 tipi diversi di aerei militari e ha raggiunto il grado di generale dell’Aeronautica militare italiana Nel luglio 1998 viene selezionato come astronauta dall’Agenzia spaziale italiana (Asi), in cooperazione con l’Esa e si unisce al Corpo astronautico europeo dell’Esa con sede a Colonia, in Germania. Nell’agosto 1998 viene trasferito al Johnson Space Center della Nasa a Houston, in Texas, e segue il programma di formazione che abilita gli astronauti alle missioni a bordo dello Space Shuttle e della Stazione spaziale internazionale (Iss). Completata la preparazione come specialista di missione, Vittori porta a termine una serie di incarichi tecnici presso lo Space Shuttle Operations Systems Branch. Nell’agosto 2001 inizia l’addestramento di ingegnere di bordo allo Yuri Gagarin Cosmonaut Training Centre, presso Star City, vicino Mosca, in previsione del suo primo volo spaziale. Nella primavera del 2002 partecipa alla missione taxi-flight “Marco Polo”, primo astronauta italiano a partire da Baikonur verso la Iss e primo astronauta non russo a pilotare una Sojuz. Successivamente, rientra a Houston, dove lavora nella sezione per lo sviluppo dei veicoli spaziali di nuova generazione e nel gruppo investigativo che si occupa dell’incidente dello shuttle Columbia. Nel 2004 segue un nuovo addestramento per preparare la seconda missione sulla Iss (“Eneide”), che si svolge ad aprile del 2005, con la consegna della nuova Sojuz TM-34, la “scialuppa di salvataggio” per gli astronauti dell’equipaggio permanente della Stazione. Il 16 maggio 2011 Vittori decolla da Cape Canaveral con l’ultimo volo della navetta Endeavour prendendo parte, in qualità di specialista di missione, alla STS-134, con la quale sono approdati sulla Iss strumenti ed esperimenti estremamente importanti, in cui l’Italia ha giocato un ruolo di primo piano, a cominciare dall’Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), un rilevatore di particelle progettato per operare come modulo esterno sulla Iss a “caccia” di antimateria (vedi in figura Roberto Vittori insieme a Paolo Nespoli nella Iss durante questa missione). Fino al 2021 Vittori ha ricoperto il ruolo di Space attaché presso l’Ambasciata italiana negli Stati Uniti.
più che esplorazione spaziale in senso stretto, ma è un’altra realtà nuova e a ascinante che sta per partire”.

LA MINACCIA VERTICALE
IL RITORNO ALLA LUNA
A proposito di esplorazione: recentemente abbiamo celebrato il 50° anniversario dei primi sbarchi lunari. Eri bambino, ma hai dei ricordi? “Pochi su Apollo 11, la
prima storica missione, mentre mi ha colpito Apollo 13, la missione del naufragio spaziale, che si concluse con il salvataggio degli astronauti ai comandi di Jim Lovell. Straordinario esempio di capacità e cooperazione tra uno straordinario equipaggio nello spazio e una straordinaria equipe di supporto a Terra”. Hai coniato un termine: “Minaccia verticale”. Di che cosa si tratta?
“È un problema che riguarda le orbite terrestri, che vanno controllate, ed è compito dell’Aeronautica militare fornire un controllo sugli space debris, cioè tutti i frammenti che orbitano attorno al nostro pianeta, e che di tanto in tanto provocano la caduta di grossi elementi spaziali”. I due moduli spaziali cinesi, che sono piombati verso la Terra in modo incontrollato, poiché privi di un
sistema tale da farli ricadere in un punto preciso del nostro pianeta, il primo dei quali nell’aprile del 2018, hanno fatto tornare di stretta attualità il problema…
“A volte si fa confusione tra ciò che viene gestito nello spazio e ciò che deve essere controllato per evitare che caschino al suolo grossi frammenti o intere componenti satellitari” –aggiunge Vittori – “Non si tratta dei

servizi di cui usufruiamo dai satelliti o dalle piattaforme satellitari, come telefoni, TV, internet e navigatori, ma la sorveglianza sui pericoli delle meteore prodotte da oggetti costruiti dall’uomo. È proprio il concetto di difesa a cui mi riferisco, e che vede l’Aeronautica militare impegnata in prima la”.
Dobbiamo dunque proteggerci dalla presenza sempre più massiccia
di oggetti che vagano in orbita e magari sono inutilizzati, tra stadi di razzi vettori, satelliti abbandonati e frammenti derivati da esplosioni, e scontri casuali (e non casuali…) tra oggetti in orbita?
“Per le orbite terrestri utilizziamo sempre i razzi” – dice Vittori – “gli stessi che mi hanno portato in orbita e che rappresentano un metodo superato. I lanciatori tradizionali
restano importanti per missioni di esplorazione, verso Luna e Marte, e per alcuni tipi di satelliti. Ma per l’orbita terrestre sono gli spazioplani il metodo migliore, da un punto di vista tecnico ed economico. Da questo punto di vista la Virgin Galactic è sulla strada giusta e presto svilupperà quelli più potenti per entrare in orbita, e non solo per i voli sub-orbitali di oggi. E la pista di Grottaglie come quelle di altre postazioni nel mondo, sono la logica conseguenza dei miglioramenti dell’aeronautica”.

Il ritorno alla Luna è ormai
imminente. Nel 2025 o 2026 i primi sbarchi, poi una base permanente: “Sì, tornare sulla Luna è molto importante” - dice Vittori - “ed è importante costruirvi delle basi per fare scienza, e poi per sfruttare le risorse presenti nelle rocce e nel terreno lunare. Inoltre, c’è l’elio-3, un isotopo che potrà essere utilizzato, tramite metodi di ssione nucleare, per poter ottenere energia sulla Terra. Dalla Luna potrebbe infatti arrivare una risposta per ottenere una nuova fonte di energia alternativa.
Il Programma Artemis è una straordinaria opportunità, ma sul
nostro satellite vi torneremo non più per brevi esplorazioni scienti che come ai tempi delle missioni Apollo, ma per sfruttarne le risorse, nell’ottica della new space economy. Per questo serviranno delle basi da collocare sulla super cie selenica, per iniziare a creare un avamposto, non solo in orbita lunare, ma anche e soprattutto su di essa”.
*ANTONIO LO CAMPO
È UN GIORNALISTA SCIENTIFICO
SPECIALIZZATO PER IL SETTORE

AEROSPAZIALE E COLLABORA
CON DIVERSE TESTATE NAZIONALI. PER COSMO CURA LA SEZIONE SPAZIO.


ESATTA REPLICA DELL’ORIGINALE REALIZZATA IN ALLUMINIO FORMATO 28X19,5 CM PER IL 50° ANNIVERSARIO DELLA MISSIONE

DISPONIBILE SU BFCSTORE.COM (bit.ly/41Fv5w4)
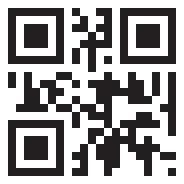
A 20,00 EURO (SPESE DI SPEDIZIONE INCLUSE)
Il suo incarico ha preso il via u cialmente lo scorso
15 giugno, dopo essere stato nominato a ne maggio. Teodoro Valente è il nuovo Presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), dopo che a Palazzo Chigi si era riunito il Comitato per le Politiche Aerospaziali (Comint), presieduto da Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy con delega ai programmi spaziali e aerospaziali, che aveva approvato la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione (CdA) dell’agenzia.
Teodoro Valente è direttore dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del Cnr. Vanta una pluriennale esperienza come professore ordinario di Scienza e tecnologia dei materiali presso l’Università La Sapienza di Roma, di cui è anche stato nominato prorettore, lo stesso ateneo in cui ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica.
Il neopresidente dell’Asi ha prestato servizio anche presso la Direzione ricerca e sviluppo della Commissione Ue e ha svolto esperienze lavorative nel settore privato, come esperto di materiali polimerici e nanotecnologie. Valente subentra così a Giorgio Saccoccia, che proveniva dal settore sulla propulsione spaziale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), che ha concluso ai primi di maggio il suo incarico. Saccoccia aveva a sua volta ereditato il ruolo di presidente nel 2019 dal sico Roberto Battiston
Con Valente è stato nominato il nuovo CdA, che sarà
composto da Giuseppe Basini, Marica Branchesi, Stefano Gualandris, Marco Lisi, Luisa Riccardi ed Elda Turco Bulgherini, con una ancora più signi cativa e quali cata rappresentanza femminile.
Nel rivolgere un ringraziamento al precedente presidente dell’Asi, il ministro Urso ha salutato il presidente e il nuovo CdA, ai quali ha augurato buon lavoro. “Sono particolarmente soddisfatto della piena sinergia con gli altri dicasteri con i quali abbiamo condiviso nomine di alto pro lo professionale e scienti co” – ha a ermato il Ministro – “che consentiranno all’Asi di a rontare meglio le s de impegnative che attendono la nostra Agenzia anche sul piano bilaterale e multilaterale. Impegni che riguardano anche un e cace e signi cativo utilizzo degli ingenti nanziamenti assegnati all’Asi, sia come trasferimenti ai programmi dell’Esa, sia sul fronte interno con i fondi ordinari e quelli messi a disposizione dal Pnrr. L’Italia - ha proseguito il Ministro - è leader globale nel settore spaziale e siamo pronti a confermare tale leadership a bene cio della liera industriale italiana e della ricerca e sviluppo a essa collegati”. Urso ha anche ricordato che è avviato il dibattito con gli attori pubblici e privati del settore per l’elaborazione di un progetto di Ddl che de nirà in tempi brevi l’intera governance nazionale sullo spazio
“L’Italia - ha sottolineato Urso - al contrario di altri Paesi dell’Unione europea e globali, manca di tale
essenziale inquadramento normativo, e contiamo di ovviare a tale lacuna entro gli inizi del prossimo anno”. Le molte tematiche del settore spaziale sono state tra gli argomenti al centro della più recente missione del ministro Urso negli Usa, dove ha

incontrato esponenti del National Space Council e delle maggiori aziende commerciali americane del settore. L’obiettivo era il ra orzamento della collaborazione tra Usa e Italia nel settore spaziale, già in atto da tempo nell’ambito di

molti programmi: voli spaziali con astronauti, missioni di esplorazione del cosmo e satelliti applicativi. Gli incontri e discussioni hanno portato a buone prospettive per le prossime, importanti s de spaziali che ci attendono.

Una grande svolta per la scienza nello spazio avvenne nel 1972, quando il geologo Jack Schmitt divenne il primo e ( nora) unico scienziato a mettere piede sulla Luna. Tuttavia, il volume di dati raccolti dalla sua missione è estremamente minore rispetto a quello ottenuto dagli studi compiuti negli anni seguenti a bordo della stazione spaziale Skylab (vedi Cosmo n. 39) e delle Saljut sovietiche.
Che si tratti di studiare il cosmo stesso, il comportamento sico e chimico della materia in condizioni di microgravità, o gli e etti del viaggio spaziale sugli animali e sul corpo umano, le nostre conoscenze vengono soprattutto dalle stazioni spaziali. I laboratori orbitali permettono di eseguire esperimenti scienti ci di lunga durata in un ambiente impossibile da ricreare sulla Terra, ma i primi a essere realizzati erano di cili da rifornire, e la rotazione degli equipaggi era problematica: se un equipaggio era a bordo, l’unico attracco disponibile era già occupato dalla loro navicella.
L’innovazione che ha permesso una presenza umana continuativa in orbita è stata la stazione spaziale modulare: i diversi settori della stazione vengono lanciati uno alla volta e collegandosi in orbita formano un ambiente abitativo e di ricerca più grande e con diversi
attracchi. Questo rende possibile ricevere capsule di rifornimenti e alternare gli equipaggi, senza lasciare mai la stazione sguarnita.
Grazie all’esperienza maturata a bordo delle Saljut e all’aiuto dello Space Shuttle statunitense, fu l’Unione Sovietica a costruire la prima stazione modulare, la Mir. Deorbitata nel 2001, lasciò il compiti dell’unico avamposto umano nello spazio alla Stazione spaziale internazionale (Iss).
Il più grande artefatto umano fuori dall’atmosfera ha ospitato decine di astronauti e cosmonauti, fra cui 44 delle 72 donne che hanno raggiunto nora lo spazio. La Iss è un esempio di collaborazione internazionale fra le agenzie spaziali che l’hanno realizzata (Usa, Russia, Europa, Canada e Giappone) e fra le oltre cento nazioni che hanno potuto utilizzarla per svolgere i propri esperimenti.
Sia sulla Iss che sulle navicelle americane Crew Dragon e sulle russe Sojuz che la raggiungono, si possono trovare cittadini di paesi ai lati opposti di un con itto bellico. Una convivenza assolutamente non scontata, soprattutto considerando gli accordi per satelliti internazionali a bordo di razzi russi cancellati nell’ultimo anno. Nonostante ciò, la durata vitale della Iss ha già superato i 15 anni inizialmente programmati, tenuto conto che buona parte della sua struttura è stata costruita negli anni 90. Gli astronauti e ettuano spesso lavori


di manutenzione all’esterno della stazione per rimediare alla sua usura, e i costi in continuo aumento hanno portato le agenzie spaziali Nasa, Esa, Csa e Jaxa alla decisione di porre ne alla sua vita operativa nel 2030, facendola deorbitare nell’Oceano Paci co meridionale l’anno successivo.
L’agenzia russa Roscosmos ha annunciato a più riprese il proprio ritiro dalla Iss, per focalizzarsi sulla futura stazione spaziale Russian Orbital Service Station (Ross).

L’anno scorso l’allora direttore Dmitrij Rogozin aveva chiesto provocatoriamente come avrebbe fatto la Iss a rimanere in orbita senza i moduli russi a fornirle
periodicamente la spinta necessaria. Ma questa posizione è stata ritrattata dall’attuale direttore, Jurij Borisov, che ha prolungato l’impegno russo sulla Iss no a quando la loro stazione spaziale non sarà costruita e operativa. Considerando i ritardi del progetto Ross e l’attuale condizione politica ed economica di Mosca, sarà di cile vedere un suo modulo in orbita prima del 2028.
La Ross potrà diventare operativa e cominciare a ospitare due cosmonauti con il quarto modulo, ma Roscosmos prevede di completare la stazione con sette moduli entro il 2035. A questo punto, un equipaggio di quattro cosmonauti visiterà la stazione che, a di erenza della Iss, avrà un’orbita eliosincrona, che le permetterà di sorvolare tutto il mondo e che, in
determinati periodi, potrà essere raggiunta più rapidamente dal suolo nazionale.
Se avrà successo, la Cina sarà la seconda nazione a completare una stazione spaziale modulare senza aiuti internazionali. La grande esclusa dalla collaborazione internazionale, ma non globale, della Iss, già nel 2011 e 2016 aveva lanciato le stazioni a modulo singolo Tiangong 1 e 2, e grazie all’esperienza maturata ha realizzato negli ultimi due anni la terza stazione modulare della storia, ancora una Tiangong
La con gurazione attuale di tre moduli le conferisce un volume abitativo di circa 340 metri cubi, che è solo una frazione degli oltre 900 della Iss, ma che permette comunque una permanenza di sei mesi a un equipaggio di tre taikonauti e l’esecuzione di attività extraveicolari. Secondo i piani iniziali, uno dei moduli doveva essere costruito in Italia da ales Alenia Space, ma l’azienda ha preferito restare vicino al partner statunitense, che ha vietato le collaborazioni spaziali con la Cina. In gioco non c’è solo la collaborazione a bordo della Iss, che ha portato alla realizzazione in Italia di cinque moduli e della Space cupola e alla permanenza in orbita di cinque astronauti italiani, fra cui l’unico comandante europeo donna, Samantha Cristoforetti. C’è anche la Luna.
Per stabilire una presenza continuativa sul nostro satellite, la Nasa ha lanciato il Programma Artemis e la realizzazione del Lunar Gateway, che sarà la prima stazione in orbita attorno alla Luna, per fare da campo base per le missioni lunari umane a partire da Artemis IV, che al momento è programmata per il 2027 Il primo modulo del Lunar Gateway verrà lanciato a novembre 2024 con un razzo Falcon Heavy di SpaceX: si tratta del Ppe (Power and Propulsion Element), che fornirà energia e la propulsione per modi care l’orbita della stazione. Assieme al Ppe verrà lanciato Halo (Habitation and Logistics Outpost), costruito in Italia da ales Alenia Space per Northrop Grumman, un modulo abitativo che potrà ospitare gli astronauti delle missioni Artemis. Agganciato ad Halo ci sarà l’hub di comunicazione Hlcs (Halo Lunar Communication System), la prima parte della sezione europea Esprit (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications), anch’essa commissionata a ales Alenia Space, che sarà larga 4,6 metri e lunga in totale 6,4 metri.
La seconda parte della sezione europea, Erm (Esprit Refueling Module), verrà lanciata nel 2029 e riceverà le capsule di rifornimento Dragon XL, appositamente realizzate per il Gateway. Il loro contenuto verrà inizialmente immagazzinato a bordo di Erm insieme al carburante per alimentare il Ppe. Esprit permetterà agli astronauti di osservare la Luna e lo spazio attraverso sei nestre disposte in modo simile a quelle della Space cupola sulla Iss.
ales Alenia Space è coinvolta anche nella realizzazione del modulo abitativo I-Hab (International Habitation Module), che porterà il volume abitativo della stazione a più di 125 metri cubi. Sviluppato in una collaborazione fra l’Agenzia spaziale europea e quella giapponese, il suo lancio è ssato per il 2028 a bordo del razzo Sls della missione Artemis IV. Altri elementi potranno essere aggiunti in futuro, come airlock, moduli gon abili e il Canadarm 3.0, il braccio robotico lungo 8,3 metri realizzato in Canada.
Non solo le agenzie statali sono al lavoro sulle stazioni spaziali. Axiom Space, dopo aver portato sulla Stazione spaziale internazionale un equipaggio privato, ha ricevuto dalla Nasa l’esclusiva per agganciare i propri moduli alla Iss.

Il primo viene realizzato, ancora una volta, da ales Alenia Space e il suo lancio è previsto a ne 2025.
A questo primo modulo abitativo seguiranno altri di supporto vitale che
consentiranno ad Axiom di separare i propri moduli dalla Iss prima della deorbitazione di quest’ultima, realizzando la prima stazione spaziale privata.
Axiom o rirà non solo un’esperienza unica per turisti facoltosi, ma soprattutto la possibilità di eseguire esperimenti scienti ci per nazioni che non hanno accesso allo spazio, come è avvenuto già nella missione Ax-2, partita il 21 maggio scorso, in cui hanno volato due astronauti dell’Agenzia spaziale saudita verso la Iss: Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi. Oppure, come recentemente concordato con l’Agenzia spaziale canadese, fornendo più tempo in orbita a nazioni che, pur essendo già inserite nelle collaborazioni internazionali, hanno ulteriori necessità. Il tempo a disposizione in microgravità sarà estremamente importante quando, dopo la fase di sperimentazione, comincerà quella manifatturiera. Le condizioni uniche dell’orbita permettono di creare leghe speci che e impianti retinici di migliore qualità. Axiom prevede che
nello spazio verranno prodotte bre ottiche, leghe e superleghe, impianti medici e biostampe 3D.
E non c’è solo Axiom Space.
Tre consorzi di aziende americane vogliono mettere in orbita le proprie stazioni spaziali prima della ne della Iss. La Nasa, nella sua recente ottica di partnership privata e concorrenziale, ha nanziato questi
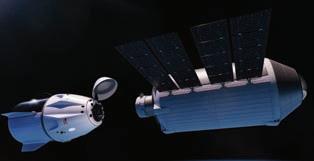
tre consorzi per assicurare agli Stati Uniti un solido accesso allo spazio anche negli anni a venire. Nanoracks, Voyager Space e Lockheed Martin vogliono essere operativi entro il 2027 con lo Starlab, aperto anche a clienti internazionali. Blue Origin e Sierra Space vogliono utilizzare il razzo New Glenn o la capsula Starliner di Boeing
La startup Vast intende lanciare con un Falcon 9 di SpaceX il primo modulo della sua stazione spaziale Haven nel 2025 e portare a bordo il primo equipaggio nell’agosto 2025 con una capsula Crew Dragon Se riuscirà a rispettare le scadenze, la missione Vast-1 avverrà prima dell’attacco del modulo inaugurale della stazione di Axiom Space alla Iss. Inoltre, batterebbe sul tempo le aziende che hanno un contratto con la Nasa per realizzare le prime stazioni spaziali private e indipendenti. Il modulo presentato da Vast ha un diametro di 3,8 metri e un’altezza di 10,1 metri; orbiterà la Terra a 500 km di
per raggiungere il loro Orbital Reef. Anche Northrop Grumman ha ricevuto un nanziamento per il progetto della stazione commerciale Hero, e la Nasa è felice di contribuire a queste iniziative, in quanto la competizione tra queste aziende si ri etterà sia nei tempi di realizzazione, sia nei prezzi dei servizi o erti.
quota e potrà ospitare fino a quattro astronauti per un massimo di 30 giorni. Equipaggiato con WiFi e finestra d’osservazione, il modulo Haven-1 avrà la possibilità di simulare la gravità lunare girando su sé stesso, per realizzare dei test in vista delle future basi lunari. Un progetto molto ambizioso, che nei progetti a lungo termine della startup prevede di aggiungere altri moduli fino a superare i 100 metri di lunghezza. Un risultato analogo a quello ottenuto con la Iss, che ha richiesto però lo sforzo combinato di numerosi Paesi. Inquadra il QR per un video dedicato a questo progetto.


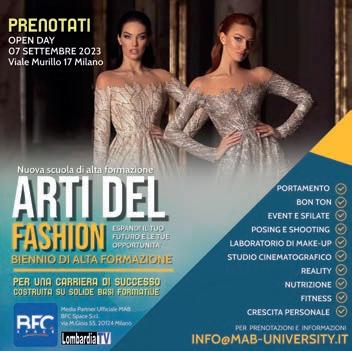
Erica Nelson è una giovane ricercatrice della Università del Colorado che durante la scuola elementare aveva fatto una ricerca sul telescopio spaziale Hubble (Hst), lanciato proprio in quegli anni. Al tempo rimase colpita dalla scoperta che più Hst guardava lontano, più forniva informazioni su oggetti sempre più giovani. Da qui nacque la decisione che “da grande” si sarebbe occupata di questo argomento. L’occasione si è presentata quando ha avuto la possibilità di lavorare con il nuovo telescopio spaziale James Webb (Jwst), il primo strumento in grado di osservare l’epoca primordiale dall’Universo, grazie ai suoi strumenti che operano nell’infrarosso vicino (1-5 micron con gli strumenti NirCam e NirSpec) e nell’infrarosso medio ( no a 25 micron con lo strumento Miri), dove si concentra la luce emessa dalla galassie più lontane, a causa dello spostamento verso il rosso del loro spettro.
Uno degli scopi principali di Jwst è proprio la ricerca di galassie lontanissime, nate 2-300 milioni di anni dopo il Big Bang, che è avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa. Per capire dalla forma e dalle caratteristiche spettrali di queste galassie il meccanismo che ha dato loro origine.
Prima del Jwst, la galassia più lontana era GN-z11, una macchia di luce rossa e allungata, individuata dalla camera infrarossa Wfc3 di Hst nel campo Goods North (Great Observatories Origins Deep Survey), con il supporto dell’osservatorio Keck-1 alle Hawaii. Sulla base dello spostamento verso il rosso delle righe spettrali, era stato determinato un redshift (z) pari a 11,6, che rivelava una nascita avvenuta 420 milioni di anni dopo il Big Bang
Ma il 6 giugno 2022 Jwst è andato ben oltre, scrutando i dintorni dell’ammasso Smacs 0J273, situato a 4,5 miliardi di anni luce nella costellazione del Pesce
» Sopra: il protagonista della prima immagine ufficiale pubblicata dal telescopio spaziale James Webb (luglio 2022) era l’ammasso di galassie Smacs 0J723, distante 4,5 miliardi di anni luce nella costellazione del Pesce Volante.

A sinistra: alcune delle galassie ad alto redshift scoperte nel campo dell’ammasso Smacs 0J273. Le distanze sono state ottenute grazie a misure fotometriche del Lyman break e a misure spettroscopiche dello spostamento verso il rosso di righe dell’idrogeno e dell’ossigeno.

Volante, che fa da lente gravitazionale a 16 galassie lontanissime retrostanti, producendo decine di tracce altamente deformate. H. Yan (Università del Missouri) ha così individuato, dietro l’ammasso, una serie di oggetti con redshift maggiore di 11, tra i quali (da confermare) alcuni addirittura con redshift pari a 20, potenzialmente nati solo 200 milioni di anni dopo il Big Bang e situati, a causa dell’espansione cosmica, a una distanza di circa 35 miliardi di anni luce da noi. Per Erica Nelson, assieme a un folto gruppo di colleghi, il lavoro è iniziato a
metà del 2022, quando la NirCam del Jwst è stata puntata su una minuscola regione dell’Orsa Maggiore già indagata da Hst negli anni 90, chiamata Ceers (Cosmic Evolution Early Release Science). Utilizzando il metodo del redshift fotometrico
*CESARE GUAITA LAUREATO IN CHIMICA E SPECIALIZZATO IN CHIMICA ORGANICA, HA LAVORATO COME RICERCATORE PRESSO I LABORATORI DI UNA GRANDE INDUSTRIA. È PRESIDENTE DEL GRUPPO ASTRONOMICO TRADATESE E DA OLTRE 25 ANNI CONFERENZIERE DEL
(cioè, misurando la posizione del Lyman break, il punto in cui decade la luminosità della galassia), sono stati scoperti 13 oggetti galattici con redshift compreso tra 7,4 e 9,1 (500-700 milioni di anni dopo il Big Bang). Sette di queste galassie primordiali hanno mostrato una struttura già ben de nita, con masse di circa 10 miliardi di masse solari e una (il cui redshift è pari a 7,4) con una massa dieci volte maggiore. Masse di questo tipo sono simili a quella della Via Lattea, ma la nostra Galassia produce in media due stelle all’anno, mentre in quel lontanissimo
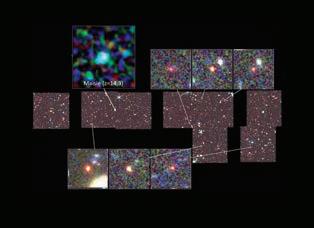
passato la produzione stellare era centinaia di volte maggiore. Un bel problema, dato che nell’Universo di soli 5-700 milioni di anni di età non dovrebbe esserci già materia su cientemente concentrata per generare strutture così massicce e produttive. A meno di ricorrere alla “materia oscura”, che l’Universo primordiale avrebbe prodotto in grande quantità.
La presenza di materia oscura sembra necessaria anche per spiegare una scoperta di Jwst ancora più imprevista: quella di galassie già organizzate in ammassi 650 milioni di anni dopo il Big Bang. La ricerca è stata condotta dal NirSpec in due momenti successivi, con progetti avviati nell’ambito di due di erenti programmi. Il target era l’ammasso Abell 2744, distante circa 4 miliardi di anni luce, che fa da lente gravitazionale con la sua enorme massa a galassie molto più lontane, già studiate da Hst. Grazie all’e etto lente, il NirSpec ha scoperto sette galassie, tutte con redshift pari a 7,9, risalenti a 650 milioni di anni dopo il Big Bang, che costituiscono quindi un vero e proprio ammasso.
Il folto gruppo degli autori della scoperta, tra cui molti italiani, ha misurato velocità relative all’interno del proto-ammasso di circa 1100 km/s. Da qui l’idea che a tenere assieme il proto-ammasso sia un alone di materia oscura di circa due milioni di miliardi di masse solari. Se l’ipotesi verrà confermata, quell’ammasso lontanissimo si rivelerà simile a quelli più massicci dell’Universo “maturo”, come l’ammasso della
Chioma di Berenice. La tendenza ad aggregazioni galattiche primordiali è stata individuata anche in una lente gravitazionale di erente, relativa alla galassia SPT 0418-47 situata nella costellazione australe dell’Orologio con redshift pari a 4,225, nata 1,4 miliardi di anni dopo il Big Bang e distorta a forma di un “anello di Einstein” quasi perfetto da una galassia “vicina” con redshift pari a 0,263. L’anello di Einstein è stato scoperto nell’ottobre 2016 dal radiointerferometro Alma, utilizzando 43

antenne da 12 metri di diametro. Dalla sua analisi è stato possibile ricostruire una galassia nucleata a spirale molto evoluta, in quanto ricca di elementi di erenti dall’idrogeno, come il carbonio ionizzato, con una massa stimata di 10 miliardi di stelle e dotata di un alone di materia oscura cento volte maggiore, determinato in base ai dati di rotazione della galassia. Nell’ambito del programma
Templates (Targeting Extremely Magni ed Panchromatic Lensed Arcs), un team guidato da Jane
Rigby del Goddard Space Center ha individuato nelle immagini NirCam e Miri due sorgenti identiche (SE-1 e SE-2), situate sul bordo dell’anello di Einstein, con le stesse caratteristiche spettroscopiche dell’anello stesso e situate a una distanza paragonabile. Queste sorgenti potrebbero essere la doppia immagine di una singola piccola compagna della galassia
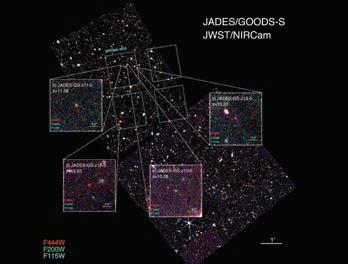
distorta ad anello, situata a una distanza da questa di circa 200mila anni luce e gravitazionalmente legata ad essa. Il “collante” per questa unione quasi primordiale sarebbe ancora una volta un alone di materia oscura.
Come si ricordava all’inizio, grazie al Jwst, il limite della galassia più
lontana (e quindi più giovane) è stato continuamente superato. Un gruppo guidato da Tommaso Treu (Università della California), nell’ambito del progetto Ers 1324, ha individuato (ancora tramite il redshift fotometrico) all’interno dell’ammasso Abell 2744 almeno cinque candidati con redshift maggiore di 10. Due di questi mostrano caratteristiche
Qui sopra: le tre proto-galassie più giovani finora scoperte dal telescopio spaziale James
speciali. Uno è la galassia Glass-z11, che mostra proprio come GN-z11 (la galassia record di Hst) indizi di una struttura a spirale, davvero prematura secondo le teorie correnti. L’altro è la galassia Glass-z13, il cui redshift la collocherebbe a soli 300 milioni di anni dopo il Big Bang. Si tratta, comunque di due galassie piuttosto piccole, estese per meno di 5000 anni luce e contenenti circa un miliardo di stelle. Risultati analoghi sono stati ottenuti della collaborazione Jades (Jwst Advanced Deep Extragalactic Survey) che nell’ottobre 2022 e poi nei primi mesi del 2023 ha “vivisezionato” con Jwst una parte della regione attorno al campo Hdf (Ultra Deep Field) studiato da Hst e che in gran parte coincide con il campo Goods-South nella costellazione australe della Fornace. La NirCam ha lavorato a 1,15 micron


(reso con un falso colore blu), a 2,0 micron (falso colore verde), e a 4,44 micron (falso colore rosso). Su circa 250 candidati, sono state individuate quattro galassie con redshift maggiore di 10. Per due di queste galassie (Jades-GS-z10 e Jades GS-z11), inizialmente osservate da Hst, sono stati confermati gli spostamenti verso il rosso di 10,38 e 11,58. Altre due galassie (GS-z12 e GS-z13) sono invece una novità, perché mostrano valori di redshift rispettivamente pari a 12,63 e 13,20. La seconda, in particolare, mostra una età di 13,5 miliardi di anni, che la colloca solo a 300 milioni di anni dal Big Bang. E dal momento che ci manda luce da 13,5 miliardi di anni, deve essere nata prima, attorno a 200 milioni di anni dopo il Big Bang: siamo al limite della cosiddetta “era oscura” quando dovrebbero essersi formati i primi
misteriosi oggetti (forse grandi buchi neri) che innescarono la formazione delle galassie. Non è nita, perché, nell’ambito del progetto Ceers, Steven Finkelstein (Università del Texas) ha trovato con Jwst una galassia con redshift pari a 14,3, quindi risalente a 280 milioni di anni dopo il Big Bang. Lo scopritore, per la soddisfazione di aver scoperto la galassia no ad allora più giovane, le ha attribuito il nome della sua giovane glia Maisie. Forse, anche questo record è durato poco: C. Donnan (Università di Edimburgo) ha individuato su immagini del Jwst almeno sei galassie con redshift maggiore di 12, tra cui la galassia siglata Ceers 93316 con redshift pari a 16,7, quindi nata solo 235 milioni di anni dopo il Big Bang. Ma questa scoperta è ancora da confermare.
Queste lontanissime galassie sono piccole, composte da 100 milioni a 1 miliardo di stelle, poco produttive (massimo una stella all’anno) e quindi povere di elementi diversi da idrogeno ed elio, con una “metallicità” del 5-10 percento rispetto alle galassie vicine. Galassie maggiori potrebbero derivare dall’unione di queste piccole protogalassie in tempi stimabili di 2-3 miliardi di anni.
Ci si chiede quindi come sia possibile che il Jwst abbia individuato anche galassie già ben strutturate come forma e massa già in un’età compresa tra 200 e 500 milioni di anni dopo il Big Bang. Speriamo che il grande telescopio spaziale ci dia risposte convincenti su questo problema fastidioso, magari chiarendo anche la presunta importanza della materia oscura.
Altre Terre – Viaggio alla scoperta dipianeti extrasolari è un libro che racconta la ricerca di altri mondi, dai primi tentativi a occhio nudo no alle conquiste dei nostri giorni, grazie a telescopi sempre più so sticati. Ma è anche la storia degli astronomi, di donne e uomini che l’hanno fatta, di coloro che si sono avvicinati alla meta o di quelli che con forza hanno portato avanti le proprie idee, spesso non comprese o errate. Senza il loro contributo non sapremmo ancora nulla degli oltre 5000 pianeti noti nella Via Lattea e di tutti gli altri che si stanno continuamente scoprendo.
Siamo soli nell’Universo? Esistono altri pianeti simili alla Terra, eventualmente abitabili?
Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui Giovanni Covone tenta di dare una risposta, accompagnando il lettore in una sorta di viaggio nello spazio e nel tempo, dal sogno di Giordano Bruno no alle scoperte più recenti dei pianeti extrasolari, descrivendo quegli strani mondi nella vastità dell’Universo che sembrano andare in contrasto con l’unicità del nostro pianeta.
“Oggi non sappiamo se troveremo altri pianeti come la Terra o altre civiltà con cui dialogare”, scrive Covone, “ma sicuramente la ricerca degli esopianeti ci aiuterà a comprendere la nostra origine e il nostro futuro, aiutandoci a conquistare una necessaria consapevolezza dell’unicità e della precarietà della nostra specie”. Altre Terre è anche un testo scienti co che Covone presenta con semplicità e chiarezza espositiva, in cui il sogno dell’autore, e cioè l’osservazione diretta di altre Terre, potrebbe un giorno diventare realtà per gli astronomi del futuro, e per questo si rivolge in particolare ai giovani lettori che decideranno di seguire questa strada. Per approfondire alcuni argomenti, Cosmo ha raggiunto Giovanni Covone, professore associato, docente di astronomia e astro sica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II”.
Il mio campo di ricerca è l’astro sica e mi interesso in particolare di due aspetti apparentemente distanti tra di loro: la cosmologia osservativa (attraverso l’uso della tecnica nota
come lensing gravitazionale) e lo studio dei pianeti extrasolari, in particolare dei pianeti di tipo terrestre.
Scrivere un libro di divulgazione per me è stato un passo naturale, motivato dal desiderio di comunicare i risultati delle nostre ricerche scienti che e anche le domande di carattere universale alle quali la scienza ci pone di fronte. La comunicazione della scienza mi appassiona quasi quanto la ricerca stessa, sia quando si tratta di didattica universitaria, sia quando si tratta di divulgazione verso un pubblico molto più ampio. Prima d’ora non avevo mai a rontato la s da della scrittura per un pubblico di non esperti. Ma nel 2020, l’interesse suscitato dal pianeta TOI-700d, che sembra simile al nostro, ha fatto scattare questa molla. Non è stato semplice: fra la prima idea e la consegna del manoscritto sono passati più di due anni.
A mio parere, la ricerca di una seconda Terra nella nostra Galassia rappresenta il Santo Graal
» Sopra: il telescopio orbitale Tess della Nasa misura la luminosità di decine di migliaia di stelle alla volta, per scoprire il passaggio di un pianeta davanti alla sua stella attraverso la piccola diminuzione di luminosità provocata dalla sua ombra.
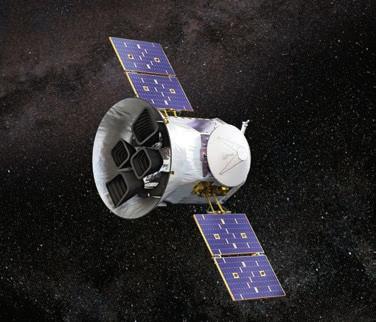

Sotto a sinistra: Giovanni Covone è docente di astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II”.
Sotto a destra: un’illustrazione artistica del sistema planetario della stella TOI-700, una nana rossa distante 102 anni luce nella costellazione del Dorado. In primo piano l’illustrazione del pianeta simile alla Terra TOI-700d.

ALTRE TERRE
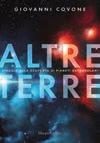
Altre Terre è un libro di Giovanni Covone, edito a Milano da HarperCollins Italia nel 2023. È composto da 336 pagine formato 14,5 x 2 x 21,2 cm con illustrazioni in bianco e nero. In vendita in libreria al prezzo di € 18,50.
un momento epocale nella storia della nostra cultura. E sarà solo il primo passo per ulteriori avventure scienti che.
UN CASO UNICO E RARO?
A proposito della Terra, nel libro parlo di “accidente cosmico”, perché la sequenza di eventi, anche fortuiti, che ha portato alla formazione di un pianeta come il nostro sembra davvero improbabile. Sappiamo che quasi ogni stella nasce con un sistema planetario, ma pianeti rocciosi davvero simili alla Terra sono probabilmente rarissimi: un pianeta ospitale per la vita come la conosciamo deve trovarsi alla giusta distanza dalla sua stella, avere acqua liquida sulla super cie, un campo magnetico protettivo, un satellite naturale come la Luna che permette all’asse di rotazione di rimanere stabile per miliardi di anni.
all’analisi delle prime osservazioni dei pianeti di tipo terrestre scoperti con questo strumento. Tess misura la luminosità di decine di migliaia di stelle alla volta, con cadenza di trenta secondi, per scoprire il passaggio di un pianeta davanti alla sua stella attraverso la piccola diminuzione di luminosità provocata dalla sua ombra. All’inizio, il gruppo di Napoli nella collaborazione Tess comprendeva solo me e uno studente in tesi di laurea. Quando a gennaio 2020 ricevetti l’invito del presidente della Camera, onorevole Roberto Fico, la segretaria fu molto sorpresa dal sapere che saremmo andati solo in due, uno dei quali non era ancora laureato. Oggi il gruppo è cresciuto, si chiama ExoplaNats (da Exoplanets e Naples) e comprende astro sici, informatici, biologi, chimici e studenti della Federico II e dell’Università Parthenope.
dell’astro sica moderna. Terra è sinonimo di “pianeta abitabile”, cioè di un pianeta che o re le condizioni ideali per la nascita e l’evoluzione della vita così come la conosciamo, no all’emergere di una specie in grado di contemplare le stelle. Non abbiamo ancora trovato un pianeta che possiamo de nire “un’altra Terra”, sia perché le nostre tecniche di osservazione non sono ancora mature, sia perché tali pianeti sono probabilmente molto rari. Io credo che la scoperta di un altro pale blu dot nella Galassia sarà
È probabile che la vita possa sorgere in ambienti anche molto estremi, come le nubi di Venere o gli oceani senza luce dei satelliti di Giove, ma da quello che sappiamo, le condizioni che ho citato (e altre ancora) sembrano davvero necessarie per permettere alla vita di evolvere no alle forme complesse che osserviamo oggi intorno a noi.
Il mio gruppo collabora dal 2018 con la Nasa e gli astronomi che hanno costruito il telescopio orbitale Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Abbiamo partecipato da subito
Il mio progetto è quello di fare crescere un gruppo di ricercatori che siano in grado di dare un contributo allo studio dei pianeti simili alla Terra. Come auspicio per il futuro, sarebbe meraviglioso leggere, da qui a qualche anno, della prima immagine diretta di un’altra Terra: sarà un momento importante per tutta l’umanità.

*CORRADO RUSCICA
HA STUDIATO ASTRONOMIA
ALL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA E DI MILANO E GIORNALISMO SCIENTIFICO
ALL’UNIVERSITÀ DI FERRARA, HA
COLLABORATO CON GIORNALI
ON LINE ED È AUTORE DI TESTI DI DIVULGAZIONE ASTRONOMICA.

La scienza che studia gli oceani è fondamentale per capire se le lune oppure i pianeti che ospitano vaste estensioni di acqua in super cie o sotterranei sono in grado di diventare ospitali per la vita come la conosciamo, e in particolare se ambienti adatti alla vita possano esistere nel Sistema solare e anche in ambienti extrasolari.
Alcuni di questi corpi, appartenenti al nostro sistema planetario, sono i principali luoghi di interesse per missioni spaziali dedicate, come la sonda europea Juice, salpata il 14 aprile verso le lune ghiacciate di Giove (presentata su Cosmo n. 37).
L’acqua è molto importante, poiché la vita sulla Terra è iniziata proprio negli oceani. L’acqua è indispensabile per tutti gli esseri viventi sulla Terra, umani compresi, e costituisce una percentuale importante del peso del nostro corpo, dal 50 al 60 per cento negli adulti e no al 75% nei neonati.
La Terra è un “pianeta oceanico” in quanto appare ricoperta di oceani, che occupano circa il 70 per cento della sua super cie, ma il nostro pianeta non è l’unico mondo oceanico nel Sistema solare, perché ne esistono almeno una decina, che rendono il nostro vicinato decisamente più umido di quanto possiamo pensare, anche se meno appariscente di quello terrestre.
La luna Europa di Giove è uno di questi mondi oceanici, dove l’oceano è racchiuso da una spessa crosta di ghiaccio. E la sonda Europa Clipper della Nasa sarà lanciata nel 2024 proprio per studiare l’atmosfera, la super cie e l’interno di questa luna, in parziale collaborazione e concorrenza con Juice (vedi l’apertura delle Spacenews di questo numero).
Dal punto di vista astrobiologico, Europa può essere esaminata suddividendola in tre zone: la crosta, l’oceano e il fondale oceanico ed è possibile, per ognuno di questi ambienti, cercare di capire quali siano gli “analoghi” sulla Terra, in
» Dall’ato in senso antiorario: la luna Europa di Giove ripresa dalla sonda Galileo. Spaccato dell’interno di Europa. La superficie, solcata da fratture nel ghiaccio originatesi negli strati sottostanti fa da cappello a un oceano salato profondo 80-100 km. La partenza della sonda europea Juice dalla base di Kourou il 14 aprile scorso verso le lune ghiacciate di Giove. Occorre avere pazienza, perché diventerà operativa nel 2031.

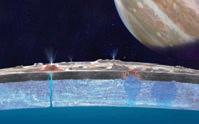
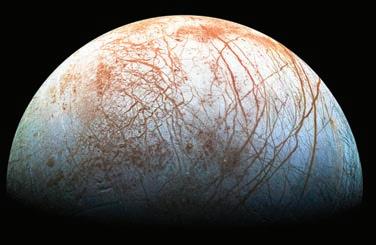
modo da stabilire dei paralleli fra il satellite di Giove e il nostro pianeta, così da de nire delle aspettative. Sulla crosta di Europa, i fattori sici che maggiormente in uenzerebbero gli organismi eventualmente presenti sarebbero la radiazione, il disseccamento e la temperatura. È di cile trovare ambienti terrestri pari per temperatura e radiazione. In alcune spiagge del Brasile si ha un livello di radiazione che arriva a 400 milligray (mGy) all’anno, un livello alto ma molto minore rispetto ai livelli della super cie di Europa. Questo è dovuto al fatto che la radiazione cui è soggetta la Terra è molto schermata dalla nostra atmosfera e infatti raddoppia ogni 1500 metri di quota. Sulla super cie di Europa si ha una radiazione che varia fra 3 e 4 Gy/anno. Per trovare valori altrettanto alti sulla Terra bisogna avvicinarsi ai giacimenti di uranio o ai reattori nucleari a piscina. Per quanto riguarda le basse temperature, si deve guardare alle croste ghiacciate antartiche, come quella che ricopre il lago Vostok. Quest’ultimo è l’ambiente terrestre più simile a Europa. È sepolto sotto quattro chilometri di ghiaccio da 25 milioni di anni ed è lo spessore del ghiaccio stesso che impedisce alcun tipo di processo fotosintetico. Questo lo rende un modello di riferimento per determinare come una potenziale biosfera potrebbe sopravvivere negli oceani di Europa. Sono state trovate forme di vita batterica no a 3590 m di profondità.

Trovare analoghi per l’oceano di Europa è una s da altrettanto ardua, poiché non si conosce l’esatta composizione chimica delle sue acque, anche se studi recenti mostrano come l’equilibrio chimico sia simile a quello presente negli oceani terrestri, ma con parametri più estremi. Un possibile analogo di Europa è il Mar Morto in Palestina, dove le concentrazioni saline sono molto alte. Anche laghi alcalini come il lago Mono in California e lo Spotted lake in Canada costituiscono un termine di paragone per quanto riguarda le condizioni ad alto valore di pH. Su Europa è stato ipotizzato un possibile ecosistema basato su batteri chemiosintetici, che operano la generazione di metano e la riduzione dello zolfo e dell’ossido di ferro. Grazie a questo processo, altri organismi potrebbero vivere grazie agli scarti degli organismi chemiosintetici. Sulla Terra sono
presenti condizioni simili sulla scarpata continentale del Golfo del Messico, dove colonie di batteri chemiosintetici operano la riduzione di carbonio e metano, senza utilizzare l’energia del Sole.
In ne, un analogo per quanto riguarda il fondale oceanico potrebbe essere la Fossa delle Marianne, il punto più profondo dell’oceano Paci co, dove una pressione di 1085 atmosfere e una temperatura di circa 2°C non impediscono la proliferazione di forme di vita batterica, in grado di resistere a condizioni proibitive.
Le osservazioni del telescopio spaziale Hubble hanno rivelato la presenza di vapore d’acqua in maniera stabile nell’atmosfera di Europa. Già nel 2013 era stato caratterizzato il vapore d’acqua associato a pennacchi che
eruttano attraverso il ghiaccio, ma i risultati più recenti mostrano che l’acqua non è localizzata soltanto in presenza di questi geyser, ma è distribuita su un’area più ampia della luna gioviana, anche se limitata al suo emisfero “posteriore”, quello che è sempre opposto alla direzione in cui si muove nel suo percorso orbitale. La causa di questa asimmetria tra l’emisfero principale e quello posteriore ancora non è stata compresa appieno. Inoltre, il

rilevamento di questo vapore d’acqua stabile cozza col fatto che le temperature massime diurne super ciali della luna sono pari a -162° C. Il rifornimento deve essere continuo, dato che si assiste a una sublimazione del ghiaccio d’acqua super ciale, che si trasforma direttamente da solido a vapore senza passare per la fase liquida.
Le osservazioni ultraviolette hanno permesso di determinare quanto ossigeno c’è in atmosfera, grazie
all’analisi delle righe di emissione dello spettro, e da queste si è ottenuta la scoperta del vapore acqueo. Sono tante le domande a cui dovranno rispondere le sonde Juice ed Europa Clipper con i loro strumenti. Inoltre, lo studio ravvicinato delle interazioni di Giove con le sue lune ghiacciate permetterà agli astronomi di ottenere informazioni utili per indagare le centinaia di pianeti simili a Giove che orbitano attorno ad altre stelle.
Negli ultimi tre decenni, la nostra conoscenza del valore scienti co della meteorite Renazzo e delle meteoriti del suo gruppo (CR) è aumentata notevolmente, poiché sono disponibili per l’analisi molti campioni provenienti da deserti, soprattutto quelli freddi come l’Antartide, che garantiscono l’assenza di contaminazione terrestre di questi veri e propri “universi in miniatura”.
Sulla base di una varietà di studi mineralogici, isotopici e spettroscopici, si è giunti alla conclusione che le meteoriti CR sono campioni eccellenti per l’identi cazione delle nebulose di tipo presolare e l’osservazione dei processi che portano alla formazione dei corpi genitori delle meteoriti, gli asteroidi.
Tra le meteoriti raccolte in Antartide, le condriti carbonacee sono le più studiate, soprattutto per il contenuto di molecole organiche e dei cosiddetti “mattoni della vita” nel loro interno. Si ritiene in particolare che le meteoriti CR (circa 190 esemplari nora catalogati) contengano nel loro interno il materiale organico più antico rispetto a ogni altra condrite carbonacee. La meteorite Renazzo, caduta il 15 gennaio 1824, oltre a essere il capo la di questa famiglia di meteoriti, è un “documento” antichissimo del Sistema solare primitivo e la prima meteorite a mostrare la presenza di polvere di stelle (“grani presolari”) e di microstrutture fossilizzate ricche di carbonio, al punto che questo esemplare della nebulosa protosolare costituisce per gli addetti ai lavori una “stele di Rosetta” per l’astro sica nucleare, cioè la chiave di lettura dei processi nucleari veri catisi negli ambienti stellari che hanno preceduto la nascita del Sole. Dall’analisi dei frammenti della Renazzo abbiamo appreso che la composizione isotopica del Sistema solare è il risultato del rimescolamento dei getti di materiale espulso a seguito di processi esplosivi da un enorme
» Rocce disseminate sul ghiacciaio antartico, l’ambiente ideale per la ricerca di meteoriti (Nasa).


» Rappresentazione artistica della sonda Osiris-Rex della Nasa durante il prelievo di un campione della superficie dell’asteroide Bennu (ottobre 2020), che riporterà a terra il prossimo 24 settembre. Inquadra il QR per un video dedicato alla fase finale di questa missione.

.Nella pagina a destra: un frammento della meteorite Renazzo conservato al museo “Luigi Bombicci” di Bologna. Vedi a pag. 128 la recensione del libro L’eredità di Renazzo di G. Cevolani.
numero di stelle all’interno della nostra Galassia. Le indagini sulle supernovae hanno evidenziato composizioni elementari e isotopiche altamente eterogenee.
Tali aspettative sono supportate dalle moderne teorie sull’evoluzione stellare e sulla nucleosintesi e confermate dalle osservazioni di supernovae, dei loro resti e dei grani meteoritici che si sono formati nelle supernovae presolari. Delle 185 meteoriti CR2 classi cate dalla Meteoritical Society, ben il 70% proviene dall’Antartide, anche se si tratta in molti casi di frammenti appartenenti alla stessa caduta e
trovati in tempi diversi. L’archivio comprende una sola CR1 (scoperta in Antartide) e una sola CR3, scoperta nell’Africa di nord-ovest.
Uno studio pubblicato nel settembre 2022 mostra che gli spettri di ri essione dell’asteroide (101955) Bennu, ottenuti nel corso della missione Osiris-Rex della Nasa, si accordano bene ai test spettrali della meteorite antartica GRO 95577 di tipo CR1. Questo signi ca che la mineralogia della super cie di Bennu e quella della condrite antartica sono
molto simili. I corpi genitori delle CR sono target di grande interesse, perché contengono alcuni dei materiali più incontaminati della nebulosa presolare; inoltre, possono contenere quantità importanti di acqua e di composti organici esotici. Il ritorno sulla Terra della sonda che ha prelevato il 20 ottobre 2020 un campione dalla super cie dell’asteroide è previsto per il prossimo 24 settembre. Le analisi del campione al Johnson Space Center veri cheranno se Bennu è veramente composto da materiale a ne a quello della meteorite antartica.

Gli studi sulla formazione del Sistema solare che emergono dall’analisi delle CR antartiche suggeriscono che il loro corpo genitore si sia formato nel Sistema solare esterno, al di là dell’orbita di Giove. In e etti, le condriti CR contengono un raro tipo di condrula che è la più simile alle strutture trovate nei campioni della cometa Wild 2, recuperati dalla missione Stardust. Un elemento costitutivo della cometa è stato identi cato anche nella meteorite antartica LAP 02342 (di tipo CR2), un clasto ricco di carbonio e di grani presolari che probabilmente è
migrato verso l’interno dalla regione di formazione della cometa e poi è cresciuto nell’asteroide genitore della condrite.
L’analisi del campione di Bennu è un’opportunità che investe anche l’esobiologia, visto che i mattoni di base della vita che costituiscono il nostro Dna potrebbero essere stati portati sulla Terra tra i 4 e i 3,8 miliardi di anni fa durante l’Intenso bombardamento tardivo (Late Heavy Bombardment), un periodo caratterizzato da un gran numero di impatti meteoritici sui pianeti rocciosi del Sistema solare. Un team di ricercatori ha pubblicato nel 2022 la scoperta, in tre diverse condriti carbonacee, delle due basi azotate del Dna (citosina e timina) che mancavano all’appello, dato che le altre due basi (adenina e guanina) erano già state scoperte in
altre condriti. Ora sarà interessante capire se le stesse molecole siano rintracciabili sugli asteroidi primordiali, certamente non contaminati da materiali terrestri, come Bennu e Ryugu, visitati dalle sonde Osiris-Rex e Hayabusa 2, che hanno raccolto campioni di materiale dalla loro super cie. I ricercatori che fanno capo a Sandra Pizzarello dell’Arizona State University hanno analizzato i principali composti organici di due meteoriti antartiche (GRA 95229 e LAP 02342) di tipo CR2, scoprendo che la loro composizione organica di erisce notevolmente da qualsiasi altra osservata prima in altre condriti carbonacee. La loro composizione organica è dominata da sostanze solubili in acqua, da amminoacidi (come glicina e alanina) e ammine. L’ammoniaca è il componente più presente, mentre gli idrocarburi e gli acidi carbossilici sono componenti minori.
Gli studi sulla GRA 95229 hanno
Le meteoriti del gruppo-Renazzo (CR) sono condriti carbonacee, una classe importante di meteoriti rocciose che presentano rapporti magnesio/silicio vicini al valore solare e composizioni di isotopi di ossigeno le cui abbondanze non trovano riscontro sulla Terra.

Le CR sono caratterizzate da grandi e abbondanti condrule (0,7 mm e oltre sul 50% del volume), molte delle quali hanno bordi ignei, poche inclusioni refrattarie, abbondanza di metalli (5-8% del volume) e una matrice a grana fine che è comunemente idratata (fino al 50% in volume). Questo gruppo è a sua volta suddiviso in tre tipi:
-CR1, condriti con alto grado di idratazione e (quasi) totale assenza di condrule;
-CR2, condriti caratterizzate da abbondanti minerali idratati e abbondante matrice a grana fine, con presenza di condrule;
-CR3, condriti con basso grado di idratazione e abbondante presenza di condrule.
» La presenza di luce polarizzata nel disco protoplanetario da cui ha avuto origine il Sistema solare potrebbe aver provocato un eccesso delle molecole di tipo L rispetto a quelle di tipo R.
L’Antartide è un imponente laboratorio naturale, in grado di dare risposte a molti interrogativi sulle origini dell’Universo, sull’evoluzione del clima e sulla forzatura dei suoi delicati equilibri da parte dall’Uomo, e infine sull’origine ed evoluzione della vita sulla Terra, ricorrendo all’esplorazione dei ghiacci e dei numerosi laghi subglaciali che nascondono una biologia pressoché sconosciuta.
L’immenso deserto di 30 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio, che ricopre il continente per oltre il 98%, è riuscito a conservare in una sorta di frigorifero naturale memorie che si perdono nella notte dei tempi, fino all’origine del Sistema solare, come testimoniano le migliaia di meteoriti (il 66% di quelle cadute sulla Terra) di età fino ad oltre 4 miliardi di anni rimaste prigioniere nel “ghiaccio blu”, il ghiaccio fossile antartico.
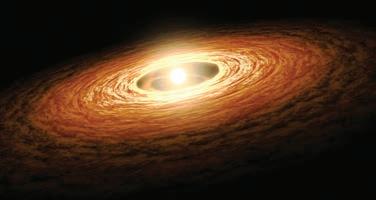
dimostrato che altri amminoacidi di provenienza extraterrestre hanno una sovrabbondanza di tipologie L (“levogira”), mentre la stragrande maggioranza delle meteoriti in cui sono stati trovati amminoacidi esibiscono concentrazioni quasi identiche delle tipologie L e R (“destrogira”). Le molecole di queste due tipologie sono identiche nella composizione ma hanno una disposizione spaziale di erente, come una mano destra e una sinistra. I ricercatori ritengono che GRA 95229 sia molto antica e che possa rappresentare una prova del trasferimento di materiale
esogeno organico sulla Terra, ricordando che gli amminoacidi che compongono gli organismi terrestri (uomo compreso) sono tutti levogiri. Questa strana caratteristica degli amminoacidi terrestri viene chiamata “omochiralità”; un elemento importante per risolvere il mistero della sua origine può essere la scoperta di uno dei venti amminoacidi del nostro Dna, la serina, nella meteorite GRA 95229. Una ricerca condotta da scienziati all’Università Purdue negli Usa ha identi cato la serina come probabile causa prima dell’omochilarità delle molecole organiche.
Secondo una teoria, la luce polarizzata all’interno del disco protoplanetario potrebbe aver provocato una fotoscomposizione selettiva delle molecole complesse presenti nelle polveri del disco, producendo un eccesso delle molecole di tipo L rispetto a quelle di tipo R. L’asimmetria riscontrata nelle molecole rinvenute nelle meteoriti rappresenterebbe quindi una sorta di “ rma” molecolare che caratterizza la vita. Senza le pietre celesti come la capostipite Renazzo e il gruppo delle CR, non avremmo potuto fare quel salto in avanti nella conoscenza che ci ha prospettato un legame molto stretto tra la nostra Galassia e il Sistema solare. Passo dopo passo, stiamo ricostruendo il collegamento tra le polveri stellari generate da mondi in estinzione e la materia solare che ha iniziato il suo percorso verso la vita - e verso la nostra stessa esistenza - dopo essere stata inseminata da queste minutissime polveri spaziali.
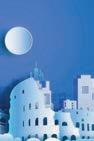
Dopo il grande successo ottenuto nelle 6 tappe del 2022, continua anche nel 2023, con ben 9 tappe, il viaggio di Forbes dedicato alla scoperta delle PMI, spina dorsale dell’Italia che cresce.


Un’occasione per confrontarsi su temi quali sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione, welfare, accesso al credito e per creare relazioni professionali.






Il progetto è rivolto a imprenditori e manager che gestiscono PMI del territorio e alle grandi aziende che vogliono mettersi in contatto con loro.
SCOPRI DI PIÙ: www.eventi.forbes.it/smallgiants/
Nato il 16 dicembre 1826 a Pisa da Pietro e Luisa Cantini, Giovanni Battista Donati già da adolescente rivela una precoce inclinazione per la matematica: si iscrive all’università e frequenta le lezioni di Ottaviano Mossotti che lo indirizza agli studi astronomici. Il 1° agosto 1852 inizia a lavorare presso l’Osservatorio di Firenze, sotto la direzione di Giovanni Battista Amici, dove due anni dopo riceve la quali ca di “aiuto astronomo”.
La modesta strumentazione disponibile limita la sua attività alla ricerca di nuove comete e alla misura della posizione delle stelle, adeguandosi alle tradizionali indagini della specola orentina. Dotato di grandi capacità come osservatore, tra il 1854 e il 1864 scopre sei comete e proprio una di queste fa conoscere il suo nome in tutto il mondo.
Il 2 giugno 1858 individua al telescopio la cometa C/1858 L1 nella costellazione del Leone, che si rivela una delle più spettacolari di quel secolo: intorno alla ne di settembre raggiunge la magnitudine -1 e al suo massimo la coda si estende nel cielo per oltre 60 gradi.
Su giornali e riviste l’astro conquista il titolo di “grande cometa” e diventa un evento mediatico mondiale sino a quando, intorno alla ne di ottobre, sparisce dai cieli europei. L’abbinamento del suo nome a quel singolare evento celeste o re a Donati l’occasione di raggiungere la ribalta internazionale, ma oltre alle singolari doti di osservatore, gli viene riconosciuto anche il merito di avere dato un contributo pionieristico all’applicazione delle tecniche spettroscopiche in campo astronomico.
Utilizza la grande “lente ustoria” di 41 cm di diametro, cimelio storico risalente all’epoca del Granduca Cosimo III de’ Medici, per rilevare gli spettri di alcune stelle e pubblica i risultati ottenuti, suggerendo una prima rudimentale forma
» Sopra: l’astronomo pisano Giovanni Battista Donati ritratto intorno al 1865.

Nella pagina destra in alto: la spettacolare cometa scoperta nel 1858 da Donati, rappresentata in un dipinto dell’epoca vicino alla stella Arturo e al Grande Carro.
In basso: Donati, in piedi al centro del gruppo alla prima inaugurazione dell’Osservatorio di Arcetri, il 26 settembre 1869.
di classi cazione. “Sembra resultare che le strie degli spettri stellari siano in una certa relazione con il colore corrispondente alle varie stelle” –scrive nelle Memorie Astronomiche, apparse negli Annali del Museo di Firenze – “Le stelle bianche hanno strie che si rassomigliano fra di loro, e lo stesso accade per quelle gialle, le arancione e le rosse”.
Il 22 dicembre 1859 ottiene la nomina a professore di astronomia e la direzione dell’osservatorio, prendendo il posto del maestro Amici, andato in pensione. Pochi mesi dopo si reca a Torreblanca, in Spagna, per studiare le protuberanze solari in occasione dell’eclissi totale del 18 luglio 1860: l’esperienza lo porta a concludere che le protuberanze sono fenomeni legati al Sole e non alla Luna, come suggerito da qualcuno, ma soprattutto indica una loro correlazione con le macchie solari.

Il grande interesse per le comete lo vede anticipare tutti i colleghi nel sottoporle all’analisi spettrale.
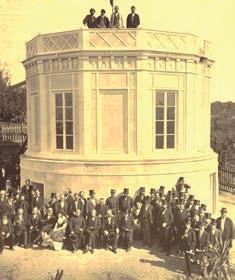
All’inizio di agosto 1864 esamina la cometa C/1864 N1, scoperta da Wilhelm Temple il mese precedente, individuando alcune bande di emissione sovrapposte al fondo continuo: pochi anni dopo, William Huggins attribuisce questi raggruppamenti di righe alla presenza di idrocarburi.
Nel ruolo di direttore della specola orentina, si sente in dovere di sollecitare la costruzione di una nuova struttura da collocare in una posizione migliore. Proprio di tali carenze si lamenta, durante la
Conferenza Geodetica Internazionale riunitasi nell’ottobre del 1864 a Berlino, confessando l’inadeguatezza del suo osservatorio alla collaborazione internazionale richiesta per realizzare precisi rilievi sulla posizione delle stelle di declinazione sud. Tra le sue molte occupazioni, ricordiamo le misurazioni geodetiche eseguite per conto dell’Associazione per la Misura del Grado Europeo e gli studi sul magnetismo terrestre e le aurore boreali, che ritiene manifestazioni di una “meteorologia cosmica”. Cura la direzione scienti ca
del laboratorio voluto da Amici, per costruire strumenti ottici di precisione, risollevandone le sorti e portandolo a diventare le O cine Galileo.
Divulga con passione scienza e astronomia, come testimoniano le numerose conferenze e gli articoli pubblicati su Nuova Antologia
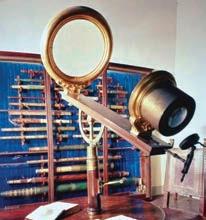
Ma è la costruzione di un nuovo osservatorio nazionale a impegnare buona parte delle sue energie sino al momento della prematura scomparsa. L’imminente spostamento della capitale del Regno d’Italia da Torino a Firenze lascia intravedere una grande opportunità per l’astronomia toscana a Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio di Brera, che il 23 settembre 1864 scrive al collega e amico Donati: “Le faccio le mie congratulazioni per la nuova ed eccellente prospettiva che si apre al suo Osservatorio per trasporto della Capitale. Non manchi di appro ttarne in tutti i modi possibili”.
Il primo e etto della decisione politica è quello di far tramontare l’idea di costruire la nuova specola nel Giardino di Boboli, perché la Corte sabauda, trasferendosi a Palazzo Pitti, non può concedere l’utilizzo di quello spazio. Ma l’incremento della super cie municipale o re valide alternative. Tra queste, vi è un’ampia
*GIANFRANCO BENEGIAMO LAUREATO IN CHIMICA, NUTRE DA SEMPRE UN PROFONDO INTERESSE PER I MOLTEPLICI ASPETTI TECNICI E STORICI DELL’ASTRONOMIA.
porzione di territorio, che comprende la collina di Arcetri, a sud di Firenze. E Donati inizia a considerare adatto ai suoi progetti un luogo poco distante dalla villa Il Gioiello, dove Galileo Galilei aveva trascorso con nato l’ultima parte della sua vita. Ancora prima di iniziare i lavori, si trova costretto a fronteggiare innumerevoli ostacoli, come testimonia la contessa Gertrude Baldelli (nata Walker), nella lettera pubblicata nel 1870 dalla rivista amatoriale inglese e Astronomical Register: “Donati mi ha riservato una lunga visita l’altro giorno. Il soggetto della conversazione [...]
erano le preoccupazioni e gli ostacoli a rontati prima di posare la prima pietra del suo nuovo osservatorio [...] gli abitanti dell’adiacente villaggio reclamavano un’indennità ‒ per cosa, penserete? ‘La perdita della libertà!’ Donati, stupito, chiese per quale ragione gli rivolgevano una così grave accusa? La risposta fu, ‘Il vostro telescopio sarà puntato sulle nostre nestre ogni volta che vorrete e le signore saranno infastidite!’”. Le più serie di coltà incontrate durante i lavori, senza contare la delusione provata dopo il trasferimento della capitale a Roma, gettano Donati nello sconforto: “Sono un Astronomo a cui non è dato nel momento di poter rivolgere al cielo il più piccolo cannocchiale […] – “scrive alla ne del 1871 all’amico Schiaparelli – “Voi crederete da ciò che l’Osservatorio Nuovo sia un pezzo avanti e prossimo al poter funzionare. Se credete così, quanto siete lontano dal vero! I lavori procedono lentamente, perché non vi è impegnata che la sola mia responsabilità; e di questa ne ho impegnata oltre misura. Il Ministero, che, per cento ragioni inutili a dirsi qui, accordò che per l’espropriazione del terreno si spendesse più del doppio di quello che era stato giustamente previsto in perizia, non accorda più neppure quel di più già speso e che ora sarebbe urgente di avere per altri lavori e insomma non ci sono denari per andare avanti […]. Maledico il momento che mi venne in testa di fare un Osservatorio Nuovo”.
Lavori a rilento e spese fuori controllo rimangono anche dopo il tentativo di rilanciare il progetto con una doppia inaugurazione. La prima, il
26 settembre 1869, permette agli invitati di vedere completata solo la cupola, con all’interno installato ancora provvisoriamente il rifrattore Amici che in quel momento era il più grande d’Italia. A questa seguirà una seconda inaugurazione, il 27 ottobre 1872, ma in assenza del Direttore, perché vittima di un infortunio. Nonostante le due cerimonie, però, la specola rimane incompleta sia nelle opere murarie, sia nella strumentazione scienti ca, gettando in ulteriore sconforto Donati.

In occasione dell’Esposizione Universale, nella tarda estate del 1873, Donati raggiunge Vienna per partecipare al primo Congresso Internazionale di Meteorologia, come delegato del Regno d’Italia, e qui presenta il suo spettroscopio a grande dispersione per indagini astro siche. Ma senza attendere la ne dei lavori, lascia Vienna il 16 settembre e già durante il viaggio di ritorno iniziano a manifestarsi i sintomi di un letale contagio.
“Quando la sera arrivò a casa” –scrive la contessa Baldelli – “rispose al benvenuto della moglie [Polissena Matarelli] dicendo ‘Sei molto contenta di vedermi, ma non sai cosa ti ho portato! ‒ Cos’è? ‒ Il colera!’ rispose [...] prima delle nove, io credo, egli morì. L’intera famiglia fu immediatamente posta in quarantena e il suo corpo ricoperto di calce viva. Non posso esprimere quanto rimasi addolorata e sconvolta dalla notizia”. L’astronomo pisano si spegne il 20 settembre 1873, giusto un secolo e mezzo fa, lasciando i suoi cari e l’astronomia all’età di soli 47 anni.
Contrariamente a Marte, che si fa desiderare, Saturno si presenta in opposizione ogni anno; neppure due settimane dopo la data dell’opposizione precedente. E così, poiché quella del 2022 è avvenuta il 14 agosto, quella di quest’anno si ha il 27 agosto. Più precisamente, Saturno è in opposizione al Sole 189 giorni dopo la congiunzione, mentre l’opposizione seguente richiede un’attesa – giorno più giorno meno –di 378 giorni.
Nell’opposizione di questo agosto il pianeta si presenta con gli anelli più chiusi rispetto agli anni precedenti, ma un aspetto positivo è la declinazione meno australe degli anni scorsi: intorno al periodo dell’opposizione è intorno a –12°. Si tratta di una declinazione ancora decisamente negativa, ma non tale da creare grossi problemi per le osservazioni, neppure dalle nostre latitudini più settentrionali. Per esempio, da Milano il pianeta
transita in meridiano a un’altezza di 32,5°; più che su ciente per liberarlo dalle foschie che stazionano in prossimità dell’orizzonte e dalla turbolenza propria delle basse altezze. Ancora più favorevole è la situazione nelle regioni più meridionali: a Palermo, nelle stesse condizioni, il pianeta transita a circa 40° sopra l’orizzonte.
Nel periodo dell’opposizione Saturno è proiettato nella costellazione dell’Acquario, qualche grado a ovest della stella Sigma e lontano da stelle brillanti. La più vicina è Fomalhaut (Alfa Piscis Austrini), luminosa come Polluce (magnitudine 1,1) che si trova ben 20° a sud.
In tabella 1 sono riportati alcuni dati relativi a questa opposizione.
La distanza, in milioni di chilometri, è quella dalla Terra; il diametro, in secondi d’arco, è quello equatoriale. Alla minima distanza, tra noi e Saturno ci saranno 1310,9 milioni di chilometri, equivalenti a 8,763 Unità Astronomiche.
In questa opposizione inizia a essere messo in evidenza il forte schiacciamento polare (1/10) di Saturno, il più accentuato tra i pianeti del Sistema solare. Lo schiacciamento è più evidente quando gli anelli sono di taglio, perché allora l’asse polare è perpendicolare alla nostra visuale. È invece mascherato quando il globo è notevolmente inclinato verso di noi (l’equatore è inclinato di 27° sul piano dell’orbita). Un buon telescopio da 80-90 mm di apertura fornisce un’immagine indimenticabile del pianeta; già con strumenti di queste dimensioni si può notare che il disco è caratterizzato da una regione equatoriale più chiara rispetto alle meno luminose regioni temperate. Le regioni polari (attualmente si vede, ma molto di scorcio, quella boreale) di norma appaiono scure, ma talvolta divengono piuttosto chiare, quasi a eguagliare la fascia equatoriale.
» Sopra: la Great Northern Spot, gigantesca tempesta ripresa nel 2010 dalla sonda Cassini nell’alta atmosfera di Saturno.
A sinistra: Saturno in opposizione al Sole il 27 agosto tra le stelle dell’Acquario (Stellarium).
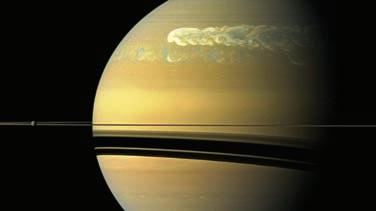

Sotto: Saturno ripreso il 21/08/2020 da Reggio Calabria con una camera ASI 178 MC applicata a un Celestron C11 su montatura NEQ6 (Angelo Meduri).

Se si utilizzano strumenti maggiori, per esempio da 15-20 cm, si possono percepire delle fasce ad alte latitudini, ma quasi sempre prive di dettagli. Eventuali attività si manifestano nella regione equatoriale, ma le macchie sono rare. William Herschel, che dedicò a Saturno più attenzioni rispetto agli altri pianeti, registrò una macchia cospicua solo una volta, nel 1780, sull’equatore. La prima delle grandi macchie bianche viste su Saturno è ritenuta quella individuata nel 1876 da Asaph Hall. Poi vi
furono quella del 1903 osservata in particolare da E.E. Barnard e quella scoperta dall’inglese Will Hay nel 1933 con un rifrattore da 15 cm; questa macchia divenne facilmente visibile anche con un rifrattore da 7,6 cm e si estese rapidamente in longitudine, diventando sempre più debole e scomparendo solo dopo poche settimane.
A queste seguirono le macchie del 1960 e 1990: quest’ultima fu ripresa dal telescopio spaziale Hubble, che però non era ancora al massimo
delle sue potenzialità, mentre quella seguente del 2010 (la Great Northern Spot) è stata immortalata dalla sonda Cassini. Poiché alcune di queste perturbazioni sono così notevoli da vedersi anche con piccoli strumenti (anche da 80 mm) e dato il loro periodo circa trentennale, ci si chiede come mai nessuna di esse sia stata registrata prima del 1876.
Naturalmente, la meraviglia di Saturno sono i suoi anelli, che lo rendono unico, anche se già dalla ne del secolo scorso sappiamo che tutti i giganti gassosi del Sistema solare possiedono degli anelli. Gli altri però sono così deboli da non poter essere visti direttamente al telescopio. Quest’anno siamo in una posizione molto prossima agli anelli di taglio, fenomeno che si veri cherà nel 2025, quando la Terra attraverserà il piano degli anelli. Comunque,

già l’apparizione del 2023 li mostra piuttosto chiusi, con l’asse minore della loro ellisse che è solo un sesto dell’asse maggiore. Alcuni sostengono che 20x sono su cienti per mostrare gli anelli; ma per averne una percezione sicura, di ingrandimenti ne occorrono almeno una trentina. Questo mette fuori gioco quasi tutti i binocoli; anche quelli che sviluppano forti ingrandimenti forniscono in genere un’immagine così luminosa da mostrare un ovale senza le zone scure alle anse. Ma a questo problema si rimedia facilmente: basta diaframmare gli obiettivi, per esempio riducendo a 30 mm l’apertura di un 30x80.
Gli anelli accessibili agli strumenti amatoriali sono i tre de niti A, B e C Quest’ultimo, l’“Anello Velo”, venne scoperto solo nel 1850, a causa della sua debolezza, da G.P. Bond, con il grande rifrattore di Harvard da 38 cm, allora il più grande del mondo.
Ci si chiede come mai non sia stato avvistato da Herschel, Schröter e Struve, che in precedenza avevano studiato Saturno con strumenti di considerevole potenza. Il mistero s’in ttisce se si considera che l’anello C venne scoperto indipendentemente in Inghilterra da W.R. Dawes con un rifrattore da soli 16 cm, mentre Herschel, alla ne del ‘700, non lo aveva segnalato, pur avendo osservato Saturno anche con il suo ri ettore gigante da 1,2 metri.

Anche un’apertura di soli 13 cm consente di scorgere cinque satelliti del pianeta (Titano, Rea, Teti, Dione e Giapeto nell’elongazione occidentale). In questa opposizione, la visione dei satelliti, in particolare di Teti e Dione, è agevolata dal fatto che gli anelli sono poco aperti verso di noi. Infatti, i satelliti si vedono meglio quando gli anelli sono di
taglio, in quanto è minore il loro disturbo luminoso.
Il più facile è Titano; è stata riportata una sua osservazione eseguita per no con uno strumento da 40 mm! Naturalmente, una cosa è vederlo come una stella e un’altra è distinguere dei dettagli sul suo minutissimo dischetto da 0,8” di diametro.
Un lavoro pioneristico sul disco di Titano fu svolto nel secolo scorso da Lyot e colleghi all’Osservatorio del Pic du Midi (Pirenei francesi) con un rifrattore da 60 cm a 1000x e 1250x. Per non in uenzarsi a vicenda, Lyot e gli altri quattro osservatori (tra i quali Dollfus) fecero i disegni indipendentemente e li confrontarono solo in un secondo tempo. Anche con questi enormi ingrandimenti, il disco di Titano appariva agli osservatori ampio solo metà di quello della Luna vista a occhio nudo!
Da queste macchie di albedo non fu possibile determinare un periodo di rotazione di Titano, anche perché Lyot sospettò correttamente che le macchie osservate fossero variabili, essendo presenti sullo strato esterno dell’atmosfera. Ora sappiamo che questo enorme satellite, che con il suo diametro medio di 5150 km è più grande di Mercurio, ha una rotazione sincrona, come la Luna con la Terra, con un periodo di 16 giorni.
» Il cielo visibile da Roma alle ore 01h 00m TC a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia.
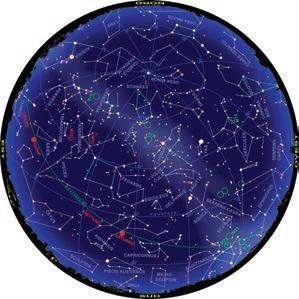

Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 00h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
l'1 alle 20h 31m
l'8 alle 12h 28m
il 16 alle 11h 38m
il 24 alle 11h 57m
il 31 alle 3h 35m
Massime librazioni in latitudine
l'1 alle 3h - visibile
il Polo nord
il 14 alle 7h - visibile
il Polo sud
il 28 alle 10h - visibile
il Polo nord
Massime librazioni in longitudine
l'8 alle 8h - visibile
il lembo occidentale
il 24 alle 14h - visibile
il lembo orientale
Perigeo
357.311 km il 2 alle 7h 52m
Apogeo
406.635 km il 16 alle 13h 54m
Perigeo
357.181 km il 30 alle 17h 54m
Seguendo il ramo discendente dell'eclittica, il giorno 11 si sposta dalla costellazione del Cancro a quella del Leone, abbassandosi sempre più sull'equatore celeste e perdendo, nel corso del mese, quasi 10° in declinazione; ne derivano un accorciamento dell'arco diurno percorso dall'astro e un vistoso calo dell'illuminazione solare, in particolar modo nelle ore serali, con una diminuzione di 1h 16m delle ore di luce.
MERCURIO
Raggiunge la massima elongazione orientale di 27°,4 il giorno 10 e può essere osservato poco dopo il tramonto, con di coltà sempre maggiore, fino al 23, quando il suo movimento diretto tra le stelle del Leone si arresta. Quindi, inverte direzione e viene rapidamente avvicinato dal Sole, fino a scomparire tra le luci del crepuscolo. È seguito dal più debole Marte, a cui si avvicina fino al giorno 13, quando raggiunge la minima distanza di 4°,7; il giorno 10 è all'afelio.
È in congiunzione inferiore con il Sole il giorno 13 ed è quindi inosservabile fino al 21, quando riappare all’alba, tra le stelle del Cancro, in prossimità dell’orizzonte orientale; a fine mese la sua levata precede di poco la comparsa delle prime luci del crepuscolo mattutino. Il giorno 8 è all'afelio.

Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese. La mappa , in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.
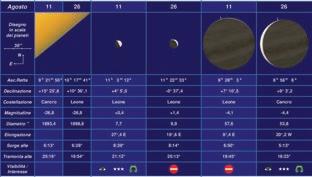 CIELO DEL MESE
CIELO DEL MESE
MARTE
Il suo lungo periodo di visibilità serale volge al termine. Il pianeta, sempre meno luminoso, attraversa velocemente la costellazione del Leone e il giorno 17 si sposta nella Vergine, immergendosi nelle luci del tramonto; alla fine del mese cala prima del termine del crepuscolo nautico, diventando inosservabile. È preceduto, pochi gradi a occidente, dall’elusivo Mercurio.

È visibile nell’Ariete, seguito da Urano, 8° a oriente; il 7 è in quadratura con il Sole, poi il suo moto diretto rallenta fin quasi ad arrestarsi a fine mese, quando sorge un’ora circa dopo la fine del crepuscolo serale. Nelle prime ore del 22 è in congiunzione stretta con Sigma Arietis (mag. 5,5), transitando 28” a nord.
E emeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate.
Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra). Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
Le stelline (da 1 a 5) misurano l’interesse dell'osservazione.
Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.
SATURNO
È in opposizione al Sole il giorno 27 nell’Acquario e per tutto il mese è visibile per l’intera notte: sorge poco dopo il tramonto del Sole e cala appena prima della sua levata. È animato da lento moto retrogrado nelle vicinanze della stella Sigma Aquarii (mag. 5), con cui è in congiunzione il giorno 4, passando 33’ a sud.
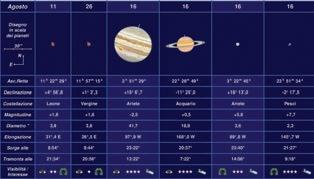
URANO
È visibile per buona parte della notte nell’Ariete, poco meno di 3° a sud-est di Delta Arietis (mag. 4), preceduto (8° a occidente) da Giove. Il 16 è in quadratura con il Sole, mentre il 29 è stazionario, quindi assume moto retrogrado; a fine mese sorge poco più di un’ora dopo il termine del crepuscolo serale.
NETTUNO
È visibile per quasi tutta la notte nei Pesci, nelle vicinanze del confine con l’Acquario, dove si muove con lento moto retrogrado. È rintracciabile meno di 5° a sud-est di Lambda Piscium, 1° circa a oriente della stella di 5a magnitudine 20 Piscium, alla quale va progressivamente avvicinandosi.
Il primo Plenilunio di agosto si verifica alle 20:31 TC del giorno 1 e precede di poco meno di 12 ore un perigeo abbastanza ravvicinato (357.311 km): un evento per il quale già da alcuni anni è invalso l’utilizzo del termine “Superluna”, di origine anglosassone. Il diametro apparente del disco lunare raggiunge il valore di 33’ 24”,7: una Superluna a tutti gli e etti, in particolare la “Superluna dello storione”, grazie a un’altra abitudine di origine anglosassone per cui ogni Plenilunio viene individuato con un nome specifico. Per gli osservatori europei è forse più indicata la tradizione celtica, che attribuisce al Plenilunio di agosto l’appellativo di “Luna del grano”.
SATURNO E SIGMA AQUARII IN CONGIUNZIONE
Saturno, ormai prossimo all’opposizione, è visibile per gran parte della notte tra le stelle dell’Acquario, dove si sposta animato da lento moto retrogrado. All’inizio del mese il pianeta inanellato è
Nelle ore che precedono l’alba, sull’orizzonte orientale spicca la presenza di Giove, seguito, 8° a levante, da Urano, quest’ultimo individuabile con l’aiuto di uno strumento, mentre in prossimità della linea dell’orizzonte va alzandosi la figura zodiacale del Toro. Il passaggio nella stessa regione celeste dell’Ultimo quarto di Luna produce alcune congiunzioni di particolare interesse: quella con Giove, 2°,5 a nord del pianeta nelle ore diurne del giorno 8, è seguita la mattina seguente dal transito del nostro satellite naturale 1°,8 a nord di Urano; nelle ore pomeridiane la Luna viene invece a trovarsi nelle vicinanze delle Pleiadi, 2° a sud dell’ammasso. Il disegno ra gura le configurazioni osservabili alle 4:30 di Tempo Civile delle date indicate, pochi minuti dopo la comparsa delle prime luci dell’alba.
protagonista di una congiunzione in Ascensione Retta con Sigma Aquarii, di magnitudine +4,8: Saturno transita 33’ a sud della stella la mattina del 4, ma la distanza che separa i due oggetti si mantiene inferiore a 1° fino al 13 agosto.

A metà mese, dopo il termine del crepuscolo civile, quando il cielo è ancora notevolmente illuminato dal chiarore del tramonto, in prossimità dell’orizzonte occidentale è possibile ammirare, pur non senza di coltà, la coppia formata da Mercurio e dal più debole Marte.

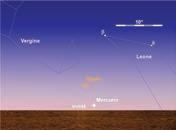
Il primo, dopo aver raggiunto il 10 agosto la massima distanza angolare dal Sole di 27°,4, va rallentando il moto diretto da cui è animato e che l’ha portato ad avvicinare il secondo, che invece perde costantemente terreno rispetto alle luci del tramonto ed è ormai al termine di un lungo periodo di visibilità serale. La distanza che li separa diminuisce fino a raggiungere il valore minimo di 4°,7 di giorno 13, per poi tornare ad aumentare.
Nel disegno la configurazione visibile alle 21:00 TC, con il Sole 9° sotto la linea dell’orizzonte.
MASSIMO DELLO SCIAME DELLE PERSEIDI
Nella seconda decade del mese è attivo il ben conosciuto sciame meteorico delle Perseidi, o “Lacrime di S. Lorenzo”, uno degli sciami annuali più attivi, con valori dello Zhr pari o superiori a un centinaio di meteore, le cui particelle hanno origine dalla cometa periodica SwiftTuttle. Utilizzando le osservazioni e ettuate negli ultimi anni, si stima che il periodo di massima attività dovrebbe cadere nelle prime ore del 13 agosto, mentre le indicazioni ottenute da simulazioni con modelli matematici mostrano ulteriori possibili picchi di attività sia alcune ore prima del massimo teorico sia la mattina del 14, quest’ultimo causato dal transito della Terra in una “coda” di particelle rilasciate oltre due millenni or sono. Le condizioni di visibilità risultano essere ottimali per buona parte della notte, grazie anche alla quasi totale assenza del chiarore della Luna, la cui levata precede di un paio d’ore l’inizio dell’alba. Nel disegno è ra gurato il cielo sull’orizzonte settentrionale alle 3:00 di Tempo Civile.
Nella seconda metà di agosto la coppia Mercurio-Marte viene raggiunta e superata, sull’orizzonte occidentale, dalla falce crescente della Luna. La sera del 17, trascorse meno di 30 ore dal Novilunio, un sottile falcetto lunare risulta osservabile una dozzina di gradi a “destra” di Mercurio, con il quale sarà poi in congiunzione, 6°,6 a nord, nelle ore diurne del giorno 18. La sera stessa il nostro satellite naturale si è spostato 3°,8 a “destra” di Marte. È inosservabile purtroppo anche la congiunzione in Ascensione Retta con il Pianeta rosso, che si verifica alcune ore dopo la loro discesa sotto l’orizzonte. Comunque, sono degne di attenzione le configurazioni, ra gurate nel disegno, osservabili alle 20:40 TC delle date indicate, alcuni minuti dopo il termine del crepuscolo civile.
Per alcuni giorni tra la prima e la seconda decade del mese, all’osservazione telescopica Giove sembrerà accompagnato da un quinto satellite. Si tratta della stella Sigma Arietis, di magnitudine +5,5, con la quale il pianeta è protagonista di un incontro estremamente ravvicinato nelle prime ore del 22, quando, grazie al lento moto diretto da cui è animato, transita soltanto 28” a nord della stella. Poiché le dimensioni apparenti di Giove sono di 42”,6 (diametro equatoriale) per 39”,8 (diametro polare), il lembo meridionale del pianeta passerà ad appena 8” di distanza da Sigma Arietis
Per tutto il mese è possibile ammirare Saturno per l’intera notte astronomica. In opposizione al Sole il giorno 27 tra le stelle dell’Acquario (vedi l’articolo di Walter Ferreri a pag. 52), il pianeta si muove di lento moto retrogrado nelle vicinanze di Sigma Aquarii, di 5a magnitudine, con cui è in congiunzione, 33’ a sud, il giorno 4. Alcuni gradi a sud del pianeta, risultano individuabili, con l’ausilio di uno strumento, i pianetini (8) Flora e (47) Aglaja, in opposizione rispettivamente il 27 e il 25 agosto, quando raggiungono le magnitudini +8,5 e +11,3. Nei primi giorni di agosto (8) Flora è rintracciabile poco più di mezzo grado a sud-est della coppia di stelle di 4a e 5a magnitudine Tau2 e Tau1 Aquarii, mentre all’inizio di settembre transita un paio di gradi a nord-ovest dell’estesa nebulosa planetaria NGC 7293.
La migliore occasione per osservare il più debole (47) Aglaja si realizza la mattina del 16 agosto, quando l’asteroide transita 15’ a nord della stella 56 Aquarii, di magnitudine +6,3. Il disegno riporta tutte le stelle fino alla magnitudine +10,5.


In un mese non particolarmente “ricco” di occultazioni, la notte tra il 29 e il 30 agosto, ad appena un giorno dal Plenilunio, il nostro satellite naturale occulta, a poche ore di distanza l’una dall’altra, due stelle relativamente luminose appartenenti alla costellazione del Capricorno. Poiché la Luna risulta illuminata per il 98% i due eventi si prospettano di cili da osservare.
La prima occultazione vede coinvolta la stella 37 Capricorni, di magnitudine +5,7, la cui scomparsa dietro la sottilissima frazione non illuminata del disco lunare è osservabile tra le 23:52 (Cagliari) del 29 agosto e le 0:05 (Lecce e Trieste) del 30. Sarà invece molto di cile riuscire a cogliere, un’ora più tardi, la riapparizione della stella da dietro il lembo lunare illuminato.

Il secondo evento vede Kappa Capricorni, di magnitudine +4,7, venire occultata dal bordo oscuro del disco lunare tra le 4:26 (Catania) e le 4:44 (Aosta) del giorno 30, con la Luna ormai bassa sull’orizzonte. Il tramonto del nostro satellite e le luci dell’alba in intensificazione impediranno di seguire la ricomparsa della stella.
Il giorno 30, tra le luci del crepuscolo serale che vanno a evolendosi, una decina di gradi sopra l’orizzonte sudorientale è possibile ammirare una bella configurazione celeste con Saturno e la Luna piena quali protagonisti.
Il nostro satellite naturale, il cui disco, del diametro di quasi 33’,5, è completamente illuminato dal Sole, si trova 3°,2 “sotto” il pianeta inanellato, dal quale va lentamente allontanandosi.
La congiunzione tra Luna e Saturno non è direttamente osservabile, poiché si verifica nelle ore pomeridiane, con la presenza in cielo dell’astro del giorno.
Nel disegno è ra gurata la configurazione che è possibile ammirare alle 21:00 TC, una decina di minuti dopo il termine del crepuscolo nautico.
Poiché il mese lunare è più breve della maggior parte dei mesi del calendario, non è infrequente che nell’ambito di uno stesso mese si verifichi due volte la stessa fase lunare. Quando si tratta del Plenilunio, la seconda Luna Piena mensile viene anche chiamata “Luna Blu”, termine di origine americana (Blue Moon): è questo il caso del Plenilunio del 31 agosto. Il colore attribuito a questo fenomeno è solo una convenzione calendariale: il nostro satellite naturale non apparirà a atto di colore blu!
A confondere ulteriormente la situazione, anche questo Plenilunio cade solo 10 ore dopo il passaggio della Luna al perigeo, a 357.181 km dal nostro pianeta; con un diametro del disco lunare di ben 33’ 25”,7, maggiore di un secondo d’arco rispetto alla Superluna dell’inizio del mese, anche questo Plenilunio è una “Superluna”, anzi una “Superluna Blu”.
*TIZIANO MAGNIESPERTO DI MECCANICA CELESTE, ELABORA LE PREVISIONI DI FENOMENI ASTRONOMICI CON SOFTWARE APPOSITAMENTE REALIZZATI (WWW.TIZIANOMAGNI.IT).
» Il cielo visibile da Roma alle ore 01h 00m a metà mese. La mappa è valida in tutta Italia.
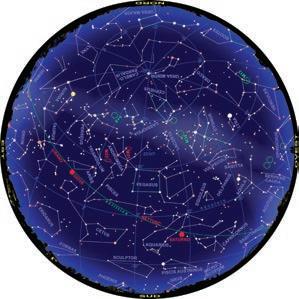

il 7 alle 0h 21m
il 15 alle 3h 39m
il 22 alle 21h 31m
il 29 alle 11h 57m
il 6 ottobre alle 15h 47m
Massime librazioni
in longitudine
il 5 alle 14h - visibile
il lembo occidentale
il 21 alle 12h - visibile
il lembo orientale
il 3 ottobre alle 22h
- visibile il lembo occidentale
Massime librazioni
in latitudine
il 10 alle 10h - visibile
il Polo sud
il 24 alle 17h - visibile
il Polo nord
il 7 ottobre alle 15h - visibile
il Polo sud
Il pallino rosso sulla circonferenza lunare mostra il punto di massima librazione alle 00h di Tempo Civile del giorno considerato: le sue dimensioni sono proporzionali all’entità della librazione il cui valore massimo è di circa 10°
Apogeo 406.291 km il 12 alle 17h 42m
Perigeo
359.911 km il 28 alle 2h 58m
Apogeo 405.426 km il 10 alle 5h 41m
Il giorno 17 esce dal Leone ed entra nella Vergine, proseguendo la discesa in direzione dell'equatore che raggiunge il 23 settembre, passando dall’emisfero celeste boreale a quello australe alle 8h 49m: è l’istante dell’equinozio autunnale, che individua l’inizio dell'autunno astronomico. La diminuzione nelle ore di luce nel corso del mese ammonta a 1h 23m.
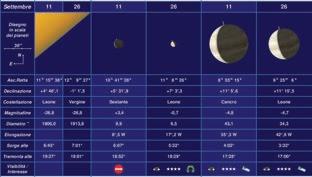
È in congiunzione inferiore con il Sole il giorno 6 ed è quindi inosservabile fino al 13, quando riappare tra le luci dell’alba in prossimità dell’orizzonte orientale per la migliore apparizione mattutina dell’anno. Nel periodo di migliore visibilità, tra il 16 settembre e il 5 ottobre, il pianeta anticipa di oltre un’ora la levata del Sole, mentre il giorno 23, poco dopo aver raggiunto la massima elongazione occidentale di 17°,9, sorge in concomitanza delle primissime luci dell’alba. Il 16 settembre è 8° a est di Regolo, il 23 è invece al perielio.
La visibilità mattutina del pianeta aumenta molto rapidamente e se all’inizio del mese leva appena prima dell’inizio del crepuscolo, alla fine anticipa di oltre 3h 30m il sorgere del Sole e di ben due ore l’inizio dell’alba. Il giorno 3 è stazionario in Ascensione Retta, quindi torna ad assumere moto diretto, uscendo dal Cancro ed entrando nel Leone il 25.
Posizioni eclittiche geocentriche del Sole e dei pianeti tra le costellazioni zodiacali: i dischetti si riferiscono alle posizioni a metà mese, le frecce colorate illustrano il movimento nell’arco del mese.
La mappa, in proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: i pianeti alla destra dell’astro del giorno sono visibili nelle ore che precedono l’alba, quelli a sinistra nelle ore che seguono il tramonto; la zona celeste che si trova in opposizione al Sole non è rappresentata. Le posizioni della Luna sono riferite alle ore serali delle date indicate per la Luna crescente e alle prime ore del mattino per quella calante.

MARTE
È inosservabile per tutto il mese, a causa della vicinanza angolare al Sole.
GIOVE
È visibile nell’Ariete, vicino alla stella Sigma (mag. 5), seguito, meno di 10° a est, dal debole Urano. Il giorno 4 è stazionario in Ascensione Retta, quindi inverte il movimento da diretto a retrogrado e il 18 è ancora in congiunzione con Sigma Arietis, 5' a sud. Alla fine del mese sorge circa al termine del crepuscolo astronomico.
E emeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 00h 00m di Tempo Civile delle date indicate.
Per i pianeti sono riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a sinistra). Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non è osservabile.
Le stelline (da 1 a 5) misurano l’interesse dell'osservazione.

Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione sull'orizzonte nel corso della notte.
SATURNO
È visibile 5° a sud di Theta Aquarii (mag. 4) e vicino a 42 Aquarii (mag. 5,3), alla quale si avvicina, fino a transitare 12’ a nordovest della stella la mattina del 26. All’inizio del mese tramonta poco dopo l’inizio del crepuscolo civile, mentre alla fine la sua discesa sotto l’orizzonte anticipa di 1h 20m le luci dell’alba.
URANO
È visibile per gran parte della notte nell’Ariete, dove si sposta animato da lento moto retrogrado meno di 3° a sud-est di Delta Arietis; è preceduto, a occidente, da Giove, dal quale il giorno 6 lo separano 7°,5. A fine mese sorge poco dopo il termine del crepuscolo serale e culmina 1h 40m prima dell’inizio dell’alba.
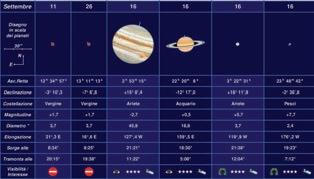
NETTUNO
È in opposizione al Sole il giorno 19 nei Pesci e per l’intero mese è visibile dal tramonto all’alba nelle immediate vicinanze della stella di 5a magnitudine 20 Piscium, 4’ a nord della quale transita il giorno 11. A fine mese tramonta 45 minuti circa dopo l’inizio dell’alba.
LUNA,
Visibile per gran parte della notte, Giove leva dall’orizzonte sud-orientale un’ora circa dopo il termine del tramonto del Sole, seguito, una quindicina di minuti più tardi, da Urano, la cui luminosità lo pone al limite della visibilità a occhio nudo. Nei primi giorni del mese i due pianeti vengono a ancati dalla Luna gibbosa calante. Il nostro satellite naturale si trova in congiunzione con Giove, 2°,3 a nord di quest’ultimo, la sera del 4, un’ora e mezza prima della loro levata dall’orizzonte, e con Urano, 2°,5 a nord, nelle ore diurne del 5. La sera dello stesso giorno il nostro satellite naturale transita poco più di 2° a sud delle Pleiadi. Le migliori configurazioni osservabili, qui rappresentate, si verificano intorno alle 23:00 TC, dopo la levata della Luna e un paio d’ore dopo la scomparsa delle ultime luci del crepuscolo.
Negli istanti che precedono l’alba, la falce calante della Luna, il cui transito nei Gemelli può essere seguito sin dalla sua levata poco prima delle 2:00 TC, è nuovamente protagonista dell’e mera configurazione celeste che vede il nostro satellite naturale trovarsi quasi sulla stessa linea che congiunge Castore e Polluce, i due gemelli Dioscuri. L’istante dell’esatto allineamento non è direttamente osservabile, poiché si verifica dopo la levata del Sole; è invece possibile ammirare la congiunzione in Ascensione Retta con Beta Geminorum, con la falce lunare 1°,9 a sud della stella poco prima dell’inizio del crepuscolo astronomico, come qui ra gurato. La mattina seguente la Luna, la cui falce si è fatta più sottile, si è spostata poco meno di 4° a nord dell'ammasso del Presepe, con cui è in congiunzione pochi minuti prima del sorgere del Sole. Da notare la luminosa presenza di Venere, 9° a sud di M44, nelle vicinanze di Alfa Cancri Nel disegno le configurazioni celesti osservabili alle 5:00 TC delle date indicate.
La mattina del giorno 8 è possibile assistere a un’occultazione lunare di un certo rilievo: la stella interessata è 136 Tauri, di magnitudine +4,6, occultata dal nostro satellite naturale in fase calante e illuminato per il 39%, poco prima delle 3:00 TC. La scomparsa dietro il lembo lunare illuminato dal Sole si verifica tra le 2:54 (Catania) e le 3:07 (Aosta e Trieste); il fenomeno, visibile dall’intero Paese, si conclude tra le 4:00 (Cagliari) e le 4:13 (Trieste) con la riapparizione della stella da dietro il bordo oscuro del disco lunare.


In opposizione al Sole il giorno 19 quando raggiunge la magnitudine +7,7, Nettuno è identificabile senza grandi di coltà con l’aiuto di un binocolo nei pressi del confine con l’Acquario, meno di 5° a sud della stella di 4a magnitudine Lambda Piscium. Il pianeta si muove di lentissimo moto retrogrado nelle immediate vicinanze di 20 Piscium, con cui è protagonista di una congiunzione relativamente ravvicinata la mattina del giorno 11, quando transita 4’ a nord dell’astro di magnitudine +5,5; la minima distanza apparente di 3’,8 viene raggiunta il giorno successivo. Nettuno rimarrà visibile per buona parte della notte fino al mese di novembre e solo nella terza decade di dicembre la sua calata anticiperà la mezzanotte.
La mappa, completa fino alla magnitudine +9,0, riporta le posizioni del pianeta fino all’inizio di dicembre, quando il pianeta sarà stazionario in Ascensione Retta.
Giocando d’anticipo rispetto alla comparsa delle prime luci dell’alba, sulla linea dell’orizzonte orientale va alzandosi una sottilissima falce di Luna calante, accompagnata, 3°,5 a sud, dalla bianco-azzurra scintilla di Regolo, con cui il nostro satellite naturale si è trovato in congiunzione un paio d’ore prima.


La distanza che separa la Luna da Alfa Leonis continua però a diminuire, pur se marginalmente, fino a raggiungere il valore minimo una ventina di minuti dopo l’inizio del crepuscolo astronomico.
Il disegno mostra invece la configurazione celeste osservabile poco dopo la levata di Mercurio, alle 6:00 TC, con il cielo via via più chiaro per l’avvicinarsi dell’alba e con la brillante presenza, oltre 20° sopra l’orizzonte, di Venere.
Una delle ultime occasioni per individuare Marte prima che scompaia tra le intense luci del tramonto si concretizza la sera del 16 settembre, al termine del crepuscolo civile, quando il Pianeta rosso, ormai in prossimità dell’orizzonte occidentale, viene a ancato 1°,4 a ovest da un sottilissimo crescente lunare.
Nelle ore seguenti Marte viene occultato dalla Luna, ma il fenomeno non è visibile dall’Italia. La sera successiva la falce lunare si è spostata 1°,3 a nord di Spica.
Dopo la congiunzione ravvicinata del mese passato con la stella Sigma Arietis, Giove, il cui movimento sulla volta stellata si è nel frattempo arrestato, invertendo direzione e diventando retrogrado, torna ad avvicinare la stella, con cui il giorno 18 è nuovamente in congiunzione in Ascensione Retta. Questa volta il transito a sud della stella si verifica a una distanza di 5'. Poiché il movimento di Giove è relativamente lento, a nché la distanza che lo separa da Sigma Arietis superi 1° bisognerà attendere fino al prossimo 2 ottobre.

(88) THISBE E (233) ASTEROPE IN OPPOSIZIONE
Nel corso del mese sono due i pianetini in opposizione nella stessa zona di cielo, in prossimità del confine tra Pegaso e i Pesci, di luminosità tale da poter essere individuati con l’ausilio di un binocolo. Il più brillante è (88) Thisbe, in opposizione il giorno 21, quando raggiunge la magnitudine +10,3. Inizialmente rintracciabile 2° a nord-ovest di Omega Piscium, di magnitudine +4,0, il pianetino si muove in direzione di Theta Piscium, 20’ a sudest della quale transita la mattina del 2 ottobre. Nelle immediate vicinanze della stella di 5a magnitudine 34 Piscium è invece possibile osservare (233) Asterope, di magnitudine +11,4 il giorno 25, quando è in opposizione al Sole. Di particolare interesse, la notte tra il 31 agosto e il 1° settembre, il passaggio dell’asteroide poco più di 6” a nord di 34 Piscium e il transito, la mattina del 15 ottobre, 6’ a nord della stella Iota Piscium, di magnitudine +4,1. Le stelle più deboli ra gurate nella mappa sono di magnitudine +11,0.
A partire dal termine del crepuscolo serale, quando l’eclisse reciproca delle due componenti non è ancora iniziata, è possibile seguire un’eclisse della variabile Algol particolarmente favorevole.
La fase massima dell’eclisse, quando Beta Persei raggiunge la luminosità minima (magnitudine +3,4), è prevista per le 0:50 di Tempo Civile del giorno 23: poiché la durata complessiva di un’eclisse è di circa 8 ore, osservazioni della stella ripetute almeno ogni mezz’ora lungo tutto l’arco della notte permetteranno di ammirare l’intera discesa verso il minimo e il successivo ritorno al massimo splendore (magnitudine +2,1), che verrà raggiunto prima che il cielo inizi d essere rischiarato dalle luci dell’alba.
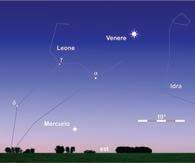
Nell’ultima decade del mese sull’orizzonte orientale risulta osservabile con relativa facilità Mercurio nella migliore apparizione mattutina dell’anno. Il giorno 22 raggiunge la massima elongazione occidentale di 17°,9 e, grazie all'elevata inclinazione dell'eclittica rispetto all'orizzonte, il pianeta sorge insieme alla comparsa delle prime luci dell’alba, mentre tra il 16 settembre e il 5 ottobre anticipa di oltre un’ora la levata del Sole. Il giorno 23 raggiunge la massima altezza apparente di ben 11°,2 sull’orizzonte all'inizio del crepuscolo civile, quando il Sole si trova 6° sotto l’orizzonte stesso. Il disegno ra gura il cielo sopra l’orizzonte orientale alle 5:55 TC del 23 settembre, all’inizio del crepuscolo nautico, quando l’altezza del pianeta è di circa 5°.
NELLA PRIMA DECADE DI OTTOBRE CI ATTENDONO
• 2 OTTOBRE: PIANETINO (29) AMPHITRITE IN OPPOSIZIONE NEI PESCI
•2-3 OTTOBRE: LUNA, GIOVE, URANO E PLEIADI ALL’ALBA

La notte tra il 26 e il 27 settembre è possibile ammirare il progressivo avvicinamento della Luna, quasi completamente Piena, a Saturno. Al termine del crepuscolo serale, quando entrambi sono già alti sull’orizzonte sud-orientale, la distanza che separa il nostro satellite naturale dal pianeta inanellato è di 6°,4 e va progressivamente diminuendo con l’avanzare della notte.
Alle 4:00 TC, quando la Luna è ormai calata fin quasi a toccare l’orizzonte sud-occidentale, la separazione è diminuita fino a 3°,2 (vedi figura). È inosservabile la reciproca congiunzione in Ascensione Retta, con la Luna a 1°,6 da Saturno, che si verifica dopo la loro discesa sotto la linea dell’orizzonte.
•5 OTTOBRE: MASSIMA LUMINOSITÀ DELLA COMETA 103P/ HARTLEY (MAG. +7,0) NEI GEMELLI
•10 OTTOBRE: LUNA, VENERE E REGOLO ALL’ALBA
I testi completi dei fenomeni sul prossimo numero di Cosmo e sul sito bfcspace.com
Della bella ed estesa costellazione zodiacale dello Scorpione abbiamo parlato nel numero scorso, trascurando però due importanti ammassi aperti, visibili a occhio nudo e situati verso la parte più orientale della costellazione. Partiamo da qui per una promenade nel cielo meridionale estivo.
UNA FARFALLA NEL CIELO
L’ammasso M6, di 4a grandezza, è relativamente compatto; con un binocolo 12x50, vi si possono contare una ventina di stelle disposte da nordest a sud-ovest, che gli conferiscono una forma oblunga.
Al telescopio se ne vedono un centinaio e fra queste spicca una stella dorata verso il margine nordorientale, la SAO 209132. Nota anche come BM Scorpii, è una variabile a lungo periodo (850 giorni), durante il quale la sua luminosità varia tra le magnitudini 6,8 e 8,7. Molti osservatori hanno ravvisato in M6 una farfalla in volo. Pare che questo appellativo sia comparso per la prima volta nello storico compendio di astronomia
popolare Splendour of the Heavens di T. Philips e W. Steavenson. Tuttavia, non tutti gli osservatori sono d’accordo sull’orientamento del lepidottero celeste: per alcuni, sembra volare verso nord-est, mentre per altri la direzione è a nord-ovest.
Circa 4 gradi a sud-est troviamo M7, un ammasso che vanta una storia remota, tanto che si trova menzionato nell’Almagesto di Tolomeo (II secolo d.C.), dove è riportato come un “agglomerato nebuloso che segue il pungiglione dello Scorpione”. Nella traduzione latina dell’Almagesto del 1551 è descritto come Girus Ille Nebulosus, una de nizione che secondo W. Burnham (scopritore di oltre 1300 stelle doppie), poteva comprendere sia questo ammasso, sia il vicino M6.
Situato a ridosso del con ne col Sagittario, a una declinazione molto negativa, M7 non poteva mancare nel catalogo del 1864 compilato da J. Herschel durante la sua permanenza al Capo di Buona Speranza; questi l’aveva descritto molto ricco e brillante, con stelle comprese tra la settima e l’undicesima grandezza.
Ake Wallenquist dell’osservatorio di
Uppsala, dopo averlo studiato nel 1959, aveva stabilito che si trattava di uno degli ammassi con il gradiente di luce più elevato (all’opposto, fra gli oggetti Messier, si trova M67 nel Cancro) e nel quale aveva notato la presenza di un’ottantina di stelle più brillanti della magnitudine 10. Per poterlo meglio apprezzare nella sua completezza e per enfatizzarne ulteriormente il contrasto sul fondo cielo, M7 va osservato al binocolo. Con un 20x80 o, meglio ancora, con un 25x100, si possono notare alcune lievi di erenze di colore sulle stelle più brillanti, che si manifestano come sfumature tra il bianco e il bianco-azzurro. Un altro vantaggio nell’utilizzo del binocolo è la possibilità di neutralizzare il seeing inevitabilmente scarso ad altezze così modeste sull’orizzonte.
Per i più arditi segnaliamo che all’interno di M7, perfettamente allineate ed equidistanti, si trovano tre piccole nebulose planetarie che non fanno parte dell’ammasso. Quella più a NE è la PK 356-4.1, osservabile anche in telescopi da 20 o 25 cm; è di aspetto stellare e si può cogliere tramite l’arti cio di far
passare davanti all’oculare un ltro OIII, così da a evolire le stelline di campo. Circa 25’ a SW c’è la PK 355-4.2, la più di cile del terzetto; si può osservare con un 40 cm ad alti ingrandimenti, in una nottata di buon seeing. In ne, spostandosi di altri 28’ a SW, si incontra la PK 3554.1, anche questa molto di cile, ma osservabile sotto cieli cristallini con

un 25 cm munito di ltro OIII; è la più estesa delle tre e appare come un debole dischetto rotondo.
Numerosi ammassi aperti e globulari si trovano in questa regione, angolarmente non lontana dal centrogalattico. Subito a ovest
dell’estremità occidentale di M7 c’è NGC 6444, un gruppo disperso di una ventina di deboli stelline in un diametro di una decina di primi d’arco; le principali sembrano disposte su una sorta di “barra” orientata da est a ovest.
A ridosso di M7 verso WNW si trova un piccolo ammasso globulare, NGC 6453, che è in realtà 50 volte
più distante: è un piccolo oggetto molto debole, con diametro di un paio di primi d’arco. Presenta un basso gradiente di luce e appare molto stemperato ai bordi; c’è una stellina quasi a ridosso del bordo occidentale. Nei telescopi di maggiori dimensioni può apparire debolmente granulato, ma questo è imputabile alle numerose stelline di campo presenti, dato che non è visualmente risolvibile in strumenti amatoriali.
NGC 6455 è stato scoperto attorno

al 1830 da John Herschel, che l’ha descritto come un notevole addensamento della Via Lattea, contenente un’in nità di stelline. Suona strana la descrizione di un oggetto che da molti è ritenuto inesistente! Il primo a bandirlo dal novero degli ammassi aperti è stato il Revised New General Catalog (Rngc) di Sulentic e Ti t, edito dall’Università dell’Arizona nel 1973. Tuttavia, non si deve pensare che Herschel sia stato un visionario; del resto,
osservando questa zona con un buon binocolo non si nota un ammasso vero e proprio, ma una tenue nube galattica situata attorno al bordo sud-occidentale di M7 ed estesa per circa un grado. Tenui formazioni scure situate attorno a questa zona sembrano darle anche maggior contrasto; peccato non poterlo osservare alto sull’orizzonte! Gli osservatori dal sud d’Italia, che hanno a disposizione diverse località con cieli bui, possano e ettuare osservazioni
più accurate di questo oggetto rispetto a chi risiede al nord.
Un genuino ammasso aperto, anche se poco appariscente, è invece Collinder
355, noto anche come Trumpler
30, situato al bordo sud-orientale di M7. Occorre fare attenzione, perché puntando un piccolo telescopio da 10-12 cm, salta facilmente all’occhio una conformazione triangolare, con una stella relativamente brillante di 8a grandezza al vertice settentrionale; l’ammasso si trova subito a sud-ovest
e in e etti, osservandolo con uno strumento da 25-30 cm, sembra come “gon arsi” in questa direzione.
Chi ha la possibilità di osservare la parte centrale della Via Lattea da località situate nei pressi dell’equatore potrebbe ricevere l’impressione di trovarsi sotto un cielo parzialmente nuvoloso; in e etti, la zona compresa tra l’Aquila e il Sagittario è particolarmente luminosa.
Ma anche alle nostre latitudini è talvolta possibile avere una visione entusiasmante della Via Lattea, se ci troviamo in località di alta montagna, dove la sua bellissima scia luminosa sembra perdersi dietro l’orizzonte; nei mesi estivi la possiamo osservare in meridiano a partire dalle prime ore della sera. Ci concentreremo sulla parte più bassa, che presenta una nestra di visibilità limitata. Lo scorso anno (vedi Cosmo n. 31) abbiamo parlato della famosa Nebulosa Laguna (M8, vedi Cosmo n. 31) che, essendo visibile a occhio nudo, è stata probabilmente notata già in tempi antichi. Poco più di un grado verso nord, c’è un’altra famosa nebulosa, la M20, u cialmente scoperta da Le Gentil nel 1747, anche se la prima descrizione è quella che ne aveva fatto C. Messier nel 1764: “ammasso di stelle [situato] poco al di sopra dell’eclittica tra l’arco del Sagittario e il piede destro dell’O uco”. Suona curiosa la denominazione di “ammasso aperto” riferito a M20, al punto che si potrebbe ipotizzare che Messier abbia confuso la nebulosa con il vicino ammasso M21; ma questa ipotesi non regge, dato che M21, scoperto da Messier nel 1764, viene descritto come “situato presso M20”, con l’aggiunta che “entrambi gli ammassi sono avviluppati in una nebulosa”. È quindi probabile che, riguardo a M20, l’astronomo francese abbia de nito come tale le stelle che prospetticamente si sovrappongono alla nebulosa: queste fanno parte dell’ammasso NGC 6514, che appare molto disperso.
William Herschel fu il primo a scoprire le bande oscure che attraversano la nebulosità di M20: questo però lo trasse in inganno,

» La nube galattica NGC 6455 si presenta come un vasto agglomerato di stelle, finemente screziata delimitata da alcune formazioni scure. Le stelle brillanti in alto a sinistra appartengono a M7 (Dss).


inducendogli a credere di aver avuto a che fare con quattro oggetti di erenti, ai quali assegnò altrettante designazioni. Il nome Tri da, con il quale è nota M20, le è stato poi assegnato dal glio John, che la osservò dal Capo di Buona Speranza. A dispetto della sua fama, M20 non è un oggetto vistoso, specialmente se osservato in piccoli strumenti; l’ammiraglio Smyth l’aveva trovata molto deludente, ma un conto è osservarla dalle elevate latitudini dell’Inghilterra, ancora più sfavorevoli di quelle italiane, un altro lo è dal Sud Africa, dove culmina a una decina di gradi dallo zenit.
In un piccolo telescopio, M21 mostra una forte concentrazione stellare verso l’interno e praticamente al centro si trova la stella più brillante dell’ammasso, la SAO 186215, di colore azzurro e magnitudine 7,2. Sia l’ammasso che la vicina nebulosa si possono rintracciare in un binocolo 10x50 che possieda un campo
abbastanza ampio da contenere anche la “Laguna”. È interessante osservare M20 in un dobsoniano da almeno 40 cm, in quanto è possibile notare una leggera sfumatura di colore tra la parte a emissione e quella più debole a ri essione, situata subito a nord: normalmente, la prima appare della tipica colorazione grigio-verdastra, mentre la seconda tende al violaceo pallido. Ma le impressioni visive possono variare da una persona all’altra e dipendere da altri fattori, come il contrasto cromatico.
Spostandoci poco meno di 9 gradi verso NW, troviamo la galassia NGC 6822, membro del Gruppo Locale, scoperta da Barnard nel 1884 quando era ancora un amatore, ma riconosciuta come tale solo negli anni 20 del secolo scorso. L’astronomo americano la riteneva una nebulosa molto debole, molto di usa e di luminosità uniforme, più facilmente visibile in piccoli strumenti che in quelli grandi.
Può sembrare una contraddizione, ma quando si ha a che fare con oggetti dotati di bassissima luminanza super ciale e di grande estensione, le dimensioni del campo apparente divengono cruciali. Chi scrive l’ha trovata relativamente facile in un binocolo 25x100 — sia pur osservando da un passo di alta montagna — ma critica al telescopio, dove è per no possibile “passarci sopra” senza vederla! In un 25 cm a circa 60 ingrandimenti appare come un’estesa chiazza lattiginosa, ovale, orientata da nord a sud e con dimensioni di circa 10’×5’. Il campo
stellare è molto ricco ed è proprio questo che tende a mascherare la galassia alla prima occhiata. NGC 6822 è distante 1,7 milioni di anni luce (più vicina, dunque, della Galassia di Andromeda) e contiene solo qualche decina di milioni di stelle; in confronto ai circa 200 miliardi di astri della Via Lattea, la “galassia di Barnard” è veramente piccola!
Un oggetto più facile si trova solo 40’ a NNW ed è una piccola e brillante nebulosa planetaria: NGC 6818, chiamata anche “La Piccola Gemma”. In un 15 cm a circa 30
ingrandimenti appare come una stella sfuocata di una tonalità azzurrastra; aumentando molto gli ingrandimenti (se la turbolenza lo consente), si può notare una forma leggermente ovale, con una elongazione da nord a sud ma per notarne i dettagli occorre uno strumento da 30 cm o maggiore.

Ben visibile nella “Coda” della costellazione del Serpente, il sedicesimo oggetto nel catalogo di Charles Messier (M16), con il suggestivo nickname di “Regina delle Stelle”, fa bella mostra di sé anche se osservato in semplici binocoli. Questo ammasso di stelle fu individuato per la prima volta dallo svizzero de Chéseaux nel 1746 e riscoperto in maniera indipendente da Messier diciotto anni più tardi, nel 1764.
Messier osservava da una Parigi con un cielo non proprio cristallino ed era dotato di una strumentazione assai modesta, inferiore anche agli strumenti più popolari che abbiamo oggi a disposizione. Pubblicò il suo famoso catalogo in due edizioni: la prima (del 1774) conteneva 45 oggetti “non stellari”, da M1 a M45; la seconda (del 1780) ne conteneva 68. La versione completa del catalogo fu pubblicata nell’edizione del 1781 della Connaissance des Temps, con un totale di 103 oggetti.
Successivamente, la lista venne estesa da altri autori no a comprendere 110 oggetti, poi ridotti a 107 dato che M40 e M73 sono considerati oggetti inesistenti, mentre M102 è
ritenuta (erroneamente) un duplicato di M101. Va tenuto presente che la strumentazione utilizzata dal francese per la seconda edizione era già di qualità superiore rispetto a quella di cui disponeva inizialmente.
M16 è uno degli ammassi aperti più luminosi e giovani del catalogo Messier: 376 membri, stipati in un’area grande quanto la Luna piena, dove la stella più vecchia ha un’età di soli 6 milioni di anni. Non solo: M16 contiene il numero più elevato di stelle luminose appartenenti alla classe spettrale O (caratterizzata da stelle estremamente luminose) rispetto a tutti gli ammassi aperti presenti nel catalogo.
L’ammasso è immerso in una vasta nebulosità, una grande regione di gas e polveri nel braccio galattico del Sagittario, a 5700 anni luce, dove si osserva la formazione di nuove stelle. Nota anche con il nome di Nebulosa Aquila, la sua scoperta è stata attribuita erroneamente a Messier, basandosi sulla descrizione di questo oggetto dell’osservatore francese (certamente al di là delle possibilità dei suoi strumenti), che la riporta
come segue: “ammasso di piccole [deboli] stelle, inserite in una debole luce di usa, nelle vicinanze della coda del Serpente. In un piccolo ri ettore, queste stelle appaiono come una nebula, ma al crescere dell’apertura, si dovrebbero riuscire a distinguere le singole stelle”. La nebulosa venne individuata fotogra camente da Barnard nel 1895 e due anni dopo da Isaac Roberts, che la inserì nell’Index Catalogue con il numero IC 4703.
Più curiosa è la mancata scoperta della nebulosità da parte degli Herschel, che utilizzavano strumenti più perfezionati rispetto a quelli di Messier. John Herschel descrive questo oggetto come: “composto da almeno cento stelle, larghe [luminose] e piccole [deboli]”.
La nebulosa mostra alcuni particolari alquanto interessanti, come i celeberrimi “Pilastri della creazione”, una regione visibile all’interno della vasta nebulosità, dall’aspetto suggestivo, che consiste in tre colonne di gas, così denominate perché sede di intensa creazione di nuovi astri.
Non è di cile da scorgere questa nebulosa, indagando visualmente con
strumenti amatoriali moderni. Chi scrive ha riportato la seguente nota: “42x – splendida visione, l’ammasso stellare (M16) è letteralmente “a ogato” in una ricca congerie di stelline più deboli. La nebulosità (IC 4703), si apre a farfalla verso sud-est, mentre verso nord risalta la parte più oscura; comincia ad assumere la classica forma fotogra ca, ricordando il perché del suo nome Aquila”. L’osservazione è stata eseguita in alta montagna, con un
CostellazioneSerpente
Ascensione retta18h 19m
Declinazione-13° 49’
Distanza 5700 a.l.
Magnitudine app. 6,0
Dimensione app. 7,0’
Tipo Regione HII
DimensioniM16: 15 a.l.
IC 4703: 70x55 a.l.
rifrattore apocromatico da 155 mm di diametro, senza ltri. Utilizzando ltri interferenziali e strumenti più larghi, è possibile fruire di visioni interessanti della nebulosità. Sotto un cielo scuro di alta montagna, con un ri ettore in montatura dobsoniana dal diametro di 508 mm, a 133x con un ltro OIII, l’autore ha riportato la seguente nota: “Si vede una parte oscura a forma di V (aperta verso nord-ovest), e i famosi Pilastri della creazione (come le colonne che formano questa V): somigliano a dita oscure anzi, nere, che si insinuano nel corpo principale della nebula, che brilla di un colore verdastro”.
La descrizione di Messier (“In un piccolo ri ettore, queste stelle appaiono come una nebula”) evidenzia il paradigma vigente all’epoca e risalente a Herschel, secondo il quale tutte le nebulose erano risolvibili in stelle, a patto di aumentare l’apertura del telescopio e l’ingrandimento. Ipotesi corretta, pensando alle galassie, ma inapplicabile alle nebulose vere e proprie, composte solo di gas. Probabilmente, Herschel, sposando il suo paradigma, non menzionò come “nebulosa” quella che avrebbe anche potuto scorgere, giudicandola risolvibile a patto di aumentare l’apertura del telescopio. Allora, la di erenza che abbiamo con Messier, Herschel e altri osservatori del passato, è che noi sappiamo che le nebulose esistono, non essendo necessariamente gruppi di stelle che lo strumento non riesce a risolvere. Una bella lezione dalla “Regina” dunque.

Venti aprile 2023, 11:29 AM, Exmouth, Western Australia. È eclisse totale: Luna e Sole si fondono. Adrenalina ed estasi sotto l’occhio infuocato di un dio maligno. Il suo sguardo di tenebra taglia quel lembo di terra su cui si trovano decine di migliaia di persone venute da tutti gli angoli del mondo. Sono i testimoni oculari della totalità, lo spettacolo cosmico regalato dagli astri a chi ha s dato il deserto australiano.
Non avrei potuto essere parte di quell’allineamento perfetto se avessi continuato il mio lavoro a Tokyo. I ritmi di lavoro giapponesi lasciano poca libertà di viaggiare. Libertà che diventa nulla se lo scopo del viaggio è raggiungere una sottile striscia di totalità che si estende dall’Oceano Indiano al Paci co, diverse migliaia di chilometri a sud del Giappone. Così ho deciso di lasciare il mio lavoro e la mia vita nel Sol Levante per intraprendere un’avventura che mi ha portato a esplorare nuove terre, nuovi mari e nuovi cieli.
Il mio interesse era caduto inizialmente su altre regioni della totalità: la costa orientale di Timor Est e la metà indonesiana dell’isola di Papua. La prospettiva di assistere all’eclissi sulle spiagge di un’isola tropicale è stata allettante nché non ho scoperto che le statistiche sul meteo locale di aprile davano nuvoloso al 90%. L’unico altro pezzo di terraferma da cui la sagoma della Luna avrebbe coperto completamente il Sole era l’angolo nord-occidentale dell’Australia. La città più vicina è Perth, nell’angolo sud-occidentale. Così, ho preso l’aereo per questo Paese con una popolazione minore di quella di Tokyo e un’estensione di quasi due volte quella dell’Unione Europea. Già dagli enormi parchi di Perth ho potuto vedere alte nel cielo le regioni centrali della Via
» Sopra: l’mmagine composita che mostra le fasi dell’eclissi, scattate nell’arco di circa tre ore (Shivam Bansal).

Sotto: l’anello di diamanti prodotto dai raggi solari che passano tra una montagna e l’altra della Luna annuncia l’imminente totalità (Shivam Bansal).
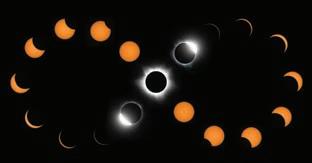
Quando il nostro satellite è nel punto più lontano della sua orbita, all’apogeo, non possono verificarsi eclissi solari totali: la Luna è troppo lontana perché il Sole possa essere completamente oscurato. Può però verificarsi un’eclissi anulare, in cui la Luna oscura solo il centro del Sole e lascia risplendere un anello brillante che, con la sua forma, dà il nome a questo tipo di eclisse. Eclissi anulari (o meglio dei transiti) possono essere osservate anche dalla superficie di Marte, dove i rover marziani hanno ripreso le lune Phobos e Deimos mentre transitano sul disco solare. La piccola e più lontana Deimos appare solo come un puntino, ma neanche Phobos, con i suoi 22 km di diametro, è abbastanza grande da oscurare tutto il Sole, nonostante orbiti a soli 6000 km dalla superficie marziana.
Sulla Terra abbiamo una coincidenza unica: un satellite naturale 400 volte più piccolo del Sole, ma anche 400 volte più vicino. Una sovrapposizione quasi perfetta e senza eguali nel Sistema solare, capace di creare uno spettacolo unico, che fa impallidire eclissi anulari e parziali, anche al 99%. Questo perché solo nelle eclissi totali la Luna copre tutta la brillantissima fotosfera, ovvero la superficie del Sole. La fotosfera illumina e riscalda la Terra, ma è pericoloso guardarla direttamente e la sua luminosità oscura la debole atmosfera solare. Lo strato inferiore della regione di gas che circonda il Sole è chiamato cromosfera. Spessa solo 2000 km e di colore rosso quasi violaceo, la cromosfera e le sue spicule possono essere fotografate solo durante le eclissi totali, quando le dimensioni angolari di Luna e Sole sono molto simili. In questa eclissi australe, la grandezza dei due astri era talmente simile che l’ombra lunare riusciva a nascondere completamente la luce solare solo nei punti della superficie terrestre più vicini ai due astri, e per il tempo massimo di un minuto. Allontanandosi dall’equatore, la punta del cono dell’ombra lunare non poteva raggiungere la superficie terrestre. Quando, come in questo caso, la stessa eclissi è in alcuni punti totale e in altri anulare, si parla di eclisse ibrida. In figura, la cromosfera esaltata con speciali filtri mostra le sue spicule più alte di un diametro terrestre (Shivam Bansal).
Lattea e le Nubi di Magellano, ma lì la Luna avrebbe oscurato il Sole solo al 70%. Dovevo quindi spingermi più a nord, ma coi prezzi dei voli per il piccolo aeroporto di Exmouth alle stelle e il noleggio di un camper non sostenibile, ho deciso di investire in un van economico, da rivendere prima di lasciare l’Australia. Così sono partito per un viaggio più lungo di Aosta-Gallipoli a bordo di un van varato nel 1998, che aveva già percorso 406mila km, come la distanza massima Terra-Luna.

Assistere alla totalità è l’esperienza naturale più anomala. E migliaia di persone si sono riunite nella contea di Exmouth proprio per quella esperienza. Chi in città, chi nell’outback, chi, come me, su una spiaggia. Arrivo di prima mattina con due amici conosciuti in viaggio. Il Sole si alza e il caldo tropicale comincia a farsi sentire, quindi cerchiamo riparo. Conosco Jenny, botanica, con cui si discute degli e etti dell’eclissi sulla ora, meno studiati e appariscenti di quelli sulla fauna, ma altrettanto interessanti.
È più evidente l’e etto inverso, cioè delle piante sull’eclissi o, meglio, sui raggi del Sole. Filtrando da tanti piccoli fori fra le foglie, i raggi proiettano sul terreno altrettanti dischi solari “mangiati” dall’ombra lunare, rivelando così l’inizio della parzialità. Prontamente indossiamo gli occhialini protettivi e guardiamo in alto: lo spettacolo dell’eclisse parziale prepara al climax imminente. I venti si muovono imprevedibili, so ando a volte verso il mare, a volte verso terra, a volte verso
quell’orizzonte vagamente più scuro. Intanto calano la luminosità e temperatura. I colori attorno a noi sono più spenti e nessuno sente più il bisogno di ripararsi all’ombra. Si continua a guardare in su con gli occhialini protettivi e a ricreare l’e etto del fogliame con le mani o con conchiglie forate. Quando mancano pochi minuti
alla totalità, i colori del paesaggio si spengono, la temperatura è sensibilmente bassa e diventa palese il comportamento anomalo degli animali. Gli uccelli cantano e volano indecisi se ritornare al nido o allontanarsi, mentre alcuni pesci saltano fuori dall’acqua. Anche i fotogra sembrano incerti fra lo scattare foto con il teleobiettivo
ltrato per immortalare ciò che resta della super cie solare, e l’eseguire gli ultimi controlli sulla camera già preparata per la totalità. Io voglio godermi tutti i 60 secondi, quindi piazzo su un sasso il mio smartphone e faccio partire un video. Il cielo ha ormai perso il suo colore, e la sua luminosità di usa si smorza a poco a poco, come se la mano cosmica di un

gigante si stesse stringendo su di noi. Cala un silenzio surreale, interrotto solo da qualche Oh my god; anche il rumore delle onde sembra ovattato. Gli ultimi istanti di luce sono sublimi: una singola sorgente luminosa si a accia da un lato della Luna. È il cosiddetto Anello di diamanti (diamond ring e ect), in cui

la luminosità del Sole è vagamente visibile attorno a tutta la Luna, ma allo stesso tempo concentrata in un punto brillante. Poi, il buio.
Tolgo gli occhialini e guardo la sovrapposizione dei due astri. Il dio maligno ricambia lo sguardo. Cado in ginocchio sulla sabbia di un mondo tetro, alieno. L’occhio di tenebra non è
niente di paragonabile a quanto si può osservare in foto. Qui, al centro della danza cosmica di Terra, Luna e Sole, il centro del mio mondo è quell’occhio cieco e le strutture biancastre che sprigiona: la corona solare, che non è composta di luce, ma di materia incandescente: è lo strato più alto dell’atmosfera del Sole, che si disperde nello spazio per decine di raggi solari. Nella parte più vicina al disco nero brilla quanto una Luna piena, ma non di luce ri essa: la corona risplende per l’assurda temperatura di oltre un milione di gradi ed è ciò che di più caldo gli occhi umani possano vedere. Anche se 500 volte più calda della fotosfera, è molto rarefatta, quindi il disco solare o usca la sua brillantezza: l’unica occasione per vederla è un’eclisse totale di Sole (vedi la foto di copertina).

Guardo Venere e Giove, guardo il mare scuro e le nuvole lontane. Ripenso ai canguri del deserto e agli squali del reef, agli stormi di pappagalli verdi e alle rocce rosse innalzate ed erose dal passaggio delle ere geologiche. Ripenso alle stelle e costellazioni australi che solo un mese fa mi erano sconosciute. Ripenso al van che si spegne nel deserto e ai bulloni della ruota rotti e risaldati. Ripenso al mio viaggio australe verso nord, con il Sole in fronte e la Luna “storta” ai miei occhi. La Croce del Sud alle mie spalle e l’occhio cosmico su di me. Dentro di me. Ora qualcuno torna a casa, qualcuno, come me, prosegue il viaggio, ma c’è un unico saluto: ci vediamo l’8 aprile 2024 in Messico, dove la totalità durerà più di 4 minuti. Abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Ne è valsa la pena.
ORGANIZZA UN GRANDE VIAGGIO PER ASSISTERE ALLA

PROGRAMMA DEL VIAGGIO (5-12 APRILE 2024)
5 aprile: partenza da Milano-Malpensa (intorno ore 12) con Fly Free Airways per l’aeroporto di Torreòn (Messico), con 1-2 scali intermedi.
6 aprile: arrivo a Torreòn e alloggio dei partecipanti in Albergo 4 stelle in città con trattamento di pensione completa.
7 aprile: visita della città di Torreòn con una guida locale.
8 aprile: trasferimento all’Osservatorio astronomico di Nazas (25 km da Torreòn) per l’osservazione dell’eclisse (massimo alle 12h 18m locali).
9 e 10 aprile: escursioni naturalistiche nei dintorni di Torreòn e in serata osservazioni astronomiche guidate all’Osservatorio di Nazas, con strumenti forniti dall’organizzazione.
11 aprile: partenza dall’aeroporto di Torreòn con Fly Free Airways per il ritorno, con 1-2 scali intermedi.
12 aprile: arrivo a Milano-Malpensa.
Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto e all’osservatorio sono operati da un pullman riservato e compresi nella quota del viaggio, fissata in 4850,00 € a testa.
I posti sono limitati! Entro il 15 settembre compila il modulo di iscrizione a bit.ly/3C7VSGx
Altre informazioni a bit.ly/3ZFdeVg, e-mail eclisse2024@bfcspace.com
Il 4 luglio 2012, al Cern di Ginevra, i portavoce delle collaborazioni internazionali degli esperimenti Atlas e Cms all’acceleratore Large Hadron Collider (Lhc), Fabiola Gianotti (attualmente direttrice del Cern) e Joe Incandela, annunciarono la scoperta di una nuova particella fondamentale, il bosone di Higgs L’importanza della scoperta fu sottolineata l’anno successivo dal premio Nobel per la Fisica assegnato a Peter Higgs e François Englert che, insieme al compianto Robert Brout, nel 1964 ne avevano ipotizzato l’esistenza. Questo bosone ha una massa di 125 GeV. Che cosa signi ca questa unità di misura?
Perché non si esprime questa massa con i chilogrammi?
Il motivo è che il chilogrammo non è un’unità di misura “comoda” per la sica nucleare e subnucleare, e non lo è neanche un suo sottomultiplo, come il grammo, che corrisponde a quella di un milione di miliardi di miliardi di protoni.
Per misurare sia le masse che le energie delle particelle elementari - non solo quelle che si trovano con nate negli atomi, ma anche quelle che vengono emesse dagli elementi radioattivi e nelle reazioni nucleari e che ritroviamo nei raggi
cosmici - i sici preferiscono utilizzare l’elettronvolt (eV), che è un’unità di misura dell’energia. Precisamente, si tratta dell’energia che acquista un elettrone soggetto a una di erenza di potenziale elettrica di 1 volt. Per esempio, se utilizziamo una comune pila da 4,5 V per realizzare un piccolo acceleratore di particelle, possiamo fornire a ogni elettrone 4,5 eV di energia. L’elettronvolt è un’energia molto piccola, che equivale a 1,6 x 10-19 J, dove la J indica il joule, l’unità di misura dell’energia nel Sistema Internazionale.
È già piccolo il joule, che corrisponde all’energia consumata per sollevare di un metro la massa di un ettogrammo, guriamoci l’elettronvolt!
Questa rubrica vuole avere una connotazione didattica, per stimolare i lettori ad approfondire l’indagine del cielo anche con gli strumenti della matematica e della fisica. Chi si ferma su queste pagine scopre che può arrivare a comprendere come funziona l’Universo, con l’aiuto di una semplice calcolatrice Domande, risposte e proposte riguardanti i problemi di calcolo astronomico possono essere inviate in redazione, all’indirizzo stroppa@bfcmedia.com
In e etti, è così piccolo che spesso devono essere utilizzati i suoi multipli: il kiloelettronvolt (1 keV = mille elettronvolt), il megaelettronvolt (1 MeV = 106 eV, un milione di elettronvolt) e il gigaelettronvolt (1 GeV =109 eV, un miliardo di elettronvolt).
Ma com’è possibile fornire il valore di una massa in termini di energia?
» Il tubo sotterraneo del Large Hadron Collider al Cern di Ginevra, dove le particelle elementari vengono accelerate fino a velocità vicine a quella della luce.

A destra: un’immagine artistica di una pioggia di particelle generate dall’impatto di un raggio cosmico di grande energia con l‘atmosfera.

La ragione è in una delle formule più famose della sica, quella stabilita da Albert Einstein nella teoria della Relatività ristretta del 1905, che sancisce l’equivalenza massa-energia: E = m c2, dove m è la massa, E l’energia e c la velocità della nel vuoto, pari a 3 x 108 m/s. Poiché il valore della velocità della luce è molto grande (e ancor più il suo quadrato), anche una piccola massa corrisponde a una grande quantità di energia. Non solo: questa formula consente di misurare masse ed energie con la stessa unità di misura, come l’elettronvolt.
Dato che m = E / c2, l’unità di misura della massa si ottiene dividendo
l’unità di misura dell’energia, per il quadrato della velocità della luce; l’unità corretta sarebbe quindi l’elettronvolt/c² (eV/c²).
I sici però utilizzano spesso un sistema di unità di misura che diventa comodo ponendo c = 1. Così, nelle misure delle masse non compare il c² e sono espresse semplicemente in elettronvolt e i suoi multipli.
LA MASSA DEL PROTONE
Il protone è uno dei costituenti del nucleo atomico, insieme al neutrone.
Il protone ha una carica elettrica uguale a quella dell’elettrone ma di segno positivo, mentre l’elettrone
Ecco le soluzioni dei problemi proposti nella puntata precedente (“L’evaporazione dei buchi neri” di A. Simoncelli), pubblicata su Cosmo n. 40.
Il tempo a nché un buco nero di 30 masse solari evapori completamente è 5,67 x 1071 anni. Si tratta, come per altri buchi neri di massa stellare, di un valore ben superiore all’età dell’Universo!
è negativo, e la sua massa è 1,67 x 10-27 kg. Determiniamo la massa del protone in elettronvolt con la formula di Einstein. E = 1,67 x 10-27 x (3 x 108)2 = 1,5 x 10-10 J. Ricordando l’equivalenza tra elettronvolt e joule, per avere il valore della massa in elettronvolt, basta dividere il valore che abbiamo trovato per 1,6 x 10-19 J. Abbiamo: m = 1,5 x 10-10 / 1,6 x 10-19 = 0,938 x 109 eV = 0,938 GeV Quindi, la massa del protone equivale a poco meno di un miliardo di elettronvolt, che corrisponde a un millesimo dell’energia cinetica di una zanzara di 1 mg, che si muove alla velocità di 1 m/s.
*ANDREA SIMONCELLI LAUREATO IN ASTRONOMIA A BOLOGNA, È UN RICERCATORE, DOCENTE E DIVULGATORE SCIENTIFICO.
In un numero precedente (vedi riquadro a pag. 93) abbiamo esplorato le costellazioni visibili in cielo nel corso dei mesi. A questo punto, siamo pronti per conoscere lo strumento principe dell’osservazione astronomia, il telescopio
UN TUFFO NEL PASSATO
Sebbene sia stato Galileo Galilei ad aver perfezionato il telescopio e ad averlo usato per l’indagine astronomica, le origini di questo strumento sono in Olanda, dove nel 1608 Hans Lippershey aveva fatto una richiesta di brevetto per un telescopio rifrattore che produceva un ingrandimento di tre volte. Nel 1609, Galileo costruì un modello migliorato di questo strumento e lo rivolse verso il cielo. Così scoprì le quattro lune principali di Giove (Io, Europa, Ganimede e Callisto), la composizione stellare della Via Lattea e le irregolarità della super cie lunare. Nasceva l’astronomia moderna.
I telescopi rifrattori più semplici so rono di un difetto chiamato aberrazione cromatica, causato
dal fatto che i vari colori di cui è composta la luce bianca non vanno a fuoco nello stesso punto. Un metodo per risolvere questo problema è quello di realizzare telescopi molto lunghi, e questa fu la strada intrapresa dai primi costruttori. Pochi decenni dopo l’invenzione di Galileo, Isaac Newton costruì il primo telescopio ri ettore, basato su specchi, che non so re l’aberrazione cromatica (ma presenta altri tipi di difetti). Ancora oggi quello newtoniano è tra gli schemi ottici preferiti, quando bisogna realizzare telescopi di grande diametro e di corta focale. Inoltre, grazie al fatto che gli specchi sono più economici da lavorare delle lenti, i telescopi newtoniani sono tra gli strumenti preferiti dagli astro li.
Nei quattro secoli ormai trascorsi dalla loro invenzione, i telescopi sono diventati strumenti estremamente so sticati, dal più piccolo telescopio amatoriale no ai grandi strumenti ospitati negli osservatori a terra e nello spazio, come il James Webb Space Telescope
Il telescopio astronomico è uno strumento che permette di osservare e studiare gli oggetti astronomici. Consente di ingrandire questi oggetti e di raccogliere la loro debole luce in modo che essi risultino più brillanti e quindi percepibili dai nostri occhi. Esistono diversi schemi costruttivi per realizzare un telescopio, ma tutti si comportano in modo simile.
I raggi luminosi provenienti da un pianeta o da una stella vengono raccolti da una super cie ottica detta obiettivo, che può essere una lente convergente o uno specchio concavo, e successivamente vengono convogliati sul piano focale, dove si forma l’immagine. Se l’obiettivo è una lente convessa, i raggi luminosi sono deviati verso il piano focale grazie al fenomeno della rifrazione, mentre nel caso dello specchio concavo, la focalizzazione avviene grazie alla ri essione.
L’obiettivo però non basta per osservare l’immagine prodotta dal telescopio. È necessario introdurre una seconda lente, detta oculare, che

permette alle immagini del piano focale di arrivare a fuoco sulle retine dei nostri occhi. All’interno di un oculare, le immagini non appaiono solo ingrandite, ma anche capovolte, ma è tutto normale e si tratta solo di abituarsi a osservare al contrario!
I raggi luminosi che vengono rifratti o ri essi dall’obiettivo del telescopio convergono sul piano focale, in corrispondenza del quale si forma
l’immagine, rimpicciolita e capovolta. Ogni lente o specchio ha una sua caratteristica distanza focale, in base alla curvatura e alla geometria della lente o dello specchio.
La distanza tra l’obiettivo e il piano focale è detta lunghezza focale, una grandezza fondamentale per determinare l’ingrandimento Sia l’obiettivo che l’oculare possiedono una loro lunghezza focale; solo quando i due fuochi si trovano nel medesimo punto, l’immagine è perfettamente a fuoco. Ecco perché i focheggiatori dei telescopi sono progettati per muoversi in avanti o indietro, un’operazione che permette di far coincidere i due fuochi. In condizioni di scarsa luminosità, la pupilla del nostro occhio si allarga il più possibile, mentre in presenza di una forte luce si restringe. Anche con un telescopio, più è grande l’obiettivo e più lo strumento è in grado di raccogliere la luce.
Gli argomenti che a rontiamo in questa rubrica sono trattati in modo più esaustivo nel libro Il cielo sopra di noi, acquistabile in formato cartaceo o Kindle su Amazon.
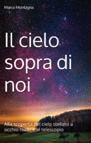
In questo volume sono trattati moltissimi argomenti, dalle prime nozioni sull’Universo alle prime osservazioni a occhio nudo, dalla scelta del primo telescopio ai consigli su come e cosa osservare nel cielo stellato. Sono presenti numerose mappe stellari con annotazioni per comprendere come localizzare gli oggetti celesti più interessanti.
La pupilla umana, al massimo della sua dilatazione, è larga circa 7 mm; perciò, un telescopio ri ettore da 114 mm possiede un diametro circa 16 volte maggiore. Il calcolo però si fa con le aree e il rapporto tra l’area dell’obiettivo del telescopio e quella della pupilla è pari a circa 265. Il telescopio da 114 mm raccoglie quindi 265 volte la luce raccolta del nostro occhio.
Un telescopio restituisce un’immagine ingrandita degli oggetti astronomici, ma quanto ingrandita? Il tubo di un telescopio è rigido e la sua lunghezza focale non può cambiare. Ma si può cambiare l’oculare, e l’ingrandimento è dato dal rapporto tra le due lunghezze focali:
i = f(telescopio) / f(oculare). Per esempio, un telescopio con focale di

750 mm, unito a un oculare da 10 mm, produce un ingrandimento di 75x.
Gli ingrandimenti, e di conseguenza gli oculari, vanno scelti secondo regole ben precise. Per osservare gli oggetti del profondo cielo, si usano ingrandimenti compresi tra 30x e
180x. Andare oltre non servirebbe a molto, dato che si tratta di oggetti astronomici di debole luminosità, dei quali non possiamo percepire dettagli troppo ni.
Per quanto riguarda invece pianeti, stelle doppie e Luna, ci si può spingere molto con gli ingrandimenti,
no a un limite massimo che (sempli cando) è pari al doppio del diametro dell’obiettivo espresso in millimetri. Per esempio, con un telescopio da 150 mm di diametro si può arrivare no a 300x, un limite oltre il quale non ha senso andare. Vediamo perché.

Vi sono persone che non credono all’autenticità dello sbarco umano sulla Luna, e uno degli indizi che portano a sostegno della loro convinzione è che non si vede la bandiera americana piantata dagli astronauti, anche puntando il telescopio più potente verso la Luna (vedi l’Ora di astronomia su Cosmo n. 19).
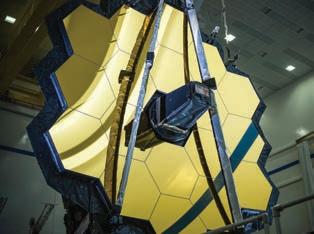
Osserviamo le onde del mare che entrano tra le banchine di un porto. Quando le onde incontrano un ostacolo, da piane e parallele
cambiano forma, diventando circolari e propagandosi al di là della dimensione dell’imboccatura. Questo fenomeno prende il nome di di razione ed è uno dei motivi per i quali si possono sentire le voci delle persone anche se si trovano al di là dell’angolo di una parete.
La luce è un’onda ed è quindi soggetta alle stesse leggi delle onde marine e di quelle sonore. Le stelle, essendo molto lontane, dovrebbero essere sempre puntiformi a qualsiasi ingrandimento. Tuttavia, quando la luce di una stella attraversa l’imboccatura del telescopio, cambia forma a causa della di razione e si genera un’immagine che non è puntiforme, ma è formata da un disco sfuocato, circondato da anelli più deboli, una gura che prende il nome di disco di Airy.
A bassi ingrandimenti, il disco è così piccolo che la stella appare puntiforme. Ma se si aumenta l’ingrandimento oltre il limite dello strumento, si comincia a ingrandire il disco di Airy. A questo punto, ogni ulteriore ingrandimento sparpaglia sul disco di Airy la luce proveniente dalla stella, senza migliorare il contrasto o il dettaglio.
Il limite di ogni strumento ottico, inclusi i nostri occhi, è determinato dal cosiddetto potere risolutivo, de nito come la più piccola distanza (misurata in secondi d’arco) che due oggetti devono avere per essere risolti singolarmente. Anche una sorgente puntiforme appare nel telescopio con un diametro angolare minimo pari al potere risolutivo dello strumento. Se due stelle hanno una distanza angolare inferiore al potere risolutivo del telescopio, i due dischi di Airy
si fondono insieme, impedendoci di vederle separatamente, e un ulteriore ingrandimento non può che peggiorare la situazione. Ora si capisce perché non si può vedere la bandiera americana sulla Luna. Per no il telescopio spaziale Hubble non può individuare sulla super cie lunare oggetti con dimensioni minori di 100 metri. Il potere risolutivo non è da confondere con la nitidezza. Infatti, pur non potendo separare due stelle, si possono comunque vedere. Cioè, è possibile scorgere dettagli più ni del potere risolutivo del telescopio, ma la di razione rimescola le carte in tavola, distruggendo le informazioni sui dettagli originali. Ma quanto vale il potere risolutivo di un telescopio? Si può ottenere in modo semplice con la formula di Dawes, secondo la quale il potere
Questa rubrica vuole rendere il cielo stellato accessibile a chiunque, con un linguaggio semplice ed esempi pratici. Tutti sono incuriositi dalle stelle, ma la pratica osservativa presenta delle barriere talvolta insormontabili. Posso dopo passo, partendo dalle basi e procedendo verso anche argomenti più avanzati, supereremo queste barriere e impareremo insieme a scrutare il cosmo.
Le puntate precedenti:
1. Prima di osservare il cielo, Cosmo n. 31
2. Orientarsi nel cielo stellato, Cosmo n. 34
3. Alla scoperta delle costellazioni, Cosmo n. 39
risolutivo si ottiene dal rapporto 117 / D, dove D è il diametro in millimetri dell’obiettivo. Per esempio, l’occhio umano, con una pupilla di entrata massima di 7 mm, ha un potere risolutivo di circa 17 secondi d’arco.
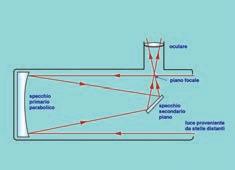
La conoscenza delle grandezze che caratterizzano un telescopio è importante per la scelta dello strumento. Qualcuno potrebbe chiedersi se questa fatica è proprio necessaria: non basta scegliere lo strumento dal prezzo più adeguato alle nostre tasche? In realtà, in questo modo si rischia di sbagliare acquisto e distruggere sul nascere la passione per il cielo.
Per esempio, vogliamo osservare i pianeti, o preferiamo gli oggetti del profondo cielo, come le nebulose e gli ammassi stellari? Nel primo caso, occorrono elevati ingrandimenti, che si ottengono con un telescopio rifrattore a lunga focale e con un sistema di lenti in grado di attenuare al minimo la rifrazione cromatica. Nel secondo caso, essendo tali oggetti molto deboli, occorre soprattutto una lente o uno specchio primario di grande diametro per raccogliere più luce possibile. Bilanciando le varie quantità, si può trovare lo strumento giusto che fa al caso nostro.
L’acquisto del telescopio va quindi ragionato, senza cedere alla tentazione dei giocattoloni da poche decine di euro, che promettono ingrandimenti incredibili con ottiche di bassa qualità e montature traballanti. L’esperienza permetterà poi di sfruttare il nostro strumento no ai limiti delle sue potenzialità.
L’amministrazione comunale di Rozzano, una città alle porte di Milano, si è posta l’obiettivo di valorizzare in modo signi cativo l’o erta culturale del territorio e per questo ha voluto realizzare una grande struttura scienti ca. Da questo progetto è nato il Civico osservatorio astronomico di Rozzano.
L’inaugurazione del nuovo osservatorio, avvenuta alla ne del mese di maggio, ha visto come madrina dell’evento Amalia Ercoli Finzi, professoressa onoraria di meccanica del volo spaziale del Politecnico di Milano e conosciuta come la “signora delle comete”; mentre il padrino è stato l’astro sico Fabio Peri, fondatore ed ex presidente dell’Associazione dei planetari italiani e Conservatore del civico Planetario di Milano.
Era presente all’evento anche Paolo Maggini, nipote di Mentore Maggini, uno dei più importanti astro sici italiani, a cui si devono quali cati e fondamentali studi sul pianeta Marte. La famiglia Maggini ha donato un’importante collezione di documenti storici, manoscritti (Libro di Urania), disegni e taccuini dello scienziato, che sono custoditi nel piccolo museo presente all’interno dell’osservatorio e per la prima volta esposti al pubblico. La gestione della struttura è a data al Gruppo Astro li Rozzano (Gar), una storica associazione cittadina composta da volontari e attiva da oltre 40 anni nella divulgazione scienti ca, che ha messo a disposizione
tutta la strumentazione tecnico-scienti ca, le foto, i libri e la collezione in suo possesso, oltre a occuparsi dell’organizzazione di visite guidate, osservazioni del cielo, conferenze, eventi divulgativi e didattici per le scuole e per il grande pubblico.
L’elemento più notevole del nuovo osservatorio è la cupola, dal diametro di sette metri, con una caratteristica apertura “a petali” che permette la presenza di due telescopi per osservazione del cielo a 360 gradi. Fra le cupole di questo genere, è la più grande in Europa e la seconda al mondo.
All’interno della cupola troviamo il telescopio MerzDallmeyer, di proprietà del Gar, che è stato sottoposto a un restauro funzionale da parte degli specialisti di ArassBrera ed è tutelato dalla Sovrintendenza dei beni culturali di Milano. Questo prezioso strumento risale al 1870 circa ed è composto per il 95% da parti originali, tra cui le lenti, che permettono il suo utilizzo per l’osservazione del cielo. Manca il meccanismo di movimentazione a orologeria, che già agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso era stato sostituito da un motore elettrico.
La parte ottica, marchiata “G.&S. Merz in Muenchen”, è composta da un obiettivo da 162 mm di diametro (6 pollici parigini, l’unita di misura in voga all’epoca), la cui rma sul barilotto dell’obiettivo fa pensare che sia stata realizzata a Monaco di Baviera fra il 1858 e il 1867.
La parte meccanica della montatura è targata “J.H.
» I due telescopi ospitati nella grande cupola a petali dell’osservatorio di Rozzano.
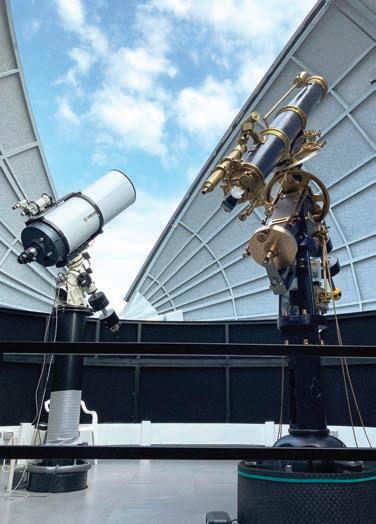
Dallmeyer. London”, che ne rivela la realizzazione da parte di John Henry Dallmeyer (1830-1883), famoso ottico anglo-tedesco, costruttore di telescopi, obiettivi fotogra ci speciali e fotoeliogra .
Il telescopio si presenta con molte parti in ottone e bellissimi cerchi graduati di Ascensione Retta e Declinazione, incisi su di una lamina d’argento. La montatura del telescopio presenta l’asse polare con latitudine variabile, più due livelle a bolla ortogonali. Questo potrebbe indicare che lo strumento è stato costruito per essere trasportato e installato in qualche luogo dove fosse possibile osservare degli eventi astronomici particolari. Forse si trattava dei due transiti del pianeta
Venere sul Sole che si sono veri cati nel 1874 e nel 1882; ricordiamo che questi eventi avvengono con uno schema che si ripete ogni 243 anni, con coppie di transiti separate da un intervallo di 8 anni che si ripetono in periodi di 121,5 e 105,5 anni.
Il Merz-Dallmeyer di Rozzano è un raro esempio di strumento scienti co costruito da quelli che all’epoca erano due dei più importanti marchi europei del settore. Di questo telescopio se ne conoscono solo alcuni pochi esemplari al mondo,

ma tutti esposti in musei e non utilizzabili (uno è ai Royal Museums di Greenwich a Londra).
Accanto allo strumento storico è presente un telescopio Meade ACF 16” da 40 centimetri di diametro, provvisto di camere di ripresa, con il quale si possono fare attività di ricerca scienti ca, soprattutto astrometria di pianeti e fotometria di asteroidi. Grazie a particolari ltri, si riesce a eliminare buona parte dell’inquinamento luminoso, con l’aiuto delle camere di ripresa digitali, che permettono di avere un’e cienza quantica vicino al 95%.
Per le osservazioni diurne, il Gar dispone anche di un telescopio solare, con ltro H-alfa e modulo double-stack che ne abbassa ulteriormente la banda passante, in modo da poter osservare molto bene i dettagli della super cie solare e fotografarli, per studiare le variazioni dell’attività solare.
L’obiettivo del Gar (www. astro lirozzano.it) è di perseguire la divulgazione scienti ca e la condivisione delle bellezze dell’Universo ai cittadini di tutte le età, oltre ad attirare l’attenzione degli specialisti e collaborare con enti di ricerca, mettendo a disposizione la propria strumentazione e gli spazi di lavoro dell’osservatorio astronomico. La nuova struttura si trova presso il centro culturale Cascina Grande, in via Togliatti 105 a Rozzano (MI). Per informazioni, rivolgersi all’e-mail info@astro lirozzano.it oppure su Facebook (Gruppo Astro li Rozzano) o su Instagram (@gruppoastro lirozzano).













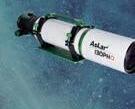


OSSERVIAMO E FOTOGRAFIAMO I CURIOSI FENOMENI GENERATI DALLA LUCE SOLARE NELLA NOSTRA ATMOSFERA
» La zona blu visibile sopra l’orizzonte è l’ombra della Terra che sale subito dopo il tramonto del Sole. La zona color porpora sopra l’ombra è la Cintura di Venere. Fotocamera Canon Eos 1DxMk2, obiettivo Sigma Art 50 mm f/1,4 chiuso a f/2,8; posa di 1/60 s.
In un precedente articolo dedicato al Cielo di giorno (vedi Cosmo n. 33), abbiamo esaminato una serie di fenomeni che possiamo osservare e fotografare in cielo anche quando splende il Sole: arcobaleni, aloni, pareli e colonne di luce. In queste pagine ci dedichiamo ad altri fenomeni ottici che possiamo vedere nell’atmosfera diurna, per scoprirne l’origine e apprezzarne (e fotografarne) la spettacolarità.
LA GLORIA DEI SANTI
Tecnicamente, il “gloria” è un fenomeno ottico visibile in direzione opposta al Sole e di non facile osservabilità, poiché è molto tenue. Supponiamo di stare sulla cima di una collina mentre alle nostre spalle brilla il Sole. La nostra ombra viene proiettata sulle gocce d’acqua delle nebbie sottostanti e viene apparentemente trasformata in una silhouette a forma di piramide, con il suo vertice nel punto antisolare, ed è lì che appare l’ombra della nostra testa. Questa ombra prende il nome di Spettro di Brocken, mentre l’aureola che avvolge le ombre è il gloria. Brocken è la più alta vetta della catena dell’Harz, in Germania dove il fenomeno non è così raro. Però, una delle prime manifestazioni del fenomeno risale al 1736 e fu descritta da una spedizione francese nelle Ande del Perù. Famoso è il “gloria del pilota”, cha mostra l’ombra di un aereo in volo, proiettata sulle nubi sottostanti, circoscritta da un’aureola con i colori dell’iride.
Poiché l’aureola circonda sempre l’ombra dell’osservatore, in passato è stata considerata come un fenomeno da associare al divino. Secondo il sico americano Robert Greenler, le aureole disegnate dietro le immagini dei santi sarebbero un’interpretazione mistica del gloria. Anche in Cina questo fenomeno ha una connotazione spirituale e viene chiamato “Luce di Budda”.
Le aureole possono formarsi anche intorno a oggetti astronomici in particolari condizioni atmosferiche. Quando la luce del Sole penetra nelle gocce di acqua degli altocumuli o dei cirri, viene rifratta e in presenza di cristalli di ghiaccio con le stesse dimensioni delle goccioline d’acqua nelle nubi si forma una corona circolare dai colori brillanti intorno alla nostra stella; lo stesso fenomeno si può veri care con la luce lunare o con quella di un astro molto brillante. Se le particelle sono invece di ormi, si generano bellissime nuvole iridescenti. Corone e iridescenze sono fenomeni che per la loro bellezza e variabilità non smettono mai di sorprendere e a ascinare gli osservatori.

L’80-85% della luce del Sole riesce a raggiungere direttamente il suolo senza subire le interferenze dell’atmosfera, mentre il rimanente 15-20% subisce il fenomeno della di usione (scattering), che determina la variazione della luce dal suo percorso originale quando colpisce una particella. Questo fenomeno dipende dalla lunghezza d’onda della luce e così la luce bianca viene dispersa nei colori dello spettro dalla di usione atmosferica. È così che si determinano i colori del cielo
Le molecole dell’aria (principalmente azoto e ossigeno) hanno dimensioni simili
alla lunghezza d’onda della luce e in queste condizioni la di usione della luce avviene in misura inversamente proporzionale alla quarta potenza della sua lunghezza d’onda. La luce viene di usa in tutte le direzioni, ma in misura decrescente dal viola verso il rosso. All’occhio giungono tutti i colori, ma il cielo sereno appare “azzurro” perché la componente
blu della luce solare viene di usa maggiormente. Nell’atmosfera sono però presenti anche altre particelle (polveri e vapori), con dimensioni maggiori della lunghezza d’onda della luce, che di ondono la luce in misura indipendente dalla lunghezza d’onda. Sono queste particelle che attenuano la vividezza dell’azzurro, così talvolta il cielo diventa biancastro.
Ma quando i venti secchi allontanano queste particelle e rendono l’aria limpida, il colore diventa blu intenso. Un fenomeno legato a questo e etto è quello dei raggi crepuscolari, fasci di ombre alternati a fasci di luce bluastra generati dall’interazione tra la luce solare e le nubi che possono trovarsi sopra o sotto l’orizzonte. Questi fasci di luci e ombre sembrano

Le Astrofile (gruppo di sole donne astrofile) hanno creato una gallery di foto di fenomeni ottici. Le immagini vengono premiate settimanalmente col nome di Wopod (Women’s Optic Picture Of the Day). L’idea è nata dopo la creazione degli Apod femminili (Wapod), e vuol essere uno stimolo a osservare ma anche a divulgare queste meraviglie che l’atmosfera ci regala.
I Wopod si possono vedere su Instagram alla pagina wapod_astrofile e su Facebook alla pagina astrofilepage
In figura, una delle foto premiate con il Wopod: un alone solare ripreso da Elena Pinna da Tallin, in Estonia.

divergere per un e etto prospettico, ma in realtà sono paralleli fra di loro e provengono da un punto che sembra in nitamente lontano: il Sole. In casi particolari questi raggi percorrono tutta la volta celeste per tornare a congiungersi nel punto antisolare, assumendo in questo caso il nome di raggi anticrepuscolari Con il nome di raggi crepuscolari vengono chiamate anche le ombre delle nuvole che si formano a qualsiasi ora del giorno. Si possono vedere per no sott’acqua. La causa di questi raggi è la di usione della luce solare determinata da particelle come la polvere e i vapori che compongono foschie e nebbie.
I raggi anti crepuscolari persistono anche dopo il tramonto e sembrano sollevarsi ed allargarsi man mano che si innalza il cono d’ombra della Terra, cioè l’ombra che il nostro pianeta proietta sull’atmosfera. Il cono d’ombra sorge a est dopo il tramonto (e tramonta a ovest prima dell’alba). Si può osservare come una banda di colore blu scuro, bassa e larga sull’orizzonte, schiacciata tra l’orizzonte e l’arco anticrepuscolare. Quando il cielo è particolarmente limpido, il bordo superiore dell’ombra si arrossa e prende il nome di “Cintura di Venere”. L’arco anticrepuscolare è una fascia posta sopra il punto antisolare, mentre l’arco crepuscolare si localizza simmetricamente sopra la zona del tramonto.
CARICATE LE VOSTRE FOTO ASTRONOMICHE SU BFCSPACE.COM
LA REDAZIONE SCEGLIERÀ LE MIGLIORI PER “LE VOSTRE STELLE”
SONO TAGGATE DA UNA STELLA LE FOTO CHE HANNO VINTO LE NOSTRE SFIDE SOCIAL INQUADRA IL QR PER VISITARE LA GALLERY DELLE FOTO

CRESCENT NEBULA (NGC 6888) NEL CIGNO
Ripresa da Casamassima (BA) il 28/05/2023
Telescopio TecnoSky RC8 Carbon f/8 su montatura EQ6 R Pro
Camera Zwo Asi 294 MC Pro con filtri
Optolong L-Ultimate e L-Pro
Guida con Zwo Asi 290 MM Mini
Pose: 87x300 s con Optolong L-Ultimate e 35x300 s con Optolong L-Pro elaborate con PixInsight, Photoshop 2023
NGC 6888 è distante 5000 anni luce ed è creata dal materiale espulso dalla violenta stella centrale, di tipo Wolf-Rayet
Autore: Davide Nardulli, Casamassima (BA).

Ripreso da Pieve di Soligo (TV) il 2/07/2022
Telescopio Askar Fma180 su montatura Heq5 Pro
Camera Asi 294 MC Pro con filtro L-eNhance
Guida con S-W 150/750 mm e camera Asi 224 MC
Pose: 22x600 s elaborate con PixInsight e Lightroom
In basso a destra si vede la Crescent Nebula (NGC 6888)
Autore: Patrizia Mazzucato, Pieve di Soligo (TV).


Ripreso da Ferrara il 28/05/2023
Telescopio Konus 200/1000 mm su montatura EQ6 R Pro
Camera Qhy 168c con ltri Optolong L_Ultimate, SvBony SII 7nm, SvBony UV/IR-cut
Guida con 60/240 mm, Barlow 2x e Asi 290 Mini
Pose: Optolong L_Ultimate 119x300 s (gain 11, o set 60), SvBony SII 7nm 78x300 s (gain 11, o set 60), SvBony UV/IR-cut 147x30 s (gain 1, o set 30)
Elaborazione: DSS, APP, PixInsight, Photoshop
La Hubble palette evidenzia i tre elementi di cui è ricca la nebulosa: idrogeno, ossigeno e zolfo ionizzati.
Autore: Massimo Di Fusco, Ferrara.
Riprese dal Deserto del Kalahari (Namibia) il 20/04/2023
Telescopio Samyang 135 mm su montatura AP 1200
Fotocamera Canon 6D
Pose: 20x3 minuti a 1600 Iso elaborate con PixInsight.
Autore: Alessandro Cipolat Bares, Aosta.



Ripresa nell’Orsa Maggiore da Margine Rosso (Sardegna) il 22/05/2023
Telescopio C11 ridotto a f/6,3 su montatura AZ-EQ6 Pro
Camera Asi 2500 MC Pro con filtro Optolong 2” L-pro
Guida con Sky-Watcher 70/500 mm f/7,1 e Asi 178 MC Pro
Pose: 41x300 s, elaborate con Dss, PixInsight, Photoshop
Distante 21 milioni di anni luce, la supernova di tipo II scoperta il 19 maggio 2023
dall’astronomo Koichi Itagaki è la più vicina degli ultimi dieci anni.
Autore: Lorenzo Busilacchi, Quartu S. Elena (CA).
INCONTRI CELESTI ALL’ALBA A CAPO PASSERO

Una meteora sorvola l’incontro tra Luna, Pleiadi e Giove a Portopalo di Capo Passero (SR) il 16/06/2023
Fotocamera Canon 6D Mark II con obiettivo Sigma DG 50 mm f/1,4 a f/2,8 su cavalletto Manfrotto
Posa di 5 s a 3200 Iso elaborata con Lightroom e Photoshop.
Autore: Gianni Tumino, Ragusa.
Inquadra il QR per un video in time-lapse di questo incontro celeste prodotto dall’autore.


Ripresa da Modena l’8/02/2023
Telescopio Apm SD Apo 140 mm f/4,6 su montatura iOptron Gem45
Camera Zwo Asi 533 MC Pro con ltri Optolong L-Ultimate e Optolong UV IR cut
Guida con Zwo Asi 220 MM Mini e Zwo Oag-L
Pose: 111x600 s con L-Ultimate, 30x60 s con Uv Ir cut.
Elaborazione: Astro Pixel Processor, PS 2022, Topaz Denoise, Starnet v2, Siril 1
Scoperta da Harold e Charles Lower nel 1939, Sh2-161 è una nebulosa a emissione
situata sul bordo più esterno della Via Lattea tra il braccio di Orione e quello di Perseo.
Autore: Andrea Arbizzi, Modena.

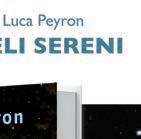

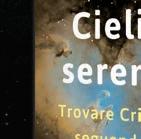
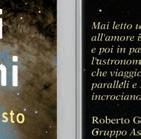
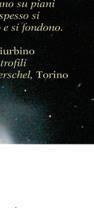


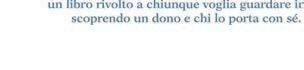


Ripresa da Gualdo Tadino (PG) il 18/10/2022
Telescopio Gso RC14 f/8 su montatura iOptron Cem120 EC
Camera Moravian G3 16200 con ltri L, RGB, H-alfa, OIII, SII
Guida con Starlight Xpress Lodestar X2

Pose: L 30x600 s bin 1x1, R 6x600 s bin 2x2, G 6x600 s bin 2x2, B
6x600 s bin 2x2, 11 dark, 11 at, 11 bias, elaborate con PixInsight.
Autore: Francesco Ciavaglia, Gualdo Tadino (PG).
Lo sconto è computato sul prezzo di copertina al lordo di offerte promozionali edicola. La presente offerta, in conformità con l’art.45 e ss. del codice del consumo, è formulata da Blue Financial Communication S.p.A. Puoi recedere entro 14 giorni dalla ricezione del primo numero. Per maggiori informazioni visita il sito www.abbonamenti.it/cga
Invece di 58,80€
*24,90€ + 5€ come contributo spese di spedizione, per un totale di 29,90€ (IVA inclusa) invece di 58,80€.
VERSIONE DIGITALE INCLUSA
COME ABBONARSI
www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
Mail: abbonamenti.bfc@pressdi.it
POSTA
Spedisci la seguente cartolina in busta chiusa a:
DIRECT CHANNEL SPA C/O CMP
BRESCIA
Via Dalmazia 13 - 25126 Brescia (BS)
TELEFONO
Chiama il numero
02.7542.9001
Attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Sì, mi abbono a FORBES per 1 anno (12 numeri inclusa l’edizione digitale) con lo sconto del 58%. Pagherò 24,90€ (+ 5€ di spese di spedizione per un totale di 29,90€ IVA inclusa) invece di 58,80€.O erta Valida solo per l’Italia.




Cognome Indirizzo
Il pagamento dell’abbonamento è previsto in un’unica soluzione con il bollettino postale che ti invieremo a casa
Se preferisci pagare con carta di credito collegati al sito www.abbonamenti.it/forbesitalia2020
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 da BLUE FINANCIAL COMMUNICATION, con sede in Via Melchiorre Gioia 5520124 Milano, titolare del trattamento, al fine di dar corso alla tua richiesta di abbonamento alla/e rivista prescelta. Il trattamento dei tuoi dati personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’abbonamento e/o per un ulteriore periodo di tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare del trattamento potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporsi a tale trattamento sin d’ora spuntando la seguente casella o in qualsiasi momento contattando il titolare del trattamento. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, il titolare del trattamento potrà e ettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il titolare del trattamento ha nominato DIRECT CHANNEL SPA, responsabile del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il DPO del titolare del trattamento è Denis Masetti, contattabile a +39023032111. Potrai sempre contattare il titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@ bluefinancialcommunication.com nonché reperire la versione completa della presente informativa all’interno della sezione Privacy del sito www.abbonamenti. it, cliccando sul nome della rivista da te prescelta, dove troverai tutte le informazioni sull’utilizzo dei tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento nonché tutte le ulteriori informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le modalità per l’esercizio del diritto di revoca.


rilascio nego il consenso per le attività di marketing indiretto rilascionego il consenso per le attività di profilazione
Siete pronti a esprimere i vostri desideri con Cosmo kid? Oggi partiamo alla ricerca delle meteore.
E lo facciamo proprio nel mese in cui possiamo osservare le più famose dell’anno, le Perseidi (vedi a pag. 61).
Viaggiando insieme alla Terra intorno al Sole, ogni anno incontriamo numerose scie di detriti interplanetari, gli “sciami meteorici”, che principalmente rappresentano il materiale rilasciato dalle comete dopo il loro passaggio. Oltre alle Perseidi, abbiamo le Quadrantidi, le Alfa Centauridi, le Tauridi meridionali, le Orionidi, le Leonidi e altre ancora; tutti sciami che conosciamo per la loro luminosità nel cielo e per la quantità di meteore visibili nell’arco di un’ora, misurate dal parametro chiamato Zhr (zenithal hourly rate). Le meteore sembrano provenire da un medesimo punto del cielo, detto “radiante”, che è situato nella costellazione che dà anche il nome allo sciame stesso: per esempio, il radiante delle Perseidi si trova nella costellazione di Perseo.
Le meteore (chiamate popolarmente “stelle cadenti”), sono fenomeni prodotti da piccoli frammenti di materia, spesso di dimensioni simili a un granello di sabbia, chiamati meteoroidi, che entrano nell’atmosfera terrestre a velocità elevate. Bruciando per l’impatto con l’aria atmosferica si disintegrano, emettendo scie luminose e colorate. Se un meteoroide ha dimensioni tali da non bruciare completamente durante l’attraversamento dell’atmosfera, può giungere in forma solida sulla super cie terrestre, diventando così un meteorite Ma con quale velocità i meteoroidi entrano nella nostra atmosfera? Finché non risentono dell’attrazione gravitazionale, la loro velocità è simile a quella che occorrerebbe per potersi allontanare dal pianeta Terra, senza ricadere giù.
È la cosiddetta velocità di fuga, pari a 11,2 chilometri al secondo. Quando i meteoroidi iniziano ad avvicinarsi e a risentire del campo gravitazionale terrestre, possono raggiungere i 72 km/s, e iniziamo a vedere gli e etti del loro ingresso in atmosfera quando si trovano a circa 100 km dal suolo. Quando una meteora è particolarmente luminosa, viene chiamata bolide o
reball, perché sembra assumere le caratteristiche di una palla di fuoco. Si tratta di eventi eccezionali e imprevedibili, ma gi avvistamenti sono numerosi, anche grazie alle reti di sorveglianza automatica, come le telecamere di Prisma, la “Prima Rete Italiana per la Sorveglianza di Meteore e Atmosfera”, coordinata dall’Inaf (prisma.inaf.it).
L’attrito generato dall’incontro dei meteoroidi con l’alta atmosfera genera scie luminose di diverso colore, dove i colori corrispondono alla composizione chimica di questi piccoli corpi celesti, ma dipendono anche dalla loro velocità all’interno dell’involucro di gas della Terra, che viene dedotta dallo spettro di luce delle meteore. I meteoroidi possono essere rocciosi e composti da silicati (di cui è costituita principalmente la parte esterna della crosta terrestre), oppure metallici e quindi composti da una composizione di ferro e nichel. Più precisamente, possiamo indicare le corrispondenze riportate in tabella tra i colori delle meteore e gli elementi chimici (del meteoroide o dell’atmosfera) che li hanno prodotti. Una analisi più accurata della composizione chimica delle meteore richiede però la produzione di uno spettro, cioè la distribuzione in


I COLORI DELLE METEORE COLORE ORIGINE
Rosso Azoto e ossigeno atmosferici
Giallo-arancioSodio
Blu-verdeMagnesio
Giallo Ferro
Viola Calcio
lunghezze d’onda della sua radiazione luminosa. Per ottenere lo spettro di una meteora, si può utilizzare una fotocamera dotata di reticolo di di razione e impostata a 20-30 secondi di esposizione. L’immagine che si ottiene, esaminata con sistemi fotometrici, cioè andando a misurare l’intensità della radiazione registrata in ogni punto dello spettro, consente di ricavare dei gra ci di intensità in funzione della lunghezza d’onda dello spettro, dove i picchi del gra co sono collegati agli elementi chimici che li hanno generati, come un codice a barre naturale. Non sono operazioni facili, a causa della rapidità di movimento delle meteore e della loro breve durata (pochi secondi). Inoltre, durante il suo percorso in atmosfera lo spettro di una meteora può cambiare, presentando diverse tonalità lungo tutta la sua scia luminosa.
Come attività per i più piccoli, toccheremo con mano i colori delle
meteore, associandoli anche alla loro composizione chimica. Come al solito, basteranno pochi elementi e il divertimento sarà assicurato. Materiale occorrente: una forma di cartoncino nero (rettangolare o quadrata), gessetti policromatici di colore bianco, viola, verde e verde chiaro, giallo, arancio e rosso. Ci serviranno anche cinque sassolini porosi/bucherellati, una matita bianca, un paio di forbici e la colla a caldo. Disegniamo sul cartoncino nero, con la matita bianca, cinque pallini bianchi e le scie delle meteore. Poi, con l’aiuto della lama metallica della forbice, “temperiamo” il gessetto policromatico rosso, per ottenere un po’ di polvere da sfumare sulla meteora 1. Ottenuta la sfumatura, disegniamo con lo stesso gesso il contorno della meteora. Poi operiamo allo stesso modo per le altre meteore, abbinando i colori in questo modo:
- meteora 2: polvere gialla e contorno arancione;
- meteora 3: polvere verde chiaro e contorno verde scuro;
Cosmo Kid è una rubrica astronomica a misura di bambino. Con l’intento di avvicinare non solo i bimbi appassionati al cosmo, ma anche quelli che hanno il piacere di stupirsi e di porsi domande davanti al cielo stellato. Tramite il gioco e le immagini, mostriamo ciò che della volta celeste non si può vedere nell’immediato e o riamo spunti per un viaggio personale e fantastico dentro l’Universo. Ma Cosmo appartiene anche ai lettori, e così invitiamo appassionati, insegnanti, genitori a farsi avanti con suggerimenti o richieste, scrivendo a info@ bfcmedia.com
Ecco le puntate precedenti, tutte a cura di LauraCiternesi:
•Il Sole “impuro” di Galileo, Cosmo n. 32
•Di che colore è la Luna?, Cosmo n. 34
•Una cometa nel freezer, Cosmo n. 35

•Di che colore sono le stelle?, Cosmo n. 36
•Tutti i colori di Giove, Cosmo n. 37
- meteora 4: polvere bianca e contorno viola;
- meteora 5: polvere bianca mischiata a quella gialla e contorno azzurro.
A questo punto, con la colla a caldo formiamo cinque pallini nei punti in cui abbiamo disegnato i pallini bianchi e applichiamo un sassolino a ciascuno di essi. Questi sassolini rappresentano i meteoroidi che diventano meteore. In ne possiamo scrivere come titolo “I colori delle meteore” e aggiungere i nomi dei colori con gli elementi chimici corrispondenti.
Inquadra il QR per un video tutorial che spiega come “colorare le meteore”.

Dal 2 luglio in edicola!




Scopri la nuova Guida de L’Espresso: il nuovo sistema di comunicare la qualità italiana
La scheda completa di mille vini con storia, foto della cantina, della bottiglia e la valutazione fatta da Luca Gardini, il miglior palato del mondo. Etichette di eccellenza e abbinamenti consigliati ti aiuteranno a scegliere il vino perfetto per te.
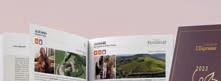

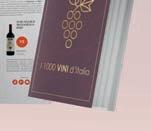


In edicola e nelle migliori librerie.
Acquista subito la guida e scarica l'app per avere tutto il mondo del vino a portata di mano!




Le “stelle cadenti” che vediamo sfrecciare nel cielo soprattutto in determinati periodi dell’anno non sono altro che granelli di polvere o piccoli sassi spaziali che, entrando ad alta velocità nell’atmosfera terrestre, si in ammano, disgregandosi completamente. In passato, si credeva che le meteore fossero stelle che si staccavano dal rmamento e questi fenomeni erano considerati dei presagi di sventure.
Però esistono davvero delle stelle che “cadono”, anche se questo non accade nella nostra atmosfera, fortunatamente (in tal caso, sarebbe il nostro pianeta a cadere nella stella!). Si tratta di stelle che si muovono nello spazio ad alta velocità, talvolta lasciando spettacolari nubi di polvere e gas sulla loro scia.
Dal 2005 al 2014, un monumentale
programma di osservazione che comprendeva la Sloan Digital Sky Survey e i telescopi del Fred Lawrence Whipple Observatory ha confermato che esiste una classe di stelle che si muovono a velocità folli, talmente alte da poter sfuggire alla gravità delle loro galassie di origine. Schegge impazzite, insomma, che sfrecciano nello spazio intergalattico a milioni di chilometri all’ora. Sono le “stelle iperveloci”.
La capostipite è S5-HVS1, trovata nel 2005 da un gruppo di ricercatori dell’Osservatorio MMT in Arizona osservando le stelle nell’alone della Via Lattea, in fuga dalla Galassia alla velocità di quasi 3,2 milioni di km/h. Un altro esempio è la stella HE 04375439, in fuga dalla Grande Nube di Magellano (Lmc) a 2,6 milioni km/h e attualmente impegnata in un viaggio di sola andata verso le profondità del cosmo. A rigore, più che di “stelle cadenti” si dovrebbe
parlare di “stelle in fuga”. Da cosa hanno origine queste gigantesche pallottole di idrogeno che sfrecciano nel cosmo?
L’idea che ha fatto germinare il seme della risposta è partita da Jack Gilbert Hills, un teorico dei Los Alamos National Labs che, nel 1988, pensò a cosa potesse succedere se un sistema stellare binario viaggiasse vicino al buco nero supermassiccio che si trova nel centro di una galassia. Le forze mareali del buco nero potrebbero dividere irrimediabilmente in due il sistema, strappando le due stelle che lo compongono al valzer cosmico che stavano ballando.
Quando si veri ca un fenomeno del genere, una delle due stelle potrebbe guadagnare abbastanza energia da essere letteralmente sparata fuori dalla galassia, mentre l’altra stella rimane in orbita attorno al buco nero. Anche gli eventuali pianeti in orbita attorno alla
» In alto: un’illustrazione della stella iperveloce HE 0437-5439 sovrapposta a una ripresa della Lmc eseguita dal Very Large Telescope dell’Eso in Cile. La fuga di questa stella è un indizio che anche all’interno della Lmc si cela un super buco nero. A sinistra: un illustrazione artistica di una stella in fuga da una galassia.

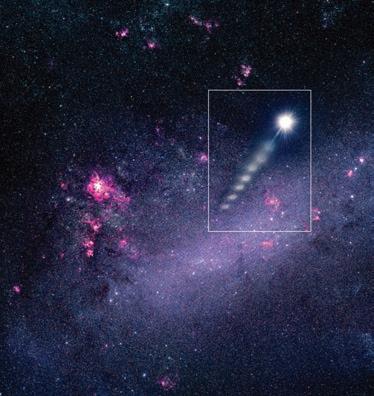
stella verrebbero scaraventati fuori dalla galassia a velocità che possono raggiungere i 15mila chilometri al secondo. Può anche accadere che le due stelle si schiantino l’una contro l’altra, per fondersi in un’unica stella molto massiccia. Oggi gli astronomi conoscono migliaia di stelle
iperveloci, ma non tutte lasciano la loro galassia (vedi nelle Spacenews un’ipotesi di migrazione stellare tra la nostra Galassia e M31). Lo studio di queste stelle potrebbe o rire indizi sulla natura e sulla distribuzione della materia oscura nell’Universo e aiutare a comprendere se al centro
delle galassie è presente un grande buco nero o più di uno. Anche nella nostra.

Guidare adulti e bambini alla scoperta delle meraviglie del cielo a occhio nudo e all’oculare dei telescopi è una delle principali missioni dell’Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia (Orsa) di Palermo, delegazione territoriale dell’Unione astro li italiani (Uai). Per avvicinare il pubblico alla conoscenza degli astri, gli esperti dell’Orsa organizzano durante tutto l’anno eventi divulgativi e osservativi, che in estate - date le condizioni meteo più favorevoli - si intensi cano, per la gioia di tutti gli appassionati di astronomia e dei semplici curiosi del cielo. A illustrarci le iniziative di divulgazione in programma, le attività portate avanti dai soci, la storia e i progetti futuri dell’Orsa - solido punto di riferimento culturale per tutto il territorio siciliano - è il presidente dell’associazione Gaspare Maniscalco.
L’Orsa si costituisce con atto notarile il 23 novembre del 1984, ma esisteva già in forma non u ciale nel 1982, grazie all’intraprendenza di Dario Giambra, uno dei soci fondatori. L’Orsa promuove l’incontro e la collaborazione tra i propri membri con l’obiettivo di divulgare le scienze astronomiche e di incentivare gli studi e la ricerca nel settore. In breve tempo, ai suoi undici soci fondatori se ne sono aggiunti altri e la crescita continua tuttora.
L’associazione attualmente non ha una sede a Palermo e molte riunioni vengono svolte in modalità online su varie piattaforme. Disponiamo di un Osservatorio astronomico nel comune di Ventimiglia di Sicilia, in
provincia di Palermo, dove svolgiamo la maggior parte delle nostre attività divulgative e di ricerca astronomica amatoriale. All’interno della cupola, dedicata a uno dei nostri soci fondatori, il compianto Giorgio Puglia, è installato un telescopio in con gurazione Newton autocostruito da noi soci nel 1986. Lo specchio primario è in vetro Duran 50 da 412 mm con una focale di 1790 mm. L’associazione dispone anche di altri strumenti amatoriali utilizzati durante gli eventi serali aperti al pubblico, di un planetario digitale itinerante e di un ampio salone per le conferenze all’interno dell’osservatorio.
Per i mesi di agosto e settembre, abbiamo organizzato molte serate osservative per avvicinare adulti e bambini al mondo dell’astronomia presso il nostro osservatorio. Veniamo da un mese di luglio molto proli co, durante il quale abbiamo organizzato la XXIII edizione del nostro tradizionale Star Party, che ha visto quest’anno la partecipazione del pluripremiato Dario Giannobile e di altri bravissimi astrofotogra siciliani, pionieri del settore, come Gianni Tumino e il “nostro” Carmelo Zannelli.
Siamo stati inoltre co-organizzatori di un evento al Castello di Carini (PA), al quale ha partecipato come ospite il divulgatore Adrian Fartade, e abbiamo preso parte a serate divulgative in vari comuni del Palermitano.
Nelle nostre attività lasciamo al cielo il ruolo di protagonista. I nostri divulgatori Jan Mariscalco e Simone Lentini illustrano le costellazioni visibili nel

periodo, raccontando i miti greci e arabi a esse legati. Ai telescopi i nostri esperti operatori, guidati dal direttore dell’osservatorio Toty Pitarresi, mostrano i principali oggetti celesti visibili. Oltre a organizzare eventi divulgativi e osservativi aperti al grande pubblico, o riamo saltuariamente ai principianti e ai curiosi del cielo dei mini-corsi di astronomia.
L’attività didattica nelle scuole è sempre stata una delle priorità dell’Orsa. Ultimamente, abbiamo partecipato a diversi progetti Erasmus e stiamo cercando di intensi care questo tipo di attività, perché bambini e ragazzi sono molto a ascinati dall’astronomia e mostrano grande entusiasmo per i nostri eventi. Una delle nostre missioni è quella di accendere ancora più curiosità in questi ragazzi.
I nostri soci sono suddivisi in gruppi di lavoro focalizzati sulla ricerca di supernovae, sull’attività di fotometria e sull’astrofotogra a.
Il nostro Angelo Gambino organizza periodicamente sessioni di astrofotogra a presso luoghi caratterizzati da cieli bui, che fortunatamente non mancano in Sicilia. Attualmente lavoriamo freneticamente per implementare un upgrade della strumentazione ausiliaria del nostro osservatorio, con l’obiettivo di inserirlo nel network di osservatori dediti allo studio astrometrico e fotometrico


di asteroidi, esopianeti e di stelle variabili, avvalendoci del contributo di alcuni soci con esperienza in campo astro sico.
STORIA ASSOCIATIVA?
Sono tanti gli episodi da ricordare in tutti questi anni di attività, come le collaborazioni con Walter Ferreri, con Margherita Hack, con Livio Scarsi e con Paolo De Bernardis Sicuramente un episodio chiave della storia associativa è stato il “regalo” di Amleto Pezzati, uno dei primi astro li palermitani. Amleto ha donato all’Orsa una corona dentata in bronzo di circa 30 cm di diametro, relativa vite senza ne e un motoriduttore alimentato in ca 24 V,
cioè i “semi” per realizzare il telescopio sociale che oggi è il nostro strumento principale e il nostro vanto.
Il nostro progetto - sogno di quasi tutte le associazioni come la nostra - è quello di realizzare un piccolo centro astronomico che possa diventare anche il fulcro delle nostre attività. Per tutti i nostri progetti e le nostre attività rimandiamo gli interessati al nostro sito internet orsapa.org e alla pagina Facebook orsapalermo.

Lo spazio raccontato a Matera dalla Sparkme Space Academy affascina e conquista l’interesse di curiosi, appassionati e studenti di ogni ordine e grado. Non solo lucani, ma anche provenienti dalle altre regioni italiane, con una partecipazione che va ben oltre ogni aspettativa iniziale.
La struttura scientifica dedicata all’istruzione e alla divulgazione della scienza e dello spazio, creata da Openet Technologies, una società materana che si occupa di connettività satellitare, in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi), intende accendere l’interesse sulle discipline Ste(a)m

che attualmente offrono le maggiori opportunità occupazionali.
UN GIORNO
DA ASTRONAUTA
Il successo dell’Academy è frutto della originalità dell’offerta scientifica e culturale che regala al visitatore una “Giornata dell’Astronauta”, perché lo porta in una missione spaziale,
» Spettacolo al Planetario dell’Academy. Per info, vedi il sito www.sparkme.space, e-mail contactpoint@sparkme.space
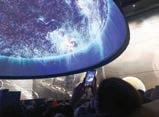
con un viaggio che parte dalla Terra e si dirige verso la Luna e Marte, il sogno di grandi e piccini. Strada facendo, si incontrano il Planetario, con uno zoom su Luna e pianeti del Sistema solare, la Stazione spaziale internazionale (Iss), dalla quale attraverso sette nestre si osserva il nostro “pianeta blu”, e il cinema 5D, che regala un’esperienza immersiva e coinvolgente tra stelle e meteoriti, grazie a speciali sedili attrezzati e visori. Tra le rocce e la sabbia marziana si aggirano in ne i Robomars, che esplorano il territorio alla ricerca di tracce di vita.
Inoltre, l’Academy ospita una mostra curata da Asimof (Associazione
italiana modelli fedeli) costituita da modelli accurati di molti mezzi e dispositivi che appartengono alla storia dell’esplorazione spaziale: Saturn V è il razzo che ha portato gli astronauti delle missioni Apollo sulla Luna, Starship è il vettore di lancio più alto e potente mai costruito, lo Space Launch System è il sistema di lancio orbitale non riutilizzabile derivato dallo Space Shuttle. In esposizione anche il modulo di comando Columbia della missione Apollo 11, che ha portato Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin verso la Luna e al primo sbarco umano del 20 luglio 1969 sul nostro satellite, e la Vostok, il
Nello scorso mese di giugno si è tenuta a Matera la Space2Connect Conference (space2connect.esa.int), organizzata dall’Esa in collaborazione con l’Asi e Openet Technologies, per fare il punto sulle nuove soluzioni spaziali (commerciali e istituzionali) che intendono favorire i collegamenti satellitari globali. Ai circa quattrocento delegati del settore aerospaziale provenienti da tutto il mondo è stato presentato uno dei più importanti progetti sviluppati da Openet Technologies in questi anni. Si tratta di One Class!, il servizio che si pone l’obiettivo di trasformare l’isolamento di un territorio attraverso una soluzione di telecomunicazione integrata con piattaforme telematiche didattiche.
One Class! è utilizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per favorire il processo di integrazione socio/educativa dei minori stranieri non accompagnati sin dal loro arrivo nei centri di accoglienza italiani in condizioni di emergenza. Il servizio consente di accedere a una serie di contenuti didattici in uno spazio di apprendimento mobile e facilitare il processo di apprendimento in corsa nella fase iniziale di arrivo in Italia.
Openet è stata protagonista durante Space2Connect anche grazie a un social event ospitato presso la Sparkme Space Academy
primo veicolo spaziale russo ad aver portato nello spazio il cosmonauta Jurij Gagarin. Troviamo anche una riproduzione dello Sputnik 1, il primo satellite arti ciale mandato in orbita intorno alla Terra nel 1957, e il lanciatore Soyuz, il razzo russo utilizzato per lanciare le navicelle Soyuz verso la Iss. Non mancano inoltre i tavoli interattivi per adulti e bambini, che presentano contenuti multimediali riguardanti il cosmo.
La scienza è raccontata all’Academy da donne e uomini che la studiano e la praticano. È il caso di Paolo Nespoli, l’astronauta Esa che lo scorso 16 dicembre, durante la Giornata nazionale dedicata allo Spazio, ha raccontato a circa cento studenti, in diretta dal Cern di Ginevra, la sua esperienza di ben tre viaggi nello spazio. La collaborazione con il Centro nucleare europeo ha messo a segno diversi obiettivi, tra cui una passeggiata virtuale con gli studenti del liceo classico “Emanuele Duni” di Matera alla scoperta di Atlas, l’esperimento sulle particelle nucleari accelerate installato a 100 metri di profondità.
Paola Catapano, giornalista scienti ca al Cern e fondatrice del gruppo di ricerca polare Polarquest2018, ha presentato il suo libro 80° Parallelo nella sede dell’Academy che per l’occasione si è trasformata in un contenitore culturale. Il sito scienti co è stato inserito dal Fondo ambiente italiano nel percorso delle Giornate di Primavera del 25 e 26 marzo scorso e ha ospitato in quei giorni oltre mille visitatori.
Segnalate eventi, mostre, star party a stroppa@bfcmedia.com
ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA CONFERMA
DEGLI EVENTI SUI SITI INDICATI
MONTE BONDONE (TN)
LE INIZIATIVE DELLA “TERRAZZA DELLE STELLE”
AGOSTO E SETTEMBRE
La sede del Muse (Museo delle Scienze) di Trento a quota 1500 m (sito Unesco “connesso al cielo”) organizza una serie di attività di divulgazione astronomica e naturalistica. bit.ly/46bLJXj
LIGNAN, NUS (AO)
SPETTACOLI AL PLANETARIO AD AGOSTO, DAL MARTEDÌ AL SABATO, ORE 16:00 E 18:00
Il Planetario di Lignan o re ai più piccoli uno spettacolo sull’esplorazione dei pianeti del Sistema solare e a tutti uno spettacolo dedicato a costellazioni e oggetti celesti visibili nella stagione estiva. bit.ly/3R5BhrD
MILANO
GALACTIC PARK
23 SETTEMBRE
Si svolge a Milano l’evento principale dell’edizione 2023 di Galactic Park, il festival dedicato a tutti gli appassionati di astro sica, astronomia ed esplorazione spaziale, con eventi, laboratori e spettacoli. bit.ly/3Iv6mna
SANTA MARIA DI SALA (VE)
E...STATE TRA LE STELLE




TUTTI I GIOVEDÌ, ORE 21:00
Il Gruppo Astro li Salese organizza eventi divulgativi, articolati in conferenze su temi di astronomia e astronautica e osservazioni del cielo al telescopio presso l’osservatorio astronomico. bit.ly/3Xo3K0I
VERONA
LUNA IN PIAZZA BRA
25 AGOSTO, ORE 21:00, E 24 SETTEMBRE, ORE 20:00

Il Circolo Astro li Veronesi o re al pubblico un evento dedicato alla scoperta e all’osservazione all’oculare del telescopio della fascinosa Luna. bit.ly/3K8fOwk

SAN PIERO IN CAMPO - ISOLA D’ELBA (LI)
SERATE ASTRONOMICHE AL PIAZZALE DELL’ASTRONOMIA
TUTTI I MARTEDÌ E SABATO, ORE 21:30
Passeggiate astronomiche e osservazioni guidate del cielo. bit.ly/3PJQUrJ
VISITE ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO PROVINCIALE 11 E 25 AGOSTO, 8 E 22 SETTEMBRE ORE 21.30
Gli esperti dell’Unione Astro li Senesi aprono al pubblico l’Osservatorio astronomico di Montarrenti per o rire osservazioni guidate del cielo notturno ai telescopi. bit.ly/3AwPw3I
PIOMBINO (LI)
I VENERDÌ DELL’OSSERVATORIO
TUTTI I VENERDÌ, ORE 21:00
L’Associazione astro li di Piombino apre al pubblico l’Osservatorio di Punta Falcone per o rire tour del cielo stellato a occhio nudo e al telescopio. bit.ly/46f9Ap1
FIRENZE
LE LACRIME DI SAN LORENZO 10 AGOSTO, ORE 21:15
Gli esperti della Società astronomica orentina organizzano presso Villa Vogel un evento dedicato alla scoperta e all’osservazione dello sciame meteorico delle Perseidi. bit.ly/3oAp2KV
BARI
SPETTACOLI AL PLANETARIO
TUTTI I WEEK-END
Presso il planetario di Bari, con cupola di 15 metri di diametro, gli esperti dell’Associazione Andromeda o rono al pubblico spettacoli di astronomia, spettacoli di teatro-scienza e laboratori. bit.ly/3pv1AvZ
ROCCA DI PAPA (RM)
ASTROINCONTRO “STELLE AL PLANETARIO”

1 SETTEMBRE, ORE 20:45




Spettacolo sotto la cupola del planetario, visita guidata al parco astronomico “Livio Gratton” e osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia. bit.ly/447tQXH

Il mondo dei videogiochi negli ultimi trent’anni è esploso e non è una novità; la situazione è evidente non solo per i budget dei titoli in uscita, sempre più alti, ma anche per le industrie che vi crescono insieme. Industrie sempre più grandi, che vogliono riuscire a tutti i costi a produrre il “gioco perfetto”. Condizioni del genere sono ottimali per lo sviluppo di qualsiasi settore; l’abbiamo visto dieci anni fa con gli smartphone e un paio di decenni prima con i personal computer, e infatti ogni anno escono videogiochi sempre più ambiziosi, so sticati e innovativi. Questo mutamento c’è stato, ma dove siamo arrivati? Forse parlare di Dead Space Remake potrebbe rispondere a questa domanda. Si tratta di un videogioco sviluppato da Motive Studio e pubblicato nel 2008 da Electronic Arts, un’avventura di sopravvivenza sci- che si svolge in terza persona, con elementi spaventosi (jumpscare). Nel 2021 il produttore aveva annunciato la produzione di un rifacimento, che è giunto in ne alla pubblicazione all’inizio del 2023.
Uno degli elementi che distinguono questo titolo da altri videogiochi è il “mondo di gioco”, che è completamente ambientato in una enorme astronave mineraria chiamata Hishimura, alla quale il protagonista attracca in seguito al ricevimento di un messaggio di soccorso. L’astronave ha dimensioni veramente colossali ed è praticamente accessibile nella sua totalità: è suddivisa in diverse aree che possono essere esplorate man mano che il gioco procede, anche mediante una sorta di tramvia che deve essere riparata all’inizio del gioco. Il gameplay risulta particolarmente intrigante, dato che l’astronave si rivela infettata da ogni sorta di virus, che devono essere attaccati in maniera intelligente in base alle vulnerabilità di ciascuno di essi. Essendo previste
all’interno dell’astronave delle aree in cui la gravità non è presente, il protagonista può muoversi in queste zone attraverso dei piccoli thruster presenti sulla tuta, che gli permettono di alzarsi e spostarsi liberamente. In generale, il gameplay risultava già “invecchiato” nella versione del 2008, ma questo remake lo modernizza in maniera corretta e bilanciata, a di erenza dei remake di altri titoli storici, che non hanno convinto il pubblico, a causa di scelte legate all’ammodernamento che nivano per distruggere il fascino del gioco originale.
Un elemento di forza della saga, particolarmente apprezzabile in questo remake, è il comparto artistico particolarmente ispirato; così il gioco risulta anche piacevole da guardare. Il modo in cui sono stati
concepiti gli interni dell’astronave è a ascinante, come se ci si trovasse immersi in un lm di fantascienza. Le capacità del motore gra co (l’ultima versione del Frostbite, usato da Electronic Arts anche per altri titoli e sempre distintosi per la sua resa gra ca) rendono il titolo ancora più immersivo. Inoltre, è implementata l’illuminazione basata su ray tracing e quindi si possono notare ri essi di luce molto realistici, grazie a questa tecnologia, che sta diventando un vero e proprio standard nei videogiochi.
La narrativa è ben costruita e i dialoghi sono scritti in maniera uida e interessante: n dall’inizio il gioco riesce a far appassionare alla storia, che gradualmente diventa sempre più complessa e profonda, in modi inaspettati.
La componente horror della narrativa è percepibile e nevralgica; basata su una colonna sonora particolarmente ansiogena e a qualche spavento disseminato lungo il percorso, che alza il grado di immersione nel gioco, trasformandolo in una vera e propria esperienza negli abissi di questa astronave in rovina, giusti cando così il titolo Dead Space
Una grande di erenza dalla versione originale del 2008, a parte la gra ca, la troviamo nella narrazione, dove è stato deciso di far parlare
il protagonista (Isaac Clarke), rimuovendo così nel giocatore quella sorta di immedesimazione nel protagonista che produceva la prima versione. Durante l’esplorazione, viene inoltre o erta la possibilità di leggere documenti che si trovano nascosti e che contengono informazioni su cosa è accaduto alla astronave prima dell’arrivo dei soccorsi.
In un titolo dalla complessità di Dead Space Remake, anche il comparto sonoro ha la sua importanza. Nelle impostazioni di gioco è possibile de nire il numero di tracce sonore prodotte dal videogioco, per esempio due stereofoniche, se si gioca in cu a; oppure no a sei, se si dispone di un impianto surround compatibile. Il gioco presenta una cura nella spazialità del suono davvero degna di nota, in grado di far capire al giocatore da quale punto dello spazio


tridimensionale proviene un rumore, in modo da schivare eventuali pericoli.
Dead Space è uno di quei titoli che chiamare videogioco può risultare riduttivo. È una vera e propria esperienza, come un romanzo o un lm che appassiona; è qualcosa in cui ci si immedesima, al punto da vivere all’interno della Hishimura al posto del protagonista, provando proprio quelle sensazioni che gli scrittori della storia hanno pensato per i giocatori. La cura in ogni dettaglio della storia e del mondo di gioco è davvero molto sviluppata, rendendo Dead Space un titolo in cui ogni componente del gioco risulta organica con le altre, per o rire un’esperienza completa. E le migliorie introdotte con il remake lo rendono ancora più apprezzabile.

TORINO, EDIZIONI L’ETÀ DELL’ACQUARIO, 2023
PAGINE 315 CON ILLUSTRAZIONI IN B/N
FORMATO 14 X 21 CM
PREZZO € 22,00
Un lo rosso unisce gli antichi siti megalitici del Nord-Europa, la civiltà celtica di usa nel nostro continente e la musica tradizionale irlandese. Realtà distanti fra loro secoli e millenni, senza collegamenti diretti, ma idealmente accomunate da un forte legame con la natura e in particolare con il cielo e le stelle. Un legame che si è propagato “come una sta etta virtuale tra mari impalpabili, a partire dalla fredda pietra eretta nella preistoria no a noi, passando attraverso i Druidi, i Magi, i Caldei, i monaci irlandesi”. Così conclude l’autore di questo volume dedicato alla Archeoastronomia dai megaliti ai Celti, il sico Guido Cossard, presidente dell’Associazione di Ricerche e studi di Archeoastronomia Valdostana. E a questa conclusione giunge dopo avere descritto molti megaliti preistorici e analizzato i loro riferimenti astronomici, ipotizzando i loro utilizzi da parte dei Celti che ne intuirono la funzione sacra e i collegamenti celesti. È un’immersione nella cultura celtica, attraverso i suoi simboli, le divinità, i calendari e le feste, che
GIORDANO CEVOLANI
AMAZON, 2023
PAGINE 301 CON 133 FIGURE B/N E COLORE
FORMATO 15,2 X 22,9 CM
PREZZO: € 25,00 (KINDLE € 12,99)

L’eredità della meteorite Renazzo è la seconda edizione di un’opera dedicata alla famosa meteorite caduta il 15 gennaio 1824 nelle campagne di Renazzo, una frazione del comune di Cento, in provincia di Ferrara. Una pubblicazione che avviene in vista del bicentenario di questo evento, come ricorda il sottotitolo del volume. Nella Prefazione, l’autore si chiede “perché scrivere un nuovo libro su questa meteorite?” (la prima edizione risale al 2001). E lui stesso risponde che si tratta di “un documento importante non solo per lo studio dell’Universo, ma della nostra stessa esistenza”. L’importanza della meteorite Renazzo è tale che nel libro viene definita “una sorta di stele di Rosetta per l’astrofisica”. In effetti, rispetto alla prima edizione sono presenti molte parti nuove e aggiornamenti. I primi due capitoli sono dedicati in gran parte alla formazione delle stelle e del Sistema solare. Sono molto utili, nel terzo, la spiegazione delle differenze tra meteora, meteorite e meteoroide, e i metodi di riconoscimento e di raccolta delle meteoriti. Ma i capitoli che ci sono piaciuti di
emergono dai ritrovamenti archeologici e dalle numerose testimonianze di autori classici che hanno narrato dei popoli del Nord. Un’originalità del volume è che è stato scritto, come ci rivela l’autore, ascoltando “musica celtica”; in realtà musica popolare irlandese, che solo idealmente si ricollega a quella dei Celti, di cui non è rimasto nulla. Una tradizione che si è sviluppata nelle aree in cui la civiltà dei Celti è sopravvissuta più a lungo, prima romanizzata e poi cristianizzata, e dove ancora si parlano lingue derivate da quelle celtiche. Cossard consiglia il lettore di tenere in sottofondo questi suoni, e per aiutarlo speci ca in ogni capitolo quali pezzi musicali ritiene più appropriati (tutti reperibili liberamente su YouTube).
Il recensore ha provato a seguire questi consigli e così anche queste righe sono state generate nella stessa atmosfera sospesa tra cielo e terra, tra presente e passato. E futuro.
più sono il quarto, il quinto e il sesto, dove si descrive in forma dettagliata e completa la meteorite Renazzo, un lavoro esclusivo e prezioso che può risultare utile non solo agli appassionati, ma perfino agli specialisti del settore.
A questi capitoli associamo l’ottavo, dove si parla di una meteorite analoga (la Vigarano), caduta quasi un secolo dopo a una ventina di chilometri da Renazzo.
In tutti i capitoli traspare comunque la grande professionalità di Giordano Cevolani, che si ritrova anche, dopo il decimo e ultimo capitolo, in una interessante e molto completa bibliografia sulla meteorite Renazzo e sulle condriti carbonacee del tipo-Renazzo (le cosiddette “meteoriti CR”). Il libro è impreziosito da più di 130 immagini, molte delle quali a colori, e completano il tutto ben 12 pagine di glossario.
Il volume è frutto di una pubblicazione indipendente e si può ordinare su Amazon in formato cartaceo o kindle
Walter Ferreri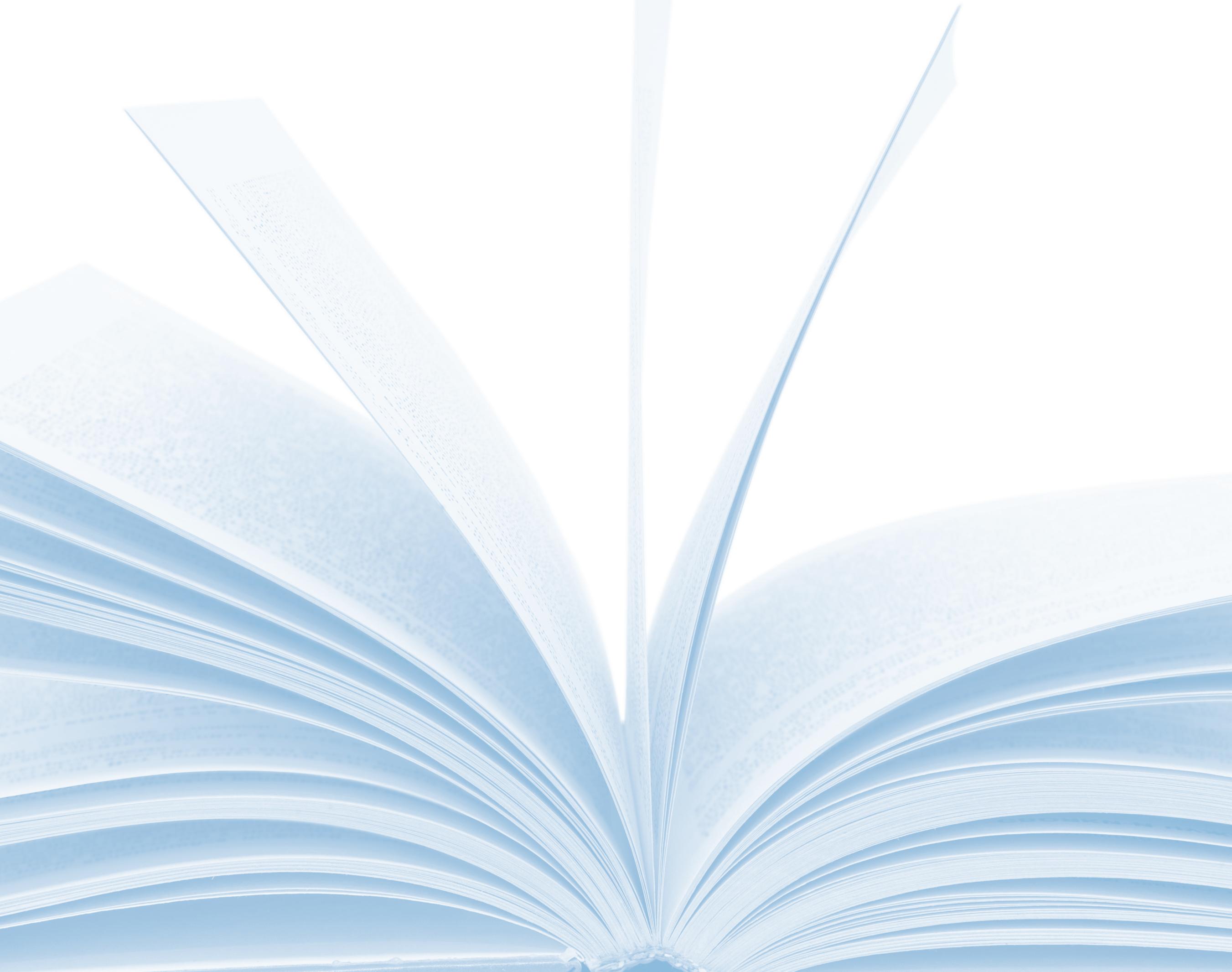
OFFERTA DEDICATA AI LETTORI DI COSMO
Acquista 6 libri a scelta dalla lista al prezzo di 60 euro, spese di spedizione incluse.
La ricerca amatoriale delle supernovae

Giancarlo Cortini, Stefano Moretti
Super-occhi per scrutare il cielo

Walter Ferreri, Piero Stroppa
I pianeti e la vita
Cesare Guaita
I giganti con gli anelli
Cesare Guaita
Alla ricerca della vita nel Sistema Solare
Cesare Guaita
Oltre Messier
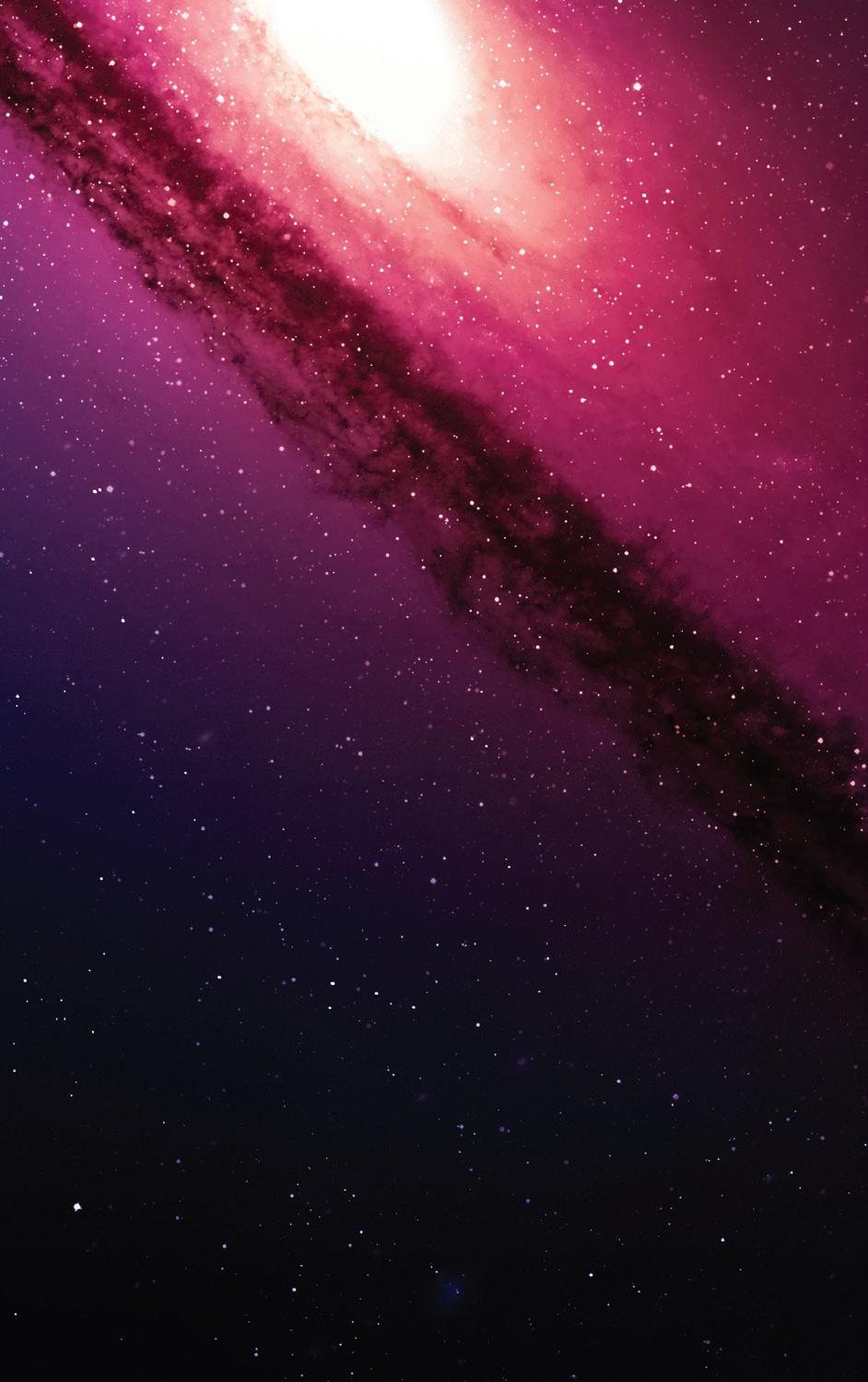
Enrico Moltisanti
I grandi astrofili Gabriele Vanin
La Luna
Walter Ferreri
In viaggio nel Sistema Solare
Francesco Biafore
Come funziona l'Universo
Heather Couper, Nigel Henbest
Come fotografare il cielo
Walter Ferreri
L'osservazione dei pianeti
Walter Ferreri
Cento meraviglie celesti Gabriele Vanin
Effettua l’ordine comodamente su BFC Store (bfcstore.com): acquistando il coupon “I best seller di Cosmo” riceverai un’email di conferma, rispondendo alla quale potrai indicare i titoli scelti.

ASTRONOMIA / COSMOLOGIA / SPAZIO
OSSERVATORI / STRUMENTI / ASTROFOTOGRAFIA INTERVISTE IN STUDIO E SERVIZI

DA UN’IDEA DI FRANCO CAPPIELLO CONDOTTO DA WALTER RIVA PRESENTA ADRIANA LALA
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA UNIONE ASTROFILI ITALIANI
TUTTE LE 12 PUNTATE DISPONIBILI SU BFCVIDEO.COM
