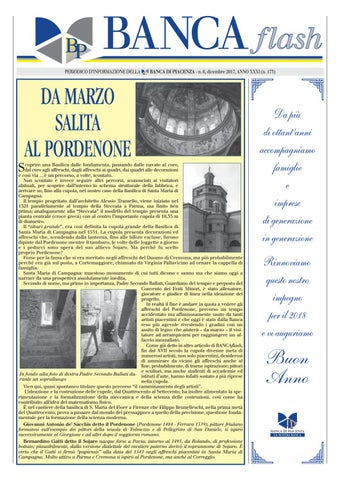lash BANCA fla dicembre 2017
PERIODICO D’INFORMAZIONE DELLA
DA MARZO SALITA AL PORDENONE
S
BANCA DI PIACENZA - n. 6, dicembre 2017, ANNO XXXI (n. 173)
coprire una Basilica dalle fondamenta, passando dalle navate al coro, dal coro agli affreschi, dagli affreschi ai quadri, dai quadri alle decorazioni e così via …è un percorso, a volte, scontato. Non scontato è invece seguire altri percorsi, sconosciuti ai visitatori abituali, per scoprire dall’interno lo schema strutturale della fabbrica, e arrivare su, fino alla cupola, nel nostro caso della Basilica di Santa Maria di Campagna. Il tempio progettato dall’architetto Alessio Tramello, viene iniziato nel 1521 parallelamente al tempio della Steccata a Parma, ma finito ben prima; analogamente alla “Steccata” il modello del tempio presenta una pianta centrale (croce greca) con al centro l’importante cupola di 10,35 m di diametro. Il “tiburi grande”, era così definita la cupola grande della Basilica di Santa Maria di Campagna nel 1531. La cupola presenta decorazioni ed affreschi che, scendendo dalla lanterna, fino alle bifore escluse, furono dipinte dal Pordenone mentre il tamburo, le volte delle loggette a giorno e i peducci sono opera del suo allievo Sojaro. Ma perchè fu scelto proprio Pordenone? Forse per la fama che si era meritato negli affreschi del Duomo di Cremona, ma più probabilmente perché era già sul posto, a Cortemaggiore, chiamato da Virginia Pallavicino ad ornare la cappella di famiglia. Santa Maria di Campagna: maestoso monumento di cui tutti dicono e sanno ma che siamo oggi a narrare da una prospettiva assolutamente inedita. Secondo di nome, ma primo in importanza, Padre Secondo Ballati, Guardiano del tempio e preposto del Convento dei Frati Minori, è stato allenatore, giocatore e giudice di linea nella ideazione del progetto. In realtà il fine è andare in quota a vedere gli affreschi del Pordenone, percorso un tempo accidentato ma affannosamente usato da tanti artisti piacentini e che oggi è stato dalla Banca reso più agevole rivestendo i gradini con un assito di legno che aiuterà – da marzo – il visitatore ad arrampicarsi per raggiungere un affaccio mozzafiato. Come già detto in altro articolo di BANCAflash, fin dal XVII secolo la cupola divenne meta di numerosi artisti, non solo piacentini, desiderosi di ammirare da vicino gli affreschi anche al fine, probabilmente, di trarne ispirazione; pittori e scultori, ma anche studenti di accademie ed In fondo alla foto di destra Padre Secondo Ballati du- istituti d’arte, hanno infatti sostato a più riprese rante un sopralluogo nella cupola. Vien qui, quasi spontaneo titolare questo percorso “il camminamento degli artisti”. L’ideazione e la costruzione delle cupole, dal Quattrocento al Settecento, ha inoltre alimentato la sperimentazione e la formalizzazione della meccanica e della scienza delle costruzioni, così come ha contribuito all’idea del matematismo fisico. È nel cantiere della basilica di S. Maria del Fiore a Firenze che Filippo Brunelleschi, nella prima metà del Quattrocento, prova a passare dal mondo del pressappoco a quello della precisione, questione fondamentale per la formazione della scienza moderna. Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone (Pordenone 1484 - Ferrara 1539), pittore friulano formatosi sull’esempio dei pittori della scuola di Tolmezzo e di Pellegrino di San Daniele, si ispirò successivamente al Giorgione e ad altri dopo il soggiorno romano. Bernardino Gatti detto il Sojaro nacque forse a Pavia, intorno al 1495, da Rolando, di professione bottaio; plausibilmente, dalla versione dialettale del mestiere paterno derivò il soprannome di Sojaro. È certo che il Gatti si firmò “papiensis” alla data del 1543 negli affreschi piacentini in Santa Maria di Campagna. Molto attivo a Parma e Cremona si ispirò al Pordenone, ma anche al Correggio.
Da più di ottant’anni accompagniamo famiglie e imprese di generazione in generazione Rinnoviamo questo nostro impegno per il 2018 e vi auguriamo
Buon Anno