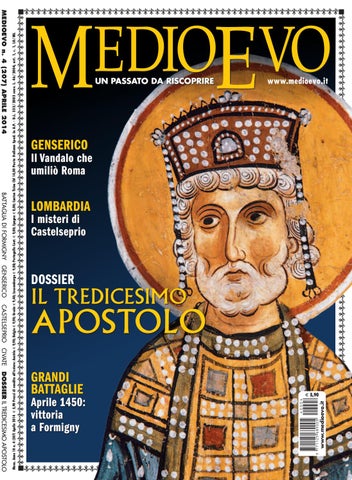battaglia di formigny genserico
castelseprio civate dossier il tredicesimo apostolo
Mens. Anno 18 n. 4 (207) Aprile 2014 € 5,90 Prezzi di vendita all’estero: Austria € 9,90; Belgio € 9,90; Grecia € 9,40; Lussemburgo € 9,00; Portogallo Cont. € 9,00; Spagna € 8,00; Canton Ticino Chf 14,00 Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, LO/MI.
MEDIOEVO n. 4 (207) aprile 2014
UN PASSATO DA RISCOPRIRE
grandi battaglie
Aprile 1450: vittoria a Formigny
www.medioevo.it
EDIO VO M E www.medioevo.it
genserico
Il Vandalo che umiliò Roma
lombardia
I misteri di Castelseprio
dossier
il tredicesimo
apostolo
€ 5,90
sommario
Aprile 2014
Dossier
ANTEPRIMA restauri Curare per conoscere
6
mostre Nel segno della rivisitazione
8
valorizzazione Droni per Venezia
10
appuntamenti Nel triangolo vichingo Il gioco delle parti Nella valle incantata La fede in trasparenza Ritorno a Clontarf L’Agenda del Mese
10 12 14 16 20 24
STORIE Formigny
di Francesco Colotta
costantino il grande: dall’impero alla fede di Furio Cappelli
56 luoghi
grandi battaglie Primavera fatale
il tredicesimo apostolo
32
32
saper vedere I colori di Castelseprio di Elena Percivaldi
56
medioevo nascosto Civate
L’abbazia del cinghiale bianco di Elena Percivaldi
94
CALEIDOSCOPIO
protagonisti Genserico
Il grande oltraggio
di Federico Canaccini
44
44
cartoline Porta d’Italia
106
libri Un profilo a tutto tondo
110
musica Un dilettante virtuoso Musiche per versi celebri La voce degli ultimi
112 112 113
73
Ante prima
Curare per conoscere restauri • Ha appena preso il via un
importante e articolato progetto di risanamento del duomo di Pisa. Tra gli obiettivi, quello di precisare meglio la storia della grandiosa fabbrica
L
a cattedrale di Pisa, che compie 950 anni, è oggetto di un’imponente campagna di restauro: il progetto prevede l’allestimento di piccoli cantieri, riguardanti porzioni del duomo di volta in volta diverse. E il tutto, stima Anton Sutter, responsabile dei restauratori dell’Opera Primaziale Pisana, «può durare dai dieci ai quindici anni. Per ora è partito un cantiere pilota, che ha toccato il catino absidale e le facciate adiacenti, ovvero quelle tergali del coro e del cleristorio». Le analisi finora eseguite hanno chiarito lo stato di conservazione dell’edificio, a tratti problematico: «Nell’ornato sono state individuate decoesioni e incrostazioni abbastanza estese, soprattutto sui materiali tardo antichi, quelli di reimpiego; sono invece relativamente buone le condizioni della parte muraria piana», precisa Sutter. La successiva fase di pulitura ha dato risalto alla policromia che caratterizza la chiesa, mettendo in evidenza
6
anche patine protettive di epoche diverse, che verranno conservate.
Specialisti a confronto Gli interventi, che si svolgono con la supervisione della Soprintendenza di Pisa e la consulenza dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, fanno capo a un gruppo nel quale lavorano gomito a gomito architetti, petrografi, archeologi degli elevati, storici dell’arte e dell’architettura. Fra gli obiettivi del cantiere, oltre
al restauro, c’è infatti quello di leggere le vicende del duomo attraverso le indicazioni fornite dalla struttura materiale dell’edificio, considerata come una sorta di archivio da sfogliare in parallelo alle fonti scritte. Gli studiosi mirano a mettere a punto una ricostruzione delle campagne architettoniche, delineando anche notizie sulla gestione interna e sul retroterra delle maestranze che, nella città dell’XI secolo, hanno dato vita a uno straordinario luogo di culto.
In alto la parte terminale della facciata e la cupola del duomo di Pisa. A destra un momento della pulitura con il laser degli elementi architettonici.
aprile
MEDIOEVO
Anton Sutter sottolinea che i restauratori lapidei dell’Opera Primaziale Pisana, impegnati nel progetto, hanno già lavorato al ripristino della torre di Pisa e seguiranno tutti gli sviluppi del cantiere appena partito. Questo è un aspetto importante, sia per garantire una continuità negli interventi, anche nell’ottica della manutenzione ordinaria di cui avrà bisogno la piazza, sia per tutelare un patrimonio di competenze, destinato a rimanere in una città che si sente legata a doppio filo ai suoi monumenti.
In alto la campagna fotografica che precede e accompagna tutte le fasi dell’intervento di restauro. A destra un operatore rimuove con il vibroincisore le stuccature in cemento.
Una chiesa per la comunità La cattedrale, fondata nel 1064, ma consacrata solo nel 1118, riveste da subito molta importanza per la comunità pisana, come testimoniano le epigrafi della facciata. Alla prima fase costruttiva, guidata dall’architetto Buscheto, è ascrivibile l’impianto, con corpo longitudinale a cinque navate, transetto a tre navate e cupola sulla crociera, mentre nell’intervento
MEDIOEVO
aprile
successivo Rainaldo ha firmato il prolungamento della chiesa e la sua facciata. Ma la struttura è stata conclusa solo nell’ultimo quarto del XII secolo, con il posizionamento dei battenti in bronzo di Bonanno per il portale centrale. Il duomo presenta piú d’un rimando alla cultura orientale: dal rivestimento esterno in cui
si alternano bianco e nero alla planimetria ellittica della cupola, al grifone posto sul culmine del tetto. L’ampio uso di materiale di reimpiego allude invece alla classicità e alla gloriosa storia di Pisa, richiamata in un edificio molto articolato, imponente e armonico al tempo stesso. Stefania Romani
7
Ante prima
Nel segno della rivisitazione mostre • Una ricca ed eclettica rassegna
presentata alla Galleria dell’Accademia di Firenze prova la straordinaria attualità della lezione di Michelangelo
N
el 1563, viene fondata a Firenze l’Accademia delle Arti e del Disegno, per volere del Granduca Cosimo de’ Medici e di Giorgio Vasari, i quali decidono di eleggere Michelangelo ad Accademico della neonata istituzione, attribuendogli il titolo di padre delle tre arti che in lui sono riunite. La morte dell’artista, avvenuta l’anno successivo, non scisse questo binomio tra l’artista e l’ente, sfociando anzi in un legame finora indissolubile. E ora la Galleria dell’Accademia offre un tributo suggestivo e non convenzionale per celebrare i 450 anni dalla sua scomparsa. La mostra «Ri-conoscere Michelangelo»
propone un percorso artistico e intimistico tramite l’occhio e il pensiero di artisti che hanno interpretato le sue opere scultoree attraverso le loro immagini, durante gli ultimi due secoli.
Un ritratto inedito Il viaggio interpretativo di grandi pittori e fotografi inizia con un ritratto inedito del Maestro attribuito a Domenico Cresti, detto il Passignano (1559-1638), originale interprete controriformato che conciliò la tradizione disegnativa fiorentina con sperimentazioni cromatiche di impronta veneta. Accanto ai pionieri francesi della «camera oscura» come Eugène Piot,
In alto Kim Ki-duk, Pietà. 2012. Corea, KIM Ki-duk Film Production. A sinistra Charles Rettrew jr. Sheeler, Cast of Giuliano de’ Medici by Michelangelo. Stampa alla gelatina di bromuro d’argento, 1942 circa. New York, The Metropolitan Museum of Art.
8
aprile
MEDIOEVO
il primo archeologo a documentare con il mezzo fotografico gli scavi a cui partecipava, o Édouard-Denis Baldus che, per primo, sperimentò il panorama, ottenendo una singola immagine dalla giustapposizione di diversi negativi, troviamo anche i Fratelli Alinari, fondatori del piú antico laboratorio al mondo nel campo dell’immagine, i cui archivi contano attualmente un patrimonio di oltre 5 milioni di fotografie, rappresentanti tutte le tecniche. L’energia creativa e l’espressiva passione della «maniera» michelangiolesca infusero una spinta vitale alla cultura del XIX secolo, desiderosa di forti emozioni; insomma un esempio di vigore che portò artisti come Eugène Delacroix a meditare sulla personalità e sul «non finito» del Buonarroti e a raffigurarlo in pensosa malinconia, circondato dalle proprie creazioni. E proprio la visione diretta di quei capolavori folgorò Auguste Rodin, durante un viaggio in Italia, diventando matrice fondamentale della sua produzione, elaborata secondo personali esperienze artistiche ed esistenziali.
Una collaborazione singolare Il percorso espositivo, dalle rappresentazioni in chiave storicistica della fisionomia e dell’indole dell’artista toscano, passa a rintracciare le forme e la materia delle opere, traducendo gli «scatti» in elemento di documentazione, instaurando una singolare collaborazione tra storici dell’arte e fotografi. Ne sono un autorevole esempio David Finn, Giuseppe Pagano e Aurelio Amendola, le cui interpretazioni hanno contribuito a nuove teorie e analisi stilistiche. La presenza di Michelangelo permeò il Novecento, alla ricerca di una fusione tra interiorità ed espressioni figurative simboliche che vide autori come Medardo Rosso fornire complesse elucubrazioni e dichiarare la sua indifferenza per il Rinascimento, mentre Henri Matisse si rivolse alla raffigurazione della Notte nella Sagrestia delle Cappelle
MEDIOEVO
aprile
Dove e quando
«Ri-conoscere Michelangelo. La scultura del Buonarroti nella fotografia e nella pittura dall’Ottocento ad oggi» Firenze, Galleria dell’Accademia fino al 18 maggio Orario ma-do, 8,15-18,50; chiuso il lunedí e il 1 maggio Info e prenotazioni Firenze Musei, tel. 055 294883; e-mail: firenzemusei@operalaboratori.com; web: unannoadarte.it
In alto Nicolò Cipriani, Madonna col Bambino o Madonna di Bruges. 1953 Stampa fine art su carta cotone da negativo originale (2014). Firenze, Polo Museale, Gabinetto Fotografico. A sinistra Édouard-Denis Baldus, Schiavo morente. Stampa su carta salata da negativo di carta, 1854. Monaco di Baviera-Londra, Daniel Blau. Medicee, tentando di assorbirne le profonde suggestioni. A rafforzare il mito, giunsero poi firme come Emmanuel Sougez, Herbert List, Tano Festa o Paolo Monti, che, con il loro obiettivo, ci conducono verso la ricerca contemporanea, qui rappresentata, tra gli altri, da Helmut Newton, Gabriele Basilico e Gerard Rondeau, noto soprattutto per il suo lungo lavoro nei musei di tutto il mondo, dove ha immortalato impiegati al lavoro, visitatori e opere d’arte. L’ultima parte dell’esposizione affronta il tema della copia e del multiplo, con Karen Knorr, Lisa Sarfati e Tim Parchikov, mentre l’omaggio di Luca Pignatelli testimonia un gioco di rimandi tra realtà ed emotività. Michelangelo si trasforma, invece, in modello formale della staged photography di Frank Horvat, Youssef Nabil e Kim Ki duk, fino a diventare «assenza» con Thomas Struth e Candida Hofer. Mila Lavorini
9
Ante prima
Droni per Venezia valorizzazione • Centinaia
di capolavori della Serenissima sono oggetto di un progetto basato sull’impiego di tecnologie avanzatissime e che porterà questo ricco patrimonio alla portata di mouse e touch screen
A
vviato nello scorso autunno, il progetto «Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell’area di San Marco» è un ambizioso intervento di valorizzazione culturale che, utilizzando strumenti multimediali, riprese fotografiche
ad altissima qualità finalizzate alla rappresentazione tridimensionale e virtual tour, interessa quasi 400 opere d’arte. Una volta concluso, darà vita a un museo virtuale fruibile da pc, tablet e smartphone. I beni culturali e artistici al centro
delle riprese fotografiche e degli elaborati multimediali sono di competenza delle principali istituzioni culturali del territorio veneto e comprendono i beni del Tesoro della Basilica di S. Marco, lo Statuario pubblico della
Nel triangolo vichingo
Qui sopra, in alto e nella pagina accanto immagini relative all’impiego di un drone per la documentazione fotografica del Leone di San Marco e di altre opere coinvolte nel progetto «Meraviglie di Venezia».
10
aprile
MEDIOEVO
Serenissima, la Tribuna di Ca’ Grimani a S. Maria Formosa e sedici «oggetti speciali», collocati all’esterno della Basilica, in piazza San Marco e all’interno del cortile di Palazzo Ducale, fra i quali il gruppo dei Tetrarchi, i Cavalli di San Marco, il «Todaro» (San Teodoro) e il Leone. Grazie alle moderne tecnologie, il pubblico potrà scoprire in modo accattivante e al tempo stesso rigorosamente scientifico, le caratteristiche di un numero notevole di beni culturali e artistici, evidenziandone origine, composizione e, talvolta, evoluzione iconografica. È il caso del Leone di San Marco, sulla sommità della colonna dell’omonima piazza, oggetto di un intervento di decostruzione virtuale interattiva. Collocato sulla colonna nella metà del XIII secolo circa, per ragioni stilistiche e tecniche, il Leone
alato non può essere considerato come un’opera medievale. È verosimile l’ipotesi che in origine fosse un’antica chimera proveniente da Costantinopoli o dal Levante, modificata nel Medioevo con simboli agiografici marciani, e sottoposto nel tempo a piú d’un restauro.
Simbolo della Serenissima Le tecnologie multimediali consentiranno di distinguere le diverse modifiche succedutesi nei secoli, ripercorrendo la storia e l’evoluzione iconografica del simbolo per antonomasia e marchio politico dell’antica Serenissima.
Per documentare il celebre simbolo cittadino e il Todaro, i responsabili del progetto hanno anche fatto ricorso a un drone, un dispositivo di pilotaggio remoto. Il velivolo si è alzato da terra fino all’altezza di ogni statua per 24 volte ciascuna. Lo stesso mezzo è stato utilizzato anche nel cortile di Palazzo Ducale, per fotografare le sei statue antiche della Collezione Grimani inserite nelle nicchie della parete dell’orologio di Federico Manopola, e all’esterno della Basilica di S. Marco, per riprendere la «Testa del Carmagnola» nel loggiato. (red.)
appuntamenti • Un ricco calendario di eventi celebra la fondazione di
Waterford, città irlandese nata nel 914 sulla costa sud-orientale dell’isola verde
L
a città piú antica d’Irlanda festeggia i suoi 1100 anni con un ricco calendario di eventi. Fondata dai Vichinghi nel 914, Waterford si adagia lungo la costa sud-orientale dell’isola e conserva la fisionomia urbanistica medievale. Grazie al clima mite e ai paesaggi verdissimi, è meta ideale per gli amanti del golf, degli sport acquatici, della bicicletta, ma negli ultimi anni ha riscoperto l’antica vocazione culturale, valorizzando la sua storia millenaria, gli edifici piú rappresentativi e il patrimonio di competenze che c’è dietro all’iter produttivo del cristallo, da secoli fra le principali voci nell’economia della contea. La celebrazione dell’anniversario è stata preceduta dagli interventi architettonici condotti nel Viking Triangle, ovvero l’area punteggiata dalle strutture medievali, nella quale si sono intrecciati stili via via diversi. L’impianto originario della città rimane però perfettamente leggibile, a partire dalla mura che cingono la parte piú antica dell’abitato: fondate nel X secolo, sono state potenziate in età normanna, quando Waterford diventò un centro commerciale vivace, secondo solo a Dublino, e i sovrani decisero di proteggerla con una doppia linea di tessuto murario. Proprio al vertice del «triangolo»,
A sinistra il Lismore Castle, nella contea di Waterford, città irlandese che festeggia i 1100 anni dalla sua fondazione.
MEDIOEVO
aprile
svetta la Torre di Reginaldo, costruita su pianta circolare all’inizio del Duecento, per fungere nel corso dei secoli da bastione, corte, zecca, prigione.
Vivere nell’Età di Mezzo Il Museo Medievale, inaugurato nel 2012, è stato ricavato in una struttura collocata fra la piazza del duomo e la sede vescovile, per ospitare porzioni di affresco, paramenti sacri, oggetti di uso quotidiano. E si snoda attorno a un coro del XIII secolo, trasformatosi nel cuore del percorso espositivo. Non lontano, il Palazzo del Vescovo incarna a pieno il gusto georgiano, sia nell’architettura sia nella raccolta permanente che annovera pezzi d’arredo, dipinti, argenti e cristalli. E proprio ai manufatti in cristallo è dedicato un altro polo espositivo, che racconta tutti i segreti di un lavoro che ancora oggi ha un ruolo di primo piano. Fra gli appuntamenti in programma, possiamo segnalare il Festival di architettura (10-13 aprile), il Waterford International Music Festival (1-13 aprile) e la prima dell’opera The Invader, una nuova produzione irlandese che debutterà al Theatre Royal (23-24 aprile). Per il calendario aggiornato di tutti gli eventi: waterford1100.com; per informazioni su turismo, musei, soggiorno: www.discoverwaterfordcity.ie S. R.
11
Ante prima
Il gioco delle parti appuntamenti • Assisi si prepara a celebrare la festa di Calendimaggio,
in occasione della quale la città rivive i fasti delle giostre e dei tornei
L
’8, 9 e 10 maggio torna ad Assisi l’appuntamento con la festa di Calendimaggio. Diverse sono le tradizioni che confluiscono nei festeggiamenti del cosiddetto «ciclo di maggio»: dalla consuetudine nordico-pagana di piantare un albero rivestito di ghirlande per salutare la fine dell’inverno (particolarmente pesante in un’epoca in cui gli unici momenti d’incontro, in questa parte dell’anno, potevano avvenire solo nella ben riscaldata taverna), a quella bassomedievale di proclamare alcuni giorni d’itineranza, durante i quali i giovani, in brigata con teatranti e menestrelli, girovagavano per le piazze delle città (ormai rinate e divenute – a partire dall’XI secolo – anche centri universitari) intonando canzoni, ballando e recitando. Anche ad Assisi, a partire dal XII secolo, si diffuse la consuetudine per i tripudiantes di percorrere le strade
12
della città, fermandosi di casa in casa per recitare «le canzoni di maggio», che, secondo l’influsso provenzale, esaltavano l’ideale cavalleresco e l’amor cortese. Tale tradizione si uní presto a quella mai sopita, dall’età arcaica in poi, di organizzare giochi militari, che nel Medioevo assunsero la forma del torneo.
Giochi a tema A partire dal Duecento, il torneo iniziò a ispirarsi a «un tema», trasformandosi nella rievocazione di un fatto d’armi. I giochi d’armi, erano inoltre il luogo privilegiato dell’ostentazione della ricchezza e del prestigio sociale delle famiglie piú in vista e per tale ragione si arrivò, nel corso del Basso Medioevo, a spendere cifre enormi per la loro realizzazione. A partire dal XV secolo, il loro carattere aggressivo (come detto, si poteva morire nel corso dei tornei) andò assumendo
un tono maggiormente ludico, trasformandosi in giostra oppure in palio. Nella prima gli sfidanti si affrontavano in coppia in due spazi di campo non comunicanti tra loro, mentre nel secondo, i rioni di una città si sfidavano in gare di vario genere (spesso con i cavalli o altri animali), a conclusione della quali il vincitore otteneva un «pallium», un drappo di stoffa o stendardo. Ad Assisi, l’usanza di celebrare i giochi di maggio s’interruppe negli anni degli acerrimi scontri tra la «parte de Sopra», di estrazione nobiliare e capeggiata dalla famiglia Nepis (cui afferivano i rioni di porta Perlici, Porta S. Chiara e S. Maria Maggiore), e la «parte de Sotto», di estrazione popolare e guidata dalla famiglia Fiumi (di cui facevano parte i rioni S. Francesco, S. Giacomo e S. Pietro). Nel 1376 la parte de Sotto attaccò nottetempo la parte de Sopra, cogliendola di sorpresa e seminando
aprile
MEDIOEVO
morti e violenze che si perpetrarono per oltre due secoli anche grazie all’appoggio di due potenti famiglie perugine: i Baglioni alleati con la parte de Sopra, e gli Oddi con la parte de Sotto. Nel corso delle reciproche ostilità si arrivò a incendiare la basilica di S. Francesco e a seguito di tale episodio furono vietate le celebrazioni comuni (tra cittadini della parte de Sopra e della parte de Sotto) di tutte le feste liturgiche e stagionali.
Un recupero filologico Nella forma in cui si svolge oggi la festa fu istituita nel 1954, a coronamento, tuttavia, di un lavorio iniziato negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Nel 1927 infatti, per iniziativa del Podestà Arnaldo Fortini, al fine d’istituire una festa di Primavera, s’intrapresero il recupero e la rivisitazione delle «canzoni di maggio» d’influenza provenzale e delle tradizioni medievali con un’attenzione filologica che ancora oggi caratterizza la manifestazione e la rende una delle piú suggestive d’Italia e d’Europa. Il Calendimaggio di Assisi si festeggia ogni primo giovedí, venerdí e domenica seguenti il 1° maggio di ogni anno. Le due fazioni storiche della Nobilissima parte
de Sopra e della Magnifica parte de Sotto si affrontano per la conquista del palio. La giuria è composta da uno storico medievista, da un musicologo e da una personalità del mondo dello spettacolo (ogni anno diversi). La gara si compone di due anime fondamentali, il corteo storico e la rievocazione di scene di vita medievali con l’intonazione delle «canzoni di maggio», e la sfida In alto miniatura raffigurante i cavalieri che imparano a combattere in torneo, da un’edizione del Romanzo del Sacro Graal. XV sec. Digione, Bibliothèque municipale. A sinistra riproduzione in facsimile della raffigurazione cinquecentesca di un torneo tra nobili bavaresi. 1817. Firenze, Museo Stibbert.
MEDIOEVO
aprile
nei giochi di Madonna Primavera: tiro alla fune, corsa delle tregge (slitte) e tiro con la balestra. Le gare sono cosí chiamate perché sfociano nell’elezione della regina della festa. A contendersi il titolo sono ogni anno dieci ragazze, cinque per ciascuna parte. Ogni ragazza è abbinata a un arciere la cui vittoria porta alla sua elezione.
La benedizione dei vessilli La festa inizia nel primo pomeriggio del giovedí con la benedizione dei vessilli e la consegna delle chiavi: presso la cattedrale di S. Rufino per la parte de Sopra, e presso la basilica di S. Francesco per la parte de Sotto. Successivamente le parti si muovono in corteo dai due lati opposti della città fino alla piazza del Comune, dove il Maestro de Campo riceve le chiavi dal sindaco, gesto che simboleggia la piena assunzione dei poteri sulla città. Il Maestro de Campo ha anche il compito di riprendere il palio dalla parte che lo ha vinto l’anno precedente e custodirlo fino al momento della sua consegna al nuovo vincitore. Nel tardo pomeriggio seguono le scene di vita medievale organizzate dalla parte che ha vinto la
13
Ante prima Dida, niet qui odio quisquunt, soluptae? Pe moloressenim estis enduci quia nim sequi doluptu rescius eni optiur, quae
In alto un momento della festa di Calendimaggio, ad Assisi. A destra, in alto e in basso immagini della Festa Medievale di Aggstein. competizione dell’anno precedente. Il venerdí è dedicato alle gare di Madonna Primavera con la sua conseguente elezione. Nel tardo pomeriggio vengono rappresentate le scene di vita medievale dalla parte che non le ha eseguite nel giorno inaugurale. Il sabato è dedicato ai cortei di parte, al termine dei quali i banditori interpretano lo spettacolo del bando di sfida. Successivamente i cortei rientrano nei propri quartieri. Alla sera le due parti raggiungono la piazza del Comune e intonano i cori medievali, al termine dei quali la giuria si riunisce e decreta il verdetto. È infine il Maestro de Campo a consegnare il Palio, sventolando il fazzoletto della parte vincente: blu per la parte de Sopra, rosso per la parte de Sotto. Chiara Mercuri
14
Nella valle incantata
T
orna la Festa Medievale che si svolge annualmente nel terzo week end di aprile presso le rovine del Castello austriaco di Aggstein, eretto nel XII secolo a circa 300 m sulla riva destra del Danubio, nella stretta e scenografica Valle della Wachau. «Elfi, gnomi e druidi» sarà il tema di questa edizione, in programma nelle giornate di sabato 19 e lunedí 21 aprile (scelta per evitare la coincidenza con la domenica di Pasqua). Come di consueto, i ruderi dell’antico maniero diventeranno lo scenario ideale per un magico viaggio nella storia, con personaggi in abiti d’epoca intenti a lavorare in mercati, botteghe e attendamenti. I visitatori potranno trovare cibi e bevande preparati secondo ricette dell’epoca, partecipare a laboratori artigianali e altre attività ludico-didattiche per adulti e bambini. E grazie alle visite guidate alle rovine del Castello, potranno conoscere la storia e i personaggi che lo hanno popolato nel Medioevo. La Valle della Wachau è stata iscritta dall’UNESCO nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità grazie alla sua eccezionale ricchezza di elementi naturalistici, storici e architettonici. Fra i quali, appunto, le rovine del Castello di Aggstein, che troneggiano su uno stretto promontorio oggi appartenente al Comune di Schönbühel-Aggsbach. Costruito all’inizio del XII secolo da Manegold III di Aggsbach per controllare la navigazione nel sottostante Danubio, il maniero passò poi alla famiglia Kuenringer, che ne mantenne la proprietà fino alla metà del Trecento, prima che cadesse in rovina. Verso la metà del Quattrocento il duca Albrecht V si incaricò di ristrutturarlo, ma nel 1529 venne dato alle fiamme dall’esercito turco in procinto di assediare Vienna. Nuovamente restaurato all’inizio del Seicento, sotto Anna Freiin von Polheim und Parz il castello ebbe un ultimo sussulto nel Rinascimento. Nei secoli successivi fu gravemente trascurato, fino al suo totale abbandono. Oggi si possono visitare i resti di una torretta a tre piani, una cappella gotica, una taverna e un palazzo con alcuni spazi restaurati, come l’ex Sala del Re. Il sito di Aggstein è aperto da marzo a novembre, ogni giorno dalle 9,00 alle 18,00. Tiziano Zaccaria
Ante prima
La fede in trasparenza appuntamenti • In un amalgama
di teatralità e sentimento religioso, le processioni storiche di Mendrisio, nel Canton Ticino, celebrano la Settimana Santa
F
in dal Medioevo, durante la settimana pasquale il centro storico di Mendrisio diventa la naturale scenografia delle suggestive processioni storiche del Giovedí e del Venerdí Santo. Nella cittadina del Canton Ticino quest’anno il rito si ripeterà nelle serate del 17 e 18 aprile, con i due cortei religiosi che, come da tradizione, prenderanno avvio e si concluderanno davanti all’ex convento dei Padri Serviti. Nella serata del Giovedí Santo circa duecento figuranti in costumi storici, divisi fra Ebrei e Romani, rappresentano la Via Crucis, in una processione che in passato degenerava spesso in una parodia irriverente, tanto da provocare polemiche e querele. Oggi questo corteo ha perso la sua sfrontatezza, pur restando una rappresentazione vivace,
sottolineata dalla presenza di cavalli, strumenti a fiato e tamburi. La processione del Venerdí è invece piú intima e vicina ai canoni religiosi. I membri delle varie confraternite cittadine (oltre seicento persone) portano i Misteri (candele, scale, spugne, martelli, chiodi, fruste, ecc) e varie effigi, tra cui spiccano il Simulacro del Cristo Morto e la Vergine Addolorata, portati a spalla, mentre tre corpi di musica intonano brani funebri. Lungo il tragitto sono posizionati numerosi pannelli, detti «trasparenti», raffiguranti un trittico di scene della Passione di Gesú. Si tratta di antichi capolavori d’arte religiosa e popolare, unici al mondo, realizzati da pittori ticinesi e italiani su tele racchiuse in cassonetti di vetro illuminati dall’interno. Nel dipinto centrale dei «trasparenti» è riprodotto un Due immagini delle processioni organizzate a Mendrisio in occasione della Settimana Santa.
16
episodio del Vangelo, mentre i due laterali rimandano all’Antico Testamento. La processione del Venerdí Santo fu ideata dai Padri Serviti, presenti a Mendrisio già alla metà del XV secolo, per rimarcare la loro venerazione verso la Madonna dei sette dolori.
Origini longobarde Il centro svizzero di Mendrisio è di origine longobarda: il toponimo Mendrici è citato per la prima volta nel 793 e richiama Mendricus, probabile nome di un capo della fara longobarda che si era stanziata nel territorio. Risalgono al 1424 i primi statuti cittadini, derivanti probabilmente dall’adozione di quelli di Lugano, con l’aggiunta di alcune feste locali tra cui appunto le celebrazioni religiose della Settimana Santa. Prima di passare alla Confederazione svizzera nel 1522, il Mendrisiotto fu amministrato dal ducato di Milano. Nel 1803 il distretto di Mendrisio, insieme con gli altri baliaggi, andò a costituire il Canton Ticino, parificato agli altri Cantoni svizzeri da Napoleone. Uno degli edifici cittadini piú antichi è il convento dei Serviti o di S. Giovanni Battista, risalente al XIII secolo; apparteneva originariamente agli Umiliati, e passò ai Serviti nel 1447, fino alla sua soppressione avvenuta nel 1852. T. Z. aprile
MEDIOEVO
Ante prima
Le grandi capitali dell’Età di Mezzo
cordova
dubrovnik
rodi
gerusalemme
T
utte le strade portano al Mediterraneo. Nell’Età di Mezzo quel mare affollato di merci rappresentava uno «spazio vitale» per i regni dell’Europa meridionale. La stessa vocazione animava gli Stati mediorientali, che per un periodo colonizzarono quelle acque a spese dell’Occidente. Nell’intricato triangolo di rapporti tra il Vecchio Continente, Bisanzio e l’Islam, il Mediterraneo si materializzò sempre come una sorta di convitato di pietra, come una delle principali cause di conflitti e trattati di pace, alla stessa stregua di un dogma religioso. Ecco perché «Medioevo», in questo secondo «Dossier» dedicato alle grandi capitali, presenta
18
ai lettori un itinerario che ripercorre la storia urbanistica di due continenti, l’Europa del Sud e l’area del Vicino Oriente, le cui ambizioni gravitavano sul medesimo scacchiere strategico. «Viviamo intorno a un mare come rane intorno a uno stagno» dicevano gli antichi, riferendosi al Mediterraneo. Il controllo di quel vasto specchio d’acqua garantiva prestigio, indipendentemente dalle epoche di splendore o di crisi globale dell’economia. Agli inizi del Medioevo, mentre l’impero romano crollava sotto i colpi delle invasioni barbariche, il traffico mercantile sul Mediterraneo continuava a essere florido, con nuovi attori protagonisti. aprile
MEDIOEVO
il nuovo dossier di medioevo gli argomenti del dossier U Italia
Venezia. La regina della Laguna Milano. Da sempre metropoli Roma. Una storia da riscrivere Napoli. Prediletta dagli Angioini U Penisola iberica Cordova. Il gioiello dei califfi Saragozza. Conquiste e contaminazioni Lisbona. Come un’araba fenice U Penisola balcanica Dubrovnik. La quinta repubblica marinara U Mediterraneo orientale Rodi L’isola dei cavalieri U Vicino Oriente Costantinopoli. Splendori della nuova Roma Gerusalemme. L’oro del tempio Damasco. Il cuore «morale» dell’Islam Baghdad. Il cerchio del potere
MEDIOEVO
settembre
19
Ante prima
Ritorno a Clontarf appuntamenti • L’Irlanda si
appresta a celebrare i mille anni dalla fatidica data del 23 aprile 1014 con la piú imponente rievocazione storica mai allestita nell’isola verde, nel ricordo di una battaglia che cambiò le sorti del Paese
A
Dublino e in altre città dell’Irlanda un ricco calendario di eventi, mostre, iniziative celebra il millennio della battaglia di Clontarf, centro costiero a pochi chilometri dalla capitale, che segna una sorta di spartiacque nella storia dell’isola. Brian Boru, il primo monarca ad avere unificato gran parte del Paese, muore nel combattimento che, il 23 aprile 1014, sancisce la sconfitta definitiva dei Vichinghi, ma fa precipitare di nuovo l’Irlanda in una condizione di guerra permanente fra clan, famiglie e sovrani (vedi «Medioevo» n. 171, aprile 2011; anche on line su medioevo.it). Nell’immaginario collettivo, la battaglia ha assunto i contorni della cacciata degli invasori da parte del primo e valoroso regnante, anche se si inserisce in un quadro politico piuttosto variegato. I Vichinghi controllavano il territorio attraverso un sistema di vassallaggio e alleanze, nel quale irruppe Boru, a capo del clan dei Dalcassiani, che intendeva
20
far convivere i sovrani provinciali sotto una guida unitaria. Per il millennio della battaglia di Clontarf, a Dublino il 19 e 20 aprile è in calendario la piú imponente rievocazione storica mai programmata in Irlanda. Per l’occasione è stato ricreato un intero borgo vichingo, con arcieri, artigiani al lavoro e falconieri impegnati nell’addestramento dei rapaci. Anche con l’ausilio di postazioni interattive, il villaggio offre uno spaccato di vita quotidiana in un abitato dell’epoca.
Il borgo ricostruito Nei loro laboratori i fabbri sono impegnati nella costruzione di diversi tipi di armi, ma anche di attrezzature marinare che vanno dalle ancore agli strumenti per misurare l’altezza del sole. Altri artigiani lavorano il cuoio o la pelle, confezionando calzature, pantaloni e caratteristici copricapo, mentre altri ancora rifiniscono i gioielli.
Nel borgo ricostruito a St. Anne’s Park Raheny, c’è quindi la possibilità di vedere le tipiche imbarcazioni, dalla struttura allungata, e gli interni delle case, in cui le famiglie addossavano alle pareti diverse panche sulle quali dormivano, accanto ad altri mobili come sgabelli, tavoli piuttosto bassi e scranni destinati al padrone di casa. Poi si vedono lenze e fiocine per pescare, oltre a pale, vomeri o aratri per la coltura. E nella due giorni non mancheranno cortei, scontri, scaramucce e battaglie. I giardini botanici di Dublino ospitano invece per tutto l’anno una tipica abitazione vichinga, circondata da orti che si rifanno a quelli di mille anni fa. Riproposta in una versione con materiali rigorosamente naturali, la semplice struttura con una sola porta d’ingresso ha lo scheletro in legno, le pareti in vimini e la copertura di paglia che scende molto in basso. Nei giardini figurano oltre novanta specie di piante, fra cui il lino e la canapa, che venivano messi a coltura assieme a legumi, rape, cipolle, cavoli, segale e orzo. Per il calendario completo del millennio, che conta eventi anche ad Armagh, Clare, Tipperary: www.brianborumillennium.ie oppure www.clontarf.ie Stefania Romani aprile
MEDIOEVO
agenda del mese
Mostre firenze UNA VOLTA NELLA VITA. TESORI DAGLI ARCHIVI E DALLE BIBLIOTECHE DI FIRENZE U Galleria Palatina fino al 27 aprile
Tre documenti archivistici di Michelangelo; un disegno di Raffaello; il certificato di battesimo di Leonardo da Vinci e un altro testo che reca le sue postille; una lezione scritta di Galileo sull’Inferno di Dante; opere di Andrea Mantegna, Alessandro Allori e Giovanni Stradano; autografi di Girolamo Savonarola, Poliziano, Cosimo I de’ Medici, Joachim Winckelmann, Ugo Foscolo, Giuseppe Pelli Bencivenni, Giovanni Fabbroni, Pietro Vieusseux, Eugenio Barsanti, Vasco Pratolini, Eduardo De Filippo e Dino Campana, del Premio
a cura di Stefano Mammini
Nobel Eugenio Montale, presente anche con due inediti acquerelli. Tutto questo, e molto altro, è possibile ammirare nella mostra in programma nella Sala Bianca di Palazzo Pitti. Obiettivo dell’esposizione è quello di offrire l’opportunità di ammirare tesori cartacei custoditi in alcuni dei principali «scrigni» culturali della città. Tra i quali non manca una selezione di inediti, sequenza di «mai visti» di carta che arrivano da vari archivi e biblioteche. info tel. 055 2388614; uffizi.firenze.it ascoli piceno angeli nel medioevo ascolano U Pinacoteca Civica, Sala della Vittoria fino al 4 maggio
La mostra è la prima tappa di un progetto
triennale sul tema degli angeli nella tradizione artistica ascolana dal Medioevo al XIX secolo. Un programma che prevede, nel triennio 2013-2015, la realizzazione di tre esposizioni che presentano opere (dipinti, sculture, miniature, oreficeria...) raffiguranti «angeli» provenienti dall’Ascolano. L’obiettivo è quello di presentare il ricco patrimonio di opere presenti nel territorio, accomunate appunto dal tema degli angeli, scelto come osservatorio sul piú vasto ambito dell’arte sacra. Il risultato atteso è quello di uno studio organico del tema, divulgato attraverso la realizzazione di un catalogo-mostra, e quindi la diffusione della conoscenza del patrimonio storico e artistico del territorio. info associazione giovaneuropa.eu
monza AMORE E PSICHE. La favola dell’anima U Villa Reale fino al 4 maggio
Dopo essere stata presentata con successo a Mantova, fa
24
tappa a Monza la mostra che approfondisce la favola di Apuleio grazie a capolavori archeologici della Magna Grecia e dell’arte romana, per arrivare a Tiepolo, Tintoretto, Auguste Rodin, Salvador Dalí. Nel nuovo allestimento viene inoltre proposto un confronto con la Rotonda
Londra
dell’Appiani, edificio realizzato da Giuseppe Piermarini nel complesso della Villa Reale, che conserva gli affreschi di Andrea Appiani del 1791 che rappresentano proprio i vari episodi della favola narrata ne L’asino d’oro di Apuleio. Amore e Psiche. La favola dell’anima si basa sull’interpretazione del mito in chiave neoplatonica che venne data nell’Umanesimo, per la quale l’errore di Psiche consiste nel ritenere il divino come una realtà tangibile e verificabile con i sensi, mentre è solo il cuore che può percepirne pienamente la presenza. info tel. 0392 312185; e-mail: info@ fondazionednart.it; reggiadimonza.it
hanno ispirato la mostra che la National Gallery dedica ai maestri del Rinascimento tedesco. La rassegna presenta in una prospettiva diversa dipinti, disegni e stampe di artisti notissimi, come Hans Holbein il Giovane, Albrecht Dürer e Lucas Cranach il Vecchio;
una strana Bellezza: Maestri del Rinascimento tedesco U The National Gallery fino all’11 maggio
Che cosa determina la bellezza di un’opera d’arte? E in quale misura la percezione di questa qualità può mutare in funzione del contesto in cui vive il suo osservatore? Sono questi i quesiti che
aprile
MEDIOEVO
appuntamenti • I Longobardi. Alle radici della nostra storia U Monticello Brianza (LC) – Villa Greppi
12 e 13 aprile info tel. 039 9207160; ilongobardi.jimdo.com; villagreppi.it
P
atrocinata da «Medioevo», la manifestazione organizzata a Monticello Brianza (Lc) ha come protagonisti assoluti i Longobardi. La storia e i segreti di questa popolazione «barbarica», che conquistò l’Italia nel VI secolo e vi regnò per duecento anni lasciando una traccia indelebile nella nostra storia, saranno svelati con una grande mostra archeologico-didattica, un campo storico, attività ludico-rievocative e didattiche, eventi spettacolari e una conferenza di approfondimento. Le sale del Granaio di Villa Greppi ospiteranno una grande mostra con riproduzioni di armi, gioielli, oggetti d’uso dell’epoca longobarda (VI-VIII secolo d.C.), mentre negli spazi antistanti verrà allestito un campo storico con scene di vita quotidiana e artigianato per immergersi nell’atmosfera dell’epoca. Aggirandosi tra le tende dell’accampamento, animate dai rievocatori dei gruppi storici La Fara e Fortebraccio Veregrense, uomini e donne in abiti ricostruiti nei minimi dettagli con grande cura scientifica mostreranno al pubblico le occupazioni della giornata, le attività artigianali, la cucina, l’abbigliamento tipico delle donne e del guerriero. Ci saranno prove di abilità nel lancio della scure, nel tiro con l’arco e duelli, con stage aperti anche al pubblico. Durante i due giorni un esperto accompagnerà i visitatori all’interno del campo e della mostra in una «visita guidata» nella Storia. In programma anche eventi altamente spettacolari come l’Ordalia, ossia il combattimento tra due guerrieri, col vincitore decretato dal «giudizio di Dio» secondo la tradizione germanica, e la rappresentazione di un tipico rito funebre longobardo. Inoltre, sabato 12 aprile, alle 21,00, nella sala convegni del Granaio, la storica e saggista Elena Percivaldi terrà una conferenza dal titolo «I Longobardi in Lombardia e nel Lecchese». La conferenza, di taglio divulgativo ma di contenuto scientifico, vuole approfondire la storia dei Longobardi in relazione al territorio lecchese, mostrando nel contempo l’eredità morale (toponomastica, parole ed espressioni nelle lingue locali, riti e usanze) e materiale (patrimonio monumentale e archeologico) che hanno lasciato. Durante la manifestazione sarà anche possibile acquistare libri, materiali, manufatti e pubblicazioni sul tema.
opere di cui viene ricostruita l’accoglienza che ebbero presso i contemporanei e nel recente passato, confrontandola con il modo in cui vengono oggi fruite. Il Rinascimento tedesco fu parte del piú ampio risveglio culturale e artistico che interessò il Nord Europa tra il XV e il XVI secolo e grazie ai suoi talenti migliori, che sono appunto i protagonisti della mostra londinese, guadagnò presto fama internazionale. info nationalgallery.org.uk
MEDIOEVO
aprile
firenze RI-CONOSCERE MICHELANGELO. LA SCULTURA DEL BUONARROTI NELLA FOTOGRAFIA E NELLA PITTURA DALL’OTTOCENTO AD OGGI U Galleria dell’Accademia fino al 18 maggio
Realizzata in occasione delle celebrazioni per i quattrocentocinquanta anni dalla morte di Michelangelo Buonarroti, la mostra affronta il complesso tema del rinnovato interesse e dell’ammirazione per l’artista dall’Ottocento alla contemporaneità, attraverso l’opera di
scultori, pittori e fotografi che hanno guardato alla figura del Buonarroti e alle sue opere come riferimento iconografico per le loro realizzazioni. Partendo dalla produzione
fotografica realizzata da alcuni tra i piú noti atelier e professionisti del XIX e del XX secolo, viene evidenziato il ruolo determinante che la fotografia ha svolto nel consolidare la
fortuna critica e iconografica di Michelangelo e, attraverso di essa, la celebrazione del suo mito. Una lettura trasversale, in chiave storico-fotografica, che mette al centro il ruolo svolto dalla fotografia, fin dalle sue origini, nel celebrare uno dei massimi artisti del Rinascimento italiano, e nell’eleggere un ristretto pantheon di immagini di sue sculture a monumenti della memoria collettiva. info tel. 055 2388609; uffizi.firenze.it
25
agenda del mese Venezia L’immagine della città europea dal Rinascimento al Secolo del Lumi U Museo Correr fino al 18 maggio
Gli spazi al secondo piano del Museo Correr si aprono alla rievocazione dell’universo urbano europeo. Il visitatore ha l’opportunità di conoscere l’evolversi e i cambiamenti iconografici che il tema della raffigurazione della città ha subito nel corso dei secoli, dalla visione rinascimentale alla concezione dinamica delle avanguardie del primo Novecento. La mostra raccoglie immagini globali della città, topografie dipinte e disegnate da mani espertissime, di grande impatto qualitativo e spettacolare, che per secoli sono state l’unico o il piú suadente e immediato mezzo per mostrare la bellezza e la ricchezza delle maggiori città d’Europa. Tavole, tele, incisioni, atlanti e disegni danno vita a un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, tra le capitali europee e le città italiane: da quel «monumento xilografico» che è la Venetie MD di Jacopo de’ Barbari alle vedute di Firenze, Roma, Napoli, Genova, Siracusa di Gaspar van Wittel, Didier Barra, Alessandro Baratta, Jacob Philippe Hackert; dalle spettacolari rappresentazioni di Varsavia di Bernardo Bellotto fino agli scorci
26
della Londra del XVIII secolo. info call center, tel. 848 082 000; e-mail: info@fmcvenezia.it; correr.visitmuve.it New York Luce raggiante: vetrate della cattedrale di Canterbury U The Metropolitan Museum of Art, The Cloisters fino al 18 maggio
personaggi – Jared, Lamech, Terach, Abramo, Noè e Peleg –, provenienti dal coro della cattedrale, dal transetto orientale e dalla cappella della Trinità: fanno parte di una serie che comprendeva in origine le immagini di 86 antenati di Cristo e che viene considerata come il piú antico ciclo genealogico nella storia dell’arte universale. info metmuseum.org
L’Aia, dal quale provengono tutti i dipinti in esposizione. La ragazza con l’orecchino di perla è accompagnata da un altro importante dipinto di Vermeer, Diana e le sue ninfe, e, tra gli altri, da opere di Rembrandt e Frans Hals, Ter Borch, Claesz, Van Goyen, Van Honthorst, Hobbema, Van Ruisdael, Steen. info Call center, tel. 0422 429999; lineadombra.it
Bologna
Treviso
LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA U Palazzo Fava fino al 25 maggio
Magie dell’India. Dal tempio alla corte, capolavori dell’arte indiana U Casa dei Carraresi fino al 31 maggio
Il capolavoro di Vermeer è la presenza piú illustre all’interno della mostra che in Palazzo Fava ripercorre la storia del Secolo d’Oro della pittura olandese, realizzata grazie ai prestiti concessi dal Mauritshuis Museum de Sei vetrate policrome della cattedrale di Canterbury hanno lasciato per la prima volta la loro sede naturale: un evento eccezionale, mai prima d’ora verificatosi nella storia del magnifico ciclo, realizzato tra il 1178 e il 1180. La trasferta a New York è stata organizzata in occasione del restauro che ha interessato le strutture murarie della chiesa inglese e che ha reso necessaria la temporanea rimozione dei preziosi vetri. Nella sezione medievale del Metropolitan Museum of Art, i Cloisters, sono dunque giunti i ritratti in trono di sei
Gli oggetti e le opere d’arte riuniti in Casa dei Carraresi permettono di immergersi nel mondo magico dell’India, godendo di una rassegna che spazia dal II millennio a.C.
all’epoca dei Maharaja. Elementi architettonici, miniature, fotografie d’epoca, oggetti di uso rituale e quotidiano, costumi, tessuti, gioielli, accanto a statue e bassorilievi sono distribuiti in un percorso espositivo che ricostruisce le tappe salienti della civiltà indiana seguendo due filoni principali, che hanno come centro focale, rispettivamente, il Tempio e la Corte: «L’arte nell’India Classica» e «L’india dei Maharaja». Due poli, quello del Tempio e quello della Corte, che sfuggono al dualismo tipicamente occidentale tra sacro e profano e che nella cultura indiana non sono in alcun modo in contraddizione. info tel. 0422 513150 BRESCIA MORETTO, SAVOLDO, ROMANINO, CERUTI. 100 capolavori dalle collezioni private bresciane U Palazzo Martinengo fino al 1° giugno
La mostra presenta i piú significativi ritrovamenti compiuti negli ultimi anni, che hanno riportato alla luce capolavori di cui si erano perse le tracce, e aprile
MEDIOEVO
propone un viaggio attraverso secoli di storia dell’arte, esplorando le correnti pittoriche succedutesi nel tempo. Tra il XV e il XVI secolo, si è vissuta in Italia una stagione artistica straordinaria, di cui furono protagonisti tre soggetti: gli artisti, i committenti e i collezionisti, legati tra di loro dal comune denominatore del «gusto per il bello». Da un lato, gli artisti, con estro creativo e perizia tecnica, diedero
senso civico, donarono alla propria città. info tel. 030 2906403; e-mail: mostre@ provinciadibresciaeventi. com
Conegliano Un CinQuecento inQuieto. Da Cima da Conegliano al rogo di Riccardo Perucolo U Palazzo Sarcinelli fino all’8 giugno
Nel XVI secolo Conegliano vive un’eccezionale esperienza di cultura e si impone come uno dei cuori culturalmente
culturali e testimonianze artistiche e letterarie di singolare ricchezza, luogo di incontri e convergenze dei protagonisti della storia dell’arte: da Cima a Pordenone, da Lotto a Tiziano. Di questo affascinante e inquieto momento storico l’esposizione percorre i tratti salienti, soprattutto negli esiti pittorici, documentando la presenza e gli influssi da alcuni dei protagonisti di una stagione d’arte manifestata in dipinti di ufficiale e di pubblica devozione, opere piú sommesse e private, decorazioni e prodotti d’arte applicata, stoffe e suppellettili religiose e profane. info uncinquecentoinquieto.it
Ravenna
alla luce opere ancora oggi capaci di emozionare; dall’altro, i committenti, appartenenti alle gerarchie ecclesiastiche, alla nobiltà o alle classi medie arricchitesi col fiorire dei commerci, investirono parte dei loro capitali commissionando dipinti, sculture e arredi destinati ad abbellire chiese e palazzi, ville e castelli; infine i collezionisti, raffinati esteti dotati di una particolare sensibilità per il bello, crearono veri e propri «musei privati», che talvolta, spinti da intenti educativi e da un forte
MEDIOEVO
aprile
piú dinamici del territorio veneto. La città, con i suoi dintorni, da Serravalle a Montello fino ad Asolo, per circostanze storiche e territoriali e per la sua ineguagliabile qualità ambientale e paesaggistica, è stata un centro di interessi
L’incanto dell’affresco. Capolavori strappati da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo U Museo d’Arte della città fino al 15 giugno
Risalgono ai tempi di Vitruvio e di Plinio le prime operazioni di distacco, secondo una tecnica che prevedeva la rimozione delle opere con l’intonaco e il muro che le ospitava. Il cosiddetto «massello», che favorí il trasporto a Roma di dipinti provenienti dalle terre conquistate altrimenti inamovibili, dopo secoli di oblio trovò nuova fortuna a partire dal Rinascimento – nel Nord
come nel Centro della Penisola – favorendo la conservazione ai posteri di porzioni di affreschi che altrimenti sarebbero andati perduti per sempre. Cosí, in un arco temporale compreso fra il XVI e il XVIII secolo, vennero traslate, tra le altre, alcune delle opere piú importanti presenti in mostra: la Maddalena piangente di Ercole de’ Roberti (dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna) e il gruppo di angioletti di Melozzo da Forlí (dai Musei Vaticani). Un modus operandi difficile e dispendioso che a partire dal secondo quarto del Secolo dei Lumi venne affiancato, e piano piano sostituito, dalla piú innovativa e pratica tecnica dello strappo, prassi che tramite uno speciale collante permetteva di strappare gli affreschi e quindi portarli su di una tela. Una vera rivoluzione nel campo del restauro, della conservazione, ma anche del collezionismo del patrimonio murale italiano. info tel. 0544 482477 oppure 482356; e-mail: info@museocitta.ra.it; mar.ra.it
Londra Il Veronese: splendore nella Venezia del Rinascimento U The National Gallery fino al 15 giugno
Conosciuto come Il Veronese, Paolo Caliari (1528-1588) fu uno degli artisti piú rinomati e ambiti che operavano nella Venezia del XVI secolo. Le sue opere decoravano chiese, palazzi patrizi, ville ed edifici pubblici in tutto il Veneto e sono legati all’idea di fasto e splendore che abbiamo della Repubblica di Venezia di quel tempo. La mostra allestita alla National Gallery (che sarà poi ripresentata in Italia, a Verona, dal prossimo 5 luglio) riunisce le opere provenienti da ogni aspetto dell’attività dell’artista: ritratti, pale d’altare, allegorie e scene mitologiche, che rappresentano il picco della produzione dell’artista per ogni fase della sua carriera. info nationalgallery. org.uk
27
agenda del mese
Milano Da Gerusalemme a Milano. Imperatori, filosofi e dèi alle origini del Cristianesimo U Civico Museo Archeologico fino al 20 giugno
A 1700 anni dalla promulgazione dell’Editto del 313 d.C., il Civico Museo Archeologico di Milano propone un percorso espositivo che illustra il contesto storico, politico e religioso in cui è nato il cristianesimo e le correnti filosofiche e religiose che interagiscono con il suo progressivo affermarsi tra il I e il IV secolo d.C., nonché i complessi rapporti tra la Chiesa cristiana e il potere imperiale. Accompagnato da un ricco corredo esplicativo di pannelli illustrati che ne spiegano le tematiche, il percorso si apre con la sezione dedicata alla Giudea al volgere dell’era cristiana. Nelle sezioni successive vengono quindi sviluppati altri temi importanti, quali il cristianesimo e le filosofie classiche, l’Egitto tra antichi e nuovi dèi, i culti misterici, i cristiani e l’impero e le origini del cristianesimo a Milano. Quest’ultima chiude idealmente il percorso nella torre poligonale delle mura romane, i
28
cui affreschi del XIII secolo documentano la devozione verso i primi martiri milanesi, a quasi mille anni di distanza dal vescovo Ambrogio, figura cardine della Chiesa locale. info tel. 02 88465720 (Direzione Museo) o 02 88445208 (Biglietteria); comune.milano.it/ museoarcheologico; e-mail: c.museoarcheologico@ comune.milano.it londra vichinghi: vita e leggenda U The British Museum fino al 22 giugno
Dopo essere stata presentata a Copenaghen, giunge a Londra una delle piú ricche esposizioni sulla storia dei navigatori scandinavi. Tra gli obiettivi della rassegna, vi è quello di presentare un volto «internazionale» della cultura vichinga ritenuta in passato, erroneamente, come un sistema chiuso di valori e usanze che riflettevano la posizione di isolamento della penisola scandinava. Oltre a oggetti d’arte e manufatti artigianali di notevole
pregio, la mostra propone la ricostruzione integrale della piú grande nave vichinga a oggi nota. Si tratta dell’imbarcazione scoperta nel 1997 a Roskilde, in Danimarca, e databili agli inizi dell’XI secolo: un legno possente, che misurava 37 m di lunghezza, 4 di larghezza, aveva circa 80 remi e poteva trasportare un centinaio di guerrieri. Degni di nota sono inoltre il tesoro scoperto nel 2007 a Harrogate, nello Yorkshire, e reperti inediti provenienti dalla Norvegia e dalla Russia. info britishmuseum.org milano Giovanni Bellini. La pittura devozionale umanistica U Pinacoteca di Brera fino al 6 luglio
Il restauro della Pietà di Giovanni Bellini, appartenente alla Pinacoteca di Brera, è l’occasione per ripercorrere la prima carriera del pittore veneziano, grande protagonista dell’arte
rinascimentale italiana, attraverso il particolare angolo di visuale offerto dal suo modo di affrontare il tema del Cristo in pietà, che ricorre con frequenza nella produzione dell’artista e della sua
efficientissima bottega. Tra i temi dominanti che come un fil rouge unisce tutte le 26 sceltissime opere della mostra – evidente nel distico di grande commozione della Pietà di Brera – vi è il legame dell’artista con gli ambienti umanistici veneziani, attraverso i quali egli conobbe e sviluppò gradualmente la sua propensione per la rappresentazione degli affetti, della natura, del sentimento, della devozione e della commozione. info tel. 02 72263.257; e-mail: sbsae-mi.brera@ beniculturali.it; brera. beniculturali.it FERRARA Ferrara al tempo di Ercole I U Museo Archeologico Nazionale fino al 13 luglio
I lavori di riqualificazione del centro storico di Ferrara
hanno permesso di effettuare indagini archeologiche che aiutano a comprendere meglio il complesso palinsesto delle residenze estensi. Gli scavi hanno interessato la piazza Municipale, il retrostante Giardino delle Duchesse e la parte interna del Castello Estense, inclusa l’area dei «Camerini d’alabastro», restituendo una notevole quantità di oggetti in ceramica, vetro, metallo, alcuni di eccezionale qualità. Reperti che sono ora protagonisti della mostra ospitata al piano nobile del Museo Archeologico Nazionale. I temi della vita a corte e dell’aspetto del palazzo estense prima della trasformazione
avviata da Ercole I, sono illustrati da circa 200 pezzi per lo piú della seconda metà del XV secolo tra cui spiccano, per bellezza e rarità, un’eccezionale coppa su alto piede in vetro, probabilmente usata come fruttiera, e una seconda coppa in vetro verde smeraldo, realizzata a Murano. Notevoli, per numero e aprile
MEDIOEVO
qualità, le ceramiche graffite e smaltate che si sommano ad altre importate dall’area mediorientale e dalla Spagna; molto interessanti le mattonelle pavimentali in ceramica smaltata, una serie di frammenti architettonici decorati e numerosi elementi pertinenti a una stufa in ceramica di grandi dimensioni. info tel. 0532 66299; archeobologna. beniculturali.it
sempre preferito dai Medici e aperto alla varietà linguistica e al rinnovamento degli schemi compositivi della tradizione, l’altro, Rosso, fu invece legatissimo alla tradizione pur con aneliti di spregiudicatezza e di
Firenze Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della «maniera» U Palazzo Strozzi fino al 20 luglio
Pontormo e Rosso Fiorentino sono i protagonisti piú anticonformisti e spregiudicati del nuovo modo di intendere l’arte in quella stagione del Cinquecento italiano che Giorgio Vasari chiama «maniera moderna». E la rassegna a loro dedicata rappresenta anche un viaggio attraverso le vite parallele di questi artisti, «gemelli diversi» che, alla fine del loro percorso, arrivarono a un riavvicinamento. Pontormo e Rosso, che hanno reso straordinaria con il loro tratto artistico la prima metà del Cinquecento, nascono da una costola di Andrea del Sarto e con lui si formano, pur mantenendo entrambi una forte indipendenza e una grande libertà espressiva: uno, Pontormo, fu pittore
MEDIOEVO
aprile
originalità. Uno piú naturalista, vicino a Leonardo, l’altro influenzato da suggestioni michelangiolesche. info palazzostrozzi.org londra costruire l’immagine: l’architettura nella pittura rinascimentale italiana U National Gallery fino al 21 setembre (dal 30 aprile)
Obiettivo dell’esposizione è quello di documentare e sottolineare l’importanza di alcuni dei piú riusciti dipinti d’ispirazione architettonica firmati da maestri italiani quali Duccio di Boninsegna, Botticelli o Carlo Crivelli e da artisti loro contemporanei. Si vuole indurre il visitatore a guardare a queste
opere con un occhio diverso, per scoprire in che modo gli spazi fossero stati concepiti dai pittori e come essi avessero reso la concreta realtà delle materie da costruzione, come i mattoni, la calce o il marmo. Attraverso i dipinti selezionati, l’intento è inoltre quello di sfatare il luogo comune secondo il quale l’architettura, all’interno dei quadri, fosse soltanto uno sfondo, passivo e subordinato alla preminenza delle figure. Le opere esposte dimostrano infatti quanto le composizioni potessero essere spesso imperniate sui motivi architettonici e come essi venissero studiati fin dal primo abbozzo. info nationalgallery. org.uk trento ARTE E PERSUASIONE. LA STRATEGIA DELLE IMMAGINI DOPO IL CONCILIO DI TRENTO U Museo Diocesano Tridentino fino al 29 settembre
L’esposizione analizza, per la prima volta, il rapporto tra le decisioni assunte dal concilio in materia di immagini sacre e le arti figurative in uno specifico contesto territoriale. In una delle ultime sessioni dell’assise tridentina, la XXV del 3 dicembre 1563, fu infatti promulgato il decreto Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre immagini, con il quale la Chiesa assolveva l’uso delle
immagini sacre, la cui liceità era stata aspramente criticata dalla Riforma protestante. Richiamandosi alla tradizione, la norma esaltava la funzione didattica delle immagini e stabiliva alcuni principi generali circa le caratteristiche delle rappresentazioni da collocare negli edifici di culto. Demandava inoltre ai vescovi il controllo sulle raffigurazioni inconsuete da esporre nelle chiese. Sulla base del contenuto del decreto, nei decenni successivi furono pubblicati numerosi trattati dedicati alle arti figurative a soggetto sacro, all’architettura dei luoghi di culto e alla suppellettile liturgica, testi a prevalente carattere precettistico che svelano la forte preoccupazione della gerarchia ecclesiastica nei confronti dell’attività artistica e la conseguente volontà di riportarla entro i parametri precostituiti e codificati da una superiore autorità religiosa. info tel. 0461 234419; e-mail: info@museo diocesanotridentino.it; museodiocesano tridentino.it
Bath Nuovo Mondo, antiche mappe U American Museum in Britain fino al 2 novembre
Organizzata per salutare la pubblicazione del relativo catalogo ragionato, la mostra si
basa sui documenti che fanno parte della collezione di mappe storiche di Dallas Pratt, uno dei fondatori dell’American Museum in Britain di Bath. Le carte documentano il mutare e l’arricchirsi delle conoscenze geografiche, resi possibili dal susseguirsi dei grandi viaggi di scoperta e di esplorazione alla volta delle Americhe. Tra il XV e il XVII il «volto» del Nuovo Mondo cambiò piú volte e, grazie alle informazioni ricevute dai navigatori, geografi e disegnatori poterno tempestivamente aggiornarne le cartografie. info americanmuseum.org Artegna (UD) Il Castrum Artenia nel ducato longobardo di Forum Iulii U Castello Savorgnan fino al 13 novembre
La mostra rientra in un piú ampio progetto di valorizzazione del territorio e degli insediamenti castrensi altomedievali della regione, un progetto collegato ai programmi di sviluppo del sito UNESCO di Cividale del Friuli. Oltre a portare all’attenzione pubblica i risultati delle ricerche archeologiche sul colle di San Martino, viene sottolineata la centralità dei siti castrensi nelle dinamiche di sviluppo del ducato del Friuli nell’Alto Medioevo. info tel. 0432 977811; e-mail: info@com-artegna. regione.fvg.it
29
agenda del mese
Appuntamenti Perugia I martedí di San Bevignate U Complesso monumentale di San Bevignate 1°, 15, 29 aprile e 13 maggio
Il complesso monumentale, di cui è parte integrante la piú importante e piú riccamente decorata chiesa templare d’Italia, ospita un ciclo di conferenze avviato in occasione del settimo centenario della morte
sul rogo a Parigi del Gran Maestro del Tempio Jacques de Molay. Questi gli appuntamenti in programma: 1° aprile, Tommaso di Carpegna Falconieri, La leggenda templare. Un caso emblematico di medievalismo contemporaneo; 15 aprile, Jean-Claude Maire Vigueur, Essere cavalieri in una città comunale; 29 aprile, Gaetano Curzi, I Templari: monaci, soldati e committenti; 13 maggio, Chiara Frugoni, Diabolus in nubecula. Il diavolo si nasconde nei dettagli. info tel. 075 577.2829-2834; comune.perugia.it
30
Civitella Cesi (VT) LE ARMI ANTICHE: DALLE FORGE AI CAMPI DI BATTAGLIA. V Convegno Internazionale di Archeologia Sperimentale U Antiquitates, Centro di Archeologia Sperimentale 25-26 aprile
Dalla preistoria al Medioevo, le armi hanno da sempre contribuito a creare e
consolidare il potere, rappresentando un elemento caratterizzante e distintivo. L’interesse di archeologi e sperimentatori nei confronti di tematiche scientifiche relative alle armi e alla tecnologia a esse connessa, ha portato alla scelta di tale argomento come oggetto di indagine del V Convegno di Archeologia Sperimentale. Insieme agli interventi di carattere storicoarcheologico sulle armi, il loro uso funzionale e quello simbolico e sacrale, particolare attenzione sarà dedicata alle problematiche
minerarie, dall’estrazione del metallo alla sua utilizzazione e alle tecniche di realizzazione dell’«oggetto» arma. Come sempre, ampio spazio sarà riservato alla sperimentazione e alla didattica. Il convegno intende inoltre portare avanti il dibattito scientifico relativo all’elaborazione di strategie e metodologie comuni nel campo delle sperimentazioni archeometallurgiche, in continuità con gli anni precedenti. info tel. 0761 415031; e-mail: archeosperimentale@ antiquitates.it; antiquitates.it Altamura FEDERICUS 25, 26 e 27 aprile
Federicus è una festa medievale di rievocazione storica in omaggio a Federico II di Svevia. Questa III
edizione avrà per tema «Federico II di Svevia, Fede, Laicità e Superstizione». Nei tre giorni della manifestazione, al rombo dei tamburi e al suono delle chiarine, i tipici claustri, i vicoli e le piazze del centro antico di Altamura saranno trasformati in veri e propri teatri all’aperto, con cortei, giochi e spettacoli di strada. Artigiani e
numerose iniziative collaterali, tra le quali conferenze, tavole rotonde, presentazione di libri, oltre che mostre nel rispetto del tema. info federicus.it; e-mail info@federicus.it
mercanti animeranno le «botteghe» del vivace mercatino medievale. Mentre nel giardino del Monastero del Soccorso e nelle piazze principali saranno allestiti accampamenti. Anche quest’anno il centro storico sarà suddiviso in quattro «quarti» (latino, ebraico, greco, saraceno) i cui rappresentanti, in squadre, gareggeranno nel Palio di San Marco, sfidandosi in antichi giochi. La manifestazione sarà caratterizzata da
aperto per la prima volta la scorsa primavera, ha permesso di accedere a una serie di locali mai aperti al pubblico e utilizzati solo dalle maestranze dirette dai grandi architetti che si sono avvicendati nei secoli. L’itinerario permette di camminare «sopra» il sacro tempio e ammirare suggestive viste panoramiche «dentro»e «fuori» della cattedrale. info tel. 0577 286300 (lu-ve, 9,00-17,00); e-mail: opasiena@ operalaboratori.com
Siena Porta del cielo U Duomo fino al 6 gennaio 2015
Il Duomo di Siena riapre la sua «Porta del Cielo». Si può cosí tornare ad ammirare la sommità dell’imponente fabbrica. Il percorso,
aprile
MEDIOEVO
grandi battaglie formigny
32
aprile
MEDIOEVO
15 aprile 1450
Primavera
fatale
di Francesco Colotta
In un alternarsi di sanguinose battaglie campali e periodi, anche lunghi, di tregua, Francia e Inghilterra si fronteggiano da piú di un secolo, quando a Formigny, in Normandia, tornano a incrociare le armi. Questa volta, però, l’esito dello scontro è decisivo: si avvicina la fine della guerra dei Cent’anni
I I
l 15 aprile 1450 è una delle date piú infauste della storia militare inglese. In quel giorno di fine Medioevo, nei pressi del villaggio di Formigny (in Normandia, poco meno di 50 km a nord-ovest di Caen), le truppe britanniche subirono una sconfitta decisiva per le sorti della guerra dei Cent’anni, che spianò la strada al trionfo finale dei Francesi. Era uno degli ultimi atti di un conflitto che aveva ormai logorato i due regni, da tempo alle prese anche con gravosi problemi di politica interna. Per questo motivo, i sovrani avevano in precedenza firmato un armistizio, non prevedendo di incrociare le armi per un lungo periodo. I vecchi rancori, però, erano riemersi e fecero riprendere le ostilità ben prima della scadenza del trattato di pace. Teatro dell’ennesima resa dei conti fu la Normandia, avamposto chiave della Francia settentrionale e regione spesso cruciale negli equilibri strategici. Dopo la morte di Giovanna d’Arco (30 maggio 1431) e la «riconquista» francese, il conflitto si era trasferito dal campo di battaglia alle sedi dei negoziati. La conferenza di Arras del 1435 fu il primo atto di una quiete apparente, ma si concluse con un nulla di fatto a causa del ritiro della delegazione inglese. Proprio sul versante britannico, tuttavia, stava maturando la con-
Miniatura raffigurante la battaglia di Formigny, dalla Chronique du règne de Charles VII di Jean Chartier. 1470-1480. Parigi, Bibliothèque nationale de France.
MEDIOEVO
aprile
33
grandi battaglie formigny Carlo VII
«Vittorioso», ma solo di nome Era detto «il vittorioso», ma Carlo VII (1403-61) fu sempre descritto come un re debole e poco portato all’azione. Divenuto giovanissimo delfino di Francia, per la morte prematura dei fratelli maggiori, ebbe la luogotenenza del regno in seguito alla malattia mentale del padre, Carlo VI. Nella guerra civile si legò agli Armagnacchi, che lo elessero loro monarca. Stabilitosi a Bourges, nel 1419 firmò un accordo di pace con i Borgognoni per unire le forze contro
34
l’invasione degli Inglesi, che avevano ormai conquistato le regioni occidentali del regno. Si trattò di un patto virtuale, visto che Carlo VII e il suo entourage furono, poi, accusati del misterioso omicidio del duca di Borgogna, Giovanni Senza Paura. Diseredato dal padre nel 1420, l’ex delfino tornò in auge grazie a Giovanna d’Arco. Beneficiando delle sue imprese, fu incoronato re di Francia a Reims nel 1429, dopo l’affermazione militare di Orléans. Nonostante la crescita del suo prestigio,
il monarca mostrò ancora una volta scarso coraggio, non adoperandosi per la liberazione di Giovanna, catturata dagli Inglesi nel 1431. Carlo riuscí, comunque nell’impresa di liberare la Francia e mostrò di possedere doti da statista, riordinando l’assetto amministrativo del regno. Con lui la Francia ebbe una rapida ripresa economica e divenne un Paese unito. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel timore di subire congiure da parte del figlio Luigi.
In basso, sulle due pagine miniatura raffigurante il re di Francia Carlo VII che riunisce a consiglio la sua corte, da un manoscritto di scuola francese. XV sec. Bruxelles, Biblioteca Reale del Belgio.
aprile
MEDIOEVO
vinzione che fosse ormai auspicabile percorrere una strada diversa rispetto all’opzione militare. Lo imponevano i problemi finanziari del regno di Enrico VI, nonostante le obiezioni del partito interventista, spaventato dalla prospettiva di perdere troppi territori sul tavolo delle trattative. A rendere poco conveniente un ritorno alle armi contribuiva, poi, il nuovo scenario di alleanze politiche maturato in quel 1435: gli Inglesi non potevano piú contare sull’amicizia dei Borgognoni – i collaborazionisti che gli avevano consegnato Giovanna d’Arco – ormai tornati nell’orbita francese. I governanti di Londra – come ha osservato lo storico Ralph Griffiths – si trovavano «in un vicolo cieco, sia dal punto di vista militare che
A destra sigillo del re di Francia Carlo VII, detto il Vittorioso. 1458. Vaucouleurs, Musée Municipal.
finanziario, e senza piú avere alla loro testa un sovrano geniale come Enrico V». Allo stesso modo il monarca di Francia, Carlo VII, era restio a tornare sul campo di battaglia, oberato anch’egli da difficoltà interne. La guerra civile armagnacco-borgognona era finita, ma il re si trovava a fronteggiare un nuovo conflitto intestino, scoppiato per via del suo riformismo troppo radicale. Il sovrano aveva varato una serie di provvedimenti costituzionali con l’intento di procedere a una rapida centralizzazione statale del territorio. Quel riordino amministrativo era però risultato sgradito ad alcuni principi, i quali avevano deciso di ricorrere a forme violente di protesta per riconquistare gli antichi privilegi. Passata alla storia
con il nome di Praguerie, la rivolta impegnò l’esercito di Carlo per mesi, distogliendo l’attenzione del re da altri possibili impegni internazionali, primo fra tutti la prosecuzione della guerra contro i Britannici.
L’armistizio di Tours
Il monarca inglese, in aperta sfida al locale partito interventista, fece il primo passo verso la distensione fra le due principali potenze europee dell’epoca. Dopo aver esautorato lo zio guerrafondaio, Humphrey di Lancaster, il re nominò suo nuovo braccio operativo William de La Pole, conte di Suffolk, convinto assertore di una linea pacifista. A lui Enrico affidò il compito di trattare una tregua, a qualsiasi prezzo. La pace si rivelò subito un’opzione poco praticabile, visti i conflittuali interessi in gioco. Con grande sforzo,
MEDIOEVO
aprile
35
grandi battaglie formigny Nella pagina accanto ritratto di Enrico VI re d’Inghilterra, dipinto attribuito alla scuola di Francois Clouet (1510 circa1572). XVI sec. Collezione privata. In basso incisione raffigurante il matrimonio di Enrico VI re d’Inghilterra (1421-1471) e di Margherita d’Angiò, nipote di Carlo VII re di Francia (14291482), nel 1444. Fine del XVIII sec. Parigi, Bibliothèque des Arts Décoratifs.
36
quindi, si giunse a prospettare una tregua le cui modalità vennero discusse a Tours nel maggio del 1444. Alla fine le parti sottoscrissero un accordo che prevedeva un periodo di non belligeranza della durata di 5 anni, consacrato dalla celebrazione delle nozze tra Enrico VI e la nipote di Carlo VII, Margherita d’Angiò. Il nuovo corso delle relazioni franco-inglesi fece, inoltre, decollare gli scambi commerciali tra i regni, con enormi vantaggi reciproci per due economie da tempo depresse. Gli eventi successivi, però, minarono quasi subito la faticosa distensione dei rapporti, a partire dall’ostilità con cui fu accolta Margherita d’Angiò in terra inglese, un astio dietro cui si sospettava ci fosse lo zampino del partito interventista.
La corsa al riarmo
L’opzione militare tornò a far parte dei piani del regno inglese, sostenuta dai magnati e dai nobili che già si erano distinti nelle battaglie della guerra dei Cent’anni, e che avevano vasti possedimenti in Normandia. Dal canto loro, i Francesi pensarono di premunirsi, temendo un’imminente ripresa del conflitto e provvidero a riorganizzare le proprie milizie: sotto la supervisione del connestabile Arthur de Richemont, i male armati communes furono dotati di archi e balestre e al loro fianco furono organizzate efficienti bande di artiglieria di campagna, addette a far fuoco con i cannoni. A partire dal 1448, ripetute schermaglie nel Nord della Francia fecero da prologo al riaccendersi del conflitto. La scintilla scoppiò nel marzo dell’anno seguente, quando un cavaliere dell’Ordine britannico della Giar-
enrico vi
Il re fragile Enrico VI (1421-1471) divenne re d’Inghilterra a soli nove mesi, e per suo conto governò la madre Caterina di Valois, con la collaborazione del duca di Bedford e di Humphrey di Lancaster. Raggiunta la maggiore età, assunse il comando del regno nel periodo delle sconfitte inglesi nella guerra dei Cent’anni e nel 1444 legò la propria dinastia a una potente famiglia francese, sposando Margherita d’Angiò. Fu spesso accusato di gestire con scarsa energia la guerra contro la Francia, durante la quale cercò piú volte di trattare con il nemico. Dopo la perdita degli ultimi avamposti britannici in Normandia, fu colpito da una grave psicopatologia. L’alterata condizione mentale, secondo gli avversari politici, rendeva inopportuna la sua permanenza al trono. E per questa ragione, nel
aprile
MEDIOEVO
1453, Riccardo Plantageneto, duca di York, venne nominato erede e reggente d’Inghilterra. L’atto di forza di Riccardo fu una delle cause principali dello scoppio della guerra delle Due Rose tra gli York e i Lancaster (dinastia a cui apparteneva Enrico). In un primo momento Riccardo prevalse sul campo di battaglia, ma presto dovette fronteggiare il coraggio e l’aggressività della moglie del sovrano, Margherita, che si comportò da vero e proprio capo militare. Il suo ardore galvanizzò l’esercito dei Lancaster che vinse contro gli York a Wakefield nel 1460, ma i successi durarono poco. Enrico VI cadde prigioniero degli avversari e fu rinchiuso nella Torre di Londra, dove morí nel 1471. Quindici anni piú tardi i suoi discendenti piegarono definitivamente gli York nella battaglia di Bosworth Field.
MEDIOEVO
aprile
37
grandi battaglie formigny A destra cartina della Francia settentrionale con l’ubicazione di Formigny e delle principali località citate nell’articolo.
INGHILTERRA Bristol
Londra Calais
Portsmouth
Sfruttandone la debolezza, Carlo VII riuscí a strappare agli Inglesi molte importanti roccaforti in terra di Francia
Plymouth Cherbourg Bayeux B Caen
FORMIGNY Y
Avranches Brest
Falaise
Fougères
Parigi
FRANCIA
Rennes Angers
A sinistra Falaise (Bassa Normandia). Statua bronzea di Rollone, capo vichingo e primo duca di Normandia (dal 911 al 931 circa), facente parte del monumento in onore di Guglielmo il Conquistatore e dei sei duchi suoi predecessori. 1850.
La Normandia
Una regione contesa I Galli furono tra i primi a insediarsi nella Francia settentrionale. Nel periodo dell’occupazione romana l’intera Normandia faceva parte della «Seconda Lionese», che aveva come capitale Rotomagno (l’odierna Rouen). Agli albori del Medioevo la città divenne un importante centro religioso, grazie alla nomina a diocesi nel IV secolo, e, con l’avvento dei Merovingi, tutta la regione beneficiò di un periodo di grande crescita economicopolitica. Inglobata nella Neustria, conservò il suo ruolo di prestigio anche all’interno del vasto impero carolingio. Con lo sfaldamento di quest’ultimo subí, nel X secolo, un’ondata di invasioni da parte dei Normanni. Restò a lungo sotto la dominazione degli Scandinavi e uno dei loro discendenti francesizzati, il nobile Guglielmo il Bastardo, riuscí nell’impresa di conquistare l’Inghilterra nel 1066. La Normandia fu, quindi, unita al regno inglese, a guida normanna, e tornò a tutti gli effetti una regione francese solo nel 1204, sotto il sovrano Filippo Augusto. Contesa a lungo tra i Britannici e la corona di Francia nella guerra dei Cent’anni, la regione fu, alla fine, conquistata dai monarchi di Parigi.
38
aprile
MEDIOEVO
rettiera, François de Surienne, espugnò la città bretone di Fougères. A difesa del borgo intervenne il sovrano Carlo VII, il quale, essendo al corrente della debolezza politica dell’Inghilterra, aveva in realtà intenti molto piú ambiziosi: voleva liberare l’intera Normandia. Louviers, Pont-de-l’Arche, Conches e Verneuil caddero subito nelle sue mani e, alla fine del 1449, ben poche roccaforti nella regione erano rimaste sotto il controllo del governo di Londra. Tra le piú importanti figuravano Caen, Bayeux, Avranches, Falaise e Cherbourg.
Agguato alle spalle
Il 1450 si aprí con un’efficace controffensiva inglese: un contingente di circa 3000 uomini costrinse alla fuga il nemico in diverse zone della Normandia settentrionale, riprendendo città chiave dal punto di vista strategico, come, per esempio, Valogne. Guidati dall’esperto sir Thomas Kyriell, le truppe britanniche si diressero verso sud, potendo contare su ben
MEDIOEVO
aprile
2000 cavalieri in piú, provenienti da Rouen. La resistenza francese, affidata a un contingente ridotto di armati (3000 effettivi circa) sotto il comando del conte Jean de Clermont, non intervenne in tempo per bloccare la rapida avanzata degli avversari. Il grande scontro, a ogni modo, era solo rinviato. Vista l’inferiorità numerica del proprio esercito, Clermont preferí evitare, poi, il confronto in campo aperto, limitandosi a braccare gli Inglesi lungo il tragitto verso Caen, in previsione di un attacco alle spalle che avrebbe sferrato qualora fossero giunti i rinforzi promessi dal conestabile Richemont. In precedenza il comandante si era opposto ai proponimenti delle milizie locali, intenzionate a compiere un’imboscata In basso miniatura raffigurante la stipula del trattato di pace di Le Goulet, il 22 maggio 1200, tra Filippo Augusto e Giovanni Senza Terra, da un’edizione de Les Grandes Chroniques de France. XIV sec. Londra, British Library.
39
grandi battaglie formigny AIGNERVILLE
Fortino inglese
FORMIGNY
Francesi Artiglieria francese
Inglesi
Riserve inglesi
Ritirata degli Inglesi (seconda fase della battaglia)
Attacco dei Bretoni
fulminea durante il guado delle armate britanniche sull’estuario del Grand Vey, tappa obbligata nella marcia verso il Sud della Normandia. Alcune bande misero in atto il piano, ma senza fortuna. Le cronache riportano la reazione di scherno da parte di uno degli ufficiali inglesi, Mattew Gough, davanti a quell’improvvisato tentativo di aggressione: «Cani rabbiosi! – urlò agli assalitori – Siamo passati!».
A sinistra schema della disposizione delle truppe francesi e inglesi durante la battaglia di Formigny e dei loro movimenti nella seconda fase del combattimento, con l’arrivo dei rinforzi bretoni di Richemont. In basso, sulle due pagine la battaglia di Formigny, in una miniatura tratta dalle Vigiles du roi Charles VII di Martial d’Auvergne. Fine del XV sec. Parigi, Bibliotheque nationale de France.
In basso il monumento eretto a Formigny nel 1903 per commemorare la battaglia combattuta il 15 aprile 1450.
Una sosta improvvida
L’avanzata inglese si fermò pochi chilometri a nordovest di Bayeux, nelle vicinanze del villaggio di Formigny, dove le divisioni guidate da Kyriell decisero di acquartierarsi prima di sferrare l’offensiva finale per la riconquista della Normandia. Nel corso di questa improvvisa pausa di riflessione britannica i Francesi concepirono la loro strategia vincente, pianificando la già ventilata aggressione alle spalle degli invasori. Il 15 aprile del 1450 il conte di Clermont, accampato con la sua armata a Carentan, qualche chilometro a ovest di Formigny, marciò verso il nemico che, nel frattempo, aveva lentamente ripreso il viaggio in direzione di Bayeux. Sentendosi minacciato sulle retrovie, Kyriell ordinò allora alle truppe di interrompere il cammino e le dispose su tre file: davanti schierò gli arcieri, mentre alle spalle collocò i fanti e i cavalieri, con il supporto delle ali, la sinistra a ridosso di un ponte su un ruscello e la destra nei pressi del villaggio. Come ulteriore misura di protezione, fece scavare alcuni fossati, predisponendo, inoltre, imponenti gabbioni in prossimità del piccolo abitato. Sembravano cautele eccessive visto che le sue divisioni, in partenza, godevano di un’evidente superiorità numerica, sfiorando le 6000 unità, mentre i Francesi, in
40
aprile
MEDIOEVO
attesa di rinforzi, avevano sul campo gli stessi 3000 uomini con i quali avevano avviato le manovre. Clermont lanciò qualche timido attacco con la cavalleria e poi si convinse ad attuare la sua vera tattica. Fece arretrare le truppe, per metterle al riparo dalle frecce inglesi, e mise in campo l’arma segreta: i cannoni a lunga gittata, le colubrine, con i quali bersagliò con una pioggia di fuoco i soldati di Kyriell. Con colpi a ripetizione produsse gravi danni nelle file rivali, senza subire ingenti perdite per mano dei temuti contrattacchi degli arcieri. Il tiro a segno durò fino al momento in cui i Britannici, con un’azione a
MEDIOEVO
aprile
sorpresa, riuscirono ad accerchiare i tiratori francesi sottraendo loro i micidiali cannoni. A quel punto, la battaglia si tramutò in una disperata contesa per il possesso delle colubrine che tornarono nelle mani degli uomini di Clermont, dopo un’incursione lampo della cavalleria. Nonostante disponessero di nuovo dell’artiglieria pesante, i transalpini non riuscirono a piegare la resistenza delle difese delle truppe di Kyriell dotate di un’organizzazione eccellente. Nel momento in cui sul campo si registrava un sostanziale stallo, giunsero da sud ovest i sospirati rinforzi francesi, sotto il comando del connestabile
41
grandi battaglie formigny
42
aprile
MEDIOEVO
Nell’estate del 1450 i Francesi portarono a termine la conquista della Normandia con la presa di Bayeux, Caen e Cherbourg. La capitolazione inglese segnò il fallimento della politica moderata del conte di Suffolk, sottoposto in patria a un vero e proprio processo pubblico con l’accusa di aver favorito i nemici d’oltremanica. Richemont. Circa 2000 nuovi soldati, perlopiú cavaIl parlamento lo condannò per alto tradimento e, in cirlieri bretoni, piombarono sul campo di battaglia, cocostanze misteriose, l’uomo che Enrico VI aveva scelto stringendo tutte le unità nemiche a battere in ritirata per la pace, fu assassinato, proprio poche settimane doverso Formigny. Tuttavia, la loro brusca manovra di po la disfatta di Formigny. arretramento si rivelò controproducente, sfaldando le La resa dei conti nel governo inglese aggiunse tencompatte maglie difensive. sione in un establishment già messo a dura prova da rivolte popolari di difficile gestione, prima fra tutte quella L’attacco decisivo capeggiata dall’irlandese Jack Cade. Per il governo di Le forze di Clermont e di Richemont ne approfittarono Londra risultava quindi poco praticabile imbarcarsi di per sferrare congiuntamente l’attacco decisivo, penenuovo in un impegno militare di una certa portata per trando nelle linee avversarie ormai sparse in numero- la riconquista della Normandia. si gruppi. L’ultima, strenua resistenza inglese si conUn tentativo venne fatto nel 1452 e sembrò, all’icentrò su un fortino che le armate nizio, rivelarsi propizio, grazie alle di Kyriell avevano costruito prima ripetute affermazioni del comanDa leggere dell’inizio della battaglia, ma quel dante John Talbot, ma furono vitpiccolo gioiello di ingegneria militorie effimere. Nel 1453, a CastilU Philippe Contamine, La guerra dei tare non li salvò dalla disfatta e dallon, il suo esercito venne annienCent’anni, Il Mulino, Bologna 2002 le esecuzioni di massa. Al massacro tato dai Francesi e lo stesso Talbot U Larissa Juliet Taylor, Giovanna dei Britannici in rotta parteciparono morí insieme alla maggior parte d’Arco e la guerra dei Cent’anni, anche i contadini del circondario di dei suoi uomini. In Inghilterra, inBruno Mondadori, Milano 2010 Formigny, che contribuirono a far tanto, si stavano manifestando le U Gérard Walter (a cura di), La lievitare il numero delle vittime, fra prime avvisaglie della guerra tra le guerra dei Cent’anni del duca di gli sconfitti, a quasi 4000 unità. casate dei Lancaster e degli York, Lévis Mirepoix, Istituto Geografico Secondo molti esperti di strateche avrebbe insanguinato il regno De Agostini, Novara 1974 gia militare, la capitolazione inglese per trent’anni. U Kenneth O. Morgan (a cura di), poteva essere evitata. L’epilogo delStoria dell’Inghilterra. Da Cesare Il riscatto di Carlo lo scontro sarebbe stato diverso se ai giorni nostri, Bompiani, Milano In Francia, invece, gli effetti di le milizie di Kyriell avessero agito in 2007 Formigny generarono una signimodo piú rapido sul campo, evitanU Georges Duby, Storia della Francia, ficativa coesione politico-territodo, per esempio, la sosta a Formigny Bompiani, Milano 2001 riale, come mai si era manifestata e attaccando in massa il nemico nel nella storia. Il vituperato e debole momento in cui non disponeva dei Carlo VII diede prova di possedere cannoni. una fine intelligenza strategica, non perseguitando la La storiografia ha, spesso, esaltato la vittoria francese fetta di nobiltà regionale che aveva collaborato con il sottolineando la condizione di evidente inferiorità numerica dell’esercito di Carlo VII a Formigny. Le cifre riferite nemico e, in questo modo, ne conquistò il consenso. Inoltre continuò a garantire ai duchi di Normandia agli schieramenti di partenza sono state, però, oggetto di un certo margine di indipendenza amministrativa, revisione nel corso degli anni, soprattutto da parte briun privilegio che quei nobili persero, poi, nel 1469, tannica. Piú d’uno studioso inglese, anche per limitare la per effetto del centralismo ancora piú assolutistico portata della disfatta, ha cercato di ridimensionare i dati impresso da Luigi IX. «tradizionali», secondo i quali i rapporti di forza in campo Gli anni seguenti alla battaglia di Formigny rivestierano, in partenza, di 2 a 1 a favore delle armate di Kyriell rono, inoltre, un’enorme importanza simbolica per i e si mantennero soverchianti, a vantaggio dei Britannici, vincitori, perché coincisero con l’avanzare del processo anche dopo l’arrivo dei rinforzi di Richemont. La storica di riabilitazione di Giovanna d’Arco. Era stato un constatunitense Larissa Juliet Taylor sostiene, invece, che i Francesi fossero in superiorità numerica, seppur lieve, sigliere di Carlo VII, il canonico Guillaume Bouillé, a iniziare l’iter, istituendo una commissione d’inchiesta grazie al contributo tardivo della cavalleria bretone. Piú sulla condanna della Pulzella. L’iniziativa tendeva ad che dai numeri, comunque, lo scontro di Formigny fu addossare solo agli Inglesi la responsabilità dell’esecudeciso in gran parte dai cannoni e passò alla storia come zione dell’eroina, assolvendo gli ecclesiastici e il re di la prima battaglia dell’Europa Occidentale in cui l’artiFrancia per non averlo impedito. F glieria ebbe un ruolo davvero determinante.
La battaglia di Castillon, olio su tela di Charles-Philippe-Auguste de Larivière. 1838. Versailles, Château et Trianon. Nel dipinto si immagina la morte del comandante inglese durante lo scontro, avvenuto il 17 luglio 1453, che segnò la fine della Guerra dei Cent’anni e la definitiva vittoria francese.
MEDIOEVO
aprile
43
protagonisti genserico
di Federico Canaccini
Il grande
oltraggio
44
aprile
MEDIOEVO
Alla guida dei Vandali, Genserico trasformò in breve tempo il piccolo regno barbarico in una delle piú importanti potenze mediterranee. Tra gli episodi che segnarono la sua carriera vi fu il saccheggio di Roma, perpetrato con inaudita violenza. Eppure, ottemperando all’esortazione del Papa, il re decise di risparmiare la popolazione e di non distruggere l’antica città...
«G
G
rande pensatore, uomo di poche parole. Disprezzava il lusso ed era terribile nei suoi scatti d’ira. Desideroso in continuazione di nuove conquiste, era molto abile nel comandare i suoi barbari e nel fomentare zizzania fra i suoi nemici». Cosí lo storico goto Giordane (attivo nel VI secolo) descrisse, circa un secolo dopo il suo apogeo, il carattere del piú abile tra i re vandali. Genserico, nato presso il lago Balaton (oggi in Ungheria) nel 389, era figlio naturale di Godigiseleo, re dei Vandali. Il popolo che noi diciamo «vandalo», era, in realtà, una confederazione di tribú germaniche stanziate oltre il Danubio. Nella Germania (I secolo d.C.), lo storico romano Tacito li situava oltre i territori dell’impero, insieme ai Marsi, ai Gambrivi e agli Suebi. Paolo Diacono, nella Storia dei Longobardi, ci informa che, dopo una migrazione dei Winnili (Longobardi) dalla Scandinavia alla Scoringia, identificabile con l’attuale Polonia, i Vandali, sotto la guida dei due re, Ambri e Assi, guerreggiavano coi popoli circostanti. Intorno al IV secolo, essi dovevano dunque trovarsi nell’area dell’Ungheria o della Polonia.
L’invasione della Gallia
Forse nel 406, i gruppi piú riottosi, i Vandali Asdingi e Silingi, attraversarono il Reno presso Magonza, con alla testa Gunderico e, insieme a gruppi di Suebi e Alani, dopo aver raso al suolo la città, invasero la Gallia. Dopo tre anni di marce e saccheggi, li ritroviamo presso i Pirenei, superati i quali, destarono la preoccupazione dell’imperatore d’Occidente, che richiese ai piú fidati Visigoti di attaccarli e cacciarli. Negli anni seguenti il popolo vandalo fu impegnato in Spagna a fronteggiare Karl Pavlovich Brjullov, Genserico e i Vandali invadono Roma. Olio su tela, 1833-35. Mosca, Galleria Tretyakov. Si noti, a destra, in alto, il particolare del trafugamento della menorah, il candelabro a sette braccia, a suo tempo razziato a Gerusalemme da Tito.
MEDIOEVO
aprile
45
protagonisti genserico Didascalia aliquatur adi odis que vero ent
qui doloreium conectu eatur INVASIONI BARBARICHE E REGNI ROMANO - GERMANICI (IV rehendebis - VII secolo) tendamusam consent, perspiti conseque nis maxim eaquis earuntia cones apienda.
PITTI MARE D EL N O R D
York
Ibernia
JUTI
DANESI
BRITANNI ANGLI SASSONI
ATLANTICO
FRI
x Londra sse We JUTI Sussex
OCEANO
Tournai
Bordeaux
Lugo
Orléans Tours
CANTABRI
Aq u i t a n i a
Lus
itan
ia
IMPERO D’OCCIDENTE
Siviglia Cadice
Valencia
Bale
ari
Cartagena
Ceuta Tangeri
M Ce sare a
A
R
Sardegna REGNO DEI VA N D A L I M E D I Ippona N u m i di a
le tribú barbare rivali, i possidenti romano-ispanici e le truppe visigote filo-romane che li ricacciarono nel Sud della penisola iberica: nella regione che, ma non è certo, ereditò il nome di Vandalusia, cioè «terra dei Vandali», oggi Andalusia. Gli anni dell’occupazione della Spagna dovettero essere particolarmente violenti. Cosí li ricorda il vescovo e cronista galiziano Idazio (395-470): «Imperversando i barbari per la Spagna, e infuriando il
Verona
Aquileia Ravenna Ancona
Cartagine
Africa
male della pestilenza, l’esattore tirannico e il soldato depredano le sostanze nascoste nelle città. La carestia infuriò cosí forte che le carni umane furono divorate dal genere umano: le madri uccisero o cossero i propri nati mangiandoseli. Le bestie feroci, abituate ai cadaveri uccisi con la spada, dalla fame o malattia, uccidono qualsiasi essere umano con le forze che gli restano, si nutrono di carne, preparando la brutale distruzione del genere uma-
DI
ia
D
OS al
Salona
Corsica
BAR
on
n Pan
Milano Genova
GO
ERULI Vienna SCIRI
I RUG Norico
Rezia
Arles e nes o Provenza rb Narbona Na Marsiglia
LON
Ratisbona
Augusta
DEI
VASCONI REGNO Lisbona DEI Toledo Barcellona VISIGOTI Tarragona Mérida
BAVARI
ALAMANNI
BURGUNDI
Tolosa
Pamplona
Cordoba
Scheidungen
Verdun Strasburgo
REGNO
Lione Vienne
Novempopulana
Salamanca
46
Colonia
BRITANNI ONI S A S S Parigi Soissons Magonza Armorica Treviri Letavia DOMINIO DI SIAGRIO Spira Poitiers
REGNO DEI Braga SUEBI
SO
ANGLI NI SO S A S Runibergun
NI
FRANCHI
Nantes
MAR BA L T I C O
Scandia
(Li ESTI tua ni)
SCOTI
m
az
Roma D O M I N I O Ostia
TRO
Sirmio
GO
TI
ia Scutari
DI
Napoli
Durazzo
O D OAC R E
Te
I Marsala
T
E
Sicilia
R
Messina
R
Siracusa
A
N
E
O
no. E la punizione di Dio, preannunciata dai profeti, si verificò con le quattro piaghe che devastarono l’intera Terra: la carestia, la peste, la spada e le bestie».
Dalla terra al mare
Nel 420 i Vandali riportarono un’importante vittoria contro l’esercito goto-romano capitanato da Castino, assicurandosi il dominio sui porti della Spagna meridionale. Dopo aver assunto i costruttori di aprile
MEDIOEVO
Principali migrazioni dei popoli barbari
Situazione politica all’anno 476 Unni Alani, Vandali e Suebi Ostrogoti
ni)
Visigoti Franchi
i re vandali (anni di regno)
?-406 Godigiseleo 406-428 Gunderico 428-477 Genserico 477-484 Unerico 484-496 Gutemondo 496-523 Trasamondo 523-530 Ilderico 530-534 Gelimero
Burgundi
P O P O L A Z I O N I S L A V E
Alamanni Angli, Sassoni e Juti Pitti e Scoti Longobardi Britanni
RDI
Razzie e spedizioni di Vandali marittime dei Vandali Impero Romano tempo romano alal tempo di Diocleziano (284-305)
ia
Divisione dell’Impero dell’impero da parte di Teodosio (395)
M A R
Sciz
I Novae
N E R O Sinop
Mesia
Filippopoli
Eraclea
Adrianopoli
T r a c i a
Teodosiopoli
Nicomedia
Costantinopoli
Tessalonica
Nicea
Cesarea
IMPERO D’ORIENTE MAR EGEO
Atene Corinto
A
Efeso
si an a
navi del luogo, iniziarono timidamente a praticare la navigazione, «arte a loro precedentemente sconosciuta», ma ben presto i loro vascelli raggiunsero le Baleari e anche la Mauritania. A capo dei Vandali, in questi anni, troviamo Gunderico, primo figlio di Godigiseleo, «ma egli – scrive lo storico greco Procopio di Cesarea (attivo tra il V e il VI secolo) – era ancora molto giovane, senza quel forte temperamento che invece era
MEDIOEVO
aprile
Trebisonda
Iconio
Is
a
i ur
a
Tarso Antiochia
A destra Genserico, re dei Vandali e degli Alani, in una incisione ottocentesca.
47
protagonisti genserico la caratteristica precipua di Genserico il quale aveva appreso l’arte della guerra alla perfezione ed era quindi il migliore fra tutti gli uomini». Cosí, verso il 428, la carica di sovrano passò – forse dopo la morte prematura di Gunderico – al fratellastro trentenne Genserico, il quale condusse il suo popolo verso memorabili imprese. Il nuovo re doveva assecondare sia il desiderio dei veterani di stabilirsi in un territorio in cui poter coltivare i campi, facendosi una famiglia, sia le leve piú giovani e ambiziose: dopo aver compreso che essi mai avrebbero potuto rivestire funzioni in nome dell’impero in Spagna, per la presenza ingombrante dei piú fidati Visigoti, il sovrano stabilí di volgere le proprie attenzioni alla vicina provincia d’Africa.
Un’antica menomazione
Zoppo da una gamba, per una caduta mal curata, Genserico riassaporò il gusto di condurre i propri uomini alla vittoria dal pontile di una nave, anziché dalla sella di un cavallo. Nel 429 l’intero popolo vandalo,
48
Nella pagina accanto verso di un solido aureo di Valentiniano III, imperatore dal 425 al 455, con il sovrano raffigurato in atto di calpestare un serpente a testa umana, mentre regge una croce e un globo sormontato da una Vittoria. In basso incisione ottocentesca raffigurante Clodione il Chiomato, re dei Franchi Salii, che, sconfitto da Ezio, generale di Valentiniano III, è costretto a riattraversare il Reno.
i decenni vandalici 425-455 Valentiniano III, figlio di Flavio Costanzo e Galla Placidia, è imperatore in Occidente. 428 Genserico diviene re dei Vandali e degli Alani. 429 I Vandali di Genserico invadono l’Africa romana. Nel corso dell’assedio di Ippona muore il vescovo della città, Agostino. 433-454 Ezio ottiene il comando supremo sull’esercito e governa in Occidente. 435 Ezio si accorda con Genserico. I Vandali ottengono terre in Numidia e Mauritania. 436-437 Gli Unni distruggono il regno dei Burgundi a Worms. Ezio sposta i superstiti intorno al lago di Ginevra (443). 436-439 Guerre tra Ezio e i Visigoti. Nuovo trattato di pace. 437 Ezio sconfigge le rivolte contadine dei Bagaudae e riprende il controllo dell’Armorica. I Franchi Salii sotto la guida del re Clodione occupano Tournai e ne fanno la loro capitale. 438-441 Gli Svevi conquistano le province romane di Betica e Cartaginense in Spagna. 439 I Vandali espugnano Cartagine e conquistano le province di Africa Proconsolare e Bizacena. Ezio riconosce ai Goti i territori da loro conquistati in Gallia. 440-453 Attila diviene re degli Unni insieme al fratello Bleda. 440-461 Leone I Magno papa. 441-442 Prima invasione unna nei Balcani sotto la guida di Attila. Angli e Sassoni invadono la Britannia. I Romani abbandonano l’isola. 442 Trattato di pace tra Ravenna e i Vandali. Genserico ottiene la Proconsolare, la Bizacena e la Numidia.
445 Attila uccide il fratello Bleda e regna da solo sugli Unni e le altre genti sottomesse. 446 Vittorie di Ezio sui Franchi. 447 Attila invade nuovamente i Balcani. Lo scontro al fiume Utus è sfavorevole ai Romani. Regno di Meroveo sui Franchi. 450 Morte di Teodosio II. Marciano (450-457), il nuovo imperatore, sale al trono con l’appoggio di Aspar. 451 Incursione di Attila in Gallia. Assedio di Metz e di Orléans. Battaglia dei Campi Catalaunici: Ezio vince gli Unni con l’aiuto di Burgundi, Visigoti, Franchi. Il re dei Visigoti Teoderico I muore in battaglia; gli succede Torrismondo. Il concilio di Calcedonia condanna l’eresia monofisita. 452 Incursione di Attila in Italia. Devastazione di Aquileia e Milano. 453 Morte di Attila. L’impero degli Unni si sgretola. Teoderico II nuovo re dei Visigoti. 454 Battaglia del fiume Nedao. I Gepidi e altri Germani orientali si liberano dal giogo degli Unni. Valentiniano III fa uccidere Ezio. 455 Assassinio di Valentiniano III da parte degli uomini di Ezio. Petronio Massimo è proclamato imperatore. Alla notizia dello sbarco dei Vandali, Petronio Massimo tenta di fuggire, ma viene ucciso. Genserico, re dei Vandali, mette a sacco Roma per la seconda volta. Tornato a Cartagine con un ricco bottino di beni e prigionieri (tra cui le principesse della famiglia imperiale), aggiunge al suo regno Tripolitania, Sardegna e Baleari. Si forma l’«impero mediterraneo» dei Vandali. Il re dei Visigoti Teoderico II sostiene la proclamazione del gallo-romano Avito a imperatore. 456 Battaglia di Piacenza. Avito è sconfitto da Ricimero e Maioriano. 457-461 Maioriano imperatore d’Occidente. Il suo potere è contrastato dal suo potente generale Ricimero. 457-474 Leone diviene imperatore a Costantinopoli con il sostegno di Aspar. 459 Gli Ostrogoti della Pannonia, sotto il
MEDIOEVO
aprile
comando dell’amalo Valamer, invadono l’impero d’Oriente e ottengono il pagamento di un tributo in cambio della pace. Teoderico l’Amalo ostaggio a Costantinopoli. 460 Fallimento della grande spedizione organizzata da Maioriano contro i Vandali. 461 Maioriano viene ucciso. Ricimero fa proclamare imperatore d’Occidente Libio Severo. 462 Incursioni dei Vandali sulla costa italiana. 464 Ricimero sconfigge a Bergamo gli Alani. 465 Ricimero fa eliminare Libio Severo. 466-484 Eurico re dei Visigoti. 467 Antemio imperatore d’Occidente (fino al 472). 468 La spedizione contro i Vandali di Basilisco, generale dei Romani, termina in una disfatta. 469 Dengizich, figlio di Attila, viene sconfitto dai Romani e ucciso. La minaccia unna sul Danubio è debellata. Eurico entra in guerra con l’impero. Sconfitta degli Armoricani alleati dei Romani. 471 L’imperatore Leone organizza una congiura contro Aspar. Il potente magister e suo figlio Ardabur vengono uccisi a Costantinopoli. 472 Guerra civile in Italia tra Ricimero e l’imperatore Antemio. Anicio Olibrio è proclamato imperatore da Ricimero. Terzo sacco di Roma e morte dell’imperatore Antemio, ucciso dal burgundo Gundobado. Morte di Ricimero. Morte di Anicio Olibrio. 473-489 Teoderico l’Amalo diviene signore degli Ostrogoti nei Balcani e combatte contro il governo di Costantinopoli. 473 Glicerio è imperatore d’Occidente. Eurico conquista Tarragona in Spagna. 474 Zenone diviene imperatore d’Oriente. Giulio Nepote depone Glicerio e viene proclamato imperatore d’Occidente da Zenone. 475 Guerra tra Oreste e Giulio Nepote che, sconfitto, si ritira in Dalmazia. Oreste proclama imperatore suo figlio Romolo Augustolo, poi conclude un patto con i Vandali. L’Alvernia cade nelle mani dei Visigoti. 476 Uccisione di Oreste e di Paolo da parte di Odoacre. Il giovane Romolo Augustolo viene deposto. Termina l’impero romano d’Occidente. Odoacre è signore dell’Italia (476-493). Eurico annette al regno dei Visigoti la Provenza e Arles. 477 Morte di Genserico. Gli succede come re dei Vandali il figlio Unerico.
49
protagonisti genserico eudossia licinia
Una vita burrascosa Figlia dell’imperatore Teodosio II e di Eudocia Augusta, Eudossia Licinia divenne, a soli 17 anni, imperatrice d’Occidente, avendo sposato, nel 439, l’imperatore Valentiniano III. Quando, nel 455, il marito fu assassinato, fu costretta, sotto minaccia di morte, a sposare l’usurpatore Petronio Massimo, già coinvolto nell’uccisione del generale Ezio. La giovane imperatrice fu la rovina del suo violento marito: come Onoria, sorella di Valentiniano III, aveva chiamato in suo aiuto Attila e i suoi Unni, cosí Eudossia si appellò a Genserico.
50
Alla notizia dell’arrivo dei Vandali, nel panico che si impossessò di Roma, Petronio venne ucciso. Eudossia, infine, dopo il sacco di Roma, fu condotta in Africa assieme alle figlie Placidia ed Eudocia; poté far ritorno a Costantinopoli solo nel 462, dove morí verso il 493. A lei si devono diverse iniziative di architettura religiosa, tra cui la edificazione della basilica di S. Pietro in Vincoli, dove vengono tuttora custodite le catene che avrebbero legato il santo e che lei avrebbe ricevuto in dono dalla madre. aprile
MEDIOEVO
A destra Gubbio, S. Agostino. Una scena del ciclo con Storie di Sant’Agostino, raffigurante l’arrivo del santo a Cartagine. Affresco di Ottaviano Nelli, prima metà del XV sec. Nella pagina accanto medaglione in oro e smalti, attribuito a Eudossia Licinia, figlia di Teodosio II, moglie di Valentiniano III e imperatrice d’Occidente. Arte bizantina. Parigi, Bibliothèque nationale de France.
che ammontava a circa 50 000 uomini, di cui almeno 15 000 armati, attraversò i pochi chilometri dello stretto di Gibilterra, riversandosi in Mauritania, dove la resistenza bizantina era minore: vi erano infatti stanziati solo 5 reggimenti comitatensi, di cui appena due effettivi, e altre truppe preposte al presidio dei castelli, per un totale di circa 1500 armati. La loro resistenza, perciò, fu pressoché nulla. A ciò si aggiunga un possibile invito da parte del condottiero imperiale Bonifacio che, secondo Giordane e Procopio, avrebbe addirittura favorito lo sbarco vandalo. Ma perché? Bonifacio aveva mantenuto l’ordine in Mauritania con l’uso della forza, ottenendo brillanti risultati contro i Mauri e altri popoli del deserto. Ma sant’Agostino, in una lettera, lo rimprovera giacché ora quello stesso Bonifacio «tollera che i barbari saccheggino e devastino ampie regioni un tempo popolose e ora ridotte a squallidi deserti». L’uomo viveva a quel tempo un profondo dissidio religioso: avrebbe volu-
MEDIOEVO
aprile
to vivere ispirandosi al messaggio evangelico, e si trovò invece sempre a combattere. Agostino lo rassicurò piú volte, affermando che «si inizia una guerra per conseguire la pace». Inoltre, pur avendo pensato di vivere in continenza per farsi monaco, Bonifacio sposò una donna ariana, suscitando lo sdegno del futuro santo: «Cosa altro posso dire in questo momento in cui i Vandali distruggono l’Africa e tu sei attanagliato da questa imbarazzante situazione, senza che tu faccia nulla? Non avrei dovuto dissuaderti dal farti monaco, non avresti fatto danno alla collettività, continuando con la tua opera militare»!
Una tregua effimera
Rifiutatosi di recarsi a Ravenna nel 427 per giustificare i suoi insuccessi, Bonifacio provocò una spedizione mirata alla cattura. A questo punto – ma gli storici non concordano – avrebbe preferito l’aiuto dell’ariano Genserico anziché affrontare da solo l’esercito imperiale: fu perciò grazie a queste truppe
– e la fede ariana della moglie non dovette essere un ostacolo! – che egli riuscí a ottenere una tregua con l’insoddisfatto imperatore per poi essere subito impegnato in una lotta contro i Vandali che, irrimediabilmente, perse. Durante l’assedio di Ippona (sulla costa mediterranea dell’attuale Algeria orientale, n.d.r.), dove riparò Bonifacio, moriva anche sant’Agostino, come narra il suo biografo Possidio, che ricorda come «gli invasori passarono anche nelle altre regioni, e imperversando con ogni crudeltà saccheggiarono tutto ciò che poterono fra spoliazioni, stragi, tormenti, incendi e altri innumerevoli e nefandi disastri. Non risparmiarono né sesso né età, neanche i sacerdoti e i ministri di Dio, neppure gli ornamenti, le suppellettili e gli edifici delle chiese». Genserico e i suoi si erano dunque convertiti al cristianesimo, ma nella versione eretica di Ario, e perciò la guerra in Africa assunse anche i toni dell’intolleranza religiosa contro coloro che abitavano quelle regioni
51
protagonisti genserico Cosí parlava Genserico
«Signore, pietà!» Come parlavano i Vandali? La lingua di Genserico è una di quelle lingue germaniche ormai morte, di cui pochissime informazioni ci sono giunte. Sappiamo che era vicina alla lingua della Germania orientale, e perciò dei Goti, idioma che conosciamo meglio. Nessun documento scritto in vandalo ci è pervenuto, e dagli scarni frammenti posteriori, possiamo elencare poche parole, oltre a un centinaio di nomi propri, formati spesso da due parole parlanti, come per esempio Hari-fridus= esercito+pace, Vili-mut= volontà+animo. I nomi vandalici mantengono sovente i suffissi, tipici anche per i goti, -ila per i maschili (Scar-ila= schiera+suffisso maschile), -ilo per i femminili (Val-ilu= scegliere+suffisso femminile). La formula piú certa, giunta in una collazione di testi sacri, è «Signore, pietà», in vandalico «Froia, arme», formula anche gotica che attesta probabilmente come, nella liturgia, venisse usata la lingua dei Goti e della Bibbia ariana di Ulfila, percepita come un linguaggio solenne e arcaico. Un brevissimo brano ci fa conoscere poi cinque parole vandaliche, inserite in un testo latino che riporta le grida udite nei banchetti vandalici. «Inter eils goticum scapia matzia ia drincan non audet quisquam dignos educere versus». Queste parole sono oggi interpretate come Eils: «Salute!», vicino all’heil tedesco; scapia: «fare»; matzia ia drincan: «mangiare e bere», dove drincan rinvia all’inglese drink. Sono ritenute vandaliche, benché con forti dubbi, baudus= signore, abra= forte, ma poco altro rimane di questa lingua ormai scomparsa.
e che, come il loro vescovo Agostino, erano invece cattolici. Alla guida di Ippona fu posto l’alano Aspar, il quale stabilí rapporti piú amichevoli con Genserico, che era «re dei Vandali e degli Alani», al punto da far riconoscere i Vandali come foederati. Aspar aveva mantenuto il controllo su Cartagine fino al 434, lasciando comunque a Genserico la possibilità di fare razzie dal porto di Ippona. Nel 439, con un attacco a sorpresa, stando a Idazio, i Vandali si impadronirono di Cartagine, del suo porto e dei suoi cantieri, riuscendo in breve tempo a far costruire una flotta assai potente.
Il sogno realizzato
Si contano quasi solo sulle dita di una mano le parole riconducibili alla lingua parlata dai Vandali 52
Già un anno dopo la conquista di Cartagine, Alani, Vandali, Goti e Mori saccheggiano le coste della Sicilia che, dopo la caduta della provincia d’Africa, era divenuta la principale fornitrice di olio e cereali dell’Italia. La flotta bizantina, con a capo il goto-romano Aerobindo, dovette rapidamente fare retromarcia, ancor prima di impegnare battaglia, per una minaccia unna nei Balcani e per gli attacchi persiani nel limes orientale. L’imperatore, a questo punto, dovette riconoscere a Genserico il titolo di Governatore indipendente, concedendogli ampi territori della Mauritania, da Gibilterra
In alto retto di un solido dell’imperatore Petronio Massimo, con il busto del sovrano incoronato dal diadema. 455 d.C. Boston, Museum of Fine Arts. In basso, a sinistra fibbia a placca per cintura e anello con iscrizione, dal tesoro di Koudiat Zaateur. Produzione vandalica, secondà metà del V-inizi del VI sec. Cartagine, Institut National du Patrimoine de la République Tunisienne. Nella pagina accanto mosaico funerario a soggetto cristiano dalla tomba di una bambina a Tabarca (l’antica Thabraca, Tunisia). IV-V sec. Tunisi, Museo del Bardo.
aprile
MEDIOEVO
a Cartagine, su tutte le province dell’Africa occidentale (Proconsolare, Bizacena e Tripolitania). Genserico aveva ottenuto ciò che per molti Germani era un sogno: essere cioè inquadrato in quel sistema imperiale che era l’autorità riconosciuta da oriente a occidente. Il poeta Merobaudo (V secolo) cosí descrive questo mutamento: «Il barbaro che ha osato devastare il palazzo reale di Didone (…) ora non si presenta piú come nemico e desidera ardentemente avvicinarsi alla dottrina di Roma, per trattare i Romani come suoi congiunti e per far unire in matrimonio la sua prole». In effetti una proposta di matrimonio fra Eudocia, figlia dell’imperatore d’Occidente Valentiniano III, e Unnerico, figlio del re vandalo, era stata probabilmente avanzata dal generale Ezio, consapevole dell’impossibilità di sconfiggere in battaglia i Vandali. L’allettante proposta però indusse Genserico a commettere il suo primo grande errore politico: Unnerico era già sposato con una principessa visigota, ma Genserico, per liberarlo da quel vincolo, fece accusare ingiustamente la fanciulla di aver tentato di avvelenarlo. Dopo averle fatto tagliare naso e orecchie, fu rimandata a Tolosa dal padre che giurò vendetta. Da allora tra Visigoti e Vandali fu guerra aperta, mentre la proposta di matrimonio proveniente da Roma fu annullata: Genserico aveva acquisito soltanto un nuovo nemico.
Un ritratto calunnioso
Dopo la conquista africana, Genserico dovette probabilmente godersi i frutti delle sue conquiste: il poeta Sidonio lo descrive come «un ubriacone, la cui flaccidezza ha preso il sopravvento e il cui stomaco, già pieno di cibarie, riesce a malapena a digerire altro». Se il disilluso poeta latino voleva raffigurare un condottiero dimentico delle sue imprese e oramai sprofondato nel vizio, i fatti degli anni successivi lo dovettero far lungamente ricredere. Dopo l’omicidio del generale Ezio, ordito dal sospettoso impe-
MEDIOEVO
aprile
53
protagonisti genserico la marineria
Didascalia aliquatur adi odis que vero ent qui doloreium conectu rehendebis eatur tendamusam consent, perspiti conseque nis maxim eaquis earuntia cones apienda.
Da cavalieri a terrore dei mari Non possediamo molte informazioni, né tantomeno manufatti, sulla formidabile flotta che spadroneggiò nel Mediterraneo occidentale nel V secolo. Attraversato lo stretto di Gibilterra nel 429, il popolo vandalico conquistò Cartagine dieci anni dopo e, nel 440, aveva già allestito una potente flotta. Non sappiamo di che tipo fossero queste imbarcazioni, ma se la popolazione cartaginese conquistata dovette – come si ipotizza – costruire le navi per gli invasori, è probabile che si ispirarono al modello bizantino della leggera galea o del dromòne («il corridore»), la veloce nave da guerra imperiale che solcava il Mar Mediterraneo. Si trattava di una diretta evoluzione delle galee liburne romane, dotata, già nel V e VI secolo, di una sola fila di ratore Valentiniano (vedi box a p. 50), quest’ultimo fu pugnalato a morte dai buccellarii, le guardie del corpo, che cosí vendicarono il generale alano. La situazione politica a Roma precipitò: la vedova di Valentiniano dovette sposare Petronio Massimo, nuovo imperatore, ed Eudocia, precedentemente promessa al figlio di Genserico, fu data in sposa al figlio dell’usurpatore. Ora che Ezio e Valentiniano, con i quali Genserico aveva stipulato un trattato di pace, erano morti, anche il trattato aveva perso la sua validità: Eudossia, inoltre, orripilata dal comportamento del suo nuovo marito, scrisse al re vandalo, richiedendo la sua protezione. Per dieci anni i Vandali avevano rafforzato la loro flotta per una grande spedizione e ora giungeva la grande occasione. La missione fu organizzata in tempi rapidissimi e la bella stagione favorí la riuscita dell’impresa. Alla fine del maggio del 455 la flotta giunse alle foci del Tevere e nessuno osò ostacolarla. A Roma si diffuse il panico e lo stesso Petronio Massimo, preso da timore, il 31 maggio montò a cavallo per fuggire. La folla però, sentendosi abbandonata, dopo averlo riconosciuto, atterratolo da cavallo, lo linciò e il suo cadavere, fatto a pezzi, fu gettato
54
rematori, capace di trasportare fino a 35 rematori, protetti da un parapetto e munita di ponte completo e di un rostro fuor d’acqua. Si stima che tali navi fossero lunghe circa 15 m, con una stazza di 18 t, in grado di raggiungere oltre i 6 nodi. Per aumentare la velocità, infine, la nave era dotata di albero e vele. Nonostante la potenza della flotta di Genserico e la serietà delle sue incursioni, comunque, la supremazia navale bizantina non fu mai messa completamente sotto scacco. Particolare di un mosaico romano raffigurante una galea a un solo ordine di remi. Fine del II-III sec. d.C. Sousse, Museo archeologico.
nel Tevere: l’usurpazione di Petronio, durata appena tre mesi, si era conclusa nel modo piú tragico. I Vandali entrarono a Roma il 2 giugno, senza alcuna milizia a ostacolarli. Il sovrano fu ricevuto da papa Leone – lo stesso che nel 452 aveva fermato Attila alle porte dell’Urbe – il quale lo convinse a non mettere a ferro a fuoco la città. Perciò Genserico, che per le due settimane seguenti risiedette nel Palazzo imperiale sul Palatino, ebbe campo libero per saccheggiare la città, scegliendo i monumenti, razziando i palazzi, facendo un enorme bottino e riportando a Cartagine un grande numero di prigionieri.
Il sacco di Roma
Valentiniano aveva fatto restaurare appena cinque anni prima il palazzo imperiale, da cui fu portata via una enorme quantità d’oro e di gemme. Fu asportata metà della volta dorata del tempio di Giove Capitolino; i tesori del tempio di Salomone, portati a Roma da Tito, furono caricati sulle navi vandale, assieme a centinaia di insegne imperiali che andarono ad adornare il palazzo di Genserico. Furono risparmiate solo le statue bronzee della città. A differenza di Alarico, il condottiero visigoto che nel 410 aveva saccheggiato Roma mostrando,
però, clemenza verso i luoghi di culto, Genserico – ariano intransigente – si accaní contro le chiese e le reliquie care ai cattolici. Inoltre, furono condotti come prigionieri anche l’imperatrice Eudossia con le sue figlie, Eudocia e Placidia, nonché Gaudenzio, figlio del generale Ezio. Dopo secoli di imbattibilità, Roma fu violata e oltraggiata, lasciando nella memoria collettiva un segno terribile e indelebile. Dopo questo enorme successo, la grandezza di Genserico non fu piú contrastata. Forte di questa consapevolezza, introdusse riforme innovative e clamorose. Per evitare congiure di tipo tribale, ai giovani furono concesse ampie fette nella gestione del potere, dando talvolta una simile opportunità anche a chi non apparteneva a famiglie aristocratiche; persino la successione al trono non fu limitata alla sola casata reale, andando contro l’antica consuetudine germanica. Procopio ci informa poi di una importante riforma militare: Genserico, infatti, inquadrò i suoi guerrieri dividendoli in 80 compagnie, guidate da capitani detti in greco chiliarca («comandante di 1000 uomini»). Lentamente, però, i veterani alani e vandali abbandonarono le armi, per crearsi una famiglia, lasciando spazio nell’esercito a guerrieri moaprile
MEDIOEVO
reschi che andarono a costituire la nuova forza militare di Genserico. Negli anni seguenti la flotta vandala continuò incontrastata a saccheggiare le coste del Mediterraneo. Dopo il velleitario tentativo di reazione dell’imperatore Maggioriano († 460), Genserico riprese le sue scorribande, soggiogando la Sardegna, la Corsica e le Baleari. Nel 467, però, commise il suo secondo errore politico, violando, durante una razzia, il territorio della Grecia meridionale, di pertinenza bizantina. Questa volta la reazione imperiale fu unanime e concorde: sarebbero stati stanziati 30 000 kg d’oro e 300 d’argento per allestire una flotta di 11 000 navi e 100 000 guerrieri. Le cifre – tramandate dagli storici coevi – sono certamente esagerate, ma l’azione imperiale fu seria, tanti da dissanguare le finanze dell’impero romano. Con a capo il generale Basilisco, la flotta bizantina si uní a quella italica di Marcellino e a quella africana guidata da Eraclio. In Sardegna, Marcellino impegnò la flotta di Genserico, fino a recuperare il controllo sull’isola. In Sicilia, Basilisco addirittura trionfò, affondando 340 galee vandale. Eraclio, giunto in Tripolitania, sbarcò con una grande armata che presto affrontò l’esercito vandalo che utilizzava una
MEDIOEVO
aprile
falange composta da cammelli e uomini appiedati, armati di lance, scudi e giavellotti. Eraclio, però, riuscí a neutralizzarli, grazie a un contrattacco di arcieri a cavallo, perlopiú unni: la strada per Cartagine era aperta. La flotta di Basilisco attendeva gli eventi presso Capo Bon, a poca distanza da Cartagine. Genserico dovette utilizzare tutta la sua abilità strategica per uscire da una rischiosa empasse: dopo aver caricato di materiale infiammabile alcune vecchie galee, il condottiero vandalo le fece andare al largo, contro le navi di Basilisco. Al mattino, complice il vento, la flotta imperiale era in rotta. Marcellino, in Sicilia, cadde vittima di un attentato, probabilmente per mano di un sicario vandalo. Rimasto solo, Eraclio preferí ripiegare verso oriente, anziché proseguire in quella che ora era una missione impossibile.
Un potere sconfinato
I due imperi erano stati sconfitti, le finanze imperiali erano sul lastrico e Genserico risultava il condottiero piú forte del Mediterraneo. Col fine di mantenere intatto il suo regno, «incoraggiava il re dei Visigoti, Eurico, ad ampliare i suoi territori a danno dell’impero d’Occidente», scrive Giordane, e altrettanto fece
con gli Ostrogoti per l’Italia e con gli Unni di Attila che contrappose, elargendo favori, ai Visigoti. Negli ultimi anni di vita, Genserico mostrò un atteggiamento particolarmente mite, specie nei confronti dei cristiani cattolici. Dopo l’incontro con l’ambasciatore bizantino Severo, il sovrano vandalo ottenne, grazie alla sua tolleranza, il riconoscimento, da parte dell’imperatore d’Oriente, di tutti i suoi territori, comprese le Baleari, la Sicilia, la Sardegna e la Corsica. L’anziano re rifuggiva ormai la guerra: aveva assistito alla caduta dell’impero d’Occidente, aveva creato un potente regno, era sopravvissuto ai piú temuti condottieri del suo tempo e aveva persino saccheggiato Roma. Un anno dopo la deposizione dell’ultimo imperatore d’Occidente, morí, all’età di circa 80 anni, di morte naturale, il 25 gennaio del 477, in uno scenario in cui sovrani e condottieri erano spesso vittime di assassini e congiure. Il suo regno, una creazione dovuta alla sua abilità e intraprendenza, non gli sopravvisse: appena cinquant’anni piú tardi, fu riconquistato dai Bizantini di Giustiniano e il suo ultimo successore, Gelimero, venne sconfitto dal generale Belisario e condotto nel 534 a Costantinopoli. F
55
saper vedere castelseprio
I colori di Castelseprio di Elena Percivaldi
La piccola chiesa di S. Maria foris portas fu riscoperta, casualmente, nel 1944. Emerse cosí uno dei piú insigni cicli pittorici dell’Alto Medioevo. Di cui tuttora, però, si ignorano la data certa di realizzazione e il nome del loro geniale artefice
T T
utto ebbe inizio il 7 maggio 1944, quando lo storico Gian Piero Bognetti (1902-1963) si imbattè in una chiesetta quasi inghiottita dal bosco, fuori dal borgo di Castelseprio, a una quindicina di chilometri da Varese. Il grande studioso, che già conosceva la zona avendo pubblicato nel 1930 un saggio sulle rovine del noto castrum, stava eseguendo un sopralluogo insieme agli altri membri del comitato scientifico che si occupava della redazione della monumentale Storia di Milano edita dalla Treccani. La chiesa era in rovina, ma celava un tesoro inestimabile: uno dei principali cicli
56
pittorici dell’Alto Medioevo italiano, miracolosamente sopravvissuto alle vicissitudini del tempo. Gli affreschi rappresentano alcune scene dell’Infanzia di Cristo ispirate ai Vangeli apocrifi, in particolare al Protovangelo di Giacomo, composto in greco intorno alla metà del II secolo e ricco di episodi improntati al gusto per il sensazionale e il miracolistico, a tratti fin troppo ingenui. Ebbero una diffusione notevole: il testo fu copiato in Oriente per tutto il Medioevo e i suoi venticinque capitoletti ci sono giunti in ben 130 manoscritti. Dal momento della scoperta in poi, Gian Piero Boaprile
MEDIOEVO
gnetti si dedicò anima e corpo allo studio della «sua» S. Maria e lo fece collaborando con gli archeologi Alberto De Capitani d’Arzago (1909-1948) e Gino Chierici (1877-1961), promuovendone anche il restauro. Frutto di questo lavoro fu la monografia pubblicata nel 1948 con il titolo di Santa Maria di Castelseprio e che avrebbe rappresentato una pietra miliare negli studi sul tema. Il volume, attesissimo, doveva essere presentato nello stesso anno a Parigi durante il VI Congresso internazionale di Studi bizantini. Ma De Capitani si spense improvvisamente nella notte tra il 29 e il 30 luglio.
MEDIOEVO
aprile
In alto il Viaggio a Betlemme, uno degli episodi affrescati nella chiesa di S. Maria foris portas, presso Castelseprio (VA). Giuseppe accompagna Maria, seduta su un’asina, condotta per la briglia da un giovane, probabilmente un servitore, di cui si vede solo una gamba. I tre sembrano entrare in
una delle porte della città di Betlemme, rappresentata da un grande arco. Nella pagina accanto una veduta della chiesetta di S. Maria foris portas. Edificato a partire dal V sec. e affrescato tra il VI e il IX sec., l’edificio sacro fu abbandonato nel XVII sec. e riscoperto da Gian Piero Bognetti nel 1944.
57
saper vedere castelseprio Bognetti, e altri dopo di lui, continuarono l’opera di studio ed esegesi del sito, e scoprirono via via una realtà sempre piú composita e affascinante. Dopo S. Maria l’attenzione fu puntata sulla torre quadrangolare che si ergeva nella parte bassa della collina. E anche in questo caso le sorprese non mancarono: si scoprí che l’antico edificio, di origine bizantina, era stato inglobato piú tardi in un monastero femminile, quello di Torba, e celava interessanti affreschi. Tutto il complesso faceva parte di un insediamento sorto in età tardo-antica, su un’altura a strapiombo dell’Olona, con funzioni militari, abitative e religiose di primissimo piano. Distrutto nella seconda metà del Duecento dalle truppe di Ottone Visconti, era come uno scrigno sepolto sotto terra. Pieno di tesori ancora da scoprire.
Un luogo strategico sin dall’antichità
Ma quali sono le ragioni di tanta ricchezza? Per comprenderlo, occorre rileggere la storia di questo lembo di terra che oggi appartiene alla porzione centro-meridionale dell’attuale provincia di Varese e a quella sud-occidentale del Comasco, ma che un tempo era un autentico – e vivace – crocevia di popoli e culture. Le radici del Seprio, come hanno dimostrato numerosi ritrovamenti archeologici che risalgono alla civiltà di Golasecca, affondano nella protostoria. L’etimo stesso del luogo, Sibrium, sembrerebbe risalire ai Celti Insubri. Grazie alla collocazione naturale, era una zona altamente strategica, non lontana dal fiume Ticino e a cavallo tra la pianura, i laghi e i passi alpini. Sin dall’antichità fu dunque attraversata da numerose strade; in età romana, la Comum-Novaria e la Mediolanum-Verbanus collegavano fra loro la fascia pedemontana alla pianura e alla grande via d’acqua del Verbano, mentre i valichi del Gottardo, del Lucomagno e del S. Bernardino conducevano da Milano uomini e merci verso l’Europa centrale. La crucialità del Seprio – con Sibrium, Castelseprio appunto, come centro piú importante – valse nel bene, ma anche nel male. Durante il IV secolo, con i barbari alle porte, fu costellato di torri di segnalazione e protetto da flotte stanziate sul Lario e sul Verbano. Questo sistema di fortificazioni, o chiuse, parte del cosiddetto «tractus Italiae circa Alpes», serviva come barriera fiscale e doganale ed era congegnato come contenimento in grado di rallentare l’avanzata dei nemici e consentire l’organizzazione delle difese. Non bastò. Il Seprio fu dapprima teatro della guerra greco-gotica (535-553), poi fu conquistato dai Longobardi. E da allora divenne un caposaldo politico, strategico e commerciale del costruendo regnum. Vista la funzione di ganglio vitale dell’intera zona, che richiedeva il controllo costante sulle vie di comunicazione dalla Lombardia occidentale all’area transalpina, il Seprio – che secondo Bognetti si estendeva a nord sino alla Valle d’Intelvi, Neggio in Valmagliasina, Canobbio a nord di Lugano, Campione, Bellinzona – fu trasformato cosí in (segue a p. 62)
58
i gioielli del castrum
SVIZZERA
Bormio
Chiavenna
TRENTINO ALTO ADIGE
Novate Mezzola
Trento
Meraggio
Lecco
Varese
Como Bergamo Castelseprio Monza Novara Milano
Brescia
VENETO
Verona Pavia
Cremona
Mantova
Meda
Piacenza Alessandria PIEMONTE
EMILIA-ROMAGNA Parma
Reggio nell’Emilia Modena
In alto cartina della Lombardia con l’ubicazione di Castelseprio.
Il monumento in sintesi
Un capolavoro «anomalo» 3 Perché è importante La chiesa di S. Maria foris portas rappresenta un unicum straordinario nel panorama pittorico altomedievale e una testimonianza significativa dei rapporti culturali e artistici tra Oriente e Occidente prima dell’anno Mille. 3 S. Maria nella storia Molto controverso è il periodo di realizzazione degli affreschi, che oscilla tra l’età longobarda e quella carolingia. I graffiti presenti, comunque, sembrerebbero assegnarli al IX secolo e individuarne la commissione da parte di una famiglia comitale legata alla corte imperiale, con probabile destinazione a mausoleo privato. 3 S. Maria nell’arte L’eccezionale qualità pittorica del ciclo, realizzato con molta probabilità da un maestro bizantino di primissimo piano, annovera gli affreschi tra i massimi capolavori dell’arte di tutti i tempi. La vivacità dei colori, l’evidente tratto naturalistico impostato su una base figurativa e compositiva di tradizione classica, la raffinatezza dell’esecuzione sono elementi decisamente inconsueti in un periodo in cui prevalgono i dettami simbolici dell’arte cosiddetta «barbarica».
aprile
MEDIOEVO
S. MARIA FORIS PORTAS
BORGO
Via Castel Vecchio
BORGO
A tutta pagina planimetria del Parco Archeologico di Castelseprio. A sinistra la cosiddetta chiesa di S. Paolo, eretta probabilmente tra l’XI e il XII sec., forse su una preesistente struttura di età tardo-romana. Qui sotto l’interno della chiesa di S. Maria foris portas.
Ingresso del Parco
N
BORGO
casaforte
s.paolo
basilica di s. giovanni
castrum monastero di s. giovanni
torba A destra la torre del complesso di Torba. Costruita nel V-VI sec. d.C. quale parte del sistema difensivo del castrum, la struttura fu in seguito trasformata in convento benedettino femminile.
MEDIOEVO
aprile
59
saper vedere castelseprio UNA STORIA LUNGA PiÚ DI UN MILLENNio IV secolo d.C. Il sito di Castelseprio è documentato come luogo militare posto lungo la via Como-Novara a difesa dei confini (limes), al di qua delle Alpi. A questo periodo risalgono le tre torri ancora oggi visibili, a livello delle fondamenta, sul pianoro del castrum. V-VI secolo Costruzione delle mura difensive per opera dei Goti, edificazione della torre di Torba e degli edifici sacri: la basilica di S. Giovanni Evangelista e il Battistero di S. Giovanni Battista. V secolo Edificazione di S. Maria come xenodochio. Costruzione dell’aula, delle absidi e, successivamente, dell’atrio. 568-9 Arrivo dei Longobardi in Italia VIII secolo Costruzione e uso di un piccolo cimitero, in cui si seppellisce fino al IX secolo. A quest’epoca risale il lastrone a doppio spiovente con scolpita una croce-spada. 774 Conquista franca. 1154-1183 Lotte tra i Comuni lombardi e l’imperatore Federico Barbarossa. Il Seprio è alleato del sovrano contro i Milanesi. 1183 Pace di Costanza tra impero e Comuni. 1185 Con il Trattato di Reggio le regalie del Seprio passano ai Milanesi. XIII secolo S. Maria è citata nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani attribuito a Goffredo da Bussero. 21 gennaio 1277 Battaglia di Desio. Ottone Visconti sconfigge i rivali Torriani e ottiene il controllo di Milano. 28 marzo 1287 Castelseprio, dove si erano rifugiati gli oppositori, viene raso al suolo (tranne gli edifici sacri) per ordine di Ottone Visconti. 1339 Il cronista Galvano Fiamma riporta il rinvenimento, nel monastero di Torba, della tomba di un «re longobardo». 1398 Citazione di S. Maria nella Notitia Cleri. 1541 L’erudito Bonaventura Castiglioni descrive i ruderi del sito nella Gallorum Insubrium antiquae sedes.
60
XVI secolo S. Maria è citata varie volte negli atti delle visite pastorali. Rifacimento degli intonaci, parziale distruzione degli affreschi, realizzazione dei dipinti rappresentanti il Presepe e la Madonna del Latte. Costruzione della sacrestia e dell’abitazione del cappellano. XVII secolo Demolizione dell’abitazione del cappellano, del campanile e della sacrestia. Costruzione del nuovo pavimento di cemento. Copertura totale degli affreschi a eccezione del presepe. 1845 La famiglia Archinto, proprietaria del luogo, durante scavi di sistemazione ritrova la lapide sepolcrale di «Wideramn», databile al VII secolo, e oggi conservata nelle Civiche Raccolte d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano. ante 1862 Demolizione delle absidi laterali (non piú citate nel catasto teresiano di quell’anno). In questo periodo S. Maria foris portas è adibita a lazzaretto durante le epidemie di colera. 1912 Il dipinto del Presepe è notificato da parte dell’Ufficio di Conservazione dei Monumenti per la Lombardia al preposto di Carnago perché «dichiarato da annoverarsi ai monumenti nazionali». 1933 S. Maria viene sconsacrata dal Cardinale Ildefonso Schuster. Trasferimento degli ultimi arredi e oggetti sacri nella chiesa di Carnago. 1934 L’Ispettore Onorario della Soprintendenza della zona opta per lo strappo del Presepe e il suo trasferimento presso il Museo di Gallarate. I lavori portano alla luce lacerti di affreschi sottostanti. 4 settembre 1934 Il soprintendente notifica al preposto di Carnago lo scoprimento di tutti gli affreschi. 1936 Abbandono della chiesa e dei lavori per mancanza di fondi. 7 maggio 1944 Lo storico Gian Piero Bognetti, durante un sopralluogo, scopre il ciclo di affreschi. 1946-47 Prime indagini archeologiche. 1948 Esce, di Gian Piero Bognetti, Alberto De Capitani d’Arzago e Gino Chierici, Santa Maria di Castelseprio, la prima monografia sul sito. aprile
MEDIOEVO
1954-1958 Campagne di scavo che riportano alla luce i complessi religiosi del castrum e le cinte turrite. 1962-1963 Scavi a cura dell’Istituto di Cultura Materiale di Varsavia. 1964 Gian Piero Bognetti, lo scopritore di S. Maria e dei suoi tesori, viene sepolto nella chiesetta. 1965-1973 Scavi eseguiti dalla Soprintendenza Archeologica con la Società Gallaratese di Storia Patria. 1977-1979 Scavi dell’Istituto di Archeologia della Università Cattolica di Milano per conto della Soprintendenza Archeologica della Lombardia con contributi del CNR. Primavera 2009 Inaugurazione dell’Antiquarium di Castelseprio. 26 giugno 2011 Castelseprio e Torba sono inserite ufficialmente, insieme ad altri sei siti, nella World Heritage List UNESCO quale parte del sito seriale «Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774)».
In alto resti del complesso basilicale di S. Giovanni, edificato tra il V-VI sec. e l’età carolingia. In basso ricostruzione ipotetica di Castelseprio, come doveva apparire prima di venire distrutto per ordine dell’arcivescovo Ottone Visconti nel 1287. Si notano S. Maria foris portas (1), il complesso di S. Giovanni (2), di Torba (3) e la Casaforte (4).
4
3 2
1
MEDIOEVO
aprile
saper vedere castelseprio area fiscale e sottoposto al governo diretto di funzionari di nomina regia. A reggere la iudiciaria fu posto uno iudex, un duca o un gastaldo, che aveva compiti sia giurisdizionali che militari: oltre all’obbligo di amministrare la giustizia per conto del re, egli era infatti il capo degli exercitales, gli uomini liberi che portavano le armi. Nell’esercizio delle sue funzioni era affiancato da cariche minori, come i centenarii o sculdasci e i decani: tutti assieme costituivano l’ossatura che gestiva le grandi curtes regie, aziende agricole che rappresentavano la base del potere regio nel territorio del regno e un cuore pulsante a livello economico. Se la vicina Arsago era sede di una delle arimannie piú importanti (terre concesse dal sovrano agli arimanni, gli uomini liberi che facevano parte dell’esercito, n.d.r.), come testimonia la ricchezza dei corredi rinvenuti nella locale necropoli, a Castelseprio e nella vicina Castelnovate erano attive due zecche. Da Angera e dalla Val d’Intelvi provenivano inoltre le pietre da costruzione utilizzate dai magistri commacini (che compaiono per la prima volta nei documenti proprio in questo periodo), dal Ticino si estraevano oro e sabbie silicee per la fabbricazione del vetro, a Laino d’Intelvi (Como) e nella stessa Castelseprio si producevano strumenti di lavoro quotidiano. Tutti beni poi commercializzati grazie alla fitta rete di comunicazione.
Da Carlo Magno a Federico Barbarossa
Nel 774 Carlo Magno conquistò il regno longobardo. I Franchi sostituirono la vecchia classe dirigente con nuovi funzionari che subentrarono nel possesso patrimoniale ai loro predecessori e trasformarono la Iudiciaria in Comitatus. Il Seprio iniziò una lenta decadenza che ne comportò la progressiva attrazione gravitazionale nei confronti di Milano. La grande crisi del potere centrale che seguí lo smembramento dell’Impero carolingio e la conseguente situazione di precariato spinse l’aristocrazia locale a cedere i propri fondi mentre l’arcivescovo di Milano (da cui il Seprio ecclesiasticamente dipendeva) concedeva beni pievani situati a Varese alle famiglie nobiliari milanesi. L’occasione di una rivalsa nei confronti di Milano si presentò nel 1158, quando l’imperatore Federico Barbarossa assediò per la prima volta la città per riportarla all’obbedienza. I nobili del Seprio allora gli giurarono fedeltà finché, sconfitto il sovrano a Legnano nel 1167, il Seprio e Varese non aderirono alla Lega Lombarda. Da quel momento in poi, e rapidamente, l’autonomia sepriese si ridusse progressivamente a vantaggio sia dell’arcivescovo (che estese la sua ingerenza sulle pievi), sia del Comune di Milano. A conflitto terminato, il Barbarossa sancí il definitivo passaggio del Seprio sotto i Milanesi insieme ad altri contadi (pace di Costanza, 1183) e poco dopo (1185, Trattato di Reggio) conferí loro anche le regalie che ancora deteneva sul territorio. La fine ormai era segnata: durante le lotte che opposero l’arcivescovo Ottone Visconti alla fazione avversa
62
dei Torriani, Castelseprio divenne l’ultimo caposaldo dei ribelli. Nel 1287, cadute le ultime resistenze, il castrum fu raso al suolo per ordine dello stesso Ottone, che ne risparmiò solo le chiese, e dispose che non venisse piú ricostruito. Da allora tutto il territorio seguí, nel bene e nel male, la sorte dei Visconti e poi degli Sforza. Ma torniamo a S. Maria. La chiesetta si trovava fuori dalle mura del castrum («foris portas», appunto). Orientata est-ovest, presentava una pianta a tre absidi e un atrio che riprendeva un modello architettonico piuttosto diffuso in Oriente. L’abside centrale è separata dall’aula da un arco trionfale. Le indagini archeologiche hanno permesso di conoscerne le varie fasi di costruzione e ristrutturazione: fu edificata come cappella annessa a un probabile xenodochio, ossia a un ricovero per pellegrini, e poi trasformata radicalmente nel corso dei secoli. Un elemento di datazione importante è dato dal pavimento originale, recuperato purtroppo solo in minima parte: era realizzato a esagoni e triangoli in marmo e calcare bianco e nero secondo modelli riscontrati anche in altri edifici (per esempio il battistero di S. Giovanni ad Fontes a Milano, di Gravedona, di Lomello) tutti anteriori all’invasione longobarda: la prima fondazione dell’edificio risale pertanto, con ogni probabilità, al V secolo. Sopravvissuta alla distruzione viscontea grazie anche alla sua posizione decentrata rispetto al castrum, S. Maria cadde in abbandono per circa due secoli, finché nel Cinquecento non fu restaurata e riaperta al culto: le pareti, reintonacate, furono allora affrescate con un Presepe e una Madonna del Latte, mentre a sud furono costruite una sacrestia e l’abitazione del cappellano che avrebbe dovuto officiare in loco. Tutti questi edifici furono abbattuti un secolo dopo, quando il culto della Madonna del Latte si esaurí e la chiesetta fu nuovamente votata all’oblio.
aprile
MEDIOEVO
le storie raccontate dal ciclo affrescato di castelseprio
Le scene: 1. Trono celestiale; 2. Annunciazione e Visitazione; 3. Prova dell’acqua amara; 4. Cristo; 5. Sogno di Giuseppe; 6. Viaggio a Betlemme; 7. Fuga in Egitto; 8. Strage degli innocenti; 9. Presentazione al tempio; 10. Natività e annuncio ai pastori; 11. I Magi portano doni; 12. Sogno dei Magi.
1
2
12
3
7
8
4
5
6
9
10
11
In basso planimetria della chiesa di S. Maria foris portas, con pianta a tre absidi e atrio.
MEDIOEVO
aprile
63
saper vedere castelseprio apparizioni, annunci e prove miracolose
annunciazione e visitazione Il quadro si compone di due scene articolate da sinistra verso destra senza soluzione di continuità. Nella prima, l’Arcangelo Gabriele appare a Maria, seduta davanti alla sua casa e intenta a filare, annunciandole il concepimento. L’Arcangelo, che indossa una veste candida, regge nella mano sinistra la verga del comando che apparteneva al taxiarca, il comandante del battaglione – taxis – dell’esercito greco. All’interno dell’abitazione una donna, forse un’ancella, si affaccia alla finestra e contempla la scena: l’artista ne rappresenta in maniera fortemente realistica lo stupore, ritraendola con le mani alzate. Questa scena deriva dalla narrazione non presente nei Vangeli canonici, ma nell’apocrifo Protovangelo di Giacomo (XI,2), che contiene i particolari della filatura (compreso il filo di porpora, contenuto in un cesto ai piedi di Maria) e della brocca posata dalla Vergine una volta giunta a casa: il recipiente si trova infatti al centro. La seconda scena, la Visitazione, è parzialmente lacunosa: tuttavia i particolari consentono di stabilire anche per questa una derivazione dagli apocrifi perché l’abbraccio tra le due donne, Maria ed Elisabetta, avviene fuori e non dentro la casa di Zaccaria (come invece narra Luca), che probabilmente era rappresentata sulla destra e chiudeva, simmetricamente rispetto a quella della Vergine sulla sinistra, l’intero quadro.
64
aprile
MEDIOEVO
prova dell’acqua amara La fonte normativa è l’Antico Testamento (Numeri 5, 11-29), che decreta come secondo la Legge la moglie sospettata di infedeltà dal marito dovesse essere condotta per una prova davanti all’altare di Jahveh. Qui il Sommo Sacerdote le porgeva un vaso di terra in cui aveva posto, assieme all’acqua santa, un po’ di polvere prelevata dal pavimento della Dimora (ossia il tabernacolo). Dopo aver giurato e terminate le invocazioni di rito, la donna doveva bere l’acqua amara della maledizione: qualora fosse risultata colpevole, la pozione le avrebbe gonfiato il ventre e avvizzito i fianchi, rendendola sterile. La scena dipinta è purtroppo mutila sulla sinistra, dove si conservano le sole gambe di Giuseppe che assisteva al rito di fianco a Maria. La Vergine è ritratta in maniera realistica (le labbra sono socchiuse) mentre sorseggia l’acqua dal recipiente che le viene porto dal Sommo Sacerdote, probabilmente Zaccaria, riccamente vestito e dotato di aureola azzurra. Anche in questo caso, la narrazione dell’episodio è contenuta nel Protovangelo di Giacomo, che sottolinea il superamento della prova e l’acclamazione della coppia da parte della folla.
MEDIOEVO
aprile
Ma le sue vicissitudini non erano ancora terminate. Alla metà dell’Ottocento furono distrutte le due absidi laterali e la chiesa fu usata come lazzaretto durante un’epidemia di colera. A poco valse il ritrovamento, avvenuto nel 1845 per opera dei proprietari Archinto, di una pregevole lastra del VII secolo (la lapide sepolcrale di Wideramn, oggi nelle Civiche Raccolte d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano) e in seguito di frammenti di affreschi del Duecento giudicati interessanti persino dalla Soprintendenza, che si mosse (invano) per recuperarli: S. Maria fu di nuovo lasciata a se stessa, sconsacrata e privata di ogni residuo arredo. Finché il 7 maggio del 1944 Gian Piero Bognetti non vi mise piede, scoprendo l’immenso tesoro che era ancora nascosto.
Un racconto inconsueto
Gli affreschi di S. Maria sono stati oggetto di lunghi dibattiti, a cominciare dalla loro collocazione temporale, variamente assegnata, come vedremo fra poco, tra il VI e il IX secolo. Ma nessuno ha mai negato l’eccellente qualità pittorica e l’originalità del messaggio veicolato. Il ciclo narra, come anticipato, le vicende dell’Infanzia di Cristo ispirate ai Vangeli apocrifi, in particolare al Protovangelo di Giacomo, dando spazio ad alcuni episodi decisamente inconsueti nell’iconografia del tempo. Le pitture giacevano sotto strati di intonaci dovuti ai ripetuti rimaneggiamenti e risultavano parzialmente danneggiati dai martellamenti operati nel XVI secolo per far aderire l’intonaco destinato a supportare le nuove decorazioni. La sensazione di aver trovato qualcosa di unico fu comunque immediata. Come scrisse Bognetti appena entrato, «lo stupore doloroso di ritrovare la chiesa in quell’abbandono desolato doveva precedere di appena pochi istanti il tutto diverso stupore per la vista di quei frammenti di affreschi, cosí inclassificabili nello schema della pittura lombarda; e un loro rapido esame; e la scoperta, sullo zoccolo, di quei graffiti in caratteri capitali e onciali, che, fuori da ogni dubbio stilistico, denunciavano un’opera anteriore al Mille». Le storie dell’Infanzia di Cristo sono rappresentate lungo due registri articolati in varie scene. Nel primo, in alto, l’Annunciazione e la Visitazione, la Prova delle acque amare, l’Apparizione dell’Angelo a Giuseppe, il Viaggio a Betlemme erano intervallate da medaglioni: si conserva solo quello del Cristo pantocratore, situato tra la Prova delle Acque e l’Apparizione. Nel secondo registro, scandito dalle finestre, si susseguono nell’ordine la Natività, la Presentazione di Gesú al Tempio e due scene purtroppo perdute (forse la Nascita della Vergine, o la sua Presentazione al Tempio, o ancora la Strage degli Innocenti). I due registri sono rinchiusi in basso, come in una cornice, da un motivo decorativo a ghirlande e nicchie dipinte a trompe l’oeil solo parzialmente conservato, in cui compaiono alcuni volatili e il motivo apocalittico del Trono coperto da un drappo su cui poggia il Libro chiuso.
65
saper vedere castelseprio tra maestà e realismo la natività
il cristo pantocratore
È la scena piú complessa del ciclo, composta da quattro episodi rappresentati in maniera sincronica: la Natività vera e propria, la Lavanda del Bimbo, il Miracolo dell’Ostetrica e l’Annuncio ai Pastori. I personaggi principali, Maria, Giuseppe e la levatrice Emea, sono indicati dal nome, scritto sulle loro teste. Nella grotta, indicata da una stella luminosa i cui raggi formano una croce, Maria si riposa dalle fatiche del parto contemplando il Bambino nella culla, dietro alla quale si intravedono le teste del bue e dell’asinello. Ai suoi piedi, una donna dal colorito scuro protende verso di lei il braccio destro, sorreggendolo col sinistro: è Emea, la levatrice che secondo il Protovangelo di Giacomo volle visitare Maria per verificarne la verginità (che riteneva impossibile conservare dopo il parto) e fu punita perdendo l’uso della mano, che si disseccò. In basso, due donne procedono alla Lavanda del Bambino sotto lo sguardo vigile di Giuseppe, la cui figura, al centro, collega la Natività all’Annuncio ai Pastori, illustrato a destra. La scena, lacunosa, è dominata dall’angelo che richiama i pastori: uno è vecchio, ritratto in piedi mentre si regge a un bastone, l’altro è giovane e riposa sdraiato all’ombra. Molti sono i particolari realistici, dalla resa del paesaggio alla città di Betlemme che si vede in lontananza, dal cane che perlustra il terreno alle pecorelle che riposano o pascolano sull’erba.
La splendida figura del Cristo, collocata in un medaglione sopra la finestra centrale dell’abside, troneggia maestosa con la veste rossa che si staglia su un prezioso sfondo ceruleo. L’aureola crociata, il rotolo nella mano sinistra e la destra in atto di benedire con le tre dita, il volto finemente tratteggiato ricordano l’iconografia presente in S. Sofia a Costantinopoli.
Cristo vi appare sia nella sua natura umana che in quella divina 66
aprile
MEDIOEVO
Infine, dietro l’arco trionfale che conduce all’abside, nel registro alto, due Arcangeli affacciati in volo protendono lo scettro e il globo sormontato dalla croce verso il Trono vuoto che sarà occupato da Cristo nel giorno del Giudizio (Etimasia). Chiude il ciclo in basso, a sinistra dell’arco, l’Adorazione dei Magi e a destra un’altra scena – forse l’Arrivo in Egitto – in gran parte perduta.
Una datazione controversa
A quando risalgono questi affreschi? Gli unici elementi certi di datazione (e che costituiscono il terminus ante quem del ciclo) sono i graffiti, ma anche in questo caso la certezza non è assoluta. Se Bertelli e altri considerano dirimente quello che nomina Ardericus, arcivescovo di Milano tra il 936 e il 948, Marco Petoletti ha recentemente individuato un riferimento a Tadone, che resse la cattedra di Ambrogio tra l’860 e l’868, retrodatando il termine all’869. Quanto «prima» di allora, però, le pitture siano state effettivamente realizzate è oggetto di uno dei dibattiti piú accesi e appassionanti della storia dell’arte. Proviamo a sintetizzarlo. Bognetti, che scoprí il ciclo, lo assegnò alla seconda metà del VII secolo per una ragione storica ben precisa: il tema dominante, che ruota attorno al mistero dell’Incarnazione, sembrerebbe voler ribadire con forza il dogma della duplice natura del Cristo, umana (come si evince chiaramente dalle storie della sua infanzia) e divina (rappresentata nel medaglione del Cristo pantocratore). Ora, tale dogma era messo in discussione dall’arianesimo, eresia che riconosceva la sola essenza umana del Figlio negandone la consustanzialità con
il Padre. Bognetti (e altri dopo di lui) era fermamente convinto che i Longobardi avessero in gran parte aderito all’arianesimo: ritenne dunque che il ciclo fosse da leggere in rapporto alla politica di lotta delle tesi eretiche intrapresa dalla corona longobarda a cominciare dal regno di Teodolinda e Agilulfo, i quali avevano favorito, in accordo con il papato e non senza opposizione interna, la conversione al cattolicesimo del loro popolo. A dire il vero, nel 1981 Stephen Fanning – seguito da numerosi epigoni – ha contestato duramente l’effettiva adesione dei Longobardi all’arianesimo, notando in primis come le fonti dell’epoca, assai prodighe di informazioni in merito se riferite ad altre genti germaniche, tacciano invece del tutto sulla questione quando parlano dei discendenti di Alboino. Ma le obiezioni alla tesi di Bognetti trovano elementi anche altrove. Essa fu subito messa in discussione da Kurt Weitzmann, per il quale le pitture di Castelseprio dovevano essere datate al primo quarto del X secolo e legate ai proficui rapporti diplomatici che in quegli anni legavano il regno d’Italia a Bisanzio. Altri studiosi in seguito cercarono di retrodatare il ciclo al VI secolo mettendolo in relazione con la riconquista dell’Italia settentrionale da parte dei Bizantini dopo la vittoria contro i Goti. Altri ancora (Lazarev) propongono come arco cronologico il periodo compreso tra la fine del VII e l’inizio dell’VIII secolo. L’ultima tesi in ordine di tempo, sebbene non risolutiva, è quella formulata da Carlo Bertelli, il quale data gli affreschi al IX secolo inquadrandoli all’interno dell’orizzonte culturale carolingio. A suo favore giocano alcune analisi condotte al radiocarbonio (sulle travi e su altri elementi lignei) e alla termoluminescenza (laterizi e tegole), ma, soprattutto, gli scavi condotti negli anni Ottanta del Novecento da Martin Carver e Gian Pietro Brogiolo, che hanno escluso l’annessione della chiesetta a un monastero: il ciclo di affreschi era stato dunque probabilmente realizzato per un importante committente privato, di raffinata cultura, in grado di apprezzarne la qualità pittorica e comprenderne il profondo messaggio teologico.
Il sepolcro del fondatore?
Le indagini hanno rivelato in effetti la presenza, a ridosso del muro ovest, di una tomba monumentale – battezzata la «tomba del fondatore» – chiusa da un lastrone di pietra con scolpita una croce-spada, simbolo di nobiltà e potere: il sepolcro, datato al IX secolo, potrebbe essere quello di Giovanni, comes (conte) del Seprio, la cui presenza è ben documentata e che apparteneva alla cerchia dell’imperatore carolingio Lotario. A lui, a questo punto, si dovrebbe la committenza dello splendido ciclo di affreschi. Ma andrebbe riconsiderata sotto una nuova luce anche la già ricordata epigrafe tombale di Wideramn: questo giovane longobardo, morto a 28 anni, era stato sepolto con corredo (ma furono ritrovati solo gli speroni di rame dorato, oggi dispersi) sotto il pavimento della chiesa prima del cosiddetto «fondato-
MEDIOEVO
aprile
67
saper vedere castelseprio
apparizione dell’angelo a giuseppe Su uno sfondo con architetture di stampo classico (tra cui una colonna decorata con un drappo purpureo e sormontata da un capitello corinzio, molto simile a quello già presente nella scena dell’Annunciazione), la scena coglie l’attimo in cui l’Angelo appare a Giuseppe dormiente per informarlo che il concepimento di Maria è opera dello Spirito Santo. La figura dell’Angelo, splendidamente lumeggiata, ricorda quello della prima scena, qui in una sorta di «seconda annunciazione», con la sola differenza che quest’ultimo procede da sinistra verso destra e rimane in volo. La testa e il busto di Giuseppe sono gravemente rovinati, tuttavia è ben visibile la scritta IOSEPH appena sotto la figura del santo.
68
aprile
MEDIOEVO
l’adorazione dei magi Questa scena si trova sulla parte mediana dell’arco trionfale, a sinistra dell’ingresso, sotto i due Angeli adoranti l’Etimasia, e continua la sequenza della Natività. Perfettamente leggibili sono solo i tre Re Magi, rappresentati in coloratissime e ricche vesti di foggia orientale (si distingue anche il tipico copricapo a forma di cilindro attribuito loro dalla tradizione) mentre porgono alla Sacra Famiglia, seduta di fronte alla grotta, i doni su vassoi d’argento. La Madonna, situata piú in alto nel gioco prospettico, porge ai tre uomini adoranti il Bambino indicato da un Angelo in volo (di queste figure resta solo il disegno in rosso, il colore è andato quasi del tutto perduto). Piú in basso, sulla destra, Giuseppe osserva la scena leggermente discosto.
presentazione di gesú al tempio Come la Prova delle Acque, anche questo episodio è raramente rappresentato. Nella grandiosa costruzione del Tempio, rappresentato con grandi finestre ad archi e un’abside decorata con una conchiglia rossa, Maria porge al sacerdote Simeone (il nome, ZYMEON, è ben visibile) il Bambino, che tende le manine verso di lui. Dietro Simeone, sulla sinistra, si intravede la profetessa Anna, mentre sulla destra Giuseppe, che reca con sé l’offerta delle colombe, osserva la scena assieme a due uomini anziani, forse altri due sacerdoti, ma la perdita quasi completa del colore rende pressoché impossibile l’identificazione.
L’autore del ciclo, tuttora ignoto, fu un artista dotato di un talento eccezionale
MEDIOEVO
aprile
re». Inaugurando cosí l’uso sepolcrale della chiesetta, inserita su un luogo di culto già esistente, ma che ora assumeva le funzioni di mausoleo familiare.
Un ignoto genio della pittura
I dubbi sulla datazione degli affreschi permangono e forse non saranno mai sciolti. Cosí come ignoto è anche l’autore (o gli autori) del capolavoro, attribuito a un generico «Maestro di Castelseprio» destinato a rimanere con ogni probabilità anonimo. Si è ipotizzato che fosse egiziano oppure siriaco, di certo orientale. Ma vista la qualità del lavoro e sulla base di confronti stilistici con le miniature della cosiddetta «Bibbia di Leone», del Rotolo di Giosuè e del Salterio di Parigi già evidenziati da Weitzmann, è probabile che provenisse direttamente da Costantinopoli e fosse un esponente della Rinascenza Macedone, corrente che, tra il IX e l’XI secolo, operò un corposo recupero dell’arte classica. Di certo conosceva il greco. Certo, i nomi che a mo’ di didascalia a volte accompagnano i personaggi non sono scritti in maniera sempre precisa. Ma hanno una loro precisa funzione. Per dirla con Bertelli, «sembra quasi che le affermazioni latine abbiano bisogno di un sostegno greco per essere piú autorevoli». Ossia servono a conferire alle scene solennità e mistero. La presenza
69
saper vedere castelseprio Torba
Dai soldati alle monache benedettine Il complesso di Torba, nel Comune di Gornate Olona, appartiene al FAI (il Fondo per l’Ambiente Italiano), e fa parte, con il parco archeologico di Castelseprio, del sito seriale UNESCO «Longobardi in Italia: i luoghi del potere». La torre, edificata nel V-VI secolo, rappresenta ciò che resta del sistema difensivo del castrum che, in età tardo-antica, si protendeva verso il fiume Olona ed è uno dei rarissimi esempi di costruzioni simili conservate in alzato. In seguito, venuto meno lo scopo militare, fu abitata da un gruppo di monache benedettine che la trasformarono in convento. Il primo piano della torre divenne area sepolcrale. Al primo piano sono visibili ancora oggi tracce di affreschi, risalenti, secondo
Carlo Bertelli, all’VIII secolo, che rappresentano due monache – una di nome Aliberga – e un vescovo. Il ciclo piú interessante è però conservato al secondo piano della torre, che fungeva da oratorio, e risale anch’esso all’VIII secolo. Si distingue in particolare un gruppo di otto monache quasi tutte «senza volto» (l’acqua piovana che filtrava dal muro ne ha cancellato i tratti) caratterizzato da un enigmatico movimento delle mani. La chiesetta, intitolata anch’essa a Maria, fu probabilmente fondata sempre nell’VIII secolo (epoca a cui risale la cripta) e poi rimaneggiata successivamente. La costruzione attuale, fatta di pietre provenienti dall’Olona, risale in gran parte al Mille mentre l’abside è duecentesca.
A destra particolare dell’affresco sulla parete ovest del secondo piano della torre di Torba, adibita a oratorio, con raffigurate otto monache in processione. In basso una veduta del complesso di Torba.
del greco rafforza la tesi che vuole il ciclo di affreschi realizzato in età carolingia: proprio a partire dal regno di Carlo Magno – e dalla diffusione del testo dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita, allora riscoperto e studiato – la conoscenza della lingua poté diffondersi nuovamente in Europa. Non a caso alcuni degli intellettuali piú vicini all’imperatore – per esempio, il longobardo Paolo Diacono – ne erano discreti cultori.
Un capolavoro dell’arte di tutti i tempi
Greco, siriaco o egiziano che fosse, l’anonimo Maestro possedeva comunque un genio pittorico fuori dal comune. Certo, alcune caratteristiche iconografiche sono ricorrenti: i personaggi indossano, anche in scene diverse, gli stessi abiti (con lievi varianti, come per esempio la presenza o l’assenza del mantello); la mano sinistra di chi partecipa ai riti è normalmente coperta da un lembo di veste, l’aureola è presente sempre intorno al capo del Cristo e della Vergine mentre manca costantemente a Giuseppe. Inoltre gli episodi non seguono sempre un ordine temporale «corretto»: alcuni sono invertiti rispetto alle narrazioni protoevangeliche e in genere prevale la tendenza – comune all’arte orientale peraltro – a rappresentare piú episodi in un’unica scena senza soluzione di continuità, affidando al massimo a una figura o a un elemento naturalistico, architettonico o paesaggistico il compito di «separarli» dividendoli in sequenze.
70
aprile
MEDIOEVO
Da leggere e in rete U Paola Marina De Marchi (a cura di),
Castelseprio e Torba: sintesi delle ricerche e aggiornamenti, SAP Società Archeologica, Mantova 2013 U Gian Piero Bognetti, Santa Maria foris portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi, in Idem, L’età longobarda, II, Giuffrè, Milano 1966; pp. 668-673. U Carlo Bertelli, Ultimi studi sulle
pitture di Castel Seprio e Torba, in Giornata di Studi «Castel Seprio e Vico Seprio-Aggiornamenti». 22 settembre 2001, atti del convegno, Castelseprio, 2002; pp. 1-8 U Elena Percivaldi (a cura di), Il Seprio nel Medioevo. I Longobardi nella Lombardia Settentrionale (secc. VI.XIII), atti del convegno, Il Cerchio, Rimini 2011
Il tratto elegante e snello, gli accenni prospettici, il sapiente uso dei colori, la potenza inventiva, il grande realismo, la capacità quasi vignettistica nel rendere il particolare, la raffinatezza dell’esecuzione rendono a ogni modo il ciclo di Castelseprio un capolavoro assoluto dell’arte di tutti i tempi, una sorta di gemma impossibile da comprendere se si trascura il contesto che la vide nascere. Un’opera in cui la tradizione figurativa e compositiva classica, dominata con maestria e sapienza, riesce a imporsi sugli stilemi contemporanei dell’arte cosiddetta «barbarica» che invece rifuggiva da ogni naturalismo per concentrarsi sul significato puramente simbolico dell’oggetto narrato.
MEDIOEVO
aprile
U Paolo G. Nobili, Tra tardoantico e
X secolo, gli scenari attorno agli affreschi di Castelseprio. Uno status quaestionis storiografico, in Porphyra, Anno VII, Supplemento 11 (aprile 2010) U http://archeologiamedievale.unisi.it/
castelseprio/ U http://www.castelseprio.net/
Dal giugno 2011 S. Maria foris portas e i suoi affreschi fanno parte del sito seriale «Longobardi in Italia: i luoghi del potere»: insieme al castrum di Casteseprio con il complesso di Torba e ad altri sei luoghi simbolo dell’eredità materiale longobarda sono dunque iscritti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Il loro scopritore, Gian Piero Bognetti, dal 1964 riposa nell’abside sud di questa piccola chiesa perduta nel bosco che vent’anni prima egli seppe riportare all’attenzione del mondo. Grazie alla sua competenza di studioso e alla sua grande passione per quell’arte cosí remota, S. Maria e i suoi tesori poterono passare cosí dall’oblio alla fama eterna. F
71
apostolo di Furio Cappelli
Il tredicesimo
Nell’Apostoleion, la grande basilica (oggi scomparsa) costruita a Costantinopoli in onore dei discepoli di Gesú, il primo imperatore cristiano aveva previsto la sua sepoltura nei pressi dell’altare, circondato da dodici lapidi in onore degli Apostoli, come se fosse uno di loro. È solo l’ultimo di una serie di atti simbolici attraverso i quali Costantino scandisce il proprio complesso percorso identitario, che da sovrano pagano lo porterà a essere «vicario di Cristo» Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana. Particolare dell’affresco di Cesare Nebbia (1534-1614) raffigurante il concilio svoltosi a Nicea, nel 325, per iniziativa dell’imperatore Costantino il Grande (seduto al centro, in primo piano).
Dossier
L L’
imperatore Costantino il Grande sfoggiava il titolo onorifico di «Vittorioso», forse sin dal momento del trionfo riportato su Massenzio a Ponte Milvio, nel 312. E, nel 325, in onore della vittoria sull’augusto Licinio, quando il labaro con il monogramma di Cristo (il chrismon) aveva fatto di nuovo da baluardo contro il nemico, decise di organizzare il primo sinodo dei vescovi della cristianità a Nicea (da nike, vittoria; è l’odierna città turca di Iznik, di fronte a Istanbul, sulla costa orientale del Mar di Marmara). Questa volta il nemico da abbattere era la discordia. Costantino vedeva una minaccia preoccupante nei dissidi teologici che contrapponevano gruppi di credenti, incrinando l’unità e l’armonia di una Chiesa sempre piú integrata nella società. Era giunto quindi il momento di porre fine a queste diatribe. Il sinodo, con le sue risoluzioni ratificate dal sovrano, doveva riportare la pace in ogni coscienza.
Tutto il mondo a Nicea
Poiché la cattedrale non era adatta a ospitare molte persone, l’incontro si tenne proprio nella sala centrale del palazzo imperiale. I vescovi giunsero a frotte. Il loro numero preciso
la prospettiva dell’islam
Costantino? Un tiranno che nulla ha a che fare con Cristo... Oltre a risolvere i dissidi sul giorno in cui celebrare la Pasqua, il sinodo di Nicea mise al bando come eretica la dottrina di Ario di Alessandria, che escludeva l’eternità di Cristo, esaltando la trascendenza assoluta e l’unicità del Padre eterno. Nella visione di Ario, Cristo era creato dal Padre, e non condivideva con Lui l’eternità e «il fatto di non essere stato generato». Con l’enunciazione del dogma cristologico, che il dettato di Nicea ergerà a stendardo della Chiesa ortodossa, il Figlio è eterno ed è generato dalla stessa sostanza di Dio padre. Il fatto che questa dottrina venisse enunciata e promossa a verità da un’assemblea di vescovi convocata da un sovrano fresco di conversione, oltre 300 anni dopo la morte di Cristo, fu piú volte
74
evidenziato dai teologi dell’Islam in funzione della loro polemica anticristiana. Molti di loro infatti furono concordi nell’affermare che fosse assurdo fondare la fede su principi che non erano espessamente enunciati nel testo sacro emanato da Dio. Il dettato di Nicea, anzi, smentiva proprio le Scritture, laddove asserivano l’unicità di Dio. Sempre secondo i teologi musulmani, Costantino stesso, poi, altro non fu se non un tiranno spietato che impose la propria fede con la violenza, guidato da visioni di stampo pagano che furono in realtà opera del demonio in persona. Per Ibn Hazm di Cordova (994-1064), credere alla scoperta della Vera Croce, poi, era come credere all’araba fenice. Come ha evidenziato Vincenzo Poggi, padre gesuita e studioso, una sintesi aprile
MEDIOEVO
A destra Istanbul, S. Sofia. Particolare del mosaico con Costantino che offre Costantinopoli. Fine del X sec. A sinistra Bucarest, chiesa del monastero di Stravropoleos. Affresco raffigurante il primo concilio di Nicea. XVIII sec.
puntuale e spietata di queste posizioni si ha nell’opera del dotto siriaco Ibn Taymiyyah (1263-1327). Egli era, infatti, convinto che la fede di Costantino non avesse niente a che fare con Cristo. D’altronde, per via delle spaccature che avevano al loro interno sin da quell’epoca, i cristiani non potevano essere sicuri di seguire il vero insegnamento di Dio. In generale, Costantino godette di cattiva fama nell’Islam proprio perché, forte della propria autorità, condivise, protesse e favorí una fede «minore», consentendo la sua affermazione come religione unica di uno Stato illustre e potente. Per giunta, realizzò il Santo Sepolcro di Gerusalemme: il pomo della discordia che scatenò le crociate.
MEDIOEVO
aprile
75
Dossier
Il Santo Sepolcro al tempo di Costantino In alto l’interno della chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme in una litografia ottocentesca basata su un acquerello originale di David Roberts. A destra pianta del complesso costantiniano del Santo Sepolcro.
3
1 2
76
A sinistra assonometria ricostruttiva del complesso religioso costantiniano, articolato in tre sezioni: il Martiryon, una basilica a cinque navate che segnava il luogo della Crocifissione (1); il Triportico, un vasto cortile colonnato che ospitava la Roccia del Golgota (2); l’Anà stasis, una rotonda colonnata, coronata da una cupola, costruita intorno alla camera sepolcrale (3). aprile
MEDIOEVO
Qui sotto incisione di David Roberts raffigurante il tabernacolo del Santo Sepolcro. 1843. Parigi, Bibliothèque des arts décoratifs.
è impossibile da determinare, ma dovettero costituire un’assemblea davvero corposa. Se seguiamo la testimonianza del vescovo Eusebio di Cesarea (260 circa-339 circa), autore di un’encomiastica e fondamentale biografia di Costantino, erano presenti 250 prelati, senza contare tutti gli uomini del loro seguito. Stando a Eusebio, appena giunta la convocazione, tutti erano scattati in modo fulmineo alla volta di Nicea e in onore di Costantino venne cosí a formarsi «un’immensa ghirlanda di sacerdoti». Sembrava che tutto il mondo fosse al cospetto dell’imperatore. «Si riuní in insieme il fiore dei ministri di Dio di tutte le Chiese che si trovavano nell’Europa intera, in Libia e in Asia». Nessuna terra mancava all’appello, dalla Spagna alla Persia.
Ritorno alle origini
Ma non era solo un’adunanza trionfale alla corte del sovrano. Grazie a quel sinodo, asserisce lo stesso Eusebio, erano tornati in auge i tempi gloriosi dei primordi del cristianesimo. Sembrava rinnovarsi l’incontro degli uomini pii provenienti da ogni angolo del mondo, cosí come è narrato negli Atti degli Apostoli (2, 9-11). Costantino si trovava tra i ministri di Dio a presiedere un vero e proprio «consesso apostolico». Lo stuolo dei partecipanti prese posto sugli scranni, secondo un A sinistra disegno ricostruttivo della camera sepolcrale nel Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda, l’edicola costantiniana custodiva la Tomba di Cristo, liberata su tutti i lati dalla roccia. La sala, di forma circolare o poligonale all’esterno, aveva copertura conica ed era sormontata da una croce. L’interno era decorato da marmi. La stanza era preceduta da un vestibolo a quattro colonne, con frontone e tetto a capanna, collocato al posto dell’atrio scavato nella roccia.
MEDIOEVO
aprile
77
Dossier
ordine puntualmente prestabilito, lungo i due lati maggiori della sala. Prima che l’assemblea si disponesse, un gran vocio doveva rimbombare in tutto l’ambiente, per l’inevitabile confusione dei momenti iniziali e per gli scambi di saluti e di commenti che sono altrettanto inevitabili negli incontri occasionali tra persone dello stesso rango. Pian piano però ognuno si trovò al proprio posto, e tutti i convenuti furono obbligati al silenzio. Ogni parola e ogni rumore erano magicamente cessati. Tutti rimasero in lunga attesa, immobili, per un lasso di tempo che dovette sembrare interminabile.
78
A un tratto, sulla porta compare un uomo, poi un altro, e un altro ancora. Giunge poi un gruppo di dignitari. Sono tutti uomini di fiducia del sovrano, e prendono posto al centro della sala. Si ordina a tutti di alzarsi in piedi.
Costantino entra in scena
Finalmente appare Costantino. Eusebio lo paragona a «un angelo del Signore». La sua altezza considerevole e la sua corporatura massiccia incutono soggezione, ma l’espressione del suo volto è pervasa da una mitezza che scaturisce dalla devozione e dal timore di Dio. Egli si para davanti all’assemblea nello
splendore delle sue vesti imperiali, che fiammeggiano grazie ai barbagli dell’oro, della porpora e delle pietre preziose. Incede verso il culmine dell’aula (il tribunal sopraelevato con un’abside sul fondo), dove i suoi attendenti gli mettono a fianco un piccolo trono di legno, rivestito d’oro. Prima di prendere posto, il sovrano invita tutti i convenuti a sedersi. In tal modo, dopo aver accettato l’omaggio dei prelati – che lo avevano accolto in piedi, in religioso silenzio, come era previsto dall’etichetta di corte –, concede loro il privilegio di accomodarsi prima di lui. Costantino si trova cosí assiso su un trono che rifulge d’oro, ma che si aprile
MEDIOEVO
Nella pagina accanto mosaico raffigurante san Costantino e sant’Elena ai fianchi della Vera Croce. Prima metà dell’XI sec. Hosios Loukas (Focide, Grecia centrale), Katholicon. In basso moneta in bronzo con un labaro sormontato dal cristogramma. Età di Costantino I, 327. Berlino, Staatliche Museen, Münzkabinett.
allinea per dimensioni agli scranni di ciascun prelato. Egli presiede i lavori, egli è l’imperatore, ma al tempo stesso vuole porsi in un rapporto paritetico con i convenuti. Non è accompagnato dai soldati della guardia imperiale, come di solito avviene in tutte le assemblee a cui partecipa, proprio perché non vuole che si creino barriere tra la sua autorità e i ministri di Dio, che devono sentirsi accolti nel suo palazzo come se fossero a casa propria. Prima che il sovrano prenda la parola, un vescovo si alza in piedi e apre i lavori con un inno di ringraziamento a Dio onnipotente. Inizia cosí il primo concilio ecumenico della storia. La discussione non manca di momenti di forte tensione, ma il sovrano sfoggia il piglio deciso di un navigatore esperto. Non entra affatto nel merito delle questioni teologiche, e non solo in segno di rispetto per l’autorità religiosa, visto che simili discussioni lo lasciano in genere piuttosto indifferente, se non addirittura infastidito. Si prodiga bensí a mitigare gli animi e a guidare l’assemblea verso una soluzione ampiamente condivisa.
Un banchetto sontuoso
I lavori si conclusero con una solenne formula di ringraziamento. Si tenne poi un sontuoso banchetto imperiale nella parte piú interna della reggia, dove si trovavano gli ambienti privati del sovrano. Stando a Eusebio, tutto era all’insegna
MEDIOEVO
aprile
dello splendore e della concordia. I vescovi erano accolti all’ingresso del palazzo da guardie in alta uniforme, disposte in circolo. Chi non poté stare a mensa con Costantino in persona, ebbe comunque modo di accomodarsi tra i divani allestiti ai lati della sala di ricevimento. Al culmine dell’incontro, l’imperatore salutò personalmente tutti i convenuti, consegnando a ciascuno di loro un prezioso omaggio con le proprie mani. Eusebio non credeva ai suoi occhi, sembrava un sogno. Sembrava di stare nella reggia di Cristo. Costantino agiva esclusivamente in nome e per conto dello Stato. La situazione, tuttavia, era molto particolare. Non si era mai visto un
sovrano di Roma coinvolto in modo cosí dirompente in questioni di natura religiosa. Aveva assunto movenze e prerogative sacerdotali, sia pure entro le mura del proprio palazzo. Sembrava un vescovo al di sopra di tutti i vescovi. L’imperatore stesso era ben consapevole di questa aura sacerdotale, e coniò per sé una definizione che doveva evitare ogni perplessità sia sul fronte cristiano che su quello non-cristiano. Egli era «il
vescovo di coloro che sono fuori». Una definizione che forse già allora si prestava a molteplici interpretazioni, e che forse era davvero volutamente fluida, nel tentativo di conciliare «interventismo» cristiano e autorità sovrana.
«Vescovo di fuori»
Egli, innanzitutto, era solo un catecumeno. Nonostante gli atti di amicizia, concordia e liberalità nei riguardi dei cristiani, sin dal celebre editto di Milano (313), Costantino era «fuori», non faceva parte dell’assemblea dei fedeli a Cristo. Tuttavia, in quanto imperatore, era comunque pontifex maximus, massima autorità riconosciuta dallo Stato in materia di religione. La definizione di «vescovo di fuori» potrebbe quindi intendere un’estensione al cristianesimo delle sue prerogative sovrane, escludendo un’appartenenza e un’assunzione di autorità religiosa tra i cristiani. Era comunque evidente a tutti che egli si sentiva investito di una missione che non si esauriva nei suoi compiti «istituzionali» di sovrano. Eusebio di Cesarea insiste ripetutamente su ogni possibile valenza biblica di Costantino Magno, trasformandolo in un redivivo eroe del Vecchio Testamento, un novello re Davide o un novello Mosè. Il sovrano, d’altronde, era convinto che le sue vittorie fossero dovute a quel labaro che annichiliva il nemico grazie al monogramma di Cristo, quel labaro difeso all’estremo da un manipolo di cavalieri accuratamente scelti. Era convinto di agire per conto di un Dio supremo di cui era lo strumento. Dalle sue lettere emerge che c’è una «unica e sovrana divinità», ed egli è il sovrano della terra che corrisponde al sovrano dei cieli. Le sue vittorie sono le vittorie di quel Dio onnipotente che ha cercato i
79
Dossier treviri, città imperiale
Damnatio memoriae all’ombra della Porta Nigra La città di Augusta Treverorum, nota in seguito come Treveris, ossia l’odierna Treviri, nella Germania occidentale ai confini con la Francia e con il Lussemburgo, fu baluardo di Roma sin dall’epoca di Augusto e fu una capitale occidentale dell’impero tra il 293 e il 312, sotto Costanzo Cloro e sotto suo figlio Costantino. In questo periodo divenne fulcro della cristianizzazione della Germania, e lo stesso Costantino concesse uno spazio di sua proprietà per l’edificazione del primo oratorio della comunità locale. A testimoniare la città antica rimangono in primo luogo la Porta Nigra (160-180), splendido esempio di porta monumentale a due torri, già conglobata nella chiesa romanica di S. Simeone, e la basilica palatina inerente al complesso imperiale, tra la cattedrale e le terme. Si tratta di un vasto e solenne ambiente a navata unica oggi adibito a chiesa protestante, e che mostra i «debiti» dell’edilizia religiosa cristiana nei riguardi delle aule destinate alle adunanze e all’amministrazione della giustizia. Questo e altri monumenti illustri, legati alla volontà e alla presenza dell’imperatore Costantino, nel 310 indussero un panegirista a mettere Treviri sullo stesso piano di Roma. La memoria della residenza imperiale si lega a una tristissima vicenda familiare, tramandata sotto forma di romanzo a tinte fosche dallo storico pagano Zosimo (fine del V-inizi del VI secolo), un alto funzionario dell’impero romano d’Oriente che si mostra detrattore acerrimo di Costantino. Crispo, nato nel 305 dal matrimonio del sovrano con la prima moglie Minervina, pare si fosse perdutamente innamorato della matrigna Fausta, che l’imperatore aveva preso in moglie in seconde nozze (307). Di fronte a questi sospetti, Costantino reagí senza mezze misure. Tolse di mezzo Crispo e, vista l’indignazione della propria madre Elena, credette di sistemare le cose preparando a Fausta un bagno soffocante, da cui questa uscí cadavere. Elena giunse in pellegrinaggio a Gerusalemme proprio per espiare quei delitti? Certo è che Costantino dispose nel 326 la demolizione del palazzo imperiale di Treviri, la casa che aveva condiviso con Fausta. Si trattò forse di damnatio memoriae? L’area dell’edificio fu subito santificata dalla cattedrale. Lo stesso nome di Crispo fu cancellato da ogni atto ufficiale, e il biografo Eusebio lo ignora scrupolosamente. Gli scavi condotti nell’area del palazzo di Treviri hanno recuperato preziosi resti della decorazione pittorica di una sala, oggi ricomposti nel locale Museo Diocesano. Due delle figure femminili che appaiono tra i lacunari di uno sgargiante soffitto, secondo un’ipotesi suggestiva (ma tutt’altro che indiscussa), rappresenterebbero la giovane Fausta e sua suocera Elena, la vittima e la «beata» madre dell’augusto carnefice.
80
In alto trittico della Vera Croce, dall’abbazia di Stavelot (Belgio). Arte mosana, 1156-1158. New York, Pierpont Morgan Library. Il pannello centrale contiene due stauroteche bizantine – con frammenti della Vera Croce – dell’XI-XII sec.; i pannelli laterali presentano clipei con scene della Leggenda di Sant’Elena. A sinistra frammento di affresco con il probabile ritratto dell’imperatrice Fausta, dal palazzo imperiale di Treviri. IV sec. Treviri, Museo Diocesano. aprile
MEDIOEVO
servigi di Costantino. I successi da lui riportati sul campo di battaglia sono altrettante manifestazioni della potenza divina. Ogni sua azione è mirata alla «gloria della potenza del Salvatore». La luce generata dal sacrificio di Cristo gli ha permesso di vincere l’errore dei suoi predecessori, che, continuando ad affidarsi agli dèi pagani, stavano per condurre l’impero alla rovina. Egli è un autocrate dalle convinzioni granitiche, per il quale la fede consiste nella dedizione a un ente supremo che guida verso la vittoria. Costantino è
MEDIOEVO
aprile
un cristiano tutto d’un pezzo, senza remore e senza sfumature. La sua è la devozione sincera e spietata di un uomo d’armi.
Vent’anni di potere
Dopo il concilio di Nicea, nel 325-6, il sovrano festeggia il ventennale del suo regno con i vicennalia. In questo momento di autocelebrazione, la luce di Cristo giunge puntuale a ispirarlo. Costantino decide cosí di riscoprire la grotta del sepolcro del Messia, per racchiuderla in un sontuoso complesso monumentale. Nel
cuore di Gerusalemme si distrugge cosí la «sozzura» di un tempio dedicato ad Afrodite per elevare un solenne edificio in onore del Figlio di Dio. Nell’ottica di Costantino, il ritorno alla luce della sacra memoria di Cristo, da secoli occultata sotto un terrapieno, ha un nesso preciso con la sconfitta e l’uccisione del suo acerrimo nemico Licinio, che senza successo aveva conteso con lui il dominio dell’Oriente romano. Il complesso del Santo Sepolcro (vedi box a p. 76) viene elevato con grande impegno e con un’immen-
81
Dossier
sa profusione di materiali di pregio. Secondo Eusebio, guardando il solo soffitto della basilica, lavorato a lacunari rivestiti d’oro lucente, si aveva l’impressione di fluttuare su un «immenso mare». Nasceva cosí la «nuova Gerusalemme», contrapposta a quella del passato, «empia», simbolizzata dalle rovine del Tempio ebraico: quella Gerusalemme che aveva meritato la distruzione per aver crocifisso il Messia. A tanto impegno veniva poi a dare man forte il fervore della madre del «beato» Costantino, Elena, che approdò in Terra Santa da devota pellegrina (326-327). La sua, in realtà, era anche una missione ufficiale per conto del sovrano. Grazie alle sue accurate perlustrazioni dei luoghi sacri, si avviarono due illustri santuari laddove si erano compiute la nascita e l’ascensione di Cristo, a Betlemme e al Monte degli Ulivi. La «beata» Elena morí alcuni anni dopo, intorno al 330, e Costantino de-
82
stinò le sue spoglie a Roma, in quello stesso mausoleo che forse, in un primo tempo, aveva predisposto per sé.
Nel segno del 3
Quando, nel 335-6, Costantino giunse a festeggiare con i tricennalia il trentennale del suo regno, fede e potere si trovarono ancora saldamente uniti, nel segno di un numero magico, il 3. Tre erano le persone della Trinità, tre i figli di Costantino associati al trono (nel 333 era stato elevato l’ultimo dei tre, Costante), trenta erano gli anni di regno, e tre furono gli eventi importanti che si erano succeduti: nel 335, un concilio e la consacrazione del Santo Sepolcro a Gerusalemme, e infine, l’anno dopo, gli stessi tricennalia a Costantinopoli. Di fronte a tanto fasto e a tanta devota sollecitudine, non mancò chi si prosternò davanti a Costantino prefigurandolo come «beato», posto di fianco al Dio supremo nel mondo ultraterreno.
Eusebio narra che il sovrano reagí di fronte a tanto entusiasmo con un certo fastidio, come se una patente di santità fosse per lui troppo generosa e comunque inopportuna. Egli, infatti, dominava il mondo terreno, e lo dominava per conto di Dio. Solo un ingenuo poteva confondere i ruoli, e proiettarlo al fianco del Padre eterno. Egli si faceva ritrarre con i piedi ben piantati per terra e con gli occhi volti al cielo, pervaso dall’ispirazione divina. Era magari rappresentato nell’atto di uccidere il nemico, sotto le sembianze di un drago (egli stesso parla di Licinio come di un «serpente sinuoso»), ma sempre e solo negli spazi pubblici e nei suoi palazzi. La sua immagine sotto forma di icona votiva era bandita dai templi per sua stessa disposizione. Forse comparve come supplice e devoto offerente a margine di alcuni mosaici delle chiese da lui commissionate. (segue a p. 87) aprile
MEDIOEVO
Nella pagina accanto il mausoleo di sant’Elena, sulla via Labicana, a Roma, in un’acquaforte di Agostino Tofanelli. 1833. Collezione privata.
MEDIOEVO
aprile
In basso il monumentale sarcofago in porfido rosso di sant’Elena. IV sec. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino.
All’impegno del «beato» Costantino in favore della fede cristiana dava man forte il fervore della madre, Elena, che approdò in Terra Santa da devota pellegrina
83
Dossier Nel ripercorrere la vicenda di Costantino Magno, ci confrontiamo con un imperatore a due facce: da un lato il sovrano di un impero tollerante, ma ancora «pagano»; dall’altro il seguace di Cristo che finisce nel novero dei santi della Chiesa ortodossa Costantino nasce in Illiria dal generale Costanzo Cloro e dalla sua concubina Elena.
280-85 circa 306
Dopo la morte del padre, viene acclamato imperatore. Battaglia di Ponte Milvio. Costantino, ispirato dalla divinità, vince su Massenzio.
312, 28 ottobre
313
Editto di Milano, ossia «lettera circolare» in applicazione di un precedente editto di Galerio (311), già persecutore dei cristiani. A conclusione di una lunga lotta di potere, l’augusto Licinio viene sconfitto a Crisopoli.
324, 18 settembre
325
Costantino uccide Licinio e indice il concilio di Nicea in nome della concordia dello Stato, condannando Ario per eresia. Celebrazione dei vicennalia a Roma per i venti anni trascorsi dalla proclamazione a imperatore. Uccisione e damnatio memoriae del figlio Crispo. Cerimonia di inaugurazione (consecratio) della città di Costantinopoli.
326 326-327
330, 11 maggio 335 336
Celebrazione dei tricennalia a Costantinopoli per i trenta anni trascorsi dalla proclamazione a imperatore. Guerra alla Persia. Morte di Costantino con esequie solenni. Viene sepolto nel mausoleo che ha predisposto a Costantinopoli. Il senato di Roma lo onora con un atto di consecratio, inserendolo nella schiera degli dèi.
84
337, 21 o 22 maggio
aprile
MEDIOEVO
Nella pagina accanto testa di una statua colossale bronzea di Costantino. IV sec. Roma, Musei Capitolini.
A destra Göreme (Cappadocia, Turchia). Karanlik Kilise. Affresco raffigurante san Costantino. Inizi del XII sec.
A seguito di una visione notturna, Costantino decide di adottare il chrismon come insegna delle proprie truppe. Ottiene cosí la vittoria grazie alla luce di Cristo. Persuaso della potenza di Cristo, decide di porre fine a ogni atto di intolleranza verso i seguaci del Salvatore, per giunta risarcendoli per le espropriazioni subite.
Secondo Eusebio di Cesarea, per via della sua condotta peccaminosa e per l’ostilità mostrata ai cristiani, Licinio merita di essere sconfitto da Costantino. A Nicea si tiene una grande assemblea di vescovi che sembra far rinascere l’età gloriosa di Cristo e dei suoi Apostoli. A seguito di una visione, Costantino decide di riscoprire e onorare il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Pellegrinaggio in Palestina della madre di Costantino, Elena. Grazie al suo interessamento, nascono due basiliche, a Betlemme e al Monte degli Ulivi. In base alla tradizione, Elena stessa scopre la Vera Croce a Gerusalemme. La nuova capitale, secondo la tradizione, si pone già allora sotto la protezione della Vergine Maria. A Gerusalemme si tiene un concilio e, nel contempo, si inaugura il complesso del Santo Sepolcro.
Confidando nelle preghiere dei vescovi e scortato da una chiesa da campo, Costantino scende in guerra contro l’empio Shapur II di Persia. Sentendo avvicinarsi la dipartita, Costantino si ritira in preghiera e decide di ricevere il battesimo nelle acque del Giordano. Per via della malattia, è costretto a fermarsi a Nicomedia, e lí può indossare l’abito di lino bianco dei neofiti. Viene sepolto accanto al cenotafio degli Apostoli.
MEDIOEVO
aprile
85
Dossier Didascalia aliquatur adi odis que vero ent qui doloreium conectu rehendebis eatur tendamusam consent, perspiti conseque nis maxim eaquis earuntia cones apienda.
In alto Roma, mausoleo di S. Costanza. Mosaico raffigurante Costanza (nel tondo, in alto) e scene di vendemmia, particolare della decorazione dell’ambulacro del mausoleo (oggi chiesa) realizzato per la figlia di Costantino. IV sec.
In alto, sulle due pagine Roma. Le dodici coppie di colonne in granito che sorreggono la cupola del mausoleo (oggi chiesa) di S. Costanza. A sinistra il sarcofago in porfido rosso di Costanza, in origine collocato nel suo mausoleo. IV sec. CittĂ del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Pio Clementino.
86
aprile
MEDIOEVO
Tutto qui. Ma la sua morte avrebbe rimesso tutto in gioco. Costantino chiuse in bellezza, nel 336, con una guerra santa ingaggiata contro la Persia dello spietato e incontenibile Shapur II (309-379; vedi «Medioevo» n. 203, dicembre 2013). Per la prima volta, Roma prese le armi tenendo conto della fede dell’avversario. A fianco dell’impero romano, scendeva in campo Cristo con le sue milizie celesti, pronto a castigare il «barbaro» adoratore del fuoco. Per
MEDIOEVO
aprile
la prima volta, Costantino richiese il pieno coinvolgimento dei vescovi, che con le loro preghiere dovevano garantirgli la vittoria. Arrivò addirittura a preparare una chiesa da campo, allestendo una tenda per i propizi riti cristiani.
Sogni di gloria
Forse faceva capolino nei suoi pensieri l’immagine di Alessandro Magno, che era un’autentica ossessione per i condottieri romani sin dall’epoca di Giulio Cesare.
Conquistando la Persia poteva emulare le sue gesta, e poi si poteva spingere fin dove il Macedone non era arrivato, privo com’era della luce di Cristo. Eusebio, d’altronde, asserisce esplicitamente che Costantino surclassava d’un colpo Ciro il Grande e Alessandro, poiché, a differenza di entrambi, conobbe una morte gloriosa. Troppe minacce si affacciavano sul fronte orientale, i Goti da una parte, i Persiani dall’altra. La città sul Bosforo fondata – o, meglio,
87
Dossier
In alto Roma, monastero dei Ss. Quattro Coronati, oratorio di S. Silvestro. Scene del ciclo affescato della Leggenda di San
88
Silvestro. 1246. Dall’alto, in senso antiorario: Cristo in maestà tra gli Apostoli; Pietro e Paolo appaiono in sogno a Costantino
malato e lo esortano ad affidarsi a papa Silvestro; i messi imperiali si dirigono al monte Soratte per incontrare Silvestro.
Nella pagina accanto un’altra scena del medesimo ciclo raffigurante Costantino battezzato da Silvestro. aprile
MEDIOEVO
rifondata – dal sovrano e che da lui prese nome, Costantinopoli, era ormai il principale presidio e l’unica vera capitale dell’impero. Concepita come una città di tradizione romana, con i riti di fondazione che si riconnettevano all’origine dell’Urbe, e con l’inevitabile dotazione di taluni templi pagani, Costantinopoli era ormai divenuta una capitale cristiana, con un numero sempre piú elevato di chiese riccamente dotate. L’immagine di città ben munita di fortificazioni, e, soprattutto, protetta dalla divinità suprema, senza sovrapposizioni con un passato imbarazzante e problematico, la resero unica candidata ad accogliere le spoglie del sovrano. Roma, che manteneva ancora il suo statuto di capitale, anche se ormai, di fatto, non lo era piú, era già stata onorata dalle spoglie di sua madre Elena, e tanto doveva bastare. Le decisioni di Costantino, tuttavia, non furono chiare a tutti sin
MEDIOEVO
aprile
dall’inizio. Nel mezzo della guerra contro la Persia, volle edificare vicino alle mura della «sua» città, presso la porta sulla strada di Adrianopoli, una fastosa basilica in onore degli Apostoli, affinché potesse godere della loro protezione in una congiuntura cosí delicata.
Un progetto ambizioso
Poi, d’un tratto, si venne a sapere che egli l’aveva eletta a propria sepoltura, disponendo la tumulazione al centro di quel santuario, presso l’altare, nel cuore della celebrazione liturgica cristiana. Si trattava di un progetto lungamente accarezzato, gelosamente custodito, e che vedeva ora la luce proprio perché il sovrano, sentendo vicino il momento della propria dipartita, si preparava a raggiungere il mondo dei cieli. A quanto pare, tra gli alti ranghi delle gerarchie religiose, nessuno seppe qualcosa di questo progetto, se non a cose fatte. Gli ultimi momenti della vita
del sovrano, seguendo la narrazione di Eusebio di Cesarea, compongono una coreografia impeccabile. Costantino, dapprima debilitato e poi caduto in grave malattia, si prepara alla morte sin dal momento delle festività pasquali del 337. Per propiziare la salvezza della propria anima, compie una sosta al santuario dei Martiri di Elenopoli, la città che prendeva il nome da sua madre, in Bitinia. Qui decide di prendere il battesimo, e per compiere il rito vorrebbe nientemeno che immergersi nelle acque del Giordano, esattamente come fece Cristo. Si appresta a raggiungere quella meta, ma durante il viaggio il male che lo affligge gli assesta il colpo finale. Si ferma a Nicomedia, presso l’odierna Izmit (Turchia), e si affida al vescovo locale. Il sovrano, al momento di ricevere il battesimo, smette per sempre gli abiti di porpora. Ora che è stato accolto nell’assemblea dei fedeli, è ben felice di
89
Dossier vestire l’abito bianco di semplice lino, come un neofita qualsiasi. Muore a Pentecoste, a mezzogiorno in punto, al culmine delle celebrazioni per l’ascensione di Cristo. Lo stesso Eusebio, dopo aver raccontato la dipartita di un Costantino pervaso di purezza e di umiltà, non nasconde alcun particolare sulle sue esequie trionfali, disposte sulla scorta di una lunga tradizione, ma di certo accolte e corroborate dalla volontà del defunto. Si allestisce la camera ardente nel palazzo imperiale di Costantinopoli. Morente, il sovrano si era liberato con gioia delle vesti purpuree, ma ora la sua salma, incoronata dal diadema, è tutta avvolta in quelle medesime vesti tinte di porpora, ed è racchiusa in una bara completamente laminata in oro, su un catafalco collocato in una delle sale centrali della residenza. Ai lati, lunghe file di vasi, anch’essi rivestiti d’oro, risplendono grazie alle fiamme che ardono al loro interno.
Vicino agli Apostoli
Un lungo corteo funebre, preceduto dall’esercito schierato in pompa magna sotto la guida di Costanzo II (337-361), figlio del defunto sovrano, conduce infine la salma alla chiesa-mausoleo degli Apostoli. Eusebio conclude il suo racconto assicurando che Costantino è partecipe della gloria degli stessi Apostoli, quasi a voler giustificare le disposizioni funerarie dell’imperatore nel segno di una pia devozione. Egli avrebbe eletto sepoltura nel mezzo della chiesa proprio per stare il piú possibile vicino ai propri protettori. Il suo nome, dice Eusebio, rimane familiare a tutti anche dopo la sua morte. Innumerevoli icone, che lo ritraggono in gloria sulla volta celeste, vengono dipinte per celebrarne il ricordo. Egli, in quanto imperatore, è stato divinizzato dal senato di Roma. Si conia una moneta celebrativa che lo ritrae sollevato in cielo dalla mano di Dio, mentre è alla guida di una poderosa quadriga di cavalli che allude al classico tema del carro del sole, tipico dell’apoteosi imperiale.
90
Si era creata una sorta di «corto circuito» tra la devozione cristiana di Costantino e le consuetudini celebrative degli imperatori defunti. Egli non aveva rinunciato alla propria divinizzazione e al proprio solenne mausoleo personale (heroon), degno di un Augusto o di un Diocleziano, pur desiderando una sepoltura nel vivo di una basilica cristiana. Il suo ruolo al tempo stesso apostolico e imperiale, solennemente assunto a Nicea nel 325, veniva riproposto per l’eternità all’interno del «suo» Apostoleion. La sepoltura era ridossata o sottoposta all’altare, e ai lati si trovava il cenotafio degli Apostoli. Il sacro collegio era simboleggiato da 12 lapidi («teche») disposte tutt’intorno, a formare un cerchio che poteva facilmente alludere alla rotonda edificata dallo stesso Costantino sul sepolcro di Cristo a Gerusalemme. D’altronde, come Cristo era l’eroe della Nuova Gerusalemme, Costantino era l’eroe e il fondatore della capitale sul Bosforo. La «messinscena» era ambigua, e dovette risultare imbarazzante. Costantino appariva a tutti gli ef-
fetti come vicario di Cristo, membro «aggiunto» del collegio apostolico in qualità di capo supremo per disposizione dell’autorità divina. Nella sua ottica, d’altronde, egli godeva di una relazione diretta, personale ed esclusiva con il dio di cui era devoto, e doveva essere evidente a tutti che quel dio lo aveva eletto a una posizione di massima eminenza nel mondo terreno. Ma una chiesa è l’immagine dell’aldilà, e ora questa signoria era stata proiettata in cielo.
Delirio mistico
D’altra parte, il mausoleo della madre Elena Augusta a Roma, forse in origine pensato proprio per lui, era sí legato alla basilica dei Ss. Marcellino e Pietro, ma costituiva un edificio a sé stante, cosí come il mausoleo della figlia Costanza (Costantina Augusta, ivi sepolta nel 354), che si può ammirare tutt’oggi presso le rovine della basilica di S. Agnese. La strepitosa decisione assunta per la sua tomba nell’Apostoleion dovette maturare dopo la morte della madre e dopo la dedicazione di Costantinopoli (330), in linea con il delirio mistico che lo aveva infi-
Nella pagina accanto Bosa (Oristano), cattedrale. Architrave della porta principale raffigurante la Madonna in trono col Bambino e san Costantino a fianco; ai lati san Pietro e san Paolo. XV sec. A destra Sedilo (Cagliari). Un momento della corsa a cavallo che si svolge ogni anno in occasione della festa con cui si celebra san Costantino.
aprile
MEDIOEVO
un santo e le sue feste
Sulle braci ardenti o al galoppo sfrenato Il culto di san Costantino godette di un enorme seguito nell’Oriente bizantino e tuttora lo si vede bene dalla diffusione del nome nella popolazione e da talune manifestazioni del folklore. È stato detto argutamente che il 21 maggio, giorno di san Costantino, mezza Grecia fa gli auguri di buon onomastico all’altra metà. Nella stessa Grecia, i rifugiati della Tracia bulgara, spinti dalle guerre balcaniche, hanno introdotto negli anni Venti del Novecento la festa nota sotto il nome di Anastenaria
MEDIOEVO
aprile
(«danze sulle braci»). Il fulcro della tradizione è nel villaggio di Sant’Elena (Aghia Eleni), situato nella Macedonia ellenica, sopra Salonicco. Al culmine della celebrazione, si sacrifica un agnello e si compie una danza rituale durante la quale gli adepti camminano a piedi nudi sulle braci ardenti, senza riportare alcun danno, poiché sono stati «chiamati» dal santo. Lungo il cammino, brandiscono un’icona raffigurante san Costantino e sant’Elena, o un drappo che è stato a contatto con un’icona siffatta. Una enclave assai particolare del culto e del folklore di san Costantino è poi la Sardegna, non a caso rimasta a lungo sotto il dominio formale dell’impero bizantino e sotto l’egida della Chiesa greco-ortodossa, anche se non è mancata una tesi «nazionalista» per spiegare questo attecchimento piuttosto isolato in area occidentale. Secondo lo storico seicentesco Agostino Tola, sant’Elena era sarda. Quel che è certo, a Nuraminis (Cagliari), la chiesa parrocchiale di S. Paolo reimpiega i resti di un ciborio di fine X secolo con l’intitolazione a Constantinu Megalou (Costantino il Grande), in greco, ma in caratteri latini. L’arredo presbiteriale era forse collocato in una vicina chiesa intitolata proprio a san Costantino. Il santo imperatore compare sulla porta principale della cattedrale medievale di Bosa (Oristano) di fianco alla Madonna col Bambino, a san Pietro e a san
Paolo. Sempre a Bosa, in linea con un’iconografia assai diffusa in Oriente, compare di fianco a sant’Elena, in un affresco trecentesco della cappella di Nostra Signora di Sos Regnos Altos del castello di Serravalle (detto anche dei Malaspina). Caso singolare, si presenta con gli strumenti della Passione di Cristo in mano (lancia e flagello), mentre sant’Elena esibisce come di consueto la Vera Croce. A Costantino, per giunta, noto come Santu Antine o Bantine, sono intitolati alcuni nuraghi, come Sa Domo de Su Re (la «Reggia») di Torralba (Sassari). Di grande effetto sono poi i festeggiamenti che si tengono in onore del santo a Sedilo (Cagliari). Tra il 5 e il 7 luglio, a conclusione dell’anno agrario, presso la chiesa di Santu Antine, si tiene la Ardia o Bardia («Guardia»). Nata forse come antichissimo rito di purificazione, è una corsa a cavallo che commemora la vittoria di Costantino a Ponte Milvio. Il sovrano è impersonato da uno dei tre cavalieri portastendardo che sono alla testa del gruppo, e che non possono essere mai superati. Si inizia dall’alto di un greppo, con una corsa a precipizio che si conclude oltrepassato l’arco che delimita il sagrato della chiesa. Seguono poi alcuni giri rituali intorno all’edificio e una nuova galoppata verso sa muredda, un recinto che racchiude una croce. La corsa si conclude con i cavalieri che girano intorno alla croce della vittoria.
91
Dossier Istanbul, Museo Archeologico. Tre sarcofagi imperiali in porfido rosso provenienti dalla basilica dei
ne portato a desiderare il battesimo nelle acque del Giordano. Non piú legato agli impacci della tradizione pagana, sciolto dalle formalità delle sue mansioni, voleva coronare nel modo piú solenne il suo sacro legame con la divinità suprema. In fondo, realizzando l’Apostoleion, egli convertí alla gloria di Cristo un luogo in cui era sorto, a quanto pare, un antico tempio dedicato ai dodici principali dèi del mondo greco-romano. Grazie a lui, gli dèi erano stati sostituiti dagli Apostoli. Costantino poteva assurgere a tredicesimo dio, occupando il posto agognato da Alessandro Magno, ma aveva preferito la compagnia dei messaggeri di Cristo. Sotto una certa visuale, era una scelta di campo che doveva onorare i ministri di Dio. Le alte gerarchie religiose di Costantinopoli, tuttavia, non si commossero di fronte a tanta dedizione, e rifiutarono questa smaccata commistione tra culto cristiano e apoteosi imperiale. Il figlio Costanzo II, che aveva svolto le esequie secondo le disposizioni testamentarie, pose fine alle polemiche insorte in seno alla Chiesa trasferendo le spoglie in
92
SS. Apostoli. Uno di essi fu forse quello destinato ad accogliere le spoglie di Costantino.
un mausoleo dinastico a sé stante, direttamente collegato all’edificio religioso tramite il «vestibolo del pescatore», cosí chiamato in onore di san Pietro. Da centro focale del santuario, Costantino fu cosí declassato a suo custode o portiere. Sul luogo già occupato dalla sepoltura del sovrano furono traslate le reliquie dell’evangelista Luca e di due apostoli, Andrea e Timoteo (35657). Solo loro potevano giustificare lo «sfratto» comminato all’augusto strumento di Dio.
Santo, suo malgrado
Gli sviluppi di questa vicenda furono sorprendenti. Uscito dalla porta del santuario, Costantino vi rientrò nelle celebrazioni liturgiche, acquisendo quella qualifica di santo che, stando a Eusebio, rifuggiva con irritazione. Esistevano nel calendario altri santi con il suo stesso nome, ma finirono tutti nel dimenticatoio. C’era un solo san Costantino a cui rendere omaggio, colui che era ricordato negli uffici liturgici come «uguale agli apostoli» (isoapostolon), fino a divenire il tredicesimo apostolo della Chiesa ortodossa. Già
nel X secolo, l’inno principale a lui dedicato che si intonava a S. Sofia, la cattedrale di Costantinopoli, innalzava lodi risonanti all’uomo «coronato da Dio», «l’Imperatore divenuto tuo apostolo, Signore». Il 21 maggio, giorno della sua ascesa in cielo (morí infatti il 21 o il 22 maggio 337), fu dedicato alla sua festa religiosa, forse già nel V secolo. Divenne anche la ricorrenza in cui si celebrava sant’Elena, ben presto accomunata al figlio nella devozione collettiva per aver rinvenuto la Vera Croce a Gerusalemme, segno evidente della nuova alleanza che si era stabilita tra il sovrano celeste e il sovrano terreno. Ma Oriente e Occidente ebbero un atteggiamento ben distinto nei riguardi di questa celebrazione. Nella Chiesa ortodossa l’accento è tuttora posto sul santo imperatore, e sant’Elena appare in secondo piano. Al contrario, il culto di Costantino non ebbe quasi alcun seguito in Occidente, a tutto vantaggio del culto di sant’Elena, soprattutto per effetto dell’ideologia e della propaganda papale. La Vita di san Silvestro papa, redatta nel V secolo a Roma aprile
MEDIOEVO
A destra miniatura raffigurante la basilica dei SS. Apostoli di Costantinopoli, da una raccolta di omelie di Giacomo Kokkinobaphos. 1100-1150 circa. Parigi, Bibliothèque nationale de France. Moneta recante al dritto il profilo di Costantino (qui sopra) e, al rovescio (a destra), la sua ascesa al cielo. 337.
e utilizzata fino in pieno Duecento in difesa del primato e del potere temporale dei pontefici, dipinge un Costantino che, prima di convertirsi, compie stragi di bambini, alla stregua di un novello Erode, per procacciarsi scorte di sangue puro onde guarire dalla lebbra (e naturalmente, solo il battesimo lo salva dalla malattia e dalla cecità spirituale).
La schiera degli epigoni
Sulla diversità del trattamento riservato a Costantino pesò, naturalmente, la concezione del sovrano orientale (basileus), direttamente ricondotta all’immagine del santo imperatore. Egli, infatti, aveva stabilito per primo un modello di autorità sovrana che esercitava la signoria sugli affari terreni per conto di Cristo in persona. E numerosi imperatori di Costantinopoli sfoggiarono quel nome autorevole. Veniva adottato anche come titolo onorifico. Novus Constantinus si appellò per ultimo Michele VIII Paleologo (1261-1282), dopo aver strappato l’impero dalle mani dei conquistatori crociati. La sua solenne
MEDIOEVO
aprile
statua bronzea, che lo ritraeva nell’atto di offrire la città all’omonimo arcangelo Michele, fu eretta proprio nei pressi dell’Apostoleion. La basilica degli Apostoli, luogo primigenio del culto costantiniano, con tutta la pletora di sepolture imperiali che la costellavano lungo i portici, oggi non c’è piú. Giustiniano la ricostruí tra il 536 e il 550, e scelse come sepoltura un mausoleo che faceva da pendant a quello di Costantino. La nuova basilica fece da modello al S. Marco di Venezia (10631071; vedi «Medioevo» n. 203, dicembre 2013), ma fu poi demolita nel 1461. Sulla sua area fu eretta la moschea del Conquistatore (Fatih), in onore del sultano Maometto II (1451-1481), colui che, nel 1453, aveva messo fine al glorioso impero bizantino. Una serie di sarcofagi imperiali è tutto ciò che ne rimane. Dapprima depositati presso la chiesa di S. Irene, sono oggi in mostra di fronte al Museo Archeologico di Istanbul. Stando ad alcune ipotesi, uno di quei sepolcri appartenne a Costantino in persona. V
Da leggere U Eusebio di Cesarea, Vita di
Costantino, a cura di Laura Franco, Rizzoli, Milano 2009 U Richard Krautheimer, Tre capitali cristiane. Topografia e politica, Einaudi, Torino 1987 U Gilbert Dagron, Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451), Einaudi, Torino 1991 U Arnaldo Marcone, Pagano e cristiano. Vita e mito di Costantino, Laterza, Roma-Bari 2002 U Francesco Sini, Pietro Paolo Onida (a cura di), Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino imperatore tra Oriente e Occidente, G. GiappichelliISPROM, Torino 2003. U Ester Pevere, Francesco Braschi, Costantino ed Elena, santi della Chiesa d’Oriente, in Gemma Sena Chiesa (a cura di), Costantino 313 d.C. L’editto di Milano e il tempo della tolleranza, Electa, Milano 2012; pp. 162-167 U Massimo Guidetti, Costantino e il suo secolo. L’«editto di Milano» e le religioni, Jaca Book, Milano 2013
93
medioevo nascosto civate
Civate (Lecco), basilica di S. Pietro al Monte. Il grandioso affresco della Visione dell’Apocalisse dipinto sopra la porta d’ingresso della controfacciata orientale. Fine dell’XI-inizi del XII sec.
L’abbazia del cinghiale bianco di Elena Percivaldi
Su un’altura circondata da magnifici boschi, a pochi chilometri da Lecco, sorge il complesso della basilica di S. Pietro al Monte e dell’oratorio di S. Benedetto. Un piccolo gioiello architettonico che, al suo interno, custodisce un eccezionale patrimonio artistico 94
aprile
MEDIOEVO
C
i si arriva dopo un’oretta di cammino nel bosco, dopo aver lasciato l’auto nell’ultimo avamposto verso monte del paese di Civate, frazione Pozzo, in provincia di Lecco. Una passeggiata abbastanza agevole lungo una mulattiera che si snoda tra le voci della natura e del torrente che si sente ma non si vede. Un ultimo strappo ed eccola all’improvviso: passato un cancello e un suggestivo arco di pietra, in una radura affacciata a mezza costa sulle montagne del Lecchese, a 662 m di quota, si stagliano la basilica romanica di S. Pietro al Monte e l’annesso piccolo oratorio di S. Benedetto. È quel che rimane di un complesso abbaziale un tempo ricco e potente e che arrivò a ospitare contemporaneamente, nonostante la collocazione impervia, decine di anime alla ricerca della pace spirituale. Non è difficile crederlo: anche oggi, la quiete e il raccoglimento del luogo restano notevoli nonostante poche centinaia di metri piú sotto scorra la Statale
MEDIOEVO
aprile
36, che collega Milano a Lecco, una delle arterie piú trafficate d’Italia in una delle zone piú industrializzate d’Europa. E se oggi l’armonia è compromessa dalla gigantesca cava aperta sulla pendice sud del monte Cornizzolo per estrarvi il calcare – ma un comitato si è opposto al suo ampliamento –, la vista rimane rapita dall’imponente mole del Monte Barro, uno dei maggiori contrafforti delle Prealpi luganesi, sede di importanti ritrovamenti archeologici (vedi box alle pp. 104-105). Un luogo spirituale, dunque, ma anche dalla storia lunga e misteriosa. A cominciare dalle origini, che affondano nel mito e nella leggenda.
Una guarigione miracolosa
Secondo il cronista milanese Galvano Fiamma (vedi box alle pp. 96-97), il monastero sarebbe stato fondato dall’ultimo re longobardo Desiderio in segno di ringraziamento per la guarigione miracolosa del figlio Adelchi. Anche altre fonti, sia cronachistiche (vari
95
medioevo nascosto civate anonimi annalisti, Lampugnano da Legnano, Jacopo Malvezzi), che documentarie, sono concordi – pur nell’ampio ventaglio di date perlopiú palesemente errate – ad attribuire all’ultimo sovrano longobardo l’edificazione. Nel giro di pochi decenni il cenobio si segnalò per una serie di presenze importanti, a cominciare dal massimo storico longobardo, Paolo Diacono, che qui forse soggiornò – come ricorda una lapide affissa nel pronao della basilica – e addirittura avrebbe preso i voti. Egli visse nel momento del trapasso del regno dai vecchi padroni ai nuovi, i Franchi, diventando un intellettuale di spicco presso la corte carolingia. E proprio in età franca S. Pietro conobbe uno dei momenti di maggior splendore. A quest’epoca risale infatti il piú antico documento che lo riguarda direttamente: una carta che menziona la presenza di una comunità, affratellata all’abbazia retica di Fabaria (Pfäffers), di ben trentacinque monaci guidati dall’abate franco
SVIZZERA
Bormio
Chiavenna
Novate Mezzola
TRENTINO ALTO ADIGE
Trento
Meraggio
Lecco Civate Bergamo Brescia Monza Milano
Varese Como Novara
VENETO
Verona Pavia
Cremona
Mantova
Meda
Piacenza Alessandria
EMILIA-ROMAGNA
PIEMONTE
In alto cartina della Lombardia, con la localizzazione di Civate. A sinistra miniatura raffigurante Adelchi, dal Codex Legum Langobardorum.
Parma
Reggio nell’Emilia Modena
XI sec. Cava dei Tirreni, Abbazia. A destra una veduta della basilica di S. Pietro al Monte (a sinistra) e dell’oratorio di S. Benedetto (a destra).
La leggenda del cinghiale
Adelchi e la caccia miracolosa Una bella leggenda lega il monastero di S. Pietro al Monte ai Longobardi e alla figura di Desiderio, il loro ultimo e pio re. Protagonista è suo figlio Adelchi, eroe anche della celebre e omonima tragedia manzoniana: un personaggio che, per la sua sorte misteriosa – secondo il cronista carolingio Eginardo (775-840), morí esule a Costantinopoli, secondo altri venne invece sconfitto e ucciso in battaglia dal nipote Grimoaldo III, nel disperato tentativo di riconquistare il regno – ha evidentemente affascinato sin dai tempi antichi. A narrarla è il cronista milanese Galvano Fiamma, vissuto nel Trecento, che la trascrisse dalla forse duecentesca Translatio reliquiarum beatorum apostolorum Petri et Pauli.
96
Adelchi (che Fiamma chiama, alla latina, Adalgiso), giovane baldanzoso e amante della caccia, si imbattè dunque un giorno nei boschi del monte Pedale (l’antico nome del Cornizzolo) in un grosso cinghiale dall’impressionante ferocia. Il principe, colpito, decise che avrebbe dovuto farlo suo a ogni costo: quale miglior preda per dimostrare a tutti il proprio valore? Lo inseguí dunque coi cani. Dopo averlo braccato per ore, l’animale esausto si rifugiò in una radura. Qui viveva in solitudine un eremita di nome Duro, che aveva costruito un rudimentale oratorio in onore di san Pietro. «Il cinghiale dunque – racconta Galvano –, cercando la salvezza nella fuga, trovò l’ingresso della chiesa spalancato. Deposta senza indugio la ferocia, si accucciò presso l’altare come se volesse consegnarsi alla protezione dell’apostolo chiedendogli aiuto. Adalgiso, non appena lo vide, irruppe nella chiesa desiderando ardentemente uccidere il cinghiale. aprile
MEDIOEVO
Ma prima di scagliarsi sull’animale, improvvisamente sperimentò un fatto meraviglioso, una cosa stupefacente mai piú vista: fu privato della vista e della luce». Duro, testimone del prodigio, pregò il Signore. Lo stesso fece il giovane, che promise di far erigere sul luogo una sontuosa chiesa, sempre dedicata al santo e arricchita con le sue reliquie. «Dopo aver pronunciate cosí tali promesse – conclude il cronista milanese –, per intervento della misericordia divina riacquistò la luce degli occhi. Tutti coloro che erano presenti rendevano grazie a Dio, che cosí meravigliosamente tutto dispone». La versione di Galvano è quella piú diffusa, ma la leggenda è nota anche attraverso altre varianti che aggiungono vari particolari, come per esempio il colore inusuale del cinghiale (bianco) e la guarigione avvenuta per mezzo dell’acqua di una fonte sacra che scorreva vicino alla cappella. Il che la rende ancora piú interessante in
MEDIOEVO
aprile
quanto fonde in sé elementi che provengono sia dalla tradizione cristiana che da quella pagana precedente, in particolare celtogermanica. L’acqua come elemento sacro è infatti ben presente nella religiosità celtica (si veneravano in particolare le fonti) e richiama il battesimo cristiano. Il cinghiale bianco, animale sacro ai Celti, accompagnava invece i i druidi e il dio Lugh ed era simbolo di sapienza e di forza guerriera. Traeva il suo sostentamento dalle ghiande, che crescevano sulla quercia, albero sacro per eccellenza. Un esempio di questo sincretismo si ha anche nella rappresentazione iconografica di sant’Antonio Abate, protettore degli animali, che compare con ai piedi un maiale (ma in origine era un cinghiale) e con attributi (dalla veste alla barba, dal bastone alla tonsura) che richiamano chiaramente i druidi e Lugh, dio celtico della luce e della sapienza legato al fuoco
come elemento di purificazione (non a caso, Antonio presiede ai rituali di lustrazione delle mandrie ed è invocato contro l’herpes zoster, malattia virale chiamata appunto «fuoco di Sant’Antonio»). Al mondo germanico appartiene invece il mito della «caccia selvaggia» o «corteo dei morti» che, nelle sue varianti, compare in molta letteratura e folklore europeo. Come «masnada di Hellequin» fu descritta per la prima volta in maniera compiuta dal monaco anglo-francese Orderico Vitale (1075-1142). Lo stesso nome di Hellequin (noto anche nelle forme Herlequin o Helething) parrebbe di origine germanica a partire dal riferimento all’esercito (in tedesco Heer) e all’assemblea dei guerrieri liberi (thing). La sua figura, inoltre, è assimilabile a quella del dio Wotan-Odino, il condottiero in capo della famigerata caccia selvaggia. Piú tardi fu «neutralizzato» nella ben piú rassicurante maschera di Arlecchino.
97
medioevo nascosto civate Leutgario (o Leudegario). Quest’ultimo, insieme al connazionale Ildemaro, era un personaggio di notevole importanza nel quadro politico e religioso del tempo. I due infatti erano uomini di fiducia dell’imperatore Lotario, figlio di Ludovico il Pio e nipote di Carlo Magno, e lo accompagnarono in Italia quando egli vi si rifugiò braccato dai fratelli, che si erano coalizzati contro di lui nel quadro delle lotte per la successione dell’impero carolingio. Lotario, al quale spettava l’Italia, si rifugiò a S.
Pietro insieme ad altri due fedelissimi, il suo architetto e orafo Wolvinio e l’abate di Corbie Wala. La presenza di Lotario e il quadro politico incerto determinarono subito la necessità di un intervento di riorganizzazione di alcuni tra i monasteri piú importanti, tra cui quello milanese di sant’Ambrogio (vedi «Medioevo» n. 206. marzo 2014), fortemente voluta dall’arcivescovo di Milano Angilberto II (824-859). Anch’egli di origine franca, chiamò Ildemaro e Leutgario nel ca-
Sulle due pagine disegno ricostruttivo del complesso abbaziale di Civate, comprendente la basilica di S. Pietro al Monte e l’oratorio di S. Benedetto; a destra, in basso, è illustrata una parte della decorazione interna della basilica.
98
aprile
MEDIOEVO
Una struttura insolita
7
A destra pianta della basilica di S. Pietro, a navata unica caratterizzata dalla presenza di due absidi contrapposte. Alla basilica si accede per una scalinata monumentale (1) che porta a un pronao (2) e all’ingresso semicircolare (3), sotto il quale si trova la cripta, accessibile da una scalinata a metà della navata (4). L’atrio d’ingresso (nartece) alla navata (5) è affiancato dalle cappelle (absidiole, 6) dei Santi (a destra) e degli Angeli (a sinistra). Dalla navata si accede all’abside occidentale (7), con altare sormontato da un ciborio (8).
8 4
6 5 3 2
6
In basso affresco della parete della navata, raffigurante san Pietro con la tiara papale, che tiene in mano una grande chiave doppia.
1
MEDIOEVO
aprile
99
medioevo nascosto civate poluogo ambrosiano per affidar loro la riforma di vari cenobi della diocesi. «Prestati» momentaneamente al vescovo di Brescia, Ramperto, per la riforma di S. Faustino Maggiore, i due furono poi rimandati a S. Pietro di Civate nell’844 in tempo per accogliervi le spoglie di san Calocero di Albenga, diocesi suffraganea di Milano, da lui fatte traslare nel monastero lecchese.
La rifondazione dell’abbazia
Per S. Pietro furono anni di grande splendore: oltre al numero dei monaci, fioriva l’attività culturale. Lo dimostra il fatto che qui Ildemaro compose un importante commento alla Regola di san Benedetto destinato a fare scuola in tutta Europa. E, nello stesso periodo, la primitiva struttura dell’abbazia fu rivista e ampliata. La vecchia torre (probabilmente di vedetta) e le cappelle della chiesa (oggi ne restano labili tracce assieme a resti di colonne e murature databili tra il V e l’VIII secolo) furono abbattute e l’edificio fu riprogettato a navata unica con tetto a capriate scoperte e due absidi. A quest’epoca risale anche lo splendido ciborio, che richiama nelle forme quello milanese della basilica di S. Ambrogio. Con l’avvento dei Franchi il monastero conobbe un forte momento di ascesa, divenne anche un punto di riferimento per quanto concerne il controllo del territorio e si collegò, culturalmente, con centri importanti d’Oltralpe e del Nord Europa come S. Gallo, Coira, Reichenau e Fulda. Accomodatosi sotto l’ala protettiva
dell’impero, S. Pietro faceva da contraltare al dilagante potere dell’arcivescovo di Milano nelle pievi della valle. Come testimoniano i documenti di questo periodo, l’abbazia riuscí a estendere la sua influenza, tramite acquisizioni territoriali, sui circostanti laghi di Annone e Pusiano ma anche in diocesi lontane – sebbene legate per motivi di carattere religioso e culturale – come Albenga. All’orizzonte, però, si profilava la minaccia degli Ungari, che si spinsero nel cuore dell’Europa saccheggiando abbazie ricche e importanti come Reichenau e S. Gallo. Per far fronte alle loro scorrerie, il territorio subí una nuova ondata di incastellamento con fortificazioni che spesso si limitavano a rafforzare quelle già esistenti e che erano state costruite in epoca gota. Dall’887, deposto Carlo il Grosso, il territorio di Civate passò, come tutto il Lecchese, al regno d’Italia e fu costituito in Comitato, che continuò la sua esistenza fino al 961, quando cadde Berengario I, l’ultimo sovrano, e il potere passò di nuovo all’impero. Poi il Lecchese, lentamente, subí la spartizione tra i vescovi di Como e di Bergamo e lo stesso arcivescovo di Milano. Con l’avvento della riforma e con l’ascesa, a Milano, Nella pagina accanto, in alto la controfacciata orientale del nartece della basilica, con le absidiole laterali decorate e l’affresco dell’Apocalisse sopra le arcate. Le pitture sono databili tra la fine dell’XI e gli inizi del XII sec. In basso l’esterno del pronao semianulare a due piani della basilica, che precede l’abside orientale dell’edificio.
la visita La basilica di S. Pietro al Monte ha una struttura originale: presenta infatti due absidi, una a ovest e l’altra a est, la seconda aggiunta forse nell’XI secolo. Ancora si discute sui motivi di tale impostazione, ma sembra ormai prevalere l’ipotesi che vede l’eventuale aggiunta della seconda abside (e non la sua presenza sin dall’inizio) come una ulteriore prova della vicinanza, anche nei modelli architettonici, all’Oltralpe. Realizzati tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, gli affreschi di S. Pietro sono stati messi in relazione con il ciclo a tema apocalittico del battistero di Novara, risalente al primo quarto dell’XI secolo, che, a sua volta, denota notevoli affinità con la scuola del monastero di Reichenau che produsse il manoscritto dell’Apocalisse di Bamberga commissionato da Ottone III. Elementi
100
aprile
MEDIOEVO
A destra l’affresco della volta del nartece della basilica, con la Gerusalemme celeste.
di vicinanza stilistica esistono anche con il Sacramentario di Warmondo di Ivrea (inizio XI secolo) e il ciclo di affreschi della chiesa di S. Michele a Oleggio, nel Novarese (secoda metà dell’XI secolo), a dimostrazione della diffusa circolazione di modelli stilistici, iconografici e ideologici che appartenevano alla cultura della corte imperiale germanica a cavallo del Mille. Gli affreschi di Civate, però, denotano anche una vicinanza stilistica con le miniature dei Commentari all’Apocalisse di Beato di Liébana, che probabilmente arrivarono a Civate per tramite milanese grazie a libri di modelli che circolavano nell’Europa centro-settentrionale di quell’epoca. Ignoti sono gli autori, anche se furono piú di uno, e ce lo dice la differenza di impostazione della Gerusalemme celeste, che si rifà a modelli ottoniani di
MEDIOEVO
aprile
provenienza nordica, rispetto alla Visione apocalittica, che sottende la conoscenza del linguaggio figurativo bizantino della seconda metà dell’XI secolo. È certo, comunque, che chi ideò il ciclo aveva anche una solida e approfondita preparazione teologica, che denota non solo la conoscenza
dei testi biblici, ma anche della loro esegesi (Ambrogio, Gregorio Magno, Ambrogio Autperto). Sulla porta d’ingresso si trova l’affresco della Traditio Legis et Clavis, raffigurante Cristo che fonda la sua Chiesa consegnando a Pietro e Paolo segue a p. 102
101
medioevo nascosto civate del partito dei Patarini sostenuti dal papa, la contesa si fece piú serrata. In questo quadro l’arcivescovo Arnolfo III, inviso ai Milanesi, fu protagonista di una concitata elezione e venne consacrato prima dal figlio dell’imperatore Corrado, e poi dai vescovi tedeschi Dimone di Salisburgo, Ulderico di Passau e Gabardo di Costanza. Potendo contare solo sull’appoggio di Anselmo da Baggio (il futuro papa Alessandro II), e del riformatore Landolfo Coppa, si ritirò a Civate a fare penitenza. Riuscí a occupare la cattedra ambrosiana solo dopo essersi riconciliato col papa, ma tre anni dopo, il 24 settembre 1097, morí e fu sepolto, per suo volere, proprio in S. Pietro. A quest’epoca, con grande probabilità, risalgono il completamento della basilica, la sua decorazione pittorica sontuosa e la costruzione dell’oratorio di S. Benedetto. E questo fu il secondo, e ultimo, grande momento di splendore.
I tesori dello scriptorium
la visita
Lo scriptorium monastico produsse nel corso del tempo molti manoscritti di pregio, purtroppo dispersi nei secoli. I piú antichi giunti fino a noi sono entrambi del IX secolo e sono oggi conservati a Berlino, presso la Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz: si tratta del Commento a Ezechiele di Gerolamo, che proprio all’inizio testimonia la propria provenienza con la didascalia «liber de clavat(e)» (dove Clavate è il nome latino di Civate) e l’Expositio in Evangelium secundum Matthaeum
rispettivamente le chiavi e le leggi. La navata della chiesa è preceduta da un nartece retto da quattro colonne unite da plutei con le raffigurazioni (eseguite a stucco) del Grifone e della Chimera in fuga. Lo spazio è diviso in tre vani: un corridoio e due absidiole laterali. Nella lunetta interna sopra l’ingresso è raffigurato il Seno di Abramo, con tre fedeli a rappresentare
102
i Giusti, mentre sulle due pareti del corridoio i papi Marcello e Gregorio Magno accolgono i fedeli. Nella volta si staglia la Gerusalemme celeste. Al centro il Cristo in Maestà che regge un libro aperto dove si legge l’invito «Qui sitit veniat» («Venga chi ha sete») ha ai suoi piedi l’Agnello mistico sotto il quale sgorga una sorgente. La scena è circondata dalle mura cittadine, aperte da dodici porte dalle
quali si affacciano altrettanti angeli. Nella volta a crociera successiva si trovano le rappresentazioni allegoriche dei quattro fiumi del Paradiso Terrestre. Nelle due piccole absidi che affiancano il corridoio d’ingresso sono rappresentati le gerarchie angeliche e il popolo degli eletti; nel catino absidale il Cristo benedicente. Al di sopra delle tre arcate del nartece interno, sopra la porta di ingresso della controfacciata orientale, si staglia la grande Visione dell’Apocalisse. Sulla sinistra, la «donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi» citata nel testo biblico partorisce un figlio. Il Bambino viene subito portato al trono di Dio, dove è assiso il Cristo: intorno a lui, san Michele Arcangelo e gli angeli trafiggono il Drago simbolo del male. Una scala sul lato sud, contornata da un parapetto con scene di grifoni e leoni che assumono valenza umana e convertendosi accedono alla Salvezza, si scende nella cripta, che conserva aprile
MEDIOEVO
di Remigio Altissidorensis, che contiene nell’ultimo folio un documento preziosissimo: l’elenco dei libri che appartenevano alla biblioteca del monastero nel XII secolo. I sessantasei titoli, parecchi per l’epoca, sono per la maggior parte di autori legati al mondo francogermanico, a sottolineare l’appartenenza al contesto «nordico» dell’abbazia. Influenza ribadita in maniera eloquente dalla mancanza – significativa anche sul piano politico – dell’opera di Ambrogio e dai nomi dei santi celebrati nel preziosissimo Messale risalente all’XI-XII secolo (probabilmente ordinato da Arnolfo III) e oggi conservato alla Biblioteca Trivulziana di Milano, anche in questo caso perlopiú cari ai Franchi. Ma proprio nel momento in cui conobbe il massimo fulgore, l’abbazia iniziò ad avviarsi verso il declino. Lo scarso spazio a disposizione, che precludeva ulteriori ingrandimenti, non consentiva di accogliere altri novizi. Per di piú, il luogo era isolato e difficile da raggiungere. A S. Pietro «al monte» si iniziò, progressivamente, a preferire la nuova fondazione che si andava edificando «al piano», S. Calocero, che già affiancata dall’oratorio di Ss. Vito e Modesto nel borgo, fu in breve contornata Nella pagina accanto oratorio di S. Benedetto. L’altare, affrescato su tre lati: su quello frontale (sotto) con una Deesis; sul destro (sopra) con San Benedetto abate. XI sec.
scene riguardanti la vita di Maria: la presentazione di Gesú al tempio, la crocifissione di Cristo (lacunosa) e la Dormitio Virginis. Le monofore che illuminano l’ambiente sono incorniciate da affreschi raffiguranti le Vergini prudenti, che portano una fiaccola accesa nella mano sinistra e l’ampolla dell’olio. Uno dei gioielli della basilica è lo splendido ciborio che sormonta l’altare di fronte all’abside occidentale. Notevolissime sono le decorazioni a stucco. Le quattro colonne presentano i capitelli con i simboli del Tetramorfo, mentre nelle fronti cuspidate sono rappresentate la Crocifissione, la Visita delle Marie al sepolcro, l’Ascensione e la Traditio Legis et Clavis. All’interno del cupolino si trova invece un affresco con l’Agnello mistico contornato da diciotto figure nimbate, dieci uomini e otto donne. L’interpretazione non
MEDIOEVO
aprile
dei altri edifici tra cui un ospizio per accogliere i pellegrini. S. Calocero esisteva già almeno dal 1018, anno a cui risale la prima pergamena che lo cita. Di questi decenni conosciamo anche i nomi di alcuni abati, che compaiono in sporadiche pergamene: Dagilberto (nel 927), Andrea (1018), Adamo (1100), Arialdo (1102-17), Algiso (115362). Quest’ultimo, in particolare, è degno di nota perché è citato in un importantissimo diploma emesso dall’imperatore Federico di Hohenstaufen il 27 aprile 1162.
Tutto il potere all’abate
Impegnato nella lotta contro i Comuni capeggiati da Milano, il Barbarossa concedeva proprio all’abate Algiso di Civate – luogo che si confermava un cruciale baluardo imperiale in un’area strategica a ridosso delle Prealpi – vari privilegi e favori tra cui la giurisdizione sulla «Bruanza» (Brianza). Il fatto poi che il documento venisse prodotto nell’«imperialissima» Pavia non fu certo un caso. Ma nell’ottobre dello stesso anno l’arcivescovo di Milano reclamò per sé dal papa e ottenne, tramite bolla pontificia, l’autorità diretta sul monastero e il possesso dei suoi beni.
A destra il ciborio che sormonta l’altare di fronte all’abside orientale della basilica di S. Pietro, decorato con scene che rappresentano una sintesi della dottrina cristiana.
è facile, anche se appare probabile un collegamento simbolico al testo dell’Apocalisse (1+4+4 = i 144mila salvati?). Nella sua struttura architettonica, il ciborio ricorda da vicino l’analogo presente nella basilica di S. Ambrogio a Milano. Il piccolo oratorio di S. Benedetto, dotato di tre absidi, contiene tre affreschi sopra l’originario altare in muratura che rappresentano san Benedetto, sant’Andrea e il Cristo benedicente con la Madonna e San Giovanni Battista. Nell’oratorio sono stati trovati molti resti ossei, il che ha fatto propendere gli studiosi per un suo utilizzo prevalentemente funerario.
103
medioevo nascosto civate MONTE BARRO
Vivere al tempo dei Goti Sul versante sud-occidentale del Monte Barro, altura antistante quella del Monte Cornizzolo (e dunque il complesso di S. Pietro al Monte), a circa 900 m di quota, tra il 1986 e il 1997 sono stati portati alla luce i resti di un importante complesso abitativo civile e militare databile tra il V e il VI secolo. Gli scavi hanno permesso di identificare l’esistenza di tre costruzioni tra cui un vasto edificio (il cosiddetto «Grande Edificio») di circa 1600 mq. L’intera area era fortificata con una cinta muraria intervallata da tre torri di avvistamento. Sicuramente il centro era di grande importanza: lo dimostra la corona in lamina di bronzo, in origine appesa al soffitto del vano centrale dell’edificio, simbolo di sovranità. Il sito ha restituito anche varie tombe, una delle quali rinvenuta di fronte all’ingresso del palazzo principale a ridosso della soglia, chiaro indizio del rapporto con la morte tipico del mondo antico germanico, destinato ad avere grandi ripercussioni anche sulla nostra cultura. Dopo aver occupato una città, infatti, vi predisponevano subito un’area cimiteriale creando una commistione tra abitazioni e luoghi di sepoltura del tutto inedita nella città tardoantica di derivazione latina. Un’usanza destinata a permanere ben oltre il Medioevo – durante il quale si fece largo uso anche delle sepolture nelle chiese – fino alle riforme dell’età napoleonica. I ritrovamenti del Monte Barro hanno inoltre fornito indizi sul tenore di vita e soprattutto sul tipo di alimentazione dell’epoca gota. Lo studio delle ossa di animali restituite dagli scavi condotti nel sito ha infatti mostrato come i Goti allevassero suini, ovini, caprini, bovini e galline: animali di taglia piú piccola rispetto all’attuale, utilizzati prevalentemente per l’alimentazione e assai meno per il lavoro. Le genti gote del Monte Barro erano anche agricoltori – coltivavano frumento, segale, orzo e avena – e integravano la loro frugale dieta con le castagne raccolte nei boschi circostanti e consumate intere o macinate per ottenere farina da panificare. L’avamposto lecchese fu distrutto da un incendio sviluppatosi alla metà del VI secolo, con ogni probabilità proprio durante la guerra greco-gotica (535-553). Di lí a poco alle porte delle Alpi orientali si sarebbero affacciati i Longobardi.
In alto, sulle due pagine ricostruzione dell’abitato di Monte Barro, occupato dai Goti tra il V e il VI sec. Sulla destra è il Grande Edificio, costruzione di oltre 1600 mq, forse a funzione pubblica e residenziale del governatore del sito. A sinistra Monte Barro. Resti di strutture riferibili alla fase di frequentazione gotica del sito.
104
aprile
MEDIOEVO
Da questo momento in poi la storia del cenobio civatese è un lento declino fino all’inesorabile tramonto. Ancora, balzerà agli onori delle cronache per aver fornito rifugio all’arcivescovo Leone da Perego († 1257) nel concitato quadro delle lotte che lo opposero ai populares, che reclamavano la partecipazione al governo cittadino.
Gli anni del declino
Piú tardi un altro arcivescovo e addirittura signore di Milano, Giovanni Visconti (1290-1354), ne divenne abate. E forse proprio per la sua illustre presenza il cronista Galvano Fiamma, che era suo cappellano, trascrisse la citata leggenda delle origini del monastero. Il declino è ormai manifesto nel 1384, quando a S. Pietro ci sono solo due monaci. Nei secoli successivi le pro-
MEDIOEVO
aprile
prietà del monastero passarono di mano in mano, ora al vescovo di Como ora addirittura a quello di Cremona. Finché papa Gregorio XIV non stipulò una convenzione con i monaci olivetani perché si impegnassero a mantenere a Civate sei sacerdoti. La sorte del monastero era però ormai segnata. Nel 1798, con la soppressione degli ordini religiosi decretata da Napoleone, S. Calocero e l’oratorio di S. Benedetto furono venduti a privati, mentre la basilica di S. Pietro al Monte fu ceduta al municipio, che in seguito la donò alla parrocchia. Ma l’isolamento che ne segnò la fine permise anche, paradossalmente, la conservazione di uno dei cicli pittorici romanici piú belli in un luogo suggestivo e di indubbio fascino. Un tesoro inestimabile, che si può ammirare dopo una semplice camminata nei boschi. F
105
caleido scopio
Porta d’Italia
cartoline •
Nelle acque del Lago Maggiore si specchia un comprensorio ricco di storia: è l’Alto Verbano, il cui Medioevo è testimoniato da borghi e monumenti di notevole pregio. Mete forse meno note, ma che valgono davvero una visita
R
ecentemente insignita del titolo di città piú ecologica d’Italia, Verbania, distesa in una lingua di terra sulla Riviera piemontese del Lago Maggiore, il Verbanus Lacus dei Romani, è nata il 4 aprile del 1939 unendo i due insediamenti storici di Pallanza e Intra, e, dal 1992, è il capoluogo della provincia VerbanoCusio-Ossola. Compresa fino all’epoca napoleonica entro i confini dello Stato di Milano, quest’area geografica costituiva nel periodo medievale un accesso naturale all’Europa centro-settentrionale. Della sua importanza economica e politica erano ben consapevoli anche gli stessi duchi milanesi, che definivano il Verbano «una giave e porta de Italia» («una chiave e porta per l’Italia»), come scriveva nel 1475 Azzone Visconti. L’escursione proposta, nell’Alto Verbano, si snoda in parte lungo le rive del lago e in parte a mezza costa sui monti retrostanti, e conduce alla scoperta di pittoreschi villaggi rurali, nei quali suggestive chiesette medievali connotate da una sorprendente ricchezza
106
di pitture parietali, provano la decisiva continuità di rapporti con il contesto ambrosiano, non senza alcune varianti. Prima fra tutte l’assegnazione di prestigiosi lavori non solo su commissione di famiglie nobili come nel Milanese, ma anche di confraternite e intere collettività per le quali il problema della fede e della devozione comunitaria doveva essere primario.
Pittori itineranti Nel Verbano, privo di un centro di entità tale da sviluppare un’arte autoctona e una tecnica esecutiva originale, è assai probabile che per le imprese decorative la committenza si sia rivolta a pittori itineranti, aggiornati sulle novità elaborate nelle maggiori città limitrofe e capaci di assicurare opere del livello
qualitativo richiesto. In questa zona, nel primo Duecento, ai raffinati esempi di naturalismo stilizzato, sperimentato dai maestri in area lombarda, si affianca cosí un diverso filone artistico individuabile in un gruppo di frescanti rustici, che si potrebbe immaginare appartenenti tutti a una stessa bottega incaricata sin dal 1200 di grandi pitture murali nel Nord della Lombardia, in Canton Ticino e nel Novarese settentrionale. Negli anni Quaranta del Duecento un esponente di questo atelier – in grado di evolversi, dando origine a immagini piú articolate, con personaggi dalle fisionomie meno ripetitive e maggior attenzione ai particolari – è all’opera nell’abside principale dell’oratorio di S. Remigio a Pallanza. Nascosto nei magnifici giardini di Villa San Remigio, aprile
MEDIOEVO
l’elegante tempietto romanico venne eretto a pianta asimmetrica sul promontorio della Castagnola nei secoli XI-XII. A ornarlo nella fascia superiore del catino absidale con dodici monumentali Apostoli, dipinti in piedi attorno a Cristo seduto in trono, e nella fascia inferiore con vivaci figure che compongono il corteo dei Mesi, intenti nelle rispettive occupazioni, fu tra il 1240 e il 1250 un anonimo frescante lombardo. Artefice delle raffigurazioni nell’abside minore destra è invece il Maestro di Borgomanero, impegnato attorno al 1280-1290 nell’affrescare un grande clipeo con l’immagine a mezzo busto del Redentore benedicente e ai lati, in posizione inferiore, gli arcangeli Michele e Gabriele.
A destra Pallanza. La chiesetta romanica di S. Remigio. Nella pagina accanto il borgo di Carmine, situato in splendida posizione panoramica sul Lago Maggiore. In basso uno scorcio del centro storico di Verbania.
I ritratti dei Visconti Nel centro di Pallanza anche il Museo storico-artistico del Verbano e del Paesaggio, allestito nel settecentesco Palazzo Dugnani, nella pedonale via Ruga, vale la visita. Tra i pezzi esposti, di grande bellezza è il fregio riferibile alla migliore produzione della miniatura viscontea, realizzato negli ultimi anni del Quattrocento da un pittore milanese e staccato nel 1919 dalla loggia esterna del Castello di Invorio Inferiore, a ovest di Arona. Nel XV secolo il maniero era proprietà di quel ramo della famiglia Visconti che con Alberto, nel 1464, ebbe da Francesco Sforza il privilegio di aggiungere al proprio nome il titolo di marchese d’Aragona. Per sottolineare il forte legame che univa i castellani di Invorio ai duchi di Milano, i feudatari del Vergante fecero perciò effigiare a un autore lombardo, affine al Maestro delle Vitae Imperatorum, prestigioso miniatore attivo in Italia settentrionale nella prima metà del Quattrocento, i volti dei membri delle famiglie Visconti e Sforza, da Gian Galeazzo Visconti a Ludovico il Moro, inseriti entro tondi attorniati da un raffinato decoro di tralci vegetali, sirene e arpie. L’affresco con l’omaggio amoroso di
MEDIOEVO
aprile
una coppia accompagnato da scritte in francese, riferibili a un dialogo tra amanti, ora conservato al Museo del Paesaggio, offre un altro esempio della diffusione della cultura profana milanese nel Verbano attraverso le grandi famiglie feudali. Considerato tra gli episodi cortesi piú significativi del Nord Italia, il riquadro si trovava a Pallanza, nel palazzo dei nobili Morigia, ed era inglobato in una piú ampia serie di scene a fresco, databile a ridosso del 1441, quando quest’ultimi divennero feudatari viscontei.
Citazioni leonardesche Dal 1929 le sale di Palazzo Dugnani ospitano anche alcuni brani di un complesso iconografico dedicato a San Rocco. Provenienti da un piccolo edificio religioso quattrocentesco, innalzato nei pressi della chiesa della
Madonna di Campagna a Pallanza e demolito nel 1879 per ingrandire la carrozzabile tra la periferia cittadina e il nucleo storico, i lacerti sono tra i piú importanti documenti figurativi della cultura rinascimentale milanese sopravvissuti ai confini settentrionali dell’antico ducato. Le rappresentazioni, istoriate nel primo decennio del Cinquecento dal Maestro di San Rocco, mettono in luce la pronta assimilazione di citazioni leonardesche e l’aggiornamento sulle esperienze prospettiche bramantesche del decoratore, nato forse in città e poi sospinto in questa terra. Circondata dal verde di alberi secolari, la chiesa della Madonna di Campagna è la nostra prossima tappa. Fabbricata a partire dal 1511 su moduli ispirati alle architetture del Bramante al posto di uno
107
caleido scopio Pallanza. La chiesa della Madonna di Campagna. In basso affresco con scena di corteggiamento. Maestro di Casa Morigia, metà del XV sec. Verbania, Museo del Paesaggio.
Dove e quando
IAT di Verbania Pallanza, corso Zanitello, 6 tel. 0323 503249 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI Stresa, via Principe Tomaso 70/72 tel. 0323 30416 www.distrettolaghi.it scomparso luogo di culto romanico, la costruzione ha conservato all’esterno il millenario campanile, ingentilito da monofore e bifore, e all’interno manufatti di Bernardino Lanino (1512-1583 ) e di Camillo Procaccini (1560 circa-1629). Come Pallanza, anche Intra possiede un prezioso scrigno d’arte: l’oratorio romanico di S. Ambrogio Vecchio ad Antoliva. Scandite da strettissime monofore, le alte superfici in pietra dell’unica aula hanno dato a vari frescanti, scalati nell’arco di non pochi secoli e accomunati dal livello qualitativo sostenuto, l’opportunità
108
di stratificare un arredo decorativo in passato molto ricco e vario, che attesta il rilievo del sito. Oltre al ciclo tardo-gotico e agli affreschi cinquecenteschi sull’arco trionfale e sull’emicalotta absidale, nelle pareti si possono ancora riconoscere le tracce di almeno tre differenti interventi. A giudicare dai frammenti superstiti, sul lato di destra si trovava una grande Natività, attribuibile al Maestro di Oropa, su quello di sinistra una Crocifissione insieme a un’effigie di sant’Ambrogio, possibile opera del Maestro di Sant’Abbondio.
Coredentrice e protettrice Lasciato il capoluogo di provincia, la nostra caccia ai tesori nascosti dell’Alto Verbano prosegue sui colli, nel paesino da presepe di Cadessino, una frazione del Comune di Oggebbio, ove si erge l’oratorio medievale della Natività di Maria, monumento nazionale. Qui il pittore e «presbiter» Battista della Valsesia sul finire del Quattrocento aprile
MEDIOEVO
ha dipinto una bellissima Madonna della Misericordia. Raffigurata con le fattezze di Madonna-madre, nell’atto di allargare il suo mantello per proteggere ogni essere umano, la Vergine rimanda nell’iconografia al ruolo di coredentrice e protettrice. Quasi si trattasse di una catechesi per la spiegazione dei dogmi cristiani, vicino si osserva una Madonna in trono col Bambino, angeli e un santo, vivacissima nel cromatismo, imbellettata al pari di un’icona e affiancata a un santo cavaliere. La medesima mano ha molto probabilmente arricchito lo spazio sovrastante le illustrazioni delle Opere di Misericordia con un’Ultima Cena.
Nella villa dei Ricordi Ripresa la statale, costeggiando le rive del lago accompagnati da una lussureggiante vegetazione, ricca di cedri, limoni, ulivi, arance, palme, azalee, rododendri e camelie, oltrepassiamo l’ottocentesca villa dove Massimo d’Azeglio scrisse I miei ricordi. Nell’ammirare il paesaggio catturano la nostra attenzione le surreali rovine dei cosiddetti castelli di Cànnero, posti su due isolotti rocciosi vicino alla sponda. Sono i resti della Rocca Vitaliana, costruita negli anni 1519-1521 per volere di Ludovico Borromeo sui ruderi del castello Malpaga (XII-XIV secolo), rifugio dei potenti e crudeli fratelli Mazzarditi, che, preso il borgo di Cannobio tra il 1403 e il 1404, diedero inizio a scorrerie e violenze ai danni delle genti rivierasche. Allo sbocco della valle Cannobina, sull’attuale confine con la Svizzera, si è sviluppato l’abitato di Cannobio, località finale del percorso. Nel grazioso centro storico conserva la slanciata torre del Comune, elevata in pietra viva nella prima metà del XII secolo, e il Parrasio, com’è denominato il Palazzo della Ragione, eretto in blocchi squadrati di granito nel 1291-1294 su ordine del podestà Ugolino Mandello e rimaneggiato nel corso del Seicento. In fondo al lungolago si trova invece il santuario della Pietà,
MEDIOEVO
aprile
Un formaggio... d’epoca L’Alto Verbano con le sue ville e i suoi alberghi, immersi in giardini e parchi storici celebri per le fioriture e il ricco patrimonio botanico, sin dal Settecento è una frequentata meta di villeggiatura estiva. Nata dalla felice interazione fra pescatori e valligiani la gastronomia locale, perciò, risente notevolmente della tradizione al servizio del turismo internazionale. Capace di coniugare con estrema versatilità i prodotti del lago, quelli della vicina pianura e quelli della montagna alle spalle, accanto al risotto con i filetti di pesce persico, con lo storione, con il ragú di pesce di lago propone i gusti forti, decisi, dei monti: selvaggina, funghi e formaggi d’alpe. Come l’aromatico Bettelmatt, proveniente dalla Valle Antigorio-Formazza e confezionato con latte munto due volte al giorno da vacche al pascolo negli alpeggi ai piedi del ghiaccio dell’Arbolà. Già apprezzato nel Duecento, durante la colonizzazione walser della fascia subalpina, questo formaggio d’eccellenza allora era merce di scambio per il pagamento di canoni d’affitto, concessioni d’alpeggio o tasse, da ciò l’origine tedesca del nome, ottenuto unendo i termini battel= questua e matt= pascolo, ossia «pascolo della questua». con all’interno la Salita al Calvario, pregevole pala cinquecentesca di Gaudenzio Ferrari. Sulla strada per Cannobio incontriamo la borgata di Carmine, disposta su due livelli: Carmine Inferiore, fulcro dell’agglomerato rurale, e Carmine Superiore, un meraviglioso balcone sul Lago Maggiore disperso fra boschi e terrazzamenti per la coltivazione di vite, segale e biade.
Un luogo senza tempo Densamente popolata sino al XX secolo e poi progressivamente abbandonata, nel Medioevo Carmine Superiore era ubicata lungo un’importante via di comunicazione. Adesso si raggiunge solo a piedi, percorrendo la vecchia mulattiera scavata nella rupe del Sasso del Carmine, e grazie al restauro di numerose abitazioni sta tornando a nuova vita. Giunti sin quassú, il tempo pare essersi fermato. Ovunque regnano pace, silenzi e panorami mozzafiato. Perdersi nel dedalo delle stradine
acciottolate, che insieme alle robuste mura delle case offrivano un eccellente sistema difensivo contro possibili aggressori, per poi sbucare sul sagrato della rustica chiesa di S. Gottardo, può essere una piacevole sorpresa. Sormontato da un elegante campanile tardo-gotico il centro cultuale, reso prezioso dalla notevole veste decorativa, fu innalzato tra il 1332 e il 1401, quindi ampliato nel 1431. Recentemente restaurati, gli affreschi del XIV secolo vengono attribuiti al Maestro di Corzoneso, attivo durante la prima metà del Trecento nel territorio del lago Maggiore e nelle attigue vallate prealpine. A fianco i cicli dedicati alle Storie di San Gottardo e alle Storie di San Bartolomeo, realizzati da anonimi pittori lombardi vissuti nel Quattrocento, con un linguaggio folto di nessi realistici e narrativi ci raccontano ancor oggi i profondi legami intercorsi tra le maestranze operose nell’Alto Verbano e la cultura tardo-gotica di matrice milanese. Chiara Parente
109
caleido scopio
Un profilo a tutto tondo
libri • La vivacità economica e politica dell’Arezzo
duecentesca emerge con forza da una ricostruzione storica rigorosa ed esemplare
S
correndo le pagine del volume, colpisce, fin dall’inzio, la capacità dell’autore di coniugare la storia politico-istituzionale con quella economica, demografica, paesaggistica, delle istituzioni ecclesiastiche, del diritto e della cultura, cioè di tutti quegli ambiti che, fin dal Duecento, costituivano la peculiarità della città di san Donato, offrendo cosí un quadro completo e articolato della società aretina del XIII secolo, basato su una straordinaria quantità di fonti archivistiche (di cui ampie tavole riassuntive vengono riportate in appendice). La fatica ultradecennale di Scharf si apre con un’introduzione storiografica relativa alla visione di Comune e Signoria, ovvero di città e contado, negli studi piú recenti, seguita da una panoramica delle fonti aretine pervenuteci. L’autore sottolinea, in particolare, l’esigenza di liberarsi dalle generalizzazioni, e di considerare in primo luogo la peculiarità di ogni realtà urbana, sia nell’indagare l’origine del Comune e dei suoi ceti dirigenti, sia nell’analisi del rapporto
110
tra nobiltà e «popolo», e tra città e contado, postulando la necessità di evitare modellizzazioni che possono portare a una visione distorta della realtà. Un quadro piú sfumato, anziché una netta contrapposizione tra città e contado, e lo studio delle reti di relazione che univano uno spazio comunale composito e articolato potranno rappresentare allora i metodi di indagine piú adatti a far emergere i singoli contesti nella loro poliedricità.
Convergenze e identità E questo, appunto, costituisce il metodo di indagine su cui si articola la ricostruzione della società aretina duecentesca, di cui il potere e i suoi meccanismi di creazione e di esercizio, tanto in ambito laico, che ecclesiastico, costituiscono la chiave interpretativa privilegiata. Infatti, l’analisi dei meccanismi di esercizio del potere nelle sue principali forme consente di appurare convergenze e identità fra i suoi detentori: da qui la necessità di esaminare il percorso di occupazione dello spazio urbano, le risorse economiche, le
Arezzo. La Piazza Grande (o Piazza Vasari), cuore della città toscana, le cui vicende nel corso del XIII sec. sono al centro del recente volume di Gian Paolo G. Scharf.
forme di cultura, per poi concentrare l’attenzione sui protagonisti dello spazio cittadino, fra i quali gli enti ecclesiastici rivestivano un ruolo primario, per appurare infine l’azione nel contado degli stessi soggetti. Solo allargando il discorso dalle istituzioni ai centri del potere e ai suoi modi di esercizio, si fa concreta la possibilità di fornire un’immagine di Arezzo piú vicina alla realtà. E per questo è appunto necessario soffermarsi sui quadri materiali della vita cittadina, sul potere economico e su coloro che lo esercitavano, e anche sul potere culturale: nella città esisteva infatti già nel Duecento uno Studium importante, rivolto prevalentemente all’insegnamento del diritto, il cui probabile nesso con le istituzioni – i vescovi erano infatti vere figure di riferimento, tanto politico che culturale – rappresenta un fecondo settore di indagine. La prima parte del volume è dedicata dunque alla città, nelle sue diverse articolazioni tematiche («il quadro urbano», «il Comune», «gli enti ecclesiastici cittadini»), e la seconda al contado («il quadro territoriale», «il controllo comunale e la presenza pubblica», «la presenza ecclesiastica», «la Signoria», «il controllo dell’attività molitoria»). aprile
MEDIOEVO
All’interno di questa struttura generale, Scharf spazia su tematiche particolari. Per la città esamina la topografia, la demografia, i ruoli sociali nel loro collegamento col paesaggio urbano tramite le strutture materiali (come le torri) che ne esaltavano l’immagine, con la conseguente esigenza di una regolamentazione urbanistica adeguata; le attività economiche, il diritto e la cultura, per approfondire poi le vicende politico-istituzionali del Comune aretino e dei suoi protagonisti, tra i quali occupavano un ruolo di tutto rilievo gli enti ecclesiastici cittadini (specialmente i Camaldolesi ) e soprattutto i vescovi, in primo luogo alla metà del Duecento Guglielmino degli Ubertini (1248-1289), il cui modello di potere si basava in ugual misura sulla signoria in ambito urbano e su quella nel territorio circostante.
Il potere dei vescovi Contado e città erano collegati proprio attraverso gli enti ecclesiastici e soprattutto attraverso la figura del vescovo: nel presule si fondevano appunto il contesto urbano e quello rurale, Comune e ambizioni signorili, mire espansionistiche sul territorio e sui centri circostanti, rapporti con Firenze e con Siena, politica ambigua delle alleanze con guelfi o ghibellini. In nessun luogo come ad Arezzo e nel suo territorio, la presenza ecclesiastica impregnò cosí totalmente la vita stessa del comune cittadino: per tutto il XIII secolo, infatti, nonostante il ridimensionamento del loro ruolo pubblico, i vescovi aretini (e Guglielmino degli Ubertini soprattutto, prefigurando la signoria vescovile di Guido Tarlati, negli anni Venti del Trecento) operarono una tenace difesa delle proprie prerogative di natura pubblica, perseguendo una costante politica di rivendicazioni e di intromissione nella vita politica della città e del suo contado. Anche se nel XIII secolo la dignità comitale era ormai venuta meno, i vescovi aretini mantennero
MEDIOEVO
aprile
il controllo su un insieme di prerogative signorili di notevole rilievo (diritto di battere moneta, pesatura delle merci, pedaggi vari, diritto di nomina dei notai), in città e nel territorio. La valenza politica del presule si esplicava poi anche nei confronti dell’espansione del Comune sul contado. Il vescovo Guglielmino fu anche il principale protagonista del fervore edilizio aretino duecentesco: per sua volontà venne iniziata, nel 1278, la cattedrale nuova, posta in uno dei punti cardine dello spazio urbano, e che sostituiva la precedente, situata invece fuori della cinta muraria, venendo cosí a costituire, anche dal punto di vista simbolico, un importante fattore di immagine, che esaltava la centralità della Chiesa aretina. E ancora Guglielmino volle la costruzione del palazzo vescovile. Uno dei molti aspetti approfonditi nel volume è il contesto economico aretino, sul quale le notizie e gli studi, soprattutto per il Duecento, sono alquanto scarsi; una carenza
Gian Paolo G. Scharf Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1214-1312) Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 676 pp. 65,00 euro ISBN 978-88-6809-028-9 cisam.org
su cui pesa ancora la tesi di Federigo Melis (1914-1973) che vedeva nella Toscana, già nel XIII secolo, un sistema economico integrato con una marcata egemonia di Firenze, cui faceva da unico contraltare Pisa, in quanto sbocco al mare obbligato. Si trattava di un’economia prevalentemente agricola che conobbe uno sviluppo minore che a Firenze, Pisa e Siena, ma reale.
Commerci e prestiti Il settore tessile, il commercio del denaro e la coltivazione del guado furono gli ambiti piú rappresentativi delle attività aretine duecentesche. Il commercio del denaro non si effettuava tramite grandi banchi di dimensioni paragonabili a quelli senesi, ma era praticato a tutti i livelli sociali, con prestiti prevalentemente al consumo, anche se non mancavano i banchieri di professione. Altro elemento di rilievo è quello dei notevoli contatti con Genova, dove gli Aretini erano impegnati nella vendita del guado, nella tintura, e nello smercio di panni «lombardi» (probabilmente panni aretini a imitazione di quelli milanesi). Anche nell’ambito della cultura Arezzo seppe distinguersi: il suo Studium, esistente da una data anteriore al 1215, non fu semplicemente il frutto del trasferimento di un gruppo di studenti bolognesi, ma rappresentò il prodotto di un fertile ambiente già esistente, che vedeva nella figura del vescovo il suo punto di riferimento. La sua esistenza ebbe ripercussioni tanto dal punto di vista economico, che da quello politico: i professori di diritto aretini furono infatti i principali consulenti del Comune in questioni dalle delicate implicazioni politiche, e con le loro sentenze, in genere a lei favorevoli, la città si affermava come centro di produzione della giurisprudenza. Altro effetto sull’organismo comunale: i giuristi dello Studium poterono influenzare in vari modi le redazioni statutarie duecentesche. Maria Paola Zanoboni
111
caleido scopio
Un dilettante virtuoso musica • Ricordato soprattutto per la sua
produzione profana, Pomponio Nenna fu un protagonista della scena musicale partenopea cinquecentesca. Che, come dimostra una recente incisione, non mancò di cimentarsi con successo anche in componimenti liturgici
B
arese di nascita e vissuto a Napoli negli ultimi anni del Cinquecento, Pomponio Nenna, pur appartenendo a pieno titolo alla categoria dei nobili dilettanti – non ebbe mai alcuna carica ufficiale come compositore o maestro di cappella – è stata una delle personalità musicali dell’ambiente partenopeo che meglio hanno saputo sviluppare, insieme a Carlo Gesualdo da Venosa, il linguaggio madrigalistico cinquecentesco. A fronte di una vasta produzione profana, Nenna ci ha lasciato una sola antologia sacra, datata al 1607 e ripubblicata a Venezia con l’aggiunta del basso continuo nel 1622: i Responsorii di Natale, e di Settimana Santa. A essi è dedicata l’antologia Pomponio Nenna. Responsoria (DCTT 09, 1 CD, www.digressionemusic.it) con una scelta incentrata sugli otto responsori da cantarsi nell’ufficio liturgico del mattutino che si celebra durante la festività del Natale, a cui si aggiungono un Te Deum e un Benedictus Dominus.
Uno stile sobrio e fluido Rispetto alle composizioni profane, in cui la «pittura» musicale crea immagini sonore di grande suggestività, l’impatto emotivo evocato dai responsori appare piú attenuato; lo stile, che fonde contrappunto puro a passaggi piú squisitamente omofonici, si fa infatti piú sobrio, senza lanciarsi nelle arditezze armoniche dei suoi madrigali, mantenendo comunque una fluidità melodica rimarchevole
112
nelle varie voci. Interpreta questi responsori l’ensemble vocale Palazzo Incantato, diretto da Sergio Lella; un gruppo amatoriale dedito principalmente al repertorio antico che, dalla sua fondazione nel 1991, si è dedicato con particolare attenzione al repertorio del Sud d’Italia. In questa incisione si presenta con un
organico di 13 voci miste che raggiungono, spesso, una buona fusione sonora. Franco Bruni
Musiche per versi celebri
musica • L’Hilliard Ensemble firma, con successo,
un interessante esperimento di contaminazione tra la musica e la grande poesia trecentesca
È
una narrazione piuttosto singolare quella proposta dal noto quartetto vocale inglese The Hilliard Ensemble che, nel riprendere brani composti su testi petrarcheschi e danteschi, si cimenta in un itinerario musicale nel quale il linguaggio polifonico del primo Cinquecento si raffronta con la polifonia contemporanea di Roger Marsh. L’insolito percorso proposto nell’antologia Il Cor Tristo (ECM 4810637, 1 CD, www.ecmrecords.com) ci propone dunque sei madrigali di Bernardo Pisano (1490-1548) e altri tre di Jacques Arcadelt (1507-1568) su testi tratti dal Canzoniere di Petrarca, toccando celeberrimi poemi come Chiare, fresche et dolci acque, ovvero Solo e pensoso e Tutto ‘dì piango messi in musica da Arcadelt. Decisamente triste e melanconico il tenore di questi splendidi brani che danno la cifra della grande stagione madrigalistica cinquecentesca. Alle pacate sonorità del linguaggio madrigalistico, si intercala la
aprile
MEDIOEVO
La voce degli ultimi musica • Dall’Inghilterra e dal
Portogallo del XVI secolo giungono brani, davvero intensi e struggenti, che raccolgono le grida di dolore degli oppressi
C
on Libera Nos. The Cry of the Oppressed (SIGCD338, 1 CD, www.signumrecords.com) il gruppo Contrapunctus diretto da Owen Rees dà voce al canto disperato degli oppressi, con brani cinquecenteschi della tradizione inglese e portoghese.
L’antologia si apre con William Byrd, compositore elisabettiano di cui si ascoltano 5 mottetti che danno voce alle speranze dei cattolici durante l’oppressione protestante di Elisabetta I e Giacomo I, per proporre poi Philippe de Monte
contemporaneità delle tre parti che costituiscono il ciclo Il Cor Tristo di Roger Marsh (2008), per quartetto vocale su testi tratti dall’Inferno di Dante. Uno stile, quello di Marsh, che riprende prevalentemente l’antica tecnica del falso bordone, caratterizzata da un movimento parallelo delle quattro linee vocali, favorendo con ciò la comprensione testuale attraverso una declamazione efficace e diretta a enfatizzare la narrazione. Allo schema del falso bordone, si alternano anche momenti solistici dando voce, in prima persona, al personaggio del conte Ugolino, protagonista del XXXIII canto dell’Inferno. Il passaggio dal linguaggio polifonico cinquecentesco allo stile prevalentemente accordale di Marsh si rivela, in realtà, senza soluzione di continuità, grazie a una interpretazione vocale in cui le quattro voci maschili di David James, Rogers Covey-Crump, Steven Harrold e Gordon Jones, grandi specialisti di polifonia antica, ma aperti al mondo musicale contemporaneo, creano una tale fusione sonora e un effetto di pastosità vocale che avvolge incredibilmente questi stili lontani tra loro, ma accomunati, evidentemente, dalla particolare cura prestata al contesto poetico. F. B.
MEDIOEVO
aprile
(1521-1603) con un suggestivo Super flumina Babylonis, dedicato all’esilio babilonese, e le musiche del grande Thomas Tallis (1505-1585), di cui ascoltiamo, tra l’altro, il brano Libera nos, pervenutoci senza alcun testo, se non la presenza del titolo, Libera, che ne ha permesso la ricostruzione vocale, qui proposta per la prima volta. Meno nota la figura di Martin Peeson (1571/3-1651) di cui ascoltiamo il mottetto Laboravi in gemitu meo, di struggente bellezza.
Momenti di dolente drammaticità Anche nel repertorio portoghese non mancano momenti di dolente drammaticità come quelli offerti da Pedro de Cristo (1550-1618) con Lachrimans e Inter vestibulum, e Manuel Cardoso (1566-1650) con Sitivit anima mea. Benché si tratti per la maggior parte di musicisti attivi tra la seconda metà del XVI secolo e i primi decenni del successivo, il linguaggio contrappuntistico erede della tradizione fiamminga quattro-cinquecentesca accomuna questi compositori che, con grande maestria, piegano le ferree regole della polifonia a una espressività in simbiosi col contesto poetico. L’ensemble inglese Contrapunctus, di recente formazione, non fa che confermare quanto gli anglosassoni siano tra i maggiori interpreti della tradizione corale antica. F. B.
113