
30 minute read
LAVORO
from Il Mondo del Consulente n. 113 del 2020
by Ordine Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma
LE 18 SETTIMANE DI INTEGRAZIONI SALARIALI COVID-19
ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI DELL’INPS
Advertisement
DI EUFRANIO MASSI EspERto In DIRItto DEL LAvoRo
Lungamente attesa dagli operatori è, finalmente, uscita la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 con la quale l’INPS ha dettato le proprie indicazioni amministrative sulle integrazioni salariali COVID-19 per le 18 settimane previste dal D.L. n. 104/2020 e, il giorno immediatamente successivo, con il messaggio n. 3525, ha fornito i chiarimenti per fruire delle seconde 9 settimane ove, a determinate condizioni, per alcuni datori di lavoro scatta l’obbligo del pagamento di un contributo addizionale. Va, da subito, ricordato come anche tali periodi, secondo un indirizzo già presente nei precedenti decreti di urgenza, non rientrino nel calcolo del quinquennio e del biennio mobile (30 mesi per i settori edili e lapidei) e non siano sottoposti al vincolo del limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui parla il comma 5 dell’art. 12 del D.L.vo n.
148/2015 e come non sia richiesto il requisito dell’anzianità di almeno 90 giorni nella unità produttiva. La circolare dell’Istituto, a differenza di alcuni indirizzi precedenti, appare chiara ed operativa anche se alcuni dubbi operativi restano e, probabilmente sono destinati ad essere sciolti in un secondo momento. La ritardata emanazione (a meno di due ore dalla scadenza del termine del 30 settembre), rischia di essere particolarmente irritante per le imprese ed i professionisti e di non sortire gli effetti sperati sul piano della comunicazione e di un rapporto corretto con l’utenza. Fatta questa breve premessa credo che sia opportuno entrare, subito, nel merito dei chiarimenti amministrativi che sono stati, in un certo senso, concordati con l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro. La prima novità da mettere in evidenza riguarda i lavoratori destinatari degli ammortizzatori COVID-19: se prima il 25 marzo era il giorno in cui dovevano essere alle dipendenze del datore di lavoro, ora, l’ultimo giorno di riferimento è il 13 luglio, in quanto il giorno precedente risulta fungere da “spartiacque” tra le nuove e le vecchie integrazioni salariali. Chi fosse stato assunto successivamente resta fuori mentre per i lavoratori che, a seguito di cambio di appalto verificatosi dopo tale giorno, siano stati assunti dal nuovo imprenditore, va verificata l’anzianità aziendale nell’appalto, con la conseguenza che rientrano “sotto l’ombrello applicativo” se la loro originaria assunzione presso la precedente impresa risulta essere antecedente al 14 luglio. Ora è l’INPS che gestisce, completamente, le nuove misure di sostegno al reddito (CIGO, assegno ordinario del FIS, Cassa in deroga): tale concetto è espresso, a chiare note, in più punti e le 18 settimane complessive da “godere” a partire dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 sono suddivise in due “tranche” di 9 settimane che possono presentare, in alcuni casi, trattamenti diversi.
La “rottura” con il passato si evince anche da altri aspetti non secondari: a) La nuova previsione consente l’accesso alle integrazioni salariali anche ai datori di lavoro che non ne hanno, in passato, usufruito ai sensi dei D.L. n. 9, n. 18 e n. 34;
b)
Non c’è più il principio

dell’”autorizzato e del fruito”: vale soltanto la regola dell’”autorizzato”, sicchè i datori di lavoro dovranno valutare le esigenze effettivamente necessarie, magari producendo più istanze nell’arco delle prime 9 settimane e di quelle 9 successive: tale concetto è espresso, chiaramente, nella circolare n. 115 laddove si dà atto che il precedente indirizzo che legava il ricorso agli ammortizzatori alla effettiva fruizione degli stessi non c’è più ed è sostituito dal concetto che prevede l’utilizzo delle settimane nei limiti dei periodi autorizzati, senza tener conto del “goduto”. Si tratta di una novità che appare penalizzante, in quanto il riferimento al “fruito” era stato ben presente nelle integrazioni salariali precedenti e non era altro che l’applicazione di quanto, da tempo, in uso per gli ammortizzatori “normali” (v. circolare INPS n. 58/2009);
c) Il conto delle settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 viene azzerato e dal 13 luglio inizia quello relativo alle prime 9 settimane anche se il periodo è stato richiesto dalle aziende sulla base delle previsioni contenute nei D.L. n. 18 e n. 34. Ciò appare penalizzante nei confronti di quei datori di lavoro che, hanno richiesto interventi salariali sulla base delle settimane a disposizione per effetto delle disposizioni precedenti e che, ora, vengono “inglobate” nelle nuove 18 settimane;
d) Le domande che ancora debbono essere oggetto di autorizzazione e che riguardano periodi “a cavallo” del 13 luglio, sono valutate dall’Istituto secondo le regole precedenti fino al 12 luglio e con le nuove regole per il periodo successivo;
e) Una volta richieste ed autorizzate le prime 9 settimane, i datori di lavoro potranno proporre la domanda per la fruizione delle ulteriori 9, seguendo specificatamente le indicazioni del messaggio n. 3525 del 1° ottobre: ciò potrà avvenire, se il periodo si è svolto, senza soluzione di continuità, a partire dal 13 luglio, il giorno 14 settembre;
f) Per i datori di lavoro che, avendo terminato i periodi COVID previsti dalle precedenti disposizioni e che, avendone i requisiti, hanno richiesto trattamenti di integrazione ordinaria ex D.L.vo n. 148/2015 relativamente ai periodi che ricadono nella tutela prevista dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020, le settimane non autorizzate e quelle già autorizzate, per le quali non siano già stati emessi dall’INPS gli ordini di pagamento, o per le quali non sia stato esposto su Uniemens il codice evento, possono essere convertite nella causale “COVID-19 nazionale”: per far ciò occorre presentare una specifica richiesta, indicando, nel cassetto bidirezionale, gli estremi della prima domanda ed i periodi settimanali per i quali si chiede la conversione. Leggermente diversa è la via per convertire le domande di assegno ordinario FIS o dei Fondi di

Solidarietà. L’azienda dovrà proporre due domande: la prima di annullamento della precedente e la seconda di richiesta con causale “COVID-19 nazionale”. Per il FIS si potrà utilizzare il cassetto bidirezionale, con gli estremi della istanza originaria e delle settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà (ad esempio, quello degli artigiani) ove l’autorizzazione avviene con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la variazione va richiesta con PEC alla direzione degli ammortizzatori sociali dell’INPS;
g) Il TFR per i periodi di integrazione salariale resta a carico dei datori di lavoro: per quelli soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria scatta l’obbligo di versare allo stesso le quote di TFR maturate durante tali periodi. In questo caso l’INPS sembra aver fatto riferimento al comma 3 dell’art. 2120 c.c..
La circolare n. 115 ricorda che nulla è cambiato per quel che riguarda l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali da effettuare, anche in via telematica, entro 3 giorni, mentre per la Cassa in deroga viene richiesto l’accordo per quei datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti. Ricordo come, soltanto alcuni mesi fa, con la circolare n. 47, l’Istituto avesse ritenuto agibile la richiesta di Cassa in deroga anche con un verbale di mancato accordo. Per quel che riguarda l’invio delle istanze di integrazione salariale vale sempre il principio per il quale

il termine ultimo resta fissato alla fine del mese successivo rispetto a quello nel quale è iniziata la sospensione o la riduzione di orario. Su questo punto, però, l’Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro, aveva prospettato la possibilità di uno spostamento della data del 30 agosto al 31 ottobre, cosa che è avvenuta, non in sede di conversione del D.L. n. 104, ma con il D.L. n. 125: tale termine vale anche per l’invio dei dati utili al pagamento delle prestazioni (modello Sr41 semplificato). A partire del 1° ottobre, essendo venuto meno il PIN INPS, le credenziali di accesso sono lo SPID di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Con il successivo punto n. 2 la circolare n. 115 e, soprattutto, il mes-
saggio n. 3525 affronta le questioni relative alla richiesta delle ulteriori 9 settimane che, come detto in precedenza, presenta alcune particolarità, legate, per alcuni, ad un costo, sotto forma di contributo addizionale. La presentazione dell’istanza è possibile nel rispetto di due condizioni preliminari: a) Autorizzazione completa di tutto il precedente periodo;
b) Decorso completo del periodo autorizzato. Il periodo si considera fruito a prescindere dalla effettiva utilizzazione.
La causale di riferimento è “COVID-19 con fatturato” e riguarda le richieste per CIGO, assegno ordinario del FIS e Cassa in deroga (ma anche quelle dirette ai Fondi ex artt. 26 e 40 del D.L.vo n. 148/2015): tutte le istanze che, necessariamente, riguarderanno, periodi successivi al 14 settembre, dovranno essere accompagnate da una autocertificazione ex DPR n. 445/2000 con la quale i datori di lavoro forniranno l’esito della comparazione tra il fatturato aziendale relativo al primo semestre 2020 e quello del 2019. Questo perché la norma stabilisce, in alcuni casi, un contributo addizionale che: a) E’ pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o la riduzione di orario, se nella comparazione il fatturato si è ridotto meno del 20%;
b) E’ pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di sospensione o di integrazione salariale, per le aziende che non hanno subito cali di fatturato.
Non è, invece, dovuto alcun contributo addizionale se la riduzione del fatturato, nel periodo sopra considerato, è pari o superiore al 20%. La stessa cosa vale per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 (vale la data di comunicazione dell’attività inviata alla Camera di Commercio e non quella di apertura della matricola aziendale) le quali non debbono versare alcun contributo addizionale. In base a quanto autocertificato l’Istituto individua l’aliquota del contributo addizionale che va versato a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. La mancanza dell’autocertificazione facoltizza l’Istituto ad applicare l’aliquota massima, ferme restando le necessarie verifiche su quanto dichiarato, che saranno effettuate sia dall’Istituto che dall’Agenzia delle Entrate sulla base di dati ed elementi di valutazione che potranno scambiarsi. Per le domande, le imprese potranno utilizzare gli stessi applicativi in uso per le istanze delle prime 9 settimane, scegliendo la causale “COVID-19 con fatturato”. Una brevissima considerazione appare necessaria: le aziende che si troveranno nella necessità di dover fruire, anche parzialmente, delle seconde 9 settimane e che non hanno subito cali di fatturato o lo hanno subito in misura inferiore al 20%, dovranno ben valutare il ricorso all’ammortizzatore in quanto il contributo addizionale costa e, costa caro, in quanto l’aliquota appare, per certi versi, superiore, a quelle previste, in via ordinaria, dal D.L.vo n. 148/2015 per la CIGO, per la CIGS e per il FIS. La circolare n. 115 ricorda come le imprese, ricorrendone le condizioni (ovviamente, per periodi diversi) possano ricorrere alla CIGO ordinaria ma in questo caso, trovano applicazione “in toto” tutte le disposizioni normative inserite nel D.L. n. 148/2015 e quelle amministrative che l’Istituto ha, negli anni, regolamentato. Per completezza di informazione ricordo che la circolare n. 115 afferma che il contributo addizionale, ove ne ricorrano le condizioni, sarà dovuto anche per i trattamenti erogati dai Fondi ex art. 26 e 40 del D.L.vo n. 148/2015.
Prima di passare alla trattazione di altre questioni credo sia opportuno focalizzare l’attenzione su alcune “voci” fondamentali richiamate dalla disposizione. La prima riguarda il fatturato da prendere a riferimento che ha significati diversi sotto l’aspetto civilistico e sotto quello fiscale. La circolare n. 115 cita, in maniera generica, “gli indici di calcolo e le modalità di raf-
fronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate”. Nel corso della crisi pandemica quest’ultima ha fornito alcune indicazioni nelle circolari n. 9/E del 13 aprile e n. 15/E del 14 giugno ove si è detto che ai fini della determinazione del fatturato occorre riferirsi alle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche dell’IVA nei periodi oggetto di raffronto. Ovviamente, per chi non ha obbligo di fatturazione, occorre riferirsi all’ammontare dei ricavi sulla scora della previsione contenuta nella circolare n. 8/E del 3 aprile. Si attendono, in ogni caso, dall’INPS indicazioni più chiare ed esaustive. La seconda “voce” riguarda l’inizio dell’attività per quelle aziende che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019. La circolare parla di data di inizio desunta dalla comunicazione alla Camera di Commercio ma, allora, il contributo addizionale non si applica ai datori di lavoro che non sono imprenditori? Le disposizioni del D.L. n. 104 al comma 2 dell’art. 1 si riferiscono a “tutti i datori di lavoro” ma per il contributo aziendale ci si riferisce al fatturato aziendale e la circolare n. 115 sembra sempre riferirsi alle imprese. Tutto ciò va, sollecitamente, chiarito.
Il ricorso agli ammortizzatori COVID-19 previsti dal D.L. n. 104/2020 è possibile anche per i datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di CIGS o di assegno di solidarietà FIS. Il percorso non è nuovo in quanto già con il D.L. n. 18 era stato previsto e la nota dell’INPS ai punti 4.1 e 4.3 non fa altro che delineare la “via amministrativa” da percorrere per il cambio del tipo di integrazione. Per quel che concerne le procedure per la Cassa in deroga l’Istituto richiama quanto già detto con la circolare n. 86/2020 con una precisazione che riguarda le imprese plurilocalizzate le quali, se hanno avuto una prima autorizzazione dal Ministero del Lavoro, dovranno inviare l’istanza come “deroga plurilocalizzata”, mentre le altre dovranno trasmettere le domande come “deroga INPS”. Due parole la circolare n. 104 le riserva anche ai trattamenti integrativi dei Fondi di solidarietà bilaterali ed a quelli delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le domande possono essere accolte nei limiti dei tetti aziendali previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi. In caso di indisponibilità, anche parziale, le aziende potranno accedere alle prestazioni nei limiti delle risorse statali previste nel D.L. n. 104/2020. Da ultimo, infine, la nota dell’Istituto si sofferma sulla proroga dei trattamenti di integrazione salariale relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA): viene ricordato che si tratta di 50 giornate da fruire entro il prossimo 31 dicembre, che i lavoratori debbono essere in forza alla data del 13 luglio, che le domande possono riguardare anche lavoratori che hanno già fruito delle 90 giornate previste dalla precedente decretazione, che le giornate richieste in precedenza per periodi successivi al 12 luglio sono imputate nel “pacchetto” delle 50 giornate, che non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa pari a 181 giornate, che per i soli lavoratori a tempo determinato sussiste la possibilità della CIG in deroga in quanto esclusi dalla tutela CISOA, che i trattamenti concessi sono “neutri” rispetto a quelli previsti dall’art. 8 della legge n. 457/1972, che le giornate di integrazione sono ritenute valide ai fini del raggiungimento del tetto delle 181 giornate e che la decisione circa l’accoglimento è demandata al Direttore della sede INPS che decide monocraticamente, in deroga alla previsione normativa che, nella legge n. 457/1972, affida tale onere ad una commissione ove sono presenti le parti sociali, la Direzione dell’INPS ed il Capo dell’Ispettorato territoriale del Lavoro che la presiede.


DAL 15 OTTOBRE 2020 INVIO COMUNICAZIONI PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO
DI ANTONIO GIGLIOTTI DottoRE CommERCIALIstA E REvIsoRE LEgALE
In base a quanto disposto dall’articolo 121 del DL Rilancio n.34/2020, convertito con modificazioni in legge n.77/2020, i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinate tipologie di interventi in materia edilizia ed energetica possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli isti-

tuti di credito e gli altri intermediari finanziari; • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al Provvedimento 283847/2020. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Invece, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso in cui si opti successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020. Invece, per gli interventi trainanti del Superbonus la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione prevista. A seguito dell’invio della Comunicazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto della medesima, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
LA SCELTA TRA I BONUS
SPETTA AL SINGOLO CONDOMINO
La circolare n. 2/2020 ha precisato che, in considerazione della possibile sovrapposizione dell’ambito oggettivo di applicazione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nonché di recupero del patrimonio edilizio, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Pertanto, in caso di attuazione di interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.49/2020 chiarisce che, qualora gli interventi ricadano in ambiti applicativi di due differenti detrazioni, ogni condomino per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.
LA CESSIONE DEL CREDITO
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato.
RATE RESIDUE NON FRUITE
L’opzione può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. In tal caso la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
EDIFICIO CON UNICO PROPRIETARIO
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.24/2020, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Gli edifici con un unico proprietario possono però usufruire delle ordinarie percentuali di detrazioni edilizie ed energetiche.

QUESTIONI IN TEMA DI CRISI D’IMPRESA E RAPPORTI DI LAVORO
DI IOLANDA PICCININI pRoF. oRD. DIRItto DEL LAvoRo (LUmsA – RomA) • AvvoCAto CAssAZIonIstA
CASS. CIV., SEZ. LAV., SENT. 26 GIUGNO 2020, N. 12833 Procedure concorsuali – Licenziamento del dirigente – Riparto di giurisdizione tra Giudice del lavoro e Giudice Fallimentare – Diverso ambito cognitorio – Contenuto
Il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare deve essere individuato nel rispetto delle rispettive speciali prerogative: di giudice del rapporto il primo e di giudice del concorso il secondo. In particolare, la prefigurata distinzione del diverso ambito cognitorio rispettivamente del giudice del lavoro e del giudice fallimentare corrisponde in modo coerente alla diversità, per "causa petendi" e "petitum", delle domande riguardanti il rapporto, di spettanza del primo e di ammissione al passivo, di spettanza invece del secondo. Nelle prime, rileva, infatti, sotto il profilo della "causa petendi", un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali, estranei alla realizzazione della "par condicio"; nelle seconde, rileva invece soltanto l'interesse alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito, rispetto al quale l'accertamento del presupposto causale dei relativi diritti patrimoniali è meramente strumentale a detta partecipazione. Quanto al "petitum", la distinzione è posta tra le domande del lavoratore intese ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, nella cognizione del giudice del lavoro ovvero dirette alla realizzazione di diritti di credito a contenuto patrimoniale, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, nella cognizione del giudice fallimentare. (Nel caso di specie, la S.C., rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale la corte del merito aveva dichiarato improseguibile la domanda della ricorrente lavoratrice di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dal datore di lavoro sottoposto a liquidazione coatta amministrativa)
CASS. CIV., SEZ. LAV., SENT. 1 GIUGNO 2020, N. 10414 Lavoro subordinato – Trasferimento d’azienda – Aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività – Accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4-bis, L. n. 428 del 1990 – Idoneità ad apportare deroghe all’art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario –Esclusione – Fondamento
In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l’accordo sindacale di cui all’art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - <<Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo>>, va letta in conformità al diritto dell’Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non <<in vista della liquidazione dei beni>>, non possono disporre dell’occupazione preesistente al trasferimento di impresa.
Gli ultimi anni sono stati molto importanti non solo per i giuslavoristi

ma anche per gli studiosi del Diritto della crisi d’impresa, dato lo slancio innovatore del Legislatore. In particolare, il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019), sebbene abbia visto slittare la sua entrata in vigore all’1 settembre 2021 (per l’effetto dell’art. 5 del Decreto Liquidità, che ha modificato l’art. 389 del Codice stesso), apre nuovi e soprattutto diretti campi di intervento per i consulenti del lavoro, al cui ruolo fanno riferimento gli artt. da 356 a 358. Oltretutto, le ultime norme dettate in materia di lavoro per fronteggiare l’emergenza pandemica hanno previsto e stanno prorogando un divieto di licenziamento per motivi oggettivi: tuttavia, questo blocco non riguarda le ipotesi di fallimento con cessazione dell’attività (cfr. art. 14 D.L. n. 104 del 2020). Ecco perché è decisivo che tutti gli operatori del settore studino e siano aggiornati sull’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Occorre, però, muovere da due insegnamenti: in primo luogo, chi si avvicina a tali temi d’indagine constata una tradizionale mancanza di dialogo tra Diritto del lavoro e Diritto fallimentare, essendo scarsa la

propensione ad un approccio omnicomprensivo del fenomeno del lavoro nell’impresa in crisi. In effetti, anche in ragione della nota vis attractiva del Giudice fallimentare, perdura la tradizione visione del Diritto della crisi d’impresa come polarizzato esclusivamente sulle questioni patrimoniali relative alla sorte dei crediti. Purtuttavia, il consulente del lavoro - meglio di altri professionisti - può dimostrarsi in grado di contemperare le istanze delle imprese con quelle dei lavoratori, in una prospettiva multidisciplinare che utilizzi, quale “bussola” orientatrice, l’idea della conservazione, al contempo dell’impresa e del posto di lavoro.

Questa riflessione conduce al secondo insegnamento: in uno scritto “profetico” di Matteo Dell’Olio, intitolato “Crisi d’impresa e crisi d’occupazione”, pubblicato nel 1983 ma che sembra pensato oggi, questo autorevole Maestro ha affermato che “un importante tratto evolutivo, nella esperienza degli ultimi decenni, è certamente la tendenza delle crisi d’impresa, tradizionalmente subite come crisi di solvibilità, ad essere vissute, e in modo sempre più totale ed assorbente, come crisi di occupazione” . Il giuslavorista attento, infatti, sa bene che la crisi d’impresa non va “vissuta” in termini statici e passivi come evento dinanzi al quale occorre tentare di conservare solo le garanzie patrimoniali dei creditori, ma va dinamicamente gestita con la finalità, innanzitutto, di conservare l’impresa. Del resto, rispetto alla originaria visione che si limitava a considerare solo l’interesse creditorio del lavoratore (si pensi agli istituti del privilegio e della prededucibilità, oppure al Fondo di Garanzia per il TFR), negli ultimi anni è diventato prevalente l’interesse al mantenimento del posto di lavoro. Ecco perché è quanto mai attuale l’insegnamento di M. Dell’Olio, secondo il quale “in una società che si afferma «fondata sul lavoro», ed impegnata a rendere «effettivo» il «diritto» a questo, la crisi d’impresa non può non essere sentita, e più intensamente vissuta, come crisi o prodromo di crisi di occupazione”. In questa prospettiva, affinché la crisi d’impresa non comporti, né costituisca, prodromo di una crisi di
occupazione, la parola chiave, già sopra citata, che rappresenta comune meta della dimensione imprenditoriale e di quella lavoristica, risiede proprio nel termine “conservazione”.
Non è questa la sede per verificare se le nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi e dell’insolvenza siano fedelmente rispettose degli insegnamenti sopraesposti; è certo, però, che si tratta della prima volta in cui il Legislatore fallimentare tenta di “armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (come si legge nell’art. 2, lett. p) della Legge delega n. 155 del 2017), nella speranza di coordinare “la disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato […] con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro” (in tal senso cfr. art. 7, comma 7, della medesima legge). Il tentativo non sembra, a chi scrive, pienamente riuscito ma la strada intrapresa è quella giusta.
Sempre guardando dall’alto l’evoluzione legislativa degli ultimi anni può, esprimersi un’ultima considerazione generale e, cioè, che è giunto il momento di valorizzare tutte le sedi di intervento “a monte” delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori (anche a livello aziendale) nella migliore prospettiva di conservazione dell’impresa e dei posti di lavoro, attraverso il contemperamento degli interessi in gioco. Come si sa, il sindacato già occupa da tempo (si pensi alla L. 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi o alla L. 428 del 1990 in materia di trasferimento d’azienda) una posizione significativa tra gli attori della gestione delle crisi d’impresa, ma la sensazione è che, fino ad oggi, le organizzazioni sindacali - pur contribuendo, spesso in modo responsabile, alla salvezza di imprese (si pensi ai tanti accordi di solidarietà sottoscritti ) - si siano accontentate di svolgere la loro parte solo “a valle”, nelle battute finali della crisi, quando è ormai inevitabile la riduzione del personale o occorre trattare il quantum di incentivi all’esodo da corrispondere. Volgendo ora lo sguardo alla Giurisprudenza recente, uno dei temi più interessanti è quello che attiene al riparto tra Tribunale del lavoro e Tribunale fallimentare, non essendo sempre facile applicare nei casi pratici la distinzione tra Giudice del “rapporto” e Giudice del “concorso”, soprattutto dopo che il Legislatore ha “spacchettato” la vecchia tutela reintegratoria contenuta nell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori in diversi e gradati regimi sanzionatori in cui compaiono tutele indennitarie economiche in aggiunta o in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro. Effettivamente sono proprio le cause di licenziamento quelle che danno luogo ai più frequenti contenziosi. La vicenda affrontata dalla prima delle sentenze qui in commento riguarda la peculiare ipotesi del licenziamento di un dirigente da parte di una società, sottoposta nelle more del giudizio a liquidazione coatta amministrativa.
La seconda sentenza riguarda la ces-

sione di un compendio aziendale e il connesso problema dell’interpretazione e della portata applicativa dell’articolo 47, comma 4-bis, della L. n. 428 del 1990. La Corte, dopo aver ricostruito puntualmente il rapporto tra la Direttiva comunitaria 2001/23/CE e la suddetta legge italiana, approfondisce, anche grazie al richiamo di precedenti della Corte di Giustizia, il contenuto del possibile accordo sindacale in deroga, nell’ipotesi di cessione di azienda in crisi; ipotesi diversa da quella disciplinata dal comma 5 del medesimo art. 47 (e cioè nei casi di crisi in cui, in sostanza, non vi sia continuazione dell’attività). La distinzione tra i due commi è condotta dalla Corte con attenzione al tenore letterale delle due disposizioni, offrendo una lettura coerente con l’interpretazione logico-sistematica (in rapporto al Diritto dell’Unione e alle decisioni della CGUE) e con la voluntas legis, “per cui l’accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai sensi del comma 4-bis dell’art. 47 legge n. 428 del 1990, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all'art. 2112 c.c. cui il comma 4-bis si riferisce, può riguardare esclusivamente le <<condizioni di lavoro>>, nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito”. Siccome chi scrive, dopo aver maturato un’esperienza di studio e professionale in materia, auspica che il consulente del lavoro sia in condizioni di aiutare datori di lavoro oppure lavoratori e loro rappresentanze nella stesura di accordi sindacali aziendali, la sentenza in commento è meritevole di una attenta lettura, poiché indica le linee guida da seguire nell’applicazione pratica.
Per leggere il testo integrale delle decisioni vai al link https://www.consulentidellavororoma.it/sites/default/files/sentenze%20rivista%20113.zip

IL DONO ACQUA DELL’ELBA Un gesto unico che nasce dalla bellezza per donare bellezza





Regalare Acqua dell’Elba significa donare tutta la poesia del mare, racchiusa in un manufatto prezioso. Diverse confezioni in cui poter inserire da 1 a 5 prodotti: dai piccoli pensieri ai grandi doni, tutti personalizzabili con il vostro logo aziendale o con qualsiasi altra scritta sul flacone e/o sulle confezioni e accompagnati, se si desidera, da un messaggio personale inserito in busta chiusa con timbro in ceralacca.


Il sistema completo per i consulenti del lavoro

Il sistema digitale integrato e modulare che ti dà massimo aggiornamento, approfondimenti e strumenti pratici con un’esperienza di consultazione unica.
Risposte chiare e soluzioni concrete a tutti i problemi relativi si rapporti di lavoro tra privati e alla disciplina previdenziale. Disponibile in formato cartaceo e digitale. Scopri i vantaggi della formula doppia edizione in abbonamento per il massimo aggiornamento. La nuova linea di corsi improntati “al saper fare” secondo l’esclusivo metodo pratico Memento, fatto di casi reali, simulazioni e risposte mirate ai quesiti. I percorsi formativi sono organizzati nella formula in aula, e-learning e mista.
QUESITI DEL MESE
A CURA DEL CENTRO STUDI DEL ConsIgLIo pRovInCIALE DI RomA
Facendo riferimento al d.l. 14/08/20 n. 104 ho un dubbio circa l'interpretazione dell'esonero del versamento dei contributi per assunzioni a tempo determinato . L'articolo cita che l'esonero e' riconosciuto ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Questo vuol dire che il contributo ivs va sempre interamente versato?
No, l’aliquota di computo è il coefficiente da applicare al reddito imponibile annuo per determinare la contribuzione figurativa. Si segnala, inoltre, che l’esonero contributivo di cui all’art. 6 del d.l. 104/2020 è previsto, a determinate condizioni, solo in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.
In riferimento alle novità introdotte dall’art. 1 del D.L. Agosto, ultimo periodo del comma 1, chiediamo se si debba ricomprendere nelle prime 9 settimane anche le settimane richieste per le c.d. “zone arancioni”.

Secondo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 104/2020, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (e smi) , collocati anche parzialmente in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati alle prime 9 settimane previste dal DL 104/2020 (Decreto Agosto). In tal senso si veda anche il punti 1 (Premessa) del messaggio Inps 3131 del 21 agosto 2020. Tale principio deve intendersi valido anche per le settimane aggiuntive previste dall'art. 22 comma 8-quater del decreto Legge n. 18/2020 a beneficio dei datori di lavoro con unità produttive nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
QUESITI DEL MESE
Il pagamento del contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativamente ad un rapporto di lavoro irregolare - dichiarato sussistente dal 10.02.20- oggetto di istanza di emersione, presentata il 06.06.20, fino a quando è dovuto? Dal 10.02.20 al 06.06.20 (data di presentazione della domanda) o sino ad oggi?
Il primo contributo forfetario come noto andava pagato all'atto della istanza , i cui termini sono stati prorogati al 15.08.2020 Solo l’8 settembre 2020 sono stati pubblicati in GURI i valori del secondo contributo . Detto secondo contributo forfetario previsto, dunque, è dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale ed è pari a 156 euro o 300 euro, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto della domanda di emersione.
ho un negozio di alimentari con un dipendente che non ha mai presentato domanda di cassa integrazione, ora, ha necessita' di chiedere una cigd dal 28/9/2020. Posso chiederla? considerando che c'e' una dich.ne di responsabilita: "che all'azienda sia stato interamente gia' autorizzato il periodo di nove settimane concedibili ai sensi dell’art. 22 D.L
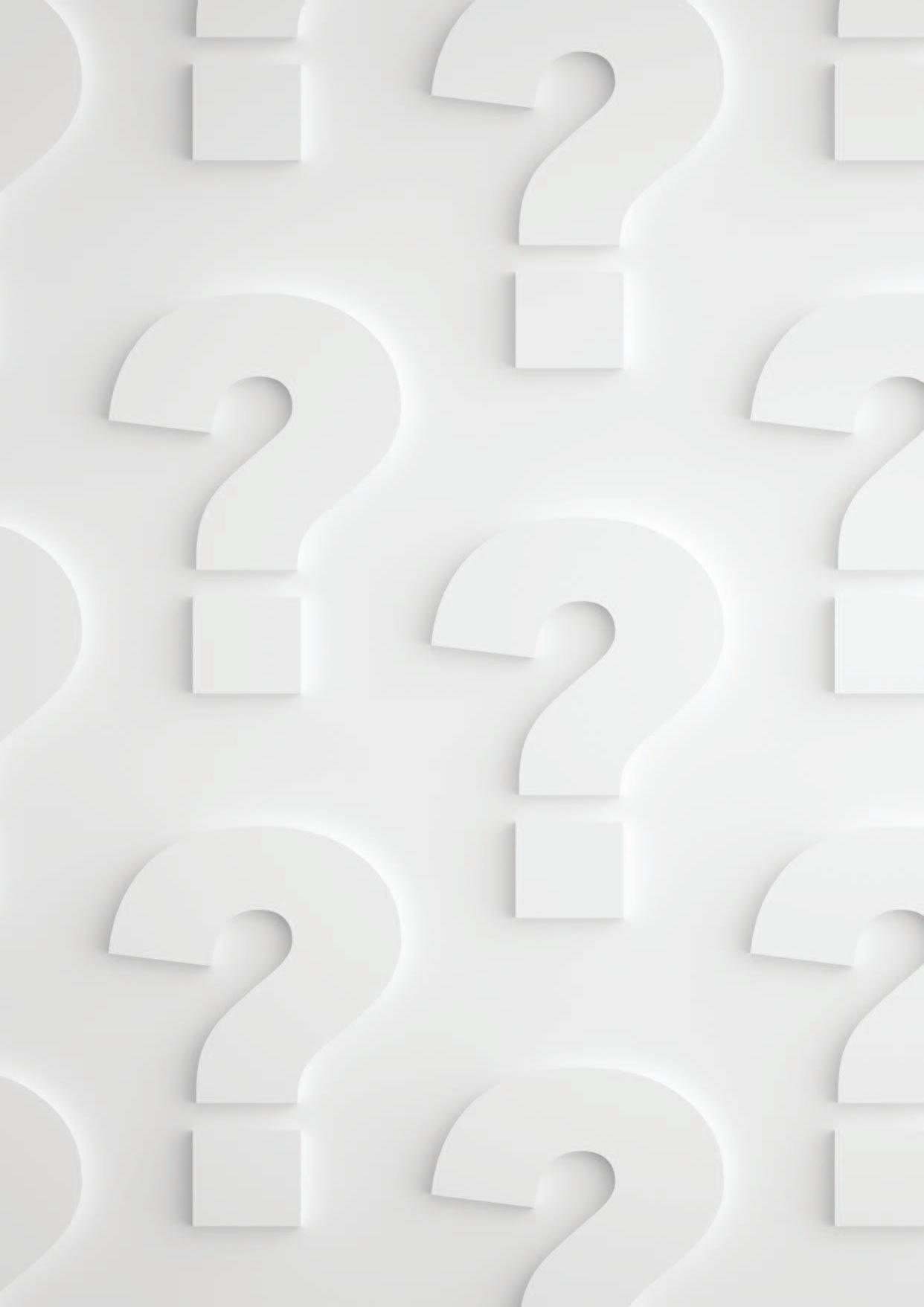
La circolare n. 115/2020 dell’Inps, commentando il D.L. n. 104/2020 consente la presentazione delle istanze anche da parte dei datori di lavoro che, in precedenza, non hanno fruito di ammortizzatori.




