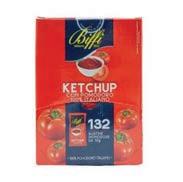Perché si mangia sempre più spesso fuori casa?
Lo chef Jacopo Iecci esordisce a Terrazza Oliva
Sabor'e Mari

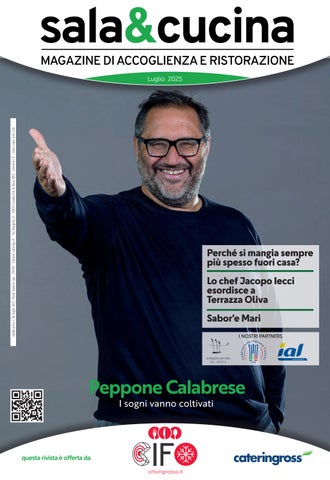
Perché si mangia sempre più spesso fuori casa?
Lo chef Jacopo Iecci esordisce a Terrazza Oliva
Sabor'e Mari


Mario Benhur Tondini
presidente Edizioni Catering srl
Imprenditore nel settore della distribuzione alimentare, gestisce con il fratello Oscar l’azienda di famiglia a Cavriana (MN), dove ha svolto anche l’incarico di sindaco.

Le competenze maturate sul piano professionale e su quello amministrativo lo hanno portato alla convinzione che il principio della condivisione sia la miglior modalità di crescita. Molte sue iniziative, anche all’interno del gruppo Cateringross (che detiene la titolarità della casa editrice), di cui è consigliere d’amministrazione, vanno in questa direzione. A questo affianca una forte sensibilità per ogni azione che dia valore al suo territorio.
benhurtondini@salaecucina.it
Marina Caccialanza
Redazione
Milanese, un passato come traduttrice, da diversi anni giornalista e redattrice per riviste del settore alimentare rivolte al mondo dell’artigianato e all’industria, in particolare nel campo della ristorazione, del dettaglio specializzato e della ricerca. Contribuisce alla realizzazione di importanti libri di comunicazione gastronomica in Italia e all’estero diretti ai professionisti e ai consumatori. Collabora con le redazioni di sala&cucina, Ecod e Trenta Editore.

Luigi Franchi
Direttore responsabile
Prima fotografo di cibo e territori, poi comunicatore, autore di numerosi libri di enogastronomia e di turismo enogastronomico. e infine giornalista di enogastronomia. Tra le sue principali pubblicazioni, scritte e/o coordinate: La prima edizione della Guida al turismo del vino in Italia, per conto del Movimento Turismo del Vino, (1997), I parchi e il turismo enogastronomico (2004), Il marketing delle Strade del Vino edizioni Agra – Rai Eri (2005), Atlante Alimentare Piacentino, con Valentina Bernardelli (2007), “cuo chi, due anime in cucina”, con Alessandra Locatelli, GL.Editore (2009), Dalle Terre Traverse al Po, GL.Editore (2010), ideatore e coautore dei Maestri del lievito madre, Edizioni Catering (2014), coautore della guida online dedicata alla ristorazione Meglio Prenotare, Edizioni Catering, Le interviste (2018) editore Mediavalue. Co-direttore di Food & Book, festival nazionale di editoria enogastronomica luigifranchi@salaecucina.it

marina.caccialanza@salaecucina.it
Redazione
Ricorda con esattezza il profumo del primo pane preparato all’età di sette anni.
Forse il suo primo traguardo e, soprattutto, l’inizio di una grande passione: per le cose semplici, per la genuinità, per gli alimenti che crescono e prendono forma. Dopo la Laurea in Scienze Gastronomiche, la specializzazione in comunicazione enogastronomica, e un periodo di alternanza nelle cucine, ha chiara la missione: scrivere per comunicare. Come? Utilizzando gli strumenti di oggi e la curiosità di sempre. Gionalista pubblicista, collabora anche con la guida di Identità Golose.

Simona Vitali
Redazione
Laureata in filosofia, ha lavorato nella comunicazione e organizzazione di grandi eventi a Parma.
Ha ricevuto una prima inconsapevole educazione al gusto per il cibo grazie all’ indimenticato oste dell’Osteria della Stazione di Felino (PR), il nonno materno Massimino. Con gli studi umanistici è poi arrivata una seconda, consapevole, educazione al gusto per l’utilizzo delle parole secondo il loro significato. Poi sono seguiti un corso di Alta Formazione alla scuola Holden e un master in Filosofia del cibo e del vino. Della ristorazione l’affascina il pensiero e la componente umana. Della formazione di settore segue movimenti ed evoluzioni.

giuliazampieri@salaecucina.it
Gabriele Adani
Grafico
Modenese, appassionato di arte figurativa, fotografia e linguaggi di comunicazione visiva.
s.vitali@salaecucina.it

Nel 1992 inizia il suo percorso professionale presso una casa editrice. Lavora poi in uno studio grafico e fonda una piccola agenzia di comunicazione in cui ricopre il ruolo di direttore creativo per 18 anni.
Viaggiatore, utilizza i frequenti viaggi a Londra e nel Sud Est asiatico per arricchire il suo bagaglio culturale e placare la sua innata curiosità per le altre culture.
Dal 2019 lavora in proprio, occupandosi di fotografia, grafica e consulenze nel campo della comunicazione.
grafica@salaecucina.it







7 LA LETTERA APERTA
Non generalizziamo | Luigi Franchi
9 L'EDITORIALE
Perché si mangia sempre più spesso fuori casa? | Benhur Tondini
10 IL CONFRONTO
Peppone Calabrese | Luigi Franchi
15 LA RIFLESSIONE
Pazza estate | Giulia Zampieri
19 LA FORMAZIONE
Ritratto di un prof di laboratorio di un istituto professionale | Simona Vitali
22 GLI AMBASCIATORI DEL GUSTO
Conoscere il riso italiano | Luigi Franchi
28 IL RISTORANTE
Lo chef Jacopo Iecci esordisce a Terrazza Oliva | Simona Vitali
32 IL RISTORANTE
ISabor'e Mari | Giulia Zampieri
36 IL RISTORANTE
Dario Cilento e il suo Zazà vini vinili vivande | Luigi Franchi
39 I CUOCHI
Ancora tanti mesi di formazione per giovani e professionisti FIC | Rocco Cristiano Pozzulo
41 LA NEUROVENDITA
Sushi, sinapsi e sacrificio | Lorenzo Dornetti
44 DOGUSTO
Le olive DoGusto | Guido Parri
46 IL TERRITORIO
Ol Minadùr | Luigi Franchi
50 LA STORIA
I menu di Auguste Escoffier | Alessia Cipolla
54 LE CONTAMINAZIONI
Bánh mì: l’intricata storia di un panino | Federico Panetta
56 IL VINO
Montetino | Giulia Zampieri
60 LA PIZZA
Viva la pizza! Nel ruoto | Marina Caccialanza
62 L'OLIO AL CENTRO
Puntare sui sommelier, per valorizzare l’olio in sala | Luigi Caricato
64 LA DIGITAL TRANSFORMATION
Il tuo ristorante risponde da solo (e meglio di prima) | Claudia Ferrero
65 LA PRODUZIONE
Spirito Contadino: radici, territorio e varietà dimenticate | Marina Caccialanza
68 DOGUSTO
Nasce il DoGusto Pizza Club | Guido Parri
70 L'ANALISI SENSORIALE
Il gusto: il senso con cui assaggiamo il mondo | Stefania Pompele
73 I LIBRI
L'olio al ristorante | Luigi Franchi
78 LA PRODUZIONE
La rivincita dei tagli poveri: duttilità la parola chiave | Guido Parri

N° 96 luglio 2025
EDITORE
Edizioni Catering srl Via Margotti, 8 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel. 051 751087 – Fax 051 751011 info@salaecucina.it - www.salaecucina.it
PRESIDENTE
Benhur Mario Tondini benhurtondini@salaecucina.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Luigi Franchi luigifranchi@salaecucina.it
COLLABORATORI ESTERNI
Luigi Caricato, Alessia Cipolla, Lorenzo Dornetti, Rocco Pozzulo, Claudia Ferrero, Federico Panetta, Guido Parri, Stefania Pompele.
FOTOGRAFIE
Archivio I Rais, archivio sala&cucina, adobestock.com, Gabriele Badiale, Gianmarco Garau, Alberto Ghezzi
* L’editore è a disposizione per eventuali crediti fotografici di cui si ignora la fonte
RIVISTA PARTNER di AMODO
PUBBLICITÀ
Tel. 331 6872138 marketing@salaecucina.it www.salaecucina.it
PROGETTO GRAFICO
Gabriele Adani - www.gabrieleadani.it
STAMPA
EDIPRIMA s.r.l. – www.ediprimacataloghi.com
TIRATURA E DISTRIBUZIONE – 28.900 copie
Ristoranti, trattorie e pizzerie 20.700 – Bar, pub e birrerie 4.000 – Hotel 3.100 – Grossisti e distributori f&b 1.100
Costo copia mensile: 4,00 euro abbonamento annuo 40,00 euro Per abbonarsi: info@salaecucina.it




I giovani non hanno voglia di lavorare! Mai come in questa estate ho sentito ripetere molte volte questo concetto generalista, ma ritengo profondamente sbagliato fare di tutta l’erba un fascio. I motivi che portano a questa valutazione sono che, dopo il Covid, si è scoperto un nuovo comportamento di vita, oppure che il vecchio reddito di cittadinanza copriva abbondantemente i bisogni economici. Analisi superficiali che eludono il vero problema, tutto italiano, degli stipendi bloccati da ormai un quarto di secolo, con aumenti di poche decine di euro mentre il costo della vita triplicava.
In questo numero della rivista portiamo almeno tre o quattro storie di giovani che, invece, hanno voglia di lavorare, di investire sul loro lavoro, di farlo bene, di trarne soddisfazione. Casi sporadici? Non lo so, forse, ma casi che meritano di essere segnalati come esempi positivi a cui guardare, come merita di venire approfondito il tema del lavoro.
Una ricerca di MAW, un’agenzia per il lavoro, evidenzia che, nel nostro Paese, solo tre lavoratori su dieci sono pienamente soddisfatti del proprio lavoro e, afferma Federico Vione, CEO di MAW, “i lavoratori coinvolti ci hanno raccontato, anche, l’importanza dell’aspetto salariale, che naturalmente continua ad essere al primo posto quando si cambia lavoro, ma anche del benessere sul luogo di lavoro: più di sei persone su dieci non lasciano i datori di lavoro che sanno valorizzarli e un buon rapporto con i colleghi è determinante nella scelta di non lasciare il proprio posto di lavoro”.
Uno stipendio adeguato è, per il 76% degli intervistati,

Luigi Franchi direttore responsabile
il principale obiettivo per restare in quel luogo di lavoro e, per il 56%, un buon clima lavorativo conta molto. Due aspetti che non si riscontrano facilmente, se poi sei un giovane appena uscito dagli studi il problema, a volte, diventa insormontabile.
Infatti, soprattutto nel settore della ristorazione, verso i giovani che approcciano per la prima volta c’è una certa intolleranza al posto di una volontà di insegnare il mestiere. Quanti casi abbiamo visto e vediamo dove un ragazzo o una ragazza vengono messi a svolgere il servizio, soprattutto in sala, senza nessun tipo di informazione relativo al locale, alla tipologia di piatto, alla carta dei vini!
È necessario, anziché dire che i giovani non hanno voglia di lavorare, adottare un linguaggio e un comportamento, da parte di entrambi i soggetti, il giovane e il titolare del locale, volto a capirsi, a dare valore al lavoro, un valore sia economico sia umano. Dove questo avviene, e sono molti i casi positivi per fortuna, non ci sono problemi, si vedono giovani che adorano questa professione, che sanno coinvolgere l’ospite, che sanno vendere l’esperienza ristorativa.
Proviamo, dunque, a non generalizzare. Cerchiamo, almeno nella ristorazione, di ribaltare quel dato negativo di tre persone soddisfatte su dieci del proprio lavoro.
Ci si può riuscire, l’estate che stiamo vivendo, con tantissimi ristoranti pieni, è un’occasione per mettere fieno in cascina da utilizzare per il vostro ristorante e per migliorare i compensi e investire sulla formazione: aspetti ormai essenziali per un’azienda che vuole essere premiata dal mercato.

Bella domanda! Le risposte sono tante ma quella che mi piace ricordare di più è che mangiare fuori casa, oggi, non è una necessità alimentare o fisica: è un fenomeno sociale che porta a evidenziare chi siamo, cosa scegliamo, è condividere uno spazio con altri, è approfondire la nostra cultura gastronomica. Reca con sé anche aspetti meno gaudenti, perché mette in scena disuguaglianze sociali tra chi può permetterselo e chi no.
Resta comunque un rito ormai definitivamente consolidato, come dimostra la velocissima ripresa del settore dopo il Covid.
I dati lo testimoniano: il Rapporto Ristorazione della FIPE stima in 94 miliardi il consumo fuori casa; il Foodservice Market Monitor 2024 di Deloitte descrive il mercato della ristorazione in Italia, citando il fatto che, nel 2023, ha superato gli 82 miliardi di euro nel 2023, crescendo del 9% rispetto all’anno precedente. Da ultimo la World Food Travel Association afferma che la spesa del mangiare fuori casa rappresenta tra il 15% e il 35% del budget totale dei turisti.
Numeri che dimostrano quanto il cibo italiano diventi una leva globale di posizionamento, un’esperienza culturale esportabile a tutti i livelli, dal ristorante stellato alla trattoria viene raccontato un significativo pezzo d’Italia.
Ma è così solo per il nostro Paese? No, il cibo è, in questo momento storico, argomento in molte parti del mondo, basti ricordare gli eventi di portata internazionale che si svolgono in Messico, come l’Authentic Traditional Mexican Food Cooking Experience, o in Perù con il Mistura Food Festival. Oppure la World’s 50 Best

Benhur Tondini presidente sala&cucina
benhurtondini@salaecucina.it
Restaurants che è diventata, nell’arco di pochi anni, la classifica più attesa e che, quest’anno, è stata presentata ufficialmente a Torino, generando una ricaduta economica e turistica di notevoli dimensioni sulla città.
Esempi di come il cibo e soprattutto il consumo fuori casa sia diventato un fenomeno di portata mondiale. In tutto questo l’Italia non può che essere protagonista; la ristorazione italiana nel mondo ha ormai surclassato quella francese; le ricette tradizionali dei nostri borghi stanno dilagando in ogni parte del mondo, complice il piacere assoluto che ogni turista straniero prova cenando in una sera d’estate in una piazza italiana o in riva al mare.
Tutto questo deve essere portato a valore, il cibo buono non può costare di meno rispetto alla custodia di plastica di uno smartphone. È necessario che tutti i protagonisti della filiera gastronomica siano consapevoli che mangiare sano, mangiare bene significa pagare il giusto non tanto e solo nel conto del ristorante ma anche in tutto quello che sta dietro a una buona materia prima. Non può più essere accettabile che esistano fenomeni come il caporalato in agricoltura o che un cameriere, un cuoco, un lavapiatti non vengano pagati il giusto. Non è così che si darà valore alla cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’umanità.
Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web



“Ed ecco che in un mosaico così ampio, come quello di cui si compone la gastronomia, un esempio di valore è rappresentato dal mio amico Giuseppe Calabrese, che in molti, me medesimo, chiamano Peppone. Il successo delle storie che da sempre riporta risiede, infatti, nell’autenticità delle relazioni che lo stesso Peppone ha saputo costruire con i produttori e le produttrici, le cuoche e i cuochi di tutta Italia”.
È con queste parole, scritte da Carlin Petrini nell’introduzione del libro L’Italia che ho visto di Peppone Calabrese che introduciamo l’intervista al protagonista di Linea Verde, rubata tra una puntata e l’altra di Camper, la trasmissione in onda quest’estate su Raiuno. Peppone Calabrese è quello descritto da Petrini: una persona di grandissima empatia, che sa tenere a bada il successo televisivo, impegnato su più fronti nelle battaglie sociali. Ma queste cose che le spiega lui stesso in questa intervista che inizia con una semplice domanda.
Ci racconti come sei arrivato, all’improvviso, nelle case di milioni di italiani?
“Certo che si! Torno a casa, a Potenza, per la malattia di mio padre che mia madre non poteva gestire da sola perché lui era medico e aveva capito tutto, compresa la gravità della malattia. E qui, dopo aver lavorato in un centro di fisioterapia, in un altro per disabili gravi, ho fondato un’associazione di volontariato insieme ai miei amici storici, Bianca, Vincenzo, Carmine e tanti altri. Parto quindi per l’Africa come volontario e, quando torno, in società con altri, apro una gastronomia che poi diventa ristorante – Cibò è il nome – dove creo una piccola comunità coinvolgendo gli agricoltori locali e promuovendo i loro prodotti. Sono loro che presidiano la tradizione. In questo ristorante, l’anno del capodanno RAI a Potenza, viene a mangiare una sera un signore, portato lì da Francesca Barra, giornalista lucana di Policoro. Questo signore, a un certo punto, resta solo e io, da buon oste custode, vado vicino e gli faccio la domanda che si fa qui a Potenza: a chi si’ figlio? A chi appartieni? Sono di Taranto, mi dice. Io, che sono un grande tifoso del Potenza, gli rispondo scherzando: fuori da qua! Poi abbiamo cominciato a chiacchierare, gli ho raccontato la filosofia del ristorante, del perché ero vicino ai contadini, rispettoso del territorio e dei prodotti. Il giorno dopo lui doveva andare a Roma e anch’io dovevo raggiungere la capitale. Vieni con me, gli dico, e in questo viaggio cantiamo io le canzoni del Potenza e lui quelle del Taranto e della Lazio. Poi ritorna a Potenza e viene tutti i giorni al ristorante, amava suonare il pianoforte e io ne avevo uno nel locale e, un giorno in cui era venuto con altre persone, gli dico “va a suonare il pianoforte”. Uno dei suoi ospiti mi apostrofa “ma perché lo tratti così, non lo sai chi è?”. Si, è un tarantino, rispondo. No, mi risponde, “è il capostruttura del Capodanno RAI. Angelo Mellone”. Dopo diversi mesi, in una riunione dove Angelo voleva ampliare e diversificare la proposta comunicativa della Prova del Cuoco, dovevano scegliere degli inviati e Carola Ortuso, che veniva sempre con lui a mangiare da me, gli fa il mio nome e mi chiamano. Quando ricevo la telefonata pensavo a uno scherzo e gli chiudo il telefono in faccia. Questo mi richiama: “Sono Beppe Bosin, capo-autore della Prova del Cuoco (oggi capo-autore di Camper e autore di Linea Verde) e la invito a fare un provino”. Sono piaciuto alla Endemol, la società di produzione televisiva, e al film-maker An-

drea Rovetta con cui ho lavorato tutto quell’anno. L’anno dopo, nel 2017, vado a fare il co-conduttore a Linea Verde e credo di essere il più longevo conduttore di questa trasmissione dopo Federico Fazzuoli
I sogni bisogna coltivarli: è un pensiero positivo il tuo, lo è sempre stato? Come sei arrivato a questo convincimento?
“Credo che la mia sia un’indole costantemente alla ricerca di positività. Questo non vuol dire che non ci siano i dolori, le preoccupazioni o i momenti di riflessione profonda. Ho perso mio padre diversi anni fa, ultimamente è toccato alla mia seconda madre, mia zia Anna, altre persone care che erano punti di riferimento per me che mi muovo nel mondo e quando fai questa vita è importante sapere che dietro hai un punto fermo su cui poterti appoggiare. Però sono sempre un adulto molto positivo e la consapevolezza è avvenuta con la morte di mio padre. Tra le sue cose abbiamo trovato questi libri di medicina dove c’era scritto che, per realizzare un grande sogno ci vogliono due requisiti: il primo è una grande capacità di sognare, il secondo è la perseverazione della fede nel sogno. Perseverazione è un termine arcaico, molto bello e importante che significa perseverare nell’azione. Io avevo il sogno di diventare cameriere perché quando ero un ragazzino andavo sempre nel bar di mia zia ad aiutare e mi piaceva molto
quel lavoro. Poi avevo un altro sogno: quando stavo da solo facevo finta di intervistare i giocatori di calcio, in particolare Maradona. Non sono riuscito nell’impresa ma ho intervistato Carlin Petrini che, per me, è il Maradona della gastronomia. I sogni bisogna assolutamente coltivarli!!”
Nel tuo libro scrivi che il formaggio, come l’olivo, sono stati strumenti di ascesa sociale, possono esserlo ancora adesso queste attività agricole?
“Sicuramente erano molto più redditizie un tempo, hanno permesso nei secoli di sfamarsi, di far studiare i figli, come nel caso di mio padre. Oggi c’è un ritorno alla terra consapevole. I contadini, un tempo, erano molto dignitosi ma anche un po’ psicologicamente assoggettati, avevano forme di deferenza verso chi stava meglio di loro anche un po’ esagerate. Adesso, invece, c’è una consapevolezza diversa dove si tiene sempre presente che l’aspetto economico è importante; che la sostenibilità economica fa di questa vita agricola non una vita di resilienti ma di persone felici. Ed è quello che auspichiamo. Parafrasando Vito Teti, antropologo che ha descritto meglio di chiunque altro il nostro sud, c’è il viaggio di chi parte e il viaggio di chi resta. Chi parte ha il coraggio di cambiare le sorti della sua famiglia, però si porta dietro tutta una serie di lutti. Il primo è quello di aver tradito la sua terra. E poi ha l’abitudine
di replicare nella città in cui è andato tutto quello che succedeva in provincia, ma non funziona così. Chi resta invece ha la frustrazione di non essere riuscito ad andare ma anche la possibilità di ridisegnare il territorio, il proprio paese in forma più vicina alla sua felicità. Quando si ha questa consapevolezza si prova a fare delle azioni virtuose e, questo, in agricoltura ti porta a non svendere il tuo lavoro e quindi cerchi di utilizzare i mezzi di comunicazione che hai a disposizione per affermare queste azioni. Andare a vivere in un altro posto dipende da come ci arrivi; se finisci, come è capitato e capita spesso, nelle periferie delle grandi città non è che avrai tutto questo bel vivere. Se invece resti nella provincia vivi una dimensione autentica, rappresenti il territorio, non sei un semplice numero. Puoi rappresentarlo quel territorio, diventarne un elemento di valorizzazione. Il viaggio di chi resta, tornando a Vito Teti, è dunque molto affascinante e noi, persone di comunicazione, abbiamo il dovere di raccontare questa cosa, di renderla appetibile, perché altrimenti restano i paesi spopolati e le periferie che diventano agglomera-

ti urbani senza storia e senza identità”.
Mi fai venire in mente la nostra nuova idea editoriale che si chiama IlBelViaggio che vuole proprio raccontare l’Italia inaspettata… “Bravissimo. Mi piace quest’idea, dobbiamo, ognuno di noi, metterci del proprio per fare del nostro Paese un luogo dove si può vivere bene”.
Come hai scelto di fare l’oste e cosa significa, oggi, la parola osteria?
“Bellissima domanda! Da bambino andavo da questa zia a Tolve che aveva il bar e, sotto casa, anche un frantoio e mia zia, al posto delle patatine, al bar dava un pezzo di pane caldo, un pomodoro del luogo e l’olio che avevano fatto loro. Io amavo questa cosa, ho amato molto questo bar a Tolve ed è nata lì la passione che mi ha portato alla ricerca di tutti questi agricoltori in memoria di mio nonno Beppe che ha fatto una vita di sacrifici per conquistare la terra. L’osteria, per venire alla domanda, ha una responsabilità: quella di essere una sentinella del territorio ma anche un pilastro della cultura gastronomica italiana. Lo deve fare soprattutto nel momento in cui viene attaccata con ogni forma da racconti e narrazioni che tendono alla omologazione e deve riprendersi lo spazio di valorizzazione del prodotto locale, dei contadini, dei mercati, della spesa quotidiana. Le osterie hanno questo obbligo! Questo non vuol dire che non debbano esserci altri posti dove andare a mangiare, anzi: il cibo italiano è il frutto di condi-

visione, i monsù, i cuochi di corte hanno da sempre innovato e ben venga l’innovazione anche adesso. Ben venga tutta la creatività degli chef per farci sognare ma dobbiamo dare alle persone la possibilità di scegliere la buona qualità accessibile e, in questo, le osterie sono fondamentali e devono riappropriarsi di quello spazio umano e autentico. Lo possono fare senza mortificare la creatività dei cuochi ma devono sempre essere rispettose, anche del paesaggio disegnato, nel corso degli anni, dalle comunità perché in quei luoghi le persone avevano e hanno delle esigenze precise. E in questo anche i camerieri, e non solo i cuochi, devono essere rispettosi; i camerieri devono essere colti, non dotti, devono essere curiosi, sapere cosa c’è dietro a quel piatto, saper raccontare quella sapienza antica, far emozionare gli ospiti. Nei corsi di formazione che faccio a Incibum a Pontecagnano e a Intrecci a Castiglione in Teverina sono felice di vedere ragazzi che arrivano in queste accademie con un’idea legata alla creatività a tutti i costi e se ne tornano con la gioia di aver riscoperto le proprie tradizioni e vedessi cosa ne esce fuori; i cuochi portano i piatti che usavano da bambini all’esame da Incibum e i camerieri raccontano storie, da Intrecci, con un pathos incredibile. È commovente tutto questo. Io vorrei andare nei ristoranti e nelle osterie per trovare questo e non lo scimmiottamento delle teorie degli altri”.
Tolve, Roseto Capo Spulico, Belmonte, Castropignano, San Giorgio Canavesano, Cancellara: nomi di paesi che, senza il tuo impegno, non sarebbero mai venuti alla luce del sole; come vivono gli abitanti di quei luoghi la notorietà che gli portate?
“Quando arriviamo noi arriva la Rai ed è sempre una festa. Ma io dico anche loro di stare attenti, perché quando arrivano le persone devono essere capaci di accoglierle e gli amministratori locali devono fare un passaggio culturale rispetto a questa cosa. Devono
lavorarci sull’accoglienza, prendere consapevolezza che è un’opportunità ma che i servizi devono essere importanti altrimenti l’economia del territorio non cresce. Linea Verde sta diventando, nel tempo, un importante agenzia di viaggi perché fa una narrazione responsabile dei luoghi e noi dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo il dovere morale di non fermarci, di dare visibilità. Dobbiamo chiedere agli amministratori di dare luce, dicendo cosa eventualmente non funziona. Dobbiamo dire a chi fa press-tour, festival, incontri che non può andarsene da quel posto che li ospita senza trasferire il proprio sapere. Bisogna dirle le cose, con educazione e rispetto ma bisogna dirle”.
Hai scritto, di recente, un libro che racconta della tua visione dell’Italia: una lettura quasi antropologica del nostro Paese. Quelle storie che racconti cosa rappresentano per l’Italia del prossimo futuro?
“Io spero che questo libro venga letto ai ragazzi nelle scuole. Le storie raccontate non sono storia passata ma, tra diversi anni, rappresenteranno un presente ancora più luminoso. Non possiamo permettere lo spopolamento della provincia, pensa a quanto sapere perderemmo. Quando dico a chi si’ figlio? A chi appartieni? si scatena un moto identitario interiore pazzesco, cambiano la prossemica, le persone alzano la schiena. Questo dovere dobbiamo sentircelo addosso”.
Hanno tratti distintivi che le accomunano le persone che difendono i loro territori?
“Si, c’è uno stile dei territori, che noi dobbiamo difendere. Nei mille e mille campanili d’Italia c’è un’identità ed è nella differenza che si alimenta l’identità”.
Potremmo andare avanti ancora per molto ma gli impegni televisivi di Peppone lo richiamano. È una grande persona e lo si capisce anche leggendo il suo libro: L’Italia che ho visto.


Giulia Zampieri
Non ci sono più regole, e nella bella stagione è sempre più evidente. Ma alcune scelte possono premiare
C’è un’immagine che rende bene l’idea dello scenario con cui devono fare i conti il settore della ristorazione e dell’ospitalità negli ultimi tempi. È quella di una tavola da biliardo in cui le biglie, dopo il primo colpo, si proiettano disordinatamente sul tappetino verde.
È una similitudine che abbiamo trattenuto dalla conversazione con Antonella Cheli, ristoratrice di Porto Venere, in provincia di La Spezia. Filippo Di Bartola, ristoratore di Pietrasanta, a Lucca, quindi geograficamente poco più sotto, si accoda definendo la situazione “schizofrenica”. Abbiamo provato a indagare quanto sta accadendo e ad intavolare una discussione, che non ha la pretesa di dare risposte ma solleva questioni.
Cambiano i turisti
Qualche mese fa scrivevamo su questa rivista una riflessione sul palato degli stranieri, sottolineando come la conoscenza da parte del pubblico d’oltre confine sia nettamente cambiata. Oggi c’è una maggior confidenza con i sapori italiani e una capacità acquisita di riconoscerli, e di giudicarli come autentici o meno, che merita opportuni accorgimenti da parte dei ristoratori.
È vero altresì che da un anno all’altro cambiano i flussi, e non sembra esserci la possibilità di individuare da quali paesi proverranno i clienti nella stagione successiva. Ce lo conferma Antonella, dell’Antica Osteria al Carugio di Porto Venere, una località ad altissima frequentazione turistica.
“Quest’anno non sembrano esserci gli statunitensi mentre sono molto più presenti i visitatori europei, in particolare dall’est Europa. Questo significa regole diverse, esigenze diverse. Inoltre sta cambiando il modo di vivere la destinazione turistica. In passato l’albergo andava per la maggiore. Oggi molti prendono
case vacanza e ville in affitto, quindi acquistano cibo da asporto (anche al ristorante) oppure si attrezzano con la spesa”.
I dati dello scorso anno ci suggerivano una forbice aperta sul pubblico statunitense, ma per ragioni legate alla situazione geopolitica e commerciale questa forbice si è - almeno apparentemente, staremo poi a vedere i dati effettivi - ridotta molto. E quindi, come ci si relaziona a questo primo stravolgimento del target?
Filippo Di Bartola ci suggerisce: “L’unico modo per rapportarsi a questi improvvisi cambi di fronte è la versatilità. Significa, banalmente, parlare tutte le lingue, sia in senso letterale che metaforico. L’altra condizione obbligata è non indossare il pregiudizio, mantenersi sul proprio posto quando un cliente manifesta un comportamento che non ci spieghiamo fino in fondo. Questo non vuol dire non pretendere che vi sia rispetto nel proprio ristorante, assolutamente no, ma dobbiamo accogliere che ci siano modi di vivere il pasto diversamente dal nostro e che le esigenze vanno studiate”.
In altre parole: apertura. Anche se questo implica sforzi notevoli, ne siamo consapevoli.
Il personale, e tutti i problemi che non sono di sottofondo
L’altro grande tema che emerge pressoché in ogni conversazione intrattenuta oggi con un attore della ristorazione riguarda il personale. È un problema che si intensifica nel periodo estivo per il maggior carico di lavoro, e che non riesce a trovare nessuna risoluzione concreta e duratura.
Antonella allarga la discussione su aspetti che passano spesso in secondo piano ma acuiscono le difficoltà a reperire figure da assumere: “Non si parla


molto di alloggi eppure la difficoltà di trovare alloggi per il personale è diffusa. Sono tantissimi gli immobili destinati all’affitto turistico mentre c’è una grande carenza per chi deve alloggiare per lavoro in una località come la nostra. L’altra faccia, ancora non risolta, è quella legata ai trasporti. Se i dipendenti non sono auto-muniti non possono pensare di affidarsi ai mezzi: al di là del sovraffollamento in determinate fasce orarie il problema è il rientro la sera, con orari incompatibili con i nostri”.
Anche Filippo aggiunge un tassello: “Se prima si lavorava a fisarmonica con le stagioni, nel senso che c’era un cambio passo dalla settimana di Pasqua in avanti, che sanciva l’avvio effettivo della bella stagione, oggi le variazioni settimanali sono improntati. La maggior parte delle prenotazioni si concentra nel fine settimana e questo genera sicuramente un grosso problema di gestione del personale”.
Un altro fattore, poco citato, è quello della concentrazione. O meglio, della de-concentrazione. Lo rimarca l’imprenditore di Pietrasanta.
“Affrontare queste nuove dinamiche, queste settimane a fisarmonica, è complesso dal punto di vista della performance perché lavorare in modo scostante influisce sulla concentrazione. E allora come intervenire? Noi cerchiamo di mantenere alta la soglia della concentrazione con eventi, serate, incontri, l’attività di banqueting. Insomma con iniziative di vario genere che possano aiutare il team a tenersi attivo ed energico”.
Non è la prima volta che discutiamo di social e di aspettative stimolate dai social. Con Di Bartola la conversazione si è incentrata anche su questo, perché il cliente di oggi è molto, molto diverso da quello che qualche anno fa lasciava il telefono in borsa quando era al ristorante, e non lo utilizzava per conoscere tutto di un locale ancora prima di andarci, come avviene invece oggi.
“Sembra che i motivi per cui si esce a pranzo o a cena siano cambiati per molti. Da un lato il cliente spende di più rispetto a prima, quindi vuole andare a colpo sicuro. Dall’altro però noto una certa attenzione per il fattore “contesto”, ovvero la tendenza a immortalare il panorama, l’ambiente, senza essere davvero concentrato sull’esperienza a tavola, anzi sul momento a tavola. Proprio in queste ultime settimane sto valutando di togliere le nostre attività di ristorazione dai social. Ci stiamo chiedendo: apportano davvero qualcosa in più? La risposta che ci diamo è che i social forse più che aggiungere sottraggono, perché anticipano le emozioni sciupandole, privando la persona intenzionata a sceglierci di vivere liberamente la circostanza, di farsi una propria idea del ristorante”.
Gli storici che non contano e una situazione economica al limite
“Se fino a prima del 2020 c’erano delle certezze, delle consuetudini che si ripetevano di anno in anno, da allora siamo senza regolarità. Ogni stagione presenta variabili

nuove, paradigmi che non possiamo anticipare”.
Lo dice con fermezza Antonella, che da anni lavora nella ristorazione. Una tendenza positiva, però, si sta affermando e consolidando, anche nel suo locale di Porto Venere: “C’è più preparazione da parte dell’ospite. Con un pizzico di orgoglio apprendiamo che tanti sanno cosa siano i muscoli ripieni, per esempio, o la mesc-ciüa, la nostra zuppa tradizionale. Questo significa che si informano, arrivano preparati, e questo è un dato che conforta”.
Dall’altra parte l’inutilità - passateci l’accento grave - dei dati delle precedenti stagioni non aiuta a fronteggiare una situazione già molto complessa dal punto di vista economico. Prevedere, per programmare, è praticamente impossibile. Antonella rivolge un pensiero anche ai fornitori, che vivono un momento altrettanto complesso, spesso trovandosi ad assumere delle decisioni mai prese finora.
Anche Filippo Di Bartola ci racconta di un sistema davvero sul filo del rasoio.
“Rileviamo degli aumenti di prezzo davvero importanti da una settimana all’altra. Naturalmente non possiamo farli pesare agli ospiti, quindi li assorbiamo fino a dove riusciamo, anche perché dall’altro lato è diminuita sensibilmente la capacità di spesa”.
Dobbiamo tenere conto anche di una progressiva disaffezione al mondo della ristorazione, perché anche questa è una tendenza che non si può ignorare. La giustifichia-

mo con la troppa mediaticizzazione del cibo degli ultimi anni.
Non c’è una regola magica, un vademecum che possa dare soluzioni efficaci ai problemi che abbiamo riportato anche grazie alle esperienze dei due ristoratori. Tuttavia c’è un pensiero, con cui ci ha congedati Filippo Di Bartola, che sosteniamo: “Tutti questi fattori stimolano la necessità di rielaborare le attività. Non si può ragionare allo stesso modo se le condizioni sono cambiate”.
Dire che bisogna prendersi del tempo per rielaborare il proprio modello di business può sembrare inopportuno, soprattutto perché ci troviamo in un contesto in cui qualsiasi investimento diventa cruciale e il tempo è davvero denaro. Ma procedere senza intervenire, aspettandosi che le tempeste si plachino, temiamo non ci porti lontano. Qualunque sia il settore di riferimento.
Autrice: Simona Vitali
Clicca e leggi l’articolo sul web
Oltre ad esperire quotidianamente il paradosso di trovarmi di fronte a una generalizzata dequalificazione degli alberghieri, incasellati troppo spesso fra le scuole di serie B, cosa che ritengo un clamoroso autogol che non fa bene al settore, devo pure assistere alla diatriba interna alla categoria che vede le scuole alberghiere guardare con aria di sufficienza alle scuole professionali. Ai fini della professione, e al netto delle differenze in termini di didattica, entrambe sono chiamate, oggi direi acclamate, a portare il loro contributo al settore. A cosa giovano queste diatribe quando ci sono attività che sanguinano, perdono terreno ogni giorno, costrette a ridurre le aperture o, peggio, ad abbassare le saracinesche?
Siamo arrivati al punto in cui si ricorre a figure non qualificate, che hanno fatto altri studi, e ci si mette di buona lena per insegnargli completamente il mestiere (c’è da dire che questo riserva anche buone sorprese). Si può o no arrivare a ragionare su un fronte unificato volto a mettere in risalto gli aspetti positivi e gratificanti del lavorare nella ristorazione (che ci sono, come confermano tutti coloro che hanno scelto di lavorarci e continuano a farlo), rendendo più attrattivi gli studi per poterci arrivare?

Senza pensarci neanche troppo conviene, converrebbe a tutti. E anche una volta che si compie questa scelta di indirizzo non bisogna sprecare le occasioni, motivandoli questi ragazzi, perché completino il percorso con l’intento di proseguire sulla stessa strada. Sappiamo bene quanto sia alta la percentuale di dispersione scolastica. In tutto questo un ruolo determinante è giocato dai docenti, quelli tecnici in particolare, che devono essere in grado di insegnare in funzione della vita là fuori, fornendo i giusti stimoli ai ragazzi.
Mi trovavo in giuria ad un concorso interno ad una scuola professionale, CFP Nazareno di Carpi, organizzato dal Consorzio Produttori Antiche Acetaie di Modena, ed ero intenta ad ascoltare gli studenti che uno ad uno presentavano la loro ricetta ma soprattutto, a domanda precisa della commissione, trasferivano ciascuno non solo l’intenzione di proseguire il percorso ma indicavano pure la tipologia di ristorazione su cui intendevano spendersi. Cioè mostravano di avere idee chiare. Eravamo di fronte ad un quarto anno, Tecnico dei servizi di preparazione pasti e bevande, anno di specializzazione facoltativa, post triennio. Colpita per quest’onda positiva intravvedo a un certo punto il docente tecnico di laboratorio che fa capolino dalla cucina e riconosco subito Domenico Della Salandra, uno chef molto eclettico e attivo, che ritrovo spesso in eventi di settore ma anche impegnato in progetti innovativi. “Ecco - mi dico - ho capito”.
Mi informo meglio e mi viene comunicato che Della Salandra ha la titolarità per il quarto anno e che quindi prende in consegna ragazzi con cui già i colleghi hanno fatto un buon lavoro negli anni precedenti. Sento che è necessario che mi soffermi sulla figura di questo chef che questi ragazzi li ha “rifiniti” portandoli all’entusiasmo che sto raccogliendo.
Non appena mi è possibile gli chiedo quindi di raccontarmi di lui e delle sue esperienze, perché il suo è un ritratto che voglio delineare.
“Nasco come cuoco – mi racconta Domenico -. Frequento l’alberghiero a Vieste, faccio alcune stagioni in ristoranti locali dove si fa cucina di pesce poi, stanco di vedere gli stessi piatti, decido di trasferirmi a Milano, che mi consente di spaziare (catering, club…). Dal 2009 inizia l’impegno serio presso Il Fioraio Bianchi Caffè, salotto milanese ideato dal noto fiorista Raimondo Bianchi e prende il via la mia partecipazione come assistente al Congresso Identità Golose, per cui seguirò eventi come Identità Expo. Qui inizia un dialogo viscerale con questo mestiere. Nel 2014 avvio Taglio, una sorta di conversione dell’alta cucina in gastronomia/trattoria, progetto innovativo che si è imposto sulla scena milanese per qualche anno. Nel 2016 faccio l’apertura di un nuovo format, San Pietro cafè e nel 2019 seguo il progetto Clotilde Brera, ristorante stiloso e bistrot, con un’ambita terrazza (una delle poche a Milano), finché non approdo alla sfida di gestire i catering di Bulgari Maison, per l’Italia e il Mondo. Nel frattempo entro nel mondo della formazione, tenendo corsi a mercato per Congusto e Italy Smeraldo,


poi divento presidente di commissione per istituti accreditati con la Regione Emilia Romagna. Comincia poi la mia esperienza di docente (laboratorio di cucina) del quarto anno preso CFP Nazareno, secondo un modello che vede alternarsi un mese di didattica/laboratorio a un mese di stage. A partire dal 2021 estendo la docenza, sempre per il quarto anno, a Formal a Bologna. Dal 2020 sospendo la mia attività di chef per iniziare un’esperienza imprenditoriale con l’apertura di Spiga Emilia, un laboratorio di pasta senza glutine a Ferrara. Nel 2022 Forbes lo segnala fra le 100 eccellenze italiane. Segue l’apertura di Estratto Lab, altro laboratorio senza glutine a Milano, dove produciamo non solo pasta ma anche altro cibo tradizionale (panificazione, piatti pronti, dolci…), assicurando un servizio che fra l’altro vuole sgravare la ristorazione, già attanagliata da diverse altre problematiche. Sto lavorando con belle realtà sul terreno milanese”.
Ritratto di Domenico Della Salandra
Essere sulla cresta dell’onda, dentro il mondo che cambia, intercettarli i cambiamenti e ritararsi di conseguenza è un esercizio che riesce in chi ha abbracciato talmente tanto la causa da avercela cucita addosso. Significa a propria volta diventare stimolo di novità, di nuovi modi di vedere.
Domenico è rigoroso e intransigente con i ragazzi quanto a educazione (guai a chi urla, bestemmia, manca di rispetto) tanto per cominciare, e qui si trova perfettamente allineato con una scuola, CFP Nazareno, che dell’aspetto educativo e sociale ha fatto la sua missione.

Non sopporta l’impostazione didascalica delle lezioni, della serie “ragazzi, aprite il libro e andate a pagina 6”, che poi arrivati in laboratorio non sanno dove mettere le mani. “Per non dire che, se mi metto dietro una cattedra, dopo dieci minuti i ragazzi li ho già persi” ci tiene a sottolineare. Purtroppo l’approccio all’insegnamento avviene spesso in fasi professionalmente acerbe. Capita che terminato l’alberghiero si faccia il concorso statale per abilitazione all’insegnamento e si svolti direttamente nella scuola, senza avere fatto esperienza alcuna. “Succede quindi che - riflette Domenico - non conoscendo bene la materia, ci si senta insicuri e si forniscano quindi meno indicazioni possibili per non sbagliare e ci si attacchi ai libri: 'andiamo a pagina 6' appunto”. Uno scenario che abbiamo ben chiaro, essendoci tolti lo sfizio di presenziare pure, come uditori, agli esami di abilitazione professionale per il settore alberghiero, momento decisamente scoraggiante.
Portare la vita dentro la classe, ricreare quelle stesse situazioni che si verificano fuori perché si abbia prontezza psicologica sotto l’aspetto tecnico, professionale, umano ma soprattutto portare i ragazzi alla consapevolezza delle loro capacità, perché si rendano conto di quello che ciascuno può fare, e prepararli di conseguenza, in base alla loro predisposizione. Un lavoro di fino, appunto, ma l’unico modo per instradarli valorizzandoli davvero.
Intendere l’insegnamento come una missione, ragionando sul bene vero da fare, è un atto d’amore verso un settore che ha bisogno di nuova linfa come di respirare.


Un autentico viaggio tra produttori, cuochi, pizzaioli e pasticceri aderenti all’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto per capirne il valore

Parlare di riso è difficile fino a quando non incontri produttori come Riso Buono, il brand dell’azienda risicola La Mondina di Casalbeltrame (NO), e la sua anima, Cristina Brizzolari, che in cinque mosse ti fa capire cose che nessuno ti ha mai spiegato così bene.
Inizia da lei il percorso di questo articolo che trae origine dal manifesto a tutela del riso italiano redatto e promosso dall’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto e che ha registrato l’adesione delle associazioni italiane di settore più autorevoli, per favorire un’attenzione attorno al prodotto che oggi rappresenta l’Italia nel mondo ma che necessita di essere maggiormente conosciuto e valorizzato. L’impegno degli Ambasciatori del Gusto, delle altre associazioni e delle istituzioni coinvolte va in questa direzione. Il Manifesto inizia con questa frase: “Il riso italiano è una risorsa preziosa e noi italiani lo sappiamo bene. Da sempre siamo il primo produttore europeo, con oltre cento varietà coltivate e un milione di tonnellate prodotte nell’ultima campagna. Ogni varietà si declina in una tradizione culinaria che racconta un pezzo del nostro territorio: dal supplì all’arancina, dalla paniscia al risotto, dal sartù alla tiella, specialità diverse che uniscono lo Stivale delineandone la storia, la cultura, l’identità”. L’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto con questo atto ha voluto contribuire a sostenere le produzioni nazionali con l’uso delle varietà di riso italiano e la diffusione della conoscenza delle nostre specialità. Lo sforzo quotidiano è infatti volto alla diffusione della conoscenza e valorizzazione delle nostre produzioni, proponendole costantemente nelle ricette che contraddistinguono l’Italia. “In sinergia con tutta la filiera, Enti e Istituzioni intendiamo continuare su questa strada rafforzando la promozione di questo nobile prodotto anche in contesti internazionali”.
Le cinque mosse di Cristina Brizzolari
È un romanzo la storia di Cristina Brizzolari con il riso. Romana d’origine è arrivata nella storica tenuta risicola piemontese di proprietà della famiglia del marito, Vittorio Guidobono Cavalchini, senza conoscere nulla del riso ma la passione che ci ha messo studiandone ogni caratteristica ha dato vita a un vero e proprio rinascimento agricolo, portando Riso Buono, in una decina d’anni, ad essere il riso più performante nel mondo della ristorazione.
“Mi sono sentita subito parte del progetto portato avanti da Ambasciatori del Gusto, l’unica Associazione che ho scelto di sostenere perché abbiamo in comune la serietà e la passione nel fare le cose; ci sono all’interno chef molto bravi, capaci di lavorare in sinergia; soprattutto, come me, credono molto nel lavoro di squadra, di chi condivide gli stessi valori impegnandosi per diffondere l’identità italiana in tutto il mondo” racconta Cristina, prima di spiegarmi come si fa, in cinque mosse, a riconoscere un riso veramente buono.
“Mi sono sgolata per anni a spiegare le caratteristiche del riso ma non riuscivo a farmi capire fino a quando non ho adottato il metodo americano del bullet points. Bullet vuol dire proiettile. Lo scopo di un bullet points è colpire chi ti ascolta con un’informazione semplice ed efficace. Ne ho elaborati cinque e con quelli
adesso riesco in un’azione fondamentale per far capire il valore del mio riso. Il primo parte dal seme: le varietà per fare un risotto sono Carnaroli, Arborio, Vialone Nano. Ma queste varietà storiche, nel corso degli anni, hanno subito profonde trasformazioni dovute a fattori climatici, malattie ecc… cosa è successo allora? Che le case sementiere hanno creato varietà similari che si possono definire in etichetta come Carnaroli, Arborio o Vialone Nano ma se non è accompagnato dalla dicitura Classico non è vero Carnaroli o vero Arborio. Per l’Arborio il 90% del riso prodotto in Italia è è costituito dalla varietà Volano. Secondo bullet points: il riso buono non deve essere bianco ma ambrato. Quindi bianco non vuol dire buono! A me non interessa che sia bello, a me interessa che il riso non scuocia e che in cottura sia al dente e che il mio risotto venga con la cremina giusta. Più tu lo pili, con una pilatura industriale e non a pietra lentamente, togli tutti i valori organolettici dal riso, oltre a eliminare la parte superficiale del riso per cui l’acqua penetra immediatamente e mi scuoce il chicco. Terzo bullet points: le rotture nel riso. Pilando troppo i chicchi si rompono. Esiste un margine di tolleranza delle rotture: un riso, per definirsi di qualità, non deve avere più del 35 di rottura del chicco. Il mio ha lo 0,50%. I chicchi rotti non entrano nella confezione e vengono utilizzati per fare farina di riso. Quarto bullet points: la gemma del riso. Quella gemma è la parte che ha più nutrimento, più grassi anche nel riso, più sapore, più odore, più tutto. Basta che lo pili in modo delicato, rimane la gemma necessaria per il tuo risotto per renderlo più saporito, più profumato, più qualitativo. Quinto bullet points: l’invecchiamento del riso. Non è che lo faccio perché
è di moda, per me è una rogna enorme fare invecchiamento. Sto col riso fermo per un anno, non guadagno, pago la corrente perché lo devo tenere a temperatura controllata, sedici gradi per tutta l’estate, praticamente da maggio con dei mega silos refrigerati in cui tengo controllata l’umidità e la temperatura. Però con l’invecchiamento l’amido si fissa nel chicco, quindi il chicco si chiude e l’amido rimane dentro. In più il chicco matura in maniera omogenea mentre se lo raccolgo e lo lavoro subito non do al chicco il tempo di stabilizzarsi con il rischio di non tenere la cottura”.
Cristina Brizzolari prosegue nella conversazione fornendo i dati sulla produzione attuale: “Sono 223.000 gli ettari di risaie in Italia e il Piemonte è il primo produttore per il 51%. L’Italia è il primo produttore europeo con il 50% del totale UE. La produzione si aggira su 1,3 milioni di tonnellate di cui circa 950.000/1.000.000 vengono esportate e le principali destinazioni sono Francia, Germania, regno Unito e USA. Importiamo circa 150.000 tonnellate all’anno da paesi come India, Pakistan, Cambogia”.
Stati
Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere lo chef Michele Casadei Massari, fondatore ed executive chef di Lucciola Italian Restaurant a New York, oltre ad essere rappresentante di noti marchi come il Parmigiano Reggiano e Associato agli Ambasciatori del Gusto.



A lui abbiamo chiesto qual è il grado di percezione del riso italiano negli Stati Uniti e questa è la risposta: “Negli Stati Uniti, il riso italiano viene percepito come un prodotto di nicchia, altamente qualitativo e carico di tradizione. In particolare, nel mondo della ristorazione di fascia alta, varietà come il Carnaroli, il Vialone Nano o l’Arborio sono ricercate per la preparazione di risotti autentici e raffinati. Il riso italiano è sinonimo di tecnica, di “sapere fare” agricolo e gastronomico. La sua identità è fortemente legata all’idea di cucina regionale, di stagionalità, e di eleganza nei piatti. Tuttavia, il consumatore medio americano e molte cucine commerciali sono ancora più familiari con il riso asiatico, in particolare basmati, jasmine, o riso da sushi, per la loro diffusione nei format fast-casual e nei piatti internazionali. Per questo motivo, c’è ancora ampio margine di crescita per la conoscenza e l’utilizzo del riso italiano, soprattutto educando sul valore della qualità, della resa in cottura, e della versatilità. Nel mio lavoro quotidiano con Lucciola, nei progetti con grandi brand internazionali e nei miei eventi privati, il riso italiano è sempre un protagonista elegante e distintivo, soprattutto quando si vuole raccontare una storia di eccellenza agricola e gastronomica italiana”.
Una seconda domanda di attualità è legata al tema dei dazi: quale effetto avranno sull’esportazione del riso italiano negli Stati Uniti?
“L’introduzione o l’inasprimento dei dazi doganali sull’importazione del riso italiano negli Stati Uniti potrebbe avere effetti molto dannosi, sia in termini economici che culturali. Il rischio principale è che i ristoratori, già messi alla prova da margini sempre più stretti, scelgano alternative più economiche e disponibili localmente o da mercati sen-

za dazi. Questo impatterebbe negativamente non solo sulle esportazioni dirette, ma anche sul posizionamento del riso italiano come prodotto simbolo del Made in Italy gastronomico. Dazi più alti rischiano di rallentare la diffusione di una cultura culinaria italiana autentica, in un mercato che invece ha dimostrato negli ultimi anni una crescente curiosità e rispetto per la nostra tradizione. Io credo molto nel lavoro congiunto tra produttori, chef, importatori e media per mantenere viva l’attenzione sulla qualità e sull’identità del prodotto. Il riso italiano non è solo una materia prima: è una storia di territori, di mani esperte e di eccellenza agricola che merita di essere raccontata e protetta”.
La farina di riso, un ingrediente impalpabile ma fondamentale
È con gli Ambasciatori del Gusto Gianni Di Lella e Manuel Marzari che parliamo dell’utilizzo della farina di riso. Il primo è un pizzaiolo, il secondo un pasticcere. Gianni Di Lella, titolare della pizzeria La Bufala a Maranello (MO), è un pizzaiolo che ha fatto della curiosità uno stile di vita, portandolo a conoscere e a collaborare con gli chef famosi del suo territorio come Massimo Bottura e Luca Marchini, anche loro Ambasciatori del Gusto, con i quali ha inventato pizze particolari: Come una lasagna e Pizza Borlengo i nomi. Ma anche a incontrare Cristina Brizzolari e la sua farina di riso.
“Sei anni fa sono entrato negli Ambasciatori del Gusto e ho conosciuto Cristina, la sua passione, la qualità che c’era in ogni chicco del suo riso. Da quel momento ho cominciato a sperimentare sulle mie pizze e sulle mie focacce la sua farina di riso scoprendo un gusto nuovo. La bellezza era data dall’emozione di vedere il colore stupendo, un viola fantastico, che prendeva forma in cottura, sentirne il profumo del riso. Le focacce che preparo, con la fermentazione
alla birra e la farina di riso integrale, si trasformano in un racconto che fa impazzire i miei ospiti, sia in pizzeria che nei catering che faccio”.
Ma in che percentuale utilizzi la farina di riso negli impasti?
“In molti si bloccano di fronte a questo ingrediente. Dicono che non contiene glutine e quindi non sanno come usarla. Io sostengo che, come in tutte le cose, ci vuole studio e sperimentazione: la farina di riso va utilizzata in percentuale dentro un impasto classico, nel mio caso un 3%, e ti dà un colore eccezionale utilizzando quella integrale, l’Artemide di Riso Buono. Nel gusto si sente il profumo di tostato che i miei clienti hanno colto benissimo pretendendone il racconto”.
Quanto tempo hai dedicato a questa sperimentazione?
“Un mese di prove per trovare la giusta quantità nel mio impasto che fa due giorni di maturazione”.
Dalla pizza ai dolci il salto è notevole ma Manuel Marzari nel suo atelier di pasticceria a Verona ci spiega il rapporto tra fisica, chimica e arte che contraddistingue il suo metodo di pasticceria innovativa
“Voglio dare alla pasticceria quegli elementi di innovazione necessari a renderla, oltre che squisita, fonte di benessere. Fa parte della mia storia familiare e della mia cultura gastronomica. Fin da piccolo mia madre mi ha insegnato a mangiare sano ed equilibrato, spezzando la dieta settimanale con diverse preparazioni dove il riso era una componente fissa. Forse è stato questo che mi ha portato a sperimentare la farina di riso non solo come componente gluten free ma come ingrediente innovativo in molte altre
preparazioni dolci. La farina di riso tostata la utilizzo moltissimo sulle basi di emulsioni, sostituendo anche il burro con l’olio, per cercare una soluzione alle intolleranze e creando dolci innovativi”
In quali dolci e in che percentuale inserisci la farina di riso?
“In tutti i prodotti da prima colazione e in diversi dessert. Aiuto la farina di riso con un sostegno proteico, con legumi e ceci. Ho creato il mix con percentuali che cambiano in funzione del prodotto, dal 15 al 20%, utilizzando anche addensanti naturali che aiutano a legare amidi, proteine, zuccheri e liquidi. La pasticceria è formata da tanti elementi e questo, a volte, mette in crisi, ma bisogna sempre sperimentare in questo campo. Ogni giorno sono in fase di sviluppo perché la materia prima cambia sempre dando vita a un gioco costante e in continuo movimento. La mia filosofia è questa: mangiare un dolce non deve far male”.
Finisce qui il nostro viaggio nel mondo del riso dove abbiamo capito perché questo prodotto, simbolo dell’Italia gastronomica, sia stato oggetto di un protocollo d’intesa tra Ambasciatori del Gusto e l’Ente Nazionale Risi che, utilizzando le conoscenze, le competenze e le informazioni in possesso di entrambi, intende: promuovere la conoscenza del riso italiano, materia prima pregiata ed eccellenza italiana del patrimonio agroalimentare; approfondire i temi relativi alla trasformazione del prodotto, agli strumenti tecnologicamente innovativi e alla preparazione delle ricette che contraddistinguono l’Italia; valorizzare la produzione del prodotto, proponendolo costantemente nelle ricette che contraddistinguono l’Italia.


Autrice: Simona Vitali

Clicca e leggi l’articolo sul web
Ho conosciuto un progetto poliedrico, intrigante, estremamente dinamico e lo voglio raccontare. L’ho conosciuto seguendo il filone della cucina ma in realtà mi sono trovata proiettata in una dimensione più grande, e direi originale, concepita come una cittadella gastronomica a cielo aperto da giugno a settembre, per cambiare vesti nel periodo autunno/invernale.
Un format costruito per step e aggiustamenti nel corso degli anni, che dalla scorsa stagione ha trovato il suo compimento, delineandosi come un progetto di senso.
Da qualche tempo mi ero riproposta di far visita allo chef Jacopo Iecci, conosciuto al Forte Village quando lavorava per Giancarlo Perbellini, che ho saputo aver preso le redini della cucina di Terrazza Oliva a La Spezia. “Ti aspetto – mi aveva detto – ho un bel progetto da raccontarti”.
La Spezia non è certo la piazza di Milano, quando senti che un nuovo progetto va ad arricchire una città di cui in termini gastronomici si parla ancora troppo poco non sei che contento. Anzi lo sei di più. La città
sta crescendo molto, ormai c’è turismo tutto l’anno ma sono ancora pochi coloro che riescono a far apprezzare la cucina del territorio. È sull’identità che bisogna lavorare di più e meglio.
“Andiamo un po’ a vedere cosa sta succedendo” mi sono detta. Mi porto sul lungomare di La Spezia fino a raggiungere il civico 2 di Viale Diaz dove mi imbatto in un edificio singolare, calato in uno spazio verde, che un cartello battezza come PIN, In Pineta La Spezia. Scoprirò poi che quell’edificio, conosciuto come Centro Allende, è stato realizzato ad opera dell’architetto Franco Oliva che, tanto ha contribuito ad alimentare il tessuto culturale di La Spezia con le sue opere, entrate nella storia dell’architettura ligure di quel periodo. In quel limbo che si colloca tra il lungomare e il centro storico mi approssimo innanzitutto a vivere la mia cena, ma nella testa iniziano inevitabilmente a frullare domande. Con calma ne parleremo all’indomani, ora lo chef è assorbito dalla cucina, che poi è il motivo principale della mia visita.
Una tovaglia bianca linda, che apprezzo sempre molto, una gerbera rosa svettante da un bicchiere, un menù pulito nella grafica sono il “mi presento” di Terrazza Oliva, che non tarda a incuriosirmi con le sue entrée gustose, acchiappanti, che già lasciano percepire una mano felice, con una bella sensibilità. Non tardo a rilevare che quella di Jacopo Iecci è una cucina che ha il grande pregio della comprensibilità: il palato riconosce distintamente gusti e sapori, sempre estremamente piacevoli, per una equilibrata capacità di combinare gli ingredienti fra loro. Non disdegna di creare acco-
stamenti particolari, con conoscenza e buonsenso. Ama dare più facce a uno stesso prodotto proponendone diverse interpretazioni, come nel caso del riuscitissimo Zucchina, zucchina, zucchina e gli piace arricchire il piatto di qualche piccolo particolare inaspettato: come quei Ravioli ripieni di solo latte, cipolla Nino Bergese, aria di bacon e guanciale croccante che scoppiano letteralmente in bocca, piacevolissima sensazione, o quelle bag di crema pasticcera di vaniglia (mini saccottini trasparenti ripieni di crema gialla) a dare originalità al dolce più semplice e strepitoso del menù: Ricotta dell’appennino tosco emiliano e zuppetta di fichi. Incuriosire il cliente con una cucina dove il menu cambia ogni mese e mezzo (altro che limitarsi a fare spaghetti e muscoli!) mostrando che anche qui il territorio c’è (ed è mare e entroterra), è certamente l’intento che sta trovando un diffuso riscontro.
Nei trascorsi di Jacopo Iecci ci sono belle esperienze lavorative accanto a chef con lo slancio di formare veramente, di tramettere sapere, che non è cosa scontata. Si è sempre più gelosi del proprio e poco propensi a insegnare, nelle cucine di oggi.
L’imprinting è partito dallo chef Gianni D’Amato, all’epoca del Rigoletto. “Di lui – ci racconta Jacopo - ricordo la maniacalità per la materia prima: tutte le nicchie le andava a scoprire. Abbiamo girato tanto. Ha aiutato a crescere il territorio emiliano, ci ha investito molto. Quella di Gianni D’Amato è una grande famiglia: ha dato la vita per la ristorazione e, da sola!, è stata chiamata a risollevarsi da quel terribile terremoto… Ho saputo della recente apertu-


ra della D’AmatOsteria e del successo che sta registrando. Mi auguro, prestissimo, di riuscire ad andarli a trovare.
Un’altra esperienza significativa per la mia formazione è stata con lo chef Andrea Mattei presso La Magnolia all’Hotel Byron di Forte dei Marmi. Lì ho compreso cosa significa affiancare uno chef con una visione ducassiana. E poi mi è rimasto quel suo sostenere che puoi essere andato ovunque ma se non sei riuscito a capire il perché un piatto lo si cucina così allora non hai capito niente. A seguire ho trovato in Giancarlo Perbellini un maestro di vita, di professione, di stile che alla formazione tiene tantissimo. Un professionista formato alla scuola francese dove il concetto di stile è completamente differente. Tre chef solidi, dalla forte ispirazione culturale”.
La freschezza di cocktail bar e sala
Nel corso della serata la mia attenzione viene calamitata anche dalla sala, grazie alla freschezza di Carolina Via-

ni e dei suoi ragazzi, Eduardo Perez e Matteo Ascoli
Un vero piacere interloquire con loro all’arrivo di ogni portata, mentre un occhio corre al grande bancone del cocktail bar, da cui Adriano Arcoraci, mi fa arrivare al tavolo un gin dai profumi mediterranei su cui spicca il basilico, così morbido e asciutto al tempo stesso da farmi decidere di pasteggiarci fino alla fine, cosa inusuale per me, senza provare il benché minimo bisogno di passare al vino.
Sta di fatto che a quell’appuntamento, che all’indomani avrebbe dovuto essere solo con Jacopo, decido di invitare anche Adriano e Carolina, pure loro figure interessanti da conoscere.
Quando di buon mattino ci incontriamo, scopro che questo grande spazio denominato PIN, frutto della lodevole volontà di rigenerare un luogo radicato nella città (il Centro Allende e l’area Pinetina), nasce dall’idea di Leonardo Pischedda e Alessandra Traini di Artificio 23

(società di programmazione culturale e intrattenimento), che a loro volta hanno coinvolto gli imprenditori Cristiano Ghiranda, Paolo Barberis e Riccardo Lia, per alzare il livello dell’offerta turistica e di intrattenimento e, possibilmente, trainare altre attività.
Da Cocktail bar, quale è all’inizi,o questo spazio si trasforma in Club (discoteca) e poi si declina in ristorante con una sua anima ben precisa e street food di qualità, senza contare la possibilità di ospitare eventi di qualsiasi natura (teatrali, musicali, sportivi…), da giugno a settembre, da mattino a sera. Questo grazie al coinvolgimento, a partire dalla scorsa stagione, di Adriano Arcoraci, figura molto nota nell’ambiente mixology per il suo brillante percorso professionale, qui nel ruolo di general manager. La sua visione ha consentito di inserire le persone giuste al posto giusto, a partire a da Carolina in sala, con il suo desiderio di far rivivere quell’ospitalità che solo un oste sa dare, come la sua famiglia in attività le ha insegnato. Con Jacopo Adriano e Carolina si sono conosciuti in occasione di un evento Yamaha, organizzato la scorsa estate giusto in PIN, dove lo hanno chiamato a collaborare. “Di Jacopo ce ne siamo innamorati – mi confida Carolina - e abbiamo fatto di tutto per averlo stabilmente qui con noi. Lui si è preso tempo per pensare poi è diventato dei nostri”.
I contributI di Jacopo Iecci al progetto PIN
A quel punto lo chef ha iniziato a fare innesti per ciò che era di sua pertinenza: l’aspetto gastronomico. Se c’è un comandamento a cui ha imparato ad attenersi nel suo percorso professionale quello è la ricerca della qualità, ovunque, per cui oltre ad improntare una cucina di un certo tenore (senza con questo avere a
disposizione chissà quali spazi), supportato dal promettente sous chef Jurgen Gika, si è poi preoccupato di alzare l’asticella quanto allo street food, organizzato in casette dislocate sul perimetro dello spazio esterno di PIN, che ospita una bella isola di tavolini e un grande palco per gli eventi. Sono così nate partnership con realtà importanti del food nel panorama nazionale, oggetto a loro volta di riconoscimenti, riservandosi la titolarità del Liguria street food, brand incentrato sui testaroli della Lunigiana: “pasta di speciale qualità (prodotta artigianalmente e più sottile di quella che si trova di solito sul mercato) che – mi spiega Jacopo - per la bassa percentuale di glutine può essere consumata anche dagli intolleranti al glutine. Non gonfia, ha proprietà nutritive importanti, riempie, è sostanziosa e, soprattutto, è del territorio. La proponiamo col pesto, con ragù ai muscoli e come testa tacos, arrostito, farcito con salumi e chiuso a tacos”. Proviamo solo a immaginare cosa significhi tener testa a un simile e complesso impianto attivo a pieno regime nel periodo estivo, tra fuori e dentro, dove da un certo orario si attiva anche la discoteca (all’interno). “Di fatto – ci racconta il general manager – ci è chiesto di avere una buona capacità di problem solving e un piano B alla mano. Una cosa è certa: si è creata una squadra molto coesa, sulla stessa linea d’onda, per cui ognuno facendo bene il suo contribuisce a un equilibrio più grande”.
Ammirata!
Viale Armando Vittorio Diaz, 2 19121 La Spezia
Tel. 0187 919829

Autrice: Giulia Zampieri
Clicca e leggi l’articolo sul web

Foto: Gianmarco Garau
Negli ultimi tempi parlare di emozione risulta davvero cacofonico. Questa parola così delicata, e al tempo stesso potente, che descrive lo scuotimento, l’energia, il ponte tra noi e fuori, è stata svuotata di significato, in particolare quando viene spalmata su ristorazione, vino e ospitalità come fosse burro. Molta responsabilità è in capo allo storytelling; la comunicazione moderna ne ha fatto il perno ormai da tempo, compromettendola in credibilità e valore. Banalizzandola, purtroppo. Dopo aver conosciuto Sabor’e Mari, a Teulada, e Alessia Madeddu, che lo gestisce dal 2023, ci siamo chiesti se non valesse la pena ripescare questa preziosa parola dal vocabolario. Ci siamo risposti che era necessario: a volte bisogna lasciar andare i termini che abbiamo bandito dal nostro linguaggio per ricucirli addosso alle situazioni che lo meritano. Solo così si difende l’autenticità di una parola, di un luogo, delle persone. E quindi aspettatevi di incontrare qualche emozione in questo racconto. È dovuta.

L’affaccio su Porto Budello
Viaggiare lungo la costa sud occidentale della Sardegna è un esercizio di concentrazione. La bellezza della strada che sfiora il mare, muovendosi rapidamente verso l’alto e verso il basso, verso destra e verso sinistra, tende a portare la testa da un’altra parte. Un buon suggerimento è sfruttare gli angoli sicuri per godersi il vento e le vedute.
A un certo punto, spostandosi da Tueredda in direzione Porto Pino, s’incontra la Torre del Budello, affacciata sull’omonimo porto. Lì, di fronte ai pescherecci e ai barchini, alle reti da pesca e agli attracchi, c’è Sabor’e Mari, che porta ancora la scritta “ittiturismo”. Difficile prevedere di quali colori si tingerà il cielo, se andate al tramonto, ma è davvero una sollecitazionepardon, emozione - che vale la pena vivere in silenzio, dimenticandosi l’ora e tutto il resto.
“Scusaci il ritardo, eravamo in orario ma il tramonto e la pace si sono messi in mezzo”.
Alessia non tarda a rispondere alle nostre scuse, sfoggiando subito l’accento sardo e un sorriso posato: “Avete fatto bene. Ci piace pensare che le persone vengano qui anche per questo, non capita tutti i giorni”.

Alessia Madeddu
Sono passati diversi mesi da quella frase ma rimane impressa: è la consapevolezza di chi sa di vivere in un luogo speciale e lascia il tempo agli altri di rendersene conto.
Il sole sembra scendere più lentamente, a Porto Budello. La luce si esprime oltre le sagome della costa e sull’acqua lenta del porticciolo. C’è un piccolo giardino davanti al locale, qualche tavolo sotto le fronde di un albero. Il “Sabor‘e mari” - il sapore del mare - nel silenzio, si sente stando anche solo stando all’uscio, ma vale la pena entrare.
Territorio e identità, dietro ad una semplice insegna
“Sono nata in un contesto di cucina tradizionale e familiare. Da quando ho preso l’attività, che prima offriva piatti semplici e casalinghi, ho sentito il desiderio di portare una cucina diversa, innovativa, in cui convergessero laguna, mare e orto. Innovativa non significa estranea al luogo, anzi. Piuttosto improntata sulla freschezza e sull’identità, supportata da tecniche di cottura e lavorazione contemporanee”.
Alessia è cresciuta a contatto con la gente, in sala, in


quello che era l’ittiturismo di zia Laura e del padre Alessio, ma ha anche frequentato un’accademia di cucina e ama il mondo del vino, in particolare dei piccoli produttori che inevitabilmente popolano la sua carta dei vini. Tra gli spazi ariosi di Sabor’e mari si muove con leggerezza, posando occhi e mani su qualsiasi dettaglio ne abbisogni. È un vero piacere vederla all’opera, ascoltarla mentre racconta la natura delle sue scelte. Sempre senza dilungarsi, a meno che non glielo si chieda.
“Abbiamo deciso di portare da subito il pesce povero nel menu, di valorizzarlo con le preparazioni e il racconto. Non è una scelta di comodo ma di etica e cultura. È anche sbagliato chiamarlo povero perché non esistono pesci di serie A e di serie B; questo approccio puramente commerciale ha impoverito il mare e ci domandiamo dove andremo se non iniziamo a puntare sulla qualità e la misura anziché sulla quantità”. Non tutti i clienti hanno reagito allo stesso modo: c’è chi si è affacciato incuriosito e chi, adagiato nel solco dell’abitudine, non ha sposato il cambiamento. Altri, poco alla volta, si sono ricreduti. Il movimento che si è
generato però la dice lunga sul futuro di Sabor’e mari. “Ci auguriamo di far ricredere le persone. Per certi versi è più semplice con chi viene da fuori. Molti non sanno cosa sia una salpa, tanti non hanno mai assaggiato una muggine. Sono pesci di laguna che richiedono conoscenza. La salpa, per esempio, è buonissima! È un pesce erbivoro, vive in ambiente salmastro e va lavorato subito. Se non avessimo totale dimestichezza non potremmo servirlo”.
Nel menu compaiono anche salumi e salsicce… di mare, naturalmente.
Si alternano sapori forti e morbidi, spesso nuovi. Non mancano i vegetali, raccolti dall’orto di proprietà, e gli scarti non sono scarti, perché vengono recuperati con altre preparazioni, come le lische impiegate per inspessire in sapore i fondi.
“Ci piace pensare che le nostre scelte generino sorpresa. L’emozione a tavola è veicolo di un messaggio”. Anche se l’abbiamo depennata, per le ragioni sopracitate, non è proprio l’emozione ciò che ci portiamo a casa quando la porta di un ristorante si chiude alle nostre spalle?
Tutti sullo stesso piano
Alessia, non l’abbiamo detto, ha meno di trent’anni. Sono giovanissimi anche i suoi collaboratori e l’aria che si respira, quando si è a tavola, è quella della condivisione e della parità.
“Viaggiamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo consapevoli che da soli non si può fare nulla quindi mettiamo in mezzo le nostre idee portando rispetto per quelle degli altri. Io, personalmente, cerco di dare ascolto alle esigenze di tutti. Nessuno qui lavora per me… piuttosto direi che tutti lavorano con me”.
Ora in cucina ci sono Luca Bertocchi e Simone Faedda; in sala, da quest’anno, c’è Filippo Lampis che si occupa dei miscelati, alcolici e analcolici, realizzati a partire da erbe e vegetali locali, tramutati in liquori e sciroppi.
L’obiettivo condiviso, leggiamo tra le righe della conversazione con Alessia, è diventare meta. Nel senso di muovere le persone fino a Porto Budello per capire questo luogo, scoprire una proposta diversa da ciò che c’è intorno, portarsi a casa uno scorcio in cui natura, cucina e persone s’incontrano con delicatezza e riservatezza.
“Questo è sicuramente il primo obiettivo. L’altro è quello di de-stagionalizzare il locale, ovvero tenerlo aperto quasi tutto l’anno e far conoscere questo tratto della Sardegna in vesti insolite. E poi vogliamo crescere, continuare a studiare, fare ricerca. Nella ricerca c’è la strada per gestire un’attività all’insegna del rispetto per l’ambiente, le risorse e il territorio”.
La voce di Alessia si rompe quando ci racconta la sua storia e il legame con il padre che da tre anni non c’è più. Con questo posto Alessio era intrecciato davvero, lo rappresentava.
Le pareti, gli oggetti, i piatti e il cibo erano impregnati di uno stile diverso, più verace e senza troppi fronzoli. Da quando se ne occupa Alessia, l’anima vera, identitaria, del sapore del mare, non si è sciupata ma si è unita all’eleganza e alla cura.
Non abbiamo mai trovato opportuno entrare nella sfera personale di chi viene raccontato in questo magazine, e non lo faremo questa volta. Ma siamo certi che il sentimento che vive in questo luogo arrivi sulla pelle di chi prende posto in sala. Si acuisce quando si apprende che dietro c’è la forza di affrontare il cambiamento, anche quando è improvviso e doloroso.
“A facci manna è un modo di dire sardo - tradotto “a viso aperto”(ndr) - che indica saper prendere di petto tutto quello che ti presenta la vita. Prenderlo di petto… ma per me anche con la capacità di evolvere” ci suggerisce Alessia.
“A un certo punto, dopo la scomparsa di papà, mi sono

chiesta: perché rinunciare a un luogo che amo? Non è stato facile ma ho scelto di continuare a starci dentro evolvendolo nel modo che più mi rappresentava”. Niente da dire sui detti regionali… ma Alessia sembra averlo più accolto, che preso di petto, il cambiamento. Sarà anche per questo che da Sabor’e mari, alla sera, dopo cena, è bello fermarsi fuori ad ascoltare. Oltre al mare, che marcia piano, si avvertono le originali vibrazioni che questo luogo ancora oggi emana… grazie a lei.
Sabor’e mari
Località Porto Budello 09019 Teulada (SU) Tel. 331 218 7025
Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web
Era il 2020 quando intervistai per la prima volta Dario Cilento, giovanissimo maître di sala al Pavillon
Ledoyen di Parigi, il locale dove Yannick Alléno detiene le tre stelle Michelin. L’intervista si chiudeva con questa domanda: da grande cosa pensi di fare?
“Vorrei aprire un mio ristorante. È il sogno di tutti quelli che hanno questa professione nel cuore. Ma vorrei aprirlo in un luogo che mi possa dare qualcosa e a cui il mio locale possa infondere uno stile di vita. Non importa la classificazione, va bene anche una semplice trattoria ma con un’anima vera”.
Zazà vini vinili vivande
Estate 2025, Sorrento: un giovane italiano dalla mente brillante torna a casa da Parigi, con un’esperienza internazionale che decide di mettere a disposizione del suo paese.
“Certo, un po’ mi manca la dimensione del ristorante tristellato, mi manca l’organizzazione di quella struttura, la ricerca della perfezione a tutti i costi. – ci racconta Dario Cilento – Ma qui sto trovando tutto quello che desideravo: il rapporto diretto con i produttori locali, con gli ospiti, la fantasia all’ennesima potenza, il gusto delle cose buone”.
Quel qui ha un nome: Zazà vini vinili vivande! Dario Cilento lo ha aperto da un paio di mesi in piazza Angelina Lauro a Sorrento e, in questo lasso di tempo, ha già cambiato quattro volte il menu.
“Ogni volta che nella mia selezione di prodotti, per l’80% del territorio, il resto mondo, ne entra uno nuovo cambio il menu” prosegue Dario, che nel raccontare come è nato il nuovo locale sprizza entusiasmo da tutti i pori.
“Mi sono confrontato con la mia ragazza che di mestiere fa la psicologa. L’unica certezza che avevo era dedicarlo a una figura che, nella mia vita, è stata di grande riferimento: mio nonno Zazà! Per il resto ci siamo confrontati sulle mie passioni: il vino in primis. Bene, mi dice Martina, allora apriamo un’enoteca.

Dario Cilento e i suoi ospiti

Però mi piacciono anche le produzioni locali: mozzarelle, alici di menaica, i pomodori di Sorrento, i mieli del Cilento, i sott’oli, i formaggi, l’olio extravergine d’oliva. Li aggiungiamo e facciamo un’enoteca con uso di cucina, è sempre Martina a suggerirmi. E la musica, l’altra mia grande passione? Non ce la mettiamo? Nasce in questo modo Zazà vini vinili vivande. E uno dei complimenti più belli e sinceri me l’ha fatto proprio uno dei produttori che ho scelto: “Questo non è solo il tuo sogno, è un sogno comune, un sogno che racconta anche noi.”
Non è un’enoteca, non è un ristorante, neppure una discoteca
“È il mio modo di intendere l’ospitalità” afferma, sicuro di sé, Dario mentre, al bellissimo bancone di Zazà mi porge quello che pensavo fosse il menu. Invece, con la forma rotonda dei long-playing è la ‘carta della musica’.
“Qui sono descritti tutti i dischi che ho a disposizione, con gli autori e i titoli delle singole canzoni inserite nel long-plaiyng. Scegli la musica che vuoi per accompagnarti nella degustazione”. Bellissimo!! Scelgo Io che non sono l’imperatore di Edoardo Bennato e diamo il via agli assaggi: insalata di pomodori di Sorrento – favolosa -, bruschetta stracciatella pomodori secchi e basilico, capocollo di Gioi e melanzane sott’olio di Maida, triglia rossa di Licosa, alici di menaica pan brioche stracciatella e zest di limone ubisco. A ogni assaggio Dario mi apre un vino diverso fino all’Aciniell’ dei fratelli Addimanda di Taurasi; un vitigno, il Roviello Bianco, vecchio di secoli e salvato dall’estinzione della fillossera dei primi del Novecento.
Ma è con una coppia di ospiti canadesi che Dario dà il meglio di sé, della sua esperienza internazionale, dell’amore che ha per il suo territorio. All’inizio queste persone erano un po’ freddine ma quando gli ha messo davanti la carta della musica e la ragazza canadese ha scelto Je veux di Zaz è cambiata l’atmosfera; ad ogni vino che sceglievano Dario gli apriva davanti il suo i-Pad per far loro vedere dove era la zona di produzione, raccontava sinteticamente la storia di quel vino e del piatto che stavano degustando, creando un’empatia che ho visto raramente in un ristorante.
I piatti esposti
Non è molto grande Zazà, un bancone che ospita una decina di persone, qualche tavolino dentro e fuori, la vista sulla cucina dove lavorano Raffaele e Luca, il primo aveva una gastronomia di grande qualità e, quando ha chiuso, ha pensato bene che la pensione atrofizza il cervello ed è venuto da Dario; il secondo, Luca, è qui da un paio di settimane, è giovanissimo studente di biomedicina ma con una passione dirompente per la cucina.
“Ho disegnato io il locale. – mi racconta Dario – Qui c’era un negozio di abbigliamento quindi ti lascio immaginare i lavori di adeguamento, dal bancone alla cucina. E ho
avuto l’idea dei piatti appesi con le facce dei produttori da cui mi fornisco guardando i piatti che mia nonna appendeva al muro e a quelli del Buon Ricordo appesi allo Stuzzichino da Mimmo a Sant’Agata ai Due Golfi”.
Anche questa è comunicazione e, guardando la faccia del titolare dell’azienda agricola Rubisco, quella dei pomodori buonissimi, mi viene voglia di approfondirne la conoscenza.
Succede tutto questo e molto altro in una bella sera d’estate da Zazà vini vinili vivande: “ma come si può classificare questo locale?“, chiedo a Dario.
“Non lo so, non è un ristorante, non è un’enoteca, non è una gastronomia ma è tutte queste cose assieme. È un posto dove chi è appassionato di vini viene per ascoltare buona musica e chi è amante della musica viene per bere una buona bottiglia” conclude Dario.
Di certo è che Dario Cilento fa bene a Sorrento!



Ogni gesto in cucina è precisione, creatività, impegno. Lo sappiamo, perché siamo al fianco, da oltre due secoli, di chi ogni giorno trasforma ingredienti in esperienze. Da oggi nasce una gamma studiata appositamente per le necessità e le richieste dei professionisti, apponendo la firma Zucchi come sigillo dei nostri valori e della nostra qualità.









Rocco Cristiano Pozzulo Presidente nazionale FIC
Nel prestigioso contesto dei nostri editoriali ospitati e pubblicati su Sala&Cucina, abbiamo già affrontato nei mesi scorsi il tema, sempre importante e attuale, della formazione FIC. Ci piace, però, tornare ancora sull’argomento partendo da un articolo pubblicato proprio da questo magazine, con cui prosegue una stretta e proficua collaborazione. Un pezzo che, firmato da Simona Vitali (a cui facciamo i nostri complimenti per la precisione e la puntualità del racconto), racchiude in sé (aspetto mai facile per chi scrive!) tutta l’essenza e l’esperienza proprio della formazione targata Federazione Italiana Cuochi.
Ci torniamo volentieri perché davvero nutrito e intenso è il programma formativo per i nostri professionisti e associati al “giro di boa” di questo 2025, con all’orizzonte ancora numerosi appuntamenti ed eventi nazionali e internazionali da svolgere nei prossimi mesi. Eventi che vedranno, come sempre, innanzitutto la centralità dei nostri giovani, che della parola “formazione” sono i principali soggetti interessati. Pensiamo, ad esempio, al grande successo che ha riscosso la prima edizione del contest “Le Stelle di Domani”, promosso e organizzato con il nostro partner storico Unilever e che ha visto l’entusiasmo di centinaia di giovani allievi tra gli ingredienti principali del format, di cui certamente nei prossimi mesi sarà lanciata la nuova edizione, proprio grazie al feedback ottenuto dagli allievi. L’evento ha contribuito, infatti, in modo concreto (soprattutto attraverso l’utilizzo diretto dei social, mezzo comunicativo ormai veloce ed efficace) a sottolineare lo stretto legame tra i momenti formativi e quelli competitivi, dimostrando come una
gara non sia semplicemente una “sfida”, quanto piuttosto un confronto costruttivo tra professionisti, sia giovani che maturi, esperti o alle prime armi, da cui imparare sempre, a qualsiasi età. Anche dalle giurie, al cui giudizio i concorrenti sono soggetti, c’è sempre da imparare. Ecco perché, prima delle selezioni regionali e della tanto attesa finale nazionale a Roma de “Le Stelle di Domani”, i mesi che hanno preceduto l’appuntamento sono stati caratterizzati da dirette social e streaming, con cooking demo e corsi di formazione. Per sottolineare quanto sia importante l’allenamento e quanto questo costituisca “formazione” concreta e sul campo, cioè in cucina!
La stessa filosofia, insomma, che pervade un evento prestigioso e internazionale come i nostri Campionati FIC, che ogni febbraio si svolgono alla Fiera di Rimini. Ed è anche la stessa filosofia che ha caratterizzato finora e che caratterizzerà ancora la collaborazione tra FIC e HOST, l’evento internazionale che ogni due anni mette in mostra il meraviglioso e sconfinato mondo dell’Ho.Re.Ca., della ristorazione, dell’accoglienza turistica. Sin dalla prima edizione a cui abbiamo collaborato attivamente, infatti, Federcuochi ha messo in campo un proprio piano di formazione e di aggiornamento professionale per tutta la durata della Fiera, con FIC Academy, realtà concreta fatta di cooking demo e cooking show, tavole rotonde, interviste social e approfondimenti con esperti di settore, coprendo le giornate espositive con programmi sempre più intensi e interessanti e, soprattutto, con la sinergia e la collaborazione dei nostri numerosi partner.



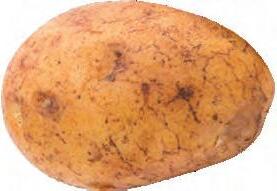
















Calibro extra, gusto autentico e avvolgente per valorizzare le preparazioni più ricche e creative. Con la loro polpa resistente alla cottura sono ideali al grill, al barbecue, o per farciture gourmet.
Una selezione di patate professionali ognuna col proprio utilizzo culinario, per soddisfare ogni esigenza ed arricchire i vostri menù con materie prime dal sapore autentico capaci di esaltare l’essenza delle vostre creazioni. Testate ogni giorno dai nostri chef, garantiscono Gusto costante, piatti sempre perfetti e facili da realizzare. L’intera gamma è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025!

























Nel cuore della frenetica Tokyo esiste un ristorante di soli dieci posti, senza menù, con una sola regola: “fidati dello chef”. Si chiama Sukiyabashi Jiro, ed è una leggenda non per la quantità dei suoi coperti, ma per la qualità straordinaria dell’esperienza che offre. Dietro a quel bancone c’è Jiro Ono, oggi novantanovenne, considerato il più grande maestro di sushi vivente. Un uomo che ha dedicato l’intera esistenza a perfezionare un gesto, a renderlo via via più preciso, essenziale e significativo. Jiro iniziò a lavorare a dieci anni. Da quel momento, non ha mai smesso. Ogni giorno si sveglia alle cinque del mattino, va al mercato, seleziona personalmente il pesce, controlla il riso, annusa il tonno. Se qualcosa non lo convince, manda tutto indietro. Una volta ha rifiutato un’intera partita di tonno perché non aveva l’odore perfetto. Nessuna deroga. Nessun compromesso. Ai suoi apprendisti insegna che ci vogliono dieci anni solo per imparare a cuocere il riso, cinque per capire come premere il pesce. Non è esagerazione. È metodo, disciplina, rigore assoluto. È questa filosofia che ha portato Sukiyabashi Jiro a ricevere nel 2007 tre stelle Michelin, primo sushi bar al mondo a ottenere un riconoscimento tanto prestigioso. Jiro non è mai stato interessato alla fama. Lo ha dichiarato più volte, con la lucidità di chi ha scelto una strada precisa: “non cerco il successo, ma la perfezione”. Quando un miliardario disse di essere disponibile a pagare qualsiasi cifra pur di avere un tavolo, Jiro rifiutò perché non aveva prenotato. Quando Barack Obama riuscì a mangiare al suo banco, fu solo perché il primo ministro giapponese, in persona, aveva prenotato per tempo. Le regole sono regole. Sempre. Per tutti. È una filosofia di vita. Per Jiro, il sushi non è un lavoro. È una missione. Una volta ha detto: “quando scegli il tuo mestiere, devi immergerti completamente, senza distrazione”. Dietro queste parole c’è qualcosa che va

Lorenzo Dornetti ceo Neurovendita
oltre l’etica del lavoro, c’è un’intera visione del mondo, fondata sulla ripetizione intenzionale e sulla cura assoluta del dettaglio.
Le neuroscienze oggi ci aiutano a capire perché questo approccio funziona per essere sempre motivati. Il cervello umano ama la ripetizione, ma solo quando è significativa. Non quella meccanica e passiva, che anestetizza, ma quella che affina. Quando un gesto viene ripetuto con attenzione, si attivano le aree prefrontali legate al controllo esecutivo e i circuiti dopaminergici. In termini pratici, si allena la parte più evoluta del cervello. Questo fenomeno si chiama “plasticità adattiva”. Jiro la chiama semplicemente “bellezza della pratica”. Ogni ripetizione consapevole aumenta la precisione e costruisce maestria. In un mondo dominato dalla distrazione, la concentrazione assoluta diventa non solo un valore umano, ma strumento commerciale.
Per chi oggi possiede o gestisce un ristorante, la storia offre spunti preziosi. La reputazione non si costruisce con una campagna social, ma con la coerenza quotidiana. Ogni piatto, ogni dettaglio, ogni interazione contribuisce a rafforzarla o indebolirla. Non esistono scorciatoie. I grandi ristoranti non si reggono sul talento una tantum, ma sulla struttura mentale che regge un ritmo continuo di lavoro.
Il modello è radicale, certo. Forse inapplicabile nella sua interezza. Ma è proprio per questo che funziona come stella polare. Ci ricorda che facendo sushi si può aspirare all’eccellenza. Siamo disposti a scegliere, ogni giorno, la via più difficile? Siamo pronti a ripetere, osservare, migliorare, ascoltare e curare? La risposta non è su ChatGPT, è dentro ognuno di noi.























Autore: Guido Parri
www.dogusto.it
Questa gamma di olive DoGusto nasce dall’esigenza di fornire al ristoratore, al barista e al pizzaiolo un prodotto selezionato e preparato, pronto per essere utilizzato. Le olive sono confezionate in secchiello e in vetro, metodo di confezionamento che garantisce una shelf life più lunga e una maggiore igienicità e salubrità del prodotto.
Olive taggiasche
La cultivar Taggiasca è una varietà di oliva tipica della Liguria di Ponente, nella zona meravigliosa che si estende dalle valli albenganesi sino a tutta la provincia di Imperia. L’oliva Taggiasca è ottima anche come oliva da tavola grazie alle eccezionali qualità di gusto del frutto che si presenta allo stesso tempo dolce e deciso. Adatta per essere servita a sé durante aperitivi o antipasti, sia per essere utilizzata per cucinare o sulla pizza.
Olive Leccino
Le Olive Leccino sono le olive più diffuse sul territorio italiano, dato il loro delicato sapore. L’origine delle olive Leccino risale all’Italia centrale con riferimenti fin dal Medioevo. Oggi sono tra le olive più coltivate nella penisola italiana. Vengono maggiormente utilizzate per preparare stuzzichini o antipasti a base di formaggi stagionati e salumi.
Olive di Gaeta DOP
La zona di produzione dell'Oliva di Gaeta DOP comprende la superficie di 44 comuni delle province di Latina, Frosinone e Roma, nella regione Lazio, e della provincia di Caserta (Sessa Aurunca e Cellole). Per DoGusto sono state selezionate olive di Gaeta DOP che, meglio di altre tipologie, si prestano al meglio per diversi piatti della cucina italiana.
Clicca e leggi l’articolo sul web

Olive verdi di Cerignola
È ovale, abbastanza grande, di un bel verde intenso e lucida. Al palato è sapida al punto giusto, carnosa e succosa. L’oliva verde di Cerignola è una cultivar tipica della zona omonima; le olive che produce non vengono usate per l’olio, ma sono olive da tavola. Adatte per ottimi aperitivi.
Olive verdi dolci siciliane
Sono le olive più famose al mondo, le Nocellara del Belice con il loro sapore unico. Perfetta per aperitivi e per sfiziosi antipasti.
Olive denocciolate Riviera in EVO
Le olive Riviera denocciolate con olio extravergine di oliva, sono uno tra i prodotti migliori della tradizione gastronomica del Sud. Per tal motivo sono state scelte a far parte di questa linea di prodotti dagli alti standard qualitativi. Ideali per aperitivi, buffet, happy hour o in gustose preparazioni.







Autore: Luigi Franchi

Foto: Archivio I Rais
Clicca e leggi l’articolo sul web
Ol Minadùr, nome evocativo, abbastanza facile da capire: significa il minatore ed è, in questo caso, riferita a un formaggio che stagiona nelle miniere.
Siamo a Dossena, in provincia di Bergamo, un paese di 880 abitanti che alla miniera devono molto: nel passato perché tutti ci lavoravano, oggi perché, oltre ad essere una vera e propria attrazione turistica, è perfettamente adatta per la stagionatura di Ol Minadùr.
La storia della miniera di Dossena È una storia molto antica, risalente all’impero romano e, probabilmente, ancor prima, agli etruschi. Il primo a parlarne fu Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia (XXXIV libro): “La vena di metallo viene cavata in questo modo e depurata col fuoco. Si produce anche da un minerale contenente rame, detto cadmia, noto nelle terre al di là del mar Mediterraneo e un tempo in Campania, ora anche nel territorio dei bergamaschi, la zona estrema dell’Italia”.
L’altro visitatore illustre fu Leonardo Da Vinci che proprio su alcune particolari tecniche utilizzate nelle miniere di Dossena, oltre che a opere di mappatura della zona, condusse dei veri e
propri studi; esistono infatti due suoi disegni di mappe riguardanti Dossena e la Val del riso, conservati a Londra, nella biblioteca reale di Windsor. Infine, prima della definitiva cessazione degli scavi, nella metà degli anni ’50 con il successivo sviluppo dell’attività spaziale, la fluorite di Dossena veniva inviata in grandi quantità in America, dove era utilizzata come uno dei principali componenti dei combustibili dei razzi vettori (gli Atlas e i Saturno) della NASA per le missioni lunari.
Qui ha inizio la storia di Ol Minadùr, con il coinvolgimento di numerosi soggetti, istituzionali e culturali come l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, oltre ai produttori di questo particolare formaggio.
“Prima di tutto è necessario capire che, in questo bel progetto, esiste una cornice di riferimento. – ci racconta Vincenzo La Forgia che, insieme a Margherita Testa, è il project manager del progetto SMAQ Minadùr - Si parte da un’associazione che si chiama Filiera Futura, che raggruppa 23 fondazioni di origine bancaria; due associazioni di categoria nazionali, Coldiretti e Confartigianato; tre atenei, Università di Scienze Gastronomiche, Politecnico di Torino e l’Università di Udine. L’obiettivo di Filiera Futura è la valorizzazione dell’agroalimentare italiano per conto delle fondazioni di origine bancaria. Tra esse vi è anche Fondazione Cariplo, la fondazione lombarda più importante d’Italia con un patrimonio di circa quattro miliardi di euro. Fondazione Cariplo decide di sostenere un progetto di Filiera Futura che si chiama SMAQ, acronimo di Strategie di marketing per l’agroalimentare di qualità. In questa cornice rientra il progetto SMAQ Ol Minadùr che viene sposato da Fondazione Cariplo.
La Fondazione propone lo SMAQ Ol Minadùr al Comune di Dossena che vanta, al suo interno, una ventina di produttori di formaggio e tre di questi anche del Minadùr. Sempre la Fondazione finanzia il progetto e lo affida all’Università di Scienze Gastronomiche, CNR e IULM. In questo contesto si inizia a coinvolgere, oltre ai tre, altri produttori con l’obiettivo di valorizzare questo formaggio al fine di dare valore all’intera comunità di Dossena. Qui c’è un sindaco, Fabio Bonzi, molto capace, sa attrarre fondi tramite bandi per la propria comunità al punto di realizzare opere, come il ponte sospeso più lungo d’Europa, che sono diventare anche attrazioni turistiche. Il progetto SMAQ Minadùr è un progetto biennale e, oggi, siamo arrivati al terzo semestre; l’obiettivo è fornire strumenti ai produttori legati al mondo della comunicazione, della vendita, della sostenibilità, in modo da poter valorizzare ulteriormente la comunità e le sue strutture. Infatti, oltre al ponte sospeso, qui ci sono: il Becco, una sorta di balconata sulle valli orobiche da cui si ammira un paesaggio meraviglioso: il Teatro rotondo, in alta montagna, dove organizzare qualsiasi performance artistica si voglia fare; i Murales donati alla comunità da 30 artisti bergamaschi”.
Il riutilizzo della miniera e le caratteristiche di Ol Minadùr
Le miniere, storico simbolo di Dossena, sono state ripristinate nel settembre 2014, grazie al lavoro di 80 volontari coordinati dal Comune di Dossena, e riaperte nel 2015. In quegli antri stagiona Ol Minadùr per circa tre mesi. Dopo accurati test sulle proprietà sensoriali e sulle modalità di affinatura, la Galleria dei Sospiri (a 350 m dall’ingresso delle miniere e a 100 m sotto il livello del suolo) si è dimostrata il luogo più adatto alla stagionatura del formaggio



Grazie alle peculiari condizioni ambientali di umidità e temperatura delle miniere, la maturazione protratta per almeno 90 giorni favorisce una minore perdita di acqua nel formaggio, donando al prodotto una struttura morbida e con un ventaglio aromatico unico, particolarmente ricercato dagli intenditori. Caratteristiche uniche: semistagionato, non particolarmente complesso, da un punto di vista palatale latticinoso, con qualche nota verde e una consistenza media che può ricordare una toma non molto stagionata.
“Ne vengono prodotte, ad oggi, pochissime forme e questo è il punto rilevante a cui stiamo dando risposta con il progetto SMAQ – ci spiega Vincenzo La Forgia
– che ha coinvolto altri produttori, con un corso di formazione dedicato al marketing e alla vendita, e buona parte della comunità. Il primo risultato è stato aprire, a fianco delle miniere, un piccolo centro che permette di fare numerose attività tra cui quella di vendere Ol Minadùr ai visitatori del territorio che, quest’anno, hanno raggiunto il numero interessante, ben 35.000”.
L’Università di Scienze Gastronomiche ha coinvolto, per formare i produttori, uno dei più bravi formatori italiani per le vendite: Paolo Sampò
A lui abbiamo chiesto come è strutturato il corso per valorizzare Ol Minadùr.
“Finora abbiamo svolto lezioni online, ogni volta sempre più partecipate. A settembre andrò direttamente a Dossena per fare incontri di persona. I temi trattati sono stati: introduzione al concetto di rete commerciale: che cos’è una rete e perché è strategica per piccoli produttori. L’importanza della narrazione territoriale. I valori guida: “buono, pulito, giusto” come si traducono in pratiche commerciali; la coerenza tra prodotto, prezzo e pubblico. L’identità del formaggio Minadùr e posizionamento come, ad esempio, differenziare: cosa
rende unico il Minadùr; come comunicarlo (in parole semplici ma efficaci). Gli esempi concreti di reti di successo: modelli replicabili in piccoli territori; casi studio brevi e pertinenti (es. consorzi, mercati contadini, gruppi d’acquisto). L’attivazione finale: spunti per riflettere sul proprio ruolo nella rete; micro-esercizio da portare al modulo in presenza (es. mappare potenziali contatti, idee di collaborazione). Nel prossimo incontro affronteremo le varianti della vendita, a chi, in quale modo, con quali strumenti. È entusiasmante questo corso per il livello di attenzione e di partecipazione; è come se un’intera comunità si ritrovasse in un percorso di cambiamento e di crescita” racconta Paolo Sampò
Sono questi i simboli di un’Italia buona, pulita e giusta.





Eccellente comunicatore e professionista di sala e cucina senza pari, il grande chef pubblicò ‘Il Libro dei menu’ nel 1912, complemento essenziale del suo più noto ‘Guide Culinaire’, alla base della cultura gastronomica moderna.

Seconda parte
Dopo aver codificato l’alta cucina francese e il servizio, Escoffier aprì la strada alla ristorazione moderna nel pieno della Belle Époque. Da, come diremmo oggi, eccellente manager f&b e cuoco di grandi hotel, sapeva bene che attraverso la pianificazione del menu si poteva organizzare al meglio sia il lavoro in cucina che in sala. Ne Il libro dei menu, primo testo specifico sul tema, presenta un’ampia tipologia di ‘carte’ con testi e consigli interessanti sui menu dedicati ai ristoranti, menu brevi, quelli à la table d’hôte ossia a prezzo fisso per piccoli, medi e grandi hotel, e ancora menu di magro, per feste e banchetti, menu reali e presidenziali dell’epoca. A questi si aggiunge la trascrizione giornaliera di molte ‘carte’ dell’hotel Carlton dove Escoffier lavorò una vita, e anche alcuni menu per circostanze speciali quali Natale e Capodanno. D’altronde l’arte della composizione dei menu è stata una componente cruciale della cucina durante tutto il corso dell’Ottocento: Auguste Escoffier, sottolineandone i criteri grafici, gastronomici e comunicativi, l’ha eletta ad arte.
Ma quando nascono i menu?

Il menu (dal latino minutus, piccolo) era presente fin dal Medio Evo ad uso esclusivo delle cucine. Era una “minuta”, ossia l’appunto con i piatti del giorno che il capo cuoco stilava in base alla disponibilità della dispensa.
Inteso come lista delle pietanze della composizione di un pasto e cartoncino sul quale è scritta, il menu nasce con il passaggio dal ‘servizio alla francese’ a quello ‘alla russa’, quindi tra la fine del Settecento e l’Ottocento. Nel “servizio alla francese” il pranzo era suddiviso in tre o più services (o sequenze). I vassoi con le portate del primo servizio, dai quali i convitati si servivano liberamente, secondo gusto e appetito, erano poggiati contemporaneamente sulla tavola. Finito ogni servizio, si sbarazzava e si disponevano a tavola le pietanze del successivo, sempre tutte insieme. Le scenografiche e abbondanti preparazioni erano ben visibili e, di conseguenza, i menu a tavola non erano necessari, rimanendo solo come promemoria per i cuochi e i maestri di casa.
All’inizio del XIX secolo si affacciò una nuova tipologia di servizio: i piatti venivano porzionati in cucina, ricomposti sui vassoi e poi serviti con una successione prestabilita. Spiega Escoffier: “Nel servi-

zio russo, i piatti caldi non vengono serviti sul tavolo; vengono preparati o tagliati in cucina e inviati in sala da pranzo per essere serviti agli ospiti. I pezzi o le porzioni più grandi, troppo grandi per essere fatti circolare, possono però essere tagliati in sala da pranzo, distribuiti su piatti caldi e poi passati ai commensali.”
Nacque, così, l’esigenza del menu scritto per gli ospiti da trovare a lato o sopra il proprio piatto.
Il libro dei menu, seppur sotto il peso del tempo, offre dei suggerimenti tutt’ora utili sulla sua redazione: “Il menu deve essere stabilito in perfetto accordo con il genere, la classe, le abitudini delle persone alle quali il pranzo verrà servito”. Deve, poi, contenere equilibrio tra le varie portate e l’occasione del pranzo, armonia tra le preparazioni e le presentazioni ma anche chiarezza d’espressione, semplicità di progettazione ed esecuzione, eleganza e correttezza nella grafia.
Prosegue Escoffier: “La compilazione di un menu, che è contemporaneamente un sommario di lavoro e un programma gastronomico, è una cosa più seria di quanto si possa supporre; perché non si tratta solamente di redigere la lista di un certo numero di cibi secondo un gusto riconosciuto o un prezzo stabilito; ma di scegliere quelle vivande con discernimento, raggruppandole armoniosamente per realizzare, con quelle che si possono considerare note dello spartito, una sorta di sapiente orchestrazione”.
Escoffier insiste sulla stagionalità, l’alternanza delle carni tra bianche e rosse, il divieto delle ripetizioni per le salse e le guarnizioni, la varietà di cotture e di
texture all’interno di uno stesso menu. La noia è bandita come anche i nomi difficili, stravaganti o barocchi. Chiaro, semplice ed elegante deve essere graficamente bello e ben scritto, perché può essere anche un bel souvenir cartaceo da portare via con sé, come ricordo. Ma il maestro mette in guardia: “Il più piccolo errore di gusto, il minimo sbaglio, la più insignificante negligenza, sono in qualche modo, messe in risalto e scontentano soprattutto se il biglietto è ricco e artistico.”
Escoffier e la cucina internazionale
Ma qual è la cucina che il maestro racconta nel libro? Qui la ‘grand cuisine’ del passato, quella di Carême e Gouffé viene alleggerita, semplificata e va incontro ai gusti della sua ricca clientela internazionale come ricorda Massimo Alberini nella prefazione al testo italiano edito da Serra e Riva Editori: “Escoffier studia e codifica ricette britanniche a cominciare dalle salse, preparazioni russe, spagnole, mediorientali e persino indiane.[..] Questa antologia viene definita con un nome che Escoffier non userà mai: la cucina internazionale. Una voce destinata, per colpa dei cattivi imitatori o del ritorno ai’ piatti genuini’, ad assumere un significato dispregiativo.” C’è, va detto, poca Francia e pochissima Italia, in questi menu.
Il grande cuoco non è solo maestro di cucina, e di tanto altro, ma anche uno dei massimi interpreti del gusto, appunto, internazionale, a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
Escoffier, oltre a un grande professionista, era anche un visionario, conosceva già come e dove stava andan-
do la cucina della Belle Époque: anche se oggi possono sembrare eccessivi, i menu, per il maestro, dovevano essere brevi, secondo le circostanze. Nel celebre testo La fisiologia del gusto Brillat-Savarin scrisse : “L’ordine dei cibi di un pranzo va dai più sostanziosi ai più leggeri.” Escoffier era d’accordo: “Questa massima lapidaria esprime veramente quello che di sostanziale c’è da dire su questo argomento.”
La struttura compositiva della ‘carta’, al tempo, era così descritta: “Di solito gli antipasti e le minestre giocano il ruolo di aperitivi; generalmente si inizia il pranzo vero e proprio con quelli che l’antica cucina chiamava relevés, cioè grosse trance di pesce tagli di carne, capi di selvaggina pollame”. In mancanza di relevés, al pesce seguono i primi piatti di carne, quindi quelli di pollame o selvaggina. Prosegue il grande chef: “Solo dopo vengono le mousses calde, i soufflés e gli altri piatti elaborati dello stesso tipo, al pari dei piatti freddi, qualora il menu li includa. I sorbetti segnano il termine della prima parte del pranzo. […] Seguono gli arrosti caldi generalmente accompagnati da un’insalata: poi, qualche volta, un arrosto freddo: paté, terrine, parfait di fegato d’oca, o galantina tartufata di selvaggina, un prosciutto bollito servito freddo. […] Una verdura, un piatto leggero di mezzo, caldo o freddo, un gelato accompagnato da pasticcini e frutti vari completeranno il menu.”
Un nuovo linguaggio
Escoffier amava rendere il pranzo un momento unico: sapeva che se non si crea tutto un mondo attorno,
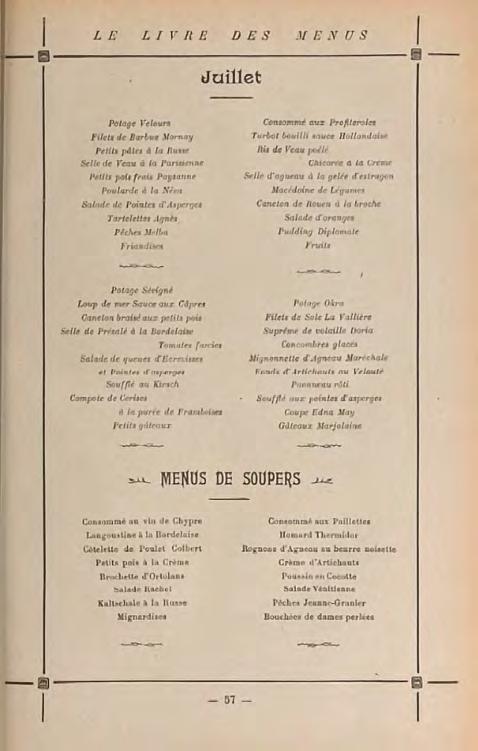
la cucina, come insieme di ingredienti, non è nulla. E senza fantasmagoria non ci possono essere emozioni: questa piacevole esperienza, per Escoffier, partiva proprio dalla lettura del menu, seduti ad una tavola elegantemente imbandita. Il linguaggio doveva essere chiaro ma anche poetico, giocando con le parole, le espressioni, le dediche personali e la musicalità dei nomi dei piatti, per trovare ritmi, colori, profumi e tanto savoir faire. Amava le parole esattamente come le ricette: tutto faceva parte del buon gusto francese. Salade Réjane, Pere Mary Garden, Gallina Adelina Patti, Coppa Yvette, Fragole Sarah Bernhardt, Pesca Melba, sono tutte ricette dedicate a dive e donne, regine del loro tempo.
Il maestro aveva anche senso dell’umorismo. Con l’approvazione del futuro Re Edoardo VII, mise in carta al Carlton di Londra le sue ‘cosce di ninfa alla bella aurora’, nome da lui ideato in quanto conosceva la ‘debolezza’ del Principe di Galles per le donne avvenenti, senza dire agli altri avventori che fossero in realtà cosce di rana, preparate con una salsa vellutata, l’aggiunta di pomodoro e paprika e quindi, rosa, come l’aurora.
Un giorno un giornalista chiese ad Escoffier cosa avrebbe fatto se si fosse trovato nella situazione di Vatel, grande cerimoniere seicentesco, il quale si suicidò perché non erano arrivati in tempo i pesci ordinati per il suo celebre banchetto e Escoffier rispose :”Io avrei preso dei polli bianchi, li avrei trattati in un modo che tutti li avrebbero scambiati per pesci e tutti sarebbero rimasti contenti”. Chapeau, chapeau!

Autore: Federico Panetta

Oggi è il simbolo più iconico dello street food vietnamita e uno dei panini più amati al mondo, ma il bánh mì, che in vietnamita significa semplicemente “pane”, è molto più di un cibo di strada: è il risultato di oltre un secolo di storia che intreccia colonizzazione francese, guerre, contaminazioni culturali e rivoluzioni gastronomiche. Dietro la sua apparente semplicità si nasconde un racconto complesso, che parla di identità e profondi cambiamenti.
Descrivere cosa sia il bánh mì non è semplice, dato che non esiste una ricetta codificata. C’è sicuramente una struttura di base, ma ogni versione può variare molto a seconda della regione, della disponibilità degli ingredienti e della fantasia del venditore. Tra gli elementi ricorrenti troviamo però le verdure, solitamente cetrioli, carote e daikon, il coriandolo e il pane tipico, “figlio illegittimo” della baguette francese
Questo piatto non deriva da una tradizione antica, ma nasce da un processo di trasformazione iniziato nella seconda metà dell’Ottocento e sviluppatosi, nella sua forma attuale, tra le due guerre mondiali. La baguette, ad esempio, fu introdotta in Vietnam dai francesi durante l’occupazio-

ne coloniale iniziata nel 1858. Nelle prime fasi della dominazione, però, non esisteva un vero scambio culturale tra coloni e popolazione locale. I francesi portavano con sé i propri prodotti, separandoli da quelli vietnamiti, e importavano ingredienti allora quasi introvabili in Asia, come farina di grano, burro, paté e salumi, per ricreare in loco la loro dieta europea. La separazione era così netta che i coloni disapprovavano apertamente i connazionali che si lasciavano influenzare dalle abitudini vietnamite, anche in cucina. Tuttavia, questa divisione cominciò a incrinarsi durante la Prima guerra mondiale, quando migliaia di soldati francesi furono richiamati in patria e i magazzini dell’Indocina rimasero pieni di prodotti europei inutilizzati, che persero di valore e furono venduti a prezzi accessibili anche alla popolazione locale. Prodotti come la baguette entrarono così nell’immaginario vietnamita e vennero adattati alle condizioni ambientali: a causa della scarsità di farina di grano, i panettieri iniziarono a mescolarla con farina di riso, ottenendo una baguette più leggera e dalla crosta sottile, più adatta al clima caldo e umido.
Oltre alla baguette, in quel periodo fecero il loro ingresso in Asia anche altri prodotti importati, come la Maggi sauce: un
condimento liquido di colore scuro e sapore deciso, simile alla salsa di soia ma con un profilo più umami e salato. Questa divenne popolarissima molto rapidamente in Vietnam e, pur non essendo un prodotto locale, oggi è considerata quasi un ingrediente “nativo” nella preparazione di molti piatti, bánh mì incluso. Nel 1941 però il processo di avvicinamento e ibridazione tra culture si interruppe bruscamente con la fondazione del movimento indipendentista Viet Minh da parte di Ho Chi Minh, che auspicava un Vietnam libero dalle potenze occidentali. In un clima di crescente sentimento anti-imperialista, molti simboli della cultura coloniale vennero rifiutati, mentre altri subirono un processo di risemantizzazione: proprio come il bánh mì, che iniziò a essere percepito non più come un prodotto ibrido, ma come un simbolo patriottico della cucina nazionale.
Nel 1954, la spartizione del Vietnam in Nord e Sud portò a grandi migrazioni interne. Si stima che un milione di vietnamiti lasciò il Nord comunista per trasferirsi nel Sud, soprattutto nella città di Saigon. Tra questi c’era la famiglia Lê, che aprì nel 1958 la panetteria Hoà Mã, considerata da molti il luogo di nascita del bánh mì đặc biệt, una versione particolarmente ricca e apprezzata del bánh mì, farcita con paté, carne, verdure, spezie e salse. Improvvisamente, il panino divenne il pasto perfetto per rispondere alle esigenze di velocità e praticità della vita urbana, diffondendosi rapidamente tra studenti, tassisti, lavoratori e impiegati e affermandosi così come cibo quotidiano, versatile ed economico.



La guerra
La guerra del Vietnam, iniziata nel 1955, oppose per oltre vent’anni il Nord comunista e il Sud sostenuto dagli Stati Uniti. Fu un conflitto durissimo che devastò il paese: milioni di morti, bombardamenti massicci, villaggi distrutti e un’intera generazione segnata. La guerra si concluse nel 1975 con la caduta di Saigon, la vittoria del Nord e la riunificazione sotto il regime comunista. Questo evento spinse centinaia di migliaia di vietnamiti del Sud alla fuga.
Dopo la caduta di Saigon e la fine delle ostilità, la diaspora vietnamita portò il bánh mì prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Come avvenuto per la pizza italiana, fu proprio il passaggio attraverso gli USA a renderlo
un fenomeno globale: nei sobborghi americani nacquero le prime panetterie specializzate, mentre catene come Lee’s Sandwiches contribuirono a standardizzarlo e a diffonderlo tra chi non ne aveva mai sentito parlare. Nel XXI secolo, il panino conquistò finalmente un pubblico più ampio. Nel 2011 il termine bánh mì venne inserito nell’Oxford English Dictionary, ufficializzando la sua diffusione nella lingua inglese. La consacrazione avvenne però il 24 marzo 2020, quando Google gli dedicò il doodle della giornata, celebrando la sua storia e importanza culturale.
Uno dei momenti più significativi per il successo occidentale del bánh mì fu il commento, all’interno di un programma televisivo, dello chef e documentarista americano Anthony Bourdain, che lo definì “a symphony in a sandwich”. Quel giudizio, trasmesso a milioni di spettatori, consolidò l’immagine del bánh mì come uno dei migliori panini al mondo. Da semplice pane importato a simbolo di fusione culturale, da prodotto elitario a cibo di strada globale, il bánh mì è oggi parte della quotidianità vietnamita e della cultura gastronomica internazionale. E se oggi può essere ordinato tanto in una bancarella di Saigon quanto in un food truck a Los Angeles, lo si deve a una lunga storia fatta di guerre, migrazioni e adattamenti, racchiusa in venti centimetri di sinfonia alimentare.
Autrice: Giulia Zampieri
Clicca e leggi l’articolo sul web

www.vinimontetino.com
Stentavo a credergli mentre Marco Carone mi accompagnava dentro alla cantina in cui, fino a un anno fa, lui e Benedetta Nicomede facevano praticamente tutto, dalla fermentazione all’imbottigliamento, dall’affinamento all’etichettatura.
Ci trovammo dentro a trentacinque metri quadri e davanti a un soppalco, nascosti dietro a un portone, nel cuore di Celano, deliziosa cittadina abruzzese che pare sospesa nell’aria, su cui troneggia una roccaforte medievale.
Eppure era così: dietro al portone, affacciato su un vicoletto del centro storico, c’era un sogno già proiettato a nuove grandezze. È da lì che comincia la storia di Montetino.


Crescere piano piano ma con senso È stato un privilegio muoversi dentro a quello spazio minuto, un po’ come lo è entrare in un ristorante che, ancora a porte chiuse, sta iniziando a concedersi ai primi ospiti.
Da qualche mese si sono spostati in una struttura più grande, con una metratura dieci volte superiore, con l’obiettivo di dare corpo e futuro al vero motivo che spinge Montetino: la tutela.
Benedetta lo racconta subito: “Il nostro progetto nasce per custodire e salvaguardare i vigneti di questa zona che rischiavano di andare perduti. Fino al 1878 proprio qui sussisteva un lago, il Fucino; poi, un grande lavoro di bonifica ha restituito agli abitanti una pianura fertile. Negli anni si è però preferito dare più spazio all’agricoltura mettendo così a rischio il patrimonio viticolo, sebbene quest’area fosse altamente vocata. Noi siamo partiti proprio dal recupero di piccole parcelle di vigne vecchie, alcune addirittura del ’67, che complessivamente ammontano oggi a due ettari. Il primo a consegnarcele è stato il signor Ermanno, un tempo postino del paese, che curioso ci ha osservati mentre ce ne prendevamo cura con pratiche diverse da quelle che aveva sempre esercitato. È stato un buon modo di affiancarci e darci fiducia”.
Quando Benedetta esprime un numero, una data, una precisazione, non c’è mai approssimazione: un po’ per inclinazione professionale, dato che è enologa, un po’ per attitudine, racconta Montetino contornando di dettagli del progetto e dando sempre un significato alle
loro scelte. Come quella investire tantissime energie sul lavoro in vigna, a cominciare dalla gestione della chioma.
“Per noi le pratiche di potatura sono importantissime. Le chiome devono essere ben arieggiate. Vogliamo sempre salvaguardare i flussi linfatici. Gestiamo il suolo e le piante con approccio biodinamico. Piantiamo sovesci, lavoriamo il suolo in superficie e utilizziamo solo rame e zolfo di copertura. Quello che ci interessa trasferire è che il nostro intervento sulla vigna e sul terreno è un’attività di cura, rispetto, custodia e ascolto. Queste sono le priorità. Parallelamente c’è la necessità di condensare il lavoro in vini che abbiano un’identità riconoscibile e riconducibile al territorio”.
Lo ricerca e lo studio sono voci portanti, sempre.
“Studiare significa capire cosa devi fare…e soprattutto cosa non devi fare, per questo è importante studiare!” sottolinea Benedetta.
Ce lo diceva, qualche mese fa, anche un altro produttore. È una risposta concreta, che ci auspicavamo, alle correnti che hanno fatto del non intervento spalleggiato dalla non conoscenza, la colonna portante. Per non intervenire bisogna conoscere.
Per Benedetta e Marco il senso risiede anche nel dare continuità ai genotipi del territorio.
“Abbiamo deciso di concentrarsi su Montepulciano e Trebbiano, quindi su una produzione di zona, identitaria, senza sfociare in sperimentazioni e nuove varietà, anche quando ci dedicheremo a nuovi impianti il lavoro sarà di recupero. Quindi il nostro bianco, Le Foci, è
da uve Trebbiano. Il Tralumescuro è un rosato da uve di Montepulciano. Le Màrie è il rosso Montepulciano. Quasi la totalità dei vigneti sono in un’altitudine che varia tra i 700 e i 750 m s.l.m e sono esposti a sud. I suoli sono prevalentemente composti da argilla, arenarie, calcare e marne blu”.
Facciamo un passo indietro per raccontarvi come, nel 2020, è nato Montetino, che prende il nome dal rilievo - anche detto Serra di Celano - che sovrasta Celano. Marco lavorava nel settore brassicolo, viveva a Roma, ma nutriva una forte affezione per l’Abruzzo. Benedetta, invece, originaria proprio di Celano, dopo aver studiato viticoltura ed enologia ed essersi formata in importanti aziende vitivinicole italiane aveva voglia di mettere le mani nella sua terra. Si sono conosciuti ad una degustazione, e questo è parte del racconto: non capita tutti i giorni che due persone di settori affini ma diversi trovino sintonia e decidano di investire in un’idea nuova insieme.
Cosa c’era sul piatto? La possibilità di costruire su fondamenta condivise, ovvero sul rispetto per la natura e per il territorio.
“Quando io e Benedetta ci siamo conosciuti abbiamo subito capito che c’era un volere condiviso, intrecciato al rispetto per l’ambiente e per la biodiversità. Avevamo inteso che se avessimo fatto qualcosa assieme non avremmo rifondato ma ricucito” ci raccontava Marco pochi giorni prima della vendemmia, lo scorso anno, mentre consumavamo una passeggiata lungo i filari, accarezzando le folte chiome, e scoprendo una vegetazione piena di vita. Ai bordi degli appezzamenti vi sono anche alberi da frutto, tra cui meli e fichi. All’epoca l’estate volgeva al termine ed erano carichi di prodotti maturi.
“L’intenzione di preservare qualcosa non può essere circoscritta a una sola specie, in questo caso alla vite. Per questo abbiamo deciso di salvaguardare ciò che c’è in mezzo e ai bordi. Inoltre lavoriamo con il compost. È alla base della nostra logica di approccio alla natura”.
L’Abruzzo che pulsa quanto ci piace!
Le ridotte dimensioni che custodivano Montetino, fino a poco tempo fa, in qualche modo rappresentavano ciò che ancora oggi c’è fuori dalla loro azienda: poco, in termini di colleghi con cui confrontarsi. Allora si guarda anche oltre, in altre zone della stessa regione, come ci raccontano.
“Non in prossimità ma in Abruzzo sì, ci sono produttori che stimiamo molto e con cui dialoghiamo tanto. C’è spirito di collaborazione e condivisione e ci piace sempre sottolinearlo. Sono persone accumunate nel fare agricoltura con sentimento e questo ci veicola
un’energia bellissima. La stessa che, d’altronde, ci trasmette questo lavoro. L’istante in cui si innesca la fermentazione è energia. È il momento in cui non possiamo che essere davvero grati alla natura per quello che ci darà!”.
Negli ultimi decenni abbiamo osservato aziende vitivinicole che marciavano in solitaria, guardando solo dentro al proprio rettangolo di gioco. Oggi, con piacere, raccontiamo anche storie di produttori che si trovano, parlano, combinano, assaggiano le rispettive bottiglie con curiosità, senza retro pensieri. In questa rubrica ne abbiamo ospitati tanti. Questa è l’energia che merita il mondo del vino… e siamo felici di averla rintracciata ancora una volta anche in Abruzzo!

Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
Nasce dalle consuetudini di famiglia e diventa un trend. La pizza nel ruoto di Pasqualino Rossi è la riscoperta del piacere di condividere un cibo semplice e tradizioni mai dimenticate
Il 5 dicembre 1996 apre Elite ad Alvignano (Ce). Una pizzeria molto particolare, che deve la sua origine all’usanza di condividere il cibo, come spiega Pasqualino Rossi: “Mamma faceva il mercato rionale la domenica mattina e preparava la pizza per le persone che vi lavoravano: pizza casalinga cotta nel ruoto, il tipico tegame di ferro. Al momento di aprire la nostra pizzeria di famiglia decidemmo che il ruoto sarebbe stato al centro del progetto per ricordare questa abitudine, per ricreare l’atmosfera conviviale e famigliare, per offrire un luogo accogliente e un cibo semplice e piacevole”. Oggi lo chiameremmo comfort food, ma nulla si inventa, dopotutto.
Ed è così che Elite apre i battenti e Pasqualino comincia a fare le prime pizze: “Per prima la marinara – racconta – e cominciai ad offrila ai clienti, perché era la più semplice, per far capire il prodotto che, subito, piacque perché ricorda la mamma, la nonna, la famiglia. Il ruoto è uno strumento classico, perfetto per lo scopo e pian piano l’abbiamo affiancato con piatti tipici della tradizione, come la parmigiana, il pancotto, i taglieri, i fritti e i crocché. Insomma, la cucina casalinga della mamma, con un occhio verso il futuro e aggiungendo man mano un pizzico di innovazione”. L’impasto è classico, con farina di tipo 0 e un pizzico di tipo 1 per dare profumo e sapore, la ricerca è soprattutto nei prodotti di accompagnamento, spiega Pasqualino Rossi: “In ogni pizza metto al massimo tre ingredienti perché gli ingredienti devono sposare bene tra loro e vanno dosati con cura. Serve a mantenere la tradizione e la classicità con un po’ di croccantezza, di vivacità. Importante è rispettare la stagionalità e scelgo sempre gli ingredienti in base al periodo, quando gli ortaggi sono freschi e mantengono le loro caratteristiche”.


Il menu di Elite
Oggi, nel menù di Elite possiamo gustare 30 pizze classiche e 10 pizze nel ruoto, una varietà che accontenta i tanti clienti che arrivano da Napoli, da Caserta: “Ci troviamo in una piccola cittadina, Avigliano, nell’alto casertano e devi conoscerci per venire qui, non è un luogo di passaggio ma di destinazione – afferma Pasqualino – però in questi anni abbiamo lavorato duramente e costruito una rete di clientela affezionata, anche turisti stranieri che sentono parlare di Elite e del nostro ruoto e vengono a trovarci”. Una meta di destinazione, dunque, dove praticare un percorso gustativo che va dalla pizza alla birra, al vino e alle specialità del territorio.
Spiega Pasqualino: “Cerchiamo di non far mancare nulla dell’identità del luogo e i turisti vengono tramite passaparola, cercano la tipicità, vedono il nostro ruoto sui social e vogliono provare la nostra pizza: cercano un po’ di folklore italiano, in senso buono, e noi glielo diamo, unendo spontaneità e professionalità per creare un ambiente accogliente”.
Specialità realizzate con prodotti locali, dunque, ma anche italiani in senso più ampio; non mancano nelle ricette il gorgonzola, l’asiago, per esempio, o i prosciutti perché la penisola è ricca di eccellenze e tutte si prestano perfettamente ad accompagnare le pizze di Elite, specialmente la pizza nel ruoto che deve il suo successo a caratteristiche molto particolari, come spiega Pasqualino: “La differenza con la pizza classica sta nel fatto che la pizza nel ruoto viene cotta del tegame di ferro. Sul fondo del tegame si mette strutto o olio, poi si stende il panetto di impasto e si lascia lievitare mezz’ora, infine si farcisce e si

cuoce. Questo determina due caratteristiche: risulta croccante fuori e morbida dentro, come se fosse pizza fritta. Inoltre, la puoi mangiare anche il giorno dopo, fredda, ed è buonissima. Si usa lo stesso impasto della pizza classica, cambia solo il metodo di cottura. E’ come la pizza fatta in casa, e di casa ricrea l’atmosfera di accoglienza”. Un successo che nasce dalla semplicità, dalla capacità di governare l’impasto, dalla naturalezza di un mestiere antico che sa di famiglia, di convivialità.
Perché non portare un pezzetto di questa piacevolezza anche fuori dalla Campania? Pasqualino Rossi e suo fratello Gianluca hanno scelto Milano: “Volevamo dare vita a un progetto importante, con un parterre selettivo, metterci alla prova in un contesto insolito per noi. Milano ci è sembrata la piazza più adatta perché vivace, movimentata, difficile se vogliamo ma proprio per questo stimolante”. Da pochi mesi infatti Elite ha aperto nella semicentrale via Tortona, zona alla moda, luogo di incontro, di arte e design. Il palcoscenico ideale per offrire un angolo di tipicità campana, una pizza buona e genuina, l’atmosfera giusta per una serata in compagnia. Ce ne sono tante di pizzerie a Milano ma il ruoto di Pasqualino Rossi mancava. I milanesi ringraziano.
L’OLIO AL CENTRO
La sala è importante, anzi è proprio fondamentale, motivo per il quale non andrebbe mai trascurata. Eppure, il più delle volte resta il punto debole di molti ristoranti. Nel luogo dell’accoglienza, proprio là dove si servono e si consumano i pasti, l’olio extra vergine di oliva è tra gli elementi/alimenti meno valorizzati. A dimostrarlo è il fatto che gli acquisti di olio sono in gran parte destinati alla cucina, soprattutto per gli impieghi in cottura, molto meno invece per la sala, tant’è che la gran parte degli acquisti si orientano sulle confezioni dai cinque litri in su. La sala, di conseguenza, tende a scarificare l’olio, così come gli altri condimenti, già a partire dal fatto che gli extra vergini non vengono in alcun modo menzionati nei menu, perché ritenuti ingredienti secondari e marginali. Così, se da un lato l’olio non compare indicato nei menu, allo stesso modo è altrettanto raro trovare una “carta degli oli” con il conseguente “carrello degli oli”. Eppure, basterebbe un minimo sforzo per introdurre queste innovazioni. Lo stesso personale di sala, formato all’occorrenza, potrebbe iniziare a valorizzare gli oli proponendoli agli ospiti e spendendo le giuste ed essenziali parole. In Spagna queste attenzioni sono ricorrenti, già a partire dalle colazioni mattutine negli alberghi. Perfino al bar l’olio è presente, messo a disposizione per quanti lo desiderano. Solo in Italia se ne disdegna l’impiego, non riuscendo ad andare al di là del piatto già condito. Basterebbe invece un minimo sforzo per ricavarne vantaggi anche in termini economici. Sì, perché un olio extra vergine di oliva che si rispetti merita una giusta valorizzazione e presentazione. È sufficiente

Luigi Caricato oleologo
far ricorso alla figura del sommelier, là dove questa è presente, il quale può attingere alle proprie competenze, annunciando e presentando gli oli ai propri ospiti ancor prima di porgere il menu. Partire dai sommelier per assegnare al personale di sala un ruolo più propositivo e performante. Questo 2025, tra l’altro, è un anno importante perché sessant’anni fa, il 7 luglio 1965, venne fondata a Milano l’Ais, l’Associazione italiana sommelier. All’epoca chi ci ha creduto è stato un pioniere che ha rivoluzionato l’arte del servizio a tavola. Erano partiti da una idea semplice ma quanto mai illuminante e decisiva. Ci hanno creduto fortemente, riuscendo a mettere in piedi un organismo che a tutt’oggi vanta oltre 40 mila soci. L’idea dei fondatori di Ais consisteva nel promuovere una profonda e diffusiva cultura del vino. Oggi l’Ais effettua corsi di formazione anche sull’olio, operando attraverso una chiave interpretativa più suggestiva e fascinosa, con linee guida che reputo di gran lunga migliori e più efficaci rispetto ai corsi di assaggio realizzati dagli oleari. Di conseguenza, per rivitalizzare la sala e renderla più attrattiva e funzionale nel processo di valorizzazione di una materia prima come l’olio extra vergine di oliva (che, non dimentichiamolo, è un nutraceutico e insieme un esaltatore di profumi e sapori), il ricorso ai sommelier è la giusta soluzione. La decisione, per dare corso a questo epocale cambio di passo, ricade tutta sui ristoratori: investire sugli oli non è una perdita, ma un vantaggio, anche economico, se solo ci si impegna nell’offrire agli ospiti un servizio adeguato.










Claudia Ferrero
Digital Strategist & Evangelist
Il tuo ristorante risponde da solo (e meglio di prima)
C’è stato un tempo in cui ogni telefonata al ristorante era un’interruzione. Il telefono squillava mentre stavi preparando la linea, accogliendo un cliente o facendo i conti. Rispondere era un dovere, certo, ma anche un peso. A volte si perdeva una prenotazione solo perché non si riusciva a rispondere in tempo.
Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, questo tempo può finalmente diventare un alleato.
I nuovi “agenti AI” non sono più i chatbot impacciati e meccanici di qualche anno fa. Oggi parliamo di veri assistenti virtuali vocali, capaci di gestire le telefonate come una persona reale: con risposte fluide e soprattutto con informazioni sempre corrette e aggiornate. Il loro compito? Rispondere al posto tuo, h24 7 giorni su 7, come lo faresti tu e certamente meglio di alcuni tuoi collaboratori.
Immagina un cliente che chiama per sapere se avete opzioni vegane, un altro che vuole prenotare un tavolo per sei persone alle 21, oppure qualcuno che cerca conferma sull’orario della cucina o sulla possibilità di portare il cane. Tutte queste richieste possono essere gestite autonomamente dall’agente AI, che risponde in tempo reale e prende nota di eventuali preferenze. Inoltre ogni conversazione viene registrata e riepilogata, così tu puoi sempre avere tutto sotto controllo. E oggi c’è una novità in più: la voce dell’agente AI non è più impersonale. Può parlare con un accento regionale, calibrato in base alla zona in cui si trova il ristorante. Che tu sia a Napoli, Bologna o Firenze, l’assistente può accogliere i clienti con un tono familiare, riconoscibile, che ispira fiducia. E non solo: grazie agli intercalari umani, può inserire espressioni spontanee come “Ci sta!” o “Guardi, glielo dico subito”, rendendo la conversazione ancora più naturale e piacevole. Piccoli dettagli che fanno
una grande differenza nella percezione del servizio. Se pensi: “i clienti vogliono parlare con le persone, non con i robot” è proprio qui la novità. L’intelligenza artificiale di oggi è in grado di dialogare in modo estremamente umano. E se serve, può sempre essere messo in contatto con una persona reale. L’agente AI non sostituisce l’accoglienza umana: la completa, la potenzia, la rende più efficiente
Chi ha già adottato questa tecnologia racconta di una drastica riduzione dello stress operativo: meno telefonate perse, meno errori sulle prenotazioni, meno interruzioni mentre si lavora. Ma anche più soddisfazione da parte dei clienti, che ricevono risposte immediate, chiare e professionali.
Un’altra buona notizia riguarda i costi. Questi sistemi non sono più riservati alle grandi catene. Oggi esistono soluzioni pensate proprio per ristoranti indipendenti, bistrot, agriturismi o pizzerie. L’attivazione è semplice e veloce, e il costo mensile può variare in base al volume di telefonate: in media si parte da circa 40-50 euro al mese fino a 100-150 euro al mese per servizi avanzati con gestione multilingua, registrazione conversazioni e integrazione con il gestionale delle prenotazioni
Chi teme di perdere il “tocco umano” può stare tranquillo: l’AI non sostituisce la relazione, la protegge. Ti libera dal rumore per farti concentrare sul cuore del mestiere: l’ospitalità. E oggi, in un mercato sempre più competitivo, anche riuscire a rispondere sempre al telefono può fare la differenza tra un cliente perso e uno fidelizzato. Investire in un agente AI non è solo un passo verso l’innovazione: è un modo concreto per lavorare meglio, con meno stress e più risultati.
Autrice: Marina Caccialanza
Autrice: Marina Caccialanza
Clicca e leggi l’articolo sul web
Una sfida dal sapore antico, intimo, quasi poetico. La ristorazione torna alle origini per guardare al futuro, cura la terra, la arricchisce, la rivitalizza. In questo contesto l’agricoltura rigenerativa e la biodiversità acquistano nuovo valore
Spirito Contadino nasce dal recupero di antiche tradizioni pugliesi della famiglia Gervasio De Palma, che diventano ogni giorno un rito, un’arte che rivaluta gesti semplici, che sanno trasmettere la forza e la passione contadina senza confini, senza tempo. Una passione per la natura e per i suoi frutti, capace di illuminare lo sguardo e l’animo di chi l’osserva, capace di raccontare storie di emozioni e sensazioni di uomini che adoperano le mani quotidianamente con caparbietà e ostinazione. Il rapporto tra uomo e natura è tanto stretto quanto fragile e delicato e oggi più che mai è un valore da difendere. Spirito Contadino, da oltre tre generazioni crede e pratica un’agricoltura che incarna questo rapporto rispettando sempre principi etici, ambientali ed economici. Una filiera etica e sostenibile che ha l’obiettivo di garantire la salute delle persone, migliorare la qualita
della vita, promuovere lo sviluppo economico solidale, salvaguardare i diritti umani, favorire l’equità sociale. È una storia di filiera a Km vero, sostenibile, circolare, ispirata alla capacità di coniugare Natura, Innovazione e Progresso.
Dalla terra al piatto: la rinascita di una ristorazione naturale Piante che crescono senza manipolazione, radici che affondano in un suolo vivo, ricco di cura e stagionalità. Da questo equilibrio nascono verdure dal sapore intenso, legumi che portano con sé sfumature di gusto inconfondibili, cereali che conservano l’energia del sole. È proprio questo che la ristorazione puòraccogliere per portare in tavola un’esperienza unica, che parla di territorio, di persone e delle sfide di chi

contadino lo è per scelta.
Dalla varietà delle piante, infatti, scaturisce l’infinita ricchezza culinaria di ogni luogo. Le specie antiche coltivate nei campi di Spirito Contadino, come ad esempio il marasciuolo selvatico, le rosette fogliari di papavero selvatico, i fiori di zucca, le cime di rapa, i mugnuli selvatici di campo, portano con sé una memoria, una cura, un racconto. Come se ogni ortaggio raccontasse una sua storia di stagioni, persone, territori che resistono all’omologazione. Proprio questa ricca diversità può fare la differenza, perché ogni ristorante può proporre sapori che non si trovano ovunque, valorizzando le eccellenze che la natura mette a sua disposizione.
Le radici di questa conoscenza affondano in terra di Puglia, ricca di odori, colori ed essenze perdute che donano autenticità agli ortaggi. Da sempre gli chef hanno dato fiducia a Spirito Contadino perchéassicura la garanzia di tesori dell’orto sostenibili, colti nel momento migliore, selezionati e mondati esclusivamente a mano nella credenza che nessuna macchina possa fare meglio dell’occhio attento delle persone.
l’eccellenza
Dal dialogo, dalla cura e dalla pianificazione prende forma Conterraneum®: una filiera corta, dove ogni anello conosce l’altro. Una sfida organizzativa, certo, ma che ripaga. Perché ogni piatto non è solo buono, diventa unico, frutto di esperienza, passione e territorio. È questo che
fa la differenza in un panorama gastronomico affollato: l’autenticità delle materie prime e l’amore di chi le produce. Materie prime che nascono dall’esclusivo metodo di Agricoltura Biofilica, un metodo che ha radici lontane: è l’innata tendenza dell’uomo a provare amore per la Terra. È la capacità di rimanere sintonizzati con quella parte di noi che “sa” che siamo Natura. È passione per la Vita, connessione con la Natura mentre la vita scorre. É il legame genetico tra Uomo e Natura che si concretizza con il senso di fiducia, rispetto, amore nei confronti del mondo. Conterraneum è una storia da scrivere insieme, mette in campo le migliori risorse e compie scelte consapevoli per il benessere comune. La priorità è diffondere l’idea che il legame uomo - natura è imprescindibile e come tale va tutelato. L’impegno è la coltivazione che arricchisce il terreno e l’apporto alla macchina ristorativa di verdure di alto pregio nutrizionale che possono curare la patologia del fegato grasso, come recentemente scoperto dalla ricerca dell’Ospedale De Bellis di Castellana Grotte. Secondo questi principi, Spirito Contadino è punto di riferimento per chi ha fatto della ristorazione la sua ragione di vita e punta all’eccellenza: è un dialogo continuo con chi ogni giorno apre le porte del suo locale e con sacrificio e creatività coniuga materie prime e tecniche culinarie per creare piatti che appaghino i propri ospiti.
Quando il campo incontra la scienza nascono progetti


dal valore unico, come l’importante progetto di ricerca dell’ospedale IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte per la cura della steatosi epatica con le verdure di Spirito Contadino.
Per realizzare il progetto è stato messo in campo il know-how dell’azienda in materia di vegetale e fornito a pazienti affetti dalla steatosi epatica, la malattia del fegato grasso per la quale ad oggi non c’è cura, quattro referenze che contengono un altissimo contenuto di sostanze utili a combattere l’accumulo di trigliceridi nel fegato: Cime di rapa, Germogli di Torzella, Cicoriella e Senape selvatica di campo.
Le verdure sono state somministrate per tre mesi in un pasto, in sostituzione di una porzione di carboidrati e i risultati della ricerca sono stati sorprendenti: regresso della malattia, dimagrimento e miglioramento di tutti i parametri vitali, come riferisce il direttore scientifico, prof. Gianluigi Giannelli. I risultati offrono nuovi spunti di riflessione sulla possibilità di curare con le verdure Biofiliche numerose malattie.
Verso una ristorazione sostenibile, esclusiva e emotiva
Dalla terra può rinascere una ristorazione sostenibile.
A partire dal sapore delle verdure di stagione, dalla varietà delle piante, dalla conoscenza dei cicli naturali, prende forma una cucina esclusiva, emotiva che non segue le mode, segue le stagioni; non uniforma, valorizza; non spreca, riusa; non svuota la terra, la arricchisce. Una sfida importante, che parte dal campo per arrivare sulle tavole di tutto il mondo e risponde al cambiamento in atto nelle abitudini e nelle priorità della gente. L’italia è il 3° paese in Europa per numero di

ristoranti vegetariani e vegani. Le priorità stanno cambiando, salute, benessere e un’alimentazione più sana sono in cima alle scelte. È la conseguenza diretta di una cultura sempre più green che si riflette sulle scelte alimentari. Le nuove generazioni, attente e informate, chiedono alle aziende un impegno concreto nel tracciare percorsi virtuosi per ridurre lo spreco di risorse e perseguire un’etica che non comprometta il futuro. Le persone sentono crescere il bisogno di “far parte di qualcosa” e creare insieme valore per ognuno. Il fast food lascia sempre più spazio al care food: cibo buono che fa bene all’organismo e alla terra. È in questo modo che per mezzo della ristorazione la terra può rinascere, una ricetta alla volta.
Autore: Guido Parri
Ci arriva una segnalazione da Marchi spa, azienda di distribuzione horeca attiva nel Veneto, che tratta le referenze del brand DoGusto relative al mondo pizza: il lancio del DoGusto Pizza Club.
Di cosa si tratta ce lo racconta direttamente Andrea Marchi, amministratore della Marchi spa: “DoGusto è la nuova linea di prodotti a marchio, nata da una sapiente selezione delle eccellenze italiane. Frutto dell’esperienza di Cateringross, consorzio che da oltre quarant’anni riunisce aziende serie e competenti nel settore della ristorazione, ogni prodotto DoGusto è scelto con cura da un team di esperti per garantire qualità, gusto e affidabilità. Da questa valutazione è nato il progetto DoGusto Pizza Club, partendo dalla pizza per antonomasia: la Margherita. Ai pizzaioli aderenti proponiamo una linea completa di ingredienti DoGusto, pensata per permetter loro di ricreare questa icona italiana con la qualità che solo un’attenta selezione può offrire”.
I benefici di DoGusto Pizza Club
“Per iniziare questo percorso insieme, il pizzaiolo che aderisce al progetto riceve in omaggio un esclusivo Welcome Kit con gadget personalizzati. Ma non finisce qui: vogliamo costruire un cammino di qualità e passione condivisa, valorizzando al massimo la linea DoGusto e quindi proponiamo di diventare un nostro #DOGUSTOAMBASSADOR e accedere a vantaggi esclusivi:
• Corsi di formazione personalizzati, tenuti da Giacomo Pini, CEO di GPSTUDIOS
• Sessioni tecniche con esperti di rilievo nel settore food, in particolare su farine, mozzarella e pomodoro
• Opportunità di crescita e aggiornamento professionale
• Visite agli stabilimenti produttivi
• Anteprime di mercato riservate
• Promozioni dedicate
• Visibilità per il tuo locale su riviste di settore


"DoGusto Pizza Club è un invito a condividere passione, cultura gastronomica e qualità”.
Con queste parole Andrea Marchi ha lanciato, nelle scorse settimane il progetto che sta raccogliendo già tante adesioni. Il Veneto, del resto, negli ultimi anni ha dato vita a un nuovo modo di intendere la pizza grazie al percorso che tanti pizzaioli hanno fatto; un percorso innovativo che necessita di prodotti di alta qualità e il brand DoGusto va in questa direzione.

Autrice: Stefania Pompele
Analista sensoriale L'ANALISI SENSORIALE
Clicca e leggi l’articolo sul web
L’intelligenza del palato: retaggi culturali e meccanismo percettivo del sistema gustativo
“L’appetito è una forza potente, inarrestabile, che deve essere tenuta in catene come un animale selvatico, affinché non sovrasti il vivente nella sua interezza” Platone Nella gerarchizzazione dei sensi propria della filosofia antica, il senso del gusto era considerato una sorta di anfratto per gli istinti più bassi. Platone sosteneva che ciò che percepiva la lingua non potesse produrre benefici sull’intelletto, ma al contrario sortisse effetti dannosi. Mentre vista e udito erano considerati sensi fondamentali per la conoscenza e quindi essenziali per l’attività intellettuale e filosofica, il gusto rappresentava il più basso recinto della dimensione umana. Se il retaggio culturale li ha relegati a sensi minori, gusto e olfatto sono oggi al centro di innumerevoli pubblicazioni scientifiche e animano i dibattiti in cui si tratta di estetica, arte, e appunto gusto, nell’accezione più ampia del termine. Gustare è un atto che ha un valore cognitivo che va oltre quello meramente sensoriale. Il gusto, secondo queste prospettive, ci permette di vivere esperienze estetiche autentiche e di conoscere aspetti del mondo, non solo di provare godimento mentre assaggiamo un piatto. L’esperienza gustativa coinvolge fattori fisiologici, culturali, psicologici e sociali, e può essere condivisa, modificata e affinata attraverso esperienza ed educazione. E se educarsi al gusto è a tutti gli effetti una forma di sapere, un mezzo per esplorare il sé e l’altro, è dalla conoscenza della dotazione sensoriale da cui è utile


partire per comprendere le dinamiche che governano il meccanismo percettivo. Perché è la cartina tornasole con cui misuriamo e interpretiamo la dimensione gustativa.
Se parliamo di gusto in senso stretto ci stiamo riferendo all’organo di senso in grado di percepire stimoli chimici, ciò che chiamiamo sapore, che giungono in contatto con i recettori gustativi. La zona maggiormente coinvolta nella percezione dei sapori è la lingua, ma sono presenti recettori anche sul palato molle, labbra, faringe ed epiglottide, anche se queste ultime svolgono un ruolo meno rilevante. Lo stimolo sensoriale ha origine nei cosiddetti bottoni gustativi (o gemme), presenti in numero variabile all’interno delle papille. Non è insomma la papilla a percepire il sapore, ma il recettore contenuto al suo interno.
Diverse papille, posizionate in zone diverse della lingua, ma con medesima funzione: sulla parte anteriore della lingua troviamo le papille fungiformi, le circumvallate si trovano invece nella regione posteriore, mentre lungo i
lati, nella parte posteriore, si trovano le papille foliate. Abbiamo poi le papille filiformi, le più numerose sulla lingua, ma in questo caso si tratta di papille prive di gemme gustative, la cui funzione è da ricercarsi nella loro capacità di restituirci informazioni sulla consistenza e struttura del cibo.
Abbiamo tutti la stessa dotazione sensoriale, eppure siamo tutti diversi. Sappiamo infatti quanto la genetica possa impattare in tal senso. In un recente studio orchestrato dalla SISS (Società Italiana di Scienze Sensoriali), è stato dimostrato come il numero di recettori vari significativamente da soggetto a soggetto. La ricerca ha evidenziato come in alcuni fosse presente un numero molto limitato di uno/due papille, fino a cento per cm2 in altri. Lo studio ha inoltre rilevato differenze genetiche in base al sesso, evidenziando come le femmine abbiamo un maggior numero di papille rispetto ai maschi, presenza che tende a diminuire con l’avanzare dell’età, soprattutto nei maschi tra i trenta e i quarant’anni, mentre nelle femmine la curva decrescente segue un andamento più graduale.
Una dotazione più o meno ricca di sensori si riper-


cuote sulla sensibilità con cui percepiamo un dato stimolo, di conseguenza sul nostro concetto di troppo o poco, godibile e sgradevole, e in una prospettiva più ampia su preferenze e abitudini alimentari. Il gusto può essere educato, ma una parte consistente di questa dimensione culturale sarà sempre governata da un’eredità sensoriale: quella genetica.
Di sapori primari e presunte geografie
Il sapore dolce si sente nella parte anteriore della lingua, quante volte lo abbiamo sentito ripetere?
Potremmo anche azzardare ipotesi sull’intelligenza del palato e la sua funzione biologica primaria, ovvero individuare fonti di macro e micronutrienti negli alimenti, ed eventualmente difenderci da possibili minacce (la nostra relazione controversa con l’amaro la dice lunga in tal senso). Insomma, percepire i sapori dolci, o per dirla in altre parole, captare fondi di zuccheri in un alimento grazie a una sorta di avamposto sensoriale esclusivo (la parte anteriore della lingua, per l’appunto), può aver rappresentato un vantaggio evolutivo, ma nella pratica le cose sono un tantino diverse.
Ci abbiamo messo un bel po’ prima per capire e soprattutto dimostrare di aver male interpretato lo studio di David
P. Hänig, lo scienziato che agli inizi del ‘900 misurò per la prima volta le soglie di percezione gustativa, basandosi a sua volta sugli studi di E. B. Tichener (allievo di W. Wundt, considerato il padre della psicologia sperimentale). Hänig dimostrò l’esistenza di una preferenza specifica dei singoli recettori rispetto ai sapori primari, cosa peraltro confermata, limitandosi però ad indagare questo aspetto della percezione. E con questa errata interpretazione abbiamo indottrinato eserciti di assaggiatori di ogni ordine e grado “geografizzando” la lingua.
Infografica 1
Ci è voluto un secolo per dimostrare che i recettori del gusto non rispondono esclusivamente a un unico sapore, ma solitamente a più stimoli gustativi, seppur in modo diverso. Esiste una preferenza specifica dei recettori rispetto a uno dei sapori primari, ma non vi è una selettività assoluta. Possiamo insomma percepire ciò che definiamo dolce non solo sulla parte anteriore della lingua, o il salato ai lati e via discorrendo, ma in quella stessa area percepiremo anche altri sapori, magari con intensità diverse. La discriminazione dei sapori non è tanto una faccenda geografica, ma è invece legata al tipo di recettore e all’attività di confronto con gli altri recettori gustativi.
Dolce, salato, acido, amaro, sapido (o umami), grasso (oleogustus), questo il vocabolario utilizzato dalle scienze sensoriali per descrivere i cosiddetti sapori primari, in quanto rispondenti a specifici stimoli sensoriali capaci di attivare i recettori del gusto. In altri termini abbiamo dato un nome alla nostra capacità di percepire zuccheri, sali, acidi organici, proteine e grassi. Un’equazione che ci aiuta a comprendere i meccanismi alla base della percezione, ma che poco ci racconta rispetto alla complessità dell’esperienza gustativa e alla nostra relazione con il cibo. Ma questa storia merita di essere raccontata in un altro capitolo.
Referenze
Exploring influences on food choice in a large population sample: The Italian Taste project https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ S095032931730053
Autore: Luigi Franchi
Clicca e leggi l’articolo sul web
Questo volume, curato da Luigi Caricato, gode del contributo di diversi autori, tutte persone legate in qualche modo al mondo del cibo e della ristorazione: chef come Giuseppe Capano, scrittrici come Rosalia Cavalieri, sommelier come Antonello Maietta, designer e architetti come Mauro Olivieri e Alessia Cipolla, esperte di comunicazione come Ilaria Legato hanno affrontato il tema olio e ristorazione in ogni possibile sfaccettatura consegnando, con le loro riflessioni, un patrimonio di conoscenza che diventa prezioso per ogni ristorante che vorrà dare il giusto valore a un ingrediente fondamentale per la cucina italiana e per la sala del proprio ristorante.
Luigi Caricato ha compiuto una disanima degli oli di tutte le regioni italiane descrivendone i profili sensoriali e gli abbinamenti consigliati. Rosalia Cavalieri mette in risalto le scelte necessarie perché il ristoratore affermi l’importanza dell’olio come, ad esempio, orientarsi verso i piccoli formati da aprire direttamente al tavolo per consentire all’ospite di conoscere e assaporare un prodotto fresco. Antonello Maietta esalta il ruolo dell’olio come strumento di accoglienza e di intrattenimento. Ilaria Legato parla della sala e di come l’olio deve diventare una vera e propria esperienza sensoriale, anche attraverso la carta degli oli che ne sappia descrivere le singole peculiarità. Mauro Olivieri traccia il design perfetto per un carrello degli oli e alessia Cipolla ne descrive la storia e la sacralità. Infine lo chef Giuseppe Capano mette a disposizione tutta l’esperienza accumulata in anni di professione svelando come utilizzarlo al meglio nelle pratiche di cucina e negli abbinamenti ideali tra cibo e olio. Un libro di cui si avvertiva la necessità e che dovrebbe essere in tutte le biblioteche dei ristoranti italiani.

A cura di Luigi Caricato Edizioni Olio Officina
240 pagine
18 euro www.olioofficina.it

I cosiddetti tagli poveri, o meno pregiati, sono parti dell’animale più economiche ma ricche di sapore, che possono essere impiegate in numerose preparazioni culinarie, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Con il suo marchio Unika dedicato alla ristorazione, l’azienda veneta Centro Carni Company, leader nella lavorazione della carne bovina con oltre 40 anni di esperienza, rappresenta una sintesi perfetta tra selezione accurata delle materie prime, lavorazione attenta e cura dei dettagli. Un vero punto di riferimento per chi desidera una materia prima di alta qualità, pronta all’uso e senza compromessi.
Le proposte di Centro Carni Company:
La linea Unika propone una selezione che abbraccia sia carni pregiate sottoposte a frollatura con tecnica dry aging sia tagli bovini spesso considerati “minori”, ma in realtà essenziali per valorizzare l’intero animale, ridurre gli sprechi e ampliare la creatività in cucina.
Tra questi, spicca il diaframma, muscolo che lavora costantemente ma che, non essendo coinvolto direttamente nella locomozione, mantiene una consistenza sorprendentemente morbida.
Tradizionalmente destinato alla carne trita, se ben pulito dalle membrane e cotto velocemente sulla fiamma,
diventa un taglio saporito e apprezzatissimo dagli intenditori.
Segue la Flat Iron Steak, ricavata dalla copertina di spalla. Questo taglio nasce dalla lavorazione di un pezzo attraversato da un tessuto connettivo particolarmente duro, che una volta rimosso consente di ottenere due porzioni regolari, dalla forma rettangolare e dallo spessore omogeneo. In origine utilizzata per bolliti o arrosti, la Flat Iron Steak si è affermata per la sua tenerezza e ricchezza di gusto: ideale sulla griglia, ma anche estremamente versatile in altre preparazioni.
Infine, il Chuck Roll si distingue per qualità e resa: da questo taglio si ottengono bistecche tipo costata, con o senza osso, ma anche ottimi arrosti. Un’alternativa eccellente per chi cerca sapore e struttura senza compromessi.
Con la sua proposta di “tagli poveri”, Centro Carni Company dimostra così la propria capacità di innovare senza rinunciare alla tradizione, trasformando ogni taglio – anche il più umile – in un’opportunità di gusto.
Grazie alla visione del marchio Unika, l’azienda celebra la carne in tutte le sue forme, offrendo una gamma variegata, pensata per i professionisti della ristorazione che cercano eccellenza, versatilità e autenticità.

Bollo
Soccorso Stradale
Gestione amministrativa Sostituzione Pneumatici
Gestione dei sinistri Assicurazioni RCA e ARD