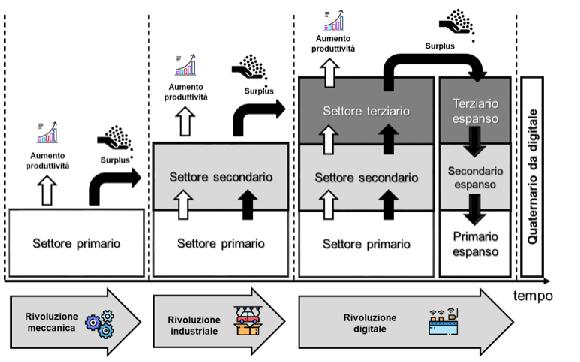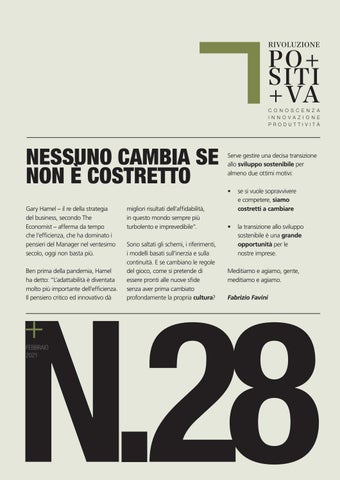5 minute read
Abbiamo bisogno di cambia-MENTI (bis)
L’emergenza che stiamo attraversando, oltre che sanitaria ed economica, è anche una crisi più generale di significato, di stili di vita e di valori che ci stimola ad interrogarci sulle sue cause scatenanti, sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo economici e sociali fin qui utilizzati, sul senso profondo delle relazioni umane.
Sono infatti saltate le protezioni e i riferimenti della vita di ogni giorno e gli esseri umani si scoprono per quello che sono.
Advertisement
E ancor di più ci interroghiamo sull’irruzione dell’incertezza nelle nostre vite: il senso di disorientamento ed impotenza che contraddistingue il nostro rapporto con eventi così importanti e di portata globale rende difficile comprendere quanto le nostre riflessioni attuali possono esserci utili per dare un significato al nostro futuro.
Le aspettative sull’uscita dall’emergenza oscillano, nell’attuale dibattito e nel sentire comune, tra i due estremi di chi prevede la mera ripartenza e di chi invece esprime a gran voce il bisogno di un radicale processo di rivisitazione del nostro stile di vita e dei suoi valori umani, economici e sociali.
Nel caso della ripartenza si auspica il ritorno alle abitudini e ai consumi nelle stesse forme e cadenze con cui li abbiamo sempre conosciuti, e lasciati prima della pandemia. Nei contesti di lavoro, nella migliore delle ipotesi si desidera ripristinare condizioni di relazione umana, diretta e in presenza, che tornino a garantire l’efficace funzionamento dei processi dell’azienda, di enti e di organizzazioni. Ciò anche in ragione del fatto che la forte accelerazione del lavoro in remoto può essere considerata come una reazione forzatamente adattativa, più che una forma di vero e proprio smart working.
La crisi assume, in questa visione, le sembianze di una momentanea sospensione, se pur drammatica e dolorosa, per poi rientrare appena possibile nella cosiddetta normalità.
Nel secondo caso, invece, ci si pone di fronte ad uno scenario profondamente diverso che alimenta consapevoli prospettive di una rivisitazione dei modelli di comportamento e di consumo, di una riconfigurazione degli assetti delle filiere produttive e distributive, di una semplificazione della burocrazia nelle organizzazioni e nei rapporti con la Società, di una ridiscussione delle condizioni di lavoro più orientata ai bisogni di life balance e ai principi di responsabilizzazione reciproca. In poche parole, una profonda riconsiderazione dei nostri valori sociali e umani.
Tutto ciò perché molti di noi hanno maturato la consapevolezza che non torneremo alla normalità perché era la normalità il problema; è stata la normalità che ha scatenato la crisi che ha fatto irruzione nelle nostre vite, mettendo in luce, se non altro, le caratteristiche intrinseche e profonde della nostra Società.
L’antropologo Jared Diamond, nel suo famoso libro Armi, acciaio e malattie (Premio Pulitzer 1998), ci racconta di come in 13.000 anni di storia dell’Umanità le epidemie e le guerre siano state i principali acceleratori dei processi di innovazione. Conflitti bellici, genocidi, carestie e malattie lasciano tracce profonde anche una volta superate ed è impossibile pensare di tornare inesorabilmente alle situazioni che le hanno generate senza sviluppare nuovi modi di vedere le cose e nuovi spunti per riorganizzare criticamente la nostra esistenza.
L’articolo del professor Guido Visconti, pubblicato su questo Magazine lo scorso gennaio, ci ha raccontato a chiarissime lettere di come siano state le abitudini umane le cause scatenanti alla base della pandemia che sta scuotendo il pianeta.
Allora, come pensare di voler tornare alla normalità pre-crisi unicamente per soddisfare la nostra pulsione di conformismo, conservazione, comfort? La nostra pigrizia mentale non può essere la dominante della nostra esistenza! Dobbiamo scuoterci da questo torpore, durato sin troppo. Anche perché, se continuiamo a concentraci sulla minaccia, e non sulle soluzioni, non riusciamo a essere innovativi, lucidi, determinati, efficaci. Col risultato di tornare alla cultura di prima, quella che ha prodotto e scatenato la crisi.
Le imprese italiane evidenziano ancora oggi comportamenti tardivi, conservativi e tradizionali rispetto alla nuova situazione da fronteggiare.
Lo vediamo in particolare nello sviluppo del Capitale Umano: gli investimenti formativi sono consueti, poco originali, poco utili, poco differenzianti, poco attraenti. L’investimento formativo tra l’altro è da tempo plafonato mediamente sotto all’1% del fatturato annuo dell’Azienda, la cui competitività non si può più giocare sul basso costo del lavoro bensì sull’investimento in sviluppo di competenze e benessere dei suoi Collaboratori. In tal senso sta diventando urgente che l’Azienda inizi a mappare il Capitale Umano in termini di analisi di competenze e di soddisfazione dei suoi Collaboratori. Fatto questo, l’Azienda deve mettere il valore del Capitale Umano a bilancio, assieme a tutti gli altri asset di Stato Patrimoniale.
Se il Capitale Umano non viene costantemente mappato, attualizzato e valorizzato nel tempo, gli azionisti dovrebbero essere messi al corrente che la loro impresa sta perdendo valore!
Rileggiamo cosa ha scritto tempo fa Severino Salvemini: “I disegni organizzativi delle nostre aziende sono rudimentali e burocratici; il management è in gran parte autoreferenziale, scarsamente orientato al rischio, all’innovazione, al pensiero critico e all’intelligenza creativa.
La governance aziendale si tramanda senza confronti ed inclusioni esterne, con continuità ed ampliamento di meri patti di controllo, piramidi societarie e forme di potere insindacabile. Il tutto è condito da una scarsa patrimonializzazione, resa ancora più traballante dalla fuga dall’Azienda dei cosiddetti animal spirits che da anni hanno privilegiato la rendita immobiliare alla scommessa imprenditoriale manifatturiera”.
Serve che, in modo urgente e senza altro indugio, le nostre élite imprenditoriali, economiche, sociali ed istituzionali si schierino e agiscano per evitare l’evaporazione del Sistema.
E, come in tutti i veri, effettivi cambiamenti, serve, prima di tutto, una nuova mentalità e una nuova cultura che accendano, come prima cosa, un sentimento vivo nelle persone. Mai come in momenti simili, abbiamo bisogno di alimentare in noi e negli altri un’idea di futuro con prospettive di benessere e di sviluppo: un viaggio nuovo, carico di opportunità, di progetti, di innovazioni, di soddisfazioni. Chiudiamo quindi rapidamente con un’idea di futuro dove prevalga incertezza, rassegnazione, paura.
Dobbiamo riprogettare la nostra vita; si può fare, basta volerlo. Adesso.
PS. Rileggiamo cosa hanno scritto due menti illuminate tanti, tanti anni fa:
Per assicurare all’Azienda la più alta efficienza, dovrà essere considerata essenziale la formazione e la valorizzazione di dirigenti dotati di qualità umane, tecniche e culturali superiori. 1946 - Adriano Olivetti - Le fabbriche del bene.
Chiamiamo impresa il luogo dove si producono innovazioni; chiamiamo imprenditori i soggetti che realizzano innovazioni. 1939 – Joseph Schumpeter.
Fabrizio Favini