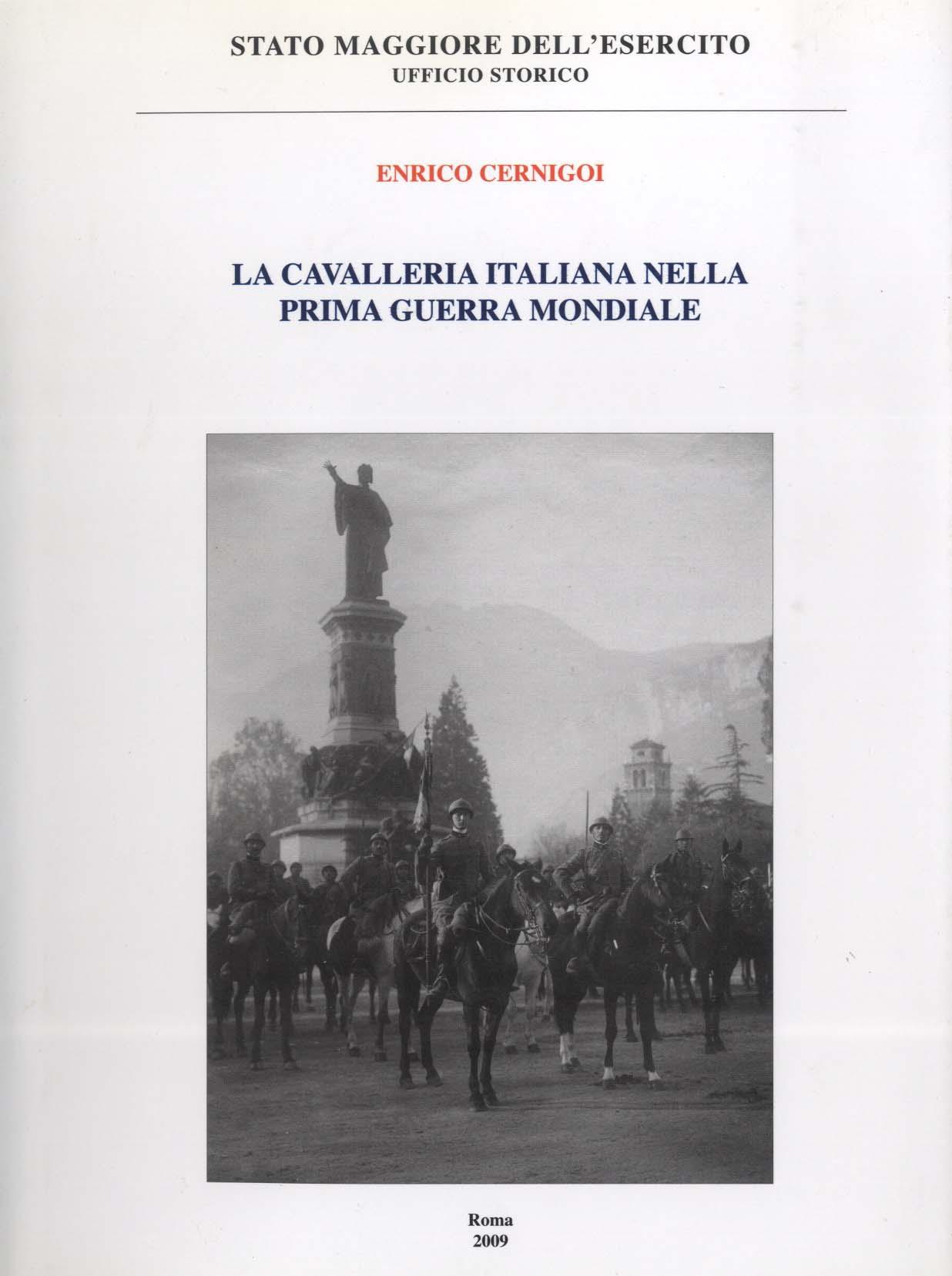

I •
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
LA CAVALLERIA ITALIANA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

· UFFICIO STORICO
Enrico CERNIGOI
Roma 2009
PROPRIETÀ RJSERVATA
Tutti i diritti riservati
Vietata la riprodu,i.ione anche parziale senza aworiu.azione
© Stlllo Maggiore dell'Esercito Ufficio Storico -Roma 2009 ISB 88-87940 98 3

PRESENTAZIONE
La Cavalleria è senza dubbio una delle Armi più affascinanti e studiate del mondo. I nnumerevoli ,o no i libri che le sono stati qedicati e che ne elogiano la storia, i fasti e gli splendori. È un'Arma che :la sempre ha trasmesso l'idea dello spirito puro, dell'onore, dei valori del rispetto e delle tradizioni Un tempo l 'essere cavaliere significava accedere ad una comunità più e levata, era una vera e propria nves titura spirituale che obbligava al coraggio individuale , a voti solenni ed a particolari forme di vi ta: devozione a Dio , rispettoso amore alla donna , fedeltà al Sovrano. Ciò permetteva ai cavalieri di iirnos trare i più nobili sentimenti umani, quali l'ardimento nei pericoli, la generosità nella vittoria, ta pietà per i deboli. L'uomo e il cavallo, insieme , han no cambiato e imposto l e regole della guerra Je r secoli, dai temp i antic hi, nei quali la cavalleria costituì va generalmente le ali degli eserciti schie ·ati in battaglia, fino all'Era moderna, quando l'evoluzione delle armi da fuoco e l'avvento di nuove :! sempre più sofisticate tec n ologie militari banno gradualmente trasformato l'impiego operativo di ~ues ta Arma

Nella seconda metà del secolo XIX, infatti, le armi da fuoco, per la loro maggiore rapidità di tiro :! più lunga gittata, resero meno efficace ed assai più sanguinoso l'utilizzo della Cavalleria in com :>attimento. Essa mantenne tuttavia importanti compiti di esplorazione, di sicurezza, di azioni a largo :-aggi o in t erritorio nemico, anche a grandi distanze dalle altre truppe (colpi di mano, distruzioni di vie di comunicazione, operazioni di sabotaggio), in ogni caso non dimenticando mai i l suo brillante Lillpiego tattico, la carica, che fu determinante specialmente contro tm nemico demoralizzato e privo :li adeguato armamento.
Ad assicurarsi gloria imperitura , nell'ora di decidere de ll a vittoria, la Cavalleria cercò di adattar :ii ai tempi: sia accettando nelle sue grandi unità aliq uote delle altri Armi, quali l'Artiglieria a cavallo, e, più tardi , reparti di Fanteria celere e di mitragliatrici, sia mettendosi in grado , con la dotazione :li efficienti armi da fuoco e di un buon equipaggiamento, di combattere tanto a piedi che a cavallo.
I particolari aspetti che assunse la lotta durante il primo conflitto mondiale e l'u so , sempre più ge nerale, di difese accessorie atte ad ostacolare l'azione della Cavalleria, indussero i comandi mili tari a ritenerne diminuita l'importanza , cosicché ne venne ridimensionata la forza rispetto alle altri Armi, misura adottat a da quasi tutti gli eserciti in campo.
Alla vigilia del conflitto, la Cavalleria italiana, dopo aver brillantemente partecipato alla conquista della Libia nel corso della guerra italo turca del 1911 1912, risultava cosfauita da ben trenta reg gi menti, di cui sei costituiti tra il 1909 ed il 19 15: dodici di dragoni e lancieri , diciotto di cavalleg ge ri. Di essi , sedici reggime n ti costituivano quattro divisioni di cavalleria, ognuna delle quali era arti: olata su due brigate; gli altri quattordici facevano parte, come truppe suppletive, dei corpi d'armata. Già nell'ottobre del 1915 , le caratteristiche della guerra di posizione , trincea reticolato-mitragliatrice, ridussero però le possibilità operative della Cavall eria che venne quas i compl etame n te appiedat a e una gran parte del personale trasferito ad altre armi e specialità: su 3 .000 ufficiali, 800 e su 24 .000 soldati 13 000
In particolare, nella nascente Aviazione , rifulse il valore di autentici assi: il maggiore Francesco Baracca, che abbattè 34 velivoli avversari, il te n. col. Gabriele D'Annunzio , il cap. Fulco Rufio di Calabria, il ten. Camillo D e Carlo, tutti decorati con medaglia d ' oro al valor militare.
Laddove fu però richiesta la sua tradizionale operatività e in so s tituibile capacità , la Cavalleria ve nne rimessa a cavallo e, nell'agosto del 1916 , co n quistò Gorizia inseguendo poi il nemico in riti rata.
Nel 1917 , in seguito allo sfondamento del fronte da parte degli austro-tede s chi a Caporetto , tre div isioni di Cavalleria in retroguardia difesero i reparti in ripiegamento sul Piave e, con grande sacri-
3-
ficio ed ero ismo, rallentarono .l'avanzata nemica: compiti che assolsero co n le due importanti battag li e del Tagliamento e di Po zzuolo del F r iuli, perdendo circa metà degli uomini.
Fedeli ai loro ideali, i cavalieri ebbero se mpre e comunque modo di distin guersi in vari fatti d'arme, come l ' incisivo motto del "Genova Cavalleria" recita: "Soit à pied soit à cheval , mon honneur est sans éga l".
·
La Cavall eria sarà protagonista anche nel 1918 con la difesa de ll a lin ea del Riave e la r iscossa di Vittor io Veneto. Alla conclusione de l conflitto, in 32 Bollettini de l Comando Supremo, le unità di Caval leria saranno citate dal giugno 1915 al novembre 1918. Nel Bollettino della Vittoria del 4 novembre I 918, ore 12 , il ge nera le Armando Diaz , proclamerà: " l'irresistibile slancio delle divisioni di Cavalleria ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente ...". Agli Stendardi dei reggime nti verra nno assegnate 8 medaglie d'argento e 10 di bronzo al valor militare e, con motu proprio sovra no, ali' Arma di Cavall eria verrà decretata la ma ssima ricompensa della ìhedaglia d 'oro con la seg uente motivazione: "In 41 mesi di guerra diede mirabile esempio di abnegazione e di sacrificio, prodigandos i nei vari campi della cruenta lotta. Rinnovò a cavallo i fasti della sua più nobile tradizione; emulò, appiedata,fanti, artiglieri e bombardieri; fornì per i duri cimenti dell 'aria piloti di rara perizia e singolare eroismo. Maggio 1915 novembre 1918".

I soldati italiani non si coprirono di gloria so ltan to s ul Piave e sug li Altipi ani, ma intervennero, a fianco degli alleati inglesi, francesi, serbi , greci e rus si, su diversi fronti anche mo lto distanti dai confini della madrepatria: in Alba ni a, in Macedonia e in Francia.
Il fro nte a lbanese ve nn e ad assumere una notevo le imp orta nza, quale baluardo al pred omi nio austriaco sull'Adriati co. In particolare , nell'estate del 191 8 ebbero luogo violenti combattim enti , ne i quali rifulse il valore della cavalleria i taliana: no n furono so lo du e reggimenti, il 22° Cavalleggeri di Catania e iJ 30° Cavalleggeri di Palermo , ad essere decorati al valor militare, ma anche, caso uni co nella storia de ll 'Arma, un singo lo squadrone: lo Squadrone Sardo.
La memoria dell'epica carica di Pozzuolo del Friuli , l 'evento bellico più sign ifi cati vo cu i prese parte la Cava lleria nel corso della Grande Gu erra, è stat a tramandata fino a i gio rn i no stri nell 'ordi name nto dell 'Ese rcito italiano. Quando ne l 195 3 fu ricostituita la ter za D iv isi on e corazzata, dopo I'" Ariete" e la "Centa uro ", quest a ven ne chi ama ta " Pozzuolo de l Friuli". Contratta nel 1958 a live llo d i Br igata, oggi la " Pozz uo lo del Friuli" inquadra propr io i reggimenti " L ancieri di Novara" e "Ge nova Cava ll eria", protagonis ti della famosa carica c he si svol se tra il 29 e il 30 otto bre I 9 17 Ogni ann o, in questa data viene ce leb rata la festa deH ' Arma. Raccon tare, a novant'anni dalla fine della Prima guerra mo ndi a le, la storia di questa nobile Arm a che mo lti , ab ituati a vedere qu el tragico co nflitto come un a g uerra di massa e di posizione, co nsiderano priva di particolare interesse, è vo lerla rip ortare nell a giusta co nsid erazione s torica Si è a nc he vo luto inserirne l 'operato in un contes to sopranaziona le, europeo, co nfronta ndolo co n quello che le a ltre cavallerie stavano organi zza ndo s ui ri spe tti vi fronti. La Cavalleri a passò g li a nn i della G rande Gue,n attraversando div erse tra sform azio ni organiche e d'impiego s trategico , tat ti co e logi sti co, in ultimo , mutate le situazioni, la riport arono sul campo di battaglia co me a rtefi ce principale della manov ra e de ll a vittoria finale.
Colo nne ll o Antonino Zarco ne
-4-
INDICE GENERALE
PRESENTA710NE pag. 3
CAPITOLO I SQ UAR C IO TEMPORALE: CARICA A PO ZZUO LO » 7
CAPITOLO Il TATIIC A EVOLUZIONE E CAMBIAMENTI: 1861-191 l » 11

CAPITOLO III L' fNTERMEZZO OLTREMARE » 31
CAP ITOLO IV VERSO LA P RIMA G UERRA MONDIALE » 35
CAPITOLO V L A CAVALLERIA E LA NUOVA GUERRA EUROPEA: LE ESPERIENZE DELL'ARMA SUGLI ALTRI FRONTI » 45
CAPITOLO VI L ' ENTRATA IN GUERRA » 53
CAPITOLO VII LE OPERAZIO NI : L'ATTACCO ALL' l SONZO » 63
CAPITOLO VIII IL SECONDO ANNO Dl G UERRA » 97
CAPITOLO IX T UTTI A PIEDI! SIGNORI, C AVALIERI ALL'ASSALTO! » 107
CAPITOLO X Ù FFENSJVA TN ASIAGO » 119
CAP ITOLO XI RITORNO SUL CARSO: LA PRESA Dl GORIZIA » 123
CAPITOLO XII IL TERZO ANNO DI GUERRA: 1917 » 143
CAPITOLO Xlll SFONDAMENTO SULLA B AINSIZZA » 157
CAPITOLO XIV SFOND AME NTO A CAPORETTO » 17 1
CAPITOLO XV TuTn A CAVALLO ! » 179
CAPITOLO XVI L A CAVALLERIA SUGLI ALTRI FRONTI » 201
CAPITOLO XVII IN ALBANIA » 207
CA PITOLO XVIII L 'ULTTMO ANNO DI GUERRA: LA RIVINCITA! » 211
APPENDICI ORDINE DI BATIAGLIA DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA ALL'TN1Z10 E ALLA FINE DELLA GUERRA » 237
I NDICE DEI NOMl » 244
INDI CE DEI REPARTI » 250
I NDICE DEI L UOGHI » 255
B IBLIOGRAFIA » 263
-5
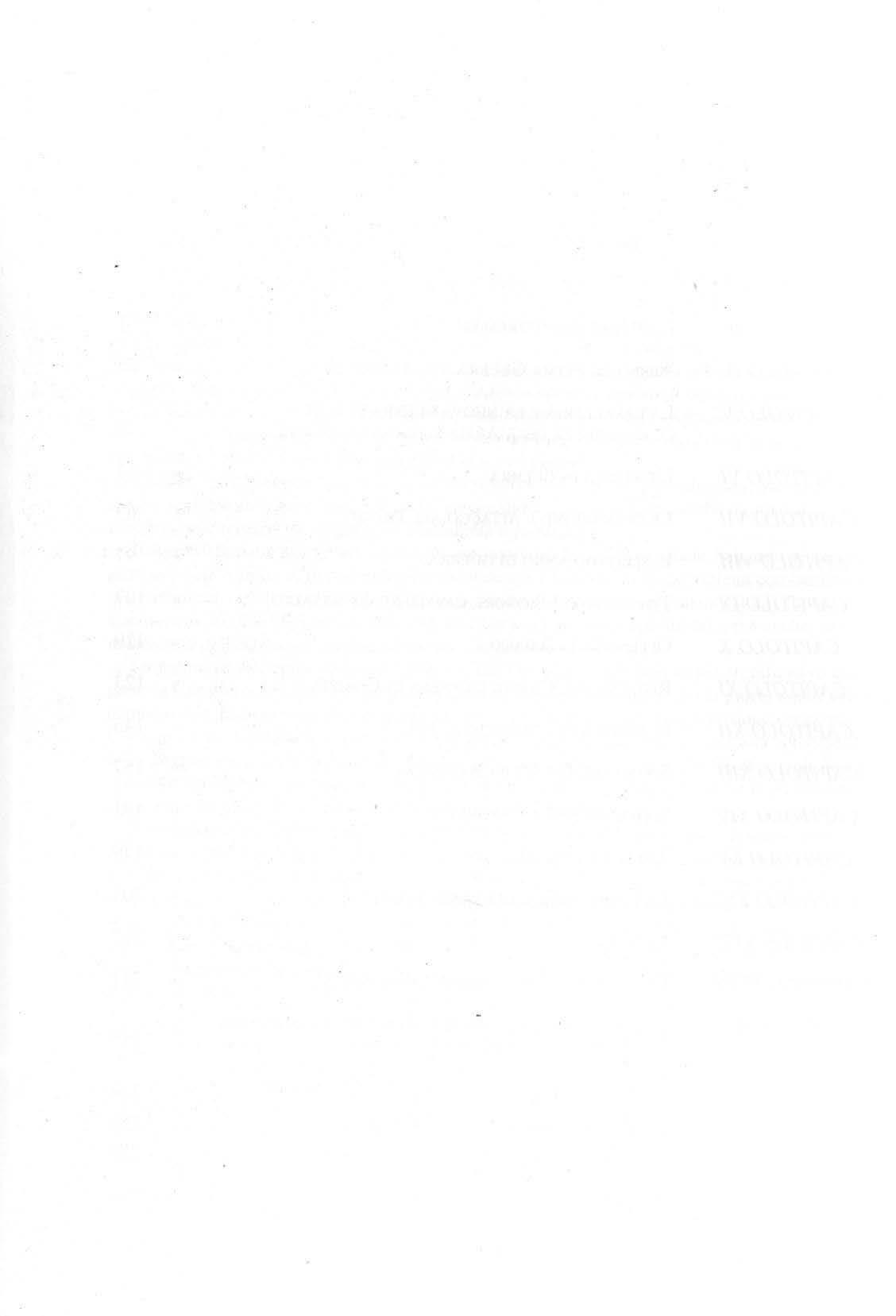
CAPITOLO I
SQUARCIO TEMPORALE: CARICA A POZZ UOLO
Il29 ottobre 1917 , cinque giorni dopo l'attacco austro-germanico su Plezzo Caporetto, il Regio Esercito italiano, ancora sotto lo shock degli avvenimenti, stava lentamente ritirando si verso i grandi fiumi Tagliamento e Piave. Gli Austro-Germanièi, anch'essi sorpresi dalle dim ensioni prese dal loro attacco, andavano dilagando nella pianura friulana. Le avanguardie della 14a Armata austro-tedesca, potentemente·armate con le nuove rrùtragUatrici 1 portatili, percorrevano ]a direttrice principale di accesso alla pianura veneta. Sol dati isolati e reparti sbandati venivano raggiu nti e catturati in un'avanzata che sembrava inarrestabile. Colonne e colonne di uomini , donne, soldati , civili, co n carri e animali, percorrevano mestamente la stessa direttrice , cercando di fuggire dall'inv asore. In mezzo a quell 'e norme tragedia la cavalleria italiana, so la , percorreva quella stessa strada in se nso inverso. Era l'e strema difesa contro le truppe nemiche. Nel vederla tutti, civili e so l dati rim anevano colpiti dalla sensazione di coraggio, onore, riscatto che infondeva. Alla II Brigata di Cav alleria del generale Erno Capodilista , composta dai reggimenti Genova e Novara ,2 era stato affi dato il compito di presidiare un piccolo paese, P ozzuolo del Friuli, con lo scopo di irradiare ricognizio ni in direzione di Udine e ritardare dove possibile l'avanzata nemica .
La sera de l 29 ottobre la Brigata di Cavalleria aveva raggiunto l 'obie ttivo. P ioveva , ed era una piog gia fredda quella che bagnava uomini e animali . Arrivati a l paese , i cavalieri avevano accudito ai loro cavalli. Alle prime luci dell'alba pochi tra loro erano riusciti a riposarsi e, mentre eseguivano i loro compiti , l a 7a D ivisione rinforzata del generale R avelli ricevette l'qrdine di contrattaccare per contenere l 'avanza ta avversaria s ul Tagliamento. I fanti della 7a dovevano disporsi su più colonne e imp egnare battaglia . L a parte orientale dello schieramento della D ivisione era costituita dalla Brigata Bergamo, co m andata dal colonnello brigadiere B a l bi, co i reggimenti 25° e 26°, che, da Santa Maria la Longa per Santo Stefa no, Tis sano , Lavariano , P ozzuolo e Carpeneto, dovevano tendere a Campoformido. Verso le 11 la Brigata si era attestata lungo la strada Carpeneto-Sclaunicco e alle 11.3 0 giungeva a Pozzuolo. I fa nt i presero immediatamente contatto coi cavalieri che dalla sera prim a si trovavano là Il colonnello brigadiere B albi dispose che i battaglioni II/25° e III/26° costituiss ero riserva col comando di brigata e che gli altri quattro, guidati dal colonnello Pela gatti , comandante del 26° , proseguissero per Carpeneto , l ocalità di attestamento dell'ulteriore avanzata.
Le truppe avevano appena iniziato la loro marcia quando vennero investite da un intenso fuoco . Mentre le mitragliatrici falciavano i] terreno, le bombe scoppiavano tra gli uomini già provati. Gli Aus tro -Tedeschi erano già padroni di Carpeneto e stavano iniziando un combattime nto che sarebbe entrato nell a storia. M entre sulla strada di Carpeneto si moriva, le truppe dell'avanguardia nemica , av anzanti da Terrenzano, attaccavano violentemente P ozzuolo Lì , bruscamente riportati alla realtà della guerra , si trovavano gli squadroni appiedati ed alcune mitragliatrici. della II Brigata di Cavalleria.3
1 E. R OMMEL, Fanterie all'attacco. Esperienze vissute, Milano, Longanesi , 1972; K KRAfff voN D ELLMENSINGEN , 1917 lo sfondamento dell ' Isonzo, a cura di Gianni Pieropan, Milano, M ursia, 1981.

2 La seconda brigata di cavalleria, la sera del 28 ottobre si era raccolta in Trivignano Udinese, verso le ore 10 del giorno 29 ri cevette l'o rdine di portarsi a Pozzuolo del Friuli. La brigata era composta dal Reggimento Genova (colonnello Bellotti) in testa, seguita dal R eggimento Lancieri di Novara (colon nello Campari) giunta verso le ore 16.30 nei pressi di Sa mmardencbia venne informata che pattuglie austriache erano state segnalate nei pressi del paese.
1 Nic olò GIACCHI, Il combattimento di Pozzuolo del Friuli nell'ottobre del 1917 , su " Nuova antologia" , Roma , Bestetti e Tuminelli , 1927.
-7
 Ottobre 1917: cavalleggeri e mitraglieri osservano un cavallo colpito a morte.
Ottobre 1917: cavalleggeri e mitraglieri osservano un cavallo colpito a morte.
8
Al mattino de l 30 ottobre il V Squ adro ne di Genova , al comando del capitano Lampugnani , era stato messo a dispos izione del comandante deJla 7 8 Divisione a Santa Maria di Sclaunicco. Al resto della Brigata era stato ordinato di tenere Pozzuolo e d'informare sulla consistenza delle truppe nemiche nella zona Canale di Ledra-Udine-fiume Torre. Per questo al1e 5.30 erano state inviate alcune pattu gli e del Reggimento Geno va Cavalleria al comando dei te nenti Bas si ed I vancich e del Regg imento Lancieri di Nov ara al comando del tenente D ' Afflitto , dei sottotenenti Morosini e Martinozzi e degli aspiranti Benin e Chigi. I tenenti Bass i e Ivancich furono i primi a trovare il nemico e segnalarono la presenza di nuclei armati di mitragliatrici nei pres si di Terrenzano. Ricevuta la no tizi a , i comandanti dei reggimenti rinforzarono la difesa de] pa ese con tutti gli appiedati disponibili e mi s ero al sicuro i cavalli nei cortili.
Poco prima di mezzogiorno , le truppe d'avanguardia austro-tedesche provenienti da Terrenzano diedero inizio all ' attacco. Mitragliatrici in testa, divis i per s quadre, i nemici puntarono decisamente ad ac cerchiare i cavalieri che , intanto , sistemati a difesa , rispondevano al fuoco e li fermavano. Me ntre i cavalieri combattevano , venne ulteriormente ordinato di resistere in attesa di rinforzi. Anche il c omandante della 7a Divisione ribadì che la resistenza in Pozzuolo doveva essere ad oltranza e che face va affidamento s ul valore e sul sacrificio della II Brigata di Cavalleria. A mezzogiorno, riavutisi dalla sorpresa dell'inattesa res istenza , gli Austro-Tedeschi accentuarono la pressione dalla parte di Terrenzano. Riorganizzatisi , i reparti partirono all ' attacco con numerose mitragliatrici in testa. F urono respinti ancora, dopo un violento corpo a corpo nel quale la baionetta era tornata ad essere reg ina delJa lotta. Disorientati , i nemici si ritirarono e riordinarono , dilagando poi in direzione ests ud per scavalcare la re sistenza accerchiando Pozzuolo. Fu quello il momento della leggenda. Il generale Giorgio Emo Capodilista ordinò aJ comandante di Novara di far uscire uno squadrone a c avallo per caricare. Il capitano Sezanne , del IV squadrone , fece montare in sella i suoi lancieri e caricò . In un mis to di sorpresa , ammirazione e panico, gli Austro-Tedeschi videro una scena ormai ritenuta d ' altri tempi: cavalli , lance, fucili, sciabole puntavano dritti su di loro , che , sorpresi e sgomenti ripiegarono su Terrenzano , raggiunti e falciati dalle mitragliatrici del Genova. Alcuni , impietriti dallo spettacolo , rimasero fermi e furono fatti prigionieri.
Da loro si venne a sapere che una brigata di fanteria nemica era già arrivata a Terrenzano , avang uardia d ' un gro s so contingente composto da più divisioni.
Alle 14, rinforzate le colonne d ' attacco e riavutisi dalla sorpresa della carica , gli AustroTedeschi sferrarono un nuovo attacco. Mitragliatrici in testa , alle 16.30 il combattimento si riaccese e in breve raggiunse l ' acme. Colpiti dall'onda d ' attacco, sottoposti a fuoco continuo , i cavalieri indietreggiarono, lasciando sul terreno decine di uomini. Sfondato infine lo sbarramento italiano , dalla paite di Terrenzano, i nemici cominciarono a penetrare nel paese. Tra spari , urla e gemiti , fra le vampate delle mitragliatrici e gli zampilli del sangue , 1e perdite si fecero sempre più gravi.
I cavalieri retrocedettero. Venne ferito il tenente Castelnuovo delle Lanze di Genova Cavalleria , c omandante di una sezione mitragliatrici che era appostata allo sbarramento principale. Sebbene di sorientati dalla perdita dell'ufficiale , i. mitraglieri ritirarono l e armi, piazzandole sulla strada dietro una seconda barricata immediatame nte costruita a difesa. A comandarla andò lo stesso capitano Ticchioni , comandante dello squadrone mitragliatrici: era l'ultimo baluardo.
Il combattimento intanto si estendeva ed impegnava tutti gli uomini , nessuno escluso. Al IV squadrone di No vara venne nuovamente affidato il compito di caricare il nemico , infiltratosi in una delle strade del paese. Per la seconda volta nella giornata , stretto il soggolo dell ' elmetto , impugnata la sciabola , la lancia e il moschetto il IV Novara caricò; e per la seconda volta impressionò l'avversario , che si fermò incerto. Questa s osta permise allo squadrone mitragliatrici di Genova di disimpegnare le proprie anni. Contemporaneamente all ' attacco dalla parte di Terrenzano , però, gli AustroTedes c hi erano riusciti a s fondare gli sbarramenti verso Carpeneto , difeso dal I s quadrone e dallo

-9-
squadrone mitragliatrici dei Lancieri di Novara . Alle 17.30, dopo un'ora d i sangue, la situazione si fece insostenibile: il paese era accerchiato; si combatteva con onore e valore sulla piazza e nelle strade, senza risparmio, ma alcuni assa lt atori austro-tedeschi e rano già entrat i nelle case del paese e, ragg iunte le finestre c he guardavano sul le strade, avevano piazzato le mitragli atrici e cominciato asparare vio lentissime raffiche.
Presi tra due f uoch i e colpiti anche dati 'alto, caddero il maggiore Ghittoni ed i tenenti Bianchini, Vernarecci e Botta d i Genova Cavalleria. A questo punto, ritenuta vana ogn i ulteriore res i stenza, Erno Capodilista diede ai suoi reggimenti l'ordine di montare a cavallo e di ripi egare su Santa Mari a di Sclau nicco, ap rendosi un varco in qualunque modo ed a qualunque costo. Gli uomini si di si mpegnarono con diffico ltà ed il ripiegame nto avvenne in circostanze estremamente difficili. Mo lti cava li eri res tarono bloccati, ne ll ' imposs ibilità di usci re coi cavalli dai corti li , mentre intorno crepitavano le mitragliatrici.

Alcuni re parti di Nol'ara riuscirono comunque a raggiungere uno sbocco fuori del paese; vennero fatti seg no dal fuoco di mitragliatrici e di fucileria ed allora, di nu ovo, come in una sce na irreale e d'un tempo passa to, i cavalieri ricevettero ancora l'ordine di caricare. Le lance infilzarono i nemici, mentre i cava lli nitr ivano e le grida degli uomini s i perdevano e smorzavano nell 'aria, pi e na del fragore degli zoccoli al galoppo c he si aprivano la strada; po i i cavali eri puntarono verso Mortegl iano. Al la loro testa, Erno Capodilista li incitava e li spronava, co mbatteva e si apriva un varco; poi, dopo una breve cavalcata, ordinò ai resti deUa sua brigata di ri o rdin ars i per reparti.
Ali 'appell o mancavano in tanti: una parte del gruppo di Novara che da Mortegliano non era riusc ito a raggiungere il punto di riunione , l'intero Stato Maggiore de l regg imento co n il co lo nn e llo Campari ed i due ufficiali superi ori, maggiore Sebellin e maggiore Sparita; e tanti altri. Era finita; ma era finit a bene: la Cavalleria aveva cari cato, assolto il suo com pito e adempi uto agli obblighi impost i dall'onore dell'Arma. Il resto, il prezzo pagato, non importava: Soit à pied, soit à cheval, mon honneur est sans égal.~
Nelle due g iorn ate di combattimento il co nteg no degli ufficiali e della truppa di e ntrambi regg i me nti era stato improntato a l valore e a ll a tradizione. La guerra di posizione che durava da due anni e c he sem brava aver l asc iato l'Arma impotente di fronte ai camb iame nti tecnologic i era tornata di mov ime nto. La cavaUeria aveva duramente pagato questo ulteriore cambiamento. Aveva combattuto co me un tempo, ma lasciando sul campo 34 ufficia li , 467 uomini di truppa e 528 cava lli. Era il duro prezzo necessario per tornare alla ribalta della storia.'
Questo glor ioso e sanguin oso ep isodio della storia della Cavalleria ita lian a rimise ne ll a g iu sta prospettiva il ru o lo dell ' Arma in un mo me nt o c riti co della sua esistenza. La guerra di pos izio ne e sopra ttutto i ri pe nsamenti sul suo impi ego, de termi nat i dal1e esper ienze degli ultim i cinqu a nt 'ann i di guerra ne l mond o, così lontani dalle esa ltanti es peri e nze delle cariche napoleoniche, stava no per re legarla ai serv izi seco ndari , facendole la~c iare per sempre il campo di battaglia.
• Motto di Genova Cavalleria.
i Effettivi della LI Brigata di Cavalleria: Comando della Brigata: ufficiali 3, truppa 4. cavalli 4; Genova Cavalleria: ufficiali 32. truppa 549, cavalli 549; Lancieri di Novara: uffi ciali 30, truppa 350. cavalli 355; total e il manino del 30 ottobre I9 I 7: ufficiali 60. truppa 903, cavalli 908. Alla sera dello stesso giorno 30, fra morti, feriti e mancanli la sit uazione di forza era la seguente: Comando della Brigata: ufficiali -. truppa 3. cavalli 3; Genova Cavalleria: ufficiali I8. truppa 300, cavalli 340; Lancieri di Novara: ufficiali I 6, truppa I 64, cavalli 185; totale: ufficiali 34, truppa 467, cavalli 528, fonte: Giorgio EMO CAPODILISTA, La seconda brigata di cavalleria "Ge nova e Novara·· a Pozzuolo del Friuli 29 e 30 ottobre 1917 (Carso 1916 Uven:a 1918). Padova. Tipografia del Messaggero, 1931.
-10-
CAPITOLO II
TATTICA EVOLUZIONE E CAMBIAMENTI: 1861 -1911
L'Esercito Italiano nacque nel 1861, con l'avvenuta Unità politica ed amministrativa del Paese. Le forze armate apparvero da subito, oltre l 'organjsmo preposto alla difesa della Nazione, anche lo strumento primo per la creazione dell'unica identità nazionale, fino allora latente nelle coscienze delle mille municipalità che formavano l'Italia.

Forse più di tutte le Armi che componevano l ' Esercito , la Cavalleria aveva il culto del senso dell'onore e del valore individuale, oltre ad un innato spirito aggressivo. Del resto il suo principio ispiratore era rimasto, dal tempo della sua formazione nel Medioevo, "il culto del punto d'onore". Erano principi condivisi dalle cavallerie di tutti gli eserciti europei e ne facevano un'Arma risolutiva sul campo di battaglia.
La Cavalleria italiana del 1861 era il risultato d ' un conglomerato di elementi disparati e di differente valore, tratti dalle forze armate dei singoli Stati diventati, con l'Unità, province del nuovo Regno e amalgamatisi nel nuovo Esercito. Il nucleo principale di tale esercito continuava ad essere costi tuito dalle forze armate sabaude, a cui si erano aggiunti man mano contingenti lombardi, truppe de11a Toscana e dell'Emilia, gran parte dell'esercito borbonico e numerosi elementi di quel1o garibaldino, ufficiai mente definito " Esercito Meridionale".
Nel 1861 , anno della proclamazione del Regno d'Italia, l'Esercito Italiano questa la denomi nazione ufficiale di allora contava 17 reggimenti di Cavalleria.
L'Unità del Paese aveva ampliato il vecchio organico piemontese, affiancando ai reggimenti sabaudi quelli delle nuove province. Erano stati chiamati, secondo le tradizioni della Cavalleria sarda, con nomi di città: Lancieri di Milano , La.ncieri di Firenze, Cavalleggeri di Lodi, Cavalleggeri di Lucca, Ussari di Piacenza. Un reggimento, i Lancieri di Montebello, aveva preso il nome da]Ja località dove , il 20 maggio 1859, la Cavalleria sabauda aveva riportato una importante decisiva vittoria sugli Austriaci; un altro, i Lancieri Vittorio Emanuele Il, venne intitolato al Re artefice dell'Unità; un terzo, il Reggimento Guide, invece derivò dalla fusione dello squadrone Guide dell'Emilia coi vari pJotoni di Guide a Cavallo divisionali.6 Come i reggimenti delle altre Armi dell'Esercito, anche quelli della cavalleria erano confluiti in un organismo unico, provenendo da tradizioni diverse7 • Più delle altre Armi però , ]a Cavalleria era amalgamata dalla tradizionale unità di ideali e dalla condivisione di valori e forme, così da presentarsi da subito come un efficace strumen-
6 BRIGNOLI, Marziano, L'arma di cavalleria 1861-1991, Milano. R.A.R.A., 1991. 1 I numeri reggimentali, per cui Guide diventò 19°, furono stabilitj dalla Riforma Ricotti Magnani, per cui, nonostante l'ordine d'anzianità fosse: 1683 (ma i_n realtà 1821), Genova (perché dal 1683 esistevano i Dragoni del Genevese, cioè del contado cli Gin evra, sciolti nel 1821 per la partecipazione all'insurrezione carbonara di quell'anno, poi ci fu forse un equivoco scambiando Genevese Génévois con Genovese, che in realtà in francese si scrive Génois e in italiano Genovesato. 1690, Nizza 1692, Piemonte e Savoia -1774 (ma in realtà I 831) Aosta 1828, Novara 1848, Monferrato 1848, Saluzzo 1850, Alessandria 1859, Firenze -1859. Gujde -1859. Lodi- 1859, Lucca 1859, Milano -1859, Montebello -1859. Pìacenza -1859. Vittorio Emanuele -1863, Caserta 1863, Foggia- 1871, Roma diventò nel 1871: 1 Nizza 2 Piemonte 3 Savoia 4 Genova 5 Novara 6 Aosta 7 Milano 8 Montebello 9, Firenze 10 Vittorio Emanuele 11 Foggia I 2, Saluzzo 13, Monferrato 14, Alessandria I 5, Lodi 16. Lucca 17 , Caserta l 8, Piacenza 19, Guide 20, Roma. A questi il l O ottobre 1883 furono aggiunti i nuovi reggimenti: 21 Padova e 22 Catania; il 1° novembre I 887 i nuovi: 23 Umberto I 24 Vicenza e il l O ottobre 1909 25 Lancieri Mantova 26 Lancieri Vercelli 27 Cavalleggeri cli Aquila 28 Cavalleggeri cli Treviso e 29 Cavalleggeri cli Udine.
- 11-
to di guerra, al pari delle s ue sorelle europee. Gli ufficiali erano iJ fior fiore della nobiltà di tutto il nuovo Regno, gli uominj avevano bella presenza e prestanza, erano coraggiosi, audaci e disciplinati, abili nel combattimento con la sciabola e con la lan cia . Era veramente una forza risolutiva su l campo di battaglia.

Del resto, all'indomani dell'Unità, la Cavalleria era, e non solo in Italia , concepita come " l'ar ma dell'urto risolutivo" e nulla faceva presagire che tale ruolo potesse cambiare. Perciò, in ottempe ranza a questo principio, ne fu aumenta la consistenza portando a 19 i reggimenti, coll'istituzione dei Cavalleggeri di Foggia e dei. Cavalleggeri di Caserta. 8
Oltre ad un incremento de] loro numero, i reggimenti v idero pure una modifica degli organici, in base alla quale, compreso lo Stato Maggiore ed i sei squadroni di base, la loro forza venne fissata in 42 ufficiali , 892 cavalieri e 67.0 cavalli, mentre veniva soppresso lo squadrone deposito.9
Il primo impegno del giovane Esercito Italiano , ancora in fase di "amalgama", fu conu·o il Brigantaggio , determinato dalla triste situazio ne creatasi nel Mezzogiorno della peniso la con la rivol ta seguita alla guerra del 1860-61 ed alla scompa r sa del Regno delle Due Sicilie. Fu un impegno cer tamente più pertinente a dei reparti di polizia che a delle forze armate, ma, nono s tante questo, la
8 "Giornale Militare'', anno 1864, R. Decreto per la costituzione di due nuovi reggimenti di cavalleria leggera; Torino, 28 gennaio 1864.
9 "Gio rnale Militare", anno 1866, Istruzioni per esecuzione dei R. Decreti 30 dicembre 1865 relativi all ' ordinamento sul piede di pace della fanteria, bersaglieri e cavalleria; Firenze, 17 gennaio 1866.
La caserma di Piemonte Reale Cava ll eria . 1900. (Archivio Dal Molin)
-12-
cav alleria vi partecipò attivamente in qualità di truppa celere. Non si era ancora del tutto concluso il Brigantaggio, che le anni furono di nuovo volte ad est, co ntro il nemico di sempre, l'Austria, per la liberazione del Veneto. Era la guerra del 1866, nella qu ale l'Esercito, guidato da generali non in accordo tra loro (e , pm1roppo per il valore dei soldati italia ni , questa sarebbe rimasta una costante fino all'avvento del generale Luigi Cadoma), nonostante il valore dei propri uomini, subì un'apparente sconfitta Custoza i cui effetti , ingigantiti dai pregiudizi, si sarebbero fatti sentire sul piano morale per diversi anni.
Proprio in quel ciclo operativo la cava11eria avrebbe potuto essere brillantemente impiegata tat tic amente, sia nell'esplorazione, sia nell'intervento in massa nel combattimento. Ma l'esplorazione man c ò totalmente Non si diedero ordini perché venisse eseguita, anche se, a dire il vero, non risulta neppure che i comandi dell'Arma li sollecitassero; nulla di strano per modo di dire dunque se no n venne eseguita. Del resto questo era pure il risultato di una radicata convinzione. Infatti, il valo re dimostrato dalla Cavalleria in genere nelle precedenti guerre e maggiormente in quelle napoleoni che, aveva confermato il generale convincimento che essa fosse essenzialmente arma da battaglia e av e va orientato i comandanti delle Grandi Unità di fanteria, agli ordini dei quali agivano i reggimenti dell'Arma, ad impiegarla nei combattimenti ogniqualvolta si presentasse la necessità di risolvere u na situazione difficile.
L' Arma diede invece valente prova di sé nella seconda fase della campagna , quando, durante l'avanzata verso l'Isonzo e Trieste, i reggimenti di Cavalleria dimostrarono il loro coraggio e valore co mpiendo di propria iniziativa numerose esplorazioni e scorrerie.
 Il co lonnello comandante il Reggimento Piemonte Reale , I900. ( Archivio Dal Molin)
Il co lonnello comandante il Reggimento Piemonte Reale , I900. ( Archivio Dal Molin)
13-
Finita la Terza Guerra d'Indipendenza, le autorità militari italiane se ntirono la necessità di disporre di quadri professionalmente preparati all'esercizio del comando. Del resto quello della catena di comando sarebbe stato uno dei grandi problemi che i vertici militari si sarebbero trova ti ad affrontare nei decenni seguenti, e che meriterebbe ancor oggi uno studio più articolato e accurato .
Comunque, sul momento si pensò di risolvere alcuni problemi in un modo tanto semplice quanto preconcetto. Essendo stata la guerra condotta in "unità" con l'esercito Prussiano ed avendo dato quest'ultimo grande prova sul campo , si decise di prenderlo come modello per migliorare lo stato e l'efficienza di quello Italiano.

L'esempio prussiano stava a dimostrare che la guerra andava fatta con metodo scientifico, non essendo più sufficienti il solo coraggio e l'esperienza per vincerla. Dunque bisognava riorganizza re l'armata e per questo era fondamentale apprendere con metodo. Venne così riorganizzato lo Stato Maggiore e creato anche in Italia un Istituto di cultura militare , che fu chiamato Scuola di G uerra. 10
Il riordino dell'organizzazione militare non riguardò però la Cavalleria . Nonostante la campag na del 1866 avesse dimostrato la grande utilità dell'esplorazione e d'un addestramento ippico che più ris p o ndesse alle esigenze di quel servizio, l'istruzione equestre non divenne tale da rispondere a quell'importante esigenza. Ci si limitò infatti ad un mutamento organico, creando, nel 1869, cinque Comandi territoriali di cavalleria quali ispettorati permanenti delle truppe di cavalleria . 11
D riordino dell'Esercito non passava però solo dalla volontà dei militari di rinnovarsi. Attuata la quasi totale un ità politica della Penisola, il Governo, in piena crisi economica, vincolò le sue forze armate ad un programma generale di strettissima economia. Il bilancio ordinario della Guerra fu per tanto ridotto nel 1867 a poco più di 144 milioni di lire, con un contingente annuo di 40 .000 uomini, ulteriormente diminuito nel 1869 a 138 milioni di lire con un contingente di 30 .000 uomini. Tale riduzione in armi e uomini non poteva non influire negativamente sulla validità di un'organizzazione ancora non pienamente efficiente.
Infatti, dopo iJ 1870, il governo, che con la spedizione di Roma aveva per la seconda volta rico nosciuto le manchevolezze dell'apparato militare , corse ai ripari e si avviò sulla strada del1e necessarie riforme . P er farlo prese ancora a modello gli ordinamenti prussiani, che avevano dato indiscussa prova d'efficienza in ben due conflitti, l'ultimo dei quali appena terminato in Fraocja in maniera trionfale. Ma le riforme italiane procedettero lente e restarono frammentarie a causa delle condizio ni finanziarie del Regno. Ad ogni modo lo sviluppo dell'esercito fu marcato da leggi quadrn, che presero il nome dei ministri che le co ncepirono. Nell'ordine furono gli ordinamenti: Ricotti Magnani, del 1870 1875; Mezzacapo, del 1876-1877; Ferrero, del 1882-1883; Bertolè-Vìale, del 1887-1888; P elloux, del 1896 e, l'ultimo, Casana-Spingardi, del 1908-1913. 12
Q uesti Ordi n amenti stabilirono l'obbligo generale di tutti i cittadini al servizio militare, prima per 12 e poi per 19 anni, predisposero la costituzione di un esercito di seconda linea coll'istituzione di unità di Milizia Mobile e Territ_oriale ed infine ridussero progressivamente la ferma annuale , da cinque a quattro e poi a tre anni per tutte le Armi , eccettuata la Cavalleria, che la mantenne di cinque.
10 " Giornale Militare" , anno 1867 , Riordinam ento del Corpo di Staio Maggiore; Firenze, Il marzo 1867.
11 " Giornale Militare", anno 1869 , Istru zione circa alla attribuzione dei comandi territoriali di cavalleria ed alle loro relazioni co lle altre autorità militari; Firen ze, IO settembre 1869.
12 MlNISTERO DELLA G UERRA, COMANDO DEL CORPO Dl STATO MAGGIORE UFFIOO STORICO, L'Esercito Italiano nella grande guerra (1915 1918), voi. I , /eforze belligeranti. Roma , 1927.
-14
 Drago ne di Piemonte Reale di guardia allo stendardo al Quirinale , in attesa del passaggio del Re , nelJ ' ultirno inverno prima della Grande Guerra. (Arc hi vio Dal Molin)
Drago ne di Piemonte Reale di guardia allo stendardo al Quirinale , in attesa del passaggio del Re , nelJ ' ultirno inverno prima della Grande Guerra. (Arc hi vio Dal Molin)
15
L 'as petto più importante d ell ' Ordinam e nto Ri co tti 13 fu la legg e s ul reclutamento, c he sa nciva il principio dell 'o bbligo generale e pe rs onale di tutti i cittadini masc hi al servi z io militare, non es clu dendo ne mmeno g li esonerati. La legge es tese gli o bblighi di leva al 39° an no di età e prev id e tre classi d i le va: la I ca tegori a, i cui appartene nti erano c hiama ti alle armj; la II , co mpre ndente i sogge tti alla chiamata per un periodo non s uperiore a cinque me si e, infine, la m , alla qu ale erano iscritti tutti i citt adini maschi fi sicamente idonei ma non isc ritti n ella I e II categoria per motivi di cara tte re s ociale o fami liare. Con segue nteme nte l ' Eser c it o fu diviso in tre linee: prima linea , Esercito a ttivo o esercito di campagna, costituito dalle classi alle armj e da qu e lle con gedate d a meno tempo; seco nd a linea, o Milizia Mobile , fo rmata da riserv isti di media età e destinata ad oper are a ridosso e rincalzo delle truppe di prima lin ea; terza linea o Milizia Terri toriale, cos tituita dalle classi più a nziane della riserva , destina ta a compiti di sic urezza interna ed a s ostituire l'e se rc ito di prima lin ea nei compiti d i presidio.' 4

Anche la Ca valleria fu rapidamente riorganiz zata . Col Regio Decreto 4 dicembre 1870 ve nne ordinata su sei brigate con la costituzione di altrettanti Comandi di Brigata di Cavalle ria. In ordine all'organico dei regg im e nti , furono seguiti due criteri, comu ni ai prin c ipali eserci ti europei: squadrone forte e reggimento su quattro squadroni , oppure squadrone leggero e reggimento s u sei squadroni. I 19 reggimenti italiani erano s u sei squadro ni di 110 cavalli ciascuno, organico troppo leggero, anche perché la forza effettiva in tempo di pace (forz a bilan ciata) era inferiore all'organico e, in caso di mobilitazione , non si era in condizioni di provv edere tempestivam e nte al fabbisogno di cavalli. In pratica quindi i reggimenti restavano su quattro-cinque squadroni leggeri invece che s u sei.
Un altro problema riguardava l ' adde stramento ippico. Le ultime vicende belliche a vevano c hiaramente dimostrato l'inidoneità della corre nte equitazione militare alle esigenze della gue rra. Occorreva trovare un adde stramento che consentisse ai reparti a cavallo di correre la campagna, per sv olgere proficuamente quell ' atti vi tà esplorativa che si avviava a dive ntare il compito prin c ipal e de lla Cavalleria. Qualco sa era già s tato fatto in qu esto senso da quando , nel J 865, aveva assunto il comando della Scuola di Cavalleria di P i ne rolo (de nominazione poi assunta nel 1887) il colonnello Lui gi Lanzavecchia di Buri , che aveva dato notevol e impul so all'equitazione da campagna .'5
La g uerra Franco-Prussiana del 1870-71 diede un' accelerazione alla necessità di adeguare l'istruzione delle truppe. Le grandi vittorie riportate sui Fra ncesi avevano richiamato l'att e nzione s ulla condotta ope rativa de ll 'eser c ito tede sco . I prin ci pali Stati europe i organizzarono allora le loro forze militari e modellarono i loro regolamenti s uJl ' esercito germanico, acce ttando quas i s enza di scuss ione gli in se gnamenti tattici proclamati frutto dell 'espe ri enza bellica del '7 0.
Nel L870-7 l i Tedesc hi erano s tati animati da un grande spirito offens i vo, i fatt i avevano dato loro ragione e, di consegue nza , tutti i re go lame n ti s i plasmaro no s ul co nc etto dell 'offen s iva ad ogni costo, generando il preconcetto c he s i do vess ero so ltan to co mbattere battaglie d ' inco ntro.
I Tedesc hi avevano messo in batteria fi n dal principio de ll e azioni tutta l ' artiglieria disponibile , ce rcando di ridurre al silen z io que ll a franc ese, perché la loro fanteria potesse avanzare. E , com e l'offe n s iva ad ogni costo aveva dato buoni frutti , perch é i Fran ces i nell'in tento di s fruttare i loro fucil i a tiro rapido si erano attestati su una forma d i difen s iva qu asi pass i va, così il s istema d'impiegare fin
'' Si deve tra l'altro proprio alle riforme del ministro Ricotti il Regio D ecreto 13 dicembre 1871, che ordinava all'E e rcito ed ali' Armata (come ve njva c hi a mata la Marina al lo ra) di po rtare, com e segno caratteristi co della divisa militare le s tellette a cjnque punte su l bavero della rispettiva divisa militare; a firma di S.M. Vittorio E manuele II , del generale Ce are Ri cotti Magnani, mini tro della Guerra e dell'ammiraglio Augusto Ri boty, ministro della Marina.
•• Oreste Bov 10. Storia dell'Esercito It aliano (1861 1990), Roma, U fficio Storico Stato Maggiore del l ' E serc ito, 1996, pag.93.
15 Cfr. ASSOCIAZIONE AMICI DEL M USEO STORICO DELLA CAVALLERIA. i/ museo storico della cm•alleria Collegno. Roberto Chiaramonte editore. 2000.
-1 6
d al principio molte artiglierie aveva dato ottimi risultati, in quanto quella francese era quasi sempre s tata ridotta al s ilenzio dalla migliore artiglieria pru ss iana. Così però era nato il secondo preconcetto, c he avrebbe influito pesantemente sulle guerre a venire, ossia che le battaglie si dovessero iniziare co n grandi duelli d'artiglieria.
l Tedeschi , dopo le prime offens ive, av e vano lanciato le loro divi s ioni di cavalleria sulle tracce de i Corpi d ' Atmata francesi in ritirata ed esse , mai ostacolate s eriamente dalle retroguardie o dalla c av alleria francese, avevano potuto assumere informazio n i , tenere il contatto e riuscire , in qualche c as o , ad operare anche delle sorprese. Era nato così il principio dell ' avanscoperta fatta dalle division i di caval1eria 16 e , visto che la cavalleria tedesca aveva esplicato un ' intensa attività esplorativa a largo raggio e l'esercito tedesco era uscito vincitore dal conflitto, anche l a cavalleri a italiana, come il re sto delle Forze Armate , prese a modello que ll a tedesca Furono quindi emanate nuove indicazio ni s ull e attività di esplorazione , scorta e sicurezza. I regolamenti di esercizio vennero adeguati alle e s igenze della guerra e, fatto importante , l e evoluzioni si ridussero so l tanto a quelle da eseguirsi da vanti al nemico. Per il resto la cavalleria doveva possedere i requisiti di mobilità e velocità. Nacque c osì un Corso compleme nta re di Equitazione di C ampagna 17 fuori Roma , a Tor di Quinto , località ri te nuta particolarmente idonea a quel tipo di addestramento, perché dotata di un ampio terre no pia neggia nte , compreso fra la sponda destra del Tevere e bassi rilievi collinari, che offriva quindi una n otevole varietà morfologica in uno spazio relativamente ristretto. Furono intensificate le lezioni teo ric he e le esercitazioni; nulla fu trascurato per addestrare la Cavalleri a nei servizi di esplorazione e sicurezza ed in quelle operazioni che allora si chiamavan o di "piccola guerra" , ossia attacchi di sor presa, i ncurs ioni , imboscate e così via. 18
Dal punto di vista tattico il decennio successivo alla guerra del 1870 fu improntato al ripensame nto del ruolo della cavalleria in una futura guerra, di c ui le armi a tiro rapido e le artiglierie stav ano cambiando l ' impostazione.
Malgrado tutte le raffinatezze dell ' addestramento e malgrado lo studio minuzioso di come e rano state condotte nel passato, nelle campagne di guerra il fattore sorp resa rimaneva sempre il fat to re dominante . D ato poi che una situazione non è mai rigorosamente identica alle precedenti, né nelle condizioni storiche, né per gli scherni teorici, l'impiego della Cavalleria nell 'esplorazione s trategica fu recepito come innovativo. I regolamenti di tutti gli eserciti recepirono immediatamente delle norme attuative in tal sen so . Qu ello però che sorprese gli ufficiali di Cavalleria, che studiavano l'importante e recentissima campagna franco-prussiana , fu il non comprendere come mai la Cavalleria francese non si fosse opposta a quella tedesca per impedirne o almeno ostacolarn e l 'es plorazione.
In realtà i fatti che erano stati alla base del totale ripensamento sulle funzioni dell'Arma consistevano in quanto era avvenuto a Sedan nel 1870: cinque reggimenti d i cava ll eria e due di lancieri, c on alla testa il generale Margueritte, si stavano preparavano alla carica , carica che forse avreb be rimes s o in discussione molti concetti. Era il sacrificio che si chiedeva alla cavalleria francese, rimas ta quasi inoperosa in quel lontano settembre 1870 , alla quale veniva quindi chiesto d'arrestare l' avanzata deJ V e dell ' Xl Corpo tedesco. Prim a che il movimento iniziasse però, un proiettile aveva c olpito mortalmente Margueritte , che , davanti al fronte dei s uoi reggimenti , guardava verso Fleigneux e stava im partendo le ultime disposizioni. Alcuni ufficiali dello S ta to Maggiore ne avevano sollevato il corpo e lo avevano portano davanti a ll a lin ea del 1° Chasseurs d ' Afrique , i cui solda-

1 • C ap. C. P ERLO, Le ultim e g uerre e l 'evolu zi one d ella tatti ca , Lucca, s tabilim e nt o Lip o lito Boc c hi , 1910.
17 A SSOCIAZIONE A MIC I DEL M USEO S TO RI CO DELLA CAVALLERIA, Tf mus eo storico de lla ca valleria , cit.
" MlNJSTE RO D ELLA G UERRA, Istru z io ni per l ' amma estrame nto tattico della cavalleria. Roma , Voghera Carlo tipografo d i S.M ., 1872.
-17
ti, ritti sugli arcioni, alla vista del loro comandante sanguinante, avevano perso ]a testa dalla rabbia. Il generale Gallifet aveva assunto il comando della massa di cava11eria francese , che, folle per il desiderio di vendetta, aveva caricato in modo disordinato. Gli squadroni avevano agito ognuno per proprio conto, erano caduti su una brigata di fanteria. ne avevano rotto la prima linea e si erano abbattuti su otto pezzi di artiglieria. Chasseurs, ussari, lancieri, corazzieri, avevano formato una massa confusa che era apparsa e scomparsa qua e là, prima di svanire per sempre 19 nel turbine del fuoco della fanteria ted esca, lasciando il campo coperto di cavalli e cavalieri feriti o morti. Di quelli che erano partiti alla carica, solo poco più della metà erano riusciti a raggiungere il bosco de11a Garonne. La carica non aveva dato alcun risultato utile. Quella cavalcata alla morte, perché quello era stata in realtà, aveva fatto sfuggire un grido di ammirazione al vecchio Re di Prussia ed al maresciallo Moltke , lasciandoli attoniti di fronte ad un simile spettacolo, ma non aveva cambiato la realtà della cose: non era servita a nulla se non all'onore; che, comunque, va specificato, per un cavaLiere non era poco.
Quello però non era stato il solo episodio che aveva indotto i vertici dell'Arma italiana ad iniziare a riflettere sul suo futuro e ad essere meno tentennanti e riluttanti nei confronti d'un cambiamento. Quattro anni prima, nel 1866 , a Custoza, durante la Terza Guerra d'Indipendenza, era accaduto ben altro : sei plotoni comandati da un capitano austriaco20 avevano sorpreso e caricato una bri gata di fanteria italiana, scompaginandola a tal punto da impedirle di prendere parte al combattimen to durante l'intera giornata. Ma non era finita qui; quell'azione aveva avuto un effetto indiretto determinante per le sorti della battaglia. Infatti, quando la Divisione del Generale Govone avrebbe potuto salvare la giornata, semp licemente riceve ndo rinforzi, il principe ereditario Umberto e Nino Bixio avevano supplicato invano l 'irremov ibile Della Rocca comandante del Corpo d'Armata di permettere loro di accorrere con le rispettive divisioni 16a e 73; non c'era stato verso: Della Rocca , spa ventato proprio dalla carica di cavalleria subita al mattino, aveva preferito tener ferme tre divisioni, attenersi alla lettera degli ordini d'operazione ricevuti ed inviare a Govone non l'atteso rinforzo, ma l 'ordine di ritirata, determinando l'insuccesso finale.
Ora , in questi due esempi, i militari italiani dell'epoca trovavano un s ingolare contrasto sia nei mezzi e nei metodi usati nella carica, sia nei risultati ottenuti: da una parte c'era stata una massa imponente di cavalleria, c he si era mossa aU 'atto decjsivo con ]a classica e dovuta ardimentosa audacia, alla quale era mancato però l'effetto della sorpresa , per cui i risultati erano stati disastrosi; dall'altra un piccolo nucleo di cavalieri che, brillantemente co ndotti , avevano co lto "l'attimo fuggente" per sorprendere l'avversario e annichilirlo; ed il risultato era stato concreto. Rimaneva quindi il dub bio: che fare della Cavalleria?
Nuove esigenze erano richieste dal carattere della guen-a; ma, man mano che gli anni passavano, diventavano sostanzialmente antiquate. Come decidersi?
Un concetto era chiaro quanto all'impiego della cavalleria: mantenerla come Arma celere. L'aggettivo celere coincideva co n una presµnta pluralità di mansionj, quindi l 'Arma sarebbe stata impiegata ovunque, affidandole spesso missioni disperate, sebbene logiche perché in linea con le carat teri stiche intrinseche di un 'Arma operante nello spazio e nel tempo con maggior rapidità delle altre.
Bisogna però avere il coraggio di affermare che l'esperienza, nelle riflessioni dell'arte militare italiana del tempo, aveva un valore mediocre , se si deve giudicare dal frutto che da essa se ne sareb-
19 Francesco VARIO. Per la cavalleria , leggendo il libro del generale Kessler , estratto dalla "Rivista Militare [taliana". Dispensa X , 1905, Roma, Enrico Voghera tipografo. J 905.
20 Era il capitano Bechtolsbeim; subito dopo la campagna fu sottoposto ad un consiglio di guerra sotto l'accusa di aver condotto al macello il proprio squadrone: ma dal processo, invece della condanna, risultò la s ua apoteosi e fu insignito della massima onorificenza austriaca.

-18-
 Piemonte Reale Cavalleria: esercitazione nel salto con gli ostacoli. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale Cavalleria: esercitazione nel salto con gli ostacoli. (Archivio Dal Molin)
-19-
be tratto, specie fino alla Prima Guerra Mondiale. Del resto le guerre sono preparate sulle esperienze passate e se queste sono state vittoriose è accaduto a tutti gli eserciti del mondo s i tende a credere che anche le pros s ime potranno es sere co mbattute e vinte senza problemi , applicando in blocco le lezioni del passato. Solo i geni militari cambiano tattica e vincono Così il successo talvolta, specie se degli altri, incatena il giudizio ed induce a percorrere vie djverse da quelle no1mali , perché si è conv inti che siano migliori. La guerra franco-prussiana ne è un esempio, perché di fatto se r vì so]o ad aumentare la confusione di idee: la cavalleria tedesca era stata indicata come il modello perfetto , al quale tutte le cavallerie avrebbero dovuto conformarsi; e tali idee si erano imposte al punto che nulla sarebbe poi apparso buono se non d 'o rigine tedesca. La r elazione della guerra scritta dallo Stato Maggiore tedesco divenne una sorta di Vangelo e tale sarebbe rimasta fino allo scop pio della Grande Gu erra sul quale, come spesso accade , non era permesso nemmeno un semplice accenno di discussione. Neanche la comparsa della relazione documentata della guerra da parte francese riu scì ad ingenerare più di qualche leggero dubbio.
La Guerra Fran co -Prussiana rimase dunque il termine di paragone per le guerre future. Tutti gli Stati Maggiori europei furono concordi quanto ai compiti strategici della cavalleria: doveva coprire e vedere. Era la via di mezzo e , chissà, forse la giusta ; ma quel "coprire" non persuadeva molti all 'in temo dello Stato Maggiore del Regio E sercito , sicché lo si tolse di mezzo e restò solo il "vedere". A consolidare tale idea sarebbero poi venuti i risultati delle grandi manovre di cavalleria tenute nel 1904 in Piemonte.
D 'altra parte il concetto, nato dalla campagna del 1870-71, dell'impiego delle masse di cavalleria in avanscoperta ed il preconcetto che la cavalleria, di fronte alle nuove armi, dovesse rinunziare quasi interamente alla sua azione nel campo tattico era stato generalmente accettato. Su di esso si erano già plasmati subi to le istruzioni ed i regolamenti dell ' Arma nei diversi eserciti. Ma non bastava , non era tutto. Sette anni dopo , nella guerra Rus so Turca del 1877-78 , le cavallerie di entrambi gli eserciti in lotta avevano dimostrato una marcata inclinazione a combattere appiedate, quindi essenzialmente con l'arma da fuoco anziché con quella bianca. Sia per la natura del teneno, sia per i caratteri di quel conflitto , cristallizzatosi contro Plevna e ridottosi in breve quasi solo ad una guerra d'as sedio, la cavalleria non aveva svolto alcuna rilevante operazione. Questo fatto, unito all'aver combattuto appiedata, era stato un ulteriore colpo alla giustificazione della sua esistenza.

Cosa dunque si doveva fare della Cavalleria, c i s i domandava in Italia. Altri problemi , di ordine politico erano poi apparsi all'orizzonte.
Al Congresso di Berlino , seguito alla guerra Russo-Turca , l'Italia , un po' anche per la sua debo lezza militare, era rimasta isolata e la s ua posizione fra le Grandi Potenze non accennò a migliorare nemmeno dopo la conclusione della Triplice Alleanza coll ' Austria-Ungheria e la Germania nel 1881. Era indispensabile un aumento dell'entità dell'Esercito ed esso venne attuato dal mfoistro Ferrero, che creò due nuovi corpi d'armata, portandone il numero a 12 ed elevando le di visioni da 20 a 24, con in più la 2S3 che coincideva col Comando militare della Sardegna. La fanteria fu artico lata in 48 comandi di B1igata e 96 reggimenti , ciascuno su tre battaglionj di quattro compagnie. L'artiglieria e la cavalleria vennero potenziate, si diede un notevole sv iluppo alle truppe da montagna e , infine , furono richiamati per la prima volta i miJjtari della m categoria. Venne fissata stabilmente la forza delle Mjlizie Mobile e Territoriale, articolando quest' ultima in 320 battaglioni di fanteria e 30 di alpini, 100 compagnie di artiglietia di fortezza e 30 compagnie del genio Poi , nel 1882 fu istituita fin dal tempo di pace la carica di Capo di Stato Maggiore del Regio E sercito. Per quanto riguardava la Cavalleria, non solo il pensiero dominante ma pure quasi tutti i più illustri cultoti ed esperti di cose militari tendevano in quel periodo ad escluderne categ01icamente I' intervento in battaglia. Il suo intervento era previ sto so lo quando si fossero presentate occasioni particolarme nte favorevoli. Così i mutamenti furono quelli determinati dalle contingenze, del resto in
-20
l inea con quelli analoghi, comuni a tutte le Cavallerie dell'epoca e dovuti alle innovazioni tecnologi che. Ecco dunque nel I 882 la modifica dell'armamento: i cavalieri vennero dotati di moschetto e il suo uso venne esteso anche ai primi dieci reggimenti, ancora armati di lancia e di sciabola.
Organicamente, nel 1883 l'Arma venne ordinata su un I spettorato generale , sette comandi di bri ga ta e 22 reggimenti, composti ciascuno da uno Stato Maggiore, sei squadroni e un deposito. Nello stesso anno furono costituiti due nuovi reggimenti: i Cavalleggeri di Padova ed i Cavalleggeri di Catania Nel 1887 si sarebbe avuto un ulteriore cambiamento, con l'aum e nto a nove dei comandi di brigata, mentre rimaneva invariata la forza del reggimento.
Di per sé l ' Ordinamento Ferrere aveva reso rEsercito nel complesso numericamente più forte, ma con una proporzione relativamente scarsa di cavalleria e, visti gli inevitabili sviluppi della tecno log ia, so prattutto di artiglieria. Esso prevedeva infatti una media di 80 pezzi per Corpo d'Armata co ntro i 96 degli altri eserciti.
Il potenziamento di queste due Armi fu attuato dal ministro Bertolè-Vial e, che nel 1887 aumentò i reggimenti da 22 a 24 , creando i due nuovi Cavalleggeri Umberto I e Cavalleggeri di Vicenza, e rio rdinò l'artiglieria da campagna, raddoppiandone i reggimenti , che passarono da 12 a 24, ciascuno s u due brigate21 di quattro batterie da se i pezzi. Ciascun Corpo d'Armata ebbe così due reggimenti da campag na (per un totale in tutto l'Esercito di 192 batterie con 1.152 pezzi) , mentre venivano creati due speciali reggimenti, riunendo le batterie da montagna e quelle a cavallo (su tre brigate rispett ivamente di sei e nove batterie ). In tal modo, col nuovo ordi namento, ciascun Corpo d 'A rmata ebbe 96 pezzi. La stessa legge provvide anche ad una nuova sistemazione delle unità alpine su se tte reg gi menti, con 22 battaglioni e 75 compagnie, e di quelle del Genio , su quattro reggimenti con un tota le di 15 brigate e 52 compagnie. Il riordinamento toccò anche le circoscrizioni territoriali e ripartì il te rritorio nazionale in 12 Corpi d'Armata, 25 divisioni e 87 distretti militari, riuniti in 12 comandi s uperiori, 6 comandi territoriali e 14 direzioni di artiglieria , 6 comandi territoriali e 19 direzioni del genio. 12 direz ioni di commissariato e 19 tribunali militari. Furono infine creati i Comitati d'Arma che però, salvo che per i Carabinieri Reali, ebbero vita breve e vennero istituiti gli ispe ttorati 22
L'a umento degli effettivi era in parte una conseguenza degli accordi militari scaturiti dalla Triplice Alleanza. Infatti , nel 1888 , sarebbe stata so tto scritta una convenzione militare che avrebbe prev isto , in caso di guerra tra l' Impero tede sco e la Francia, l'invio in Germania di sei Corpi d'Armata e di tre divisioni di Cavalleria italiani, mentre accordi di cooperazione sarebbe ro stat i presi anche in campo navale.
Intanto, grazie all'istituzione delle varie scuo le ed alla consapevolezza che il ruolo della caval leria andava cambiando, stava cominciando ad apparire una nuova generazione di ufficiali , dei quali sarebbe interessa nte analizzare i percorsi di carriera e l'influenza sul pensiero militare italiano coevo e su quanto di esso trasudava all'estero. Comunque, per limitarsi all'Arma , come acutamente osserva Brignoli. in quel periodo:

"un nuovo tipo di ufficiale di Cavalleria andava i_ntanto delineando si. La figura, tramandata sopratt utto dalla tradizione napoleonica , di un cavaliere cuor di leone ma non necessariamente dotato intellettualmente , andava scompare ndo ; non pochi auspicavano che scomparisse del tutto per fare luogo ad un nuo vo tipo di ufficiale di Cavalleria nel quale , accanto al coraggio , era indi spe nsabile si trovassero lucidi tà di mente nonché prontezza di vedute e di decisione. Né chi possedesse soltanto valore personale né chi brillasse per la sola intelligenza poteva esse re un buon
1 S i noti che. all'epoca. la definizione " b1igata" in Artiglieria corri spondeva all'insieme definito in seguito "gruppo'', mentre nel Genio lo si sarebbe chiamato "battaglione''. 22 Bo v ro, op. cit.. pag. 135.
-21
ufficiale di Cavalleria. Si diffondeva la convin1ione essere la Cavalleria un· arma speciale ed essere pertanto indispensabile per l'ufficiale dell'arma un particolare corredo di diverse qualità: ma ciò che doveva costituire il shze qua non del suo valore dove, a essere: una speciale attitudine a comprendere il meccanismo di una azione di Cavalleria; una grande prontezza di mente. atta a cogliere con rapidità una situazione: spiccate qualità di comando. Fra i compiti dell'Arma. la ricognizione veniva non a torto ritenuto il più importante e soprattutto al buon espletamento di questo servizio era indiriuato raddestramento di ufficiali e soldati. Infatti. se, per esempio, il collocamento intelligente ed opportuno degli avamposti era compito dell'ufficiale, il funzionamento dipendeva dagli uomini di truppa. Pertanto ristruzione mirava: ad avvenare l'ufficiale al sicuro e facile uso delle carte topografiche stando a cavallo; ad abituarlo ad avvalersi delle risorse del terreno; a sapere, trovato il nemico, mantenersi in contatto con esso e sapersi fare un concetto delle sue intenzioni .''1'
Le variazioni introdotte dal ministro Bertolè-Viale nella struttura militare di terra non rimasero circoscritte al solo Esercito Permanente, ma toccarono anche le unità di Milizia Mobile e Territoriale, nonché il sistema di reclutamento. Fissate da tassative disposizioni di legge, le condizioni per cui spettava all'iscritto di leva il diritto all'assegnazione alla terza categoria, vennero stabilite cinque specie di fenna, corrispondenti a diverse durate dell'obbligo di servizio alle armi: le ferme normali di tre e due anni (in base al numero di estra.lione ed in relazione alJa forza bilanciata), quelle speciali di un anno (volontari di un anno), di quattro (per la Cavalleria) e di cinque (per i sottufficiali e la truppa dei Carabinieri Reali. gli allievi sergenti, i maniscalchi ed i musicisti).
Circa dieci anni dopo, nel 1896, il generale Pelloux presentò un nuovo progetto di potenziamento dell'Esercito. che poggiava sui seguenti punti: mantenimento dei 12 Corpi d'Armata e delle 25 divisioni; trasformazione dei distretti di reclutamento in distretti militari. cioè in organi incaricati in tempo di pace del reclutamento ed in tempo di guerra della requisizione quadrupedi e della formazione delle unità di Milizia TeITitoriale; conseguente passaggio delle opera?ioni di mobilitazione di tutte le unità di Milizia Mobile (comprese quelle di fanteria e bersaglieri) ai depositi, già incaricati di tali operazioni per le unità dell'Esercito Permanente; organici di 100 uomini per compagnia per i primi sette mesi dell'addestramento, subito ridotti a 60 per compagnia nei successivi cinque: aumento della consistenza della Territoriale costituendo parte dei suoi quadri con ufficiali provenienti dall'Esercito Permanente e, infine, reclutamento regionale come per le unità alpine. Questo ultimo progetto fu però respinto dal Parlamento e Pelloux lasciò la questione dell"Esercito ben lontana dal 1'essere risolta, a causa dell'esiguo aumento accordato al bilancio della Guerra, causa pòncipale, antica e perenne, dei mali dell'Esercito e dcl1e Forze Armate.

Intanto la fine delr 800 vedeva la tecnologia progredire a passi da gigante nella costruzione di anni ed armamenti, che erano in piena e rapida trasforma.Lione in tutte le Grandi Potenze. L'Italia, uscita dalla corsa coloniale (anche se Adua non era certo una sconfitta di proporzioni tali da gridare, come fu fatto. alla disfatta) e sempre con gravissimi problemi finanziari, non avendo soldi per nuove sperimentazioni, scelse di attendere che terminassero gli studi esteri, già avviati, per avvalersene ed adottare quindi i nuovi materiali.
L'attività degli otto ministri succedutisi dal dicembre 1897 al dicembre 1907 si concentrò pertanto sul personale, per creare nell'Esercito una situazione di forza (quadri degli ufficiali, truppa, bilancio). che, a tempo debito, potesse servire da base sicura per il rinnovamento dell'organizzazione. Per quanto riguarda la Cavalleria, le guerre seguite a quella Russo-Turca continuarono a influire sulle teorie d'impiego e, quindi. a modificarne i fini operativi, portando spesso a confondere J'impie-
8R1G:-:ou. op. cit.. pag. 33.
-22
go con le s ue modalità. Certo la Cavalleria, come del resto tutta l'arte della guerra, doveva seguire il movimento evolutivo imposto dai tempi e dalle nuove armi. Questa evoluzione toccava però so lo le modalità de11'impiego, il quale in realtà era immutabile perché le caratteristiche de]l' Anna non erano affatto cambiate. La Cavalleria nel campo strategico avrebbe dovuto "vedere", ma doveva anche ·'coprire", direttamente o indirettamente , e ciò dipendeva dall'intervento di elementi che nessun rego lamento poteva prevedere. Le regole e le formule si addicono aJle scienze, ma , per quanto la riguarda, l'arte della guen-a per essere innovativa e vincente abbisogna di genialità , di attenzione nell'impiego dei mezzi ed elasticità di mente da parte dello stratega, so prattutto e forse nu11 'altro che elasticità. Nelle guerre napoleoniche ed in quella di Secessio ne americana, i cui insegnamenti sfortuna tamente non sembravano essere pervenuti ai vertici militari italiani ed europei, la cavalleria era stata impiega ta con ampia varietà di compiti e sempre opp01tunamente, a seco nda del bisogno, delle condizioni create dalla situazione, senza regole costanti ed aridi formalismi. Era s tata davanti alle colonne marcianti quando era servito che così fosse, spesso era s tata tenuta dietro la fanteria ed altre volte ad un 'ala di tutto l'esercito, svolgendo sempre dei compiti definiti , degli scopi determinati da ordini c hiari che non avevano consentito false interpretazioni. Aveva potuto così assolverli facilmente, rispecchiando del resto la chiara visione che il comandante aveva di quel che avrebbe potuto e dovuto pretendere dall 'Arma. In vece, specie in Italia, si prese alla lettera lo studio del generale Kessler:
" la cava lleria è la preziosa ausiliaria della fantetia in tutte le circostanze che impone la guen-a nel combattimento, nelle marce, né gli accantonamenti, ecc., s} che nessuna missione affidata ad un grosso corpo di fantetia può essere compiuta, in crisi generale, se nza che vi si aggreg hi un reparto di cavalleria . La quale vuo le le missioni diverse da compiere, ma quella che le è propria e che tutte le comprende consiste nell'allontanare dalla fanteria l 'eventualità di un attacco imprevisto , circondandola di una zona protetta per cui le sorprese non siano possibili. La sua forza è nella grande mobilità di cui è dotata; arma di urto a carattere essenzialmente offensivo : le s ue qualità difensive sono nulle. Allorché debba difendere una posizione piegata, ed allora opera e manovra come pura fanteria senza raggiungere negli effetti del proprio fuoco l'efficacia propria di quest'arma per ragioni assai ovvie. I servizi che presta si riassumo no :

a) avanscoperta b) esplorazione vicina c) protezione immediata delle colonna di fanteria." 24
In grazia di queste teorie, che non tenevano conto di brillanti e Iiusciti episodi di contrasto dinamico su larga scala, come quello della btigata di Custer contro i Confederati nel 1862, si pensava al possibile impiego della cavalleria L 'arma venne ridotta, riorganizzata ed in sostanza tenuta così com ' era quando altre due crisi internazionali, sfociate in guerra aperta, alimentarono ulteriormente la visione negati va sul futuro del s uo ruolo: la guerra del Sud Africa e quella Ru sso- Giapponese. Nella Guerra Anglo-Boera si assisté ad una sola vera carica di cavalleria, a Diamond-Hill, purtroppo oscurata dai gravi scacchi su biti prima e dopo di essa dalla cavalletia inglese , caratteristica dei quali furono le numerose capitolazioni di reparti di cavalleria in piena campagna. La più grave di esse avven ne nella giornata di Talana Hill, fuori e lontano dal campo di battaglia , quando tre sq uadroni al completo furono circondati e fatti prigionieri. Nel Sud Africa la cavalleria inglese non aveva alcun sistema di sicurezza ed era continuamente nella più completa ignoranza di ciò che le succedeva intorno. Al combattimento di Sannaspos t , una grossa colonna di cavalleria fu spinta dagli eventi sui fianchi e alle spal le dei B oeri; una qualunque azione che avesse fatto alle loro spalle avrebbe migHorato e forse salvata
"4 V ARTO. op. cit., pag -23
la s ituazjone degli Ingle i, ma nulla in vece ve nn e neppure tentato. L·insufficienza della preparazio ne del tempo di pac e si manifestò c hi aramente. Le caratteri st ich e stesse dei Boe ri assai mobili perché tutti e rano montati , privi di uruformi appariscenti, o meglio, se nza nessu na uniforme che li distinguesse dai non com battenti , eccezionalmente ca paci ne lla scelta e netroccupazione delle posizioni e tutti abili ss imi tiratori re se ro press oché impo ss ibile il servi zio di es ploraz ion e e la cavalleri a non se ppe quasi mai dare informazi o ni sul nemi co In un solo caso la c a valleria in gle se reagì energicamente: inseguendo i Boeri che s i ritiravano in di so rdin e dopo i combattimenti di Elandslaagte e prendendo nume ro si prigioni e ri. Ma negli ultimi combattime nti in campo aperto, che terminaro no più o m eno tutti co n la rotta e la fuga disordinata dei Boeri , la cava ll eria non fu impiegata ne ll'in seguim e nto , anche se la sola sua presenza fra le colonne in fuga le av rebbe costrette certamente alla resa a discrezione. :?..~ Ciò c he permi s e ai Boeri di infli gg ere pe rd ite con s istenti agli inglesi e li indu sse a preferire posizioni difen s ive , fu l ' ado z ione d e i fu c ili se nza fum o Dal fatto poi che i Boeri così face ndo obbligassero il nemi co ad attaccare allo co perto, facendogli subire delle e levate perdite in fase d 'avv icinamento , presero form a i co ncetti di " offe ns iva s trateg ica" e ' ·difes a tattica". Tali concetti e bbero molti fautori, specialmente quando gli scacchi ubiti dagli In glesi in Sud Africa potero no essere citati a sos teg no della validità del combattimento difen s ivo. In più , l 'adozio ne della polvere se nza fumo aveva ulteriormente aumenta to i vantaggi della dife sa, perc hé l 'attaccante incominciava a s ubire delle perdite prima ancora di sco rgere il nemico ed a nch e alle brevi di s tanze gli riusc iva molto diffici le sco prirne g li appostamenti, subendo intan to perdite sempre crescenti. Da tutto que s to nacque l ' impre ss ione c he l ' abilità dei comandanti dovesse mirare a condurre l ' avversario ad attaccare contro pos izioni co nvenientem e nte prepara te. Ma tale co ncetto della guerra , co ntrari o ad ogni s ano prin ci pio , non poteva durare. Già ne ll a seconda parte della Guerra Anglo Boe ra, Lord Robcrts avrebbe op posto a lla tattica difens i va avversaria una mano vra avvolgente che. ev itando gli a tta cchi frontali, avrebbe mina cc iato invec e la lin ea di ritira ta de l ne mico, costri ngendolo quasi semp re a evitare l 'accerchiamento sg omberando in fretta l e posizioni difen s iv e preparate. 26

In contrappos iz ion e agli in success i della cav alleria nel Sud Africa, furono maggiormente pos te in rili evo le num erose operazioni là com piute dalla fanteria montata , specialmente nelJ a liberaz ion e di Kimberle y, nell'in seg uimento del ge nerale Cronje ed a Eland s laagte. Consi derando i fatti nel loro in sie m e, s i ve nn e a lla concl u sione che la cavalleria ave sse ormai fatto il s uo tempo e per sop ravv i ve re s i dov esse trasformare tutta in fa nteria monta ta. Il cavall o do veva essere so ltanto un m ezzo di tra sporto ed il cavaliere combattere s oltanto a piedi; doveva perciò armars i di fucile e baionetta e, come il fuciliere , esercitarsi al tiro. Evidentemente però la fante ria montata , oltre ad esse re legata ai cava lli durante il combattime nto, ri s ultava pure in cap ace di un ' offen siva a fo nd o, propri o perché era preoccupata di perdere i cava lli. E ssa dimo s trava quindi d'avere gli s tes si svantaggi della cavalleri a appiedata ; in più , quan do e r a a cavallo, non solo s i esponeva se nz a difesa a tutte le offese del nemico , ma era incap ace di un rapido, efficace e vio lento inseguimento. Sembrò quindi migliore so lu zione quella di is tru ire nel tiro i cav ai ieri , perc hé a ll 'occ orrenza potesse ro combattere appiedati.
2 ~ P ERLO, op. c it. Qu es to il commento coev o ma va nota to c he l'errore di base degli Inglesi fu proprio quello di aon attribuire alcun valo re tattico, tanto offensivo quanto difensivo. alla cavalleria. ritenendo poco pericolo~a quella boera e quin di inutile la propria. Winston Churchill, che cominciò la sua carriera come ufficiale d i cavalleria e comba tlé appiedato in Ind ia, ma cari cò ad Omdum1an co ntro i Dervisci nel 1899, fu in Sud Africa da poco dopo lo scoppio della guerra e. nelle sue memorie pubblicate in Italia come Gli anni della mia gio,·ine~a, da Garzanti a Milano nel 1973 riferì che tale era la convinzione dei supremi gradi britannici dell'inutilità della cavalleria che. qu a ndo Canada e A us tralia s i offriro no di mand arne dei contingenti ebbero in risposta che erano preferibili truppe a piedi: e so ltanto dopo i di astri della ··settimana nera·· culminata a Colenso e le altissime pe rd ite s ubite, la G ran Bretagna cominciò ad impiegare s u larga scala truppe a ca vallo , spec ie Ca nad es i . Australiane e Yeomanry in glesi. 16 PERI.o, op cit.
-2 4
Anche la Guerra Russo-Giapponese fornì nuovi elementi dì valutazione sull ' impiego della cav alleria; perché alla prova dei fatti la meravigliosa cavalleria cosacca dei Russi diede un risultato ass ai infe1iore a quello che si poteva legittimamente aspettare da essa.
Molti osservatori attribuirono i suoi scarsi risultati da un lato al fatto che, pur avendo adottato il f uoco come mezzo normale di combattimento , non aveva addestrato sufficientemente gli uomini al ti ro e , dall'altro , che le era stata assegnato un supporto d'artiglieria troppo debole per vincere la resiste nza dei villaggi fortificati dai Giapponesi. Altri pensarono invece che si dovesse attiibuire l ' insuc cesso della cavalleria russa proprio all'aver rinunciato al tradizionale suo impiego, riducendosi a co mpetere s parpagliata con la fanteria avversaria , perdendo quindi il suo carattere di mobilità e di a rma dalle azioni rapide e di sorpresa.
Tuttavia, mentre la cavalleria giapponese, forse perché assai scarsa e molto inferiore a quella ru s sa. fu tenuta sempre legata alla propria fanteria , que11a russa ebbe occasione di compiere delle es plorazioni e delle incurs ioni a lungo raggio. Così, al principio della guerra , la brigata Mistscenko si spinse fino oltre lo Yalu , verso Seul , per più di 150 chilometri e si ritirò poi lentamente, evitando il contatto con le truppe della I Armata giapponese e mandando al quartiere generale russo molte utili in formazioni. Il colonnello Madritov fece un'incursione di circa 1 .200 chilometri in Corea, impadronendosi di approvvigionamenti nemici, intimorendo le popolazioni ostili ai Russi , bruciando villag g i e raccogliendo importanti notizie. Infine, nel gennaio 1905 , una colonna di 60 squadro n i, 22 pezzi e quattro mitragliatrici, al comando del generale Mistscenk:o, effettuò un'incursione su Inkeu; i risultati furono però scarsi, perché si perse molto tempo contro i villaggi difesi del nemico, invece di aggirarli e raggiungere lo scopo della missione.
Alla cavalleria non furono affidate altre azionj di carattere strategico e quelle ricordate non rap presentarono davvero quanto era lecito aspettarsi dalla numerosa e allora famosa cavalleria russa. Ne11e esplorazioni essa non riuscì mai a rompere il velo di reparti misti con cui si coprivano le Grandi Unità giapponesi e quindi la sua attività d'avanscoperta dette dei risultati insoddisfacenti.
Nel campo tattico la cavalleria russa fu adoperata quasi sempre a coprire i fianchi. ALiao-yang, a d esempio , il generale Rennekampf riuscì a ritardare di ventiquattr ' ore il passaggio del Taitzè alla I Annata giapponese, mentre sull'ala destra Samsonov e Mistscenko segnalavano e ritardavano l ' avanzata dell'Armata del generale Oku, che cercava di avvolgere la destra russa , fi nché non furo no richiamati a sostenere la sinistra, compromessa dalla disfatta della brigata Orlov. Allo Scia ho la cavalleria russa era di nuovo sulle ali, ma , nel terreno montuoso alla sinistra, per quanto si spingesse arditamente avanti , non riuscì a compiere il movimento offensivo ideato dal generale Kuropatkin. Invece sulla destra, dove il terreno le era favorevole, non fece nulla. Alla battaglia di Sampidu con corsero tre divisioni di cavalleria russa , ma a Mukden erano divise in tre masse distinte e distanti fra loro e troppo strettamente .legate ai Corpi d ' Armata a cui erano state assegnate in supporto . Nel suo insieme la cava11eria si mostrò quindi insufficiente alla protezione dei fianchi
Anche i piccoli reparti combatterono quasi sempre a piedi, logorandosi in sporadici e diseguali combattimenti contro la fanteria giapponese. senza azioru aggressive e audaci, le sole capaci di produrre grandi risultati. Fu un peccato, perché le cariche, be nché eseguite solo dai reparti minori, sortirono grandi effetti morali 27
Mentre le guerre del primo '900 provocavano valutazioni , discussioni e ripensamenti del ruolo e del futuro della cavalleria, il Regio Esercito intraprese un riordinamento generale .
Dal .1907 i] Governo , grazie al notevole progresso economico verificatosi sotto Giolitti, aveva deciso di rinunziare definitivamente all'esiziale sistema degli espedienti, delle mezze misure e dei ripieghi. Per procurarsi dati più precisi sulla vera portata ed entità dei bisogni del! 'Esercito, aveva vicever-

27 P ERLO op. cit. - 25-
sa affidato ad un'apposita Commis ione il compito di valutare le necessità dei singoli ervizi. L 'o nere. che allora la Nazione sosteneva per l 'organi smo militare in uomini e in denaro, in base alla sua popolazione ed alla sua ricchezza, era proporzionalmente inferiore a quello di tutte le altre Grandi Potenze europee. La conclusione fu che bi sognava spe ndere di più se si voleva un esercito più efficiente e moderno, pronto sia al confronto, che si temeva non remoto e tutt'altro che improbabile, con altre Potenze europee, sia a conquistarsi i pochi s pazi lasciati ancora di s ponibili oltremare dalla corsa coloniale.
All'effettiva opera di riordinamento dell 'esercito . iniziata dal ministro Casana e s ubito interrotta per il suo a ll ontanamento dal Governo, provvide il s uo successore, generale Spingardi. Quest i, in pieno accordo col genera le Alberto Pollio, nuovo capo di Stato Maggiore nominato nel 1908, concretò un vasto programma di riforme militari, investendo il lato tecnico (o rdinamento della difesa mobile, composizione dell'esercito, organico dei quadri, forza in tempo di pace , ordinamento della difesa permanente), quello morale (limiti e metodi di avanzamento, questione discip l inare), nonché l'aspetto sociale (reclutamento) e finanziario (bilancio).28

La riforma non portò ad una sol uzione radicale del problema, ma so ltanto ad una soluzione soddisfacente. Continuarono a mancare direttive certe e la riforma non rispose al complessivo fab bisogno dell'orga nizzazione mi litare, ma solo a quanto era r i tenuto più strettamente n ecessario ed urgente. Era , insomma, un programma di minima, che mirava a fronteggiare non tutti, ma molti dei bisogni reali dell'Esercito e che prevedeva il riordino dell'e erc ito in base al progetto Ca ana. Venne adottata la ferma biennale per tutte le armi (a sancire l'uguaglianza de l tributo di tutti i singol i cittadini alla Patr ia) e conseguentemente un aumento della forza bilanciata; fu deciso il com pletamento della sistemazione d ifensiva terrestre e marittima; la costituzione di adeguati reparti di mitragliatrici per fanteria e per cavalleria; venne avviata la soluzione, o al meno si tentò di farlo, del prob l ema della trazione animale, introd u ce n do il traino meccan ico nei servizi dell 'Ese rcito. Venne introdotta l'organizzazione aerea nazionale: venne proposta la soluzione definitiva del problema dell ' armamento d'artiglieria nelle varie specialità da campagna, a cavallo, da montagna, pesa nte campale e d 'assedio.
Il programma Spingardi-Poll io doveva essere attuato entro quattro anni, cioè per il luglio 1913 o, al più tardi , per il gennaio 1914; ma la sua attuazione non sarebbe stata ancora comp l eta alJo scoppio del conflitto mondiale. Per di più ag li inizi del 1915 l ' ammini trazione della Guerra non sarebbe ancora stata in possesso dei fondi necessari. La conseguenza fu che, all 'a tto dell'entrata in guen·a, 1'ossatura maestra dell'Esercito s arebbe stata ancora quella sancita dal primo progetto del 1909 , basato su cinque leggi fondamentali, che comunque avevano modificato profondamente la no tra compagine militare.
Per la cavalleria, più che uo vero e proprio aumento venne sancito un semplice rimaneggiamento e s i pensò all'idea dei Raggruppamenti come Grandi Unità d i cavalleria destinate, appena indetta la mobilitazione , a coprire la frontiera dalla minaccia nemica.29
Con l a legge del IO luglio 1910 e le tre del 17 Juglio dello stesso anno, furono introdotte nell'organizzazione dell'esercito le seguenti innovazioni: la creazione permanente di quattro comandi d'armata, cariche fino a quel momento ricoperte da generali di Corpo d·Arrnata , i quali e rano designati ad assumere, in tempo di guerra, il comando delle armate; riconoscimento legale della Commissio ne Mista per la difesa dello Stato e de l consiglio dell'Esercito e, per la Cavalleria, l'istituzione di tre comandi permanenti di divisione nonché la formazione di squadroni di rimonta presso i depositi alle-
MINISTERO DELLA G UERRA, COMANDO DEL CORPO D I STATO M AGGIORE UFFICIO STORICO L'Esercito Italian o nella grande guerra (1915 1918), vol. 1. /e forze belligeranti, Roma. 1927.
M INISTERO DELLA GUERRA, COMA.'l.'1)()
CORPO DI STATO MAGGIORE UFFI C IO STORI CO, L 'Esercito ltalia,w ..., cit.
28
:9
DEL
-26-
vamento cavalli. Poi vennero formate due nuove batterie a cavallo ottenendole però dalla contrazione delle esistenti da sei a quattro pezzi.
L ' adozione della ferma biennale portò anche ad un nuovo tentativo di soluzione del problema del reclutamento dei sottufficiali, la cui deficienza si andava gradualmente accentuando di fronte ai più vari e remunerativi impieghi civili. I sottufficiali in Italia non erano mai divenuti la spina dorsa le dell ' esercito , come negli altri eserciti europei , né lo sarebbero stati in seguito. Anche la legge dell ' 8 luglio 1883, che per la prima aveva dato stabile assetto al loro stato, negli anni dal I 902 al 1908 aveva già subito numerose modifiche , che però si erano limitate a miglioramenti economici ed a r i ngiovanire i quadri. Adesso , con la ferma biennale , per la prima volta si ebbe la possibilità di 1idune al minimo che comunque s ignificava 6.500 unità il numero dei sottufficiali di carriera necessari all ' Esercito , con la creazione del sottufficiale di leva , a ferma di poco superiore a quella normale. Infine sarebbe s tata approvata la legge definitiva del 17 novembre 1912, che avrebbe sta bilito le norme generali di arruolamento e di carriera del corpo sottufficiali.
All ' avvento del generale Spingardi al ministero della Guerra , i quadri degli ufficiali dell'Esercito e rano in profonda crisi morale, materiale e numerica. I problemi accumulatisi nei cinquant'anni trascorsi dall ' Unità, consistenti in trattamenti economici irri sori , carriere lente e p1ivilegi nella formazione dei quadri , rendevano necessaria una netta riorganizzazione. TI corpo ufficiali versava in una profonda cri s i , che ne deprimeva lo spirito. Per molti l'Esercito era più una sistemazione finanziaria che una vera profes s ione. Vi erano poi numerosi nobili che , in relazione diretta con la Casa regnante, si sentivano svincolati dalla disciplina, a scapito ovviamente dell'efficienza. I rimedi presi fino a quel
 Le scuderie di Piemonte Reale. ( Archivio Dal Molin )
Le scuderie di Piemonte Reale. ( Archivio Dal Molin )
-27
momento e ran o stati più dei palliativi che delle vere so lu zioni e si erano dimostrati tota l mente in suf ficienti. L 'acce le raz ion e della carriera non poteva essere co nsegu ita se non co n una rigorosa selezione dei meno idonei e questa, a s ua vo lta , non p o teva essere fatta se non dopo aver accordato agli ufficiali un trattamento economico adeg uato a l livello di vita e di posizione soc iale che ci si as pettava mantenessero. 10 l n conclu io ne, la classe dirigente puntava ad un a so luzione della complessa que stio ne dei quadri uffi ciali , basandosi prin cipalme nte s ulla so lu zio ne dei problemi materiali. 11 Siccome la Cavalleria si sare bb e trovat a a com batte re contro quanto Ja nuova tecnologia offriva. i decise di incidere a n c he s ull 'armame nt o. Nonos tante il delinearsi della co n sapevolezza che n elle prossime guerre l'Arma non av rebb e, sa lvo cas i eccezionali, p arteci p ato come un tempo all' az ione tattica, il concetto di arma riso lutiva faticava ad essere a bband o nato. L 'appi edament o e ra ancora considerato un modo eccezionale di co mbattere. anc he perché riduceva di un quarto la forza dei re parti montati. per il distacco degli uomini nece ssari a custodire i cava lli durante la fase a ppi edata. Poiché e ra guidata ovu nqu e ne l Contin e nte da perso ne che, a parte il co lore dell'uniforme , co ndivid evano gli s tess i valori e le med es ime idee, la cava ll e ria europea alla v ig ilia de ll a co nflagra zione mondiale e ra armata in mod o a bb asta nza omoge neo e cioé:
Germania: carabina mod. 1888, calibro 7 ,9 mm, lun gh ezza 0,95 m, cartu ccia a polvere infu me. alzo ma ss imo 1.200 m ;
Francia: cara bina m od 1890 , cali bro 8 mm, lun g hezza 0,94 m, c artu ccia a pol vere infume , a lzo massi mo 2.000 m;
Austria: carabina mod. 1890 , ca libro 8 mm , lun g hezza 1 m , c artu ccia a polvere infume, a lzo ma ss imo 1.800 m;
Ru ssia: carabina per dragoni mod. 189 1, calib ro 7 ,6 mm e cara bina per cosacchi mod. 1870, calibro 10 ,6 mm ;
Italia: mo sc hetto da Cavalleria mod. 1891 , calibro 6,5 mm , c artuc c ia a polvere infume, lunghezza 0 ,92 m , alzo mass imo 1.500 m.
Per il resto, a parte le discussioni , l a lancia rimase più o meno nell'arm ame nto delle cava ll erie e uropee . L a Germarua la fece adottare a tutte le unità32 in s ie me alla sc iabola ; in Austria J~ invec e la s i abolì totalme nte.3• Gli altri eserciti s i attennero ad un s is te ma mjsto. Pe r esempio, alla fine dell '8 00
10 Le non numero!>c memorie di ufficiali in servizio in quel periodo co ncordano sul fatto che le paghe era no terribilmente ba sse, appena sufficienti a mantenere il decoro esteriore degno d'un ufficiale e ta li da indurre chi no n ce la faceva a chiedere 1·assegnazio ne in colonia. dove gli assegni erano maggiori e minori le pese. Lo scrisse la Medaglia d"Oro generale DE Rossi nel suo La vita di lln ufficiale italiano fino alla guerra, pubblicato nel 1927 a Milano da Mondadori: lo confermò, riferendosi al proprio periodo da subalterno dei Bersaglieri, quindi agli a nni into rn o al 1890. Em ili o DE BONO ne l s uo nostro prima della Guerra, pubblicato a Mi lano da Mondadori nel 193 1. sc ri ve ndo: "Chi riceveva cinqllanta lire mensili dalla famiglia era ritenuto un signore. Chi ne avesse ricevute cento (ne ho conoscimo solta1110 lino) era considerato lln Creso. Dopo il 15 del mese coswi era assillato dagli amici che gli chiedevano le cinque o maga ri le due lire in prestito"' e, infine, avrebbe aggi unto mali nco njcamcnte nella propria autobiografia un altro Mare scia llo d ' Ita li a, Rodol fo GRAZIANl, riferendosi al proprio periodo da sottotene nte al IO Granatieri, a Roma . neg li anni 1905-1908: "Bisognava essere eleganti.Jreqllentare , andare al Salone Margh erita. alle corse dei cavalli. al ristorante servono dfri se per l'estate e per l'inverno, da campagna e di gala:·
11 Enrico CERNIGOI, Soldati del regno. La struttura e organizzazione de/l'esercito italiano nella Grande Guerra, Bassano d e l Grappa, Edizioni Jtinera progetti , 2005.
32 Enrico CERN1GO l, Sciabole e lance, s u "Storia Militare··. anno X. n. 12 (120), dicemb re 2004.
33 Enrico CER: IGOI, La cm•alleria aL1stro-ungarica nella prima guerra mondiale. su " Storia Militare". Anno Vill. n. 9 (88), settem bre 200 I
34 La Gran Bretagna conobbe un periodo di incertezze anche in questo e, come ri ferisce il generale barone Alberto di MARGUTII nel suo Francesco Giuseppe. Edoardo VIl. vista la differente scelta compiuta in Austria e Germania. chiese per lettera il parere personale dell"imperatore d'Austria il quale gli rispose con una lunga relazione autografa in cui, dopo aver soppesato vantaggi e svantaggi dell'impiego della lancia, sostanzialmente consigliava all'esercito britannico una soluzione mista.

-28-
in Russia si diede la sciabola a tutti e lancia alla prima riga di 49 reggimenti cosacchj e di 6 reggiment i regolari e pugnale a 15 reggimenti cosacchi; mentre in Italia fu data la sciabola a tutti e la lancia ai primi lO reggimenti.
Per l'armamento della Cavalleria, come per le altre Armi , il problema principale non era però costituito dalle armi bianche , bensì da quelle da fuoco. Scontata per l ' Arma la neces sità di combat te re anche a piedi, si intuì che il fuoco delle armi individuali della Cavalleria non sarebbe bastato a re ndere pagante l'azione del cavaliere appiedato , né in attacco , né in difesa. Si cominciò allora a dotare la Cavalleria di mitragliatrici e l'arma favorita parve essere la mitragliatrice Maxim che , pesando soltanto 11 kg circa, sembrava facile da portare , appesa alla sella entro una speciale guaina Ed ecco un problema non secondario da risolvere per il Regio Esercito: l ' accaparramento ili que sto nuovo tipo d'arma automatica, la mitragliatrice. Era stata genericamente adottata nel 1906, ma ancora nel 1910 , non si era deciso il modello da acquistare definitivamente.
Dopo innumerevoli discus s ioni , più che altro sulla scelta di fabbricare mùragliatrici direttamente in Italia per svincolarsi dalla sudditanza dall ' industria straniera, si sce lsero una mitragliatrice italiana, ideata e fabbricata dalla FIAT di Torino , ed un nuovo tipo ili Maxim leggera , che nell'ottobre del 1911 venne defirutivamente adottata per le truppe mobili .
L ' assetto organico d i queste armi fu ultimato solo nel 1914 e, per quanto concerneva la Cavalleria, se ne prevedeva l ' assegnazione nella proporzione di una sezio ne ili due armi someggiate a tutti i 16 reggimen ti di cavalleria
Oltre alle armi, l'altro problema che si stava presentando era la comparsa del petrolio suJla scen a mondiale: era u n nuovo t ipo di combustibile che consentiva alla tec nologia di modificare progressivamente e per sempre il trasporto terrestre, marittimo ed aereo .3 5
Per la Cavalleria l'accettazione di questo progresso tecnologico implicava lo s naturamento della sua principale caratteristica. Per quanto si dimostrasse sensibile alle innovazioni (come la mitragliatrice e le nuove disposizioni nel campo tattico), lasciare il cavallo, simbolo stesso del suo prestigio , per il traino meccanico era scioccante. Ma, sotto questo aspetto, alle innovazioni tecniche, si som mava un altro prob lema di carattere materiale: il cavallo aveva un peso economico rilevante e, purtroppo per l'Arma , ormai ritenuto sempre meno determinante. La Cavalleria s i vide quindi assegnare reparti d i battaglioni bersaglieri ciclisti ed inserire nel proprio parco mezzi i primi autoveicoli; questi due nuovi mezzi di locomozione, nonostante le strade non fossero ancora totalmente adatte ad essi, diedero buoni risultati soprattutto durante le grandi manovre , vere prove generali di guerra. E mentre la Cavalleria era tutta protesa a trovare una nuova giustificazione alla sua esistenza, iJ Governo italiano rompeva i rapporti diploma tici con l'Impero turco e gli dichiarava guerra
 i, C. SPINGER E.J. H OLMYARD AR. HAL L T.L. WI LLIAMS, (a cura di), Storia della lec,wlogia, voi. 5 tomo I e II: L 'età dell'acciaio, Torin o, B o llati Boringhieri . 1994.
i, C. SPINGER E.J. H OLMYARD AR. HAL L T.L. WI LLIAMS, (a cura di), Storia della lec,wlogia, voi. 5 tomo I e II: L 'età dell'acciaio, Torin o, B o llati Boringhieri . 1994.
-29-

CAPITOLO III
L'INTERMEZZO OLTREMARE
Da molti anni l'Italia stava svolge ndo un'azione diplomatica per impedire ad altre Potenze di occupare la Libia , che considerava di suo interesse esclusivo . Dopo l'incidente di Agadir del 28 luglio 1911 , iJ ministro degli esteri, marchese Antonino di San Giuliano avev a inviato al presidente del consig li o Giolitti un promemoria segreto, dal quale si potevano desumere i motivi essenziali della decisione italiana di conquistare la Libia in quel momento. Erano una valutazione, sostanzialmente esatta, della situazione internazionale, che offriva all'impresa coloniale italiana un'occasione propizia , ma irripetibile: bisognava agire subito .

Il 24 settembre Giolitti chiese telegraficamente al re, che si trovava a San Ro ss ore, il consenso all'invio di un ultimatum al governo turco; il sovrano lo concesse immediatamente. Il 26 l'incaricato d'affari turco disse a San Giuliano che il suo Governo era disposto a concessioni economiche pur di evitare la guerra. Pressioni perché si iniziassero negoziati su questa base furono fatte, lo stesso giorno ed il successivo, da parte tedesca sui rappresentanti italiani a Berlino e a Costantinopoli. Nella notte tra il 26 e il 27 partì però da R oma l'ultimatum con cui si chiedeva al governo turco di acconsentire entro 24 ore all'occupazione italiana della Tripolitania e della Cirenaica. I motivi addotti dal governo di Roma erano lo stato di abbandono in cui erano tenute quelle regioni e l'ostilità dell'autorità ottomana alle iniziative italiane. All ' ultimatum fu data, come ci s i a spettava , risposta negativa, sicché il 2 9 se ttembre 1911 l'Italia dichiarò guerra alla Turchia. Tra il 5 ed il 21 ottobre i principali centri costieri della Libia Tripoli, Homs, Bengasi, Dema , Tobruk- furono occupati dalle truppe italiane. Le ope razi oni più importanti avvennero a Tripoli , conquistata e difesa per alcuni giorni da un contingente di 1.700 marinai , comandati dal capitano di vascello Cagni, che rimase sul posto fino all ' arrivo dei reparti dell'Esercito, e a Bengasi occupata dai reparti del generale Arneglio , che incontrarono subito forte resistenza e dovettero lottare duramente per assicurarsi il po ssesso della te sta di ponte
Entro J' 11 ottobre si concentrò a Tripoli il corpo di spedizione incaricato de1la conqui sta della Libia, forte di 35 .000 uomini e al comando del gen erale Caneva.
L'occupazione fu tutt'altro che facile. I Turchi iniziarono una guerriglia, impegnando i soldati italiani in qualcosa a cui non erano abituati ed apparve s ubito chiaro che molto difficilmente la guerra poteva essere vi nta sul territorio libico. L'occupazione italiana intorno a Tripol i , nonostante qualche s uccesso, come la presa di Aio Zara del 4 dicembre 1911 , procedeva molto lentamente, mentre in Cirenaica le truppe furono subito costrette alla difensiva. Si configurava un o stano, che a l1a lu ng a avre bbe avvantaggiato i Turchi e messo gli Italian i in condizioni difficili dal punto di vista militare ed economico 36
Va so ttolineato che e non sarebbe stata l'ultima volta in quell ' occasione la classe dirigente ita liana decise la guerra senza consultare preven tivamente il Capo di Stato Maggiore , che pure era il respon sa bile primo , oltre che l ' uomo s u cui comunque sarebbe ricaduta pubblicamente tutta la responsabilità dell 'az ione.
La campagna africana, so tto il profilo dell'incidenza s ull 'o rganizzazione e sull'efficienza dell'Esercito, ebbe gli indiscutibili vantaggi di accelerare l'ammodernamento tecnologico e dei materiali. Fu certamente un salasso per il bilancio dello Stato , ma costit uì un fattore propagandi stico di indubbio valore, perché la vittoria, rapida e pre c isa sulle forze dell ' impero ottomano rivalutò le qua lità militari italiane gU occhi della comunità internazionale.
, 6 Gioachino VOLPE, L ' I talia Mode rna 1910/1914, F irenze , Sansoni , 1973.
-31 -
Per quanto riguarda la Cavalleria, la Guerra di Libia segnò una certa rinascita, almeno a livello di valore d'impiego.
I Lib ici avevano attuato da subito l a guerrigli a, che è, tra le forme di guerra. la più totale, s pietata e feroce. Per batterla, un esercito regolare, all'epoca come in seguito, doveva essere mobile; e quale Arma più delle altre poteva effettivamente partecipare con successo all'azione militare?
Vere battaglie non ve ne furono. ma la Cavalleria fu impegnata totalme nt e. Arrivò in Libi a agli inizi di ottobre in due contingenti , il primo costi tuito dalla 1a Divi sione e truppe suppletive, includeva il Il sq uadrone del 15 ° Reggim en to Cavalleggeri di Lodi. Poi. alla fine di ottobre, co n la 2a Divisione arrivarono il Hl e IV s qu adrone del 18° Cavalleggeri di Piacenza, assegna ti alla Brigata del generale Ameglio. Quest i due sq uadroni , agendo individualmente o in collaborazione coi reparti di altre Armi, furono subito impiegati in ricognizioni e permisero di sequestrare affusti di cannoni. bardature, armi e munizioni nascoste un po' dovunque dal nemico nelle campagne.
Le ricog nizioni proseguirono per tutto il mese di novembre ed il primo combattimento si eb be il 24, quando lo sq uadrone al comando del capitan o Molari fu seriamente impegnato contro bande beduine a Koefia. 37
Negli scontri seguenti la cavalleria fu impiegata in avanguardia ed a s upporto della fanteria. Raggiungeva l'obiettivo , smo ntava , combatteva e rimontava a cavallo.
La s ua mobilità fu altamente apprezzata. Nelle g uerre coloniali ed in quelle similari, l'uso otti male della forza in campo tattico è molto difficile, perché la s ituazione è resa di più difficile soluzione da un numero d'incognite maggiore che nella guerra normale: lo sp irito, il numero. l'ubicazione, l'armamento, il munizionamento e il modo di combattere dell'avversario; il terreno, che, considerato nei suoi particolari topografici, ostacola la marcia , impone soste frequenti, il più delle volte non permette il transito dei mezzi e delle artiglierie e. all'epoca, rende va difficoltoso pure quello dei cavalli e difficile il foraggiarli.

Numerosissimi furono gli scontri coi ribelli arabi, che attuavano la tattica del "mordi e fuggi" e la cavalleria fu impegnata sia a tenere il collegamento fra le unità impegnate, sia in combattimento , dovendo identificare ed attaccare anche le carovane nemiche di armi e rifornimenti , come fece nel dicembre del 1911 il sottotenente Fede, che disperse i ribelli e prese parecchie armi.
Nell'insieme le operazioni dimostrarono che, almeno in quel contesto, la cavalleria, se impiegata razionalmente dava risultati più c he positivi, cosicché, proprio in dicembre, il contingente di caval1eria fu ulteriormente aumentato coll'arrivo del Il [ s quadrone dei Cavalleggeri di Lucca, segui to poco dopo, dal 10° Reggimento Lancieri di Firenze, mobilitato s u quattro squadroni e al comando del colonne11o Vittorio Litta-Modignani. Appena arrivati, i Lancieri di Firenze furono impiegati con tro l'oasi di Zanzur: la raggiunsero all'alba, la circondarono all'improvviso, ne tagliarono le comunicazioni e catturarono parecchi prigionieri 38 Poi , prima della fine dell'anno, arrivò in Libia anc he un mezzo reggimento dei Cavalleggeri Guide.
Ques to invio a spizzico di reparti di cavalleria non organici ri s pondeva ad una ben precisa e meditata vo lontà del comando italiano, applicata del resto a tutte le Armi: quasi tutti i reparti dell'Esercito dovevano inviare proprie aliquote per guadagnarne una diretta esperienza di guerra , visto che ormai da decenni non erano più abin1ati a combattere. Di conseguenza ben 24 dei 29 reggimenti di cavalleria parteciparono alla campagna di Libia , inviandovi propri contingenti e, oltre ai già citati Fire nze, Lodi, Guide , Lucca e Piacenza furono impiegati: Nizza Cavalleria, Piemonte Real e, Savoia Cavalleria e Genova Cavalleria; i Lancieri di Novara , Aosta, Milano, Vercelli, Mantova e Vittorio Emanuele II; i Cavalleggeri di Foggia, Saluzzo, Monferrato, Alessandria. Caserta, Roma, Pado va, Umberto T, Aquila, Treviso e Udine.
" Rivista di Cavalleria anno XV. fascicolo I, 1° gennaio 1912.
'" Rivista di Cavalleria'· , anno XV, fascicolo m, 1° marzo 1912.
-32
Il fatto poi che in Libia il consumo dei materiali fosse notevole , si spiegava con la vo lontà cli r innovare i magazzini, resa possibile dal considerevole aumento, avutosi in quell'anno, del bilancio della Guerra. 39
L' impiego di materiali e uomini , tra reparti , complementi e magazzini, coinvolse praticamente tutte le divisioni dell'esercito , di ognuna delle quali almeno un reggimento partecipò direttamente a lle operazioni coi propri uomini, sostenuto dagli altri con derrate, complementi, materiali e ripiana menti. Questo consentì all'Esercito di rimodernare il s uo armamento coi mezzi più moderni che la tec nica metteva a disposizione e di migliorare la propria struttura aumentandone l'efficienza.
Già nel novembre del 19 I 1 era stata ordinata la sollecita ricostituzione di tutte le dotazioni di mobilitazione consumate in guerra, in base al criterio di massima di sostituire indistintamente, in Italia, tutti i materiali inviati nella nuova Colonia con altri più perfezionati , in modo che non se ne veri ficasse alcun decremento in quantità e se ne avesse invece un incremento in qualità.
Furono pertanto ordinate mitragliatrici leggere e fucili '91, approntate unità carreggiate e altre someggiate che vennero dotate di materiali moderni e si accelerò la distribuzione delle nuove uniformi grigio-verde e dei materiali di riserva per la mobilitazione.
D al punto di vista operativo i cavalieri furono impegnati sempre di più nel pattugliamento quo tidiano conto i beduini, imparando sul terreno nuove tattiche d'attacco e difesa. Infatti i beduini a cavallo erano sempre sostenuti da altri a piedi e, con capacità innate, le due aliquote agivano in perfetta armonia.
Le loro tattiche di disimpegno erano poi talme nte specifiche ed efficaci che, spesso, un reparto cli cavalleria si trovava di essere sta to inviato contro un singolo individuo. Ne derivò un ripensamento della tattica adottata : le evoluzioni della cavalleria italiana erano, a confronto con quelle dei cava lieri arabi , lente e pesanti; ma la nuova guerra imponeva mobilità, iniziativa personale e ardimento. Erano tutte caratteristiche che, a causa della brevità dell'occupazione iniziale , non erano state pienamente acquisite. Per questo, oltre a perfezionare la caval1eria nazionale nella nuova tattica , sotto il comando del capitano Piscicelli dei Cavalleggeri di Lodi fu organizzato pure un reparto di cavalle ria indigena, che fu il nucleo dal quale, dopo la Grande Guerra , sarebbe scaturita la cavalleria indi gena della L ibia.
Nel gennaio del 1912 restava comunque il problema dell'impossibilità dell'azione risolutrice ed i reparti finivano col logorarsi nella guerriglia, forma di combattimento alla quale non erano preparati. Così, nel febbraio, venne mandato in Libia il comando de] Reggimento Cavalleggeri di Lucca, col comando del proprio secondo mezzo reggimento ed uno squadrone. Nello stesso mese alcuni reparti formarono un Reggimento Cavalleggeri della 2a Di visione, costituito da l comando di reggimento, dal secondo mezzo reggimento di Lucca e da uno squadrone , dal coma nd o del secondo mezzo reggimen to e da due squadroni di Piacen za e da uno squadrone di Lucca, mettendo il tutto al comando del colonnello Carlo B orsarelli di Rifreddo.40

Tra gli sco ntr.i successivi, di varia intensità, va soprattutto ricordato quello del 12 marzo che prese il nome delle Due Palme. Agli ordini del colonnello Borsarelli, tre squadroni di cavalleggeri comandati dai capitani Ajrolcli, Pastore e A n selmi, partiti dalla Berka per l'Oasi deJle Due Palme come parte dell'ala destra delle truppe del generale Ameglio, staccarono pattuglie per il controllo della zona , notarono un forte contingente nemico di fanteria e cavalleria, l 'attaccarono e lo distrussero dopo un violentissimo combattimento. La lezione era stata appresa bene e da quel momento la campagna di Libia della Cavalleria seguì un itinerario fatto di attacchi e contrattacchi, eseguiti sem pre con la stessa tattica ed effettuati da reparti s ia a cavallo che a piedi.
39 Bovro, op. cit.
"') '"Rivis ta di Cavalleria' . anno XV, fascicolo IV. 1° aprile 1912.
-33-
Le ultime azioni di rilievo furono lo scontro dell'oasi di Guesciat, il I 3 maggio 1912, a cui prese parte tutto il Reggimento Cavalleggeri della 2a Divisione e, il 20 maggio , la ricognizione fatta nei dintorni di Tripoli dal Reggimento Lancieri di Firen ze al completo, agU ordini del comandante colonnello Litta-Modignani.

La pace, finnata il 18 ottobre 1912 , non comportò la fine delle operazioni, continuate ad opera di forze turco-arabe beduine che non riconoscevano la sovranità i taliana. I combattimenti pertanto non cessarono ed i reparti di Cavalleria furono impegnati a proteggere le ridotte, i posti di guarnigione e la popolazione. Per meglio sopperire a queste incombenze, fu deciso di affidarsi a reparti di cavalleria indigena , la cui prima unità , dopo quella formata dal capitano Piscicelli, fu quella denominata V squadrone. Costituito negli ultimi mesi del 1911 nella località bengasina di Sabri, agli ordini del capitano Bonati, comprese alcuni gregari di un plotone di savari arrivati dalla Tripolitania col Piscicelli, rinforzati da elementi della popolazione costiera bengasina e combatté negli anni dall' 11 al ' 13 dimostrando un "fiero spirito bellico"41 sin dai primi scontri. Seguendo l 'abi tudine locale, le sue nuove reclute venivano portate all'attacco senza arrni per dimostrare il proprio coraggio; e a quelle che mostravano paura o anche solo titubanza non era consentito rimanere nel reparto. Il V Squadrone nel 1912 partecipò agli scontri di Suani Osman, Fuehiat, Mohamed Scetuan, Hauari e Gariunes ed in seguito, ulteriormente accresciuto con nuovi squadroni, rimase a presidio della Libia fino alla seconda guerra mondiale.
• 1 Capitano Ademaro TNVREA La cavalleria libica in Cirenaica, s.i., Libia , agosto 1938. La Cavalleria jjbica si formò in quest"ordine: 1912 , banda a cavallo del capitano Giuseppe Maroni, zona Bengasi; 1912. banda a cavallo del capitano Secondo Diana Crispi. zona B e ngas i; 1912 , banda a cavallo del capitano Maurizio Pi sc ice lli De Vito, zona Bengasi; J912 , 5° Squadrone Savari del capitano Maurizio Piscicelli De Vito , zona Bengasi; 1913, l O Squadrone Sa vari del capitano Luigi Guarini Matteucci zona Tripoli; 19 I 3, 2° Squadrone Savari del tenente Ultimo Grilli, zona Tripoli; 1913 , 3° Squadrone Savari del capitano Carlo Orero , zona Tripoli; 1913 , 1° Squadrone Mehari sti (quindi cammellato su cammelli Mehari) del tenente Ettore Galliani, zona Tripoli; 1914. 4° Squadrone Savari del te nente Vittorio B e ri o , zona Bengasi; 1914, 2° Squadrone Meharisti (quindi carnrnellato su cammelli Mehari) del capitano Alberto Pollera, zona Tripoli: 19 14, 3° Squadrone Meharisti (quindi cammellato su cammelli Mehari ) del capitano Roberto Penicone , zona Tripoli: 19 16, Gruppo Spahis del tenente Francesco Navarra Viggiani , zona T1ipoli.
-34-
CAPITOLO IV
VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Lunedì 24 maggio 1915 il cannone tuonava per la prima volta lungo il confine italo-austriaco, confine fissato da11a Terza Guerra d'Indipendenza nel lontano 1866. Iniziava così, anche qui, la guerra che da ormai dieci mesi insanguinava l ' intera Europa.
Al principio della crisi, nell ' estate del 1914 , il Governo italiano aveva preso le distanze dalla politica degli Imperi Centrali, giudicando inaccettabile il loro intervento contro la Serbia dopo l'attentato di Sarajevo e si era accostato lentamente alla Triplice Intesa: Francia, Gran Bretagna e Russia. Per di più, mentre all'orizzonte si addensavano nubi sempre più plumbee, il 1° luglio 1914 era improvvisamente morto il Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito italiano , generale Alberto Pollio, convinto triplicista, e al suo posto era stato nominato il generale Luigi Cadoma. La volontà riformatrice di quest'ultimo si era innestata nel processo di riorganizzazione dell'Esercito, che, uscito vi ncitore dall'avventura libica nel 1911, si trovava adesso in condizione di poter riempire i magazzini ed ammodernare gli armamenti.
DalJa serie di direttive emanate da Cadorna per l'applicazione del nuovo orientamento emergeva evidente la volontà di accentrare il potere nelle mani di una sola figura: il Capo di Stato Maggiore. Sotto la sua direzione, la mai sopita aspirazione dei militari di togliere la direzione dell'Esercito al potere politico, ponendola alle dipendenze di un organo di comando che rispondesse direttamente al Re, trovò una prima realizzazione con la se parazione tra le funzioni amministrative e quelle tecniche e, successivamente, con un rafforzamento della posizione del Capo di Stato Maggiore. Qu esto rafforz amento fu reso possibile sia dalla forte personalità di Cadorna, che dall'atteggiamento di Salandra, presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva preferito non informare i militari della posizione poli tica del Governo e della sua scelta di un ' imminente guerra contro l'ex-alleata Austria-Ungheria.
Col passar del tempo l ' incomprensione fra i due avrebbe portato ad una netta frattura tra il potere politico e quello militare, dando come risultato che ognuno dei due, a ll ' in saputa dell ' aJtro, avrebbe portato avanti una s ua pianificazione della guerra. Agli occhi degli Italiani tutti gli avvenimenti s uccessivi sarebbero però apparsi come responsabilità del solo Cadorna e non del Governo.
Il confine- destinato a tramutarsi dina pochissimo in fronte italo austriaco si estendeva allora per circa 600 chilometri. Di questi, poco meno di 500 correvano lungo i crinali delle Alpi; i rimanenti erano nel tratto che dalla vetta del Monte Canin porta alle calme acque del Mare Adriatico. L ' altitudine di questi ultimi 100 chilometri cala costantemente e, dai 2.000 metri d'altezza iniziali , arriva alla pianura friulana e ai modesti riljevi del Carso Goriziano. Furono qu esti ultimi chilometri lo scenario deUe dodici battaglie dell'Isonzo.
La sce lta di combattere in quest'ultimo tratto del fronte fu imposta dalla convinzione che la bassa elevazione delle colli ne avrebbe consentito azioni fulnùnee e la possibilità di manovrare adeguatamente uomini e armi, movimenti preclusi dalla morfologia del terreno nel resto del fronte. Tale decisione fu inoltre influenzata in modo determinante dal piano concertato coi nuovi al1eati, che prevedeva la simultanea azione delle forze serbe a s ud e di quelle russe in oriente , in modo da distogliere le forze aust1iache dalla frontiera sud -occidentale dell'Impero.
L ' Itali a si era trovata a cambiare lentamente posizione fin dal principio deJla crisi. Come si è detto, già il l O lu g lio 1914 era morto improvvisamente a Torino il generale Pollio e, col Regio. Decreto del 10 luglio, era stato nominato Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito il tenente generale, già designato per il comando di un'armata in guerra , conte Luigi Cadoma. Cadoma era l'uomo gius to per attuare le riforme di cui l ' Esercito abb isognava nella previsione di una possibile e immi-

-35-
nente guerra in Europa. Un mese dopo la s ua effett iva assunzione della carica, quando il conflitto era appena scoppiato, aveva riassunto la s ituazione dell ' Esercito, in relazione all ' eventualità di una mobilitazione generale, individuandone i punti deboli: nella scarsezza della forza bilanciata, dovuta all'abbondanza delle esenzioni; nella mancanza d'istruzione della fil categoria e, infine, nel fatto che l'E sercito di prima linea doveva fare assegnamento so lo su 13 classi, entrando in campagna con un organico inferiore ri spetto alle altre grandi Potenze Europee. La conclusione che Cadorna ne trasse fu impietosa. Non si limita va solo alla questione del materiale, ma riguardava tutto quell'esercito in cui aveva passato la vita fin dalla nascita -suo padre Raffaele aveva fatto tutte le guerre del Ri so rgimento , terminando col comandare il contingente che aveva preso Roma nel 1870. Cadoma inoltre univa all'esperienza un carattere forte ed una personalità dominante, sorretta da una profonda conoscenza degli uomini e dei limiti dell'organizzazione mii itare italiana.
Il problema principale era da lui individuato nella catena di comando. Non esisteva un'effettiva piramide gerarchica, ma, in virtù del fatto che l'Esercito serviva anche da contenitore sociale, si poteva ri scontrare al suo interno una frammentarietà di quadri non sempre preparati, né animati da spirito bellico , né, soprattutto, disposti ad obbedire ciecamente ad un 'unica personalità. Molti nobili, legati alla casa regnante , mal tolleravano di obbedire a uomini che ritenevano di rango inferiore al proprio. Ne conseguiva che, se si volevano dei risultati, si sarebbero dovuti cercare cominciando dal l'inquadramento del corpo degli ufficiali , tagliando la zavorra costituita dai peggiori e inquadrando gli altri in un ' unica struttura piramidale, della quale Cadorna era ed intendeva rimanere al vertice .
Per quando riguardava l'Esercito, il nuovo Capo di Stato Maggiore continuava la sua relazione evidenziandone la carenza di quadri, molti dei quali erano ancora in Libia, per le nuove unità e che, comunque, erano molto scarsi anche per quelle in Patria; pochi anche i nuclei di Milizia MobiJe costituiti nel tempo di pace per le varie Armi e, soprattutto, scarsa la loro forza. Risultava che i nuclei di Milizia Mobile da impiegare in prima linea erano completamente da improvvisare all'atto della mobilitazione, contrariamente alle altre Nazioni che avevano provveduto già dal tempo di pace. Infine , la Milizia Territoriale era armata cogli antiquati fuciLi Verterli-Vitali 70/87; non aveva neppu re le divise.
La relazione sottolineava poi la mancanza d'istruzione militare per le classi in congedo, principalmente perché i richiami non erano frequenti né generali: mancavano campi d 'esercitazione, difettavano tra l 'altro anche le munizioni per le esercitazioni, oltre al munizionamento di tutti i livelli e per tutte le Armi.
Le dotazioni poi erano del tipo più antiquato, i servizi automobilistici erano in via di organizzazione, mancavano i depositi per la benzina ed i magazzini per il grano e l'avena.
Deficienze qualitative e quantitative affliggevano il parco d'artiglieria, ancora forte di circa 96 pezzi per Corpo d'Armata, contro gli ormai 144-160 della media degli eserciti stranieri, per di più tutte le sezioni mitragliatrici erano insufficienti ed incomplete.

Quello che però pesò in modo determinante all'inizio della guerra contro l ' impero Asburgico fu l'organizzazione difensiva, ritenuta anch't?ssa insufficiente da Cadorna. La mancanza di sicurezza influenzò all'inizio della guerra la concezione d'arroccamento dell'Esercito, che fu evidenziata da su bito dall'ossessione d 'attestarsi a difesa dei punti più impossibili e insignificanti
Cadorna si trovò quindi a dove cominciare il vero consolidamento dell'Esercito, ma lo dovette fare coll'incubo dell ' imminente coinvolgimento dell'Italia nella guerra gia divampante in Europa e senza sapere quando ciò sarebbe successo, cioè senza neanche sapere se aveva davanti a sé ancora un mese o un rumo. Il suo lavoro si svolse in una situazione di generale accaparramento di materie prime e fu reso ancor più difficile daUa loro penuria e dal loro elevato e continuamente crescente costo, dovuto alla co r sa agli approvvigionamenti su quasi tutti i mercati mondiali da parte delle Potenze già coinvolte nel conflitto.
-3 6-
Di questa ristrutturazione accelerata furono artefici il generale Vittorio ZuppelJj, dal 12 ottobre 1914 nuovo ministro della guerra , e appunto lo stesso Cadoma. La base del nuovo riordino fu il completamento di tutte le dotazioni, specialmente quelle d'armamento; la costituzione immediata di tutte le unità di Milizia Mobile e di quelle presidia.rie previste in caso di mobilitazione generale; la formazione dei reggimenti di artiglieria da campagna, contemplati dalla legge del 1910 e non ancora costituiti, ed un aumento di 26 batterie per l'Esercito permanente.
Per quanto riguardava il materiale umano, a partire dal 1911 solo raramente le reclute avevano avuto modo di completare l'addestramento militare. Di massima erano state prelevate pochi giorni dopo il loro arrivo ai corpi . per essere impiegate in servizi territoriali , compreso quello di ordine pubblico, o incorporate nei reparti mobilitati in Libia. Un po' più accurata era stata l ' istruzione de11e fanterie speciali (granatieri, bersaglieri , alpini) alla quale aveva contribuito anche l ' elevato spirito di corpo, ma dei 40 reggimenti di linea per i quali era previsto l'impiego in concors o alle truppe da montagna, soltanto pochi avevano potuto eccezionalmente svolgere qualche esercitazione specifica. La scarsità dei mezzi finanziari si era fatta sentire ancor più gravemente nell ' istruzione tattica per la mancanza di veri e propri campi di esercitazioni. Le truppe erano state costrette ad addestrarsi in aperta campagna, ma, per la preoccupazione di non danneggiare le proprietà private, si erano limitate ad agire sulle strade , ottenendone solo una preparazione teorica sui principi di massima della rego lame nt azione tattica, ma senza alcuna applicazione.
Nel 1910 si erano iniziati i primi studi per l ' acquisto di campi di esercitazioni, ma , ripresi nell ' ottobre 1913 sotto l'incalzare delle necessità di avere dei poligoni di tiro per l ' artiglieria, che nella maggior parte delle guarnigioni trovava nelJa fitta vegetazione seri ostacoli ai tiri in campo aperto , non avevano portato a nulla di concreto. La Guerra di Libia sotto questo aspetto era stata una fortuna, perché aveva permesso a molti ufficiali e quadri di farsi un ' idea precisa di cos'era la guerra , operando in un contesto reale.
 Uno squadrone di Piemonte Reale nella campagna romana, a Tor di Quinto. ( Archivio Dal Molin )
Uno squadrone di Piemonte Reale nella campagna romana, a Tor di Quinto. ( Archivio Dal Molin )
-37-
'
Quello che mancavano erano gli ufficiali, soprattutto quelli inferiori. Nonostante raumento di ufficia li in Servizio Attivo Permanente, come si diceva allora. l'aumento deg li esuberi. l'apertura di nuovi corsi accelerati nelle varie scuole militari. il bando di concors i fra i sottotenenti di complemento, fra quelli della Territoriale in possesso di detenni nati titoli di studio e fra gli stessi marescialli, il gettito era di gran lunga inferiore alla necessità. Al reclutamento di ufficiali di complemento necessari alle Anni combattenù si provvide mediante quattro successivi corsi accelerati e coll"istituzione dei sottotenenti di artiglieria e del genio per i servizi tecnici presso i corpi, reclutati direttamente "senza corso di istruzione" tra i militari di l , II e li1 categoria muniti di diploma o laurea. Lo stesso dicasi per g li altri corpi e ervizi dell'Esercito come Sanità. Servizio fannaceutico. Veterinari. Amministratori e Commissari.
L 'artiglieria era un altro dei problemi da affrontare subito. La guerra che si prospeltava aU'Italia, viste le esperienze degli altri fronti, evidenziava la necessità di una supremazia distruttiva dell'artiglieria, necessaria contro le difese nemiche, rinforzate dalle mitragliatrici in difesa fissa.
In base al programma nel 1913, il parco d'assedio doveva risultare costituito su "comandi d'artiglieria d'assedio", quattro comandi d' artigLieria di settore, 10 comandi d'artiglieria di brigata (gruppo) e 24 di batteria da combattimento, de1Je quali: IO di cannoni da 149A;~ 2 otto di mortai da 210 A e sei di mortai da 2(i() A, con 40 batterie da combattimento (avamparco), delle quali: 28 di obici da 149 A e 12 di cannoni da 120. Facevano p arte del1 'Esercito di prima linea in formazione di guerra IOdivisioni di Milizia Mobile, da crearsi ex-novo all'atto della mobilitazione. Per facilitarne la formazione. fin dal 1910 era stata prevista presso i 94 reggimenti di fanteria, i 26 battaglioni al pini ed i 24 reggimenti di artiglieria da campagna l'imme diata costituzione dei nuclei di Milizia Mobile, che sarebbero dovuti essere veri reparti organici. capaci di funzionare da organi centrali delle unità componenti le divisioni. Nel 1911 però non erano ancora stati costituiti; e la successiva Legge 638 del 19 luglio 1913 aveva sancito so ltanto l'obbligo del serviz io alle anni per due anni per tutti i militari di prima categoria e ribadito che il limite minimo di statura per idoneità al serv izio militare era di 1,54 metri, ratificando così la già riconosciuta idoneità fisica del Re al servizio militare. Con le quattro classi di Esercito Permanente in congedo che sarebbero risultate esuberanti, si sarebbero potute costituire le cosiddette divisioni di Milizia Mobile, gli uomini delle quali avrebbero dovuto formare vere e proprie unità di riserva, mentre la ili categoria avrebbe potuto funzio nare da comp leme n to. Ammesso quindi di chiamare alle armi in un unico tempo le 10 classi dell'Esercito Permanente (dalla più giovane, la 1895, alla più anziana, la 1886) e le quattro di Milizia Mobile (rispettivamen te dalla 1885 alla 1882) l'immediata d i spo nibilità di complementi sarebbe risultata di 400.000 uomini, pari al 43% delle forze dell'esercito di cam pagna, c ifra che consentiva di formarlo con un numero di classi inferiore rispetto a quello sino aJJora previ to. Effettivamente di esse ci si valse nel 1915. Il 24 maggio l'Esercito entrò in campagna con l a classe 1895, che consentì di costituire le unità di fanteria, e cioè la g ran massa dell'Esercito di prima lin ea, co n 8 classi di Esercito Permanente (da lla 1895 alla 1888) e cioè con uomini dai 20 ai 28 anni. lasciando a disposizione le due classi di Esercito Permanente 1887 e I 886 e pressoché al completo le quattro di Milizia Mobile (dalla 1885 alla 1882). c h e vennero poi ch iamate tra il lu g li o e l'ottobre 1915

L 'entrata in guerra vedeva il Regio Esercito italiano mobilitato costitu ito da un Comando Supremo e da Grandi Unità comp lesse (le armate e i corpi d'armata), ciascu n a delle quali comprendente un numero variabile di Grandi Unità elementari: le Divisioni e le B1igate di fanteria e di cava lleria. con la relativa artiglieria da campagna. o da fortezza, i Gruppi Alpini e, al Livello inferiore. le unità come i reggimenti. i raggruppamenti ed i repa11i autonomi.
2 Le sigle in uso nell'artiglieria italiana dell'epoca. tanto di terra come di mare. indicavano le caratteristiche tecniche del pezzo ed erano, per il materiale: A (acciaio), 8 (broaLo), F (ferraccio) e G (ghisa): e per il tipo di lavorazione AL (accia io lungo). AR (acciaio rigato ) ARC (acciaio rigato cerchiato ) BR ( bronzo rigato ) GL (ghisa liscio) GR (ghisa rigato) GRC (ghisa rigato cerchiato).
-38
 Esercitazioni di Piemonte Reale nella campagna romana presumibilmente sulla via Braccianese Claudia. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale: nella campagna romana. (Archivio Dal Molin)
Esercitazioni di Piemonte Reale nella campagna romana presumibilmente sulla via Braccianese Claudia. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale: nella campagna romana. (Archivio Dal Molin)
-39-
Ogni Grande Unità complessa comprendeva aliquote delle tre anni e delle loro specialità ed era fornita di tutti quei mezzi tecnici speciali, necessari per il regolare sviluppo delle azioni di guerra, o consigliati dalle particolari caratteri tiche del terreno dove e s sa operava, o richiesti dagli speciali compiti eventualmente ad essa assegnati. Le truppe non inquadrate nelle divisioni comprese nei Corpi d'Armata, di qualsiasi arma o corpo fossero, prendevano il nome di Truppe Suppletive (TS).
Le truppe erano al comando di ufficiali che ne erano gli istruttori e per molti ver i gli educato ri. Le Grandi Unità erano al comando di ufficiali generali, anche se a volte poteva capitare che le Brigate fossero affidate a un colonnello brigadiere; i reggimenti e le unità affini erano comandate da colonnelli; i battaglioni, i gruppi squadroni o di batterie da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie, le batterie e gli squadroni da capitani, o, a volte, da tenenti; i plotoni e le sezioni da subalterni. Ciascuna unità, poteva essere comandata da un ufficiale di grado inferiore a quello competente, con funzioni di titolare (comunemente al comp l esso degli ufficiali dell'Esercito, o di ciascuna unità, si dà il nome di quadri, per rispondere al concetto delle funzioni degli ufficiali stessi rispetto alle truppe, poiché essi costituiscono l' ossatura dei reparti e cioè la parte più importante e più solida).
A sostegno delle truppe combattenti si trovavano i servizi, parola con cui si designavano le branche dell'organizzazione che permetteva alla truppa di vivere, rifornirsi di munizioni, di materiali e di vettovag li e e che provvedeva alla salute dei combattenti. Nei servizi andavano distinti gli organi direttivi (a lato dei comandi) e g li organi esecutivi (con le truppe o vicini ad esse). Erano organi direttivi: l 'intendenza generale, le intendenze di Armata, le direzioni dei Corpi d'Armata, gli uffici delle divisioni; erano organi esec utivi: glj enti incaricati del funzionamento diretto di ciascun servizio, i magazzini e g li stabil imenti vari, fissi o mobili. Ognuno degli organi suddetti aveva una doppia dipendenza: disciplinare e d'impiego, rispetto al comando delle unità , od a ll e unità, cui esso era assegnato; tecnico-amministrativa, rispetto agli e nti superiori del proprio serv izio. Presso le unità minori (reggim enti reparti autonomi) l a direzione dei servizi vari si fondeva con il comando delle unità stesse. Infine il territorio delle operazioni fu ripartito fra le grandi unità, con limiti ben definiti: in ciascuna zona, dalla fronte di combattimento (a co ntatto del so ldato) ogni servizio aveva suoi vari elementi scaglionati indietro, sino a collegarsi con il paese. Le zo ne interposte fra la fronte di combattimento ed il paese, e nelle quali si effettuavano i movimenti di riforni mento e di sgombero, prendevano, e prendono, il nome di retrovi e. Questa breve descrizione è necessaria per comprendere il ruolo che nella Grande Guerra, specie durante i primi ventiquattro mesi, ebbe l 'Arma di Cavalleria, Arma che rimase pressoché inalterata nell a struttura fino alla fine delle osti l ità. Era costituita da uomini appartenenti soltanto alle classi deH'Esercito Permane nte e della Milizia Mobile, non esistevano reparti costi tuiti con classi di Milizia Territoriale. Comprendeva le specialità dei dragoni (primi quat tro reggimenti: Nizza Cavalleria, Savoia Cavalleria, Piemonte Reale e Genova Cavalleria), dei lanc ieri e dei cavalleggeri. Le unità che la componevano normalmente combattevano a cava11o, ma potevano esse re articolate in modo da essere impiegate anche a piedi (ed in fatti molte unità furono immediatamente ap piedate) e dalle unità minori a quelle Grandi si dividevano in plotonj, quadroni, gruppi di sq uadroni , reggime nti, brigate e divisioni. I regg ime nti che non erano inquadrati in Grandi Unità cli cavalleria, ma a disposizione delle altre Grandi Unità, facevano parte delle TS GJj sq uadroni erano unità organiche, tattiche ed amministrative; se operavano a cavallo aveva no i mez z i per rendersi autonomi; se erano appiedat i potevano funzionare analogamente a l le compa gnie di fa nteria . Venivano numerati per reggimento; due o tre d i essi formavano un Gruppo Squadroni e due Gruppi Squadroni formavano un reggimento. Il Re ggime nto, allora come in seguito, era l'unità tattica, organica ed amministrativa e normalmente comprendeva- appunto- due g ruppi di sq uadroni. I reggimenti a uton omi avevano struttura sim il e, ma numero di sq uadroni variab ile . Tutti erano numerati progressivamente ed og ni reggimento aveva, inoltre, una denominazione pro pria (in due cas i il nome dei sovrani, se no di regioni o di città, con la sola eccezione dei Cavalleggeri Guide). Ciascun reggimento divisionale montato era stato fornito di una sezione mitragliatrici. Due

-40
 Marcia in colonna. (Archi v io Dal Molin )
Squadrone in sosta . (Archivio D aJ Molin)
Marcia in colonna. (Archi v io Dal Molin )
Squadrone in sosta . (Archivio D aJ Molin)
41-
 Dragone di Piemonte Reale nella tenuta grigioverde in uso nel 1915. ( Archivio Dal Molin)
Dragone di Piemonte Reale nella tenuta grigioverde in uso nel 1915. ( Archivio Dal Molin)
-42
reggimenti componevano una brigata e due brigate fornivano l ' ossatura principale di una divisione di cavalleria, composta anche da artiglieria , ciclisti ed aliquote dei servizi.
Per quanto concerneva l'armamento, le truppe a cavallo avevano a disposizio ne, se L ancieri: sciabola, lancia e moschetto di cavalleria mod. 1891; se Cavalleggeri lo stesso ma senza l a ncia . L e dotazioni di munizioru erano : individuale, cartucce 96; di riserva con il cru.Teggio: 24; presso la colonna munizioni: 77. Ogni armato di pistola portava con se 18 cartucce. Lo squadrone mitraglia trici era dotato di Maxim leggere mod. 191 l .
Come attrezzatura , le truppe a caval lo avevano (per squadrone) gravine, badile, fen-i ramponi , picozzini; materiale radiotelefonico (per reggime nto) e materiale esplosivo (per sq uadro ne).

Gli squadroni a cavallo avevano inoltre personale addestrato e materiali ed utensili per la fen-atura dei quadrupedi e per la manutenzione degli oggetti di selleria
Il servizio sarutario per le truppe a cavallo era esercitato da ufficiali medici, in forza ai comandi di reggimento ed ai Gruppi Squadroru, con personale e materiale in quantità adeguata ai bisogni; gli squa droni avevano inoltre personale richiamato ed addestrato . Nelle zone di combattimento si formavano posti di medicazione; lo sgombero dei feriti veniva fatto verso le sezioni di Sanità delle rispettive divis ioni.
Per i quadrupedi esisteva ovviamente un servizio veterinru.·io composto da ufficiali medic i e per sonale specializzato distribuito come quello per gli uomfoj .
11 vettovagliamento dei so ldati era analogo a quello della fanteria. Per i foraggi gli squadroni a cavallo trasportavano con il proprio carreggio una razione di avena di riserva (kg. 5); i vari preleva menti si effettuavano presso le sezioni sussistenza per divisioni di cava ll e ria 43
• 3 AUSSME. Regio Esercito. Comando Supremo. Reparto operazioni. Ufficio affari vari e segreteria. Notizie organiche somma rie s ull 'esercito mobilitat o gennaio 1917.
Ese rcitazione di guado dei fiumi. (Archivio Dal Molin)
43-
 Prove di attacco al galoppo di Piemonte Reale (Arch i vio D al Molin )
Prove di attacco al galoppo di Piemonte Rea le. (A rchivio Dal Molin)
Prove di attacco al galoppo di Piemonte Reale (Arch i vio D al Molin )
Prove di attacco al galoppo di Piemonte Rea le. (A rchivio Dal Molin)
-44-
V
LA CAVALLERIA E LA NUOVA GUERRA EUROPEA: LE ESPERIENZE DELL' ÀRMA SUGLI ALTRI FRONTI
Mentre il Regio Esercito italiano s i preparava ad entrarci, la guerra in Europa aveva già subito una battuta d ' arresto. Dalla breve esposizione fatta sullo svil uppo della cavalleria in Europa , si può affermare che in teoria l ' opportunità di un mutamento di indirizzo nelle sue forme di impiego si era sentita molto prima della Grande Guerra e, all'atto pratico, questo bisogno si era realizzato solamente in emb rione negli organici dei reparti, con la creazione delle sezioni cLi mitragliatrici a cavallo, aggiunte ai reggimenti. Dopo l e pubblicazioni dei generali francesi D e Negriere Kessler nel 1902 e nel 1908, tendenti a una trasformazione dei criteri d'impiego dell ' Arma, che consigliavano di far evolvere verso l'u so del fuoco, si cercò di indirizzare l'Arma verso il potenziamento di tale volume. Si riteneva infatti che il co ntinuo perfezionamento delle armi portatili, divenute celeri ed a lunga gittata, avesse affievolito l'effetto delle cariche contro la fanteria. La reazione alla nuo va dottrina ebbe successo e lo spirito "offeso" dei cavalieri trovò molti difensori, anche tecnici, che, proprio nella patria dei due innovatori , fecero capo con successo ai generali Bonnal e Langlois , cosicché il regolamento della cavalleria francese del 1912 si limitò ad affermare nell ' introduzione che: "senza rinnegare nulla del suo passato di gloriosa tradizione, la cavalleria deve vivere con i tempi e conformare i suoi progressi a quelli delle altre armi."44
Poco prima dello sco ppio della conflagrazione europea, in Francia si guardava all'esercito del futuro nemico, l a Germania, nel quale le proposte innovazioni sull 'impiego della cavalleria non avevano risveglfato alcuna eco. Il generale von Bernhardi , lo scritto re tedesco più autorevole in materia, nel suo libro Quale futuro per La cavalleria, insisteva nel preconizzare lo scontro fra l e masse di cavalleria alle quali: dovevasi infondere il più alto spirito offensivo, di c ui era stato simbolo l'estens ione a tutti cavaUeri germanici della lancia come arma d ' urto e d 'effetto morale. Al1e grandi manovre tedesche le grandi masse di cavalleria chiudevano i l ciclo delle esercitazioni con cariche di poderosissime schiere, guidate dallo stesso Kaiser. L'esperienza della guerra insegnava però l'utilità dell 'arma da fuoco data ai cavalieri; gli Ingle si traevano ammaestramento dalla loro guerra contro i Boeri per dotare tutti i reggimenti di cavalleria dello stesso fucile della fanteria e, neJ1a Guerra RussoGiapponese, si era vista la grande utilità d ' impiegare corpi misti , dove, a distaccamenti di cavalleria, s i aggiungevano fanteria ed artiglieria: elementi di fuoco che consentivano di co ndmre a termine missioni importanti, per le quali la so la cava11eria non aveva mezzi sufficienti.
Che nell'anteguena si fosse potenzialmente ed in parte anche praticamente iniziata un'evoluzione tattica della cavalleria, lo s i 1iscontra anche dall ' esame dei dibattiti fra gli studios i di materie militari nei riguardi della attuazione pratica dei compiti affidati aU 'Arma Per il primo , 1'esplorazione , si riteneva che sarebbe mancato il più deIJe volte lo spazio, giacché le due parti avverse , mobilitando ai confini, si sarebbero trovate già a contatto allo scoppio delle ostilità. Si aggiungeva poi che le 1icogniz ioni di piccole pat tuglie non avevano speranza di notevole successo informativo, incapaci , come sarebbero s tate , di arrivare a contatto del grosso dei nemici. Di esso avrebbero potuto bensì disegnare e riferire il contorno apparente , ma ce1to non rilevarne la vera massa e le intenzioni, come " pretenziosame nte" si richiedeva; questo sarebbero avvenuto per la debolezza delle pattuglie nei confronto delle forze di copertura de ll 'avver sario. Come rimedio si erano propo ste esploraz ioni fatte non più da deboli pattuglie , ma da forti distac
44 Rip. in C OMANDO DELLE SCUOLE CENTRALI , Cavalleria, la sua evoluzione tattica, in La cooperazione d e lle armi, anno I, fascicolo 3. settembre e ottobre 1923.

CAPITOLO
-45
camenti esploranti, con mitragliatrici, rompendo così la consuetudine dell'avanscoperta sistematica a ventaglio, disegnata in teoria con scherrti esatti, da essere ripetuti tali e quali sui campi d'operazione.
Per le azione sui fianchi dell'avversario si temeva l'insufficienza dei mezzi di fuoco della Cavalleria rispetto a que11i delle truppe di contorno nemiche e, infine, nella battaglia si avvertivano la difficoltà d'ottenere un successo coll'attacco all'arma bianca e la necessità, quindi, che 1a Cavalleria potesse impegnarsi agendo col fuoco.
Da queste discussioni, dai timori degli studiosi, dagli insegnamenti delle guerre combattute dopo il 1870 in merito a1J 'im piego della cavalleria, avevano preso forma concreta disposizioni e regolamenti tendenti ad aumentare la potenza di fuoco delle unità di Cavalleria, ma non era certo entrato nello spirito dell'Arma il sentito bisogno d'approfittarne.4 s Infatti, alla vigilia della guerra, nell'esercito inglese era stato sancito il principio di dover valutare la potenza del fuoco, ma subito dopo l'avvertenza d'evitare che, per addestrare le truppe di cavalleria nell'impiego a piedi, si potesse far perdere la fiducia in quello a cavallo. Anche in Germania si affermava la doppia funzione nel combattimento, ma si confermava che quella a cavallo doveva restare la principale. Sempre in Germania (esercito che faceva scuola) si erano avuti molti avversari delle assegnazioni di ciclisti alle unità di cavalleria ma poi, visto ciò che si faceva negli altri eserciti, si era convenuto di dare importanza ai mezzi ausiliari. Nel 1913, a quelle grandi manovre tedesche che furono quasi una prova della guerra dell'anno seguente , la Cavalleria venne molto impegnata, usandone i mezzi di fuoco per evitare le perdite e facendo cooperare con essa mitragliatrici, ciclisti ed artiglieria. Quest'ultima fu usata in larga misura dalle di visioni germaniche di cavalleria nel 1914 quando evitarono la lotta all'arma bianca.
In Francia, mentre si assegnava e si dava grande importanza ai mezzi di fuoco aggiunti alla Cavalleria , si rimaneva in una giusta via di mezzo circa i suo i principi di impiego e, pur sviluppandone lo "spirito progressivo", i regolamenti non erano precisamente propensi all'attacco a cavallo di grandi masse, come invece quelli tedeschi. I fatti avrebbero però capovolto la situazione e la cava1leria francese non avrebbe trovato presa presso quella avversaria. In Italia, infine, nelle norme per il combattimento del 1913 si erano preconizzate "le ardite imprese" delle unità celeri, costituendole con le divisioni di cavalleria, mitragliatrici, artiglieria a cavallo, ciclisti e sezioni del genio. Nel servizio di guerra poi , si accennava alla possibile assegnazione di unità di fanteria al corpo di cavalleria, inten dendo quest 'u ltimo come una Grande Unità complessa formata di più divisioni di Cavalleria.
Se dovunque nei regolamenti echeggiavano previsioni, nello spirito dell'Arma in tutta Europa non era entrato il giusto apprezzamento delle necessità di un lungo impiego dei mezzi di fuoco ad essa assegnati. D 'altronde, i concetti tattici sanciti mettevano sempre in prima linea l'uso normale dell'attacco a cavallo e dell'azione di grandi masse all'arma bianca: era quindi naturale cosa che l'evoluzione tattica della cavalleria, iniziata prima della guerra soltanto teoricamente, trovasse realmente in quest'ultima sua stringente necessità alla stregua dei fatti. 46
Allo scoppio della guerra tutte le Armi ebbero immediatamente a subire delle modifiche, spesso radicali, nei campi organico e tecnico per potersi mettere all'altezza del1e nuove esigenze di guerra che man mano si venivano manifestando. L'alto comando della monarchia danubiana compattò le unità di cavalleria dell'Esercito Comune, della Hon véd ungherese e della Landwehr austriaca in Divisioni di cavalleria47 e, allo scoppio della guerra, ne aveva già 11 a disposizione. Esse erano, comunque, unitamente ad alcuni reggimenti di cavalleria, inquadrate come cavalleiia divisionale, pertanto furono divise e le loro parti aggregate alle di visioni o alle brigate di fanteria.
45 Cavalleria, la sua evoluzione tattica. cit.
46 Cavalleria, la sua evoluzione tattica, cit.
47 CERNIGOT-LENARDON-POZZATO, Soldati dell'Impero, la struttura e l'organizzazione dell'esercito della monarchia Asburgica, Bassano del Grappa, Edizioni Itinera progetti, 2002.

46-

'
Dragoni francesi in avanscoperta: 1914. (Archivio Cernigoi).
Ussari francesi in avanscoperta: 1914. (Archivio Cemigoi).
47
La loro mobilità fu sfruttata per ricognizioni a breve raggio d'azione, per la protezione del sistema di mantenimento dell'ordine, per le comunicazioni, la rapida occupazione delle posizioni, la copertura delle ritirate e, frequentemente, in rinforzo alle unità combattenti.

In linea di massima, l'alto comando austro-ungarico contava di condurre la guerra al massimo in uno o due teatri operativi contemporaneamente. Per questo aveva sviluppato tre raggruppamenti di forze disponibili: uno alla frontiera sud, il secondo in Galizia e il terzo come riserva strategica. Inoltre aveva pianificato lo spiegamento della cavalleria quasi esclusivamente contro il teatro rnsso, dove la cavalleria dello Zar, grazie alle sue dislocazioni del tempo di pace , poteva aprire i combatti menti con un grandioso attacco in massa. E contro questa eventualità dovevano essere utilizzate le 11 divisioni della cavalleria asburgica. Comunque, nelle previsioni del comando imperiale ]a distruzione della cavalleria avversaria doveva essere raggiunta solo attraverso cariche in massa, in ordine chiuso, col supporto dell'artiglieria e di pochi distaccamenti di mitragliatrici. E questo si doveva al fatto che nella Duplice Monarchia il mantenimento della tradizione era considerato più importante di qualsiasi esperienza. La preparazio ne , l'equipaggiamento , le dotazioni di munizioni, le uniformi della cavalleria tutto indica va che l'Alto comando austriaco non aveva compreso per niente che il prossimo sarebbe stato un conflitto di fanterie.
Allo scoppio delle ostilità, tre armate erano state concentrate tra la Vistola e Leopoli, per prevenire con un'operazione aggressiva l'esercito russo. Siccome non era disponibile nessuna informazione concernente in dettaglio i movimenti russi , era stato proposto di utilizzare tutta la cavalleria in ricognizioni a lunga distanza. Nel I, IlI e IV Corpo d'Armata (operante in Galizia) furono quindi usate sette divisioni di cavalleria; sul fianco destro tre e , sul fianco sinistro, una.
La ricognizione strategica su larga scala , eseguita tra il 14 e il 23 agosto 1914, falli nei ri sul tati. 11 corpo di cavalleria non riuscì a penetrare dietro la linea avanzata delle forze russe, le cui formazioni erano in avanti ma chiuse in profondità. Fu comunque eseguita una serie di ricognizioni, durante le quali non mancarono scontri di una certa rilevanza e, vista la volontà della cavalleria di attac care a qualunque costo, il comando imperiale dovette emanare una serie di direttive per impedire tra la sc ia sse o abbandonasse il principale incarico della ricognizione, a favore dell'attacco immediato.
L'esperienza acquisita nell e prime battaglie dal)' esercito della monarchia portò ad un drastico riass estamento del molo tradizionale della cavalleria. Le unità ve nnero inizialmente indirizzate ad un ruolo di difensjva dei fianchi e di collegamento e copertura dei vuoti aperti tra le varie unità. Non vi furono più cariche sotto i] fuoco delJ ' artiglieria, in quanto , nonostante i s uccessi, il numero delle perdite era spro porzionato rispetto ai risultati. Dopo breve tempo l e unità di cava]leria vennero fatte smontare, riequipaggiate e fatte combattere insieme alla fanteria; di cavalleria non si parlò più. La prima grande novità che la guerra aveva fatto apparire , una vera sorpresa, il reticolato, era risultata il vero nemico tanto dell'azione a cavallo, come della baionetta.
Sul fronte franco belga il colpo di mano tedesco su Liegi del 4 agosto 1914 ed il conseguente delinearsi di un'avanzata germanica attraverso il Belgio , avevano indotto il comando francese ad inviare il Corpo di Cavalleria Sordet su tre divisioni 1a, 2a e 5a, per un totale di 72 sq uadroni tre gruppi ciclisti e 9 batterie da Sedan verso Liegi , ad oriente della Mosa, per prendere contatto col l'ala destra germanica e riconoscerne l 'entità. Entrato in Belgio il 6 agosto per Buillon, in tre lunghe tappe il Corpo Sordet s i era portato 1'8 nella regione Modal e -Ouffe t (Ourthe), a 24 chilometri circa, in linea d ' aria, dalla piazza di Liegi e dal contatto con la 9'' Divisione di cavalleria germanica.
I Tedeschi avevano stabilito un dispositivo di copertura attraverso il quale riuscì difficile alla cavalleria francese la penetrazione. La sera stessa intorno alle 21 dell'8 agosto il Corpo Sordet aveva ripiegato dalla foresta di Saint Hubert e , salvo qualche spostamento il giorno 11 si era por tato verso Neufchateau ed il 12 era tornato verso la Lesse per avvicinarsi alla Mosa era restato nella regione fino al 14. Poi era passato alle dipendenze della V Armata, cbe l'aveva impegnato per copri-
-48
re l'armata stessa e per prendere, a nord della Sambra , contatto colJ'ala destra germanica, che procedeva ad occidente della Mosa anziché ad oriente , come invece il comando francese si era aspettato. I risultati dell'incursione nel Lu ssemburgo belga non erano stati giudicati soddisfacenti. La cavalleria francese, giunta a contatto con quella germanica, era tornata indietro senza riuscire a batterla o neutralizzarla. Stava però il fatto che, oltre a ragioni moraJi48 , il ripiegamento deJl '8 era stato deter minato anche dall'insufficiente funzionamento dei servizi: il carreggio ordinario - a traino animale non aveva potuto seguire il grosso e l ' unica autosezione leggera disponibile era rimasta circa 30 chilometri più indietro.
Senza contare lo sfo rzo compiuto il 7 e 1'8 agosto, che era stato enorme ed aveva esaurito uomini e cavalli, privi di qualsiasi rifornimento, non sarebbe s tato prudente impiegare il Corpo l 'i ndoma ni in combattimento contro le forze tedesche. Cercando il combattimento, il Corpo di Caval leria si sarebbe allontanato maggiormente dai propri servizi e dal proprio sostegno di fanteria, costituito dall'VTIT Brigata di fanteria, che era anch'esso vincolato ai trasporti automobilistici e tardava ad arrivare. Un buon risultato si sa rebbe veramente potuto avere dal fatto che un prigioniero tedesco, catturato in una carica il 9, aveva descritto a grandi linee lo sc hieramento di tutto l 'ese rcito germanico. Ma pare che l'informazione non fosse stata ritenuta sufficientemente attendibile dal comando fran
,s AUSSME, relazioni degli addetti militari : "la cavalleria francese giunse da vanti a Liegi completamente di sorpresa e la sua comparsa gettò il panico in un Corpo d'Armata tedesco. Ma parve prevale sse la prudenza anche nell 'anim o dei comandanti la cavalleria francese, perché il Sordet fece retro ce dere i suoi reparti per evitare che rimanessero a troppo strel/o contauo con il nemico." lnformazioni del colonnello MORI-UBALDINI DEGLL ALBERTJ dal quartiere ge nera le francese nel 1915.
 Cavalleria inglese. 1914. (Archivio Cernigoi).
Cavalleria inglese. 1914. (Archivio Cernigoi).
-49-
cese, in quanto non concordante con altre notizie pervenute da fonte diversa. L'incursione comunque diede ai Belgi, che fino allora avevano sostenuto da soli [,invasione tedesca, la concreta sensazione d ,u n appoggio.
Poi c'era stata la Battaglia delle Ardenne, dal 20 al 28 agosto 1914. Nel quadro generale della cosiddetta "Battaglia delle frontiere,, impegnata da tutto l'esercito francese, quella delle Ardenne doveva sfondare il centro tedesco a sud della Mosa. Tre divisioni di cavalleria 3\ 4a e 7a francesi erano state spinte nel Belgio, col compito di esplorazione lontana a profitto delle armate schierate nelle Ardenne. Tale esplorazione aveva però incontrato difficoltà, specialmente da parte della 3a e 4a divisione, le qua]j, la sera del 21, erano state raggiunte dalla fanteria del1e Grandi Unità. TI 22 la 7a divisione si era resa indisponibile perché troppo stanca, mentre le altre due avevano avuto l'ordine di portarsi sulla sinistra della JV Annata per esplorare in direzione di Givet.
Da parte tedesca i Corpi di Cavalleria Il (von der Marwitz con le tre divisioni 2a, 4a e 9a) e I (von Richthofen , sulle due divisioni sa e della Guardia) avevano intanto avuto il compito di assicu rare l'esplorazione delle armate I, II e Iil e coprirne il movimento, in modo da permetter loro una rapida avanzata. La cavalleria aveva perciò avuto una duplice funzione di esplorazione e di copertura, che restava effettivamente iJ suo compito maggiore, poiché i Tedeschi non cercavano informazioni sul nemico. Essi prendevano contatto con lui alla massima distanza per avere il tempo e la possi bilità di manovrare di conseguenza ed al contempo per impedire che i Francesi potessero, penetran do con le loro punte esploranti, disturbare l'avanzata e annullare la sorpresa. In sostanza il comando tedesco voleva essere certo di poter attuare completamente i propri piani. Con quest'ordine di idee però la Cavalleria tedesca, pur spingendosi talvolta a grande distanza, aveva assunto un contegno che l'aveva fatta gravitare più verso le proprie truppe che sul nemico e non aveva cercato la cavalleria
 Cavalleria inglese in una raffigurazione del 1914. (Archivio Cemigoi).
Cavalleria inglese in una raffigurazione del 1914. (Archivio Cemigoi).
-50-
francese, per impegnarla in quel dueJlo decisivo che i teorici prebellici le avevano affidato. Non ci fu da stupirsi se dunque, specie fino al 18 agosto, la cavalleria tedesca si fosse limitata ad eseguire missioni più che altro d'esplorazione con combattimenti occasionali.
Tra 1' agosto e il settembre 1914 la situazione creatasi suJ teatro di guerra occidentale, dopo gli scontri a Mons e Charleroi e I 'insuccesso delJa Battaglia delle frontiere, che aveva indotto Joffre a ordinare il ripiegamento cli tutta l'ala sinistra francese dalla Sambra alla Senna, avrebbe dovuto presentarsi favorevole ad un inseguimento. Le grandi unità di cavalleria tedesca avrebbero dovuto poter aggirare l'ala francese e cadere alle spalle delle armate in ripiegamento. Ma per raggiungere questo risultato sarebbe stata necessaria una massa di cavalleria fresca e potente, capace di manovrare a grande raggio. Invece i due corpi di cavalleria tedeschi, che avevano fino allora operato in esplorazione e copertura delle armate dell'ala destra, restarono troppo legati ad esse. Non furono quindi in grado di manovrare nel campo strategico, nonostante le unità di fanteria nemica procedessero a marce forzate anche di 40 chilometri e potessero essere facilmente raggiunte dalla cavalleria, che procedeva attraverso i campi L'inseguimento fu lento e si limitò ad una sporadica e rada attività d'artiglieria contro le colonne francesi ed inglesi in ritirata. Questa lentezza determinò la completa inazione della cavalleria germanica dopo Charleroi, ulteriormente aggravata dagli scacchi subiti dalla stessa a Haelen e a Dinant, che influirono sul contegno circospetto assunto in quel periodo della campagna. Poi anche qui la cavalleria si arrestò fino al 1918.49
9 Note sulla costituzione e sull'impiego delle unità in cavalleria, Torino, Scuola di applicazioni e studi militari dell ' esercito, s.d.

-51-

CAPITOLO VI
L'ENTRATA IN GUERRA
Abbiamo detto che il fronte italo austriaco nella guerra del 1915-18 si estendeva per circa 600 chilometri, poco meno di 500 dei quali però correvano lungo i crinali delle Alpi, mentre solo i iimanenti erano nel territorio che dalla vetta del Canin porta al Golfo di Trieste e che quelli -il Carso furono il teatro delle principali e più sanguinose operazioni. La ragione stava nel fatto che si riteneva possibile ed auspicabile sfondare immediatamente verso Trieste e scontrarsi coll'Esercito imperiale in una pianura lontana da difese naturali a cui potesse appoggiarsi.

U 24 maggio 1915 i fanti italiani passarono fiduciosi la frontiera ed iniziarono ad occupare le ultime propaggini del1a monotona pianura friulana davanti ai primi, dolci rilievi del Carso.
Gli Austro-Ungarici, impensieriti dall'avanzata e dalla pressione nemjca , che veniva considera ta notevole, abbozzarono due piani . Il primo prevedeva una resistenza sul fronte di Gorizia, il secondo un arretramento su una linea di resistenza posta più ad est, segnata dall'allineamento TarnovaSchonpass Lipa Iwanigrad. Fu scelto il primo.
L'avanzata delle truppe italiane fu lenta e circospetta e coincise con la vittoria a Gorlice delle armate imperiali sui Ru ssi del fronte orientale e, a sud, con un inspiegabile arretramento dell'esercito serbo, circostanze che permisero a ll 'Austria- Ungh eria di inviare nel nuovo scacchiere italiano altre truppe A capo di esse fu posto il FeldleutnantmarschaJl Boroevic von Bojna , i l quale diramò immediatamente alle truppe l 'originale ordine, che esprimeva la sua filosofia di guerra: il fronte andava mantenuto a qualsiasi costo.
Le forze imperiali a protezione della frontiera era no state minime fino al mese di maggio , essendo costituite da due divisioni di fanteria in via di costituzione la 93a (Gorizia) e la 94a (Lubiana) formate per lo più da uomini della Landsturm, in minima parte da formazioni di marcia dei vari corpi di truppa, da un battaglione di marina, da alcune formazioni di volontari ed infine da un'aliquota insignificante d'artiglieria Solo un paio di giorni prima dello scoppio delle ostilità arrivò sul nuovo fronte sud-occidentale dell'Impero l a 57a Divisione cogli effettivi di guerra prescritti. Successivamente, con la venuta di nuove truppe, fu costituita l a sa Armata, cbe, nel 1915, comprendeva il XV Corpo, con le divisioni l a e 50\ ed il XVI con la 18a e la 58\ più la 48a Di visione autonoma e le forze già presenti in luogo Queste erano le forze di Boroevic, il cu i fronte fu diviso in tre settori, ripartendovi le truppe disponibili in tal modo : il XV I Corpo, comandato dal FeldzeugmeisterTurm, da Duino a Brotof, iJ XV Corpo del generale Fox da Tolmino fino alla Boinsizza , il XVI del genera le di artiglieria Wurrn da Auzza a Gori zia , il gruppo del Feldmarschall Ooiginger dal Vippacco all cittadina istriana di Parenzo.
Le rocce di carattere car s ico re sero difficile lo scavo in profondità delle linee di collegamento della difesa, in quanto non potevano essere coperte da sacch i di terra e zolle d'erba; ma risultarono comunque micidiali sia per gli attaccanti che per gli stessi difensori, in quanto, frantumate dai proiettili, venivano proiettate in tutte le direzioni, moltiplicando l'effetto distruttivo delle esplosioni. La natura, comunque, aiutò in modo determinante l'esecuzione dell'ordine perentorio di Boroevic. I soldati austro ungarici avevano dalla l oro parte le forti posizioni montane, imme diatamente a ridosso del fiume I sonzo. Tutta la sponda sinistra del fiume si prestava ad un'efficace difesa attiva ed essi continuaro no a fortificarla febbrilme nte. 1n due tratti del fiume, i noltre , davanti a Tolrnino, già quasi ultimata, e a Gorizia, sulla sponda destra del fiume vennero costituite due teste di ponte. Erano posizioni strategiche : da li non solo partivano le principali arterie di comunicazione verso l ' interno dell'Impero, ma si garantivano anche quelle tra i vari settori del fronte, fra le montagne ed il mare.
-53
 Il colonnello Lui si to , comandante di Piemonte Reale. (A rchivio Dal Molin )
Il colonnello Lui si to , comandante di Piemonte Reale. (A rchivio Dal Molin )
-54-
 Piemonte Reale: in attesa della sfilata (Archivio Dal Molin)
Sfilata di Piemonte Reale per le vie della città. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale: in attesa della sfilata (Archivio Dal Molin)
Sfilata di Piemonte Reale per le vie della città. (Archivio Dal Molin)
-55
La tenuta di queste due te te di ponte , ve re cerniere di collegamento e cardini dell'intero s is tema di difesa, era fondamenta le. La prima e ra rappresentata dalle modeste alture di Santa Maria e Santa Lucia di Tolmino , c he s barravano il passo alle truppe attaccanti in arrivo dai c ontrafforti dello Jeza verso la direttrice di Lubiana; la sec onda , formata dai monti Sabotino e Podgora, con la cortina intermedia di O slavia e di Peuma , fermava l'accesso alla valle del Vipacco e da questa a Trie ste.

Ai fanti italiani che s uperarono i confi ni dell ' Impero apparve allora nella sua s plendida bellezza e imprendibile imp onenza la barriera montana che dal Monte Nero passa per il Mrzli e d il Vodil, degrada verso la conca di Tolmino e risale, tra le due te s te di ponte , s ull 'a ltopiano della Bains izza. Al contempo s i delineò l ' ultimo se ttore principale dell'attacco: l'asperrimo altopiano car ico. le cui estreme propaggini meridionali toccano l"Adriatico.
L' azione italiana si basava su un 'avan za ta generale, in modo da non sco prire pos izioni pericolose per l a s icurezz a delle varie armate , cosicc hé la 2 a Armata dovev a prec e dere l a 3a nelle diverse fasi operative. Successe però che la 2u rima se inchiodata s ulla s ponda destra d e ll ' I so nzo per oltre du e anni , mentre la 33, av anz a ndo , esponeva peri co lo sa mente il proprio fianco s ini stro al nemico. Con la prima ava11zata le truppe italiane raggiunsero la I inea Corrnon s- Ver sa -Cervi g nano -A quileia. La pianura e ra stata presa sen za eccessive difficoltà, ma il primo ostaco lo naturale, l'Isonzo, fece subire un immediato rallentamento. Il ponte di Pieri s era stato fatto saltare dagli Austro-Ungarici il gio rn o dell' ini z io de lle ostili tà e c i ò fermò l a Cavalleria, mandata in avanscoperta co l compito di prendere i passaggi sul fiume.
Cadoma s i re se conto immediatamente c he l'avanzata era eccessivame nte l e nta ed impartì l' ordine di accelerarl a, perlomeno dove gli Au stro-Un garic i non s i erano arroccati. L"avanzata riprese e furo no raggiunte le falde del Carso. La 2a Armata, a nord , ferma tra l ' I so n zo e l e falde del si s tema
Lancieri a cavallo sfilano nel piazzale della caserma. ( Archivio Dal Molin )
-56-
 Parata. ( Archivio Dal Molin)
Dragoni a cavallo in rassegna. ( Archivio Dal Molin)
Parata. ( Archivio Dal Molin)
Dragoni a cavallo in rassegna. ( Archivio Dal Molin)
57-
della B ainsizza, cercò di conq u istare i monti c he si protendo no verso la valle de l Vipacco, m e ntre agli uomi n i della 3a, che passarono s ulla sponda sinistra del fiume, ap parivano le brulle e anonime qu ote del primo cig l ione carsico, quote c he di lì a breve s arebbero divenute tristemente fa mo se fra i popoli dell'Italia e della monarchia danubiana.
V is ta da ll 'alto, l a parte ette ntrionale del Carso di Dob erdò assomiglia ad un triango lo la cu i base corre parallela aJJa pianura isontina che, dolcemente, in vita a lla via per Trieste. La s trada è ch iusa in prossimità di San Giovanni di Duino , dove i rilievi carsici, seppur modesti , ne sbarrano 1' acce s so. Il s econdo l ato del triango lo costeggia l'intero a l to p iano d i Dob erdò, passa in quello di Com e no e fo rma , delimitato daJle a lture di O s]av ia , la valle del Vipac co, nella quale sco rro no l'I sonzo e il s uo affluen te Verto ibiza e s i eleva il Monte Fortin. A es t , ai piedi del Monte San Gabriele e s ulla s ponda s ini stra de ll ' Iso nzo, so rge Gorizia.
Tre p aesi: Fogliano (P olazzo), Sagrado e Poggio (ora Pogg io della Terza Armata) , so no posti alle pendici del San Michele e lo delimita no , face ndogli ass um ere una peculiare configu razione a trian golo . Dalla s ua vetta poi sce ndono un a serie di costo ni c he paiono ancorarlo al s uolo.
Verso s ud es t, in direzione di Trieste , dalla caten a s i staccano du e s peroni: il primo sce nde verso Fogliano , l 'altro verso il Coll e di Sant ' Elia.
Il settore del Carso d i venne il fronte principale della g uerra degli anni 1915/19 16. AJla 33 Ar m a ta , posta agli ordini del Duca D ' Aosta e d ivi pos iz ion ata, fu affidato il compito di sfondare il fronte avversario, in pratica di es pu g nare il Monte San Michele e co nquistarne l 'al topi ano. Ne furono incaricati l'XI e d il X Corpo d ' Armata.
Sul versan te o pp os to , ag li uomini del Gruppo Lu ckachich, venne dato l 'ordi ne di difenderlo. TI Co m ando imperiale notò immediatame nt e c he gl i attacc hi italiani era no slega ti: vi era una po de
 Pi emonte R eale schierato per la rivista. (Archivio Dal Molin)
Pi emonte R eale schierato per la rivista. (Archivio Dal Molin)
-58-
rosa azione d'artiglieria, ma questa era indipendente e si sviluppava lungo tutto il fronte, creando aspettative di attacchi a fondo, che puntualmente però non avvenivano. Le truppe regie infatti venivano impiegate in azioni parziali , s legate nel tempo e nello spazio, che causavano sanguino sissime perdite con risultati scarsi . Questo pessimo impiego tattico fu un ulteriore vantaggio con cesso ai difensori.
Il Comando imperiale, vista la situazione, creò dei gruppi di combattimento e concesse ai comandanti la facoltà di impiegare uomini e mezzi secondo le loro esigenze , fermo restando l 'ordine di non retroc edere. Questa facoltà, negata ai comandanti italiani dall'eccessiva rigidità della struttura del1'esercito, fu indubbiamente una carta vincente. Significava, infatti, snellire la burocratica ricerca del consenso superiore, responsabilizzare gli uomini ed impiegare le forze sul momento, evi tando tempi morti, che in gue1Ta possono significare sconfitte certe. Ovviamen te questa tattica com portò di converso un'accesa critica all'opera di comando di Cadorna, critica assolutamente infondata, in quanto il Capo di Stato Maggiore si trovava a dover gestire un'organizzazione carente sotto più punti cli vista, con uomini al fronte e politici a casa non preparati alla guerra e non pronti ad una simile avventura.
Oltre al fronte carsico , il Regio Esercito doveva operare pure sul fron te alpino, che sarebbe giu stamente stato ricordato come uno dei più difficili fronti naturali, prima che militari, dell'intero con flitto mondiale. La zona d'operazioni andava dal versante meridionale del grande spartiacque costituito dalle Alpi R et ich e e dagli Alti Tauri , che degradano con una serie di allineamenti montani, fino ai luo ghi propri dei combattimenti: le Alpi Trentine, la muraglia delle Dolomiti, le Alpi e Prealpi Carniche e le Alpi e Prealpi Giulie a scendere verso la pianura veneta e friulana. Per l'aspetto militare era ev idente che la zona montana non si prestava a operazioni di grandi masse. P er questo, duran-
 Gruppo di sottufficiali di Piemonte Reale; a destra , co l mantello. il co lonn ello Luisito e , identificato dalla croce, Francesco Baracca. (Archivio Dal Molin )
Gruppo di sottufficiali di Piemonte Reale; a destra , co l mantello. il co lonn ello Luisito e , identificato dalla croce, Francesco Baracca. (Archivio Dal Molin )
-59-
 25 maggio 1915: Cavalleggeri di Roma. il colonnello Tamajo ed il capitano Fungaia vicino a uno dei primi feriti del Reggimento. (Museo Arma Cavalleria Pinerolo, da ora MCP).
25 maggio 1915: Cavalleggeri di Roma. il colonnello Tamajo ed il capitano Fungaia vicino a uno dei primi feriti del Reggimento. (Museo Arma Cavalleria Pinerolo, da ora MCP).
-60-
te gli anni precedenti la Grande Guerra, sia l'Italia che l'Austria-Ungheria avevano eretto imponenti opere di fortificazione permanente, lasciando però gli Austro-Ungarici sempre in posizione dominante.L'Austria, infatti, con la pace del 1866, si era riservata gli sbocchi e le posizioni più importanti del confi ne: testate di valli, origini di comunicazioni e regioni di ' raccolta, oltre ad insinuarsi pericolosamente all 'intemo delle regioni più industrializzate del Regno con il cosiddetto "cu neo " del Trentino, una vera zampa leonina in attesa di penetrare nelle vie di comunicazione verso il Veneto.
In quel settore la difesa era affidata ad un cinquantina di forti permanenti, garanzia d'arresto di possibili invasioni. Più ad est, verso il Cadore e la Carnia, questo sistema di difesa si legava ad altre opere fisse.
La conformazione orografica del terreno e la disposizione del confine facevano sì che l'Esercito italiano si trovasse nelle disagiate condizioni di dover attaccare sempre dal basso verso l'alto, trovando il soldato imperiale in ogni caso in posizione dominante, perché padrone delle testate delle valli. A questo proposito è bene ricordare le parole del Capo di Stato Maggiore austro-ungarico, Franz Conrad von Hoetzendorff, che si riferiscono al Tirolo, ma possono essere ben estese a tutta la fronte: "in nessuna altra fronte si può trovare una base di partenza che permetta, in caso di successo, di mettere il nemico in una situazione così pericolosa come quella in cui si verrebbe a trovare l' esercito italiano di fronte ad una offensiva sferrata dal Tirolo ."50 A sinistra e a destra una catena di montagne inaccessibili proteggeva i fianchi delle armate imperiali.
 Il confine italo-austriaco prima della guerra.
50 Franz CONRAD VON H OETZENDORFF relazione tenuta dal capo di stato maggiore ai comandanti d'armata, in Oe sterr. Staatsarchiv.
Il confine italo-austriaco prima della guerra.
50 Franz CONRAD VON H OETZENDORFF relazione tenuta dal capo di stato maggiore ai comandanti d'armata, in Oe sterr. Staatsarchiv.
-61-
 Ufficiali di Cavalleria presso postazioni di artiglieria nei pressi delle Fornaci (Pieris) nelragosto 1915.
Ufficiali di Cavalleria presso postazioni di artiglieria nei pressi delle Fornaci (Pieris) nelragosto 1915.
62
OPERAZIONI: L'ATTACCO ALL'ISONZO
Mentre fervevano i preparativi di guerra, nella pr.imavera del 1915 fu costituita una nuova divisione, la 4a che prese il nome cli "Piemonte". L 'Arma comprendeva adesso quattro divisioni con una forza di 16 reggimenti. Vi erano poi altri 14 reggimenti non indivisionati, che costitujvano unità di supporto per i corpi d'armata. Alla fine del 1914, erano stati costituiti 10 gruppi autonomi, con una forza di 23 squadroni, detti dì "Nuova Formazione".
Delle quattro di visioni costituenti la massa di manovra e schierate al confine coll'Impero, la 1a ~ e la 2a furono poste alle dipendenze della 3a Armata, mentre la 3a e la 4a rimasero a disposizione del Comando Supremo , nella zona di San Vito al Tagliamento Spilimbergo.

Alla vigilia delle ostilità, essendo la 4 a Divisione di Cavalleria ancora lontana dalla zona di guerra ed essendo la 3a destinata a rimanere di riserva, si trovavano in posizione avanzata la 1a e la 2a Divisione, quest'ultima priva del reggimento Lancieri Aosta.51 La 1a Divisione fu rinforzata dal 94° Reggimento Fanteria, da un battaglione del 2° Reggimento Fanteria , dai battaglioni ciclisti dell' 11 ° e 8° Reggimento Bersaglieri e da un gruppo del 3° Reggimento Artiglieria da campagna. La divisione così composta occupava il 23 maggio la zona immediatamente vicino a Palmanova. La 2a D ivisio ne fu rinforzata da truppe di altre Armi e venne designata con il nome di Distaccamento Vercellana; alla sera della vigilia d'operazioni era dislocata intorno a San Giorgio cli Nogaro ed era costituita dalla III Brigata di Cavalleria, da due batterie a cavallo campali, da un gruppo di due bat terie di obici pesanti campali, un gruppo di tre batterie someggiate, dal 10° Reggimento Fanteria e da una compagnia zappatori del Genio della 21 a Di visione.
Tale distaccamento formava l 'ala destra della 3a Armata e aveva avuto il compito di provvedere, prima della mobilitazione generale, a.Ila sorveglianza della frontiera con l'Impero da Castions di Mure ali' Adriatico. Nel caso gli Austriaci avessero anticipato l 'a ttacco italiano con un 'i ncursione
s, AUSSME B 4 09651 Ordine di battaglia delle divisioni di cavalleria all'inizio della guerra: 24 maggio 1915: I • divisione cJj cava ll eria (Friuli) comandante Mag g. General e Nicola Pìrozzi , composta dalla I brigata comandante Magg. Generale Michele Lisi Natoli: Reggime nto Monferrato (13°) comandante colonnello Nicola Vercellana; Reggimento Roma (20°) comandante colonnello Corrado Tamajo. Il brigata comandante Maggior Generale Giuseppe Del Re , Regg imento Genova (4°) comandante colonnell o co nte Giorgio Erno Capodilista; Reggimento Novara (5°) colonnello Alessandro Robolini ; 8° e 11 ° Reggimento Bersaglieri ciclisti; 2 ° Gruppo batterie a cavallo.
2 • divisione cavalleria (Ven eto) comandante Magg. Generale Gi ov anni Vercellana; lil brigata comandante Magg. Generale Giovanni Pellegrini; Reggimento Milano (7°) comandante colon nello Carl o Formag gini; Reggimento Vittorio Emanuele Il ( 10°) comandante colonn ello Carlo Salmoiraghi; IV brigata comandante Maggior Generale Gustavo Rubin de Cervin: Reggimento Aosta (6°) comandante colonnello Alberto Rejnaud ; Reggimento Mantova (2 5°) colonn ello Faustino Curti: 3° e 7° Regg imento Bersaglieri ciclisti; 1° Gruppo batterie a cavallo. 3n divisione di cavalleria (Lombardia) comandante Magg. Generale Carlo Gui cciardi conte di Cervarolo; V brigata comandante Magg. Generale I talo Rossi; R eggimento Sa/uzzo (1 2 °) comandante colonnello Guglielmo Calderai cJj Palazzolo; Reggimento Vicenza (24°) comandante colon nello Camillo Campeis; VI brigata comandante Maggi or AmiJcare Generale Giacometti ; Reggimento Savoia (3°) comandante co lonn ello Pi etro Filippini; Re ggimento Montebello (8°) colonnello Luigi De Silvestris; 3° Grupp o batterie a cavallo. 48 divisione di cavalleria (Piemonte) comandante Ten. Generale conte Alessandro Malingri Di Bagnolo; VII brigata comandante Magg. Gen Mario Schiffi; Reggimento Nizza (l 0 ) co mandante ten. co lonnello Alberto Solaro Del Borgo; Reggimento Vercelli (26°) comandante colo nn e ll o Arturo Casanova Ie rs erin gh; VIIl brigata comandante Maggior Generale Vittorio De Raymondi dei conti D e Ra ymondi; Regg im e nto Guide ( 19°) comandante colonnello Pietro L anfranco; Re ggimento Treviso (28°) co lonnello Alessandro Rattazzi; 4° Gruppo batterie a cavallo.
CAPITOLO VII LE
-63-
verso la pianura , le divisioni di cavalleria avrebbero dovuto interrompere la strada per Torre di Zuino e provvedere alla protezione della te ta di ponte di Latisana in attesa della fanteria.
Il 23 la Divisione ricevette il compito di occupare parte della linea difen siva, preparata ad oriente del Tagliamento , da Campoformido a Marano , fin tanto che fossero giunti e dislocati i Corpi d·Armata VI, VII e XI destinati a difenderla.52
La I a Divi s ione aveva avuto il compito di sorvegl iare la frontiera fra il fiume Torre cd il mare, io collegamento con il Distaccame nto Vercellana , che e ra stato sistemato tra il Torre e Castions di Mure. Verso la era dello stesso giorno veniva stab ilito il concetto offensivo dell'avanzata, che doveva essere svolta dalla 18 Di v isio ne di Cavalleria e dal Di staccamen to Vercellana: la corsa ai ponti sull'Isonzo.
Operativamente la 1a Divisione era alle dipendenze del VI Corpo d'Armata, che si trova va inquadrato fra l'ala destra della 2a Armata e la s inistra della 3 8 • Obi e tti vo delle truppe della 2a Armata: la linea Verholje SanMartino di Quisca Dobra Medana. In questo schieramento il VI Corpo d'Armata doveva occupare Monte Quarin , Cormons, Monte Medea ed affermarsi saldamente s ulla linea costituita dai torrenti che confluiscono nel Torre: il Versa e lo Judrio. Si trattava di assicurare lo sbocco verso i primi contrafforti del ciglione carsico al1e trupp e che avanzavano s ulle direttrici Talmassons Gonars-Strassoldo e Latisana-Cervignano.
Dopo una notte d'attesa, alle 4.30 del 24 maggio fu diramato l 'ordine esecutivo: "le pattuglie dovevano varcare contemporaneamente tutta la fronte della linea del confine, per dare all'operazione carattere di energica ed improvvisa irruzione." 53 Alla la Divisione spettava il compito di dare inizio a11a guerra e di "occupare la linea dell'Judrio da Versa alla confluenza del Torre ; sorvegliare la Linea del basso Torre dalla confluenza dell'Judrio a quella dell'Isonza ed occupare i ponti di Pieris o perlomeno impedirne la distruzione">'<.
Il comando della 3a Armata impartiva invece al Distaccamento Vercellana l'ordine di passare, all'ora designata , il confine seguendo la direttrice San Giorgio di Nogaro-Cervignano-Ponte di Pieris ed indicava che l 'o perazione doveva "aver carattere d'improvvisa irruzione". Esso doveva mantenersi in collegamento con la 1a Divisione, la cui avanzata verso gli stessi ponti di Pieris, per i_l fascio stradale proveniente da Trivignano e Palmanova , avrebbe, in caso d'opposizion e, facilitato lo s bocco del Di staccamento dalla s tretta di Cervignano. La mancanza di notizie sulla forza nemica effettivamente prese nte, l'assenza di un'esplorazione occulta che sve lasse , almeno in linea di massima , le mosse e soprattutto i sistemi difensivi degli avversar i avevano immediatamente dato all'avanzata un carattere d'incertezza. Per parare eventuali colpi imprevisti e tenere sotto mano una riserva celere, fu prescritto al Di taccamento stesso di formare uno 'scagl ione alquanto arretrato rispetto alla 1° divisione di cavalleria."
In questa confusione di indirizzi nei primi obiettivi appaiono da una parte la palese inesperienza di comando di truppe e di azione in un conflitto reale.55 dal1'altra tutta l'ec cessiva preoccupazione dei comandi di Corpo, di Divisio ne e di Brigata d'incorrere in s ituazioni spiacevoli e di deludere Cadoma, anche se lo sc opo precipuo dell 'o perazione nel suo complesso consisteva nell'oc cu-
2 AUSSME Ordine di opera~ione del Comando Terza Armata: Portogruaro 23 maggio 1915 Diario s torico della I brigata di cava ll eria l divisione, 142S LE.

53 AUSSME- VI Corpo d ' Armata ordine d'opera;;ioni 11 °1- Pozzuolo del Friuli 23 maggio 1915 ore 20. s, AUSSME Ordine di Operazioni 11° 1, Comando del VT Corpo d' Am1ata.
;; Considerando le cro nache gio rnaliere della campagna libica e le onorificenze assegnate, il recente contlino coloniale, a mi o avviso, aveva seg nato in modo certamente positivo l'esperienza di guerra dell'esercito regio nell' azione concreta. ma se ne erano giovati soprattuno i quadri inferiori e intermedi. Furono poi essi. in effeni, coloro che. a s rreno contatto con la truppa, risol sero le situazioni critiche durante gli anni successivi. I comandanti di Corpo e di divisione non avevano fatto alcuna reale espe rien za e per questo era riluttanti nell'azione e parsimoniosi nell'impiego delle forze.
-64
 Attendamenti cli Piemonte Reale nella pianura friulana nella tarda prima vera del I915.
Costruzione di un riparo per cavalli. (Archivio Dal Molin)
Attendamenti cli Piemonte Reale nella pianura friulana nella tarda prima vera del I915.
Costruzione di un riparo per cavalli. (Archivio Dal Molin)
-65-
pare i ponti di Pieris, per formare possibilmente una te s ta di ponte che garanti sse il passaggio alle truppe retrostanti della Y Annata, o quanto meno nell ' impedire al nemico Ja distruzione dei ponti stessi. L ' ordine , infatti , pro seguiva indicando che se non si fos se potuto raggiungere l ' obiettivo , il Dist accamento Vercellana doveva rafforzarsi al calar del sole, fuori dal tiro dell ' artiglieria austriaca posta s ulla sinistra dell ' Is onzo , quindi lontana dalla riva del fiume. Eventualmente esso avrebbe dovuto garantire lo sbocco alla stretta di Cervignano alle truppe della 3a Armata, distante una decina di chilometri dall ' Isonzo. In realtà , dato che la l8 Di visione di Cavalleria aveva l ' ordine di operare sul ponte di Pieris e che al Di staccamento Vercellana era stato prescritto di mantenersi collegato con la 1a Divisione , anzi "di formare scaglione alquanto arretrato", il reale compito del Distaccamento non poteva risolversi se non nel sostenere un atto che ven isse iniziato dalla 1a Divi sione. In alterna tiva avrebbe potuto sos tituirsi ad essa nel caso che ordini a tale sco po fossero stati poi emanati in seguito ad ostacoli che la 1a Di visione stessa avesse incontrato. A conferma di quanto diceva 1'ordine di operazioni, in seguito ad un colloquio avuto dal tenente generale Vercellana con il capitano Grassi, il comandante interinale della 3a Armata generale Garioni scriveva in data 23 maggio da Portogruaro nel foglio n. 33: "co,ifermo che VS. non si deve spingere oltre Cervignano , se prima non venga assicurato il concorso della prima divisione di cavalleria , utile peraltro assicurare lo sbocco offensivo da questa località nei modi che VS. riterrà più opportuni."
Spesso , negli anni del dopoguerra, la Cavalleria fu accusata di non aver osato lanciarsi verso i primi contrafforti ed anzi l'incertezza s tessa data alle sue ricognizioni sembrava fosse stata la causa della lentezza del primo sbalzo offensivo. In realtà furono gli ordini emanati dall'alto che la fecero procedere a singhiozzo, d'altronde in piena assonanza con quanto si era verificato nel suo impiego sug li altri fronti europei. Poiché dunque il compito assegnato al Distaccamento era in certo modo sussidiario all'azione da svolgersi da parte della P Di visione, conviene concentrare l'esame appunto sull ' operato della Divisione stessa

Per porre in atto il concetto contenuto nell ' ordine di operazioni del VI Corpo d'Armata, il Comando della l a stabiliva di voler "procedere successivamente a sbalzi ad occupare in primo luogo lafronte Visco Joanniz, successivamente lafronte San Vìto del Torre-Ajello , e lafronte Versa (escluso)-fino alla confluenza dell'Judrio nel Torre. " Successivi compiti sarebbero stati assegnati con ordini s usseguenti; tra questi "compiti successivi", era inclusa l ' azione verso i ponti di Pieris
Così ] 'impulso e l ' irruenza che nell 'animo del Comando Supremo , e soprattutto di Cadorna , parevano doversi imprimere al primo sbalzo , venivano fortemente moderati dagli ordini dei coman di dipendenti. Ed il Comando della 1a Div is ione di Cavalleria del generale Pirozzi aveva omesso, forse per non averli ricevuti in forma chiara, di emanare immediatamente ordini per l ' occupazione dei ponti ed aveva (forse per mancanza di libertà di iniziativa) trascurato persino di lanciarsi subito con pattuglie di ricognizione su Pieris, che in quel momento era sg uarnita. Il concetto di Cadoma (il quale, non va mai dimenticato, oltre ad essere impegnato nella gestione totale e politica della macchina militare, era altresì teso alla riorganizzazione interna della catena di comando) era stato quello di uno sbalzo unico , violento , senza esitazioni e tentennamenti offensivi. Ma il Comando deJla l a Divis ione di Cavalleria lo spezzò in tre sbalzi minori, che misuravano ciascuno circa 2 chilometri in linea retta , e ritenne compito successivo e subordinato lo sbalzo uJtimo dalla linea Versa (escluso)-nord di Topogliano in direzione Isonzo; vi erano appena 7 c hilometri in linea d'aria dal punto d ' immissione dello Judrio e del Torre ai ponti di Pieris . Lo stesso ordine d'operazioni stabi liva che Ja colonna di destra o meridionale delle due s u cui le truppe assegnate alla Di visione dovevano procedere, fosse costituita dal 94° Reggimento Fanteria e dal Genova Cavalleria oltre ad un'aliquota di artiglieria. La colonna di sinistra , che doveva compiere una conversione verso sud, era invece costituita dalla I Brigata di Cavalleria, due battaglioni bersaglieri ciclisti ed una batteria a cavallo: una forza d'urto considerevole . Senonché la ne cessi tà di operare in direzione s ud-est
-66
 Accampamento di cavalleria (Friuli 1915).
Gruppo di cavalleria in posa per foto ricordo: 1915.
Accampamento di cavalleria (Friuli 1915).
Gruppo di cavalleria in posa per foto ricordo: 1915.
-67-
apparve subito tanto cbiara (non vi erano difese di nessun tipo), che l'Ordine di operazioni l bis dello stesso giorno 23 modificava il primo, spostando la direzione dell'azione e stabilendo le tre successive linee di occupazione:
a) Yisco-Joanniz;
b) Crauglio-Ajello;
c) Campolongo-Perteole.
TI collegamento co n la 123 Di visione che avanzava a tergo era provveduto dalla colonna di sini stra cbe, occupato Crauglio, doveva provvedere alla sorveglianza lungo il Torre, se si fosse proceduto tanto oltre.
La colonna di destra invece doveva tenere la Divisione co llegata, verso Strassoldo prima, poi verso Muscoli, con la III Brigata di Cavalleria (Di staccamento Vercellana), che procedeva frontalmente da Castions di Mure per Strassoldo. Tali dispositivi se mbrano senza dubbio ispirati , piuttosto che all'irruente sbalzo dell'ordine cli massima, ad un concetto di prudenza. Ma a ben leggere gli ordini di operazioni, le origini deUa prudenza si evincono dall'Ordine di operazioni n. 1 della 1a Di visione di Cavalleria, che, come si può intuire, non aveva idea di cosa le stesse succedendo davanti. L'ordine infatti recita:
"dalle notizie fino ad ora pervenute, e già comunicate, risulta che in complesso nel territorio oltre confine vi sono lavori di trincea, di sbarramento e di mina che aumentano di giorno in giorno, si prescrive perciò che i reparti avanzanti per primi debbono fare il minor uso possibile delle rotabile, procedendo anche guardinghi per il terreno adiacente alle strade e preceduti da individui che, muniti di strumenti, rimuovono nella maggiore misura possibile gli impedimenti alla marcia e siano in grado di avvertire a tempo i reparti retrostanti." 56
Mancava un servizio informativo capace di dare notizie certe. La cavalJeria da sola, come ampiamente avevano già dimostrato i fatti sui fronti occidentale ed orientale, non pote va compiere nessuna puntata d'esplorazione in una guerra che dalle prime battaglie si intuiva essere diversa dalle precedenti. Sempre lo stesso giorno la convinzione di dover vincere una serie di ostacoli traspariva dall'ordine di operazioni n° 2: "l'avanzata, come ho detto, dovrà procedere prudente, lenta, metodica ma sicura Oltre ai drappelli zappatori si dovrà fare in modo che le colonne siano guidate da persone fidate che conoscono il terreno e meglio ancora se saranno in grado di segnalare tutte le difese attive che l'avversario ha posto dappertutto." 51
Il 24 maggio alle ore 4.30 le truppe della l3 Divi sione varcarono il confine e raggiunsero l'obiet tivo del primo s balzo alle 6.45 (alle 8 la l Brigata), senza incontrare resistenza; Ajello era raggiunta dalla II Brigata alle 8.50, ma la I Brigata non giunse a Crauglio che tra le 15.30 e le 16 , perché l ' ordine di avanzare, a causa di un ritardo, non le pervenne che alle 10.50. Dopo un ordine di pernottamento, ricevé un contrordine e verso le 18 ripartì per ]o sbalzo successivo, che portò alla fronte Campolongo Perteole, ed alle ore 20 la Divisione sostava ne11a zona Ruda, Santa Andrea, Campolongo, Cavenzano, Ajello con l'intenzione di riprendere l 'avanzata il giorno seg uente.
Per impedire la distruzione dei ponti ad un nemico che cercava di supplire all'insufficienza delle forze con l'oculatezza e l'abilità, si sarebbe richiesta un'azione di sorpresa . Invece la sorpresa mancò , tanto che alle 9.35 dal campanile di Visco il generale Lisi-Natoli scorse il fuoco e le fiamme avvolgere uno dei ponti di Versa (probabilmente que1lo su l Torre). La notizia venne confermata dal tenente D el Pozzo di Genova Cavalleria, che si era spinto, senza ordini, fino al trivio
56 A USSME Pratica Commissione d'Inchiesta: Relazione sul!' impiego dell'Arma di Cavalleria, 17 giugno I919.
57 AUSSME- Comando dj Cavalleria Meretto di Capitolo. 23 maggio 1915; Diario storico della 1° divisione. 142S JE.

-68
Campolongo-Ruda-Villesse, e riferita al comando della Brigata ad Ajello alle 10.45. Il Tenente spe cificava che i ponti di Villesse (presso il trivio) e di Versa erano stati incendiati e che il trivio stesso era ostruito da una semplice barricata. Più rapida, anche se di poco, aveva proceduto l'avanzata del Distaccamento Vercellana. Da San Giorgio di Nogaro la colonna di destra, formata da fanteria e artiglieria someggiata, si era spinta su Cervignano; quella di sinistra, formata da cavalleria e artiglieria a cavallo, si era mossa per Strassoldo e di là verso sud est su Cervignano. Varcata alle ore 5 la fron tiera, Strassoldo era stata occupata alle ore 5.30. Superata una barricata sulla strada StrassoldoCervignano e vinto un debole tentativo di resistenza di alcuni gendarmi austriaci vicino a Cervignano, si occupava la borgata alle ore 8.30; qui veniva rimossa una barricata sul ponte dell' Ausa in Cervignano. D a lì furono mandate pattuglie di copertura sulla linea Strassoldo-Perteole. La colonna di destra, oltre a rafforzarsi in Cervignano, occupava con un battaglione ciclisti Terzo di Aqu iJei a e, dopo lieve resistenza, anche Scodovacca alle 9.15 e San Martino. Sono paesi che distano in media 1 o 2 chilometri l 'uno dall'altro.
Esplorazioni furono inviate anche verso Aquileia e Pieris. Una pattuglia di bersaglieri ciclisti del 3° Reggimento, il cui rapporto fu consegnato al generale Marghieri, specificava che, verso le 18, si era avv icinata ai ponti di Pi eris ancora intatti e che appena giunt i si "udì. una detonazione inseguita da una immensa.fiammata." I nostJ.i non si erano avvicinati oltre, non avendo ricevuto ordini in proposito, ma si era no informati da abitanti de1la zona sulla situazione ed avevano così scoperto che era quasi certo che i ponti fossero stat i fatti saltare. L'ufficiale che comandava la pattuglia non aveva potuto sincerarsi della notizia, in quanto le sponde dell'Isonzo in quel momento erano state occupate da una compa gnia austro ungarica di circa 200 uomini. Sebbene arrestata dalla distruzione dei ponti, la velocità di marcia del Distaccamento Vercellana fu maggiore rispetto alla la Di visione e, purtroppo, fu resa più lenta dall'ordine ripetutamente ricevuto di mantenersi come scaglione arretrato.
 Squadra dj cavalleggeri in un casolare della pianura friulana nell'autunno del 19 lS.
Squadra dj cavalleggeri in un casolare della pianura friulana nell'autunno del 19 lS.
-69-
La trasformazione della "improvvisa irruzione" in " lento e dubbioso progresso" va comunque ricercata anche nei provvedimenti presi dal comando austro-ungarico. Alcune ore prima dello scoppio delle ostilità, il nemico aveva provveduto ad interrompere le comunicazioni stradali. I ponti di Versa e di Ruda erano stati distrutti prima delle 10 ed in ogni caso prima che all'orizzonte comparissero le pattuglie di ricognizione. La sponda sinistra dell'Isonzo era stata contemporaneamente occupata da truppe da combattimento, c he avevano ricevuto l'ordine di proteggere i ponti o distruggerli all'avvicinarsi delle forze italiane. Sulla distruzione dei ponti di Pieris diede notizie alquanto diverse il comandante del posto di scoperta di Vi11esse, tenente Guz zard i. Scriveva infatti in data 27 maggio un avviso, giunto a Campolongo alle ore 20: "da informazioni assunte da persone attendibili, risulta che i ponti di Pieris furono fatti saltare dalle 5.30 alle 6 del giorno 24 maggio". Cosa v id e allora il comandante della pattuglia bersaglieri ciclisti nel pomeriggio di quel giorno resta un'incognita.
Fallita la sorpresa che si era preparata per il giorno 24, alla l a Divis ione fu assegnato il compito di proteggere un fianco del VI Corpo d'Armata, stabilitosi sulla fronte Russiz-Versa , e di spinge re le esplorazioni se poss ibile oltre l'Isonzo sulla fronte Gradisca-Sagrado. Le pattuglie informarono immediatamente che la riva destra era sgombra, la riva sinistra debolmente occupata, ma che si scorgevano intensi preparativi di appostame nt i difensivi su lle pendici carsiche. Il ponte di Sagrado era inoltre parzialmente distrutto. Le medesime fo nti informative che avevano riferito al tenente Guzzardi la distruzione del ponte di Pieris, gli dissero lo s tes so giorno 27 che il ponte di Sagrado era stato distrutto dopo le ore 24 della notte sul 25 maggio li giorno 26 intanto proseguì metodicamen te l 'esplorazione , che confermò l'arretramento sulla sinistra del fiume delle truppe avversarie e l'assenza delle stesse sulla destra dell ' Isonzo , da Lucinico a]Ja confluenza del Torre. Anche Ja passerella di Cassegliano, individ uata dal tenente Cotterelli di Genova Cavalleria il 26 maggio , alle ore 11.55 era stata fatta saltare ed il fiume, che in quel punto forma un ansa guadabile, a causa della forte cor rente e della piena risultava insuperabile. Gli Imperiali , sorpresi dalla lentezza dell'avanzata, stava no approfittando del tempo concesso loro , fortificando le alture del Podgora, di Monte Fortin e del Carso e si valevano, a quanto sembrava, della passerella di Bruma , ad est di Gradisca, per dare l 'impressione che Gradisca stessa e Parra potessero essere ancora occupate. 58
Durante quel giorno venne sparato qualche co lp o di cannone. Era la prima volta che il cannone tuonava sul basso I sonzo ed il suo primo obiettivo fu una pattuglia di Genova Cavalleria.
Il tenente Cotterelli, già nominato , riferiva sempre da Cassegliano e più tardi dalla linea Redipugli a-Sagrado, che l'Isonzo era inguadabi le a causa alla forte corrente là e , per la stessa ragione ed anche per la profondità , negli altri punti del settore. Le sue osservazioni furono confermate anche da informatori. Una pattuglia di esp lorazione, che fu responsabile di errate valutazioni, scorse sulla riva sinistra del fiume soldati nemici in pattugUa ed intenti ai lavori di difesa accessoria davan ti a tre ordini di trincee. Dal posto di scoperta di ViJlesse , invece , alle 18 si scorsero ardere i sei ponti sul canale di Monfalcone, tra San Pietro e Sdraussina (avviso ricevuto il giorno 27).
Gli ostacoli incontrati nell'avanzata dalle truppe della 2 3 Armata consigliarono di far sostare il VI Corpo d ' Armata sulla fronte Russiz-Versa , sorvegliando a mezzo della la Divisione di Cavalleria il ponte di Sagrado ed esplorando la riva destra del fiume. Il VII Corpo d'Armata venne schierato da San Leonardo a Papariano ed il Distaccamento VercelJa na ricevette l 'o rdine di ma ntenere Cervignano, prolungare verso sud l'ala destra del VII Corpo d 'Armata e perlustrare la pianura verso Aquileia, Grado ed Isola Morosini, dove il nemico aveva un punto di passaggio tra le due sponde.5 9
58 Sull ' argomento rimando a: CER NIGOI- CUCJNATO VOLPI, Sui sentieri della prima guerra mondiale , alla ricerca della storia, Mariano del Friuli, edizioni del la Laguna, 1999.
59 AUSSME 3" Annata: Ordine di operazioni n° 3 Mortegliano 26 maggio 1915.

-70
 Luglio 1915: un ufficiale di cavalleria osserva il quadrante dell'orologio di un campanile precipitato a terra.
Ca vall eria appiedata a Castelnuovo (Carso di Doberdò ) nel 1915.
Luglio 1915: un ufficiale di cavalleria osserva il quadrante dell'orologio di un campanile precipitato a terra.
Ca vall eria appiedata a Castelnuovo (Carso di Doberdò ) nel 1915.
-71-
Il 27 maggio, tre giorni dopo l'inizio delle ostilità, le pattuglie ebbero qualche scontro con analoghe forze avversarie presso Lucinico ed alla confluenza del Torre nell'Isonzo. Fu anche, ma inutilmente, tentato il guado. Dal posto di scoperta di Villesse si videro invece due pattuglie austro-ungariche sulla destra del fiume, apprestamenti difensivi presso Biasiol. armi appostate e carreggio sulla sinistra dell'Isonzo.{,() A questo punto era necessario passare l 'Isonzo! La 281 3 Compagnia dell'XJ Battaglione Bersaglieri Ciclisti raggiunse Gradisca e vi rimase l'intero giorno, sebbene sottoposta al tiro di fucileria nemka. La sera però si ritirò, lasciando il paese terra di nessuno. Nella giornata si segnalarono qualche scontro di pattuglia sull' I sonzo, colpi di fucileria e nuJla di più. Le pattuglie informarono invece sui continui lavori difensivi su lla fronte Fogliano-Sagrado, dove, sottolinearono, "il nemico è trincerato alla perfezione"61 e che anche in quel settore l'Isonzo era assolutamente inguadabile.
li 29 cominciarono ad entrare in attività le artiglier ie posizionate a San Martino del Carso e sulle alture presso Podgora. Maggio è un mese particolarmente piovoso in Friuli e quell'anno non fece eccezione. Le continue piogge resero anche il Torre inguadabile.
li 30, ritenendo gli Austro-Ungarici, e specialmente il generale d'artiglieria Wunn ed il Feldmarschalleutnant Aurei von Le Beau. troppo titubanti le mosse degli Italiani, intensificarono le attività di contrasto e fecero rioccupare, rafforzandovisi, Biasio1 e Monte Fortin, che era stato in un primo momento ritenuto indifendibile e sgomberato dagli Austro-Ungarici.
La resistenza delle truppe Austriache si estese il 31 anche a Lucinico e a Villanova, Gradisca rimase sgombra. Ad impensierirsi della lenta avanzata fu anche Cadoma, che iniziò a diramare ordini di accelerare le operazioni.
lJ 2 giugno squadroni esploranti di Genova Cavalleria e dei Cavalleggeri di Roma constatarono che sia San Lorenzo che Mossa erano occupati da poche truppe, mentre si stava facendo più sa lda l'occupazione di Monte Fortin e Gradisca permaneva sgombra da truppe.
Il 3 giugno la Divisione passò alla diretta dipendenza della 3a Armata e, dal giorno 5 al 7, ebbe l'incarico di stabilire i collegamenti con i comandi dei Corpi d'Annata VI, XI e VIII e con l ' IP e 13° Divi sione, oltre ad istituire posti di scoperta. Il giorno 8 si spostò. In conseguenza, la I Brigata fu dislocata allo sbocco ovest di Villesse, per tenere il collegamento fra l'XI e il VTI Corpo, mentre la II Brigata si portò per Crauglio, Versa e Mariano a 500 metri a sud ovest di San Loren zo di Mossa, stabilendo il collegamento fra il VI e l'XI Corpo d'Armata. La Brigata dovette più vol te spostarsi perché fatta segno ad intenso fuoco di artiglierie. Facilmente individuabile, il giorno 9 fu nuovamente sottoposta al tiro, tanto che si spinse a quota 43 a sud di Moraro e da lì si spostò per Mariano a Chiopris. Nei giorni successivi. non ebbe alcuna occasione di impiego. salvo che nella sorveglianza delle linee ferroviarie e telegrafiche dietro delle truppe operanti ed a nord della ferrovia di Cervignano. Rimase impegnata nella sorveglian za fino al 23 luglio, quando, con le prim e battaglie e con l'arrivo di prigionieri, fu incaricata di raccoglierli e sorvegliarli nei campi di concentramento istituiti ad Ajello ed a Bagnaria Arsa.
A questo punto il generale Piroz zi venne esonerato e sostituito col generale Giovanni Pellegri ni. Probabilmente ciò avvenne per dare un esempio forte e chiaro di indirizzo politico. La vittima era infatti un generale di cavalleria non determinante neJl'immediato, ma certame nte il Comando Supremo, e Cadorna soprattutto, per motivi di ordine più generale che non l'azione di comando di Pirozzi nelle prime fasi della campagna, si resero perfettamente conto dell'impo ssibilità per la cavalleria di operare in quel settore e ne decisero il riutilizzo. Chiunque conosce il Carso non può che convenire con tale decisione. La cavalleria, analogamente a lle sue sorelle europee, aveva mostrato il limite del suo impiego in una guerra di posizione.
«> AUSSME. Relazione del tenente Guzzardi alla sera del 27 maggio. 61 AUSSME, Relazione del1a pattuglia del tenente del Pozzo di Ge1101 •a Cavalleria, 28 maggio alle ore 16.

-72-
 Teatro delle operazioni della 3' Armata, maggio 1915.
Teatro delle operazioni della 3' Armata, maggio 1915.
73-
Fu quindi ordinato alle Brigate dipendenti di provvedere a ll a sicurezza delle truppe, tra il 9 ed il l 2 agosto, e fino a l 15 novembre alla difesa mobile costiera tra porto Cortellazzo e la foce dell ' Ausa Corno.
La III Brigata di Cavalleria della 2a Divisione , col Re ggimento Lancieri di Mantova 62 riuscì inv ece a passare l ' l sonzo . M erita a questo punto ricordare lo s pirito con cui si muoveva l'Arma in quel momento.
Il 24 maggio il comandante il reggimento, colonne llo Faustino Curti, emanava il seguente ordine del giorno:
"Lancieri di Mantova!
Per ordine di S. M. il Re, l' Italia da oggi è in stato di guerra contro l'Austria-Ungheria. Orgoglioso di darvene l ' annuncio , e più ancora di trovarmi vostro capo in questo storico momento , non dubito che saprete compiere fermamente tutto il vostro dovere, memori delle gloriose tradizioni dell'Arma. Lancieri di Mantova! Sappiate che da oggi gli sguardi del Paese sono rivolti all'Esercito e all'Armata: ad essi è affidato l'onorifico compito di combattere questa guerra per l'unità e la grandezza d'Italia, per riunire alla Patria le terre ancora soggette allo straniero. Sappiate che le vostre madri e le vostre spose commosse vi salutano oggi partenti, e anelano il giorno in cui potranno abbracciarvi vincitori; sappiate c he il nome d' Italia e l'onore della Dinastia sono a voi affidati; sappiate che ho ferma fede che con voi, miei fieri lancieri, non conosceremo e non seguiremo altra via che quella della vittoria e del dovere virilmen te compiuto per la gloria del Re, per la grandezz a d'Ita/ia,per l 'onore del Reggimento . Viva il Re, viva l ' Italia, viva i Lancieri di Mantova!".
La fede dei Cavalieri nell'avanzata era talmente eviden te che rafforza ancora di più la convinzione che ad imprimere il carattere di lentezza al1a guerra furono i responsabili delle Grandi Unità. Narra infatti il tenente medico Zanelli:
"Con la soddisfazione di sì felice esordio, cocente era in noi l'avvilimento per vederci tuttora lontani da lassù, pungente l'invidia per chi già aveva il privilegio di occupare le prime terre redente , mentre con amarezza vedevamo crollare il sogno così a lungo covato di galoppare subito a lance basse verso la vittoria.
La sera del 23 maggio ci eravamo rasati i capelli, avevamo riposto con cura nelle cassette la divìsafiammante per l'ingresso trionfale in Trieste. Pronti con armi e bagagli , bardati ed equipaggiati, avevamo bevuto alle fortune delle nostre armi, indugiando in quartiere come in una immeritata prigione. Qualche arietta nostalgica si levava qua e là dai gruppi di lancieri che nelle ore franche miravano pensosi le groppe dei cavalli, vergognandosi quasi che uscendo, la città li vedesse ancora inattivi; canticchiavano « Le ragazze di Trieste», l ' inno di Mam eli, «Fuori i barbari!», mentre qualche tromba esalava la sua malinconia compitando a ripetizione i segnali, di buttasella , trotto, galoppo, allarme, carica.
Nei primi giorni che seguirono, tuttavia, i successivi bollettini del Comando Supremo ci distesero alquanto i nervi.
"Gli austriaci da lungo tempo hanno rinforzato con numerose artiglierie anche di medio calibro le posizioni della riva sinistra dell'Isonza dominanti i passaggi del fiume "
Qual cuno vifu tra noi che ebbe la vaga intuizione d'una guerra alquanto meno semplice del previsto. Fuori intanto la città brulicava d'uniformi grigioverdi , in gran parte richiamati della territoriale, l'aria un po' goffa, baffoni, giubbe troppo larghe, scarponi chiodati di vacchetta gialla.

6 : AUSSME, Diario storico della 2• divisione di cavalleria, 128/ 0 1613 B -74-
Quando ci fu concesso di poterci imbarcare "sul lungo treno che andava al confine" , la gioia soverchiò la mestiz ia pel distacco da persone e cose care. A San Donà di Piave giungemmo eh ' era notte, cercammo nell'oscurità i nostri alloggi di fortuna, petali di fiori che la gentilezza delle donne venete ci avevano offerto , caddero dalle nostre vesti senza rumore. Là si fece sosta il 30 maggio , ricevendo quindi l'ordine di recarci a S. Vito al Tagliamenro per via ordinaria. Durante la marcia, altro ordine del comando del Corpo di Cavalleria ci fece proseguire sino a Palazzolo sullo Stella: circa 70 km cioè furono percorsi a passo e trotto, spesso sotto pioggia torrenziale. L'indomani / 0 giugno, ordine divisionale di trasferirci a Terzo di Aquileia. Al passaggio del vecchio confine presso Torre di Zuino, il colonnello fece togliere dalla guaina lo stendardo, sfoderare le sciabole agli ufficiali, presentare le lance, e i trombettieri intonarono la fanfara reale e la marcia del Principe Eugenio."63
Dopo che l a sezione pontieri divisionale ebbe gittato presso Colussa un primo ponte di barche alle ore 9 del 5 giugno , la Di visione passò sull a riva sinistra dell'Isonzo e sp in se reparti in esplorazione sulla linea Bi strigna Casa Nuova. I ricognitori aerei avevano riferito che le alture del Carso lungo il tratto ad es t della linea Ron chi Monfalcone erano del tutto sgombre dal nemico, che si sare bb e trovato pure con forze ridotte nel territorio ad est dell'Isonzo ed a sud della ferrovia Villa Vicentina Monfalcone. La 2a Di visio ne ebbe l'ordine di controllare tali informazioru all'imbrunire. Avanzò s u San Canziano facendosi procedere dal R eggimento Mantova. Questo mandò l'ordine al Battaglione Ciclisti del 3° Reggimento Bersaglieri, che si avviava a Bistrigna ed era stato destinato in rinforzo al Mantova, di puntare su Aris per cooperare even tu almente all'occupaz ione dei ponti sul can ale di Monfalcone ed all'esplorazione delle alture di levante, queste ultime fortemente presidiate.
Il Reggimento Lancieri di Mantova al suo ingresso a Staranzano fu fatto segno a fucileria, che impegnò pure il Battaglione Bersaglieri Ciclisti che avanzava da S taranzano su Bi strigna.
Gli Austro-Ungarici stava no schierandosi a cavallo della strada Staranzano-Aris Monfalcone ed erano sos te nu t i dalle forti posizioni difensive a nord est della ferrovia R onchi-Monfalco ne.
I sottotene nti Norsa e Manetti, inviati l'uno dopo l'altro a portare al comando del 3° Bersaglieri l 'ordine di puntare su Aris a nziché su Bi strigna , al ritorno vollero fare una via più breve e caddero prigionieri.64 Furono i primi cavalieri catturati nella Grande Guerra.
Lo scontro intanto si faceva totale e diretto. Due barricate c h e erano a Stranzano e rano state rimosse e vi fu un intenso scambio di fucileria fra iJ nucleo ciclisti del Mantova ed unità nemiche. Essendosi poi sviluppato un nutrito fuoco a nord est di Staranzano, si ebbe uno scontro s ulla linea Aris-San Nicolò con gli squadroni di Mantova e l a pressio ne andò a mano a mano spostandosi in direzione di San Nicolò.
In questo inferno i cavalieri dovettero risolvere un ulteriore problema, i cava lli. Dal diario dell'allora tenente medico Zanell.i:

"All'imbocco di Staranzano, il reggimento sosta tra le prime case per consentire agli zappatori e di sgomberare la strada d'una grossa barricata in difesa. Avanza quindi il comando, il nucleo ciclisti, lo squadrone di avanguardia , in un silenzio assorto. Il sole alle nostre spalle s'inclina verso l'orizzonte quando echeggiano le prime fucilate. Il colonnello, raggiunto l'or lo orientale del paese, ordina al III squadrone d'appiedare, inastare la baionetta, procedere in ordine sparso. 1 cavalli sosteranno al riparo d'angoli morti, dentro androni bui, in cortiletti abbandonati.
63 C. F. ZANELLI , Lancieri di Mantova, Bologna , Tamari editrice, 1965.
""' Caddero prigionieri unitamente ai lancieri Berselli e Conterie. Quest'ultimo riuscì a fuggire e rientrò al reparto.
-75-
Ora sempre più fitti si sgranano i colpi, le pallottole sibilano radenti con zirli metallici in un concerto di ronzi d'api, di corde da chitarra strappate, di fili d'acqua su lastre d'acciaio rovente. Musica nuova per noi, misteriosa, che mette subito più stupore che terrore, e solo quando i colpi raffittiscono, schiantano rami, trinciano frasche, rimbalzano sui muri, solo allora allo stupore segue un certo sbigottimento, i denti si stringono, il dorso si curva un poco, la corsa in avanti si fa guardinga, piccolo il cuore batte nel petto.
Ma lo sgomento non tarda a cedere alla volontà, alla necessità e di fare ciò che bisogna, di dimostrarsi forti a faccia del nemico, alla truppa che in silenzio avanza a catena, ubbidiente alla parola e all'esempio di chi la guida.
Avanzano ora di corsa gli uomini, si buttano nei fossi, sparano, si rialzano, ciascuno guarda l'altro incuorandolo e incuorandosi. Il colonnello immobile sul suo cavallo, sprezzante del fuoco che non cede, guarda i suoi soldati con l'occhio di chi osservi una manovra. L'aiutante maggiore ne prende gli ordini, s'allontana al galoppo del suo potente grigio, ritorna, riparte senza mai stanchezza.
Intanto La fucileria si fa sempre più rabbiosa, ci batte anche su un fianco. Sia fatto avanzare lo squadrone Curioni. Le nostre punte sono già ad Aris, l'orlo del Carso appare tra i fusti sempre più netto, grigio, calvo, sinistro. L'avversario ha buon giuoco, ci fulmina dagli argini che gli sono baluardi naturali, dai mureta d'un cimitero. Mitragliatrici punteggiano la fucilata come, un coro di raganelle impazzito. Già si cominciano a distinguere le luci degli spari, che danno alle prime ombre un aspetto feroce.
 Passerella tra Gradisca e Sdraussina sulrlsonzo nel I915.
Passerella tra Gradisca e Sdraussina sulrlsonzo nel I915.
-76-
 L'avanzata della 3• Armata verso il Carso, maggio-giugno 1915.
L'avanzata della 3• Armata verso il Carso, maggio-giugno 1915.
-77
Giunge frattanto dietro di noi al ga l oppo e prende posizione al c iglio d ' una strada una s ezion e delle batterie a cavallo. Piazzati i p ezz i , gli artig li e ri s i ingino c chiano, puntando c almi e prec isi , i proietti si scatenano fulminei sulle nos tre teste con Lung o rabbioso rimbombo. I pi cc oli lan cieri intanto avan zano ancora , scompaiono dietro i rilievi , affondano tra le erbe non recise, gua zz ano nel fango , talora e ntro l ' ac qua s ino alle ginocchia, mentre la ,norte s i avventa come una fiera libera di mordere , colpendo qua e là a capriccio.
Il primo ferito ritorna z oppicando, con una gamba trapa ssata. S ' odono nel fragore i comandi degli ufficiali, i pezzi ripetono a quando a quando le loro salve, le vampe degli spari si fanno man mano più lucenti. Pare tuttavia che il fuoco poco a poco s ' afflosci , s ' allontani , g li austriaci si vadano ritirando, ormai la notte è imminente .
Ed ecco a lato del villaggio di Aris, entro una capanna di falasco la fiammella d ' una candela rischiara un gruppo di soldati abbandonati sullo strame , lancieri e bersaglieri: bianco di supplici sguardi su volti contratti, labbra coperte di schiuma , tra fiochi lamenti e rantoli di chi muore. M'affretto a lavar ferite, a tergere il sangue a stringere fasciature di fortuna, a praticare iniezioni, mentre il mio caporale e i portaferiti raccolgono intorno nei campi e nei fossi altri colpiti e i morti.
Intanto la tempesta urlante si va placando, pare poco a poco s'estingua. Solo qualche pallottola randagia frusta ancora l ' aria, si conficca nella terra. Il combattimento è ormai terminato, i cac ciatori austriaci, col favore dell'oscurità paiono scomparsi. Padroni del terreno, occorre tuttavia nella notte ancora insidiosa , mettere in salvo i feriti, portar con noi i nostri morti. Il capitano Kingsland provvede a lasciare un plotone di scorta per proteggere il nostro convoglio di barrocci e carrette rinvenuti sul posto, su cui i feriti mescolati ai morti gemono ad ogni sobbalw. A Staranzano tutti raggiungono i cavalli, che paventano e scartano ad ogni ombra entro il fumo nero della notte. Intorno, la campagna sembra esalare un fiato di caverna e di putrefazione." 65
Nella mischia, magnificamente descritta , intervennero alcune batterie austro ungariche deJJa zona di Monte Sei Busi. Le vampate di fuoco di queste ultime dimostravano senza ombra di dubbio l'occupazione da parte del nemico delle alture e delle pendici carsiche, come la sua presenza in discrete forze sulla linea de] canale di Monfalcone. Era dunque assolto il compito d'esplorazione; ed i Lancieri di Mantova vennero dal Comando della Di visione fatti dispiegare con l'appoggio del Battaglione Ciclisti del 7° Reggimento Bersaglieri.
L a J3 e la 2a Divisione di Cavalleria furono ritirate e dislocate all'estrema ala dell'esercito e si videro assegnare compiti strettamente collegati allo sviluppo generale dell ' operazione, che , in fase d'attuazione, non diedero luogo ad episodi di rilievo. Poi, via via che le caratteristiche della guerra si andavano delineando, la possibilità di un largo impiego della cavalleria apparve sempre meno pro babile. Solo ad alcuni reparti, come i Lancieri di Mantova, fu concesso di misurarsi con il nemjco, ma limitatamente alle prime fasi del combattimento; iJ mantenimento dei cava1li delle truppe che combattevano ormai a piedi cominciava ad essere un problema.

Intanto il 1° giugno Sua Altezza Reale jJ Conte di Torino, stabilitosi a San Vito al Tagliamento , aveva assunto il Comando del Corpo di Cavalleria66 • Delle divisioru però, Ja 48 , che si era andata dislocando intor no a Spilimbergo, era in riserva a disposizione del Comando Supremo: la l a, che era incaricata della sorve-
6S ZANELLI, op. cit., pagg. 27-29. Il ten e nte medico Felice Zanelli ricevette il giorno 9 novembre per il comportamento tenuto a Staranzano la medaglia di bronzo al valor militare dalle mani di S.A.R. il Conte di Torino , comandante generale la cavalleria, AUSSME 128/D 1613 B.
66 L ' Ispettorato di Cavalleria assunse il nome di Comando del Corpo di Cavall eria nel maggio d e l ' 15 e. secondo Puletti , diventò Comando General e dell"Arma di Cavalleria nel dicembre del ' 15.
78-
 Vista del Cantiere di Monfalcone dalle posizioni austriache di q. 85 nell'autunno del 1915.
Sempre da q . 85: panoramica sul Lisert.Adria e, sullo sfondo a sinistra, l'Hermada e il Gol fo di Trieste nell'autunno del 1915.
Vista del Cantiere di Monfalcone dalle posizioni austriache di q. 85 nell'autunno del 1915.
Sempre da q . 85: panoramica sul Lisert.Adria e, sullo sfondo a sinistra, l'Hermada e il Gol fo di Trieste nell'autunno del 1915.
-79-
glianza della linea ferroviaria, di quelle telegrafiche e telefoniche ed anche della strada ferrata di Cervignano dietro alle truppe operanti, si trovava nei pressi di Ajello, alle dipendenze deU 'XI Corpo d'Armata. La 2a, che ebbe il 5 giugno l'incarico della ricognizione su Monfalcone, varcò l'Isonzo il 7, lasciando alcuni reparti oltre il ponte di Colussa, poi ricevé temporaneamente ordini dal VII Corpo d'Armata, pur dipendendo dal comando del Corpo di Cavalleria. Infine la 3a era in riserva a Cordovado e concorreva, sotto l'immediato controllo del Comando del Corpo, alla protezione delle retrovie tra i fiumi Ausa , Como e Livenza.
Allo scopo di mantenere le divisioni nel massimo grado di efficienza, pronte ed allenate ad un impiego più attivo, il Comando del Corpo di Cavalleria mirò a svincolarle dalle svariate dipendenze provvisorie, nella misura consentita dalle esigenze della guerra.
Con il 23 giugno 1915 al Corpo di Cavalleria, che riebbe a disposizione la 2a e la 3a Divisione, veniva dal coma n do della 3a Armata affidato l'incarico di proteggere il fianco destro ed il tergo dell'Armata stessa, in quanto era chiaro che le operazioni avevano ormai acquistato, anche sul fronte italiano, il carattere di una guerra di posizione. Di conseguenza andavano modificati pure i com piti assegnati alla Cavalleria.
La 4a D ivisione rimase presso Spilimbergo, a disposizione del Comando Supremo; la 1a nelle vicinanze di Ajello e di B agn aria Arsa, mentre la 2 8 assunse l a difesa costiera e la protezione della linea ferroviaria tra l' I sonzo e la foce dei fiumi A usa e Como e la 3a ebbe un analogo ufficio per il settore compreso tra la strada ferrata costiera e i fiumi Ausa, Como e Livenza, più tardi estendendo la propria sorveglianza fino alla vecchia foce del Piave.67
Dopo aver attentamente studiato la nuova situazione di guerra , il Conte di Torino trasmise al Comando Supremo la proposta d'una nuova dislocazione delle quattro divisioni di cavalleria , intesa ad assicurare gli stessi servizi in quel momento affidati alle divisioni. In pari tempo, essa avrebbe dovuto garantire u n a rotazione dei compiti ed una distribuzione negli aJloggiamenti che consentissero la preparazione e l'allenamento dell'Arma, nonché la conservazione dei quadrupedi nel miglior modo.68
La nuova dislocazione proposta tendeva, ai fini dell'addestramento e della preparazione, a due scopi:
"a) assicurare ai reparti la preparazione tecnica e l'allenamento necessari per il caso si presen ti il momento opportuno per un impiego delle divisioni più rispondente alle caratteristiche spe ciali dell'arma;
b) ripartire, data l'attuale situazione speciale,fra le divisioni in modo rispondente alle esigenze della buona conservazione dei quadrupedi elemento tanto scarso quanto prezioso, i disagi inerenti, non tanto alle cooperazioni, ma alle inevitabili condizioni di alloggiamento che in alcuni tratti del teatro di operazioni non possono logicamente essere dei migliori."69
La dis l ocazione per le divisioni dipendenti fu Ja seguente :
1a D ivisione : fra Piave e Tagliamento comando a Cordovado;
2a D ivisione: Sedegliano e dintorni, a nord della rotabile Codroipo Udine (esclusa), comando a Sedegliano a disposizione del Comando Supremo;

3 8 Divisione: Claujano e dintorni ( P almanova esclusa) comando a Claujano;
4 8 Divisione : ad est del Tagliamento, a nord della rotabile Latisana Cervignano (esclusa) comando a Gonars a provvedere alle difese costiere ad est del Tagliamento a misura, a seconda del!' occorrenza, di assicurare il fianco destro dello schieramento della 3aArmata, senza arrecare ingombro nel settore compreso fra l'Ausa e l'Isonzo, e della ferrovia San Giorgio-Monfalcone.
6 ' AUSSME Diario storico della / 0 2", 3° e 4° divisione di cava lleria , da 128/D I605 B a 1624 C. llll AUSSME- El 186, 22 luglio 1915 , Ufficio annate , dislocamento delle divisioni di cavalleria.
69 AUSSME El 186. 22 luglio I915, Ufficio armate, dislocamento delle divisioni di cavalleria
-80-
Il nuovo schieramento veniva in un momento preciso della vita operativa dell'am1a. Esso corrispondeva alle esigenze della situazio ne del momento, in armonia con quelle dell'addestramento e della preparazione del]' Arma, fortemente raccomandata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. In ottemperanza a questi ordini e per galvanizzare i suoi uomini, che "con alti sen tim en ti di coraggio e di voglia di battersi per la riunjone delle terre irredente all' Italia erano partiti" il comandante del Corpo di Cavalleria emanò il seguente proclama:
" Porto a conoscenza dei comandi delle quattro divisioni di cavalleria per opportuna norma e perché si è data comunicazione a tutti gli ufficiali di quanto loro direttamente concerne, uno stralcio di lettera pervenutami da sua eccellenza il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito: So che l'arma di cavalleria molto si duole per non essere impiegata nel momento attuale in operazioni di guerra, e ben mi rendo conto dello stato d'animo degli ufficiali, cui non è con cessa l'opportunità di combattere, come ai loro colleghi delle altre armi Ma se le condizioni del terreno non permettono ora di affidare alla cavalleria compiti corrispondenti alle sue caratteristiche , non per questo gli ufficiali debbono sentirsi sminuiti nella considerazione altrui e meno ancora scoraggiati, tanto da dubitare dell'avvenire dell'arma. Quanto oggi si verifica della nostra cavalleria non è che la ripetizione di quanto è già avvenuto alla caval leria di altri eserciti europei, dal che io ebbi già ad avvertire fin dall'inizio della campagna con la mia circolare n. 5 del 15 maggio 1915, nella quale prevedevo che come già avvenuto presso altri eserciti belligeranti, unità di cavalleria, grandi e piccoli non trovassero impiego nelle azioni a cavallo che sono proprie di quest'arma. Il caso che a quest'arma debbasi affi dare compiti di spettanza delle armi a piedi è peraltro ben lontano dal verificarsi Siamo del resto appena all'inizio della guerra, e non è da escludere che le operazfoni possono essere trasportate su altri terreni, che consentiranno alla cavalleria di dar prova del proprio slancio e della propria preparazione. Occorre per questo che le divisioni si mantengano perfettamente allenate e pronte. Il presente periodo di inattività guerresca non deve certo risolversi in inattività militare, bisogna anzi profittare di questo periodo per perfezionare l'istruzione professionale di tutti, curare l'addestramento delle parti, allenare giudiziosamente i cavalli, così che, quando scoppi il momento opportuno, la cavalleria si trovi pronta ad entrare in azione , in stato di piena efficienza , quale non si può sperare se non con l'allenamento ininterrotto, diligente e tenace e con la salda e continua preparazione morale. A questa ed a quelle diano pertanto gli ufficiali la costante opera loro, e conservino ferma fede nell'avvenire. Ramm entino essi che da un momento all'altro, anche improvvisamente, può manifestarsi quella occasione di agire, che essi attendono ed agognano, e che essi sapranno cogliere, ne sono certo, con tutto il loro slancio, con tutta La loro energia . Ma in questo periodo in cui l'attività di tutti deve essere rivolta ad ottenere la più salda ed efficace preparazione, è necessario che gli ufficiali di cavalleria non siano distolti dai reggimenti per essere adibiti ad incarichi non di stretta competenza degli ufficiali dell'arma, senza la preventiva autorizzazione del Comando Supremo, il quale a sua volta soltanto per superior i esigenze si è valso talora degli ufficiali esuberanti al servizio degli squadroni." 70

TI mese di luglio fu un momento emotivamen te difficile per la cavalleria. Mentre sul Carso infuriavano i combattimenti, l'Arma che forse più di ogni altra portava in sé il sentimento del guerriero, rimaneva controvoglia lontana dai campi della gloria.
70 Vittorio Emanuele di SAVOIA AOSTA. Conte dì Torino, Lettera del 20 luglio 1915 sull'addestramento e impiego delle ca valleria, contTOfirmata da colonnello capo di Stato maggiore Sani , in A USSME El I 86 .
81
Verso la metà di agosto, la nuova dislocazione delle quattro divisioni di cavalleria divenne operativa e, nello specificarne i compiti principali- la difesa mobile costiera a porto di Cortellazzo e sull' I sonzo -furono emanate le direttive sul pe1fezionamento della preparazione e de l l ' addestramento. 71

Le direttive tendevano a coordinare l 'attività dei comandi dipendenti in un momento in cui, al di là delle parole di Cadorna sulla volontà di non smem brare 1' Arma, molti ufficiali di Cavalleria e intere unità comi nciavano ad essere destinati a prestare servizio presso le altre Armi, come i reparti d ' artiglieria a cavallo , i battaglioni bersaglieri ciclisti , le sezioni mitragliatrici dei R eggimenti. Venivano poi costituiti reparti di formazione composti da zappatori e m ilitari di truppa tratti dei reggimenti di cavalleria, mentre reparti di truppe tecniche e aliquote di servizi in orga ni co alle Divisioni venivano destinati ad altre Grandi Unità per ] ' impiego sul fronte.
Vi era l ' esigenza quindi innanzitutto d'una preparazione morale e, successivamente, d'u n adde s tramento tecnico professionale per non far deperire lo spirito dell 'Arma. A meglio coordinare l 'azio ne dei comandi di Divisione dipendenti furono emanati i seguenti punti:
a) Dipendenza: il Comando Supremo disponeva che le quattro divisioni di cavalleria fossero alla piena e completa dipendenza del Comando del Corpo di Cavalleria. Eccetto la 2a Divisione che, per quanto riguardava il suo impiego, 1imaneva a disposizione del Comando Supremo stesso , la dipen denza di essa dal Corpo di Cavalleria andava intesa in modo pieno e completo per tutto ciò che si riferiva all ' istruzione e alla disciplina.
' 1 AUSSME E I - 186 12 agosto 1915 comunicazione direttiva ai comand i della I •, 2", 3" e 4" divisione di cavalleria ai comandi di brigata di cavalleria; ai comandi di reggimento di c avalleria.
Sagrado: il ponte s ull ' Isonzo distrutto; al s uo fianco la passerella costruita dal Genio italiano nel maggio del 1915.
-82
 Panorama del corso dell ' Isonzo. con a sinistra l'abitato di Plava e q. 383.
Panorama del corso dell ' Isonzo. con a sinistra l'abitato di Plava e q. 383.
-83-
b) Istruzioni: veniva specificato che il principio di base di norma per tutti. strumento indispensabile aJJa riuscita di qualsiasi azione dell ' Anna era il cavallo, il cui mantenimento e cura era cosa assai ardua e problematica in tempo di guerra. Si doveva pertanto, ognuno per la parte che gli spettava porre ogni cura alla sua conservazione, la quale non era il frutto dell'inerzia forzata del quadrupede, rispetto alla quantità maggiore o minore di lavoro richiesta, bensì della scelta, per quanto possibile, di un ricovero adatto alla stagione, della vigilanza oculata per quanto riguardava il suo nutri mento ed infine delle cure assidue prima, durante e dopo il lavoro stesso.
c) Ufficiali: era alquanto precaria la loro situazione, soprattutto in conseguenza dei movimenti che ragioni d ' ordine pratico avevano imposto. Vi erano , come si sa, ufficiali in servizio permanente, di complemento e deJla Milizia Territoriale .
Era ovvio che la situazione rendeva sommamente necessaria ed importante la loro azio ne, visto che agli ufficiali competeva l'istruzione dei quadri. Poiché era innegabile che, per quanto animati da buona volontà e dal più sacro zelo, molti degli ufficiali subalterni, di complemento e della Territoriale mancavano, per la brevità del servizio prestato, delle cog n izioni tecnico profes sionali indispensabili per rendere effettivamente buoni servizi i n guerra, spettava ai comandanti d i squadrone, e più specificatamente a quelli di gruppo squadroni e di reggimento, dedicare tutta la loro attività al prepararli ed addestrarli, anche se continuavano a essere distaccati presso altri Corpi. Per di più, con la continuazione della guerra e con la necessità di raccogliere informazioni, molti ufficiali di cavalleria colti, intelligenti e capaci di parlare più lingue venivano utilizzati anche per il Servizio Informazioni di Guerra di nuova costituzione. Quella degli ufficial i era quin di per l 'Arma, ed è facile intuirlo, una questione vitale; pertanto si confidava che i comanda nt i di Divisione e di Brigata esercitassero la più assidua vigilanza e portassero il loro contributo di esperienza per ottenere il massimo rendimento dai richiamati . Da tale continuo interessamento poi, e dal più stretto contatto fra i vari comandi nel diretto esercizio delle proprie funzioni, sarebbero apparse più chiare le capacità e 1'attività dei singoli comandi sia nelle eve n tuali operazioni di guer ra, sia nell'ordinario governo del reparto a cui erano preposti, di modo che ciascuno "potesse con sicura coscienza, in qualsiasi momento, esprimere il proprio giudizio in merito alla energia ed alla capacità dei propri dipendenti . " 72
d) La truppa: diverse contingenze speciali avevano impedito quella completa istruzio ne dei reparti che sarebbe stata desiderabile, pertanto fu ordinato :

1 che fosse perfezionata e completa l'istruzione individuale della classe più giovane;
2 che, visto il carattere della guerra, fosse data la dovuta importanza ali 'istruzione di pun ta mento e dove possibile ad esercitazioni di tiro in campo aperto;
3 che fosse coltivata l'istruzione delle cariche speciali e degli elementi sce l ti deg l i sq uadroni: esploratori, pattuglie reggimentali, zappatori.
Doveva essere comunque intensificata l'istruzione tattica, dando il massimo sviluppo a quella di squadrone, poiché l'efficienza tattica dei reparti maggiori non era che la ris ultante di quelle de i si ngoli elementi. Pur nondimeno i comandanti dei gruppi di squadroni, reggimento ed unità maggiori dovevano approfittare di tutte le occasioni per esercitare i repruti dipendenti, mentre i comandi di Divisione doveva no assicurarsi l'esecuzione degU ordini di Sua Eccellenza il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, rappresentati dalla circolare del 3 giugno 1915 e cioè: le truppe non devono poltrire nelle caserme o negli alloggiamenti .
Nelle zone assegnate per l'istruzione non vi doveva essere nessun intralcio, come anche lu ngo le principali linee di tappa, segnate dalla rotabile Codroipo-Udine e Portogruaro-Cerv ignano. E si specificava che:
12 AUSSME El 186. 84
a) nessun reparto e drappello. a meno che non fosse per ragioni di servizio, doveva essere avvistato o portarsi ad est della linea segnata della rotabile Udine- Palman ova-Sedegliano-Bagnaria-Torre Zuino-Casali Zarnero (esclusa) ed il fiume Ausa. I reparti dislocati ad est di tale linea ed a sud della rotabile Torre Zuino Cervignano-Villa Vicentina , dovevano rimanere entro i limiti della zona fra 1' Ausa e l'Isonzo, a sud della ferrovia San Giorgio-Papariano.
b) le zone assegnate all'istruzione alle singole divisioni restavano così determinate:
l a Divisione: zona compresa fra Piav e e Ausa Corno, limitata a sud dal litorale, a nord dalla rotabile Gonars Talmassons-Codroipo San Vito al Tagliamento-Villotta-Motta di Livenza Ponte di Pia ve esclusa.
2a Divi sione : zona compresa fra Tagliamento e la rotabile Martignacco-Colloredo di Prato-Campoformido , limitata a sud dalla rotabile Codroipo Udine (esclusa) a nord dalla linea della ferrovia a scartamento ridotto San Daniele Udine.
3a Divisione: zona co mpre sa fra Tagliamento-Cellina-Meduna limitata a sud dalla rotabile Codroipo Pordenone (esclusa) a nord dalla rotabile pedemontana Maniago Cavasso-TravesioPi nzano San Daniele (esclusa).
4 " Divisione: zona compresa fra la rotabile Udine-Palmanova-Sedegliano-Bagnaria-Torre Zuino (esclusa), il fiume Corno-la rotabile Gonars Talmassons-Codroipo (inclusa)- la rotabile CodroipoUdine (esclusa).
in fine , per quanto riguardava la disciplina, si specificava di imporla rigida e severa, ma so prattutto che fosse una "disciplina degli animi disciplina delle forze , disciplina delle intelligenze. Bandita pertanto qualsiasi competizione, evitata qualsiasi discussione, in quanto doveva esservi che
 L'Ison zo ai piedi della Bainsizza; sullo sfondo Sagora, il Monte Santo e, all'estrema destra, il San Gabriele e la q. 383 di Plava : 1915.
L'Ison zo ai piedi della Bainsizza; sullo sfondo Sagora, il Monte Santo e, all'estrema destra, il San Gabriele e la q. 383 di Plava : 1915.
-85-
uno che comanda e di altri c he o bbedis cono. Primi fra tutti g li ufficiali qualunque fosse stato il loro grado a dare l'esempio sotto ogni rapporto di questa ferrea disciplina già proclamata in parecchie circostanze da Sua Ecc ellenza il Capo di Stato Maggiore dell ' Esercito." 73

I compiti rimanevano la difesa costiera mobile, il servizio di protezione della ferrovia e delle batterie , quello dì scorta ai prigionieri e di s orveglian z a ai campi di concentramento ed alle lin ee telegrafiche e telefoniche per impedire atti di spionaggio. La 4a Divisione doveva assolvere in maniera permanente questi servizi e doveva forni re 300 uomini, comprendenti tutti gli zappatori divisiona li , per i lavori campali e 70 uomini alla Marina per i lavori d'impianto delle batterie di punta Sdobba e Golametto.
Presto si palesò la necessità di creare una protezione contro lo spionaggio. Alla I a D ivisione Friuli veniva assegnata la zona della destra del1'Isonzo , a nord della ferrovia Cervignano-Papariano. Tale sorveglianza fu poi limitata alla linea Versa-Torre, in seguito all ' ordine dell ' Armata relativo al l 'isolamento delle batterie in genere e a quelle di medio calibro in particolare. A tale isolamento dovevano provvedere i comandi di Corpo d ' Armata di prima linea e ciò non rendeva più ammissibile che la 1a Divi sione di Cavalleria spingesse pattuglie in quella zona, oltre la linea Versa-Torre. I servizi furono ripartiti fra tre reggimenti della divisione e si esplicarono mediante pattuglie mobili di giorno ed appostamenti di notte. Il servizio di perlustrazione lu ngo le linee telegrafiche e telefoniche fu svo lto da uno squadrone del Reggimento Roma, che dispose 24 pattuglie a cavallo mobili di giorno ed appiedate di notte in appositi appostamenti.
Con l 'affluenza d'un sempre maggior numero di prigionieri , fu allestito anche un servizio di custodia prigionieri nei tre campi di concentramento iniziali:
Campo numero I in Ajello: affidato al R eggimento Cavalleggeri di Monferrato, che vi destinava giornalmente una guardia della forza di un capitano, tre subalterni e 120 uomini di truppa a piedi;
Campo numero Il in Ajello: affidato ai Cavalleggeri di Roma, che vi destinavano una forza uguale a quella indicata per il R eggimento Monferrato;
Campo numero ill di Bagnaria Arsa (o Madonna della Salute): affidato al Reggimento Lancieri di Novara, che vi destinava una forza uguale a quella indicata per il Reggim e nto Monferrato.
Inoltre veniva destinato un drappello scorta del R eggimento G enova Cavalleria, forte di 1 ufficiale e 40 uomini appiedati a San Vito al Torre ; per cui in totale erano impegnati 7 squadroni.
P er il serv izio di scorta dei prigionieri internati fino a Mestre erano impegnati costantemente: due capitani, quattro subalterni e 120 appiedati del R eggimento Roma , più due subalterni medici. Speciale cura fu data alla sorveglianza delle batterie e dei depositi di munizioni e fu stabi lito che: a) attorno al luogo dove sarebbero state costruite o postate le materie, fosse isolata un'ampia zo na di terreno, in modo da impedire a chiunque di vedere, anche da lontano, l'esatta posizione dei lavori e d elle batterie.
b) l'i solame nto sarebbe stato ottenuto circondando la zona con uo convenien te numero di pic cole guardie, con la chiara ed esplicita consegna di non lasciar entrare ed uscire nessuno, né borghesi, né militari. Un solo posto di riconoscimento con un ufficiale per ogni zona , avrebbe regolato il movimento di chi avrebbe avuto la facoltà di entrare di uscire.
c) allo scopo di trarre in inganno i confidenti e le spie del nemico, sarebbero state circondate anche le altre zone, in cui si simulavano lavori, postazioni di batterie ecc ..
d) veniva impedito l'accesso a campanili , terrazze , belvedere e posizionj dominanti in genere dalle quali qualche informatore nemico avesse potuto studiare ed individuare le posizioni. 74
73 In pratica la fùosofia cadomiana era quella di riorganizzare l ' esercito secondo un modello da lui ritenuto funzionale e imprescindibile: quello del merito e non della nascita.
1 • AUSSME EJ 186 Comando del Corpo di c avalleria: Situa zion e d e lle retrovie co ntro lo spionag gio
86
Nonostante però la loro preparazione non fosse trascurata, la graduale paitenza di ufficiali comandati in aggregazione o distacco presso altri Corpi e la loro sostituzione con ufficiali richiamati dal congedo o di Milizia Territoriale rendevano necessario che le unità rimanessero raccolte e potessero procedere ai necessari periodi di istruzione; comunque tutto ciò non consentiva d'impiegare l'Arma in combattimento.

Alla fine dell'estate era chiaro a tutti che, nella situazione operat iva creatasi , l a Cavalleria non avrebbe avuto la poss ibilità del grande combattimento fatto di manovra, velocità e urto. Stessa sorte ebbero i reggimenti non inquadrati nelle divisioni. Piemonte Reale raggiunse la zona di guerra senza prendere parte ad alcuna operazione. Firenze operò nella zona del Col di Lana con servizi di prima linea e di collegamento con la Brigata Cacciatori delle Alpi; Foggia fu impegnato in azioni di collegamento e pattuglia nei settori a s ud ovest di Gorizia e precisamente tra· Gradisca, Lucinico e San Lorenzo di Mossa. Alessandria ebbe invece modo di impegnare i s uoi squadroni. Il 30 maggio 19 J5 il Reggimento era partito da Lucca in ferrovia, raggiungendo Moimacco in zona di guerra, a disposizione del comando del IV Corpo d 'Armata. Il 5 giugno il II Gruppo di Squadroni (4° e 5° Squadrone), agli ordini del tenente colonnello Felice Cicerchfa , 75 si era spostato nella va lle deJJ' Alto Natisene, col 4° Squadrone a Creda e il 5° a Suzid , in servizio di polizia prigionieri ed alle retrovie. Gli Squadroni del I Gruppo rimasti a Moimacco (1 ° squadrone), Bottenicce (2°) e San Pietro al Natisene (3°), erano sta ti anch'essi adibiti a servizi di scorta prigionieri fra Caporetto e Udine fino al 13 giugno. Alla stessa data li avevano raggiunti a Moimacco anche gli Squadroni del II Gruppo. Il 13 agosto il Reggimento riunito, precedu to dal nucleo Ciclis ti, con marcia notturna, per Stupizza-Caporetto , si trasferì a Idersko da dove, attraversato l ' Isonzo sul ponte di barche di Ledra, raggiun se Kamno , pronto ad entrare in azione nella conca di Tolmino , se le fanterie fossero riuscite a scacciarne il nemico. Vi rimase, all'addiaccio, a disposizione della Fanteria fino al 19, mentre il Nucleo Ciclisti venne impiegato a Volaire e Gabrie in servizio di collegamento e poi a Selice , in trincea , di rinforzo ad un Battaglione di Bersaglieri in riserva.
Fallito l'attacco di Tolmi no alla fine dell 'agosto, rientrato anche il Nucleo Ciclisti, il Reggimento venne spostato più indietro a Idersko. Il 3° Squadrone ed i ciclisti passano a djsposizione del comando della Divisione Speciale Bersaglieri (denominata Ternova ), che operava nella Conca di Plezzo.16
Il Reggimento Cavalleggeri di Lodi giunse in zona di guerra, al coma ndo del co lonnello Roberto Brussi 77 il l O giugno 1915 , formato dal 2°, 3°, 4 °, 5° e 6° Squadrone. Alla data di inizio delle ostilità il 1° sq uadrone s i trovava ancora in Libia , ove sarebbe rimasto fino al termine della guerra. Lodi raggiunse la zona di Spilimbergo e Casarsa , a disposizione del XII Corpo d'Armata e passò poi, sino al 4 luglio, nella zona Azzano-lppolis Leproso; alla fine dell'estate fu spostato tra Orzano e Spessa, ed alla fine dell ' anno tra San Daniele e San Tommaso , fornendo guardie, pattuglie e scorte.
Il Reggimento Cavalleggeri di Lu cca prese parte alla campagna quale truppa suppletiva. Fu dislocato all'inizio nel settore del Medio Isonzo, alle dipendenze del Il Corpo d 'Armata, effettuò ser vizi di pattuglia , collegamento e controllo per lo sgombero dei civili, distaccando un plotone a San Martino di Quisca e uno squadrone al castello di Dobra. A metà novembre rientrò ai s uoi quartieri a Saluzzo.78
I Cavalleggeri di Caserta partirono per la zona di guerra, co n funzione di truppa sup pletiva del VI Corpo d'Armata, per se rvizi di pattuglia, collegamento e portaordini. I Cavalleggeri di Piacenza,
15 Sarà promosso colonnello ed andrà a comandare il 30° R eggimento Cavalleggeri di Palermo.
76 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA, Cenni storici del Reggimento Cavalleggeri di Alessandria ( 14 °) dalla fondazione 3 gennaio 1850 al 4 novembre 1918, Raduno di Lucca: 27 giugno 1965.
11 Pass ò immediatamente a comandare una brigata di fanteria.
18 Le Glorie dei cavalieri d ' Italia , compilarono Pietro PEZZ1-S1BON1, ten. col. di cavalleria e Emilio R AVAGNATI-LARGHJNl tenente di cava lleria , sotto gli auspici dell ' Associazio ne dell'arma dj cavalleria, Milano. E. R avagnati editore, 1925; ma anche in BRIGNOLI, op. cit., pagg. 78 79.
87
eredi del reggimento Ussari di Piacenza , giunsero ai primi di giugno nelJa pianura friula na, alle djpendenze del X Corpo d'Annata. Tennero il collegamento fra il VII e l ' XI Corpo d ' Armata e sorvegliarono le batterie di obici pesanti campali nel settore ru Turriaco Villesse, rimanendovi per tutto l'anno.

Anche i reggimenti Cava/legger; di Padova, Cavalleggeri di Catania, Cavalleggeri Umberto I, Cavalleggeri di Aquila e Cavalleggeri di Udine parteciparono al primo anno dj guerra fornendo ai Corpi d'Armata truppe suppletive e in funzione di polizia.
Il 1915 si chiudeva quindi con un bilancio amaro per la Cavalleria. Il nuovo tipo ru guerra aveva cambiato le forme di combattimento e tutti, a commciare dai suoi vertici, intuivano che il problema principale era d'adattarla alle nuove circostanze per non lasciarla inattiva.
L o stesso problema si presentava sugli altri settori del fronte. Le divisioni cominciarono ad esse re appiedate a scaglioni ed inviate a combattere come unità di fanteria; le prime furono la 1a e la 4a Divisione di Cavalleria. Ma il cavallo non fu abbandonato, per non intaccare la loro efficie nza qualora fossero state richiamate ad agire in sella , per conservare la loro personalità e mantenere la loro speciale costituzione. Era necessario sfruttare il loro pregio di repar6 fortemente coesi e mantenere, per quanto possibile nelle mutate condjzioni di ambiente e d'impiego , Le loro caratteristiche: la rapi dità dell'azione e lo spirito offensivo.
Ottobre 1915: in primo piano Monfalcone , sullo sfondo le colline dell e q. 82 , 121 e 77 sotto bombardamento da parte italiana
-88
 Maggio-giugno 1915, Campolo ngo: mitraglieri dei Cavalleggeri di Roma in funzione antiaerea.
Maggio-giugno 1915, Campolo ngo: mitraglieri dei Cavalleggeri di Roma in funzione antiaerea.
-89

..
N izza Cavalleria con i primi prigionieri austriaci: giugno agosto 1915
90
 Gruppo cli fanti au s tro ungarici prigionie ri in attesa cli muovere , sco11ati da cavalleggeri italiani.
Gruppo cli fanti au s tro ungarici prigionie ri in attesa cli muovere , sco11ati da cavalleggeri italiani.
-91

, .
Luglio agosto 1915, sezione mitragliatrici dei Cavalleggeri di Roma in trincea sul Carso ( MCP ).
-92-
 Grado: 8 Ottobre 1915 , Reggimento Vercell i in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera in barca.
Grado: 8 Ottobre 1915 , Reggimento Vercell i in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera in barca.
93-
 9 Ottobre 1915, Reggimento Guide in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera. (MCP)
9 Ottobre 1915, Reggimento Guide in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera. (MCP)
-94-
 Ajello 1915: Cavalleggeri di Monferrato in servizio di scorta prigionieri.
1915: un dragone di Piemonte Reale in primo piano e Cavallegge1i di Monferrato di sco rta a prigionieri austro ungarici del 2° Re ggimento bo sn iaco.
Ajello 1915: Cavalleggeri di Monferrato in servizio di scorta prigionieri.
1915: un dragone di Piemonte Reale in primo piano e Cavallegge1i di Monferrato di sco rta a prigionieri austro ungarici del 2° Re ggimento bo sn iaco.
95

VIII
IL SECONDO ANNO DI GUERRA
Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi mesi di pace, dal 1914 al 1915 , e soprattutto nel 1915 , dallo Stato Maggiore Italiano e da Cadorna in particolare, i mezzi necessari a imprimere un andamento accelerato alle operazioni erano pochì. Mancavano ancora e innanzitutto artiglieria e munizioni, erano deficienti i materiali del Genio ed i trasporti , poche le mitragliatrici nono stante i progressi fatti.

L a povertà dei mezzi risultava ingigantita se paragonata all 'ampiezza del fronte. Come accen nato, l'Esercito non era preparato ad una guerra e , per di più , non lo era nemmeno mentalmente a quella di posizione. Chi aveva sperato (la Cavalleria in modo particolare , a livello operativo) nella guerra di manovra , rapida, brillante e di breve durata , fu costretto, invece, e non solo per deficienze organizzative, a combattere una guerra di posizione, oscura, monotona , triste e della quale non si vedeva mai la fine. I giorni e le notti venivano trascorsi nelle fa ngose trincee e negli angusti camminamenti ; servivano lunghe pause neces s arie per accumulare quantità enormi di uomini e di materiali, specie munizioni , cui seguivano assalti furibondi che si concludevano con poche centinaia, a vo lte poche decine, di metri conquistati.
Vista la diversità morfologica della zona di operazioni sul fronte alpino , l ' Esercito italiano fu da subito costretto ad attestarsi sulle vette delle montagne, mentre lungo i modesti rilievi carsici veniva impresso lo sforzo maggiore. Si trattava di rilievi modesti, ma non facili da conquistare. Anche qui l ' Impero asburgico aveva eretto sistemi difensivi solidi, dominanti sempre e comunque le fanterie regie avanzanti. Per necessità più politica che militare dalla classe politica fu imposta a Cadorna, e quindi alJ ' Esercito , la regola dell'attacco a tutti i costi e il divieto di qualsiasi arretramento, anche parziale.
Ora, una cosa che non è mai stata chiaramente ed esplicitamente detta , ma che accadeva i n tutta Europa , o quantomeno nei Paesi Alleati, durante il conflitto, era che i militari dovevano giu stificare se stessi di fronte alla classe politica. Quest ' ultima a sua volta doveva farlo davanti ai propri elettori e , in Italia e Gran Bretagna, anche davanti ai propri sovrani, dai quali aveva ricevuto il mandato di governo. I militari, specie in Francia e Gran Bretagna, in quel periodo avevano difficoltà a spiegare le enormi perdite che s ubivano ad ogni scontro, perché in termini di territori con quistati no n potevano mostrare ri s ultati che apparissero tali da giustificare il numero di morti subi ti. Questo li portava ad ingigantire le difficoltà della guerra di materiali, peraltro già abbastanza gravi di per sé, ed a magnificare ogni minimo progresso che si fosse ottenuto. Insomma, in condizioni operative che i cap i militari dichiaravano senza precedenti ed era vero e di difficoltà inaudita ed insormontabile e di questo però più passava il tempo e meno erano convinti i civili a casa la conquista di una trincea, a trenta metri di distanza. era vantata come un successo consisten te e clamoroso . Naturalmente però, se erano un successo clamoroso i trenta metri presi , erano un altrettanto clamoroso disastro i mede s imi trenta metri persi. No n si poteva dire che le conquiste erano un valore immen s o e le perdite di terreno un nonnulla , perché neanche il più sprovveduto politico l'avrebbe creduto, specie perché doveva rispondere a un elettorato. 11 corpo elettorale, per quanto ignorante , non era pri vo di buon se nso ed e ra progressivamente sempre meno fiducioso nella val idità della condotta politica e militare di una guerra che gli riduceva le entrate, lo privava dei sacrifici di una vita e, molto s pesso, sempre più spesso, ne marchiava a sangue e per semp re la vita, privandolo anche dei figli e dei parenti più stretti. Per non perdere la propria posizione, i politici erano dunque pronti a disfarsi dei militari il cui operato non desse risultati tali da giustificarne il mantenimento in comando davanti all'opinione pubblica; era un caso di " mors tua, vita mea ",
CAPITOLO
97
 Appiedat i della 1• Divi s ione di Cavalleria: Cavalleggeri di Roma in trincea nel I915 ancora senza elmetto. ( MCP )
Appiedat i della 1• Divi s ione di Cavalleria: Cavalleggeri di Roma in trincea nel I915 ancora senza elmetto. ( MCP )
98-
il cui prezzo era pagato in tutto il Continente dalle fanterie 1anciate a massacrar si contro i reticolati. Come French , Haigh, Joffre e Foch , an che Cadorna doveva subire una tremenda pressione politica, tanto più forte jn quanto implicita e silenziosa, con in più il problema che lui era l' unic o di tutti i comandanti alleati ad avere il Capo dello Stato in prima linea; dunque al corre nte di tutto quel che s ucced eva e, al caso, perfettamente in grado d ' interferire.
Ecco dunque perché Cadorna era obbligato a non retroce dere, neanche quando la logica e l'arte militare avrebbero s uggerito qualche piccolo a rretramento per assestare meglio le linee. A legargli ulteriorm ente l e mani poi , c'era la sua opera d 'anteguerra,"Attacco frontale ed ammaestramento tattico", che, con la circolare n. 191 del 25 febbraio 1915 dal medesimo titolo, era divenuta il procedi mento tattico cardinale del Regio Esercito. 79 In simili condizioni politiche ed avendo pubblicato in tempi n on sos petti un 'o pera con un tale titolo ed implicante tali principi opera6vi, la cui validità aveva po i co nfermata in pieno, adottandola co me dottrina uffi c iale , come a vr ebbe potuto Cadoma anche so lo ipotizzare pubblicamente di cedere terreno per una quals iasi ragione , se nza su bire delle pesantissime conseguenze? Dunque attacco, per di più frontale, anche se ciò comportava uno s bilanciame nto in avanti di una parte del dispositivo, determinava la nece ss ità di erigere a difesa i fianchi
79 Scriverà nel proprio diario (1915-1919: diario di guerra, Milano, Longanesi, L968, pag. 169) sotto Castagnevizza, il 17 agosto 1917, il tenente del Genio Lanciafiamme Paolo Caccia Dotninioni di Sillavengo: " C'è in giro, da qualche tempo, un noioso pestilenziale libretto intitolato "Attacco frontale e ammaestramento tattico": c'è scritto dentro come bisogna fare a prendere la posizione. E allora possiamo anche dimenticare che il colle obiettivo è .fiancheggiato da due valloncelli aperti e ben visibili fino in fondo, molto meno fort(ficati, che sembrano messi lì apposta per l 'agg iramento."
 Appiedati d ella l" Di v is io ne di Cavalleria: Cavalleggeri di R o ma in accampamento ai piedi del Carso.
Appiedati d ella l" Di v is io ne di Cavalleria: Cavalleggeri di R o ma in accampamento ai piedi del Carso.
-99-
con tutti i mezzi a disposizione e, da ultimo, non faceva contemplare la possibilità di attacchi nemici in grande stile.
La piramide di co mando , necessaria per far funzionare il sistema, fu durante la guerra ulteriormente riorganizzata in senso vert ici stico Chi sbagliava veniva su bito esonerato. Doveva vigere il principio del merito. Se questo ebbe certamente un effetto benefico nel creare un esercito docile e disciplinato, ne ebbe anche uno negativo: l'ufficiale di qualsiasi grado non prendeva iniziative per sonali, anche se costretto dagli eventi, per non essere esonerato o peggio giudicato per insubordinazione e deferito al tribunale militare. Ovviamente il risultato andava nel senso opposto a quelJo immaginato da Cadoma. Ne conseg uiva infatti un rallentamento delle operazioni, a tutto vantaggio degli Imperiali che, centinaia di volte sul punto di cedere irrimediabilmente, venivano salvati dal l 'i ndeci sione dei su bordinati italiani al comando delle unità minori di fanteria o artiglieria, colpiti dal dilemma tra procedere in avanti se nza curarsi degli ordini o arrestarsi a difesa e accontentarsi del terreno conquistato. Cadorna, da fine militare qual era, come appare chiaramente dalla lettura delle direttive che impartì, intuì questo problema, ma, impegnato a gestire, compattare, riorganizzare e rinvigorire l'intera struttura militare di terra, non riuscì a risolvere la situazione . L'amara conclusione fu che la guerra l'avrebbe vinta so lo chi fosse arrivato alla fine dell'ultima battaglia con più uomini e più mezzi.
Va ricordato che l'attacco ad ogni costo in un terreno come quello carsico e montano era un suicidio, le perdite per conquistare poche centinaia di metri erano talmente elevate da compromettere l'intero sistema di reazione in caso di contrattacco. Solo per motivi prettamente politici Cadoma non permise mai un arretramento, anche se dalla lettura dei suoi scritti coevi sembrerebbe averlo desiderato, per sbloccare la situazione di stallo Per questa ragione, a partire dal 1916, decise di rinforzare il Monte Grappa80 in previsione di una possibile rotta, con il chiaro intento , nell'ipotetico caso di uno sfo ndamento , di invertire le parti e impantanare l 'esercito imperiale nelle stesse condizioni nel quale si trovava il suo sul Carso.
Per quanto riguarda l ' organizzazione tattica, il modo di procedere delle fanterie italiane si uniformò a quello più generale europeo. Il cannone e la bombarda preparavano il terreno con giorni di estenuante bombardamento, che aumentava più intenso il giorno precedente l'attacco, fino a diventare, come indicato nel gergo, distruttivo lo stesso giorno dello scatto delle fanterie. Quando si avvicinava l'ora dello sbalzo offensivo, il cannone allungava il tiro o addirittura smetteva dj sparare e le fanterie andavano all'attacco in tre, quattro, cinque ondate success ive. Lo scatto deJle fanterie veniva però frenato immediatamente dal reticolato, la vera novità della guerra. Succedeva purtroppo che la maggior parte delle volte i reticolati fossero rimasti intatti; in questo caso l'assalto si trasformava immediatamente in una strage delle fanterie attaccanti.
Per quanto riguardava l'organizzazione, Cadorna conscio ormai che il confhtto non sarebbe stato di breve durata , continuò nel progetto di ampliamento e di razionalizzazion e della struttura lungo tutto il corso del 19 16 e del 1917.
80 Come è noto, Cadorna aveva st udiato e predi s po sto la linea difensiva Grappa Piave da tempo e, fin dal 1916 , dall'alto d ' una montagna, l'aveva indicata agli ufficiali del suo Stato Maggiore, cresta per cresta, ansa dopo ansa , soffermandosi su ogni paese e su ogni isolotto e terminando (come riporta Franco Bandini nel s uo Il Piave mormorava, Milano, Longanesi, 1965 , pag. 124) con le parole: "Signori, in caso di disgrazia, ci difenderemo qui."

100-
 Appiedati della 1° Divi s ion e di Cava ll eria: Cavalleggeri di Roma in trincea, notare l' uso delle mollettiere, tipiche delle truppe a piedi , al posto degli stival i e, finalmente , l'elmetto metallico. (MCP)
Appiedati della 1° Divi s ion e di Cava ll eria: Cavalleggeri di Roma in trincea, notare l' uso delle mollettiere, tipiche delle truppe a piedi , al posto degli stival i e, finalmente , l'elmetto metallico. (MCP)
101
 n sottotenente Otto Giulini del 20° Reggimento Cavalleggeri di R oma in trincea con i fanti_ del 152° Reggimento della Brigata Sassari alla Trincea delle frasche: morirà da li a poco colpi to da un cecchino. (MC P)
n sottotenente Otto Giulini del 20° Reggimento Cavalleggeri di R oma in trincea con i fanti_ del 152° Reggimento della Brigata Sassari alla Trincea delle frasche: morirà da li a poco colpi to da un cecchino. (MC P)
- 102 -
 Giug no 1916: Cavall e gger i di Roma in ui ncea a Plava Cana le (MCP)
Giug no 1916: Cavall e gger i di Roma in ui ncea a Plava Cana le (MCP)
103
 Gi ugno 1916: altra immagine dei Cavalleggeri di Roma in trincea a Plava Cana le . (MCP)
Gi ugno 1916: altra immagine dei Cavalleggeri di Roma in trincea a Plava Cana le . (MCP)
-104
 Giugno 19 I6: Cavalleggeri di Roma nei baraccamenti in una dolina a Plava Canale . ( MCP)
Giugno 19 I6: Cavalleggeri di Roma nei baraccamenti in una dolina a Plava Canale . ( MCP)
105
-

Le difficoltà di alloggjamento, ragioni di conservazione del prezioso quanto scarso mate riale quadrupedi, l'opportunità di lasciare a disposizione delle unità di fanteria, delle salmerie e dei carreggi il maggior numero possibile di accantonamenti, la necessità di alleggerire notevolmente il servizio trasporti liberandolo dal gravame ingente del rifornimento foraggi e ragioni di economia consigli aro no, negli inverni del l 915 16 e 1916-17, di fare assumere alla caval leria una dislocazione informata ai seguenti criteri di base:
a) riportare nelle proprie sedi il maggior numero possìbile di unìtà, la qual cosa facilitava anche l'istruzione, potendo disporre di cavallerizza, campi di esercitazìoni, piazza d'armi e tutte le infrastrutture necessarie;
b) tenere in zona rispondente agli scopi delle sistemazioni invernali quei reggimenti che, per avere le sedi ordinarie troppo lontane, non sarebbe stato conveniente trasportare (in linea di massima rientravano dalla zona di guerra tutti i reggimenti aventi sede ordinaria a nord del parallelo di Firenze);
c) lasciare ali' Arma ed ai Corpi d'Armata il minimo numero di squadroni ritenuto necessario per i servizi vari di polizia stradale, posto di conisponde nza ecc., che purtroppo erano i soli normalmen te affidati ai reparti di cava lleria.
Tali provvedimenti dettero certo nel primo e anche secondo inverno di guerra buoni risultati, tanto per la conservazione del materiale quadrupedi e bardature, quanto, e maggiormente, nei riguardi delJ'istruzione a cavallo delle classi più giovani, per le quali più sentito era il bisogno, specie per coloro che erano stati chiamati dopo l'entrata in guerra ed avevano appartenuto ai reparti impegnati in guerra, appiedati nel 1916.81
Comunque le brigate delle divisioni di cavalleria, la l3 e la 43, parzialmente appiedate, furono inviate subito in prima linea già dal primo inverno di guerra.
Il Reggimento Monferrato (1 a Divisione, I Brigata) rimase in linea nel basso I sonzo fino all 'esta te del 1916, fu quindi trasferito nel settore di Monfalcone, con l'obiettivo di occupare la parte su d della linea. Le battaglie combattute sul Carso di Monfalcone furono tra le più crue nte: i suoi rilievi so no dolci, adatti all'offensiva e, cosa non trascurabile, Monfalcone era ed è la porta per Trieste.
Il settore propriamente monfalconese del Carso era costituito da una serie di modeste alture, disposte in s tretto allineamento sulla direttrice sud -est nord-ovest. Partendo da ovest e procedendo verso est si trovano lo Zochet (36 metri sul livello del mare), la Gradiscata (q. 60), le Forcate (q. 61), j] colle della Rocca (q. 88), il Golaz (q 87 99), la cima di Pietrarossa (q. 121), la quota Toti (q 85 86), la cima Grand e (q. 56), il Sablici (q . 76-77), infine il Montuoso (q . 56). Da lì si scende nella parte paludosa fino al mare e si trova la q. 12 o Sant' Antonìo.
TI loro succedersi, con regolarità e forma tondeggiante, costituisce una baniera che chiude a nord il territorio di Monfalcone, anda ndo a congiungersi co n l'Adriatico a levante della città. La flora particolare che li contraddistingue fa sì che il terreno si presenti al primo esame come una successio ne di radure erbose, separate da fo lti boschi, rivelandosi poi solcato ovunque da grigie pietre calcaree affioranti tra l'erba e chiamate "grize".
Nel giugno 1915 il fro nte difensivo austro-ungaiico sull ' l sonzo era diviso in quattro settori dei quali il Ili andava dal Vipacco a Parenzo, e riuniva sotto la responsabilità operativa del Feldmarscha11eutnat Goinginger la 57a e 94a Divisione di fanteria, più la 60a Brigata da montagna.
"'AUSSME . djvisioni di cavalleria, Commissione d'fochiesta B 4 9651.

CAPITOLO IX
TUTTI A PIEDI! SIGNORI, CAVALIERI ALL'ASSALTO!
-107
Obiettivo dei difensori sul Carso era trattenere il più a lungo possibile l e truppe italiane sulla linea più esposta, di c ui quell a delle quote monfalconesi costituiva il tratt o s ud- or ie ntale, i n attesa di sviluppi offen s ivi s trettame n te l egati all'and ame n to ge neral e del conflitto.
La mede s ima tattica fu sce lta e adoperata co n successo lungo il fronte a lpin o, dal Tonale all'alto Ison zo, per tutta l' estate 1915, co n perdite contenute. Sul Carso però no n s i poté evi tare un cresce nd o esponenziale delle perdite, a ca us a dell' i nferior it à materiale, d ell'im possibilità di trincerar i in pro fondità ricoverando in cave rna le trupp e, del martellamento disordinato ma co ntinu o e micidiale del1 'artigli e ria itali ana. Gli effetti d e lle granate italiane s ui precari ripari cos tituiti da muretti a secco e scav i poco profondi ve ni van o accre sc iuti d a ll a natura particolare del terreno: a ll e terribili schegge dei proiettili sparati d a i pezzi campal i e d el pa rco d'assedio si aggiungeva la pioggia di pietri sco calcareo, con e ffetti mi c idiali sui fanti rannicchiati nelle buche o ab barbicati a1 terre no più es posto
Eccettuata la co nquista di sacche s ul ciglione carsico , che dal San Mi c hele pi ega fino a raggiunger e Monfal co ne , il possesso de l Coll e della Ro cca e delle alture ad ovest di qu est' ultim o, le trupp e d e lla 3a Armata italiana riu sciro no ne l prim o se me stre di guerra solo ad intaccare la s i s temazi o ne dife nsiva austriaca.

Alla 13a Divis ion e del VII Corpo della 3° Armata s pettò l 'a ttacco ne l s ettore di Monfalcone , ai primi di giugno 1915. La I Brigata di Fante ri a " R e" ava nzò lungo l a lin ea R onc hi-Sel z, mentre i Granatieri di Sardegna seg ui va no l a direttri ce Bi s trig na- Monfa lco ne.
Sul colle della Rocca vi furono i primi sco ntri co n le fante ri e avversarie, apparte nenti ai battaglioni della 2a e 60" Brigata da monta g na , d e lla 57a D ivisione e del ''Gruppo Monfalcon e". Tre o rdini di reticol at i , in al c uni punti disposti s u cinque file , fermaron o l ' impet o it aliano. Ogni attacco frontale fu infatti arrestato dall 'az ione combinata del grovig li o di fi l o s pinato e delle armi automati che
Le battag lie dell'e sta te -au tunno 1915 (prima, seco nda , t erza e quarta batta g lia dell ' Isonz o) si conclusero pe r le trupp e italiane co n pesanti perdite, d ovute alla dispersione delle fo rz e s u fronti d'attac co troppo estesi ed all'azione ancora non perfe ttamente coordinata d e ll'artiglieria
Nel prim o semestre del 1916 l'Esercito italiano accrebbe e potenziò i p ropri mez zi. inaugurando la s tagion e della g ue rra di m ateriali In questo quadro morfo logico ed operati vo i Cavalleggeri de l Monfe rrato agirono in collaborazio ne con il 155° e il 156° Reggimento Fanteria: la Brigata Al essandria.
L'altro reggimento della I Brigata di Ca va lleria , i Cavalleggeri di Roma, ne ll 'a pril e del 1916 fu mandato a pres idiare le trincee del se ttore Pl a va Canale sul m e dio l so nz o e ne l lu g li o sos tituì le Guide nel se ttore di Monfalco ne.89
li reg gi m en to G enova 13 Di visio ne, II Brigata fu in viato a presidiare il setto re Pl ava-Anhovo e in luglio s o s tituì le Guide ne l settore di Vermegliano.
Novara rimase dalla prima vera all ' estate del 191 6 nel setto re di P lava-Anho vo . Alla metà del mese di lu g l io, fu in viato a presidiare le trincee di Sel z.
La 4a Divisione fu mandata in lin ea ne] se ttore di Monfalcone e Il s i sarebbe coperta di gloria: Nizza Ca valleria fu in v iato a presidia re le trincee della fabbrica dell'Adria Werk e nel maggio d e l 1916 ed il seco ndo reggime nto dell a brigata, i Lancieri di Vercelli, fu inviato ne ll e s te sse posi zioni.
L '8 ma gg io 191 6 la 4a Divis ione di Cavalleria , appiedata. passò alle dipend e n ze dell ' VIII Corpo d 'A rmata. Nella notte tra il 9 e 10 l a VII Bri gata di Cavalleria, com pre ndente Nizza, sostituì metà dell'88 ° Fanteria e, ne lla nott e s ucce ssiva, dal IO al 11 , l 'a ltra metà dello ste sso Reggim e nto , ve ne n do ad assumere co sì la fronte Mandri a - Adria.
Contempora neamente a nche l 'altra B rigata dell a D ivisione, l 'VIIT, costituita dai reggimenti Ca valleggeri Guide e Cavalleggeri di Treviso fu schiera ta s ul Carso. L e Guide nel me se di mag g io
02 PEZ21 -Smo N1 e R AVAGNATI-LARGHINI, op. cit. e in AUSSME Diario storico delle divisioni di cavalleria 108-
 1915 16: fante in una trincea de l Carso
1915 16: fante in una trincea de l Carso
109-
 Si scava nel fango: un fante sistema la trincea dopo la pioggia, 1916.
Si scava nel fango: un fante sistema la trincea dopo la pioggia, 1916.
-110
furono tr asferite da Aquileia a Monfalcone, a presidio delle trin cee fra quota 98 e quota 93. NeJJa notte dall ' 11 a l 12, sostituirono metà dell ' 87° Fanteria e, ne lla notte seguente, il Reggimen to Treviso rilevò l'a ltra metà dell'87 ° , venendo così. ad assumere la fronte compresa fra q 98, q. 93 e Mandria. In questo modo il comando della 4 a Divis ione di Cavalleria aveva assunto di fatto il co mando della zo n a di Monfalcone per le 7 del mattino del 13 mag g io 1916 , trovandosi ad avere alle proprie dipen denze anche la Brigata Cremona (21 °e 22° Fanter ia) , c he teneva il fronte fra la Sella di q. 98-93 e q. 61, punto di contatto con il se ttore di Ronc hi, dov ' era la 16a Divi s ione.
Due giorni dopo, il 15 maggio 1916 , la sa Armata austro-ungarica fece eseguire delle offensive locali a scopo dimo strati vo nel setto re di Tolinino , n ella z ona de] San Mic he le ed in quella di Monfalcone: il R eggimento au striaco L andstunn " Eger" doveva attaccare le posizioni i taliane nel 1' officina di Adria e a q. 93 a est di Monfalcone.83
Il Reggimento Niv.a Ca va lleria era organicamente formato s u sei squadroni app i edati e due sezioni mitragliatrici Quattro squadroni ed una sezione mitragliatrici furono di s locati lungo le trincee di prima linea , un plotone occupò una lunetta avanzata presso q. 12 e, dei rimanenti squadroni, uno fu impiegato alla Marcilliana di riserva e l'altro con la seconda sezione mitragliatici a Molino Reis, pronto alla difesa costiera. I reparti in prima linea sulla sinistra e rano a contatto con i Lancieri di Vercelli , c he occupavano la trincea di Mandria e sulla des tra si appoggiavano al canale di porto Ro sega sino al mare , costituendo quindi l'estrema destra della linea di occupazione di Monfalcone, nella zona carsica. I primi giorni erano trascorsi in quasi assoluta tranquillità. La mattina del 14 l ' artiglieria nemica repentinamente diede segni di grande attività. Cominciò a sparare ed intensificò il tiro durante la giornata fino ad un vero e proprio bombardamento tambureggiante , con ogni sorta di calibri , proseguito nella sera e nella notte , tanto da sconvo l gere le trincee appena abbozzate dell ' Adria Werke. Queste ultime costituivano un facile bersaglio essendo situate in rilievo lungo l a s trada di Trieste, ben conosciuta dagli Imperiali. In quello stesso 14 maggio all'azione violenta e distruttrice delle artiglieria nemica si unirono i tiri della fucileria, nonché i reiterati interv e nti di aero plani, che volavano a quota bassa lanciando bombe che scoppiavano fragorosamente nel caseggiato di Adria Werke e s ulle trincee. Vers o le ore 23 .30 fu rallentato il tiro tambureggiante delle artiglierie. I cavalieri ne approfittarono per dar febbrilmente mano al riattamento delle trincee e delle postazioni delle mitragliatrici, in alcuni punti già rase al suolo. Intanto anche lo s quadrone di rincalz o della Marcilliana fu fatto ava nzare ad occupare il caseggiato di Adria Werke in attesa degli eventi . L 'alba del 15 non era ancora spuntata quando gli Imperiali con forze soverchianti, se pur non ben valutabi li , attaccarono improvv isamente le trincee dell ' Adria Werke , avendo facilmente ragione del plotone di s taccato a q. 12 e riu scendo a sfondare là dove la trincea non esisteva più e restava solo qualche intrepido cavaliere, prontamente abbattuto. L ' irruzione venne bravamente co ntenuta dagli squadroni di Nizza, con s uccessivi assalti alla baionetta in cui persero la vita numerosi ufficial i e so ldati. Quota 12 , c h e era stata perduta , fu ripre sa e poi perduta nuovamente e divenne ad un tratto l'oggetto a cui te ndevano i mas simi sforzi italiani e austro-ungarici. Intanto dai fo lti e in s idio si canneti del Lisert , fino a11ora ritenuti impraticabili , altri Imperiali giungevano di rinforzo , irrobus tendo il fronte avversario Un momento veramente tragico fu allora vissuto da Niv.a, quando questi rinforzi freschi e soverchianti sorpresero i Dragoni , già provati , stanchi , abbattuti dalla lunga ten s ione nervosa del giorno avanti e li costrin sero ad una lotta e strema. Sos pinti e sc ompaginati a piccoli g ruppi tra le ombre degli edifici diruti dell ' Adria We rk e, ingaggiarono ugualmente una lotta furiosa . Pri vati del comando e della gran parte degli ufficiali, che erano già caduti, petto contro petto , con i denti e con le unghie tenacemente i cavalieri si difesero, riuscendo a contrastare il passo ai soldati il cui obie ttivo ultimo era Monfalcone. Mentre i po chi rima sti combattevano di speratamente, sopraggiungevano

83 AUSSME B4 9651: Attacco contro la nostra 4a di visione di cavalleria e Monfalcone 15 maggio 1916. 111
 1916: trincee su l Carso: sullo sfondo l'Altopiano di Comeno.
1916: trincee che scendono da q. 77 alla Palude del Lis ert
1916: trincee su l Carso: sullo sfondo l'Altopiano di Comeno.
1916: trincee che scendono da q. 77 alla Palude del Lis ert
112
i rinforzi del Reggimento Vercelli ed altri elementi di fanteria , co n l'aiuto dei quali il nemico fu vo lto in fuga. Molto sangue corse in quel giorno e molti ufficiali e s oldati caddero. ma le ingenti perdite avversarie ed il forte numero di prigionieri rimasto nelle mani dei difensori fu il compenso dei cavalieri. Quota 12 era rimasta in mano al nemico , ma venne poi riconquistata il 14 giugno con una brillante operazione, insieme a parecchio materiale, dalla fanteria, con il concorso di aliquote del Nizza Cavalleria e dei Lancieri di Vercelli. Le perdite furono alte, ma non così spaventose come quelle vistesi in altre occasioni e in altri punti del fronte; Nizza : ufficiali morti 2, feriti J , dispersi O; sottuf ficiali e truppa: morti 32, feriti J 83, dispersi 26; Lancieri di Vercelli: ufficiali morti O, feriti 3, dispersi 2; truppa: morti 28, feriti 37, dispersi 26.

Infine nella notte tra il 28 e 29 giugno una parte del Reggimento Nizza, insieme a due compagnie di fanteria , partecipò ad un attacco contro quota 21, con notevoli risultati e consistenti perdite . 84
Mentre si svolgevano questi avvenimenti sul fronte della VII Brigata , gli Imperiali bombardarono violentemente le posizioni occupate dall'VIII , provocandole gravi perdite e, alle 17 circa, lanciarono contro di essa un violento attacco. Riu sciro no ad imporsi temporaneamente nelle trincee tenute dal Reg gimento Treviso (Trincea del Tamburo), ma vennero ricacciati da un pronto contrattacco degli squadroni I 0 e IV 0 , che riconquistò la posizione catturando circa 150 austriaci. Nel frattempo però, sulla destra, il Reggimento Guide, attaccato sua volta, dovette ripiegare e, a questo punto , trovand osi il fianco indifeso , anche Treviso fu costretto a seguirne i] movimento. Vennero così sgombrati il Tamburo di q. 93 e le trincee che scendevano verso la ferrovia
Giunti in rinforzo il IW22° Fanteria , i Bersaglieri del IV e XI Battaglione Ciclis ti ed il L e LI Battaglione del 15° Reggimento Bersaglieri, l'avanzata del nemico fu contenuta e venne anche riconquistato un tratto della trincea limitrofa a quella tenuta dalla Brigata Cremona. Le perdite subite in quella sola giornata dall 'V III Brigata di Cavalleria furono: Reggimento Guide, ufficiali: morti 1, feriti 3, dispersi 4; truppa: morti 33 , feriti 199, dispers i 51; Reggimento Treviso, ufficiali: morti 4, feriti 9, dispersi 2; truppa (molti corpi erano così orribilmente mutilati, letteralmente ridotti a brandelli, che non poterono essere co ntati con precisione) fra morti, feriti e dispersi: 457. Secondo la relazione della Divisione , i morti di truppa sarebbero stati 170, 156 i feriti e 94 i dispersi. Poiché l 'avversario fece ascendere in complesso a 150 i prigionieri fatti e di questi circa un centinaio appartenevano agli altri reggimenti, i] Treviso avrebbe avuto circa una cinquantina di prigionieri e quindi dei 94 dispersi una quarantina sarebbero stati uccisi. Il totale dei morti sarebbe salito oltre i 200, il che rappresentava una perdita percentuale sulla forza di reparto fra le più gravi della guerra, almeno fino a quel momento Ovvio che in queste condizioni, nella notte dal 15 al 16 e nella mattina del 16, il Reggimento Treviso venisse sostituito. Le Guide invece rimasero in linea, insieme a truppa di fanteria , e su birono ancora qualche p erdita (cinque feriti) prima d'essere inviate a riposo, il 17 se ra. Rimase in linea come rinforzo di truppa di fanteria invece la VII Brigata di Cavalleria sulla fronte Mandrie-Adria85
Il Treviso, dopo un breve riposo, fu trasferito a Vem1egliano-Selz e sostenne altri combattimenti: il suo 2° squadrone, i] 28 e 29 giugno, conquistò la posizione di q. 77 di Selz.
H• AUSSME- B4 4111 Comando de ll a VIl brigata di cavalleria: Relazione del comandante la brigata maggior genera le A. Milanesi. ·
Ns AUSSME 84 9651: Attacco contro la nostra 4° divisione di cavalleria e Monfalcone, 15 maggio 1916.
113-
 Fante in azione co n la mitragliatrice in una trincea di prima linea.
Soldati italiani ammassati nelle trincee di 1• 1inea ad est di Monfalcone. ve rso q. 77
Fante in azione co n la mitragliatrice in una trincea di prima linea.
Soldati italiani ammassati nelle trincee di 1• 1inea ad est di Monfalcone. ve rso q. 77
-114-
 Panorama dell'Adriawerke e dei Cantieri Navali visti dalle posizioni austro ungariche dell'Hennada nell 'a utunno del 1916.
Dalla q.85 verso il cant iere navale: in primo piano reticolati e cadaveri, primavera del l 916.
Panorama dell'Adriawerke e dei Cantieri Navali visti dalle posizioni austro ungariche dell'Hennada nell 'a utunno del 1916.
Dalla q.85 verso il cant iere navale: in primo piano reticolati e cadaveri, primavera del l 916.
115
 L ' Adriawerke vista dalle posizioni austro ungariche di q. 77 nel 19 I6.
L ' Adriawerke vista dalle posizioni austro ungariche di q. 77 nel 19 I6.
116
 Traspo1to cadaveri dopo un assalto s ulle alture di Monfalcone nell'estate del 1916.
Traspo1to cadaveri dopo un assalto s ulle alture di Monfalcone nell'estate del 1916.
J 17
 L' Adriawerke nel 1916.
L' Adriawerke nel 1916.
118-
OFFENSIVA IN ASIAGO
Nel maggio del 1916, cominciata l ' offensiva austriaca degli Altipiani- la Strafexpedition la 2a e la 3a Divisione di Cavalleria , ancora montate, furono immediatamente mandate a presidiare gli sbocchi delle valli che scendono alla pianura vicentina, ma non ebbero occasione di intervenire. A contrastare il nemico avanzante veniva invece mossa immediatamente la IV Brigata di Cavalleria, composta dai reggimenti Aosta e Mantova.
Il 12 maggio 1916 la Brigata , in previsione di un suo possibile imminente appiedamento, si tro vava a Villanova sul Iudrio , al campo di addestramento per la distruzione di reticolati. Poi venne spostata verso l'Isonzo. Il 31 maggio le fu ordinato di coprire la radunata della Y Annata, destinata a bloccare la Strafexpedition e in quel momento in via di costituzione nel Vicentino , nel settore delimitato ad ovest dall' Astico, ad est dal Brenta fino a Cartigliano e dalJa strada Cartigliano Nove Marostica-Crosara.86 Il comando della Brigata disponeva in quel momento del Reggimento Mantova e di un gruppo di formazione cli due squadroni, provenienti dai reggimenti Lucca e Umberto /. Terminata l'attività di pattugliamento a copertura della costituenda 5a Armata e cessata l'emergenza d'Asiago, in luglio le unità sarebbero state trasferite nella zona tra Brescia e Mantova. Ben altro intanto era stato l 'impegno delle altre unità di cavalleria sul medesimo Altopiano, su cui ogni azio ne di massa di cavalleria è destinata a fallire per via del terreno Dopo aver contrastato dinamicamente ed aver rallentato l'irruzione nemica su Asiago , 87 nel giugno 1916 i1 3° e 4° Squadrone dei Cavalleggeri di Padova, unitamente al giovane Reggimento Cavalleggeri di Palermo ed a l 5° Squadrone dei Cavalleggeri di Aquila, contribuirono a terminare con successo le operazioni sull'altipiano di Asiago, specialmente nelle giornate del 26 e 27 giugno.88 Seguiamone le operazioni. Alle 15.30 del 25 giugno 1916 il comando della cavalleria riceveva a Breganze l 'ordine di partire al più presto per San Giacomo di Lu siana con gli squadroni dei reggimenti Palermo, Aquila e Padova ed i nuclei ciclisti reggimentali.
Il comandante del R eggimento Cavalleggeri di Palermo, giunto per primo a San Giacomo, prese g li ordini per effettuare cogl i squadroni un'incursione sull'altopiano. Doveva raggiungere come primo obiet tivo Gallio , Asiago e Camporovere. Se avesse trovato sgombre queste località , la cavalleria avrebbe dovuto raggiungere le retrovie nemiche sulle strade della loro ritirata che, irradiandosi dall'Altopiano, risalivano la zona montuosa verso nord cioè : Gallio Valle di CampomuJo Asiago Giardini-Camporovere-Val d'Assa Nel raggiun gimento di questi obiettivi. i cavaJleggeri dovevano trarre il maggior profitto dalla si tu azione favorevole data dal nemico in ritirata. Prima di iniziare l'operazione dovevano essere presi accordi con il comandante della 28" D ivisione e quindi coi comandi delle B rigate L ombardia ed Arno. Alle 22.30 giunsero a Mosca i ciclisti, trasp01tati da autocarri e, poiché era giunto avviso dalle due brigate che l 'incursione poteva senz'altro essere effettuata, essi furono lanciati su Asiago, dove giunsero i ntorno a mezzanotte. Qui effettuarono il collegamento con il comandant e di un battaglione del 213° Fanteria, che stava per giu ngervi. A mezzanotte giunsero a Mosca i cinque squadroni di cavalleria, due di Palermo , due di Pado va e uno di Aquila. Mentre i cavalli prendevano un breve riposo, gli ufficiali furono edotti sull'operazione e sJll modo in cui doveva svolgersi. Ciascuno dei comandanti si vide assegnare la propria missio-
86 AUSSME -142S lOE Diario storico delle IV brigata di cavalleria 2 " divisione.
87 Per un approfondimento rimando a Paolo POZZATO, Un anno s ull 'altipian o con i diavoli rossi. Storia della brigata Sassari e Reggio nella Grande Guerra. Udine. Gaspari editore. 2006.
88 PEZZI-SIBONI e RAVAGNATI-LARGIUNI, op. cit. ·

CAPITOLO X
-119-
ne. Nessun compito era in termini troppo rigidamente determinati: la mis sione degli squadroni doveva cessare là ove sarebbe stata contrastata da forze nemiche preponderanti, in modo che le resis tenze avrebbero di per sé stesse tracciato la linea suUa quale il nemico appoggiava la sua nuova difesa. Alla 13.00 del 26 tutto il Reggimento di formazione partì, nel1 'ordine secondo il quale le varie colonne avrebbero dovuto deviare per seguire la strada a ciascuna assegnata , raggiungendo in tal modo, senza interruzione di marcia, i primi obiettivi. Così il 5° Squadrone di Aquila, comandato dal capitano Del Carretto, che marciava in coda , al bivio del Turcio deviò per la strada del Pennar e, rotti i reticolati in prossimità di Asiago, vi penetrò da sud , dopo aver fatto riconoscere convenientemente l ' abitato. I quattro rimanenti squadroni mar ciarono in colonna fino al bivio di Bertigo , dove i due di Padova al comando del capitano Spadaccini proseguirono per Gallio e vi giunsero alle ore 13 .30. I due ultimi squadroni, di Palermo , deviarono invece per Zocchi e, dopo aver tolti i reticolati nemici in vicinanza di Asiago , vi entrarono alle ore 16 previa ricognizione. Tanto Gallio che Asiago erano in fiamme e Ie pattuglie delle due colonne provenienti da Pennar e da Zocchi si collegarono nell'abitato devastato e deserto. Nella piazza di fianco alla chiesa, il cui campanile non era del tutto crollato e quindi era ancora visibile a distanza, si stabiu il posto di raccolta notizie. Raggiunta così la linea Gallio-Asiago eri.conosciuto che questi due centri erano sgombri dal nemico, ogni colonna si avviò per assolvere il secondo compito, precedentemente assegnato a ciascun comandante.

La colonna Padova, diretta su Gallio, oltrepassato il paese risalì la valle di Campomulo, malgra do un'interruzione stradale ed il fuoco di artiglieria nemica da cui era bersagliata. A due chilometri da Gallio ottenne il collegamento con il 138° Fanteria e intorno alle 8 30 giungeva a Marcesina, senza trovare tracce del nemico. Siccome la sua presenza poteva ostacolare l'azione della fanteria, il coman dante decise di ripiegare su Gallio , il che fu fatto sotto l'azione del fuoco d ' artiglieria avversaria, arri vandovi a mezzogiorno. Qui fece una breve sosta e, non avendo ricevuto l'ordine che gli era stato mandato, di mantenere cioè il collegamento con semplici pattuglie e di ritirarsi su Asiago , per iJ caso si dovesse procedere ad altra operazione, di propria iniziativa ripiegò . Questo movimento avvenne a gruppi per la strada Gallio-Asiago ed in parte sul fondo del Ghe l pac, senza seri inconvenienti, sebbene il tiro dell'artiglieria nemica, che aveva scorto la colonna, cercasse seriamente di ostacolarlo Alle ore 14 la colonna Palermo , comandata dal tenente colonnello Manzotti, da Asiago si mise in marcia per Costa e Giardini , dopo aver fatto riconoscere 1'abitato di Rodighieri. A q. 1103 fu raggiunta dal nucleo ciclisti provenienti da Gallio, che furono subito impiegati quale avanguardia del gruppo di squadroni. Nell ' avanzata la colonna fu sottoposta a fuoco nemico che, dalJa direzione, iJ comandante stabili proveniente dal Mosciagh e, dati gli effetti , classificò come di artiglieria da mon tagna. Alla terza svolta trovò la strada interrotta da esplosioni di mine, ma, deviando , passò oltre, sempre sotto il fuoco d ' artig l ieria , raggiungendo il bivio delle mulattiere che conduce a Monte Zebio. La marcia divenne sempre più difficile per altre interruzioni stradali provocate da mine esplose e abbattute di abeti. Ciò nonostante, la colonna proseguì per Monte Zebio, fortemente occupato dal nemico, che vi stava costruendo reticolati; mantenne il contatto con pattuglie e, con giusta percezio ne de] pericolo cui poteva andare incontro, evitò di percorrere la strada già fatta, dove il nemico le aveva certamente preparato qualche insidia nei punti interrotti.
Il comandante stabilì che i ciclisti rimanessero in retroguardia e , sebbene sotto il fuoco della artiglieria nemica, con una marcia fatta in parte a piedi con i cavalli alla mano , scese in Val di Nos raggiungendo la strada Gallio-Asiago a villa Rossi . A questo punto la colonna fu fatta segno a colpi di grosso calibro, ma il comandante raggiunse ugualmente Asiago a scaglioni, passando nel fondo de l Ghelpac, sempre inseguito dal fuoco nemico, che fu poi aJlungato contro Asiago stessa dopo che la colonna vi era entrata.
Il 5° squadrone dei Cavalleggeri dell'Aquila , lasciata Asiago alle ore 14.30, si diresse su Camporovere ma, appena oltrepassato l'abitato . fu accolto da fuoco di fucileria proveniente dalle falde meridionali del Monte Rasta. Il comandante vi constatò una forte presenza di fanteria in due ordini di trincee con reticolati e ne valutò la forza a una compagnia con mitragliatrici. Lo squadrone 1ispose al
120-
Truppe di rincalzo in marcia sug li altopiani.
fuoco, sia per guadagnar tempo che per riconoscere meglio il terreno ed informarsi più esattamente del l'entità delle forze nemjche c he aveva di fronte, disimpegnandosi solo all'arrivo di una mezza compagnia di fanteria che lo rilevò Quindi rimon tò a cavallo, in attesa del momento propizio per spinger si nuovamente in ricognizione nella Val d' Assa e sul Monte Interrotto . Constatata però l'impossibilità di procedere oltre, ebbe l'ordine di tenersi da quella parte a contatto con il nemico con pattuglie e di diri gersi col grosso s ulJ 'abitato di B osco per riconoscerlo . Alle 16.15 il comandante dello squadrone infor ma va che Bosco era occupato dal nemico, il quale tendeva a scendere con grosse pattuglie anche da Buscar su Asiago. Fu mantenuto il contatto per tutto il giorno anche da quella parte dal grosso delJo squadro ne , che poi si ritirò provvisoriamente ad Asiago sotto il fuoco dell ' artiglieria nemica
La situazione· restò così per qualche ora, in attesa dell'avanzata della fanteria ad Asiago, ove però rimase effettivamente fino alle 18 solo i l Reggimento di Cavalleria, mentre la città era fatta segno a un bombardamento intenso , che impediva qualsiasi movimento . I cavalieri sbarrarono le su·ade di accesso e costruirono linee di reticolati coll'abbondante materiale che si trovava ovunque, presidiando ogni settore così protetto co n un plotone per tutta la notte fra il 26 e il 27 Alle ore 16.30 il comando del reggimento ricevé gli ordini di operazioni seco ndo i quali, in cooperazione con un battaglione del 213° Fanteria e con un'altra compagnia mjtragli atrici , avrebbe dovuto operare in Valle d 'Assa. Una ricognizione fatta esegui re alle pattuglie e l'intensificarsi in quel momento del fuoco di fucileria nemica , appostata in trincee paral lele alla strada che rimonta la Val d' Assa , consigliarono di far eseguire l'operazione al nucleo ciclisti seguito da uno squadrone rinforzato, tenendo gli altri ad Asiago, pronti a intervenire. Alle 18 30 l'operazione iniziò con i ciclisti all'avanguardia, i quali, giunti a casa Rutser, furono accolti da fuoco di fucileria nemica proveniente dal L ambara, fuoco che superarono fac ilmente proseguendo per Camporo vere.
L 'uscita dei cicl isti dal paese fu contrastata da un altro tiro di fucileria nemica , proveniente stavolta dalle falde del Monte Rasta . Il comandante del nucleo appiedato rispose aJ fuoco , per tenere impegnato il nemic o e dar modo così allo squadrone, che stava ruTivando, di olu·epassare Camporovere. Appena giunto, lo squadrone non trovò ancora nessun Battaglione, né la compagnia di fanteria che avrebbero dovuto

-121
esserci. Allora i cavalleggeri si portarono a sud della strada di Camporovere, sottoposta al fuoco di fucileria e artiglieria nerrùca, riuscirono ad entrare nell ' abitato e vi trovarono il nucleo cicUsti fortemente impegnato. Giunto anche un reparto del 213° Fanteria al comando di un maggiore, furono fatti diversi tentativi per uscire dal paese, ma tutti inutili. Vi rimasero feriti il sottotenente Croppi ed il capitano Spadaccini. Visto vano ogni sforzo di proseguire sulla strada di Val d' Assa, fortemente battuta, ed essendo entrata in azione anche la fanteria italiana, lo squadrone iniziò il ripiegamento su Asiago, seguito anche dai ciclisti. Alle ore 21, nell 'oscurità, si avvicinò alla posizione di Camporovere un battaglione di fanteria proveniente da Zocchi ed i cavalieri, impossibilitati ad operare, rimasero ad Asiago pronti ad intervenire. Al mattino del 27, Asiago fu fatta segno ad un intenso bombardamento nemico con grossi calibri. Essendo pericoloso rimanervi coi cavalli, il Corpo d'Armata ordinò il ripiegamento s u Campo dj Mezzavia. Facilmente individuati, i cavalleggeri furono fatti segno al fuoco d'interdizione lontana dell'artiglieria nerrùca, per cui il comandante della 28a Divisio ne ordinò la sospensione del ripiegamento degli squadroni fino a notte inoltrata.
Anche lo squadrone che era rima sto di collegamento tra le truppe della 28a Divi sio ne e quelle operanti sull'Altopiano , il giorno 27, dopo aver svolto il suo servizio con pattuglie appiedate, ripiegò e si riunì al Reggimento a Campo Mezzavia. Concluse la sua relazione il comandante:
"Se il reggimento ai miei ordini non raccolse, intimo desiderio di tutti, risultati tangibili nella prima parte della sua operaz;ione, dipese dall'essersi il nemico ritirato silenziosamente ed accortamente fin dal giorno innanzi. Tuttavia nella seconda parte, con intelligente ed ardita esplorazione, gli squadroni riuscirono in poche ore ad avere esatta visione della ritirata del nemico e tracciare la sua nuova linea di resistenza. Così fin dalle primissime ore del giorno 26 si riuscì a stabilire che Gallio-Asiago e Camporovere erano sgombre e che non si sarebbe trovato nemico, se non oltre Marcesina, la cresta di Monte Zebio e alle falde del Monte Ra.sta. Ciò era stato richiesto alla cavalleria come definitivo compito, e questo compito,fu pienamente e sollecitamente raggiunto. " 89
Uomini e cavalli diedero prova di grande resistenza, perché alcuni s quadroni percorsero in conti nuazione oltre 65 chilometri in condizioni molto disagiate e fu quasi una prova per le grandi operazio ni che di li sarebbero seguite e nelle qua]i la cavalleria riprese il suo posto nella storia della guerra. Il diario del reggimento parla di "mirabil e comportamento dei cavalie1i" ma , con obiettività, non tacque nulla e riferì anche il comportamento poco edificante di due graduati, che non fecero completamente e sollecitamente il loro dovere e furono quindi retrocessi di grado davanti a tutto il reggimento riunito. I due erano il caporale Tartaglino , "perché disorientatosi nelle retrovie non raggiungeva il proprio repar to e rientrava a Pria dell 'Acqua propalando esagerate notizie sulle perdite subite gli squadroni" ed il serge nte Monteverde il quale "disorientatosi nella ritirata non escogitava le conoscenze in possesso di un sottufficiale per raggiungere il proprio reparto unitamente ad altri cavalleggeri dispersi." È degno di nota che il metodo deU'efficienza, voluto dal Comando Supremo ed attuato in alto coi siluramenti , cominciasse a fare presa anche sulla truppa con punizioni più morali che fisiche. Le perdite subi te dagli squadroni furono lievi: due ufficiali feriti, uno dei quali gravemente; tre morti e 19 feriti fra la truppa; sei cavalli morti, 28 feriti ed uno disperso. Furono presi cinque prigionieri co n arrrù e rnunizioni.90
89 AUSSME R elazione del comandante del Reggimento dj cavalleria Cav alleggeri dell'Aquila. 90 AUSSME B4 9652 Altopiano di Asiago, giugno 1916, Comando del XIV Corpo d'Armata San Giacomo di Lusiana R eggimento Cavalleggeri di Palenno: relaz ioni sulle operazioni svolte dagli squadroni di cavalleggeri di Palermo-PadovaAquila, nei giorni 25, 26, 27 giugno sull 'altopiano di Asiago. Nei diari storici delle brigate di fanteria coinvolte, come la Milano o la Sassari. per fare un esempio , nei combattimenti, manca un riscontro di conferma sull'azione specifica della cavalleria sul l'altop iano. Va ricordato, inoltre , c he vi era da parte delle truppe coinvolte la mancanza di una di.retta co noscenza dei lu ogbj e una deficiente cartografia (erano carte al 100.000) insufficiente ad un efficace orientamento ed esatta conoscenza dei luoghi.

122-
RITORNO SUL CARSO: LA PRESA DI GORIZIA
Nel seco ndo semestre del 1916 la mobilitazione delle risorse industriali , lo sfruttamento del potenziale umano e l'adeguamento alle regole della guerra di materiali, fatta di preponderanza nel numero di battaglioni e pezzi d ' artiglieria, nella quantità di armi, munizioni , mezzi tecnici e logistici di ogni genere , resero il R egio Esercito uno strumento bellico adeguato alle necessità imposte dal conflitto. L'arti g lieri a riuscì a soverchiare il dominio della mitragliatrice sul terreno, distruggendone le postazioni con il fuoco di distruzione , ma per la cavalleria non c ' era, in una guerra del genere , nulla o poco da fare , nonostante ancora sull'altopiano di Asiago avesse dato buona prova di sé e , appiedata, avesse in genere dato risultati brillanti, soprattutto grazie al suo spirito aggressivo ed impavido.

L 'Esercito italiano era ormai stato messo in condizione di impone aU ' avversario il peso della battaglia di materiali, supportata dal pronto ingresso di riserve fresche, per alimentare lo sforzo e superare l'inevitabile logoramento imposto dalle terribili condizioni di vita e lotta nelle trincee. Alle nuove divi s ioni ed alla potenziata artiglieria it aliana però le truppe austro-ungariche sc hierate lungo l ' I sonzo e sul Carso potevano opporre linee difensive più solide. In mesi di estenuante scavo, i genieri austro-ungarici, le squadre di lavoro e le ste sse truppe, libere dai compiti di vedetta, avevano inci so in profondità la dura roccia carsica per ricavarne caverne e trincee.
La seco nda linea austriaca, partendo dalla foce del Vipacco, includeva nel tracciato il Monte San Michele, si inarcava sulle cime del Cmi Hrib e del Debeli e si co11egava alle posizioni nei press i di Quota 121. Il caposaldo della seconda linea rimaneva il San Michele, che, per il fatto di essere la chiave difensiva delJ'altopiano di Doberdò , divenne un l abirinto trincerato, nel quale le rispettive posizioni obbedivano alla logica del continuo adattamento alla situazio ne. Dietro la seconda linea, ad est del Vallone , era stata attrezzata la " Posizione Vallone ", terza linea difensiva: appoggiandosi con l'ala destra all'ansa del Vipacco ne i pressi di Raccogliano , partiva dal Convento di San Grado di Mema , passava per la Quota 212 del Nad Logem , Vizintini , Palchisce, Ferleti , Boneti, Quota 175, Quota 235, Jarniano , Qu ota 131, Flondar, Quota 145, Quota 199 , terminando presso Duino.
Tenendo ben presente l' eventualità della perdita del San Michel e, era stata tracciata una linea intermedia di contenimento tra la seconda e la terza s ul tratto Gabria-Gorn e Bres tovec-Quota 110Marcottini. Tale linea s i ancorava alla terza s ulla destra, presso Pri Stanti, e alla sec onda sulla sinistra, in cima al Crni Hrib. Il fronte sud occidentale fu poi rafforzato con i mezzi che lo sforzo logistico-o rganizzatjvo aveva messo a disposizione. Ciò nondimeno l' inferiorità numerica e materiale dell ' armata dell'Isonzo non le permetteva d i passare all'offensiva ne l corso del 19 16.
La testa di ponte di Tolmino , quella di Gorizia ed il Carso di Doberdò erano in grado dì regge re l'assalto italiano ; pure , laddove questo si scate nav a, costringeva l'armata del generale Boroevic a lottare per sopravvi ve re. Per l'esercito imperiale le prospettive per il 1916 non erano rosee ed i fatti lo dimostrarono.
L ' offensiva di maggio dal salien te trentino, passata aJJa s toria con il nome di Strafexpedition (sped izione punitiva) , fallì nel suo disegno strategico: la di scesa dagli altipiani e la presa al1e s palle delle armate italiane sc hierate a lla fronte giulia. Contemporaneamente, tra maggio e giugno, si sca tenò l 'i mprovvi sa, violenta offensiva ru ssa che apri la breccia di Lutsk, in Volinia; le truppe austroungariche de] settore ve nnero travolte o coinvolte nella rotta.
La crisi su l fronte orientale non so ttrasse ingenti forze al teatro bellico italiano, ma costrinse l'esercito imperial regio a rimanere sulJa difensiva, nell ' attesa della prevedibile offensiva d 'estate
CAPITOLO XI
-123-
italiana. Con una riuscita operazione tattico-logistica il generale Cadorna trasferì sulla fronte giulia le truppe che gli erano servite per arginare l'avanzata austro-ungarica in Trentino e lanciò in agosto la sesta offensiva sull'Isonzo, godendo della piena superiorità numerica e materiale.
Furono adottate delle innovazioni tattiche. Nei combattimenti passati si usava allungare il tiro delle artiglierie quando le truppe uscivano dalle trincee, un fatto che permetteva al nemico di guadagnare l'attimo necessario per prender posizione e aprire il fuoco con le mitragliatrici.
Si cercò allora di fare in modo che le fanterie avanzassero sotto l'arco della traiettoria dell'artiglieria, in modo da giungere a ridosso delle trincee nemiche contemporaneamente all'allungamento del tiro. Gli avversari, costretti a rimanere al riparo fino all'esplosione dell'ultima granata, si sarebbero trovati addosso gli attaccanti prima di poter abbozzare una reazione. La tecnica venne in aiuto alla tattica ossidionale: il massiccio uso delle bombarde, che divennero ben presto una specialità italiana, risolse almeno in parte il problema dei reticolati , un ostacolo che arrestava lo slancio della fanteria, permettendo all'artiglieria e alle mitragliatrici di infierire più a lungo s ull e ondate all'attacco. L ' azione contro il campo trincerato di Gorizia si svolse fulminea, in sincronia con l'attacco della 3a Armata sul San Michele. L'improvvisa caduta del Sabotino fu l'elemento che compromise la tenuta della testa di ponte da parte austro-ungarica. La mancanza di consistenti riserve e le perdite della 58a Divisione indussero il comando del fronte sud-occidentale ad ordinare il ripiegamento a oriente di Gorizia. A sua volta Boroevic impartì anche l ' ordine di sgombero del Carso di Doberdò. La riti rata austriaca non si trasformò in una rotta perché l'Armata deJ Duca d'Aosta non si accorse dell' abbandono delle posizioni da parte dell'avversario. Cinque giorni di furiosi scontri sull'altopiano carsico avevano d'a ltro canto logorato anche le divisioni italiane , ormai trincerate sulla sommità del Monte San Michele. All 'alba del 10 agosto le truppe italiane si diedero ad inseguire iJ nemico di propria iniziativa, provando per la prima volta l'ebbrezza e l'inquietudine dell 'av anzata senza contrasto sul terreno aperto. L ' XI ed il XIII Corpo si inoltrarono sul terreno quasi privo di rotabili , fra trincee, doline ed i soliti muretti io pietra carsica, che creavano non poche difficoltà alle truppe in marcia con jl loro incrociarsi labirintico e irregolare. Le alture ad est di Monfalcone vennero abbandonate il 12 agosto ( D ebeli, Quota 121 , Quota 85) . 91
I reggimenti della V Brigata della 3a Divisione di Cavalleria nell'agosto del 1916 parteciparono e si distinsero nella battaglia per la l iberazione di Gorizia . IJ 9 agosto 1916 la 3a D ivisione di Cavalleria si avvicinò alla z ona di operazio n i della 3a Armata. La V Brigata era composta dal Comando D ivisione , dai reggimenti Cavalleggeri di Salua,o e Cavalleggeri di Vìcenza , dal IX Battaglione Bersaglieri Ciclisti e da una sezione di auto-mitragliatrici; la VI B rigata da Savoia Cavalleria , dai La,ncieri di Montebello e da una batteria a cavallo.
D opo la presa di Gorizia , la Divisione fu improvvisamente chiamate a cooperare allo sfondamento delle linee avversarie. Era sbarcata dai treni la sera del IO agosto a Cormons , dove ricevè l'ordine di occupare i nodi stradali di Schonpass e D oremberg, appena le fanterie avessero aperto un varco nelle linee nemiche.All'alba dell ' indomani si recava sull' Isonzo, al ponte di Mainizza e, percorrendo con i cavalli condotti a mano i camminamenti abbandonati dal nemico sulla sponda sinistra del fiume, la testa di essa si porta va a poche centinaia di metri dalle trincee nemiche, per non lasciarsi sfuggire l'attimo favorevole all ' adem pimen to del compito assegnatole. In tale operazione fu ammirevole il contegno delle truppe che, malgrado le perdite, percorsero senza alcuna esitazione o defezione , sotto il tiro aggiustato delle artiglierie nemiche, tanto il quachivio di Mainizza quanto il ponte omonimo, a più riprese colpito, interrotto e riparato

L'll agosto 1916 al Comando del1a V Brigata di Cavalleria fu da t o l 'ordine, come primo obiet tivo, di assicurare i nodi stradali di D omberg e di Schoenpass e, come obiettivo ulteriore , di occupare la conca di Aiduss in a, spingendo punte verso Zolle Vipacco. La conca di Aidussina apriva la stra
-VOLPJ, Sui sentie ri della prima guerra mondiale , op. cit.
91 C ERNIG01-CucINATO
-124
da per l ' interno dell ' Impero ed era, qualora fossero state conquistate le vette circostanti, percorribiJe da reparti di cavalleria. La resistenza del nemico in zona tendeva a coprirne il ripiegamento ed il rafforzamento su posizioni arretrate , nonché la messa in batteria di artiglierie pesanti.
La fanteria prese contatto con il nemico s u una linea di due chilometri ad est di Gorizia e , a sud, per Vertoiba verso San Grado di Mema. L ' 11 la linea fu fortemente battuta dall'artiglieria per sfondarla ed irrompere oltre.
In questa situazione si prescrisse alla cavalleria, grazie alla sua celerità , di passare, cader e alle spalle dell'avversario e fame crollare la resistenza. Ovviamente chi stilò l'ordine non conosceva affatto il terreno che da Vertoiba sale verso San Grado di Mema , rotto da grize e con una pendenza particolaimente pronunciata. Per aprirsi la strada il comando intendeva, ad onore della verità, impiegare la Brigata , sostenuta dal IX Bersaglieri Ciclisti e da una batteria de11a prima sq uadri glia automitragliatrici, impiegando queste sop rattutto sulle direttrici Aidussina-Schoenpass e Gorizia Domberg. Le rimanenti truppe sarebbero rimaste a disposizione, per rinforzare quelle che si fossero poi trovate nelle migliori condizioni di agire alle spalle dell'avversario. Così all'alba la V Brigata si trovò incolonnata su lla strada San Lorenzo di Mossa-Mariano, con la testa alla chiesa di San Lorenzo di Mossa, avanzò alle 9.45 ed iniziò operando ver so il Vallone
Il 12 agosto Genova Cavalleria occupò l'Altopiano di Doberdò e Monte Cosich e, in coopera zione con la Brigata Cremona, conqui stò quota 144; mentre i Lancieri di Novara combattevano sul Monte Cosich e su l Debeli e venivano poi schierati sulla linea Mucile-quota 121, dove sare bbero rimasti fino a tutto il dicembre 1916 92
Il 13 agosto 1916 gli Imperiali furono respinti da q. 212 a sud del Vipacco ed a Oppacchiasella , a nord del Vipacco. O ccupavano in quel momento in modo saldo tutte le linee del fiume Vertoibica e tutte le linee ad est di Gorizia, in forti trinceramenti, ma ancora co n una scarsa quantità di uominj, per di più molto scossi . Un'azione ardita alle loro spall e avrebbe forse provocato un crollo morale che, con la disorganizzazione dei movimenti nelle retrovie, avrebbe probabilmente costretto i nostri avversari ad un ' ulteriore ritirata. P er raggiungere questo scopo era necessario che le truppe italiane si trovassero aperta la strada pedemontana che corre parallela a sud del Vipacco, strada che era facilmen te percorribile da reparti celeri , a differenza della zona di San Grado di Merna. In tal modo avreb bero potuto attraversare il fiume ad est di Biglia, per agire sulle strade a levante della Vertoibica.
A questo punto urgevano informazioni ed era necessario che l a cavalleria le reperisse con una ricognizione. P er farla fu ritenuto sufficiente l'impiego di una brigata e di un battaglione ciclisti. Il compito fu quindi affidato alla V Brigata ed al XII Battaglione Ciclisti , messo alle sue dipendenze 93
I Cavalleggeri di Saluzzo furono ammassati a sud di Villanova , a ridosso del Monte Fortin; il Re ggime nto Cavalleggeri Vicenza fu messo in riserva. Saluzzo eseguì l'incarico, scoprendo che da sud del fiume Vipacco alla chiesa di San Grad o le linee erano tutte occupate da fanterie munite di numerose mitragliatrici ed artiglieria, come ad est di San Grado, verso il cimitero di Biglia. Dopo aver effettuato ricognizioni nella piana di San Pietro di Go.rizia, il R eggimento ripiegò sulle alture di Monte Fortin, presso San Lorenzo di Mossa.
Per quanto riguardava l'altra Brigata di Cavalleria , anche i suo reggimenti avevano preso parte alla battaglia di Gorizia: Savoia aveva passato l'Isonzo sotto il fuoco nemico, per poi spostarsi a Peteano, mentre Monrebello si era trovato nel settore ru Monte Fortin, sube ndo perdite in uornin:i e caval li.
Non fecero molto di più perché, vista l'impossibilità di operare efficacemente, alla Di v isione di Cavalleria era stato ordinato di tenersi in posizione d'attesa, a cavallo del Vi pacco, per cui per sette giorni consecutivi era rimasta intorno all'Isonzo , col Comando tra Boschini e Rubb ia e con reparti oltre il
92 AUSSME Diario s torico delle divi s ioni di cavalleria.
91 AUSSME 142S 12E V brigata di cavalleria , 3• Divi sione.

125
Vipacco. Il settimo giorno le superiori autorità, ritenuto ormai impossibile lo sfondamento deUe linee nemiche , le avevano ordinato d'arretrare. In quel lasso di tempo erano stat i impiegati due battaglioni di B ersaglieri Ciclisti. in cooperazione con la fanteria, per tentare di rompere le resi stenze nemiche, mentre le autom itragliatri ci blindate divisionali avevano fatto un prezioso lavoro di avanscoperta, portandosi si no sulle trincee austriache, tanto che uno dei loro ufficiali era rimasto ferito da una bomba a mano.94 Poi , iJ 17 agosto 1916, constatata l'impossibilità di proseguire e la necessità di rafforzarsi sulle posizioni co nqui state, alla 3a Di visione di Cavalleria fu impartito l'ordine di rientrare nei propri alloggi.
Con la caduta della testa di ponte di Gorizia nell 'agosto 1916, gli Austro-Ungarici, già duramente provati su l fronte o riental e, dove erano in ritirata a seguito della catastrofe di Luck, dove si era appena aperta una gigante sca falla nelle loro linee in seg uito all'offensiva del generale russo Bru s ilov , furono costretti ad arretrare anche ne l settore meridionale del Carso. Lo fecero abbandonando il pilastro ango lare del Cosich, fino allora inespugnabile, ritirandosi sulle alture c he sbarrano ad oriente la conca del lago di Doberdò e sovrastano quello di Pietra.rossa.
L 'autunno del 1916 vide le coJline del monfalconese diventare un immenso agglomerato di trincee, depositi e strutture per il ricovero dei rincalzi. La linea del fronte di combattimento rimase ancorata fino al maggio 1917 a ridosso delle alture che fasciano la strada del Vallone, nel tratto che emerge dal solco Devetachi-Boneti fino allo sbocco presso San Giovanni di Duino: giogo di Jamiano , falde occidentali di Quota 144 (Aru pacupa), Quota 100, alture del Locavaz, San Gio vanni.
Alla 3a Armata l 'a utunno portò piani di battaglia; più esattamente, col benestare di Cadorna, si pianificò la VII Battaglia dell'Isonzo e la si ini ziò il 14 settembre.
Per la cavalleria, furono coinvolti i Cavalleggeri di Roma che nei primi due giorni 14 e 15 settembre 1916 attaccarono quota 77 a s ud di Pietra.rossa , ripetendo gli assalti per ben sei vo lte consec utive e s ubendo forti perdite. La 3" Armata infatti aveva pre parato su l Carso l 'attacco delle pos izioni nemich e ad est di Oppacchiasella e, con la sua ala sinistra, vo leva cercare di raggiun gere le alture del Volkovniak-Fajti Krib. Ali 'VIII Corpo d'Armata della 2a Armata era stato quindi ordinato di appoggiare l 'avanzata dell'ala s ini stra della 3a Armata, cercando di occupare la Vertoibica, impadronendosi del paese di Biglia e coadi uva ndo l'attacco delJe alture di San Grado. Nell'eventualità che ta li azio ni fossero fortunate e consentissero d'impiegare ancora la cavalleria, fu ordinato che aliquote della 38 Di visione s i tenessero pronte per l'esplorazione. Era importante stab ilire su quali nuo ve linee della Valle del Vipacco i l nemico potesse tentare d'opporre resistenza, in caso si fosse ritirato. Oltre a que sto la Divisione doveva effettuare, se possibile, l'aggiramento da tergo dell e forze che l'avversario avesse eventualmente l asciato indi etro a proteggersi la ritirata. Ma, effe ttuato il primo sba l zo s ull'altopiano di Comeno e arroccatisi gli Imperia li su una linea ancora più resistente, l'azione della cavalleri a fu vanificata e la Divisione restò nelle retrovie. 95

I guadagni ottenuti dalla VII Battaglia dell'Isonzo furono così scar i - piccoli successi int o rno al Veliki e nell 'ansa del Vìpacco, l'occupazione di San Grado di Merna ed una breve avanzata nel piano di Comeno che proprio Cado.ma J'inten-uppe d'autorità già il 16. Di lì a tre settimane però, il 9 ottobre, egli ordinò l'inizio dell'VIII Battaglia dell'Isonzo. i cui ri su ltati si sare bbero al l a fine condensati nella conquista dell a seconda linea austriaca ad est del Vallone di Doberdò, nell'ava nzata verso il Pecinka e nell'allargamento dell'occupazione intorno a Gorizia.
TI 10 ottobre i Cavalleggeri del Monferrato, passati alle dipendenze della Brigata Arezzo (225° e 226° Fanteria) furono impegnati per la conquista di quota 77 di Monfalcone e si comportaro no con grande valore e spirito di sacrificio. Ali 'al ba di quel giorno il Reggimento, dislocato col I Gruppo di
"' AUSSME B 4 9651 Comando 3• divisione di caval leria. Incidentalmente. salvo errore. que s ta dovrebbe essere stata la prima azione di fuoco in avanscoperta faua da mezzi blindati della Cavalleria italiana in guerra. 95 AUSSME 142S 14E VT brigata di cavalleria. Comando della 3• divisione di cavalleria, 14 senembre 1916.
126
Go,izia appena conquistata: agosto 1916.
due sq uadroni nei trinceramenti di Mandria e col II Gruppo di rincalzo alla fabbr i ca del grasso di Monfalcone, ebbe l ' ordine di tenersi pronto a lanciarsi alJ'assalto, in giornata, delle forti posizioni austriache di quota 77 (falde meridionali), dal castello diruto al Lisert .
Nelle prime ore del mattino i tre squadroni di prima linea si portarono in posizione di attesa per l ' attacco, nella località avanzata di "casa diroccata" e " Ridottino Roma", situata a 500 metri circa dalle posizioni nemiche , mentre il II Gruppo Squadron i dalla fabbrica del grasso avanzava a presidiare i trinceramenti lasciati dal I. Alle quattro precise del mattino il tenente di complemento Nicolò Maiero si portò fin sotto il reticolato nemico con dodici cavalleggeri e vi fece tagliare i fili dei reti colati e b1illare i tubi di ge latina esplosiva, apre ndo in tal modo varchi per una cinq uantina di metri dinanzi al tratto di trinceramento verso la palude Li sert .
Alle 14.50 Maiero uscì di nuovo , stavolta con due pattuglie di quindici uomini ciascuna, e distrusse le ultime opere di reticolato nemico verso il Lisert. Dopo aver visto saltare il filo spi nato , al grido di Savoia, si lanciò coi suo i dentro la trincea, catturando numerosi prigionieri e chiedendo subito rinforzi al comandante del I Gruppo. Nel frattempo, dal ricovero centrale situato alle falde di quota 77 , comin ciarono ad affluire i primi contrattaccanti, prontamente accolti a fucilate dal reparto zappatori di Maiero.
Erano le 15 .50 quando il 1° squadrone ebbe ordine di lasciare il più celermente possibile la "casa diroccata", per aiutare il plotone zappatori seriamente impegnato , che il nemico da quota 77 stava tentando d'aggirare e che si dife ndeva energicamente, ma rischiava d'esaurire le munizioni e le bombe a mano. Dieci minuti dopo lo stesso o rdine venne impartito pure al 2° Squadrone.
Nel primo sbalzo, ferito il capitano Di Tocco , il tenente Campanaro B iase portò il 1° Squadrone fin presso ai "tre alberi ", dove fu accolto da un furioso fuoco di mitragliatrici ed artiglieria avversaria. Poi il tenente Muscoline giunse su ll 'orlo della trincea nemica col proprio plotone e riuscì a disimpegnare il plotone zappatori i cui superstiti, usciti con uno sbalzo, riusciro no a riunirsi , prendendo alcuni prigionieri.

-127
 Agosto 1916: truppe italiane a Gorizia in marcia verso il San Marco.
Agosto 1916: truppe italiane a Gorizia in marcia verso il San Marco.
128
Gli Austro-Ungarici intanto si precipitavano dall 'a lto della seconda trincea e, con un violentissimo ed ininterrotto fuoco di mitragliatrice e lancio di bombe a mano, alla fine costrinsero a ripiegare i cavallegge ri del 1° Squadrone, già duramente provati dal fuoco, specialmente intenso da quota 21. Ma proprio in quel momento giu nse a sbalzi il 2° Squadrone, preceduto da un plotone guidato dal sottotene nte Muzzati , il quale , s1anciandosi s ull'orlo della trincea , cadde colpito alla fronte. Parte del suo plotone riuscì a penetrare nelle trincee avversarie, ma dovette subito ripiegare per la viva resistenza dei nemici, continuamente affluenti dalle caverne, e per l ' intervento di fuoco di sempre nuove mitragliatrici In quel mentre, giunse ordine di ritirarsi al "Ridottino Roma " e riordinarvi si Il ripiegamente venne effettuato a sbalzi e con calma, lungo l'efficace riparo d'un muretto che evitò maggiori perdite.
Riordinato s i il 1° Squadrone nei pressi di "casa diroccata", alle ore 17 precise si lanciò una seconda volta fuori della linea avanzata ed a sbalzi procedé decisamente nella stessa direzione di prima, seg uito dal 2° che si portò ali' altezza del I O nel braccio di trinceramenti verso il Lisert.
Intanto anche il 3° Squadrone muoveva a rincalzo e sostegno delle due prime ondate. In due sbalzi s uccessivi si lanciò nella direzione del "casello ferroviario" ed entrò in combattimento, tentando di superare il reticolato austriaco. Il IV plotone del 3°, con il sottotenente Rodriguez in testa, ingaggiò un combattimento a bombe a mano sul ciglio della trincea al "CaseUo" e l'ufficiale cadde ferito a morte mentre continuava ad incitare all'assalto agitando l'elmetto.
Il violento fuoco di fucileria, mitragliatrici ed artiglieria nel complesso arrestò la sortita dei tre squadroni , costringendoli ad impiegare bombe a mano e moschetteria dai pochi appigli offerti dal terreno roccioso. Il combattimento appariva ancora incerto, quando giungeva a rincalzo il II Gruppo Squadroni. Il 4° Squadrone aveva seguito il movimento del 3°: il suo I plotone ora venne lanciato in direzione del "casello distrutto" e riuscì a raggiungerlo, nono stante le raffiche del fuoco avversario; ma una fortissima esplosione fece strage tra i cavalleggeri che vi erano entrati e si erano mischiati a quelli del 3° Squadrone. Gli altri plotoni del 4° avanzarono nella stessa direzione, ma furono fermati dal soverchiante fuoco avversario dalle caverne e dall'alto della quota. Nonostante tutto, tentarono per ben due volte d'assaltare i trinceramenti nemici, ma furono se mpre costretti a ripiegare
Analoga sorte ebbe il 5° Squadrone, che si lanciò con un plotone verso il "casello" e coi rima nenti tre contro la trincea che dal "casello" scendeva verso sud. Il terreno particolarmente anfrattuoso agevolò l 'avanzata e permise al 5° di giungere sotto i reticolati nemici quasi all'imbrunire, mentre il I Gruppo Squadroni, cbe aveva attaccato la trincea avversaria, era già duramente colpito. Più fortunato fu il 6° Squadrone, anch'esso lanciato in direzione del "casello", dove più cruenta era la lotta, fu protetto dall ' incipiente oscurità e poté avanzare velocissimo fino all'obiettivo designato, riusce ndo a rinforzare i reparti già impegnati sulla posizione.

A que sto punto, erano le ore 19 circa , il comandante del Reggimento , ricevuta informazione che la colonna di sinistra aveva ripiegato sulla linea di partenza e vista l'inutilità degli sforzi per espugnare la trincea avversaria, inviò ordine a tutti gli squadroni di ritirarsi, a sbalzi ed ordinatamente, verso "casa diroccata". Il ripiegamento avvenne ordinatissimo e, alle ore 20.30 circa, tutto il Reggimento si trovava riunito nella linea avanzata "casa diroccata- iidottino Roma ".
Il Il plotone del 6° Squadrone era stato assegnato alla 5a Compagnia del 225° Fanteria, che era stata il collegamento fra il medesimo Re ggimento di Fanteria a sinistra ed i Cavalleggeri del Monferrato a destra nell'azione su quota 77. Alla compagnia di fanteria era stato anche aggiunto, al mattino, un plotone del 1° Squadrone di Monferrato , il quale era stato oggetto del tiro intenso del l'artiglieria avversaria , uscendone con forti perdite , fra cui il tenente Di Loreto, colpito a morte.
Allora era stato inviato in rincalzo il II plotone del 6° Squadrone dei Cavalleggeri di Piacenza, comandato dal tenente Lui gi Sequi. Alle 17, viste uscire le ondate d'attacco del Monferrato, il tenente Segui aveva preso il comando de1Ja prima ondata della sa Compagnia e, alla testa dei fanti e dei
-129-
 •.
Sant' Ignazio (Gorizia) con truppe di cavalleria della 3" Di visione di Cavalleria nell'agosto 1916.
•.
Sant' Ignazio (Gorizia) con truppe di cavalleria della 3" Di visione di Cavalleria nell'agosto 1916.
-130 -
suoi cavalleggeri si era precipitato fuori dalle trincee verso il "casello ferroviario". Si era spinto . sotto il fuoco avversario, fino ai reticolati nemici, assecondando l'azione del Reggimento e cercando di rafforzarsi sul terreno conquistato . fin quando, visto che i reparti laterali non riuscivano a superare l'aspra resistenza nemica, all'imbrunire aveva ricevuto l'ordine di rientrare in linea .'16
Nell'azione, le perdite subite dal R eggimento assommarono a tre ufficiali morti (tenente D i Loreto e sottotenenti Rodrigue z e Muzzati, (caduti nella trincea nemica) e sette feriti, mentre fra sottufficiali e truppa si registrarono 23 uccisi, 21 dispersi e ben 200 feriti.
Terminata il 12 ottobre l'VIII, il 31 cominciò la IX Battaglia dell'Isonzo, che po1tò la 3a Armata all'occupazione del Pecinka , del Veliki Krib e delle falde del Fajti Krib ed all'avanzata fino a Castagne vizza
In tutto l'arco di questo ininterrotto ciclo operativo, da settembre a dicembre, l ' artiglieria nemica tornò padrona della situazione , battendo intensamente tutte le posizioni italiane; la cavalleria rimase non impegnata. Mentre alcuni reggimenti restavano in attesa a cavallo , il resto dell'Arma fu impiegato appiedato ed in differenti modi, cos icché Roma agì da fanteria, respingendo tutti gli attacchi nemici alle sue linee da quota 144 al mare.
I reggimenti non inquadrati divisionalmente avevano partecipato in vario modo, o non avevano partecipato affatto, aUe operazioni correlate alle ultime quattro battaglie dell'Isonzo.
Nel fortunato mese di agosto avevano preso parte, appiedati, alla battaglia di Gorizia il 3°, il 5° e il 6° s quadrone di Piemonte Reale, subendo perdi te s uJla Vertoibiza e sul Vipacco, mentre il 1° squadrone dello ste sso reggimento in autunno sarebbe rimasto in trincea tra q. 144 e le quote ad est di Monfalcone.
I Lancieri di Firen ze, assegnati al IX Corpo d'Armata, erano andati in Cadore con compiti di supporto. Il reggimento Foggia rimase da settembre a novembre di massima negli accantonamenti; i suoi squadroni, a turno, prestarono servizi temporanei fuori sede per scortare i numerosi prigionieri catturati durante le operazioni s ul Carso. Foggia fornì così, saltuariamente, distaccamenti a Romans, a Sdraussina, a San Martino del Carso, a Bosco Cappuccio, a Parra ed a Rub bia .
Gli esiti delle battaglie dell'Isonzo, come si è visto, non permisero comunque un costante impie go delle truppe di Cavalleria, cosicché, cessata l'azione, gli Squadroni rimanevano nella zo na di retrovia dei Corpo d'Armata e riprendevano i consueti servizi di vigilanza e di perlustrazione in ausilio ai Carabinieri R eali.97
Nel 1916 Lodi fu smembrato . Il Comando col I e il II Gruppo furono mandati in Albania, dove, fin dall 'an no prima, lo Stato Maggiore aveva inviato un contingente di truppe.
Anche Lucca appiedò i s uoi squadroni e il 1° si segnalò nelle trincee di Monfalcone, Plava e Canale , meritando la citazione sul bollettino.
Gli squadroni dei Cavalleggeri di Catania furono destinati ad operare in Albania. TI Reggimento Umberto I , impeg nato come truppa supp le tiva, appiedato, fu inviato nella zona di Gorizia, alla cui liberazione , 1'8 agosto, concorsero i Cavalleggeri di Udine, che poi puntarono sul San Gabriele e sul Monte Santo. Il giorno successivo raggiunsero Vertoiba e M erna, dove conquistaro no la posizione del cimitero, nonostante le fort i perdite subite.
Il 1916 s i chiudeva con la cavalleria in una situazio ne di incertezza quanto al suo futuro. I risultati erano stati comunq ue buoni, tanto per la conservazione del materiale quadrupedi quanto per coloro che avevano partecipato alle operazioni con le grandi unità di caval le ria appiedate, dimostrando di sa per combattere bene anche in maniere a cui non erano stati originariamente addestrati.
9(, AUSS ME B 4 9651 Comando Generale arma di caval leria reggimento Cavalleggeri di Monferrato: Relazione sull'a zione svolta da reggimento nell'attacco di quota 77 ad est di Monfalcone il IO ottobre 1916.
PEZZT SIBONl e RAVAGNATI LARGHlNl, op. cil.

91
- 131-

. ...,_
La 3° Divi s ione di Cavalleria a Gorizia in via Alvarez nel 1916 .
9 agosto 1916: la stazione dalla strada del ponte di Lucinico con le truppe della 3" Divisione di Cavalleria.
132
 Lucinico: truppe della 3" Divisione di Cavalleria a riposo nel 1916.
Gorizia, Via Rastello con truppe della 3" Di visione di Cava ll eria a riposo.
Lucinico: truppe della 3" Divisione di Cavalleria a riposo nel 1916.
Gorizia, Via Rastello con truppe della 3" Di visione di Cava ll eria a riposo.
- 133 -
 Una sezione di autoblindomitragliatrici della 3" Divisione di Cavalleria sbarra la strada di Vertojba.
Soldati italiani a riposo sulla s ponda del fiume Yipacco oltre Rubbia.
Una sezione di autoblindomitragliatrici della 3" Divisione di Cavalleria sbarra la strada di Vertojba.
Soldati italiani a riposo sulla s ponda del fiume Yipacco oltre Rubbia.
134-
 La 3a Divisione di Cavalleria nella piana di Gorizia.
1916: Il lag o di Dob erdò visto dall'abitato di Dob erdò; sullo sfondo a sinistra la q. 208 nord e s ud e , a destra, la q. 144 , aU'orizzonte: l'Hermada.
La 3a Divisione di Cavalleria nella piana di Gorizia.
1916: Il lag o di Dob erdò visto dall'abitato di Dob erdò; sullo sfondo a sinistra la q. 208 nord e s ud e , a destra, la q. 144 , aU'orizzonte: l'Hermada.
135
 Truppe italiane a Gorizia nel 1916 in attesa d ' avanzare ancora .
Il generale Cadoma e il generale Porro a San Martino del Carso: agosto 1916.
Truppe italiane a Gorizia nel 1916 in attesa d ' avanzare ancora .
Il generale Cadoma e il generale Porro a San Martino del Carso: agosto 1916.
136
 Il Carso di Doberd ò ne l 1916.
Trincee di approccio al la prima linea del fronte sul Carso di Doberdò nell 'autunno del 1916.
Il Carso di Doberd ò ne l 1916.
Trincee di approccio al la prima linea del fronte sul Carso di Doberdò nell 'autunno del 1916.
137-

.,.....__ ...
1 fronte nel 19L6.arcia verso 1Autocolonna m m
1916 Carso i Cavalleggeri di Romad" Monfalcone, Luglio agoS!o
' _ 138
 Autunno 1916. Carso dj Monfalcone. Cavalleggeri dj Roma in un osservatorio in trincea.
Settembre 1916: reparto di cavalleria appiedato in marcia per il fronte.
Autunno 1916. Carso dj Monfalcone. Cavalleggeri dj Roma in un osservatorio in trincea.
Settembre 1916: reparto di cavalleria appiedato in marcia per il fronte.
139-

,
Autunno 1916, q. 77 del Carso di Monfalcone, Tenente dei Cavallegge1ì di Roma ali 'entrata dj un ricovero. (MCP)
140-
 Autunno 1916, q. 77-78 del Carso di Monfalcone. prima Linea pre sidia ta dai Cavalleggeri di Roma. ( MCP)
Autunno 1916, q. 77-78 del Carso di Monfalcone. prima Linea pre sidia ta dai Cavalleggeri di Roma. ( MCP)
141
 Cavalleria a riposo lungo l' argine cti un fiume (probabilmente l'Isonzo nei pressi cti Pieris).
Settembre I 916: un reparto di cavalleria appiedato pronto a partire per il fronte.
Cavalleria a riposo lungo l' argine cti un fiume (probabilmente l'Isonzo nei pressi cti Pieris).
Settembre I 916: un reparto di cavalleria appiedato pronto a partire per il fronte.
-142-
CAPITOLO XII
IL TERZO ANNO DI GUERRA: 1917
11 1917 si apriva in modo non differente dal precedente anno di guerra. L'andamento delle operazioni sulla nostra fronte e le condizioni del terreno, dove le operazioni si erano svolte all'inizio della guerra, offrivano un troppo modesto contributo di esperienze per orientare in modo sicuro l'addestramento tattico dell'Arma di Cavalleria in relazione alle esigenze della guerra moderna. Fu pertanto giocoforza confrontarsi con g li altri Stati Maggiori alleati sul ruolo della cavalleria, per poter fare tesoro anche dell'esperienza altrui. Il Comando Supremo concorreva allo scopo con il portare a conoscenza del Comando in Capo dell 'Anna i rapporti e le re lazioni che gli pervenivano dagli organi competenti. Già all'inizio della guerra europea, come abbiamo visto, prima che l'Italia entrasse nel conflitto, era apparsa chiara la grande importanza che aveva assunto, anche per la cavalleria, l'impiego del fuoco ne] combattimento come ausilio dell'azione a cavallo. La cavalleria italiana, attenta a quanto avveniva all'estero, si avvaleva per il s uo addestramento, si n dal 1913 , del nuovo regolamento di esercizi, volume Il in cui il combattimento, largamente trattato, era informato e rispondeva, in massima, alle esigenze quali erano apparse allora. Nello stesso senso andava il mutamento organico, approvato dalle s uperiori autorità, di aumentare i ciclisti negli squadroni , ordinandoli in modo da poter costituire, quando fosse stato necess ario, un nucleo reggimentale forte di 60 ciclisti. Quest'ultimo , in unione alla sezione mitragliatrici (e ne] 1916 autoblindomitragliatrici) nei reggimenti divisionali, sviluppava un volume di fuoco non disprezzabile, non appesantiva le unità e non ne vincolava minimamente la mobilità e la capacità manovriere. Questa era stata la situazione di fatto in cui si era trovata la Cavalleria all 'entrata in guerra.
Poi, durante il primo periodo del conflitto, l'addestramento delle divisioni di cavalleria era s tato esse nzialmente informato al criterio di abituare reparti ed unità a conseguire il più armonico ed efficace impiego dell'azione concomitante del fuoco, della manovra e dell'urto nei reggimenti divisionali, conseguendo ottimi risultati. Una parte d ella cavalleria, quella non indivisionata, era s tata assegnata alle truppe TS. Durante l'inverno 1915-16 il Comando su premo aveva deciso, ed il Ministero approvato, l'appiedamento delle divisioni di cavalleria, rinforzate da sedici squadroni tratti dalla cavalleria delle TS, cosicché s i era imposto un addestramento ispirato a criteri nuovi , s ia p er i quadri sia per la truppa. Si trattava di mettere dei cavalieri in grado di combattere come vere e proprie fanterie e di allenarli al nuovo genere di servizio, di istruirli nei lavori di trincea e di siste mazione difensiva, come fu fatto. L' offensiva austriaca nel Trentino nel maggio del 1916 aveva costretto il Comando Supremo , so tto la spi nta degli eventi , a impiegare due delle quattro divisioni. Due sol e Divis ioni erano quindi rimaste per qua si un anno lontane dai propri cavalli.

Nel se ttembre 1916 venne portata a conoscenza dell'Arma di Ca valleria la nuova " Istruzi o ne francese", riservata, s ull 'impiego della cavalleria nel combattimento offensivo delle Grandi Unità, istruzione che vale la pena di riportare in quanto anche la Cavalleria italiana vi s i adeguò:
" L 'istruzione francese sull'impiego della cavalleria nell'azione offensiva delle grandi unità, tende a determinare l'azione della cavalleria stessa nel momento in cui, avvenuto lo sfondamento di un tratto del sistema di organizzazioni difensive nemiche, si passi della guerra di trincea a quella di movimento. La suddetta istruzione pone naturalmente a base delle sue considerazio ni il tipo di organizzazione difensiva nemica sulla fronte francese, costituita cioè da tre succes sive zane, distanti l'una dall'altra circa tre chilometri, che comporta ciascuna varie linee di trincea con elementi più continui e più robusti nella prima e nella seconda zana, meno nella terza . Su questa base i criteri essenziali di impiego della cavalleria sono i seguenti:
143
a) durante la battaglia di sfondamento delle linee nemiche qualunque tentativo di intervento di masse di cavalleria non solo è inutile ma dannoso;

b) sfondata la prima zona, e manovrando all ' attacco della seconda , è possibile l'impiego di singoli cavalieri arditi, di qualche pattuglia di collegamento o al massimo di qualche plotone presi dagli squadroni temporaneamente assegnati alle divisioni , per effettuare qualche colpo d; mano su cannoni, mitragliatrici, ecc. e per riconoscere;
c) sfondata anche la seconda zona, può presentars; l'occasione di impiegare squadroni per operazioni di sorpresa , per mettere scompiglio nelle file nemiche, individuare le posizioni avversa rie o, ancora, per tenere il contatto con esso , qualora stia ritirandosi;
d) l'impiego delle masse di cavalleria è riservato al momento in cui anche nella terza zona sia stata aperta una breccia ampia 15-20 chilometri. Internamente i corpi di cavalleria devono inseguire direttamente il nemico con qualche divisione, e con le rimanenti lanciarsi a tagliare le retrovie delle truppe ancora rimaste in posizione. La, cavalleria non deve provvedere ad allargare la breccia: tale compito deve essere lasciato alle grandi unità di fanteria che devono seguire immediatamente la cavalleria."
Sono pure degni di nota i seguenti punti dell'annesso fascicolo:
"a) di impiego in trincea di osservatori di cavalleria negli squadroni divisionari da servire da guida agli squadroni stessi quando possono e debbano intervenire; b) di impiego previsto della esplorazione aerea a servizio della cavalleria, anche quando la breccia non è stata ancora aperta, al fine di potere subito cogliere il fuggevole momento del tempestivo intervento; c) di impiego degli aeroplani come mezzo di collegamento alle grandi unità di cavalleria d'armata o di gruppo di armata; d) di impiego a sostegno delle division i di cavalleria del reggimento leggero (squadroni permanentemente appiedati, trasportati con i mezzi più celebri possibili) dalle automitragliatrici e da; cannoni su automobili dati alle divisioni stesse."98
Secondo precedenti informazioni, la cavalleria francese aveva subito le seguenti varianti. Nel 1914 esistevano in Francia 10 divisioni di cavaJleria così costitu ite : Una divisione : tre brigate di cavalleria; un gruppo le ggero (sei squad ron j a piedi), 1200 uomini ; un gruppo batterie a cavallo; un gruppo ciclista (3 compagnie), 450 uomini.
Con lo scioglimento della 9a e 10a Di visio ne di Cavalleria e la riduzione dei reparti ciclisti, la costituzione delle otto rimanenti divisioni di cavalleria rimase modificata come segue: U na divisione : tre brigate di cavalleria; un reggimento l eggero (12 squadroni e piedi raggruppati in tre battaglioni di 4 squadroni ciascuno ), 2400 uomini; una compagnia ciclisti (tre plotoni di sessanta uomini) cen tottanta uomini; un gruppo di batterie a cavallo.
P er giungere a quest'ordinamento si procedette nel seguente modo: i sei reggimenti di cavalleria leggera dei dodici reggimenti di cavalleria componenti la 9a e 10a Divisione furono mantenuti montati e furono ripartiti fra le divisioni di fanteria ed i Corpi d'Annata composti di unità di riserva, in sostituzione di
AUSSME Fl 142 , Notizie cavalleria frances e e britannica. 1916.
98
-144-
altrettanti reparti di cavalleria di riserva , i quali fumno sciolti. I sei reggimenti corazzieri furono appiedati ed assegnat i ognuno ad una divi s ione di cavalleria montata, dove , fondendosi con i gmppi leggeri esistenti, costituirono i reggimenti leggeri di 6 divisioni di cavalle1ia. I gruppi leggeri delle due disciolte divis ioni di cavalleria furono assegnati uno a ciascuna delle rimanenti due divisioni d i cavalleria , dove, fondendosi coi gruppi leggeri esistenti di queste divisioni , formarono i reggimenti leggeri stabiliti dai nuovi organici. I reggimenti leggeri furono immediatamente dotati di un numero di mitragliatrici trainate corris pondente a quello delle tre compagnie mitragliatrici esistenti presso i reggimenti di fanteria (in fanteria ogni reggimento aveva tre compagnie su sei pezzi e ogni plotone due fucili mitragliatori). Ai reggimenti montati furono distribuiti fuciU mitragliatori nella proporzione di uno per plotone. Il fucile-mitragliatore automatico distribuito era simile per tutti i reparti di fanteria e vi erano due fucili per ogni sezio ne.
A Livello massimo , il II Corpo di Cavalleria francese e r a organizzato in questo modo:
Stato Maggiore, che comprendeva:
un capo di Stato Maggiore tenente colonnello di cavalleria;
un sottocapo di Stato Maggiore maggiore di cavalleria;
1 Reparto (Bureau) Org anizzazioni Servizi, con tre ufficiali;
2 Reparto Informazioni, con due ufficiali;
3 Reparto Operazioni , con tre ufficiali.
Quest'organico era ritenuto il minimo indispensabile per il buon funzionamento del comando. V'erano inoltre: un cap itan o del Genio direttore del Servizio Telegrafico; un capitano di Cavalleria direttore del Servizio Automobili del Corpo di Cavalleria; un funzionario d'Intendenza (consigliere tecnico); un capitano di Gendarmeria come comandante del quartiere ge ne rale , c he disponeva di: quattro scritturali (di cui almeno uno sottufficiale); quattro ciclisti; 30 vetture automobili; un autocarro ufficio; cinque autocarri per bagaglio e 60 ciclisti di sco1ta; una sezio ne di 20 gendarmi.
Le truppe del II Corpo erano: la 3a Divisione di Cavalleria; la sa Di visione di Cavalleria, la 7a Divisione di Cavalleria, un distaccamento telegrafico "con filo" del G enio, su 20 apparecchi e con 50 chilometri di cavo su autocarro; un distaccamento telegrafico "senza filo", cioè radio, del Genio s u tre sezioni radiotelegrafiche autocarrate; un gruppo elettrogeno su autocarro.
I servizi erano quelli dei trasporti, di san ità e veterinario:
I trasporti "in t empo di riposo" constavano di due gruppi autocarri, su quattro sezioni l'uno, che "in tempo di operazioni" sali vano a quattro gruppi d ' autocarri , sempre su quattro sezioni l'uno, ognuna delle quali era sufficiente a l vettovagliamento di una Divisione di Cavalleria ed era capace di trasportare 300 uomini dei Gruppi a piedi. A supporto, esisteva un Laboratorio di riparazioni mobile dotato di tre autocarri.
La sanità aveva "tre vetture di ambulanza automobili" , il servizio veterinario consisteva in un deposito mobile di quadrupedi, che comprendeva: un capitano e due suba lterni di cavalleria, uno o due ufficiali veterinari ed un numero di uomini e quadrupedi variabile. Il servizio veterinario curava ovviamente i quadrupedi ammalati dei reggimenti e seguiva le truppe a due o tre giorni di distanza.
O gni Di visione di cavalleria era composta da uno Stato Maggiore, retto da un maggiore di cavall eria capo di stato maggiore con sei ufficiali; da un'Intendenza , un ufficiale medico direttore del Servizio Sanitario divisionale, un ufficiale pagatore, uno di gendarmeria, uno del Genio in qualità di direttore del servizio telegrafico, i quali avevano a di.sposizione complessivamente vari scri tturali , una sezione di G endarmi , 10 motociclisti e 10 automobili .
Le truppe della Di visione si articolavano su tre brigate binarie di cavalleria, ogni reggimento delle quali era su quattro squadroni , con una forza effettive media dello squadrone combatte nte di 140 cavall i. C'erano poi in ogni divisione: un Gruppo Cacciatori (chasseurs) di 400 uomini; un Gruppo di se i sq uadroni a piedi per un totale di 1.200 uomini; un Gruppo d'artiglieria di tre batterie; un Gruppo di

-145-
 Cavalleggero a cavallo del 22° R eggimento Cava ll eggeri di Catania in posa per la foto con tutto l'equipaggiamento
Cavalleggero a cavallo del 22° R eggimento Cava ll eggeri di Catania in posa per la foto con tutto l'equipaggiamento
146-
autocarri con quattro pezzi da 37 mm e sei mitragliatrici; un distaccamento Zappatori del Genio; un distaccamento telegrafisti autocarrato del Genio; un distaccamento telegrafisti cli Cavalleria, a cavallo.
I Servizi della ruvisione consistevano in: una Sezione Sanità con tre ufficiali medici ; una dj Sus sistenza con quattro autocarri per il trasporto della carne macellata; tre autocarri attrezzi.
In ogni reggimento di cavalleria ed in ogni gruppo ciclisti vi era una sezione mitragliatrici ed in ogni gruppo di squadroni a piedi ce n ' erano quattro, su carrette a ruote trainate da un cavallo. Il gruppo di squadroni a piedi, oltre all'attrezzo da lavoro che ogni uomo portava con sé , aveva una "carretta attrezzi" che conteneva 70 attrezzi da parco, 100 chilogrammi di filo di ferro, 50 chilogrammi di e splosivo, 150 granate e 50 razzi.
Gli uomini di questi gruppi erano armati col fucile di fanteria con baionetta e portavano co n sé 150 cartucce e due giornate di viveri aJ sacco. Avevano lo stesso zaino della fanteria, ma il suo carico poteva suddividersi , prevedendo che, in alcune circostanze, potesse convenire far lasciare il corredo sugli autocarri , conservando negli zaini solo i viveri e le cartucce.
Provvedimenti eccezionali intesi a facilitare l'applicazione dei concetti espressi ebbero ru mira tre scopi principali:

1°) di mettere i reparti in condizioni di s up erare gli ostacob che si presentavano, per penetrare nella breccia aperta della fanteria nella linea avversaria;
2°) dotare i reparti di mezzi per distruggere le artiglierie nemiche, che costituivano il primo obiettivo da raggiungere;
3°) consentire ai reparti di provvedere al proprio vettovagliamento, in modo da potersi spingere a fondo nelle loro operazioni, senza preoccuparsi dei rifornimenti per alcuni giorni.
Per ottenere il primo scopo e cioè permettere ai reparti di scavalcare le trincee e le difese accessorie accumulate dalle due parti, mentre si addestravano i cavalli a saltare gli scavi, furono distribuiti tra gli uomini e gli squadroni 60 attrezzi e 24 pinze taglia.fili in più o ltre alle dotazioni. Si costituì così in ognuno quel che venne chiamato equipaggiamento brèches, ossia squadre cli guastatori che si componevano di uomini predesignati per aprire o allargare i passaggi nelle trincee o ne i reticolati. Si studiò il modo cli far istruzione di ripiegamento, avvalendosi del fuoco di mitragliatrici a supporto incrociato.
Per ottenere il secondo scopo , furono costituite squadre di guastatori e lanciatori cli bombe che si componeva no di cavalieri predesignati per attaccare con bombe a mano i serventi delle batterie fra i pezzi e nei loro ripari. Anche i cavalieri furono armati di "cartocci esplosivi ", per distruggere il materiale d'artiglieria; ne furono distribuiti 160 per squadro ne .
Per ottenere il terzo scopo, furono portate a tre le razioni di viveri a secco degli uomini e ad una razione 5 112 6 chilogrammi quella cli biada trasportata in arcione.
Per permettere poi agli autocarri , che pesavano dalle 7 alle 8 tonnellate, di superare guadi o interruz ionj stradali., oppure fossi o piccoli corsi d'acqua , i Gruppi di autocarri da trasporto furono dotati di eleme nti da ponte speciali , composti da tavole a rotaie di ferro, che si potevano montare in brevissimo tempo e coi quali si poteva costruire un ponte della lunghezza massima di 30 metri.
Poi si pensò alla costituzione di unità di combattimento che la cavalleria potesse appiedare.99 Siccome la condizione di guerra dell ' epoca era il combattimento a piedi, che non era il metodo normale di com battimento della cavalleria, era necessario che essa, quando appiedava, costituisse per quanto possibile, delle unità cli combattimento identiche a quelle della fanteria. A nche le unità di cavaJleria dovevano quindi p ossedere tutti i mezzi di fuoco , di manovra e di collegamen to che l'esperienza di guerra aveva riconosciuto necessari. L a costitu zione di unità ru combattimento a piedi doveva risultare della massima semp licità. Lo stesso principio che regolava il riordino dell ' Arma france-
99 AUSSME Comando dell e Almate del nord e nord est 27 novembre 1917 , Maggiore Alberti: Riorgan izzaz ione dello squadron e di ca valleria. Rela zione del ten ente colonnello addetto militare Bre ganz e.
147-
 Cavalleggero del 22° Reggimento Cavalleggeri di Catania smontato.
Cavalleggero del 22° Reggimento Cavalleggeri di Catania smontato.
-148-
s e era stato attuato dagli Austro-Ungarici e dai Tedeschi (i quali però avevano mantenuto alcune divis ioni montate, usandole durante la campagna di R omania) , con la trasformazione automatica di due unità di cava lleria in unità di fanteria mezzo reggimento in compagnia ecc. mentre lo squadro ne rimaneva su quattro plotoni. Le specializzazioni erano poi ripartite nei plotoni, in modo che questi fornissero unità minori di combattimento, ossia squadre complete per specializzazione.
L'unità più piccola cli combattimento, il plotone inquadrato, formava una mezza sezione di combattimen to ; appi edato , aveva un minimo di 13 o 14 uomini. Così lo squadrone 100 formava due sezioni di combattimento, il mezzo reggimento una compagnia ed una sezione mitragliatrici, il reggimento due compag ni e e mezza compagnia mitragliatrici, la brigata un battaglione su quattro compagnie ed una compagnia mitragliatrici.
Stante la nece ssità di conservare a ncora il cavallo (l'addestramento del cavaliere non era una questione di improvvisazione) , per aumentare gli effettivi per il combattimento a piedi (non tutti gli uomini appiedavano nelle unità) si facevano combattere a piedi aliquote di più unità. Con questo cri terio il comandante poteva impegnare tutti gli effettivi a piedi oppure conservare, per ragio ni tattiche, parte delle sue unità cavallo in piena efficienza.
La tra sformazione di un reparto d i cavalleria montato in un reparto appiedato doveva di ventare un fatto automatico. Gli ufficiali destinati ad inquadrare gli appiedati dovevano essere designati in per manenza, i graduati per l a mezza sezione erano presi nel plotone che la formava, come pure i comandanti di sez ione nel mezzo squadrone, il comandante di compagnia nel mezzo reggimento e così via. Tutti i so ldati di cavalleria dovevano essere istruiti all'impiego del moschetto e della baionetta.
La costituzione organica dello squadrone diventava di quattro plotoni su quattro squadre ciascuno, con un capitano, quattro su balterni e 151 uomini di truppa , di cui: 128 montati 13 sottufficiali, 16 gra duati e 99 cavalieri e 23 non montati: 10 uomini di complemento, un ciclista, tre operai, tre militari c he portavano i cavalli degli ufficiali, due conducenti, un uomo per iJ servizio di fatica e un cuciniere 101 •
I criteri ai quali si ispirava la nuov a "istruz ion e francese" , frutto dell'esperienza di due a nni di guerra d i posizione, collimavano perfettamente con quelli che avevano formato fino allora la base della preparazione della cavalleria italiana e che s i possono così sistematicamente riassu mere:
a) l'impiego di massa della cavalleria non p oteva essere concepito se non quando fosse stato aperto un varco suffic ie nteme nte ampio sul terreno Libero;
b) compito delia cava ll eria era allora di sfruttare il successo, impedendo al nemico di organizzarsi, vincere rapidamente le piccole resistenze che avrebbe tentato di opporre e cambiare la sua ritirata in fuga disordinata; wz

e) ogni comandante di cavalleria, qualunque fosse il suo grado, doveva agire di s ua iniziativa con slanc io ed audacia
Sentita sempre più ]a necessità di aumentare l'efficienza di fuoco delle unità di cavalleria, senza dover ricorrere a11 'appiedamento, nel febbraio 1917 il Comandante Generale dell'Arma di Cavalleria proponeva al Comando Supremo, che approvava , di aumentare da due a quattro le mitragliatrici di ciascun reggimento divisionale, trasformando le sezioni in squadro ni mitraglieri. E nell 'aprile 1917 si emanarono alcune direttive contenenti criteri circa l 'impiego della cava lleria nella battaglia e le norme per la preparazione dei reparti, che tenevano presente la configurazione topo grafica della zona in cui sarebbe stato probabile l 'impiego di cavalleria (zona carsica!). Quest 'ultima escludeva dj mas-
100 Nelle fùe dello squadrone a cavallo v i erano cinque ufficiali e 125 uomini di truppa di cui 3 erano con il carre ggio Di questi appiedavano 2 ufficiali compreso 1 capitano e 56 uomini di truppa. Questo e ra il minimo che doveva fornire lo squadrone.
io , AUSSME Fl 142 , Noti z ie ca valleria fran c ese e britannica, 1916. ioi Cosa che avvenne effettivamente nell'ultimo anno di guerra.
149
sima l'impiego anche in scala ridotta di Grand i Unità di Cavalleria , ma consentiva, in speciali condizioni (zona della valle del Vipacco e vallone di Brestovizza) di impiegare con efficacia unità minori, soprattutto se convenientemente addestrate e comandate da ufficiali "a udaci " ,10' a conoscenza del terreno e di quello che il cavallo poteva rendere in tali circostanze.
In s intesi s i prescriveva:
a) conoscenza da parte dei comandanti di reparto della situazione, ora per ora, per entrare in azione momento opportuno ;

b) stretto e sicuro collegamento fra il comandante ed i gregari per il tempestivo impiego del reparto;
c) conoscenza perfetta, grazie ad opportuna ricognizione da parte di tutti gli ufficiali , della zona di probabile impiego;
d) audacia, spirito d ' iniziativa e tenacia da parte dei comandanti;
e) formazioni rade linee di colonna di plotone e , se necessario, di squadre per diminuire la vulnerabilità e facilitare il movimento;
f) impiego coordinato dei piccoli elementi, la c ui azione di ai uto reciproco per l ' avanzata doveva i nformarsi al concetto di avvolgere fulmineamente per le ali i pi ccoli centri di resistenza nemica;
g) carattere del combattimento irruente e decisamente aggressivo ;
h) logico ed opportuno sfruttamento del fuoco anche di piccoli elementi in ausilio, in sostituz io ne dell'azione a cavallo;
i) mirare , quando si dovesse agire , alla buona utilizzazione del cavallo più che alla conservazione del medesimo.
In base a questi concetti fu introdotta nell'Arma di Cavalleria , per renderl a meglio aderente alle particolari esigenze imposte dalla guerra, la seguente organizzazione:
Premesso che compless ivamente , tra indivisionati e non indivisionati , vi erano 30 reggimenti di cava1leria , oltre a vari squadroni dislocati oltremare , che concorrevano a formare quattro divi sioni di cava11eria (1 3, 2 3, 3 3 e 4 3 ) per un totale di 1.130 ufficiali e 20.893 fra sottufficiali e truppa , la Brigata di Cavalleria era su due reggimenti , costituiti ciascuno da due gruppi:
il I Gruppo comprendeva tre squadrooj, ciascuno dei quali era formato da un reparto ciclisti con sezione mitragliatrici;
il II Gruppo compre nd eva due squadroni, costituiti come quelli del I Gruppo ed uno squadro ne mitragliatrici.
I reggimenti di cavalleria non indi visionati, assegnati ai Corpi d ' Armata , erano formati anch 'es si da due gruppi: I su tre squadroni e II su due squadroni; ma gli squadroni comprendevano soltan to reparti a cavallo.
I reggimenti indivisionati , nei quali erano in dotazione armi automatiche, potevano sviluppar e azioni di fuoco oltre che le azioni d ' urto; i reggimenti non indi visio nati erano composti solo di reparti a cavallo. I reggimenti appiedati , su due gruppi, sei sq u adro ni , due sezioni mitragliatrici e salme ria reggimentale, si uniformavano ai procedimenti tattici della fanteria, senza però averne i mezzi e la particolare attitudine tattica. Ed a questi criteri s i informò particolarmente l'addestramento tattico dell'Arma durante il periodo maggio-settembre 1917 , pur non tralasciando l ' addestramento di reparti maggiori. Ne conseguì che i reparti divi sionali si abituarono ad una tattica sciolta , snodata, che trovava il suo nesso nella concomitanza degli sforzi , senza offrire presa al tiro nemico. Tale tattica, opportunamente applicata, avrebbe potuto dare ottimj ri su ltati se, nelle poche circostanze in cu i la cavalleria ebbe occasione di essere impiegata dai comandanti delle Grandi Unità di fanteria c he l'ebbero a di sposizio ne , non si fosse sperato di ricavare il successo più dall'impiego di masse che dal-
103 Era il ricorso alla filosofia cadorniana dell ' efficienza.
-1 50
 Cavalleggero a Gorizia, nel 19 16.
Cavalleggero a Gorizia, nel 19 16.
- 151 -
 Un reparto di fanteria attraversa un paese dell'lsontino diretto verso iJ Carso.
Fanti ammassati sotto la ferrovia per Trieste, a est di q. 77.
Un reparto di fanteria attraversa un paese dell'lsontino diretto verso iJ Carso.
Fanti ammassati sotto la ferrovia per Trieste, a est di q. 77.
152-
l'azione tempestiva e irruenta di piccoli nuclei audaci. Risultò evidente in questo caso iJ richiamo a gli ormai tramontat i criteri di impiego dell ' Arma.
La nascita e lo s viluppo degli arditi, certo non a cavallo , sta a dimostrare che il comando dell ' Arma non s i sbagliava di molto sull ' uti]ità dell ' impiego rapido , chirurgico, audace che le operaz ioni a v rebb e ro dovuto assum e re per vincere l ' immobilismo della guerra di posizione.
Difatti , neJlo spirito dell ' Arma e nella nuova sistemazione imposta dalla guerra , anche la CavalJeria fu invitata a studiare la creazione di propri reparti d ' assalto. Il problema però era sempre dove mettere il cavallo, e la Cavalleria trovò una sua soluzione: passato e presente (e forse futuro) dovev ano convivere nell ' Arma che più conservava la tradizione delle armi . Certo, la creazione di tali unità avrebbe portato alcuni inevitabili inconvenienti negli squadroni, quindi per un più sicuro rendimento, i reparti di assalto dovevano fondersi con lo squadrone a cavallo , perché il cavallo, onore del cavaliere , non andava abbandonato. Era noto come, per effetto di promozioni e passaggi volontari o meno ad altri corpi, per la cos tituzione e rotazione delle compagnie mitragliatrici e date le inevitabili perdite in malati , licenze e così via , la stabilità del personale ufficiali, graduati gregari era in ogni squadrone alquanto precaria. Le specializzazioni inoltre erano così numerose -zappatori, trombettieri, esploratori , cavalieri di prima classe, segnalatori, nuotatori, allievi sellai, maniscalchi, sarti, barbie ri, cucinieri che aumentare ancora di 11 o 12 individui quanti ne occorrevano per ogni squadrone per i repruti ili assalto- gli s pecialisti , rendeva sempre più rufficile iJ conciliare l'istruzione a cavallo dell'intero squadrone in formazione organica con quella particolare dei vari spe cializz ati All ' istruzione interveniva giornalmente una media di 95 cavalieri e già non piccole erano le rufficoltà da superare per l'addestramento orrunario e la buona conservazione dei cavalli e del materiale. Con l'aumento dell ' organico di ogni squadrone di altri 11 o 12 soldati a pieru si sarebbe otte nu to però:
a) di fare intervenire all'istruzione un maggior numero di uomini , affiatandoli e completan done l ' istruzione tattica di cavalleria;
b) di semplificare l'istruzione dei reparti d'assalto, liberandoli, quando necessario , dalla cura dei cavalli;
c) di avere ad immediata disposizione un primo rifornimento di complemen ti, già pronti e non nuovi allo squadrone, con il quale ripianare le perdite , criterio simile a quello che aveva consigliato la costituzione dei VII battaglioni di ogni Brigata di Fanteria e dai quali il comandante della Brigata poteva attingere giornalmente i complementi necessari a mantenere a 200 effettivi i combattenti delle compagnie degli altri battaglioni.

Oltre a questo, poiché un repaito di assa lto valeva quanto il valore e la perizia dei suoi coma ndanti e poiché senza un reale pratica , ottenuta sui luoghi e nell'ambiente, l'istruzione rimaneva priva di valore, si proponeva che fossero inviati ai campi già istituiti presso le armate 2a e 3a uno o due subalterni per reggimento ed uno o due graduati per squadrone , oltre ad un tenente anziano o un capitano per divisione, per farne dei provetti istruttori. Era ritenuto giustamente necessario creare prima i comandanti e poi costituire reparti , tanto più che non esisteva nulla di simi le né presso le truppe rupendenti , né presso quelle dipendenti dalle autorità territoriali . Si trattava, inoltre, di istituire ex novo campi di esercitazione non troppo lontani, perché gli uomini dovevano continuare a rimanere nei propri squadroni e perché dovevano intervenire anche i ciclisti e le sezioni mitragliatri ci sul 1' esempio di quanto praticato nei reparti di fanteria.
Tutti i repruti di assalto dovevano essere dotati di pistole mitragliatiici, che avrebbero risolto il problema di aumentare la potenza di fuoco della Cavalleria senza appesantirla. Anche i reparti ciclisti dovevano essere muniti di queste armi , che davano un volume di fuoco impressionante, montandole suUe bici stesse. Il repruto d'assal to doveva essere parte integrante dello squadrone a cavallo ed impiegato come tale anche negli appiedamenti temporanei. Stante il volume di fuoco dei nuovi reparti, grazie alla dovizia di nuove armi , soprattutto inruviduali, ve ne erano molte che meglio esprimevano il carattere dell'Ardito
-153
(pugnale, bomba, pistola), ma nel caso dell'inserimento nell'organico a cavallo era probabile c he al momento d'agire venisse a mancare l'anna essenziale, ossia la bomba a mano. Bisognava studiarne il trasporto. Il problema principale restavano i reparti di assalto staccati dagli squadroni a cavallo, che in effetti erano reparti con specialità di arditi, non più cavalieri. Tutte le proposte escogitate tendevano a lenire le difficoltà che sorgevano nell'Anna per una sana costituzione dei reparti d'assalto, non già a risolvere completamente le prime, ma per inserire i secondi organicamente come specialità. La difficoltà maggiore scaturiva essenzialmente dalle prescrizioni , in seno al comando generale dell ' Arma, che i reparti fossero formati e continuassero a far parte dello squadrone a cavallo, con conseguenti danni alle compagi ni ed all'istruzione degli squadroni e un non completo né s icuro sviluppo dei reparti d'assalto stessi. Oltre un certo limite , diventava un problema quasi insuperabile fondere e armonizzare negli stessi individui la perfezione dell 'is truzione a cavallo con quella della guerra di trincea. Questo era evidente a tutti , ma la Cavalleria doveva salvare se stessa, il proprio mito e soprattutto il proprio onore; per questo nutriva la speranza e la fiducia di poter essere impiegata ancora se la guerra fosse tornata di movimento . Era giu sto aumentare il volume di fuoco, giusto creare reparti scelti di ar·diti, ma gli squadroni ed i reggimenti dell'Arma dovevano conservare la caratteristica delle unità a cava11o . Il reparto d 'assalto , in effetti, altro non era che la riunione di elementi, selezionati per coraggio, coli' istruzione dei normali combattenti di fanteria, i quali nell a guerra di trincea fossero capaci sia di trascinare le masse di combattenti, sia d'ese guire piccole operazioni locali. Si trattava del ruolo che la Cav alleria aveva avuto per secoli.

Era pertanto da escJudersi che i combattenti e cavallo dovessero perfezionarsi nel combattimento a piedi sino ad essere elementi di un reparto d 'ass alto autonomo , ma era invece considerata sufficiente l'istruzione che sarebbe stata impartita. Pertanto si proponeva di aggiungere alle unità di cavalleria, o di trarre da esse, gli elementi perfezionati nel combattimento piedi e con questi costituire e istruire reparti speciali, "a latere" degli sq uadroni , per aumentamela potenza di fuoco senza paralizzare la vita delle unità di cavalleria depauperandone l'organico. Il rimedio consisteva nel perfezionare l'istruzione nel combattimento a piedi; aumentare i ciclisti, se necessario; creare reparti d'assalto con le forze stabilite in aggiunta all'organico delle unità cavallo, mandandoli su biciclette. Si pensava d'ottenere una maggiore coesione e istruzione dei reparti d 'assalto , i quali dovevano vivere in un ' atmosfera morale superiore alla media e dovevano esse re veramente provetti nell'impiego dei mezzi loro assegnati. Si mirava inoltre ad un più facile loro impiego nelle piccole e spec iali operazioni di ar·diti, anche lontano dagli squadroni, dove gli uomini sarebbero stati liberi dalle preoccupazionj dei cavalli e dalle eventuali deficienze che le perdite avrebbero potuto creare nello squadrone. Si richiedeva la fornitura d'un equipaggiamento e annarnento rispondente al loro impiego senza essere costretti ogni volta a depositare sui carri le lan ce e le sciabole ed a togliere speroni, gambali e buffetterie da equitazione. Si perseguiva infine il mantenimento degJj squadro ni a cavallo in efficienza e in condizioni di poter più agevolmente continuare il proprio perfezionamento. La c reazi o ne dello squ adrone e del plotone d 'assal to era integrata con l 'a umento: nell ' organico delJa divisione di un capitano, o un tenente anziano, specializzato nel difficile compito e in grado di dare vita e impul so al reparto , senza dover togliere un comandante di squadro ne o un tenente tutte le volte che si dovesse impiegare lo squadrone d ' assalto; nell 'organico del reggimento di un subal terno con analogo scopo ed incarico rispetto ai plotoni. Similmente dovevano essere costituite la sezione pistole mitragliatrici. 104 Intanto però le truppe non indivisionate erano state assegnate alle TS e, per la quasi totalità , salvo rarissime eccezioni, impiegate soltanto per servizi di polizia stradale nelle retrovie , scorta di prigionie1i, guardie e così via. In una parola la cavalleria cominciava ad essere non più considerata come elemento combattente di possibile e prolungato impiego, sia pure a gruppi, a squadre , per plotone , a cavallo o appie dati , ma quasi come truppa non combattente da adibire unicamente e permanentemente a servizi ausilia
iOJ AUSSME B4 4108 4" divisione, disposizioni.
154
ri. Fatto grave: a molti comandanti di reggimento e cli gruppo erano pesso affidati incarichi permanenti lontani dai loro reparti e sovente dalla zona di azione. Nonostante il comando dell'Arma presentasse richieste di limitare il fenome no , non fu a solutamente possibile modificare tale stato di cose. Ne co nse gu ivano , fra gli altri, due gravi inconvenienti. Innanzinmo l'addestramento tecnico-tattico della maggior parte di queste truppe non poteva effettuarsi che saltuariamente. ed agg iun giamo, effettivamente con scarsi risultati. In secondo luogo, anche ne.Ile circostanze favorevoli, in cui si sarebbe potuta impiegare la cavalleria con ottimi risultati, di nonna non si otteneva nulla, perché non e ra possibile rimettere in se lla e distogliere dai servizi vari gli squadroni, ormai appiedat i ed assegnati aUe unità di fanteria.L'Arma non riusciva quindi ad agire con quella perfetta co no scenza della situazio ne che nei casi specia li era indi spe nsabile, in quanto nuova dell'ambiente. Non a ca o la Germania aveva mantenuto in organico alcune ctivisio ni a cavallo, dotandole dei mezzi moderni; lo stesso avevano fatto gli In g lesi ed i Ru ssi.
L 'addestrame nt o dell'Arma di C avalleri a, fino ali 'ottobre 1917, e durante il re to della guerra, era comunque analogo a qu e llo degli altri eserci ti europei ed era il più rispondente alle esigenze della guerra moderna. per cui la preparazione dell'Arma era nel complesso sod di sfacente. Non poteva essere ottima per un complesso di circostanze varie, fra le quali va segnalato l 'eso do della quasi totalità dei giovani ufficiali in e r vizio attivo permanente, chiamati a coprire i più svar iati incarichi nei corpi e servizi dell'esercito mobilitato: av iazione , artiglieria, collegamento, Stato Maggiore, aiutanti, fanteria, bombardieri, interpreti Ad un certo momento del conflitto la massa dei subalterni ai reparti era rappresentata da ufficia li di comp l emento richiamati.' 05
Unico neo: la po vera immagine che la Cav alleria cominciava a dare di sé nella pubblica opinione e, quel che era peggio, tra le truppe comba ttenti.
 Mitragliere ciclista di cavalleria.
Mitragliere ciclista di cavalleria.
10 ~ AUSSME B 4 9651 pratica commissione inchiesta: Relazione sull'impiego dell'arma di cavalleria, 17 giugno 19 I9. -1 55
 Sezione Mitraglieri ciclisti di cavalleria coli ' arma in posizione di tiro.
Sezione Mitraglieri ciclisti di cavalleria coli ' arma in posizione di tiro.
156
SFONDAMENTO SULLA BAINSIZZA
All'inizio della guerra il confine austro-italiano correva lungo la Val Pontebbana, tagliava l'abitato di Pontebba e si inoltrava nell'inaccessibile sistema delle Alpi Giulie occidentali fino al Jof di Montasio. Passava quindi sul crinale del Canin in corrispondenza del Monte Cergnala e scendeva giù attraverso la Val Uccèa , la conca di Platischis, il Monte Mia, il medio solco del Natisone ed il Monte Matajur. Da lì, attraverso la dorsale del Kolovrat e la valle dello Judrio si arrivava (e si arriva tutt'ora) nella pianura isontina alle pendici del Carso , scenario delle battaglie dell'Isonzo
L'Esercìto italiano aveva conquistato Saga, passando dalla Val Uccèa a quella dell'Isonzo , e aveva occupato l ' intera dorsale dello Stol. All'occupazione di Caporetto era seguita quella del crinale Matajur Sella di Luico-Monte Kuk Kolovrat Monte Jeza , che in tal modo cambiò bandiera e divenne italiano.
La zona è montuosa e rotta da forre ed era forse la più difficile da conquistare di tutto il fronte. La Decima Battaglia dell' I sonzo aveva portato il Regio Esercito alla conquista del Monte Kuk, della quota 383 e delle posizioni a nord ed a sud degli stessi. Ciò significava la possibilità di espugnare, con un'azione ai fianchi, il Monte Santo che domina la Bainsizza. Dal settore del Kuk , parte della fanteria italiana si era spinta sempre più avanti verso quota 652 , presso il Vodice, mentre un'altra parte raggiungeva contemporaneamente le falde settentrionali del San Gabriele. Il fronte, dal Monte Nero al San Gabriele, presentava quindi una breccia in corrispondenza della Bains izza. Le fanterie italiane si trovavano in una posizione avanzata ma difficile da tenere, in quanto battuta dal tiro delle mitraglie e delle artiglierie nemiche. Il punto raggiunto era d'altro canto vicino alle reti di comunicazione delle truppe austro ungariche, che garantivano il contatto tra il fronte dell'alto Isonzo ed il Carso triestino. Per ambedue gli eserciti , tuttavia, le posizioni tenute destavano grosse preoccupazioni in quanto, non essendo fortificabili in profondità, davano insicurezza e precarietà alla difesa.
Nel 1917 l'Esercito itali ano era profondamente cambiato, si era potenziato, impadronito dei mezzi offerti dalla tecnica ed aveva imparato dai suoi errori. Era un organismo efficiente ed era pronto a mettere jn opera una nuova strategia, il cui fine era di infliggere un colpo che spezzasse la monotonia della guerra di posizione.

Tale strategia, tenendo conto delle perdite subite e degli scarsi successi raggiunti in precedenza, fu attuata nell'Undicesima Battaglia Fu incrementata in maniera massiccia l'artiglieria e si rinunciò a quelle manovre complicate basate su comb in azioni di attacchi che , in passato, avevano dato risultati puntualmente inferiori alle più pessimistiche previsioni. Si doveva bensì sferrare un attacco all'intero fronte, ma indirizzandone lo sforzo maggiore su posizioni ri strette, senza perdere di vista, nel contempo, l'evolversi della si tuazione. Per attuare tale tattica, le truppe avrebbero dovuto con centrarsi immediatamente in linea, mentre le artiglierie avrebbero dovuto diluire i loro co lpi in più giorni, in modo da stordire ed inebetire le difese nemiche.
Opera va nella zona del medio Isonzo la 2a Armata al comando del generale Capello, che estendeva il suo controllo sulla zona che va dal Monte Ro mbon alla confluenza dei fiumi Vipacco e Vertojbica Alle s ue dipendenze c'erano il IV Corpo d'Armata (dal Monte Rombon a Costa Raunza), comandato dal generale Cavacioccbi; il XXVII Corpo d ' Armata (da Costa Raunza a Ronzina) del generale Badoglio; il XXIV Corpo d ' Armata (da Ronzina ad Anhovo), agli ordini del generale Caviglia; il LI Corpo d'Armata (da Anbovo al Sabotino), sotto il generale Montuori ed il VI Corpo d'Armata (dal Sabotino a Gorizia esclusa), del genera le Gatti , che chiudeva la zona operativa assegnata all'Armata.
CAPITOLOXID
-157-
L'armata austro ungarica contrapposta era al comando di Boroevic von Bojna, alle cui dipendenze si trovavano i Corpi d'Armata XV, XXIV e XVI , ripartiti in tre settori: nel I (da S. Maria Bodrez), il XV Corpo d'Armata del Feldleutnatmarschall Scotti, nel Ila (da Bodrez a Salcano) il XXIV Corpo d'Armata del Genera] der lnfanterie Lukas, nel Ilb (da Salcano al solco del Vipacco) il XVI Corpo d'Armata del Generai der Infanterie Kralicek.
All'armata del generale Capello fu affidato il compito di attaccare l'altopiano della Bainsizza, quale preludio per la conquista di quello di Tarnova. Nei piani strategici generali ciò avrebbe significato l'apertura della via verso Lubiana e la creazione contemporanea di un corridoio verso Trieste. Le indicazioni dello Stato Maggiore erano quelle di effettuare contro la testa di ponte di Tolmino (Santa Maria e Santa Lucia) solo attacchi diversivi.
L'fosormontabile testa di ponte di Tolmino rappresentava il pilastro settentrionale nello schieramento austro-ungarico del medio Isonzo. Le alture di Santa Lucia e Santa Maria erano state trasformate in una fortezza inespugnabile. Da lì, le linee di difesa della fanteria asburgica correvano lungo un canalone parallelo a quello italiano, occupando un'area oblunga lungo tutto il corso dell'Isonzo, fino a saldarsi con quelle del Monte Santo. In mezzo stavano i Lom di Tolmino, Auzza, Loga, Bodrez, Canale, Morsko, Descla, il Vallone del Rohot, i monti Kuk, Vodice e Santo.
Il 18 agosto le fanterie regie passarono l'Isonzo in più punti e si riversarono dall'altro lato. I ripetuti attacchi provocaro no ancora un avanzamento tra Descla e Morsko. Il Kuk, preso d'assalto da nord e da sud, divenne italiano e la linea di difesa imperiale arretrò tra il Kolk e q. 856.
Poi fu la volta dello Jelenik-Kolk q. 856 e delle posizioni di Rutarsce. La battaglia finì sulla Bainsizza il 25 agosto, sulla nuova linea Log, Hoje, Vrh, Kal, Zagomje, San Gabriele, Vodice e Monte Santo.
Mentre le fanterie attaccavano sul fronte di Gorizia e sul Carso, la 2a Armata, gittati i ponti, passò l'Isonzo. Investite nei loro punti di congiunzione, le linee di difesa caddero. Siccome il nemico si ritirava celermente, occorreva inseguirlo senza dargli tregua e, nello stesso tempo, bisognava riconoscere e tentare di aggirare le nuove linee difensive. A questo scopo avrebbe dovuto concorrere la cavalleria, che dislocò la sua 2a Divisione fra Lozice e Anhovo e la V Brigata nelJa zona Plava-Britof. Alla 2a Divisione furono assegnati tre battaglioni Bersaglieri Ciclisti con il comando di gruppo. Alla V Brigata ne fu assegnato uno.
La situazione delle truppe italiane in quel momento era la seguente. La Divisione di Cavalleria era stata aggregata al XXVII Corpo d'Armata, che a nord stava operando per la conquista dell'alto piano di Lom di Canale e Loro di Tolmino, allo scopo di prendere di rovescio la testa di ponte di Tolmino. Il suo compito generale era inseguire il nemico, quello particolare consisteva nel concorrere alle operazioni in corso per l'occupazione dell'altopiano della Bainsizza , fornendo informazioni alla fanteria, nonché occupare la valle di Chiapovano-Idria, dando sicurezza alla fanteria che dove va raggiungere il margine orientale della valle .
Per questo scopo la 23 Divisione doveva seguire la direttrice di Chiapovano e, in caso di sfondamento totale, si doveva spingere nella valle dell'Idria, occupando Baza di Modrejia per facilitare il compito al XXVII Corpo d'Armata.

Alla V Brigata spettava la direttrice Tamova e settore Lokovec-Tarnova e, in caso di sfondamento, l'azione sul rovescio della linea di Schonpass. 106
Il XXIV Corpo d ' Armata seguiva la direttrice d'attacco lungo la strada VrhRumarjie-Podlesce-Locovec-Chiapovano. Alla sua sinistra agiva il XIV Corpo d'Armata lungo la direttrice Leupa Kal-Velivrh. Alla sua destra invece lo fiancheggiava il II Corpo d'Armata , lungo la strada Bate-Sveto-Madoni, mentre una divisione dello stesso Corpo d'Armata doveva attaccare sul rovescio del San Gabriele.
106 AUSSME 128D 1615 B, diario storico della 2• divisione di cavalleria. 158
'
Il 26 agosto le ctivisioni del XXIV Corpo d"Armata stavano combattendo per avanzare ed affacciarsi al vallone dj Chiapovano. Se fossero riuscite a rompere la linea di resistenza avrebbero potuto spingersi verso il paese di Chiapovano, cercando di aiutare nel tempo stesso le divisioni laterali. Era intenzione del comandante l'Armata di spingere subito innanzi i tre battaglioni ciclisti per impadronirsi del varco di Locve, occupando la g. 979 a nord della strada, q. 965, q. 907 e Chiesa dj Locve. L'occupazione aveva possibilità di riuscita non passando per Ch.iapovano paese, ma più a sud. Una volta aggirato l'obiettivo non ci sarebbero stati più limiti ad un'azione di cavalleria sia verso Ajdussina, sia verso Chiapovano, sia verso Tamova. Il terreno, infatti, si prestava meglio ad essa, presentando le caratteristiche tipiche del terreno carsico a leggera ondulazione. Ancora il 26 però si specificava che, qualora non fosse stato possibile aprire il varco, la cavalleria avrebbe dovuto agire a nord. Era quindi indispensabile studiare il terreno per la marcia d'avvicinamento e cercare luoghi di ammassamento per i reggimenti, i quali, data la natura del terreno e dell'occupazione nemica, avrebbero dovuto marciare a piccole colonne.
Il problema principale erano le risorse idriche. L'altopiano della Bainsizza non ne offre e tutt'ora è possibile rifornire uomini. ma non masse di quadrupedi. Gli uomini potevano rifornirsi più oltre, alle sorgenti note molte delle quali erano però secche nel 19 l 7 -fra Humarji e Lucari. Data la scarsezza d'acqua però, i cavalli potevano essere abbeverati al mattino di partenza e, se si fosse riusciti a rompere le linee nemiche, si sarebbero potuti riabbeverare solo nel vallone di Chiapovano. In caso contrario, avrebbero dovuto tornare sull'Isonzo per trovare dell'acqua. 101
AUSSME 1280 1615 B, diario storico della 2a divisione di cavalleria Conferenza lenuta da sua eccellenza il comandante del XXl V corpo d'armata a Verh il 26 agosto 1917.
 Le linee dell'avanzata italiana del 1915. 1916. 1917.
Le linee dell'avanzata italiana del 1915. 1916. 1917.
07
159-

u~. raa\UJll;i alJa 11n~ dtl1I , balla,tla 1\lll'horu,1, • 4!4Ua banmlli,a di l'.iilriut. t ddl4 16" balllllll• lbll'l,0,110. • cleig bacuaJja <léUa aa.,....,., Carta delle operazioni del medio Isonzo con le linee raggiunte nelle varie battaglie fino alla conqui sta della Bainsizza. -160-
In esecuzione agli ordini ricevuti, nella mattina del 26 agosto , il 1° Squadrone di Aosta si trasferì a Verh per il servizio di collegamento e si provvide all'impianto di drappelli di corrispondenza (ciclisti di Mantova) tra Canale eAnhovo. Nel pomeriggio del 26 furono stabilite Je direttrici di marcia della Divisione e, nella mattina successiva, inviate pattuglie di ufficiali. Il giorno 27, infatti, due pattuglie doppie di ufficiali della IV Brigata riconobbero la direttrice Canale Verh-Hurarji-Podlesce-quota 845-Breg e due pattuglie doppie, composte da ufficiali della III Brigata, la direttrice: Canal.e-Verb-Humarji-Lonka-Breg, in modo da fornire informazioni rispettivamente sulla zona di sinistra e di destra del Corpo d'Armata.
In seguito alle difficoltà prospettate il giorno prima, il 26, per incanalare tutta la Divisione sulla mulattiera Canale-Verb, il comandante la Divisione dispose che il 28 fosse riconosciuta la mulattiera Deskla-Gabrje-Bate neli 'intento di assegnarla come itinerario alla III Brigata, inoltrando la sola IV sulla mulattiera Canale-Verh. Il 28 furono eseguite ricognizioni di ufficiali su entrambe le direttrici, ma le notizie sulla percorribilità della mulattiera Deskla-Bata risultarono poco favorevoli al movimento. Per avere una conferma, fu incarico il comandante laIIl Brigata (colonnello brigadiere Fè d'Ostiani) d'eseguire la stessa ricognizione, facendosi accompagnare da un ufficiale superiore dipendente e da alti ufficiali. L'esito confermò ]'impossibilità di usufruire della mulattiera Descla-Gabrje-Bata.
Nella stessa giornata altri ufficiali della IV Brigata compirono servizi di pattuglia, svol gendo compiti speciali. Nell'intento di trovare una nuova strada percorribile dalla IIl Brigata, il 30 il comandante i Lancieri di Milano riconobbe la mulattiera che, partendo da Morsko, passa nella sella fra Jelenik e Planina e, per Dragovice, arriva a Ravne. Anche questa risultò però inadatta al transito di reparti a cavallo. La situazione diventava effettivamente imbarazzante. I comandanti di reggimento della IV Brigata, colonnelli De Giorgio e Lostia, eseguirono ricognizioni, lo stesso giorno 30, sulla direttrice della propria Brigata. Dal complesso delle informazioni raccolte, il comandante la Divisione si formò l'idea che la zona di terreno adatta all'impiego di cavalleria sull'altopiano fosse (come era effettivamente, conoscendo la zona) già in possesso ed oltrepassata dalle fanterie regie Queste ultime procedevano già contro l'avversario che si era arroccato, favorito dalle asperità del terreno roccioso e sconvolto, nella fascia orientale dell'altopiano, dalla quale non si sarebbe mosso. Quindi a causa de l terreno, dell'acqua e delle forti posizioni nemiche, risultava possibile un'azione dj cavalleria fatta non da unità o Grandi Unità, ma soltanto da pochi squadroni isolati. Dato che anche questi avevano scarsa possibilità di riuscita, il 31 agosto 1917 la Divisione si trasferì sul Natisone e sullo Judrio. ios
Un particolare compito toccò invece alla V Brigata di Cavalleria. Lo sfondamento sull'altopiano della Bainsizza, favorito dal cedimento della linea meridionale ancorata sulle cime del Kobilek e dello Jelenik, aveva prodotto l'arretramento generale dello schieramento imperial-regio ed il conseguente abbandono delle sommità aspramente contese del Vodice e del Santo. Il risultato immediato era stata l'importanza assunta dal San Gabriele, quale elemento di raccordo tra il fronte del medio Isonzo e la zona di Gorizia.
Il San Gabriele, dall'alto dei suoi 646 metri di quota, domina completamente Gorizia e la pianura isontina a sud e la conca di Gargaro-Britov ed il margine meridionale della Bainsizza a nord Sorgeva allora come un gigantesco frangiflutti dinanzi alle ondate d'assalto italiane, che stavano scendendo dal Vodice e dal Santo per unirsi alle forze arniche che salivano dalla stretta di Salcano. Per la prima volta dall'inizio delle ostilità era possibile aggredire il colle da tre versanti, i l più abbordabile dei quali, nel caso che le forze attaccanti fossero riuscite ad affermarsi sul Veliki Hrib (Quota 526, la sommità che incombe sulla sella del Dol, a sua volta dominata dalla cima del Monte Santo) era senza dubbio il pendio nord-occidentale. La conquista del Monte si sarebbe però rivelata effimera se le truppe italiane non avessero eliminato le posizioni d'ala: il villaggio di Ravnica a nord, lo sperone di Kamarca e l'altura di Santa Caterina a sud.
108 AUSSME 128D 1615 B. Diario storico della 2• divisione dì cavalleria Comando della 2" divisione di cavalleria; oggetto: ri cognizioni zona di guerra , 31 agosto 1917.

-161
Il fronte più abbordabile era quello settentrionale, che aveva però lo svantaggio di essere sotto il costante tiro dell ' artiglieria nemica , posta sul Monte San Daniele e sull'altopiano di Tarnova .
Dopo la perdita del Monte Santo e di gran parte della Bainsizza, alla fine d'agosto 1917 le forze austro ungariche non potevano rischiare l'abbandono del San G abriele, senza compromettere la tenu ta dell ' intero fronte goriziano. Le linee ancorate sulle cune andavano infatti a collegarsi direttamente con quelle della conca di Gorizia e del Carso. D all'Hermada al San Gabriele correva dunque l'ultima ridotta dell'impero sul fronte sud occidentale. Sfondata questa , sarebbe stato estremamente dif ficile ricostruire il fronte e sa lvare l ' esercito dal tracollo morale e materiale .

Il giorno 24 agosto il Comando della V Brigata di Cavalleria e quello del R eggiinento Cavalleggeri di Sa/uzzo con tre squadroni e sezioni mitragliatrici , che si trovavano accantonati a Lumignacco e dintorni, ricevettero ordine del Comando della 2a Divisione di Cavalleria di portarsi a Pia va dalle ore 8 del 25, in attesa di ordini .
A Globna li raggiunsero il Comando del Reggimento Cavalleggeri di Vicen za , la II Sezione Mitragliatrici ed il 3° e 4° Squadrone di Vìcenza, che fino allora, erano stati a disposizione dei quattro corpi d'armata. L' ordine d ' operazione della 23 Armata per la V Brigata era "azione della cavalleria , con compito per la brigata di inseguire nemico , agendo sul roves cio delle linee di Tarnova."
Per riconoscere il terreno , tutti gli ufficiali della Brigata si trovarono al1 'altezza di q. 65, suUa strada di Plava-Salcano , riva sini stra dell' I sonzo, dov e , lasciati i cavalli, in due ore circa, per la mulattiera Forlì, raggiunsero il comando dell'8 8 Divisione sul Monte Santo L'intera Brigata, com posta di tre squadroni Cavalleggeri di Salu zzo con sezioni mitragliatrici, di tre squadroni di Vicenza
M. Je/r,nicli. 1q. 786\ p,.J,e,o
L' altopiano della Bainsiz za.
19 535>.
162
con sezioni mitragliatrici , e del II Battaglione Bersaglieri Ciclisti, si trovò ammassata dalle 7 .30 del 26 agosto 1917 a q. 65 , ad est della strada, in attesa di ordini.
Chiunque co n osce la se lla del Dol ed il complesso del Monte Santo sa che, con gli Austriaci fortemente trincerati sul San Gabriele , era impossibile qualsiasi movimento; la battaglia era quindi necessaria e sarebbe divenuta unica ed epica nella storia dell'Esercito ltaliano w9 •
Il 26 agosto un fortissimo acquazzone complicò ulteriormente il quadro già abbastanza precario per la cavalleria. Il co ngestionamento del traffico stradale, la salita a piedi del Monte Santo ed i ripetuti e violenti acquazzoni non agevolarono la marcia. Così, anche per la mancanza di calzature adatte, l'avvicinamento alJa zona d'attesa dell'attacco presentò per l a Cavalleria più difficoltà del previsto. Mentre gli ufficiali ed il Comando della Brigata discutevano e studiavano la situazione, il comandante del II Corpo d'Armata diede ordine agli squadro ni di raggiungere sollecitamente, per Dolg aniva e la selletta di q. 503, la località di Gargaro, con lo scopo di " .puntare poi verso est in direzione nord di Lanisce, cercando cadere sul rovescio della linea di difesa nemica dell'altopiano di Tarnova per produrre mass imo sbaraglio."
Riorientati si sulla situazione col Comandante dell'8a Di v isione e studiato rapidamente il terreno della conca di Gargaro , si ordinò al II Battaglione Bersaglieri ciclisti, che avrebbe dovuto portare le biciclette , di ridiscendere a quota 65, sulla s trada Plava-Salcano. Qui doveva concorrere, insieme alla destra dell'8a Di visione, al rafforzamento de] passaggio della sella di Dol , raggiungendo poi di là la B rigata di cavalleria a Gargaro. Avrebbe quindi cooperato con essa all'azione contro il rovescio delle linee nemiche sull'altopiano di Tarnova.
Così il Battaglione , nei giorni 26, 27 e 28 agosto operò insieme aJJ'8 8 contro il Dol, senza però riuscire a forzarne la sena ed il 28, in seguito ad ordine del comandante dell'Armata , si sarebbe trasferito a Baske a temporanea disposizione della 53a Divisione. Da lì, la sera ed il 31 si sarebbe poi riunito nuovamente alla Brigata a Globna.
Intanto, il 26, la colonna dei cavalleggeri provenienti da D olganiva e selletta di q. 503, con Vicenza in testa e Sa/uzzo in coda, verso le ore 14.30 comi nciò ad affacciarsi alla conca di Gargaro, nei pressi di q. 346. Fu subito avvistata dall'artiglieria nemica e fatta segno a tiro a shrapnels. Il Reggimento Vicenza, avanzando molto celermente ed a piccoli gruppi distanziati , riuscì a scende re tutto nella conca con perdite non rilevanti , ammassandosi al coperto dietro il costone di q. 366 imme diatamente a nord di Gargaro. Mentre scendeva l'ultimo squadrone di Vicenza, essendosi fatto il fuoco dell'artiglieria sempre più vio lento fino a divenire vero e proprio tiro d'interdizione, fu ordinato ai cavalleggeri di Sa/uzzo di arrestarsi al coperto a l di là della sella di q. 503 e di riprendere il movime nto solta nto a notte. Accortosi della difficoltà di avanzare in quel tratto, a ll e ore 16 il comandante del II Corpo d'Armata ordinò a sua volta di non oltrepassare nella sera la linea del1e fanterie e di disporre la Brigata in modo da proteggerla da tiro nemico. Il Reggimento Saluzzo comunque passò e raggiunse la Brigata verso mezzanotte , ammassandosi anch'esso dietro il costone di quota 366. L 'i nd omani , 27 agosto, la Bri gata si raccolse a stormi su una larga fronte del costone dietro il quale era ammassata. Attraverso la campagna ed i sentieri irradiantisi dalla direttrice Gargaro-Britof (in precedenza riconosciuti dalle pattuglie ufficiali inviate a Fobca ed in collegamento co n le fa nt erie che occupavano la selle di fronte all'osteria di Kal e la località "caverne" a q. 664), puntò diret tamente per San Pietro su Fobca. Qui si sarebbe ammassata a sud est delle case , sotto il costone sul quale corre a mezza costa la strada che, per la sella di q. 451, immette nel vallone di Chiapovano. Mentre i cava ll eggeri attendevano il momento dell'azione, verso le ore 10, il comandante dell'8 a Di visione ordinò che: "essendo possibile una sospensione dell'azione progettata per la giornata, la
109 Rimando per una descrizione della battaglia a Enrico CERNIGOI, S. Gabriele, la morte e il Monte io La grande guerra e l'lsontino, s u ··Qualestoria", Rivista dell'Istituto Regionale per la Storia deJ Movimento di Liberazione nel Friuli Venezia Giulia , Trieste, 1998.

-163-
Vodice cq. 59.2)
!
Zagom,11> Forrino,J/ Vodiee ZagomHa 1q. ~52)
I
lq. 5031 M. Santo (Conv~nlol fq. Ge21
M. San Gabriele \q. 646)
 Allineamento Palievo monte San Gabrìele
Allineamento M.rzli- Vo dil.
Allineamento Palievo monte San Gabrìele
Allineamento M.rzli- Vo dil.
164
brigata attendesse nuovi ordini prima di iniz iare mo v imento."
Verso le 11 venne dal comando del II Corpo d'Annata l 'ord ine di mettere a disposizione della 50° Divi sio ne uno sq uadron e, con incarico di portarsi a Fobca, per prendere poi collegamento con il comando della Brigata Aquila ed attendere ordini. Alle ore 12 il 5° Squadrone dei Cavalleggeri di Saluzza eseguiva l 'ordine, giungendo a Fobca alle ore 13.

Durante tutta la giornata la Brigata , pur rimanendo sempre in se lla a disposizione del Comando del II Corpo d'Annata, non ricevé altri ordini e continuò a staz ionare dietro i l costo ne, dove cominciò a subire qualche perdita per opera dell'artiglieria nemica.
A mezzanotte del 27 , tramite il Comando dell' ga Di visione, arrivò l'ordine con cui il comandante del Il Corpo d'Armata confermava alla Brigata il compito già assegnatole. L'azione doveva iniziare aIJe ore 9 ma, verso le 8 , un fonogramma del Corpo d'Armata la differiva alle 12. D opo le abbondanti piogge però, verso le ore I 1, so rse improvvi samen te un po ' di foschia sul fondo nella conca di Gargaro , provocata probabilmente dall'umidità dal ten-eno, mista al fumo del violento fuoco d'artiglieria nemica che ve niva rovesciato sulla conca stessa. Il comandante la B rigata decise d'approfittarne subito per muovere gli uomini verso il punto stabilito, a s ud es t di Fobca , con il minimo possibile di perdite. L'ordine fu eseguito, con qualche perdita , dai Cavalleggeri di Vicenza che, nello spostame nto, o ltrepassarono Bri tof, quota 451 del vallone di Chiapovano , intensamente battuta dall'artiglieria nemica. Vennero staccate s ubito numerose pattuglie ufficiali, sia a piedi che a cavallo, sulla linea delle fanterie e venne preso con tatto con la 53a Divisione. T utte le informazioni, sia direttamente raccolte che perve nute dagli ufficiali informato1i della 53 \ risultarono per tutta la giornata concordi nel confermare l'assoluta impossibilità di sboccare dal sito d'ammassamento ed oltrep assare le linee di fuoco delle fante1ie per puntare su Lanisce. Fuori dalla strada il ten-eno non risultava percorribile a cavallo, sia per la sua natura rocciosa, s ia per la presenza di robusti reticolati e numerosi nidi di mitragliatrici nonché di piccoli ca]jbri, che già immobilizzava la fanteria in linea, causandole elevate perdite. Verso le 16, passan do per il luogo dell'ammassamento della Brigata, il comandante la 53a Divisione diede a1 comanda nte di Brigata schiarimenti circa la linea raggiunta dalle truppe e l 'andamento dell'operazione. Il medesimo divisionario constatò a s ua volta che qualunque azione a cavallo in quella zona sarebbe stata destinata a fallire . Alle ore 19 circa un gruppo di aeroplani nemici volò a media quota sulla Brigata, sganciando alcune bombe, senza però arrecarle danno . Verso le 20, visto che la resistenza nemica s i faceva più forte e che l'impiego della Brigata diventava sempre meno probabile , il comandante decise di ripor tare la Brigata sotto il costone di q. 356 di Gargaro. E fu bene poiché , mentre iJ movimento si stava ultimando, Salu zzo, che era in coda, ebbe a subire perdite di uomini e di cavalli da numerosi colpi di artiglie1ia sparati s ul luogo dove la Brigata era stata fino allora ammassata. Ques to tiro era stato aggiustato probabilmente in seguito alle informazioni fomite dagli aerei che l'avevano sorvolata poco prima. Comunque dopo le 21.30 la Brigata aveva ripre so la s ua dislocazione dietro il costone di Gargaro.
TI 29 ed il 30 la Brigata rima se a Gargaro, sempre a disposizione del II Corpo d'Armata , costantemente al coITente della situazione, grazie allo stretto collegamento con le brigate impiegate , in attesa di poter entrare in azione. Di nuovo s ubì qualche perdita, specialmente in cavalli, provocata sempre dall'ininterrotto tiro delle artiglierie nemiche. Alle 21 del 30 agosto le arrivò dal Corpo d'Armata l'ordine di portarsi a riprendere, approfittando della notte, l'addiaccio a Globna.
L 'i ndomani , 31 agosto, la Brigata giunse a Plava alle 9, dopo aver percorso l'itinerario Gargaro Zlatna-mulattiera del Roth-Globna. Alla sera ricevé ordine di spostarsi entro la giornata del 1° settembre su Dolegna e Vencò, re stando alla dipendenza tattica della 2a Armata ed a quelle disciplinare ed amministrativa della 2a Divisione di Cavalleria. 110
11 0 AUSSME B4 4105. Comando della V Brigata di Cavalleria sulla Bains izza -165
 Passaggio sull'Isonzo dopo lo sfondamento della Baiusizza , 1917.
La Fanteria italiana passa l'Isonzo a Canale nell'ago sto l 917.
Passaggio sull'Isonzo dopo lo sfondamento della Baiusizza , 1917.
La Fanteria italiana passa l'Isonzo a Canale nell'ago sto l 917.
166-
 Canale, il castello nell'agosto del 1917.
Agosto 1917: una compagnia mitraglieri appiedata guada l'Isonzo andando s ul Carso.
Canale, il castello nell'agosto del 1917.
Agosto 1917: una compagnia mitraglieri appiedata guada l'Isonzo andando s ul Carso.
167-
 Ago to 1917: 853" compagnia rnitraglieri di Cavalleria s ulla Bainsizza.
Ago to 1917: 853" compagnia rnitraglieri di Cavalleria s ulla Bainsizza.
- 168 -
 Agosto 1917: la cavalleria appiedata sale . u11 ·Altopiano della Bainsizza.
Agosto 1917: lo sq uadro ne mitraglieri di un·urutà dj cavalleria appiedata.
Agosto 1917: la cavalleria appiedata sale . u11 ·Altopiano della Bainsizza.
Agosto 1917: lo sq uadro ne mitraglieri di un·urutà dj cavalleria appiedata.
169
 Agosto 1917: un reparto di cavalleria appiedata passa l'Isonzo su una passerella.
T Cavalleggeri di Alessandria attraversano il ponte ricostruito nei pressi di Caporetto.
Agosto 1917: un reparto di cavalleria appiedata passa l'Isonzo su una passerella.
T Cavalleggeri di Alessandria attraversano il ponte ricostruito nei pressi di Caporetto.
170
CAPITOLO XIV
SFONDAMENTO A CAPORETTO
Dopo 11 battaglie il fronte austro-ungarico dell ' Isonzo vacillava pericolosamente. L'ultima di queste aveva prodotto un suo arretramento dall'altopiano della Bainsizza, mettendo così in serio pericolo le comunicazioni tra i settori del basso e dell'alto I sonzo. La continuità del fronte era ormai garantita solo dalla tenuta della testa di ponte di Tolmino e dal San Gabriele , pilastro settentrionale del sistema difensivo imperiale, unitamente aJl' H ermada (pilastro meridionale).
Così, mentre sul resto del fronte la battaglia si stava spegnendo, la lotta s'infittì con progressione geometrica sul San Gabriele , che diventò l'ago della bilancia dello scontro.
Il generale Capello, comandante della 2a Armata e responsabile del settore del fronte da Monte Rombon al fiume Vipacco, continuò a tenere sotto pressione il San Gabriele , ritenendo possibile sfo ndare, contro il parere di Cadorna , e assumendosene la piena responsabilità. Tra queste due stra tegie si inserì il piano austro -ungarico di alleggerimento del fronte.
Il Comando Supremo austro-ungarico non era in grado di garantire adeguata resistenza ad un 'ulteriore offensiva. I fanti in servizio risentivano della stanchezza di tre anni di guerra, la monarchia era allo stremo, non aveva più cibo per i suoi soldati e non aveva più uomini da inviare al massacro nella difesa del fronte sud occidentale L'impero si stava sfa ld ando. Perciò il Comando austro-ungarico fu costretto a ricorre all'aiuto tedesco per battere le fanterie italiane.
Lo studio dell ' offensiva austriaca fu affidato al generale tedesco Krafft von Dellmensingen, che visitò i I fronte nei primi giorni di settembre, mentre era in pieno svo lgimento l 'attacco al San Gabriele. Preso atto della situazione ed individuata nella zona di Plezzo Tolmino l ' area critica del futuro attacco, fu lasciato alle truppe del San Gabriele il compito di attirarvi ancora l'attenzione del] 'avv ersario. impegnandone le fanterie .
Krafft von Dellmensingen elaborò un 'a udace operazione , che fu denominata convenzio nalmente ''.fedeltà d'armi", da attuare nel tratto compreso tra P lezzo e Tolmino. Il piano si basava su una nuova tattica , che univa la s orpresa alla s celta di una regione montuosa alla fulminea azione combinata della fanteria e dell 'artiglieria. L ' orografia del terreno, la disposizione delle difese italiane su tre ordini di linee correnti in cresta ai monti, la mancanza di ridotte nella valle ne facilitavano l'attuazione P er attuarlo si costituì una nu ova Armata , la XIV austro-tedesca, composta di 15 divisioni, divise in quattro gruppi di combattimento ed al comando di uno stato maggiore germanico. Il comandan te supremo era Otto von Below, il capo di stato maggiore Krafft von D ellme nsingen.

Obiettivo strategico era il raggiungimento della vecchia linea del confine italo-austriaco del 1915; J00.000 soldati circa erano pronti a sferrare l'attacco, che injziò la notte del 24 ottobre 1917, alle ore 02.00. Dopo tre giorni di scontri si potevano tirare le somme dell ' offensiva: la meta finale della XIV Armata austro-tedesca e dell ' Armata di Boroevic era il Tagliamento e stavano per raggiungerlo.
Con la conquista , il quarto giorno, del Monte Maggiore , non esistevano più ostacoU tra la valle dell'Isonzo e la pianura friu lan a Le operazioni di Caporetto si erano concluse.
Per fermare gli Austro-Germanici e a protezione dei reparti in ritir ata, tutte le forze italiane di Cavalleria furono gettate nella battaglia: quello su cui si contava maggiormente erano il loro se nso dell ' onore , la relativa freschezza e, più ancora , la tradizionale saldezza dei loro vi ncoli organici.
-171
 Costruzione di ponti sull'Isonzo nel l 917.
Pieris, ponte della ferrovia nel 1917.
Costruzione di ponti sull'Isonzo nel l 917.
Pieris, ponte della ferrovia nel 1917.
-172
 Ponti in costruzione.
La cavaUeria passa un ponte di barche.
Ponti in costruzione.
La cavaUeria passa un ponte di barche.
173
 Trincee sul S. Marco, 191 7.
T rincee di p rima linea. tarda estate del I 9 I7.
Trincee sul S. Marco, 191 7.
T rincee di p rima linea. tarda estate del I 9 I7.
-174
 18° Reggimento Fanteri a Acqui in linea , i nverno 1917.
Sezione mitragliatrici di cavalleri a in esercitazione sul Carso nell'estate del 1917.
18° Reggimento Fanteri a Acqui in linea , i nverno 1917.
Sezione mitragliatrici di cavalleri a in esercitazione sul Carso nell'estate del 1917.
175
 Una griza carsica.
Osservatorio di cavalleria in linea su l Carso davanti alle q. 208n e 208 s de ll'Altopiano di Comeno .
Una griza carsica.
Osservatorio di cavalleria in linea su l Carso davanti alle q. 208n e 208 s de ll'Altopiano di Comeno .
176-
 Un reparto di cavalleria passa un torrente in montagna.
Cavalleria in montagna.
Un reparto di cavalleria passa un torrente in montagna.
Cavalleria in montagna.
-177

CAPITOLO XV
TUTTI A CAVALLO!
La diffi c oltà di allog g iame nto , l e s tesse ragi oni c he a vev ano portato l'anno pre cedente ad inviare ai quartieri invernal i le unità di Cavalleria e appiedarne le Grandi Unità avevano indotto il Comando Supremo a comportarsi nel mede simo mo do nell ' autunno del 1917. Il c iclo delle operazioni coll ' arrivo dell ' in verno poteva dirsi c oncluso , la pross ima offens iva s arebbe stata effettuata non prima della primave ra del 1918 , per cui e ra pre ve di bile che, anche per l ' inverno 1917-18 la Caval1eria avrebbe potuto a ss umere una di s locazione pres soché s imile a quella degli inverni precede nti. Il 3 ottobre il Comando Supremo aveva emanato le direttive a cui il progetto per la s istemazione invernale doveva adeguarsi. Il 6 ottobre il Comando di Cavalleria aveva tras me sso il prog e tto ed il 13 il Comando Supremo l'aveva approvato, aggiungendo: "pre g asi tutto predisporre in modo che iniz io movimento possa effettuarsi quanto più presto possibile specie per quanto riguarda il ritiro d e lle divis ioni cav alleria", cosicché con successivo telegramma del 13 stesso il Comando di Cavalleria aveva irnpartito gli ordini e preso gli accordi opportuni per " iniziare il ritiro delle divisioni di cav alleria".
Di conseguenza , intorno alla metà d'ottobre del 1917 era stato stabilito che le divisioni andas sero così dislocate: la 1a a Motta di Livenza e dintorni , ]a 2a a Pavia di Udine e dintorni per essere poi spostata in Emilia, la 3a in Lombardia, a Gallarate e dintorni , meno il comando della V Brigata ed il Reggimento Salu zzo lasciati a Povoletto e Udine; la 4a infine doveva tornare addirittura a Torino e Vercelli , a disposizione deJle autorità territoriali per il servizio di ordine pubblico.

Il movimento dalla frontiera orientale doveva svolgersi così: la l a Divisione doveva spostarsi a Motta di Livenza , nella zona fra Montagnana e Treviso , per , via ordinaria dal 20 al 27 ottobre ; la 23 da Pavia di Udine a Ferrara per via ordinaria dal 20 ottobre al 3 nove mbre.
Nei riguardi delle T.S. , sulla base degli accordi , era s tato concretato un progetto di sistemazione invernale , approvato dal Comando Supremo , che lasciava a disposi z ione delle Armate g1i squa droni necessari per i movimenti, per la cui sis temazione avrebbero dovuto cominciare a provvedere solo dopo il termine dello spostamento delle divi s ionj; ma l'offensiva au s triaca arrivò prima che l'ordine al riguardo fosse diramato. 111
La sensibile diminuzione di personale concesso alle altre armi e la scarsezza di complementi e anche di quadrupedi, impiegati per il traino delle batterie campali , avevano imposto alla cavalleria una sensibile riduzione nei suoi organici , tanto che la forza degli squadroni era stata ridotta a 100 cavall i e quella dei reggimenti a quattro squadroni , mentre ogni reggimento divi s ionale aveva uno squadrone mitraglieri formato da due sezioni someggiate su due armi ciascuna.
Con l'ordine di richiamo , giunto alle divisioni già la sera del 24 ottobre , la l a Divisione iniziava subito la marcia di ritorno, mentre la 3a e la 4 a seguivano il trasferimento in ferrovia
Contemporaneamente veniva ordinato dal Comando Supremo che le batterie a cavano impie gate come batterie da posizione fos sero rimontate e rimesse a disposizione delle Divisioni, a cui dov e vano e ssere riassegnati subito pure i Battaglioni Ciclisti e le squadriglie autoblindo-mitragliatrici. In tal modo iJ Comando Supremo poté disporre per un primo contrasto dinamico di due masse di cavalleria: la l " D ivi s ione e la 2\ rinforzata da un reggimento della 3 \ in attesa di poter allineare in un secondo tempo tutto il Corpo di Cavalleria
Il primo reggimento a prendere contatto con gli invasori fu il Cavall egge ri di Ale ssandria , in manovra ]ungo la valle Venzonazza per mantenere il collegamento con la 63 3 Divi s ione ed il IV
11 1 A USSME, B 4 965 l. 2 • Di v is ion e 179
Corpo d'Armata a Forcella Forador. Rotta dal nemico la linea e fatta irruzione verso ldersko, i cavalleggeri del 3° Squadrone, assieme a commilitoni del 5° che prestavano servizio di pattuglia e di porta-feriti sul Kra , avevano evitato la cattura. Raggiunto dal nemico, il comando dello Squadrone aveva però subito gravi perdite, abbandonando per ultimo ldersko e Caporetto.
Il giorno dopo, il 25 ottobre , a Stupizza, verso le ore 13.30 il generale Gonzaga ordinò ad un plotone del 3° Squadrone , agli ordini del tenente Laus e dell'aspirante Minutoli, di riconoscere le posizioni nemiche, azione a cui vollero partecipare anche il capitano Delleani, il tenente Casnati e il maresciallo Randazzo.
Aperti dai fanti i reticolati, il plotone si slanciò al galoppo, disperse i nuclei di avamposti nemici e, dopo aver scoperto una serie di appostamenti di mitragliatrici, subendone il fuoco, dovette arrestarsi davanti ad un'invalicabile interruzione stradale. Ripiegò , quindi, ma fra le linee amiche torna rono solo quattro dei 29 cavalieri partiti alla carica, col capitano Delleani e il tenente Casnati.
Il generale principe Gonzaga (uno degli eroi della guerra, e non in senso retorico) segnalò con commossa ammirazione l'eroico contegno dei cavalleggeri. I resti del 2° e del 5° Squadrone protessero , nella notte del 28, il ripiegamento della 34a Divisione da Nimis al Torre e poi, giunti a Marano di Riviera, concorsero a proteggere il Comando del IV Corpo che ripiegava su Sequals, mentre il 1° Squadrone proteggeva il ripiegamento su Zugliano del carreggio del II Corpo.
Alle 5 del mattino del 28 il Comando del Reggimento partì da Venzone per Braulins, con un plotone del 2° Squadrone , rinforzato da mezza compagnia di bersaglieri ciclisti e da una compagnia del 32° Fanteria, da due Batterie da montagna , da un battaglione del 49° Fanteria. Raccolti i reparti che passavano, esso costituì una testa di ponte sul Tagliamento a difesa della stretta di Braulins. Alla sera del 29, quando era transitata l'ultima colonna e dopo aver respinto un tentativo di forzamento, fece saltare il ponte e si ritirò.
Il 2° Squadrone era invece a Venzone co n il comando della 63a Divisione e come estrema retroguardia di questa Grande Unità, fra Stazione di Carnia e Tolmezzo. Distrusse, prima che cadessero in mani nemiche, magazzini e ponti e giunse il 31 sera ad Alesso, unendosi al Comando del Reggimento che, il 3 novembre, con lo Stendardo , ripiegò attraverso le Prealpi Carniche, raggiungendo a Cimolais il comando del XII Corpo d'Armata, presso il quale 1imase, prestando servizio di vigilanza.
Intanto il 2° Squadrone, che con la 63 3 Divisione da Alesso si era trasferito a San Francesco per Clausette, il 5 mattina si scontrò con un intero battaglione nemico e, dopo una violenta sparatoria, inferiore di numero e di vo lu me di fuoco , si ritirò. Ne] complesso i Cavalleggeri di Alessandria persero nella ritirata dal Friuli il 50% degli effettivi in uomini e cavalli. 112
Il 4° Squadrone dei Cavalleggeri di Caserta, assegnato alla 26a Divisione, sostenne violenti scontri nel vallone del But, proteggendo il ripiegamento delle retroguardie delle Grandi Unità e sacrificando nel compimento dell'azione tutti i suoi cavalli.
I Lancieri di Firenze, dipende nti dal XIV Corpo d'Armata, dopo aver sostenuto anch'essi violenti scontri, raggiunsero il Torre.
La cavalleria si era reimpadronita del suo ruolo ed era , per certi versi, con la sua maestosità, l 'unjca Arma che moralmente infondeva sprezzo del pericolo e coraggio e materialmente difendeva 1'Armata in ritirata.
TI Reggimento Cavalleggeri di Saluzzo, su tre squadroni, da Povoletto si trasferì a Cividale passando a disposizione del comando di tappa. Da lì iniziò ad esplorare la zona, co nt enendo l'avanzata e fornendo informazioni sugli Austro-Tedeschi , che parevano inarrestabili nella loro progressione. Gli squadroni del Reggimento si unirono successivamente al Il0 Gruppo Squadroni dei Cavalleggeri Umberto 1 e passar·ono alle dipendenze del XXVIII Corpo d'Armata. Con questa unità assunsero la

111 Associazione Nazionale Arma di cavalleria , Cenni storici , cit. 180
difesa della vallata del Chiarò di T01Teano, diedero alta prova delle loro qualità militari e si sco ntrarono numerose volte con le truppe nemiche, riuscendo a trattenerle, suscitando ammirazione anche tra loro e facilitando il ripiegamento delle proprie colonne.

Nelle prime ore del mattino i Cavalleggeri di Sa/uzzo ricevettero dal comando della 211 Divisione di Cavalleria l'ordine di trasferirsi a San Gottardo.
La 2a Divisione di Cavalleria , composta dalla m B rigata, Lancieri di Milano e Lancieri di Vittorio Emanuele Il, e dalla IV Brigata, Lancieri di Aosta e Lancieri di Mantova, quest'ultima agli ordini del colonnello brigadiere Arnaldo FiJippini, 1t3 si trovava , il 25 ottobre, nella zona di Premariacco e Pavia di Udine, dove riceveva , dal Comando della 2a Armata , l'ordine di spostarsi sulla destra del fiume Torre , tra Udine e Tricesimo , per sorvegliare le provenienze dalle vallate che portano al fiume stesso.
Nel pomeriggio del 27 la IV Brigata di Cavalleria, agli ordini del colonnello Lostia di Santa Sofia , venne impiegata per ostacolare l 'a vanzata delle avanguardie avversarie, che erano arrivate in piano e tentavano di passare il Natisone poco oltre Cividale. Con violente azioni di fuoco, protrattesi sino a notte, riuscì a trattenere gli Austro-Tedeschi ed a frustrarne i tentativi di passaggio del fiume ai guadi di Crupignano , Borgo Viola e Firmano . Poiché altre forze nemiche erano riuscite, a nord di Cividale, ad avanzare in direzione di Moimacco, fu giudicato inutile protrarre oltre la resistenza lungo il fiume e l a Brigata, dopo avere caricato a notte inoltrata il nemico tra Moimacco e Ziracco per aprirsi l a vi a, ripiegò in ordine, subendo però sensibili perdite , sulla destra del Torre. 114
Nella stessa giornata la 2a Divisione di Cavalleria, rinforzata dal 3° Gruppo Battaglioni Bersaglieri Ciclisti (Il , ID e IV Battaglione) e dai due squadroni dei Cavalleggeri di Sa/uzzo, passava agli ordini del generale Sagramoso, comandante del XIV Corpo d 'Armata ed incaricato della difesa sul Torre. Ne riceveva l'incarico di esplorare il settore Ci vidale-lpplis-Manzano per respingere i reparti nemici che sce ndevano in pianura e per trattenere , mantenendone il contatto, quelli di maggiore consistenza. Orm ai però la situazione era compromessa: il 1ipiegamento di civili e militari creava caos e confusione e le notizie sugli invasori erano parziali e foriere di valutazioni spesso errate. L'esplorazione, anche per non far scoprire subito al nemico la presenza di forze dì cavalleria , veniva affidata ai ciclisti, mentre i reparti montati si concentravano nei pressi di Feletto Umberto, a ridosso dell'occupazione del Torre, per essere mandati, vista la loro capacità di movimento, dove la situazione l 'avesse richiesto.
Nelle prime ore del mattino del 28 ottobre la Di visione si schierava, fronte ad est, tra Santa Foca e Beivars con la III Brigata , colonnello brigadiere Manfredini a nord e la IV a sud, ed ordinava ai Cavalleggeri di Sa/uzzo del colonnello Ajroldi di Robbiante di prendere posizione tra Beivars e San Gottardo per prolungare lo schieramento verso sud.
Mentre il Reggimento si trasferiva da Salt sulla destra del Torre , i] nemico attaccava la linea di resistenza , riuscendo a forzarla nei pressi di Beivars. Gli squadroni di Sa/uzzo, sentiti i colpi di fucileria, si diressero in quella direzione e , dopo una cruenta lotta a cavallo, spiazzarono l'avversario, incredulo nel vedersi attaccato da cavalieri, e riuscirono a ritardarne l 'ava nzata ed a proteggere il ripiegamento delle truppe verso Udine.
Conseguito lo scopo, il Reggimento si portò verso San Gottardo , da dove, con successive resistenze che facilitarono il deflusso delle fanterie, ripiegò con i] grosso della Divisione, trasferendosi verso Colugna e giungendovi ridotto a soli 120 cavalieri . 11 5
113 Che aveva fatto una splendida carriera durante la guena e aveva dato prove di capacità e di coraggio tali da diventare in breve comandante di brigata.
11 • Alberto TRENTI, tenente colonnello di cavalleria. Le nostre divisioni di cavalleria nel ripiegamento dall'Isonzo al Pia ve, estratto da " Rassegna dell'esercito italiano", Fase. VIl-VIlJ , (2° sem.) , 1925, Roma. Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato , 1925.
IIS Ibidem.
181
 Ponte sul Torre, aprile 1917: sullo sfondo l'Ntopiano di Doberdò.
Pieris, i ponti dalla riva destra nel 1917.
Ponte sul Torre, aprile 1917: sullo sfondo l'Ntopiano di Doberdò.
Pieris, i ponti dalla riva destra nel 1917.
182
Il comandante della Divisione , vista la situaz ione creatasi lungo la linea del Torre , occupò allora la linea Feletto Umbert<rColugna-Canale Ledra sino a Molino Nuovo , schierando da nord-e st a sud-ovest il 3° Gruppo Bersaglieri Ciclisti ed i resti del Reggimento , ormai ridotto a pochi uomini e misto ad altri reparti. Con tale occupazione il Comando di Divisione tendeva alla protezione delle colonne della 2a Armata che si ritiravano a nord del Canale Ledra dirette al Tagliamento. L ' intento era di contrastare al nemico l'avanzata verso ovest a mezzo di puntate offensive, partenti dalla linea protetta dal notevole ostacolo rappresentato dal canale , non di sacrificarsi interamente, nemmeno di resistere ad oltranza su quel canale. La spiegazione è d ' obbligo in quanto gli ordini furono diversamente interpretati. Senonché , nel pomeriggio, il tratto di fronte tra Colugna e Feletto , fortemente premuto dagli Austro-Tedeschi, che attuavano una tattica nuova di nuclei avanzanti muniti di mitragliatrici portatili e che sviluppavano un volume di fuoco notevole, fu s uperato e la linea di difesa ripiegò al torrente Cormor, passando per Tavagnacco , Pagnacco , Plaino.
Verso sera il comandante delle retroguardie della 2a Armata , generale Sagramoso , ordinava alla Divisione di operare su Udine, per ricacciare dalla città i reparti nemici che, secondo notizie giunte, dovevano essere di scarsa consistenza numerica. Da sicure informazioni pervenute al Comando della Divisione di Cavalleria risultava , per contro, che Udine era sa ldamente occupata e quindi il risultato dell 'azione, ostacolata anche dal sopraggiungere della notte, diveniva assai incerto se non privo di logica. Il Comandante della Divisione ordinò quindi alle truppe dipendenti di eseguire puntate so lo a sud del Canale e alla Divisione di Cavalleria nel s uo in s iem e di portarsi sul Ledra , a sud di Torreano , collegandosi e sinistra con i Cavalleggeri di Salu zzo e a destra stendendosi fino a Santa Caterina. Il suo compit o era impedire le infiltrazione del nemico ver so nord, per assicurare il ripiegamento delle colonne arniche, che si ritiravano dal Torre al Tagliamento, al nord del Ledra. Il Comando della Divisione comunicò che in un primo tempo si sarebbe trasferito a Castellerio ed in un secondo tempo a Moruzzo e che in quella località avrebbero dovuto essere avviate le notizie.
Il Comandante della ID Brigata, Manfredini, in ottemperanza all'ordine, si avviò con la sua Unità alla propria destinazione di Torreano. Giunto alla stazione ferroviaria si portò in posizione di attesa , nei campi a ovest della strada tra le quote 136 e 123, coi reggimenti affiancati , fronte al canale Ledra, circa un chilometro a sud di Torreano. L'incarico di sbarrare ed occupare i ponti e di so rvegliare il cana le stesso fu assegnato ai vari squadronj, ripartendo fra loro le zone comprese tra il Cormon e Santa Caterina. Il Comandante della Brigata ordinò di sbarrare e minare i due ponti con cavalieri appiedati e sezioni mitragliatrici del Vittorio Emanuele Il, che i tre ponti più ad ovest venissero tenuti dai Lancieri di Milano e che le singole postazioni difensive dei ponti fossero collegate fra loro, lateralmente ed a nord con il grosso della Brigata con il quale lui sareb be rimasto per intervenire alla bisogna.
Sistemate le difese, il brigadiere Manfredini ispezionò personalmente i ponti, rilevò che quello di Santa Caterina era difeso da un reparto di Arditi mandati da Martignacco e, data la grandissima importanza del ponte stesso, dispose, di sua iniziativa, che i Lancieri rimanessero ugualmente in rinforzo, tanto più che gli Arditi erano senza mitragliatrici ed armati so l o di moschetto. Al giungere della sera Manfredini ordinò di ricoverare uomini cavalli . Il cielo era da tregenda: pioggia e freddo su tutto e tutti rendevano ancora più cupa la scena. La notte fu lun ghissima.
La mancanza di passaggi sul Tagliamento nel tratto Pinzano-Codroipo intanto stava costringendo il centro della 2a Armata a staccarsi dall'ala destra ed affluire verso la sinistra , nella zona di San Daniele, per passare il fiume ai ponti di Comino e di Pinzano. Questo ebbe come conseguenza la necessità di prolungare quanto più possibile la difesa della testa di ponte di San Daniele, estendendola sino a l Canale Ledra , per dar modo ai Corpi d'Armata dell'ala sin istra e del centro (IV, XII , XXVIl e XXVIlI) di passare.

183
Per cercare di risolvere favorevolmente la crisi della 2a Armata e progressivame nte anche della 3a, in marcia di ripiegamento verso il tratto della Delizia-Latisa na, assumeva ora importanza s trategica per la difesa la linea del Tagliamento nel tratto montano, costituita dalle Prealpi Carniche , s pecialmente nei passaggi di Comino e di Pinzano. La caduta della linea Monte Festa Monte Ragogna e qualunque infiltrazione nemica attraverso le Prealpi verso la piana di Maniago avrebbero infatti compromesso irrimediabilmente la resistenza sul Tagliamento e l'ordinato ripiegamento delle due Armate. Per questo il Comando Supremo aveva formato con la 20a e la 33a Divisione un Corpo d ' Armata speciale, agli ordinj de] generale Di Giorgio , con giurisdizione dal Tagliamento a Trasaghis e Pinza no. Tre divisioni venivano ino]tre mandate nelle giornate del 29 sulle Prealpi Carniche a difesa dell'alto Tagliamento, in attesa di ricevere altre due divisioni di fanteria che stavano scendendo. La testa di ponte di San Daniele, delimitata ad oriente dal Canale Ledra, venne messa il giorno 29 alle dipendenze del generale Sanna, comandante della 33° Divisione. Essa comprendeva la fronte Ragogna-San Daniele-Maiano-Cornino e doveva essere presidiata dalla 163 Divisione , da una Brigata del XXVffi Corpo d'Armata, da quattro battag1ioni della 33a Divisione , da cinque compagnie mitragliatrici del Corpo d'Armata speciale e da due gruppi di artiglieria in posizione su Monte Ragogna. Le tre autoblindomitragliatrici, poste al quadrivio ad est di San Daniele, dovevano intanto gettarsi sulle colonne nemiche che fossero riuscite a varcare il Ledra, a protezione del quale era schierata la 2 a Divisione di Cavalleria, col compito di sorvegliare le provenienze da Pagnacco e da Udine. Mentre venivano adottare le misur e atte a trattenere il più a lungo possibile l'invasore, la 148 Armata germanica, vera massa di manovra del nemico, era già schierata nella pianura friulana e si proponeva di adoperare la propria ala destra per precedere le unità italiane al Tagliamento, ai ponti di Comino e di Pinzano. L'ala sinistra sarebbe stata diretta verso sud-ovest, in modo da tagliare alla 3a Armata la strada prima che questa giungesse al Tagliamento stesso e da chiuderJa in una gigantesca sacca : se la manovra avesse avuto successo, sarebbe stata la fine del Regio Esercito italiano
I ntanto il 29 ottobre 1917, alle 2 del mattino, il Comando della Divisione comumcava da Moruzzo che il comando del XIV Corpo d'Armata ordinava alla Divisione di sbarrare la strada U dine- P onte di Bonzicco, fronte ad est e ad est di San Vito di Magagna . Egli ordinava pertanto alla fil Brigata di spostarsi a ovest di San Vito di Fagagna, per costituire a est di esso il centro dello sbarramento, da prolungare verso sud fino a Plasencis e San Marco coi Bersaglieri Ciclisti e verso nord avvalendosi della IV Brigata. In ottemperanza a questa indicazione, il comandante della fil Brigata ordinò la raccolta degli elementi distaccati ai ponti e diede le disposizioni per la marcia della Brigata , che giunse a destinazione intorno alle 5 del mattino e fu disposta in posizione di attesa ad ovest. Il collegamento a nord con la IV B rigata era tenuto dal Reggimento Vittorio Emanuele Il , che sbarrava anche due nodi stradali posti immediatamente ad ovest del paese.

Verso mezzogiorno arrivarono gli Austro Tedeschi, preceduti da un violento fuoco di artiglieria , che si limitò per il momento a ferire due cavalli del reggimento Vittorio Emanuele Il. A questo punto il Comandante della Brigata ordinò che i reggimenti si appostassero quanto più possibile vicini al ciglio, per diminuire l'efficacia del fuoco. Le pattuglie inviate in perlustrazione intanto riferivano che fanterie nemiche, di forza imprecisata e con mitragliatrici in testa , avanzavano verso San Vito. Il colonnello Manfredini ordinò allora ai Reggimenti di appiedare metà delle forze e di prendere posi zione sul ciglio unicamente con le armi dei due Squadroni Mitragliatrici, ma senza rispondere al fuoco, per non smascherarsi, in attesa del momento più opportuno . Lentamente il fuoco e le direttrici di marcia avversarie andavano però spostandosi verso nord, dando l'impressione di cercare di aggirare il fianco sinistro della Brigata. Verso le 14 un ufficiale riferì che la IV Brigata, attaccata dal nemico, stava ripiegando verso il ponte di Ceseano.
Manfredini chiese al collega, comandante della IV, di tornare indietro e venire a rincalzo dell'ala sinistra della sua III per contenere quanto più possibile nemico , ma non ebbe risposta. La situazione,
184-
 Cavalleria in marcia , ottobre 1917.
Ripiegamento al Piave, ottobre 1917.
Cavalleria in marcia , ottobre 1917.
Ripiegamento al Piave, ottobre 1917.
185
molto fluida, cambiava di minuto in minuto e gli eventi, anche i più insignificanti, cominciarono ad avere un effetto a catena , facendo sfuggire di mano la situazione. Alle ore 14.45 il Comando della Divisione trasmise l'ordine di tenersi in collegamento col generale Di Benedetto a San Vito di Fagagna; ma non lo si poté eseguire perché quel generale non era più là. In questa situazione di incertezza , dopo due ore, intorno alle 16, la Divisione ordinò di ripiegare ordinatamente , combattendo se del caso, sul Ledra. Manfredini ordinò allora ai Reggimenti di montare a cavallo e, senza alcuna molestia da parte del nemico, per San Vito raggiunse verso le 20 la IV Brigata, già dislocata immediatamente a nord della strada San Daniele-Ponte Pieli. La marcia era stata molto lenta, dapprima per i continui incroci con colonne di fanteria e di artiglieria, poi, nelle vicinanze di San Daniele, co ll ' enorme ingombro causato dai carri fermi lungo la strada. A destinazione, la III si mise all'addiaccio dietro la IV, data l'importanza di ponte Pieli e la necessità di occuparlo quanto più saldamente possibile. A questo punto però sorse un dubbio, che diventò un problema e incise sulla funzionalità della catena di comando. Dal colloquio avuto col comandante interinale della Divisione, il comandante della III Brigata si formò il convincimento che l'indomani mattina, 30 ottobre, le truppe della Div isione di Cavalleria avrebbero dovuto svolgere un'azione ritardatrice di fuoco sul Ledra e, successivamente, ripiegare oltre il Tagliamento sotto la protezione della testa di ponte già in costituzione e formata da fanteria ed artiglieria.
11 30 ottobre si presentò anch'esso come una classica giornata autunnale, con temperatura fredda e pioggia continua ed insistente. Nella notte appena trascorsa, la Sezione Mitragliatrici del Reggimento Milano, appostata al ponte Pieli , si era opposta a tentativi nemici di impadronirsi del ponte, controbattendo il fuoco delle mitragliatrici e delle nuove pistole revolver del nemico. Nel frattempo il ponte era stato minato. Sempre nella notte il coman dante della III Brigata , in seguito agli accordi presi la sera, aveva ordinato al comandante del Reggimento Vittorio Emanuele li di inviare una pattuglia ufficiali a riconoscere il ponte sul Tagliamento, in moda da poterne usufruire , all'occorrenza, per il passaggio della Brigata su lla destra del Tagliamento. Adesso , al primo albeggiare, il brigadiere Manfredini ordinò c he ciascun reggimento appiedasse metà della forza e lasciasse i cavalli in posizione arretrata ed al coperto, poi dispose la Brigata in ordine di combattimento. Verso le 8 la pressione nemica contro il ponte di P ieli e le adiacenze aumentò di intensità. Manfredini allora ordinò che la Sezione Mitragliatrici appostata e gli appiedati dei reggimenti Milano e Vittorio Emanuele II si spostassero di conseguenza. Il combattime nto andò immediatamente intensificandosi, coinvolgendo l'ala destra della IV Brigata (Lancieri di Mantova) e la sinistra della III (Lancieri di Milano). La su periorità del nemico , grandemente favorito dal terreno , apparve s ubito manifesta. Verso le 8.40 il Comando di Milano comunicò che gli Arditi si erano ritirati da Arcano, avviandosi verso San Daniele, come pure il plotone di cavalleggeri incaricato della difesa del ponte di legno. Pochi istanti dopo, il ponte Pieli ed il ponte in legno furono fatti saltare. Erano quasi le 9. Il colonnello brigadiere Manfredini ritenne di aver ormai adempiuto il compito di trattenere il nemico durante la notte e nelle prime ore del mattino, per consentire alle truppe incaricate di costituire la testa di ponte di stabilirsi sulle loro posizioni. In considerazione del fatto che col ripiegamento degli Arditi sulla destra della IV Brigata, la sua sinistra veniva a mancare di qualsiasi appoggio e ve nivano a trovarsi in pericolo anche i cavalli, fortemente scossi e ormai visibilissimi dalle alture dominanti di Arcano, mandò al Reggimento Milano l'ordine di ripiegare ordinatamente, per scaglioni successivi dalla sinistra, sotto la protezione del Vittorio Emanuele Il Quest'ultimo rimase in posizione fino alla fine del movimento di Milano, al termine del quale si ritirò a sua volta. Intorno alle 9.30 la Brigata , a cavallo, s i trovava raccolta nei pressi del cimitero di San Luca e là Manfredini riceveva dall'ufficiale a disposizione del comandante interinale della Divisione l 'ordine di recarsi a San Daniele per comunicazioni di servizio. Manfredini però ritenne opportuno non muoversi. Del resto, come dargli torto? L'ordine era stato redatto alle 7.30, cioè circa due ore prima

-186-
 Nella pianura friulana: terza lin ea di difesa della 3a Armata.
Trincee italiane di q. 121 dopo essere state conqui s tate dagli Austro Ungarici , novembre 1917.
Nella pianura friulana: terza lin ea di difesa della 3a Armata.
Trincee italiane di q. 121 dopo essere state conqui s tate dagli Austro Ungarici , novembre 1917.
-187
ed ormai la situazione era completamente cambiata; inoltre, data la distanza del cimitero di San Luca da San Daniele e la difficilissima percorribilità de1la strada , gli sarebbe occorso un tempo non indifferente per andare al Comando della Divisione e tornare. Infine. in quel momento San Daniele era sotto un violento bombardamento, visibilissimo dal cimitero di San Luca e non si poteva proprio cre dere che il comandante della divisione fosse rimasto là , sotto le granate, per cui il viaggio sarebbe stato inutile Cosa fare, allora? Manfredini si regolò in base agli intendimenti espressigli dal comandante interinale della Divisione la sera precedente e si avviò alla testa della Brigata per Ragogna al ponte di Pinzano, con Vittorio Emanuele in testa e Milano in coda Come avanguardia , la Brigata era stata preceduta dal reggimento Aosta.
Oltre Ragogna, all'incirca a mezzogiorno, Manfredini venne fermato dal generale Badoglio, che g l i ordinò d ' arrestare la Brigata e raccoglierla sulla strada. Eseguì , ma intanto il Reggimento Milano che aveva perso il collegamento col Vittorio Emanuele li a causa delle sfavorevoli condizioni di percorribilità della strada, congestionata da innumerevoli quantità di carri salmerie e pedoni prosegui va per il ponte di Pinzano, che poi oltrepassò , recandosi a Valeriano. Proseguì fino a Valeriano anche lo Squadrone Mitraglieri del reggimento Vittorio Emanuele Il, che procedeva in coda anch'esso. Dop o circa un'ora di sosta, Manfredini, vista vana l'attesa di Milano, seguito dal comandante di Vittorio Emanuele II e dai due squadroni del reggimento stesso, tornò indietro verso San D aniele. Erano le 13 circa quando Manfredini, adesso a R agogna, trovò il comandante interinal e della D ivisione che gli ordinò di fermarsi e radunare il Reggimento Vittorio Emanuele II. Fatto ciò, furono inviate pattuglie alla ricerca di Milan.o, della IV Brigata, dei Battaglionj B ersaglieri Ciclisti e degli Arditi, coll'ordine di farli immediatamente tornare a Ragogna. Non si ottenne nulla, perché tutti i reparti avevano già o ltrep assato il ponte di Pinzano ed erano ormai sulla destra de] Tagliamento. Nel pomeriggio de1Jo stesso giorno 30 , giunse a Ragogna il comandante ti tolare della divisione, tenente generale Litta Modignani, che riprese il comando e riuscì a riprendere il controllo dell'unità. Durante la notte sul 31 il comandante della Brigata distaccò il reggimento Milano, co.l compito di costituire una linea di osservazione formata da gruppi di squadroni vari , collegati tra di loro verso gli sbocchi dei monti nel piano, per avvertire in tempo circa eventuali infiltrazioni nemiche.
Il 1° novembre vedeva la IV Brigata ferma a Basaldella. Nel pomeriggio e nella notte sul 2 fu fatta segno di forte bombardamento nemico dalla sponda sinistra del Tagliamento, che però non provocò nessun danno ag1i uomini e ai cavalli; anche il tempo fu clemente e ritornò il sereno. Il 2 novembre, a causa del bombardamento subito nella notte, il Comando delle Di visione ali' alba ordinò alla III Brigata di trasferirsi nella zona Medino-Sottomonte. La marcia fu effettuata con un inter va llo di mezz'ora fra reggimento e reggimento. Il giorno dopo alle o.re 10 il comando della Divisione ordinava che entrambe le Brigate si raccogliessero ad est del Meduna, tra Colle e Ciago, per quanto possibile al coperto dall'osservazione, la III a nord ovest dj Sequals, la IV a nord di Spilimbergo, e ordinò di mandare pattuglie in osservazione. 116
L'abbandono del compito loro affidato da parte della III e IV Brigata fu certamente un atto non conforme allo spirito della Cavalleria ed al dovere dell'ubbidienza. Di conseguenza i comandanti delle Brigate furono irnmediatamente destituiti , va comunque precisato che agirono per preservare l'integrità delle truppe e l'efficienza del reparto in vista di un possibile migliore impiego. Certamente
11 6 AUSSME, 142S 8E III Brigata di Cavalleria ottobre novembre 1917. Ottobre I9 17: non è possibile segnare esatta mente , giorno per giorno, le operazioni svolte daUa Brigata nel periodo di tempo compre so tra il primo e il 24 ottobre . perché il relativo diario, alla partenza da Buttrio il 25 sera, fu riposto neJla cassa cancelleria del Comando e andò poi smarrito nella giornata del 30 col carro bagaglio del Comando stes so. Non si ebbero peraltro , nel periodo di cui trattasi , a segnalare attività degne di rilievo: iJ Comando della Brigata ed il Reggimento Lancieri di Milano continuarono ad accantonare come prima a Buttrio, il Reggimento Lancieri Vittorio Emanuele fl a Pavia di Udine.

188-
 Opere di difesa in terza linea nella pianura friulana ai piedi del Carso.
Ripiegamento co n civili nell'ottobre 1917.
Opere di difesa in terza linea nella pianura friulana ai piedi del Carso.
Ripiegamento co n civili nell'ottobre 1917.
-189-
la situazione era talmente chiara ed il compito di protezione del ripiegamento della fanteria , che la Cavalleria aveva svolto fino ad al1ora, era stato così continuo, che non poteva e s servi dubbio alcuno sulla fu nzion e del canale del Ledra. Esso consenti va il deflusso delle truppe e dei carri affluenti al ponte di Pinzano , non poteva quindi dar luogo ad equivoci, specie per ufficiali di grado così elevato e con alle spalle una carriera b1illante , quali i due comandanti di Brigata. La linea del Ledra doveva essere difesa ad oltranza, salvo preciso ordine in contrario. Il comandante della ill Brigata, che era il più elevato in grado e il più anziano dei due ed al quale spettava la maggiore responsabilità di avere preso l 'i niziati va del ripiegamento sulla destra del Tagliamento, giustificò poi il suo operato. Egli affermò che , da un colloquio verbale avuto la notte del 29 al 30 col comandante interinale della Divisio ne , aveva desunto che si stesse formando una testa di ponte a Pinzano e che la 2 ° Divisione di Cavalleria dovesse pertanto trattenere il nemico il tempo necessario a completarla, per poi passare sulla destra del Tagliamento. Sostenne inoltre che la mancanza di ordini specifici da parte del comandante de1la Divisione nella notte dal 29 al 30 , e soprattutto il mattino del 30, gli aveva fatto · confermare come giusto atto l'iniziativa di ripiegare. 11 7

La 3a Divisione, mentre si trovava in marcia di trasferimento ai quartieri invernali, era stata richiamata improvvisamente per arginare l'offensiva nemica. Sbarcò dai treni a Conegliano e fu inviata ad Aviano, non essendo giunta in tempo per passare il Tagliamento. Di là prese gli ordini da Sua Altezza Reale il Conte di Torino, comandante delle truppe mobili, e fu mandata a Croce di Venchiaruzzo per proteggere, in unione ad altri reparti di cavalleria, le estreme retroguardie che si ritiravano dal Cellina al Piave fra la pedemontana Aviano Polcenigo-Vittorio e la provinciale UdineTrev iso. Da Croce di Venchiaruzzo, essendo giunte notizie che il nemico , passato il ponte di Pinzano, premeva sulla 2a Divi sione, la 3a si mosse per soccorrerla. Procedette manovrando in massa e sotto l 'azione del tiro nemico, al quale seppe sottrars i con opportuni spostamenti, fin verso il ponte Giulio. Qui giunto, e saputo da proprie pattuglie che il nemico manovrava verso sud e procedeva con le sue avanguardie verso San Foca, il comandante decise sotto la sua responsabilità di non proseguire nella direzione ordinatagli, ma di portare velocemente l ' intera Di visione proprio a San Foca per rinforzare una brigata, che sap eva aver ricevuto ordine di trattenervisi E fu una vera fortuna l'aver presa tale decisione , perché quella Brigata , ritenendo forse di aver sufficientemente protetto l'estrema retroguardia, si era già ritirata. La D ivisione, co n successivi appiedamenti tra San Foca e la BreteUa, riuscì a trattenere fino a sera ]e truppe nemiche, ritirandosi poi , come da ordine, verso la Livenza. Senonché, giunta sull'imbrunire a Vigonovo, le pervenne dal generale Montuori il contrordine di tornare ad Aviano per appoggiare due divisioni, che dalla montagna dovevano sboccare in piano verso Maniago. La Divisione passò così la notte completamente isolata a più di 12 chilometri oltre la linea degli avamposti. La notte permise di controllare tutta la sottostante pianura e confermarne la compl eta invasione da parte degli austro tedeschi. Questo confermò ulteriormente le informazioni ricevute e cioè che dalla p edemontana non scendevano truppe, perché in questo caso Aviano sareb be stato occupato, dato che anche la 2a Divisione si era già ritirata al di là del Livenza.
La 3\ poco prima dell'alba, ricevette quindi dal generale Montuori l'ordine di ripiegare dietro gli avamposti e s'incanalò su lla strada Aviano Polcenigo, ma, quando la testa si trovava quasi a Polcenigo , ricevette l'ordine di ritornare nuo vamente verso Aviano per il compito già accennato. Ritornata ancora sui suoi passi trovò Castel d'Aviano già fortemente occupato, tuttavia riuscì a trattenere il nemico sino a che, per un successivo ordine del generale Etna, ripiegò definitivamente, man tenendo il contatto sulla sponda destra del Livenza.
Il giorno seguente, abbandonando le fa n terie sulla linea del Livenza per portarsi su quella del Mo nt icano, la divisione esplicò il compito di protezione a nord della strada provinciale Udine-
AUSSME, B 4 9651, 2" divisione, l28D e 1615B.
117
190-
Treviso , nella zona di colle Umberto , restandovi fino a notte inoltrata e portandosi successivamente a San Fior e San Vendemiano, sempre a contatto col nemico. Lì mantenne , appiedata , la sua posizione fino alla sera successiva , nella quale come da ordine , passò il Monticano e , verso l ' alba , in seguito a nuove disposizioni, varcò il Piave.
All ' intera attività della Divisione parteciparono due battaglioni di bers aglieri c iclisti , una squadriglia di automitragliatrici blindate ed un gruppo di batterie. 118
La 1a Divisione di Cavalleria , comandata dal maggiore generale Piero Filippini e formata dalla I Brigata del generale Annibale Gatti, coi Cavalleggeri di Monferrato e di Roma, e dalla II Brigata del generale Giorgio Erno Capodilista, con Genova Cav alleria e i Lancieri di Novara , era stata me s sa a disposizione della 3a Armata il 25 ottobre, mentre si trovava nei quartieri invernali fra Treviso e Padova. Aveva raggiunto Lestizza-Mortegliano e le era stato assegnato il compito di opporsi al nemico nel tratto Risiano-Palmanova zona di congiunzione tra la 2 3 e la 3a Armata e di proteggere contemporaneamente il fianco nord dell ' Armata. L'azione della Brigata del generale Erno Capodilista è stata già descritta all'inizio, per cui ci limiteremo qui a descrivere le operazioni di guerra durante la protezione delle due Armate.
Il 25 ottobre il comando della 1a Divisione di Cavalleria era ritornato nelle sue precedenti sedi di Pravisdomini e Ozzano. Il 28 il comando della II Brigata da Mortegliano si portò nelle prime ore del mattino a Palmanova. Il Reggimento Genova aveva il compito di respingere forti nuclei sulla linea Orgnano-Risano-Pozzuolo del Friuli.
Il giorno successivo la 1a D i visione di Cavalleria, in seguito ad ordine del comandante del IV Corpo d'Armata, generale Lombardi, assunse uno schieramento davanti alle linea Pozzuolo del Friuli-Pasian Schiavonesco-Lumignacco, fronte a Udine con la I Brigata a Pasian Schiavonesco e la II a Pozzuolo del Friuli. Quest'ultima con in testa Genova e seguita da Novara, raggiunse verso le 17 .30 Pozzuolo del Friuli, che venne occupata senza difficoltà , e durante la notte vi si asserragliò. Genova si vide affidata la metà orientale del paese, col compito di guardare le provenienze da Udine, Sammardenchia e Lavariano; Novara ebbe la metà occidentale, con la sorveglianza degli sbocchi di Mortegliano, Santa Maria di Sclaunicco e Carpeneto: dappertutto burrasca e pioggia ininterrotta.
Il 30 ottobre, alle 4, giunse l'ordine di cooperazione col comandante la 7a Divisione di Fanteria generale Ravelli, che conteneva le disposizioni per l'attacco coordinato al nemico che avanzava da Campoformido in direzione di Codroipo. Tale attacco doveva essere sferrato contemporaneamente da tre colonne di fanteria Brigata Lucca, Brigata Bergamo e 3° Reggimento Fanteria Piemonte che dovevano attestarsi alle 11 sulla linea Carpeneto-Sclaunicco-Galleriano. Il 5° Squadrone di Genova Cavalleria , al comando del capitano Lampugnani, alJe 8.30 passò a disposizione del comandante della 7a Divisione a Santa Maria di Sclaunicco.

Alla 1a Divisione di Cavalleria era stato affidato l'incarico di informare ogni mezz'ora il comando della 7a sulla consistenza delle truppe nemiche nella zona Canale di Ledra-Udine-fiume Torre e sud di Palmanova, ma la ia Divisione in quel momento era di fatto costituita dalla sola brigata del generale Erno Capodilista.
Le pattuglie, inviate alle prime luci sulla fronte stabilita, segnalarono subito la presenza di nuclei nemici armati di mitragliatrici nei pressi di Terrenzano. Avute queste notizie, il comandante la brigata diede ordine di rinforzare la difesa del paese con tutti gli appiedati disponibili ed informò i comandanti della 73 Divisione e della 1a di Cavalleria.
Verso le 11, cioè all'ora per cui era previsto l'attacco italiano, gli Austro-Tedeschi lanciarono il loro, eh~ venne respinto dalle mitragliatrici di Genova Cavalleria. Il comandante della 1a Divisione ordinò di tenere Pozzuolo fino all'arrivo dei rinforzi; da Mortegliano infatti doveva arrivare un bat-
AUSSME, B 4 9651 , 3• divisione, 1280 e J619C.
111
-191 -
Il sistema di difesa sulla destra del Torre. taglione di bersaglieri, che però non giunse mai. La pressione del nemico andava crescendo, ma Erno tenne, anche perché il comandante della 7a Divisione di Fanteria, informato della situazione , gli aveva fatto sapere, a voce, che la resistenza a Pozzuolo andava fatta ad oltranza e che faceva affidamento sul valore e sul sacrificio della Il Brigata di Cavalleria. Dopo mezzogiorno, gli attacchi si s usseguirono sempre più violenti. Il 4° Squadrone di Novara, al comando dell'appena promosso capitano Giovanni Sezanne, caricò nuclei nemici facendoli ripiegare su Terrenzano, subendo notevoli perdite, ma facendo parecchi prigionieri, che concordemente affermarono che una brigata nemica era già arrivata a Terrenzano , seguita da parecchie divisioni. Alle ore 16.30 il combatti.mento si intensificò al massi.mo . Il nemico riuscì a sfondare lo sbarramento di Terrenzano e incominciò a penetrare in paese. Il 4° squadrone di Novara caricò nuovamente, permettendo allo squadrone mitragliatrici di Genova di disimpegnare le sue amù . Le perdite intanto si facevano sempre più gravi. Alle 17 .30 la situazione si fece critica, perché gli Austro-Tedeschi erano riusciti a sfondare anche gli s barramenti della parte di Carpeneto, difesi strenuamente dal 1° Squadrone e dallo Squadrone Mitragliatrici di Novara, accerchiando il paese. Si combatté con indomito valor e sulla piazza e su lla s trada , mentre dalle finestre di alcune case le mitragliatrici nemiche iniziavano un violentissimo fuoco. Dopo otto ore di combattimento continuo, e quando ogni ulteriore resistenza appariva ormai vana, il generale Erno Capodilista ordinò di rimontare a cavallo e ripiegare su Santa Maria di Sclaunicco, aprendosi un varco in qualunque modo ed a qualunque costo. Come già narrato , il ripiegamento avvenne in cir costanze estremamente difficili Alcuni reparti di Novara, usciti da un altro sbocco, furono bersaglia-

-192
ti appena fuori del paese da fuoco di mitragliatrici e fucileria e costretti a ripiegare in direzione di Morteg liano attraverso la campagna, aprendosi la strada con la lancia e la sciabola, caricando ripetutamente l'avversario e subendo forti perdite.
Alle 18.30 i resti della Brigata erano riuniti in Santa Maria di Scalunicco. Il comandante la 7a Divisione, informato dell'accaduto e della situazione, ordinò che la Brigata di Cavalleria raggiungesse la destra del Tagliamento percorrendo la direttrice Talmassons-Aris-Rivignano-ponte di Latisana. Le perdite erano state alte, quasi il 50% della forza impiegata Il Comando Brigata aveva perso tre cavalieri e tre cavalli; Genova 16 ufficiali e 300 tra morti, feriti e dispersi di sottufficiali e truppa, con 340 cavalli,Novara l'intero Stato Maggiore del reggimento e in totale 16 ufficiali, 164 tra morti, feriti e dispersi di sottufficiali e truppa e 185 cavalli.
Il 1° novembre la Brigata ricevette l ' ordine di raggiungere Pordenone Il 4 la l3 Divisione si attestò al guado di Croce di Vencbiaruzzo ed iniziò il servizio di protezione alle colonne di fanteria che ripiegavano dietro la Livenza per il ponte di Brugnera. Il 7 novembre ricevé l ' ordine di passare sulla destra del Piave per il ponte gittato dal Genio a Lovadino e di restare a Lovadino: per lei la ritirata del Friuli era finita. 11 9

Al momento di Caporetto, la 4a Divisione si trovava già in Piemonte nei quartieri invernali. Ricevuto l'ordine di ritornare al confine orientale, venne messa ad esclusiva disposizione dell'inten-
ottobre novembre 1917.
La carica di Stupizza , 1917: la cavalleria si avvicina agli sbarramenti mentre i fanti li aprono.
119 AUSSME , 142 S 6E , Comando della II Brigata di Cavalleria , )3 Divisione , mesi di
193
dente generale e si trasferì a Oderzo con tutti servizi, meno una sezione del 24° Autoreparto e metà della Sussistenza. Le sue Brigate VII e VIII furono utilizzate per il servizio di protezione ferroviaria fra Tagliamento e Piave , affidato precedentemente alla 3a Divisione di Cavalleria dal 30 ottobre, per assicurare la piena libertà e regolarità del movimento, in quel momento fortemente compromesso da militari sbandati e da profughi.
La 3a aveva quindi dovuto vigilare le linee Treviso-Casarsa, Treviso Motta dj Livenza, Mestre San Donato e Piave-Portogruaro-ponte di Latisana, con l'ordine di tenere le stazioni sgombre da borghesi e miljtari sbandati, respingendo i primi fuori dalle stazioni e fermando e indrappellando i secondi in zone di concentramento, ricorrendo a qualunque mezzo. Doveva poi percorrere le linee mantenendole sgombre a qualunque costo; allontanare rapidamente da tutti i treni in movimento nelle stazioni di sua competenza tutti i civili e militari sbandati; tra questi ultimi, individuati specialmente tutti quelli appartenenti al 6° Reggimento Genio Ferrovjeri, li doveva avviare a una delle più vicine località di concentramento fra Portogruaro, Casarsa, Pordenone, Sacile, Conegliano, e Treviso. Invece i drappelli in servizio dei Ferrovieri del 6° Genio dovevano essere lasciati circolare nelle stazioni, lungo le linee ed i ponti ferrovieri.
Garantito il movimento ferroviario, la Cavalleria doveva estendere la sua attività alle vie ordìnarie cioè alle strade arrestando i militari sbandati a raccogliendoli nei luoghi dì concentramento. Infine doveva "Proteggere gli impianti.fissi delle stazioni, il materiale rotabile e di trazione nonché le comunicazioni telegrcifi.che e telefoniche delle stazioni e lungo la linea. Impedire e reprimere con qualunque mezzo il saccheggio di carri ferroviari delle stazioni. Richiedere il concorso dei cara binieri e delle armate Seconda e Terza."
Il 2 novembre alla 3a Divisione Cavalleria subentrò la 4a con le stesse consegne e continuò a pattugliare costantemente la riva destra del Piave. 120
Durante quei tragici. giorni, specie sulla fronte della 2 8 Armata, da subito la Cavalleria ebbe due compiti precisi, il primo certame nte "rallentare l'avanzata degli invasori", ma anche dì evitare nel modo più assoluto la più piccola infiltrazione per scongiurare il panico sia fra le truppe in ritirata, sia, e maggiormente, nelle colonne di civiU in fuga di fronte all'invasore.
Con questo compito limitato nessuna manovra a largo raggio era possibile , date anche le condìzioni di spirito della maggior parte delle truppe, la presenza tumultuosa nelle colonne di civiU, la maggior parte donne e bambini , il fantastico groviglio di carri e altre impedimenta che ingombrava no ogni strada. Sarebbe stata sufficiente infatti l'azione di nuclei celeri nemici, di avanguardìe ardite, con armj automatiche, per impedire qualsiasi riorganizzazione che consentisse di resistere con la fanteria. Qualsiasi sortita sarebbe stata pericolosa se avesse trascurato le infiltrazioni dei numero si piccoli nuclei avanza nti , che si dirigevano verso sud-ovest penetrando sul fianco e nelle retrovie della 3a Armata, il cui ripiegamento procedeva laborioso ma ordinato . 121
L'O AUSSME , 142 S l 7E , VU Brigata , 4" Divisione di Cavalleria, ottobre novembre 1917.
121 Per dare un ' idea dell ' importanza del compito di sorveglianza delle linee affidato alla Cavalleria, bisogna tener presente quanto fosse importante a sua volta il mantenimento del traffico ferroviario per la salvezza dell'Esercito. Al 26 otto bre 1917 si trovavano in zona di guerra 120 locomotive e 4.000 carri ferroviari di vario genere. Preso dall ' urgenza del l ' evacuazione , il colonnello O scar Spinelli, capo del servizio ferroviario della 3" Armata da San Giorgio di Nogaro aveva ordinato ravvio dei treni a "distanza di segnale" , cioè senza rispettare il previsto intervallo di dieci minuti fra un convoglio e l'altro. Rischiava la fucilazione anche per un solo incidente ferroviario che si fosse verificato in seguito a tale ordine , contrario a tutti i regolamenti. Andò bene. Grazie a lui ed alla cavalleria, che teneva sgombre e proteggeva le linee e le stazioni , garantendon e il funzionamento , i ferrovieri civili e militari riuscirono a spostare in ventiquattr'ore a Cervignano tutto quello che e;a a Gradisca , Sagrado , Ronchi , ViJla Vicentina ed Aquileia. Tra il 28 ed il 29 il traffico s i spostò sempre più verso l'interno ed il 30 la quasi totalità del materiale era già oltre il Tagliamento. Facendo la spola in continuazione. protetti dalla Cavalleria. 104 treni avevano salvato l'intera 3° Armata.

-194
 La cavalleria passa gJj sbarramenti
La carica di Stupizza, I9 I7: passati gli sbarramenti, la cavalleria si prepara a caricare.
La cavalleria passa gJj sbarramenti
La carica di Stupizza, I9 I7: passati gli sbarramenti, la cavalleria si prepara a caricare.
-195-
Nei primi giorni dell'offens.iva nemica, ]e quattro d.ivisioni di cavalleria non erano certamente nella loro piena efficienza organica e non erano neppure ben sistemate strategicamente , tutte riunite in una zona conveniente fra il Tagliamento e il Torre come riserva mobile nelle mani del Comando Supremo. Se questo fosse avvenuto, l'impiego di tale massa avrebbe forse potuto lasciare perplesso l'avversario sull'opportunità o meno di sboccare in piano e questa massa avrebbe certamente potuto operare con successo contro le colonne che si affacciavano in pianura da Tarcento e da Cividale. In una carica dispe rata indubbian1ente ne avrebbe ritardata o resa difficile l'avanzata nonché impedito il congiungimento. Ma, come già esposto, due divisioni erano dislocate, in parte per ragioni di ordine pubblico, in Lombardia e in Piemonte, le altre due erano in marcia verso le sed.i invernali e, per giunta, non si trattava di divisioni al completo. Gli organici dei loro reggimenti erano ridotti perché da ognuno era stato sottratto uno squadrone per adibirlo come T.S., in sosthuzione di altrettanti squadroni sparsi all'in terno del paese, a loro volta adibiti al servizio di ordine pubblico. Erano stati inoltre ridotti gli organici degli squadroni per ricavarne i cavalli necessari alle nuove formazioni d'artiglieria. Le Divisioni erano poi prive dei propri battaglioni ciclisti che, fin dall'inizio o quasi della guerra, erano stati assegnati alle Grandi Unità di fanteria; erano in parte senza le batterie a cavallo, anche perché impiegate sul fronte come artiglieria da campagna. Erano quindi divisioni per modo di ciire: più che altro delle brigate rinforzate.
Sulla costituzione di una riserva mobile formata con le quattro divisioni di cavalleria122 c'è da specificare quanto segue. In un momento della storia dell'esercito, quando quasi tutto si trovava al fronte, sistemare migliaia d.i uomini nelle retrovie, senza compiti immediati ma in prospettiva d'impiego eventuale, poteva suscitare, da parte dei combattenti, sentimenti non amichevoli nei co nfronti dell'Arma. I fanti potevano essere indotti a farsene una cattiva opinione, che inevitabilmente avrebbe lasciato il fronte per diffondersi all'interno della Nazione.

Per quanto riguarda poi "1 'increscioso dibattito" relativo alla III Brigata di Cavalleria e all'interpretazione di quel famoso ordine verbale, tipo d'ordine che tra l'altro in quei momenti era abituale 123, esso non riguardò che l'interpretazione, data dal comandante della III Brigata, ad un colloquio inciden tale, avvenuto la sera del 29 col comandante la Divisione. Il colloquio non fu convalidato da nessuna prova scritta, ed in quel momento di concitazione poteva anche sfuggire la necessità di apporre burocraticamente un timbro su una situazione. C'è però da dubitare che ufficiali così elevati in grado ed abituati a non discutere gli ordini abbiano ritenuto di assumersi arbitrariamente la responsabilità d 'abbandonare la posizione che, secondo gli unici e soli ord.ini ricevuti, avrebbero invece dovuto difendere. Il ripiegamento volontario rimane un enigma difficilmente risolvibile Resta il fatto che fu prematuro, in quanto la pressione nemica non era eccezionale -e lo prova il fatto che non subirono perdite pur essendo però 1isultato che i reparti d.i fanteria, compresi i Bersaglieri Ciclisti e gli Arditi, a loro volta "compresero male" gli ordini . Essi si ritirarono infatti dalla linea del Ledra prima della cavalleria, che si trovò priva di protezione ai fianchi, per cui a questo punto viene da domandarsi: come hanno fatto a capire male in tanti, e tutti nello stesso modo, se l'ordine era stato emanato ed in modo tanto chiaro? Oltrepassato il Tagliamento, il compito assegnato alle Grandi Unità di Cavalleria sulla destra del fiume era stato duplice: concorrere con le retroguardie di fanteria alla protezione del ripiegamento delle colonne di fanteria della 2a Armata; coprire, in concorso con le retroguardie parziali della regione Casarsa-Ponte della Delizia, il fianco destro della 3a Armata da incursioni di truppe celeri nemiche
i n AUSSME, B 4 9651, 2• Divisione.
m Va comunque notato che , nei riguardi dell'occupazione del Ledra , nessun altro ordine, né verbale né scritto, che parlasse di ripiegamento era stato emanato dal Comando della 2° Divisione; e questo lo ammisero anche i comandanti di Brigata, i quali giustificarono la propria azione d'iniziativa come imposta propiio dalla mancanza di ordini da parte del comandante interinale della Divisione.
-196-
La linea d ' osservazione s·estendeva per circa 25 chilometri da Pinzano al ponte della Delizia e interessava una regione, sulla destra del Tagliamento, facilmente percorribile in qualsiasi direzione da truppe celeri nemiche. Il compito di protezione immediata del ripiegamento della 2a Armata venne dato alle due divisioni, ad un distaccamento misto quello di coprire il fianco della 3a dalle incursioni sulla direttrice ponte della Delizia-Casarsa; una divisione era in riserva per rinforzare l'azione dove fosse stato necessario.

In conseguenza delJe disposizioni emanate, che si dimostrarono rispondenti alla situazione e che permisero il ripiegamento indisturbato delle due Annate dietro la linea del Piave, inizialmente una divisione veniva a trovarsi dislocata verso Sequals e Spilimbergo, una nella zona di Domanins, il distaccamento speciale a Casarsa e la riserva a Vincbiaruzzo, in corrispondenza del guado di Meduna, che dava più sicuro affidamento di passaggio in qualunque ora, anche della notte. L'azione della 2a Divisione di Cavalleria, che collaborò in stretto collegamento con il Corpo d'Armata specia le del generale Di Giorgio, era in direzione degli sbocchi di Travesio e di Pinzano, da dove sarebbero dovute arrivare la 36a e la 63a Divisione di Fanteria, in ripiegamento. La Divisione, costantemente aggiornata sulla situazione ed in stretto collegamento con il corpo speciale Di Giorgio, anche dopo che questo, a causa degli scontri era stato ridotto a soli 4.400 fucili ed era stato costretto ripiegare dietro il Meduna, si mantenne in potenza di fronte allo sbocco di Travesio. Il suo compito era di agire eventualmente in concorso con le truppe che avessero cercato di aprirsi il passo verso il sud. Qui rimase fino alle 5 del mattino del 5 novembre, quando il nemico, vinte le resistenze al ponte di Sequals e passato il Meduna, la costrinse a ripiegare verso Panna, da dove sarebbe poi dovuta muovere verso sud, per sbarrare al nemico almeno il passaggio del torrente Col vera. Ma le truppe in pianura non ebbero alcun indizio di un'azione in corso verso le pendici meridionali delle Prealpi Carniche che indicasse la presenza delle due attese divisioni di fanteria. In aggiunta, la regione prealpina dove risultava dirigersi il nemico dopo aver sfondato la linea di Comino, non era tale da consentire anche a non voler considerare il diverso compito comunque assegnato alle truppe mobili italiane qualsiasi efficace impiego di cavalleria. Le comunicazioni fatte a] comando delle retroguardie fin dalle 18.30 de] 4 novembre 1917 dal comandante il settore sinistro, il generale Etna, attraverso il comando delle truppe mobili, e cioè che "le divisioni 36a e 63° che devono scendere delle Prealpi Carniche non sono ancora entrate in azione sul fianco destro del nemico. Ho ricevuto l'ordine che si aprano ad ogni costo il passo verso ovest" e le analoghe comunicazioni del comando della 2 3 Armata, non lasciavano dubbio che le due divisioni avrebbero cercato di sboccare in piano in un'altra direzione. Ed era naturale che fosse così, date le difficoltà di sboccare fra il Tagliamento ed il Meduna, visto che il nemico, sfondata la linea di Comino, aveva potuto dilagare sulle pendici meridionali delle Prealpi Carniche ed impadronirsi dei punti di passaggio. Ciò nonostante, la 2a Divisione di Cavalleria, informata della situazione, prese durante la notte dal 4 al 5 tutte le disposizioni per dare eventualmente una mano ai reparti che da nord avessero tentato di aprirsi il varco e ciò non appena si fosse avuto un indizio qua lsiasi di combattimento nella zona prealpina .
Ma non se ne ebbe alcuno, né in quella notte né per tutta la giornata del 5, mentre le tre divisioni si aggiravano fra Cellina e Meduna per contrasrare e ritardare l'avanzata nemica verso ovest; non arrivò alcuna notizia sicura delle divisioni di fanteria, nonostante la presenza, soprattutto, della III e IV Brigata. La sera del 5 il comando della 2a Armata ordinò al generale Etna: "occorre domani 6 novembre fare un ultimo tentativo durante la nostra sosta sulla Livenza per sostenere la raccolta delle 63a e 36° divisione verso la Livenza stessa." Tale compito venne affidato alla 3a Divisione di Cavalleria la quale, nella notte dal 5 al 6, era rimasta, come abbiamo visto, oltre la linea degli avamposti, nella zona di Aviano. Durante la stessa notte fu eseguita un'ampia esplorazione in direzione est, verso Travesio, per avere notizie di eventuali combattimenti e poter accorrere a sostegno, a qualunque costo, delle due attese divisioni di fanteria. Poiché le informazioni raccolte furono concordi
197
 Stupizza: la cavalleria si avvia all'obiettivo.
Reduci da!Ja carica tornano alla base di partenza.
Stupizza: la cavalleria si avvia all'obiettivo.
Reduci da!Ja carica tornano alla base di partenza.
-198-
nell'escludere indizi dj combattimento in corrispondenza della zona montana, dalla quale dovevano provenire le truppe , il generale Etna, fra le 13 e le 14 del giorno 6 giudicò "mancata l'opportunità di impiegare in aiuto della 63° e 36° divisione le truppe messe a sua disposizione". La 3 3 Divisjone di Cavalleria fu quindi rimessa in libertà e riprese il primitivo principale compito di protezione del ripiegamento della 2a Armata.
Dopo lo sfondamento della linea di Comino, avvenuto fra il 3 ed il 4 novembre, il 4 le fanterie del corpo speciale Di Giorgio in~iarono alle 15 il ripiegamento dietro il Meduna: erano trascorsi due giorni, il nemico non si trovava 01mai più di fronte altro che le truppe mobili ed era stato trattenuto efficacemente dalle unità di caval1eria ad est del Cellina.
Le due divisioni di Cavalleria furono fermate da truppe nemiche operanti nelle Prealpi Carniche, terreno dove la cavalleria non avrebbe assolutamente potuto agire. A questo punto vale la pena di ricordare lo stato generale delle unità e degli elementi costituenti le retroguardie: erano in parte elementi stremati dopo l'enorme logorio subito nel ripiegamento dal Torre al Tagliamento-Saluzzo, ad esempio, contava poco più di 200 cavalleggeri e coi cavalli dimezzati. Era umanamente da e.scludere in quella situazione qualsiasi manovra azzardata che, se poteva dar luogo a qualche episodio brillante, avrebbe rischiato di compromettere lo scopo principale che alle Grandi Unità era stato affidato e cioè di proteggere il ripiegamento dei resti delle Grandi Unità elementari e complesse dietro alle quali bisognava arrestare o almeno rallentare il più possibile il nemico, per sa lvare l'onore e l'integrità della Patria. 124

Quasi tutti i reparti delJ' Arma furono impegnati, in modi e forme differenti, durante il ripiegamento al Piave. La mutata situazione diede nuova linfa e dinamicità alla volontà d'azione che l'Arma racchiudeva in sé; non a caso il figlio di Cadoma, Raffaele, futuro comandante di Divisione e a capo della Resistenza di lì a meno di trent'anni, prestava servizio nei Lancieri di Firenze, a riconoscimento del valore dell'Arma in seno all'Esercito. Adesso la guerra di movimento le co nsentiva di tornare sul campo nelle vesti che le erano consone.
Con lo schieramento dell'Esercito sulla linea Grappa-Piave, a suo tempo preparata e rinforzata da Cadoma proprio in previsione di una simile situazione, si concludeva il primo ciclo della Grande Guerra.
Il ripiegamento diede immediatamente nuova forza alla Nazione ed all'Esercito e permise di riorganizzarsi e prepararsi alla battaglia decisiva. L'arretramento poi, ingigantito da un catastrofismo nazionale sempre presente e quello s'ì specificatamente italiano non era dei più gravi. Negli altri fronti gli arretramenti e le avanzate si erano verificati nelle stesse proporzioni, ma a nessuno venne mai in mente di farne una disgrazia nazionale, anzi.
Dopo la ritirata, alla Cavalleria furono affidati, in collaborazione con i Carabinieri, compiti di polizia militare, compiti certo non graditissimi, ma indispensabi]j per far riacquistare a11'Esercito sbandati, disertori, dispersi o uomini comunque fuori dai ranghi. I Cavalieri disponevano non solo della mobilità necessaria per quel servizio, ma anche della sa ldezza morale indispensabile per assolvere un compito sotto molti aspetti non facile.
Dopo le prove dell'autunno 1917, i reggimenti di Cavalleria furono riordinati e rinforzati nel1' armamento e negli organici. In ogni squadrone fu aumentata la forza del nucleo ciclisti. Si volevano evidentemente aumentare le possibilità di movimento su strada con un mezzo meno logorabile, meno costoso, meno visibile, più duttile e che, tutto sommato, poteva esser inteso come un primo preludio al1a definitiva sostituzione, nel tempo, della locomozione animale.
leria.
12 • A USSME, B 4 9651, Comando generale dell'arma di cavai
-199-
 La carica di Stupizza, è finita: si recupera un cavallo scosso.
La carica di Stupizza, è finita: si recupera un cavallo scosso.
-200
XVI
LA CAVALLERIA SUGLI ALTRI FRONTI
Ilprimo periodo della guerra .aveva dato , almeno sugli altri fronti, come abbiamo visto , ancora una certa possibilità di movimento. Le ali scoperte delle annate durante l'avanzata iniziale avrebbero potuto permettere alla cavalleria di tentare l'aggiramento, per cui l'Arma, all'inizio del conflitto e per i primi pochissimi mesi, aveva trovato spazio per la manovra ed era stata ancora di diretto concorso, tanto nel campo strategico quanto ne] campo tattico.
Poi nel secondo periodo comprendente gli anni 1915, 1916 e 1917 le operazioni assunsero quasi dappertutto (eccetto in Galizia, Romania e Medio Oriente) il carattere di guerra di posizione su fronti continue e di logoramento. Il reticolato chiuse la via alla fanterie e quindi ancora di più alla cavalleria. La forzata inoperosità dell'Arma e le esigenze varie della lotta , es i genze particolarmente di carattere organico , indussero quasi tutti gli eserciti (eccetto il tedesco, il turco ed il russo) a sensibili r iduzioni delle unità di cavalleria, mentre quelle conservate a cavallo si riducevano nella composizione degli organici ed incrementavano la potenza dei mezzi di fuoco.
In questo secondo periodo dunque fu prevalente ne11 ' Arma europea il concorso diretto alla g u er ra d i stabilizzazione.
L'u l timo periodo della guerra , il terzo comprendente il 19 18 vide nuovamente l a possibilità di impiego dell'Arma. Sul fronte occidentale le azioni di rottura compiute dai Tedeschi provocarono sentiti spostamenti del fronte degli Alleati, i quali si servirono della caval1eria come di una riserva mobile , pro n ta ad i ntervenire dove la situazione si fosse fatta più critica. L a co ntroffensiva degli Alleati, iniziatasi con la Seconda Battaglia della Marna il 18 luglio 1918 , si svolse fra i sistemi difensivi fissi ai quali i Tedeschi si appoggiava no nei loro successivi ripiegamenti . La cavalleria non aveva ancora spazio sufficiente per sfruttare il successo tattico con la manovra in profondità, essa però risultò essere l ' Arma dell a crisi nei ripiegamenti ed inseguimenti conseg u enti a vaste rotture de l fro n te .

Nelle offensive alleate del 1917 e 1918, e com u nque g ià n ell ' offensiva della Somme del 14 luglio 1916 , il comando britannko aveva impiegato piccoli reparti di cavalleria, che operavano in unione con la fanteria, progredendo a sbalzi verso la linea de] fuoco, pronti a sfruttare favorevo li occasioni di intervento, dovute a momentanea disorganizzazione nemica .
A tal riguardo, la cavalleria ing lese si era ristrutturata e nell'inverno 1917 1918 l'esercito britannico in Fra ncia comprendeva: un Corpo di Cavalleria, Cavalleria di Corpo d'Armata.
Il Corpo di Cavalleria era composto da : un comando, una sezione pa11 oni frenati, un servizio segnalatori, uno squadrone segnalatori per il Corpo di Cavalleria; una sezione con cavo telegrafico per cavalleria; uno squadrone radiotelegrafico per corpo di cava ll eria; un equipaggio da ponte per corpo di cavalleria; uoa sezione di parco munizioni , una colonna vettovagliamento; un'officina di riparazione mobile leggera; una compagnia di fatica; un reggimento Yeomanry 125 e cinque divisioni di cavalleria. Ciasc un a di esse prevedeva: un comando , un G ruppo di tre batterie a cavallo da sei pezzi, uno Squadrone Ge n io, uno Squadrone Segnalatori, un Parco Munizioni per Cavalleria , una Compagnia Treno , tre Ambulanze da Campo, tre Sezioni Veteri narie Mobili , u n a Compagnia di Fatica e tre B rigate di Cava ll eria, ognuna delle quali s u
125 La Yeomanry era la ca vall eria volontaria di mili z ia fornita e co stin1ita dalla nobiltà e dai grandi e piccoli possidenti di campagna inglesi; veniva chiamata alle armi in caso di guerra generale e l' u l timo s uo impiego era stato in Sud Africa contro i Boeri , a partire da dopo i disastri della settimana di Colenso.
CAPITOLO
201
tre reggimenti ed uno squadrone mitragliatrici. I Reggimenti a loro volta erano sia ternari cbe quaternari.
La Cavalleria di corpo d'armata era assegnata a qualunque corpo d'armata in misura assai limitata. Infine esistevano i depositi di base: un deposito di cavalleria britannico ed un deposito avanzato di cavalleria indiana. Inserito nella 5a Armata britannica, esisteva il Corpo d 'Arma ta portoghese , che comprendeva due squadroni di cavalleria. 126
Durante l'inverno 1917-1918 le divisioni di cavalleria furono assegnate proprio alla sa Armata, comandata dal generale Gough , che costituiva l'ala destra dell'esercito britannico e difendeva il settore di San Quintino. Durante i due anni precedenti le divisioni non avevano fatto parte del Corpo di Cavalleria, ma erano state assegnate singolarmente ai corpi d'armata ed avevano fornito turni dei reparti appiedati, a difesa di alcuni tratti di linea.
Dai resoconti dei corrispondenti dei giornali inglesi e dalla relazione ufficiale britannica si possono trarre gli elementi per ricostruire in parte l'azione della cavalleria britannica durante i sanguinosi combattimenti avvenuti sul fronte occidentale. In sostanza fu impiegata in grosse unità, sia appiedata, sia a cavallo, ed in piccoli nuclei che avevano il compito di proteggere gli elementi di fanteria nella loro ritirata.
Nella battaglia di Arras, il 9 aprile 1917, le pattuglie di cavalleria francese operarono nuovamente con la fanteria e vi fu la possibilità di intervento di un corpo di cavalleria su tre divisioni tenu to a portata di impiego e che, il 10 aprile, dopo la caduta del terzo sistema difensivo germanico, tentò di avanzare ma fu arrestato dal fuoco delle mitragliatrici .
La Battaglia di Cambrai del 20 novembre 1917 fu un esempio veramente tipico delle predisposizioni tattiche, con cui, dopo una minuziosa preparazione logistica, il comando superiore britannico aveva preso a sfruttare il successo di un attacco di sorpresa impiegando Grandi Unità di cavalleria. La sorpresa doveva realizzarsi conduceodo l'attacco senza preparazione di artiglieria, coll'irruzione di numerosi carri d'assalto che accompagnavano la fanteria e con la puntata del Corpo di Cavalleria sulle comunicazioni nemiche. L'irruzione dei carri d'assalto e l'attacco delle fanterie britanniche sorpresero all'alba i Tedeschi. Favorito dalla pioggia , cbe ostacolava l'azione dell'aviazione , e preceduto dalle sue pattuglie che operavano nuovamente insieme agli elementi avanzati di fanteria ed ai carri d ' assalto, il Corpo di Cavalleria britannico, formato dalla la, 2 a e Y Divisione e da una brigata della 43, schierato con due divisioni in prima linea ed una in seconda, era già verso mezzogiorno sul campo di battaglia.
La distruzione dei ponti sul canale della Schelda fermò l ' avanzata della divisione di cavalleria di destra 127 e permise l'accorrere dei rinforzi tedeschi , mentre la divisione di sinistra fu nettamente arrestata dalla resistenza nemica; ma alle 16 i] tempo necessario al passaggio del canale della Schelda e la brevità della giornata invernale fecero sospendere l'operazione, visto che lo sfruttamento del primo successo era divenuto irrealizzabile.
Nei primi giorni del marzo 1918 cinque brigate di cavalleria indiana della 4a alla 5a Divisione di cavalleria furono inviate in Egitto e la Brigata di Cavalleria canadese passò a disposizione del Comando Supremo .t28 Così il Corpo di Cavalleria rimase costituito da tre sole divisioni. Verso la
126 AUSSME Fl 142 Appunti sulla cavalleria britannica e il suo impiego a/la fronte occidentale, 21 aprile 1918.
127 Meritevole di speciale menzione l 'azione dello squadrone di testa del reggimento Fort Garry Brigata di cavalleria canadese della s• Divisione il quale , gettatosi in terreno paludoso per attraversare il canale della Schelda e ritenutosi seguito ed appoggiato dal resto del reggimento , continuò celermente l'avanzata, passò attraverso i varchi dei reticolati, riconosciuti in precedenza , attaccò una batteria ne sciabolò i serventi, penetrò per oltre due chilometri in profondità della zona nemica e poi ritornò conducendo con sé 300 prigionieri, perdite s ubite: 40 cavalieri e i cavalli quasi tutti feriti.
128 Sulla campagna in Egitto sarebbe interessante un apposito srudio sul ruolo che questa ebbe nelle operazioni di controgueniglia.

-202-
metà del mese furono ritirati tutti reparti appiedati e la cavalleria fu rimessa a cavallo, proprio in tempo per prendersi in pieno la "legnata" della Somme. Il 21 marzo ebbe inizio l'offensiva tedesca sulla fronte della Somme: 6.000 cannoni tedeschi aprirono il fuoco sugli 80 chilometri di fronte compresi fra Croisilles e La Fere, in Piccardia. Dopo solo cinque ore di preparazione, 63 divisioni germaniche attaccarono . La 3a Armata britannica indietreggiò; ma le 17 divisioni della 5a si sfasciarono molto peggio di quelle italiane a Caporetto, determinando sul fronte uno squarcio lungo 15 chilometri e consentendo ai Tedeschi di puntare su Amiens, la cui presa avrebbe separato i Francesi dagli Inglesi.
Il 22 marzo reparti di cavalleria britannica furono impiegati a tenere la linea tra Ram e Hollezy , il 23 la cavalleria fu impegnata per arginare l'inarrestabile avanzata dei tedeschi, il 25 la cavalleria combatteva suli'Oise, e quando Noyon fu abbandonata, difese delle posizioni a sud di essa, sulla riva destra del fiume. Ne l la notte sul 26 reparti di cavalleria tentarono di impadronirsi delle alture di Porquericourt, a nord ovest di Nyon, s ull a linea della Divette. Ma intanto i Tedeschi puntavano in forza su Montdidier; Amiens era seriamen te minacciata e la cavall eria vi dovette accorrere, benché fosse già ammassata ad occidente di Mo n tdidier. Nella notte su l 30 esse si portò a Boves , a sud est di Amiens. La mattina del 30 la situazione intorno a Moreui l si fece critica, e la cava ll eria intervenne nella lotta , combatté a cavallo e a piedi e riuscì a tene re le posizioni lungo la strada Moreuil Démuin. Nella stessa giornata reparti di cavalleria si trasferirono qualche chilometro più a Nord, per difendere con le truppe australiane Marcelcave e la ferrovia di Amiens. Nella zona fra la Somme e la Luce i combattimenti continuano violenti, il 31 marzo la cavalleria combatté nel terreno boschivo intorno a D émuin, e riuscì a respingere gli attacchi in forza sferrati dei Tedeschi.

Intanto le r i serve britanniche erano state bruciate in un batter d'occhio e, mentre le strade s'intasavano di civili in fuga e di sbandati, accorsero 50 d i visioni francesi che, il 4 aprile, riuscirono a chiudere la falla. Le tre div isioni di cavalleria britannica avevano combattu t o ininterrotta mente per 10 e più giornate e adesso, ristabilita dai Francesi la situazione, i cavalieri britannici poterono trovare il meritato riposo. Il 3 aprile solo la l a D ivisione di Cavalleria era ancora in linea con i] XIX Corpo d'Armata, all 'estrema ala meridionale dello schieramento britannico, mentre le divisio ni 2a e 3a erano passate e far parte dell'Armata di Riserva di Gough.114 aprile, col completamento dell'entrata in linea dei Francesi, anche la la Divisione passava nelle retrovie Il 7 aprile tutto i l corpo di cavalleria formava parte della riserva della nuova 4 a armata, comandata da Sir H enry Rawlinson. Ma non era finita. Mentre il conto dei morti e dei feriti era appena all'ini zio ed i primi 90.000 inglesi venivano avviati ai campi di prigion ia in Germania, il 9 aprile le truppe del Kaiser attaccarono sulla Lys . Di nuovo la linea saltò, mentre le riserve ed i rincal zi alleati si liquefacevano.
Quando finalmente i Tedeschi si fermarono altri 204 .000 inglesi mancavano all'appello e 24.000 di loro erano prigionieri .
I Tedeschi avevano attaccato ad occidente di Lilla, nella zona di Arrnentières oltre che sulla Lys, e la nuova azione si era sviluppata nei giorni seguenti da Ypres sino al Canale di La Bassée. Il corpo di cavalleria fu quindi chiamato più a nord e si trovò, il 12, nelle retrovie della 3a Armata del gene rale Byng a sostenere dei combattimenti veramente epici.129
Nell'offensiva alleata della Somme del1'8, 9 elO agosto 1918 vi fu un altro esempio di impiego di masse di cavalleria, per sfruttare il successo in seguito alla rottura di una fronte stabilizzata aperta grazie ad un attacco di sorpresa. Venne impiegato a tale scopo il corpo di cavalleria britan-
129 Field MarshaJ Lord CARTER , Britain's Army in the 20th century, in assocìatìon with The Imperia! War Museum , London, Macmillan , 1998.
-203-
nico composto di tre divisioni -1a, 23 e 3a aJle quali furono assegnate anche aliquote di carri d'assalto leggeri. L 'azio ne offensiva iniziata alle 4 del mattino del1'8 agosto, favorita dalla nebbia, riuscì: in poche ore furono raggiunti gli obiettivi assegnati alla fanteria. Poco dopo le 9 il Corpo di Cavalleria avanzò con due divisioni in prima linea ed una in seconda, precedute a loro volta da squadroni d'avanguardia. Oltrepassata 1a linea della fanteria in movimento, la cavalleria penetrò rapidamente per 4-6 chilometri di profondità dalla linea della fanteria nelJa zona nemica e catturò prigionieri ed artiglierie. Accurate predisposizioni erano state prese per il passaggio di una divisione attraverso la Luc e (affluente della Somme). Sopraggiunta la sera. la resistenza nemica era divenuta considerevole. Il giorno appresso fu rinno vato dalla fanteria l'attacco su tutta la fronte e furono fatti nuovi e sensibHi progressi, nonostante la crescente resistenza opposta dai tede schi. Anche durante questa giornata la cavalleria britannica fu fortemente impegnata: essa aveva il compito di sostenere stre ttamente l 'attacco della fanteria e cogliere quaJunque occasione per oltrepassarla e spingersi sugli obiettivi, compito che disimpegnò con s lancio ed ardimento. Nella notte le due divisioni di cavalleria che si erano venute a trovare in prima linea furono rilevate da truppe di fanteria e furono ritirate nella valle della Luce, per portare ad abbeverare i cavalli. Nella giornata l'avanzata era stata di ben 6 chilometri!
Contrariamente alle informazioni raccolte, i Tedeschi opposero una forte resistenza, la quale, unita alle difficili condizioni del terreno, sconvol to dalla battaglia. rese impossibile alla cavalleria di avanzare. So lo la brigata di cavalleria canadese riuscì a compiere uno sbalzo di circa 4 chilometri e ad impadronirsi di una località , poi consegnata alla fanteria. Analoghe erano state le predisposizioni da parte dell'annata francese, operante sulla destra degli Inglesi, per impiegare il II Corpo di Cavalleria francese con analoga missione, ma la rottura del fronte tedesco non si era verificata. È indubbio che i risultati degli Alleati furono scars i , perché i Tedeschi ristabilivano presto la linea appoggiandosi ad una sistemazione difensiva già predisposta in profondità. In tre giornate di combattimento , oltre ad un bottino dichiarato "rilevante", il Corpo di Cavalleria riuscì a catturare oltre 3.000 prigionieri, ma perse 700 uomini ed ebbe circa 2.300 cavalli fuori combattimento. Notevole fu l'azione della cavalleria il primo giorno, nel quale essa seppe trarre profitto dal vantaggio datole dalla sorpresa e dalla rapjdità deJJ'avanzata , sfruttando il terreno, leggermente ondulato e quasi tutto unito. Manovrando a cavaJJo, a celere andatura, pur mantenendo un buon contatto con la fanteria , l'oltrepassò e aggirò i centri di resi stenza nemici, che poi occupò appiedando, in attesa dell'arrivo della fanteria amica, facilitando così l'avanzata generale. La ce lere andatura sot trasse in parte i reparti alle eccessive perdite dovute al fuoco delle mitragliatrici germaniche, le quali però, è bene specificarlo, erano dotate di un campo di tiro limitato e non potevano, se nza muovere il treppiede, seguire un bersaglio che si spostava celermente. La cavalleria non fu sottopos ta nemmeno a vio lenti tiri di artiglieria, però si dovette arrestare dinanzi alle posizioni efficacemente difese dalle mitragliatrici. Il notevole numero dei prigionieri catturati comprovò, come lo stesso maresciallo Hindenburg confermò poi nella parte deJJe s ue memorie re l ativa a quest'offensiva, che l 'azio ne della cavalleria aveva notevolmente contribuito ad accrescere la demoralizzazione dei Tede sc hi.
Nella battaglia di Le Cateau dell '8, 9 e 10 ottobre l 918 la missione del Corpo di Cavalleria britannico la, 3a e 4a di v isione fu analoga a quella dell'azione precedente.

L'8 ottobre i carri d'assalto superarono facilmente le incomplete organizzazioni difensive nemiche e penetrarono per 5 o 6 km entro la zona avversaria. 130 Durante tutto il resto della giornata, l'avan-
30 A questo punto è bene sottolineare come, benché sorpresi dal primo impiego dei carri armati inglesi. i Tedeschi non solo ne avessero approntati rapidamente di propri, ma avessero aJtrettanto rapidamente scoperto che i pezzi da campagna da 75 erano di solito sufficienti ad arrestare qualsiasi carro armato dell'epoca.
-204-
zata della cavalleria non riuscì, perché i Tedeschi si erano ritirati ordinatamente, presentando una continua barriera di mitragliatrici e di artiglierie. Nella notte il Corpo di Cavalleria fu soggetto ad un bombardamento aereo che gli inflisse delle perdite.

Il giorno appresso, senza scoraggiarsi, la cavalleria britannica seguì pazientemente lo sviluppo del combattimento della fanteria. Seppe cogliere prontamente il fugace momento adatto ad un suo intervento , che eseguì con una rapida manovra, combinando la celere azione a cavallo con l'azione a piedi, appoggiata dal fuoco della sua artiglieria a cavallo e dalle sue autoblinde. Le sue modalità d'azione furono analoghe a quelle indicate nel precedente esempio. Precedé la fanteria raggiungendo gli obiettivi ricevuti e compiendo uno sbalzo in avanti di circa 16 chilometri. Catturò prigionieri e pezzi di artiglieria. 13 1
Come si vede l'impiego della cavalleria anche sugli altri fronti fu analogo all'uso fatto sul fronte italiano. Unico punto di differenza: gli Inglesi mantennero un apposito intero Corpo di Cavalleria completamente equipaggiato per questo scopo.
131 C. RM. F. CRUTWELL. The Histo,y of the Great War, 1914-1918, Oxford, 1936.
-205-

CAPITOLO XVII
IN ALBANIA
la Cavalleria italiana era già da tempo presente in Albania con squadroni dei Reggimenti Catania , Lodi, Lucca, Palermo, Umberto I e con lo Squadrone Sardo. Le operazioni principali erano state quelle di contrasto alle bande irregolari e, nell'ultima parte della guerra, le azione di Fieri e sul Semeni e le operazioni svolte da] 7 luglio al 7 agosto 1918.
Intanto
Ai primi di luglio del 1918 la linea di contatto delle opposte forze sulJ'ala sinistra della fronte albanese correva lungo la Vojussa. Già da tempo il comando delle truppe italiane in Albania era preoccupato dalle condizioni poco favorevoli dell'ala sinistra dello schieramento , appoggiata ad ostacoli naturali di scarsa entità, come le colline di Mifoli e di Zercovina nonché il basso corso della Vojussa, e troppo vicina all'importante base navale di Valona, tanto che aveva deciso un'operazione offensiva avente lo scopo d'occupare le alture della Malakastra, fra la Vojussa ed il Semeni. Procrastinata due volte, nel giugno e nel settembre 1917, l'offensiva fu intrapresa nel luglio 1918 su tutta la fronte, in concorso al]' operazione dei Francesi su li' Alto De voli, ed aveva da parte italiana per obiettivi Perati sulla destra e Fieri sul1a sinistra.

Il carattere montuoso ed impervio del terreno sulla destra italiana, la deficienza di comunicazioni e la difficoltà di farvi affluire i rifornimenti facevano dipendere il successo de11 'operaz ione in gran parte dall'esito dell'attacco sull'a la sinistra, che aveva per asse la strada Valona-Durazzo, strada che, superata la Vojussa, scavalcava le alture della Malakastra e proseguiva per Fieri ed il ponte di Metali sul Semeni.
Fra le ultime pendici occidentali della Malakastra ed il mare si stendeva una striscia di terreno piano, ampia circa da due a tre chilometri, acquitrinosa ed in parte boschiva, che costeggiava il litorale fino allo sbocco del Semeni nella laguna di Soli. Le truppe imperiali, che erano schierate sulle alture de11a Malakastra , della quale avevano organizzato a difesa il declivio scendente dolcemente come uno spalto verso la Vojussa, si limitavano a far esplorare da qualche rara pattuglia la prospiciente zona pianeggiante ed in gran parte scoperta, di una profondità var iabile dai 4 ai 5 chilometri, che si stendeva fino al fiume. Stante questa situazione, perché le truppe italiane operanti ali' estrema s inistra potessero gittare i ponti attraverso la Vojussa, passarla e percorrere tutta l 'ampia zona battuta dall'artiglieria nemica in condizioni non troppo sfavorevoli, occorreva che i preparativi fossero fatti con la massima segretezza e sotto la protezione delle tenebre. Il comando italiano progettò pertanto di attaccare frontalmente le alture della Malakastra con cinque battaglioni di fanteria e di affidare ad una colonna di sette sq uadroni di cavalleria con due sezioni mitragliatrici, someggiate di ripiego, il compito di sfilare fra le alture e il mare e puntare sulle retrovie nemiche in direzione di Fieri e del ponte di Metali. Ultimato il concentramento delle truppe la sera del 6 luglio 1918, appena cadute le tenebre si iniziò il gittamento di un ponte di barche nella località detta Poro. Venne fissato alla mezzanotte il potenziale passaggio della colonna di cavalleria agli ordini del tenente colonnello Bonati, composta da quattro squadroni di Cavalleggeri di Catania con le due sezioni di mitragliatrici, due squadro ni di Cavalleggeri di Palermo ed il 9° Squadrone di nuova formazione lo Squadrone Sardo. La forza dei singo li squadroni poteva essere calcolata mediamente in 100 cavalli circa ma uomini e cavalli erano ridotti dal clima e dalle privazioni in condizioni di scarsa resistenza fisica, specie per via della malaria che falcidiava inarrestabilmente le truppe italiane.
Alle 4 e 30, ora fissata per l'inizio dell'attacco, la colonna di cavalleria si trovava nel boschetto della laguna di Soli in formazione di linea di sq uadroni ed iniziò il s uo movimento in tale formazione , preceduta dallo Squadrone Sardo in avanguardia. Con la protezione di una provvidenziale
-207-
nebbia mattutina, poté traversare la laguna , che era totalmente allo scoperto. Le poche pattuglie nemiche incontrate vennero ricacciate verso il mare. In tale modo la colonna poté proseguire il s uo cammino senza destare 1 ' allarme , né incontrare res istenza , fino sul tergo dell e alture della Malakastra Alle 7.30, mentre si dirigeva vers o la strada di Fieri , una pattuglia s egnalò un campo d ' aviazione. Gli squadroni presero il galoppo e , s enza neppure cambiare forma zione, fecero irruzione nel campo nemico, che fu colto completamente di sorpresa. Catturarono quattro aerei che vi si trovavano, un quinto che stava atterrando e ne abbatterono un sesto col fuoco dei mo sche tti e delle mitragliatrici , prendendo prigioniero tutto il personale aviatori e meccanici per un totale dj sette ufficiali e 85 uomini di truppa. Solo un pilota , insospettito dall'asp e tto insolito del campo, riu s d a fuggire mentre stava per atterrare.
Dopo aver provveduto alla custodia ed all'avviamento dei prigionieri , il comandante la colonna stabilì di considerare il campo di aviazione come punto di concentramento e di riordino dei reparti e distaccò il 2° e 4° Squadrone Catania, con una sezioni mitragliatrici al comando del maggiore Giusti dei Cavalleggeri di Palermo, verso il ponte di Metali per prenderlo e distruggerlo . Nel giungere sulla strada Fieri-Metali questo Gruppo si imbatté in reparti e convogli nemici che procedevano verso Fieri e, rovesciati i carreggi e i vagoncini della Décauville, fece numerosi prigionieri. Proseguì quindi verso il ponte, dove fu accolto da un vivo fuoco di fucileria e di mitragliatrici da parte di truppe nemiche, accorse sulla riva destra del Semeni.

Il comandante la colonna inviò allora in rincalzo il 3 ° Squadrone Palermo e la Squadrone Sardo , con una seconda sezione mitragliatrici. Contemporaneamente ordinò al maggiore Tonini di spingersi su Fieri col 2° Squadrone Palermo, col 5° Catania ed una ventina di uomini del 6° Catania: in totale non più di 100-120 cavalli al comando del Magg. Tonini.
Il Gruppo Tonini, giungendo sulla strada di Fieri, s'imbatté anch'esso in truppe austriache che procedevano verso Fieri, le quali, prese dal panico, si arresero con tutto il comando di battaglione senza opporre resistenza.
Senza perdere tempo, il Gruppo proseguì e, prima che il nemico avesse potuto organizzare una difesa , caricò e giunse fino alla piazza di Fieri, dove fece prigioniero il personale del comando della 94a Brigata e numerosi militari isolati. Il pronto sopraggiungere di reparti di fanteria austriaca provenienti dall'esterno però, che contrattaccarono risolutamente , mutò aspetto alla situazione. Gli squadroni, già depauperati degli elementi staccati in pattuglia e di scorta ai prigionieri , subirono in breve tempo rilevanti perdite. Cercarono di reagire all'arma bianca e appiedando, ma , esposti anche al lanci di bombe ed al fuoco di fucileria dalle case , capirono che la loro insistenza a rimanere nel paese si sarebbe risolta in un inutile sacrificio. Pe1tanto il comandante, considerate le perdite subite e la stanchezza di uominj e cavalli, decise di ripiegare verso il campo d'aviazione.
Intanto il comandante la colonna, avvisato che il Gruppo Tonini era stato attaccato a Fieri, stava accorrendo in suo aiuto dal ponte di Metali con parte del 2° e del 5° squadrone Catania , col 3° Palermo ed una sezione mitragliatrici. Prima di giungere a Fieri però , seppe che il Gruppo si era disimpegnato e stava tornando verso il campo d ' aviazione. Vi si diresse pure lui e lì si riunirono. Mentre gli squadroni si riordinavano, vennero rinviati la sezione mitragliatrici ed il 2° Squadrone Catania al ponte di Metali , dove erano rimasti lo Squadrone Sardo e l'altra sezione mitragliatrici, scortata da un plotone del 2° e da uno del 4° Catania. Il comandante la colonna intendeva intensifi care l'attacco , per tentare poi coi rimanenti squadroni di vincere la resistenza nemica in quel punto . Mentre si disponeva ad eseguire questo piano , sulla riva oppos ta del Semeni gli Austro Ungarici aprirono il fuoco sia sui reparti che agivano sul ponte, sia su quelli che si trovavano al campo d ' aviazione, facendo inoltre aumentare l'intensità del fuoco delle mitragliatrici a difesa del ponte stesso. Contemporaneamente venne s egnalata , nelle boscaglie vicine al campo d'aviazione, la presenza di pattuglie nemiche provenienti da Fieri.
-208-
Privo completamente di notizie sulle vicende dei reparti di fanteria che dovevano respingere il nemico dalla Malakastra, e nell'impossibilità di ottenerne, poiché un ufficiale inviato con una pattuglia per prendere contatto col comando della Divisione a stento era riuscito a sfuggire all'inseguimento di una banda albanese a cavallo, 132 e considerata la stanchezza degli uomini e dei cavalli a fron te della reazione del nemico, il comandante la colonna inviò ai reparti impegnati al ponte di Metali l'ordine di ripiegare sul grosso. Alle 14.30, avvisato che lo Squadrone Sardo, che scortava le mitra gliatrici, attaccato da varie parti non poteva raggiungere il grosso e ripiegava su Res Baciova, il comandante la colonna, incendiati gli aeroplani, gli hangars e il materiale non trasportabile, ripiegò con tutti reparti sul monastero di Pojani, dove giunse alle 18 e pernottò. Durante la notte le alture della Malacastra furono sgombrate del nemico. Le perdite subite nella giornata dalla colonna di cavalleria, la quasi totalità delle quali toccarono al Gruppo Tonini durante l'episodio di Fieri, furono: nove ufficiali (due morti, due feriti, cinque dispersi), 34 uomini fra sottufficiali e truppa (tre morti, 13 feriti, 15 tra dispersi e prigionieri), 72 cavalli (35 morti, 13 feriti, 24 dispersi).
Invece i risultati materiali dell'azione consisterono nella cattura di 1.200 prigionieri, fra i quali una quarantina di ufficiali, nella distruzione d i u n campo d'aviazione e di sei velivoli, di una colonna di rifornimenti, nel danneggiamento d'una colonna di carreggio e di due treni Décauville carichi. Fu poi paralizzata l'azione del comando della 948 brigata austro-ungarica e si determinò il ripiegamento di tutti i settori dello schieramento nemico sulla Vojussa, schieramento che aveva resistito all'attacco preparato e combinato dalle truppe italiane e francesi .
Di singolare valore e di particolare eloquenza è la testimonianza133 circa i sensibili effetti, anche morali, che quest'operazione determinò nel campo austro ungarico, perché "anche se la cavalcata della cavalleria italiana era terminata con perdite gravi,permane nondimeno il fatto sostanziale che essa decise le sorti della giornata."
Nonostante fosse andata fino allora perduta soltanto la posizione più avanzata del settore dell'ala più esterna, e gli Italiani incalzassero appena, l'effetto addirittura catastrofico prodotto sulla fronte dall'eco delle fucilate a Fieri e dalle voci, subito propagate dell'occupazione dell'abitato e del ponte sul Semeni, della cattura del comando di brigata e della perdita dell'unica linea di ritirata, portarono alla ritirata anche del settore nemico contiguo sul medesimo fronte Tale settore era stato appena attaccato dagli Italiani. Sotto l'impressione di questi avvenimenti, le unità austriache si sbandarono, i rimanenti settori della fronte del1a Vojussa anziché verso nord ripiegarono irrimediabilmente verso est e furono abbandonati 13 pezzi di artiglieria. "Anche ad eccezione dell'estrema ala destra dello schieramento, la fronte della Vojussa e dell'altro Devoli aveva resistito gli attacchi nemici. Ciò nonostante il comando della 47° divisione di fanteria, ad onta avesse gran parte delle proprie riser ve ancora intatte, diede la partita perduta, ordinò anche il ripiegamento della 93° brigata- schierata a sud di Beret- e stabili nelle prime ore del giorno 8 il proprio posto di comando a Liuzna e di giorno seguente a Rogozia." Infine "in questa situazione svanì anche nell'ultimo uomo la prospettiva della possibilità di una rinnovata sicura resistenza Sulle truppe pesava come un incubo la catastrofe di Fieri, dipinta in proporzioni fantasticamente smisurate ed il terrore della cavalleria che dopo molte settimane dominava ancora gli animi". È ancora da notare che il 10 luglio il generale von Pflanzer-Baltin fu inviato in tutta fretta ad assumere il comando delle forze in Albania comando di Corpo d'Armata dove giunse il 12 in aeroplano.
Le operazioni dei giorni seguenti ripresero già l'indomani, 8 luglio 1918, quando alla colonna di cavalleria venne impartito l'ordine di risalire la sinistra del Semeni verso Kuci, col compito di cat-

132 Inquadrata da elementi regolari e comandata dal capitano di cavalleria dell'esercito austro ungarico A. Schaumann.
133 S CHWARTE, Der Grosse Krieg 1914-1918, vol. V Der Osterreichisc hungarische Krieg , n. 22; Der Feldzug in Albanien. ed. 1922.
-209
turare i reparti austriaci in ritirata che tentassero di ripassare il fiume. Questo compito venne disimpegnato fino ali' 11 luglio, dando per risultato la cattura di sbandati e la distruzione di un ponte militare di barche il 9 luglio presso Jagodina.
Il 12 la colonna ricevé l'ordine di passare il Semeni e puntare verso lo Skumbi, con un Gruppo in direzione di Liuzna e l'altro di Dragosti. Ambedue, scontratisi con rilevanti forze di fanteria austriaca e presi di mira dall'artiglieria nemica, furono però costretti a ripiegare su Kuci (sul Semenj).
L'indomani la colonna di cavalleria ebbe l'incarico di sorvegliare il corso del Semeni da Stamatica ad Hassan Boyut (40 chilometri circa) e di contrastarne il passaggio al nemico. Da Kuci, e poi da Sina, la colonna, già notevolmente ridotta di forze per le perdite e la malaria, disimpegnò il compito tenendo testa quotidianamente ai ritorni offensivi del nemico, che, specialmente dopo il 21, si facevano ogni giorno più violenti e accennavano all'intenzione di passare il fiume a Kuci. Finalmente il 24 le forze nemiche, ormai divenute rilevanti, prevalsero anche contro le truppe di fanteria inviate a contenerle. Il giorno dopo, jJ 25, la colonna fu raggiunta da due squadroni dei Cavalleggeri di Lucca ed i reparti di cavalleria furono impiegati in concorso con la fanteria, prima a trattenere il nemico, che aveva passato il Semeni, quindi a ricacciarlo.
Il 6 agosto, lanciati all'attacco della fanteria austriaca asserragliata in un bosco vicino a Jagodina, subirono perdite sensibili anche se il risultato del1a giornata consisté nella cattura di 62 prigionieri, due mitragliatrici, 54 fucili, molte munizioni e materiale vario. Si persero però cinque ufficiali (due morti, tre feriti fra cui il comandante la colonna tenente colonnello Bonati), 26 tra sottufficiali e truppa (sei morti, 18 feriti, due dfapersi) e 64 cavalli (28 morti, 26 feriti e 10 dispersi) . D ato l'esaurimento dei reparti, 1'8 agosto il Reggimento Catania venne ritirato dal fronte ed inviato a Zercovina.' 34 Poco prima della fine delle ostilità, cogli squadroni presenti in Albania, venne formata la IX Brigata di Cavalleria, che partecipò all'avanzata finale delle truppe alleate che pose termine alla guerra nei Balcani.
 134
134
Colonnello
Aldo AYMONINO,
Note sull'impiego
delle grandi unità di cavalleria, febbraio 1922.
-210-
CAPITOLO XVIlI
L'ULTIMO ANNO DI GUERRA: LA RIVINCITA!
Secondol'esperienza degli Alleati franco-inglesi , se le quattro divisioni italiane di cavalleria al completo , con l'armamento e coi cavalli, alla fine deJl ' ottobre ' 17 fossero state disponibili come riserva sul Tagliamento, esse avrebbero potuto essere suH'Judrio il 25 ottobre con una massa di 1.000 mitragliatrici e 120-150 pezzi. E se la stessa massa anziché tentare di frenare frontalmente l'inseguimento nemico, nella zona Palmanova-Mortegliano, avesse agito fronte a nord est ed a nord, la ritirata sarebbe stata protetta ben diversamente ed il passaggio del Tagliamento si sarebbe forse svolto in maniera diversa; purtroppo la guerra, com 'è noto, non si fa con i se.
Ritornando alla Cavalleria italiana, essa, dopo le magnifiche prove fornite nel ripiegamento stava, nel 1918, per dare a tutte le Armi consorelle degli eserciti, alleati e no , un esempio di impiego razionale, violento, audace, vittorioso.

Dopo essersi sistemati a difesa sul Piave, era apparso chiaro che su quel fiume si decidevano tutti i destini della Patria, non solo quelli militari.
Nell'inverno 1917-1918 la necessità di potenziare il volume di fuoco e la celerità d'intervento dell'Arma fece sì che si costituissero cinque sezioni mitragliatrici ciclisti, una per ogni squadrone a cavallo, armate di due mitragliatrici pesanti ciascuna . Questi reparti avrebbero dato ottima prova nella fase fina le della lotta.
Durante il periodo trascorso s ul Piave, la Cavalleria sbrigò i compiti che le erano stati affidati di controJJo, esplorazione e sicurezza. Durante l'offensiva austriaca del giugno I 918 e le operazioni susseguenti, furono impiegati sulla linea di fuoco squadroni dei reggimenti Piemonte Reale, Lancieri di Firenze, C avalleggeri di Foggia e di Caserta; furono impiegate pure la ID Brigata e la 4a Divisione di Cavalle1ia, che fornirono pattuglie esploranti.
Come esempio dei servizi resi dall'Arma, il Reggimento Cavalleggeri di Caserta era dislocato da tempo nella zona del Montello e nelle retrovie, un po' più a sud di esso. Dopo intense esercitazio ni e sorveglianze, esso aveva una perfetta conoscenza della difficile zona. Ai vari repart i di altre Armi presenti nei singoli settori della zona assegnatagli, esso poteva fornire guide sicure, brave anche di notte, a perfetta conoscenza delle strade e di sentieri di fortuna, capaci di evitare le zone scoperte o principalmente battute del fuoco nemico. Sferratasi il 15 giugno, l'offensiva nemica, che interessò specialmen te la zona di uno degli sq uadroni di Caserta , i cavalleggeri, incitati dai loro ufficiali, si prodigarono incessantemente per otto giorni. Collegarono sotto il fuoco le prime linee, ristabilendo il contatto coi reparti in linea interrotto dall'azione nemica e più in generale sostituendosi a tutti gli altri mezzi di collegamento che il fuoco dell ' avanzata nemica aveva paralizzato o distrutto.
Si dovette in gran parte a quei Cavalleggeri se i comandi poterono funzionare , anche nei momenti più duri. Essi ed i loro commi Li toni degli altri squadroni divennero quasi leggendari tra le truppe deJle altre Armi, che li avevano battezzati "guide del Montello". Ciascun reparto e ciascuna unità affluente in quella zona ebbero la guida di nuclei di Cavalleggeri e, quando apparve chiaro che il nemico accennava a ripiegare , i Cavalleggeri, sebbene esausti non meno dei loro cavalli , con entusiasmo accompagnarono e qualche volta soccorsero i reparti inseguitori, fornendo loro preziose indicazioni. Analogo servizio prestarono gli sq uadroni dei Lancieri di Firenze un po' più a sud e non furono meno apprezzati o lodati. La loro opera può essere esemplificata da un episodio che in quel contesto di guerra di posizione appariva come di altri tempi: nel tardo pomeriggio del 15 giugno era
-211-
corsa voce che intorno a Giavera fossero apparsi degli Ulani. Uno squadrone, il 2°, era stato inviato a controllare la notizia. Era falsa. Ma il capitano che lo comandava, avendo avuto l'impressione che poche forze nemiche tenessero il paese, non esitò a lancìare due plotoni alla carica. I nuclei nemici ne furono tanto impressionati da abbandonare le mitragliatrici per darsi alla fuga, ma non così in fretta da evitare che 25 di loro fossero trafitti dalle lance; così lo squadrone riconquistò un cannone e altro materiale bellico e tenne il paese finché accorsero truppe di fanteria.
Nella zona sud di Monastièr fu costantemente impiegato Piemonte Reale; esso pure diede nuclei colleganti e fornì guide; ed esso pure, con uno Squadrone al comando di un tenente riconquistò dei pezzi di artiglieria con una magnifica carica. Poi passò ad operare intensamente nella zona tra Sile e Piave.
Presso ponte di Piave una pattuglia uffidali del Reggimento Foggia il 23 giugno tentò la traversata del fiume, ma il fuoco delle mitragliatrici nemiche le causò perdite ed impedì il passaggio.
Il giorno successivo la 4a Divisione di Cavalleria fornì sei pattuglie ufficiali della VII Brigata che dovevano tentare il passaggio a nuoto del fiume fra il ponte della Priula e Palazzon. La vigilanza nemica impedì la riuscita del tentativo, benché una pattuglia rimanesse per ben diciotto ore su uno degli isolotti. Durante tutte queste azioni sparse vi furono perdite di uomini e di cavalli, ma le truppe malgrado le incessanti e prolungate fatiche, furono magnifiche .
Più complesse le azioni della ID Brigata di Cavalleria a Monastièr. Era stata chiamata il 18 giugno per tentare un'irruzione a cavallo contro nuclei ed infiltrazioni nemiche. Costretta a passare sulle strade dalla natura del terreno, effettuò una carica che non riuscì e perse 50 uomini. Il giorno seguente, aumentando la pressione nemica contro la linea avanzata del caposaldo, un gruppo di squadroni fu appiedato e, poiché avvenne che i reparti laterali ripiegarono rapidamente (come del resto era già successo durante la ritirata al Tagliamento), la Brigata tenne da sola per giorni la linea di resistenza del caposaldo. Sostenne validamente l'urto nemico e ne alleggerì la pressione con irruenti contrattacchi alla baionetta. Ne uscì con perdite per 200 uomini, quattro ufficiali uccisi e 12 feriti.' 35
Quando, ai primi di luglio, fu chiaro che la possente offensiva dell'esercito austro-ungarico era naufragata, fu chiaro pure che la riconquista delle terre invase e la vittoria decisiva potevano arrivare in breve tempo. Le direttive del Comando Supremo orientarono in tal senso la preparazione della Cavalleria, assegnandole compiti precisi e potenziandone il volume di fuoco.
L'esperienza delle azioni della Battaglia del Solstizio, come sarebbe poi stata chiamata la batta glia difensiva di giugno, avevano meglio chiarito come alla Cavalleria, ed anche gli squadroni delle T.S., spettassero compiti importanti e complessi quali l'esplorazione ed il collegamento. Va poi considerato il fatto che le esperienze al1eate avevano dimostrato, in una certa misura, che esisteva ancora la possibilità di agire in profondità nella conquista del terreno. Infine la celerità della Cavalleria era tanto più apprezzata quanto più rapidi e profondi erano i movimenti delle masse di fanteria, e quanto più vaste le zone su cui ess.i si svolgevano.
Perciò il Comando Generale dell'Arma di Cavalleria intensificò l'istruzione dei quadri e quella dei reparti sui mezzi di collegamento, che vennero aumentati e coordinati, sul modo di combattere delle altre armi e sull'adattamento delJ'azione della Cavalleria alla natura del terreno di prossimo impiego. Si mirò a rendere familiare la tattica dell'infiltrazione e a coordinare l'impiego dei reparti a cavallo con quelli più specificamente atti ad esplicare azione di fuoco, facendo anche esercitazioni d'insieme tra squadroni di cavalleria ed unità d ' Assalto. Si stabilirono pure criteri d'impiego per

135 AUSSME, B 4 9651, Riassunto operazioni svolte della cavalleria periodo giugno luglio 1918. -212-
le batterie a cavallo e per le autoblindo mitragliatrici. Di conseguenza, dovendo agire in coordinamento con le altre Armi, a turni , durante l'estate del 1918, vennero inviati gli ufficiali superiori ai corsi istituiti presso le Armate e presso una Grande Unità di Cavalleria e gli ufficiali inferiori ai diversi corsj tenuti dal]e Armate e al corso di perfezionamento ufficiali. Venne fatta un'attiva preparazio ne, emanando direttive e sorvegliando esercitazioni intese a tenere desto lo slancio e l'ardimento, qualità essenziali dell'Arma, e a stimolare ed allenare costantemente le forze fisiche ed intellettuali degli ufficiali e della truppa.
Si ottenne dalle superiori autorità cioè dal Comando Supremo e , per suo tramite , dal Mini stero che la mobilità e l'efficienza dei reparti fossero accresciute con l'aumento dei mezzi meccanici di trasporto, anche se questo in prospettiva era un passo in più verso l'abbandono del cavallo. Fu deciso che anche la potenza di fuoco dei reggimenti di T.S. fosse incrementata con l ' assegnazione di altro personale a ciascun nucleo di ciclisti, e che nuovi mezzi di collegamento fossero assegnati ai coman di di unità e di reparto dell ' Arma. Poi s i coordinò l'impiego di questi ultimi , esercitando i reparti all'uso di essi e delle pistole Very, mai adoperate prima nell ' Arma, e stabilendo speciali codici di segnalazione, si predis pose il concorso dell ' aviazione per le divisioni di cavalleria e si costituì presso ciascun reparto un nucleo speciale di ufficiali e di personale di truppa esclusivamente addetto alle segnalazioni ed ai collegamenti. L ' organico ufficiali dei reggimenti e dei comandi di Brigata e di Divisione venne di conseguenza aumentato e, infine, furono emanate disposizioni per l'integrazione in ogni circostanza del funzionamento dei vari mezzi di collegamento.
 Schierati per la cerimonia, Piemonte Reale, 1918.
Schierati per la cerimonia, Piemonte Reale, 1918.
-213-
 Scorta ai prigionieri nel I918 , poco prima della fine della guerra.
Scorta ai prigionieri nel I918 , poco prima della fine della guerra.
-214
E, siccome il terreno di futuro impiego era intersecato da numerosi corsi d'acqua con andamento normale al prevedibile asse di operazioni, fu disposto che tutti i reparti indistintamente fossero addestrati ai guadi ed ai passaggi a nuoto. Furono quindi adottati speciali sistemi di passerelle di corda per varcare piccoli corsi d'acqua e si studiò la possibilità di trasportare oltre i fiumi le autoblindo-mitragliatrici, valendosi dei mezzi delle Sezioni da ponte per Cavalleria. 136
Come è noto, il piano offensivo concretato dal Comando Supremo Italiano prevedeva una duplice azione: dimostrativa sulla fronte della 6a e 4 3 Armata, risolutiva su quella delle Armate 12a, 8a e 10\ che doveva essere completata dall'intervento, in un secondo tempo, della 3a Armata e delle divisioni di cavalleria.
Le forze austro-ungariche in Italia ammontavano a 57 divisioni e mezza, con 6.030 pezzi e 564 aeroplani ed erano adesso articolate in tre gruppi d'armate: quello del Trentino, ora comandato dall'arciduca Giuseppe, binario come l'altro di Boroevic sul Piave, ed il nuovo Gruppo d'Armate dj Belluno, incaricato della difesa tra Piave e Brenta e sottoposto a von Goglia. In totale però solo 36 divisioni e mezza erano in prima linea, perchè l'Imperiale e Regio Stato Maggiore aveva schierato le proprie forze prevalentemente in difesa, sulle due linee all'uopo predisposte: la Kaiserstellung, profonda 2 o 3 chilometri, e la Konigstellung, in via di completamento.
Dall'altra parte Diaz nuovo Capo di Stato Maggiore aveva, da sinistra a destra, le armate 1\ 4U, 12\ 83, 10a e 3 3 • La 12° e la 10\ rispettivamente agli ordini del generale francese Graziani e dell'inglese Lord Cavan, contavano però una tre divisioni italiane ed una francese e l'altra due divisioni italiane e due britanniche. Complessivamente Diaz, su 57 divisioni che aveva, ne poté mettere 22 in prima linea e 16 in seconda, con 4.150 pezzi ed oltre 600 bombarde. Nella terza settimana di ottobre tutto il dispositivo era pronto per queJla che sarebbe passata alla storia come la battaglia di Vittorio Veneto.
Iniziò la 4a Armata, attaccando gli Austriaci sul Monte Grappa il 24 ottobre 1918, ad un anno esatto dall'offensiva di Caporetto. Sull'altopiano di Asiago entrarono in azione gli uomini della 6a, mentre quelli della 12a attaccavano sul Piave. Il 25 ed il 26 il fiume in piena arrestò le operazioni lungo tutto il suo corso, mentre la 4a Armata continuava a combattere sul Grappa.
Nella notte fra il 26 ed il 27 il Genio gittò ponti e passerelle sotto un fuoco tremendo, consentendo alle armate 83, 10a e 12° di traversare il fiume e costituire delle teste di ponte, rispettivamente verso Sernaglia, Valdobiaddene ed Ormelle. Gli Austriaci si difesero con tutte le forze su tutta la linea, concentrando il fuoco del1e loro artiglierie sui ponti appena gittati e cbe il Genio doveva continuamente ricostruire per gli effetti delle cannonate e della piena.
Il 28 il generale Caviglia fece passare il XVIII Corpo sui ponti usati dalla 10a Armata e lo fece convergere sul ne mico, consentendo l'ampliamento delle teste di ponte. Nella notte il Genio gittò un'altra serie di ponti per i rinforzi, che permisero di prendere Susegana e minacciare Vittorio Veneto. Davanti ad una simile situazione Boroevic, nel pomeriggio stesso del 29, ordinò la ritirata sulla seconda linea difensiva. 11 giorno seguente 1'8a Armata forzò la stretta di Serravalle, ]a 10° arrivò sulla Livenza, la 12a prese la strettoia di Quero e la 33, ricevutone l'ordine, passò il Piave.

Il 31 ottobre 1918 l'avversario, contro cui gli Italiani si battevano da oltre cent'anni, l'Imperiale e Regio Esercito Austro-Ungarico, sj sfasciò per sempre.
Ed ecco cosa aveva fatto la Cavalleria. Il 27 ottobre 1918 il Comando Generale dell'Anna di Cavalleria si era trasferito da Este a Villa Franchetti (a San Trovaso di Treviso) assumendo la denominazione di Comando del Corpo di Cavalleria. Aveva alle proprie dipendenze la 28 e 3a Divisione di Cavalleria, ma si era previsto d'assegnargli anche la 1a e la 4a se, verificatosi l'atteso sfondamento, si fosse reso possibile l'impiego in massa delle truppe celeri.
136 AUSSME, Comando generale dell'anna di cavalleria: ai comandi di divisione, brigata e di reggimento cli cavalleria, Appunti sull ' azione della cavalleria nei giorni 26 ottobre 4 novembre 1918.
-215-
Il 28 ottobre la situazione fece passare la 1a Divisione dalle dipendenze dell' 83 Armata a quelle della 103 per rimetterla a disposizione deU'8 3 il 30 e farla passare al Corpo di Cavalleria il l O novembre, in vista dell'inseguimento. Similmente la 4a Divisione , a disposizione del1'8° Armata, passò il 29 ottobre a far parte del Corpo di Cavalleria.

Il favorevole andamento dell'offensiva aveva indotto il Comando italiano il 28 ottobre 1918 a muovere le quattro divisioni di cavalleria, che erano: la la a Paese, Castagnole e Monigo, la 2° a Presina , Gazza, Ospitale di Brenta, San Giorgio in Bosco; la 33 a Camisano, Grumolo delle Badesse e Crisignano e la 4a a Piombino Dese, Scandolara e Trebaseleghe. I compiti assegnati loro oltre Pia ve dal Corpo di Cavalleria erano i seguenti:
I) prevenire il nemico ai ponti del Tagliamento, da Pinzano al mare, e occuparli;
II ) tenere il contatto con le colonne nemiche in ritirata;
III) se impossibile oltrepassare il Livenza, agire contro il fianco destro dell'avversario e recargli il maggior danno possibile.
Per riuscirci, il Comando del Corpo aveva deciso di raggiungere al più presto con il nucleo principale della forza la pianura compresa tra la ferrovia Sacile Codroipo al sud, il corso del Tagliamento ad est, la linea pedemontana Maniago-Aviano al nord ed il corso del Livenza tra Polcenigo e Sacile all'ovest. Di là poi bisognava proseguire velocemente verso il Tagliamento , per prevenire il nemico ai ponti di Pinzano , Bonzicco e della Delizia, mentre un distaccamento, operando a sud della suindicata ferrovia, doveva agire con lo stesso scopo verso i ponti di Latisana.
Occorreva prima di tutto assicurarsi i passaggi su I Livenza. Infatti l'avanzata delle tre di visioni di cavalleria 2a, 33 e 4a dal Piave aveva come primo obiettivo proprio il passaggio sul Livenza , che non poteva effettuarsi al nord della ferrovia Conegliano-Sacile, perché là avrebbe operato già la Ia Divisione di Cavalleria e la ristretta zona di terreno racchiusa fra la ferrovia stessa e le colline, percorsa da due sole rotabili in senso ovest-est, rendeva rischioso un eccessivo agglomeramento di unità. Sarebbe s tato giocoforza formare lungh e e lente colonne, facile bersaglio dell'artiglieria nemica. Di conseguenza il Comando del Corpo di Cavalleria fissava alla quattro divi s ioni, come primo fronte da raggiungere, il tratto di Livenza tra Sacile e Brugnera inclusa dando alla 2 3 Divisione il tratto tra Brugnera e Porto Buffolè inclusa. Da tale fronte, avanzando con l'ala destra della 411 Divi sio ne da Brugnera , per Porcia , su Pordenone , la massa principale del Corpo di CavalJeria sarebbe sboccata nella pianura al nord della ferrovia Pordenone-Codroipo, per procedere poi celermente sul Tagliamento. La 3a rnvisione, giunta ultima sulla sinistra del Piave. doveva rimanere momentaneamente in riserva nella zona Tezze-Marano-Vazzola. Di là doveva seg uire la 1a a nord di Sacile e buttarsi nella pianura appena fosse sta to aperto un passag gio, portandosi poi in linea sulla sinistra delle altre divisioni: avrebbe avuto come speciale obiettivo i ponti di Pinzano.
Era stato infine ordinato che, qualora le divisioni non avessero potuto oltrepassare il Livenza, dovevano arrecare il maggior danno al nemico agendo ''con ardite puntate" s ul fianco delle colonne in ritirata dal Piave al Livenza. Essendo poi stato disposto che la 1n Divisione di Cavalleria volgesse verso il nord Vittorio ed alta valle del Piave il comando del Corpo di Cavalleria provvide perché anche la 3a entrasse in linea , dirigendosi s ul tratto di Livenza fra Polcenigo e Sacile. Come ri serva venivano destinate un Brigata di Cavalleria (la III) ed una Batteria a cavallo della 2° Divisione , assegnando loro come dislocazione la località di Orsago. L'altra Brigata della stessa Divisio ne, la IV, doveva operare a s ud della ferrovia Sacile-Pordenone-Codroipo, gravitando però col grosso delle sue forze verso la ferrovia stessa ed inviando un distaccamento per l'occupazione di ponti del Livenza . In tal modo il Corpo di Cavalleria operava con due divisio ni e mezza nella piana a nord della citata ferrovia, verso il tratto del Tagliamento fra Pinzano ed i ponti della Delizia , e soltanto con una Brigata al sud della linea suddetta.
-2 16-
 Messa al campo per il Piemonte Reale nel 1918.
Piemonte Reale schierato per la cerimonia, 1918.
Messa al campo per il Piemonte Reale nel 1918.
Piemonte Reale schierato per la cerimonia, 1918.
- 217 -
Nelle prime ore del 29 ottobre si iniziarono i movimenti. La 1a Divisione si attestò sul Piave tra Spresiano e Lovadina; la 23 si trasferì nella zona Istrana-Quinto di Treviso-Zero Branco-Badoere; la 3a si trasferì nella zona Piombino Dese Scandolara-Trebaseleghe e la 4a passò nella zona PaeseCastagnole-Monigo.
La 1a Divisione, passata sulla sinistra del Piave per i ponti di Palazzon e Salettuol passaggio difficile e laborioso, vista la profondità del fiume e la velocità della corrente ebbe il compito di puntare su Sacile e Vittorio, in cooperazione con le truppe della 103 Armata. A sera raggiunse la linea del Monticano, saldamente tenuta dal nemico; due brigate britanniche ed una italiana non eran o riuscite a superarla
Il Corpo di Cavalleria costituito dalle divisioni 2 8 , 3a e 4a si apprestò a passare sulla sinistra del Piave e, nella notte sul 30 ottobre, raggiunse la linea Cimadolmo-Borgo Malanotte, dove sostò in attesa di ordini. La 4a Divfaione in particolare si attestò al ponte H, 500 metri a valle del ponte della Priula, la 3a si accodò alla 2\ che si portò al ponte di Palazzon. Complessivamente nella giornata del 29 ottobre le quattro divisioni avevano percorso_, la 1a 35 chilometri, la 2a 65, la 3a 70 e la 4a 40.
Il passaggio del Piave da parte della 4a Divisione difficile per le condizioni di corrente, la poca stabilità del ponte ed il buio notturno sub1 un arresto dalle 2 alle 6 del mattino del 30 ottobre, per l a rottura del ponte stesso Soltanto alle 10 la parte combattente della Divisione raggiunse l'altra sponda, poi iniziò l'attraversamento la 38, che passò dopo aver dato la precedenza a due reggimenti di artiglieria di Corpo d'Armata. Perciò soltanto nel pomeriggio del 30 le divisioni riuscirono a raggiungere la dislocazione seguente: 4a Divisione, tra Codognè e Vazzola; 2 8 tra Visnà e Borgomalanotte e 3a tra Mareno e Tezze.
Intanto la 1a occupava, combattendo, Fontanelle, Codognè, Gaiarine e Conegliano, mentre i suoi distaccamenti erano spinti su Vittorio. Data la situazione, vennero fissati quali obiettivi sul Tagliamento: i ponti di Pinzano e di Bonzicco alla 33 Divisione, iJ ponte della Delizia alla 4a e quelli di Latisana alla 2a, che doveva occuparli con un distaccamento, gravitando col grosso delle sue forze verso nord in concorrenza delle conversione della massa del Corpo di Cavalleria.
Si prescrisse di non diluire l'azione su tutta la fronte, ma di attaccare con impeto in alcuni punti concentra ndovi tutti i mezzi di penetrazione disponibili. Aperto un varco, si doveva procedere celermente sugli obiettivi assegnati, subordinando a ciò qualsiasi altra considerazione.

Il 31 ottobre, il giorno decisivo, vinte le resistenze incontrate lungo il Monticano, la 4a Divisione si attestò al Livenza tra Sacile e Brugnera: un gruppo di Cavalleggeri Guide attaccò Sacile, fortemente difesa da forze nemiche. Tre battaglioni britannici, trascinati dall'impeto dei Cavalleggeri, concorsero all'azione e la città sulla sinistra de] Livenza ridiventò italiana. All'alba dello stesso giorno una pattuglia di Vittorio Emanuele e una di Milano 2a Divisione di Cavalleria entrarono per prime in Oderzo. Ricognizioni spinte su tutta la fronte del Livenza trovano tutti i ponti distrutti, la riva sinistra saldamente occupata e guarnita da uno schieramento di mitragliatrici e di reparti di assalto. La 3° Divisione di Cavalleria nel pomeriggio raggiunse il ponte di Fiaschetti a nord di Sacile, l'unico preso intatto grazie alla pronta e decisa avanzata della 1a Divisione di Cavalleria, e si diresse su Polcenigo. Forze austriache ne occupavano saldamente la stretta.
La cooperazione tra il Gruppo d'Artiglieria a cavallo, le mitragliatrici e i ciclisti dei reggimenti Montebello e Vicenza costrinse gli Austro-Ungarici a ripiegare. Alle 18.30 la 3° Divisione occupò Polcenigo e spinse una pattuglia sul Tagliamento. Lo stesso giorno la la Divisione di Cavalleria riuscì, come si è accennato, ad occupare il ponte di Fiaschetti ed alle 15.30, prima tra le truppe italiane ed alleate, passò il Livenza. Il Reggimento Genova caricò i reparti nemici sostenuti da mitragliatrici e vicini alla sinistra del fiume, poi, a notte, la Divisione sostò con la TI Brigata a Vigonovo e la I richiamata da Vittorio a Cordignano. Nella giornata la 1a Divisione aveva catturato circa 1.000 prigionieri ed una ventina di mitragliatrici a fronte di qualche perdita, tra cui un ufficiale e 30 uomini
-218-
 Uom ini , cavalli e biciclette dj Piemonte Reale.
Panoramica del Reggimento Piemonte Reale sc hierato in aperta campagna, 1918.
Uom ini , cavalli e biciclette dj Piemonte Reale.
Panoramica del Reggimento Piemonte Reale sc hierato in aperta campagna, 1918.
-219-
feriti. Alla sera la Divisione ricevé dall'8a Armata l'ordine d'agire per Vittorio verso l'Alto Cadore, raccogliendosi l'indomani a sud est del lago di Santa Croce. Nella notte del I O novembre elementi esploranti della 4a Divisione passarono sulla sinistra del Livenza e riferirono che il nemico si stava ritirando. Alle 14, gettato un ponte a Francenigo, la VII Brigata puntò su Pordenone, che risultò sgombra e saccheggiata, constatando che il ponte sul Meduna verso Casarsa era distrutto. Nella notte stessa elementi leggeri della 2a Divisione passarono il Livenza tra Varda e Porto Buffo]è, mentre venivano allestiti passaggi per il transito del resto dell'Armata.
Il 1° novembre, all'alba, la 3a Di visione mosse verso il Tagliamento, ma truppe austriache, fra cui la 6a Divisione di Cavalleria, appiedata e sostenuta da batterie e da numerose mitragliatrici, occu pavano la linea San Martino-Sedrano-San Quirino-Nogaredo.
La XII Squadriglia autoblindo-mitragliatrici venne lanciata su Nogaredo: artiglieria e mitragliatrici nemiche aprirono il fuoco a brevissima distanza. Quattro autoblindo furono colpite ed immobilizzate e quasi tutti gli ufficiali feriti. Giunsero in rincalzo i ciclisti del Reggimento Saluu.o e la lotta si protrasse fino a sera. Il Reggimento Savoia sulla sinistra, nonostante iJ fuoco d'artiglieria e di mitragliatrici avversarie, caricò arditamente verso San Martino ed ebbe sensibili perdite; oltrepassata la prima linea nemica, si trovò di fronte ad altre successive resistenze, appiedò e combatté. Contro Sedrano un Gruppo del Reggimento Sa/uzzo effettuò un'azione aggirante, contemporaneamente uno di Vicenza per San Quirino puntò su San Foca, per tagliare la ritirata al nemico. La pressione sulla fronte e la minaccia di aggiramento costrinsero sull'imbrunire l'avversario a ripiega re e nella notte ad abbandonare] 'intera linea. Nella stessa giornata del 1° novembre, la 1a Divisione raggiunse Vittorio Veneto, mentre, alla stretta di Fadalto, le fanterie ancora combattevano per vincere la resistenza nemica. A sera la Divisione ricevette l'ordine dal Comando Supremo di raggiungere al più presto Stazione per la Carnia, per interrompere le comunicazioni del nemico che facevano capo alla Val del Ferro.
Per assolvere questo compito, il 2 novembre la 1a Divisione, preceduta da colonne celeri mosse su Stazione per la Carnia per Maniago e Pinzano e tagliò le provenienze dal Mauria, mentre con un'altra colonna, risalendo il Meduna, scese in Val Tagliamento tra Ampezzo e Tolmezzo.

La colonna celere di avanguardia, composta da ciclisti, superata una breve resistenza sul Meduna occupò Maniago e, alla sera, Travesio. L'altra colonna, un Gruppo Squadroni di Genova Cavalleria con lo Squadrone mitragliatrici, raggiunse Tramonti di Sopra.
La 3a Divisione, informata che due colonne nemiche si erano dirette durante la notte tra il 1° e il 2 novembre rispettivamente ai ponti di Pinzano e di Bonzicco, mosse all'alba del 2 novembre e giunse a Tauriano. Staccato contro la colonna nemica diretta su Pinzano, il Reggimento Saluu.o caricò e catturò 400 prigionieri, due cannoni e sei mitragliatrici presso Istrago, annoverando fra i caduti il capitano Libroja, poi il Reggimento proseguì su Pinzano.
Contro la colonna nemica diretta a Bonzicco si mosse Montebello: un'intera divisione nemica era asserragliata e si difendeva disperatamente nei caseggiati di Bardeano e Provesano. Entrò in azione una batteria a cavallo, mentre i lancieri appiedati attaccavano gli abitati con azione avvolgente. Il rimanente della divis ione, senza preoccuparsi delle mitragliatrici in posizione nei pressi di Spilimbergo, conquistò di viva forza la località, catturando prigionieri, sei cannoni, molte munizioni, materiali e un treno di vettovagUe. Savoia Cavalleria, sostenuto dall'artiglieria a cavallo procedé subito verso i guadi del Tagliamento. Il sopraggiungere della notte sospese l'operazione.
La 4 3 Divisione, all'alba del 2 novembre, occupato Cordenons dopo una breve ma vivace azione contro nidi di mitragliatrici e dopo aver catturato 140 prigionieri e ingenti materiali, si spinse su Bonzicco. Alle 16 la sua Vll Brigata proseguì per San Giorgio nella Richinvelda, ma si arrestò perché ostacolata da un nutrito fuoco di mitragliatrici appostate sulla linea Provesano-Cosa e Pozzo. lo nemico intanto bruciava il ponte di Bonzicco.
-220
TI 3° Gruppo Bersaglieri Ciclisti, addetto alla 4a Divisione, era stato intanto avviato ai ponti della Delizia. Occupato Orcenigo di Sotto, informava che Cevraia, Orcenigo di Sopra, Villa Si]e e Castions, che costituivano parte della testa di ponte sulla destra del Tagliamento in corrispondenza dei ponti deJJa Delizia già fatti brillare, erano saldamente in mani avversarie.
La IV Brigata della za Divisione, guadato il Meduna nei pressi di Pordenone, prosegu} su Azzano Decimo, incontrò notevoli resistenze ed i ponti sui numerosi corsi di acqua tutti distrutti. Tale situazione lasciava naturalmente prevedere una lenta e difficile avanzata. Il comandante la Divisione pro pose allora ed ottenne di costituire una colonna celere , formata da una compagnia ciclisti, dalle sezioni mitragliatrici e dalla III Brigata in riserva ad Orsago con due sezioni autoblindo, da inviare per Sacile al ponte di Latisana. Allo scopo di aggirare la resistenza oltre il Meduna, il generale Luigi di Robbiante venne autorizzato a spostare la Brigata a nord della ferrovia Pordenone-Casarsa. Dalla mattina, in segu ito all'ordine del Comando Supremo di inseguire il nemico in ritirata su tutto il fronte, il comando del Corpo di Cavalleria, dal quale veniva a dipendere anche la la Divisione di Cavalleria, ordinò alla I a Divisione di raggiungere al più presto Stazione per la Carnia per interrompere le comunicazioni nemiche che facevano capo alla Val del Ferro e di spingere distaccamenti verso i] nodo stradale di Tarvisio; alla 3a d'inseguire il nemico puntando su Udine e Cividale, intercettare le strade che da San Quirino e Monte Purgessirno risalgono le valli del Natisene e dei suoi affluenti e spingere esplorazioni su Tolmino e Plezzo; alla 4a di puntare su Pozzuolo-CormonsGorizia, occupando i ponti dell'Isonzo da Salcano a Peteano, e di spingere esplorazioni su Schonpass e Dromberg; infine alla 28 d'inseguire il nemico sulla direttrice Palmanova-Monfalcone, occupando i ponti sull'Isonzo da Peteano al mare.

L'indomani, 3 novembre, la la Divisione perseguì energicamente gli obiettivi assegnatile. La colonna celere d'avanguardia occupò Pinzano e le alture di Campeis, dopo aver vinto la forte resis tenza nemica. Il grosso della cavalleria marciò s u Travesio e a sera la I Brigata giunse nei pressi di Flagogna.
La 3a Divisione alle 7 .30 guadò al galoppo il Tagliamento nei pressi di San Odorico e di sorpresa s'infiltrò nella linea delle fanterie austriache, sorpassandola e giungendo sulle artiglierie prima che potessero aprire il fuoco. La situazione era pericolosa: un'intera divisione austriaca e numerosissime mitragliatrici guarnivano il tratto di sponda raggiunto; ma lo slancio dei cavalieri e la depressione morale degli avversari la risolsero. Il nemico rinunciò ad ogni ulteriore difesa e chiese di parlamentare.
Nella stessa mattina la 4a Divisione iniziò il passaggio del Tagliamento con la VII Brigata ed una batteria a cavallo ai guadi di San Odorico. Malgrado il fuoco di artiglierie e mitragliatrici nemiche, il Reggim ento Vercelli raggiunse il costone di San Odorico e catturò 536 prigionieri e due batterie, mentre Nizza Cavalleria, con un'altra marcia, raggiungeva anch'esso la sinistra del Tagliamento. Parlamentari austriaci si presentarono ai comandi della 3a e 4a Divisione annunciando che l 'armistizio era stato firmato. Il Conte di Torino, comandante del Corpo di Cavalleria, che seguiva da presso le due divisioni, aveva anch'egli passato il Tagliamento e, saputo dell'armistizio, ordinò ai comandan6 delle divisioni stesse di imporre la resa nemico e, neJ caso non venisse accettata, di con tinuare senz'altro l'offensiva.
Di fronte a tale contegno energico e deciso, il generale Schonauer, comandante della difesa sulla sinistra del Tagliemento, si arrese. Passata frattanto sulla sinistra del Tagliamento anche la VIII Brigat.a, che si dislocò tra San Odorico e Turriva, i cavalieri procedettero al disarmo dei reparti della 44a Divisione austriaca, che complessivamente comprendeva cinque generali, 370 ufficiali, 6.996 uomini di truppa, 70 cannoni da campagna, 60 da trincea, 103 mitragliatrici, munizioni e numerosissimi materiali vari.
Precedentemente anche la 3a Divisione era passata sulla sinistra del Tagliamento ed uno squadrone di Savoia, in avang uardia alla Divisione stessa e. condotto dal colonnello Amedeo Marchino,
-22 1
appena nominato comandante del Reggimento, sfuggì al fuoco avversario. Poi galoppò alla volta di Udine e vi giunse alJe 13.30, recando l'annuncio della riscossa e occupando la stazione ferroviaria.
La VI Brigata giunse nella mattinata presso Bagnara dove ricevé messi che annunciavano l'armistizio. Il comandante la Brigata li trattenne e proseguì l'avanzata. Prese così di forza Bagnara, Cordovado e Saccudello, catturando complessivamente J .600 prigionjeri tra i quali un colonnello. Reparti celeri della Brigata, spinti su Cinto Caomaggiore, inflissero perdite notevoli all'avversario e catturarono prigionieri, raggiungendo nelJa mattinata la Saga, a nord ovest di Portogruaro. Il Gruppo Celere staccato il 2 novembre dalla 2a Divisione compì un largo giro e, superate non lievi difficoltà, giunse verso il mezzogiorno del 3 novembre davanti al ponte di Latisanotta. Una compagnia ciclisti passò sul ponte della ferrovia di Latisana ed entrò in paese, catturando 278 prigionieri, dei quali 8 ufficiali. Alia sera la Brigata si attestò al Tagliamento tra Morsano e Latisana. Il comando del Corpo di cavalleria rimise a disposizione della 2 3 Divisione la III Brigata con l'ordine d'eseguire un'energica puntata su Palmanova e Gradisca: la Brigata guadò il Tagliamento nei pressi di S. Odorico e nella serata raggiunge Flaibano.
Il 4 novembre, il giorno della Vittoria: al comando del Corpo di Cavalleria venne comunicato l'ordine del Comando Supremo che alle 15 le ostilità dovevano essere sospese. Il Comando impose alle divisioni un ultimo sforzo, perché all'ora stabilita, puntando sugli obiettivi già fissati, venisse raggiunta la linea più avanzata possibile.

La colonna celere della t a Di visione di Cavalleria, vinte le ultime resistenze a Tolmezzo e ad Amaro, giunse verso le 14 a Stazione per la Carnia. Sorprese una colonna nemica in ritirata su Resiutta e la fece prigioniera; erano il comandante della 343 Divisione con il suo stato maggiore, circa 10.000 uomini di truppa. Le autoblindo aprendosi la marcia fra carreggi, quadrupedi e truppe nemiche, catturarono un comandante di Corpo d'Armata austriaco, mitragliarono un treno in movimento verso Pontebba e arrivarono a Chiusaforte.
All'armistizio il Reggimento Monferrato raggiunse Tolmezzo, dove stavano per arrivare la colonna che aveva risalito il Meduna e il Reggimento Roma proveniente da Chiaulis.
Tra Gemona e Venzone restarono bloccate le divisioni nemiche 41 a Honved ungherese e 12° di cavalleria appiedata. Per concessione del Comando Supremo dette divisioni avrebbero poi avuto passo libero per Pontebba, ma disarmate. Il bottino ammontò a 98 cannoni, 5.000 fucili e ingente quantità di materiale bellico di ogni specie.
La 3a Divisione, aperto il varco alle nostre fanterie che stavano arrivando al Tagliamento, puntò su Udine, dove giunse alle 11, proseguì per Cividale e, alle 15, si arrestò nella valle del Natisene all'altezza di Biarzo tenendo alcuni elementi avanzati a Robic, a 4 chilometri circa da Caporetto. Durante questa rapidissima avanzata, la divisione catturò convogli nemici, per complessivamente altri 3.000 prigionieri, tra i qua1i due colonnelli, 300 cavalli ed ingenti quantità di materiali.
La 4a Divisione lasciò l'Vlll Brigata a custodia di prigionieri, dato il contegno poco rassicurante di alcuni ufficiali nemici, e procedé su due colonne verso Gorizia. Una colonna celere di Bersaglieri Ciclisti e mitragliatrici di cavalleria mosse da Flaibano e urtò contro un forte reparto avversario, schierato con artiglierie e mitragliatrici presso il cimitero di Galleriano. L'attacco, breve e risoluto, portò alla cattura di 18 ufficiali, 985 soldati. sei cannoni, 20 mitragliatrici, cavalli e materiali vari. Il comandante la divisione, venuto a sapere che parecchi ufficiali austriaci, compresi i due generali, erano riluttanti e deporre le armi a Pozzuolo del Friuli, vi si recò e impose loro il disarmo nonché quello delle truppe là dislocate. L'altra colonna, costituita dalla VII Brigata di Cavalleria, muovendo da Flaibano incontrò una tenace resistenza a Lumignacco da parte di due compagnie ungheresi di Honved, che si an·esero dopo uno scambio di colpi, cosicché a]le 15 la Brigata poteva schierarsi sulla fronte Lumignacco-Risano-Tissano.
Per la stessa ora elementi celeri della 4a Divisione erano arrivati a Cormons, Manzano e Buttrio.
-222-
 La la Divisione di Cavalleria in movimento verso il Piave nel 1918.
Sezione Autoblindomitragliatrici e reparti montati della 2" Divisione di Cavalleria verso il Torre.
La la Divisione di Cavalleria in movimento verso il Piave nel 1918.
Sezione Autoblindomitragliatrici e reparti montati della 2" Divisione di Cavalleria verso il Torre.
223
La III Brigata, nelle prime ore del 4, da San Odolico puntò verso Palmanova. Vinta la tenace resistenza di una retroguardia asserragliata a Morsano, con un'azione in cui rimasero feriti il colonnello Panicati , il maggiore Zarone ed altri ufficiali del Reggimento Vzttorio Emanuele li , la Brigata alle 15 raggiunse, presso il km 4 della strada napoleonica Codroipo-Palmanova, una colonna nemica in ritirata. Il comandante della 23 Divisione di Cavalleria, che marciava in testa alla Brigata, stabilì col colonnello austriaco comandante 1'83° Fanteria quale linea raggiunta quella di Feletis-Fauglis.
La VI Brigata, passato il Tagliamento ali' al ba del 4 novembre sui ponti di Latisana e Latisanotta , avanzò celermente su Cervignano. Incontrò resistenza nemica sul Cragno, ad ovest di Palazzolo dello Stella, e, trovato un ponte distrutto, cercò un passaggio più a nord. Il Reggimento Mantova caricò brillantemente nei pressi di Talmassons la scorta di una colonna carreggio in ritirata, infliggendole forti perdite e catturando oltre 1.000 prigionieri: tra le perdite de] Reggimento vi fu un ufficiale ucciso e qualche altro ferito.
Il Reggimento Aosta catturò due colonne nemiche nei pressi di Pocenia, facendo complessivamente 600 prigionieri, di cui 20 ufficiali, e 70 carri. A Torsa fu accolto da fuoco di mitragliatrici, cercò un varco più a sud e, con successive azioni a fuoco e a cavallo, entrò alle 15 a Cenriolo, caricando al galoppo e con lo stendardo in testa.
La colonna celere della 28 D1visione, spinta innanzi alla VI Brigata di Cavalleria reparti ciclisti divisionali, 7a Squadriglia Autoblindo e una compagnia Bersaglieri Ciclisti, a cui si erano uniti in seguito due squadroni di Piemonte Reale vinse, con audace azione, successive resistenze a San Giorgio di Nogaro, a Torre di Zuino e a Masseria di Tre Ponti, catturando numerosi prigionieri, carreggio, cannoni e materiali. Alle 15 occupò Cervignano dove, col comandante la 588 Divisione austriaca, fatto prigioniero assieme a tutto il suo stato maggiore, venne stabilita come linea raggiunta quella Joanniz-Cervignano Grado.
Il Corpo cli Cavalleria aveva così assolto i compiti fissatigli. Agendo come avanguarclia delle Armate, valendosi dei suoi soli mezzi, superò per primo tutte le resistenze incontrate sui successivi corsi d'acqua che sbarravano le sue direttrici cli marcia, sopravanzando fin dal 2 novembre il Corpo britannico dislocato sulla sinistra del Piave, quando le divisioni di cavalleria distavano da quel fiume circa 70 chilometri. La capitale del Friuli fu occupata dalla cavalleria il 3. Il 4 le di visioni avevano superato com battendo percorsi varianti dai 40 ai 90 chilometri e, dal 29 ottobre al 4 novembre, ne avevano percorsi da 300 a 350, spesso non ricevendo a causa della celerità della marcia, i viveri ed i foraggi.
Nei giorni di combattimento ufficiali e truppe si nutrirono con la carne dei cavalli caduti, uccisi e feriti. Complessivamente il bottino raccolto dal Corpo di Cavalleria assommò a: 10 generali, 1.378 ufficiali di altro grado, 40.200 prigionieri fra sottufficiali e truppa, 3.500 quadrupedi, 322 can noni di vario calibro, 628 mitragliatrici, 27 .900 fucili , 3 treni completi ed altro materiale ferroviario, oltre a ingente carreggio, numerosi autocarri, grandissimi depositi di munizioni e quantità notevoli di viveri e foraggi. Nel calcolo dei prigionieri non si tenne conto delle tre divisioni intere che, chiuse dall'avanzata del 4 nella zona di Osoppo, virtualmente catturata, furono, d'ordine del Comando Supremo, lasciate ritirare disarmate per la Pontebbana. le quali avevano nel complesso una forza di circa 31.000 uomini e 7.000 quadrupedi. 137
La guerra era finita e la Cavalleria sembrava tornata ad essere un'Arma preziosa. La tecnologia però aveva compromesso per sempre l'uso del cavallo.L'Arma sopravvisse alla guerra, ma cambiando, nel corso degli anni, il suo tradizionale mezzo di trasporto , sostituendolo con altri più moderni, ma sempre con lo stesso spirito che l'aveva e l'avrebbe ancora contraddistinta sui campi di battaglia.
m AUSSME, B 4 9651 2, Comando del corpo di cavalleria; oggetto: relazione sommaria sulle operazioni svolte dal corpo di cavalleria, 16 novembre 1918.

-224-
 Autoblindomitragliatrici e batterie a cavallo della 2" Divisione di Cavalleria nell'ottobre 1918.
CavaJJeria e ciclisti della 3• Divisione di Cavalleria sul Piave: 1918.
Autoblindomitragliatrici e batterie a cavallo della 2" Divisione di Cavalleria nell'ottobre 1918.
CavaJJeria e ciclisti della 3• Divisione di Cavalleria sul Piave: 1918.
-225
 Elementi della la Divisione di Cavalleria in montagna nel 1918.
Un ufficiale di cavalleria cammina a fianco a delle truppe inglesi, Piave 1918.
Elementi della la Divisione di Cavalleria in montagna nel 1918.
Un ufficiale di cavalleria cammina a fianco a delle truppe inglesi, Piave 1918.
226-
 Lanciere a Udine liberata. 1918.
Lanciere a Udine liberata. 1918.
-227
 Cavalieri sul greto del Tagliamento nel 1918.
Cavalieri sul greto del Tagliamento nel 1918.
-228-
 Ottobre 1918: la cavalleria avanza in Friuli.
Ottobre 1918: la cavalleria avanza in Friuli.
-229-
 Attraversamento del Meduna.
Motta di Livenza , attraversamento de l fiume s u un ponte di barche .
Attraversamento del Meduna.
Motta di Livenza , attraversamento de l fiume s u un ponte di barche .
230-
 4 novembre 1918: guardia allo stendardo dei Cavalleggeri di Roma, custodito nel fodero.
4 novembre 1918: guardia allo stendardo dei Cavalleggeri di Roma, custodito nel fodero.
231
 Ufficiali dei Cavalleggeri di Alessandria a Trento nel novembre del 1918.
Ufficiali dei Cavalleggeri di Alessandria a Trento nel novembre del 1918.
232-
 Quel che resta del campo di battaglia dell'Adriawerke nel novembre 1918.
3 novembre 1918 il tenente Genovesi con il plotone di avanguardia a Trento, davanti al monumento a Dante.
Quel che resta del campo di battaglia dell'Adriawerke nel novembre 1918.
3 novembre 1918 il tenente Genovesi con il plotone di avanguardia a Trento, davanti al monumento a Dante.
-233-
 Trento 1918, lo stendardo dei Cavalleggeri di Alessandria.
Trento 1918, lo stendardo dei Cavalleggeri di Alessandria.
234-
 Il Reggi.mento Cavalleggeri di Alessandria con lo s tendardo a Trento nel 1918.
L o stato maggiore della 3° Divisione con le AA RR i Duchi di Pistoia e di Bergamo a Trento passa in rassegna il Reggimento Ale ssandria, 1918.
Il Reggi.mento Cavalleggeri di Alessandria con lo s tendardo a Trento nel 1918.
L o stato maggiore della 3° Divisione con le AA RR i Duchi di Pistoia e di Bergamo a Trento passa in rassegna il Reggimento Ale ssandria, 1918.
-235-
,·
 ORDINE DI BATTAGLIA DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA
ORDINE DI BATTAGLIA DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA
ALL'INIZIO E ALLA FINE DELLA GUERRA
1a Divisione di Cavalleria (Friuli)
24 maggio 1915
comandante div. Maggior Generale Pirozzi Nicola
I Brigata comandante magg. Generale Lisi Natoli Michele
Reggimento Cavalleggeri Monferrato (13°), comandante colonnello Vercellana Nicola Reggimento Cavalleggeri di Roma (20°), comandante colonnello Tamajo Corrado
II Brigata comandante Maggior Generale Del Re Giuseppe
Reggimento Genova Cavalleria (4 °), comandante colonnello Erno Capodilista conte Giorgio Reggimento Lancieri di Novara (5°), comandante colonnello RobolioiAles sandro
8° e 11 ° Reggimento Bersaglieri ciclisti
Il0 Gruppo batterie a cavallo
4 novembre 1918
comandante div. Maggior Generale Filippini Pietro
I Brigata- comandante Maggior Generale Solari nobile Di Lorerto, di Recanati e di Matelica march. Filippo Reggimento Cavalleggeri Monferrato (13°), comandante colonnello Domenico Maggi Reggimento Cavalleggeri di Roma (20°), comandante colonnello Camillo Filippini di Mombello
II Brigata comandante Maggior Generale Erno Capodilista conte Giorgio
Reggimento Genova Cavalleria (4°), comandante colonnello Paolo Celebrini di San Martino Reggimento Lancieri di Novara (5°), comandantecolonnello Marengo Maurizio
I 0 gruppo batterie a ca vallo
2a Divisione di Cavalleria (Veneto)
24 maggio 1915
comandante div. Maggior Generale Vercellana Giovanru
III Brigata comandante Maggior Generale Pellegrini Giovanni Reggimento Lancieri di Milano (7°), comandante colonnello Fomùggini Carlo Reggimento Lancieri di Vittorio Emanuele Il (10°), comandante colonnello Salmoiraghi Calo
IV Brigata comandante Maggior Generale Rubin de Cervin Gustavo Reggimento Lancieri di Aosta (6°), comandante colonnello Rejnaud Alberto Reggimento Lancieri di Mantova (25°), comandante colonnello Curti Faustino

3° e 7° Reggimento Bersaglieri ciclisti
I0 Gruppo batterie a cavallo
-237-
4 novemb re 1918
comandante cliv. Tenente Generale Litta Modignani Vittorio
ID Brigata comandante colonnello Brigadiere Ajroldi Di Robbiante Luigi Reggimento Lancieri di Milano (7°) , comandante colonnello Manzotti Giuseppe Reggimento Lancieri di Vi.ttorio Emanuele Il (10°), comandante colonnello Panicali Pietro
IV Brigata - comandante Maggior Generale Filippini Arnaldo Reggimento Lancieri di Aosta (6°), comandante colonnello De Ruggero Ruggero Reggimento Lancieri di Mantova (25°), comandante colonnello Annibale Avogadro cli Collobiano
7° Reggimento Bersaglieri ciclisti
7a s q uadra autoblindomitragliatrici
Il 0 Gruppo batterie a cavallo
3a D ivisione cli Cavalleria (Lombardia) 24 mag gio 1915
comandante div. Maggior Generale Guicciardi conte di Cervarolo Carlo
V Brigata comandante magg. Generale Rossi Italo Reggimento Cavalleggeri di Saluu_o (12°), comandante colonnello Calderari di Palazzolo Guglielmo Reggimento Cavalleggeri di Vi.cenza (24 °), comandante colonnello Campeis Camillo
VI Brigata comandante Maggior Generale Giacometti Amilcare Reggiment o Savoia Cavalleria (3°), comandante colonnello Filippini Pietro R eggimento La.ncieri di Montebello (8°), comandante colonnello De Silvestris Luigi m0 Gruppo batterie a cavallo
4 novembre 19 18
comandante div. Tenente Generale Guicciardi conte di Cervarolo Carlo
V Brigata - comandante Maggior Generale P averi Fon tana Lionell o R eggimento Cavalleggeri di Saluzzo (12°), comandante colonne ll o Sarlo Enrico Reggimento Cavalleggeri di Vicenza (24 °), comandante colonnello Pasetti Fehce

V I brigata comandante Maggior Generale B erardi Gustavo Reggimento Savoia Cavalleria (3°), comandante colonnello Marchino Amedeo Reggimento Lancieri di Montebello (8°), comandante colonnello Tavani Augusto 12a squadra autoblindomitragliatrici
III 0 Gruppo batterie a cavallo
238-
4a Divisione di Cavalleria (Piemonte)
24 maggio 1915
comandante div. Tenente Generale Malingri Di Bagnolo conte Alessandro
VII Brigata comandante Maggior Generale Schiffi Mario Reggimento Nizza Cavalleria ( l 0 ), comandante ten colonnello Solaro Del Borgo Alberto Reggimento Landeri di Vercelli (26°), comandante colonnello Casanova-Ierseringh Arturo
VIII Brigata comandante Maggior Generale De Raymondi dei conti De Raymondi Vittorio Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), comandante colonnello Lanfranco Pietro Reggimento Cavalleggeri di Treviso (28°), comandante colonnello Rattazzi Alessandro

IV 0 Gruppo batterie a cavallo
4 novembre 1918
comandante div. Maggior Generale Barattieri Di S. Pietro conte e patrizio piacentino Warmondo
VII Brigata comandante Maggior Generale Milanesi Arturo Reggimento Nizza Cavalleria (1 °), comandante tenente colonnello Tosti Duca di Valminuta Luigi Reggimento Lancieri di Vercelli (26°), comandante colonnello Rochis Luigi
VIII Brigata comandante Maggior Generale Varini Ettore Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), comandante colonnello Mori-Ubaldini degli Alberti Guido Reggimento Cavalleggeri di Treviso (28°), comandante colonnello Giubbilei Carlo
IV 0 Gruppo batterie a cavallo
239-
CITAZIO NI SUL BOLLETTINO
Ci tazione sul Bollettino di guerra n. 891 del 1° no ve mbre 19 17 "Lare la 2° Divisione di Cavalleria, specie i reggiment; "Genova" e " Novara ", eroicamente sacrificatisi .. meritano sopra tutti l'ammirazione e la gratitudine della Patria"
Citazione sul Bollettino di guerra n . 1266 del n ove mbre 1918 " La Il Brigata "Genova Cavalleria" (4°) e " Lancieri di Novara" (5°), già immortalatisi or è un anno a Pozzuolo del Friuli, il 31 ottobre, con brillanti cariche ha assicurato alle truppe retrostanti il ponte della Livenza di fronte a Fiaschetti .. ."
e infine la Cavalleria è citata nel bollettino della Vittori a " .D al B renta al Torre l'irresistibile slancio delle D ivisioni di Cavalleria, ricaccia sempre più indietro il nemico fuggente ."

-240-
I) in Italia
Medaglia di Bronzo a Nizza Cavalleria, per l'azione del 14 e 15 maggio 1916 a Monfalcone "per il bel contegno aggressivo e tenace dimostrato col mantenere le posizioni della officina di Adria".

Medaglia di Bronzo ai Cavalleggeri di Udine, per l'azione dell'8 agosto 1916 a Gorizia perché "in terreno difficile , rotto da numerosi apprestamenti difensivi, caricava, per ben tre volte l'avversario con slancio e ardimento, riuscendo a causargli sensibili perdite".
Medaglia d'Argento ai Cavalleggeri di Treviso, per l'azione del 14 e 15 maggio 1916 a Monfalcone "per la tenace resistenza opposta ai violenti attacchi nemici; per lo slancio con cui seppe aver ragione di forze preponderanti, per il largo sacrificio di sangue offerto al successo delle armi nostre. Monfalcone Selz- maggio giugno 1916'.
Medaglia d 'Argento a Genova Cavalleria, per l'azione del 14, 15 e 16 settembre 1916 a Monfalcone perché "rinnovando le belle gloriose tradizioni confermò le antiche singolari virtù guerriere, concorrendo nei giorni 14, 15 e 16 settembre 1916 alla conquista ed al mantenimento della forte e ben munita posizione di quota 144 ad est di Monfalcone".
Medaglia d'Argento a Genova Cavalleria, per l ' azione de] 30 ottobre 1917 a Pozzuolo del Friuli, perché "con alto valore e sublime spirito di sacrificio , contrastava all'imbaldanzito nemico l ' avanzata al Tagliamento. Costretto ad asserragliarsi in Pozzuolo del Friuli, ne contese il possesso a/l'avversario, resistendo sul posto 24 ore,finché, isolato ed accerchiato, si apriva a sciabolate un varco tra le fanterie nemiche".
Medaglia d'Argento ai Lancieri di Novara , per l'azione del 30 ottobre 1917 a Pozzuolo del Friuli, con la stessa motivazione di Genova, perché "con alto valore e sublime spirito di sacrificio, contrastava all'imbaldanzito nemico l'avanzata al Tagliamento. Costretto ad asserragliarsi in Pozzuolo del Friuli, ne contese il possesso all ' avversario , resistendo sul posto 24 ore,finché , isola to ed accerchiato, si apriva a sciabolate un varco tra le fanterie nemiche" .
Medaglia di Bronzo ai Lancieri di Vittorio Emanuele, per il Solstizio, "per l'abnegazione e l'elevato sentimento del dovere spiegati nella giornata del 10 giugno 1918 sul Piave , per le brillanti qualità militari riaffermate nelle successive azioni del 23-24 giugno 1918 sul Piave Vecchio e nella rapida irruenta avanzata dell'ottobre-novembre 1918 dal Piave a Palmanova e Cervignano".
Medaglia di Bronzo ai Lancieri di Milano, per il Solstizio, con la stessa motivazione di Vittorio Emanue le "per L'abnegazione e l'elevato sentimento del dovere spiegati nella giornata del 10 giugno 1918 sul Piave , per le brillanti qualità militari riaffermate nelle successive azioni del 2324 giugno 1918 sul Piave Vecchio e nella rapida irruenta avanzata dell'ottobre-novembre 1918 dal Piave a Palmanova e Cervignano".
Medaglia di Bronzo ai Lancieri di Firenze, per la Vittoria , perché "in numerosi combattimenti, tanto nelle azioni di squadroni isolati e di gruppi di squadroni, come in quelle alle quali prese parte l'intero reggimento, brillò sempre per slancio, valore ed alto spirito di sacrificio".
Medaglia di Bronzo ai Cavalleggeri Guide, per Sacile, perché "a piedi e a cavallo si distinse per continue prove di valore e di femiezza. Nella battaglia della riscossa con brillante attacco di alcuni reparti, occupava di slancio Sacile, agevolando il passaggio della 4a Divisione di Cavalleria sul Livenza".
Medaglia d'Argento ai Cavalleggeri di Saluzzo, per l'azione del 2 novembre 1918 a Tauriano, perché "già distintosi nella battaglia di Gorizia ed in quella della Bainsizza, copertosi di gloria nel
MEDAGLIE
a) 1915-18, Medaglie al Valor Militare ai reparti
-241-
contrastare il sacro suolo della Patria al nemico invasore, nel giorno della riscossa si lanciava in brillante, irresistibile carica contro forti retroguardie nemiche avversarie annientandole".
Medaglia di Bro n zo ai Lancieri di Aosta , per Latisana, perché "Lanciati all'inseguimento del nemico, gli squadroni di "Aosta" giunsero primi ai ponti di Latisana, salvandoli dalla distruzione. Caricarono poi e travolsero a Corgnolo l'estrema pugnace resistenza nemica".
Medaglia di Bronzo ai Lancieri di Manto va , per vari episodi fino a Castions "già distintosi agli albori della guerra, suonata l'ora della riscossa, i suoi lancieri assalirono il nemico sulla Livenza, lo ricacciarono al Medusa, lo incalzarono al Tagliamento,finché sul campo di Castions di Strada, ne vinsero la estrema pugnace resistenza".
Medaglia d'Argento ai Lancieri di Vercelli , per l'azione del 14 e 15 maggio 1916 a M onfalcone e per l'arri vo a Tren to "in critici e gravi momenti, appiedato, dava prova di fe r mezza, di a rdimento e di fedeltà al dovere, sia resistendo strenuamente nelle trincee affidategli, sia accorrendo ad arrestare l'avanzata dell'awersario (Monfalcone, 14-15 maggio 1916). Si distingueva anche in s uccessive operazioni (12-15 giugno 1916): 27 giugno e 3 4 luglio 191 6). Nell'inseguimen to del nemico ne attaccò e ne travolse le ultime resistenze, contribuendo efficacemente allo sfruttamento della vittoria (Tagliamento 4 e 5 novembre 1918)".
Il) In Albania
Medaglia d ' Argento ai Cavalleggeri di Catania , per l' azione di Malakastra, perch é "con mirabile valore ed impeto travolgente contribuiva con i suoi arditi squadroni alla caduta delle linee nemiche della Malakastra, ed aggravava di poi la rotta nemica con audace inseguimento nella valle del Semeni Animato da inestimabile fede, in un mese di ininterrotta battaglia, fu sempre primo ai più aspri cimenti".
Medaglia di Bronzo ai Cav allegg eri di Palermo , per l 'azione di Fieri, "per le prove di valore e di audacia date in un mese di ininterrotti combattimenti , pa r tecipando con il I gruppo alla brillante azione su Fieri e cooperando, in seguito, alle azioni svoltesi nella pianura del Semeni".

Medaglia d ' Argento allo Squadrone Sardo , per l 'Alb ania, pe rch é "I cavalleggeri dello squa drone "Sardo", avanguardia di un'ardita colonna di cavalleria, travolgevano impetuosamente l'accanita resistenza nemica, seminando ovunque lo scompiglio ed il terrore. In un mese di asprissima lotta, infaticabilmente cercavano e caricavano l'avversario, spezzandone audacemente la superiorità del numero e le ostinate difese Con le superbe loro gesta, l'incrollabile disciplina, l'abnegazione e l'ardimento, si congiungevano nella glo ria alle più fiere tradizioni, antiche e recenti, dell'intrepida gente di Sardegna".
b) 1915-18 , Medaglie d 'Oro alle persone
Gianfranco Castelbarco Visconti, ca pitano del 20° R oma, alla memor ia, morto a P asia n Schiavonesco il 29 ottob re 1917, alla testa de l suo squadrone.
Franceso Ros si , colonnello comandante di P iemonte R eale, alla memoria, cad uto a ll a testa dei suoi uomini me ntre il 9 novembre 1917 difendeva il paese di Cess alto, copre ndo il ripiegamento del IX Corpo d'Armata.
Carlo Castelnuovo delle Lanze, a ll a memoria, tenente di Genova, ferito graveme nte a Pozzuolo il 30 ottobre e morto il 1° dicembre 1917.
Ettore Laiolo, cap itano del 4° Squ adro ne di Gen ova, caduto a Pozzuolo iJ 30 otto bre 19 17.
Raffaele Libroia , alla memoria, capita no d i Sal uzzo, ucc iso caricando una batte r ia nemica a Tauriano il 2 n ovembre 1918.
242
Altre sono state date a ufficiali di cavalleria, ma sempre e solo per atti compiuti dopo essere passati in altri Corpi, Armi o Specialità:
1. Francesco Baracca, capitano (maggiore per merito di guerra) di Piemonte Reale: in Aviazione, per la 30° delle sue 34 vittorie;
2. Fulco Ruffo di Calabria, tenente di Foggia: in Aviazione con 20 vittorie;
3. Carnillo Giacomo De Carlo, subalterno di Firenze, aeroportato in territorio occupato come ufficiale informatore;

4. Maurizio Piscicelli De Vito, morto al comando di un battaglione di fanteria neU'ottobre '17;
5. Fulcieri Paolucci de'Calboli, volontario, sergente in Saluzzo, sottotenente in Savoia, decorato dopo il passaggio in Artiglieria come osservatore;
6. GLlido Brunner, (triestino, nome di battaglia Mario Berti) del Roma, come comandante di plotone di fanteria della Brigata Sassari, a Monte Fior, nel 1916;
7. Gabriele D'Annunzio, tenente colonnello di Novara, medaglia d'oro per il Timavo (azione con la fanteria) e per il Volo su Vienna (azione aerea);
8. Annibale Caretta, ufficiale di Monferrato, per il comportamento alla testa di un Gruppo batterie di bombarde nel giugno 1918;
9. Elia Rossi Passavanti, volontario, in Genova Cavalleria, promosso sottufficiale per merito di guerra, accecato a Pozzuolo e portato indietro dal suo cavallo Quo, Medaglia d'Oro dopo essere passato negli Arditi, per quanto fece da ufficiale sul Grappa; poi legionario fiumano e senatore del Regno.
-243-
INDICE DEI NOMI
Ajroldi Di Robbìante Luigi colon. Brigadiere 33,181,238
Alberti, Adriano, maggiore, 147
Ameglio, Giovanni, generale, 31, 32, 33
Anselmi, Attili, capitano, 33
Avogadro di Collobiano, Annibale, colonnello, 238 Badoglio, Pietro, generale, 157, 188
Balbi, Pietro, colonnello brigadiere, 7 Bandini, Franco, 100
Baracca, Francesco, 3,242
Barattieri Di S. Pietro, conte e patrizio piacentino, Warmondo, generale, 239 Bassi, tenente, 9 Bechtolsheim, capitano, 18
Bellotti, Francesco, colonnello, 7 Below, Otto, von, generale, 171 Berardi, Gustavo, generale,238 Berio, Vittorio, tenente, 34 Bernhardi, Friedrich, von, generale, 45 Bertolè-Viale, Ettore, 14, 21, 22 Bianchini, Cesare, tenente, 10 Bixio, Nino, 18

Bonati, Cesare, tenente colonnello, 34,210 Bonin, aspirante, 9 Bonnal, Guillaume, generale, 45
Boroevic, von Bojna, Svetozar, generale, 55, 124, 158,171,215 Borsarelli di Rifreddo, Carlo, colonnello, 33
Botta, Camillo, tenente, 10 Bovio, Oreste, 16, 21
Breganze, Giovanni, Giuseppe, colonnello, 147
Brignoli, Marziano, 11, 21, 22, 87
Brunner, Guido (Berti, Mario), 243 Brusilov, Alexiei, Alexieievich, generale, 126 Brussi, Roberto, colonnello, 87
Byng, Sir Julian, generale, 203
Caccia, Dominioni di Sillavengo, Paolo, tenente, 99 Cadorna, Luigi, generale, 13, 35, 36, 37, 56, 66, 72, 82, 97, 99, 100, 124, 126, 171, 199 Cadorna, Raffaele, capitano, 36, 199
Cagni, Umberto, capitano di vascello, 31
Calderari, di Palazzolo, Guglielmo, colonnello, 63,238 Camillo, Filippini, di Mombello, colonnello, 237 Campanaro, Biase, tenente, 127
Campati, Carlo, colonnello, 7, 10
Campeis, Camillo, colonnello, 63,238 Caneva, Carlo, generale, 31
Capello, Luigi, generale, 157, 171
-244-
Caretta, Annibale, 243
Carter, Lord, 203
Casana, Severino, 14, 26
Casanova-Ierseringh, Arturo, colonnello, 63, 239
Casnati, Riccardo, tenente, 180
Castelbarco Visconti, Gianfranco, capitano, 242
Castelnuovo delle Lanze, Carlo, tenente, 9,242
Cavaciocchi, Alberto, generale, 157
Ca van, Lord, Frederick, Rudolph, Lambart , generale, 215 Caviglia, Enrico, generale, 157,215
Celebrini, di San Martino, Paolo , colonnello, 237
Cemigoi, Enrico, 28, 46, 70, 124 , 163

Chigi, aspirante, 9 Churchill, Winston, 24
Cicerchia, Felice, tenente colonnello, 87
Conrad , von Hoetzendorff, Franz, generale, 61
Cotterelli, tenente, 70
Crispi, Sdiana , Secondo, capitano, 34 Cronje, Pieter, Arnoold, generale, 24
Crutwell , C.,R.,M.,F , 205
Cucinato , Flavio, 70, 124
Curoni, Giuseppe, capitano, 76
Curti, Faustino, colonnello, 63, 74, 237
Custer, George, A., generale, 23
D 'Afflitto, Camillo, tenente, 9
D'Annunzio, Gabriele , 3,243
De Carlo , Giacomo , Camillo 243
De Bono , Emilio, 28
De Negrier, François, Oscar, generale, 45
De Giorgio, Armando, colonnello, 161, 197
De Raymondi , dei conti De Raymondi , Vittorio, generale239
De Rossi , Eugenio, generale, 28
De Ruggero , Ruggero, colonnello, 238
De Silvestri, Luigi, colonnello, 63,238
Del Carretto, di Torre Bormida e Bergnolo, Carlo, capitano, 120
Del Pozzo, Aroldo, tenente, 68, 72
Del Re, Giuseppe, generale, 63,237
Della Rocca, Enrico, Morozzo , generale, 18
Delieani , Attilio, capitano, 180
Dellmensingen, von Krafft, Konrad, ge neral e, 7 , 171
Di Benedetto, Vincenzo, generale, 186
Di Giorgio, Antonino, generale, 184 , 199
Di Loreto, tenente, 129, 131
Di Robbiante , Luigi, colonnello, 221
Di Tocco, Francesco, capitano, 127
Diaz , Armando, generale, Edoardo Vll, re d'Inghilterra, 28
Emanuele, Filiberto, Duca D 'Aos ta , 58, 124
-245
Erno, Capodilista, conte Giorgio, generale, 7, 9, 10, 63,191,192,237 Etna, Donato, generale, 197, 199
Ettore, Galliani, tenente, 34
Eugenio Principe, 75
Fè d'Ostiani, Alfredo, colonnello brigadiere, 161 Ferrero, Giacinto, generale, 14
Filippini, Arnaldo, generale, 181, 238
Filippini, Pietro, generale, 63, 191,237,238
Flebus, Antoni, 240
Foch, Ferdinand, generale, 99
Fox, generale 53
Fontana, Pietro, colonnello, 238
Formiggini, Carlo, colonnello, 63,237
Francescorn, Giuseppe, imperatore d'Austria Ungheria, 28 French, Sir John, generale, 99
Fulceri, Paolucci de calboli 243 Galliani, Ettore, tenente, 34 Gallifet, Gaston, generale, 18 Garioni, Vincenzo, generale, 66
Gatti, Annibale, generale, 157, 191
Ghiottoni, Sante, maggiore, 10 Giacchi, Nicolò, 9 Giacometti, Amilcare, generale, 63, 238
Giolitti, Giovanni, 25, 31 Giubbilei, Carlo, colonnello, 239 Giuseppe, Arciduca, D'Austria, 215 Giusti, Luigi, maggiore, 208
Goglia, Ferdinad, von generale, 215 Goiginger, Heinricb, generale, 53, 107 Gonzaga, Maurizio, Ferrante, principe, generale, 180 Govone, Giuseppe, generale, 18

Gough, Hubert, generale, 202, 203
Grassi, capitano, 66
Graziani, Rodolfo, generale, 28,215 Grilli, Ultimo, tenente, 34 Croppi, Antonio, sottotenente, 122 Guarini, Matteucci, Luigi, capitano, 34 Guicciardi, conte di Cervarolo, Carlo, generale, 63, 238 Guzzardi, Francesco, tenente, 70, 72 Haigh, Douglas, generale, 99
Hall, A.,R., 29
Hindenburg, Paul, maresciallo, 204 Holmyard, E., J., 29
lnvrea,Ademaro, capitano, 34
lvancicb, tenente, 9 Joffre, Joseph, generale, 51, 99 Kessler, B., generale, 23, 45 Kingsland, Alberto, capitano, 78
-246-
Kralicek, Rudolf , generale, 158
Kuropatkin, Alexie, generale, 25
Laiolo, Ettore, capitano 242
Lampugnani, Raul , capitano, 9, 191
Lanfranco, Pietro , generale, 63. 239 Langlois, Hyppolite, generale, 45
Lanzavecchia di Buri, Luigi, colonnello, l 6
Laus , Ludovico, tenente, 180
Le Beau, von Aurei, generale 72 Lenardon, Roberto, 46 Libroja, Raffaele, capitano, 220,242
Lechi , conte 240
Lisi, Natoli, Michele , generale, 63, 68,237
Litta, Modignani, Vittorio, generale, 32, 34,188,238 Lombardi, Stefano, generale, 191 Lostia di Santa Sofia , Gherardo , colonnello, 161, 181 Luckachich, Geza, generale, 58 Lukas, generale, 158 Madritov, colonnello, 25 Maggi, Domenico , colonnello, 237 Maiero, Nicolò, tenente , 127 Malingri Di Bagnolo , conte, Alessandro, generale, 63, 239 Manetti, sottotenente, 75

Manfredini, Luigi , colonnello brigadiere, 181, 183, 184 , 186, 188 Manzotti, Giuseppe, tenente colonnello, 120 ,238 Marchino, Amedeo, colonnello, 221, 238 Marengo , Maurizio, colonnello, 237
Marghieri, Guglielmo , generale, 69 Margueritte, generale, 17 Margutti , Alberto di generale barone , 28 Marezzi , Giuseppe, capitano, 34 Martinozzi, sottotenente, 9 Marwitz, von Georg, generale, 50 Mezzacapo,Cesare, generale, 14 Milanesi, Arturo , generale, 239 Minutoli, Gaetano, aspirante, 180 Mistscenko, generale, 25 Molari, Francesco , capitano, 32 Moltke, Wilhelm, conte Helmuth , generale, 18 Monteverde, sergente, 122
Montuor:i , Luca , generale, 157, 190 Moro-Ubaldini , degli Alberti, Guido , colonnello, 49,239,240 Morosini, sottotenente, 9 Muscolina, tenente , 127 Muzzati , sottotenente, 129, 131 Navarra, Viggiani, Francesco, tenente, 34 Norsa, Paolo , sottotenente, 75 Oku, Yasukata, generale, 25
-247-
Orero, Carlo, capitano, 34
Orlov, principe di, generale, 25
Panicati, Pietro, colonnello, 224, 238
Pasetti, Felice, colonnello, 238
Pastore, capitano, 33
Paveri , Fontana, Lionello , generale, 238
Pelagatti , Aspreno, colonnello, 7
Pellegrini , Giovanni, generale, 63, 72,237
Pelloux, Luigi, generale, 14, 22
Perlo , C., capitano, 17, 24, 25
Perricone , Roberto, capitano, 34
Pezzi- Siboni, Pietro , ten colonnello, 87, 108, 119, 131
Pflanzer-Baltin , generale, 209
Pieropan, Gianni, 7
Pirozzi , Nicola, generale, 63, 66, 72,237
Piscicelli , Maurizio, capitano, 33, 34,243
Pollera, Alberto, capitano, 34 Pollio, Alberto, generale, 26, 34 Pozzato, Paolo, 45, 119
Puletti , Rodolfo, 78
Randazzo , Pietro , maresciallo , 180 Rattazzi, Alessandro, colonnello, 63, 239 Ravagnatj-Larghini, Emilio, tenente, 87,108,119,131
Ravelli, Alberto, generale, 7, 191 Rawlinson, Sir Henry, 203
Rejnaud , Alberto, colonnello, 63,237 Rennekampf , PauJ, generale, 25 Riboty , Augusto, ammiraglio, 16 Richthofen, von, 50
Ricotti Magnani, Cesare, 11, 14, 16
Roberts Lord of Kandahar , generale, 24
Robolini, Alessandro, colonnello, 63,237
Rochis ,Tos ti, Duca di Valmfouta, Luigi tenente colonnello, 239 Rodriguez, sottotenente, 129 , 131 Rommel, Erwin, generale, 7

Rossi , Italo , generale, 63, 238
Rossi , Passivanti, Elia 243
Rubin de Cervin , Gustavo , generale, 63, 237 Ruffo di Calabria, Fulco, 3,243
Sagramoso, Pier Luigi , generale, 181, 183
Salanclra, Antonio, 35
Salrnoiraghi, Carlo, colonnello, 63,237
San Giuliano, Spinger, marchese, Antonino, 31 Sani, maggiore, 81
Sanna, Carlo , generale, 184
Samsonov, Aleksander, Vasilievich, generale, 25 Sarlo, Enrico, colonnello, 238 Schaumann, A., capitano, 209
-248-
Schiffi, Mario , generale, 63 ,239
Schonauer, generale, 221 Schwarte, 209
Scotti, von Karl, generale, 158
Sezanne, Giovanni, capitano, 9, 192
Sebellin, Achille , maggiore, 10
Sequi, Luigi, tenente, 129
Solari, nobile Di Lorerto, Filippo, generale, 237
Solaro, Del Borgo, Alberto , tenente colonne11o, 63 , 238 Sordet, generale, 48
Spadaccini, Lorenzo, capitano, 120, 122
Sparita, Giovanbattista, maggiore, 10
Spinelli, Oscar, colonnello, 194 Spingardi, Paolo, generale, 14, 26, 27
Spinger, C., 29
Tamajo, Corrado, colonnello , 63,237
Tardit, Ernesto, di Centallo, colonnello 240 Tartaglino , caporale, 122 Tavani, Augusto, colonnello, 238 Ticchioni , capitano, 209,210
Tonini, Roberto, maggiore, 208,209
Tosti, Duca di Valminuta. Luigi , tenente colonnello, 239
Trendi, Alberto, tenente colonnello, 181 Umberto di Savoia , principe, 18
Varini, Ettore, generale, 239 Vario, Francesco, 18, 23
Vercellana, Giovanni, generale, 63, 64, 66,237
Vercellana, Nicola, colonnello, 63, 237
Vemerecci,di Fossombrone, Carlo, tenente, 10
Vittorio, Emanuele, di Savoia Aosta, Sua Altezza Real e Conte di Torino, 78, 80, 81,190,221 Vittorio, Emanuele, Il Re d'Italia, 16
Volpe, Gioachino, 31
Volpi Gianluca, 70, 124 Williams, T.,I , 29 Wurrn, Venceslao, generale, 53, 72 Zanelli, Felice, 74, 75, 78 tenente Zarone, Tommaso, maggiore, 224 Zuppelli, Vittorio, 37

-249-
INDICE DEI REPARTI
1a Divisione di fanteria austro ungarica, 53
10° Reggimento Fanteria italiano
1° gruppo artiglieria a cavallo, 63
11 ° Reggimento Bersaglieri 63
11 a Di visione italiana, 72
123 Divisione italiana, 68
12a Divisione cavalleria appiedata austro ungarica, 22
13a Divisione italiana, 72, 108
14a Armata austro-tedesca, 7, 171, 184
15° Reggimento Bersaglieri ciclisti, 113
16a divisione di fanteria italiana, 18,111, 184
1a divisione di cavalleria (Friuli), 63, 64, 66, 68, 69, 70, 78, 80, 82, 85, 86, 107,108,150,179, 191,193,215,216,218,220,221 , 240
21 a Divis ione di fanteria italiana, 63
1a Divisione di Cavalleria inglese, 202, 203, 204
13 Divisione di cava11er ia francese, 48
1a Armata italiana, 215
23 Armata italiana, 56, 63, 64, 70, 126, 153, 157 , 158, 162, 165, 171, 181, 183, 184, 191, 194 , 196, 197,199
28 divisione cavalleria (Veneto), 63, 74, 75, 78, 80, 82, 85, 119, 150, 158, 159, 161, 162,165,179, 181,184,190,196,197,215,216,218,220,221,222,224,240
2° gruppo artiglieria a cavallo, 63
2° 3° Reggimento Fanteria, 191
20 3 Divisio ne di fanteria italiana, 184
263 Divisione di fanteria italiana, 180
28a Divisione italiana , 119, 122
2 8 Bri gata da montagna austro ungarica, 108
2a Divisione di cavalleria francese, 48
23 Divisione di cavalJeria tedesca, 50
2a Divisione di Cavalleria inglese, 202,203,204
3° gruppo artiglieria a cavallo , 63
3° gruppo Bersaglieri ciclisti, 181,183,221
3° Reggimento artiglieria da campagn, 63
3° Reggimento Bersaglieri ciclisti, 63, 69, 75
32° Reggimento fanteria, 180
33a Divisione di fanteria italiana, 184

34a Divisione di fanteria italiana, 180
34a Divisione di fanteria austro ungarica, 222
363 divisione di fanteria italiana, 197, 199
3a Armata italiana, 56, 58, 63, 64, 66, 80,107, 124, 125, 126, 131, 153, 191, 194, 196, 197, 212, 215
3a Armata inglese, 203
3a divisione di cavalleria (Lombardia), 63, 80, 82, 85, 119, 124, 125, 126, 150, 179, 190, 191, 194, 197,199,215,216,218,220,221,222
33 Divisio ne di Cavalleria francese, 50, 145
-250-
3a Divisione di Cavalleria inglese, 203 , 204
41 a Hon ved unghere se , 222
47 a Divis ione austriaca , 208
49° R e ggimento fanteria, 180
4a armata inglese, 203
4a Armata italiana , 215
4a divisione di cavalleria (Piemonte) , 63 , 78 , 80, 82, 85, 86 , 107 , 108 , 111 , 150 , 154 , 179 , 193, 194 ,
2)1 , 212 , 215 , 216 , 218 , 220,221 , 222 , 241
4 a divi s ione di cavalleria tede sca , 50
4 3 Divisione di Cavalleria france se , 50
4a Divisione di cavalleria inglese , 202 , 204
4° gruppo artiglieria a cavallo, 63
57a divisione di fanteria austro ungarica, 107
sa Annata austro-ungarica , 53 , 111
53 Annata britannica , 202 , 203
53 Divisione di cavalleria francese , 48
S8 Divisione di cavalleria inglese, 202
S3 Divisione di cavalleria tedesca, 50
503 Divisione di fanteria au s tro ungarica, 53
588 Divisione di fanteria austro ungarica , 224
63 armata italiana, 215
6a divisione cavalleria austro ungarica , 220
6° Reggimento Genio Ferrovieri , 194
603 Brigata da montagna austro ungarica , 107 , 108
63 3 Divisione di fanteria italiana , 179 , 180 , 197 , 199
7° Reggimento Bersaglieri ciclist , 63, 78
7a Divisione italiana di fanteria, 7, 9 , 18 , 191 , 192, 193
7a Divisione di Cavalleria francese , 50, 145
3a armata italiana , 215 , 216 , 220
83 Divisione italiana di fanteria , 162, 163, 165
9a divisione di cavalleria tedesca , 48 , 50 ,
9a divisione di cavalleria francese , 144
103 divisione di cavalJeria francese , 144
103 armata italiana , 215 , 216 , 218
123 armata italiana , 215
183 Divisione austro ungarica, 53
50a Divisione di fanteria italiana , 165
53a Divisione di fanteria italiana , 165

57a Divisione austro ungarica , 53 , 108
8° Reggimento Bersaglieri , 63
83 ° reggimento di fanteria au stro ungarico , 224
87° reggimento di fanteria, 111
88° reggimento di fanteria, 108
93a Brigata di fanteria austro ungarica, 209
93a Fanteria imperiale (Gorizia) , 53
94a Brigata di fanteria au s tro ungarica , 208, 209
94a Divisione di fanteria austro ungarica , 107
94a fanteria imperiale (Lubiana) , 53
-251
94° Reggimento Fanteria italiano, 63, 66
Alessandria ( 14°) Reggimento cavalleria, 11 , 87 , 179 , 180 , 240 Alessandria (155 °- 156 °) Brigata di fanteria , 32, 108
Aosta (6°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63 , 119,161 , 181 , 188 ,224,242 Aquila (269°-270) Brigata di fanteria , 165 Aquila (27°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 88,119,120,122,240
Arezzo (225°-226°) Brigata di fanteria , 126 , 129 Arno (213°-214°) Brigata di fanteria , 119
Bergamo (25°-26°) Brigata,cli fanteria , 7, 191
Brigata Cacciatori delle Alpi, 87
Brigata di cavalleria canadese Fort Garry , 202 Brigata cli Cavalleria II, 7, 9
Brigata di Fanteria "Re" (1°-2°), 108 Carabinieri Reali, 21, 22, 131
Caserta (17°) Reggimento cavalleria, 11, 12, 32 , 87, 180, 211 Catania (22°) Reggimento cavalleria , 4 , 11, 21 , 88, 131,207 , 208, 210, 240 , 242 Chasseurs d ' Afrique 1°, 17 , 18 , 145 Corazzieri francesi, 18 Corpo d ' Armata portoghese , 222
Cremona (21° 22°) Brigata cli fanteria , 111 , 113 , 125
Divisione Speciale Bersaglieri (denominata Tarnova) , 87 Dragoni del Genovese Reggimento cavalleria, 11 Dragoni, 111
Firenze (9°) Reggimento cavalleria , 11 , 32, 34, 87,131,180 , 199,211,241 Foggia (11 °) Reggimento cavalleria , 11 , 12 , 32 , 87 , 131 , 211 , 212, 242 Genova (4°) Reggimento cavalleria, 4, 7, 9, 10, 32, 40, 63 , 66 , 70, 72 , 86 , 108 , 125 , 191 , 192, 193, 212,220 , 240 , 241,242,243
Granatieri di Sardegna, 63 , I 08
Guardia, divisione di cavalleria tedesca, 50 Guide (19°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63 , 108 , 113,218,241 Guide dell ' Emilia Reggimento cavalleria, 11
I Brigata di cavalleria , 63, 64, 66, 68, 72, 107 , 108 , 218, 221
I Corpo d'Armata austro ungarico, 48
II Battaglione Bersaglieri ciclisti , 163
IICorpod'Arrnataitaliano , 87, 157,158,163,165,180,240
II Brigata di cavalleria , 63, 68, 72, 108, 191, 192 ,1 93 , 248
II Corpo cavalleria francese, 145,204
II Corpo di cavalleria tedesco, 50
ID Brigata di cavalleria , 63 , 68, 74, 161, 181, 183 , 184, 186 , 188 , 190, 191, 196, 197,211 , 212,216 , 221 , 222,224
m Corpo d'Armata austro ungarico , 48 , 240
IV Brigata cavaJJeria, 63 , 119 , 161,181 , 184 , 186 , 188,197 , 216 , 221
IV Corpo d ' Armata austro ungarico, 48
IV Corpo d'Armata italiano, 66, 87 , 157,179 , 180,183,191

IV battaglione Bersaglieri ciclisti , 113
L Battaglione Bersaglieri, 113
LI Battaglione Bersaglieri, 113 Lancieri francesi, 18
-252
Landsturm "Eger" reggimento austro ungarico, 111
Lodi (15°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 33, 87 , 131,207,240
Lombardia (73° 74°) Brigata di fanteria, 119
Lucca (163°-164) Brigata cli fanteria, 33, 191
Lucca (16°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 87, 119,131,207,210,240
Mantova (25°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63, 74, 75, 78,119,161,181,186,224,242
Milano (7°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63, 161, 181, 183, 186, 188, 212, 241
Monferrato (13°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63, 86,107,108,125,129,191,222,240,243
Montebello (8°) Reggimento cavaUeri, 63,124,125,218
Nizza (1 °) Cavalleria Reggimento cavalleria, 10, 32, 40, 63, 108, 111, 113, 221, 241
Novara (5°) Reggimento cavalleria , 4, 7, 9, 10, 11, 32, 63, 86, 108, 125, 191,192,193,240,241,243 Orlov Brigata 25
Padova (21°) Reggimento cavalleria, 11, 21, 32, 88, 119, 120, 122
Piacenza (18°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 33, 87, 88, 129
Palermo (30°) Reggimento cavalleria, 4, 87,119,120,122,207,208,240,242
Piacenza "Ussari" Reggimento cavalleria, 11
Piemonte Reale (2°) Reggimento cavalleria, 10, 32, 40, 87,131,211,212,224,242 Roma (20°) Reggimento cavalleria, 10, 32, 63, 72, 86, 108, 126,131,222,243
Saluzzo (12°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63,124,125,162,163,179,180,181,183,199,220, 241,242,243
Sardo Squadrone, 204,208,209,240,242 Savari,34
Savari 1° Squadrone, 34 Savari 1° Squadrone Meharisti, 34
Savari 2° Squadrone, 34 Savari 2° Squadrone Meharisti, 34
Savari 3° Squadrone, 34
Savari 3° Squadrone Meharisti, 34
Savari 4° Squadrone Savari, 34
Savari 5° Squadrone, 34
Savoia (3°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 40, 63, 124, 125,127,220,221,243
Spahis Gruppo, 34
Treviso (28°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63, 108, 111,113,241
Udine (29°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 88,131,241 Ulani, 212
Umberto I (23°) Reggimento cavalleria, 11, 21, 32, 88, 119, 131,180,204,240
Ussari francesi, 18
V armata francese, 48
V Armata italiana, 119

V Brigata di cavalleria, 63, 124, 125, 158, 161, 162, 165, 179
V Corpo d'Armata tedesco, 17
Vercellana Distaccamento, 66, 68, 69, 70
Vercelli (26°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63,108, 11 L, 113,221,242
VI Brigata di cavalleria, 63, 124,126,222
VI Corpo d'Armata italiano, 64, 70, 72, 157
Vicenza (24°) Reggimento cavalleria, 11, 21, 63, 124, 125, 162, 163,165,218
VII Brigata di cavalleria, 63, 64, 108,113,194,212,220,221,222,224
VII Corpo d'Armata italiano, 70, 72, 80, 88, 107
-253
VIII Corpo d'Armata italiano, 72,108,126,221,222
VIII Brigata di cavalleria, 63, 108, 113, 194
Vittorio Emanuele II (10°) Reggimento cavalleria, 11, 32, 63 , 181,183 , 184 , 186 , 188,218,224,241
IX Battaglione Bersaglieri Ciclisti, 72, 124, 125
IX Brigata di cavalleria, 240
IX Corpo d'Armata italiano, 58,242
X Corpo d'Annata italiano, 58, 88
XI Corpo d'Armata italiano, 64, 72, 80, 88, 124
XI Battaglione Bersaglieri Ciclisti, 113
XI Corpo d'Armata tedesco, 17
XII Battaglione Bersaglieri ciclisti, 125
XII Corpo d'Armata italiano, 87, 180 , 183
XIII Corpo d'Armata italiano, 124
XIV Corpo d'Armata austro ungarico, 240
XIX Corpo d'Armata inglese, 203

XIV Corpo d'Armata italiano, 122, 158, 180, 181 , 184
XV Corpo d'Armata austro ungarico, 53, 158
XVI Corpo d'Armata austro ungarico, 53, 158
XVIII Corpo d'Armata italiano, 215
XXIV Corpo d'Armata austro ungarico , 158
XXIV Corpo d'Armata italiano, 157, 159
XXVII Corpo d'Armata italiano, 157 ,158,183
XXVIII Corpo d'Armata italiano, 180, 183, 184
Yeomanry, 24,201
-254-
INDICE DEI LUOGID
Adria Werke, fabbrica, 108, 111,113,241
Adua, 22 Agadir, 31 Aidussina, 124, 125, 159
Ain Zara, 31 Ajello,66,68,69,72,80,86
Albania, 131,207,240,242 Alesso, 180 Amaro, 222 Amiens, 203 Anhovo, 108,157,158,161 Antivari, 240 Aquileia, 56, 69, 70, 111, 194 Ampezzo,220 Arcano, 186 Aris,75, 76,78, 193 Armentières, 203 Arras, 202
Asiago, 119, 120, 121, 122,123,215 Astico, 119
Ausa, fiume, 69, 74, 80, 85 Auzza, 53, 158 Aviano, 190, 197,216 Azzano Decimo , 87,221
Badoere , 218 Bagnaria Arsa, 72, 80, 85, 86 Bagnara , 222 Bainsizza , altopiano, 53, 56 , 58, 157 , 158, 159 , 161 , 162 ,171 ,241 Bardano, 220 Basaldella , 188 Baske, 163 Bassano del Grappa, 46 Bate , 158, 161
Baza di Modrejia, 158 Beivars, 181 Belgio , 48, 50 Bendasi , 31, 34 Belluno ,2 15 Beret , 209 Berka, 33 Berlino, 20, 31 Bertigo, 120 Biarzo , 222 Biasiol , 72

Biglia, 125 Bistrigna, 75, 108 Bodrez, 158 Boneti, 123, 126 Bonzicco , 184,216,218,220 Borgo Viola, 181 Borgo Malanotte, 218 Bosco, 121 Bosco Cappuccio , 131 Bottenicce, 87 Boves, 203 Braulins, 180 Breg, 161 Brenta, fiume, 119,215 Brescia, 119 Brestovec, 123 Brestovizza, 150 Britof, 158 , 161, 163 Brugnera, ponte, 193,216 Bruma , 70 Buillon, 48 Buscar, 121 But , vallone, I 80 Buttrio , 188,222
Cadore , 61, 131 Cambrai , 202 Camisano, 216 Campeis, 221 Campo di Mezzania, 122 Campoformido, 7, 64, 85, 191 Campolongo, 68 , 69, 70 Campo mulo, 119, 120 Camporovere, l 19 , 121, 122 Canale, 108,131,158,161 Canale di Ledra, 183,184 , 186, 190, 191, 196 Canin, Monte, 35, 53 , 157 Caporetto, 3, 7, 87,157, 171, 180 ,193,203,215, 222
Carnia , 59 , 61 Carpeneto, 7, 10, 191, 192 Carso, 10, 35, 56, 70, 75, 76, 81,100, 107, 108, 123 , 126,131 , 149 , 157 ,158,162 Cartigliano, 119 Casa Nuova, 75 Cosa, 220
-255-
Casali Zamero, 85
Cas ars a della Delizia, 87, 194 , 196 , 197 , 220
Cassegliano , 70
Cas tagnole, 216 , 218
Cas tegn e vizza , 99 , 131
Castellerio , 183
Castions di Mure , 63, 64, 68 ,2 21 ,242
Cavasso 85
Cavaja , 240
Cadenzano , 68 Cellina,fiume,85, 190 ,1 97 , 199

Cessano , 184
Cergnala , Monte, 157
Ceraiola , 157 , 224
Cervignano, 56 , 64, 66, 69 , 72, 80, 84, 85, 194, 224,241
Cessalto, 242
Cevraia, 221
Char]eroi, 51
Chiapovano, vallone, 158 , 159, 163, 165
Cbiarò di Torreano, 181 Chiaulis, 222 Chiopris , 72 Chiusaforte, 222
Ciago , 188
Cima di Pietrarossa , 107, 126 Cima Grande, 107 Cimadolmo, 218 Cimolais, 180
Cinto Caomaggiore, 222 Cirenaica , 31, 34
Cividale , 180, 196,221 ,222
Claujano, 80
Clausette, 180 Codognè, 218
Codroipo , 80 , 82, 85 , 183 , 216 , 224
Col di Lana, 87 Colenso, 24, 201 Colle, 188 Collegno , 16 Colloredo di Prato, 85 Colugna, 80, 183 Colussa , 75 Colvera, torrente, 197 Comeno, altopiano, 126 Conegliano, 190,194,216 , 218 Cordenons, 220
· Cordignano , 218
Cordovado,80 ,222 Cormons, 56 , 64,124,221,222 Cormor, torrente , 183 Comino , 184 ,1 97 , 199 Corniolo , 242 Corno,fiume, 74,80,85 Corte11azzo , 74, 82 Cosìch, monte , 125 , 126 Costa, 120 Costa Raunza 157 Costantinopoli, 31 Cragno , 224 Crauglio, 68, 72 Creda , 87 Crisignano , 216 Cmi Hrib, 123
Croce di Venchiaruzzo, 190 , 193, 197 Croisilles , 203 Corsara , 119 Crupignano , 181 Custoza, 13, 18
Debeli , monte, 123 , 124 Delizia, ponte, 184, 196, 197, 216 , 218, 221 Démuin , 203 Derna, 31 Deskla , 158 , 161 Devetachi, 126 Diamond-Hill , 23 Dinat, 51 Divette , 203 Doberdò , altopiano, 58, 123 , 124 , 125, 126 Dobra , 67 , 87 Dolegna, 165 Dolganiva, 163 Dolomiti , 59 Domanin s, 197 Domberg , 124 , 125,221 Dragasti, 210 Dragovice , 161
Due Palme , oasi, 33 Duino, 53, 123 Durazzo, 240
Elandslaagte , 24 Emilia, 11 , 179 Este, 215
-256-
Fadalto, stretta, 220 Fajti Krib, 126, 131 Feletto Umberto, 181, 183 Panna, 197 Parra ,70, 131 Fauglis,224 Feletis, 224 Ferleti, 123 Festa, monte, 184 Fiaschetti, 218, 240 Fieri, 207,208,242 Firenze, 12, 14 Firmano, 181 Flagogna,221 Flaibano, 222 Fleigneux, 17 Flondar, 123 Fobca, 163,165 Fogliano, (Palazzo) 58, 72 FontaneUe, 218 Forador, 180 Forcate, 107 Fortin, Monte, 70, 72, 125 Francenigo , 220 Fuehiat, 34
Gabria, (Carso), 123 Gabrie, 87, 161 Gaiarine, 218 Galizia, 48, 201 Gallarate, 179 Galleriano, 191,222 Gallio, 119, 120 Gargaro, 161, 163, 165 Gariunes, 34 Garonne, 18 Gazza, 216 Gemona , 222 Ghelpac, 120 Giardini, 119, 120 Giavera, 212 Ginevra, 11 Givet, 50 Globna, 162,163,165 Golametto, 86 Golaz, 107 Gonars, 64, 80, 85 Gorizia, 3, 53 , 58, 87, 123, 124 , 125, 126, 131,
157,158 ,1 61 , 162 ,2 21 ,2 22 , 24 I Gorlice, 53 Gome, 123 Graclisca ,70 , 72 ,87, 194,222 Gradiscata , 107 Grado, 70,224 Grappa, Monte, 100 , 199,215,243 , Grumolo delle Badesse, 216
Haelen, 51 Ham, 203 Hassan Boyut , 21 O Hauari, 34 Hermada, Monte, 162, 171 Hoje , 158 Hol1ezy, 203 Homs, 31 Hubert, 48 Humarji, 159, 161
Idersko, 87, 180 Idria, fiume, 158 leza , Monte, 56 Ilnkeu, 25 Ipplis, 181 Ippolis, 87 Isola Morosini , 70 Isonzo, fiume, 13, 35, 56, 58, 64, 66, 70, 72, 74, 75,80, 82, 85,86,87 , 107 , 108,119,124,125 , 126,131,157,171 , 221 Istrago, 220 Istrana, 218 lwanigrad, 53 Jagodina, 210 Jamiano, 123,126 Jelenik, Monte, 158, 161 Jeza, Monte , 157 Joanniz, 66, 68,224 Jof di Montasio , 157 Judrio , fiume , 64, 66, 157,161 , 221
Kal , 158, 163 Kamarca, 161 Kamno, 87 Kimberley , 24 Kobilek, 161 Koefia , 32

-257-
Kolk, Monte, 157 Kolovrat, Monte, 157 Kra, 180
Kuci, 209,210 Kuk, Monte, 157, 158
La Basse, canale, 203 La Pere (Piccardia), 203 Lambara, 121 Lanisce, 163, 165 Latisana, 64, 80, 184, 193, 194, 216, 221, 222, 224,242
Latisanotta, 222, 224 Lavariano, 7, 191 Le Caveau, 204 Ledra, canale, 9, 87 Leopoli,48 Leproso, 87 Lesse, 48 Lestizza, 191 Leupa Kal, 158 Liao-yang, 25 Liegi, 48 Lilla, 203 Lipa, 53 Liuzna, 209,240 Livenza, fiume, 10, 80, 190, 193,197,216,218, 220,240,242
Loca vaz, 126 Locve, 159 Log, 158 Loga, 158 Lokovec, 158 Loro di Canale, 158 Loro di Tolmino, 158 Lombardia, 179, 196 Lonka, 161 Lovadino, 193,218 Lozice, 158 Lubiana, 56, 158 Lucari, 159 Lucca, 17, 87 Luce, 203, 204 Lucinico,70,72,87

Luck, 126 Luico, Sella, 157 Lumignacco, 191,222 Lussemburgo, 49
Lutsk, 123 Lys,203 Madoni, 158 Maggiore, Monte, 171 Maiano, 184 Mainizza, 124 Malakastra, 207,208,209,242 Mandria, 108,111,113,127 Maniago, 184,190,216,220 Mantova, 119 Manzano,181,222
Marano, 64,216, 218 Marano di Riviera, 180 Marcelcave, 203 Marcesina, 120 Marcilliana, 111 Marcottini, 123 Mareno, 218 Mariano del Friuli, 70, 72, 125 Marna, 201, 220 Marostica, 119 Martignacco, 85, 183 Masseria di Tre Ponti, 224 Matajur, Monte, 157 Mauria, 220 Medana,64 Medea,64 Medino, 188 Meduna,fiume,85,188,197,199,220,221,222, 242
Meretto di Capitolo, 68 Merna, 131 Mestre, 194 Metali, 207, 208, 209 Mia, Monte, 157 Mifoli, 207 Milano, 7,11,24,28,99, 100 Modale, 48 Mohamed Scetuan, 34 Moimacco, 87, 181 Molino, Reis, 11 l Molino, Novo, 183 Monastiér, 212 Monfalcone, 75, 78, 80,107,108,111, 113, 124, 126,127,131,221,241,242 Monigo, 216,218 Mons,51
-258-
Montagnana, 179 Interrotto, Monte, 121 Nero, Monte, 56 Rasta, Monte, 122 Santo, Monte, 161 Monticano, 190,191,218 Montdidier, 203 Montello, 211 Montuoso, 107 Moraro, 72 Moreuil, 203 Morsano, 222,224 Morso, 158, 161 Mortegliano, 10, 70,191,211 Moruzzo, 183, 184 Mosa, 48, 49, 72 Mosca, 119 Mosciagh, 120 Motta di Livenza, 85,179,194 Mrzli, Monte, 56 Mucile, 125 Mukden,25 Muscoli, 68
Nad Logem, 123 Natisone,fiume,87, 157,161,181,221 Nero, Monte, 157 Neufchateau, 48 Nimis, 180 Nogaredo, 220 Nove, 119 Noyon, 203
Oderzo, 194,218 Oise, 203 Omdurman, 24 Oppacchiasella, 125, 126 Orcenigo di Sopra, 221 Orcenigo di Sotto, 221 Orgnano, 191 Ormelle, 215 Orsago, 216, 22J Orthe, 48 Orzano, 87
Oslavia, Alture, 56, 58 Ospitale di Brenta, 216 Osoppo, 224 Ouffet Saint, 48
Ozzano, 191 Padova, 10 Paese, 216, 218 Pagnacco, 183,184 Palazzolo dello Stella, 75,224 Palazzon,212,218,224 Palkisce, 123 Palmanova, 63, 64 , 80, 85, 191, 211, 222, 224, 241 Papariano,70,85,86 Paradiso, 240 Parenzo, 53, 107 Pasian Schiavonesco, 191,240,242 Pavia di Udine, 179,181,188 Pecinka, 126, 131 Pennar, 120 Perati, 207, Perteole, 68, 69 Peteano, 125,221 Peuma, 56 Piave, fiume 4, 7, 80, 85, 100, 190, 191, 194, 197,199,211,212,215,216,218,224,241 Piave, Ponte, 85 Pieli, 186
Pieris, 56, 64, 66, 69, 70 Pinerolo, 16 Pinzano, 85, 183, 184, 188,197,216,218,220, 221
Piombino Dese, 216,218 Planina, 161 Plasencis, 184 Platischis, Conca, 157 Plava, 108,131,162,163 Plevna, 20 Plezzo, 7,87, 171,221 Pocenia, 224 Podgora,56,70,72 Podlesce, 158, 161 Poggio, (ora Poggio della Terza Armata), 58 Pojani, 209 Polcenigo, 190,216 Pontebba, 157,222,224 Porcia, 216
Pordenone,85, 193,194,216,220,221 Poro, 207 Porquericourt, 203 Porto, Rosega, 111

-259-
Porto Buffolè, 216, 220 Portogruaro, 84, 194,222
Povoletto, 179,180
Pozzuolo del Friuli, 4 , 7, 9, 10, 64, 75, 191, 192, 221,222,241,242,243
Pravisdomini, 191 Premariacco, 181 Presina, 216 Pri Stanti, 123 Pria dell'Acqua, 122 Priula, 212 Provesano, 220 Purgessimo, Monte, 221

Quarin, Monte, 64 Quero, strettoia, 215 Quinto di Treviso, 218 Quisca, 64 Quota Toti, 107
Raccogliamo, 123 Ragogna, Monte, 184, J 88 Rasta, Monte, 120 Ravne, 161 Ravnica, 161 Redipuglia, 70 Res Baciava, 209 Resiutta, 222 Risano, 191, 222 Rivignano, 193 Robic, 222
Rodighieri, 120 Rocca, Colle, J07, 108 Rogozia, 209 Rohot, 158, 165 Roma,9,14, 16, 17,18,26,31, 181 Romania, 149,201 Romans, 131 Rombon, Monte, 157, 171 Ronchi dei legionari, 75, 108, 111, 194 Ronzina, 157 Rubbia, 125, 131 Ruda, 68, 69, 70 Rumarji, 158
Russia, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 35 Russiz, 70 Rutarsce, 165 Rutser, 121
Sabotino, Monte, 56, 124, 157 Sabri, 34 Sacile, 194,216,218 ,221 ,2 41 Saga, 157,222
Sagrado,58,70,72,126, 194 Saint Hubert, 48 Salcano, 158,162,163,221 Salettuo, 1,218 Salici, 107 Salt, 181 Saluzzo, 87 Sambra, 49, 51
Samrnardenchia, 191 Sampidu, 25 Santa Andrea, 68 San Canziano, 75
San Daniele, 85, 87, 162, 183, 184, 186, 188 San Donà di Piave, 75 San Donato, 194 San Fior, 191 San Francesco, 180
San Gabriele, Monte, 58, 131, 157, 158, 161, 162,163,171
San Giacomo di Lusitana 119, 122
San Giorgio di Nogaro, 63, 64, 69, 80, 85,224
San Giorgio in Bosco, 216
San Giorgio nella Richinvelda, 220
San Giovanni di Duino, 58, 126
San Gottardo, 180, 181
San Grado di Merna, 123, 125
San Leonardo, 70
San Lorenzo, 72, 87, 125
San Luca, 186, 188 San Marco, 184
San Martino, (Aquileia), 69
San Martino del Carso, 64, 72, 131
San Martino di Quisca, 87,220
San Michele, Monte, 58, 108, 111, 123, 124
San Nicolò, 75
San Odorico, 221,222,224
San Pietro, 125, 163
San Pietro al Natisone, 87 San Quirino, 220,221
San Quintino, 201 San Rossore, 31 San Tommaso, 87 San Trovaso di Treviso, 215 San Vendemiano, 191
-260
San Vìto cli Magagna , 184 , 186
San Vito al Tagliamento , 63 , 74 , 78 , 85
San Vito del Torre , 66 , 86
Sannas post , 23
Sant' Antonio , 107
Sant' Elia , Colle , 58
Santa Caterina , 161, 183
Santa Croce Lago , 220
Santa Foca , 181 , 190,220
Santa Lucia di Tolmino , 56, 158
Santa Maria cli Tolmino , 56 , 158
Santa Maria di Sclaunicco , 9, 10, 191, 192 , 193
Santa Maria la Longa, 7
Santo,Monte, 131,157 , 158,162 , 163
Santo Stefano , 7 Sarajevo, 35 Sardegna, 20 Scandolara , 216, 218 Schelda, 202

Schonpass , 53 , 124 , 125 , 158,221 Scia-ho , 25 Sclaunicco ,7, 191 Scodovacca , 69 Scutari, 240 Sdobba punta, 86 Sdraussina, 131 Sedan, 17
Sedrano , 220 Sei Busi , Monte , 78 Selice , 87
Sella del Dol , 161, 163 Selz , 108,113 , 241 Semeni,207,208,209,210,242 Senna,51 Sequals, 180, 188 , 197 Sernaglia, 215 Seul, 25 Sedegliano , 85 Sile,212 Sina , 210 Skumbi , 210 Soli, 207 Somme,201,203 , 204 Sommardencbia , 7 Sottomonte , 188 Spessa, 87 Spilimbergo, 63, 78, 80 , 87 , 188, 197 Spresiano , 218
Staranz ano , 75 , 78 Stazione di Carnia , 180,220 , 221 , 222 Stamatica, 210 Stella, fiume , 75 , 240 Stol , 157 Strassoldo, 64 , 68 , 69 Stupizza , 87, 180 Suani Osman , 34 Sud Africa , 24 , 201 Susegna,215 SucciadeJlo, 222 Sveto, 158 Szid , 87
Tagliamento , fiume , 4 , 7, 80 , 85 , 171, 180, 183 , 184 , 186,190 , 193 , 194,196 , 197 , 199 , 211,212 , 216 , 220,221 , 222 , 224,241,242 Taitzè, 25 Taluna-Hill , 23 Talmassons , 64,85, 193 , 224 Tarcento, 196 Tarvisio , 220, 221 Tauriano , 220 , 241,242 Tavagnacco , 183 Tarnova , 53, 158 , 159 , 162 , 163 Terrenzano , 9 , 10,191,192 Terzo di Aquileia , 69 , 75 Tevere, fiume, 17 Tezze,216,218 Timavo , fiume, 243 Tissano , 7 , 222 Tobruk, 31
Tolmezzo, 180, 120,222
Tolmino, 53, 56 , 87,111,123,158 , 171,221 Tonale, 108 Topogliano,66
Tor di Quinto, 17
Torino, 12 , 29 , 35 , 51, 179
Torre di Zuino , 64, 75 , 85 , 224
Torre , fiume , 9, 64, 66 , 68, 70, 72, 86, 180, 181 , 183,196 , 199
Torreano , 183 Torsa, 224
Tramonti di Sopra, 220 Trasaglis , 184 Travesto, 85 , I 97 , 221 Traves , 222 Trebaseleghe , 216 , 218
-261-
Trentino, 143, 215
Trento, 240,242
Treviso, 179, 190, 191, 194

Trieste, 15, 53, 56, 58, 74, 158, 163
Tripoli, 31, 34 Tripolitania, 31 Trivignano Udinese, 7, 64
Turco, 20, 22 Turriaco , 88 Turriva,221
Udine,7,9,80,85,87, 119,179,181 , 183 , 184, 190,191,221,222 Umberto, Colle, 191
Val d'Assa, 119,121, 122
Va] di Nos , 120
Val Pontebbana, 157
Val Uccea, 157
Valdobiaddene, 215
Valeriano, 188
Valle di Campomulo, 119 Valona, 207
Varda, 221
Vazzola, 216,218 Veliki Krib, 131, 161 Velivrh, 158
Vencò, 165 Veneto, 61 Venzonazza, 179 Venzone, 180,222 Vercelli, 179 Verh, 161 Verhovlje, 67 Vermegliano, 108, 113 Versa, fiume, 56, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 86 Vertoiba, 125, 131
Vertojbica (o Vertoibiza), fiume, 58, 125 , 126, 131 , 157 Vienna, 243 Vigonovo, 190 ,2 18 Villa Sile. 221
Villa Vicentina , 75, 85, 194 Villanova, 72, 125 Villanova sul Iudrio, 119 Villesse, 69, 70, 72, 88 Villotta, 85 Vipacco (Vipava), fiume, 53 , 56 , 58, 107 , 123, 124,125,126,131,150,157 , 158,171 Visco , 66, 68 Visnà , 218
Vittorio Veneto , 4, 190,215,218,220 Vodice, 157, 158, 161 Vodil, 56 Vojussa, 207, 209 Volaire, 87 Volkovniak , 126 Vrb, 158, 161 Yalu, 25 Ypres, 203
Zagomje, 158 Zanzur, 32 Zebio, Monte , 120, 122 Zercovina, 207,210
Zero Branco, 218 Ziracco, 181 Zlatna , 165 Zocchi, 120, 122 Zochet 107 Zoll, 124 Zugliano, 180
-262-
BIBLIOGRAFIA
FONDI CONSULTATI DELL' .ARCHIVIO DELL'UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE ESERCITO (AUSSME)
AUSSME B4
AUSSME-F 1
AUSSME 142S
AUSSME-da 128/D 1605 Ba 1624 C.
AUSSME El 186
SULLA CAVALLERIA IN GENERE DALL'UNITÀ AL 1913
"Giornale Mmtare, ossia raccolta ufficiale deUe leggi, regolamenti e disposizioni relativi al servizio dell'amministrazione militare di terra e dj mare, pubblicato per cura del Minjstero della Guerra", annate dalla 1864 alla 1919 incluse. "Rivista dj cavalleria", Pinerolo, Linotipografia già Chiantore Mascarelli, annate 1910-1919.
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO STORICO DELLA CAVALLERJA, n museo storico della cavalleria , Collegno, Roberto Chlaramonte editore, 2000.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA, Cenni storici del reggimento Cavalleggeri di Alessandria (14°) dalla fondazione 3 gennaio 1850 al 4 novembre 1918, Lucca , 1965. BERARDT, Gustavo, Cavalleria, Udine, tipografia Del Bianco e figlio, 1921.

BIANCHl o' ADDA, Marziale, Esempi di esercitazioni di combattimento della cavalleria, in "Rivista militare italiana", Serie ID, Anno XXI, Tomo I, Dispensa II, Febbraio 1876, Roma, Carlo Voghera tipografo editore, 1876.
B1ANC1:ll D'ADDA, Marziale, La cavalleria nelle esercitazioni di combattimento di 3° grado, in "Rivista militare italiana", Serie m , Anno XX , Tomo IV, Dispensa XI, Novembre 1875, Roma, Carlo Voghera tipografo editore, 1875.
BO UTHO UL, Gaston, Le guerre, Milano, Longanesi, 1982. Bovm, Oreste, Storia dell'Esercito Italiano dal 1861 al 1990 , Roma, USSME, 1996.
BRIGNOLI, Marziano, Savoye bonne nouvelle, Milano, Mursia,1989.
BRIGNOLI, Maurizio, L'arma di cavalleria 1861-1991, Milano, R.A.R.A. , 1991.
COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE UFFICIO ISTR UZIONI E MANOVRE, Relazione sulle grandi manovre 1909, Roma, lab. tip. de] Comando del Corpo di Stato Maggiore, 1909.
DE BoNO, Emilio, Nell'esercito nostro prima della Guerra , Milano, Mondadori , 1931.
DE LIETO VOLLARO, Italo, Tommaso Lequio, campione, soldato, dirigente sportivo , su "UNUCI'', n.10 ,1991.
DE RossI, Eugenio, La vita di un ufficiale italiano fino alla guerra , Milano, Mondadori , 1927.
DELFRATE, Settimo , Azione unita della lancia e del moschetto nei reggimenti di cavalleria , in "Rivista militare italiana", Serie m , Anno XX , Tomo I, Dispensa m, Marzo 1875 , Roma, Carlo Voghera tipografo editore, 1875.
FILIBERTI , Il culto dell'incompetenza nell ' esercito, Casale Monferrato, Unione Tipografica popolare, 1922.
GAIBJ, A., Storia delle colonie italiane - sintesi politico-militare, Torino, Schioppo, 1934.
GASPARINEITI,Alessandro , Cavalleria d ' Italia, Gli Ussari di Piacenza , Modena, Stem Mucchl, 1974. GIACCHI, Nicolò,/ Granatieri di Sardegna nell ' impresa libica , Tivoli , s .i. , 1914.
-263-
GruBTLEI, Carlo, Cavalleria, su "Bollettino delle Scuole centrali di Fanteria, Artiglieria e Genio'', fase. III e IV, Civitavecchia, 1923.
GUICCIARDI DI CERVAROLO, Carlo Dell'impiego dell'artiglieria a cavallo in unione con la cavalleria, Roma , Casa editrice italiana, 1903.
lNvREA, Ademaro, La cavalleria libica in Cirenaica, s.i., ma Libia, agosto 1938.
La cavalleria e le sue riforme relativamente alle finanze dello stato, ai nuovi portati dalla scienza ed il progresso dei tempi, Torino , Tipografia della bandiera dello studente, 1868.
Lus1, Luigi, Genova cavalleria, Roma , s.i., 1939.
MALTESE, Paolo , La terra promessa, Cles, Mondadori , 1976.
MINISTERO DELLA GUERRA, Istruzioni per l'ammaestramento tattico della cavalleria, Roma, Carlo Voghera tipografo di Sua Maestà, 1872.
MINISTERO DELLA GUERRA, Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'Esercito, tomo 111, Istruzione per la mobilitazione, del 1° settembre 1883, Roma , Carlo Voghera, 1883.
PERLO, C.,Le ultime guerre e l'evoluzione della tattica, Lucca, Stabilimento tipo-lito Bocchi, 1910. PEZZI-SIBONI , Pietro RAVAGNATI-LARGHINI, Emilio, Le Glorie dei cavalieri d'Italia, compilarono Pietro Pezzi-Siboni, ten col di cavalleria e Emilio Ravagnati Larghini tenente di cavalleria, sotto gli auspici dell'Associazione dell'arma di cavalleria, Milano, E. Ravagnati editore, 1925.
PULEITI, Rodolfo, Caricati tre secoli di storia dell'Arma di Cavalleria, Bologna, Capito!, 1973.
PULErn, Rodolfo, Cavalleria d'Italia, I lancieri di Aosta 1774-1974, duecento anni di storia di un reggimento, Modena , Sten Mucchi, l 974.
PULETTI, Rodolfo, Genova Cavalleria , su "Rivista Militare", anno CXXX , n. 1, 1986.
PULETII, Rodolfo, La cavalleria italiana, su "Rivista Militare", anno CXXV, n. 4, 1981.
QuJRJ CO, Domenico, Squadrone Bianco, Milano, Mondadori, 2002.
ROSATI, Antonio , Squadroni bianchi, su "Panoplia", n. 25, 1996.
SPINGER, C.- HOLMYARD, E.J. HALL, A.R. WILLIAMS, T.I (a cura di), Storia della tecnologia, L'età dell'acciaio, vol. 5, tomo I e Il, Torino , Bollati Boringhieri, 1994.
Studio storico tattico sulle scorrerie della cavalleria del maggiore van Vitzleben, Casale, Tipografia Operaia, 1905.
ThEZZANI, Claudio, Manuale di tattica e servizio in guerra, Roma, Carlo Voghera editore, 1928.
VALLE, P., Manuale per l'ufficiale di fanteria e di cavalleria, s.i , 1875
VARANINI, Varo, Le nostre imprese coloniali, Torino , Paravia, 1937.
VARIO, Francesco Per la cavalleria, leggendo il libro del generale Kessler, estratto dalla "Rivista Militare Italiana", Dispensa X, 1905, Roma, Enrico Voghera tipografo , 1905.

VOLPE, Gioachino, L'Italia Moderna 1910/1914, Firenze, Sansoni, 1973.
S ULLA G RANDE G UERR A
**, Il generale Raffaele Cadorna, su "Bollettino dell'Istituto Storico dell'Arma del Genio", anno XXX, n. 4 (88), ottobre-dicembre 1964.
ALESS1, Rino, Dall'Isonzo al Piave, Milano , Longanesi , 1966.
BAND INI , Franco, Il Piave mormorava, Milano , Longanesi, 1968.
BARNEIT, Correlli, J generali delle sciabole, Studi sui comandi supremi della prima guerra mondiale, Milano, Longanesi, 1965.
BRIGNOLJ, Marziano, Savoye bonne nouvelle, Milano, Mursia,1989.
CACCIA DOMINION! rn SlLLAV ENGO, Paolo , 1915-1919, Treviso, Longanesi, 1979.
CADORNA, Luigi, La guerra alla fronte italiana, Milano , Fratelli Treves, 1934.
CADORNA, Luigi, Lettere famigliari, Milano, Mondadori, 1967.
CALDAROLA , Michele, l fiumi sacri d'Italia: Isonzo, Tagliamento e Piave, su "L'universo", anno
-264-
XLVIII, n. 6, nov. dic. 1968.
CAPRIN , La Grande Guerra 1914 -1918, Milano, Istituto Studi Politici Internaziona1i, 1938.
CARTER, Britain's Army in the 20 th century, London, Macmillan, in association with Tue Imperia} War Museum , 1998.
CERNIGOI, E. C UCINATO, R. VOLPI, G. , Sui sentieri della prima guerra mondiale, alla ricerca della storia, edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 1999.
C ERNIGOI, Enrico L ENARDON, Roberto POZZATO, Paolo, Soldati dell'Impero la struttura e l'organiuazione dell'esercito della Monarchia asburgica, Bassano del Grappa, Itinera progetti, 2002.
CERNIGOI, Enrico LENARDON, Roberto, Le postazioni militari austro-ungariche della Grande Guerra sulle quote 121, 85 e 77 del Carso monfalconese, Fogliano Redipuglia, Società di Studi Carsici "A .F. Lindner", 2002.

CERNIGOI , Enrico, Le ultime battaglie del Carso e la conquista dell'altopiano di Comeno, su " Studi Storico-Militari 2005", Roma, USSME, 2007.
CERNIGOI, Enrico, Soldati del regno, Bassano del Grappa, Itinera, 2005.
COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, L'esercito italiano nella grande guerra ( 1915 - 1918), vol. I, Le forze belligeranti, Roma , 1927.
Cronaca e storia del Corpo dei Bersaglieri, Torino, Daniela Piazza , 1986.
CRUTWELL, C.R.MF., The History of the Great War, 1914-1918, Oxford, 1936.
FALDELLA, Emilio, w grande guerra, 2 voli. , Milano, Longanesi, 1978.
FALDELLA, Emi]jo, La grande guerra: le battaglie dell'lsonw, 1915-1917,Milano,Longanesi, 1965.
FEDELE, Pietro, Perché siamo entrati in guerra, Roma, l'Universale, 1918.
FERRO, Marco, La grande guerra 1914- 1918, Mursia, Milano 1972.
FLoREs, Ildebrando La guerra in alta montagna, Milano, Corbaccio , 1934.
GELOSO, Carlo, Il primo anno di guerra, Milano , Corbaccio , 1937 .
GRATION,Luigi, Armando Diaz nell'ultimo anno della Grande Guerra, Roma, Rivista Militare, 1994. HODNIG, Armando, La guerra europea fino all'intervento italiano, Roma, l'Universale, 1918.
I bollettini della guerra MCMXV MCMXV/// , Milano, EdizioniAlpes, 1923 .
IsNENGHI, Mario RocHAT, Giorgio, La grande guerra 1914 1918, Firenze , Sansoni, 2004.
MIROUZE, Laurent, Soldati della prima guerra mondiale, Parma, Ennanno Albertelli Editore, 1990. PrnRI , Piero , L'Italia nella Prima Guerra Mondiale, Torino, Einaudi, 1965.
PIER!, Piero, La prima guerra mondiale 1914 -1918 problemi di storia militare, Torino, Gheroni , 1947.
PIERI , Piero , Storia della prima guerra mondiale, Torino, ERI, 1965.
PIEROPAN, Gianni, 1914 1918, Storia della grande guerra, Milano, Mursia, 1985.
PozzATo, Paolo, Un anno sull'altipiano con i diavoli rossi, Storia della brigata Sassari e Reggio nella Grande Guerra, Udine, Gaspari editore, 2006.
PULETIL, Rodolfo , Caricati tre secoli di storia dell'Arma di Cavalleria, Bologna, Capitol, 1973.
PULEITI, Rodolfo, Cavalleria d'Italia, I lancieri di Aosta 1774-1974, duecento anni di storia di un reggimento, Modena, Sten Mucchi, 1974.
PULETTI, Rodolfo, Genova Cavalleria, su "Rjvista Militare", anno CXXX , n. 1, 1986.
REGGIMENTO ARTTGLIERlA A CAVALLO, Caricat ! Voloire 150 anni di artiglieria a cavallo, Milano, Cavallotti, 1981.
ROCCA, Gianni, Cadorna , Milano, Arnaldo Mondadori Editore, 1988.
ROCHAT, Giorgio , L'esercito italiano in pace e in guerra, studi di storia militare, Milano, ed. R.A.R.A., 1991.
SILVESTRI, Mario, Isonzo 1917, Torino , Einaudi, 1965.
TOSTI, Amedeo, La guerra italo austriaca 1915 1918, Milano, ed Alpes, 1925.
VARANtNl, Varo, Luigi Cadorna , Torino, Paravia, 1935.
-265-
VOLPE, Gioachino, L'Italia Moderna 1910/1914, Firenze, Sansoni, 1973.
ZANELLI, C. F., Lancieri di Mantova , Bologna, Tamari editrice, 1965.
S ULLA GUE RRA IN M ONTA GNA
BADINI, Darnjano, La conquista del Col di Lana, Roma. USSMRE,1925.
BENCrvENGA, Roberto, La campagna del 1916 La sorpresa di Asiago e quella di Gorizia, Saggio critico sulla nostra guerra, Roma, Tipografia "Madre di Dio", 1935.
BOCCARDI, Renzo, Uomini contro montagne, Milano, Mondadori, 1935.
EBNER, Oswald, La guerra sulla Croda Rossa, Mjlano, Murs ia, 1978.
LANGES, Gunther La guerra fra rocce e ghiacciai, Bolzano, Athesia, 1981.
MARI01TI, Felice, Operazioni militari in Ampezzo Cadore e Alta Val Cordevole Cortina d'Ampezzo, Cortina , Cooperatva pol igrafica, 1964.
NAVA, Lu igi, Operazioni militari nei primi quattro mesi della campagna di guerra 1915, Cherasco, tip. Munic ipale, 1922.
SILVESTRJ, Mario, Riflessioni sulla grande guerra, Bari, L aterza, 199 1.
TOURING CLUB ITALIANO. Sui campi di battaglia, 8 voll., Milano TCI , 1923.
VrAZZI, Luciano, Col di La.na 1915 1917, Milano Mursia, 1985.
WEBER, Friz, Dal Monte Nero a Caporetto le dodici battaglie dell'Isonzo Mursia, 1994.
WEBER, Friz, Guerra sulle Alpi 1915 1917, Milano, Mursia, 1978.
MEMORIAL ISTICA
Bussi, Gianni, Forse nessuno Leggerà queste parole: diario della grande guerra, Roma, Malterru, 2002. CAPELLO, Luigi, Note di guerra, Milano, Treves, 1921.
LEONI, Diego MANDRA, Camillo (a cura di), 'La Grande Guerra, Esperienza, memoria, immagini, Bologna, il Mulin o, 1986.
QUINTAVALLE, Cronistoria della prima guerra mondiale, Milano. H oepli, 1923.
ZANELLI, C. F., Lancieri di Mantova, Bolog na, Tamar i editrice, 1965.
C APORETT O
ALBERTI, Adriano, L'importanza dell ' azione militare italiana- Le cause militari di Caporetto. Roma, USSME, 2004.
BENCJVENGA, Roberto, La sorpresa strategica di Caporetto, Udine, Gaspari Editore, 1997.
CAVIGLIA, Enrico, 'La dodicesima battaglia (Caporetto), Milano, Mo ndadori , 1933.
COMMJSSIONE D'INCHIESTA SUI FATTI DI CAPORETTO, Dall' l sonzo al Piave, 24 ottobre 1917 9 novembre 1917, 2 vol i. , II vo i. Le cause e le responsabilità degli avvenimenti, Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amminis trazione della Guerra, 19 19.
EMo CAPODLLISTA, Giorgio, 'La seconda brigata di cavalleria "Genova e Novara" a Pozzuolo del Friuli 29 e 30 ottobre 1917 (Carso 1916 Livenza 1918), P adova, Tipografia del Messaggero, 1931. GIACCID, N icolò, Il combattimento di Pozzuolo del Friuli nell'ottobre del 1917, su "Nuova antologia", Roma, Bestetti e Tumjne lli , I 927.
LADINI, Francesco, Caporetto dalla parte del vincitore, Otto von Below e il suo diario inedito, Milano, Mursia, 1992 .
PULEITI, Rodolfo, Genova Cavalleria, su "Rivista Mi}jtare", anno CXXX, n. 1, 1986.

ROMMEL, Erwin, Fanterie all'attacco. Esperienze vissute, Milano, Longanesi, 1972.
SJLVESTRJ, Mario, Caporetto una battaglia e un enigma, Milano, Arno ldo Mondadori Editore, 1990
-266-
TRENTI, Alberto, Le nostre divisioni di cavalleria nel rzpzegamento dall'lsonza al Piave, su "Rassegna dell'Esercito Italiano", Fase. VIl VITI (2° sem.)- 1925, Roma, Stabilimento poligrafi co per l'amministrazione delJo Stato, 1925.
VARANINI, Varo, Luigi Caàoma, Torino, Paravia, 1935.
ESER CITO AUSTRO- UNGARIC O
ACERBI, E. Le truppe da montagna dell'esercito austro-ungarico nella grande guerra 1914-1918, Valdagno, Edizioni Gino Rossato, 1995. Adiufterungsoorfdirikt,fur das K.u.K. Heer, I 0 , Il 0 , lli 0 Teil, Wìen, 1911.
ALLMAYER-BECK, Johann Christoph, Heeresreorgan;sation vor 50 Jahren, m Oesterreichische Militarische Zeitschrift, Wien, 1967.
COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE, Notizie sommarie sulla costituzione delle forze militari di terra della Monarchia austro-ungarica, Fascicolo VII, Formazione di guerra delle grandi unitàTruppe e formazioni per la guerra in montagna Notizie logistiche e tattiche Ordine di marcia di una divisione difanteria ;n vicinanza del nemico Segni distintivi dei comandi, stab ilimenti, ecc. Segn; convenzionali per l'indicazione, sugli schizzi, dei comandi, truppe e stabilimenti principali segni convenzionali della carta austro-ungarica al 75 .000 Circoscrizione militare territoriale e sedi dei comandi di Corpo d'armata e di divisione, Roma, 1914 .

COMANDO SUPREMO UFFICIO OPERAZIONI, Nazionalità delle truppe componenti le divisioni di fanteria dell'esercito Austro Ungarico 25 aprile 1918, s.l , Regio Esercito Italiano, Comando Supremo, Sezione Tipo-Utografica, 1918 .
DIRRHEIMER, Gunther BRUCH, Oskar, Das K.u.K. Heer 1895, vol. 10, in Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wìen, Wien, Militarwissenschaftliches Institut, Oesterreichischer Bundesverlag, 1983.
Documenti della 5a Annata austro-ungarica, situazione nel settore principale zona costiera Carniola Carinzia, in AUSSME .
Friedens-Ordre de bataille, des K.u.K. Heeres der K.K und der K.u.K. Landwehr, Wien, 1914
JUNG, Petre, Der K.u.K. Wustenkrieg Oesterreich-Ungarns im Vorderen Orient 1915-1918, Graz Styria Verlag, 1992.
MANTOVAN, Nevio, Bombe a man.o austro-ungariche 1914-1918.
MASSIGNANI, Alessandro, Le truppe d'assalto austro ungariche nella grande guerra, Valdagno, Ed izioni Gino Rossato, 1995.
MINISTERO DELLA GUERRA, COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGJORE UFFlCIO STORICO, L'esercito italiano nella grande guerra, 1915-1918, voli. I, II, Ill e IV, Roma, Istituto poligrafico dello Stato, 19 MoRIN, Marco, Le armi portatili dell'impero austro-ungarico, Firenze, Olimpia, 1981.
Oesterreich-Ungarns letzter Krieg 1914 1918, Wien, s.d.
RAUCHENSTEINER, Manfred, Der Tod des Doppeladlers, Oesterreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg, Graz, Styria Verlag, 1994.
REGIO ESERCITO ITALIANO, COMANDO SUPREMO,Notizie sulle truppe e sui servizi dell'esercito austroungherese, Ufficio operazioni, Maggio 1918.
SANTANGELO, F., Notizie sull'esercito austro-ungarico, Torino, Scuola di Guerra, 1909.
SEEMANN, Helfried LUNZER Christian, (a cura di), Album. die K.u.K. Arm.ee 1860-1914, Wien, REMAprint, 1995.
Situazione opere e lavori, Direzione del Genio di Klagenfurt, Rapporto sulle fortificazioni, Comando Militare di Graz I, n. 12.191, 20 maggio 1915.
Studii vari sulla cavalleria austro-ungarica nella Guerra Mondiale, su "Rivista Militare italiana", anno II, n. 8, agosto 1928, VI E.F.
-267-
ALBANIA
FALDELLA, Emilio, La grande guerra, 2 voli., Milano, Longanesi, 1978.
FATUITA, Francesco, Le operazioni in Albania tra il 1914 e 1918 e La guerra di bande, su ''RID", n. 3, 2001.
I bollettini della guerra MCMXV MCMXVIII , Milano , Edizioni Alpes, 1923.
MINISTERO DELLA DIFESA, STATO MAGGIORE DELL'EsERCITO, L 'esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918) Volume Vll, tomo 3° Le operazioni fuori del territorio nazionale: Albania, Macedonia, Medio Oriente, Roma , USSME, 1983.

MONTANARI , Mario, Le truppe italiane in Albania 1914-20, 1939, Roma , USSME , 1978. PuLETII, Rodolfo , Caricati tre secoli di storia dell'Arma di Cavalleria, Bologna , Capitol, 1973. TALARICO, Achille, Scoglio e marosi ricordi di un chirurgo soldato e marinaio d'Italia (1915 1945), Milano , Le settimane d'Italia, 1953.
DA CAPORETTO A VITTORIO VENETO
ALESSI , Rino, Dall'Isonzo al Piave, Milano , Longanesi , 1966.
B ANDINI, Franco , Il Pia ve mormorava, Milano , Longanesi, 1968.
BRIGNOLI, Marziano, Savo ye bonne nouvelle, Milano, Mursia,1989.
CADEDDU, Lorenzo POZZATO , Paolo (a cura di) , 'La battaglia di Vittorio Veneto , gli aspetti militari, Udine , Gaspari , 2005.
CALDAROLA, Michele , I fiumi sacri d'Italia: Isonza, Tagliamento e Piav e, su "L'universo", anno XLVTII, n. 6, nov. dic. 1968.
CAPRlN , La Grande Guerra 1914 1918, Mj}ano , Istituto Studi Politici IntemazionaJi , 1938.
C ARTER, Britain's Army in the 2dh century, London, Macmillan , in association with The Imperial War Museum , 1998.
CERN!GOJ, Enrico, Soldati del regno, Bassano del Grappa, Itinera , 2005.
FALDELLA, Emilio , 'La grande guerra, 2 voli., Milano, Longanesi, 1978.
FERRO, Marco , La grande guerra 1914- 1918, Mursia, Milano 1972.
GRA'ITON, Luigi, Armando Diaz nell'ultimo anno della Grande Guerra, Roma, Rivista Militare , 1994.
1 bollettini della guerra MCMXV MCMXV!ll , Milano, Edizioni Alpes, 1923.
ISNENGHI, Mario ROCHAT, Giorgio, La grande guerra 1914 -1918, Firenze , Sansoni, 2004.
LECHI , Fausto, Paradiso , ore 15 del 4 novembre 1918, Brescia, Industrie grafiche bresciane, s.d. (ma 1988).
MARIETII, Giovanni, Armando Diaz, Torino, Paravia, 1935.
MJROUZE, Laurent, Soldati della prima guerra mondiale, Parma, Ermanno Albertelli Editore, 1990.
PIERI , Piero, L'Jtalia nella Prima Guerra Mondiale, Torino , Einaudi , 1965.
PIER1, Piero , La prima guerra mondiale 1914 -1918 problemi di storia militare, Torino, Gheroni, 1947.
PIER!, Piero , Storia della prima guerra mondiale, Torino , ERI, 1965.
PIEROPAN, Gianni, 1914 1918, Storia della grande guerra, Milano , Mursia , 1985.
PuLETII, Rodolfo, Caricati tre secoli di storia dell'Arma di Ca valleria, Bologna , Capitol, 1973.
TOSTI, Amedeo, la guerra italo austriaca 1915 1918, Milano, ed Alpes, 1925.
ZAVAROITI, Edmondo, La terza brigata di cavalleria a Monastiér di Treviso (giugno 1918), Edizioni della Rivista di Cavalleria, 1936.
-268
RINGRAZIAMENTI
L'autore sente il dovere di ringraziare il Col. Antonino Zarcone, capo dell ' Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, i Tenenti Colonnelli Roberto Di Ro s a , capo Sezione Archivio , Salvatore Orlando, capo Sezione Editoriale , Filippo Cappellano , capo della ID Sezione , Giancarlo Marzocchi, della Sezjone Editoriale , il maggiore Andrea Crescenzi della Sezion e Archivio, i Luogotenenti Daniele Prinari , Antonio Sangiovanni , Maurizio Saporiti e il dott. Alessandro Gionfrida; il Museo Storico dell ' Arma di Cavalleria di Pinerolo , il Conte Roberto Nasi; il Ten. Col. Calogero Scolaro e il Maresciallo Massimo Gubbiotti; la Scuola d ' Applicazione Militare di Torino e in particolare il Col. Antonio Tucciarone, il Ten. Col. Sabino Piemonte, il Maresciallo Capo Giancarlo Sorintano e la Dott.ssa Laura Ferrati; gli amici Prof. Paolo Pezzato e i signori Roberto Lenardon e Ruggero Dal Molin e, infine non ultimo , il dott. Ciro Paoletti.

269-

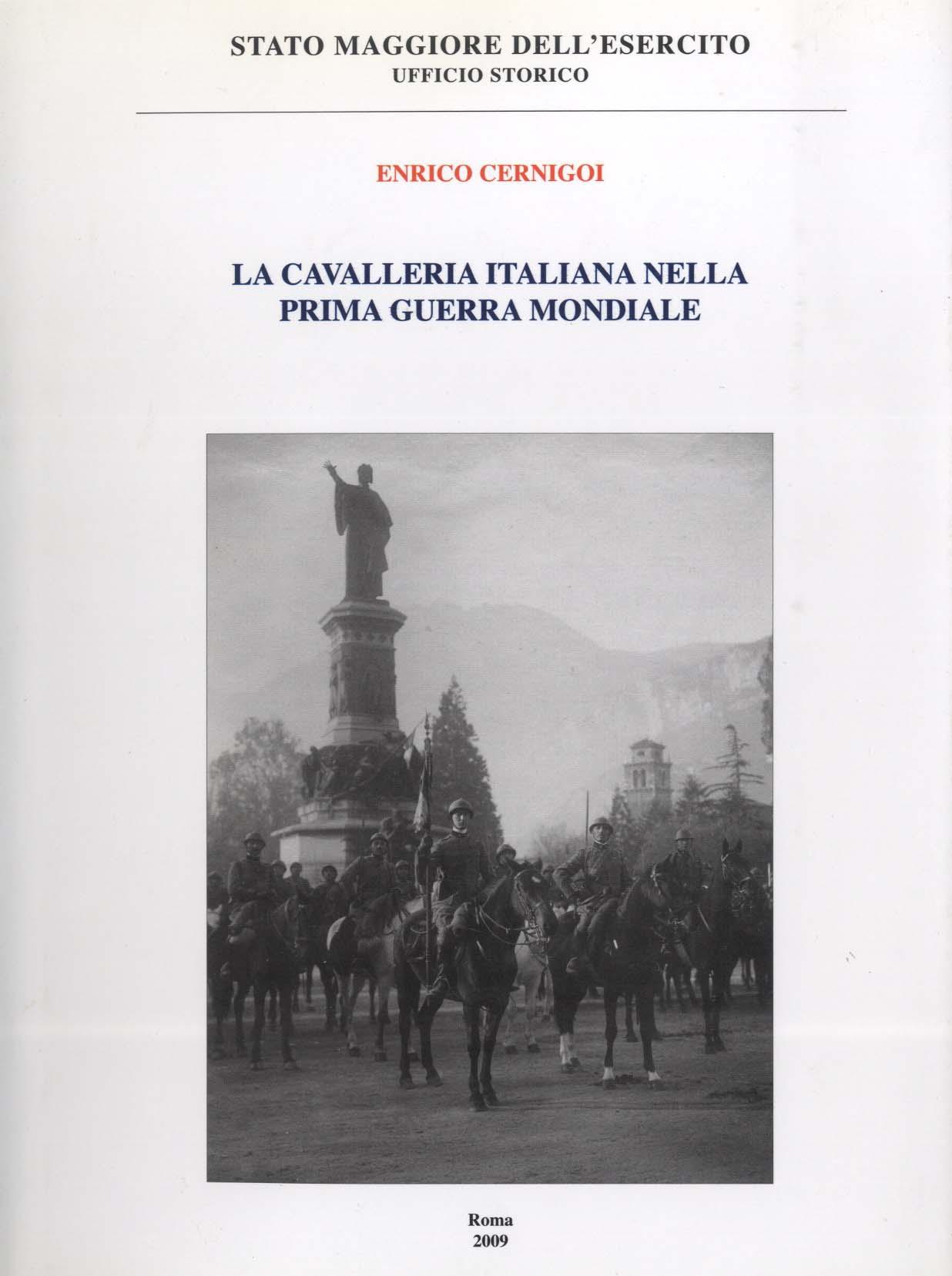







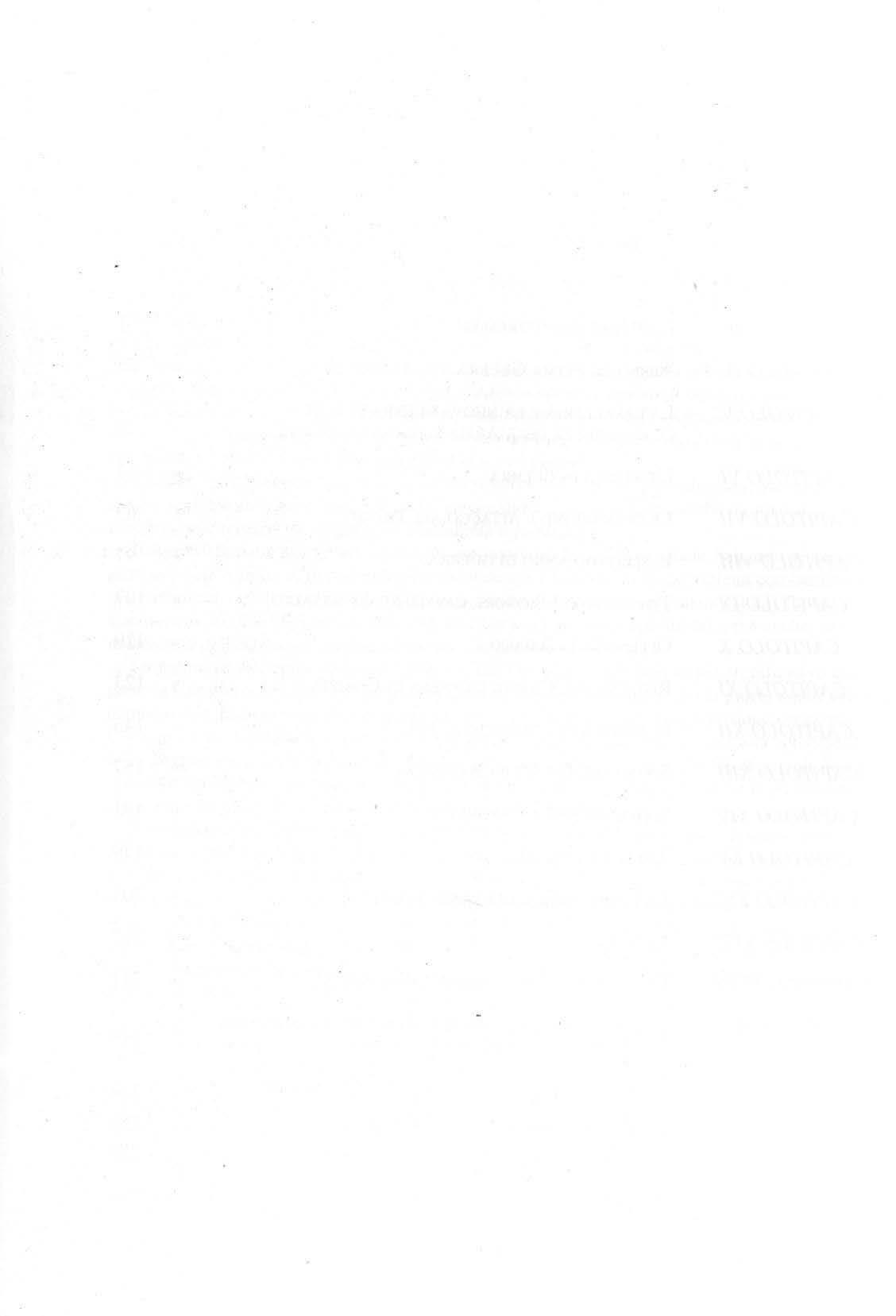

 Ottobre 1917: cavalleggeri e mitraglieri osservano un cavallo colpito a morte.
Ottobre 1917: cavalleggeri e mitraglieri osservano un cavallo colpito a morte.




 Il co lonnello comandante il Reggimento Piemonte Reale , I900. ( Archivio Dal Molin)
Il co lonnello comandante il Reggimento Piemonte Reale , I900. ( Archivio Dal Molin)

 Drago ne di Piemonte Reale di guardia allo stendardo al Quirinale , in attesa del passaggio del Re , nelJ ' ultirno inverno prima della Grande Guerra. (Arc hi vio Dal Molin)
Drago ne di Piemonte Reale di guardia allo stendardo al Quirinale , in attesa del passaggio del Re , nelJ ' ultirno inverno prima della Grande Guerra. (Arc hi vio Dal Molin)



 Piemonte Reale Cavalleria: esercitazione nel salto con gli ostacoli. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale Cavalleria: esercitazione nel salto con gli ostacoli. (Archivio Dal Molin)







 Le scuderie di Piemonte Reale. ( Archivio Dal Molin )
Le scuderie di Piemonte Reale. ( Archivio Dal Molin )

 i, C. SPINGER E.J. H OLMYARD AR. HAL L T.L. WI LLIAMS, (a cura di), Storia della lec,wlogia, voi. 5 tomo I e II: L 'età dell'acciaio, Torin o, B o llati Boringhieri . 1994.
i, C. SPINGER E.J. H OLMYARD AR. HAL L T.L. WI LLIAMS, (a cura di), Storia della lec,wlogia, voi. 5 tomo I e II: L 'età dell'acciaio, Torin o, B o llati Boringhieri . 1994.







 Uno squadrone di Piemonte Reale nella campagna romana, a Tor di Quinto. ( Archivio Dal Molin )
Uno squadrone di Piemonte Reale nella campagna romana, a Tor di Quinto. ( Archivio Dal Molin )

 Esercitazioni di Piemonte Reale nella campagna romana presumibilmente sulla via Braccianese Claudia. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale: nella campagna romana. (Archivio Dal Molin)
Esercitazioni di Piemonte Reale nella campagna romana presumibilmente sulla via Braccianese Claudia. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale: nella campagna romana. (Archivio Dal Molin)

 Marcia in colonna. (Archi v io Dal Molin )
Squadrone in sosta . (Archivio D aJ Molin)
Marcia in colonna. (Archi v io Dal Molin )
Squadrone in sosta . (Archivio D aJ Molin)
 Dragone di Piemonte Reale nella tenuta grigioverde in uso nel 1915. ( Archivio Dal Molin)
Dragone di Piemonte Reale nella tenuta grigioverde in uso nel 1915. ( Archivio Dal Molin)

 Prove di attacco al galoppo di Piemonte Reale (Arch i vio D al Molin )
Prove di attacco al galoppo di Piemonte Rea le. (A rchivio Dal Molin)
Prove di attacco al galoppo di Piemonte Reale (Arch i vio D al Molin )
Prove di attacco al galoppo di Piemonte Rea le. (A rchivio Dal Molin)




 Cavalleria inglese. 1914. (Archivio Cernigoi).
Cavalleria inglese. 1914. (Archivio Cernigoi).
 Cavalleria inglese in una raffigurazione del 1914. (Archivio Cemigoi).
Cavalleria inglese in una raffigurazione del 1914. (Archivio Cemigoi).



 Il colonnello Lui si to , comandante di Piemonte Reale. (A rchivio Dal Molin )
Il colonnello Lui si to , comandante di Piemonte Reale. (A rchivio Dal Molin )
 Piemonte Reale: in attesa della sfilata (Archivio Dal Molin)
Sfilata di Piemonte Reale per le vie della città. (Archivio Dal Molin)
Piemonte Reale: in attesa della sfilata (Archivio Dal Molin)
Sfilata di Piemonte Reale per le vie della città. (Archivio Dal Molin)

 Parata. ( Archivio Dal Molin)
Dragoni a cavallo in rassegna. ( Archivio Dal Molin)
Parata. ( Archivio Dal Molin)
Dragoni a cavallo in rassegna. ( Archivio Dal Molin)
 Pi emonte R eale schierato per la rivista. (Archivio Dal Molin)
Pi emonte R eale schierato per la rivista. (Archivio Dal Molin)
 Gruppo di sottufficiali di Piemonte Reale; a destra , co l mantello. il co lonn ello Luisito e , identificato dalla croce, Francesco Baracca. (Archivio Dal Molin )
Gruppo di sottufficiali di Piemonte Reale; a destra , co l mantello. il co lonn ello Luisito e , identificato dalla croce, Francesco Baracca. (Archivio Dal Molin )
 25 maggio 1915: Cavalleggeri di Roma. il colonnello Tamajo ed il capitano Fungaia vicino a uno dei primi feriti del Reggimento. (Museo Arma Cavalleria Pinerolo, da ora MCP).
25 maggio 1915: Cavalleggeri di Roma. il colonnello Tamajo ed il capitano Fungaia vicino a uno dei primi feriti del Reggimento. (Museo Arma Cavalleria Pinerolo, da ora MCP).
 Il confine italo-austriaco prima della guerra.
50 Franz CONRAD VON H OETZENDORFF relazione tenuta dal capo di stato maggiore ai comandanti d'armata, in Oe sterr. Staatsarchiv.
Il confine italo-austriaco prima della guerra.
50 Franz CONRAD VON H OETZENDORFF relazione tenuta dal capo di stato maggiore ai comandanti d'armata, in Oe sterr. Staatsarchiv.
 Ufficiali di Cavalleria presso postazioni di artiglieria nei pressi delle Fornaci (Pieris) nelragosto 1915.
Ufficiali di Cavalleria presso postazioni di artiglieria nei pressi delle Fornaci (Pieris) nelragosto 1915.


 Attendamenti cli Piemonte Reale nella pianura friulana nella tarda prima vera del I915.
Costruzione di un riparo per cavalli. (Archivio Dal Molin)
Attendamenti cli Piemonte Reale nella pianura friulana nella tarda prima vera del I915.
Costruzione di un riparo per cavalli. (Archivio Dal Molin)

 Accampamento di cavalleria (Friuli 1915).
Gruppo di cavalleria in posa per foto ricordo: 1915.
Accampamento di cavalleria (Friuli 1915).
Gruppo di cavalleria in posa per foto ricordo: 1915.

 Squadra dj cavalleggeri in un casolare della pianura friulana nell'autunno del 19 lS.
Squadra dj cavalleggeri in un casolare della pianura friulana nell'autunno del 19 lS.

 Luglio 1915: un ufficiale di cavalleria osserva il quadrante dell'orologio di un campanile precipitato a terra.
Ca vall eria appiedata a Castelnuovo (Carso di Doberdò ) nel 1915.
Luglio 1915: un ufficiale di cavalleria osserva il quadrante dell'orologio di un campanile precipitato a terra.
Ca vall eria appiedata a Castelnuovo (Carso di Doberdò ) nel 1915.

 Teatro delle operazioni della 3' Armata, maggio 1915.
Teatro delle operazioni della 3' Armata, maggio 1915.


 Passerella tra Gradisca e Sdraussina sulrlsonzo nel I915.
Passerella tra Gradisca e Sdraussina sulrlsonzo nel I915.
 L'avanzata della 3• Armata verso il Carso, maggio-giugno 1915.
L'avanzata della 3• Armata verso il Carso, maggio-giugno 1915.

 Vista del Cantiere di Monfalcone dalle posizioni austriache di q. 85 nell'autunno del 1915.
Sempre da q . 85: panoramica sul Lisert.Adria e, sullo sfondo a sinistra, l'Hermada e il Gol fo di Trieste nell'autunno del 1915.
Vista del Cantiere di Monfalcone dalle posizioni austriache di q. 85 nell'autunno del 1915.
Sempre da q . 85: panoramica sul Lisert.Adria e, sullo sfondo a sinistra, l'Hermada e il Gol fo di Trieste nell'autunno del 1915.



 Panorama del corso dell ' Isonzo. con a sinistra l'abitato di Plava e q. 383.
Panorama del corso dell ' Isonzo. con a sinistra l'abitato di Plava e q. 383.

 L'Ison zo ai piedi della Bainsizza; sullo sfondo Sagora, il Monte Santo e, all'estrema destra, il San Gabriele e la q. 383 di Plava : 1915.
L'Ison zo ai piedi della Bainsizza; sullo sfondo Sagora, il Monte Santo e, all'estrema destra, il San Gabriele e la q. 383 di Plava : 1915.



 Maggio-giugno 1915, Campolo ngo: mitraglieri dei Cavalleggeri di Roma in funzione antiaerea.
Maggio-giugno 1915, Campolo ngo: mitraglieri dei Cavalleggeri di Roma in funzione antiaerea.

 Gruppo cli fanti au s tro ungarici prigionie ri in attesa cli muovere , sco11ati da cavalleggeri italiani.
Gruppo cli fanti au s tro ungarici prigionie ri in attesa cli muovere , sco11ati da cavalleggeri italiani.

 Grado: 8 Ottobre 1915 , Reggimento Vercell i in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera in barca.
Grado: 8 Ottobre 1915 , Reggimento Vercell i in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera in barca.
 9 Ottobre 1915, Reggimento Guide in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera. (MCP)
9 Ottobre 1915, Reggimento Guide in collaborazione con la Regia Guardia di Finanza in difesa costiera. (MCP)
 Ajello 1915: Cavalleggeri di Monferrato in servizio di scorta prigionieri.
1915: un dragone di Piemonte Reale in primo piano e Cavallegge1i di Monferrato di sco rta a prigionieri austro ungarici del 2° Re ggimento bo sn iaco.
Ajello 1915: Cavalleggeri di Monferrato in servizio di scorta prigionieri.
1915: un dragone di Piemonte Reale in primo piano e Cavallegge1i di Monferrato di sco rta a prigionieri austro ungarici del 2° Re ggimento bo sn iaco.


 Appiedat i della 1• Divi s ione di Cavalleria: Cavalleggeri di Roma in trincea nel I915 ancora senza elmetto. ( MCP )
Appiedat i della 1• Divi s ione di Cavalleria: Cavalleggeri di Roma in trincea nel I915 ancora senza elmetto. ( MCP )
 Appiedati d ella l" Di v is io ne di Cavalleria: Cavalleggeri di R o ma in accampamento ai piedi del Carso.
Appiedati d ella l" Di v is io ne di Cavalleria: Cavalleggeri di R o ma in accampamento ai piedi del Carso.

 Appiedati della 1° Divi s ion e di Cava ll eria: Cavalleggeri di Roma in trincea, notare l' uso delle mollettiere, tipiche delle truppe a piedi , al posto degli stival i e, finalmente , l'elmetto metallico. (MCP)
Appiedati della 1° Divi s ion e di Cava ll eria: Cavalleggeri di Roma in trincea, notare l' uso delle mollettiere, tipiche delle truppe a piedi , al posto degli stival i e, finalmente , l'elmetto metallico. (MCP)
 n sottotenente Otto Giulini del 20° Reggimento Cavalleggeri di R oma in trincea con i fanti_ del 152° Reggimento della Brigata Sassari alla Trincea delle frasche: morirà da li a poco colpi to da un cecchino. (MC P)
n sottotenente Otto Giulini del 20° Reggimento Cavalleggeri di R oma in trincea con i fanti_ del 152° Reggimento della Brigata Sassari alla Trincea delle frasche: morirà da li a poco colpi to da un cecchino. (MC P)
 Giug no 1916: Cavall e gger i di Roma in ui ncea a Plava Cana le (MCP)
Giug no 1916: Cavall e gger i di Roma in ui ncea a Plava Cana le (MCP)
 Gi ugno 1916: altra immagine dei Cavalleggeri di Roma in trincea a Plava Cana le . (MCP)
Gi ugno 1916: altra immagine dei Cavalleggeri di Roma in trincea a Plava Cana le . (MCP)
 Giugno 19 I6: Cavalleggeri di Roma nei baraccamenti in una dolina a Plava Canale . ( MCP)
Giugno 19 I6: Cavalleggeri di Roma nei baraccamenti in una dolina a Plava Canale . ( MCP)



 1915 16: fante in una trincea de l Carso
1915 16: fante in una trincea de l Carso
 Si scava nel fango: un fante sistema la trincea dopo la pioggia, 1916.
Si scava nel fango: un fante sistema la trincea dopo la pioggia, 1916.

 1916: trincee su l Carso: sullo sfondo l'Altopiano di Comeno.
1916: trincee che scendono da q. 77 alla Palude del Lis ert
1916: trincee su l Carso: sullo sfondo l'Altopiano di Comeno.
1916: trincee che scendono da q. 77 alla Palude del Lis ert

 Fante in azione co n la mitragliatrice in una trincea di prima linea.
Soldati italiani ammassati nelle trincee di 1• 1inea ad est di Monfalcone. ve rso q. 77
Fante in azione co n la mitragliatrice in una trincea di prima linea.
Soldati italiani ammassati nelle trincee di 1• 1inea ad est di Monfalcone. ve rso q. 77
 Panorama dell'Adriawerke e dei Cantieri Navali visti dalle posizioni austro ungariche dell'Hennada nell 'a utunno del 1916.
Dalla q.85 verso il cant iere navale: in primo piano reticolati e cadaveri, primavera del l 916.
Panorama dell'Adriawerke e dei Cantieri Navali visti dalle posizioni austro ungariche dell'Hennada nell 'a utunno del 1916.
Dalla q.85 verso il cant iere navale: in primo piano reticolati e cadaveri, primavera del l 916.
 L ' Adriawerke vista dalle posizioni austro ungariche di q. 77 nel 19 I6.
L ' Adriawerke vista dalle posizioni austro ungariche di q. 77 nel 19 I6.
 Traspo1to cadaveri dopo un assalto s ulle alture di Monfalcone nell'estate del 1916.
Traspo1to cadaveri dopo un assalto s ulle alture di Monfalcone nell'estate del 1916.
 L' Adriawerke nel 1916.
L' Adriawerke nel 1916.









 Agosto 1916: truppe italiane a Gorizia in marcia verso il San Marco.
Agosto 1916: truppe italiane a Gorizia in marcia verso il San Marco.

 •.
Sant' Ignazio (Gorizia) con truppe di cavalleria della 3" Di visione di Cavalleria nell'agosto 1916.
•.
Sant' Ignazio (Gorizia) con truppe di cavalleria della 3" Di visione di Cavalleria nell'agosto 1916.


 Lucinico: truppe della 3" Divisione di Cavalleria a riposo nel 1916.
Gorizia, Via Rastello con truppe della 3" Di visione di Cava ll eria a riposo.
Lucinico: truppe della 3" Divisione di Cavalleria a riposo nel 1916.
Gorizia, Via Rastello con truppe della 3" Di visione di Cava ll eria a riposo.
 Una sezione di autoblindomitragliatrici della 3" Divisione di Cavalleria sbarra la strada di Vertojba.
Soldati italiani a riposo sulla s ponda del fiume Yipacco oltre Rubbia.
Una sezione di autoblindomitragliatrici della 3" Divisione di Cavalleria sbarra la strada di Vertojba.
Soldati italiani a riposo sulla s ponda del fiume Yipacco oltre Rubbia.
 La 3a Divisione di Cavalleria nella piana di Gorizia.
1916: Il lag o di Dob erdò visto dall'abitato di Dob erdò; sullo sfondo a sinistra la q. 208 nord e s ud e , a destra, la q. 144 , aU'orizzonte: l'Hermada.
La 3a Divisione di Cavalleria nella piana di Gorizia.
1916: Il lag o di Dob erdò visto dall'abitato di Dob erdò; sullo sfondo a sinistra la q. 208 nord e s ud e , a destra, la q. 144 , aU'orizzonte: l'Hermada.
 Truppe italiane a Gorizia nel 1916 in attesa d ' avanzare ancora .
Il generale Cadoma e il generale Porro a San Martino del Carso: agosto 1916.
Truppe italiane a Gorizia nel 1916 in attesa d ' avanzare ancora .
Il generale Cadoma e il generale Porro a San Martino del Carso: agosto 1916.
 Il Carso di Doberd ò ne l 1916.
Trincee di approccio al la prima linea del fronte sul Carso di Doberdò nell 'autunno del 1916.
Il Carso di Doberd ò ne l 1916.
Trincee di approccio al la prima linea del fronte sul Carso di Doberdò nell 'autunno del 1916.

 Autunno 1916. Carso dj Monfalcone. Cavalleggeri dj Roma in un osservatorio in trincea.
Settembre 1916: reparto di cavalleria appiedato in marcia per il fronte.
Autunno 1916. Carso dj Monfalcone. Cavalleggeri dj Roma in un osservatorio in trincea.
Settembre 1916: reparto di cavalleria appiedato in marcia per il fronte.

 Autunno 1916, q. 77-78 del Carso di Monfalcone. prima Linea pre sidia ta dai Cavalleggeri di Roma. ( MCP)
Autunno 1916, q. 77-78 del Carso di Monfalcone. prima Linea pre sidia ta dai Cavalleggeri di Roma. ( MCP)
 Cavalleria a riposo lungo l' argine cti un fiume (probabilmente l'Isonzo nei pressi cti Pieris).
Settembre I 916: un reparto di cavalleria appiedato pronto a partire per il fronte.
Cavalleria a riposo lungo l' argine cti un fiume (probabilmente l'Isonzo nei pressi cti Pieris).
Settembre I 916: un reparto di cavalleria appiedato pronto a partire per il fronte.



 Cavalleggero a cavallo del 22° R eggimento Cava ll eggeri di Catania in posa per la foto con tutto l'equipaggiamento
Cavalleggero a cavallo del 22° R eggimento Cava ll eggeri di Catania in posa per la foto con tutto l'equipaggiamento

 Cavalleggero del 22° Reggimento Cavalleggeri di Catania smontato.
Cavalleggero del 22° Reggimento Cavalleggeri di Catania smontato.


 Cavalleggero a Gorizia, nel 19 16.
Cavalleggero a Gorizia, nel 19 16.
 Un reparto di fanteria attraversa un paese dell'lsontino diretto verso iJ Carso.
Fanti ammassati sotto la ferrovia per Trieste, a est di q. 77.
Un reparto di fanteria attraversa un paese dell'lsontino diretto verso iJ Carso.
Fanti ammassati sotto la ferrovia per Trieste, a est di q. 77.


 Mitragliere ciclista di cavalleria.
Mitragliere ciclista di cavalleria.
 Sezione Mitraglieri ciclisti di cavalleria coli ' arma in posizione di tiro.
Sezione Mitraglieri ciclisti di cavalleria coli ' arma in posizione di tiro.


 Le linee dell'avanzata italiana del 1915. 1916. 1917.
Le linee dell'avanzata italiana del 1915. 1916. 1917.




 Allineamento Palievo monte San Gabrìele
Allineamento M.rzli- Vo dil.
Allineamento Palievo monte San Gabrìele
Allineamento M.rzli- Vo dil.

 Passaggio sull'Isonzo dopo lo sfondamento della Baiusizza , 1917.
La Fanteria italiana passa l'Isonzo a Canale nell'ago sto l 917.
Passaggio sull'Isonzo dopo lo sfondamento della Baiusizza , 1917.
La Fanteria italiana passa l'Isonzo a Canale nell'ago sto l 917.
 Canale, il castello nell'agosto del 1917.
Agosto 1917: una compagnia mitraglieri appiedata guada l'Isonzo andando s ul Carso.
Canale, il castello nell'agosto del 1917.
Agosto 1917: una compagnia mitraglieri appiedata guada l'Isonzo andando s ul Carso.
 Ago to 1917: 853" compagnia rnitraglieri di Cavalleria s ulla Bainsizza.
Ago to 1917: 853" compagnia rnitraglieri di Cavalleria s ulla Bainsizza.
 Agosto 1917: la cavalleria appiedata sale . u11 ·Altopiano della Bainsizza.
Agosto 1917: lo sq uadro ne mitraglieri di un·urutà dj cavalleria appiedata.
Agosto 1917: la cavalleria appiedata sale . u11 ·Altopiano della Bainsizza.
Agosto 1917: lo sq uadro ne mitraglieri di un·urutà dj cavalleria appiedata.
 Agosto 1917: un reparto di cavalleria appiedata passa l'Isonzo su una passerella.
T Cavalleggeri di Alessandria attraversano il ponte ricostruito nei pressi di Caporetto.
Agosto 1917: un reparto di cavalleria appiedata passa l'Isonzo su una passerella.
T Cavalleggeri di Alessandria attraversano il ponte ricostruito nei pressi di Caporetto.

 Costruzione di ponti sull'Isonzo nel l 917.
Pieris, ponte della ferrovia nel 1917.
Costruzione di ponti sull'Isonzo nel l 917.
Pieris, ponte della ferrovia nel 1917.
 Ponti in costruzione.
La cavaUeria passa un ponte di barche.
Ponti in costruzione.
La cavaUeria passa un ponte di barche.
 Trincee sul S. Marco, 191 7.
T rincee di p rima linea. tarda estate del I 9 I7.
Trincee sul S. Marco, 191 7.
T rincee di p rima linea. tarda estate del I 9 I7.
 18° Reggimento Fanteri a Acqui in linea , i nverno 1917.
Sezione mitragliatrici di cavalleri a in esercitazione sul Carso nell'estate del 1917.
18° Reggimento Fanteri a Acqui in linea , i nverno 1917.
Sezione mitragliatrici di cavalleri a in esercitazione sul Carso nell'estate del 1917.
 Una griza carsica.
Osservatorio di cavalleria in linea su l Carso davanti alle q. 208n e 208 s de ll'Altopiano di Comeno .
Una griza carsica.
Osservatorio di cavalleria in linea su l Carso davanti alle q. 208n e 208 s de ll'Altopiano di Comeno .
 Un reparto di cavalleria passa un torrente in montagna.
Cavalleria in montagna.
Un reparto di cavalleria passa un torrente in montagna.
Cavalleria in montagna.




 Ponte sul Torre, aprile 1917: sullo sfondo l'Ntopiano di Doberdò.
Pieris, i ponti dalla riva destra nel 1917.
Ponte sul Torre, aprile 1917: sullo sfondo l'Ntopiano di Doberdò.
Pieris, i ponti dalla riva destra nel 1917.


 Cavalleria in marcia , ottobre 1917.
Ripiegamento al Piave, ottobre 1917.
Cavalleria in marcia , ottobre 1917.
Ripiegamento al Piave, ottobre 1917.

 Nella pianura friulana: terza lin ea di difesa della 3a Armata.
Trincee italiane di q. 121 dopo essere state conqui s tate dagli Austro Ungarici , novembre 1917.
Nella pianura friulana: terza lin ea di difesa della 3a Armata.
Trincee italiane di q. 121 dopo essere state conqui s tate dagli Austro Ungarici , novembre 1917.

 Opere di difesa in terza linea nella pianura friulana ai piedi del Carso.
Ripiegamento co n civili nell'ottobre 1917.
Opere di difesa in terza linea nella pianura friulana ai piedi del Carso.
Ripiegamento co n civili nell'ottobre 1917.





 La cavalleria passa gJj sbarramenti
La carica di Stupizza, I9 I7: passati gli sbarramenti, la cavalleria si prepara a caricare.
La cavalleria passa gJj sbarramenti
La carica di Stupizza, I9 I7: passati gli sbarramenti, la cavalleria si prepara a caricare.


 Stupizza: la cavalleria si avvia all'obiettivo.
Reduci da!Ja carica tornano alla base di partenza.
Stupizza: la cavalleria si avvia all'obiettivo.
Reduci da!Ja carica tornano alla base di partenza.

 La carica di Stupizza, è finita: si recupera un cavallo scosso.
La carica di Stupizza, è finita: si recupera un cavallo scosso.









 134
134


 Schierati per la cerimonia, Piemonte Reale, 1918.
Schierati per la cerimonia, Piemonte Reale, 1918.
 Scorta ai prigionieri nel I918 , poco prima della fine della guerra.
Scorta ai prigionieri nel I918 , poco prima della fine della guerra.


 Messa al campo per il Piemonte Reale nel 1918.
Piemonte Reale schierato per la cerimonia, 1918.
Messa al campo per il Piemonte Reale nel 1918.
Piemonte Reale schierato per la cerimonia, 1918.

 Uom ini , cavalli e biciclette dj Piemonte Reale.
Panoramica del Reggimento Piemonte Reale sc hierato in aperta campagna, 1918.
Uom ini , cavalli e biciclette dj Piemonte Reale.
Panoramica del Reggimento Piemonte Reale sc hierato in aperta campagna, 1918.



 La la Divisione di Cavalleria in movimento verso il Piave nel 1918.
Sezione Autoblindomitragliatrici e reparti montati della 2" Divisione di Cavalleria verso il Torre.
La la Divisione di Cavalleria in movimento verso il Piave nel 1918.
Sezione Autoblindomitragliatrici e reparti montati della 2" Divisione di Cavalleria verso il Torre.

 Autoblindomitragliatrici e batterie a cavallo della 2" Divisione di Cavalleria nell'ottobre 1918.
CavaJJeria e ciclisti della 3• Divisione di Cavalleria sul Piave: 1918.
Autoblindomitragliatrici e batterie a cavallo della 2" Divisione di Cavalleria nell'ottobre 1918.
CavaJJeria e ciclisti della 3• Divisione di Cavalleria sul Piave: 1918.
 Elementi della la Divisione di Cavalleria in montagna nel 1918.
Un ufficiale di cavalleria cammina a fianco a delle truppe inglesi, Piave 1918.
Elementi della la Divisione di Cavalleria in montagna nel 1918.
Un ufficiale di cavalleria cammina a fianco a delle truppe inglesi, Piave 1918.
 Lanciere a Udine liberata. 1918.
Lanciere a Udine liberata. 1918.
 Cavalieri sul greto del Tagliamento nel 1918.
Cavalieri sul greto del Tagliamento nel 1918.
 Ottobre 1918: la cavalleria avanza in Friuli.
Ottobre 1918: la cavalleria avanza in Friuli.
 Attraversamento del Meduna.
Motta di Livenza , attraversamento de l fiume s u un ponte di barche .
Attraversamento del Meduna.
Motta di Livenza , attraversamento de l fiume s u un ponte di barche .
 4 novembre 1918: guardia allo stendardo dei Cavalleggeri di Roma, custodito nel fodero.
4 novembre 1918: guardia allo stendardo dei Cavalleggeri di Roma, custodito nel fodero.
 Ufficiali dei Cavalleggeri di Alessandria a Trento nel novembre del 1918.
Ufficiali dei Cavalleggeri di Alessandria a Trento nel novembre del 1918.
 Quel che resta del campo di battaglia dell'Adriawerke nel novembre 1918.
3 novembre 1918 il tenente Genovesi con il plotone di avanguardia a Trento, davanti al monumento a Dante.
Quel che resta del campo di battaglia dell'Adriawerke nel novembre 1918.
3 novembre 1918 il tenente Genovesi con il plotone di avanguardia a Trento, davanti al monumento a Dante.
 Trento 1918, lo stendardo dei Cavalleggeri di Alessandria.
Trento 1918, lo stendardo dei Cavalleggeri di Alessandria.
 Il Reggi.mento Cavalleggeri di Alessandria con lo s tendardo a Trento nel 1918.
L o stato maggiore della 3° Divisione con le AA RR i Duchi di Pistoia e di Bergamo a Trento passa in rassegna il Reggimento Ale ssandria, 1918.
Il Reggi.mento Cavalleggeri di Alessandria con lo s tendardo a Trento nel 1918.
L o stato maggiore della 3° Divisione con le AA RR i Duchi di Pistoia e di Bergamo a Trento passa in rassegna il Reggimento Ale ssandria, 1918.
 ORDINE DI BATTAGLIA DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA
ORDINE DI BATTAGLIA DELLE DIVISIONI DI CAVALLERIA

































