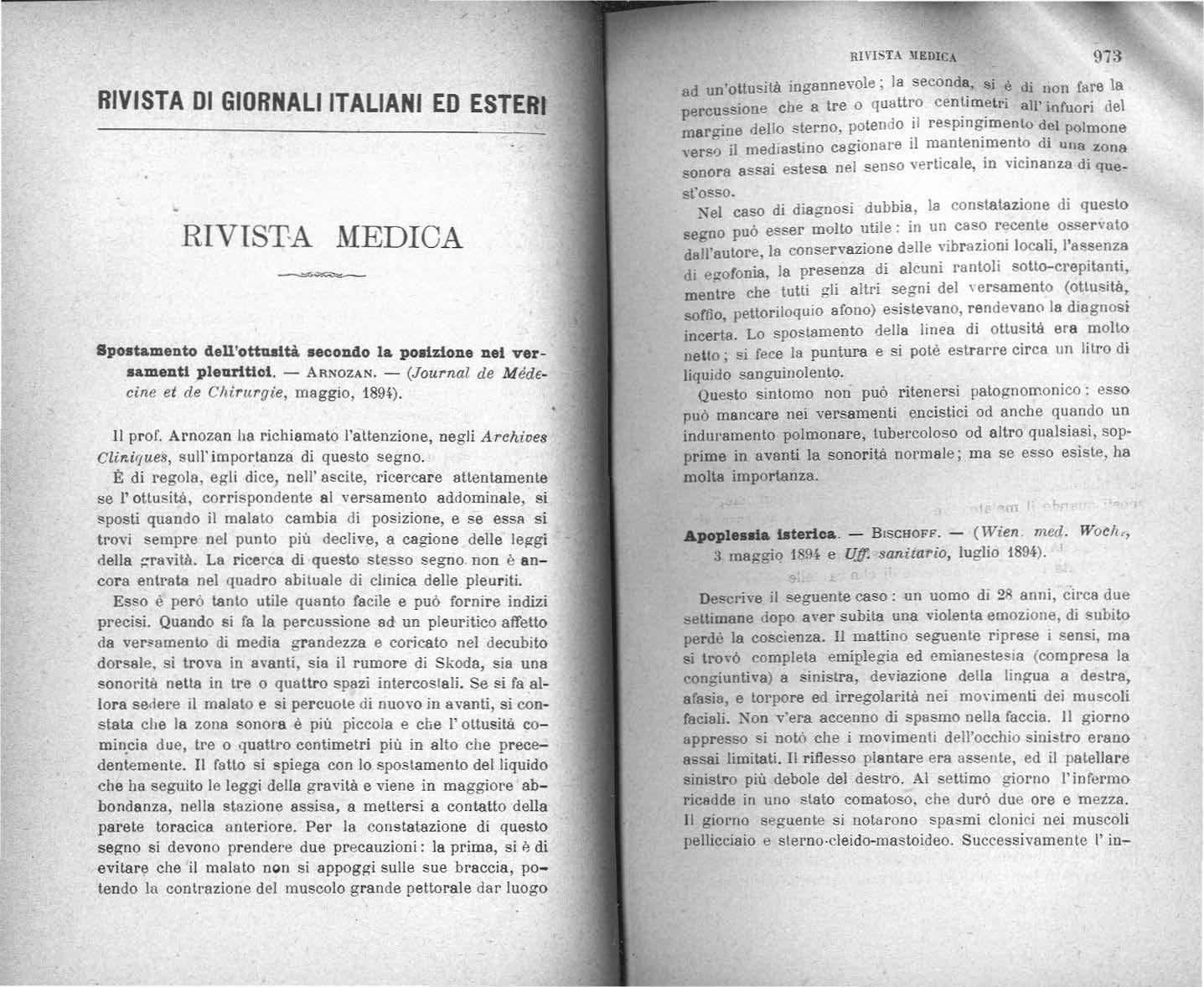
32 minute read
RIVISTADIGIORNALIITALIANIEDESTERI RIVISTA MEDICA
Spostamento dell'ottusità secondo la pouzione nei versamenti plenrlttol. - ARNOZAN. - (Journal de M édecine et de Chirurgie, maggio,
Il prof. Arnozan ha richiamato l'attenzione, negli Archioes Clir.iques, sull' di questo segno.
Advertisement
È di regola, egli dice, nell'ascite, ricercare attentamente se l'ottus ità, corrispondente a l versamento addominale, si sposti quando il malato cambia di posizione, e se essa si trovi sempre nel punto più declive, a cagione delle letzgi della La ricerca di questo stesso segno non è ancora entrata nel quad ro abituale di clinica delle pleuriti.
Esso è però tanto utile quanto facile e può fornire indizi precisi. Quando si fa la percussione ad un pleuritico affetto da ver.;>amenlo di media grandezza e coricato nel decubito dorsale, si trova in avanti, sia il rumore di Skoda, sia una sonorità neUa in tre o quattro spazi iotercostali. Se si fa allora sedere il malato e si percuote di nuovo in avanti, si cOnstata elle la zona sonora è più piccola e che l' ottusita comin.cia due, tre o quattro centimetri più in alto che precedentemente. Il fatto si spiega con lo spostamento del liquido che ha seguito le leggi della gravità e viene in maggiore abbondanza, nella stazione assisa, a mettersi a contatto della parete toracica anteriore. Per la constatazione di questo segno si devono prendere due precauzioni: la prima, si è di evitare che il malato non si appoggi sulle sue bra ccia, potendo la contrazione del muscolo g rande petlorale dar luogo ad un'ottusità ingannevole; la seconda, si è di non fare la percussione che a tre o qua ttro all'infuori del margine dello sterno, poten do Il respmgtmento del polmone verS'J il mediastino cagionare il mantenimento di una zona sonora assai estesa nel senso verticale, io vicinanza di quest'osso. caso di diagnosi dubbia, la constatazione di questo segno può esser mollo utile: in un caso osserv ato dall'autore, la conservazione delle vibrazioni locali, l'assenza d• la presenza di alcuni rantoli sotto-crepitanti , mentre che tutti gli altri segni del Yersamento (ottusità, soffio, pettoriloquio afono) esistevano, rend evano la diagnosi incerta. Lo spostamento della linea di ottusità era molto netto ; si fece la puntura e si potè estrarre circa un litro di liquido sanguinolento.
Questo sintomo non può ritenersi palognomonico : esso può mancare nei versamenti encistici od anche quando un induramenlo polmonare, tubercoloso od altro qualsiasi, sopprime in avanti la sonorita normale; ma se esso esiste, ha molta importanza.
Apoplessia isterica . - BtsCHOFF. - (Wien. med. Woch,, 3 1894 e Uff. sanitario, luglio 1894).
Descrive il seguente caso : .un uomo di anni , cit·ca due ::;ettimane dopo aver subita una violenta emozione, di subito perdè la coscienza. Il mattino seguente riprese i sensi, ma si trovò completa emiplegia ed emianestesia (compres a la congiuntiva) a sinistra, deviazione della lingua a destra, afasia, e torpore ed irregolarità nei mo,·imenti dei muscoli faciali. v'era accenno di spasmo nella faccia. 11 giorno appresso si notò che i movimenti dell'occhio sinistro erano assai limitati. Il riflesso piantare era assente, ed il patellare sinistro più debole del destro. Al settimo giorno l'infermo ricadde in uno stato comatoso, che durò due ore e mezza. Il giorno seguente si notarono spasmi clonici nei muscoli pellicciaio e sterno.cleido-mastoideo. Successivamente l' io- fermo !!U adagnò nella rnotilitil, ma non nell'anestesia e nei clisordini otulari; ma poco dopo il bra ccio sinistro s' indebolì di nuùvo e si fece manifesto il restringimento del campo visi..-o . Questi sintomi, per altro, a poco a poco si dilegu arono e l'infermo fini col guarire del tutto.
L'A. osser;a come la partecipazione della faccia e della lingua in questi casi sia rara, e come l'esempio atluale non an,alori l' a ffermazione di 'charcot, che le lesioni isteriche nella regione della raccia regolarmente si mostrino sol-to form a di spasmi. La natura isterica del caso risultò evidente al terzo giorno per l'emiplegia sinistra con deviazione della lingua a destra, per l'afasia senza per l'emianestesia • involgente le mucose, e pel restringimento del campo visivo. È da notare che nell' isterismo il disturbo del linguaggio suole esplicarsi col mutismo; mentre nel caso attuale l' infermo emelleva i suoni, ma non poteva articolarli. Quanto ai sintomi oculari, non era possibile darn e una spiegazion e anatomo-patologica.
L' A. ritiene che in questo caso l'emiplegia s ia stata primaria e la perdita di coscienza secondaria, e cbe esso non si possa considerare come un e sempio di stupore isterico seguito da pa ral isi, ovvero di isterismo complicante una lesione org!mica. ..
Cara della dl Mé Dlère. - (P rog r ès Médi.cal, 13, 1894).

Da tutti si conosce il trattamento ideato da Cbarcol nella V ertigine di M éniè re. Suo scopo era quello di sostituire ai rumori intollerabili che formano il sintomo princi pale permanente di questa malattia, i fenomeni ud itiTi che produce l'impiego prolungato, a dosi crescenti del solfato di chinina. Questo trattamento ha reso dei notevoli vantaggi a gran numero di malati, e l'autore dichiara di averne ottenuto o una guar igione completa o un marcatissimo miglioramento in una dozzina di casi.
KEDlCA 9i5
Lo stel'!'O aveva inspir ato Ha r d, sessanta anni fa in un caso speciale. e ciò si rileva dall'elogio pronuncia tone all' Accademia di Medicina da Bousquet ne!
• Traltavasi lli una donna , a cui lo spavento di un 10cendio c produsl'e ronzii d'orecchio continui. Dopo aver consultato • inutilmente parecchi medici , essa V(llle senttre anche 1tard. il quali-l vide subito c he il !:'enso ud itivo si la"c•ava ingan, c nare dall'immaginazione. .Edi invito lA sua cliente a pren« der dimora nella massima vicinanza di una oft'ìc•na, nella c s oeranza che l'orecch io assalito da nuooi rumori, r•en• t;erebbe nell'i ntef[rità. delle sue facoltà per la forza e con.. fusion e ste,.sa delle sue impressioni, il che appnnto sue• cPdette. •
L'&ulore a!<!liunge filosoficamente • È così che per estinguere una passione, la saggezza pr escrive talora di accender ne un'altra. • S enza rilevare questa riflesl' ione analoga al vecchio simiho. similibus curantur si può notare l' interesse pra•ico della citazione che permise all'autore di ricordare il trattamento più facile e raziona le del Char cot.
Bota aulla batteriologia delle f eci nella dissenteria oronioa endemica del paesl oaldl . - L. E . BERTRAND, medico capo, e BAUCHER, rarmacista principale della marina francese.- (Estratto daJla Go:&ette hebdomadaire de méckcine et de chir1'rgie, aprile 1891}.
Questo studio analitico è un corollario di altro lavoro degli stessi autori sulla batteriologia delle reci nella dissenteria nostrale epidemica, pubblicato sulla medesima Gazzella nelrottobre del decorso ann o.
Da quf'lsto nuovo studio gli autori deducono come conclusione che la microbiologia delle feci dà dei risultati molto analoghi nella dissenteria noslrale epidemica e nella forma cronica della dissenteria endèmi ca dei paesi caldi: l e sole differE'nze da no tarsi sono le seguenti : nostraJe, affezione acuta, il microbo predollllnante è il bacillo piocianico. 'ella dissenteria cronica
976 Rivista
dei paesi caldi che sia l'influenza del coli- bacillo, più o meno modificato, che predomina.
La scoperta degli streptococchi esige più ricerche ·nella dissenteria nostrale che in quella dei paes1 caldi; il contrario di ciò cht' accade pei vibrioni.
La parte sLatiloccbi é quasi uguale nelle due condizioni patologiche: sembra, in altri termini, che nella dtssenLeria oostrale e in quella dei paesi caldi i microbi siano gli stessi, ma che essi agiscano aggruppati e associati in modo diverso ne1 due casi.
Quanto alle amibe di Kartulis gli autori non hanno nulla da dire a pr oposito della dissenteria cronica dei paesi non avendo personale su questo punto. Le ha no() forse riscontrate, se é permesso di inscrivere sotto questa rubrica delle grandi cellule irregolari, cilindroidi, rotonde, oblunghe o fusiformi, con un punto centrale nucleolato e dei vacuoli, immobili e senza pseudopodi.
G.
Alcu ne rl1le88lont sulla pretesa. •terilità del pus n egli ascessi del f ega t o . - Dott. L. E. BERTRAND, medico capo nella marina fraùcese.
In questa nota, che venne letta all'accademia di medicina di Francia, si riferisce la storia clinica di un caso di epatite suppurata con esito di guarigione in seguito ad opportuno intervento chirurgico (aspirazione prima, indi incisione).
Del pus, raccolto con tutte le dovute cautele, venne praticato l'esame baUeriologico il quale diede il seguente risultato: t• Stafilococco pioaene, colle sue tre varieta: aureus, albus, citreus;
2• Bacillo di Eberth;
3° Un altro bacillo morfologicamente eguale a quello dì Eberth, ma ancora indeterminato. ·
La causa più probabile di questo ascesso epatico fu la dissenteria acuta che l'individuo in esame quando era al
l{EDICA 977
Tonchino, poichè non si può farla dipendere da una febbre tifoide sofferta dieci anni prima, quantunque l'esame batteriologico abbia fatto rilevare l'esistenza di un mi crobo in tutto simile a quello di Eberth.
L'autore melle in riliHo la ricchezza baltericn di i]uesto pus, che anebbe do,·uto essere sterile se le conclusioni d• certi lavori scientifici rispondessero alla realta dei fatti. Soggiuoge però che .non sarebbe da meravigliarsi se la virulenza del contenuto microbico fosse anche notevolmente diminuita. e le co!Lure av(:lssero dato risultato poiché può avvenire negli ascessi del fegato ciò chE' avviene in una coltura qualsiasi, nella quale a luogo andare i microbi pe riscono, uccisi dalle tossine che essi fabbricano.
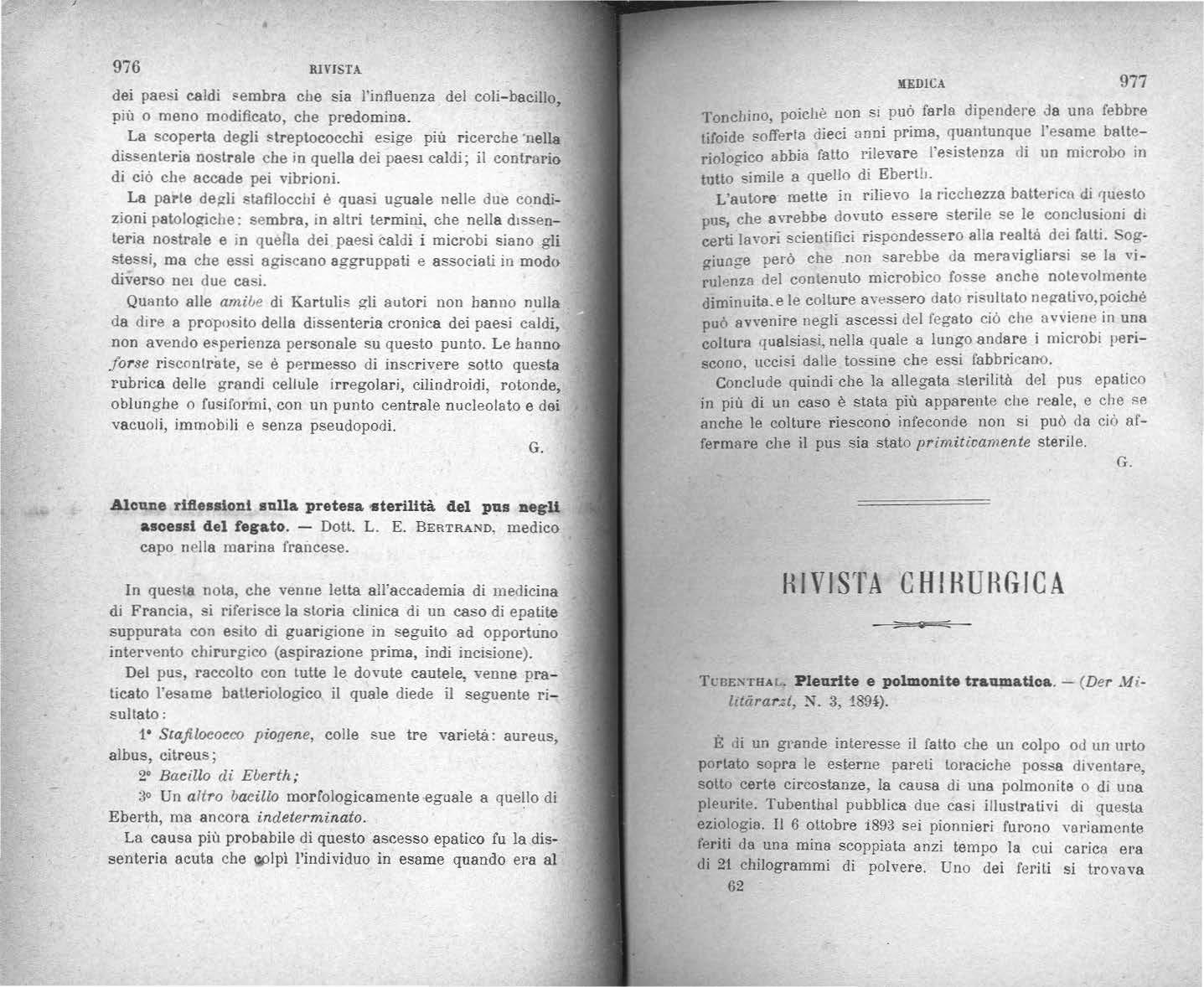
Conclude quindi che 1a allegata sterilità del pus epatico in più di un caso è stata più apparente cl1e reale, e che se anche le coUure riesconò infeconde non si può da ciò affermare che il pus sia stato primitivamente sterile.
HIVfSTACHIHUBGICA
Pleurite e polmonite t raumatica.- (Der Miltiiirar:;t, N. 3, 189i).
È rli un geande interesse il fatto che un colpo où un urto portato sopra le esterne pareti loraciche possa diventa r e, solto certe circostanze, la causa di una polmonite o di una pleurite. Tubenthal pubblica due casi illustrativi di questa eziologia. Il 6 ottobre i893 sei pionnieri furono variamente feriti da una mina scoppiata anzi tempo la cui carica er·a di 21 chilogrammi di polvere. Uno dei feriti si trovava
Rivista
un'ora più tardi in uno staLo di profondo shock ; alltt regione del dorso a W altezza della 6-8 costola sensibilità alla pres:>ione, la pelle in quel punto era un poco gonfia ed arrossata; la percussione normale, ad ambedue i polmon i rantoli a mediocri bolle. Al secondo giorno si riscontrò una polmonite destra accompagnata da febbre alta, ed al cruar"to giorno vi si aggiun!1e una pleurite destra consecutiva; quest'ultima recidivò dopo punzwne ed estrazione di 500 grammi di essudato torbido, sanguinolento. Solo diciannove giorni dopo il trauma il paziente si riebbe; finalmente guarigione. Circa alla eziologia è da notarsi che il paziente era stato lanciato dalla miua a cinque metri di altezza e quindi con tut.to il peso del suo corpo era caduto battendo a terra il dorso (fortunatamente sopra terreno molle). L' autore riferisce ancora su di un altro caso analogo per le sue conseguenze.
Un cannoniere l'iceveva i1 17 settembre 1892 un calcio da un cavallo non ferrato, alla regione costale inferiore destra; cadde a terra ma si rialzò !'ubito, un' ora dopo si sc!opr 1 su di un tratto dell'estensione di otlo centimetri in corri -
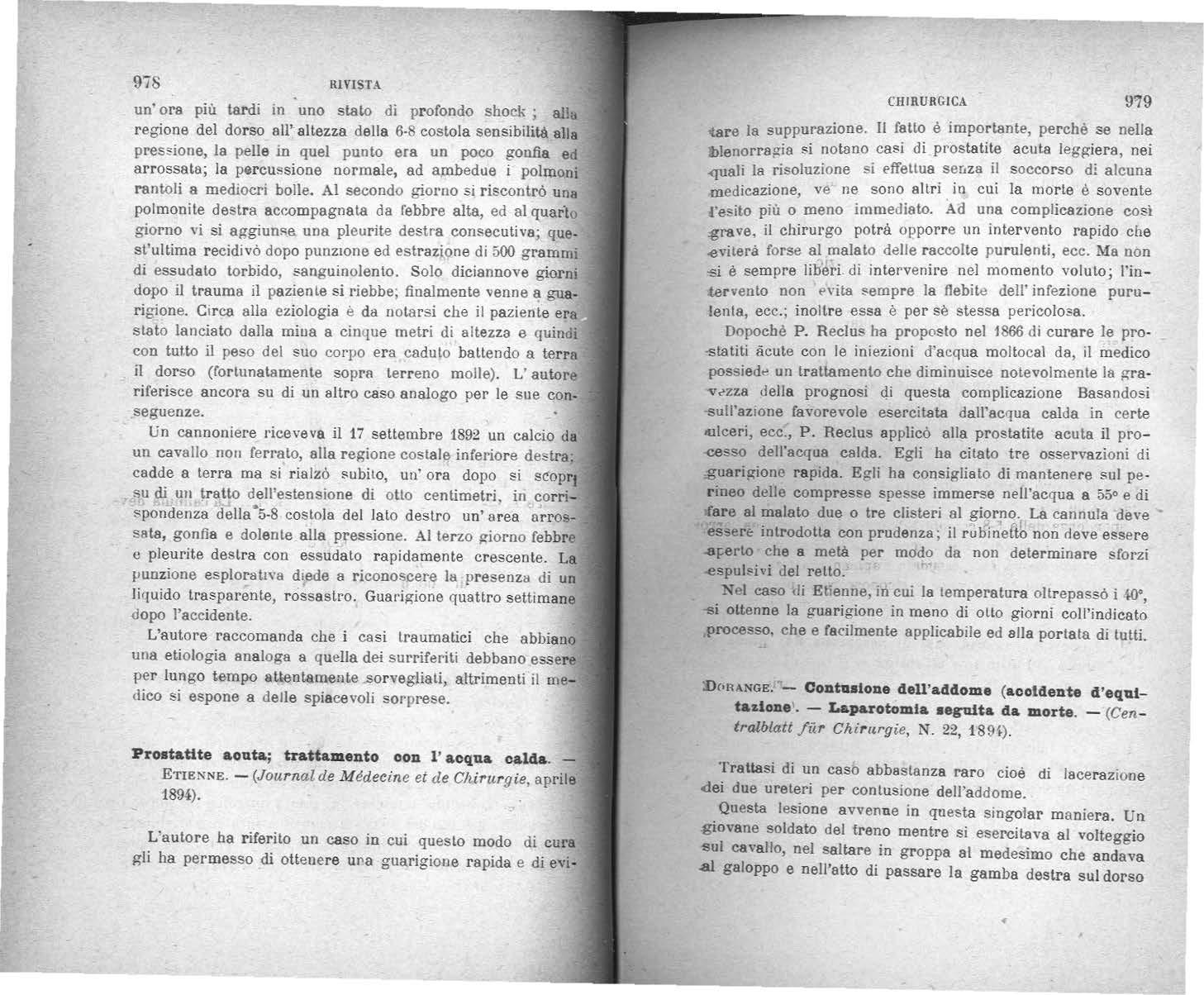
• ' spondenza della 5-8 costola del lato destro un'area arrossata, gonfia e dolente alla pressione. Al terzo giorno febb re c pleurite destra con essudato rapidamente crescente. La lJUOZione esploratl\'a d1ede a riconoscere la presenza di un liquido trasparente, rossastro. Guarigione quattro settim ane dopo l'accidente.
L'autore raccomanda che i casi traumatici che abbia no una etiologia analoga a quella dei surriferiti debbano essere per lungo tempo sorvegliati, altrimenti il medico si espone a delle spiacevoli sorprese.
Prostatlte aouta; trattamento oon l ' acqua calda.ETIENNE. - (Journal de M édecine et de Chirurgie, aprile 1894).
L'autore ba riferito un caso in cui questo modo di cura gli ba permesso di ottenere uPa guarigione rapida e di evi ·
CHIRURG-ICA 979
tare la suppurazione. Il fatlo è importante, percbè se nella .blenorragia si notano casi di prostatite acuta leggiera, nei -<JUali la risoluzione si effettua ser..za il soccorso di alcuna medicazione, ve ne sono altri in cui la morte é sovente l'esito piu o meno immediato. Ad una complicazione così :grave, il chirurgo potrà opporre un intervento rapido che .eviterà forse al malato delle raccolte purulenti, ecc. Ma non -si é sempre liberi . di intervenire nel momento voluto; l'intervento non e\·it.a sempre la flebite dell' infezione puru!enta, ecc.; inoltre essa è per sè stessa pericolosa.
Dopoché P. Reclus ha proposto nel 1866 di curare le pro-statiti àcute con le iniezioni d'acqua moltocal da, il medico possiedt> un trattamento che diminuisce notevolmente la gra· -vnza della prognosi qi questa complicazione Basandosi -sull'az•one favorevole esercitata dall'acqua calda in certe llliceri, ecc., P. Reclus applicò alla prostatìte acuta il pro-cesso dell'acqua calda. Egli ha citato tre osservazioni di rapida. Egli ha consigliato di mantenere sul per ineo delle compresse spesse immerse nell'acqua a 55o e di fare al malato due o tre clisteri al giorno. La cannula deve essere introdotta con prudenza; il non cleve essere che a metà per modo da non de terminare sforzi -espulsi \' i del retto.
Nd caso di Etienne, in cui la temperatura oltrepassò i w•, "Si ottenne la guarigione in meno di otto giorni coll'indicato processo, che e facilmente applicabile ed alla portata di tutti.
:Dc•RANGE. - Contusione dell'addome (acot dente d 'equitazione'. - Laparotomla seguita da morte. - (Centralblatt fùr Chi r urgie, N. 22, 189i).
Trattasi di un caso abbastanza raro cioè di lacerazione dei due ureleri per contusione dell'addome.
. Questa lesione avvenne in questa singolar maniera. Un gwvane soldato del treno mentre si esercitava al volteggio sul cavallo, nel saltare in groppa al medesimo che andava .al galoppo e nell'atto di passare la gamba destra sul dorso del cavallo, per un improvviso salto dell'animale urtava violentemente due volle contl'o il pomo della sella colle parett addominali prima a destra e poi a sinistra.
Sintomi del trauma furono v.omiti, vivissimi dolori, tumefazione del Yentre, polso piccolo, frequente, irl'egolare, abbassamento di temperatura, sete, stupore, stitichezza, ed anuria COJilpleta. Il cateterismo pl'aticato più. volte restò senza effetto.
Al qua!'lo giorno, supponendosi rotta la ves.!ica fu decisa e praticata la laparotomia. ·
Dopo evacuato due litri di un liquido sanguinolento · con odore orinoso si constatò tanto la vescica che l'intestini iJ.
La cavità addominale venne sciacquata con soluzionecalda di acido fenico e poi chiusa con sutu!'a pr·evia applicazione di tubo di fognatura. Due giorni dopo il pa. ziente morì. All'autopsia si tro,·ò ch e tutti e due gli u!'eteri erano lace!'ati in vicinanza alla loro origine. I reni contusi, con emoidronefrosi bilaterale molto più estesa a sinistradove si trovò raccolto un litro e mezzo di orina sanguinolent.{l. •
L'Autore crede., che in questo caso esistesse già prima idronefrosi bilaterale senza nqtevoli manifestazioni
P erò si conoscono dei casi anche puramente trademalica e questo potrebbe esserne un nuo,·o esempio.
MoRZIENOWSKI. - Del oasi di reBeZ19De del piede secondo Wladlmirow-llrltknltoz. - (Centralblatt.rur Chirurgie. N. 8, 189i).
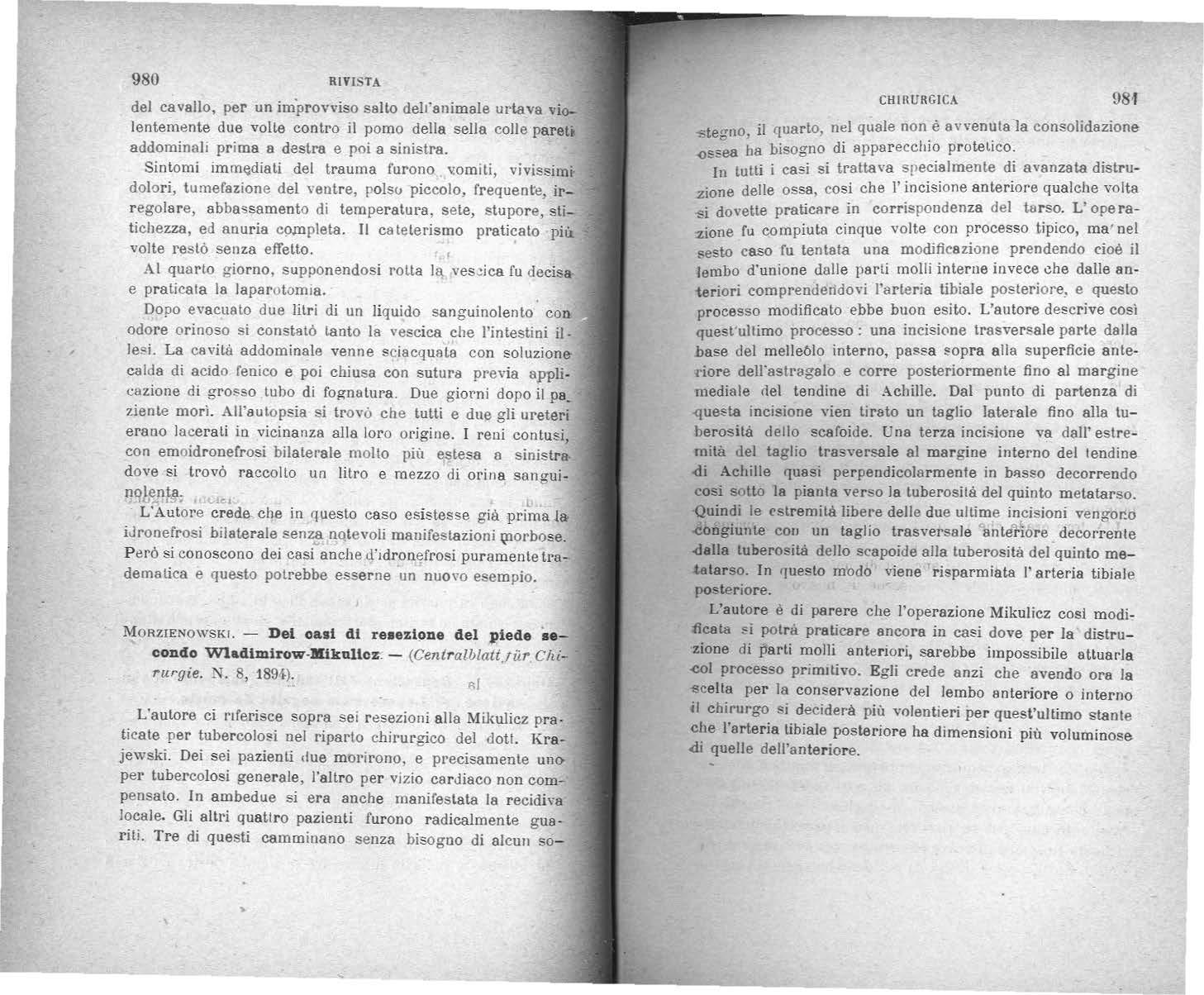
L'autore ci r1ferisce sopra sei resezioni alla Mikulicz praticate per tubercolosi nel riparto chirurgico del dott. Krajewski. Dei sei pazienti due moril'Ono, e precisamente uno per tubercolosi generale , l'altro per vizio cardiaco non compensato. In ambedue si era anche manifestata la recidh·a locale. Gli altri quatlro pazienti furono radicalmente gua · riti. Tre di questi camminano senza bisogno di alcun so-
CHIRURGICA 98f
il quarto, nel quale non è an-enuta la consolidazione .ossea l1a bisogno di apparecchio protetico.
In tutti i casi si tratta,·a s pecialmente di avanzata distruzione delle ossa, cosi che l'incisione anteriore qualche volta si dovette prati re in corrispondenza del tarso. L'operazione fu compiuta cinque volte con processo tipico, ma ' nel sesto caso fu tentata una modificazione prendendo cioè il lembo d'unione dalle parti molli interne invece l!he dalle an · teriori comprendendovi l'arteria tibiale posteriore, e questo processo modificato ebbe buon esito. L'autore descrive così quest ultimo p!'ocesso : una incisione trasversale parte dalla base del melleOio interno, passa sopra alla superficie anter-iore delrastl'agalo e corre posteriormente fino al margine mediale rlel tendine di Achille. Dal punto di partenza di <juesta incisione vien tirato un taglio laterale fino alla tuberosita dello scafoide. Una terza incisione va dall' estremità del taglio trasversale al margine interno del tendine -di Achille quasi perpendicolarmente in bJlsso decorrendo cosi S<>tto la pianta verso la tuberosilà del quinto metatarso. Quindi le estremità libere delle due ultime incisioni vengor.o -congiun te cou un taglio trasversale ante'hore decorrente -dalla tuberosilà dello scapoide alla tuberosità del .quinto metetarso. In IJUesto modo viene risparmiata l'arteria tibiale posteriore.
L'autore é di parere che l'operazione Mikulicz cosi modi· ticata si potrà praticare ancora in casi dove per la distruzione di parti molli ante r iori, sarebbe impossibile attuarla -eol processo primttivo. Egli c red e anzi che avendo ora la 15celta per la conservazione del lembo anteriore o interno fl chirurgo si deciderà più volentieri per quest'ultimo stante l'arter ia tibiale posteriore ha dimensioni più voluminose d1 quelle dell'anteriore.
982 Rivista
LA WICKI e Ro3&. - Solle •morragte In seguito ad estrazione di denti, e aulla loro oura. - (Centralblatt (ilr Chirurgie, 9, 189i).
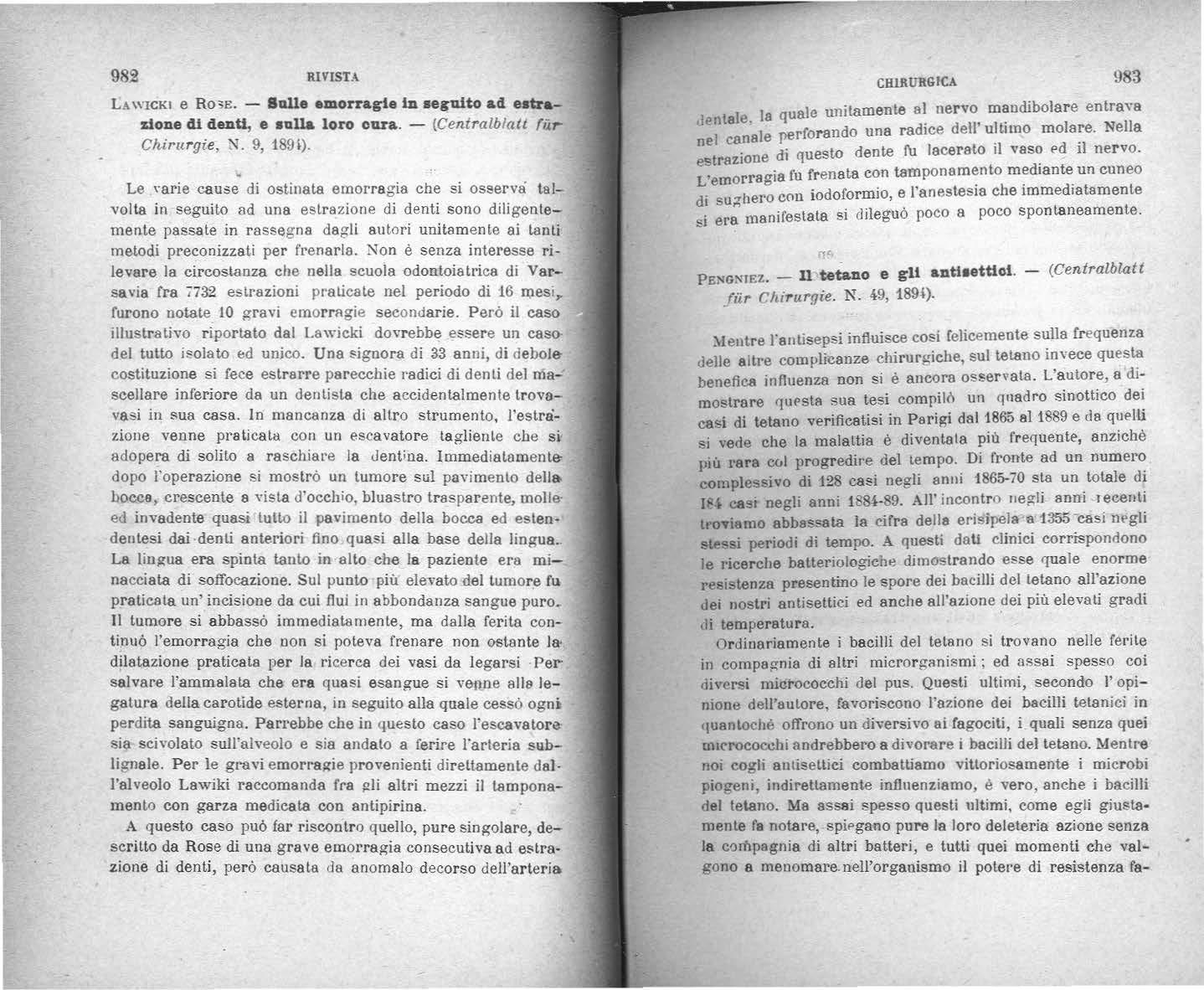
Le \·arie cause di ostinata emorragia che si osserva talvolta in seguHo ad una estrazione di denti sono diligentemente passate in rasseg na dagli autori unitamente ai tanti metodi preconizzati per frenarla. Non è senza interesse rilevare la che nella scuola odontoiatrica di Varsavia fra i732 estrazioni praticate nel periodo di 16 mesi,. furono notate 10 gravi secondarie. Però il caso illustrativo riportato dal Lawicki dovrebbe essere un casodel tutto isolato ed unico. Una signora di 33 anni, di debolecostituzione si fece estrarre parecchie J'adici di denti del mascellare inferiore da un dentista che accidentalmente trovavasi in sua casa. In mancanza di allro strumento, l'estràzione venne praticata cou un esca valore tagliente che si· adopera di solito a raschiat•e la ùentina. Immediatamentedopo l'operazi<>ne si mostrò un tumore sul paYimento dell& bocca, crescente a vista d'occhio, bluastro trasparente, molle· ed invadente quasi tutto il pavimento della bocca ed estendentesi dai denti anteriori fino quasi alla base della lingua. La lingua era spinta tanto in alto che la paziente era minacciata di soffocazione. Sul punto più elevato del tumore fu praticata un'incisione da cui flui in abbondanza sangue puroIl tumore si abbassò immediatament-e, ma dalla ferita continuò l'emorragia che non si poteva frenare non ostante l& dilatazione praticata per la ricerca dei vasi da legarsi ·Persalvare l'ammalata che era quasi esangue si veQne alle legatura d-ella carotide esterna, in seguito alla quale cessò ogni perdita sanguigna. Parrebbe che in questo caso sia scivolato sull'alveolo e sia andato a ferire !"arteria sublignale. Per le gravi emorragie provenienti direttamente dal· l'alveolo Lawiki raccomanda fra gli altri mezzi il tamponamento con garza medicata con antipirina.
A questo caso può far riscontro quello, pure singolare, descrilto da Rose di una gra ve emorragia consecutiva ad estrazione di denti, però causala da anomalo decorso dell'arteria
Chirurgica 983
1 la quale unitamente al nervo mandibolare entrava ,Jenla e, 1 r>Arforando una radice dell'ultimo molare. Nella nel cana e ,.. . d1 • questo dente fu lacerato il vaso E'd Il nervo. . 8 a 1·a fu frenata con tamponamento mediante un cuneo L'emorr o . hero con iodoformio e l'anestesia che 1mmedtatamente d1 ' man 1·•estala si dileouò poco a poco spontaneamente. s1 era •· "'
P , _ n tetano e ooll antt•etUol. - (Centralblat t ENGNIEZ. D jiir rhirurgie. N. 49, 1894).
:\lentre rantisepsi influisce cosi felicemente sulla frequenza delle aìtre complicanze chirurgiche, sul tetano invece questa benefica influenza non si é ancora osservata. L'autoreJ a dimostrare questa sua tesi compilò un quadro sinottico dei casi di tetano verificatisi in Parigi dal 1865 al1889 e da quelli si vede che la malattia è diventata più frequente, anziché più rara ool progredire del tempo. Di fronte ad un comple!:;sivo di 128 casi negli anni 1865-70 sta un totale d1 IH casr negli anni 1884-89. All'incontro ne p:li anni 1 ecenti troviamo abbassata la cifra della erisipela- a 1355 -casi n t>gli stf'<>si periodi di tempo. A questi daU clinici corrispondono le ricerche batteriologiche dimostrando esse quale enor me resistenza presentino le spore dei bacilli del tetano all'azione dei nostri antisettici ed anche all'azione .dei più elevati gradi di temperatura.
Ordinariamente i bacilli del tetano si trovano nelle fet•ite in compagnia di altri ; ed assai spesso coi diversi micrococchi del pus. Questi ultimi, secondo l'opinione dell'autore, favoriscono l'azione dei bacilli tetanici in quantochè offrono un diversivo ai Cagociti, i quali senza quei andrebbero a divorare i bacilli del tetano. Mentre noi cogli antisettici combattiamo vitloriosamente i microbi piogeni, indirettamente influenziamo, é vero, anche i bacilli del tetano. Ma assai spesso questi ultimi, come egli giustamente fa notare, spiPgano pure la loro deleteria azione senza la compagnia di altri batteri, e tutti quei momenti che valgono a menomare. nell'organismo il potere di resistenza fa- voriscono questa loro azione; tali momenti sarebbero i traumi, le operazioni, le iotossicazioni, malattie intercorrenti, influenze atmosferiche, ecc.. e per dimostrare il suo rautore riferisce numerosi esempi tratti dalla clinica e dalla fisiologia sperimental e. La sola antisepsi è inefficace ; il trat Lamento interno come pure la sieroterapia ci hanno dato finora risultati mollo Perciò come unico mezzo veramente utile l'autore consiglia una opportuna trasformazione meccanica della ferita. Siccome i bacilli del tetano sono anerobi, tutte le ferile, specialmente le fe.rite contuse nelle quali havvi la possibilità di avvenuta infezione dei bacilli del tetano devono essere così trattati col coltello, colle forbici o col cucchiaio ta glien te, che l'aria vi abbia libero accesso,to che possano essere allontanati tutti i tessuti infetti. Ben inteso che qu es to trattamento puramen te locale deve considerarsi come essenzialmente profilatlico ; esso però può esser-e attuato con vantaggio anche nell'invasione della malattia durante la manifestazione dei suoi sintomi iniziali. L'autore ritiene non necessaria l' amputa:t:ione dopo manifestatosi il tetano e crede che un trattamento energico deUa fnita infetta e delle parli olle la circondano condotta nei modi• suindicali potrà aver e gli stessi effetti della demolizione dell'arto.
BECK. - L'emplem&edn 8UO tT&tt&mento. (Cenlralblatt .fùr ( hirurgie. N. 52 , 1893).
L' unica cura razionale dell'em piema è certamente la resezione di costa, ed in questa sua affermazione l'autore non trova molti oppositori. Però l'indicazione principale di q uesto atto operativo non consisterebbe già, secondo Beck, nella necessità di un sufficiente drenaggio, nell'avvicinamento reciproco delle costole e nella retrazione delle pareti tora.cicho, come è cred uto "dai più, ma anzitutto lo scopo che si vuoi raggiun gere si è di aver la possibilità di introdurre le dita nel cavo pleurale e di esplorare la pleura. Questo sarebbe il solo processo conosciuto che ci farebbe con sicu-
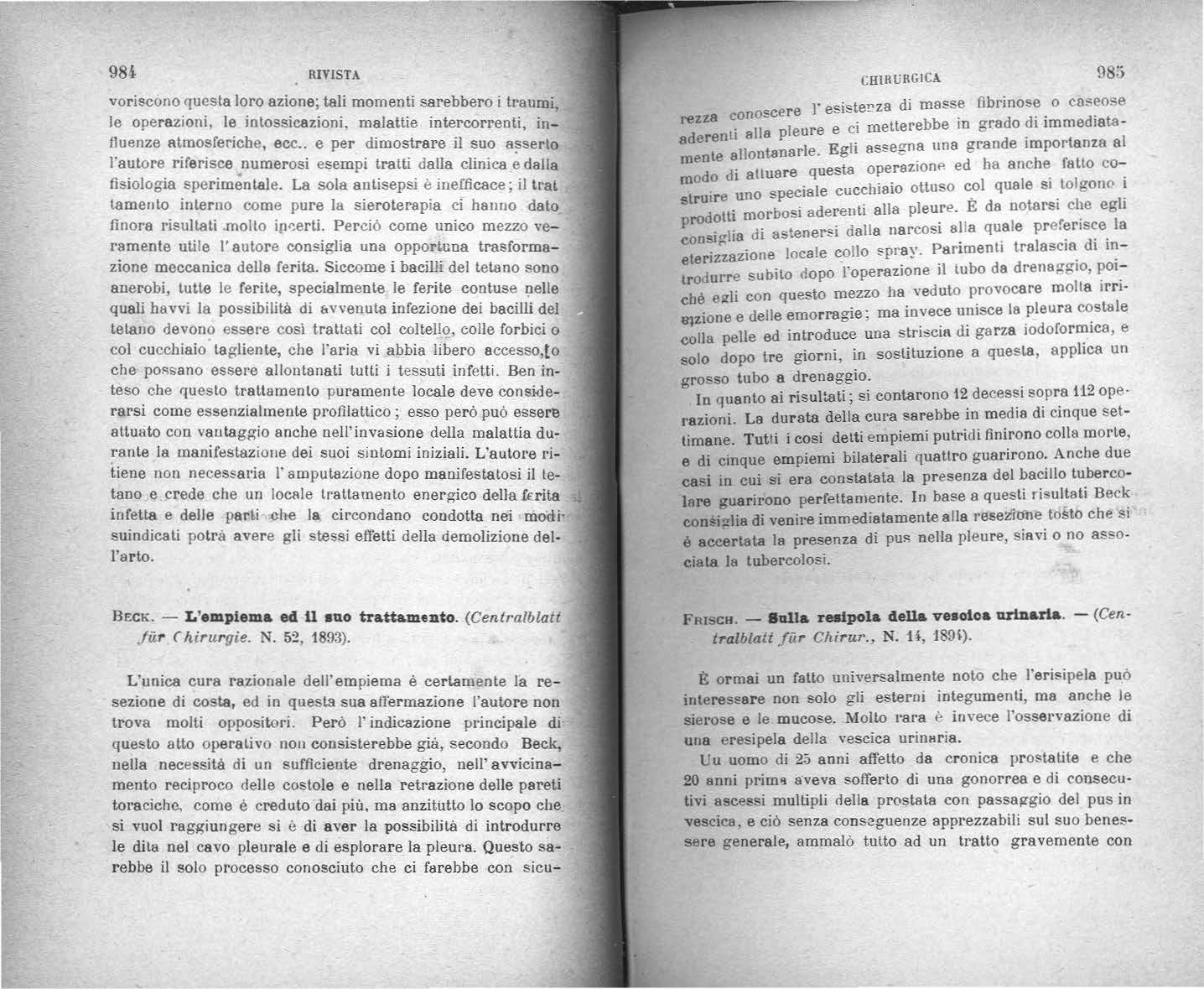
Chirurgica 985
l. di masse fibrinose o caseose conoscere - - ·· . . . rezza . 11 leure e ci metterebbe in grado d1 Immediataaderen ti a a P · 1 l e S ubito dopo roperazione il tubo da drenaggio, p01lro urr 1 · · ebè egli con questo mezzo ha \·eduto mo la trrl8lzione e delle emorragie ; ma invece umsce la pleura colla pelle ed introduce una striscin di garza e solo dopo tre giorni, in sostituzione a questa, applica un grosso tubo a drenaggio. .
Il t arie Egli asse"na una grande Importa nza a mente a on an . c . d tt re questa operaz1onfl ed ha anche fatto co- modo l a ua . l . . ·aie cucchiaio ottuso col quale SI to gonc> 1 strUire uno specJ . . r d tl. morbosi aderenti alla pleure. E da notars1 che eg 1 pro o l r · 1 · 1· di astenersi dalla narcosi alla quale pre .er1sce a conSJft la . . . d.. · ·one locale collo c:pra\'. Pa.nment1 tralascia 1 m- eter1zzaz1 . ' · . .
In quanto ai risultati; si contarono i2
112 ope· razioni. La du r ata della cura sarebbe in medta dt c10que settimane. T utti i cosi detti empiemi putridi finirono colla morte, e di cinque empiemi bilater ali quattro guarirono. Anche due casi in cui si era constatata la presen za del bacillo tubercolare guarirono perfettamente. In base a ris ultati con$iglia di venire immediatamente alla tosto che st è accertata la presenza di pus nella pleure, siavi o no associata la tubercolosi.
FRISC H - reaipola della ve•olo a urln&rl&. - (Centralblatl fii. r Chirur., N. H , •J89i) .
È ormai un ratto universalmente nolo che l'eris ipela può interessare non solo gli esterni integumenti, ma anche le sierose e le mucose. MolLo rara è in vece l'osservazione di uua eresipela della vescica
Uu uomo di 25 anni affetto da cronica prostatite e che 20 anni prim11 aveva sofferto di una gonorrea e di consecutivi ascessi multipli della prostata con del pus in vescica, e ciò senza apprezzabili su l suo benessere generale, ammalò tutto ad un tratto gravemente con febb re elevata, b r ividi, tenesmo vescicale e dolori urenti di vescica.
Nei 7 giorni consecutivi si m a nifestarono ancora due brividi con elevazione di temperatura intercalati da giorni di epi ressia; all' Òttavo gior no sopore, fe bbre alta, brivido, lenesmo vescicale dolprosissimo, tumore di m ilza. Al decimo g iorno di malattia comparve una risipola migrante lipica a d una estremità inferiore.
Si stabilì quindi la diagnosi probabile di risipola della muCO!;a vescicale. All'i ·Jo giorno la diagnosi fu confermata dalla cistoscopia. T utto l 'interno della vescica pr esentava una C(llorazione rossa intensa, in parLe pa onazza e dape rlutto piPgheLlata e tumida, qua e là con ecchi mosi disseminate.
Progredendo la risipola cutanea i fe nomeni vescic ali cedettero con el •minaz ione di epiteli mentre l'orina indicava una forte desquamazione della mucosa . Questa, esplo r ata al 22• gior no si mostrava ancora arrossata ma del r esto quasi normale.
Frisch qual ifica il caso come risipola di Egli riu scì a fare colture ed innesti di streptococcbi col materiale segregato dalla p r ostata e quello tolto dall'ur ina .
CBIRC RGIC.\ 987
· mpire di nuovo la ca,·ità sierosa con nuova . spelle per r•e
SI e ' . ··a via (tre 0 quattro ,·ollt>) fino ad ottenere acqua e cO!;I \1 · d lb · t
' ·d d. lavagaio interamente o quas1 ea umma o. un ltqul o l "' l d l
)'ult" a lavanda si toglie la caonula, SI c llll e a p1C· Fatta 1m · · fi · · t ' l · na croccia di colloJ10n e tutto e mto, u 1 e cola rer1ta con u ,., ' . · naere una Ie"o-era fasciatura dello è però aggiU .., .,..., · · fi tenere l'infermo a letto uno o due g iorm no a a . . · b · a l l Ile sia fin ito oani sintoma di irrJtazJone; g1acc e, m • tan o c e grado l'appar e nte innocenza del liquido di eno,·rril.ativi sono qualche volta r elativ a mente vtvl. mem Ir l · t.a L'acqua da iniettare deve essere di fr esco bo ila e asc1a raffredda re fino ai as-. .
Questo meto.Jo di cura risponde anche nel cas1 di idroceli antichissimi. L'allo operatorio una_ sem· plicità straoroinaria, purché si badi a non lasc1are distende1·e troppo la sacca our ante la iniezione e s'impedisca lo scroto ricco come è d i elementi contrattili, retraendos1 piulloslo 'vivamenlè qua ndo si sv uota, non l'estr emo della cannula dalla cavità, essendo ch1aro ch e m questo caso il liquido iniettato determina un edema artificiale Jella parete dello scroto.
RIVA. - Nuovo metodo 4t oura dell'idrocele. - (Morgagni, 1894).

Il metodo di cura dell'A. consiste nella lavatura apneumalica della vaginale del testicolo, mediante acqua disti!lata, semplice, sterilizzata ; i risultati ottenuti sono bellissimi e sempre sicuri. P er la piccola operazione è utile avere l'apparecchio dall'A. proposto per la lavatura del peritoneo e delle cavità in gener·e, appa r ecchio che come aspiratore e Javatore nulla lascia a desiderare; ma può esser sostituito, con poche aggiunte, da un trequarti di P otaio, od anche (ma meno bene) da un trequarti sem plice. Esitato il liquido d'idr ocele, mediante l'apertura del rubinetto d'immissione s i riempie la vaginale di acqua sterilizza ta; indi questa
Delle alterasloDi dl resbtenza del ml s terlll zzatl colla bollltura. - (Gazetie des Hòpitau:r, N. 91, 1893).
1 pr ofessori Forgue e Mousseret hanno fatto delle ricerche molto interessanti sulle alterazioni prodoLle dall'ebollizione sui lili di seUi adoperati in chirurgia per la legature dei vasi· o per la sutura dei tegumenti.
Ecco i risultati ai quali sono arrivati gli sper imentatori: t • La resistr,nza d iminuisce in ragione della durala dell'ebollizione:
2o La resistenza diminuisce secondo la natura della sostanza adoperala, nell'ordine seguente: acqua, sublimato, ca1·bonato.
988 Rivista
I l sul>limato altera la solidila del filo più de!l'acqua, ma però mollo meno del carbona to. Di più, questo sale ha il grande inconveniente di deteriorare molto p r es to gli istrumenti adoperati pet• la bollitura. P er cui, a cagione di questo inconveuiente ed anche dell'alterazione che esse comunicano ai fili, gli esperimenllltori riconoscono aJJe so luzioni di suDlimato un'infet•iorità rronunci ata sulracqua.
De Yesi rigellarè il carbonalo? Date le alterazioni manifeste che esso cagiona, non si può far troppo calcolo sulla solidità del filo. an che di forte calibro, quando esso abbia bollito per un certo tempo in quella soluzione.
H.imane l'acqua !JUI'a: da ciò che si conosce sperimentai· mente e clinicamente della ste ri lizzazione coll'acqua in ebollizion e, siamo autorizzati a ritenere che essa è sufficiente.
In una delle lo ro esperienze gli autori hanno visto brodi di c ultura rimanere sterili dopo essere stati seminati èon fili bollili nell'acqua, d urante otto minuti solamen te. Or a questi fili erano stati immersi nel pus dt flemmone.
Ecco le conclusioni molto pratiche alle quali arrivano gli autori:
No n vi ha a lcun vantaggio manifesto aJ adopera re soluzion i antisettiche çd alcaline per la bollitura dei fili; le garanzie di sterilizzazione non sono 11olevolmente aumentate, perché è soprattutto per il suo valore termico che il bagno d'ebol· liziooe a gisce, ed i pericoli di fr agilità dei fi li sono aumentati i u una importante proporzione dopo coltura nei liquidi alcalini.
MANLEY. - Operaslolle lncruenta delle emorroidi.- (Brit . M ed. Journ., 10 marzo 189! e Boston M ed. Jou rn. , febb ,
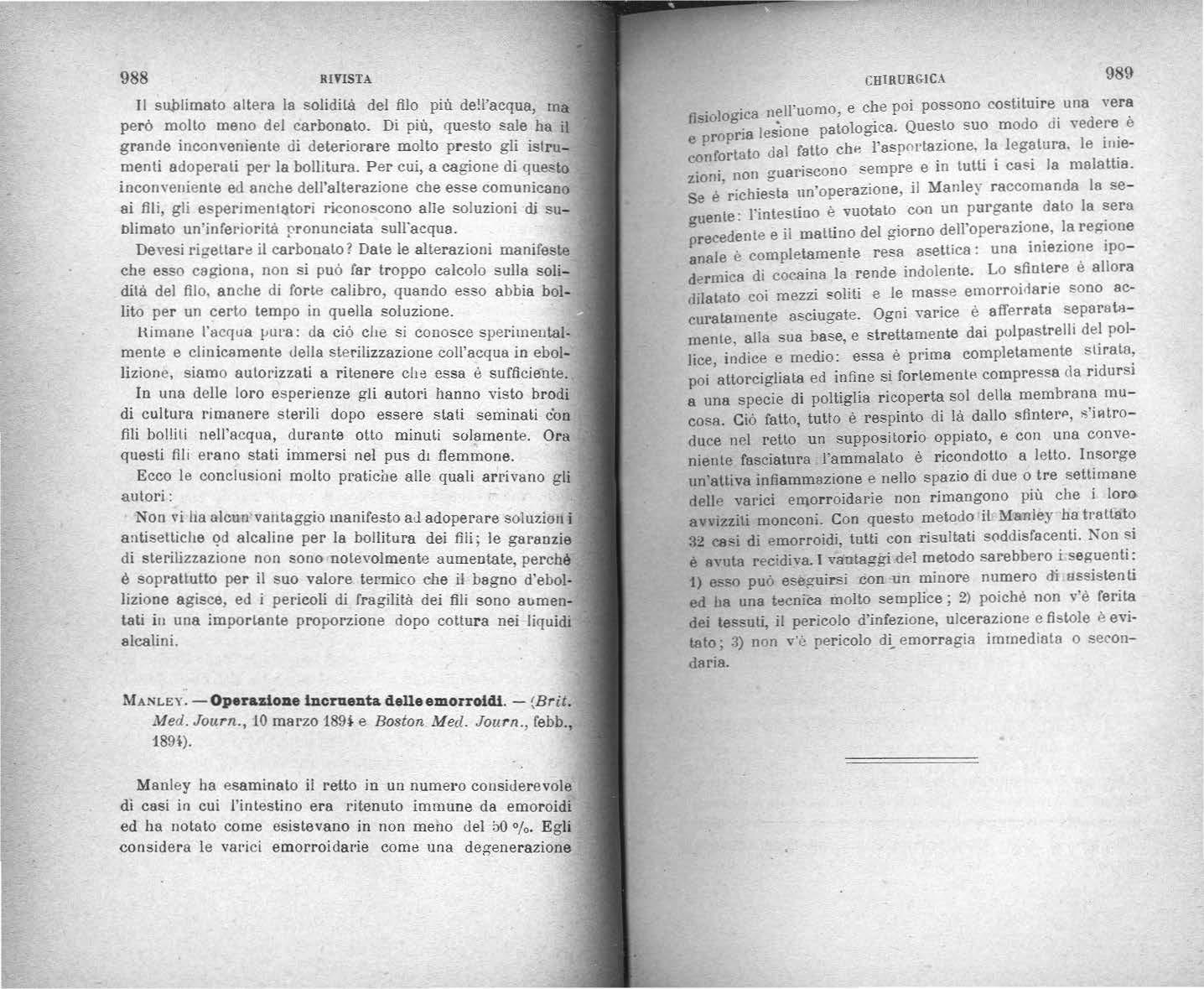
Mantey ha esaminalo il retto in un numero considerevole di casi in cui l'intestino era eitenuto immune da emoroidi ed ha notato come esistevano in non meno ùel t>O 0 /o. Egli considera le val'ici emorroidarie come una degenerazione
Chirurgica 989
!l'uomo e che poi possono costituire una vera fis1ulogiC8 ne ' · d · · 1 ··one palolo<Yica. Questo suo modo <h ve ere e e propria esi o· l t dal ratto che l'asportazione. la legatura, le 11118confor a o . . . · 1 1· rruariscono sempre e m lutti 1 C8!:1 la ma at 1a. ZIODI, non o . Se è richiesta un'operazione, Il Manley raccomanda la sel . t··ntec:.t1·no è vuotato con un p urgante dalo la ser a auen e. J" d te e il malti no del aiorno dell'operazione, la regione prece en . . . . anale è completameJ?Ie resa asellica: una Imezione •poder mica di cocaina la rende indolente. Lo é allora dilatato coi mezzi soliti e le masse emorroJIIarie sono accuratamente asciugate. Ogni varice è afferrata mente, alla sua base, e strettamente dai pulpastrelli pollice, indice e medio: essa é pi·ima completamente poi attorcigliata ed infine si compressa da r1durs1 a una specie d i poltiglia ricoperta sol della mucosA. Ciò fatto, tutto è respinto di là dallo sftnterP, :';'IAtroduce nel retto un suppositorio oppiato, e con u na conveniente fasciatura rammalalo è ricondotlo a letto. Insorge un'attiva infiammazione e nello spazio di d ue o tre settimane dell(' varici emorroidarie non rimangono più che i loro avvizziti monconi. Con questo metodo il Manley ha tl'allato :u c.asi di emorroidi, tutti con risultati soddisfacenti. Non s i è 1wuta recidi va. 1 vantaggi MI metodo sarebbero i s e guenti : t) esso pu ò esef!uirsi con -un minore numero di assistenti ed ha una tacnica molto semplice; 2) poiché non v'è ferita dei tessuti, il pericolo d'infezione, ulcerazione e fistole P evitato; :3) non v'è pericolo emorragia immediata o secondaria.
Rivista Delle Malattie Veneree Edella Pelle
Un'inchiesta americana sullo stato dell'uso tpodennt .. del merouriaU nella cura della aUlUde. - LA UREN \VoLn. - Statns oj' the Hgpodermie Use qf Mercuriat8 in the T reatment oj Sgphilis. - Philadelpltia, i89i.(Ga::zetta Medica Lomoarcla, 1894. 26 giugno).
Con questo titolo il dottor L. Wolff leggeva il 25 scorso alla Società medica di F iladelfia i risultati dell' chiesta da lui falLa a tale scopo) riguardo in modo pa · lare all'Europa. L'A. gia in una precedente lettura alla s • detta Società aveva detto che « tra i metodi tera estesamente usati sul continente europeo, ma che trovò seguaci nel continente americano è, senza la cura ipodermica della sifilide ». Ta li parole relative l'Europa incontrarono una forte opposizione, vennero vi mente discusse ed il dott. J. W. White (1) in un suo tentava confutarle. Di falto egli citava l'opfnione di 32 matologi e sifilogratì americani, tra i quali solo tre si in senso favorevole a l metodo ipodermico, mentre gh altri erano più o meno contrari; affermava ancora che in Germania taluni tra i migliori specialisti si pronunciavano contrari, e che di questo parere erano e ziandio Fournier in Francia ed Hutchinson in I nghilierra.
In seguito a tutto questo il Wolff venne nella determina· zione di fare, per conto suo, un'inchiesta più gene rale ed estesa a tutta l'Europa, e ciò a sostegno della shrriferi ta asserzione. Xella relazione egli spiega e considera nel suo
RIVJSTA DELLE MAL...\TTIE VENEREE E DELLA PELLE
giusto ,a}ore il metodo ipodermibco, aUri metodi di cura; lo difende con uom argomenti ag 1 attacchi più o meno fond ati a cui venne fatto segno; !amen la che i medici americani si occupino troppo poco della lelteratura med ica che non sia in lingua inglese, dice che in Europa la medicina b a due grandi scuole, la francese e la tedesca, grandemente diverse Ira loro nelle dottrine co me lo sono per la lingua ; afferma essere Vienna il più gran centro di sifilologia de!.l' Europa tedesca e r iferisce infine le risposte fatte al questionario da lui proposto ai sitìlografi di tutte le nazioni, per avere così un consenso generale di pareri, e non gia quello di un sol paese o di una sola scuola. Gli interrellali, tra pratici e professori delle princi pal i Università d'Europa, furono 44 e tra gli italiani figurano il Pellizzari di Firenze, il Campana di Genova, il Breda di Padova, il Gamberini di Bologna, lo Scarenzio di Pavia, il Ferrari di Catania ed il Barduzzi di Siena.
11 quesiti proposti erano dieci, ed erano cosi concepili : ottenne risposta abbastanza categorica la quarta que· slione cosi espressa: Quale, secondo la vostra opinione, è d'azione più rapida e d'effetto più duraturo? Di fatto sette risposero in modo evasivo e dubbio, nove però preferiscono il calomelano, meutre due dichiarano essere più rapido il sublimato, ma più duraturo il calomelano, gli altri diedero risposte diverse.
Prèmo: Usate la cura ipodermica per la sifilide? Ora su -H 1 36 risposero affermativamen te, gli altri otto in modo negativo più o meno reciso; sicché nelle successive risposte hi!=:ogna calcolare sui soli 36 favorevoli.
Secondo: Quale dei mercuriali usate principalmente? Risulta dalle risposte che il più usato è il sublimato1 q uindi il calomelano e poi decrescendo il salicilato, l'ossido giallo, il sozojodolato e l'olio grigio.
Dal terzo: Quali dei mercuriali preferite : i solubili o gli insolubili? si rileva che 20 stanno pei primi, 11 pei secondi, uno è indeciso, due indifferenti e due a seconda le indicazioni.
Alla quinta domanda: Usate il metodo ipodermico come
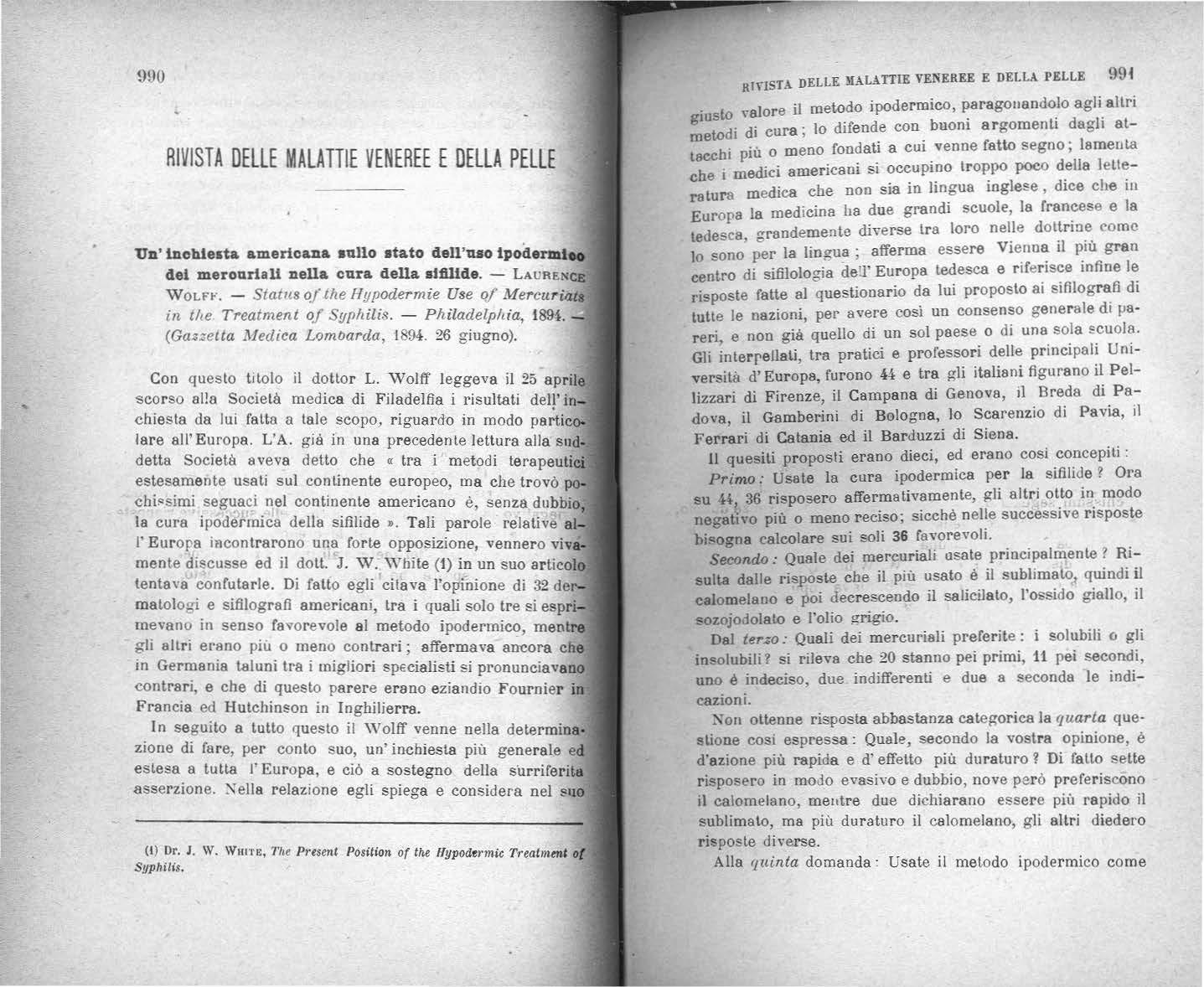
992 !li VISTA cura generale della sifilide? be n ventisei att·Prmm._ tivamente, il resto in modo evasivo o non completo.
II s!sto quesito era : Quanto tempo in media la cura ipoòermica? Qui è molto d ifficile riassumere le varie t·isposte, ma la maggior parte riferisce che usa la cura fino a scomparsa completa sinto mi .
Alle settima domanda : Quali inconvenienti e dannosi effell', se pur ne aveste, vi ha dato il metodo ipodermico nella vostra pratica ? la maggior parte (23) rispose di non averne a\'ulo sia coi sali solubili che cogli insolubili; altri invece ri· portano casi di ascessi, stomatiti, entero-coliti, ecc.
Invece all'ottava questione: a se il metodo ipodermico sia ben stabilito • cJUatlro l'ispondono evasivamente, uno non risponde, e tre credono non lo sia ancora, ben ventotto sponclono esserlo fermamente.
.Vono quesito : Credete voi che tal modo debba continuato ori abbandonato quale cura regolare della Jide? Tren ta danno una categorica risposta in ::;enso revole, gli allri sei o non rispondono o lo fanno in modo indeciso.
Alla decima ed ultima domanda : Credete Yoi che tal todo abbia J i gran lunga superato l'amministrazione del curio per bocca nella cura della sifilide? Ventitrè risposero si, cinque evasivamente, mentre sette non lo credono.
Distribuendo geograficamente le risposta avute, H vennero dall' Austria, 6 dalla Germania, 4 dalla Russia, 1 dall'Olanda, 7 dall'Italia. 2 dalla Svizzera, 5 dall' 2 dal Belgio ed 1 dall' America. Risulta pvi dall'esame di esse che l'iniezione ipodermica è poco in voga in Inghilterra ed in FranCia, fatto dovuto, secondo il Wolff, all'influenza del H utchinson per l'una e del Fournier per l'allra. La scuola ital iana segue sempre il metodo Scarenzio, mentre che i russi e gli olandesi sembra che seguano i pratici germanici ed austriaci, i primi ll·a i quali sono favorevoli al metodo ipodermico, mentre i secondi non ne sembrano troppo caldi sostenitori.
In seguito ai suesposti risultati dell'inchiesta si crede
DILLE l!ALATTIE VEXEREE K DELLA PELLB
quithll il Wolff autorizzato ad enuneiare le seguenti v>n - t• L'uso ipodermi co dei mercu riali è larjlam en te u;;ato per lA cura della sitllide nell'Europa continentale, con probabile esclusione della Ffancia (1) . l' Le opinioni dei corrisponden!i riguardo gli incoo,·enienti ed effetti nocivi della cura dimostrerebbero che questi non sono cosi frequenti e così seri come venne e che più frequenti colle preparazioni insolubili e colle !"Oiubili. Pat·e anche essere opiuione generale della magdei corrispondenti che si possono evi tare complicazioni con cure adatte e pulizia. La testimonianza d1 i ochi indh·idui pat·e soLto questo rapporto molto io contrad<Jizione cCIII" esperienza dei più. Gli accidenti che pos'-'Ono derivare dall'uso di tutti i metodi di mercurializzazinn , non si possono attribuire in special modo alla cura ipor!crmica.
2o che tutti tra i vari preparati me rcu1·iali si u"ano per questa cura, il preferito é il su blimato; ' 'eogono il calomelano., quindi il salicilato, seguito dall' os,ido g1allo, dal sozojodola lo e dall'olio g rigio. Gli altr·i dono prt:fet·enze individuali.
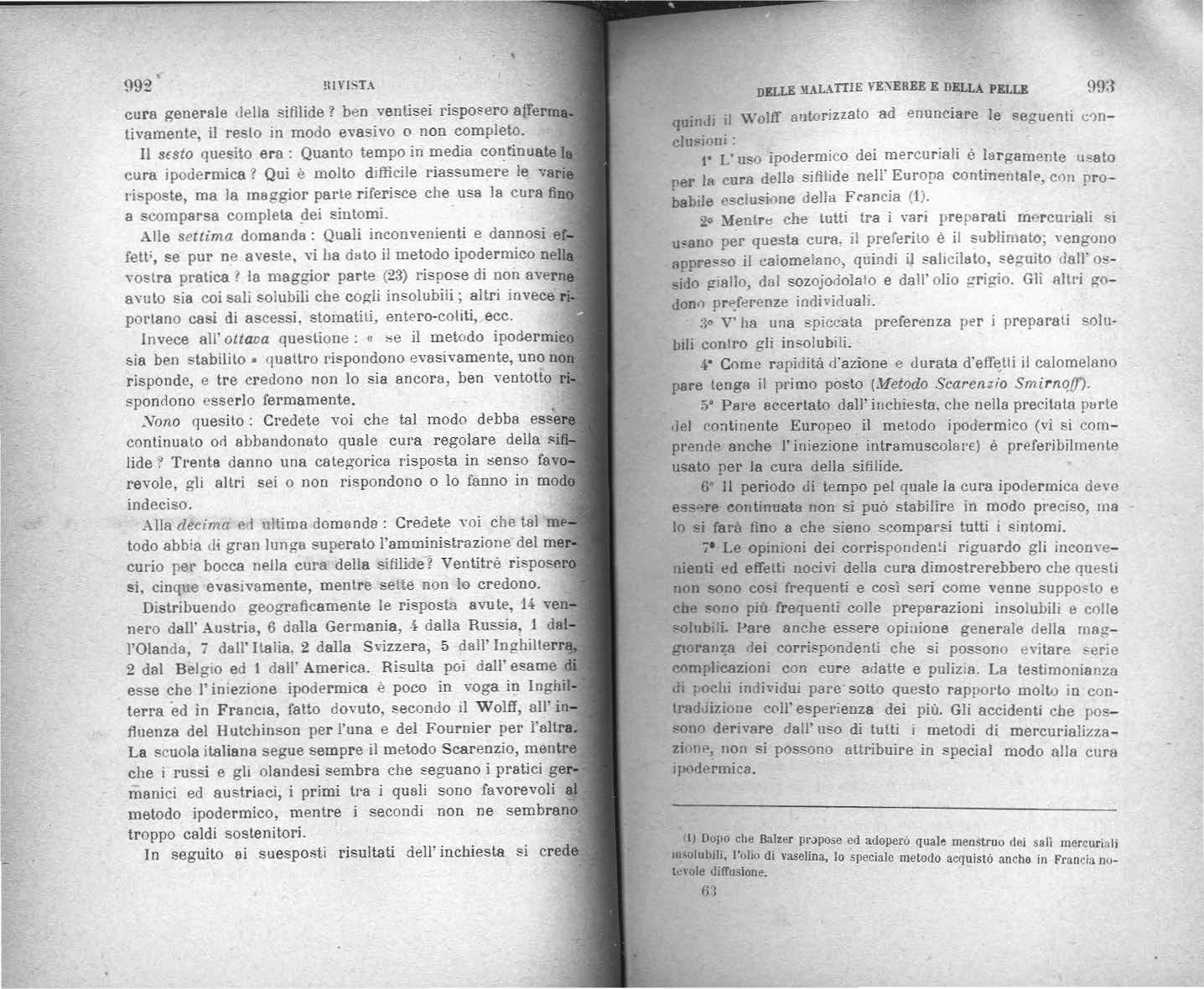
:lo v· ha una spiccata preferenza per i preparali solu· bili contro gli insolubili.
4• Com e rapidità d'azione e durata il calomelano pare tenga il primo posto (.'ld'etodo Scarenzio Smi rn oJf).
:>• Pare ac.certato dall'inchiesta, che nella precitata p11rte .Jel ro:ltinente Europeo il metodo ipoùermico (vi si comprendi' anche l'iniezione intramuscolar'€) é preferibilmente usato per la cura della sifilide.
6' Il periodo di tempo pel quale la cura ipodermica de,·e continuata non si può stabilire in modo preciso, ma lo ,-j farà tino a che sieno scomparsi tutti i sintomi.
RIVISTA
s- La questione se il metodo ipodermico sia posto o ra su solide basi ottenne una risposta affermativa q uàsi gt>nerale. ·
!Jo Il consenso delle opinioni dei corrispondenti se il metodo ipodermico sia da continuarsi od abbandona r si, quale cura regolare, della sifilide, è pressoché universalmente espresso dal desiderio che tale metodo ven ga continuato, per quanto una debole minora nza vi imponga taluue limitazioni o restrizioni. .
10" Pare quindi fuori di dubbio, da lla natura delle risposte ricevute e citate sopra, che l' A. era giustificato nell'afi'tlrmare tempo fa che « nei principali centri medici dell' Europa continentale si somministrano inter namente piccole o nessuna dose di mercurio per la cura della sifilide ,. ma che nel suddetto continente la cura ipodermica ha superato di gran lunga l' ingestione orale.
G. BERGONZOLI.
LORAND. - T.raUamento delle ulcerl molli col calore.(Brit. Med. Journal, 11 nove mbre 189:3 e W ien. med. Woeh.,. iO, 1893).
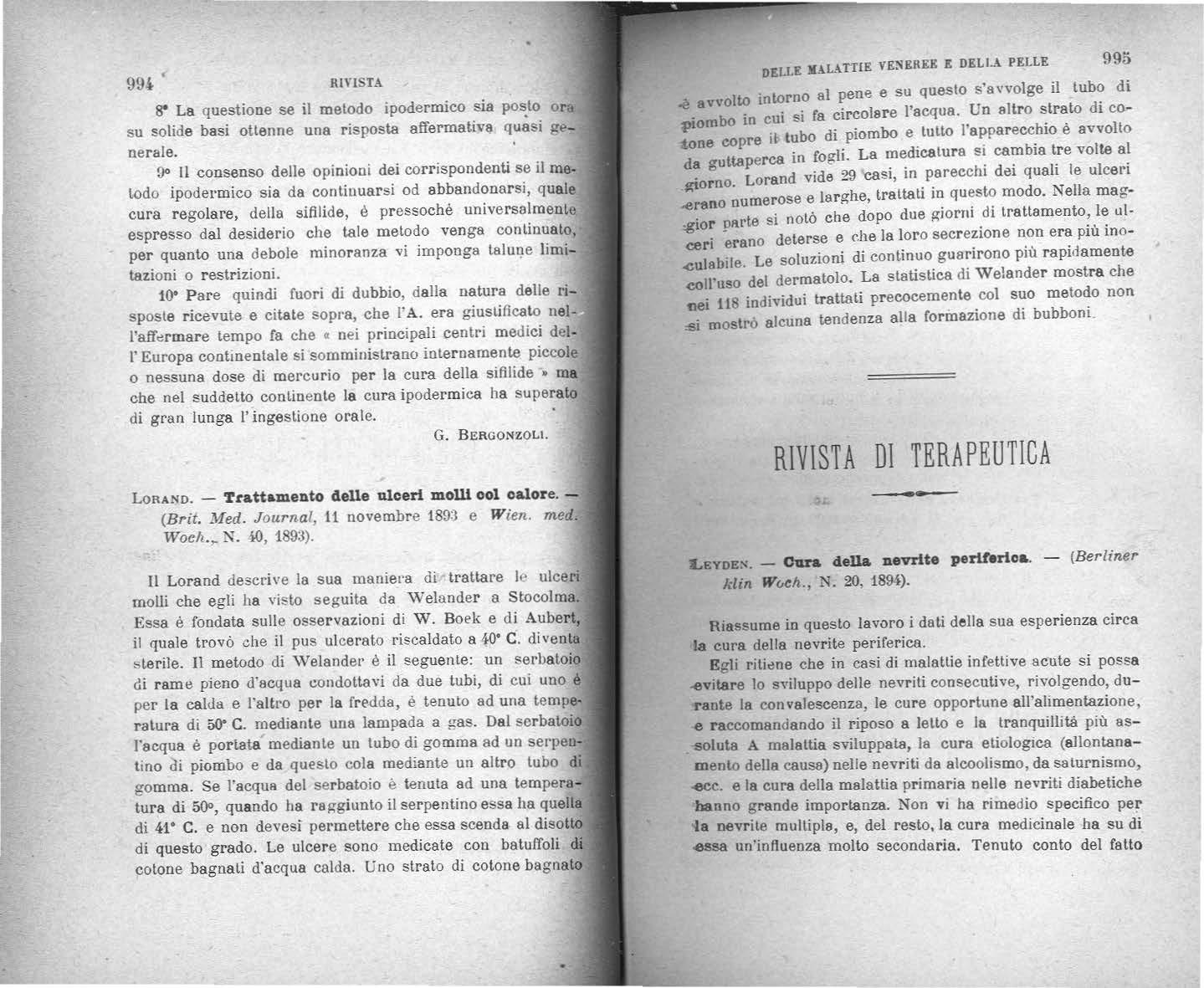
Il Lorand descri ve la sua manieea di trattare le ulceri molli che egli ha visto seguita da \Velander a Stocolma. Essa è fondata sulle osservazioni di W. Bo ek e d i Aubert il quale trovò che il pus ulcerato riscaldato a 40• C. dive nt; 5terile. Il metodo di \Velander è il seguente: un serbatoio di rame pieno d'acq ua condottavi da due tubi, di cui uno è per la calùa e l'altro per la fredda, è tenuto ad una temperatura di 50" C. mediante una lampada a gas. Dal serbatoio è_ portata mediante un tubo di gomma ad un se1·peotmo (h pwmbo e da questo cola mediante un a ltr o tubo di gomma. Se l'acqua del serbatoio è tenuta ad una te m peratura di 5Qo, quando ha raggiunto il serpenti no essa ha quella di 41• C. e non devesi permettere che essa scenda al disotto di questo grado. Le ulcere sono medicate con batuffoli di cotone bagnali d'acqua calda. Uno strato di cotone bagnato
DELLE JIIAL.HTlE VE!'iEREE E DELLA PELLE 995
-é a v,·olto intorno al peol3 e su questo s'a vvolge il tubo di piombo in cui si fa circolare l'acqua. Un al tro strato di cotone copre il tubo di piombo e tutto l'apparecchio è avvolto da guttaperca in fogli. La medicatura si cambia tre volte al Lorand vide 29 casi, in parecchi dei quali le ulcerì -erano numerose e larghe, trattati in questo modo. Nella ma gpllrte si notò che dopo due giorni di trattamento, le ulceri erano deterse e che la lor o secr ezione non era più inoLe soluzioni di continuo guarirono più rapidamente eoll'uso del dermatolo. La statistica di Welander mostra che nei 118 indi\'idui trattati pr ecocemente col suo metodo non :Si mostrò al cuna tendenza alla fo rmazione di bubboni.
Rivista Di Tera Peutica
LevoE:-o. - Cura della uevrUe perlterlc&. - (Berliner klin W c..ch., N. 20, 1894).
Riassume in questo lavoro i dati della sua esperien za circa la cura della nevrite periferica . rilidne che in casi di malattie infettive acute si possa lo sviluppo delle nevrili consecutive, rivolgendo, d urante la convalescenza, le cure opportune all'alimentazione e raccomandando il riposo a !ello e la tranquillità più soluta A malattia sviluppata, la cura etiolog1ca (al lontanam ento della causa) nelle nevriti da alcoolismo, da salurnismo, -ecc. e la cura della malattia primaria nelle nevriti diabetiche banno Non vi ha rimedio specifico per la nevr1te mulllpla, e, del resto, la cura medicinale ha su di un'influenza molto secondaria. Tenuto conto del fatto che il reumatismo non di rado rappresenta un fattore etiologico, si sono usati il salicilato di sodio ed altri farm aci anti -reumatici; ma, nella mag,.;ioranza dei casi, sènza risultato. L'ioduro di potassio rende servigio in qualche caso; il mercurio è di dubbia utilita. L'antipirina, la fenacetin a, l'esalgina, l'euforbia ed il bleu di metilene qual<'he volta proficui ad attutire il dolore; ma spesso non bastano,. e convien ricorrere alla morfina , al cloralio, ar solfonale,
La stricnina, un tempo adoperata largamente ma poi duta in disuso, merita di essere tentata. Accrescendo l'eccitabilità dei muscoli lesi, essa ne favorisce il l'ilorno alla normale nutri;:ione e funzione. ·vi si deve ricorrere segnatamenle nelle forme progressive, in cui sono minacciati i muscoli della respirazione. L'A. preferisce usarla per iniezioni ipodeJ•micbe, alla dose di milligrammi, due volte al giorno.
Il massaegio ed i bagni sono potenti coadiuva!l ti, indicati specialmente nelle f&si tardive della malattia. Molta importanza ba pu1·e la cura igienica generale. Nelle prime fa"i è da il riposo a letto. Nelle tardive , giova svegl iare le energie latenti dell'infermo, incoraggiarlo si moto attivo e sottoporlo ai passivi, e corroborarne l'orgarÌismo con un'opportuna alimentazione.
L'elettricità, un tempo usata troppo, oggi è usata .troppo poco; ma la sua utilità è grandemente limitata dal fatto che in m?lti casi il dolore da essa prùdollo è cosi vivo da non permettere che se ne continui l'applicazione.
.E1feW terapeutlol della elettrizzazione diretta dello stomaco. - M. EtNHOR:-1. "- ( D eut. med. WQehens. e Centralb. fu r die med.' Wissensch, N. 9, 1894).
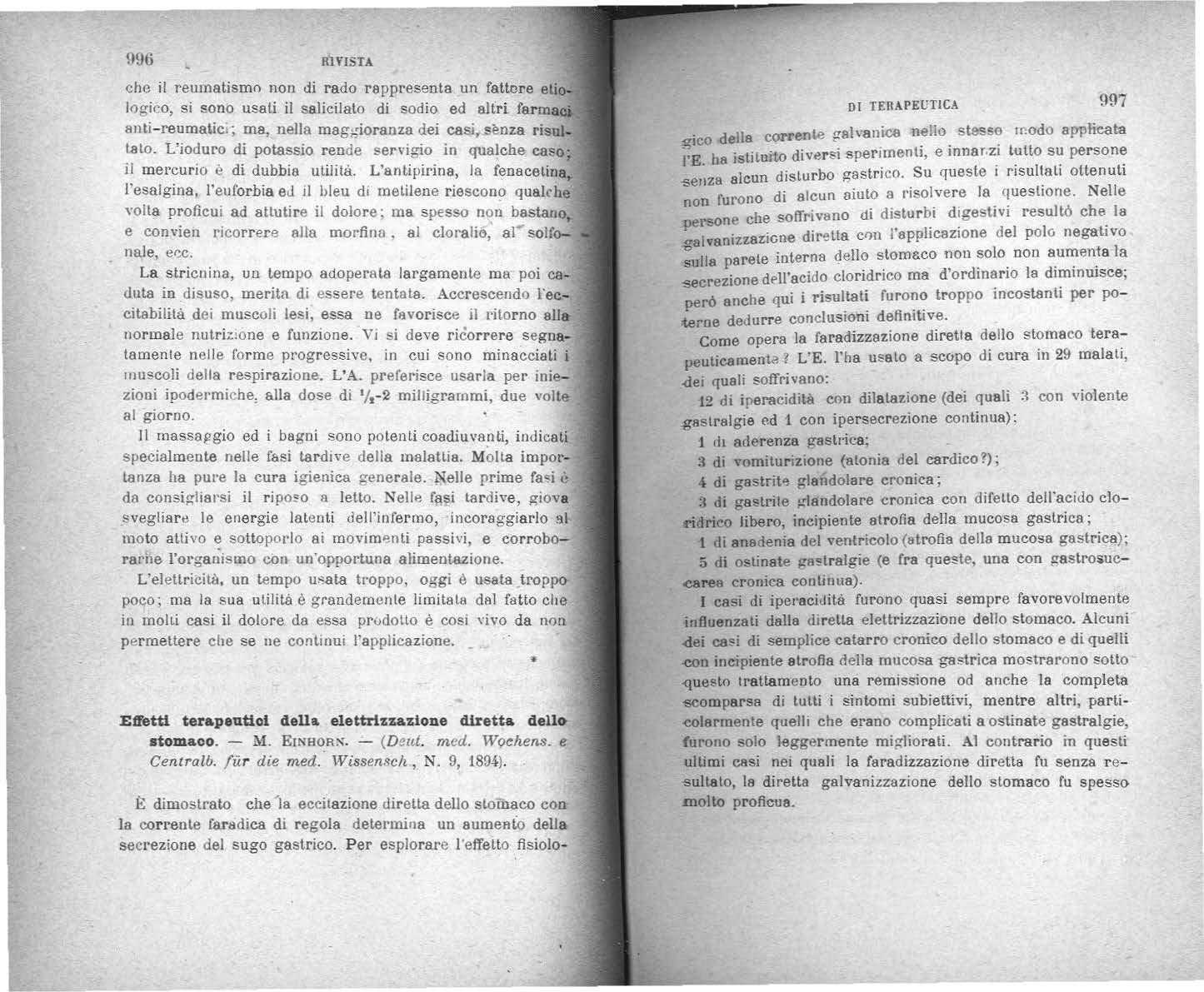
È dimostrato che ' la eccitazione diretta dello stomaco con la corren te fa radica di regola determina un aumeHto della secrezione del sugo gastrico. Per esplorare l 'effetto
Di Terapeutica 997
della cOJ'l'enle frah·anice nello stesso mod{) applieata rE. ha istitutto diversi sperimenti, e innar z.i lcun dl.sturbo aastrico. Su queste l rJsultaLl ottenuti -senza a , . furono di alcun aiuto a risolvere la questione. Nelle non · · ul ò h l e che soffrivano di disturbi d1gest1V1 res t c e a person • . . . aalvanizzaz.icne diretta CI)Jl l apphcaz10ne del polo negat1vo ;ulla parete interna çello stomaco non non a.ufl_len:a la -secrezione drll'acido cloridrico ma d'ordmar10 la pe•·ò anche qui i risultati furono troppo incostanh per pocteroe dedurre conclusioni definitive.
come opera la faradizzazione diretta dello stomaco terapeuticameota? L'E. l'ba usato a scùpO di cura in 29 malati, -dei quali soffrivano:
12 di iperacidità con dilatazione (dei quali 3 con violente gastralgie f\d 1 con ipersecrezione continua):
1 d1 aderenza gastrica;
3 di 'fomilurlzione (atonia del cardico ?) ;
4 di cronica;
:1 di gastrite glandolare cronica con difetto dell'acido cloridrico libero, incipiente atrofia della mucosa gastrica;
1 di snadenia del ventricolo (atrofia della mucosa gastrica);
5 d i oslinate (e fra queste, una con carea cronica continua).
1 casi di ipe1·acidità furono quasi sempre favorevolmente influenzali dalla diretta elettrizzazione dello stomaco. Alcuni -de i ca"i di semplice catarro cronico dello stomaco e di quelli -con incipiente a trofia della mucosa fr<istrica mostraro no solto <Jueslo trattamento una remissione od anche la completa -scomparsa di tulti i sintomi subiellivi, mentre altri, parti-colarmente quell1 che erano complicali a ostin ate gastralgie, furono solo leggermente migliorati. Al contrario in questi ultrmi casi nei quali la faradizzazione diretta fu senza re-sultato, ls diretta galvanizzazione dello stomaco fu spesso molto proficus.










