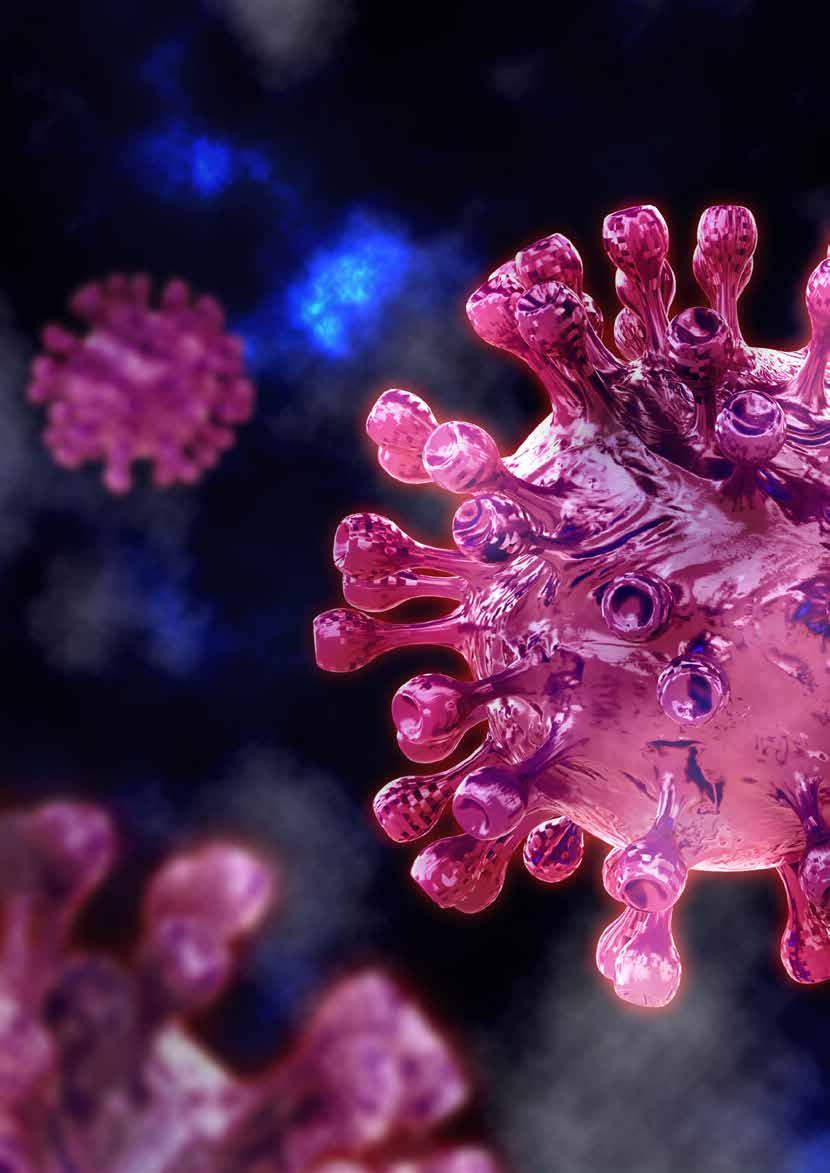6 minute read
Nuove vulnerabilità e fragilità sociali dopo l’emergenza coronavirus
Intervento - Ketty Vaccaro * Nuove vulnerabilità e fragilità sociali dopo l’emergenza coronavirus
Parlare delle nuove vulnerabilità e fragilità sociali dopo l’emergenza COVID-19 significa trattare un tema ampio, complesso e difficile che si può tuttavia inquadrare con il supporto di alcuni dati ed elementi significativi, i quali non esauriscono certo la vasta dimensione delle fragilità sociali ed economiche del nostro Paese ma ben ne possono spiegare alcune caratteristiche essenziali. Innanzitutto, dobbiamo chiederci che cosa rende particolarmente complessa l’emergenza che stiamo attraversando. E la risposta risiede nel fatto che essa ha conseguenze che non sono solo sanitarie, ma anche economiche, sociali e psicologiche, a tal punto che addirittura in certi momenti il dibattito pubblico ha visto quasi contrapporsi l’interesse economico a quello sanitario collettivo.
Oggi noi assistiamo a un intreccio fra vecchie e nuove fragilità che s’intensificano e che sono fra
loro connesse. Ma l’elemento di specificità che si va a sommare é che l’Italia si muoveva in una situazione particolarmente problematica già prima dell’epidemia. L’intreccio delle conseguenze che l’epidemia ha comportato s’inserisce quindi in un contesto assolutamente difficile nel caso italiano, proprio in riferimento alle fragilità e alle vulnerabilità sociali. A dimostrazione di questa argomentazione, si parta da un dato economico emblematico, quello sulla povertà. E’ importante evidenziare come negli anni della crisi si fosse già assistito a un più che raddoppio delle condizioni di povertà estrema in termini di incidenza sul totale delle famiglie (da 3,5% a 7,0%) che, in valore assoluto, sono passate da 800mila nel 2007 a 1,8 milioni nel 2018.
Un dato che include differenze storiche che ci portiamo appresso e non ancora eliminate – su tutte senz’altro il gradiente Nord-Centro-Sud- ma insieme anche ad un mosaico di fragilità specifiche che deve necessariamente essere tenuto in considerazione.
Prendendo come indicatore la povertà assoluta, il dato nazionale del 7,0% diventa 10,0% al Sud, ed è noto. Ma all’interno della stessa condizione di povertà si rispecchiano ulteriori fragilità, specifiche di alcune determinate situazioni, come, ad esempio, le famiglie monogenitoriali (11,0%), le famiglie numerose con 3 o più figli minori (19,7%), le famiglie di soli stranieri (30,3%) e le famiglie con capofamiglia con basso titolo di studio (10%), ove noi sappiamo che le risorse individuali sono fondamentali per garantirsi l’accesso alle risorse economiche. C’è un problema di mappa generazionale della povertà che è profondamente cambiata nell’arco di questo decennio di crisi. Se prima coincideva sostanzialmente con la condizione di anzianità, oggi la situazione è completamente ribaltata: l’incidenza di povertà nelle famiglie con capofamiglia di età compresa tra i 18 e i 34 anni è pari al 10,4% contro il 3,2% di quelle con anziano, che può anche avere un reddito basso ma garantito dalla pensione. Il dato noto è che nei nuclei famigliari ove il capofamiglia é in cerca di occu-
pazione l’indicatore è pari al 27,6%, ma qual è il dato meno noto su cui innestare la riflessione, dal momento che rappresenta, tra l’altro, il rischio specifico della situazione che stiamo vivendo? Senz’altro il fenomeno dei working poor: anche nelle famiglie in cui il capofamiglia è operaio l’incidenza della povertà assoluta raggiunge il 12,3%, mentre nel 2007 era solo dell’1,7%. Questo significa che, se prima della crisi economica del 2008 l’occupazione poteva in larga misura rappresentare una garanzia di reddito, oggi le difficoltà economiche che il Paese ha vissuto e tuttora vive e la precarizzazione del lavoro hanno determinato una drastica riduzione di sicurezza, causando, tra l’altro, un ampliamento della forbice relativa alle differenze di reddito. E questa situazione non potrà che peggiorare a causa del COVID-19. Volendo poi fare riferimento più specificamente al tema della salute nelle città, bisogna porre l’accento sulle specificità territoriali. Non solo le differenze relative alla variabile Nord-Sud che non riusciamo a sradicare, ma anche le differenze di contesto, del luogo in cui si vive sono rilevanti: sono proprio queste ultime che ci mettono di fronte a maggiori o minori possibilità, in termini di accesso differenziato alle risorse. Il fatto di vivere in un nucleo urbano con specifiche caratteristiche ha un impatto diverso sulla condizione individuale: la grande area metropolitana del Sud aggrava le condizioni di povertà, il rischio di povertà, la vulnerabilità, una condizione sociale più deprivata, mentre in altri contesti funziona diversamente. Nelle metropoli del Centro, come ad esempio Roma, sono le periferie ad avere una maggiore difficoltà. La specificità dei contesti impatta dunque fortemente sulle condizioni di vita e di salute delle persone. Un esempio importante: sono 8 milioni e 500 mila (il 33%) le famiglie unipersonali (il 40% nelle città centro dell’area metropolitana) e di queste poco meno della metà sono di anziani che vivono soli (15,7% delle famiglie). Le famiglie unipersonali di over 64enni sono distribuite in modo diverso nelle varie realtà urbane. Il problema degli anziani soli si riscontra con maggiore frequenza anche nei comuni più piccoli, fino a 2mila abitanti. Per questo, la realtà territoriale è importante da conoscere, analizzare, affrontare in modo specifico.
Richiamare il grafico ISTAT sulla linea della povertà serve a mostrare che oggi siamo in un momento in cui questa soglia si rende del tutto permeabile e il rischio è che alcune persone precipitino al di sotto, che i “quasi poveri” più o meno inavvertitamente scivolino al di sotto di essa. La stima Caritas parla di circa 200mila persone che dell’ultimo mese e mezzo sarebbero già scivolate sotto questa linea di povertà. Ma ancor più rilevante, in questo momento di emergenza, è parlare dell’intreccio di condizioni, del legame fra fragilità sociali, economiche e sanitarie. Il livello d’istruzione, utilizzato come proxy del livello socio-economico complessivo, impatta in maniera consistente, facendo emergere quasi dieci punti di differenza, a parità di età, tra persone laureate anziane e persone anziane con il livello di istruzione più basso che si dichiarano cronici in buona salute. C’è pertanto un problema di vissuto della cronicità che è strettamente correlato dalle condizioni socio-economiche individuali.
E questo vale anche nel caso del COVID-19. Non è vero che sia una “livella”: se parliamo di contagio forse il virus appare più democratico, a livello di conseguenze negative lo è molto meno. Il 61% delle persone che sono decedute aveva almeno tre patologie croniche concomitanti. E non è solo un problema di età, bensì di fragilità vere e proprie. Un vissuto più problematico comporta una doppia penalizzazione: il rischio di incappare nelle conseguenze più gravi della patologia infettiva e
il rischio di una gestione quotidiana più problematica della patologia cronica, che sappiamo essere differente a seconda dei determinanti di partenza e e con un impatto differenziato. Alcuni modelli di gestione della cronicità nella popolazione anziana, come le RSA, hanno - come già si evidenziava da anni - fatto il loro tempo; oggi dobbiamo mettere mano a questa problematica in modo più diretto, immediato ed efficace. “Più che l’età poté il reddito”, potremmo dire. Se, infatti, guardiamo alle persone con diabete a Roma, i risultati dello studio CCD mostrano la maggiore incidenza del diabete nelle periferie, anche se le zone periferiche sono abitate da cittadini più giovani. Questo dipende anche dal fatto che la struttura dei servizi è diversa, è più rarefatta, più difficoltoso l’accesso anche a causa di problemi di mobilità e probabilmente insufficiente. Di nuovo il contesto, insieme al livello socio-economico, incide fortemente sulla condizione di salute e di rischio.
Oggi abbiamo la necessità di agire nelle città, a partire dal grande vantaggio di poter operare in maniera intrecciata, integrando le risorse a disposizione e contando sul valore della prossimità e della tempestività di intervento. È l’unica strategia efficace per combattere la dimensione economica e sociale ma anche sanitaria della fragilità.
* Direttore Area Welfare CENSIS