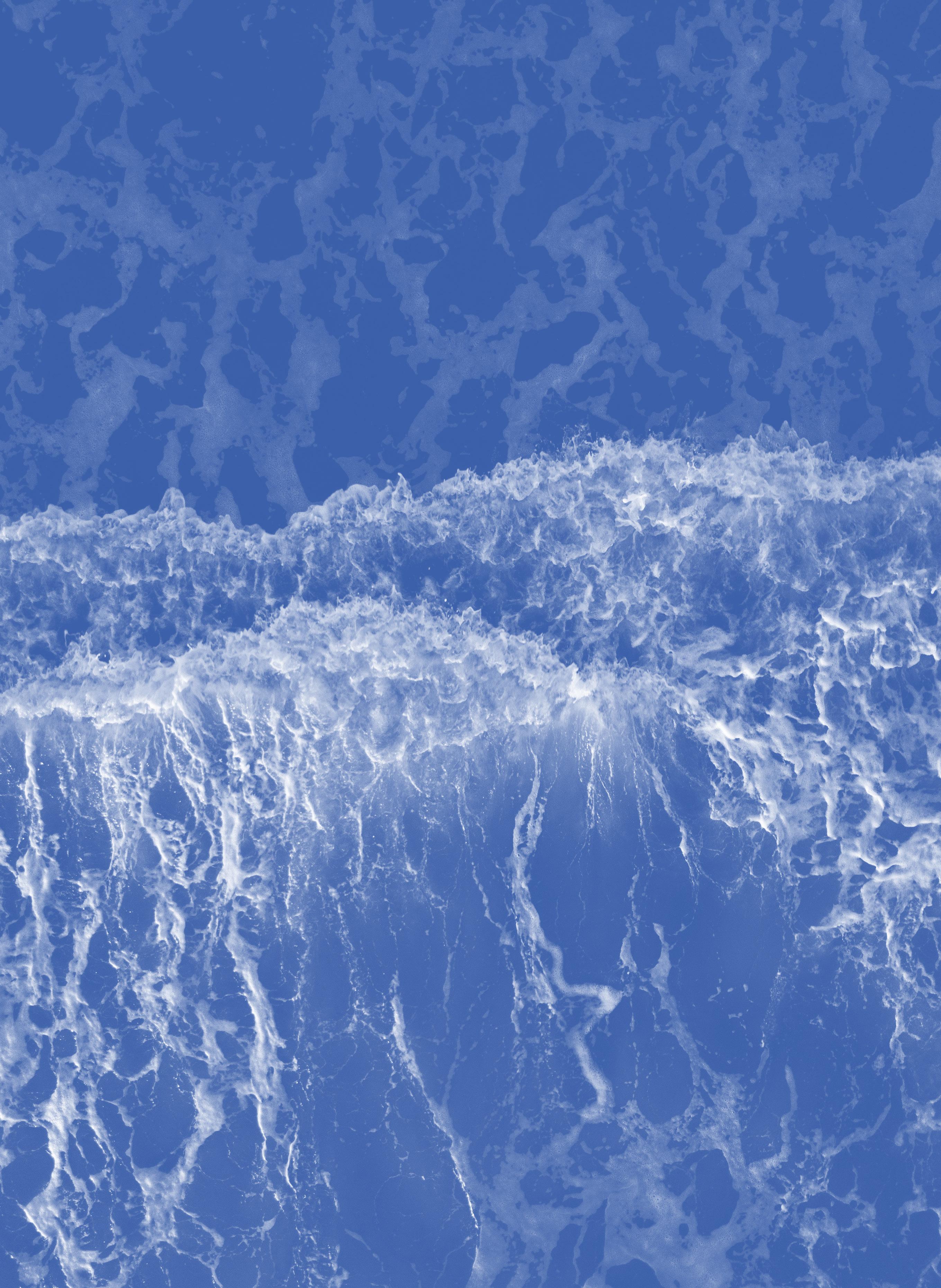intervista a Stefano Schirato: “Senza voltarci indietro”
Capitano mio capitano di Filippo Polenchi
Se mi ami, vieni con me di Riccardo Meozzi
Catabasi di Elena Giorgiana Mirabelli

viaggio
issue
luglio 2023
—
n°6
Contributi di Riccardo Meozzi
Elena Giorgiana Mirabelli
Inediti di Demetrio Marra
Intervist a Stefano Schirato
Racconti di Filippo Polenchi
Maria Colella
Illustrazioni di Antonio Cammareri in copertina / @ cammamoro su ig
Coordinatore editoriale
Massimo Salvati
Direzione artistica
Francesca Crescimone
Amministrazione
Filippo Dodero
Community manager
Matteo Glendening
Redazione
Chiara Rotondo
Martina Cofano
Chiara Scatena
Maria Colella
Daniele Costantini
Giorgia Ciolli
Chiara Schirato
Anna Battista
chi è palin?
Palin è la storia di un piccolo pesce rosso che, un giorno, decide di uscire dalla sua piccola boccia di vetro, scoprendo che il mondo non è fatto di spazi chiusi e a sé stanti, ma da un unico mare che sfiora ogni costa; con la voglia di ‘tornare’ (palin dal greco significa infatti ‘di ritorno’) a parlare liberamente, con tutti e di tutto, senza barriere, senza limiti.
Palin è un progetto di divulgazione culturale, di dialogo e confronto sul mondo, diviso in quattro aree – arte, letteratura, scienza, società – che ogni mese affrontano uno stesso tema, attraverso le tante penne che costituiscono il progetto.
indice↘ Tornare al punto di partenza, vedere il luogo per la prima volta di Massimo Salvati in dialogo con Edoardo Rialti 04 Stefano Schirato: “Senza voltarci indietro” di Chiara Rotondo 10 Stranieri che conosco. Viaggio nella produzione di Claudia Durastanti di Anna Battista 24 Se mi ami, vieni con me di Riccardo Meozzi 08 Catabasi di Elena Giorgiana Mirabelli 20 La gamba storta di Maria Colella 30 Capitano mio capitano di Filippo Polenchi 28 Inediti di Demetrio Marra 26 Il viaggio di due anime. PalinLegge «Anna sta coi morti» di Daniele Scalese. di Chiara Scatena 22
Tornare al punto di partenza, vedere il luogo per la prima volta
4 palin issue 06
in Dialogo con Edoardo Rialti
di Massimo Salvati
MS: Immagino quello di oggi come un viaggio apolide; geografico nell’attraversamento dei confini; immaginifico nel suo aprirsi a un nuovo canone, che accoglie echi di porti lontani, migliori perché stranieri.
E.R: Dire viaggio e dire letteratura è in fondo il medesimo prisma. A me fa sempre piacere ricordare una delle esperienze per me fondamentali, che getta luce su altri processi di rapporto con la narrativa e la poesia: la traduzione, la transizione, la traslazione, il trasporto. Sono tutti termini che hanno a che fare con un movimento, da A a B. Mi ha sempre fatto sorridere come la parola trasporto in alcuni dialetti italiani è quella con cui ci si dichiarava un tempo: “Signorina, io porto per lei un certo trasporto”, ma è anche il carro funebre in alcuni dialetti, penso al romagnolo. La lettura è sempre trasporto e il viaggio è compiuto quando c’è un lettore che lo completa, lo integra, lo porta nel suo cosmo immaginativo. Lettura e scrittura sono esperienze di trasporto, di movimento. Andando sui testi su cui lavoro, l’immagine più bella è quella dei primi capitoli dello Hobbit di Tolkien. Inizia con una dimensione metaletteraria: c’è Bilbo che non vuole partire per un’avventura, le definisce “brutte e sgradevoli cose che fanno fare tardi a cena". Arrivano questi nani, questi migranti, questi nomadi nella sua casa e gli spazzolano tutto.
È un’invadenza, ed è anche questa un’immagine metaletteraria: le storie arrivano e prendono degli spazi che noi per primi forse non vorremmo accordargli. E fino a quel momento Bilbo li sta semplicemente subendo. Non è desideroso di partire
con loro. Non basta l’enunciato, la comunicazione di un’esperienza per rendercela interessante. Però succede una cosa. I nani dopo cena si mettono a cantare.
Cito letteralmente: “E mentre cantavano, qualcosa che gli veniva dai Tuc toccò il lato pazzo della sua famiglia, si ridestò in lui il desiderio di andare a vedere le grandi montagne, pire, i pini e le cascate, impugnare la spada”. Il risveglio dei 5 sensi. “Vedere”, “udire”, “impugnare”, e poi dice, “Guardò fuori dalla finestra”, e questa frase è una frase semplicissima; potrebbe scriverla anche un bambino, ma incastonata lì testimonia che Bilbo è già partito. Non importa uscire di casa. Il moto introdotto dall'esperienza artistica, il canto, è già un movimento che ci fa guardare il noto pensando all'ignoto. Infatti, Bilbo guarda fuori dalla finestra, vede le stelle e pensa ai gioielli dei nani, vede un fuoco e pensa al fuoco del drago. La cosa interessante è che questo movimento, innescato dall'arte dal noto all'ignoto, ha poi il suo necessario completamento alla fine con gli elfi che cantano: “Tutto, le stelle sono più lucenti dell'argento, il fuoco di casa è più luminoso dell'oro”, perché è solo quando hai fatto il viaggio verso l'ignoto che torni verso il noto e lo riscoprì, come diceva T. S. Eliot: “Al termine di tutto il nostro viaggiare sarà tornare al punto da cui eravamo partiti e conoscere il posto per la prima volta”, e questo mi sembra, mi sono sempre sembrate alcune delle dinamiche, almeno per me, fondamentali dell'esperienza narrativa.
M.S: Il movimento avviene anche quando lo evitiamo. Le storie così come la realtà non si possono
5 viaggio issue 06
Il viaggio di Palin si apre con un dialogo sul tema di questo mese insieme a Edoardo Rialti, (Firenze, 1982). Di formazione italianista e comparativista, è stato traduttore per Rizzoli, Marietti, Lindau. Per Mondadori è traduttore e curatore delle opere di G.R.R. Martin, J. Abercrombie, R.K. Morgan, P. Brown. Ha insegnato Letteratura Comparata in Italia e Canada. È critico letterario de «Il Foglio», sulle cui pagine ha curato le biografie letterarie di J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, G.K. Chesterton e C. Hitchens. È editor de «L’Indiscreto» e scrive per «Minima&moralia» e «Nazione Indiana».
tenere fuori di casa. Di questo movimento non si può far a meno, così come delle storie, come diceva anche Kafka, in realtà, non occorre che tu esca di casa. Resta al tuo tavolo e ascolta, non ascoltare nemmeno, aspetta soltanto, il mondo verrà da te a farsi smascherare, non può farne a meno, si volterà estatico ai tuoi piedi. Noti una tendenza alla corsa verso l’irrealtà?
E.R.: Faccio un passo indietro storico. Quando Tolkien, tanto per citare uno dei grandi baffi, scrive il suo storico saggio On Fairy Tails, non stories, lui disse, perché l'accusa fondamentale che veniva mossa alle fiabe e ai racconti fantastici era quella di escapismo. E lui fece questa distinzione, diceva che c'è una bella differenza - proveniente da una cultura anche militare e patriottica - tra la fuga del disertore e la fuga del prigioniero. Condanniamo il disertore che abbandona la propria postazione, mentre facciamo il tifo per il prigioniero che cerca di evadere. La cosa interessante mi sembra, me l’ha indotta una battuta all'interno di di L'impero del sogno di Vanni Santoni, quando uno dei personaggi dice, “la realtà è sopravvalutata” prima di suicidarsi. Diversi autori contemporanei hanno impugnato la diserzione come un atto conoscitivo, se non addirittura politico. Penso a tutto l'utilizzo del fantastico, ad esempio nei romanzi dei Wu Ming. C'è una generazione per la quale la diserzione da una determinata postura nel mondo è una possibilità, più o meno individuale, più o meno collettiva, di attingere a qualcos'altro. Come sempre tutto questo va giudicato non dalle petitio principi, ma dagli esiti, cioè da quanta realtà aggiuntiva questo è in grado di introdurre nel testo.
M.S: L'ultima battuta, sei reduce da un viaggio ad Atene, com’è andata?
E.R:Io amo molto una frase di Baudelaire, credo dicesse che ai diritti fondamentali dell'uomo bisognerebbe aggiungere il diritto di contraddirsi e il
diritto ad andarsene. E quindi io quando posso me ne vado.
La cosa per me impressionante di questo viaggio è stata da una parte un bel riaggiustamento di un facile feticismo, perché chi come me ama immensamente quel mondo deve fare uno strano movimento di aggiustamento delle lenti interiori, deve dire quasi dentro di sé: “Cazzo, sono veramente ad Atene” e aggiustarsi rispetto a quasi duecento anni di turismo sempre più invadente. Ma la cosa per me impressionante di Atene, al netto di essere salito di corsa all'Acropoli, è stata aver fisicamente baciato la terra, nello sconcerto della gente intorno. Insomma, lì hanno camminato Pericle, Socrate e Platone, tutti. E quindi ovviamente ho baciato la terra. Ma l’aspetto più forte ad Atene è stata la sensazione di essere come a Chernobyl. Ho avuto questa strana impressione, cioè di essere in una centrale nucleare quasi dismessa, da dove è partita? Una cosa che adesso non ha più confini, una cosa che per uno strano miracolo è avvenuta lì tremila e quattrocento anni fa. Ora gli dèi sono nei manga giapponesi, nei film della Marvel, sono dappertutto, lì è esploso qualcosa che poi si è diffuso dappertutto e che molto spesso ci attende altrove, perché, paradossalmente, certo che ho fatto il bagno nel mare Egeo, ma la prima volta che ho incontrato Poseidone l'ho incontrato nel Mar Tirreno, quando da ragazzino ho letto l'Odissea e questa è la misteriosa vittoria di quello che è successo in quel luogo per me.
6 palin issue 06
↘
Dire viaggio e dire letteratura è in fondo il medesimo prisma.
7 viaggio issue 06
Se mi ami, → vieni con me di
Riccardo Meozzi

C’è chi promette qualcosa soltanto per, a tempo debito, tradirlo. Non sono in molti, ma io faccio parte di questa minoranza. Vorrei poter dire che è qualcosa che faccio mio malgrado, ma non ne sono convinto: sono sempre stato più interessato a come qualcosa finisce che alla cosa in sé. Ricordo bene l’ultimo momento, mai la sequenza degli eventi che mi ci ha portato, e allo stesso modo la sola cosa che so raccontare di un viaggio è come tutto si è concluso, la traversata finale, l’addio. Fuori da tutto questo, però, resta ciò che non ho mai compiuto e che non è più possibile avvenga, e le cose che ho solo immaginato.
Anni fa ho provato ad amare una donna che non mi piaceva ma verso la quale avevo un gran debito d’amore. Più ci provavo più diventavo crudele; tentavo di farmi amare meno, di sentirmi meno in colpa. Ci vedevamo una volta alla settimana e lei, dopo che eravamo stati insieme, piangeva. Quando non ne poteva più viaggiava, e al ritorno mi portava regali costosi, come un dipinto a olio di San Pietroburgo comprato da un antiquario del posto. Di solito, insieme al regalo, mi chiedeva di seguirla nella prossima avventura. Diceva Se mi ami, vieni con me. Io facevo finta di pensarci e poi, all’ultimo, glissavo. Esistevamo a malapena nella mia camera da letto e a malapena riuscivamo a tenerci il minimo di compagnia per non sentirci soli: come potevamo viaggiare all’estero insieme?
Facevamo però piccole gite fuori porta, soprattutto nelle colline intorno alla città. Cercavamo i fiumi che spuntavano tra le gole. Erano estati molto lunghe, le nostre, e durante la prima che trascorremmo insieme fermavamo il motorino sulla strada non appena sentivamo il rumore dell’acqua. Scendevamo poi fino agli argini e li ripercorrevamo verso la fonte in cerca di una pozza larga e profonda. Non avevamo mai il costume; stavamo in mutande o nudi. La foresta intorno a noi, con fronde immense e ombre mutanti come uccelli, e il rumore dell’acqua, ci isolavano, e il silenzio che si creava era quello che ho provato poi quando, solo, sono salito su treni o metropolitane che attraversavano stazioni di cui non sapevo pronunciare i nomi.
Quella donna che mi amava era buona: mi carezzava i capelli bagnati che portavo ancora corti e lasciava che io non la amassi e che cercassi altre donne. Se non le dicevo nulla, pur sapendo, restava calma; se parlavo, se osavo dire con la lingua quella cosa taciuta, invece mi assaliva. Mi picchiava sulla testa, sulle spalle, e tentava di tenermi ferme le braccia mentre provavo a ripararmi. Le guance le diventavano rosse, le labbra le tremavano. Spesso ridevo
della sua rabbia. Ma lei continuava a chiedermi di viaggiare insieme, di essere chi eravamo altrove; o magari mi stava chiedendo di non esserlo più.
L’ultima estate insieme le regalai una copia di Tenera è la notte. Le dissi che Dick e Nicole eravamo noi e che l’anno successivo saremmo andati insieme in Costa Azzurra. Le promisi di bere vino in spiaggia e di fare l’amore tra le due e le quattro ogni pomeriggio dopo la siesta, storditi dal caldo. Lei mi abbracciò stretto, lei che era magrissima e ogni volta mi pareva che il suo scheletro si stesse per saldare col mio, proprio come avrebbe voluto, e mi disse che lo avrebbe letto tutto in pochi giorni. Era una copia Einaudi, la mia personale. Gliela lasciai e le dissi di averne cura. Lei mi disse di restare, mi disse che non voleva restare sola. Era notte, e le sue labbra vibravano come se fosse sul punto di picchiarmi. Così mi rifeci di nuovo vicino e le parlai ancora della Costa Azzurra e dei costumi che avremmo indossato, e di come si sarebbe arrossata la mia pelle al sole e dei baci che ci saremmo dati, della mia lingua sulla peluria della sua nuca avvolta nel sale, e di quanto la luce sarebbe stata forte e bianca. Glielo dissi toccandola piano con l’indice al centro dello sterno. Lei lo prese e mi costrinse a fermare il movimento; lo strinse fino a togliermi la sensibilità, in silenzio, e poi mi lasciò andare.
Non siamo mai andati in Costa Azzurra; lei non mi ama più da anni e io ricordo poco del suo volto sagomato e del suo amore. Non ho più riletto Tenera è la notte e la Costa Azzurra è rimasta una conclusione mai avverata almeno fino a questa estate, quando ci andrò, pare, con amici. Ci sdraieremo su qualche spiaggia, berremo e leggeremo e discuteremo, visto che è il modo in cui abbiamo deciso di volerci bene, e mi chiedo se questo non equivalga a mantenere quella promessa. Sarebbe la prima volta nella mia vita, e visto che ho fatto questa traversata per essere migliore mi piace pensare di sì e che noi, quell’estate, in Costa Azzurra ci siamo davvero andati, che abbiamo fatto l’amore subito dopo pranzo, che abbiamo bevuto vino bianco in spiaggia e che, esausti e stinti dal caldo, abbiamo poi provato rimpianto per la stanza in cui ci vedevamo una volta alla settimana solo per creare promesse che io infrangevo e immaginare luoghi che non abbiamo mai visto insieme.
9 viaggio issue 06
“Senza voltarci indietro”
Ci sono viaggi e viaggi: quelli di piacere, quelli di lavoro; ci sono viaggi che sono la sola ancora di salvezza, anche a costo di mettere a repentaglio la stessa vita. Ma è proprio per questo che migliaia e migliaia di persone, ogni giorno, si spostano lungo tratte estenuanti e infinite perché il luogo che hanno sempre chiamato ‘casa’, ormai, non è più sicuro di mettersi su un barcone tra le onde impervie del Mar Mediterraneo.

E una volta raggiunta la meta cosa troveranno? Braccia aperte e sorrisi di conforto, oppure, come purtroppo accade, muri alzati.
Per fortuna esistono persone che contribuiscono a sensibilizzare le persone su questa drammatica realtà, come Stefano Schirato, fotografo freelance che da più di vent’anni si occupa di tematiche sociali. Tra i suoi lavori, Migrazioni. La rotta balcanica (o, come definito dal titolo della sua mostra, One way only. Senza voltarci indietro) documenta le vite di chi fugge dal proprio paese nella speranza di un futuro migliore. Attraverso le sue fotografie Schirato mostra che dietro ad un ‘migrante’ c’è sempre una persona, un essere umano di pari dignità. E un nome.
10 palin issue 06
Schirato
Stefano
intervista a cura di Chiara Rotondo
Schirato:

11 viaggio issue 06
Questo mese con Palin affronteremo il tema del viaggio. I suoi lavori sono fortemente legati a questa tematica: grazie al suo lavoro lei è sempre in movimento. Partirei, quindi, da una sua definizione personale di viaggio e perché ha scelto di svolgere la professione di fotoreporter.
Mi viene da citare una frase di Fabrizio De André che in una sua canzone dice «per la stessa ragione del viaggio, viaggiare», che credo mi rappresenti abbastanza. La meta indica dove si va, dove si arriva, è tutto quello che puoi andare a vedere, ma è il viaggio che caratterizza quello che vuoi raccontare, per lo meno per me. È il mentre succedono le cose, non la visione finale dell’arrivo da qualche parte. C’è da dire anche che non mi interessa il viaggio fine a sé stesso: mi interessa sempre per un’idea da raccontare, per cui il viaggio è un mezzo che ti fa arrivare in un luogo nel quale trovi, infine, la tua storia. Il viaggio, poi, non è proprio il motivo per cui faccio questo mestiere. Il motivo è perché ho urgenza di raccontare le vite delle persone umane, denunciare le cose che mi indignano.

12 palin issue 06
Nelle sue fotografie traspare l’urgenza di mettere a fuoco delle problematiche drammaticamente attuali, dalle tragedie dei migranti, all’aria che respiriamo (nel suo lavoro, Terra Mala) e che uccide lentamente le persone, fino all’emergenza climatica. La fotografia può essere considerata come strumento di verità e di denuncia?
Assolutamente sì. A mio parere esistono due livelli di fotografia. Esiste una fotografia più documentativa, che definirei “superficiale”. Senza nulla togliere a chi la fa, perché anch’essa ha importanza: diventa urgente per una news, ad esempio, un fotografo di news che viene mandato da una testata giornalistica per raccontare un fatto, qualcosa che sta accadendo. Dall’altro lato c’è quella che preferisco: un tipo di fotografia più interpretativa che racconta in maniera più approfondita quanto è accaduto. Sono di quei fotografi che, a differenza dei giornali che se ne vanno dalla notizia, vogliono approfondire quanto è successo, ti fanno fare delle domande, ti fanno prendere coscienza veramente di un avvenimento. Al giorno d’oggi siamo abituati a guardare così tante cose contemporaneamente, vedere immagini anche strazianti davanti alla televisione, che non ci colpisce più nulla, siamo impermeabili. Mentre quando c’è qualcuno che riesce a penetrare profondamente in una tematica, la gente che si imbatte in un lavoro del genere, così approfondito, ha la possibilità di cambiare la propria coscienza o farsi delle domande. È quello che io in qualche modo cerco di raggiungere.

13 viaggio issue 06
Mi rendo conto che ormai siamo assuefatti da notizie che parlano di rotte nel Medio Oriente, dal Nord africa, di scafisti e vittime, e quest’anno ce ne sono state diverse: la strage di Cutro, pochi giorni fa l’ennesimo naufragio a Pylos, che è stato definito dalla commissaria UE per gli Affari Interni, Ylva Johansson, «la tragedia più grande nel Mediterraneo». Lei soprattutto ha svolto un lavoro importante sulla rotta Balcanica. Ci parli di questo progetto.
È nato per esigenza di andare a vedere con i miei occhi quello che stava accadendo, che era un’emigrazione epocale, come lo è anche adesso in realtà. Però, nel 2015-2016 era la prima volta che si parlava dell’emigrazione di siriani, afghani e iracheni in maniera così epocale. Con la guerra in Siria ci fu questa emigrazione di massa e, infatti, la rotta balcanica è nata in quegli anni lì. Poi c’è stata l’Ungheria che aveva chiuso il muro, per cui i migranti erano stati spostati in Croazia. Quando sono partito non avevo nessun tipo di giornale che mi aveva dato un assegnato, nessuna motivazione economica. Ma dentro di me, dentro il mio cuore, sentivo una ragione molto forte, che mi ha spinto ad andare a vedere con i miei occhi cosa stesse accadendo. Anche perché devo dire, avendo tre figli, ho incominciato a pensare che questa cosa l’avrebbero studiata. La Storia passava a cinquecento chilometri da casa mia; ho preso la macchina e sono andato a vedere, per cui ho investito del denaro per andare io stesso a rendermi conto. Una volta lì, mi sono trovato in una situazione veramente straziante di 8.000-10.000 migranti buttati in

14 palin issue 06
una stazione per terra che aspettavano questi treni e, come spesso accade, inizi a scattare senza farti domande. Ho fatto tantissime fotografie finché, a un certo punto, due giorni dopo passano questi treni speciali per l’Austria e per la Germania. La stazione rimane vuota e io inizio a entrare in crisi, mi chiedo: aspetto che arrivino i prossimi migranti oppure vado in Grecia, alla foce? Per cui entro in una sorta di crisi esistenziale e inizio a riguardare le fotografie che avevo fatto, e non ce n’era manco una che mi aveva colpito, ne avevo scattate più di 2.000 e mi chiedo perché non ci fosse una fotografia buona, come mai non ero riuscito ad ‘entrare’. La risposta è stata a Lesbo, quando ho deciso di andare in Grecia. Ho preso l’aereo e sono andato sull’isola greca dove arrivavano queste barche e mi sono imbattuto in una situazione molto forte. Ho incontrato una bambina che scendeva dalla barca, avrà avuto forse undici, dodici anni, piangeva e tremava dal freddo. Mi colpì quella scena, ero pronto a scattare ma, quando ho messo l’occhio nell’obiettivo, ho riconosciuto mia figlia. Sono entrato in una sorta di breakdown: non sono riuscito a scattare.
Mi sono messo a piangere e non sono riuscito ad andare avanti. Questa scena mi ha fatto capire che io dovevo dare un nome a queste persone. Quella bambina, poi, l’ho fermata, le ho dato la mia giacca, ho saputo che aveva perso i genitori e per me quella bambina si chiamava Sofia. Così ho capito che dovevo dare un nome alle persone, dovevo fermarle, dovevo chiedere da dove venivano, perché se ne andavano, dove erano diretti, i loro sogni. Da quel momento in poi il mio lavoro è decollato, nel momento in cui ho compreso che questi migranti non erano ‘i migranti’ ma erano delle persone con dei nomi, delle storie. E da quel momento in poi è nato questo lavoro. Sono ritornato lì varie volte, poi la Caritas mi ha finanziato e ne ha fatto una mostra. L’allora presidente della Camera Boldrini l’ha vista e ha deciso di portarla alla Camera dei deputati. Ha avuto una grossa eco. Nel momento in cui sono riuscito a dargli un nome, a far uscire delle persone da una massa indistinta di migranti, che spesso un nome non ce l’hanno, mi sono reso conto che cercavo delle storie. Forse la mia storia, in qualche modo.

15 viaggio issue 06
In particolar modo mi ha colpito l’ultima foto, quella dei palmi attaccati al vetro del finestrino, il particolare del viso del giovane che sorride, un sorriso di speranza. Ho visto proprio una scintilla di voglia di vivere.Il desiderio di vivere che accomuna tutti noi esseri umani. Non esistono esseri umani di serie A o di serie B.
Assolutamente
Come diceva lei prima li chiamiamo ‘migranti’ ma sono ‘persone’.

16 palin issue 06
Sono donne e uomini, sì.
Tornando alla mostra, il titolo è One way only. Senza voltarci indietro. Secondo lei, le persone si stanno veramente interessando a non lasciare indietro nessuno? Mi ha detto che ha avuto molti riscontri a livello istituzionale. Attualmente vede che la situazione sta cambiando, oppure siamo rimasti indietro?
È una domanda complessa. Considero che la cosa sia molto peggiorata. Spesso qualcuno dovrebbe fare un’esperienza di dieci minuti, entrarvici, fare in modo di pensare che potrebbe essere lui o lei al posto loro. Certo, all’interno di queste persone che partono, che migrano, ci sono delinquenti, come ci sono delinquenti in Italia, persone che scappano per vari motivi, ci sono scafisti, ci sono anche persone deprecabili. Però ci sono persone che vanno via perché la situazione nel loro paese è terrificante; ma in realtà nessuno se ne vorrebbe andare. Quando sono morti i bambini a Cutro, leggevo sui vari social questa frase che mi ha colpito: «nessun genitore sano di mente metterebbe un figlio in una barca con il timore che non arriverebbe mai alla meta». In fondo è vero. Io sono genitore, nessuno lo farebbe mai se non ci fosse un bisogno profondo di cambiare vita e di andare da un’altra parte. Io penso che le cose stiano peggiorando, si è esacerbata la questione dell’accoglienza e stanno limitando ancora di più, anche un po’ in base al colore della pelle. Sì, l’accoglienza nei confronti di chi scappa c’è, esiste, ma non ho contezza di numeri, quindi, è un pour parler il mio.

17 viaggio issue 06
Io adesso sto realizzando il terzo capitolo di Terra Mala in Veneto, sto “scandagliando lo scandalo”, scusa il gioco di parole, dell’inquinamento dell’acqua che è una cosa incredibile. Ormai sono sei, sette mesi che vado in Veneto per cercare di raccontare questa storia. Mentre dal punto di vista internazionale sto lavorando a un progetto sui “Virus Hunters”, cacciatori di virus, per cui dovrò andare in Africa almeno un paio di volte, ma è abbastanza in fieri, sto ancora cercando dei contatti.


18 palin issue 06
Prossima tappa? Prossimo viaggio?
Stefano Schirato nasce a Bologna nel 1974, dove si laurea in Scienze Politiche.
Lavora come fotografo freelance con un attento interesse sui temi sociali da più di 20 anni. Collabora con diverse riviste, associazioni e ONG quali Emergency, Caritas Internationalis, AVSI, ICMC, con le quali ha partecipato a progetti sui diritti umani, crisi dei rifugiati e immigrazione clandestina.
Il suo lavoro è stato pubblicato dal New York Times, CNN, Newsweek Japan, Al-Jazeera, Vanity Fair, Le Figaro, Geo International, Burnmagazine, National Geographic, L’Espresso.
Ha diversi progetti in corso in Russia, Europa dell’Est, Africa ed India.
Dal 2014 insegna fotogiornalismo per la scuola Mood Photography, di cui è socio fondatore. Insegna fotografia anche alla Leica Akademie.

19 viaggio issue 06
Catabasi
di Elena Giorgiana Mirabelli
Ormai era radice
↗R.M. Rilke
Lei scrive sul quaderno e lo rilegge. Le scelte sintattiche sono quasi inalterate. Il lessico si rafforza, il tono diventa più netto, forse più denso, perché la rabbia, è la rabbia il tratto di cui si ha bisogno.

#territorialpissings
La primavera è verde e temperata. La stanza è sempre luminosa. Hai sei anni, ne hai tredici, poi sono ventidue. Non hai ricordi di pezzi della tua vita. Salti l’adolescenza perché esiste solo come concetto. C’è chi ricorda con esattezza – profumi, forme, sensazioni – e a te capita di pensare che il ricordo esatto spetti a chi ha vissuto quel momento cristallizzandolo. Non sbiadisce perché è fermo.
C’è chi dice che le ossessioni siano poche, pochissime. Che sei agito da una forza misteriosa che ti interroga, ma che la domanda è solo una anche se hai la sensazione che le domande esplodano, che la tua testa si riempia di frasi, e parole, e lettere, e occlusive, e fricative, canzoni, fiori, salotti, bilabiali, palatali e cose e ancora cose. Ma il tuo cosmo risponde a una sola domanda. E l’infanzia è la domanda che si ripete, sempre uguale.
Quando ti sposti nel cervello, la ricerca di punti fermi diventa un modo per costruire una mappa. Le mappe sono rappresentazioni della realtà. I tuoi punti fermi diventano la tua realtà.
#somethingintheway
Il quaderno è pieno di citazioni. Sono inventate come quelle dello scrittore che ha fatto dire a Casanova «… poi, per quella notte, non la pensai più». Lei sa che quel quaderno può prendere vita perché lo ha visto pulsare per anni. Le pagine si gonfiano, diventano bolle, l’odore di carne, il sapore di muschio.
Quel quaderno, la donna, lo ha nascosto. Si convince. La donna ha il camice e le unghie smaltate di rosso. È bella perché tutti dicono che lo sia. Descrive. La donna esiste perché è di carne, ha annotato. Poi sono arrivate le pagine dedicate al bambino che si trasferisce d’estate accanto alla sua vecchia casa. D’estate il bambino sta dai nonni, ha scritto. Lei legge le pagine del quaderno che lo riguardano e pensa che quel bambino nella sua memoria non c’è, ma nel quaderno sì, nelle sue note sì, e quel bambino diventa simile a un documento apocrifo. Il quaderno ha una vita al di là di lei. E allora la percezione si sfalda.
Il quaderno è arrivato a casa sua e lei non lo ricorda.
Il quaderno ha la copertina ocra. È sottile. Le è capitato di vedere le lettere andarsene in giro per
20
la stanza, le è capitato di sentire gli odori che descriveva. Ha condiviso la natura dell’oggetto con la sua migliore amica dell’epoca, le ha detto che le cose magiche esistono solo se lo vogliamo. E allora le pagine si sono moltiplicate, gli odori sono saltati fuori ogni volta che sfogliava, le persone hanno preso consistenza.
#negativecreep
La foto che usi per sollecitare la memoria è della tua infanzia. Hai scelto questa foto perché è uno dei pochi casi in cui la tua memoria è stabile. C’è un prato pieno di margherite e indossi dei collant di lana rossa perché poco prima non sei riuscita a trattenerti e ti sei sporcata di urina.
Non hai provato vergogna. Ha smesso di scrivere il quaderno perché una notte una persona che apparteneva alla sola realtà del quaderno le ha posato la mano sulla fronte. Ha aperto gli occhi, non vedeva nulla ma la mano era lì, e non la percepiva solo con la pelle del viso. Ha allungato la mano e ha afferrato il polso della persona. Il polso aveva la consistenza del marmo. È uno dei miei morti, ha pensato. Non poteva riconoscere chi ormai era radice.
Ha acceso l’abat-jour e ha iniziato a riconoscere gli oggetti della stanza di sua nonna. Allora ha pensato di trovarsi in un pezzo di sogno, ma non c’era nulla di trasfigurato – il letto era di legno, le coperte
erano quelle rosse, l’odore di agrumi. Era, lei, in una stanza che aveva descritto nel quaderno. Ha riletto e ha notato la sua calligrafia ancora più fitta, c’erano freccette e altre note a margine. In una nota riconosce il disegno di un tappeto pieno di piccoli insetti. Quel tappeto era lì sul pavimento lucido di cera. La paura che le cose della sua mente potessero andarsene in giro e che i suoi morti potessero tornare, le hanno fatto abbandonare il quaderno.

#loungeact
Non ha più sentito la mano sulla fronte, ma le capitava di urlare, di notte. Le serviva per tornare e capitava quando stava per cadere, quando non aveva più denti in bocca e c’era chi le tagliava i seni. Allora l’urlo, limpido. Tornava nella stanza. Si riaddormentava. Si trovava in un altro luogo. Poi non ricordava nulla perché non scriveva sul quaderno, tenuto in un cassetto a rimpicciolire. La copertina si anneriva, le pagine sembravano perdere porosità, lasciando che l’inchiostro sformasse le parole. Quando si ricordava di riattivarlo, disegnava solo occhi e cinque e fiori bombati inesistenti. Ma quei fiori non saltavano fuori come prima perché nella vita, nella vita era diventata radice.
21
Il viaggio di due anime.
PalinLegge «Anna sta coi morti» di Daniele Scalese.

Un angoscioso percorso tra la vita e la morte definisce il romanzo protagonista del PalinLegge di questo mese, Anna sta coi morti di Daniele Scalese, edito da Pidgin Edizioni. Nata a Napoli nel 2017 come forma di associazione culturale, la casa editrice ha come obiettivo quello di pubblicare libri «sopra le righe» e fuori dagli schemi, caratterizzati da contenuti che «spingano un po’ più in là l’asticella di ciò che caratterizza il libro medio». Questi possono essere contenuti «forti, espliciti e crudi, situazioni al limite, linguaggio diretto, scenari ostici o selvaggi», ai quali si accompagna la scelta di «ambientazioni urbane, underground», nonché la rappresentazione di «controculture e realtà sotterranee».
Daniele Scalese è scrittore di romanzi e racconti. Nato a Taranto, vive a Milano. I suoi brani sono apparsi su diverse riviste letterarie come «Risme», «Gradozero», «Sulla quarta corda», «Lorem Ipsum», e su importanti quotidiani come «La Repubblica». Il romanzo Anna sta coi morti (Pidgin, 2023) è la sua terza pubblicazione, dopo i precedenti romanzi Le Streghe (Virgilio, 2019) e Non desiderare la roba d’altri (Porto Seguro, 2021).
La narrazione si profila come il drammatico racconto delle vicende di Anna ed Enzo, una coppia sull’orlo del baratro, divisa tra l’attesa per la nascita di un figlio e la tragica scoperta della malattia di Anna, colpita da una grave forma di leucemia linfoblastica acuta. La donna si trova pertanto ad affrontare una scelta crudele: abortire e seguire la chemioterapia, oppure portare a termine la gravidanza a costo della propria vita e, così facendo, salvare l’embrione. La disperazione prende rapidamente il sopravvento sulla quotidianità inaridisce ll sentmento tra i due amanti e li trascina in una spirale di vuoto ed estraneità nella quale finiscono
22 palin issue 06
di Chiara Scatena
Anna sta coi morti Pidgin edizioni, 2023
per essere soffocati.
Silenzio. Rabbia. Silenzio. Attraverso le parole ciniche e disilluse di Enzo il lettore è partecipe della lenta distruzione di un amore. La passione e la complicità che univano la coppia si sono ormai consumate. Ognuno è chiuso nel proprio dolore, sospeso nell’attesa di qualcosa, che sia una nascita o una perdita. Le loro strade, da tempo intrecciate, progressivamente si separano. Anna si allontana da Enzo, affidando i propri pensieri a una pagina social nella quale, giorno dopo giorno, racconta la sua dolorosa lotta. Accetta di partecipare ad un patinato programma televisivo chiamato “Ricordati di santificare i vivi”, mentre il compagno, semi-disoccupato, decide di prendere il suo posto all’obitorio, in cui Anna lavora alla movimentazione dei corpi. L’obitorio è il terzo grande protagonista della storia: un luogo mortifero, freddo come i cadaveri che ospita, ma che al contempo riesce sinistramente ad affascinare chiunque vi lavori. Enzo qui si sente a casa. Egli riesce a recuperare quel senso di pace e di sicurezza che ha perduto tra le mura domestiche, dominate dall’atmosfera opprimente della malattia. L’obitorio è però un luogo ambiguo e pieno di segreti, dove l’uomo verrà finalmente a patti con le ombre del suo passato.
«Noi oscilliamo tra distruzione e rinascita, lotta e accettazione, e quando stiamo andando giù dobbiamo solo capire che è un momento. Tutto si rovina e ricomincia. E bisogna conservare una fede ostinata nell’esistenza […]. Finché saremo qui, noi soffriremo. È la sofferenza il nostro modo di resistere alla morte. Noi soffriamo perché siamo vivi».
La morte accompagna i pensieri e i gesti della coppia. La morte impera, punisce, toglie. Enzo ha dimestichezza con la perdita, con il lutto. L’abbandono del padre e la scomparsa della sorella Eva,
sono per lui un monito costante, una ferita aperta che neanche l’amore di Anna è riuscito a curare. Per quanto concerne il contorto percorso esistenziale, i due incarnano visioni antitetiche. Enzo è già morto. È morto quel giorno con Eva e non riesce a proiettarsi nel futuro, è perso e immobile nella sua inettitudine, nel suo dolore. Vorrebbe che la vita restasse immutata, ma per quanto si sforzi, non può impedire il cambiamento. Anna si sta lentamente spegnendo sotto i colpi della malattia: per lei la morte diviene simbolo di una condizione certa e inevitabile che la spinge ad essere ancora più ferma nella sua scelta vitalistica. Anna ha coraggio, affronta il suo destino con lucidità e sicurezza. Il suo corpo diviene sempre più gracile, un guscio di carne che, però, ospita al suo interno un’anima risoluta, la quale non ha timore di affrontare l’ignoto.
La scrittura ermetica, cruda e incisiva di Scalese è articolata in capitoli brevi, costellati da dialoghi asciutti, mirati ed essenziali. Le parole scavano nella coscienza dei personaggi, mettono a nudo le loro fragilità, le loro ossessioni, le loro paure e in questo modo arrivano dritte al cuore del lettore, il quale, così, si ritrova immerso nella loro sofferenza. Dolore e solitudine si rincorrono tra le pagine del romanzo, trascinando i protagonisti verso la resa dei conti con la propria umanità.
23 viaggio issue 06
« La vita è ciò che facciamo per noi mentre lei fa qualcosa di noi e sott’acqua non puoi chiederti perché stai annegando, ma come tirarti fuori».
Stranieri che
Viaggio nella produzione di Claudia Durastanti
 di Anna Battista
di Anna Battista
Il mio primo incontro con Claudia Durastanti è avvenuto qualche estate fa, in una mattina calda e appiccicosa molto simile a quella in cui sto scrivendo adesso. Cominciai a leggere La straniera perché me lo avevano consigliato, perché era stato candidato allo Strega e perché parlava di legami famigliari e dell’amore di cui sono dolorosamente innervati. A lettura conclusa, oltre ad averne apprezzato l’eleganza e la funzionalità formali su cui molti recensori si sarebbero poi dilungati, avrei avuto la sensazione di aver appena mosso i passi nella storia di una persona che non ero io, ma che in qualche modo parlava di me.
Lo stesso senso di estranea familiarità mi avrebbe accompagnata nella lettura di Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra, A Chloe, per le ragioni sbagliate e Cleopatra va in prigione. Prevedibile, certo: i teorici della ricezione saprebbero sviscerare molto meglio di me il meccanismo che conduce il lettore a immedesimarsi in ciò che legge, ma nel caso della produzione di Durastanti l’impressione di riconoscibilità è ben lungi dal risultare didascalica, e per diverse ragioni.
I romanzi di Durastanti sono estremamente diversi gli uni dagli altri. Viaggiano nel tempo - attraversano un pezzo di storia americana del Novecento, raccontano i primi anni Duemila o abbracciano la cronologia di un’esistenza dagli anni Ottanta alla contemporaneità – e non restano mai a lungo nello stesso posto, spostandosi da una New York luminosa e crudele alla periferia romana, da piccole realtà della Basilicata alla Londra fumosa degli anni Novanta, da Brooklyn a Roma. I personaggi che li popolano, compresi quelli più strenuamente autobiografici, sono affetti da un malessere invisibile che li spinge a spostarsi compulsivamente, o si
24 palin issue 06
conosco.
muovono stando fermi, lasciando che i vagabondaggi del pensiero sostituiscano quelli del corpo, o esistono staticamente, pedine di un gioco crudele che li costringe in una durevole casella di partenza. Tutti infelici a modo loro, ma estranei a ciò che li circonda: e forse è questo che li accomuna e che li rende simili a noi.
L’aggettivo “straniero”, nella sua accezione comune, indica un gruppo di persone, cose, lingue appartenenti a un altro paese; secondo il vocabolario il suo secondo significato più in uso è “estraneo”, “esterno”. È un termine che utilizziamo continuamente, spesso in riferimento a ciò che sembra diverso da noi, senza interrogarci mai davvero su quanto in realtà ci descriva. Siamo endemicamente stranieri, protagonisti di una realtà che ci sembra precostituita e uguale a sé stessa finché non ci scontriamo con quella altrui; lo siamo sempre per gli altri, talvolta lo siamo per noi stessi. E i personaggi di Durastanti – fors’anche perché quello letterario è il territorio deputato al racconto del diverso – ce lo ricordano continuamente: sono stranieri che conosciamo.
A permeare i racconti delle loro vite c’è un senso di alterità che dice molto della nostra generazione, e anche di quella della stessa Durastanti. È nascosto in A Chloe, per le ragioni sbagliate, nei tentativi disperati di Chloe e Mark di salvarsi a vicenda, convinti che l’essenza profonda dell’amore risieda nell’annullarsi nell’altro augurandosi che uno dei due ne esca vivo o viva; si accovaccia nei pensieri di Jane, che per sua stessa ammissione si è «formata nella mediocrità» e vive nel terrore di non riuscire a liberarsene neanche fuggendo in Un giorno verrò a lanciare sassi alla tua finestra; segue Caterina/ Cleopatra nelle sue passeggiate per Roma Est, nel-
la sua normalità naturalistica e nell’accettazione di una realtà che percepisce estranea ma che sceglie di non ripudiare in Cleopatra va in prigione; vive, e vivendo si moltiplica, nella voce narrante di Durastanti in La straniera, nel racconto della disabilità di sua madre e nella descrizione di realtà altre da noi.
C’è un episodio, in La straniera, che racconta di un regalo di compleanno. La madre di Durastanti, sorda dalla nascita, compie gli anni e qualcuno le regala un walkman. Lei accetta il regalo di buon grado, senza lamentarsi dell’apparente controsenso, e la figlia non capisce, si interroga a lungo sulla reazione della madre, quella contentezza la confonde. Ma poi lo comprende: ascoltare la musica senza che ci sia alcun suono ha perfettamente senso nel suo universo ovattato. Sono i mondi che creiamo a nostra misura per sopravvivere all’estraneità di quello reale, quelli in cui non siamo stranieri, ma stranieri che conosciamo.
25 issue 06 viaggio →
Inediti
l'incipit di Tautoromanzo è stato pubblicato sul sito di Poesia del nostro tempo

Da Tautoromanzo:
[...]
Quando su whatsapp vede / la foto di sua madre truccata con alle spalle un bastione secentesco, / a Catania per un convegno, / a maggio, si ricorda dei giorni prima / quando lei si chiedeva / se andarci avesse senso, / dico – sì, insiste, perché non dovresti / – ma perché è troppo tempo, / sono vecchia sono e lui con il suono / distinto dei treni e la trap da una cassa senza fili, / sul marciapiede opposto / dove si sdraiano e si rialzano / per evitare le piaghe i senzatetto, / quasi nudi delle piaghe che suo nonno morirà, / a novantanni, tra poco, / lui si conta i giorni sulle dita, / e lui dice vabbè ma che ti frega? /
Demetrio Marra (Reggio Calabria, 1995) è laureato in Filologia moderna all'Università di Pavia. Ha frequentato il Master “Il lavoro editoriale” della Scuola del Libro di Roma. È vicedirettore di «Birdmen Magazine», rivista di cinema, serie e teatro. È direttore editoriale di «lay0ut magazine», rivista di letterature, traduzione e ricerca visuale. Scrive in qualità di critico per diverse riviste, tra cui la sezione Lingua Italiana di Treccani e Triennale Magazine. Attualmente lavora a Milano come professore, collaborando con diverse realtà editoriali, su tutte Industria&Letteratura e Interno Poesia. Ha esordito con Riproduzioni in scala (Interno Poesia), con prefazione di Flavio Santi, finalista al Premio Ceppo Under35 e al Premio Elio Pagliarani. Suoi testi inediti sono stati pubblicati su Altri Animali, Mirino, Neutopia
Quando ci si addolora ci si / abbandona alla fantasia, che gliene frega / di quell’odissea banale, / casa-scuola-scuola-casa dove la variazione / sta se passare dalla rotonda con le fioriere o dalla Conad, / o se risponda prima mamma o papà, / e se è oggi che il ragazzo già ossessivo scomparirà, / dalla scuola come campo di forze, / e Io, gli faceva giorni prima, non ho forze, non ho un campo, / come posso… alle volte mi disconosco persino alla luce /
26 issue 06 palin
*foto copyright Laura Pusceddu
non solo prima di dormire, parafrasa, / quando cerca di convincere il consiglio / che se si blocca non è per vizio o negligenza / ma ha una malattia, / se si assenta non torna la burocrazia, / i voti le pagelle – la foto di sua madre truccata / è una cosa che non vedeva da anni / dice cioè pensa, cioè non lo sa, / non sa quantificare nulla / di ciò che non lo riguarda / strettamente come un’animale e / Mamma la scrittura non vivifica un bel cazzo, / lei pronuncia il suo nome con tono di biasimo, poi gli fa / va bene amore, ci sentiamo dopo, mi chiamano, / e lui pensa com’è che hanno una vita i genitori. / Just new in the city and want to meet cool / people and discover Milano, nothing more / quando si sente sopraffatto apre Tinder / e scorre l’introversa mista di tagliatelle al ragù, teatro, gattini e psicologia che siede sulle scale di un condominio / mostrando la sideboob sinistra, o destra, se è un selfie. /
Al lago d’Iseo giura di essere meglio dal vivo, / in questo laico rosario lui / si riconosce come uomo, nel fine riproduttivo. /
Ha conosciuto molte donne nella vita, / tutte troie, pensa. Lo pensa perché / si censura anche e pensa / a quel suo amico assistente all’università / che non esisto come uomo, / come cazzo che può incontrare figa / e menomale, gli diceva, / se ridevano insieme fosse buona educazione, / o sommossa, e ripassa dal tunnel, / era fuori non sa come non rifinirci, / si strofina le mani guardando il rider per il freddo /
che indossa un cappellino di lana giallo / pensando per un attimo di assomigliare a un bianco. / Ripensa a quante volte si sia sentito solo / e affossa le unghie sul dorso della mano: / somigliare a un bianco, pensa, / è davvero buona educazione, qualche passo / e Gimme Shelter andrà in dissolvenza, / grazie al cielo, quanto costa in termini di dignità / informarsi sulla contemporaneità, / rimette a posto le cuffie pensando / che qualcuno vuole assomigliargli, / e poi ai pensieri in rima e scorrendo / i nuovi colori della galleria / e le scritte Carlo Vive Genova 2001 / e poi Batman Salva Milano / e poi Sbirri Merda e poi Sara Ti Amo / decidetevi per carità che qui non si respira / dalla muffa dal lampeggiante del camion / che disinfetta – tò, guarda, fa, / fotografando il rudere a metà tra il cielo / stranamente blu, stranamente vero, / hanno buttato giù la vecchia fabbrica / senza tetto, e poi, ad alta voce, no offence, / ci costruiranno un palazzone vuoto, / vicino al parcheggio a pagamento, / di fronte ai magazzini che hanno ripulito / per esporre percorsi critici sull’arte contemporanea, / che dovrebbe si legge nel manifesto / occuparsi e riprendersi le città, / per fortuna almeno quello lì, / che da banchiere si commuove in parlamento, / è andato a fanculo, / ed è come se gliel’avesse detto in faccia, / dato il caldo, i fuochi l’aria di rivolta. /
27 viaggio issue 06 di Demetrio Marra
[...]
Capitano mio capitano
di Filippo Polenchi
Sprofonda dietro le palpebre delle serrande. Orchestra la disposizione degli oggetti sul laminato della cucina. Al mattino, la luce cromata che viene dalle tessere degli avvolgibili illustra il pentolino per il latte, la macchinetta del caffè, il barattolo di lavapiatti sul lavello. Dalle tendine di stoffa e punto-croce vede la piattaforma rialzata del Penny Market, la guglia di Fendi. Prende servizio al supermarket: veste con la divisa tecnica dell’azienda. Usa guanti da lavoro, il marsupio, ripone merce nei sarcofaghi refrigerati del banco-frigo. La sera percorre la strada fino oltre il capannone della Jolly Caffè, attraversa il ponte sul fiume. Qui è tutta proliferazione vegetale, scarto ibrido di linfa e macchina, talea cementizia dentro la muraglia delle acacie: è tutta pianta infestante, erbaccia schiumante. Da qui si accede, salendo sudici scalini, al casello autostradale.
Di giorno la frontiera è spoglia, spazzata dal vento della diossina, perpetuamente grigia al passaggio delle auto e dei Tir. Di notte, invece, la barriera di luci mette paura: il transito dei fari fa la radiografia al cielo. Stella ha appuntamento con Luigi: è solo, negli uffici smerigliati del Punto Blu, fa il turno di notte. Guardano insieme la Tv, si stendono sulle sdraio che lui ha messo da parte. Al centro del muro di schermi sintonizzati su porzioni d’autostrada, l’emissione terrestre manda stralci di telegiornali. Luigi le dice che lei è carne di angelo. Poi le dice che il rosario che Salvini impugna gliel’ha donato lui; lui direttamente, cioè. Adesso lo bacia, le dice. L’ho baciato anch’io, di conseguenza anche tu stai baciando il Capitano. Ride. Ti piacerebbe se chiamassero anche me, il Capitano? Lo sai che alcuni ragazzi del turno di giorno mi chiamano così, perché sanno che il rosario gliel’ho regalato? Gliel’ho fatto recapitare direttamente, tramite mani fidate. Ti piacerebbe tornare qui anche domani sera? Oltre il sonnifero della notte è l’arrivo dell’estate. Si scatena la battaglia delle irragioni, della de-potenza; il resoconto dell’apatia che si ripete senza

28 palin issue 06
aver appreso nulla. È l’obliterazione della linea temporale: rimane l’Evento. Abolito ogni progetto rimane la disgrazia delle folate bollenti, la concrezione vegetale. Dalle paratie del suo ufficio Luigi assiste alle torme di persone che attraversano le autostrade per rifocillarsi oltre le frontiere dei padiglioni, dietro ai vetri, nelle salette d’attesa, vivendo l’ologramma di sé stessi sul divano, stesi a prendersi la misura. Cercano refrigerio nella criogenesi ordinata dei Mall, nella quiete disperata di un cartesianesimo fai-da-te. Anche loro sono carne in purezza, che sbianca nel cielo candeggiato dell’Evento, della paura solenne delle malattie. Non c’è farmacopea del rimedio; persiste l’angelico transito da e verso i parcheggi. Tutto è sorvegliato dal deserto dei capannoni cinesi. Un chiosco ambulante s’ustiona nel parcheggio, all’ombra dell’immane parete color manganese, nella stereofonia rombante della depressione autostradale, fra i vincoli e le tradotte. Là dentro, nell’esilio, la vita essuda sulla piastra, intiepidita dall’asma del ventilatore: quel dettaglio color fagiolo, immemore, calma il sonnambulismo del commercio, la costrizione senza necessità, l’induzione.
Luigi vede tutto questo e di tanto in tanto scatta una fotografia. Vorresti vederle?, le domanda.
A Luigi piace guidare: non sente la fatica della strada, la canicola che si frange in lampi sul parabrezza. Inoltre, Luigi non paga il pedaggio autostradale. È uno dei vantaggi di lavorare per l’Azienda. Ti faccio vedere l’Italia, le dice. Scendono in direzione Roma. Dallo specchietto retrovisore penzola un rosario. Luigi non accende la radio, non fa conversazione, ma è un ottimo guidatore. Lei nota le sue mani salde al volante, le nocche sbiancate dalla pressione, il volto sempre immobile, lo sguardo concentrato sul percorso. Si fermano una volta, in un autogrill con il ponte che attraversa le carreggiate. Stella, col vassoio del self-service in mano, mentre segue Luigi, si ferma al centro del corridoio. Più tardi, quando sono seduti entrambi, sempre in silenzio, a mangiare, lei gli vede il collo: la carne
sotto la linea della rasatura è irsuta: una peluria grigionera e setosa, il derma indistruttibile. Gocce di sudore, incendiarie sulla pelle arrossata, gli colano giù per il collo, dentro la Polo turchese. Dopo pranzo riprendono il cammino: stavolta lui accende la radio, su una stazione religiosa, e invita Stella a unirsi nella preghiera. Lei non conosce le parole, perciò muove le labbra con disinvoltura, articolando significanti muti. Luigi esce a Orte: Non andiamo subito a Roma, le dice. L’auto devia verso un paesaggio di grano macerato, verso la frattura rossastra del tramonto: l’aria gocciola, umida e spessa; il cielo è livido, le nuvole gonfie di pioggia non hanno forza; il temporale rimane uno sfondo, carica l’aria di elettricità repressa e di malattia. È la carne frusta del cielo, la strada a doppio senso: le cascine ai lati della statale, le aie con i cani che abbaiano nel doppler del loro transito. L’immobilità del caldo, la sua presenza apodittica fa spavento: non è semplicemente una stagione. Finalmente Luigi svolta e imbocca una delle vie laterali, approdando in un parcheggio sassoso. Nella casa tutti lo conoscono: si scambiano baci, abbracci, dicono che hanno molto pregato per lui. Presenta Stella all’assemblea. Cenano fuori, sotto il portico. Stella non scambia una parola; i gechi sfuggono rapidi alla mira dello sguardo. A tavola parlano di un certo Mario, che non è potuto venire. Dicono che Mario ormai è «cieco» e Stella non capisce se la cecità è una metafora o una menomazione. Alla fine della cena si alza la donna che sedeva a capotavola: è gigantesca, vestita con un prendisole azzurro, colmo di girasoli stampati, la carne bianca che scolma dalle bretelle. Intinge due dita nel piatto vuoto di insalata e incide un’icona sacra sulla fronte di Stella. Lei chiude gli occhi, terrorizzata: sente scivolargli sul naso una goccia di olio, che la donna le raccoglie prima che cada. A occhi chiusi sente il coro degli astanti che dice: Benvenuta sorella. Porterai tu il nuovo rosario al Capitano?
29 viaggio issue 06

La gamba storta
di Maria Colella
Quale dolce mela che su alto ramo rosseggia, alta sul più alto; la dimenticarono i coglitori; no, non fu dimenticata: invano tentarono raggiungerla.
(fr. 105a Voigt)
Aveva notato il modo in cui zoppicava quasi per caso.
Lei e T. stavano passeggiando per la campagna del paese, parlando di scuola, di libri e di canzoni famose in quel momento (un folk americano che entrambe ascoltavano per ore), quando il suo sguardo era finito sulla piega delle gambe di lei. Il cinguettio degli uccelli era un canto dolce, si rifletteva negli occhi neri di T. dando a lei che la guardava una sensazione di singolare struggimento. Tutt'intorno, la campagna si apriva in campi di tabacco, facendo eco al rumore insistente delle macchine agricole.
Loro due camminavano verso la strada, in silenzio, con le mani nelle tasche.
Lei e T. si erano accordate per una passeggiata nei campi; erano giorni di vacanza, e lei aveva aspettato l’ora dell’appuntamento con insolita impazienza. Incontrarsi da sole aveva sempre avuto il sapore di un frutto troppo maturo, ma l’attesa di quei momenti era diventata col tempo dolce, graffiante: si sentiva spossata di fronte a T., con il fiato corto di una corsa infinita.
Vedendola avvicinarsi in lontananza, aveva assaporato per un po’ una sensazione di sazietà: T. aveva i capelli neri e corti, dritti sulle spalle, la sua om-
bra si apriva in riverberi sotto il sole pomeridiano, come fosse uno spirito. L’aveva guardata con un sorriso timido che aveva fatto abbassare lo sguardo anche a lei; poi aveva posato gli occhi sul suo ginocchio sinistro, rosso di cicatrici, scoperto dai pantaloni tagliati.
Il cuore le si era dilatato, colandole nello stomaco.
Quella era stata la prima volta in cui si era resa conto di guardare T. con un desiderio che non riconosceva. Sentiva il richiamo a prendere con la forza una parte di lei che le apparteneva di diritto, un comando cieco che non capiva fino in fondo: le era stato rubato qualcosa a cui non sapeva dare un nome e lei ora lo voleva indietro da T.
Non glielo aveva detto, né lo aveva detto a sé stessa; si era solo lasciata andare al loro fitto chiacchierare, finché T. non aveva svoltato in uno dei frutteti, facendole segno di fermarsi. Il sole era basso, forte e obliquo, T. traspirava dalla fronte e dalle narici: le era sembrata un animale in agonia, l’aveva guardata con tenerezza e impotenza.
«Mi trasferirò in città la prossima estate», aveva finalmente detto T., con gli occhi socchiusi fissi sui piedi, la fronte aggrottata a ricordare qualcosa.
Lei non aveva capito subito il significato di quelle parole.
Spostando lo sguardo verso i canali di scolo, si era invece chiesta se anche in lei non ci fosse una parte nascosta di T. da restituirle in qualche modo, se T. riuscisse a sentire con quanta forza battesse il suo cuore, un tappeto impolverato contro una ringhiera. Si era tesa e di nuovo si era ritratta, sentiva i muscoli punti da una scossa: la notizia non l’aveva sconvolta, aveva solo un vertiginoso vuoto allo sto-
31 viaggio issue 06
maco.
«I miei genitori dicono che c’è una scuola migliore», T. parlava all’aria, sottraendosi al suo sguardo per girare in tondo fra gli alberi.
Seguendo il passo di T., si erano avvicinate ad una fila di casupole, strusciando pigramente le mani contro i tronchi e le siepi di oleandro: i campi erano freschi, c’erano vestiti stesi al sole ad asciugare e nell’aria l’odore della ruggine, delle fette di pigna zuccherata che le donne mangiavano sedute nei loro portoni.
Si sorprese a cogliere tutti i rumori di quella vita che continuava: al paese non importava nulla di T., non si sentiva offeso dal suo abbandono, né dalla sua grazia estranea alla terra.
«Come fai a sapere che è migliore?» aveva chiesto allora lei, guardandola diffidente, assottigliando gli occhi al sole.
Mentre lo diceva, pensava che quello che rivoleva indietro da T. fosse un segreto del mondo che solo lei sembrava conoscere. Lo intuiva anche lei, quel segreto, quando ascoltava gli alberi frusciare, quando si fermava in mezzo alla campagna nera di ritorno da una festa e si lasciava inghiottire dal buio del silenzio. Era un segreto che era nato con lei, ma di cui si era presto dimenticata, lasciandolo indietro in una pelle ormai vecchia.
T. invece no, non dimenticava: conservava dentro il mondo, che era per lei una roccia marina da cui cavare granchi, in una pesca paziente e ostinata.
Si era chiesta come avrebbe fatto senza di lei: la sua presenza era un richiamo continuo, la punta di un coltello che solletica la gola, qualcosa di pauroso e inevitabile. A lei bastava sentirlo per tremare, per sperare con tutta sé stessa di non ricordare mai. Eppure fare a meno di T. sembrava ora un’ipotesi disastrosa, era gettare in malora tutta la bellezza che avesse mai visto.
«Lo so e basta», aveva detto T., riprendendo a camminare dritto, cogliendo le spighe che crescevano ai lati della strada.
Se T. se ne fosse andata, sarebbe andato via anche quello strano desiderio, la sua bizzarra simpatia, le sue parole astruse e tenere, disseminate nei discorsi come gemme preziose.
Tanto meglio che se ne vada, aveva pensato.
Lei e T. erano figlie di quel luogo nascosto, figlie del paese: chiese arroccate, campi bruciati, poveri zappatori di terra. Erano nate nello stesso ospedale, dalle mani della stessa donna. Le loro nonne si erano odiate, incrociandosi nelle domeniche di festa. Ma T. era sempre stata una ragazzina per bene, dritta nel grembiule nero di scuola: per lei c’erano stati giochi nuovi, attenzioni, complimenti. Lei in-
vece era già troppo cresciuta alla soglia dell'adolescenza, gli uomini la guardavano con insistenza e volgarità.
Nella gara fra lei e T., non c’era speranza. Tanto meglio.
Nel sole del pomeriggio, T. aveva continuato ad incedere nello stesso modo noncurante di quando erano bambine.
Aveva preso a raccontare della futura scuola, delle gite in bicicletta, del mare vicino che avrebbe visto ogni volta che ne avesse avuto voglia. Era un flusso senza fine; bravissima ad intrecciare parole per gli adulti, passava inosservata ai suoi coetanei. Parlava con la voce degli antichi poemi: era la giovane abbandonata su lidi lontani, l’eroe che torna sempre in vita, era la donna innamorata, il veggente senza volto, la favorita di tutti.
Solo i tratti del viso, col tempo, erano cambiati: si erano irrigiditi, la pelle olivastra le si era riempita di brufoli di cui si vergognava. Le aveva confidato di voler diventare invisibile, di non voler essere nient’altro che parole. Ma lei la vedeva. Invidiosa ed incantata, non aveva distolto lo sguardo da T. e dalla sua gamba altalenante.
Scoppiava di vita e di una voglia brutale, che nessuno, tranne lei, sentiva.
«La tua gamba sinistra è storta» aveva detto allora lei, improvvisamente, vergognandosi subito del sollievo di quella cattiveria.
Le era sembrata un’urgenza farglielo notare, tirare fuori da lei una stortura per ferirla. Sapeva anche lei i segreti del mondo, li sentiva muoversi dentro T.: erano pesci impazziti nel buio pesto dei suoi silenzi, guizzavano via dagli spazi angusti delle sue logiche parole. Voleva dimostrarglielo.
«Cosa?»
Mentre la chiesa suonava i rintocchi della messa, erano arrivate al limitare del paese, dove i campi finivano e iniziavano i rumori delle trebbiatrici. T. sembrava sconvolta, si era fermata di colpo, come per negare a sé stessa la verità del suo corpo. Ho solo detto la verità, aveva pensato lei, facendole segno che era ora di andare. E mentre T. riprendeva a camminare in silenzio, lei si era ricordata che non fosse la migliore e nemmeno l’unica: aveva una gamba storta. Quel malessere del cuore era tornato e se n’era andato con l’eco delle campane.
32 palin issue 06
“L’amore e il la stessa cosa, detta per giustificarsi, nessuno si accorge differenza.
«Non ci hai mai fatto caso? Hai una gamba più corta dell’altra.»
T. aveva continuato ad avere gli occhi spenti per tutto il resto del pomeriggio. La sua pelle, squamata dal sole, sembrava fredda, tradiva un turbamento che conosceva solo lei. Si era impercettibilmente allontanata, offesa nell’orgoglio, raccontando della città con meno convinzione, per non farle vedere che qualcosa si era spezzato.
Erano tornate a casa poggiando le mani contro i muri bianchi, in silenzio, non osando guardarsi.
Era stata quella l’ultima volta che lei e T. si erano perse in chiacchiere innocenti, custodendo insieme il fuoco delicato che cresceva nei loro mondi: al rientro a scuola non si erano più rivolte la parola. Era stato un tacito accordo di fine.
Tornando con la mente al pomeriggio di vacanza, allo sguardo rotto di T., lei aveva pensato solo che la gamba storta era stata un sasso che infrange il vetro, che il vero motivo che spinge a ferire chi si ama è il desiderio, profondo come un abisso, di non essere mai lasciati.
Quel desiderio lo sentiva lei, quando si rigirava fra le lenzuola prima di andare a dormire, e lo sentiva anche T., ne era certa: lo sentiva nel fondo dello stomaco, le saliva alla gola, raschiando. E mentre la loro amicizia si perdeva per sempre, lei si ubriacava di quella rottura in solitudine: il sangue le si faceva denso in un miracolo, un filo le partiva dallo stomaco per terminare sotto l’ombelico di T.
Iniziò ad infliggere a T. la trama di angherie a cui non riusciva a dare un senso, guardandola trasformarsi in una martire, con gli occhi confusi di una bestia braccata. Era quello il solo modo che aveva per dirle del suo dolore, per lasciare andare la forza della sua profonda solitudine: odiava T. per il modo in cui ne aveva bisogno, detestava la sua logica brillante, la sua pacata innocenza. Ogni sua parola risuonava ora lontana, come fosse su un altro pianeta, in un’altra città.
«Hai i capelli crespi, perché non rimedi?» le diceva, quando si cambiavano dopo l’ora di corsa al ginnasio.
«Non capisco perché ti ostini a non truccarti, in città ti servirà» le ripeteva all'orecchio quando, a ricreazione, gruppetti di ragazze si univano in cerchio per scambiarsi i rossetti.
L’amore e il dolore sono la stessa cosa, si era detta per giustificarsi, nessuno si accorge della differenza. E se era cattiva a fare del male a T., non riusciva comunque ad impedirlo. In quei rari momenti in cui si parlavano, T. diventava rigida, impreparata, scappava guardandola da lontano con risentimento. Smetteva di recitare la sua parte di eroina. A lei sembrava che fosse sempre stata una persona disonesta, che ingannasse tutti tranne lei, che era riuscita a guardarle dentro, a cavarla fuori dal suo scoglio.
La verità stava in basso, nel fondo delle cose, nella loro intima bruttezza. E lì, in basso, avrebbe voluto trascinare T. con lei.
Tutti sapevano che avevano litigato: al ginnasio non si guardavano, il patto segreto era di studiarsi a vicenda solo quando erano da sole.
Era in quei momenti che scorgeva di sfuggita gli occhi angosciati di T., accesi da una luce che brillava. Non riusciva a non pensare, sempre più insistentemente, che lei e T. dovessero restare legate per sempre: mentre il mondo andava avanti, nessuna delle due avrebbe dovuto allontanarsi troppo.
Sarebbero dovute restare intrecciate, piantate nella terra secca del paese, per sempre.
Ci fu solo una volta, in quei mesi, in cui T. le si era avvicinata. Lei aveva pensato subito che T. era diversa, così sconvolta e disordinata, che era sempre stata un’ipocrita a nascondere quella forza dentro di lei.
Anche tu, come me, sei maledetta avrebbe voluto dirle. Non sei la favorita. Lei era rimasta in silenzio, stringendo le labbra viola per rimescolare il rossetto, calciando i sassi e fissando i ragazzi che facevano rombare i motori.
«Non parliamo più» le aveva detto allora T., con tono piatto, di sfida e timore insieme «è strano.»
Lei, con gli occhi fissi in un punto lontano, mentre l’ultima campanella suonava e gruppi di studenti si dirigevano disordinati verso la strada, aveva solo percepito il terrore di starle vicino, di sentirsi di nuovo schiacciata da lei. Aveva respirato a fondo il sentore delle foglie: sentiva di colpo il peso dei loro segreti, mille squame blu sgusciavano via dal suo silenzio, una nuova pelle era cresciuta e non era riuscita a liberarsene.
«Strano è il modo in cui mi guardi tu.»
Si erano guardate, solo per un secondo, due animali sotto il getto di un faro, prima di essere travolte dal flusso di persone. Gli occhi di T. avevano scagliato una lancia nel suo stomaco, colpendo a fondo.
«Mi fai del male, quando ci parliamo. Ti odio» aveva detto allora T., con le labbra serrate, con la voce spezzata di una frase detta a metà.
33 viaggio issue 06
„
il dolore sono cosa, si era giustificarsi, accorge della differenza.
«Tu pensi di essere migliore di me, ma mi hai sempre mentito» aveva risposto lei, calma e fredda, stringendo forte la stoffa dei jeans.
Avrebbe potuto spingerla a terra, tirarle uno schiaffo in pieno volto.
Scuoterla, dirle che era una bugiarda, che leggere libri non l’avrebbe portata da nessuna parte, che la scuola di città non le avrebbe insegnato la verità delle cose. Che evitava la vita, la bruttezza del paese, la violenza, il sangue, la morte. Che chiudeva tutto dentro di lei, in una scatola nera, sepolta a fondo. Che sarebbe scappata, dimenticandosi di lei, della campagna secca, dello zucchero della frutta andata a male, e che per questo sarebbe stata per sempre dannata.
Eppure si era limitata ad avvicinarsi, a sfiorarle con le dita una guancia.
L’aveva osservata per un momento, distinguendo con chiarezza le macchie da sole sulla sua fronte, la screpolatura delle labbra: T. era sconcertata e impassibile. Poi, con un gran desiderio di colpirla, aveva steso un braccio in avanti, verso i libri che teneva stretti ai fianchi. Aveva sentito il calore della stoffa del suo maglione.
Si era specchiata nello sguardo sconvolto e arrossato di T.: si era vista forte, implacabile. Aveva visto il vortice dei loro desideri, delle loro storie, delle loro bugie messe insieme.
Poi era corsa dall’altro lato del cortile, sentendo i polmoni pesanti, l’urlo di T. che la chiamava in lontananza, cercando di calmare il respiro, esploso in uno sparo.
Fu quello, fra tutti, il momento a cui lei pensò quando, anni dopo, rivide T. in mezzo alla folla del paese: era stato quello l’istante in cui si erano innescate a vicenda. Si erano legate in una materia viva e lei non era più stata in grado di dimenticarsi di quel sentimento di fine, urgenza e vertigine insieme.
Erano passati anni futili.
T. si era trasferita in città senza salutarla, lasciandole solo un biglietto sotto al banco; lei non le aveva mai risposto, aveva tenuto il biglietto nascosto per anni in un cassetto dell’armadio, tirandolo fuori solo quando voleva avere la conferma che T. avesse pensato davvero quelle cose, brutte e sregolate, vere, incontrollabili. A volte aveva sentito un brivido: si era immaginata alla fine di uno strapiombo, in procinto di buttarsi giù, con T. a guardarla dall’altro lato. Altre volte non aveva sentito niente e se n’era dimenticata dopo poco.
Così era finito il tempo della scuola per lei, scivolando via nel fuoco delle sue fantasticherie: aveva preso a uscire con persone nuove, a leggere di meno e ad ascoltare musica diversa. L’intensità del
sentimento per T. era scemata in indifferenza, si era piantata più a fondo nelle sue convinzioni, aveva respinto ogni tentativo di cercarla. Si era sentita spesso sola, senza ammetterlo mai, e a volte, passeggiando per la campagna riarsa, aveva pensato a quando lei e T. erano ragazzine e parlavano degli insegnanti, dei compiti, dei castighi dei genitori.
«Te la ricordi T.? Dicono che lavori per un pezzo grosso» qualcuno le aveva detto una volta, in fila alle poste.
Quell’anno avrebbe compiuto, come lei, ventotto anni.
Lei aveva annuito, ma non aveva detto niente. Ci aveva solo pensato quando, bloccata in autostrada in una mattina di lavoro, era passato un pezzo di folk americano alla radio: allora si era chiesta che cosa facesse, se avesse trovato quello che cercava in città. Si era guardata nello specchietto retrovisore e, invece del suo viso stanco, aveva visto l’espressione indecifrabile di T., nell’ultima volta che si erano parlate. Una studentessa punita, un’adolescente viva, un arco pronto a scoccare la sua freccia nel mondo.
Aveva sperato, con una sensazione di disgusto di sé, di non incontrarla mai più; poi era tornata a pensare a lei con l’intensità di una preghiera, come si fa per tenere lontano il demonio, come si spengono le luci delle candele alla fine di una funzione: con silenzio e reverenza. T. era ancora lo spettro che abitava la campagna, l’ombra tremula e minacciosa, sapeva ancora più cose di lei; ma ormai lei non sapeva che farsene dell’odio, né del desiderio. Era diventata arida, era morta senza rendersene conto.
Si era chiesta solo se anche T. fosse stata delusa, se anche lei avesse conosciuto la sconfitta, la perdita, la noia della vita. Se anche lei avesse dimenticato lo stordimento dei loro pomeriggi insieme.
Quando la rivide, non la riconobbe subito, qualcuno la strattonò per indicargliela: era una Madonna in processione, la vide alta, che troneggiava su un gruppo di persone che ridevano, stretta in un cappotto ampio e scuro. I difetti dell’infanzia erano stati mascherati con dovizia; era sempre stata logica, meticolosa, misurata.
Il tempo non era passato, si era trascinato in avanti permanendo in una cappa, un involucro freddo che le aveva avvolte senza toccarle, senza penetrare a fondo in niente. Lei non si sentiva cambiata, né trasformata. Si sentiva solo trascinata da un'illusione: il vento aveva rimescolato le carte del mazzo, tutto si era mosso tranne lei, che si era ritrovata la stessa mano sfortunata dell’inizio.
«Non ci credo, sei proprio tu» le aveva detto T., avvicinandosi, con due occhi leggeri, frivoli; sem-
34 palin issue 06
brava parlasse con una vecchia vicina di casa, con la donna che le aveva venduto la verdura.
Il tempo per lei era passato in modo denso, appiccicoso: chiudendo gli occhi, si era risvegliata già grande, già sfatta, sfinita. Per T. era invece stato una benedizione, la promessa mantenuta dalle storie che aveva sempre raccontato.
«Ho ancora la tua lettera. È la più bella che mi abbiano mai scritto» le aveva detto allora lei, senza riflettere, per cercare di rompere l’incanto.
Sentiva di nuovo la voglia di farle del male, di fare del male a sé stessa: le sembrò che il miracolo non fosse mai cessato, che tutto di lei lottasse per tornare ai pomeriggi in campagna. Mi guardi ancora così, come quando eravamo ragazzine, aveva pensato ciecamente, come se sapessi che in verità ne so più di te. Nascondi alla perfezione quanto ti faccio paura, quanto hai bisogno di me. Ma io vedo i tuoi segreti, sono la parte migliore di te.
T. era andata lontano e aveva pensato, nella sua testa di diamante, cose che lei non riusciva più ad immaginare. Ma sapeva, anche dopo tutti quegli anni, che T. voleva le cose esattamente come le voleva lei: T. era volitiva e cattiva, contorta, crudele. Non era fatta di parole, ma di carne, e lei la vedeva ancora.
Non si dissero nulla, lei fissò T. mentre cercava qualcosa nelle tasche del cappotto con fare impacciato: la vide scuotere la testa, abbassare gli occhi. Poi rivide entrambe, una di fronte all’altra, nel cortile della scuola: rosse in viso, disorientate. Le avrebbe dato uno schiaffo, l’avrebbe spinta a scacciarla via, ad urlare, a tirare fuori i loro segreti più neri. Avrebbe fatto in modo che non morissero dimenticate.
Tornò per un attimo alla rivelazione nello specchietto retrovisore in autostrada, poi di nuovo alle loro passeggiate in primavera.
Non l’aveva fatto: T. era rimasta imbottigliata in sé stessa, rumorosa come una sirena lontana, un’infezione latente.
Pensò, con dolore e sollievo, che non sarebbe più tornata.
«A proposito, la mia gamba sinistra è ancora storta?»
Allora lei sorrise, mentre T. faceva finta di salutare qualcun altro nel via vai della festa, continuando a guardarla, con gli occhi fissi nei suoi, come per una risposta che aveva cercato da sempre.
35 viaggio issue 06
vuoi mandarci un racconto per il prossimo numero? scrivici! redazione@palinwebmagazine.it HEY!
la rivista per una cultura
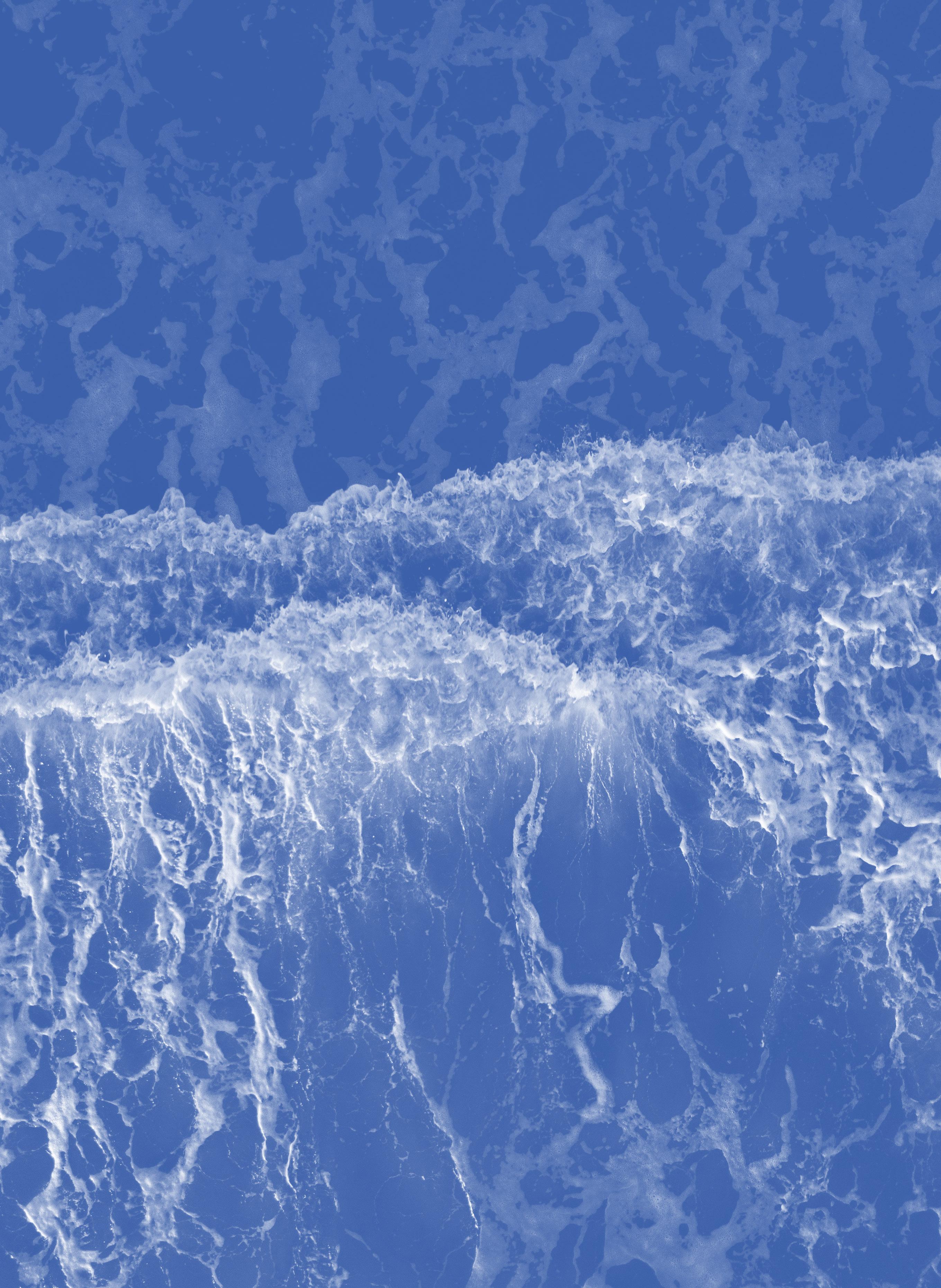
in
viaggio — issue n°6 luglio 2023
mare aperto

















 di Anna Battista
di Anna Battista