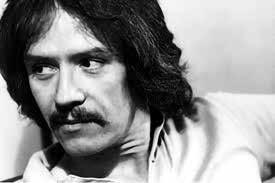8 minute read
introduzione John Carpenter e l’invasione degli anni Cinquanta
Basta qualche cenno biografico per rendersi conto di come già nell’infanzia di John Carpenter fossero presenti tutti gli elementi che presagivano una futura carriera da regista. E non un regista come tanti, ma uno dei più immaginifici, straripanti, iconici.
Una vera e propria leggenda che avrebbe disseminato il cinema americano di una serie di titoli la cui fama sembra crescere, generazione dopo generazione, inarrestabile come le creature mutanti di uno Sci-fi degli anni Cinquanta. Le sue sono opere popolate da antieroi che conquistano fieri lo schermo e l’immaginario collettivo con il carisma dei grandi personaggi del cinema classico hollywoodiano mentre percorrono i paesaggi posti alla frontiera dei nostri incubi, accompagnati dalle note tenebrose di colonne sonore indelebili.
Advertisement
John Howard Carpenter nasce a Carthage, New York, il 16 gennaio 1948 e cresce a Bowling Green, nel Kentucky, in una famiglia in cui si respira l’amore per l’arte. La passione per la musica gli viene trasmessa da suo padre, Howard, titolare della cattedra di musica moderna dell’Università del Kentucky, nonché apprezzato musicista che lavora a tempo perso come session man per cantanti come Roy Orbison, Frank Sinatra e Brenda Lee e che contribuisce alla nascita del sound country di Nashville. La passione per il cinema la deve invece a sua madre, che è solita condurlo in sala sin da bambino. Lo stesso Carpenter nel ricordare la sua infanzia afferma: «Mia madre mi ha regalato la fantasia. Mio padre la musica. Regali non da poco».
Il giovane John spettatore cinematografico è un divoratore di film western, horror e di fantascienza, il primo film che afferma di aver visto è La regina d’Africa di John Huston con Humphrey Bogart.
La sua folgorazione avviene però nel 1953, quando ha cinque anni. È al cinema con sua madre e in sala proiettano la versione 3D di Destinazione... Terra! di Jack Arnold, uno dei film fantascientifici più agghiaccianti dell’epoca. Una volta indossati gli occhiali speciali il piccolo John vede un asteroide uscire dal grande schermo per esplodergli sulla faccia.
Per lui è uno spettacolo sconvolgente: «Mi sono alzato scaraventandomi verso l’uscita. Sul momento ero terrorizzato, ma poi ho cominciato a pensare: Wow è fantastico, lo voglio fare anch’io”»1. Sarà nel 1956 che maturerà l’idea di fare il regista, dopo una visione de Il pianeta proibito. «È stato uno dei primi film che ho visto che fosse interamente ambientato in un altro mondo. Era semplicemente incredibile. Una rielaborazione della Tempesta di Shakespeare»2 .
Negli anni Cinquanta è in atto una vera e propria invasione di mostri: le creature aliene prendono d’assalto il mondo di celluloide e i coetanei di John scoprono le meraviglie della fantascienza, con tutte le loro possibilità narrative, le immagini sfolgoranti di asteroidi e astronavi, pistole laser, scienziati pazzi, pianeti lontani e mostri terrificanti che stringono d’assedio la nostra piccola Terra.
I motivi del proliferare di pellicole di fantascienza sono legati ad almeno due elementi sociopolitici: da un lato c’era l’entusiasmo per la corsa alla spazio, con il naturale fiorire di ipotesi narrative sugli abitanti di pianeti lontani, sulle nuove tecnologie per raggiungere prima la Luna e poi gli altri pianeti. Dall’altro, il secondo Dopoguerra aveva visto sostituire il sollievo per la fine del conflitto mondiale e la distruzione dell’esercito nazista, con la paranoia per il pericolo comunista: ed ecco dunque una vera e propria esplosione della science fiction nella quale la paura per i sovietici viene rappresentata metaforicamente da creature aliene che minacciano l’incolumità dei terresti.
Film come L’invasione degli ultracorpi di Siegel, Ultimatum alla terra di Robert Wise, La cosa da un altro mondo di Nyby, La conquista dello spazio e La guerra dei mondi di Byron Haskin, L’uomo dagli occhi a raggi X e Il vampiro del pianeta rosso di Roger Corman, Tarantola e Il mostro della laguna nera di Jack
1 G. D’Agnolo Vallan, R. Turigliatto, John Carpenter, Lindau, Torino 1999, pag. 11 2 Ibid.
Arnold, Cittadino dello spazio di Leslie Newman, non hanno solo attirato nelle sale orde di ragazzini entusiasti, ma hanno influenzato tutta una generazione di registi che negli anni Settanta e Ottanta avrebbero rivoluzionato il cinema dell’orrore. Joe Dante riesce a darci un’idea di quale fosse il clima cinematografico di quel periodo con il suo incantevole Matinèe, vero e proprio omaggio ai B-Movies, simbolo di una età dell’innocenza del cinema che riusciva a trasfigurare le paranoie degli adulti in un mondo prodigioso. Tim Burton fu più romantico ancora, dedicando un film a Ed Wood, considerato (a torto) il peggiore dei registi di sempre, artigiano coraggioso e ingenuo, cineasta disperato e appassionato fino all’autodistruzione.
Per non parlare poi di tutta una serie di remake che i ragazzi di allora, una volta cresciuti e diventati registi, avrebbero girato, come nel caso di David Cronenberg che nel 1986 dirigerà La mosca, remake de L’esperimento del dottor K., e di John Carpenter stesso, che dirigerà un remake de La Cosa di Nyby e Howard Hawks. La fantascienza e l’horror degli anni Cinquanta e Sessanta fornirono le coordinate lungo le quali salparono le navi colme di incubi di Romero, di Craven, di Larry Choen, di John Landis, di Sam Raimi, Henenlotther, Brian Yuzna, Tobe Hooper, Stuart Gordon, solo per citarne alcuni, i più noti. Questi ragazzi frequentavano cinema e drive in dove spesso si imbattevano negli horror della Hammer e nei film thriller e fantascientifici italiani, come quelli di Mario Bava, leggevano i racconti di Edgar Allan Poe e di Howard Phillip Lovecraft, i fumetti della EC Comics e numerose fanzine. Carpenter stesso, ai tempi del college, ne fonda una, dedicata al cinema fantastico, dal titolo Fantasy Film Illustrated, dove trovano spazio i film di Hitchcock e i Kajou-eiga.
Ma la sua passione di ragazzino per il cinema, John Carpenter la mette in atto maneggiando una cinepresa, una Brownie 8.mm con la quale gira i primi cortometraggi. Al 1962 risale il suo primo tentativo, dal titolo Revenge of the Colossal Beasts che si ispira a Fredric Brown, al quale seguono Terror from Space, del 1963 e, nel 1969, Gorgo Versus Godzilla e Sorceror from Outer Space, che presentano elementi del moster movie nipponico, del western e della commedia. Si tratta in ogni caso di esercizi di stile su scenografia ed effetti speciali fatti in casa.
Per finanziare questi film, che non superano i 45 minuti, fonda una minuscola casa di produzione, la Emerald Prod., grazie alla quale riesce a girare due corti più elaborati: Warrior and the Demon, che presenta
riferimenti con i film di Bert Gordon, e Gorgon, the Space Monster, il tentativo giovanile più tecnicamente riuscito, nel quale abbondano effetti speciali artigianali e make-up.
Durante gli studi universitari alla Western Kentucky University mette su anche un gruppo rock con il quali suona nei locali, i “Caleidoscope”, nel quale John suona il basso e canta. Nel 1968 fa domanda per iscriversi alla scuola di cinema alla UCLA e alla USC, viene ammesso a quest’ultima avendo ragione delle prove di selezione piuttosto difficili.
Durante gli studi alla USC John segue corsi dedicati non solo alla regia, ma a ogni singolo aspetto che riguardi la produzione di un film, al montaggio, al missaggio, alla fotografia, impara quali acidi si usano per tagliare la pellicola, come proiettare il film e come sviluppare e stampare la pellicola. In questa maniera assimila un vasto bagaglio di competenze che gli permetteranno di orientarsi agilmente nel contesto della produzione di film e nel suo caso, assecondare la sua tendenza gestire il più possibile ogni fase della lavorazione dei suoi film. Un’attitudine che lo porterà nella carriera futura anche a circondarsi di collaboratori abituali dei quali può fidarsi, molti dei quali conosciuti proprio durante gli studi alla Usc, costituendo una sorta di factory, a cominciare dalle produttrici, prima Debra Hill e Sandy King (la sua attuale compagna) passando poi per Tommy Lee Wallace, Nick Castle, Dean Cundey, Gary B. Kibbe, Larry Franco.
In quel periodo di studio, durante il quale fonda anche una band rock, i Coup de Villes, insieme ai suoi compagni di corso, Nick Castle e Tommy Lee Wallace, Carpenter ha l’opportunità di incontrare diversi registi, come Howaks, Polanski, Welles, Ford, Hitchcock, Vidor, invitati dalla scuola alle proiezioni dei loro film per discutere con gli studenti. Dei tanti esperimenti filmici condotti durante la sua formazione universitaria, uno dei più interessanti è Captain Voyeur, del 1969. Si tratta di un cortometraggio di 7 minuti che racconta le vicende di un tecnico di computer che di notte, indossando un cappuccio e una maschera, si aggira tra i villini del quartiere per spiare i vizi privati delle coppiette. Il film è un breve esperimento tutto dominato dall’ironia, ma dove alcuni movimenti di macchina e l’idea dell’uomo mascherato che si vaga inquieto e minaccioso fra i viali notturni di un tranquillo quartiere, anticipano in quale modo Halloween.
Poco dopo Carpenter partecipa alla realizzazione di The Resurrection of Broncho Billy, che nel 1971 vince l’Oscar come Miglior Cortometraggio.
Il film, diretto da James Rokos, racconta di Billy, un ragazzo costretto in una quotidianità che non gli appartiene, mentre sogna di vivere nel selvaggio West. La sceneggiatura è scritta dal regista insieme a Nick Castle e John Carpenter, che si occupa anche del montaggio e delle musiche. L’idea del protagonista fuori dal tempo, che non riesce a riconoscersi nei valori contemporanei, anticipa tutta una serie di eroi carpenteriani, come Napoleone Wilson, Jena Plissken e Jack Burton. Il saggio di fine corso, Dark Star Carpenter lo realizza con Dan O’Bannon e si tratterà anche del suo esordio nelle sale cinematografiche, ma rappresenta anche il punto di rottura con la USC che gli fa causa per aggiudicarsi i diritti del film.