
8 minute read
I nuovi Cam, luci e ombre
i nuovi cam,

Advertisement




Il primo di una serie di approfondimenti sui nuovi CAM per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. Una lettura scrupolosa e attenta. Una revisione critica, alla luce di una lunga esperienza sul campo
testo e foto di Valerio Pasi
TEMPO DI LETTUR A: 13 minuti
Nel bel mezzo della bufera Covid-19, il 4 aprile 2020 con Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati pubblicati in Gazzetta
Ufficiale i nuovi Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde, che andranno in vigore dopo 120 giorni, ovvero il 2 agosto 2020. Tre sono gli ambiti di applicazione: il servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente; il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico; la fornitura di prodotti per la gestione del verde. Ben rilevanti dunque le novità, che non si limitano a indicazioni circa gli ammendanti, gli impianti di irrigazione e le piante ornamentali, come nei CAM precedenti (DM 13 dicembre 2013). In questo primo articolo ci concentriamo sulla parte relativa alla progettazione del verde.
LE CAPACITÀ TECNICHE RICHIESTE
Per quanto riguarda la progettazione, anche se non obbligatorio, si individua il criterio di selezione in
SPECIE AUTOCTONE: L’ESEMPIO DI MILANO
Come detto, nelle grandi città è difficile dire quali siano le specie autoctone. A Milano, per esempio, dopo secoli e secoli di urbanizzazione, di antropizzazione della campagna e di eliminazione totale delle cenosi forestali, quali sono le specie autoctone? Ci si deve riferire al Bosco di Cusago (reliquati delle foreste planiziali del querco-carpineto) o all’Oasi di Lacchiarella (reliquati delle foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior)? È evidente che per la città di Milano non si può stabilire quali siano le specie autoctone. base all’interdisciplinarietà, ovvero l’elaborazione da parte di un team di professionisti con diverse competenze professionali in grado di garantire una visione completa e organica. Curioso come tra le capacità tecniche non figurino quelle agronomiche, che sono quelle maggiormente rilevanti, ma vengano citate genericamente le competenze relative al campo ambientale, paesaggistico, naturalistico, forestale, ingegneristico, geologico e urbanistico. Nella documentazione di gara devono invece essere indicati i criteri di scelta delle specie vegetali, le eventuali soluzioni per la conservazione e la tutela della fauna selvatica, la gestione delle acque, eventuali sistemazioni
luci e ombre
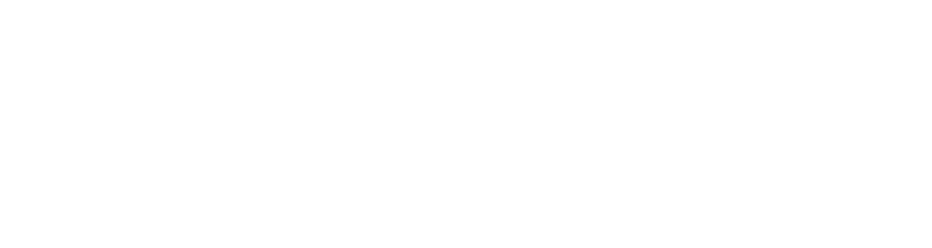

In questo articolo affrontiamo la parte dei CAM relativa alla progettazione del verde. Sui prossimi numeri focalizzeremo l’attenzione sul con tecniche di ingegneria servizio di gestione e manutenzione pubblicati dalla Società naturalistica, impianti di del verde pubblico e la fornitura Italiana della Scienza illuminazione, eventuali di prodotti per la gestione del verde. del Suolo - SISS che arredi, indicazioni per la stabiliscono le caratteristiche gestione dei cantieri, piano fisiche e chimiche e la di gestione e manutenzione delle aree verdi, qualità della sostanza organica presente nel eventuale predisposizione di un’area per il suolo oggetto di progettazione. Buon punto di compostaggio all’interno del sito progettuale. partenza, ma le analisi necessitano di una corretta Niente che non sia già incluso nel Codice Appalti, interpretazione ai fini agronomici nel senso più ma è stato opportuno puntualizzare nello specifico ampio, e implicano quindi l’apporto di competenze elencando i criteri. Tra gli elementi conoscitivi di specifiche, che possano orientare le scelte base, è necessario disporre di analisi del terreno, relative alle specie da impiegare a seconda delle possibilmente eseguite secondo i metodi e i caratteristiche del terreno o che possano stabilire parametri normalizzati di prelievo e di analisi quali accorgimenti occorrono per rendere possibile


LUCI
• Criterio di selezione in base all’interdisciplinarietà • Tra gli elementi conoscitivi di base previste le analisi del terreno • Progettazione del verde urbano secondo il principio Nature-Based Solution

il successo dell’impianto di una determinata specie scelta in base alle finalità progettuali. E se mancano le specifiche competenze, è difficile che le analisi siano utili.

LA SCELTA DELLE SPECIE VEGETALI
Se si entra nel dettaglio dei criteri riguardo la scelta degli elementi vegetali, si nota come l’approccio relativo alla progettazione del verde urbano sia incentrato soprattutto sulle grandi città, secondo il principio Nature-Based Solution, ovvero secondo il presupposto che il verde, per offrire servizi ecosistemici, debba necessariamente imitare criteri e regole della natura. In questa visione ideologica, si impone la scelta delle specie, selezionando quelle autoctone, “al fine di favorire la conservazione della natura e dei suoi equilibri”. Nelle grandi città è difficile però dire quali siano le specie autoctone (approfondimento nel box “Specie autoctone: l’esempio di Milano). Il principio dell’impiego di specie autoctone, che deve essere perseguito nella gestione di infrastrutture naturalistiche (piano strategico di gestione degli ambienti naturali, come foreste e zone umide, zone rurali e di altri spazi aperti, che conserva e migliora le funzioni dell’ecosistema e fornisce benefici alla società) non è propriamente adeguato nella progettazione delle infrastrutture verdi (rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri

elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici), specialmente nel verde urbano. Basti pensare a realizzazioni con funzione prettamente ornamentale o con finalità ludicoricreative in campo sanitario (es. giardini terapeutici). È pur vero che nel decreto si specifica che “laddove si ravveda che tale caratteristica non sia adeguata all’area specifica, deve esserne data valida motivazione scientifica inserita nel progetto, basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia dell’operazione di piantagione, considerando i vincoli paesaggistici eventualmente esistenti, i limiti stazionali di spazio per la chioma e per le radici della futura pianta, i sostanziali vantaggi attesi dall’utilizzo della eventuale specie alloctona selezionata”. Una complicazione inutile se si impiegano specie appartenenti ad altre zone fitoclimatiche o specie ampiamente naturalizzate. Infatti, limitare la scelta alle specie autoctone, oltre che a essere una scelta arbitraria, significa che tutte le specie alloctone naturalizzate, come ad esempio il Platanus

x acerifolia, la Magnolia grandiflora, gli aceri orientali, gli ippocastani, le conifere nordamericane così come tutte le cultivar orticole coltivate nella totalità dei vivai di piante ornamentali in Italia, restano escluse in maniera aprioristica dall’impiego nel verde urbano. Inoltre, si prescrive che “le specie selezionate, a basso consumo idrico, a elevata resistenza agli stress ambientali e alle fitopatologie, presentino la migliore potenzialità per attivare capacità autonome di organizzazione
LE RIPERCUSSIONI SUI VIVAI ITALIANI
Continuiamo la riflessione col dire che non esistono solo grandi città: in Italia i comuni con più di 60.000 abitanti sono un centinaio, mentre quelli sotto i 20.000 abitanti sono 7.400 circa! Le esigenze sono chiaramente molto diverse, in quanto i servizi ecosistemici delle aree verdi nei piccoli centri sono finalizzati e quasi sempre legati alla mitigazione dei deflussi idrici. Sarebbe stato opportuno, invece, indicare come utilizzabili “le specie autoctone e comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi” (crf. DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).
Le ripercussioni di queste scelte a livello economico sui vivai italiani, già in crisi da parecchi anni saranno sicuramente pesanti, ora che vedono precluso un mercato sinora parte dello sbocco naturale della produzione. Si noti anche come pochi siano in Italia i vivai che producono piante forestali (=autoctone) in taglie idonee alle richieste: basti pensare che la maggior parte delle specie utilizzate per le riforestazioni o per l’impiego in contesti naturalistici e di infrastrutture verdi sono prodotti finiti in contenitore dell’altezza di 60-80 cm!
OMBRE
• Tra le competenze tecniche non figurano quelle agronomiche • Nelle analisi del terreno mancano le specifiche competenze agronomiche, a discapito dell’effettiva utilità • Imposizione delle specie autoctone anche laddove è difficile individuarle, come nelle grandi città • Il criterio premiante scelto per l’affidamento del servizio di progettazione basato sul punteggio tecnico proporzionale al numero di anni di esperienza

verso forme più evolute di comunità vegetali”. Ciò contrasta parzialmente con il principio Nature-Based Solution, incentrato sul fatto che le infrastrutture verdi vengono utilizzate con sempre maggiore frequenza per mitigare i deflussi idrici e ridurre l’impatto ambientale causato dall’inquinamento dei deflussi urbani, come le zone umide che sono in grado di biodegradare o di trattenere una vasta gamma di inquinanti emergenti, spesso con migliori risultati rispetto alle soluzioni convenzionali. Le piante adatte alle zone umide chiaramente non sono da scegliere tra quelle a basso consumo idrico e potrebbero non essere tra quelle autoctone, così come le specie a elevata resistenza agli stress ambientali.
IL CRITERIO DEL PUNTEGGIO TECNICO
Niente di nuovo per quanto riguarda i principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti quali l’adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche, l’efficace resistenza a fitopatologie di qualsiasi genere, la resistenza alle condizioni di stress urbano e all’isola di calore, l’assenza di caratteri specifici indesiderati per una specifica realizzazione, come essenze e frutti velenosi, frutti pesanti, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollinifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali; e ancora, la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta, a livello delle radici e delle dimensioni della chioma a maturità, quali ad esempio la presenza di linee aeree o d’impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, etc., la presenza di specie vegetazionali autoctone o storicizzate riconosciute come valore identitario di un territorio. Davvero deludente invece il criterio premiante scelto per l’affidamento del servizio di progettazione relativamente al punteggio tecnico, che sarà proporzionale al numero di anni di esperienza in servizi di progettazione con caratteristiche analoghe a quelle richieste. Poteva essere fatto di meglio, introducendo quanto già previsto ma non obbligatorio, ovvero la multidisciplinarietà dei progettisti e l’approccio olistico con cui il progetto viene calato nel contesto.





