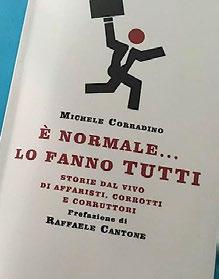7 minute read
Responsabilità solidale, un referendum per “tornare alle origini
from GSA 1/2017
by edicom srl
28
gennaio 2017
responsabilità solidale, un referendum per “tornare alle origini”
Via libera della Consulta al referendum abrogativo sugli appalti. Il tema, spinoso, è quello della responsabilità solidale: si vuole tornare all’origine, ripristinando la formulazione iniziale della legge Biagi e, quindi, la piena e completa responsabilità in solido fra committente e appaltatore. Uno sguardo alla questione.
Lo scorso 11 gennaio la Consulta ha dato il via libera al referendum in materia di responsabilità solidale negli appalti: un tema che seguiamo con particolare attenzione da molto tempo, e che per certi versi risulta più impattante, nel nostro settore, rispetto a quello sollevato dal quesito (bocciato) sull’articolo 18.
Istituita nel 2003 dalla “legge Biagi”
Di responsabilità in solido ci occupiamo, in pratica, fin dalle “prime mosse” della legge Biagi 276/2003, che all’articolo 29 comma 2 istituiva la piena responsabilità fra committente e appaltatore per paghe e contributi previdenziali: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
di Simone Finotti
appalto.” In sintesi l’articolo 29, comma 2, del decreto 10 settembre 2003, n. 276 prevedeva che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o il datore di lavoro fosse obbligato in solido con l’appaltatore alla corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti ai lavoratori: si fissava, dunque, il principio della responsabilità solidale per tutti i soggetti della catena dell’appalto. Già, la teoria sembrerebbe funzionare. Ma poi in pratica la cosa rischiava di andare a scapito del lavoratore e del primo committente, visto che che nel caso qualcosa andasse storto (ad esempio l’impresa appaltatrice, o sub appaltatrice, fallisse) il dipendente si trovava di fatto a doversi rivalere, dopo un lungo iter, sulla committenza, la quale non poteva né rivalersi sull’appaltatore, né tantomeno ingerirsi nell’eventuale rapporto fra quest’ultimo e i subappaltatori.
Un lavoro continuo sul testo di legge
Il lavoro tecnico su questa spinosa questione, frutto di un costante confronto fra politica, legislatore e parti sociali, è dunque proseguito, fra tagli, reintroduzioni, revisioni e limature, fino al 2012: le prime criticità, relative soprattutto alla “catena” del subappalto (che succede se il servizio che ho affidato viene a sua volta subappaltato? Chi deve rispondere in caso di mancati pagamenti, versamento dei contribuiti, ecc.? Chi deve accertarsi che l’impresa a o b sia in regola e affidabile?), erano emerse nel 2006, anno in cui il decreto Bersani cercò di prevedere una procedura alternativa di acquisizione della documentazione di regolarità, poi mandata in soffitta, prima ancora di entrare in vigore, in ragione della sua complessità. L’idea di fondo, comunque, era quella di attenuare la responsabilità in capo al committente per fare leva maggiormente su quella tra responsabilità in relazione al rapporto appaltatore-subappaltatore, che peraltro veniva estesa (articolo 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248) anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Le modifiche della “legge Fornero”
Ma le principali modificazioni del decreto sono state quelle introdotte dal governo Monti, e in particolare dalla “Legge Fornero” 92/2012, che innanzitutto abrogò l’originaria formulazione della “Legge Biagi” sostituendola con la seguente: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla ces-
sazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.” Quindi aggiunse la seguente formula: “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”
Ma restano non poche criticità
Una toppa che, per molti versi, si rivelò peggiore del buco: infatti le criticità di tale formulazione non tardarono a farsi sentire, a partire dal fatto che appare rischioso e ridondante concedere alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della responsabilità solidale con la previsione di metodi di controllo sostitutivi (deroga peraltro già resa possibile, a livello di contrattazione aziendale, dalla legge Sacconi del 2011, art. 8). D’altra parte la 92/12 si è mossa nello spirito di “capovolgere” l’iter della procedura di tutela del dipendente, consentendo al committente il beneficio della preventiva escussione (prima accadeva il contrario: e cioè che il committente, dopo aver pagato, potesse al limite rivalersi sull’appaltatore che peraltro era già stato pagato per il servizio svolto e poteva anche “prendersela con comodo”) e di conseguenza facendo sì che il lavoratore procedesse preventivamente nei confronti dell’appaltatore e solo dopo, in caso di incapienza, del committente. Il rischio, però, è che in tal modo il committente risulti ipertutelato, e possa muoversi in un territorio-limite stipulando contratti con imprese di dubbia trasparenza.
Il testo del quesito
Ed è proprio in relazione a queste modifiche che si muove il quesito referendario, il cui testo è il seguente: “Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori?”
La politica darà una risposta?
Ora, al di là della tenuta del referendum, cui non sarà facile –immaginiamo- raggiungere il quorum necessario (50+1 degli aventi diritto, è lecito attendersi, come sulla questione dei voucher (l’altro dei tre referendum depositati dalla Cgil al quale la Consulta ha dato disco verde), una risposta della politica e del legislatore che riordini una situazione senza dubbio intricata e troppo confusa. A nostro parere, infatti, è auspicabile che vengano messi precisi paletti in tema di responsabilità in solido, anche per porre un limite ad eventuali “calcoli”, da parte delle committenze, nell’affidare servizi a imprese che operano a basso costo e in modo non sempre trasparente.
Il rischio è la deresponsabilizzazione delle committenze
Ciò per due ordini di ragioni: la prima, che riguarda più le imprese, è che tali comportamenti hanno un effetto distorsivo sulla leale e seria concorrenza; il secondo, che riguarda il committente stesso, è che questi servizi vengono di fatto svolti “a casa sua” e per suo conto, con tutte le conseguenze che ciò comporta. E a cui è indispensabile porre la massima attenzione. Il rischio da scongiurare, insomma, è quello di una deresponsabilizzazione dei committenti che non farebbe per nulla bene al mercato, e alla qualità di servizi svolti, fra l’altro, proprio presso di loro.
29
gennaio 2017