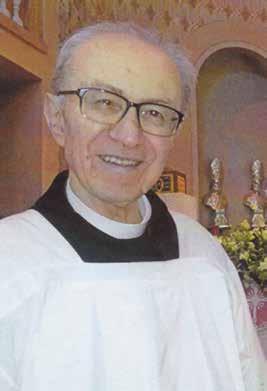7 minute read
Maria, al primo presepe in in contemplazione
Maria, al primo presepe, in contemplazione “Maria serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”
Il modo di stare dinanzi al primo presepe è molto differente: i pastori e i casuali visitatori sono presi da meraviglia, ma il tutto in loro si chiude a un fatto transitorio che non lascia alcuna traccia. Questo si evince dal verbo all’aoristo: ethàumasan (thaumàzo), indica (un’actio punctualis) un momento che viene vissuto in un breve spazio e poi si passa ad altro, senza lasciare traccia. Maria invece è là profondamente raccolta, impegnata a riflettere, a meditare. Si assenta spiritualmente dal contesto ambientale; non la preoccupa il freddo, l’oscurità, il silenzio, le tante privazioni, la solitudine, e si immerge nella contemplazione del Dio fatto uomo. Il suo profondo atteggiamento contemplante viene reso con un verbo all’imperfetto “conservava” (synetèrei) per sottolineare il suo prolungato sostare in meditazione. E tuttavia in questo raccolto atteggiamento di Maria non tutto è facile, scontato e di immediata comprensione. Al contrario, in questi eventi che le stanno accadendo e la coinvolgono intimamente, vi sono degli aspetti che, umanamente parlando, risultano paradossali, contrastanti, per cui lei non riesce a penetrarne tutta la portata teologica e spirituale. Il testo greco rende questo aspetto con il verbo symbàllousa (syn-ballo): esprime un confronto in senso forte, opposizione, contrarietà, contrasto. Quali sono questi aspetti contrastanti che impegnano l’attività meditativa di Maria? La liturgia natalizia della Chiesa li sintetizza in una eloquente espressione: Jacet in praesepio et in coelis regnat (giace nel presepio e contemporaneamente regna nei cieli). È là su un po’ di paglia, ed è il Signore del mondo; è un esserino bisognoso come ogni bambino di latte, di caldo, di protezione, ed è il Dio onnipotente; in cielo cantano gli angeli e sulla terra nessuno si interessa di lui. San Pier Crisologo aggiunge: “Colui che il mondo intero non può contenere, è racchiuso in un minuscolo corpo” (Pl 52,621). È appunto per questo che Maria è là attenta, raccolta per cogliere qualche nuovo elemento che porti ulteriore luce dentro e l’aiuti a entrare di più nel mistero… Perciò va silenziosamente coordinando e ricollegando insieme quel che già sa con quel che cade sotto i suoi occhi. Lei è come di fronte a due pagine bibliche: da una parte l’Antico Testamento con le profezie che annunziavano lui, il Messia, l’atteso; dall’altra, la pagina del Nuovo Testamento, che è là viva, palpitante, sotto i suoi occhi. È una pagina tutta da leggere, tutta da scoprire e, particolarmente, tutta da vivere. È là su un po’ di paglia, ed è il Signore del mondo
Advertisement
Maria, al primo presepe, in contemplazione
di padre Ubaldo Terrinoni
Nei giorni che subito seguiranno e poi negli anni successivi, Maria seguiterà a scendere nelle profondità di questa pagina. E andrà di scoperta in scoperta; gusterà i momenti dolci e sereni accanto al suo Figlio nell’umile casetta di Nazaret, ma assaporerà anche con piena lucidità le prove, le notti, le difficoltà, i silenzi…, come è proprio di ogni altro comune mortale. La sequenza degli eventi la conosciamo molto bene: a dodici anni Gesù si reca a Gerusalemme con i suoi genitori; al termine delle celebrazioni liturgiche, rimane nella città santa; i genitori lo cercano affannosamente e, finalmente, lo trovano nel tempio. È l’unico racconto dell’infanzia e segna il passaggio tra il racconto delle origini e quello dell’inizio del ministero. A dodici anni, il ragazzo ebreo, secondo le usanze religiose ebraiche, poteva intraprendere il viaggio per Gerusalemme e partecipare alle feste pasquali. Da tener presente che il riconoscimento della maturità religiosa del giovane era fissata a tredici anni; egli diventava il “figlio dei precetti” e acquisiva il diritto di leggere la toràh nella sinagoga. Dopo giorni di angoscia, Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio. Notiamo come è vissuto in modo differente lo stesso evento: dal pubblico e dai dottori della legge che ascoltano Gesù e dai suoi genitori. I primi sono al colmo della meraviglia, sono fuori di sè: exìstanto; c’è in loro una favorevole e vibrata ammirazione, c’è stupore, incanto. “Tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte” (Lc 2,47). Per Maria e Giuseppe invece l’autore riserva il verbo greco exeplàghesan (ek-plesso): “Al vederlo, restarono sorpresi e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo” (Lc 2,48). Il verbo che si riferisce all’atteggiamento di Maria e Giuseppe indica lo smarrimento interiore, un momento dolorosamente vissuto; c’è in loro l’accento di un evento penosamente subito; c’è attonita e dolorosa sorpresa. Non sanno darsi ragione di tutto quello che è successo. Gesù, rivolgendosi a loro, risponde: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” Ma essi non compresero le sue parole” (Lc 2,49-50). La risposta di Gesù si riferiva, di certo, al gesto liturgico che un giorno essi avevano compiuto nel presentarlo al tempio, quando l’avevano consegnato al Signore. Egli, dunque, apparteneva, prima che ad altri, al Padre celeste. Tuttavia, la risposta di Gesù guardava anche avanti, al futuro della sua propria vita, della sua missione… «Tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore...»
“Ed essi non compresero!” Pur avendo ascoltato le sue parole, pur richiamandosi a quella offerta al tempio, essi non riuscirono a penetrarne tutta la portata salvifica. Avevano intravisto qualche spiraglio di verità, avevano colto vagamente qualche elemento di verità, ma si sentivano ancora lontano dall’aver compreso bene il messaggio degli eventi. Maria ricorda a suo Figlio la paternità di Giuseppe (“tuo padre ed io…”); Gesù, a sua volta, le risponde anteponendo la paternità divina. Con ciò vuol far capire che non rinnega il suo rapporto affettivo col padre putativo, ma lo pospone al legame col Padre celeste. Ed è allora che “la figura di Gesù le si delinea d’un tratto nella mente con tutta la sua complessità, ed ella rimane più abbagliata che compenetrata”. A questo punto, Maria viene presentata dall’evangelista in atteggiamento di profondo raccoglimento, in meditazione: “Sua Madre serbava tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2,51). Maria avverte l’urgente bisogno interiore di raccogliersi per aumentare in sé la luce per disporsi meglio nella traiettoria della volontà di Dio. Ha intuito in qualche modo, da quella risposta che quel Figlio ormai non è più “suo” nel senso umano… Maria va scoprendo che deve imparare a ritirarsi per cominciare a ricevere ora da lui, comprende che deve farsi discepola per disporsi, con diligenza e umiltà, alla scuola della Parola: Lui, la Parola: lei, il silenzio; lui, il messaggio, lei, l’accoglienza; deve continuare il cammino nella fede in atteggiamento di totale disponibilità al Figlio; deve rimanere fasciata dal silenzio nell’umile casetta di Nazaret. Dai due racconti evangelici risulta chiaramente che Maria non è stata la creatura che, fin dal primo istante, si è presentata a noi tutta immersa nella luce di Dio, ricolma di grazie carismatiche e di straordinari e abbondanti favori. No! Lei è la creatura che, sebbene dotata di intelligenza perfettissima, ha dovuto apprendere, sapere e conoscere attraverso la normale via dell’esperienza, via comune ad ognuno di noi. Quindi lei, nel suo pellegrinaggio terreno, è salita a Dio, battendo la strada della fede, considerando e contemplando il volto umano di suo Figlio, volto di un comune operaio, volto sfigurato da stenti e da sofferenze, volto disfatto di un condannato a morte. “È la reale fatica del cuore nel credere” come scrive Giovanni Paolo II, nella sua enciclica “Redemptoris Mater”. Ed è in queste ascensioni verso Dio che Maria ha fatto la dura e necessaria esperienza delle notti spirituali. Il monte della santità che va scalando non le lascia intravedere che cosa le è riservato se gloria o dolore, se croce o trionfo, se consolazioni o desolazioni. Lentamente lei cammina e sale, raggiunta da improvvise tenebre, da silenzi, paure, trepidazioni, incertezze… Il suo cammino è rischiarato dalla scarsa, fioca luce della fede. Maria verrà allo scoperto, uscendo dall’oscurità del silenzio, quando si tratterà di raccogliere, non gli applausi di quel Figlio, ma i dissensi, le ingiurie, gli insulti e gl’improperi. Lei sola sotto la croce si dichiarerà con coraggio di essere la Madre del condannato, la Madre del Crocifisso. Per lei non si tratterà soltanto di un dolore indicibile, ma di una vera “passione”, della stessa Passione di suo Figlio, portata simultaneamente. E nella delusione e nello smarrimento di tutti, lei seguiterà a credere fermamente che quel Crocifisso è Dio. Maria ci insegna, quindi, maternamente a scendere nelle profondità dell’anima per fare i conti con la propria vita. È necessario rimanere soli di tanto in tanto per vedere con più chiarezza che cosa si ha e chi dovremmo essere; per guardare meglio in faccia a noi stessi. Già sant’Agostino ammoniva sulla necessità di ritornare dalla esteriorità dispersiva nelle profondità intime e segrete dell’uomo interiore. Là non si scoprirà solo il proprio io ma anche Dio. È necessario talvolta rimanere soli quando abbiamo appuntamento con Dio. Andare da soli all’incontro per tornare più ricchi di doni per i nostri fratelli. «Sua Madre serbava tutte queste cose nel suo cuore».