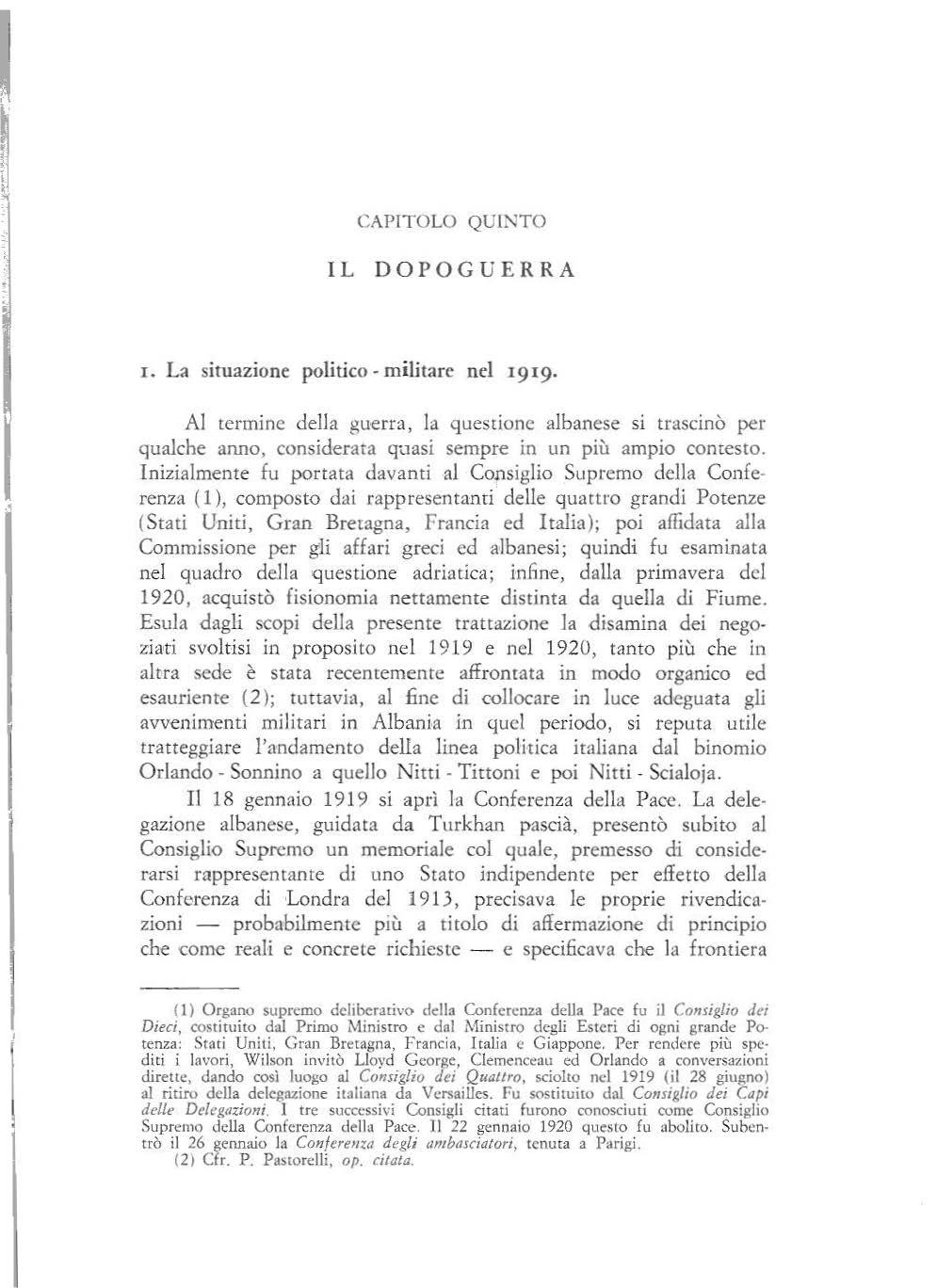
81 minute read
CAPITOLO QUINTO
Il Dopoguerra
1. La situazione poliùco- militare nel 1919.
Advertisement
Al termine della guerra, la questione albanese si trascmo per qualche anno, considerata quasi sempre in un più ampio contesto. Inizialmente fu portata davanti al Consiglio Supremo della Conferenza (l), composto dai rappresentanti delle quattro grandi Potenze (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia ed Italia); poi affidata alla Commissione per gli affari greci ed albanes-i; quindi fu esaminata nel quadro della questione adriatica; inhne, dalla primavera del 1920, acquistò fisionomia nettamente distinta da quella di Fiume. Esula dagli scopi della presente trattazione la disamina dei negozia•ti svoltisi in proposito nel 1919 e nel 1920, tanto più che in altra sede è stata recentemente affrontata in modo organico ed esauriente ( 2 ); tuttavia, al fine di collocare in luce adeguata gli avvenimenti militari in Albani·a in quel periodo, si reputa utile tratteggiare l'andamento della linea politica italiana dal binomio Orlando - Sonnino a quello Nitrì - Tittoni e poi Nitti - Scialoja.
Il 18 gennaio 1919 si apl'Ì la Conferenza della Pace. La delegazione albanese, guidata da Turkhan pascià, presentò subito al Consiglio Supremo un memoriale col quale, premesso di considerarsi rappresentante di uno Stato indipendente per effetto dell a Conferenza di ·Londra del 19 13, precisava le proprie rivendicazioni - probabilmente più a titolo di affermazione di principio che come reali e concrete richieste - e specificava che la frontiera albanese doveva comprendere tutti i rerritori albanesi incorporati a suo tempo nel Montenegro, nella Serbia e nella Grecia, vale a dire:
(l) Organo supremo deliberativo della Conferenza della Pace fu il Consiglio dei Dieci, costituito dal Primo Minimo e dal Ministro degli Esteri di ogni grand.: Potenza: Stati Uniti. Gran Bretagna, Francia, Italia c Giappone. Per rendere più spc· diti i lavori, Wilson invitò Lklyd Georgc, Clemenceau ed Orlando a conversaz ioni dirette, dando così luogo al Consiglio dei Quattro , sciolto nel 1919 (i l 28 giugno) al ritiro della delegazione italiana da Vcrsailles. Fu sostituito dal Comiglio dei Capi delle Delegazioni. I tre successivi Consigli citati furono conosciuti come Consiglio Supremo della Conferenza dellu Pace. ll 22 gennaio 1920 questo fu aboliw. Suben· trò il 26 gennaio la Con/erenw degli amb11sciatori, tenuta a Parigi.
(2 1 Cfr. P. Pastorelli, op. citata.
- a nord: Virpazar e Podgorica;
- ad est: il Kossovo sino a Pristina, parte del distretto di Uskub (Skoplje), Gosrivar e Dibra;
- a sud: tutto I'Epiro sino al golfo di Arta.
Per amore di precisione il memoriale aggiungeva: <<Tutti i territori situati ad oveJt di questa frontiera costituisc ono l'Albania etnica e storica ( ). Noi non chiediamo nulla che non sia albanese ( ... ). Noi chiediamo di rientrare in pon·esso dei territori albanesi che ci sono stati strappati dal Trattato di Bedù10 e dalla Conferenza di Londra ( ... ) ».
Il documento, unitamente alle rivendicazioni presentate dalle delegazioni montenegrina, serba ·e greca, fu affidato alla Commissione per gli affari greci ed albanesi. Comunque le posizioni delle grandi Potenze si delinearono subito: Francia e Gran Bretagna erano per l 'applicazione dell'art. 7 del Patto di Londra, cioè seguivano la politica della spartizione dell'Albania; gli Stati Unici, prima molto incerti, finirono per adegua rsi sostanzialmente a tale indirizzo, meno per Korça che essi riconoscevano albanese; l'Italia - o meglio Sonnino personalmente - era invece indine a sostenere !'-indipendenza albanese nelle frontiere del 1913, con argomento Valona in sospeso . Formalmente, dunque, erano gli altri Alleati più « a posto », e tanto improntavano la loro azione al rispetto del Patto - mostrandosi correttamente disposti a riconoscere V alona in dominio diretto e l'Albania centrale musulmana in mandato - in quanto così facendo soddisfacevano le ambizioni scrbe e greche e avevano un elemento di più per non attribuire Fiume all'Italia Le trattative portarono ad un irrigidimento delle parti, poi ad una flessione nell'atteggiamento i taliano, infine ad un rinvio della soluzione nell'ambito dell'intero problema adriatico. Però due fatti erano subentrati : la presa di posizione della delegazione albanese, che in una nota r infacciò alla Conferenza di usare l'Albania come merce di scambio per appianare controversie fra altri Stati concludendo con una frase estremamente significativa: « il popolo albanese non potrà riconoscere stipuluzioni che contrastino con l a sua integrità territoriale e la sua ùtdipendenza ed ancor meno vi si sottometterà», e l'indebolimento della posizione italiana per effetto del noto ritiro dei nostri delegati dalla Conferenza.
II 23 giugno dello stesso anno il governo 1\:itti, con Tittoni agli Esteri, sostituì il Orlando. Il nuovo ministro degli

Esteri, al quale fu affidato anche l'incarico di presiedere la delegazione jraliana a Vcrsailles, appena giunto a Parigi ricevette un memorandum anglo-francese nel quale veniva duramente contestata la vaDdità dcU'intero Patto di Londra a causa di violazioni attribuite all'Italia, deprecata la spedizione italiana in Asia minore, rivolto l'invito ad un nuovo riesame globale della situazione per trovare una soluzione eh\! Cosse compatibile con gli interessi di tutti. Però se J'Iralia non avesse ritirato le sue truppe dall'Anatolia avrebbe perduto ogni diritto ed appoggio. A parte la sgradevole sorpresa per il durissimo documento - tanto che sul momento Titroni pensò di abbandonare una seconda volta, e definitivamente, la Conferenza - diventò chiaro che la ripresa dei negoziati implicava un contatto con la Grecia, dietro la quale era la Gran Bretagna. Ciò posto, la linea di condotta decisa da Ti troni si basò su due punti fermi: primo, accordo con la Grecia, con ampie concessioni fra cui il Dodecanneso c l'Albania meridionale c ricevcndone in compenso sostegno per il protettorato sull'Albania; secondo, proposta di un compromesso per l'Adriatico consistente nella rinunzia alla Dalmazia contro il protettorato sull'Albania. Di conseguenza, lo spirito con cui fu affrontata la questione a'lbanese divenne quello del dominio diretto, più o meno velato, in netto contrasto con la visione precedente. Era l'abbandono della politica indipendentistica. Ed era un grave errore di sottovalutazione della coscienza politica acquisita dagli Albanesi negli ultimi tre anni.
Il 23 luglio Tittoni e Venizelos firmarono un documento segreto secondo il quale, in particolare:

- l'Italia si impegnava a sostenere le rivendicazioni greche circa l'a1messione dell'Albania meridionale (Epiro del nord) sino all'allineamento Himara- Tepeleni- Klisura -lago di Prespa con Korça alla Grecia (art. 2);
- la Grecia, oltre a cedere in affitto all'Italia per 50 anni una parte del porto di Santi Quaranta, si impegnava ad appoggiare davanti alla Conferenza 11 mandato sullo Stato albanese, la sovranità su Valona ed il territorio reputato dall'Italia necessario alla sua difesa (art . 3 ).
L'infelice accordo - infelice sotto molteplici aspetti - non appena trapelato, sia pur vagamente, in Albania provocò una violenta irritazione nei nostri confronti. Si può bene affermare che esso fu la scintilla dalla quale doveva divampare l'incendio dell'insurrezione contro la presenza italiana, a qualsiasi titolo, nell'anno seguente.
Nel giro eli otto mesi, dal novembre 1918 al luglio 1919, l'atteggiamento dei maggiori esponenti delle varie comunità albanesi verso di noi era cambiato notevolmente. Non erano soltanto le notizie amareggiate provenienti da Parigi la causa del mutamento. Come sempre accade, l'occupazione militare pesava ed urtava e suscitava uno spirito di insofferenza crescente. Si aggiunga una certa divergenza di opinioni fra il gen. Piacentini, il comm. Castoldi, esperto della delegazione italiana alla Conferenza della Pace , ed il ren. col. Lodi , fiduciario del Ministero degli Esteri presso il Governo di Durazzo. Mentre gli ultimi due, più a contarto con i personaggi politici e con i maggiorenti albanesi avevano percepito il guastarsi della situazione (della quale conoscevano i retroscena) e l'ostilità montante, :il Comandante delle truppe tendeva a sopravalutare gli effetti dell'opera svolta dai nostri soldati nel mezzogiorno del Paese. Ora, il gen. Piacentini vedeva e sapeva quanto era apprezzato quello che aveva fatto il suo predecessore, il geo. Ferrere, però, almeno per il momento, non comprese che tutto passava in seconda linea per chi voleva l'indipendenza. A parte ciò, poiché gli aspetti politico-amministrativi non erano nettamente separati da queHi militari, diventava fatale il verificarsi eli errori di tratto e di psicologia nell'una o nell'altra sfera di attività. La mancanza di chiarezza in questa sede, però, trovava la sua origine più in alto. Già Sonnino non aveva potuto riconoscere formalmente il Governo provvisorio - che ancora le altre Potenze ignoravano volutamente -e questo, sul piano loc-ale, aveva impedito di semplificare le cose. Inoltre, col nuovo Governo si verificò un contrasto di vedute anche fra i tre uomini politici interessati, per l'incarico, al problema albanese. Nitti, per la verità, vedeva solo gli aspetti negativi della nostra presenza in Balcania: quelli economici. Tittoni, ministro degli Esteri, considerava l'Albania soltanto per le possibilità che attraverso eli essa esistevano per un accordo intetnazionale suJI.a questione adriatica. Sforza , 'SOttosegretario agli Esteri, si preoccupava invece della situazione interna albanese - in seguito, come vedremo, il suo atteggiamento cambierà e eli molto- e, ricevuto un orientamento piuttosto sommario e vago, decise di convocare a Roma due ministri del Governo provvisorio di Durazzo, Mufid bey Libohova e Fejzi AJizoti, entrambi filoitaliani, ma anche, c specialmente, ferm i nel difendere gli interessi della propria terra. Il 20 agosto fu s<,ttoscritto un accordo transitorio, in attesa cioè delle deliberazioni della Conferenza della Pace, sulla cui base la cosa pubblica in Albania doveva essere retta da tre organi:

- ìl Governo provvisorio albanese, con giurisdizione su tutto il territorio occuparo Italiani (meno il campo trincerato di Valona) con poteri esecutivi e giudiziari;
- .il Comando Truppe Albania, con poteri totali nel solo campo trincerato di Valona, delimitato dalla Vojussa sino a Tepeleni e poi, attraverso il Kurvelesh, da una linea che raggiungeva il mare a Himara; un Alto Commissario civile italiano presso il Governo provvoisorio, dipendente dal Ministero degli Esteri, come consigliere (ma in realtà come controllore).
Inoltre, era prevista la costituzione di una gendarmeria albanese alle dipendenze del Governo provvisorio e di una milizia albanese agli ordini del Comando Tmppe Albania. Turto questo, più o meno, tendeva a realizzare un certo assetto politico locale. Ma altri due punti rivestivano particolare valore e dovevano trovare soluzione: Argirocastro e Valona. Per la prima, i delegati albanesi avevano chiesto l'amministrazione diretta con un prefetto italiano (il Lodi), in modo da essere più tranquilli di fronte alle agitazioni greche; per la seconda un prefetto albanese, quale rappresentante del Governo provvisorio, coadiuvato da un rappresentante dell'Alto Commissario italiano. Di fronte, poi, al diniego nostro, si accontentarono della semplice registrazione del loro desiderio, con la qual cosa ponevano una riserva da utilizzare 1n futuro. I due diplomatici albanesi avevano avuto, in effetti, notizia di un accordo Thtoni-Venizelos, ma non sapevano che l'Italia si era impegnata a favorire la Grecia per la sovranità sulle provincie di Argirocastro e di Korça. Anche se avevano sospetti, vedendo accettare dai colleghi itaLiani il documento si tranquillizzarono. L'approvazione del Governo di Roma, necessaria a rendere operante l'accordo, naturalmente non venne e l'equivoco durò sinché il 27 ,settembre Tittoni non pronunciò alla dei Deputati un discorso in cui, dopo aver riepilogato i termini delle trattative quali erano venute a svilupparsi fra le grandi Potenze, specificò che il controllo sull'Albania serviva da compenSQ alla cessione della Dalmazia alla Jugoslavia e del porto di Fiume alla Lega delle Nazioni. Era così sciolto ogni dubbio su Valona, sul mandato italiano e sugli impegni presi per le frontiere greco-albanesi. La forma usata ed il dare come scontato il « baratto » a spese dell'Albania ferirono a fondo la sensibilità nazionale albanese ed inasprirono il risentimento verso l'Italia. Difficilmente, anche volendolo, sarebbe stato possibile conseguire un risultato così negativo come invece ottenne il discorso di Tittoni, a degno corredo della mancata appro\'azione e ad ine\'Ìtabile conseguenza dell'accordo con Venizelos. Jn Albania gli ele menti tuttora favorevoli all'Italia videro il chiaro fallimento della loro politica e la caduta del loro personale prestigio; si creò una corrente eli opposizione, decisamente indipendentista, che basò il proprio programma sulla convinzione che gli Albanesi dovevano soprattutto contare su stessi, imponendo il loro diritto alla piena indipendenza alle Grandi Potenze; la plù o meno larvata insofferenza nei confronti dell ' Itali-a divenne pitl spiccata e si accompagnò ad una aperta diffidenza e sfiducia. Lo sdegno massimo si rifletté in una noLa che la delegazione albanese a Parigi presentò il 9 ottobre alla Conferenza, in cui si dichinrava cbc il popolo albanese non imendeva riconoscere all'Italia il possesso di Valona; non accettava la cessione dell'Albania meridionale alla Grecia; non si riteneva vincolaoo allit realizzazione della linea ferroviaria Valona-Alene (concordata fra Tittoni e Venizelos ); ed infine «noi/ si sarebbe mai sottomesso all'umiliazione di un mandato co;z il qr{ale si proponeva di togliergli la sovranità e l'indipendenza già riconosciute nel 1913 ». Anche se le Potenze dertero visibilmente poco ascolto a questa voce, il nuovo capo della delegazione albanese, mons. Bumçi, si sforzò ancora di trovare una soluzione conciliante che evitasse di portare la vertenza fuori dal campo diplomatico . Purtroppo urtò contro il compromesso avanzato da Nitti, sempre poco aggiornato sulla evoluzione dei sentimenti albanesi verso di noi o non molto curante di quello che poteva accadere. Si pensi che proprio in quel periodo gli Albanesi assistevano allo sgombero del triangolo epirora da parte delle nostre truppe ed al conseguente arrivo di quelle elleniche. Infatti, ,in relazione all'accordo, ,il 28 ottobre Tittoni telegrafava da Parigi al Ministero della Guerra:
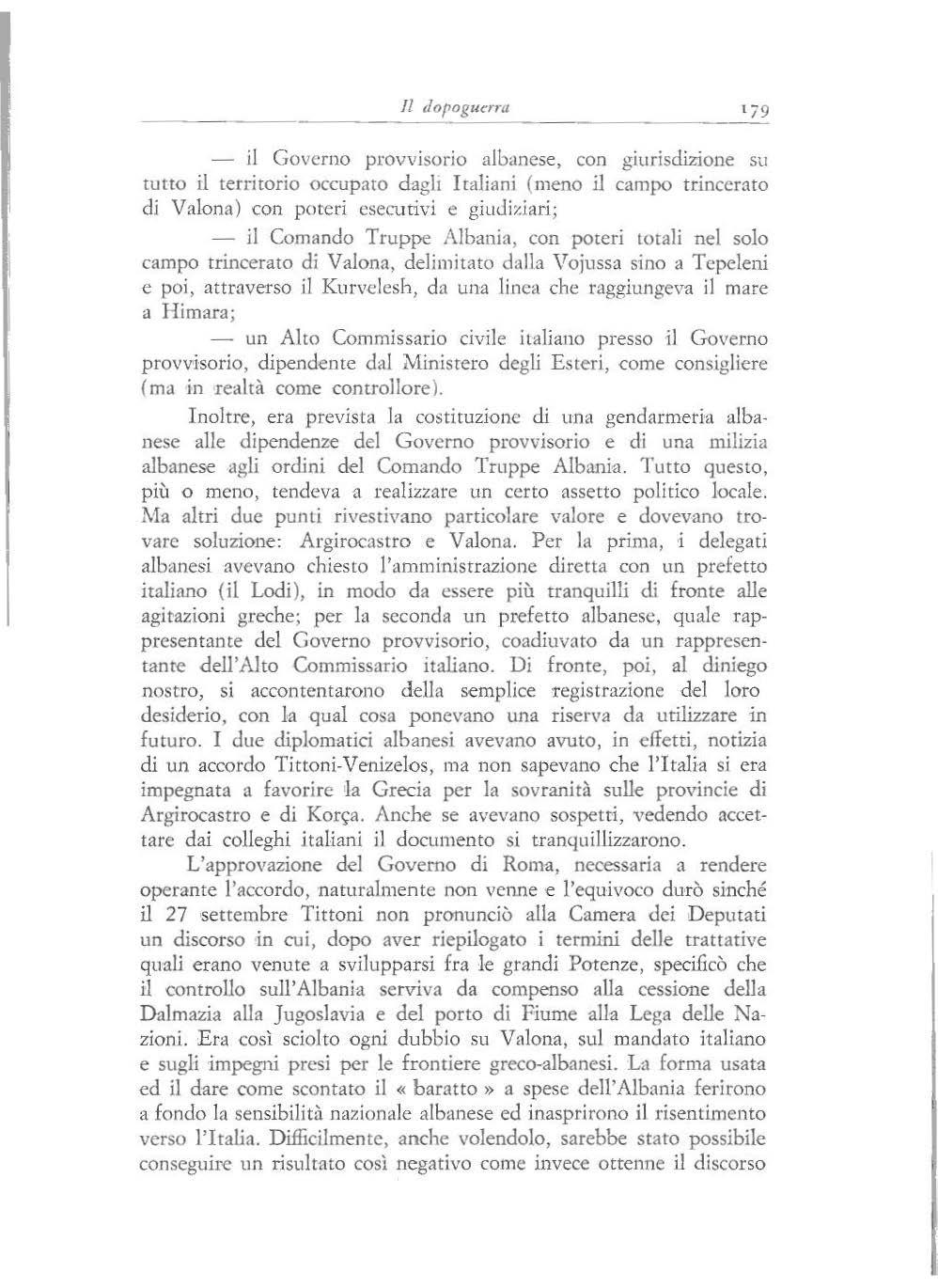
«Essendo venuta meno necessità difesa mil i tare che nel 1917 rese saria occupazione triangolo fuori confini albanesi di Londr:1 e posto ? in territorio greco ed in pari tempo essendosi determinata una diversa situazione politica con Governo greco, è necessario disporre lo sgombero del triangolo la cui occupazione non può oggi essere se mai giustificata che da motivi non essenziali, che renderebbe vani gli sforzi per una cordialità di rapponi con la Grecia stop
«Prego pertanro V. E. perché Comando Albania prenda l'iniziativa necessaria con generale greco Orfanidis per rispettive ? stop Poiché contemporaneamente R. Legazione Atene si assicurerà che a nostre truppe siano garantiti passaggi sulla stmda Santi Quaranta - Coritza sarà possibile rifornimento dci presidi di Liaskoviki e Perati nonché vigilanza regione Coritza, motivi che costituivano principali obiezioni indicatcmi da Comando Supremo con sua nota lO ottobre n . 3422 stop

«Comando Supremo obiettava nnche che o meno strada Santi Quaranta - CoritZil dovrà subordinarsi sistemazione Albanitt meridionale ma la questione non può essere presa in esame essendo già stata decisa a Londra nel 1913 né ritenendosi oggi possibile migliorare rali decisioni a fa\'Ore Albania <...) stop «Converrà che Comando Valona nell'attuare sgombero si adopri con ogni suo mezzo per evitare che neUa popolazione albanese possa sorgere il ti· more che esso prduda ad occupazione greca dei territOri albanesi di Argiro castro e Coritza stop Su queste due provincie nessuna decisione potrà essere presa che daUa Conferenza della Pace ( ... ) » (l).

11 13 novembre si incontravano a Doliana il gen. Riveri, Ispettore della souozona di i\.rgirocastro, ed il gen. Orfanidis, comandante de1l'8• divisione greca, c firmavano la convenzione per lo sgombero del triangolo da pane italiana.
Lo spirito del1e popolazioni dell'Albania meridionale stava radicalmente mutando. La celebrazione dell'anniversario della proclamazione dell'indipendenza fatta il 28 noyembre a Valona mostrò senza ombra di dubbio che lo stato d'animo nei confronti degli Italiani non era certo di gratitudine. Le voci, continuamente ripetute dalla stampa italiana, che Valona sarebbe stata stabilmente occupata dall'Jtalia avevano risvegliato il nazionalismo albanese sia in Valona sia nei distretti di Tepeleni e del Kurvelesh. A tenere acceso e far trasmodare in eccessi verbali siffatto nazionalismo concorrevano potentemente i sobillamenti del Governo provvisorio, quelli provenienti dall 'America, dalla Svizzera, da Parigi e da Scutari. Tutto ciò produceva un'ostilità latente, astiosa, specialmente contro il Comando militare italiano, accusato di essere l'ostacolo maggiore all'integrità ed all'indipendenza dell'Albania. Conseguentemente, per timore dei più scalmanati - come sempre avvienela massa della popolazione, già così espansiva con noi, si mostrava fredda e riservata. Nella provincia di Argirocastro le cose apparivano differenti a causa della Grecia. La popolazione della provincia era per metà musulmana e per metà ortodossa. L'elemento musulmano aveva interpretato l'accordo italo-greco, di cui però nessuno conosceva il contenuto, nel senso che l'intera zona sarebbe stata data alla Grecia. Notizie continue provenienti da Parigi e da Roma confermavano tale interpretazione. I bey, che guidavano lo elemento musulmano, erano innegabilmente costernati e mantenevano un'agitazione \'ivissima nelle masse popolari con c.ontinue riunioni, col fornire armi e munizioni e col registrati gli uomini delle bande che dovevano insorgere contro i Greci non appena questi avessero messo piede sul suolo albanese. Tal une di queste bande - decisamente bande di briganti - erano già costituite ed csct· citavano la loro azione contro i connazionali ortodossi, accusandoli di connivenza con i Greci. I bey soffiavano suJ fuoco ma chiedevano agli Italiani di restare per g uardare la frontiera e di non abbandonarli come avevamo fatto nella Ciamuria nel 1917. L'elemenro ortodosso, pacifico, laborioso, meno ricco di quello musulmano, ovviamente avrebbe visto di buon occhio l'arrivo dei Greci, ma soprattutto chiedeva la presenza italiana paventando il predominio musulmano. Anche il Governo provvisorio premeva, e attraverso la delegazione a Parigi e direttamente a Roma, per il passaggio della provincia di Argirocastro sotto la propria giurisdizione. A P <lrigi la delegazione albanese era divisa, com'era da attendersi, in più gruppi: taluni, fra i quali emergevano Turkhan pascià e mon· signor Bumçi, erano di tendenze italofile: altri, quali il gruppo proveniente da Costantinopoli e ispirato dai Giovani Turchi, il dottor Turtulis, Midhat Frashcri (giunto dalla Svizzera) e Medbi bey Fra sheri, erano apertamente italofobi; Mehmet Konica oscillava fra le due tendenze. Naturalmente però su certi obiettivi esisteva piena concordanza. Così, la delegazione informò che non esisteva motivo per cui la provincia di Argirocastro non passasse all'amministrazione governativa. Contemporaneamente Mufid bey si era recato a Roma proponendo un prefetto italiano ed un maggiore dei Carabinieri a capo della gendarmeria. L'll dicembre 1919 alfine il gen . Piacentini, su decisione del Governo italiano, concordava con Mufid bey le modalità dell'atto, sulla base di un modus vivendi pochi giorni prima inviato al col. Vincenzi, Alto Commissario presso il Governo provvisorio, inteso a pacificare gli animi, a tranquillizzare gli ortodossi, ad impedire il predominio musulmano, senza intaccare in nulla l'unità e la sovranità dello Stato albanese. Da rilevare che ratto accluso al verbale di passaggio delle consegne amministrative di Argirocasrro sottoscritto il 21 Jicembre fra il conte Capialbi, Segretario per gli Affari Civili d'Albania, per il Comando Truppe, c Mufid bey Libohovo, per il Governo provvisorio , fa esplicito ripetuto riferimento all'« accordo stipulato il 20 agosto 1919 a Roma fra i rappresentanti del Regio l\.Iinistero degli Affari Esteri e quelli del Governo Provvisorio Albanese >> (non approvato a suo tempo dal Governo italiano). Non si può certo sostenere che esistesse molta chiarezza nei rapporti ha Roma e Durazzo. l n conclusione, la sintazi.onc dell'Albania meridionale non era lieta. Il nazionalismo era essenzialmente antiellenico e, di consc- guenzn, era stato indotto inizialmente a vedere in not 1 suoi alleati naturali. I nostri errori indussero gli Albanesi a rendersi conto che non potevano contare sul no5tro appoggio: di qui il rancore, alimentato per giunta dai riflessi di un movimento panislamico, che scuoteva tutto il mondo musulmano. In ques to quadro, gli errori e gli abusi inevitabilmente commessi dalle nostre autorità militari ed amministrative in posto, anche se in generale di scarso rilievo, non soltanto non erano perdonati ma il loro peso veniva esasperato dall'azione della propaganda a noi wntraria in terreno fertile.
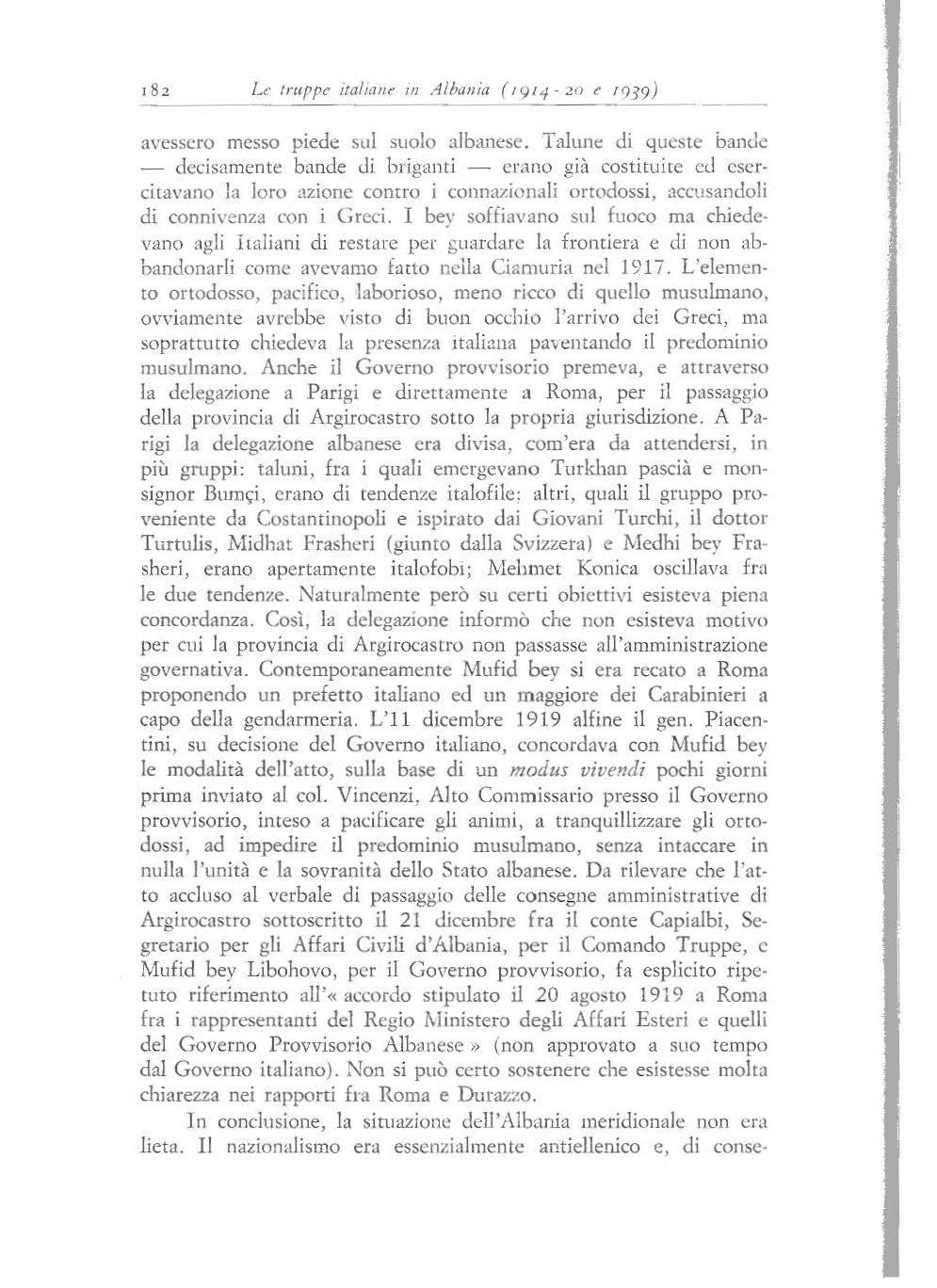
« Specialmente le voci di ogni genere che circolano intorno alle intenzioni dell ' Italia, c che non si sa se c fino a che punto possano essere smentite, tengono in grand<.: orgasmo queste popolazioni. Un cenno sia pure fugace intorno a tali intenzioni toglierebbe quesro Comando e gli organi che ne dipendono da una situazione abbastanza penosa » ( l l.
Il fallimento della politica adriatica di Tirroni nei rapporti con gli Alleati (in particolar modo con gli Stati Uniti) condusse alle dimissioni del Ministro, che il 25 novembre passò la mano a Scialoja, ma iJ1 pratica direttameme a Nitti, il quale da allora seguì le trattative in prima per sona. Nel suo primo periodo Nitti aveva piuttosto trascurato l'Albania ed il suo interesse era puramente negativo : « liqttidare presto la questione dei confini dell'Albania e ritirare il nostro corpo di spedizione riducendo/o al minimo, altrimenti la voragine .finanziaria non sarà più colmabile » fu l'indirizzo che diede a Scialoja in missione a Londra per ricevere e discutere il memorandum anglo- franco- americano dell'8 dicembre. Nonostante tale convinzione, che per estensione lo induceva a considerare anche il mandato sull'Albania indipendente come onere economico e per di più gravoso, Nitti, tutto sommato, si dimostrò disponibile ad accettare la parte del memorandum riferentesi all'Albania, con due eccezioni però. I1 documento, che rifletteva l'intesa raggiunta fra gli alleati, diceva:

« ( ) 5. L'Italia riceverà dalla Società delle Nazioni mandato di amministrare lo Stato indipendente de ll ' Albania ( ). Al nord cd all'est le frontiere saranno per il momento quelle che sono srate fissate dalla C.onferenza di Londra nel 1913. La frontiera meridionale resta oggetto di trattative. Tuttavia, per non ritardare un accordo generale con negoziati a tale scopo, potrà essere adottata la seguente soluzione provvisoria: la Grecia occuperà... (2).
(ll Piacentini a .\lin. Esteri, .\Iin . Guerra e Comando Supremo. f. '7799 Op. Risen·atissimo clara 16 nowrnbre 1919.
(2J I n sostanza, si tratta\'a delle provincie d i Argirocasrro e dì Korça, con unn riserva per un a zo na che doveva essere oggetto di ulreriori ttarradve fra le tre Porenze alleare, a nome dell 'Albania, e la Grecia.
« 6. La città di Va lona, con l'hinterland streLtamcnte alla difesa ed ;ll suo sviluppo economico. sarà attribuita atl 'Iralia in pie na sovranità >>.
In allegato erano indicate le clausole che avrebbero dovuto regolare il mandato affidato all'Italia. In linea di principio era dunque confermato il concetto dell'indipendenza e dell'unità albanesi, salvo il mandato e le cessioni territoriali, a proposito delle quali erano previste alcune rettifiche ai confini settentrionale ed orientale fav ore della Jugoslavia.
La controproposta italiana (3 gennaio 1920) si limitò a respingere queste ultime rettifiche e ad apportare qualche variante allo schema di mandato. Tuttavia , a questo punto occorre dire che assai più grave, ed anzi nodo cruciale eli tutto il problema adriatico , era la questione di Fiume, tanto importante per l ' Italia che Nitti ebbe a dichiarare a Clemenceau c Lloyd George, durante i successivi negoziati con i rappresentanti ju goslavi (12 gennaio), che

« se Fiume fosse stata attribuita all'It alia, egli era pronto a discutere una revisione dei confini settentrionali dell'Albania, a condizione ch e l'Italia avesse rice vut o il mandato sull'Al bania cent rale». Il dissidio fra i delegati serbo e croato, ciascuno diversamente interessato , portò al diniego jugoslavo per Fiume - ma accettando come dovuto tutto lo Scutarino e, in più, chiedendo le rettifiche ai confini orientali albanesi -, diniego confermato da Belgrado e che fece sfumare qualunque possibilità di accordo , perché di lì a poco l'Albania si sarebbe sollevata, rendendo inutile parlare, sia pur teoricamente, di spartizione.
Al termine del 1919 la situazione generale in Albania non era delle migliori cd anche a Roma esistevano preoccupazioni. A fine ottobre il gen. Albricci scrivendo a Tittoni, e riconoscendo che le condizioni delle nostre truppe in Albania lasciavano a desiderare sotto molti aspetti, sottolineava che tale stato di fatto era la naturale conseguenza del contrasto esistente fra le varie esigenze, tutte egualmente importanti , alle quali doveva essere subordinata la nostra occupa:done mililare, oltre naturalmente alle ragioni climatiche, ai disagi ed all'ambiente di insicurezza in cui vivevano i reparti. Ad esempio , uno dei punti più importanti, come quello della sistemazione degli alloggiamenti, era troppo strettamente collegato con l a definitiva soluzione del problema albanese, perché - senza conoscere esattamente i limiti entro i qual i sarebbe stata contenuta la nostra occupazione - si potesse dare un vasto incremento alla costruzione di costosi baraccamenti anche per i distaccamenti in zone la cui assegnazione poteva essere contestata. Ma anche la precisa definizione deJla nostra presenza in Albania non avrebbe probabilmente consentito di realizz are il necessario assetto di stabilità con la desiderata soiiedtudìne e facilità, essendo note le difficoltà di carattere interno che inconrrava il gen. Piacentini, la cuj opera non era certo agevolata dal Governo provvisorio albanese, il quale all'attO pratico si dimostrava pitl propenso a creare imbarazzi alla autorità militare italiana che a concorrere con essa per superare i non semplici problemi di carattere politico- militare.
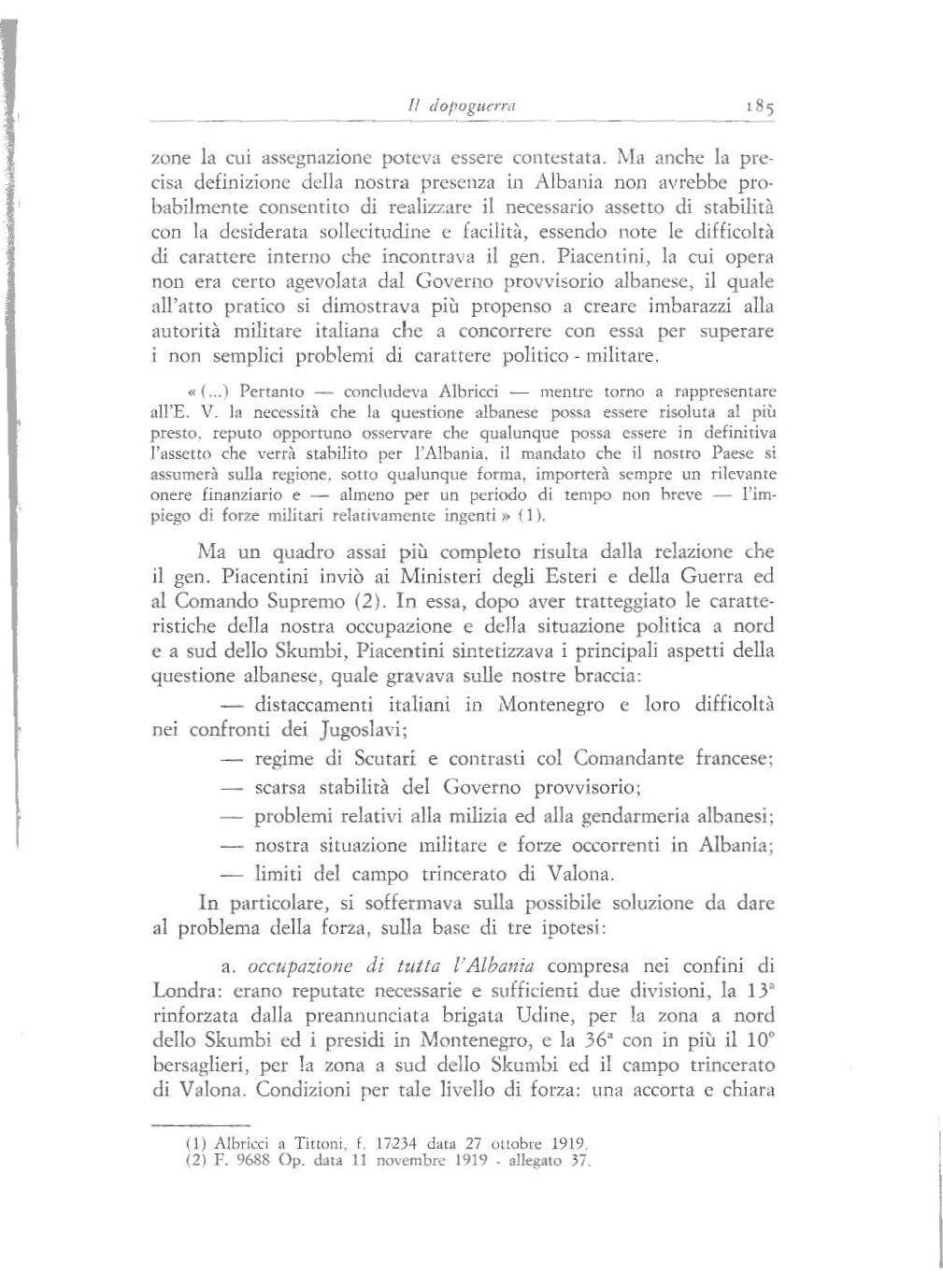
<< ( •.• ) Pertanto - concludeva Albricci - memrc torno a rappresentare all'E. V. la necessità che la questione albanese poss:t essere risoluta al più presto reputo opportuno osservare che qualunque possa essere in definitiva l'assetto che verrà stabilito per l'Albania. il mandato che il nostro Paese si assumerà sulla regione. sotto qualunque forma, importerà se mpre un rilevante onere finanziario e - alm(;no per un periodo di tempo non brc\·e - l'impiego di forze militari relativame nte ingenti » ( l )
Ma un quadro assai più completo risulta dalla relazione che il gen. Piacentini .inviò ai Ministeri degli Esteri e della Guerra ed al Comando Supremo (2 ) In essa, dopo aver tratteggiato le caratteristiche della nostra occupazione e della situazione polìtica a nord e a sud dello Skumbi, Piacentini sintetizzava i principali aspetti della questione albanese , quale gravava sulle nostre braccia:
- distaccamenti italiani in Montenegro e lo ro difficoltà net confronti dei JugoslaYi; regime di Scutari e contrasti col Comandante francese; scarsa stabilità del Governo provvisorio; problemi relativi alla milizia ed alla gendarmeria albanesi: nostra situazione militare e forze occorrenti in Albania ; limiti del campo trincerato di Valona.
In particolare, si soffermava sulla possibile soluzione da dare al problema della forza, sulla base di tre ipotesi: a. occupazione di tutta !''Albania compresa nei confini di Londra: erano reputate necessarie e sufficienti due divisioni, la 1.3 a rinforzata dalla preannunciata brigata Udine, per la zona a nord dello Skumbi cd i presidi in Montenegro, c la 36a con in più il 10° bersaglieri, per la zona a sud dello Skumbi ed il campo trincerato di V alona. Condizioni per tale livello di forza: una accorta e chiara dl6 Le rruppe italtane 111 Albanta (r914-20 e 1939) politica da parte del Governo italiano ed ampie dotazioni di organi dei servizi (specialmente nel campo dei trasporti) e di unità trasmissioni; b. occupazione ridotta alla fttSCLa cos tiera: pote\·a bastare una divisione su tre brigate, una per tutta la costa e due per il campo trincerato. Condizione vincolativa: la div.isione doveva avere l'apparato logistico di un corpo d'operazioni oltremare; c. occupazione ru/otta al campo trmcerato di V alona: era necessaria una divisione con i servizi di un corpo di spedizione. La relazione chiudeva con il parere che << tale questione dovrebbe essere definita al più pre.1·to, poiché il protrar/a in queste condizioni non può che aumentare il danno cbe a noi proviene». Il gen. Albricci convenne pienamente sulle considerazioni esposte a proposito della nostra situazione e delJe difficoltà in cui versavano i reparti, sulle quali assicurò di aver richiamato l'attenzione del Ministro degli Esteri, ma dovette ammettere che l'adozione di uno dei tre progetti di occupazione nulitarc prospettati, rispondente a tre diverse concezioni di quello che sarebbe potuto essere il nostro definitivo mandate sull'Albania, « è1 naturalme1zte, troppo subordinata alla soluzioue del problema albanese, perché sia possibile, fin d'ora, dare inizio all'attuazione di u1to di essi».

In merito a Valona ed al suo retroterra t! bene però soffermarsi un momento. Subito dopo l ' armistizio ed in vista delle discussioni alla Conferenza della Pace sulla delimitazione della zona di Valona da assegnare all'Italia, il gen. Diaz si era premurato di fornire al Ministero degli Esteri clementi in proposito (l). Prendendo spunto dall'art. 6 del Patto di Londra: « L'Italia otterrà in pieno dominio Valona, l 'isola di Saseno ed un territorio di estensione sufficiente ad assicurare il territorio contro pericoli di natura militare, approssimativamente fra il f. Voju ssa al nord ed all'est, ed al distretto di H i mara a sud », rilevava la contraddizione esistente fra lo scopo da raggiungere (assicurare il territorio contro pericoli di natura militare) ed approssimativo limite (Vojussa- Bimara). Dopo talune considerazioni di carattere tattico - topografico , concludeva indicando come area minima, che per sicurezza militare avrebbe dovuto costituire l'hinterland di Va1ona, quella delimitata dal f. Semeni (dalla foce aU'Osum) - testa di ponte di Ardcnica
- q. 900 (Gorica ) - Ciafa Darz - m. Tomori - Mali Kiarista - t. Lo- mnica- Paleocastro - Mali Lucis - Pikernion (schizzo 30 ). Ovviamente la linea di difesa sarebbe stata più arretrata ed appoggia ta a posizioni naturalmenw f orti. Tra il perimetro e la linea difensiva sarebbe esistita una fascia d; copertura sufficiente ad impedire al nemico di effettuare colpi di mano o attacchi di sorpresa. La determinazione dei limiti in questione sfumò sempre di più nelle trattative diplomatiche, anche perché- contraddizioni a parte- a nessun alleato interessava molto allargare ìl retrorerra di V alona per far piacere all' Italia, né questa aveva molte carte da g iocare. La memoria sulla questione adriatica presentata ufficialmente il 6 agosto 1919 all'apposito Comirato della Conferenza da Sci aloja così recitava:
<' ( ) In quanto all'assegnazione di Vatona all'Italia, la Delegazione ita· tiana ritiene che questa sia fuori di ogni contestazione; essa ''uole rutta\' Ìa ricordare come il possesso di quesro porto, col retroterra necessario pe r la sua difesa sia indispensabile per garantire la libertà dell'Adriatico {... ). Il retroterra indispensabile per la sicurezza di Valona è indicato nello schizzo allegato 4 (linea verde). Esso è limitaw renuto como che l'essere lo Stato albanese posto sotto il rnandmo dell'lmlia, costituisce già una parziale garanzia}> (l).
La linea verde corrispondeva più o meno al margine del campo trincerato.
Due giorni dopo Tittoni, in una lettera mandata a Nitti dopo l'accordo con Venizelos, accennando a Valona, scri veva :
<< ( ) Circa Valona ritengo dO\•ersi mantenere nostro dominio sul campo trincerato con limite al fiume Vojussa, fino al TcpeJcn, e ai monti del Curve lesh . Ciò non impedisce che a tale territorio sia conservata pretta fisionomia albanese, ma nel momento attuale, c fino a quando non sia decisa c chiarita la situazione, conviene a nosrra garanzia di non dare limiti maggiormenre ri· stretti alla zona militare ( ) » ( 2 )
Ma nei suoi colloqui con il Sottosegretario di Stato americano, Polk, e gli altri capi delegazione accettò la fo rmul a, piuttosto vaga e suscettibile perciò di diverse interptetazioni, di una << sovranità italiana sulla città con tanto retroterra quanto è strettc1mente necessario alla sua vita economica 11d allu sua sicurezza», tanto che la controfferta di \'Xlilson parlò Ji « piccolissimo retroterra, sufficiente solo per i bisogni economici assoluti dell4 città e la sua sicurezza». Ad ogni modo, interessando fermare sul piano diplomatico prima il concettO e poi la definizione concreta della delimitazione - ev i-
(l) Riporrato Alatri , op. citata , pag. 503 e
(2) Lettera data 8 agosto 1919 riportata da Pnstorelli, up. citata, pag 146 e segg dentcmente era dato per scontato che l'Albania non potesse essere un contraddittore valido per la soluzione che le sarebbe stata imposta - si giunse fino ,,Il'aprile del 1920 senza che un chiaro indirizzo fosse fornito al Comando di Valona, talché questo quando si troverà con le spalle al muro agirà di testa sua.
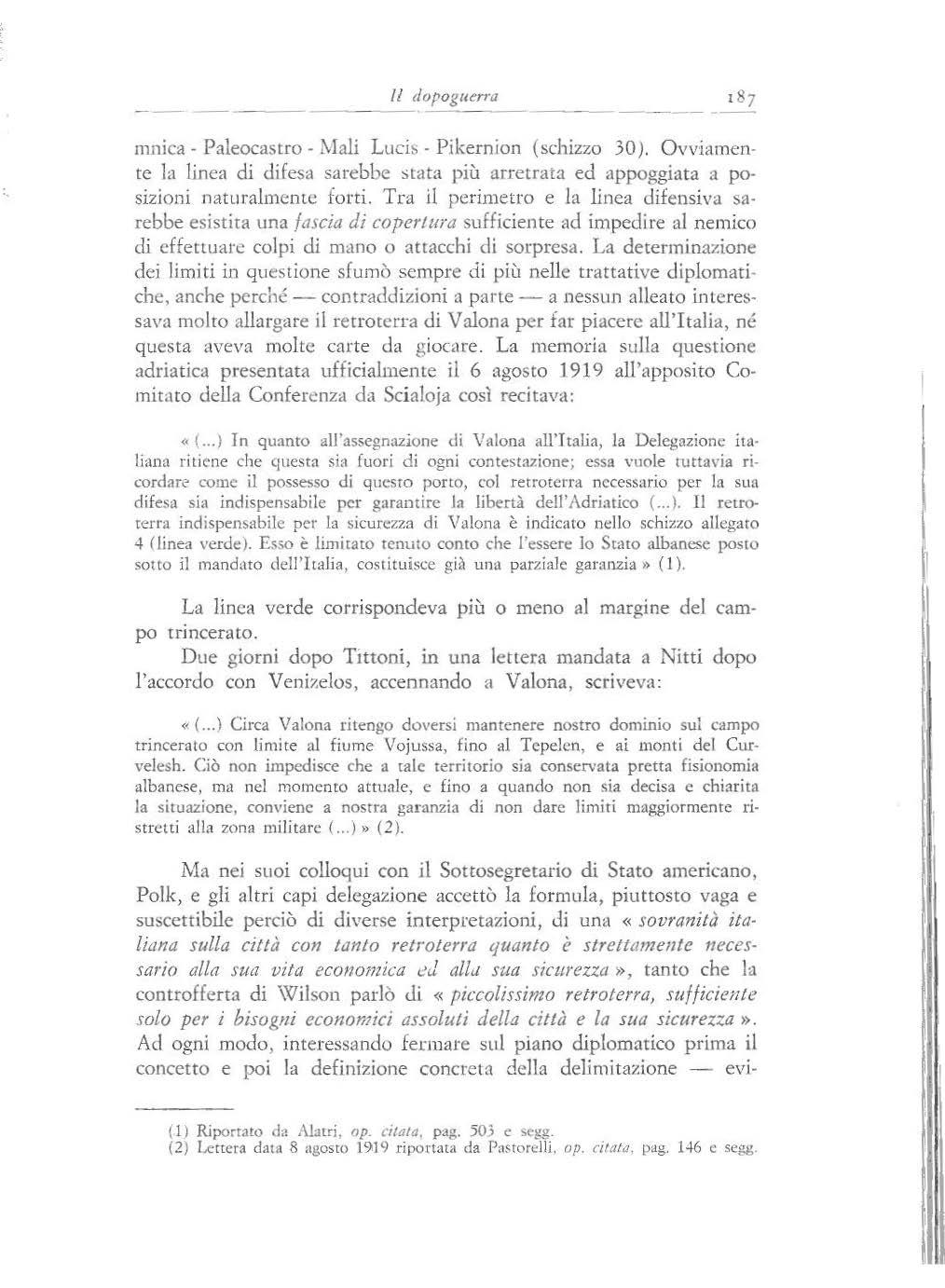
2. L'Assemblea di Lushnja e la crisi.
Alla fine del 1919 la maggioranza dell'Assemblea di Durazzo si era convinta che nessun'altra possibilità rimaneva sul piano politico. Favorevoli all'Italia - entro certi limiti - rimanevano pochi esponenti ormai, fra cui Mufid bey Libohovo, ai quali era stato detto che l 'accordo Tittoni- Veni zelos non avrebbe avuto esecuzione (l) e che vantavano come solo per l'intesa dell'agosto Argirocastro era tornata all'amministrazione albanese. Come si è detto, il più attivo panito d'opposizione era que1lo nazionalistico, che si agitava contro l'Italia. In particolare era ostile il gruppo di Argirocastro, tanto da inviare, dopo un comizio tenuto il 19 dicembre (due gio rni prima del passaggio della provincia al Governo albanese) due mozioni contro il citato accordo Tittonl- Venizelos, rispettivamente al « Presidente della Conrerenza della Pace >> ed ai Presidenti del Senato e della Camera ·italiani (2). Però i nazionalisti si agitavano anche contro il Go verno di Durazzo, di cui ponevano in discussione la linea politica ed i cui membri reputavano non idonei a realizzare un programma di indipendenza. Il l o gennaio 1920 alcuni esponenti di questo partito promossero la convocazione di una nuova assemblea nazionale a Lushnja, pe.r protesta contro il Governo provvisorio e senza suo permesso . I lavori cominciarono effettivamente il 28 gennaio e in tre giorni condussero ai seguenti risultati:
- approvazione della decadenza del Governo provvisorio di Durazzo e della sua delegazione a Parigi (che però venne subito riconfermata con il preciso compito di difendere i confini naturali e l'indipendenza incondizionata della patria albanese);
- approvazione dello statuto provvisorio da dare al Paese;
- nomina dell'Alto Consiglio di Reggenza (quattro membri), del Senato (trentasette membri) e del nuovo Governo (sei membri). Primo ministro divenne Suleiman bey Delvino, agli Esteri fu designato .Mehmet bey Konica ed agli Interni fu preposto Ahmed bey Mathi, più noto come Ahmed Zogolli c poi come re Zog I;
(l) Memori:tle di i\lufid bey Libohovo citato.
(2) Piacentini a \lin. Esteri e Guerr:t e Comando Supremo, tele 10528 del 22 dicembre 1919 e f. 10565 del 25 dicembre 1919.

- scelta di Tirana come capitale provvisoria deJlo Stato.
L'Assemblea di Lushnja (28 gennaio- l febbraio ) ebbe un'impor tanza che, almeno inizialmente, sfuggì al Comando Truppe Albania ed ancor più a Roma. Prima di tutto, il sostegno popolare era effettivo e molto ampio; in secondo luogo, il governo che essa aveva nominato era significativamente rappresentativo di tutte le componenti religiose ed emiche del Paese; in ten:o luogo, in analogia all'indirizzo dato alla delegazione a Parigi, il nuo\'O governo doveva iniziare la sua opera realizzando il co ntrollo di tutto il territorio nazionale e facendo cessare il regime di occupazione. Bisogna riconoscere che, nonostante la perentorictà dei termini con la quale si erano espressi i congressisti, l'Italia non venne presa di petto. Forse per prudenza, forse per mantenere sino al limite possibile buoni rapporti con lo Stato vicino dal quale era possibile sperare una concreta collaborazione. Il Presidente dell'Assemblea si fece premura, infatti, di comunicare subito al Comando Truppe Albania le decisioni prese, aggiungendo che tutti i delegati erano animati da un sincero proposito di conservare l'amicizia italiana. Il gen. Piacentini, dal canto suo, avuta notizia dell'imminenza della convocazione di Lushnja si preoccupò essenzialmente che l'ordine pubblico non fosse turbato e che la riunione non rivestisse carattere di ostilità verso l'Italia; poi, ricevuta la notifica della decadenza del Governo pro vvisorio, inte rvenne in modo da consentire al nostro Ministero degli Esteri libertà di decisione: dichiarò all'Assemblea di non poter riconoscere ufficialmente la sua autorità e la invitò a sciogliere la riunione, in quanto essa poteva ingenerare turbamento nell'ordine pubblico, del quale l'Autorità militare italiana era divenuta responsabile per effetto dell'esautorazione del Governo provvisorio di D urazzo; però l'inviato, giunto a Lushnja, fece in modo di comunicare l'invito a sospendere i lavori quando questi erano praticamente ultimati. Il l 0 febbraio i delegati ritornarono alle rispettive provincie avendo preso tutte le decisioni p iù importanti. Il 6 febbraio, Ahmed Zogolli annunciava ufficialmente, con una circolare a tutte le prefetture ed ai municipi, il cambiamento di regime. Il 10 il nuovo Governo ent rava in Tirana e pochi giorni dopo gli ultimi esponenti del vecchio governo consegnavano archivi c tesoro.

Nessun dubbio sull'abilità politica dei nuovi dirigenti. Benché sicuri del consenso popolare, con l'adesione immediata di larga parte della gendarmeria e della milizia albanese, erano riusciti ad insediarsi pacificamente senza opposizione alcuna da parte dei politici di Durazzo , senza che nulla turbasse la vita pubblica e potesse provocare l'intervento del Comando di Valona, con un conseguente scontro fra truppe italiane e unità albanesi. Anche con il Comando Truppe Albania seppero destreggiarsi bene, in modo da evitare allarmi. Il 3 marzo due ministri conferirono a Valona con il geo. Piacentini esordendo con ampie dichiarazioni di amicizia e di ammirazione per l'Italia, di rispetto per l'occupazione militare che auspicavano continuasse, di speranza nell'appoggio italiano. Espressero il desiderio di riallacciare subito relazioni cordiali con il Governo di Roma ed il Comando di Valona, pronti a dare tutti i chiarimenti utili a dissipare prevenzioni e malintesi. Affermarono poi di avere il solo proposito di seguire l'indirizzo indicato dal Congresso di Lushnja ed infine, alle osservazioni mosse dal loro interlocutore, risposero minimizzando e smussando tutti i possibili angoli. Il gen. Piacentini riferì a Roma dettagliatamente e chiuse il suo telegramma cosl:
« Est mia convinzione che Govern o Tirana oggi rimasto solo irr Albania desidera nostro appoggio anche più dd Governo di Durazzo et che noi potremo riguadagnare in breve più di quanto si est perduto purché si adotti verso Albanesi una linea condotta meno dubbia et incerta di quella seguita finora /,/ si proceda con idee chiare et ferme intorno a quello che vogliamo /,/ s1 abbandoni l'idea di smembrare l'Albania ( ) » (l).
La sua convinzione era troppo ottimista. Nell'ambito del Governo di Tirana si delinearono subito due correnti: gli esponenti delle regioni settentrionali intendevano cominciare la liberazione del territorio nazionale dal nord, mentre quelli delle zone merjdionali caldeggiavano il programma inverso. Furono le circostanze stesse a stabilire la priorità. La prima prova di for:::a fu originata dalla decisione francese di ritirarsi dall'amministrazione internazionale di Scutari. Il gen. De Fourtou, il quale già più volte aveva provocato attriti con le nostre autorità, evitò di trasferire i poteri al comandante italiano che doveva succedergli per ragioni di grado , tentando di agevolare cosl il passaggio del controllo della città al Governo jugoslavo. Invece fu colto di contropiede dalla decisione unanime dei notabili cittadini di procla- mare la loro piena obbedienza al nazionale Ji Tirana, che per sua parte si affrettò ad inviare sul posto il ministro Zogoll.i. La mossa ebbe ripercussioni a Belgrado, ovc si sperava di poter offrire aiuto a Tirana contro gli Italiani per ottenere il rilascio di Valona. Visto che le cose si erano messe in altro modo, Ja Jugoslavia cercò c.Ji riesumare un vecchio personaggio, Essad pascià, con la promessa di appoggiare la sua candidatura al trono dell'Albania centrale musulmana, tuttora valida .ipotesi nelle trattative parigine. E il movimento essadista -- appoggiato da quello, più generale, islamlco ispirato da Costantinopoli, nonché da personaggi del precedente regime messi in disparte e desiderosi di rivincita ben presto si profilerà come minaccia molto seria.

L 'evolversi della situazione politica albanese era seguito attentamente dal gen. Piacentini che ne informava con periodica regolarità (l) sia il Ministew della Guerra sia quello degli Esteri. Nella relazione del 3 3prile egli poneva in risalto come l'agitazione nazionalista, propagatasi ed intensificatasi in tutto il paese, rappresentava ormai non più l'atteggiamento di taluni notabili albanesi, bensì l'indirizzo prevalente del Governo di Tirana. I riferiment i all'unità territoriale entro i confini del 19 i 3 erano generali in tutte le classi sociali, così come frequentissimi erano gli accenni espliciti alla «liberazione>> della provincia di Valona. Al riguardo appariva valido motivo di propaganda il passaggio dell'amministrazione di Scutari all'autorità nazionale, che dimostrava al popolo come a Tirana si lavorasse per eliminare ogni ingerenza straniera. Ma dove le cose si mettevano male era nell'Albania meridionale, ove il terrorismo politico contro i funzionari locali devoti all'Italia stava allontanando da noi molti amki ed inducendo a passare fra gli avvetsari quelli incerti: ll dopoguem1

«Intanto i capi della gendarmeria, a cui principalmenLC sono da attti· buire i sistemi terroristid inscenati nell'Albania meridionale, continuano in· disturbati nella loro opera nazionalista, scalzando il nostro prestigio. Tale opera fa sì che la nostra situazione p<.!ggiori giorno per giorno, tanto più che si S\'Olge fra popolazioni aifatto ignoranti ed impulsive.
« ln cotali condizioni i nostri presidi dell'Albania meridionale si rrovano a dover essere spettatori passivi di tutto ciò che fanno i gendarmi albanesi, anche in odio all'Italia, senza poter in alcun modo intervenire; sono ridotti nella penosa condizione di non sentirsi più sicuri in un territorio che hanno riscattato dall'ignavia c dal giogo straniero col proprio la voro e col proprio sangue.
(ll Vcdansi gli :tUeg;ni da n. 40 :1 n. 48 , riferiti agli ultimi mesi della nostra permanenza in Albania.
<< La politica ambigua da noi fino ad ora seguita nell'Albania meridionale ci è materialmente e più ancora moralmente ed ha portato a turbare profondamente questa popolazione che fino a qualche mese fa ci considerava quali liberatori e salvatori.
« Considerando pertanto la situazionc complessiva d e ll'Albania e tenendo como inoltre che con l'imminente ripresa dell<t sragione malarica, i nostri Presidi, già esigui, subiranno rapidamente un ulteriore fortissimo as sottigliamento. dato che molti dei militari sono già stati in passato colpiti da malaria , questo Comando ad evitare conseguenze funeste non vede che le seguenti due soluzioni da applicarsi immediatamente:
- o rinforzare le truppe con una brigata per modo che si possa imporre la nostra volontà agli Albanesi;
- o riconoscere decisamente ed apertamente il Governo di Tirana e la integrità dell'Albania , se nza attendere più oltre, perché l'attesa e l'indecisione ci hanno già creato la più pericolosa delle situazioni.
« 11 nuovo Governo vede forzatamente, c forse suo malgrado, la necessità della nostra amicizia e la chiede; ma poiché essa tarda a manifestarsi, la reputa dubbia e V<l sempre più orientandosi verso una politica anti·italiana per avere l'appoggio degli elemen ti più spinti, ma più fattivi, dai quali è già oggi dominato ed a cui finirà domani per essere completamente assorbito » (l).
Alla relazione era allegato un interessante rapporto circa un colloquio fra il ministro Ahmed bey Zogolli ed il gen . Freri, comandante del 6" rgpt. alpini e del presidio di Tirana, colloquio che lo Zogolli desiderava venisse portato a conoscenza del Governo italiano perché rifletteva il pensiero albanese su due questioni in particolare: Argirocastro e VaJona. Sul primo si chiedeva che le truppe italiane non abbandonassero la regione, come correva voce, perché assai ben viste e garanzia di sicurezza contro le bande locali di armati; e, comunq ue, nella eventualità di un tale provvedimento, si raccomandava di dare un preavviso di una decina di giorni in modo da poter inviare in posto alcune migliaia di gendarmi. Sulla questione di Valona, Ahmed Zogolli pregava
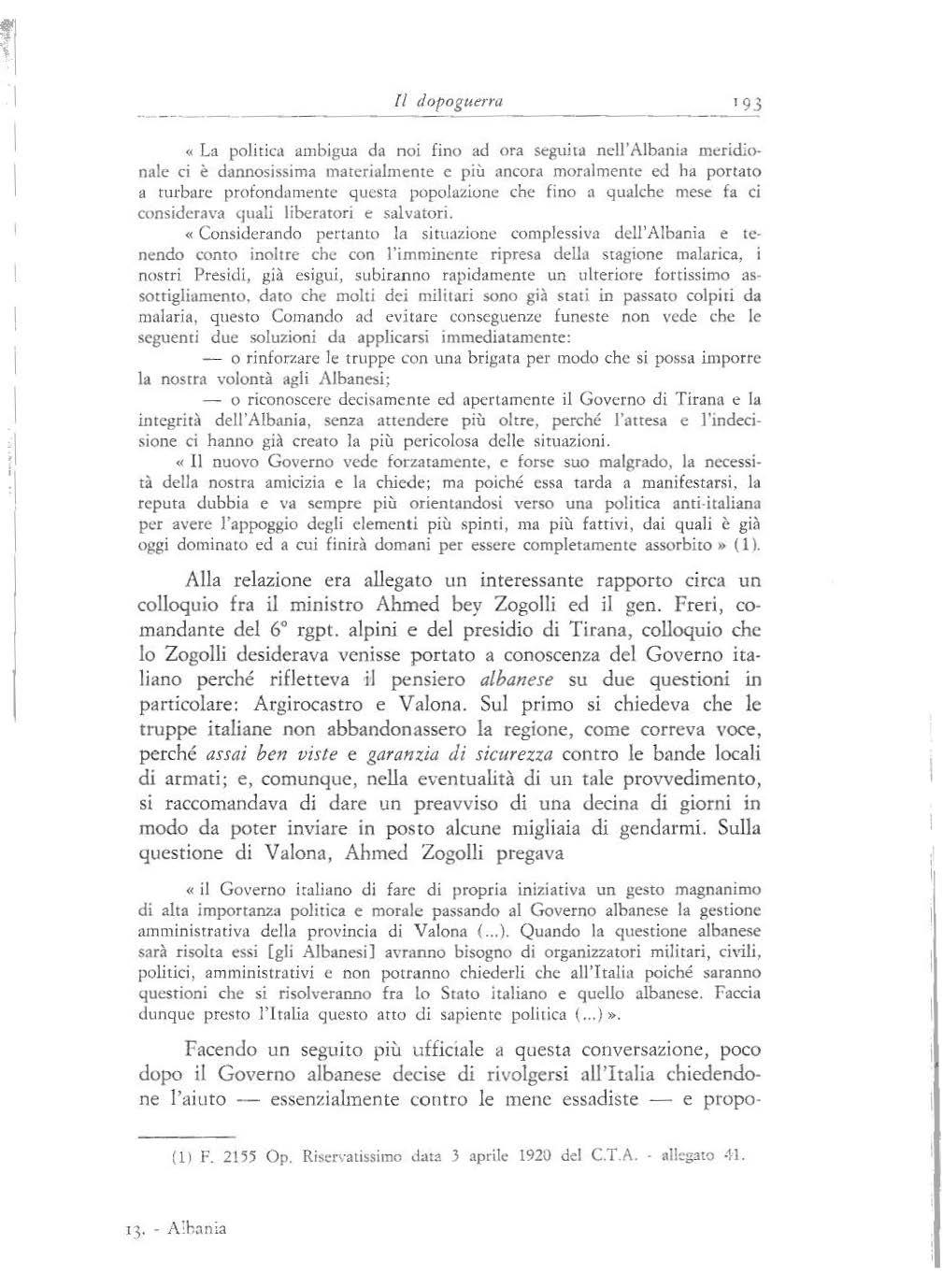
« il Governo iraliano di fare di propria iniziativa un gesto magnanimo di alta importanza politica e morale passando al Gove rn o albanese la gestione amministrativa della provincia di Valona (. ). Quando la questione albanese sarà risolta essi [gli Albanesi) avranno bisogno di organizzatori militari, civili, politici, amministrativi c non potranno chiederli che all'Itali<l poiché saranno questioni che si risolveranno fra lo Stato italiano e quello albanese. Faccia dunque presto l'Italia questo atto di sapiente politica ( ... ) ».
Facendo un seguito più ufficiale questa conversazione, poco dopo il Governo albanese decise di rivolgersi all'Italia chiedendone l 'a iuto - essenzialmente contro le menc essndiste -e propo- nendo un compromesso per Valona, vale a dire che le Autorità civili e politiche (compresa la gendarmeria) delle provincie di Valona c di Argirocastro passassero alle sue dirette dipendenze, mentre alle truppe italiane era com:csso il consenso governativo a rimanere in questi territori, dove anzi la loro presenza era desideratelo Come si vede, siamo in fondo nell'ambilo dell'idea di Sonnino di una « preminenza militare » locale senza pregiudizi per la sonanità nazionale.
A Valona si aveva adesso un quadro abbastanza completo dei vari aspetti del problema albanese ed era possibile formulare su di esso un apprezzamento sostanzialmente corretto. .Mantenendo fer mi i principi di non guastare - almeno finché possibile - i buoni rapporti con le autorità locali e di evitare decisioni di iniziativa che potessero compromettere future decisioni del Governo italiano, il gen. Piacenrini richiamò - su richiesta di Tirana - gli ufficiali italiani in servizio presso 1a gendarmeria e di talune unità di milizia passate agli ordini governativi e propose al Ministero della Guerra di far ripiegare i presidi minori dell'interno (schizzo 31 ). Come infatti aveva più volte rappresentato, la situazione della forza era allarmante e se le autorità albanesi erano tuttora ben disposte, nel popolo i segni di ostilità aumentavano a vista d'occhio. Scopo del ripiegamento programmato delle truppe verso la costa era anche quello di agevolare il passaggio di tutto il territorio da noi controllato alla giurisdizione totale albanese, e\'Ìtando un vuoto di potere in talune zone di cui avrebbe potuto approfittare il movimento cssadista. Senonché, a questo punto, le incertezze della politica del ministero Nitti impressero agli avvenimenti un'altra fatale accelerata verso la guerra di V alona. Nitti inizialmente accettò di buon grado Ie proposte dello Stato Maggiore dell'Esercizio, giacché collimavano con il suo pensiero fisso di ridurre gli effettivi e smobilitare le forze di campagna (a prescindere dalle necessità locali); ma, di fronte alla resistenza di Scialoja a riconoscere ufficialmente il Governo albanese senza alcun guadagno politico, fece marcia indietro. Il conte Sforza, dal camo suo, suggerì di inviare sul posto una persona competente e di fiducia con ampi poteri decisionali. Tale suggerimento fu accolto nella riunione del Comitato di guerra del 6 aprile; di conseguenza, fu deciso l'invio di un Alto Commissario, il commenda tor Castoldi, col compito di assumere la direzione e la trattazione di tutti gli affari politici albanesi e tener e , solo, i rapporti col Governo di Tirana. Unica limitazione alla sua azione era il campo trincerato di Valona, che doveva rimanere sotto l'esclusiva responsabilità del gen. Piacentini.

Lo scopo della nostra pennançnza era ormai solo politico, il compito assegnato alle truppe (possesso dei principali punti della costa) militare. Ancora una volta l'entità delle forze non era adeguata al compito e quesro non era proporzionato allo scopo.
La missione Castoldi non poteva nascere sotto peggiori auspici .
Il fatto di mantene re Valona sotto amministrazione militare, con l'evidente intenzione di bcilitare l'eventuale annessione italiana, infirmava alla base la possibilità di colloquio con Tirana; la disperata povertà numerica dei nostri reparti, che nessuna rispondenza aveva più con l'ordinamento del corpo di spedizione, impediva una qualsiasi politica di forza; la reticenza tlfficiale di fronte ai governanti albanesi ed una benevola neutral ità verso gli essadisti (l) erano in contrasto netto con la linea di condotta che il gen. Piacentini aveva ben compreso essere l'unica possibile; in ultimo, sul piano perso· na le, era quanto meno grave errore di psicologia e di senso pra t ico l'affidare al Castaldi mansioni che lo ponevano al di sopra del tenente generale Piacentini (2). Anche il momento non poteva essere più infelice : in quei giorni si era sviluppato un movimento insurreziona le essadista rivolto contro il governo e specialmente contro il ministro Zogolli. Il Castaldi, dunque, sbarcò a Valona il 10 aprile e in un colloquio col gen. Piacentini seppe o meg lio, ebbe confer ma, in quanto la notizia era giunta a Roma prima ancora d ella sua partenza che il Governo di Tirana aveva chiesto al Comando Truppe di Albania il citato passaggio di Valona sotto la propria amministrazione. Da notare che la tichiesta albanese, p ur non essendo redatta sotto forma di ultimatum, si concludeva con l'avvertimento che in caso di risposta negativa il Governo albanese « si riservava libertà di azione».
Dopo aver stabilito con il comandante delle Truppe che l'ormai deciso ripiegamento avrebbe avuto inizio solo dopo la presa di contatto con gli esponenti governa tivi, il Castaldi p roseguì per Durazzo, il cui prefetto, da buon essadista, gli fornì un quadro piut· tosto interessato della rivolta te té scoppiata. Per ben illustrare l'atteggiamento dci protagonis t i sarà utile sottoli neare che i r ivol- tosi protesta vano che la loro iniziativa nulla aveva di inquietante per le truppe italiane, essendo diretta unicamente contro Tirana. Nel segnalare gli eventi ai Ministeri della Guerra c degli Esteri, il gen. Piacentini terminava con queste parole:
(l l Cfr. P. Pasrorelli, op. citata, pag. 334 e seg.
(2) Il CastOldi. già capo ufficio informazioni dd corpo speciale italiano, ricopriva quell'incarico quando il gcn. Piacentini venm:, nel marzo 15H6 , a prendere il comando delle truppe: d'Albania, diventate XVI corpo d'armata. Ebbe qualche contras to col nuovo Comandante sul modo di esplicare il sen·izio c dopo pochi mesi. in occasione della desriruzione di Osman Effendi, fu nominato prcfcuo di Valona e poi Commissario italiano. Infine. fu chiamatO, come esperto, alla ddegazione italiana alla Conferenza de lla Pace e lasciò il servizio Ja tcn. colonnello per c:ntrare in diplomazia. Questo era il primo incarico.

« ( ... ) In conclusione, in due zone ben distinte Mathi e Kruja est scoppiat:J rivolta contro Governo Tirana il quale per ora si mostra impotente a domarla stop Avendo detta rivolta carattere evidentemente essadista est necessario conoscere linea di condotta che dovranno tenere nostre truppe verso Essad pascià et suoi seguaci qualora si verificasse ipotesi non impossibile che detto pascià compaia imprO\'\'Ìsamente in Albania >> (l}.
Nel contempo giunsero a Durazzo notizie dalla capitale circa la presenza di alcune centinaia di essadisti intenzionati a rovesciare il Governo e sull'opposizione di quel presidio italiano al loro ingresso in città, sulla base delle disposizioni ricevute dal gen. Piacentini. Il diverso orientamento mentale dei due nostri esponenti in Albania, l'Alto Commissario ed il Comandante delle truppe, ostile al governo di Tirana e favorevole ad Essad pascià (2) ìl primo, evidentemente in relazione a direttive specifiche o generiche, e del tuttO opposto i l secondo, sia p(!r l'atteggiamento ormai da tempo assunto ufficialmente dall'Italia nei confronti del discusso personaggio, sia per una più chiara valutazione dello stato di fatto, creò subito il primo incidente. 11 Castoldi, infatti, telegrafò a Roma recrimin ando per gli ordini del Comandante d'Albania e chiedendone la revoca:
«Nuovi avvenirnenri grav i dimostrano crescend o veloce azione essaclista stop nei pressi di Tirana sta Osman bey con 400 armati circa e chiede se in città gli Italiani rimarranno neutrali stop go\·emo et senato ritenendosi malsicu ri contano chiedere nostro concorso per trasferirsi altrove stop ove mi rivolgano tale domanda conto invitarli rih1giarsi Durazzo in attesa avvenimenti che per ora non sono chiari e consigliano prudenza stop colonnello Lodi mi riferisce che situazione ha dato luogo adozione provvedimenti secondo istruzioni scritte da gen. Piaccntini che prescrivono nostre tm ppe donanno contrastare azione essadista e serba ( ... ) » (3) .
Poi , con altro messaggio, precisò che il movimento essadista stava prendendo maggior piede talché era da prevedersi che in bre- ve avrebbe cercato uno sforzo nsolutivo per abbattere gli avversari, con esito favorevole, « salvo circostanze imprevedibilz o nostro intervento, che non stimo conve11ga nelle attuali condizwni ». E' chiaro che secondo l'Alto Commissario la partita si profilava come facile vittoria per gli essadisti: soluzione da vedere con favore. Ma il 14 aprile si presentarono a Durazzo due ministri albanesi ed invece di sollecitare un aiuto per fuggire da Ti rana chies<.:ro formalmente l'inten·ento italiano contro l'agitazione essadista, non esitando a dù·e che la nostra pretesa neutralità in pratica si traduceva in un coperto appoggio ai rivoltosi; rinnovarono, poi, la richiesta di estendere l'amministrazione governativa su Valona pur concedendo agli Italiani l'uso della base marittima. La risposta del nostro rappresentante fu sostanzialmente negativa. Per le implicazioni che ciò comportava egli allora fu invitato nella capitale per esporre davanti al Primo ministro, Suleiman Delvino, il pensiero ufficiale deli'Jtalia su tutta la questione. A Tirana, il Cas taldi ripeté quanto già ave\·a detto - parlando da una posizione di forza assolutamente inesistente - e tolse ogni residua speranza o illusione agli Albanesi, i quali dovettero rendersi conto come Roma intendesse ottenere la piena sovranità su Valona, fosse consenziente alle cessioni territoriali a favore dei Greci e dei Jugoslavi e preferisse H governo essadista a quello in atto (l).
(l) Tele 2390 op. datato 12 aprile 1920. Fin dal 7 aprile, però, il geo. Piacenti n i aveva comunicato a Roma di avet ordinato alle di salvaguardare l'ordine pubblico e jare opposizione rollanto ad avanzata serba ed a mene palesemente t?ssadiste ( tele 2258 op. l senza ricevere commen10 di sorta.

(2) Essad pascià in quel periodo si trovava nella capitale francese in attesa che l'azione dei suoi uomini di fiducia in Albania provocasse la situazione più idonea per il suo ritorno. Egli conta\'3, non del tutto a torto , sulle favorevoli disposizioni italiane, dati i contatti ristabiliti con la nostra delegazione rutrora a Parigi.
( .3) Tele 675 datato 12 aprile 1920.
Intanto il gen. Piacentini aveva preso posizione nei confronti dell'Alto Commissario rivolgendosi al J'vli nistero della Guerra. Prima di tutto mise in rilievo che gli organi di informazione erano costhuiti quasi esdusjvamente dai ptesidi italiani e dalla rete di stazioni dei Reali Carabinieri coprente quasi tutto il t erri torio albanese; cioè, in definitiva, da elementi dipendenti dal Comando Truppe Albania, e giustamente perché esso era l'unico responsabile della sicurezza d ei reparti. Per converso, l'Alto Commissario non disponeva che delle informazioni di carattere politico passategli dallo stesso Comando Truppe o dai pochissimi suoi informatori. Poi, nel riferire sulla confusa situazione verificatasi nell'Albania centrale, specificò che fino a quel momento non erano avvenuti conflitti fra Albanesi grazie alla presenza delle nostre truppe ed al deciso contegno dei comandami di presidio. Di frame, infine, al-
( l ) Da rilevare che alla Conferenza di San Remo per Fiume e la questione 3driatica ( 19-27 aprile 1920) Nirri e Scialoja si pn:senrarono con un progctro, sostan?.ialmentc accettato da Gran Bretagna e Francia . che per quanro concerneva l'Albania si limitava a contemplare. a favore dell 'Italia, il mandato Stato albanese (senza accenn.tre a frontiere ) (art. 35) e la sovranità su Valona con adeguato retrorerra <.: Saseno (ari . .36).

J"inrervenro deJ ministro Bonorni che, informato dal degJi Esteri sul disaccordo fra i due rapprescutanti italiani, politico e militare, cercava di puntualizzare le comJ.>etenze:

« f ) l\. Ienrre prego V. E . volermi dare panec.ipazi one accordi gencnc1 presi negli scorsi giorni con Alto Commissario nel caso particolare cui <1C· cenna ripo rtat o rdeg ramma , trasferimento cioè G o verno Tirana a Durazzo, desidero conoscere quale spe ciale comunicazione sia intervenuta con Alto Commissa rio swp ln ogni modo rammento V. L \'Olcr re golare su a nzi o ne in base diretti\·e d a te con teh:gramma 5928 / 33 del 19 marzo passato et 7206/ B d e l 7 corrente conforme deliberata Comitato Guerra et intesa lasci are escl ush amente ad Alto Commissario trattazi o ne o gni question.: politica stop(. )» O), replicò:
« Questo Comando ignora intenz ione Governo et Senato Tirana volersi trasferire Durazzo stOp Esso est sorpreso intendasi aderire anzi invitare Go•:erno Tirana trasferirsi colà senza prima interpellare truppe cui azione potrebbe essere coinvolta in tale avvenimento stop secondo stop Nessun accordo generico aut specifico est stato preso con Alto Commissario non ave ndo egli nessuna istruzione da comunicare a questo Comando da parte Regio Governo contrariamente quanto annunziava telegramma 7206 del 7 corn:nte di Ministero stop soltanto Alto Commissario si riservò parlare con Governo Tirana prima di addivenire ripiegamemo truppe verso costa stop risulta che ha telegrafato Ministero Esteri ma nulla più si est saputo in propositO fino ad oggi per cui ripiegamcnto generale non est ancora stato iniziato srop ter zo stop in un telegramma a u • divisione, questo Comando, wute presenti direttive mai modificate fin dal principio armistizio che dovevasi considerare Essad pascià come nemico italiani. usò espressione che nostra opera do veva essere contraria a mene essadiste stop Ciò esr noto ad Al to Commissario stop ( ). Deve però ora far presente che Alto Commissario sta a Durazzo et ha agenti in pochissime località Albania, me ntre truppe stanno in quasi tuuc le localitiì più importanti stop Fregasi far conoscere come devono contenersi quando autorità locali et popolazioni si rivolgono urgentemente ad esse et quando debbono pro\'Vcdere d'urgenza mantenimento ordine pubblico stop ( ... ) > ) ( 2) .
Naturalmente all'ultimo interrogativo non vi fu risposta, né poteva esserci stante l'incertezza governativa sul da farsi. Ma il punto cruciale era un altro: i l ripiega mento dei presidi d eU 'interno. Il gen. Piaccntini vedeva con angoscia ridursi il margine di sicurezza per i propri uomini. Fin dal 18 febbraio aveva diramato le direttive generali per il caso della ritirata sulla costa. Con esse aveva stabilito centri di raccolta, al riparo di Jinee di resistenza. e
Le truppe italiane in Albania ( 19r4- 20 e 1939) basi di rifornimento per le due sottozone (Bojana - Fani e MathiSkumbi) a nord del f. Skumbi, e per le due (Berat- Valona- Himara e Argirocastro) a sud del fiume, nelle ipotesi di popolazione favorevo.le od ostile. Per i presidi del Montenegro e di Scutari c'era tuttora da sciogliere una riserva di ordine politico. Il 14 aprile, poi, aveva impartito altre direttive generali riguardanti il rimpatrio in Italia, prevedendo una successione di tempi con un ordine di priorità di imbarco, e stabilendo per ogni turno i Comandi responsabili delle truppe ancora a terra. Secondo tale ordine, sarebbero rimasti a Valona soltanto la brigata Udine (ivi trasportata dal nord), un gruppo di artiglieria da montagna ed alcuni servizi divisionali e territoriali. Comunque, il gen. Piacentini non poteva acce ttare di subire passivamente il deteriorarsi di una situaz ione locale già molto grave mentre in ambito politico si traccheggiava senza una chiara visione di quella che era l'Albania del 1920 e nell'attesa di una vittoria essadista. Il 17 aprile, dando notizia ai Ministeri degli Esteri e della Guerra ed allo Stato Maggiore Regio Esercito di incidenti provocati dai gendarmi albanesi a Zagran (Malakastra), precisava di aver provveduto al ritiro di piccoli presidi dell'interno ed aggiungeva:
«Nel comunicare presente telegramma ad Alto Commissario lo si prevenga che questo Comando non può tardare più oltre emanare ordine ripiegamento generale motivo sicurezza truppe» ( 1).
Infine ruppe gli indugi e il 24 aprile telegrafò all'Alto Commissario dicendo che se non avesse ricevuto ordini entro tre giorni avrebbe dato il via all'operazione Su pressione del ministro Bonomi, intervenne allora Nitti, disponendo che il ripiegamento delle truppe avvenisse senza ulteriore ritardo e rimanendo naturalmente in sospeso le questioni del Momenegro e di Scutari.
A questo punto, il Castoldi si rese conto che ]a stabilità del Governo di Tirana era più della carta essadista e che le cose stavano precipitando, perciò, d'iniziativa prese contatto con il Primo ministro albanese. Occorre riconoscere un 'estrema sincerità e buona volontà a Delvino, il quale ancora una volta toccò il problema della presenza militare italiana a Valona, dell'accordo Tittoni - Venizelos e del recente consenso italiano alla cessione di Scutari alla Jugoslavia . Tutto ciò, disse Delvino, non può essere accettato dal Governo perché perderebbe di credibilità davanti al popolo. Poiché, invece, era reale il desiderio di molti di avere un'Italia amica, perché non cercare un amichevole componimento della vertenza? Altrimenti sarebbe stato ine\'itabile per l 'A lbania il desiderare un'imesa con i vidni balcanici. Castoldi, in un lungo telegramma del 26 aprile al conte Sforza, riferì il colloquio e propose con giusto realismo l'abbandono della linea di condotta politica sino ad allora seguita, suggerendo di riesaminarc tutta la questione ::mche sotto il punto di vista di Tirana, ed infine concludendo: « Qualot·a semplice unione amministrativa Vtrlona a restante Albania accontentasse Albanesi, pare a me che interessi politici e militari sarebbero difesi, ma che interessi economici farebbero trovare corpo ad ogni accusa C01Jtro di noi e condurrebbero ad aperto dissidio dal quale possono trarre motivo avversari per causare anche conflitto. I n tale condizione diverrebbe arduo esercizio mandato ed occupazione V atona diverrebbe sacrificio che occorre prevedere». Contemporaneamente il gen. Piacentini , che già da tempo aveva disposto concentramenti parziali di piccoli presidi, ordinava ai comandanti della 133 e 3 6• divisione di iniziare sotto la data del l, maggio l'integrale ripiegamento delle truppe sulla costa, secondo le direttive già impartite. Quindi si rivolgeva all' AJro Commissario per un'altra questione che stava diventando scottante: le milizie nazionali albanesi. Tale corpo era stato costituito durame la guerra con uWciali italiani ed aveva anche partecipato alle operazioni belliche. Dopo l 'armistizio entrarono nei quadri di dette milizie uffic iali subalterni albanesi che avevano frequentato .le scuole militari italiane. Imenzione del Governo era di formare un saldo nucleo attorno al quale si potesse poi creare l'esercito nazionale albanese; tuttavia il progetto organico approntato rimase inattuato non avendo il placet ministeriale. Ora, durame iJ corso del 1919 il problema della milizia era andato radicalmente cambiando per effetto del probabile smembramento dcii' Albania. Se lo scopo era quello di poter dare all'Albania del 1913 un nucleo di forze per gara ntire le frontiere contro Jugoslavi e Greci, dopo un accordo del genere di quali frontiere s i trattava? Venizelos aveva proclamato che la Grecia doveva arrivare ai piedi del passo del Logora, dove comincia l'hinterland di Falona; la Jugoslavia pretendeva il nord-est.

« ( ) Così che - scriveva il gen. Piacenti ni - voler costituire oggi un nucleo di milizie nazionali con quel misero avanzo di Alb.mia che resterà fra Vojussa e Mathi sembrerebbe quasi una crudele ironia dopo il trattamento brutale fattole dalla Conferenza di Parigi. Non si saprebbe nemmeno in quale territorio reclutare dette milizie. Inoltre tutto era staro predisposto a Dclvino ed Argirocastro, ove si trovano i resti della milizia formata durante la guerra (l ) , tutta roba che dovrebbe essere trasferita a Durazzo e Tirana, cosa praticamente non at t uabile anche data la s t agione e le difficoltà materi<lli. L'unica cosa è dare impulso alla gendarmeria per il manten i mento dell 'ordine interno» (2).
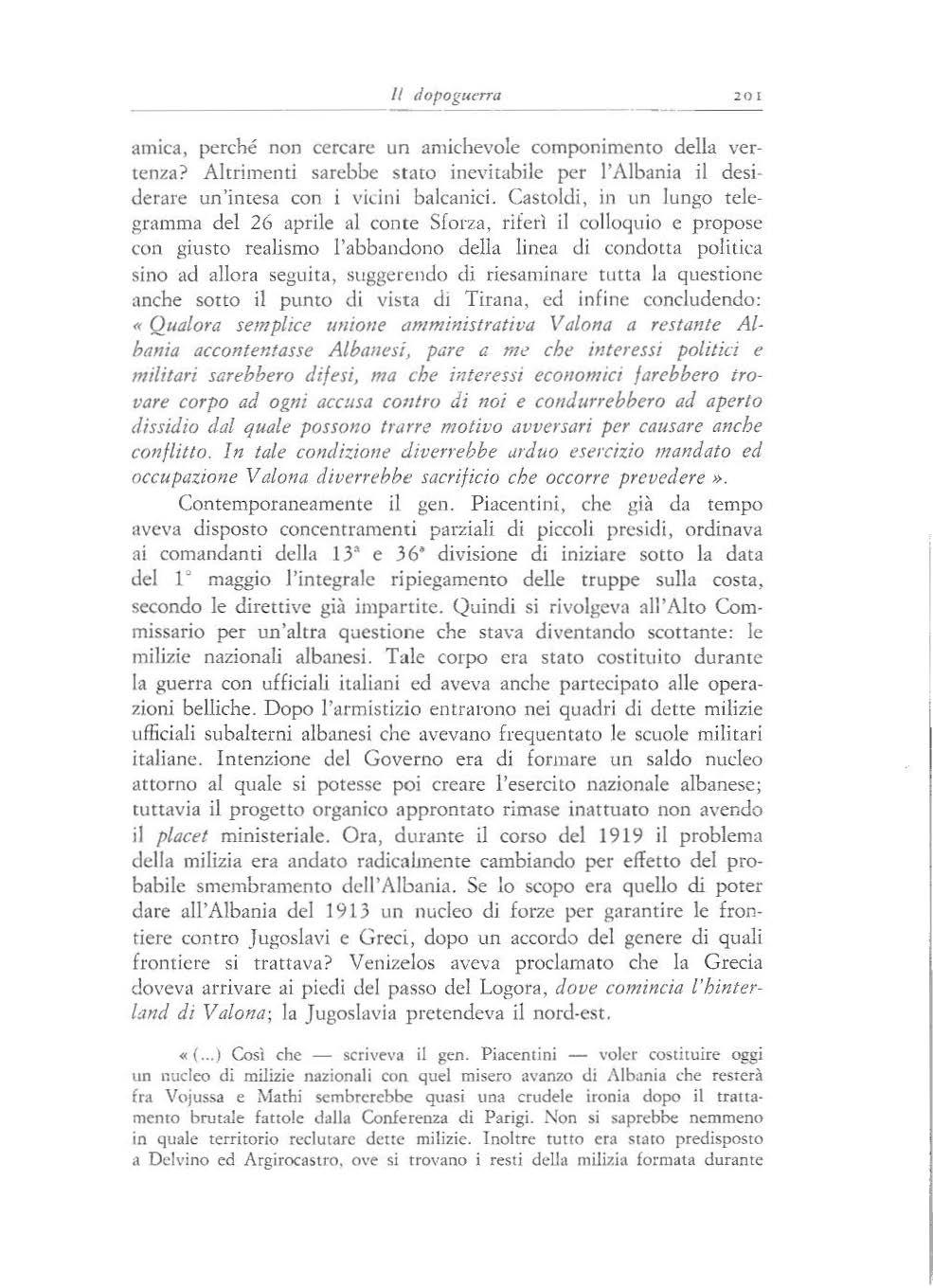
Per questi motivi l'arruolamento venne sterilendosi piano piano. Senonché dai primi di aprile 1920 la propaganda nazionalista nell'Albania meridionale cominciò a dare frutti inattesi: moltissimi giovani della regione di Argirocastro (Delvino era la sede del Comando della Legione) si presentarono come volontari , rappresentando sia un pesante aggravio finanziario sia un motivo di ulteriore preoccupazione. Non era infatti da escludere che parecchi si arruolassero per venire armati ed equipaggiati e poi disertare con l 'armamento ad un cenno dei capi nazionalisti, il che avvenne . Si trattava di saggiare i l Governo di Tirana - previo naturalmente benestare di Roma - affinché esso stesso proponesse il passaggio della milizia alle sue proprie dipendenze, ovviamente con i soli quadri albanesi e con tutti gli oneri relativi. Poiché nessuna risposta venne in merito, il 9 maggio il gen. Piacentini si rivolse àl 11inistero della Guerra proponendo di sciogliere le fo rmazioni in causa, dando un compenso pari a sei mesi di paga ai soldati ed offrendo ai 24 ufficiali albanesi di prestare sen;izio presso nostri reparti a Scutari ovvero nella divisione di Bari. Anche questa proposta cadde nei vuoto, talché il problema si risolse da sé: co n il passaggio in massa delle milizie agli ordini della gendarmeria albanese entro la fine dello stesso mese di maggio. E' doveroso, tuttavia, dare atto a queste milizie di aver conservato fino all'ultimo un contegno di sciplinato e leale (3) .

Il l O maggio si poteva considerare concluso il npregamento alla costa. Si aveva così la seguente dis.locazione delle unità (schizzo 32): a Comando Truppe Albania e unità direttamente dipendenti: Valona;
(-1) La legione era su due coorti (battaglioni), ciascuna su tre vessilli (compagn ie) per un totale di 45 ufficiali e .565 gregari (effettivi al 10 novembre 1919).
(2) F. 582 op. RR. data 28 gennaio 1920.
(3) Cfr f. 3500 data 30 maggio 19-20 del C.T.A.
lA SITUAZIONE IN AlBANIA NEl 1920
dopo il ripiega mento sulla costa ( 10 maggio)

Le truppe italiane in Albania {1914 20 e 1939) b. lY divisione (magg. gen. Raimondo):
-Comando divisione: Durazzo;
-Comando brigata Udine (magg. gen . .Maggi): S. Giovanni di Medua;
- Comando 95" fanteria e I battaglione: Scutari;
-II e III/9Y fant eria: S. Giovanni di Medua- Alessio;
-Comando 96° fanteria: S. Giovanuì di Medua;
- I e II/96° fan t eria: Antivari;
- III/96"" fanteria: fra Scutari ed Alessio;
-l e II battaglione di manovra : S. Giovanni di Medua;
- Comando 6° raggruppamento alpin i (magg. gen. Freri): Durazzo;
- II gruppo alpini (btg . Dronero, Saluzzo e lntra): Durazzo;
-X IV gruppo alpini (btg. Feltre, Fenestrelle e Borgo S. Dalmazzo): S. Giovanni di Medua · Alessio;
-Comando 3° raggruppamento misto artiglie ria: Durazzo;
-X LI gruppo da montagna: Durazzo;
- L gruppo da montagna: Durazzo;
- l" sqd. cavalleggeri di Palermo: S. Giovanni di Medua;
-XX brg. genio: Durazzo· S. Giovanni di Medua;
-unità dei servizi: Durazzo · S. Gio vann i di Medua; c. 36• divisione (magg. gen. Pugliese):
-Comando divisione: Valona;
-Comando brigata Puglie (brig. gen . Rossi): Santi Quaranta;
-Comando 71° fanteria e III btg.: Santi Quaranta;
- I/71° fan te ria : Tepeleni;
-
II/7 1" fanteria: Delvino;
- 72° fanteria : Valona;
-Comando brigata Verona (magg . gen. De Luca) : Valona;
- 8Y' fanteria: Valona;
- 86° fanteria: Vaiona;
- 10° reggimento bersaglieri : Himara ·Santi Quaranta;
- 4" raggruppamento misto artiglieria: Valona;
- 30a co mpagn ia zappa tori : Vnlona;
- 15.5• compagnia telegrafisti : Santi Quaranta;
- unità dei servizi: Valona- Santi Quaranta; d. F legione milizie albanesi: Delvino- Argirocastro. Insieme con il ritiro dei presidi dall'interno erano state completate le misure per il rimpatrio. Al riguardo, però, occorreva che i Ministri della Guerra e degli Esteri. risolvessero alcuni aspetti particolari:
- presidi del Montenegro: si trattava di più di due battaglioni, dislocati nella zona di Antivari, da alimentare direttamente dall ' Italia, ove le truppe d'Albania fossero rimpatriate;
- presidio di Scutari: un battaglione del 95° fanteria, che aveva acquistato un certo carattere interalleato, e per il quale si poneva un problema analogo al precedente ma più grave, giacché bisognava lasciare una base a S. Giovanni di Medua oppure predisporre i rifornimenti da Antivari attraverso il lago di Scutari;
- residenza dell'Alte Commissario: evidentemente non era pensabile che, partite le truppe, l'Alto Commissario rimanesse da solo a Durazzo. Quindi occorreva o farlo risiedere a Valona (con la perdita di ogni contatto con il Governo di Tirana) oppure costituire un piccolo presidio ad hoc a Durazzo (poco economico e poco sicuro);

- campo trincerato di Valona : era previsto fosse affidato alla brigata Udine rinforzata, ma poiché questa doveva lasciare, almeno in un primo tempo, tre battaglioni in Montenegro ed a Scutari, bisognava provvedere a darle una nuova fisionomia attingendo a tutto quello che si t rovava a Valona.
Tutto ciò ven i va rappresentato il 9 maggio dal geo . Piacentini e sottoposto alle decisioni superiori, con un'importante raccomandazione finale :
«Riassumendo: le questioni oonnesse col nostro ritiro dall'Albania ( ... ) troverebbero facile soluzione se in Albania restasse una congrua forza di truppe . Questo Comando già dal novembre 1919 espresse l'opinione che OC· corresse una divisione con tutti i servizi di un corpo di spedizione d'oltremare qualora l'occupazione fosse ridotta al solo campo trincerato di Valona.
« La questione rimase allora insoluta, ma questo Comando non ritiene che sia oggi cambiata, mentre si è molto complicata. Eppertanro esso, oggi che vede le cose più da vic ino ed in tutti i loro particolari. reputa che fino ad assestamento completo delle questioni balcaniche non sarebbe conveniente, a meno di continui stenti e sac rifici, che potrebbero condurre a gravi conseguenze, di lascia re in Albania meno della forza di una divisione in efficienza » (l).
Come vedremo, per un insieme di amari av\·enimenri in ItaliJ le truppe d'Albania dovranno sopportare co;zlinui stenti e sacri/h.i che condurranno a gravi conseguenze. La decisione di rinunciare all'occupazione dell'Albania era incYitabi le ed anche politicamente giusta: non avevamo mai, in fondo, mirato al controllo materiale di rutta l'Albania; la dissoluzione Jell'i\usrria- Ungheria ;1VeV<l cambiato molte nella valutazione del blocco dell'Adriatico; le spese di occupazione per il nostro bilancio erano insostenibili; la incidenza nociya della rnalaria era diventata assai piì:1 grave della guerra. Purtroppo alla decisione non scgul la necessaria fermezza e razionalità di provvedimenti, nel doppio intento di far uscire dignitosamente l'Italia da un vicolo cieco e di non ab bandonare i soldati mandati sull'altra sponda. Il doppio intento fu raggiunto esattamente nella versione negativa. Per ii momento Bonoml rispose di dar corso a l primo tempo del rimpatrio.
Il concentramento sulla costa si era svolro complessivamente in ordine, anche se la carenza dei mezzi d1 trasporto aveva consentito di portare via soltanto le armi, le munizioni, i viveri, il materiale automobilistico e poco altro di valore, abbandonando quanto non metteva conto di recuperare, ma senza distruggerlo sia per !asciarlo alle poverissime popolazioni sia per non dare al movimento un carattere di ritirata di fronte al nemico. Tuttavia aveva presentato aspetti differenti secondo le zone. Nell'Albania centro- meridionale la partenza delle truppe fu vista quasi ovunque con aperto rammarico c se in qualche caso ''Ì fu indifferenza, mai si giunse ad atti apertamente ribelli - nonostante l'ostilità della gendarmeriacome invece si verificò in qualche località del nord. Anche questi, però, erano probabilmente da attribuire più a singoli episodi di brigantaggio che ad azioni di natura politica. L'attrito politico stava invece per esplodere nel meridione per effetto della rottura dei rapporti fra il Governo di Tirana cd il Castoldi.
Le proposte inoltrate dal nostro Alto Commissario al Ministero degli Esteri non erano state ricevute di buon grado, essenzialmente a causa della presa di posizione di Sforza sull'argomento (l), per cui le istruzioni che questi inviò in data 28 aprile - su approvazione di Nitti - ingiungevano di guadagnare tempo sino a ripiegamento delle truppe ultimato. « Prenderemo più tardi norma degli aovenimenti interni albunesi ed internazionali per precisare le dichiarazioni da farsi>> Le premesse a tale conclusione erano che il Go- vcrno di Tirana si trovava « sern:,: autoril,ì e p,tà gravemente scosso», il che non era del tutto esatto, e che (< \ · • .tona, ci rcondata da sufficiente hinterland» potesse es:-ere « stildameuté: e senza impacci nelle nostre mani», il che non rispondeva alle reali possibilità. Naturalmente Castaldi si ac<.:inse ad aspettare e non prese piì:t contatto con b capitale. In compenso, fu 1! Primo ministro, Delvino. ad assumere l'iniziativa: il 2 maggio infatti - quando il ripiegamento era iniziato - gli inviò una nota verbale nella quale rifiutava di considerarlo Alto Commissario civile italiano, autorità dall 'accordo del 20 19l9 (fra l'altro non appro\·ato dal Governo italiano, come si è visto), accordo che il Governo di Thana considerava illegale c nullo perché lesivo della sovranità albanese. La mossa complicava la situazione ma non di molto, a causa di un'ennesima rivolta contro Tirana, turtavia nel giro di un paio di settimane, approfittando abilmente d i un insieme di circostanze, in gran parte fortuite, il Governo albanese , da una posizione quanto meno insicura, riuscl a trovarsi saldamente al potere sia di fronte al mov imento essadista ed a quello pilt recente di Kruja, che era perfino arrivato ad ingiungere al Governo di dimetters i , sia di fronte all'Italia.
(li Cfr. l'acuta analisi in P. PasLOrelli, op citala, pag .344 e seg.
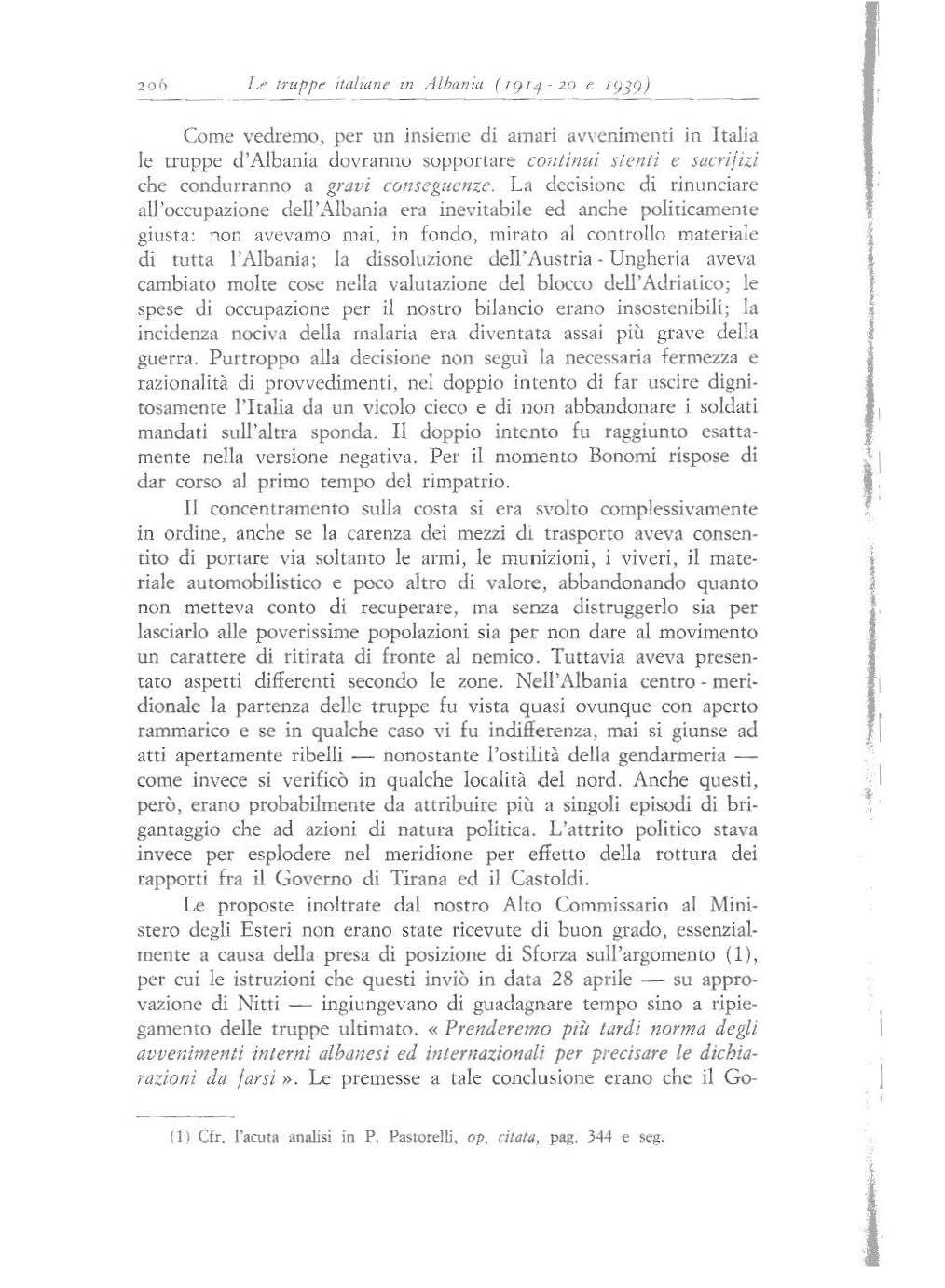
Prima di tuuo Deh·ino era riuscito a venire ad un'intesa col partito di Essad pascià, cosicché le bande armate che minacciavano la capitale si erano sciolte mentre tre inviati governativi partivano alla volta di Parigi per un colloquio con Essad. In secondo luogo, il ripiegamento degli Italiani venne presentato sempre più apertamente come un traguardo vo luto dal Governo c rafforzò il dilagante nazionalismo. In terzo luogo av\·cnne lo sgombero, proprio quasi contemporaneamente al movimento italiano, dei Francesi dal Kazà di Ko.rça. Questa poreva essete una svolta cruciale per l'Albania, stante il pericolo che Greci e Jugoslavi subentrassero nelle zone abbandonate. Ma la Gran Bretagna , soprattutto, e la Francia premertero su Atene e Belgrado affinché rimanessero in attesa delle decisioni della Conferenza della Pace. Ciò rese possibile il cosiddetto Protocollo d i Kapistica, accordo locale firmato da Albanesi e Greci il J5 maggio, w base al quale il Korçano tornava all'Albania c le parti promettevano, in sostanza, di astenersi da atti di ostilirà rimettendosi alle future delibera..::ioni delle Grandi Potenze . A questo punto, a parte Scutari che però era da considerarsi sotto l'egida internazionale, ed i presiJi di Durazzo e ài S Giovanni di Medua notoriamente in fase di sgombero, i'Albania poteva dirsi unita e libera da stranieri trannl! Valona. Dulcis in fundo per gl i Albanesi , il 12 maggio era caduto il terzo ministero Nitti e l'Italia era turbata da agitazioni sociali.

Il gen. Piacenrini si trO\'Ò, dunque, a fronteggiare una crisi che, pur paventata e prevista, si ingigantì oltre misura. Ormai. senza più nemmeno un'esatta conoscenza degli eventi per effettù dell'abbandono del paese e quindi ridotto a fonti di informazione: più o meno attendibili ma quasi sempre esagerate, non potendo.>i più fidare della milizia, egli <:CI;CÒ di rafforzarsi quanto meglio poteva in Valona. Già in aprile aveva modificato con un ordine amministrativo la circoscrizione dl Valona, raggiungendo Tepeleni ed inglobando il Kurvelesh {l), con l 'evidente proposito di utilizzante le posizioni più forti come difesa marginale del campo trincer a to e con l 'aggiunta di una piccola zona di sicurezza ad est ed a sud-est (schizzo 33 ). Sorto il profilo strettamente tattico fu un errore ampliare l'area da difendere o semplicemente da occupare, per il maggior onere della difesa e la minore possibilità di controllo e di aiuto nei confronti dei centri perimetrali. A parte il decadimento delle opere di fortificazione non più curate da mesi ed oggetto di saccheggio da parte di bande e di contadini, la iinea della Vojussabenché più forte - era già stara considerara indifendibile a suo tempo per l'ent ità delle forze occorrenti. E' pur vero che adesso non c'era da prevedere un attacco wbusto da parte di truppe regolari, ma proprio per questo ed avendo compagnie di una ventina di uomini si poteva rinunciare ad un territorio in cui i pochi capisaldi occupati da scarni presidi si perdevano nel vuoto e le molte stazioni di carabinieri (parte dei quali albanesi ) erano destinate a soccombere in un batter d'occhio senza alternative . Di fronte, infatti, alle ampie possibilità di infiltrazione degli insorti attraverso le larghe maglie della difesa , di accerchiamento e di isolamento dei nuclei di difensori in questa o quella posizione, non stupisce il successo albanese iniziale. Tanto valeva ridursi subito ad una difesa ancor più ra ccorciata della linea Sushica , così come studiato nel 1917 e come applicato - dietro pressione degli avvenimenti - in seguito . Anche sul piano politico è dubbia la bontà d el provvedimento E' pur vero che in fondo si trattava di voler tenere un pegno sulle cui dimensioni c'era da contrattare, non essendo stata presa
(l) Fin dal maggio 1916 il gen. Piacentini a\·eva rappresentato al Comando Su· premo che la delimitazione della zona di influenza greca lasciava al nemico, che avesse passaro la Vojussa a Tepeleni , la possibilità di raggiungere indisturbaro le regioni Griba e Maja Lops , dalle quali era possibi le dominare il sud est di M Tarrarit, c la regione d<d Mali Cikes, da cui veniva controllaw il fronte me ridionale del campo trince rato.

Principale linea di resisten za linea avanza ta di resi stenz a
Ampliamento circoscr izion e di V
Scala appros . 1:1.500.000 Schizzo n decisione alcuna sulla delimitazione del retroterra di Valona, tuttavia durante la guerra la zona ora inglobata nella difesa era stata tolta dalla provincia di Valona c passata a quella di Argirocastro (per bilanciarvi la preponderanza ortodossa) e questo passo indietro. compiuto unilateralmcnre, originò proteste - non manifestamente infondate - di carattere giurisdizionale d<1 parte albanese. Inoltre, sotto il profilo psicologico, un conto era « perdere » la posizione tale o la quota talahra, ed un contO «perdere>> Tepeleni. Ad ogni modo, bisogna anche tener ben presente che il Comandante delle Truppe d'Albania non solo stava cercando di risolvere un problema operativo di cui non possedeva turd gli elementi, ma che era soggetto all'attesa di decisioni politiche p res<.: da lontano e senza chiara percezione dei fatti in corso.

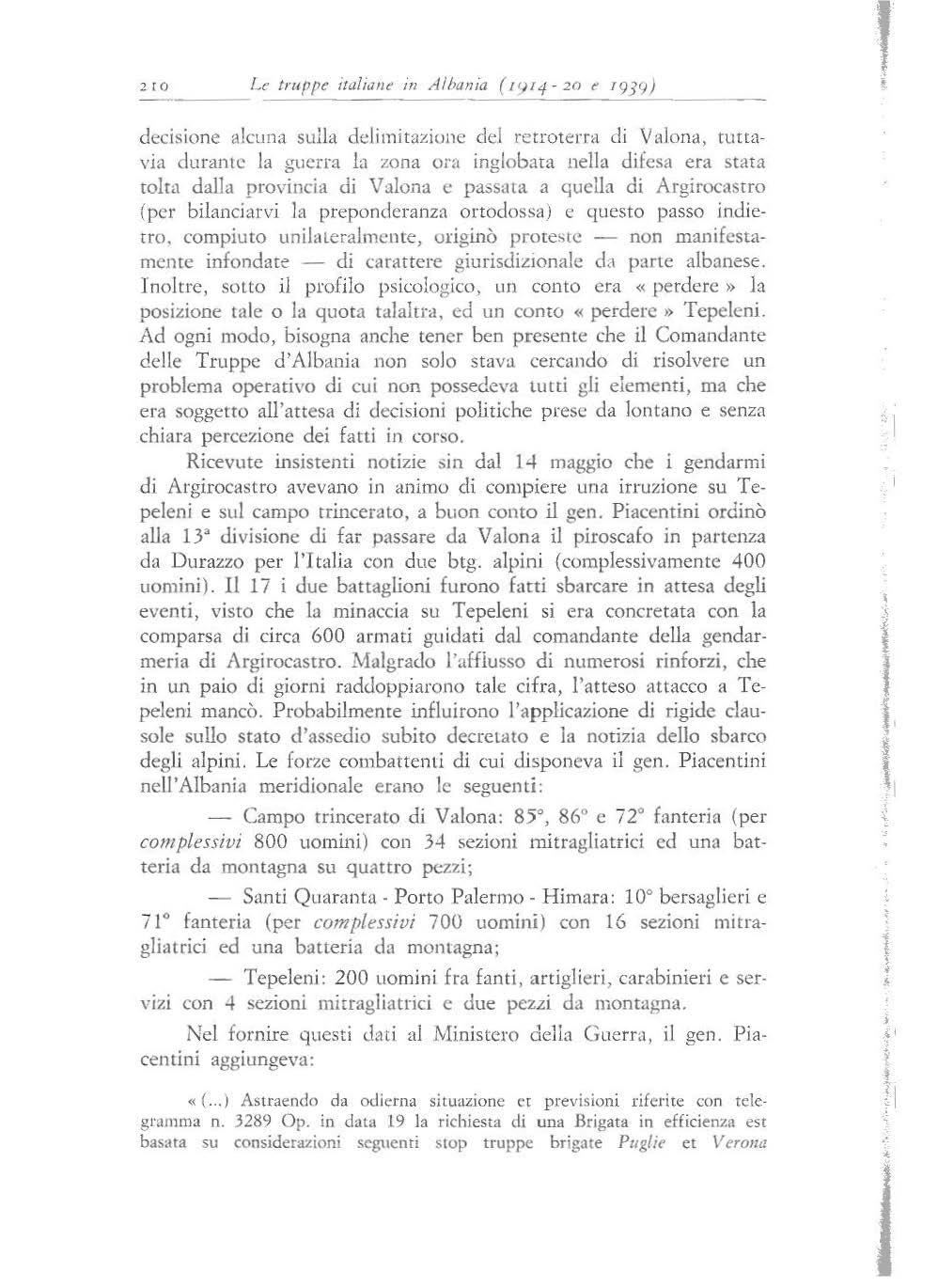
Ricevute insistenti notizie sin dal 14 maggio che i gendarmi di Argirocastro avevano in animo di com p iere una irruzione su Tepeleni e sul campo trincerato, a buon conto il gen. Piacentini ordinò alla 13 3 divisione di far passare da Valona il piroscafo in partenza da Durazzo per l'Italia con due btg. alpin i (complessivamente 400 uomini). Il 17 i due battaglioni furono fatti sbarcare in attesa degli eventi, visto che la minaccia su Tepeleni si era concretata con la comparsa di circa 600 armati guidati dal comandante della gendarmeria di Argirocastro. Malgrado l'affiusso di numerosi rinforzi, che in un paio di giorni raddoppiarono tale cifra, l'atteso attacco a Tepeleni mancò. Probabilmente influirono l'applicazione di rigide clausole sullo stato d'assedio subito decretato e la notizia dello sbarco degli alpini. Le forze combattenti di cui disponeva il gen. Piacentini nell'Albania meridionale erano le seguenti:
- Campo trincerato di Valona: 85°, 86° e 72° fanteria {per complessivi 800 uomini) con 34 sezioni mitragliatrici ed una batteria da montagna su quattro pezzi;
- Santi Quaranta- Porto Palermo- Himara: 10° bersaglieri e /1° fanteria (per complessivi 700 uomini) con 16 sezioni mitragliatrici ed una batteria da montagna;
- Tepel.en i : 2 00 uomini fra fanti, artiglieri, carabinieri e ser,-izi con 4 sezioni mitragliatrici c due pezzi da montagna. Nel forn ire questi dati al Ministero della Gllerra, il gen. Piacentini aggiungeva:
« ( ) Astraendo da odierna situazione cr previsioni riferite con telegramma n. 3289 Op. in data 19 la richiesta di una Brigata in efficienza esr basata su considerazioni seguenti stop truppe brigate Pugfie et V erona et 10" bers.1glieri ouimc ogni aspetro sono però esaurite et non raggiu ngono in tOtale che l. 500 combaucnri srop mo lti sono ma la rici et sta per iniziarsi nuovo periodo rn<'l la r ico questo comando restituirebbe tutte tali truppe per avere unica Brigata in efficienza stop esso si accomcncerebbe anche di sola Brigata \1 e1'0na Yersando i n essa truppe rimanenti meno bersaglieri ma accorrerebbero sempre 3.500 complementi stop sesto per il momento non può fa re assegnamento su Brigata Udine perché impegnata presidi Monrenegro et Scu tari er pcrché non si ritiene possa subito sguaxnirsi completamente Durazzo stop » ( l ).
La risposta del minist ro Bonomi fu deludente (« impossrbilità invio Albania Brigata fanteria aut 3500 complementi richiesti)>) e burocratica ( « Reputo che prov vedmzenti di cui sopra - si trattava del semplice rimaneggiamento delle forze in loco - valgano a mettere V. E. in condizioni potere fronteggiare situazione da V. E. stessa prospettatami ») ma dava una speranza di soluzione pol itica:
« .. .Info rmo infine V.E. che ho interessato Ministero Affari Esteri affinché inviti Alto Commissario fare pressione su governo albanese onde Ot· tenere che gendarmi ribelli siano indo tti desist ere insano tentativo contro Te· pcleni o al t r e località campo trincerato Valona » (2).

Purtroppo su una politica c'era poco da fare affidamento. Il Governo di Tirana, considerando inopportuno ed incauto esporsi in prima persona, agevolò la costituzione di un Comitato di difesa nazi.onale, composto da esponenti della provincia di Valona (3), al quale affidò la funzione di braccio armato albanese contro la presenza italiana. Il 20 maggio il Conùtato si fece vivo con un proclama di incitan1ento alla insurrezione, tanto diffuso nella zona che riuscì: a riumre nel b reve volgere di una settimana alcune migliaia di armati. sorretti vivacemente, adesso, dall'opinione pubblica. Visto il successo dell'iniziativa, il Comitato redasse il 28 maggio un ultimatum per il gen. Pìacentini. Prima, però, che il documento fosse inviato, il Presidente della delegazione albanese alla Conferenza della Pace, mons. Bumçi, fece un estremo tentativo personalmente a Sforza, a Roma. Si trattò di un passo inutile: Sforza rispose evasivamente, ma in modo sufficientemente dùaro da far comprendere al suo interlocutore che l'Italia non intende\·a lasciare V alona e che per i confini albanesi essa avrebbe pensato anzitutto ai p1opri inLeressi. Il 3 giugno fu nllora presentato al Comando Truppe Albania l' ultimaturn (4), mentre tre o quattro (l)
{4) mila uomini si raccoglievano in Val Sushi<:a ed in Val Vojussa, a nord -est di Tepeleni.
Il gcn. Piacentini si era ben reso conto che il Governo albanese non aveva alcuna intenzione di nella questione di Tepcleni e «quel cbe è più, eccita gendarmi e na:::ionahsti dell'Al bania meridionale contro di noi sia per f'avtJenione agli Italiani. sia per quel senso di tunore cbe nutre nei riguardi della gendarmeria da cui dipenclc la sua esisten:::.a » (1), ma si manteneva calmo e dava corso al secondo tempo del rimpatrio, ordinato il 26 maggio dal nuovo ministro della Guerra. Rodinò, e, una decina di giorni dopo, anche al trasporto delle truppe del Monrenegro, appartenenti alla brigata Udine, in V alona (schizzo 34 ).
Il comm. Casto!di. che aveva formulato a Ti• an a inutili rimostranze, era praticamente esautorato e per giunta poco informato su quanto accadeva a Valona. TI 1° giugno si rivolgeva al Piacemini con evidente preoccupazione:
« In via del tutto personale chied<• a V. E. di volermi concedere che esprima mio parere circa convenienza costà cercare \"ie moderare persuasive presso capi dei centri rurali ç rimediare perniciose influen7e estere stop azione italiana nella questione di Valona assume fisionomia speciale che rende ne cessario evitare atti di rigore dar .luogo a più palese opposizione della popolazione ( ) » (2}.
Ma l'interessato poteva rispondere subito trattarsi di esagerazioni e voci tendenziose, posto che nessun atto ostile era stato effettuato contro Je nostre truppe, non si aveva sintomi della presenza di malinrenzionati provenienti dall'esterno e nessuna repressione era stata adottata su alcuno. La stasi veniva, appunto, rott a il 3 giugno:
« 1... ) A seguito minacce \·erbali ( ... )sono giunte minacce scritte di un sedicente comitato di difesa in cui dopo solito preambolo di imperialismo italiano. mancanza di parola. asservimento di Valona etc. si dà tempo a questo Comando fino alle ore 19 di questa sera per e cedere la città ad una :unminisrrazione albanese stop naturalmente non verrà dara risposta( )» (3).

In realtà l'ultimatum non era poi tanto rozzo e le accuse rÌ\'Olte al Governo italiano esphcite c centrate: « it popolo albanese ( ... ) ritiene che la spartizione dell'Albania è opera dell ' Italia». Da rilevare che l 'ingiunzione riguardilva « il pdssaggio dell'amministrazione di V atona, T epelenz e Chimara, paesi questi che dovranno essere rimessi al più presto al Gov·erno na zionale di Tirana ». La partenza delle truppe italiane non figurant - almeno apertamente - nella richiesta. Evidentemente , il Comando Truppe Albania non poteva accettare l'ultimatum, tuttavia il valore pol itico di esso non doveva essere trascurato né sottOvalutato.
(l) Tele n. 3380 Op. datato 2.3 maggio 1920.
( 2) Tele n. 1>80 dataro 1° giugno 1920.
0) Tele n. 3596 datato 4 giugno 1920.
Il 5 aveva luogo il previsto attacco, costituito d:t un seguico ininterrotto di azioni in varie località, perimetrali e non, comro reparti italiani di scarsa consistenza e poi contro le difese della città di Valona. L'interruzione delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche rendevH più acuto il senso di incertezza nei Comandi ed a Roma. Occorre dire che fu necessario qualche giorno per {ormarsi un esatto quadro delle proporzioni dell'offensiva albanese c delle perdite subite. Purtroppo le condizioni di isolamento e di limitata forza dei numerosi, troppo numerosi, distaccamenti condusse a resistenze sporadiche e ad u na elevatissima percentuale di prigionieri. Solo a Giormi (97 uomini e 10 mtr.) ed a quota 115 (85 uomini con 14 mtr. e 2 pezzi), in Val Sushica, i combattimenti furono accaniti per la maggiore consistenza della difesa ed il migliore inquadramento. I morti, quasi tutti a q. 115, furono 3-t, di cui dieci ufficiali, compreso il col. Gotti comandante del 72° fanteria. I prigionieri salirono, in due o tre giorni, ad oltre 800. Dati questi che - specie se raffrontati con i successivi scontri a Valona, ove la difesa era bene organizzata - inducono ad evidenziare l'errore di aver lasciato eccessivamente disperse le già limitate truppe disponibili, specialmente ovc si tenga conto del logoramento fisico e nervoso cui da mesi esse erano sottoposte. Purtroppo la sommossa venne inizialmente sottovalutata nella sua portata militare:
«L'azione dei ribelli, qualunque essa sia ed in qualunque numero si facc.ia non appare estremamente pericolosa - scrisse il 4 giugno il gen. Piacentini al gen. Pugliese, comandante della 36"' divisione ( l ) - perché si tratta di una massa amorfa senza cnpi e senzn ordine e mancante di qualsiasi organizzazione di servizi. Da questo punto di vista può darsi che quamo più numerosa essa sarà tanto maggiormente disordinata ( ...).

<<Di fronte a cosiffatto avversario il quale, oltre al numero non ha al t ri vantaggi su di noi che la sua mobilità, ci conviene conservare immmate le nostre posizioni c quivi difendersi ( ... ) ».
In guesta prospettiva, alguanto ottimistica, spiccavano tre righe di acuta percezione sui possibili sviluppi:
( l i F. 3595 dararo 4 giugno
« ( ) Cosa essenzialissima è di non fare onenere il più piccolo successo all'avversario, poiché questo lo imbaldanzirebbe di tamo in quanto deprimerebbe noi ed allora meglio varrehbe ridursi nani a Valona ( ... ) ».

Per obiettività, bisogna nconoscere che se in rema di valutazione la soggettività ha un suo peso inevitabile, il citato apprezzamento - esattissimo - induce a dichiarare errore tattico non giustificabile la persisten za nello sp:wpagliamento delle forze.
Di fronte alle prime notizie: piccoli presidi catturati, silenzio sulla sorte di Tepeleni e di Dasciai in val Vojussa , gruppi di centinaia di armati alle porte di Valona, popolazione locale pronta a sollevarsi, il Governo italiano si allarmò c decise l'invio della brigata Piacenza e di un raggruppamento di assalto di stanza a Trieste, oltre alla 15" squadriglia autoblindo, mentre il gen. Piacentini accelerava il ripiegamento su Valona di tutto ciò che poteva recuperare, compreso il 10° bersaglieri (ridotto a 250 uomini) dislocato a Himara, Porto Palermo e Santi Quaranta. Il 9 g iunse la brigata Piacenza (col. brig. TelJini) con il llP e 1121) fanteria, pari a 1.500 uomini, e la situazione migliorò notevolmente. La sera stessa il Comitato di difesa nazionale presentò una nuova richiesta di sgombero della città (l), ormai circondata da circa 5-6.000 ri voitosi. Alle 4 del 10 giugno si pronund.ò l'attacco contro tutta la cinta difensiva. L 'azione, svolta con intento diversivo a nord, ebbe particolare violenza a sud e ad est, specialmente contro il sobborgo di Kanina, il cui C'astello era difeso da un centinaio di operai spontaneamente offertisi di partecipare alla difesa . Dopo quattro ore di lotta il tentativo fu respinto, specialmente dopo un vigoroso contrattacco alla baionetta condotto dai due battaglio ni alpini, le cui recriminazioni all'inopinato sbarco a Valona - in verità molro umane posto che erano destinati al rimpatrio ed al congedamento successivo - avevano generato un « caso >>, presto ridotto alle dimensioni di episodio non rilevante. In concomitanza con lo sforzo esterno, ebbe luogo una sollevazione interna partente dal quartiere musulmano. L'intervento di un centinaio di carabinieri e di un reparto di formazione costituito da militari carcerati in attesa di giudizio, che, anch'essi, avevano domandato di riprendere le armi c di combattere, fu sufficiente a soffocare il moto insurrezionale. Naturalmente, la situazione anche se tuttota sostenibile era ben lungi dall'essere risolta. Era impossibile non vedere il senti- memo di odio nutrito ormai verso gli ltaliani nelle zone insorte. A parre lo sforzo militare, «un vero miglioramento dello spirito pubblico albanese - commentò il gen. Piacentini ( 1) - non si avrà che quando saremo a convincere questo popolo con fatti e non con le parole soltanto, a cui più 11o;z credono, che noi vogliamo veramente l'integrità dell'Albania» Fra Je misure reprcssive assunte a Valona c'era l'internamento a Saseno di alcu ne ce ntinaia di musulmani e l'incendio delle case di due fra i ca pi più noti degli insorti ; misure che bastarono ad evitare n ripete rsi di pericolose fiammate di guerriglia urbana.

4 · L'accordo di Tirana .
A D urazzo, intanto, n on appena ricevuta notizia d ei primi moti, il Castaldi aveva compreso di trovarsi di frome ad eventi non facilmen te controllabili. Nella sua analisi, la responsabilità maggiore dei fatti risa]iva al comportamento delle truppe in genere e del loro Comandante in particolare. In tal senso informò il Ministero degli Esteri , p recisando :
« ( ) Siamo in presenza di una crisi maturata da tcmpo, divenuta gra · datamente più p ericolosa mentre nulla mai \·enne fatto di quanto si poteva per prevenirla. Il gen. Piacentini faceva co nto unicamente sulle t ruppe. Un lunghissimo periodo di debolezza ha reso il comando di Valona da molto tempo inadatto alle delicate funzioni che gli incombevano di fronte a1la questione albanese e specialmente a quella di Valona. La p<.:rmanenza del gen Piacentini ha impedito un'efficace azione sopra il Governo e la popolazio ne per allontanare la c risi. mentre veniva segnalata da varie fonti la manchevo· lezza della sua azione ( ... ) » ( 2 ).
E, di rincalzo, soggiunse:
<< ( ••• l senza farsi ormai soverchio affidamento sul risultato immediato del provvedimento, n on rimane altro che la sostituzione urgentissima del gen. Piacentini conforme alle proposte di questo Commissariato. Aggiungo che ritengo aswlutamente necessario dare istruzioni al nuovo comandante che comportino un mio intervo..:nro diretto a Valona e la facoltà di stabilire con il Governo albanese eventuali premesse per la futura s istemazione di Valona che acconrenrinu le popolazioni>> (3).
(U F. 3877 Op. Ris. datato l3 giugno 1920 al Ministero della Guerra
(21 Tele n. 2999 data 9 giugno 1920.
(.3) Telt: n. 3000 data 10 giugno 1920.
A pane la generJClta delle accuse, attribuire al gen. Piacentini il potere di prevenire la crisi è sin troppo palesemente ingiusto (l). Comunque, se da un lato il riversare ogni addebito sul Comandante delle Truppe poteva apparire comodo, dall'altro non era pensabile né rilasci<tre car ta bianca al Castoldi né mettere in discussione le sorti di Va1onn, in un momento in c.:ui, rorbidi o no, in Italia si sapeva che le nostre truppe erano impegnate molto seriamente. Da qui la replica di Scialoja:
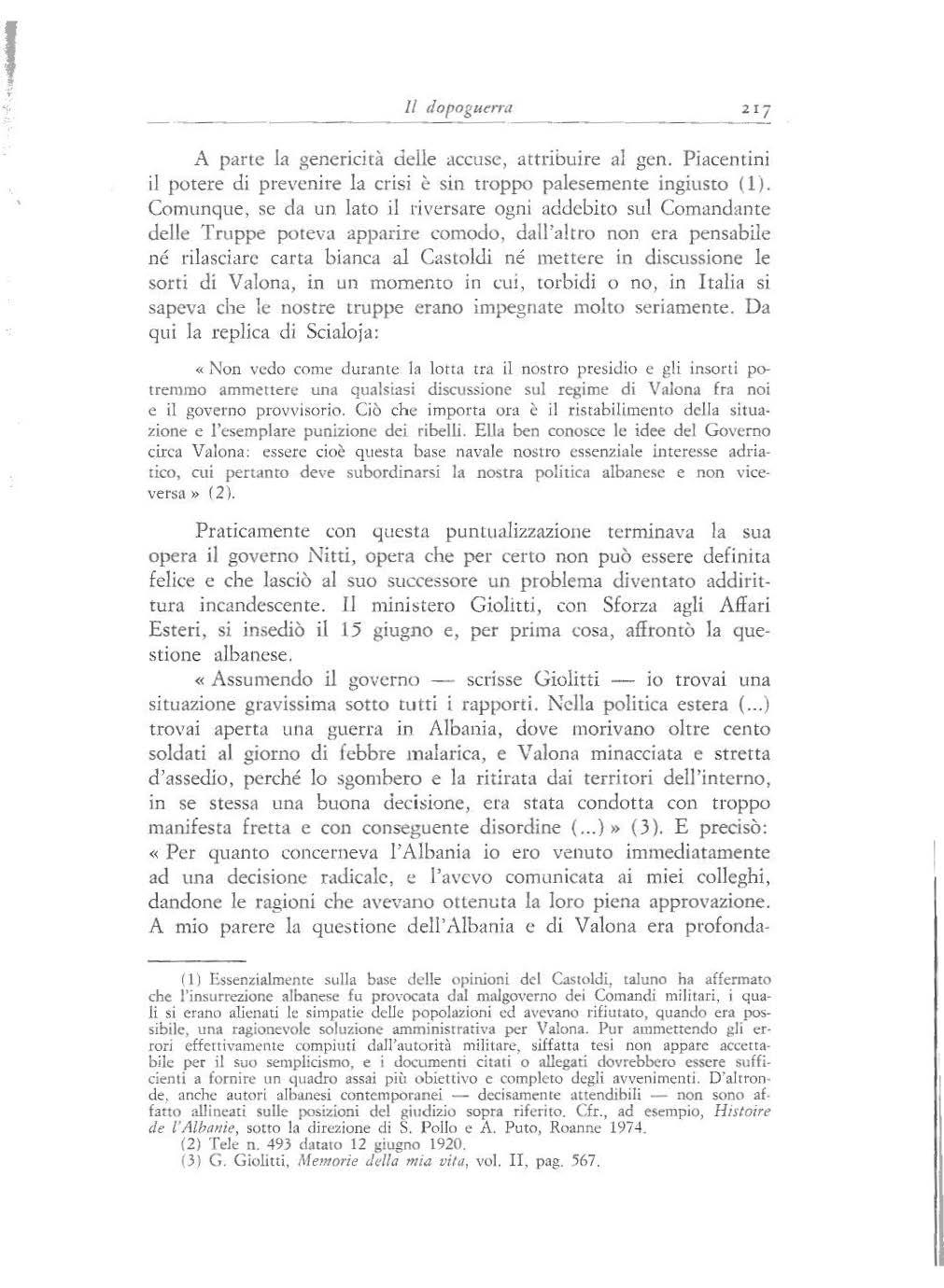
« Non vedo come durante la lotta tra il nostro presidio e gli insorti potremmo ammettere una qualsiasi discussione sul regime di Valona fra noi e il governo provvisorio. Ciò che importa ora t: il ristabilimento della situazione e l'esemplare punizione dei ribelli. Ella ben conosce le idee del Governo circa Valona: essere cioè qu esta base navale nostro essenziale imercsse adriatico, cui pertanto deve subordinarsi la nostra politica albanese e non viceversa » ( 2 ).
Praticamente con questa puntualizzazione terminava la sua opera il governo Nitti, opera che per certo non può essere definita felice e che lasciò al suo successore un problema diventato addirittura in candescente. U mm1stero Giolitti, con Sforza agli Affari Esteri, si insediò il 15 giugno e, per prima cosa, affrontò la questione albanese.
« Assumendo il governo - scrisse Giolitti - io trovai una situazione gravissima sotto t u tti i rapporti. Nella politica estera ( ...) trovai apertu una guerr a in Albania, dove morivano oltre cento soldati al giorno di febbre malarica, e Valona mi nacciata e stretta d'assedio, perché lo sgombero e la ritirata dai terrirori dell'interno, in se una buona decisione, era stata condotta con troppo manifesta fretta e con conseguente disordine ( ... ) » (3 ). E precisò:
«Per quanto concerneva l 'Albania io ero venuto immediatamente ad una decisione radicale, e l'avevo comunicata ai miei colleghi, dandon e le ragioni che avevano ottenuta la loro piena approvazione
A mio parere la questione dell'Albania e eli Valona era profonda- mente murata per noi dopo la caduta dell'impero degli Asburgo ( ... ).
(l) sulla base delle opirùoni del Castoldi. tal uno ha affermato che l'insurrezione albanese fu pro,·ocara dal malgoverno dc:-i Comandi militari, i quali si erruJo alienati le simpatie delle popohl7ioni cd avevano rifiutato, quando era possibile, una ragione\·ole soluzione amministrativa per Valona. Pur ammettendo gli er· rori effettivamente compimi da ll'autodtiì militare, siffatta tesi non appare accerta· bile per il suo semplìcismo, e i documenti citati o allegati dovrebbero essere sufficienti a fornire un quadro assai più obiettivo e completo degli avvenimenti. D' altronde. anche autori albanesi contemporanei - decisanJt:nte :mendibili - non sono af. fattO allineaci sulle posizioni del giudizio sopra rifcriro. Cfr., ad esempio, H1stoire de l'Albanie, sotto la direzione di S. Pollo c A. Puto, Roanne 1974.
(2) Tele n. 493 datatO 12 giugno 1920.
(3) G. Giolitti, Memorie dl!lla mia vifu, vol. II. pag. 567.
Nelle nuove condizioni sortite dalla guerra europea, l'interesse nostro era pure che l'Albania fosse autonoma, e che nessuno potesse insediarsi nelle sue coste e nei suoi porti; sicuri che l ' Albania per proprio conto non avrebbe mai avuto una flotta che potesse essere una minaccia alle nostre coste ed alla nostra libertà di traffico in questO mare» (1). Per Valona, invece, nelle sue «Memorie» Giolitti anticipa alquanto i tempi, giacché la dedsionc di abbandonarb e di limitare la nostra occupazione all'isola di Saseno in realtà non fu compresa nella solz.zionc: radicale, ma si venne formando trattative durante e, a dire il vero, facendo buon viso a cattivo gioco. Il 27 giugno, infatti, parlando alla Camera, Giolitti affermò:
« Valona è un punto strategico, che, se fosse occupato da una Potenza non amica dell'Italia. costituirebbe per noi un grave pericolo. Ora l'Albania, com'è costituita oggi, è nell'impossibilità di difendere Valona contro qualsiasi Potenza, che abbia una qualsiasi forza navale ( ). Perciò non possiamo oggi abbandonare Valona senza avere la sicurezza che non l'Albania la occupi, ma qualche altra Potenza, che potrebbe servirsene ai danni nostri e che cenamente non l'abbandonerebbe più. In questo momenro, adunque, occupando Valona, noi garru1tiamo l'Albania da un'occupazione permanente di Valona da parre di altre Potenze. Aggiungo che quando ci sarà un'Albania solidamente costiruita ( ) allora probabilmente chi sarà al Governo in quel potrà fare l'accordo complt:to con l'Albania, anche sulla questione di v,,_ lona » (2).
A Valona c'era calma. Respinto anche l'attacco del 10, erano arrivati i due battaglioni del 96° fanteria provenienti dal Montenegro, poi il giorno 15 era giunto il reggimento d'assalto da Trieste (3) e la 15" squadriglia autoblindo da Monfalcone. L'afflusso di talj unità aveva consl.!ntito una sortita, effettuata all'alba del 19, allo scopo di:
-affermare la nostra superiontà sugli insorti, ce rcandoli laddove segnalati per indebolirli sempre di più ed infligger loro perdite quanto più forti possibile;
-rastrellare tutta la zona compresa fra il parallelo di Drasciovizza e quello di Trev!ase, sgomberandola dagli individui e da{ bestiame tro\•ati m modo da togliere punri di appoggio a1 nostri avversari.
O) G. Giolini, op. cztata, pag. 569-570.
(2) Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XXV legislatura. Dis,·rmi011i, pag. 2549.
(3) Gli avvenimenti albanesi avevano aspra risonanza in Italia. Alle dimostrazioni di piazz:1, che rro,·avano eco in Parlamento e sulla stampa, si aggiunsero episodi di insubordinazione. Uno di quesli avvenne appunto a Trk-ste, ove il lO giugno furono promosse agirv:ioni comro la partenza del reggimento di assalto. Vi fu qualche vittima, ma il reggimento si imbarcò il 12 senza ulteriori incidenti.

L'operazione ebbe un iniziale facile successo ma poi si arrestò in parte per taluni errori di esecuzione, in parte per la difficoltà di mettere con le spalle al muro un nemico mobile e sfuggente. In definitiva , essa contribuì ad alleggerire la pressione ma , per converso, confermò l'impossibilità di rompere il sostanziale blocco terrestre della città. Lo stesso giorno, il ministro Bonomi chiedeva, a nome del Governo, «che debba essere ripristinato il nostro prestigio militare mediante U!Za vigorosa azione militare tendente ad imporre la cessclzione delle ostilità e la resa dei prigionieri» (1), ma , in verità , era chiedere troppo alle truppe d'Albania.
Il 20 giugno il gen. Piacentini illustrava particolareggiatamente la situazione al Ministero della Guerra (2): a. Cinta difensiva di Valona: la linea di resistenza attorno alla città aveva un perimetro di venti chilometri e non appariva riducibile, essendo già tutt'altro che felice in rapporto alle colline esterne; b. Truppe occorrenti per la difesa: 3.600 u. per la difesa statica (la linea richiedeva un'occupazione permanente con 1.800 u. ); 3.200 u. per operazioni esterne e per difesa mobile; 1.500 u. per i servizi. In totale 6.800 combattent>i pitt 1.500 a tergo. Per tenere a livello questa forza era stimato necessario un rifornimento di mille uomini ogni quindici giorni, a causa della malaria già ripresa e che sarebbe andata intensificandosi fino al settembre-ottobre. Era calcolato che nel pieno della stagione malarica la percentuale dei colpiti saliva al 60-65%, di cui metà con la febbre in atto; c. Tmppe richieste . La disponibilità ammontav·a a circa 3.000 u., oltre ai 1.700 u. del rgpt. d'assalto non adatti per la difesa statica (vds. specchio pagina seguente). Dedottone un quarto per indisponibilità dovuta a cause varie, quali malattie, servizi, ecc., rimanevano per il presidio della cinta 2.250 u. circa contro i 3.600 u. reputati occorrenti, con un fabbisogno, dunque, di 1.350 combattenti. Di questi , 700 dovevano essere possibilmente alpini per portare i tre battaglioni su una forza di circa 300 (!) uomini ciascuno. Venivano poi richiesti 350 artiglieri , di cui 50 da for-

(1) F 11756/ 33 D.S.).l. datato l9 giugno 1920.
(2) F. 4052 Op. datato 20 giugno 1920.
TRUPPE DI S P0:-.1IBILI PIAZZA DI VALO:-IA
rczza, con L5 ufficiali compreso un colonnello, cui affidare il comando e l 'i mpiego dell'artiglieria. Ai 18 pezzi disponibili erano jnfatti da aggiungere tre batterie da 70, una da 149 C ed una di bombarde, in corso di costitu zio ne con materiale disponibile nei magazzini. Per le truppe mobili, poi, era auspicabile un incremento di un migliaio di alpini con Lm gruppo di artiglieria su quattro batterie da montagna. Infine. un cospkuo rinforzo di personale e mezzi per i servizi. fra cui venti medici e cento autocarri con relativi conduttori.
E concludeva:
« Con tutto quanto sopra richiesto è garantito ad ogni cosro il possesso di Valon<l. Circa la \•igorosa azione militare tendente ad imporre la cessazione delle ostilità e la resa dei p rigionieri , questo Comando deve richiamarsi alla sua lettera n. 3877 Op. Ris. del i3 çorr. mese c ripetere con essa che non dobbiamo farci illusioni.
« Dato il genere del paese. dato il genere del nemico e data sopratrutro la campagna ostile con cui da molti in Europa ed in America si cerca di scalzare ed abbattere la posi?:ione dell'l tali a nei Balcani, il pensare di poterla sostenere e consolidare soltanto con le armi t: pericoloso. oltre che molto dispendioso.
« Pur senza voler invadere un campo che non è suo, questo Comando si permette di ricordare il proprio pensiero, affermato già nel promemoria n. 2000 R/mo del l3 luglio 1939, consegnato ai Ministeri e nel f. 756 R. del 4 febbraio 1920 din:rto pure agli stessi - Esteri e Guerra - (pensiero nel qua le i recenti av\·enimcnti lo hanno pienamente confermato 1 secondo cui noi non potremo conservare c migliorare la nostra posizione sulla orientale adriatica se non agiremo in pieno accordo col popolo albanese>>.
Le prime direttive inviate dal nuovo ministro degli Esteri all' Alto Commissario, ricalcano dunque il precedente indirizzo con una sensibile attenuazione dovuta ad una maggiore considerazione per il Governo albanese (anche perché il 12 giugno Essad pascià era stato assassinato a Parigi ) ed all'abbandono dell'idea del mandato:

- ribadito che il pieno possesso di Valona era considerato indispensabile ed indiscutibile per l'Italia, « siamo disposti maggiore rispetto libertà amministrativa popolazione Valona »;
- netta <..'Ontrarietà -del Governo italiano a qualsiasi forma di protettorato o di mandélto sull'Albania. << Può mni considerare con favore riconosciment o piena indipendenza albanese » (l).
Con questi punti fermi. comunicati a Castoldi « per sua norma di condotta e di linguaggio». a Roma si riteneva di aver assunto un atteggiamentO eslrcmamentc conciliante, anzi generoso . n che è sufficiente per rendersi conto dell'incomprensione tuttora esistente circa la realtà albanese e della contraddizione fra il caldeggiare la piena indipendenza dell'Albania ed il voler tenere Valona. D 'altra parte, fra i nostri rappresentanti 1n Albania si era verificato un nuovo scontro. Mentre il gen. Piacentini sosteneva apertamente che il Governo di Tirana stava dietro i rivoltosi - sia perché questi parlavano sempre a nome di. detto Governo, sia per la presenza determinante della gendarmeri-a fra le loro fi'le, sia per l'ausilio che le bande dovevano pur ricevere da qualcuno per permanere in armi attorno a Valona - il Castoldi, pur prestando poca fede alle smentite di Tirana, non riteneva di ave re in mano solidi elementi di accusa per una decis-a azione diplomat:ica. Ad ogni modo, il 22 giugno, l'Alto Commissario informò il Comando Truppe che nuovi rilevanti gruppi armati albanesi raccolti nelle regioni di e di Elbasan erano in procinto di scendere verso sud per dar man forte aoll' insurrezione. Il gen. Piacentini sollecitò il Ministero della Guerra per i rinforzi, poi ringraziò l'Alto Commissario per le informazioni e, con molta tranquillità, aggiunse:
<< Credo sa!'ebbe bene avvertire Governo Tirana che appena questo Comando avrà certezza della esistenza et marcia di tali rinfoni esso farà bomba rdare dagli aeroplani le località di Fieri. Lushnja e Berat » (l).
A dire il vero l 'idea fu apprezzata dal gen. Badoglio, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, che si affrettò a confermare a centini la disponibilità di 6 Caproni e 8 SVA della base di Brindisi, vi aggiunse due dirigibili e chiese se era necessario un maggior numero di apparecchi, ricordando che era possibile costruire nuovi hangars in Valona per aumentare la ricettività in loco (2). Chi, invece, allibì di fronte ad una simile prospettiva fu il Castoldi, il quale, dopo aver cercaro di dissuadere il gen. Piacentini dal suo proposito, si rivolse direttamente al Ministero degli Esteri, che, a sua volta, chiese l'immediato intervento di Bonomi (3 ). Non solo, ma espresse al Piacenrini il suo vivo disappLIIHO per j provvedimenti di messi in atto a Valona, dopo la rivolta del quartiere musulmano ddl' 11 giugno:
( 1) Tele n. -109/ Op. dala w 22 giugno 1920.
12) F. 3132 Op. da1ato 25 giugno 1920.
( 3) II Bonomi relegrafb :'tl gen Piaccntini: «Ministero Es1eri seg uito comunicazioni (illeggibilcl relegrammi scambiati fra V.E. e Casroldi manifesra serie apprensioni per ripercussione et conseguenza che potrebbe avere in tutta Albania e\·emuale bombardamento Fieri, Lushnja, Berat stop Benché V.E. dopo mio td<!grnmma 12359 in data 28 corr avrà cer tamente soprasseduto manifestati inte ndimenti rurra. \·ia sarò gralo se vorrà compiacersi darne » (tele n. D.S M. datato 29-6-20). Ovviamente la cosa si chiuse così.

«f ) Non condivido idee di codesw Comando e s uo modo di giudicare sitl.lnzione ( ... ). Ritengo urgente provvedere r itorno alla quiete c non gjà cercare soddisfazione militare forse con danno ceno senza gloria. Questi concetti ho esposto a Regio Governo. proponendo le vie della moderazione e della demenza ( ). Appena ricevuto risposta da Regio Governo informerò V. E di quanto sarò per decidere ( ) » (l l.
Il gen. Piacenrini rispose:
« Ringrazio del telegramma 1700 cui rispondo stop Sembrami mio pensiero sia stato frainreso stop Non ho possibilità in questo momentO di fare rettificht: ed entrare in discussioni che nulla risolverebbero stop Questo Comando in questa ora deve soltanto decidere et agire assumendo naturalmente intera responsabilità proprie a7.ioni stop Continuerò dare informazioni et comunicare mie idet non per discuterle ma per necessario affiatamento et per notizia di quanto qui accade srop Gradirò per contro ricevere informazioni che possano interessare nostre truppe stop» (2).
Poi inviò una accurata relazione al Ministero della Guerra sull'intera vicenda (3 ).

Comunque anche al Parlamento italiano le cose non procedevano affatto nel migliore dei modi. Posto di fronte all'intenzione deiJo Stato Maggiore di inviare a Valona i rinforzi richiesti (era stata dispost·a la partenza della brigata Como da Triesre) ed all'impennata dei socialisti e della Confederazione Generale del Lavoro conrro la partenza di altri soldaci per l'Albani-a (impennata sostenuta con gli incresciosi fatti di Ancona) (4}, il Governo decise di soprassedere all'invio di truppe. ln cambio mandò un nuovo plenipotenziario, il barone AHotti.
(l) Tde n. 1700 datatO 22 giugn<>. unto indecifrabile c pervenuto a mano il 25 . allegato 51.
{2) Tele n. 4158 Op. datato 26 giugno 1920.
(3 l r. n. 4164 Op. datato 27 giugno 1920 - allegato 52.
(4) Sparsasi la not izia che 1'11° bersaglieri, Ji guarnigione ad Ancona, dovev:1 essere inviato in Albania per rinforzare le nostre truppe, elementi esterni sobillarono una sedizione fra i reparti del reggimento allo scopo di provocare un mm·imento insurrezionale. «In quella occasione - scrisse Giolitti - io percepii in tuffa la gra IJttà le cor1dizioni tftd paese, in quanto non si poterono trasportare con la ferrovia le truppe e i carabinieri necessari a domare la rivolta ed a ristabilire la disciplina e l'imperio della leggt·; e per l'urge11za della situazione dovemmo provt·edere a! trasporto dr'ile truppe a mez::o dt camiom. Chl' un tale stato di cose fosse in buo11a parte e//é'tiO di inerzia e troppa paura da parte del precedentt: govemo, che nulla aveva fatto per impedire che si formasse , o per alte prime manifestazioni , fu poi mostrato dal /allo che per rimettere 1111 po' di disciplina fra i ferrovieri, non fu necessario ricorrer!! a me::.;:i eccezio11ali ( ) >> (Giolini. op. ntatJ, pag. 568).
La decisione governativa giunse a Valona attraverso i giornali, che ripeterono le dichiarazioni farre da Nitti alla Camera, e l'Intendenza di Taranto. che comunicò esserle pervenuto un ordine del Ministero della Guerra di sospendere qualsinsi partenza di volontari o regoLari, e fu confermata dall' Aliotti. Evidentemente il gen. Piacentini non poteva che giudicare le cose dal proprio punto di vista - anche perché era il più interessato - e telegrafò al ministro Bonomi rappresentando il danno che siffatte dichiarazioni avevano arrecato alle truppe. Anzitutto gli Albanesi avevano acquistatO nuovo slancio ritenendo di poter presto raggiungere un soverchiante vantaggio. In secondo luogo i soldati « vedendosi aut credendosi abbandonati da! Governo centrale rispondono meno be· ne ai loro compiti». Per giunta dei rinforzi prima promessi era arrivato ben poco, per cui le bocche da fuoco tolte da·i magazzini c l'imesse in efficienza giacevano inutHizzate per mancanza di artiglieri; la panificazione era in sofferenza per carenza di panettieri ed il ricorso alla galletta aveva quas,i esaurito le scorte; il servizio telegrafico e telefonico era del pari in crisi.
« ( ... 1 Questo Comando non crede di aggiunge re altro. ma est facile comprendere come il suo statO d 'animo non sia quale dovrebbe c.:ssere, renuro anche conto delle menzogn<:: et delle insinuazioni che hanno impetTersato nella stampa et che non hanno trovato risposta aut smentita dficace in chi solo aveva il dirirto di (l).
Bonomi rispose subito:
« Mi rendo conto stato d'animo in cui trovansi truppe per situazione paese che non consente pc.:r ora invio chiesti rinforzi stop Confido Ella vorrà comLmque fare opera tenere saldo morale truppe portando loro a conoscenza che la presentazione di ,·olontari per Albania es t promessa ( et} che caso pericolo la nazione non abbandonerà suoi figli stop Posso assicurare che nel Parlamento nessuno ha mos'IO accusa contegno truppa et azione Comando srop Presunt:l intervista Casro ldi comparsa in giornale Bari non est vera stop i\1inistcro Affari Esteri l'ha fermamente smentita stop Confido che capi et gregari continueranno con generosa abnegazione a mantenere il loro posto c a ben meritare dalla Patria che li segue con amorosa» (2).
Ma, dopo tre giorni, dovette prosegu'ire su altro tono:
« Condizioni interne Paese non consentono prelevamcnto truppe per Albania stop Tentativi invio rinforzi provocherebbero sciopero generale et dimosrrazioni popolari con gra,·e nocumeoro stessa compagine eserciro italiano che occorre non menerc.: dura prova stop Posso manclarle soltanto ma- tcriali ufficiali c reparti di volontari et pro\·vedere solh:ciLO recupero uomini licenza srop Confido che con questi pochi mezzi et conlando suirabnegazione dciJc truppe Ella possa tenere posizioni attuali finché Barone Aliotti riuscirà iniziare trattative et CJ1.Jindi Jererminare tregua d'armi stop Ma poiché est prudente tutte k ipotesi pregola considerare peggiore ipotesi cioè fallimento trattative et propO$Ìti nemico rinforzato pro:ndcrc Valona stop Per tale previsione occorre che Ella studi possibilità di ripiegare sue forze et imbarcarle tenendo occupate le penisole et isola Saseno :.top Riferisca di urgenza et segnali quante navi imbarco et marina da guerra occorrono eventuale operazione che \·oglio sperare possa essere risparmiata » (l ).

Intanto l' Aliotti, sbarcaro a Valona il 30 giugno, era stato subito ragguagliato da Piacentini sulla situazione politico-militare con un promemoria in cui venivano riepilogati gli avvenimenti degli ultimi due mesi (2). Il diplomatico non poteva obiettivamente riproporsi grandi risultati. A prescindere dallo scarso credito che gli derivava dall'essere stato nel 19 14 ministro di Gt1glielmo di \Xfied e di essere ora inviato del conte le cui 1dec erano ben note, dovette combattere contro il consapevole irrigidimento di Delvino e di Zogolli nel nulla voler cedere di territorio, tranne eventualmente Saseno: essi conoscevano troppo bene le difficoltà interne italiane e la precarietà in cui versava il presidio di Valona, dato il rilievo che ad esse la stampa italiana aveva conferito cd i particolari messi in luce. In un col'loquio con Corrado Zoli, Suleyman Delvi no disse con pungente « Noi ce l'abbiamo col GoV'Crno italiano, che ha fatto sinora una politica stolta ed ostile all'Aiban1a, senza voler riconoscere 11 superiore interesse comune di una salda e duratura amicizia fra i due Paesi. Ma non abbiamo alcu n rancore contro il popolo italiano. Sappiamo bene che il popolo italiano ci ama, che esso non vuole combatterci e non permetterà che il Governo di Roma ci combatta, com'esso ha pur recentemente e luminosamente dimostrato coi fatti di Bari, di Ancona e di Brindisi. .. » (3) Aliotti si rese conto che nelle condizioni in cui ci trovavamo non era né pratico né po11tico respingere le « proposte » albanesi sull ' accordo provvisorio approntato (schizzo 35). Il progetto di protocollo ( 4) sostanzialmente si imperniava su due articoli:
« I. Il Distretto di Valona cd il suo litorale saranno evacuati dalle truppe iraliane, sah·o l'isola di Sascno ( ).
11 1 Tele 1281.5/.33 data 6 luglio 1920.
(2) F. 4258 Op. ris. data 1° luglio 1920 allegato 5.3
(3) C. Zoli, Il moto rh·olu::iorrario albanese, in «Politica " • \ ' OI. V, fase. III, p:tg. 317.
( 4) Testo completo in allegaw 54.

« li. Tutte: le concerne nti le (urure am ichevoli relazioni fm l'Italia c saranno e risolte da una Delegazione italiana cd una Delegazione albanese. in modo da dare garanzia e soddisfazione ai legittimi interessi Jdri talia e deii'Albani;l >>.
A Roma il progetro fu accettato, ma con la controproposta di talune modifiche formali (atte a salvare la faccia) ed una sostanziale (ma più come richiesta che come p re resa): la facoltà di tenere piccoli posrì di vigilanza costiera ncl.la zona nord della penisola che da occidente cinge la baia di Valona. Questo provocò un nuovo protrarsi delle trattative con assai scarso vantaggio psicologico e concreto, finché il 23 luglio Sforza, d 'accordo con Giolitti, telegrafò -ad Aliotti di « ( ... ) considerare utilità eli procrastinare una decisione, tanto più che generale Pi.acentini afferma che può resistere e visto anche arrivo Valona entro dieci giorni mille uomini da Rodi » (l). Infatti, in seguito alla riduzione in corso delle nostre truppe a Rodi ed in Anatolia, era stato deciso di sbarcare a Valona un migliaio di uomini resisi disponibili.
« ( ... ) E' probabile - scrisse in propositO Bonomi a Piacenrini - che possa verifi carsi fra detri clementi, già desrinari al rimpatrio, un senso di spia cevole delusione allorché apprenderanno la loro destinazione in Albania; sono però sicuro che sotto la sperimentata direzione di V.E. la sgradevole impressione sarà vinta rapidamente ( ) » {2).

Alle 3 circa del 23 luglio iniziava un nuovo \riolentissimo attacco alle pos,i:doni di Valona ad opera di 4.000 insorti (schizzo 36 ). Lo sforzo fu portato su tutto l'intero sviluppo di venti chilometri del perimetro difensivo, che in talun'i punti fu perfino superato, ma l'insucceso fu totale e le perdite albanesi mo lto gravi. Alle 11, dopo otto ore, di combattimento ed un terzo impetuoso contrattacco portato dal IX e XX reparto d'assalto e dagli alpini del Dronero e dell'Inrra, gli assalitori battevano in ritirata. << Nostre truppe hanno tutte fatto splendidamente loro dovere (. . .). Nostra situazione migliorata immensamente » scrisse subito il geo. Piacentini al Ministero deJ.la Guerra ed al barone Aliotti. Se non si fu in grado di ricavare akun frutt o dalla vittoria per assoluta mancanza di riserve, le notizie che g iunsero nei giorni seguenti alle nostre linee indicarono ampiamente la portata del sanguinoso scacco subito dagli insorti Fu chiaro, molto chiaro che ,Ja forza delle armi non poteva rappresentare per il Governo di Tirana la carta vincente.
(!) Tele 138 Cab. da ta 23 luglio 1920.
(2) Tele 13811 da[a 22 luglio - allegato 55. 11 3 agosto il numero degli uomini era sceso a circa 650, infine la cosa sfumò per il wpra\>yenuto accordo.
Sforza, allora, cercò di riprendere i negoztan con un altro inviato, il conte Manzoni, il quale, avvalendosi di una nuova carca - la denunzia dell'accordo Tittoni- Venizelos, doveva cercare eli ottenere una tregua di fatto in cambio di un de6so appoggio italiano all'indipendenza albanese. Se, poi, non fosse apparso possibile tale risultato, egli era autorizzato a concludere le tratt-ative interrotte dieci giorni prima: cioè il progetto di protocollo preliminare con le modifiche formali in precedem:a accennate. Il nuovo plenipotenziario, a ventiquattr'ore dallo sbarco a Durazzo, ebbe nitida l'atmosfera locale e la assoluta posizione di forza del Governo di Tirana, al quale - informato com'era sulle condizioni delle truppe di Va,lona - bastav•a aspettare che attacchi :ripetuti e soprattutto la malaria riducessero a poca cosa la capacità difensiva del nostro presidio: <<Complesso prim e informazioni ed impressioni raccolte indicherebbero nostra situazione assai meno favorevole di quanto io potevo giudicate dall'lttllia » (1), telegrafò a Roma con una chiarezza pari alla correttezza formale e chiese senz'altro di concludere una buona volta la penosa vertenza. Il 2 agosto venne firmato a Tirana il seguente Protocollo:
<< Essendo cessare le ragioni per le quali l'Italia aveva durante la guerra inviato delle truppe in Albania ed essendo sorti incidenti che hanno disturbaco il già iniziato rimpatrio di queste truppe, tra il Nob. Gaetano dei Conti Manzoni, Ministro PJenipotenziario di S.M. il Re d'Italia, incaricato di sistemare i rapporti fra l'Italia e l'Albania , e S.E. Suleiman bey Delvino. Presidente del Consiglio dci :...1inistri del Governo Provvisorio albanese,

« Entrambi deb itamente autorizzati dai rispetti\·i Governi ( ) è stato convenuto quanto segue :
''I. Tutte le questioni concernenti le future amichevoli relazioni fra l'Italia e l'Albania saranno esaminate e risolte da una Delegazione italiana e da una Delegazione albanese in modo da dare garanzia e soddisfazione ai legittimi interessi dell ' lralia c dell ' Albania.
«II. II Governo italiano per dare prova dei suoi sentimenti di rispetto della sovranità albanese su Valona e della integrità ter ritoriale dell'Albania, farà rimpatriare le truppe italiane attualmente dislocate in Valona e suo litorale e nel resto dell ' Albania, eccezion fatta per l'isola di Saseno. li termine della evacuazione del litorale di V11lona verrà fissato in una lettera che il Plenipotenziario italiano scri\·erà al Preside nre del Governo albanese (2 ). Le modalità saranno stabilite da apposita Commissione mista italo-albanese.
« Il I. Nel frattempo le forze albanesi saranno trasferite oltre il fiume Sushica e il territorio fra Ja Sushic-a ed il mare considerato zona neutra dutMiC il periodo di rimpatrio. Tuttavi a il Governo alb,mese mandare suoi funzionari ad l'amministrazione della città c della provincia Ji Valona. accompagnati da sufficicnre reparto di gendarmeria, dopo trascorsi quindici giorni dall'initio d el rimpatrio delle tmppe italiane. I posti di gendarmeria necessari aJ mantenimento dell'ordine nella zon.1 neutm saranno in\'Ìa ti dalle :\utorità albanesi.
(l) Tele n 290/156 Gab. datato 27 luglio 1920.
( 2) 11 fissatu dall'ftalia per il rimpatrio fu di un mese.
« IV., V. , VI., VH
« Vlii. Il tesro di gue:;to Protocollo preliminare non pubblicare né comunicato a stramcn salvo accordo fra le parti . Tutta\'ia qualora la questi one aìh:mese portata alla della Conferenza della Pace prima della condusionl: del Protocollo definitivo le parti contraenti potranno usare in sede di Conferenza del presente atto >> l l )
A partire dal 3 agosto, entro trenta giorni le truppe italiane dovevano portare a termine lo sgombero completo di Valona e del litorale albanese. Rimaneva in posto, -ancora per poco, il solo distaccamemo di Scutari.
Il 7 agosto il conte Sforza annunciava alla Camera: « Abbiamo ritirato le nostre truppe mantenendo il nostro potere sull'isola di Saseno che domina e neutralizza Valona (. .. ). Siamo partiti da Valona dopo un brillante combattimento che mostrò agli Albanesi che mai ci avrebbero fatti ritornare di là ».
Pet: gli Albanesi, il Protocollo di Tirana rappres'entò la vittoria degli uomini di Lushnja, la prova dell 'esistenza di un sentimento nazionale, la definitiva affermazione della riacquistata indipendenza. Per l'Italia costituì l'inevitabile conclusione di una successione di errori, parte dei quali dovuta a superficialità e, soprattutto , ad una scarsa conoscenza , non esente da colpa, del problema particolare.










