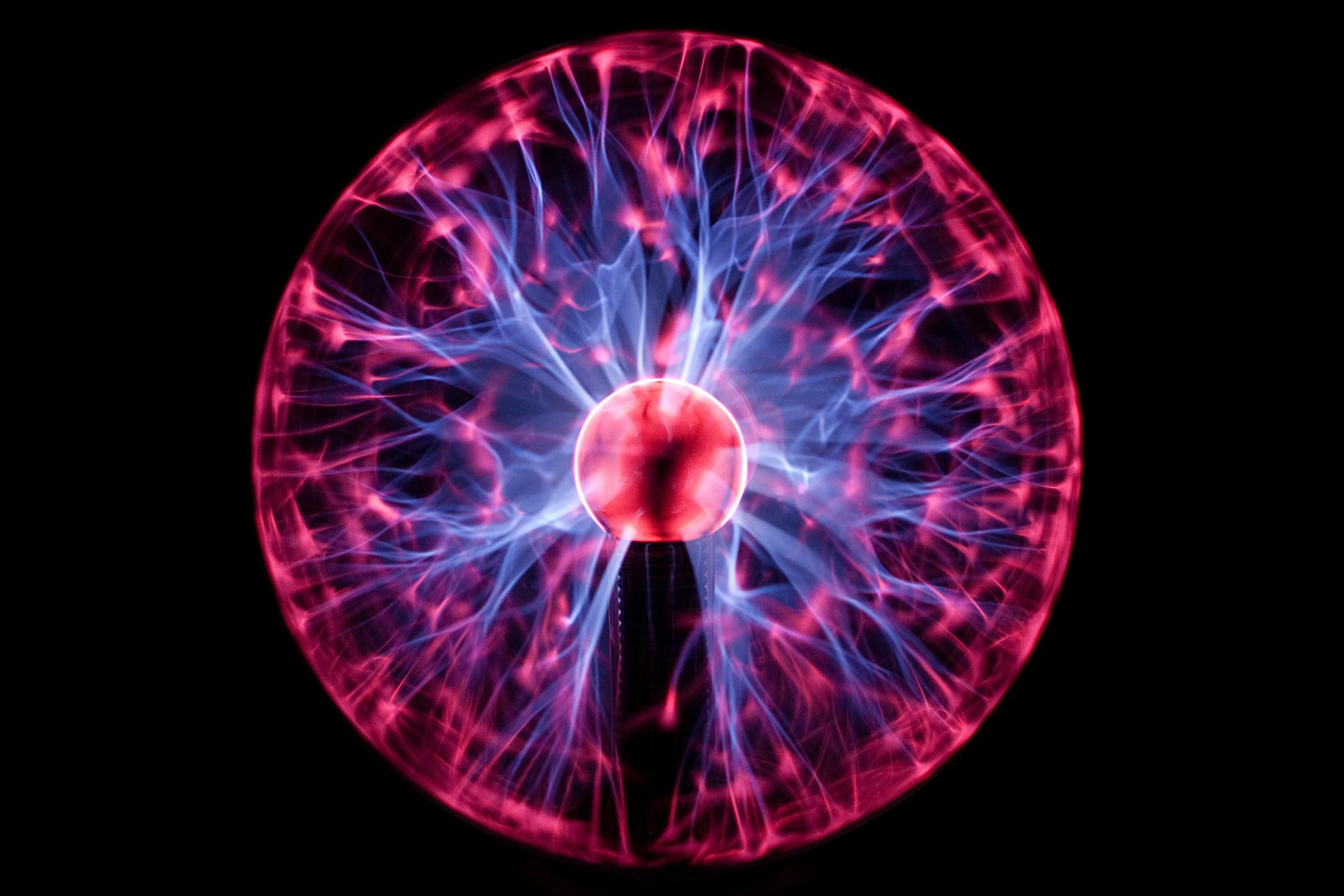6 minute read
Scienze e tecnologia blu in natura: un colore particolare
Blu in natura: Un colore particolare
Di irene volante
Advertisement
Il blu è il colore più amato e diffuso nel mondo. Da bambini impariamo che il blu è il colore del cielo e del mare. Eppure ritrovarlo in natura è estremamente difficile. Inoltre, quando si presenta, lo fa in un modo particolare: sotto forma di illusione ottica. Su 64mila specie di vertebrati solamente 2 di loro presentano un vero pigmento blu e oggi sappiamo che perfino il colore blu degli occhi umani è un marrone molto chiaro.
Per comprendere il perché di questa rarità e i meccanismi che spesso fanno sì che gli animali appaiano blu, dobbiamo capire cosa sono i colori che vediamo e a cosa generalmente gli animali devono il proprio colore.
I colori sono semplicemente il modo in cui percepiamo le diverse lunghezze d’onda dello spettro visibile della luce. I colori che vediamo, dunque, dipendono dalla luce riflessa e trasmessa dagli oggetti ai nostri occhi. In natura i colori assunti da quasi tutti gli animali e le piante dipendono dalla presenza nelle loro cellule di particolari molecole, dette pigmenti biologici o biocromi, che assorbono determinate lunghezze d’onda, mentre riflettono le altre, ovvero quelle che corrispondono al colore che vediamo.
Il blu usa un meccanismo diverso, che ha a che fare con il modo in cui la luce viene rifratta, producendo il cosiddetto colore strutturale, ovvero una colorazione prodotta dall’interazione della luce con strutture fisiche grandi poche centinaia di nanometri. Le modalità con cui questo colore viene prodotto sono simili tra loro, ma variano a seconda delle diverse specie.
Un esempio di colore strutturale è quello delle farfalle Morpho blu, che sfoggiano meravigliose ali blu iridescenti, ovvero aventi un colore che varia (entro un determinato intervallo di lunghezze d’onda) con la posizione e l’angolo da cui vengono osservate. Questo rende evidente che il loro colore non può essere causato da pigmenti blu; infatti, in quest’ultimo caso, il loro colore rimarrebbe invariato da ogni angolazione. Questo colore è dato da microstrutture che sfruttano i fenomeni di diffrazione e interferenza.
La diffrazione è il fenomeno che avviene quando un’onda incontra un ostacolo comparabile alla sua lunghezza d’onda e che fa sì che l’onda riesca in qualche modo ad aggirare l’ostacolo. L’interferenza è, invece, il fenomeno che avviene quando due o più onde si incontrano. L’interferenza è definita costruttiva, quando le creste delle onde, ovvero i punti più alti dell’oscillazione, si sovrappongono, mentre è definita distruttiva, quando alle creste si sommano le valli, cioè i punti più bassi. In questo caso le onde si annullano fra loro.
Le strutture responsabili del colore di queste farfalle hanno dimensioni dell’ordine di centinaia di nanometri, sono strutturate come degli alberi di natale e disposte in fila. La luce bianca in entrata, quando viene diffusa dalle nervature trasversali di queste strutture, risulta divisa nelle diverse lunghezze d’onda che la compongono e viene riflessa contemporaneamente dai diversi strati che costituiscono le nanostrutture, producendo così diverse onde che interagiscono tra loro. La luce blu è l’unica che, a causa della sua specifica lunghezza d’onda e del rapporto di essa con le distanze tra i punti in cui la luce viene riflessa, produce un’ interferenza costruttiva, facendo in modo che il colore blu rimanga visibile e venga reso più intenso e brillante. Tutte le altre lunghezze d’onda vengono riflesse in modo da produrre un’interferenza distruttiva, annullandosi tra loro e risultando quindi invisibili. La melanina, ovvero
il pigmento scuro contenuto nelle ali della farfalla, contribuisce al colore, rendendolo più scuro, poiché assorbe eventuali onde luminose “in eccesso”. L’iridesceza è dovuta al fatto che, con la variazione dell’angolo visuale, si altera il percorso dei raggi interferenti e quindi il colore che ne risulta. Un’altra prova del fatto che il colore delle ali di tali farfalle è strutturale è il fatto che, se si immergono in una sostanza diversa dall’aria, come, ad esempio, l’alcool, queste cambiano colore, poiché cambia l’indice di rifrazione, diventando, in questo caso, verde scuro, ma, quando questa sostanza evapora, esse riacquistano il particolare colore blu. A questo proposito, ci si potrebbe domandare come faccia il colore blu a rimanere invariato nelle continue piogge della foresta amazzonica in cui vivono questi animali: questo avviene perché la superficie delle ali di queste farfalle è ricoperta di cheratina, che la rende naturalmente impermeabile.

Gli uccelli che sfoggiano penne blu sfruttano altri meccanismi simili a questo: ne è un esempio la ghiandaia azzurra americana, un piccolo uccello che vive, appunto, nel Nord America. Il meccanismo usato da questo e molti altri uccelli è lo stesso che fa apparire il cielo blu. Il pigmento contenuto nelle piume di questi uccelli è la melanina, che assorbe la totalità dello spettro visibile; ciò renderebbe le piume marroni, ma esse hanno una struttura porosa che contiene sacche d’aria che riflettono la luce blu e assorbono quella rossa, mentre tutte le altre lunghezze d’onda possono passare attraverso di esse e vengono assorbite dalla melanina. Le ghiandaie non mostrano alcun effetto iridescente, ma il loro colore può variare da esemplare a esemplare, a seconda delle dimensioni delle sacche.
Se si guardano un’ala di una farfalla Morpho o una piuma di un uccello blu controluce, esse rivelano il loro vero colore, ovvero quello dato dai pigmenti scuri, perché, in questo caso, la luce che arriva ai nostri occhi non è quella riflessa dalle microstrutture.
Anche nelle piante il blu è un colore raro: meno del 10% delle 280000 specie floreali presentano fiori blu.
In questo caso le piante utilizzano le antocianine, una classe di molecole molto diffuse; esse sono pigmenti di base rossi, ma che possono cambiare dal rosso al blu all’aumentare dell’alcalinità dell’ambiente. Le piante possono, quindi, avere i fiori (o, ancora più raramente, il fogliame ) blu solo in determinate condizioni ambientali, in cui si può attuare una varietà di modifiche ai pigmenti degli antociani rossi, che coinvolgono i cambiamenti di pH e la miscelazione di pigmenti, molecole e ioni.
I motivi per cui gli animali hanno sviluppato queste microstrutture per apparire blu non sono ancora certi, ma la teoria dominante afferma che a questi animali l’assumere una colorazione blu potrebbe avere portato dei benefici, ed è stato per molte specie più facile cambiare la propria struttura che assumere un pigmento blu. Questa teoria è legata al fatto che gli animali e le piante usano i colori per mandare determinati messaggi, ad esempio le tinte vivaci dei fiori servono ad attrarre gli insetti, mentre nel mondo animale i colori hanno funzione mimetica, di richiamo sessuale, o di difesa.
Per capire il motivo per cui i pigmenti blu sono così rari, bisogna scavare più a fondo nei meccanismi con cui funzionano i pigmenti. Infatti l’assorbimento della luce dipende dall’energia necessaria per far passare un’elettrone della molecola dallo stato fondamentale a un stato eccitato, con energia maggiore. Per fare in modo che un pigmento sia blu, questo dovrebbe assorbire la luce rossa, ovvero quella che nello spettro visibile ha la frequenza minore; quindi, per l’equazione di Planck, quella che ha l’energia minore. Questo comporta che l’assorbimento nel rosso sia difficile, perché tale è abbassare, oltre una determinata soglia, la differenza tra gli stati energetici della molecola.