


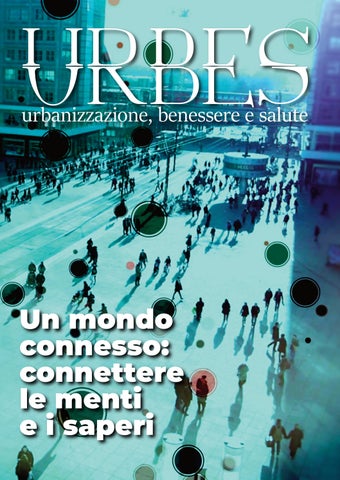





Promosso da: https://www.urbesmagazine.it/ https://healthcityinstitute.com/


di Federico Serra
Viviamo in un’epoca caratterizzata da un’accelerazione senza precedenti della connettività. Internet, i social media, l’intelligenza artificiale e le reti globali hanno trasformato radicalmente il nostro modo di comunicare, apprendere e condividere conoscenza. Tuttavia, questa iperconnessione porta con sé nuove sfide: come garantire che questa interconnessione sia un’opportunità per tutti e non una fonte di disuguaglianza? Come preservare la qualità dei saperi in un mare di informazioni?
L’importanza della connessione tra le menti
La storia dell’umanità è la storia della condivisione delle idee. L’evoluzione culturale e scientifica è stata possibile grazie all’incontro e alla contaminazione di saperi diversi. Oggi, le tecnologie digitali permettono una collaborazione su scala planetaria: ricercatori, artisti, imprenditori e studenti possono dialogare in tempo reale, superando barriere geografiche e linguistiche. Tuttavia, la connessione tra le menti non si riduce alla sola infrastruttura tecnologica: richiede un contesto di apertura, scambio e spirito critico.
La conoscenza, infatti, si arricchisce quando è messa in discussione, quando diversi punti di vista si incontrano e si confrontano. La connessione tra menti diverse non è soltanto un mezzo per la trasmissione di informazioni, ma un processo attivo di costruzione del sapere. Le università, i centri di ricerca e le piattaforme di apprendimento online giocano un ruolo chiave in questo scenario, ma è necessario un impegno collettivo per rendere questi strumenti accessibili a tutti. Un esempio significativo è rappresentato dai progetti di ricerca collaborativa come il CERN, dove scienziati
da tutto il mondo lavorano insieme per esplorare i misteri dell’universo. Allo stesso modo, il Progetto Genoma Umano ha dimostrato come la cooperazione internazionale possa portare a progressi straordinari nella biomedicina.
In ambito artistico, piattaforme come Behance e DeviantArt permettono a creativi di ogni parte del mondo di condividere opere, trovare ispirazione e collaborare a progetti innovativi. Anche il mondo dell’educazione è stato trasformato dalla connessione globale: la Khan Academy, ad esempio, offre corsi gratuiti che hanno raggiunto milioni di studenti, abbattendo le barriere economiche e geografiche dell’apprendimento.
Connessione tra città e aree rurali
Uno degli aspetti fondamentali della connessione globale riguarda il divario tra le aree urbane e quelle rurali. Mentre le città sono spesso epicentri dell’innovazione, delle infrastrutture tecnologiche avanzate e delle istituzioni educative, le zone rurali e le periferie rischiano di rimanere indietro. La digitalizzazione può diventare un ponte per colmare questo divario, permettendo agli abitanti delle zone meno sviluppate di accedere alle stesse opportunità formative, lavorative e culturali di chi vive nei grandi centri.
Esempi concreti includono il progetto Starlink di SpaceX, che mira a fornire connettività internet ad alta velocità nelle zone più remote del pianeta, e iniziative governative che incentivano la creazione di smart villages, dove la tecnologia viene utilizzata per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. Anche l’agricoltura di precisione, basata su sensori e intelli-
genza artificiale, rappresenta un esempio di come la connessione tra tecnologia e mondo rurale possa migliorare la produttività e la sostenibilità ambientale.
Inoltre, molte periferie urbane stanno vivendo una trasformazione grazie alle nuove tecnologie. Progetti di rigenerazione urbana, come quelli adottati in città come Barcellona e Berlino, sfruttano la connettività digitale per migliorare i servizi pubblici, aumentare la partecipazione cittadina e promuovere lo sviluppo economico locale. Questi esempi dimostrano come le connessioni tra le aree urbane e rurali possano essere rafforzate per garantire uno sviluppo più equo e inclusivo.
Globalizzazione, nazionalismi e connessione tra i popoli
Uno degli aspetti più complessi della connettività globale è il rapporto tra globalizzazione e nazionalismo. Da un lato, la globalizzazione ha portato a un’accelerazione negli scambi commerciali, culturali e scientifici, permettendo a diverse società di collaborare e prosperare insieme. Le economie sono sempre più interdipendenti e le tecnologie digitali consentono una circolazione senza precedenti delle idee e delle informazioni. Esempi di questa connessione sono le collaborazioni internazionali in campo scientifico, come l’Agenzia Spaziale Europea, e le reti di volontariato globale che operano in situazioni di emergenza.
Dall’altro lato, l’ascesa di movimenti nazionalisti in diverse parti del mondo riflette una crescente resistenza alla perdita delle identità locali e alla percezione di un’eccessiva omogeneizzazione culturale. Molti paesi stanno cercando di proteggere le proprie tradizioni, economie e autonomie politiche, spesso attraverso politiche di chiusura e limitazione degli scambi internazionali. Questo porta a un paradosso: mentre le tecnologie ci connettono come mai prima d’ora, le tensioni geopolitiche e culturali minacciano di dividere i popoli.
In questo scenario, è fondamentale trovare un equilibrio tra connessione globale e rispetto delle identità locali. Le reti digitali possono diventare strumenti per il dialogo interculturale, promuovendo la comprensione reciproca e riducendo le distanze tra i popoli. Esempi virtuosi includono iniziative come il progetto Erasmus, che favorisce la mobilità studentesca in Europa, e le collaborazioni tra università di diversi continenti che permettono la condivisione delle conoscenze e il superamento delle barriere geografiche.
Un futuro di connessioni significative
Il futuro dipenderà dalla nostra capacità di costruire connessioni significative, capaci di alimentare il progresso e il benessere collettivo. La tecnologia da sola non basta: servono politiche educative inclusive, investimenti nella ricerca e una responsabilità condivisa nel promuovere un uso etico delle reti digitali. In un mondo sempre più interconnesso, la vera sfida non è solo connettere, ma farlo in modo consapevole, critico e costruttivo.
Infine, anche a livello individuale, possiamo fare la nostra parte. Essere cittadini digitali consapevoli significa non solo consumare informazioni, ma anche contribuire alla diffusione di un sapere di qualità. Significa essere aperti al confronto, accettare la complessità e riconoscere il valore delle differenze. In un’epoca in cui tutto è connesso, il vero progresso dipenderà dalla capacità di costruire ponti, e non muri, tra le menti e i saperi.


EDITORIALE
AGORÀ
ZIBALDONE
IN PUNTA DI PENNA
CITTADINI
FOCUS ON SOCRATIC DIALOGUE
GAETANO MANFREDI NUOVO PRESIDENTE ANCI
INTERVISTA A GAERANO MANFREDI
RICORDO DI FULCO PRATESI
RECENSIONI
TAKE AWAY
CITIES SPEAKING
Città e clima
Città e sostenibilità
CITIES +
CITIES+ NUOVA GOVERNANCE DEL NETWORK CITIES+
Alfabetizzazione digitale
Digital Divide
Le Ciità intelliggenti
URBES DIALOGUE
SCIENCE FOR CITIES
ARTICOLO RECUI
Intervista ad Andrea Lenzi, nuovo portavoce RECUI
OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE COME BENE COMUNE
Planetary Health Los Angeles
Health City Manager course
HCM Alumni
YMCA
Speciale DAVOS
SPECIALE AREE INTERNE
Connessi
Intervista al Sen. Liris

Borghi - Petralia Sottana
Isole minori - Lampedusa
Isole Minori - Lampedusa intervista all'Assessore
Comuni Montani Montereale con intervista al Sindaco CITTÀ
Ascoli, Intervista al Sindaco
Roma e il suo Giubileo
Londra
SPECIALE SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN COLLABORAZIONE
CON EDRA E BHAVE
Intervista On. Loizzo
IA ACTION Summit
Democratizzazione e IA
IA nella salute pubblica
IA nella ricerca clinica
IA e connessioni umane
Valorizzare l'IA come nuova risorsa
CITIES FOR BETTER HEALTH
Cities for better health, Vincitori della Healthy Cities Challenge di Cities for better health e C40
Cities for better, health obesità infantile
LE VIE DEL VINO, DEL GUSTO
Fattoria Svetini
Street Food
LE CITTA' IL BENESSERE E L'ARTE
Mostra di Caravaggio
ARTICOLI
La Fondazione Diabete & Ricerca entra a far parte della Fondazione Venzia Capitale mondiale della sostenibilità
Giornata mondiale sul Cyrberbullismo
World Obesity Day
Integrazione ospedale territorio e Malattie infettive
Adolescenti e iperconnessione;: quando il digitale diventa una fuga dalla realtà ADVERTISING
MULTIPLA
REGIA CONGRESSI
Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri


Viviamo in un’epoca in cui la scienza è spesso percepita come un dominio distante, fatto di laboratori, formule e tecnologie complesse. Eppure, la scienza non è solo un metodo di indagine: è un linguaggio, un modo di pensare, un filo invisibile che unisce discipline, individui e comunità. Gregory Bateson, antropologo, scienziato e filosofo del pensiero sistemico, ci ha insegnato che la conoscenza non è mai isolata, ma sempre intrecciata in reti di relazioni. Questo principio, oggi più che mai, è fondamentale per affrontare le sfide globali e costruire una società più interconnessa e consapevole.
La scienza come rete di connessioni
Bateson ha dedicato la sua vita allo studio dei sistemi complessi, cercando di comprendere come la conoscenza emerga dall’interazione tra elementi diversi. Per lui, la mente non era confinata al cervello umano, ma distribuita nell’ambiente, nelle relazioni sociali, nei processi biologici e culturali. Questa visione olistica ci invita a superare la frammentazione del sapere per abbracciare una prospettiva sistemica: la scienza non è solo una somma di scoperte settoriali, ma una rete di connessioni che attraversa le discipline e le società.
Nella crisi climatica, ad esempio, non possiamo limitarci alla fisica dell’atmosfera o alla chimica degli oceani: dobbiamo considerare l’economia, la politica, la psicologia collettiva. Analogamente, nella medicina moderna, non basta curare i sintomi di una malattia senza analizzare le condizioni sociali, ambientali e mentali del paziente. Questa capacità di “connettere i punti” è essenziale per una scienza che voglia davvero rispondere ai bisogni della società.
lisi dei dati scientifici, o alle iniziative di divulgazione che rendono accessibili concetti complessi. La scienza aperta, partecipativa e condivisa è il modello di conoscenza di cui abbiamo bisogno per affrontare le grandi sfide globali, dall’emergenza climatica alle pandemie, dalle disuguaglianze alla transizione digitale.
Un esempio concreto è la risposta collettiva alla pandemia di COVID-19: mai prima d’ora la scienza è stata così visibile nella vita quotidiana, coinvolgendo cittadini, governi, aziende e istituzioni in un processo globale di apprendimento. Tuttavia, abbiamo anche visto quanto sia difficile comunicare la scienza in modo chiaro, contrastare la disinformazione e costruire fiducia tra gli esperti e la società. Qui entra in gioco un altro insegnamento di Bateson: la scienza non può essere imposta dall’alto, ma deve essere un dialogo, un processo di apprendimento reciproco tra comunità scientifica e società civile.
Il futuro della scienza: un’intelligenza collettiva
Se vogliamo una scienza che connette, dobbiamo ripensare il modo in cui la produciamo e la comunichiamo. Dobbiamo investire nell’educazione scientifica come strumento di cittadinanza attiva, promuovere la collaborazione tra discipline, favorire modelli di ricerca partecipativa. Il futuro della scienza non è isolato nei laboratori, ma nella capacità di costruire intelligenza collettiva.
Bateson ci ha insegnato che la conoscenza non è un insieme di informazioni, ma un processo in continuo divenire, un sistema di relazioni che si trasforma e si adatta. In un mondo sempre più interconnesso, il vero progresso scientifico non sarà solo quello delle scoperte tecnologiche, ma quello della capacità di creare legami, generare empatia e costruire una società più consapevole e armonica. La scienza che connette è la scienza del futuro.
all’ana-
Connettere le comunità attraverso la scienza Oggi, il sapere scientifico non può rimanere confinato all’accademia o ai laboratori: deve essere un ponte tra le persone, uno strumento per rafforzare il senso di comunità. Pensiamo ai progetti di citizen science, in cui cittadini comuni contribuiscono


Il recente documento vaticano “Antiqua et Nova” rappresenta una riflessione profonda sul rapporto tra intelligenza artificiale (IA) e intelligenza umana, evidenziando le sfide etiche e antropologiche emergenti in un’epoca di rapida innovazione tecnologica. Questo testo, frutto della collaborazione tra il Dicastero per la Dottrina della Fede e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, si inserisce in una serie di interventi di Papa Francesco sull’argomento, tra cui il discorso al G7 sull’IA nel giugno 2024 e il Messaggio per la 57ª Giornata Mondiale della Pace.
In “Antiqua et Nova”, la Chiesa sottolinea che l’IA non è una forma artificiale di intelligenza indipendente, ma un prodotto dell’ingegno umano. Questo riconoscimento porta a una duplice considerazione: da un lato, l’IA possiede un potenziale straordinario per promuovere lo sviluppo umano integrale, introducendo innovazioni significative in settori come l’educazione, la sanità e l’economia; dall’altro, solleva preoccupazioni etiche riguardanti la dignità umana, la giustizia sociale e la salvaguardia del bene comune.
Un aspetto centrale del documento è l’avvertimento contro la tentazione di attribuire all’IA qualità umane o divine. La Chiesa mette in guardia dal rischio di considerare l’IA come un sostituto di Dio o dell’intelligenza umana, sottolineando che tale prospettiva potrebbe portare a una forma di idolatria tecnologica. Inoltre, si evidenzia il pericolo che l’essere umano diventi schiavo delle proprie creazioni, specialmente se l’IA viene utilizzata in modo da ridurre le persone a meri ingranaggi di un sistema tecnocratico.
Essere Connessi Secondo Papa Francesco
Papa Francesco ha spesso sottolineato l’importanza di essere connessi in modo autentico e significativo. Essere connessi non significa semplicemente essere sempre online o immersi nei social media, ma costruire relazioni basate sull’ascolto, sulla comprensione e sulla solidarietà. La connessione autentica implica un coinvolgimento reale con il prossimo, evitando l’isolamento digitale e promuovendo una cultura dell’incontro. Nel contesto dell’IA, questo significa utilizzare la tecnologia in modo che rafforzi la comunità e il senso di appartenenza, piuttosto che creare nuove forme di esclusione e divisione. La tecnologia, se ben utilizzata, può diventare uno strumento per favorire il dialogo tra le persone e tra le culture, ma deve sempre essere orientata al bene comune e non alla mera efficienza o profitto.
IA e Sanità: Una Svolta Etica e Tecnologica
Uno degli ambiti più sensibili e cruciali affrontati in “Antiqua et Nova” è quello della sanità. L’IA sta rivoluzionando la medicina, offrendo strumenti di diagnosi avanzati, terapie personalizzate e un supporto senza precedenti per i professionisti sanitari. Tuttavia, il documento sottolinea la necessità di un utilizzo etico di queste tecnologie, affinché non si perda di vista la centralità del paziente e il valore inalienabile della viIl Va-
ticano avverte che, sebbene l’IA possa migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari, non deve mai sostituire il giudizio clinico e l’empatia del medico. L’uso di algoritmi per la diagnosi e la prescrizione di trattamenti deve essere accompagnato da un rigoroso controllo umano, evitando il rischio di una medicina disumanizzata, in cui il paziente venga ridotto a un insieme di dati piuttosto che a una persona con bisogni unici e irripetibili.
Un altro punto critico sollevato dal documento riguarda l’accesso equo alle tecnologie basate sull’IA. Esiste il rischio che queste innovazioni possano essere monopolizzate da pochi attori economici, ampliando il divario tra chi può permettersi cure all’avanguardia e chi rimane escluso dai progressi scientifici. La Chiesa richiama alla responsabilità di garantire che i benefici dell’IA nella sanità siano distribuiti in modo equo e giusto, senza discriminazioni di alcun tipo.
IA e Decisioni di Vita o di Morte
Il documento affronta con particolare preoccupazione l’uso dell’IA in decisioni critiche legate alla vita umana, come il fine vita e la selezione dei pazienti nei contesti di emergenza sanitaria. L’automazione delle decisioni mediche potrebbe portare a scenari distopici in cui il valore di una vita viene calcolato in base a parametri algoritmici, piuttosto che alla dignità intrinseca di ogni essere umano.
La Chiesa sottolinea che nessuna macchina può sostituire la responsabilità morale dell’uomo. L’assistenza sanitaria deve rimanere un atto di cura e di servizio, guidato dalla compassione e dal rispetto per la persona, piuttosto che da logiche di mera efficienza economica o tecnologica. In questo senso, “Antiqua et Nova” ribadisce la necessità di porre limiti etici all’uso dell’IA in ambito medico, impedendo che diventi uno strumento di selezione e discriminazione tra vite degne e non degne di essere vissute.
Un Futuro Sostenibile per l’IA
In conclusione, “Antiqua et Nova” invita a un discernimento etico sull’uso dell’IA, promuovendo un approccio che metta al centro la persona umana e il bene comune. La Chiesa esorta a sviluppare e implementare l’IA in modo responsabile, assicurando che essa rimanga uno strumento al servizio dell’umanità, piuttosto che un potenziale dominatore delle nostre vite.
Questo documento rappresenta un richiamo alla saggezza sia antica che nuova, invitando a considerare come le innovazioni tecnologiche possano essere integrate nella società in modo da promuovere autenticamente la dignità umana e il progresso sociale. In un’epoca in cui l’IA sta rapidamente trasformando vari aspetti della nostra esistenza, il messaggio di Papa Francesco offre una guida preziosa per navigare le complessità etiche e morali che emergono, assicurando che la tecnologia rimanga al servizio dell’uomo e non viceversa.

di Fabio Mazzeo Giornalista e divulgatore scientifico
Il termine “connessione” ci porta immediatamente al mondo del web, e tra le citazioni che definiscono il nuovo scenario c’è quella dello straordinario Stephen Hawking: “Siamo tutti collegati a Internet, come i neuroni in un cervello gigante.”
Ma “connessione”, che deriva dal latino, già prima dell’invenzione della sfera mediatica dentro la quale oggi tutto scorre, e rimane, aveva il significante di stretta correlazione, unione, tra fatti e idee. Il web ha solo accorciato i tempi e annullato le distanze. Lo ha fatto in modo talmente assoluto da portare il filosofo Luciano Floridi, reso celebre dall’avere rispolverato il termine “infosf era” per definire l’ambiente globale costituito da tutte le informazioni digitali e fisiche, a coniare il termine “Onlife”. Determinata da dispositivi mobili attraverso i quali ogni nostra intenzione diventa azione, nella nostra vita non c’è più separazione tra mondo fisico e mondo virtuale. Solo le due dimensioni che, profondamente interconnesse attraverso smartphone, social media e intelligenza artificiale portano la nostra esistenza a essere costantemente connessa.
Istruzione, lavoro, salute, tutto è mediato dalle nuove tecnologie. È cambiato così, in un battito di ciglia, il nostro modo di relazionarci, di pensare, perfino di pensare noi stessi.
Lasciando sullo sfondo il pensiero filosofico e citando alcuni evidenti pericoli, la perdita di privacy innanzitutto e l’utilizzo dei nostri dati per fini commerciali o politici, è possibile evidenziare una serie di questioni che possono produrre effetti di straordinario vantaggio per l’umanità. La velocità nel trasferimento dei dati apre, per esempio, alla possibilità di avere efficienza e personalizzazione delle risposte ai bisogni personali come mai avremmo pensato fino a qualche anno fa. Non si tratta solo di potere acquistare attraverso una piattaforma digitale un bene fisico prodotto e finito in un banco merci di qualsiasi parte del mondo e riceverlo a casa, ma pensiamo soprattutto ai servizi per la salute, tra tutti il bene supremo che abbiamo in dote. Sono le connessioni che oggi consentono l’assistenza domiciliare attraverso un costante monitoraggio dei
parametri utili a tenerci nella migliore efficienza fisica. Ed è grazie alla potenza e alla velocità di trasmissione dei dati che oggi è davvero possibile generare per tutti una rete efficace di telemedicina, teleassistenza e teleriabilitazione.
La connessione, dunque, è un superpotere e, come per gli eroi della Marvel, il superpotere va gestito con super responsabilità e una visione di bene comune.
Secondo l’Istat, il nostro Istituto Nazionale di Statistica, al 31 dicembre del 2022 nel nostro Paese il 17% della popolazione risiede in zone rurali, il 47,9% in piccole città e sobborghi. Si tratta di persone che respirano aria pulita e che possono avere una qualità complessiva di vita molto alta ma che hanno bisogno di ottenere alcuni servizi fondamentali, come la sanità appunto, per vivere i vantaggi del presente.
Lo spopolamento delle campagne, delle zone rurali, o delle isole non è una condanna, anzi oggi sarebbe possibile senza scomodare l’utopia immaginare un ripopolamento di tutte le aree abbandonate per mancanza di servizi. Tanti i giovani che, tornando a radici anche lontane, sembrano sposare la tendenza a ricerca una vita diversa dalla frenesia cittadina, usufruendo di un’altra velocità, quella della rete.
La sfida da vincere è quella del digital divide, il divario digitale, troppo spesso liquidato come un problema che riguarda i più anziani, in difficoltà nell’uso degli strumenti digitali. Se una corretta formazione, insieme a un sistema di sostegno, potrebbe rispondere con relativa facilità a questa carenza, un intervento necessario è quello di portare le reti tecnologiche di trasmissione di dati in quelle zone dove oggi sono assenti o addirittura scadenti. La grande sfida degli organismi regolatori e quindi della politica è questa, provvedere a garantire a ciascuno il diritto di partecipare con gli strumenti del presente per costruire un futuro migliore. Lincoln diceva “la cosa migliore del futuro è che arriva un giorno alla volta”. Non era la frase di chi predicava calma, ma il monito per dire che non c’è un giorno da perdere.

di Antonio Gaudioso
COME LE CONNESSIONI NELLE CITTÀ INFLUENZANO DIRETTAMENTE LA QUALITÀ DELLA VITA, RENDENDO
NECESSARIO UN APPROCCIO INTEGRATO CHE CONIUGHI SALUTE PUBBLICA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E INCLUSIONE SOCIALE PER COSTRUIRE COMUNITÀ PIÙ VIVIBILI E RESILIENTI
Nel mondo contemporaneo, la parola connessione assume molteplici declinazioni: sociale, sanitaria, tecnologica e normativa. Essa rappresenta un nodo essenziale per garantire la centralità delle persone nelle trasformazioni che stiamo vivendo e che influenza la qualità della vita delle persone e il funzionamento delle comunità. Pensiamo, ad esempio, all’importanza di questo concetto per chi vive nelle aree interne del nostro Paese. Chi sceglie di rimanere in piccoli centri, spesso meno serviti e con minori opportunità, compie un atto di resistenza che non dovrebbe essere visto come una sfida, ma come un’opzione sostenibile e consapevole. Tuttavia, senza adeguati investimenti in connessioni, il rischio è lo spopolamento, con un conseguente impoverimento sociale ed economico.
In un sistema sanitario e sociale sempre più complesso, investire sulla connessione significa creare un nuovo tessuto di relazioni sociali e potenziare infrastrutture e tecnologie che garantiscano l’accesso ai servizi essenziali senza costringere chi vive in aree meno servite ad abbandonare la propria comunità. In questo contesto, il potenziamento della banda larga e delle soluzioni digitali diventa essenziale per migliorare l’accesso ai servizi, ad esempio la telemedicina, e per rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, contribuendo così a una rete territoriale più integrata e inclusiva.
Affinché la connessione si traduca in un’integrazione reale tra servizi sanitari e sociali, è inoltre fondamentale valorizzare la collaborazione tra medici di famiglia, farmacisti e infermieri di comunità, creando una rete di assistenza territoriale capace di garantire a ogni cittadino, indipendentemente dal luogo in cui vive, l’accesso alle cure e ai servizi necessari.
In questo scenario, anche le amministrazioni pubbliche devono evolversi per supportare una società più connessa e inclusiva mettendo al centro i bisogni delle persone, sia nelle aree periferiche che nei centri urbani.
Per farlo, è necessario un cambio di prospettiva che promuova un modello di comunità più coesa e resiliente. Essere connessi, dunque, significa sostenere le comunità sociali, dare loro strumenti per affrontare le
sfide del presente e del futuro. Significa anche ridefinire la resilienza in un’epoca di cambiamenti travolgenti. L’invecchiamento della popolazione e l’evoluzione dei bisogni sanitari e sociali sono fenomeni che richiedono risposte tempestive e integrate.
Le città sono ecosistemi complessi, in cui l’interconnessione tra spazi pubblici, trasporti e servizi sanitari e sociali influisce direttamente sulla qualità della vita. Un approccio integrato, capace di coniugare salute pubblica, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, è fondamentale per costruire comunità più vivibili e resilienti. In questo contesto, il modello One Health, che unisce salute umana, ambientale e animale, rappresenta un paradigma innovativo per la gestione delle città del futuro.
La capacità di connettere politiche e risorse è infatti cruciale per affrontare le sfide del nostro tempo. Il PNRR, ad esempio, offre un’opportunità unica per ridisegnare i rapporti tra Stato e territori, promuovendo un’integrazione efficace tra politiche sociali e sanitarie. Un esempio virtuoso è rappresentato dalla legge 33 sugli anziani e non autosufficienti, che ha favorito nuove forme di collaborazione tra istituzioni locali e nazionali in una gestione sinergica dei servizi.
Il futuro passa attraverso una politica capace di rafforzare il dialogo e il lavoro comune tra le istituzioni, connettendole e interconnettendole. Solo così sarà possibile rispondere alle necessità di una società in continua trasformazione, garantendo che il punto focale resti sempre l’interesse delle comunità e delle persone. La connessione, nelle sue molteplici declinazioni, è la chiave per costruire società più eque e resilienti, capaci di affrontare sfide globali come l’invecchiamento e le migrazioni. Una comunità sana, dove le disuguaglianze non sono un problema irrisolvibile ma un obiettivo da superare, è più pronta a gestire fenomeni complessi. Non bastano leggi, servono contesti economici, sociali e culturali che permettano a tutti di stare bene.
Solo in comunità connesse e solidali si può costruire un futuro sostenibile per tutti.

di Ludovica Serra
Un Mondo di Connessione e Innovazione
La Generazione Z, composta da individui nati tra la metà degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2010, rappresenta la prima generazione ad essere cresciuta in un mondo dominato dalla tecnologia digitale. A differenza dei Millennials, che hanno vissuto il passaggio dall’analogico al digitale, i Gen Z sono nativi digitali, immersi fin dall’infanzia in un ecosistema di smartphone, social media e intelligenza artificiale (IA). Questa generazione non si limita a utilizzare la tecnologia, ma la considera un’estensione naturale della propria vita quotidiana e fa della connettività 24/7 un modo rimanere connessi con gli atri.
La connettività 24/7 si riferisce alla possibilità di essere sempre connessi a internet e ai dispositivi digitali in ogni momento della giornata, senza interruzioni. Questo fenomeno è reso possibile dalla diffusione di smartphone, tablet, computer e altri dispositivi smart, oltre alla presenza di reti Wi-Fi, dati mobili e tecnologie di cloud computing che permettono un accesso continuo alle informazioni e alle comunicazioni.
Caratteristiche della Connettività 24/7
1. Accesso costante alle informazioni – Grazie ai motori di ricerca, ai social media e alle app di notizie, è possibile ottenere qualsiasi informazione in tempo reale, senza limiti di orario o di luogo.
2. Comunicazione immediata – Applicazioni come WhatsApp, Telegram, Instagram e Messenger permettono di rimanere in contatto con chiunque nel mondo in ogni momento.
3. Lavoro e studio senza confini – Il lavoro da remoto, l’e-learning e le piattaforme di collaborazione digitale permettono di studiare e lavorare ovunque e in qualsiasi momento.
4. Automazione e notifiche personalizzate – L’IA e gli algoritmi personalizzano le esperienze digitali, suggerendo contenuti, notificando aggiornamenti e fornendo assistenza immediata.
5. Dipendenza e iperconnessione – Il lato negativo della connettività 24/7 è la difficoltà a “disconnettersi”, con effetti sulla salute mentale, sul sonno e sulle relazioni interpersonali.
Implicazioni della Connettività 24/7
• Vantaggi: maggiore accesso alle informazioni, opportunità di lavoro flessibili, socializzazione facilitata, efficienza e comodità nella gestione delle attività quotidiane.
• Svantaggi: rischio di sovraccarico di informazioni, riduzione della privacy, stress digitale, dipendenza da dispositivi e minor tempo per attività offline.
In sintesi, la connettività 24/7 ha rivoluzionato il modo in cui viviamo e lavoriamo, ma richiede un uso consapevole per evitare effetti negativi e mantenere un equilibrio tra mondo digitale e vita reale.
L’intelligenza artificiale e la connettività 24/7 stanno modellando la loro identità, il loro modo di apprendere, lavorare, comunicare e persino percepire il mondo. Ma come influiscono questi elementi sulla Gen Z? Quali sono i rischi e le opportunità che derivano da una connessione costante e da un’interazione crescente con l’IA?
La Generazione Z e la Connessione Permanente: la Cultura dell’Istantaneità e l’Accesso Illimitato alle Informazioni
Per la Gen Z, la connessione non è un’opzione, ma una necessità. Sono cresciuti in un mondo in cui le risposte a qualsiasi domanda sono a portata di clic e dove l’accesso all’informazione è immediato. Le piattaforme di social media come TikTok, Instagram e YouTube non sono solo spazi di intrattenimento, ma anche fonti di apprendimento, attivismo e socializzazione.
L’iperconnessione ha trasformato la loro capacità di elaborare le informazioni: i Gen Z preferiscono contenuti rapidi, visivi e interattivi. Il consumo di notizie e conoscenza avviene spesso attraverso video brevi e
post sintetici, piuttosto che tramite articoli lunghi o libri tradizionali. Questo cambiamento ha implicazioni profonde sul loro modo di pensare, influenzando la soglia dell’attenzione e il processo decisionale.
Il Paradosso della Connessione: Più Vicini ma Più Isolati?
L’iperconnessione ha reso i rapporti interpersonali più fluidi, abbattendo le barriere geografiche e permettendo ai giovani di costruire relazioni con persone di tutto il mondo. Tuttavia, questa continua esposizione digitale solleva anche interrogativi sulla qualità delle interazioni sociali. Il fenomeno del “phubbing” (ignorare le persone fisicamente presenti per concentrarsi sullo smartphone), la pressione sociale imposta dai social e il timore di essere esclusi (FOMO, Fear of Missing Out) sono problematiche sempre più diffuse tra i Gen Z.
Nonostante siano più connessi che mai, molti giovani della Gen Z sperimentano alti livelli di ansia sociale e solitudine. Le interazioni digitali, pur essendo comode e immediate, non sempre riescono a sostituire la profondità e l’intimità dei rapporti faccia a faccia.
L’Intelligenza Artificiale e il Ruolo della Generazione Z:l’IA come Parte Integrante della Vita Quotidiana
Per la Gen Z, l’IA non è un concetto futuristico, ma una realtà quotidiana. Gli assistenti vocali come Alexa e Siri, gli algoritmi di raccomandazione su Netflix e Spotify, e le chatbot di servizio clienti sono strumenti con cui interagiscono regolarmente. L’IA sta diventando sempre più personalizzata, adattandosi ai gusti, alle abitudini e alle preferenze individuali.
Un aspetto particolarmente interessante è il ruolo che l’IA gioca nell’educazione e nel lavoro. Strumenti come ChatGPT e Google Bard stanno rivoluzionando il modo in cui gli studenti apprendono, fornendo risposte immediate, riepiloghi intelligenti e persino generando contenuti personalizzati. Tuttavia, questo solleva interrogativi sull’autonomia del pensiero critico e sulla capacità della Gen Z di distinguere informazioni veritiere da manipolazioni algoritmiche.
Lavoro e IA: Una Generazione tra Opportunità e Incertezze
L’IA sta trasformando radicalmente il mondo del lavoro e la Gen Z sarà la prima generazione a dover convivere con questa realtà per tutta la carriera. Da un lato, l’IA offre nuove opportunità, creando professioni innovative nel campo del machine learning, della cybersecurity e dello sviluppo di algoritmi. Dall’altro, l’automazione minaccia diversi settori, mettendo in discussione la stabilità occupazionale e richiedendo un costante aggiornamento delle competenze.
Uno dei principali vantaggi della Gen Z è la loro capacità di adattamento. Essendo cresciuti in un ambiente digitale in continua evoluzione, sono più propensi a imparare nuove tecnologie e a reinventarsi professionalmente. Tuttavia, la rapidità con cui l’IA avanza impone loro una continua formazione, rendendo l’aggiornamento delle competenze una necessità costante.
I Rischi della Dipendenza Tecnologica: Algoritmi e Bolle Informative,un Rischio per il Pensiero Critico?
L’IA non è solo uno strumento neutrale: i suoi algoritmi sono progettati per massimizzare il coinvolgimento degli utenti, mostrando contenuti che rafforzano le loro convinzioni e interessi. Questo fenomeno, noto come “filter bubble”, può limitare l’esposizione a punti di vista differenti, riducendo la capacità di sviluppare un pensiero critico.
Per la Gen Z, abituata a ricevere informazioni su misura, il rischio è quello di rimanere intrappolata in una visione del mondo limitata, senza confrontarsi con opinioni contrastanti. Questo può avere un impatto negativo sulla loro capacità di comprendere la complessità dei problemi globali e di sviluppare una mentalità aperta e critica.
Dipendenza da Tecnologia e Salute Mentale
L’uso prolungato dei dispositivi digitali ha conseguenze significative sulla salute mentale della Gen Z. Studi recenti hanno evidenziato una correlazione tra l’uso eccessivo dei social media e l’aumento di ansia, depressione e disturbi del sonno. La costante esposizione a vite idealizzate sui social può generare insicurezze e bassa autostima, mentre l’iperstimolazione digitale può interferire con la capacità di concentrarsi e rilassarsi.
Alcuni giovani stanno già cercando di contrastare questi effetti, adottando pratiche di “digital detox” e impostando limiti di utilizzo delle app. Tuttavia, il problema resta complesso e richiede un’educazione digitale più consapevole, che aiuti i giovani a trovare un equilibrio tra connessione e benessere psicologico.
Il Futuro della Generazione Z tra Tecnologia e Umanità: una Generazione Consapevole e Attivista
Nonostante le sfide, la Gen Z sta dimostrando di essere una generazione consapevole e impegnata. Utilizzano la tecnologia non solo per il divertimento, ma anche per sensibilizzare su temi cruciali come il cambiamento climatico, i diritti umani e la giustizia sociale. Movimenti come Fridays for Future, #MeToo e Black Lives Matter hanno trovato nei social media uno strumento fondamentale per amplificare le loro voci.
Questa generazione ha la possibilità di utilizzare l’IA
e la connettività per costruire un futuro più equo e sostenibile. La loro capacità di navigare nel mondo digitale li rende protagonisti di un cambiamento che potrebbe ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita globale.
Per garantire che la Gen Z possa sfruttare appieno il potenziale dell’IA senza subirne gli effetti negativi, è necessario investire nell’educazione digitale. Scuole, famiglie e istituzioni devono fornire strumenti per sviluppare il pensiero critico, proteggere la privacy online e promuovere un uso equilibrato della tecnologia.
La sfida principale sarà trovare un punto d’incontro tra innovazione e umanità, tra progresso tecnologico e benessere psicologico. Solo così la Gen Z potrà costruire un futuro in cui l’intelligenza artificiale non sia una minaccia, ma un’opportunità per migliorare la società.
Un Futuro Digitale a Misura d’Uomo
La Generazione Z sta plasmando il futuro con la sua capacità di adattarsi alla tecnologia e di utilizzarla per scopi positivi. L’intelligenza artificiale e la connessione costante sono strumenti potenti che, se gestiti con consapevolezza, possono migliorare la qualità della vita e rendere il mondo un luogo più inclusivo e sostenibile.
Il vero obiettivo non è abbandonare la tecnologia, ma imparare a viverla con equilibrio, mantenendo sempre al centro l’elemento più importante: l’umanità.



Introduzione
Con la recente rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti nel novembre 2024, il “trumpismo” ha riaffermato la sua influenza sulle politiche nazionali, in particolare riguardo alla sostenibilità e allo sviluppo urbano. Il trumpismo, caratterizzato da populismo, nazionalismo economico, deregolamentazione e scetticismo verso il cambiamento climatico, si scontra con le iniziative di sostenibilità adottate da molte città americane. Questo contrasto solleva interrogativi sul futuro delle politiche ambientali e urbane negli Stati Uniti.
Trumpismo e Politiche Ambientali nella
Seconda Presidenza
Dopo l’insediamento nel gennaio 2025, il presidente Trump ha avviato una serie di misure per smantellare le politiche ambientali della precedente amministrazione Biden, con un forte impatto sulle città. Tra le principali decisioni:
• Ritiro dall’Accordo di Parigi: Il 20 gennaio 2025, Trump ha firmato l’ordine esecutivo “Putting America First In International Environmental Agreements”, ritirando nuovamente gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi.
• Revoca delle normative sulle emissioni di CO₂:

Sono stati eliminati gli standard federali per la riduzione delle emissioni automobilistiche, aumentando la dipendenza dai combustibili fossili.
• Taglio ai fondi per le energie rinnovabili: Bloccato un investimento di 5 miliardi di dollari destinato all’espansione della rete di ricarica per veicoli elettrici.
• Promozione dell’industria fossile: Trump ha aumentato le concessioni per l’estrazione di petrolio e gas in aree protette.
Queste azioni hanno impatti significativi sulle città, aumentando l’inquinamento, riducendo le opportunità di sviluppo sostenibile e ostacolando i piani per la transizione energetica.
L’Impatto delle Politiche di Trump sulle Città
Le decisioni dell’amministrazione Trump potrebbero avere gravi conseguenze per le città americane, in particolare per le metropoli che stanno cercando di combattere il cambiamento climatico e migliorare la qualità della vita urbana. Alcuni degli impatti principali includono:
• Aumento dell’inquinamento e peggioramento della qualità dell’aria: Con l’allentamento delle restrizioni sulle emissioni industriali e automobili-

stiche, molte città rischiano di subire un peggioramento della qualità dell’aria. Secondo un rapporto dell’Environmental Protection Agency (EPA), l’abbassamento degli standard sulle emissioni potrebbe portare a un aumento del 10% nelle morti premature legate all’inquinamento entro il 2030.
• Crescita della dipendenza dai combustibili fossili: Il taglio ai fondi per le rinnovabili rende più difficile per le città investire in energie pulite, rallentando la transizione energetica.
• Maggior rischio di eventi climatici estremi: L’assenza di politiche federali per la resilienza urbana aumenta la vulnerabilità delle città a uragani, ondate di calore e inondazioni. Secondo un’analisi della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’assenza di investimenti in infrastrutture resilienti potrebbe costare agli Stati Uniti oltre 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2050.
• Diminuzione della qualità della vita urbana: Il blocco degli investimenti nel trasporto pubblico e nelle energie rinnovabili rallenta la crescita economica nelle città, limitando la creazione di posti di lavoro nei settori emergenti della green economy.
Come Stanno Reagendo i Sindaci
Molte delle principali città americane si stanno organizzando per contrastare le politiche dell’amministrazione Trump, rafforzando le loro strategie di sostenibilità e intensificando la collaborazione a livello locale e internazionale. Alcuni esempi di resistenza urbana includono:
• Coalizioni di città contro il cambiamento climatico: Più di 300 città americane, tra cui New York, Chicago e Los Angeles, si sono impegnate a rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi indipendentemente dalle decisioni del governo federale. Questo è stato possibile grazie a iniziative come il Climate Mayors Network, un’alleanza di sindaci che mira a ridurre le emissioni di gas serra.
• Investimenti locali in energie rinnovabili: Stati e città progressiste come la California e New York stanno aumentando gli incentivi per il solare e l’eolico, sfidando apertamente le politiche federali.
• Opposizione legale: Alcuni governatori e sindaci
stanno preparando battaglie legali contro le nuove politiche ambientali. Ad esempio, la città di San Francisco ha annunciato un’azione legale per impedire la ripresa delle trivellazioni petrolifere lungo la costa californiana.
• Espansione dei trasporti pubblici: Diverse metropoli stanno investendo in infrastrutture di mobilità sostenibile per ridurre la dipendenza dalle automobili, nonostante i tagli ai finanziamenti federali.
• Alleanze con l’Unione Europea e altre nazioni: Alcuni sindaci, come quelli di New York e Boston, stanno stringendo accordi con città europee per lo scambio di best practices sulla transizione ecologica.
Eric Adams, sindaco di New York, ha dichiarato: “Non ci faremo intimidire dalle politiche federali. Continueremo a investire in energia pulita e a ridurre le emissioni della nostra città perché è la cosa giusta da fare per il nostro futuro e per i nostri cittadini.”
Karen Bass, sindaca di Los Angeles, ha affermato: “Se Washington non vuole agire, lo faremo noi. Non possiamo permettere che l’inquinamento e il cambiamento climatico mettano a rischio la salute e l’economia delle nostre città.”
Conclusione
La rielezione di Donald Trump ha riacceso il dibattito tra politiche federali orientate alla deregolamentazione e iniziative locali a favore della sostenibilità. Le città americane, in particolare quelle più progressiste, stanno cercando di contrastare le politiche ambientali di Trump con strategie autonome, investimenti locali e alleanze internazionali. Tuttavia, l’assenza di un supporto federale potrebbe rallentare la transizione ecologica e aumentare i rischi per la qualità della vita urbana.
Il futuro della sostenibilità urbana negli Stati Uniti dipenderà dalla capacità delle città di resistere alle pressioni politiche e di mantenere il loro impegno per un modello di sviluppo più verde e resiliente.
* “THREE BEES INNER CIRCLE”, ha sede a Washington DC, ed è formato da un gruppo chiuso di policy makers internazionali, che attraverso il dialogo socratico, animano il dibattito ed elaborano orientamenti e strategie in merito alle questioni più rilevanti per la società e la politica.


GAETANO MANFREDI NUOVO PRESIDENTE DI ANCI:
Il 20 novembre 2024, durante la 41ª Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) tenutasi al Lingotto di Torino, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato eletto all’unanimità presidente dell’ANCI. La sua elezione segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione tra i Comuni italiani e le istituzioni nazionali, con l’obiettivo di affrontare le sfide del futuro, tra cui la crisi ambientale, il dissesto idrogeologico e la gestione delle risorse economiche locali.
prime dichiarazioni di Manfredi
Nel suo discorso di insediamento, Gaetano Manfredi ha ringraziato i sindaci per la fiducia accordatagli e ha sottolineato il ruolo centrale dei Comuni nell’amministrazione del Paese:
“Ringrazio tutti voi dell’onore che mi avete dato, nel rappresentare la più grande comunità istituzionale del Paese. Noi sindaci siamo il fronte più esposto alle sfide della realtà, il primo riferimento per chi vive il malessere sociale e civile, per chi chiede risposte a istanze spesso ignorate.”
Manfredi ha poi evidenziato la necessità di una collaborazione forte tra ANCI e il Governo per affrontare temi urgenti come l’emergenza ambientale, la manutenzione del territorio e la gestione delle risorse idriche. In particolare, ha sottolineato che è indispensabile definire obiettivi chiari e condivisi, con controlli adeguati e responsabilità ben definite.
Le reazioni delle istituzioni
Sergio Mattarella: “I sindaci, una magnifica raffigurazione dell’Italia”
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia inaugurale e ha espresso il suo sostegno ai sindaci italiani: “Vi assicuro che visti da questa parte siete una magnifica raffigurazione dell’Italia intera. I sindaci rappresentano il volto più vicino dello Stato e sono in prima linea nell’affrontare i problemi quotidiani delle comunità locali. La Repubblica vi è vicina.”
Mattarella ha poi sottolineato l’importanza di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ha ribadito il ruolo chiave dei Comuni nella tutela delle diversità locali e nel rafforzamento della coesione sociale.
Giorgia Meloni: “I Comuni sono la spina d orsale del Paese”
Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Manfredi, evidenziando il ruolo strategico dei Comuni italiani:
“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto oggi all’unanimità Presidente dell’ANCI. Siamo la Nazione dei campanili, dei borghi e delle identità e il Governo considera centrale la collaborazione con i Comuni e i Sindaci, che rappresentano la prima fila dell’impegno politico e il volto più prossimo dello Stato.”
Le sfide per il futuro
Manfredi ha ribadito che una delle priorità della sua presidenza sarà il miglioramento delle condizioni finanziarie dei Comuni italiani. Ha espresso preoccupazione per alcune misure contenute nella legge di bilancio, sottolineando la necessità di evitare tagli agli investimenti per i territori.
Inoltre, ha annunciato un’agenda condivisa con il Governo che comprenderà:
• La riforma del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);
• La revisione del sistema di finanziamento dei Comuni;
• Politiche per la casa e la sanita di prossimità;
• Sicurezza urbana e sostegno ai cittadini più fragili.
Nel suo discorso di chiusura dell’Assemblea, Manfredi ha ribadito la volontà di portare avanti un dialogo costante con il Governo e le istituzioni europee per garantire maggiore autonomia e strumenti di sviluppo ai Comuni italiani.
Età: 60 anni
Nato a: Ottaviano (NA)
Formazione: Ingegnere, Professore Universitario
Ruolo attuale: Sindaco di Napoli dal 2021
Esperienza politica: Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte II
Gaetano Manfredi è una figura di spicco della politica italiana, con una solida esperienza accademica e amministrativa. Già rettore dell’Università di Napoli Federico II, ha guidato il Ministero dell’Università e della Ricerca durante la pandemia, contribuendo al potenziamento della digitalizzazione e alla riforma del sistema universitario. Dal 2021 è sindaco di Napoli e ha avviato un processo di risanamento economico della città. Con la sua elezione a presidente di ANCI, si appresta a rappresentare le esigenze di oltre 8.000 Comuni italiani nel confronto con il Governo e le istituzioni europee.

Gaetano Manfredi

di Federico Serra
Introduzione
In un momento storico in cui le città si trovano al centro delle grandi trasformazioni sociali, economiche e ambientali, il ruolo dei Comuni italiani diventa cruciale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più equo e vivibile. La qualità della vita urbana, la salute di prossimità, la rigenerazione culturale, la promozione dell’attività sportiva e la transizione ecologica sono temi che richiedono un approccio integrato e una governance multilivello.
L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) si pone come interlocutore strategico tra le istituzioni centrali e i territori, accompagnando le amministrazioni locali nell’elaborazione e nell’attuazione di politiche pubbliche innovative e inclusive. Ne abbiamo parlato con il presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ed ex Ministro dell’Università e della Ricerca, per comprendere meglio le priorità dell’Associazione su alcuni temi chiave come Benessere e Qualità di vita, Salute e Servizi Sanitari Locali, Cultura e Innovazione Urbana, Sport e Spazi Pubblici, Ambiente e Transizione Ecologica
Benessere e Qualità della Vita
L’ANCI ha un ruolo centrale nel supportare i Comuni nella promozione del benessere urbano. Quali sono le strategie prioritarie che l’ANCI intende promuovere per migliorare la qualità della vita nelle città italiane, in particolare nelle aree più densamente popolate?
Il benessere urbano è una sfida complessa che richiede visione integrata e strategie che tengano conto di diversi aspetti fondamentali della vita dei cittadini, dalle politiche abitative ai servizi di prossimità, in particolare socio-sanitari, e alla mobilità. Esigenze e priorità che cambiano a seconda del contesto urbano (città metropolitane, città capoluogo o piccoli comuni). Nelle grandi aree urbane, l’accesso a un’abitazione dignitosa a costi sostenibili è un’emergenza che colpisce anche il ceto medio. Serve una politica abitativa incisiva con maggiori investimenti e strumenti coordinati, riprendendo esperienze positive come Piani per l’Abitare e housing sociale, e regolamentando gli affitti brevi. Prioritarie anche sostenibilità ambientale, mobilità urbana, sicurezza urbana integrata per le quali occorre un’efficace collaborazione istituzionale. Infine, prioritario intervenire sul contrasto al disagio e alla violenza giovanile con politiche culturali, educative e sportive per rafforzare il senso di comunità e offrire alternative positive.
Salute e Servizi Sanitari Locali
La pandemia ha evidenziato la necessità di rafforzare la sanità territoriale e i servizi di prossimità. Quali iniziative sta portando avanti l’ANCI per migliorare l’accesso ai servizi sanitari locali, soprattutto nelle periferie e nei piccoli centri?
La promozione della salute locale richiede un approccio integrato e multidimensionale, analizzando bisogni e determinanti di salute. La pandemia ha evidenziato l’interconnessione tra ambiente, trasporti, urbanistica e welfare, e la necessità di saper affrontare le emergenze. L’integrazione tra sociale e sanitario è cruciale per un welfare locale efficace, superando divari territoriali e integrando LEA e prestazioni sociali. Il PNRR offre opportunità per rafforzare la sanità territoriale (case di comunità, telemedicina), anche grazie all’interoperabilità dei dati. Utile per questo l’Osservatorio Agenas-Federsanità-ANCI che raccoglie buone pratiche sociosanitarie locali, con l’obiettivo di realizzare un Osservatorio nazionale per la condivisione e il supporto decisionale, migliorando i servizi per la salute e il benessere dei cittadini.
Cultura e Innovazione Urbana
La cultura è un motore di sviluppo e coesione sociale nelle città. Quali misure l’ANCI sta promuovendo per sostenere il settore culturale nei Comuni, favorendo l’inclusione e la partecipazione dei cittadini?
Cultura e riqualificazione urbana sono leve fondamentali per il futuro dei territori, con la rigenerazione culturale che rivitalizza il patrimonio, specialmente nei borghi e nelle aree interne, arginando spopolamento e desertificazione, ricreando il tessuto sociale e colmando il divario con le città. In questo quadro, il turismo diventa strategico per l’economia locale, ma deve essere intelligente e sostenibile, con un ruolo centrale dei Comuni per un’offerta autentica, anche basata sul turismo di prossimità. Serve un impegno strutturale con risorse dedicate per contrastare la marginalità e creare sviluppo. Il PNRR - Piano Borghi è un primo passo, ma occorre accompagnare i Comuni e prevedere una strategia turistica ampia con maggiori risorse. Positiva l’”Agenda Controesodo” messa in campo, così come la Strategia nazionale per le aree interne, per uno sviluppo integrato basato su economia sostenibile, incentivi al ripopolamento, valorizzazione ambientale e miglioramento dei servizi, da rendere politica strutturale affinché il processo di crescita sia duraturo e inclusivo.
Sport e Spazi Pubblici
L’attività sportiva è fondamentale per il benessere della popolazione, ma molte città soffrono la carenza di impianti sportivi accessibili. Quali politiche l’ANCI sta sviluppando per migliorare l’accessibilità e la qualità delle infrastrutture sportive nei Comuni italiani?
L’ANCI si impegna a fondo per lo sport nei Comuni, riconoscendone il valore per la salute e la coesione sociale, specialmente nelle aree più fragili. In sinergia con Governo, Sport e Salute, CONI e ICS, le azioni messe in campo mirano a potenziare le infrastrutture sportive. Il PNRR offre un’occasione cruciale con 700 milioni per riqualificare gli impianti in chiave inclusiva, supportando i Comuni con bandi mirati per nuove costruzioni e rigenerazioni. Diverse iniziative concrete promuovono l’accessibilità: “BICI IN COMUNE” per la mobilità ciclistica, “Sport nei Parchi” con palestre all’aperto gratuite. Il bando “Sport e Periferie”, seguito con il Dipartimento per lo Sport, ha già finanziato oltre 1300 progetti dal 2014 per colmare il divario infrastrutturale e usare lo sport come strumento di inclusione e sicurezza. La partnership con l’ICSC tramite “Sport Missione Comune” offre inoltre mutui agevolati per l’impiantistica di base, con oltre 3000 cantieri aperti dal 2014. Queste collaborazioni, insieme a quelle con CONI, Leghe, Federazioni (come FIDAL con “Bandiera Azzurra”), PANATHLON, AIA e FEDERGOLF, sono vitali per una promozione sportiva a 360 gradi, condividendo competenze e lanciando iniziative specifiche. La stessa partecipazione alla candidatura per UEFA EURO 2032, con FIGC e Comuni, riflette la nostra visione di uno sport come volano per lo sviluppo e l’immagine nazionale.
Ambiente e Transizione Ecologica
Le città devono affrontare sfide importanti legate all’inquinamento, alla mobilità sostenibile e alla resilienza climatica. Quali sono le priorità dell’ANCI per supportare i Comuni nella transizione ecologica e nella promozione di città più sostenibili e vivibili?
ANCI e Comuni sono costantemente impegnati su vivibilità, resilienza ed economia circolare contro il cambiamento climatico, attraverso iniziative in rete. Per la qualità dell’ambiente, siamo concentrati su concetti chiave come la vivibilità, la resilienza delle nostre città e la promozione dell’economia circolare. Lo abbiamo dimostrato anche con l’attuazione di quanto previsto in PNRR e Politica di Coesione 2021-2027 che vedono i Comuni protagonisti della transizione ecologica. L’impegno comunale si allinea ad agende internazionali (ONU 2030), europee (Agenda Urbana) e nazionali (Carta di Bologna). Azioni che perseguiamo attraverso la collaborazione con realtà come ISPRA e ASviS, tramite il coordinamento sulla mobilità sostenibile (come nel caso dei Piani Urbani per la Mobilità sostenibile e il trasporto pubblico locale), attraverso specifiche azioni finalizzate all’economia circolare (grazie all’accordo ANCI-CONAI), alla gestione del verde e transizione energetica, sottolineando il ruolo chiave dei Comuni nello sviluppo sostenibile italiano.

di Federico Serra
Segretario generale Planetary Health Inner Circle
Fulco Pratesi è stato molto più di un ambientalista: è stato un visionario, capace di vedere con decenni di anticipo l’interconnessione tra la salute umana e quella degli ecosistemi. Nato a Roma nel 1934, la sua vita è stata segnata da una trasformazione radicale che lo ha portato da cacciatore a difensore della natura, ispirando intere generazioni di ambientalisti.
Il momento che cambiò tutto avvenne in una foresta dell’Anatolia, in Turchia, dove si trovava per una battuta di caccia all’orso. Fu lì che si rese conto della sacralità della vita animale e dell’assurdità della distruzione della natura per mano dell’uomo:
«Tanti anni fa io ero un cacciatore. Un giorno, mentre mi trovavo a caccia di orsi nei boschi della Turchia, ho assistito ad una scena che mi ha cambiato la vita: un’orsa con i suoi tre cuccioli, a pochi metri da me. In una manciata di secondi ho capito che stavo facendo una follia. Sono tornato in Italia, ho venduto i fucili e, con un gruppo di amici appassionati di natura, ho fondato il WWF. In me era nato un sogno: proteggere gli animali, gli ambienti, fare qualcosa per costruire un mondo di armonia tra uomo e natura...»
Da quel momento in poi, Pratesi ha dedicato tutta la sua vita alla tutela della biodiversità, fondando nel 1966 il WWF Italia e contribuendo alla creazione di oltre 100 oasi naturalistiche nel nostro Paese. Il suo impegno è andato oltre la semplice protezione della fauna: ha combattuto contro l’inquinamento, la caccia indiscriminata e la distruzione degli habitat, portando avanti un’idea di equilibrio tra uomo e natura che oggi chiamiamo Planetary Health.
Il suo pensiero anticipava quello che oggi è diventato un principio cardine della scienza ambientale: la salute del pianeta è la salute dell’uomo. Proteggere la biodiversità non è solo una questione di etica o conservazione, ma un’esigenza vitale per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Il concetto di One Health, che collega la salute umana, animale e degli ecosistemi, trova in Pratesi un precursore illuminato.
La sua eredità non si spegne con la sua scomparsa: continua a vivere nelle battaglie per la protezione del nostro patrimonio naturale e nella crescente consapevolezza che la tutela dell’ambiente non è un lusso, ma una necessità per il benessere dell’intera umanità.

“INGEGNERIA REPUTAZIONALE.
COMPRENDERE, MISURARE E COSTRUIRE LA REPUTAZIONE”
Andrea Barchiesi
Editore: Franco Angeli
“Ingegneria Reputazionale. Comprendere, misurare e costruire la Reputazione” è un’opera di Andrea Barchiesi, edita da Franco Angeli nel 2024. Il libro introduce una metodologia innovativa per progettare, gestire, proteggere e ottimizzare l’identità digitale e la reputazione sul web di brand, aziende, professionisti e personaggi pubblici. Barchiesi propone un approccio scientifico alla reputazione, trasformandola da concetto astratto a elemento misurabile e plasmabile attraverso strumenti analitici.
I lettori hanno apprezzato la profondità e l’originalità con cui l’autore affronta il tema, evidenziando la chiarezza espositiva e l’utilizzo di esempi concreti che facilitano la comprensione di concetti complessi. La narrazione è descritta come coinvolgente, arricchita da spunti di ironia e illustrazioni che rendono la lettura piacevole. Molti considerano il libro un riferimento fondamentale per professionisti della comunicazione, del marketing e per chiunque sia interessato a comprendere le dinamiche della reputazione nell’era digitale.
In sintesi, “Ingegneria Reputazionale” offre una prospettiva unica su come costruire, mantenere e proteggere l’immagine e la reputazione di individui e aziende,
di Francesca Policastro

fornendo strumenti pratici e riflessioni teoriche per navigare nelle complesse dinamiche della percezione pubblica
Note biografiche
Andrea Barchiesi, ingegnere elettronico, è riconosciuto come maggior esperto in Italia e pioniere in tema di analisi e gestione della reputazione online. Fonda nel 2004 Reputation Manager, società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico, che ha definito e declinato i fondamenti dell’Ingegneria Reputazionale®, metodologia e marchio registrato di Reputation Manager. L’Ingegneria Reputazionale® è una rigorosa metodologia per progettare, gestire, proteggere e ottimizzare l’identità digitale e la reputazione sul web di brand, aziende, professionisti, personaggi pubblici, basata sulla stretta sinergia tra strumenti di analisi e intervento, che coniugano competenze tecnologiche, di marketing, di comunicazione e legali a supporto della completa gestione del ciclo reputazionale.
Pioniere nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni in ambito web intelligence e data analysis, negli ultimi 20 anni ha guidato primari progetti digitali di monitoraggio e consulenza sulla reputazione online per aziende, istituzioni, top manager e figure apicali di società leader nel mercato italiano.
Vincitore del Premio Nazionale dell’Innovazione 2011 conferito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e del Premio Adriano Olivetti nel 2018.
Nel 2023 fonda Artificial Minds, società di servizi di intelligenza artificiale per aiutare le aziende a crescere usando in modo sicuro e etico l’AI.

TIMELESS TALE.
RICORDI DI DOMANI
Giuseppe Sant’Elia, Alessandro Verre
Editore: Gagio Edizioni
Timeless Tale: Ricordi di Domani è la graphic novel scritta da Giuseppe Sant’Elia e Alessandro Verre, illustrata da Marco Monelli e introdotta da una prefazione di Claudio Chiaverotti.
Marco e Paolo vivono in epoche diverse, ma nel giorno di Natale un carillon misterioso li connette, creando un ponte tra i loro mondi. Scoprono di abitare nello stesso luogo, ma in un tempo in cui il clima ha trasformato radicalmente ogni cosa. Molto è andato perduto, anche ciò che sembrava scontato.
La graphic novel fonde un’atmosfera magica con una realtà tangibile e attuale. Senza retorica né toni didascalici, il libro mostra come il tempo per intervenire sia ormai limitato. L’ambiente non è un concetto astratto, ma il contesto stesso in cui la nostra esistenza si svolge: ogni scelta lascia un segno.
Con uno stile evocativo e un’impronta visiva cinematografica, definita cine-fumetto o cine-romanzo, Timeless Tale: Ricordi di Domani è una storia sospesa tra sogno e realtà, capace di unire emozione e riflessione. Un’opera che arricchisce il panorama italiano delle graphic novel con una narrazione intensa, destinata a lasciare il segno.
Note biografiche
Giuseppe Sant’Elia è scrittore, giornalista e critico cinematografico. È anche avvocato specializzato in diritto del lavoro. Timeless Tale: Ricordi di Domani segna il suo esordio come autore di graphic novel.
Alessandro Verre è autore e sceneggiatore. È anche avvocato specializzato in diritto del lavoro. Timeless Tale: Ricordi di Domani segna il suo esordio come autore di graphic novel.
Marco Monelli è illustratore e fumettista. Ha realizzato il comparto grafico di Timeless Tale: Ricordi di
Domani, conferendo all’opera uno stile visivo unico e fortemente evocativo.
Claudio Chiaverotti, autore della prefazione, è uno degli sceneggiatori più noti del fumetto italiano. Ha lavorato per anni su Dylan Dog e ha creato le serie Brendon e Morgan Lost per Sergio Bonelli Editore.

BUTTA VIA I FAZZOLETTI
Sabrina De Federicis
Editore: Libri d’impresa
“Butta via i fazzoletti: Scegli di curare l’allergia, non di addormentarne i sintomi” è un libro che si propone di fornire una guida pratica per riconoscere, comprendere e affrontare le allergie, offrendo soluzioni che mirano a curare la causa piuttosto che limitarsi a sopprimerne i sintomi.
Il libro è strutturato in modo semplice e chiaro, rendendolo accessibile a tutti coloro che desiderano approfondire il tema delle allergie. Tra gli argomenti trattati, l’autrice spiega come identificare i sintomi allergici, l’importanza di una diagnosi specialistica e il ruolo fondamentale della terapia desensibilizzante. Quest’ultima è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come l’unica terapia che agisce sulle cause dell’allergia, offrendo una soluzione a lungo termine.
Sabrina De Federicis condivide anche storie di persone che hanno superato le loro allergie grazie a percorsi terapeutici mirati, offrendo testimonianze incoraggianti per chi è alla ricerca di una soluzione definitiva. L’autrice stessa ha vissuto l’esperienza di cercare una cura efficace per l’allergia di suo figlio, il che aggiunge un tocco personale e autentico al suo racconto.
In sintesi, “Butta via i fazzoletti” è una lettura consigliata per chi desidera comprendere meglio le allergie e scoprire approcci terapeutici che vanno oltre la semplice gestione dei sintomi, puntando a una cura definitiva.
Note biografiche
Sabrina De Federicis è una professionista italiana, divulgatrice, con una formazione scientifica. Ha conse-
guito la laurea in Paleontologia presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore farmaceutico,. Attualmente, ricopre la posizione di Country Manager presso HAL Allergy, un’azienda farmaceutica specializzata nel trattamento delle allergie.
Sabrina De Federicis è anche attiva sui social media, dove condivide aggiornamenti sulla sua attività professionale e personale.

HEALTH CARE MARKETING
Strategie e modelli di marketing comportamentale per la salute
Lucio Corsaro
Editore: Egea
Nell’ambito della salute urbana, l’accesso equo alle cure e la qualità dei servizi sanitari rappresentano sfide fondamentali per le amministrazioni locali e le istituzioni sanitarie e la crescente centralità dell’uso dei dati per migliorare l’efficacia degli interventi rendono essenziale l’adozione di strategie di marketing innovative. In questo contesto, il volume Healthcare Marketing. Strategie e modelli di marketing comportamentale per la salute di recente pubblicazione con la casa Editrice Egea e a cura di Lucio Corsaro, si inserisce in un quadro di crescente rilevanza del tema per il sistema sanitario contemporaneo, dove la gestione strategica della comunicazione e della relazione con tutti gli attori del mondo della salute – e il marketing è fondamentalmente comunicazione e relazione – assume un ruolo centrale nel determinare l’efficacia del servizio e la sua sostenibilità nel lungo periodo. L’obiettivo ultimo del manuale è quello di fornire a operatori sanitari, amministratori e policy maker degli strumenti formativi e di analisi, nonché delle best practice operative per costruire un nuovo approccio alla salute fondato su una visione scientifica e multidisciplinare capace di rispondere alla complessità del contesto contemporaneo e alle sfide derivanti dai comportamenti individuali e collettivi.
In un’epoca in cui la personalizzazione delle cure e la digitalizzazione stanno trasformando rapidamente la
sanità, c’è, infatti, bisogno di aggiornare gli strumenti concettuali e pratici con cui si interpreta il mondo per affrontare le nuove sfide del settore e per utilizzare al meglio l’innovazione, anche digitale, a partire da un uso intelligente delle informazioni sanitarie. Uno degli aspetti più innovativi del testo, che si propone come un manuale completo di teorie, strategie e strumenti per l’applicazione del marketing sanitario, riguarda l’attenzione alle scienze comportamentali, ambito di studi che a livello internazionale sta emergendo in maniera sempre più congiunta rispetto a quello della Salute. Questo approccio pone una nuova attenzione sugli aspetti multifattoriali implicati nelle scelte di cura messe in campo da ogni soggetto facente parte del sistema salute – dai pazienti ai medici, fino alle istituzioni – e permette così di arrivare al cuore delle esigenze profonde, delle motivazioni sottostanti e dei fattori ultimi determinanti i comportamenti di cura, aprendo la strada a strategie di intervento più consapevoli, appropriate e orientate al miglioramento complessivo del sistema.
Adottare questo approccio in termini operativi, significa aprirsi alla possibilità di inserire figure specializzate in marketing comportamentale all’interno delle istituzioni e delle amministrazioni sanitarie regionali e locali. Questo modello di Behavioral Public Administration (BPA), già avviato in vari contesti internazionali, ma anche con l’esperienza a livello italiano del Team di Analisi Comportamentale (TAC) presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, apporta uno slancio innovativo nello sviluppo di strategie sanitarie ed è stato accolto recentemente anche a livello regionale, con l’esempio significativo della Nudge Unit Toscana Salute (NUTS). Queste esperienze hanno utilizzato e utilizzano al momento metodologie tratte da studi comportamentali per migliorare gli esiti sociosanitari in ambiti determinanti come le vaccinazioni, la donazione organi, la correzione degli stili di vita, l’igiene e le cure palliative. L’efficacia che hanno dimostrato negli anni questi approcci con la promozione di comportamenti virtuosi di salute e prevenzione e il miglioramento di parametri quali l’alfabetizzazione sanitaria e l’aderenza terapeutica, dimostra come un’analisi approfondita dei comportamenti possa tradursi in politiche sanitarie più aderenti alle reali necessità della popolazione. Ed è proprio in questa direzione che il libro punta, mostrando, capitolo dopo capitolo, come strumenti di analisi avanzata, modelli comportamentali e innovazioni digitali possano essere utilizzati al meglio per progettare interventi orientati a migliorare il benessere della collettività e del sistema sanitario.
Il volume dedica ampio spazio alla centralità dei dati, nei confronti dei quali urge una ristrutturazione d’approccio, evidenziando come l’adozione di un pensiero sistemico e l’uso congiunto di big e small
33
data permettano di superare la dicotomia tradizionale tra analisi di larga scala e di dettaglio, rendendo possibile un approccio d’ampio raggio, ma calato al singolo contesto. Un approfondimento viene dedicato anche all’analisi di tutti i determinanti che incidono fortemente sulle decisioni sanitarie degli individui; in questo contesto anche l’analisi dei sistemi di pensiero, dell’approccio emotivo e di quello bayesiano alla logica decisionale offrono spunti utili per interpretare le scelte di salute e ridurre l’impatto dei bias cognitivi nel rapporto di cura.
Una parte del volume è dedicata poi alle nuove prospettive aperte dall’uso dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi e dei modelli predittivi che offrono strumenti avanzati per anticipare i bisogni sanitari e migliorare gli interventi anche in ottica di prevenzione. A completamento di queste sezioni vengono infine affrontate alcune applicazioni pratiche del marketing comportamentale nel settore farmaceutico in grado di dare al lettore un’idea delle potenzialità di tali strumenti e concetti applicati, delineando ad esempio il processo di costruzione di personas e profili comportamentali o l’uso del funnel journey e del Multichannel Monitoring per identificare e prevedere i canali di intervento.
L’auspicio con cui è stato pubblicato questo libro è dunque di assistere nel prossimo futuro all’inserimento sistematico in sanità di tali strumenti, nonché sempre più di specialisti in marketing sanitario che dettino un cambio di passo verso politiche più efficaci, una gestione più efficiente delle risorse e, di ritorno, una maggiore soddisfazione e fiducia della popolazione nei servizi sanitari.
Note biografiche
Lucio Corsaro inizia la carriera nel 1999, dopo la Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Tor Vergata nel 1999 ed un Master in ”Fundamentals of Managerial Finance for non-financial Managers”. Il Market Access e lo studio delle scienze comportamentali sono i sui più grandi interessi e, nel tempo, ha avuto la determinazione affinché diventassero il fulcro del suo lavoro.
Lungo il suo percorso professionale, infatti, ha sviluppato con successo diversi metodi di ricerca qualitativa, modelli di approccio previsionale ed altrettanti modelli di business. Dopo anni di esperienza in Aziende Farmaceutiche quali Angelini e Daiichi-Sakyo, è diventato Vicepresidente aggiunto di Health Web Observatory, in qualità di esperto di marketing farmaceutico e Market Access per lo sviluppo del mercato di assistenza sanitaria in Europa e docente e vice direttore del Master in Marketing e Market Access dell’Università La Sapienza di Roma.
Negli ultimi 11 anni ha rivestito il ruolo di General Manager in MediPragma, dove ho avuto la possibilità di implementare le mie competenze in merito allo sviluppo di modelli di approccio previsionale, modelli di business e di ricerca qualitativa.
Dal 2020 è Fondatore e Consigliere Delegato di BHAVE, una startup che studia ed analizza i comportamenti decisionali delle persone nell’ambito sanitario per comprenderne le motivazioni, supportando i propri clienti nel trovare soluzioni, attraverso l’osservazione ed analisi predittiva dei comportamenti delle persone, dei medici e stakeholder nell’ambito della salute, sfruttando l’Intelligenza Artificiale (IA) e il Machine Learning (ML) per integrare ed elaborare big e small data.
In BHAVE si occupa principalmente del patient access, ovvero quella componente della nostra strategia che racchiude i servizi basati sulla conoscenza della relazione con il cliente e il miglioramento delle performance della Forza Operativa aziendale. Tramite strumenti e metodiche avanzate e soprattutto efficaci, crea e misura, unitamente al suo team, modelli e progettualità di comportamento delle persone in base ai quali determinare le strategie sia “Business-to-Business” che “Business-to-Consumer”, in ottica sales, public affairs, patient advocacy e market access.

di Ludovica Serra
Oslo, capitale della Norvegia, è da tempo un esempio di innovazione urbana sostenibile. Tra i progetti più emblematici di questa trasformazione spicca il quartiere di Vulkan, un’ex area industriale lungo il fiume Akerselva, oggi riqualificata in un hub ecologico e culturale. Il progetto rappresenta un perfetto equilibrio tra sviluppo urbano, sostenibilità e vivibilità, ponendosi come modello per le città del futuro.
Dalla Fabbrica al Quartiere Verde
Un tempo cuore dell’industria manifatturiera, Vulkan era un’area degradata e poco sfruttata fino all’inizio degli anni 2000, quando lo studio di architettura LPO Arkitekter ha dato il via a un ambizioso progetto di rigenerazione. L’obiettivo era trasformare questa zona in un ecosistema urbano a basso impatto ambientale, con edifici a consumo energetico ridotto, spazi pubblici inclusivi e un’integrazione armoniosa tra natura e infrastrutture.
Un Sistema Energetico Avanzato
Uno degli aspetti più innovativi di Vulkan è il suo sistema energetico. Il quartiere utilizza pozzi geotermici profondi 300 metri per riscaldare e raffreddare gli edifici, riducendo così la dipendenza da fonti fossili. Inoltre, sono stati installati pannelli solari e sistemi di recupero del calore, ottimizzando il consumo energetico. Queste tecnologie permettono a Vulkan di autoprodurre il 70% dell’energia necessaria, rendendolo un quartiere a bassissime emissioni di CO2.
Architettura Sostenibile e Verde Urbano
Gli edifici di Vulkan sono stati progettati con materiali ecologici e tecnologie per il risparmio energetico. Molti di essi sono dotati di tetti verdi, che oltre a migliorare l’isolamento termico, assorbono le piogge riducendo il rischio di allagamenti. Il quartiere è inoltre caratterizzato da una grande presenza di spazi verdi, che migliorano la qualità dell’aria e incentivano la biodiversità urbana.
Mathallen: La Cittadella del Cibo Sostenibile
Uno dei punti focali di Vulkan è Mathallen, una food hall che ospita numerosi produttori e ristoratori locali. Qui vengono promossi prodotti a km zero, biologici e di alta qualità, incentivando un’economia circolare e sostenibile. Il mercato è diventato un punto di riferimento per la cultura gastronomica norvegese, dimostrando come il cibo possa essere un motore di sviluppo ecologico e sociale.
Mobilità Green e Accessibilità
Vulkan promuove uno stile di vita sostenibile anche attraverso la mobilità urbana. Il quartiere è progettato per favorire i pedoni e i ciclisti, con ampie piste ciclabili e zone a traffico limitato. Sono disponibili numerosi parcheggi per biciclette e punti di ricarica per veicoli elettrici, incentivando una mobilità a basso impatto ambientale.
Uno Spazio per la Cultura e la Comunità
Oltre agli aspetti ambientali, Vulkan è un centro di aggregazione culturale e sociale. La zona ospita teatri, gallerie d’arte, spazi per eventi e coworking, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e dinamica. Il quartiere è spesso sede di festival, mercati e iniziative culturali, coinvolgendo cittadini e turisti in un’esperienza di cittadinanza attiva.
Un Modello per le Città del Futuro
Il successo di Vulkan dimostra che è possibile rigenerare aree urbane in modo sostenibile, combinando innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e valorizzazione della comunità locale. Questo progetto rappresenta un modello replicabile in altre città, ispirando nuove soluzioni per rendere gli spazi urbani più vivibili, inclusivi ed ecologici.
Con il suo mix di efficienza energetica, mobilità sostenibile e vitalità culturale, Vulkan incarna una visione moderna di sviluppo urbano, dimostrando che la sostenibilità non è solo una necessità, ma un’opportunità per costruire comunità più resilienti e connesse.
Nordhavn, Copenaghen e la città dei 5 minuti
Nordhavn, un distretto innovativo di Copenaghen, rappresenta una delle più ambiziose trasformazioni urbane in Europa. Situata lungo la costa settentrionale della città, Nordhavn è un esempio lampante di urbanistica sostenibile e visione futuristica. Questo quartiere, in fase di sviluppo dal 2009, è progettato per essere un modello globale di città intelligente, sostenibile e vivibile, incarnando il concetto della “città dei 5 minuti”.
Il concetto della città dei 5 minuti
La “città dei 5 minuti” è un approccio urbanistico che punta a creare comunità dove tutti i servizi essenziali – come scuole, negozi, parchi e trasporti pubblici –siano raggiungibili a piedi o in bicicletta in un tempo massimo di cinque minuti. Questo modello riduce la dipendenza dall’automobile, migliorando la qualità della vita, abbattendo le emissioni di carbonio e promuovendo uno stile di vita sano e inclusivo.
Nordhavn ha integrato questo concetto nel suo piano urbanistico, combinando spazi residenziali, commerciali e ricreativi con infrastrutture all’avanguardia. Le strade del quartiere sono progettate per essere accoglienti per pedoni e ciclisti, mentre il sistema di trasporti pubblici garantisce collegamenti rapidi con il centro città e altre aree di Copenaghen.
Sostenibilità al centro
Uno degli aspetti più impressionanti di Nordhavn è il suo impegno verso la sostenibilità. Il quartiere punta a essere carbon neutral e utilizza tecnologie avanzate per la gestione dell’energia e delle risorse. Ad esempio:
Energia rinnovabile: Nordhavn sfrutta energia solare ed eolica, oltre a sistemi di riscaldamento centralizzato efficienti.
Mobilità verde: Le piste ciclabili sono ovunque, e molte strade sono chiuse al traffico automobilistico. Inoltre, la presenza di veicoli elettrici e punti di ricarica è altamente incentivata.
Architettura sostenibile: Gli edifici sono costruiti con materiali ecologici e progettati per massimizzare l’efficienza energetica.
Vita comunitaria e spazi pubblici
Nordhavn è un quartiere che incoraggia la socializzazione e il senso di comunità. I suoi spazi pubblici –come piazze, parchi e lungomare – sono stati progettati per favorire incontri e attività all’aperto. Il porto, ad esempio, è stato trasformato in un’area ricreativa con piscine naturali e spazi per lo sport.
Inoltre, il quartiere ospita una varietà di negozi, caffè e ristoranti, rendendo facile per i residenti accedere a
tutto ciò di cui hanno bisogno senza dover percorrere lunghe distanze.
Un modello per il futuro
Nordhavn non è solo un progetto ambizioso per Copenaghen, ma una fonte di ispirazione per città di tutto il mondo. Dimostra che è possibile creare comunità moderne e sostenibili, bilanciando innovazione, rispetto per l’ambiente e benessere dei cittadini. Attraverso il concetto della “città dei 5 minuti”, Nordhavn offre un modello tangibile per affrontare le sfide urbane del XXI secolo.
In un mondo sempre più urbanizzato, Nordhavn è una prova concreta che la sostenibilità e la qualità della vita possono andare di pari passo. Una visita a questo quartiere innovativo non è solo un viaggio nel futuro dell’urbanistica, ma anche un promemoria di ciò che è possibile raggiungere con una visione chiara e un impegno deciso verso il cambiamento positivo.
Delhi e l’inquinamento: una crisi ambientale senza fine
Introduzione
Delhi, la capitale dell’India, è una delle città più inquinate al mondo. Ogni anno, soprattutto nei mesi invernali, la città si trasforma in una camera a gas a causa dell’inquinamento atmosferico estremo. La qualità dell’aria peggiora drasticamente, mettendo a rischio la salute di milioni di persone. Questo articolo analizza le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni alla crisi dell’inquinamento a Delhi.
Le principali cause dell’inquinamento a Delhi
L’inquinamento atmosferico a Delhi è il risultato di molteplici fattori, tra cui:
1. Emissioni industriali e veicolari
La rapida crescita economica ha portato a un aumento esponenziale del numero di veicoli su strada e delle industrie che operano nei dintorni della città. Le emissioni di gas tossici come il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e il particolato fine (PM2.5 e PM10) sono tra le principali cause della scarsa qualità dell’aria.
2. Bruciatura delle stoppie agricole
Ogni anno, tra ottobre e novembre, gli agricoltori degli stati vicini come Punjab e Haryana bruciano le stoppie dei raccolti per preparare i campi alla prossima semina. Questo fenomeno, noto come “stubble burning”, rilascia enormi quantità di fumo nell’atmosfera, che si accumula sopra Delhi e peggiora l’inquinamento.
3. Polveri da costruzione e rifiuti urbani
I cantieri edili e lo smaltimento inefficiente dei rifiuti contribuiscono alla dispersione di polveri sottili nell’aria, peggiorando ulteriormente la qualità dell’aria.
4. Condizioni meteorologiche sfavorevoli
Durante l’inverno, i venti più deboli e l’inversione termica intrappolano gli inquinanti vicino alla superficie terrestre, impedendone la dispersione. Questo porta a una concentrazione elevata di particolato nell’aria.
Le conseguenze sulla salute e sull’ambiente
L’inquinamento atmosferico a Delhi ha effetti devastanti sulla salute pubblica.
• Problemi respiratori: Bronchiti croniche, asma e altre malattie polmonari sono sempre più comuni tra i residenti.
• Malattie cardiovascolari: L’esposizione prolungata all’inquinamento aumenta il rischio di infarti e ictus.
• Riduzione della speranza di vita: Studi dimostrano che vivere a Delhi può ridurre l’aspettativa di vita di alcuni anni a causa dell’aria tossica.
• Effetti sull’ambiente: L’inquinamento danneggia anche la biodiversità, compromettendo la crescita delle piante e contaminando le risorse idriche.
Possibili soluzioni
Le autorità hanno adottato diverse misure per contrastare il problema, ma con risultati contrastanti:
• Limitazioni al traffico: Il sistema di circolazione a targhe alterne è stato sperimentato per ridurre le emissioni veicolari.
• Chiusura temporanea delle industrie e dei cantieri: Durante i periodi di forte inquinamento, alcune attività industriali e di costruzione vengono sospese.
• Adozione di energie rinnovabili: L’incremento dell’uso di energie pulite potrebbe ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.
• Tecnologie anti-smog: L’uso di torri anti-inquinamento e dispositivi di purificazione dell’aria è stato introdotto in alcune aree della città.
• Politiche di riduzione della combustione agricola: Incentivi e alternative sostenibili per gli agricoltori potrebbero ridurre l’impatto della bruciatura delle stoppie.
Conclusione
Delhi si trova di fronte a una crisi ambientale che richiede azioni immediate e durature. È necessario un impegno congiunto tra governo, cittadini e aziende per
ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Solo attraverso strategie sostenibili e politiche efficaci sarà possibile garantire un futuro più sano per la capitale indiana e i suoi abitanti.
The Line: La Città del Futuro Senza Inquinamento e Auto
L’Arabia Saudita sta realizzando un progetto ambizioso e rivoluzionario che potrebbe ridefinire il concetto stesso di urbanistica: The Line. Si tratta di una città lineare lunga 170 km, alta 500 metri e larga soltanto 200 metri, progettata per ospitare 9 milioni di persone senza strade, automobili e inquinamento. Alimentata al 100% da energia rinnovabile, The Line rappresenta un modello di sviluppo sostenibile senza precedenti. Questo progetto fa parte dell’iniziativa NEOM, un piano di sviluppo futuristico sostenuto da investimenti che superano i 500 miliardi di dollari.
Una Metropoli Verticale e Sostenibile
A differenza delle città tradizionali che si espandono orizzontalmente, The Line cresce in altezza, formando un tunnel urbano tra due strutture gigantesche ricoperte di specchi che riflettono il paesaggio circostante, integrandosi armoniosamente con l’ambiente. Questo design innovativo permette di ottimizzare lo spazio abitativo e ridurre l’impatto ambientale. Il 95% del territorio circostante sarà lasciato intatto, preservando la biodiversità e riducendo al minimo l’intervento umano sull’ecosistema.
Trasporti Ultraefficienti e Zero Emissioni
Uno degli aspetti più innovativi del progetto è l’eliminazione totale delle automobili. Il trasporto sarà garantito da treni magnetici ad alta velocità, capaci di coprire l’intera lunghezza della città in soli 20 minuti. Grazie a questa infrastruttura avanzata, gli spostamenti saranno rapidi, confortevoli e privi di emissioni di carbonio. Inoltre, la città offrirà un sistema di trasporto pubblico completamente automatizzato e integrato con l’intelligenza artificiale, ottimizzando i percorsi per garantire efficienza e comfort ai cittadini.
Vivere a 5 Minuti da Tutto
Un altro principio chiave di The Line è il concetto “5 minuti”: ogni quartiere sarà progettato in modo che scuole, ospedali, negozi e spazi ricreativi siano raggiungibili a piedi in meno di cinque minuti. Questo modello riduce la necessità di lunghi spostamenti, migliorando la qualità della vita e rendendo più accessibili i servizi essenziali. Inoltre, la disposizione verticale degli edifici ridurrà il consumo di suolo e garantirà un uso più efficiente dello spazio disponibile.
Energia Verde e Intelligenza Artificiale
The Line funzionerà esclusivamente con energia rinnovabile proveniente da fonti solari, eoliche e da idrogeno verde, eliminando completamente le emissioni di carbonio. L’implementazione di sistemi avanzati di intelligenza artificiale consentirà di monitorare e ottimizzare il consumo energetico, la gestione delle risorse idriche e il controllo climatico degli ambienti interni. I sistemi di smart grid contribuiranno alla distribuzione intelligente dell’energia, riducendo gli sprechi e migliorando l’efficienza complessiva della città.
Un Nuovo Centro Globale per l’Innovazione e la Tecnologia
L’Arabia Saudita punta a trasformare The Line in un hub tecnologico di livello mondiale, attirando aziende innovative, centri di ricerca e startup. La città offrirà infrastrutture all’avanguardia per il settore tecnologico, scientifico e medico, con laboratori avanzati e spazi dedicati allo sviluppo di nuove soluzioni per l’urbanistica sostenibile. The Line potrebbe diventare un polo di attrazione per menti brillanti e imprenditori visionari che desiderano contribuire a un modello di città all’avanguardia.
Un Modello per le Città del Futuro
The Line non è solo una città, ma un esperimento di come le metropoli del futuro potrebbero essere progettate per garantire sostenibilità, efficienza e benessere per i cittadini. Se questo modello dovesse avere successo, potrebbe ispirare altre nazioni a ripensare l’urbanistica tradizionale e a investire in soluzioni eco-compatibili e tecnologicamente avanzate. Inoltre, potrebbe rappresentare una risposta concreta ai problemi ambientali e alla crescente urbanizzazione del pianeta.
Sicurezza, Benessere e Qualità della Vita
Grazie all’uso della tecnologia avanzata, The Line offrirà un livello di sicurezza senza precedenti, con sistemi di monitoraggio in tempo reale per la protezione dei cittadini. La città sarà progettata per garantire elevati standard di qualità della vita, con spazi verdi, centri benessere e strutture sportive integrate nell’architettura urbana. Il benessere psicofisico degli abitanti sarà una priorità, con ambienti progettati per ridurre lo stress e migliorare la salute mentale.
Conclusioni
Con un design innovativo, un’impronta ecologica ridotta al minimo e un’economia basata sulla tecnologia, The Line potrebbe rappresentare il punto di partenza per una nuova era urbana. Questo progetto ambizioso non solo ridefinisce il concetto di città, ma propone un modello concreto per il futuro della vita urbana, dove sostenibilità, innovazione e benessere convivono in perfetta armonia.



CLIMATICI: L’IMPEGNO DEI SINDACI PER IL NATIONALLY
DETERMINED CONTRIBUTION (NDC)
Il C40 Cities Climate Leadership Group è una rete globale che riunisce le principali città del mondo impegnate nella lotta contro il cambiamento climatico. Negli Stati Uniti, numerosi sindaci hanno assunto un ruolo di primo piano nell’attuazione di politiche climatiche ambiziose, contribuendo significativamente agli obiettivi delineati nei Contributi Determinati a livello Nazionale (Nationally Determined Contributions, NDC) previsti dall’Accordo di Parigi.
Il Ruolo delle Città Statunitensi negli NDC
Le città americane svolgono un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali. Secondo ricerche condotte da C40, le politiche e le azioni ambientali implementate nelle città degli Stati Uniti e a livello globale possono rappresentare fino al 40% delle riduzioni necessarie delle emissioni di gas serra per limitare il riscaldamento globale a un aumento di 1,5 gradi Celsius.
Le grandi metropoli come New York, Los Angeles, Chicago e Houston hanno introdotto strategie per ridurre le emissioni, promuovendo la mobilità sostenibile, il miglioramento dell’efficienza energetica e la transizione verso l’energia rinnovabile. Molte città hanno stabilito obiettivi net-zero, con l’intento di eliminare le emissioni nette di carbonio entro il 2050 o addirittura prima.
Iniziative Chiave e Impegni dei Sindaci
Nel marzo 2017, i sindaci di 38 città statunitensi, inclusi tutti i 12 sindaci membri di C40 negli Stati Uniti, hanno riaffermato il loro impegno a rispettare gli obblighi morali, economici, di salute pubblica e di sicurezza per proteggere i loro cittadini e il pianeta dagli effetti del cambiamento climatico. Questi “sindaci del clima” hanno sottolineato i benefici economici derivanti dall’azione climatica, evidenziando, ad esempio, un mercato potenziale di 10 miliardi di dollari per l’elettrificazione di quasi 115.000 veicoli municipali in 30 città americane.
Un’altra iniziativa di rilievo è stata l’adesione di 130 città americane alla campagna “Cities Race to Zero” nell’ottobre 2021, sostenuta dalle Nazioni Unite. Questo impegno globale prevede l’adozione di misure concrete per ridurre le emissioni, migliorare l’efficienza energetica e sviluppare economie verdi.
Le città che fanno parte del C40 hanno attuato politiche innovative per favorire la sostenibilità urbana. Ad esempio:
• New York City ha lanciato il programma “OneNYC 2050”, che include obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni e l’espansione dell’energia pulita.
• Los Angeles ha introdotto un piano per convertire l’intero sistema di trasporto pubblico in elettrico entro il 2030.
• Chicago ha investito in infrastrutture verdi per migliorare la resilienza climatica.
• Houston ha adottato il “Climate Action Plan” con lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra del 40% entro il 2030.
Collaborazione Internazionale e Sostegno Reciproco
I sindaci delle città C40 hanno espresso solidarietà e sostegno ai loro colleghi statunitensi, riconoscendo l’importanza di una collaborazione globale per affrontare la crisi climatica. In una dichiarazione congiunta, hanno affermato: “Restiamo uniti e determinati ad andare avanti per creare le città sostenibili del futuro. È nostro dovere come leader e insieme non falliremo”.
La cooperazione internazionale si rivela essenziale per garantire il successo degli obiettivi climatici. Le città statunitensi collaborano con altre metropoli nel mondo per condividere le migliori pratiche e sviluppare strategie congiunte. Il C40, infatti, promuove lo scambio di conoscenze e la creazione di partenariati tra le città, aiutandole a implementare progetti sostenibili su larga scala.
Attraverso iniziative locali e collaborazioni internazionali, i sindaci delle città statunitensi stanno dimostrando una leadership significativa nell’attuazione degli NDC. Il loro impegno non solo contribuisce agli sforzi globali per mitigare il cambiamento climatico, ma genera anche benefici economici e sociali per le comunità locali.
La strada verso la neutralità climatica è ancora lunga, ma grazie all’azione determinata delle città e dei loro leader, il futuro sostenibile diventa una realtà sempre più concreta.

di Ludovica Serra
Negli ultimi anni, molte città in tutto il mondo hanno adottato strategie innovative per migliorare la sostenibilità, rigenerare gli spazi urbani e promuovere il benessere della popolazione. Le sfide ambientali, il cambiamento climatico e la necessità di migliorare la qualità della vita hanno spinto amministrazioni locali a investire in progetti di mobilità sostenibile, efficienza energetica e riqualificazione urbana. Di seguito, esploriamo alcune città globali che hanno recentemente implementato soluzioni significative in questi ambiti.
1. Copenaghen, Danimarca - Copenaghen è una delle città più avanzate al mondo in termini di sostenibilità ambientale. L’obiettivo della città è diventare carbon neutral entro il 2025, attraverso l’implementazione di energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’espansione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile. Il sistema di trasporto pubblico è stato potenziato, con particolare attenzione alle piste ciclabili, che oggi coprono oltre 400 km. Inoltre, sono stati realizzati quartieri autosufficienti dal punto di vista energetico, con edifici a basso consumo e tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti e dell’acqua.
2. Singapore, Indonesia - Singapore ha adottato una strategia di pianificazione urbana sostenibile che include soluzioni innovative come il raffreddamento urbano attraverso tetti verdi, la gestione intelligente dell’acqua e la riduzione dell’inquinamento atmosferico. Il progetto “One Million Trees” mira a piantare un milione di alberi entro il 2030 per migliorare la qualità dell’aria e mitigare l’effetto isola di calore urbana. Inoltre, la città ha investito nel potenziamento della mobilità pubblica e nell’elettrificazione dei trasporti per ridurre l’impronta di carbonio.
3. Vancouver, Canada - Vancouver è impegnata a diventare la città più verde del mondo con il piano “Greenest City Action Plan”. La città ha investito nella creazione di quartieri sostenibili, riducendo le emissioni di gas serra e migliorando l’efficienza energetica degli edifici. Inoltre, Vancouver ha promosso l’utilizzo di veicoli elettrici e ha sviluppato un sistema di tra-
sporto pubblico efficiente e sostenibile. Le iniziative includono la costruzione di edifici a energia positiva, che producono più energia di quella consumata.
4. Melbourne, Australia - Melbourne ha sviluppato una strategia di adattamento climatico per affrontare le sfide ambientali, tra cui la gestione delle risorse idriche e il miglioramento della biodiversità urbana. Il progetto “Green Your Laneways” mira a trasformare vicoli trascurati in spazi verdi vivibili, migliorando così la qualità della vita e la resilienza urbana. Inoltre, la città sta investendo in infrastrutture urbane per migliorare l’uso dell’energia solare e dell’illuminazione pubblica intelligente.
5. Amsterdam, Paesi Bassi - Amsterdam sta investendo nella mobilità sostenibile, con un piano per diventare una città a emissioni zero entro il 2030. La città ha sviluppato una rete di trasporti pubblici basata su veicoli elettrici e ha promosso attivamente l’uso della bicicletta. Inoltre, progetti di rigenerazione urbana hanno trasformato vecchi quartieri industriali in spazi sostenibili e multifunzionali. L’implementazione di tecnologie smart per il monitoraggio dei consumi energetici e la riduzione degli sprechi è un altro punto cardine della strategia cittadina.
6. Medellín, Colombia - Medellín è diventata un esempio di rigenerazione urbana attraverso la creazione di infrastrutture innovative come le scale mobili nelle aree collinari, che hanno migliorato l’accessibilità e l’integrazione sociale. La città ha anche investito nella creazione di spazi verdi e nella promozione di trasporti pubblici sostenibili. Progetti di riqualificazione urbana hanno permesso di ridurre il tasso di criminalità e migliorare la qualità della vita dei residenti.
7. Parigi, Francia - La sindaca di Parigi ha lanciato il piano “15-minute city”, un concetto di urbanistica che mira a garantire che i cittadini possano raggiungere tutti i servizi essenziali in 15 minuti a piedi o in bicicletta. Inoltre, la città ha piantato migliaia di alberi, ampliato le aree pedonali e ridotto il traffico automobilistico per migliorare la qualità dell’aria. Parigi ha
anche introdotto incentivi per la ristrutturazione ecologica degli edifici e il passaggio a fonti di energia rinnovabile.
8. Tokyo, Giappone - Tokyo ha adottato strategie per la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso l’efficienza energetica degli edifici e la promozione dell’uso dell’energia solare. Il progetto “Smart City” include anche soluzioni tecnologiche per migliorare la gestione dei rifiuti e ottimizzare il traffico urbano. La città sta investendo in progetti di agricoltura urbana per migliorare la sicurezza alimentare e ridurre l’impronta ambientale.
9. Curitiba, Brasile - Curitiba è famosa per il suo avanzato sistema di trasporto pubblico basato su autobus a corsia preferenziale (BRT) e per l’implementazione di numerosi parchi urbani che fungono da sistemi di drenaggio naturale per prevenire le inondazioni. La città ha promosso anche la partecipazione cittadina nella gestione ambientale. Inoltre, Curitiba sta implementando progetti di economia circolare per ridurre gli sprechi e incentivare il riutilizzo dei materiali.
10. San Francisco, USA - San Francisco ha implementato strategie per ridurre i rifiuti con il programma “Zero Waste” che punta a riciclare il 100% dei rifiuti entro il 2030. La città ha anche sviluppato una rete di trasporti pubblici elettrificati e ha incentivato la costruzione di edifici a basso impatto ambientale. Inoltre, ha introdotto normative per la riduzione del consumo di plastica monouso e il miglioramento della qualità dell’aria.
Questi esempi dimostrano come le città di tutto il mondo stiano adottando soluzioni concrete per affrontare le sfide ambientali e migliorare la vita dei cittadini. Il futuro delle città sostenibili dipende dalla capacità di combinare innovazione tecnologica, politiche efficaci e un forte coinvolgimento della comunità.
Città italiane all’avanguardia nella sostenibilità
Oltre ai casi internazionali, l’Italia sta sviluppando numerose iniziative per la sostenibilità e la rigenerazione urbana. Ecco dieci esempi di città italiane impegnate in questo processo:
Milano - Ha sviluppato il progetto “ForestaMi”, che prevede la piantumazione di 3 milioni di alberi entro il 2030 per ridurre l’inquinamento e migliorare il microclima urbano. Inoltre, ha ampliato le aree pedonali e le piste ciclabili.
Bologna - Ha investito in mobilità sostenibile con il progetto “Bicipolitana”, una rete di piste ciclabili integrate al trasporto pubblico. Inoltre, ha sviluppato un piano per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Torino - Si distingue per il progetto “Torino Green City”, che include la creazione di nuovi parchi urbani, la riforestazione e l’uso di energie rinnovabili per edifici pubblici e privati.
Firenze - Ha introdotto il piano “Smart City Firenze”, che mira all’uso efficiente dell’energia attraverso reti intelligenti, illuminazione pubblica a LED e trasporto pubblico elettrico.
Napoli - Sta lavorando alla riqualificazione delle aree urbane degradate, come il progetto “Restart Scampia”, che prevede la demolizione delle Vele e la creazione di nuovi spazi abitativi e aree verdi.
Venezia - Ha avviato progetti di salvaguardia ambientale per contrastare l’innalzamento del livello del mare, tra cui il sistema MOSE, oltre a iniziative per ridurre l’inquinamento da traffico navale.
Genova - Ha investito in infrastrutture verdi e nella riqualificazione delle aree portuali con il progetto “Waterfront di Levante”, che prevede nuovi spazi pubblici e maggiore sostenibilità urbana.
Palermo - Ha avviato iniziative per la mobilità sostenibile, con il potenziamento del trasporto pubblico elettrico e la creazione di nuove piste ciclabili, oltre a progetti di recupero del centro storico.
Trento - È tra le città italiane più sostenibili grazie a investimenti nella mobilità elettrica, alla promozione dell’efficienza energetica e alla gestione intelligente delle risorse idriche.
Perugia - Ha sviluppato un piano di riqualificazione urbana basato sulla mobilità sostenibile e sul potenziamento degli spazi verdi per migliorare la qualità della vita dei cittadini.



L’On. Roberto Pella nuovo Presidente e il Dott. Ranieri Guerra nuovo DG di CITIES+, l’alleanza per il benessere e la salute delle città
È l’On. Roberto Pella il nuovo Presidente di CITIES+ (C14+), il network dedicato ai temi del benessere, della salute, dell’ambiente e dello sport nelle città. CITIES+ raccoglie tutti quei comuni che hanno adottato il Manifesto della Salute nelle città come bene comune e/o documenti correlati o ispiratori dello stesso, come ad esempio la Roma Urban Health declaration sottoscritta in occasione del G7 salute del 12 Dicembre 2017, l’Urban Diabetes Declaration, la Carta SportCIty , The city commitment on better health e il parere adottato dal Comitato delle Regioni dell’UE nella 123° sessione plenaria dell’11 e 12 maggio 2017 su La salute nelle città: bene comune. L’adozione di questi documenti e di politiche a livello della comunità di riferimento, da parte delle amministrazioni locali, sancisce l’impegno a volersi occupare fattivamente delle dinamiche correlate al miglioramento della qualità di vita, del benessere e della sostenibilità delle proprie città. Attualmente son circa 350 i comuni che hanno adottato questi documenti o avviato politiche inerenti e che fanno parte del network CITIES+. «Sono onorato del ruolo che mi viene affidato in una organizzazione, come questa, che molto ha contribuito fin qui su temi chiave per le città e che molto ancora può contribuire - dichiara il neo Presidente di CITIES+, On. Roberto Pella, che è sindaco di Valdengo, Deputato, Vice Presidente di ANCI con delega alla salute, lo sport e le aree interne, Presidente della Confederazione Europea dei Piccoli Comuni e membro del Comitato delle Regioni dell’UE- CITIES+ è uno spazio di indagine, studio e approfondimento all’interno del quale affrontare i temi relativi ai determinati della salute nelle città, in un ruolo anticipatore e di guida per processi di miglioramento della salute nei contesti urbani. CITIES+ offre alle Istituzioni e alle amministrazioni locali un luogo per il dibattito e il confronto da trasformare in proposte concrete di politica pubblica, consentendo così alle popolazioni delle città di adottare stili di vita salutari. Si tratta di obiettivo centrale nel
contesto contemporaneo. Ringrazio Enzo Bianco per il grande lavoro svolto fin qui come Presidente. Il mio massimo impegno sarà devoluto affinché questi temi siano sempre più al centro dell’agenda politica e dell’azione decisa delle amministrazioni».
Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi negli ambienti urbani. Le città contribuiscono per il 70 per cento alle emissioni globali di carbonio e per oltre il 60 per cento all’uso delle risorse. In Italia circa il 37 per cento della popolazione vive nelle aree metropolitane.
CITIES+ è un think tank, una alleanza e un osservatorio permanente sul benessere , la salute, l’ambiente, e lo sport delle città, delle aree metropolitane, delle comunità montane, delle aree interne marginali e dei borghi italiani, realizzato in sinergia con le Istituzioni, l’Anci, le regioni, le province, le comunità montane, le università, le Fondazioni, i centri di ricerca, il mondo dell’industria e con il supporto scientifico di Health City Institute e della rete delle società scientifiche aderenti a Science for Cities.
CITIES+ offre alle Istituzioni e alle amministrazioni locali un luogo per il dibattito e il confronto da trasformare in proposte concrete di politica pubblica, consentendo così alle popolazioni delle città di adottare stili di vita salutari. Gli ambiti di confronto e dibattito di CITIES+ riguardano: la sostenibilità ambientale, la globalizzazione della salute, i determinanti della salute nelle Città Metropolitane e nelle grandi città come nelle aree interne marginali del Paese, temi sociali riguardanti il rapporto tra urbanizzazione, declino demografico dei territori e salute. CITIES+ è costituito da un gruppo di amministratori locali impegnati nell’elaborare proposte attuali, fattive e d’impatto e per individuare le priorità sulle quali agire su questi temi. Il think tank aggrega inoltre come esperti, persone di massima integrità, motivate da una forte passione civica e provenienti dai mondi delle professioni, dell’industria, della finanza, dell’imprenditoria, dell’innovazione, della consulenza, dell’accademia, della
pubblica amministrazione, della magistratura, della cultura, della scienza e dei media, le quali mettono le proprie competenze al servizio del Paese, delle Istituzioni e dei Comuni.
Alle Istituzioni CITIES+ offre confronto permanente con competenze diversificate (orizzontali, verticali e di sistema) e accesso a best practice comparate e globali; una controparte professionale animata da senso civico, credibile e indipendente, disposta a lavorare su specifici progetti e azioni mirate per la promozione della salute. CITIES+ si pone in relazione con i diversi livelli decisionali previsti dalla Costituzione affinché le proposte possano essere condivise e recepite, impegnandosi a creare consenso e a monitorarne l’impatto attraverso un Osservatorio permanente sulla salute, il benessere, l’ambiente e lo sport nelle Città e nelle comunità locali.
Nel contempo il Dott. Ranieri Guerra è stato nominato nuovo Direttore Generale di CITIES+
Ranieri Guerra, è un medico esperto in Igiene pubblica, ex direttore generale dell’ufficio di Prevenzione del Ministero della Salute, ed ex direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
Inoltre è stato addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Washington e in Australia e Direttore del centro di collaborazione dell’OMS e Direttore dell’Ufficio per le relazioni esterne presso l’Istituto superiore di sanità.
In qualità di esperto medico della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri, dove è rimasto fino al 1989. Tra il 1995 e il 1996 è stato Direttore Sanitario d’azienda presso l’ASL di Friuli Occidentale. Nei primi anni 2000 è entrato a far parte del Fondo globale per la lotta all’Aids, la tubercolosi e la malaria di Bruxelles e Ginevra, in rappresentanza dell’Italia.
Ha lavorato in Tanzania e quando gli viene affidato il ruolo di Direttore Generale aggiunto dell’OMS per le iniziative strategiche, si è dedicato all’eradicazione della poliomielite e della salute dei migranti (Egitto, Palestina, Siria, Libano e Giordania).
Dal mese di settembre 2021, lasciato l’incarico nell’Oms, ha assunto quello di direttore delle relazioni internazionali dell’Accademia Nazionale di Medicina che ha sede a Genova, lavora su progetti di analisi sanitari con organizzazioni di primaria importanza internazionali.
Per Federico Serra, segretario Generale di CITIES+
«Rafforzano i legami sia a livello nazionale che internazionale, con le città e le Istituzioni, facendo diventare CITIES+ un network di assoluta importanza sui temi della salute, dell’ambiente, dello sport e del benessere nelle città»
« CITIES+ mira a coinvolgere le energie intellettuali del Paese, attraverso un’efficace piattaforma d’impatto sullo studio dei determinati della salute nelle città.dichiara il Prof. Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute e Coordinatore di Science for Cities – I suoi interlocutori di riferimento sono le istituzioni (nazionali, europee e internazionali, regionali e locali), le università e i centri di ricerca, in un dialogo e confronto per la creazione e lo sviluppo di una partnership culturale, scientifica e operativa a livello di policy making, con un approccio leale, trasparente, inclusivo, aperto e costruttivo. I membri di CITIES+ dedicano il proprio tempo e impegnano le proprie competenze al servizio del Paese e delle Città per un impatto tangibile della propria azione sulla società, declinato come consapevolezza sociale, proposta di legge, sensibilizzazione politica, ricerca e studio o proposta di riforma vera e propria. È un impegno di ampio profilo che affronta temi cruciali. Al neo Presidente Roberto Pella vanno i miei complimenti per questo importante incarico e l’augurio di buon lavoro, certo che saprà portare in questo il ruolo il suo grande contributo di competenza, di esperienza e di sensibilità verso queste tematiche».


Ranieri Guerra
Direttore Generale CITIES+,
Federico Serra
Segretario Generale CITIES+
L’alfabetizzazione digitale rappresenta una sfida cruciale per l’Italia contemporanea, in quanto le competenze tecnologiche sono diventate fondamentali per l’inclusione sociale e lavorativa. Tuttavia, il nostro Paese evidenzia ritardi significativi in questo ambito, con disparità che si manifestano sia a livello territoriale che di genere.
Il quadro delle competenze digitali in Italia
Nel 2023, solo il 45,8% dei cittadini italiani possedeva competenze digitali almeno di base, un dato inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto alla media europea del 55,6%. Questo posiziona l’Italia tra i Paesi con le performance peggiori in Europa, superando solo Lettonia (45,3%), Polonia (44,3%), Bulgaria (35,5%) e Romania (27,7%).
Analizzando la fascia d’età tra i 16 e i 29 anni, spesso considerata composta da “nativi digitali”, la percentuale di coloro con competenze digitali almeno di base sale al 58,5%. Tuttavia, questo dato rimane significativamente al di sotto della media UE del 70,7%, collocando l’Italia al terzultimo posto, davanti solo a Bulgaria (52,3%) e Romania (46%).
In Svezia l’85% della popolazione ha competenze digitali di base, e anche la Germania, con il 78%, l’Olanda con l’82 e l’Estonia con il 79 rappresentano obiettivi raggiungibili realizzando un ecosistema adeguato e evolutivo, con una politica e una strategia di sviluppo coerenti e sostenute, senza le quali l’Italia rischia un progressivo isolamento tecnologico.
Disparità di genere nelle competenze digitali Un aspetto interessante riguarda le differenze di genere. In Italia, le giovani donne tra i 16 e i 19 anni mostrano competenze digitali superiori rispetto ai coetanei maschi: il 59,1% delle ragazze possiede competenze di base o superiori, contro il 52,7% dei ragazzi. Questo divario di 6,4 punti percentuali è quasi il doppio rispetto alla media europea di 3,4 punti.
Nonostante ciò, questa superiorità nelle competenze non si traduce in una maggiore partecipazione femmi-
nile nei percorsi accademici e professionali legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Nel 2023, solo il 16,8% dei laureati in informatica e ICT in Italia erano donne. Questo fenomeno suggerisce la presenza di stereotipi di genere e aspettative sociali che influenzano le scelte educative delle ragazze, allontanandole dalle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Le scuole e la carenza di infrastrutture digitali
La scuola riveste un ruolo centrale nell’acquisizione di competenze digitali. Tuttavia, la disponibilità di infrastrutture adeguate è limitata. Nell’anno scolastico 2022-2023, solo il 35,7% degli edifici scolastici italiani disponeva di aule informatiche. Questa carenza è più accentuata nelle aree rurali e nelle zone con alta concentrazione di famiglie a rischio disagio socio-economico.
A livello regionale, esistono differenze significative. La Liguria registra la percentuale più alta di edifici scolastici con aule informatiche (56,5%), seguita da Piemonte (52,6%) e Valle d’Aosta (52,1%). Al contrario, regioni come Abruzzo (24%), Campania (22%), Calabria (21,8%) e Lazio (18,1%) presentano percentuali inferiori.
Anche tra i comuni capoluogo emergono disparità: Pavia guida con il 91,7% degli edifici scolastici dotati di aule informatiche, mentre città come Latina (5,4%), Catanzaro (4%) e Cosenza (3,3%) si collocano agli ultimi posti.
Il divario digitale tra aree interne e città
Uno dei problemi più critici riguarda le aree interne, ovvero quei territori lontani dai centri urbani, caratterizzati da scarsa accessibilità ai servizi essenziali. Qui, il digital divide è ancora più evidente: molte scuole non dispongono di infrastrutture adeguate, connessioni internet veloci e dispositivi tecnologici sufficienti per garantire una formazione digitale di qualità.
Queste difficoltà si riflettono sull’accesso ai percorsi di apprendimento e sulle opportunità lavorative future
per i giovani che risiedono in queste zone. Mentre nelle città l’accesso alla rete e alle tecnologie è più diffuso, nelle aree interne la mancanza di connessioni adeguate e di strumenti digitali rischia di amplificare le disuguaglianze sociali e formative.
D’altra parte, anche le città presentano sfide importanti. Se è vero che nei centri urbani la diffusione di connessioni veloci è più capillare e l’accesso alla tecnologia è facilitato, il divario sociale rappresenta un fattore di disuguaglianza. I quartieri più svantaggiati delle grandi città spesso vedono una minore diffusione di dispositivi digitali nelle famiglie e un accesso ridotto a percorsi formativi avanzati.
In particolare, nei grandi centri metropolitani come Roma, Milano, Napoli e Torino, esistono differenze significative tra i quartieri centrali e quelli periferici. Mentre le zone più ricche sono dotate di scuole con strumenti digitali all’avanguardia, nelle periferie molte istituzioni scolastiche soffrono di carenze infrastrutturali e di connessioni instabili. Questo fenomeno evidenzia che il digital divide non è solo una questione di distanza geografica, ma anche di disuguaglianza economica e sociale.
Per affrontare queste problematiche, molte città stanno investendo in progetti di digitalizzazione, con l’obiettivo di ridurre il gap digitale. Ad esempio, Milano ha avviato programmi per potenziare l’accesso alla rete nelle scuole, mentre Torino ha promosso iniziative per fornire dispositivi e corsi di formazione digitale alle fasce più deboli della popolazione.
Progetti nazionali di alfabetizzazione digitale
• Alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori: Questo progetto, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mira a finanziare iniziative che educano i minori all’uso consapevole delle tecnologie digitali. Gli obiettivi includono la prevenzione del cyberbullismo e il supporto alla genitorialità per una maggiore consapevolezza dei rischi online.
• Tandem: Un’iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea attraverso il Programma Erasmus+, che promuove la collaborazione tra scuola e famiglia per sviluppare l’alfabetizzazione mediatica digitale nei bambini dai 6 ai 12 anni. Il progetto offre percorsi pedagogici che possono essere adattati per garantire una continuità educativa tra casa e scuola.
• DIG4All: Finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, questo progetto si rivolge a 240 giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano né lavorano (NEET). L’obiettivo è fornire competenze digitali avanzate per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro e promuovere l’inclusione sociale.
Iniziative per le aree interne
• Digital Roots: Questo progetto si propone di rilanciare le aree interne combinando tecnologia e strategie innovative. Coinvolge esperti di vari settori per approfondire temi come l’innovazione nell’agroalimentare, il marketing digitale per le piccole imprese e l’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle PMI, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali attraverso la digitalizzazione.
Programmi per le città
• Nonni su Internet: Un’iniziativa dedicata agli over 60, che offre corsi di alfabetizzazione digitale nelle scuole. Gli anziani partecipano a lezioni tenute da studenti tutor, favorendo così uno scambio intergenerazionale e promuovendo l’inclusione digitale tra le fasce più mature della popolazione.
• Connessi in buona compagnia: Un progetto pilota rivolto agli over 65, finalizzato a supportarli nell’uso delle tecnologie e nell’accesso ai servizi pubblici digitali regionali. L’iniziativa mira a ridurre il divario digitale tra le generazioni più anziane, facilitando l’inclusione digitale e l’accesso ai servizi online.
Questi progetti rappresentano passi significativi verso la riduzione del divario digitale in Italia, affrontando le esigenze specifiche di diverse fasce della popolazione e promuovendo un accesso equo alle opportunità offerte dalla digitalizzazione.
D’altro canto, esistono modelli di eccellenza globali, da cui attingere conoscenze e capacità utilizzabili per il nostro Paese. Singapore si distingue per un approccio sistemico che si basa su un programma nazionale di alfabetizzazione digitale che ha reso obbligatoria la formazione in competenze digitali per tutti i cittadini, con un investimento del 2% del PIL. In Estonia si è promossa un’educazione digitale precoce, con coding obbligatorio dalle elementari, una piattaforma nazionale di e-learning e una digitalizzazione che ormai ha raggiunto il 99% dei servizi pubblici. In Danimarca la parola d’ordine è stata l’inclusione intergenerazionale, con programmi specifici per over 65, corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale e un supporto personalizzato nelle comunità locali a rischio di aggravamento del divide digitale.
I progetti di ANCI sulla alfabetizzazione digitale
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è attivamente impegnata in numerosi progetti volti a promuovere l’alfabetizzazione digitale e a facilitare la transizione tecnologica nei comuni italiani. Ecco alcuni esempi significativi:
Mappa dei Comuni Digitali e Accademia dei Comuni Digitali
ANCI, in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha sviluppato la “Mappa dei Comuni Digitali”, un’indagine volta a valutare lo stato di digitalizzazione dei comuni italiani e a identificare le loro esigenze specifiche. Parallelamente, è stata istituita l’Accademia dei Comuni Digitali, un ambiente formativo dedicato al personale comunale, con l’obiettivo di rafforzarne le competenze digitali e supportare la transizione tecnologica degli enti locali.
Digitalmente Attivi
Questo progetto, realizzato in collaborazione con la Fondazione Lottomatica e la Fondazione Longevitas, mira a promuovere l’alfabetizzazione digitale tra gli over 65 in cinque regioni: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Toscana. Attraverso incontri formativi organizzati in centri sociali e associazioni, gli anziani vengono guidati nell’uso di strumenti digitali come smartphone e tablet, con l’obiettivo di migliorare la loro autonomia e prevenire l’emarginazione sociale.
Progetto “Next Stop: Digitale” del Comune di Saluzzo
Il Comune di Saluzzo ha sviluppato il progetto “Next Stop: Digitale”, un percorso di alfabetizzazione digitale rivolto alle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione agli anziani e agli stranieri. L’iniziativa ha ricevuto il primo premio nella sezione Piemonte del concorso “Innovazione e Sviluppo Next Generation” organizzato da ANCI Piemonte, riconoscendo l’importanza di colmare il divario digitale e promuovere l’inclusione attraverso servizi pubblici innovativi.
Rete dei Punti di Facilitazione Digitale in Puglia
In Puglia, ANCI ha collaborato con la Regione per l’avvio di una rete regionale di Punti di Facilitazione Digitale. Questi centri, distribuiti su tutto il territorio regionale, offrono supporto ai cittadini nell’acquisizione di competenze digitali di base, prevenendo l’esclusione sociale e riducendo le disuguaglianze. L’iniziativa mira a garantire un accesso equo ai servizi digitali della pubblica amministrazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.
Digitale Facile in Toscana
La Regione Toscana, in collaborazione con ANCI e i sindacati, ha lanciato il progetto “Digitale Facile”, creando oltre 250 punti di accesso su tutto il territorio regionale. Questi centri sono pensati per assistere, in particolare, anziani e persone fragili nell’utilizzo autonomo e consapevole delle nuove tecnologie e dei servizi online, come lo SPID, l’e-commerce e la sanità digitale. L’obiettivo è facilitare l’inclusione digitale e
garantire che nessuno venga lasciato indietro nella transizione tecnologica.
Questi progetti testimoniano l’impegno di ANCI nel sostenere i comuni italiani nel processo di digitalizzazione, promuovendo iniziative che favoriscono l’inclusione e l’accessibilità ai servizi digitali per tutti i cittadini e indicano come la creatività e le iniziative italiane siano appropriate e rilevanti, ma abbiano al tempo stesso bisogno di essere sostenute e diventare parte di un vero ecosistema nazionale in continua evoluzione.
Conclusione
L’alfabetizzazione digitale è fondamentale per garantire pari opportunità e ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche. Tuttavia, l’Italia deve affrontare una doppia sfida: da un lato il divario tra le città e le aree interne, dall’altro le disuguaglianze digitali anche all’interno dei centri urbani stessi.
Per superare questi ostacoli, è essenziale che le istituzioni investano in infrastrutture scolastiche adeguate, connessioni veloci e programmi di formazione mirati. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile colmare il gap digitale e preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro.

di Ranieri Guerra
Direttore Generale CITIES+

Introduzione
Il digital divide rappresenta una delle sfide più rilevanti per lo sviluppo socio-economico dell’Italia. Nonostante i progressi tecnologici, molte fasce della popolazione rimangono escluse dalle opportunità offerte dalla digitalizzazione. Questo fenomeno è particolarmente critico nel settore sanitario, dove l’accesso limitato alle tecnologie digitali compromette la qualità dell’assistenza, soprattutto nelle aree più periferiche e meno servite.
L’obiettivo di questa analisi è analizzare in dettaglio la situazione attuale del digital divide in Italia, evidenziando le principali criticità e le opportunità di miglioramento. Inoltre, viene illustrato il ruolo di CITIES+, attraverso un’iniziativa strategica per la trasformazione digitale della sanità e per la riduzione delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi digitali.
L’Attuale Scenario del Digital Divide in Italia
La trasformazione digitale rappresenta una grande opportunità per l’Italia, ma i dati mostrano un quadro preoccupante di disuguaglianze nell’accesso e nell’uso delle tecnologie digitali. Negli ultimi cinque anni, il digital divide si è ridotto, ma permangono gap significativi tra diverse fasce della popolazione.
Italiani con difficoltà nelle competenze digitali
• Competenze digitali di base: il 54,1% della popolazione non possiede competenze adeguate, il 28% non ha mai utilizzato Internet e il 21% non ha mai usato un computer.
• Competenze informative: il 45% non sa cercare informazioni online in modo efficace, il 38% non sa verificare l’attendibilità delle fonti e il 52% non sa utilizzare i servizi di e-government.
• Competenze di comunicazione: il 35% non sa usare la posta elettronica, il 48% non usa servizi di messaggistica avanzata e il 55% non sa partecipare a videoconferenze.
• Competenze per il problem-solving: il 62% non sa risolvere problemi tecnici semplici, il 71% non sa configurare le impostazioni di privacy e il 58%
• non sa installare applicazioni.
• Competenze software: il 65% non sa usare software di elaborazione testi, il 75% non sa utilizzare fogli di calcolo e l’82% non sa creare presentazioni digitali.
Divario digitale per fasce d’età
L’alfabetizzazione digitale varia significativamente con l’età:
• 18-24 anni: 6% di analfabetismo digitale
• 25-34 anni: 11%
• 35-44 anni: 23%
• 45-54 anni: 35%
• 55-64 anni: 48%
• 65-74 anni: 65%
• Over 75: 79%
Divario digitale per tipologia di servizio
• Bancari: il 55% non sa usare l’home banking, il 63% non effettua pagamenti online, il 70% non gestisce investimenti digitali.
• Pubblica amministrazione: il 58% non usa SPID, il 65% non accede ai servizi comunali online, il 72% non utilizza il portale dell’Agenzia delle Entrate.
• E-commerce: il 45% non ha mai fatto acquisti online, il 62% non sa comparare prezzi online, il 68% non sa valutare l’affidabilità di un venditore.
Il Caso Particolare delle Aree Interne, delle Comunità Montane e delle Piccole Isole Italiane
Nelle aree interne, nelle comunità montane e nelle isole minori, il digital divide è ancora più accentuato. La mancanza di infrastrutture digitali e di programmi di alfabetizzazione tecnologica penalizza gravemente la

popolazione di queste zone, rendendo difficile l’accesso ai servizi essenziali, tra cui quelli sanitari e amministrativi.
• Tasso medio di analfabetismo digitale: 68% nelle isole minori, 62% nelle comunità montane e 58% nelle aree interne (vs. media nazionale 54,1%)
• Percentuale di popolazione over 65: 28% nelle isole minori, 30% nelle comunità montane e 29% nelle aree interne (vs. media nazionale 23,8%)
Divari Digitali nei Settori Chiave
• Infrastrutture: il 45% delle aree ha una copertura internet insufficiente, il 35% non ha accesso alla banda larga, il 60% ha una connessione instabile.
• Sanità digitale: l’82% non utilizza servizi di telemedicina, il 75% non accede al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l’88% non usa app sanitarie.
• Istruzione: il 65% degli studenti ha difficoltà nella DAD, il 58% dei docenti ha competenze digitali limitate, il 72% delle famiglie ha problemi di supporto tecnologico.
L’Impatto Economico del Digital Divide
• Perdita di produttività: 3,2% del PIL
• Costi aggiuntivi per la PA: 2,2 miliardi €/anno
• Mancate opportunità di lavoro: 1,8 milioni di posizioni
• Costi sociali indiretti: 4,3 miliardi €/anno
CITIES+: Una Soluzione per la Trasformazione
Digitale della Sanità
CITIES+ si configura come un’alleanza tra 350 comuni, amministrazioni, università e imprese per ridurre il digital divide e migliorare la salute digitale.
Le Tre Dimensioni Chiave di CITIES+
a. Knowledge Hub
• Mappatura dei bisogni digitali sanitari
• Analisi comparativa delle soluzioni
• Monitoraggio real-time degli impatti
• Condivisione delle best practice
b. Innovation Laboratory
• Sperimentazione di soluzioni in contesti reali
• Co-progettazione con le comunità locali
• Adattamento di modelli internazionali di successo
• Sviluppo di prototipi scalabili
c. Capacity Builder
• Formazione per amministratori e operatori sanitari
• Sviluppo di competenze digitali territoriali
• Creazione di partnership pubblico-private
Risultati Attesi
• +0,07 QALY per paziente/anno
• -30% di accessi impropri al pronto soccorso
• +40% di aderenza terapeutica
• +25% di partecipazione ai programmi di prevenzione
CITIES+ si pone come integratore di sistema, catalizzatore di innovazione e garante di sostenibilità, trasformando il digital divide in opportunità per la sanità italiana.

Un paese a due velocità: la sfida del divario digitale
Il digital divide rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per lo sviluppo socio-economico dell’Italia. Mentre i centri urbani corrono verso la digitalizzazione, ampie fasce della popolazione italiana restano escluse da questa rivoluzione, creando un vero e proprio paese a due velocità. Nonostante i significativi progressi tecnologici degli ultimi anni e gli sforzi fatti con il PNRR, persistono profonde disuguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie digitali, con ricadute particolarmente critiche in settori essenziali come la sanità.
Questo fenomeno è particolarmente accentuato nei territori più fragili del nostro paese: aree interne, comunità montane e isole minori si configurano come “deserti digitali” dove l’accesso ai servizi essenziali, inclusa l’assistenza sanitaria, è compromesso dalla mancanza di infrastrutture tecnologiche adeguate e di competenze digitali diffuse.
L’obiettivo di questa analisi è fornire un quadro dettagliato della situazione attuale, evidenziando le criticità ma anche le opportunità di miglioramento, e illustrare il ruolo di CITIES+ come risposta strategica a questa emergenza nazionale, con un focus specifico sulla trasformazione digitale della sanità come leva per ridurre le disuguaglianze territoriali.
Lo scenario attuale: un quadro preoccupante
I dati raccolti negli ultimi cinque anni mostrano una tendenza al miglioramento, ma il quadro generale resta critico. La trasformazione digitale rappresenta una straordinaria opportunità per l’Italia, ma il persistente digital divide rischia di trasformarla in un ulteriore fattore di disuguaglianza.
Le statistiche parlano chiaro: il 54,1% della popolazione italiana non possiede competenze digitali adeguate. Questo significa che più di un italiano su due è parzialmente o totalmente escluso dal mondo digitale. Il dato diventa ancora più allarmante quando sco-
priamo che il 28% della popolazione non ha mai utilizzato Internet e il 21% non ha mai usato un computer. Sono numeri che collocano l’Italia tra i paesi europei con il più alto tasso di analfabetismo digitale, nonostante le politiche di digitalizzazione avviate negli ultimi anni.
Le carenze si manifestano su molteplici fronti: il 45% degli italiani non sa cercare informazioni online in modo efficace, il 38% non possiede gli strumenti per verificare l’attendibilità delle fonti e il 52% non riesce a utilizzare i servizi di e-government, ormai essenziali per l’interazione con la pubblica amministrazione. Sul fronte della comunicazione digitale, il 35% non sa usare la posta elettronica, il 48% non utilizza servizi di messaggistica avanzata e il 55% non è in grado di partecipare a videoconferenze, strumenti diventati fondamentali durante la pandemia e ormai integrati nella vita quotidiana e lavorativa.
Le competenze tecniche di base sono anch’esse carenti: il 62% non sa risolvere problemi tecnici semplici, il 71% non è in grado di configurare le impostazioni di privacy (esponendosi così a rischi per la sicurezza dei propri dati) e il 58% non sa installare applicazioni. Preoccupante anche il dato relativo alle competenze software: il 65% non sa usare software di elaborazione testi, il 75% non sa utilizzare fogli di calcolo e l’82% non sa creare presentazioni digitali, competenze ormai essenziali nel mondo del lavoro contemporaneo.
La demografia del divario: un’Italia invecchiata e disconnessa
Il divario digitale in Italia ha una forte connotazione demografica, con un’evidente correlazione tra età e competenze digitali. Mentre la generazione Z mostra un tasso di analfabetismo digitale limitato al 6%, la percentuale cresce progressivamente con l’età: 11% nella fascia 25-34 anni, 23% tra i 35-44 anni, 35% tra i 45-54 anni, 48% tra i 55-64 anni, fino a raggiungere il 65% nella fascia 65-74 anni e addirittura il 79% tra gli over 75.
Questo dato assume particolare rilevanza se consideriamo che l’Italia è uno dei paesi più anziani al mondo, con il 23,8% della popolazione che ha più di 65 anni, percentuale destinata a crescere nei prossimi decenni. Si configura quindi un pericoloso circolo vizioso: una popolazione sempre più anziana in un mondo sempre più digitale.
Il divario digitale si manifesta in modo particolarmente critico nell’accesso ai servizi essenziali. Nel settore bancario, il 55% degli italiani non sa usare l’home banking, il 63% non effettua pagamenti online e il 70% non gestisce investimenti digitali, con conseguenze significative sulla gestione delle finanze personali e sull’accesso ai servizi finanziari.
Ancor più critica la situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione: il 58% non utilizza SPID, nonostante sia diventato lo strumento principale per l’accesso ai servizi pubblici, il 65% non accede ai servizi comunali online e il 72% non utilizza il portale dell’Agenzia delle Entrate, aggravando la burocrazia e rallentando l’efficienza amministrativa.
Anche nel commercio elettronico, che ha conosciuto una straordinaria crescita negli ultimi anni, persistono ampie sacche di esclusione: il 45% degli italiani non ha mai fatto acquisti online, il 62% non sa comparare prezzi sulla rete e il 68% non sa valutare l’affidabilità di un venditore, limitando così le proprie opportunità di risparmio e accesso a beni e servizi.
Le aree fragili: quando il divario diventa abisso
Se il quadro nazionale è preoccupante, la situazione nelle aree interne, nelle comunità montane e nelle isole minori assume contorni drammatici. In questi territori, definibili come “Italia fragile”, il digital divide si intreccia con lo spopolamento, l’invecchiamento demografico e la carenza di servizi essenziali, creando un mix potenzialmente esplosivo.
Nelle isole minori il tasso medio di analfabetismo digitale raggiunge il 68%, nelle comunità montane il 62% e nelle aree interne il 58%, ben al di sopra della già preoccupante media nazionale del 54,1%. A questo si aggiunge un’incidenza di popolazione anziana significativamente superiore alla media: 28% nelle isole minori, 30% nelle comunità montane e 29% nelle aree interne, contro il 23,8% nazionale.
Questa combinazione di fattori - maggiore analfabetismo digitale e popolazione più anziana - crea le condizioni per un’esclusione digitale strutturale, difficilmente superabile senza interventi mirati e sostanziali.
Il problema non è solo di competenze ma anche di infrastrutture: il 45% di queste aree ha una copertura in-
ternet insufficiente, il 35% non ha accesso alla banda larga e il 60% soffre di connessioni instabili. In un’epoca in cui la connettività è considerata un diritto fondamentale, questi territori vivono ancora in un’Italia disconnessa.
Particolarmente critica la situazione della sanità digitale: l’82% della popolazione in queste aree non utilizza servizi di telemedicina, il 75% non accede al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e l’88% non usa app sanitarie. Considerando che proprio in questi territori la distanza dai centri ospedalieri è maggiore, la telemedicina potrebbe rappresentare una soluzione fondamentale per garantire il diritto alla salute. Anche il settore dell’istruzione risente pesantemente di queste carenze: il 65% degli studenti ha difficoltà nella didattica a distanza, il 58% dei docenti ha competenze digitali limitate e il 72% delle famiglie ha problemi di supporto tecnologico, creando un divario educativo che rischia di perpetuarsi nelle prossime generazioni.
Il costo del divario: un’ipoteca sul futuro dell’Italia
Il digital divide non è solo un problema sociale ma anche economico, con costi diretti e indiretti che pesano sull’intero sistema paese. Secondo le nostre stime, la mancata digitalizzazione comporta una perdita di produttività pari al 3,2% del PIL, un dato che in termini assoluti si traduce in decine di miliardi di euro ogni anno.
A questo si aggiungono i costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione, stimati in 2,2 miliardi di euro all’anno, derivanti dalla necessità di mantenere sportelli fisici e procedure cartacee.
Il mercato del lavoro subisce anch’esso le conseguenze del divario digitale, con 1,8 milioni di potenziali posizioni lavorative che non si concretizzano per mancanza di competenze adeguate.
Non vanno inoltre trascurati i costi sociali indiretti, quantificabili in circa 4,3 miliardi di euro all’anno, legati all’esclusione sociale, alle spese sanitarie evitabili e al mancato accesso a servizi essenziali.
Complessivamente, il digital divide rappresenta un’ipoteca sul futuro dell’Italia, un freno allo sviluppo economico e sociale che richiede interventi urgenti e strutturati.
CITIES+: una risposta sistemica al digital divide sanitario
In questo scenario nasce CITIES+, un’alleanza strategica che riunisce 350 comuni, amministrazioni pubbliche, università e imprese con l’obiettivo di ridurre il digital divide e migliorare la salute digitale, con particolare attenzione alle aree più fragili del paese.
CITIES+ non è un semplice progetto ma un ecosistema di innovazione che opera su tre dimensioni complementari:
a. Knowledge hub: conoscere per agire
Come knowledge hub, CITIES+ realizza una mappatura dettagliata dei bisogni digitali sanitari nei territori coinvolti, con particolare attenzione alle aree interne, alle comunità montane e alle isole minori. Questa attività non si limita alla raccolta di dati ma include un’analisi comparativa delle soluzioni già esistenti e un monitoraggio in tempo reale degli impatti delle iniziative avviate.
Particolarmente importante è la condivisione delle best practice: CITIES+ funziona come un collettore di esperienze di successo, permettendo la loro replica in contesti simili e l’adattamento alle specificità locali.
b. Innovation lab: sperimentare per innovare
La seconda dimensione di CITIES+ è quella di laboratorio di innovazione, dove le soluzioni identificate vengono sperimentate in contesti reali, con un approccio di co-progettazione che coinvolge attivamente le comunità locali. Questo permette di adattare modelli internazionali di successo alle specificità italiane e di sviluppare prototipi scalabili che possano essere poi implementati su scala più ampia.
L’innovation lab opera secondo il principio “think global, act local”, combinando gli standard più avanzati a livello internazionale con le peculiarità dei territori italiani.
c. Capacity builder: formare per trasformare
La terza dimensione, quella di capacity builder, è forse la più importante per assicurare la sostenibilità dell’iniziativa nel lungo periodo. CITIES+ investe nella formazione di amministratori e operatori sanitari, nello sviluppo di competenze digitali territoriali e nella creazione di partnership pubblico-private che possano garantire continuità ai progetti avviati.
L’obiettivo è creare un ecosistema di competenze diffuse che permetta ai territori di gestire autonomamente la propria trasformazione digitale, superando la logica dell’intervento calato dall’alto.
Gli impatti attesi di CITIES+ sono ambiziosi ma misurabili. Sul fronte della salute, si prevede un incremento di 0,07 QALY (Quality-Adjusted Life Years) per paziente/anno, un indicatore che misura l’aumento della qualità della vita correlata alla salute.
Sul piano dell’efficienza del sistema sanitario, l’obiettivo
è una riduzione del 30% degli accessi impropri al pronto soccorso, con un conseguente risparmio economico e un miglioramento della qualità dell’assistenza per i casi realmente urgenti.
Particolarmente significativi gli obiettivi relativi all’aderenza terapeutica, che si prevede di aumentare del 40%, e alla partecipazione ai programmi di prevenzione, con un incremento atteso del 25%. Questi risultati, oltre al valore in termini di salute pubblica, comporterebbero un significativo risparmio per il sistema sanitario nazionale, stimabile in centinaia di milioni di euro all’anno.
Conclusioni
CITIES+ si configura quindi come un integratore di sistema, un catalizzatore di innovazione e un garante di sostenibilità, capace di trasformare il digital divide da problema in opportunità per la sanità italiana. La sfida è complessa e richiede un approccio sistemico, che CITIES+ sta sviluppando grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche, mondo accademico e settore privato. Il digital divide nelle aree interne, nelle comunità montane e nelle isole minori rappresenta certamente una criticità, ma offre anche l’opportunità di ripensare completamente il modello di assistenza sanitaria, rendendolo più equo, efficiente e centrato sul paziente.
Se sapremo cogliere questa opportunità, il digital divide potrà trasformarsi da fattore di esclusione a motore di innovazione, contribuendo a costruire un sistema sanitario più equo e sostenibile per tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal luogo in cui vivono. La trasformazione digitale della sanità non è solo una questione tecnologica ma una sfida culturale e sociale che richiede l’impegno di tutti gli attori coinvolti. CITIES+ è pronta a raccogliere questa sfida, per costruire insieme un’Italia digitalmente inclusiva, dove la tecnologia sia al servizio della salute di tutti.

Ranieri Guerra, Direttore Generale CITIES+
L’urbanizzazione sta ridefinendo la nostra esistenza, trasformando il concetto stesso di salute e benessere. Le statistiche epidemiologiche non sono banali numeri, ma rappresentano la cartografia di un cambiamento globale, rivelando l’evoluzione delle malattie in un’era dominata dalle metropoli.
Le città non sono più semplici aggregati di edifici e infrastrutture, ma ecosistemi viventi che respirano, si adattano e si trasformano, influenzando profondamente la nostra biologia, genetica e traiettorie di salute. Dietro questa metamorfosi si cela una rivoluzione tecnologica e concettuale che ridisegna il nostro rapporto con gli spazi urbani, l’ambiente e la salute collettiva.
Le malattie cardiovascolari, che oggi rappresentano il 31% dei decessi globali, non sono più considerate un problema individuale, ma l’espressione di un ecosistema urbano malato. L’interconnessione tra stili di vita, ambiente costruito e genetica rivela una complessità che va ben oltre il singolo episodio clinico. Il cancro, che copre il 16% della mortalità mondiale, sta rivelando nuove geografie delle patologie. La correlazione diretta con l’inquinamento ambientale e gli stress urbani cronici trasforma questa malattia in un indicatore di squilibri sistemici più profondi. I disturbi neurodegenerativi, che colpiscono oltre 50 milioni di persone, rappresentano l’emergenza silenziosa delle metropoli contemporanee. L’intreccio tra inquinamento ambientale, stress cronico, isolamento sociale e accelerazione dei ritmi urbani sta ridisegnando le mappe della salute mentale. Il diabete, che interessa 463 milioni di adulti, non è più solo una malattia metabolica, ma un complesso indicatore di trasformazioni sistemiche: alimentazione industriale, sedentarietà urbana e modificazioni genetiche indotte dall’ambiente si intrecciano in un ecosistema di malattia. La diabesità, che incrocia due patologie dominanti come diabete e obesità ne è l’espressione più emblematica.
Il cambiamento climatico: innesco nascosto
I numeri parlano chiaro: aumento di temperatura di 1,1°C dal 1880, innalzamento dei mari di 3,4 mm all’anno, eventi climatici estremi aumentati del 300% negli ultimi cinquant’anni. Questi non sono solo dati, ma meccanismi di trasformazione profonda che richiedono un’analisi dettagliata.
Modificazione degli habitat: gli ecosistemi terrestri stanno subendo trasformazioni radicali. Le zone climatiche si spostano, alterando profondamente gli equilibri biologici. Foreste tropicali si riducono, deserti avanzano, e le catene alimentari si ridistribuiscono in modi imprevedibili, con conseguenze dirette sulla salute umana e sul benessere degli ecosistemi.
Alterazione dei cicli biologici: i ritmi naturali che hanno scandito la vita sul nostro pianeta per millenni stanno cambiando. Le stagioni perdono i loro confini tradizionali, i cicli riproduttivi delle specie si modificano, e i meccanismi di adattamento biologico vengono messi a dura prova. Questo squilibrio ha conseguenze dirette sulla salute umana, modificando la distribuzione di malattie e vettori.
Ridistribuzione dei vettori di malattia: le zanzare che trasmettono la malaria, le zecche portatrici di malattie come la Lyme, gli insetti che veicolano virus stanno espandendo i loro habitat tradizionali. Regioni un tempo considerate sicure diventano zone a rischio, con un impatto drammatico sulla salute pubblica globale.
Stress ambientale sugli ecosistemi urbani: le malattie non sono più fenomeni isolati, ma manifestazioni di squilibri ecosistemici, dove le città diventano laboratori di adattamento forzato. L’effetto isola di calore urbano, l’inquinamento atmosferico, la pressione antropica sugli ecosistemi creano nuove forme di stress ambientale che modificano profondamente la resilienza degli insediamenti umani.
Qualcosa, tuttavia, si innova per promuovere, ancora timidamente, un adattamento progressivo:
a Rotterdam si progetta architettura galleggiante:
• Edifici progettati per convivere con l’innalzamento dei mari
• Investimento: €250 milioni
• Riduzione rischi idrogeologici: 65%
a Singapore si investe in infrastruttura verde intelligente:
• Sistemi di raccolta e riciclo dell’acqua
• Copertura verde urbana: +30%
• Riduzione temperature urbane: 2-3°C
e a Copenaghen si traghetta verso una mobilità a zero emissioni:
• 62% degli spostamenti in bicicletta
• Riduzione CO2: 40% dal 2005
• Obiettivo: Prima capitale neutrale entro il 2025
Architettura degli investimenti: economia della trasformazione
Servono ormai nuovi paradigmi che devono inquadrarsi in una visione sistemica, riorientare gli investimenti con un approccio preventivo possibile avvalendosi di tecnologie integrate, perché la sfida vera delle nostre città non è curare, ma rigenerare ecosistemi di benessere. Il futuro si costruisce con investimenti strategici, comprendendo che la trasformazione delle città non è una spesa, ma una polizza di resilienza, salute pubblica e sostenibilità ambientale.
Le proiezioni indicano che il mercato delle smart cities raggiungerà i 12 trilioni di euro entro il 2032, con un tasso di crescita del 1100%. Attualmente, USA e Canada guidano l’innovazione tecnologica, mentre la Cina registra la crescita più rapida, seguita dall’Europa che rappresenta il 25% degli investimenti globali. Il costo della trasformazione urbana include infrastrutture tecnologiche per un valore compreso tra 425 e 650 milioni di euro, costi operativi annuali tra 65 e 105 milioni e un budget per ricerca e sviluppo tra 50 e 75 milioni.
Questi investimenti sono giustificati da un impatto economico annuale positivo. Il risparmio sanitario derivante da una migliore gestione ambientale e da sistemi di prevenzione avanzati è stimato tra 700 e 980 milioni di euro, mentre la maggiore produttività generata da un ambiente più sano e funzionale potrebbe tradursi in un incremento economico di 360-540 milioni di euro. I benefici degli interventi preventivi, infine, ammontano a 290-460 milioni all’anno. Il ritorno
sull’investimento stimato, con un beneficio annuale di €1,35-1,98 miliardi, è tra il 300 e il 400%, dimostrando che le smart cities non sono solo un’esigenza ambientale e sanitaria, ma anche un’opportunità economica senza precedenti.
Anatomia di una rivoluzione tecnologica
L’adozione di tecnologie avanzate sta ridefinendo il rapporto tra città e salute. A Milano, la rete di sensori urbani ha ridotto l’inquinamento del 12%, con un investimento di 40 milioni di euro. A Bolzano, la mobilità elettrica ha permesso una riduzione del 25% delle emissioni di CO2, mentre Singapore, attraverso il progetto “Smart Nation”, ha ridotto del 20% l’incidenza delle malattie respiratorie grazie al monitoraggio integrato della qualità dell’aria e delle risorse idriche.
Parallelamente, la previsione sanitaria personalizzata sta rivoluzionando la medicina preventiva. La profilazione genomica avanzata, l’intelligenza artificiale predittiva e l’analisi dei big data sanitari permettono di anticipare le malattie e intervenire prima che si manifestino. Il progetto AI-Health di Boston ha dimostrato che è possibile identificare segni precoci di malattie neurodegenerative con 5-7 anni di anticipo rispetto ai metodi tradizionali, aprendo la strada a trattamenti più efficaci e meno invasivi.
Immaginiamo adesso una replica digitale perfetta di una città, capace di simulare ogni respiro, movimento e flusso. I gemelli digitali rappresentano più di una tecnologia: sono un nuovo paradigma di comprensione e gestione urbana e rappresentano la prossima frontiera nella gestione delle città intelligenti. Grazie all’uso di sensori Internet of Things (IoT), machine learning e modellazione 3D avanzata, le amministrazioni urbane possono simulare scenari futuri, ottimizzare le infrastrutture e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il costo di realizzazione varia da 15-30 milioni di euro per le piccole città, fino a 150-300 milioni per le metropoli, con risparmi stimati che includono un’ottimizzazione delle infrastrutture tra il 20 e il 35% e una riduzione dei costi di manutenzione tra 25 e 50 milioni di euro all’anno. In base alla simulazione di scenari complessi, si promuove una pianificazione preventiva basata su dati e evidenze che permette la gestione e la mitigazione dei rischi ambientali con l’ovvia ottimizzazione delle risorse che vengono investite in maniera ragionata con prospettive di successo che la simulazione riesce a garantire con approssimazione molto elevata. L’impatto sociale che ne deriva si traduce in un miglioramento della qualità di vita e della resilienza urbana.
L’integrazione dei gemelli digitali non riguarda solo la
gestione infrastrutturale, ma incide profondamente sul trinomio “health, wellness & happiness”. L’uso dell’intelligenza artificiale e della simulazione avanzata permette di creare ambienti urbani più vivibili, riducendo il traffico, ottimizzando la gestione dei rifiuti e migliorando la qualità dell’aria. L’influenza di queste tecnologie si riflette direttamente sul benessere psicologico e sulla percezione della felicità dei cittadini, riducendo lo stress derivante da congestione, inquinamento e inefficienze urbane. I fattori chiave della felicità urbana sono stati identificati nell’ultimo rapporto globale sulla felicità legati alla connettività, alla qualità degli spazi pubblici, all’accessibilità dei servizi e alla sostenibilità ambientale.
Nel cuore di Singapore, un gemello digitale nazionale traccia un percorso rivoluzionario. Oltre 70.000 sensori distribuiti capillarmente raccolgono dati in tempo reale, trasformando la città in un organismo tecnologicamente consapevole. Gli algoritmi di machine learning processano milioni di input al secondo, generando scenari predittivi con un’accuratezza superiore al 90%.
I risultati sono straordinari:
• riduzione dei consumi energetici del 22%
• ottimizzazione dei flussi di traffico
• previsione di rischi ambientali con precisione millimetrica
Nell’olandese Rotterdam, il gemello digitale diventa uno strumento di sopravvivenza. La città ha modellizzato gli scenari di innalzamento marino, progettando infrastrutture che si adattano dinamicamente ai cambiamenti climatici. Un investimento che ha già fatto risparmiare 500 milioni di euro in interventi preventivi.
A New York, i ponti non sono più solo strutture passive, ma organismi monitorati in tempo reale. Il gemello digitale analizza ogni vibrazione, ogni stress strutturale, prevenendo potenziali collassi e riducendo i costi di manutenzione del 35%.
Una delle innovazioni più promettenti nel contesto delle smart cities è l’iniziativa Breath Cities , un progetto che mira a migliorare la qualità dell’aria e il benessere dei cittadini attraverso una combinazione di tecnologie avanzate e strategie urbanistiche sostenibili. Questo programma integra sistemi di purificazione dell’aria, utilizzo di superfici bioattive in grado di assorbire inquinanti, e un network di intelligenza artificiale per il monitoraggio in tempo reale della qualità atmosferica. Breath Cities è stato implementato con successo in città come Londra, Tokyo e Stoccolma, dove i primi risultati mostrano una riduzione significativa dei livelli di PM2.5 e NO2 nelle aree urbane più
trafficate. La combinazione di pareti verdi, infrastrutture urbane eco-compatibili e tecnologie di purificazione attiva rende questo approccio replicabile e scalabile per molte altre metropoli.
Trasformazione urbana globale
Dalla smart city al 2025 di Singapore alla trasformazione di Tokyo entro il 2030, assistiamo a una rivoluzione globale. I fattori chiave che sono comuni alle due esperienze pilota sono:
• Investimenti tecnologici mirati
• Volontà politica di cambiamento
• Infrastrutture digitali all’avanguardia
• Sostenibilità ambientale come priorità
Tuttavia, non dimentichiamo che il nostro pianeta sta attraversando una metamorfosi epocale. Le zone climatiche si spostano come placche tettoniche invisibili. Foreste tropicali si riducono, deserti avanzano, e le catene alimentari si ridistribuiscono in modi imprevedibili. Non si tratta solo di cambiamenti geografici, ma di una ridefinizione profonda degli equilibri biologici. Questo significa, ad esempio, che a Mumbai il 40% del territorio sarà potenzialmente sommerso entro il 2050, che a Miami il rischio di allagamento permanente si estende al 30% dell’area urbana, mentre Jakarta è già parzialmente sommersa, e l’Indonesia è costretta a progettare il trasferimento della capitale.
Questi non sono scenari apocalittici, ma proiezioni scientifiche che richiedono un’azione immediata e sistemica.
Le città tradizionali stanno diventando trappole sistemiche con quattro indicatori comuni:
• sovraffollamento che genera stress sociale
• inquinamento atmosferico che compromette la salute
• sistemi sanitari saturi
• migrazione forzata come nuova forma di emergenza globale
Il costo umano è drammatico: perdita di produttività, crescita esponenziale dei costi sanitari, frammentazione sociale. Per questi motivi, ancora poco esplorati e discussi nei Think-tank tradizionali e nelle associazioni di cittadini, oltre che dalla politica mainstream, le città intelligenti non sono un lusso tecnologico, ma l’unica risposta praticabile alle sfide globali. Parliamo di investimenti significativi:
• 425-650 milioni di euro in infrastrutture
• 65-105 milioni di costi operativi annuali
• 50-75 milioni in ricerca e sviluppo
Ma questi numeri raccontano solo una parte della sto-
ria giacché i fattori chiave per la trasformazione sono un’aggregazione virtuosa di volontà politica e capacità di investimento verso una sostenibilità che richiede tempi medi di trasformazione di almeno 10-15 anni.
Ecco i principali agglomerati urbani globali con potenziale di trasformazione in smart city, con una proiezione temporale di sviluppo (e l’Italia?):
Asia-Pacifico:
1. Singapore: Già leader (completamento entro 2025)
2. Tokyo: Trasformazione completa entro 2030
3. Shanghai: Sviluppo completo entro 2035
4. Seoul: Implementazione avanzata entro 2032
5. Mumbai: Trasformazione parziale entro 2040
Nord America:
1. New York: Completamento entro 2030
2. San Francisco: Già parzialmente smart, completamento entro 2028
3. Toronto: Trasformazione completa entro 2035
4. Chicago: Implementazione avanzata entro 2032
Europa:
1. Amsterdam: Già smart city, completamento entro 2025
2. Copenaghen: Trasformazione completa entro 2030
3. Barcellona: Implementazione avanzata entro 2035
4. Londra: Completamento entro 2035
5. Stoccolma: Smart city entro 2028
Medio Oriente:
1. Dubai: Leader tecnologico, completamento entro 2025
2. Tel Aviv: Trasformazione completa entro 2030
America Latina:
1. San Paolo: Sviluppo parziale entro 2035
2. Buenos Aires: Implementazione avanzata entro 2037
Dimensioni etiche: oltre la tecnologia
La vera sfida non è però solo tecnologica, bensì, principalmente, etica e si articola su versanti molteplici:
Protezione della privacy: non si tratta solo di proteggere dati personali, ma di salvaguardare l’autonomia individuale in un mondo sempre più connesso. Le città intelligenti raccolgono migliaia di informazioni ogni secondo: dal movimento dei cittadini ai loro consumi
energetici, dai pattern di salute alle abitudini quotidiane. La sfida è trasformare questi dati in strumenti di miglioramento della vita, non in mezzi di controllo sociale.
Equità di accesso tecnologico e superamento del digital divide: l’innovazione non deve creare nuove forme di segregazione. Mentre alcune aree urbane si trasformano in ecosistemi tecnologicamente avanzati, altre rischiano di rimanere indietro. L’obiettivo è garantire che i benefici delle smart cities siano democraticamente distribuiti, superando i divari sociali, economici e geografici.
Mitigazione dei bias algoritmici: gli algoritmi non sono neutri. Possono replicare e amplificare pregiudizi inconsci presenti nei dati di training. Nella progettazione di sistemi di intelligenza artificiale per le città, è cruciale sviluppare meccanismi di verifica e correzione che garantiscano decisioni eque e non discriminatorie.
Trasparenza del consenso informato: i cittadini devono essere non solo informati, ma coinvolti attivamente nelle scelte che riguardano la loro città. Il consenso informato va oltre la semplice firma di un documento: significa creare spazi di dialogo, comprensione e partecipazione democratica alle scelte tecnologiche.
Conclusione: danzare con il cambiamento
Le città intelligenti non sono un destino tecnico, ma una scelta collettiva, una trasformazione sociale e culturale. Siamo di fronte a una trasformazione che va oltre la tecnologia: stiamo ridisegnando il nostro rapporto con gli spazi urbani, con l’ambiente, con noi stessi. La visione prospettica è chiara: città che non siano semplici contenitori tecnologici, ma ecosistemi viventi in grado di adattarsi, apprendere e prosperare insieme ai loro abitanti. Il vero obiettivo non è solo quello di costruire città più efficienti, ma di creare spazi urbani sani, sostenibili e inclusivi, in cui la tecnologia diventi un mezzo per migliorare la qualità della vita, senza mai sostituire il valore insostituibile delle relazioni umane e dei legami sociali, che la vita urbana spesso distrugge.
Il futuro si costruisce non difendendosi dal cambiamento, ma imparando a danzare con esso.

di Simone Aureli
Dalla scienza alle istituzioni l’appello di un “Patto per la salute e il benessere delle città”. Oltre 100 realtà scientifiche riunite in un’alleanza innovativa promossa da Health City Institute, con l’obiettivo di mettere al centro la salute come bene comune e affrontare le sfide dell’urbanizzazione.
È nata lo scorso 4 Dicembre , promossa da Health City Institute, l’alleanza Science for Cities tra oltre 100 qualificati e riconosciuti soggetti scientifici, che si pone l’obiettivo di promuovere politiche e soluzioni innovative per affrontare le sfide sociali legate alla salute e al benessere nelle città moderne, valorizzando il ruolo della Scienza, e delle società ed enti scientifici, in un lavoro comune per la promozione della salute nelle città. La salute, infatti, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, è al centro dell’impegno dell’innovativa alleanza, che punta a migliorare la qualità della vita urbana in modo sostenibile e inclusivo, attraverso una fattiva azione sui determinanti sociali nelle aree urbane. L’alleanza Science for Cities è stata presentata in Senato in un evento su iniziativa della Sen. Daniela Sbrollini, alla presenza di esperti e rappresentanti delle istituzioni, durante il quale è stato lanciato il “Patto per la salute e il benessere delle città”, rivolto da Science for Cities alle istituzioni, ai sindaci e a tutti i soggetti chiamati a prendere decisioni sulle città e per il benessere delle comunità. Un patto che richiama l’attenzione sull’urgente necessità di un cambiamento fondamentale nel nostro approccio complessivo per giungere a un mondo in cui l’umanità viva in armonia con la natura e costruisca comunità e città sostenibili e resilienti.
«L’interconnessione e la collaborazione sono gli ingredienti fondamentali per progredire nel campo della sostenibilità e della qualità della vita - ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini - È un processo che deve costruirsi mediante l’impegno di tutte le discipline scientifiche e di tutti gli attori, quali istituzioni, imprese, cittadini. Ecco perché
l’università cerca di offrire diversificazione nell’offerta formativa degli studenti e, anche tramite i moderni campus, un modo di vivere diverso, puntando sul verde, sul digitale e sulla rigenerazione urbana.
Questo viaggio deve iniziare dai protagonisti del cambiamento, dal punto di vista del MUR gli studenti, che saranno gli attori e i cittadini del futuro.»
«L’urbanizzazione è una delle maggiori sfide del nostro tempo rispetto alla salute delle comunità e degli individui, dobbiamo affrontarla con tutti gli strumenti a disposizione, in un approccio globale, e in questo contesto l’alleanza del mondo della scienza riunito in Science for Cities costituisce una risorsa unica e innovativa. Il fenomeno della grande urbanizzazione va conciliato con il diritto di ogni cittadino a una vita sana e integrata nel proprio contesto urbano. Occorre incoraggiare gli stili di vita sani nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie e ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, favorendo così lo sviluppo psicofisico dei giovani e l’invecchiamento attivo. Questo significa promuovere un assetto One Health, ovvero un approccio che tiene conto delle connessioni tra salute umana, animale e ambientale considerando tutti i rischi per la salute umana, e in questo quadro l’alleanza con la scienza rappresenta un apporto imprescindibile», ha sottolineato la Sen. Daniela Sbrollini, Vice Presidente della 10a Commissione permanente del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e co-Presidente Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città.
Science for Cities si ispira all’indicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che considera la salute un “bene comune”. Oltre la metà della popolazione mondiale vive oggi negli ambienti urbani. Le città contribuiscono per il 70 per cento alle emissioni globali di carbonio e per oltre il 60 per cento all’uso delle risorse. In Italia circa il 37 per cento della popolazione vive nelle aree metropolitane. In questo
contesto, sono proprio gli ambienti urbani ad avere un ruolo primario nella tutela della salute pubblica. Se, infatti, l’inurbamento e l’urbanizzazione sono responsabili dell’aumento delle malattie croniche non trasmissibili come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e molti tumori, la pianificazione urbana consapevole e inclusiva e la sinergia e comunità d’intenti tra istituzioni, accademia e società civile possono trasformare le aree urbane in ambienti più sani e resilienti. Obiettivo di Science for Cities è quello di fare proprie le proposte emerse nel Pact for the Future sottoscritto dall’Assemblea delle Nazioni Unite lo scorso 20 settembre, e traslarle nelle nostre città e negli ambienti dove viviamo e agiamo, proponendo e realizzando un “Patto per la salute e il benessere delle città”. Siamo in un momento di profonda trasformazione globale e siamo chiamati a confrontarci con crescenti rischi catastrofici ed esistenziali, molti dei quali causati dalle scelte che facciamo in tema di sostenibilità degli ambienti in cui viviamo, in primo luogo città e centri urbani. Urge un cambio di rotta: i progressi nella conoscenza e nel sapere, nella scienza, nella tecnologia e nell’innovazione potrebbero offrire una svolta verso un futuro migliore e più sostenibile per tutti. La scelta spetta a tutti noi, istituzioni, scienziati, cittadini e assieme dobbiamo trovare sinergie per investire e costruire il futuro delle nostre città. Attraverso azioni concrete e sinergie, le realtà scientifiche riunite in Science for Cities si impegnano per avere città giuste, eque, inclusive, sostenibili e in prosperità, un mondo in cui benessere, salute, assistenza sanitaria e dignità siano assicurati a tutti i cittadini.
«È essenziale sviluppare una roadmap che affronti la relazione tra urbanizzazione e salute, in linea con le raccomandazioni dell’OMS e con il Pact for the Future dell’ONU - ha detto Andrea Lenzi, Coordinatore di Science for Cities, Presidente CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente di Health City Institute - L’obiettivo è aumentare la consapevolezza riguardo ai rischi per la salute legati all’urbanizzazione, promuovendo azioni concrete e politiche governative mirate. La roadmap dovrà affrontare l’esposizione a fattori ambientali come inquinamento e gestione dei rifiuti, che aumentano i rischi per la salute urbana. Inoltre, dovrà individuare azioni per ridurre le disparità e garantire a tutti i cittadini una vita sana. L’Italia ha l’opportunità di guidare lo studio su questi temi, favorendo la collaborazione tra istituzioni, enti locali, università e esperti per evitare approcci settoriali e frammentati.»
Forte della collaborazione con Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Comitato nazionale per la
biosicurezza le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del consiglio, ANCI, CITIES+, università, imprese, organizzazioni di cittadinanza e del terzo settore e numerose altre istituzioni pubbliche e private, Science for Cities vuole creare un ambiente di collaborazione tra tutte le realtà coinvolte con lo scopo di sviluppare e implementare soluzioni concrete che affrontino le problematiche urbane, proponendosi di agire come punto di riferimento per le politiche urbane che pongano la salute come obiettivo primario.
Unanime il consenso degli intervenuti: il futuro delle città passa anche dalla consapevolezza che la salute è un bene comune da tutelare e promuovere attraverso azioni concrete, integrate e multidisciplinari.
«Le aree interne e montane rappresentano contesti profondamente diversi dalle realtà metropolitane, caratterizzati da specifiche caratteristiche che, viste in chiave di opportunità, richiedono opportuni interventi mirati. - ha dichiarato il Sen. Guido Quintino Liris, Presidente Intergruppo parlamentare per la Prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne marginali, le aree montane e le isole minori – Proprio queste peculiarità, infatti, offrono un’opportunità unica: affrontare le sfide di questi territori consente di individuare e sviluppare soluzioni innovative per contrastare alcuni effetti negativi dell’isolamento geografico. In questo senso, tali aree possono diventare veri e propri laboratori per innovare verso nuovi approcci in tema di salute e benessere, su aspetti cruciali come la prossimità dei servizi socio-sanitari, la gestione dell’invecchiamento demografico, la lotta all’isolamento e le dinamiche di spopolamento. Il Patto proposto oggi dalla comunità scientifica riunita in Science for Cities rappresenta una preziosa occasione per integrare conoscenza e azione in queste aree. Sta a noi, come rappresentanti delle istituzioni, della politica e delle amministrazioni locali, raccogliere questa sfida, ponendo tali tematiche al centro dell’agenda politica e trasformandole in iniziative concrete e sostenibili per il benessere delle comunità».
Il Sen. Mario Occhiuto, co-Presidente Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città ha parlato della rigenerazione urbana, tema sul quale ha presentato un Ddl a sua firma: «Una città a misura d’uomo è una città che pone al centro il benessere dei cittadini, e questo significa garantire loro non solo accesso a servizi sanitari di qualità, ma anche a spazi pubblici salutari, sicuri e inclusivi. In ambito sanitario, significa adottare politiche integrate che promuovano la prevenzione, l’accesso a cure di qualità e il miglioramento dell’ambiente urbano, affinché ogni persona possa godere di una vita sana. Oggi bisogna puntare a modelli di rigenerazione urbana come nuovo processo, multidimensionale e in-
tegrato di intervento progettuale nel recupero delle città non solo dal punto di vista urbanistico ma che abbia un impatto positivo sul benessere delle città. In questo scenario, l’apporto della scienza rappresenta un contributo fondamentale, ed è per questo che la nuova grande alleanza che nasce oggi costituisce un’importante svolta nell’affrontare le problematiche dell’urbanizzazione in chiave costruttiva».
Infine, l’on. Roberto Pella, Vice Presidente di ANCI, membro della 5a Commissione permanente della Camera (Bilancio, tesoro, programmazione) e co-Presidente Intergruppo Parlamentare Qualità di Vita nelle Città, Vice Presidente ANCI, ha evidenziato l’importanza della nuova figura professionale dell’health city manager: «Nel 2022, promosso da Anci, è stato avviato un percorso di formazione a tappe per la figura dell’health city manager, che proseguirà anche quest’anno e negli anni venturi. Un progetto importante, che è stato inserito tra i cinque case study a livello mondiale nel report Health Inclusivity Index, sviluppato da Economist Impact e dall’University College of London. A seguito di questo percorso, abbiamo visto un’adozione crescente di questa figura nelle città italiane. Ci sono stati alcuni esempi concreti di applicazione di questo profilo, come ad esempio nei comuni che hanno avviato progetti di mobilità sostenibile e di promozione della salute pubblica. Un’esperienza che prosegue con il nuovo percorso di alta formazione in “Sport and Health City Manager”, che costituirà un’opportunità per altri 40 giovani partecipanti. Il futuro dell’health city manager è promettente, poiché le città si rendono conto che la gestione della salute e del benessere urbano richiede figure specializzate.»

di Simone Aureli
Il Prof. Andrea Lenzi, Presidente di Health City Institute (HCI), è il nuovo Portavoce della Rete delle Cattedre UNESCO Italiane (ReCUI) per il mandato 2025-2027. L’elezione del Prof. Lenzi, che riveste, accanto al ruolo di Presidente di HCI, quelli di Direttore della UNESCO Chair “Urban Health Through Education and Research for improved health and Wellbeing in the cities” dell’Università di Roma la Sapienza e Professore Emerito di Endocrinologia - Dipartimento di Medicina sperimentale della stessa Università, e di Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolta nei giorni scorsi in occasione del convegno annuale della Rete delle Cattedre UNESCO Italiane, tenutasi presso il Rettorato dell’Università di Roma la Sapienza, alla presenza del Ministro per l’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini. Il Prof. Lenzi subentra nel ruolo di Portavoce della ReCUI al Prof. Patrizio Bianchi, ex Ministro dell’Istruzione.
La Rete delle Cattedre UNESCO Italiane si inserisce in un network globale, lanciato nel 1992, di cui fanno parte oltre 1000 Cattedre in 125 Paesi presenti nel mondo (Programma UNITWIN/UNESCO Chairs).
Le Cattedre UNESCO sono programmi istituiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) con l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale tra università e centri di ricerca su temi di grande rilevanza globale, come l’istruzione, la cultura, la sostenibilità, il benessere e la salute. Attraverso un approccio multidisciplinare, queste cattedre favoriscono la condivisione di conoscenze, la formazione e lo sviluppo di progetti innovativi per affrontare le sfide globali e locali.
In Italia, le Cattedre UNESCO sono coordinate dalla ReCUI, un organismo che riunisce le istituzioni accademiche italiane impegnate nella promozione degli obiettivi dell’UNESCO. La ReCUI lavora per rafforzare la collaborazione tra le diverse cattedre, valorizzare il loro impatto sulla società e facilitare il dialogo tra università, istituzioni pubbliche e organizzazioni inter-
nazionali. Tra i suoi principali obiettivi vi sono la promozione della cultura, della salute e del benessere, elementi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale. Grazie a questa rete, l’Italia contribuisce attivamente alla diffusione delle buone pratiche e delle conoscenze accademiche nel panorama internazionale, con un forte focus sull’educazione di qualità, l’innovazione scientifica e la tutela del patrimonio culturale e naturale.
«È sempre più importante e urgente rafforzare il ruolo della multilateralità e delle cooperazione internazionale, cui le Cattedre UNESCO nel mondo contribuiscono per un futuro dell’educazione che possa essere sempre più al servizio della pace - dichiara il Prof. Andrea Lenzi, nuovo Portavoce ReCUI - Sono onorato del compito conferitomi ed esprimo un ringraziamento alla Rete italiana per avermi eletto a Portavoce, un ruolo che svolgerò con il massimo impegno nel solco di quanto Patrizio Bianchi, con merito e con passione, ha plasmato in questi anni di intenso lavoro».

Quale è il significato delle Cattedre UNESCO e della Rete Italiana?
Le Cattedre UNESCO hanno nel loro DNA la cooperazione internazionale con mission principali l’Educazione e la Formazione, la Scienza e la Cultura come strumenti di Pace e con focus sui temi di maggiore impatto a partire dalla sostenibilità dello sviluppo, al confronto pacifico fra i popoli attraverso strumenti quali la trans-disciplinarietà.
La Rete delle cattedre UNESCO Italiane (ReCUI) si inserisce in un network globale, lanciato nel 1992, di cui fanno parte molte centinaia di Cattedre in 125 Paesi presenti nel mondo (Programma UNITWIN/UNESCO Chairs). La Rete che raggruppa le 44 Cattedre italiane, nasce dapprima come luogo spontaneo di confronto e dibattito, “I Dialoghi delle Cattedre Unesco”, per poi costituirsi in un’associazione che ha inteso riconoscere e sottolineare il valore della multidisciplinarietà e l’importanza della cooperazione trasversale fra tutti gli ambiti coinvolti. Per questa ragione il Ministro Bernini ha consegnato alla ReCUI il Sigillo di merito, conferito con suo decreto dello scorso 6 marzo 2024, quale segno distintivo a dimostrazione dell’impegno profuso nel predisporre programmi volti a rispondere prontamente e con maggiore autonomia alle rinnovate richieste di nuovo apprendimento e ricerca in un mondo in rapido cambiamento economico, sociale e tecnologico.
In che modo la Rete delle Cattedre UNESCO Italiane (ReCUI) intende favorire la diffusione della cultura come strumento di benessere e sviluppo sostenibile in Italia?
La ReCUI potenzia e sviluppa relazioni nazionali e internazionali ogni giorno, partecipando unitariamente, proprio grazie alla forza della Rete che abbiamo costituito, ai principali eventi in materia di educazione,
scienza, cultura della pace, tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale. La Cattedra UNESCO che presiedo, altresì, ha sviluppato una piattaforma di educazione, alfabetizzazione, health literacy e formazione rivolta a gruppi specifici: educatori e maestri, famiglie, ricercatori e medici, enti pubblici e amministratori, con l’ambizione di diffondere, attraverso uno strumento gratuito e semplice, la cultura della salute attraverso esperti.
Quali sono le principali iniziative che ReCUI sta portando avanti per promuovere il legame tra istruzione, cultura, salute, benessere in linea con le direttive dell’UNESCO?
Abbiamo partecipato al trentennale delle Cattedre UNESCO a Parigi rilanciando i contenuti propri dei temi della salute e del benessere nei contesti urbani, affinché siano inseriti in misura crescente nei programmi e nei mandati dell’Agenzia ONU, chiedendo una maggiore centralità degli stessi, in coordinamento con l’OMS.
Tutte le Agenzie legate all’ONU, compresa l’UNESCO, attribuiscono grande valore al concetto di “salute globale” e benessere sociale. Quali strategie concrete possono essere adottate dalle università italiane e dalle Cattedre UNESCO per integrare questi principi nei loro programmi accademici e di ricerca?
Gli Atenei sono luoghi sempre più permeabili, spazi aperti per promuovere studi, analisi e confronti sui temi prioritari per il Paese e per la cooperazione internazionale. Il significato di un Ateneo aperto sta nello sviluppare una maggiore capacità di formare professionisti e cittadini che potranno incidere in maniera positiva sulla qualità della vita della collettività e sui
luoghi che abitano. In questo contesto le Cattedre UNESCO attivano formazione multidisciplinare, stimolando il confronto a livello globale, per sviluppare competenze e conoscenze ma anche abilità in grado di intercettare i bisogni di salute e benessere delle comunità in cui insistono e accompagnarle in un percorso di sviluppo. Ad esempio, la Cattedra sull’Urban Health che presiedo é parte del Master, recentemente attivato presso la SASS Sapienza, proprio sui temi One Health aperto a profili provenienti da tutte le classi di laurea.
Qual è il ruolo della collaborazione tra le Cattedre UNESCO e le istituzioni nazionali e internazionali nella promozione di politiche pubbliche che migliorino la qualità della vita e la salute della popolazione?
Le attività della ReCUI sono naturalmente sottoposte all’attenzione del Ministro dell’Università della Ricerca e dell’Università e del MAECI, proprio perché funzionali al perseguimento degli obiettivi della cooperazione internazionale. Più recentemente, la Rete é entrata a far parte dei soggetti che si occuperanno attivamente di conseguire i traguardi previsti dal Piano Mattei, attraverso gli investimenti stanziati dal Governo.
Guardando al futuro, quali sono le sfide principali che RECUI dovrà affrontare per garantire che il patrimonio culturale, la pace, la salute e il benessere restino al centro delle agende accademiche e istituzionali in Italia?
Il periodo che stiamo vivendo ci impone una riflessione importante rispetto all’urgenza e alla necessità di promuovere e trovare la pace attraverso attività concrete e costanti. La ReCUI, in questo senso, si appresta, con il nuovo mendato biennale, a mettere al centro proprio la trandisciplinarietà e il multilateralismo come strumenti di pace e coesione sociale.



Federico Serra per l’Osservatorio Salute bene comune e il Planetary Health Inner Circle
Negli ultimi mesi, Los Angeles è stata devastata da una serie di incendi senza precedenti, che hanno causato la distruzione di migliaia di edifici e la perdita di vite umane. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulle cause che hanno reso tali incendi così incontrollabili e sulle strategie previste per la ricostruzione della città.
Le cause degli incendi: una tempesta perfetta di fattori
Gli incendi in California non sono una novità, ma la loro frequenza e intensità sono aumentate negli ultimi anni a causa di una combinazione di fattori climatici, ambientali e antropici.
1. I venti di Santa Ana: il combustibile perfetto
Uno dei principali fattori che alimentano gli incendi a Los Angeles sono i venti di Santa Ana, che soffiano dalle regioni desertiche dell’entroterra verso la costa del Pacifico. Questi venti caldi e secchi, con velocità che superano i 100 km/h, non solo favoriscono la propagazione delle fiamme, ma rendono estremamente difficili le operazioni di spegnimento.
Come spiega Daniel Swain, climatologo dell’Università della California, “I venti di Santa Ana possono trasformare un piccolo incendio in una catastrofe in poche ore. Queste condizioni rendono impossibile per i vigili del fuoco contenere le fiamme in modo efficace.” (Los Angeles Times)
2. Siccità estrema e cambiamenti climatici
Un altro fattore chiave è la prolungata siccità che sta colpendo la California. Negli ultimi mesi, Los Angeles ha registrato precipitazioni inferiori alla media, con appena 4 cm di pioggia da ottobre, meno del 20% delle
precipitazioni attese. Questa condizione ha reso la vegetazione estremamente secca e altamente infiammabile.
Secondo un rapporto del California Department of Forestry and Fire Protection (CalFire), “Gli incendi stanno diventando più grandi, più caldi e più distruttivi a causa del cambiamento climatico. La stagione degli incendi non esiste più: oggi bruciamo tutto l’anno.” (CalFire)
3. Urbanizzazione e gestione del territorio
La crescita urbana ha avuto un ruolo determinante nell’aumento del rischio di incendi. Molti nuovi quartieri sono stati costruiti ai margini delle foreste, creando una zona di interfaccia urbano-rurale particolarmente vulnerabile. Inoltre, la gestione inadeguata delle foreste ha portato a un accumulo di materiale infiammabile.
Richard Minnich, esperto di incendi presso l’Università della California, aff erma: “Abbiamo costruito in zone che naturalmente bruciano ogni 20-30 anni. Senza una gestione più attenta, questi incendi diventeranno sempre più devastanti.” ( The Guardian)
L’impatto devastante degli incendi
Gli incendi hanno causato danni senza precedenti:
• Perdite umane: Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 24 morti, con numerosi dispersi.
• Distruzione di proprietà: Oltre 12.000 edifici sono stati distrutti o danneggiati, lasciando più di 150.000 persone senza casa.
• Danni economici: Le stime preliminari parlano OSSERVATORIO

di oltre 150 miliardi di dollari di danni, rendendo questi incendi tra i più costosi della storia statunitense.
Secondo il governatore della California Gavin Newsom, “Ci troviamo di fronte a un disastro senza precedenti. È necessario un intervento straordinario per la ricostruzione della nostra comunità.” (Fortune)
Il piano di ricostruzione: come rinascerà
Los Angeles
Di fronte a questa devastazione, le autorità locali e statali hanno elaborato un ambizioso piano di ricostruzione, con l’obiettivo di rendere la città più sicura e resiliente agli incendi futuri.
1. Snellimento della burocrazia per la ricostruzione
Il governatore Newsom ha firmato un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente alcune parti del California Environmental Quality Act (CEQA), al fine di accelerare la ricostruzione delle case e delle attività distrutte.
“Sono preoccupato per i tempi di realizzazione di questi progetti. Per questo vogliamo eliminare qualsiasi requisito che rallenti la ricostruzione.” - Gavin Newsom (Fortune)
Anche la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha promesso di eliminare gli ostacoli burocratici:
“Dobbiamo abbandonare il solito sistema cittadino e permettere ai cittadini di ricostruire senza inutili ritardi.” (Los Angeles Times)
2. Il “Piano Marshall” per la ricostruzione
Il governatore del la California ha annunciato un “Piano Marshall” per la ricostruzione, coinvolgendo leader locali, imprese, organizzazioni non profit e sindacati.
“Lavoreremo insieme per coordinare le risorse e garantire che ogni cittadino colpito possa ricostruire la propria casa e la propria vita.” - Newsom (Fortune)
3. Investimenti in infrastrutture e prevenzione
Il piano di ricostruzione prevede un investimento di 2,5 miliardi di dollari per ripristinare le infrastrutture danneggiate, comprese strade, marciapiedi, lampioni e reti elettriche.
“Non possiamo limitarci a ricostruire. Dobbiamo ripensare il nostro modo di abitare queste zone, adottando strategie più sicure e sostenibili.” - Karen Bass
Tra le misure di prevenzione previste:
• Creazione di zone cuscinetto tra aree urbane e foreste.
• Adozione di nuovi materiali ignifughi per le abitazioni.
• Aumento degli investimenti in sistemi di allarme e spegnimento automatico.
Le sfide della ricostruzione
Nonostante gli sforzi, la ricostruzione presenta diverse sfide:
1. Tempi lunghi: La ripresa potrebbe richiedere oltre 10 anni, considerando la vastità dei danni.
2. Equità sociale: Le famiglie più povere rischiano di essere escluse dalla ricostruzione senza un adeguato supporto economico.
3. Adattamento al cambiamento climatico: Le future infrastrutture dovranno essere progettate per resistere a incendi sempre più intensi.
Gli incendi di Los Angeles sono il risultato di una tempesta perfetta di fattori climatici, ambientali e urbanistici. La ricostruzione richiederà anni di impegno e miliardi di dollari di investimenti, ma rappresenta anche un’opportunità per ripensare la città in modo più sicuro e sostenibile.
Come ha detto Gavin Newsom:
“Dobbiamo trasformare questa tragedia in un’opportunità per costruire una California più resiliente.”


Dopo due mesi di formazione, si è concluso con la consegna degli attestati presso ANCI il percorso per Sport & Health City Manager, che ha visto coinvolti 24 giovani under 35. Un’iniziativa promossa da ANCI e cofinanziata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di formare nuove figure strategiche per supportare le amministrazioni locali nella promozione della salute e del benessere urbano.
Un percorso formativo di 100 ore che ha portato alla proclamazione dei nuovi Sport & Health City Manager. Si è concluso giorno 25 Febbraio con la consegna degli attestati nella sede ANCI nazionale a Roma, al termine di due mesi intensi di percorso organizzato da ANCI e co-finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del progetto “I giovani per le ‘Città dello Sport e della Salute’”, in collaborazione con HCI – Health City Institute e Sapienza Università di Roma, e con il patrocinio della Cattedra UNESCO sull’Urban Health, Cities+ e Science for Cities.
Il percorso di alta formazione ha visto coinvolti 24 giovani under 35, che hanno ricevuto l’attestato da Roberto Pella, Vicepresidente ANCI e delegato sport, salute, politiche giovanili e aree interne, e Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute. “È stato un corso ben riuscito, dinamico e partecipato, con corsisti che hanno dimostrato impegno e volontà di impegnarsi per il bene comune – ha concluso Roberto Pella -, oltre ad aver manifestato l’interesse per poter vivere esperienze amministrative in futuro. Voglio ringraziare in particolare il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha voluto sostenere e finanziare questo progetto insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale”.
Roberto Pella ha ricordato anche l’importante funzione dello Sport & Health City Manager nell’interazione con le amministrazioni locali: “È una figura importante perché contribuisce alla crescita sociale, sportiva e socio-economica dei territori. Lo Sport & Health City Manager fa da raccordo con i diversi assessorati e supporta il sindaco grazie a una collaborazione attiva e concreta nel coordinamento su temi
come salute e benessere, promozione dell’attività fisica e lotta alle malattie non trasmissibili, ma anche su ambiente e rilancio economico. ANCI ha saputo fare sistema e l’obiettivo dell’Associazione è anche quello di allargare il proprio confine non solo a chi oggi è amministratore, ma a chi lo può diventare e collaborare con i Comuni per la risoluzione delle sfide legate alla salute”.
Alla consegna degli attestati presente anche Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute: “Sappiamo che la città diventa sempre più patogenica e che, anziché promuovere la salute, può compromettere la qualità di vita dei cittadini. Da questa considerazione è nata l’idea di mettere a punto una nuova figura professionale con competenze utili al management transdisciplinare delle città, creando un percorso simile a quelli dei corsi di alta formazione universitaria e depositando ‘l’ordinamento didattico’ su una rivista scientifica internazionale. Questo percorso sta dando grandi risultati e soddisfazioni, ma il miglior risultato, visto dagli occhi di un professore universitario, è quando un nuovo percorso formativo consente ai giovani di ottenere poi importanti risultati professionali”.
I nuovi Sport & Health City Manager appena formati sono: Claudia Beatrice Bagnato, Andrea Barbara, Pietro Bellini, Giulio Benevento, Andrea Catese, Michela Cavagnuolo, Ambrogio Cerri, Antonio Ciccarelli, William Cittadini, Gianluca Di Rosario, Pierluigi Donia, Laura Facondini, Beatrice Giacomuzzo, Benedetta Goletti, Ferdinando Iazzetta, Clara Sofia Lavezzi, Fulvio Morgese, Rebecca Nicolini, Marco Occari, Francesco Rosiello, Giulia Santolini, Eugenio Soldati, Vittoria Tricomi e Francesco Zanfardino.
Inizia così un nuovo percorso per i nuovi Sport & Health City Manager, al termine della terza edizione del percorso che ha fornito loro nuovi strumenti e conoscenze fondamentali per affrontare le future sfide della salute urbana insieme ai Sindaci e agli Assessori dei Comuni italiani.
Per info: www.anci.it
di Alessandro Indovina segretario generale YMCA Italia
L’YMCA (Young Men’s Christian Association) è un’organizzazione globale con una lunga storia di supporto alla comunità, educazione e inclusione sociale. Nata nel 1844 a Londra, oggi YMCA opera in oltre 120 paesi, offrendo programmi di sviluppo giovanile, sport, educazione e sostegno sociale. Negli ultimi anni, l’organizzazione ha iniziato a esplorare nuove tecnologie, tra cui l’Intelligenza Artificiale (IA), per migliorare i propri servizi e ampliare il suo impatto sociale.
Il Ruolo dell’IA nell’YMCA
L’introduzione dell’IA nelle attività dell’YMCA può rivoluzionare il modo in cui l’organizzazione opera, facilitando la gestione dei programmi, migliorando l’accessibilità e personalizzando le esperienze degli utenti. Alcuni ambiti di applicazione includono:
1. Educazione e Formazione Digitale
YMCA da sempre offre programmi educativi per giovani e adulti. Con l’IA, è possibile personalizzare i percorsi di apprendimento attraverso:
• Tutor IA: chatbot e assistenti virtuali che forniscono supporto agli studenti in tempo reale.
• Piattaforme di e-learning adattive: algoritmi che regolano il livello di difficoltà in base alle prestazioni degli studenti.
• Traduzione automatica: strumenti basati sull’IA per rendere i contenuti accessibili in più lingue.
2. Inclusione e Accessibilità
L’IA può favorire l’inclusione sociale migliorando l’accesso ai servizi YMCA per persone con disabilità o dif-
ficoltà linguistiche. Alcuni esempi includono:
• Riconoscimento vocale e traduzione in tempo reale per non udenti.
• Strumenti di lettura automatica per ipovedenti.
• Interfacce intuitive che semplificano l’uso delle piattaforme digitali.
3. Miglioramento della Gestione Organizzativa L’IA può ottimizzare le operazioni interne dell’YMCA, tra cui:
• Analisi predittiva per la raccolta fondi: prevedere donazioni future in base ai dati storici.
• Gestione dei volontari: assegnazione intelligente dei volontari in base alle competenze e alla disponibilità.
• Ottimizzazione della logistica: gestione delle strutture e delle attività sportive tramite algoritmi intelligenti.
4. Benessere e Attività Fisica
YMCA è nota per i suoi programmi sportivi e di benessere. Con l’IA, si possono sviluppare:
• Coach virtuali e assistenti fitness: app che suggeriscono allenamenti personalizzati.
• Monitoraggio della salute: analisi dei dati biometrici per suggerire attività specifiche.
• Gamification dell’attività fisica: algoritmi che incentivano la partecipazione tramite premi e sfide. Esempi di YMCA che Usano l’IA
Alcune sedi YMCA stanno già sperimentando l’IA per migliorare i propri programmi. Ad esempio:
• YMCA Canada ha avviato progetti di apprendimento automatico per analizzare le esigenze delle comunità locali.
• YMCA USA utilizza chatbot per fornire informazioni sulle attività ai membri.
• YMCA Australia sta testando strumenti di intelligenza artificiale per rendere i corsi di formazione più accessibili.
Sfide e Considerazioni Etiche
Nonostante i vantaggi, l’adozione dell’IA nell’YMCA presenta alcune sfide:
• Privacy e protezione dei dati: è fondamentale garantire la sicurezza delle informazioni personali dei membri.
• Esclusione digitale: l’uso dell’IA deve essere accompagnato da strategie per evitare che alcune fasce della popolazione rimangano escluse.
• Bilanciamento tra tecnologia e interazione umana: YMCA deve mantenere il suo approccio umano e comunitario, senza sostituire completamente l’interazione personale con l’IA.
L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei programmi dell’YMCA rappresenta una grande opportunità per rendere i servizi più efficienti, inclusivi e accessibili. Tuttavia, è essenziale adottare un approccio etico e inclusivo, garantendo che la tecnologia serva realmente la missione dell’organizzazione: costruire comunità più forti e supportare il benessere di tutti.
L’YMCA può diventare un pioniere nell’uso responsabile dell’IA nel settore no-profit, dimostrando come innovazione e valori umani possano andare di pari passo per un futuro migliore.
YMCA HEALTH E L’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE: IL PROGETTO ITALIANO “WELL-CONNECT” PER GIOVANI, FAMIGLIE E ANZIANI
Per affrontare le sfide del benessere fisico e mentale in un mondo sempre più digitale, YMCA Health Italia intende sviluppare il progetto “Well-Connect: Benessere Digitale per Tutte le Età”, un’iniziativa che unisce Intelligenza Artificiale (IA), inclusione digitale e servizi sanitari per migliorare la qualità della vita di giovani, famiglie e anziani.
Obiettivi del Progetto “Well-Connect” Il progetto mira a:
–– Promuovere il benessere fisico e mentale attraverso tecnologie digitali accessibili a tutti.
–– Ridurre il digital divide con programmi di alfabetizzazione digitale per le diverse fasce d’età.
–– Fornire supporto sanitario e psicologico tramite IA e professionisti della salute.
–– Creare una comunità intergenerazionale che utilizza la tecnologia per restare connessa.
Struttura del Progetto per Diverse Fasce d’Età
1. Giovani (14-30 anni): IA per il Benessere e la Salute Mentale
I giovani spesso affrontano stress scolastico, lavorativo e sociale. L’IA può aiutarli con:
• App con assistenti IA per la gestione dello stress (mindfulness, meditazione, tecniche di rilassamento).
• Piattaforme di telemedicina con psicologi e coach sportivi.
• Sfide digitali per l’attività fisica, incentivando uno stile di vita sano con giochi e premi.
• Programmi di alfabetizzazione digitale per il lavoro, migliorando le competenze tech.
Obiettivo: aumentare la consapevolezza sul benessere mentale e fisico attraverso strumenti digitali innovativi.
2. Famiglie: Salute e Connessione Digitale
YMCA può supportare le famiglie nel migliorare la salute con:
• Coach virtuali per la nutrizione e il benessere familiare basati su IA.
• Piattaforme di gestione della salute familiare, con promemoria per visite mediche e vaccinazioni.
• Corsi digitali interattivi per genitori e figli su benessere, sport e alimentazione.
• Spazi digitali sicuri per lo scambio di esperienze tra genitori e supporto di esperti.
Obiettivo: migliorare la qualità della vita delle famiglie attraverso il supporto tecnologico e la prevenzione sanitaria.
3. Anziani: Inclusione Digitale e Telemedicina L’IA può migliorare l’accesso alla salute per gli anziani con:
• Assistenti vocali per la gestione della salute (ricordare farmaci, appuntamenti medici, attività fisica).
• Piattaforme di telemedicina per consulti con medici e fisioterapisti.
• Corsi di alfabetizzazione digitale per imparare a
usare smartphone e computer.
• Iniziative di socializzazione digitale con giovani volontari per combattere la solitudine.
Obiettivo: favorire la salute e l’integrazione sociale degli anziani riducendo il digital divide.
Innovazione Tecnologica del Progetto
Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per personalizzare i percorsi di salute e benessere.
Piattaforme digitali accessibili da smartphone e PC per facilitare la connessione tra generazioni. Chatbot e assistenti virtuali per rispondere alle esigenze di salute e benessere 24/7.
Creazione di una rete YMCA intergenerazionale, dove giovani, famiglie e anziani collaborano per una vita più sana e connessa.
Possibili Partner e Finanziamenti
Il progetto potrebbe essere sviluppato in collaborazione con:
• Istituti di ricerca e università (per validare scientificamente le soluzioni proposte).
• Aziende tecnologiche (Google, Microsoft, Meta per supporto digitale e dispositivi).
• Regioni e Comuni (per ottenere finanziamenti e supporto istituzionale).
• Organizzazioni sanitarie e ospedali (per il coinvolgimento di medici e specialisti).
Conclusione
Il progetto “Well-Connect” di YMCA Health Italia rappresenta un’opportunità concreta per migliorare il benessere della comunità attraverso la tecnologia, garantendo accessibilità, inclusione e supporto sanitario per tutte le generazioni.
Grazie all’Intelligenza Artificiale e alla collaborazione tra giovani, famiglie e anziani, YMCA può diventare un punto di riferimento per la salute digitale e la connessione intergenerazionale, creando un futuro più sano e inclusivo per tutti.



Dall’inviato di URBES, Federico Serra
Il World Economic Forum (WEF) di Davos 2025, svoltosi dal 20 al 24 gennaio, ha rappresentato un appuntamento cruciale per affrontare le sfide globali più urgenti. Il focus dell’evento si è concentrato su città, salute, benessere, ambiente e sostenibilità, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche e alle strategie necessarie per contrastare il cambiamento climatico.
L’evento ha riunito oltre 2.800 leader provenienti da 120 paesi, tra cui capi di Stato, amministratori delegati delle più grandi aziende del mondo, rappresentanti di ONG e attivisti. Tra le figure di spicco presenti a Davos 2025, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il fondatore di Microsoft Bill Gates e il CEO di BlackRock Larry Fink.
Il tema chiave dell’edizione 2025 è stato il “Riorientare il Futuro”, un chiaro invito a trovare soluzioni concrete per uno sviluppo economico più equo e sostenibile.
Città: Il Futuro dell’Urbanizzazione e delle Infrastrutture Verdi
Le città sono oggi il cuore pulsante dell’economia glo-
bale, con oltre il 55% della popolazione mondiale che vive in aree urbane, una percentuale destinata a salire al 70% entro il 2050. Tuttavia, queste sono anche i principali centri di consumo di risorse ed emissioni inquinanti.
A Davos 2025 si è parlato della necessità di sviluppare smart cities, ovvero città intelligenti capaci di integrare tecnologia e sostenibilità. Yes/Cities, una delle principali iniziative presentate, mira a sostenere oltre 1.000 startup per migliorare la vivibilità delle città con innovazioni legate alla mobilità elettrica, all’energia rinnovabile e alla gestione dei rifiuti.
Tra le città modello presentate, Singapore è emersa come un esempio globale di innovazione urbana, con l’uso massiccio di IA e big data per ottimizzare la gestione dei trasporti e dell’energia. Amsterdam, invece, si distingue per il suo modello di economia circolare, con oltre l’80% dei nuovi edifici costruiti con materiali riciclati.
Il concetto di Baukultur, promosso dal Bhutan, sottolinea l’importanza di progettare città che non siano solo sostenibili ma anche centrate sul benessere delle persone. Questo significa più spazi verdi, maggiore inclusione sociale e riduzione della cementificazione selvaggia
Salute e Benessere: L’Impatto dell’Ambiente sulla Qualità della Vita
La connessione tra ambiente e salute è stata uno dei temi centrali del WEF 2025. Il rapporto State of Nature and Climate 2025 ha rivelato che sei su nove limiti planetari sono già stati superati, con un impatto diretto sulla salute umana.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’inquinamento atmosferico provoca oltre 7 milioni di morti premature ogni anno, mentre il cambiamento climatico sta favorendo la diffusione di nuove malattie infettive.
Davos ha posto l’accento su soluzioni per ridurre l’inquinamento urbano, tra cui:
• Miglioramento dei trasporti pubblici e mobilità elettrica per ridurre le emissioni
• Sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale per avvisare i cittadini
• Incentivi alle aziende per ridurre l’uso di plastica monouso e sostanze tossiche
Parallelamente, il forum ha sottolineato l’importanza della salute mentale, con un aumento del 30% dei disturbi legati allo stress e alla depressione negli ultimi cinque anni. Soluzioni come la riduzione delle ore lavorative, la promozione dello smart working e l’inclusione di programmi di supporto psicologico nelle aziende sono state discusse come misure necessarie per il benessere globale.
Ambiente e Sostenibilità: Una Sfida Non Più Rimandabile
I dati climatici presentati a Davos 2025 sono stati allarmanti: il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato e oltre il 70% delle barriere coralline mondiali ha subito fenomeni di sbiancamento.
Un’importante novità discussa è stata l’integrazione della biodiversità nei mercati del carbonio. Il Presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, ha proposto che le aziende siano responsabili non solo delle emissioni di CO₂, ma anche dell’impatto che hanno su risorse naturali come acqua e foreste.
L’agricoltura sostenibile è stata un altro tema centrale: il settore agroalimentare è responsabile di circa il 30% delle emissioni globali di gas serra. Soluzioni come l’agroecologia, l’uso di biotecnologie e l’agricoltura verticale sono state evidenziate come strategie necessarie per ridurre l’impatto ambientale della produzione alimentare.
Le Voci di Davos 2025
10 citazioni dai protagonisti del World Economic Forum 2025:
1. Klaus Schwab (WEF): “L’innovazione e la cooperazione globale sono la chiave della sostenibilità.”
2. Antonio Guterres (ONU): “Il cambiamento climatico è una crisi attuale, non futura.”
3. Kristalina Georgieva (FMI): “Gli investimenti green creeranno milioni di posti di lavoro.”
4. Ursula von der Leyen (UE): “L’Europa guiderà la transizione ecologica.”
5. Tharman Shanmugaratnam (Singapore): “Dobbiamo integrare biodiversità, carbonio e risorse idriche.”
6. Christian Bruch (Siemens Energy): “L’idrogeno verde è il futuro dell’energia.”
7. Bill Gates (Microsoft): “Le tecnologie climatiche cambieranno il mondo.”
8. Vanessa Nakate (Attivista): “Non c’è sostenibilità senza giustizia climatica.”
9. Tshering Tobgay (Bhutan): “Le città devono essere luoghi di felicità e benessere.”
10. Larry Fink (BlackRock): “Le aziende che ignorano la sostenibilità falliranno.
Cos’è il World Economic Forum?
Il World Economic Forum (WEF) è un’organizzazione internazionale fondata nel 1971 da Klaus Schwab. Ogni anno, a Davos (Svizzera), ospita un incontro tra leader politici, economisti, imprenditori e accademici per discutere delle sfide globali.
Il WEF si concentra su temi come economia, geopolitica, innovazione tecnologica e sostenibilità, cercando di promuovere soluzioni concrete per lo sviluppo globale
L’evento è noto per essere un luogo di networking e definizione di strategie a lungo termine, con
Fine modulo



di Simone Aureli
La digitalizzazione della sanità non è solo un’opportunità, ma una necessità per migliorare la presa in carico dei pazienti e garantire più efficienze ed equità di accesso ai servizi sanitari nelle aree interne e nelle comunità montane, dove la carenza di strutture e personale medico rende necessaria una trasformazione del modello di assistenza. È da questo punto di vista una vera e propria leva strategica. Questo il tema del Convegno svoltosi lo scorso 25 febbraio in Senato, su iniziativa del Sen. Guido Quintino Liris, “Connessi. La digitalizzazione nella sanità delle aree interne e nelle comunità montane”. Un tema questo che è al centro dell’attenzione dell’Intergruppo parlamentare sulla Prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne, di cui il Sen. Liris è Presidente, impegnato nell’individuare soluzioni mirate a garantire il diritto alla salute nelle zone più svantaggiate del nostro Paese. La transizione digitale rappresenta un’opportunità fondamentale per ridurre le diseguaglianze territoriali e abbattere le liste d’attesa, ottimizzando i percorsi di cura e migliorando la gestione delle risorse sanitarie. «La digitalizzazione della sanità rappresenta una sfida cruciale per garantire servizi efficienti e accessibili nelle aree interne e nelle comunità montane. – ha dichiarato il Sen. Guido Quintino Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulla prevenzione e le emergenze sanitarie nelle aree interne, Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Con il convegno ‘CONNESSI’ vogliamo porre l’attenzione sulle soluzioni concrete che Governo e Parlamento stanno promuovendo per superare il digital divide e rafforzare l’assistenza territoriale, mettendo la tecnologia al servizio delle persone. L’Italia ha storicamente dimostrato una straordinaria capacità di trasformare le sfide in opportunità e, oggi più che mai, la nostra azione politica deve essere orientata su innovazione e resilienza per costruire le solide basi di un sistema sanitario sempre più giusto, performante ed efficiente. In questo contesto la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) rappresenta lo strumento principale per promuovere lo
sviluppo e la coesione di questi territori, unitamente alle linee a ciò dedicate del PNRR. Tuttavia, ad oggi, in Italia non esiste una “Giornata Nazionale delle Aree Interne” ufficialmente riconosciuta che celebri l’unicità di questi territori e ne valorizzi il ruolo strategico. Per questo motivo ho deciso di depositare in Senato un Disegno di legge sulla Istituzione della Giornata nazionale delle aree interne e dei piccoli comuni montani. Abbiamo bisogno di uno strumento simbolico, ma concreto, per accendere i riflettori su una parte d’Italia geograficamente marginale ma di preminente interesse. Vogliamo dare voce alle esigenze delle comunità locali e costruire un futuro in cui le aree interne possano esprimere appieno il loro potenziale. Il nostro impegno è chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro.»
Il Convegno ha voluto quindi mettere a sistema le migliori esperienze e delineare le prospettive future per un’efficace integrazione delle tecnologie digitali nella sanità territoriale, grazie al contributo di istituzioni, esperti di sanità digitale, rappresentanti delle agenzie sanitarie, con un focus sulle potenzialità della telemedicina, dell’intelligenza artificiale e delle piattaforme di interoperabilità e l’efficienza dei servizi. «Il tema delle aree interne mi appartiene, non solo per le deleghe assegnate, ma anche in termini culturali e politici – ha dichiarato il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, Tommaso Foti - Nelle prossime settimane porterò in Consiglio dei Ministri un’informativa sul Piano Strategico delle Aree Interne. Le principali sfide che interessano le aree interne attengono alla salute, all’istruzione e ai trasporti. In particolare, per garantire un sistema sanitario moderno, è indispensabile disporre di reti digitali solide e adeguate, soprattutto in questi territori. Per questo motivo, il PNRR ha previsto una strategia per la banda ultralarga, con l’obiettivo prioritario di coprire le aree non servite. Il Programma di Connessioni Internet Veloci, con un investimento di 5 miliardi di euro, rappresenta un passo fondamentale in questa direzione. A questo si aggiunge il Piano “Sanità Connessa”, che, con 335 milioni di
euro, prevede l’attivazione di oltre 9.000 strutture sanitarie, di cui 4.300 già in fase di attivazione. È bene poi ricordare l’importanza delle Case di Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali. Entro giugno 2026, inoltre, verrà attivato per tutte le Regioni l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico, migliorando la gestione delle informazioni sanitarie. Grande attenzione è stata dedicata anche alla telemedicina, con un investimento di 1,5 miliardi di euro che consentirà di assistere 300.000 pazienti a distanza, garantendo cure più accessibili. Infine, sono stati finanziati interventi per il potenziamento e l’efficientamento di 900 farmacie rurali, presidi fondamentali per garantire servizi sanitari di prossimità nelle aree interne. È evidente come il PNRR e, soprattutto, il governo Meloni, abbiano posto e continuino a porre un’attenzione concreta e mirata alle esigenze di questi territori, con interventi strutturali che ne rafforzano il futuro».
«L’Italia vanta un Servizio Sanitario Nazionale universalistico, istituito con la legge 833 del 1978, ma il contesto attuale impone una revisione strutturale – ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero della salute Marcello Gemmato - Oggi, l’80 per cento della spesa sanitaria è destinato alla gestione delle malattie croniche non trasmissibili, mentre la natalità è ai minimi storici (1,24 figli per donna), con un conseguente aumento dell’età media della popolazione. Per affrontare queste sfide, il Fondo Sanitario Nazionale ha raggiunto i 136,5 miliardi di euro nel 2025, ma il solo aumento delle risorse non è sufficiente se non accompagnato da un ripensamento del nostro SSN attraverso nuovi modelli organizzativi. Il PNRR sta accelerando questa trasformazione, con l’80 per cento delle nuove strutture territoriali – Case e Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali – già avviate per rafforzare la medicina di prossimità e ridurre il sovraccarico ospedaliero. La sostenibilità deve essere il principio guida: investire in prevenzione, innovazione e digitalizzazione è essenziale per garantire un SSN efficiente e accessibile a tutti. Il futuro della sanità italiana passa da un sistema più vicino ai cittadini e capace di rispondere alle nuove esigenze della popolazione, soprattutto le più fragili e anziane residenti nelle zone interne e montane della nostra penisola».
Occorre individuare soluzioni concrete e sostenibili per superare le barriere tecnologiche, infrastrutturali e normative che ancora limitano la diffusione degli strumenti digitali in sanità. Un aspetto cruciale sarà l’adeguamento del quadro normativo, su cui il Governo in carica sta lavorando con l’obiettivo di garantire una regolamentazione chiara ed efficace per la sanità digitale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) pone, infatti, la sanità digitale al centro della sua strategia di rinnovamento del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, per esempio, rappresenta un pilastro essenziale per garantire la continuità assistenziale e migliorare l’efficienza dei percorsi di cura, soprattutto nelle aree più remote. Parallelamente, la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) ha riconosciuto la necessità di rafforzare i servizi sanitari nelle zone caratterizzate da maggiore isolamento geografico, promuovendo modelli di assistenza innovativi basati sull’integrazione tra ospedale e territorio, sull’utilizzo della telemedicina e sul potenziamento della connettività digitale.
Il Piano Nazionale della Telemedicina, adottato in coerenza con gli obiettivi del PNRR, rappresenta un ulteriore passo avanti nella trasformazione digitale della sanità, delineando un quadro strutturato per l’implementazione di soluzioni come la televisita, il telemonitoraggio e la teleassistenza. Queste tecnologie, supportate dall’intelligenza artificiale e dall’uso dei big data, non solo migliorano la qualità e l’accessibilità delle cure, ma consentono anche una gestione più efficiente delle malattie croniche, particolarmente diffuse tra le popolazioni delle aree interne. Inoltre, il Piano Nazionale della Sanità Digitale 2022-2027 fornisce una visione strategica per l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate nel settore sanitario, con l’obiettivo di superare le barriere geografiche e garantire equità nell’accesso alle cure.
«Il Governo Meloni è impegnato a colmare le disparità tra i territori per garantire ai cittadini un accesso equo ai servizi, indipendentemente dalla loro posizione geografica. – ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano - Per combattere il declino demografico che stanno attraversando le aree interne, è fondamentale assicurare la presenza di servizi e infrastrutture adeguati: scuole, presidi strategici, abitazioni sicure e combinate a servizi legati al terzo settore e al digitale, come la telemedicina. Il digitale rappresenta un’enorme opportunità per ridurre le disuguaglianze tra territori e deve essere sfruttato appieno».
«La digitalizzazione della sanità è fondamentale per garantire un accesso alle cure equo e veloce. – ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio ButtiCon il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0, il Piano Sanità Connessa e gli investimenti del PNRR, il Governo sta costruendo un modello sanitario più efficiente e vicino ai cittadini. Anche l’Unione Europea ha certificato i nostri progressi nell’ultimo Digital Decade Report, dove l’Italia ha ottenuto un punteggio di 82,7 per cento in ambito e-Health, passando dal quintultimo posto al podio dei grandi paesi europei in un solo anno».


di Enrica Frutti
Il Sen. Guido Quintino Liris è medico, politico e specialista in Igiene pubblica. Attualmente ricopre il ruolo di Senatore della Repubblica di Fratelli d’Italia e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per la prevenzione delle emergenze sanitarie nelle aree interne, nei comuni montani e nelle isole minori. Da sempre impegnato nel settore sanitario e nelle politiche per le aree svantaggiate, ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo in Abruzzo, come Assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione sanitaria.
Si distingue per il costante dialogo con i sindaci e gli amministratori locali, con i quali collabora attivamente nella ricerca di soluzioni concrete per il miglioramento della sanità nelle aree interne. Il suo impegno si traduce in un lavoro sinergico tra istituzioni locali e nazionali, per garantire interventi mirati e sostenibili nel lungo termine.
Fondamentale è anche la sinergia sviluppata con il Go-
verno, grazie all’attenzione costante del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su questi temi e al supporto di figure chiave come il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, oggi Tommaso Foti e in precedenza Raffaele Fitto, il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Sottosegretario Marcello Gemmato per le politiche sanitarie, oltre al Ministro Nello Musumeci, che segue con particolare attenzione la situazione delle isole minori.
Inoltre, è attiva una stretta collaborazione con il Sottosegretario con delega per l’Innovazione Alessio Butti, per garantire che il processo di digitalizzazione sanitaria nelle aree interne sia supportato da un’infrastruttura tecnologica solida e accessibile a tutti. Centrale è anche la sinergia con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con i sindaci, che rappresentano il punto di riferimento primario per l’attuazione di politiche efficaci e aderenti alle esigenze reali delle comunità locali.
L’intervista
D: Senatore Liris, quali sono le principali criticità sanitarie che le aree interne e montane affrontano oggi?
Le aree interne e montane soffrono di una carenza cronica di servizi sanitari. La difficoltà di accesso a ospedali e specialisti è una delle principali cause di spopolamento. Inoltre, l’invecchiamento della popolazione rende necessario un modello di assistenza più capillare e innovativo.
Il ruolo dei sindaci e degli amministratori locali è fondamentale: sono loro i primi a confrontarsi quotidianamente con i problemi delle comunità e a individuare le soluzioni più efficaci. Per questo, stiamo sviluppando un forte coordinamento con ANCI e con i primi cittadini per costruire strategie di lungo periodo che possano garantire un reale miglioramento dei servizi.
Grazie all’impegno del Governo e alla sensibilità della Presidente Meloni su questi temi, stiamo portando avanti strategie coordinate tra amministrazioni locali e ministeri per rafforzare la sanità territoriale, soprattutto attraverso il digitale.
D: In che modo il digitale può colmare queste lacune?
Il digitale è la chiave per superare la distanza fisica e migliorare la qualità delle cure. Tecnologie come la telemedicina e la cartella clinica elettronica permettono ai cittadini di ricevere assistenza senza spostarsi. Inoltre, con l’uso di dispositivi di monitoraggio a distanza, possiamo garantire un’assistenza continuativa anche ai pazienti cronici o fragili.
Grazie alla collaborazione con il Ministro Schillaci e il Sottosegretario Gemmato, stiamo lavorando per migliorare l’accessibilità delle cure digitali, anche attraverso le farmacie dei servizi e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e la formazione del personale sanitario. Con il Sottosegretario Butti, invece, stiamo affrontando il tema dell’innovazione e dell’adeguamento delle infrastrutture digitali, essenziali per garantire un’effettiva implementazione della sanità digitale. Parallelamente, con il Ministro Musumeci, ci concentriamo sulle isole minori, che affrontano problematiche simili alle aree interne, ma con ulteriori sfide logistiche.
D: Quali sono le principali difficoltà nell’implementazione di questi strumenti digitali?
Il primo ostacolo è la mancanza di infrastrutture adeguate, come una connessione internet stabile. Inoltre, molti cittadini non hanno ancora familiarità con gli
strumenti digitali, quindi è fondamentale investire nella formazione, sia per gli utenti che per gli operatori sanitari.
Grazie alla sinergia con il Ministro Foti, stiamo lavorando affinché i fondi del PNRR e delle politiche di coesione siano destinati in modo mirato a ridurre il divario digitale in queste zone. Con il Sottosegretario Butti, invece, stiamo studiando soluzioni per potenziare la connettività nelle aree periferiche e garantire la piena operatività della sanità digitale.
D: Quali iniziative l’Intergruppo Parlamentare ha promosso per incentivare la digitalizzazione sanitaria?
Abbiamo proposto misure per incentivare la telemedicina e per accelerare la copertura di banda larga in tutte le aree svantaggiate. Inoltre, stiamo lavorando per garantire finanziamenti dedicati alla sanità digitale nel PNRR e per rafforzare la rete delle farmacie rurali, che possono diventare un punto di riferimento per la sanità di prossimità.
Il coinvolgimento di ANCI e dei sindaci è cruciale: vogliamo che siano parte attiva in questo processo, portando le esigenze specifiche di ogni territorio nelle sedi istituzionali.
D: Quali sono le prospettive future per la digitalizzazione della sanità in queste zone?
Il nostro obiettivo è una sanità più vicina al cittadino, dove il digitale aiuta a ridurre le disuguaglianze e ad aumentare l’efficienza del sistema.
L’attenzione del Governo su questo tema è una garanzia che le riforme in atto non saranno temporanee, ma parte di una strategia a lungo termine. Con il supporto della Presidente Meloni, il coinvolgimento dei Ministri e del Sottosegretario Butti per l’innovazione, siamo certi che la digitalizzazione della sanità diventerà una realtà concreta per tutte le aree interne, i comuni montani e le isole minori.
D: Un messaggio finale per chi vive in queste aree e teme di rimanere escluso dalle innovazioni sanitarie?
La digitalizzazione non deve essere vista come un limite, ma come un’opportunità. Il nostro impegno è quello di garantire che nessuno venga lasciato indietro, rendendo la sanità accessibile a tutti, indipendentemente da dove si vive.
Continueremo a lavorare in sinergia con il Governo, i sindaci, ANCI e le amministrazioni locali per portare innovazione e servizi sanitari di qualità anche nelle zone più periferiche.

Immerso nel cuore del Parco delle Madonie, Petralia
Sottana rappresenta uno dei borghi più belli d’Italia, un luogo dove storia, cultura e natura si intrecciano in un’armonia perfetta. Situato a circa 1.000 metri sul livello del mare, questo incantevole borgo siciliano offre panorami mozzafiato, un centro storico ricco di arte e tradizioni e una qualità della vita che attira visitatori da ogni parte del mondo.
Storia e Origini
Petralia Sottana ha origini antiche, risalenti al periodo greco e romano, ma il suo nome e il suo assetto urbano attuale derivano dall’epoca medievale. Durante la dominazione normanna e sveva, il borgo divenne un importante centro amministrativo e religioso, con la costruzione di chiese e monasteri che ancora oggi ne definiscono il carattere. Nel corso dei secoli, Petralia Sottana ha saputo conservare la sua identità, mantenendo intatto il suo fascino storico.
Un Centro Storico di Inestimabile Valore
Passeggiando per le stradine acciottolate del centro storico, si viene avvolti da un’atmosfera d’altri tempi. Tra i luoghi di maggiore interesse spiccano:
La Chiesa Madre dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, un capolavoro dell’architettura barocca e rinascimentale, con affreschi e decorazioni preziose.
Il Palazzo Municipale, un edificio storico che testimonia l’importanza amministrativa del borgo nel passato.
La Fontana dei Quattro Cannoli, simbolo del paese e luogo di ritrovo per gli abitanti.
Il Museo Civico Antonio Collisani, che ospita reperti archeologici e una sezione dedicata alle Madonie.
Una Natura Generosa e Itinerari Suggestivi
Petralia Sottana è una meta perfetta per gli amanti della natura e dell’escursionismo. Il borgo è una delle porte d’accesso al Parco delle Madonie, un’area naturale protetta ricca di flora e fauna uniche. Qui è possi-
bile praticare trekking lungo sentieri che conducono a paesaggi spettacolari, come Piano Battaglia, località nota per le sue piste da sci in inverno e per le escursioni in estate.
Tradizioni e Sapori Autentici
Le tradizioni di Petralia Sottana sono vive tutto l’anno, grazie a eventi e manifestazioni che celebrano la cultura locale. Una delle più importanti è la Festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, che si tiene a giugno con processioni e spettacoli folkloristici.
Dal punto di vista gastronomico, il borgo offre piatti tipici della cucina siciliana e madonita. Tra le specialità imperdibili ci sono:
La ricotta fresca e i formaggi locali, prodotti dai pastori delle Madonie.
Le paste di mandorla e i dolci tradizionali, come i cannoli e la cassata.
La pasta con le fave e il macco di fave, piatti contadini dal sapore .
Un Borgo da Vivere e Scoprire
Petralia Sottana è molto più di una semplice meta turistica: è un borgo che racconta storie di un passato glorioso e di una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici. Visitare questo angolo di Sicilia significa immergersi in un’esperienza autentica, tra bellezze architettoniche, natura incontaminata e una tradizione culinaria che conquista ogni palato. Non a caso, è considerato uno dei borghi più belli d’Italia, un gioiello nascosto tra le montagne che merita di essere scoperto e apprezzato.

di Ludovica Serra

Lampedusa e Linosa, le due isole principali dell’arcipelago delle Pelagie, sono luoghi di contrasti affascinanti e drammatici. Situate nel cuore del Mediterraneo, più vicine alle coste africane che a quelle siciliane, queste isole rappresentano un paradiso naturalistico con paesaggi mozzafiato, ma sono anche crocevia di flussi migratori che le rendono simboli delle sfide geopolitiche contemporanee.
Un Paradiso Naturale
Lampedusa, con una superficie di circa 20 km² e una popolazione di poco più di 6.000 abitanti, è famosa per il suo mare cristallino e le sue spiagge incantevoli. Tra queste, la Spiaggia dei Conigli è considerata una delle
più belle del mondo, grazie alla sua sabbia bianca e alle acque turchesi. L’area fa parte di una riserva naturale gestita da Legambiente ed è anche un luogo di nidificazione per la tartaruga marina Caretta caretta, una specie protetta.
Linosa, più piccola e meno conosciuta, si distingue per il suo paesaggio vulcanico e la sua vegetazione lussureggiante. Con una superficie di appena 5 km² e una popolazione di circa 400 abitanti, l’isola è un gioiello naturale con un ecosistema unico. I suoi fondali marini incontaminati attirano appassionati di immersioni e snorkeling, mentre le sue colline vulcaniche offrono panorami spettacolari.
Le due isole fanno parte di un ecosistema fragile e prezioso, caratterizzato da una vegetazione tipicamente mediterranea e fondali ricchi di biodiversità. La loro bellezza e unicità attirano ogni anno turisti da tutto il mondo, sebbene la loro capacità ricettiva sia limitata e fortemente dipendente dalla stagionalità.
Lampedusa fa parte della rete regionale Global Atmosphere Watch dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, contribuendo al monitoraggio delle condizioni atmosferiche globali.
Un Ponte tra Due Mondi
Oltre alla loro bellezza paesaggistica, Lampedusa e Linosa sono note per il loro ruolo di “porta d’Europa” per migliaia di migranti che tentano di raggiungere il continente dalla Libia e dalla Tunisia. La loro posizione le rende uno dei principali punti di approdo per chi cerca una nuova vita lontano da guerre, persecuzioni e povertà.
Negli ultimi decenni, Lampedusa in particolare è diventata il simbolo delle politiche migratorie europee e delle loro contraddizioni. Il Centro di Accoglienza per Migranti di Lampedusa è spesso sovraffollato e al centro di polemiche, mentre la popolazione locale si divide tra sentimenti di solidarietà e difficoltà nella gestione dell’emergenza continua. Anche gli abitanti di Linosa, sebbene meno coinvolti direttamente nel fenomeno, vivono le conseguenze della posizione geografica dell’arcipelago e delle politiche nazionali e internazionali in materia di immigrazione.
I lampedusani e i linosani hanno più volte dimostrato grande accoglienza e umanità, come dimostrano i numerosi riconoscimenti attribuiti alla comunità, tra cui il Premio Nobel per la Pace simbolico assegnato nel 2017 all’isola di Lampedusa e alla sua gente. Tuttavia, le infrastrutture limitate e la dipendenza economica dal turismo rendono difficile affrontare un fenomeno di tale portata senza un adeguato supporto da parte dello Stato italiano e dell’Unione Europea.
Nel corso della sua visita a Lampedusa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato un piano d’azione in 10 punti per affrontare la crisi migratoria. Tra le misure previste vi sono un maggiore coordinamento tra gli Stati membri, un rafforzamento della gestione delle frontiere e un aumento del supporto alle comunità locali.
La Storia e la Cultura delle Isole Lampedusa e Linosa hanno una storia antica e affascinante. Popolate fin dall’epoca preistorica, hanno visto passare Fenici, Greci, Romani, Arabi e Normanni, che ne hanno fatto punti strategici per il controllo del Mediterraneo. Tuttavia, per lunghi periodi sono rimaste quasi disabitate, fino alla colonizzazione avviata dai Borbone nel 1760.
Oggi, l’identità lampedusana e linosana è un mix di influenze siciliane e africane, evidente nella cucina, nelle tradizioni e nella parlata locale. Il pesce è l’ingrediente principe della gastronomia isolana, con piatti tipici come il cous cous di pesce, eredità della vicinanza con la Tunisia, e la pasta con l’anciova e muddica (acciughe e pangrattato), tipica della Sicilia.
Le isole hanno anche ispirato scrittori, registi e artisti. Il documentario “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso d’Oro al Festival di Berlino nel 2016, ha portato all’attenzione internazionale la difficile realtà di Lampedusa, raccontando le storie di chi vi approda e di chi vi vive.
Le Sfide del Futuro
Nonostante la loro straordinaria bellezza e l’importanza strategica, Lampedusa e Linosa affrontano numerose sfide. Il turismo, principale risorsa economica, è legato alla stagionalità e spesso insufficiente a garantire benessere ai residenti tutto l’anno. Inoltre, la gestione dell’emergenza migratoria continua a essere una questione irrisolta, con periodici momenti di tensione e difficoltà logistiche.
La sostenibilità ambientale è un altro tema cruciale. La scarsità di acqua dolce, la gestione dei rifiuti e il consumo energetico sono problemi che richiedono soluzioni innovative per evitare che il paradiso naturale delle isole venga compromesso. Linosa, grazie alla sua natura più selvaggia e alla minore pressione antropica, conserva un ambiente meno alterato rispetto a Lampedusa, ma necessita comunque di attenzione e tutela. Lampedusa può diventare un laboratorio di idee per la salute e il benessere nelle isole minori italiane, sviluppando modelli di sostenibilità e soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. Lampedusa e Linosa sono luoghi di straordinaria bellezza e di grandi contraddizioni. La loro storia, la loro cultura e il loro ruolo nel Mediterraneo ne fanno simboli di accoglienza e di resilienza. Tuttavia, senza un adeguato supporto, il futuro delle isole rischia di essere sempre più difficile. È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire a Lampedusa e Linosa un futuro all’altezza della loro straordinaria identità.

di Ludovica Serra
“Lampedusa non può essere lasciata sola. Abbiamo dimostrato che si possono realizzare progetti concreti, ma serve un impegno costante per garantire a tutti il diritto alla salute.”
Lampedusa e Linosa, le due isole dell’arcipelago delle Pelagie, sono spesso al centro dell’attenzione per la questione migratoria, ma c’è un’altra emergenza che si combatte quotidianamente: quella sanitaria. Il territorio, essendo un punto strategico nel Mediterraneo, necessita di particolari attenzioni per le peculiarità sanitarie che presenta. Ne parliamo con Aldo Di Piazza, medico e assessore alla Sanità del Comune di Lampedusa e Linosa, che racconta la realtà sanitaria locale, i problemi strutturali e le soluzioni possibili per migliorare l’assistenza. Aldo Di Piazza , viene da Palermo e da oltre trent’anni vive un’osmosi personale e professionale con l’isola. La sua lunga esperienza lo ha portato a conoscere profondamente le criticità clinico e socio-sanitarie del territorio e a lavorare per migliorare l’assistenza sia ai residenti che ai migranti.
La sanità nelle Pelagie: tra emergenze e carenze strutturali
Assessore Di Piazza, qual è la situazione sanitaria attuale tra Lampedusa e Linosa?
“Lampedusa e Linosa dipendono dall’ASP 6 di Palermo ,in relazione alla continuità territoriale con la città di Palermo, legata ai plurimi collegamenti aerei giornalieri . In questi anni si è fornita l’isola di Lampedusa di un Poliambulatorio con 21 specialità a cadenza settimanale oltre un PTE ( presidio territoriale emergenza ) funzionante h\24 ,sette giorni su sette , con quattro figure mediche presenti costantemente ( uno specialista in emergenza-urgenza , un anestesistarianimatore , un cardiologo ,un ginecologo) supportate da un elicottero del 118 regionale con relativo equipaggio e anestesista rianimatore . Completano l’organico sanitario in servizio sull’isola tre medici di base di libera scelta ed un Pediatra di base di libera scelta oltre naturalmente i medici in servizio presso la guardia medica e turistica .Per l’isola di Linosa la situazione è meno brillante e la piccola popolazione isolana( 470 abitanti) è seguita da un Medico di base di libera scelta e dalla guardia medica in servizio h\24..”
Come si gestiscono i casi più critici?
“ Lampedusa non ha un Ospedale , considerando ciò che il termine Ospedale definisce , una struttura complessa capace di dare risposte concrete ed immediate all’emergenza medico-chirurgica. . Molto più concretamente utile immaginare le strutture sanitarie su un isola ,soprattutto se realmente posta a grande distanza dalla “terraferma” , come un qualcosa capace di erogare i livelli essenziali con una presenza specialistica costante e con tempi di attesa contenuti , e la gestione dell’emergenza creando i presupposti per considerare il PTE ( Presidio Territoriale Emergenza ) come un pezzo di un grande Hub di Pronto Soccorso che dista un’ora di volo.
Questo è quello che si è cercato di fare per Lampedusa ,dove l’emergenza viene prima riconosciuta ,poi inquadrata ,quindi stabilizzata ,alla fine trasportata con un mezzo dell’Elisoccorso Regionale ,sempre presente e di stanza sull’isola.”
L’impatto degli sbarchi sulla sanità locale
Quanto pesa l’emergenza migranti sulla sanità delle isole?
“È un aspetto centrale. Lampedusa è il primo punto di approdo per molte persone che arrivano in condizioni sanitarie precarie. Abbiamo casi di disidratazione, ipotermia, ustioni da carburante, ferite e traumi. Alcuni migranti hanno malattie croniche non curate, mentre altri sono vittime di violenze subite durante il viaggio o nei centri di detenzione in Libia. Per dare qualche numero i dati del 2023 mostrano a fronte di una popolazione residente di 6450 residenti ,sono transitati sull’isola 115.000 migranti ai quali bisogna aggiungere 250.000 presenze turistiche , tutto ciò comporta la necessità di concepire una “ Sanità a Geometria Variabile” con le difficoltà che ciò può determinare. Linosa riceve meno sbarchi, ma in caso di emergenza deve comunque fare i conti con una sanità limitata.”
Chi si occupa dell’assistenza ai migranti?
“Il primo screening medico viene effettuato sul Molo Favaloro, grazie ai medici dell’Unità Sbarchi dell’ASP di Palermo e alle organizzazioni umanitarie come la Croce Rossa, e le ONG che operano sul territorio. I casi gravi vengono subito portati al PTE per una valutazione più attenta, ma se le condizioni del paziente sono critiche, è necessario un trasferimento urgente in Sicilia. Tuttavia, il problema maggiore è il sovraffollamento: quando arrivano centinaia di persone in poche ore, il sistema sanitario locale rischia di collassare.”
Nuovi servizi sanitari per i residenti e i migranti
Nascono in tale ottica nuovi servizi sanitari per rispondere alle esigenze della popolazione locale e dei migranti.
L’Ambulanza Medicalizzata, in servizio ormai da circa un anno, rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza d’emergenza, in aggiunta ad altre due Ambulanze non medicalizzate
L’Ambulatorio di Odontoiatria Sociale e l’Ambulatorio di Oculistica Sociale sono stati attivati per fornire alla popolazione a basso ISEE servizi essenziali come la protesica odontoiatrica e la protesica oculistica, evitando così lunghi e costosi spostamenti sulla terraferma.
Il Camper Ginecologico, con personale medico e infermieristico, è stato posizionato nei pressi dell’Hotspot, dove convergono i migranti in arrivo, consentendo di gestire il problema delle gravide in terzo trimestre senza sovraccaricare le strutture sanitarie fisse.
L’Ambulatorio Infettivologico, specializzato nell’individuazione dei soggetti con TBC attiva bacillifera, permette di prevenire il rischio di diffusione della malattia tra migranti e popolazione locale.
Tutti questi servizi sono il frutto di una collaborazione attiva tra diversi enti sanitari e istituzionali che sono :
ASP 6 di Palermo
INMP (Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà)
Comune di Lampedusa e Linosa
Assessorato Regionale alla Sanità
Centrale Operativa del 118 Regionale
Croce Rossa Italiana, che gestisce l’Hotspot di Lampedusa
Progetti futuri: il Servizio Oncologico Decentrato (SOD)
Oltre a quanto già realizzato, è in fase di studio il Progetto SOD (Servizio Oncologico Decentrato), un’iniziativa ambiziosa che mira a portare le cure oncologiche vicino al domicilio dei pazienti e garantire un monitoraggio costante della malattia. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra:
Comune di Lampedusa e Linosa
INMP
ASP 6 di Palermo
Policlinico Universitario di Palermo
Assessorato Regionale alla Sanità
Centrale Operativa del 118 Palermo-Trapani
“L’obiettivo – dice Di Piazza- è quello di ridurre i disagi per i pazienti oncologici, che attualmente devono affrontare viaggi complessi per sottoporsi a terapie e controlli.”
Lampedusa e Linosa rappresentano una delle frontiere più difficili d’Europa, non solo per i flussi migratori, ma anche per la sanità. Grazie al lavoro dell’amministrazione locale e alla collaborazione tra diversi enti sanitari, sono stati avviati servizi innovativi per garantire cure migliori alla popolazione e ai migranti. Tuttavia, la strada è ancora lunga e il futuro dipenderà dagli investimenti e dalle scelte politiche dei prossimi anni. “Lampedusa non può essere lasciata sola”, conclude l’assessore Di Piazza. “Abbiamo dimostrato che si possono realizzare progetti concreti, ma serve un impegno costante per garantire a tutti il diritto alla salute.”




Situato nell’estremo nord-ovest dell’Abruzzo, al confine con il Lazio, Montereale è un incantevole borgo montano della provincia dell’Aquila. Circondato dalle maestose vette dell’Appennino e immerso in un paesaggio suggestivo, questo piccolo centro vanta una storia antica, un ricco patrimonio artistico e una profonda identità culturale. Con i suoi borghi e frazioni disseminate tra colline e altopiani, Montereale rappresenta una delle località più affascinanti dell’entroterra abruzzese.
Le origini di Montereale risalgono all’epoca romana, quando il territorio era abitato dai Sabini, un antico popolo italico. Alcuni resti archeologici testimoniano la presenza di insediamenti romani nella zona, in particolare lungo la valle dell’Aterno. Tuttavia, il vero sviluppo del borgo si ebbe nel Medioevo, quando il paese divenne una fortezza strategica sotto il dominio di diverse famiglie nobiliari.
Durante il XIII secolo, Montereale fu incluso nei territori del Regno di Napoli e successivamente del Regno delle Due Sicilie, subendo le influenze culturali e politiche che caratterizzarono l’intera area dell’Abruzzo aquilano. Nel corso dei secoli, il paese fu colpito da terremoti, tra cui quello devastante del 1703, che segnò profondamente il tessuto urbano e architettonico della zona. Nonostante le difficoltà, Montereale mantenne il suo fascino storico e culturale, conservando preziosi edifici e tradizioni.
Arte e Architettura
Passeggiando per le strade di Montereale, si possono ammirare diversi edifici di pregio storico e artistico. Uno dei principali luoghi di interesse è la Chiesa di Santa Maria Assunta, che risale al Medioevo ma ha subito numerosi restauri nel corso del tempo. La facciata, sobria ed elegante, nasconde un interno ricco di affreschi e opere d’arte sacra.
Un altro monumento significativo è la Chiesa di San Rocco, costruita dopo la peste del 1656 come segno di devozione al santo protettore. Questa chiesa è un simbolo della resilienza e della fede della comunità locale.
Montereale è anche noto per i resti delle sue antiche mura e torri difensive, che testimoniano il suo passato medievale come roccaforte strategica. Passeggiando nel centro storico, si possono ancora osservare tracce delle strutture difensive che un tempo proteggevano il borgo dagli attacchi esterni.
Le Frazioni e il Territorio
Il comune di Montereale comprende numerose frazioni e borgate, ognuna con la propria identità e bellezze paesaggistiche. Tra queste, spiccano Ville di Fano,
Marana, Verrico e Capitignano, che offrono panorami mozzafiato sulle montagne circostanti e conservano antiche chiese e palazzi storici.
Il territorio è caratterizzato da una natura incontaminata, con boschi rigogliosi, pascoli e corsi d’acqua cristallina. Le montagne circostanti offrono numerose possibilità per gli amanti del trekking, dell’escursionismo e degli sport invernali. In particolare, la vicinanza con i Monti della Laga rende Montereale una base ideale per esplorare uno dei paesaggi più affascinanti dell’Appennino centrale.
Tradizioni e Gastronomia
Montereale è anche un centro di tradizioni popolari e culinarie. La cucina locale è caratterizzata da sapori genuini e piatti tipici della tradizione abruzzese. Tra le specialità più apprezzate ci sono:
• La pasta fatta in casa, come le sagne e i maccheroni alla chitarra, spesso condita con sughi di carne o di funghi.
• L’agnello arrosto e gli arrosticini, simbolo della tradizione pastorale dell’Abruzzo.
• Le zuppe di legumi, in particolare a base di lenticchie e fagioli locali.
I dolci tradizionali, come i torroncini e le ferratelle, che accompagnano le festività e le ricorrenze.
Le feste popolari rappresentano un’occasione per riscoprire le antiche usanze del paese. Tra gli eventi più sentiti c’è la Festa di San Giovanni Battista, patrono di Montereale, che si celebra con riti religiosi e manifestazioni folkloristiche.
Un Borgo da Scoprire
Montereale è un luogo perfetto per chi cerca tranquillità, storia e natura. La sua posizione privilegiata tra montagne e valli lo rende una meta ideale per gli amanti della montagna e della cultura locale. Che si tratti di una passeggiata tra le sue vie storiche, di un’escursione nei dintorni o di un viaggio alla scoperta della cucina abruzzese, Montereale sa regalare esperienze autentiche e indimenticabili.
Se sei alla ricerca di una destinazione lontana dal turismo di massa, ricca di fascino e immersa in un contesto naturale unico, Montereale è il posto giusto per te.
Salute e Benessere a Montereale: Un’Oasi di Aria Pura e Relax
Oltre alla sua ricchezza storica e paesaggistica, Montereale offre anche un ambiente ideale per chi cerca benessere fisico e mentale. Grazie alla sua posizione tra le montagne dell’Appennino centrale, il borgo garantisce aria pura, paesaggi rilassanti e un’atmosfera lon-
tana dallo stress della vita cittadina.
Aria Salubre e Benefici per la Salute
La purezza dell’aria di Montereale, combinata con un clima montano fresco e temperato, rende il paese una meta perfetta per chi soffre di problemi respiratori o semplicemente desidera rigenerarsi in un ambiente privo di inquinamento. Il contatto diretto con la natura favorisce il relax e riduce i livelli di stress, contribuendo al benessere psicofisico.
Attività Fisica e Sport nella Natura
Per chi ama mantenersi in forma, Montereale offre numerose opportunità per praticare sport all’aria aperta:
Escursionismo e trekking: I sentieri che si snodano tra le montagne e le colline circostanti permettono di immergersi nella natura incontaminata. Percorsi di varie difficoltà consentono di scoprire angoli suggestivi del territorio.
Ciclismo e mountain bike: Le strade panoramiche e i percorsi sterrati rendono Montereale una meta apprezzata dagli appassionati di bicicletta e MTB.
Sci e sport invernali: La vicinanza con le località sciistiche dell’Appennino abruzzese consente di praticare sci di fondo e ciaspolate nei mesi più freddi.
Passeggiate rigeneranti: Il semplice camminare nei boschi e nei borghi del comune rappresenta un toccasana per corpo e mente, grazie al contatto con la natura e al silenzio rilassante del paesaggio montano.
Benessere e Prodotti Naturali
L’alimentazione sana è un altro punto di forza della vita a Montereale. I prodotti locali, come formaggi, miele, legumi e carne proveniente da allevamenti naturali, garantiscono un’alimentazione genuina e nutriente. La dieta tradizionale abruzzese, ricca di ingredienti freschi e piatti preparati secondo antiche ricette, favorisce la salute e il benessere.
Inoltre, nelle vicinanze di Montereale si trovano centri termali e spa, ideali per chi desidera concedersi momenti di relax e trattamenti rigeneranti. Le acque termali della regione sono note per le loro proprietà benefiche e offrono esperienze di benessere uniche.
Ritrovare Equilibrio e Serenità
Montereale non è solo una destinazione turistica, ma anche un luogo ideale per chi cerca un ritmo di vita più lento e salutare. La quiete del borgo, la cordialità della comunità locale e la bellezza della natura circostante favoriscono uno stile di vita equilibrato, lontano dallo stress e dalla frenesia delle grandi città.
Che si tratti di una vacanza detox, di una fuga rigenerante o di un cambiamento di stile di vita, Montereale offre tutto ciò di cui si ha bisogno per riscoprire il proprio benessere, unendo salute, natura e tradizione in un contesto autentico e accogliente.ù
1. Servizi sanitari nelle aree interne Montereale, come molte altre realtà dell’entroterra abruzzese, si trova a dover affrontare il problema della distanza dai principali centri sanitari. Quali strategie sta adottando l’amministrazione comunale per migliorare l’accesso ai servizi sanitari di base e specialistici per i cittadini, soprattutto per gli anziani e le persone con difficoltà di spostamento?
Montereale, come molte realtà dell’entroterra abruzzese, deve affrontare la difficoltà di accesso ai servizi sanitari, un problema particolarmente sentito dagli anziani e da chi ha difficoltà di spostamento. Per questo, come amministrazione, stiamo lavorando per migliorare la rete di assistenza sul territorio, in collaborazione con la Regione Abruzzo.
Uno dei punti di riferimento per i cittadini è il consultorio familiare, che offre supporto sanitario e sociale. Inoltre, grazie alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), sono stati finanziati progetti per potenziare i servizi socio-sanitari e migliorare i collegamenti con le strutture ospedaliere. Abbiamo anche attivato un Punto Unico di Accesso per facilitare l’orientamento verso i servizi disponibili.
Il nostro obiettivo è garantire un’assistenza più vicina ai cittadini, rafforzando la medicina territoriale e assicurando cure accessibili, affinché nessuno rimanga escluso per motivi di distanza o difficoltà di spostamento.
2. Telemedicina e innovazione sanitaria
Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il settore della salute, con l’introduzione della telemedicina e della sanità digitale. Il Comune di Montereale ha previsto progetti o collaborazioni con la Regione Abruzzo per potenziare questi strumenti e garantire un’assistenza più efficiente ai residenti delle aree interne?
Il Comune di Montereale riconosce l’importanza delle nuove tecnologie nel settore sanitario, in particolare la telemedicina e la sanità digitale, per migliorare l’assistenza ai residenti delle aree interne. In collaborazione con la Regione Abruzzo, sono stati avviati progetti per potenziare questi strumenti e garantire un servizio più efficiente.
Uno dei progetti pilota, denominato “Telepallium”, è stato testato proprio a Montereale. Questo progetto ha permesso ai medici della ASL di L’Aquila di stabilire un collegamento telematico con pazienti residenti nel cratere sismico di Montereale, effettuando controlli a distanza e definendo terapie domiciliari, evitando così ricoveri ospedalieri non necessari. Inoltre, la Regione Abruzzo ha elaborato un progetto regionale di telemedicina per la gestione dei pazienti diabetici, coinvolgendo diabetologi di tutte le ASL per uniformare la gestione dei pazienti sul territorio. Per supportare queste iniziative, è in fase di realizzazione una piattaforma regionale di telemedicina, con un investimento di 1,5 miliardi di euro previsto entro il quarto trimestre del 2025.
L’Ospedale di Comunità di Montereale, come parte integrante della rete regionale finanziata con i fondi del PNRR, svolge un ruolo cruciale nell’offrire assistenza intermedia tra il domicilio e l’ospedale, facilitando l’implementazione di servizi di telemedicina per i residenti delle aree interne. Queste strutture sono progettate per fornire cure a pazienti che necessitano di assistenza sanitaria non gestibile a domicilio, ma che non richiedono il ricovero ospedaliero.
Tali progetti rappresentano passi significativi verso un’assistenza sanitaria più accessibile ed efficiente per i cittadini di Montereale e delle aree interne dell’Abruzzo.
3. Prevenzione e promozione del benessere
La prevenzione è un aspetto fondamentale della salute pubblica. Esistono o sono in programma iniziative per promuovere stili di vita sani, attività fisica e alimentazione equilibrata tra i cittadini, magari attraverso eventi, percorsi salute o collaborazioni con associazioni del territorio?
La prevenzione è un tema centrale per la nostra comunità, soprattutto in un territorio come il nostro, dove l’accesso ai servizi sanitari può essere più complesso. Per questo, il Comune di Montereale è impegnato nella promozione di stili di vita sani attraverso diverse iniziative. Organizziamo eventi dedicati alla salute e al benessere, in collaborazione con associazioni locali e professionisti del settore, e stiamo lavorando per valorizzare percorsi salute e spazi dedicati all’attività fisica. Inoltre, promuoviamo incontri sull’educazione alimentare e la prevenzione delle malattie croniche, coinvolgendo scuole e famiglie. Il nostro obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione, creando opportunità concrete per migliorare la qualità della vita di tutti.
4. Infrastrutture e mobilità per la salute
Uno dei principali ostacoli per chi vive in aree interne
è la difficoltà nel raggiungere ospedali e ambulatori, spesso a causa di trasporti pubblici limitati. L’amministrazione sta lavorando a soluzioni per potenziare la mobilità sanitaria, ad esempio con servizi di trasporto dedicati per chi necessita di visite o cure mediche?
Siamo consapevoli delle difficoltà che i cittadini di Montereale affrontano per raggiungere ospedali e ambulatori. Per questo, l’amministrazione sta lavorando a soluzioni concrete per migliorare la mobilità sanitaria. In collaborazione con la Regione e le ASL, stiamo valutando servizi di trasporto dedicati per chi deve effettuare visite o cure mediche, con particolare attenzione agli anziani e alle persone con difficoltà di spostamento. L’obiettivo è garantire un accesso più semplice e rapido alle strutture sanitarie, riducendo i disagi per i nostri cittadini.
5. Turismo del benessere e valorizzazione del territorio
Montereale è immerso in una natura incontaminata e offre un ambiente ideale per il turismo slow e del benessere. Ci sono progetti per valorizzare il territorio in questo senso, magari sviluppando percorsi benessere, attività outdoor o collaborazioni con strutture ricettive orientate alla salute e al relax?
Montereale, con il suo straordinario patrimonio naturale, è il luogo ideale per sviluppare un turismo slow e del benessere. L’amministrazione sta lavorando per valorizzare il territorio attraverso la creazione di percorsi benessere e attività outdoor, come trekking e cammini nella natura, che favoriscano sia il relax che la salute. Inoltre, stiamo incentivando collaborazioni con strutture ricettive e operatori locali per promuovere un’offerta turistica orientata al benessere, puntando su esperienze sostenibili e a contatto con l’ambiente. L’obiettivo è rendere Montereale una meta attrattiva per chi cerca tranquillità, aria pulita e un ritmo di vita più sano.
E` di recente approvazione dal CIPESS, inoltre, il progetto “Il Ponte tra i Parchi”, un’iniziativa approvata nell’ambito del programma di sviluppo RESTART, con un finanziamento di oltre 10 milioni di euro, che coinvolge anche il Comune di Montereale insieme ad altri comuni del cratere sismico 2009, con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali e culturali dell’Alta Valle dell’Aterno, integrandole in un sistema turistico di qualità.

di Federico Serra
Mobilità sostenibile, sport per tutti, cultura diffusa e partecipazione civica: sono questi i pilastri del progetto di città promosso da Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
In questa intervista, il primo cittadino di Ascoli illustra le principali azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, attraverso strategie integrate e inclusive. I temi affrontati spaziano dalla Promozione del Benessere e della Salute alla volontà di Incentivare lo Sport per Tutti, passando per la Valorizzazione del Patrimonio Storico e Culturale, il rilancio attraverso Eventi e Manifestazioni per il Turismo e la Comunità, fino al Coinvolgimento della Comunità e delle Collaborazioni locali come leva per costruire una città più coesa e partecipata. Chiude l’intervista un focus sulle best practice del Comune su questi temi, come esempio di innovazione e buone politiche locali.
1. Promozione del Benessere e della Salute
Ascoli Piceno vanta un territorio ricco di risorse naturali e ambientali. Quali strategie intendete adottare per incentivare stili di vita sani e il benessere dei cittadini, ad esempio attraverso la mobilità sostenibile, il verde urbano e le attività all’aria aperta?
Per incentivare stili di vita sani e il benessere dei cittadini di Ascoli Piceno, l’Amministrazione ha adottato una serie di strategie che coinvolgono diversi aspetti della vita quotidiana. A partire dalla promozione di iniziative sulla mobilità sostenibile, attraverso un forte incentivo all’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici: sono state realizzate piste ciclabili e corsie ciclabili sicure, è stato istituito l’apposito “Osservatorio permanente sulla mobilità sostenibile e la qualità dell’abitare” e adottato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Sono stati, inoltre, implementati i progetti “green”, che mirano a riqualificare le aree urbane con spazi verdi, parchi e giardini, rendendo la città più vivibile e accessibile e con una miglior qualità della vita per i cittadini.
Lo sport è un elemento chiave per la salute e la coesione sociale. Quali sono i progetti dell’Amministrazione per migliorare le infrastr utture sportive esistenti e per promuovere l’accesso allo sport per giovani, anziani e persone con disabilità?
L’Amministrazione comunale ha sempre investito molto sul tema sportivo, vedendo premiati i propri sforzi con il riconoscimento di Ascoli Piceno Città Europea dello Sport 2025. Tanti gli interventi di riqualificazione e miglioramento degli impianti sportivi portati a termine, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire pieno accesso e fruibilità alle persone con disabilità. Grande attenzione viene riservata a tutte le discipline sportive, nessuna esclusa, oltre all’organizzazione di corsi e attività rivolte ai più giovani. Tra le nuove iniziative, quella dell’organizzazione di un corso di primo soccorso sportivo riservato a tutti gli atleti e ai tesserati delle varie società sportive cittadine, a dimostrazione dell’attenzione riservata dall’Amministrazione al fondamentale e indissolubile connubio tra sport e salute.
3. del Patrimonio Storico e Culturale
Ascoli Piceno è una città d’arte e di storia. Quali iniziative culturali e turistiche si stanno sviluppando per far conoscere meglio il patrimonio artistico, le tradizioni e le eccellenze locali, sia ai cittadini che ai visitatori?
Ascoli Piceno, con il suo ricco patrimonio artistico e culturale, offre numerose opportunità per valorizzare le tradizioni locali e attrarre visitatori. L’Amministrazione ha messo in campo una serie di iniziative culturali che comprendono visite guidate tematiche, mostre d’arte e concerti, adatti a una fascia di pubblico vasta ed eterogenea. Sono numerosi gli appuntamenti che, nel corso dei mesi, animano la vita culturale cittadina, come certificato anche dagli ottimi numeri registrati dai Musei Civici.
Inoltre, l’Amministrazione prevede di collaborare con le scuole per sviluppare programmi didattici che inco-
raggino i giovani a conoscere e apprezzare la storia della loro città. L’organizzazione di eventi stagionali, come i festival dedicati alle tradizioni culinarie locali e le rievocazioni storiche, rappresenterà un modo per coinvolgere la comunità e attrarre turisti. Un’altra iniziativa importante è il potenziamento della comunicazione digitale, con l’implementazione di app e siti web interattivi che consentano ai visitatori di esplorare il patrimonio artistico attraverso tour virtuali e informazioni storiche. In questo senso, si sta lavorando alla digitalizzazione del patrimonio culturale, in modo tale da fornire un servizio innovativo ai visitatori che vanno alla scoperta di monumenti e opere d’arte.
È prevista la realizzazione di itinerari turistici tematici, che mettano in risalto i luoghi iconici ma anche le piccole botteghe artigiane e i prodotti tipici del territorio. Infine, l’Amministrazione intende collaborare con le scuole e le associazioni locali per organizzare eventi di valorizzazione del patrimonio, coinvolgendo direttamente i cittadini nella promozione della cultura locale.
4. Eventi e Manifestazioni per il Turismo e la Comunità
Eventi culturali, sportivi e rievocazioni storiche possono attrarre visitatori e stimolare la crescita economica locale. Ci sono nuovi progetti o potenziamenti previsti per rendere Ascoli ancora più attrattiva su questi fronti?
Per rendere Ascoli Piceno sempre più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale, l’Amministrazione si sta muovendo su un doppio binario: da un lato la pianificazione di nuovi eventi e dall’altro il potenziamento delle manifestazioni esistenti. Tra i progetti in cantiere ci sono festival di musica, danza e arte contemporanea, che si terranno in spazi pubblici e storici, per offrire un’esperienza unica ai visitatori. Inoltre, verranno organizzate rievocazioni storiche, in primis la tradizionale Quintana, che coinvolgeranno la comunità, creando un forte legame tra passato e presente.
L’ampliamento del calendario di eventi stagionali, come mercati artigianali e fiere gastronomiche, sarà un altro strumento per attrarre turisti e stimolare l’economia locale. Inoltre, il Comune prevede di collaborare con associazioni culturali e artistiche locali per garantire una programmazione diversificata e inclusiva, che possa soddisfare i gusti di tutti. Questi eventi rappresentano non solo un’opportunità economica, ma anche un modo per rafforzare il senso di comunità e appartenenza tra i cittadini.
Per rendere Ascoli Piceno ancora più attrattiva, l’Amministrazione sta investendo su cultura e sport. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, saranno introdotte competizioni di livello, come maratone e tornei, per promuovere la città come meta per eventi sportivi. In tutto questo un ruolo importante è affidato alla comunicazione e al marketing di questi eventi, attraverso
l’uso dei social media e delle piattaforme digitali con l’obiettivo di raggiungere un vasto pubblico. Infine, la collaborazione con sponsor e partner locali sarà fondamentale per garantire la sostenibilità economica di queste iniziative.
5. Coinvolgimento della Comunità e Collaborazioni Il benessere e la valorizzazione culturale possono essere potenziati con il coinvolgimento attivo di cittadini, scuole, associazioni e imprese. Quali strumenti o iniziative il Comune sta mettendo in campo per favorire questa partecipazione attiva? Può segnalarci se ritiene una best practice che debba essere posta in evidenza?
Il coinvolgimento attivo dei cittadini è essenziale per promuovere il benessere e la valorizzazione culturale di Ascoli Piceno. L’Amministrazione sta attuando diverse iniziative per favorire la partecipazione della comunità, tra cui la creazione di tavoli di lavoro e forum di discussione in cui i cittadini possono esprimere le proprie idee e suggerimenti. Inoltre, sono previsti bandi per finanziare progetti proposti da associazioni locali, scuole e gruppi di cittadini, incentivando così l’autoorganizzazione e la creatività.
Un’altra strategia prevede la promozione di eventi di volontariato che coinvolgano le scuole e le associazioni, creando opportunità per lavorare insieme su progetti di riqualificazione urbana e iniziative culturali. Infine, il Comune intende instaurare collaborazioni con le imprese locali per sviluppare progetti che uniscano il settore privato e quello pubblico, creando una rete di supporto che favorisca il benessere della comunità.
5. Best practice del Comune
Quale è una best practice di Ascoli da evidenziare?
Più che una best practice già consolidata, stiamo lavorando alla creazione di un “Festival della Comunità”, dove i cittadini possono presentare i loro talenti e idee, rafforzando i legami sociali e celebrando la diversità culturale. Nel complesso, il Comune di Ascoli sta implementando diverse iniziative per favorire la partecipazione attiva di cittadini, scuole, associazioni e imprese alle attività culturali e sociali. Uno strumento chiave sarà la creazione di un forum cittadino, dove i residenti possano esprimere opinioni, idee e suggerimenti su progetti e iniziative locali. Inoltre, saranno organizzati workshop e incontri di formazione per sensibilizzare e formare i cittadini sulle opportunità di partecipazione attiva, come il volontariato e la co-creazione di eventi. Le scuole saranno coinvolte in progetti di educazione civica e culturale che stimolino i giovani a diventare protagonisti della vita comunitaria. Infine, l’Amministrazione intende incentivare la collaborazione tra le associazioni locali e le imprese, creando reti di supporto e sinergie per la realizzazione di eventi e attività che valorizzino il patrimonio culturale e sociale della città.
Situata nel cuore delle Marche, Ascoli Piceno è una città che incanta i visitatori con il suo straordinario patrimonio artistico, la sua vivace scena culturale e un’attenzione sempre crescente al benessere. Nota come la “Città delle Cento Torri”, Ascoli rappresenta una delle perle più affascinanti del centro Italia, un luogo in cui storia, tradizione e innovazione si fondono armoniosamente.
Un Patrimonio Artistico e Architettonico Unico
Il centro storico di Ascoli è un vero e proprio museo a cielo aperto, caratterizzato dall’uso quasi esclusivo del travertino, la pietra locale che dona uniformità e luminosità agli edifici. La città vanta uno dei centri storici meglio conservati d’Italia, con una disposizione urbanistica che risale all’epoca romana.
Piazza del Popolo e Piazza Arringo
Il cuore pulsante della città è Piazza del Popolo, una delle piazze più belle d’Italia, circondata da portici eleganti e dominata dalla maestosità del Palazzo dei Capitani del Popolo. Qui si trova anche la storica Caffetteria Meletti, un caffè in stile liberty che ha accolto artisti e intellettuali nel corso dei secoli.
A pochi passi, Piazza Arringo, la più antica della città, ospita importanti edifici come il Duomo di Sant’Emidio, patrono della città, con la splendida cripta e il Battistero di San Giovanni, una delle strutture medievali più affascinanti delle Marche.
Chiese, Palazzi e Torri Medievali
Ascoli è una città che ha saputo conservare intatto il suo passato medievale. Le numerose chiese, come la Chiesa di San Francesco con il suo imponente portale gotico e il Convento dell’Annunziata, arricchiscono il patrimonio artistico cittadino. Il Ponte di Cecco, costruito in epoca romana, collega la città al passato glorioso dell’antica Asculum.
Un altro elemento distintivo sono le numerose torri medievali, che le hanno conferito il soprannome di “Città delle Cento Torri”. Tra queste spiccano la Torre degli Ercolani e la Torre del Palazzo Longobardo, simboli della potenza delle famiglie nobiliari del passato.
Cultura e Tradizioni
Ascoli Piceno è una città viva culturalmente, con un fitto calendario di eventi e tradizioni che affondano le radici nella storia.
La Quintana: il Torneo Cavalleresco
Uno degli eventi più attesi dell’anno è la Quintana, una rievocazione storica medievale che si tiene due volte l’anno, a luglio e agosto. Il torneo cavalleresco vede i sei sestieri della città sfidarsi in una gara di abilità a cavallo, accompagnata da sfilate in costume d’epoca e spettacoli.
Musei e Spazi Culturali
La città ospita numerosi musei e spazi culturali di grande valore. Tra questi spicca la Pinacoteca Civica, situata nel Palazzo dell’Arengo, che conserva opere di artisti come Carlo Crivelli
e Tiziano. Il Forte Malatesta, antica fortezza difensiva, oggi è uno spazio espositivo che ospita mostre temporanee e percorsi interattivi.
Di grande interesse anche il Museo dell’Arte Ceramica, che testimonia la lunga tradizione della lavorazione della ceramica ascolana, e il Museo Archeologico Statale, dove si possono ammirare reperti della civiltà picena e romana.
Gastronomia e Benessere
Ascoli Piceno è anche una città che esalta il benessere attraverso il cibo e la qualità della vita.
Simbolo della tradizione gastronomica ascolana sono le Olive all’Ascolana, deliziose olive ripiene di carne e fritte, che hanno ottenuto il riconoscimento DOP. La cucina locale offre piatti genuini come i maccheroncini di Campofilone, la frittata al tartufo, e le carni di qualità provenienti dalle colline circostanti.
Benessere e Natura
Per chi cerca relax e contatto con la natura, Ascoli offre numerose possibilità. I Monti Sibillini, a pochi chilometri dalla città, sono un paradiso per escursionisti e amanti del trekking, mentre le vicine Terme di Acquasanta rappresentano una meta perfetta per rigenerarsi grazie alle acque sulfuree.
I Centri di Promozione della Salute
Una best practice significativa nel campo della salute ad Ascoli Piceno è rappresentata dall’istituzione dei Centri di Promozione della Salute da parte dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno. Questi centri sono stati creati nell’ambito dell’azione congiunta CIRCE-JOINT ACTION, finanziata da EU4Health, con l’obiettivo di trasferire e implementare la Best Practice “Health Promotion Center (HPC)” proveniente dalla Slovenia.
I Centri di Promozione della Salute, attivi dal 2 dicembre 2024, sono situati presso il Distretto Sanitario/Casa della Comunità di Ascoli Piceno e quello di San Benedetto del Tronto. Essi offrono programmi gratuiti di prevenzione delle Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) e promozione della salute per persone di età compresa tra 18 e 69 anni. Le attività si concentrano su tematiche quali alimentazione sana, attività fisica, fumo e consumo di alcol.
L’équipe multidisciplinare è composta da infermieri, psicologi e biologi nutrizionisti, in collaborazione con i medici di medicina generale e i servizi specialistici della AST di Ascoli Piceno. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di promozione della salute pubblica, mirata a migliorare gli stili di vita dei cittadini e a prevenire l’insorgenza di patologie croniche attraverso interventi educativi e di supporto personalizzati.
Ascoli Piceno è molto più di una semplice città d’arte: è un luogo dove storia, cultura e benessere si intrecciano, creando un’esperienza unica per chi la visita. Che si tratti di passeggiare tra le sue vie storiche, partecipare a eventi culturali o assaporare le eccellenze gastronomiche, Ascoli sa regalare emozioni indimenticabili. Una città che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, esempio concreto di come arte, tradizione e salute possano convivere in armonia.

Il Giubileo 2025, noto anche come Anno Santo, rappresenta un evento di straordinaria importanza per la Chiesa Cattolica e per i fedeli di tutto il mondo. Proclamato da Papa Francesco, il Giubileo avrà come tema “Pellegrini di speranza”, ponendo al centro il concetto di rinnovamento spirituale, accoglienza e carità. L’evento avrà un impatto significativo non solo su Roma, sede principale delle celebrazioni, ma anche su altre città italiane ed europee che vedranno un afflusso straordinario di pellegrini e turisti.
Cos’è il Giubileo?
Il Giubileo è un evento religioso che si celebra ogni 25 anni e rappresenta un momento di perdono, riconciliazione e rinnovamento spirituale per i fedeli. Durante l’Anno Santo, i pellegrini possono ottenere l’indulgenza plenaria visitando le basiliche e partecipando alle
celebrazioni liturgiche. Il primo Giubileo della storia fu istituito nel 1300 da Papa Bonifacio VIII e da allora è diventato un appuntamento centrale per la Chiesa Cattolica.
Le Città Coinvolte nel Giubileo 2025
Anche se Roma sarà il cuore pulsante del Giubileo 2025, molte altre città italiane e internazionali avranno un ruolo importante nel supportare i pellegrini, organizzare eventi e valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale.
1. Roma: Il Centro del Giubileo
Roma sarà il fulcro delle celebrazioni giubilari, con milioni di fedeli attesi da tutto il mondo. Tra i luoghi più importanti che verranno visitati dai pellegrini troviamo:
• Le quattro Basiliche Maggiori: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, dove si potrà ottenere l’indulgenza plenaria.
• La Porta Santa: verrà aperta simbolicamente il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, dando inizio ufficialmente all’Anno Santo.
• Il Cammino Giubilare: saranno potenziati percorsi pedonali e infrastrutture per facilitare il movimento dei pellegrini, con particolare attenzione al rinnovamento urbano.
2. Assisi: La Città di San Francesco
Assisi, città natale di San Francesco, avrà un ruolo centrale nel Giubileo 2025 grazie al suo profondo legame con la spiritualità e la pace. Molti pellegrini faranno tappa nella Basilica di San Francesco, dove riposano le spoglie del santo patrono d’Italia.
3. Loreto: Il Santuario della Santa Casa
Il Santuario della Santa Casa di Loreto, uno dei principali centri mariani d’Europa, accoglierà numerosi fedeli nel corso dell’Anno Santo. Il luogo è particolarmente caro ai pellegrini per il suo legame con la Vergine Maria e per la tradizione che vuole la “Santa Casa” come la dimora originale della Madonna.
4. Santiago de Compostela: Un Ponte con il Cammino
Anche Santiago de Compostela, in Spagna, avrà un’importanza particolare durante il Giubileo. Essendo una delle principali mete di pellegrinaggio cristiano, molti fedeli potrebbero combinare il Cammino di Santiago con il pellegrinaggio a Roma.
5. Gerusalemme: Il Legame con le Radici del Cristianesimo
Gerusalemme, città santa per il cristianesimo, l’ebraismo e l’islam, potrebbe essere un’altra meta di pellegrinaggio significativa per coloro che desiderano approfondire la loro fede visitando i luoghi della vita di Gesù.
6. Torino: La Sacra Sindone
Torino, con la sua storica reliquia della Sacra Sindone, potrebbe vedere un incremento del turismo religioso in occasione del Giubileo. La possibilità di una nuova ostensione della Sindone potrebbe richiamare migliaia di fedeli.
7. Napoli e Pompei: Devozione Mariana
Il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei
è uno dei luoghi più visitati dai fedeli, e potrebbe avere un ruolo di rilievo nelle celebrazioni giubilari, accogliendo migliaia di pellegrini devoti alla Madonna.
L’Impatto del Giubileo 2025
Il Giubileo 2025 avrà un impatto enorme non solo dal punto di vista spirituale, ma anche economico e infrastrutturale. Si stima che oltre 30 milioni di pellegrini visiteranno Roma e altre città italiane, portando con sé un notevole incremento del turismo e della domanda di servizi.
Le principali conseguenze saranno:
• Miglioramento delle infrastrutture: Roma ha avviato un ambizioso piano di riqualificazione urbana con nuovi percorsi pedonali, restauro di monumenti e potenziamento dei trasporti pubblici.
• Sviluppo del turismo religioso: città e santuari vedranno un aumento dei visitatori, con effetti positivi sull’economia locale.
• Coinvolgimento delle comunità locali: molte diocesi organizzeranno eventi speciali per accogliere pellegrini da tutto il mondo.
Conclusione
Il Giubileo 2025 sarà un’occasione straordinaria di preghiera, incontro e scoperta. Oltre a Roma, numerose città italiane ed estere si preparano ad accogliere milioni di pellegrini, offrendo loro non solo un percorso di fede ma anche un’opportunità unica per riscoprire il patrimonio storico e culturale cristiano. Sarà un evento globale che unisce spiritualità, cultura e turismo, lasciando un’eredità duratura per il futuro.


Londra, capitale del Regno Unito, è una metropoli vibrante che coniuga storia millenaria, cultura cosmopolita e un’attenzione crescente al benessere dei suoi cittadini e visitatori. Dai monumenti iconici ai quartieri moderni, passando per i parchi rigogliosi e i centri di relax, Londra offre un’esperienza unica e completa.
Cultura e Arte
Londra è una delle capitali culturali del mondo, con una scena artistica straordinaria. I suoi musei e gallerie sono tra i più prestigiosi a livello globale. La National Gallery, con opere di Van Gogh, Caravaggio e Monet, e la Tate Modern, simbolo dell’arte contemporanea, sono tappe obbligate per gli amanti dell’arte.
Il British Museum custodisce reperti storici di inestimabile valore, tra cui la celebre Stele di Rosetta, mentre il Victoria & Albert Museum celebra il design e le arti decorative. Gli amanti del teatro troveranno nella Royal Opera House e nel Globe Theatre, ricostruzione del teatro di Shakespeare, esperienze culturali senza pari.
Storia e Monumenti
Londra è un palcoscenico a cielo aperto della storia britannica. Il Palazzo di Westminster, sede del Parlamento, con il celebre Big Ben, è uno dei simboli della città. A pochi passi, l’Abbazia di Westminster, luogo di incoronazioni e sepoltura di numerose figure storiche, rappresenta un capolavoro dell’architettura gotica.
La Torre di Londra, antica fortezza e prigione, custodisce i gioielli della Corona, mentre Buckingham Palace, residenza ufficiale della monarchia, attira migliaia di visitatori per il famoso cambio della guardia.
Tra le tracce della Londra romana e medievale, la Cattedrale di San Paolo, con la sua iconica cupola, e il Tower Bridge, simbolo ingegneristico della città, testimoniano la continua evoluzione della metropoli.
Benessere e Relax
Nonostante la sua frenesia, Londra offre numerosi spazi verdi che favoriscono il benessere fisico e mentale. Hyde Park, con il suo lago Serpentine, è perfetto per passeggiate e sport all’aperto. Regent’s Park ospita il celebre Zoo di Londra e offre splendidi giardini fioriti, mentre il Richmond Park, con i suoi cervi in libertà, trasporta i visitatori in un angolo di natura incontaminata.
Il benessere a Londra si estende anche alla gastronomia, con ristoranti che promuovono un’alimentazione sana e sostenibile. Dai mercati biologici come il Borough Market ai ristoranti vegetariani e vegani di Soho, la città offre alternative salutari senza rinunciare al gusto.
Le spa e i centri di benessere abbondano: dai lussuosi trattamenti di The Ned e ESPA Life at Corinthia, ai bagni termali giapponesi di Aire Ancient Baths, Londra è una destinazione ideale per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi.
Politiche di Salute e Benessere
L’amministrazione comunale di Londra ha intrapreso diverse iniziative per migliorare la salute e il benessere dei suoi cittadini. Tra queste, il programma Healthy Streets, che punta a rendere le strade più sicure e vivibili, incentivando la mobilità sostenibile e riducendo l’inquinamento.
Inoltre, il Mayor’s Health Inequalities Strategy si concentra sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie, migliorando l’accesso alle cure e promuovendo stili di vita sani. La città investe anche nella creazione di spazi pubblici inclusivi, con l’obiettivo di incoraggiare l’attività fisica e il benessere mentale.
Durante la pandemia, Londra ha implementato strategie efficaci per supportare la salute mentale e il benessere economico dei cittadini, con aiuti specifici per le comunità più vulnerabili. Programmi di supporto psicologico e iniziative per la riduzione dello stress lavorativo sono stati promossi per migliorare la qualità della vita urbana.
Come Vivere Londra al Meglio
Per immergersi completamente nello spirito della città, è consigliabile esplorarla a piedi o in bicicletta lungo il Tamigi. La rete di trasporti pubblici, tra cui la famosa metropolitana “The Tube”, è efficiente e ben collegata.
Londra è una città che sa sorprendere e incantare. Che si tratti di un viaggio culturale, storico o di puro relax, la capitale britannica offre esperienze indimenticabili a ogni tipo di visitatore.
Londra vanta una delle scene teatrali più vivaci e prestigiose al mondo. Dai musical di fama internazionale agli spettacoli di prosa, la città offre un’ampia varietà di esperienze teatrali.
West End: Il cuore del teatro londinese, noto per musical di successo come “The Phantom of the Opera”, “Les Misérables” e “The Lion King”.
Shakespeare’s Globe: Una fedele ricostruzione del teatro elisabettiano, dove si possono vedere rappresentazioni delle opere di Shakespeare nel loro contesto originale.
National Theatre: Situato sulla South Bank, ospita produzioni innovative e di alta qualità, con un mix di classici e nuove opere.
Royal Opera House: Tempio della lirica e del balletto, sede del Royal Ballet e della Royal Opera.
Old Vic & Young Vic: Due teatri iconici che propongono spettacoli di prosa e produzioni sperimentali, attirando alcuni dei più grandi talenti teatrali.
Per chi ama il teatro, Londra è una destinazione imperdibile, con spettacoli per tutti i gusti e una lunga tradizione di eccellenza artistica.
Londra è una delle capitali del calcio mondiale, con numerosi club che militano nelle principali categorie del calcio inglese.
Arsenal: Uno dei club più titolati della Premier League, con sede all’Emirates Stadium.
Chelsea: Squadra vincitrice di numerosi trofei nazionali e internazionali, gioca a Stamford Bridge.
Tottenham Hotspur: Club con una lunga tradizione, con sede al Tottenham Hotspur Stadium.
West Ham United: Storica squadra londinese, gioca al London Stadium.
Crystal Palace: Basato a Selhurst Park, noto per il suo tifo appassionato.
Fulham: Club con sede al Craven Cottage, una delle squadre più antiche di Londra.
Brentford: Attualmente in Premier League, gioca al Brentford Community Stadium.
Queens Park Rangers (QPR): Squadra che milita nel campionato di Championship, con sede a Loftus Road.
Millwall: Altro storico club londinese, noto per la sua tifoseria, gioca al The Den.
Con una tale varietà di squadre e una passione profonda per il calcio, Londra è una città imperdibile per gli amanti di questo sport.
Londra ospita alcune delle migliori università al mondo, attrattive per studenti da ogni angolo del pianeta.
University College London (UCL): Una delle migliori università a livello globale, famosa per la ricerca e l’innovazione in vari campi.
Imperial College London: Specializzata in scienze, ingegneria, medicina e business, con un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale.
King’s College London: Università storica, con un forte focus sulle scienze umane, giuridiche, mediche e sociali.
London School of Economics and Political Science (LSE): Tra le migliori al mondo per economia, scienze politiche e relazioni internazionali.
Queen Mary University of London: Conosciuta per i suoi programmi di medicina, ingegneria e scienze sociali.
City, University of London: Celebre per i suoi corsi di business, giornalismo e diritto.
Royal Holloway, University of London: Nota per la sua eccellenza nelle arti, umanistiche e scienze sociali.
Con un’offerta accademica così vasta e prestigiosa, Londra è una delle destinazioni più ambite per chi desidera una formazione di alto livello.
Londra è stata teatro di alcuni dei concerti più iconici della storia della musica. Ecco alcuni degli eventi più memorabili:
The Beatles - Rooftop Concert (1969) Savile Row, Londra L’ultimo concerto dal vivo dei Beatles si tenne sul tetto della loro casa discografica Apple Corps. Un’esibizione improvvisata che sorprese i passanti e divenne leggenda.
Queen - Live Aid (1985) Wembley Stadium
Freddie Mercury e i Queen rubarono la scena con una performance leggendaria durante il Live Aid, evento di beneficenza che raccolse fondi per la carestia in Etiopia.
The Rolling Stones - Hyde Park (1969 e 2013) Hyde Park Il primo concerto fu un omaggio a Brian Jones, scomparso due giorni prima. La band tornò nel 2013 per celebrare 50 anni di carriera.
Pink Floyd - The Wall Live (1980-81) Earls Court Exhibition Centre
Uno show spettacolare con scenografie monumentali, tra cui il celebre muro che veniva abbattuto durante il concerto.
Led Zeppelin - O2 Arena (2007) O2 Arena
Un concerto tributo per Ahmet Ertegun, con la band riunita per un’unica serata memorabile, segnando uno dei concerti più attesi di sempre.
David Bowie - Ziggy Stardust Farewell (1973) Hammersmith Odeon
Bowie scioccò i fan annunciando la fine di Ziggy Stardust durante il concerto, chiudendo un capitolo epico della sua carriera.
The Who - Live at Leeds & Londra (1970 e 1979) Shepherd’s Bush Empire, Wembley Arena Energia pura e spettacoli esplosivi, con il leggendario “Quadrophenia Tour”.
Oasis - Knebworth Park (1996) Knebworth Park (vicino Londra)
Due serate con oltre 250.000 spettatori, segnando l’apice della Britpop-mania.
Madonna - The Confessions Tour (2006) Wembley Arena Un evento epico con coreografie e scenografie spettacolari, consolidando Madonna come regina del pop.
The Rolling Stones - 50 & Counting Tour (2012-2013) The O2 Arena, Hyde Park Per celebrare i 50 anni di carriera, la band ha riportato l’energia dei vecchi tempi con uno show mozzafiato.
Londra continua ad essere una capitale della musica live, ospitando ogni anno artisti leggendari nei suoi stadi e arene storiche.
Londra, una delle metropoli più dinamiche del mondo, continua a rafforzare il proprio impegno per il benessere, l’integrazione e lo sviluppo sostenibile. Il sindaco Sadiq Khan ha più volte sottolineato l’importanza di costruire una città più equa e attenta alla salute dei suoi cittadini.
“La nostra ambizione non dovrebbe essere un ritorno alla ‘normalità’: il nostro obiettivo è costruire una società migliore, più sostenibile, più resiliente e più equa dalla ripresa dalla crisi del COVID-19”, ha dichiarato Khan. Questa visione si è concretizzata attraverso politiche innovative volte a migliorare la qualità della vita a Londra.
Uno degli aspetti fondamentali è stato il miglioramento della qualità dell’aria. Grazie all’introduzione dell’Ultra Low Emission Zone (ULEZ), la capitale britannica ha visto una significativa riduzione delle emissioni nocive, proteggendo così la salute pubblica. “Ogni londinese ha il diritto di respirare aria pulita”, ha affermato Khan, evidenziando l’impegno della città nel contrastare l’inquinamento.
Inoltre, l’integrazione sociale è una priorità per l’amministrazione londinese. Con oltre 300 lingue parlate e una popolazione estremamente diversificata, Londra è un esempio di multiculturalismo. “Vogliamo che ogni cittadino, indipendentemente dalla sua origine, si senta parte integrante della nostra città”, ha ribadito il sindaco. A tal fine, sono stati lanciati programmi di supporto per le comunità meno rappresentate e strategie per combattere le disuguaglianze economiche.
Sul fronte dello sviluppo sostenibile, Londra punta a diventare una città a zero emissioni entro il 2030. L’investimento in trasporti pubblici ecologici, piste ciclabili e spazi verdi è al centro delle politiche urbane. “Abbiamo un’opportunità unica per ricostruire una città più verde e più giusta”, ha affermato Khan.
Con queste iniziative, Londra si conferma una città all’avanguardia, impegnata a garantire un futuro migliore per tutti i suoi abitanti.
L’University College London (UCL) si distingue come un centro di eccellenza nell’ambito della “Urban Health”, affrontando le complesse interazioni tra ambiente urbano e salute umana. Con l’urbanizzazione in costante crescita, le sfide legate alla salute nelle città richiedono un’attenzione interdisciplinare e innovativa.
Il Professor Sir Michael Marmot, direttore dell’UCL Institute of Health Equity, ha dedicato la sua carriera allo studio delle disuguaglianze sanitarie. Egli afferma: “Dovremmo mirare affinché tutti abbiano lo stesso livello di buona salute dei migliori. Non basta migliorare l’accesso per i più poveri o vulnerabili, ma consentire a tutti nella società di raggiungere ‘il livello di buona salute potenzialmente raggiungibile’”.
Il Professor David Napier, antropologo medico presso UCL e direttore della Science, Medicine, and Society Network, sottolinea l’importanza di rimuovere le barriere che impediscono una salute ottimale. Egli definisce l’inclusività sanitaria come “il processo di rimozione delle barriere personali, sociali, culturali e politiche che ci impediscono di sperimentare una buona salute fisica e mentale e una vita pienamente realizzata”.
Attraverso iniziative come la Urban Health Community, UCL promuove la collaborazione tra ricercatori di diverse discipline per sviluppare strategie volte a migliorare la salute nelle aree urbane e ridurre le disuguaglianze. Questo impegno interdisciplinare rafforza la posizione di UCL come leader mondiale nella promozione della salute urbana.
Inoltre, UCL organizza eventi come “Urban Health: A Dialogue Across Disciplines”, che riuniscono esperti per discutere su come sfruttare le competenze dell’università in questo settore a livello locale, nazionale e globale. Questi incontri facilitano discussioni su come migliorare il supporto per la ricerca e le attività educative legate alla salute urbana presso UCL.
L’Economist Impact Health Inclusivity Index di luglio 2024, curato con il supporto di UCL, analizza l’inclusività sanitaria in 40 paesi. Il report, con il contributo degli esperti dell’UCL, sottolinea l’importanza dei determinanti sociali della salute, dell’empowerment comunitario e dell’effettiva implementazione delle politiche.
Il report di Economist Impact evidenzia il ruolo dell’Health City Institute come un’entità chiave per promuovere strategie urbane di inclusione sanitaria. L’istituto lavora per integrare la salute pubblica nelle politiche cittadine, affrontando disuguaglianze sanitarie e migliorando la qualità della vita urbana attraverso governance multilivello. Il report sottolinea come il modello proposto dall’Health City Institute sia cruciale per sviluppare politiche sostenibili e basate su evidenze. Maggiori dettagli nel rapporto completo: Economist Impact Report.
Attraverso queste iniziative e la leadership di esperti come i professori Marmot e Napier, e di un gruppo di ricercatori di assoluta qualità, UCL si afferma come capitale dell’Urban Health, affrontando le sfide poste dall’urbanizzazione e promuovendo ambienti urbani più sani e sostenibili.


Negli ultimi anni, la sanità digitale ha assunto un ruolo sempre più centrale nel miglioramento dell’assistenza sanitaria, offrendo strumenti innovativi per ottimizzare i processi clinici, migliorare la qualità delle cure e garantire un accesso più equo ai servizi sanitari. Tuttavia, l’Italia si trova ancora a dover affrontare diverse sfide, tra cui la necessità di un quadro normativo chiaro, l’integrazione delle terapie digitali nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e, soprattutto, la formazione delle competenze digitali per il personale sanitario e i pazienti.
L’On. Simona Loizzo, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Sanità Digitale e Terapie Digitali”, è tra i principali promotori di una transizione efficace verso la digitalizzazione del sistema sanitario italiano. In questa intervista, ci parlerà delle opportunità offerte dalla sanità digitale, delle principali difficoltà che il Paese deve affrontare e delle azioni concrete per garantire un’integrazione efficace delle nuove tecnologie, puntando anche sulla formazione del personale sanitario e sulla sensibilizzazione dei cittadini.
Domanda: Onorevole Loizzo, quale importanza riveste la sanità digitale nel contesto del sistema sanitario italiano?
Risposta: La sanità digitale rappresenta una componente fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari nel nostro Paese. Attraverso l’integrazione di tecnologie digitali, possiamo ottimizzare i processi clinici, rendere più efficienti le strutture sanitarie e, soprattutto, offrire ai pazienti cure più personalizzate e accessibili. Questo approccio non solo migliora la qualità dell’assistenza, ma contribuisce anche a una gestione più sostenibile delle risorse sanitarie.
Domanda: Recentemente, l’Intergruppo da lei presieduto ha presentato un disegno di legge sulle terapie digitali. Quali sono gli obiettivi principali di questa iniziativa legislativa?
Risposta: Il disegno di legge mira a colmare il vuoto normativo esistente riguardo alle terapie digitali in Italia. Uno degli obiettivi primari è l’inserimento di queste terapie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantendo così la loro accessibilità a tutti i cittadini. Per raggiungere questo traguardo, prevediamo l’istituzione di un comitato di valutazione che, sotto la guida di AGENAS, definirà un percorso di valutazione accelerato per l’inclusione delle terapie digitali nei LEA. Questo processo richiederà evidenze cliniche solide, con almeno due studi di alta qualità per ogni terapia proposta.
Domanda: Quali sono le principali sfide che l’Italia deve affrontare per l’implementazione efficace della sanità digitale?
Risposta: Una delle sfide principali è la mancanza di un quadro normativo chiaro e specifico che regoli l’adozione e il rimborso delle terapie digitali. Questo ha portato l’Italia a rimanere indietro rispetto ad altri Paesi europei, come la Germania, che ha già integrato numerose terapie digitali nel proprio sistema sanitario. È essenziale, quindi, sviluppare normative precise che facilitino l’adozione di queste innovazioni.
Un’altra sfida riguarda la formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione dei pazienti sull’utilizzo efficace delle tecnologie digitali in ambito sanitario. È fondamentale che medici, infermieri e operatori sanitari acquisiscano competenze digitali per poter integrare al meglio le nuove tecnologie nei percorsi di cura e assistenza. Allo stesso modo, i cittadini devono essere informati e formati sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione, affinché possano utilizzare questi strumenti in modo consapevole.
Domanda: Quali opportunità vede per il futuro della sanità digitale in Italia?
Risposta: Le opportunità sono molteplici. L’adozione diffusa della sanità digitale può portare a una maggiore equità nell’accesso alle cure, specialmente nelle aree remote o meno servite. Inoltre, le terapie digitali offrono soluzioni innovative per la gestione di malattie croniche, migliorando l’aderenza terapeutica e la qualità della vita dei pazienti. Dal punto di vista economico, l’investimento in tecnologie sanitarie digitali può stimolare la crescita di startup e aziende nel settore, creando nuovi posti di lavoro e promuovendo la ricerca e lo sviluppo.
Tuttavia, per cogliere appieno queste opportunità, dobbiamo investire nella formazione di competenze digitali, sia per gli operatori sanitari che per i cittadini, in modo da garantire un utilizzo consapevole ed efficace delle tecnologie disponibili.
Domanda: Come intende l’Intergruppo promuovere la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica e settore privato per avanzare in questo campo?
Risposta: L’Intergruppo si propone come piattaforma di dialogo e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Abbiamo istituito un comitato tecnico-scientifico e collaboriamo strettamente con AGENAS e il Ministero della Salute per sviluppare linee guida e normative efficaci. Inoltre, riteniamo fondamentale il coinvolgimento delle aziende private, poiché rappre-
sentano l’avanguardia nello sviluppo di soluzioni innovative. Solo attraverso una sinergia tra pubblico e privato possiamo realizzare una trasformazione digitale efficace del sistema sanitario italiano.
Domanda: Quali sono i prossimi passi per l’Intergruppo e per l’implementazione della sanità digitale in Italia?
Risposta: In questi mesi, ci siamo concentrati sulla discussione e sull’approvazione del disegno di legge sulle terapie digitali, coinvolgendo tutti gli stakeholder per raccogliere contributi e suggerimenti. Ora vogliamo individuare iniziative di formazione per il personale sanitario e campagne informative per i cittadini, al fine di favorire una cultura digitale diffusa. Senza un’adeguata formazione delle competenze digitali, il rischio è che le tecnologie innovative rimangano inutilizzate o implementate in modo inefficace. Continueremo inoltre a monitorare le esperienze internazionali, con l’obiettivo di adottare le migliori pratiche e adattarle al contesto italiano.
In conclusione, l’On. Simona Loizzo sottolinea come la sanità digitale rappresenti una sfida cruciale per il futuro del sistema sanitario italiano, richiedendo un impegno congiunto di istituzioni, comunità scientifica e settore privato per superare le sfide attuali. Fondamentale sarà l’investimento nella formazione di competenze digitali, affinché gli operatori sanitari possano integrare efficacemente le nuove tecnologie nei percorsi di cura e affinché i cittadini possano beneficiarne appieno.
di Federico Serra
Il 10 e 11 febbraio 2025, Parigi ha ospitato l’AI Action Summit, un evento di portata globale che ha riunito leader politici, esperti tecnologici, rappresentanti del mondo accademico e della società civile per discutere il futuro dell’intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo principale del summit è stato quello di tracciare una strategia condivisa per un’IA sostenibile, etica e accessibile a tutti, in un momento storico in cui questa tecnologia sta ridefinendo ogni aspetto della società, dal lavoro all’economia, dalla cultura alla governance globale.
L’evento, co-presieduto dal Presidente francese Emmanuel Macron e dal Primo Ministro indiano Narendra Modi, ha evidenziato il ruolo cruciale dell’IA nel futuro dell’umanità, ponendo al centro del dibattito temi fondamentali come la regolamentazione internazionale, l’accesso equo alla tecnologia, le implicazioni etiche e l’impatto sul mercato del lavoro.
Opportunità emerse: un’IA per il bene comune
Una delle principali iniziative annunciate al summit è stata la creazione di una fondazione internazionale per l’IA open-source, finanziata con 2,5 miliardi di euro in cinque anni. L’obiettivo è quello di fornire strumenti di IA accessibili ai paesi in via di sviluppo, contribuendo a colmare il divario digitale e a favorire l’innovazione globale. “L’intelligenza artificiale non deve essere un privilegio per pochi, ma un’opportunità per tutti”, ha dichiarato Macron durante il suo intervento inaugurale.
Un altro annuncio significativo riguarda i 35 “convergence challenges”, progetti pilota volti a dimostrare l’impatto positivo dell’IA in ambiti cruciali come la sanità, l’educazione e la lotta ai cambiamenti climatici. Queste iniziative mirano a evidenziare il potenziale dell’IA nel risolvere problemi globali complessi. “L’IA può aiutarci a prevedere e mitigare le catastrofi climatiche con una precisione mai vista prima”, ha affermato
il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.
Il futuro del lavoro e la rivoluzione industriale dell’IA
Il summit ha dedicato ampio spazio al tema del futuro del lavoro, affrontando la necessità di nuove politiche per garantire che l’IA migliori le condizioni lavorative senza causare disoccupazione di massa. Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha sottolineato che “l’IA non sostituirà i lavoratori, ma trasformerà il modo in cui lavoriamo. Dobbiamo concentrarci sulla riqualificazione delle persone, non sulla loro sostituzione”.
Il dibattito ha portato alla firma di un accordo tra aziende tecnologiche e governi per investire in programmi di formazione sull’IA, con l’obiettivo di garantire che i lavoratori possano adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro.
Criticità e divisioni: la regolamentazione e le preoccupazioni per i diritti umani
Nonostante gli annunci positivi, il summit ha rivelato profondi contrasti tra le nazioni sulla regolamentazione dell’IA. Mentre l’Unione Europea, la Cina e l’India hanno sostenuto una dichiarazione congiunta per un’IA inclusiva e sostenibile, gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno rifiutato di firmarla, citando preoccupazioni per la competitività economica. “Dobbiamo garantire che la regolamentazione non soffochi l’innovazione. La competizione globale è fondamentale per il progresso”, ha dichiarato il Segretario al Commercio degli Stati Uniti.
Un altro tema controverso è stato quello dell’impatto dell’IA sui diritti umani. Amnesty International ha criticato il summit per la scarsa rappresentanza della società civile, sottolineando che “l’IA non regolamentata può amplificare le disuguaglianze e minacciare la libertà di espressione”. La direttrice di Amnesty, Agnès Callamard, ha esortato i governi ad adottare normative
vincolanti per proteggere i cittadini dagli abusi delle tecnologie IA.
L’impatto ambientale dell’IA: una questione urgente
Un altro tema di grande importanza emerso al summit è stato quello dell’impatto ambientale dell’IA. I grandi modelli di intelligenza artificiale richiedono enormi quantità di energia per funzionare, sollevando preoccupazioni sull’aumento delle emissioni di CO2. Per affrontare questa sfida, è stato proposto un accordo multilaterale per ridurre l’impronta ecologica dei centri di elaborazione dati.
“Abbiamo bisogno di una rivoluzione nell’efficienza energetica dell’IA. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per questa tecnologia”, ha dichiarato il CEO di Google, Sundar Pichai.
Conclusioni: un futuro da costruire insieme
L’AI Action Summit 2025 ha segnato un passo importante nel dialogo globale sull’intelligenza artificiale, mettendo in evidenza sia le immense opportunità che le sfide ancora da affrontare. Se da un lato sono emerse iniziative promettenti per un’IA più equa e sostenibile, dall’altro le divisioni tra le nazioni dimostrano che il percorso verso una regolamentazione efficace sarà lungo e complesso.
Il summit ha lasciato un messaggio chiaro: l’IA non è solo una questione tecnologica, ma un tema politico, sociale ed etico che richiede cooperazione internazionale, trasparenza e un impegno collettivo per garantire che questa rivoluzione porti benefici a tutti, e non solo a pochi.

di Emanuele Corsaro1, Piero Savastano2, Gianluca Vaccaro3
1Founder and Advisor at Bhave 2 Founder Cheshire Cat AI; Data Scientist 3 Methodological Advisor at Bhave; Sociologo U.O. Educazione e Promozione della salute, Azienda Sanitaria provinciale di Catania
Nel dibattito sull’intelligenza artificiale (IA), l’attenzione si concentra sempre più sulla necessità di garantire innovazione tecnologica, trasparenza ed equità sociale. Il focus è su un’IA che non solo rafforzi la privacy e la gestione dei dati, ma che stimoli anche una democratizzazione dell’innovazione, permettendo a utenti, imprese e istituzioni di accedere a soluzioni etiche e sostenibili.
Intelligenza Artificiale nel settore sanitario e urbano: le opportunità da cogliere
Uno degli ambiti più delicati in cui l’IA sta avendo un impatto significativo è quello sanitario. L’IA può essere infatti utilizzata in una moltitudine di modi, molti dei quali già visibili e altri ancora in fase di valutazione per via delle numerose implicazioni che si portano dietro. È così che oggi grazie al machine learning, alle reti neurali e al deep learning, l’IA non si limita a supportare i medici nelle diagnosi o nella raccolta o sistematizzazione delle informazioni cliniche, ma può ridefinire in senso più ampio la gestione dei pazienti, supportare la personalizzazione delle terapie e accelerare la ricerca di nuovi trattamenti, solo per fare alcuni esempi. Analizzando milioni di dati in tempo reale, l’IA è infatti in grado di pianificare l’utilizzo più efficace delle risorse, snellire le liste d’attesa, fornire previsioni sui tassi di aderenza terapeutica dei pazienti (su questo ad esempio l’esperienza del progetto e algoritmo Da.Ba.Tool di Bhave che consente di prevedere l’aderenza terapeutica dei pazienti e modellizzare in tempo reale gli elementi comportamentali e attitudinali che incidono su di essa) e numerosi altri sbocchi che permettono di progettare, e non più solo immaginare, un nuovo sistema sanitario del futuro.
Ma oltre alla sanità, altri campi sociali, in cui si stanno giocando sfide di democratizzazione dell’IA, riguar-
dano la gestione e la pianificazione delle città. L’IA applicata alla gestione urbana può ridurre l’inquinamento, migliorare la sicurezza e rendere le città più vivibili. Ad esempio, nella mobilità sostenibile, sistemi predittivi regolano i flussi di traffico, riducendo emissioni e tempi di percorrenza. Tuttavia, l’implementazione di modelli IA nelle infrastrutture deve essere accompagnata da una progettazione urbanistica che privilegi il benessere umano: ridurre il traffico non è sufficiente se non si creano spazi pubblici che favoriscano socialità e accessibilità.
Nella gestione dei rifiuti, l’IA ottimizza i percorsi di raccolta e promuove il riciclo intelligente, prevenendo rischi sanitari legati all’accumulo di scarti. Ma è cruciale garantire che queste tecnologie siano implementate in modo equo, evitando di trascurare le zone meno redditizie per gli algoritmi.
Anche nella sicurezza urbana, strumenti di sorveglianza avanzata e analisi predittive permettono di prevenire crimini e migliorare il controllo del territorio. Tuttavia, l’eccessivo affidamento a questi sistemi potrebbe minare la privacy e la libertà individuale. La sicurezza urbana dovrebbe essere progettata non solo con un approccio tecnologico, ma anche con strategie sociali che rafforzino la coesione comunitaria e la partecipazione cittadina. Tutti esempi che ci permettono di capire come la dimensione gestionale e tecnologica dell ‘IA debba essere guidata e bilanciata da un’intelligenza umana consapevole, capace di integrare criteri etici, scelte valoriali e indirizzi politici nel processo decisionale. In poche parole, diventa sempre più importante elaborare sistemi consapevoli attraverso i quali le organizzazioni e le istituzioni siano in grado di prendere decisioni di pianificazione ed operative, stabilire regole e gestire risorse per raggiungere determinati obiettivi. Sono sistemi di processi, strutture e mecca-
nismi che guidano e controllano l’azione collettiva, garantendo trasparenza, responsabilità e partecipazione e la cui elaborazione non può essere delegata a modelli di linguaggio o statistici.
L’equilibrio tra automazione e responsabilità umana diventa dunque essenziale per garantire un utilizzo dell’IA che rispetti i diritti fondamentali e promuova il benessere collettivo.
In questo contesto anche nello specifico l’IA generativa sta rimodellando profondamente sia il settore sanitario che quelli urbani, influenzando l’organizzazione dei servizi, la gestione e la distribuzione delle risorse. Gli impatti più rilevanti includono:
• Medicina personalizzata e diagnosi predittiva: L’IA generativa consente ad esempio analisi avanzate sui dati genetici e clinici, permettendo diagnosi più precise e trattamenti su misura per i pazienti. Ciò migliora le possibilità di cura e previene l’aggravarsi delle patologie.
• Ottimizzazione delle risorse ospedaliere con strumenti di previsione avanzati supportando ad esempio la pianificazione della capacità ospedaliera, assicurando che strutture e personale siano impiegati nel modo più efficiente possibile.
• Rilevamento precoce delle epidemie e gestione delle crisi sanitarie permettendo di analizzare dati epidemiologici e sociali in tempo reale, identificando focolai di malattie infettive e permettendo risposte tempestive per contenere la diffusione.
• Sistemi di assistenza digitale per pazienti e cittadini come Chatbot e assistenti virtuali basati su IA che migliorano l’accesso alle informazioni sanitarie, riducendo la pressione sui centri di assistenza e garantendo un supporto immediato ai cittadini.
a cui si può assistere in sostanza non è solo la costruzione di realtà a misura di IA ma anche implicitamente e non deterministicamente la costruzione di bisogni umani a misura di IA come, ad esempio, la costruzione di modelli di relazioni sociali che ripercorrono modalità di interazione superficiali e sul piano esistenziale insoddisfacenti e/o disfunzionali per gli esseri umani. Strade, reparti ospedalieri, procedure sanitarie, parchi, supermercati, spazi verdi e strumentazioni diagnostiche sono sempre più progettati in funzione delle logiche e delle esigenze del l’IA, piuttosto che delle necessità e del benessere umano. Si tratta di mondi che risultano più ‘IA-friendly’ che ‘human-friendly: delle ergonomie algoritmiche, computazionali, digitali, automatizzate più che umane.
IA nel settore sanitario: i rischi da attenzionare per una reale democratizzazione
In questo momento di cambiamento radicale del nostro processo di produzione del sapere, infatti sono numerosi anche i rischi che emergono e gli aspetti da attenzionare da vicino in modo tale da indirizzare il cambiamento nella giusta direzione e con gli opportuni confini. Quando di parla di “democratizzazione dell’IA” in ambito sanitario non si può fare a meno di considerare infatti l’effetto snowball che tali strumenti possono produrre a valle, se non vengono ben progettati a monte.
Ora questi indiscutibili vantaggi legati all’uso dell’IA necessitano di un adattamento tecnologico ai sistemi se non in alcuni casi alla costruzione stessa di nuovi sistemi e realtà che siano sintatticamente e semanticamente basati sull’IA, in sostanza che siano su misura per queste tecnologie.
Questo ha creato un divario tra i progressi tecnici e le capacità umane di sfruttarli al meglio sviluppando condizioni in cui le persone sono sempre meno in grado di controllare le proprie scelte, lasciandosi dominare dalla tecnologia per comodità e immediatezza. Quello
Uno degli aspetti che è stato messo in evidenza già da tempo, è ad esempio un bias insito nell’algoritmo che può determinare discriminazione nell’analisi delle informazioni sanitarie. Gli algoritmi di intelligenza artificiale infatti, per funzionare in modo efficace, necessitano di un ampio numero di dati su cui essere addestrati. Tuttavia, quando il dataset di riferimento è limitato o non rappresentativo dell’intera popolazione, il rischio di distorsioni nei risultati aumenta considerevolmente (cfr. Domingos, 2016) e in ambito sanitario, questi bias possono avere conseguenze significativamente negative, portando a decisioni errate che penalizzano interi gruppi di pazienti storicamente sottorappresentati nei database biomedicali. Di conseguenza, l’IA rischia di riprodurre e amplificare pregiudizi già radicati nella società, contribuendo a rafforzare le disuguaglianze esistenti invece che abbatterle.
A ben vedere, infatti, è in realtà errato sostenere che l’IA lavori sui dati grezzi che le vengono forniti. Per funzionare adeguatamente, come dimostrano vari successi in campo biomedico (Jumper et al., 2021), l’IA ha bisogno di dati preparati adeguatamente, ossia di lavorare su modelli di conoscenza preesistenti. Per rendere efficace il processo di democratizzazione della co-
noscenza, non ci si può limitare a rendere i dati disponibili, bensì questi devono andare incontro ad un processo di curation, che li trasformi in modelli coerenti ed espliciti, ossia in rappresentazioni strutturate della conoscenza (Dessimoz & Thomas, 2024).
Le sfide attuali che mettono a repentaglio l’imparzialità nell’intelligenza artificiale sono perciò complesse e si manifestano in quasi ogni fase dello sviluppo di un strumento e vedono numerosi dei rischi di bias che accomunano qualsiasi ricerca scientifica. Fin dall’inizio, il problema può insorgere con l’utilizzo di dataset che possono essere usati come base di addestramento e che risultano, come abbiamo accennato, non equilibrati o non rappresentativi dell’intera popolazione. A ciò si aggiunge la fase di raccolta dei dati, che spesso avviene attraverso sistemi influenzati dalla soggettività umana, introducendo ulteriori distorsioni. Inoltre, la mancanza di regolamentazioni adeguate durante la progettazione degli algoritmi apre la porta a errori strutturali, mentre la replicazione involontaria di pregiudizi già presenti e radicati nella società, dovuta alle informazioni già presenti nei database, contribuisce a perpetuare ineguaglianze.
Tutto ciò rende necessaria una governance sia verso gli strumenti che verso le realtà e i sistemi in grado di relazionarsi con questi strumenti con protocolli etici ben strutturati per garantire equità e trasparenza nell’uso della tecnologia. Margaret Goralski, una delle studiose più autorevoli sul tema, ha fatto notare a questo proposito che i leader politici devono, con urgenza, assumersi la responsabilità di pianificare e gestire attivamente l’accesso e l’adozione di applicazioni dell’IA a beneficio della società, proteggendo così le persone più vulnerabili e attenuando gli impatti negativi sui gruppi sociali più a rischio (Goralski, 2020).
La gestione dei dati e le implicazioni etiche: i paradigmi open source
In questo contesto, la gestione dei dati e le implicazioni etiche assumono un ruolo dunque determinante nel dibattito attuale.
Fra le principali sfide attuali nell’ambito dell’intelligenza artificiale vi è la tutela e il controllo sui dati, una problematica che ripropone le stesse criticità già emerse con il web e i social network. I dati sensibili e personali rappresentano il vero valore nell’ecosistema digitale, eppure il loro ruolo cruciale rischia di essere trascurato. In realtà data driven il “dato” è il valore e la misura. Sia per l’addestramento dei modelli che per l’interazione con gli utenti, i dati sono il fulcro dell’IA, ma la fluidità e la naturalezza dell’esperienza d’uso pos-
sono indurre a dimenticare che dietro ogni conversazione si cela un software, spesso centralizzato e controllato da grandi aziende tecnologiche internazionali.
Legato a questo tema quello che riguarda il grado di autonomia conferito a questi sistemi. Sebbene l’obiettivo sia quello di automatizzare il più possibile, l’automazione si configura come un continuum e non può prescindere dalla valutazione del contesto d’uso. In molti settori, la responsabilità finale non potrà che rimanere in capo agli esseri umani, relegando l’IA al ruolo di assistente. Il monitoraggio e la supervisione umana risultano indispensabili per garantire che le decisioni prese dai sistemi intelligenti siano conformi ai criteri etici e operativi richiesti.
Un ulteriore nodo critico è rappresentato dai sistemi di valori su cui le IA vengono addestrate. Questo tema è estremamente complesso e articolato, poiché le intelligenze artificiali riflettono inevitabilmente i principi e le prospettive dei loro sviluppatori. Ad esempio, le IA occidentali tendono a privilegiare una visione favorevole ai paesi occidentali, una maggiore sensibilità alle tematiche di genere, la promozione del libero mercato e una determinata narrazione politica. Tuttavia, tali impostazioni non sono oggettive o neutre, bensì frutto delle scelte compiute da individui e imprese. È quindi essenziale interrogarsi in profondità sulle implicazioni culturali e ideologiche che questi sistemi incorporano e diffondono.
A rendere ancor più complesse queste problematiche è la nostra naturale tendenza a proiettare caratteristiche umane sulle macchine con cui interagiamo. Il linguaggio e il comportamento apparentemente “intelligenti” delle IA possono indurre a dimenticare che si tratta di software privi di coscienza e intenzionalità. Questa antropomorfizzazione rischia di offuscare la consapevolezza delle dinamiche tecniche e commerciali che stanno alla base dell’intelligenza artificiale.
In questo contesto l’approccio open source emerge come una valida strategia per contrastare alcune criticità. Un esempio concreto di questo approccio è il progetto tutto italiano del data scientist Piero Savastano Cheshire Cat, un framework open source di rilevanza europea che consente agli utenti di mantenere il controllo sui propri dati, evitando la condivisione obbligata con server esterni. Questo modello rappresenta un caso di successo nell’integrazione di etica e tecnologia, ponendosi come alternativa ai modelli centralizzati dominati dai giganti tecnologici.
In definitiva, a differenza del modello centralizzato proposto dai grandi player tecnologici, progetti come Cheshire Cat dimostrano che è possibile sviluppare so-
luzioni IA open source integrate con modelli come GPT o altre soluzioni aperte, fornendo alle aziende strumenti efficaci senza la necessità di dipendere da colossi tecnologici.
Progetti come questi dimostrano che la collaborazione tra sviluppatori, tecnici e aziende può generare valore condiviso, favorendo una crescita collettiva basata sulla condivisione del sapere. Il futuro dell’IA vedrà una crescente integrazione tra capacità linguistiche, visive e simboliche. L’evoluzione dell’IA renderà questi strumenti sempre più personalizzati e predittivi, capaci di ampliare la nostra capacità di anticipare scenari, adattarci al cambiamento e trasformare i dati in intuizioni strategiche, aprendo a nuove sinergie tra conoscenza e visione.
Il ruolo sociale dell’IA e le responsabilità degli sviluppatori sono ancora in fase di definizione. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la responsabilità non ricade esclusivamente su chi progetta e distribuisce queste tecnologie, ma anche sugli utenti che ne fanno uso. L’attuale ondata di automazione avrà ripercussioni significative non solo sul mercato del lavoro, ma anche sulla percezione stessa dell’essere umano e della sua quotidianità. La sfida non è solo tecnologica è ontologica e profondamente culturale e sociale, e richiede un impegno condiviso per garantire un’evoluzione dell’IA eticamente sostenibile e inclusiva.
Come si può vedere, l’IA può influenzare dunque profondamente il comportamento umano e migliorare le dinamiche decisionali di aziende e istituzioni. Tuttavia, è essenziale riflettere sulle implicazioni sociali e psicologiche dell’interazione con gli assistenti virtuali e sulle responsabilità legate al loro sviluppo.
L’IA non si inserisce su una tabula rasa di conoscenze, bensì su millenni si sapere organizzato e sistematizzato elaborato dalle comunità umane. In questo senso, non può essere considerato come uno strumento autonomo e isolato dal comportamento umano, e l’integrazione tra metodologie di behavioral sciences e soluzioni IA consentirà di migliorare il rapporto tra tecnologia e utente, e la consapevolezza crescente dell’IA non come mero acceleratore di calcoli, ma ponte dinamico tra l’ingegno umano e il futuro, dove il dialogo tra uomo e macchina diventa co-evoluzione e non sostituzione.
E di rimando, tutto ciò ci aiuterà a comprendere meglio anche il nostro stesso di comportamento: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea l’importanza di combinare scienze comportamentali e IA per analizzare i dati e comprendere meglio i modelli decisionali umani, prevedere tendenze future e ottimiz-
zare strategie di intervento. Tuttavia, come è stato mostrato, la governance etica - la cui responsabilità rimane tutta umana - sia dell’IA che dei diversi mondi prodotti e significati è fondamentale per produrre un sapere non distorto, garantire equità e trasparenza nella conoscenza e, in ultima analisi, una reale democratizzazione di tale strumento, dei diversi sistemi e della realtà.
Riferimenti
Dessimoz, C., & Thomas, P. D. (2024). AI and the democratization of knowledge. Scientific Data, 11, Article 268
Domingos P., (2016), L’algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo. Bollati Boringhieri, Torino.
Goralski M., Keong Tan T. (2020), Artificial intelligence and sustainable development, in «The International Journal Of Management Education» 1, Marzo 2020, pp. 200-325.
Jumper J, Evans R, Pritzel A, Green T, Figurnov M, Ronneberger O, Tunyasuvunakool K, Bates R, Žídek A, Potapenko A, Bridgland A, Meyer C, Kohl SAA, Ballard AJ, Cowie A, Romera-Paredes B, Nikolov S, Jain R, Adler J, Back T, Petersen S, Reiman D, Clancy E, Zielinski M, Steinegger M, Pacholska M, Berghammer T, Bodenstein S, Silver D, Vinyals O, Senior AW, Kavukcuoglu K, Kohli P, Hassabis D. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 596, 583–589 (2021).
Pattaro, A. F. (2022, 18 gennaio). Più diseguaglianze in sanità con l’intelligenza artificiale? Le sfide. Agenda digitale. Consultabile al: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/lia-in-sanita-alimenta-le-disuguaglianze-problemi-epossibili-precauzioni/
di Carlo Signorelli
Professore Ordinario di Igiene e Salute Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (con la collaborazione di S. Calabretta Medico in formazione in Igiene)
L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente trasformando il panorama della sanità pubblica, offrendo strumenti innovativi per rispondere in maniera efficace ai bisogni di salute della popolazione. Questa tecnologia, in grado di elaborare enormi quantità di dati in tempo reale e di operare in modo quasi autonomo, rappresenta una vera e propria rivoluzione per l’efficienza, la precisione e l’accessibilità dei servizi sanitari.
Nel campo medico, le applicazioni dell’IA spaziano dalla gestione e analisi dei dati clinici alla diagnostica automatizzata, fino all’automazione dei processi amministrativi. Tuttavia, una delle sue potenzialità più significative potrebbe riguardare l’ottimizzazione della prevenzione delle malattie. Attraverso l’analisi integrata di dati clinici e demografici, l’IA consente di identificare in anticipo fattori di rischio e tendenze emergenti, permettendo così di individuare le aree e le popolazioni più vulnerabili. Questo approccio predittivo è fondamentale, ad esempio, nella prevenzione di epidemie influenzali o altri focolai infettivi, fornendo alle autorità sanitarie la possibilità di intervenire in modo mirato e tempestivo.
Un ulteriore ambito di applicazione riguarda il monitoraggio in tempo reale delle emergenze sanitarie. La pandemia di COVID-19 ha messo in luce l’importanza di sistemi di sorveglianza avanzati, dove l’IA è stata impiegata per raccogliere, analizzare e interpretare dati relativi ai casi di infezione, alle zone a rischio e all’efficacia delle politiche preventive adottate. Strumenti come gli algoritmi predittivi hanno dimostrato la loro utilità anche nella gestione e distribuzione dei vaccini, aiutando a identificare le aree prioritarie per la somministrazione, riducendo sprechi e ottimizzando l’impiego delle risorse. Anche per le utilissime anagrafi vaccinali, per le chiamate attive delle popolazioni target per le vaccinazioni e per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza l’IA potrebbe rivelarsi un utile supporto per gli operatori di sanità pubblica.
Non solo nel settore infettivo, ma anche nella prevenzione delle malattie croniche l’IA sta dimostrando il suo valore. Modelli predittivi basati su fattori genetici, stili di vita e dati storici permettono di calcolare la probabilità di insorgenza di patologie quali diabete e malattie cardiovascolari. Ciò consente di attuare interventi personalizzati e mirati, inclusi gli screening, migliorando la prevenzione e contribuendo a contenere i costi complessivi del sistema sanitario.
Infine, l’IA supporta anche l’obiettivo fondamentale della sanità pubblica: garantire l’accesso alle cure a tutti, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle condizioni socioeconomiche. Strumenti di telemedicina e chatbot sanitari offrono consulenze a distanza, riducendo la necessità di spostamenti e abbattendo le barriere all’accesso, soprattutto per le popolazioni che risiedono in aree rurali o svantaggiate.
In conclusione, l’intelligenza artificiale sta emergendo come alleato indispensabile nella trasformazione dei sistemi sanitari. La sua capacità di anticipare e gestire le emergenze, di personalizzare la prevenzione e di ottimizzare le risorse, rappresenta un passo decisivo verso un futuro in cui la sanità pubblica potrà rispondere in maniera sempre più efficace e tempestiva alle sfide globali.


di Fidelia Cascini
Esperto nominato a supporto della Direzione Generale dei Sistemi Informativi e della Digitalizzazione del Ministero della Salute per le attività nazionali ed internazionali
La ricerca clinica è indispensabile per diagnosticare e curare malattie, scoprire nuove terapie, fare prevenzione, innalzare la qualità della vita e aumentarne la durata in condizioni di benessere. Richiede tuttavia tempi lunghi e costi molto alti per la sua realizzazione, sicché il completamento degli studi risulta difficile per complessità di progettazione ed esecuzione. L’intelligenza artificiale promette invece un cambio di passo, con enormi potenzialità di sviluppo dovute ad algoritmi di machine learning (inclusi i large language models), deep learning e altri che, alimentati da grandi quantità di dati sanitari a disposizione dei ricercatori (es. da cartelle cliniche elettroniche, dispositivi indossabili), consentirebbero di risparmiare miliardi di euro migliorando significativamente velocità e sostenibilità delle sperimentazioni a parità di efficacia e sicurezza di intervento.
Non si tratta solo di scoprire nuove molecole di farmaci, di comprendere e correlare fenomeni biologici, di disegnare terapie personalizzate, ma anche di aumentare la capacità di stratificare il rischio di malattia e fare previsioni di sopravvivenza nonché di riuscire a selezionare e coinvolgere i pazienti negli studi in modo preciso e mirato, automatizzando complessi e rigorosi criteri di inclusione. L’Intelligenza artificiale può, ad esempio, migliorare selezione e idoneità della popolazione di pazienti da coinvolgere in uno studio riducendo la dimensione campionaria necessaria per osservare un effetto terapeutico significativo. E può contestualmente ridurre sia i tempi che i costi della sperimentazione prima dell’immissione del prodotto terapeutico sul mercato, limitando anche il numero di pazienti inutilmente esposti a effetti collaterali del trattamento sperimentale.
Tuttavia, lo stato delle conoscenze scientifiche non permette ancora di conoscere quali siano gli strumenti di intelligenza artificiale da preferire per lo sviluppo della ricerca clinica, né il mercato è sufficientemente maturo per offrire un confronto oggettivo tra soluzioni
tecnologiche preferibili per lo scopo in termini di affidabilità ed efficacia. Se, dunque, l’uso dell’intelligenza artificiale può intervenire direttamente sui fattori chiave responsabili del fallimento di una sperimentazione clinica (es. modelli di selezione e coinvolgimento dei pazienti, sistemi per l’aderenza al protocollo di ricerca, strumenti di monitoraggio dei pazienti, sistemi di rilevamento degli endpoint clinici), non vi è ancora uniformità di intenti né di evidenza scientifica per quanto riguarda la progettazione e realizzazione degli studi clinici mediata da intelligenza artificiale. Ciononostante, vi è uno sforzo da parte della comunità scientifica nel cercare di sviluppare linee guida e raccomandazioni (ad esempio i progetti CONSORT-AI e SPIRIT-AI) per superare l’eterogeneità accelerando la ricerca clinica.
Sono inoltre necessarie ulteriori ricerche per esplorare se i miglioramenti dovuti all’uso dell’intelligenza artificiale per una maggiore efficienza nel coinvolgimento dei pazienti e nella progettazione della sperimentazione, si traducano in miglioramenti nella fattibilità, nella valutazione e nel costo della sperimentazione, oltre che nella trasferibilità dei suoi risultati. Infatti, per garantire la riproducibilità dei risultati e la validità clinica di una ricerca, anche i modelli basati sull’intelligenza artificiale devono essere valutati e convalidati. Questo passaggio meriterebbe l’integrazione di tutti gli attori chiave interessati alle fasi di progettazione e pianificazione della sperimentazione clinica: un quadro coordinato sarebbe vantaggioso per il successo di un’operazione innovativa di così grande entità. L’affiancamento di istituzioni e organizzazioni pubbliche sanitarie e accademiche all’industria tecnologica e farmaceutica, gioverebbe molto nel superare le barriere legate alla fiducia dell’opinione pubblica.
1 CONSORT-AI: Consolidated Standards of Reporting Trials-Artificial Intelligence
2 SPIRIT-AI: Standard Protocol Items: Recommendations for Interventional Trials- Artificial Intelligence

di Luca Pani
Ordinario di Farmacologia, Università di Modena e Reggio Emilia, Italia; Full Professor of Clinical Psychiatry, University of Miami, USA
La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale (IA) sta rimodellando le connessioni umane su molteplici fronti, dalle interazioni sociali quotidiane alla progettazione urbana e persino alla comprensione scientifica del nostro cervello. Questo breve articolo intende analizzare, in chiave tecnica, strategica, scientifica e filosofica, l’impatto dell’IA sulle relazioni sociali, sull’etica, sull’urbanistica e sulle neuroscienze, fornendo una visione aggiornata e multidisciplinare. In una prospettiva storica ampia, lo storico Yuval Noah Harari nel suo recente Nexus sottolinea come il flusso di informazioni abbia sempre plasmato la società umana, avvertendo che oggi ci stiamo lanciando “a capofitto nell’era dell’intelligenza artificiale, una nuova rete di informazioni che tuttavia minaccia di annientarci”. In quest’ottica, diventa cruciale esaminare il ruolo dell’IA nel tessuto delle connessioni umane contemporanee e future.
IA e relazioni sociali
Nel campo delle relazioni sociali, l’IA permea ormai piattaforme digitali e comunicazioni mediatiche, influenzando il modo in cui interagiamo. Algoritmi di raccomandazione dei social network collegano miliardi di persone, ma possono anche creare bolle informative e amplificare disinformazione, alterando dinamiche di coesione sociale. Sul piano interpersonale diretto, è in corso un dibattito sul ruolo dei chatbot come “amici” artificiali: alcuni esperti suggeriscono che le IA conversazionali possano alleviare la solitudine e rafforzare l’autostima, mentre altri temono che conducano a relazioni umane più instabili e insoddisfacenti La ricerca empirica conferma effetti sfumati: uno studio ha rilevato che l’uso di un assistente AI nelle chat rende le conversazioni più efficienti e il linguaggio più positivo; tuttavia, quando i partecipanti percepivano (o sospettavano) che il loro interlocutore stesse usando risposte suggerite dall’AI, lo valutavano meno cooperativo e sentivano minore affinità verso di lui. Ciò indica che l’IA può migliorare certe metriche comunicative, ma al contempo influire sulla fiducia e sull’autenticità
percepita nelle interazioni umane.
Implicazioni etiche dell’IA nelle connessioni umane L’adozione diffusa dell’IA solleva questioni etiche profonde in relazione alle connessioni umane e sociali. Organizzazioni internazionali come l’UNESCO avvertono che senza adeguate salvaguardie, l’IA rischia di riprodurre bias e discriminazioni presenti nella società, alimentando divisioni e minacciando diritti fondamentali. Ad esempio, algoritmi di riconoscimento facciale e di decision-making automatico hanno mostrato pregiudizi razziali e di genere, mettendo in luce il pericolo di affidare funzioni sociali critiche a sistemi non adeguatamente certificati. Ulteriori dilemmi etici riguardano la privacy (dato che l’IA può analizzare immense quantità di dati personali) e l’autonomia: se le nostre scelte e connessioni sono mediate da algoritmi, come garantire trasparenza e controllo umano? Di fronte a tali sfide, si stanno sviluppando linee guida e regolamentazioni (es. il AI Act europeo) per assicurare uno sviluppo responsabile dell’IA. Oltre agli aspetti normativi, la comunità scientifica enfatizza l’importanza di un’IA “umanocentrica”, progettata tenendo conto di valori etici, diversità culturali e inclusione. In teoria è tutto giusto ma non sarà facile.
IA e urbanistica
In ambito urbanistico, l’IA sta trasformando sia la gestione delle città sia il modo in cui progettiamo gli spazi urbani, con implicazioni sociali rilevanti. Le cosiddette smart cities utilizzano sistemi AI per analizzare dati urbani e ottimizzare servizi pubblici: ne risultano potenzialmente maggiore sicurezza, sostenibilità e qualità della vita per i residenti. Al tempo stesso, l’IA apre nuove strade per la pianificazione partecipativa: un esperimento recente a Panama ha impiegato un algoritmo generativo (UrbanistAI) in workshop di co-progettazione urbana, coinvolgendo attivamente sia giovani sia anziani nel ripensare spazi pubblici. I risultati hanno mostrato un significativo aumento della
percezione di inclusione sociale e di collaborazione intergenerazionale, con i partecipanti che si sono sentiti più valorizzati e ascoltati. Questo esempio illustra come gli strumenti di IA, se ben impiegati, possano fungere da catalizzatori per la coesione comunitaria e la partecipazione civica. Restano, tuttavia, considerazioni strategiche importanti: l’uso pervasivo di sensori e AI in città pone interrogativi su privacy urbana e sicurezza delle infrastrutture digitali. I decisori urbani sono chiamati a bilanciare innovazione e tutela dei cittadini, integrando l’IA in modo da migliorare la connettività sociale senza erodere la fiducia pubblica.
Nel campo delle neuroscienze, l’intreccio tra IA e studio del cervello rappresenta una frontiera affascinante e altamente interdisciplinare. Gli esperti parlano di una “relazione simbiotica” tra IA e neuroscienze, in cui la comprensione dell’architettura neuronale umana ispira la progettazione di macchine intelligenti, e l’IA a sua volta aiuta i neuroscienziati a esplorare nuove teorie sul funzionamento della mente. Questa sinergia bidirezionale è evidenziata da progressi concreti: reti neurali artificiali modellate su principi cerebrali stanno avanzando lo stato dell’arte del machine learning, mentre algoritmi di IA vengono utilizzati per analizzare enormi quantità di dati neuroscientifici (ad es. imaging cerebrale) individuando schemi complessi altrimenti difficili da cogliere. Tale collaborazione ha anche risvolti filosofici: man mano che comprendiamo e simuleremo meglio i processi cognitivi, emergono interrogativi su cosa distingua realmente l’intelligenza umana da quella artificiale. Inoltre, l’interfaccia cervello-macchina non è più fantascienza: progetti pionieristici di neurotecnologie (dai dispositivi impiantabili stile Neuralink alle protesi neurali smart) prospettano un futuro in cui le linee di confine tra mente e computer si assottigliano ulteriormente. Le neuroscienze forniscono quindi non solo ispirazione tecnica all’IA, ma anche un contesto per riflettere sulle implicazioni dell’estendere le capacità cognitive umane attraverso agenti artificiali.
Conclusioni
L’impatto dell’IA sulle connessioni umane è un fenomeno multidimensionale, che richiede un approccio integrato complesso. Abbiamo visto effetti contrastanti nelle relazioni sociali, grandi potenzialità ma anche rischi etici, applicazioni urbane che possono sia migliorare la coesione sia porre dilemmi di governance, e una convergenza con le neuroscienze che ridefinisce i confini dell’intelligenza. In linea con il taglio editoriale
di Urbes Magazine, è fondamentale adottare una prospettiva strategica e umanistica: comprendere l’IA non solo come tecnologia, ma come parte di un ecosistema socio-urbano-culturale. Dobbiamo ricordarci costantemente la necessità di riscoprire la nostra “comune umanità” nell’era di questi nuovi network informativi. Ciò implica guidare lo sviluppo dell’IA con principi etici solidi, interdisciplinarità e visione a lungo termine. Solo così le connessioni potenziate dall’IA – nelle città, nelle comunità e nelle nostre menti – potranno arricchire la società senza disgregarla, mantenendo l’innovazione al servizio dell’essere umano e non viceversa.
Bibliografia Essenziale:
1. Russell, S. e Norvig, P. (2020) Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4ª ed. Harlow: Pearson.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y. e Courville, A. (2016) Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press.
3. UNESCO (2021) Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Parigi: UNESCO. Disponibile da: https://unesdoc.unesco.org (Consultato il: 10 febbraio 2025).
4. European Commission (2021) Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Bruxelles: Commissione Europea. Disponibile da: https://eur-lex.europa.eu (Consultato il: 10 febbraio 2025).
5. Townsend, A. (2013) Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. New York: W.W. Norton & Company.
6. Harari, Y.N. (2024) Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, Random House Publishing Group 2024
di Mattia Altini
Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena
Oggi oltre il 23% degli italiani ha superato i 65 anni, le patologie croniche interessano quasi il 40% della popolazione: si contano 3,6 milioni di pazienti oncologici, 7 milioni di persone con patologie cardiache o cerebrovascolari (ipertensione, cardiopatie, scompenso cardiaco, ecc.) e tra i 3,5 e i 4 milioni di pazienti diabetici. Più della metà di questi pazienti presenta almeno una comorbidità. A fronte di tale scenario, la spesa sanitaria pubblica supera i 120 miliardi di euro, mentre il numero di professionisti sanitari è in diminuzione: entro i prossimi 10 anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) potrebbe perdere decine di migliaia di medici per raggiunti limiti di età, con un gap che potenzialmente sfiorerà le 50.000 unità qualora non si intervenga su programmazione, formazione specialistica e politiche di reclutamento. Inoltre, secondo la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche (FNOPI), mancano almeno 60.000-80.000 infermieri per raggiungere gli standard di altri Paesi europei e garantire un’adeguata continuità assistenziale.
Nel libro Wharton on Managing Emerging Technologies, Paul Schoemaker e George Day definiscono le tecnologie emergenti come breakthrough scientifici in grado di creare o trasformare interi settori. L’IA rientra appieno in questa categoria, poiché il suo potenziale dirompente non è paragonabile alle classiche innovazioni incrementali. Affrontarla come una “tecnologia qualsiasi” sarebbe rischioso: la portata del cambiamento che essa può generare è tale da rivoluzionare la prevenzione, la diagnosi e la cura, ed è un fenomeno che i manager della sanità pubblica devono affrontare e governare in modo rapido e consapevole.
L’intelligenza artificiale di oggi è applicabile a qualsiasi processo, primario o di supporto, nella sanità pubblica. Tuttavia, sono necessarie figure professionali specializzate che attualmente non trovano un adeguato riconoscimento nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), generando criticità sia nell’attrazione
sia nella permanenza di queste competenze. Inoltre, in un contesto sensibile come quello sanitario, la protezione dei dati sensibili è imprescindibile: una corretta gestione della privacy difende i diritti del paziente e pone le basi per un uso etico e responsabile delle tecnologie. Tuttavia, la sicurezza è un processo volto a proteggere il valore: bloccare l’accesso ai dati rischierebbe di vanificare le opportunità offerte dall’IA. Un utilizzo corretto e consapevole dei dati può infatti contribuire a ridurre costi superflui, individuare precocemente patologie e ottimizzare i percorsi clinico-assistenziali, generando miglioramenti significativi negli esiti di salute.
In questo ambito, la SIMM – in collaborazione con altre società scientifiche – ha promosso l’iniziativa “Open Privacy”, che ha portato alla modifica dell’articolo 110-bis della legge sulla privacy, facilitando l’uso dei dati sanitari a fini di ricerca e analisi avanzate, pur mantenendo elevati standard di sicurezza e tutela della persona. Resta però ancora molto da fare per definire in modo chiaro concetti fondamentali come, ad esempio, “uso secondario” e “dato anonimo”.
L’IA non è solo una tecnologia abilitante, ma una vera e propria leva strategica. Per coglierne appieno i benefici, è necessaria una strategia condivisa, profondamente incastonata nei bisogni dei pazienti. L’IA non dovrebbe rimanere un tema per pochi “addetti ai lavori”: ogni figura professionale adeguatamente formata – dal medico all’infermiere, dal farmacista all’amministrativo – può trarre vantaggio da sistemi di supporto alle decisioni e strumenti di analisi predittiva. Investire in formazione e aggiornamento continuo è dunque essenziale per superare le resistenze culturali e promuovere un uso responsabile dell’innovazione.
I dati sono il motore del cambiamento in sanità: dal Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 alla telemedicina, fino al progetto europeo EHDS (European Health Data Space), tutto converge verso un sistema interoperabile e orientato alla condivisione sicura delle in-
formazioni. In questo scenario, la SIMM sta sviluppando, insieme alle società scientifiche, a Federsanità, a Fondazione GIMBE e a big tech partner, una serie di indicazioni operative tramite l’iniziativa “Data Strategy”. In un contesto di trasformazione così rapido, occorre evitare la miopia di chi valuta la velocità dell’innovazione basandosi sul passato: l’IA potrebbe progredire molto più rapidamente di quanto immaginiamo. Sta a noi prepararci, con lungimiranza e responsabilità, per valorizzare questa nuova risorsa e migliorare il sistema delle cure.
AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM, PASSI, ISTAT, I numeri del cancro in Italia 2022.
Istituto Superiore di Sanità (ISS), rapporti e bollettini epidemiologici su malattie croniche e cardiovascolari. Ministero della Salute, sezione dedicata a cronicità e prevenzione, www.salute.gov.it
Società Italiana di Cardiologia (SIC), dati su prevalenza e incidenza delle patologie cardiovascolari.
Società Italiana di Diabetologia (SID) e Associazione Medici Diabetologi (AMD), rapporti periodici e progetti di monitoraggio del diabete in Italia.
Fonti:
Popolazione italiana (circa 60 milioni di abitanti, con oltre il 23% di over 65)
- ISTAT, Bilancio demografico nazionale e Popolazione residente.
Diffusione delle patologie croniche (circa 40% della popolazione, con comorbidità nella metà dei casi)
- Ministero della Salute, Rapporto sull’Assistenza Sanitaria.
- Istituto Superiore di Sanità (ISS), documenti su cronicità e multimorbidità.
- Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (Università Cattolica del Sacro Cuore), Rapporto Osservasalute
In molte pubblicazioni (es. “Osservatorio Nazionale sulla Salute 2022”), si sottolinea che il numero di persone con almeno una patologia cronica importante supera il 30-35% della popolazione; a seconda delle definizioni adottate, la stima può arrivare e superare il 40%, e di questi pazienti una quota significativa presenta due o più patologie in contemporanea.
Spesa sanitaria pubblica (oltre 120 miliardi di euro)
- Ragioneria Generale dello Stato, Conto Economico delle Amministrazioni Pubbliche – Spesa per funzione “Sanità”
- OECD Health Statistics, Country Health Profiles, sezione dedicata all’Italia.
Secondo la più recente Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) e i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la spesa sanitaria pubblica italiana si aggira effettivamente intorno a 124-127 miliardi di euro (variabile a seconda delle annualità di riferimento).




I
Le città del futuro: i vincitori della Healthy Cities Challenge di Cities for better health e C40
Nel febbraio 2025, C40 Cities ha annunciato i vincitori della Healthy Cities Challenge, un’iniziativa lanciata nell’aprile 2024 in collaborazione con Novo Nordisk, all’interno del progetto Cities fr better health . L’obiettivo della sfida era individuare progetti innovativi per migliorare la salute delle comunità e la resilienza climatica in contesti urbani inclusivi. Tra oltre 90 proposte provenienti da 33 paesi, sono stati selezionati tre progetti vincitori provenienti da Buenos Aires, Nairobi e Rio de Janeiro, ciascuno dei quali riceverà un finanziamento di 100.000 dollari per l’implementazione.
TRASFORMAZIONE DI DUNGA ROAD A NAIROBI
Il GoDown Arts Centre di Nairobi ha proposto un progetto per riqualificare Dunga Road, una strada trafficata nel distretto industriale della città. L’iniziativa mira a riconvertire spazi destinati alle auto in aree pubbliche inclusive, migliorando la sicurezza pedonale.
Il progetto prevede l’integrazione di pocket parks, marciapiedi più ampi, piste ciclabili, arredi urbani e zone ombreggiate per creare una strada attiva, sicura e vivace. Saranno organizzati eventi culturali, fiere di strada e installazioni artistiche locali per trasformare la strada in un punto di ritrovo centrale per le comunità locali.
Nei prossimi mesi, il team implementerà un progetto pilota di urbanismo tattico lungo un tratto di 500 metri della strada, concentrandosi sulla riallineamento stradale con barriere temporanee e dissuasori, con particolare attenzione ai contributi della comunità, soprattutto delle donne. Il pilota consentirà di testare e perfezionare il design stradale prima dell’implementazione completa.
RINVERDIMENTO DEL QUARTIERE
La Facoltà di Architettura e Urbanistica dell’Università Federale di Rio de Janeiro, in collaborazione con il Dipartimento di Pianificazione di Rio, sta affrontando la mancanza di spazi pubblici sicuri, le scarse condizioni pedonali e l’insufficiente verde urbano nel quartiere Oswaldo Cruz.
Il progetto si basa su un pilota realizzato nel luglio 2024 come parte del progetto del Corridoio della Sostenibilità della città, per sviluppare percorsi pedonali e ciclabili di alta qualità in tre nuove aree di intervento. L’iniziativa migliorerà la mobilità attiva con strade condivise, piste ciclabili e zone a bassa velocità. Inoltre, giardini pluviali, orti comunitari e forestazione urbana aiuteranno a mitigare il calore e le inondazioni. Il team
inizierà workshop per consultare le parti interessate, inclusa la comunità e il comune, per definire gli interventi.
L’ONG Asociación Sustentar, in collaborazione con il Comune di Vicente López e Sabe la Tierra, mira a potenziare l’impatto di un mercato settimanale che collega direttamente i produttori locali con i consumatori, garantendo l’accesso a cibo sostenibile e sano.
Nel corso del progetto, verrà istituita una rete di 30 attività commerciali, tra cui negozi di alimentari locali e ristoranti, impegnati a vendere i prodotti locali del mercato. I residenti avranno un accesso maggiore a cibo sano e conveniente, rafforzando al contempo l’economia locale e modificando i modelli di consumo del quartiere.
Saranno introdotti orti comunitari permanenti e sistemi di compostaggio in due scuole, oltre a workshop sull’agricoltura urbana e sulla preparazione di pasti a base vegetale. Il team mira a replicare il modello nei 16 mercati alimentari aggiuntivi gestiti da Sabe La Tierra.
Questi progetti evidenziano come le partnership tra organizzazioni locali e governi cittadini possano dare vita a idee innovative necessarie per proteggere il nostro futuro. Nei prossimi due anni, i vincitori lavoreranno a stretto contatto con C40 per monitorare i progressi e pianificare la sostenibilità e l’impatto a lungo termine delle loro iniziative.
C40 Cities: una rete globale per il clima
C40 Cities è una rete di quasi 100 città leader nel mondo impegnate ad affrontare la crisi climatica con azioni ambiziose e sostenibili. L’organizzazione supporta le città nella riduzione delle emissioni, nella resilienza urbana e nella promozione della giustizia climatica attraverso progetti innovativi e collaborazioni strategiche.
Cities for Better Health: la visione di un futuro urbano sano
Cities for Better Health è un’iniziativa globale promossa da Novo Nordisk che mira a promuovere ambienti urbani più sani, inclusivi e sostenibili attraverso interventi di mobilità attiva, verde urbano e accesso a cibo sano. Collaborando con città e organizzazioni locali, il programma punta a migliorare la qualità della vita dei residenti e a ridurre le disuguaglianze sanitarie nelle comunità urbane.

L’obesità infantile rappresenta una delle sfide sanitarie più urgenti del nostro tempo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 390 milioni di bambini di età compresa tra 5 e 19 anni erano in sovrappeso nel 2022, di cui 160 milioni affetti da obesità. Il fenomeno è in crescita, con impatti significativi sulla salute pubblica, aumentando il rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e disturbi cardiovascolari.
Per contrastare questa crisi, Novo Nordisk ha lanciato nel 2024 la Childhood Obesity Prevention Initiative (COPI), un’iniziativa innovativa focalizzata sulla prevenzione dell’obesità infantile nelle comunità urbane più vulnerabili. Questa iniziativa fa parte del più ampio programma Cities for Better Health, un progetto globale che mira a migliorare la salute pubblica attraverso interventi mirati a livello locale.
Obiettivi e Strategie di COPI
L’iniziativa COPI è stata sviluppata con un approccio scientifico e basato sull’evidenza, con l’obiettivo di creare ambienti urbani più sani per i bambini. Le strategie chiave includono:
• Promozione dell’attività fisica: Creazione di spazi pubblici sicuri per il gioco e lo sport.
• Miglioramento delle abitudini alimentari: Educazione alimentare nelle scuole e accesso a cibi sani nei quartieri svantaggiati.
• Coinvolgimento delle famiglie e delle scuole: Programmi di sensibilizzazione per incoraggiare stili di vita sani.
• Monitoraggio e valutazione: Raccolta di dati per misurare l’impatto degli interventi e migliorare le strategie nel tempo.
L’approccio è innovativo in quanto non si concentra esclusivamente sul comportamento individuale, ma cerca di trasformare l’ambiente urbano e sociale in cui
i bambini crescono, rendendo le scelte salutari più facili e accessibili.
Le Città Coinvolte nel Progetto
COPI sarà implementata inizialmente in sei città distribuite su cinque continenti, tra cui:
• Brasile
• Canada
• Francia
• Giappone
• Sudafrica
• Spagna
Queste città sono state scelte in base alla loro disponibilità a collaborare, alla presenza di comunità svantaggiate con alti tassi di obesità infantile e alla capacità di misurare l’efficacia degli interventi. Ogni città svilupperà soluzioni personalizzate per affrontare le sfide specifiche della propria popolazione.
Un Modello Basato su Dati e Analisi
Uno degli aspetti distintivi di COPI è il suo focus sulla valutazione scientifica. Ogni città condurrà studi trasversali per raccogliere dati dettagliati su:
• Indice di Massa Corporea (BMI) dei bambini coinvolti.
• Livelli di attività fisica e abitudini alimentari.
• Impatto psicologico e qualità della vita correlata alla salute.
Questo approccio basato sui dati permetterà di affinare gli interventi e sviluppare strategie replicabili in altre città del mondo.
Il Ruolo di Cities for Better Health
COPI si inserisce all’interno di Cities for Better Health, un’iniziativa più ampia che mira a creare città più sane attraverso partnership pubblico-private. Il progetto coinvolge governi locali, organizzazioni sanitarie
e il settore privato per implementare politiche urbane sostenibili.
Un elemento chiave di Cities for Better Health è la collaborazione con esperti di diversi settori, tra cui urbanistica, sanità pubblica e scienze comportamentali. Tra i principali partner di COPI troviamo Delivery Associates e The Behavioural Insights Team, che contribuiscono con strategie innovative per rendere gli ambienti urbani più favorevoli a uno stile di vita sano.
Perché È Importante Intervenire Ora?
L’obesità infantile non è solo una questione estetica, ma una condizione che può avere gravi conseguenze sulla salute a lungo termine. I bambini obesi hanno un rischio significativamente maggiore di:
• Sviluppare diabete di tipo 2 già in giovane età.
• Essere obesi anche in età adulta, aumentando la probabilità di malattie cardiovascolari.
• Avere problemi psicologici, come bassa autostima e depressione.
Inoltre, le disparità economiche giocano un ruolo cruciale: i bambini provenienti da famiglie a basso reddito hanno meno accesso a cibi sani e opportunità di fare attività fisica, aggravando ulteriormente il problema.
Un Futuro Più Sano per le Nuove Generazioni
COPI rappresenta un passo fondamentale nell’impegno globale per la prevenzione dell’obesità infantile.
L’iniziativa non si limita a fornire soluzioni temporanee, ma punta a creare un cambiamento strutturale e duraturo nelle città, migliorando la salute delle generazioni future.
Se l’iniziativa avrà successo, potrà diventare un modello per altre città del mondo, dimostrando come le politiche urbane possano essere strumenti potenti per la prevenzione delle malattie croniche.

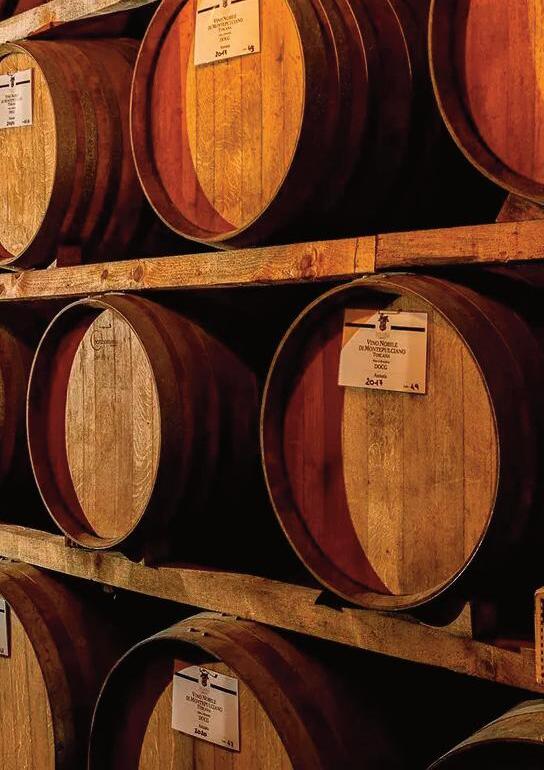
di Federico Serra
Situata nel cuore della campagna toscana, a Montepulciano, patria del Vino Nobile di Montepulciano, la Fattoria Svetoni è un luogo dove la tradizione vinicola si fonde con la bellezza naturale e l’ospitalità. Fondata nel 1865, questa azienda vinicola è circondata da vigneti di Sangiovese, il Prugnolo Gentile, vitigno autoctono che dà vita al prestigioso vino rosso del territorio. La storia di questa Fattoria risale tuttavia alla fine del XVIII secolo, quando fu commissionata da Pietro Leopoldo, allora Granduca di Toscana. La produzione di vino iniziò invece nel 1865 con la famiglia Svetoni, per l’appunto. Dal 2017, con l’arrivo della nuova proprietà fatta da cinque amici appassionati e un importante investimento per il restyling della struttura, la Fattoria Svetoni ha abbinato alla cantina il primo wine resort del territorio di Montepulciano. Dodici eleganti camere per una ospitalità all’insegna della naturalità, del benessere e dei sapori di questa terra. Gli ampi giardini, l’oliveto e il vigneto, permettono di vivere in prima persona l’autenticità della campagna toscana, tra vigneto e cantina dove nei periodi di raccolta è anche possibile provare l’emozione della vendemmia. Oltre alla piscina immersa nel parco tra i vigneti e gli olivi, anche una area Spa studiata per gli ospiti.
La Cantina, fiore all’occhiello della Tenuta. Proprio sotto alla Fattoria è stata ricavata una cantina, ormai secolare. Questo è l’ambiente dove dal 1865 viene prodotto il Vino Nobile di Montepulciano, primo storico marchio DOCG italiano. Dalla vite al vino, dalla potatura alla vendemmia, dalla vinificazione all’imbottigliamento, la storia del vino viene scritta ogni giorno in questo luogo magico dove anche gli ospiti hanno la straordinaria possibilità di accedere. In tutto l’azienda conta 23 ettari di vigneto, che si estendono a un’altitudine di 300-350 mt slm., dove il Prugnolo Gentile, così viene chiamato il Sangiovese a Montepulciano, ha modo di esprimersi nel suo massimo potenziale. Uno staff qualificato organizza per gli ospiti tour e degustazioni. Il momento della vendemmia poi diventa una esperienza da condividere in prima persona.
Osmosi: un ristorante stellato con vista vigneto. Un reciproco flusso di idee. È da questo concetto che nasce
la collaborazione tra la Fattoria Svetoni e Mirko Marcelli, insieme a Simone Migliorucci, con l’obiettivo di riportare a Montepulciano una cucina di territorio, ma con uno sguardo internazionale. È da questo progetto che nasce il primo ristorante stellato della città di Montepulciano, dove la cucina è un laboratorio che si basa su materie prime stagionali. Una cantina che partendo da Montepulciano, con il Vino Nobile in primis, viaggia per la Toscana fino ad arrivare in Francia crea abbinamenti vino cibo unici. È questo il fiore all’occhiello della tenuta, un modo per cominciare o finire la giornata con il giusto sapore.
Il Vino Nobile di Montepulciano. Sono numerose le particolarità che fanno del Vino Nobile un prodotto identitario, di carattere e soprattutto fortemente legato al suo territorio di origine. Il disciplinare di racchiude tutte le peculiarità e le caratteristiche distintive di questo prodotto. A partire dal forte legame con una zona di produzione molto circoscritta che comprende il solo territorio comunale di Montepulciano. I vitigni previsti dal disciplinare sono per lo più quelli autoctoni ed è per questo che prevale il Sangiovese (che a Montepulciano prende il nome di Prugnolo Gentile) che deve essere presente per almeno il 70 per cento. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate in cantine situate nel territorio di Montepulciano e l’invecchiamento deve durare almeno due anni, conteggiati a partire dal primo gennaio successivo alla vendemmia. Entro questo periodo il produttore può decidere se far maturare il Vino Nobile per 24 mesi in legno, oppure 18 mesi in legno e i restanti in altri recipienti, oppure almeno 12 in legno, sei in altri recipienti e sei in bottiglia. Dal 2025 è entrato in commercio anche il Vino Nobile di Montepulciano Pieve, un nuovo disciplinare, ancora più rivolto alla tradizione, che racconta il vino attraverso le 12 Pievi del territorio.
www.fattoriasvetoni.it
di Ludovica Serra
Il cibo di strada è molto più di un semplice pasto veloce: è una finestra sulle tradizioni e sulla cultura di un popolo. Passeggiando per le strade di una città, tra mercati affollati e vicoli nascosti, si possono scoprire sapori autentici che raccontano storie di generazioni. Ogni angolo del mondo ha il suo street food caratteristico: dai tacos messicani ai falafel mediorientali, dagli hot dog newyorkesi ai samosa indiani.
Lo street food nasce come una necessità, un pasto economico e accessibile per lavoratori e viaggiatori, ma oggi è diventato un’attrazione turistica e una forma d’arte culinaria. Molti chef rinomati si ispirano ai piatti di strada per creare versioni raffinate nei loro ristoranti, dimostrando che anche il cibo più semplice può essere un’esperienza straordinaria.
In Italia, lo street food ha una lunga storia, con specialità che variano da regione a regione. A Palermo, il Pani ca Meusa è un’istituzione, mentre a Napoli non si può resistere alla pizza a portafoglio. In Asia, lo street food è un vero e proprio stile di vita: bancarelle affollate servono piatti succulenti come il Pad Thai, gli spiedini di satay o i soffici baozi al vapore.
Oggi ti portiamo in un viaggio gastronomico con due ricette straordinarie: una specialità cinese, i Baozi, soffici panini al vapore ripieni di carne, e un classico dello street food italiano, il Pani ca Meusa, un panino dal sapore intenso che ha conquistato generazioni di siciliani.
Queste due ricette rappresentano alla perfezione la magia dello street food, dove il cibo racconta la storia e le tradizioni di un luogo. Preparale a casa per un viaggio gastronomico senza uscire dalla tua cucina!
Prepara questi piatti nella tua cucina e lasciati trasportare dai sapori autentici dello street food!
1. Baozi (Panini Cinesi al Vapore con Ripieno di Maiale)
I Baozi sono soffici panini al vapore ripieni di carne o verdure, molto popolari nei mercati cinesi. Questa versione classica è farcita con un saporito ripieno di maiale.
Ingredienti (per 8-10 baozi)
Per l’impasto:
• 300 g di farina 00
• 150 ml di acqua tiepida
• 1 cucchiaino di zucchero
• ½ cucchiaino di lievito secco
• 1 pizzico di sale
Per il ripieno:
• 250 g di carne di maiale macinata
• 1 cipollotto tritato
• 2 cucchiai di salsa di soia
• 1 cucchiaino di olio di sesamo
• 1 cucchiaio di zenzero grattugiato
• 1 cucchiaino di zucchero
• 1 pizzico di pepe
Preparazione
1. Sciogli il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida e lascia riposare per 5 minuti.
2. In una ciotola, mescola la farina e il sale, poi aggiungi l’acqua con il lievito. Impasta fino a ottenere un composto liscio. Copri e lascia lievitare per 1 ora.
3. Prepara il ripieno mescolando la carne di maiale con tutti gli altri ingredienti.
4. Stendi l’impasto e ricava dei dischi di circa 10 cm di diametro.
5. Farcisci con il ripieno, chiudi i baozi e lasciali riposare per 15 minuti.
6. Cuoci a vapore per 12-15 minuti. Servi caldi!
2. Panino con la Milza (Pani ca Meusa) - Specialità Siciliana
Il Pani ca Meusa è un’icona dello street food palermitano: un panino farcito con milza di vitello, cotta nello strutto e servita con formaggio o limone.
Ingredienti (per 4 panini)

• 4 panini morbidi (tipo mafalde o rosette)
• 300 g di milza di vitello già bollita
• 2 cucchiai di strutto
• 50 g di caciocavallo grattugiato (opzionale)
• Succo di limone q.b.
• Sale e pepe q.b.
Preparazione
• Taglia la milza a fettine sottili.
• Sciogli lo strutto in una padella e cuoci la milza per 5-7 minuti finché diventa tenera.
• Taglia i panini a metà e scaldali leggermente.
• Farcisci i panini con la milza e scegli se aggiungere formaggio o limone.
• Servi caldi, accompagnati da una birra fresca!

“Maddalena in estasi”
«L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.»
Paul Klee
“CARAVAGGIO
di Frederik Greenhouse
Roma è da sempre molto più di una capitale: è una città-mondo, un luogo in cui arte, storia e cultura si intrecciano profondamente con la vita quotidiana e il benessere collettivo. In questo contesto privilegiato, la mostra “Caravaggio e il suo tempo”, allestita a Palazzo Barberini nell’ambito del grande progetto “Caravaggio 2025”, si presenta non solo come un evento espositivo di eccezionale valore, ma come una vera e propria esperienza di rigenerazione culturale e urbana.
Promossa dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, l’esposizione inaugura un percorso di riscoperta del genio di Michelangelo Merisi detto Caravaggio, riportandolo idealmente al centro della città che ne ha accolto l’arte, ne ha vissuto la forza rivoluzionaria e ne custodisce ancora oggi le tracce più autentiche. Roma, con la sua identità stratificata, si conferma luogo vivo dove la cultura non è ornamento, ma motore di senso, cura e benessere diffuso.
Il percorso espositivo si sviluppa in dieci sezioni tematiche, accompagnando il visitatore in un viaggio che attraversa la forza drammatica del chiaroscuro, l’umanità potente dei volti, la spiritualità incarnata nella materia pittorica. Accanto ai capolavori già presenti nella collezione permanente – come Giuditta che decapita Oloferne, San Francesco in meditazione e Narciso –arrivano in mostra alcuni prestiti straordinari che rendono questo appuntamento unico e irripetibile.
Tra questi, spicca l’Ecce Homo, proveniente dal Museo del Prado di Madrid, che rientra in Italia per la prima volta dopo secoli. Insieme a lui, opere come la Santa Caterina d’Alessandria del Museo Thyssen-Bornemisza – già parte della collezione Barberini e ora restituita idealmente al suo contesto originario – e Marta e Maddalena del Detroit Institute of Arts, per il quale Caravaggio utilizzò la stessa modella della Giuditta, permettendo oggi un confronto visivo diretto, per la prima volta nella storia.
La mostra è anche l’occasione per riunire un nucleo fondamentale di opere legate alla figura del banchiere e collezionista Ottavio Costa, tra i principali committenti del pittore. Accanto alla Giuditta di Palazzo Barberini, troviamo il San Giovanni Battista del Nelson-Atkins Museum di Kansas City e il San Francesco in estasi del Wadsworth Atheneum of Art di Hartford. Si aggiungono capolavori legati alla storia del collezionismo Barberini, come I Bari del Kimbell Art Museum di Fort Worth, che torna nel palazzo dove fu a lungo conservato.
A concludere la selezione, il prezioso prestito di Intesa Sanpaolo: il Martirio di sant’Orsola, ultima opera conosciuta di Caravaggio, dipinta poco prima della sua morte. Un’immagine intensa, drammatica, quasi profetica, che chiude idealmente il percorso espositivo con una riflessione sul destino, sulla spiritualità e sul confine tra arte e vita.
Il valore della mostra non risiede solo nell’eccellenza delle opere esposte, ma nella capacità di restituire il senso profondo dell’arte come elemento centrale nel benessere delle comunità. Come ha sottolineato il New York Times in una recensione entusiasta, “la mostra è una rivelazione” non solo per l’alta qualità curatoriale, ma perché è capace di raccontare Caravaggio all’interno di un sistema culturale e sociale più ampio, dove la città diventa palcoscenico e protagonista.
In questo senso, “Caravaggio e il suo tempo” è anche un invito a riscoprire Roma non solo come sede della grande arte, ma come luogo di benessere culturale, di rigenerazione civile, di dialogo tra passato e presente. L’arte, qui, non è solo contemplazione, ma esperienza viva, strumento di coesione, stimolo alla riflessione individuale e collettiva.
È una mostra che unisce storia e contemporaneità, memoria e visione, e che ci ricorda come la bellezza –quando è condivisa, narrata e vissuta – possa essere una forma profonda di benessere.

Un importante passo avanti nella sinergia tra salute e sostenibilità è stato compiuto con l’ingresso della Fondazione Diabete & Ricerca Onlus all’interno della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF) in qualità di socio co-fondatore. Questa adesione segna un’importante alleanza tra la ricerca scientifica sulle malattie metaboliche e le strategie di sostenibilità urbana, rafforzando l’impegno verso una società più sana e resiliente.
Un’alleanza tra salute e sostenibilità
La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità è un’organizzazione che mira a sviluppare un modello integrato di sviluppo sostenibile per la città di Venezia e il suo territorio metropolitano. La sua missione è promuovere una crescita economica e sociale che sia al tempo stesso rispettosa dell’ambiente e del patrimonio storico-culturale della città lagunare.
L’inclusione della Fondazione Diabete & Ricerca
Onlus tra i soci fondatori sottolinea la necessità di unire le tematiche della sostenibilità ambientale con quelle della salute pubblica. Il diabete e altre malattie metaboliche rappresentano una delle principali sfide sanitarie globali, e il loro impatto sulle comunità urbane è sempre più rilevante. Creare politiche sostenibili significa anche promuovere la prevenzione e la cura delle malattie croniche attraverso la ricerca e l’innovazione.
Le dichiarazioni dei protagonisti
Renato Brunetta, Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ha dichiarato: «L’ingresso della Fondazione Diabete Ricerca Onlus come socio co-fondatore rappresenta un arricchimento per la nostra Fondazione. Venezia, con le sue specificità ambientali e urbane, sarà il contesto ideale per sviluppare iniziative innovative che approfondiscano il le-
game tra ambiente e salute, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere soluzioni sostenibili».
Angelo Avogaro, Presidente della Fondazione Diabete Ricerca Onlus, ha aggiunto: «È con profondo orgoglio che annunciamo questa partnership strategica con la Fondazione Venezia, un’alleanza che nasce da una visione comune: rendere le nostre città più vivibili e i nostri cittadini più sani. Questo progetto innovativo esplora per la prima volta il complesso intreccio tra ambiente urbano e salute pubblica, con particolare attenzione al diabete e alle altre malattie croniche non trasmissibili attraverso la rilevazione di dati da diverse fonti. La nostra ricerca, condotta con il massimo rigore metodologico, permetterà di comprendere come l’inquinamento atmosferico e altri fattori ambientali influenzino la salute dei veneziani. È un passo concreto verso una prevenzione più efficace e una migliore qualità della vita nella nostra straordinaria città lagunare, caratterizzata da una complessità ambientale unica».
L’importanza della ricerca per una città più sostenibile
Il diabete è una patologia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo e il suo trattamento richiede non solo innovazioni scientifiche, ma anche cambiamenti nel modo in cui le città sono progettate e gestite. Un ambiente urbano sano, con spazi verdi, mobilità sostenibile e accesso a un’alimentazione equilibrata, può contribuire alla prevenzione e alla gestione del diabete e di altre malattie croniche.
L’ingresso della Fondazione Diabete & Ricerca Onlus nella VSF rappresenta un’opportunità per sviluppare progetti innovativi che favoriscano il benessere dei cittadini. Tra le iniziative che potrebbero emergere da questa collaborazione vi sono:
• Programmi di prevenzione mirati a sensibilizzare la popolazione sui rischi del diabete e su corretti stili di vita.
• Sviluppo di politiche urbane sostenibili, con particolare attenzione alla mobilità attiva (biciclette, camminabilità) e all’accessibilità di alimenti sani.
• Ricerca scientifica e innovazione tecnologica, con il supporto di università e istituti di ricerca per migliorare la gestione del diabete attraverso nuove tecnologie e cure personalizzate.
Venezia, un modello per il futuro
Venezia, con la sua unicità e le sue sfide ambientali, può diventare un modello globale per una città sostenibile e attenta alla salute dei suoi abitanti. La collaborazione tra la Fondazione Diabete & Ricerca Onlus e la VSF rappresenta un esempio concreto di come la sostenibilità non sia solo una questione ambientale, ma anche sociale e sanitaria.
Questo nuovo ingresso tra i soci fondatori rafforza la visione della VSF di una Venezia all’avanguardia nella ricerca e nelle politiche urbane sostenibili, con l’obiettivo di creare un modello replicabile anche in altre città del mondo.
L’unione tra scienza, innovazione e sostenibilità sarà quindi il motore per un futuro più sano e resiliente, in cui la prevenzione e la cura delle malattie croniche diventino parte integrante delle strategie di sviluppo urbano.
Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (VSF)
La Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità è un’organizzazione che promuove la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della città di Venezia e del suo territorio. Creata con il sostegno di istituzioni pubbliche e private, la VSF lavora per sviluppare modelli di crescita sostenibile che possano essere replicati a livello internazionale. Tra i suoi obiettivi principali ci sono la tutela dell’ambiente lagunare, la promozione di tecnologie innovative per la gestione del territorio e il rilancio economico della città attraverso progetti di sviluppo responsabile.
�� Fondazione Diabete & Ricerca Onlus
La Fondazione Diabete & Ricerca Onlus è un ente senza scopo di lucro, promosso dalla Società Italiana di Diabetologia, impegnato nella ricerca scientifica sul diabete e sulle malattie metaboliche. La sua missione è migliorare la prevenzione, la diagnosi e la cura di queste patologie attraverso studi innovativi e la promozione di progetti di sensibilizzazione. La Fondazione collabora con università, ospedali e centri di ricerca per sviluppare strategie di intervento efficaci e migliorare la qualità della vita delle persone affette da diabete.


di Ludovica Serra
Il cyberbullismo è una delle piaghe sociali più gravi dell’era digitale. Con la diffusione di internet e dei social media, sempre più persone, in particolare giovani e adolescenti, si trovano esposte a forme di violenza psicologica che possono avere conseguenze devastanti sulla loro salute mentale e sul loro benessere. Per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo problema e promuovere un uso responsabile delle tecnologie digitali, ogni anno, il 7 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale contro il Cyberbullismo.
Cos’è il Cyberbullismo?
Il cyberbullismo si riferisce all’uso di strumenti digitali come social media, chat, e-mail e forum per intimidire, minacciare, umiliare o molestare una persona. A differenza del bullismo tradizionale, che si verifica in ambienti fisici, il cyberbullismo ha la caratteristica di essere persistente, pervasivo e anonimo, rendendo difficile per la vittima sottrarsi all’aggressione.
L’Importanza della Giornata Mondiale contro il Cyberbullismo
Questa giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi del cyberbullismo, educare giovani e adulti sulle buone pratiche di comportamento online e promuovere una cultura del rispetto e dell’inclusione.
Durante questa giornata, scuole, associazioni e istituzioni organizzano eventi, seminari e campagne informative per diffondere consapevolezza sul problema e fornire strumenti utili per contrastarlo. I social media, spesso teatro di episodi di cyberbullismo, vengono utilizzati in questa occasione per lanciare messaggi positivi e iniziative di prevenzione.
Le istituzioni sottolineano l’importanza di questa giornata come un’occasione per rafforzare l’educazione digitale e promuovere la sicurezza online. “Dobbiamo unire le forze per proteggere i più giovani dagli abusi digitali e garantire loro un ambiente virtuale sicuro e rispettoso” ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione.
Anche le Nazioni Unite e la Commissione Europea hanno ribadito il loro impegno nel contrastare il fenomeno con misure legislative e campagne di sensibilizzazione.
Come Contrastare il Cyberbullismo
Contrastare il cyberbullismo richiede l’impegno di tutti: istituzioni, scuole, famiglie e singoli individui. Ecco alcune azioni fondamentali:
1. Educare all’uso consapevole del web: Insegnare ai giovani l’importanza della privacy, della sicurezza online e del rispetto reciproco.
2. Segnalare e denunciare: Le piattaforme social offrono strumenti per segnalare contenuti offensivi; in casi gravi, è importante rivolgersi alle autorità competenti.
3. Sostenere le vittime: Chi subisce atti di cyberbullismo deve sapere di non essere solo. Parlarne con genitori, insegnanti o specialisti può aiutare a superare il trauma.
4. Promuovere una cultura della gentilezza: In un mondo digitale sempre più interconnesso, diffondere messaggi positivi e praticare l’empatia online può fare la differenza.
Conclusione
La Giornata Mondiale contro il Cyberbullismo rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di un uso responsabile delle tecnologie digitali e per ribadire l’impegno collettivo nel contrastare ogni forma di abuso online. Solo attraverso l’educazione, la consapevolezza e la collaborazione possiamo costruire un web più sicuro e inclusivo per tutti.

Il 4 marzo si è celebrata con un evento al Ministero della Salute la Giornata Mondiale dell’Obesità: 800 milioni di malati nel mondo, in Italia le persone con obesità sono l’11,8 per cento della popolazione. Da qui una lettera-appello che le organizzazioni italiane aderenti e partner della World Obesity Federation hanno voluto rivolgere in questa occasione alle Istituzioni. Fra le priorità: il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica, l’inserimento nei LEA, la piena attuazione dell’obesità nel Piano Nazionale della Cronicità e il potenziamento della prevenzione. L’obesità è una delle principali sfide per i sistemi sanitari oggi, un’emergenza globale, che impatta fortemente anche nel nostro Paese: secondo le stime saranno 1,9 miliardi nel 2035 le persone nel mondo con obesità, ovvero una persona su quattro, con un impatto economico stimato di 4,32 trilioni complessivamente sul pianeta a causa di sovrappeso e obesità. L’incremento stimato dell’obesità fra i bambini dal 2020 al 2035 è del 100 per cento. Numeri allarmanti, portati all’attenzione di tutti in occasione della World Obesity Day, che ricorre ogni anno il 4 marzo. L’edizione 2025 della Giornata Mondiale è stata promossa in Italia dalle società, network, fondazioni e associazioni aderenti e partner della World Obesity Federation quali la Società Italiana dell’Obesità, la Società Italiana di Diabetologia, l’Italian Obesity Network, IBDO Foundation, OPEN Italy, l’Associazione Amici

Obesi, in collaborazione con EASO e ECPO. La lettera aperta alle Istituzioni lanciata nel corso dell’evento al Ministero della Salute mira a mettere il tema saldamente al centro dell’agenda politica, riconoscere l’obesità pienamente come una malattia e affrontarla come tale con gli strumenti adeguati. L’obesità è un’emergenza che riguarda, come il mondo, anche il nostro Paese. Secondo l’Italian Barometer Obesity Report 2024, pubblicato da IBDO Foundation e basato sui dati ISTAT e ISS, l’11,8 per cento della popolazione adulta italiana soffre di obesità, in aumento rispetto all’11,4 per cento del 2022. Il 36,1 per cento degli adulti è in sovrappeso, con un incremento progressivo negli ultimi dieci anni. L’obesità infantile rimane una questione critica: circa il 19 per cento dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso e il 9,8 per cento è obeso. Questi dati evidenziano una tendenza all’aumento dell’obesità in tutte le fasce d’età, con un impatto più marcato nelle regioni meridionali e nelle aree economicamente più svantaggiate.
In questo contesto negli ultimi anni il Parlamento italiano ha esaminato diverse proposte di legge mirate alla prevenzione e alla cura dell’obesità, tra cui la Proposta di Legge n. 741 (Camera dei Deputati) a firma dell’On. Roberto Pella, Presidente dell’Intergruppo parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili, che riconosce l’obesità come malattia cronica e la include nei Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA), e che potrebbe rendere presto l’Italia il primo Paese al mondo con una legge specifica sull’obesità. «Riconoscere l’obesità come una vera e propria malattia e affrontarla come una priorità nazionale, a tutti i livelli istituzionali, è il principale contenuto della proposta di legge, a mia prima firma, che é stata approvata in Commissione XII alla Camera dei Deputati, grazie al supporto dei Colleghi e del Presidente Cappellacci – ha dichiarato l’On. Roberto Pella, Presidente Intergruppo Parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili - Unitamente a questo provvedimento, nell’ultima legge di Bilancio, in accordo con i Ministri Schillaci e Giorgetti, abbiamo creato e finanziato per tre anni un Fondo per il contrasto a questa malattia. Queste azioni concrete consentiranno all’Italia di diventare il primo paese al mondo con una legge di questo tipo, di essere un’avanguardia e un modello di confronto con gli altri sistemi sociosanitari. Nella trasformazione epocale di tipo demografico, sociale, economico e ambientale, che il mondo sta vivendo, l’epidemia dell’obesità e delle malattie non trasmissibili, insieme all’invecchiamento della popolazione, minaccia seriamente la sostenibilità dei sistemi sanitari e dobbiamo proseguire questo cammino di fattiva collaborazione».
«La Giornata Mondiale dell’obesità è un’occasione importante per dare voce ai numeri e alle criticità che riguardano questa malattia, e soprattutto per alimentare il dibattito istituzionale sulla necessità di programmare interventi mirati in termini di prevenzione e cura – ha dichiarato la Sen. Daniela Sbrollini, Presidente Intergruppo Parlamentare Obesità, diabete e malattie croniche non trasmissibili e Vice Presidente della 10a Commissione Permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato - È giunto il momento che la politica si impegni ad attuare gli obiettivi prioritari che riguardano il contrasto a questa malattia. Occorre una forte alleanza tra istituzioni governative, parlamentari, scientifiche, accademiche e persone con obesità per coinvolgere e rendere partecipi tutti della necessità di agire ora e intervenire». “Cambiare i sistemi, vite più sane” (“Changing systems, healthier lives”) è il tema a cui è stata dedicata quest’anno la Giornata Mondiale. La World Obesity Day, istituita nel 2015 dalla World Obesity Federation, ricorre in tutto il mondo, coinvolgendo organizzazioni, associazioni e individui, con l’obiettivo ambizioso di invertire la crisi globale dell’obesità. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni e di incoraggiare la prevenzione dell’obesità, evitando discriminazioni, pregiudizi e l’uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con l’obesità. L’edizione di quest’anno si è focalizzata sull’importanza di porre l’accento sui sistemi – e non sulle per-
sone – , che devono cambiare.
«Il riconoscimento dell’obesità come una malattia cronica è un aspetto fondamentale nel contrasto a questa emergenza, che richiede il pieno supporto da parte della società e della politica – ha dichiarato il Prof. Andrea Lenzi, Presidente del CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente OPEN ItalyLa governance a livello globale, di Paese e città è importante, ma di solito è frammentaria, bloccata in silos, spesso focalizzata sulla scelta individuale e incapace o non disposta a prendere le distanze da una forte influenza commerciale e da obiettivi politici a breve termine, motivo per cui è necessario lavorare insieme per cambiare percorso per una migliore salute umana e planetaria».
«È importante sottolineare che l’obesità rappresenta una vera e propria malattia e non soltanto un fattore di rischio per altre condizioni cliniche, le quali possono peraltro peggiorare un quadro di comorbidità complesso e articolato. Può essere definita come una malattia eterogenea e multifattoriale influenzata da fattori genetici, ambientali e psicologici - ha dichiarato il Prof. Luca Busetto, Vice-President for the Southern Region of European Association for the Study of ObesityOccorre considerare l’obesità come una malattia cronica e pensare alla prevenzione e al trattamento dell’obesità al pari delle altre malattie croniche non trasmissibili. Questo implica un miglioramento dell’assistenza per i pazienti che hanno già questa malattia, e richiede, dal punto di vista della prevenzione, degli interventi non più basati solo su delle scelte individuali, ma di tipo sistemico. La responsabilità per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità non ricade quindi solo sulle professioni sanitarie, ma coinvolge le istituzioni politiche nazionali e locali, gli amministratori dei sistemi sanitari, le istituzioni educative ad ogni livello, i luoghi di lavoro, i cittadini. È quindi necessario che tutte le figure coinvolte condividano la visione dell’obesità come malattia cronica e parlino un linguaggio condiviso. L’EASO ha quindi proposto una tassonomia dell’obesità in grado di fornire un linguaggio comune su questa malattia e utilizzabile nei molteplici contesti di interesse. L’Italia, in quanto membro del gruppo EASO, è il primo elemento dell’associazione a proporre un adattamento della tassonomia alla lingua nazionale. Con questo progetto, speriamo di incoraggiare i cittadini Italiani all’utilizzo di un linguaggio riguardante l’obesità che, da qui in poi, sarà corretto, rispettoso, e scientificamente accurato, per promuovere la salute e il benessere non solo di chi è affetto da questa malattia, ma di tutti».
In risposta al quadro allarmante, in termini sia di salute sia di costi sociosanitari, che l’obesità configura nel nostro Paese, l’evento è stata l’occasione per lanciare una
lettera aperta alle Istituzioni, firmata dalle organizzazioni promotrici della Giornata Mondiale in Italia, con l’invito ad affrontare l’emergenza obesità attraverso un impegno concreto per: riconoscere l’obesità come malattia cronica e inserirla nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), garantendo un accesso equo alle cure per tutti i pazienti; dare piena attuazione alla legge sull’obesità, che ne sancisca il riconoscimento come patologia cronica e preveda misure di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento; dare piena attuazione all’obesità nel Piano Nazionale della Cronicità, per garantire un approccio sistematico e coordinato tra i vari livelli dell’assistenza sanitaria; potenziare la prevenzione attraverso campagne educative nelle scuole, promozione di una corretta alimentazione e incentivazione dell’attività fisica; migliorare l’accesso alle cure specialistiche, aumentando il numero di centri dedicati alla gestione dell’obesità e rafforzando il ruolo dei medici di famiglia nella diagnosi precoce e nella gestione della malattia; regolamentare la pubblicità e il consumo di alimenti non salutari, soprattutto nei confronti dei minori, promuovendo scelte alimentari consapevoli; contrastare lo stigma e le discriminazioni nei confronti delle persone con obesità, attraverso iniziative di sensibilizzazione e campagne informative che promuovano una cultura dell’inclusione e del rispetto; sostenere la ricerca scientifica per sviluppare nuove strategie di trattamento e prevenzione.
«In termini di impatto clinico e di spesa medica per il trattamento anche delle malattie che ne derivano, l’obesità rappresenta una sfida che, se non adeguatamente affrontata, condizionerà le generazioni future con importanti conseguenze negative sul sistema sanitario e sulla nostra società tutta - ha dichiarato il Prof. Rocco Barazzoni, Presidente della Società Italiana dell’Obesità - Prevenire l’aumento di peso e il riacquisto di peso sono impegni essenziali per centrare gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e per far sì che sia efficace il trattamento dell’obesità. È tempo che la politica ponga questi obiettivi pienamente al centro della sua agenda». «È giunto il momento di mettere in atto soluzioni di politica sanitaria e di governance clinica che siano in grado di dare risposte concrete alle persone con obesità e soprattutto che coinvolgano e siano disponibili per l’intera popolazione, al fine di aumentare il supporto e diminuire le disuguaglianze di accesso alle cure sul territorio – ha dichiarato il Prof. Paolo Sbraccia, Presidente IBDO Foundation - Nonostante il crescente riconoscimento come malattia cronica, l’obesità continua a rappresentare una crisi sanitaria globale. La cura dell’obesità richiede lo stesso livello di urgenza riser -
vato alle altre malattie non trasmissibili, per le quali un accesso equo alle cure, la centralità della persona e la presenza di risorse adeguate costituiscono un punto fermo dell’assistenza sanitaria».
«L’obesità rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo del diabete di tipo 2 e di numerose altre patologie metaboliche. – ha dichiarato la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia - SID e Presidente FeSDICome Società Italiana di Diabetologia riteniamo fondamentale l’approccio integrato alla prevenzione e alla cura dell’obesità, riconoscendola come malattia cronica a tutti gli effetti. È necessario che le istituzioni investano in percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali specifici, inserendo l’obesità nei LEA e garantendo l’accesso alle cure per tutte le persone obese allo scopo di limitare l’insorgenza del diabete e delle sue complicanze e comorbilità. Il legame tra obesità e diabete è strettissimo, ed è per questo che la SID e la FeSDI sostengono con convinzione questa iniziativa e l’adozione di strumenti legislativi adeguati per affrontare questa emergenza sanitaria che impatta fortemente sulla qualità di vita delle persone e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari».
«Nel contrasto all’obesità occorre un approccio multidisciplinare, di cui sia parte centrale, accanto alle politiche di prevenzione e agli interventi mirati su alimentazione e sport, anche la lotta allo stigma sociale – ha dichiarato il Dott. Giuseppe Fatati, Presidente Italian Obesity Network – Occorre far sì che l’obesità sia considerata da parte dei governi, dei sistemi sanitari e delle stesse persone con obesità, come già fatto dalla comunità scientifica, una malattia cronica che richiede una gestione di lungo termine, e non una responsabilità del singolo. Non dobbiamo dimenticare il ruolo che l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo riveste nell’eziopatogenesi dell’obesità. Questo contribuirebbe in modo decisivo a ridurre la disapprovazione sociale e gli episodi di discriminazione verso chi ne è affetto, oltre a incidere sulla prevenzione, sulle cure e sui trattamenti». «È ora che l’obesità venga considerata una priorità sociosanitaria da tutti gli attori coinvolti, per il presente e il futuro del nostro sistema – ha dichiarato Iris Zani, Presidente Amici Obesi - Il pieno riconoscimento dell’obesità come malattia rappresenta un obiettivo prioritario per il contrasto a questa emergenza che impatta fortemente sulla società e sulle persone. Occorre portare avanti un lavoro comune con un’alleanza tra scienza, istituzioni, pazienti, promuovendo la prevenzione e la lotta allo stigma, ma soprattutto sollecitando affinché la malattia venga inclusa nei LEA per far sì che migliaia di persone in grosse difficoltà possano ricevere un adeguato percorso di cura».

di Giovanna Elisa Calabrò1, Lucio Corsaro2, Marco Falcone3, Lorena Trivellato4, 1. Department of Human, Social and Health Sciences, University of Cassino and Southern Lazio; VIHTALI (Value In Health Technology and Academy for Leadership & Innovation), a spin-off of the Catholic University of the Sacred Heart, Rome. 2. Founder and Advisor at Bhave; Patient Access Think Tank (PATT) President. 3. Infectious Diseases Unit, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, University of Pisa (Italy). 4. Researcher at Bhave

le Case della Comunità, le Centrali Operative Territoriali e i servizi di assistenza domiciliare diventano in
vista è possibile cogliere il vero valore di ciò che è stato proposto, dal potenziamento dell’assistenza domiciliare
anche tramite telemedicina, all’estensione di servizi per la salute dei minori e delle donne, passando per un miglioramento generalizzato del processo di presa in carico, e che sono tutti interventi concreti e strategici, già in fase di attuazione, che dovranno diventare sempre più una realtà nei prossimi anni.
Ma se l’obiettivo della riforma è portare la sanità più vicina alle persone, è altrettanto fondamentale garantire che questa vicinanza non sia solo geografica, ma anche sociale. Le fragilità legate all’età, alla disabilità, alle condizioni socioeconomiche o alle cronicità richiedono un approccio che superi la semplice assistenza biomedica, intrecciandosi con il supporto sociale per costruire nuovi percorsi di cura calati sulle esigenze del paziente. Parlare di integrazione sociosanitaria significa, infatti, riconoscere la necessità di considerare la persona come un unicum, superando la tradizionale frammentazione tra interventi sanitari e sociali e valorizzando quell’approccio bio-psico-sociale promosso dalla definizione di salute dell’OMS (Perino, 2023).
Questo significa non limitarsi a curare, ma anche “prendersi cura” della persona nell’accezione più ampia possibile, attraverso interventi multilivello che tengano conto delle condizioni di vita, delle risorse personali, del contesto in cui ogni individuo è inserito e di come questi elementi confluiscano in dei comportamenti effettivi di salute.
È importante infatti considerare l’intersezione tra salute pubblica e scienze comportamentali. Se da un lato, infatti, gli interventi di salute pubblica puntano a costruire comunità e società sane attraverso gli interventi promossi, dall’altro lato i comportamenti reali della popolazione possono influenzare negativamente i risultati di tali sforzi. Per ovviare a questo gap, a livello nazionale il governo ha introdotto nel 2016 la figura di un Consigliere per le Scienze Sociali e Comportamentali all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, nel 2020, è stato istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica il Team di Analisi Comportamentale (TAC), un gruppo di ricerca e supporto per le Pubbliche Amministrazioni, con l’obiettivo di applicare le conoscenze delle scienze cognitive e comportamentali per ottimizzare le prestazioni lavorative e il benessere dei dipendenti pubblici. Questa iniziativa si inserisce in un contesto internazionale più ampio, seguendo l’esempio di esperienze consolidate in altri paesi, come il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia
Anche a livello regionale è stata costituita un’unità di analisi comportamentale, la Nudge Unit Toscana Salute (NUTS), un gruppo di lavoro multidisciplinare

nato dalla collaborazione tra ARS Toscana e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Questo team si occupa di sviluppare interventi volti a migliorare gli esiti sociosanitari nella regione, attraverso l’impiego di approcci e strumenti propri delle scienze cognitive e comportamentali in are come la vaccinazione, la donazione di organi, la promozione di stili di vita sani, l’igiene delle mani e le cure palliative.
Un esempio concreto e recente sul panorama nazionale è l’ottimo risultato raggiunto con l’esperienza condotta in provincia di Messina, dove è stato mostrato che attraverso una semplice riformulazione della lettera di invito alla partecipazione agli screening tumorali per il cancro al seno, il tasso di adesione è aumentato quasi del 25%, con un conseguente impatto positivo in termini di prevenzione e riduzione della mortalità associata alla patologia. Tutto questo potrebbe senz’altro facilitare ulteriormente la connessione tra servizi sanitari e sociali, rendendo i percorsi di cura più fluidi ed efficaci.
Tuttavia, come evidenziato da diversi studi e rapporti, l’integrazione sociosanitaria, pur essendo riconosciuta come necessaria e sancita da normative nazionali e regionali, presenta ancora forti criticità operative. La frammentazione dei servizi, la difficoltà di coordinamento tra operatori sanitari e sociali e la scarsa conoscenza delle trasformazioni sociali del territorio sono alcuni degli ostacoli che impediscono un’efficace presa in carico integrata e che si sono resi particolarmente evidenti durante il periodo pandemico (Totis, 2023). Da qui la necessità di rafforzare il coordinamento tra sanità ospedaliera e servizi territoriali, includendo anche le funzioni socio-educative per recuperare una reale dimensione di prossimità e continuità assistenziale. Per superare queste difficoltà, è necessario adottare un modello che favorisca il lavoro di rete, il dialogo tra istituzioni e la costruzione di una vera e propria cultura dell’integrazione basata su approcci multidimensionali. Molte delle esperienze in corso mostrano che quando servizi sanitari e sociali lavorano in sinergia, il risultato è un miglioramento tangibile nella qualità della vita delle persone più vulnerabili e la presa in carico integrata diventa così una leva essenziale per trasformare l’assistenza da un sistema di risposte frammentate a un ecosistema di cura che accompagna la persona con fragilità lungo tutto il percorso di vita. Ne sono un esempio le oltre 100 buone pratiche individuate dall’Osservatorio promosso da AGENAS e Federsanità-ANCI, che hanno messo in luce modelli innovativi di integrazione sociosanitaria sperimentati in diverse regioni italiane. Progetti volti al miglioramento dell’assistenza domiciliare, alla continuità delle
cure per le persone fragili e all’uso di strumenti digitali per la gestione dei pazienti hanno dimostrato l’efficacia di un approccio sistemico, e stanno favorendo la creazione di una vera e propria comunità di pratica che si confronta, condivide esperienze e affina strumenti e procedure di cura.
Quando si parla di integrazione sociosanitaria è essenziale considerare anche alcuni modelli di cambiamento comportamentale, che si pongono come impalcature teoriche imprescindibili per comprendere e, in secondo luogo, promuovere l’adozione di comportamenti salutari (o disincentivare il perpetuarsi di comportamenti non-salutari). Ne è un esempio il Modello Transteorico elaborato da Prochaska e DiClemente, e che descrive il cambiamento come un processo graduale e a più fasi (precontemplazione, contemplazione, preparazione, azione e mantenimento), che parte dalla mancanza di consapevolezza del problema fino al mantenimento stabile di nuovi comportamenti. Tale approccio si dimostra particolarmente utile negli interventi di promozione della salute poiché permette di adattare le strategie allo specifico stadio di cambiamento in cui il soggetto si trova, accompagnando di fatto il soggetto nel suo percorso verso abitudini più responsabili. Si pensi ad esempio alla vaccinazione antinfluenzale annuale nell’anziano: un individuo che si trova in fase di “precontemplazione” probabilmente percepisce il vaccino come non necessario, e un intervento realmente efficace su questa classe di individui dovrebbe puntare soprattutto sull’informazione e sulla sensibilizzazione relativa ai rischi dell’influenza. Tale modello permette dunque di focalizzare l’attenzione anche verso gli aspetti di resistenza al cambiamento, ottenendo una maggiore comprensione delle motivazioni (consapevoli o inconsapevoli) e delle opzioni efficaci per superare tali barriere. Ma a ben guardare i modelli sono innumerevoli, e ciascuno di essi permette di attenzionare un determinato aspetto del comportamento, o guardare ad esso da un nuovo punto di vista. Se rimaniamo sul tema dei comportamenti di prevenzione, ad esempio, la Protection Motivation Theory di Maddux e Rogers sottolinea come la percezione del rischio e la capacità di affrontarlo influenzino la motivazione a proteggersi, un aspetto che è evidentemente determinante per incentivare l’adesione a misure preventive come le vaccinazioni o l’igiene delle mani. Sempre su questo tema l’Health Belief Model, evidenzia anche come la probabilità che un individuo adotti comportamenti preventivi dipenda sì dalla percezione della minaccia, ma anche ai benefici attesi, e ciò rappresenta un elemento importante da tenere in considerazione quando si parla di comunicazione sanitaria sul tema della prevenzione. Integrare questi modelli nella visione strategica dei de-
cisori che intendono a migliorare l’integrazione sociosanitaria significa sia spianare nel piccolo la strada del singolo cittadino verso un accesso di qualità ai servizi, ma anche favorire un cambiamento culturale e comportamentale più ampio della società che rafforzi la prevenzione e gli outcome di salute a lungo termine, specialmente nei soggetti più vulnerabili.
Degno di nota è anche quanto rilevato con l’OSSERVATORIO SCENARIO SALUTE* di BHAVE che ha condotto un’indagine comportamentale sul tasso di traduzione delle preferenze dichiarate in comportamenti effettivamente realizzati dai cittadini italiani. L’indagine realizzata da BHAVE (2.450 cittadini italiani intervistati via mail, nel 4° trimestre 2024) esamina le differenze significative nei comportamenti e nelle preferenze in ambito sanitario, analizzando i fattori socioeconomici, culturali e demografici che influenzano le scelte individuali nella gestione della salute. L’analisi si è concentra sulle variazioni nelle modalità di accesso ai servizi sanitari, nella prevenzione, nel rapporto medico-paziente della popolazione adulta italiana. Lo studio ha rilevato che il tasso medio di trasformazione della popolazione italiana da preferenze a comportamenti nell’accesso ai servizi sanitari, nel compiere atti di prevenzione o nel seguire i suggerimenti del medico si attesta intorno al 45-50% con variazioni significative in base al contesto geografico, al sistema sanitario regionale di riferimento e alle specifiche caratteristiche socio-culturali della popolazione considerata. In particolare, nel caso delle vaccinazioni tra adulti, la preferenza dichiarata nel volersi vaccinare è del 70%, ma solo il 45% dei rispondenti ha dichiarato che si è vaccinato effettivamente negli ultimi 12 mesi, con un tasso di conversione del 64%. I tassi di trasformazione più alti (60-65%) sono stati registrati, con diverse sfaccettature e pesi a seconda del territorio e delle caratteristiche psico-demografiche del rispondente, quando il servizio di vaccinazione era facilmente accessibile, i costi sono coperti dal SSN, hanno ricevuto dei remainder da parte del sistema sanitario, gli individui erano integrati in un sistema di supporto sociale (welfare) e le persone ne percepivano chiaramente i benefici. Al contrario, i tassi più bassi (25-30%) emergono in presenza di barriere economiche, difficoltà logistiche, lunghi tempi di attesa, scarsa comprensione del servizio.
Un esempio concreto di vulnerabilità su cui è fondamentale concentrare l’attenzione è rappresentato dalle malattie infettive, il cui impatto in termini di diffusione e predisposizione dei soggetti a rischio è fortemente influenzato dai comportamenti individuali e collettivi. La trasmissione di queste patologie non dipende infatti
solo dalla presenza dell’agente eziologico, ma anche da fattori comportamentali propri del soggetto a rischio e dell’operatore sanitario che è importante investigare, come la percezione del rischio, l’adesione alle misure di prevenzione e il livello di consapevolezza generale. Ed è così che comportamenti individuali errati, come la scarsa adesione ai programmi vaccinali o il mancato rispetto delle misure di profilassi, possono aumentare l’incidenza di infezioni prevenibili e favorire la diffusione di focolai epidemici. Come si accennava, anche la risposta degli operatori sanitari gioca un ruolo determinante: la bassa compliance nei confronti della sorveglianza delle malattie trasmissibili e delle pratiche di controllo delle infezioni può compromettere l’efficacia delle strategie di contenimento e rendere ancora più vulnerabile un sistema di risposta alle emergenze infettive che già necessita di rafforzamento.
Tra le malattie infettive che richiedono particolare attenzione c’è sicuramente, il virus respiratorio sinciziale (RSV) come una delle principali cause di infezioni respiratorie nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone immunocompromesse, target che mostra come siano proprio i soggetti più fragili ad essere esposti a rischi maggiori. L’analisi dei comportamenti legati alla prevenzione, come l’adesione alle vaccinazioni, l’uso di dispositivi di protezione e l’accesso tempestivo alle cure, diventa quindi essenziale per sviluppare strategie contenimento efficaci e l’integrazione tra sanità ospedaliera e territoriale può giocare un ruolo importante nel garantire una risposta assistenziale adeguata, ma anche a monte, nel promuovere interventi educativi e preventivi. Proprio in quest’ottica, col supporto non condizionato di Pfizer si è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti dell’area, dedicato a rilevare il burden of disease (BoD) dell’RSV, con l’obiettivo di quantificare l’impatto della malattia sulla popolazione in morbilità, mortalità e costi sanitari e sociali diretti e indiretti tramite la raccolta di dati amministrativi. Nello specifico, il progetto punta ad identificare indicatori epidemiologici e sociologici in grado di fornire una stima chiara della diffusione dell’RSV e delle sue conseguenze in alcune regioni italiane, individuando in particolare i gruppi più vulnerabili e i principali fattori di rischio. Tra le varie dimensioni che costituiscono il BoD, il gruppo di lavoro si propone di valutare anche le ricadute economiche dell’RSV, sia per i sistemi sanitari sia per le famiglie colpite, esplorando al contempo le barriere che ostacolano la prevenzione e l’accesso ai trattamenti, per ottenere in ultima istanza una migliore comprensione dell’impatto dell’RSV sulla società e supportare l’elaborazione di strategie di intervento e azioni concrete per la gestione e la prevenzione della malattia.
Tale progettualità rientra nell’ambito del Patient Access Think Tank (PATT), un percorso avviato nel 2024 e portato avanti da un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da figure che operano a vari titoli e livelli nel SSN, come medici, esperti di politiche sanitarie, rappresentati delle associazioni pazienti, ma anche dell’area farmaceutica, sociologi ed esperti di scienze comportamentali. Con l’espressione Patient Access ci si riferisce alla capacità delle persone, dei medici, degli operatori sanitari e sociosanitari e delle organizzazioni di ottenere e utilizzare servizi, informazioni e risorse sanitarie. Migliorare l’accesso dei pazienti alle cure e in generale all’assistenza sanitaria e sociosanitaria deve essere, infatti, un obiettivo fondamentale del sistema sanitario, in quanto può portare a migliori risultati sanitari sia sul piano clinico che su quello della qualità della vita dei pazienti.
In un momento di profondo cambiamento del sistema sanitario, il Patient Access diventa una priorità sia per ridisegnare l’organizzazione delle cure sia per sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione digitale. L’integrazione di nuove tecnologie e soluzioni digitali può rendere il sistema più sostenibile, migliorando l’efficienza e la centralità del paziente. Nella cornice concettuale e operativa del PATT, anche l’informazione e la comunicazione giocano un ruolo determinante, ossia quello di fornire ai pazienti strumenti adeguati per conoscere la propria condizione di salute, accedere alle cartelle cliniche e usufruire di servizi di telemedicina, come fattori essenziali per ottenere cure tempestive ed efficaci.
Le principali sfide legate al Patient Access e su cui il gruppo di lavoro si sta concentrando riguardano in particolare il superamento delle barriere sistemiche alle cure, come quelle sociali, economiche, religiose, linguistiche e culturali, le difficoltà di trasporto e la mancanza di informazioni sulle risorse disponibili, per aprire ad un servizio sanitario fruibile da tutti, indipendentemente dallo status sociale o demografico. Uno tra i tavoli di lavoro creati per il 2025 ha al centro proprio il tema dell’Epidemiologia e Burden of Disease, con l’obiettivo di Comprendere l’epidemiologia e il «peso» delle malattie per pianificare interventi sanitari e sociosanitari mirati ed equi ed è in questo ambito che si colloca il lavoro in corso relativo all’RSV i cui risultati saranno disponibili nei prossimi mesi.
Mantoan, D. (2024, 30 aprile). Integrazione sociosanitaria: le buone pratiche per potenziare l’assistenza territoriale. Osservatorio. Consultabile al: https://www.agendadigitale.eu/sanita/integrazione-sociosanitaria-le-buone-pratiche-per-potenziare-lassi-
stenza-territoriale/
Marco Bertoni & Luca Corazzini & Silvana Robone, 2020. “ The Good Outcome of Bad News ,” American Journal of Health Economics , University of Chicago Press, vol. 6(3), pagine 372-409.
Perino, 2022 “L’integrazione socio-sanitaria: dalla teoria alla pratica” in Marco Accorinti, Monia Giovannetti, Annalisa Gramigna, Chiara Poli cur. “Occasioni e spazi per l’integrazione tra il sociale e il sanitario in Italia” Sociologia e servizio sociale ed Roma Tre-press, Roma, 2022.
Ragazzoni, P., Di Pilato, M., Longo, R., Scarponi, S., & Tortone, C. (2009). Modelli socio cognitivi per il cambiamento dei comportamenti: Rassegna e analisi critica. DoRS – Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute, Regione Piemonte.
Totis M., Costruire l’integrazione sociosanitaria e socioassistenziale , Intervento a “Anticipazione dei fabbisogni professionali nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari: Scenario 2030”, Roma, Inapp, 27 marzo 2023.
*OSSERVATORIO SCENARIO SALUTE di BHAVE, è una indagine che ha come obiettivo di raccogliere ed analizzare un enorme mole di dati qualiquantitativi relativamente ai comportamenti di tutti coloro che gravitano intorno al sistema sanitario (cittadini, operatori sanitari, pazienti, payor, politici, stakeholder, etc…) per cogliere i diversi contributi utili a comprendere il tema di come evolverà il sistema sanitario italiano, oltre a rilevare la conoscenza e percezione degli italiani relativamente al proprio stato di salute e delle diverse patologie correlate. I dati vengono sintetizzati e integrati con lo scopo di comprendere le problematiche connesse alla salute. Infine, attraverso l’analisi comportamentale e sociale viene individuato il framework concettuale alla base delle scelte di salute degli stakeholder e degli italiani. Specificatamente nel periodo Maggio-Settembre 2024, anche attraverso la somministrazione di un questionario sia online sia telefonico (della durata di 20-30 minuti), sono state rilevate informazioni e dati relativamente al livello di conoscenza, percezione e relazione degli italiani nei confronti dell’Intelligenza artificiale. La dimensione del campione era 2.455 casi. Il campionamento per quote rileva che 29% dei rispondenti rientrava nella fascia di età over 65 anni, in questo articolo riportiamo l’analisi di alcuni dei dati emersi relativamente a questa fascia di età.
di Francesca Romana Gigli
Negli ultimi anni, il mondo digitale ha assunto un ruolo predominante nella vita degli adolescenti, diventando per molti una vera e propria estensione della realtà. Smartphone, social network e videogiochi sono strumenti ormai imprescindibili della quotidianità giovanile, ma il loro uso eccessivo sta generando una serie di problematiche psicologiche e sociali preoccupanti.
Secondo il XIV Atlante dell’infanzia a rischio in Italia di Save the Children (dati 2023), il 73% dei minorenni tra i 6 e i 17 anni si collega a internet quotidianamente, con punte del 91,9% nella fascia 14-17 anni. Un’indagine pubblicata sulla rivista Archives of Disease in Childhood ha evidenziato che gli adolescenti trascorrono in media 5,8 ore al giorno con lo smartphone, di cui 3,9 ore sui social media.
Questo tempo trascorso online non è solo una questione di intrattenimento: in molti casi rappresenta una fuga dalla realtà. Sempre più adolescenti si rifugiano nel digitale per evitare le difficoltà della vita quotidiana, che vanno dalla pressione scolastica ai problemi familiari, dall’insicurezza sociale all’ansia da prestazione. L’iperconnessione, però, può portare a fenomeni molto più complessi e dannosi, come il cyberbullismo, il ritiro sociale e la dipendenza da approvazione digitale.
I Rischi dell’Iperconnessione: Tra Isolamento e Cyberbullismo
Come anticipato l’uso eccessivo del digitale sta avendo impatti significativi sulla salute mentale degli adolescenti. Secondo una ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità, l’8,3% degli studenti italiani tra i 12 e i 16 anni mostra segni di dipendenza da internet, con un’incidenza maggiore tra le ragazze. Inoltre, si registra
una crescente tendenza al ritiro sociale, noto come fenomeno Hikikomori, con 100.000 adolescenti in Italia che evitano il contatto con il mondo esterno e vivono quasi esclusivamente nella dimensione digitale (Istituto Superiore di Sanità).
Un altro problema diffuso è quello del cyberbullismo, che colpisce circa il 22% degli adolescenti italiani, con forme di violenza verbale, minacce e condivisione illecita di contenuti personali che portano a gravi conseguenze psicologiche. La percezione di anonimato che offre il digitale rende gli atti di bullismo ancora più aggressivi e difficili da controllare.
Il Ruolo della Scuola e delle Istituzioni: Serve un Cambiamento
Abbiamo chiesto alla Prof.ssa Anna Maria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, di aiutarci a comprendere il fenomeno e individuare strategie per un’educazione più consapevole all’uso del digitale.
Professoressa, la scuola sta facendo abbastanza per educare gli studenti a un uso corretto della tecnologia?
L’educazione al ruolo della rete e dei social in particolare nella scuola deve essere sistematica, ovvero inserita in modo costante e continuativo nella programmazione scolastica. Ad oggi i progetti che vengono proposti e attuati, che sono di indiscutibile qualità, sono troppo spesso un momento isolato nel percorso scolastico e non vengono percepiti dai ragazzi e dalle ragazze nella loro giusta rilevanza.
Ci dovrebbe essere, quindi, un’educazione sistematica che ponga al centro il tema del rispetto dentro e fuori

dalla rete, e deve essere erogata in modo efficace. Deve, quindi, dare informazioni e attivare il canale cognitivo, ma anche quello emozionale cercando quindi di far sviluppare ai ragazzi e alleragazze l’empatia, che è all’origine della possibilità di non aggredire e di non attivare azioni e comportamenti di cyberbullismo.
Quali sono le azioni più urgenti che le istituzioni dovrebbero mettere in campo?
Le istituzioni dovrebbero lavorare su due fronti: legislazione e formazione. Servono normative più severe per prevenire il cyberbullismo e molte campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Inoltre, occorre finanziare progetti di supporto psicologico e spazi di aggregazione giovanile per offrire ai ragazzi alternative concrete all’isolamento digitale.
4. Qual è la relazione tra iperconnessione e comportamenti antisociali come il cyberbullismo?
L’iperconnessione amplifica il rischio di comportamenti antisociali. Il cyberbullismo è un fenomeno legato alla percezione di impunità che si ha online, dove si può attaccare una persona senza affrontarne le conseguenze dirette. Inoltre, il confronto continuo con immagini e vite idealizzate sui social media può portare a frustrazione, ansia e comportamenti aggressivi.
Oltre alla scuola, quali altre attività possono aiutare gli adolescenti a disconnettersi?
Lo sport, l’arte e gli interessi culturali sono strumenti fondamentali per contrastare l’iperconnessione. Lo sport, in particolare, aiuta a sviluppare competenze sociali, a ridurre lo stress e a migliorare la gestione delle emozioni. Le attività artistiche e culturali offrono ai
ragazzi un modo per esprimersi al di fuori dei social media. Serve un impegno condiviso da parte delle istituzioni, della scuola e della famiglia.
Lo Sport e gli Interessi: Le Vie d’Uscita dall’Iperconnessione
Non tutto è perduto: esistono strumenti efficaci per ridurre la dipendenza dal digitale. Lo sport è uno dei più potenti antidoti all’iperconnessione, in quanto promuove il benessere fisico e mentale, aiuta a sviluppare autodisciplina e costruisce relazioni sane con i coetanei.
Anche le attività artistiche e culturali possono giocare un ruolo fondamentale: teatro, musica, fotografia e scrittura permettono ai ragazzi di esprimere emozioni reali, sviluppando creatività e autostima. Il problema è che spesso questi spazi non vengono incentivati.
Le istituzioni dovrebbero investire di più nella creazione di luoghi fisici di aggregazione, come centri sportivi, laboratori creativi e biblioteche interattive, dove i giovani possano trovare stimoli reali alternativi al mondo digitale.
L’iperconnessione è una sfida complessa che coinvolge genitori, scuole, istituzioni e la società intera.
Serve un cambiamento radicale nel modo in cui affrontiamo il rapporto tra giovani e tecnologia: il digitale non deve essere un rifugio, ma un’opportunità di crescita consapevole. La soluzione non è demonizzare internet, ma educare i ragazzi a un uso equilibrato e responsabile, offrendo loro esperienze e stimoli che li riportino alla realtà.
