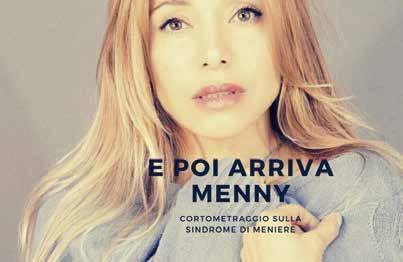8 minute read
d’allarme nell’infezione
La triade dell’atleta femmina: cos’è e come riconoscerla
∞ A CURA DI MASSIMO VALVERDE
Si chiama la triade dell’atleta e riguarda soprattutto, ma non solo, le giovani atlete ad alti livelli che si allenano eccessivamente senza alimentarsi in modo adeguato. Una condizione clinica caratterizzata da tre elementi: deficit energetico, spesso associato a disturbi dell’alimentazione;disturbi mestruali e amenorrea (assenza di mestruazioni); perdita di massa ossea e osteoporosi, ancora poco conosciuta e spesso sottovalutata che però può esporre a rischi di salute importanti e in alcuni casi irreversibili.
PIÙ A RISCHIO LE GIOVANI GINNASTE La “Female Athlete Triad” (Triade dell’Atleta Femmina) è una patologia diffusa fra chi pratica sport ad alto livello e in particolare in sport come la ginnastica artistica femminile e la ginnastica ritmica, in cui le giovani atlete sono sottoposte a regimi di allenamento inadeguati ed eccessivi per intensità e durata. Si tratta, come dice il nome, di una combinazione di tre fattori, strettamente interconnessi, che possono presentarsi singolarmente oppure associati a formare un quadro clinico che la ricerca scientifica ha individuato e delineato sempre più chiaramente solo in tempi recenti (Arch Pediatr Adolesc Med.2006;160:137-142). Oltre agli allenamenti particolarmente stressanti le giovani atlete subiscono spesso condizionamenti culturali e tecnico agonistici secondo i quali il rapporto peso-potenza e l’aspetto fisico sono ritenuti fondamentali. Sinteticamente e a grandi linee, alla base di questa patologia sono gli allenamenti troppo impegnativi e stressanti, la mancanza di adeguato riposo e un apporto calorico insufficiente, la cui concomitanza ha ripercussioni significative sull’organismo e può determinare alterazioni del normale profilo ormonale.
RITARDO O ASSENZA DEL CICLO MESTRUALE, IL SEGNALE PIÙ EVIDENTE Nell’atleta femmina la manifestazione più evidente è il ritardo nella comparsa del ciclo mestruale (ricordiamoci il caso di Nadia Comaneci) o, nel caso di soggetti già fertili, la comparsa di amenorrea
prolungata. Queste alterazioni hanno conseguenze meno evidenti ma non meno rilevanti, soprattutto in termini di salute. Infatti, gli ormoni estrogeni che inducono e regolano il ciclo hanno anche un ruolo fondamentale nella mineralizzazione delle ossa. Pertanto, una loro carenza nell’età dello sviluppo, dovuta a un’alimentazione insufficiente e/o a una condizione di stress prolungato, determina un apporto di calcio nelle ossa insufficiente e a volte irreversibile. Questo predispone allo sviluppo di una condizione di osteoporosi, unitamente ad altre e immediate manifestazioni patologiche a carico del sistema muscolo scheletrico, quali fratture da stress (quelle che intervengono in assenza di particolari eventi traumatici), lesioni muscolari etc.. Questo quadro, già di per sé preoccupante, può essere ulteriormente aggravato dal manifestarsi nell’atleta di alterazioni del comportamento alimentare. Alterazioni che costituiscono infatti la terza faccia della Female Athlete Triad. I disturbi del comportamento alimentare possono variare da forme leggere e reversibili fino ai casi più gravi e pericolosi di anoressia nervosa, i cui sintomi più evidenti sono una preoccupazione e un susseguente rifiuto nei confronti del cibo e del proprio peso corporeo, rituali psicologici che accompagnano i pasti, spesso associati a vomito auto-indotto, abuso di lassativi, perdita di peso etc.. Se a questi sintomi si aggiungono quelli relativi agli aspetti già considerati, ovvero assenza di ciclo mestruale, stato di affaticamento, ridotta capacità di concentrazione, fratture da stress e infortuni muscolari, si ha il quadro sintomatologico completo della Triade.
L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE Con riferimento a questa patologia, la più importante organizzazione mondiale di medicina dello sport e di scienza dell’allenamento, l’American College of Sports Medicine, raccomanda come prioritaria “l’azione preventiva basata sull’informazione e sull’educazione di atlete, genitori, allenatori, giudici e dirigenti”. Il caso della ginnastica sportiva femminile, artistica e ritmica è emblematico. Nel contesto di queste attività sportive, infatti, è facile riscontrare tutti gli elementi che predispongono a questa patologia. I programmi tecnici internazionali, su cui inevitabilmente vengono modellati i programmi tecnici delle singole Federazioni Nazionali, sono tali da favorire, soprattutto nella ginnastica artistica, una tipologia fisica in cui ogni etto di massa grassa è visto, e oggettivamente è, come un ostacolo in più, per il raggiungimento della performance ottimale. Ciò determina, da parte di atlete molto motivate e/o dei loro tecnici, un’attenzione particolare al profilo ponderale della ginnasta. A ciò si aggiungono almeno altri due fattori: il primo è la convinzione, per diversi aspetti discutibile, che la ginnastica sportiva di alto livello necessiti di molte ore giornaliere di duro allenamento. Contemporaneamente manca spesso il convincimento sull’assoluta necessità di adeguati e corrispondenti periodi di riposo, che invece rientrano, con pari importanza, nel processo di allenamento nel suo complesso. Il secondo fattore è l’aspetto fisico: un particolare tipo di fisico non di rado rientra addirittura nei criteri “occulti” di giudizio e, quindi, è in grado di influenzare il punteggio dell’atleta. Alla luce di queste semplici e incontrovertibili constatazioni appare in tutta la sua essenzialità la raccomandazione dell’American College of Sports Medicine. La ginnastica sportiva, anche quella di alto livello, può e deve essere uno strumento di salute, ma è assolutamente indispensabile che tutti, atlete, genitori, allenatori, giudici e dirigenti siano informati prima e protagonisti poi di quei cambiamenti tecnici e soprattutto culturali indispensabili a contrastare questa insidiosa e diffusa patologia.
PROF. MASSIMO VALVERDE
Specialista in Patologia della Riproduzione Umana, Endocrinologia, Farmacologia e Tossicologia
Direttore Sanitario Centro Medico MR Bergamo
Quando la mano soffre per colpa del gomito La compressione del nervo ulnare

∞ A CURA DI DAVIDE SMARRELLI
Il formicolio, o in termine medico parestesia, è il modo con cui il nervo ci comunica un suo problema. I formicolii alle mani sono disturbi piuttosto frequenti e spesso fonte di preoccupazione nonché di varie interpretazioni. Una volta escluse cause acute cardiache e neurologiche o subcroniche degenerative legate alle patologie neurologica o neoplastica, laddove si evidenzi una causa ortopedica, prevalentemente formicolio è riconducibile a lesioni artrosiche delle articolazioni del rachide (colonna vertebrale) cervicale o a forme di compressione lungo il decorso dei nervi periferici dell’arto superiore. NON SOLO TUNNEL CARPALE Nell’arto superiore i nervi principali che originano dalle radici nervose del rachide cervicale confluiscono in tre nervi maggiori che arrivano alla mano: mediano, radiale e ulnare. I formicolii non sono sempre causati da una sindrome del tunnel carpale. Una localizzazione molto frequente è al gomito e colpisce il nervo ulnare. Questo quadro è anche noto come sindrome del canale cubitale, ed è la seconda più comune neuropatia da compressione di un nervo periferico dopo la sindrome del tunnel carpale alla mano.
DOTT. DAVIDE SMARRELLI
Specialista in Ortopedia e Traumatologia Responsabile Chirurgia della mano
LE CAUSE: DALLE POSTURE QUOTIDIANE ALLO SPORT, ALL’ARTROSI La compressione del nervo ulnare o sindrome del tunnel cubitale nella maggioranza dei casi è idiopatica, cioè senza causa apparente, e dovuta a un ispessimento del legamento di Osborne che costi-
IL NERVO ULNARE: COSA È E A COSA SERVE
Il nervo ulnare è un nervo misto cioè motorio e sensitivo, che ha origine dal rachide (colonna vertebrale) cervicale, e precisamente dalle radici C7-C8-T1, e decorre lungo il braccio e l’avambraccio fino ad arrivare alla mano. Qui innerva il muscolo flessore ulnare del carpo, il flessore profondo del 4 e 5 dito, permettendo la flessione del polso e del 4 e 5 dito ma, soprattutto, controlla tutta la muscolatura intrinseca della mano cioè tutti i muscoli “interni” alla mano, che hanno origine e inserzione nella mano. Questa muscolatura intrinseca determina tutti i movimenti fini e delicati di precisione e coordinazione delle dita.
tuisce il tetto del canale cubitale in cui scorre. Non raramente può però essere correlata a cause meccaniche specifiche quali fattori occupazionali, microtraumatismi ripetuti (vibrazioni e compressioni ripetute), posture prolungate specialmente in flessione del gomito (ad esempio il gomito flesso e appoggiato su una superficie rigida a lungo); anche alcuni sport come tennis, pesistica, baseball che prevedono il gesto del lancio possono determinare la compressione del nervo ulnare al gomito. Possono esserci poi cause legate alla particolare struttura congenita del gomito come l’instabilità del nervo ulnare, deformità del gomito quale una deviazione in valgismo, oppure cause secondarie come l’artrosi di gomito, traumatismi diretti, fratture-lussazioni o loro esiti e neuriti legate a infiammazioni croniche articolari.
FORMICOLIO ALLE DITA E DOLORE AL GOMITO: I CAMPANELLI D’ALLARME CHE PEGGIORANO COL TEMPO Il formicolio al 4 e 5 dito e un dolore al gomito associato a disturbi della sensibilità alle ultime due dita della mano, che si esacerba col gomito in flessione forzata, rappresentano il campanello di allarme. I disturbi inizialmente sono spesso aspecifici e sottostimati, ma tendono a peggiorare gradualmente. I formicolii alla mano, sintomo principale, variano da un lieve intorpidimento (addormentamento) o lievi parestesie (alterazione della sensibilità) nell’anulare e nel mignolo della mano, a un intenso bruciore. Possono essere notturni ma sovente sono continui nell’arco della giornata. I pazienti lamentano difficoltà a mantenere a lungo la posizione di flessione del gomito (telefonare, scrivere, guidare, quando distesi su un lettino appoggiando le braccia ai braccioli etc.), difficoltà nelle prese, nell’esecuzione di manovre che richiedono una forza di torsione della mano, talora anche una sensazione di freddo sul lato ulnare (interno) della mano. Il dolore, spesso associato, è localizzato sul versante mediale del gomito, dell’avambraccio e della mano. Più tardivamente compaiono deficit di forza (debolezza muscolare) e ipotrofia muscolare (cioè perdita della massa muscolare) a carico dei muscoli della mano innervati dal nervo ulnare (interossei, ipotenari, adduttore del pollice, lombricali del 4 e 5 dito, parte del flessore breve del pollice). Come conseguenze si può avere una più o meno evidente difficoltà nel tenere oggetti nella mano, perdere la funzione dei suddetti muscoli e può comparire un’evidente atrofia del primo muscolo interosseo della mano (tra pollice e indice) e dell’eminenza ipotenar (rilievo carnoso localizzato nella regione interna della faccia palmare della mano e alla base del mignolo). Nelle fasi più avanzate si arriva a perdere la possibilità di estendere le ultime due dita della mano e parzialmente anche le altre tre, con conseguente flessione obbligata del mignolo e anulare, determinando la cosiddetta mano benedicente o ad artiglio.