Giornale dei Biologi



La Fnob collaborerà con l’Agenzia Spaziale Italiana per studiare la vita in condizioni di microgravità
di Vincenzo D’Anna
La nuova sfida della biologia: portare il grano sulla Luna di Rino Dazzo
La ricerca dell’elisir di lunga vita: così i biologi andranno nello spazio di Matilde Andolfo
La Space Factory lancia le nuove sfide per un futuro sostenibile di Matilde Andolfo
A natale attenti a frodi e sofisticazioni di Rino Dazzo
È boom di abusivi e falsi nutrizionisti di Rino Dazzo
L’Italia è il paese dei centenari: oltre 23mila nel 2025, 2mila in più rispetto al 2024 di Matilde Andolfo
I biologi e la ricerca del Santo Graal di Matilde Andolfo
Compie 115 anni la più longeva d’Italia di Matilde Andolfo
I biologi e novità nella formazione specialistica di Alberto Spanò
Crediti Ecm gratuiti a portata di click per i biologi di Carla Cimmino ed Elvira Tarsitano
Il coordinamento che dà voce ai biologi: entra nel CNBN di Livia Galletti e Veronica Di Gaetano
INTERVISTE
Il gel che elimina le microplastiche contenute nell’acqua di Emanuela Birra
Non tutti i parassiti vengono per nuocere: Leishmania infantum e Alzheimer di Ester Trevisan
In laboratorio un nuovo modello di embrione umano produce cellule del sangue di Sara Bovio
Nuova tecnica consente di riprogrammare cellule mature in staminali pluripotenti di Sara Bovio
Individuato un meccanismo chiave che controlla la morte cellulare programmata di Sara Bovio
Dentro la mente che cresce: il cervello e le sue origini nascoste di Carmen Paradiso
Nanostelle di Dna e anticorpi: nuova frontiera dei biomateriali intelligenti di Sara Bovio
Vaccini a mRna aumentano l’efficacia delle cure contro i tumori di Domenico Esposito
Una firma molecolare per predire l’aggressività del tumore della prostata di Carmen Paradiso
Capelli bianchi: un meccanismo di difesa contro il cancro di Carmen Paradiso
Uno studio globale scopre 13 geni legati all’obesità di Carmen Paradiso
Dalla campagna ungherese al Nobel: la vita da biologa di Katalin Karikó di Carmen Paradiso
Alzheimer, l’asse cellula T-neurone che innesca la neurotossicità di Elisabetta Gramolini
L’ombra invisibile: la morte cardiaca improvvisa nei giovani è prevenibile di Elisabetta Gramolini
È allarme per il cuore delle donne di Domenico Esposito
Trapianti, Italia eccellenza mondiale di Domenico Esposito
Protezione solare attraverso l’utilizzo di analoghi sintetici simili a micosporine e gadusol di Carla Cimmino
BENI CULTURALI
Capitale italiana della cultura 2028, la carica delle 23 candidate di Rino Dazzo
La storia del Tren Maya dello Yucatán di Michelangelo Ottaviano 66 64 68
Microbi delle radici per salvare gli uliveti dal caldo di Gianpaolo Palazzo
Il record di alberi non basta: l’urbanizzazione prende il sopravvento di Gianpaolo Palazzo
Record decennale e corsa senza freni nel consumo del nostro suolo di Gianpaolo Palazzo
La svolta del patrimonio edilizio: quando i muri imparano a risparmiare di Gianpaolo Palazzo
I prezzi della spesa? Li detta il clima di Domenico Esposito
Risorse dagli scarti agroalimentari di Michelangelo Ottaviano
I pipistrelli, predatori più abili dei leoni di Michelangelo Ottaviano
INNOVAZIONE
La fibrosi cardiaca favorisce le aritmie di Pasquale Santilio
Industria del pomodoro, meno sprechi d’energia di Pasquale Santilio
L’elettrodeposizione per i superconduttori di Pasquale Santilio
Italia padrona del tennis: a Sinner le Finals, agli azzurri la “Davis” di Antonino Palumbo
Da Borg a Titmus: campioni che smettono presto di Antonino Palumbo
Ciclismo, “Last dance” d’oro per Viviani di Antonino Palumbo
Volley, anche Verona sogna lo scudetto di Antonino Palumbo
Arfid: disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo di Daniela Bencardino
La valutazione della frammentazione del Dna degli spermatozoi di Giovanni Ruvolo
Evoluzione della nutrizione grazie alle nuove scoperte sulle interconnessioni di Gianno Zocchi
Dalla predizione alla prevenzione: integrazione dei sensori multiparametrici e dei biomarcatori in un nuovo modello ospedale–territorio di Luca Santini e Claudia Sorrentino
Storia del rapporto tra uomo e pianteseconda parte di Giuliano Russini
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 11/12 Novembre/Dicembre 2025
Edizione mensile di Bio’s
Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna
Giornale dei Biologi

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione il 26 novembre 2025.
Contatti: protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: @ Alones/shutterstock.com

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Per coloro che hanno studiato la filosofia e gli insegnamenti che ne sono derivati, posti alla base di tutta la conoscenza umana fin dai tempi degli antichi greci, è molto più semplice comprendere quali siano i limiti del sapere umano. Limiti che ci fanno capire quanto sia ristretta la conoscenza alla quale siamo pervenuti e quanto invece sia vasta e illimitata la quantità di ciò che ancora ignoriamo. Ne consegue che coloro che sanno,
I più ignoranti sono sempre i più presuntuosi, che si sopravvalutano e nutrono ambizioni non supportate da reali capacità e competenze
rendendosi conto di “non sapere” tutto ciò che ci sarebbe da conoscere, agiscono con umiltà e tolleranza. I più ignoranti sono invece sempre i più presuntuosi, quelli che si sopravvalutano e nutrono ambizioni non supportate da reali capacità e competenze. Una condizione, quest’ultima, che induce i detentori di un potere momentaneo a sopravvalutare se stessi, montarsi la testa, assumere atteggiamenti megalomani e mostrarsi sleali, fino a rinnegare ogni ricordo delle proprie limita -
te potenzialità, confondendo la propria persona con la carica che ricoprono. Sono insomma disposti a tutto pur di mantenere un livello sociale, professionale o politico (inteso nel senso più ampio del potere sugli altri), anche a tradire i propri benefattori o coloro ai quali devono il posto che hanno raggiunto. Una condizione, quella della superbia degli ignoranti, molto diffusa e causa di non pochi guai e controversie in ogni ambito delle vicende umane. A tal proposito ci soccorre il paradosso di Dunning-Kruger, che descrive la tendenza delle persone con scarsa competenza in un’area a sovrastimare le proprie abilità, mentre le più compe -
Una condizione, quella della superbia degli ignoranti, molto diffusa e causa di non pochi guai e controversie in ogni ambito
tenti tendono a sottovalutarsi. Questo accade perché la mancanza di competenza impedisce di rendersi conto dei propri limiti e di valutare accuratamente la propria attitudine al comando. Lo sciocco divenuto superbo tende a sopravvalutare il proprio operato e a denigrare o ignorare quello altrui; non ha né gratitudine né rispetto per i suoi maestri né per coloro che deve governare, e non ha altre mete che lucrare vantaggi materiali o acquisire porzioni di potere fini a se stesse. Chi è giunto a questo punto della lettura si chiederà: cosa c’entrano i Biologi con tutto ciò? Ebbene sì, c’entrano eccome! C’entrano perché sono sempre più numerosi, e sempre
maggiori sono le conoscenze che la Biologia ci rivela. Con esse aumentano le competenze riconosciute ai Biologi e quindi il numero di attività professionali che essi esercitano nella società e nell’ambito scientifico. Tuttavia, per quanto negli ultimi anni siano cresciute sia le conoscenze sia le competenze riconosciute
alla nostra Categoria professionale, non è aumentato lo spirito di Categoria, ossia la consapevolezza di essere parte di una comunità umana e professionale con un unico denominatore. In questi anni, grazie al lavoro e alle capacità della dirigenza - prima del disciolto ONB e poi della Federazione e degli Ordini Territoriali, creati in
Grazie al lavoro e alle capacità della dirigenza sono aumentate le competenze professionali, le conquiste di traguardi mai prima raggiunti
seguito all’ingresso per legge dei biologi nelle professioni sanitarie - sono aumentate le competenze professionali, le conquiste di traguardi mai prima raggiunti (borse per gli specializzandi, aumento dei posti disponibili e nuovi ingressi in scuole di specializzazione prima precluse, leggi per il riconoscimento di denominazioni, ambiti e ruoli professionali ai Biologi Ambientali ai Biologi Nutrizionisti), una radicale revisione dell’Albo professionale, una riorganizzazione dei servizi e delle tutele, una delocalizzazione di poteri e competenze dal centro alla periferia regionale, con più servizi e opportunità, una parificazione della Categoria alle al -
tre professioni sanitarie più antiche, un capillare inserimento in ogni ambito istituzionale (Ministeri, Istituzioni ed Enti e legislazione parlamentare) e così via. Ma la risposta dei singoli o dei gruppi organizzati non è sostanzialmente cambiata: indifferenza, ignoranza dei progressi e dei traguardi raggiunti, scarso riconoscimento delle maggiori opportunità a tutti i livelli - compreso quello occupazionale e reddituale -, inclinazione al lamentarsi, critica ignara e irriconoscente verso quanto proviene dalla dirigenza, sebbene questa sia stata democraticamente scelta dagli stessi iscritti, scarsa partecipazione alla vita degli Ordini territoriali.
Per i Biologi, come Categoria unita e consapevole, resta ancora molta strada da fare per affrancarsi dalla mediocrità degli ignoranti
Insomma: una diffusa indolenza e indifferenza, le lotte e le invidie dei mediocri, la slealtà e la superbia di taluni appena assurti al potere. Come spiegarlo? Credo che la chiave sia la conoscenza e che il paradosso di Dunning-Kruger lo illustri adeguatamente. E tuttavia occorre operare lo stesso, con temperanza e spirito di tolleranza, almeno fino alla scadenza del mandato ricevuto, per consegnare comunque a chi verrà un contesto più autorevole e qualificato. Ma per i Biologi, come Categoria unita e consapevole, resta ancora molta strada da fare per affrancarsi dalla mediocrità degli ignoranti e dal solipsismo ambizioso dei singoli.


Prende forma il progetto in collaborazione tra la FNOB e l’Agenzia Spaziale Italiana Due i laboratori per eseguire studi sui microrganismi in condizioni di microgravità di Rino Dazzo
La sfida è affascinante e impegnativa, addirittura cruciale se si pensa ai possibili risvolti per il futuro stesso dell’umanità: verificare la possibilità di coltivare grano sul suolo lunare, un’eventualità che consentirebbe di sostenere compiutamente e a lungo termine la vita umana nello spazio. E i biologi, anche su questo fronte, sono in prima fila. Definita, infatti, la partecipazione della FNOB, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, al progetto lanciato dall’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, che prevede la realizzazione di due mini-laboratori utili a eseguire studi in condizioni di microgravità. Un’iniziativa che coinvolge e mette insieme altri importanti partner e sostenitori e che offre interessanti opportunità lavorative e di crescita professionale: la FNOB, a supporto della stessa, stanzierà delle borse di studio per consentire a due biologi di prendere parte a questa esperienza unica e di eccezionale interesse sotto il profilo della ricerca, della formazione e dello sviluppo.
In particolare, l’Agenzia Spaziale Italiana ha sottoscritto un contratto con la società ALI S.p.A. del gruppo Space Factory per lo sviluppo di due MiniLab 3.0, dei mini laboratori in cui eseguire studi ed esperimenti di Life Science. Due i progetti. Il primo si chiama GAIA, ideato dal professor Mariano Bizzarri dell’Università Sapienza di Roma, ed è destinato a controllare la crescita del germe di grano utilizzando come substrato un campione di suolo terrestre e lunare. L’altro si chiama ASTROGUT ed è stato concepito dal professor Geppino Falco, dell’Università Federico II di Napoli: la sua funzione è monitorare il ciclo di vita del probiota intestinale. Entrambi i MiniLab 3.0 rappresentano il primo esempio di laboratorio di Life Science attraverso cui è posibile controllare, in tempo reale, dei veri e propri esperimenti nello spazio. Già, perché i mini laboratori saranno imbarcati su un micro satellite, IREOS-0/Amalia, in onore della scienziata italiana Amalia Ercoli Finzi, messo a punto dal Gruppo Space Factory.
Si tratta di un satellite dotato di capacità di rientro dallo spazio, oltre che di recupero e riutilizzo del materiale, alloggiato all’interno della piattaforma di transfer orbit ION Satellite Carrier della società D-Orbit. Proprio durante la missione orbitale di ION saranno attivati gli esperimenti, controllati da Terra dai ricercatori attraverso strumenti semplici quali comuni tablet o smartphone, coi quali monitorare lo stato di avanzamento dei progetti stessi e le risposte date dalla coltivazione del germe di grano e del probiota intestinale in condizioni mai verificate in precedenza. Inutile sottolineare quanto possa essere importante valutare la possibilità di coltivazione di cibo per gli astronauti in ambiente lunare (e in futuro su Marte), oltre che per lo sviluppo di sistemi bio-rigenerativi. Ma è anche essenziale l’opportunità di accertare più compiutamente le varie fasi dello sviluppo di batteri, virus e funghi che crescono nel

Non è la prima volta che la FNOB affianca ALI e il Gruppo Space Factory. Una sinergia era stata già stretta nel recente passato in coincidenza del lancio di una precedente versione del MiniLab, modello 1.0, sulla Stazione Spaziale Internazionale, in particolare per quanto riguarda un’attività di ricerca sull’osteoporosi. Con la partecipazione agli innovativi progetti lanciati dall’Agenzia Spaziale Italiana, il mondo della biologia conferma la sua vocazione al servizio di un settore molto promettente e dalle notevoli ricadute, al fianco di partner importanti e di spessore nel quadro di un’iniziativa a totale impulso italiano
nostro intestino, per meglio comprendere il funzionamento della fisiologia umana durante le missioni.
Una volta terminate le attività di sperimentazione, seguirà la certificazione in orbita dell’apertura dello scudo termico flessibile IRENE, una tecnologia proprietaria del Gruppo Space Factory che permetterà ai satelliti di rientrare integri dallo spazio e di recuperarli per successive missioni. I due MiniLab 3.0 sono inseriti nel Marketplace dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. «Il contratto appena firmato conferma il forte interesse dell’ASI nelle nuove opportunità offerte alla sperimentazione in orbita di applicazioni biopharma e scienze della vita», le parole di Mario Cosmo, direttore Scienza e Innovazione dell’ASI. «Prevediamo che questo settore diventerà sempre più strategico nei prossimi anni anche grazie all’ingresso dei privati nelle attività in orbita terrestre e quelle legate all’esplorazione della Luna e di Marte. La missione IREOS rappresenta un esempio concreto del posizionamento del nostro Paese nella progettazione e sviluppo di tecnologie applicate al rientro dall’orbita bassa e riutilizzo».
Non è la prima volta che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi affianca ALI e il Gruppo Space Factory, realtà fondata nel 2006 e che ha il suo quartier generale nella Zona Industriale di Napoli, in importanti missioni scientifiche. Una sinergia era stata già stretta nel recente passato in coincidenza del lancio di una precedente versione del MiniLab, modello 1.0, sulla Stazione Spaziale Internazionale, in particolare per quanto riguarda un’attività di ricerca sull’osteoporosi: anche in quel caso la FNOB ha previsto l’assegnazione di due borse di studio. Ora, con la partecipazione agli innovativi progetti lanciati dall’Agenzia Spaziale Italiana, il mondo della biologia conferma la sua vocazione al servizio di un settore molto promettente e dalle notevoli ricadute, al fianco di partner importanti e di spessore nel quadro di un’iniziativa a totale impulso italiano.

L’intesa tra FNOB e Space Factory non è solo una sfida scientifica ma una spinta concreta verso una medicina più intelligente, personalizzata e sostenibile
L“a Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) ha intrapreso una nuova frontiera nella ricerca spaziale con l’obiettivo di esplorare le applicazioni della biologia nello spazio. Il presidente della FNOB, Vincenzo D’Anna, ha annunciato che due biologi italiani saranno coinvolti in esperimenti in condizioni di microgravità, condotti dal Gruppo Space Factory. Questi esperimenti riguarderanno lo sviluppo di tecnologie avanzate come minisatelliti e sistemi per il rientro controllato di payload spaziali recupero e riutilizzo, nonché test microbiologici e biotecnologici in orbita.
Su questo ambizioso progetto e, in generale, sulle novità della ricerca spaziale in condizioni di microgravità abbiamo intervistato i protagonisti: Geppino Falco biologo, ordinario di Biologia Cellulare ed Applicata del Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Napoli Federico II e membro del coordinamento scientifico del Gruppo Space Factory, Valeria Lucci, ricercatrice in Biologia Cellulare ed Applicata del Dipartimento di Biologia - Università degli Studi di Napoli Federico II.
Quello che una volta sembrava fantascienza, adesso diviene realtà. Cosa intendiamo quando parliamo di microgravità?
Geppino Falco: «Quando parliamo di microgravità, ci riferiamo a una condizione in cui la forza di gravità è quasi assente. È ciò che accade a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti vivono e lavorano in assenza di peso. Dal punto di vista scientifico, si tratta di un ambiente unico: un vero laboratorio naturale che ci consente di osservare come i sistemi biologici, fisici e chimici si comportano senza l’influenza della gravità terrestre. Questo ci permette di analizzare in modo più chiaro i processi cellulari e molecolari che regolano la vita. È come “accelerare il tempo biologico”: fenomeni che sulla Terra richiedono anni, nello spazio si manifestano in poche settimane. Ed è proprio in questa accelerazione che si nasconde un grande valore per la ricerca biomedica».
Qual è il ruolo dei biologi coinvolti nel progetto MiniLab per esperimenti biofarmaceutici in microgravità?
Geppino Falco: «I biologi sono i protagonisti di questa nuova frontiera della ricerca. Sono loro a progettare gli esperimenti, a selezionare i modelli cellulari o microbici e a interpretare i risultati biologici e molecolari. Il MiniLab è un piccolo laboratorio automatizzato che permette di condurre esperimenti biologici in orbita. È stato impiegato, ad esempio, per studiare come gli osteoblasti - le cellule responsabili della formazione ossea - reagiscono alla microgravità e alle radiazioni, valutando l’effetto di formulazioni a base di collagene e metaboliti naturali derivati dal vino. Il contributo del biologo è cruciale perché la comprensione dei processi fisiopatologici passa attraverso la caratterizzazione cellulare e molecolare. Solo un approccio di questo tipo permette di capire come e
perché la funzione di un tessuto si altera in condizioni estreme e come possiamo proteggerlo o ripristinarlo».
Perché è così importante l’impiego di un biologo in questo tipo di progetti?
Geppino Falco: «Perché la biologia è la chiave per comprendere come la vita si adatta all’ambiente spaziale. La microgravità e le radiazioni cosmiche alterano profondamente le funzioni cellulari e i processi fisiologici. Il biologo interpreta queste variazioni e, insieme a ingegneri e fisici, contribuisce a sviluppare sistemi sperimentali avanzati e tecnologie di monitoraggio non invasive. Questo approccio integrato consente di unire la conoscenza della vita con l’innovazione tecnologica, e di trasformare la ricerca spaziale in un motore di progresso anche per la medicina terrestre».
Che tipo di esperimenti scientifici si conducono in microgravità?
Geppino Falco: «Si va dagli studi di biologia cellulare e microbiologia fino alla farmacologia e alla medicina rigenerativa. Nel progetto ReADI abbiamo analizzato l’effetto della microgravità sulla rigenerazione ossea e sull’espressione genica degli osteoblasti. In altri esperimenti, come ASTROGUT, abbiamo studiato la sopravvivenza e la crescita di batteri benefici per il microbiota umano, valutando l’efficacia di molecole naturali nel proteggerli dallo stress spaziale. Tutti questi studi contribuiscono a comprendere come l’ambiente spaziale influenzi la vita e come possiamo adattarci a missioni sempre più lunghe, sviluppando al tempo stesso nuove soluzioni per la salute sulla Terra».
Perché è importante la ricerca in condizioni di microgravità? Geppino Falco: «Perché ci offre la possibilità di osservare processi fisiopatologici in forma accelerata. Nella microgravità si verificano rapidamente alterazioni che sulla Terra si sviluppano nel corso di anni: perdita di massa ossea, riduzione della forza muscolare, indebolimento del sistema immunitario. La caratterizzazione cellulare e molecolare di questi fenomeni, di cui il biologo è specialista, consente di individuare i meccanismi alla base dell’invecchiamento e di altre condizioni degenerative. Inoltre, lo spazio è un banco di prova ideale per testare nuove strategie terapeutiche, biomateriali e approcci farmacologici in un contesto controllato, dove gli effetti biologici possono essere misurati in modo chiaro e quantitativo. La ricerca in microgravità, quindi, non serve solo a capire come vivere meglio nello spazio, ma anche come vivere più a lungo e in salute sulla Terra».
Da tempo il presidente della FNOB, Vincenzo D’Anna, ama ripetere che la biologia è la scienza del terzo millennio, una scienza che guarda cioè al futuro anche in termini di ricerca per il benessere e la longevità. In tal senso la medicina predit-
STUDIARE L’INVECCHIAMENTO
BIOLOGICO ACCELERATO IN ORBITA
AIUTA A SVILUPPARE STRATEGIE E FARMACI UTILI ANCHE PER LA LONGEVITÀ E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE SULLA TERRA

tiva e la medicina di precisione sono le nuove frontiere. In che termini una visione del genere trova compimento nell’intesa con il Gruppo Space Factory?
Geppino Falco: «La collaborazione tra FNOB e Space Factory nasce proprio dalla consapevolezza che la biologia è destinata a guidare la nuova rivoluzione scientifica e tecnologica. Studiare la vita nello spazio significa comprendere i suoi limiti e individuare nuovi strumenti per proteggerla e migliorarla. I nostri progetti puntano proprio in questa direzione: sviluppare piattaforme sperimentali capaci di raccogliere dati biologici in tempo reale, per arrivare a una medicina sempre più personalizzata, predittiva e preventiva. Le tecnologie nate per le missioni spaziali, come i MiniLab, potranno avere ricadute concrete sulla diagnostica portatile, sulla telemedicina e sulla cura delle patologie croniche anche sulla Terra».
L’accordo tra FNOB e il Gruppo Space Factory coinvolge biologi, ingegneri e ricercatori. Che valore ha questa sinergia?
Geppino Falco: «È un valore strategico. La ricerca spaziale richiede competenze che nessuna disciplina da sola può garantire. Biologi, ingegneri, fisici e informatici lavorano insieme per ideare, realizzare e controllare esperimenti complessi in un ambiente estremo. Questa collaborazione permette di unire il rigore della scienza con l’innovazione tecnologica e di creare un ecosistema di conoscenza che rafforza la posizione del nostro Paese nella nuova Space Economy. Il nostro obiettivo è chiaro: portare l’Italia all’avanguardia nella biologia spaziale e, allo stesso tempo, restituire alla Terra i benefici concreti di questa straordinaria avventura scientifica».
È possibile sviluppare nuove tecnologie per la ricerca biomedica e la medicina personalizzata?
Valeria Lucci: «Assolutamente sì. Lo spazio è un motore di innovazione straordinario. Le soluzioni tecnologiche che sviluppiamo per condurre esperimenti in orbita - sistemi automatizzati, sensori miniaturizzati, dispositivi diagnostici compatti - sono direttamente applicabili in ambito medico e clinico. Lo sviluppo di dispositivi capaci di misurare parametri biologici e molecolari, in affiancamento a quelli chimici
e clinici, consente di valutare l’efficacia dei trattamenti farmacologici in modo più preciso e individualizzato. La ricerca spaziale, quindi, non è solo una sfida scientifica ma una spinta concreta verso una medicina più intelligente, personalizzata e sostenibile».
Ha destato scalpore il caso dell’astronauta della NASA Suni Williams che, tornata dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo 288 giorni (ma doveva restarci poco più di una settimana), sembrava avesse dieci anni in più, recando i segni evidenti di un invecchiamento accelerato. È vero che la permanenza nello spazio “invecchia”?
Valeria Lucci: «Sì, ma bisogna chiarire che l’invecchiamento biologico non è sinonimo di invecchiamento cronologico. Nello spazio il tempo biologico accelera: processi che sulla Terra richiedono anni, in microgravità si verificano in settimane. Questo non significa che l’età anagrafica aumenti, ma che si manifestano più rapidamente i segni cellulari e molecolari dell’invecchiamento. Ed è proprio questo che rende lo spazio un modello di studio eccezionale: ci permette di capire in tempi brevi come avviene il deterioramento dei tessuti e come intervenire per prevenirlo. Studiare l’invecchiamento biologico accelerato in orbita aiuta a sviluppare strategie e farmaci utili anche per la longevità e la prevenzione delle malattie croniche sulla Terra».
Quali sono i vantaggi di testare le terapie in microgravità?
Valeria Lucci: «In microgravità possiamo osservare gli effetti di una terapia o di un composto biologico in un contesto privo delle interferenze terrestri. I risultati sono più chiari e arrivano in tempi più brevi. Ad esempio, la crescita di cristalli proteici risulta più omogenea, utile per la progettazione di nuovi farmaci; la proliferazione cellulare tridimensionale avviene in modo più naturale, migliorando gli studi di medicina rigenerativa. Per questo motivo, molte aziende farmaceutiche guardano con interesse alle piattaforme spaziali come veri laboratori per la ricerca preclinica e lo sviluppo di bioterapie. È una nuova frontiera dove ricerca pubblica e industria farmaceutica possono collaborare in modo virtuoso».
Il fondatore del gruppo Gruppo, Norberto Salza, svela il ruolo sempre più determinante dei nostri scienziati. Tra i fiori all’occhiello c’è “Amalia” dedicata alla Ercoli Finzi, pioniera nel campo delle scienze e tecnologie dello spazio
Il Gruppo Space Factory è un’azienda giovane che ha già raggiunto importanti traguardi. Il suo fondatore l’ingegnere Norberto Salza ripercorre il lungo percorso aziendale costellato di successi e di conquiste. Ingegnere come nasce il Gruppo Space Factory e qual è il vostro fiore all’occhiello?
«Il Gruppo Space Factory comprende al suo interno imprese con consolidate esperienze nel settore spaziale e con differenti competenze. In particolare faccio riferimento alle società Marscenter e alla ALI.
Il Marscenter è nato nel 1988 da un’intuizione di Luigi Gerardo Napolitano, pioniere della microgravità e di Rodolfo Monti. Si immagini che negli anni ‘80 c’erano solo tre centri di eccellenza al mondo impegnati nella ricerca in microgravità, uno dei quali era il Marscenter. Dal suo centro di controllo localizzato nella zona industriale di Napoli est, gli scienziati della “piccola Nasa italiana”, progettarono e gestirono direttamente esperimenti a bordo di piattaforme spaziali quali lo SpaceLab, SpaceHab, Mir e la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
In oltre vent’anni di attività, la società ha realizzato più di trenta esperimenti scientifici nello Spazio, impiegando circa 40 fisici e ingegneri. Nel 2019 il Marscenter riprende ad operare presso la sede originaria. Il nuovo management ha avviato una strategia di riposizionamento, sempre incentrata sulla R&S in microgravità, ma sfruttando le nuove
opportunità della New Space Economy.
ALI S.p.A., fondata nel 2006 come Scarl, è specializzata nella progettazione e sviluppo di tecnologie innovative proprietarie per il rientro di microsatelliti e di device utilizzati per servizi di esperimenti biopharma e life-sciences in orbita, denominati MiniLab.
ALI ha condotto con successo tra il 2021 e il 2024 cinque missioni spaziali, di cui 4 scientifiche con il MiniLab, modello 1.0, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e una missione di certificazione suborbitale di qualifica del sistema di protezione che permette ai satelliti di rientrare in modo sicuro sulla Terra, IRENE®. La missione, denominata MIFE, è stata finanziata con fondi GSTP di ESA/ ASI e coordinata dal Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali - CIRA. Le 4 missioni scientifiche hanno in particolare riguardato due filoni di ricerca con forti ricadute sulla Terra, ossia l’osteoporosi (missioni ReADI-FP e ReADI-SP) e la fertilità femminile (OVOSPACE e ORION). In particolare, per quanto riguarda l’osteoporosi è in corso un’attività di ricerca, attraverso l’assegnazione di due borse di studio, con la Federazione Nazionale Ordine Biologi - FNOB».
Nella vostra sede, che si trova a Napoli, sono presenti due Clean Rooms per l’integrazione dei microsatelliti IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLabs. Come funziona il MiniLab e quali sono i suoi principali utilizzi nella ricerca scientifica?
«La sede del Gruppo Space Factory è localizzata nell’area industriale di Napoli est e si estende su una superficie

Durante la missione orbitale saranno attivati gli esperimenti controllati da Terra dagli scienziati, per la prima volta, tramite un semplice tablet o smartphone. Terminate le attività di sperimentazione si avvieranno le attività per la certificazione in orbita dei sottosistemi del microsatellite, a partire dal meccanismo di apertura dello scudo termico flessibile IRENE ®
di 3.000 metri quadrati, tra uffici, laboratori, aree espositive e strutture dedicate tra cui: 2 Camere Bianche per l’integrazione dei microsatelliti IRENESAT-ORBITAL e dei MiniLab; l’Officina dello Spazio, per lo sviluppo di dimostratori terrestri e la Sala di Controllo per il monitoraggio e il controllo in tempo reale delle operazioni orbitali e degli esperimenti.
I MiniLab ad oggi sviluppati e in fase di sviluppo sono di tre modelli con dimensioni e modelli di gestione differenti. Il modello MiniLab 1.0 che è automatizzato, ha le dimensioni di un 2U (10x10x20 cm.) e può contenere un solo esperimento ed è stato realizzato con un investimento del Gruppo Space Factory e la co-partecipazione della Regione Campania e della BCC Napoli. La prossima missione del MiniLab 1.0 sulla ISS, ORION 2, è prevista a giugno 2026. Al modello 1.0 segue il MiniLab 2.0 che ha le dimensioni di un 4 U (10x10x40 cm.) e potrà contenere 4 esperimenti in contemporanea controllati e gestiti in diretta. La prima missione, Space Slime, finanziata da ASI è prevista a luglio 2026.
Il MiniLab 3.0, infine, che ha le dimensioni di un 2U (10x10x20 cm.), rappresenta un vero salto tecnologico rispetto al precedente modello automatizzato, MiniLab
1.0. Finanziata da ASI, grazie alle tecnologie proprietarie, gli scienziati, per la prima volta, potranno controllare in diretta gli esperimenti, più di 126, e gestirli anche con azione correttive da un semplice tablet su cui sarà installata un’app. Attualmente i MiniLab sono inseriti nel Marketplace dell’Agenzia Spaziale Europea - ESA, rendendo la società fornitore ufficiale in Europa dei servizi biopharma e life-sciences in orbita».
Quali sono le principali sfide che Space Factory affronta nello sviluppo di tecnologie per il rientro dallo spazio e la gestione di esperimenti scientifici in condizioni di microgravità?
«L’integrazione della tecnologia IRENE® e dei MiniLab, modello 3 hanno portato alla realizzazione dei microsatelliti, denominati IRENESAT-ORBITAL con capacità di rientro autonomo e controllato dallo spazio, il loro recupero e riutilizzo.
Qualcosa attualmente di unico che porta il nostro Paese all’avanguardia nei servizi di sperimentazione delle life-sciences e biopharma in orbita bassa e nella progettazione e realizzazione di tecnologie del rientro dallo spazio di satelliti. Sono previste nel prossimo triennio tre distinte missioni: IREOS-0/Amalia, IREOS 1 e IREOS 2. IREOS-0/ Amalia è la prima missione del programma di microsatelliti IRENESAT-ORBITAL. Il nome Amalia è stato dato in onore della scienziata italiana Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana e pioniera nel campo delle scienze e tecnologie spaziali. Durante la missione orbitale saranno attivati gli esperimenti controllati da Terra dagli scienziati, per la prima volta, tramite un semplice tablet o smartphone. Terminate le attività di sperimentazione si avvieranno le attività per la certificazione in orbita dei sottosistemi del microsatellite, a partire dal meccanismo di apertura dello scudo termico flessibile IRENE®.
Nelle successive missioni, IREOS-1 e IREOS-2, previste rispettivamente nel 2028 e 2029, oggetto di un importante piano di investimenti, il microsatellite potrà imbarcare fino a tre MiniLab 3.0. La loro principale peculiarità è la capacità di rientrare autonomamente integro dallo spazio grazie allo scudo termico flessibile IRENE®, tecnologia proprietaria del Gruppo, che consente il loro recupero e riutilizzo per missioni successive, contrastando in tal modo anche il fenomeno sempre più crescente dello Space Debris (detriti spaziali ndr). La tecnologia del rientro e riutilizzo di satelliti è stata oggetto di un’importante audizione del Gruppo Space Factory con la IV Commissione (Difesa) della Camera dei Deputati.
IREOS 0/Amalia è stato realizzato grazie ad un modello virtuoso tra investimenti diretti del Gruppo Space Factory e un finanziamento di Intesa SanPaolo attraverso lo strumento Nova+». (M. A.).



Durante il periodo delle feste, storicamente, si riscontra il maggior numero di raggiri, sequestri e interventi
Arrivano le feste natalizie e impazzano frodi e sofisticazioni alimentari. È proprio questo il periodo dell’anno, infatti, in cui si registrano agghiaccianti impennate di un fenomeno sempre attivo, purtroppo, ma che ha nelle occasioni di festa, quella in cui si spende di più per piatti tipici, antiche ricette e prodotti della tradizione, il suo boom.
Natale e Capodanno, in particolare, offrono diverse occasioni per mettere in piedi vere e proprie truffe e raggiri ai danni dei consumatori, che non hanno soltanto implicazioni
economiche, ma prestano il fianco a rischi da non sottovalutare per la salute. Tra gli alimenti che non possono mancare sulle tavole degli italiani per le festività di fine anno, da nord a sud, ci sono il panettone e il pandoro e sono proprio queste due prelibatezze a essere maggiormente oggetto di contraffazioni. L’invito è quello di prestare attenzione alla qualità e alla provenienza di ciò che si acquista anche nel caso di prodotti artigianali, o presunti tali. Tutti, come prescritto dal decreto ministeriale del 22/07/2005, devono riportare la composizione degli ingredienti,
la data di produzione e di scadenza. L’obbligo, naturalmente, vale per tutti i tipi di prodotti e alimenti, lavorati e non. Tra le frodi alimentari più frequenti del periodo, molte riguardano l’industria salumiera e casearia, con la vendita di finti prodotti DOP e realizzati invece con materia prima scadente o diversa da quella prevista dai disciplinari di produzione. Mozzarella di bufala prodotta in realtà con latte vaccino, prosciutto crudo comune spacciato per Parma o San Daniele, finti Parmigiano Reggiano e Grana Padano, ma anche pesce congelato venduto come fresco: sono i raggiri più comuni del periodo, oggetto di anno in anno di numerosi sequestri e provvedimenti dei N.A.S., i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri. Non bisogna fidarsi dei venditori improvvisati, bensì affidarsi unicamente a circuiti di vendita legali, quelli che assicurano la tracciabilità dei prodotti venduti. Anche i prezzi troppo bassi, naturalmente, sono indizi di cui tener conto.
Anche frutta secca, noci, mandorle, olio e insaccati sono oggetto ogni anno di interventi, segnalazioni e sequestri. Un discorso a parte meritano poi vini e spumanti utilizzati per i brindisi e gli auguri nelle tavolate. Anche questi sono tra i prodotti più contraffatti. Prima di acquistare una bottiglia va tenuta presente la classificazione dei vini italiani: DOCG, DOC, IGT e da tavola. Se si acquista una bottiglia denominata come DOCG senza la fascetta numerata che la sigilla, ci troviamo di fronte a una frode. Occhio anche alle aggiunte di anidride carbonica a un vino comune. E occhio a chi, dopo le feste, fornisce consigli sull’alimentazione e il regime nutrizionale da seguire per rimettersi in forma. L’invito, per non incappare in brutte sorprese, è sempre quello di affidarsi a veri professionisti del settore e non a ciarlatani o a improbabili «esperti» che in realtà non lo sono. (R. D.).
Uno dei fenomeni più pre occupanti degli ultimi anni è il proliferare dei falsi nutrizionisti, di tut ti coloro che offrono - attraverso il web, i social o addirittura su qualche testata online - indicazioni su dieta, regime alimentare, cibi da privilegia re o da cui tenersi lontani, senza ave re le competenze per farlo.

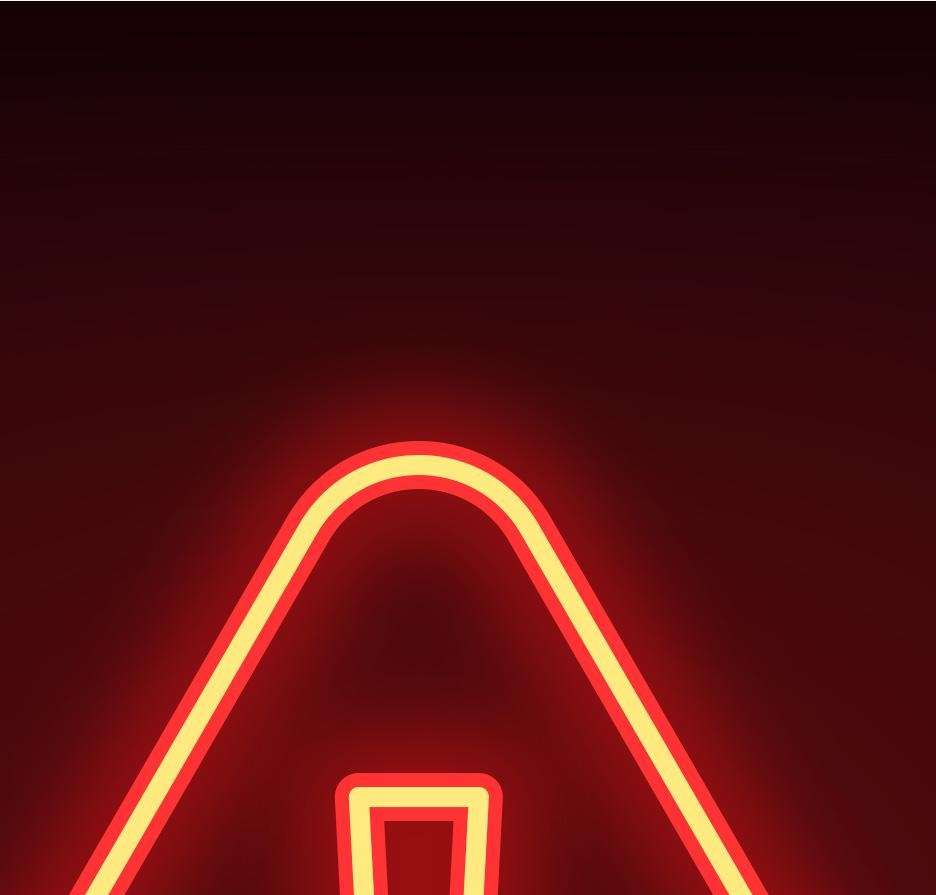

Veri e propri abusivi della profes sione, che non solo mettono a repen taglio la salute di chi si affida ai loro «consigli», ma recano anche danno allo Stato, visto che la loro attività non è inquadrata.
I numeri sono impietosi e - pur troppo - ancora parziali. Soltanto fino a ottobre 2025 si sono registrate 455 segnalazioni e 68 processi in tutta Italia contro i falsi nutrizionisti. Tra gli ultimi scandali va citata l’operazione Vera Salus della Guardia di Finanza di Firenze, che ha portato all’individuazione di 41 abusivi che esercitavano la professione di nutrizionista in varie regioni italiane senza averne titolo.



Attraverso strutture pseudo-universitarie, i frequentatori ricevevano un presunto titolo online rilasciato per il tramite di un ateneo svizzero, non avente valore legale in Italia.
La normativa vigente stabilisce che la professione di nutrizionista può essere esercitata esclusivamente da soggetti in possesso di un titolo rilasciato da un ateneo riconosciuto dal MUR e regolarmente iscritti all’Ordine dei Biologi o, in alternativa, a quello dei Medici o Dietisti. Quanti tra la pletora di personal trainer, food influencer e presunti esperti, lo sono davvero? «Il termine nutrizionista è meramente una semplificazione semantica», chiarisce Vincenzo D’Anna, presidente della FNOB, in un’intervista al quotidiano La Repubblica.
«Non c’è alcun corso di studi né alcuna qualifica di questo tipo. Esistono invece i dietologi: medici,
L’allarme del presidente Vincenzo D’Anna: «I biologi la categoria più esposta alle lesioni della propria attività»
specializzati o meno, e anche biologi nutrizionisti, specializzati o meno in scienza della Alimentazione. I biologi hanno riconosciuta questa competenza dalla legge 369 del 1967».
«I biologi che esercitano sia nel campo della nutrizione umana che in quella animale sono 13mila», prosegue D’Anna. «La categoria più esposta alle lesioni della propria attività professionale da parte di coloro che esercitano abusivamente. A cominciare dai trainer e preparatori atletici nelle palestre, da quanti acquisiscono pseudo diplomi senza alcun riscontro di legge. E, quel che è peggio
sono privi di specifica competenza». Come nel caso messo in luce dall’operazione Vera Salus, ci sono appunto delle scuole che rilasciano grotteschi pseudo certificati: «Università farlocche che rilasciano titoli ai malcapitati che vi si iscrivono e sedicenti albi professionali in nutrizione». I rischi sono enormi: «Un regime alimentare non idoneo per un soggetto sano oppure con patologie metaboliche (obesità, diabete, insufficienza renale ed epatica e malattie) aggrava lo stato di salute, così come per gli sportivi che subiscono scompensi e patologie post-attività». (R. D.).
Èrecord di centenari in Italia. Al primo gennaio 2025, i residenti che hanno almeno 100 anni sono 23.548. Ma il dato più sorprendente è che rispetto al 2024 sono oltre duemila in più. Siamo destinati a lunga vita quindi, anzi la tendenza è andare oltre considerato che sono infatti diciannove gli over 110 secondo quanto riferisce il report aggiornato “I centenari in Italia” pubblicato dall’Istat. I numeri dell’Istat fotografano una realtà già acclarata e cioè che l’Italia non è soltanto un Paese in cui si invecchia, ma che si invecchia anche bene. I numeri rispetto a qualche decennio fa sono più che raddoppiati: rispetto al 1° gennaio 2009, quando erano 10.158, la percentuale è un +130%. Un altro aspetto non trascurabile è che la longevità appartiene alle donne e infatti l’82,6% dei centenari è rappresentato da donne. Per quanto riguarda i semi supercentenari, cioè dai 105 anni in su, sono 724 con la quota di donne che sale al 90,7%. Il decano d’Italia ancora in vita si conferma, anche per quest’anno, un uomo residente in Basilicata che ha superato i 111 anni mentre la decana dei centenari è una nonnina che risiede in Campania e che da poco ha festeggiato i 115 anni. E proprio la Cam-
pania Felix è tra le regioni che ospita più longevi: sono 1.359 i centenari, con un rapporto di circa 4 donne per ogni uomo. Le aree con una maggiore concentrazione di centenari sono il Cilento e il Vallo di Diano, dove fattori come dieta mediterranea, ritmi di vita lenti e forti legami sociali sembrano favorire la longevità. In cima alla classifica c’è però il Molise con circa 61 centenari ogni 100mila residenti mentre è la Liguria la regione storicamente a più forte invecchiamento del Paese: «la sua quota di centenari è pari a 59,4 per 100mila residenti al 1° gennaio 2025, davanti a quella del Friuli-Venezia Giulia (55,4) e della Toscana (49,1)». %». Se guardiamo alle province, il primato dei centenari spetta alla provincia molisana di Isernia che presenta la concentrazione più elevata di centenari: 78,7 per 100mila abitanti, quella sarda di Nuoro, a sua volta, detiene la più alta quota di semi-supercentenari con 4,6 per 100mila abitanti.
Il report dell’Istat riferisce che tra il 2009 e il 2025 sono 8.980 le persone che hanno superato i 105 anni di età, la
In Campania vive la super Nel Belpaese si invecchia

maggior parte donne: ben 7.956 e quindi l’88%. Gli over 105 sono quasi tutti vedove e vedovi (86% e 80%, rispettivamente, per donne e uomini). Le nubili sono il 12%, il doppio rispetto ai celibi (6%), e le donne coniugate rappresentano solo l’1%. Mentre gli uomini coniugati sono quasi il 14%, per effetto della maggiore longevità femminile. Per quanto riguarda la probabilità di morire, dopo i 105 anni di età il rischio «non cresce in misura esponenziale, come si riteneva in passato». Dalle tavole di mortalità della popolazione residente, Istat spiega come ci sia «un’accelerazione ben più veloce dei rischi di morte nel tratto che va dai 75 anni di età fino ai 100. Ad esempio, dalla tavola di mortalità 2016, mediamente rappresentativa del periodo 2009-2024, emerge come tra i 75 e gli 82 anni di età la probabilità di morte salga dal 2,3% al 5,2%, mentre tra gli 85 anni e i 92 passi dal 7,7% al 17,9». Un’ultima curiosità i nomi di battesimo: i più diffusi in questa categoria sono Giuseppe tra gli uomini e Maria tra le donne, «nomi legati alla tradizione religiosa che oggi assai raramente si ritrovano nelle nuove generazioni». (M. A.).
Perdasdefogu, situato nell’Ogliastra in Sardegna, è il comune con la più alta concentrazione di centenari al mondo. È considerato una “Blue Zone”, un’area geografica con un’eccezionale longevità studiata per i segreti della longevità. Il toponimo “Perdasdefogu” deriva dal sardo “pietre da fuoco”, riferendosi alle pietre calcaree utilizzate nelle fornaci locali. Nel 2014 il borgo divenne meta di studiosi, giornalisti e troupe televisive provenienti da tutto il mondo che volevano carpire i segreti della longevità della famiglia Melis. Al centro dell’attenzione Consolata, la più grande degli otto fratelli, che poco prima di compiere 108 anni decantava le proprietà del “minestrone ogliastrino” una ricetta poi riproposta da vari chef nel mondo.

nonna che compie 115 anni invecchia in salute


Così la scienza, attraverso l’analisi dei fattori genetici, aiuta a vivere a lungo e meglio
Da anni i biologi sono impegnati nella ricerca della longevità attraverso l’analisi dei fattori genetici, epigenetici e ambientali che influenzano l’invecchiamento e la durata della vita. In origine c’è lo studio dei meccanismi biologici di base e lo sviluppo di approcci preventivi e personalizzati. Genetica e longevità sono legate a doppio filo, tra ciò che ereditiamo e ciò che scegliamo ogni giorno. Scienze come la biologia hanno dimostrato che la longevità non dipende solo dal DNA, ma da uno scambio tra geni, epigenetica e am -
biente. Genetica, epigenetica e ambiente sono i tre fattori che si combinano tra loro. Nei primi decenni della vita, siamo soprattutto ciò che facciamo. Negli ultimi, entrano in gioco i geni, che ci permettono di superare la soglia dei 90 e dei 100 anni. Comprendere questi meccanismi non significa solo prolungare la vita, ma trasformare l’allungamento della sopravvivenza in un prolungamento della longevità in salute. Se importante è l’ambiente in cui viviamo e gli stili di vita, dopo i 90 anni, invece, il contributo della genetica diventa più evidente: nei centenari,
i geni incidono per circa il 33% nella longevità femminile e per quasi il 50% in quella maschile. I geni, però, non agiscono da soli. Sempre più evidenze sottolineano il ruolo dell’epigenetica, ovvero le modifiche che regolano l’attività dei geni senza alterare la sequenza del DNA. L’epigenoma è sensibile a fattori come dieta, stress, inquinamento, esercizio fisico. Ciò significa che stili di vita salutari non solo prevengono malattie, ma possono anche modulare l’espressione della genetica e della longevità. (M. A.).

© Digitala World/shutterstock.com
L’ epigenetica è la branca della biologia che studia come fattori esterni come stile di vita, dieta e stress possano influenzare l’espressione dei geni senza alterare la sequenza del DNA. I biologi studiano i meccanismi epigenetici per capire come i geni possono essere “accesi” o “spenti” e come questo influisce sul fenotipo (le caratteristiche fisiche e funzionali dell’organismo). L’epigenetica ha implicazioni cruciali per la salute, l’invecchiamento e lo sviluppo, poiché le modifiche epigenetiche sono spesso reversibili e possono persino essere ereditabili. A differenza della genetica, non è il DNA a essere modificato, ma il suo utilizzo: modificazioni epigenetiche come la metilazione del DNA possono attivare o disattivare geni che influenzano la longevità e l’insorgenza di malattie legate all’età. In sintesi, l’epigenetica dimostra che il nostro destino non è interamente scritto nei geni, ma che possiamo influenzare attivamente la nostra longevità attraverso scelte di vita consapevoli.

La donna ha spento le candeline il 22 novembre, con un record nel nostro Paese. È la quarta più anziana nel mondo
Nonna Laurina ha spento il 22 novembre scorso le 115 candeline ed entra nel guinness dei primati. È la più longeva d’Italia, terza in Europa e quarta nel mondo. Lucia Laura Sangenito, detta Laurina, vedova Abbondandolo è nata a Sturno, in provincia di Avellino, il 22 novembre 1910.
Dopo la morte di Claudia Baccarini, avvenuta il 24 dicembre 2024, è stata Laurina a prendere lo scettro della più longeva. Si tratta inoltre della quarta
persona più longeva vivente al mondo (dopo Ethel Caterham, Marie-Rose Tessier e Naomi Whitehead) e della quinta persona più longeva di tutti i tempi tra quelle viventi o decedute in Italia.
La longevità è un vizio di famiglia: la mamma di Laurina Sangenito, infatti, ha vissuto 101 anni. Oggi vive con la figlia Maria nella tranquillità della casa circondata dal verde. L’aria buona, lo stile di vita sano, purtuttavia nella vita di Laurina non sono mancati i
malanni. A 107 anni la frattura del femore che ha superato dopo l’intervento e le cure presso l’ospedale di Ariano Irpino. E ancora, sempre qualche anno fa Laurina ha sconfitto un tumore. Oggi tutta la comunità fa festa con lei e il sindaco di Sturno è giunto a farle gli auguri e donarle la pergamena del Comune. L’Irpinia è terra di centenarie (ma il primato spetta al Molise) a Volturara Irpina pochi giorni Angela Meo ha compiuto 105 anni. In ogni caso le più longeve sono le donne. (M. A.).
Fabbisogni formativi e nuove direttive sull’accesso alle scuole di specializzazione
di Alberto Spanò*
Il 6 novembre 2025 la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l’Accordo per la determinazione del fabbisogno degli specialisti da formare per le professioni di biologo, chimico, farmacista, fisico, odontoiatra, veterinario e psicologo per gli anni accademici 2025, 2026, 2027 (di cui all’art. 8 della Legge n. 401/2000).
Si è trattato di un lavoro complesso, avviato dal Ministero della Salute all’inizio del 2025, al quale hanno contribuito le Regioni e le Federazioni degli Ordini che hanno proposto ed elaborato i valori di fabbisogno per le specifiche scuole di specializzazione di ciascuna categoria, per ciascun anno. Tutto ciò anche in considerazione dell’avvenuta approvazione, nella legge finanziaria 2025, delle borse di studio per le categorie sanitarie non mediche, che attendevano tale adempimento da oltre venticinque anni, ossia dalla promulgazione della citata Legge 401/2000.
Per i biologi in particolare, il fabbisogno annuo calcolato è stato di 1136 posti per il 2025 e di 1107-1087 posti rispettivamente per il 2026-2027. I dati riguardano le scuole di Farmacologia e Tossicologia clinica, Genetica medica, Microbiologia e Virologia, Patologia clinica e Biochi-
* Vicepresidente FNOB
mica clinica, Scienza dell’alimentazione, Statistica sanitaria e biometria.
Al riguardo si è osservato il sostanziale accoglimento delle proposte formulate dalla FNOB, con delle riduzioni formulate dalle Regioni. Si dovrà procedere ora con i provvedimenti attuativi da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e delle stesse Università per pervenire al più presto all’emissione dei bandi e alla corresponsione dei trattamenti economici previsti. Sull’entità ridotta di tali trattamenti, la FNOB sta sviluppando apposite proposte per giungere a un relativo adeguamento.
Una ulteriore fase di sviluppo sta riguardando la richiesta di accesso alla formazione specialistica in ambiti disciplinari ancora carenti, come, per i biologi, il settore ambientale. Al riguardo è molto importante registrare la bollinatura da parte del MEF dello Schema di Disegno di Legge in materia di professioni sanitarie che, oltre ad altre previsioni rilevanti, all’art.5 c.1, consente l’accesso dei biologi alla scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva in materia di protezione della salute pubblica attraverso la gestione e il controllo dei rischi sanitari legati all’ambiente. Tali specialisti avranno poi accesso ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, alle Agenzie regionali di Prevenzione Ambientale, in enti pubblici e privati che si occupano di salute e ambiente o
in ambito di ricerca e consulenza.
In tale scenario resta aperto il confronto per valutare l’accesso dei biologi, tra le cui competenze professionali è prevista la cito-istopatologia, alla scuola di specializzazione in anatomia patologica.
Sullo schema di disegno di legge in questione è stato presentato un ulteriore emendamento, concordato con MUR e Ministero della Salute, per sopperire alla elevata riduzione degli accessi alle scuole di specializzazione della medicina di laboratorio pluriaccesso da parte di laureati medici. L’emendamento prevede che dall’anno accademico 2025/2026 i regolamenti didattici di ateneo, nel disciplinare le scuole di specializzazione di area sanitaria aperte anche a biologi e altre categorie sanitarie, prevedano di aumentare gli accessi in funzione dei posti eventualmente rimasti vacanti, nello stesso anno accademico, nelle omologhe scuole aperte ai laureati in Medicina, attingendo ai finanziamenti di queste ultime entro i limiti di copertura con contestuale riduzione di spesa.
Uno scenario quello sia pur sommariamente descritto che riporta evidenti ipotesi di sviluppo per la formazione specialistica post-lauream delle categorie sanitarie non mediche in parte realizzate, in parte in via di perfezionamento, finalizzate complessivamente a consentire un reale innalzamento della qualità dei servizi offerti in ambito sanitario.

Gentili Colleghi, si approssima il termine di fine anno entro il quale i Biologi che ne hanno l’obbligo devono entrare in possesso dei crediti formativi ECM previsti dalla legge per il triennio 2023-2025. La legge non prevede ulteriori deroghe per i trienni trascorsi, ancorché disponga che i crediti eccedenti il minimo dovuto per il corrente triennio possano essere utilizzati per quello prossimo a venire. Le sanzioni previste per gli inadempienti sono gravose: sospensione dall’Albo e comminazione di una multa. In questo contesto si ritiene utile un avviso e un resoconto informativo.
Obblighi formativi e attività della Fnob
Entro il 31 dicembre 2025 i biologi devono concludere la loro formazione e raggiungere i 150 crediti, considerando i corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) e le attività di formazione a distanza (FAD) del 2023, 2024 e del 2025. Un obiettivo, potenzialmente, raggiunto (e anche superato) senza difficoltà e in maniera totalmente gratuita se si considerano i Fad promossi dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi com -
presi quelli legati al Giornale dei Biologi del 2024 e del 2025.
Nel dettaglio, nell’ultimo biennio, sono stati elargiti in totale 723.684 crediti così distribuiti: 704383,5 per i Fad asincrono; 10542 Fad sincrono; 8758,8 per eventi Residenziali.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) ha messo a disposizione dei professionisti una serie di corsi FAD (Formazione a Distanza) che consentono di accumulare i crediti ECM (sono compresi anche gli eventi promossi dalla Fnob) richiesti entro il 31 dicembre 2025. L’obiettivo è duplice: aggiornare le competenze tecnico - scientifiche e facilitare la fruibilità della formazione, soprattutto in un periodo in cui la flessibilità è fondamentale.
Tutti i percorsi sono accreditati e rilasciano crediti ECM validi per il triennio 2023 - 2025.
Le tematiche spaziano dalla diagnostica molecolare alla gestione ambientale, passando per le malattie rare. La piattaforma sul sito della FNOB (nella sezione My bio) permette di seguire le lezioni 24 h su 24, con la possibilità di scaricare i materiali per rivederli offline.

Formazione a distanza e residenziale: le proposte della Fnob consentono di raggiungere gli obiettivi formativi grazie al Giornale e ai corsi del 2024 e 2025
di Carla Cimmino, delegata Fnob per la Formazione ed Elvira Tarsitano, delegata Fnob per gli Eventi
Approssimandosi i provvedimenti di riorganizzazione dello specifico ambito di attività di esercizio della professione di Biologo Nutrizionista, del riconoscimento per legge della medesima denominazione, della elencazione delle competenze afferenti a tale settore, dell’aggiornamento e delle integrazione delle medesime, dell’inserimento tra le figure professionali pertinenti al Servizio Sanitario Nazionale (pubblico e privato), delle possibilità di utilizzare apparecchiature elettromedicali, di un apposita sezione dedicata dell’Albo professionale, si invitano i colleghi nutrizionisti ad aderire al Coordinamento Nazionale dei Biologi Nutrizionisti. Qui di seguito la specificazione delle attività, dei vantaggi e degli ausili a disposizione degli aderenti. Tutto quello che di “storico” sta per concretizzarsi ricade nella esclusiva azione promossa e sostenuta dalla Federazione Nazionale FNOB. Non vi sono al riguardo altri Enti titolati a tanto e risultano estranei a questa categoria professionale tutte le attività promosse da questi ultimi per mero fine propaganda. Allorquando questo contesto sarà definitivo ed operativo si assumeranno le opportune iniziative per fare chiarezza in un ambito
che è molto inflazionato da sedicenti professionisti senza titolo, da altri senza competenze autonome e da Enti che esorbitano i loro compiti istituzionali.
Dott. Vincenzo D’Anna Presidente Fnob
Introduzione
La nutrizione è oggi uno dei pilastri della salute pubblica, della prevenzione e della pratica clinica. Ogni giorno, come biologi nutrizionisti, affrontiamo nuove sfide: l’aumento delle patologie metaboliche, la disinformazione che confonde i cittadini, la necessità di linee di intervento chiare e condivise.
Per rispondere con autorevolezza serve una professione unita, competente e capace di incidere.
È con questo obiettivo che la FNOB ha istituito il CNBN – Coordinamento Nazionale Biologi Nutrizionisti: uno spazio dedicato alla nostra
Il gruppo di studio della Fnob dedicato alla nutrizione si occupa di sviluppare idee e progetti di supporto a coloro che operano in questo settore professionale

di Livia Galletti* e Veronica Di Gaetano**
comunità professionale, un luogo dove confrontarsi, collaborare e costruire insieme il futuro della nutrizione in Italia.
Il CNBN sta crescendo e strutturando il suo percorso. Questo è il momento di esserci: di partecipare, portare idee, rappresentare il proprio ambito, contribuire alla definizione delle linee operative nazionali che guideranno la categoria nei prossimi anni.
Entrare nel CNBN significa diventare parte attiva di un progetto concreto, trasformare le competenze individuali in valore collettivo e avere voce in un contesto nazionale.
Coordinamento potrai:
• contribuire alla costruzione di

strumenti e indirizzi utili per l’intera categoria;
• portare la tua esperienza all’interno dell’area tematica più vicina alle tue competenze;
• partecipare ai talk nazionali, momenti di confronto tra colleghi junior e senior;
• proporre iniziative, attività e progetti che possano arricchire la professione;
• entrare in un network in espansione, composto da professionisti motivati e con una visione condivisa.
Un momento decisivo per la professione
Il nostro settore sta cambiando rapidamente. Il ruolo del biologo nutrizionista deve essere forte, riconosciuto e supportato da una rappresentanza competente.
Unirsi ora al CNBN significa contribuire direttamente a definirne identità, obiettivi e direzione.
A chi è rivolto l’appello
A tutti i biologi nutrizionisti che credono nella collaborazione, nella crescita professionale, nella rappresentanza e nella costruzione di una visione comune per il futuro della categoria.
Come candidarsi
Per proporre la propria candidatura al CNBN è necessario inviare:
• Curriculum Vitae
• Carta d’Identità (fronte/retro)
• Breve presentazione con l’indicazione dell’area tematica di interesse
Invia tutto a: cnbn@fnob.it
Le aree tematiche sono consultabili sul sito della FNOB al seguente link: https://www.fnob.it/ aree-tematiche-cnbn/
Il futuro della nutrizione in Italia si costruisce insieme.
E questo è il momento di esserci.
* Delegata Fnob per la Nutrizione
** Coordinatrice Cnbn

Un progetto innovativo messo in piede da una giovane studentessa americana appassionata di scienza e sostenibilità ambientale
S“i chiama Sheyna Patel e a soli 14 anni ha inventato un gel in grado di distruggere circa il 93 per cento delle microplastiche presenti nell’acqua. Una scoperta rivoluzionaria quella della studentessa americana, nata dal suo amore per la scienza e per la natura. Il gel, testato in laboratorio, funziona come una spugna e riesce ad assorbire efficacemente le microplastiche di tipo PET. L’invenzione l’ha portata alle fasi finali della “3M Young Scientist Challenge 2025”, un’importante competizione scientifica rivolta agli studenti delle scuole medie.
Cominciamo dalla tua straordinaria scoperta. Hai sviluppato un idrogel innovativo capace di assorbire oltre il 90% delle microplastiche presenti nell’acqua. Puoi spiegarci come funziona concretamente e cosa lo rende così efficace?
L’idrogel funziona principalmente grazie a un’interazione chiamata attrazione elettrostatica. Poiché la maggior parte delle microplastiche ha una carica negativa, ho progettato il mio idrogel con una superficie a carica positiva, così che i due si attraggano - un po’ come accade con un magnete. Altre interazioni, come i legami a idrogeno, le forze di Van Der Waals e il π-π stacking idrofobico, contribuiscono a far sì che il gel si leghi fortemente alle microplastiche. Insieme, questi meccanismi rendono l’idrogel estremamente efficiente, capace di rimuovere oltre il 90% delle microplastiche dall’acqua contaminata.
Dietro ogni invenzione c’è una storia. Qual è stato il percorso che ti ha portato a creare questo idrogel? Ci sono state difficoltà particolari o momenti decisivi lungo la strada?
L’idea è nata circa due anni fa, durante un viaggio con la mia famiglia in Kenya. Ho visto persone bere acqua contaminata, circondate da rifiuti di plastica, e ho capito quanto urgente fosse questo problema. Quell’esperienza mi ha spinta a studiare le microplastiche e i limiti delle soluzioni esistenti. Volevo creare qualcosa di efficace ed ecologico, e così è nato il mio idrogel. Una delle sfide principali è stata capire come formare il gel in modo sicuro senza usare agenti chimici tossici per il reticolamento. Attraverso la ricerca, ho scoperto un processo fisico di reticolazione tramite congelamento, che ha reso il gel allo stesso tempo sostenibile ed efficiente.
Solo quattordici anni, ma già una determinazione incredibile. Com’è nata la tua passione per la scienza e per la tutela dell’ambiente? C’è stato un momento o un’esperienza in particolare che l’ha fatta scattare?
La mia passione per la scienza è nata quando avevo sei anni, durante una visita al museo della scienza della mia città. Mi affascinava il modo in cui questa poteva spiegare e trasformare il mondo che ci circonda, e questo mi ha spinta


a cominciare a fare esperimenti a casa. Ho sempre amato la natura e mi sono sentita profondamente legata ad essa; per questo, scoprire i danni ambientali mi ha motivata a usare la scienza per proteggere il pianeta e costruire un futuro più sostenibile.
La crisi ambientale spesso fatica ad attirare davvero l’attenzione dei più giovani. Qual è la tua opinione in merito?
E che messaggio vorresti mandare ai tuoi coetanei sull’importanza di agire per il pianeta?
Penso che molte persone tendano a sottovalutare la crisi ambientale. Tuttavia, ho imparato che anche le azioni più piccole, se sommate, possono avere un impatto enorme. La scienza ci offre gli strumenti per trasformare le idee in soluzioni concrete, e la nostra generazione ha la creatività necessaria per cambiare davvero le cose. Il mio messaggio è: inizia da dove sei, sii curioso e segui le tue passioni - che si tratti di scienza, arte o altro - per contribuire alla salvaguardia del pianeta. Ogni gesto conta.
Il tuo percorso appare già estremamente promettente. Come ti immagini nel futuro? Hai altri progetti scientifici o obiettivi che desideri realizzare?
In futuro spero di guidare l’innovazione scientifica capace di generare un impatto reale sul pianeta. Voglio incoraggiare i giovani a capire che le loro idee e la loro voce contano davvero. Il mio obiettivo è sviluppare nuove tecnologie ecologiche per affrontare sfide globali come il riscaldamento climatico, la contaminazione delle acque e l’inquinamento da plastica. Vorrei anche contribuire a cambiare la percezione della plastica, trasformandola da materiale dannoso a risorsa da ripensare e gestire in modo sostenibile, attraverso il design e l’innovazione responsabile.
Uno studio dell’Università Statale di Milano rivela un nuovo meccanismo di immunosoppressione in grado di inibire uno dei principali fattori di neuroinfiammazione Ne abbiamo parlato con la dottoressa Estefanía Calvo Alvarez, prima autrice della ricerca
© nechaevkon/shutterstock.com

La leishmaniosi viscerale è una malattia tropicale negletta causata dal parassita Leishmania infantum, trasmesso dalla puntura di piccoli insetti chiamati flebotomi. Colpisce soprattutto le popolazioni più povere del pianeta. Una volta nell’organismo, il parassita infetta i macrofagi e si diffonde a organi vitali come milza, fegato e midollo osseo
Dottoressa Calvo Alvarez, la vostra ricerca dimostra che non tutti i parassiti vengono per nuocere. È il caso di Leishmania infantum, che si è rivelato un prezioso alleato contro l’Alzheimer. Ci racconta come nasce questo studio e cosa vi ha spinto a indagare il legame tra Leishmania infantum e la malattia di Alzheimer?
Anni fa ci ha incuriosito uno studio pubblicato su FASEB Journal (2016), che mostrava come i portatori dell’allele APOE4 (associato a un aumento del rischio di Alzheimer), in una popolazione indigena della Bolivia, i Tsimane, caratterizzata da elevata esposizione a infezioni parassitarie, presentassero migliori funzioni cognitive. Poiché L. infantum è endemica in quelle aree, ci siamo chiesti se questi parassiti potessero ricoprire un ruolo neuroprotettivo nei confronti della malattia. Grazie alla collaborazione con il gruppo del professore Mario Clerici della Fondazione Don Gnocchi, abbiamo pubblicato un primo studio in cui abbiamo osservato che L. infantum riduceva l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3 in cellule THP-1 esposte ad amiloide β (Aβ), ma i meccanismi erano ancora ignoti. Il lavoro attuale ha analizzato questi meccanismi in microglia primaria murina, un modello molto più rappresentativo dell’Alzheimer.
Può spiegarci in parole semplici che cos’è la leishmaniosi viscerale e perché questo parassita è interessante dal punto di vista della ricerca biomedica?
La leishmaniosi viscerale è una malattia tropicale negletta causata dal parassita Leishmania infantum, trasmes-

so dalla puntura di piccoli insetti chiamati flebotomi. Colpisce soprattutto le popolazioni più povere del pianeta. Una volta nell’organismo, il parassita infetta i macrofagi e si diffonde a organi vitali come milza, fegato e midollo osseo. Leishmania è un modello molto interessante per lo studio dell’interazione ospite-patogeno, perché ha sviluppato strategie sofisticate per modulare l’immunità dell’ospite, aprendo nuove prospettive per la ricerca terapeutica.
Come agisce il meccanismo infiammatorio chiamato inflammasoma NLRP3 e quali danni provoca?
L’inflammasoma NLRP3 è un “sensore molecolare” presente nelle cellule immunitarie, tra cui la microglia cerebrale. Quando rileva segnali di pericolo, come l’Aβ nell’Alzheimer, si attiva e promuove una risposta infiammatoria. In condizioni patologiche, però, questa attivazione diventa cronica: la microglia resta stimolata in modo eccessivo e produce continuamente citochine pro-infiammatorie. Questo alimenta un circolo vizioso che amplifica la neuroinfiammazione e contribuisce alla disfunzione e morte neuronale.
Lo studio ha utilizzato un approccio multidisciplinare. Quali tecniche sono state impiegate?
Abbiamo impiegato colture primarie di microglia murina attivate con Aβ, per mimare le condizioni dell’Alzheimer. Le cellule sono state esposte a L. infantum e analizzate con tecniche di parassitologia molecolare, biologia cellulare, immunologia e imaging ad alta risoluzione: immunofluorescenza, microscopia confocale, live-cell imaging e imaging flow cytometry. Questo ci ha permesso di studiare con precisione i meccanismi immunitari coinvolti.
Ci può dettagliare i risultati raggiunti grazie alle tecniche utilizzate?
Abbiamo visto che L. infantum infetta la microglia senza attivarla, ma anzi la protegge da un’eccessiva stimolazione da Aβ. Il parassita inibisce in modo mirato l’attivazione dell’inflammasoma NLRP3, bloccando la formazione de-
gli aggregati ASC, la maturazione della caspasi-1 e la secrezione di IL-1β. Sopprime la fase di priming attraverso l’induzione del regolatore negativo A20, inibendo NF-κB. Inoltre, riduce lo stress ossidativo e preserva l’integrità dei lisosomi. Il risultato è un effetto antinfiammatorio potente e multifattoriale.
Le evidenze emerse potranno servire per mettere a punto terapie farmacologiche in grado di contrastare l’Alzheimer?
Questa è l’idea che ci ha guidato. Comprendere come L. infantum spenga l’infiammazione potrebbe portare all’identificazione di nuove molecole di origine parassitaria da sviluppare come candidati terapeutici. Tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi preliminare: serviranno molti studi per validare i risultati e valutarne la traducibilità clinica.
Quali potrebbero essere i prossimi step della ricerca?
Vogliamo capire se l’infezione con L. infantum possa esercitare un effetto neuroprotettivo anche in vivo, in modelli murini di Alzheimer, riducendo la neuroinfiammazione e l’attivazione dell’inflammasoma. Stiamo anche cercando di identificare i fattori parassitari responsabili di questo effetto, in particolare tra i noti immunomodulatori usati da Leishmania per favorire la propria persistenza.

Estefanía Calvo Alvarez è ricercatrice e parassitologa molecolare presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari “Rodolfo Paoletti” dell’Università degli Studi di Milano. Studia l’interazione ospite-patogeno e la modulazione immunitaria da parte di Leishmania nella (neuro)infiammazione. Ha lavorato su due parassiti causa di malattie tropicali neglette, studiandone biologia, trasmissione e dinamiche in vivo tramite tecniche di imaging preclinico.

Ricercatori di Cambridge hanno creato modelli di embrioni umani che potrebbero offrire nuove fonti di cellule staminali del sangue per trapianti e terapie rigenerative
Un team internazionale di ricercatori, coordinati da scienziati del Gurdon Institute dell’Università di Cambridge, ha generato in laboratorio modelli di embrioni umani in grado di produrre cellule del sangue, simulando il processo di sviluppo tipico degli embrioni naturali. Il successo dell’esperimento potrebbe offrire un nuovo approccio alla produzione di riserve di sangue sempre disponibili e pienamente compatibili con il paziente, da utilizzare in trapianti e trasfusioni, con potenziali applicazioni anche nelle terapie per le patologie ematologiche e nello sviluppo di farmaci più efficaci.
Come primo passo, gli scienziati di Cambridge hanno utilizzato cellule staminali umane per creare strutture tridimensionali simili a embrioni, capaci di replicare le fasi iniziali dello sviluppo umano, inclusa la produzione di cellule staminali del sangue. Nei Paesi occidentali la sperimentazione su modelli di embrioni simili a quelli umani è rigorosamente regolamentata, e per questo motivo gli autori dello studio dichiarano di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.
Come precisato dai ricercatori, le strutture chiamate “ematoidi”, non potrebbero mai svilupparsi in veri embrioni umani, poiché prive di diversi tessuti embrionali, oltre che del sacco vitellino e della placenta indispensabili per l’ulteriore sviluppo. Gli autori chiariscono anche che i modelli embrionali derivati da cellule staminali sono fondamentali per approfondire la conoscenza delle prime fasi dello sviluppo umano.
Negli ematoidi, le cellule del sangue si sviluppano fino a uno stadio equivalente alla quarta o quinta settimana di gestazione. Si tratta di un momento molto precoce della vita che non può essere osservato direttamente in un embrione umano reale, poiché a quel punto è già impiantato nell’utero materno. Questi modelli offrono quindi un’opportunità unica per studiare pro-
cessi normalmente inaccessibili.
Il team, coordinato da Jitesh Neupane ricercatore presso il Gurdon Institute dell’Università di Cambridge e coautore dello studio, ha osservato al microscopio la comparsa e lo sviluppo degli ematoidi tridimensionali: entro il secondo giorno, i modelli si erano auto-organizzati in tre strati germinali - ectoderma, mesoderma ed endoderma - le fondamenta del piano del corpo umano che sono cruciali per la formazione di ogni organo e tessuto, compreso il sangue. Entro l’ottavo giorno si erano già formate cellule cardiache pulsanti, le stesse che, in un embrione umano in via di sviluppo, daranno origine al cuore. Al tredicesimo giorno, il team ha osservato negli ematoidi la comparsa di piccole macchie rosse di sangue.
Neupane ha dichiarato: «È stato emozionante quando il colore rosso del sangue è apparso nella capsula: era visibile anche a occhio nudo». Ha poi aggiunto: «Il nostro nuovo modello imita lo sviluppo del sangue fetale umano in laboratorio. Questo fa luce su come le cellule ematiche si formano naturalmente durante l’embriogenesi umana, offrendo potenziali progressi medici per lo screening dei farmaci, lo studio dello sviluppo precoce del sangue e del sistema immunitario e la modellizzazione di malattie del sangue come la leucemia».
Come chiariscono gli scienziati, esistono anche altre tecniche per generare in laboratorio cellule staminali del sangue umano, ma queste richiedono l’aggiunta di specifiche proteine per favorirne la crescita e lo sviluppo. Il nuovo metodo imita invece il processo di sviluppo naturale, basato su un modello auto-organizzante simile all’embrione umano, in cui l’ambiente di supporto intrinseco delle cellule guida la formazione delle cellule del sangue e delle cellule cardiache pulsanti all’interno dello stesso sistema.
Le cellule staminali umane utilizzate nello studio per ottenere gli ema-

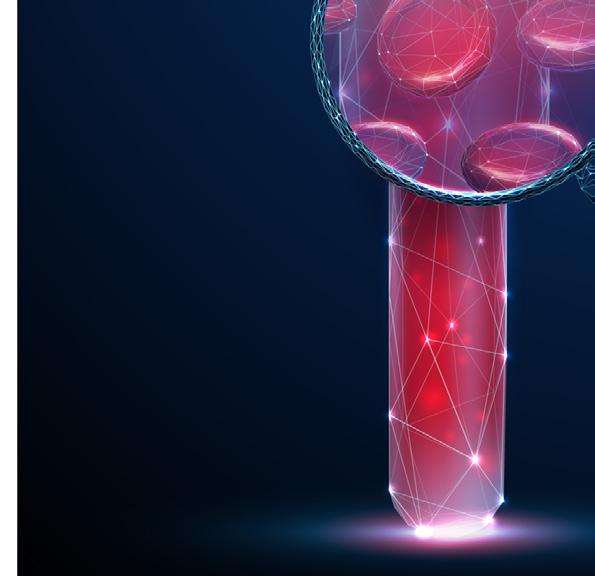


Il nuovo metodo imita il processo di sviluppo naturale, basato su un modello auto-organizzante simile all’embrione umano, in cui l’ambiente di supporto intrinseco delle cellule guida la formazione delle cellule del sangue e delle cellule cardiache pulsanti all’interno dello stesso sistema
toidi possono essere generate a partire da qualsiasi cellula del corpo. Questo approccio apre quindi interessanti prospettive per la medicina personalizzata, poiché in futuro potrebbe consentire la produzione di sangue completamente compatibile con l’organismo del paziente. Azim Surani, autore senior dell’articolo, ha aggiunto che sebbene sia ancora in una fase iniziale, la capacità di produrre cellule del sangue umane in laboratorio segna un passo significativo verso future terapie rigenerative, che utilizzano le cellule del paziente stesso per riparare e rigenerare i tessuti danneggiati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Reports, ha inoltre dimostrato che le cellule staminali del sangue presenti negli ematoidi possono, proprio come quelle naturali, differenziarsi in vari tipi di cellule ematiche, comprese cellule immunitarie specializzate come i linfociti T, aprendo la strada a interessanti prospettive per il loro impiego nello studio dello sviluppo del sangue sano ma anche di quello associato ai tumori.
I ricercatori concludono che il nuovo modello embrionale rappresenta uno strumento versatile per studiare i meccanismi dello sviluppo umano, oltre che una potenziale fonte di cellule staminali ematopoietiche per indagare i processi biologici e sviluppare terapie cellulari innovative. (S. B.).

Ricercatori americani hanno scoperto un meccanismo che regola il differenziamento e, modulandolo, hanno trasformato cellule mature in cellule simili a staminali pluripotenti
Come fa una cellula indifferenziata a scegliere chi diventare? A quasi trent’anni dalla scoperta delle cellule staminali embrionali umane, questa domanda continua a sfidare la scienza. Ora, un nuovo studio di ricercatori americani ha aggiunto un tassello al mistero, dimostrando come alcune strutture citoplasmatiche di stoccaggio chiamate corpi P, contenti RNA e proteine leganti l’RNA, siano in grado di influenzare il destino di ognuna delle circa 200 cellule del nostro corpo. Manipolando i corpi P, gli scienziati sono stati inoltre in grado di generare in modo efficiente tipi di cellule difficili da ottenere, tra cui le cellule germinali primordiali (che danno origine ai gameti, spermatozoi e ovociti) e le cellule staminali pluripotenti indotte (che possono dare origine a qualsiasi tipo di cellula del corpo). Queste cellule sono fondamentali per la ricerca e la medicina rigenerativa, poiché possono essere utilizzate per creare nuovi tessuti e terapie.
Il processo di differenziamento cellulare è molto complesso e coinvolge molteplici livelli di regolazione biologica. Ciò che è noto è che tutte le cellule possiedono lo stesso patrimonio genetico, ma differiscono per quali geni vengono attivati o silenziati. I risultati dello studio americano, pubblicati sulla rivista Nature Biotechnology, hanno rivelato che il sequestro dell’RNA nei corpi P è un meccanismo regolatorio conservato che spesso porta all’immagazzinamento di specifici trascritti che riflettono le fasi precedenti di sviluppo cellulare.
Per la ricerca, il team ha esaminato cellule staminali embrionali mentre attraversavano varie fasi di differenziazione. Gli esperti si sono concentrati sui corpi P, gruppi di RNA e proteine presenti nel citoplasma delle cellule di molti vertebrati. I corpi P sono stati scoperti nel 2003 e da allora, diversi studi hanno associato la loro disregolazione a malattie quali il morbo di Parkinson e alcuni tipi di cancro.
In precedenza, gli scienziati ritenevano che i corpi P fungessero da una sorta di raccoglitore dei rifiuti per la cellula, dove l’RNA, la molecola che indica alla cellula quali geni esprimere, veniva nascosto e degradato quando non utilizzato. Il nuovo studio ha scoperto che i corpi P sono più simili a contenitori organizzati che a un raccoglitore di rifiuti, con diversi tipi di cellule che immagazzinano diversi tipi di RNA che, se rilasciati, avrebbero guidato la cellula verso un destino diverso. «Il nostro lavoro dimostra che i corpi P sequestrano i prodotti di determinati geni per attenuarne la funzione e indirizzare i cambiamenti di identità cellulare», ha affermato Brumbaugh.
La sorprendente scoperta dei ricercatori americani consiste nel fatto che la perturbazione dei corpi P o la loro apertura, potevano rendere nuovamente leggibili le istruzioni immagazzinate in essi e riportare le cellule a uno stadio di sviluppo precedente. In questo modo, gli autori dello studio sono stati in grado di riprogrammare in modo efficiente cel-

Il processo di differenziamento cellulare è molto complesso e coinvolge molteplici livelli di regolazione biologica. Ciò che è noto è che tutte le cellule possiedono lo stesso patrimonio genetico, ma differiscono per quali geni vengono attivati o silenziati. I risultati dello studio hanno rivelato che il sequestro dell’RNA nei corpi P è un meccanismo regolatorio conservato che spesso porta all’immagazzinamento di specifici trascritti che riflettono le fasi precedenti di sviluppo cellulare
lule mature a diventare simili a cellule germinali primordiali (cellule coltivate in laboratorio che imitano le cellule germinali), o a cellule simili a quelle totipotenti.
Dallo studio è emerso che a svolgere un ruolo fondamentale nel determinare quali RNA vengono immagazzinati all’interno dei corpi P sarebbero alcuni RNA non codificanti chiamati microRNA. «Mi piace pensarla come un’alchimia cellulare», ha detto Justin Brumbaugh, coautore senior e assistente professore di Biologia molecolare, cellulare e dello sviluppo all’Università del ColoradoBoulder. «Se riusciamo a capire come manipolare il destino delle cellule, per indurre un tipo di cellula a diventare un altro tipo di cellula, si apre un intero mondo di applicazioni. Il nostro articolo getta le basi per questo».
I risultati potrebbero, secondo gli autori, contribuire a migliorare la comprensione di come si formano gli embrioni e di come hanno origine le malattie. Ad esempio, gli scienziati potrebbero prelevare un neurone da una persona affetta dal morbo di Parkinson, riportarlo alle sue prime fasi di sviluppo ed esaminare cosa ha portato alla malattia. Oppure potrebbero analizzare le cellule germinali coltivate in laboratorio per esplorare cosa potrebbe causare infertilità o difetti alla nascita.
Bruno Di Stefano, coautore dello studio e professore presso il Baylor College of Medicine di Houston ha affermato che i risultati della nuova ricerca potrebbero anche aprire nuove vie per lo sviluppo di trattamenti per la fertilità, la rigenerazione di organi e la sperimentazione di nuovi farmaci.
I ricercatori sperano che in futuro le cellule germinali sviluppate in laboratorio tramite il processo scoperto possano dare origine a spermatozoi o ovuli per nuovi trattamenti di fertilità. In teoria, secondo gli esperti, anche le cellule totipotenti, derivate per esempio da una semplice cellula della pelle, potrebbero essere utilizzate per rigenerare organi o tessuti devastati da una malattia. Infine, anche i produttori di farmaci potrebbero utilizzare tali cellule per creare tessuti specializzati su cui testare i nuovi farmaci. (S. B.).
Ricercatori di Monaco hanno scoperto la funzione della proteina VDAC1 nella regolazione dell’apoptosi, con potenziali terapie per cancro, malattie neurodegenerative e cardiache

Un gruppo di ricercatori dell’Università Tecnica di Monaco (TUM) ha identificato un nuovo interruttore molecolare che regola l’apoptosi, un processo essenziale con cui l’organismo elimina le cellule non più necessarie o pericolose.
Nella lotta contro le malattie, l’apoptosi ovvero la morte cellulare programmata, è una funzione protettiva fondamentale. In particolare, essa distrugge le cellule danneggiate o che hanno subito cambiamenti pericolosi come le cellule cancerose. Tuttavia, le cellule tumorali spesso riescono a eludere questo meccanismo riuscendo così a sopravvivere a lungo.
Secondo i ricercatori di Monaco, che hanno pubblicato di recente la loro ricerca sulla rivista Nature Com -
munications, studiare in modo più approfondito i meccanismi naturali che regolano l’apoptosi può avere importanti implicazioni biomediche.
In particolare, una migliore comprensione di questi processi biologici può permettere di individuare nuove molecole o sostanze attive capaci di modulare l’apoptosi (stimolandola o inibendola) aprendo la strada a nuove terapie per malattie in cui la regolazione della morte cellulare è alterata, come tumori, malattie neurodegenerative e patologie cardiache.
Secondo gli autori dello studio, l’esame dei meccanismi di attivazione e disattivazione dell’apoptosi rappresenta un campo promettente per la ricerca biomedica di base. Franz Hagn, autore responsabile dell’arti -

Nella lotta contro le malattie, l’apoptosi ovvero la morte cellulare programmata, è una funzione protettiva fondamentale. In particolare, essa distrugge le cellule danneggiate o che hanno subito cambiamenti pericolosi come le cellule cancerose. Tuttavia, le cellule tumorali spesso riescono a eludere questo meccanismo riuscendo così a sopravvivere a lungo

colo e professore presso la Facoltà di Scienze Naturali della TUM, ha dichiarato: «Molti team di ricerca in tutto il mondo stanno lavorando sull’affascinante tema dell’apoptosi e del suo controllo mirato. Il grande vantaggio è che si tratta di un meccanismo di regolazione altamente efficiente, affinato nel corso dell’evoluzione. Questo significa che non è necessario inventare qualcosa di completamente nuovo, ma piuttosto sfruttare gli strumenti strutturali adeguati a comprendere e imitare i processi già ottimizzati dalla natura».
Per impedire che le cellule sane si autodistruggano accidentalmente, il sistema di apoptosi è ben controllato. Il team ha dimostrato che la proteina VDAC1 può, se necessario, neutralizzare l’inibitore Bcl-xL, attivando così la morte cellulare programmata. Ciò si verifica principalmente quando aumenta lo stress cellulare, condizione che può essere un’indicazione di uno sviluppo cellulare anomalo.
VDAC1, proteina essenziale dei mitocondri, le centrali energetiche della cellula, una volta attivata modifica parte della sua struttura e si lega alla proteina Bcl-xL, inattivandola e avviando così la morte cellulare programmata.
VDAC (Voltage-Dependent Anion Channel) è il principale canale della membrana mitocondriale esterna, responsabile del passaggio di metaboliti e ioni tra citosol e spazio intermembrana. In stato “aperto” permette il transito di anioni e molecole idrosolubili, mentre a determinati potenziali elettrici si “chiude” parzialmente, modificando la propria permeabilità. Grazie a questa regolazione, VDAC svolge un ruolo fondamentale nel controllo del traffico metabolico e in numerosi processi cellulari.
Umut Günsel e Melina Daniilidis, primi autori dello studio, hanno aggiunto: «Nel nostro studio abbiamo utilizzato metodi strutturali ad alta risoluzione come la risonanza ma -
gnetica nucleare (NMR), la cristallografia a raggi X e la microscopia crioelettronica per studiare come la proteina VDAC1 cambia in condizioni di stress. Abbiamo anche combinato questi dati con esperimenti funzionali biochimici per dimostrare che VDAC1 si lega effettivamente alla proteina inibitrice Bcl-xL, promuovendo così l’apoptosi».
Secondo il gruppo di ricerca di Monaco, il meccanismo di regolazione identificato potrebbe offrire nuove opportunità nello sviluppo di composti bioattivi in grado di influenzare in modo mirato l’attività dell’inibitore VDAC1.
Nella terapia contro il cancrodove l’apoptosi è spesso ridotta e le cellule sopravvivono troppo a lungo - i farmaci futuri potrebbero mirare a potenziare in modo selettivo l’attivazione di VDAC1 favorendo così la morte programmata delle cellule tumorali.
Potenziali applicazioni terapeutiche si potrebbero sviluppare anche nel campo delle malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer o il Parkinson, in cui accade il contrario: l’apoptosi è eccessiva e porta alla perdita progressiva dei neuroni. In questi casi, l’obiettivo sarebbe quindi quello di inibire la morte indesiderata delle cellule nervose.
La modulazione di VDAC1 potrebbe inoltre rivelarsi utile in alcune patologie cardiache, come il danno da ischemia-riperfusione, dove la morte cellulare contribuisce ai danni del tessuto, e la sua prevenzione potrebbe offrire un effetto protettivo.
Tuttavia, sottolineano gli esperti, resta ancora molta strada da percorrere prima che queste scoperte possano tradursi in applicazioni cliniche concrete. La ricerca di molecole capaci di modulare il meccanismo individuato può ora concretamente iniziare, ma la sua efficacia - concludono gli autori - dovrà essere verificata attraverso ulteriori studi.

Un atlante cellulare rivela come il cervello si forma, si trasforma e come errori nello sviluppo possono generare disturbi come autismo e schizofrenia
Capire come nasce e si sviluppa il cervello è una delle più grandi sfide della scienza moderna. Dietro la complessità di questo organo straordinario, capace di generare pensiero, emozione e memoria, si nasconde un processo di costruzione finissimo, regolato da milioni di cellule e miliardi di connessioni che si formano in una coreografia perfetta. Ma cosa accade quando tutto questo viene interrotto? E se riuscissimo a comprendere dove e quando nasce il problema, potremmo fermare sul nascere disturbi come l’autismo, la schizofrenia o la sclerosi multipla?
A fornire nuove risposte a queste domande è una serie di studi pubblicati sulla rivista Nature. Si tratta di un risultato senza precedenti del Brain Initiative Cell Atlas Network (Bican), un ambizioso progetto internazionale che riunisce decine di laboratori di ricerca nel mondo, tra cui anche alcuni con la partecipazione di scienziati italiani, con l’obiettivo di costruire la mappa più completa mai realizzata delle cellule del cervello dei mammiferi.
«Questa serie di lavori ci fornisce un modello dettagliato di come emergono e maturano nel tempo diversi tipi di cellule cerebrali», spiega Hongkui Zeng, neuroscienziata dell’Allen Institute for Brain Science e docente alla Scuola di Medicina dell’Università di Washington, tra i coordinatori del progetto. «Comprendendo quando e dove i geni critici vengono attivati durante lo sviluppo, possiamo iniziare a scoprire come le interruzioni di questo processo possano portare a disturbi come l’autismo o la schizofrenia. È una conoscenza fondamentale, aggiunge, che apre la strada a diagnosi migliori e terapie mirate». Per arrivare a questo risultato, i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 1,2 milioni di cellule cerebrali provenienti da cervelli di mammiferi in diverse fasi dello sviluppo. Ciò ha permesso di disegnare una mappa evolutiva straordinariamente precisa, capace di mostrare come le cellule si differenziano, si organizzano e si connettono tra loro nel corso del tempo. Uno degli studi si è concentrato su un gruppo particolare di cellule: gli interneuroni inibitori, che agiscono come i freni del cervello. Questi neuroni regolano l’attività elettrica, evitando che l’eccitazione diventi eccessiva, e consentono alle diverse aree cerebrali di comunicare in modo armonioso. Negli esseri umani, questi neuroni sono cruciali per funzioni che vanno dal movimento alla memoria, fino alla gestione delle emozioni. I ricercatori hanno ricostruito il loro albero genealogico più completo mai tracciato, scoprendo che queste cellule migrano per lunghe distanze durante lo sviluppo, attraversando intere regioni cerebrali per raggiungere la loro destinazione finale. Sorprendentemente, alcune di esse continuano a maturare molto tempo dopo la nascita, specialmente in aree legate all’apprendimento e alle emozioni. Ciò suggerisce che lo sviluppo del cervello non si conclude con il parto, ma prosegue in fasi successi-

Negli esseri umani, gli interneuroni inibitori sono cruciali per funzioni che vanno dal movimento alla memoria, fino alla gestione delle emozioni. I ricercatori hanno ricostruito il loro albero genealogico più completo mai tracciato, scoprendo che queste cellule migrano per lunghe distanze durante lo sviluppo, attraversando intere regioni cerebrali per raggiungere la loro destinazione finale. Sorprendentemente, alcune di esse continuano a maturare molto tempo dopo la nascita, specialmente in aree legate all’apprendimento e alle emozioni
ve, modulato dalle esperienze e dagli stimoli ambientali.
Un’altra ricerca, sempre pubblicata su Nature, ha seguito 770mila cellule della corteccia visiva. Lo scopo era capire come si forma la parte del cervello che elabora le immagini. Anche in questo caso, i risultati hanno messo in discussione un’idea radicata: lo sviluppo della corteccia visiva non si completa prima della nascita, ma continua anche dopo, in corrispondenza di momenti cruciali come l’apertura degli occhi o le prime esperienze visive.
«Le esperienze vissute nei primi giorni e mesi di vita hanno un impatto profondo sul modo in cui il cervello costruisce i propri circuiti», spiegano gli autori. Questo significa che l’ambiente e l’apprendimento possono influenzare lo sviluppo cerebrale molto più di quanto si pensasse, e che alcuni disturbi neurologici potrebbero essere ancora trattabili durante queste fasi critiche. Un ulteriore passo avanti è arrivato dalla mappa dell’espressione genica di milioni di singoli neuroni nella corteccia cerebrale. Questa mappa ha permesso di identificare firme molecolari, combinazioni uniche di geni e tipi cellulari, che caratterizzano le diverse regioni del cervello. È un po’ come se ogni area avesse la propria impronta digitale biologica.
Questa scoperta aiuta a comprendere meglio come le diverse funzioni cerebrali, come la memoria o il linguaggio, emergano da specifiche configurazioni cellulari e genetiche. Inoltre, gli scienziati hanno osservato che alcuni programmi genetici attivi durante lo sviluppo possono riattivarsi più tardi nella vita, ad esempio in risposta a processi infiammatori o degenerativi come quelli che si verificano nella sclerosi multipla, quando il sistema immunitario attacca le fibre nervose. L’obiettivo finale del progetto BICAN è quello di costruire un atlante cellulare completo del cervello, una sorta di mappa interattiva che mostri come i geni, le cellule e le connessioni si combinano nel tempo e nello spazio. Questo strumento potrebbe rivoluzionare non solo la ricerca neuroscientifica, ma anche la medicina clinica.

La nanotecnologia del DNA unita con la precisione degli anticorpi può offrire una svolta nella creazione di nuovi biomateriali intelligenti. È quanto annunciato dai ricercatori delle Università di Tor Vergata e Sapienza di Roma che sono riusciti a sviluppare una nuova e promettente tecnologia in grado di creare micro-compartimenti programmabili che imitano il modo in cui le cellule organizzano le proprie funzioni interne. Lo studio, pubblicato sul Journal of the American Chemical Society, apre le porte a diverse applicazioni in campo biomedico, farmacologico e della scienza dei materiali.
Alla base della nuova tecnologia illustrata nello studio ci sono strutture chiamate nanostelle di DNA, cioè molecole di DNA sintetico progettate in laboratorio con quattro bracci. Tre terminano con sequenze adesive che permettono alle nanostelle di riconoscersi e agganciarsi tra loro in modo controllato. Il quarto braccio è invece modificato con un antigene, cioè una porzione molecolare che viene riconosciuta in modo specifico da un anticorpo. Il legame tra l’anticorpo corretto e gli antigeni di nanostelle diverse funziona come un ponte molecolare, collegandole tra loro e facendo nascere i micro-compartimenti sferici. «I nostri micro-compartimenti ibridi anticorpo-DNA sono come un ponte tra biologia e tecnologia - afferma Francesco Ricci, ricercatore principale del progetto e professore ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata - non sono solo stabili e precisi, ma programmabili, fornendo un modo per creare strutture artificiali simili a cellule e sostenere la ricerca di nuovi biomateriali». «Unire DNA e anticorpi - aggiunge Sara Scalia, prima autrice dell’articolo - è come costruire un ponte tra due mondi: scoprire come queste molecole interagiscono e collaborano apre nuove prospettive e rende la ricerca che faccio sempre più stimolante».

All’interno delle cellule avviene normalmente un processo biologico che porta alla formazione di organuli privi di membrana, fondamentali per organizzare il contenuto cellulare e compartimentalizzare specifiche reazioni biochimiche. Si tratta di un fenomeno fisico-chimico che prende il nome di separazione di fase dei condensati e si verifica a causa di cambiamenti nelle condizioni ambientali (come concentrazione, temperatura, pH, o interazioni molecolari). Sebbene questo meccanismo alla base dell’organizzazione cellulare naturale sia, secondo gli autori dello studio, molto complesso da riprodurre in laboratorio, il team è riuscito a dimostrare che DNA e anticorpi possono essere usati per creare micro-strutture sferiche dinamiche che riproducono artificialmente una logica tipica dei sistemi biologici: formare ambienti interni altamente regolati in risposta a un segnale specifico. Come spiegato nello studio, è proprio la presenza dell’anticorpo a “decidere” quando questi compartimenti si formano, si dissolvono o si riformano: per questo il sistema è programmabile. Variando tipo e quantità di anticorpo, gli scienziati sono riusciti a controllare in modo preciso il comportamento del sistema. In particolare, aggiungendo concentrazioni crescenti dell’anticorpo specifico a una concentrazione fissa di nanostelle coniugate con antigeni, hanno potuto osservare la formazione dipendente dalla concentrazione di condensati anticorpo-DNA, a partire da livelli nanomolari bassi dell’anticorpo. «Questa scoperta apre le porte a possibilità entusiasmanti. La capacità

© PeopleImages/shutterstock.com
Sebbene questo meccanismo alla base dell’organizzazione cellulare naturale sia, secondo gli autori dello studio, molto complesso da riprodurre in laboratorio, il team è riuscito a dimostrare che DNA e anticorpi possono essere usati per creare micro-strutture sferiche dinamiche che riproducono artificialmente una logica tipica dei sistemi biologici: formare ambienti interni altamente regolati in risposta a un segnale specifico
dei micro-compartimenti di formarsi in risposta a molecole specifiche, per esempio, potrebbe essere utilizzata per rilevare marcatori biologici, permettendo nuovi strumenti diagnostici» afferma Erica Del Grosso, ricercatrice principale del progetto e docente dell’Università di Roma Tor Vergata. I condensati biomolecolari che si formano naturalmente nelle cellule attraverso il processo di separazione di fase, sono fondamentali per diverse funzioni cellulari come per esempio ottimizzare l’efficienza delle reazioni o rispondere a condizioni di stress come variazioni di pH, ioni, metaboliti all’interno della cellula. La formazione di questi condensati è un processo fisiologico reversibile, la cui disfunzione è però spesso associata a diverse malattie umane, in particolare patologie neurodegenerative e cancro. «Dal punto di vista teorico siamo riusciti a sviluppare un modello che ha permesso di spiegare l’origine dei micro-compartimenti e di prevederne il comportamento - afferma Lorenzo Rovigatti, professore presso la Sapienza Università di Roma - un passo importante verso lo sviluppo di applicazioni in ambito biomedico e della scienza dei materiali». I ricercatori concludono che l’introduzione delle interazioni anticorpo-antigene nel processo di separazione di fase del DNA avvicina questi sistemi ai sistemi cellulari naturali che si basano su intricate reti di interazioni proteina-proteina o proteina-acido nucleico e consente una maggiore programmabilità e versatilità che potrebbero trovare applicazione anche nel rilevamento e nella somministrazione di farmaci. (S. B.).
Ricercatori di Tor Vergata e Sapienza hanno sviluppato un sistema molecolare che riproduce l’organizzazione interna delle cellule, aprendo nuove prospettive in campo biomedico

Una scoperta rivoluzionaria arriva grazie a uno studente di biologia
Dalle armi contro il Covid una possibile strada per il trattamento dei pazienti oncologici
In un momento storico in cui la ricerca oncologica sta già compiendo passi avanti, arriva una scoperta che potrebbe riscrivere alcune regole dell’immunoterapia. Uno studente di biologia della University of Houston, Cole Woody, ha giocato un ruolo chiave in uno studio dell’MD Anderson Cancer Center che ha evidenziato come i vaccini mRNA contro il Covid-19 possano incrementare l’efficacia delle terapie immunitarie nei pazienti oncologici. La ricerca, presentata al congresso europeo di oncologia ESMO 2025, ha mostrato che i pazienti che avevano ricevuto un vaccino a mRNA entro cento giorni dall’inizio della terapia immunitaria avevano più del doppio delle probabilità di essere vivi dopo tre anni rispetto a quelli che non lo avevano fatto. Questo risultato rappresenta una potenziale svolta: un vaccino comune e accessibile potrebbe potenziare la risposta antitumorale del sistema immunitario, migliorando la sopravvivenza di migliaia di pazienti. Per capire la portata di questa scoperta, basti ricordare che le terapie immunitarie, in particolare gli inibitori dei checkpoint immunitari, hanno già rivoluzionato la cura di alcuni tumori. Nel caso del melanoma avanzato, ad esempio, i trattamenti con questi farmaci hanno portato la sopravvivenza a cinque anni fino al 50%, un traguardo impensabile solo un decennio fa. Tuttavia, l’immunoterapia funziona in modo molto variabile: solo tra il 20 e il 50% dei pazienti risponde in maniera significativa, a seconda del tipo di tumore e dello stadio della malattia. Lo studio condotto all’MD Anderson ha rivelato che nei pazienti che avevano ricevuto il vaccino mRNA, la sopravvivenza a tre anni raggiungeva il 55,7% contro il 30,8% dei non vaccinati, con un aumento medio della sopravvivenza da 20 a oltre 37 mesi nei casi di tumore al polmone non a piccole cellule e melanoma.
In termini semplici, il vaccino contro il Covid sembra quasi raddoppiare la probabilità di vivere più a lungo. Il contributo di Cole Woody è stato determinante per validare questa scoperta. Studente di biologia all’Università di Houston, originario di Sugar Land in Texas, Woody lavora nel laboratorio di sequenziamento dell’ateneo sotto la guida della professoressa Preethi Gunaratne, dove si occupa dello sviluppo di potenziali vaccini contro il cancro basati su RNA chimerici. Quando il team di ricerca dell’MD Anderson gli ha chiesto di unirsi al progetto, il giovane scienziato ha avuto il compito di dimostrare che nei pazienti vaccinati si verificava un aumento significativo delle cellule T, le cellule del sistema immunitario incaricate di riconoscere e distruggere le cellule tumorali. Per farlo, ha progettato anticorpi su misura in grado di identificare i linfociti T specifici per il tumore, confermando così che il vaccino rafforza in modo misurabile la risposta immunitaria del corpo contro il cancro.
«Abbiamo visto un aumento molto netto di cellule T an-

La ricerca, presentata al congresso europeo di oncologia ESMO 2025, ha mostrato che i pazienti che avevano ricevuto un vaccino a mRNA entro cento giorni dall’inizio della terapia immunitaria avevano più del doppio delle probabilità di essere vivi dopo tre anni rispetto a quelli che non lo avevano fatto. Nel caso del melanoma avanzato, ad esempio, i trattamenti con questi farmaci hanno portato la sopravvivenza a cinque anni fino al 50%
tigene-specifiche nel gruppo vaccinato - ha spiegato Woody - è il tipo di risultato che ogni ricercatore spera di ottenere, chiaro e con potenziali implicazioni reali per i pazienti». L’impatto di questa scoperta va ben oltre lo studio iniziale. Se un vaccino mRNA generico, pensato per un virus respiratorio, può migliorare l’efficacia dell’immunoterapia, si apre la strada a una nuova generazione di trattamenti combinati, più efficaci e meno costosi. Potrebbe essere possibile ampliare l’effetto benefico anche ad altri tipi di tumore con meccanismi immunitari simili, come suggerisce lo stesso studente di biologia. Molti tumori, infatti, sviluppano strategie per nascondersi al sistema immunitario; l’immunoterapia serve proprio a riattivare queste difese, ma non sempre riesce da sola. Un vaccino in grado di allenare ulteriormente il sistema immunitario potrebbe rappresentare il tassello mancante per aumentare le percentuali di successo. Nonostante l’entusiasmo, i ricercatori restano cauti.
Lo studio è ancora in una fase preliminare e saranno necessari nuovi esperimenti su larga scala per confermare i risultati. Ogni tumore, inoltre, risponde in modo diverso, e sarà fondamentale capire quali pazienti traggono maggior beneficio e in quale finestra temporale il vaccino risulta più efficace. Ma la direzione è chiara: integrare vaccini e immunoterapia potrebbe diventare un nuovo standard nel trattamento oncologico. La storia di Cole Woody dimostra anche quanto sia cruciale il legame tra università e centri di ricerca di eccellenza. Lo studente ha ricevuto una formazione che gli ha permesso di contribuire a un progetto di portata mondiale.
«L’Università di Houston è in una posizione unica - ha detto -. Essere così vicini al più grande centro medico del mondo offre ai giovani ricercatori opportunità straordinarie. Ma senza la solida base scientifica che ho ricevuto qui, non sarei riuscito a lavorare in istituzioni di livello come l’MD Anderson Cancer Center». Questa scoperta porta con sé un messaggio di speranza: il vaccino anti-Covid, simbolo di una pandemia globale, potrebbe ora diventare uno strumento per migliorare la vita dei malati di cancro.

Una scoperta italiana rivela una firma di 18 geni capace di distinguere i tumori prostatici indolenti da quelli aggressivi, aprendo la via alla medicina di precisione
Una scoperta tutta italiana potrebbe cambiare il modo in cui il tumore della prostata viene diagnosticato e trattato. Un gruppo di ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare (Ingm) e dell’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione Airc (Ifom) ha identificato una firma molecolare composta da 18 geni in grado di distinguere precocemente i tumori prostatici a basso rischio da quelli più aggressivi. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, rappresenta un passo avanti significativo verso una medicina di precisione capace di personalizzare le terapie e ridurre il rischio di trattamenti inutilmente invasivi.
Il tumore della prostata è la seconda neoplasia più comune tra gli uomini nel mondo e la più frequente nei Paesi occidentali. In Italia, secondo i dati più recenti, si contano oltre 36mila nuovi casi ogni anno, in prevalenza tra gli uomini sopra i 65 anni.
Sebbene molte di queste forme siano a lenta evoluzione e potenzialmente non letali, circa il 20% dei pazienti sviluppa una forma aggressiva e metastatica, con conseguenze gravi sulla sopravvivenza. Il problema principale, però, è che oggi non esistono strumenti sufficientemente precisi per distinguere, al momento della diagnosi, tra tumori indolenti e tumori destinati a progredire. Questo limite porta a un fenomeno noto come sovra-trattamento: molti pazienti con forme a basso rischio vengono sottoposti a interventi chirurgici o terapie ormonali e radioterapiche non necessari, con effetti collaterali importanti, tra cui incontinenza, disfunzioni sessuali e riduzione della qualità della vita. La ricerca italiana è partita da una domanda cruciale: se il tumore prostatico non può essere distinto in modo affidabile attraverso le sole analisi istologiche e genetiche tradizionali, è possibile che la risposta si nasconda nell’organizzazione tridi-
mensionale del Dna?
Analizzando campioni di tessuto tumorale prostatico, i ricercatori hanno studiato la conformazione tridimensionale della cromatina, scoprendo che nei tumori aggressivi questa struttura risulta profondamente alterata rispetto alle forme indolenti. È proprio da queste differenze che è emersa la firma molecolare dei 18 geni: una combinazione unica di elementi genetici e strutturali in grado di fornire un “profilo comportamentale” del tumore, indicando se esso tenderà a rimanere localizzato o a evolvere in forma metastatica. A coordinare lo studio sono stati Chiara Lanzuolo, del Cnr e dell’Ingm, e Francesco Ferrari, dell’Ifome del Cnr.

Analizzando campioni di tessuto tumorale prostatico, i ricercatori hanno studiato la conformazione tridimensionale della cromatina, scoprendo che nei tumori aggressivi questa struttura risulta profondamente alterata rispetto alle forme indolenti. È proprio da queste differenze che è emersa la firma molecolare dei 18 geni
«Questi risultati aprono prospettive concrete per la medicina di precisione nel tumore prostatico - spiegano i due ricercatori -. Se validata in ulteriori studi preclinici e clinici, la firma molecolare identificata potrà essere implementata nella pratica clinica».
Un semplice test molecolare basato sull’espressione di questi 18 geni po-
trebbe in futuro diventare parte integrante della diagnosi iniziale, aiutando l’urologo e l’oncologo a scegliere il trattamento più adeguato a ciascun paziente. Il concetto di medicina di precisione sta rivoluzionando l’oncologia. Non più cure standard uguali per tutti, ma strategie terapeutiche su misura, basate sulle caratteristiche genetiche, epigenetiche e ambientali del singolo individuo. In questo contesto, la scoperta italiana rappresenta un modello concreto di come la ricerca possa tradursi in benefici diretti per i pazienti. Identificare con precisione i tumori a basso rischio consentirebbe, per esempio, di optare per un approccio di sorveglianza attiva, evitando terapie aggressive e monitorando nel tempo l’andamento della malattia. Al contrario, nei casi con una firma genetica di tipo aggressivo, si potrebbe intervenire subito con trattamenti mirati, aumentando le possibilità di successo e di sopravvivenza.
Come sottolineano gli autori, i risultati ottenuti rappresentano un punto di partenza. La firma molecolare dovrà ora essere validata su un numero più ampio di campioni e di pazienti, in diversi centri clinici e contesti geografici, per garantirne la robustezza e la riproducibilità. Parallelamente, sarà fondamentale trasferire queste conoscenze nei laboratori clinici, sviluppando test diagnostici accessibili e affidabili. Un obiettivo che richiederà la collaborazione tra ricercatori, clinici e industria biotecnologica. Il tumore della prostata, pur essendo spesso curabile, resta una malattia che incide fortemente sulla vita di chi ne è colpito e delle loro famiglie. Ridurre il rischio di diagnosi errate e di trattamenti superflui significa restituire serenità, autonomia e fiducia a migliaia di pazienti. Se la firma dei 18 geni manterrà le promesse, potrà diventare uno strumento decisivo per trasformare la diagnosi del tumore prostatico da incerta a predittiva, aprendo definitivamente l’era della medicina di precisione anche in uno dei tumori più diffusi al mondo. (C. P.)

Le cellule staminali del bulbo pilifero, per difendersi da gravi danni al DNA, scelgono di morire: così si diventa canuti
Da sempre simbolo di saggezza, di tempo che passa o di stress accumulato, i capelli bianchi potrebbero nascondere un significato molto più profondo e sorprendente: rappresenterebbero un meccanismo di difesa naturale contro il cancro.
A rivelarlo è uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Tokyo, guidati da Emi Nishimura e Yasuaki Mohri, pubblicato sulla rivista Nature Cell Biology.
La scoperta getta nuova luce sui processi biologici che regolano la pigmentazione dei capelli e sul ruolo che le cellule staminali svolgono nel mantenere l’equilibrio tra rigenerazione e rischio tumorale. Al centro dello studio ci sono le cellule staminali dei melanociti, un particolare gruppo di cellule localizzate nel bulbo pilifero, la struttura da cui nascono i peli e i capelli. Queste staminali hanno il compito di generare i melanociti, ovvero le cellule che producono la melanina, il pigmento che dona colore alla pelle e ai capelli. Quando tutto funziona correttamente, il ciclo di rigenerazione del capello avviene senza intoppi: le staminali si dividono, si differenziano e riforniscono il follicolo di nuove cellule pigmentate. Ma cosa accade quando il Dna di queste cellule subisce un danno grave?
I ricercatori giapponesi hanno scoperto che, in presenza di rotture del doppio filamento di Dna, un tipo di danno particolarmente pericoloso, le cellule staminali reagiscono in modo radicale: si differenziano in maniera irreversibile e poi muoiono, rinunciando alla loro capacità di autorinnovarsi. In pratica, scelgono di sacrificarsi pur di evitare che il danno genetico possa propagarsi e trasformarle in cellule tumorali. Il risultato visibile di questo processo è la perdita dei melanociti e, quindi, la comparsa dei capelli bianchi.
Questo comportamento può essere interpretato come un vero e proprio meccanismo di difesa dell’organismo. Il processo è regolato da due note molecole segnale: p53 e p21, entrambe già conosciute per il loro ruolo di guardiani del genoma. La prima, p53, è una proteina chiave che blocca la proliferazione cellulare quando viene rilevato un danno al Dna, inducendo eventualmente la morte programmata (apoptosi). La seconda, p21, agisce come un “freno” del ciclo cellulare, impedendo alle cellule di dividersi finché non è garantita l’integrità del materiale genetico.
L’attivazione coordinata di queste vie molecolari induce le staminali del bulbo pilifero a differenziarsi e poi scomparire, determinando così la perdita di pigmento, ma allo stesso tempo prevenendo la possibile formazione di tumori cutanei come il melanoma. In altre parole, l’ingrigimento dei capelli non sarebbe un semplice effetto collaterale dell’invecchiamento, ma un atto di autodifesa biologica: le cellule, accorgendosi di un danno potenzialmente irreparabile, scelgono la strada dell’esaurimento

I ricercatori giapponesi hanno scoperto che, in presenza di rotture del doppio filamento di Dna, un tipo di danno particolarmente pericoloso, le cellule staminali reagiscono in modo radicale: si differenziano in maniera irreversibile e poi muoiono, rinunciando alla loro capacità di autorinnovarsi. In pratica, scelgono di sacrificarsi pur di evitare che il danno genetico possa propagarsi e trasformarle in cellule tumorali. Il risultato visibile di questo processo è la perdita dei melanociti e, quindi, la comparsa dei capelli bianchi
piuttosto che quella della trasformazione maligna.
Tuttavia, la ricerca mostra anche il rovescio della medaglia. Quando le stesse cellule staminali vengono esposte a particolari agenti cancerogeni, come ad esempio i raggi ultravioletti di tipo B (Uvb), la risposta è completamente diversa. In questo caso, invece di disattivarsi, le staminali mantengono la capacità di autorinnovarsi e di proliferare.
A guidare questo comportamento opposto è una molecola segnale chiamata Kit, prodotta dalla stessa epidermide. Kit stimola le cellule staminali a espandersi, indirizzandole però verso un destino tumorale. Si tratta, dunque, di un equilibrio delicatissimo: la stessa popolazione cellulare può scegliere tra due destini completamente opposti, autoeliminazione o proliferazione incontrollata, a seconda del tipo di stress a cui è sottoposta e del contesto biologico in cui si trova. Come spiega Nishimura, «questi risultati rivelano che la stessa popolazione di cellule staminali può seguire destini opposti, esaurimento o espansione, in base ai segnali del microambiente. Questo ridefinisce l’ingrigimento dei capelli e il melanoma non come eventi indipendenti, ma come esiti divergenti delle risposte cellulari allo stress».
Le implicazioni di questa scoperta sono molteplici. Da un punto di vista biologico, offre una nuova prospettiva sul processo di invecchiamento e sulla prevenzione dei tumori. Comprendere come le cellule decidono se “suicidarsi” o continuare a dividersi potrebbe aprire la strada a strategie innovative per contrastare le malattie degenerative e i tumori cutanei. D’altra parte, lo studio aiuta anche a sfatare alcuni miti popolari: i capelli bianchi non sono semplicemente un segno di stress o di vecchiaia, ma il risultato visibile di una scelta cellulare intelligente, frutto di milioni di anni di evoluzione.
Come osserva Nishimura, «capire il comportamento di queste cellule non significa solo comprendere perché i capelli diventano bianchi, ma anche come il nostro corpo protegge sé stesso dai rischi del cancro». (C. P.).

Un’analisi condotta dall’Università della Pennsylvania su oltre 835mila persone di origini diverse rivela nuovi fattori chiave nel sovrappeso e nel diabete
Un gruppo di ricercatori guidati dall’Università della Pennsylvania ha analizzato i dati genomici di oltre 835mila adulti provenienti da sei diverse aree del mondo, Africa, Europa, Americhe e Asia, individuando tredici geni associati all’indice di massa corporea e al rischio di obesità grave. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communications, è di grande rilievo perché cinque di questi geni non erano mai stati collegati prima all’obesità. Il risultato sottolinea quanto gli studi che si concentrano su popolazioni geneticamente omogenee, in particolare di origine europea, possano trascurare segnali fondamentali per comprendere le basi biologiche della malattia.
Negli ultimi anni la genetica dell’obesità ha compiuto enormi progressi, ma con un limite importante: la maggior parte delle ricerche è stata condotta su individui europei. Ciò ha creato una visione parziale e distorta, con il rischio di trascurare geni rilevanti per altre popolazioni. Per colmare questa lacuna, il team coordinato da Deepro Banerjee ha unito due immense banche dati biomediche: la UK Biobank, che raccoglie informazioni genetiche e cliniche di circa 450mila persone del Regno Unito, e l’All of Us Research Program, iniziativa statunitense che include circa 385mila adulti di origini molto più diversificate. In questo modo i ricercatori hanno potuto analizzare in modo comparativo varianti genetiche rare che influenzano fortemente la funzione dei geni e misurare il loro impatto sull’indice di massa corporea in diverse popolazioni.
Dall’analisi congiunta sono emersi tredici geni che esercitano un effetto importante sull’obesità, aumentando fino a tre volte il rischio di sviluppare una forma grave della malattia. Cinque di questi geni (Ylpm1, Rif1, Gigyf1, Slc5a3 e Grm7) non erano mai stati associati prima a questa condizione. Molti dei tredici geni individuati sono espressi prevalentemente nel cervello e nel tessuto adiposo, a conferma del fatto che l’obesità nasce dall’interazione complessa
tra la regolazione cerebrale dell’appetito e il metabolismo del grasso. I ricercatori hanno anche osservato che diversi di questi geni influenzano direttamente o indirettamente il rischio di altre patologie correlate, come il diabete di tipo 2, l’ipertensione e le malattie cardiovascolari. Questo dato contribuisce a spiegare perché l’obesità è spesso accompagnata da un corteo di disturbi cronici che ne aggravano le conseguenze sulla salute. L’importanza dello studio non risiede solo nell’ampiezza del campione o nella scoperta di nuovi geni, ma anche nel suo valore metodologico e sociale. Per la prima volta, un’analisi genetica su larga scala ha incluso un numero significativo di individui di origini diverse, superando i limiti di rappresentatività che da anni penalizzano la ricerca genomica. Ciò dimostra quanto sia cruciale la diversità nello studio delle malattie complesse: alcuni segnali genetici risultano infatti visibili solo in determinate popolazioni, e la loro assenza negli studi tradizionali ha finora impedito di coglierne l’importanza. Questo approccio inclusivo apre la strada a una medicina di precisione più equa e

Dall’analisi sono emersi tredici geni che esercitano un effetto importante sull’obesità, aumentando fino a tre volte il rischio di sviluppare una forma grave della malattia. Molti dei tredici geni individuati sono espressi prevalentemente nel cervello e nel tessuto adiposo
globale, in grado di offrire strumenti diagnostici e preventivi validi per tutti.
La scoperta di nuovi geni coinvolti nell’obesità offre anche una prospettiva biologica inedita. Questi geni, molti dei quali agiscono a livello cerebrale, suggeriscono che esistono vie molecolari ancora poco conosciute che regolano la fame, il dispendio energetico e l’accumulo di grasso. Comprendere meglio tali meccanismi potrebbe consentire in futuro lo sviluppo di terapie mirate o di strategie preventive personalizzate. Lo studio contribuisce inoltre a chiarire i legami tra obesità e le cosiddette comorbidità metaboliche: i geni identificati non solo predispongono a un aumento di peso, ma intervengono anche su processi infiammatori, ormonali e cardiovascolari che favoriscono l’insorgenza di diabete e ipertensione. Naturalmente, restano alcune limitazioni. Anche se il campione è vastissimo, in nessuna singola popolazione non europea un gene ha raggiunto da solo un livello di significatività statistica paragonabile a quello ottenuto nella metanalisi complessiva. Ciò indica che, per comprendere pienamente le basi genetiche dell’obesità, è necessario ampliare ulteriormente gli studi, coinvolgendo ancora più individui di origini diverse. Un altro passo importante sarà capire come queste varianti rare agiscano a livello biologico: sapere che un gene è associato all’obesità è solo il punto di partenza; resta da scoprire il percorso molecolare attraverso cui provoca l’aumento del BMI o influisce sul metabolismo dei grassi.
Lo studio guidato da Deepro Banerjee rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico della ricerca sull’obesità. Mette in luce la complessità di una condizione che non può essere spiegata solo dallo stile di vita o dall’alimentazione, ma che trova parte delle sue radici nel genoma umano. Al tempo stesso, ribadisce che la genetica non è un destino immutabile: conoscere i propri fattori di rischio può servire a costruire strategie di prevenzione più efficaci e a personalizzare gli interventi terapeutici. (C. P.).

Le parole di Katalin Karikó, premio Nobel per la Medicina 2023, riportano al centro del dibattito una delle più importanti rivoluzioni scientifiche degli ultimi decenni: l’utilizzo dell’mRNA non solo contro le infezioni, ma anche come arma contro il cancro. In un’intervista concessa al Manifesto, la biologa ungherese, oggi docente all’Università della Pennsylvania, ha ricordato come la sua passione per la scienza sia nata grazie alla natura.
«Sono cresciuta nella campagna ungherese, senza elettricità né acqua corrente, circondata da animali e piante. La scienza era ovunque attorno a me, e io volevo solo capire come funzionava», racconta. Da quella curiosità infantile è nata una carriera capace di cambiare la storia della medicina. Dopo anni di scetticismo accademico e mancanza di fondi, Karikó ha dimostrato che l’Rna messaggero può essere modificato e reso stabile, fino a diventare la base tecnologica dei vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna. È così che nel 2023 è stata insignita del Premio Nobel con Drew Weissman: grazie ai due scienziati è stato possibile sviluppare i vaccini a mRNA efficaci contro il Covid-19 salvando milioni di vita dalla minaccia globale che ha stravolto le nostre esistenze.
Oggi quella stessa tecnologia apre una nuova frontiera: potenziare le terapie immunitarie contro i tumori. La ricercatrice cita, nell’intervista, uno studio condotto dall’MD Anderson Cancer Center e dall’Università della Florida, secondo il quale i pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid mostrano una sopravvivenza a tre anni quasi doppia rispetto a chi non è stato vaccinato. «È una correlazione che merita ulteriori conferme, ma apre la strada a nuove strategie combinate contro il cancro», spiega Karikó.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno vengono diagnosticati oltre 18 milioni di nuovi casi di cancro nel mondo, con quasi nove milioni di decessi. In Italia, nel 2024, le nuove diagnosi sono state circa 395mila, in aumento del 10% rispetto a dieci anni fa. Il carcinoma del polmone resta il più letale, seguito da colon, seno e pancreas. Le proiezioni indicano che entro il 2050 i casi globali cresceranno del 77%, spinti dall’invecchiamento della popolazione, dall’inquinamento e da stili di vita poco salutari. L’immunoterapia, oggi usata soprattutto nei tumori della pelle, del polmone e
in alcuni linfomi, ha già cambiato la prognosi di migliaia di malati, ma non funziona per tutti. Solo una parte dei pazienti risponde positivamente, e i costi restano elevati. L’idea che una semplice vaccinazione possa amplificarne gli effetti, a basso costo e su larga scala, apre scenari che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. A questo si aggiunge il crescente interesse dell’industria farmaceutica: secondo le stime, il mercato globale delle terapie basate su mRNA potrebbe superare i 40 miliardi di dollari entro il 2030, spinto proprio dalle applicazioni oncologiche e personalizzate.
Karikó, che per anni ha lavorato nell’ombra senza ottenere riconoscimenti, invita alla prudenza ma anche alla perseveranza. Dall’Ungheria agli Stati Uniti. Dal Centro di Ricerca Biologica di Szeged alla Temple University di Philadelphia. No, non è stato affatto facile. Soprattutto per come erano etichettati i suoi lavori sull’mRNA. «Negli anni Ottanta nessuno credeva nell’mRNA. Mi dicevano: “Povera Kati, l’RNA è instabile, si degrada subito”. Ma io non ho mai smesso di crederci. Non
Le sue ricerche sull’mRNA sono risultate fondamentali per lo sviluppo dei vaccini contro il Covid. Eppure, all’inizio nessuno le prestava ascolto: «Ho sempre tenuto duro»

serve essere geni, serve lavorare sodo e non arrendersi». E al Manifesto svela la formula del successo. «Ho tenuto duro fino a quando non ho incontrato persone che hanno creduto in quello che stavo facendo. Non ero interessata a fare mille pubblicazioni all’anno, me ne stavo nel mio laboratorio e osservavo i progressi che facevo». Oggi, mentre i laboratori di tutto il mondo sperimentano vaccini terapeutici personalizzati basati sull’mRNA per melanoma, tumori cerebrali e pancreatici, la sua visione si sta concretizzando. Le nuove formulazioni puntano a insegnare alle cellule immunitarie a riconoscere le mutazioni specifiche del tumore di ciascun paziente. In prospettiva, ogni vaccino potrebbe essere unico e costruito su misura, riducendo la tossicità e aumentando le probabilità di successo.
Per la scienziata ungherese, la vera lezione è un’altra: «La scienza deve restare curiosità, non competizione. Io non cercavo di essere la migliore, volevo solo capire un po’ di più la natura». E proprio da questa visione semplice, è nata una delle più grandi rivoluzioni biomediche del nostro tempo. Oggi l’mRNA non è più una promessa, ma un pilastro delle nuove biotecnologie, capace di unire virologia, immunologia e oncologia in un unico linguaggio molecolare. Se le ricerche in corso confermeranno i risultati preliminari, il futuro della lotta al cancro potrà partire dallo stesso principio che ha salvato milioni di vite durante la pandemia: un minuscolo frammento di informazione genetica, capace di riscrivere il destino delle cellule e forse, ancora una volta, quello dell’umanità. (D. E.).
Una luce inattesa sui meccanismi alla base della malattia di Alzheimer e l’identificazione di un potenziale “tradimento” nel cuore stesso del sistema immunitario. I ricercatori dell’Università di Verona hanno pubblicato su Nature Communications uno studio in cui dimostrano che quelle stesse cellule T, che quotidianamente agiscono come difensori contro virus e infezioni, possono in specifiche circostanze trasformarsi in elementi dannosi, capaci di aggredire i neuroni e alimentare i processi neurodegenerativi tipici della patologia. Questa prospettiva giunge in un momento di crescente preoccupazione globale per l’Alzheimer, la forma più comune di demenza.
Le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità infatti delineano un futuro complesso: si prevede che circa 66 milioni di persone conviveranno con questa malattia nel 2030, una cifra destinata a salire a 115 milioni di pazienti entro il 2050. L’impatto di questa “epidemia sociale” non si misura solo in termini di sofferenza umana, ma anche sotto il profilo economico e sociale. In Italia, ad esempio, i costi diretti e indiretti, comprensivi delle spese a carico del Servizio sanitario nazionale e dei costi di assistenza informale, sono stimati in decine di migliaia di euro all’anno per singolo paziente.
L’onere ricade prevalentemente su famiglie e caregiver, il cui impegno sottrae tempo al lavoro, intacca la salute personale e pone una pressione insostenibile sui bilanci familiari. La malattia, che ha una durata media di 3-9 anni, resta attualmente priva di terapie in grado di arrestare il decorso, rendendo la ricerca di base e l’identificazione di target terapeutici innovativi un’urgenza critica per la sanità pubblica mondiale.
Gli autori dello studio, guidati da Gabriela Constantin, prorettrice alla Ricerca dell’ateneo e docente di Patologia generale, insieme al gruppo del dipartimento di Medicina, diretto da Domenico Girelli, si sono concentrati sulle neuroimmune interactions – le interazioni
tra il cervello e il sistema immunitario – un campo oggi all’avanguardia nella ricerca biomedica e neuroscientifica. Normalmente, l’ingresso dei leucociti circolanti nel parenchima nervoso è ostacolato dalla barriera emato-encefalica. Tuttavia, in contesti patologici come l’Alzheimer, la migrazione di queste cellule nel cervello aumenta significativamente, scatenando un vero e proprio “dialogo ostile” che innesca la degenerazione neuronale. Il lavoro ha documentato in modo pionieristico e dettagliato come questa comunicazione alterata non sia casuale, ma orchestrata da un preciso meccanismo.
La metodologia utilizzata dai ricercatori ha combinato le analisi e l’esame dei dati provenienti da pazienti umani, confermando l’identificazione di un meccanismo neurotossico mediato dalle cellule
Individuata una specifica sottopopolazione immunitaria potrebbe essere la chiave per capire

immunitarie cruciale nella patogenesi della malattia. La ricerca ha rivelato che una specifica sottopopolazione di cellule T, le cellule T residenti della memoria Cd103–Cd8+, si accumula in modo anomalo nel cervello dei pazienti affetti da Alzheimer. Queste cellule, che esprimono la molecola Lfa-1 (Lymphocyte function-associated antigen-1), sfruttano questa integrina come una sorta di “passaporto” molecolare per aderire alla parete dei vasi sanguigni cerebrali e migrare attivamente dalla circolazione sistemica verso l’ambiente cerebrale, superando di fatto la barriera emato-encefalica alterata. Una volta penetrate nel sistema nervoso centrale, le cellule T assumono il loro ruolo neurotossico, promuovendo una forma di neuroinfiammazione tossica attraverso il rilascio massivo di granzima K (GrK). La granzi-
immunitaria come causa della neuroinfiammazione: capire l’origine e sviluppare trattamenti

ma K è una serina proteasi nota per il suo ruolo nell’uccisione delle cellule infettate da virus, ma in questo contesto si rivolge contro i neuroni sani. Il meccanismo di danno si completa quando la granzima K interagisce con il recettore Par-1 (protease-activated receptor-1), che si trova sulla superficie dei neuroni. È questa specifica interazione GrK–Par-1 che funge da “interruttore”, innescando una cascata di eventi intracellulari che culminano nella disfunzione neuronale e nell’iperfosforilazione anomala della proteina tau.
Il processo contribuisce direttamente alla formazione dei grovigli neurofibrillari, uno dei due segni neuropatologici (insieme alle placche di amiloide beta) che definiscono la malattia, portando alla progressiva perdita di memoria e al deterioramento cognitivo. L’identificazione dettagliata di questo asse molecolare non solo fornisce una comprensione profonda di un tassello fondamentale nella patogenesi dell’Alzheimer, ma apre anche orizzonti estremamente concreti per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.

I ricercatori dell’Università di Verona hanno pubblicato su Nature Communications uno studio in cui dimostrano che quelle stesse cellule T, che quotidianamente agiscono come difensori contro virus e infezioni, possono in specifiche circostanze trasformarsi in elementi dannosi, capaci di aggredire i neuroni e alimentare i processi neurodegenerativi tipici della patologia

I risultati dello studio Suddy confermano i sintomi premonitori e i fattori che identificano gli individui a rischio Sads

La morte cardiaca improvvisa nei giovani è spesso percepita come un evento tragico e totalmente imprevedibile, un fulmine a ciel sereno che squarcia la vita di chi è apparentemente in piena salute. Tuttavia, una analisi condotta dall’Università di Goteborg e pubblicata sulle pagine di American Journal of Cardiology suggerisce che per molti giovani colpiti, il dramma finale non sia arrivato senza preavviso. I risultati dello studio denominato Suddy (Sudden cardiac death in the young cohort) hanno così confermato non solo la presenza di sintomi premonitori, ma anche i fattori clinici e demografici che identificano gli individui a rischio della sindrome di morte aritmica improvvisa (Sads), un termine che racchiude i casi di morte cardiaca improvvisa in assenza di una chiara patologia cardiaca strutturale.
La ricerca è stata guidata dalla cardiologa Matilda Frisk Torell, affiliata alla Sahlgrenska Academy e al Sahlgrenska University Hospital. Il team si è concentrato sull’esaminare in retrospettiva tutti i casi di morte aritmica improvvisa registrati in Svezia in un decennio, tra il 2000 e il 2010, focalizzandosi specificamente sulla fascia d’età compresa tra 1 e 35 anni. Su un totale di 149 casi analizzati in questo periodo, l’età mediana al momento del decesso era di 23 anni, con una netta predominanza maschile, rappresentante il 65% dei casi. Nonostante l’assenza di differenze socioeconomiche significative, i dati demografici hanno confermato un rischio maggiore per gli uomini giovani adulti.
I risultati dello studio hanno rivelato un dato tanto scioccante quanto cruciale per la prevenzione futura: una frazione significativa delle vittime, pari al 34% del totale, aveva cercato attivamente assistenza medica nei 180 giorni immediatamente precedenti la fatalità. Questa percentuale è significativamente più alta rispetto al gruppo di controllo. In particolare, ricoveri o visite
ambulatoriali per malattie cardiovascolari entro i tre anni precedenti il decesso erano ben sette volte più frequenti nei casi Sads. Inoltre, una diagnosi di malattia cardiaca aritmica era presente nel 4,2% delle vittime, ma in nessun controllo, evidenziando una storia sanitaria già alterata in una piccola ma significativa porzione dei casi. Questi giovani non erano, dunque, del tutto asintomatici. I sintomi per i quali si erano rivolti al medico non erano generici o ambigui, bensì si trattava di manifestazioni spesso indicative di un potenziale disturbo cardiaco sottostante. I segnali più rilevanti e significativamente più comuni nelle vittime Sads, circa 20 volte più frequenti, erano la sincope (svenimento) e, in misura simile, le palpitazioni. L’aver avuto contatti sanitari per sincope o per crisi convulsive (queste ultime potenzialmente potevano essere sincopi aritmiche mascherate) entro un anno prima della morte era un fattore di rischio estremamente elevato, aumentando la probabilità di Sads di oltre dieci volte. Questi segni, dunque, non devono mai essere liquidati con leggerezza, specialmente in un giovane. Ancora più determinante è stata la scoperta relativa ai dati elettrocardiografici precedenti all’evento. Sebbene una registrazione Ecg fosse disponibile solo per il 45% delle vittime Sads, il 18% di tutte le vittime presentava Ecg patologici. Tra i reperti più comuni figuravano la pre-eccitazione e la sindrome del QT lungo, due condizioni aritmogene ben note e potenzialmente fatali. Per gli autori dello studio, tale evidenza è l’indicazione di una potenziale “finestra d’opportunità” diagnostica mancata. La ricerca ha inoltre identificato fattori di rischio meno intuitivi, tra cui la salute mentale e l’uso di farmaci. Una diagnosi psichiatrica era presente nel 17% dei casi Sads, e l’uso di farmaci psicotropi era documentato in modo significativamente più frequente nelle vittime rispetto ai controlli. Sebbene il nesso causale richieda ulteriori indagi-
ni, i farmaci psicotropi sono noti per influenzare i canali ionici del cuore, un elemento che sottolinea la necessità di un’attenta valutazione cardiaca prima di iniziare queste terapie. Infine, un’anamnesi positiva per storia familiare di malattia cardiaca o MCI era presente nel 13% delle vittime Sads.
L’analisi si conclude con una duplice e fondamentale raccomandazione che mira a ridefinire i protocolli medici. In primo luogo, è imperativo che gli episodi di sincope o di crisi convulsive nei giovani vengano trattati con la massima serietà clinica, innescando un protocollo diagnostico. In seguito, lo studio suggerisce un cambiamento sistematico nell’assistenza sanitaria di base, caldeggiando l’inclusione dell’elettrocardiogramma come parte integrante dei controlli clinici di routine per i giovani. Un uso più diffuso e una lettura più attenta dell’Ecg potrebbero infatti agire come un radar, permettendo di identificare precocemente le patologie silenti e di intervenire prima che il potenziale fatale si manifesti, trasformando l’imprevedibile in prevenibile. (E. G.).
I risultati dello studio hanno rivelato un dato tanto scioccante quanto cruciale per la prevenzione futura: una frazione significativa delle vittime, pari al 34% del totale, aveva cercato attivamente assistenza medica nei 180 giorni immediatamente precedenti la fatalità © Chinnapong/shutterstock.com


Fumo, sovrappeso e stili di vita scorretti: il 90% presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare
Dalla seconda edizione della campagna Cuore in farmacia, iniziativa promossa da Cittadinanzattiva e Federfarma, è emerso che il 90% delle donne presenta almeno un fattore di rischio cardiovascolare.
Nel dettaglio, il 37,4% delle donne (quasi quattro su dieci) presenta anomalie all’esame dell’elettrocardiogramma, soprattutto legate al ritmo cardiaco (50%) e alla conduzione intraventricolare (41,2%). Tra le 804 donne con anomalie ecg, il 23,6% è in sovrappeso e il 13,2% in condizione di obesità. Lo scenario è stato traccia-
to prendendo in considerazione 30 parametri tra misurazioni, patologie pregresse e stili di vita. Ma ci sono anche altri fattori di rischio che vanno sottolineati, come ad esempio la sedentarietà (57,2%), il fumo (31,8%) e l’ipercolesterolemia pregressa (28,2%).
E ad allarmare gli esperti c’è un dato che può essere ignorato e che è spia di un problema da affrontare: quasi tre donne su dieci per un totale del 29,3% in trattamento antipertensivo mostrano valori pressori ancora alti. Ciò può significare solamente due cose: che si riscontrano problemi legati all’aderenza terapeutica oppure che
il trattamento in corso non è così efficace. All’iniziativa - particolarmente significativa poiché le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità femminile - hanno aderito oltre 200 farmacie associate a Federfarma di sei regioni italiane (Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Puglia) che hanno coinvolto 2.328 donne tra i 40 e i 60 anni.
Come spiegato da Francesca Moccia, vicesegretaria generale di Cittadinanzattiva, «la campagna conferma che una parte significativa della popolazione femminile convive con fattori di rischio multipli rispetto al rischio cardiovascolare, infatti oltre un quarto delle partecipanti presenta tre o più criticità concomitanti. Allo stesso tempo, i dati positivi rilevati (stili di vita corretti, valori protettivi di HDL, pressione nella norma nella maggioranza dei casi) mostrano come la prevenzione funzioni, se sostenuta da informazione, screening accessibili e monitoraggio costante». In tal senso, un ruolo sempre più importante lo ricoprono le farmacie, veri e propri presidi di prossimità. Lo ha ricordato anche Marco Cossolo, presidente di Federfarma nazionale. «La farmacia è il presidio sanitario più vicino al cittadino, soprattutto nei piccoli centri, dove accedere ai servizi sanitari è più difficoltoso. Grazie alla telemedicina in farmacia la prevenzione e gli screening diventano a portata di tutti».
Il ruolo del farmacista è sempre più centrale anche per quanto concerne l’aderenza terapeutica. Può infatti spiegare al paziente come e quando assumere i farmaci seguendo così le indicazioni del medico di base, è in grado di chiarire dubbi su effetti collaterali e interazioni tra medicinali e offrire un supporto prezioso a pazienti cronici o politerapici, anche attraverso l’utilizzo di schede promemoria, blister personalizzati, app o sistemi digitali per ricordare l’assunzione dei farmaci. (D. E.).
Partendo dal presupposto che si può sempre migliorare, l’Italia risulta già tra le eccellenze mondiali in quanto a donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule. L’ultimo - senza precedenti - è stato eseguito presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma.
Già, per la prima volta al mondo si è proceduto a effettuare un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l’arteria polmonare associato all’asportazione dell’intero polmone di sinistra. E, ora, veniamo ai dati che certificano lo status dello Stivale, come emerso dall’ultima edizione della Newsletter Transplant. Il Belpaese è secondo soltanto agli Stati Uniti per il trapianto di fegato ed è settimo per quelli di cuore.
Numeri in forte aumento, ma che ancora non bastano a coprire le richieste, dal momento che sono circa ottomila gli italiani in attesa di un organo. Di certo, il futuro fa meno paura. Perché il Centro Nazionale Trapianti riferisce che il 2024 è stato un anno record: 4.642 i trapianti realizzati (+3,9%), dei quali 179 in urgenza nazionale (75 di fegato, 86 di cuore, 14 di polmone, quattro di rene) e 191 pediatrici (79 di fegato, 76 di rene, 32 di cuore, quattro di polmone). Sul gradino più alto del podio per numero di trapianti troviamo la Città della Salute e della Scienza di Torino con 440, a seguire l’ospedale di Padova (413) e l’Ismett di Palermo (276). Torino detiene anche un altro primato: è nel capoluogo piemontese, infatti, che si sono registrati più trapianti di fegato (ben 179). Padova, invece, eccelle per trapianti di rene (217) e polmone (41), mentre per i trapianti di cuore Bari è capofila con 73. Nessuno come il San Raffaele di Milano per trapianti di pancreas (14). Commentando i risultati lusinghieri dell’Italia, nei mesi scorsi il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha comunque evidenziato

Per il Belpaese il 2024 è stato un anno record
Ecco quali sono i migliori ospedali, Torino in prima fila
che c’è «ancora strada da fare, soprattutto per rafforzare la cultura della donazione. Il fabbisogno, infatti, non è ancora soddisfatto e molte più vite potrebbero essere salvate se in numero sempre maggiore dicessimo sì alla donazione, un sì convinto».
La strada, però, è tracciata. Basta confrontare i numeri del nostro Paese con quelli del resto d’Europa per avere le idee più chiare, anche per quanto riguarda la donazione. Dal report europeo sul 2024 viene fuori che l’Italia occupa la seconda posizione tra i grandi Paesi del Vecchio Continente per tasso di donazione con 29,5 dona-
tori per ogni milione di abitanti. Solo la Spagna ci precede con 48, mentre alle nostre spalle figurano Francia (28,3), Regno Unito (19,2) e Germania (10,9). Se il discorso si estende anche ai Paesi più piccoli per abitanti e per attività di trapianto, solo Portogallo, Repubblica Ceca, Belgio e Croazia stazionano davanti all’Italia. Una menzione merita l’attività di donazione a cuore fermo, la cui crescita è stata addirittura del 34,6%: a eccezione della solita Spagna, che domina le statistiche, nessuno tra i grandi Paesi europei ha registrato un incremento così alto. (D. E.).


Filtri UV sintetici ispirati a composti naturali Connubio perfetto tra sicurezza per l’uomo e rispetto per l’ambiente
La crescente necessità di tutelare la salute umana e l’ambiente, spinge la ricerca allo sviluppo di nuove strategie di fotoprotezione dai raggi ultravioletti (UV), che ormai rappresentano un ambito in rapida evoluzione. Le numerose sfide alle quali sono sottoposte le formulazioni destinate alla protezione contro gli UV sono legate non solo all’efficacia protettiva, ma anche alla sicurezza, alla sostenibilità e alla conformità regolatoria. È appunto essenziale aumentare la copertura dell’intero spettro solare e studiare nuovi filtri innovativi, che possano incoraggiare l’uso regolare dei prodotti fotoprotettivi. Proprio per questo, i filtri UV naturali sono visti come alternative promettenti ai filtri organici sintetici tradizionali, perché garantiscono biocompatibilità, fotostabilità e un ottimo profilo ecotossicologico. Il ruolo di protagonisti se lo accreditano:
1. gli amminoacidi simili alle micosporine (MAA), studiati per la capacità di assorbire selettivamente la radiazione UV e per le loro proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e immunomodulatrici;
2. i gadusoli, metaboliti correlati strutturalmente ai MAA con un’eccellente fotostabilità e elevate proprietà antiossidanti, in grado di contrastare i danni indotti dalle specie reattive dell’ossigeno (ROS).
Entrambi mostrano però avere un problema legato alle loro caratteristiche fotofisiche, che possono subire influenze dallo stato di protonazione, dipendente dall’ambiente circostante.
Nonostante i filtri naturali siano di interesse scientifico, il loro utilizzo è limitato; per i MAA la produzione in grande quantità, trova ostacoli dalle numerose incertezze legate ai meccanismi di biosintesi e dai processi estrattivi da microalghe, macroalghe, cianobatteri e organismi marini, a questo si aggiunge la purificazione industriale e la disponibilità costante. In alternativa a tali ostacoli, sono state considerate nuove strategie: l’espressione eterologa dei cluster genici biosintetici tramite biologia sintetica e biocatalisi, la sintesi chimica di analoghi strutturali.
Losantos et al., hanno dimostrato la possibilità di ottenere analoghi sintetici dei MAA attraverso un semplice processo chimico ad alte rese; i composti ottenuti hanno un’eccellente stabilità termica e fotochimica, assenza di fotoreattività e bassa tossicità, tutte caratteristiche che li rendono ideali per l’utilizzo cosmetico. Invece, gli analoghi sintetici del gadusolo mostrano maggiore complessità. legata alle vie sintetiche necessarie.
Le formulazioni dei prodotti solari moderni richiedono due cose importanti, da un lato un’efficace protezione
* Comitato Centrale FNOB
UV; dall’altro la presenza di antiossidanti in grado di ridurre lo stress ossidativo e migliorare la sicurezza cutanea complessiva. Se si riescono a combinare in un’unica molecola proprietà fotoprotettive e antiossidanti questo rappresenterebbe un importante vantaggio sia in termini tecnologici che economici, dove però la valutazione della sicurezza per l’uomo e per l’ambiente è un aspetto cruciale.
Uno studio fatto sull’analisi computazionale condotta su uno di questi analoghi, ha evidenziato una spiccata dipendenza del suo comportamento fotofisico dal pH, riproducendo le variazioni viste negli spettri UV-vis delle molecole naturali. La caratterizzazione mediante orbitali di transizione naturali ha anche permesso di identificare, per alcuni composti rappresentativi, le principali transizioni elettroniche responsabili dell’assorbimento UV. La fotolisi invece ha permesso di valutare la fotostabilità dei composti attraverso esperimenti, e in tutti i casi si è notata una degradazione ridotta, con rese quantiche di foto-decomposizione inferiori a 1 molecola su 2000 fotoni assorbiti.
Le prestazioni risultano infatti comparabili a quelle dei fotoprotettori naturali più efficienti, come shinorina, porphyra-334 e gadusolo a pH fisiologico. Dopo la fotostabilità, l’efficacia dei filtri solari è data anche dalla loro capacità antiossidante, infatti la produzione di ROS negli strati cutanei profondi, contribuisce molto ai danni cellulari indotti dalla radiazione UV. Dalle costanti di quenching dell’ossigeno singoletto (k_r) si è osservato che alcuni analoghi e il gadusolo naturale sono circa dieci volte più reattivi rispetto ad alcuni composti, coerentemente con quanto riportato per le strutture cicloesenoniche naturali (gadusolo, deossigadusolo, micosporina-glicina, micosporina-glutammina).
La capacità dei composti sintetici di eliminare radicali idrosolubili e lipofili è stata valutata mediante i saggi ABTS e DPPH. Alcuni composti, mostrano una capacità di scavenging radicalico superiore a quella dei MAA naturali, con valori vicini a quelli dell’acido ascorbico. I composti analoghi del gadusolo, presentano comportamenti diversi: uno mostra un’attività paragonabile al gadusolo naturale, l’altro risulta meno efficace. Nel test DPPH, alcuni composti superano le prestazioni della miscela di MAA naturali, e uno invece mostra una capacità sovrapponibile; per i gadusoli sintetici, uno mostra attività più elevata rispetto ad un altro, confermando i risultati dei saggi ABTS.
Per valutarne la sicurezza, sono stati effettuati test di sicurezza preliminari e test antimicrobici, i composti naturali e i nuovi analoghi non mostrano attività significativa contro Escherichia coli e Staphylococcus aureus, confermando la loro bassa tossicità.

I filtri UV naturali sono visti come alternative promettenti ai filtri organici sintetici tradizionali, perché garantiscono biocompatibilità, fotostabilità e un ottimo profilo ecotossicologico. Le formulazioni dei prodotti solari moderni richiedono due cose importanti, da un lato un’efficace protezione UV; dall’altro la presenza di antiossidanti in grado di ridurre lo stress ossidativo e migliorare la sicurezza cutanea complessiva. Se si riescono a combinare in un’unica molecola proprietà fotoprotettive e antiossidanti questo rappresenterebbe un importante vantaggio sia in termini tecnologici che economici, dove però la valutazione della sicurezza per l’uomo e per l’ambiente è un aspetto cruciale
In definitiva, dai risultati si evidenzia come gli analoghi sintetici ispirati ai filtri naturali siano candidati promettenti per lo sviluppo di nuove generazioni di sistemi fotoprotettivi, grazie alla combinazione di elevata fotostabilità, assorbanza UV mirata e capacità antiossidante significativa.
In questo lavoro sono state valutate le proprietà fotoprotettive e antiossidanti di analoghi sintetici dei filtri UV naturali MAA e del gadusolo, confrontandoli con quelli biologici. I risultati dimostrano:
1. i composti sintetizzati hanno un livello di efficienza comparabile ai filtri naturali (in termini di profili di assorbimento, di fotostabilità), mostrando una risposta alla radiazione UV che si può sovrapporre a quella dei sistemi biologici dai quali sono ispirati;
2. la loro attività antiossidante evidenza un duplice ruolo: gli analoghi agiscono come efficaci assorbitori UV, ma hanno anche la capacità di neutralizzare radicali liberi e specie reattive dell’ossigeno, offrendo protezione complessiva della pelle dal danno ossidativo indotto dagli UV.
Dai test di sicurezza preliminari, inclusi i saggi di attività antimicrobica, si evidenzia un comportamento iden -
tico a quello delle molecole naturali, ovvero l’assenza di effetti indesiderati nei range di concentrazione studiati.
Il risultato interessante è quello di poter accedere a questi composti con facilità e tramite un processo sintetico semplice, che rappresenta un vantaggio significativo rispetto all’estrazione da organismi marini spesso con basse rese, costi elevati e impatti ambientali. Pertanto, gli analoghi sviluppati in questo modo, costituiscono un’alternativa sostenibile e più accessibile per applicazioni industriali nel settore cosmetico.
I dati raccolti indicano che questi nuovi composti possiedono tutte le caratteristiche per diventare la nuova generazione di filtri UV: altamente efficienti, fotostabili, dotati di attività antiossidante e prodotti tramite procedure ecocompatibili e scalabili, aprendo prospettive significative per lo sviluppo di formulazioni solari più sostenibili, affidabili e performanti.
In due oliveti sperimentali, vicino Perugia, i ricercatori hanno tracciato la prima mappa dettagliata di come le radici degli olivi negoziano la sopravvivenza con eserciti invisibili di batteri quando l’acqua scarseggia. Il risultato è uno studio firmato da Enea, Cnr e dalle Università di Milano, Torino e Tuscia, pubblicato su “Applied Science” (https://doi.org/10.3390/app15179667) nell’ambito del progetto internazionale BIOMEnext, che getta luce su meccanismi biologici potenzialmente utilizzabili per rendere l’olivicoltura mediterranea più resiliente ai cambiamenti climatici.
«L’ulivo - spiega il responsabile del progetto per Enea Gaetano Perrotta, ricercatore del Laboratorio di Bioeconomia circolare rigenerativa - è stato scelto come specie modello per sviluppare un sistema colturale innovativo, rappresentativo dell’agricoltura mediterranea che è sempre più minacciata dal fenomeno della siccità. Con questo studio abbiamo voluto analizzare la resilienza e l’adattamento funzionale dei microrganismi presenti nelle radici e nel suolo (la rizosfera, il micromondo intorno alle radici, dove avviene uno scambio continuo e vitale tra piante e microbi) di quattro cultivar di ulivo, confrontando piante irrigate e
sottoposte a siccità in Umbria, in diverse stagioni dell’anno».
I ricercatori hanno lavorato su quattro varietà di provenienza internazionale - Arbequina spagnola e Koroneiki greca (considerate più sensibili allo stress idrico), Chemlal algerina e Shengeh iraniana (reputate più resistenti) - coltivate in condizioni controllate presso i siti di Boneggio e Lugnano. Le piante, di otto anni, sono state monitorate sia in estate sia in inverno, confrontando esemplari irrigati (circa 180 millimetri d’acqua aggiuntivi in estate) con altri esposti alle sole precipitazioni naturali (media di 692 millimetri annui). Ventiquattro alberi campionati, centinaia di analisi del Dna, migliaia di articoli scientifici setacciati con algoritmi di text mining.
Il quadro emerso rivela una strategia biologica sofisticata. Come spiega Andrea Visca, biotecnologo del laboratorio Enea innovazione delle filiere agroalimentari: «Abbiamo osservato che nel suolo i microrganismi rimangono abbastanza stabili anche in condizioni di scarsità idrica, grazie al fatto che molte specie svolgono funzioni simili. Nelle radici, invece, le comunità microbiche cambiano notevolmente: la pianta seleziona i batteri che la aiutano a resistere meglio alla man-

canza d’acqua». È un paradosso apparente: mentre il terreno conserva stabilità grazie alla ridondanza funzionale - molte specie diverse possono svolgere lo stesso compito - i tessuti radicali riorganizzano attivamente il proprio microbioma, privilegiando partner più utili in condizioni di stress. Questa plasticità suggerisce che gli olivi affrontino la siccità anche attraverso una selezione attiva dei propri alleati microbici, probabilmente modulando la composizione degli essudati radicali.
Dall’analisi genomica sono emersi sessantasei generi batterici condivisi da tutte le condizioni testate, un core microbiome ricorrente. Tra questi, tre gruppi si distinguono come contributori principali alle funzioni legate alla resistenza: Solirubrobacter, abitante tipico dei suoli aridi e specializzato nella degradazione della materia organica; Microvirga, capace di fissare l’azoto atmosferico quando l’assorbimento di nutrienti è compromesso; Pseudonocardia, produttore di metaboliti secondari con funzioni protettive.
In condizioni di carenza idrica, il microbioma radicale potenzia reperto-
ri genetici specifici: sistemi di trasporto di nutrienti sotto stress, enzimi antiossidanti che neutralizzano danni cellulari, proteine che guidano i batteri verso micro-nicchie più umide.
«L’interfaccia tra radici e rizosfera rappresenta una zona cruciale di interazione tra piante e microrganismi, dove si svolgono molti processi essenziali per la salute e lo sviluppo delle piante, come l’assorbimento di nutrienti e di acqua», ricorda Annamaria Bevivino, ricercatrice della divisione Enea sistemi agroalimentari sostenibili.
I risultati vanno, però, interpretati con cautela. L’analisi statistica multiva-
riata (Permanova) non ha rilevato differenze formalmente significative tra le comunità microbiche di piante irrigate e non irrigate, probabilmente per l’alta variabilità tra campioni e il numero limitato di repliche. La traduzione in pratica agricola richiederà passaggi ulteriori: validazione su scala geografica più ampia, test su cultivar locali tradizionali, sperimentazione di inoculi microbici in campo aperto, verifica di compatibilità con pratiche agronomiche esistenti.
«Enea - conclude la Bevivino - è attivamente impegnata nella selezione e nella caratterizzazione di consorzi microbici che migliorano resa, qualità, salute delle

piante. L’approccio combinato di culturomica e metagenomica che Enea applica nelle sue ricerche permetterà di sviluppare soluzioni sempre più innovative per l’agricoltura, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili, resilienti e ad alta efficienza». Questo studio fissa un punto fermo: la resistenza alla siccità non abita solo nel genoma della pianta o nelle tecniche dell’agricoltore, ma anche nel traffico sotterraneo tra radici e batteri, un traffico che gli olivi gestiscono da millenni e che la scienza ha cominciato a mappare.
Lo studio BIOMEnext rivela come le piante selezionino specifici microrganismi dalla rizosfera per resistere alla mancanza d’acqua, creando una speranza per l’agricoltura
di Gianpaolo Palazzo
Mentre l’Italia celebra tre milioni di nuovi alberi impiantati, il territorio nazionale continua a perdere suolo naturale a un ritmo doppio rispetto a quanto viene recuperato con il verde. È il paradosso che emerge incrociando i dati della quinta edizione dell’Atlante delle Foreste - rapporto annuale di Legambiente e AzzeroCO2 con Compagnia delle Foreste, consultabile sul sito del cigno verde - e il recente monitoraggio SNPA sul consumo territoriale. Nel periodo compreso tra ottobre 2024 e marzo 2025 (considerato convenzionalmente come “anno 2024” per ragioni di ciclo vegetativo) sono stati trapiantati oltre tre milioni di esemplari arborei e arbustivi su circa 4mila ettari, con un valore stimato di servizi ecosistemici pari a venti milioni di euro annui.
La forestazione copre ottobre 2024 - marzo 2025, il consumo suolo l’anno solare 2024: periodi sostanzialmente
comparabili, ma non identici. In questo arco temporale il cemento ha divorato 7.800 ettari netti di natura secondo i dati SNPA. Il bilancio complessivo resta quindi in rosso, nonostante l’accelerazione impressa dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle città metropolitane. L’indagine, basata sull’analisi di 294 interventi distribuiti lungo la penisola, mostra una geografia della riforestazione italiana a geometrie variabili: le grandi aree urbane trainano grazie al Decreto clima e alle risorse europee, mentre le amministrazioni regionali si trovano paralizzate dal passaggio tra vecchi e nuovi programmi di sviluppo rurale. Il contributo delle imprese private crolla del 72%, scendendo ad appena 40.852 esemplari, dato che lascia interrogativi sulla tenuta dell’impegno volontario nonostante il settore lo giustifichi con una “diversificazione strategica”. In cima alla classifica regionale si conferma per il secondo anno consecutivo il
Trentino-Alto Adige, con oltre 748mila alberature, seguito dalla Basilicata con più di 539mila. Le due realtà hanno adottato strategie opposte: la provincia autonoma ha fatto leva su dotazioni provinciali e comunali, la regione meridionale ha sfruttato gli ultimi stanziamenti disponibili del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 prima della sua scadenza. Sale sul podio il Veneto, che insieme al Friuli-Venezia Giulia ha già attivato interventi previsti dal nuovo Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027, dimostrando capacità amministrativa nell’anticipare la fase transitoria. Seguono Sicilia, Lazio e Calabria, ma le loro posizioni dipendono quasi interamente dalle performance delle rispettive città metropolitane di Messina, Roma e Reggio Calabria.
Esaminando, infatti, solo gli interventi sostenuti direttamente dagli enti regionali con risorse proprie, emerge un dato preoccupante: otto territori - Abruzzo,
L’Atlante delle Foreste rivela la messa a dimora è stimato in oltre 20 milioni di euro

Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria - non hanno avviato alcun nuovo impianto nel periodo analizzato. La causa è dichiaratamente burocratica: il vuoto tra la conclusione del vecchio PSR e l’entrata a regime del nuovo ha congelato le iniziative. Caso a parte la Liguria, che conferma la scelta di non investire in nuove piantagioni data l’elevata copertura boschiva già presente, dato che il rapporto non quantifica né confronta con altre regioni montane. A compensare questa stasi amministrativa sono state le città metropolitane, vero motore della riforestazione 2024 grazie al PNRR. Il Centrosud domina: Messina guida con 357.612 nuovi esemplari, quasi il 12% del totale nazionale concentrato in una sola area metropolitana, un dato eccezionale che però il rapporto non contestualizza in termini di superficie interessata o tipologie di intervento. Segue Roma con 265.501, poi Reggio Calabria, Cagliari e Napoli.
Circa il 75% degli interventi ammessi a contributo nel 2022 tramite fondi PNRR ha completato la fase di trapianto, anche se permangono opacità: per Catania e Palermo, secondo quanto indicato nel rapporto, le piante sarebbero ancora in fase vivaistica, ma mancano conferme ufficiali dai comuni interessati. Bologna, Firenze e Milano non compaiono affatto, non avendo richiesto o ottenuto dotazioni dal primo bando PNRR 2022.
Sul fronte finanziario, lo studio registra una divergenza netta: gli investimenti pubblici crescono del 31% trainati dall’Europa, mentre il settore privato subisce una contrazione del 72%. «Il calo degli investimenti privati, che potrebbe sembrare un segnale negativo, in realtà racconta un cambio di prospettiva. Le aziende proseguono sempre sulla strada della sostenibilità superando però l’approccio focalizzato su un singolo tipo di intervento per adottare piani più ampi e integrati, che includono ad esempio azio-
ni di tutela e ripristino degli ecosistemi», ha commentato Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCO2.
L’analisi economica attribuisce alle nuove superfici verdi un valore annuo complessivo di 20,7 milioni di euro, calcolato sommando tre voci: mitigazione climatica e regolazione di aria e suolo (2.202,9 euro per ettaro annui), valore socio-culturale legato a turismo e ricreazione (639,2 euro), e “valore di lascito” alle generazioni future (2.342,5 euro). «Non basta piantare, ma è fondamentale progettare, scegliendo specie adatte e garantendo manutenzione nel tempo», sostiene Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. La forestazione italiana, quindi, accelera grazie all’Ue, ma naviga tra luci e ombre: i numeri ci sono, le intenzioni anche. Mancano ancora i meccanismi per verificare che quanto piantato oggi non sia solo una statistica celebrativa, ma infrastrutture verdi funzionanti domani. (G. P.).
dimora di quasi 4mila ettari. Il ritorno economico euro l’anno in servizi ecosistemici


Le aree protette subiscono nuove coperture: 81 ettari nei parchi, 192,6 nelle zone Natura 2000. Il verde urbano cala ancora, compromettendo la capacità di adattamento climatico
L’Italia perde pezzi. Fisicamente. Sotto i nostri piedi, il mosaico del territorio si sta sbriciolando a un ritmo che non si vedeva da dieci anni: nel 2024, quasi 84 chilometri quadrati di superfici naturali sono stati sepolti sotto asfalto, capannoni e nuove costruzioni, con un’accelerazione del 16% rispetto all’anno precedente. Al netto di timidi interventi di ripristino, la perdita netta ammonta a 78 km², un valore record. Ogni ora, una porzione di suolo pari a circa 10mila metri quadrati scompare per sempre, come se dal paesaggio italiano venisse strappato un tassello dopo l’altro.
Il nuovo rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa), disponibile integralmente con mappe interattive sull’EcoAtlante Ispra, mostra un Paese a diverse velocità, ma con un’unica direzione. Se in termini assoluti Lombardia (12,22%), Veneto (11,86%) e Campania (10,61%) detengono il triste primato delle regioni più coperte da cemento, la voracità più recente si manifesta altrove.
A guidare la crescita percentuale di nuove superfici artificiali nel 2024 è la Sardegna (+0,83%), seguita da Abruzzo (+0,59%) e Lazio (+0,56%).
L’Emilia-Romagna, pur registrando la sottrazione annuale più elevata in termini assoluti (circa mille ha), si distingue per un paradosso tecnico rilevante: è anche la regione più attiva nel recupero, con 143 ha rinaturalizzati da cave dismesse o cantieri, e l’86% del suo nuovo consumo risulta classificato come reversibile, quindi potenzialmente recuperabile in futuro attraverso interventi mirati. Persino la Valle d’Aosta, la meno toccata dal fenomeno, aggiunge comunque oltre dieci ha al bilancio negativo.
Due fenomeni, in particolare, alimentano questa espansione: la transizione energetica e la rivoluzione
digitale. L’installazione di pannelli fotovoltaici a terra tradizionali è quadruplicata, passando dai 420 ha del 2023 a oltre 1.700 nel 2024, con l’80% posizionato su terreni precedentemente agricoli; Lazio (443 ha), Sardegna (293 ha) e Sicilia (272 ha) guidano questa corsa. Di contro, emerge un dato preoccupante: la superficie destinata all’agrivoltaico - impianti che limitano l’impatto permettendo la doppia funzione energetica e agricola, e per questo non computati come consumo - è scesa dai 254 ha del 2023 ai 132 del 2024, un calo del 48% che dimostra come le tecnologie più compatibili stentino ancora a decollare nonostante i vantaggi ambientali, probabilmente per costi iniziali più elevati e normative ancora poco incentivanti. Parallelamente, l’inarrestabile sviluppo della logistica, che dal 2006 ha occupato oltre 6.000 ha complessivi, è ora affiancato dalla fame di spazio dei data center: queste infrastrutture digitali, concentrate prevalentemente nel Nord Italia, hanno richiesto 37 ha nell’ultimo anno, un dato in rapida crescita alimentato dalla diffusione di intelligenza artificiale, cloud computing e servizi digitali.
Ancora più preoccupante è dove si costruisce: la cementificazione avanza proprio nelle zone più fragili. Nel 2024 sono stati sottratti altri 1.303 ha in luoghi a media pericolosità idraulica e 600 ha in quelle a rischio frana, un paradosso che amplifica l’esposizione del territorio agli eventi estremi. Lungo le coste, nella fascia dei trecento metri dal mare, la copertura artificiale raggiunge il 22,9%, oltre tre volte la media nazionale. Nemmeno le zone protette sono immuni: 81 ha sono stati trasformati all’interno di parchi nazionali (28,7 ha) e regionali (30,8 ha), mentre le porzioni della rete Natura 2000 hanno ceduto 192,6 ha di naturalità (+14% rispetto all’anno precedente).
Nelle città, la situazione peggiora: il 2024 registra la perdita di ulteriori
3.750 ha di spazi verdi urbani, un dato che si traduce in isole di calore più intense, minore capacità di assorbimento delle piogge, peggioramento della qualità dell’aria e riduzione degli spazi di socialità e benessere per i cittadini. Di fronte a questa progressione, gli interventi di ripristino appaiono insufficienti: nel 2024 sono stati restituiti alla natura 5,2 chilometri quadrati, in calo rispetto agli 8,2 dell’anno precedente. A livello europeo, però, la consapevolezza sta crescendo: dopo il Regolamento sul ripristino della natura, il 23 ottobre 2025 il Parlamento Ue ha approvato una storica Direttiva sul suolo, che istituisce un monitoraggio comune per contrastarne il degrado e punta a raggiungere l’obiettivo di terreni sani in tutto il continente. Il sistema di rilevamento Snpa è stato uno dei modelli di riferimento per la nuova legislazione comunitaria. Il rapporto rappresenta un appello urgente a un cambio di paradigma: abbandonare la logica dell’espansione per abbracciare quella della rigenerazione urbana, dando priorità assoluta al riuso delle zone già edificate e dismesse. La vera sfida per l’Italia non è fermare lo sviluppo, ma costruirlo diversamente: invertire il rapporto tra nuovo consumo e rigenerazione. Oggi per ogni metro quadrato recuperato se ne coprono sedici. Fintanto che il sistema fiscale premierà chi costruisce su terreno vergine e penalizzerà chi recupera l’esistente, che le rendite fondiarie renderanno più conveniente espandersi, o che i piani urbanistici comunali continueranno a prevedere espansioni al posto di densificazioni sostenibili, i rapporti resteranno cronache di un declino annunciato. Serve un cambio radicale d’incentivi economici, fiscalità, cultura urbanistica e modelli di governance territoriale. La volontà politica, da sola, non basta. Occorre un intero sistema che smetta di guadagnare dalla distruzione e impari a prosperare dalla rigenerazione. (G. P.).
Se potessimo visualizzare le dispersioni termiche degli edifici, l’Italia apparirebbe diversa rispetto a cinque anni fa: dove dominava il rosso dello spreco, oggi emergono aree verdi di efficienza. Il VI Rapporto annuale sulla certificazione energetica degli edifici, presentato da Enea e Cti, documenta una trasformazione silenziosa, ma profonda del patrimonio immobiliare nazionale.
Nel residenziale, gli immobili nelle classi dalla A4 alla B raggiungono il 20% del totale, mentre quelli nelle classi dalla F alla G scendono al 45,3% (oltre due punti percentuali in dodici mesi). Riguardo al comparto non residenziale, gli edifici ad alta efficienza arrivano al 20%; quelli inefficienti si riducono al 30,9%, dal precedente 40,9%. È un segnale di cambiamento strutturale del parco edilizio.
Oltre 1,2 milioni di Attestati prestazione energetica (Ape) elaborati nel 2024 e archiviati nel sistema informativo SIAPE alimentano il più ampio database energetico nazionale: non semplici certificati, ma basi informative che consentono di diagnosticare criticità, definire interventi e monitorarne i risultati. Una base conoscitiva che permette a decisori pubblici, operatori e proprietari di orientare le scelte con dati comparabili e verificabili.
La svolta riguarda la qualità: l’introduzione di controlli legati alla coerenza nei dati a monte riduce le incongruenze e rende gli Ape più affidabili, tracciabili e utili per valutare scenari di riqualificazione e impatti ambientali. Passando da adempimento a strumento di supporto decisionale, la certificazione diventa un linguaggio condiviso tra progettisti, imprese, investitori e utenti finali.
Due innovazioni ridisegnano l’infrastruttura dei dati. Il Catasto energetico unico integra informazioni su impianti termici e attestati, anticipando la revisione normativa verso un’anagrafe energetica più completa. Il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici si arricchisce del Sistema esperto per la prestazione energetica (SEPE), un’interfaccia che orienta su incentivi, analisi costi-benefici e stima dei risparmi di CO2, traducendo la complessità in percorsi operativi.
Giorgio Graditi, direttore generale di Enea, inquadra la portata strategica: «Il settore edile italiano è al centro di una trasformazione strategica e il Rapporto pre -
sentato oggi evidenzia come la certificazione energetica sia oggi una leva strategica per migliorare la qualità del costruito e accelerare la transizione energetica». Il dirigente evidenzia la dimensione industriale: «per le imprese del settore questo Rapporto costituisce un punto di riferimento strategico per rispondere alla crescente domanda di interventi qualificati, alla necessità di soluzioni integrate e all’esigenza di strumenti informativi chiari e affidabili a supporto delle decisioni di investimento». Graditi attribuisce all’Ape una missione culturale: «è oggi chiamato a svolgere un ruolo sociale e cul - turale, in grado di informare, orientare scelte e contribuire alla diffusione di una vera cultura dell’energia che ci aiuterà ad affrontare con successo le sfide future».
Antonio Panvini, direttore generale del Cti, conferma il trend evolutivo: «l’edizione 2025 del Rapporto conferma la tendenza positiva
Nel residenziale le abitazioni virtuose

delle performance energetiche del parco immobiliare e il miglioramento della qualità degli Attestati di prestazione energetica». La precisione diventa essenziale: «gli Ape rappresentano uno strumento conoscitivo fondamentale per supportare le politiche nazionali di efficienza energetica, e proprio per rafforzarne l’affidabilità è in corso un continuo processo di affinamento dei sistemi di controllo e validazione dei dati». Il dirigente collega il percorso nazionale agli obiettivi europei: «il miglioramento della qualità degli Ape è un obiettivo strategico, soprattutto alla luce della nuova Direttiva EPBD, (Energy Performance of Buildings Directive) che richiederà requisiti più stringenti e una conoscenza sempre più precisa dello stato del patri - monio edilizio. Il Rapporto 2025 contribu -
isce in modo decisivo a questa conoscenza, offrendo una base solida per la definizione delle future politiche energetiche».
Il sondaggio Cti-Anaci su 1.500 amministratori di condominio evidenzia un divario tra sensibilità e attuazione: il 76,7% riconosce l’importanza dell’efficienza energetica, ma l’81,5% segnala barriere economiche e il 47,4% complessità burocratiche. Parallelamente, il quadro europeo va nella stessa direzione: la nuova EPBD richiede criteri più stringenti e una mappatura accurata del parco edilizio, in coerenza con l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Per allinearsi servono dati dettagliati e indicatori comparabili: in altri termini, una base dati ad alto livello di dettaglio che consenta diagnosi e interventi mirati.
La tecnologia abilita il salto di scala: dall’intelligenza artificiale per l’analisi dei consumi ai gemelli digitali (repliche virtuali) per simulare gli interventi di riqualificazione, fino a piattaforme interoperabili che trasformano gli Ape da istantanee statiche in basi informative dinamiche per manutenzioni predittive e ottimizzazione in tempo reale. Non più fascicoli cartacei, ma infrastrutture di dati connessi.
L’evoluzione del costruito è guidata dai numeri: l’efficienza come requisito, non come opzione. Gli edifici tendono a diventare nodi attivi della rete, capaci di produrre, accumulare e scambiare energia. Un’evoluzione che procede, trasformando il “mattone” da consumatore passivo a risorsa della transizione ecologica. (G. P.).
virtuose toccano il 20% e le energivore scendono al 45,3%; nel non residenziale A4-B al 20% F-G giù al 30,9%, dieci punti in meno in un anno


La produzione agricola è legata anche alle differenze di temperatura tra Nord e Sud: i prodotti più convenienti
Siamo in autunno inoltrato, ormai, ed è il clima a stabilire i prezzi della spesa. Già, la differenza di temperatura tra Nord e Sud si ripercuote inevitabilmente anche sulla produzione agricola. Se al Settentrione la colonnina di mercurio già strizza l’occhio al Natale, nel Mezzogiorno c’è anche chi è riuscito a ritagliarsi un’ultima giornata di sole e relax al mare.
Quando la disparità di clima è così marcata, anche il raccolto cambia di zona in zona. Ed è proprio l’aspetto che emerge dal servizio settimanale della Borsa della Spesa, realizzato da
BMTI (Borsa Merci Telematica Italiana) e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No Profit, che suggerisce quali sono le opportunità da cogliere per una spesa conveniente e nello stesso tempo sostenibile. In questa fase dell’anno a essere favorita è soprattutto la produzione di ortaggi, da cui deriva un calo generale dei prezzi.
Per quanto riguarda la frutta di stagione, invece, non essendo ancora decollata la domanda, anche i prezzi all’ingrosso tendono al ribasso. Esempio perfetto è l’uva da tavola, che costa addirittura il 44% in meno rispet-
to all’anno scorso. Oggi è possibile trovarla a un prezzo che si aggira da 1,30 a 2,20 euro al chilogrammo.
Nei primi giorni del mese di novembre, anche per via della festa di Halloween, si è registrata un’alta disponibilità di zucche (-17% in confronto al 2024), utilizzate sia per decorazioni sia per piatti tipici. A prezzi più bassi rispetto allo scorso anno è possibile trovare le castagne: la pezzatura più grande si attesta sui 4,50 euro/kg, quella piccola si aggira sui 3,50 euro/kg. E passiamo alle mele. Buona la disponibilità, soprattutto della varietà Fuji con quotazioni intorno a 1,70 euro al chilogrammo. Si tratta di un tipo mela tondeggiante dalla buccia che presenta un fondo verde-giallo chiaro e sovraccolore rosso-rosato o rosso-scuro: ha un sapore croccante e dolce e in Italia è prodotto in diverse regioni del Settentrione, dal Piemonte al Trentino Alto Adige passando per l’Emilia Romagna. Aumenta la produzione di melograno, di conseguenza i prezzi scendono (circa 2,20 euro al chilo). In calo per via delle temperature ancora miti che ne favoriscono la coltura anche il cavolo nero (1,40 euro/kg) e le cime di rapa (1,30 euro/kg), per cui si è registrato un -21,6% rispetto ai prezzi del 2024. Conviene sicuramente approfittarne, viste le proprietà benefiche che contengono. Il cavolo nero, verdura tipica della Toscana e ingrediente essenziale della ribollita, è ricco di polifenoli, flavonoidi e vitamine A, C e K, grazie ai quali contrasta lo stress ossidativo e i radicali liberi, aiutando a prevenire l’invecchiamento cellulare. Ma non solo: l’alto contenuto di vitamina C e betacarotene si rivela un validissimo alleato delle difese immunitarie.
Come spiegato dalla biologa nutrizionista Anna Maria De Santis, le cime di rapa contengono minerali importanti come il potassio, il fosforo e il calcio, con quest’ultimo che è molto importante per la salute delle ossa. (D. E.).

Scarica il Giornale dei Biologi
dall’area riservata MyBio
Ogni mese riceverai crediti Ecm in autoformazione e Fad

Grazie alla tecnica dell’elettrofilatura i rifiuti biologici vengono trasformati in materiali “intelligenti”
La crescente pressione ambientale e la necessità di ridurre la dipendenza da risorse fossili stanno spingendo la ricerca verso soluzioni tecnologiche in grado di valorizzare i rifiuti organici. In questo contesto, l’elettrofilatura si sta configurando come una tecnica molto promettente per la trasformazione degli scarti agroalimentari in materiali avanzati e biodegradabili.
Il processo è basato sull’applicazione di un campo elettrico ad una soluzione polimerica, e consente di ottenere delle nanofibre con diametri inferiori al micron, caratterizzate da
elevata porosità, leggerezza e versatilità chimica. Le fibre, infatti, possono essere impiegate in ambiti strategici come la sensoristica ambientale, il packaging sostenibile, la filtrazione selettiva e la medicina rigenerativa. Le ricerche condotte dal CNR-IIA, in collaborazione con CREA, Università della Tuscia e CNR di Bari, hanno dimostrato la possibilità di impiegare sottoprodotti come bucce di frutta, siero di latte o alghe infestanti per generare dei biopolimeri adatti all’elettrofilatura.
Gli scarti, ricchi di polisaccaridi, proteine e polifenoli, offrono una
base chimica versatile per la produzione di fibre “funzionali”. Il progetto TERRE ha evidenziato, ad esempio, come le fibre ottenute dagli scarti agricoli possono essere integrate in sensori per il monitoraggio del suolo e della qualità dell’aria, contribuendo perfino alla digitalizzazione sostenibile dell’agricoltura. Altri studi hanno dimostrato che le fibre “elettrofilate” dalle proteine del siero di latte, dotate di proprietà antimicrobiche, sono adatte alla realizzazione di membrane bioattive, mentre quelle derivate da scarti vegetali, in grado di rilevare composti volatili, possono essere utilizzate per la creazione di sensori indossabili. L’Europa considera la bioeconomia circolare una leva strategica per ridurre le emissioni di CO2 e quindi promuovere l’uso efficiente delle risorse. L’Italia, pur essendo tra i leader europei per tasso di riciclo, presenta margini di miglioramento molto ampi per quel che riguarda la circolarità dei processi produttivi.
L’elettrofilatura potrebbe contribuire a colmare questo divario, poiché offre una via per la reimmissione dei rifiuti biologici nel ciclo industriale. Dunque, le sfide future saranno l’ottimizzazione dei protocolli di estrazione dei biopolimeri, la standardizzazione dei processi, la loro integrazione su scala industriale e, in ultimo, lo sviluppo di sistemi di raccolta e pretrattamento degli scarti, i quali devono garantire la qualità e la “continuità” della materia prima. Ma il primo necessario faticoso passo sarà la promozione di politiche di incentivazione e trasferimento tecnologico, affinché le imprese adottino queste soluzioni. In conclusione, l’elettrofilatura degli scarti agroalimentari è una tecnica che concretamente riesce a coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e rigenerazione economica, e potrebbe contribuire notevolmente alla transizione verso un’economia circolare.
Nell’immaginario collettivo dell’essere umano, probabilmente da che questi ne ha memoria, i grandi felini sono associati a una serie di “valori” come la forza, il coraggio o la regalità, in virtù della loro natura di feroci predatori. Eppure, essere grandi o feroci, non sempre significa essere i migliori. Nelle foreste tropicali, infatti, il piccolo pipistrello dalle labbra frangiate (Trachops cirrhosus) ha dimostrato al mondo come la sua strategia di caccia sia ben più efficace e letale di quella dei suoi più apprezzati colleghi.
Uno studio, condotto dall’Università di Aarhus insieme allo Smithsonian Tropical Research Institute e pubblicato sulla rivista Current Biology, ha spiegato come la tecnica del piccolo mammifero che abbina pazienza a sensi sopraffini, abbia un tasso di successo molto superiore rispetto a quello dei grandi carnivori. I dati raccolti dall’osservazione degli studiosi raccontano di una percentuale di riuscita del 50%, a fronte del 14% dei leoni e del 2% dei grandi orsi polari.
In cosa consiste, quindi, la formidabile strategia di Trachops cirrhosus? Innanzitutto, al contrario di ciò che volgarmente si può pensare, non è un pipistrello che vola incessantemente alla ricerca di cibo, anzi: questo esemplare trascorre l’89% del tempo aspettando, silenzioso, nascosto, tra le fronde, un rumore o un fruscio, per poi essere pronto a piombare sulla preda con tempismo e precisione chirurgica. L’agguato paziente è anche una tattica tipica dei felini, che permette ai predatori di risparmiare energia e di ridurre i rischi. Ma la sua straordinaria efficienza deriva anche da altri due fattori: l’udito finissimo, grazie al quale distingue i richiami delle prede (le rane, per esempio, delle quali riesce a riconoscere persino i richiami autentici da quelli “falsi”), e la letale capacità di

Uno studio rivela come la specie Trachops cirrhosus supera i grandi felini nelle strategie di caccia
adattarsi a diverse tipologie di prede. Esse possono infatti raggiungere anche il 7% del suo peso corporeo, e, in alcuni casi, le dimensioni del predatore stesso. Parafrasando Sun Tzu, si potrebbe dire che le sue prede, grazie alle abilità di calcolo e alla pazienza del piccolo chirottero, siano spacciate ancor prima che inizi la sua caccia. Il confronto di Trachops cirrhosus con i grandi carnivori mette in luce un paradosso biologico: i piccoli predatori, che dovrebbero puntare a prede facili, hanno sviluppato tecniche raffinate per catturare animali di dimensioni considerevoli. Ciò ribalta
le gerarchie del regno animale, nonché l’idea che l’efficienza predatoria sia proporzionale alla forza fisica. L’evoluzione, ci dimostra, quindi, come siano premiate anche la pazienza e l’uso intelligente dei sensi. Gli autori dello studio hanno sottolineato come l’osservazione della foresta «attraverso le orecchie dei pipistrelli» abbia rivelato un mondo nascosto di strategie invisibili all’occhio umano. Un invito che deve portarci a ripensare la nostra percezione dei pipistrelli, spesso associati a paure e superstizioni, ma in realtà protagonisti di un equilibrio ecologico sofisticato. (M. O.).

Il “grande serpente metallico” promette sviluppo al costo di deforestazione, disuguaglianze e minacce alla biodiversità
Il Tren Maya, la grande infrastruttura ferroviaria che attraversa la penisola dello Yucatán, è stato presentato dal governo messicano come un progetto di giustizia sociale e di rilancio economico. Con oltre 1500 chilometri di binari, 34 stazioni e un costo stimato vicino ai 30 miliardi di dollari, il treno dovrebbe collegare siti archeologici, aeroporti e località turistiche, portando lavoro e opportunità in una delle regioni più povere del Paese.
Ma dietro la retorica dello sviluppo si nasconde un impatto ambientale e sociale di proporzioni enormi.
Come ha raccontato il naturalista
Andrea Monaco su Il Tascabile, il progetto è molto più di una linea ferroviaria: è un riordinamento territoriale che include resort, centri commerciali e poli di sviluppo da 50mila abitanti ciascuno. Un modello di trasformazione «estrattivista», che privilegia interessi economici e turistici rispetto ai diritti delle comunità locali e alla tutela della natura. Dal punto di vista ambientale, il tracciato attraversa la seconda foresta pluviale più grande dell’America Latina e la Grande falda acquifera Maya, un sistema di fiumi sotterra -
nei che garantisce acqua potabile a milioni di persone.
La costruzione ha già comportato la deforestazione di migliaia di ettari e la frammentazione degli habitat, con conseguenze gravi per le specie che li abitano. Inoltre, i cenotes, le cavità carsiche considerate sacre dai Maya, rischiano di essere danneggiati irreversibilmente. Secondo il Tribunale internazionale per i diritti della natura il progetto rappresenta una violazione dei diritti bioculturali, nonché un possibile ecocidio, mentre sul piano sociale le promesse di sviluppo si scontrano con una realtà fatta di espropri, gentrificazione e marginalizzazione delle popolazioni indigene. Molti benefici economici finiranno nelle mani dei grandi operatori turistici, a discapito delle comunità locali che rischiano di perdere la loro terra e, quindi, la loro identità culturale.
Oltretutto, il processo di consultazione pubblica è stato giudicato insufficiente e poco trasparente, poiché al referendum per l’approvazione del Tren Maya ha votato meno dell’1% degli aventi diritto. Il caso dell’infrastruttura messicana è paradigmatico: le grandi opere in nome del “progresso”, quando provengono da politiche “dall’alto”, finiscono troppo spesso per diventare meri strumenti di consenso politico e profitto privato, lasciandosi dietro un’eredità fatta di conflitti, disuguaglianze e danni permanenti al patrimonio naturale.
Il nuovo governo messicano ha annunciato misure di compensazione e piani di ripristino ambientale, ma resta da capire se queste azioni avranno la concretezza necessaria per riparare le perdite già registrate. Il convoglio che attraversa lo Yucatán non è soltanto un’infrastruttura ferroviaria, ma il simbolo di un modello di sviluppo che sacrifica giustizia sociale e sostenibilità ambientale in ossequio alla crescita economica. (M. O.).


La ricerca è stata pubblicata
su Nature Cardiovascular Research
Uno studio internazionale, coordinato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche- Unità di Firenze, può contribuire alla comprensione del legame tra l’insorgenza di aritmie cardiache e le fibrosi. Si tratta di quel processo, comune a molte cardiopatie, di sostituzione delle cellule muscolari cardiache con tessuto connettivo. La ricerca ha beneficiato di un protocollo ottico avanzato di clearing dei tessuti e un microscopio a foglio di luce mesoscopico, grazie al quale il team di ricercatori ha ricostruito in 3D l’intera
struttura dei ventricoli, identificando con precisione le zone fibrotiche e la loro relazione con i cardiomiociti circostanti. È emerso, a seguito dell’integrazione di questi dati con modelli computazionali, che la fibrosi non è un tessuto “inerte”, ma può promuovere un anomalo accoppiamento elettrico tra cellule muscolari e fibroblasti, creando così il substrato per aritmie da rientro.
Leonardo Sacconi, del Cnr-Ifc e coordinatore dello studio, ha spiegato: «Finora non era chiaro come questo rimodellamento influisse sulla conduzione elettrica e sulla predisposizione
alle aritmie. Questa tecnica innovativa, che combina la mappatura elettrofisiologica del cuore con ricostruzioni tridimensionali ad alta risoluzione, ci ha permesso di osservare che le aree fibrotiche si comportano come una sorta di filtro: permettono la normale conduzione elettrica a frequenze fisiologiche, ma bloccano o rallentano la propagazione a frequenze elevate, come quelle che si verificano durante condizioni di stress o tachicardia». Il ricercatore ha poi proseguito: «Abbiamo così dimostrato che non basta conoscere la struttura del cuore per prevedere il rischio aritmico: è fondamentale integrare anche i processi di rimodellamento elettrofisiologico che si verificano nelle zone fibrotiche». Questo lavoro certamente rappresenta un risultato di grande impatto scientifico della nuova Unità di Ricerca presso Terzi (URT) OptoCARD del Cnr-Ifc attiva all’interno dell’Università di Firenze in stretta collaborazione con la professoressa Elisabetta Cerbai, ordinario di Farmacologia dell’ateneo fiorentino. Inoltre, è frutto di una vasta collaborazione di ricerca internazionale, che ha visto lavorare insieme ricercatori e ricercatrici dell’Università di Friburgo, King’s College London, Università di Padova, Florida State University, Politecnico di Milano, Karlsruhe Institute of Technology, Università di Firenze, University of Connecticut, e Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari.
Lo studio apre la strada anche a nuovi modelli predittivi “personalizzati” (digital twin) per la valutazione del rischio aritmico nei pazienti e per l’orientamento verso strategie terapeutiche mirate, incluse quelle di medicina di precisione e le terapie geniche di nuova generazione: un approccio che il ricercatore porta avanti anche con il progetto HeartCORE, vincitore nel giugno 2025 di un ERC Advanced Grant per il suo elevato impatto di innovatività.
Grazie alla collaborazione tra ENEA e l’Università di Salerno, sono state messe a punto nuove tecnologie per la pelatura industriale dei pomodori, in grado di ridurre i consumi di energia termica fino al 50%. La ricerca è stata condotta in un’azienda in provincia di Salerno che lavora circa 60mila tonnellate di pomodori all’anno e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Sustainabily. Si tratta di una valutazione comparativa degli impatti energetici, economici e ambientali tra i metodi di pelatura tradizionali e tre tecnologie innovative come infrarossi, ultrasuoni e riscaldamento ohmico.
Giovanni Landi, ricercatore del Laboratorio ENEA Soluzioni integrate per l’efficienza energetica e coautore dello studio insieme alla collega Miriam Benedetti e a Gianpiero Pataro ed Elham Eslami del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno, ha spiegato: «Nell’industria di trasformazione del pomodoro, le tecniche di pelatura più diffuse sono ancora quelle a vapore e con la liscivia, apprezzate per la loro efficienza operativa e la facilità di utilizzo nei medi e grandi impianti».
Sebbene la pelatura a vapore rappresenti un’alternativa più ecologica rispetto a quella chimica, può produrre frutti più molli, con minore consistenza e maggiore perdita di prodotto (15% rispetto al 13,6%). Inoltre, entrambi i metodi comportano un elevato consumo di energia e di acqua e generano ingenti volumi di acque reflue che, nel caso della pelatura chimica, sono anche inquinate.
Landi ha proseguito: «Per rispondere a queste criticità, la ricerca si sta orientando verso tecniche di pelatura innovative e sostenibili capaci di migliorare l’efficienza, la resa e la qualità del prodotto e ridurre al minimo gli sprechi e impatto ambientale. Le soluzioni che proponiamo in questo studio rappresentano valide alterna-

Nuove e più efficienti tecnologie per la pelatura industriale
Abbattuti i consumi nel settore
tive o “complementi” alle tecniche tradizionali, aprendo la strada a una trasformazione dell’industria agroalimentare più efficiente e sostenibile».
Lo studio dimostra che l’adozione dei nuovi metodi di pelatura migliora il grado di “pelabilità” dei pomodori con un aumento della capacità produttiva (2,6-9,2%) e una riduzione dello scarto (16%-52%) rispetto alle tecniche tradizionali. Sul fronte ambientale la pelatura mediante tecnologia a infrarosso (IR), detta anche “pelatura a secco”, risulta il metodo più ecocompatibile perché riduce l’uso di energia elettrica e termica, grazie alle radiazioni infra-
rosse che riscaldano rapidamente la superficie del prodotto, favorendo il distacco della buccia senza ricorrere all’uso di acqua o sostanze chimiche. Questo trattamento evita la produzione di acque reflue e risulta più veloce, meno dispendioso e con un ridotto spreco di pomodoro (9,8%).
Il ricercatore ha sottolineato: «Nonostante i vantaggi economici ed ambientali di queste nuove tecnologie di pelatura, persistono criticità legate alla temperatura dell’emettitore IR, la distanza tra il prodotto e la sorgente di calore e il tempo di esposizione». (P. S.).

Una nuova metodologia per stendere in modo conveniente ed efficace spessi strati di materiali d’interesse
Il Laboratorio Superconduttività di ENEA, in sinergica collaborazione con ricercatori dell’Università Roma Tre, nell’ambito di un progetto che è stato finanziato da Eurofusion, poi proseguito nel progetto INFN SUPERMAD, ha messo a punto una nuova metodologia che permette di stendere in modo semplice, veloce e a basso costo, spessi strati di materiale superconduttore per la preparazione di nastri superconduttori di nuova concezione.
Laura Piperno, ricercatrice del Laboratorio ENEA di Superconduttività e inventrice con Andrea Masi del nuo-
vo processo, ha spiegato: «Il nostro studio è partito dalla comprensione dei fenomeni che avvengono durante l’elettrodeposizione, una tecnica chimica versatile e a basso costo che consente di depositare, velocemente e in condizioni standard di laboratorio, strati più o meno spessi del materiale di interesse. Inoltre, sfrutta semplici soluzioni acquose e può essere utilizzata su elettrodi delle più svariate forme e dimensioni. Tuttavia, abbiamo appurato che dopo l’elettrodeposizione il materiale risultava troppo granulare per essere superconduttore, per cui è stato necessario introdurre
un trattamento termico per eliminare le impurezze». Ricordiamo, che l’elettrodeposizione è un processo elettrochimico (noto anche come galvanostegia) che consiste nel rivestire un oggetto metallico con un sottile strato di un altro metallo tramite deposizione elettrolitica. Il processo richiede di immergere il pezzo da rivestire, collegato al polo negativo (catodo), in una soluzione contenente ioni del metallo da depositare.
Il primo impianto di elettrodeposizione moderno iniziò la produzione nel 1876 e fu inizialmente chiamato Norddeutsche Affinerie di Amburgo. Man mano che la scienza alla base del metodo cresceva, la sua adozione aumentava costantemente fino a raggiungere oggetti di placcatura su larga scala e applicazioni manifatturiere e ingegneristiche specifiche. L’arrivo dei generatori elettrici alla fine del XIX secolo diede un grande impulso all’industria della placcatura, rendendo disponibili correnti più elevate da applicare a vari componenti metallici in grandi volumi. I diversi processi di elettrodeposizione comprendono l’incisione, la deposizione elettrochimica, l’elettrodeposizione a impulsi, l’elettrodeposizione a pennello e l’elettrodeposizione.
Questo nuovo procedimento per la crescita di materiali superconduttori si presta alla preparazione di campioni di geometria complessa, ma anche come valida alternativa ai metodi attualmente in uso, che necessitano di condizioni molto controllate e di strumentazioni complesse poco adatte ad essere trasferite alla produzione su larga scala.
La studiosa Laura Piperno ha così concluso: «Al momento il metodo utilizzato per la crescita di superconduttori è ancora al livello di ricerca di base, ma potrebbe rappresentare già un’opportunità per quelle applicazioni le cui tecniche attualmente in uso non possono essere sfruttate per la forma e la dimensione dai campioni da creare». (P. S.).
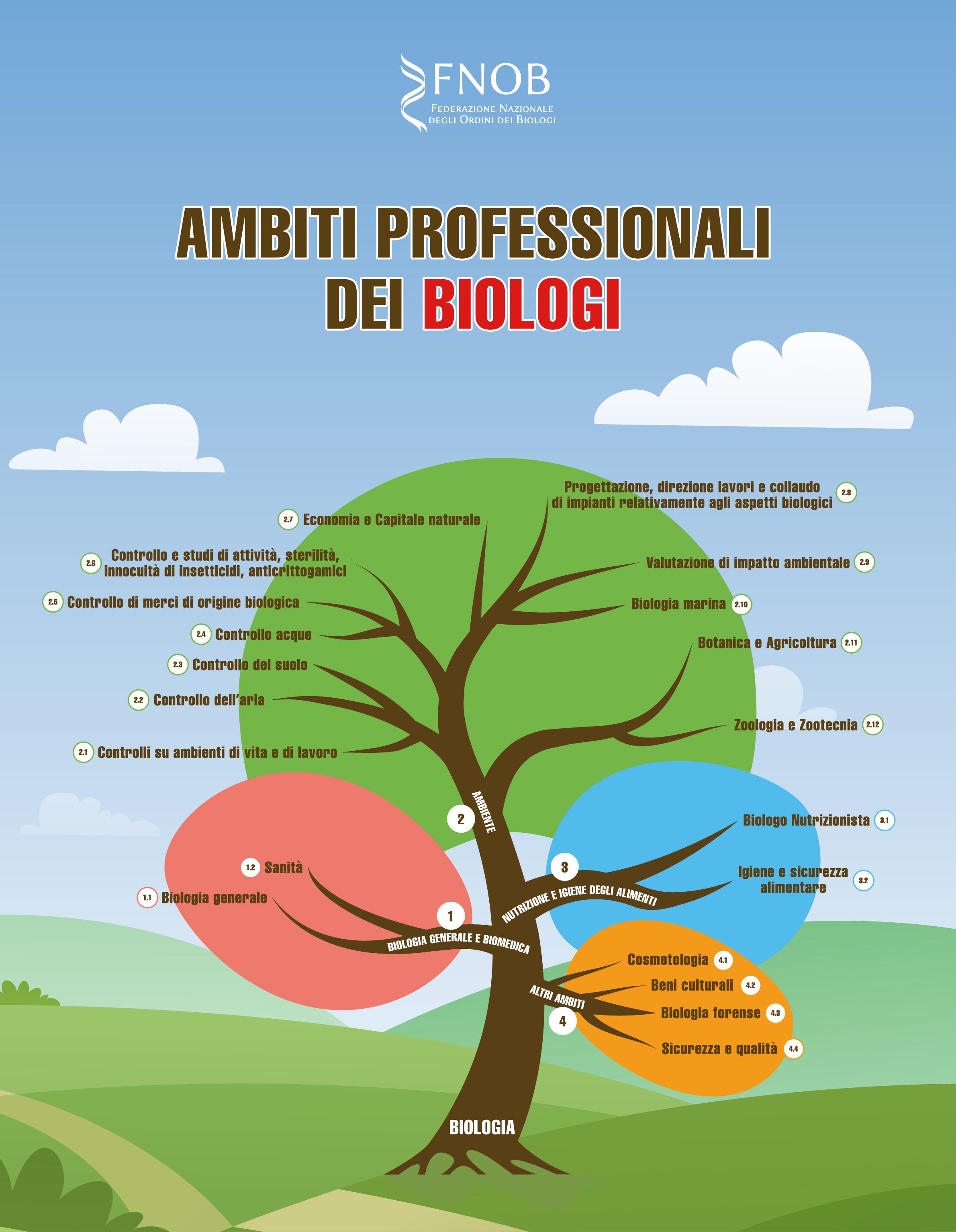

Il 27 marzo 2026 l’annuncio della città che raccoglierà il testimone da Pordenone Progetti e dossier da nord a sud: alla prescelta un contributo da un milione di euro
Quale sarà la Capitale italiana della Cultura 2028?
Entra nel vivo la corsa che porterà, il prossimo 27 marzo, alla proclamazione della città vincitrice che raccoglierà il testimone da Pordenone, selezionata per il 2027. Una prima scrematura è stata fatta lo scorso 25 settembre, con l’ammissione di 23 città e Unioni di Comuni alla procedura di selezione, che avrà un’altra data importante nel 18 dicembre, quando verranno scelte le dieci finaliste, le città che proseguiranno il loro percorso attraverso audizioni pubbliche e presentazioni ufficiali, rispondendo alle domande e agli interrogativi della giuria. L’iter promozionale si concluderà il 12 marzo 2026: seguiranno appunto quindici giorni in cui la Commissione giudicante si riunirà per prendere la sua decisione e indicare al Ministero della Cultura la città (o l’insieme di cittadine) ritenuta più idonea per l’efficacia del progetto, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, il rafforzamento dell’identità del territorio coinvolto.
Ognuna delle località candidate ha la possibilità di presentare un progetto della durata di un anno, corredato da uno specifico cronoprogramma e da un accurato piano economico-finanziario che garantisca la sostenibilità delle iniziative illustrate. A valutare i dossier, una commissione ad hoc e indipendente costituita da sette esperti nei settori della cultura, dell’arte e della valorizzazione territoriale. La città premiata come Capitale italiana della Cultura riceverà un contributo di un milione di euro, destinato a realizzare compiutamente il progetto illustrato.
Una realizzazione che non si esaurisca al 2028, ma capace di avere un impatto duraturo sia in termini culturali sia sociali. Insieme alla scelta della Capitala italiana della Cultura, il Ministero ha lanciato - attraverso il Dipartimento per le Attività culturali - anche
la corsa a Capitale italiana del Libro, assegnata di anno in anno a una città impegnata nella promozione della lettura e dell’editoria, e quella a Capitale italiana dell’arte contemporanea.
Ma quali sono le città in gara? Eccole, da nord a sud. Il Piemonte scende in campo con Moncalieri, in provincia di Torino, e il suo progetto «La periferia fa centro». Per la Lombardia c’è Rozzano, in provincia di Milano, col dossier «La cultura oltre i luoghi comuni». Due le candidature per il Veneto: Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, presenta il progetto «Io Siamo» mentre Valeggio sul Mincio, nel Veronese, propone il dossier «Coltiviamo le persone». La Liguria si concentra su Sarzana, in provincia di La Spezia, in gara con «L’impavida. Crocevia del futuro», mentre sono tre le candidature per la Toscana: Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena, con «Colle28. Per tutti, dappertutto», Fiesole, alle porte di Firenze, con «Dialoghi tra terra e cielo» e Massa con «La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia». L’Emilia Romagna è in gara con Forlì e la sua iniziativa denominata «I sentieri della bellezza». Ancona, capoluogo delle Marche, presenta invece il suo progetto «Ancona. Questo adesso».
Tre le candidature per il Lazio. Anagni, in provincia di Frosinone, si rifa alle sue radici italiche con «Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce», Pomezia, in provincia di Roma, punta sul dossier «Dal mito di Enea alle città di fondazione» mentre Tarquinia, in provincia di Viterbo, presenta «La cultura è volo». Ben cinque le proposte dalla Campania. Bacoli, in provincia di Napoli, ci prova con «Il futuro parte da una scossa», Benevento con «Attraversare l’invisibile», Mirabella Eclano (provincia di Avellino) con «L’Appia dei popoli», Sala Consilina (Salerno) con «Un ponte tra storia e futuro» e l’Unione dei Comuni della Città Caudina con «Terra futura. Eu-

Ognuna delle località candidate ha la possibilità di presentare un progetto della durata di un anno, corredato da uno specifico cronoprogramma e da un accurato piano economico-finanziario che garantisca la sostenibilità delle iniziative illustrate. La città premiata come Capitale italiana della Cultura riceverà un contributo di un milione di euro, destinato a realizzare compiutamente il progetto illustrato
ropa abita qui». Puglia in gara con la leccese Galatina e il suo dossier «Il sogno dei luoghi», la barese Gravina con «Radici al futuro» e la foggiana Vieste con «L’anima bianca della Puglia». La candidatura della Calabria è quella di Gioia Tauro, in provincia di Reggio, col suo progetto «La cultura è Gioia» mentre per la Sicilia c’è Catania con «Catania continua».
La storia delle città premiate è abbastanza recente, visto che si tratta di un titolo istituito soltanto nel 2015. Le prime Capitali italiane della Cultura sono state Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. Nel 2016 è stata selezionata Mantova, nel 2017 Pistoia e nel 2018 Palermo. Nel 2021 è stata la volta di Parma, nel 2022 di Procida, nel 2023 di Bergamo e Brescia e nel 2024 di Pesaro. Il 2025 è stato l’anno di Agrigento, che sta portando a termine le ultime fasi del suo progetto «Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali», mentre nel 2026 toccherà a L’Aquila con «Città Multiverso». Per il 2027, infine, la capitale sarà Pordenone col suo dossier «La cultura fiorisce». Curiosità: tra le 23 candidature in lizza, sette sono espressione di quattro regioni finora mai premiate: una per il Piemonte, due per il Veneto, una per la Liguria e tre per il Lazio. (R. D.).

Jannik Sinner campione delle Atp Finals di tennis. L’Italia vincitrice della Coppa Davis, la Coppa del Mondo a squadre maschile, malgrado le assenze del suo fenomeno e del n. 2 azzurro Lorenzo Musetti.
È stato un mese di novembre da incorniciare per il tennis italiano, che ha concluso in bellezza un 2025 memorabile, fra titoli Slam maschili e misti e successi indimenticabili anche in campo femminile. È mancato solo il n. 1 di Sinner in classifica Atp. Ma con tre mesi di stop per la vicenda Clostebol, chiudere l’anno a soli 550 punti dall’amico-rivale Carlos Alcaraz (11.500 contro 12.050)che ha vinto otto torneoi nel 2025 - è un risultato emblematico.
L’atto decisivo delle Nitto Atp Finals è stato quello che tutti attendevano. Jannik Sinner è arrivato alla finale senza perdere un set, regolando nel gruppo “Bjorn Borg” i vari Alexander Zverev, Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime in due set e riservando lo stesso trattamento ad Alex De Minaur (7-5, 6-2) in semifinale. De Minaur, che è passato come secondo nel gruppo “Jimmy Connors”
vinto da Carlos Alcaraz, malgrado la sconfitta dell’australiano con l’altro italiano, Musetti.
Sinner e Alcaraz avevano vinto due Slam a testa, quest’anno: gli Australian Open e Wimbledon erano andati a Jannik, il Roland Garros e gli Us Open a Carlos. Melbourne a parte, tre finali su quattro li hanno visti l’uno di fronte all’altro. Le Nitto Atp Finals valevano quasi come una “bella”. L’ha spuntata il campione altoatesino per 7-6 (4) 7-5, dopo 2 ore e 15 minuti di grande tennis, prolungando la serie positiva a livello indoor a 31 match consecutivi: l’ultimo ko proprio a Torino, nel 2023, in finale con Djokovic.
Rubino/shutterstock.com
© Marco

L’atto decisivo delle Nitto Atp Finals è stato quello che tutti attendevano. Jannik Sinner è arrivato alla finale senza perdere un set
In finale l’italiano ha dovuto annullare un set point sul 5-6, 30-40, affidandosi a una gran seconda di servizio. Poi ha allungato in maniera autoritaria nel tie-break, vinto 7-4. Di contro, Alcaraz ha ottenuto un break a inizio secondo set, ma Sinner ha risposto andando sul 3-3 malgrado un calo vistoso della prima di servizio. Partiti serratissima in ogni gioco, poi sul 6-5 è arrivato improvviso il match point che Sinner non ha fallito, facendo impazzire di gioia Torino e tutta l’Italia sportiva.
Sinner campione delle Atp Finals, Sinner orgoglio nazionale. Eppure anche i campioni hanno “pagliuzze” pronte a essere ingigantite da invidia e populismo. Così la conferma dell’annunciata assenza del numero 2 mondiale per la Coppa Davis ha scatenato la solita pletora di commenti indignati e spesso disinformati. Oltre a essere riferimento per il movimento, Jannik si è tuttavia rivelato anche profeta: «La possibilità di vincere è alta». Certo, la rinuncia di uno stremato Musetti aveva ridotto ulteriormente le chance dell’Italia di conquistare il trofeo per il terzo anno di fila, il quarto in assoluto. Ma alle Final Eight di Bologna è emersa tutta la profondità della squadra azzurra. Non a caso l’Italia ha due giocatori in Top 10, quattro nei primi 26 al mondo e otto nei primi 100. Il capitano Filippo Volandri ha convocato i singolaristi Flavio Cobolli (n. 22 Atp) e Matteo
Berrettini (n. 56), con Lorenzo Sonego (n. 39) riserva, e gli specialisti del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Nella formula attuale, ogni turno di coppa si disputa su tre partite, due singolari più eventuale doppio di spareggio. L’Italia, però, ha rivinto il trofeo senza perdere neppure un singolare. A partire dal quarto di finale con l’Austria: Berrettini ha battuto per 6-3, 7-6(4) Jurij Rodionov, mentre Cobolli ha lasciato pochi spiccioli a Filip Misolic imponendosi a sua volta in due set 6-1, 6-3. È dalle semifinali, però, che le emozioni sono aumentate in maniera esponenziale. Tanto da preallertare e mandare a scaldare gli specialisti del doppio. Matteo Berrettini è rimasto fedele alle abitudini, superando in due set (6-3, 6-4) Raphael Collignon e portandoci sull’1-0 col Belgio. Poi è toccato ai numeri 1 delle rispettive squadre, Flavio Cobolli e Zizou Bergs. Di prepotenza, l’azzurro ha colto un break nel quarto game e vinto il primo set. Il belga si è preso il secondo, al tie-break. Bergs ha annullato due match point nel terzo e lì i due hanno inscenato uno dei tie-break più palpitanti della storia della Coppa Davis: alla fine, dopo 7 palle-match a testa e uno stillicidio di emozioni, l’ha spuntata Cobolli.
La finale ha opposto Spagna e Italia, capaci di eliminare tutte le rivali malgrado l’assenza del numero 1 mondiale Alcaraz da un lato, del 2 (Sinner) e dell’8 (Musetti) dall’altro. Copione simile alla semifinale. Un solidissimo Berrettini si è sbarazzato in due set (6-3, 6-4) dell’ex Top 10 Pablo Carreño Busta. Poi Cobolli ha dovuto dar fondo a tutte le proprie risorse tecniche e caratteriali per rimontare uno Jaume Munar a tratti irreale.
Dopo più di tre ore, Flavio l’ha spuntata col risultato di 1-6, 7-6, 7-5, dando il via alla festa-show nella Supertennis Arena di Bologna. Tre Davis di fila, in epoca moderna, non le aveva mai vinte nessuno. E considerato che da due anni l’Italia è anche regina in Billie Jean King Cup, l’omologa competizione femminile, si può dire che il movimento tennistico italiano non è mai stato così forte.

lettera alla Ariarne bambina, la 25enne australiana Titmus ha annunciato l’addio al nuoto professionistico per godersi nuovi obiettivi. I casi di Stoner, Barty e Schurrle
«Te ne vai senza rimpianti. Sei soddisfatta, contenta e felice. Ciò che ti aspetta è emozionante. Nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stessa e non il tuo sport. Assicurati di goderti ogni momento, grande o piccolo». Lo ha scritto Ariarne Titmus, 25enne stella del nuoto, nella lettera a se stessa bambina con la quale ha annunciato al mondo il ritiro dall’attività agonistica. Quattro volte olimpionica, sei volte iridata fra vasca lunga e corta, l’australiana ha detto “basta” dopo diciotto anni in piscina e dieci in Nazionale. Così giovane, così veterana: prima di lei lo avevano fatto altri due grandi campioni del nuoto come Ian Thorpe e Melissa Franklin, ma anche stelle di altri sport come Ashleigh Barty (tennis), Casey Stoner (moto), Nico Rosberg (auto) e calciatori di classe e fama come Marco Van Basten e Michel Platini.
«I sogni che avevi si sono avverati tutti. Gli amici che hai conosciuto sono per la vita. Hai ottenuto più di quanto avresti mai pensato di essere capace e dovresti essere così orgogliosa» ha scritto nelle prime righe della lettera Arianne, ricordando le «persone incredibili» che le hanno permesso di raggiungere i suoi obiettivi, dagli allenatori ai tifosi, passando per staff, compagni, rivali, sponsor, amici e famiglia. A cominciare dal padre e la madre che sacrificarono tutto per seguirla, a 14 anni. «Credimi, il tempo vola».
Nel nuoto, del resto, si diventa grandi già da giovanissimi. Sacrificando spesso gran parte dell’adolescenza per inseguire i propri sogni sportivi. Comprensibile, quindi, che soprattutto ad alti livelli si
senta il bisogno di “normalità” o perlomeno di altre gratificazioni. A 14 anni era stato convocato per la prima volta in Nazionale Ian Thorpe, anch’egli australiano, cinque volte d’oro e otto volte a medaglia alle Olimpiadi, 16 volte campione del mondo. Aveva deciso di salutare il nuoto dopo Pechino 2008, salvo poi essere costretto ad anticipare l’addio di due anni, quando ne aveva ancora 24, a causa di problemi di salute che ne condizionarono pesantemente la preparazione all’annunciata “last dance”. Tornato in vasca nel 2011, mancò la qualificazione alle Olimpiadi dell’anno successivo.
Londra 2012 furono invece i Giochi di Melissa “Missy” Franklin, 17enne statunitense che portò a casa quattro titoli e una medaglia di bronzo, consacrandosi sul palcoscenico più suggestivo. Ancora meglio l’anno dopo, ai Mondiali di Barcellona con tre medaglie d’oro individuali e tre nelle staffette: l’atleta più medagliata dell’intera manifestazione. Complessivamente fra il 2011 e il 2015, è stata campionessa del mondo per 11 volte. Opaca ai Giochi di Rio, si è fermata per problemi alle spalle subito dopo, senza mai riuscire a venirne a capo. E nel 2018, a 23 anni, in una lettera all’emittente televisiva americana Espn, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. Nessun acciacco, invece, per l’ex numero femminile del tennis Ashleigh Barty, ritiratasi tre anni fa. Pure lei australiana, pure lei all’epoca venticinquenne. Mollò dopo aver dato tutto, per «inseguire altri sogni» fuori dal campo. Si era già presa una pausa fra il 2014 e il 2016. Poi si è ricordata del sogno di vincere Wimbledon. Quando ci è riuscita, cinque anni dopo, la felicità non è stata quella che avrebbe immaginato. E dopo
tre titoli Slam, 15 complessivi Wta e le Finals ha detto basta.
Precedente illustre, nel tennis, è quello di Björn Borg che nel 1983 fece calare il sipario sulle sue gesta a soli 26 anni. Era reduce da un decennio di grandi sfide e di successi, ne avrebbe potuti ottenere altri. Ma pagò la stanchezza e la delusione per la sconfitta nella finale degli Us Open 1981 con John McEnroe. «Non avevo più né motivazione né concentrazione» ha raccontato di recente. Sarebbe tornato in campo, senza lasciare il segno, solo a inizio anni ‘90.
Dalla racchetta ai motori. Il due volte campione del mondo Casey Stoner ha smesso a 27 anni, a fine 2012. L’affaticamento cronico e l’ansia, che gli procurava anche dolori fisici, erano diventati insopportabili. Ha invece smesso da campione del mondo di Formula 1 il tedesco Nico Rosberg. Aveva appena conquistato il titolo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, nel 2017. E tutti attendevano un altro grande duello. Ma alla consegna dei premi della stagione lui gelò tutti, spiegando di «aver raggiunto il punto più alto della mia carriera».
Nel calcio i ritiri anticipati sono spesso legati a gravi infortuni, come quelli alle caviglie che tormentarono nei primi anni ‘90 Marco Van Basten, considerato fra i centravanti più forti della storia. Smise a 30 anni. Noie simili per Michel Platini, uno dei grandi numeri 10 degli anni ‘80. Diversi i casi di due calciatori tedeschi, che hanno appeso gli scarpini prima del 30 anni. Martin Hinteregger non si sentiva più felice. André Schurrle, campione del mondo 2014 e d’Inghilterra l’anno dopo, era stanco della solitudine e della competizione. «Ho vissuto più ombre che luci» commentò. (A. P.).

All’ultima gara della carriera, il veronese ha festeggiato il terzo titolo iridato nella Corsa a eliminazione
«Èil finale di carriera che avevo sempre sognato». Così Elia Viviani, asso della velocità in sella a una bicicletta, dopo l’impresa che ha suggellato in maniera indimenticabile la sua ultima gara. The Last Dance, l’ultimo ballo del fenomeno veronese è stato la prova di Corsa ad eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista a Santiago, in Cile, quella in cui l’ultimo piazzato di ogni sprint intermedio (ogni due giri su pista di 250 metri) è out, finché ne rimangono due a giocarsi la vittoria. Per il 36enne veronese, che ha festeggiato incrociando
le braccia per ricordare che «Finisce qui», si è trattato del terzo titolo iridato nella specialità, dopo quelli conquistati a Roubaix nel 2021 e a Saint-Quentin-en-Yvelines nel 2022.
Quella di Viviani è stata una gara da campione, malgrado prima del via lo abbia pervaso un insolito nervosismo. Fugato, poi, dall’evolversi della gara. Uno sprint dietro l’altro, il pluricampione veronese ha eliminato tutti i concorrenti. Fra i primi a cedere, a sorpresa, anche l’iridato uscente, il danese Tobias Aagaard Hansen. Poco più tardi il canadese Dylan Bibic, che era stato terzo dietro Viviani ai Mon-
diali di Ballerup 2024 e argento l’anno prima. L’uscita di scena del britannico William Tidball, iridato nello Scratch due anni fa a Glasgow, ha garantito ad Elia il podio. Ma Viviani non è uno che si accontenta. Soprattutto nell’ultima gara della carriera. Fuori anche l’olandese Yoeri Havik, l’azzurro ha completato il capolavoro con lo scatto finale sul neozelandese Campbell Stewart, battuto ben prima della “linea fatale”. Poi l’abbraccio dello staff e di tutti i compagni, compresa la moglie Elena Cecchini, tutti con addosso la maglietta dedicata “The last dance”. Viviani non ha ballato da solo.
In quasi trent’anni di ciclismo e quindici di professionismo, il veronese si è tolto le più grandi soddisfazioni che una “ruota veloce” possa immaginare. Su strada, ha colto successi in tutte le più grandi corse a tappe (5 al Giro d’Italia, 3 alla Vuelta a Espana, 1 al Tour de France), la maglia verde della classifica a punti al Giro 2018, è stato campione d’Italia e d’Europa. Su pista, si è laureato campione olimpico a Rio 2016 nell’Omnium malgrado una caduta e una clavicola in disordine. Ha vinto il bronzo nella stessa disciplina a Tokyo 2020. E poi l’argento assieme a Simone Consonni a Parigi 2024 nell’Americana.
La medaglia di Viviani a Santiago ha completato un bilancio aperto brillantemente dall’oro conquistato dall’inseguimento femminile a squadre e incrementato dal bronzo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella Madison femminile. Nell’inseguimento, Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza e Federica Venturelli hanno battuto in finale la Germania, riportando l’oro in Italia a tre anni dal trionfo in terra francese. In una gara di Madison resa imprevedibile dalle cadute, fra cui quella di Consonni, le azzurre olimpioniche in carica sono riuscite a trovar il podio alle spalle delle britanniche Leech-Archibald e delle francesi Berteau e Borras. (A. P.).
La sfida fra campioni d’Italia e campioni d’Europa ha visto prevalere Trento su Perugia. Ma la lotta per lo scudetto del volley, quest’anno, ha l’aria di essere molto più aperta anche a terzi e quarti incomodi. Verona su tutte, ma anche una Civitanova in cerca di continuità. Alle loro spalle, fra alti e bassi, si stanno muovendo come da pronostico, Milano, Modena e una ringiovanita e rampante Piacenza, mentre la neopromossa Cuneo svetta fra le squadre che hanno ufficialmente la salvezza come obiettivo.
A un terzo del campionato, in testa c’è la “solita” Sir Susa Scai Perugia assieme all’attesa Rana Verona, con 17 punti. I campioni d’Europa hanno però giocato una partita in più, anticipando l’impegno dell’ultima d’andata con Cuneo (3-0) per la concomitanza con il Mondiale per club. In cerca della condizione migliore, per via dei tanti reduci dal Mondiale, Perugia ha perso qualche punto nei 3-2 su Civitanova (sua “giustiziera” nella semifinale della passata Superlega) e Piacenza. E nelle ultime due settimane è caduta prima in casa al tie-break con Verona, malgrado un numero di punti complessivi superiore, poi per 3-1 a Trento. Insuccesso, questo, seguito da una pesante tirata d’orecchie del presidente della Sir, Gino Sirci, che ha parlato di pesante lezione e di «una squadra remissiva, che non ha battuto, non ha murato e non ha difeso». Ricordando che «così si perdono immancabilmente pubblico e sponsor».
Capace di battere sia Perugia (2-3) sia l’Itas Trentino (3-1), terza con 15 punti, Verona è caduta solo con Civitanova, un 3-0 secco ma combattuto. I veneti sono partiti con grandi ambizioni, con l’ex campione d’Europa e “tricolore” in carica Fabio Soli alla guida tecnica, l’opposto Darlan Ferreira de Souza e in regia il fuoriclasse statunitense Micah Christenson, per citare solo tre dei rinforzi più pregiati.
La nuova stagione dell’Itas Tren-

La squadra allenata dal tecnico tricolore Fabio Soli comanda la classifica dopo le prime sette giornate
tino, allenata dall’argentino Marcelo Méndez, è stata indubbiamente condizionata sinora dall’infortunio alla mano destra di Daniele Lavia, asso della Nazionale italiana. Malgrado ciò, i campioni d’Italia uscenti sono in scia alle principali rivali. Grazie, anche, a un’imbattibilità casalinga giunta a 32 partite. Gli insuccessi ravvicinati con Civitanova e Verona, entrambi per 3-1, tra fine ottobre e inizio novembre, sono maturati entrambi in trasferta. Ottima la reazione dell’Itas che ha poi vinto le tre successive partite. Talentuosa ma incostante, Civitanova è quarta. Capace di fare bottino
pieno con Trento e Verona e portar via un punto a Perugia, la squadra di Giampaolo Medei è però caduta in maniera secca a Piacenza (3-0) e ha deluso anche sul campo della Sonepar Padova. Dopo la sconfitta al tie-break nella città antoniana, Medei ha tirato sonoramente le orecchie ai suoi: «Credo che ci voglia un grosso bagno di umiltà – le sue parole – e ritrovare lo spirito di ragazzi promettenti, ragazzi potenzialmente molto forti che devono sempre lavorare e dare il cento per cento ogni giorno. L’abbiamo fatto solo con avversari blasonati e non va bene». (A. P.).
Un viaggio nei territori del riso attraverso la lente di una ricercatrice
di Anna Lavinia
Francesca Grazioli
La moneta bianca
Il Saggiatore, 2025 – 19,00 euro
Il riso, con quel suo colore candido, dà subito un’idea di purezza, di genuinità, chi non ne fa diventare un pasto quando sta male o a dieta? Un bel piatto di riso bianco e passano tutti i mali. Eppure sotto la superficie del suo piccolissimo chicco si nascondono insidie che non avremmo mai immaginato. Le sue radici affondano in un sistema di poteri molto sottili che spezzano dignità, impongono modelli economici e trasformano la cura in sfruttamento. L’autrice del saggio, ricercatrice presso il centro di ricerca Bioversity International, intreccia una fitta trama che attraversa campi, piatti e palazzi di potere intorno al cereale più divisivo di tutti: il riso.
“Nessun grande impero si è sviluppato a partire da un tubero, come la manioca o la patata” afferma. I cereali sono quelli che hanno sempre fatto la differenza, sono i veri protagonisti della storia. La loro produzione dà il ritmo alla vita comunitaria. Da est a ovest, quella del riso è una coltivazione millenaria. Anche le nuove rotte globali dell’alimentazione seguono la mappa del riso ridisegnata sulle frontiere
della biotecnologia, dello sfruttamento ambientale e delle tensioni di genere.
Per esempio, le lavoratrici del riso come braccianti, contadine e raccoglitrici sono da sempre annodate a storie di fame, di potere, di sopravvivenza e giustizia. La melodia di una vecchia canzone popolare che viene alla mente quando si pensa alle mondine - le mondariso italiane della metà del ‘900 - cela in realtà anni di lotta femminile contro lo sfruttamento padronale e per i diritti del lavoro agricolo. Le voci di quelle donne che un tempo non si ribellavano in silenzio assomigliano sempre più a quelle delle indigene che si fanno sentire nelle sedi istituzionali del potere. Tuttavia, pochi ricordano o conoscono la loro ribellione.
L’invisibilità che permea il riso nello spazio di lavoro è la stessa che si propaga nel luogo in cui viene cucinato. La cucina è perennemente pensata come “spazio femminile e campo di prova del desiderio maschile” suggerisce Grazioli nel suo testo. Il riso ed il cibo in generale, non sono solo un linguaggio di affetto ma anche un sistema economico attraverso cui “si esercita un’altra importante forma di potere ancora attuale,

quello patriarcale”. Poi aggiunge “il piatto della neutralità apparente, si rivela un incrocio tra due sistemi di potere, di cui quello patriarcale è solo una faccia della moneta”.
La forza e l’influenza del riso sulla società non sono una questione medievale, ancora oggi è in grado di scuotere coscienze e governi. È ciò che è successo nella primavera del 2025 in Giappone quando Taku Eto (Ministro dell’agricoltura) si è dimesso per una frase inappropriata pronunciata proprio sul cereale. Aveva affermato in modo scherzoso di non comprare più riso grazie agli ingenti regali ricevuti ma ha attirato critiche e malumori di tutto il paese. Si è dovuto dimettere, al suo posto è arrivata una nuova figura proclamatasi subito «ministro del Riso».
Il valore del riso va oltre il suo apporto calorico, è un affare di politica, di civiltà e di onore. Dalle Filippine al Piemonte, un lungo viaggio permeato da conflitti e contraddizioni segue la moneta bianca più nutriente di tutti.
In un mondo (ragionevolmente) in lotta contro la carne, è indispensabile sapere che l’industria del riso non è tanto più innocente.
Bernard-Henri Lévy
Insonnia
La nave di Teseo, 2025 – 17,00 euro
C’è un mostro silenzioso che rovina le ore di sonno notturno ed è capace di condizionare negativamente anche quelle diurne, porta il nome di insonnia. Non è sempre nemica, talvolta può diventare anche un’amica, una compagna fedele per meditare e riflettere. Mai sottovalutare le notti in bianco, possono cambiare il mondo. (A. L.).

Antonella Fioravanti
Viaggio nel mondo invisibile
Aboca, 2025 – 20,00 euro
Microrganismi, salute e cambiamento climatico: il difficile equilibrio della vita sulla Terra. Il mondo invisibile intorno a noi ha plasmato il nostro passato, influenza il presente e sicuramente deciderà il nostro futuro. La biologa molecolare e scienziata italiana spiega gli organismi più abbondanti e antichi del nostro pianeta. (A. L.).

Daniela Perani
Quando il cervello si emoziona
Rizzoli, 2025 – 18,00 euro
Con l’aiuto della neurologa e scienziata di fama internazionale, un affascinante e imprevedibile cammino attraverso il cervello alla scoperta delle nostre emozioni. La loro struttura complessa ci accompagna dalla nascita alla morte: ci tormentano, ci ispirano e ci coinvolgono senza tregua nella mente e nel corpo. Ma come funzionano? (A. L.).

Verso un approccio multidisciplinare Neurobiologia, nutrizione e terapie
ARFID è l’acronimo di Disturbo Evitante/Restrittivo dell’Assunzione di Cibo (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder). Le persone affette da questo disturbo possono limitare la quantità e la varietà degli alimenti, a causa di: un apparente scarso interesse per il cibo, ipersensibilità sensoriale (relativa a odore, gusto o consistenza), paure legate all’alimentazione (ad esempio, timore di ingrassare o di sentirsi male). Si tratta di una condizione complessa, caratterizzata da una restrizione drastica nell’assunzione di cibo [1].
Negli ultimi anni la ricerca neurobiologica ha proposto un modello che aiuta a comprenderne meglio le manifestazioni cliniche mettendo in luce tre aree chiave:
1. la percezione sensoriale, che spiega l’ipersensibilità a stimoli gustativi, olfattivi e tattili;
2. l’omeostasi dell’appetito, legata ai sistemi di regolazione della fame e della sazietà;
3. i circuiti cerebrali deputati alla risposta a stimoli percepiti come minacciosi o pericolosi.
L’insieme di questi fattori contribuisce a trasformare il momento del pasto in un’esperienza di ansia, stress e difficoltà [1,2].
Dal punto di vista clinico, l’ARFID è riconosciuto come un disturbo alimentare persistente e molto eterogeneo, la cui diagnosi viene spesso basata su quattro criteri:
a) conseguenze nutrizionali e fisiche dato che l’ARFID
* Comunicatrice scientifica e Medical writer
può comportare perdita di peso o, nei bambini, una crescita rallentata. Le carenze nutrizionali possono rendere necessario il ricorso a integrazione o, nei casi più gravi, alla nutrizione enterale (somministrata direttamente nel tratto gastrointestinale, bypassando la normale ingestione orale).
Anche l’impatto sul funzionamento psicosociale è importante con ripercussioni nella vita quotidiana, scolastica o lavorativa;
b) l’esclusione di cause esterne perché l’alterazione non deve dipendere unicamente dalla mancanza di cibo o da pratiche culturali che prevedono particolari restrizioni alimentari;
c) la differenziazione da altri disturbi alimentari;
d) l’esclusione di altre condizioni mediche o psichiatriche perché quando coesistono altre condizioni cliniche, le difficoltà alimentari devono comunque manifestarsi con una gravità tale da richiedere un’attenzione specifica e mirata.
Quindi l’ARFID è un disturbo che unisce aspetti biologici, psicologici e sociali, e che necessita di un approccio multidisciplinare per essere compreso e trattato efficacemente. La restrizione alimentare legata alle caratteristiche sensoriali dei cibi tende a manifestarsi già nei primi dieci anni di età e può persistere fino all’età adulta. L’ARFID, infatti, può seguire un decorso cronico, con un impatto sul comportamento psicosociale del paziente e sull’equilibrio familiare [1,3].
Manifestazioni cliniche
L’ARFID può presentarsi in tre sottotipi clinici in base

alle cause che portano a evitare il cibo:
1. l’ARFID a basso appetito si riscontra nelle persone che provano scarso interesse nel cibo e un appetito ridotto, spesso consumano porzioni piccole e impiegano molto tempo per completare un pasto;
2. l’ARFID con limitazioni sensoriali si manifesta in persone che evitano specifici alimenti a causa di caratteristiche come gusto, consistenza e odore. In altri casi, può emergere sotto forma di una forte selettività alimentare o addirittura di una vera e propria fobia nei confronti del cibo;
3. l’ARFID aversivo si riscontra in persone che tendono a evitare o limitare l’assunzione di cibo in seguito a esperienze negative, come episodi di soffocamento o vomito, oppure a causa di timori specifici, ad esempio la paura di soffocare, di provare dolore o di avvertire nausea.
Gli esperti, però, tendono a sottolineare che questi sottotipi rappresentano descrizioni cliniche utili alla diagnosi, ma non esistono ancora prove definitive sulle cause alla base di tali presentazioni. Vengono quindi considerate “categorie illustrative”, dato che altre cause possono contribuire alle restrizioni alimentari osservate [4]. Diversi studi hanno messo a confronto i pazienti con ARFID e quelli con anoressia o bulimia nervosa, evidenziando alcune differenze significative:
• i pazienti con ARFID tendono a essere più giovani, con un’età media compresa tra 11,1 e 14,6 anni, rispetto ai 14–15,6 anni nell’anoressia e ai 14,9–16,7 anni nella bulimia;
• il disturbo mostra una durata più prolungata, oscillando tra 12 e 33 mesi, contro gli 8–23 mesi osservati negli altri disturbi alimentari;
• la percentuale di maschi con ARFID è più elevata (tra il 21% e il 50%), sebbene le femmine rimanga-
© New Africa/shutterstock.com
no prevalenti in tutti i gruppi diagnostici. Nei campioni pediatrici, invece, l’ARFID appare distribuito in modo quasi equo tra maschi e femmine.
Dal punto di vista psicopatologico, i pazienti con ARFID mostrano più comorbidità con condizioni mediche o disturbi d’ansia rispetto a chi soffre di anoressia o bulimia, ma meno spesso con disturbi dell’umore. Tendono a presentare un peso inferiore rispetto ai pazienti con bulimia, ma simile o leggermente superiore a quello di chi soffre di anoressia. Un aspetto distintivo, emerso durante i colloqui nei programmi dedicati ai disturbi alimentari, è che chi soffre di ARFID non ha una percezione distorta del proprio corpo né desidera dimagrire. Inoltre, i pazienti con ARFID riportano meno frequentemente comportamenti compensatori tipici di altri disturbi, come condotte di eliminazione o esercizio fisico eccessivo [5,6].
La selettività alimentare
Gli individui con ARFID a sensibilità sensoriale tendono a evitare alcuni alimenti perché percepiti come fonte di disagio per via di alcune caratteristiche come la consistenza, la temperatura, il colore, o l’odore. Queste persone parlano di esperienze negative con i cibi non graditi, mentre accettano serenamente quelli considerati “sicuri” o preferiti. Le differenze legate alla sensibilità sensoriale variano da individuo a individuo e sono associate a fenomeni di selettività alimentare. In questo contesto si parla spesso di ipersensibilità, cioè una reazione esagerata agli stimoli sensoriali.
Nelle persone con autismo, la selettività alimentare sembra essere strettamente legata ad alterazioni della sensibilità sensoriale, della modulazione e dell’elaborazione degli stimoli, con risposte iper- o ipo-reattive. Atteggiamenti simili sono riscontrati quotidianamente nei bambini affetti da autismo che operano scelte alimentari estremamente se-
lettive e ripetitive. Le comorbidità tra ARFID e autismo sono comuni: le stime indicano una sovrapposizione che varia dal 13% al 50% dei pazienti [7].
L’inappetenza potrebbe essere associata a differenze nell’attivazione dei centri regolatori della fame e della sazietà. L’inizio di un pasto è influenzato da fattori sia esterni (non omeostatici), come contesti sociali o vincoli di tempo, sia interni (omeostatici), legati ai substrati energetici e alla percezione di fame e sazietà. L’ipotalamo e la corteccia insulare svolgono un ruolo cruciale nell’integrare i segnali di fame e sazietà: la fame tende ad aumentare l’attività ipotalamica, mentre la sazietà esercita un effetto inibitorio. I centri distinti responsabili dell’appetito e della sazietà sono l’ipotalamo laterale, che regola la fine del pasto, e il nucleo paraventricolare dell’ipotalamo che è associato all’inizio del pasto. Nelle persone con ARFID a cui vengono mostrate immagini di alimenti appetibili a digiuno, è stata osservata una marcata iperattivazione della corteccia orbitofrontale e dell’insula anteriore, le aree cerebrali che regolano l’anticipazione del pasto e la percezione del piacere associato al cibo. Questa risposta è risultata maggiore nei soggetti con ARFID in sovrappeso e obesi rispetto a quelli con ARFID in normopeso. Rimane, però, da chiarire se queste alterazioni siano specifiche di un sottotipo clinico o se siano conseguenza dell’alterato stato nutrizionale dei pazienti.
Inoltre, nei pazienti con ARFID e basso peso sono stati osservati livelli differenti di ormoni intestinali che regolano l’appetito, rispetto sia ai soggetti con anoressia nervosa, sia alle persone sane utilizzate come gruppo di controllo negli studi. I pazienti con ARFID a basso peso i livelli di grelina (l’ormone della fame) misurati in prossimità del pasto risultano più bassi rispetto alle persone con anoressia nervosa, mentre i livelli di colecistochinina (l’ormone che regola la sazietà e la digestione) a digiuno sono più elevati. Sono state osservate anche altre alterazioni endocrine in ARFID rispetto all’anoressia, tra cui una ridotta alterazione del ciclo mestruale, livelli più alti di T3 e un rapporto T4/T3 più basso (ormoni tiroidei). Queste modificazioni neuroendocrine sono strettamente correlate alla disregolazione omeostatica e richiedono ulteriori studi, in partico-
lare nell’ambito del recupero del peso, per verificare se i livelli ormonali possano normalizzarsi e per chiarire se tali alterazioni rappresentino una componente della patofisiologia del disturbo o siano semplicemente una conseguenza della malnutrizione. Una migliore comprensione di questi meccanismi potrebbe facilitare la diagnosi differenziale e aprire la strada a nuovi target terapeutici [8,9].
Gli individui che hanno vissuto esperienze traumatiche legate al cibo possono sviluppare comportamenti che li portano a evitarlo per proteggersi da ulteriori conseguenze negative. In questi casi, qualsiasi episodio avverso associato al cibo può innescare una vera e propria paura condizionata, soprattutto nei soggetti più vulnerabili. Questi episodi possono manifestarsi sotto forma di paura di mangiare dopo un soffocamento, oppure dopo procedure orali dolorose, come una nutrizione enterale prolungata. In tutti questi casi, il momento del pasto può essere percepito come una minaccia anziché come un’esperienza naturale e sicura. Queste persone presentano spesso una predisposizione ansiosa, che porta a evitare anche altri alimenti oltre a quello inizialmente associato all’evento traumatico. Alla

base possono esserci meccanismi neurobiologici specifici, come l’iperattivazione dei circuiti dell’amigdala e della corteccia cingolata anteriore, coinvolte entrambe nell’elaborazione della paura, oppure un’attivazione eccessiva dei sistemi di difesa. Anche il disgusto, strettamente legato a un alimento andato a male, potrebbe spiegare l’evitamento.
Nel complesso, la combinazione tra ansia, paura e disgusto è centrale nella genesi e nel mantenimento dell’ARFID aversivo ed è al centro di numerosi studi con l’obiettivo di creare nuove prospettive terapeutiche in grado di intervenire su questi meccanismi emotivi e neurobiologici [1,10].
Il trattamento terapeutico
I principali obiettivi terapeutici comprendono la stabilizzazione clinica del paziente, il ripristino dello stato nutrizionale, la riduzione della paura e/o del dolore associato al cibo, la graduale varietà della dieta e il recupero delle abitudini alimentari. Le strategie nutrizionali per favorire l’aumento di peso e prevenire il dimagrimento devono garantire un apporto calorico e di nutrienti adeguato. I nutrizionisti forniscono indicazioni, supporto e strategie pratiche per affrontare le difficoltà che possono emergere durante il trattamento, tra cui problematiche comportamentali ed emotive, disturbi gastrointestinali, modificazioni della composizione corporea ed eventuali complicanze cliniche [11].
Ad oggi, non esistono linee guida o protocolli condivisi e questo può tradursi in ricoveri prolungati e in una maggiore necessità di cure intensive nei casi più complessi. Attualmente, non ci sono molte evidenze riguardanti il trattamento farmacologico ma l’olanzapina, un antipsicotico atipico di seconda generazione, è stata associata a una riduzione della rigidità del comportamento cognitivo nella scelta del cibo e a un aumento dell’appetito e del peso corporeo. Inoltre, ha contribuito a ridurre ansia, sintomi depressivi e compromissioni cognitive. Un altro farmaco di interesse è la mirtazapina, un antidepressivo noto per la sua sicurezza ed efficacia nel trattamento dei sintomi depressivi e ansiosi negli adulti. Viene comunemente impiegato nel trattamento dell’ARFID per via della sua attività antagonista sui recettori istaminergici H1, che può stimolare l’appetito, quindi l’aumento di peso, e accelerare lo svuotamento gastrico. Anche il trattamento con buspirone ha portato a una riduzione dei sintomi di ansia, a un miglioramento dei comportamenti alimentari attraverso la diminuzione della paura del vomito e a un incremento ponderale [1].
In generale, gli approcci psicoterapeutici integrati con il trattamento farmacologico richiedono una valutazione individualizzata dei comportamenti del paziente per sviluppare un piano terapeutico personalizzato, volto a ridurre i comportamenti evitanti e restrittivi e a favorire il graduale ampliamento del consumo di diversi gruppi alimentari [12].
Conclusioni
L’ARFID coinvolge molti sistemi corporei e il trattamento richiede la collaborazione di diversi professionisti con implicazioni cliniche importanti. Infatti, a seconda della gravità e della presentazione clinica, alcuni pazienti possono essere trattati solo da un professionista di salute mentale, mentre altri richiedono un team multidisciplinare completo. Infine, la raccolta di dati clinici sull’ARFID è in crescita, sia per quanto riguarda la valutazione sia il trattamento e sono necessari ulteriori studi, in particolare trial clinici randomizzati su campioni più ampi, per migliorare la comprensione del disturbo e valutare l’efficacia dei trattamenti.
1. Fonseca NKO, Curtarelli VD, Bertoletti J, Azevedo K, Cardinal TM, Moreira JD, Antunes LC. Avoidant restrictive food intake disorder: recent advances in neurobiology and treatment. J Eat Disord. 2024 Jun 7;12(1):74
2. Ramirez Z, Gunturu S. Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. [Updated 2024 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK603710/
3. F. Feillet, A. Bocquet, A. Briend, J.-P. Chouraqui, D. Darmaun, M.-L. Frelut, J.-P. Girardet, D. Guimber, R. Hankard, A. Lapillonne, N. Peretti, J.-C. Rozé, U. Simeoni, D. Turck, C. Dupont, Nutritional risks of ARFID (avoidant restrictive food intake disorders) and related behavior, Archives de Pédiatrie,Volume 26, Issue 7, 2019, Pages 437-441, https://doi.org/10.1016/j.arcped.2019.08.005
4. Bourne L, Bryant-Waugh R, Cook J, Mandy W. Avoidant/restrictive food intake disorder: a systematic scoping review of the current literature. Psychiatry Res. 2020;288:112961
5. Sanchez-Cerezo J, Nagularaj L, Gledhill J, Nicholls D. What do we know about the epidemiology of avoidant/restrictive food intake disorder in children and adolescents? A systematic review of the literature. Eur Eat Disord Rev. 2023;31(2):226–46. https:// doi. org/ 10. 1002/ erv. 2964
6. Nicely TA, Lane-Loney S, Masciulli E, Hollenbeak CS, Ornstein RM. Prevalence and characteristics of avoidant/restrictive food intake disorder in a cohort of young patients in day treatment for eating disorders. J Eat Disord. 2014;2(1):21
7. Bourne L, Mandy W, Bryant-Waugh R. Avoidant/restrictive food intake disorder and severe food selectivity in children and young people with autism: a scoping review. Dev Med Child Neurol. 2022;64(6):691–700
8. Zickgraf HF, Lane-Loney S, Essayli JH, Ornstein RM. Further support for diagnostically meaningful ARFID symptom presentations in an adolescent medicine partial hospitalization program. Int J Eat Disord. 2019;52(4):402–9
9. Aulinas A, Marengi DA, Galbiati F, Asanza E, Slattery M, Mancuso CJ, Wons O, Micali N, Bern E, Eddy KT, Thomas JJ, Misra M, Lawson EA. Medical comorbidities and endocrine dysfunction in low-weight females with avoidant/restrictive food intake disorder compared to anorexia nervosa and healthy controls. Int J Eat Disord. 2020;53(4):631–6
10. Tovote P, Fadok JP, Lüthi A. Neuronal circuits for fear and anxiety. Nat Rev Neurosci. 2015;16(6):317–31
11. Białek-Dratwa A, Szymańska D, Grajek M, Krupa-Kotara K, Szczepańska E, Kowalski O. ARFID: strategies for dietary management in children. Nutrients. 2022;14:1739
12. King LA, Urbach JR, Stewart KE. Illness anxiety and avoidant/restrictive food intake disorder: cognitive-behavioral conceptualization and treatment. Eat Behav. 2015;19:106–9
di
Un parametro sempre più importante nell’analisi della fertilità maschile anche per comprendere la futura genetica dell’embrione
Giovanni Ruvolo*
La frammentazione del DNA nemaspermico rappresenta un parametro sempre più considerato nell’ambito della valutazione della fertilità maschile. A differenza dei parametri convenzionali dello spermiogramma, che si focalizzano su concentrazione, motilità e morfologia, l’integrità del DNA nemaspermico fornisce informazioni essenziali sulla qualità del materiale genetico trasmesso all’embrione, così come suggerito anche nell’ ultima versione del manuale del WHO (1).
La frammentazione del DNA nemaspermico consiste nella rottura delle catene di DNA presenti nella struttura della cromatina presente nel nucleo dello spermatozoo. Tali rotture possono essere a singolo o doppio filamento e compromettono la capacità dello spermatozoo di fecondare l’ovocita e di supportare il corretto sviluppo embrionale. La presenza di frammentazione elevata, dunque, può essere correlata agli esiti riproduttivi. (2)
I fattori che possono determinare un aumento della frammentazione del DNA spermatico sono numerosi e diversificati. Tra i principali troviamo:
• Stress ossidativo: la presenza di specie reattive dell’ossigeno (ROS) in eccesso può danneggiare il
* Biologo e Biotecnologo, Responsabile dei laboratori di embriologia clinica del Centro di Biologia della Riproduzione di Palermo e del Centro Italiano di Riproduzione Assistita CIPA-SDM di Roma. È membro del Consiglio direttivo della SIRU e socio fondatore della SIERR ed è membro del CIG di Enpab
DNA degli spermatozoi.
• Infezioni e infiammazioni: processi infiammatori a livello del tratto genitale maschile possono aumentare la frammentazione, in conseguenza dell’aumento dei ROS.
• Varicocele: la stasi venosa, e l’associato aumento della temperatura scrotale tipica del varicocele, può indurre stress ossidativo e aumentare la frammentazione del DNA.
• Fattori ambientali e stili di vita: esposizione a sostanze quali le polveri sottili (PM10 e PM2.5), metalli pesanti, pesticidi, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), droghe, fumo, alcol e dieta non equilibrata possono contribuire al danno del DNA nemaspermico.
• Febbre e aumenti di temperatura scrotale: eventi febbrili possono compromettere l’integrità del DNA.
• Età avanzata: negli uomini più anziani è stata osservata una maggiore incidenza di frammentazione.
• Errori nella spermatogenesi: anomalie nei processi di maturazione degli spermatozoi possono determinare la presenza di DNA danneggiato. (3,4)
Per l’analisi della frammentazione del DNA degli spermatozoi esistono diverse metodiche, tra cui:
• Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA): utilizza la citofluorimetria a flusso per valutare l’instabilità della cromatina nemaspermica.
• TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transfera-

Foto 1. Tunel assay su vetrino eseguito su spermatozoi umani con normale morfologia e con DNA frammentato (fluorescanza verde)
se dUTP nick end labeling): identifica le rotture a doppio filamento del DNA tramite l’incorporazione di nucleotidi marcati. È l’unico test diretto su vetrino che consente di associare la fluorescenza con la morfologia degli spermatozoi. (Foto 1)
• Comet Assay (Single Cell Gel Electrophoresis, SCGE): analizza il danno al DNA a livello del singolo spermatozoo.
• Sperm DNA Dispersion Test (SCD, Halo Test): valuta l’integrità del DNA basandosi sulla formazione di un alone di dispersione della cromatina. (5,6)
I test più utilizzati nella pratica diagnostica sono l’SCD ed il Tunel test su vetrino. I valori di riferimento variano a seconda della metodica utilizzata, ma in generale viene considerato normale un valore di frammentazione inferiore al 15%, tra il 15% e il 30% è considerato borderline, mentre oltre il 30% è indicativo di una fertilità ridotta.
L’importanza della frammentazione del DNA degli spermatozoi è stata ampiamente studiata negli ultimi anni, con numerose pubblicazioni che ne evidenziano il ruolo nella fertilità maschile e negli esiti riproduttivi (7). Tuttavia, la frammentazione del DNA non è ancora un parametro standardizzato nei protocolli di routine per la valutazione della fertilità maschile, principalmente per la mancanza di consenso internazionale sui cut-off definitivi e sull’interpretazione clinica dei risultati. Inoltre, rimane da definire su quale popolazione di spermatozoi, nel campione seminale, debba essere effettuata l’analisi. In genere si esegue sugli spermatozoi presenti nel campione seminale, ma sembrerebbe più indicativo eseguire l’analisi solo sugli spermatozoi mobili che sono quelli che con maggiore probabilità possono competere per la fecondazione dell’ovocita, sia naturalmente, sia mediante le tecniche di fecondazione assistita.
Per chi si occupa da anni dello studio della frammentazione del DNA nemaspermico rimane consolidato il convincimento che essa ha importanti implicazioni biologiche e cliniche. Infatti, diverse pubblicazioni scientifiche sembrano dimostrare che elevati livelli di frammentazione possono avere un impatto sulla fecondazione naturale e ridurre la capacità degli spermatozoi di fecondare l’ovocita. Nei trattamenti di PMA, alti livelli di frammentazio-
ne sono associati a bassi tassi di successo e a una minore qualità embrionaria con un aumentato rischio di aborto spontaneo e aborti ripetuti. (7). Nei casi in cui viene rilevata una consistente percentuale di spermatozoi presenti frammentazione della cromatina, vengono proposte terapie con antiossidanti, diete ricche di antiossidanti naturali (polifenoli, flavonoidi, vitamina C ed E), alimenti con alto contenuto di acidi grassi omega-3 ed un apporto equilibrato di carboidrati a basso indice glicemico, che riducono l’infiammazione sistemica. Nei casi più gravi possono essere somministrate terapie con le gonadotropine (8,9).
In conclusione, lo studio della frammentazione del DNA nemaspermico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella valutazione della fertilità maschile. Sebbene non ancora universalmente standardizzato, fornisce informazioni preziose per la gestione clinica dei pazienti infertili e per l’ottimizzazione delle strategie di fecondazione assistita. La ricerca futura dovrà concentrarsi sull’ulteriore validazione scientifica di questo parametro e sulla sua integrazione nei protocolli diagnostici di routine.
1. World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen, 6th ed.; WHO Press: Geneva, Switzerland, 2021
2. Evaluation of sperm DNA fragmentation in male infertility. Zeynep Caliskan, Canan Kucukgergin, Gulsan Aktan, Ates Kadioglu, Gul Ozdemirler. Andrologia. 2022 Dec;54(11):e14587. doi: 10.1111/and.14587. Epub 2022 Sep 15.
3. Lifestyle-, environmental-, and additional health factors associated with an increased sperm DNA fragmentation: a systematic review and meta-analysis. Anett Szabó, Szilárd Váncsa, Péter Hegyi, Alex Váradi, Attila Forintos, Teodóra Filipov, Júlia Ács, Nándor Ács, Tibor Szarvas, Péter Nyirády, Zsolt Kopa. Reprod Biol Endocrinol. 2023 Jan 18;21(1):5. doi: 10.1186/s12958-023-01054-0.
4. Sperm DNA fragmentation: An early and reliable marker of air pollution. Liana Bosco, Tiziana Notari, Giovanni Ruvolo, Maria C Roccheri, Chiara Martino, Rosanna Chiappetta, Domenico Carone, Giosuè Lo Bosco, Laura Carrillo, Salvatore Raimondo, Antonino Guglielmino, Luigi Montano. Environ Toxicol Pharmacol, . 2018 Mar:58:243-249. doi: 10.1016/j. etap.2018.02.001. Epub 2018 Feb 7.
5. Evaluation of Sperm DNA Fragmentation Using Two Different Methods: TUNEL via Fluorescence Microscopy, and Flow Cytometry. Katerina Chatzimeletiou, Alexandra Fleva, Theodoros-Thomas Nikolopoulos, Maria Markopoulou, Glykeria Zervakakou, Kyriakos Papanikolaou, George Anifandis, Anastasia Gianakou, Grigoris Grimbizis. Medicina (Kaunas). 2023 Jul 15;59(7):1313. doi: 10.3390/medicina59071313.
6. The sperm chromatin dispersion test: a simple method for the determination of sperm DNA fragmentation. Jose Luis Fernández, Lourdes Muriel, Maria Teresa Rivero, Vicente Goyanes, Rosana Vazquez, Juan G Alvarez. J Androl. 2003 Jan-Feb;24(1):59-66.
7. Correlation analysis of sperm DNA fragmentation index with semen parameters and the effect of sperm DFI on outcomes of ART. KangSheng Liu, XiaoDong Mao, Feng Pan, YaJun Chen, Ruifang An. Sci Rep. 2023 Feb 15;13(1):2717. doi: 10.1038/s41598-023-28765-z.
8. Micronutrient supplements as antioxidants in improving sperm quality and reducing DNA fragmentation. Nguyen Dac Nguyen, Minh Tam Le, Nhu Quynh Thi Tran, Quoc Huy Vu Nguyen, Thanh Ngoc Cao. Basic Clin Androl. 2023 Sep 14;33(1):23. doi: 10.1186/s12610-023-00197-9.
9. Recombinant human FSH reduces sperm DNA fragmentation in men with idiopathic oligoasthenoteratozoospermia. Nicola Colacurci, Maria Gaia Monti, Felice Fornaro, Gaia Izzo, Pierluigi Izzo, Carlo Trotta, Daniela Mele, Pasquale De Franciscis. J Androl. 2012 Jul-Aug;33(4):588-93. doi: 10.2164/jandrol.111.013326. Epub 2011 Aug 25.

Un approccio multidimensionale basato sulle scienze omiche, la biochimica d’organo, la tossicologia ambientale, il microbiota e il metabolismo per una risposta fisiologica integrata fondata sulla Biologia
La nutrizione contemporanea sta attraversando una profonda evoluzione verso una visione integrata, sistemica e personalizzata, in cui convergono le scienze omiche, la biochimica d’organo, la tossicologia ambientale e lo studio del microbiota. Le recenti acquisizioni in genetica, epigenetica e microbiomica hanno ridefinito il concetto di alimentazione, trasformandola da semplice fonte energetica a strumento di modulazione biologica attiva, capace di interagire con i meccanismi molecolari che regolano metabolismo, infiammazione e risposta ormonale.
In questo contesto, la cultura biologica, intesa come insieme integrato di discipline interconnesse e interdisciplinari, rappresenta la base essenziale per armonizzare i diversi livelli di informazione biologica e ambientale. Tale approccio consente di formulare strategie nutrizionali di precisione, fondate sulla fisiologia individuale e orientate al mantenimento dell’equilibrio omeostatico e della salute globale e non ultimo della prevenzione.
Pertanto la nutrizione sia clinica che preventiva moderna sta attraversando una trasformazione epocale grazie al contributo delle nuove scienze omiche, della genetica, dell’epigenetica, della microbiologia intestinale, della biochimica ormonale e delle evidenze tossicologiche derivate dall’ambiente. Questi ambiti, un tempo considerati separati, oggi concorrono a ridefinire la comprensione della risposta fisiologica dell’organismo ai nutrienti e al contesto ecologico.
L’approccio dietetico tradizionale, basato su grammature e calcoli standardizzati dei fabbisogni, appare riduttivo e in parte anche superato rispetto a una visione più dinamica e personalizzata, capace di integrare variabili genetiche, epigenetiche, metaboliche e ambientali e di correlare i nutrienti con la genetica, risposta biochimica e fisiologica individuale. La genetica e la nutrigenetica permettono di comprendere come specifici polimorfismi influenzino la risposta ai nutrienti e come questi ultimi possano modulare l’espressione genica.
Varianti dei geni coinvolti nel metabolismo lipidico, glucidico o proteico determinano la capacità dell’organismo di utilizzare i nutrienti in modo ottimale. La nutrigenomica, in sinergia con l’epigenetica, mostra come alimentazione e ambiente modifichino l’espressione genica attraverso processi di metilazione del DNA, modificazioni istoniche o regolazioni mediate da microRNA.
L’epigenetica sottolinea che l’alimentazione non è soltanto una fonte energetica o plastica, ma un’informazione biologica in grado di modulare la fisiologia cellulare e di trasmettere segnali molecolari che influenzano la salute a
* Biologo Nutrizionista
lungo termine. Dieta, attività fisica, esposizione a tossici ambientali e composizione del microbiota rappresentano stimoli epigenetici in grado di condizionare profondamente la longevità e la prevenzione delle malattie.
Le scienze omiche, genomica, transcriptomica, proteomica, metabolomica e microbiomica offrono oggi una visione integrata del metabolismo e consentono di individuare biomarcatori predittivi della risposta individuale ai nutrienti. Il microbiota intestinale, considerato un vero organo metabolico, svolge un ruolo attivo nella digestione, nella produzione di metaboliti bioattivi e nella modulazione immunitaria e infiammatoria.
L’alterazione della flora intestinale, o disbiosi, riduce l’efficienza digestiva e favorisce la formazione di sostanze bioattive, come ammine e fenoli, che interferiscono con la biochimica cellulare. In tale scenario, la quantità ingerita di un nutriente non corrisponde necessariamente a quella realmente utilizzata a livello tissutale, poiché il microbiota, l’infiammazione mucosale, la competizione per i trasportatori intestinali o la presenza di antinutrienti modulano la biodisponibilità.
Parallelamente, la disponibilità dei nutrienti è regolata da un complesso sistema ormonale che coinvolge insulina, glucagone, leptina, ormoni tiroidei, cortisolo e mTOR, i quali rappresentano nodi centrali del controllo metabolico.
L’alterazione dell’asse ormonale, lo stress ossidativo e l’infiammazione cronica di basso grado influenzano la capacità dell’organismo di utilizzare correttamente i substrati energetici. In questo contesto si inserisce la tossicologia ambientale, poiché l’ambiente esterno, attraverso la presenza di sostanze tossiche, metalli pesanti e interferenti endocrini, condiziona la funzionalità cellulare, la flora batterica e i processi epigenetici.
L’esposizione a pesticidi, microplastiche, IPA, ftalati o bisfenolo A interferisce con la segnalazione ormonale, agendo come mimetici o antagonisti dei recettori di estrogeni, androgeni e tiroxina, alterando la sintesi proteica e la funzione mitocondriale. Questi composti lipofili tendono ad accumularsi nel tessuto adiposo, generando stress ossidativo e disregolazione endocrina.
A livello epatico, la biochimica della detossificazione si articola in fasi I e II (CYP450, glutatione S-transferasi, metilazioni, solfatazioni, coniugazioni), e la saturazione di queste vie determina un incremento delle specie reattive dell’ossigeno (ROS) con conseguente danno ossidativo, perossidazione lipidica e alterazioni mitocondriali. I mitocondri, oltre a costituire la centrale energetica della cellula, rappresentano bersagli primari dei tossici ambientali: metalli come mercurio e cadmio inibiscono la catena respiratoria, mentre interferenti endocrini alterano la biogenesi mitocondriale e l’espressione di PGC1- α ,
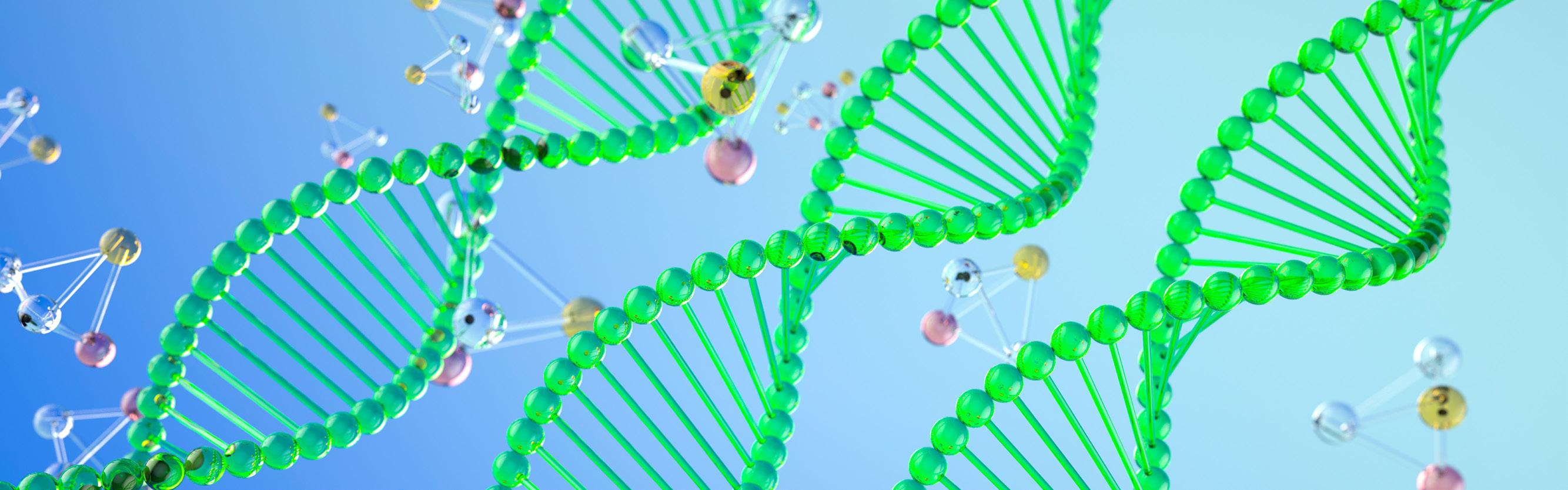
compromettendo la capacità ossidativa dei tessuti. Queste alterazioni si riflettono sul metabolismo sistemico con riduzione della sensibilità insulinica, disfunzione endoteliale e infiammazione persistente e solo per citarne alcune. Il paradigma della nutrizione di precisione si fonda sull’idea che ogni individuo possieda una propria impronta biologica determinata da fattori genetici, epigenetici, microbici e ambientali che modulano la risposta metabolica a nutrienti, tossine e stimoli infiammatori.
La genetica predittiva, attraverso l’analisi di polimorfismi dei geni del metabolismo, della metilazione e della detossificazione, permette di individuare vulnerabilità che solo l’integrazione con il microbioma e il carico tossico consente di interpretare pienamente. Il microbioma, con i suoi phyla dominanti e le sue specie chiave, può amplificare o mitigare gli effetti dei polimorfismi genetici a rischio, modulando permeabilità intestinale, infiammazione e metabolismo glucidico.
Lo stato di permeabilità intestinale aumentata (“leaky gut”) favorisce il passaggio di tossine microbiche (lipopolisaccidi, peptidi batterici) e di molecole esogene (residui alimentari, glutine, nichel, xenobiotici), innescando risposte immunitarie locali e sistemiche che alterano la biochimica d’organo. La tossicità ambientale e quella alimentare si sovrappongono: pesticidi, additivi e residui industriali aumentano lo stress ossidativo e il danno epiteliale, aggravando l’infiammazione cronica e l’insulino-resistenza.
In presenza di varianti genetiche dei sistemi di detossificazione (GST, CYP, NAT), l’organismo manifesta maggiore vulnerabilità a questi stress tossici, con accumulo di specie reattive e attivazione disfunzionale della via AMPK/mTOR/NRF2.
La biochimica ormonale si intreccia strettamente a questi fenomeni: per fare un esempio, l’aumento del cortisolo da stress ambientale altera la gluconeogenesi e la sensibilità insulinica, la leptina perde la sua funzione di segnale di sazietà e l’asse tiroideo si riduce per adattamento metabolico.
Questi eventi creano una condizione di “metabolismo adattativo” disfunzionale che ostacola la perdita di massa grassa e favorisce l’infiammazione cronica.
Dal punto di vista non ultimo anche clinico, la nutrizione di precisione integra oggi dati genetici, microbiomici e biochimici per costruire una mappa di rischio individuale e definire strategie alimentari realmente personalizzate nel rispetto anche dei concetti mediterranei.
La formazione biologica alla luce di quanto detto, rappresentata da ambiti scientifici quali biologia molecolare, biochimica, microbiologia, tossicologia e scienze omiche, rappresenta la più completa per tradurre questi dati in interventi nutrizionali basati sulla fisiologia individuale.
In conclusione, la nutrizione vista in chiave moderna e contemporanea deve essere intesa come un sistema complesso che integra appunto; genetica, epigenetica, microbiota, tossicologia e biochimica d’organo in un modello unitario di salute.
L’approccio basato e fondato sulle conoscenza biologiche, consente di coniugare non solo personalizzazioni nutrizionali in base a parametri obiettivi e quindi generare una nutrizione di precision e sostenibile, riportando la scienza dell’alimentazione a una dimensione realmente fisiologica, dove ogni intervento dietetico diviene una modulazione consapevole della biologia umana.
1. Chiurazzi P, et al. Polymorphisms, diet and nutrigenomics. J Prev Med Hyg. 2022;63(2 Suppl 3):2754.
2. Mitsis T, et al. Influence of epigenetics and microbiota in early-life development. Int J Epigen. 2024;4:3.
3. Ferenc K, et al. Modulation of the Gut Microbiota by Nutrition and Its Relationship to Epigenetics. Int J Mol Sci. 2024;25(2):1228.
4. Lagoumintzis G, et al. Triangulating nutrigenomics, metabolomics and microbiomics toward personalized nutrition. Hum Genom. 2023;17:109.
5. Oz E, et al. A review on microbiota: relation with diseases and nutrients role. Int J Food Sci Technol. 2023;58(8):4100.
6. Chaudhary D, et al. Nutrigenomics and personalized diets – Tailoring nutrition. SciDirect. 2025.
7. Bellinato F, et al. Nutritional modulation of hormonal pathways: a molecular perspective. Front Nutr. 2024.
8. Lagoumintzis G, et al. Environmental toxicants and nutritional modulation in human health. Hum Genom. 2023.
9. Wang T, et al. Predicting metabolite response to dietary intervention. Nat Commun. 2025.
10. Randeni N, et al. Diet, gut microbiota, inflammation: a comprehensive review. Int J Mol Sci. 2024.
11. Hughes RL, et al. The Role of the Gut Microbiome in Predicting Response to Diet. Trends Endocrinol Metab. 2019.
12. Di Vincenzo F, et al. Gut microbiota, intestinal permeability, and systemic inflammation in metabolic diseases. Front Immunol. 2023.
13. Inczefi O, et al. The Influence of Nutrition on Intestinal Permeability and Disease. Nutrients. 2022.
14. Qin Y, et al. Combined effects of host genetics and diet on human gut microbiota. Nat Genet. 2022.
15. Arifuzzaman M, et al. Nutritional regulation of microbiota-derived metabolites. Immunity. 2024.
16. Wang T, et al. Predicting metabolite response to dietary intervention. Nat Commun. 2025.
17. Lagoumintzis G, et al. Triangulating nutrigenomics, metabolomics and microbiomics. Hum Genomics. 2023.
18. Hernandez-Calderón P, et al. The microbiota composition drives personalized nutrition. Front Nutr. 2022.
19. Van Hul M, et al. What defines a healthy gut microbiome? Gut. 2024.
20. Dmytriv TR, et al. Intestinal barrier permeability: the influence of gut microbiota and nutrition. Front Physiol. 2024.
21. Randeni N, et al. Diet, gut microbiota, inflammation: a comprehensive review. Int J Mol Sci. 2024.
22. Kviatcovsky D, et al. Gut microbiome and its potential link to personalized nutrition. Trends Food Sci Technol. 2021.

Consulta gli eventi
della Fnob che erogano i crediti formativi
Strategia avanzata per la gestione dell’Insufficienza Cardiaca in pazienti con dispositivi impiantabili
di Luca Santini* e Claudia Sorrentino*
L’insufficienza cardiaca (IC) rappresenta una delle maggiori sfide attuali per i sistemi sanitari, in un contesto di crescente prevalenza dovuta all’invecchiamento demografico e alla progressiva riduzione delle risorse disponibili. Gli algoritmi multiparametrici integrati nei dispositivi impiantabili consentono oggi un monitoraggio remoto avanzato, capace di individuare precocemente la fase preclinica della riacutizzazione dello scompenso. La combinazione di tali tecnologie con biomarcatori, in particolare NT-proBNP, incrementa sensibilmente la specificità della predizione, migliorando l’efficienza del triage clinico e riducendo il burden assistenziale. Questo articolo propone un modello organizzativo integrato ospedale–territorio che include farmacie e Case della Salute, finalizzato a ottimizzare la
* UOC Cardiologia, P.O. G.B. Grassi, Roma
gestione dei pazienti con IC attraverso percorsi predittivi, tempestivi e sostenibili.
Introduzione
La prevalenza dell’insufficienza cardiaca (IC) è in costante aumento, stimata tra l’1% e il 2% della popolazione generale e superiore al 10% negli over 70. Tale crescita è determinata dall’invecchiamento della popolazione e dalla maggior sopravvivenza alle patologie cardiovascolari acute. Parallelamente, il sistema sanitario affronta una diminuzione strutturale delle risorse disponibili: posti letto ridotti, carenza di personale e crescente carico assistenziale cronico. Ne deriva un mismatch significativo tra domanda e capacità del sistema di rispondere in modo adeguato.
Molti pazienti con IC sono portatori di dispositivi impiantabili (CIEDs) come defibrillatori automatici impiantabili (ICD) e dispositivi per la re-sincronizzazione cardiaca (CRT) che da oltre vent’anni posso-
no essere monitorati in remoto. Se inizialmente il controllo remoto era orientato alla verifica dei parametri tecnici del dispositivo, negli anni si è assistito a un’evoluzione concettuale: dal “telemonitoraggio del dispositivo” al “telemonitoraggio del paziente”. I CIED moderni consentono infatti l’analisi continua di diversi parametri fisiologici, diventando veri e propri sensori clinici in grado di rilevare precocemente eventuali variazioni dello stato di compenso emodinamico.
In questo contesto, gli algoritmi multiparametrici integrati nei dispositivi stanno diventando un elemento chiave nella gestione dell’IC, permettendo un’assistenza preditti-
va e proattiva che, intercettando precocemente il rischio, può trasformarsi in una reale strategia di prevenzione degli episodi acuti [1][2].
Un altro pilastro nella gestione dei pazienti con IC è rappresentato dai biomarcatori. In particolare, i peptidi natriuretici come BNP e NT-proBNP, rappresentano uno strumento consolidato per la diagnosi, la stratificazione prognostica e il monitoraggio dei pazienti con insufficienza cardiaca [3]. La loro misurazione seriata consente di cogliere variazioni precoci correlate al peggioramento clinico. Negli ultimi anni sono stati sviluppati kit point-of-care per la determinazione del NT-proBNP al domicilio o


alla necessità di standardizzare i percorsi e all’integrazione con piattaforme cliniche centralizzate [4]. Se, come le più recenti evidenze lasciano intendere [3] [4], si riuscisse a superare queste attuali limitazioni, l’utilizzo diffuso dei kit point-of-care per la determinazione del NT-proBNP rappresenterebbe uno strumento estremamente prezioso per la gestione dei pazienti con insufficienza cardiaca, permettendo un’azione ancor più tempestiva e una stratificazione del rischio più raffinata.
L’associazione tra algoritmi multiparametrici e biomarcatori territoriali appare quindi una strategia naturale per combinare sensibilità e specificità, migliorando la capacità di intercettare e stratificare i pazienti ad alto rischio.
Algoritmi multiparametrici e razionale fisiopatologico
I singoli parametri misurabili tramite i dispositivi impiantabili, come impedenza toracica, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza, attività fisica, burden aritmico o toni cardiaci, mostrano limitazioni predittive se considerati isolatamente [2]. Le recenti evidenze in letteratura confermano che il valore aggiunto risiede invece nella loro integrazione, grazie all’utilizzo di modelli matematici di intelligenza artificiale predittivi che combinano trend temporali e variazioni relative e che sono in grado di generare un alert quando l’indice integrato superi la soglia prestabilita [1][2].
I principali algoritmi oggi in uso clinico sono:
presso le farmacie: un’innovazione che potrebbe rafforzare il ruolo del territorio nella gestione della cronicità. Nonostante questi strumenti abbiano dimostrato risultati promettenti in termini di fattibilità e potenziale utilità clinica, persistono limiti legati alla variabilità delle misurazioni,
• HeartLogic™ (Boston Scientific): Integra cinque sensori (Toni cardiaci : S1 e S1/S3, frequenza respiratoria, impedenza toracica, frequenza cardiaca, attività fisica) e fornisce un indice continuo ; quando il valore supera una soglia definita, viene generato un alert con un anticipo sull’evento clinico acuto fino a 30-40 giorni [5]
[6].
• riageHF™ (Medtronic) Utilizza un modello bayesiano che classifica il rischio di scompenso nelle successive quattro settimane in basso, intermedio o alto [1][7].
• HeartInsight™ (Biotronik) Algoritmo che integra sette parametri clinici e il Seattle HF Model, generando alert con un pre-avviso medio dell’evento acuto di circa quaranta giorni [8].
Un elemento cruciale è che questi algoritmi identificano la fase preclinica della riacutizzazione, quando il paziente è spesso ancora asintomatico [6]. Intervenire in questa fase consente potenzialmente di intraprendere se necessario un’azione clinica (es: ripristinare l’aderenza terapeutica , ottimizzare la terapia diuretica o neuro-ormonale, correggere eventuali fattori scatenanti, ottimizzare la programmazione del dispositivo etc.) evitando così la progressione verso la congestione conclamata.
La possibilità di intervento in questa fase, ha un impatto rilevante: i pazienti con IC, infatti, sono tra i maggiori “frequent flyer” del sistema sanitario, con tassi di riospedalizzazione a 30 giorni fino al 25% e mortalità annuale che può superare il 30%. L’IC rappresenta inoltre una delle voci di costo più pesanti per il SSN, con un impatto stimato pari all’1–2% dell’intera spesa sanitaria nazionale.
Evidenze cliniche
Dalla letteratura scientifica emergono alcuni punti consolidati:
• il tempo di anticipo medio degli algoritmi multiparametrici sull’evento clinico acuto è compreso tra 30 e 45 giorni [2][5][8];
• Gli algoritmi multiparametrici offrono un’elevata sensibilità e un altissimo valore predittivo negativo (8590%), permettendo di escludere con sicurezza un rischio imminente di scompenso nei pazienti senza alert e permettendo quindi di convogliare le risorse prioritariamente sui
• pazienti a rischio più alto [5][8];
• il telemonitoraggio strutturato riduce accessi urgenti e ospedalizzazioni [6];
• la performance dei sistemi è ottimale quando integrata in percorsi clinici organizzati [1].
• Lo studio di Gardner ha evidenziato, inoltre, che HeartLogic™ e NT-proBNP mantengono ciascuno un valore prognostico indipendente [9]. La loro combinazione incrementa significativamente la specificità predittiva, riducendo i falsi positivi e rendendo più efficiente il triage clinico.
Valutazione HTA: l’esperienza del NICE
Nel Regno Unito il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) ha recentemente valutato HeartLo-
• Gli algoritmi multiparametrici disponibili nei dispositivi impiantabili identificano precocemente la fase preclinica dello scompenso e hanno dimostrato alla valutazione di HTA un rapporto costo-efficacia favorevole.
• Preavviso medio su evento acuto di 30–45 giorni: possibilità concreta di intervento proattivo.
• L’aggiunta del NT- proBNP incrementa significativamente la specificità predittiva.
• Telemonitoraggio strutturato attraverso una rete ospedale-territorio: riduzione di ospedalizzazioni e burden assistenziale.
gic™ e TriageHF™ come tecnologie costo-efficaci, approvandone l’adozione nei percorsi di monitoraggio remoto dei pazienti con IC e CIED [10]. La valutazione è basata su evidenze robuste di riduzione delle ospedalizzazioni, miglioramento degli outcome clinici e sostenibilità economica. Questo rappresenta un precedente di rilievo per tutti i sistemi sanitari europei, inclusa l’Italia, dove tali tecnologie potrebbero essere integrate nei modelli regionali di gestione della cronicità.
Proposta per un modello ospedale–territorio
Il pieno potenziale degli algoritmi predittivi può essere sfruttato solo all’interno di una rete organizzativa in grado di rispondere rapidamente agli alert generati dal dispositivo. Poiché gli ospedali sono oggi gravati da un carico assistenziale crescente e spesso insostenibile, l’implementazione efficace di tali strumenti richiede il coinvolgimento strutturato del territorio, così da garantire una gestione degli alert tempestiva, capillare e sostenibile.
In questa prospettiva, un possibile modello operativo – capace di valorizzare al massimo il potere predittivo dei dispositivi e di tradurlo in interventi clinici concreti – può essere articolato secondo la seguente flow-chart:
1. Centro ospedaliero di telecardiologia:
• ricezione dell’alert dal dispositivo;
• valutazione iniziale da parte del case-manager (tecnico/infermiere);
• revisione clinica da parte del cardiologo:
- “Alert Conclusivo”: se il quadro suggerisce già chiaramente la necessità di intervento (nuove aritmie, variazioni cliniche note, problemi di aderenza, programmazione del device, etc), il centro procede direttamente all’ottimizzazione terapeutica.
- “Alert non conclusivo”: se l’alert non si associa all’evidenza di una causa specifica si attiva la “Valutazione territoriale”
2. Valutazione territoriale in caso di alert non conclusivo: Quando il paziente è asintomatico o il quadro non è chiaro, è necessario un approfondimento attraverso la rete territo-
riale per confermare la progressione della congestione:
a) Il centro ospedaliero di telecardiologia:
- indirizza il paziente presso un Punto di Prossimità (POC), idealmente la farmacia, per l’esecuzione rapida del NT-proBNP point-of-care
- invia contestualmente il report dell’alert al Team Cardiologico Territoriale (cardiologo e infermiere specializzato della Casa della Salute)
b) Farmacia (POC): Il farmacista esegue il test NT-proBNP e trasmette l’esito alla Casa della Salute e, per conoscenza, al centro ospedaliero di telecardiologia.
c) Cardiologo territoriale:
Sulla base dei dati integrati (alert del device + NT-proBNP POC), dell’anamnesi mirata e dell’esame obiettivo:
- procede, se necessario, all’azione clinica appropriata (ripristino aderenza, ottimizzazione terapeutica, etc), inoltrando il resoconto dell’azione intrapresa al centro di Telecardiologia ospedaliera.
- oppure, in caso non ritenga necessario intraprendere alcuna azione terapeutica, comunica l’indicazione alla sola prosecuzione di uno stretto monitoraggio.
Ruolo delle Case della Salute / Ambulatori Territoriali
In questo modello le Case della Salute operano come hub clinici intermedi, assicurando una valutazione rapida, idealmente entro 48-72 ore dall’alert. Deve essere disponibile, quando necessaria, anche l’interazione in teleconsulto con il cardiologo del centro ospedaliero di riferimento.
È fondamentale, inoltre, la presenza di una piattaforma digitale condivisa tra ospedale, territorio e farmacie, contenente:
- storia clinica completa
- terapia attuale e pregressa
- storico e trends dei biomarcatori
- storico e trends degli algoritmi del dispositivo
L’integrazione dei dati, infatti, consente al Cardiologo Territoriale di stabilire se l’alert richieda un intervento terapeutico, una visita in office o una televisita programmata o una semplice osservazione nel tempo con uno stretto follow-up e monitoraggio dinamico.
La combinazione tra algoritmi multiparametrici e NT-proBNP point-of-care permette una strategia a due livelli altamente efficiente: alta sensibilità grazie all’algoritmo e alta specificità grazie al biomarcatore [3][4] [5][8][9].
È questo il principio chiave che permette di passare dalla semplice predizione alla prevenzione dell’evento acuto.
Conclusioni
Gli algoritmi multiparametrici integrati nei dispositivi
impiantabili si stanno affermando come una tecnologia chiave per una gestione proattiva e predittiva dell’insufficienza cardiaca, offrendo la possibilità di predire l’evento acuto settimane prima della manifestazione clinica [1][2]. La loro integrazione con biomarcatori come l’ NT-proBNP, , anche mediante test point-of- care, consente di aumentare la specificità, migliorare la stratificazione del rischio e ridurre interventi non necessari, con un potenziale impatto diretto sulla sostenibilità del sistema [3][4][9]. In un contesto di crescente pressione assistenziale e risorse limitate, le recenti valutazioni HTA – come quelle del NICE – confermano la rilevanza e la sostenibilità di questi strumenti [10].
Il futuro della gestione dell’IC non può prescindere da un modello integrato ospedale–territorio, in cui farmacie, Case della Salute e telecardiologia lavorano in rete per garantire interventi tempestivi, personalizzati e realmente in grado di prevenire le riacutizzazioni.
Si tratta di un cambiamento organizzativo che non solo migliora la qualità dell’assistenza, ma rappresenta anche una risposta concreta alla sfida della cronicità nel sistema sanitario italiano.
1. Pierucci G, Adamo F, Mahfouz K, Vergaro G, Passino C, Emdin M, et al. Remote monitoring and heart failure: state of the art and future perspectives. Eur Heart J Suppl. 2025;27(Suppl 1):i126-i131. doi:10.1093/eurheartjsupp/suae116
2. Santini L, Adamo F, Mahfouz K, Colaiaco C, Finamora I, De Lucia C, et al. Remote management of heart failure in patients with implantable devices. Diagnostics. 2024;14(22):2554. doi:10.3390/diagnostics14222554
3. Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, Filippatos G, Coats AJS, Rosano G, et al. Biomarkers and point-of-care strategies in HF management. ESC Heart Fail. 2021;8(4):2346-2362. doi:10.1002/ehf2.13393
4. Clerico A, Zaninotto M, Passino C, Plebani M. Reliability of point-of-care natriuretic peptide testing. Clin Chem Lab Med. 2020;58(9):1385-1399. doi:10.1515/cclm-2020- 0148
5. Boehmer JP, Hariharan R, Devecchi FG, Smith AL, Molon G, Capucci A, et al. A multisensor algorithm predicts heart failure events: MultiSENSE study. J Am Coll Cardiol. 2017;69(11):1349-1359. doi:10.1016/j.jacc.2016.12.033
6. Santini L, D’Onofrio A, Dello Russo A, Calò L, Pecora D, Favale S, et al. Prospective evaluation of the multisensor HeartLogic algorithm for heart failure monitoring. Clin Cardiol. 2020;43(7):691-697. doi:10.1002/clc.23366
7. Virani SA, Sharma V, McCann M, Koehler J, Tsang B, Zieroth S. Integrated device diagnostics for HF: TRIAGE-HF study. ESC Heart Fail. 2018;5(5):809-817. doi:10.1002/ehf2.12339
8. D’Onofrio A, Pieragnoli P, Ricciardi G, Molon G, Leoni L, Botto G, et al. SELENE-HF: Multisensor prediction of heart failure events. Europace. 2021;23(7):1070-1079. doi:10.1093/europace/euab020
9. Gardner RS, Singh JP, Stancak B, McEneaney D, Moreton R, Wright DJ, et al. HeartLogic multisensor algorithm and NT-proBNP for prediction of HF events. Eur Heart J. 2022;43(5):432-441. doi:10.1093/eurheartj/ehab706
10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). HeartLogic™ algorithm for heart failure monitoring (MTG72). London: NICE; 2024.TriageHF™ for heart failure risk stratification (MTG81). London: NICE; 2024.

Segui la sezione Bandi e Concorsi sul sito della FNOB
Troverai gli avvisi pubblici dedicati ai Biologi
Dalla medicina all’abuso, il fragile confine nel rapporto millenario tra uomo e mondo vegetale
di Giuliano Russini*
Il rapporto uomo-piante è costellato anche da eventi non sempre piacevoli. Secondo gli storici delle vicende di Carlo Magno, quando il suo esercito invase il nord dell’India nel III secolo a.C., le truppe macedoni si ammalarono di colera: probabilmente perché si nutrirono di manghi lavati con acqua infetta dal bacillo del colera (Vibrio cholerae), per le scarse condizioni igieniche presenti. Tornando ai giorni nostri, un esempio a livello merceologico sanitario ove l’uomo ha coltivato una pianta ad un certo punto, soprattutto per scopi illegali, che ha generato una vera e propria piaga nella salute pubblica della società umana è quello che si ritrova nel “Triangolo d’oro”.Sebbene l’origine è da far risalire ad almeno mille e più anni indietro per la produzione dell’oppio comunemente fumato in Asia è solo però a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, che con la coltivazione estesa di una pianta angiosperma a ciclo annuale con radice a fittone e fusto eretto e come frutto una capsula (treto) poricida deiscente (che si apre spontaneamente), il papavero dell’oppio (Papaver somniferum Linnaeus, 1753), che viene a propagarsi in tutto il mondo occidentale, una vera epidemia sociosanitaria, con il consumo dell’eroina**, che ha portato a migliaia di morti tra i giovani che ne fecero uso e abuso, in particolare tra gli anni ’70 e ’80 del XX secolo.
Papaver somniferum e il Triangolo d’oro: Sebbene la coltivazione estensiva del papavero dell’oppio
* Biologo
oggi è molto praticata anche in Afghanistan, Pakistan e Kirghizistan e lo era da secoli in Cina e, tale pianta la si ritrova (perché importata dai turchi nel XVIII secolo), anche in Europa, l’origine della sua coltivazione a scopi illegali e poi del traffico mondiale dell’eroina da essa derivata è da ricondursi in tre paesi asiatici, nello specifico dell’Indocina, che per la loro posizione geografica e i miliardi di dollari che erano i ricavi, venne denominato il Triangolo d’Oro e il periodo del suo massimo splendore fu negli anni ’70 del XX secolo.
Con il termine Triangolo d’Oro - Golden Triangle - s’intende un’area di circa 950.000 km², che interessa la Tailandia (ex Siam), il Laos e la Birmania (oggi Myanmar). In particolare, i tre paesi confinano nel punto in cui il fiume Ruak (Birmania) confluisce nel Mekong (confine Thai-Lao). Più specificamente la coltivazione (per decine di migliaia di ettari), coinvolgeva più il Laos e la Birmania, la Tailandia per le condizioni pedoclimatiche era meno avvezza e se ne coltivava meno, ma lo sviluppo di questo ultimo paese rispetto gli altri due era molto più avanzato, quindi fungeva più da centro di trasformazione per produrre l’eroina e di partenza per la distribuzione via Hong Kong, verso tutto il mondo occidentale, in primis Europa e USA.
La società degli anni ’70 del secolo scorso, in tutto l’occi-
** L’eroina è una sostanza stupefacente semi-sintetica da endovena, ottenuta elaborando chimicamente la morfina, il principale alcaloide che si ricava dall’oppio grezzo, il succo lattiginoso estratto dalle capsule del “Papaver somniferum” attraverso processi di laboratorio piuttosto semplici.

Kirghiso intento nella raccolta delle capsule del papavero dell’oppio. dal libro di Turdakun Usubaliev “Bisogna conoscere il passato, per non fare errori in futuro” ed. Sputnik, 1979.
dente, era pervasa dal fascino del lontano oriente, accanto alle discipline esotiche della meditazione, o alle pratiche dell’induismo e delle nuove tendenze new age, i giovani trovarono nell’uso degli oppiacei prima e dell’eroina poi, una forma di ribellione e anticonformismo che divenne quindi dipendenza cronica, quest’ultima li faceva sprofondare nella più cupa alienazione, fino alla morte, poiché l’abuso determinava un crollo del sistema nevoso centrale, fino al collasso e alla fine della vita.
Il Kirghizistan e la coltivazione del papavero da oppio per uso medico:
I primi campi di papaveri da oppio apparvero in Kirghizistan molto prima che arrivassero i sovietici. Alcune fonti affermano che sia arrivato nella regione nel 1870 dalla Cina. Il papavero da oppio veniva coltivato nella valle intorno al lago Issyk-Kul, dove il clima era il più favorevole per la coltivazione della pianta. Gli zar e successivamente le autorità sovietiche avevano il monopolio statale sulla produzione di oppio. Entrambi hanno affrontato il contrabbando e il contrabbando della sua produzione e di conseguenza hanno dovuto ridurre i campi di papaveri da oppio, vietando la coltivazione nelle aree vicine al confine cinese e introducendo ulteriori sanzioni penali per gli agricoltori non autorizzati. La regione di Issyk-Kul divenne rapidamente l’epicentro della produzione di questo prezioso materiale medico non solo in Kirghizistan, ma in tutta l’URSS; infatti gli oppiacei prodotti dalla ossidazione del lattice estratto dalla capsula del frutto incisa, venivano utilizzati come antidolorifici e in chirurgia.
Il bambù:
Il bambù (Poaceae: Bambusoideae) rappresenta invece una tra le migliaia di tipologie di piante con cui l’essere umano ha avuto ed ha un rapporto utile. Un genere di piante che sopravvisse addirittura come il ginkgo, alla esplosione della bomba atomica di Hiroshima: nell’epicentro dell’esplosione, i botanici trovarono dei germogli che continuavano a svilupparsi regolarmente. Al bambù, nome generico per il botanico, appartengono 33 generi e circa 500 specie originarie per la gran parte dell’Asia meridionale e orientale.
Nelle regioni equatoriali queste piante assumono l’habitus

Biologo della stazione sperimentale di Przhevalsk (Kirghizistan), intento a creare nuove razze di papavero dell’oppio più resistenti alla siccità. Dal libro di Turdakun Usubaliev, 1979.
arboreo raggiungendo i 30 e più metri di altezza. Tipico di queste piante che appartengono al gruppo delle graminacee (affini quindi all’orzo al grano e all’avena) è il fusto cavo, detto “culmo”, suddiviso da nodi, che si allunga non solo all’apice ma anche nelle varie sezioni di cui è formato. Alla base della pianta madre, germogliano e si sviluppano velocemente altre piante, fino a formare densi ammassi, impenetrabili foreste; la cinetica di crescita del bambù lo rende una delle piante a più rapido sviluppo, circa 40 cm al giorno. Nell’Asia sudorientale e orientale, il bambù nelle aree agricole, ancora oggi è importante quanto l’acqua; serve per fare capanne, tetti, stuoie, mobili, tramezzi, utensili per lavorare la campagna, carri per trasportare merci e ancora stoviglie, recipienti, ventagli e canestri; l’elenco potrebbe continuare.
Per i saggi dell’antica Cina, il bambù era uno dei “Quattro Venerandi Signori”, con il crisantemo, il susino e l’orchidea, o anche, uno dei “Tre Amici” con il dusino e il pino: il bambù era il simbolo di Budda, mentre gli altri due alberi lo erano di Confucio e Lao-Tzu. Il bambù è così parte integrale della cultura orientale, che dopo l’essere umano è il soggetto più dipinto, da 2.000 anni in qua.
1. Il Libro delle Piante, Franceso e Maria Vittoria Bianchini- Fabbri Editori
2. Scienze Biologiche “Gli esseri viventi”, AA.VV. -Istituto Geografico de Agostini Novara
3. Tropical Plants, W. Lötschert, G. Beese -Collins Guide
4. Il grande Libro delle Piante e dei Fiori- AA.VV. Reader’s Digest
5. John Aberth “Plagues in World History”
6. Ulrico di Aichelburg “Igiene e Medicina Sociale”, Società Editrice Internazionale
7. Abbiw, D.K., 1990, Useful Plants of Ghana. West African uses of wild and cultivated plants. Intermediate Technology Publications and the Royal Botanic Gardens, Kew. p 41
8. Anderson, E. F., 1993, Plants and people of the Golden Triangle. Dioscorides Press. p 205
9. Awasthi, A.K., 1991, Ethnobotanical studies of the Negrito Islanders of Andaman Islands, India - The Great Andamanese. Economic Botany 45(2) pp274-280.
10. Latimer, Dean, and Jeff Goldberg “Flowers in the Blood: The Story of Opium”. New York: Franklin Watts, 1981.
11. Turdakun Usubaliev “Bisogna conoscere il passato, per non fare errori in futuro” ed. Sputnik, 1979
12 . The Bamboos by G.P. Chapman, Linnean Society Symposium Series No. 19, 1997
4 Crediti Ecm

4 Dicembre 2025 Ore 9:30 - 16:30
